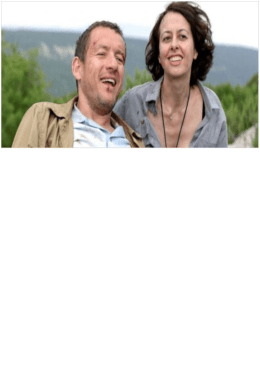RUDOLF ARNHEIM RUDOLF ARNHEIM I baffi di Charlot Scritti italiani sul cinema 1932-1938 ISBN 978-88-89908-37-2 € 25,00 kaplan Adriano D’Aloia (Milano 1980) è dottorando di ricerca in Culture della Comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Collabora alle attività di ricerca e didattica del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo dello stesso ateneo. Suoi saggi sulla storia e la teoria del cinema sono apparsi in volumi collettanei e sulle riviste «Bianco e Nero», «Cinéma&Cie», «E|C» e «Fata Morgana». I baffi di Charlot Rudolf Arnheim (Berlino 1904Ann Arbor, Michigan 2007) è stato uno dei maggiori pensatori del Novecento nel campo della psicologia dell’arte. Laureatosi a Berlino sotto la guida dei fondatori della Psicologia della Gestalt, ha esordito come critico cinematografico in Germania alla fine degli anni Venti. Dopo la pubblicazione di Film als Kunst (1932) è approdato in Italia per lavorare al progetto incompiuto dell’Enciclopedia del cinema. Fra il 1935 e il 1938 ha collaborato alle più importanti riviste italiane di cinema e pubblicato La radio cerca la sua forma (1937). Nel dopoguerra ha insegnato a Harvard e alla University of Michigan. Fra le sue opere più importanti, oltre alla nuova versione di Film come arte (1957, tradotto in italiano nel 1960), Arte e percezione visiva (1954) e Pensiero visivo (1969). a cura di Adriano D’Aloia prefazione di Leonardo Quaresima kaplan Nel cuore degli anni Trenta Rudolf Arnheim fu tra i principali animatori del dibattito italiano sul cinema. Le tracce di quella fugace ma intensa stagione, segnata da una rocambolesca fuga a causa delle leggi razziali, rischiavano di andare perdute. Questo volume riporta alla luce un consistente corpus di articoli e saggi apparsi sulle più importanti riviste specializzate dell’epoca, a testimonianza del significativo ruolo che Arnheim ebbe nel panorama culturale del nostro paese e dell’importanza che la sua parabola italiana ricoprì nella maturazione del successivo lavoro. Ad emergere è un volto inedito di Arnheim, acuto osservatore della produzione cinematografica internazionale e ponderato divulgatore degli aspetti psicologici e tecnologici dell’arte delle immagini in movimento. Una voce autonoma, originale e diretta che ancora oggi può parlare agli studiosi e agli appassionati di cinema. Archivi della teoria del cinema in Italia La collana “Archivi della teoria del cinema in Italia” è resa possibile da un finanziamento da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale della Cinematografia. Un ringraziamento particolare al dott. Gaetano Blandini. La collana è collegata alle attività del Permanent Seminar on History of Film Theories, un network internazionale di studiosi coordinati da Jane Gaines (Columbia University) e da Francesco Casetti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano/Yale University). Per il Permanent Seminar, si veda http:// museonazionaledelcinema.it/filmtheories/ RUDOLF ARNHEIM La collana è diretta da un comitato scientifico composto da: Francesco Casetti (coordinatore), Dudley Andrew, Sandro Bernardi, Paolo Bertetto, Antonio Costa, Roberto De Gaetano, Ruggero Eugeni, Giorgio De Vincenti, André Gaudreault, Vinzenz Hediger, Leonardo Quaresima, David Rodowick, Phil Rosen. Veronica Pravadelli cura la segreteria del progetto. I baffi di Charlot Scritti italiani sul cinema 1932-1938 a cura di Adriano D’Aloia The series “Archivi della teoria del cinema in Italia” is published with a support from the Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale della Cinematografia. Special thanks to Dr. Gaetano Blandini. The series is linked to the activities of the Permanent Seminar on History of Film Theories, an international network of scholars directed by Jane Gaines (Columbia University) and Francesco Casetti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan/Yale University). For the Permanent Seminar, see http://museonazionaledelcinema.it/filmtheories/ The series is directed by a scientific board formed by: Francesco Casetti (coordinator), Dudley Andrew, Sandro Bernardi, Paolo Bertetto, Antonio Costa, Roberto De Gaetano, Ruggero Eugeni, Giorgio De Vincenti, André Gaudreault, Vinzenz Hediger, Leonardo Quaresima, David Rodowick, Phil Rosen. Veronica Pravadelli follows the organizative aspects of the series. prefazione di Leonardo Quaresima kaplan Rudolf Arnheim I baffi di Charlot. Scritti italiani sul cinema 1932-1938 a cura di Adriano D’Aloia Indice 9 Con imperterrita cura 15 Prefazione. I baci di Mae Murray 25 Introduzione. La parabola italiana di Rudolf Arnheim di Leonardo Quaresima di Adriano D’Aloia Antologia. Rudolf Arnheim e il cinema nelle riviste italiane In copertina Rudolf Arnheim nella redazione di «Cinema», Roma 1938 (Deutsches Filminstitut – Frankfurt am Main) Gli antecedenti 96 98 101 Soggettista e direttore artistico (1932) Arte riproduttiva (1933) Contrappunto sonoro (1933) Il lavoro all’IICE © 2009 edizioni kaplan Via Saluzzo 42bis 10125 Torino Tel. e fax 011-7495609 104 107 113 127 132 137 142 147 152 155 160 164 167 [email protected] www.edizionikaplan.com ISBN 978-88-89908-37-2 L’editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare. Nostro pane quotidiano (1935) Espressione (1935) Vedere lontano (1935) L’Enciclopedia del cinema (1935) Espressione (1935) Espressione (1935) Espressione (1935) Espressione (1935) Espressione (1935) Il critico cinematografico di domani (1935) Espressione (1935) Espressione (1935) Espressione (1935) Il contributo a «Cinema» 173 177 180 182 183 Perché sono brutti i film a colori? (1936) A proposito del cinema a colori (1936) Polarizzazione. La lotta contro i riflessi (1936) Danza macabra (1936) La mano del regista (1936) 5 184 185 186 187 188 191 193 194 196 198 201 203 206 209 212 214 216 220 223 226 227 229 231 232 234 237 240 244 249 252 253 L’uomo invisibile delle attualità (1936) Lux e lumen (1936) Montaggio senza montaggio (1936) Senza parola (1936) Psicologia del “Gag” (1936) Una notte sul Monte Calvo (1936) Dominatrici (1936) Uno zio del cinematografo (1936) Cinema “in persona prima” (1936) Uno spettro in tre versioni (1937) Analisi d’una ignota (1937) Gli occhi del cervello (1937) Dettagli che non sono dettagli (1937) Televisione. Domani sarà così (1937) Espressione e bellezza (1937) La luce in movimento (1937) Resurrezione del Cineasta? (1937) Il paesaggio ispiratore (1937) Ma che cosa è questo cinema? I. Sonoro e muto? (1937) Un mondo più colorato (1937) Ma che cos’è questo cinema? II. Bisogna seguire il gusto delle masse? (1937) Orizzonte perduto (1937) Una signora mai vista (1938) Il cifrario del successo (1938) Il formato ridotto diventerà formato normale? (1938) La loro vita privata (1938) L’attore e le stampelle (1938) Il nuovo sistema italiano per la cinematografia a colori naturali (1938) Il detective soggettista (1938) Un lettore ci domanda (1938) Il cinema documentario e i popoli (1938) Le rubriche di «Cinema» 258 264 268 272 275 Rubrica “Capo di Buona Speranza” (1937/1938) Rubrica “Scienza e tecnica” Pesci d’aprile. Le meraviglie della tecnica (1937) Le leggi del colore (1937) Rubrica “Fotografia” Memorie della camera oscura (1937) Esame di coscienza (1938) 6 279 280 281 281 282 282 283 284 284 285 286 287 288 289 290 291 291 292 292 Rubrica “Bianco e Nero” (1937) Vigilia d’armi È arrivata la felicità Voglio essere amata L’imperatore della California Il sentiero della felicità Lo studente di Praga Amore tzigano L’amato vagabondo I nostri parenti Maria di Scozia I cavalieri del Texas Il mio amore eri tu La carica dei 600 La donna del giorno Il paradiso delle fanciulle Ramona La bambola del diavolo Seguendo la flotta Contessa di Parma «Bianco e Nero» 295 298 322 Principi del montaggio (1938) Il film come opera d’arte (1938) Nuovo Laocoonte (1938) Appendice bibliografica 349 358 359 360 Scritti sul cinema di Rudolf Arnheim nelle riviste italiane Storia di un libro. La vicenda editoriale di Film come arte Estratti da Film als Kunst/Film/Film come arte in Italia Arnheim, Cinema, Italia. Bibliografia secondaria 365 385 393 Appendice iconografica Indice dei nomi Indice dei film 7 Con imperterrita cura Un sogno, un incontro e molti ringraziamenti Ridere davvero non può che l’uomo d’ingegno, perché lui solo conosce il manchevole e l’errato1. Fumi di lava vulcananica fuoriescono da fori sparsi ovunque sul terreno. Sulla vetta dell’altopiano, esausto ma incolume, un uomo procede camminando tra lingue di fuoco rasenti il suolo. Una donna – sua moglie – lo esorta a esser cauto. Ma lui non si scotta, il suo corpo non brucia tra le fiamme. È un fuoco freddo, lo si può persino attraversare a piedi nudi. La donna gli domanda il motivo per cui non voglia scostarsi dalle fiamme. Ma non vi è motivo di sottrarsi a vampe che non ustionano. Certo quel fuoco avrebbe potuto – almeno crede, ma non saprebbe dire per quale ragione – essere pericoloso per il futuro. Nell’ultima pagina del diario italiano di Rudolf Arnheim, datata martedì 13 dicembre 1938, è trascritto, in tedesco, questo sogno, nello stile narrativamente confuso e incoerente che contraddistingue la logica delle visioni oniriche e il loro ricordo. Non occorrono gli strumenti dell’interpretazione psicoanalitica per scorgere in quella vaga paura per il futuro, simbolizzata dalle lingue di un “fuoco freddo” che inspiegabilmente non hanno effetto alcuno sul corpo, l’ombra inquietante che i regimi europei della prima metà del XX secolo avevano allungato sull’Europa e sulla vita di molti. La vicenda ultracentenaria di Arnheim, nato nel 1904 a Berlino in una famiglia di origini ebree e per questo costretto alla fuga per i primi trentacinque anni della sua vita – dalla Germania all’Italia e poi negli Stati Uniti con passaggio da Londra –, si è nutrita di una biografia appassionata e appassionante, sia sul fronte personale sia su quello professionale, segnata dall’alternarsi di momenti di fitta oscurità e di fulgido bagliore e conclusa all’incredibile età di oltre 102 anni, il 9 giugno 2007 ad Ann Arbor, Michigan. Arnheim è sopravvissuto a chiunque, a tutti i coetanei che già alla fine degli anni Venti si erano avventurati come lui nel territorio della psicologia percettiva, a tutti i componenti della sua famiglia, alla sua seconda moglie Mary (sposata nel 1953), e persino a se stesso, lungo l’ultimo ventennio di vita, trascorso modestamente in una residenza immersa nella natura del Michigan, non lontano dall’università e dalla città che avevano ospitato l’ultima stagione del suo lavoro. Da molti – certo non dai suoi più vicini colleghi e amici – fu dimenticato e da alcuni, che pure negli anni erano venuti in contatto con lui o con le 9 sue idee, era dato per morto, nonostante i suoi articoli e i suoi libri continuassero a essere ripubblicati e tradotti in tutto il mondo. Come del resto tuttora. Sulla scia della rinnovata attenzione esplosa nel 2004 in occasione del suo centesimo compleanno e nel 2007 per la sua scomparsa, Arnheim è tornato a essere una figura interessante fra le molte che hanno abitato e segnato l’universo culturale del XX secolo. Una figura di cui è necessario raccontare di nuovo la storia, una vera e propria parabola, soprattutto nel suo tratto italiano, di cui le fasi di ascesa e declino purtroppo sono molto ravvicinate. Arnheim fu accolto in Italia a braccia aperte, e fu cacciato senza riconoscenze. L’inscindibilità di fatti personali e fatti professionali lo ha segnato sin dagli anni dei suoi esordi berlinesi come critico cinematografico, primo ad applicare ai mezzi di comunicazione di massa e alle arti della Modernità – la fotografia, il cinema, la radio – gli assunti della psicologia della Gestalt appresi direttamente dai suoi fondatori Max Wertheimer e Wolfgang Köhler. I baffi di Charlot che danno il titolo al volume vogliono essere un esplicito rimando a quell’“unicità biografica” in virtù e a causa della quale persino un articolo troppo allusivo alla somiglianza fra i baffi di Charlie Chaplin e quelli di Adolf Hitler e le implicazioni psicologiche di tale corrispondenza sul piano dell’espressione poté costringerlo all’esilio. Quando nel 1933 scese in Italia, per lui quasi una seconda patria e certamente un terreno di maturazione professionale e personale, non poteva certo immaginare che un’altra beffa lo stava attendendo quasi in fondo allo sciagurato eppure così fervido decennio dei Trenta. Gli anni roventi del sole romano, durante i quali diede un grande contributo al contesto culturale del nostro paese e strinse profonde amicizie – cui si diceva “disperatamente attaccato”2 – che avrebbe poi dovuto amaramente troncare, cominciarono troppo presto a bruciare anche sotto il profilo politico. L’estate del 1938, come nel suo sogno premonitore, raggelò la penisola, divenuta d’un colpo razzista e antisemita. Il paese che lo aveva accolto con grandi onori gli era divenuto d’un tratto ostile e lo costrinse alla fuga, intrapresa dopo mille esitazioni nel maggio del 1939. Con la fiduciosa rassegnazione che lo contraddistinse in ogni epoca – ma che al contempo celava il fermento interiore che gli ha dato la forza di vivere per oltre cent’anni –, pur di fronte a eventi dolorosi, anche famigliari, ricominciò la propria vita tre volte azzerata: Berlino, Roma, Londra… dal cuore ammalato del suo amato continente sino all’altra sponda dell’Atlantico, nel 1940, per una vita nuova nella Nuova York, come ancora era in uso chiamare l’avamposto che per lui e molti suoi compagni di sventura fu approdo sicuro e opportunità di risalita. Il resto – la sua carriera accademica ebbe il suo culmine a Harvard negli anni Settanta – fu l’attuarsi di un destino segnato, ma non scritto. Guadagnato con tenacia e grande lucidità, sempre a cavallo fra la passione umanistica per le arti e il rigore dei suoi convincimenti teorici, fra percezione audio-visiva e comprensione del mondo, in un unico sforzo intuitivo basato sulla con- templazione, un’unica esperienza vitale fondata sulla pregnanza della realtà nel suo darsi alla percezione e l’onestà di uno sguardo consapevole delle proprie limitazioni. C’è qualcosa di profondamente umano in questo approccio, qualcosa che non solo era mirato a elidere la separazione fra mente e natura riformulando le basi teoriche della loro relazione di coesistenza, ma indirizzato anche a sviluppare un “pensiero visivo”, uno strappo di natura epistemologica che non riguarda tanto gli oggetti dell’investigazione, quanto il formarsi di un inedito paradigma che consenta di illuminare di luce nuova – una insight – la relazione fra una scienza e il suo oggetto. Riguarda, insomma, le modalità con cui esploriamo, percepiamo, comprendiamo, viviamo il mondo. Lo stesso strappo si è verificato nel percorso di ricerca che ha portato alla pubblicazione di questo volume. Il giorno in cui, un pomeriggio dell’agosto 2005, ho incontrato di persona Rudolf Arnheim, qualcosa è cambiato nell’idea e nella percezione che avevo di tale percorso. Quell’ora trascorsa nella sua stanza alla Glacier Hills Retirement Community di Ann Arbor ha dato una svolta non tanto agli obiettivi della ricerca, quanto al piglio con cui, subito dopo essermi congedato, ho ripreso a cercare, studiare e scrivere. Benché la sua età avanzata – aveva all’epoca appena compiuto 101 anni – non permise uno scambio di opinioni e non servì in senso puramente scientifico, l’incontro con la sua persona riformulò il campo entro cui ho poi continuato a lavorare attorno alla sua “vicenda cinematografica”. Con mia grande sorpresa, e nonostante le difficoltà che qualsiasi altra persona tanto anziana si sarebbe trovata ad affrontare, riuscimmo a dialogare in italiano. Faticò non poco a comprendere le ragioni di quella visita, ma accolse l’ospite con vivo interesse. In quei pochi momenti ho avuto modo di apprezzare direttamente quell’umanità che avevo intuito ma non ancora saggiato attraverso le letture e lo studio. Nonostante gli stenti nell’udito e nella vista, riuscì a comunicarmi la nostalgia per un lavoro di cui era innamorato e che non poteva più portare avanti. Fra i molti piccoli eventi, il cui racconto può apparire banale per via del modo quasi infantile con cui i vecchi tornano a scoprire la realtà, ho avuto l’onore di ricevere un suo autografo sulla mia copia di Film as Art (e conservo gelosamente una fotografia di ricordo). Con grande attenzione volle ascoltare in italiano il testo della lettera con cui gli anticipavo la mia visita, dando prova dell’amore e della costanza quasi maniacale con cui nel corso di lunghi decenni aveva mantenuto corrispondenze con centinaia, forse migliaia, di colleghi, amici, studenti e studiosi. Scrivere era per lui un’attività naturale e istintiva. Non passò un giorno, neppure durante le ferie, senza che avesse scritto, a mano o a macchina, almeno una lettera a un amico, steso appunti per una lezione o un libro, contattato un editore o un traduttore, chiosato un testo, abbozzato un saggio o trascritto un pensiero sul proprio diario. Ogni giorno, con imperterrita cura. I molti 10 11 archivi in cui sono conservate le sue carte sono spaventosamente colmi di tanta costanza e passione. Più di tutto però mi colpirono gli istanti di silenzio dopo una domanda o una frase, durante i quali il suo sguardo limpido si fermava, fisso nel vuoto che separa gli occhi di due dialoganti, a cercare una risposta o un’interpretazione a qualcosa che sembrava svanito dalla memoria, una parola non capita o non udita bene. “Immagine” è per Arnheim ciò che comunica un significato attraverso l’esperienza sensoria, il mondo fisico degli oggetti, fra cui anche le opere d’arte e dunque il film; ma è anche ciò che si dà alla visione interiormente: i pensieri, le invenzioni, le fantasie, i ricordi, immagini sensoriali non prodotte dalla presenza degli oggetti fisici. In entrambi i casi, le immagini partecipano a un movimento di continuo «andare e venire»3. In questo flusso ininterrotto è indispensabile che ci siano immagini significative a offrire un contrappeso all’inevitabile logorio dovuto al tempo e all’incuria. Occorrono le immagini durevoli e stabili dell’arte, che offrono un deposito di significato senza il quale saremmo irrimediabilmente esposti al «volo degli avvenimenti transitori»4. Nella mente di Arnheim, nel suo “cinema cerebrale”5 fatto di pensieri e ricordi, le immagini non si erano ancora fermate e gli occhi sembravano ancora seguirne la scia. Dimenticare è come chiudere gli occhi – avrebbe detto –, «la memoria ritorna in tempo, ma rimane il sospetto che alla fine morire sarà semplicemente dimenticasi di vivere»6. Una consapevolezza che sembrava averlo reso immortale. Negli oltre cento anni di una vita incredibilmente longeva, Rudolf Arnheim ha esplorato con rigore e inesauribile passione i vasti territori dello sguardo. La sua avventura attorno alle coordinate del visibile maturò durante quella breve ma intensa e “fervida stagione italiana”7 – stretta fra il 1933 e il 1938 – in cui il vivo interesse per i fenomeni della percezione e lo studio dell’espressione erano totalmente inscritti nei confini del cinema. Metafora assoluta dello sguardo e dei suoi limiti, il cinema sembrò da subito ad Arnheim il miglior oggetto artistico e comunicativo su cui provare la tenuta della teoria. Il cinematografo costituiva un campo perfetto di applicazione dei principi gestaltici – applicazione poi estesa all’intera gamma delle manifestazioni artistiche. Il colpo di fulmine fra Arnheim e il cinema era già scoccato in terra tedesca alla fine degli anni Venti, ma l’amore maturò in Italia nel cuore degli anni Trenta. Nella certezza che possa essere uno strumento utile per studenti e studiosi di teoria e storia del cinema, questa antologia di scritti sul cinema di Rudolf Arnheim sulle riviste italiane vuole ricostruire e soppesare più obiettivamente il suo apporto teorico e divulgativo al panorama culturale (non solo cinematografico) del tempo, nel tentativo di porre rimedio all’inaccuratezza e alla parzialità delle bibliografie esistenti. Una ricostruzione filologica il più possibile attenta e completa della produzione critica e scientifica di Arnheim durante il suo periodo di permanenza e lavoro a Roma ha consentito di colmare molte lacune e di riportare alla luce una parte dimen- ticata o inesplorata, talvolta ignorata, di tale apporto, con numerosi e rilevanti elementi di novità. L’acquisizione di nuovi materiali che testimoniano il ruolo decisamente attivo di Arnheim nelle vesti di pubblicista-divulgatore cinematografico può rilanciare l’indagine sull’effettiva entità dell’influenza della sua teoria rispetto al panorama culturale del nostro paese fra le due guerre, nonostante la sua formazione per così dire “esogena” rispetto all’idealismo crociano abbia contribuito a farne uno “spirito libero”. Archivi ben nutriti di documenti sono stati esplorati, da questa e quella parte delle Alpi e su entrambe le sponde dell’Atlantico, centinaia di lettere e documenti sono stati consultati e molti rapporti epistolari sono stati ricostruiti, studiosi di diversa generazione e nazionalità sono stati interpellati, decine di periodici di varia natura sono stati consultati. Progressivamente e costantemente si sono aperte nuove ipotesi e un certo numero di piste è stato seguito, fiutando le tracce, rincorrendo i rimandi, ricostruendo percorsi. Il risultato somiglia al restauro di un antico mosaico insidiato dal tempo e da molti scossoni. Un mosaico ampio e complesso, nel suo insieme davvero degno di ammirazione, ma che come ogni opera restaurata ha subito un certo trattamento e forse manca di qualche tessera. È pur sempre il recupero di un’opera che avrebbe potuto deteriorarsi irreparabilmente. Questo lavoro di restauro non sarebbe stato possibile senza l’aiuto attento, prezioso e decisivo di molte persone, in varie fasi del lavoro e a diverso titolo. Su tutte Margaret Nettinga-Arnheim, con estrema gentilezza, mi ha concesso l’incontro con suo padre, mi ha permesso di intervenire al Memorial Meeting organizzato in suo onore il 31 settembre 2007 ad Ann Arbor e con eccezionale disponibilità mi ha fornito preziose informazioni e documenti privati durante l’intera ricerca. Molti esimi professori mi hanno supportato durante il percorso. Francesco Casetti ha supervisionato l’intero lavoro consigliandomi sapientemente. Massimo Locatelli mi ha costantemente dato preziosi suggerimenti e coadiuvato per le traduzioni dal tedesco. Ho la grande opportunità di collaborare con loro presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ringrazio Helmut H. Diederichs (Fachhochschule, Dortmund) per i materiali forniti attraverso il forum on-line8, sui quali la ricerca ha basato le sue prime mosse, e per avere accolto e dato risposta alle mie tante domande. Desidero ringraziare per la loro disponibilità anche Giuseppe Mazzotta della Yale University e Giorgio Bertellini della University of Michigan. Roy R. Behrens (University of Northen Iowa) ha contribuito alla costruzione dell’apparato iconografico, in cui appaiono per la prima volta fotografie che risalgono agli anni italiani di Arnheim. Per i preziosi consigli ricevuti ringrazio Giulia Carluccio, Antonio Costa, Raffaele De Berti, Federico di Chio, Ruggero Eugeni, Lucia Pizzo Russo, Leonardo Quaresima, Antonio Somaini. 12 13 Ringrazio l’organizzazione e la giuria del XXVI Premio “Adelio Ferrero” (2006) – in particolare Lorenzo Pellizzari e Nuccio Lodato – per il riconoscimento e il contributo che mi sono stati concessi. I responsabili e il personale degli archivi e degli istituti che ho visitato in Italia e all’estero hanno fatto molte eccezioni al regolamento, permettendomi di acquisire materiale altrimenti inaccessibile. Infine, fra i molti amici che mi hanno aiutato a vario titolo, ma tutti in modo determinante, ringrazio soprattutto Marco Muscolino, Roberta Busnelli e Lavinia Tonetti. Francesca Gambaro non solo mi ha assistito in molte fasi del lavoro, ma ne è stata testimone fin dall’incontro con Rudolf Arnheim. Adriano D’Aloia Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 13 giugno 2008 NOTE Rudolf Arnheim, Nostro pane quotidiano, «Intercine», 1, 1935, p. 16. Rudolf Arnheim, Fedele d’Amico, Eppure, forse, domani. Carteggio (1938-1990), Archinto, Milano, 2000, p. 24. 3 Rudolf Arnheim, The Coming and Going of Images, «Leonardo», 3, 2000, p. 167. 4 Ivi, p. 168. 5 Edmondo De Amicis, Cinematografo cerebrale, in «L’Illustrazione Italiana», 1 dicembre 1907, pp. 532-533, poi in Ultime pagine di Edmondo De Amicis, 3. Cinematografo cerebrale: bozzetti umoristici e letterari, Treves, Milano, 1909. 6 Questa frase fu scritta da Arnheim sul proprio diario il 26 aprile 1972 e riportata in Rudolf Arnheim, Parables of Sunlight. Observation on Psychology, the Arts, and the Rest, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1989 (tr. it. Parabole della luce solare, Editori Riuniti, Roma, 1992, pp. 173-174). 7 L’espressione è mutuata da Ernesto G. Laura, La fervida stagione italiana di Rudolf Arnheim, «Filmcronache», 1, 2005, pp. 14-21. 8 Il forum è attualmente lo strumento più aggiornato e completo sulla vita e il lavoro di Arnheim. È consultabile all’indirizzo http://www.sozpaed.fh-dortmund. de/diederichs/arnheim.htm. 1 2 14 Prefazione I baci di Mae Murray di Leonardo Quaresima 1. Non sappiamo come il fenomeno verrà interpretato tra qualche anno: certamente ora non possiamo che registrare il grande ritorno di attenzione per le teorie del cinema, viste in una prospettiva storica. L’interesse in realtà è sempre esistito: la differenza è che in passato, legato soprattutto alla manualistica, faceva riferimento alle forme di un sapere fisso, corrispondente alle caratteristiche di fasi circoscritte e sentite come lontane. La novità della presente congiuntura poggia sulla convinzione, invece, che tale sapere possa interagire con la situazione, attuale, della discussione teorica e della stessa pratica cinematografica. O meglio, interagire con i processi contemporanei di trasformazione di componenti essenziali del dispositivo cinematografico e della stessa istituzione cinematografica, o più in generale del sistema delle arti visive. Un capitolo importante di questa storia è rappresentato dall’elaborazione teorica di Rudolf Arnheim, così come è stata sistematizzata da Film als Kunst (1932), ma anche dal libro sulla radio (apparso in Inghilterra nel 1936, ma scritto alcuni anni prima), e da molti testi degli anni Venti e Trenta, confluiti in tempi più o meno recenti in due volumi: Kritiken und Aufsätze zum Film (1977) e Die Seele in der Silberschicht (2004), entrambi a cura di Helmut H. Diederichs1. Un numero cospicuo di tale saggi risale al periodo del soggiorno italiano dell’autore (1933-1939), ma essi non erano stati più oggetto, nella loro integralità, di una riedizione – neppure nel nostro paese. Il libro che abbiamo in mano colma meritevolmente questa lacuna. Si tratta di testi che hanno avuto un forte impatto sulla cultura (cinematografica) italiana dell’epoca. È ad essi che si deve un importante contributo all’aggiornamento della riflessione teorica sul cinema nel nostro paese, per l’ancoraggio con la Gestalttheorie, con gli studi di psicologia della percezione e più in generale per le basi scientifiche dell’approccio da cui muovono. Essi sono stati protagonisti di un collegamento, il più qualificato, con le principali tendenze della ricerca internazionale (e del sapere tecnico internazionale) – così come del resto era negli intendimenti dell’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa (presso cui Arnheim trovò accoglienza), della «Rivista internazionale del cinema educatore» e successivamente di «Intercine» che ne erano emanazione, e del progetto della mai compiuta Enciclopedia del cinema (il cui carattere progressivamente “borghesiano” è vividamente messo in luce dal testo omonimo apparso su «Intercine», 3, marzo 1935). Alcuni di questi scritti hanno un’impostazione esplicativa rispetto a quelli weimariani, o anche apertamente divulgativa, ma sempre (e, malgrado il mutato contesto e le mutate ambizioni), anche nella fase di «Cinema», di alto livello, e costantemente in rapporto con le punte più alte dell’elaborazione internazionale (si veda, ad esempio, la tempestiva discussione di A Grammar of the Film, 1935, di Spottiswoode). dium avrebbe riportato alla ribalta (impostazione accostabile, sul piano metodologico, alla riscoperta del gesto visibile compiuta dal cinema nelle premesse di Der sichtbare Mensch di Balázs, cui il saggio di Arnheim rimanda anche per l’individuazione di una sorta di fisionomia sonora: un versante della ricerca dello studioso tedesco, mi sembra, ancora tutto da indagare). Ma il punto di vista può anche essere capovolto. Cosa aggiunge – possiamo chiederci – la parte italiana dell’attività di Arnheim alla sua elaborazione? Si approfondisce l’interesse per la tecnica cinematografica (in secondo piano o del tutto assente nella sua riflessione precedente), ma comunque ritenuta una componente fondamentale. Alla base della nascita del nuovo mezzo sta per Arnheim innanzitutto una nuova tappa dell’evoluzione tecnologica: «L’invenzione del cinema trova la sua collocazione naturale nel quadro dello sviluppo tecnico»9. Si intensifica l’interesse per la dimensione storiografica. Forte impulso trova lo studio dei meccanismi della percezione visiva e auditiva. Su un piano generale, ovvero in riferimento a determinati ambiti di applicazione: la visione stereoscopica, le dimensioni dello schermo in rapporto al campo visivo dello spettatore, la pellicola a grande formato. 2. I contributi “italiani” mettono in evidenza forti elementi di continuità con l’elaborazione precedente. Vi si confermano innanzitutto i tratti di una teoria estetica, fondata sui principi della teoria della Gestalt, sulla separatezza degli ambiti sensoriali. E su un’originale concezione delle “arti riproduttive” (fotografia, cinema, radio, cinema sonoro), contrassegnate da un rapporto diretto, di “riproduzione meccanica”, con la realtà, ma al contempo “arti” a pieno titolo, per la capacità di mettere a frutto le falle, i limiti delle procedure di riproduzione e dunque di trasformarsi in pratiche della rappresentazione. «Quando i raggi luminosi imprimono il chiaro e lo scuro sullo strato di bromuro d’argento, quando le onde sonore si disegnano nello strato di cera o sulla celluloide, è come se il modello prendesse il pennello togliendolo di mano al pittore! – è la felice immagine proposta dallo stesso Arnheim –. Ebbene, sappiamo da tempo che non si tratta di un semplice, meccanico processo di riproduzione. Altrimenti avremmo avuto a che fare con un dispositivo tecnico, del tipo della stampa, che non avrebbe niente a che fare con l’attività creativa artistica dello spirito umano»2. Ma gli scritti italiani confermano la continuità di impostazione anche su altri aspetti, meno vistosi (e meno indagati) della riflessione di Arnheim, e tuttavia di originale rilievo. Mi riferisco, ad esempio, al ruolo attribuito alla funzione dello spettatore (esemplare un Feuilleton degli anni Venti, Kino von hinten 3, in cui l’autore suggerisce di andare al cinema rivolgendo lo sguardo agli spettatori invece che al film), pur senza arrivare a forme organiche di integrazione: se «non c’è dubbio che ogni prodotto artistico deve “trascendere se stesso” […] questo non dà il diritto al fruitore di completare a sua volta l’opera privando la rappresentazione dei suoi limiti necessari»4. La continuità si evidenzia egualmente nel rilievo assunto dalla nozione di stile, che può emergere in modo ancora convenzionale e limitativo nell’opposizione stile/maniera, e nel legame con il contributo creativo di “grandi personalità”5, ma anche come qualità più indipendente, forma ricorrente svincolata da ancoraggi autoriali6. La stessa antiautorialità, che serpeggia negli interventi critici weimariani e che si insedia anche in Film als Kunst7, trova riscontro in Rundfunk als Hörfunk 8. Gli scritti italiani sono continuamente attraversati inoltre (ma qui torniamo a un momento centrale della ricerca dello studioso) dalla presenza della radio, la cui autonomia estetica viene edificata sui medesimi principi che sono alla base di Film als Kunst e su un’idea di atto udibile, che il nuovo me- 3. Gli anni passati nel nostro paese producono anche momenti di discontinuità con l’attività precedente. Si perde quasi completamente il taglio da Feuilletonist dei suoi scritti, la verve polemica, il linguaggio affilato, la qualità letteraria della scrittura. Il giovane Arnheim si era sentito subito a suo agio in questo solco. La collaborazione con i periodici dell’epoca (quotidiani influenti come il «Berliner Tageblatt» e la «Vossische Zeitung», riviste satiriche come «Das Stachelschwein», e quindi la celebre, autorevole e militante assieme, «Weltbühne») era avvenuta proprio servendosi di questo “formato”, utilizzato anche nell’attività “istituzionale” di critico cinematografico. Se i suoi punti di riferimento sono i più grandi esponenti del genere (Alfred Polgar, innanzitutto, uno dei principali collaboratori della stessa «Weltbühne»), i risultati non sfigurano rispetto ai modelli dei “maestri”. Non si dimentichi che nel 1928 vide la luce, oltre alla sua tesi di dottorato (Experimentell-psychologische Untersuchungen zum Ausdrucksproblem), proprio una raccolta di Feuilletons (comprendente un’ampia sezione di scritti di argomento cinematografico), Stimme von der Galerie, introdotta da una prefazione di Hans Reimann (l’animatore di «Das Stachelschwein»), e accolta da una lusinghiera recensione di Kurt Tucholsky sulla «Vossische Zeitung»10. Da questa formazione Arnheim ricava un’accanita passione per la lingua e la convinzione più viva del ruolo centrale dello stile di scrittura. Ricordando i suoi anni alla «Weltbühne» lo studioso stesso ha richiamato direttamente l’attenzione su tali aspetti, ricordando l’“attenzione da certosini” con cui il gruppo della rivista si dedicava anche alla correzione delle bozze, «dal momento che, per noi fanatici della lingua, i refusi erano una cosa inimmaginabile»11. L’attività come critico cinematografico di Arnheim è inseparabile 16 17 da tale impostazione. È lo stile di scrittura che sostiene la programmatica tendenziosità di molti giudizi, che alimenta l’intelligenza valutativa e interpretativa anche nei passaggi più faziosamente polemici. Un altro aspetto che si modifica è l’impostazione militante della sua prassi critica (la «Weltbühne» era una delle voci più “schierate” della sinistra intellettuale weimariana). Dove non erano riferimenti tematici e principi ideologici a funzionare da riferimento (criteri verso cui anzi Arnheim apertamente polemizza), ma sempre soluzioni di messa in forma, modalità della rappresentazione. Questa impostazione si smorza (sul versante squisitamente cinematografico) e naturalmente si perde su quello politico nella diversità della scena italiana degli anni Trenta. Il taglio diviene (anche in questo caso per una necessità dettata dall’esterno) piuttosto divulgativo, “educativo”. Fino a farsi (deliziosamente) impressionistico nelle recensioni brevi per «Cinema». L’acuminatezza della scrittura si stempera a sua volta, oltre che per il venir meno della tensione militante, per il filtro imposto dalla lingua italiana, che lascia nondimeno affiorare tracce significative del regime d’origine (si veda, esempio tra tutti, il testo Pesci d’Aprile. Le meraviglie della tecnica12), ma in un quadro ormai “normalizzato” sul piano della scrittura. Quando Film als Kunst viene pubblicato, la “battaglia” di Arnheim contro il film sonoro è ormai persa. Ma nei primi anni Trenta l’impegno dell’autore nel sostenere la propria concezione teorica (che vede nel sonoro un elemento di contraddizione e di regressione rispetto alle condizioni che hanno reso possibile l’affermarsi della dimensione estetica del cinema) prosegue di pari passo con l’accentuarsi del carattere provocatorio e tendenzioso della sua impostazione. Il trasferimento in Italia segna anche da questo punto di vista uno spartiacque. Se l’autore non modifica di una virgola le proprie idee di fondo, fa proprio al tempo stesso l’obiettivo di tallonare e interpretare da vicino la situazione presente (l’avvento del colore, i primi passi della televisione, l’insistenza sulla stereoscopia), anche – di nuovo – per far fronte alla commessa scientifico-divulgativa cui è chiamato a corrispondere. Se la presa sul contemporaneo si fa maggiore (gli scritti sulla televisione ci appaiono per molti versi “profetici”), l’impatto delle proprie concezioni originarie finisce necessariamente per attenuarsi. Pur risultando tutt’altro che trascurabili i “guadagni” di tale allargamento di prospettiva: all’attenzione per gli aspetti tecnologici si è già fatto cenno, così come a quella per la componente della ricezione (apprezzabile non solo sul piano della elaborazione, ma anche nel coinvolgimento del lettore-spettatore nella propria prassi critica: ciò che è alla base della conduzione della rubrica di corrispondenza con i lettori di «Cinema»). Ma lo spostamento conduce anche a una maggiore attenzione al contributo specifico dell’attore; a un allargamento di interesse per il fenomeno del divismo, per il cinema documentario, per quello amatoriale. 4. Negli anni di Weimar il critico Arnheim si muove senza complessi di soggezione nei confronti degli emergenti, acclamati, registi-autori dell’epoca: Dreyer, Gance, Lang, Murnau. La Passione di Giovanna d’Arco (1928) di Dreyer gli sembra affetta da un iper-estetismo, che se può trovare la sua ragion d’essere nell’ambito del cinema sperimentale, del film assoluto, «non è ammissibile in un film a soggetto». E si spinge fino alle valutazioni più eretiche (o liberatorie?): «Se un’interprete sta andando verso il proprio martirio, non è il momento di riprendere il suo volto e quello del suo boia, con tutte le loro rughe, come se fossero una graziosa opera d’artigianato uscita dalla bottega del Padreterno». Per arrivare, in riferimento agli eccessi nell’utilizzazione del primo piano, al giudizio più tranciante: «Un processo non è una galleria di quadri»13. Ancora un «eccesso di bellezza» gli sembra compromettere la riuscita di Tabù (1931) di Murnau, messo in discussione, tuttavia, anche rispetto alle sue premesse “etnografiche”. Il film gli sembra il risultato di cineasti-antropologi (denominati «missionari della croce di Malta»: definizione impareggiabile, da registrare…) che operano con “attori” e paesaggi come se girassero in studio; e l’estetismo, in più, di discutibile matrice: «Domina un’eccedenza di rami fioriti e corone tra i capelli, come se in Paradiso si stessero facendo dei saldi di fine stagione della bellezza per svuotare i magazzini». Ma l’operazione gli sembra anche “pericolosa”, per gli equivoci nella commistione tra piano “documentario” e “drammatico”, anche a livello del sonoro, ove la musica, scrive, echeggia «ora danze popolari bavaresi, ora corali evangelici, il tutto mescolato con jodel alpini»14. Giudizi feroci sono riservati ai film di Lang, «romanzi d’appendice che hanno fatto dei soldi», varianti milionarie dei «giornalini di Nick Carter», peraltro distinguendo sempre il piano di competenza del regista da quello della sceneggiatrice Thea von Harbou, messa comunque con le spalle al muro per le sue, specifiche, responsabilità: «dare travestimento ideologico a un qualche destino privato»15. Metropolis (1927), così, è visto come fusione, da una parte, della cultura dell’americanismo (seppure la sua origine venga rintracciata «più nei racconti di fantascienza dei libri per ragazzi che nei politecnici») e dall’altra di «polverosi ninnoli della cultura europea dell’interiorità», un immaginario in cui «la donna ideale è vestita come la Margherita di Goethe, […] e la strega viene mandata al rogo». Risultato: un «Kunstsalon piccolo-borghese», «scene mondane di genere e pitture medievali di spiriti dipinte con l’olio delle macchine». «Si colori pure la sfera sessuale con miniature e storie sentimentali – si tengano lontane dal socialismo le mani fresche di manicure!»16. Una delle stroncature più irridenti e distruttive fu probabilmente quella riservata al Napoléon (1926) di Abel Gance (vi si parla di personaggi caricaturali, «simbolismo da francobollo», malaccorta fiducia nel «principio di accumulazione»), del quale la stessa soluzione dei tre schermi, oltre che ridicolizzata sul piano della efficacia spettacolare, è valutata «esteticamente sbagliata»: «la limitazione imposta da una cornice fissa costituisce la prima 18 19 premessa per un qualunque effetto dell’immagine»17. Ma, seppure a posteriori, in occasione di una riedizione proposta nel 1925, un giudizio sferzante aveva salutato anche Il gabinetto del dottor Caligari (1920), considerato dominato da un’impostazione decorativa (per nulla corrispondente agli assunti dell’espressionismo), quella stessa impostazione secondo cui era stato volgarizzato l’espressionismo, trasformato (nei primi anni Venti) in “stile” della moda, dell’arredo, della stessa pubblicità. «Nel 1925 il ricordo di insegne pubblicitarie e slogan del tipo: “Devi fumare solo Walasco!” impediscono di gustare nella maniera più appropriata […] le ossessioni del Dottor Caligari […] rese con le lettere “Devi diventare Caligari!” che appaiono sulle pareti o contro il cielo»18. Su questo punto il parere dello studioso non sarebbe mutato. In un testo datato 1934, scritto per l’Enciclopedia del cinema, e rimasto non pubblicato, il presupposto centrale dell’esperienza del cinema espressionista è valutato come fallito: quei film non sarebbero riusciti a trasferire i principi di figurazione (bidimensionali) della pittura e della grafica su forme corporee e spazi tridimensionali. Anche se viene riconosciuta l’importanza della valorizzazione degli aspetti formali, e dell’uso della luce fatti dalle opere in questione e l’influenza che avrebbero avuto sul cinema posteriore: «L’arte di trattare la luce secondo questa impostazione non si è più persa»19. Si tratta di posizioni (pressoché dimenticate) tanto più interessanti perché non sostenute da argomentazioni tematiche e ideologiche (neppure immaginabili nel caso di Arnheim), e inoltre perché prive di riserve preconcette e altrettanto ideologizzate nei confronti del cinema di genere, visto invece come terreno su cui possono realizzarsi procedure di formalizzazione egualmente complesse e originali. Di qui l’apprezzamento per alcuni film di von Sternberg, proprio quelli, magari, per cui “la migliore Berlino” aveva gridato al kitsch. Di essi Arnheim apprezza la modernità e la sapienza della messa in scena («la vita vi si manifesta solo nel raggio di un metro attorno ai personaggi. Ma questo spazio ristretto si trasforma in un cerchio magico») pur nei rischi sempre incombenti della “maniera”, del puro gioco delle forme che può farsi “sregolatezza”: «Hollywood è una colonia di uomini sradicati. Il loro cuore non appartiene a niente al mondo. Il loro occhio appartiene ad ogni cosa. […] Questi uomini giocano con le risorse creative così come giocano a golf». E allora il giudizio può tornare a farsi feroce (è il caso di Shanghai Express) arrivando anche a smontare il “mito” di Marlene Dietrich: «Da una parte fa troppo, quando rotea gli occhi senza sosta, ironicamente e nervosamente; dall’altra troppo poco, quando non lascia trasparire il calore interiore e la capacità di sopportare le sofferenze. […] Non riesce più a camminare senza dondolare le anche, non riesce più a stare in piedi senza allungare un braccio verso il quadro della porta. Dovrebbe riposarsi quattro settimane sulle spiagge della California e quindi recitare subito in una commedia vestendo i panni della tenera donna di casa, con due bambini e un allevamento di animali da cortile»20. E anche su questo versante l’indipendenza di giudizio del critico lascia il segno. Si veda quanto scrive di Mae Murray (il film da cui parte è Altars of Desire, 1927, di Christy Cabanne): «Bacia senza bagnarsi le labbra e le lacrime che scendono dai suoi occhi sono pensate solo come effetti luminosi. […] Grande artista nel suo genere, ma di quel genere, appunto, di cui vorremmo volentieri perdere per sempre la chiave». (Il film in questione, possiamo osservare noi, probabilmente non la aiuta, se vi può capitare, sempre vedendolo con gli occhi di Arnheim, che «il partner la conduca sotto un inverosimile albero fiorito, dove i due siedono mano nella mano, come un tempo Sigfrido e Thea von Harbou»)21. Anche in questo caso le valutazioni risultano interessanti perché non discendono da una riserva generalizzata (ideologicamente o moralisticamente motivata) nei confronti del divismo. Al contrario, Arnheim dedica un’attenzione scevra di ogni pregiudizio a questa sfera (si vedano ad esempio i calorosissimi omaggi a Greta Garbo o Hans Albers)22, mostrando una straordinaria capacità nel cogliere i tratti più caratteristici di un interprete. L’influenza di Balázs affiora assai marcata in questi frangenti: è da qualità fisionomiche, dai “gesti visibili” che muove l’analisi del critico – e non dalle competenze attoriali, dalle tecniche di recitazione (messe in questione anche in Film als Kunst). Va da sé: il critico Arnheim non scrive solo stroncature. Loda, naturalmente, i film sovietici; apprezza Flaherty, tanto più quanto inserisce nella dimensione “naturalistica” delle sue esplorazioni impianti e situazioni che hanno «tensione drammatica, progressione, scioglimento. […] Abbiamo imparato […] che ci sono film drammatici senza essere film a soggetto» (L’uomo di Aran)23. Apprezza il cinema francese: Renoir (Nana, 1926; La Petite Marchande d’allumettes, 1928), Clair (Entr’acte, 1924; Un chapeau de paille d’Italie, 1927; Le Million, 1931), ma con la più grande indipendenza di giudizio prende le distanze da A nous la liberté (1932), considerato privo di uno stile unitario e, sul piano politico, un’opera dal «romanticismo tardo-borghese»24. Rispetto all’attività critica degli anni Venti e dei primi anni Trenta quella esercitata in Italia, come si diceva, pur fedele ai medesimi assunti di fondo, perde certamente in verve polemica e in “scrittura”. Ma non senza colpi di coda. Nell’analisi di Lost Horizon (1937) di Frank Capra la rappresentazione del Paradiso gli sembra guidata da una «specie di buddismo malinteso, interpretato dagli americani come un regime dietetico da sanatorio», e l’impianto generale un «urto di convenzionali elementi disparati: architettura novecentesca, le oleografie delle ciliegie in fiore, delle candele, dei bei vecchi, la commedia teatrale dei caratteristi buffi e il realismo documentario dei tibetani in pelliccia e delle montagne – ognuno messo in scena col mestiere perfetto e pulito dei tecnici americani»25. Ma forse il testo più “di tendenza” è rappresentato dalla recensione appassionatamente positiva di Nocturno (1934) di Gustav Machatý, «un raggio di luce nelle tenebre», di cui si apprezza il «culto dei simboli ottici» e le «esagerazioni formalistiche di un fanatismo che ha qualcosa di polemico»: «Che soddisfazione, che sentimento di benessere, quando un 20 21 regista osa ancor oggi di adoperare quell’autentico linguaggio cinematografico»26. Ho insistito sull’attività critica di Arnheim (pressoché sconosciuta, sottolineo ancora, al lettore italiano) perché di qui è partita la riflessione teorica dell’autore (come egli stesso ha messo in evidenza27). Se dunque Film als Kunst può essere valutato come una sorta di «seconda lettura del cinema weimariano»28, le recensioni del periodo 1925-1932 costituiscono un riferimento non parallelo, ma convergente verso l’impianto sistematico del volume. Inoltre l’ampia seconda parte di quel saggio (soppressa quasi interamente nell’edizione in inglese del 1957, sostituita da alcuni testi “italiani”) è fortemente legata alla battaglia critica dell’inizio degli anni Trenta condotta dallo studioso nei confronti del sonoro. Un’edizione italiana della versione originale del 1932 di Film als Kunst, al di là della funzione di recupero di un testo storico, ritenuto ingannevolmente acquisito dalla cultura cinematografica italiana del dopoguerra, offrirebbe un contributo tra i più importanti per ricostruire dal di dentro, attraverso l’impegno critico e teorico di un protagonista come Arnheim, il momento cruciale del passaggio dal cinema del muto a quello del sonoro. NOTE 5. Ma pressoché sconosciuta al lettore italiano (se si eccettuano proprio i testi inclusi nell’edizione del 1957 di Film als Kunst e pochissimi altri contributi successivamente ristampati) era rimasta, come dicevo, anche l’attività critica e di riflessione dello studioso condotta durante il soggiorno nel nostro paese. Questa importante pubblicazione di Adriano D’Aloia rende ora finalmente accessibile una parte fondamentale degli scritti “italiani” di Arnheim (la quasi totalità, restano esclusi soltanto i dodici testi che lo studioso predispose per l’Enciclopedia del cinema): da quelli “ufficiali” pubblicati per «Intercine», «Cinema», «Bianco e nero» e altre riviste dell’epoca a quelli apparsi sotto pseudonimo. Per la prima volta questo corpus consente di apprezzare pienamente l’evoluzione del pensiero del loro autore tra il 1933 e il 1939, quando l’abbandono del nostro paese coincise con una svolta non meno radicale negli indirizzi della sua ricerca. D’Aloia non solo ha minuziosamente consultato le riviste dell’epoca, ma ha attinto a una ricca rete di altre fonti (carteggi, archivi, testimonianze), tra cui spicca il Diario italiano di Arnheim29. L’ampia, documentata introduzione ci aiuta, inoltre, a valutare il rilievo, l’originalità e l’influenza dell’attività dello studioso nell’orizzonte della cultura cinematografica dell’epoca. Un ulteriore merito va ascritto inoltre a questo lavoro: quello di aver riaperto il confronto con le proposte teoriche dell’autore tedesco che (come è sottolineato dallo stesso D’Aloia) si era progressivamente spento, dopo l’introduzione di Aristarco all’edizione italiana di Film als Kunst e il dialogo tra i due, prolungato dagli interventi di Arnheim ospitati su «Cinema Nuovo» fino all’inizio degli anni Novanta. La rilettura di uno dei protagonisti della riflessione cinematografica del Novecento ha ora a disposizione un forte stimolo e uno strumento prezioso. Film als Kunst è stato ripubblicato, in inglese, in una nuova versione rimaneggiata dall’Autore, nel 1957. Da questa edizione è tratta quella italiana: Film come arte, Il Saggiatore, Milano, 1960. In Germania è stata sempre ripubblicata l’edizione del 1932 (Carl Hanser, München, 1974; Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002). Il saggio sulla radio (Radio, Faber & Faber, London, 1936) venne prontamente tradotto anche in Italia (La radio cerca la sua forma, Hoepli, Milano, 1937). È stato ripubblicato dallo stesso Arnheim, in una nuova versione, in Germania, nel 1979 (Rundfunk als Hörkunst, Carl Hanser, München, 1979), da cui deriva l’edizione italiana: La radio. L’arte dell’ascolto, Editori Riuniti, Roma, 1987. Kritiken und Aufsätze zum Film e Die Seele in der Silberschicht sono stati pubblicati dall’editore Suhrkamp, Frankfurt am Main. Nel 2000 un numero monografico della rivista «montage/av» (2, 2000) aveva contribuito a sua volta, in Germania, a richiamare l’attenzione sullo studioso, anticipando la pubblicazione di alcuni testi di Die Seele in der Silberschicht. 2 Rudolf Arnheim, Film und Funk, «Neue Zürcher Zeitung», 21 giugno 1933, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., p. 22. 3 Rudolf Arnheim, Kino von hinten, «Das Stachelschwein», 6, 1 giugno 1927, p. 63, successivamente in Rudolf Arnheim, Stimme von der Galerie, Verlag Dr. Wilhelm Benary, Berlin-Schlachtensee, 1928 (ristampa anastatica: Philo, Berlin-Wien, 2004). 4 Rudolf Arnheim, La radio, cit., p. 80. 5 Rudolf Arnheim, Stil und Stumpfsinn im Film, «Die Weltbühne», 51, 22 dicembre 1931, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., e in Die Seele in der Silberschicht, cit. 6 Robert Ambach [Rudolf Arnheim], Geräusche in der linken Hand, «Berliner Tageblatt», 2 aprile 1933, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., e in Die Seele in der Silberschicht, cit., apparso in Italia con il titolo Contrappunto sonoro, «La Stampa», 20 giugno 1933 (cfr. infra, pp. 101-102). 7 Cfr. Karl Prümm, Epiphanie der Form, in Rudolf Arnheim, Film als Kunst, cit., pp. 288-289. 8 Cfr. ad esempio quanto l’autore stesso afferma nella sua “Introduzione” del 1933, p. 9 dell’edizione italiana del 1987. 9 Rudolf Arnheim, Zum ersten Mal!, «Berliner Tageblatt», 25 ottobre 1931, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., p. 20, e in Die Seele in der Silberschicht, cit. 10 Peter Panter [Kurt Tucholsky], Stimmen von der Galerie, «Vossische Zeitung», 8 dicembre 1928, ora in appendice alla già citata ristampa anastatica del volume di Arnheim. Una seconda antologia di Feuilletons (tra cui testi provenienti anche dalla raccolta precedente) è stata pubblicata nella DDR: Rudolf Arnheim, Zwischenrufe. Kleine Aufsätze aus den Jahren 1926-1940, Gustav Kiepenheuer, Leipzig-Weimar, 1985. Qui si trova riproposto anche un omaggio ad Alfred Polgar, originariamente apparso sulla «Weltbühne», 6, 5 febbraio 1929. 11 Rudolf Arnheim, “Vorwort”, in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., p. 12. 12 «Cinema», 18, 25 marzo 1937 (cfr. infra, pp. 264-268). 13 Rudolf Arnheim, Vorwürfe gegen einen guten Film, «Die Weltbühne», 49, 4 dicembre 1928, p. 857, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., p. 209. Tali giudizi sarebbero riemersi anche in Film als Kunst (pp. 75-76 dell’ed. it.). 14 Rudolf Arnheim, Tabu, «Die Weltbühne», 35, 1 settembre 1931, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 237-238. 15 Rudolf Arnheim, Die Frau im Mond, «Die Weltbühne», 43, 22 ottobre 1929, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 221-222. 22 23 1 Rudolf Arnheim, Metropolis, «Das Stachelschwein», 2, 1 febbraio 1927, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 185-186. L’articolo era stato inserito dall’autore, con il titolo, Die Politik in der Gartenlaube, in Stimme von der Galerie, cit. 17 Rudolf Arnheim, Vortrag über den „Napoleon“-Film, «Das Stachelschwein», 11, novembre 1927, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 193-196. L’articolo era stato inserito dall’autore, con il titolo Experimentalvortrag über veraltete Regietechnik, in Stimme von der Galerie, cit. 18 Rudolf Arnheim, Dr. Caligari redivivus, «Das Stachelschwein», 19, Mitte Oktober 1925, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 177-178. 19 Rudolf Arnheim, Expressionistischer Film [1934], testo rimasto inedito, scritto per l’Enciclopedia del cinema, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., p. 150, e in Die Seele in der Silberschicht. 20 Rudolf Arnheim, Marokko, «Die Weltbühne», 42, 20 ottobre 1931; Betrübliche Filme, «Die Weltbühne», 2, 12 gennaio 1932; Zwei wichtige Filme, «Die Weltbühne», 16, 19 aprile 1932, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 242, 249, 258. 21 Rudolf Arnheim, Die Tänzerin vom Moulin Rouge, «Das Stachelshwein», 6, 1 giugno 1927. Il testo venne inserito dall’autore in Stimme von der Galerie, cit., con il titolo Ein Kitschfilm. Le citazioni alle pp. 103 e 105. 22 Rudolf Arnheim, Greta Garbo, «Das Tagebuch», 9, 3 marzo 1928. Inserito dall’autore in Stimme von der Galerie, cit., ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit.; Rudolf Arnheim, Hans Albers, «Die Weltbühne», 36, 8 settembre 1931, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit. 23 Rudolf Arnheim, Der Mann von Aran, «Neue Zürcher Zeitung», 2 ottobre 1934, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 271-273. 24 Rudolf Arnheim, Der französische Film, «Die Weltbühne», 4, 26 gennaio 1932, ora in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 250-253. 25 Rudolf Arnheim, Orizzonte perduto, «Cinema», 34, 25 novembre 1937, (cfr. infra, pp. 229-231). Il testo è stato incluso, in traduzione tedesca, con il titolo Lost Horizon, anche in Kritiken und Aufsätze zum Film, cit. 26 Rudolf Arnheim, Espressione, «Intercine», 11, novembre 1935 (cfr. infra, pp. 164167). 27 Rudolf Arnheim, Vorwort zur deutschen Neuausgabe [1974], in Film als Kunst, cit., p. 12. 28 Karl Prümm, Epiphanie der Form, cit., p. 296. 29 Alcuni brani sono stati pubblicati in «Bianco e Nero», 563, gennaio-aprile 2009, a cura dello stesso D’Aloia e di Massimo Locatelli. 16 24 Introduzione La parabola italiana di Rudolf Arnheim di Adriano D’Aloia Prologo Siamo a Roma, in un assolato mattino dell’agosto 1933. Un taxi sta percorrendo via Nomentana, lunga arteria che dal centro della capitale si lancia verso nordest, e si arresta di fronte all’ingresso di villa Torlonia, residenza privata di Benito Mussolini. Dalla vettura scende, con un’aria piuttosto smarrita, un giovane neppure trentenne, sembra forestiero. Percorre con passo incerto alcuni metri lungo il solido muro che circonda la villa e giunge di fronte all’imponente cancello in ferro battuto, chiuso e inaccessibile. Alcuni agenti della polizia segreta, in abiti borghesi, posti a presidio dell’abitazione del Duce, notano i movimenti sospetti di quel giovane. E quando si sentono chiedere informazioni su come si potesse accedere alla villa, decidono di arrestarlo e lo portano in questura. L’identità del sospetto non viene accertata finché all’ufficio di polizia non giunge in automobile il dottor Luciano De Feo, direttore dell’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa (che presso una dipendenza di villa Torlonia ha sede). Quel giovane, appena giunto da Berlino, viene finalmente identificato: si chiama Rudolf Arnheim. Un po’ come al cinema, dopo un prologo così fitto di mistero, compiremo qualche passo indietro nel tempo, per ripercorrere dapprincipio gli eventi e indagare le motivazioni che hanno portato il giovane Arnheim di fronte al portone di villa Torlonia, un giorno come tanti in una lontana estate capitolina. Solo a quel punto potremo proseguire, seguendo le tracce della sua intera parabola italiana. liner Psychologisches Institut2 con una tesi sull’espressione del volto umano in cui dimostrò l’esistenza del cosiddetto dono fisiognomico, o grafologico3. Determinante influenza sul giovane studioso ebbero i suoi maestri Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, padri fondatori, assieme a Kurt Lewin, della Gestaltpsychologie. Antefatto Gli anni tedeschi (1904-1933) Ero solo ventenne quando la Corazzata Potëmkin di Ejzenštejn salpò in mare1. Rudolf Arnheim durante gli anni tedeschi 1. «Die Weltbühne» Nato il 15 luglio 1904 nel sobborgo berlinese di Charlottemburg, Rudolf Julius Arnheim crebbe in una famiglia di origini ebraiche. Entrò in contatto con il mondo dell’arte fin dai primi anni della sua vita, grazie al lavoro del padre, fabbricante di pianoforti, all’ascendente della madre e all’influenza che sulla sua formazione ebbe il cognato Karl Badt, artista e storico dell’arte. Dopo la maturità ottenuta nel 1923 e un periodo di lavoro presso la ditta del padre, Arnheim studiò psicologia, filosofia, storia dell’arte e storia della musica all’università di Berlino, allora capitale della Germania nella parentesi della Repubblica di Weimar. Completò il dottorato nel 1928 al Ber- In risposta alla psicologia associazionista di Wundt, secondo cui era possibile scomporre ogni fenomeno nei suoi aspetti elementari per ottenere unità semplici non ulteriormente riducibili, i gestaltisti enfatizzarono la presenza di una connessione fra la realtà fenomenica costituita dagli oggetti del mondo esterno e la realtà interiore del soggetto, basandosi sull’assunto fondamentale che il “tutto” è costituito dalla relazione e non dalla semplice somma, o associazione, delle sue parti. Secondo la prospettiva della Gestalttheorie la percezione è un effetto di leggi strutturali che organizzano i dati sensoriali in modo necessario secondo unificazioni 26 27 e segmentazioni spontanee e naturali. La responsabilità primaria nella conoscenza della realtà e l’organizzazione del comportamento sono insite nel soggetto, in quanto fondate sulla percezione non semplicemente dei tratti visivi di un oggetto, ma della sua espressione nel contesto generale in cui è inserito4. Ispirato da queste stesse premesse epistemologiche, Arnheim si concentrò attorno al concetto di Ausdruck (Espressione), inteso come principio dinamico di manifestazione della negoziazione fra oggetto e soggetto, mai isolati rispetto al contesto e alle funzionalità che esso designa. L’espressione è «un aspetto che inerisce a qualsiasi qualità percettiva di dimensione, di spazio, di movimento, di illuminazione e così via» e si fonda dunque «sulle costellazioni di forze che possono rinvenirsi in tutto ciò che si percepisce»5. In questo senso essa è cerebrale e non meramente retinica. Arnheim mutuò dai suoi maestri anche le idee sul movimento stroboscopico6 e sull’insight7 come processi cognitivi su cui si fondano le pratiche di comprensione psicologica da parte di un osservatore posto di fronte a delle immagini in movimento. Rudolf Arnheim durante gli anni tedeschi 28 Nonostante avesse buone prospettive di carriera all’interno dell’università, il giovane e brillante laureato era poco propenso a respirare l’aria troppo conservatrice e arida dell’accademia8. La possibilità, forse anche la necessità, di entrare da subito nel mondo del lavoro prevalse9. A quel tempo – siamo in fondo alla stagione espressionista che aveva esaltato la cinematografia tedesca – egli riteneva di conoscere «tutto ciò che si potesse conoscere sul cinema»10. Possedeva uno spiccato interesse per quel fenomeno al contempo artistico e sociale che stava vivendo un momento cruciale della sua storia – il passaggio dal muto al sonoro – e non era privo di una certa verve che gli consentiva di ricondurre costantemente i problemi dell’estetica e della produzione cinematografica, e più in generale dell’arte, alle questioni aperte nella società e nella politica. Rispetto alle tendenze ideologiche dell’epoca, tuttavia, Arnheim mantenne una posizione intermedia e piuttosto cauta, sia in politica sia in estetica, schierandosi sostanzialmente contro la semplicistica sovrapposizione fra realismo artistico e progresso sociale. Alla metà degli anni Venti, opponendosi ai fautori della Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività) e all’equazione fra estetica modernista radicale e politica progressista, preferì sostenere che soltanto i film che avessero realizzato appieno l’espressività del mezzo, accettandone i vincoli oggettivi e le specifiche leggi formali, avrebbero ottenuto il desiderato impatto sociale11. Con grande entusiasmo del resto Arnheim si era provato nel mestiere di critico fin dall’estate 1925, componendo recensioni cinematografiche per il mensile satirico «Das Stachelschwein»12. Il primissimo articolo tuttavia apparve su «Die Weltbühne», influente settimanale berlinese diretto da Carl von Ossietzky e Kurt Tucholsky13. La collaborazione con la «Weltbühne» si consolidò a partire dall’autunno del 1928 e si protrasse con regolarità sino alla metà del 193314, periodo entro il quale Arnheim arrivò a pubblicare 174 articoli come assistente di redazione prima, come redattore poi e ben presto come condirettore15. Come egli stesso ebbe modo di ricordare, componeva mentalmente le recensioni nel lungo tragitto verso casa, dopo aver assistito alla proiezione delle novità cinematografiche in una sala del centro di Berlino. Una volta rincasato, sedeva alla scrivania e letteralmente si dettava, parola per parola, virgole incluse, l’intero articolo così come era nato nella sua testa16. Il tono polemico e talvolta provocatorio che caratterizza il corpus di quei primi scritti va considerato un riflesso del difficile contesto storico-politico che stava vivendo la Germania negli anni finali della Repubblica di Weimar, un periodo in cui gli ideali della nuova democrazia repubblicana erano già stati minati dalla censura e da atti di violenza militare – avvisaglie del Terzo Reich ormai alle porte17. «Da qui il tono bellicoso nelle mie recensioni, – sebbene a quell’epoca ci fosse un’evidente sfumatura di rassegnazione. Il gusto della satira per il kitsch e la boriosità borghese, e l’amore per la provocazione, giocavano anch’essi un ruolo»18. Ma satira e regime a quell’epoca non convivevano affatto. E, come vedremo, Arnheim pagò le conseguenze di tale incompatibilità. 29 2. Film als Kunst Rudolf Arnheim durante gli anni tedeschi Egli non fece altro che applicare l’approccio gestaltista che aveva appreso dai suoi maestri a Berlino a quel fenomeno emergente che più di altri sembrava dare la possibilità agli psicologi di uscire dal guscio della concezione classica e di approdare, attraverso l’esperienza in laboratorio, a una scienza “viva”, più vicina alla vita quotidiana dell’uomo. Aveva capito che non potevano esserci miglior laboratorio e miglior soggetto della sala cinematografica e dello spettatore. Il cinema costituiva un eccellente caso concreto di esperimento psicologico di massa, un laboratorio pubblico di verifica e messa a punto della teoria. A cavallo fra gli anni Venti e gli anni Trenta si stava compiendo il delicato passaggio dal muto al sonoro e il giovane teorico tedesco ridiscusse con una prospettiva nuova l’idea secondo cui il cinema non è una passiva riproduzione meccanica della realtà: ogni percezione è anche pensiero e dunque la visione non è una registrazione meccanica di elementi sensibili, bensì un’attività di organizzazione creativa della «materia grezza sensoria» secondo criteri di semplicità, regolarità ed equilibrio. Una teoria «intesa a dimostrare il fatto che le affermazioni scientifiche e artistiche non sono semplici derivati dalla realtà osservata ma piuttosto equivalenti della realtà creati secondo le proprietà formali del relativo medium»25. In sintesi estrema, la teoria filmica arnheimiana passa puntigliosamente in rassegna le differenze fra la realtà e la sua rappresentazione mediante la macchina da presa: l’assenza del colore e della profondità, la bidimensionalità dello schermo, la manipolazione della dimensione spazio-temporale attraverso il montaggio e l’assenza di stimoli provenienti dalle sfere percettive non-visive. Queste differenze, definite fattori differenzianti, rivelavano l’insuperabile parzialità della visione dell’occhio umano di fronte alla natura. Ma proprio dalle sue “manchevolezze” il cinema ricavava la possibilità di essere arte, in quanto l’impiego in chiave espressiva di tali fattori, intesi come mezzi formativi, consentiva all’“artista cinematografico” di operare una sorta di compensazione creativa del divario fra rappresentazione e realtà26. Quando Film als Kunst vide la luce il regime nazionalsocialista aveva già avviato la persecuzione razziale, per quanto non ancora in forma spietata, e cominciava a ventilarsi l’ipotesi dell’estromissione degli ebrei da università e dalle professioni intellettuali. La minaccia nazista si rese sempre più pressante, al punto che verso la metà del 1933 «Die Weltbühne», ideologicamente troppo critica nei confronti del regime, fu messa al bando. Arnheim continuò a pubblicare articoli sotto lo pseudonimo di Robert Ambach sul «Berliner Tageblatt», con cui aveva aperto una collaborazione sin dal 1931 (e prima dell’estate cominciò ad apparire anche sulla svizzera «Neue Zürcher Zeitung», avviando idealmente il suo spostamento verso Sud). Ma la censura tedesca colpì senza riserve Film als Kunst: l’opera venne ritirata dal mercato dopo soli tre mesi dalla sua uscita27. Con la promulgazione delle leggi razziali contro gli ebrei e ancora prima della Notte dei lunghi coltelli e del brusco e infame giro di vite 30 31 Quel primo periodo di tirocinio nel settore della critica cinematografica fu fondamentale per la formazione di Arnheim19, per due ragioni. Da un lato perché gli articoli pubblicati sulle riviste tedesche furono preparatori alla composizione di Film als Kunst20, libro che contiene l’esposizione completa della sua teoria sul cinema21; dall’altro perché tutti i suoi sforzi in campo cinematografico erano già diretti verso un più generale e profondo interesse per la teoria del visibile nell’arte: il cinema non era che un terreno di prova dei principi della percezione visiva che più avanti avrebbero trovato una formulazione generale di grande lucidità e fecondità: Dato che il mio era un interesse prevalentemente teorico, andavo in cerca di quegli esempi che dimostrassero come doveva diventare il cinema. Difatti avevo un libretto d’appunti in cui annotavo singole scene commentando: ecco, questo è vero cinema! È sulla base di questi appunti che ho scritto il mio libro Film als Kunst22. Preceduta da brevi anticipazioni, apparse a cavallo fra il 1931 e il 1932 su alcuni periodici tedeschi23, l’opera uscì nel 1932 in Germania. Fu subito tradotta e nel 1933 pubblicata in Inghilterra dall’editore Faber & Faber con il titolo Film24, esattamente cento anni dopo i primi esperimenti sulla percezione del movimento di Joseph Plateau. Arnheim aveva solo ventotto anni ma fu da subito considerato uno studioso di calibro internazionale. che seguì, molti psicologi della Gestalt di religione ebraica avevano cominciato, con diversa urgenza, a considerare l’ipotesi dell’emigrazione. Probabilmente già per via del lavoro svolto alla «Weltbühne» e soprattutto di un articolo troppo allusivo sull’affinità fra i baffi di Charlot nei film di Charlie Chaplin e i baffi di Adolf Hitler28, consigliato da alcuni amici, Arnheim scelse fra i primi la via dell’esilio. 3. Gli antecedenti Prima ancora della sua dipartita da Berlino e dalla Germania, Arnheim era virtualmente già approdato in Italia. La prima recensione di Film als Kunst nel nostro paese apparve nel febbraio del 1932 sul numero inaugurale di «Scenario» a firma di Paolo Milano, critico letterario coetaneo di Arnheim e poi divenuto suo stretto amico29. Nella recensione viene sottolineato lo sforzo dell’autore di spiegare i rapporti fra «quadro del mondo» (Weltbild) e «quadro cinematografico» (Filmbild) e la loro reciproca irriducibilità in termini fisiologici. Il recensore mette in guardia il lettore dalla «precisa sistematicità» con cui Arnheim riprende le idee di Pudovkin e Timoshenko per delineare le caratteristiche tecniche del montaggio30. La parte essenziale del libro è ritenuta «quella che tratta del contenuto, o argomento, dell’opera cinematografica», affrontata attraverso ricche e incisive analisi psicologiche dei film più noti dell’epoca. L’allora attualissima questione dell’introduzione del sonoro nel cinema, trattata soprattutto nella seconda parte dell’opera, apre al problema estetico dell’integrazione fra media, ma non riscontra l’interesse che susciterà invece la proposta riformulata dallo stesso Arnheim nel 1938 con il suo Nuovo Laocoonte. Inoltre almeno tre articoli di Arnheim trovarono spazio in altrettanti periodici italiani, grazie soprattutto al decisivo lavoro di “importazione” e divulgazione delle teorie di molti teorici allora poco conosciuti nel nostro paese, operato da Umberto Barbaro, collaboratore di Luigi Chiarini al Centro Sperimentale di Cinematografia. Poco dopo la pubblicazione di Film als Kunst, un breve estratto scelto e tradotto da Barbaro apparve nelle pagine dedicate al teatro de «L’Italia letteraria» con il titolo Soggettista e direttore artistico31. Nella nota aggiunta in calce dal traduttore, Film als Kunst è definito un «ampio studio sulla cinematografia e sui suoi metodi caratteristici, ricco di preziose e utili notizie, osservazioni e teorie, nonché di esempi e documentazioni aggiornatissimi». La scelta dell’estratto è giustificata «non tanto per originalità, quanto perché può servire a confrontare la nuova direzione artistica della massima Casa di Produzione Italiana nelle sue direttive, in tutto coerenti a quanto l’Arnheim qui auspica». Dopo aver illustrato le differenze fra l’autore e il régisseur nel teatro e i loro corrispettivi nel film, l’articolo tratta uno degli argomenti ricorrenti in Arnheim, e cioè la necessaria collaborazione fra autore (oggi diremmo sceneggiatore) e regista, senza la quale l’artisticità del film sarebbe irrealizzabile. 32 Quasi un anno dopo, quando la «Weltbühne» aveva già subito il bando nazista, apparve su «Cine-Convegno» l’articolo Arte riproduttiva32, un vero e proprio saggio che contiene la prima fondamentale esposizione in termini estetici del tema dell’artisticità del film. Arnheim propone un’unica categoria entro la quale ricondurle le “arti” (il film, la radio, il sonoro) nate nei precedenti cento anni, dal 1830 al 1930: “arte riproduttiva”, la cui particolarità è «che in essa la realtà ritrae sé medesima»33. Un terzo articolo, Contrappunto sonoro 34, venne pubblicato nel giugno del 1933 su “Cine-Stampa”, pagina cinematografica del quotidiano «La Stampa». Arnheim espone i tratti essenziali della propria teoria sul cinema, inserendosi nel dibattito sulla specificità del mezzo cinematografico. In una nota introduttiva viene presentato come uno «tra i pochi autorevoli iniziatori di un’estetica cinematografica», «[u]n campo, questo, ancora incerto, irto di pericoli, cui i vari tentativi si riducono sovente nel tessere una serie di constatazioni, o di profezie». Nella frase conclusiva la nota specifica che la pubblicazione di quel primo articolo avrebbe inaugurato la collaborazione di Arnheim con “Cine-Stampa”. Tuttavia non c’è più traccia del suo nome sulle pagine del quotidiano torinese. L’operazione più importante in favore dell’introduzione della teoria arnheimiana nel contesto italiano avvenne però al di fuori delle pubblicazioni ufficiali, ancora grazie a Barbaro, ma stavolta su suggerimento del direttore della Cines, Emilio Cecchi. Si trattava di una sintesi parziale ma sostanziale della prima parte di Film als Kunst, inserita nella lista di letture proposte agli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia nel 193235 (e ufficialmente pubblicata alcuni anni più tardi su «Bianco e Nero»36). Raccontò lo stesso Arnheim: Quando anni fa venni in Italia, vidi che circolava fra gli “iniziati”, come il manifesto segreto di una carboneria, un fascicolo poligrafato, redatto da Umberto Barbaro su suggerimento di Emilio Cecchi, allora direttore artistico della Cines. Era un breve riassunto del mio libro [...] e precisamente della prima ed essenziale metà del libro, che avevo scritta nel 192937. A riprova che Arnheim era stato preceduto in Italia dalla propria fama e che le sue teorie avevano già cominciato a circolare negli ambienti istituzionali legati allo studio e alla divulgazione del cinema nel nostro paese, vi sono anche alcune tracce apparse sulla «Rivista internazionale del cinema educatore», organo d’informazione dell’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa (IICE). Vale la pena ricordare che l’IICE era nato nel 1928 in seno alla Società delle Nazioni e si prefiggeva lo scopo di favorire la produzione, la diffusione e lo scambio internazionale dei film documentari di carattere educativo38. L’iniziale progetto elaborato dalla Francia fu realizzato in Italia per volontà di Mussolini, il quale aveva promesso una lauta offerta economica e messo a disposizione del- 33 l’Istituto una sede operativa in una dipendenza della propria residenza privata a villa Torlonia, oltre a un’elegante sede di rappresentanza a Frascati. Con la propria politica sempre sornionamente attenta ai mezzi di comunicazione, il Fascismo aveva intuito le potenzialità propagandistiche del cinema e l’opportunità di ricavarne risonanza internazionale. Aveva così voluto assumersi strategicamente il compito di diffonderne il linguaggio nelle scuole e formare la classe operaia e contadina, laddove l’iniziativa privata non aveva stimoli d’intervento39. Nella primavera del 1933, quando Hitler era già riuscito a farsi nominare Cancelliere, l’autorevolezza di Arnheim come studioso di cinema, radio e fotografia stava crescendo anche al di fuori dei confini della Germania. Sui numeri di maggio e luglio della «Rivista internazionale del cinema educatore» vennero pubblicati, all’interno della rubrica “Fatti, opinioni, commenti”, due brevi trafiletti che definivano Arnheim «il più giovane e il più autorevole fra i teorici del cinema»40 e il suo Film als Kunst come «ormai il codice estetico di cineasti giovani»41. Il primo dava notizia di un suo intervento sul tema dei rapporti fra fotografia, cinema e radio presso la Biblioteca Artistica Nazionale di Berlino; il secondo segnalava la pubblicazione sulla «Neue Zürcher Zeitung» di un suo articolo sui doveri della critica cinematografica a fronte dell’industrializzazione del cinema. Intanto sul numero di giugno della rivista apparve anche la seconda recensione italiana di Film als Kunst42, anch’essa incentrata sulla diversità fra Weltbild e Filmbild e sulla proposta di una teoria estetica del neonato film sonoro. Per Arnheim stavano per chiudersi le porte del paese natio e spalancarsi quelle dell’Italia. Rudolf Arnheim durante gli anni tedeschi 34 Primo tempo Gli anni italiani (1933-1939) Ma gli occhi, pur obbedendo a certe leggi, non ne conoscono nessuna43. 1. All’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa Subito dopo la pubblicazione di Film als Kunst, la fama e il valore di Arnheim giovane teorico del cinema avevano già raggiunto a Roma Luciano De Feo, ex direttore dell’Unione Cinematografica Educativa (LUCE) e ora direttore dell’IICE. L’Istituto sovrintendeva non solo alla realizzazione della «Rivista internazionale del cinema educatore», ma anche, fin dal 1929, a un ambizioso progetto anch’esso di respiro internazionale: l’Enciclopedia del cinema. Forse obbedendo alla controversa strategia del regime, De Feo poté ingaggiare e accogliere esponenti del mondo culturale non simpatizzanti fascisti o convinti democratici e antifascisti di molti paesi d’Europa, fra cui anche gli esuli del Terzo Reich. E fra questi Arnheim, a cui De Feo aveva commissionato la stesura di alcune voci44 già prima della presa del potere da parte dei nazisti. Quando quest’ultimo ricevette una lettera da Berlino nella quale Arnheim si diceva pronto a trasferirsi a Roma per lavorare al progetto, accettò e lo assunse all’Istituto. Motivato dalla prospettiva di lavorare per un ente internazionale che aveva già avviato progetti e pubblicazioni di alto livello45, ma in parte in virtù della propria formazione umanistica e di un minimo di conoscenza dell’italiano, Arnheim scelse di rifugiarsi in Italia, dove visse per oltre sei anni, innamorandosi ben presto della Città Eterna e di quello stile di vita “meridionale” e in certo modo provinciale, per quanto capitolino46. Più che una terra d’esilio, l’Italia fu per Arnheim una seconda patria47 e tale rimase per lungo tempo, senza che le sue origini ebraiche costituissero un problema, in virtù non solo dell’assenza di tendenze antisemite da parte del regime sino al 1938, ma anche per «una specie di liberalismo che distingueva […] le pratiche del fascismo dall’ortodossia nazista»48 in alcuni settori della cultura. L’IICE in effetti era una sorta di enclave internazionale nel cuore di Roma, in grado di rimanere sostanzialmente estranea alle rigide influenze censorie del regime. In nome del prestigio e della natura internazionale dell’Istituto che il Fascismo voleva arrogarsi, si creò una paradossale situazione per la quale studiosi di diversa provenienza e diverso orientamento culturale poterono lavorare senza che vi fossero pressioni volte a conformare le attività professionali alle dottrine del regime, protetti da ampi stralci di libertà che lasciavano aperta, per esempio, la possibilità di accedere a pellicole sovietiche o americane proibite dalla censura49. Pochi potevano immaginare quale corso avrebbero preso gli eventi 35 nell’arco di pochi anni. L’Istituto sembrò proprio il luogo ideale per ospitare la “seconda vita” dell’esule Arnheim. Ecco dunque svelato il mistero del prologo: un semplice disguido, dovuto alla vicinanza fra la residenza privata di Mussolini e la sede dell’IICE, fece sì che quel giovane studioso giunto da Berlino, già affermato e tuttavia dall’aria sempre modesta, incappasse nell’arresto della polizia segreta proprio il suo primo giorno di lavoro50. Un episodio che ci appare curioso, forsanche comico, ma che suona quasi come un funesto presagio. Poco dopo il suo arrivo a Roma, Arnheim prese domicilio sulle colline di Albano Laziale51. Era l’agosto del 1933 e si apriva una stagione che avrebbe segnato, nel bene e nel male, l’intero corso della sua vita. Ritratto di Rudolf Arnheim utilizzato nella copertina del libro La radio cerca la sua forma (Hoepli, Milano, 1937) 36 2. «Intercine» I primi effetti dell’inserimento di Arnheim all’IICE riguardarono il profondo rinnovamento della «Rivista internazionale del cinema educatore», di cui il neoarrivato fu il principale ispiratore52. Per quanto il mensile, pubblicato in formato libro in cinque differenti edizioni (italiana, francese, inglese, spagnola, tedesca), avesse un taglio scientifico-accademico più che giornalistico, ricchissimo di analisi e informazioni in svariati ambiti legati al cinema documentario, esso riservava poco spazio all’estetica e alla riflessione teorica. La rivista soffriva insomma di una certa burocratica e tediosa aridità ed era «assai priva di scintille creative»53. Per Arnheim avrebbe invece dovuto rivolgersi a lettori colti, ma meno di nicchia, spettatori più consapevoli e interessati non solo al documentario e alla sua vocazione educativa, ma anche al film di finzione. Nel 1935 la testata mutò il proprio nome in «Intercine», fu varato un formato più ampio, in cui trovavano spazio analisi di opere filmiche, profili critici di registi, saggi di estetica, con un linguaggio tuttavia accattivante e molte illustrazioni. Per i primi tre mesi vennero mantenute cinque edizioni in lingua italiana, francese, inglese, spagnola e tedesca (di quest’ultima Arnheim fu nominato responsabile), poi ridotte a quattro sino a luglio (decaduta l’edizione spagnola) e infine a due (una in italiano e una internazionale interamente in lingua francese) nell’ultimo trimestre dell’anno. Sotto la direzione di De Feo si consolidò un nuovo gruppo di lavoro, formato da specialisti di vasta competenza fra cui spiccavano Gianni Puccini, Paul Rotha, Luigi Chiarini, Massimo Bontempelli, Francesco Pasinetti, Gian Francesco Malipiero e Thomas Mann. Arnheim figurava nel frontespizio della rivista come membro del comitato di redazione assieme a P. Berne De Chavannes, Giuseppe De Feo, Corrado Pavolini e Edward Storer, ma era il personaggio di spicco e gli vennero affidati ruoli operativi di primo piano54. È proprio sulle pagine di «Intercine» che si sviluppò il primo sostanziale e organico contributo di Arnheim al contesto culturale italiano nel campo del cinema. La parte più consistente di tale contributo è costituita dalla compilazione delle “sintesi”, apparse sotto il titolo Espressione, in cui Arnheim, traendo spunti da volumi o articoli recentemente pubblicati in Europa o negli Stati Uniti (fra cui l’«American Cinematographer», l’«International Photographer» e «Sight and Sound»), discusse i diversi aspetti delle tecnologie impiegate nella produzione cinematografica, valutandone le ricadute sullo stile e più in generale sull’estetica filmica. Nel primo intervento, per esempio, sollevò programmaticamente il problema della già decadente artisticità del film, accusando, con un tono forse moralistico, che Il livello artistico medio del film è sceso in modo spaventoso. La perfezione raggiunta da attori, operatori e autori dei commenti musicali conserva ancor oggi ai prodotti cinematografici un 37 certo valore, ma un buon spettacolo, dei bei quadri, e dei suoni gradevoli non sono ancora un film55. Villa Torlonia, sede dell’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa (fotografia tratta dal primo numero della «Rivista internazionale del cinema educatore») Con evidente e talvolta esplicito riferimento alla trattazione di Film als Kunst, affrontò tematiche legate al film sonoro e a colori, alla stereoscopia, al film plastico, al realismo, al movimento, alla forma, alla prospettiva, all’illuminazione, al montaggio e così via. Nel fascicolo estivo, interamente dedicato all’analisi della situazione del cinema mondiale con uno sguardo al passato, al presente e al futuro, vennero proposti un quadro della produzione cinematografica internazionale e un gruppo di riflessioni di carattere estetico sulla relazione fra le arti a firma di Massimo Bontempelli, Gian Francesco Malipiero, Paul Rotha, Allistair Cooke, Alberto Cavalcanti, Giacomo Debenedetti e Jean Epstein. Arnheim apriva la parte dedicata al “domani” con un saggio sulla figura e sul destino del critico specializzato56 – una dichiarazione di autonomia e indipendenza della critica cinematografica, da concepire come una competenza specifica, e non più soltanto come una facoltà accessoria di cronisti, critici teatrali o recensori letterari. Copertina della «Rivista internazionale del cinema educatore» (1929) Copertina della rivista «Intercine» (1935) 38 39 L’interesse dell’IICE per il funzionamento, il ruolo sociale e i possibili utilizzi artistici della televisione coinvolse anche Arnheim57, che nell’ampio saggio intitolato Vedere lontano58 illustrò i principi fondamentali del funzionamento tecnico della televisione, richiamando le differenze fra percezione auditiva e visiva e collocando il nuovo mezzo a metà strada (e dunque d’impaccio) fra il cinema e la radio: La sfera degli interessi degli uomini oltrepassa di molto la portata dei loro sensi. […] Fra le invenzioni che tendono a compensare tale sproporzione, la più recente e forse la più importante è la televisione. Meraviglioso, magico appare il nuovo apparecchio e la curiosità di saperne un po’ più intimamente è molto viva59. All’IICE Arnheim non si limitò al lavoro di ricerca e divulgazione teorica, misurandosi spesso direttamente con i film e con i cineasti: sulla rivista si trova anche una accurata analisi del film di King Vidor Nostro pane quotidiano 60. Una buona occasione per criticare la tendenza generale del cinema a diventare «il terreno d’azione della menzogna», e per converso esaltare, nel film di Vidor, l’impegno sociale e la semplicità umana. La vita di «Intercine» tuttavia durò soltanto dodici mesi. Il 3 ottobre 1935 l’Italia attaccò l’Etiopia senza dichiarazione di guerra e il 18 novembre subì l’embargo della Società delle Nazioni come sanzione per aver aggredito uno Stato membro. Per questo motivo si profilava anche la chiusura dell’IICE o il suo trasferimento dal territorio italiano. De Feo, rimpatriato per motivi di salute dopo alcuni mesi di lavoro proprio in Etiopia e assunto nuovamente l’incarico di direttore del Luce, ebbe sentore della crisi e lavorò sotterraneamente per salvare l’eredità della rivista. L’ultimo numero di «Intercine» apparve nel mese di dicembre del 1935. Ma di lì a pochi mesi sarebbe risorta dalle proprie ceneri, con un nuovo editore e una nuova testata: «Cinema». dall’Institut für Kulturforschung di Berlino. L’idea venne fatta propria da De Feo già nel 1929. Al gruppo dei redattori, capeggiato da Corrado Pavolini62, appartenevano alcuni giovani professionisti del cinema italiano come Francesco Pasinetti, Domenico Meccoli e Gianni Puccini. Il già «celebre teorico tedesco del cinema»63 Rudolf Arnheim era apprezzatissimo da De Feo e per questo fu assegnato a incarichi di alta responsabilità e direzione64, come testimoniato direttamente dallo stesso Arnheim nel dopoguerra65. Svolse peraltro anche la funzione di reclutatore di collaboratori66 e fu spesso inviato alla Mostra del cinema di Venezia o a convegni e conferenze67. Nel 1930, dopo un anno di lavoro e già prima dell’arrivo di Arnheim, i materiali raccolti per l’Enciclopedia potevano considerarsi sufficienti per la pubblicazione. Nel 1932 De Feo annunciò il completamento dell’opera, composta da 800 pagine riccamente illustrate. Prima di procedere alla ricerca di un editore per la pubblicazione fu deciso di sottoporre l’Enciclopedia al vaglio di una commissione di esperti composta dai più eminenti tecnici del mondo del cinema, convocati per l’occasione a Roma presso l’Istituto. Già dopo un primo esame, l’opera acquisì nuovi possibili sviluppi e la pubblicazione ufficiale fu rimandata. In un articolo del 1933 sulla storia e le attività dell’IICE68 si parla di 8.000 voci già raccolte, di cui 600 di portata monografica, con 3.000 illustrazioni previste. Di anno in anno il progetto continuava a espandere i propri confini. Nel 1934 la direzione decise di ampliare ulteriormente gli sforzi e intanto vennero presi accordi con l’editore milanese Ulrico Hoepli. 3. L’Enciclopedia scomparsa Quando nel 1933 Arnheim giunse di persona a Roma e prese a lavorare all’IICE, De Feo gli affidò l’impegnativo ma prestigioso compito di occuparsi del grande progetto di cui l’Istituto era responsabile, ovvero la redazione di una monumentale Enciclopedia del cinema, primo caso storico di sistemazione del sapere universale riferito al fenomeno cinematografico in tutte le sue espressioni e i suoi ambiti di pertinenza, ma anche «bilancio spirituale d’una manifestazione della cultura contemporanea, che durante gli ultimi trent’anni aveva influenzato quasi tutti i campi dell’attività umana e da quasi tutti aveva a sua volta ricevuto suggestioni ed influssi»61. Il progetto dell’opera era stato concepito sulla scia di un’iniziativa della rivista tedesca «Die Licht-Bild-Bühne», che nel 1928 aveva pubblicato un repertorio di termini cinematografici redatto Rudolf Arnheim durante gli anni italiani 40 41 Nel marzo del 1935 i dettagli dell’opera furono ufficialmente presentati in un ampio articolo di «Intercine»69, corredato da una Tavola sistematica dei contenuti e dall’anticipazione di alcune illustrazioni tratte dall’archivio iconografico in costruzione. Nel corso del tempo erano state coinvolte nel progetto molte eccellenti personalità internazionali provenienti dal campo dell’arte, della tecnica, della scienza e dell’industria, al punto che il materiale originariamente acquisito dalla Germania fu totalmente accantonato. Il personale che componeva la redazione aumentò notevolmente e al progetto cominciarono a partecipare anche organizzazioni, istituti scientifici e case produttrici di tutto il mondo, tanto che l’Enciclopedia «ogni volta sembrava quasi finita e quattro settimane dopo appena incominciata»70. L’Enciclopedia crebbe fino a raggiungere 3.500 pagine nel 1936, alla vigilia della trasformazione di «Intercine» in «Cinema». Nel giugno 1937 De Feo annunciò che il primo volume dell’opera sarebbe stato mandato in stampa nel mese di luglio, assaggio di un lavoro costituito da oltre 4.000 pagine di testo e 15.000 illustrazioni71. Nell’ottobre del 1937 sulle colonne della rivista «Cinema» venne data come prossima la pubblicazione del primo volume (lettere A-E)72. All’inizio del 1938 un corposo editoriale di «Cinema»73 annunciò con tono quasi trionfale l’ultimazione dell’Enciclopedia delle arti e delle industrie del cinema che «già si sta stampando con celerità» e i cui primi due volumi, di mille pagine l’uno, avrebbero dovuto apparire entro l’anno. Eppure nessun annuncio ebbe un seguito concreto e nessuna promessa trovò mai realizzazione. Com’è noto nel 1938 Mussolini decise di uscire dalla Società delle Nazioni. L’IICE dovette essere riorganizzato e il lavoro dell’Enciclopedia fu sospeso74 (nonostante nell’editoriale di «Cinema» si parli di una corrispondenza voluta fra la chiusura dell’Istituto e il licenziamento dell’opera). Ancora oggi, dopo settant’anni, il progetto dell’Enciclopedia del cinema continua a essere avvolto dal mistero e nessuno studioso è ancora riuscito a rintracciare le bozze o le matrici di stampa neppure dei primi volumi. Un mancato ritrovamento che ha dato adito a voci su possibili furti e plagi75 e che contribuisce ad aumentarne la leggenda ed espandere l’alone enigmatico che la circonda. Enigma che, tuttavia, un’attenta ricostruzione storico-filologica può contribuire quantomeno a ridurre76. so grazie al fatto che nel corso degli anni Arnheim, come probabilmente altri autori, recuperò e pubblicò il materiale originariamente composto per l’Enciclopedia78. È importante precisare fin d’ora che gli scritti composti da Arnheim durante quei primi anni di lavoro in Italia andranno a costituire una sezione essenziale dell’aggiornamento (in realtà una vera e propria sostituzione) della seconda parte di Film als Kunst, prefigurata già nel 1938: Negli anni successivi pensai più volte di far tradurre il libro per esteso e letteralmente, ma praticamente non lo feci. Sentivo che la “revisione” del testo mi avrebbe convinto di non lasciarne in piedi nemmeno una parola. Avrei voluto scrivere un nuovo libro, e infatti lo scrissi: le varie voci compilate da me per l’Enciclopedia del Cinema di Luciano de Feo rappresenterebbero, messe insieme, il volume ampliato e aggiornato che avrei dovuto sostituire a quella traduzione79. Per quanto riguarda il lavoro e le voci di Arnheim, il mistero può dirsi svelato. Si tratta di dodici testi redatti fra il 1933 e il 1934, a cavallo fra gli ultimi mesi a Berlino e il primo periodo a Roma. La ricostruzione organica di quel contributo è già stata compiuta da Helmut H. Diederichs sulla base dei manoscritti originali forniti direttamente da Arnheim (che evidentemente li aveva conservati) e pubblicata in forma antologica a partire dal 197777. Ma una buona parte di quel corpus era già riemer- Quel volume ampliato e aggiornato troverà la luce poco meno di vent’anni più tardi, quando una versione radicalmente rivista di Film, inclusiva di due saggi originariamente redatti per l’Enciclopedia, fu pubblicata negli Stati Uniti con il titolo Film as Art80. Il primo dei due saggi, intitolato Le idee che fecero muovere le immagini81, ricostruisce l’era del precinema considerando i congegni tecnici che portarono alle invenzioni dei Lumière e di Edison come «stati d’un processo ideale che si svolse in modo collettivo attraverso molti cervelli»82. Arnheim individua come caratteristica tecnica del cinema nei trent’anni iniziali della sua storia la capacità di riprodurre fedelmente gli oggetti del mondo, il movimento e gli avvenimenti, in modo fotografico, dunque per mezzo di un processo meccanico, su un piano bidimensionale. Questo aspetto segna per Arnheim un passo fondamentale nell’antico sforzo dell’uomo di rappresentare la realtà: la priorità della rappresentazione del movimento rispetto alla rappresentazione degli oggetti statici o dei colori è motivata dal fatto che la «reazione biologica fondamentale consiste nel reagire ai fatti, non nel contemplare gli oggetti. Ciò che tocca e commuove l’uomo – soprattutto l’uomo primitivo – non è l’essere, ma l’accadere»83. Il secondo saggio, intitolato Movimento 84, è di carattere puramente psicologico-percettivo. L’illusione del movimento dato dallo scorrimento della pellicola nella “camera” e nel proiettore non influisce sul ritmo estetico del film. Quest’ultimo, il movimento percepito dallo spettatore, dipende dal movimento dei corpi, dalla prospettiva e dalla distanza fra macchina da presa e oggetto ripreso, dai movimenti di macchina e dal montaggio, ma anche dalla velocità di presa, dal ritmo, dalla musica e così via. Per quanto il cinema sia «specializzato nel rappresentare i fatti», esso non ha soltanto uno scopo informativo, ma «è anche espressivo» in quanto, per esempio, la rappresentazione del gesto di una persona può 42 43 4. L’Enciclopedia ricomparsa Veniamo alle voci non incluse in Film as Art, ma pubblicate più tardi in forma antologica. La voce La pittura e il film 85 tratta del rapporto fra pittura e cinema con particolare attenzione agli aspetti antinaturalistici del medium fotografico. Sin dagli albori della fotografia, sostiene Arnheim, i pittori sono diventati spesso dei fotografi. È possibile che il fattore che determina il successo reale di un film non sia tanto la creazione dell’immagine nello spazio quanto piuttosto la creazione di una serie di eventi drammatici che si sviluppa nel tempo. Allo stesso modo, la pittura ha avuto una forte influenza sul cinema nella misura in cui si è occupata della creazione di un’immagine, e questa influenza ha prodotto i suoi effetti attraverso una “deviazione” della fotografia. Il cinema non si occupa quasi mai delle immagini statiche come fanno invece la pittura e la fotografia, sebbene i principi di divisione dello spazio possano essere considerati i medesimi. L’impossibilità di tradurre letteralmente la pittura in cinema è argomentata in Film espressionista86. Arnheim ascrive le debolezze stilistiche de Il gabinetto del dottor Caligari di Wiene87 e di altri film espressionisti al trasferimento della forma di espressione spaziale pittorica nello spazio fisico del cinema. La difficoltà maggiore non consiste nel fatto che non si riesca a mostrare una scena innaturale in un film (così come avviene, per esempio, sul palcoscenico di un teatro), ma che le tecniche di illuminazione e di costruzione della scenografia finiscano per sembrare «imbarazzanti falsificazioni». Altre due voci originariamente composte per l’Enciclopedia sono state pubblicate in forma d’articolo su «Cinema Nuovo» (anticipando di alcuni mesi la versione italiana di Film as Art). Nella voce Erich von Stroheim 88 Arnheim elogia l’indipendenza del regista austriaco dal rigido sistema produttivo statunitense. A differenza di Chaplin, Stroheim non poteva contare sul successo economico delle proprie opere, ma era comunque in grado «di crearsi la libertà di lavorare secondo le proprie esigenze artistiche» e «rimane uno di quei tre, quattro artisti del cinema che si possono classificare senza incertezza tra i grandi artisti di tutte le arti». La seconda voce apparsa su «Cinema Nuovo» è Autore89 e tratta della necessità di riconsiderare la figura del regista alla luce dell’importante lavoro svolto dal soggettista e dalle altre professionalità del cinema. Il vero “regista creatore” dovrebbe ricoprire anche il ruolo di soggettista della propria opera, cosa che avveniva di rado, nonostante la critica continuasse ad attribuire l’intero merito o demerito di un film al regista, tralasciando l’apporto del soggettista, degli attori, degli operatori e degli altri collaboratori che compartecipano all’autorialità. Nel lungo articolo, corredato da brevi interviste a René Clair e Jean Renoir, viene affrontato il tema della paternità dell’opera, l’adattamento cinematografico di opere letterarie e la distruzione della pellicola originaria in caso di remake. Per Arnheim una concezione teatrale del cinema porta a considerare il soggettista, cioè colui che compone il copione, come vero autore del film, a discapito del regista, a cui rimane la possibilità di rendere una buona o cattiva interpretazione ma senza aggiungere nulla di sostanziale. Inoltre, alla radice della differenza artistica fra teatro e cinema c’è una ragione per così dire di “gerarchia mediologica”, secondo cui 44 45 esprimere anche il suo stato emotivo o la natura del rapporto interpersonale con il soggetto cui il gesto è rivolto. Espressiva è dunque la relazione che si instaura fra i fatti rappresentati e il loro significato spirituale. Rudolf Arnheim durante gli anni italiani Il film invece viene concepito in forma (audio)visiva e la sua stesura in parole è soltanto un’operazione supplementare. Si origina da questa concezione la “dittatura del regista”, considerato dalla critica (e dal pubblico) l’unico vero fautore della pellicola, a scapito dello sceneggiatore90. Altre voci completano il quadro di quello che avrebbe dovuto essere il contributo di Arnheim all’Enciclopedia. Su un tema affine ad Autore, la voce Asincronismo 91 tratta dell’uso creativo e dei pericoli della mancanza di simultaneità fra il visivo e l’uditivo. Gli elementi di criticità del film sonoro sono gli argomenti fondamentali della voce Simboli92. Si parla di simbolismo, sostiene Arnheim, quando un processo o un oggetto sono sostituti da un altro processo o da un altro oggetto che rende evidente il significato dell’elemento sostituito, rimpiazzando cioè un’idea concreta con un’idea astratta. A differenza della scienza, che presenta l’universale tramite concetti e forme astratte, l’arte preferisce compie il proprio lavoro formativo e cognitivo nello scoprire casi individuali che esprimano l’essenza della realtà. Così essa descrive ciò che è accessibile ai sensi, delineando in maniera diretta la legge generale che ha effetto sul caso individuale. Questa “sensorializzazione”, spiega Arnheim, è la rappresentazione simbolica. Ogni arte fa uso di uno o più sensi, e così il simbolismo nel cinema è la trasposizione dei concetti nel territorio del visibile e dell’udibile. Ma se la relazione fra la rappresentazione e il rappresentato non appare immediatamente evidente, il linguaggio parlato (e il riferimento ovviamente è al dialogo nel film) non ha a che fare con la percezione visiva perché utilizza l’astrazione e le associazioni di memoria e per questo sarebbe sconsigliato per le creazioni artistiche in campo cinematografico. Nella voce Stile93 Arnheim ravvisare come i precedenti vent’anni della giovane storia del cinema avessero registrato due soli stili emergenti: il film grottesco americano e il «naturalismo incarnato più puramente» dal film russo. Nel primo caso la macchina da presa non veniva ancora utilizzata come elemento creativo e serviva piuttosto come apparato neutrale di preservazione della realtà. Eppure, sotto la «pressione del silenzio», in virtù dell’assenza del sonoro, il film aveva cominciato a sviluppare uno stile pantomimico proprio. Tuttavia, negli stessi termini con cui la tecnica stava perfezionando sé stessa, il film si stava fortemente avvicinando alla realtà. Per esempio, il primo piano contribuì a “scoprire” il mondo delle piccole cose e dei dettagli e l’illuminazione a rendere chiara la fisicità degli oggetti. In breve, il film ha simulato nella costruzione delle sue creazioni la vera rappresentazione della realtà. Di qui l’emergere della necessità di storie verosimili che Arnheim associa alle tecniche dei russi. Egli infatti sostiene che un film non debba essere “stilizzato”, nel senso di omologato a uno stile dominante, e fornisce esempi di registi che hanno mantenuto la propria indipendenza non assimilandosi a uno stile (Chaplin, Keaton, Stroheim, Ejzenštejn, Clair e Pudovkin) e di altri che sarebbero incappati in una svalutazione stilistica (Pabts, Dupont e Lang). La perdita di uno stile personale, conclude lapidariamente Arnheim, preclude la grande arte. La voce Narrazione (Film epico e drammatico) 94 illustra tre proprietà essenziali del film come medium artistico di cui tenere conto per decidere che tipo di soggetto narrativo è adatto e come esso dovrebbe essere presentato. Prima di tutto, il fatto che il film è un’arte visiva, qualcosa che racconta una storia agli occhi, anche quando è utilizzato il suono. Secondo, le immagini che raccontano la storia sono ottenute meccanicamente attraverso la fotografia, ritraendo la realtà con fedeltà documentaria. Terzo, le immagini possono susseguirsi in una sequenza ininterrotta anche se mostrano i luoghi e azioni diversi in momenti differenti. Arnheim applica al film la distinzione fra racconto epico e racconto drammatico, ispirandosi direttamente al saggio Über epische und dramatische Dichtung di Goethe95. Strettamente legata a questo tema è la voce Unità d’azione96, in cui si afferma la superiorità dell’assunto aristotelico dell’unità di azione rispetto all’unità di luogo e tempo, poiché la prima già contiene e implica le altre due. Secondo un principio di economia narrativa, ogni elemento rappresentato in un film deve essere assolutamente necessario. Ma mentre nel film drammatico occorre veicolare la concentrazione dello spettatore su un’azione drammatica unitaria, nel film epico l’azione può essere frammentaria, purché ogni dettaglio sia posto in rapporto di coerenza con il tutto. Infine, in Illuminazione (Parte estetica) 97 si evidenzia il potere creativo della gestione della luce in riferimento agli aspetti di plasticità e profondità, “clima” della scena, direzione dell’occhio, selezione e concentrazione, divisione ornamentale dello spazio. Ecco dunque in sintesi quale avrebbe dovuto essere il corpus di articoli e saggi composti da Arnheim per l’Enciclopedia, pubblicato comunque in forme e in epoche diverse. Oltre a queste dodici voci non è escluso che altri testi, pubblicati nel 1935 su «Intercine», dovessero rientrare nell’opera. Si tratta in particolare di alcune “sintesi” sull’Espressione, peraltro spesso corredate da illustrazioni98. Per quanto Arnheim stesso abbia attestato in più occasioni quale sia stato il suo ruolo nella redazione dell’Enciclopedia, suggerendo peraltro anche il possibile utilizzo che gli altri autori coinvolti potrebbero aver fatto delle proprie voci, restano alcuni elementi di incertezza99. Tuttavia, nonostante le illazioni sulla scomparsa delle bozze, l’Enciclopedia del cinema rappresenta il primo tentativo di sistemazione generale del sapere cinematografico. Certo, un tentativo 46 47 [l]’opera teatrale era creata dal poeta con un solo mezzo artistico, la parola, e completata poi visivamente e acusticamente, cioè con un secondo e un terzo mezzo, che la rendevano visibile e udibile, ma non la cambiavano sostanzialmente, lasciandola quel che era. rimasto irrealizzato. Un fallimento che riflette emblematicamente le contraddizioni della politica culturale del Fascismo, nella fattispecie rispetto all’IICE. Quel sostanziale liberalismo che in principio assicurava protezione, celava in realtà una precarietà che avrebbe presto prodotto un’incolmabile voragine. 5. «Cinema» Con il deterioramento dei rapporti fra Italia e Società delle Nazioni, l’esperienza di «Intercine» in seno all’IICE terminò. D’accordo con l’editore Ulrico Hoepli, Luciano De Feo riuscì sapientemente a salvare l’eredità della rivista, pur rivoluzionandone ancora una volta impostazione, periodicità e formato. Appena sette mesi dopo la chiusura di «Intercine», il 10 luglio 1936 uscì il primo numero di «Cinema». Abbandonata ogni pretesa di carattere internazionale, il nuovo periodico aveva un taglio decisamente divulgativo e popolare, un vero e proprio rotocalco che prevedeva un uso molto esteso della fotografia, seguendo sostanzialmente il modello di «Sapere», altra rivista di successo della scuderia Hoepli100. Rudolf Arnheim nella redazione di «Cinema», con Francesco Pasinetti, Domenico Meccoli e Gino Visentini (1938) 48 Pur restando una pedina fondamentale della redazione, Arnheim era fondamentalmente contrario a tale rivoluzione, poiché nella rivista «l’accento principale cadeva, in ogni numero, su un ampio articolo scritto con poca ambizione intellettuale»101. Tuttavia «Cinema» non era privo «di informazioni solide e di certe analisi estetiche»102 e Arnheim restò attivo suggeritore di temi e fu autore in prima persona di oltre trenta articoli in due anni, fra il luglio del 1936 e il luglio del 1938, molti dei quali di carattere tecnico, con spiegazioni scientifiche dei processi di funzionamento del cinema e delle dinamiche psicologiche percettive. L’esperienza di Arnheim a «Cinema» fu preceduta in realtà da un articolo apparso sulle colonne di «Scenario». In Perché sono brutti i film a colori?103 prende da subito posizione rispetto a uno dei suoi temi caratteristici, cioè lo scetticismo rispetto all’introduzione del colore nel film. Non a caso il suo primo articolo su «Cinema», apparso sul n. 2 del 25 luglio 1936, si intitolava proprio A proposito del cinema a colori104 e si apriva con la provocazione: «Trionferà il cinema a colori? Non ci decidiamo ancora a crederlo come già non avevamo creduto all’avvento del sonoro»105. Nell’arco di circa due anni il lavoro di Arnheim spaziò fra molti argomenti: dalla supremazia dell’inquadratura sul montaggio106 al ruolo dell’attore107 e all’importanza della mimica nell’espressione delle emozioni a fronte dell’introduzione del sonoro108, dal funzionamento psicologico dei gags – di cui Chaplin era il nuovo indiscusso maestro109 – al ruolo del cinema d’animazione 49 Copertina del primo numero di «Cinema» (1936) Copertina del n. 48 di «Cinema» (1938) per dimostrare il falso legame fra realtà e rappresentazione110, dalla ricostruzione storica delle origini del cinema111 e della sua base fotografica112 alle differenze fra racconto letterario e racconto cinematografico113, dalle innovazioni tecnologiche in campo cinematografico114 all’impatto della televisione115, dal film documentario116 alle professioni del cinema117 e al dilettantismo118, dal divismo119 all’industrializzazione hollywoodiana e alla sua ricaduta in campo recitativo120 ed estetico121, dal rapporto fra figura umana e paesaggio122 alla critica al gusto di alcuni registi123. Un gruppo di saggi, articoli e interventi davvero consistente. Altri due articoli di Arnheim, risalenti all’estate del 1938, trovarono spazio al di fuori delle colonne di «Cinema». Nel primo, rispondendo a un lettore sulle pagine di «Sapere»124, intervenne nuovamente sull’argomento delle invenzioni che diedero origine al cinema. Nel secondo, apparso sul numero speciale dell’estate del 1938 de «Il Ventuno» – rivista del Gruppo Universitario Fascista –, pubblicato in occasione della VI Mostra di Venezia125, tornò ad affrontare il tema del film documentario, non meno capace del film a soggetto di servirsi «dei metodi dell’arte per dare un’immagine espressiva e caratteristica del nostro mondo nei suoi vari aspetti»126. novembre 1936) la rubrica venne firmata, per esteso, da Gianni Puccini. Lo pseudonimo “Nostromo” comparve a partire dal n. 11 (10 dicembre 1936) ed è proprio da questo momento che passò con certezza nelle mani di Arnheim, anche se, come vedremo, non è escluso potesse trattarsi già dal n. 6 (25 settembre 1936) di una collaborazione fra Meccoli, Pasinetti, Puccini e Arnheim. 6. Le rubriche di «Cinema» Ma il contributo di Arnheim a «Cinema» non si limita al gruppo degli articoli per così dire “ufficiali”. Alcune note inserite in apertura o a margine di interventi pubblicati negli anni Settanta e Ottanta su «Cinema Nuovo» aprono la strada a nuove piste di ricerca. Ripensando ai suoi anni italiani e ricordando la sua collaborazione con Debenedetti, De Feo, Pasinetti, Pavolini, Meccoli, Arnheim ebbe modo di affermare: «Io scrivevo articoli, resoconti su invenzioni tecniche e redigevo anche i “Colloqui con i lettori”, ero il Nostromo»127. E ancora: «Oltre ad articoli su vari soggetti redigevo una rubrica sulle innovazioni tecniche e un’altra, in collaborazione con mia sorella, di consigli ai fotoamatori. Inoltre per qualche anno ho scritto regolarmente la pagina del Nostromo che firmava la rubrica “Il Capo di Buona speranza”»128. Si tratta di affermazioni molto importanti, perché attestano che il coinvolgimento di Arnheim nella redazione di «Cinema» andava ben oltre gli interventi a lui chiaramente attribuibili. “Colloqui” con i lettori, innovazioni tecniche e consigli ai fotoamatori: tre rubriche fisse, firmate da altrettanti pseudonimi. Proprio l’assenza di una esplicita firma, e la conseguente ambiguità della paternità di tali interventi, ha generato notizie discordanti e, in sostanza, reso pressoché inesplorato un capitolo davvero considerevole, in termini sia quantitativi sia qualitativi, del “passaggio” italiano di Arnheim. Quanto al “Capo di Buona Speranza”, rubrica di corrispondenza con i lettori, non deve confondere il fatto che nelle sue prime apparizioni – la prima in assoluto avvenne sul n. 2 (25 luglio 1936) – e sino al n. 10 (25 50 Un numero della rubrica “Capo di Buona Speranza”, firmata dallo pseudonimo Il Nostromo («Cinema», 46, 1938) 51 Paradossalmente, allo svelamento dell’identità del Nostromo ha contribuito un lungo periodo di oblio che ha annebbiato e confuso la memoria di molti critici e studiosi delle generazioni successive. In un articolo pubblicato nel 1981 da «Cinema Nuovo», Massimo Mida ricorda la figura di Francesco Pasinetti attribuendogli lo pseudonimo129. L’articolo scatenò un dibattito a distanza che ci permette di fare chiarezza sulla questione. Nello stesso numero della rivista, infatti, Guido Aristarco confermò l’informazione di Mida130, contribuendo così a suscitare la reazione di Arnheim. Lettore fedele di «Cinema Nuovo» anche dagli Stati Uniti, egli scrisse di suo pugno e inviò in redazione una precisazione, dicendosi sorpreso dell’integrale attribuzione della rubrica “Capo di Buona Speranza” a Pasinetti e rivendicandone la parziale paternità131. Tuttavia, Arnheim ammise di non ricordare lucidamente, dopo così tanti anni, né avrebbe voluto sminuire i meriti di Pasinetti. Così chiamò in causa Meccoli, il quale, sollecitato a sua volta da Aristarco132, intervenne sul numero successivo della rivista. Arnheim aveva ragione – scrisse Meccoli – specificando la scansione temporale del passaggio della rubrica da Puccini (dal n. 6 al n. 11, periodo entro il quale tuttavia l’apporto fu collettivo) ad Arnheim («unico nostromo per un paio d’anni, fino a che dovette lasciare Cinema e l’Italia per la crescente pressione del razzismo») e solo in seguito a Pasinetti (fino al 1943). Anche Meccoli tuttavia ammise di non avere memoria certa di quel periodo in cui, dovendo assistere Arnheim quando ancora non era padrone della lingua italiana, «avev[a] l’incarico di rivedere i suoi testi, scritti direttamente in italiano»133. A ogni modo, come ancora lo stesso Meccoli suggerì, in cui essa passò totalmente nelle mani di Arnheim nel 1936, né quando avvenne il passaggio di testimone a Pasinetti nel 1938. Tanto più che, nonostante la reazione di Arnheim all’articolo di Mida e le precisazioni di Meccoli nel 1981, oltre dieci anni più tardi Mino Argentieri firmò un articolo intitolato Il Nostromo del Capo di Buona Speranza interamente dedicato a Pasinetti e cadde nello stesso errore di Mida137. (Ma stavolta Arnheim non si scomodò). Una seconda rubrica è da attribuire, perlomeno parzialmente, ad Arnheim. Si tratta di “Voi fotografate noi pubblichiamo”, dedicata ai fotografi amatoriali lettori della rivista. Come egli stesso ha svelato138, una rilettura della rubrica potrebbe fornire interessanti indicazioni di diversità, almeno nelle risposte concettualmente più impegnative. In quelle di Arnheim prevaleva il teorico illuminato che non perdeva mai di vista i principi generali; in quelle di Pasinetti prevaleva il filosofo puntiglioso che anzitutto pretendeva negli interlocutori il suo stesso rigoroso amore per il cinema134. Effettivamente la somiglianza nello stile di scrittura di Arnheim e l’affinità dei temi trattati dal Nostromo in molte delle risposte ai lettori appare evidente anche da una rapida scorsa dei contenuti nel periodo fra il 1936 e l’estate del 1938135. Un rapporto, questo fra il Nostromo e i suoi “marinai”, per quanto mediato dallo pseudonimo e dalla sua natura di rubrica su rivista, che segnò significativamente il percorso di molti giovani lettori che avrebbero in futuro giovato di quei consigli136 così puntuali e franchi, sempre interessati e mai sporcati da toni di superiorità. Ma per la natura stessa della rubrica, ossia per le numerose risposte di carattere puramente tecnico o meramente “colloquiali” che vi trovavano spazio, non è facile individuare con precisione quale fu il momento esatto Un numero della rubrica “Voi fotografate noi pubblichiamo”, firmata dallo pseudonimo Marie Onussen («Cinema», 46, 1938) 52 53 la rubrica era redatta in collaborazione con la sorella fotografa Marie Arnheim-Gay139 e firmata da “Marie Onussen”, nome fittizio ricavato dall’inversione della parola “Nessuno”. Lo pseudonimo purtroppo impedisce di stabilire con certezza chi, fra Arnheim e la sorella, fosse di volta in volta l’autore dei commenti alle fotografie inviate dai lettori. Inoltre, la rubrica per i fotoamatori era generalmente affiancata alla pagina dedicata alla “Fotografia” e gli interventi in questo spazio erano in larga parte firmati da Guido Pellegrini. In due occasioni però comparve per esteso il nome di Rudolf Arnheim140 e in altrettante quello di Marie Onussen141. Mentre nel secondo caso si tratta di interventi rivolti a fotografi dilettanti (dunque molto simili ai commenti della rubrica “Voi fotografate noi pubblichiamo”), gli articoli di Arnheim sono di carattere storico, teorico e tecnico142. Con molta probabilità, dunque, per quanto riguarda la pagina dedicata ai fotoamatori, Arnheim si limitava a dare consigli o a supportare la sorella, che gestiva con una certa autonomia la rubrica. Più vaga ma comunque probabile è l’attribuzione degli articoli di carattere tecnico firmati dallo pseudonimo “Ciak”, generalmente per la rubrica intitolata “Notizie tecniche” (e talvolta “Scienza e tecnica”). Sebbene non venga menzionato da Arnheim nelle proprie testimonianze, lo pseudonimo potrebbe nascondere proprio il suo contributo alle rubriche sulle innovazioni tecniche a cui egli stesso ha accennato. Gli argomenti toccati (tecniche di ripresa, trucchi ed effetti speciali, introduzione del sonoro e del colore, relazioni di convegni scientifici, aspetti psicologici della percezione) sono infatti compatibili con quelli affrontati nelle pagine di «Intercine» dedicate all’Espressione. Questa ipotesi è suffragata dalla presenza di due articoli chiaramente firmati da Arnheim143 e più in generale dai contenuti trattati e dal tono utilizzato144. Assolutamente certa è invece l’attribuzione di un quarto pseudonimo. All’inizio del 1937 su «Cinema» cominciò ad apparire una nuova rubrica di recensioni intitolata “Bianco e Nero” in cui, sotto gli pseudonimi “Candido” e “Arpagone”, Arnheim e Gianni Puccini145 ricoprivano rispettivamente il ruolo di critico “ottimista” e critico “pessimista” rispetto alle novità cinematografiche in sala146. Si trattò tuttavia di un esperimento che si concluse dopo sole quattro uscite, peraltro non regolari147. A far abbandonare la rubrica furono l’artificiosa semplificazione a cui portava la necessità di ridurre le recensioni a elogi e stroncature148, nonché la lamentata mediocritas della produzione cinematografica del tempo che un nuovo pseudonimo, “L’uomo grigio” – ovvero, ironicamente, la fusione di Bianco e Nero – denunciava nell’intervento di congedo della rubrica, significativamente intitolata “Momento grigio”149. Questo corposo contributo alla divulgazione degli aspetti tecnici del cinema e della fotografia, così come i colloqui con i lettori e le recensioni cinematografiche stese in coppia con Puccini, è attribuibile con certezza ad Arnheim fino all’estate del 1938, dopodiché la paternità degli interventi nelle rubriche in questione siglati dagli stessi pseudonimi (che del 54 resto nascondono la reale identità del redattore) è da considerare probabile e rimane incerta. La politica antisemita, infatti, cominciava proprio in quei mesi a trovare concreta realizzazione con la promulgazione delle leggi razziali150, al punto che nell’arco di poche settimane il lavoro profuso e la stima conquistata sul campo da parte di una personalità ancora giovane ma già eminente come quella di Arnheim furono annullati dalla deriva razzista del regime. Tuttavia, ora è finalmente appurato con più obiettività quale fu l’entità del contributo di Arnheim a «Cinema». Un apporto ben più consistente di quanto non sia stato sinora chiaramente riconosciuto. 7. «Bianco e Nero» Ma è proprio in fondo alla parabola italiana di Arnheim che «Bianco e Nero», rivista avviata nel 1937 da Luigi Chiarini (con Luigi Freddi direttore) al Centro Sperimentale di Cinematografia – presso cui peraltro Arnheim era stato saltuariamente invitato a tenere lezioni e seminari151 –, pubblicò due fondamentali saggi152. Il nuovo periodico, con un taglio rigorosamente scientifico e un livello universitario, ben si prestava a ospitare in forma ufficiale quell’estratto di Film als Kunst che Cecchi e Barbaro vollero distribuire in forma di ciclostilato agli allievi del Centro Sperimentale già alcuni anni prima. Fu così, molto tempo dopo il suo approdo a Roma, che Arnheim vide pubblicato in Italia Il film come opera d’arte153, sintesi essenziale dei primi due capitoli del suo libro154. Nella nota introduttiva al saggio viene annunciata anche la prossima pubblicazione sulle pagine della stessa rivista di un nuovo contributo in cui Arnheim avrebbe tentato di «fissare i fondamenti estetici del film parlato e d’inquadrare, ad un tempo, il Cinema nel sistema delle arti, e cioè dell’Arte»155. Si trattava del fondamentale Nuovo Laocoonte, apparso infatti sul numero di agosto di quello stesso anno156. In esso Arnheim presenta un’indagine teorico-estetica ispirata al problema dei generi artistici, già sollevato da Gotthold Ephraim Lessing nel 1766 nel Laocoonte157. Lessing si era ribellato alla similitudine oraziana della poesia-pittura, primo inconsapevole passo verso l’unificazione indistinta delle arti, sostenendo che ognuna di esse avesse un proprio particolare ed esclusivo mezzo espressivo che ne costituiva l’anima e la differenziava dalle altre e dalla natura. Arnheim riformula in chiave moderna la questione, motivando la propria ipotesi a partire dal disagio provocato dallo scontro fra più “sostanze espressive”. A fondamento della sua analisi vi sono ancora la sua originaria impostazione gestaltista e l’assunto dell’ineliminabile scarto fra la realtà fenomenica e la sua percezione: l’arricchimento che nasce nell’arte dal concorso di più mezzi non è uguale a quella fusione di percezioni sensorie di ogni specie che caratterizza la nostra immagine del mondo reale. 55 L’unità di tutti questi elementi sensori non è uguale all’unità che l’artista può creare servendosi del concorso di più mezzi. Giacché nell’arte l’eterogeneità degli elementi sensori rende necessarie separazioni fra questi ultimi, separazioni che si possono superare soltanto attraverso una superiore unità158. Infine, è particolarmente significativa l’ultima apparizione di Arnheim su una rivista italiana – ancora «Bianco e Nero» – prima della guerra. L’attore e le stampelle162, già pubblicato su «Cinema», fu coraggiosamente inserito da Chiarini sul numero speciale dedicato all’attorialità del marzo 1939 nonostante l’epurazione razziale fosse già ampiamente avviata. 8. La fuga La purezza del medium visivo (nel film muto) costituiva la prerogativa essenziale affinché il cinema fosse arte, cioè mezzo capace di “formare” i dati sensori grezzi secondo criteri espressivi di semplicità e chiarezza, ovvero di pregnanza159. Al contrario, il raggiungimento dell’espressività artistica tramite la combinazione del visivo con altre sostanze espressive, per esempio il suono, esigeva l’applicazione di un principio gerarchico (secondo cui la percezione sonora risulterebbe sottomessa a quella visiva o viceversa). Le conclusioni del ragionamento possono apparire paradossali nella loro formulazione: il progresso tecnologico, aumentando la fedeltà riproduttiva, accresceva nel cinema le possibilità documentaristiche, mentre impoveriva il linguaggio del film inteso come creazione artistica. Per arricchire l’immagine con il sonoro (ma anche con il colore e con lo schermo stereoscopico) il film doveva accettare espedienti che ne compromettevano la purezza formale. Per Arnheim il cinema rimaneva un mezzo puramente visivo, la cui natura artistica sarebbe stata preservata solo dall’incontaminatezza da elementi percettivamente “estranei”. Nell’ibridazione di tecniche artistiche diverse ravvisava la decadenza stessa del cinema, solo in parte dovuta alle logiche dell’industrializzazione: era la tendenza a naturalizzare lo spettacolo a nuocere al film come arte. Come è facile immaginare, negli anni seguenti e per lungo tempo il saggio attirò diverse critiche160, marcando in modo indelebile come rigidamente purista e conservatrice la posizione di Arnheim. Il Nuovo Laocoonte rimane tuttavia ancora oggi un testo fondamentale della sua teoria estetica del cinema. Si tratta del resto del primo ampio e completo scritto per così dire “massmediologico”, in cui Arnheim si interessa in termini generali, e non solo cinematografici, alla natura e all’impiego artistico dei mezzi espressivi a disposizione dell’uomo. Proprio durante gli anni italiani l’attenzione per la purezza espressiva (visiva) del cinema come pre-condizione di artisticità era già stata applicata da Arnheim anche a un altro medium. Composto nel 1933, a cavallo fra gli ultimi mesi di lavoro in Germania e il primo periodo di attività a Roma, Radio161 segnò un’altra tappa fondamentale del suo percorso professionale (incidendo, ancora una volta, su quello personale). Arnheim non fece altro che applicare ai problemi della comunicazione-espressione radiofonica la propria teoria sui “mezzi differenzianti”. Così come nel cinema muto era fondamentale la mancanza del suono, analogamente nella radio era importante l’assenza dell’immagine visiva. (Di qui le perplessità di Arnheim sulla televisione che, dotando la radio dell’immagine visiva, ne avrebbe annullato la specificità). Le ultime tracce esplicite del lavoro di Arnheim in Italia risalgono dunque all’estate del 1938, in corrispondenza con i primi provvedimenti antisemiti adottati dall’Italia fascista. È molto difficile, se non impossibile, in assenza di testimonianze dirette, stabilire con certezza quanto e con quali modalità Arnheim abbia continuato a pubblicare articoli, in particolare su «Cinema». Per alcuni mesi i suoi interventi potrebbero essere stati siglati da altri redattori, o firmati da pseudonimi. Ma è probabile che l’escalation dei provvedimenti razziali e il clima di crescente tensione in quel periodo abbia portato Arnheim a un sostanziale isolamento, quantomeno professionale, una fase di stasi occupata soltanto da una esitante attesa e dalla ricerca di un’alternativa lavorativa all’estero. Le ultime pagine del diario italiano di Arnheim e il suo passaporto163 ben raccontano, in modo assai diverso ma complementare, le preoccupazioni e le ansie di quei mesi. Arnheim ottenne il passaporto tedesco presso l’ambasciata del Reich a Roma il 24 settembre 1938, alla vigilia della conferenza di Monaco164. Per quanto consapevole di dover lasciare il paese a breve, decise di visitare un’ultima volta i dintorni della capitale, privilegiando zone e monumenti che non aveva ancora avuto occasione di vedere. «In giorni di terribile tensione – scrisse sul suo diario – è bello passare momenti di tranquillità fuori dal tempo e dalle sue atrocità»165. Di ritorno in centro, palpitò assieme ai romani sulle sorti dell’Europa, leggendo le edizioni straordinarie dei giornali che venivano pubblicate ogni mezz’ora e ascoltando in via Frattina le ultime notizie diffuse via radio dagli altoparlanti. Furono momenti di attesa e di grande apprensione che rimarranno ben impressi nella sua memoria. Sperava per la pace, ma intanto, titubante, discuteva con alcuni confidenti dell’opportunità di una trasferta precauzionale in Svizzera – viaggio tuttavia mai intrapreso. Le prime settimane dell’ottobre del 1938 vennero vissute da Arnheim con una sorta di distacco dall’evoluzione degli eventi politici. Furono giorni trascorsi in casa propria, in compagnia della moglie e delle figlie, rinchiuso in un mondo domestico posto a filtro verso l’esterno. Quasi a voler accrescere quel distacco e cercando una distrazione, lavorò duramente al suo romanzo Eine verkehrte Welt166. Nel diario sottolineò proprio come il momento decisivo della scrittura delle sue opere cadesse sempre in periodi particolarmente drammatici dal punto di vista storico e politico. Il cuore di Film als Kunst era nato nel 1930 in piena crisi economica, Radio nacque a Berlino nel 1933 alla vigilia della fuga dal nazismo. Allo stesso 56 57 modo, il suo “mondo sottosopra” maturò nei difficili mesi che precedettero la sua dipartita dall’Italia. Quasi una conferma in declinazione sociopolitica della teoria estetica sulle limitazioni formali dei media come leva per raggiungere l’artisticità espressiva! Il 23 ottobre del 1938 Arnheim si recò al consolato americano di Napoli, supportato probabilmente da alcuni amici, per chiedere l’accesso alle quote di emigrazione per gli Stati Uniti. Il console però non gli diede molte speranze. Arnheim si sentì trattato con una certa diffidenza, quasi abbandonato. Pensieroso e solo, quel pomeriggio d’autunno salì al Vomero. Sull’autobus provò invidia per gli altri passeggeri, che avevano la fortuna di sentirsi a casa propria senza aver bisogno di accorgersene, come se per loro quella sicurezza fosse un bene scontato e naturale. Per lui, invece, nessun luogo sembrava poter essere realmente chiamato “casa”167. Nonostante la voragine che si stava aprendo attorno a lui, non cedette mai al fatalismo, preferendo credere a un «destino sensato», fondato sul «potere della personalità, che sa sempre scegliere il meglio fra le possibilità che sono offerte e protegge dalle sventure»168. Per ottenere il visto d’ingresso negli Stati Uniti si mosse su più fronti, chiedendo lettere di attestazione del proprio lavoro alle riviste straniere su cui erano stati pubblicati i suoi articoli169 e cercando di ripristinare i rapporti con i vecchi maestri berlinesi170 (che avevano optato per il trasferimento oltreoceano già dai primi anni Trenta). Il 14 novembre 1938 richiese al British Passport Control in Roma il visto d’ingresso nel Regno Unito. Attorno a lui, intanto, si stringeva la morsa del razzismo. Nell’ultima pagina del suo diario dell’epoca, il 13 dicembre 1938, certamente turbato dagli eventi politici e preoccupato per la sua famiglia, raccontò quell’incubo premonitore, in cui, disorientato, si ritrovava a vagare fra lingue di un fuoco inspiegabilmente innocuo, simbolo di un mondo rovesciato che non poteva più ospitarlo171. Il 3 gennaio 1939 si recò all’ambasciata tedesca a Roma per ottenere l’estensione del passaporto. Quel giorno un’inquietante “J” rossa fu stampata sulla prima pagina del documento, a contrassegno indelebile delle sue origini ebraiche. Perdipiù, accanto al suo nome e a quello delle figlie apparvero le diciture “Israel” e “Sara”, con cui il regime hitleriano stava macabramente “battezzando” i cittadini di discendenza semita. Quando il suolo italiano cominciò pericolosamente a vacillare sotto i piedi di Arnheim, furono i suoi interessi professionali a costituire, come già era accaduto per il cinema, un’àncora di salvezza. Grazie al consiglio di Herbert Read, traduttore dal tedesco all’inglese di Radio, Arnheim si convinse a emigrare a Londra, dove avrebbe avuto l’opportunità di lavorare come traduttore per la BBC. Nei primi mesi del 1939, ancora a Roma, inoltrò richiesta d’assistenza al German Jewish Aid Commitee172. Il 25 aprile di quell’anno ottenne il visto per il Regno Unito e il 3 maggio 1939 richiese al consolato di Francia a Roma il visto di transito senza fermata sul territorio francese che, in seguito, gli avrebbe permesso di imbarcarsi per l’Inghilterra a Boulogne-sur-Mer o a Calais. Di lì a pochi giorni avrebbe lasciato l’Italia. Forse a causa della concitazione di quelle settimane, nessuna biografia o autobiografia riporta la data esatta della dipartita di Arnheim dalla penisola. Il suo passaporto scioglie questo dubbio. Nella parte bassa dell’ultima pagina, un piccolo timbro testimonia il passaggio di Arnheim dalla frontiera ferroviaria italiana il 9 maggio 1939 a Bardonecchia, limite nord-occidentale del territorio nazionale. Dieci giorni più tardi s’imbarcò a Boulogne-sur-Mer e raggiunse Folkestone, sulla costa del Kent. Il suo visto venne confermato il 25 maggio 1939 a Londra e prorogato sino al 19 novembre dello stesso anno173. Certamente Arnheim avrebbe voluto evitare quella tappa in Inghilterra, paese belligerante quando ancora Mussolini non aveva dichiarato guerra alla Francia, schierandosi al fianco dei paesi dell’Asse. Pochi mesi prima del bombardamento tedesco di Londra da parte della Luftwaffe, già fra molte angosciose preoccupazioni, scrisse a Fedele d’Amico chiedendogli di convincere la moglie, rimasta in Italia, a raggiungerlo rapidamente nella capitale britannica con il resto della famiglia174. Purtroppo l’improvvisa morte per malattia della figlioletta Anna, avvenuta a Roma nel settembre 1939, e il corso degli eventi bellici e politici avrebbero rimandato quel ricongiungimento di oltre un anno. Finalmente, il 18 settembre 1940, Arnheim ottenne il visto d’immigrazione negli Stati Uniti presso il Consolato generale americano a Londra. Approdò sul suolo statunitense alla fine di quello stesso mese. Una ennesima nuova vita lo attendeva sull’altra sponda dell’Atlantico. 58 59 Intervallo Ma se ella fosse più bella, sarebbe meno mutabile: e, quindi, un’attrice minore. Giacché la bellezza, seppure alla lunga appassisce, è qualcosa di stabile. Per lo meno lo spazio di una serata175. Gli anni che legarono Arnheim, il cinema e l’Italia si collocano in fondo al dibattito sull’artisticità e sullo specifico del film. La sua formazione nell’ambito della psicologia sperimentale lo rendeva una figura non precisamente inquadrabile all’interno del panorama culturale italiano del tempo, in cui il dibattito sull’arte si ispirava alla filosofia estetica dominante, e cioè all’idealismo crociano, basato su una mistica indistinzione di tutte le arti, indipendentemente dai mezzi tecnici mediante cui queste sapevano rivelarsi all’esterno dell’opera176. L’approccio alle arti era dunque di natura filosofica e nel caso del cinema si doveva misurare con il presunto ostacolo del mezzo meccanico che secondo gli idealisti avrebbe condizionato, o addirittura impedito, l’attività creatrice dell’artista, essendo quest’ultima un puro atto dello spirito177. Prendendo le mosse da una linea di partenza diversa e da un’impostazione di matrice fenomenologica, l’indagine di Arnheim consentiva di spostare la discussione teorica sul piano dell’esperienza pratica del rapporto fra l’individuo e la realtà. I risultati di questa impostazione pongono la riflessione di Arnheim su un doppio livello178: “linguistico”, in cui l’attenzione si sofferma sugli aspetti tecnico-pratici del lavoro di realizzazione di un film e della sua grammatica179; ed “estetico”, ovvero teso ad affermare la necessità di un medium di mantenere la propria purezza o, eventualmente, di stabilire criteri di giustapposizione e ibridazione di “forme” differenti in un medesimo mezzo. Più precisamente, la novità del suo approccio stava nel concepire la percezione visiva non come premessa fisiologica della produzione/fruizione artistica, ma come fattore organico. Secondo Arnheim, infatti, esisteva un vero e proprio “pensiero visivo”180 in grado di includere percezione e cognizione in un processo dinamico di fruizione e analisi dell’opera filmica. Tale processo avrebbe un esito non speculativo, bensì “pragmatico”, capace cioè di incidere concretamente sul comportamento e di tradursi in processi ideativi e progettuali che includono elementi operativi o tecnici. Una prospettiva strategica e fruttuosa maturata in un contesto in cui far fronte alla crescente affermazione di sistemi industrializzati di produzione delle immagini (per esempio, il cinema) implicava una verifica non tanto delle caratteristiche estetiche dei prodotti, quanto dell’artisticità dei modi di produzione. Benché fosse ben inserito in Italia e lavorasse a stretto contatto con molti studiosi italiani di estetica cinematografica181, Arnheim attingeva a una matrice culturale che fu motivo di sostanziale estraneità e isolamento rispetto all’idealismo e, in un certo senso, ne agevolò il superamento182. In particolare contribuendo con il Nuovo Laocoonte a creare un vero e proprio cortocircuito nel pensiero predominante rispetto alla fondamentale questione estetica di come vari mezzi potessero essere combinati in un’unica opera d’arte. Con chiarezza e caparbia coerenza, Arnheim sostenne quasi estremisticamente la purezza visiva del film, medium capace di realizzare la propria vocazione artistica e di comunicare le idee solo se mantenuto incontaminato (dal dialogo, dal colore e da altre fusioni linguistiche e innovazioni tecniche). Anche limitandosi a una rassegna dei testi sull’estetica del cinema pubblicati in Italia nei primi quarant’anni del secolo scorso e pur trascurando l’esistenza di alcuni “punti di contatto” teorico, è possibile constatare una certa distanza fra Film als Kunst e i contributi dei principali esponenti di matrice prevalentemente idealista (ma in alcuni casi marxista) della scuola italiana, per esempio Sebastiano Arturo Luciani, Carlo Ludovico Ragghianti, Luigi Chiarini, Umberto Barbaro, Francesco Pasinetti, Anton Giulio Bragaglia183. Rispetto al contesto italiano Arnheim fu dunque portatore di un approccio umanistico non svincolato dal pensiero scientifico, e soprattutto di una ventata culturale che suonava inedita per molti giovani intellettuali e che incise sulla formazione di coloro i quali avrebbero preso in mano le redini della cultura italiana del secondo dopoguerra. In particolare sui registi e sui critici del Neorealismo, chiusi in un ambiente autarchico, anche dal punto di vista culturale184, ma al contempo testimoni di una passione per l’arte cinematografica infiammata dai loro maestri sulle pagine delle riviste specializzate. Una passione che prescindeva dalla censura ideologica e dalle imposizioni del regime fascista185. Arnheim rappresentava una “guida mitteleuropea”186 e spingeva i suoi amici ad allontanarsi dalla tradizione chiusa e scolastica predominante nella cultura italiana (diversamente da quanto accadeva in altre nazioni dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti). Nonostante l’isolamento geografico e culturale, fu dunque una figura decisiva cui va oggi tributato il giusto riconoscimento. La storia ha poi fatto il suo corso, costringendolo a una nuova fuga, portandolo ad abbandonare la passione per il cinema come oggetto privilegiato dei suoi studi. Si stava aprendo per lui la strada di una nuova – finalmente non rocambolesca – stagione della sua vicenda umana e scientifica. 60 61 Secondo tempo Gli anni americani (1940-2007) * Senonché l’arte è un’altra cosa. Nell’arte, la vita ricondotta alle sue radici rimane pur vita, e l’espressione semplice e universale vien sempre animata dall’ispirazione che si coglie dal mondo reale187. 1. Una terza vita Con la fuga dalla persecuzione antisemita, il trasferimento negli Stati Uniti e la voragine culturale provocata dalla guerra, il distacco dall’Italia fu per Arnheim inevitabile e profondo e si protrasse per almeno dieci anni. Quella separazione forzata segnò anche un decisivo allontanamento dello studioso dal campo della teoria del cinema, divenuto quasi uno spettro di quegli ultimi bui mesi italiani188. Si realizzò in un certo senso ciò che Arnheim aveva da tempo previsto e auspicato. Già durante gli anni italiani, infatti, il cinema stava divenendo per lui soltanto uno strumento «fedelmente servito da base a quanto si sviluppò più tardi»189, un lavoro giovanile che * Gli scritti sul cinema di Rudolf Arnheim sulle riviste italiane a cui si riferisce questa parte non sono inclusi nel presente volume, ma pubblicati nell’archivio on-line www. RudolfArnheim.it. costituiva quel «germe dell’idea, cui un uomo dedicherà poi tutta la sua attività futura»190. Il film non era altro che un caso concreto eccezionalmente efficace per testare i principi di una teoria che avrebbe trovato in seguito un’applicazione generale nel campo dei mezzi di comunicazione e dell’arte. Peraltro il lavoro all’IICE, ente che si prefiggeva di promuovere il valore educativo del cinema, va posta all’origine dell’interesse di Arnheim per il ruolo pedagogico delle arti e dei mezzi di comunicazione. Alle prese con la ricerca di un’occupazione in un paese che ancora non riconosceva appieno il suo lavoro e i suoi meriti, Arnheim optò con coraggio e determinazione per l’avvio di un nuovo e radicale capitolo di studi e ricerca, abbandonando l’attenzione specifica verso il cinema per un più ampio interesse per la psicologia delle arti e i processi cognitivi191. I rapporti fra Arnheim e i suoi compagni italiani subirono il drastico colpo della separazione fisica, ma non si dissolsero. Se ne ha traccia concreta nelle corrispondenze e nelle testimonianze delle molte amicizie maturate durante gli anni di lavoro a Roma, per esempio con Francesco Pasinetti, Emilio Cecchi, Suso Cecchi e Fedele d’Amico, Pietro Ingrao, Paolo Milano, Gianni Puccini192. Con tono sempre nostalgico e rammaricato, Arnheim ha ricordato in molte occasioni le tante riunioni informali nella sua casa a Monte Sacro e la fitta frequentazione con quel vecchio gruppo di colleghi. Con il passare degli anni però quelle amicizie a distanza divennero sempre più rarefatte. Lasciati alle spalle gli anni bui dell’esilio e della guerra Arnheim riallacciò i contatti con l’Italia e con alcuni intellettuali che non si erano totalmente dimenticati del loro vecchio (ma giovane) maestro. Decisiva fu la corrispondenza con Guido Aristarco, che avrà un ruolo chiave nel mantenere il legame fra Arnheim, l’Italia e il cinema (continuando a pubblicarne gli interventi sulla nuova serie di «Cinema» prima e su «Cinema Nuovo» poi) e nel reintrodurre la teoria cinematografica arnheimiana nel panorama accademico a partire dal dopoguerra. 2. «Bianco e Nero» e «Cinema» nuova serie no pubblicati tre brevi saggi di Arnheim. In Cinema e psicologia196 viene affrontato il tema dell’utilità del cinema come strumento di supporto per l’attività scientifica degli psicologi, di studio della produzione cinematografica documentaristica e di finzione, e di analisi dell’influenza delle immagini sullo spettatore. Il cinema e la folla197, posto a editoriale dell’intero numero, problematizza le ricadute dell’industrializzazione e della meccanizzazione sul cinema e il conflitto fra film d’arte e gusto delle masse. Originalità di europeo198 tratta dell’opera di Fritz Lang in Germania e a Hollywood. È interessante segnalare che il saggio Cinema e psicologia è preceduto dal resoconto di un’intervista realizzata da Domenico Meccoli durante un recente soggiorno di Arnheim in Italia, in cui lo studioso, americano ormai anche di nazionalità (e di influenza culturale), si dice ancora interessato al cinema, ma non più agli aspetti formali del film, bensì all’analisi del contenuto e alla sua interpretazione ideologica: Non sono un critico. Io mi interessavo e m’interesso di principi generali. Non m’interessa quindi se un certo film è buono o cattivo, ma di vedere quali sono i nuovi mezzi che si possono trarre dalla forma di espressione cinematografica. […] Se adesso, dunque, mi dovessi occupare di cinema, m’interesserebbe l’analisi del contenuto e anche la interpretazione dei mezzi formali dal punto di vista ideologico199. Dopo avere avuto occasione di vedere Ladri di biciclette in una proiezione speciale al Centro Sperimentale, Arnheim si sofferma soprattutto sull’elemento della bicicletta come strumento di problematizzazione «della posizione dell’individuo nella società in un momento in cui egli ha bisogno di aiuto»200. Il Neorealismo cominciava ad affascinarlo e a divenire per lui la risultante politica, sociale, etica ed economica del Ventennio fascista e delle sue contraddizioni sugli stessi fronti. In un articolo del 1953 pubblicato sulla «Rivista del cinema italiano» con il titolo Ripensando alle cose di allora201, Arnheim ricorda quanto in quegli anni fosse Prima di assistere al ritorno di Arnheim nella pubblicistica italiana trascorsero quasi dieci anni dalla sua fuga. Il primo passo venne compiuto dalla stessa rivista che ne aveva ospitato l’ultimo importante intervento prima della guerra, ovvero «Bianco e Nero». Nel 1947 la rivista aveva ripreso la sua regolare attività, ancora sotto la guida di Chiarini. Sul numero di giugno di quell’anno apparve una significativa, fin dal titolo, Lettera dagli Stati Uniti193, in cui Arnheim sostiene che fra le novità librarie sul cinema, apparse nel panorama editoriale dell’epoca, la più interessante fosse Da Caligari a Hitler di Siegfried Kracauer194. In un successivo intervento proseguì la collaborazione recensendo l’ultimo libro di Renato May, Il linguaggio del film195. Sulle pagine della nuova serie di «Cinema», rifondato nel 1948, furo- impressionato dall’arguta dialettica di tanti studenti che si servivano del formidabile strumento crociano, acquistato nelle aule universitarie, per impadronirsi almeno in modo teorico di un campo culturale particolarmente attraente per loro. Per mezzo del cinema penetrava attraverso le frontiere quasi impermeabili lo spirito forestiero e proibito delle democrazie, reso ancora più affascinante dalla rarità e incompletezza degli accenni. Ma a causa di questa scarsità di materia prima, unita a quell’irrealismo astratto che sotto i regimi totalitari crea inevitabilmente una specie di pellagra del pensiero, le discussioni sul cinematografo si esaurivano spesso nel trattamento dei concetti più generici: bellezza e forma, realtà e intuizione202. 62 63 3. Film come arte Il punto di svolta nella carriera scientifica e accademica di Arnheim si verificò proprio nel corso degli anni Cinquanta, quando l’interesse internazionale nei suoi confronti sembrava essersi sopito. Proprio in quegli anni si stava compiendo il lavoro di “antologizzazione” teorica della riflessione estetica sul cinema voluto da Guido Aristarco, il quale riservò ad Arnheim sempre ampio spazio e larga attenzione, pubblicando alcuni estratti tradotti di Film als Kunst203 e posizionandolo fra i “sistematori” della teoria del cinema assieme a Balázs, Pudovkin e Ejzenštejn nella sua diffusissima Storia delle teoriche del film204. Arnheim forse non sospettava di essere neppure a metà della sua vita quando nel 1954, all’età di cinquant’anni, diede alle stampe quella che è considerata la sua opera fondamentale, ovvero Art and Visual Perception205, libro di grande longevità e fecondità su cui si sono formate intere generazioni di psicologi e storici dell’arte. Un’anticipazione del paragrafo “Una scala di complessità”, tratto dal capitolo intitolato “Movimento”206 – molto vicino ai temi legati al funzionamento del cinema –, fu pubblicata nel 1953 sulla «Rivista del cinema italiano»207. La notorietà riconquistata da Arnheim con la sua nuova opera avrebbe presto cominciato a diffondersi in molti paesi e raggiunto anche l’Italia. Ma la vera riscoperta di Arnheim nel nostro paese avvenne paradossalmente all’insegna della sua prima passione. Come già anticipato, nel 1957 egli decise di mettere in pratica il proposito già espresso alla fine degli anni Trenta, ovvero la pubblicazione di una versione aggiornata di Film als Kunst. La nuova edizione, uscita negli Stati Uniti in quell’anno208 (e in Inghilterra l’anno successivo209) con il titolo Film as Art, è costituita dalla prima fondamentale parte di Film210 e da un gruppo di saggi ritradotti dall’originale (si trattava di alcune voci dell’Enciclopedia del cinema e dal saggio Nuovo Laocoonte, già apparso in Italia su «Bianco e Nero»). Contemporaneamente Arnheim rovistò nei propri archivi e propose alla rivista americana «Film Culture» la pubblicazione di tre voci dell’annunciata e mai stampata Enciclopedia 211, integrando la nuova versione del libro e completando il quadro della sua revisione. La stessa operazione, ma in ordine inverso, fu realizzata in Italia. Tra il 1958 e il 1959 due voci dell’Enciclopedia furono tradotte in italiano per essere pubblicate sulla rivista «Cinema Nuovo»212. Pochi mesi più tardi, nel 1960, uscì per l’editore il Saggiatore la traduzione italiana (a opera di Paolo Gobetti) di Film as Art con il titolo Film come arte. Il volume era arricchito dalla prefazione di Guido Aristarco, testo definitivo di una serie di interventi progressivamente ampliati, rimasto per lungo tempo sostanzialmente l’unica, quasi obbligata, chiave di lettura della teoria cinematografica arnheimiana. Significativamente, Film come arte213 fu la prima di una lunghissima serie di traduzioni e origine di un’ampia diffusione internazionale214. La pubblicazione del libro riaccese il dibattito attorno alla natura delle idee di Arnheim sul cinema, principalmente perché quest’ultime rimasero in gran parte immutate215. Nella sua Prefazione, Aristarco riconduceva proprio alle «basi rigorosamente scientifiche e talvolta troppo ortodosse»216 di Arnheim tutte le critiche attorno alle quali si era conformato il pensiero comune: la convinzione nel considerare, pur senza ripudiare il montaggio, l’inquadratura come lo specifico del film217 (condizione che differenzia Arnheim dagli altri “sistematori” Ejzenštejn, Pudovkin e Balázs)218; la conseguente critica – decisamente paradossale perché rivolta a un gestaltista – di uno sguardo “miope”, colpevole di «dare troppo importanza al singolo pezzo al di fuori del tutto, spesso considerato a sé stante e non nella totalità del film»219; e, ancora, l’accusa di formalismo, cioè di un’attenzione limitata ai mezzi formali della rappresentazione filmica e, contestualmente, la sopravvalutazione in termini negativi della natura tecnica del film, perdendo così di vista il suo carattere analitico documentario. Non si può negare che l’inamovibile purismo di Arnheim e la natura intrinsecamente controversa della sua teoria estetica – l’idea che la carenza di mezzi tecnici espressivi sia la condizione per il raggiungimento di un autentico statuto artistico dell’opera, ovvero la limitatezza tecnica come leva per l’artisticità formale – hanno elevato il suo pensiero a teoria classica e, al contempo, ne hanno ostacolato una sostanziale applicazione. Come troppo sbrigativamente è stato sottolineato dai suoi detrattori e dalle “letture ufficiali”, l’attenzione di Arnheim era rivolta, più che alle tendenze stilistiche del momento, ai principi estetici generali e alla natura mediale e artistica del cinema, considerato un oggetto-pretesto di una più ampia riflessione epistemologica. Film come arte fu preceduto da una lunga intervista-colloquio fra Arnheim e Aristarco, pubblicata su «Cinema Nuovo» con il titolo La bomba dei ritrovati tecnici sulla cattedrale cinematografica220. In quell’occasione Arnheim ebbe modo di chiarire i motivi per cui persisteva nel considerare il cinema come una “cattedrale distrutta”, un luogo che, chiusa la stagione d’oro del muto, aveva perso la propria sacralità221. Quell’intervista rappresenta l’unica concreta risposta di Arnheim in lingua italiana alle molte critiche che gli erano state avanzate. Egli giustifica la propria opposizione a considerare il montaggio come l’unica caratteristica del “cinema come arte” con l’idea che «non si può avere una relazione tra immagini se le immagini stesse non sono già formate […]; il montaggio è impossibile se l’immagine in se stessa è materia grezza»222. All’accusa di formalismo ribatte che il senso per così dire “contenutistico” o “ideologico” del suo approccio al film – la capacità di un’inquadratura particolare di esprimere un’idea, una condizione psicologica individuale, o di descrivere un momento storico o un aspetto sociologico della collettività – non aveva avuto, a stessa ammissione di Arnheim, una spiegazione e una esemplificazione sufficienti. Tuttavia, «il formalismo e la preoccupazione della forma sono 64 65 due cose diverse»223. Rispetto al colore è confermata l’idea che la sua introduzione non aumentava, bensì riduceva i “gradi di libertà” dell’artista, costretto a scegliere fra infinite possibilità224. E rimane drastico sul parlato e sulla fusione di più “forme” in un medesimo mezzo espressivo: se la relazione fra due “forme” è chiara, «allora l’espressione c’è. Se questa relazione è invece confusa, accidentale, allora l’espressione non ci sarà, in quanto le due espressioni si distruggono a vicenda, come avviene […] nel parlato»225. Attenzione alla composizione formale dell’inquadratura, utilizzo del contrasto bianco/nero a scopo simbolico, alternanza fra ripresa in campo lungo e primi piani, uso del suono, e in particolare del dialogo, limitato ai casi in cui si veicoli un significato chiaro: la “politica estetica” di Arnheim non aveva bisogno di aggiornamenti. Incalzato da Aristarco, non usò mezzi termini per criticare la tendenza del cinema a commercializzarsi e ibridarsi: L’Arnheim “cinematografico” continuò a essere presente in Italia anche negli anni successivi. Nei mesi che precedettero la pubblicazione di Film come arte si trovava in Giappone227, da dove avviò una “collaborazione per corrispondenza” con «Cinema Nuovo» inviando un articolo di commento ad alcuni film di Ozu e Kinoshita, dal titolo Reazione e progresso nel film giapponese228. Nel 1964 peraltro fu chiamato nella giuria della Mostra del Cinema della Biennale di Venezia (vinse Deserto Rosso, primo film a colori di Michelangelo Antonioni229). La collaborazione con «Cinema Nuovo», rada ma costante, fu assicurata grazie al rapporto mantenuto con Guido Aristarco. A partire dalla fine degli anni Ottanta, infatti, la rivista non smise mai di pubblicare saltuariamente un intervento originale, una traduzione o una ripubblicazione di scritti di Arnheim su temi legati al film. Si tratta di interventi che mostrano una certa progressiva apertura rispetto alle innovazioni tecnologiche e all’aggiornamento dei temi e delle problematiche connessi allo studio del film. Senza che per questo mutassero sostanzialmente gli assunti fondamentali su cui si basava, ostinatamente, la sua teoria filmica. Negli anni Settanta vennero pubblicati alcuni lunghi interventi di carattere saggistico, fra cui Tendenza dell’arte occidentale e diminuzione della visività230, ovvero un testo di commento e approfondita analisi del libro Il film: ritorno alla realtà fisica di Siegfried Kracauer231. Questa speciale recensione, apparsa negli Stati Uniti su rivista e in volume, era per la verità già stata tradotta e pubblicata in Italia nel 1969232, ma Aristarco non se n’era avveduto. Uno specchio del consumismo la didattica del film in Usa233 apparve nel 1978 come parte di una inchiesta sulla “didattica del cinema”. Arnheim ne approfittò per sottolineare l’importanza dell’impiego degli audiovisivi nell’insegnamento, soprattutto nelle università e in particolare ad Harvard234 – dove si era trasferito nel 1969 –, e per delineare un quadro generale della presenza del cinema nei corsi di studi accademici. Il cuore dell’intervista intitolata L’esito ideologico ultimo approdo del film235, pubblicata anch’essa nel 1978, tratta del rapporto (sbilanciato) fra analisi “delle idee” e analisi estetico-formale. Ma Arnheim non sposa le implicazioni ideologiche che sottostavano alla domanda di Aristarco e chiarisce che, nel contesto del tempo, l’analisi ideologica del contenuto era certamente essenziale, ma che il problema risiedeva nella carenza e nella parzialità di opere degne di essere analizzate dal punto di vista estetico. Nello stesso anno uscì, stavolta su «Filmcritica», un’intervista di Giovanni Spagnoletti ad Arnheim sul cinema tedesco degli anni Venti236. Particolarmente rilevante durante gli anni Ottanta fu la pubblicazione sulla «Rivista di storia e critica della fotografia» di due lunghi saggi in cui sono richiamate le teorie classiche del cinema237. Nel 1983 «Cinema Nuovo» pubblicò il significativo intervento Come un tifoso d’oggi amai il cinema in Italia238, corposa testimonianza degli anni di lavoro e soggiorno in Italia, utilissimo per ricavare informazioni e dettagli storici. Parte della stessa testimonianza sarà ripresa, una decina d’anni più tardi, in Un fedele lettore239. Con gli anni Ottanta si aprì anche il dibattito sul digitale e sul problema dell’autenticità dell’immagine cinematografica. L’articolo Immagineavvenimento e durata240 è la trascrizione di un intervento registrato su nastro e inviato ad Aristarco in occasione del convegno “Cinema: dietro e dentro l’immagine elettronica”, organizzato da «Cinema Nuovo» nel mese di novembre del 1986 all’Università La Sapienza di Roma. Il convegno affrontò tre temi principali: le ricadute in campo estetico della ricerca elettronica nel cinema, l’uso delle tecnologie avanzate nella produzione cinematografica, gli effetti sociologici e psicologici dello spettacolo elettronico. L’intervento di Arnheim era previsto sul primo tema, ma l’età avanzata e alcuni impedimenti personali lo indussero a rifiutare l’invito. Aristarco richiese allora ad Arnheim un intervento videoregistrato dal titolo “La ricerca elettronica, riflessi in campo estetico” e ottenne un nastro audio con un saluto e alcune brevi suggestioni sul tema. L’intervento fu utilizzato per aprire il convegno e la trascrizione del testo fu pubblicata sulla rivista241. Riferendosi alle antiche “previsioni” sulla televisione avanzate 66 67 Questo rientra nel problema dell’integrità dell’artista. Se una cosa non si può più fare, non si può più fare. […] Ah, certamente, è tragico. È, non so, come la bomba sul tempio greco. Si distrugge. Ci sono delle distruzioni storiche, come il fatto di Stroheim che è appunto un’autentica distruzione storica. […] Il grande artista non ha scelta; la scelta esiste solo nelle persone mediocri: se una cosa non si può fare, non c’è nulla da dire. Si tratta di un semplice fatto di distruzione226. 4. «Cinema Nuovo» su «Intercine» nel 1935 con il saggio Vedere lontano 242, Arnheim afferma che «[o]rmai, un mezzo secolo più tardi, vediamo con più chiarezza che la tecnica elettronica ha liberato l’immagine registrata dalla sua base tangibile e l’ha resa avvenimento»243. Cercando di restare al passo coi tempi, pur rimanendo legato ai propri consolidati strumenti interpretativi, Arnheim si focalizzò su questo tema nell’articolo Le due autenticità del medium fotografico244 in cui, citando la possibilità di manipolare le immagini videoregistrate, discute la doppia autenticità dei media a base fotografica. Da una parte essi cercano di rappresentare i fatti della realtà, dall’altra riguardano l’espressione umana. L’introduzione del movimento nella fotografia aveva permesso la manipolazione delle immagini. L’avvento del digitale aveva ulteriormente confuso la distinzione fra realtà concreta e realtà espressiva, incrementando la sfiducia nell’affidabilità delle immagini. 5. Il cinema resta arte A parte queste poche, ma costanti apparizioni, la “presenza” dell’Arnheim cinematografico in Italia andò scemando di anno in anno. Non certo per motivi d’età (l’ultima parte della sua vita fu in realtà la più fertile dal punto di vista della produzione scientifico-culturale). Piuttosto, in primo luogo perché la ricomparsa del suo libro sul cinema nel 1960, sebbene in una forma rinnovata, fu considerata niente più che un’operazione di ristampa – quel libro rivoluzionario era nato già come un classico e tale rimaneva nonostante il rimaneggiamento – perché non fu affatto accompagnata da una revisione almeno parziale della posizione assunta trent’anni prima dal suo autore. Nonostante il procedere della storia, della tecnologia e della teoria del cinema, Arnheim mantenne una “ostinata coerenza”: Film come arte resta un «libro fatto di documenti [che a]iuterà a conservare i resti dei tentativi di riflettere il nostro secolo in chiare immagini animate»245. In secondo luogo perché nel 1962 uscì la traduzione italiana di Art and Visual Perception a opera di Gillo Dorfles e da quel momento in poi la “riscoperta” italiana dell’importanza degli studi di Arnheim si legò non tanto al campo cinematografico quanto a quello della psicologia dell’arte. Il cinema, tuttavia, non fu affatto espulso da Arnheim dal campo dell’arte e dal campione di oggetti esemplari cui approcciarsi con gli strumenti della psicologia. È assolutamente errato pensare che il suo interesse per il film si sia totalmente dissolto nel passaggio da una sponda all’altra dell’Atlantico – ennesimo pregiudizio che pesa sulla valutazione della sua teoria. Oltre alla collaborazione a distanza con «Cinema Nuovo», il perdurare di quell’antico legame è testimoniato dalla sua amicizia con Maya Deren, assieme a cui fondò la Creative Film Foundation e con cui intrattenne una fitta corrispondenza fin dalla metà degli anni Quaranta 246. Conobbe inoltre Jonas Mekas e Amos Vogel, sostenne le attività del movimento Cinema 16 e si interessò all’uso dei nuovi media nel cinema non 68 commerciale247. Non smise dunque di opporsi “per principio” alla logica commerciale di Hollywood248 – come già alla fine degli anni Venti a Berlino –, continuando a sostenere il film d’arte e d’avanguardia. Si tratta di attività che confutano la sbrigativa interpretazione che ha per lungo tempo liquidato Arnheim soltanto come uno strenuo oppositore del cinema sonoro. Film come arte e l’intero pensiero arnheimiano sul cinema sono, al contempo, una lucidissima sintesi delle leggi generali che governano i processi di visione e comprensione nell’esperienza filmica e un’opera che racconta a posteriori una “distruzione”, un crollo inevitabile. Quasi un grido di protesta, un avvertimento e, contemporaneamente, una presa di coscienza dei risultati che stavano provocando il passaggio dalle dinamiche espressivo-creative come principi-guida dell’“artista cinematografico” nella stagione d’oro ai processi produttivi industrializzati che ibridavano e contaminavano l’estetica filmica. Eppure l’arte si trovava a vivere in un mondo che aveva marginalizzato, anche se non totalmente perduto, la possibilità di raggiungere la purezza stilistica anche nei nuovi media, come era già avvenuto per il cinema. 6. Arnheim nel nuovo millennio Un’attenzione e un interesse più ampi dell’Italia nei confronti di Arnheim (e viceversa) riguardarono anche l’avvio di un rapporto di corrispondenza e collaborazione con alcune figure di spicco del contesto culturale e accademico italiano, come Gaetano Kanizsa, Fabio Metelli (dei cui lavori Arnheim fece uso quando ancora erano sconosciuti in America)249, Augusto Garau e Giulio Carlo Argan. Furono molte le occasioni in cui Arnheim ebbe modo di tornare in Italia per partecipare a incontri e convegni e numerose conferenze vennero organizzate in suo onore a partire dagli anni Ottanta250 fino al 2005, per celebrare il suo centesimo compleanno e il 50° anniversario di pubblicazione di Art and Visual Perception251. Va precisato che nell’ambito di questi convegni solo una minima parte è stata dedicata all’esplorazione della lontana stagione italiana – una parte a dire il vero proporzionale rispetto all’intero corso della sua vita! Una longevità biografica che si riflette nella durevolezza e nella fecondità delle idee contenute nei suoi libri. Tuttavia non affatto proporzionale se si pensa al peso e al ruolo formativo e fondativo che quella prima passione avrebbe avuto nella sua carriera scientifica. Benché si tratti di ricontestualizzazioni che ben rendono l’idea dell’organicità, della complessità e dell’apertura dell’approccio arnheimiano all’estetica dell’arte e dei media, queste poche testimonianze sono volte non tanto a ricostruire l’effettivo contributo di Arnheim all’ambito cinematografico e culturale italiano o a valutare l’eredità e la tenuta attuali della sua teoria, quanto piuttosto a rendere il giusto tributo a una figura che ha costituito un vero e proprio riferimento culturale per molti amici, studenti e colleghi e che prematuramente fu sottratta all’Italia dalla storia 252. Nonostante tutto, 69 ciò che rimane di Arnheim è la sua modestia, la sua meraviglia di fronte all’infinita serie di opere d’arte che l’Italia gli ha messo a disposizione, la sua gratitudine e il suo affetto per gli amici: Pensare all’Italia è pensare a una patria e agli anni più belli della nostra vita; sono gli anni in cui la profonda umanità del popolo e delle sue creazioni ci ha insegnato che cosa significa vivere sul serio e con dignità253. Titoli di coda L’immortalità mi è sempre sembrata una cosa contro la mia natura, che richiede le cose ben confinate. Così quando penso del poco tempo che rimane per la vita dei vecchi, penso con una certa tranquillità a un compito completato, a una porta che si chiude, ma anche a una specie di piccolo tesoro che rimane accessibile nella memoria di quelli che ne hanno bisogno 254. Per quanto controversa per sua stessa natura e per la prospettiva entro cui è stata accolta, la teoria filmica di Arnheim da un lato non ha mai smesso di attirare l’attenzione di studenti e studiosi di tutto il mondo, dall’altro non è mai stata sottoposta seriamente a una riflessione sufficientemente organica e a una verifica in chiave contemporanea. Il patrimonio teorico arnheimiano in ambito cinematografico può invece ancora essere riscattato e ricollocato all’interno di un quadro più lucido e complesso che ne evidenzi l’apporto a una storia e teoria del visibile. Le idee di Arnheim conservano ancora un potere esplicativo e una fecondità interpretativa nella comprensione, per esempio, dei fenomeni crescenti della visività contemporanea, sempre più inserita in un contesto di complessità sensoriale. Nonostante si renda necessaria un’integrazione in chiave storico-filologica della sua prospettiva, non possono essere disconosciuti nei suoi studi alcuni punti fermi che potrebbero ridivenire fecondi se applicati alle tendenze contemporanee dei fenomeni di produzione/ricezione audiovisiva. Particolarmente interessanti risultano alcuni tentativi in questa direzione, per esempio nel campo dei nuovi media255, della realtà virtuale256 e in generale volti a riabilitare la figura di Arnheim come mass-mediologo257. Potrebbe certamente rivelarsi fruttuosa persino l’immissione delle idee di Arnheim nel dibattito sull’incorporazione in ambito estetico di alcune scoperte provenienti dalla ricerca neurocognitiva – scoperte peraltro funzionali al consolidamento del filone di studi sugli aspetti sensibili e corporei dell’esperienza filmica. Paradossalmente l’ambito italiano, terreno d’elezione della vicenda 70 cinematografica di Arnheim, è ancora totalmente estraneo a tale operazione, che però si svolge piuttosto attivamente su campi differenti e cui già abbiamo accennato citando le iniziative e i contributi raccolti in occasione del suo centesimo compleanno. Ciò che ancora resta incompiuto è un’operazione volta non a giustificare posizioni paradossali o a manipolare e riabilitare teorie superate poiché riferite a casi precisi e limitati, bensì a testare la plausibilità dell’attualizzazione di principi teorici generali. Intendere il cinema non semplicemente come dispositivo della visione (la cui complessità del rapporto oggetto-soggetto è risolta nell’analisi percettiva), ma come disposizione dello sguardo significa aprirlo a un metodo che intercetti il senso delle pratiche di produzione testuale e di ricezione spettatoriale ripartendo dalla sua consistenza estetico-formale e dalla sua vocazione artistica. Il superamento della tradizionale lettura marxista, che ha portato a massimizzare l’attenzione verso l’Arnheim per così dire “sintattico” del linguaggio formale e a minimizzare l’interesse per l’Arnheim “semantico” dei rapporti fra la realtà e la sua “messa in forma”, necessita di essere ricontestualizzato in una prospettiva che valuti le relazioni fra la realtàformata e i processi di organizzazione del visibile, inteso non solo in senso percettivo/ottico – come le letture restrittive continuano a proporre –, ma anche emotivo e cognitivo. Più propriamente, una concezione (ancora nella sua fase nascente) di “visibile performativo”, entro cui dibattere non più la legittimità estetica o la specificità linguistica del medium, ma la sua capacità di farsi strumento formativo dell’esperienza, di essere cioè luogo di comunicazione, terreno di negoziazione sociale e ambito di manifestazione espressiva. Un mezzo capace ancora di avere un peso simbolico determinante e di segnalare e misurarsi con le controverse, quasi contraddittorie, coordinate dell’esperienza umana del XX secolo di cui Arnheim è stato integralmente testimone. 71 Cfr. James R. Peterson, Eyes have they, but they see not. A conversation with Rudolf Arnheim about a generation that has lost touch with its senses, «Psychology Today», giugno 1972, pp. 55-59, trad. del curatore. 2 Fra le molte biografie di Arnheim si vedano soprattutto l’autobiografia Rudolf Arnheim: Lebenslauf, nel Rudolf-Arnheim-Forum on-line a cura di Helmut H. Diederichs (http://www.sozpaed.fh-dortmund.de/diederichs/arnforum/arnheiml.htm), 1981; Rudolf Arnheim, My Life in the Art World, School of Art, University of Michigan, Ann Arbor (MI), 8 febbraio 1984; Ian Verstegen, The Thought, Life and Influence of Rudolf Arnheim, «Genetic, Social and General Psychological Monographs», 122, 1996, pp. 197213 (http://ianverstegen.googlepages.com/lifeofarnheim); Helmut H. Diederichs, Der Filmkritiker und Filmtheoretiker Rudolf Arnheim, Symposium “Rudolf Arnheim. Film Kunst Literatur”, Bonn, 14-15 novembre 1997 (http://www.sozpaed.fh-dortmund.de/ diederichs/texte/arnheimb.htm); “Tributes”, in Kent Kleinman, Leslie Van Duzer (a cura di), Rudolf Arnheim. Revealing Vision. Dialogues, Essays, Tributes, University of Michigan Press, Ann Arbor (MI), 1997; Roy R. Behrens, Rudolf Arnheim: The Little Owl on the Shoulder of Athene, «Leonardo», 3, 1998, pp. 231-238 (http://mitpress2. mit.edu/ejournals/Leonardo/isast/articles/arnheim.html); Id., Rudolf Arnheim: An inadvertent Autobiography, «Gestalt Theory», 2, 2004, pp. 99-113. 3 Rudolf Arnheim, Experimentell-psychologische Untersuchungen zum Ausdrucksproblem, «Psychologische Forschung», 11, 1928, pp. 2-132. Secondo alcuni studiosi la tesi di Arnheim rimane un classico nella teoria sull’espressione, al punto che vi si riferiscono, per esempio, Maurice Merleau-Ponty e Werner Wolff per dimostrare la realtà epistemologica delle proprietà espressive, (cfr. Ian Verstegen, The Thought, Life and Influence of Rudolf Arnheim, cit.). 4 Per una ricostruzione esaustiva degli assunti teorici e della storia della psicologia della Gestalt si veda Mitchell G. Ash, Gestalt Psychology in German Culture, 18901967, Cambridge University Press, Cambridge (MA), 1998 (tr. it. La psicologia della Gestalt nella cultura tedesca dal 1890 al 1967, Franco Angeli, Milano, 2004). 5 Rudolf Arnheim, Toward a Psychology of Art. Collected Essays, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1966 (tr. it. Verso una psicologia dell’arte, Einaudi, Torino, 1969, pp. 247 e 255). 6 Max Wertheimer, Experimentelle Studien über das Sehen der Bewegung, «Zeitschrift für Psychologie», 61, 1912, pp. 161-265 (tr. ing. Studies in the Seeing of Motion, in AA. VV., Classics in Modern Psychology, Philosophical Library, New York, pp. 10321089). 7 Wolfgang Köhler, The Mentality of Apes, Harcourt and Brace, New York, 1925. 8 Rudolf Arnheim, “Nachwort”, in Id., Zwischenrufe: Kleine Aufsätze aus den Jahren 1926-1940, Gustav Kiepenheuer, Leipzig-Weimar, 1985, p. 235. 9 David A. Pariser, A Conversation with Rudolf Arnheim, «Studies in Art Education», 3, 1984, Washington DC, p. 179. 10 Rudolf Arnheim, My Life in the Art World, cit., p. 6. 11 Su questi temi si veda Mitchell G. Ash, “Estetica gestaltista e impegno politico: la teoria del film di Rudolf Arnheim”, in Id. La psicologia della Gestalt, cit., pp. 366-374. 12 Il primo articolo in assoluto fu Die Seele in der Silberschicht e venne pubblicato in «Die Weltbühne», 30, 28 luglio 1925, pp. 141-143. Con lo stesso titolo è pubblicata un’antologia di scritti curata da Helmut D. Diederichs in occasione del centesimo compleanno di Arnheim: Die Seele in der Silberschicht. Medientheoretische Texte Photographie - Film - Rundfunk, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004. 13 Per un suggestivo ritratto di Ossietzky, deportato in campo di concentramento nel 1933 e premio Nobel per la pace nel 1936, e per alcune indicazioni sulle modalità di lavoro alla «Weltbühne», si veda Rudolf Arnheim, “Introduction”, in Id., Film Essays and Criticism, cit., p. 6. Sui dettagli che portarono Arnheim nella redazione del giornale si veda la sua diretta testimonianza in Rudolf Arnheim, Rudolf Arnheim: Lebenslauf, cit. 14 Molti di quegli articoli si trovano anche in un’altra precedente antologia a cura di Helmut D. Diederichs: Rudolf Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film, Carl Hanser, München-Wien, 1977, ripubblicata da Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main, 1979 (tr. ing. Film Essays and Criticism, cit.). Si vedano in particolare i capp. VII (“Stachelschwein Reviews”) e VIII (“Weltbühne Reviews”). 15 Cfr. Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Exil in Italien 1933-1945. vol. I, Klett-Cotta, Stuttgart, 1989 (tr. it. Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, La Nuova Italia, Firenze, 1993, p. 425); Rudolf Arnheim, Rudolf Arnheim: Lebenslauf, cit.; Elia Franzini, “Rudolf Arnheim. Revealing Vision”, «Domus», 805, 1998, p. 113. 16 Rudolf Arnheim, My Life in the Art World, cit., p. 7. 17 Arnheim peraltro partecipò in prima persona ai movimenti d’avanguardia berlinesi che proponevano opere di critica sociale attraverso l’uso artistico dei nuovi media. In opposizione alla prima ondata di commercializzazione dell’industria cinematografica che seguì immediatamente l’introduzione del sonoro, Arnheim promosse il lavoro di Wilfried Basse, presentandone i film alla DEGETO (Deutsche Gesellschaft für den Tonfilm, antecedente della televisione tedesca). Basse fu tra i primi a impiegare tecniche come la camera a mano e a ingaggiare attori non professionisti (fra cui lo stesso Arnheim, nel ruolo di comparsa), mescolandosi alla vita quotidiana di Berlino allo scopo di attaccare la censura e proporre una visione critica della società. Cfr. Ingrid Scharmann, “Ordine, espressione e media nella teoria estetica di Rudolf Arnheim”, in Lucia Pizzo Russo (a cura di), Rudolf Arnheim. Arte e percezione visiva, Aesthetica Preprint, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo, 2005, pp. 162-163. Si veda inoltre Rudolf Arnheim, “Erinnerung an Wilfried Basse”, in Stiftung Deutsche Kinemathek (a cura di), Liebe, Tod und Technik. Kino des Phantastischen 19331945 / Wilfried Basse. Notizen zu einem fast vergessenen Klassiker des Deutschen Dokumentarfilms, catalogo della mostra a cura di Kraft Wetzel e Peter Hagemann, “Internationale Filmfestspiele Berlin”, Berlin, 1977, pp. 77-78. 18 Rudolf Arnheim, “Introduction”, in Id., Film Essays and Criticism, cit., p. 6. 19 Sul peso di questa esperienza nella carriera di Arnheim si veda anche Dirk Grathoff, Rudolf Arnheim at the Weltbühne, in Kent Kleinman, Leslie Van Duzer (a cura di), Rudolf Arnheim. Revealing Vision, cit., pp. 18-23. Nella sua autobiografia (Rudolf Arnheim: Lebenslauf, cit.) Arnheim ricorda che in quel periodo lavorò anche per il quotidiano «Vossische Zeitung» ed ebbe modo di entrare in contatto con Béla Balázs, Josef von Sternberg e altre personalità dell’ambiente culturale. 20 Rudolf Arnheim, Film als Kunst, Ernst Rowohlt, Berlin, 1932. L’opera tuttavia fu composta in gran parte a Badenweiler, località nella regione del Baden, nel 1930. Lo si apprende dal diario personale di Arnheim, 5 ottobre 1938 (Archives of American Art, Washington DC). 21 Su questo aspetto cfr. Rudolf Arnheim, “Introduction”, in Id., Film Essays and Criticism, cit., pp. 3-7. 22 Rudolf Arnheim, Ricordando gli anni venti, intervista a cura di Giovanni Spagnoletti, «Filmcritica», 283, 1978, p. 95. Il legame fra gli articoli e il testo del libro, oltre a risultare evidente dalla loro lettura comparata, è testimoniato in diverse fonti, per esempio in una lettera di Arnheim a Fedele d’Amico datata 25 agosto 1987, in cui vengono forniti altri dettagli sugli anni tedeschi: «Non ho mai lavorato per l’Ufa, né per 72 73 NOTE 1 un’altra casa cinematografica, eccetto un paio di tentativi per scrivere sceneggiature (mai eseguite). No, sono stato critico del cinematografo per riviste, specialmente la “Weltbühne” di Ossietzky, e da quella esperienza è derivato Film als Kunst», (Rudolf Arnheim, Fedele d’Amico, Eppure, forse, domani, cit., p. 170). 23 Die wirkliche Greta Garbo, «Filmtechnik/Filmkunst», 10, 1931, pp. 4-5, poi con il titolo Der Fall Greta Garbo, «Neue Zürcher Zeitung», 2450, 1931; Die Gestaltungsmittel der Kamera, «Filmtechnik/Filmkunst», 22, 1931, pp. 5-7; Argumente gegen den Tonfilm, «Berliner Tageblatt», 528, 1931; Psychologie des Konfektionsfilms, «Die Weltbühne», 45, 1931, pp. 711-714. 24 Rudolf Arnheim, Film, Faber & Faber, London, 1933 (traduzione di L. M. Sieveking e J. F. D. Morrow), con prefazione di Paul Rotha, sedici illustrazioni concesse dalla Film Library del Museum of Modern Art di New York. 25 Rudolf Arnheim, Ripensando alle cose di allora, «Rivista del cinema italiano», 1-2, 1953, pp. 93-94. 26 Si trova traccia di questa concezione estetica, molto diffusa durante il periodo delle teorie classiche del cinema, già in György Lukács, “Gedanken zu einer Ästhetik des Kinos”, «Pester Lloyd», XC, 16 aprile 1911, pp. 45-46, poi in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 251, 1913, pp. 1-2 (tr. it. “Riflessioni per una estetica del cinema”, in Alberto Barbera, Roberto Turigliatto (a cura di), Leggere il cinema, Mondadori, Milano, 1978); Hugo Münsterberg, The Photoplay: A Psychological Study, D. Appleton & Co., New York-London, 1916 (tr. it. Film: il cinema muto nel 1916, Pratiche, Parma, 1980); Victor O. Freeburg, The Art of Photoplay Making, The Macmillan Company, New York, 1918. Per una ricostruzione generale cfr. Alberto Boschi, Teorie del cinema. Il periodo classico 1915-1945, Carocci, Roma, 1998, pp. 130-138. Per un approfondimento critico in ambito italiano sull’impostazione teorica di Arnheim si vedano anche Emilio Garroni, “La teoria dello «specifico filmico»”, in Id., Progetto di semiotica. Messaggi artistici e linguaggi non-verbali. Problemi teorici e applicativi, Laterza, Bari, 1972, pp. 336-342; Antonio Costa, “Il potere del centro: R. Arnheim”, in Id., Cinema e pittura, Loescher, Torino, 1991, pp. 98-105, poi in Id., Il cinema e le arti visive, Einaudi, Torino, 2002, pp. 230-238; Alberto Angelini, “Un confronto esemplare: la nozione di montaggio in Rudolf Arnheim e Sergej M. Ejzenštejn, in Id., Psicologia del cinema, Liguori, Napoli, 1992; Liborio Termine, Chiara Simonigh, “Rudolf Arnheim”, in Id., Lo spettacolo cinematografico. Teorie ed estetica, Utet, Torino, 2003, pp. 104-114. 27 Rudolf Arnheim, My Life in the Art World, cit., p. 7; Id., “Introduction”, in Id., Film Essays and Criticism, cit., p. 4. 28 «One essay, which I had the bad judgment of writing three months before the Nazis came to power, was a comparison between the moustache of Hitler and the moustache of Charlie Chaplin. In that little piece I analysed the particular physiognomic quality of what that moustache does to the nose. Chaplin’s humor consisted in his trying to pretend that he was aristocratic and one of the higher classes, while he actually was a tramp. This, in relation to the Führer was an unfortunate observation to make in public print and so when, three months later, I talked to a friend who had a connection with the Nazis, he said, “You know that article of yours, they have it in their files. So you better get out of the place.” And then, fairly soon I did get out», (David A. Pariser, A Conversation with Rudolf Arnheim, cit., p. 179). 29 Paolo Milano, Rudolf Arnheim: “Film als Kunst”, «Scenario», 1, 1932, pp. 59-60. 30 Vale la pena riportare un breve stralcio: «Qui il lettore occidentale forse sorride all’accorgersi che lo scrittore non sospetta neppure che nel campo di una tecnica la ricerca di una classificazione scientificamente rigorosa non approda mai […]. Ogni tecnica non può che rassegnarsi ad essere empirica», (Ivi, p. 60). «L’Italia letteraria», 15 maggio 1932, p. 5, estratto tradotto dal paragrafo “Manuskript und Regie”, in Rudolf Arnheim, Film als Kunst, cit., pp. 220-223. 32 «Cine-Convegno», 2-3, 1933, pp. 34-36. 33 Ivi, p. 34. 34 «La Stampa», 20 giugno 1933, p. 5, tit. or. Robert Ambach, Geräusche in der linken Hand, «Berliner Tageblatt», 154, 2 aprile 1933. 35 Si veda Gli anni della Cines. Inediti dai “Taccuini”, «Bianco e Nero», 4, 1983, p. 22. La sintesi è così segnalata: “Estratti da Film als Kunst di Rudolph Arnheim. Edit. Ernst Rowohlt, Berlin 1932, a cura di Umberto Barbaro (“Cines” 1933)”. 36 Rudolf Arnheim, Il film come opera d’arte, «Bianco e Nero», 4, 1938, pp. 11-42. 37 Ivi, p. 11. 38 Sulla natura e gli scopi dell’IICE si veda [Anonimo], “Introduzione”, «Rivista internazionale del cinema educatore», 1, 1929, pp. 7-11; Louis Dop, Il posto e la missione dell’Istituto della Cinematografia Educativa nel quadro delle organizzazioni ufficiali internazionali, «Rivista internazionale del cinema educatore», 1, 1929, pp. 12-25; i rapporti periodici di Luciano De Feo alla Società delle Nazioni riportati sulla stessa «Rivista internazionale del cinema educatore» (cfr. 2, 1930, pp. 161-163); Gastone Bosio, Un importante istituto: l’I.I.C.E., «La Stampa», primavera 1933. 39 Christel Taillibert, L’Institut International du cinématographe éducatif. Regard sur le rôle du cinéma éducatif dans la politique internationale du fascisme italien, L’Harmattan, Paris, 2000. 40 «Rivista internazionale del cinema educatore», 5, 1933, p. 391. 41 «Rivista internazionale del cinema educatore», 7, 1933, p. 550. 42 [Edward Kleinlercher], Film als Kunst (Film come arte), «Rivista internazionale del cinema educatore», giugno 1933, p. 499. 43 Rudolf Arnheim, Le leggi del colore, «Cinema», 29, 1937, p. 171. 44 Cfr. Rudolf Arnheim, My Life in the Art World, cit., p. 8; Id., Come un tifoso d’oggi amai il cinema in Italia, «Cinema Nuovo», 301, 1986, p. 35. 45 «And the people in the Institute for the Educational Film did a great deal of publication. […] they were preparing a monumental encyclopedia of the cinema, which was to come out in two or three big volumes, on which they were working», (Rudolf Arnheim, My Life in the Art World, cit., p. 8). 46 Arnheim amò profondamente l’Italia, tanto da definirla “casa propria”: «And so then I moved to Rome, and I had the privilege to live in Rome for six years. By now this is almost like my home town – even though it has been changing, of course, as every city has», (Ivi, p. 7). «The privilege of spending decisive years of my development in the Eternal City gave me standards of what is noble and lasting in Western culture, it created a kind of internal home base that remained with me wherever I went to live thereafter», (Vineta Colby [a cura di], World Authors 1980-1985, Wilson Company, New York, 1991, p. 46). Alcune biografie riportano racconti di episodi curiosi. Per esempio, come scrive Roy Behrens riportando il testo di una lettera di Arnheim del 1993: «In one of his memories of Italy, he recalls how he “arrived in Rome and took a room near the piazza di Spagna. It was August and very hot. The old lady showed me my room and asked me not to put lemons on the marble top of the chest and not to disturb the turtle egg she had put up for incubating it. “I have put it in this room because the hot water pipes run through it, and so it is the warmest room in the house!”», (Roy R. Behrens, Rudolf Arnheim: An inadvertent Autobiography, cit., pp. 106-107). Un altro episodio è riportato dallo stesso Arnheim: «Una delle cose belle di Roma è che non si sa mai esattamente che ore sono. Due orologi non sono mai d’accordo. Si percepisce il momento attraverso una morbida messa a fuoco, in cui i margini di tutti 74 75 31 i doveri e di tutti gli impegni sono felicemente attenuati», (Rudolf Arnheim, Parabole della luce solare, cit., p. 249. Sull’amore non dimenticato di Arnheim per l’Italia si leggano anche le parole di Giulio Carlo Argan nella “Prefazione” alla pubblicazione degli atti del convegno “Pensiero e visione in Rudolf Arnheim” svoltosi a Milano dal 9 all’11 giugno 1986: «Il convegno era anche la testimonianza di un’amicizia antica, costante e reciproca, quasi una affinità elettiva. Dice Arnheim che quando viene in Italia si sente come a casa propria; può essere certo che in Italia nessuno lo considera uno straniero. C’è un legame di simpatia umana, Arnheim ne è ricco e prodigo, ma il rapporto non è soltanto affettivo, c’è una convergenza e uno scambio di interessi e di esperienze di studio», (Giulio C. Argan, “Prefazione”, in Augusto Garau [a cura di], Pensiero e visione in Rudolf Arnheim, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 7). 47 Testimonianze personali sulle affinità fra Arnheim e l’Italia si trovano anche nel carteggio Rudolf Arnheim, Fedele d’Amico, Eppure, forse, domani, cit. 48 Rudolf Arnheim, Un fedele lettore, «Cinema Nuovo», 336, 1992, pp. 5-6. 49 Cfr. I.C.E.: A Reply to G. F. Noxon, «Cinema Quarterly», 3, 1935, pp. 95-97. 50 Il curioso episodio dell’arresto in cui incappò Arnheim il primo giorno di lavoro è testimoniato in Come un tifoso…, cit., p. 35. 51 Rudolf Arnheim, Confessions of a Maverick, «Salmagundi», 78-79, 1988, pp. 4553. In seguito si trasferì nel quartiere Monte Sacro, (cfr. Pietro Ingrao, “Ricordo di Arnheim”, in Gabriella Bartoli, Stefano Mastandrea [a cura di], Rudolf Arnheim. Una visione dell’arte, Anicia, Roma, 2006, p. 23). 52 Cfr. Ernesto G. Laura, “Il sodalizio con Rudolf Arnheim e la nascita di «Cinema»”, in Id., Parola d’autore. Gianni Puccini tra critica, letteratura e cinema, ancci, Roma, 1995, p. 58. 53 Rudolf Arnheim, Come un tifoso…, cit., p. 35. 54 Cfr. Gian Piero Brunetta, “4. La costellazione delle riviste specializzate”, in Id., Storia del cinema italiano. Il cinema del regime 1929-1945, vol. 2, Editori Riuniti, Roma, 1979. Sul ruolo di Arnheim all’IICE cfr. anche Jürgen Wilke, Cinematography as a Medium of Communication. The Promotion of Research by the League of Nations and the Role of Rudolf Arnheim, «European Journal of Communication», 6, 1991, pp. 337-353. 55 Rudolf Arnheim, Espressione, «Intercine», 1, 1935, p. 34. 56 Rudolf Arnheim, Il critico cinematografico di domani, «Intercine», 8-9, numero speciale per la III mostra internazionale cinematografica, 1935, pp. 36-37, poi in «Cinema 60», 85-86, 1971, pp. 48-52; e in «Filmcronache», 1, 2005, pp. 22-25. 57 Arnheim parteciperà peraltro al Primo congresso mondiale sulla Televisione, promosso e organizzato a Nizza nel 1935 sotto la responsabilità di Luciano De Feo e del Ministro guardasigilli Alfredo Rocco e affidato alla presidenza di Louis Lumière. Sugli esiti della conferenza si veda [Anonimo], Un centro internazionale di televisione, «Intercine», 5, 1935, pp. 251-253. 58 Rudolf Arnheim, Vedere lontano, «Intercine», 2, 1935, pp. 71-82. 59 Ivi, p. 71. 60 Rudolf Arnheim, Nostro pane quotidiano, «Intercine», 1, 1935, pp. 14-18. Per un commento al saggio-recensione di Arnheim si veda l’intervento anonimo (ma si tratta di Ettore Margadonna) in «L’eco del mondo», 26 giugno 1935. 61 L’Enciclopedia del cinema, «Intercine», 3, 1935, pp. 131-132. 62 Cfr. Domenico Meccoli, Ancora su Arnheim e il Nostromo, «Cinema Nuovo», 275, 1982, p. 29. 63 Ibidem. 64 A riprova del ruolo di primo piano ricoperto da Arnheim si vedano anche la sua replica a G. F. Noxon in difesa del lavoro dell’Istituto: Rudolf Arnheim, I.C.E.: A Reply to G. F. Noxon, cit.; Jürgen Wilke, Cinematography as a Medium of Communication, cit., p. 347. 65 Ecco alcune testimonianze particolarmente significative: «Il nostro compito più ambizioso era la preparazione dell’Enciclopedia del cinema, progettata dall’editore Hoepli di Milano come opera in tre grandi volumi. Da parte mia, scrivevo alcune delle voci estetiche e tecniche. Una volta, quando il materiale era in bozze, mi occupai anche di illustrare centinaia di pagine con le fotografie ottenute da tutto il mondo. I collaboratori per certi articoli speciali erano esperti di vari paesi, e ricordo con piacere le visite in Italia di certi personaggi noti, fra cui John Grierson, il direttore del Filmboard canadese. Conservo ancora come prezioso ricordo un articolo di Louis Lumière sul cinema a colori con la dedica personale dell’autore fattami in occasione della sua visita a Roma», (Rudolf Arnheim, Come un tifoso…, cit., p. 36). «L’Istituto internazionale per la Cinematografia Educativa, creato in Roma dalla Lega delle Nazioni, andò al di là degli scopi compresi nel suo nome. Quando io entrai nella direzione, nel 1933, il suo intraprendente direttore, dott. Luciano de Feo, aveva incominciato a raccogliere, da esperti di tutto il mondo, materiale per un’enciclopedia che doveva comprendere in due grandi volumi gli aspetti storici, artistici, sociali, tecnici, educativi e giuridici del cinema. L’opera, che doveva essere pubblicata dall’editore Hoepli di Milano, era già in bozze quando l’Italia uscì dalla Lega delle Nazioni nel 1938 e l’attività su larga scala dell’Istituto ebbe fine. Essendo tra i direttori dell’enciclopedia, compilai molte voci, due delle quali sono qui riprodotte», (Rudolf Arnheim, “Nota personale”, in Film come arte, Il Saggiatore, Milano, 1960, p. 43); «[…] we worked on the encyclopedia. I was working on the layout – I remember I must have laid out about one thousand pages – which was photographs and text. But then the encyclopedia never got published because Mussolini left the League of Nations», (Rudolf Arnheim, My Life in the Art World, cit., pp. 7-8). Informazioni sullo stato dei lavori dell’Enciclopedia sono fornite anche attraverso la rubrica di corrispondenza con i lettori di «Cinema» chiamata “Capo di Buona Speranza” e firmata da uno pseudonimo riconducibile ad Arnheim (si veda il par. successivo): «L’“Enciclopedia del cinema” è attualmente in stato d’impaginazione. Si tratta di una opera enorme – diversi grossi volumi – e che perciò, purtroppo, non salta fuori corazzata dalla testa di Giove. Ma Le posso assicurare: si tratta di un lavoro da lasciare stupefatto ogni studioso del cinema. Sarà quella base che finora non esiste. Vale la pena dunque di aspettare ancora un po’», (Il Nostromo, Capo di Buona Speranza, «Cinema», 19, 1937, p. 278); «La grande Enciclopedia del Cinema è preparata dall’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa per l’editore Ulrico Hoepli che fra pochi mesi farà uscire il primo volume (lettera A-E)», (Il Nostromo, Capo di Buona Speranza, «Cinema», 32, 1937, p. 283); cfr. la medesima rubrica anche nei nn. 12, 1936, p. 490; 23, 1937, p. 467; 38, 1938, p. 67; 49, 1938, p. 35. 66 Ernesto G. Laura segnala l’assegnazione di una voce di “prova” sul tema Argomenti che ritornano, «ossia lo stesso soggetto ridotto più volte», assegnata da Arnheim a Gianni Puccini quando, nell’estate del 1936, quest’ultimo si apprestava a entrare nelle file di «Cinema»: il riferimento è a una cartolina datata Bagni di Lucca, 9 agosto 1936, citata in Ernesto G. Laura, “Il sodalizio con Rudolf Arnheim e la nascita di «Cinema»”, cit., p. 62. 67 Arnheim prese parte come rappresentante dell’IICE al convegno sulla musica nel film organizzato dal Maggio fiorentino nel 1935. Cfr. [Anonimo], Il convegno di musica cinematografica, «Il popolo d’Italia», 19 maggio 1935; [Anonimo], Il convegno della “Musica nel film” ha iniziato i suoi lavori, 28 maggio 1935 (Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar, Mediennummer BF000114870). Al convegno, presieduto 76 77 da Freddi, parteciparono anche Paolo Milano, Manuel Roland, Sebastiano Arturo Luciani e Giacomo Debenedetti. Si ha traccia inoltre della partecipazione di Arnheim a una conferenza internazionale sull’educazione tenutasi a Oxford nell’agosto 1935, (cfr. C. Lebrun, Il congresso di Oxford, «Intercine», 10, 1935, pp. 75-78; Klaus Voigt, Il rifugio precario, cit., p. 428. 68 Gastone Bosio, Un importante Istituto, cit. 69 L’Enciclopedia del cinema, cit., pp. 130-138. L’articolo non è firmato ma con molta probabilità fu redatto da Arnheim (Helmut H. Diederichs conferma questa ipotesi nella bibliografia in Rudolf Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film, cit, pp. 430-431). L’unico precedente articolo in cui si parla esplicitamente dell’Enciclopedia è Gli ospiti dell’I.C.E., «Rivista internazionale del cinema educatore», 5, 1933, p. 388. 70 Ibidem. 71 Christel Taillibert, L’Institut International du cinématographe éducatif, cit., cfr. in particolare il par. “La concentration sur l’Encyclopédie du cinématographe”, pp. 340347. 72 Cfr. Il Nostromo, Capo di Buona Speranza, «Cinema», 32, 1937, p. 283. 73 «Cinema», 38, 1938, p. 41. 74 Sulle ambiguità politiche del Fascismo in relazione all’IICE è interessante l’articolo di Christel Taillibert, L’Ice e la politica estera del fascismo, «Bianco e Nero», 547, 2003, pp. 107-115. 75 Antonio Sassone, Una colossale enciclopedia del cinema desaparecida, prima di essere pubblicata, www.edscuola.it/archivio/antologia/recensioni/desaparecida.htm, 24 aprile 2004. Sassone si riferisce all’Enciclopedia dello Spettacolo, ideata e diretta da Silvio D’Amico, (AA. VV., Enciclopedia dello Spettacolo, Le Maschere, Roma, 195462), alla cui stesura lavorarono oltre cinquecento collaboratori. L’opera, costituita da 16.500 voci, 7.000 illustrazioni nel testo, 1.800 tavole fuori testo e 320 tavole a colori, fu pubblicata in dieci volumi: nove tra il 1954 e il 1962 e il decimo, di solo aggiornamento, nel 1968. Vale la pena ricordare che nell’Enciclopedia dello Spettacolo è presente anche la voce “Arnheim, Rudolf”, compilata da Guido Aristarco (Ivi, vol. I, pp. 938-939). Costituito essenzialmente da una sintesi dei contenuti fondamentali di Film als Kunst, il testo di Aristarco si conclude peraltro con la frase: «È collab. di questa enciclopedia». Della firma di Arnheim tuttavia non c’è traccia su alcuno dei volumi dell’opera. 76 Gli archivi dell’editore Hoepli sono stati distrutti durante la Seconda guerra mondiale. Questa ipotesi è confermata da una comunicazione del 18 novembre 1975 fra la casa editrice Karl Hanser e l’amministrazione Hoepli (Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar), oltre che dal diretto interessamento del curatore di questo volume presso l’editore milanese, nonché dalla testimonianza di Helmut H. Diederichs: «Negli anni Settanta ho pregato un’amica italiana, che studiava germanistica a Francoforte, di richiedere informazioni presso Hoepli, quando fosse stata in Italia. Con il risultato che conosciamo: tutti i materiali sono andati persi in guerra. Più tardi ho letto da qualche parte che anche Aristarco aveva fatto lo stesso tentativo, con il medesimo risultato. Per fortuna Arnheim aveva tenuto per sé i propri manoscritti per l’Enciclopedia. […] Mi ha poi spedito via via negli anni Settanta e Ottanta il materiale manoscritto completo, cosicché solo nel 2004 sono arrivato a completare la pubblicazione degli interventi di Arnheim per l’Enciclopedia con Die Seele in der Silberschicht (2004)», (comunicazione personale, novembre 2005). 77 La prima antologia è Kritiken und Aufsätze zum Film, cit. Le voci dell’Enciclopedia sono inserite nella parte I. La seconda antologia, pubblicata in occasione del centesimo compleanno di Arnheim, è Die Seele in der Silberschicht, cit. 78 «È ben noto che l’Enciclopedia non fu mai pubblicata. Con l’uscita dell’Italia dalla Lega delle nazioni ai tempi della guerra in Etiopia, le nostre risorse finanziarie terminarono. Più tardi, ho utilizzato alcuni dei miei articoli per la nuova versione del mio libro […] pubblicata prima nel 1957 in America e in seguito anche […] in Italia e in altre lingue», (Rudolf Arnheim, Come un tifoso…, cit., p. 36); «Si trovano qui stampati per la prima volta gli articoli scritti a Roma nel 1933 e 1934 per la progettata Enciclopedia del cinema. Li ho tradotti dal manoscritto tedesco», (Id., “Nota personale”, cit. p. 39); «When Italy left the League of Nations, the Institute was all reorganized, and the book was never published. So each of us, each of the people who had written for that encyclopedia, used their articles in their own way. And when I published the new version of that film book in English [Film as Art], which is now available here, I used some of the articles that I had originally written for that encyclopedia», (Id., My Life in the Art World, cit., pp. 7-8). 79 Rudolf Arnheim, Il film come opera d’arte, cit., p. 11. 80 Rudolf Arnheim, Film as Art, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1957. 81 Tradotta da Arnheim dal manoscritto tedesco Systematik der frühen kinematographischen Erfindungen (1933) e pubblicata per la prima volta con il titolo “The Thoughts that Made the Pictures Move”, in Rudolf Arnheim, Film as Art, cit., pp. 161-180 (tr. it. “Le idee che fecero muovere le immagini”, in Film come arte, cit., pp. 181-197). 82 Rudolf Arnheim, “Nota personale”, cit., pp. 42-43. 83 Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., p. 183. 84 Tit. or. Bewegung im Film, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta con il titolo “Motion”, in Rudolf Arnheim, Film as Art, cit., pp. 181-187 (tr. it. “Il movimento”, in Film come arte, cit., pp. 201-206). 85 Tit. or. Malerei und Film, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in Rudolf Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 151-153 (tr. ing. “Painting and Film”, in Film Essays and Criticism, cit., pp. 86-88). 86 Tit. or. Expressionistischer Film, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in Rudolf Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 148-150 (tr. ing. “Expressionist film”, Film Essays and Criticism, cit., pp. 84-86). 87 Su questo tema si veda anche l’articolo di Rudolf Arnheim, Dr. Caligari redivivus, «Das Stachelschwein», 14, 1925, pp. 47-48. 88 Tit. or. Stroheim, Erich von, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta con il titolo Portrait of an Artist, «Film Culture», 18, 1958, pp. 11-13; ripubblicato in P. Adams Sitney (a cura di), Film Culture Reader, Praeger, New York, 1970, pp. 57-61; (tr. it. Lo stile e la donna nell’opera di Stroheim, «Cinema Nuovo», 134, 1958, pp. 50-52, pubblicata in concomitanza con la retrospettiva che la Mostra di Venezia dedicò nel 1958 all’appena scomparso attore-regista). Le citazioni sono tratte dalle pp. 4-5 della versione italiana. 89 Tit. or. Urheber, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta con il titolo Who is the Author of a Film?, «Film Culture», 16, 1958, pp. 11-13 (tr. it. come La dittatura del regista e la responsabilità della critica, «Cinema Nuovo», 139, 1959, pp. 221-226; nuova tr. it. Può essere anche la Garbo, «Cinema Nuovo», 313, 1988, pp. 39-45). 90 La dittatura del regista e la responsabilità della critica, cit., p. 221. Sul tema si veda anche il fondamentale saggio Rudolf Arnheim, Nuovo Laocoonte, «Bianco e Nero», 8, 1938, pp. 3-33; incluso con il titolo “Nuovo Laocoonte”: le componenti artistiche e il cinema sonoro in Id., Film come arte, cit., pp. 217-242. 91 Tit. or. Asynchronismus, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in Rudolf Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 78-81 (tr. ing. “Asynchronism”, in Film Essays and Criticism, cit., pp. 49-51). 78 79 Tit. or. Symbole, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in «Medium», 9, 1975, pp. 28-29. 93 Tit. or. Stil, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in Ibidem. 94 Tit. or. Erzählung (Epischer und dramatischer Film), dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in inglese con il titolo Epic and Dramatic Film, «Film Culture», 11, 1957, pp. 9-10; ripubblicato in Richard D. MacCann (a cura di), Film - A Montage of Theories, Dutton, New York, 1966, pp. 124-128. 95 Johann W. Goethe, Friedrich Schiller, Über epische und dramatische Dichtung, 1797, in Johann W. Goethe, Sämtliche Werke, 36, Jubiläum Ausgabe, Stuttgart, 1902-7, pp. 149-152. 96 Tit. or. Einheit der Handlung, dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in Rudolf Arnheim, Die Seele in der Silberschicht, cit., pp. 216-220. 97 Tit. or. Beleuchtung (ästhetischer Teil), dattiloscritto, 1934; pubblicato per la prima volta in Rudolf Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film, cit., pp. 117-124 (tr. ing. “Lighting (Aesthetic Part)”, in Film Essays and Criticism, cit., pp. 56-62). 98 Sono tratte dall’apparato iconografico in preparazione per l’Enciclopedia anche le illustrazioni inserite in Perché sono brutti i film a colori?, «Scenario», 3, 1936, pp. 112114. La prima immagine si riferisce alla «Attrezzatura tecnica di una casa americana specializzata nei film di propaganda industriale (macchine di ripresa ottica e l’apparecchio della registrazione sonora, ideati per la cromocinematografia)»; la seconda a «la macchina Technicolor per la presa cinematografica a colori naturali». 99 Helmut H. Diederichs fornisce alcune preziose indicazioni: «[…] ho riconosciuto altri saggi per l’Enciclopedia nella rivista “Intercine”, di cui Arnheim è stato redattore nel 1935 – lì era stata anticipata la loro pubblicazione, con tanto di illustrazioni. [...] Naturalmente ho chiesto anche ad Arnheim a riguardo dell’Enciclopedia. Ma all’epoca non ho pensato a una ricostruzione del gruppo di collaboratori (ora è troppo tardi per interrogarlo, pur essendo ancora in vita). Non credo peraltro che sarebbe stato disposto a rispondere. Non si direbbe che avesse neppure preso alcun appunto sugli indici dei contenuti e degli autori dell’Enciclopedia», (comunicazione personale, novembre 2005). 100 Per i dettagli sulle questioni amministrative ed editoriali del passaggio da «Intercine» a «Cinema» si veda Orio Caldiron, L’impero di carta, «Bianco e Nero», 547, 2003, pp. 93-99. 101 Rudolf Arnheim, Come un tifoso…, cit., pp. 35-36. 102 Ibidem. 103 Cit.; tit. or. Remarks on the Color Film, «Sight and Sound», 16, 1935/36, pp. 160162. 104 «Cinema», 2, 1936, pp. 67-68. Il primo paragrafo dell’articolo è riportato da Guido Aristarco nel primo numero di «Sequenze», dedicato integralmente al colore nel cinema, (cfr. Avvenire del colore, «Sequenze», 1, 1949, p. 25). 105 Sulle caratteristiche tecniche dell’introduzione del colore si vedano anche Le leggi del colore, cit., pp. 170-171 e Il nuovo sistema italiano per la cinematografia a colori naturali, «Cinema», 47, 1938, pp. 370-372. Per una riflessione critica sulla posizione di Arnheim rispetto al colore si veda Orsola Silvestrini, “Arnheim e il problema del colore”, in Raffaele De Berti, Massimo Locatelli (a cura di), Figure della modernità nel cinema (1900-1940), Ets, Pisa, 2008, pp. 251-263. 106 Montaggio senza montaggio, «Cinema», 9, 1936, p. 343. 107 Per esempio, L’attore e le stampelle, «Cinema», 46, 1938, pp. 335-337, poi in «Bianco e Nero», 3, 1939, pp. 98-101. 108 Senza parola, «Cinema», 10, 1936, p. 377. Una critica al cinema sonoro è contenu- ta anche in Ma che cosa è questo cinema? I - Sonoro o muto?, «Cinema», 33, 1937, p. 306. 109 Psicologia del “Gag”, «Cinema», 10, 1936, pp. 378-379. 110 Una notte sul Monte Calvo, «Cinema», 11, 1936, pp. 428-429. Sulla differenza psicologica fra realtà e rappresentazione si veda anche Gli occhi del cervello, «Cinema», 16, 1937, pp. 148-149. 111 Uno zio del cinematografo, «Cinema», 12, 1936, p. 457, poi con il titolo Un pioniere del cinematografo, «Bianco e Nero», 1, 1937, pp. 116-117. 112 Memorie della camera oscura, «Cinema», 36, 1937, pp. 433-435; Esame di coscienza, «Cinema», 44, 1938, pp. 289-290. 113 Uno spettro in tre versioni, «Cinema», 13, 1937, pp. 22-23. 114 Le meraviglie della tecnica, «Cinema», 18, 1937, pp. 217-219. 115 Televisione. Domani sarà così, «Cinema», 20, 1937, pp. 337-338. 116 La luce in movimento, «Cinema», 24, 1937, p. 508. 117 Resurrezione del cineasta?, «Cinema», 25, 1937, pp. 7-9; Il detective soggettista, «Cinema», 50, 1938, pp. 56-58. 118 Il formato ridotto diventerà formato normale?, «Cinema», 42, 1938, pp. 190-191. 119 La loro vita privata, «Cinema», 42, 1938, p. 195. 120 Il cifrario del successo, «Cinema», 38, 1938, p. 44. Sul tema si veda anche Ma che cos’è questo cinema? II. Bisogna seguire il gusto delle masse?, «Cinema», 34, 1937, pp. 345-346. 121 Espressione e bellezza, «Cinema», 23, 1937, pp. 443-444. 122 Il paesaggio ispiratore, «Cinema», 32, 1937, pp. 262-264. 123 Dettagli che non sono dettagli, «Cinema», 17, 1937, pp. 180-182; Una signora mai vista, «Cinema», 37, 1938, p. 14. 124 Un lettore ci domanda, «Sapere», 86, 1938, p. 66. 125 Il cinema documentario e i popoli, «Il Ventuno», 3-4, 1938, pp. 36-38. 126 Ivi, p. 36. 127 Rudolf Arnheim, L’esito ideologico ultimo approdo del film, «Cinema Nuovo», 255, 1978, p. 9. 128 Rudolf Arnheim, Come un tifoso…, cit., pp. 35-36. 129 Massimo Mida, La testimonianza di un allievo, «Cinema Nuovo», 271, 1981, p. 41. 130 Guido Aristarco, Francesco Pasinetti, una lezione disattesa, «Cinema Nuovo», 271, 1981, p. 44. 131 Cfr. Rudolf Arnheim, Arnheim e il Nostromo, «Cinema Nuovo», 274, 1981, p. 58. 132 Lo si apprende da una lettera di Aristarco ad Arnheim datata 14 novembre 1981: «Carissimo Arnheim, dopo la tua lettera del 9 settembre ho subito telefonato e scritto a Meccoli, il quale naturalmente conferma quanto tu dici. Pubblicherò, se non hai nulla in contrario, sia la tua precisazione che quella di Meccoli, in modo da ristabilire i dati precisi riguardanti la redazione di “Cinema”», (Archives of American Art, Washington DC). 133 Tutte le citazioni di questo paragrafo sono tratte da Domenico Meccoli, Ancora su Arnheim e il Nostromo, «Cinema Nuovo», 275, 1982, p. 29. 134 Ibidem. 135 Il Nostromo fornisce informazioni professionali (film visti, letture consigliate) e di tanto in tanto particolari di carattere personale che, alla luce di un’indagine approfondita, risultano tradire la sua identità. 136 Ricorda, per esempio, lo psicologo Renzo Canestrari: «Ritengo che la mia vocazione per lo studio e la prassi dello psicologo nasca dalla lettura dei saggi di Arnheim col quale del resto io comunicavo, senza saperlo, scrivendo al “nostromo”, il redattore del- 80 81 92 la rivista Cinema che teneva la rubrica delle lettere dei lettori. Il “nostromo”, cortesemente, mi rispondeva segnalandomi le letture disponibili e diventando di fatto il mio docente di psicologia scientifica […]. Dovevo quindi conoscere e ringraziare di persona Arnheim e nel 1968 mi recai a fargli visita a New York alla New School for Social Research. Lì parlando del suo soggiorno italiano e della rivista Cinema, scoprii che egli era il “nostromo”: ci abbracciammo con intensa commozione», (Renzo Canestrari, “L’opera di Rudolf Arnheim e la nascita di una vocazione psicologico-scientifica nella cultura italiana degli anni Trenta”, in Gabriella Bartoli, Stefano Mastandrea [a cura di], Rudolf Arnheim, cit., pp. 35-36). Fra i molti colloqui che sarebbe interessante citare, ve n’è uno fra il Nostromo e Guido Aristarco: «Lei si lamenta perché di un certo film ha letto critiche discordanti. Lei vorrebbe che tutti i critici fossero d’accordo: eh, da che mondo è mondo questa proposizione non s’è mai avverata. Tanto è vero che io non sono affatto d’accordo con Lei. Quel film rappresenta un certo progresso nella carriera del regista, e poteva condurlo davvero a un’opera forte e cinematografica: invece egli s’è impantanato in un racconto disuguale e pesante, portando gli attori verso una recitazione di tono eccessivo e di cattivo gusto. Restano, a quel film, i pregi di un soggetto vivo e ricco di azione: e sono quei soli pregi a sorreggere la visione ed a renderla in certa misura attraente», (Il Nostromo, Capo di Buona Speranza, «Cinema», 16, 1937, p. 151). Sull’importanza di «Cinema» sulla formazione di Arnheim si veda la sua stessa testimonianza in L’esito ideologico ultimo approdo del film, cit., p. 8. 137 Mino Argentieri, Il Nostromo del Capo di Buona Speranza, «Cinema Nuovo», 343, 1993, p. 34. 138 Rudolf Arnheim, Arnheim e il Nostromo, cit. 139 L’interesse per gli aspetti educativi e psicologici della fotografia da parte della sorella di Arnheim è comprovato dalla pubblicazione del volume Rudolf Arnheim, Mary Arnheim-Gay, Phototips on Children. The Psychology, the Technique and the Art of Child Photography, Focal Press, London, 1939. 140 Si tratta di Memorie della camera oscura, cit., pp. 433-435 e di Esame di coscienza, cit., pp. 289-290. 141 Marie Onussen, Istantanee in casa, «Cinema», 17, 1937, p. 192; Id., Pronti in 45 minuti!, «Cinema», 19, 1937, p. 263. 142 È significativa la perizia tecnica con cui anche il Nostromo del “Capo di Buona Speranza” dispensava consigli e forniva informazioni ai lettori in tema di fotografia. 143 Si tratta di Le meraviglie della tecnica, cit. e Le leggi del colore, cit. 144 Cfr. ad es. Ciak, Psicologia dei colori naturali, «Cinema», 43, 1938, p. 234; Id., Gli schermi riflettenti, «Cinema», 19, 1937, p. 272. 145 Fra Arnheim e Puccini nacque un vero e proprio sodalizio professionale e amicale: cfr. Ernesto G. Laura, Parola d’autore, cit., pp. 50-87. 146 «[...] il duo Candido-Arpagone, ovvero Arnheim e io [...]», (Gianni Puccini, “Storia di «Cinema»”, in Orio Caldiron [a cura di], Il lungo viaggio del cinema italiano. Antologia di «Cinema» 1936-1943, Marsilio, Padova, 1965, p. LXXIX, testo che unisce due precedenti pubblicazioni: Gianni Puccini, I tempi di «Cinema», «Filmcritica», 5, 1951, pp. 151-155 e Id., Il venticinque luglio del cinema italiano, «Cinema Nuovo», 24, 1953, pp. 340-342). Cfr. anche Orio Caldiron, «Cinema» 1936-1943. Prima del neorealismo, Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, Roma, 2002, p. 10. 147 Precisamente sui nn. 14, 1937, pp. 69-71; 15, 1937, pp. 109-111; 16, 1937, pp. 155157; 21, 1937, pp. 389-390. 148 Dalle colonne della rubrica “Capo di Buona Speranza”, il Nostromo ebbe modo di chiarire che «Non era nelle intenzioni della nostra rubrica “Bianco e Nero” di presentare delle contraddizioni, in modo che Candido esaltasse quel che condannava Arpagone. Si voleva, invece, esporre separatamente i lati positivi e quelli negativi dei film […]», (Il Nostromo, Capo di Buona Speranza, «Cinema», 25, 1937, p. 29). 149 Ecco un passaggio interessante: «Colpa dell’estate anticipata, o di Candido ed Arpagone? Sta di fatto che, questo mese, il nostro ottimista s’è messo improvvisamente a trovar da ridire su tutto, e il nostro pessimista, abbandonato ad un tratto il suo umore bisbetico, si è fatto di un’indulgenza imperdonabile. Venendo l’uno dal polo nord della manica larga e l’altro dal polo sud dell’avarizia critica, si sono incontrati all’equatore di una stracca indifferenza, colorata di grigio. Francamente, non sapremmo condannarli. Nel periodo ultimo di programmazione, una mediocritas più o meno aurea ha regnato sovrana sugli schermi, così da rendere ingiusta ed eccessiva a priori, tanto ogni velleità di stroncatura degli esteti intransigenti, quanto ogni inno degli spettatori più portati ad un entusiasmo senza controllo. Perché dire troppo bene o troppo male, infatti, di un’“ordinaria amministrazione” in cui i pregi compensano su per giù i difetti, e dove alla mancanza di novità e genialità nelle trame ripara la squisitezza dell’interpretazione o la furbizia delle regie, quando non è il caso contrario d’interpretazioni scadenti o di regie fiacche che trovano compenso in trovate gustose di sceneggiatura, in spunti felici, in gags sopraffini? Il conto insomma non torna stavolta né sul bianco né sul nero; ma torna benissimo sul grigio perla che i due compari pongono a sfondo della cronachetta odierna», (Momento grigio, «Cinema», 24, 1937, p. 509). 150 Com’è noto, l’escalation antisemita subì un’impennata dopo la visita di Adolf Hitler a Roma, dal 3 al 9 maggio 1938, pochi giorni dopo l’invasione e l’annessione dell’Austria. Il 25 luglio di quell’anno venne pubblicato sul «Giornale d’Italia» il “Manifesto della razza” (poi sul primo numero de «La difesa della razza» il 5 agosto). Il 3 settembre la «Gazzetta del Popolo» annunciò le prime misure razziste contro gli ebrei dal regime. E infatti il 5 settembre venne pubblicato il Regio decreto di espulsione degli ebrei dalle scuole, seguito il 7 settembre dal decreto di espulsione degli ebrei stranieri. 151 Cfr. Rudolf Arnheim, Rudolf Arnheim: Lebenslauf, cit.; Klaus Voigt, Il rifugio precario, cit., p. 428; Ingrid Scharmann, “Ordine, espressione e media…”, cit., p. 162. 152 La prima apparizione di Arnheim su «Bianco e Nero» avvenne sul numero inaugurale della rivista con la pubblicazione di Un pioniere del cinematografo, cit., originariamente pubblicato in «Cinema» con il titolo Uno zio del cinematografo, cit. 153 Rudolf Arnheim, Il film come opera d’arte, cit., anche in Mario Verdone (a cura di), Antologia di Bianco e Nero 1937-1943, vol. I - Scritti teorici, Edizioni di Bianco e Nero, Roma, 1964. 154 Va precisato che «Bianco e Nero» pubblicò già sul primo numero del 1938 un lungo saggio di Renato May nel quale viene riportata e commentata la tabella relativa al montaggio redatta da Arnheim per Film als Kunst (e probabilmente inclusa nella sintesi Cines del 1933). Si tratta di “Principi di montaggio”, in Renato May, Per una grammatica del montaggio, «Bianco e Nero», 1, 1938, pp. 37-42. 155 Rudolf Arnheim, nota introduttiva a Il film come opera d’arte, cit., p. 13. 156 Rudolf Arnheim, Nuovo Laocoonte, cit.; incluso come “A New Laocoön: Artistic Composites and the Talking Film”, in Id., Film as Art, cit., pp. 199-230 (tr. it. “Nuovo Laocoonte”: le componenti artistiche e il cinema sonoro”, in Film come arte, cit., pp. 217-242). 157 Gotthold E. Lessing, Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie, Christian Friedrich Voß., Berlin, 1766 (tr. it. Laocoonte, Angelo Maria Soriani, Voghera, 1832). 158 Rudolf Arnheim, Nuovo Laocoonte, cit., pp. 5-6. 159 Secondo Max Wertheimer e la Gestalttheorie, tutti i fattori di organizzazione per- 82 83 cettiva (vicinanza, somiglianza, chiusura, moto comune ecc.) possono essere raggruppati sotto il principio della pregnanza, o “buona Gestalt”, ovvero la tendenza delle forme percepite ad assumere spontaneamente, in determinate condizioni, la configurazione più equilibrata, semplice, omogenea, compatta, completa, chiusa, stabile, regolare, coerente, bilanciata, simmetrica. Cfr. Gaetano Kanizsa, “La percezione”, in Gaetano Kanizsa, Paolo Legrenzi, Maria Sonino, Percezione, linguaggio, pensiero, il Mulino, 1983, pp. 75-80. Per una discussione critica del concetto di pregnanza in Arnheim si veda Riccardo Luccio, “Arnheim e la pregnanza”, in Lucia Pizzo Russo (a cura di), Rudolf Arnheim, cit., pp. 39-50. 160 Cfr. Carlo L. Ragghianti, Immagine e parola, «Cinema», 18, 1949, p. 11; Emilio Garroni, Progetto di semiotica, cit. 161 L’originale manoscritto tedesco Der Rundfunk sucht seine Form del 1933 fu rifinito e terminato nel 1935. Fu impossibile però pubblicarlo in Germania e così il manoscritto venne portato in Inghilterra e tradotto: Rudolf Arnheim, Radio, Faber & Faber, London, 1936 (tr. it. La radio cerca la sua forma, Hoepli, Milano, 1937). 162 L’attore e le stampelle, cit., già pubblicato con lo stesso titolo quasi un anno prima in «Cinema», cit. 163 Le informazioni contenute in questo paragrafo sono tratte dalle ultime pagine del Diario italiano di Arnheim, scritto in tedesco fra il 1934 e il 1938, (Archives of American Art, Washington DC) ed evinte dal suo passaporto, la cui consultazione mi è stata gentilmente concessa da Margaret Nettinga-Arnheim. 164 Come è noto, la conferenza di Monaco si svolse il 29 e 30 settembre 1938 e legittimò l’annessione dei Sudeti alla Germania grazie soprattutto alla mediazione di Benito Mussolini, sembrando scongiurare l’avvento della Seconda guerra mondiale. 165 Diario italiano, cit., 28 settembre 1938. 166 Il dattiloscritto, rimasto inedito a lungo, è stato pubblicato in Rudolf Arnheim, Eine verkehrte Welt. Phantastischer Roman, Edition Memoria, Hürth (Köln), 1997. La parola tedesca “verkehrte” è traducibile in italiano come “sottosopra”, “inverso”, “all’incontrario”. Una possibile resa del titolo del romanzo potrebbe dunque essere “Il mondo sottosopra. Romanzo fantastico”. 167 Diario italiano, cit., 23 ottobre 1938. 168 Ivi, 30 ottobre 1938. 169 Si veda ad es. la lettera datata 8 dicembre 1938 in cui Boris V. Morkovin, direttore di «Cinema Progress» di Los Angeles, attesta il contributo di Arnheim alla rivista e auspica l’ottenimento del visto. Di lì a meno di un mese la rivista americana pubblicherà un articolo di Arnheim, A Motion Picture World’s Fair, in «Cinema Progress», 3-4, 1939, p. 2; seguito alcuni mesi più tardi da A Miracle of Color, in «Cinema Progress», giugnoluglio 1939, pp. 18-19, traduzione sintetica di un articolo già pubblicato in Italia (Il nuovo sistema italiano per la cinematografia a colori naturali, cit.). 170 La corrispondenza epistolare raccolta negli archivi testimonia la ripresa dei contatti fra Arnheim e Max Wertheimer, Kurt Lewin, Kurt Koffka e soprattutto Wolfgang Köhler, in particolare a partire dal 1940, allorquando, approdato negli Stati Uniti senza alcun impiego, ebbe necessità di pubblicizzare il proprio lavoro e chiedere consigli e lettere di raccomandazione, (Archives of American Art, Washington DC). 171 Diario italiano, cit., 13 dicembre 1938. 172 Lo si evince dalla lettera di Herbert Read, datata 3 marzo 1939, in cui Arnheim è informato sui problemi nello stato di avanzamento della sua pratica, (Archives of American Art, Washington DC). 173 In quel periodo Arnheim lasciò il Regno Unito soltanto una volta, dal 3 al 14 giugno 1939, per partecipare a un congresso sul cinema a Basilea, in Svizzera. Lo si evince dai visti d’entrata e d’uscita inglesi, francesi ed elvetici riportati sul suo passaporto. 174 Cfr. le lettere inviate da Londra da Rudolf Arnheim a Fedele d’Amico nel 1940, in Eppure, forse, domani, cit., pp. 22-26. Vale la pena riportare almeno alcuni stralci: «La guerra è stata accettata qua come una disgrazia, ma senza la minima preoccupazione, anzi con una fiducia ottimista, che ogni tanto sembra necessario scuotere con l’emissione di notizie deliberatamente allarmanti. Passate le prime giornate, in cui si aspettava un assalto, Londra è tornata man mano alla sua normale attività e pochissime cose ti indicano che stiamo vivendo in uno stato d’eccezione»; «Dovrei partire per quel paese pulito e pacifico in Agosto o in Settembre – vedremo»; «Avrei tanta voglia di tornare ora e di vivere con i miei e in quella nuova casetta che evidentemente è una meraviglia. Ma per tante ragioni questo è assolutamente escluso. Sono invece contento di avere ottenuto per Annette e i bambini il visto d’entrata con eccezionale rapidità e spero che possano raggiungermi presto senza che le circostanze si intromettano. È una grande responsabilità, naturalmente, di farle venire in un paese belligerante, ma mi pare tuttavia necessario e non posso credere in un immediato pericolo», (lettera del 21 aprile 1940). Il tono cambia drammaticamente nell’arco di pochi giorni: «È passata una settimana, piuttosto turbolenta. Dopo una mezza dozzina di telegrammi e di lettere di posta aerea e dopo alcuni tentativi di comunicare per telefono non so ancora se ho potuto persuadere Annette che l’unica cosa è di partire immediatamente per Londra»; «Ho tanta paura che questa perdita di tempo possa avere delle conseguenze brutte, voglio dire che possa essere troppo tardi per loro di partire del tutto, dato che la situazione generale è talmente elettrizzata», (lettera del 29 aprile 1940). 175 Paul Schlenther (1892), cit. in Rudolf Arnheim, Espressione e bellezza, cit. 176 Cfr. soprattutto Benedetto Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Sandron, Milano-Palermo-Napoli, 1904; Id., Una lettera, «Bianco e Nero», 10, 1948, pp. 3-4, poi in Guido Aristarco (a cura di), L’arte del film. Antologia storicocritica, Bompiani, Milano, 1950, p. 235, in cui Croce sancisce l’artisticità del film. 177 Per un quadro generale del dibattito si vedano Peter Dal Monte, Le teoriche del film in Italia dal muto al sonoro, «Bianco e Nero», 1-2, 1969; 5-6, 1969; 7-8, 1969; Vito Attolini, “La scuola italiana”, in Id., Teorie classiche del cinema, G.A. Graphis, Bari, 1997, pp. 107-130; Lorenzo Pellizzari, “La nascita di una fazione. Sul mestiere di critico nell’arte del silenzio”, in Id., Critica alla critica. Contributi a una storia della critica cinematografica italiana, Bulzoni, Roma, 1999, pp. 23-39; Giorgio Bertellini, Dubbing. L’Arte Muta: Poetic Layerings around Italian Cinema’s Transition to Sound, in Jaqueline Reich, Piero Garofalo, Re-viewing Fascism. Italian Cinema, 1922-1943, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis (IN), 2002, pp. 30-82. 178 La distinzione è proposta da Ruggero Eugeni, “Rudolf Arnheim: tecnica, grammatica, estetica del film”, in Orio Caldiron (a cura di), Storia del cinema italiano, vol. V - 1934/1939, Marsilio - Edizioni di Bianco & Nero, Venezia, 2006, pp. 526-529. 179 Cfr. anche Emilio Garroni, “Prefazione”, in Rudolf Arnheim, La radio, l’arte dell’ascolto e altri saggi, Editori Riuniti, Roma, 2003, pp. 7-16. 180 Cfr. Rudolf Arnheim, Visual Thinking, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1969 (tr. it. Il pensiero visivo, Einaudi, Torino, 1974). 181 Riferimenti all’influenza dell’estetica crociana nel cinema sono presenti in due recensioni di Arnheim a opere italiane: Rudolf Arnheim, Discorso tecnico delle arti (Gillo Dorfles), «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», 3, 1958, pp. 399-340; Id., Il cinema e l’astrazione nell’arte (Giovanni Bianca), «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», 2, 1965, pp. 320-321. 182 Come più tardi ebbe occasione di dire Giulio Carlo Argan, «Arnheim ha aiutato la cultura italiana a superare senza traumi né perdite i limiti di un dominante idea- 84 85 lismo che la difendeva bensì dal nazionalismo fascista, ma riduceva il suo raggio europeo e la sua incidenza nel frangente storico», (Giulio C. Argan, “Prefazione”, in Augusto Garau [a cura di], Pensiero e visione…, cit., p. 8). 183 Si prenda, per esempio, il caso di Luciani. Guido Aristarco vedeva in quest’ultimo un precursore italiano del pensiero di Arnheim: «sin dal 1920 [Luciani] tenta un’estetica del cinema basata sulla fotografia e sul film non intesi come autografi della natura, e dove le presunte deficienze del film stesso (assenza del suono, del colore) risultano invece le caratteristiche essenziali del nuovo mezzo di espressione, e non di riproduzione», (Guido Aristarco, “Prefazione”, in Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., p. 17); cfr. anche Guido Aristarco, Storia delle teoriche del film, Einaudi, Torino, 1951, p. 193. Tuttavia, interrogato esplicitamente sulla questione, Arnheim dichiarò di non conoscere affatto le teorie di Luciani: «[Aristarco]: A proposito di “mezzi differenzianti” e “formativi”, quando scrisse nel 1932 Il film come arte, conosceva le analoghe teorie di Luciani, che risalgono al 1920? [Arnheim]: No, è il solito provincialismo», (cfr. l’intervista-lezione La bomba dei ritrovati tecnici sulla cattedrale cinematografica, «Cinema Nuovo», 140, 1959, p. 322. Come è noto, Luciani si spese a favore dell’artisticità del film e, benché fosse di estrazione crociana, intendeva il cinema come una sintesi delle varie arti. Come Arnheim, vedeva nel ritmo e nella “visività” gli elementi fondamentali del film. La sua impostazione di teorico e critico musicale lo portò a proporre un parallelo fra la successione ritmica delle immagini e quella delle note che le accompagnano e, stavolta al contrario di Arnheim, a far prevalere il montaggio all’inquadratura, (cfr. Sebastiano A. Luciani, Verso una nuova arte. Il Cinematografo, Ausonia, Roma, 1921; Id., L’Antiteatro. Il cinematografo come arte, Anonima editrice, Roma, 1928). 184 Cfr. Rudolf Arnheim, “Nota personale”, cit., pp. 43-44; Id., Ripensando alle cose di allora, cit., pp. 96-97. 185 Cfr. Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano, cit., p. XLIX. 186 Cfr. Pietro Ingrao, “Ricordo di Arnheim”, cit., pp. 23-24; Id., “Caro Arnheim... Caro Ingrao”, in Sergio Toffetti (a cura di), Mi sono molto divertito. Scritti sul cinema (19362003), Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma, 2006, pp. 136-140; Augusto Garau (a cura di), Pensiero e visione…, cit., pp. 69-75. 187 Rudolf Arnheim, Il cifrario del successo, «Cinema», 38, 1938, p. 44. 188 Scrive Arnheim il 1° dicembre 1940 da New York a Gianni Puccini: «Attualmente mi si chiede di cominciare la vita per la quarta volta, e finora il mio entusiasmo è limitato. È vero che l’esperienza di queste cose sviluppa una certa tecnica e anche la pelle più dura. Ma mi sembra piuttosto indegno di andare in giro a offrire i propri servizi propagandando i propri meriti. C’è un vantaggio: un nuovo inizio potrebbe permettere di saltare fuori dalla routine, di cominciare un’altra cosa, più piacevole. Faccio, infatti, tutti gli sforzi per liberarmi dal cinematografo e di entrare più decisamente nel campo della psicologia dell’arte», (cfr. Ernesto G. Laura, Parola d’autore, cit., pp. 84-85). 189 Domenico Meccoli, Posizione di Arnheim. I mezzi formali e il loro significato, «Cinema», 23, 1949, p. 161. 190 Guido Aristarco, “Prefazione”, in Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., p. 14. 191 Grazie alla stima che aveva guadagnato a Berlino presso i suoi maestri, che l’avevano preceduto negli Stati Uniti, anch’essi per sfuggire alla persecuzione razziale, Arnheim riuscì a ottenere l’appoggio necessario per introdursi nel mondo della ricerca e, successivamente, dell’insegnamento universitario. Arnheim infatti collaborò nel 1941 con l’Office of Radio Research della Columbia University e nel 1942-43 ottenne una borsa di studio della Guggenheim Memorial Foundation di New York, presentando un progetto di ricerca sui rapporti fra psicologia percettiva e arti visive. Nel 1943 iniziò la sua carriera accademica presso la facoltà di psicologia del Sarah Lawrence College di Bronxville, dove insegnò sino al 1968. Ottenne la cittadinanza americana nel 1946. 192 Cfr. Augusto Garau (a cura di), Pensiero e visione…, cit.; Ernesto G. Laura, Parola d’autore, cit.; Rudolf Arnheim, Fedele d’Amico, Eppure, forse, domani, cit.; Pietro Ingrao, “Ricordo di Arnheim”, cit., pp. 23-24; Id., “Caro Arnheim... Caro Ingrao”, cit., pp. 136-140. 193 «Bianco e Nero», 4, 1948, p. 44. 194 Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1947 (tr. it. Cinema tedesco (19181933), Mondadori, Milano, 1954). Anch’egli tedesco di origine ebraica, nel 1933 si trasferì a Parigi e nel 1941 emigrò negli Stati Uniti. 195 «Bianco e Nero», 6, 1948, pp. 56-58. 196 «Cinema», 23, 1949, pp. 161-164. 197 «Cinema», 25, 1949, pp. 219-220. 198 «Cinema», 28, 1949, pp. 316-318. 199 Domenico Meccoli, Posizione di Arnheim, cit., p. 161. 200 Ibidem. 201 Cit., pp. 93-97. Questo articolo è la prima versione della “Nota personale” che aprirà Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., pp. 39-44. 202 Ripensando alle cose di allora, cit., pp. 96-97. Cfr. anche Rudolf Arnheim, “Nota Personale”, cit., pp. 43-44. 203 “Immagine reale e immagine filmica” / “Soggettista e regista” / “Film sonoro = teatro?”, in Guido Aristarco (a cura di), L’arte del film. Antologia storico-critica, Bompiani, Milano, 1950, pp. 29-54 / 83-86 / 95-98. 204 Guido Aristarco, “I sistematori: Balázs e Pudovkin, Eisenstein e Arnheim”, in Id., Storia delle teoriche del film, cit., pp. 129-215. Si vedano anche Id., I “mezzi formativi” del cinema, «La Rassegna d’Italia», 5, 1949, pp. 512-522; Id., “Arnheim, Rudolf”, in Enciclopedia dello Spettacolo, cit., pp. 938-939. 205 Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1954. 206 Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1962, pp. 324-328. 207 Movimento organico ed inorganico, «Rivista del cinema italiano», 9, 1953, pp. 86-91. 208 Rudolf Arnheim, Film as Art, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1957; settima edizione 1969, con nuova prefazione di Arnheim del 1968; edizione 50° anniversario 2006. 209 Rudolf Arnheim, Film as Art, Faber & Faber, London, 1958; ristampa brossurata 1969; ristampato nel 1983 con la prefazione “After Fifty Years” poi inclusa nelle successive ristampe americane. 210 Ovvero la traduzione inglese del 1933 della versione originale tedesca del 1932, di cui peraltro Arnheim si disse insoddisfatto, (cfr. Rudolf Arnheim, Rudolf Arnheim: Lebenslauf, cit.). Nella versione del 1957 si notano infatti molti aggiornamenti di linguaggio. 211 Epic and Dramatic Film, cit., pp. 9-10 [voce Narrazione (Film epico e drammatico)]; Who is the Author of a Film?, cit., pp. 11-13 [voce Autore]; Portrait of an Artist, cit., pp. 11-13 [voce Erich von Stroheim]. 212 Lo stile e la donna nell’opera di Stroheim, cit. [voce Erich von Stroheim]; La dittatura del regista e la responsabilità della critica, cit. [voce Autore]. Una nuova traduzione di quest’ultima voce verrà pubblicata ancora da «Cinema Nuovo» trent’anni più tardi con il titolo Può essere anche la Garbo, cit. 213 La prima edizione de Il Saggiatore (1960) fu ristampata da Feltrinelli nel 1983, senza la prefazione di Guido Aristarco e senza illustrazioni. 86 87 214 A Arte do Cinema, Editorial Aster, Lisboa, 1960; Misuzu Shobo, Tōkyō, 1960; Kino kak iskusstvo, Moskva, 1960; Film Jako Szutuka, Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1961; Film Kao Umetnost, Narodna Knjiga, Beograd, 1962; A Film min Muveszet, Gondolat, Budapest, 1984; Film a Skuteènost, in J. Brož (a cura di), Film je umìní. Sborník statí, Orbis, Praha, 1963 (selezione); El Cine como Arte, Infinito, Buenos Aires, 1971; El Cine como Arte, Paidos, Barcelona, 1986; Le Cinéma est un Art, L’Arche, Paris, 1989; Film kot umetnost, Krtina, Ljubljana, 2000. Da sottolineare invece che l’edizione tedesca non mutò mai nel tempo. Sarà infatti ripubblicata con la stessa impaginazione nel 1974 e nel 2002: Rudolf Arnheim, Film als Kunst, Carl Hauser, München, 1974, con nuova prefazione dell’autore; in brossura, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main, 1979, con postfazione di Helmut H. Diederichs; nuova edizione con aggiunta di nuovi saggi e articoli, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002, con postfazione di Karl Prümm. Quest’ultima edizione contiene anche tre recensioni all’opera originale: Kurt Busse, Film als Kunst?, «Preußische Jahrbücher», 82, 1932, pp. 138-143; Siegfried Kracauer, Neue Filmbücher, «Die Neue Rundschau», 1, 1933, p. 143; Andor Kraus Kraszna, Film als Kunst?, «Die Weltbühne», 28, 1932, pp. 447-449. 215 Oltre alle critiche avanzate da Guido Aristarco nella “Prefazione” a Film come arte, cit., pp. 13-14 si vedano ad es. E. Baragli, Rudolf Arnheim ed i “fattori differenzianti”, «La civiltà cattolica», 2668, 1961, pp. 405-440; Giorgio Prosperi, Riflessioni sul cinema, «Mercurio», 35, 1948, pp. 92-97. 216 Guido Aristarco, Storia delle teoriche del film, cit., p. 192. 217 Su questo si veda anche Nino Ghelli, L’inquadratura e il mondo poetico del regista, cit. 218 Per un confronto fra Arnheim e i sovietici si vedano, per esempio, David Harrah, Aesthetics of the Film. The Pudovkin-Arnheim-Eisenstein Theory, «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», 13, 1954, pp. 163-174; Alberto Angelini, Psicologia del cinema, Liguori, Napoli, 1992, in particolare il capitolo X, “Un confronto esemplare: la nozione di montaggio in Rudolph Arnheim e Sergej M. Ejzenštejn”. 219 Cfr. Guido Aristarco, “Prefazione”, in Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., p. 19; Id., Il teorico senza mani Rudolf Arnheim, «Cinema Nuovo», 136, 1958, p. 221. 220 Cit.; pp. 320-325. Il testo del colloquio con gli studenti dell’Università di Milano mediato da Aristarco viene riportato parzialmente in nota alla “Prefazione” a Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., pp. 30-35. 221 Aristarco torna a utilizzare questa espressione in Guido Aristarco, “Destroyed Cathedrals”, in Kent Kleinman, Leslie Van Duzer (a cura di), Rudolf Arnheim. Revealing Vision, University of Michigan Press, Ann Arbor (MI), 1997, pp. 26-35. 222 Ivi, p. 321. 223 Ibidem. 224 Ivi, p. 322. 225 Ivi, p. 323. 226 Ivi, p. 325. 227 Nel 1959-60 Arnheim ottenne una borsa di studio Fulbright e studiò in Giappone presso l’Università Ochanomizu di Tokio e l’Università Kyushu di Fukoka. 228 «Cinema Nuovo», 144, 1960, pp. 109-110. 229 Per un commento di Arnheim a Deserto Rosso si vedano L’esito ideologico ultimo approdo del film, cit., p. 10; Immagine-avvenimento e durata, «Cinema Nuovo», 305, 1987, p. 22. 230 «Cinema Nuovo», 205, 1970, pp. 195-204. 231 Siegfried Kracauer, Theory of Film: the Redemption of Physical Reality, Oxford University Press, New York, 1960 (tr. it. Il film: ritorno alla realtà fisica, Il Saggiatore, Milano, 1962). 232 Rudolf Arnheim, Melancholy Unshaped, «Journal of Aesthetics and Art Criticism», 3, 1963, pp. 291-297, incluso in Id., Toward a Psychology of Art, cit., pp. 181-191 (tr. it. “Malinconia senza forma”, in Verso una psicologia dell’arte, cit., pp. 222-234). 233 «Cinema Nuovo», 252, 1978, pp. 88-91. 234 Nel 1969, all’età di 65 anni, Arnheim divenne professore di Psicologia dell’arte nel dipartimento di Visual and Environmental Studies dell’Università di Harvard. Vi rimase sino al 1974, anno in cui raggiunse l’età della pensione e si trasferì ad Ann Arbor, dove continuò a insegnare presso l’University of Michigan. 235 Cit., pp. 8-11. 236 Ricordando gli anni venti, cit., pp. 92-96. 237 Si tratta della traduzione di Rudolf Arnheim, On the Nature of Photography, «Critical Inquiry», 1, 1974, pp. 149-161 (tr. it. Sulla natura della fotografia, «Rivista di storia e critica della fotografia», 2, 1981, pp. 6-23); e di Id., Splendor and Misery of the Photographer, «Bennington Review», settembre 1979, pp. 2-8 (tr. it. Splendore e miseria del fotografo, «Rivista di storia e critica della fotografia», dicembre 1984, pp. 2-9). Entrambi i saggi sono stati successivamente inclusi in Id., New Essays on the Psychology of Art, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1986 (tr. it. Intuizione e intelletto. Nuovi saggi di psicologia dell’arte, Feltrinelli, Milano, 1987). 238 «Cinema Nuovo», 301, 1986, pp. 35-36, con una lettera di Rudolf Arnheim a Guido Aristarco, datata 23 febbraio 1953. 239 Cit., pp. 5-6. 240 «Cinema Nuovo», 305, 1987, p. 22. 241 Queste informazioni emergono dalla corrispondenza fra Aristarco (lettere del 4 giugno 1986, 12 settembre 1986, 6 ottobre 1986) e Arnheim (lettera del 24 settembre 1986), (Archives of American Art, Washington DC). 242 Cit.; parzialmente ripubblicato con il titolo, appunto, di “A Forecast of Television”, in Rudolf Arnheim, Film as Art, cit., pp. 188-198. 243 Immagine-avvenimento e durata, cit., p. 22. 244 «Cinema Nuovo», 344-345, 1993, pp. 27-30. 245 Rudolf Arnheim, “Nota personale”, cit., pp. 41 e 43. 246 Si veda, per esempio, Rudolf Arnheim, To Maya Deren, «Film Culture», 24, 1962, pp. 1-2. 247 Cfr. Ingrid Scharmann, “Ordine, espressione e media…”, cit., p. 164. Fra gli articoli sul cinema pubblicati da Arnheim negli Stati Uniti si vedano, per esempio, Rudolf Arnheim, Free Cinema II, «Film Culture», 17, 1958, p. 11, in cui Arnheim significativamente scrive: «We find ourselves in the presence of a work of art when the actors, actions, and objects of the foreground appear transparent and lead our glance to the basic themes of human existence. These films possess this transparency to varying degrees and thereby take us from the opacity of the daily scene to the clarity of ideas, and back to our intricate streets and homes»; Id., Art Today and the Film, «Art Journal» , 3, 1966, pp. 242-244, (saggio presentato al convegno su “Cinema and the Contemporary Arts” presso il Lincoln Center for the Performing Arts in occasione della terza edizione del New York Film Festival, settembre 1965). 248 Arnheim era stato invitato a recarsi a Hollywood da Alfred Polgar e Kurt Lewin. In una cartolina inviata a Max Wertheimer il 4 novembre 1938 scrisse: «Entrerei nella produzione cinematografica solo per non morire di fame. È un ambiente orribile», (cit. in Ingrid Scharmann, “Ordine, espressione e media…”, cit., p. 164). Nel 2003 dichiarò: «Because film has become a victim of the entertainment industry, which considers telling stories more important than form or expression. In the early years, when the great films were being made, the film industry still had very little influence, 88 89 even after the UFA [film studios in Germany] had been founded. The filmmakers had much more artistic freedom, and one could see this. Only the best works are just good enough for art history. In this respect, film is not an art-historical problem today, but rather a topic for the social sciences», (Uta Grundmann, The Intelligence of Vision, cit.). 249 Cfr. Gillo Dorfles, “Nota alla nuova versione”, in Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, cit., p. 18. Sulla reciprocità dell’influenza si veda Renzo Canestrari, “L’opera di Rudolf Arnheim…”, cit., pp. 35-36. 250 L’incontro personale fra Arnheim e gli psicologi italiani avvenne invece nel giugno 1986 al convegno organizzato in suo onore a Milano da Augusto Garau, (cfr., Giulio C. Argan, “Prefazione”, in Augusto Garau [a cura di], Pensiero e visione…, cit., pp. 7-8). 251 Arnheim prese parte in prima persona al convegno di Milano del 1986, occasione in cui disse di considerare l’Italia “casa propria”, (cfr. Rudolf Arnheim, “Postfazione”, in Augusto Garau (a cura di), Pensiero e visione…, cit., pp. 281-284). Più recentemente si sono svolti in Italia due convegni: a Palermo nel 2004, atti pubblicati in Lucia Pizzo Russo (a cura di), Rudolf Arnheim, cit.; e a Roma nel 2005, atti pubblicati in Gabriella Bartoli, Stefano Mastandrea (a cura di), Rudolf Arnheim, cit.. 252 Cfr. in particolare gli interventi che trattano del periodo italiano di Arnheim o dei suoi rapporti con il cinema: in Augusto Garau (a cura di), Pensiero e visione…, cit., si vedano l’intervento di Guido Aristarco, “Arnheim e le conversioni al cinema negli anni ’30”, pp. 22-27; l’“Intervista di Augusto Garau a Fedele D’Amico”, pp. 69-75. In Lucia Pizzo Russo (a cura di), Rudolf Arnheim, cit., si veda l’intervento di Ingrid Scharmann, “Ordine, espressione e media…”, pp. 155-167. In Gabriella Bartoli, Stefano Mastandrea, Rudolf Arnheim, cit., si vedano Pietro Ingrao, “Ricordo di Arnheim”, pp. 21-24; Adriano Ossicini, “Con Arnheim un «dialogo» che parte da lontano”, pp. 25-31; Renzo Canestrari, “L’opera di Rudolf Arnheim…”, pp. 33-37. 253 Rudolf Arnheim, Fedele d’Amico, Eppure, forse, domani, cit., p. 33. 254 Ivi, pp. 183-184. 255 Anche Arnheim non si è mostrato indifferente a questo tema: si vedano, per esempio, Rudolf Arnheim, Immagine-avvenimento e durata, cit.; Id., Le due autenticità del medium fotografico, cit.; Id., Composites of Media: the History of an Idea, «Michigan Quarterly Review», 4, 1999, pp. 558-561. 256 Si vedano in particolare Roberto Diodato, “Visual Thinking as Virtual Thinking”, in Lucia Pizzo Russo (a cura di), Rudof Arnheim, cit., pp. 235-245; Virgilio Tosi, Luciano Mecacci, Elio Pasquali, “Movimenti oculari e percezione di sequenze filmiche”, in Sebastiano Traccis, Daniela Zambarbieri (a cura di), I movimenti di inseguimento lento, Patron, Bologna, 1994, pp. 229-274; Idd., Scanning Eye Movements Made when Viewing Film: Preliminary Observations, «International Journal of Neuroscience», 92, 1997, pp. 47-52; Rainer Schönhammer, Human ‘Sense of Space’, Moving Images and Architecture, «International Symposium Aesthetics and Architectural Composition», Dresden, 2004 (http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2005/554/); Id., “Mit Arnheim Kino”, in Christian G. Allesch, Otto Neumeier (a cura di), Rudolf Arnheim oder die Kunst der Wahrnehmung. Ein interdisziplinäres Porträt, WUV Universitätsverlag, Wien, 2004, pp. 87-96. 257 Cfr. Helmut H. Diederichs, “Nachwort”, in Rudolf Arnheim, Die Seele in der Silberschicht, cit., pp. 421-427; Id., “Materialästhetik der reproduktiven Künste. Rudolf Arnheim als Medientheoretiker”, in Frank Furtwängler, Key Kirchmann, Andreas Schreitmüller, Jan Siebert (a cura di), Zwischen-Bilanz: Eine Internet-Festschrift zum 60. Geburtstag von Joachim Paech, 2002 (http://www.uni-konstanz.de/paech2002/ zdm/beitrg/Diederichs/Diederichs.htm); Ingrid Scharmann, “Ordine, espressione e media…”, cit., pp. 155-165; Ian Verstegen, Arnheim, Gestalt and Art. A Psychological Theory, Springer, Wien-New York, 2005 (in particolare il cap. 6, “The Dynamics of Pantomimic Form”). Cfr. anche Id., A Formalist Reborn, «Film-Philosophy», 3, 1999. 90 91 Antologia Rudolf Arnheim e il cinema nelle riviste italiane 1932-1938 Gli antecedenti 1932-1933 Questa antologia include tutti gli scritti sul cinema di Rudolf Arnheim pubblicati sulle riviste italiane nel periodo compreso fra il maggio 1932 e l’agosto 1938. Gli scritti successivi (1948-1993) sono raccolti nell’archivio on-line www.RudolfArnheim.it. Nota redazionale Tutti i testi antologizzati sono fedeli trascrizioni dell’originale. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche tipografiche volte ad aggiornare termini desueti e a uniformare gli standard redazionali utilizzati da riviste diverse. Soggettista e direttore artistico L’autore e il régisseur hanno, nel teatro, funzioni ben distinte. L’opera del drammaturgo è una composizione chiusa in sé che non necessita della messinscena per divenire arte. Nel film le relazioni tra i due sono del tutto diverse, cosa di cui purtroppo molto spesso non si tien conto. Certamente il soggetto cinematografico è un volume di carta manoscritta come il dramma teatrale, ma questa è la sola analogia che esiste fra le due cose. L’exposé non ha ancora molto a che vedere col film. Esso presenta una trama più o meno filmabile; e la cosiddetta elaborazione, la forma intermedia tra l’exposé e la sceneggiatura, non è altro che una diretta descrizione del film: gli avvenimenti che in seguito si vedranno sullo schermo qui si possono leggere. La sceneggiatura completa si differenzia dal film realizzato, solo per il fatto che le immagini, che nel film sono realizzate e recitate, qui sono unicamente descritte mediante parole. Per l’autore di soggetti cinematografici è cosa straordinariamente difficile descrivere con parole, non troppo prolisse e tuttavia acconce, le immagini che, secondo le sue intenzioni, dovranno poi succedersi nel film compiuto. Perché, che cosa fa egli in realtà? Vede innanzi a sé, con gli occhi della fantasia, un film e lo descrive. Ma descrivere un solo quadro cinematografico con brevità è, per la maggior parte dei casi, una cosa molto difficile; è già cosa più semplice se la descrizione contiene già una prima indicazione della posizione della camera e della disposizione degli attori e della scena. La cosa poi più semplice ed efficace è realizzare sul posto, in atelier, la scena voluta. Soggettista e régisseur cinematografico costituiscono dunque un solo ed unico mestiere. Cosa questa che in pratica veramente non avviene. Ma chi potrebbe sostenere che la pratica della produzione cinematografica sia ragionevole? Il régisseur continua il lavoro che il soggettista ha cominciato, ed è in ciò che sta il punto nero della produzione, perché il lavoro artistico non può passare da una mano all’altra come un messaggio tra le staffette. Se si facesse cominciare un quadro a Max Liebermann e lo si facesse condurre a termine da Max Pechstein, il risultato sarebbe indiscutibilmente brutto, e Liebermann protesterebbe perché il lavoro non sarebbe stato terminato in conformità alle sue intenzioni. Così il soggettista cinematografico, come si sa bene, è colui che, alla fine del film, protesta perché si è trasformato il suo lavoro fino al punto di renderlo irriconoscibile. Di questa soperchieria non è responsabile soltanto il direttore della produzione, col suo timore della censura e col suo ossequio ai gusti del pubblico. Sarebbe un miracolo se l’autore avesse saputo elaborare la materia del film in modo corrispondente ai metodi del régisseur e alla speciale esigenza della materia cinematografica. E precisamente quando entrambi sono due esseri dotati e cioè a dire, quando essi hanno una personalità spiccata, la discrepanza tra i loro lavori sarà forte. Il régisseur deve quindi alterare il soggetto secondo il suo temperamento se vuol produrre un’opera della quale possa coscienziosamente rispondere. Egli deve violentare l’autore. In pratica si vede molto di rado che il régisseur si scriva da sé il suo copione. Lo fa per esempio C. Chaplin (e quando Chaplin fa una cosa si può essere ben sicuri che è una cosa ben fatta). Oppure l’autore e il régisseur lavorano molto concordemente uniti e fanno il film in collaborazione. In questo caso essi devono essere adatti l’uno all’altro, cosa che naturalmente avviene molto di raro, come Thea von Harbou e Fritz Lang che sono marito e moglie. Nella maggior parte dei casi però l’autore e il direttore non sono marito e moglie, ma sono personalità molto distanti, accoppiate solo dalla casa di produzione; e ne nascono attriti e dispiaceri perché il régisseur non fa il film che dovrebbe e l’autore è esasperato perché, non avendo egli l’ultima parola, è costretto a cedere: e non gli resta poi altro da fare che mandare una lettera circolare raccomandata alle redazioni dei giornali cinematografici e spiegare che il film porta sì la sua firma ma che non ha niente a che fare col suo lavoro. Chi sa scrivere un buon soggetto cinematografico solo per circostanze esteriori potrebbe non essere in grado di realizzarlo lui stesso in stabilimento: potrebbe per esempio mancargli la pratica di atelier. Perché egli certamente non è uomo di carta e di penna, ma di camera e di pellicola: non è un poeta come il soggetto non è letteratura. Perciò sono privi di senso gli appelli ai poeti che i produttori di film sogliono fare di tempo in tempo per rendersi graditi agli intellettuali. Particolarmente oggi, dopo la scoperta del film sonoro, si sente ogni tanto l’invocazione: «Ora che il film parla abbiamo bisogno della collaborazione dei poeti!». È da sperare che i poeti, nel loro interesse e in quello dell’arte del film sapranno resistere a questa lusinga che significa per essi larga notorietà e larghi incassi. È sicuro che i poeti non vi farebbero mai una buona figura. Non si chiede ad Ejzenštejn o da Pudovkin che si mettano a scrivere romanzi, non si chiede dunque che Zuckmayer e Döblin facciano dei film. Anche nell’ora del film sonoro vale la massima semplice, eppure tanto lontana dalla realtà: l’arte cinematografica ha bisogno di artisti cinematografici e di nient’altro. Sono gli stessi produttori che vietano l’accesso al mondo cinematografico agli elementi che le sarebbero necessari, della nuova generazione. Che cosa si penserebbe di una casa editrice che mettesse come condizione ai suoi autori quella di dare, dei loro romanzi, riassunti brevissimi, non più lunghi di due pagine dattilografate – gli exposés? E così invece lavorano, per lo più, le case cinematografiche. Un exposé di due pagine può certamente contenere una materia cinematografica sorprendentemente buona e originale. Ma gli exposés di film di prim’ordine spesso, al contrario, non rivelano 96 97 «L’Italia letteraria», 15 maggio 1932, p. 5 Si direbbe che gli ultimi cent’anni abbiano apportato una fioritura di arti nuove. Non si era abituati forse a pensare che l’arte vantasse un’età rispettabile come quella dell’umanità stessa? L’inizio della danza, della musica, della poesia, del teatro e dell’architettura si perdono dinnanzi al nostro sguardo nella nebbia di un lontano passato. Ed ora si guardi ai nostri ultimi cent’anni: verso il 1830 nasce la fotografia, verso il ’90 il film, nel 1920 la radio, nel ’30 il film sonoro. Sono arti veramente nuove? Se si esaminano i mezzi di riproduzione, con l’aiuto dei quali queste arti nuove esprimono la loro funzione artistica, ne risultano concordanze così sorprendenti, nonostante le grandi differenze dei vari apparati tecnici e delle opere risultanti, che ci sentiamo tentati di parlare qui di suddivisione di un’unica arte nuova, che si potrebbe chiamare “arte riproduttiva”. È chiaro che le leggi determinanti l’effetto di quest’arte nuova non differiscono sostanzialmente da quelle delle altre arti, ma come una armonia coloristica si distingue nettamente da un’armonia musicale, così una creazione dell’arte riproduttiva, differisce nettamente dalle creazioni di altri campi artistici. Qual è ora la particolarità di quest’arte riproduttiva? Che in essa la realtà ritrae sé medesima. Avviene qui come se un modello togliesse di mano al pittore il pennello, quando i raggi di luce fanno risaltare su uno strato di nitrato d’argento il chiaro e scuro, e quando le onde sonore s’imprimono sullo strato di cera e sulla pellicola. Ora noi sappiamo perfet- tamente che qui non si tratta di un procedimento di riproduzione puramente schematico. Nel qual caso ci troveremmo di fronte ad un processo tecnico come potrebbe essere la stampa, che non avrebbe nulla a che fare con una manifestazione artistica e creativa dello spirito umano. No, anche nell’arte riproduttiva si tratta di opera di creazione assolutamente umana. Il fatto, che la realtà si manifesta di per se stessa, ci insegna dove soltanto sia da ricercarsi il lato originale, caratteristico di questa nuova arte: ci insegna anzi «che la forza sua sta appunto nel ritrarre e che i suoi particolari metodi di figurazione consistono nel riprodurre da un luogo d’osservazione definito, con un definito criterio di selezione». La macchina da presa e il microfono ci permettono di fissare le percezioni delle nostre due facoltà più importanti, quelle della vista e quelle dell’udito, di conservarle e di trasportarle attraverso il tempo e lo spazio. La fotografia e il film muto si limitano al campo ottico, la radio e il disco grammofonico all’acustico, mentre il film sonoro si giova contemporaneamente di entrambi i campi. Ora la percezione visiva da sola è in grado di offrirci un quadro di vita molto più completo e fedele di quel che ci possa offrire la sola percezione acustica. Ne segue quindi che gli elementi visivi dell’arte riproduttiva (fotografia e film), per la loro stessa essenza, sono più vicini alla natura di quelli acustici. Questi ultimi si limitano ad un campo così ristretto della realtà che anche il loro migliore effetto è raggiunto con rappresentazioni astratte e irreali. Perciò dunque anche buone fotografie e film sono per lo più vicino alla realtà (l’arte di Chaplin forma sotto quest’aspetto un capitolo particolare), mentre buone audizioni non sono altro che visioni cariche di simbolismo e di pensiero che non si lasciano affatto rappresentare, o tutt’al più in modo molto incompleto, sul molto più naturalistico palcoscenico. (Così pure il Faust di Goethe con le sue innumerevoli figure simboliche è più un lavoro auditivo che un dramma scenico). Il fatto nuovo che mediante l’aiuto di apparecchi scoperti di recente permetteva improvvisamente di riprodurre il visibile e l’udibile in modo fedele alla natura, parve così straordinario, che nello stadio iniziale di quel ramo d’arte riproduttiva, noi non troviamo che questa unica aspirazione: creare riproduzioni della natura. Ma questo non ha ancora niente a che vedere con l’arte. Solo a poco a poco, sotto le dita dell’artista che ha l’esatta concezione di “ciò che la materia vuole” si accumulano i fattori creativi in un primo piano, e dalla riproduzione nasce l’arte. Da principio ci si accontenta di riprodurre su un “piano normale”, che non vuol altro se non garantire la migliore riproduzione tanto nel campo ottico che nell’acustico. Si colloca la macchina da presa in modo che l’oggetto entri in quadro nel modo più completo e più chiaro possibile; si pone il cantante davanti al microfono in modo che la sua voce non suoni né troppo alta né troppo bassa, ma semplicemente “normale”. Di qui si sviluppa a poco a poco l’arte, che sa variare le distanze dell’apparecchio da presa, in modo che mediante l’ubicazione particolare 98 99 nessuna particolarità artistica. L’arte cinematografica è tutta nei particolari. Così che l’aspirante, con le sue due paginette dattilografate, non ha modo di mettere in evidenza nulla di particolarmente adatto a questa arte. Se le case di produzione intendono fare sul serio un appello alla giovane generazione occorre che non si fidino solo dei sorveglianti e degli aiuto direttori, ma che esaminino soggetti ben estesi e diano la possibilità agli autori di realizzare negli stabilimenti la loro creazione. Il soggettista, cioè colui che inizia e non conduce a termine un’opera d’arte, e che ha per unico compito quello di dare guai al direttore artistico, è una comica e pietosa figura destinata a scomparire. Le porte degli atelier gli debbono essere aperte per vedere se egli è in grado di intendersi col direttore e di divenirne collaboratore. Oppure che siano i direttori stessi a scrivere i loro soggetti. Il terzo metodo è solo quello che esiste in pratica, purtroppo, nelle attuali condizioni della cinematografia. Arte riproduttiva «Cine-Convegno», 2-3, 25 aprile 1933, pp. 33-36 dell’oggetto riprodotto, si formi una relazione soggettiva dello spettatore con quanto è da lui visto, che da vicino dà maggiormente un senso di intimo e di dettagliato, da lontano un’impressione di estraneo e di vago. Non si mostra più soltanto l’oggetto in sé ma lo si inquadra in prospettiva nel suo mondo, lo si mostra in relazione con quanto lo circonda e col soggetto che guarda. Si scelgono elementi vicini nel tempo e nello spazio, ciò che si produce contemporaneamente e nello stesso ambiente, in modo che attraverso questo simbolico accostamento vengono messe in evidenza le relazioni favorevoli al complesso. Si rappresentano le cose senza alterarle in questo accostamento ponendo i corpi in una caratteristica luce e i suoni in uno spazio caratteristicamente risonante. Ombre cupe o luce leggera, uno spazio privo di risonanza, oppure delle pareti fortemente riflettenti che danno un suono debole e confuso. Al principio invece vi era l’auditorium normalmente risonante e una luce normale che illuminava ogni cosa distintamente. Così noi troviamo al principio del film e della radio l’unità di tempo e, quanto più è possibile, 1’unità di luogo. C’è una cesura soltanto alla fine di ogni scena, come sul palcoscenico. Più tardi ci si serve del fatto che nel montaggio del film e davanti al microfono il cambiamento delle scene si può fare più velocemente che sul palcoscenico; si accorciano certe scene sino al minimo, talora si lasciano apparire, come in Joseph von Sternberg, soltanto qualche attimo e a poco a poco si giunge anche a rappresentare, nello svolgersi di una sola scena, ciò che contemporaneamente accade in altre scene. Infine si riesce ad ottenere la scomposizione di una stessa scena in diversi frammenti. L’unita di tempo risulta così da un mosaico di piccole parti. Il film e la fotografia hanno raffinato e perfezionato sino ad un alto grado queste forme, ed oggi già, dopo le prime incertezze sonore, coi nuovi metodi di realizzazione, si è raggiunta una chiarificazione, in quanto si cerca di ottenere profondità di effetti con mezzi semplici. Nella radio invece, che è 1’ultima nata di questa famiglia artistica, si è ancora assolutamente ai primordi. La radio serve ancora per lo più (così come ai loro inizi la fotografia e il film), come semplice strumento di riproduzione, le sue possibilità artistiche vengono ancora assai spesso negate e infatti è certo che fino ad ora si è fatto poco per dimostrare il contrario. Pure il sorprendente parallelismo con la fotografia e il film ci confermano nella speranza che l’arte sonora abbia davanti a sé una possibilità di sviluppo nella quale, dati i suoi mezzi di realizzazione più limitati, non raggiungerà forse la ricchezza e l’originalità delle arti visive, ma porterà tuttavia ad un’importante, interessante cultura auditiva. 100 Contrappunto sonoro «La Stampa», 20 giugno 1933, p. 5 In qualsiasi arte esistono motivi formali che direttamente derivano dal carattere dei suoi mezzi espressivi, tanto che riappaiono sempre in ogni tempo e in ogni paese. Contrariamente alle piccole novità di stagione, si tratta qui di forme semplici fondamentali: come la composizione triangolare nella pittura, la catastrofe nel dramma, il ritmo nel canto, nella poesia e nella danza. Anche il film già conosce queste forme classiche fondamentali; citiamone qualcuna. A ogni frequentatore di cinema verranno in mente certi film nei quali, durante tutta una scena, persisteva un solo motivo sonoro, monotono, uniforme: un rumore determinato, un tono determinato, una parola determinata. Qui non intendiamo parlare dei casi nei quali una tonalità di sfondo, ad esempio, un mormorio d’acqua, era posta a base di una scena quale costante “rumore di coulisse”; ma pensiamo invece a forme brevi a netto contorno, le quali imprimevano all’azione di primo piano un certo ritmo, come le battute di un metronomo. Si cercò già di ottenere effetti consimili nel film muto, con mezzi puramente visivi: da un rubinetto d’acqua o da un ghiacciolo gocciolava l’acqua, su una parete si vedeva la regolare oscillazione d’un pendolo. Poi, nel film sonoro, per citare uno dei primi esempi, si sentì, durante la famosa operazione di parto nel Canto della vita di Granowsky, il chirurgo dare i suoi brevi ordini con voce monotona; e così, di recente, nel Ribelle, durante la movimentata scena nella quale si fa la leva militare dei giovani tirolesi, si sentì l’uniforme, tipico comando dell’ufficiale. Ove risieda la particolare efficacia di tali scene si comprende agevolmente quando si pensi che già da lungo tempo esiste un’analoga forma di composizione anche nella musica. Consideriamo soltanto la musica per pianoforte, nella quale la mano sinistra conserva di solito un’uniformità di ritmo e di intervalli, ed anche nelle varie tonalità esegue di solito figure d’accompagnamento poco variate; mentre invece la mano destra svolge liberamente i suoi temi. Che effetto si ottiene con ciò? Anzitutto la monotonia della mano sinistra fa risaltare fortemente la pienezza delle variazioni melodiche, le particolari improvvisazioni dello sviluppo; poi essa viene a rappresentare il tono di fondo, ossia la base normale dalla quale sgorga la melodia ed alla quale essa ritorna; riduce i diversi aspetti dell’episodio ad un comune denominatore e mantiene questo denominatore costante nello spirito dell’ascoltatore. Così, secondo il principio del contrasto, viene accentuata la veemente mobilità dell’azione. Le applicazioni e gli esempi che di tale principio si possono trarre dal film sonoro sono innumerevoli. Si ricordi nella recente Atlantide di Pabst il giovane legionario correre attraverso i laberinti della città del 101 deserto per cercare il suo amico. Sempre nuove vie, svolti, incroci passano davanti all’occhio; un senso di smarrimento pervade lo spettatore nel rapido succedersi delle visioni sceniche; ma come motivo acustico sempre si trascina un grido che sempre uguale si ripete: il giovane, che cerca affannosamente, sempre invoca il nome del suo amico. Nel Che cosa sanno dunque gli uomini! di Lamprecht l’eroina, mentre sta fortemente agitata davanti alla porta dell’abitazione della Signora Bianca vede un bimbo, con un carrettino giocattolo, scendere tranquillamente per le scale, gradino per gradino. Il contrasto già dato dal tenore dell’azione tra la donna appassionatamente commossa e la lieta tranquillità del bambino viene ancora intensificata acusticamente facendo sentire il ritmico cadere del giocattolo, che lentamente balza di gradino in gradino. In questi esempi si tratta di casi specialmente vivaci ed accentuati. E ciò perché la “monotonia della mano sinistra” acquista il suo giusto senso solo quando fornisce il contrastante accompagnamento a una “melodia” assai animata. Ciò è invece alquanto diverso in altri casi, dove la molteplicità di aspetti dell’episodio è ridotta ad un denominatore generale. In Sotto i tetti di Parigi di Clair, nelle più recenti operette dell’Ufa, nel Love Me Tonight di Mamoulian una canzone passa di bocca in bocca a guisa di staffetta, su diversi piani stanno diverse persone e cantano una battuta in progressione: variazioni ottiche sopra un ritornello acustico. Qui suono e immagine si alternano e si fondono in maniera classica. Il principio del contrasto è applicato in un campo il più elementare possibile; e nello stesso tempo questo contrasto è fornito nella sua massima efficacia con tutti gli elementi del ritmo e dell’arte. 102 Il lavoro all’IICE 1935 Nostro pane quotidiano Come si spiega che dopo aver veduto il nuovo film di King Vidor: Nostro pane quotidiano, uno si sente lieto, libero e come purificato, mentre ci eravamo pressoché abituati ad uscire dal cinema con la coscienza turbata, di cattivo umore, e quasi col disgusto di uno stravizio? In King Vidor non c’è né grande arte né profonda saggezza, ma egli ci procura la rara occasione di vedere e di udire, da quell’uomo semplice e dabbene che è, i suoi pensieri e sentimenti espressi nella maniera a lui più naturale e senza involuzioni. Il cinema è diventato il terreno d’azione della menzogna: si dice che si vuol mostrare l’uomo e ci si dà il prodotto, disgustoso nel suo immutabile sapore dolciastro, d’una fabbrica di confetture; ci si dice che vien rappresentata la verità, il sentimento, la passione ed invece non abbiamo che la ricetta degli esperti per il gusto del pubblico, e si distilla un veleno inebriante dal delitto, dalla miseria e dalla crudeltà; si simula interessamento ai problemi vitali del presente, pietà, e persino spirito rivoluzionario, ma in realtà si tien conto solo dell’attrazione che tali problemi suscitano in funzione dell’interesse di cassetta. Il produttore fa i propri conti mentre finge d’essere ispirato, il regista mescola insieme diverse bevande raffinate e dice di fare una creazione artistica. L’attore espone i muscoli del petto, il profilo, le belle gambe e chiama ciò “espressione”. I cinematografi non si sono trasformati in case di malaffare, immorali in senso ben diverso da come s’intende nelle riunioni delle brave signore reclamanti il boicottaggio del cinema, le quali considerano che morale sia un silenzio di tomba su certi problemi? Immorale al contrario il cinema, perché vi si battezza come amore ciò che non è se non bassa speculazione, e che ha trasformato quegli istinti naturali da cui nasce la vita in una brama di sensazioni e di godimenti privi di senso e di funzione. In un simile ambiente, l’opera di un uomo schietto come King Vidor appare sempre come una rivelazione e una liberazione. I suoi film sono lo specchio terso dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri; pensieri e sentimenti che sono quelli dell’uomo medio di oggi. Se ciò ha i suoi svantaggi dal punto di vista artistico-spirituale, è però utile ed educativo nel senso morale e sociale. L’ultimo film è tratto – come dice la didascalia – «dai titoloni delle prime pagine dei giornali», il che è vero in maniera più profonda ch’egli stesso non credesse. Quanto si può dire del nostro tempo con pochi grossi caratteri tipografici – miseria, insensatezza, iniquità, – ciò ha ispirato King Vidor: non le molte colonne in caratteri minuti che si stampano ogni giorno sotto a quei titoli, e che con migliaia di argomenti disperatamente sofistici ingarbugliano, deviano, inorpellano e mascherano ciò che in quei titoli era pur tanto chiaro. Se si considera come una proposta di politica realistica per risolvere la crisi economica, come una pratica illustrazione della tesi: «Torniamo alla terra!», allora questo film ci appare primitivo, superficiale e muffito come le chiacchiere da caffè: esso a forza di aneddoti sorvola sui problemi, le richieste dell’istituto di credito e l’avidità degli speculatori terrieri vi sono eluse con un semplice ruggito di rabbia, con la minaccia di una dozzina di pugni; e il capitale necessario all’esercizio dell’impresa agricola vien messo assieme con la taglia posta sopra un membro della colonia. No, questo film non è una ricetta di Realpolitik. È bello perché esprime il sentimento di uomini che risalgono stupefatti agli elementi primordiali della vita, che risentono, come un miracolo nuovo le cose più antiche e più naturali: si addestrano, campano con nulla, faticano e raccolgono non la disoccupazione e la fame, la disperazione e il disprezzo, ma dalla terra spuntano, premio automatico e infallibile come le leggi di natura, i fitti germogli che promettono il pane. Più grande che il miracolo stesso della vita è, per gli uomini semplici che in questa bellissima scena rendono grazie in ginocchio al campo, la scoperta che morale e giustizia sono nella natura, la rivelazione che a colui che dà sarà dato! E quando essi stringono i pugni, l’atto è ben primitivo ma, appunto per questo, rivoluzionario. E quando il gigantesco ricercato va a costituirsi per agevolare, con la riscossione della taglia, il compimento dell’opera, ci troviamo di fronte ad un arguto paradosso: ma è un paradosso che per la Giustizia ha sapore amaro. Verrebbe fatto di pensare a un film solenne e patetico nella linea dello stile russo. Al contrario esso è asciutto, e neppur molto serio. Addirittura non s’intende nella sua sostanza se non lo si giudica come un film umoristico. Ridere davvero non può che l’uomo d’ingegno, perché lui solo conosce il manchevole e l’errato. E se è vero che per la soluzione dei problemi d’oggi occorrono soprattutto intelligenza e indipendenza di spirito, è vero anche che senza il senso del comico non si potrà raggiungere quella saggezza di cui abbiamo bisogno. In King Vidor si sente il genuino umorismo anglosassone. Qui, e non nelle raffinatezze importate da Hollywood, parla la vera America, la terra delle studentesche esuberanti, dei cowboys e dei boxeurs, del gioco del calcio tra polizia e dimostranti, la terra dove le sommosse politiche possono ancora essere sedate con le pompe da incendio. È il paese di Charlie Chaplin e di Buster Keaton, di Tom Mix e di Douglas Fairbanks, dove il cowboy Will Rogers è filosofo da radio; un paese sorridente come Mark Twain e semplicista come Upton Sinclair. Una terra ancora troppo giovane per la grande tragedia. In Robert Flaherty, in Ejzenštejn, in Pudovkin, la lotta per la vita, contro il bisogno e la sofferenza, ha forza drammatica; in Vidor gli ostacoli sono solo molesti ed incomodi. Ciò che negli uni è grandezza, nell’altro è sport. Quale gigantesco simbolo in Flaherty, quando gli uomini di Aran estraggono il magro terriccio di tra le fessure delle rocce! Il giovanotto vidoriano che con la vanga raschia la dura terra, è invece un giovane incerto, benevolmente deriso dalla moglie. E nelle stesse scene dove non sembrerebbe 104 105 «Intercine», 1, gennaio 1935, pp. 14-18 possibile evitare una grandiosità patetica di gesti, Vidor riesce a mantenere la sua sobria concretezza. Quando non è il cavallo solo a tirar l’aratro, ma gruppi di uomini, vecchie Ford e motociclette, allora la commozione ci prende, ma nello stesso tempo non possiamo non accorgerci del sorriso nascosto con cui Vidor considera l’uomo civilizzato, le cui superbe invenzioni fanno sui campi lavorati una mediocre figura. E quando il colono si getta col proprio corpo contro l’acqua che devia traboccando dal canale per riportarla verso il terreno assetato, allora nell’eroe salta fuori evidente anche il portiere generoso, che ripara il pallone con lo stomaco. Ma chi assolverà i còmpiti che oggi impone la vita: lo sportivo che si avventa giovanilmente e senza parole grosse a combattere l’errore ed a vincerlo col ridicolo, o chi, gravato dalla certezza dell’inevitabile tragicità dell’esistenza, sente con la serietà d’un vecchio e dispera? «Vedete come è dura la vita!» esclama l’arte europea. E da lontano, con voce limpida, questo film americano risponde: «Cari amici, perché rendiamo così tremendamente complicata una cosa semplice?». Questo film è l’abbiccì del sano buonsenso. Esso ci mostra che dieci possono più di uno; ci fa vedere l’organizzazione collettivistica: terra in comune, rancio in comune, portafogli in comune; ci ricorda che il forte che scaccia il debole e dice: «Qui comando io!» deve esser punito. L’uno aiuta l’altro. Al muratore rovinano i travi della sua casetta, e accanto a lui il falegname si affatica invano intorno al muro: i due si uniscono e si aiutano a vicenda. Un film pieno di fede nella bontà degli uomini. Nel modo più schematico, come una esemplificazione ricavata immediatamente dal concetto, muratore e falegname stanno l’uno vicino all’altro. Questo non è verismo; qui siamo nella stilizzazione. Se il film russo non altera la sostanza della realtà, ma fa fluire un’azione ampia e semplice, il cui significato – contrasto e confronto – risulta soltanto dalla suddivisione dell’azione stessa in inquadrature, dal montaggio dei primi piani e dei campi lunghi, Vidor, al contrario, costruisce, secondo i vecchi metodi del film comico, una trama dalle situazioni accentuate e dai gags stilizzati. Il suo film si svolge nella natura, ma egli non lo fa sentire: il sole di Vidor non risplende, il suo campo di grano non ha mormorii, la sua acqua non rinfresca. Le sue immagini sono astratte come quelle lineari di Disney ed hanno anche minor stile, in quanto non sfruttano espressivamente gli elementi visivi, ma li lasciano inoperosi. La luce non crea l’ambiente né ci fa sentire la qualità e diversità delle varie materie. L’inquadratura dà solo una cornice accidentale e fortuita alla trama, il montaggio allinea scene su scene come si sovrappongono dei tozzi blocchi da costruzione, il racconto è diviso nelle sue parti da semplici pause di oscurità. Anche questa volta, Vidor è tutt’altro che un regista “interessante”. Si è ancora nella tradizione dell’anteguerra, quando in film di questo genere, e come in Chaplin e Keaton, i mezzi espressivi vengono dalla sceneggiatura e non dalla ripresa. È ancora la sceneggiatura – non l’inquadratura e il montaggio – che solleva l’attore dal peso della mimica. Un buon regista non è quello che fa recitar bene gli attori, ma quello che li mette in condizione di recitar poco. Quando l’uomo e la donna tornano a riunirsi, noi non vediamo né occhi naufraganti né braccia sollevate. Lei gli porge da bere ed egli la guarda un attimo, calmo, col bicchiere davanti al viso. E come qui il bicchiere nasconde il volto, così Vidor nasconde sempre, con un senso sicuro dei suoi limiti, l’espressione dei grandi sentimenti. Ciò non solo è onesto, ma produce un effetto di purezza e di sincerità ed offre allo stesso tempo, con quella parsimonia artistica, un esempio che meriterebbe d’esser seguìto. Con lo stesso coraggio che ha anche Sternberg, egli sopprime tutto ciò che non ritiene assolutamente indispensabile. Uno sguardo fugace del giovane colono è l’unica manifestazione della relazione di lui con la bella bionda. Un personaggio secondario, di qualche importanza nell’azione esclusivamente per il fatto del suo trapasso, non appare, né vivo, né morto, sullo schermo: solo si vede per un attimo, attraverso una porticina, passare il corteo funebre. Chi crede ancora di poter separare, in un film, soggetto e regia, vede qui come questa sia già manifesta nella sceneggiatura. In ogni buon film, soggetto, sceneggiatura e messinscena provengono da una sola persona: e anche questo è l’espressione di un solo uomo, di un ragazzo con gli occhi chiari, che getta via il giornale, batte il pugno sulla tavola e dice la sua opinione. Nessun capolavoro intellettuale od artistico: ma proprio quello che dovrebbe essere il “pane quotidiano” di noi tutti. Ahimé, noi resteremo ancora a lungo digiuni. E in fatto di appetito, purtroppo siamo diventati veri artisti: una o due volte l’anno un banchetto come questo, e poi di nuovo con contenuta rassegnazione vedremo apparire le Caterine, le Cleopatre, i gangster in marsina e le vamps giunoniche, i tenori focosi e le fredde ragazze di pasta frolla. Fino a quando King Vidor continuerà ad essere un’eccezione anziché una regola? 106 107 Espressione «Intercine», 1, gennaio 1935, pp. 34-37 Il livello artistico medio del film è sceso in modo spaventoso. La perfezione raggiunta da attori, operatori e autori dei commenti musicali conserva ancor oggi ai prodotti cinematografici un certo valore, ma un buono spettacolo, dei bei quadri, e dei suoni gradevoli non sono ancora un film. Col film, come autonoma forma d’espressione, si va male. A poco a poco il carattere proprio del cinema viene dimenticato, non solo dai creatori di film, ma anche dalla critica. E quando Nicola Chiaromonte («Scenario», Roma, novembre ’34) scrive che: «lirica, musicalità e ritmo sono concetti generali, la cui applicazione al film può condurre solo a vuote frasi retoriche», questa asserzione poteva, in riguardo al film muto, essere giusta soltanto in un senso molto profondo; mentre per il parlato d’oggi è tanto palesemente giusta, da sembrar quasi banale. Dove va l’arte cinematografica? Donde la decadenza attuale? Il dialogo del film sonoro, e la sempre più forte meccanizzazione del processo produttivo, ne sono probabilmente le colpevoli principali. L. Moholy-Nagy accenna, nella sua Lettera aperta (primo numero della nuova rivista ceco-tedesca «Ekran», Brno, 15 novembre ’34) all’estinguersi dell’avanguardia, la quale, sgradita concorrente, sarebbe stata soffocata dall’industria. «L’arte si voleva ucciderla per i profitti, ma il bumerang, tornato sibilando indietro, colpì i profitti». Bisogna dunque creare una nuova forza d’attrazione del film per mezzo di un nuovo impulso artistico! Ma quale via l’arte del film deve percorrere? Il rinnovamento della cinematografia avverrà attraverso il film documentario, dice – un poco pro domo sua – Joris Ivens («Ekran», n. 1); poiché «nel documentario il creatore del film è costretto a dichiararsi lealmente e apertamente solidale col proprio soggetto, ciò che gli farà trovare la forma cinematografica più genuina». Il documentario con la sua energia indicherà una nuova via al film teatrale dell’avvenire; si raggiungerà così un’autentica drammaturgia cinematografica. Sincerità e verità, e non il bello superficiale, formano l’incanto del film. «L’errore incredibile in cui il cinema s’è finora incaponito, fu, secondo Corrado Pavolini, («Scenario», Roma, settembre ’34) di tendere al bello, un bello che determinò la rottura d’ogni contatto e rapporto dell’immagine con la cosa; e ciò attraverso il truccaggio dell’attore come attraverso velature e sfocature, giuochi di luce e d’ombra, suggestioni e livellamenti di ogni genere. Un mezzo, nato apposta per riprodurre tutte le rughe e tutte le imperfezioni dell’universo, ha praticamente costretto a scomparire dalla faccia del mondo ogni povero e caro sbaglio, ogni segno d’umanità dunque, ogni idea di patimento e logoramento, di scorrer del tempo, di ciò che si sciupa, si perde, si corrompe, va lentamente al macero dei secoli». il commediografo Marcel Pagnol, allo stesso modo della Comédie Française che s’è indotta a trasportare sullo schermo il proprio repertorio, intende cinematografare del teatro puro, e creare un “film senza movimento”. Così, con molto disprezzo, egli si esprime nella sua rivista «Cahiers du Film» sulla gente troppo avida di vedere: «Pel fatto che il film può mostrare tutto, il cineasta, il pubblico, il critico, pretendono di vedere ogni cosa; molti drammaturghi, quando s’inducono a elaborare per il cinema uno dei loro lavori, si lasciano influenzare assai da questa teoria semplicista». Non lui Pagnol: il quale, in compenso, crede che il pubblico debba udire tutto. «Per tre ore d’orologio e 4.500 metri di pellicola, cinque persone stanno sedute sopra un letto, su un cofano, sopra un tronco d’albero, e parlano, parlano, parlano»; così informa nel suo numero 7 «Cinegiornale», nuova rivista quindicinale di alcuni giovani giornalisti cinematografici romani, compilata con intelligenza. Si cerca davvero la salvezza col cinematografare il teatro? Max Reinhardt girerà prossimamente, a quanto si legge, insieme a Wilhelm Dieterle, per la Warner Bros, il Sogno di una notte d’estate. Trucchi Tuttavia una fedeltà documentaria nel più superficiale senso della parola certamente non basta ancora. Marcel Pagnol ha girato interni ed esterni del suo film Angèle senza ricorrere affatto al teatro di posa e allo scenografo. Improvvisò le riprese in caseggiati cittadini e casali di campagna; per il resto usufruì del paesaggio provenzale; con tale procedimento – per il primo, come egli dice – ha girato riprese a carrello senza interruzione da un interno all’aria aperta; al quale scopo, però, fu necessario, per mezzo di filtri, creare una compensazione fra la luce solare e quella artificiale («Le Figaro», Parigi, 27 ottobre ’34). Malgrado tutto questo pare che non ne sia risultato un film. E si capisce: Il film può presentare fedeltà documentaria anche nella rappresentazione dell’impossibile e del meraviglioso. Coll’aiuto dei suoi trucchi, esso mostra, con tutta esattezza, l’aspetto che assumerebbe l’impossibile se fosse possibile. Per il film americano L’uomo invisibile, con raffinatissimo lavoro di precisione, si son create scene che sarebbero state degne di uno scenario più intelligente e di una regia più briosa. Nella scena della morte, per esempio, sopra un cuscino deve apparire un cranio che a poco a poco si trasforma in un volto d’uomo vivente. Per far ciò si sovrappose un cranio e una serie di plastici che con tratti sempre più precisi rappresentavano la testa dell’attore, e da ultimo l’attore stesso in carne ed ossa, passando dall’una all’altra immagine con dissolvenze tanto perfette da dare allo spettatore l’impressione di seguire, come a suo tempo nel Dott. Jekill, un procedimento unitario di trasformazione. Ancora più complicate sono le scene in cui l’uomo invisibile si veste e si spoglia, o, sotto il dipanarsi delle bende che avvolgono il capo, appare il vuoto nulla. In questo caso si usò il procedimento di sovrastampare parecchi negativi, intanto che mascherini scorrevoli impedivano che lo sfondo della scena trasparisse attraverso la figura del protagonista. Un mascherino scorrevole è un negativo della parte di scena che si trova in primo piano, negativo sviluppato a completo annerimento, che si mette davanti al negativo dello sfondo, mentre questo secondo negativo attraversa la stampatrice: e così lascia vuoto sulla positiva lo spazio sul quale più tardi si stamperà il negativo del primo piano. Col mascherino scorrevole si ha dunque la possibilità di coprire una parte dell’immagine che, da fotogramma a fotogramma, modifica i suoi contorni («American Cinematographer», Hollywood, settembre ’34). 108 109 Film parlato Disegni animati Quale mirabile strumento potrebbero diventare tali trucchi magici nelle mani di un favolista esperto nel suo campo come Walt Disney in quello dei disegni animati! Disney non delude i suoi ammiratori. Con sempre maggior forza le sue linee e i suoi colori esprimono un sentimento poetico. La sinistra fosforescenza dell’aurora boreale nel film dei pinguini, il verde spettrale dei pipistrelli che danzano, nella favola del topo alato, fanno ripensare al cromatismo simbolico di un Hans Baldung. Qui c’è molto più che una colorazione di gusto. E ciò, malgrado l’incompiutezza di una tecnica che ancora non permette di riprodurre l’azzurro. Il procedimento Technicolor rende possibile l’impiego di tre colori fondamentali e dei composti che si ottengono mescolando giallo, rosso e verdazzurro. (Earl Theisen in «International Photographer», Hollywood, ottobre ’34). Anche Oskar Fischinger ha posto, con molto successo, i colori al servigio dei suoi film disegnati. Egli adopera il procedimento Gasparcolor, la cui caratteristica non sta nel processo di ripresa, ma in quello di stampa. I cerchi variopinti, i triangoli, i quadrati di Fischinger, che, nella loro astrattezza, sembrano così fuor del mondo, hanno dimostrato recentemente di poter essere bene utilizzati per il film reclamistico («Lichtbildbühne», Berlino, 18 ottobre ’34). Fra i nuovi tentativi, nel campo dei disegni animati, sia menzionata la Joie de vivre che testé è stata per la prima volta presentata da Hector Hoppin e da Anthony Gross alle Ursulines di Parigi. La particolarità di questa pellicola, secondo Emile Vuillermoz («Le Temps», Parigi, 27 ottobre ’34), consiste in ciò: che certi aspetti della meccanica, i fili telegrafici, scambi, treni, sono introdotti in una produzione fiabesca. Ma dal momento che, nel nuovo film natalizio di Disney, s’è visto come un aeroplano da bambino, con la sua scia di nebbia, crea una graziosa catena a spirale intorno all’abete che il servo Ruprecht ha spalancato poco prima come un ombrello, così bisogna dire che, anche in ciò, il campione mondiale dei quadri viventi non è stato superato. Con un nuovo procedimento tecnico è stata prodotta da Claire Parker e A. Alexeiev Night on the Bald Mountain. Secondo una relazione assai imprecisa che gli autori ne danno in «Cinema Quarterly» (Edimburgo, autunno ’34), si tratta di un unico disegno – non dissimile per l’effetto da una litografia a matita – che dopo la presa di ogni fotogramma viene ritoccato nel senso del movimento desiderato. cenna in «IdeaI Kinema and Studio» (8 novembre ’34). Invece di un trapasso improvviso dal monocromo al colorato, dalla scena in bianco e nero si passa ad immagini colorate prima lievemente e poi sempre più forte; oppure a una scena monocroma ne segue una leggermente colorata, a questa una colorata più fortemente, e così via dicendo. Come buon gusto, sarebbe lo stesso effetto d’un a solo d’organo dal quale si passasse per dissolvenza in un tutti orchestrale del medesimo pezzo. Chi cerca un primo avviamento ai metodi principali della tecnica del film a colori, legga il saggio di H. D. Waley nel fascicolo d’autunno 1934 di «Sight and Sound», l’eccellente rivista trimestrale del British Film Institute; mentre i partigiani delle lampade a incandescenza potrebbero spigolare, nel fascicolo d’ottobre 1934 dell’«International Photographer», la notizia che il grande atrio d’ingresso in Casa Rothschild era esclusivamente illuminato con lampade ad arco (specialmente indicate per riprese a colori) in numero di 250: e che, ciò nondimeno, contemporaneamente all’immagine veniva registrato anche il suono. In Nana si è usato un proiettore ad arco di nuovo tipo, posto a circa 70 centimetri dal microfono, senza dar luogo a ronzii disturbatori. A prescindere dal problema tecnico, gli industriali del cinema aspettano oggi con un certo nervosismo l’uomo che, col coraggio della disperazione, dia il segnale di partenza al film colorato. Frattanto, intorno ai begli apparecchi già pronti, essi eseguono una graziosa ridda e cantano come i due maialini rosa: «Chi ha paura del lupo cattivo?». Noi, per parte nostra, confessiamo d’aver paura. Montaggio Mentre il colore nei disegni animati si è ormai saldamente conquistato il suo posto, l’impiego del film a colori naturali giustifica, ora come per l’innanzi, ogni diffidenza. Soprattutto il procedimento per cui s’innestano singole scene colorate nella pellicola in bianco e nero – ballons d’essai dell’industria – come ad esempio nella Casa Rothschild, dimostra un assai scarso sentimento riguardo alla purezza dei mezzi d’espressione. Questo difetto di omogeneità stilistica non scompare neanche usando il metodo al quale si ac- Chi non era riuscito a spiegarsi perché proprio i russi avessero raggiunto allora la vetta più alta dell’arte cinematografica, potrà farselo insegnare, in maniera da restar sbalordito, da Karl Freund, operatore cinematografico a Berlino nel periodo di splendore della produzione Erich Pommer, ed oggi regista operatore ad Hollywood. Se i russi han saputo rendere eloquenti le immagini con tanta virtuosità, ciò si deve al fatto che gli abitanti dell’Unione Sovietica erano e sono per il 90% analfabeti, e, oltre a questo, parlano cento linguaggi diversi. Si dovettero quindi evitare, il più possibile, le didascalie. Il famoso montaggio a tagli rapidi è dovuto, a sua volta, al fatto che i russi non avevano danaro per acquistar pellicole vergini, e si facevano venir da Berlino i ritagli di scarto rimasti, dopo la presa, negli apparecchi dei loro ben più provvisti colleghi tedeschi. Tanto più facile l’arte, quanto maggiori le difficoltà! («American Cinematographer», settembre ’34). Al contrario Erik Charell – anche lui dall’Ufa trasferitosi in America ha l’aria di soffrire per la troppa pellicola; egli disdegna il taglio, nel montaggio, fra il campo lungo e il primo piano, fondandosi sul fatto che, nella realtà, l’occhio non può saltare direttamente da un punto all’altro, ma deve percorrere per intero lo spazio interposto. In Carovana, quindi, sostituisce quanto più spesso può il taglio con 110 111 Film a colori la mobilità della ripresa. La tendenza a sostituire il salto d’immagini con panoramiche o riprese a carrello si era già potuta osservare dovunque dopo l’introduzione del film sonoro, il cono del dialogo costringendo qui a scene il più possibile ininterrotte. Ma se con ciò si venga a secondare o meno il modo naturale di vedere, è del tutto indifferente: ché l’assistere a uno spettacolo cinematografico è un osservare immagini, non un imitare l’osservazione del reale. Oltre a ciò, un salto nel montaggio offre un tutt’altro effetto di movimenti, un altro ritmo, e quindi un’altra espressione artistica da quella del graduale trapasso tra due inquadrature. In un articolo di Walter Bluemel, molto saggio benché dedicato ai soli cinedilettanti e concernente la Prassi della composizione delle immagini, («International Photographer», agosto ’34), Charell potrebbe leggere quanto segue: «Nel film dev’esserci movimento certamente, ma non movimento senza ragione. Come ogni altra cosa, così anche ogni movimento – sia esso quello dell’oggetto che si deve ritrarre, sia quello della macchina da presa – deve avere una sua ragione». Bluemel scrive anche molte cose degne di considerazione sul danno che arreca, alla composizione delle immagini, il procedimento panoramico, sul valore espressivo delle diverse traiettorie secondo le quali avviene il movimento nell’immagine, e sull’influenza che una buona scelta dell’asse dell’inquadratura ha sopra le linee che formano la composizione dell’immagine. Nel fascicolo d’ottobre 1934 della stessa rivista, Paul E. Bowles inizia un ciclo di articoli su I rapporti tra sceneggiatura e montaggio. Egli dice che il tagliatore assume la funzione dello scenarista quando il regista non ha già innanzi agli occhi, al momento della ripresa, la successione delle diverse inquadrature nel film realizzato, ma, in modo relativamente meccanico, gira di ogni scena una serie d’inquadrature. Con questo non risulta abbastanza chiaro che anche, e specialmente, in un film ben fatto, il lavoro dello sceneggiatore, del regista e del tagliatore è un processo unitario e omogeneo. Molto chiaramente scrive in questo senso René Le Henaff («Comœdia», 30 ottobre ’34): «Si ritiene in genere che il taglio sia una faccenda secondaria; in realtà niente s’avvicina di più allo scrivere una sceneggiatura come il montaggio». Ed egli raccomanda di far collaborare fin dal principio il tagliatore al soggetto da girarsi. Un’ulteriore amplificazione del concetto di montaggio la suggerisce Karl Freund quando, nel citato articolo, distingue tra montaggio di una successione di inquadrature e “montaggio” eseguito durante la ripresa o la stampa di una scena, ossia stabilisce un rapporto tra l’incollatura di scene diverse e le esposizioni multiple, le combinazioni di più prese con la stampatrice ottica ecc. In tal modo egli pone una distinzione simile alla nostra tra montaggio simultaneo e montaggio successivo nonché tra montaggio riconoscibile dallo spettatore e montaggio non riconoscibile (cfr. Rudolf Arnheim: Film als Kunst, 1932). Storia Del resto, per quel che riguarda la ripresa a carrello, già D. W. Griffith e 112 il suo operatore Billy Bitzer (vedi l’articolo di quest’ultimo in «International Photographer», ottobre ’34), per una grande scena di masse del film Intolerance, girato nel 1915-16, costruirono una torre piramidale mobile, alta 140 piedi, che aveva una superficie di 6 piedi quadrati alla sommità mozza e di oltre 60 alla base; questo apparecchio correva, con sei zoccoli a quattro ruote ciascuno, su rotaie, spinto da venticinque uomini attraverso la turba delle comparse radunata nel fastoso salone del re Baldassarre; e nello stesso tempo la macchina da presa saliva lentamente su per l’interno della torre mobile a mezzo di un ascensore, in maniera che, al termine della scena, l’iniziale campo lungo veniva a concludersi in un primo piano dei prìncipi seduti su un alto trono, che lassù celebravano una leggiadra scena d’amore. L’intera scena fu girata alla luce del sole, con un unico apparecchio Pathé a mano. A molti altri notevoli particolari accenna ancora Billy Bitzer. Come sarebbe utile vedere di nuovo questi vecchi film! Se noi leggiamo che per rendere omaggio al loro vecchio regista Mack Sennett, – l’opera e la vita del quale saranno rappresentate in un film, – Gloria Swanson, Wallace Beery, Buster Keaton, Harold Lloyd ed altri han dichiarato di essere pronti a rappresentare ancora una volta le loro vecchie parti, e per di più gratuitamente («Internationale Filmschau», Praga, 15 ottobre ’34), la cosa ci commuove, ma insieme ci fa pensare quanto più bello ed istruttivo sarebbe rivedere, in questa occasione, i pezzi più caratteristici degli antichi film originali. Vedere lontano «Intercine», 2, febbraio 1935, pp. 71-82 La sfera degli interessi degli uomini oltrepassa di molto la portata dei loro sensi. Fra le invenzioni che tendono a compensare tale sproporzione, la più recente e forse la più importante è la televisione. Meraviglioso, magico appare il nuovo apparecchio e la curiosità di saperne un po’ più intimamente è molto viva. È vero, che appena l’apparecchio avrà figurato in tutto il mondo fra i regali di Natale e di compleanno, la curiosità diminuirà. Tutte le cose di questo mondo sono misteriose ed incomprensibili, ma il bisogno di vedere svelato il loro segreto esiste solamente finché sono ancora recenti. Passato un certo tempo, solamente i fanciulli ed i saggi domandano: Perché, e: Come? Il momento presente è propizio. Sfruttiamolo. Prima di tutto cerchiamo di spiegare il principio fondamentale della televisione, per la cui soluzione sono stati ideati gli apparecchi descritti negli articoli che seguono. Di che cosa si tratta dunque? L’occhio e l’orecchio hanno còmpiti ben diversi e diversamente, quindi, sono organizzati. L’occhio ci dà nozioni di forma, colore, superficie, movimento dei corpi esistenti nello spazio tridimensionale, mostrandoci la loro 113 reazione ai raggi della luce. L’orecchio invece non ci riferisce nulla delle cose in sé; ci fa avvertire una certa attività emanante da esse, che genera oscillazioni atmosferiche. Esprimendoci negativamente: mentre l’occhio generalmente ha poco interesse per il genere, il luogo, le condizioni della fonte luminosa il cui effetto cade sulla rètina in forma di raggi luminosi, l’orecchio vuole percepire le onde sonore nel loro cammino fino al timpano influenzate e modificate il meno possibile, onde avere cognizione esattissima della natura della fonte sonora. Anche il suono parte da oggetti corporei, ma nulla ci giunge della loro forma. L’occhio invece, se vuole essere all’altezza del proprio compito, deve offrire una riproduzione dell’immagine di almeno due dimensioni, cioè a dire piana. Perché la proiezione di un corpo sul piano, spessissimo dà una nozione sufficiente, sebbene unilaterale e ristretta, mentre la riduzione, ancora maggiore, su una linea spaziale o temporale (vale a dire rappresentante una simultaneità lineare o di trasformazioni successive in un solo punto) non ci darebbe più una nozione sufficiente. Siccome un singolo organo dei sensi può registrare solo successivamente e non contemporaneamente un certo numero di stimoli, il nostro occhio è composto di un numero ingente di ricevitori funzionanti simultaneamente. L’immagine-mosaico che è il risultato della loro collaborazione, ricrea le tre dimensioni dello spazio alla meglio, mentre un’ulteriore dimensione disponibile – quella temporale, ossia la successione degli stimoli in ogni singolo organo – serve per la percezione dei movimenti e dei mutamenti nel campo visivo. Per ciò, invece, che riguarda l’udito, tutti i suoni che si riproducono simultaneamente nel campo uditivo, non si ricevono isolatamente ma si sommano in una sola vibrazione più o meno complessa, percepita mediante una membrana sola: il timpano. Ta1e vibrazione corrisponde tanto al semplice suono di un diapason come alla confusione sonora di un’orchestra che accordi gli strumenti in mezzo al chiasso di una folla. Se l’orecchio nostro può analizzare fino ad un certo punto un risultato così complesso, certamente non lo fa separando l’una dall’altra, secondo il loro luogo di provenienza, le singole sorgenti sonore, perché ciò, non essendo molto utile, può essere addirittura trascurato. L’orecchio tende meno a collocare le cose nello spazio che a smistare i singoli suoni. Anche l’orecchio dispone di un campo di ricevitori isolati. Essi sono disposti nell’organo a spirale del labirinto, scoperto dal medico italiano Alfonso Corti. «Un vero strumento musicale», come scrive il Tyndall, «le cui corde sono tese in modo da poter percepire vibrazioni di differenti frequenze, trasmettendole alle fibre nervose che lo percorrono. Questa arpa di tremila corde esisteva dunque a nostra insaputa da migliaia d’anni nell’orecchio umano». Ciascuna di quelle corde è accordata ad un determinato suono, ma non corrisponde ad un determinato punto nello spazio. È vero che l’orecchio spesso ci dice qualche cosa sull’ambiente donde i suoni ci pervengono, sulla direzione dalla quale partono, ma tutti sappiamo che questi dati sono trascurabili. Volutamente il grammofono e la 114 115 radio spesso non danno alcuna risonanza dell’ambiente e mai forniscono dati sulla direzione, ma registrano e riproducono solamente la distanza della fonte sonora dal microfono. In quell’ambiente dal quale i suoni giungono fino a noi, non vi è né destra né sinistra, né sopra né sotto, ma solamente vicino e lontano: eppure il nostro orecchio riceve un’impressione completa e soddisfacente. E quand’anche noi riconosciamo la direzione del suono, ciò non avviene mai a mezzo di una “carta topografica auditiva” (come è il caso dell’occhio) la quale attribuisce alle cose il loro posto, ma in modo che il suono singolo contiene delle qualità spaziali. (Tali qualità derivano o dal fatto che il suono, strada facendo, subisce modificazioni – fenomeno che corrisponde alla prospettiva aerea – o per mezzo di una “parallassi temporale” fra i due orecchi, dato che il suono, che arriva da una parte, giunge a un orecchio prima che all’altro). Poiché la direzione dalla quale il suono proviene non ha, come abbiamo detto, molta importanza, per il nostro orecchio bastano tre dati: il carattere fonico, il quale definisce la differenza di suono fra flauto, campanello, latrato o canto, e che si esprime nella forma della curva di vibrazione; l’ampiezza della curva, ossia l’intensità con la quale il timpano reagisce indica la forza del tono; mentre il terzo dato è l’altezza del tono, che si stabilisce dal numero delle oscillazioni. Per mezzo di questi tre fattori, vengono anche espresse le qualità suddette, che indicano la distanza o la “prospettiva”. Siccome gli intervalli fra i toni si distinguono mediante organi situati l’uno accanto all’altro, l’orecchio può registrare successivamente tutto ciò che caratterizza il suono in un momento dato. (Che anche l’altezza del tono abbia carattere d’un processo che si svolge nel tempo, non è a tutta prima facile a capirsi; ma la cosa è resa evidente dal fatto, che un tono ci pare più basso, se noi ce ne andiamo allontanando: effetto Doppler). Dato che tutti i suoni simultanei si fondono in una sola vibrazione, che solo nell’orecchio viene rianalizzato, basta un solo organo di trasmissione per il trasporto del tono. Nel campo ottico, alla stessa vibrazione corrisponde invece uno solo tra gli innumerevoli stimoli dei quali si compone l’immagine. Anche nel campo ottico, gli stimoli che colpiscono un solo punto possono caratterizzarsi in una successione temporale: al colore, – che sarebbe l’“altezza del tono” ottica, – corrisponde il numero di vibrazioni per minuto secondo; il grado di luminosità, – che sarebbe la “intensità del tono” ottica, – si definisce per l’ampiezza delle vibrazioni. Tutto ciò che si muove o si trasforma dinanzi agli occhi porta a modificazioni successive dei valori di colore e di luminosità in ogni singolo punto della rètina. Il mosaico di occhi isolati riuniti sulla rètina – e che nell’occhio umano si serve di una sola grande lente in comune, mentre nell’occhio dell’insetto vi è un grande numero di singoli occhi completi in sé e ciascuno munito di una sua propria lente – riproduce dunque con due dimensioni lo spazio a tre dimensioni, e per mezzo della dimensione temporale riproduce la componente “tempo” di ogni movimento. È questa la base sulla quale debbono fondarsi i metodi moderni di trasporto del suono e della luce attraverso lo spazio. Sappiamo che la trasmissione delle onde visive ed auditive non porta di per sé ad un risultato soddisfacente, neanche su una distanza relativamente piccola e quando la capacità dell’occhio e dell’orecchio è aumentata per mezzo di apparecchi ausiliari. Nel campo dell’ottica, la grandezza delle immagini sulla rètina dipendendo dall’angolo visuale, già ad una mediocre distanza gli oggetti diventano così piccoli da non poter più essere individuati. Questa è la ragione per cui un progresso decisivo fu possibile solamente quando si poterono stabilire relazioni esatte fra suono, luce e corrente elettrica. La corrente elettrica, infatti, si trasmette per mezzo di un filo o anche liberamente attraverso lo spazio senza andare soggetta a modificazioni essenziali: segue la curvatura del globo terrestre, e la sua velocità, praticamente, è infinita: talché ne risulta una simultaneità fra emissione e ricezione, restando così completamente superati spazio e tempo. In massima il trasporto del suono consiste in ciò, che le vibrazioni della membrana del microfono, causate dalle onde sonore, possono essere trasformate in oscillazioni di energia della corrente elettrica, la quale, dopo aver trascorso lo spazio imprime alla membrana ricevente (nel telefono o nell’altoparlante) per mezzo di un elettromagnete, le medesime oscillazioni che generano nuovamente il suono. La trasmissione della luce è basata sulla teoria della affinità fra luce ed elettricità, formulata nel 1871 dal Maxwell e negli anni seguenti controllata in via sperimentale da Heinrich Hertz: la luce non è che un’oscillazione elettromagnetica. Con l’aiuto della cellula fotoelettrica, che rappresenta per così dire il microfono ottico, una corrente elettrica viene “modulata” al ritmo delle onde ottiche; nel ricevitore poi, la lampadina incandescente, oppure il fascio di elettroni generante una luminescenza, trasforma nuovamente l’elettricità in luce. Se oggi ancora ci sembrano un paradosso la trasmissione di immagini per filo telefonico e la radiovisione, ciò è dovuto unicamente al fatto che non ci rendiamo conto come il diritto di primogenitura dei suoni sulla trasmissione elettrica sia soltanto fortuito, e come la trasmissione acustica non sia miracolo minore della trasmissione ottica. La corrente elettrica si può modulare con oscillazioni di qualsiasi curva, frequenza ed ampiezza. Essa è dunque in grado di riprodurre tutte le qualità essenziali dei fenomeni che sono da trasmettere. Le difficoltà specifiche della televisione consistono in questo, che un numero infinito di punti deve essere trasmesso simultaneamente. Si pensi che nell’occhio umano vi sono circa 130 milioni di bastoncini sensibili alla luce e 7 milioni di coni sensibili al colore. Sarebbe quindi necessario per ogni trasmissione un impianto di milioni di fili telefonici, milioni di stazioni radio ciascuna con la sua propria lunghezza d’onda? Fortunatamente l’occhio umano ha bisogno di un certo, benché minimo, tempo per passare da uno stimolo visivo ad un altro. Se i singoli 116 117 punti dell’immagine non si presentano all’occhio contemporaneamente, ma successivamente, con tanta velocità però da essere percepiti nel loro insieme nel frammento di un minuto secondo, l’occhio rimane contento e gabbato nell’illusione di una contemporaneità: vede cioè un’immagine completa. La soluzione del problema della televisione dipende dunque da ciò, che l’unico fattore di simultaneità contenuto nell’oggetto da trasmettere venga trasformato in un fattore di successione, e così reso trasmissibile per mezzo di un solo filo elettrico o di una sola stazione radio. Anche per un’altra ragione la trasmissione dei singoli punti del quadro esige una grande velocità. Gli oggetti nel campo visivo generalmente si muovono con tanta velocità che occorrono (ce lo insegna il cinema) da 16 a 24 fotografie al secondo per riprodurre i movimenti in un numero sufficiente di fasi e renderli naturali e non a scatti. Se il mondo fosse una tavola con sopra una dozzina di lumache, anche una frequenza minore sarebbe sufficiente. Non ci fossero nel mondo che piante, basterebbero delle istantanee eseguite a determinati intervalli di tempo, secondo il sistema dell’acceleratore cinematografico. Ma purtroppo nel mondo esistono uomini, veicoli, vento. Negli articoli che seguono è spiegato come oggi sia possibile, per mezzo dei raggi catodici, “esplorare” punto per punto il campo visivo 24 volte al secondo. Il raggio catodico è un indice di una sensibilità inimmaginabile, che non solamente si muove, guidato dalle forze di repulsione e di attrazione di due coppie di poli, sopra la superficie dell’immagine con la voluta velocità, ma è pure capace di cambiare d’intensità così presto, quanto occorre per produrre in ogni singolo punto dello schermo ricevente il grado di luce o di oscurità necessario. Questo nervoso tentacolo, organo sensitivo nuovo e caratteristico di una generazione frettolosa e raffinata, ci permette di scorgere immediatamente ciò che luoghi lontani ci offrono di visibile, o, per essere più esatti, piace loro di offrirci. Ma anche di fronte a questo miracolo, noi – padroni e in pari tempo vittime della tecnica – dobbiamo domandarci: che cosa vedremo? e ci gioverà vedere? Già sappiamo che le manifestazioni degli apparecchi di televisione saranno di due generi diversi. Potremo vedere ciò che avviene lontano, così come la radio ci fa sentire quello che si produce nella cabina di trasmissione, nel teatro lirico, nelle vie della città, in una assemblea politica. D’altra parte vedremo da lontano pitture e disegni, film, avvenimenti e spettacoli, così come la radio ci trasmette i dischi. Ancora non si può prevedere se la televisione avrà altre conseguenze per il cinema all’infuori di un semplice cambiamento nel modo di assistervi, vale a dire la sostituzione della proiezione nelle sale cinematografiche con la consegna a domicilio: cambiamento di portata sociale ed economica, ma non artistica. Il fatto di dover ridurre il quadro di proiezione, che sparirebbe dallo schermo gigantesco per contrarsi nel ricevitore su uno spazio di pochi decimetri quadrati, quale quello offerto dal fondo esterno del tubo catodico, non ha alcuna importanza. Primo, perché in arte una cosa piccola ha lo stesso valore di una grande; secondo, perché al quadro impiccolito corrisponde la maggior vicinanza dello spettatore; e terzo, perché in teoria nulla vieta di riproiettare le immagini ricevute dall’apparecchio su un altro schermo della grandezza desiderata. Conviene piuttosto esaminare se la televisione non interromperà del tutto la produzione di nuovi film. La giustificazione artistica dell’esistenza del film consiste nel carattere e nella scelta delle riprese, nel montaggio di scene girate in luoghi e tempi diversi, dopo una preparazione speciale, con mezzi speciali che hanno per risultato creazioni che si distinguono dalla realtà, rappresentandola, in una parola, artisticamente. Se per quanto abbiamo detto, la produzione del film può ritenersi esteticamente giustificata, il comune produttore cinematografico, alla domanda perché egli produca dei film, darà una risposta del tutto differente. Egli non parlerà del film come d’un mezzo di creazione bensì di diffusione, il quale offre la possibilità di presentare agli abitanti di tutto il globo sia contemporaneamente, sia successivamente, storie divertenti come la gente ama per passare la serata, benché gli attori debbano recitare una volta sola e quindi una sola sia la spesa di produzione. Se invece un nuovo mezzo tecnico permettesse di dare uno spettacolo al momento stesso della sua creazione, contemporaneamente ed immediatamente a tutti gli abitanti del mondo, non sarebbe resa del tutto inutile la registrazione su pellicola, ed il teatro universale senza filo non diventerebbe il tipo più indicato di rappresentazione? E quand’anche, come oggi avviene con le trasmissioni della radio, si dovessero replicare gli spettacoli ad uso delle singole stazioni trasmittenti, potrebbe la produzione cinematografica nella sua forma attuale fare ancora concorrenza al teatro radio tanto più economico e più comodo? Che, poi, ci sia una differenza fra cinema e teatro, non importerà molto agli impresari fino a che non importi al pubblico. Nemmeno un ottimista se la sentirebbe di affermare, che il pubblico aderisca al film come espressione d’arte: per il fascino del montaggio, dell’inquadratura, delle carrellate ecc. Gli intenditori stessi del cinema forse neppur loro diranno che temono la televisione, perché anche senza di essa il film è condannato. Il dialogo – essi dicono – avrebbe ridotto l’azione visiva sotto il giogo di un elemento non ottico, così da sopprimere il valore espressivo del movimento. Distrutto così il linguaggio visivo, anche inquadratura e montaggio avrebbero perduto il loro significato. I valori del chiaroscuro, lasciati relativamente intatti anche dal film sonoro, ormai per causa del film a colori sarebbero condannati a sparire: l’impiego del colore in fotografia sarebbe un problema artisticamente difficilissimo e forse insolubile, e quindi il film a colori praticamente annienterebbe l’ultimo residuo della costruzione volontaria dell’immagine, per non parlare del film stereoscopico e di quello a grande formato. La differenza tra cinema e teatro scomparirebbe lo stesso, 118 119 praticamente parlando, e perciò la televisione darebbe il colpo di grazia ad una agonia poco piacevole. Non bisogna tuttavia dimenticare che il cinema possiede due qualità predilette dal pubblico ed artisticamente importanti, ed alle quali il teatro difficilmente potrebbe supplire. Nel cinema il “cambiamento di scena” è facilissimo: senza la minima difficoltà l’azione passa di scena in scena, sopra anni, mari, continenti, e ne risulta perciò un grande divago. Inoltre il cinema dispone, per i suoi ambienti, di tutto il mondo: in ottanta minuti lo spettatore con Douglas Fairbanks fa il giro del mondo, vedendo non semplicemente fondali dipinti, ma la stessa realtà. Il cinema come descrittore va incontro alla curiosità delle masse avide di vedere, ma anche il cultore d’arte apprezza moltissimo questo elemento epico-naturalistico. È vero che la produzione cinematografica degli ultimi anni si è gradatamente liberata dagli “esterni” e tende ad attirare la realtà negli studi a mezzo di trucchi: il che costituisce senza dubbio un passo verso il teatro. D’altra parte il decadere e il falsarsi del vero che ne risultano, hanno condotto ad una reazione che tende al documentario ed incontra molte approvazioni. Potrebbe dunque avvenire, che anche per la televisione, si facesse uso di codesta tecnica cinematografica, per non perdere così belle qualità descrittive. Ma, per le ragioni già dette, anche questa non sarebbe più vera cinematografia. Sarebbe invece teatro: arricchito delle possibilità scenografiche del cinema, arricchito dei suoi sfondi autentici, del suo magico palcoscenico girevole; un teatro somigliante a quei prodotti pseudocinematografici, che al giorno d’oggi trionfano nel cinema. Alludendo al carattere documentario del cinema abbiamo accennato pure al suo valore come mezzo di informazione e di educazione. Questo valore non solamente non viene compromesso dai perfezionamenti tecnici, i cui effetti catastrofici sull’arte cinematografica abbiamo già denunciati, ma anzi molto aumentato. È evidente che dal punto di vista del documentario, un film sonoro, colorato, plastico è preferibile ad uno muto, bianco-nero, piatto; e l’effetto di un simile documentario come mezzo di appercezione diventa tanto più affascinante, quando, sfruttando l’apparecchio di televisione, ci dà la possibilità di vedere non solamente scene in scatola, ma anche d’essere testimoni di avvenimenti nello stesso momento in cui si svolgono. Con la televisione le possibilità documentarie della radio divengono gigantesche. Il mondo puramente uditivo è (e lo sanno bene i radioascoltatori) povero di qualità documentarie. I vantaggi dell’orecchio consistono nella ricezione di parole e di musica, insomma di prodotti dell’ingegno, ma molto meno nella ricezione di elementi della realtà. Senza la mediazione di uno speaker – della parola che illustra, dunque – la riproduzione di un fatto che la radio ci “trasmette” rimane povera fino all’incomprensibilità. E se col rumore di piedi in cadenza di marcia, con frammenti di musica militare, con un vociferare di folla, nasce in noi la visione di una enorme massa, che festosamente con migliaia di fiaccole passa per le vie oscure di una grande città, tanto da darci la sensazione d’esser presenti, qui è piuttosto la prova della nostra fantasia che non della ricchezza del quadro auditivo, fornitoci dall’altoparlante. Il nostro orecchio è prima di tutto un organo dell’intelletto, del cervello, ricevitore di elementi già plasmati. La vista invece è intuito, esperienza, raccolta di “materie prime” dei sensi. Con la televisione la radio diventa documentaria. Soltanto quando è diretta anche all’occhio, completa la sua funzione (forse non la sola e nemmeno la più importante) di farci rivivere visivamente tutto ciò che succede nel vasto mondo attorno a noi. Noi vediamo il popolo adunato sulla piazza della città vicina, vediamo parlare il Capo del Governo di uno Stato confinante, vediamo i pugilatori che combattono al di là dell’oceano per il campionato del mondo, vediamo un’orchestra-jazz inglese, una soprano italiana, un professore tedesco, i rottami incandescenti di un treno fracassato, le mascherate di carnevale, ammiriamo dall’aeroplano attraverso le nubi i ghiacciai delle Alpi, osserviamo dall’oblò di un sommergibile i pesci del mare, visitiamo una fabbrica di automobili, seguiamo un rompighiaccio alle prese con i ghiacci nei mari artici, ammiriamo il sole sopra il Vesuvio ed un secondo più tardi le pubblicità luminose di Nuova York notturna. Spariscono la mediazione della parola che descrive, la barriera delle lingue straniere, il mondo stesso nella sua vastità entra nella nostra stanza. In tal modo la televisione si dimostra una parente dell’automobile, dell’aeroplano, un mezzo di comunicazione spirituale. È un puro mezzo di trasmissione e non contiene, come il cinema e la radio “cieca”, gli elementi di una originale elaborazione artistica della realtà. Ma al pari dei mezzi di comunicazione, che ci ha regalato il secolo scorso, modifica i nostri rapporti con la stessa realtà, ci insegna a conoscerla meglio e ci lascia sentire la molteplicità di tutto ciò che avviene simultaneamente, togliendo (per la prima volta nella storia della nostra concezione del mondo) agli avvenimenti simultanei quel carattere di successione che era loro proprio per la lentezza del nostro corpo e la miopia dei nostri occhi. Da oggi viviamo e sentiamo ciò che finora solamente sapevamo. Abbiamo coscienza del punto di mondo nel quale ci troviamo, il quale non è che uno fra tanti altri; diventiamo più modesti, meno egocentrici. È vero che per questo risultato l’apparecchio di televisione non basta. Esso ci offre il materiale per estendere le nostre esperienze, perfino per conquistare una nuova concezione del mondo, ma spetta a noi di utilizzare questo materiale. La televisione significa una nuova immensa vittoria dei nostri sensi sopra lo spazio ed il tempo, ed arricchisce straordinariamente il mondo dei nostri sensi. Ma con ciò essa è, nello stesso tempo, un nuovo strumento di quel culto dell’appercezione per via sensoria, il quale – traendo origine dal lieto orgoglio procuratoci dall’invenzione della fotografia, del grammofono, del cinema, della radio – è così caratteristico per l’abito spirituale dell’epoca presente. Si pone in rilievo – e con molta ragione – il valore educativo dell’intuizione e dell’esperienza, dei viaggi e delle immagini, e si introduce nell’educazione scolastica la fotografia ed il cinema. In una rivista 120 121 di un Istituto dedicato al cinema educativo non c’è bisogno d’insistere sul valore della dimostrazione. Oggi non possiamo più renderci conto di quanto più concreto, più ampio, più immediato e fino ad un certo punto più esatto sia il concetto che del mondo si fa un uomo moderno, di quello dei suoi maggiori. Non dimentichiamo tuttavia che alla coltivazione dell’appercezione sensoria corrisponde un regresso della parola parlata e scritta, e si potrebbe credere, per conseguenza, del pensiero stesso. Più i mezzi di appercezione diventano facili ed accessibili, più si consolida in noi l’illusione pericolosa, che il vedere sia già conoscere. La televisione è una nuova dura prova alla quale viene sottoposto lo spirito umano: se questo riuscirà ad assimilare il nuovo mezzo e a farne un proprio strumento, ne sarà notevolmente arricchito; ma può anche accadere che ne sia indotto al sopore mentale e messo fuori corso. Non dimentichiamo che l’impossibilità per il riguardante di trasmettere altrui la propria sensazione visiva, e la necessità che ne risultava di comunicare per mezzo della parola e quindi di formare una lingua, hanno dato origine al più importante fra i mezzi di educazione dello spirito umano. Chi vuole descrivere, infatti, deve estrarre dal caso particolare l’universale, formare concetti, comparare, pensare; ma dove basta muovere un dito per indicare, può succedere che la bocca ammutolisca, la mano che scrive o che disegna si arresti, lo spirito deperisca. L’appercezione sensoria è formativa soltanto per colui che sa usarne. Un buon film d’insegnamento, ad esempio, non è unicamente un surrogato della visione diretta, ma presenta la materia già ordinata e chiarita. La materia prima è già passata per il mulino dello spirito: ecco perché è digeribile. La riproduzione meccanica della realtà abbisogna almeno di un commento, se vuol essere utile non soltanto a chi ha l’abitudine di pensare ma anche all’uomo comune. Così le trasmissioni per televisione di scene dal vero non saranno che riproduzioni meccaniche della realtà; e solo chi sappia pensare, dedurre, arrivare alla conoscenza, potrà trarne suggerimenti fecondi. Chi invece non sa, resterà tutto preso dalla radiovisione senza cavarne alcun utile. L’abbondanza e la varietà delle immagini lo confonderà: ammesso che, orgoglioso di tanta ricchezza visibile e troppo disavvezzo a concepire e assimilare, sia ancora capace di confondersi! Purtroppo c’è il pericolo che egli resti soddisfatto, soddisfatto come quelle vecchie zitelle inglesi, le quali, dopo un lungo giro del mondo, sbarcano nella stazione del loro paese nativo tali e quali l’avevano lasciata. Né si dimentichi che la cultura ha reso la sostanza della vita meno “visibile”. Pessimo attore, il mondo moderno fa vedere, è vero, la sua superficie variopinta, ma non fa conoscere a prima vista, né agli occhi né agli orecchi, la sua vera essenza. Se le “attualità” cinematografiche sono così poco utili, ciò non dipende né solamente dalla scelta dei soggetti, né unicamente da noi. Il carattere dell’attuale situazione mondiale, della crisi, di una forma di Stato moderno, non è immediatamente riconoscibile per mezzo dei sensi, come lo è il carattere di un uomo dal suo volto. Che giova osservare i sintomi esterni, se uno non è medico? Chi desidera com- prendere l’epoca presente, parli con il popolo, con gli industriali, legga le memorie dei diplomatici. Se l’apparecchio di televisione non vorrà limitarsi unicamente a farci vedere il mondo, ma anche farcelo capire, occorre che ci dia oltre alle immagini, al suono, ai rumori, anche la voce del commentatore invisibile. Che ci sia la parola, capace, volendo, di riportarci al concetto generale quando vediamo nell’immagine il caso particolare; alle cause, quando ne contempliamo gli effetti. 122 123 La televisione è un mezzo di diffusione. Emanano da essa conseguenze sociali in quanto rende l’oggetto della visione indipendente dal suo luogo di origine, e per conseguenza rende anche superfluo l’affluire del pubblico davanti all’“originale”. Emanano inoltre da essa conseguenze economiche, in quanto viene a sostituire altri mezzi di diffusione. Che la televisione farà concorrenza al cinema ed al teatro è fuori di ogni dubbio. Sappiamo che la radio ha aumentato l’interesse verso la musica e ha dato un certo impulso ad assistere a concerti e ad acquistare dischi, ma d’altra parte ha sostituito concerti e grammofoni e quindi sotto questo riguardo li ha danneggiati. Né si dimentichi che l’eccesso di offerta – nel senso quantitativo e qualitativo – da parte della radio, ha molto diminuito il valore ed il fascino della musica. Teatro, opera, operetta, cinema, sport sentiranno la concorrenza della radio solo nel momento che il radioascoltatore diventerà veggente. Tanto poco alla radio si potrà impedire la trasmissione di film, rappresentazioni teatrali, opere, corse di cavalli, quanto finora le si è impedito di trasmettere concerti e audizioni di radioteatro in séguito a proteste di musicisti e direttori di compagnie drammatiche. Per l’abbonato alla radio ci sono vantaggi e danni. Egli arriva con più facilità a divertirsi, elevarsi, istruirsi, ma avrà probabilmente una scelta più ristretta, e quanto gli viene offerto non può rispondere che in parte alle sue esigenze personali. Già oggi la differenza fra cinema e teatro, come fra concerti in sala e concerti alla radio consiste in questo, che invece di una rappresentazione diretta ad un numero limitato di spettatori, che prenda in considerazione gusto, livello culturale, individualità intellettuale etnico-geografica, viene offerto un prodotto normale corrispondente ad esigenze più generali, il quale, per essere adatto a tutti richiede sacrifici da tutti. La monopolizzazione della vita intellettuale, alla quale la radio tende evidentemente, non porta solo alla standardizzazione nel senso negativo della parola, ma agevola contemporaneamente quella unificazione della cultura del popolo che, al giorno d’oggi, sta a cuore ad ogni Governo che sappia interpretare lo spirito del nostro tempo. A tal uopo, è vero, è necessario che il cibo intellettuale offerto a tutti non venga volgarizzato con troppo riguardo per il cattivo gusto della maggioranza, come è accaduto col cinema. In questo senso la televisione porterà ad un contrasto interessante tra forze nemiche. È noto che il cinema, pur essendo un problema sociale della massima importanza, finora è sottoposto quasi dovunque all’influenza dello Stato solamente in senso negativo. Da impresa privata senza importanza il cinema si è sviluppato in modo così graduale fino a divenire un elemento cospicuo della vita pubblica, che lo Stato non ha saputo cogliere il momento giusto per impadronirsene. La produzione del cinema diretta da impresari abili, ma di pessimo gusto e di minima cultura, e affidata ad artisti in maggioranza più adatti a vedere che a sentire ed a pensare, non ha mai perduto un non so che di mondanità, di passione da salotto, di filosofia da caffè. La radio invece (in armonia al carattere della sua tecnica del tutto diversa) fin dal primo giorno si diede a conoscere con evidenza come uno strumento di monopolio riguardante le collettività, tanto che nella maggior parte degli Stati subìva l’influenza immediata dei Governi. È per questo, e perché non esiste una concorrenza che potrebbe adescare il pubblico con prodotti volgari, che il programma della radio fin da principio si formò avendo come mira la qualità e l’educazione del popolo. Sebbene tale mira non appaia sempre con sufficiente evidenza nella pratica, anche un rapido confronto fra i programmi del cinema e quelli della radio palesa a prima vista la differenza di livello (almeno in molte nazioni). In ogni modo, fu diverso il punto di partenza: se anche per ambedue i campi è caratteristico quel miscuglio di roba di valore e priva di valore, nel cinema ciò si verifica in modo che un’industria la quale si piega di regola alle predilezioni della folla, concede ogni tanto qualche piccolo favore agli “intellettuali”; mentre nella radio si creano serate di passatempo, come concessione a quel pubblico che protesta contro le sinfonie e le conferenze istruttive. La radio, dominio dell’orecchio e non dell’occhio, della parola, della poesia, della dottrina, della musica, era da principio il campo d’azione di istruttori, educatori, letterati, e come istituto statale diretto da funzionari (spesso anche burocrati), ma non da industriali. Dovessero per mezzo della televisione realizzarsi le nozze fra radio e cinema, scene in famiglia saranno inevitabili: perché l’impulso del voler capire cozzerebbe contro l’impulso del voler vedere, la parola contro l’immagine, l’arte contro il divertimento, l’educatore contro il mimo, il funzionario contro il “direttore di produzione”. L’esito di tale battaglia non è possibile prevederlo: ma questa battaglia – forse il più caratteristico fenomeno dell’avvenire – sarà molto istruttiva. La nostra rapida scorsa sarebbe incompleta, se non dessimo un’occhiata all’elemento antisociale proprio della radio. Abbiamo già detto che dal programma unico della radio può derivare la unificazione della cultura popolare, e negli ultimi anni abbiamo visto in casi significativi che con la trasmissione di dichiarazioni di Governi, sedute parlamentari, feste, processi celebri, il cittadino era portato a prendere una parte più immediata ai destini dello Stato e del popolo. In certo qual modo, il complicato sistema di tubature che gradatamente portava la corrente della vita pubblica dalla centrale nelle case particolari, fino ad un certo punto è sostituito da quello della “presenza senza fili” della collettività alle faccende dello Stato. Poco tempo 124 fa è accaduto in Germania che il Capo di quel Governo ricevette la notizia di un avvenimento politico di primissimo ordine (la votazione nella Saar) non prima di tutti, ma contemporaneamente a tutto il popolo tedesco per mezzo della radio; dopo di che egli tenne subito a tutto il popolo un suo discorso. Ma “contemporaneamente” e “insieme” non sono la stessa cosa. Se la radio porta nelle forme della vita pubblica un certo senso di familiarità, dispensa d’altra parte l’individuo dal dovere di riunirsi con i suoi cittadini per feste, per funerali, per imparare, per godere, per applaudire, per criticare. È certo che, considerando la sala da concerti o il teatro di oggi, non si può parlare che raramente, nel significato proprio della frase, di “sensazioni collettive”. L’uno siede accanto all’altro; ciascuno sente e vede per conto proprio, e la presenza di un altro gli è piuttosto molesta che simpatica. Una “prima” teatrale o un concerto sinfonico, come avvenimenti mondani, interessano più il sarto o il cronista che non l’uomo di cultura. Ma dovunque il pubblico ride, risponde, esulta, brontola, piange, prendendo parte alla rappresentazione, dovunque la ribalta non costituisce un confine fra attività e passività, ivi si forma dagli individui la massa e nasce qualche cosa che l’onda elettrica non può sostituire, né per l’ascoltatore e lo spettatore né per l’attore, l’oratore, l’insegnante. La televisione compenserà l’assenza corporea anche meglio che non abbia fatto sinora la radio, e con ciò il canale che divide l’isola sulla quale l’individuo si ritira e separa dalla comunità, diventerà più profondo ancora. E la “bilancia commerciale” – in senso spirituale – di tale isola, ne diventerà tanto più passiva: importazione di cose preziose da tutto il mondo, consumo senza contropartita. L’eremita che nella sua cameretta assiste alla rappresentazione, da cui lo separano centinaia e migliaia di chilometri, e che non può nemmeno applaudire senza rendersi ridicolo, è il risultato finale, lievemente grottesco, di un’evoluzione millenaria, che dal popolo riunito attorno al fuoco di un bivacco, sulla piazza del mercato, nell’arena, per la festa, per la danza, per le deliberazioni, ha tratto di più in più un “pubblico” e uno “spettatore”. Lo Stato moderno cerca di superare l’individualismo e di risvegliare il sentimento della collettività; tende a trasformare la burocratica macchina di Governo, alla quale il cittadino paga tasse quanto meno può per averne in cambio i maggiori vantaggi possibili, in un simbolo concreto della comunità. Lo Stato vuol salvare le forze creatrici dell’individuo, affievolite dalla divisione del lavoro, – le forze che sono artistiche, politiche, sociali, – prima che vadano definitivamente distrutte. Che questo Stato dia al nuovo e bell’apparecchio il suo giusto posto; compensi la passività con l’attività, così che quanto l’onda elettrica porta, in ogni casa, di tesori, non ammuffisca nel salvadanaro come capitale morto, ma diventi invece fruttifero. 125 L’Enciclopedia del Cinema «Intercine», 3, marzo 1935, pp. 130-138 È nata piccola, la grande Enciclopedia del Cinema la cui redazione l’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa sta portando a termine in questi mesi dopo un lavoro preparatorio di più anni. Quella raccolta di brevi “voci” esplicative dei principali termini tecnici del campo cinematografico, che in un primissimo tempo l’Istituto aveva rilevata da un Editore tedesco per completarla e pubblicarla in lingua italiana, avrebbe costituito già, nella sua forma originaria, una pubblicazione di mole considerevole. Ciò nonostante, se oggi ci avviene di ripensare a tale repertorio davanti all’ampio armadio zeppo di voluminose cartelle dattiloscritte, che rappresentano il materiale della Enciclopedia destinato alla stampa, quel nucleo iniziale ci appare come il microscopico germe di un organismo che, prima d’esser dichiarato degno di vivere, doveva ancora enormemente ingrandirsi, affinarsi, e darsi un’architettura. Non pochi sono i motivi che spiegano l’incontenibile accrescersi del lavoro durante le fasi successive della sua elaborazione: fatto, questo, certamente utile per un’opera che pretenda di essere non solo informativa, ma formativa e critica, e che tuttavia spaurisce, ruba tempo e richiede energia e nervi. Primo motivo: nel corso della difficile impresa venne via via delineandosi e concretandosi nei compilatori il sentimento di quale vasto compito, non mai prima affrontato e degno d’essere assolto, poteva spettare all’Enciclopedia: compito che superava di molto le intenzioni d’un modesto dizionario tecnico. Si trattava di dare il bilancio spirituale d’una manifestazione della cultura contemporanea, che durante gli ultimi trent’anni aveva influenzato quasi tutti i campi dell’attività umana e da quasi tutti aveva a sua volta ricevuto suggestioni ed influssi. Il vivo, plaudente interesse che in tutto il mondo aveva accolto l’iniziativa fin dal suo primo annuncio, l’ansia con cui se ne attendeva la realizzazione, dimostravano come fosse universalmente diffuso il bisogno di un’opera che investisse in pieno, sotto tutti i suoi aspetti, il grandioso fenomeno del Cinema. La lieta prontezza onde i più autorevoli competenti d’ogni Paese accettarono l’invito a collaborare col meglio della loro esperienza e sapienza, veniva d’altro canto a costituire un nuovo stimolo e ad implicare una più alta responsabilità. Proprio all’entusiasmo e all’eccellenza di questi collaboratori si deve in gran parte se l’opera è andata sempre più aumentando sia nel senso quantitativo che qualitativo, se il materiale primitivo è stato messo completamente da parte, e se insomma da un dizionario si è giunti ad una vera “Enciclopedia”. Primo requisito dell’opera dovendo essere l’equilibrio tra le varie parti e l’omogeneità del carattere, così un’ampia “voce” riflettente un campo particolare e svolta da un elevato punto di vista spirituale, poteva trovarvi posto soltanto a patto che il livello generale vi corrispondesse. 126 127 Praticamente detto: accanto a una voce “Trasporto della pellicola”, contenente i più minuti calcoli atti a mostrare di quanto proporzionalmente la tensione di trazione della pellicola sia minore tra foro e foro che nella superficie centrale, non si poteva mettere una voce “Film storico” dove era detto in cinque righe che si trattava d’una specie assai diffusa di film teatrale, in cui episodi della storia si trovavano rappresentati da attori in costume dell’epoca; non si potevano mettere, accanto al brillante saggio polemico d’un teorico di fama mondiale, le scarne definizioni del tecnicismo empirico. Così l’Enciclopedia del Cinema riceveva, tanto dall’esterno come dall’interno, sempre nuovi impulsi ad allargarsi e completarsi; così tornava sempre a sconfinare dai limiti che le erano stati assegnati; ogni volta sembrava quasi finita e quattro settimane dopo appena incominciata; né colmava a poco a poco, automaticamente, un’impalcatura prestabilita, ma cresceva come il crostaceo, che ogni tanto spacca la propria corazza divenuta troppa stretta, e l’abbandona. Quanto più complessa si faceva l’opera, tanto più prendeva il carattere d’un lavoro collettivo. E ciò non soltanto nel corpo della redazione, con l’aumento progressivo del personale addetto, ma anche per il sopravvenire di un’attiva collaborazione da parte di organizzazioni varie, istituti scientifici, case produttrici e costruttrici di tutto il mondo (come, ad esempio, le rappresentanze professionali dell’industria dei diversi paesi, l’Agfa, la Telefunken, il Museo di Storia Cinematografica di Los Angeles, l’Istituto Nazionale di Ottica di Firenze, per nominarne soltanto alcuni, e per tacere di tutti i singoli collaboratori, fra i quali si trovano vere illustrazioni dell’arte, della tecnica, della scienza e dell’industria). Non bisogna neppure dimenticare che era impossibile, – come sarebbe stato, invece, facile per la compilazione d’un manuale medico, d’una grammatica o d’un dizionario di consultazione, – desumere da lavori già esistenti, come base di operazione, un piano generale dell’opera e un elenco dei singoli argomenti da svolgere: si trattava, qui, d’un tentativo senza precedenti di raccogliere e coordinare tutto ciò che, direttamente o indirettamente, riguarda il Cinema. Quel tanto che si trovava erano per lo più concetti imprecisi e casuali, nati dalla pratica quotidiana e non elaborati in definizioni scientificamente esatte: difettosi quindi, diversi a seconda dei diversi idiomi, dell’abito mentale, del grado di cultura. È vero bensì che, per molti campi speciali, v’erano ricerche e trattazioni approfondite: ma la diversità dei punti di vista in esse adottati e il fatto della rigida specializzazione impedivano di utilizzare codesti studi senza sottoporli ad una radicale armonizzazione. Spesso, per definire la stessa cosa, s’incontravano cinque o sei vocaboli pressocché sinonimi, i cui significati interferivano senza però combaciare esattamente. Occorreva, in questo caso, trovar modo di mettere d’accordo i due obblighi di una buona enciclopedia: quello di spiegare tutti i termini usati nella pratica, e quello, anche più importante, di trovare per ogni cosa una (e soltanto una) denominazione adeguata. Difficoltà del genere si presenteranno fatalmente ogni qualvolta si tratti di descrivere per la primissima volta, e con dettagliata precisione scientifica, un elemento del nostro mondo e della nostra vita. Ciò che è finora cresciuto liberamente deve, per la prima volta, essere considerato nelle leggi della sua natura, nella sua struttura e nei suoi limiti. Né basta: per diversi campi speciali ci si avvedeva ora, nel vagliare i dati disponibili, che non sempre questi erano documenti seri, da servirsene come base ad affermazioni indiscutibili. Se quelle notizie non controllate erano state tollerabili fin qui per le normali esigenze giornalistiche e propagandistiche, si dimostravano, per un’opera seria, affatto insufficienti. Ciò vale per le cifre statistiche (per quelle in particolare che riguardano il commercio e l’industria), per le indicazioni sulla vita e sull’opera di registi, attori, produttori, e specialmente per la preistoria e la storia iniziale del Cinema: così, se si trovava in quattro diverse opere che il padre Athanasius Kircher era stato l’inventore della lanterna magica e che Plateau aveva chiamato “fenachistoscopio” la sua “ruota vivente”, si poteva esser certi di leggere nella quinta che il Kircher non aveva dato nulla più d’una difettosa descrizione d’una invenzione altrui, e che Plateau aveva respinto il nome di “fenachistoscopio” come quello di un tardo prodotto della concorrenza commerciale. E poiché l’Enciclopedia, se non si voleva andar vagando all’infinito, doveva soltanto per eccezione lasciarsi trascinare ad una vera e propria indagine sulle fonti, ma limitarsi in genere ad una compilazione, anche se di carattere critico, delle ricerche precedenti, ci si trovava spesso dinanzi a dubbi e difficoltà di soluzione tutt’altro che agevole. Non esisteva base alcuna per impiantare un catalogo generale delle “voci” da trattare: così dall’accanito spoglio di libri e riviste fu a poco a poco creato empiricamente un elenco, che non potrà tuttavia considerarsi finito prima del termine dell’Enciclopedia stessa, soprattutto perché l’arrivo di ciascun contributo apre ulteriori prospettive su soggetti e quindi su “voci” nuove. Così, soltanto quando una parte considerevole di tutto il materiale fu raccolta, o per lo meno affidata a specialisti, si poté pensare a sostituire il primo, provvisorio e grossolano raggruppamento delle “voci” di ciascun campo con una sistematica precisa: il che significa che fu necessario adattare posteriormente a detta sistematica tutti i testi e gli elenchi di voci già pronti. Compiuto questo passo decisivo, il panorama che si presentava era bello ma allo stesso tempo preoccupante: si sapeva ora quali erano gli argomenti da trattare e in quale rapporto stessero fra loro, ma in pari tempo si vedevano con molta precisione le lacune ancora restanti. Due ragioni particolarmente avevano reso ardua la creazione di una sistematica, e quindi dell’opera stessa. Primo: si trattava di considerare il fatto cinematografico sotto l’aspetto economico, tecnico, spirituale, artistico, storico, giuridico, scientifico, sociologico e politico, e moltissimi dei concetti singoli di ciascun campo andavano svolti da parecchi di questi punti di vista, se non da tutti. Un’immagine veramente viva e fedele del Cinema, quale esso si presenta in concreto, avrebbe potuto essere ottenuta soltanto a patto di non descriverlo da ciascuno di tali punti di 128 129 vista, ma attraverso il tentativo di rappresentarlo organicamente sotto l’influenza simultanea di fattori così diversi. Se non si voleva apparire astratti, bisognava considerare l’aspetto artistico insieme a quello tecnico, il sociale insieme all’economico, l’applicazione pratica insieme al principio scientifico. La maggior parte dei collaboratori essendo per l’appunto formata da specialisti delle singole branche, il lavoro fu distribuito a tecnici, scienziati, esteti, giuristi ecc., mentre il coordinamento e la fusione di tutto questo materiale, l’armonica rielaborazione, l’unità della terminologia e il gioco dei rimandi spettavano, compito tutt’altro che semplice, alla redazione centrale. L’ufficio creato a tale scopo ha dovuto e deve assolvere a funzioni di assai vario carattere. La rielaborazione del materiale, confluente da sorgenti così lontane e diverse, esigeva da parte del corpo redazionale conoscenze in tutti i campi del Cinema. Venendo in luce contraddizioni, incertezze relative a dati o a date, erano necessarie lunghe e spesso difficili ricerche nella bibiblioteca e nell’emeroteca dell’Istituto o a mezzo d’altre fonti d’informazione. Bisognava anche controllare attentamente se dal complesso del materiale risultava veramente una ricostruzione senza lacune di tutti gli innumerevoli argomenti che determinano, nel loro assieme, la fisionomia del Cinema. Si trattava di procurar buone traduzioni dalle varie lingue, di testi difficili e di carattere molto diverso, e di compensare quanto potesse trovarvisi di unilaterale a favore di determinate tesi, nazioni, case produttrici ecc. Per parecchi campi vennero distribuiti ai collaboratori esterni dei piani, dettagliati e precisi, da tener presenti nello svolgimento del loro lavoro. La maggior parte, infine, delle “voci” non richiedenti un esperto specializzato, venne compilata in seno all’Istituto stesso. Il secondo problema che si presentò fu il seguente: in linea di principio fu scelta la successione di “voci” singole, così da poter presentare al lettore trattazioni brevi, isolata ciascuna in se stessa, anche di concetti o fatti particolari. Ma in pari tempo si dovevano render palesi i rapporti di parentela fra ciascuna voce e le altre, e specialmente anche la subordinazione tra voce e voce. Dal momento che si trattava di una “gerarchia” di voci, dalle più generiche e late giù giù fino alle più particolari, e dal momento che ciascun gruppo di voci e ciascuna voce isolata rientrano in gruppi e classificazioni logicamente più comprensive, il pericolo delle ripetizioni e di una errata “dosatura” nel trattarle era grande. Nella voce “Otturatore”, per esempio, questa parte della macchina da presa appare per così dire in “primo piano”: dettagliata, isolata, se anche descritta con riferimento a quell’intero di cui fa parte. Nella voce “Presa cinematografica” l’otturatore appare di nuovo, ma questa volta come un punto minuscolo in mezzo a un “campo lungo”: perché questa volta si descrive non la cosa in sé, ma il luogo che essa occupa, la sua funzione nel complesso della macchina da presa. La tabella che pubblichiamo mostra i quarantaquattro campi generali nei quali si divide, idealmente, l’Enciclopedia. Tabella che basta a suggerire il complicato sistema di coordinamento e di dipendenza, che continua poi all’interno di ciascuno dei quarantaquattro campi. Ogni campo comprende infatti almeno una cosiddetta “voce madre”, che ha l’ufficio di dare una visione panoramica del complesso del campo stesso, di rimandare alle voci singole da essa dipendenti, e di chiarire i reciproci rapporti fra tali voci. Spesso si tratta di più “voci madri”, che si dividono tale funzione; spesso anche voci secondarie fungono per parte loro quali “voci madri” per determinati sottogruppi. Le “voci madri” rivestono talvolta il carattere di una vasta e completa monografia, mentre in altri casi non sono le più estese nel campo cui si riferiscono. Fra le voci che trattano un argomento singolo e relativamente isolato alcune, infatti, sono molto diffuse; alcune, al contrario, non danno che l’essenziale con una breve definizione, quando ciò sia consentaneo al carattere dell’argomento. Si va così da trattati voluminosi come un libro a semplici voci di rimando, che in tre parole avvertono il lettore come un determinato concetto si trovi svolto in altra parte dell’opera sotto altra denominazione. La cifra totale delle “voci” ascende a parecchie migliaia. È qui opportuno soggiungere che la nostra tabella sistematica pone in luce particolarmente i concetti relativi alla pratica cinematografica: talché la reale estensione della parte di carattere scientifico non vi figura secondo la sua effettiva importanza e sviluppo. Ciò che la tabella si limita a chiamare: “Ottica generale, Chimica generale, Elettroacustica generale, Elettrotecnica generale”, rappresenta in realtà quattro campi di eccezionale ampiezza, e ciascuno dei quali ha una propria struttura profondamente studiata. Ogni campo è stato trattato da specialisti con un notevole sviluppo di formule, grafici, fotografie, in modo da far corrispondere ad ogni concetto della pratica l’illustrazione della sua base scientifica. La caratteristica dell’ordinamento sistematico è che in esso, – eccezion fatta per alcuni argomenti di natura astratta e particolarissima, – diversi punti dai quali uno stesso concetto può essere esaminato (tecnica, estetica, economia, diritto ecc.) non si trovano separati, per le ragioni espresse, l’uno dall’altro, come a prima vista potrebbe sembrar più opportuno. Così, ad esempio, nel complesso “Sala di proiezione” si trova tanto l’estetica della facciata di un cinema quanto le scale di sicurezza, tanto il divieto fatto ai minori di assistere a talune proiezioni quanto la disposizione delle poltrone, tanto il sistema di programmazione a due grandi film quanto l’acustica spaziale. Soltanto l’intreccio di cento concetti di questo genere può circoscrivere e definire il vivo fenomeno “Sala di proiezione”. E se anche il raggruppamento sistematico è destinato a scomparire nella definitiva sistemazione alfabetica, è stato esso tuttavia a condizionare l’elaborazione complessiva del materiale: ed è quindi da sperare che ne resti il segno nell’impianto di ciascuna voce isolata. Si voleva, così operando, rispecchiare la molteplicità di aspetti e la complicata ossatura tecnica del Cinema, le quali rendono così pieno di imprevisti e di ostacoli, così disperatamente arduo ogni lavoro in questo campo. In generale, del resto, stava a cuore ai compilatori di non cader 130 131 mai nell’aridità del repertorio, ma di offrire una rappresentazione quanto più possibile piena di vita e di carattere d’un argomento profondamente legato alla pratica. È anche per questo motivo che molte “voci”, specialmente quelle più vaste e che recano firme di particolare autorità, hanno un carattere decisamente personale: esse vogliono dare sì un’informazione esauriente, ma sono nello stesso tempo soggettive e spesso polemiche. Esse vogliono non soltanto documentare, ma dare in pari tempo delle norme e indicare nuove vie, rinunciando all’apparenza di una “obiettività” incompatibile con un buon livello spirituale, e che potrebbe condurre soltanto alla noia. Vogliono nello stesso tempo non chiudersi nel professionalismo, ma interpretare il Cinema, per poterlo giustamente inquadrare, come un tipico settore dell’attività moderna. In tutto, saranno alcuni grossi volumi che, adorni di migliaia d’illustrazioni, rappresenteranno un’opera degna di restare soltanto se in essa non ci si limiterà a parlare del Cinema ma si terrà conto dello spirito che lo anima. una buona parte del suo lavoro di trucchi gli venga sottratta dalla stampatrice ottica. «Gli operatori hanno superato oggidì i problemi tecnici del film sonoro, così come ieri avevano superato i problemi del materiale pancromatico in collaborazione con gli ingegneri delle fabbriche di lampade da illuminazione, con i chimici, e con i coaudiutori tecnici delle case di produzione della pellicola vergine». Trucchi A proposito della sceneggiatura del film: La vita privata di Enrico VIII, pubblicata poco tempo addietro in volume dall’editore londinese Methuen, G. F. Dalton («Cinema Quarterly», Londra) ha calcolato che questo film comprende soltanto 239 inquadrature di scene, mentre film come L’amore di Giovanna Ney o Tempeste sull’Asia ne avevano circa 2.000. Di queste 239, ben 76 sono mute e rappresentano, quasi tutte, riprese di dettagli poco importanti. Nelle restanti 163 tutto si riduce, quasi esclusivamente, al solo dialogo. «Queste cifre – soggiunge il Dalton – ci danno un’idea fino a qual punto l’orecchio abbia invaso la provincia dell’occhio. La maggior parte dei metodi, dai quali l’arte cinematografica in senso proprio trae i suoi effetti, sono qui necessariamente esclusi. Una lunghezza media di scena di 20 secondi non consente il taglio rapido, e dove non c’è taglio rapido anche il taglio lungo non ha più senso». Tale è la situazione non soltanto in riguardo all’Enrico VIII ma, come è noto, anche in riguardo al film teatrale comune; ed è molto caratteristico come, per esempio in Germania, nel momento attuale si discuta a fondo di Estasi del Machatý in tutte le disquisizioni teoriche, e ciò probabilmente non perché si tratti di un’opera d’arte singolare, ma semplicemente perché in essa, fatto ormai rarissimo, c’è uno che parla in linguaggio cinematografico. D’altra parte «Filmtechnik» (Berlino) osserva, nell’introduzione sulla tecnica di ripresa di nuovi film, come l’arte dell’operatore si trovi oggi in uno stadio di rinascimento, anche se ormai L’arte dei trucchi di ripresa riguarda oggi, per lo più, due campi: le “riprese combinate” e quelle con modellini. In riguardo alle prime H. G. Tasker nota in un suo articolo: Lo sviluppo dei metodi di produzione a Hollywood («Journal of the Society of Motion Picture Engineers», Easton) che la proiezione sullo sfondo abbia ormai sostituito il metodo della separazione di colori tipo Dunning. Anche il vecchio trucco di combinare una scena dipinta con una scena “vera” torna in onore, a quanto risulta da un saggio di Arthur J. Campbell nell’«American Cinematographer» (Hollywood). La parte dell’immagine che dovrà eseguire il pittore viene esclusa con un mascherino, posto nella macchina, dalla ripresa della scena. Un fotogramma singolo della scena stessa viene poi sviluppato, stampato e proiettato sopra uno schermo di 75 x 100 cm. Le parti dell’immagine proiettata lasciate in bianco, il pittore le colma poi col suo pennello, e tale dipinto viene fotografato sullo stesso negativo dove già si trova fissata la ripresa della scena. A. von Barsy, per il film Acqua morta che come si sa gli ha fruttato alla Biennale di Venezia il premio per la migliore fotografia cinematografica, ha combinato una diapositiva su vetro contenente la fotografia di grosse nubi con una ripresa cinematografica del mare, in modo da esprimere nel modo più plastico il senso opprimente degli statici nuvoloni sulla massa mobile delle acque. Una mezza lente biconvessa gli servì per compensare la differenza di messa a fuoco fra paesaggio e diapositiva («Die Kinotechnik», Berlino). I modellini si usano per risparmiare le costruzioni costose in grandezza naturale. Ma oggi, si risparmia perfino sui modellini: la battaglia navale di Azio è stata combattuta nella Cleopatra di Cecil DeMille con due sole minuscole navi; la scena fu arricchita mercé una plurimpressione e proiezione sullo sfondo, e si moltiplicò il numero delle navi all’infinito facendole muovere fra specchi paralleli («American Cinematographer»). Questo metodo d’una fittizia produzione in serie non potrebb’essere estensibile ad altri campi e di sapore molto attuale? Nelle “riviste” cinematografiche, per esempio, le differenze individuali fra le varie girls presentate in fila costituivano finora un fattore di disturbo addirittura vergognoso rispetto ai modernissimi metodi di confezione del film; ora, non si potrebbe specchiare cento volte una sola e ben costruita ragazza, presentando così allo spettatore, finalmente, quel prodotto standard di bellezza che non si era mai riusciti ad offrirgli? 132 133 Espressione «Intercine», 3, marzo 1935, pp. 164-167 Illuminazione Mediante la fotocellula, che ha dato origine, fra l’altro, alla costruzione di speciali fotometri, si può oggi regolare automaticamente, in rapporto ai mutamenti dell’intensità di luce solare, il tempo di esposizione e l’apertura del diaframma nelle riprese all’aperto. A un tale metodo propone di ricorrere Heinz Linke («Filmtechnik») per risolvere il problema, molto interessante dal punto di vista culturale, di cinematografare mediante l’acceleratore la costruzione di edifici (nell’articolo Più cinema nella scienza, che contiene un rapido quadro dell’applicazione del rallentatore, dell’acceleratore, della Röntgencinematografia, del film a colori ecc. nella scienza e nella tecnica). Come si sa, l’illuminazione rappresenta la vera difficoltà di tutte le riprese ad acceleratore, inquantoché, a causa dei lunghi intervalli fra le singole riprese, essa comporta non un cambiamento graduale d’intensità ma un cambiamento a scatti. Ora, se si usa il regolatore automatico sopra menzionato, basta accorciare il settore dell’otturatore e il diaframma all’intensità minima dell’illuminazione. Quando poi l’illuminazione sorpassa questo minimo, il regolatore comandato dalla cellula fotoelettrica restringe automaticamente il settore e il diaframma al grado di apertura necessario. Una cosa tuttavia nella quale nessun apparecchio meccanico potrà sostituire l’uomo, è l’arte di determinare il carattere d’una scena e dei personaggi che vi figurano mediante un giusto impiego delle lampade e l’intelligente collaborazione fra tecnici dell’illuminazione e della ripresa. Il lavoro dell’operatore moderno non si esaurisce affatto nella creazione di quadri “belli” e di effetto ornamentale, ma ha anche e soprattutto una funzione drammatica, caratterizzante, entrando così in modo decisivo nel campo della vera e propria regia. L’operatore è il regista della luce: egli dev’essere d’accordo col “regista superiore” sul modo d’interpretare l’azione e i personaggi, se si vuole raggiungere un risultato unitario. Victor Milner, operatore di Ernst Lubitsch, dimostra nel suo ultimo articolo: La creazione dell’atmosfera mediante l’illuminazione («American Cinematographer») fino a qual punto il compito dell’operatore sorpassa il semplice fatto d’illuminare la scena e di registrarla. Egli ha voluto, per il film Le Crociate di DeMille, porre in rilievo quanto vi è di eccezionale nelle figure dei due protagonisti, Riccardo Cuor di Leone e il Sultano Saladino, mettendoli in forte contrasto luminoso con l’ambiente in cui operano e che affonda nell’ombra («La forza di carattere dei due personaggi può essere espressa tanto attraverso l’illuminazione come attraverso il dialogo e l’azione»), mentre ha espresso il tipo di donna fragile, eterea dell’epoca dei cavalieri, con una luce morbida e tenera. Si vede come l’illuminazione determina qui addirittura la concezione fondamentale del soggetto, ed è soltanto da deplorare che un lavoro di mestiere, il quale dimostra tanta intelligenza e sensibilità, non venga quasi mai posto al servizio d’uno spirito che sappia sfruttarlo a scopi più elevati. 134 Tecnicamente è interessante che, secondo il Milner, l’atmosfera propria di una scena viene espressa non tanto dall’intensità della luce quanto dall’equilibrio delle luci e dall’applicazione della luce diffusa. Milner preferisce di dar luogo alla luce diffusa per mezzo delle lampade anziché per mezzo della macchina da presa, divenendo così possibile un gioco di rapporti più personale, specialmente per quanto riguarda la relazione fra primi piani e campi lunghi. Si adotti perciò nella fotografia un grado di diffusione costante, e venga variata l’illuminazione a seconda della scena. «Così mi pare anche più giusto cambiare, quando si muta il punto di presa, la diffusione della luce e il concentramento del fascio dei proiettori, anziché sostituire gli aggregati di lampade con altri più grandi e più piccoli e di diversa reazione attinica». Quanto alla posizione delle lampade, anch’essa deve possibilmente rimanere la stessa durante una sequenza di scene: regola questa che purtroppo è di rado seguìta nei primi piani. Scenografia Nulla quindi di più logico che il Milner pretende che si dia all’operatore il modo di familiarizzarsi col soggetto del film nella prima fase dell’elaborazione e di determinare insieme al regista, allo scenografo e al vestiarista, i punti fondamentali e i dettagli della ripresa. La stessa cosa che per l’operatore vale per lo scenografo. La scenografia è forse l’elemento teoricamente e praticamente più trascurato dell’arte cinematografica. È perciò da raccomandare la lettura dell’eccellente articolo: Il compito dello scenografo di Alberto Cavalcanti in «Cinema Quarterly». Da questo scritto risulta molto chiaramente che la scena cinematografica non dev’essere concepita come un pezzo d’architettura indipendente, ma dev’essere, al contrario, costruita in stretto rapporto con l’obbiettivo, l’inquadratura e l’illuminazione. Ciò significa che anche qui è necessaria una profonda collaborazione col regista e con l’operatore: come, del resto, il problema fondamentale della produzione cinematografica consiste nella distribuzione di un unico processo creativo a più persone, che non sono soltanto esecutori meccanici ma collaboratori artistici. Troppo spesso ancora, dice Cavalcanti, la scenografia cinematografica viene affidata a pittori, architetti, decoratori e scenografi di teatro, i quali non hanno la minima idea dello speciale compito dello scenografo cinematografico. «Prima regola: la scena cinematografica dev’essere costruita in modo che la si possa bene illuminare». Molti scenografi infatti hanno dato cattiva prova solo per aver trascurato di adeguarsi al progresso della tecnica dell’illuminazione. «La luce ad arco, dura e bianca, e le lampade a mercurio del vecchio cinema rendevano la fotografia molto dura e ricca di contrasti. Con l’avvento della pancromatica e degli obbiettivi grandangolari si passò alla luce ad incandescenza, più morbida e che dà un’immagine meno definita. Questo cambiamento si sarebbe dovuto compensarlo, dove era necessario, con una scenografia più dura e profilata. Invece, 135 per mancanza d’iniziativa da parte degli scenografi, tutte le scene hanno oggi lo stesso monotono aspetto di morbidezza delle panoramiche e delle carrellate. Quegli ambienti mastodontici, infine, che si usa costruire per sbalordire il pubblico, possono esser benissimo sostituiti da ambienti di proporzioni minori, sol che si applichino gli obbiettivi grandangolari, senza perciò dover rinunciare all’effetto desiderato. Un ambiente più piccolo non è soltanto meno costoso, ma facilita anche al regista e agli attori la composizione spaziale». Cavalcanti accenna infine all’importanza drammatica ed atmosferica delle linee principali di contorno della costruzione scenografica, così come esse risultano nella prospettiva di una inquadratura determinata e non «in sé»; e arriva a concludere che bisogna passare dalla scena costruita sul tipo teatrale al «Camera Set», ossia alla «costruzione scenica per macchina da presa». 16 mm e 35 mm Il cinedilettantismo non è soltanto un divertimento privato. Nell’avvenire accadrà ad esempio, sempre più spesso, che un dilettante faccia per caso, o sulla base di particolari possibilità, delle riprese d’interesse generale. Così si sono viste, nei giornali d’attualità americani, delle riprese che il colonnello Lindberg aveva fatto del suo bambino; e anche le isole Galapagos sono state registrate per i curiosi contemporanei da un amatore, lo scienziato G. Allan Hancock («American Cinematographer»). In ambedue i casi si trattava di riprese a 16 mm, che, ingrandite per gli scopi dei giornali d’attualità a formato normale, risultavano abbastanza granulose. Migliori risultati si ottengono naturalmente con processo inverso: cioè col rimpicciolimento delle pellicole normali al formato dei proiettori a passo ridotto. «Si può o partire da un negativo a 35 mm e far poi passare ogni positivo a 16 mm traverso la stampatrice ottica; o si può fare da una copia campione a 35 mm un negativo a 16 mm mediante riduzione ottica, e stampar poi da questo, per contatto, le copie a 16 mm. Le immagini che si ottengono dalla diretta riduzione ottica della pellicola a 16 mm risultano molto meglio, specialmente in riguardo alla granulosità». (E. W. Kellogg: L’evoluzione del film sonoro a 16 mm, «Journal of the S.M.P.E.»). sità dei dilettanti, e si arriva così, in meno di dieci minuti, a registrazioni pronte per essere eseguite e che possono essere usate fino a 200 o 300 volte. Il metodo di adattare l’immagine al suono è un avanzo dell’epoca dei vecchi film sonori a disco, da quando, al principio del secolo, era ancora necessario cantare o parlare molto da vicino nella tromba del grammofono se si voleva arrivare ad una ripresa sonora utilizzabile. Negli ultimi anni si usò il prescoring per i film disegnati (film astratti per illustrazioni di brani musicali, disegni animati ecc.) sincronizzando i movimenti delle figure, e specialmente i movimenti della bocca, al suono registrato prima. A questo proposito ricordiamo che i fratelli Diehl, due produttori di film di marionette, muniscono ogni loro fantoccio di sei o sette mandibole cambiabili onde poter rendere nel modo più naturale i movimenti delle labbra e della bocca nei dialoghi. I fratelli Diehl hanno già pubblicato una serie di allegri film di marionette, per i quali hanno scritto essi stessi lo scenario. Alcuni di tali film sono accompagnati da musica sintetica secondo il metodo di Rudolf Pfenninger. All’inizio i Diehl producevano disegni animati specialmente per uso pubblicitario, e fecero anche un film a ombre cinesi: Il califfo cicogna, lungo 1.200 metri. («Filmkurier», Berlino, n. 43). Gags A proposito del gag, di cui si tratta largamente in altra parte di questo fascicolo, e del film Il figliuol prodigo che interessa tanto e giustamente la critica (se ne parlerà nel fascicolo di aprile), vogliamo citare un adatto esempio del trapasso d’una trovata comica al campo drammatico. In una delle scene più interessanti del Figliuol prodigo si vede come il poliziotto, dopo lunga caccia, trovi il disoccupato che divora con avidità la pagnotta rubata; il poliziotto scrolla le spalle e se ne va. Ora, in un vecchio cortometraggio grottesco, La strada della paura, il poliziotto Charlot sorprende una povera donna che si nasconde impaurita sotto al grembiale un prosciutto rubato: Charlot, commosso, comincia a singhiozzare, corre ad una vicina “bancarella”, afferra tutto quello che può, e torna a versare la provvista nel grembiale della povera donna. Non è privo d’interesse un confronto tra il poliziotto che scrolla le spalle di Trenker e l’ingenuo rivoluzionario di Charlot. Il suono comanda Espressione Le scene che si basano sopra un ritmo musicale vengono per solito eseguite così: si suona, mentre vien girata la scena, la parte sonora ripresa prima, adattando i movimenti degli attori, generalmente dei danzatori, alla musica. I dischi usati per tale scopo richiedevano finora un tempo di fabbricazione dalle 6 ore fino ai due giorni, se dovevano consentire un uso replicato reso necessario dalle innumerevoli prove che precedono la ripresa. Oggi, come riferisce H. G. Tasker nell’articolo sopra menzionato del «Journal», a Hollywood si ritorna ai dischi di celluloide in uso anni addietro per curio- Gli esperimenti da più di ottant’anni iniziatisi per la realizzazione di immagini stereoscopiche, dei quali nuovamente tanto si parla in occasione degli ultimi lavori di Louis Lumière, non hanno fino ad oggi portato 136 137 «Intercine», 4, aprile 1935, pp. 225-227 a nessun decisivo progresso. A prescindere dagli effetti risultanti dal carattere dell’immagine stessa, la visione stereoscopica dei nostri occhi si basa su tre fattori: 1) Dato che ciascuno dei nostri occhi vede da un punto differente dall’altro, ci risultano nella prospettiva due differenti visioni della medesima scena; l’assimilazione psichica di queste due differenti immagini, fuse in un insieme unico, dà l’impressione della dimensione spaziale; 2) Quando i nostri occhi volgono lateralmente lo sguardo verso un determinato punto di fissazione, l’angolo fra le assi ottiche è tanto più grande quanto più vicino è il punto di fissazione; 3) Il cristallino, adattando la sua curvatura in modo che i raggi luminosi provenienti da un punto del piano di fissazione vengano nuovamente raccolti in un punto della retina (accomodamento), produce sulla medesima un’impressione nitida. Per i casi 2 e 3 possiamo supporre che lo stimolo psichico, provocato dall’accomodamento fisiologico dell’occhio, la risultante “tensione”, cioè, di differente intensità, serva come indice della distanza spaziale degli oggetti osservati. Vasco Ronchi, in un suo recente studio su La visione stereoscopica (Numero unico dell’Annuale 1934 della Società Ottica Italiana, Firenze 1935), ha accennato al fatto che una visione “parallattica” del tipo da noi indicato nel punto 1, è possibile anche con un solo occhio, dato che la larghezza della pupilla rappresenta già di per sé una base visiva di tale ampiezza da permettere visioni stereoscopiche fino ad una distanza di 7 metri (Sempre però nell’ipotesi, se l’osservazione ci è concessa, che i singoli punti visivi della retina possano, come gli occhi, funzionare quali organi visivi, separatamente uno dall’altro). I casi 1 e 3 sono, per l’osservazione di immagini e quindi anche per quello dei film, da escludere, dato che nelle immagini tutto giace in un unico piano. L’occhio può dunque solamente constatare quanto lontana sia da esso l’immagine nel suo insieme. Resta soltanto da considerare il caso 1): si proiettano agli occhi dello spettatore due immagini della medesima scena prospetticamente diverse, essendo esse immagini state riprese con una certa distanza orizzontale una dall’altra. Per la fotografia, come per la cinematografia, si può, accontentandosi, facilmente ottenere che un solo spettatore guardi attraverso due spioncini (stereoscopio), e l’effetto, come ognuno sa, è sorprendente quando però vogliano vedere più persone contemporaneamente, ci si domanda, come fare che ciascuno degli occhi veda soltanto la sua immagine e non ambedue? Il sistema classico, se pur non molto soddisfacente, adottato oggi nuovamente anche da Lumière consiste nell’uso di occhiali con lenti a colori complementari (anaglifi) e due immagini analogamente colorate e sovrapposte una all’altra. Si sono già dagli inizi praticati due metodi: quello additivo (Almeida 1858) che lavora con due proiettori le cui immagini – ad esempio l’una rossa e l’altra verde –, allo schermo, si sovrappongono; oppure quello sottrattivo (Rollmann 1853) che consiste nel proiettare, con questo apparecchio, una diapositiva oppure un film su cui già sono sovrapposte le due immagini di differente colore. Come Louis Lumière, il 25 febbraio scorso ebbe ad esporre all’Accademia Francese delle Scienze, questo sistema è stato da lui perfezionato in due sensi: le due mescolanze di colori complementari sono state portate al punto da dare insieme una perfetta luce bianca e da richiedere da ambedue gli occhi il medesimo sforzo. Di aver inventato “il film stereoscopico”, come oggi ovunque si scrive, lo scienziato, modesto come lo sono tutti gli uomini di valore, non lo ha mai affermato. Può darsi, non di meno, che gli sia riuscito di eliminare gli inconvenienti del sistema anaglifico al punto da rendere ora possibile la sua applicazione pratica. Realizzatori di film e proprietari di cinema si affannano oggi nel dubbio: se l’onnipossente sovrano, il pubblico, accetterà o meno gli occhiali, e, in caso affermativo, se il consenso del pubblico non sarà forse tale da indurlo a mettere gli occhiali in tasca e portarli via. Obiezioni d’indole igienica, a parte. Del resto, Lumière ci diceva che vorrebbe sostituire gli occhiali con degli schermi – da collocarsi davanti ai posti a sedere; – come ciò si voglia però fare senza fissare la testa dello spettatore in una determinata posizione, non ce lo possiamo facilmente immaginare. Un’altra preoccupazione è data dal fatto che tutti gli apparecchi da presa, e nel sistema additivo anche tutti i proiettori, devono venir sostituiti da altrettanti nuovi che siano muniti di due obbiettivi. Certamente, gli occhiali colorati sono molto più comodi di quelli indicatici, pure dall’Almeida, nel 1858, per il cosiddetto sistema alternato. Secondo questo sistema, ronzerebbe sul naso di ogni spettatore un otturatore che, azionato elettricamente, avrebbe il compito di nascondere, volta per volta, ad un occhio, le immagini che vengono proiettate in successione non contemporaneamente, ma alternativamente. Con un terzo sistema, di Anderton, brevettato nel 1891, la luce delle due immagini viene polarizzata in due differenti piani e resa così captabile separatamente. Un altro sistema, fondamentalmente diverso, è quello della proiezione su schermi scannellati. Le due immagini, simultaneamente proiettate, vengono composte da tante strisce verticali quante sono le scannellature, e precisamente: al lato destro della scannellatura è proiettata una immagine, e al lato sinistro l’altra. Gli occhi dello spettatore, che per la loro distanza uno dall’altro guardano sullo schermo da diverse direzioni, vedono così, ciascuno per sé, la loro immagine separatamente. Per quanto gli occhiali non siano qui necessari, l’effetto si ottiene soltanto nel caso che l’osservazione avvenga da determinate direzioni e distanze. Di minor interesse sono certi sistemi in cui per evitare gli occhiali, ci si accontenta, già da bel principio, di un effetto parziale: si proiettano all’occhio nudo le immagini contemporaneamente o successivamente, ottenendo in ambedue i casi delle immagini a contorni poco nitidi e, inoltre, nel secondo, delle immagini oscillanti che, per quanto si afferma, danno un certo effetto plastico. 138 139 L’unica cosa che realmente si possa vedere, anche senza occhiali, è l’inesistenza di un ideale sistema per la realizzazione del film plastico. Ecco perché si accenna oggi sempre più con insistenza ai fattori pseudo-stereoscopici, quali la modellazione dei corpi per mezzo di forti luci e ombre, i netti contrasti bianconeri degli oggetti giacenti in diversi piani di profondità. Vanno qui pure menzionate la prospettiva lineare e la prospettiva aerea (come pure Mae West, che da qualche burlone è stata chiamata la protettrice del film plastico). Non dimenticato va però soprattutto il cosiddetto effetto di ferrovia, che si produce quando la macchina da presa si muove durante la ripresa o quando gli oggetti passano o roteano davanti alla medesima. Il forte effetto plastico, in questi casi ottenuto, dipende, a nostro avviso, anzitutto da due circostanze: 1) in causa dello spostamento parallattico gli oggetti che stanno uno dietro l’altro si “sciolgono” l’uno dall’altro; la distanza fra loro si fa, in causa del continuo cambiamento delle sovrapposizioni, sensibile, e 2) il singolo oggetto appare successivamente sotto due diversi aspetti. F. Paul Liesegang, dal cui interessantissimo opuscolo Zahlen und Quellen zur Geschichte der Projektionskunst und Kinematographie, Berlino 1926, (Cifre ed origine della storia dell’arte della proiezione e della cinematografia) abbiamo potuto trarre alcuni dei dati storici sopra indicati, ha trattato questo fenomeno nella «Rivista mensile per l’insegnamento biologico, chimico, grafico e geologico», 1916, Volume XXIII, fasc. 3, sotto il titolo Stereoscopia di movimento. Di grande importanza per il grado di illusione stereoscopica, dataci dalla proiezione cinematografica, è di constatare fino a qual punto lo spettatore avverta che lo schermo è piatto e che egli si trova ad una distanza costante da questo. Il prof. Ronchi afferma, nel suo scritto, di aver avuto l’impressione di una plastica molto forte ogni qual volta egli, al cinema, osservava un film attraverso un foro di 2-4 mm2, che gli permetteva appunto di vedere soltanto l’immagine proiettata e nulla dell’ambiente. Orbene: «le figure che si vedono, vengono subito riportate alla grandezza naturale: e perciò, se dentro il quadro vi sono delle figure grandi di primo piano, siccome queste appaiono più piccole e vengono per così dire allontanate, il quadro sembra rimpicciolito. Al contrario se vi compaiono figure minuscole. I paesaggi acquistano una profondità incredibile, e se vi è del movimento, come si ottiene spostando o ruotando la macchina da presa, l’effetto diviene completo». L’effetto potrebbe forse venir interpretato nel modo seguente: non appaiono più, come nelle proiezioni normali, figure di diversa grandezza a uguale distanza dallo spettatore, ma figure che danno il senso della loro grandezza reale, soltanto più vicine o più lontane dallo spettatore – proprio come avviene nella vista diretta. Anche l’apertura dello schermo partecipa di questo fenomeno: se l’immagine è vicina (primo piano), la cornice che obiettivamente è in tutti i casi della medesima grandezza, apparirà naturalmente più piccola; infatti essa abbraccia un campo più ristretto, mentre come delimitazione dell’immagine lontana abbracciante il campo lungo, apparirà più grande, perché l’occhio attribuisce erroneamente la riduzione prospettica anche alla cornice, per il fatto che, se due oggetti posti in diverse distanze appaiono di grandezza identica, il più vicino è obiettivamente sempre il più piccolo. Non appena lo schermo non è più localizzato nello spazio, sembra scomparire il fenomeno, di fondamentale importanza estetica, che i cambiamenti di distanze si trasformino in cambiamenti di grandezze; risultano cioè dei salti che si effettuano dal davanti all’indietro e viceversa, salti cioè corrispondenti alla reale situazione di ripresa; l’impressione della differenza di grandezza tra due diverse riprese di uno stesso oggetto scompare, perché risulta come semplice conseguenza della differenza di distanza del quadro dallo spettatore: il valore costante di grandezza e distanza dello schermo è, nella proiezione normale, esteticamente importante come “tonica” della gamma dei mezzi d’espressione. Si dovrebbe studiare in quale misura i medesimi svantaggi estetici si riscontrino anche nella stereoscopia vera e propria. Al proposito ci permettiamo di ricordare le obiezioni contro il film plastico da noi sollevate nella pubblicazione Film als Kunst (1932). Il film plastico toglie alle sovrapposizioni di piani e grandezze illusorie prospettiche, nonché alla cornice il carattere di necessità e fa del montaggio una violazione della realtà. (Vedi in proposito gli articoli Cinema e realtà, di A. E. Denekamp, in «Filmliga», n. 2, Rotterdam; Stereoscopia – una risposta a Arnheim in «Sight and Sound», Londra). Ronchi conclude le sue interessanti osservazioni affermando che il valore estetico del film plastico gli è parso molto dubbio, e che perciò preferisce osservare il film normale senza i diaframmi forati. Interessantissima è al riguardo l’opinione del francese Jean Vidal, il quale, dopo aver osservato che le perfezioni tecniche verso una sempre maggiore fedeltà di ripresa tolgono al film le sue capacità artistico-creative, arriva alla rimarchevole affermazione: «Non è per nulla dimostrato che il film artistico, narrativo, che noi oggi conosciamo, rappresenti la forma definitiva; tutto accenna anzi al fatto ch’esso sarà ben presto puramente un mezzo d’informazione, d’educazione e di studi». Un pronostico, questo, che ci sembra di molta probabilità e molto confortante. Un certo fascino estetico e psicologico hanno del resto i problemi che sorgono dal fatto che la cosiddetta “base” delle riprese stereoscopiche non deve assolutamente corrispondere allo scartamento degli occhi. Sappiamo di poter vedere stereoscopicamente fino alla distanza di circa 200 metri perché i 7 centimetri di scartamento degli occhi sono troppo pochi per poter dare, a maggiori distanze, immagini notevolmente differenti, accomodamento e angolo di convergenza. Secondo una tabella di A. Maitre, riprodotta da Ronchi, e dalla quale noi per maggior concretezza abbiamo sviluppato il seguente grafico, si avverte già alla distanza di un metro una differenza di 0.005 metri, mentre a 100 metri di distanza la differenza minima tra due piani è di 33 metri. Il nostro grafico indica la curva dei valori della “soglia” in metri, e 140 141 il punteggiato la percentuale della distanza. Dato dunque che paesaggi lontani appaiono perfettamente piani, Ferdinando Todeschini ha proposto di fare delle riprese plastiche a grande distanza mediante obbiettivi molto distanti uno dall’altro, analogamente ai telemetri usati nella marina i quali alla base di 10 metri ed ingrandimento di trenta volte rendono possibile di vedere stereoscopicamente anche alla distanza di 1.000 chilometri. Per la penetrazione del velo atmosferico, Todeschini consiglia di usare lastre sensibili all’infrarosso, la cui nota assenza di plastica sarebbe molto felicemente compensata dalla stereoscopia. («Note fotografiche» dell’Afa italiana, n. 9, Milano). Interessante dal punto di vista estetico è il fatto che qui si producono effetti, che nella natura non si possono riscontrare, dato che appunto oggetti lontani non possono da noi mai esser visti plasticamente. È, a nostro avviso, d’aspettarsi che i panorami di paesaggi così ottenuti, ci appariranno per la loro plastica vicini e quindi così piccoli come costruzioni-giocattolo. (Il medesimo effetto si potrebbe del resto avere nel film plastico usando i soliti modellini: la loro plastica tradirebbe la loro vicinanza e piccolezza). Se le riprese si fanno da vicino, su di una base più larga del normale, l’impressione plastica si fa più forte con conseguenti svisamenti nella dimensione di profondità. Lo zelante orrore con cui gli specialisti ammoniscono di tenersi lontani da tali metodi, dovrebbe invece essere agli avanguardisti d’incitamento, poiché si sa che tutti i mezzi d’espressione dell’arte cinematografica hanno cominciato con essere degli “errori”. (Considerazioni analoghe valgono per alterazioni dell’angolo fra le assi dei due obbiettivi). Comunque non sono da aspettarsi che divertenti effetti occasionali di trucco, come sinora è avvenuto con tutti i trucchi cinematografici che comportavano una deformazione. esso mostrava prese notturne, fotografia sfumata, carrellate, dissolvenze, esposizioni multiple, scorci e dissolvenze ad iride, in una potente rievocazione della nascita della nazione americana. (Il film ebbe dapprima come titolo The Clansman, in seguito The Birth of a Nation). Il regista era David Wark Griffith che l’aveva realizzato con l’aiuto dell’operatore G. W. Bitzer. Costato mezzo milione di dollari, fruttò 18 milioni). L’arte cinematografica superata Sono trascorsi vent’anni dal giorno in cui un certo film venne offerto alle case di noleggio e da queste senz’altro rifiutato, come assolutamente invendibile. Era lungo 4.000 metri, troppo dicevano, per poter essere contenuto in una qualsiasi programmazione cinematografica. Il regista dovette fondare un’apposita agenzia di noleggio, la Epoca Film Corporation, e così il 3 maggio 1915 alle ore otto e cinque di sera, la “prima” del film ebbe inizio, al Liberty Theatre di Nuova York. Quarantacinque settimane nonostante il prezzo d’ingresso di due dollari, esorbitante per quei tempi, durò l’affollamento, cosa davvero eccezionale. Ed eccezionale, si potrebbe pensare, doveva essere la mediocrità di quel film. Invece, una sorpresa: per la prima volta Oggi è assai raro che il buon senso del noleggiatore di film sia smentito dall’irragionevolezza del grosso pubblico. Nel paese di D. W. Griffìth, l’arte cinematografica è ormai considerata come un fastidioso articolo d’importazione europea, che ha fatto già il suo tempo, liquidato dalla tecnica sonora cinematografica americana. Di tutto questo si può considerare sintomo caratteristico l’articolo The Fallacy of the Art Theatre di Herman G. Weinberg, direttore di una piccola sala di Baltimore, pubblicato con una fotografia dell’autore, nella rivista «Motion Picture Herald» (n. 13). Non esistono sale cinematografiche dedicate a produzioni artistiche – scrive il Weinberg – sebbene se ne senta parlare già da tempo. Il film artistico è morto col film muto. La repentina apparizione del cinema sonoro ha emesso una volta per sempre il verdetto di morte per tutto l’astuto gruppo di piccoli “cinema specializzati” che avevano formato in America, nei lamentati anni dal 1927 al 1931-32, il movimento delle “piccole sale”. In quel periodo, tutto ciò che sotto la marca “Made in France”, “Made in Russia”, oppure “Made in Germany” giungeva dall’Europa, veniva dall’élite cinematografica, dai cosiddetti “High Brows”, dagli Intellettuali (che orrenda parola!) ingoiato con particolare fervore. Un mucchio di film venne allora, sotto la rispettabile marca “Arte”, offerta sul mercato. Era infatti relativamente facile procurarsi con tali film una piccola fortuna, visto che costavano pochissimo e si tenevano sullo schermo, senza speciale impulso reclamistico, spesso per tre, quattro ed anche per cinque settimane. Una pubblicità fatta a mezzo di lettere personali bastava a far accorrere il pubblico. I critici, da parte loro, abituati a vedere i monotoni prodotti di origine hollywoodiana, si mostravano assai indulgenti. Il risultato di questo stato di cose fu un periodo di ottimi, magnifici affari per una mezza dozzina d’impresari; (allora ben conosciuti ma oggi tenuti, molti di essi, in scarsa considerazione, che si davano a fare in tal campo). Queste malsane condizioni sono state nel frattempo, come ci assicura Mr. Weinberg, eliminate. Bisogna tener presente che Hollywood, assolutamente incapace a gareggiare nell’epoca del film muto con l’arte della presa e dell’illuminazione dei tedeschi o con la potenza drammatica dei russi, ha invece ora superato tutti nel campo della riproduzione sonora. Il film europeo non può oggi tener fronte a questa concorrenza, nemmeno nelle “sale specializzate”. Se abbiamo capito bene, l’Arte è dunque stata battuta ed eliminata 142 143 Espressione «Intercine», 5, maggio 1935, pp. 286-288 dalla Tecnica. E qualora anche si dovesse, in un avvenire non lontano, avere delle scuole come materia d’insegnamento l’Arte cinematografica – apprendiamo dal «Film Kurier» (n. 102) che il dr. Johannes Eckardt e Frank Leberecht stanno preparando per le scuole superiori tedesche un libro introduttivo al suo studio, con un film a passo ridotto, ricco di esempi sull’Arte del cinema – gli allievi dovranno sin dal principio comprendere che si tratta in questo caso di una disciplina storica. La riproduzione del movimento La presa e la riproduzione del movimento non erano originariamente così strettamente legate tra di loro come adesso. Basta pensare a Marey, che con le sue cronofotografie ha compiuto opera da precursore nel campo dell’analisi del movimento, cioè della presa ottica. Egli costruiva i suoi apparecchi senza tener conto delle possibilità della sintesi del movimento da lui considerato come privo d’interesse, anzi come cosa indegna. Quando già si poteva vedere nella scatola del Kinetoscopio delle immagini in movimento, nessuno pensava che si potessero anche proiettare. Circa questo periodo iniziale dello sviluppo tecnico ci informa ampiamente un notevole studio di Thomas Armat, apparso nel «Journal of the Society of Motion Picture Engineers» (n. di marzo): Armat si era già, sin dai primi tempi, interessato al problema cercando di costruire un apparecchio da proiezione utilizzabile. Nell’estate del 1894, egli ebbe modo di vedere a Washington la prima esposizione dei Kinetoscopi, ideati e costruiti da Edison. Si cercò di interessarlo alla distribuzione di questi apparecchi peep show; egli rispose che non attendeva dal Kinetoscopio, in quella sua forma primitiva, alcun successo che avrebbe potuto invece (e molto meglio) essere ottenuto qualora si fosse riusciti a proiettare le immagini sopra uno schermo; ed aggiunse che era disposto a costruire un simile apparecchio. Gli fu detto che la Edison Company l’aveva già tentato, ma senza risultati, e che c’era quindi da supporre la cosa irrealizzabile. Armat, però, si mise all’opera, insieme con lo scenografo C. F. Jenkins, suo compagno di studi nella Bliss School of Electricity a Washington, ed insieme presero nel 1895 due brevetti per apparecchi da proiezione, costruiti secondo i principi del Kinetoscopio, e nei quali il trasporto della pellicola avveniva mediante una ruota a un dente che azionava sopra una ruota stellata. Tale apparecchio, però, risultò insufficiente: non si potevano proiettare più di venti fotogrammi a secondo, mentre i film Edison, gli unici allora a disposizione, erano stati ripresi alla velocità di 40 immagini al secondo. Armat continuò le sue ricerche e la sua più importante invenzione fu il Vitascop, brevettato il 2 marzo 1879. Per il movimento della pellicola esso prevedeva una croce di Malta a quattro parti con fessure radiali. Questo perfezionamento della macchina da proiezione suscita un’accanita lotta di brevetti: Armat procedette alla protezione legale del suo apparecchio mentre Edison aveva pensato a brevettare il suo procedimento, l’unico esistente, di ripresa filmistica e l’uso del film perforato. 144 Chi faceva proiettare film correva il rischio di essere citato in giudizio. Tale situazione che ostacolava ogni progresso, fa pensare precisamente, come osserva il redattore della «Filmtechnik» (n. 9), alla lotta dei brevetti dei primi anni del cinema sonoro. In quanto alla riproduzione del movimento, è stato stabilito come norma attuale la velocità di presa o di una riproduzione in 24 immagini per secondo. R. Thun ha recentemente comunicato in una conferenza («Die Kinotechnik» n. 7) i dettagli, i contrasti e la velocità con la quale un’immagine cinematografica dovrebbe essere ripresa per ottenere un buon effetto. Una frequenza di 5-8 quadri può accontentarci soltanto quando si tratta di azioni calme, prive di vivacità; di solito è necessario, per una sufficiente riproduzione dei movimenti che avvengono nella vita di ogni giorno, almeno da 15 a 20 quadri a secondo. Ci sono i fenomeni di movimento, i quali non possono essere, in modo sufficiente, riprodotti, e resi evidenti anche con la frequenza di 24 immagini al secondo, oggi abitualmente usata. Per la completa e perfetta riproduzione di tutti i movimenti rilevati dall’occhio umano sono necessari, secondo Thun, da 50 a 80 immagini a secondo. Si deve dunque tener presente che la frequenza delle immagini deve essere fissata secondo la velocità dei movimenti da riprodurre, il che spiega alcuni particolari effetti in campi limitrofi. Così, per esempio, nella cinematografia ra- dioscopica – si guardi l’articolo di F. R. James nel «Journal of the S.M.P.E.», n. 3 – non si è affatto d’accordo se siano necessarie prese frequentissime a serie, nel vero senso cinematografico della parola, oppure possano risultare sufficienti prese periodiche del tipo dell’acceleratore, poiché i movimenti interni del corpo, all’infuori del cuore, registrabili dalla tecnica attuale della radioscopia, sono relativamente assai lenti. Due scuole sono quindi l’una contro l’altra riguardo al modo migliore e privo di pericoli per far fotografie radioscopiche a serie. Le prese “periodiche” vengono ottenute quando, senza l’applicazione di un obbiettivo, i raggi Röntgen agiscono direttamente sulla pellicola, mentre nelle prese cinematografiche vere e proprie, viene filmata 145 sullo schermo l’immagine formatasi dalla luce di fluorescenza, sotto l’effetto dei raggi Röntgen. Documenti dell’epoca Così come oggi la vita di certi uomini, di certe famiglie viene già fissata in immagini cinematografiche a mezzo del film dilettantistico, nello stesso modo anche organismi politici – città, paesi, partiti – dimostrano sempre più di voler conservare, attraverso la riproduzione cinematografica, le loro opere e le loro azioni per dimostrarle alle future generazioni. La città di Berlino ha recentemente proiettato una serie di film realizzati da Fritz Gripe con quali intende costituire il suo proprio archivio cinematografico. Giustamente si cerca di fissare per sempre tutto ciò che sta per sparire e per subire radicali trasformazioni. Il Krögel, un quartiere dell’antichissima Berlino, caduto vittima del piccone demolitore, resta almeno conservato nel film. Altri film sono dedicati alla costruzione delle strade per la prossima Olimpiade, alla costruzione di un canale nuovo, ad una colonia di abitazioni croata per gli invalidi di guerra, alla preparazione di una grande cantina protettiva contro le incursioni aeree, all’erezione di un nuovo monumento ed a festeggiamenti ufficiali di ogni genere. («Berliner Tageblatt», n. 113). Scopi consimili si è prefisso il film Il Trionfo della volontà che ha avuto il premio di Stato germanico, e nel quale la regista Leni Riefenstahl, aiutata da un intero gruppo di operatori, ha ripreso e fissato per lo schermo i festeggiamenti del Congresso nazional-socialista a Norimberga. Si sono dovute qui risolvere una serie di notevoli difficoltà tecniche: piste di legno per le carrellate, balconate montate sulla facciata d’uno stabile, e, per le prese dall’alto, scale da pompieri e piattaforme di autobus. Per raggiungere i primissimi piani degli oratori e le singole, vivissime inquadrature del pubblico degli ascoltatori, senza turbare le riunioni del Congresso, si sono usati obbiettivi di grande lunghezza focale, per esempio, obbiettivi a specchi molto luminosi. Notevoli difficoltà ha offerto l’illuminazione dei vasti ambienti con proiettori o torce di magnesio: e completi impianti d’illuminazione si sono dovuti montare o smontare in pochi minuti. («Filmtechnik», n. 9). Ma non sempre ciò che riprende la macchina da presa riscontra il favore del pubblico. Recentemente, a Los Angeles, Mrs. Doris Preisler ha citato dinanzi al Tribunale, il servizio di attualità cinematografica della Universal, perché la visione del cadavere del gangster “Baby Face” in un film, le aveva procurato l’aborto. La sua querela è stata, però, respinta; vi è un indubbio fine morale – dice il verdetto – quando si dimostra al pubblico, attraverso simili pellicole, quale misera fine attenda, chi vuol mettersi fuori legge. Mrs. Preisler poteva poi dagli avvisi cinematografici ben comprendere che i quadri da essa incriminati, erano compresi nel programma del cinema. («Motion Picture Herald», n. 13). La stessa Universal è protagonista di un altro grazioso episodio. 146 Durante il processo contro Hauptmann, la Corte aveva proibito le prese cinematografiche. L’Universal ha trovato modo di ingannare la legge ed ha perfino esposto nella stampa cinematografica, in quale maniera è riuscita a farlo. La macchina da presa era silenziosa e costruita in modo da riprendere a distanza. Essa si trovava in un nascondiglio di legno compensato, coperto da feltro. Prima dell’inizio del dibattito processuale venne opportunamente collocata e posta in azione da un operatore, che si trovava a circa 15 metri di distanza, fra il pubblico, come uno spettatore qualsiasi e non doveva far altro che premere un bottone nei momenti importanti. («Filmtechnik», n. 9). Inoltre tutte le Case in servizio di attualità cinematografiche, cercano attualmente, come sembra, d’impegnare tutti i loro sforzi, per accelerare talmente il loro lavoro, da far fronte alle trasmissioni di televisione. La British Movietone ha addirittura chiamato a coprire il posto di direttore l’uomo più veloce del mondo: Sir Malcolm Campbell, il detentore del primato mondiale di velocità per automobili. Sir Campbell fornirà anche i testi che accompagneranno le proiezioni delle attualità. Chi sa che il conducente della Submean, del Raggio di Sole non riesca, unico mortale, a gareggiare con fortuna con le onde dell’elettricità! Espressione «Intercine», 6, giugno 1935, pp. 354-356 La produzione cinematografica ha cercato sempre, in modo evidente e continuo, di superare il contrasto fra due tendenze, due orientamenti che, a prima vista, sembrano fra loro antitetici: si vorrebbe infatti, alla sempre più fedele riproduzione realistica della natura, aggiungere, nello stesso tempo, sempre più bellezza. Tale contrasto si risolve, in certo senso, nel fatto che i produttori si sforzano di presentare sullo schermo un mondo più attraente, più bello, ricco e nobile del mondo reale, ma in maniera tale da approssimarsi il più possibile alla visione effettiva della realtà. Si vuole insomma mettere lo spettatore non soltanto in grado di avvicinarsi ad un seducente mondo ideale, ma anche di aver l’impressione che questo stesso mondo assuma attorno a lui forme reali, sostanziali, corporee. Il grado di bellezza si riferisce dunque al come; il grado di verismo al cosa della rappresentazione. Mentre l’Arte cerca di concepire, di afferrare la realtà interiore, risolvendola in una forma che si discosta dalla realtà esteriore, il fabbricante di film vuol ricoprire un mondo bugiardamente illusivo con le vesti delle realtà apparenti ed esteriori. 147 Forme senza forma In un articolo sul Rapporto tra le dimensioni del quadro di proiezione, il campo visivo dell’occhio umano e la tecnica cinematografica («Journal of the S.M.P.E.», n. 5) B. Schlanger afferma che un’immagine dipinta o fotografata può dare soltanto l’effetto di una riproduzione d’un fatto avvenuto, mentre il film deve profittare della sua particolarità di svolgersi temporalmente per procurare in ogni modo allo spettatore la sensazione che l’azione del film si svolga proprio in quel momento sotto i suoi occhi, come se egli vi prendesse personalmente parte. (Si potrebbe, tuttavia, osservare che un’opera d’arte non si trova mai in funzione di tempo rispetto a chi la osservi: essa non è – indipendentemente da ciò che rappresenta – né presente, né passato, né futuro). È dunque necessario per prima cosa, secondo Schlanger, che l’immagine proiettata si liberi da ogni delimitazione, che diventi shapeless shape: una «forma senza forma», come si dovrebbe appunto dire per porre esteticamente tale premessa nel dovuto rilievo. Mediante il film di grande formato dovrebbe scomparire la non naturale delimitazione dello schermo: ai margini del quadro così ingrandito un’alonatura, dovutamente illuminata, dovrebbe servire per segnare un tenue, lieve, quasi impercettibile trapasso fra il quadro e la parete della sala di proiezione. La soluzione ideale sarebbe (anche se questo non viene esplicitamente confessato dall’autore) di eseguire la proiezione su un orizzonte circolare a cupola. Si raggiungerebbe così di sopra e di sotto, a destra e a sinistra, un mondo illusorio completo, incongruente soltanto in quella piccola zona dove si trova la poltrona dello spettatore. Nel suo fermo desiderio di far scomparire i limiti fra parvenza e realtà, il newyorchese amante del verismo cade nell’errore di proporre che quel suo quadro di proiezione ingrandito debba essere nitido soltanto nel centro e sfumato ai margini, «perché corrisponda alla visione dell’occhio». È ovvio invece che lo spettatore troverebbe per l’appunto poco naturale un quadro parzialmente sfumato, mentre un’immagine omogeneamente nitida subisce la stessa degradazione di nitidezza ai margini, come qualsiasi altro oggetto percepito direttamente dall’occhio. È sintomatico che, fra le proposte dello Schlanger, si trovano anche dei suggerimenti per superare il montaggio: egli dice per esempio che la zona nitida potrebbe essere spostata dal centro in qualsiasi altro punto del vasto campo visivo, così da attrarre l’attenzione dello spettatore su un punto qualsiasi del panorama. Si tratta qui – come anche nel caso della carrellata, che però è praticamente molto più utile – di tentativi di analizzare l’ambiente rappresentato senza uso del taglio, tentativi che ricordano i vecchi procedimenti dell’iride decentrata. Indubbiamente, i giorni del montaggio sono ormai contati: il che, del resto, si poteva già prevedere da molto tempo! Un altro saggio riguardante il problema del film a grande formato lo troviamo nello stesso fascicolo del «Journal of the S.M.P.E.». Nella sua pro- 148 lusione: Obbiettivo rotante per riprese panoramiche, F. Altman riferisce su esperimenti fatti alcuni anni addietro, di riprese filmistiche con pellicola di 70 mm. a mezzo di obbiettivo rotante. Partendo dagli esperimenti di J. D. Elms (1922), il quale componeva le sue immagini – Widescope – mediante una macchina da presa a due obbiettivi ed una corrispondente macchina da proiezione a due immagini parziali; e dagli esperimenti con l’obbiettivo pendolare di Ziliotto (1924), col quale non si potevano fare più di 8 prese al secondo, si è giunti al sistema di due obbiettivi doppi, ruotanti attorno ad un asse verticale, sistema che viene completato da un elemento fisso (un menisco negativo), posto verso l’oggetto da riprendere. Il film viene tenuto in posizione orizzontale e curvata, cosicché la sua distanza dall’obbiettivo corrisponde ovunque alla lunghezza focale di quest’ultimo. Uno speciale otturatore ruotante è destinato a far sì che soltanto una stretta striscia della pellicola venga illuminata: la curvatura del film in un quadro più vasto risulterebbe infatti a scàpito della nitidezza di questo. (Curioso che non venga qui neppur menzionato il nome dell’inventore italiano Filoteo Alberini, il quale faceva già nell’anteguerra delle riprese panoramiche con obbiettivo a ventaglio e cedette poi il suo brevetto in America). Nella discussione seguita alla prolusione dell’Altman, McGuire ha trattato delle macchine di proiezione per grande formato (Grandeur). Per la costruzione delle prime sei macchine di questo tipo la International Projector Cor. aveva speso circa 200.000 dollari. Ora questi apparecchi, dopo le prime proiezioni fatte nel Roxy Theatre, non vennero più utilizzati. Il valore pratico, secondo McGuire, del film a grande formato, risulterebbe evidente dal fatto che, adottandolo, si riuscirebbe a proiettare sullo schermo l’intero panorama di un campo da baseball e nello stesso tempo ad ottenere immagini dei singoli giocatori, abbastanza grandi da essere ben distinguibili. Di fronte ad argomenti simili, l’estetica, s’intende, deve ritirarsi in buon ordine. Truccaggio correttivo A questo punto sono dunque giunti gli sforzi per avvicinarsi sempre di più alla verosimiglianza. Per quanto riguarda la “bellezza”, è stato introdotto negli stabilimenti della Warner Brothers un nuovo sistema di truccatura, denominato “Truccaggio correttivo”, il quale, come comunica Percy Westmore nell’«American Cinematographer» (n. 5), semplifica assai il lavoro dell’operatore e rende i volti delle dive della Warner molto più seducenti e graziosi. «Supponiamo che la fanciulla, per il ruolo che deve interpretare, abbia un viso troppo rotondo, troppo pieno, particolarmente nella parte delle labbra e del mento, un naso troppo largo e piatto, labbra sporgenti, un’infossatura sul mento e pieghe non molto giovanili agli angoli della bocca; gli occhi poi talmente azzurri da sembrare slavati. Entra allora in funzione il truccatore, il quale finge delle ombre mediante sfumature di colori scuri, che aggiustano il viso alla stessa maniera come l’operatore crea le ombre con le sue lampade. Si comprende che se l’ope- 149 ratore viene, fino a un certo punto, dispensato da questo compito, egli disporrà di maggior libertà per dedicarsi alla migliore illuminazione del quadro». Quel che può interessare dal punto di vista teoretico in questo procedimento (che poi veramente non risulta tanto nuovo) è lo sforzo di non mettere in rilievo le particolari caratteristiche della fisionomia reale come mezzi d’espressione specificamente fotografici, ma di appianare invece, di livellare al massimo quelle caratteristiche stesse del materiale naturale con le quali si è costretti a lavorare. Tutti hanno presenti certe coppie di fotografie, dove si vede un’attrice prima e dopo il procedimento del truccaggio. La trasformazione è senza dubbio sorprendente: si ha l’impressione che un compressore stradale sia passato sopra il viso, e la prima fotografia appare, in generale, molto più seducente della seconda. Lo stesso compressore, lo sappiamo, passa del resto soprattutto il film, dal copione fino al montaggio: e per ciò appunto il risultato finale è così piatto. Mentre così la stampa del cinema industriale indica e rivela con melanconica precisione quale somma di capacità, d’ingegno, di scienza e di sensibilità artistica sia impegnata e fino ad un certo punto assimilata da un processo produttivo di carattere nettamente non artistico, alcune riviste dedicate ai problemi dell’arte cinematografica, discutono i loro argomenti su di un livello assai elevato; il che avviene, in primo luogo, sulle riviste dell’Inghilterra, paese che con i suoi Film Societies, i suoi Istituti, i suoi giovani registi di film documentari, può esser oggi considerato, sia dal punto di vista teoretico che pratico, un’oasi dell’Arte cinematografica (nonostante la filiale hollywoodiana a Londra). Nel numero di primavera della rivista «Cinema Quarterly», edita da Norman Wilson e che va migliorando di numero in numero, il romanziere Campbell Nairne pubblica un importante e divertente articolo sui rapporti fra letteratura e cinema. Egli condivide, per prima cosa, la diffidenza che si nutre verso il poeta come scenarista, ma è tuttavia d’avviso che in una nuova generazione di scrittori, la quale sia cresciuta insieme ad una Cinematografia intesa quale mezzo di educazione e di divertimento, andrà indubbiamente perdendosi quel senso di estraneità verso il Cinema, che viene giustamente oggi rimproverato a molti letterati, il cui nome è sfruttato dai produttori di film come semplice fattore di attrazione per il pubblico. Campbell Nairne pensa inoltre che il film può essere soltanto «o pieno di sfumature e incomprensibile, o comprensibile ma privo di ogni sfumatura»: e ciò perché il breve tempo di cui dispone il cineasta non gli consente di sviluppare delle finezze in modo comprensibile a tutti, mentre un romanzo può avere qualsiasi estensione e può essere inoltre riletto in qualsiasi momento. Con ciò il Nairne certamente non vorrà intendere che non si possano esprimere anche nel film delle finezze e delle sfumature. Per citare un esempio solo: il motivo essenziale del film Mascherata di Willy Forst e Walter Reisch sta in una sola sfumatura: il chirurgo torna nel palco dell’Opera, dopo esser riuscito a portare a buon termine la cruenta operazione, si mette a sedere ed affabilmente, con un insignificante ma significativissimo movimento della mano, carezza la mano della moglie che ha la colpa di tutto; la donna senza accorgersene, senza intuire quanto è accaduto, superficiale, pericolosa e sciocca, sorride fugacemente e continua a guardare il palcoscenico. Una infinità di sfumature, tali che neanche un Poeta avrebbe potuto con maggiore sottigliezza esprimere, si trovano facilmente nei film di Chaplin o nei disegni animati di Disney. Detto questo ci sembra poi che il problema delle sfumature, per caratteristico che esso sia nell’Arte odierna, rappresenta una questione estetica di second’ordine, e, quindi, non decisiva per la differenza fra Cinema e Letteratura. Se certe forme letterarie non possono esser portate sullo schermo ciò non avviene per la loro sottigliezza, per le sfumature che contengono, bensì per il loro carattere astratto, che non può prescindere dalla parola. Un monologo di Shakespeare è inadattabile al Cinema, non perché i personaggi sono disegnati con arte troppo sottile, ma per il fatto che esprime pensieri i quali non possono essere trasformati in serie di immagini e ancor meno in “azione”. Per il Cinema può essere adattata specialmente quella forma letteraria, il cui senso si esprime attraverso l’azione e la descrizione dell’ambiente; ma ci sono anche delle opere letterarie, dove l’azione non è altro che una base ed un mezzo per delle considerazioni, che rappresentano la materia essenziale dell’opera: e neppure esse sono adattabili al film. Se il cineasta può ancor tentare di trarre un’opera cinematografica da Stendhal o da Hamsun, egli può esser sicuro che non riuscirebbe a nulla se volesse portare sullo schermo per esempio Goethe o Dostoevskij. Se alcuni singoli episodi dell’“Antico Testamento” potrebbero forse esser filmati, si può senz’altro affermare che ciò risulterebbe impossibile per Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann. Ma bisogna anzitutto ed in senso più fondamentale constatare che il novanta per cento di tutti i film, che vengono oggi realizzati, sono destinati sin dall’inizio all’insuccesso, per il fatto che si propongono di narrare, di esporre un intreccio sovraccarico di fattori psicologici, di complicate interferenze di ogni ordine, politico, economico ecc. Se si vuole assolutamente far confronti tra il cinema e le altre arti, non bisogna allora chiamare il film un romanzo rappresentato o un dramma fotografato, ma piuttosto un dipinto in movimento. Così semplici come sono i soggetti dei quadri o delle opere di scultura, altrettanto semplici dovrebbero essere anche i soggetti filmistici, ed infatti i pochi grandi film che abbiamo confermano questa tesi. Come Rodin ha potuto rappresentare il Pensatore ma non avrebbe potuto trasformare in bronzo un determinato sistema filosofico, così anche un film dovrebbe, sia nel tema essenziale sia nei dettagli, rappresentare delle cose comprensibili direttamente dall’occhio; siano esse sottili e pervase di sfumature tenuissime come la Monna Lisa, oppure monumentali come un grani- 150 151 Letteratura e cinema tico Re Egiziano. Per dirla con i nostri modesti termini filmistici: dovrebbero essere piene di finezza psicologica come un personaggio di Sternberg o grandi come il sorriso e l’inchinarsi del capo nei messicani di Ejzenštejn. (Ci sia poi perdonato se in queste nostre considerazioni non abbiamo preso nota dell’esistenza del film parlato). Espressione «Intercine», 7, luglio 1935, pp. 407-409 Nel 1589 Giovanni Battista della Porta esprimeva l’idea che dovesse esser possibile captare pensieri, suoni, parole in un tubo di piombo chiudibile, in modo da farli risuonare a piacere aprendo semplicemente il coperchio. Questo tubo di piombo, che nel frattempo si è rivelato come un vero vaso di Pandora, sta all’inizio della storia del film sonoro, come ha osservato il dott. Joachim in una sua conferenza, tenuta davanti alla Kinotechnische Gesellschaft di Berlino in occasione del recente Congresso cinematografico («Kinotechnik», n. 10). Circa duecento anni dopo, verso la fine del 1877, Edison brevettò il suo fonografo, in cui la registrazione si faceva a mezzo di una punta che si spostava lateralmente a spirale sopra un cilindro di cera, e che, sotto l’azione di una membrana mossa dalle onde sonore, eseguiva delle oscillazioni in direzione verticale, cioè dall’alto in basso e viceversa. Le pellicole prodotte da Edison nel Cinetoscopio del 1892 erano già accompagnate da dischi sincroni. A Parigi, la prima rappresentazione di pellicole sincronizzate di questo genere fu organizzata nel 1902 da Gaumont; a Berlino, nel 1903 da Oskar Messter. Mentre Edison, come abbiam detto, faceva oscillare la punta di registrazione del suo Fonografo in senso verticale, nel 1878 Berliner propose di registrare non su cilindri ma su dischi, e di far oscillare l’ago in senso orizzontale; egli diede al suo apparecchio il nome di Grammofono, col quale è conosciuto oggi in tutto il mondo L’importante passaggio dal grammofono meccanico a quello elettrico fu reso possibile dall’invenzione della valvola amplificatrice, dovuta a Lieben. Quanto l’apparecchio elettro-acustico sia superiore a quello meccanico, il dott. Joachim ha dimostrato facendo suonare dei “dischi di controllo” sui quali erano registrate le frequenze di 400, 200 e 100 cicli e quelle di 800, 1.600, 3.800 e 6.400 cicli su ambedue gli apparecchi. Le frequenze di 100 e di 6.400, attraverso l’apparecchio elettrico ancora udibili, non si sentivano più attraverso il grammofono meccanico. La sostituzione poi – importantissima per la tecnica sonora attuale – della incisione con la “scrittura sonora” registrata fotograficamente su pellicola, si basò essenzialmente sulle ricerche del triumvirato Tri-Ergon: i brevetti relativi, come del resto anche quello del Lieben, hanno dato luogo ad esa- 152 sperate lotte finanziarie (vedi la decisione della Suprema Corte nella causa della Paramount Publix Corp. e degli Altoona Publix Theaters contro la American Tri-Ergon Corp., pubblicata nel numero 6 del «Journal of the Society of the Motion Picture Engineers»). Dopo esser caduto in disgrazia nel campo del fonofilm, il grammofono è tornato negli ultimi tempi, se non altro come apparecchio di registrazione, in onore; anzi si dimostra superiore al metodo unicamente fotoelettrico per l’ampiezza delle intensità e anche per la esiguità dei rumori di fondo. La Columbia americana si è servita di questo sistema con successo per il suo film One Night of Love (Una notte d’amore) basato sul canto di Grace Moore. Per la registrazione grammofonica (che del resto poi viene ri-registrata fotoelettricamente su pellicola) si è ricorso al metodo di registrazione edisoniano, ossia all’oscillazione verticale della punta («Filmtechnik», n. 9). Sulla stessa registrazione e oscillazione verticale si basa un nuovo sistema di ripresa sonora, ideato dall’inventore americano James A. Miller e sviluppato negli ultimi tempi nei laboratori della Philips. In esso però l’incisione più o meno profonda non serve all’esplorazione meccanica; ma l’angolo più o meno largo prodotto alla superficie di una pellicola dalla penetrazione più o meno profonda di una punta a forma di cuneo (traccia che si presenta come una striscia bianca, simmetricamente dentellata su sfondo nero) serve all’esplorazione ottica normale con fotocellula. Se i lati della punta formano un angolo largo, allora la larghezza dell’incisione supera la profondità di parecchie volte: ossia basta un movimento minimo della punta in senso verticale per dar grande ampiezza alla curva nel senso orizzontale («Kinotechnik», n. 9). Regolazione del suono nella sala Un’ottima registrazione sonora però non serve a niente, se il film viene riprodotto male nelle sale di proiezione. Louis Lumière, nel suo recente soggiorno a Roma, ci disse che egli considerava come il compito fosse più importante della tecnica cinematografica di domani, quello di rendere indipendente dal proiezionista la riproduzione del suono. Lo scopo si può però raggiungere soltanto se nelle pellicole fornite dalla casa produttrice le colonne sonore sono di densità talmente omogenea che il proiezionista non sia costretto a regolare continuamente l’intensità del suono. Queste oscillazioni della densità oggi sono spesso talmente considerevoli che in una scena il proiezionista, pur usando al massimo il fader (regolatore dell’intensità dalla cabina), non riesce a portare il suono ad una altezza sufficiente, mentre nella scena successiva gli altoparlanti, di colpo, si mettono a urlare in modo tale che al pubblico tremano gli orecchi, anche se il fader attenua il suono il più possibile. Aggiungiamo che il proiezionista, anche trascurando la regolazione del suono, è già abbastanza occupato e che inoltre è quasi impossibile giudicare l’intensità del suono 153 dalla cabina. La maniera di risolvere il problema consiste, secondo F. H. Richardson (La necessità di densità uniforme nelle colonne sonore a densità variabile, n. 6 del «Journal of the S.M.P.E.»), non nel migliorare il controllo del suono nella sala, ma nell’elaborazione più accurata delle copie sonore negli stabilimenti di sviluppo e stampa. Solo se si arriva a questo, i suoni che arrivano al pubblico avranno precisamente quell’intensità che voleva dar loro il regista. Prospettiva Dell’effetto di profondità prospettica nell’immagine cinematografica parla Harry Walden («American Cinematographer», n. 6) dal punto di vista fisico e psicologico. Moltiplicando per esempio la distanza della macchina da presa dall’oggetto da riprendere e, nella stessa proporzione, la lunghezza focale dell’obbiettivo, il quadro rimane press’a poco identico per quanto riguarda il taglio e la grandezza degli oggetti; ma la prospettiva cambia. La prospettiva di un’immagine dipende unicamente dalla distanza di presa, non dalla lunghezza focale dell’obbiettivo. Nell’illustrazione (che riportiamo dall’articolo di Walden), i due gruppi di figure che stanno l’uno sopra all’altro a sinistra mostrano, in maniera schematica, due figure umane “oggettivamente” equidistanti; supponiamo che la presa sia fatta con un obbiettivo a fuoco lungo e che essa mostri (figure in alto) l’uomo che sta avanti con un quarto della sua altezza più grande di quello che sta dietro, mentre un fuoco più corto (facendo stavolta la ripresa a distanza proporzionalmente diminuita) mostrerebbe l’uomo che sta avanti di doppia altezza di quello che sta dietro (figure in basso). A causa della maggior differenza di altezza, la distanza fra le due figure sembra maggiore nel secondo caso, ed è questa la ragione perché nel Cinematografo si usano le brevi lunghezze focali, quando si vuol arrivare ad un effetto di grande profondità, oppure ad un movimento molto violento nella direzione dell’asse di presa: sia per esempio una carovana “senza fine” o un treno espresso che si avvicini con grande rapidità. Oltre a questo fenomeno fisico, basato sul fatto che la differenza degli angoli, sotto i quali le due figure si registrano sulla retina o sulla pellicola, aumenta col diminuire la distanza fra lente e oggetti, Walden avrebbe osservato anche un effetto psicologico di una certa importanza. Il gruppo di figure a sinistra in basso è di diversa grandezza di quello a destra, ma tutte le proporzioni sono identiche. Ciò nonostante la distanza tra le figure del gruppo a destra apparirebbe, secondo Walden, minore. (I due disegni corrispondono alle immagini che si avrebbero eseguendo l’ingrandimento di una fotografia o facendo da identica distanza dall’oggetto due riprese con diversa lunghezza focale dell’obbiettivo). Walden spiega questo effetto press’a poco così: il gruppo maggiore sembra più vicino, e perciò ad esso la differenza di grandezza tra le figure viene prospetticamente messa meno in conto (dato che, oggettivamente, quella differenza di grandezza da vicino è sempre maggiore). 154 Resterebbe da controllare se questa influenza della grandezza assoluta dell’immagine si verifica anche quando le figure si presentano non su sfondo bianco ma invece, come quasi sempre nelle fotografie, in un ambiente il quale naturalmente concorre a determinare con una certa precisione da quale distanza le figure sono prese e, quindi, sono da “considerare”. Nel caso affermativo potrebbe accadere che con una proiezione grande (o guardata molto da vicino) rispettivamente ad una ripresa fatta a grande lunghezza focale, l’effetto di profondità diminuisce, anche se nella proporzione tra le figure, e cioè nella situazione prospettica, niente fosse oggettivamente cambiato. Il critico cinematografico di domani «Intercine», 8-9, agosto-settembre 1935, pp. 36-37 C’è voluto molto tempo prima che la critica cinematografica finisse d’essere un compito accessorio dei cronisti, dei critici teatrali e dei recensori di libri. Mancava lo specialista, mancava l’estetica cinematografica, e mancava anche nei direttori dei giornali l’idea che avrebbe potuto trattarsi d’altro che di una cortesia delle redazioni a compenso delle inserzioni pubblicitarie delle sale cinematografiche. Quando poi, alla fine, la critica cinematografica si fu messa a lavorare con concetti propri, cinematografici per l’appunto, ed ebbe conquistato, insieme ad un buon livello spiritua- 155 le, un posto nel giornale corrispondente per dignità a quello riservato alla critica del teatro e dell’arte, proprio allora l’arte cinematografica, dopo una rapida fioritura, cominciò a decadere; ed oggi l’errore principale del critico cinematografico consiste appunto nel giudicare i film allo stesso modo come i suoi colleghi giudicano i dipinti, i romanzi e le commedie. È vero che anche nel corso di quei quindici anni, durante i quali si sviluppò un’arte cinematografica, non nacque che di rado una vera opera d’arte, sia pure allo stato intenzionale; in quei giorni però il critico cinematografico avrebbe avuto la possibilità di osservare, registrare e commentare nelle sue fasi successive un processo così raro ed emozionante da suscitar l’invidia dei suoi colleghi (anche se, nel campo proprio a questi ultimi, un’antica tradizione artistica consentiva il sorgere di opere più pure nelle intenzioni e di più alto livello): giacché qui bene o male nasceva una forma d’arte, e qui, da un metodo dapprima puramente meccanico di rappresentazione venivano individuandosi a poco a poco dei mezzi atti a caratterizzare artisticamente la realtà. E questa esperienza, la prima del genere, era per l’estetica talmente preziosa da render ciò, almeno in un primo tempo, molto più importante del dato (decisivo per un giudizio definitivo del fenomeno cinematografico) fino a quale altezza potrebbe svilupparsi la nuova arte (del resto, la questione se il cinema sia o no un’arte ci pare male impostata, e da sostituirsi con quest’altra: fino a che grado esso possa essere arte). Se dunque, come abbiamo detto, soltanto molto di rado si presentarono in passato opere d’arte pure come intenzione e come risultato, d’altro canto quasi ogni nuovo film rappresentava, in un episodio della sceneggiatura, in un’inquadratura, o in un effetto d’illuminazione, una tappa nella formazione del nuovo linguaggio ottico; avrebbe dovuto essere allora il compito del critico cinematografico di seguire questa evoluzione. Ma a tal compito la critica cinematografica in generale non era matura; e l’occasione passò quasi inutilizzata. Creazione artistica non è lusso, ornamento o superfluità; ma serve ad esprimere l’argomento, l’azione; così, nel cinema, i mezzi artistici si eran venuti sviluppando dal fatto che, data la mancanza della parola, l’azione, i caratteri dei personaggi e l’ambiente dovevano essere illustrati otticamente. Si era giunti in tal modo ad una caratteristica pantomimica muta, alla trasformazione di motivi interiori di trama in motivi visibili, ai mezzi d’espressione della macchina da presa e al montaggio. Col film parlato la necessità di applicare tali mezzi scomparve. Anzi, non scomparve soltanto la necessità, ma, fino ad un grado elevato, la stessa possibilità. È vero che, da un punto di vista puramente estrinseco e pratico, si aveva ormai a disposizione un mezzo più comodo ed immediato per rendere l’azione, i caratteri e l’ambiente; ma la parola e l’immagine erano d’altra parte, ciascuna per sé, un mezzo di rappresentazione talmente comprensivo che, applicate insieme e simultaneamente, dal punto di vista artistico non potevano completarsi ma soltanto ridursi e violarsi. L’evoluzione che ne risultava – la decadenza dei mezzi d’espressione cinematografica – non è ancor oggi terminata. Anch’essa è esteticamente molto interessante, e meriterebbe quindi maggiore attenzione da parte dei critici cinematografici. Ci sarebbe da dimostrare come – sotto l’influenza del dialogo – le inquadrature perdono di valore, le scene singole si prolungano, e come, quindi, decade anche il montaggio; come la carrellata guadagna d’importanza, l’attore occupa di sé tutto il campo visivo e l’azione visiva si riduce in favore di quella parlata. Ciò che il film sonoro ha iniziato, completeranno il film a colori, quello stereoscopico e quello a grande formato, nonché la trasmissione diretta di scene reali a mezzo della televisione. Purtroppo la maggior parte dei critici non si rende conto di questa situazione. Si vede che i film sono artisticamente insufficienti, ma non si vede che deve per forza esser così. Si dà la colpa al singolo produttore o regista, proprio come se dei buoni film parlati potessero esistere. Sarà compito del critico cinematografico di domani – e può darsi ch’egli si chiamerà “critico televisivo” – di far scomparire quella figura ridicola che è oggi il comune critico o teorico del cinema: questo individuo che vive sullo splendore delle sue reminiscenze come le ex-attrici settantenni, e che, come quelle, sfoglia delle fotografie ingiallite e cita dei nomi che non si sentono più da tanto tempo. Discute con i suoi amici dei film che da dieci anni nessuno ha più potuto vedere, e dei quali dunque si può dire tutto e niente; discute sul montaggio come i filosofi scolastici sull’esistenza di Dio, e crede che tutto questo sia valido ancor oggi. La sera, quale critico amico dell’arte, se ne sta con pia attenzione nel buio dei cinema come se si vivesse ancora all’epoca dei Griffith, degli Stroheim, dei Murnau e degli Ejzenštejn. Crede di vedere dei pessimi film invece di capire che tutto ciò che vede non è più cinema. Tutti questi studi teorici sarebbero magnifici se fossero consapevolmente fatti in sede di ricerca storica o puramente teorica. Sono al contrario ridicoli dal momento in cui essi vengono, come accade dovunque, presentati alla produzione cinematografica d’oggi come una ricetta. Sappiamo che talvolta anche ora (e ciò succederà anche domani) nasce sotto le mani di un avanguardista, di un cine-amatore, di un cacciatore di documenti un vero film; ma l’attività del critico non si rivolge ad eccezioni di questo genere, bensì alla larga produzione di ogni giorno: e questa può essere ammessa all’esame critico soltanto nel caso che, buona o cattiva, rientri appunto nel campo dell’estetica, ossia se abbia la possibilità di attingere all’arte. Nel passato i buoni film si distinguevano da quelli normali soltanto per la qualità; oggi essi sono delle eccezioni, degli avanzi, cose fondamentalmente diverse da tutto ciò che normalmente passa attraverso i cinema. Quanti critici ricorrono oggi, non potendo fare a meno di scrivere, all’ironia, si contentano di battute più o meno riuscite e di una critica dettagliata degli attori. Non avrebbero niente di meglio da fare? Senza 156 157 dubbio. Il critico cinematografico dovrebbe oggi ricordarsi seriamente del suo secondo grande compito, compito che gli era già stato affidato da sempre ma che un tempo poteva magari trascurare con la scusa che la critica estetica voleva per sé tutto lo spazio e tutto l’interesse. Parliamo dell’esame del film come prodotto economico e come espressione di dottrine etiche e politiche. I film vengono creati dal produttore come una merce che deve rendere la maggior quantità possibile di danaro, che deve cioè esser fatta in modo da essere accettata dal più gran numero di clienti possibile. Con tutto ciò, in passato c’erano sempre dei casi nei quali il produttore lasciava all’artista da lui scelto una certa libertà quanto al soggetto e all’esecuzione, con la speranza che il film, a causa di ciò o malgrado ciò, avesse un buon successo finanziario. Ogni organizzazione economica ha però la tendenza a perfezionarsi, ad eliminare tutti i fattori non controllabili; e quindi la produzione cinematografica ha fatto intanto diventare il regista sempre di più un semplice organo esecutivo degli ordini dati dal produttore in base ad un suo istinto sottile di “ciò che piace”. Noi pensiamo qui al tipo più individuato dell’odierna produzione cinematografica commerciale, quella americana. Nella produzione industrializzata è oggi molto più caratteristico, per un film, sapere da quale Casa è stato prodotto che non da quale regista. I nuovi registi si distinguono sempre meno l’uno dall’altro, e così anche i nuovi attori. Il comune critico cinematografico d’oggi conosce benissimo, in teoria, questa situazione, ma in pratica fa dell’analisi stilistica a proposito di George Cukor e si approfondisce nelle sfumature psicologiche di Joan Crawford senza rendersi conto che figure di questo genere, anche se in origine abbiano una qualche personalità artistica, sono condannate nella loro attività pratica a una completa mancanza di libertà d’azione. Si rimprovera al regista di non aver messo bene in rilievo nella “sua” sceneggiatura le caratteristiche dell’ambiente, e si considera l’incontro di un certo regista con un certo attore come un avvenimento artisticamente motivato, le cui ragioni varrebbe la pena di ricercare e giudicare. In un articolo pubblicato di recente su questa rivista (articolo che per il resto non mancava di accennare anche ai fatti così come si svolgono in realtà), si rimproverava al regista Mamoulian di essersi sottomesso alla «vanità ingenua» di Greta Garbo. Quasi simultaneamente, su di un giornale tedesco appariva un’intervista nel corso della quale Greta Garbo diceva: «Se sono contenta del film sulla regina Cristina? No, per niente. Come può crederlo? Se fosse spettato a me decidere, le cose sarebbero andate in tutt’altra maniera. È vero che quanto uno desidera sappiamo che non si realizza mai. Il ruolo che io sogno, questo non lo reciterò mai». Non si tratta qui di un’apologia della Garbo, ma del fatto che un film come quello, fossero regista ed attrice d’accordo o in contrasto, poteva esser realizzato soltanto così come è stato fatto! Si può, volendo, rimproverare a un artista, in linea generale, di vendere l’anima sua a metodi di produzione di questo genere. Ma giudicare un film cosiffatto come la libera opera di artisti, al modo di un romanzo o d’un dipinto (mentre oggidì neanche la regina delle attrici può decidere con quale curva le sue sopracciglia debbano venir tracciate), è un sistema che nasconde in modo nocivo la realtà dei fatti. Ugualmente insufficiente è, per esempio, il modo oggi diffusissimo di criticare i film storici. Si constatano le deviazioni dal fatto storico, e si giudicano poi lo scenarista o il regista o il produttore come se avessero studiato male le fonti o avessero deviato dalla verità per puro capriccio, per incomprensione, per mancanza di obbiettività, oppure anche in ossequio ad una determinata idea artistica o scientifica, precisamente come si giudicherebbe l’autore di un romanzo, di una commedia o di un’opera scientifica di carattere storico. In realtà il produttore, consigliato da esperti e munito di magnifici archivi, conosce probabilmente i fatti storici meglio del critico stesso e non pensa neanche per idea di sfogare nella creazione di un film i suoi capricci, la sua incomprensione o una sua interpretazione personale. Una fabbrica non è luogo adatto per tali passioni. Ogni mutamento della storia rappresenta invece – esattamente come ogni riduzione di un romanzo o di una commedia per lo schermo – una misura economica precisamente calcolata, destinata a rendere il film più simpatico, più attraente, più fastoso e più emozionante per il pubblico. In questi film c’è molta meno arbitrarietà che nelle opere di tanti artisti o scienziati; la loro preparazione si effettua secondo regole ben sperimentate, e dai fondamenti della trama fino ai gesti delle mani del protagonista tutto serve allo stesso scopo. Fino a che il critico non saprà o non dirà questo, la sua critica non avrà valore. Non avrà valore fino a che egli distribuirà a singole persone e in casi singoli la sua approvazione o disapprovazione, senza capire che i film sono come sono a motivo delle seguenti leggi generali. Prima legge: il film parlato esclude, come mezzo di rappresentazione, l’arte. Seconda legge: il film viene prodotto come una merce che si vuol vendere il meglio possibile. Terza legge: il film non è tanto l’espressione di opinioni individuali quanto l’espressione di opinioni politiche e morali diffuse. In riguardo al terzo punto diciamo che nei Paesi ispirati ad una determinata dottrina, i Governi richiamano oggi in modo molto utile l’attenzione sul contenuto politico-morale di ogni film. Purtroppo, sotto questo punto di vista, il critico cinematografico non li aiuta ancora abbastanza. Egli non vede per esempio che un film normale americano, che a lui sembra soltanto privo d’interesse artistico e sciocco, diventa estremamente interessante nel momento in cui lo si consideri come sintomatico dei gusti del popolo di laggiù. Si tratti d’un film fatto dal produttore in modo da corrispondere all’anima del popolo, o nasca esso sotto l’influenza di una richiesta politica come mezzo di propaganda e di educazione, sem- 158 159 pre, oggi come domani, dovrà esser compito del critico cinematografico di analizzare questo contenuto e di giudicarlo, in senso positivo o negativo che sia. Il cinema è uno dei più caratteristici mezzi di espressione e uno dei più efficaci strumenti d’influenza del nostro tempo. Esso rappresenta l’attività non tanto di individui quanto di popoli, di classi, di sistemi politici. Il critico cinematografico dovrà tenerne conto. Quello d’oggi purtroppo, in molti casi, sembra considerare il cinema come un piccolo teatro di lusso nel quale un gruppo di artisti indipendenti recita per un gruppo di amici dell’arte. Questo critico d’oggi, è di ieri. Espressione otticamente il concetto poetico della similitudine; ma il capitolo sul movimento della macchina da presa avrebbe potuto essere più esauriente, ed in materia di colori naturali ci dice che essi non aggiungeranno niente all’elenco dei mezzi che determinano la differenza fra cinema e natura, non badando che, anche se questo fosse vero, le possibilità dei colori si troveranno forse nella scelta di inquadrature adatte e che quindi la discussione deve affrontare il problema in questo punto. Si tratta di sapere se mediante una tale scelta sarà possibile quel “controllo” del colore da parte del regista, che l’autore giustamente ritiene indispensabile. Egli conclude dicendo: «Il colore magari migliorerà il livello dei film mediocri; ma di tanto in tanto sarà migliore il film, di altrettanto minore sarà il vantaggio». Sonoro «Intercine», 10, ottobre 1935, pp. 64-66 Persuaso che «per il cinema di oggigiorno occorrono meno film ma ragionamenti più seri», Raymond Spottiswoode, autore fino adesso ignoto, ha scritto negli anni 1933-34 a Oxford una nuova grammatica del cinema, un volume di trecento pagine, pubblicato in questi giorni (A Grammar of the Film, Faber & Faber, Londra). L’aspirazione dello Spottiswoode è di dare un sistema completo del fenomeno “cinema”, sistema a cui ha conferito nella parte estetica una struttura basata su di una logica severa e che ha rappresentato, alla fine del volume, in un grafico assai istruttivo. Ogni tentativo di offrire una simile pianta topografica del cinema incontrerà, nel momento attuale, due difficoltà: quella di dover ripetere, per rendere compiuto il sistema, tante cose ormai diventate comuni o perfino banali, e quella di riempire alla meglio certe zone bianche che portano fin’ora poco più di un grande punto interrogativo. Certo è che la maggior parte dei lettori cercherà oggi, in un trattato di teoria cinematografica, in prima linea una risposta alla domanda: «Abbiamo oggi ancora la possibilità di fare del buon cinema?» e inoltre delle direttive concrete per l’uso dei nuovi mezzi quale il suono, il colore ecc.; ed è altrettanto certo che il fastidioso lavoro di creare un sistema generale – scheletro di un corpo di cui la carne ormai corrode da diversi anni nella tomba – incontrerà oggi una certa ingratitudine. Film a colori In quanto agli ultimi acquisti del cinema, lo Spottiswoode ci dà alcune osservazioni giuste sul whipe, il nuovo mezzo di dissolvenza per passare da una scena all’altra, presentatoci dalla stampatrice ottica: mezzo di cui egli descrive bene gli svantaggi, ma che ritiene adatto ad esprimere 160 Con maggiore ottimismo, invece, lo Spottiswoode ci dice che il «film sonoro si è giustificato, dimostrandoci che abbraccia tutte le possibilità, più diverse, altre nuove, del suo predecessore» (p. 28). Ma le prove di questa affermazione non sembrano molto convincenti. Evitando una discussione fondamentale sul problema del parlato – problema essenziale del sonoro – egli osserva semplicemente che «il regista deve costantemente tendere ad eliminare le parole» (p. 246), e ci fornisce begli esempi persuasivi del come in certe scene di film recenti il dialogo avrebbe potuto essere sostituito, col risultato di una efficacia maggiore, con motivi ottici (p. 226). Tralasciando, per il resto, il problema del parlato, si occupa delle questioni dell’asincronismo, più o meno conosciute già attraverso i trattati di Pudovkin in poi. È strano: lo Spottiswoode vede benissimo l’artificiosità del montaggio simultaneo “inter-ottico”: «Le contiguità sono tanto più convincenti quanto meno sono forzate; e lo spettro trasparente di una torre di radiotrasmissione che si accampi, fotografata con angolazione di una obliquità preoccupante, in mezzo a una strada di sobborgo, suscita un’impressione quasi ridicola (nel film Telephone Workers di Stuart Legg)»; ma poi si oppone ai nostri rilievi contro il montaggio simultaneo ottico-acustico (“asincronismo”), rilievi che si servono proprio delle stesse argomentazioni. L’interruzione della continuità naturale (mezzo creativo essenziale del cinema, secondo l’autore), può essere giustificata benissimo se si tratta di delimitare il quadro o per il montaggio, ma allo stesso tempo può essere un errore quando questa interruzione si verifica nell’interno della porzione che si è già tagliata dalla continuità naturale: tanto è vero che anche un dipinto veristico sarà delimitato dalla cornice, ma non ci presenterà una figura umana composta soltanto di testa e di gambe, senza tronco in mezzo. Montaggio Nell’esaltazione del montaggio, che egli difende contro gli attacchi del 161 sonoro, lo Spottiswoode si trova sulle orme dei russi. Mentre dei mezzi costruttivi della singola scena (inquadratura) egli ci dà una panoramica piuttosto rapida – nella quale per esempio manca completamente una valutazione dell’illuminazione –, il suo cuore si apre nell’ampio capitolo dedicato alla virtù del taglio. L’antica tesi sovietica che la singola presa sia piuttosto materia grezza, e che unicamente il taglio possa plasmarla, si trova in forma attenuata nella distinzione fra analisi e sintesi, offerta dallo Spottiswoode: «Il regista continuamente scompone la sua materia in sezioni le quali, in diversissime maniere, possono essere mutate per raggiungere i suoi scopi. Allo stesso tempo egli riunisce queste sezioni in unità più vaste, rappresentanti il suo atteggiamento di fronte al mondo, di cui rivela carattere e senso. L’analisi è un’analisi di struttura, degli elementi cinematografici che il regista distingue nei raggruppamenti del mondo reale. La sintesi, d’altra parte, è una sintesi di effetto; costruzione di una struttura mentale dai suoi elementi emotivi ed intellettuali». È chiara dunque la tendenza di attribuire alle singole riprese un carattere passivo di pura esplorazione, mentre al montaggio dei pezzi rimane riserbata l’attività creativa. Opponendoci a tal punto di vista, suggerito dalle estrinseche manipolazioni tecniche, diremo che anche la singola inquadratura può essere sintesi, quando si mettano insieme per esempio due elementi contrastanti, mentre il montaggio è certamente anche analisi del mondo. Vuol dire che non basta affermare che «sintesi ed analisi si determinano l’un l’altra», ma che la creazione di un film è un processo unico che comprende in ogni suo elemento l’insieme di attività e passività, ossia di ricezione e di plasmazione, caratteristica di ogni processo artistico in generale. Non si tratta qui di pura teoria astratta, in quanto le conseguenze pratiche le vediamo subito quando lo Spottiswoode – trattando dei rapporti fra contenuto e taglio – ci dice che un montaggio può dare un effetto artistico anche quando il contenuto delle singole scene sia nullo (p. 211), oppure che il montaggio di sequenze di varia lunghezza distrugge le intenzioni del regista tanto che quest’ultimo deve ricorrere al montaggio di pezzi di lunghezza uguale (mentre sembra ovvio che il ritmo delle lunghezze non possa essere stabilito senza tener conto del ritmo dei movimenti nell’interno di ciascuna inquadratura. A questo proposito è caratteristica (benché non le manchi un certo valore pratico) anche la seguente osservazione del nostro autore: l’apparire di ogni nuova inquadratura sullo schermo produce un certo effetto di sorpresa; effetto che si conserva fino al momento in cui lo spettatore si è completamente impadronito del contenuto dell’inquadratura stessa; poi decade. «Il taglio dev’essere eseguito nel momento in cui la curva del contenuto raggiunge il suo vertice» (p. 219), per non lasciar svanire l’attenzione dello spettatore; spesso, anzi, anche prima, quando cioè si tratti di creare un effetto d’incalzante dinamismo. Anche qui l’autore non ha sufficientemente tenuto conto del carattere dell’inquadratura singola. A parte il fatto che per arri- vare a certi effetti di monotonia e staticità, il regista talvolta prolungherà la durata di un quadro assai più del tempo strettamente necessario per la comprensione del suo contenuto (la tristezza della scrivania deserta di un uomo morto), non bisogna dimenticare che ogni movimento (mutamento) nella singola inquadratura rinnova la necessità della comprensione, e che quindi un tale movimento assolve, per questo rispetto, alla stessa funzione di un taglio. Non pare perciò possibile stabilire in questa maniera il giusto momento per il taglio. Bisogna invece concepire il ritmo di una sequenza cinematografica come fenomeno unico, composto tanto dai tagli quanto dai dinamismi interni delle scene. Limitandoci a discutere alcuni punti del libro di Spottiswoode, non ne possiamo dare un quadro completo. Diciamo soltanto che l’autore conosce il mestiere, cita una quantità di esempi da film vecchi e nuovi, ma dispone allo stesso tempo di una cultura generale che gli permette di rendersi conto del fatto che il cinema non è il mondo, bensì una piccola parte della vita sociale, economica, politica, artistica attuale. In un capitolo apposito egli cerca di dare un senso e una definizione alla terminologia cinematografica, e l’umoristico buonsenso (non sempre molto indulgente) delle sue osservazioni sarà per molti lettori un’utile cura ricostituente contro la continua seduzione di sottomettersi alle valutazioni imposte dalla pubblicità dell’industria cinematografica. 162 163 C’è bisogno della bellezza? Molto significativa da un punto di vista più generale ci appare la discussione finale sulle due tendenze dell’estetica moderna: quella che sostiene che «l’opera d’arte ha un valore in sé, mentre il contenuto è necessario ma indifferente», e l’altra «che fa del contenuto il fattore determinante, stimando un’opera d’arte a seconda dell’effetto che essa produce sullo spettatore». Su questo punto si desidererebbe un’opinione più precisa da parte dell’autore. Egli vede bene che nel documentario «c’è maniera di usare ogni possibilità di inquadratura, cadenza di presa ecc., così da rendere la rappresentazione di una scena più efficace» (p. 296), ma nella stessa pagina ci dice che «il contenuto dev’essere scelto per la sua importanza e non per la sua adattabilità allo schermo», e in un altro punto, discutendo il cinema propagandistico, non si perita di affermare che in questo caso non si richiede, generalmente, dall’artista una tecnica perfetta, «dato che la capacità di stimolare gli altri all’azione è di rado direttamente connessa alla chiarezza dell’espressione» (p. 237). Discussioni di questo genere, caratteristiche della preoccupante deficienza d’istinto artistico nella nostra epoca, hanno oggi una influenza diretta sulla produzione del documentario – il settore più importante del cinema attuale – in quanto lo espongono a due pericoli opposti: il pericolo di dedicarsi unicamente al gioco delle pure e belle forme, o quello dell’arida didattica e della mera propaganda, piena di disprezzo puritano per le “bellezze mondane”. È necessario che arriviamo ad un concetto più moderno, più vero e più degno della bellezza definendola come il mezzo indispensabile per rappresentare ai nostri sensi un argomento importante nella maniera più precisa ed efficace. Espressione «Intercine», 11, novembre 1935, pp. 47-49 mezzo d’espressione che, strettamente riservato al Cinematografo, trasporta la realtà radicalmente su di un altro piano dove ogni dettaglio materiale lascia trasparire un significato generale dove ogni fenomeno individuale è allo stesso tempo immagine precisa di un concetto. Lo sentiamo appunto nelle esagerazioni formalistiche di un fanatismo che ha qualcosa di polemico. Godiamo il sapore di queste belle forme ottiche, senza sentire molto le tristezze del dramma che esse vorrebbero interpretare per noi. È qualcosa come quei dolci che per un massimo di raffinatezza hanno un fondo amaro. Divulgazione Siamo forse al Giudizio universale del cinema? Gli spiriti dei classici risorgono dalle loro tombe e avanzano attraverso gli studi cinematografici di tutto il mondo: il Dottor Caligari in Inghilterra, il Golem in Francia, lo Studente di Praga, Giovanna d’Arco e gli acrobati di Variété in Germania, la Vedova allegra in America; ritornano Bohème, Show Boat, Il ventaglio di Lady Windermere, The Informer, La santa e il folle e Louis Lumière, più radicale di tutti, ha rifatto, per i suoi esperimenti di film stereoscopico, il primo film del mondo, l’Arrivo del treno, che è del 1895. Siamo ad un rinascimento o si tratta piuttosto di una esumazione di nomi, di titoli? Non ci daranno questi tentativi la prova più chiara del fatto che il cinema, attratto dai poli di due mezzi d’espressione opposti – immagine e parola – si è allontanato per sempre da quella forma condensata, pura, e perciò così efficace, che si manifestava in quei vecchi capolavori? Che soddisfazione, che sentimento di benessere, quando un regista osa ancor oggi di adoperare quell’autentico linguaggio cinematografico. Notturno di Gustav Machatý dieci anni fa sarebbe stato un buon film normale. Oggi esso rappresenta – malgrado il suo titolo – un raggio di luce nelle tenebre. Machatý, apparentemente disinteressato del suo soggetto, puramente commerciale – atteggiamento che senza dubbio deriva da un certo distacco di questo artista dalla vita in generale –, si è dedicato completamente al culto dei simboli ottici; ed è appunto perché egli non sente la materia emotiva del soggetto, questi simboli si irrigidiscono in una vera e propria ideografia, non troppo dissimile dai geroglifici egiziani. Ricordiamo la prima scena del giardino zoologico: quella tigre in gabbia, col minaccioso ritmo del suo andare e venire a pendolo; quella donna immota, sul volto della quale si muove, nello stesso ritmo pendolare, l’ombra di un tralcio mosso dal vento. Questi non sono più particolari di un ambiente organico, non sono più movimenti naturali; sono addizioni sintattiche di concetti, dinamismi astratti imposti alla natura. Eppure: malgrado che l’ispirazione si esprima qui in una sequenza di formule, sentiamo con vivo piacere in questo film la potenza di un Fino dai suoi primordi, il cinema si è servito delle grandi opere letterarie per trasfondere nelle proprie vene – sempre un po’ anemiche per quanto riguarda spirito e “materia umana” – qualcosa del succo vitale dei poeti. Il che va benissimo fino a quando la riproduzione cinematografica non è che un surrogato dell’opera originale. Praticamente, in questi casi, il pericolo non è troppo grande: tanto, la massa degli spettatori non avrebbe in nessun modo con le opere originali quel contatto diretto che le edizioni cinematografiche delle opere letterarie potrebbero altrimenti impedire; mentre lo spettatore colto certo non smarrisce il ricordo della lettura di Dostoevskij quando vede sullo schermo Rodjon Raskolnikov o Dimitri Karamazov. Si è formata però negli ultimi tempi – e precisamente da quando la parola è entrata nel cinema – una tendenza pericolosa a considerare il cinema come un autorizzato “divulgatore” della letteratura. Nel numero 8-9 di «Intercine», Emile Vuillermoz ci ha detto che il film parlato mette alla portata di tutti, in perfetta interpretazione, tante commedie che fino ad ora erano affidate alle mediocri stagioni teatrali di provincia. Ed anche Erich Engel, il regista della riduzione di Pygmalion, ci dice che il cinema dà alle masse l’occasione di conoscere opere che in forma di libri non avrebbe mai conosciute («Film Kurier», n. 245). Ora ci pare che opinioni di questo genere siano energicamente da combattere, perché un giorno esse potrebbero avere serie conseguenze nella pratica educativa. Un film, anche se è buono ed istruttivo – e magari in misura equivalente alla letteratura – non potrà mai sostituire una determinata opera di un’altra arte. Confessiamo francamente che, fra la recitazione difettosa di un testo originale di Shakespeare, presentata da una compagnia teatrale di terz’ordine, e la riduzione della stessa opera fatta per il cinema da Max Reinhardt con i migliori attori del mondo, ci pare, ex principio, enormemente più shakespeariana la prima. Può darsi che le messe in scena del Globe Theatre susciterebbero tutto il disprezzo e l’ira di un produttore cinematografico d’oggigiorno. Eppure… Certo, le opinioni sul miglior modo di divulgare un’opera letteraria divergono alquanto. Così, per esempio gli esercenti cecoslovacchi – i quali evidentemente non si fidano molto della cultura letteraria dei loro clien- 164 165 Notturno ti – annunciano il film del suddetto Erich Engel con le seguenti parole: «Pygmalion non è un rimedio contro il mal di testa, ma un bel film». Tutti i colori Per i bisogni del film a colori, il truccaggio degli attori deve essere molto attenuato, ci dice Ray Rennahan, capo-operatore del Technicolor e quindi attualmente uno dei più importanti personaggi del mondo cinematografico («American Cinematographer», n. 7). Tanto è vero, egli dice, che gli attori di Becky Sharp, se fossero andati a passeggiare per strada, non avrebbero suscitato «nessun commento». Non ne dubitiamo: ma c’è da aggiungere che sullo schermo codesto truccaggio suscitava molti commenti da parte dei critici. Quando, infatti, nella prima scena di Becky Sharp la tenda si apre, lasciando vedere i volti di alcune belle ragazze, il colore giallo-arancio di questi era talmente pronunciato che non si aveva l’impressione dell’epidermide umana. L’impressione generale che gli attori dei film a colori soffrano di un eccesso di buona salute, porta a discutere se l’estrema violenza dei colori sullo schermo, distraendo enormemente l’attenzione del pubblico dall’azione, rappresenti un fenomeno “costante” (e quindi da abolire) oppure se la colpa sia dei nostri occhi, troppo poco abituati finora alle nuove sensazioni. Nel suo articolo Learn about Shouting Color from “Becky Sharp” (nello stesso numero dell’«American Cinematographer»), Karl Hale mette giustamente in rilievo l’enorme potenza dei colori fondamentali e raccomanda di evitarli, appunto per mantenere il predominio del contenuto sulla forma. Meglio che sopprimerli del tutto, sarà probabilmente di usarli con molta cura così da accentuare i centri dell’attenzione. È indiscutibile che nell’immagine media degli attuali film a colori, lo spettatore si perde e si sente abbandonato. Ciò dipende in parte dalla scomparsa quasi completa delle ombre, – difetto che, secondo J. A. Ball («Journal of the Society of Motion Picture Engineers», n. 2), si abolirebbe adoperando sorgenti di luce di numero minore ma di intensità maggiore –, in parte dall’uso puramente decorativo e scenografico dei colori. Sul valore espressivo dei colori fa delle osservazioni molto giuste Rouben Mamoulian in un articolo: Some Problems in Directing Color Pictures («Journal of the S.M.P.E.», n. 2; «Cinema Quarterly», n. 4) articolo che potrebbe riuscire molto utile a Rouben Mamoulian, regista di Becky Sharp. Egli non manca di citarci una scena che, appunto perché rappresenta un esempio isolato ed unico, è stata sùbito citata in tutte le critiche, diventando “classica” da un giorno all’altro nel campo della teoria del colore cinematografico: è la sequenza del pànico che si verifica al ballo della Duchessa di Richmond allorché si sentono tuonare i cannoni di Napoleone. «Vedrete», scrive Mamoulian, «come in maniera impercettibile ma efficace la sequenza arrivi al suo vertice attraverso una serie di immagini che progrediscono dalla freddezza e sobrietà di colori quali il grigio, il blu, il verde e giallo pallido, fino all’azzardo eccitante e pauroso 166 dell’arancio profondo e del rosso fiamma. L’effetto è aumentato dalla scelta dei costumi e delle divise e dai colori degli sfondi e delle luci». È appunto la mancanza di continuità pittorica nella successione delle inquadrature, che colpisce in prima linea nella maggior parte dei film a colori attuali. Ogni quadro è studiato come un dipinto, ma la loro successione dà l’impressione di una serie di quadri messi insieme senza criterio sulla parete di una sala d’esposizione. Il più importante ostacolo contro l’uso veramente cinematografico del colore sembra essere la nuova istituzione del “regista del colore”: il quale è un pittore incaricato di dare alle singole scene colori “belli ed armonici”. È chiaro che la colorazione dev’essere una parte inseparabile del processo creativo affidato al regista; che quest’ultimo insomma, non può ideare l’architettura e il movimento di una scena senza idearne allo stesso tempo i colori, e che certi motivi elementari di colore daranno, in un vero cinema a colori, origine a spunti importanti della trama stessa: talché lo scenario dev’essere già preparato sub specie della tavolozza. Le scene immaginate dallo scenarista e dal regista, farle colorare dopo, con criteri cinematografici, da un pittore, non potrà condurre in nessun modo ad un cinema a colori. Espressione «Intercine», 12, dicembre 1935, pp. 44-46 Molto intelligente e divertente il contributo che John Grierson, capo dell’«unico centro sperimentale del cinema in Europa» (come lui stesso lo chiama) ha dato a un volume dedicato alle arti d’oggigiorno (The Arts To-day, a cura di Geoffrey Grigson, Londra 1935, John Lane The Bodley Head). Non si può esser meno retorici senza cadere nell’ingiustizia. Grierson spoglia il cinema di tutti i pregiudizi commerciali ed intellettuali. Strappando il presuntuoso vestito tessuto dallo zelo dei capi degli uffici stampa e dall’isterica indulgenza dei fanatici, che assolutamente non vogliono venir disillusi, egli ci mostra un corpo nudo: magro, un po’ misero, ma più giovane di quello che si pensava e suscettibile di ogni sviluppo. Volete qualche citazione? «Il costo di un film oscilla fra il prezzo di un ospedale e il preventivo di spesa per la sistemazione dei quartieri poveri di Southwark». «Griffith ha dichiarato, come colpo d’addio sparato dal suo retiro, che una sola riga di Shakespeare vale tutto ciò che il cinema ha prodotto». «Forse i critici hanno commesso uno sbaglio grave e continuo per il fatto che, non trovando nel cinema argomenti abbastanza profondi per le loro considerazioni, hanno finito con l’identificare la semplice abilità di presentazione con la volontà creativa stessa. Così facendo hanno pervertito la 167 critica e indirizzato almeno una generazione di giovani di buona volontà verso apprezzamenti falsi». «La storia intima di un uomo si racconta in modo più facile mediante il suono anziché mediante il silenzio. Il silenzio la spingeva inevitabilmente verso orizzonti più larghi, verso tempeste e maree, vasti avvenimenti di natura. Il silenzio poteva difficilmente evitare l’epos, mentre il suono ne è capace. Nello stesso modo però come il silenzio ha creato una propria forma temporale e un proprio senso della distanza, così anche il nuovo mezzo potrebbe offrire la sensazione profondamente contrappuntata di grandi avvenimenti. Delle voci di una folla o di un popolo si potrebbe dar la sensazione; avvenimenti complessi potrebbero essere drammatizzati mediante il montaggio di suono e di voce e mediante tutte le possibilità di combinare, a mezzo del suono, un fatto presente con i suoi effetti lontani». «L’avanguardia alzava la testa ovunque ricchezza di famiglia ed entusiasmo giovanile lo permettevano». «La parte più interessante della storia del film russo non comincia che subito dopo il Potëmkin e La fine di San Pietroburgo. Perché quei primi film con i loro racconti di guerra e di morte presentavano un materiale relativamente facile ed il loro carattere melodrammatico non divergeva molto dall’esempio di D. W. Griffith. C’era lo stile cinematico più brillante; c’era l’importante creazione artistica della folla; ma l’effetto totale era tisico e, in fin dei conti, romantico [...] I registi russi sono troppo impegnati nell’estetismo vano di ciò che chiamano i loro film spettacolari, per poter contribuire ad un efficace insegnamento popolare attraverso il cinema. Hanno veramente risentito molto della libertà data agli artisti in un primo momento di fiducioso entusiasmo rivoluzionario, perché la loro tendenza era di isolarsi sempre di più in situazioni e rappresentazioni di carattere intimo. Non meno di un qualunque borghese si sono adornati coi nastrini dell’arte». «Come lo vedo io, l’avvenire del cinema forse non sta per niente nel cinema stesso. Esso potrà anche presentarsi umilmente in forma di propaganda e pubblicità, o francamente in forma di elevazione e educazione. Può diffondersi pian piano col mezzo di associazioni come quella dei Giovani Cristiani, di auditori ecclesiastici e altre fortezze di bonifica suburbana. Lì è l’avvenire per l’arte cinematografica, giacché nel cinema commerciale non c’è avvenire degno d’essere salvato». Dato però che per il momento le “stelle” non si sono ancora del tutto estinte, occupiamoci un po’ delle loro proporzioni corporee. «Dal punto di vista della biotipologia sociale, nessuno vorrà misconoscere né l’importanza del film come elemento che agisce sulla valutazione estetica del corpo umano e indirettamente sulla scelta sessuale, né come mezzo per conoscere e descrivere quale sia l’ideale della bellezza somatica in un dato momento». È questa la ragione perché Raffaello Maggi si è dato allo studio degli attori cinematografici, e il risultato di questo studio vien pubblicato nella serie ottava dei «Contributi del laboratorio di statistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore» di Milano. Era attraente anche la ricchezza del materiale che lo scienziato facilmente poteva avere a propria disposizione: oltre ad infinite fotografie ed ai film stessi, si sapevano anche le altezze degli artisti in centimetri, e gli allevatori di Hollywood hanno perfino procurato il peso dei principali stars –«appellativo usato per ambo i sessi», come ci spiega il nostro autore. Il “canone ideale” di cui si preoccupavano già i grandi scultori greci, gli artisti-scienziati del Rinascimento e tanti altri, non ha dunque perduto niente del suo fàscino, e diciamo subito agli aspiranti di una carriera così splendida che il prof. Maggi ha trovato per l’altezza media degli attori la cifra di 177 centimetri, per quella delle attrici 165 centimetri, mentre per il peso risultano 74 chilogrammi per gli uomini e 52 per le donne. Che queste cifre non rappresentino una semplice media casuale ma che abbiano, nella produzione cinematografica, un certo valore normativo, si deduce dal fatto interessante «che la variabilità della statura è costantemente superiore nelle popolazioni prese come base di controllo che negli attori, così di sesso maschile come femminile. Le differenze sono molto forti e dimostrano che, in ciascun gruppo nazionale di attori e di attrici, v’è una rilevantissima omogeneità di statura». Certo bisogna d’altra parte, per la valutazione di queste ricerche, tener conto del fatto che le differenze di misura dalle quali l’autore trae le sue conclusioni non superano mai pochi centimetri o percenti, mentre il numero dei casi esaminati è assai basso, in modo che si può fidarsi – come osserva del resto l’autore stesso – di questi risultati soltanto approssimativamente. Tuttavia è interessante sapere che, per esempio, fra gli attori (americani, francesi, inglesi e tedeschi) quelli americani hanno l’altezza media maggiore (179 cm.), mentre per le donne vincono le tedesche con 168. La media minima la troviamo nei francesi (175 cm.) e nelle americane (162 cm.). «Secondo i registi tedeschi, attori ed attrici devono essere molto uniformemente assortiti, mentre ai registi americani piace un forte distacco fra i due sessi». Se si mettono in rapporto, come è indispensabile, queste cifre con quelle medie per la popolazione dei paesi relativi, vediamo: primo, che gli attori sono in genere più alti della popolazione a cui appartengono (ad eccezione delle sole attrici americane); e, secondo, che la grande differenza di statura fra attori e attrici americani corrisponde ad una altezza eccezionale degli uomini rispetto all’americano medio, mentre l’altezza delle donne è uguale a quella media dell’americana; la scarsa differenza di statura fra attori ed attrici tedeschi invece ripete esattamente la proporzione che si trova – su di un livello più basso di cifra assoluta – nella popolazione tedesca in genere. Mentre il peso dell’attore americano supera quello dell’americano medio di 10 chilogrammi – in corrispondenza alla differenza di statura –, le attrici, malgrado che siano di altezza uguale a quella media delle americane, pesano 4 chilogrammi di meno della donna media. Cavando poi, grosso modo, dal quoziente peso-statura una misura per l’armonia del corpo, il Maggi osserva che «tanto negli attori, quanto nelle attrici, ha 168 169 Antropologia delle stelle luogo una rilevantissima armonia di proporzioni fra massa e lunghezza corporea, maggiore assai che non nella popolazione in generale». Dalle sole dimensioni corporee, l’autore passa poi ai rapporti fra costituzione fisica e psichica, contentandosi però per la parte statistica, dato il numero scarso dei casi esaminati, di un solo tentativo di raggruppamento dal quale risulta che, fra gli attori americani, i «caratteristi» hanno un’altezza media di 182 cm., i «ruoli gai» una di 174 cm., mentre in mezzo stanno i ruoli seri con 178 cm.; per le attrici non si constatano differenze di questo genere. La stessa situazione si presenta per i pesi. Infine, il Maggi si dà all’analisi degli attori rispetto ai singoli «tipi di costituzione», esaminando la forma dei visi. Dato che si scende qui nell’esame particolare dell’individuo, non possiamo riferire i risultati, ma ci sembra che appunto queste ricerche, staccandosi dalle indagini statistiche (di valore più o meno dubbio) a favore della descrizione individuale, possano dar lo spunto il più fecondo ed utile. Poiché nell’attore si cristallizzano molto probabilmente quei vari tipi costituzionali che nell’uomo normale si trovano realizzati generalmente in modo piuttosto impuro, la scienza biotipologica potrebbe trarre, dall’esame di questo gruppo di tipi scelti, dei risultati altrettanto interessanti di quelli che per adesso ha saputo trarre dallo studio dei... pazzi. gravita come uno scafandro da palombaro. L’avvenire di Sternberg dipenderà dal fatto se egli si deciderà a staccarsi da questi residui di gravità terrestre, di quel dramma per il quale, come ormai dobbiamo capire, non c’è humus in California, e a darsi invece al balletto splendido e spiritoso, molto più congruo con la mentalità del luogo di provenienza in generale e col regista Sternberg in particolare. Capriccio Fino allo Scarlet Empress, ogni nuovo film di Josef von Sternberg ci dava l’impressione: «così non può continuare!». Ma quando si vedeva quella zarina snella, palesemente antistorica, muoversi agilmente in un ambiente di un decorativismo altrettanto ostentato, si cominciava a capire che qui non si trattava più della rappresentazione di problemi drammatici ma di tentativi verso un nuovo stile di pantomima coreografica. Se l’estremo tradimento del verismo sternberghiano dell’epoca dei Docks di New York e dell’Angelo azzurro fece infatti prevedere un prossimo irrigidimento completo, questo nuovo tipo di Cinema stilizzato, ancora in uno stato impurissimo, sembra dar al nostro regista l’occasione di una nuova evoluzione lunga ed interessante. Sembra però che egli stesso finora non senta con molta precisione la sua direzione futura, oppure che gli dispiaccia di rinunciare all’alto compito del dramma. Perché mentre, in The Devil Is a Woman, da una parte Marlene Dietrich non è più “poco naturale” ma invece non meno stilizzata e dinamizzata che le comiche classiche di Mack Sennett, trasformando cioè ogni mimica e pantomima veristica in un linguaggio di movimenti continui e forti, movimenti del corpo serpeggiante, del bacino, delle membra, dei globi oculari, delle palpebre palpitanti... mentre insomma Marlene, rappresentante del “nuovo” Sternberg, incarna il carattere instabile della sua Concha oscillando materialmente e instancabilmente, il suo partner Atwill oppone al viso rigido della donna tutte le finezze psicologiche del suo, e alla di lei ginnastica capricciosa un corpo pesante sul quale una sofferenza continua 170 171 Il contributo a «Cinema» Perché sono brutti i film a colori? «Scenario», 3, 1936, pp. 112-114 1936-1938 Anche un breve chiarimento sull’estetica del film a colori non può partire (così ci pare) che dai dati ottici e fotomeccanici del problema. Il lettore che stimasse poco attraente, anzi arido addirittura, un simile “cappello”, salti a piè pari tutta la prima parte di questa nota. Tutte le tinte su cui si basa l’immagine bianca e nera del Cinema, si possono raggruppare in una gamma ad una sola dimensione, che dal nero conduca al bianco, attraverso tutte le sfumature del grigio. Ogni immagine di questo genere si potrebbe anche rappresentare sotto la forma di un rilievo, i cui punti più alti simbolizzerebbero i bianchi estremi, mentre i neri corrisponderebbero ai punti più bassi. Ad un’immagine colorata, invece, una simile rappresentazione “a valli e a monti” non si può applicare; giacché la immagine policroma ci presenta di regola un insieme di più gamme più o meno incrociantisi, la cui tonica è sempre un colore fondamentale o composto. Possono darsi due tipi di gamme ad una sola dimensione; le chiameremo gamme quantitative e gamme qualitative. Gamme quantitative, o di chiarezza, sono quelle in cui un certo colore fondamentale o composto vien condotto dal suo valore più scuro fino a quello più chiaro, per esempio un blu scuro fino ad un celeste chiaro. Le gamme qualitative, o di tinte composte, conducono invece da un colore all’altro, per esempio dal giallo fino al rosso attraverso il giallo-rosso ed il rosso-giallo. Dal film monocromo sappiamo che due tinte possono essere uguali, simili o estremamente diverse, a seconda che distino più o meno sulla “gamma”. L’uguaglianza serve: 1) a produrre una superficie omogenea (per esempio un cielo monocromo); 2) a creare un intimo rapporto fra più oggetti per rendere identica la loro funzione nell’immagine (per esempio la vedova nera e il canino nero nella Vedova allegra); 3) a far fondere oggetti confinanti (per esempio un vestito nero su sfondo nero); Il contrasto serve: 1) a distinguere un oggetto dall’altro (per esempio un vestito nero su sfondo bianco); 2) a creare una suddivisione all’interno di un oggetto (per esempio l’uniforme a strisce bianche e nere delle Ragazze in uniforme); La somiglianza serve: 1) ad esprimere una distinzione attenuata fra due oggetti che né si contrastano né si eguagliano; 2) a dare delle ombreggiature all’interno di un oggetto. 173 Nel film monocromo esiste un’unica maniera di distinguere recisamente un oggetto da un altro: il contrasto fra bianco e nero. Nell’immagine policroma sono invece possibili tante distinzioni recise quanti sono i colori fondamentali. Se supponiamo tre i colori fondamentali (gli esperti non sono ben d’accordo sul loro preciso numero…), saranno possibili tre coppie di colori recisamente contrastanti: azzurro-giallo, azzurro-rosso, giallo-rosso, oltre al contrasto fra tinte di chiarezza estremamente diversa. Ne segue, in primo luogo, che nel film monocromo un certo oggetto si può distinguere in modo reciso dal resto dell’immagine soltanto se questa parte rimanente è omogenea in sé, cioè ad esempio se quella vedova nera e il suo canino nero si trovano su uno sfondo completamente o quasi completamente bianco. Nell’immagine policroma invece, si può mettere in rilievo un oggetto anche se nel resto dell’immagine esistono altre distinzioni estreme; per esempio, una ragazza vestita di rosso su uno sfondo di cielo azzurro, alberi verdi, campi gialli. La netta accentuazione di un determinato oggetto – strumento sovrano della regia ottica – perde così, nel film policromo, molto della propria crudezza. Il contrasto diventa meno duro, potendo distribuirsi su più che un’unica coppia di poli, diffondersi, per così dire, in più dimensioni, e avvenire, inoltre, su un unico livello di chiarezza, non avendo cioè bisogno di ricorrere ai contrasti di chiarezza (che in generale danno effetti assai violenti). Mentre dunque nel film monocromo esiste una sola coppia di poli – bianco e nero – nella cromocinematografia ne esistono tante quanti sono i colori fondamentali, ed inoltre l’impiego di colori composti non comporta senz’altro, come nel film monocromatico, un’attenuazione del contrasto: un rosso, per esempio, può differenziarsi estremamente da tutti i valori della gamma azzurro, azzurro-verde, verde-azzurro, verde-giallo, giallo-verde, giallo. Dal fatto che nel film a colori la probabilità che due oggetti abbiano lo stesso colore è assai minore, ne risulta considerevolmente arricchita la “sintassi ottica”; con la doppia conseguenza di poter da un lato stabilir rapporti molto più complicati fra gli oggetti di una stessa immagine, ma dall’altra di trasformare la composizione artistica del quadro in un compito enormemente più difficile. Questa composizione si solleva – per servirmi d’un paragone soltanto approssimativamente esatto – nel campo della polifonia. Sorge la possibilità di disarmonie. Entro un’unica gamma ottica sembra che non possano esistere disarmonie, poiché tutte le sue tinte singolari – al contrario degli elementi di una gamma musicale – hanno l’identica funzione: non esistono, per esempio, le “dominanti”. Perciò nell’immagine monocroma non genera disarmonie neanche un raggruppamento casuale e arbitrario, e gli errori di composizione riguardano soltanto l’equilibrio spaziale del quadro. La stessa regola sarebbe valida, se non ci inganniamo, per un’immagine policroma che si tenesse rigidamente nei limiti di una unica gamma di chiarezza (per esempio tutte le sfumature fra azzurro scuro e chiaro) o di una “gamma qualitativa” (per esempio tutte le sfumature fra azzurro e rosso); e sarebbe valida probabilmente anche per un’immagine composta soltanto dei colori fondamentali, non misti fra di loro (se è vero che anche i colori fondamentali hanno tutti l’identica funzione nell’immagine). Ma appena si cominciano ad introdurre tinte miste di elementi di gamme diverse – ciò che in pratica naturalmente avviene in quasi tutti i casi –, ecco che diventano possibili le disarmonie, probabilmente perché in questo caso il rapporto fra due colori, potendo comprendere più che due colori fondamentali, perde la propria “monodimensionalità”; un tale rapporto, per esempio, può contenere ad un tempo uguaglianza e differenze: arancio (= rosso + giallo) e violetto (= rosso + azzurro) – e può darsi che questa ambiguità “logica” si riveli all’occhio in forma di disarmonia. Ma con ipotesi come la nostra bisogna andare assai cauti, dato che ci troviamo in un terreno quanto mai inesplorato, anzi addirittura paludoso. Le leggi a cui obbediscono le armonie dei colori, non sono finora mai state formulate in modo soddisfacente malgrado vari, anche illustri, tentativi (Goethe, Ostwald). Un occhio dotato di sensibilità le osserva istintivamente, mentre, ove questa capacità manchi, poca speranza rimane di coglierle per caso. (E si osservi che non abbiamo ancora detto niente delle dimensioni, della sagoma e della posizione delle superfici colorate, e niente del soggetto rappresentato nel quadro – fattori, questi, che non soltanto complicano ancor più la composizione, ma che probabilmente hanno anche una influenza sulle stesse armonie dei colori!). Molte persone di gusto chiamano brutti i colori “naturali” dello schermo; e molti li chiamano poco naturali. Ciò che può significare o che i colori sullo schermo sono altrettanto brutti che quelli della natura, oppure che i colori belli della natura vengono falsificati dal cinema. Facciamo un esperimento pratico: mettiamo nella luce del sole una signorina a colori possibilmente naturali, e osserviamo la sua immagine sul vetro smerigliato di una macchina fotografica. Quel che vediamo somiglia in un modo preoccupante alle immagini del film a colori. Tutti i colori appaiono esagerati, disarmonici, la ragazza sembra tinta esageratamente, tutto il quadro appare volgare e insipido. Se guardiamo un buon dipinto nella stessa maniera, lo vedremo apparire sul vetro smerigliato nella sua solita bellezza. Ne segue evidentemente che la colpa degli effetti brutti sullo schermo non è, come si afferma spesso, degli apparecchi di registrazione o dei truccatori (seppure può ammettersi che gli uni e gli altri non adempiano ancora il loro compito con piena soddisfazione). Si tratta invece in prima linea di cause psicologiche, non fisiche: appena una fetta di realtà diventa immagine, diventa rappresentazione, noi la guardiano con occhi diversi. (La riduzione dello spazio tridimensionale a superficie piatta favorisce probabilmente assai questo nostro mutar d’atteggiamento). Noi consideriamo forse quella fetta di realtà come un dipinto, e le poniamo perciò tutt’altre esigenze. Quando vidi per la prima volta un film a colori naturali ebbi, uscito dal cinematografo, una sensazione terribile: vedevo tutto il mondo come un film 174 175 a colori. I Monti Albani mi si offrivano in un violetto sdolcinato e volgare, dietro a una fila di pini di un verde scuro, con sopra un cielo verde smeraldo: tutto uno sfarzo di tinte enfatiche, velenose, un’immagine caotica, stonata, nemica. L’immagine non durò per fortuna che pochi minuti, dopo di che, senza che l’illuminazione fosse gran che cambiata, il nostro consueto paesaggio serale mi riapparve in tutta la sua calma: i monti lontani, gli alberi solenni, il cielo romano nell’ultima luce del giorno. È bella la natura, ma non nel senso dell’arte. Raggruppa i colori a caso e perciò generalmente in modo disarmonico, o meglio, al di là di armonia e disarmonia. Ove la natura, per caso, sembra accennare un interessante motivo d’armonia, il pittore può servirsi del suggerimento per realizzarlo, ciò che significa: precisarne le uguaglianze, le distinzioni, le somiglianze; subordinare e adattare al motivo centrale tutto il resto. Da questo sistema di rapporti che include anche i valori suggestivi dei colori – quello che Goethe chiamava il loro effetto “sensoriale” – risulta una rappresentazione caratteristica e univoca del soggetto. A primo sguardo, si constata un ordine lucido e chiaro, e i colori messi a servizio degli oggetti rappresentati non appaiono più come macchie di vernice. Siamo dunque abituati a percepire un quadro come un organismo architettato e significativo; di qui il nostro spavento, il nostro senso di disinganno, di fronte alla maggior parte delle fotografie a colori naturali. Non vi troviamo arte e, d’altronde, non sappiamo deciderci a considerarle natura, realtà. Nella vita pratica la vista non è altro che uno strumento dell’uomo per orientarsi nel suo ambiente. I colori l’aiutano a identificare gli oggetti e a separarli l’uno dall’altro. L’interesse si concentra perciò sugli oggetti singoli, non sui rapporti fra i singoli elementi ottici. La visione complessiva di quel che l’occhio in un determinato momento ci presenta non ha valore biologico e perciò non vi percepiamo né armonia né disarmonia. Soltanto la visione estetica (che non è da confondersi col “godimento della natura”) crea la premessa indispensabile di ogni arte visiva. Dunque: la confusione babilonica delle immagini del cinema a colori, il rilievo irritante concesso a certe tinte, la complicatezza dei quadri, la distrazione dal soggetto a favore del colore come materia astratta – tutto questo dipende da ragioni tecniche al più in via secondaria. La ragione principale è la “naturalezza”, la mancanza di elaborazione estetica. Né sapremmo scorgere un rimedio nell’attenuazione schematica di tutte le tinte – ricetta oggi spesso raccomandata nelle riviste professionali –, né crediamo indispensabile di abbandonare il verismo per giungere ad una forma artistica (seppure nei disegni animati, come si sa, il problema diventi molto più semplice). Perché in un buon dipinto non danno nessun disturbo, anzi risultano assolutamente naturali visi molto più colorati di quelli d’un film a colori? Perché perfino un color rosso acceso non urta affatto? Appunto perché in un buon dipinto ogni elemento è inquadrato in un sistema di forme e di colori, che dà il giusto equilibrio all’insieme; perché non vi esistono parti senza colore preciso, senza carattere colori- stico; perché le intensità dei colori e delle chiarezze sono in proporzione indovinata rispetto alle dimensioni delle singole forme. Per quale ragione i colori non distraggono dal soggetto? Perché sono scelti ed eseguiti in modo da servirgli. Per quale ragione il dipinto è chiaro e comprensibile? Perché i contrasti, le eguaglianze e le somiglianze interpretano il soggetto; perché le intensità più forti si trovano precisamente nei punti ove il soggetto richiede un’accentuazione. E perché constatiamo nel film a colori sempre il contrario? Perché finora non si sa dirigere il processo meccanico. Ci sembra poco probabile che il problema sia solubile per il film documentario dal vero, giacché qui tutti i colori sono a priori fissati. Ma ci sembra indiscutibile che con un bel po’ di ingegno la maggior parte delle deficienze possano essere superate nel caso del film fatto in studio, cioè con ampia libertà di determinare a piacere i singoli colori. Per giungervi è però indispensabile creare dall’inizio ogni scena in forme e colori, anzi basare il soggetto su motivi coloristici. Non si può assolutamente invece (sembra assurdo, ma fino ad oggi si procede dappertutto così) determinare l’azione e l’ambientazione di ogni scena con definitiva accuratezza sul copione, e poi consegnarlo ad uno “specialista in colorazione” perché scelga i colori da applicarvi. (È lo stesso errore, che purtroppo è diventato sacrosanta tradizione per la musica cinematografica d’accompagnamento: con l’aggiunta, nel caso dei colori, che le conseguenze sono ben altrimenti disastrose). Se è vero che la sintassi del cinema a colori si presenta, come abbiamo tentato di dimostrare, alquanto complicata, è ovvio che occorra una sensibilità molto più sviluppata di quella richiesta dal film monocromo, per giungere a soluzioni sopportabili. D’altra parte, i risultati potranno essere assai più belli, insomma meno primitivi. In un volume d’estetica cinematografica recentemente apparso, Raymond Spottiswoode dice: «Il colore servirà forse a sollevare il livello dei film medi; ma quanto migliore sarà il film, tanto minore sarà il vantaggio che potrà trarsi dal colore». Il lettore che ha fatto la fatica di seguirci sin qui, converrà che noi siamo dell’opinione nettamente opposta. 176 177 A proposito del cinema a colori «Cinema», 2, 25 luglio 1936, pp. 67-68 Trionferà il cinema a colori? Non ci decidiamo ancora a crederlo, come già non avevamo creduto all’avvento del sonoro. Verrà il colore recando dovizia di nuove possibilità e nuove responsabilità e difficoltà per i registi. Realizzato da un direttore geniale, il film a colori ci potrà dare un ammirabile polifonia, sostituendo la primitiva gamma dei grigi con un nuovo sistema di rapporti molto più complessi: il linguaggio di una pittura che si estende nel tempo, che cambia secondo per secondo e che esige, quindi, armonie espressive non soltanto per un unico “quadro” ma per una successione continua di migliaia di quadri. Compito difficilissimo nei “cartoni animati” di Walt Disney – il quale però non ha bisogno di preoccuparsi del realismo dell’immagine fotografica – ma non ancora risolto in film quale Becky Sharp che tuttavia rappresentano esperimenti preziosi, tentativi ragguardevoli di pionieri. È lo studio di una tecnica che fa le sue prove, che va acquistando fiducia in se stessa, avanti di provocare una vera e propria svolta nella storia estetica del cinema. Ora, se anche il pubblico della sala non se ne avvede, convien dire che gli scogli di questa tecnica non sono ancora del tutto superati. Uno dei sistemi più divulgati, il Technicolor, ha vinto da un pezzo le difficoltà della proiezione: nel senso che permette di stampare le scene a colori su una pellicola unica e dello stesso formato di quella monocromatica, dispensando così i cinematografi dalla spesa di nuovi impianti di cabina. Ma il problema della presa rimane ancora complicatissimo. Per ottenere l’unico positivo colorato occorrono tre prese, corrispondenti ai tre “colori fondamentali”: rosso, blu e verde; e per ottenere queste tre prese simultanee occorre una macchina a più obiettivi, oppure per esempio, un dispositivo atto a spezzare il fascio di luce raccolto da un obiettivo unico. Completo sovvertimento, quindi, nel macchinario e nelle installazioni per la ripresa; senza contare che questi tipi di macchine sono mastodontici, pesanti, inadatti ad una lavorazione agile e disinvolta. Un passo avanti, in certo senso, è compiuto dal nuovo sistema Kodachrome, che permette tanto la presa quanto la proiezione con l’attrezzatura usuale. Ma dal negativo ottenuto con questo sistema non si può realizzare che un’unica copia positiva (per inversione); sicché rimaniamo anche qui nella fase dei tentativi; tanto è vero che le applicazioni sono state finora limitate al passo ridotto (16 mm). Il fondamento tecnico dell’attuale cinematografia a colori è, in sostanza, quello notissimo della tricromia: ottenere l’immagine policroma mediante la combinazione dei tre “colori fondamentali”. Il metodo più diffuso per giungere a tale risultato potrebbe chiamarsi “sottrattivo”: per ogni punto dell’immagine si sottraggono dalla luce bianca, mercé adatti filtri, tutti i colori, ad eccezione di quello che si vuole realizzare. A prima giunta parrebbe ovvio che per ridurre la luce bianca, poniamo, a luce rossa dovrebbe bastare un filtro rosso. Invece è così: anche nella fisica, come nella vita, spesso la via buona è proprio quella più lunga. Scomposta la luce bianca nei tre colori fondamentali, è chiaro che, mescolando due di questi, otteniamo un terzo colore (colore “complementare”) il quale, sommato col terzo (per ipotesi rimasto intatto) riproduce il bianco. Per esempio, la miscela Blu + Verde risulterà complementare al Rosso: cioè, unita al rosso, restituirà il bianco. Tali colori “complementa- ri” sono evidentemente tre, corrispondenti alle tre possibili combinazioni dei colori fondamentali. E sono: Blu + Verde; Blu + Rosso; Verde + Rosso (Giallo). Ciascuno di questi assorbe uno dei tre colori fondamentali, lasciando passare gli altri due: per esempio, un filtro blu-verde assorbirà il rosso, lasciando passare Verde col Blu. Ora in una pellicola positiva a colori troviamo appunto tre strati, tinti nei tre colori “complementari” (detti anche “negativi”). Supponiamo che in uno di essi, per esempio in quello blu-verde, ci sia una lacuna chiara, priva di colore. Allora la luce bianca della macchina da proiezione attraverserà prima lo strato giallo, che ne assorbirà il blu; poi lo stato blu-rosso, che ne assorbirà il verde. Il colore superstite, cioè il rosso, non trovando più ostacoli nel terzo strato, dove abbiamo supposto esserci la lacuna chiara, rimarrà intatto e quindi giungerà sullo schermo. È questa la lunga, seppur fulminea, storia dei colori che vediamo finalmente ridere e balzare verso il nostro occhio in sala di proiezione. Il positivo che abbiamo esaminato proviene naturalmente da un negativo. Ma mentre il solito negativo della pellicola monocroma era composto semplicemente di un supporto di celluloide ricoperto da uno strato di emulsione, qui le emulsioni dovranno essere parecchie per poter captare separatamente e fissare ciascuno dei tre colori fondamentali i quali, insieme, compongono il colore dell’oggetto fotografato. La […] sezione microscopica di una pellicola […], diremo l’anatomia di essa, […] vuole spiegare il meccanismo “fisiologico” di ciò che succede quando la luce proveniente dall’oggetto da riprendere attraversa la pellicola. Il supporto è coperto di cinque strati sottilissimi. Esternamente troviamo come primo strato un’emulsione non sensibilizzata che registra soltanto luce azzurra. Segue un secondo strato di gelatina tinto in giallo che serve come filtro per assorbire la luce blu, divenuta ormai inutile, dal momento che ha già impressionato la prima emulsione. Terzo strato: una nuova emulsione che viene impressionata dalla sola luce verde. Quarto strato: altro filtro di gelatina preparato in modo da assorbire i raggi verdi. Quinto e ultimo strato: un’emulsione pancromatica, molto sensibile al rosso, che registra gli ultimi raggi superstiti, cioè i rossi. Il dramma comincia al momento dello sviluppo, il quale deve soddisfare nientemeno che alla delicatissima condizione di tingere in colori diversi i tre strati sovrapposti su pellicola unica. Si tratta poi di render chiari e trasparenti in ciascuna delle tre emulsioni i punti impressionati dalla luce, in modo da creare quelle lacune delle quali abbiamo parlato sopra. Le parti poco o punto impressionate debbono invece venir tinte in colore complementare a quello della luce che ha colpito quella determinata emulsione; quanto meno colpito un punto, tanto più intensamente colorato esso deve risultare sul positivo. La storia di tutti i bagni successivi a cui bisogna sottoporre la pellicola, per sviluppare le tre emulsioni e per passare, secondo un metodo 178 179 nuovo e ingegnoso, dal bromuro d’argento all’argento metallico, nonché ad una tinta del colore desiderato, distribuita in equivalente proporzione; l’elenco di tutte le avvertenze e cautele ed attenzioni che occorre adoperare costituiscono, nei resoconti della Kodachrome, un mezzo trattato di chimica e di pratica fotografica, e non dei più ovvi. Diremo soltanto che esistono finora due tipi di pellicole Kodachrome. Una destinata alla luce solare ed utilizzabile a normale luce artificiale (molto rossa) con la sola aggiunta di filtro il quale però provoca una forte perdita di luminosità; un’altra fatta per la luce artificiale delle lampade sopravoltate Photoflood, molto in uso presso i cineamatori americani. Volendo utilizzare questo secondo tipo all’aperto, bisognerà adoperare un leggero filtro arancio che assorbe il blu; mentre in ogni altro caso occorrerà comunque evitare l’illuminazione mista di luce solare e luce artificiale. I bicchieri, le vetrate, le maniglie, i mobili lucidati, le unghie, l’occhio umano, irradiano dalla loro superficie dei caratteristici riflessi. Colpiti dalla luce rispecchiano una minuscola immagine molto intensa, e più o meno deformata della sorgente luminosa: un piccolo sole, la lampada elettrica o il rettangolo della finestra. Questi riflessi sono poco o tanto la disperazione dei fotografi e degli operatori cinematografici. Si vuol riprendere, puta caso, una vetrina: ma per effetto del riflesso non si riesce che a scorgere la casa di fronte, specchiata nel cristallo; mentre degli oggetti in mostra dietro il cristallo non si vede più nulla. Problema: come evitare questi riflessi pur senza ridursi a fotografare soltanto delle superfici opache? Il rimedio è stato trovato pochi mesi fa, in uno schermo speciale, il cui funzionamento si basa sul principio della luce polarizzata. Ne sono stati lanciati sul mercato due tipi: uno dalla Eastman, che lo chiama schermo Pola; l’altro dalla Zeiss che lo chiama Herotar. Questi schermi hanno lo scopo di eliminare o diminuire l’effetto della luce rispecchiata dagli oggetti, lasciando intatta la luce diffusa che li illumina. La fisica ci insegna che, sotto certe condizioni, luce rispecchiata e luce diffusa sono di natura differente: quella rispecchiata è “polarizzata”, quella diffusa no. È quindi chiaro che un dispositivo capace di eliminare la luce polarizzata risolverà il problema. La luce è un fenomeno d’ondulazione trasversale: oscilla cioè in tutte le direzioni perpendicolari a quella secondo cui il raggio si propaga. Ma c’è un determinato tipo di raggi che non oscilla in tutte le direzioni, bensì in una direzione unica, o quasi unica, al modo dei pendoli. È questa la luce che si chiama polarizzata. Per esempio: la luce diurna che non ci proviene direttamente dal sole, ma dalle parti del cielo orientate perpendicolarmente alla direzione dei raggi solari, è polarizzata. I raggi riflessi in un determinato angolo da certe superfici (per esempio da una lastra di vetro secondo un angolo di circa 33 gradi) sono polarizzati. Ed infine talune composizioni chimiche e molti tipi di cristalli hanno la proprietà di polarizzare la luce che li attraversa. Ciò premesso, è ovvio che la luce polarizzata, oscillante, per esempio in un piano verticale, può senz’altro passare attraverso un dispositivo polarizzatore, ove il piano di polarizzazione di quest’ultimo sia anch’esso verticale; se il piano sia invece orizzontale, la luce non passerà. Supponiamo di guardare attraverso uno schermo Pola o Herotar le unghie ben lucidate di una ragazza. Queste unghie siano illuminate da luce diffusa (non polarizzata) e brillino inoltre di riflessi (luce polarizzata). Girando lentamente lo schermo, disco di vetro leggermente grigio, vedremo ad un certo momento quei riflessi risplendere più che nella realtà, poi successivamente impallidire ed infine dileguarsi del tutto, mostrandoci opachi quei piccoli artigli poc’anzi così splendidi. Nel primo momento il piano di polarizzazione dello schermo corrisponde a quello su cui oscillava la luce dei riflessi; nell’ultimo era perpendicolare ad esso. Ora, la emulsione fotografica si comporta esattamente come il nostro occhio. Basterà quindi cercare ad occhio la posizione dello schermo che dia l’effetto desiderato, e ripeterla poi identica davanti all’obbiettivo. Si giungerà così, secondo che piaccia od occorra, a rinforzare o diminuire, od eliminare addirittura i riflessi. Si voglia riprendere la solita vetrina, sotto un angolo di circa 30 gradi. Lo schermo polarizzante può abolire tutti i riflessi fastidiosi, se anche la vetrina sia illuminata da una luce qualunque, non polarizzata. In questo caso, infatti, è la stessa superficie riflettente che opera la polarizzazione. Ma in quasi tutti gli altri casi occorre che la luce illuminante sia polarizzata. Per ciò nelle riprese all’aperto si dispone la macchina in modo che la direzione di presa risulti perpendicolare a quella dei raggi solari; nel teatro di posa invece si muniscono le lampade di schermo polarizzante. Un altro schermo di identico tipo si trova davanti all’obbiettivo della macchina. Si tratti di cinematografare lo specchio di un lago. Se durante la presa giriamo gradualmente il nostro schermo, i forti riflessi dell’acqua spariranno a poco a poco, finché sarà dato di scorgere sempre più nitidi i pesci e le piante sottomarine: effetto miracoloso, e, fino a poco tempo fa, irraggiungibile. Ma ancora, siccome la cosiddetta “saturazione” di un colore diminuisce a seconda dello splendore della luce illuminante, si potrà in cromocinematografia cambiare a piacere, anche durante la presa, l’intensità dei colori della scena, girando semplicemente lo schermo davanti all’obbiettivo. 180 181 Polarizzazione. La lotta contro i riflessi «Cinema», 7, 10 ottobre 1936, p. 276 Ma badiamo: la lotta contro i riflessi è solo una parte del problema risolto da questi nuovi schermi. Gli americani, per esempio, hanno molto studiato l’espressione cangiante dell’occhio di un attore, secondo la forma circolare o rettangolare del riflesso sulla cornea: ecco un’applicazione dello schermo. E il gioco dei riflessi rimane pur sempre uno degli effetti più belli della fotografia: talvolta, anzi, basta a creare una sensazione di sfarzo e di lusso: una scena di ballo, poniamo, prenderà maggiore vita dallo scintillio dei gioielli, della seta, dei bicchieri, del pavimento, dei candelabri e degli occhi animati. E non abbiamo imparato in scuola che applicando sul disegno di una mela o di una bottiglia un bel riflesso bianco si ottiene quasi automaticamente un effetto di rilievo e di plasticità? Non si tratta dunque di distruggere semplicemente i riflessi; ma di eliminarli o attenuarli là dove abbagliano od impediscono la vista, conservandoli invece dove abbiano valore espressivo o caratterizzino la materia dell’oggetto. Ma come mai un modesto dischetto di vetro grigio può avere tante virtù? Lo schermo Herotar si serve di una combinazione di chinino e iodio chiamata Herapathite dallo scienziato inglese Herapath che ne studiò le proprietà polarizzanti ottanta anni fa. Nello schermo Pola invece si trova una cultura di innumerevoli minuscoli cristalli bifrangenti e quindi polarizzanti, in cui si riesce, con mezzi delicatissimi, ad ottenere che tutti gli assi risultino in posizione parallela. con trasporti di tenerezza, ci dimostra con un esempio estremamente tipico fino a qual punto è arrivato il distacco dell’arte dalla vita reale. Mentre in un’epoca primitiva fra arte e vita non c’era vera distinzione, in maniera che la creazione artistica sorgeva da impulsi e necessità del momento, in seguito l’artista di teatro fu costretto a recitare ad ore prestabilite e in un ambiente artificiale davanti ad un pubblico passivo e nascosto nel buio. Il cinematografo ha tolto all’attore perfino il suo pubblico: circondato da macchinismi di una sobrietà e di un’indifferenza quasi insolenti, l’artista deve manifestare le sue più intime emozioni, ripeterle, spezzettarle secondo le dure esigenze della tecnica. E se, in generale, le macchine da presa si accontentano della funzione di spettatori, in casi speciali – come in quello di cui parliamo – la macchina entra addirittura in scena a sostituirvi l’uomo vivente: e viene così a ricordarci quelle scene macabre sulle quali si compiaceva di esercitarsi la fantasia di tanti antichi pittori: la danza dello scheletro, con la bella donna giovane. Ammirevole lo sforzo onde l’attrice riempie un vuoto polare col calore dei suoi sentimenti. La mano del regista «Cinema», 8, 25 ottobre 1936, p. 312 A tutti coloro che hanno l’intenzione di far l’attore cinematografico si raccomanda di guardare la fragile e sensibile Ingeborg Theek mentre sta ballando insieme con la macchina da presa. Terribile partner per un ballo, la macchina: due scarne braccia di ferro si stendono verso la ragazza, indicando alle mani di lei la posizione giusta. Una larga cintura nera, chiusa con due forti correggie, lega l’anca della giovane donna ad una grande tenaglia metallica che serve a mantener costante la distanza fra l’attrice e l’obbiettivo della macchina. Vincolata così la propria vittima, la macchina da presa (montata su ruote) si mette a ballare con lei al ritmo della musica. E ricordatevi che si tratta di una scena d’amore (Mazurka tragica): e che, dunque, la giovane deve guardare con sguardo innamorato il morto occhio di vetro nascosto dentro alla scatola nera; che deve, senza badare allo splendore abbagliante dei bulbi di fuoco bianco, sussurrare delle tenere parole verso l’orecchio duro e lucido del microfono che dall’alto si inchina verso di lei. Il gelido abbraccio della macchina, al quale l’attrice deve rispondere Per comprendere una delle funzioni essenziali di quella misteriosa attività che si chiama regia basta osservare il gesto di mano con cui il regista Willy Forst accompagna la recitazione di questa scena di Mazurka tragica: è un gesto che dice: «Andateci piano! Non esagerate!». Ogni individuo chiamato a collaborare ad un’opera collettiva avrà la naturalissima tendenza a sviluppare il più possibile la propria parte, a porla nel centro dell’azione. Così anche l’attore di cinema cercherà più o meno inconsciamente di mettersi in primo piano, di esternare con la massima intensità tutte le sue virtù. L’aspetto più evidente di questo fenomeno è il noto costume dei divi di respingere verso il fondo tutti i loro colleghi, sfogandosi in lunghi monologhi melodrammatici ed esponendo all’occhio sbalordito del pubblico l’intera gamma delle loro formidabili espressioni. Ma anche i più modesti, i più dotati di “senso sociale” vedranno, per forza di cose, l’opera da compiere sempre dal punto di vista del loro compito personale. Ed ecco che deve intervenire il regista. Anche lui è spinto dalla sua funzione personale, ma questa sua funzione consiste appunto nel non partecipare in nessun modo particolare all’azione, ma di plasmare l’insieme di questa. Egli deve stabilire e indicare i limiti necessari all’attività, e anche all’entusiasmo e all’ambizione di ciascun attore, creando l’equilibrio fra tante opposte energie. Quando fra gli attori di un film si trova una personalità molto spiccata o 182 183 Danza macabra «Cinema», 8, 25 ottobre 1936, p. 312 quando il regista non ha una visione precisa dell’opera o è troppo debole per imporla, allora si avrà il pietoso spettacolo – in pratica non tanto raro – di un’anarchia individualistica. Ogni scena (e perciò nessuna di esse) sembrerà la scena centrale; ogni battuta, ogni gesto sarà eseguito in “fortissimo” e si disperderà perciò in un mare di chiasso, ottico ed acustico. Sarà distrutta la gerarchia saggiamente architettata delle scene e dei personaggi. E spariranno le mezzetinte, quegli “effetti intimi” tanto indispensabili al cinema che dovrebbe esser l’arte della discrezione aristocratica, del sottovoce, degli accenni. E perciò la mano “attenuante” del regista, anche se resta invisibile al pubblico, gli si farà ugualmente palese per il suo benefico effetto. un’unità organica, e che quindi siano concepiti insieme. Senza rendersene conto, alcuni direttori di giornali di attualità – osserva lo esperto inglese – vivono ancora nell’epoca del muto. Vedono dapprima la scena ottica e come pura aggiunta il testo, la musica ed altri effetti acustici. Lux e Lumen «Cinema», 9, 10 novembre 1936, p. 340 Una nuova professione, sorta col cinema parlato, è quella del commentatore dei giornali di attualità. Ma bisogna dir subito che una mezza dozzina di anni sembra non sia ancora bastata per trovare le norme necessarie ad un commento efficace. Uno degli errori fondamentali è quello di ostinarsi a scrivere il commento soltanto dopo che il montaggio del film è stato terminato in base a principi unicamente ottici. Tale è l’opinione di uno di questi commentatori, pubblicata da «World Film News». Ci vuole invece, egli sostiene, una stretta collaborazione fra commentatore e montatore: ordine e lunghezze delle singole scene stabilite in riguardo alle parole che le accompagneranno. Ciò non toglie che il commento verbale rimane sempre un elemento secondario, la cui funzione non è che di spiegar meglio ciò che si vede sullo schermo, senza l’aggiunta di parole o frasi estranee al contenuto delle immagini. Le prime cronache dei viaggi dello Zeppelin Hindenburg non includevano scene prese a bordo dell’aeronave, dato che l’accesso ne era interdetto agli operatori. L’espediente di far descrivere a voce l’interno delle cabine, la vita a bordo, le macchine, mentre sullo schermo si vedevano delle scene prese da terra, risultò poco soddisfacente in quanto l’attenzione del pubblico ne restava fuorviata. Fatti resi evidenti dalla sola visione non hanno bisogno di essere commentati. Delle frasi come «Rapidamente la folla occupa la piazza», o «Il mistero ride cordialmente» sono peggio che inutili: diminuiscono l’efficacia della scena. È anche errato pensare che la parola debba intervenire e riempire quei punti nei quali la colonna sonora “dal vero” risulta povera. In questi casi, invece, la musica è molto più adatta per colmar lacune. Soprattutto però occorre insister sul punto che scena e dialogo formino Nella fotometria si distingue fra Lumen e Lux. La quantità di luce emessa da una sorgente si misura in Lumen. La luminosità di una superficie, colpita dalla luce, si misura invece in Lux. Una forte macchina da proiezione emetterà molti Lumen; ma se lo schermo è lontano, o piccolo, o sporco, il numero di Lux prodotto da tutti quei Lumen rimarrà sempre esiguo. Sono due concetti preziosi: perché consentono di distinguere senza equivoco tra valore di un’opera determinata e la reazione che essa provocherà sopra l’oggetto che casualmente la riceve. La più robusta delle sorgenti resta senza effetto se l’oggetto ricevente non è adatto; mentre un grande schermo ben situato farà fare un effettone anche a una sorgente misera. Ne deriva che misurare l’efficacia della sorgente in Lux – ossia misurare una cosa con una misura adatta invece e soltanto agli effetti che essa procura – gli scienziati lo considerano un errore badiale. Vorremmo proporre di trasferire questi due concetti dal campo della scienza a quello dello spirito, perché ci sembra che potrebbero creare un ordine molto utile, eliminando un mucchio di confusioni. Pensiamo a quella quantità di luce spirituale, più o meno grande, che provenendo dallo schermo del cinema colpisce gli spettatori. È chiaro che il flusso luminoso si deve misurare in Lumen, mentre la chiarezza che esso diffonde nel pubblico si misurerà in Lux. Come si spiega allora che tante persone intelligenti, le quali non solo parlano ma anche scrivono di cinema, si mettono a misurare in Lux il flusso luminoso? Se io domando: «Come è questo film?» a una persona cui non verrebbe mai in mente di dire: «Gli affreschi di Masaccio nella Cappella Brancacci hanno scarso successo commerciale; il custode non supera mai le dieci lire di mancia al giorno!», questa stessa persona mi risponderà: «Lo hanno fischiato» oppure: «È il più grande successo della stagione». Evidentemente non ci siamo capiti. Io ho fatto la domanda in Lumen: l’altro mi risponde in Lux. S’intende che qui non parliamo di produttori o di esercenti. Essi non s’interessano della merce in sé ma del suo effetto sul cliente: perché è da questo effetto che dipende il loro guadagno. Essi si occupano unicamente dei Lux e parlano di Lumen soltanto la domenica. E qui non ci sono equi- 184 185 L’uomo invisibile delle attualità «Cinema», 9, 10 novembre 1936, p. 340 voci. Alludiamo invece a quelli che parlano come se ci guadagnassero anche loro, mentre, senza saperlo, ci perdono: i critici. Esiste veramente un settore di una certa importanza nel quale possa esser lecito ammettere il cattivo perché piace ai consumatori; oppure disprezzare il buono perché non piace? È vero, dicono: ma il cinema è lo spettacolo delle masse! E ciò significa “destinato alle masse” o “soggetto al gusto delle masse”? Le due proposizioni si equivarrebbero? Senza dubbio il cinema, in quanto spettacolo per masse, deve andar d’accordo col gusto dei tanti. Occorre però precisare: ai tanti così come sono, o ai tanti come dovrebbero essere? Al gusto, in altri termini, dell’uomo del popolo al quale vanno a genio le cose semplici, forti, essenziali, o al gusto di quelli che si sono sovraccaricato e guastato lo stomaco con cibi troppo dolci o troppo piccanti? Un grande scrittore del Settecento, G. Ch. Lichtenberg, ha detto: «Il libro è uno specchio; se ci si guarda una scimmia, non si può vedere un apostolo». È un’eresia credere che, in questo senso, anche il cinema sia uno specchio? Esiste una sola via: quella di produrre più Lumen che sia possibile, e di far sì, con tutti i mezzi, che ne venga fuori la maggiore quantità di Lux. Scopo niente affatto irraggiungibile se lo sforzo sarà universale e collettivo. Montaggio senza montaggio mo la bocca ciliegia della donna spalancarsi in un grido improvviso di orrore. Così uno spunto d’azione può completamente cambiare senso ed espressione quando gliene venga aggiunto un altro. Larry Semon potrebbe anch’esser nascosto dietro la porta: ma non sarebbe allora poco cinematografico abbracciare i due motivi distanti con una sola inquadratura? Si vedrebbero dunque, supponiamo, prima i due amanti; poi – seconda inquadratura – il rivale in ascolto. Si arriverebbe, anche in questo modo, ad un senso di tensione non dissimile dal primo, per mezzo di una successione (la quale, del resto, è innegabile, trasmetterebbe anch’essa allo spettatore l’idea della simultaneità. Esempio classico della funzione del montaggio: un’unità superiore creata dalla somma di elementi disparati; una tensione drammatica ottenuta con la fusione di motivi contrastanti). Secondo certe teorie ortodosse, un effetto del genere si può raggiungere unicamente attraverso il montaggio. La nostra fotografia dimostra il contrario: è un allegro esempio di “montaggio” all’interno di un solo quadro. Quale dei due metodi è il più efficace? Volendo, si potrebbe affermare che il nostro quadro dà simultaneità nel modo immediato e che l’urto fra i due motivi contrari è quasi assolutamente diretto, senza tagli separatori: basta guardare l’incurvarsi del divano elastico, tanto fastidioso per il povero Larry. Con questo non si vuol dire che il montaggio sia superfluo. Tutt’altro: spesso non sarà né possibile né indicato raccogliere elementi diversi in una sola inquadratura. Ma si vuol dimostrare che il montaggio non ha nessun monopolio. Se ciò può servire a convertire qualche ortodosso, allora Larry Semon non avrà sudato invano in quella scomoda posizione. «Cinema», 9, 10 novembre 1936, p. 343 Senza parola Per quei due ignoranti mortali è un idillico tête-à-tête: ma non per lo spettatore onnisciente. Lo spettatore vede un quadro solo, ma con due centri d’attenzione: in una regione secondaria della scena, riservata alle sole gambe, quasi ai domestici, appare come una fiammella preoccupante la pallida faccia di Larry Semon, corpo estraneo. Loro non ne sanno niente, sono assorbiti l’uno dall’altra, il mondo esteriore non esiste per loro; mentre lui, il terzo incomodo, completamente fuori di sé, è trattenuto dalla paura ma contemporaneamente attirato dalla calamita di quel deplorevole idillio. Il sapore di questa scena sta tutto nella forte tensione prodotta da quella faccia sotto la sedia. Grazie ad essa, l’heure bleue della coppia, in sé tanto pacifica, tranquilla, destinata a durata eterna, vien caricata di una dinamicità latente. Nel bel mezzo dell’estrema serenità si prepara l’estremo opposto: il più vivace movimento. Li vediamo già balzar su, questi due gamboni comodamente abbandonati, vediamo gettare a terra il caffè e latte queste due mani teneramente occupate dalla tazza, vedia- «Cinema», 10, 25 novembre 1936, p. 377 Rodjon Raskolnikov non aveva avuto il coraggio di fare una confessione del suo delitto alla stazione di polizia. «Egli scese ed uscì. Nel cortile, vicino all’entrata, stava Sonia, pallida, mezza morta, e lo guardava fissamente. Egli si arrestò davanti a lei. Un segno di malattia, di dolore era sul volto di lei, misto alla disperazione; un sorriso smarrito, incosciente era sulla sua bocca. Raskolnikov si arrestò, le sorrise e si volse; ritornò all’ufficio di polizia». Anche nel romanzo di Dostoevskij, dunque, questa scena si svolge senza una parola. Si tratta di un’azione qualunque: un uomo vede una donna, si arresta e torna indietro; eppure l’estrema emozione che si impossessa di noi ci dice che siamo ad un vertice del racconto. Potrebbe essere un dipinto, questa semplice raffigurazione di due persone; e, come in tanti dipinti, il momento rappresentato, di per sé poco significativo, è drammaticissimo per 186 187 chi conosce la trama intera. Nel cinema e nel romanzo, è l’opera stessa a narrare gli antecedenti, mentre il pittore non può contare che sulla cultura dello spettatore. (Una delle ragioni perché la pittura preferisce dedicarsi a scene tratte da ben noti racconti religiosi, mitici o simili, è infatti quella di poter evitare a questo modo di limitarsi a soggetti elementarissimi, i soli che possano essere compresi di per se stessi, con i soli mezzi del quadro). Come nella pittura, anche qui l’avvenimento psicologico è completamente sostituito da presenze fisiche: reso quindi visibile. Raskolnikov avendo promesso a Sonia di costituirsi alla giustizia, Sonia è diventata – tanto per l’assassino quanto per il pubblico – simbolo concreto del motivo “confessione”, concetto astratto e quindi anticinematografico. Perciò, quando, dopo la scena nell’ufficio di polizia, la donna di colpo compare, essa si impone quale incarnazione della coscienza, del rimorso. Per arrivare a questo effetto non occorre nemmeno molta “recitazione”: basta la semplice presenza della donna. Effetto fortissimo anche per il fatto banale che Sonia sta ferma. (E qui il cinema materializza magnificamente la visione del poeta). In mezzo al continuo movimento dell’azione cade l’immagine immobile della ragazza, quasi il tempo crollasse; quasi si presentasse qualcosa al di là del movimento e quindi della vita: qualcosa che non fa parte del mondo ma che è invece puro significato, eterno come sono eterni i concetti. Il contrasto tra movimento e l’immobilità della donna – elementare contrasto fisico – aumenta dunque considerevolmente l’efficacia della comparsa di Sonia, traducendo in termini di dinamica un avvenimento che, per tutto il resto, acquista espressione soltanto dal fattore indiretto del significato. Tale effetto, irraggiungibile in pittura, è tipico per il linguaggio dell’immagine animata e quindi in prima linea del cinematografo. E basta una scena di questo genere per farci ricordare immediatamente ciò che le lunghe scene dialogate di questo stesso Delitto e castigo (come di tanti altri film) vorrebbero farci dimenticare: ciò che veramente sia il cinema. Psicologia del “Gag”* «Cinema», 10, 25 novembre 1936, pp. 378-379 Chi ride forte arriva a lagrimare. E, anche in un senso più intrinseco, il vero ridere non è tanto lontano dal pianto. Una strana inversione nei nostri sentimenti ci fa provare un’impressione di gaiezza quando vediamo soffrire, lottare, spaventarsi uomini che siano, per qualche aspetto, “inferiori”: basta per esempio, che invece d’esser “belli”, l’avvenimento e i protagonisti di esso presentino qualche deformità espressiva e che lo * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, pp. 368-369. 188 spettacolo sia o chiaramente avulso dalla realtà (trasportato, diciamo, nella sfera dell’arte), oppure che si tratti di disgrazie o difetti non troppo gravi. L’insufficienza dell’uomo, dunque, e le sue disgrazie, nonché una certa sua astuta maniera di eludere le potenze avverse, ci fanno ridere. E dove si ride “sul serio”, ivi sicuramente non si tratterà mai di cose superficiali, bensì sempre dei fatti più profondi ed elementari della nostra vita; e saranno spesso risvegliate oscuramente in noi delle sensazioni ancestrali, raffioranti cioè nella nostra coscienza civile da un lontanissimo passato selvaggio e animale. Chi ha la pelle del pachiderma ride semplicemente e né sente né sa il perché. Ma chi è più sensibile prova spesso, ridendo, una commozione che di rado danno le tragedie. Quelle vecchie burlette del cinema americano che negli anni dell’anteguerra sbocciavano nel rudimentale “studio” di Mack Sennett, erano tutte intessute dei cosiddetti gags: “trovate” cioè, nelle quali per un attimo l’effetto comico si concentrava fino ad un quadro di densità insuperabile. Di quell’arte, da nient’altro nata che dall’attenta ricerca di ciò che faccia più ridere il pubblico, ci è rimasto oggi, unico, il grande Chaplin. E ci sono rimaste delle fotografie: deboli ricordi, ma che perpetuano spesso proprio quell’attimo della trovata, del gag. È sufficiente una rapida analisi per capire che ogni buon gag si basa ora su questo ora su quell’elemento fondamentale della vita umana. Ed è perciò che quelle vecchie “comiche” di Mack Sennett, oltre al divertire pazzamente spettatori di ogni paese, di ogni età, di ogni classe sociale, erano anche “arte”, a modo loro. Figg. 1 e 2 – Nel mondo magico dei popoli primitivi, il simulacro possiede vita e potenza. È pura apparenza, quel suo carattere di oggetto morto e rigido. Non ci attaccherà alle spalle quando ci volteremo? Questa paura primordiale, benché resa ridicola da un’ambientazione realistica e niente affatto surreale, conserva la sua efficacia anche nel film comico, ed è per l’appunto il terrore nascosto che dà sostanza alla risata. Fig. 3 – Il coperchio, sollevandosi come un sipario di teatro, scopre un brutto tiro del Destino, che cerca sempre di distruggere quanto l’uomo fa per assolvere al suo compito il meglio possibile. E non è un oggetto qualunque, quello che la magia del grande Nemico fa apparire sul vassoio. La visione della bestia viva, proprio nel momento in cui il coltello è brandito, risveglia nel subcosciente il rimorso – mai completamente soppresso – del carnivoro. Anche qui nella risata trema il brivido. Fig. 4 – L’incontro casuale di due oggetti che non hanno niente a che fare l’uno con l’altro crea, con effetto sbalorditivo, una identità nuova. Il “caso” che, in funzione creativa, sostituisce in questa circostanza l’ingegno umano, scopre nel capitello capacità di cappello. Se non riconoscessimo il viso di Buster Keaton potremmo senz’altro credere di trovarci davanti a un’opera “surrealista” di un Fernand Léger o di un Jean Cocteau: 189 i quali – proprio come accade in questo caso di film comico – cercano di comporre, con elementi contrastanti della realtà, un mondo di incubi fantastici, assurdo ma “pensabile”. Figg. 5 e 6 – C’è voluto un dispositivo un po’ complicato per rendere possibile questo trucco prospettico. Il quale è tuttavia ben indovinato perché riesce ad effettuare con la massima concretezza ciò che il povero strabico sognava: la fusione fra uomo e donna non avviene qui certo con la dignità di quella creatura, mezza uomo mezza donna, di cui parla Aristofane nel Convito di Platone; ma questa creatura favolosa, combinando in sé gli elementi eterogenei del brutto e del bello in un nuovo organismo, appare ridicola… oppure tragica (a seconda del punto di vista). In questo caso è un senso di pudore quello che eccita al riso. Fig. 7 – L’ingegno, l’astuzia, sono le uniche armi dell’uomo nella lotta contro le forze barbare della natura. Il gigantesco campione dei gangster sforza il lampione a curvarsi per dar prova delle sue capacità fisiche. Ma per l’appunto nello strumento indifferente di questa prodezza, il gracile poliziotto Charlot trova un potente alleato: il gas narcotizza l’avversario. La spiritosa trovata gli dà la vittoria nel duello mortale. Ridendo, lo spettatore – ometto debole anche lui – trova un po’ di speranza e di conforto. Fig. 8 – Considerare in modo nuovo le cose del mondo e dar loro funzioni nuove: ecco ciò che agevola il progresso e diminuisce le insufficienze della vita. Nel mondo del film comico poi, la buona trovata serve soltanto nel caso specifico senza acquistar valore generale, ma ciò non diminuisce la sua ingegnosità. Sulle acque minacciose la nostra bella invenzione, l’automobile, non serve a nulla, ma ciò che in questo caso porta fortuna è la mentalità dell’eroe comico che vede sempre le soluzioni assurde invece di quelle “naturali”: la modesta capote tramutata in vela dimostra di poter sostituire il motore. La macchina del ventesimo secolo si riduce a veicolo primordiale. Contenti della furberia umana, dobbiamo – sorridendo – riconoscere tuttavia che in fondo non abbiamo fatto neppure un passo avanti. Fig. 9 – Nella fase della sua decadenza, il film comico ci presenta un mondo troppo ben fotografato, troppo “vero”: nel quale appare quindi semplice pazzia ciò che nel regno irreale di Mack Sennett rappresentava il “buon senso” degli strani abitanti di esso. Vediamo un povero pazzo in mezzo a gente ragionevole che lo guarda preoccupata, mentre nelle vecchie comiche la gente si inquietava a volte ma non si meravigliava mai. Le trovate burlesche non persuadono più, perdono l’eleganza, non hanno più significato. I loro strumenti sono raccolti e rappezzati con fatica e sudore. E quando questo sforzo si nota, non si ride più. 190 Una notte sul Monte Calvo «Cinema», 11, 10 dicembre 1936, pp. 428-429 I disegni animati tanto cari al pubblico hanno divulgato la coscienza del fatto che il cinematografo non è rigidamente collegato alla riproduzione fotografica di cose reali. E chi conosce un po’ la preistoria dell’arte filmistica sa benissimo che l’immagine animata non è sorta come fotografia, bensì come disegno vivente. Le immagini che si trovano su quel disco creato nel 1832 da Plateau e da Stampfer – che posto in movimento rotatorio dava la sensazione di una scena animata – non erano fotografie, ma semplici disegni; e se, sessanta anni dopo, la fotografia iniziò una marcia trionfale sullo schermo, condannando il disegno animato a una funzione secondaria, si può ciononostante sostenere che l’immagine voluta dal disegnatore o dal pittore è sempre più “vicina” all’arte che non il film “fotografato”; la materia grezza di quest’ultimo, infatti, rimane sempre la riproduzione meccanica di cose reali, ed i più ingegnosi e soggettivi metodi di ripresa non superano mai un ultimo residuo materiale che si oppone alla forza creatrice dell’artista, mentre è completamente libero il volto dell’invenzione poetica quando si tratti di creare col pennello l’immagine animata. Si può dire di più: dato che il cinema “fotografato” sembra destinato a finire come puro strumento – anche se perfetto – di riproduzione, non è impossibile che dopo un certo tempo l’arte dell’immagine animata si trasferisca nelle mani dei pittori. Non è un fatto significativo che fra i pochissimi artisti autentici del cinema attuale quello meno discusso sia proprio Walt Disney? Ma lo stesso Disney, insieme ai suoi più modesti colleghi, ha d’altronde indirettamente determinato la persuasione che il regno dei disegni sia limitato ai soggetti comici. In linea di principio, invece, non c’è ragione perché l’arte della pittura non debba arricchirsi un giorno delle seducenti possibilità del movimento e della dimensione temporale. (Fra i critici italiani ce n’è almeno uno che ripetute volte ha insistito su questo concetto: Eugenio Giovannetti). È vero che, finora, i tentativi pratici in questo campo sono scarsi, e nella maggior parte limitati al cosiddetto film “astratto”. Sono abbastanza noti gli esperimenti di Walter Ruttmann di animare sullo schermo semplici forme geometriche; esperimenti che, in seguito, furono ripresi e approfonditi da Oskar Fischinger. Né sono sconosciute agli iniziati dell’arte le danze dei pallidi pettini nella Sinfonia delle diagonali di Viking Eggeling. Nel campo dell’arte pittorica, invece, si può ricordare l’interessante tentativo di Berthold Bartosch di animare una di quelle serie di incisioni del pittore fiammingo Frans Masereel le quali, narrando una trama unicamente attraverso quadri figurativi, si servono già di un principio prossimo a quello del cinema. Volendo, si può inoltre citare un film come La joie de vivre, che tende a sublimare un 191 poco la robusta comicità dei disegni americani portandola verso un’eleganza profumata e stilizzata di gusto francese. Si spiega, forse, in buona parte con ragioni tecniche se finora soltanto il disegno animato comico ha trovato larga applicazione, e se d’altro canto i film di pittura “seria” sono quasi tutti astratti. Vogliamo dire che questi tipi di film riducono di molto l’enorme mole di lavoro necessario per la produzione di un film disegnato. I soliti disegni animati si svolgono in generale davanti a pochi sfondi, i quali, anche se talvolta si spostano in “panoramica”, rimangono per il resto costanti, in modo che disegnati una volta gli sfondi, restano da cambiare, fotogramma per fotogramma, soltanto i “personaggi”. Ed i personaggi sono “standardizzati”: cioè stilizzati in forme semplici e costanti, il che permette all’ideatore di farsi aiutare da quante persone vuole. Se d’altra parte una sola persona, per ragioni artistiche od economiche, deve far tutto da sé, il lavoro diventa gigantesco, e in tal caso vien naturale contentarsi delle forme più semplici, più sbrigative, che sarebbero appunto quelle geometriche. Volendo invece creare una pittura animata, nella quale non si muovano soltanto, alla maniera teatrale, personaggi davanti a uno sfondo fisso, ma nella quale il quadro intero “reciti” mutando ad ogni momento – in modo simile all’effetto che deriva da carrellate, tagli di montaggio ecc. –, allora diventa desiderabile aver sottomano una tecnica di animazione meno complessa e faticosa. Ed ecco che ultimamente è nato un nuovissimo procedimento, detto Ciné-Gravure, realizzato dal russo Alex Alexeiev e dall’americana Claire Parker, tutti e due stabiliti a Parigi. Walter Ruttmann dipingeva le sue pitture direttamente sui minuscoli fotogrammi: una fatica da benedettino del medioevo. Fischinger, fotografando le successive sezioni di un blocco di cera, a venature di vario colore e di varia forma, aveva escogitato un metodo ingegnoso ma di limitatissima applicazione. Per uno dei soliti cartoni animati comici ci vogliono circa 15.000 disegni diversi: un lavoro industriale tipo Ford! Alexeiev, invece, si serve di un unico pannello che consente continui, anzi infiniti cambiamenti di disegno. Figuratevi dunque, davanti alla macchina da presa, un pannello bianco disposto verticalmente, di circa un metro per un metro e trenta di superficie, e bucato con circa 500.000 forellini del diametro di un millimetro ciascuno. In ciascuno di questi fori si trova un perno spostabile, e di cinque in cinque i fori sono disposti in modo da formare i punti angolari e il punto centrale di un quadratino (come il numero cinque nel gioco dei dadi). Se il pannello viene illuminato da quattro lampade, poste in corrispondenza dei quattro spigoli del pannello e formanti un angolo di circa 45 gradi, i perni dei forellini formeranno delle ombre, non appena li si faccia sporgere dalla superficie del pannello. Con una sporgenza massima di 10 millimetri ogni cinque perni, copriranno con le loro ombre il quadratino corrispondente, in modo da farlo apparire nero. Se viceversa non sporgono affatto, il quadratino appare bianco, e, negli stadi interme- di, il quadratino, in parte bianco, in parte ombrato, darà il risultato di un grigio omogeneo, data la sua straordinaria piccolezza. I bianchi e neri dell’immagine si ottengono dunque mediante un fine reticolo di ombre, che offre un aspetto morbido simile a quello delle litografie. L’artista proietta uno schizzo della scena sul pannello, e ne crea la riproduzione fedele spingendo indietro i perni nei punti dove vuole del bianco, e spingendoli avanti dal rovescio del pannello nei punti dove vuole del nero (ossia dove occorrono delle sporgenze). Dopo aver impressionato un fotogramma, egli cambierà, con semplici pressioni del dito, la sua immagine in tutti quei punti dove occorre. Non è dunque costretto a sostituire ogni volta il disegno completo o a limitarsi al movimento dei personaggi davanti a uno sfondo fisso: lo sfondo si cambia con la stessa facilità delle figure: si hanno così tutte le stesse possibilità a disposizione del pittore normale. Una volta costruito il pannello, l’artista potrà lavorare con spesa minima; niente carta, celluloide, materiale da disegno ecc. Leggermente modificato, il dispositivo si presta anche al cinema a colori. La bontà del sistema è provata dal film Una notte sul Monte Calvo, disegnato da Alexeiev e dalla Parker sulla base dell’omonimo brano musicale di Mussorgskij. Il film si distingue per la plasticità delle figure, la delicatezza delle mezzetinte e le efficaci dissolvenze, che gradualmente sostituiscono un’immagine all’altra senza che lo spettatore se ne accorga. 192 193 Dominatrici* «Cinema», 11, 10 dicembre 1936, p. 440 Il film si chiama La moglie di Craig ma, come vedete, il signor Craig non figura affatto sulle fotografie. È un film di donne, fatto da donne e per donne. «Se ci fossero più registi femminili il cinema andrebbe meglio», dice Dorothy Arzner che finora ha il monopolio di regia femminile a Hollywood. «Le donne hanno lavorato bene in tutte le arti, e l’intelligenza non ha sesso». Esisterebbero anzi problemi tipicamente femminili che soltanto una donna saprebbe rappresentare artisticamente. Si potrebbe obiettare che nelle arti le donne più vere sono state create da uomini, ma senza insistere su questo punto diremo piuttosto che il soggetto della Moglie di Craig, seppure davvero molto femminile, ci sembrerebbe invece adatto per esser realizzato da uomini spinti da quell’odio amoroso, che già tante volte è stato così produttivo in arte. La signora Harriet Craig, infatti, è una di quelle massaie severe e tetragone che non permettono di- * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, p. 367. scussioni su quanto stabiliscono riguardo all’andamento della casa, sia che si tratti del gusto dell’arredamento, sia dell’osservanza di alcune regole, come sarebbe, per esempio, quella del non fumar sigari fra le pareti domestiche. Ora, visto nel modo femminile, si direbbe che il film dovesse concludersi così: la donna dura finisce per manifestare un cuore dolce e buono, cosicché un happy end ci renderebbe soddisfatti mentre una fine tragica ci riempirebbe di compassione. Invece va che tutti i parenti e amici fanno i bauli, che perfino ne muoiono tre, che il marito, dopo aver fatto un’ampia fumata nella stanza più bella, fugge pure lui e che la signora rimane sola in una casa molto ordinata ma vuota. Sembra poco probabile che un tale soggetto, tipica emanazione di vendetta maschile, venga realizzato da un gruppo di donne con un sorriso tanto sereno quale ci dimostra la fotografia: sorriso franco che non pare ispirato nemmeno da una punta di indulgenza offensiva per il sesso maschile. Queste donne si divertono fra di loro: la regista, Dorothy Arzner, più alta e più bianca delle altre tre; la scenarista, Mary McCall, che dimostra la paziente devozione necessaria per il suo mestiere; la protagonista, Rosalind Russell, niente affatto tirannica perché siamo in un momento di intervallo; e la montatrice, Viola Lawrence, rassomigliante a quelle sarte modeste le quali, con l’eleganza del “taglio”, trovano modo di realizzare i loro sogni segreti sul corpo di creature più ambiziose. Per di più questa atmosfera di pace non finirà col chiudersi dell’obbiettivo del fotografo. Perché il teatro in cui “gira” la signora Arzner, ci viene assicurato che è il più tranquillo di tutti. Niente discussioni arrabbiate, niente scoppi di temperamento femminile o maschile che sia. Non c’è neanche quella tirannia feroce che fa fare i bauli ed è causa di morti; e può darsi perfino che vi sia permesso di fumare. È dunque forse perché la signora Arzner non ha da temere confronti che trova il coraggio di realizzare, con psicologia femminile, un soggetto così maschile. Alla nostra generazione sembra che il cinema sia sempre esistito. L’epoca dei suoi inizi ci pare talmente remota che guardiamo i suoi avanzi – purtroppo non pietrificati ma esposti ad ogni attacco del tempo e degli ignoranti – senza poterci immaginare che ad essi furono legati, pochi decenni fa, persone che in parte vivono ancora fra noi. È la generazione di Louis Lumière, di Georges Méliès e anche di Oskar Messter il quale ha compiuto il suo settantesimo anno in questi giorni. Oskar Messter fu il più importante pioniere della tecnica cinematografica tedesca. Non era proprio uno dei tanti “padri” del cinematografo, bensì uno zio: uno di quei buoni zii che non dimenticano mai di portare il regalino ai nipoti. Al principio del 1896, costruì la prima macchina da proiezione tedesca, destinata a proiettare su schermo i film fatti per il Kinetoscopio di Edison, un dispositivo che non permetteva la proiezione, ma soltanto la visione diretta della pellicola in movimento per un solo spettatore. Nella macchina di Messter il trasporto della pellicola avveniva mediante una croce di Malta a cinque fenditure comandata da un disco a un dente. Nello stesso anno il Messter costruì pure una macchina da presa munita anch’essa di croce di Malta ed atta a produrre 16-18 fotogrammi al secondo su pellicola perforata. La distanza tra i fotogrammi era esattissima e non richiedeva quindi nessuna correzione nella stampa. Ma più interessante ancora è la parte di primo piano che Oskar Messter ebbe in quella grande produzione di film sonori che fiorì dal 1903 al 1914. Centinaia e centinaia di corti fonofilm sono stati prodotti vent’anni prima del Cantante pazzo di Al Jolson e non pochi di essi erano di produzione Messter. Per la ripresa dei film sonori egli si serviva non solo del metodo ormai diventato normale, ossia della presa simultanea del suono e delle immagini, ma anche della registrazione preliminare del suono che recentemente è di nuovo tornata di moda per scene di ballo, di canto ecc., sotto il nome di prescoring. Nella primitiva “casa di vetro” del Messter si vedeva un grammofono azionato da motore sincrono e destinato a far suonare il disco – per esempio un’aria d’opera lirica – durante la presa. La macchina da presa, munita di motore sincrono, girava anch’essa la recitazione degli attori i quali, davanti ad un bello sfondo dipinto, cantavano in corrispondenza al disco, in modo che poi, nella proiezione, il sincronismo fra scena ottica e canto risultava perfetto. Molti anni dopo, quando verso il 1928 scoppiò la lotta fra disco e registrazione fotoelettrica, il Messter entrò nuovamente in campo partecipando alle discussioni con varie proposte pratiche, molte delle quali rispecchiano in modo curioso le opinioni che allora si avevano sul fonofilm. Oltre il Messterphon, dispositivo per la rappresentazione sincrona dei dischi di accompagnamento, ricordiamo il Messtronom che doveva accordare la velocità di proiezione al tempo della musica eseguita dall’orchestra nella sala: una pellicola in movimento, sulla quale erano inscritte le note della musica corrispondente all’azione, doveva esser regolata da uno dei musicisti in modo che sul nastro si vedessero a ogni momento le note che si stavano via via suonando, e questo nastro comandava il proiettore! Né appariva strano a quell’epoca, così poco remota, il Chronomesster destinato a garantire il sincronismo tra proiezione di un film e commento parlato, trasmesso da lontano mediante il telefono o la radio. Messter credeva necessario un simile dispositivo per poter organizzare simultaneamente in diversi cinematografi la proiezione di varie copie dello stesso film, proiezione accompagnata da un discorso tenuto, nel momento stesso della proiezione, da qualche personaggio celebre. 194 195 Uno zio del cinematografo «Cinema», 12, 25 dicembre 1936, p. 457 Oskar Messter, caratteristico superstite della Germania imperiale, anche nel suo aspetto esteriore, non manca mai quando si tratta di discutere o di festeggiare il cinema. Il suo buonsenso, le sue vaste esperienze, come pure l’umorismo delle sue osservazioni e dei suoi ricordi storici, servono a condire e a rendere vivace ogni riunione in Cinelandia. Cinema “in persona prima”* «Cinema», 12, 25 dicembre 1936, p. 480 Regola elementare: non guardare verso l’obbiettivo! Nel significato più elementare, questa regola vale in primo luogo per le scene “dal vero”: se lo spazzino, colto dalla macchina mentre maneggia la scopa, all’improvviso interrompe il suo lavoro, si volta verso la macchina e sorride, quel pezzo di pellicola sarà da buttar via; perché l’esistenza della macchina – corpo estraneo nell’ambiente di cui essa registra l’immagine – non deve manifestarsi allo spettatore, neanche in modo indiretto. Molto di rado, infatti, il pubblico guardando ciò che si svolge sullo schermo, ha occasione di ricordarsi che nell’immediata vicinanza della scena stava l’operatore; nell’ammirare l’arrampicata difficoltosa di un alpinista, non pensa che più ammirevole ancora è l’opera dell’operatore che corre l’identico rischio – con la fatica in più di azionar l’apparecchio. Ed è giusto che sia così: perché un’opera degna non rammenta mai colui che la creò, ma ha una sua vita autonoma, indipendente. A teatro, la presenza “reale” dell’attore nella sala giustifica in certi casi che esso si rivolga direttamente al pubblico; e allo stesso modo nel cinema primordiale, figlio del teatro, l’attore recitava spesso guardando l’obbiettivo. In un secondo tempo, il cinema prese coscienza di non essere che “rappresentazione” di ciò che si svolge in un ambiente lontano dal luogo dello spettacolo e senza rapporto con esso; e fece perciò divieto all’attore di sfiorare con lo sguardo quel punto in cui si trovava la macchina durante la presa, lo spettatore durante la proiezione. Ma, infine, i registi cinematografici si accorsero del fatto che questo rivolgersi, da parte dell’attore, al punto d’osservazione, non sempre ha l’effetto di trascinar nell’azione fattori che le dovrebbero restare estranei, ma che invece si offre così al cinema un mezzo simile a quello che adopera il romanziere quando racconta “in prima persona”. Neanche l’“io” del romanzo ha la caratteristica di far diventare il lettore parte dell’azione, mentre può render più intimo e diretto l’interesse di lui in quanto che la situazione, vista con gli occhi di un determinato personaggio * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, p. 370. 196 centrale, corrisponde di più a quelle che sono le sensazioni proprie del lettore nella sua vita. Ma ammesso ciò, quello del romanzo rimane pur sempre un mondo a sé, che può esserci rappresentato dal poeta in due modi diversi: nel primo caso la situazione è vista unicamente con gli occhi del poeta, il quale (se è poeta) ha naturalmente una sua maniera personale di vedere le cose. Ma questa maniera di vedere le cose si manifesta soltanto nel modo della rappresentazione; l’osservatore resta al di fuori del racconto e non viene in nessun modo caratterizzato. Nel secondo caso, invece, la situazione viene interpretata come “sensazione” di un determinato personaggio: ciò che può andare fino all’artifizio letterario della “prima persona”. Anche il regista cinematografico si serve di ambedue i metodi. Nel primo caso la macchina, nel suo modo di inquadrare, di angolare e di muoversi, rispecchia unicamente l’interpretazione del narratore; nel secondo caso la macchina si mette nei panni di uno dei personaggi, vede con i suoi occhi, cammina con i suoi passi: la qual cosa spesso viene resa evidente facendo agire, per esempio, altri personaggi nella direzione di quel personaggio invisibile, che si suppone trovarsi nel punto in cui è la macchina da presa. Nella nostra fotografia (tolta dal recentissimo film La vergine di Salem con Claudette Colbert) i personaggi, pur essendo presi di fronte, guardano in una direzione leggermente divergente dall’asse della presa: ciò che esclude da una diretta partecipazione la macchina e lo spettatore, mentre devia i sentimenti di sdegno o di paura, dai quali è animata la folla, verso un terzo che noi non vediamo ma che comparirà. Se, invece, l’indice dell’uomo al centro e tutti questi occhi spaventati fossero rivolti direttamente all’obbiettivo (e cioè a noi che guardiamo), certo neanche allora noi spettatori ci sentiremmo colpevoli, ma la rappresentazione artistica si sarebbe identificata con la persona che è causa di quelle emozioni, e la situazione verrebbe da noi interpretata nel senso individuale di quella persona. Se la macchina si avvicinasse alla folla, sarebbe per noi quell’uomo invisibile ad avvicinarsi. Si capisce subito quanto il linguaggio cinematografico venga animato ed arricchito da questo mezzo d’espressione. È bene però tener presente che della rappresentazione “soggettiva” il cinema conosce soltanto il caso estremo: quello dell’“io”. Ossia, il cinema non è capace di dire: «egli vedeva» ma soltanto: «io vedevo». Nel romanzo, un personaggio può essere simultaneamente soggetto e oggetto dell’osservazione: mentre osserva, può essere osservato dal poeta. Nel cinema, invece, un personaggio diventato soggetto osservatore, presto sparisce quasi completamente. La sua individualità si riflette soltanto nel modo di guardar l’ambiente e di muoversi rispetto ad esso; ma non c’è più modo di parlare delle sue azioni, del suo aspetto, dei suoi sentimenti, come il romanzo è capace di fare anche quando racconta l’‘io”. È questa la ragione perché nel cinema l’“io” vien generalmente utilizzato soltanto per scene brevi, e per lo più interrotte da inquadrature di diverso tipo, destinate a presentar l’uomo che guarda. 197 Una lunga scena di quel genere avrà invece qualcosa di molto misterioso, in quanto ci nasconde proprio il personaggio centrale dell’azione: effetto che ogni tanto può essere buono e voluto (vedi la carrellata iniziale del Dottor Jekill di Mamoulian). Ma a parte certi casi eccezionali, basta fare un po’ d’attenzione per accorgersi che, oggi, quasi non passa scena che non sia animata, almeno per un attimo, da quel contatto diretto e sempre un po’ inquietante che nasce dall’incontro fra occhio e occhio. Uno spettro in tre versioni «Cinema», 13, 10 gennaio 1937, pp. 22-23 Chiunque abbia intenzione di studiare sul serio l’arte di trasformare i motivi elementari di un racconto in materia cinematografica, può trovare un materiale di studio veramente prezioso nel recente libro in cui Seton Margrave tratta dei metodi di scrivere un film (Successful Film Writing, Methuen & Co., London 1936). Dopo una breve introduzione, molto utile anch’essa, l’autore non fa che presentarci l’ultimo film di René Clair nelle diverse fasi della sua evoluzione: dalla novelletta pubblicata su una rivista fino alla sceneggiatura definitiva. L’esempio è scelto bene giacché in questo film si combinano le qualità di un buon artista – senza le quali l’esemplificazione non potrebbe servire al suo scopo – con le esperienze di un esperto industriale, Alexander Korda, atte ad inquadrare le trovate del regista nelle ponderate e sperimentate norme dell’attuale mestiere cinematografico, di cui lo studio sembra indispensabile all’aspirante regista o scenarista. Se il film avesse seguito strettamente la trama della short story di Eric Keown, pubblicata dal «Punch», non ci sarebbe stato modo di cambiare, per l’edizione italiana, il titolo originale Lo spettro va all’ovest in Il fantasma galante, perché in essa il motivo secondario della vicenda d’amore manca ancora completamente. Si racconta semplicemente la storia del milionario americano Plugg che compra e porta nel suo paese natale il vecchio castello scozzese; Tristram, spettro del castello e poeta, salva il nuovo padrone della casa dai gangsters intenzionati a rubare certi brevetti preziosi, liberandosi mediante questa impresa eroica dalla maledizione impartitagli dal padre per la sua vigliaccheria. Il primo treatment, di Robert Sherwood e di René Clair, presenta il racconto già con quasi tutte le modificazioni importanti che distinguono il film dalla novelletta; il nobile proprietario originale del castello, Donald Glourie, raggiunge i protagonisti del film diventando il sosia dello spettro storico Murdoch – una trovata che permette di dare ad un bravo europeo molto semplice quella mistica aureola delle strane tradizioni antiche che il medio snob americano crede di riconoscervi. 198 Inoltre, nel treatment, lo spettro non ha più da compiere un qualunque atto di coraggio, ma ha da vendicarsi su di un discendente di quella famiglia scozzese che, secoli addietro, lo oltraggiò. In questo modo non solo il racconto acquista un’utile tensione da film poliziesco, ma inoltre l’incarnazione di quella vecchia famiglia Mac Laggan in un comunissimo cittadino americano serve a precisare il motivo ironico centrale del film. Nel treatment però, quest’americano è ancora una qualunque comparsa. La sceneggiatura poi concentra in modo definitivo il motivo facendo discendente dei Mac Laggan l’industriale Ed Bigelow, personaggio importante della trama e rappresentante dello scetticismo più assoluto che non riconosce se non i valori finanziari. Facendo proprio di lui il misero oggetto della vendetta antica, il film si impernia con precisione radicale sul motivo del cervello moderno affascinato, impaurito e vinto dalle vecchie ed eterne angoscie irrazionali. Segue ora, nella traduzione italiana, il testo originale della scena di cui abbiamo parlato, nelle tre fasi della sua creazione. I – Da Sir Tristram goes West di Eric Keown Tristram (lo spettro) non si era accorto degli altri. Egli studiava una pagina di Spencer quando Redgat scattò il grilletto del suo fucile e soltanto allorché una pallottola pesante gli strappò il libro dalla mano, Tristram capì che qualche cosa succedeva. Un flusso di piombo attraversò il suo corpo ritrasformando in mezza pasta una rarissima edizione del Boccaccio, ma egli non sentì niente. Era soltanto sdegnato della maniera ineducata con cui lo disturbavano. Nessuno dei gangsters aveva mai visto un uomo pigliare 50 pallottole nel petto e rimanersene in piedi. Questo spettacolo li impressionò. Redgat continuò il fuoco, gli altri tre stavano indecisi. Prima che Bolloni potesse far largo, Tristram aveva già colto ciò che gli era rimasto dalla Faery Queen e glielo aveva lanciato in testa con forza terribile; arrabbiatissimo prese poi l’Anatomia della Malinconia e colpì Toledo e Bug... Però trovava la cosa molto strana. Ma poi nella sua mente la nebbia si chiarì, ed egli cominciò a capire. Finalmente era stato un eroe! Finalmente era libero. Quella grandine di proiettili non solo aveva schiacciato il Boccaccio, ma cancellato anche la maledizione di suo padre. II – Dal primo treatment del film Sequenza 23. – In un’altra parte del castello, Murdoch gira molto malinconico. Non gli piacciono questi americani di cui non comprende il linguaggio e che si rifiutano di aver paura di lui. Deciso a non entrare nella sala da pranzo per non essere insultato, incontra un uomo ubriaco mandato dal signor Martin per accompagnare lo spettro nella sala. Murdoch rifiuta di seguirlo. L’uomo ubriaco si arrabbia ed insulta Murdoch che lo 199 batte in faccia. Appena fatto questo, egli sente una strana musica e la voce, molto debole, di suo padre. Allora Murdoch, ansioso, domanda il nome dell’uomo ubriaco. Quello risponde con un nome americano comunissimo ma aggiunge subito di essere l’ultimo discendente di un’antica famiglia scozzese dei Mac Laggan. Murdoch comprende che finalmente ha rivendicato la sua famiglia e che non sarà più costretto a rimanere uno spirito legato a questa terra. III – Dalla sceneggiatura definitiva 340. Campo medio. 132 fotogrammi. Donald si avvicina a Bigelow e gli afferra i rovesci del vestito. Donald: Diceva Mac Laggan? – Bigelow: Sì, Mac Laggan. Via le mani! Donald (abbandonandolo): Murdoch! Murdoch! Vento - Musica. 341. Campo medio. 89 fot. La finestra si apre, le tende volano fuori e un vaso di fiori cade dal tavolo. Servitore entra di corsa cercando di tenere le tende. Donald: Hai sentito questo? Vento - Musica. 342. Primo piano. 23 fot. La sedia in fondo al tavolo cade. Vento - Musica - Grida. 343. Mezzo campo lungo. 30 fot. Gli ospiti in fondo al tavolo si alzano e scappano via gridando. Grida - Musica. 344. Mezzo campo lungo. 64 fot. Murdoch appare in una nuvola di fumo. Grida - Musica. 345. Primo piano. 62 fot. Murdoch. Volge gli occhi attorno. Murdoch: Dov’è il Mac Laggan? 346. Mezzo primo piano. 47 fot. Martin. Martin: Ecco, quello lì! Quello col sottanino scozzese! 347. Mezzo campo lungo. 164 fot. Bigelow stupefatto. Guarda Donald che sta a sinistra sorridendo. La gente corre via. Nella parte davanti, a destra, vediamo il dorso di Murdoch che entra e cammina verso Bigelow. Bigelow eccitato guarda da Donald a Murdoch. Bigelow (a Donald): Uno scherzo molto buono, signor Glourie. Molto... molto divertente davvero! Grida - Musica. 348. Campo medio. 79 fot. Bigelow entra, ritirandosi verso la porta. Bigelow: Si allontani da me! Murdoch entra dalla destra. Bigelow passa la porta chiudendola con rumore. Murdoch (ride): Ah! Ah! Attraversa la porta chiusa. Musica continua. 349. Interno. Corridoio di sopra. Campo lungo. 126 fot. Bigelow corre verso la macchina da presa. Si arresta e guarda indietro. Musica ferma. Murdoch (fuori campo): Mac Laggan! Bigelow si volta e guarda diritto, al di sopra della macchina. 350. Campo medio. 85 fot. Inquadratura contraria. Murdoch rivolto verso 200 la macchina da sinistra; Bigelow a destra, col dorso verso la macchina. Bigelow: Le ho detto di lasciarmi! – Murdoch: Ah, ah! – Bigelow: Non mi vanno gli scherzi grossolani... 351. Campo medio. 192 fot. Inquadratura nuovamente rovesciata. Bigelow verso la macchina, Murdoch fuori campo. Bigelow: ... Lei non mi intimidisce! Bigelow si volta e cammina, poi corre verso il fondo. Murdoch gli sbarra il passo. Musica comincia. Murdoch: Ah, ah! Bigelow scappa via verso destra. Musica. 352. Interno. Corridoio di sotto. Carrellata d’inseguimento a distanza media. 236 fot. Bigelow entra, corre da sinistra giù per il corridoio, inseguito dalla macchina. Si nasconde dietro un divano, poi corre di nuovo, contro un tavolino. Tavolino crolla, ma egli continua, aprendo di colpo una doppia graticola. Si ferma finalmente in fondo al corridoio. Guarda a sinistra. Musica. 353. Primo piano. 159 fot. Bigelow guarda a sinistra. Fa due passi verso la destra, poi guarda di nuovo a sinistra. Dietro di lui compare Murdoch nello specchio. Murdoch: Vòltati, Mac Laggan! Bigelow si volta e vede Murdoch. Cade giù fuori campo verso sinistra. Musica. 354. Mezzo primo piano. 62 fot. Bigelow entra cadendo da destra. Primo piano. 81 fot. Murdoch avanza attraverso lo specchio e guarda giù verso la sinistra. Musica finisce. 355. Mezzo primo piano. 162 fot. Bigelow a terra. Murdoch (fuori campo): Adesso avrà la bontà di ripetere le parole che le dico? – Bigelow: Sì, signore... sì, signore. Qualunque cosa mi dice, signore. Ecc. Analisi d’una ignota* «Cinema», 13, 10 gennaio 1937, pp. 23-24 È una di quelle fotografie che fanno la disperazione dei bravi “botanici” del cinema. Secondo un’indicazione buttata giù con frettolosa matita sul rovescio, dovrebbe trattarsi di un fotogramma dal film di G. Pabst. Ma da quale? Nessuno di noi ha una precisa idea (forse qualche dotto lettore di «Cinema» aiuterà). Non è però tanto questa ricerca della paternità che ci interessa, quanto il fatto che la scena, in sé così poco sensazionale, * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, p. 371. 201 dà tuttavia l’impressione di non essere creata da un regista qualunque. Essa dimostra una certa originale audacia – non soltanto nel senso delle convenzioni morali – che va al di là del comune linguaggio cinematografico standardizzato. Di dove ci viene la precisa e viva sensazione che questa donna ha un tipo e un destino d’eccezione, eccentrici, inquietanti? In fondo noi vediamo soltanto una persona che la cameriera sta aiutando a vestirsi, e che si accinge a telefonare. Eppure non è così: vediamo, chi sa come, molto di più. Osservate questo modo singolare di cercare un numero telefonico. L’elenco pesante, appoggiato alla poltrona in modo niente affatto normale e adatto, oscilla sullo stretto spigolo della spalliera e minaccia non soltanto di cadere ma di scuotere l’equilibrio stesso della poltrona, buon quadrupede dalla base larga e solida, però già un po’ degradato nella sua dignità borghese da una giacchetta buttata negligentemente su di essa. La mancanza di staticità nel senso puramente fisico caratterizza questo momento di azione: ma diventa subito significativa nel suo descriverci una donna che non respinge l’instabilità, che anzi forse la ama. Quale disarmonia, poi, in questo essere simultaneamente vestiti e spogliati e in questa combinazione di due azioni incompatibili. La parte superiore del corpo è già lanciata nell’avvenire senza badare che quella inferiore è ancora legatissima al presente. Il cappello, questo contrassegno dei legami ufficiali dell’uomo con la società, rende quasi scandalosa l’incompletezza dell’abito (secondo la strana aritmetica di quella legge psicologica la quale vuole che una persona a metà vestita sia più spogliata di una nuda). Costretta ad alzare una gamba, la donna si trova in condizioni di gravità altrettanto inquietanti dell’elenco telefonico – inquietanti però soltanto per noialtri, giacché l’espressione tranquilla di lei dimostra che essa è completamente a suo agio. Il nero della cameriera, la quale umilmente si fonde con le ombre del pavimento, fa risaltare lo splendore dei bianchi della seta, e l’accoccolarsi della cameriera rende quasi maestosa la posizione verticale della strana donna. (Si tratterebbe della Lulu di Wedekind? Dell’attrice Louise Brooks? Silenzio, botanica!). Ma c’è d’altra parte la giarrettiera, questo meccanismo così deludente, troppo “tecnico” per una creatura che forse fra cinque minuti sembrerà a qualcuno un’apparizione eterea, immateriale. Apprezzate infine la disperazione silenziosa con cui la cameriera cerca di sottoporre la padrona alle necessità e alle convenzioni della nostra vita: come le riesce difficile arginare quest’impeto pagano, primitivo, spensierato! Comprenderete allora come nell’arte – se è permesso di parlare di arte in questa occasione – non esiste niente di casuale e nessuna differenza tra fatti interni ed esterni e come, in modo particolare, il cinema illustra l’uomo non soltanto con la mimica dell’attore ma con la sottile espressività di tutto ciò che si presenta e si svolge fra i quattro bordi dello schermo. 202 Gli occhi del cervello* «Cinema», 16, 25 febbraio 1937, pp. 148-149 Ogni nostra conoscenza comincia coll’adoperare i sensi e soprattutto gli occhi. Ma non tutto quel che esiste è anche visibile; e soltanto una minima parte delle cose svela i suoi segreti intrinseci al semplice sguardo. Certi fenomeni naturali si verificano entro limiti così grandi o così piccoli, che anche se riusciamo a penetrarvi coll’aiuto dei nostri strumenti tecnici, noi non sappiamo farcene un’idea precisa nella nostra immaginazione. C’è poi il fatto che noi vogliamo non soltanto vedere ma anche capire, e che, purtroppo, le cose non portano la formula della loro struttura sulla propria fronte. Soltanto la scienza, dopo lunghi studi, ci spiega il significato delle immagini. Ne segue che non basta guardare la natura per comprenderla. Ma si sono sviluppati ottimi metodi di sfruttare la nostra facoltà visiva per facilitarci il compito di afferrare con la nostra immaginazione ciò che non possiamo percepire direttamente, e per comprendere ciò che vediamo. Rimpicciolendo i fenomeni troppo vasti, semplificando e schematizzando i processi troppo complicati, riducendo l’ignoto a fatti analoghi all’esperienza pratica, riusciamo a creare un nuovo mondo, altrettanto concreto ma, nello stesso tempo, concentrato e di struttura più evidente. Interponendo questo nuovo mondo fra quello reale e i nostri concetti, ci salviamo dall’astrattezza del pensiero. È uno strumento didattico di prim’ordine, oggigiorno già largamente sfruttato, e il cinematografo vi ha saputo dare un contributo decisivo: l’immagine in movimento non permette soltanto di introdurre in quel nostro orbis pictus anche i processi, ossia tutto ciò che si modifica nel percorso del tempo, ma inoltre rende la dimostrazione molto più attraente; giacché, per ragioni biologiche, il movimento è uno stimolo al quale l’uomo risponde immediatamente. Vale soprattutto per l’uomo primitivo, incolto, pel bambino: tutto ciò che si muove interessa di colpo. Ma abbiamo detto che non basta guardare la natura. Perciò, per insegnare, il cinema non può limitarsi a presentarci semplicemente delle vedute fotografiche. Infatti, esso ha saputo adoperare, con molto successo, i metodi summenzionati per render percepibile buona parte di quel che la natura vuol tener al di fuori della nostra sfera sensoria. Scegliamo come esempio uno dei tanti film a cortometraggio con i quali l’Ufa svolge nelle pubbliche sale da proiezione con grande entusiasmo degli spettatori un’attività divulgatrice veramente preziosa ed esemplare. Il film, nientemeno, si chiama: L’universo infinito. Non manca, si intende, la semplice ripresa fotografica che porta nel * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, pp. 372-373. 203 film, per così dire, la materia prima dell’argomento. Ma basta guardare qualche fotografia delle “nebulose a spirale” (fig. 1) per capire subito i limiti di questo mezzo. Non soltanto rimane da spiegare che si tratta di vie lattee gigantesche composte ognuna da miliardi di astri, e perché ci appaiono così piccole e perché non vediamo niente del loro movimento vertiginoso. Ma neanche la loro sola forma si impone troppo bene prima che uno ci abbia detto la parola spirale – aggiungendo in questo modo alla visione il concetto. È vero che cambiando opportunamente il punto di presa – l’angolazione – si può arrivare a chiarimenti importanti. Vista di profilo, la nebulosa si rivela come una specie di lente piatta. Eppure soltanto quando la scienza ci ha informato che si tratta di spirali, queste macchie più o meno confuse rivelano allo sguardo la loro struttura. Ossia: gli oggetti naturali non realizzano con precisione matematica il loro principio costruttivo. Il nostro cervello estrae l’idea platonica di cui sono la manifestazione impura, ma essa idea può venir facilmente dimostrata anche all’occhio; basterà tracciare, nel nostro caso, le linee matematiche di una spirale, messa in movimento rotatorio con i mezzi del cinema. Così il grafico si associa all’immagine fotografica. Guardando l’osservazione di Treptow (fig. 2) che si vanta del più grande telescopio a lente del mondo – lungo 21 metri – ci accorgiamo ancora di un altro fatto: il telescopio, costruito dall’uomo, realizza appunto per questo il suo principio con la massima esattezza. Eppure, di questo principio non vediamo niente di essenziale, perché il meccanismo ottico è nascosto nel tubo. Anche in questo caso dunque occorre un grafico che dimostri il percorso dei raggi luminosi nel sistema delle lenti; oppure l’immagine cinematografica di un semplice esperimento fisico che renda visivo l’identico fenomeno. La costellazione siderea dello Scorpione (fig. 3) ci esemplifica l’alleanza fra fotografia e grafico. Sullo schermo si muove la canna ai bordi del lago; l’aspetto familiare del paesaggio ci attrae, ci avverte che si tratta di cose nostre: della vita, mentre la sagoma stilizzata dell’animale simbolico ci fa guardare il cielo con “gli occhi del cervello”. La casuale configurazione delle stelle si razionalizza e si concretizza entrando in rapporto con qualche elemento dell’esperienza di ogni giorno – trucco antichissimo per rendere più facile al pensiero e alla memoria di impadronirsi dei fenomeni. Qualche volta l’analogia con un semplice fatto pratico che dimostra identica situazione, presenterà l’inimmaginabile. Per dimostrare la proporzione fra due volumi, le loro dimensioni assolute non contano: una palla di vetro e infinite palline (fig. 4) ci fanno capire benissimo l’enorme differenza di grandezza fra il Sole e la Terra. E parlando del solo volume possiamo anche trascurare la reale situazione topografica ossia la terribile distanza fra Sole e Terra e il loro posto fisso nel sistema cosmico. Spensieratamente prendiamo in mano la Terra e la gettiamo nel Sole – modo più naturale ed istruttivo per confrontare due volumi – e moltiplichiamo la Terra infinite volte, la gettiamo nel Sole sempre di nuovo. 1.300.000 palline “Terra” riempiono il Sole! Il vuoto infinto dell’universo… ma ci sono vuoti rispettabili e un po’ meglio immaginabili anche nella nostra vicinanza. Due barche (fig. 5), l’una partendo dalla Groenlandia, l’altra dall’Africa del Sud, difficilmente si investiranno in mezzo al vasto oceano. Altrettanto improbabile è il fatto che due stelle si incontrino nell’universo! Il movimento cinematografico ci fa vedere il cammino delle barche – ma a dire la verità, non sembra tanto impossibile che si incontrino. Perché c’è da constatare una seconda riduzione: ognuna delle barche coprirebbe mezza Italia, e l’oceano si è ristretto fino a diventare un laghetto; per ragioni ovvie: una barca nella proporzione giusta non si vedrebbe più, e non si può nemmeno ingrandirne la pianta. L’immagine dunque è in questo caso non tanto rappresentazione quanto simbolo di un fatto che press’a poco possiamo rettificare nella nostra fantasia. Più simbolico ancora è il trenino che corre lungo l’equatore (fig. 6). La velocità del treno, che non soltanto conosciamo ma che possiamo anche immaginarci, dà una misura per le grandi distanze. La Terra è rimpicciolita e schematizzata, il giro del mondo purificato da tutti quei fattori secondari rappresentati dalle difficoltà e complicazioni di un vero viaggio – ciò che è lecito perché la nostra fantasia facilmente sa farne a meno. Correndo per sedici giorni a cento chilometri all’ora, il treno avrà compiuto il giro. Ma un film non può durare sedici giorni, e non occorre, perché anche in questo caso un accenno alla situazione supposta sostituisce benissimo una vera e propria rappresentazione: si riduce il tempo come si riduce lo spazio. L’immaginazione, condotta dall’occhio fino a questo punto, compie il resto senz’altro. I fogli di un calendario, cadendo rapidamente, danno la scala ridotta del tempo. Ed eccoci finalmente alla completa eliminazione dell’immagine fotografica, dello spazio tridimensionale, della plasticità, degli oggetti reali! Il sistema cosmico di Tolomeo (fig. 7) è rappresentato da un puro grafico in movimento, grafico umanizzato un po’ dai visi dei pianeti, dalla corona della Terra e dai simboli astrologici. Trattandosi qui della sola topografia, le dimensioni degli astri non sono proporzionate. Lo spazio è sostituito con un piano, tutte le distanze sono ridotte al minimo. Per non complicare, anche il sistema tolemaico stesso è ristretto a poche caratteristiche: si noti che le traiettorie dei pianeti sono concentriche invece che eccentriche, e mancano i famosi “epicicli” – semplificazione che si potrebbe chiamare esagerata. Ma in complesso è ammirevole l’ingegno con cui – mediante i semplici trucchi cinematografici dei modellini e dell’animazione – viene illustrato all’occhio un argomento così astratto e complicato. Si potrebbe aggiungere che il film a soggetto non adopera quasi mai mezzi di questo genere. Magari preciserà il luogo dell’azione o un viaggio dei personaggi sulla pianta geografica. Potrebbe servirsene un po’ di più ma ci sono ragioni estetiche perché esso per esempio non illustra un conflitto psichico del protagonista facendo combattere tra loro in un grafico pupazzi che rappresentino l’amore, l’onore offeso e la paura. D’altra parte vale anche per il film a soggetto l’afferma- 204 205 Ricorderò sempre quella statua equestre, di un metro e mezzo di altezza, che un regista cinematografico di cattivo gusto aveva fatto mettere sulla scrivania di un industriale per farne vedere le qualità artistiche ed i mezzi per raggiungerle. Vidi anche, due anni fa, un altro regista, uomo di una certa sensibilità, esaminare una stanza di biblioteca, che era stata messa su nel teatro di posa per alcune scene di un suo film. Gli scaffali della biblioteca avevano circa due metri di altezza, e su di essi, i bravi operai del teatro avevano messo, come al solito, una folla di quei deliziosi soprammobili che stavano nei magazzini da qualche decennio. Ma il regista ingrato, appena se ne fu accorto, si mise a gridare: «Via tutta questa roba! Via questi orrori!». E fu subito fatta tabula rasa. Sul palcoscenico del teatro, queste sono cose d’importanza relativa. Neanche dai palchi più vicini gli spettatori distinguono con precisione se il tavolino da tè è apparecchiato con gusto o in modo che corrisponda all’ambiente della scena. Il contrario vale per il cinematografo. La macchina da presa potrà disinteressarsi completamente, per un momento, dei personaggi della stanza in cui essi agiscono: ma prenderà di mira un modesto portasigarette e lo darà sullo schermo nelle dimensioni di due metri quadrati. Forse nel coperchio è incisa una iscrizione, importante per l’azione del film; forse le dita femminili che vi prendono una sigaretta faranno vedere, nell’enorme ingrandimento, un certo tremolio assai più rivelatore dell’espressione facciale. Lo spettatore se ne renderà conto; ma egli tuttavia vedrà un’altra cosa: vedrà quel portasigarette. Lo vedranno migliaia di persone, ogni sera, per mesi e mesi, in tutto il mondo. A molti di essi questo dettaglio servirà soltanto d’informazione sul tipo di portasigarette attualmente di gran moda. A molti altri piacerà sul serio, e lo compreranno. È chiaro che all’artigianato si offre così il mezzo più efficace per la propaganda dei suoi prodotti. Ma dato che questi prodotti possono essere buoni o cattivi, è il caso di dire che il cinema, influendo sul gusto delle masse, permette anche di addestrarlo e di affinarlo: cioè che, simultaneamente, può rappresentare una lezione utile allo stesso artigianato. Poche cose sono più caratteristiche per una persona che l’ambiente da essa creato per la sua vita. L’“uomo del gregge” accetterà meccanicamente quegli oggetti che vengono preparati, in quel determinato momento, per le persone della medesima sua condizione sociale. Colui invece che possiede una forte personalità sceglierà con cura anche le cose secondarie in modo che anch’esse si accordino al suo gusto personale e contribuiscano all’espressione del suo carattere. Sono ormai diventati rari i casi in cui una persona può dare l’impronta individuale ad una cosa creandola con le sue stesse mani (le donne hanno ancora la possibilità di farsi i vestiti, i cibi ecc.); tuttavia, anche la semplice scelta fra quel che hanno fatto gli altri e messo in commercio, è un mezzo non trascurabile per esprimere la propria personalità. Entra nello studio – meglio lo studio che il salotto! – di un uomo qualunque e dopo aver dato uno sguardo in giro saprai di quella persona più di quanto non ne avresti saputo dopo una lunga conversazione. Questa espressività delle cose è uno strumento prezioso per il cinema, il quale deve caratterizzare i suoi personaggi con mezzi visivi. Con precisione microscopica l’obbiettivo cinematografico può esaminare l’ambiente scenico e completarci subito la immagine e il carattere dell’attore. La melodia tracciata dalla maschera, dai gesti, dalle azioni del personaggio, viene variamente orchestrata dall’aspetto di tutti quei particolari che sono altrettanti testimoni per il suo modo di vivere. Ma, impostato così il problema, dobbiamo comprendere subito che l’artigianato non può adempiere al suo compito solo offrendo “oggetti belli”. A chi voglia mettere su un ambiente per la vita propria o per quella di un personaggio cinematografico, esso deve invece offrire quella grande varietà di “stile” che permetta di scegliere secondo i casi. In altre parole non deve imporre una rigida moda la quale, per quanto cambi ogni stagione, non permetterà mai quella molteplicità individuale di cui abbiamo parlato e che probabilmente può sorgere soltanto quando un gran numero di buoni artigiani può creare con ogni libertà. C’è però un fattore che permette e che anzi esige di limitare la varietà della produzione: ed è quel particolare “spirito dell’epoca” che è ben distinto dalla moda. Emanazione di questo spirito non è soltanto la forma della nostra vita. Il cinema, se vuol essere specchio di vita, dev’essere altrettanto impregnato di esso. Ora qual è la caratteristica fondamentale che lo spirito dell’epoca impone al nostro artigianato? È senz’altro questa: che ogni oggetto deve avere una sua funzione; non deve essere inutile. Sono dunque preferiti gli oggetti che siano ben adatti ad un loro scopo pratico: le caffettiere che versano bene, i bicchieri che non cadono, le posate che si puliscono senza fatica, le lampade liscie che offrono pochi punti di attacco alla polvere. Una esperienza millenaria ci insegna che questa praticità non ostacola la fantasia artistica ma anzi le dà più felici ispirazioni. Lo spazio ristretto poi, che la casa moderna necessariamente riserva per gli oggetti senza scopo pratico, si dovrebbe lasciare soltanto ad opere d’arte di indiscutibile qualità. Voglio dire che un’ottima statuetta giustificherà da sé la sua presenza, sempre premesso che si 206 207 zione che non sempre basta guardare per capire. Perciò esiste una forte difficoltà di spiegare fattori astratti e psichici di una certa complicatezza – difficoltà che si è voluta superare con i mezzi impuri delle didascalie e del dialogo mentre, al contrario, si sarebbe dovuto sviluppare il cinema d’arte verso la rappresentazione di fatti semplici ed elementari, analoghi a quelli che formano i soggetti della pittura e della scultura. Dettagli che non sono dettagli «Cinema», 17, 10 marzo 1937, pp. 180-182 accordi all’ambiente. L’opera d’arte ha una sua funzione. Ma, salvo errore, non capirò mai quale ragione d’essere possa avere una enorme e mediocre tigre di porcellana, o un bambino nudo dai capelli blu, il quale, in ginocchio su di un grande delfino, alza verso il cielo un altro piccolo delfino. È la mancanza di qualità artistiche che toglie la funzione a tali oggetti. Anche questi del resto sono caratteristici, perché servono a delineare il gusto e la mentalità di chi li preferisce, e perché indicano inoltre la tenace presunzione di alcuni artisti che potrebbero riuscire in opere più modeste se non insistessero a credere che una tigre mediocre o brutta valga più di un semplice ma gradevole ed utile portacenere. Intanto abbiamo capito che ci sono due tipi di “soprammobili” non adatti alla scenografia cinematografica; ossia, oltre alle esumazioni del magazzino, anche quelle masse di bibelots lussuosi ed eleganti quanto sono sciocchi e inutili, dei quali ambiziosi produttori cinematografici cospargono gli appartamenti dei milionari e delle relative segretarie: ambienti scenici attrezzati in questa maniera non corrispondono alla nostra sensibilità, e rendono falso anche un personaggio di gusto buono, solido e moderno. Non parliamo di quando tali produttori sembra ci vogliano persuadere che una piccola impiegata custodisca un’esposizione di arti applicate all’industria. Se poi ci poniamo ad osservare questo metodo dal punto di vista educativo si deve dire che esso, invece di migliorare il gusto del pubblico, lo peggiora. Inoltre manca allo scopo pubblicitario, in quanto presenta oggetti che per la grande maggioranza del pubblico non sono commercialmente accessibili. Quest’ultimo punto è importante. Né nel senso commerciale, né in quello artistico ed educativo, il problema dei rapporti fra artigianato e cinema si risolve col fornire qualche gioiello prezioso. Più importante che il vaso raffinato per le orchidee sono i milioni di calendari da cinquanta centesimi che si vendono ad ogni capodanno. Se l’artigianato riesce a conquistare questo enorme campo ed a far vedere nella camera della cuoca, sullo schermo, un calendario disegnato con gusto nuovo e fresco, farà cosa molto utile a tutti ma anche a se stesso. Il problema economico sta lì: lo spettatore medio paga due lire per il suo posto, volete che ne paghi cinquecento per un lampadario? Invece comprerà un bel calamaio al posto di uno orribile se l’avrà visto comparire sullo schermo; invece di un Amorino di smalto atrocemente dipinto regalerà alla fidanzata un semplice spillo d’argento se l’avrà visto sul petto di Margaret Sullavan. Non volendo apparire come un lusso inutile nella vita reale, l’artigianato non dovrà nemmeno servire da semplice complemento decorativo nel film. Vuol dire che la messa in primo piano di un oggetto deve essere giustificata. Un buon esempio recente ci fornisce quella scena dello Studente di Praga in cui il dottor Carpis dice: «Guardate questo magnifico specchio veneziano!». Quello specchio non è soltanto bello e ben accordato alla camera della cantante; è inoltre un indispensabile elemento drammatico della azione. Proprio per questa ragione, lo spettatore si lascerà volentieri indurre a guardarlo con quella attenzione che può piacere all’artigiano. Se invece un regista vuol incorniciare in modo “interessante” un’inquadratura in cui non si vede altro che un signore che consegna il soprabito alla cameriera, spingendo nel primo piano la statua, enormemente ingrandita, di una signorina nuda di bronzo a cavallo di un elefante, lo spettatore, inutilmente distratto dal centro della scena, guarderà quel bronzo soltanto con la coda dell’occhio. Quindi, la messa in rilievo mal giustificata nel senso dell’arte cinematografica non serve neanche all’artigiano. Si assiste attualmente ad una importante rinascita dell’artigianato, reazione agli effetti disastrosi di un’industria che assale l’uomo della strada con ogni tipo di oggetti brutti, malfatti, privi di ogni elemento genuino ed umano. Rinasce anche l’arte popolare, la preziosa spontaneità creativa dell’uomo non-artista. In questo senso ci auguriamo una nuova cultura della nostra vita. Per preparare a questa evoluzione le grandi masse, il cinema è uno dei mezzi più importanti. Se esso si assumerà questo compito, sarà certamente anche a suo beneficio; perché chi mangia roba fresca, vive bene. 208 209 Televisione. Domani sarà così* «Cinema», 20, 25 aprile 1937, pp. 337-338 A guardare la fig. 1, sembra cinematografo. C’è il solito teatro di posa, con gli attori, la macchina da presa, il microfono – sospeso sul suo “braccio” – e le lampade. Eppure è un poco strana, questa fotografia. Invece di una sola macchina da presa, ce ne sono due; e la loro forma si distingue notevolmente da quella consueta. Gli attori poi (se davvero sono attori cinematografici) si sentiranno quasi soli, abbandonati; perché c’è poca gente a guardarli: due operatori, un elettricista, un tecnico del suono, e basta. Niente regista e scenarista, niente script girl! In fondo alla sala poi, l’acuto osservatore nota due lunghe finestre, quali non si trovano mai nei teatri di posa normali. Si trovano invece sempre... nelle sale trasmittenti della radio. Passando alla cabina, collegata al nostro teatro di posa mediante le finestre di cui parlavamo, vediamo diventare l’ambiente ancor più decisamente “radiofonico” (fig. 2). Riconosciamo subito il “mischiatore”, il quale sul pannello degli amplificatori regola la trasmissione del suono, e anche il radioregista, seduto davanti al microfono di comando e che legge il copione. Ma anche questa fotografia ha qualche cosa di strano: c’è, in fondo, un terzo signore, davanti ad un tavolo di controllo anche lui, ma evidentemente non preoccupato di cose sonore. Egli guarda quei piccoli schermi, un po’ convessi, posti sulla parete davanti a lui. Continuando a camminare, ci troviamo invece davanti ad una scena * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, pp. 374-375. che di nuovo ha sapore cinematografico (fig. 3). Si sta truccando una attrice. Ma anche stavolta s’impongono delle osservazioni: non è il solito guardaroba degli attori; evidentemente ci troviamo dietro le quinte, quasi l’attrice volesse trovarsi pronta per non mancare la sua “entrata”: ciò che, veramente, ci fa venir in mente il palcoscenico teatrale. Che ambiente enigmatico, che creatura ibrida, generata dal cinema, dalla radio, dal teatro! Qualcuno l’avrà già indovinato; siamo in una stazione trasmittente di televisione. Più precisamente, nello studio NBC di televisione, situato nel palazzo della RCA a New York. Non affrettiamoci a credere che questa rivelazione ci spieghi tutto. Faremo bene a non dimenticare l’impressione di ibridità da noi avuta quando non sapevamo ancora di che si trattava. Ma almeno è chiaro, ora, in qual modo si svolge il lavoro in questo stabilimento, che ci dà una emozionante sensazione di avvenirismo; che sembra la realizzazione di una fantasia utopica. Gli attori recitano la loro scena senza interruzione, e non soltanto una sola scena ma tutta la commedia. Fin qui, ci troviamo a teatro. Ma è un teatro senza pubblico, registrato da macchine... Cinematografo, quindi? Sembrerebbe; ma, nelle macchine, non c’è pellicola. Non sono macchine da presa ma da trasmissione: sono, come dicono gli iniziati, “iconoscopi”. Dove trasmettono ciò che vedono? Trasmettono le immagini su quei minuscoli schermi che abbiamo notati nella cabina di controllo, e che fanno parte dei tubi a raggio catodico. Questi sono tubi di vetro che rassomigliano a fiaschi di vino, ma dei quali si vede soltanto il fondo, funzionante appunto da schermo. Si tratta di piccoli schermi fluorescenti che si trovano non soltanto nella cabina, ma anche nell’apparecchio domestico di chiunque si sia abbonato alla televisione. Lo stesso succede per il suono. Il microfono trasmette il dialogo all’altoparlante dinanzi al quale sta in ascolto, nella cabina, il tecnico numero 1, nonché ai tanti altoparlanti che si trovano nelle case degli ascoltatori-spettatori. Perché si usano due macchine da trasmissione invece di una sola? È un provvedimento che dà alla recitazione della commedia teatrale qualche elemento cinematografico, o possiamo anche dire radiofonico. Infatti, la semplice trasmissione non basterebbe ancora per distinguere lo spettacolo di televisione da quello del solito teatro. Sarebbe del teatro elettricamente trasmesso attraverso lo spazio: ma sempre teatro! Rendiamoci conto adesso che la scena trasmessa dalla macchina più prossima figurerà sullo schermo come una specie di “primo piano”, mentre quella più lontana darà quasi l’effetto del “campo lungo”. Dunque se, durante la recitazione, il “tecnico dell’immagine” nella cabina passa – su comando del regista – dalla prima macchina alla seconda o viceversa, avremo un cambiamento d’inquadratura, nel senso cinematografico. Naturalmente le possibilità di tali cambiamenti d’inquadratura sono limitate. Dipendono, primo, dal numero delle macchine; secondo, l’inquadratura si deve scegliere in modo che non entrino nel quadro né le altre macchine, né le lampade, né l’impianto sonoro, né gli operatori. Nel cinematografo questa difficoltà è enormemente minore: soltanto di rado – in generale soltanto quando si tratti di scene che non sia possibile ripetere – si procederà alla presa simultanea con più macchine. Invece per la recitazione continuata, inevitabile quando si tratta di trasmissioni, l’unico modo di cambiare inquadratura è quello di mettere in azione più macchine successivamente. Non è necessario che queste si trovino nello stesso ambiente. Volendo rappresentare due azioni simultanee in ambienti diversi (per esempio, in un salotto e in un’osteria), si prepareranno due “teatri di posa”, oppure due “palcoscenici”: il salotto e l’osteria, trasmettendo alternatamente dall’uno e dall’altra. Nello stesso modo si può saltare fulmineamente dall’interno di una casa alla strada, dalla città alla campagna, da un paese all’altro, possibilità che non è affatto estranea all’attuale pratica radiofonica. Non solo, infatti, durante le trasmissioni di radiocommedie si trasmette talvolta da più sale, diverse fra di loro, soprattutto per il diverso effetto acustico di risonanza; ma ricordiamo anche che, poco fa, la cronaca radiofonica di un esperimento di protezione antiaerea a Berlino fu eseguita nel modo seguente: i cronisti si trovavano simultaneamente nei punti più disparati della città, per le strade, sui campanili, sui tetti degli edifici pubblici nei diversi rioni, e perfino a bordo degli aeroplani che volteggiavano al di sopra della città oscurata. Ogni cronista era munito di una stazione trasmittente a onde corte, portatile. Le singole trasmissioni venivano captate nella sede della radio, dalla quale il capo cronista (o “regista”), in grado di mandare ai singoli cronisti comandi e indicazioni “senza filo” mediante analoga trasmissione a onda corta, dirigeva lo spettacolo, dando la parola ora al cronista sulla torre del municipio, ora a quello in aeroplano, ora a uno in strada, e collegando le singole descrizioni con qualche parola sua. Erano tante “inquadrature” radiofoniche, che permettevano di osservare l’avvenimento da ogni punto di vista, da ogni distanza. Altrettanto si può fare per la televisione, sia che si tratti di cronache come anche di rappresentazioni teatrali. Per dirla in termini cinematografici: si girano in successione immediata e senza alcuna interruzione tutti gli interni e gli esterni! Sono ovvi però i limiti di questo metodo. Gli attori non hanno le ali, e perciò la trasmissione televisiva non permette di saltare da un determinato luogo a un altro quando debbano esservi presenti gli stessi attori. Così, dovendo gli attori cambiar costume, ci vogliono intervalli sufficienti, come a teatro. Né sarà possibile sottrarre del tempo, presentando al pubblico soltanto i momenti salienti di un avvenimento “reale”, come fanno, grazie ai tagli di forbice e il montaggio, i giornali di attualità cinematografici. Il montaggio televisivo permette, sì, di eseguire la trasmissione dal punto che in un determinato momento può essere il migliore, ma non permette di sopprimere quel momento! Si può trasmettere un avvenimento soltanto in parte (per esempio, soltanto la prima metà di una partita di calcio), ma mai concentrare la cronaca in pochi minuti che diano i punti salienti della partita intera. Salvo che non si ricorra alla registrazione su pellicola e su disco. Bastano questi rapidi cenni per far comprendere che la registrazione dell’immagine e del suono, l’indipendenza della rappresentazione dal mo- 210 211 mento della “presa”, la possibilità di scegliere, tagliare ed elaborare liberamente e tranquillamente il materiale, offre vantaggi che non si vorranno sacrificare senz’altro alla nuova tecnica della trasmissione diretta. Dipenderà da tanti fattori – anche commerciali – in qual grado e in quale funzione la cinematografia continuerà ad esistere accanto alla visione ed audizione diretta. Se poi ai film rimarrà conservato lo schermo delle sale pubbliche, o se essi si trasferiranno del tutto su quello domestico in casa dell’abbonato, ecco un altro quesito al quale risponderà un avvenire non troppo lontano. «Ma se ella fosse più bella, sarebbe meno mutabile: e, quindi, un’attrice minore. Giacché la bellezza, seppure alla lunga appassisce, è qualcosa di stabile. Per lo meno lo spazio di una serata. Un viso bello è in generale un viso regolare, di taglio classico; e un viso regolare ha poca voglia di modificarsi. L’attore, d’altra parte, è tenuto a cambiare, non a conservare [...] Proprio tutto ciò che si voleva chiamar brutto in questa donna, intensifica e moltiplica i mezzi della sua espressività mimica. La Duse, pur non essendo bella, può tuttavia diventarlo: giacché ad ogni sua emozione corrisponde l’espressione del suo viso». Queste parole, riportate dal Rheinhardt, furono scritte nel 1892 dal critico Paul Schlenther, in occasione della prima recita di Eleonora Duse a Berlino. Sembra che queste proposizioni, ideate per difendere la bruttezza, sottintendano una critica contro quel normale figurino cinematografico che non soltanto ha poca voglia di modificarsi ma che è anzi costretto a non deformarsi con espressioni violente. Critica, dicevamo, rivolta anche contro la mania di voler spingere ad ogni costo un attore, per sua natura espressivo, verso un ideale di “bellezza” troppo studiata. – E non crolleranno – ci potrà rispondere il grande produttore cinematografico leggermente appoggiato contro la sua magnifica biblioteca piena di difficili libri europei, – non crolleranno le basi dell’estetica se il critico si mette a dichiarare contrari o addirittura nemici l’espressione e la bellezza? La bellezza in sé, è vero, non è altro che armonia ed equilibrio, ciò che però condurrebbe al vuoto completo se non si riferisse ad un soggetto. Come poi potrebb’essere vuota in questo senso la bellezza dell’attore che si riferisce al soggetto “di mostra” e rappresentandolo armonicamente gli dà, proprio per questo mezzo, una determinata espressione? E come, d’altra parte, l’espressione potrebbe diventar comprensibile senza la bellezza (il produttore si smuove dalla biblioteca verso la sua scrivania, altrettanto magnifica, e ci afferra alcune fotografie) dato che l’espressione artistica non è altro che quel rendere precisi, dominanti ed incontrastati certi tratti, i quali nella natura si presentano confusi, occasionali e contradditori? Non è forse un’opera della bellezza se l’espressione di un naso viene accordato a quella di una fronte; se la linea delle sopracciglia viene subordinata al carattere degli occhi; oppure, per creare un personaggio più complesso, se vien precisato il contrasto di una bocca voluttuosa con la discrezione paurosa degli occhi? Si è certamente nell’ordine della bellezza ove si crea unanimità, armonia e nitidezza, scegliendo fra gli attori aspiranti i tipi adatti e completando con artifizi l’opera della natura. – Non possiamo nasconderle – replicheremo noi, la nostra ammirazione per questa teoria, ma dubitiamo che in pratica sia veramente seguita. Al pubblico cinematografico bruciano gli occhi dal sonno per effetto proprio di quella bellezza anti-espressiva di cui parla il critico della Duse. Ma si tratta forse di un altro tipo di bellezza, o non piuttosto di quello citato da voi signor produttore, con tanta abilità? Domandiamoci se per caso tale bellezza, sulla cui utilità insistete con buone ragioni, non renda questo servizio soltanto forzatamente, costrettavi cioè da una specie di controforza. Abbandonata a se stessa, essa non mirerebbe unicamente al completo equilibrio e alla distensione delle energie, arrivando in questo modo all’inerzia e al vuoto completi? Tendere verso questa bellezza significherebbe dunque voler uscire dalla discordanza, dalla incompletezza e dalla lotta; infatti l’arte classica nata nei paesi del sole, cercherebbe di realizzare lo stato ideale respingendo fino ad un certo punto la controforza a cui accennavamo. Una simile sensazione di gioia, benché un po’ vuota e fredda, susciterebbero anche quegli uomini nei quali la natura ha incarnato l’ideale classico; ma in fondo, l’impressione che lasciano, spesso è negativa e penosa. (Non però nel concetto della folla, la quale trova ebbrezza e fascino in una superficiale perfezione di forma). Prevale il senso di una certa manchevolezza, e infatti ci manca un’altra specie di bellezza, quella romantica, propria dei paesi del nord, dove si chiama bella la forza vitale, efficace nell’uomo come nella natura intera; si chiamano belli il movimento e la lotta tanto tipici della nostra vita. In questo senso sarebbe da considerarsi bello tutto ciò che porta il conio della vita vissuta, molto dunque di quel che si dice “brutto”. Questo effetto per l’attività vitale è la controforza di cui parlavamo, ed è la vitalità che manca nelle persone troppo armoniche, che non hanno – come le statue classiche – superata la vita ma ci dovrebbero star dentro. Manca l’elemento che ce le renderebbe vive. Sono esse che hanno poca voglia di muoversi; la loro bellezza è ottenuta con la mancanza di spontaneità e di impressionabilità. – Va benissimo – ribatterà impaziente il nostro produttore. Ma l’attore non è mica l’uomo della vita. Entrato nell’opera d’arte, diventa arte anche lui, simile alla statua. – Giustissimo –. Tuttavia non dimentichiamo che l’attore entra in un’opera destinata non a rappresentare l’armonia ma la lotta vitale, ossia in un’opera drammatica. L’uomo drammatico, impregnato della vita che lo fa fremere e soffrire, dev’essere maggiormente espressivo, mentre troppo spes- 212 213 Espressione e bellezza «Cinema», 23, 10 giugno 1937, pp. 443-444 so i figurini umani, scelti e preparati da voi, fanno pensare a statue di legno, portate via dalle acque di un fiume, scostate dalle rive di quelle arti capaci di rappresentare ciò che, compiuto, riposa, perché hanno per principio escluso l’elemento del tempo. E anzi, quasi sembra che alla stessa folla cominci a mancare il sugo vitale di questa bellezza dolce: vedo che negli ultimi film di vostra produzione prevalgono i colpi contro il mento, le bastonate, i maltrattamenti sadici, le operazioni chirurgiche eseguite possibilmente a semplice coltello di cucina scene però in cui il critico, sempre scontento, non riesce a scoprire quell’elemento di bellezza sublimante senza il quale, come poco fa dicevate voi stesso, non può nascere espressione. La luce in movimento «Cinema», 24, 25 giugno 1937, p. 508 Si crederebbe che la produzione cinematografica, nella sua affannosa ricerca di effetti originali, abbia sfruttato fino in fondo tutte le capacità tecniche, attualmente a disposizione, del suo strumento. Invece ce ne sono alcune, senza dubbio efficaci, che sono quasi inutilizzate. Certamente non senza buone ragioni, in quanto, generalmente, si tratta di capacità il cui impiego disturberebbe lo stile veristico adatto ai prodotti delle fabbriche delle illusioni. Il nostro esempio illustrerà subito ciò che vogliamo dire. Qualche occasionale scena, brevissima, in cui per esempio le luci di un treno che passava sfioravano i visi delle persone che lo guardavano da ferme, ci rivelò fulmineamente la stupenda efficacia della luce in movimento. La lanterna del poliziotto, scrutando in una cantina buia il viso di un ignoto, nascosto immobile nell’angolo, dimostrò, di passaggio, un ottimo modo di rendere movimentati gli oggetti rigidi, di interpretare tutte le sporgenze e concavità di un rilievo. Ciò nonostante, la ragione per cui i registi comuni sono poco affezionati a questo mezzo, sta nel semplice fatto che in realtà le sorgenti di luce sono quasi sempre fisse. Il Sole praticamente non si sposta, e i lampadari si muovono soltanto in alto mare. Se la nostra terra girasse intorno al suo asse con una velocità molto maggiore, allora la luce dinamica sarebbe anche sullo schermo un mezzo comune. C’è però un campo speciale del cinema che recentemente ha trovato questo mezzo molto adatto ai suoi scopi, ed è il film documentario. Si sa che il documentarista spesso non può far a meno di occuparsi di soggetti del tutto fermi e quindi poco cinematografici. Onde la necessità di animare scene di questo tipo con mezzi “soggettivi”, ossia con i mezzi della presa. Un rimedio di prim’ordine è fornito dai movimenti della macchina, dalle panoramiche e carrellate, dato che esse producono un movimento 214 illusorio dell’oggetto. Infatti questo mezzo viene utilizzato fin troppo dai poveri documentaristi in tutti quei casi in cui le condizioni tecniche lo permettono. Effetti analoghi li dà la sorgente di luce in movimento. E come la carrellata, questo serve non soltanto a dar un po’ di vita alle “nature morte” ma soprattutto anche ad interpretare meglio l’oggetto, la cui plasticità rimane spiegata sempre in modo unilaterale finché esso viene preso e illuminato da un punto unico. Sappiamo tutti che guardando una statua da un solo punto o esaminando la riproduzione fotografica di un bassorilievo illuminato, necessariamente, in modo invariabile, riceviamo una impressione assai insufficiente. Comprenderemo e sentiremo invece il carattere della creazione tridimensionale camminando intorno all’opera (carrellata) o muovendo la lanterna davanti al rilievo – come fanno i custodi nelle tombe e nelle catacombe (luce in movimento). Né si contenta il documentarista di muovere le lampade; infatti riesce ad accelerare il cammino relativo del Sole, nel modo sopra accennato, servendosi dell’acceleratore. Basta lasciar passare dopo l’esposizione di ogni fotogramma un certo spazio di tempo, per vedere poi concentrato sullo schermo in pochi secondi il movimento del Sole, rispecchiato dallo spostamento delle ombre. Questo crescere e ridursi delle ombre, create per esempio dalle sporgenze degli ornamenti sulla facciata di un bel palazzo, è uno degli spettacoli più emozionanti, più fantastici e grandiosi che il cinema ci ha saputo dare: le proporzioni armoniche, ideate dall’architetto, pur rimanendo sempre ferme e corrispondenti al loro carattere, subiscono un gioco di movimenti che nella continua trasformazione “discute” ogni lato della plasticità, dal caso estremo delle ombre lunghe fino alla pienezza completa, data dalla mancanza di ombre. Le prime applicazioni di questo trucco meraviglioso le abbiamo ammirate nel film Che cos’è il mondo, di Svend Noldan, proiettato a Venezia nel 1934. Le nostre fotografie sono prese da un esempio più recente: da un documentario fatto da prof. Charles Lamb nella chiesa Die Wies, capolavoro del barocco bavarese. Potrebbe sembrare paradossale che proprio il documentario, ossia il cinema che più di tutti rimane legato alla realtà, abbia voluto impossessarsi di un mezzo che il film a soggetto respinge come poco naturale. Ma basta ricordarsi che il documentario se ne serve soprattutto per rappresentare soggetti indifferenti al passaggio del tempo, quali sono appunto le opere dell’architettura. Infatti, quelle scene girate con l’acceleratore non danno l’impressione di un avvenimento temporale e quindi neanche quella del tempo deformato, ma si impongono invece come una interpretazione ottica di quel che l’artista ha fissato nella pietra rigida. Si tratta di un mezzo non tanto del documentario registrativo, quanto di quello esplicativo. 215 Resurrezione del Cineasta? Il cinema cammina ormai sulla stessa strada di tutte le altre industrie. La situazione economica crea le necessità interne di questa sua evoluzione, e perciò la produzione europea la subirebbe anche se non avesse davanti agli occhi l’esempio di quella americana, già arrivata alle forme estreme. Gli organismi isolati si allargano e si fondono in unità sempre più grandi, e i metodi organizzativi tendono alla produzione sempre più esatta, sicura ed economica della merce desiderata. Il primo di questi fenomeni si può studiarlo in occasione della trasformazione della Tobis tedesca, originalmente limitata al campo dell’elettroacustica, ma che in seguito, per ragioni commerciali, dovette interessarsi sempre di più anche della produzione e del noleggio. Ultimamente, la Tobis ha assunto e centralizzato completamente la produzione dei tre enti da essa controllati: ossia dell’Europa, della Rota e della Syndikat, formando così un formidabile organismo, il quale, insieme all’Ufa, concentra praticamente l’industria cinematografica della Germania in due grandi blocchi. Ma simultaneamente a questo concentramento industriale si verifica, in ambedue questi blocchi, un altro fenomeno, sorto evidentemente per compensare certe conseguenze negative dell’industrializzazione totale. Nel consiglio d’amministrazione della Tobis, infatti, sono stati assunti quali consiglieri artistici della produzione Emil Jannings, Gustaf Gründgens e Willy Forst. Analogamente, durante la sua recente e radicale trasformazione, l’Ufa ha creato un comitato artistico, al quale partecipano, fra altri, i registi Carl Froelich e Karl Ritter e gli attori Eugen Klopfer, Paul Hartmann e Mathias Wieman. Dopo questa sistemazione, gran parte delle personalità artistiche del cinema tedesco è entrata nella direzione delle case produttrici. L’artista produttore, ecco l’ultima parola in fatto di soluzione del problema: «Come salvare il cinema industriale da una meccanicità sterile?». Soluzione strettamente europea, del resto, giacché in America, dove questa necessità avrebbe dovuto esser sentita da un tempo molto più lungo ed in modo più allarmante, troviamo invece pochissimi casi paralleli: tra i quali quello di Ernst Lubitsch produttore, caso che poi, come è noto, ebbe a dar luogo a parecchie difficoltà. Ricordiamoci che ultimamente René Clair rese noto il progetto di farsi produttore dei propri film. L’idea era questa: «Dato che non sembra si possa più evitare che il produttore controlli ogni dettaglio della creazione artistica, perché non mutare in produttore lo stesso artista? È superata l’epoca in cui il produttore non era altro che finanziatore e venditore. Sono superate anche le occasionali ribellioni di forti personalità artistiche tipo Erich von Stroheim contro l’industria. L’artista è vinto; ma poiché rimane sempre indispensabile, perché non farlo industriale?». Idea seducente, a primo sguardo; ma che tuttavia non ci sembra troppo propizia. Inutile dimostrare ancora una volta che i metodi del vero artista sono nettamente opposti a quelli industriali. Praticamente, perciò, ci vuole un compromesso. Che questo compromesso avvenga nell’anima dell’artista, non servirà certo ad agevolare la sua spontaneità creativa. Meno grave di un paralizzante conflitto interno sarà sempre quello esterno fra due uomini testardi, ognuno in possesso di tutte le proprie forze, ognuno intento a salvare il più possibile dei propri interessi nell’opera comune. Un film sorge dalla collaborazione di tanti individui. Ciascuno di essi potrà possedere una certa originalità; tuttavia dal risultato finale del loro lavoro scompare, attualmente, sempre di più l’impronta dell’individuo creatore unico. Il film porta, più che altro, i tratti della casa produttrice, e le poche eccezioni alla regola fanno, perciò, un effetto sempre maggiore: un film costruito in una maniera un po’ personale ci sembra oggi di una originalità addirittura travolgente! Proprio mentre il concetto del regista, grazie all’intensa propaganda dei teorici, comincia finalmente a divenire familiare allo spettatore medio, mentre per esempio all’inizio dell’ultimo film di Capra appare sullo schermo il ritratto del regista, il film medio diventa anonimo come è anonimo un nuovo modello di automobile. Al cinema americano sono rimaste alcune personalità dell’epoca in cui si lavorava ancora sotto forma quasi artigiana: aiutati dal loro antico prestigio, mantengono ancora la libertà di esprimersi in quel loro “stile”, almeno fino al punto ammesso dallo strumento standardizzato della produzione. L’ultimo decennio invece ha prodotto molti film buoni, ma nessuna nuova personalità creatrice. Soggetti sempre pieni di nuovi elementi, confezionati con una precisione da ingegneri, realizzazione perfetta, spettacoli emozionanti, divertenti, talvolta educativi; ma non più la visione personale nel senso assoluto dell’arte. Una tecnica perfezionata fino alla genialità di accennare a tutti i problemi scottanti, senza tuttavia compromettersi con la proposta di soluzioni, o di rendere armoniosa, pittoresca o suggestiva la materia grezza della realtà, di evitare cioè ogni motivo che potrebbe offendere o urtare, ha creato un genere di film simpatici, divertenti, corretti e pallidi come i prodotti dei collegi inglesi. Ma la natura, la realtà, la personalità, anche se espulse col forcone rientrano per la finestra. Nel pubblico (in un primo momento solo nei suoi strati più colti) si prepara una reazione. Pare che ci sia una nostalgia, alquanto diffusa per lo spettacolo meno elaborato, più immediatamente umano, più personale: nostalgia espressa benissimo in una risposta di Robert Donat, protagonista del Fantasma galante, ad un referendum di «World Film News». Fra i suoi film prediletti della stagione passata, Donat cita quello di Chaplin «per l’incapacità di Charlie di aerodinamizzare le sue sempiterne follie». (Aerodinamica, si sa, è attualmente la parola di gran moda nel mondo americano per tutto quello che è moderno e razionale). Non sappiamo fino a quale punto il cinema americano industrializzato sarà capace di riprendere forme più vicine a quelle della creazione 216 217 «Cinema», 25, 10 luglio 1937, pp. 7-9 artistica, per adattarsi a questo inevitabile ritorno alla vita e all’uomo, e non sappiamo se il cinema europeo farà ancora in tempo a ritrovare la strada; ma è più interessante, in fondo, che accanto ai visi aerodinamizzati dei divi, stia sorgendo un movimento cinematografico completamente anti-industriale, destinato forse a ricondurre il cinema alle sue fonti. Ci può essere cosa meno industriale di quelle migliaia di dilettanti, ciascuno dei quali va a “girare” per conto proprio secondo il proprio gusto filmetti di poco costo e senza scopo commerciale? Si tratta di un movimento non soltanto rapidamente crescente ma che comincia anche a diventare un elemento importante della vita pubblica. Ogni anno, l’insegnamento in materia di cinematografo diventa più serio e universale. In Italia abbiamo l’attività dei Cine-Guf e anche in diversi altri paesi gli studenti non sono rimasti inoperosi. Gran parte delle università americane, come anche molte di quelle tedesche, offrono agli studenti dei veri e propri corsi sul cinema dal punto di vista artistico, sociale, educativo e tecnico. L’Università della California del Sud dispone perfino di un completo Reparto Cinematografico, diretto dal dott. Boris V. Morkovin, che fornisce l’istruzione pratica in tutte le branche del mestiere. Alcuni studenti, così preparati, andranno a cascare proprio nell’industria cinematografica; ma più importante il fatto che per la generazione studentesca attualmente in sviluppo, il cinema sarà un elemento di cultura generale. Avendo il cinedilettantismo superato lo stadio del semplice “girare” i bambini nel giardino e la fidanzata nella barca, non sembra esagerato se, per esempio, Pierre Boyer, editore del «Cine Amateur» poneva mesi fa la domanda: «Dei 100 milioni di franchi riservati dal Ministero dei Lavori Pubblici francese per la presa di film, fotografie e dischi in occasione dell’esposizione mondiale del 1937, saranno messi da parte alcuni grossi biglietti per la realizzazione di film dilettantistici a formato ridotto?». Non lo crediamo, continua Boyer, ed è un peccato. «Non si dovrebbe ignorare negli ambienti competenti che il formato ridotto è il film ideale per la propaganda turistica, industriale e anche artistica. Costa molto meno del suo fratello maggiore; la sua attrezzatura è estremamente maneggevole; con essa uno può infilarsi dovunque e precisamente anche dove l’accesso è difficile per apparecchi ingombranti». Con questo esempio abbiamo già accennato alle possibilità pratiche che esistono per coloro che vorrebbero dedicarsi all’attività del “ridottista” senza poter disporre di biglietti da mille. Si apre una strada che, oltre ad assicurare all’amatore la base finanziaria di cui ha bisogno, lo conduce anche subito da un puro sport personale (che facilmente può perdersi nei giochi estetici) ad una attività di alto valore sociale. È di pochi mesi fa una proposta di John Grierson che riguarda particolarmente i cine-amatori: «A quale amatore non piacerebbe di trasformare il suo cavallo di battaglia in uno strumento di utilità pubblica?». Egli si riferisce ai tanti ospedali, istituti educativi, enti rurali, industriali, ecclesiastici ecc. che ogni anno si rivolgono a lui per sapere in quale maniera essi, non avendo a loro diposizione che mezzi modesti, potrebbero arrivare a film propagandistici capaci di dar testimonianza della loro attività. Ecco le occasioni per l’amatore! «Il professionista a costoro non serve perché costerebbe più di quanto possono disporre. La spesa di diecimila lire, per un film professionale, in quasi tutti i casi non si discute neanche, mentre l’amatore, con non più di tremila, è in grado di far meraviglie». Grierson vorrebbe insomma che gli amatori cercassero dappertutto queste occasioni da tremila lire; essi potrebbero diventare il più grande gruppo produttore del mondo, facendo migliaia di film all’anno! Né la cosa è rimasta nella sfera della pura teoria e dei bei sogni. Rappresenta infatti una pietra miliare nella storia del cinedilettantismo la fondazione, avvenuta in queste settimane, di un gruppo destinato a dare agli amatori, sotto la direzione di Robert Flaherty e di John Grierson, «aiuto professionale nella produzione di film di carattere documentario e sociale, per quanto riguarda lo scenario, il lavoro con la macchina da presa, l’organizzazione ecc.». Si sono messi a disposizione del gruppo i più esperti artisti nel campo del documentario; fra essi, Paul Rotha, Basil Wright, Andrew Buchanan e Evelyn Spice. E ci è voluto un solo mese perché il gruppo fosse in grado di annunciare che alcune grandi compagnie di diversi rami dell’industria avevano messo a disposizione le somme necessarie per realizzare dei film che potranno illustrare e propagandare la loro attività. Ora, è evidente che anche questo sistema vincola in certo senso l’artista alle esigenze e ai desideri del finanziatore. Ma è inutile dimostrare che passa una bella differenza tra le influenze che può esercitare il direttore di una Società del Gas per un film sugli scaldabagni, e quelle di un vero produttore cinematografico. Si tratta di un sistema realizzabile in tutti i paesi. Forse vedremo dunque sorgere, fra non molto, una vasta attività cinematografica in cui gli artisti esprimeranno le loro visioni personali con la libertà concessa loro nel campo delle altre arti. Ma… si tratta quasi unicamente del film documentario. Il vero e proprio film a soggetto non si potrà mai fare con tremila lire. È vero; tuttavia bisogna anche pensare che il compito del cinema artistico consisterà sempre meno nel creare spettacoli. Basta esaminare le tendenze della tecnica cinematografica, per vedere che essa mira sempre più decisamente alla registrazione di rappresentazioni teatrali; e forse la televisione finirà per rendere inutile anche la stessa registrazione. Infatti, la registrazione è indispensabile non tanto allo spettacolo teatrale (che si può ripetere e trasportare a piacere) quanto piuttosto a tutto quel che è irriproducibile, passeggero, raro, ossia agli avvenimenti della vita di ogni giorno in tutto il mondo. E i mezzi espressivi offerti dalla tecnica cinematografica servono non solo allo spettacolo teatrale (il quale, infatti, restringe sempre di più i limiti della loro applicazione), ma soprattutto a quel mondo reale che non è arte ma argomento dell’arte. Disegnare l’immagine di questo mondo, ecco il compito del cinema artistico di domani; ed è per questo che diamo tanta importanza ai lavori dei dilettanti, dedicati al film documentario. Spetterà al dilettante – che non 218 219 Uno degli elementi che distingue subito, anche per l’occhio di un osservatore non molto cauto, il cinematografo dal teatro, è il paesaggio naturale. Anche sul palcoscenico si muovono gli attori, si vedono stanze e sale riprodotte con varietà. Ma nei paesaggi del teatro facilmente si sente la rigidezza della morte, e i colori vivi di essi – spesso troppo vivi – non servono che a sottolineare quest’impressione. L’uomo che si muove in piena vita, l’attore, appare combinato con un quadro dipinto, e il lento volo di qualche nuvola attenua soltanto leggermente il contrasto. Perciò il pubblico, abituato alle quinte ed ai fondali, rivelò fin dalla nascita del cinema con emozione particolare la nuova sensazione del paesaggio animato, e nei primi film di Louis Lumière quasi più ancora degli attori in movimento ammirò gli sfondi “veri”: le foglie che s’agitavano, gli alberi che si piegavano al vento. Poteva sembrare questo un deviar l’attenzione dall’arte: mentre il farsi adescare dall’immagine della natura, corrispondeva perfettamente al carattere della nuova arte, la quale non partiva, come il teatro, dall’uomo, ma dal fenomeno complessivo del cosmos, di cui l’uomo doveva dimostrarsi solo una piccola parte, dotata di alcune caratteristiche del fenomeno più vasto. L’uomo presentato come prodotto della natura, e quindi “spiegato” dalla natura: ecco forse il fattore essenziale della nuova arte, considerata dal punto di vista del “contenuto”, ossia della sua materia. Il paesaggio: attore più sensibile di quello umano per quanto riguarda il senso della rappresentazione, più ricco di mezzi per quanto riguarda la varietà delle manifestazioni. Stava proprio al paesaggio d’indicare al cinematografo la via buona, quella della descrizione dei fatti elementari, da interpretarsi con l’immediata espressione di una superficie, di un gesto. Una mano rugosa come la corteccia di un albero, un viso tremante come le foglie nel vento, ecco il materiale della nuova arte ottica, la quale, – come la pittura, la scultura e la danza – era destinata a trovar la sua virtù nel ri- nunciare alla dimensione della parola. Per un certo tempo la predica senza parola, l’efficace esempio della natura fu accolto. Sullo schermo si vedevano una pianura, una montagna, gigantesche ma vuote, come dopo il quarto giorno della Creazione; apparve poi un puntino nero, quasi invisibile ma semovente, che avvicinandosi ingrandiva: un uomo a cavallo, scaturito dal seno della natura davanti agli occhi del pubblico. Uomo che anche quando le dimensioni del suo corpo finivano per coprire quella pianura e quella montagna, non faceva dimenticare d’esser figlio della natura. Muto come il suo cavallo, si mosse con gesti semplici, simili a quelli dell’animale, dimostrando sì maggiore complessità, maggiore finezza, ma non distinguendosi in nessun modo essenziale dai movimenti e atteggiamenti vitali dei monti, delle piante, delle bestie. L’uomo. pur essendo arrivato per mezzo della coscienza e dello strumento di essa – la parola – ad una vita diversa da quella degli esseri non umani, rimaneva sempre riducibile agli elementi dai quali era nato. Era questa la lezione della Creazione, ma era un fenomeno prossimo e familiare per l’umanità civilizzata, già un po’ distaccata da quell’arcaica semplicità che rappresentava l’uomo muto del cinema. Quella distanza non sapevano superarla se non le persone dalle emozioni o molto semplici o molto forti. Doveva vincere la vicinanza, più diretta e più facile, dell’uomo parlante. Comprendere lui era più facile. Davanti a questa evoluzione delle cose, il paesaggio silenziosamente si ritirò nello sfondo; lasciando il primo posto all’uomo portatore delle parole. Non è un caso, dunque, se durante lo svilupparsi del cinema parlato, la funzione del paesaggio si ridusse sempre di più – e questo, in modo paradossale, proprio mentre si imparava sempre meglio a fotografarlo (basti accennare all’introduzione della pancromatica) – mentre l’attore, protagonista incontestato, interpretò l’azione quasi da solo, proprio come avviene nelle rappresentazioni teatrali. Si muovevano sempre le foglie, è vero, ma in fondo, soltanto perché vederle ferme sarebbe sembrato poco naturale e non perché si volesse affermare il significato di quelle oscillazioni. Questo lo diciamo cum grano salis, s’intende. Perché, pur essendo evidente una tendenza ad escludere quasi del tutto l’ambiente come fattore espressivo, non se ne dimenticò d’altra parte la forza vivificatrice e ci si preoccupò sempre d’arricchire l’azione – tante volte schematica ed arida – con le bellezze e curiosità di uno scenario naturale ben scelto. Ciò non toglie che il paesaggio fosse ormai destituito: non era più l’interprete, ma, anche se curato bene, un puro mezzo scenografico. I casi eccezionali in cui vediamo ancora la tradizione – I cavalieri del Texas di King Vidor, per esempio, o L’imperatore della California di Trenker – servono a sottolineare la differenza. E soltanto in questa fase dell’evoluzione poteva assumere grande importanza un mezzo tecnico che, se si fosse sviluppato prima, certo non avrebbe corrisposto alle esigenze del cinema tanto più cinematografico di allora: intendiamo la tecnica degli sfondi artificiali. È ormai noto a chiunque che, attualmente, soltanto in minima parte gli “esterni” si girano in esterno. Si fanno invece entro le mura del teatro di posa come tutte le altre scene. Per essere più precisi: i paesaggi 220 221 sarà più dilettante – di completare il quadro ufficiale, rappresentativo e talvolta sensazionale offertoci dagli operatori dei giornali d’attualità con la visione più tranquilla, più anonima e più costante di quel che è la vita quotidiana dei popoli, l’aspetto dei loro costumi e del loro lavoro. Così come oggi le cronache delle attualità ci fanno partecipare quali spettatori alla storia dei nostri tempi, domani una vasta documentazione cinematografica potrà creare una coscienza universale delle innumerevoli risorse ed energie che dovunque ed in ogni momento alimentano la nostra vita. Il paesaggio ispiratore «Cinema», 32, 25 ottobre 1937, pp. 262-264 vengono ancora, spesso, fotografati sul posto, ma a questo scopo non si fa più viaggiare la truppa intera, inclusi gli attori, bensì il solo operatore, accompagnato qualche volta magari dal regista, perché sorvegli le prese, come avvenne qualche tempo fa nel caso del regista Tay Garnett, che fece il giro del mondo dai mari del Sud fino alla Scandinavia, per far prendere gli “sfondi” necessari ad un suo prossimo film. Questi paesaggi fotografati si combinano con la scena recitata dagli attori nel teatro di posa. Più in uso del famoso Dunning, è oggi la proiezione degli sfondi su appositi schermi di vetro, posti dietro gli attori. Questi sfondi artificiali riproducono qualunque paesaggio con la solita fedeltà fotografica e cinematografica. Ma c’è un difetto essenziale ed è quello che non vi sono più rapporti diretti fra paesaggio e attore. L’attore non può entrare in un paesaggio fotografato, non può salire su un monte proiettato, né bere da un ruscello-ombra. Ora, dopo quel che abbiamo detto, è inutile specificare quale colpo fatale significhi questo netto distacco fra ambiente e uomo. Effettuata spiritualmente la detronizzazione, la porta del paradiso si trova ormai chiusa anche nel senso materiale. Volendo penetrare nella foresta selvaggia, l’attore travestito da cacciatore esotico si deve arrestare davanti ad uno schermo piatto di vetro opalizzato. Se dunque oggi l’attore si muove fuori dell’ambiente della scena (davanti ad essa invece che in essa), questo fatto simboleggia anche la distanza intrinseca che esiste oggi fra l’ambiente di un film e gli attori che lo recitano come anche gli altri collaboratori artistici. Se un attore medio come Fred MacMurray, giovanotto semplice ma forse non privo di una certa sensibilità, va nel Texas o a New Messico per interpretare le vicende del coraggioso cavaliere, l’intensità dell’ambiente non mancherà di renderlo più aperto alle suggestioni del regista Vidor che vorrebbe trasformare in cowboy l’elegante favorito di Hollywood. Ma se le scene di Swing High, Swing Low si sono recitate davanti alle immagini di paesaggi presi nelle vicinanze del Canale di Panama, lo stesso MacMurray non avrà sentito in nessun modo influenzata e facilitata la sua interpretazione da quell’atmosfera dell’ambiente che tanto spesso ha dato spunti fecondi alla realizzazione dei film, soprattutto nel senso di conferir loro una naturalezza più immediata. Molte altre sfumature caratteristiche e curiose esistono nei rapporti fra il paesaggio naturale e lo spirito del teatro di posa. C’è chi riesce a far apparire come di cartapesta il paesaggio più autentico, per merito di un’azione e recitazione artificiose (qualche volta basta anche il modo di scegliere i motivi, le inquadrature, le luci). C’è la natura creata appositamente nelle vicinanze degli stabilimenti: vedi i giardini più o meno esotici di Hollywood. Ci sono delle zone geografiche preparate alle visite dei cinematografari, così come certi “tipi pittoreschi” di Capri offrono ai turisti il caro romanticismo dell’opera lirica. La cittadina di Kernville in Germania si vanta di una permanente “strada tipo Western” costruita appositamente a scopi cinematografici. Per gli esterni della Vergine di Salem l’ambiente storico fu ricostruito a Salem nello stato di Massachussetts e a Santa Cruz. 222 Fortunatamente, ancor oggi non si è del tutto perduta la buona, seppure più costosa e meno elegante, abitudine di girare in ambiente “vero”. Così anche in Italia, ove si possono girare all’aperto anche i film storici senza che si debba ricorrere a ricostruzioni, abbiamo visto la truppa di Luis Trenker eseguire un assalto intorno al magnifico castello di Torrechiara. Furono girati nelle cave di Carrara gli esterni di La fossa degli angeli e così via. Sono altrettanti tentativi di utilizzare, finalmente, le inesauribili bellezze del paesaggio italiano, umanizzato da una storia millenaria, e di presentarle non soltanto ai popoli del mondo ma in modo speciale anche a quelle compagnie cinematografiche estere che, recandosi in Italia, generalmente non sanno staccarsi da piazza di Spagna e da piazza San Marco. Ma che cos’è questo cinema? I. Sonoro o muto? «Cinema», 33, 10 novembre 1937, p. 306 Le innumerevoli risposte pervenute al concorso di «Cinema» (i nomi dei vincitori sono apparsi nel numero passato) rappresentano un materiale raro e prezioso, in quanto non sono – come le risposte alle solite inchieste organizzate un po’ dappertutto – dei semplici sì o dei semplici no a domande più o meno artificiali (“Qual è il vostro attore preferito?”), bensì, nella maggior parte, veri e propri scritti in cui si ragiona esplicitamente sui principali problemi del cinematografo. Non basta, perciò, nel caso nostro, uno sfruttamento puramente statistico delle risposte, ma si impone un’analisi accurata e dettagliata delle opinioni esposte dai lettori. Prima d’iniziare il lavoro, è indispensabile distinguere le risposte a seconda dei ceti ai quali appartengono i concorrenti. Evidentemente non si potrebbe dare una visione chiara mescolando la riposta di un professore di fisica con quella di un autista. Per questo motivo, eliminate le risposte dove non era indicata la professione dell’autore, abbiamo diviso tutto il materiale in sei gruppi principali, che si presentano nel modo seguente: Studenti Professionisti Funzionari e impiegati Donne di casa Operai Artisti 34% 21% 21% 8,7% 7,7% 7,6% -----100% Dato che in queste settimane cade il decennale del cinema parlato, 223 abbiamo creduto opportuno esaminare, come prima cosa, la posizione che il pubblico cinematografico assume di fronte a questo nuovo dono della tecnica, limitandoci alle risposte di due gruppi molto distanti, e precisamente degli operai e degli studenti. Fra gli operai, il film muto sembra che non abbia più fautori. Si delineano molto chiaramente due ragioni per cui la preferenza è data al sonoro. L’uomo semplice trova nello spettacolo filmistico la possibilità di partecipare ad avventure emozionanti. Non gli importa gran che se queste avventure siano presentate o meno con quella purezza stilistica che avvicina l’avvenimento individuale alla validità dell’idea universale; cerca lo stimolo della realtà immediata. Ora, questo senso di realtà immediata è evidentemente aumentato di molto dall’aggiunta delle voci e dei rumori all’immagine. Nel film sonoro «c’è più realismo», scrive un operaio; esso dà «maggiore vita e risalto alla scena e agli interpreti», dice un altro. Il sonoro «dà vita e animazione alla scena che si svolge». (Le parole in cui si esprime questa sensazione sono spesso quasi identiche). Conseguenza del maggiore realismo è naturalmente un effetto emotivo più intenso: «il sonoro mi dà più emozione». Un altro vantaggio del film parlato è non meno persuasivo. Il cinema muto trovava una considerevole difficoltà nello spiegare trame un poco complicate e nel far comprendere i rapporti fra i vari personaggi: bisognava ricorrere a simboli visivi, al mezzo indiretto delle didascalie ecc. La necessità delle trasposizioni ottiche di concetti e pensieri ha portato il cinema, indubbiamente, alle sue più originali e più belle espressioni, ma il silenzioso gesto di un giovane innamorato che sfiorava con le labbra il bicchiere in cui la ragazza aveva bevuto, non aveva certo la diretta comprensibilità delle poche parole banali: «Ti amo tanto!». Perciò: «Si può seguire più facilmente la trama», oppure: «Il parlato definisce meglio certe situazioni che affaticherebbero troppo la mente…». Gli stessi argomenti ritornano anche nelle risposte degli studenti («Il sonoro è alla portata di tutti i cervelli» – «ci evita lo sforzo di leggere» – «aiuta e rende esplicite molte allusioni che prima si affidavano al più difficile linguaggio della pantomima o dei giochi di inquadratura, d’obbiettivo o di illuminazione»), ma sono completati da molti altri ragionamenti di diverso genere. Gli studenti cercano di dimostrare che, al di là della loro impressione personale, il film sonoro rappresenta in sé un maggior valore assoluto: «Una frase ben detta dall’attore vale più di una frase, anche se è ben letta, dallo spettatore». Il sonoro è un mezzo di registrazione più completa: ci permette di sentire «il canto di certi magnifici artisti» e, soprattutto nei film documentari, presenta, oltre all’immagine, anche «le voci e rumori di paesi lontani». I mezzi dell’attore sono arricchiti, il suo lavoro è facilitato: gli interpreti manifestano una «personalità più spiccata» e una «mimica più economica». Data l’età degli studenti, non tutti si sentono in grado di giudicare il muto: «Ne conservo pochi e vaghi ricordi» – «non ricordo nessun film muto». Ci troviamo di fronte a una generazione che, frequentando le sale solo da circa dieci anni, quasi non discute più il sonoro; al massimo, si sforza di giustificarlo. Una certa prevalenza dell’argomento più debole in favore del sonoro si spiega anch’essa con la giovinezza di chi lo cita: i giovani sono incantati dall’idea del «progresso» senza indagare troppo quale ne sia la portata. Infatti, chiamare «antistorica» la preferenza data al muto, è un punto di vista mai ammesso nel campo dell’arte, dove si equivalgono le opere di tutte le epoche. Altrettanto male regge l’analogia con la tecnica («significherebbe usare la candela invece della luce elettrica»), perché anche se il sonoro rappresenta un importante perfezionamento della registrazione documentaria, abbracciando come fa un maggior numero di dati reali, non è, con questo, deciso ancor niente sul valore artistico dell’innovazione. È molto più seria l’affermazione che il sonoro abbia messo a disposizione del regista «un nuovo mezzo espressivo», anche se non tutti siano disposti ad ammettere che esso «non disturba minimamente l’immagine». Molti anzi si lamentano dell’irrigidimento subito dalla scena visiva: «Dopo l’introduzione del sonoro, il cinema, invece di diventare sonoro, è diventato più o meno teatro» – «Occorre che la musica e il suono non invadano il primo piano, perché il cinema è e rimarrà sempre arte visiva» – «Si constata una sorta di contaminazione fra il cinema, che non è parola, e il teatro, che è, quasi esclusivamente, parola» – «Dialogo scarno: azione, azione, azione!». Abbiamo detto che la maggior parte dei giovani studenti non vede la possibilità di discutere il parlato come principio, e perciò le obiezioni qui citate non si dirigono contro il nuovo mezzo in sé, bensì contro il suo uso attuale. È «questione di misura». Tuttavia non mancano quelli che vi sospettano un problema più fondamentale. Dà a pensare il fatto che «l’arte di alcuni grandi artisti, per esempio quella di Keaton, è stata distrutta dal parlato». Per questa ragione, alcuni non esitano a dare la preferenza al muto: «Certi gesti di Charlot e della Garbo valgono qualunque battuta». I capolavori del cinema appartengono all’epoca pre-sonora; ma potrebbe tuttavia darsi che la colpa non sia unicamente della parola parlata: «La sempre più perfetta organizzazione industriale tende a fare del film un prodotto soprattutto commerciale, anonimo, o che al massimo reca l’impronta della casa editrice. Questa eleva il tono medio della produzione, ma non permette più a personalità potenti di esprimere liberamente il proprio mondo poetico. E le opere vitali sono più rare che mai». Un’osservazione che tocca le radici del problema estetico: «Il suono mi impedisce di gustare gesto e fotografia»; e due risposte alle affermazioni di quelli secondo i quali una maggiore completezza dei mezzi tecnici porta ad una forma artistica più elevata: «Un vero capolavoro resta tale anche se gli è tolta la favella» – «Ogni forma d’arte in sé e completa, e quindi un muto non è da meno di un parlato». Ma c’è anche un argomento più specifico: la mancanza del dialogo; l’incompletezza del fenomeno dava alle ombre sullo schermo qualcosa di misterioso e di irreale 224 225 che affascinava e lasciava maggior spazio alla fantasia dello spettatore: «Preferisco il muto perché io potevo dare ai personaggi le mie parole» – «Il muto mi faceva sognare, il parlato mi avvicina di più alla realtà; preferisco sognare però». Il che tornerebbe a dire che le creazioni del cinema muto erano più vicine a quella sfera irreale dove si muovono i fantasmi leggeri e puri dell’arte. Un mondo più colorato «Cinema», 34, 25 novembre 1937, p. 337 Tutti coloro i quali, avendo letto o viaggiato poco, non sapevano che il Broadway di New York era chiamato la Grande Strada Bianca, perché risplendeva ogni sera in un puro bianco, non potevano apprendere questo fatto neanche dai film, sebbene fosse visibile quasi ogni sera anche nel cielo delle stelle cinematografiche. Giacché il film in bianco e nero, non solo non rende i colori, ma nemmeno il bianco e nero. Le arti grafiche non scelgono dalla tavolozza variopinta della realtà le due tinte della massima chiarezza e della più profonda oscurità per servirsi unicamente di esse. Il nero di un fiocco di velluto, il bianco di una camicia accanto a pelle rosea, a vino rosso, a foglie verdi – che in questi giorni abbiamo potuto ammirare in un Bacco del Caravaggio – è un’estrema raffinatezza della pittura. Di questo nero e di questo bianco non c’è segno nelle arti grafiche: esse non si limitano all’uso di poche tinte, ma le trascurano del tutto ed esprimono i loro soggetti col solo chiaroscuro. Perciò anche le bianche scritte luminose di Broadway non conservavano, sullo schermo cinematografico, niente della loro monotonia elettrica, che avrebbe potuto staccarsi in modo istruttivo dai colori floridi di un mondo più reale. Pure apparendo bianche e nere, potevano essere, nella realtà, colorate. Il film a colori ci darà questa sensazione di cui il bianco e nero non è stato capace? Quante volte una persona che fino a quel momento conoscevamo soltanto sullo schermo, dopo averla veduta per la prima volta in carne ed ossa c’è sembrata rosea, piccola, corporea, in modo stupefacente e deludente! Ci spaventerà, al contrario, Broadway, per la sua pallidezza rivelatrice? Già è annunciata la sua apparizione in un grande film di rivista: già un gruppo di operatori della Technicolor si è stabilito all’angolo della Quarantaduesima strada... no, non lo vedremo. Perché è pure annunciato che nello stesso tempo in cui lo schermo cinematografico acquisterà il colore lo acquisteranno anche le scritte di Broadway. I produttori di quel film vorrebbero far intendere che questo succede soprattutto a beneficio loro, e ai loro ordini, ma noi vi constatiamo un altro rapporto casuale. 226 È tipico come alcune merci non vengano raccomandate al cliente in maniera discreta e soltanto per il loro valore, ma assalendolo con mezzi violenti, quasi fosse una fortezza. Questi assalti debbono essere sempre originali e sempre più veementi perché la qualità e la quantità del loro effetto svaniscono più velocemente di quelle di una cosa di concreto valore. Ora, il pallido lampeggiare sulle facciate e le trombe degli altoparlanti cominciano a lasciarci più indifferenti: sembra che i nostri nervi divengano ottusi di fronte al chiasso delle offerte. Ecco: entra in scena il colore. Mezzi d’espressione artistica più ricchi? Maggiore autenticità documentaria? Il confronto fra il viale pubblicitario e lo schermo potrà impedire illusioni nocive. Che cosa vedremo sulle facciate? Dipinti di una fauna e flora esotiche; pesci verdi e blu si muovono in un mare azzurro cromo; cascate di noccioline bionde fluiscono da una cornucopia; una stella aurea brilla accanto ad una bottiglia di champagne; e un artista virtuoso fa volteggiare turbinosamente tre anelli sui quali sono scritte le tre qualità principali di una marca di birra. Ci sono ben note le immagini di questo genere, ma non sarà tanto facile stabilire in quale punto di quel film a colori di Broadway, finisca la pubblicità e in quale cominci l’arte cinematografica. Broadway chiama il colore uno stimolante; il produttore cinematografico lo chiama arte. I confronti, ogni tanto, sono istruttivi. Ma che cos’è questo cinema? II. Bisogna seguire il gusto delle masse? «Cinema», 34, 25 novembre 1937, pp. 345-346 Fra la massa ingente delle risposte pervenuteci in seguito al nostro concorso “Ma che cos’è questo cinema?”, abbiamo pubblicato nel numero scorso le risposte alla domanda: «Sonoro o muto?». Queste risposte sono state scelte fra quelle degli studenti e degli operai; esse sono state particolarmente interessanti perché hanno permesso di vedere come non solo il gusto del cinema sia diffuso in tutte le classi, ma come la forma sua più recente, il parlato, sia quella che ha incontrato maggiormente il gusto del pubblico, perché è veramente completa. La quantità delle risposte è tale che non ci è possibile di dare un quadro completo per ogni domanda fatta, utilizzando tutte le risposte pervenuteci. Questa volta perciò abbiamo scelto alcune risposte alla terza domanda del concorso (Vi sembra che i produttori cinematografici debbano adattare i loro film al gusto attuale delle masse, oppure, secondo voi, il criterio ispiratore della produzione dovrebbe essere un altro?) prendendo due altre categorie: gli artisti ed i professionisti. 227 Prima di parlare di “massa” bisognerebbe sapere se esiste veramente una massa. Per alcuni non c’è: si tratta piuttosto di pubblici, con gusti e tendenze molto diverse, che si trovano mischiati nel modo più eteroclito. Il pubblico del cinema è infatti il più vario che si possa immaginare: dal bambino al vecchio, dal semplice operaio al dotto, dalla umile bottegaia alla dama dell’aristocrazia. Ogni età, ogni professione, ogni condizione sociale dà il suo apporto a quella “massa” che frequenta il cinematografo. Ne consegue che i gusti non possono essere identici; lo vediamo da quello che ci rispondono i nostri lettori. C’è chi vuole «solo film commerciali» come ci dice un giovanissimo “aspirante regista”, che ha già evidentemente il senso degli affari sviluppato prima di incominciare; «ispirarsi al gusto delle masse» è per un altro «la via giusta»; c’è persino un lettore che ritiene questo il «dovere estremo di ogni produttore». Ma c’è chi è di parer contrario, e che sostiene che «l’artista deve sempre imporre il suo gusto al pubblico», creando dei lavori «eminentemente artistici» senza curarsi dei gusti dominanti o «dei fattori economici». Preferiamo forse giudizi meno categorici; esigenze commerciali, dalla considerazione delle quali non si può prescindere nel caso del cinematografo che è una industria, consigliano di adattarsi «al gusto delle masse perché i film sono per esse», senza indulgere troppo su certi aspetti educativamente in realtà piuttosto dannosi (film polizieschi per esempio), correggendo contemporaneamente il gusto «nobilitandolo piano piano senza darne l’impressione». C’è chi persino propone delle cifre: «cinquanta per cento, film commerciali per le masse; venti per cento, per l’elevazione delle medesime; il restante a disposizione... dell’intelligenza dei produttori», ai quali giriamo la proposta. Tirando le somme si torna alla eterna questione del film come arte e come strumento d’educazione, oltre che di divertimento. «Se ciò che è arte è prodotto dello spirito è naturale che certi periodi storici diano dei capolavori (in letteratura, pittura ecc.) che sono l’espressione viva del movimento spirituale di un popolo in quel periodo. Anche i film devono avere questa caratteristica (criterio ispiratore); un popolo in essi vi deve trovare realizzate le sue aspirazioni più nobili ed elevate: politiche, militari, morali ecc. Il cinema allora diventa anche uno strumento mirabile di formazione della coscienza nazionale». Benissimo ma... con giudizio. Il film a tesi rischia più d’ogni altro genere di cadere nel ridicolo e di sortire l’effetto completamente opposto a quello che si vuole ottenere. In questo caso soprattutto è necessario che il regista sia essenzialmente «“un artista” il quale deve creare qualcosa di nuovo che possa influire, anche poco alla volta, sul gusto delle masse, così come hanno fatto scrittori, poeti, musicisti, pittori d’ogni tempo». Egli insomma «dovrebbe avere in ogni film qualcosa da dire». Dunque condizione essenziale è che il film sia diretto da un vero artista, tanto quello commerciale di medio calibro ma di ottima fattura, come il “fuori classe” ispirato a puri criteri artistici. «La massa degli spettatori va ancora educata» ed è appunto con una produzione varia, Nel Tibet sono del parere che per indurre un romanziere a recarsi nei paesi da lui inventati bisogna rapirlo con la forza, rivoltella in mano. Forse non hanno torto. Almeno nel caso di Sangri-la, paese fantastico presentatoci dal film Orizzonte perduto, questa misura preventiva non sembra del tutto superflua. È vero che si tratta di un paese molto simpatico: lì tutto si fa con moderazione, perfino le lezioni scolastiche e con la sola 228 229 cercando di diminuire sempre più i film «correnti» che piacciono al pubblico «piccolo borghese che fa esclusivamente il tifo per i divi» in qualunque condizione lavorino ed applaude soltanto al sensazionale, che si può farlo. Del resto «già molti film buoni od eccellenti per la loro concezione artistica hanno dimostrato di avere anche un valore commerciale». Sarebbe lungo citare. «I produttori di film, tenendo sempre più alto il livello della loro produzione, dopo un certo tempo si accorgerebbero che si può guidare il pubblico ad avere gusti più raffinati ed equilibrati insieme». Così intesa la questione diventa più complessa; i produttori dovrebbero essere oltre che degli industriali e degli artisti, dei “medici-psicologi” con un altissimo compito: quello di «creare il gusto» e di «guidare la massa, non di asservirsi ad essa». È chiaro che così il produttore viene ad avere una vera e propria missione sociale, di cui forse non sempre può sentirsi all’altezza. In questo caso basterebbe che ogni tanto, fra commedie comico-sentimentali e drammi da far rabbrividire, si ricordasse che esistono degli «strati di umanità più evoluti» e dedicasse qualche cosa della sua produzione «a quella aristocrazia della mente e dello spirito» che forma in parte la classe dirigente di una nazione. È per questo che in conclusione si può dire, tornando a quanto esponemmo in principio, che «un gusto attuale delle masse categoricamente definibile non esiste» e che vi sono vari strati di pubblico con gusti e cultura diversi e che bisogna tentare di portare il gusto delle classi meno evolute verso quello delle classi più colte. Qui sorge un’altra domanda: queste “classi colte” vanno al cinematografo per aumentare il loro patrimonio intellettuale, o per lo meno per restare nel loro ambiente spirituale, oppure per evadere e mettersi a contatto con altre idee e soprattutto con un’altra vita, anche se si svolge su un piano molto diverso ed in un certo senso inferiore? C’è molto da dire anche su questo punto, ma allora saremmo noi ad… evadere dai limiti della terza domanda del nostro concorso e perciò rimandiamo la trattazione dell’argomento ad un’altra occasione. Orizzonte perduto «Cinema», 34, 25 novembre 1937, p. 34 eccezione dell’alcolismo; la tubercolosi si guarisce col latte caldo; basta entrare nella camera di una signorina affatto estranea per sentirsi dire: «Sedete, il tè sarà pronto subito!»; i bambini cantano, in lingua tibetana, delle canzoni di Brahms; nei laghi solitari, le ninfe nuotano a crawl, e gli unici custodi della decenza sono gli scoiattoli. Cose molto belle, e perciò può sembrare sorprendente che tuttavia guardiamo questo paradiso con un sorriso di riserva e con un po’ di disagio. Per comprendere il perché, basta sapere che a Sangri-la non c’è tempo brutto: le alte vette delle montagne tengono lontane ogni tempesta, ogni pioggia. Basta questa eterna serenità per farci pensare che la cosa non ci riguarda, giacché senza le violenze degli elementi non possiamo e non vogliamo vivere. Sono appunto esse a cui dobbiamo buona parte della nostra robustezza e della gioconda consapevolezza della nostra forza. Altrettanto sereni sono i cuori degli abitanti di Sangri-la: anch’essi sono fortificati contro le violenze degli elementi, ossia delle passioni e degli istinti umani. Ora, abbiamo tutti la nostalgia dei paradisi utopistici, ma non accettiamo l’equilibrio ideale se dobbiamo sacrificare a un culto di dolce moderazione le energie vitali della nostra esistenza. Questa specie di buddismo malinteso, interpretato dagli americani come un regime dietetico da sanatorio, non è fatto per noi. «Vorrei che tutti gli uomini venissero quassù...! – Allora questa terra cesserebbe di essere il paradiso!». Ecco il punto grave. Un nostro paradiso non dovrebbe trascurare il fatto che siamo uomini: dovrebbe liberarci soltanto degli ostacoli inutili provvedendo che gli istinti antisociali non possano diventar nocivi alla vita comune. Quando il giovane, arrabbiato dalla troppa pace, si mise a sparare disperatamente, ero curiosissimo di sapere che cosa sarebbe successo: era questa la prova per il valore del sistema! Invece tolleravano che un forestiero, con un pugno non tanto moderato contro il mento, calmasse il malfattore, il quale poco dopo se ne andò dal paese. Ecco l’essenziale differenza fra Sangri-la e, poniamo, l’Utopia di Sir Thomas More: l’Utopia ci presenta un serio tentativo di risolvere i problemi della vita sociale. Sangri-la è come uno di quei posti balneari calmi, molto piacevoli, che però dopo quattro settimane ci rendono inquieti perché sono sospese le attività umane. E ce ne andiamo. (Forse non è inutile ricordare l’utopia molto più modesta ma tanto più impegnativa per noi, presentata da King Vidor in Nostro pane quotidiano). Ma c’è ancora un fatto di tutt’altro genere che menoma la nostra indulgenza. Il soggetto di questo film ha avuto una trattazione del tutto descrittiva e quindi statica, mentre il cinema è azione. Frank Capra e il suo scenarista Robert Riskin hanno sfruttato le capacità affascinanti dell’immagine animata soltanto nelle sequenze negative, che si svolgono all’infuori della valle pacifica: sono seducenti le scene della guerra cinese, incise con scarse macchie di luce nello sfondo nero, e il violento dinamismo delle bufere e delle valanghe, scene in cui trionfano le capacità narrative del Capra, tanto suggestive per le masse. Ma nella parte centrale del film tutto si risolve in dialoghi lunghi e in panoramiche idil- liche, dato che si è evitata la discussione fra le tempeste della vita reale e le norme dello Stato utopistico. Scansando il nocciolo del problema, si è perduta anche la drammaticità, ossia, detto in termini cinematografici, il movimento. Non basta. Nei film di ambiente quotidiano – Accadde una notte, È arrivata la felicità – è meno sensibile la necessità di creare un mondo artistico personale. Ma nei film fiabeschi non se ne può far a meno. I Nibelunghi non erano un capolavoro: ma il manierismo di Fritz Lang ci assorbiva tuttavia in una atmosfera speciale, realizzata rigidamente in ogni dettaglio della recitazione e della scenografia. In Orizzonte perduto, al posto di una visione omogenea, abbiamo l’urto di convenzionali elementi disparati: architettura novecentesca, le oleografie delle ciliegie in fiore, delle candele, dei bei vecchi, la commedia teatrale dei caratteristi buffi e il realismo documentario dei tibetani in pelliccia e delle montagne – ognuno messo in scena col mestiere perfetto e pulito dei tecnici americani. Perché invece ci troviamo un po’ rimossi dalla nostra terra, guardando il viso del protagonista Ronald Colman e perché in esso vediamo realizzato qualcosa di uno stato più perfetto dell’umanità? La ragione è che con questo viso ci incanta una personalità d’artista e perché vi indoviniamo i forti sentimenti di una vita vissuta, dominati e armonizzati dall’intelletto – su un livello spirituale, senza il quale non ci piacciono neanche le cose piacevoli. 230 231 Una signora mai vista «Cinema», 37, 10 gennaio 1938, p. 14 Vedo continuamente sullo schermo una signora che non ho mai incontrato in vita mia. Si tratta di una donna fra i quaranta e i cinquanta, un po’ grassa, troppo elegante; si affacciano sul suo viso poche tracce di una bellezza passata. Questa signora entra nelle stanze simile a una tempesta: come gli aeroplani per atterrare hanno bisogno di uno spazio piuttosto esteso, così anche a lei occorrono appartamenti dalla prospettiva profonda. Accorre, dunque, a passi veloci e con le braccia aperte, che minacciano di avviluppare tutti i presenti. Ciò infatti succede. I malcapitati sopportano l’abbraccio con disperazione, guardano la signora con occhi freddi e scambiano fra loro sguardi di insopportabile fastidio. Ma lei non si accorge di niente. Si butta subito in una poltrona, strappa dalla borsa uno specchio e un rossetto, e comincia a maltrattare il proprio viso con inspiegabile fretta e crudeltà. Poi, rivolge uno sguardo panoramico, sfacciato, ai quadri attaccati alle quattro mura del salotto (o della camera da letto), tira fuori una Assistendo alla stupenda interpretazione che Bonita Granville, la bambina cattiva, ci offre in These Three (La calunnia), si può constatare come gli effetti più immediati e violenti sul pubblico nascano proprio da quei pochi momenti in cui la giovane attrice, diretta da un regista mediocre, cade in atteggiamenti schematici e teatrali. Quando, nascosta in un angolo, la bambina spia ciò che accade, o, carezzando la nonna con simulazione evidente, finge la tenerezza, oppure, con un sorriso crudele osserva le convulsioni della sua vittima, si vedono passare attraverso la platea ondate di emozione. Ma sono invece i momenti in cui bruscamente il fascino ci abbandona e sorge la disincantante impressione di trovarci di fronte alla finzione. Così pure l’ilarità universale scatenata da un film come Three Smart Girls (Tre ragazze in gamba), si spiega col fatto che in un tal film non c’è personaggio, atteggiamento o avvenimento che possa esistere in realtà. La ragione del favore che Deanna Durbin trova nel grande pubblico è tutta lì: nel caso del film, quasi non c’è attimo in cui essa – caso analogo a quello di Shirley Temple – si comporti come una ragazza immaginabile nella realtà. La nostra affermazione potrebbe forse sembrare paradossale, ma non è. Quanto meno complesso è un fenomeno psicologico, tanto più facilmen- te si può capirlo; e quanto più semplice appare un gesto, tanto maggiore risulta il suo effetto. Basta tendere rapidamente il pugno verso il viso di una persona per vederla chiudere gli occhi in una reazione automatica. Altrettanto automatiche sono le reazioni del pubblico alle impressioni semplici. Servendosi freddamente di certi gesti schematici, o timbri della voce, o espressioni del viso – che si imparano alla scuola elementare della recitazione – si è non soltanto compresi immediatamente, ma si provocano pure delle emozioni profonde e sincere. Si tratta di reazioni biologiche molto primitive e perciò sicure. In un certo senso, non c’è ricetta migliore per raggiungere un largo successo che la recitazione, diciamo, filodrammatica. Lo stesso vale per la creazione del personaggio. Quanto più esso si avvicina a un tipo schematico, quanto più è “concetto diventato carne e ossa”, tanto più grande ne sarà l’efficacia sulla moltitudine. Il conte ubriacone al cento per cento, la donna “fatale” e soltanto fatale, la bambina che mostra una ingenuità fabbricata in serra, sarà capita e apprezzata di colpo, con la stessa facilità con cui una parola stampata ci trasmette automaticamente il proprio significato. Così anche le situazioni più spinte danno il rendimento più sicuro: il poliziotto che procura una panchina alla coppia d’amore che non sa dove sedere, le tre giovinette che gridando: “papà, papà!” mettono in imbarazzo l’anziano adoratore di signorine eleganti; situazioni puramente astratte e fittizie ma di una espressività così immediata e rettilinea che assoggettano i cuori dei semplici. Non è quindi un fatto paradossale che le cose più lontane dalla spontaneità della vita producano il maggior effetto: esse sono poco naturali nel senso che effettuano in forma estrema le basi della mimica, della fisiognomica e del destino umano sulle quali si costruisce la vita. E non soltanto sono gli elementi della vita, ma anche quelli dell’arte. Ma se è così, perché allora essi non accontentano pure il gusto meno modesto? La ragione è che un cifrario che provoca automaticamente determinati effetti, rimarrà sempre lontano dall’arte. Artisticamente, un’espressione che diventa formula non rende più. Soltanto una rappresentazione personale e originale, fresca perché colta direttamente dalla vita, ci dà l’opera d’arte. L’artista si serve degli elementi di cui sopra per arrivare ad effetti puri e profondi; ma invece di applicarli schematicamente li fa trasparire attraverso una descrizione ricca delle tante piccole spontaneità individuali e casuali della vita reale (basta ricordare qualcuna delle scene più indovinate di Katharine Hepburn), oppure ne crea forme astratte, stilizzate, forse culturali, ma di impronta così nuova e significativa da scoprirvi senz’altro un equivalente della naturalezza: vedi il modo di camminare di Charlot, affatto irreale, molto vicino a certi tipi elementari (e quindi comprensibili) di movimenti buffi, ma tuttavia originalissimo. (Nei vecchi film comici, si vedeva spesso anche la parodia della recitazione semplicista. Uno dei mezzi mimici più avvincenti del grassone Fatty era il suo modo di esprimere l’imbarazzo davanti alla ragazza amata. Egli metteva il dito in bocca, si torceva come un verme all’amo, strofina- 232 233 sigaretta, la accende con ansiosa avidità, come se corresse il rischio di soffocare respirando aria pura invece che fumo. La signora è il tipo di attore più “parlato” che il cinema abbia saputo creare: parla dal momento del suo ingresso, fino a quello del suo svenimento, ciò che fortunatamente succede presto, ma purtroppo non dura lungo tempo. Parla senza prendere fiato. Le sue azioni sono sonorizzate al cento per cento. Più che di dialogo si tratta del rumore del suo motore vitale. Tacere, per lei significa, appunto, svenire o, peggio, morire. Tacciono invece gli altri. Perché la signora, col proprio passato, rovina il presente delle signorine e dei giovanotti. È lei che fa scappare i fidanzati per bene, che separa i promessi sposi e che accetta gli assegni, respinti con disprezzo dalla giovane bionda, bella ma povera. Ma è anche lei che, con fazzoletto impregnato da un profumo troppo dolce, sa magnificamente asciugare le lacrime versate per colpa sua. Ripeto che questa signora, nella mia pratica quotidiana, non mi è mai capitata. Perciò ho il sospetto che sia stata semplicemente inventata dagli scenaristi, che hanno bisogno della sua rapida lingua per complicare la vicenda nel primo tempo, e del suo odoroso fazzoletto per sistemarla nel secondo. Il cifrario del successo «Cinema», 38, 25 gennaio 1938, p. 44 va il corpo al muro, faceva arrampicare le mani allo stipite della porta, imitava in forma esageratissima, il comportamento delle “ingenue” di operetta). La risonanza internazionale del cinema americano si spiega in buona parte col fatto che esso, in tutti i suoi elementi, rimane sempre assai legato a questi schemi basilari. Mentre per esempio certi film tedeschi, che rendono con maggiore sensibilità l’atmosfera di ambienti e di personaggi, staccandosi dal canone dei tipi e delle convenzioni tradizionali, provocano reazioni piuttosto deboli. Appunto per questo, il produttore americano prevede già nello scenario una buona quantità di situazioni “sperimentate” che pur ripetendosi in maniera monotona producono con certezza matematica quella risata, quel brivido, quella commozione, e tiene conto anche nella rappresentazione dei personaggi e nella loro interpretazione di quel cifrario, la cui comprensione ci è innata e il cui effetto si può prestabilire come la reazione chimica di una determinata combinazione di materie. Con questo non si vuol negare che una dose di genuina spontaneità artistica non sia dal produttore accettata volentieri per evitare che dall’applicazione degli schemi risulti quella arida monotonia che distingue le produzioni meno raffinate. Senonché l’arte è un’altra cosa. Nell’arte, la vita ricondotta alle sue radici rimane pur vita, e l’espressione semplice e universale vien sempre animata dall’ispirazione che si coglie dal mondo reale. I due campi in cui si divide oggi il mondo del cinema, hanno trovato finora una loro manifestazione concreta anche in una differenza puramente tecnica. I film che si producono per l’ordinazione di commercianti secondo principi industriali, e che sono rappresentati da commercianti alla massa del pubblico, pronto a pagare per il suo divertimento, vengono ripresi e proiettati su un nastro di pellicola largo 35 mm, che è il formato normale introdotto da Edison. Il dilettante, invece, il quale adopera l’apparecchio cinematografico per il piacere dell’immagine animata; il seguace dell’arte cinematografica, che proietta in famiglia copie di vecchi film a soggetto; lo scienziato che si serve della “camera” per fissare azioni in movimento a scopo di ricerca e di didattica, e infine il professore che utilizza il film per la cosiddetta educazione visiva – tutti costoro lavorano con un nastro di pellicola più stretto, a formato ridotto. I rapporti fra questi due campi, fino ad oggi si sono sempre trascurati, mentre invece potrebbero e dovrebbero essere più stretti. Un ostacolo, pu- ramente tecnico, sta appunto negli inconvenienti pratici che derivano dalla differenza dei formati. Per l’amatore, le pellicole e le macchine da presa e da proiezione del formato normale, sono troppo care, e d’altra parte le pellicole a formato ridotto prodotte dall’amatore stesso non potrebbero essere proiettate nelle comuni sale cinematografiche, che hanno un’attrezzatura adatta solo per il formato normale. In più, l’amatore che volesse proiettare in famiglia le pellicole dei comuni programmi cinematografici, è ostacolato dal fatto che il suo proiettore è limitato al formato ridotto. L’amatore si lamenta di questi ostacoli, che il commerciante cinematografico ritiene in un certo senso provvidenziali, in quanto eliminano la possibilità della concorrenza dei film non industriali nelle sale pubbliche. Non solo, ma evitano inoltre il danno che l’esercente potrebbe avere se diventasse possibile proiettare nelle famiglie private i film commerciali in corso di programmazione. È quindi evidente come alcuni potenti gruppi economici siano direttamente interessati a non voler gettare il ponte fra questi due campi del cinema. Fortunatamente, la situazione si presenta al commerciante anche sotto un altro aspetto. Egli desidera, è vero, evitare ogni concorrenza da parte dei “ridottisti”, ma d’altra parte non può ignorare i vantaggi che il formato ridotto potrebbe offrire a lui stesso. In prima linea è da considerarsi il notevole risparmio che risulterebbe dall’uso di pellicole più strette e più corte e da macchine più piccole. Ma poi, la macchina da presa a passo ridotto rappresenterebbe anche per l’operatore professionale lo strumento ideale per tutte le occasioni in cui si tratta di viaggiare con le macchine, di entrare di nascosto, di fare ascensioni, di lavorare velocemente e senza grande preparazione, di contentarsi di uno spazio ristretto e così via. Questo vale soprattutto per le prese di attualità e per i film documentari, ma pure per certi tipi di scene dei film a soggetto. Ora è vero che ci sono le “camere a mano” del formato normale, ma queste macchine finora non hanno saputo soddisfare al loro compito di essere leggere e maneggiabili e allo stesso tempo solide, capaci. Secondo le indicazioni, fatte a suo tempo, da Hans Pander nella «Filmtechnik», una capacità di 25-30 metri di pellicola e un motore a molla che trasporti non più di 16 metri, non bastano per le inquadrature “lunghe” richieste oggi dal cinema sonoro; bastano appena per quello muto. Se, d’altra parte, si costruiscono modelli di una capacità di 60-120 metri, allora si arriva a tipi pesanti e ingombranti. L’unica via di uscita è offerta dalla macchina 16 mm. Ma anche per l’esercizio, il formato ridotto può avere i suoi pregi. Poco fa, il noto industriale francese André Debrie ha messo in rilievo il fatto che in Francia esistono 2.000 comuni di più di 1.500 abitanti che non dispongono ancora di una sala cinematografica perché la spesa dell’impianto sarebbe troppo alta. Il Debrie perciò propone di creare per questi luoghi «il cinema da trecento posti» munito di proiettore sonoro 16 mm e rende noto che egli già attualmente dirige la sua produzione di macchine in questo senso. Secondo lui, con una macchina di questo genere si può proiettare per un’ora intera senza interruzione, e la pellicola di sicurezza, ininfiammabile, rende superflue le cabine costruite secondo le prescrizioni della legge. «La 234 235 Il formato ridotto diventerà formato normale? «Cinema», 42, 25 marzo 1938, pp. 190-191 differenza fra i film normali e quelli a formato ridotto deve scomparire; tutti i film nuovi si debbono stampare simultaneamente anche a formato ridotto». Il formato ridotto non sarebbe un concorrente, ma un complemento indispensabile. In altri paesi, naturalmente, ci troviamo di fronte a una situazione analoga; per l’Italia basta rileggere l’articolo del Marchese Paulucci di Calboli sul numero 25 di «Cinema» per trovare l’identica soluzione proposta per i 4.000 comuni italiani ancora sprovvisti di sale e inoltre per le sale che hanno ancora l’impianto muto. Le difficoltà puramente tecniche si potrebbero ormai considerare superate. Volendo utilizzare pellicole a formato ridotto per la proiezione nelle sale comuni, basta trarne delle copie a formato normale a mezzo della stampatrice ottica (la quale, come l’ingranditore fotografico, dispone di un sistema ottico fra negativo e positivo). Queste copie attualmente non sono più inferiori a quelle dei film ripresi su formato normale. Infatti, nelle copie del film tedesco sulla spedizione del Nanga-Parbat, fatte interamente su formato ridotto, e in quelle del film di Walter Mittelholzer sull’Abissinia, nessuno è riuscito a trovare quelle deficienze che, secondo l’opinione di certi tecnici conservatori, dovevano rivelare nella proiezione in sala normale. Ma la relazione di Debrie permette anche la supposizione che, nell’avvenire, forse non ci si contenterà di stampare su formato normale le pellicole “ridotte” ma che invece, in un certo momento, la proiezione passerà al formato ridotto: quello che oggi è possibile nella sala da 300 posti, sarà impossibile domani nella sala grande? Rimane da aggiungere che il commerciante cinematografico non è poi disinteressato nel cinema a formato ridotto come tale. Una grande industria infatti vive della produzione e della elaborazione delle pellicole a formato ridotto e dalla fabbricazione delle relative macchine da presa e da proiezione. Per i bisogni delle proiezioni in famiglia si è formato uno speciale servizio di noleggio. E il numero dei cineamatori cresce di anno in anno. Verrà il momento in cui i film degli amatori faranno il loro ingresso nella sala cinematografica e in cui si proietteranno a casa le produzioni dell’industria cinematografica? L’industria e il commercio cinematografici avrebbero la potenza di impedirlo anche se l’ostacolo tecnico della differenza dei formati fosse superato. Ma si intende che un progresso di questo genere indebolirebbe la loro forza di resistenza e chi sa se alla lunga una tale resistenza sembrerebbe loro ancora opportuna. Tutti coloro che desidererebbero trovare sullo schermo rappresentazioni sincere e fresche della nostra vita, avrebbero motivo di rallegrarsi per una tale evoluzione. Attualmente, l’industria cinematografica ha raggiunto, con perfetti mezzi tecnici e organizzativi, un prodotto talmente sterile perché lontano dalla vita reale che le occasionali iniezioni di sangue fresco servono sempre di meno. Quello che da lungo tempo non è approvato dai fautori dell’arte e della verità, perde man mano il suo fascino attrattivo pure per il grande pubblico. Già si verificano sintomi strani: è recentissimo un articolo di un uomo che nessuno vorrà chiamare un intellettuale fuori del mondo pratico, ossia di Ernst Lubitsch, in cui il produttore e regista americano indica come esempio alla produzione del suo paese un film francese, in cui si sarebbe ottenuta una affascinante naturalezza e vivacità girando molte scene in ambienti che offrivano le stesse difficoltà degli ambienti “veri”! Infatti ciò che manca di più ai “grandi” film d’oggigiorno è appunto un elemento dilettantesco, ossia l’ispirazione immediata dalla realtà, gli utili ostacoli offerti da quell’ambiente naturale, in cui la vita stessa corregge le immagini di fantasia create dagli uomini del cinema con le loro macchine. La forza del cinema sta appunto in quel che rappresenta la sua più intima debolezza; in quel suo essere vincolato alla realtà; e sono proprio questi vincoli che il regista del film a soggetto, racchiuso fra le quinte del teatro di posa, ha saputo eliminare fino ad un punto da trasformare la sua opera in pura ombra inconsistente. Scritturare nuovi registi e attori, ormai non può più portare la salvezza. La macchina produttrice disgrega le nuove forze prima che si siano potute mettere a lavorare. L’unica cosa che potrebbe arginare questa decadenza sarebbe la concorrenza del dilettante, ossia, come si suol dire in altri campi, dell’artista individuale che crea per la gioia dell’espressione sincera; sarebbe la concorrenza dell’uomo civile che desidererebbe proiettare a casa propria dei film che potrebbero anche non essere dell’ultima stagione e non fatti secondo il canone dell’industria del divertimento. Con questo non si vuol dire che il cinema debba ridursi a una produzione a domicilio e che il pubblico delle sale debba spezzarsi in tanti spettatori singoli. Si vorrebbe dire soltanto che una grande industria irrigidita potrebbe essere utilmente influenzata e rinnovata se apparisse accanto ad essa l’opera di individui per individui, ossia se si ricorresse alla forma attualmente più sicura per qualunque lavoro culturale. 236 237 La loro vita privata «Cinema», 42, 25 marzo 1938, p. 195 La signora era seguita da un alto e magnifico cane lupo nero siberiano, in tutto simile a quello della Metro che ha avuto un ruolo importante in parecchi film e specialmente in quello intitolato Il richiamo della foresta, dove la Garbo si è prodotta con insuperabile successo. (Da un grande quotidiano) Poniamo che qualcuno di noi si ritirasse in una spiaggia solitaria per rimettersi, lontano dai rumori della vita, dal logorio di un lavoro faticoso e dal quotidiano contatto con altri. E poniamo che, appena arrivati, ci si trovasse assediati da un centinaio di persone accorse da tutto il mondo che, con la massima insistenza, tentassero di vederci, di accompagnarci dappertutto, di parlarci ininterrottamente, di strapparci confessioni sui nostri più intimi fatti personali, non soltanto per conoscerli ma per trasmetterli, più o meno falsificati, a tutto il mondo. Come si giudicherebbe il comportamento di queste persone? Bisognerebbe allora sopprimere questo costume pubblicistico, che si manifesta ogni giorno un po’ dappertutto? La cosa non è tanto semplice. Le vittime non sono individui casuali ma persone che per le loro particolari capacità hanno assunto una funzione importante nella società umana. Ed è noto che sempre questa società non si è occupata soltanto dell’opera dei grandi uomini ma anche della loro vita. Per ragioni ovvie: il grande personaggio non è soltanto caratterizzato dalle sue facoltà in un campo speciale, sia dell’arte, della scienza, della politica o altro; ma dal suo modo di andare fino in fondo, di considerare molto impegnativi i compiti della vita e di soddisfarli con una intensità che non conosce compromessi. Basta, per esempio, leggere una buona biografia di Eleonora Duse o anche quella di Marie Curie, pubblicata poco fa, per persuadersi che il valore di queste persone non sta affatto soltanto nel saper recitare o scoprire nuovi elementi della fisica, ma anche in quel capolavoro che è la loro vita privata. L’esempio dato da queste vite rappresenta un tesoro prezioso che l’umanità non può ignorare e non ha mai ignorato, e bisogna ammettere che, in questo senso, sono significativi tutti gli elementi di una tale vita, anche i più intimi, e anche i piccoli costumi d’ogni giorno. C’è poi evidente rapporto fra opera e vita, per cui, per esempio, il lavoro di un artista si può comprendere molto meglio conoscendo il carattere, le opinioni e le intenzioni di colui che lo fa. Ma naturalmente sarebbe ridicolo voler comparare la delicatezza e l’intelligenza di un Johann Peter Eckermann, che ci ha conservato con tutti i dettagli la preziosa vita di Goethe, con le manifestazioni di certo giornalismo attuale, dal tipo americano (di cui, del resto, è responsabile soltanto in parte il giornalista stesso, il quale, una volta preso il suo incarico, è costretto a eseguire gli ordini). Questo giornalismo è uno dei non pochi elementi della vita presente che, con la scusa di servire ai bisogni e ai gusti del grande pubblico, lo corrompono. Indubbiamente esiste una forte curiosità dell’uomo comune per la vita altrui e specialmente per quella dei personaggi di primo piano. La psicologia di questo fenomeno è assai complessa: in parte questa curiosità è la conseguenza del desiderio di voler raggiungere un ideale incarnato appunto in qualche personaggio pubblico, di cui si cerca di sapere tutto per poter imitarlo sempre meglio – tendenza che, se indirizzata bene, è senz’altro di grande valore educativo; ma questa curiosità è anche conseguenza del fatto che l’uomo comune sogna rapporti personali col suo idolo, in termini cinematografici: che lo spettatore, inconsapevolmente, si crede per esempio amato da quella perfetta creatura che egli vede sullo schermo e di cui vorrebbe saper tutto per poter corredare in modo sempre più completo il proprio sogno. (È significativo, a questo proposito, l’episodio di quello squilibrato che si presentò a Ravello pretendendo che Greta Garbo fosse sua moglie). Ecco il motivo del fan mail ossia delle lettere dei “tifosi” e dell’enorme interesse che trova ogni informazione, possibilmente indiscreta, sulla vita di tali persone. Una tendenza psicologica, insomma, che, se sublimata, produce notevoli valori culturali, viene spinta alle sue più sciocche espressioni da un genere pubblicistico di cui l’unica intenzione è quella di attirare, con qualunque mezzo, il più grande numero di lettori. Il comune “divo” cinematografico non è certo da paragonare a quei personaggi secolari di cui si scrivono e si leggono le biografie. È gente semplice, talvolta volgare, da cui non c’è da trarre un grande profitto culturale. Eppure basta leggere certi scritti, dettati o ispirati da essi, per vedere che nei loro costumi e nelle loro opinioni ci sono tanti elementi che possono, modestamente, essere utili a un pubblico che si diverte a conoscerli. Le loro esperienze tratte da un’ardua lotta per la vita, la loro disciplina richiesta da un lavoro snervante, possono certamente fornire al grande pubblico delle letture dignitose e allo stesso tempo piacevoli, se il giornalista si preoccupa di presentare questo materiale con la responsabilità indispensabile alla sua mansione. È un caso analogo a quello della cronaca giudiziaria, la quale, se non decade in cronaca nera, può avere effetti benefici sul lettore che appagando la sua curiosità perfeziona, senza saperlo, la propria sensibilità morale. Bisogna essere signori col pubblico ma anche con gli idoli di esso. Non esiste nessun diritto di disturbare la libera vita altrui. Normalmente, l’“uomo famoso” non è affatto avverso a parlare di se stesso, del proprio lavoro, delle proprie opinioni. Ma se si vede fatto oggetto di stupide domande, se vede deformati i propri giudizi e i fatti più intimi da un basso pettegolezzo, non gli rimane che la difesa e la fuga. Il noto atteggiamento di Greta Garbo, che si vuol chiamare misterioso o ispirato da ragioni pubblicitarie, non è altro che la più naturale reazione di una persona sensibile contro il cattivo gusto delle continue invasioni nella sua vita personale. Lei, come ogni altra persona, probabilmente non avrebbe nessuna difficoltà a parlare ogni tanto di se stessa, magari anche dei suoi vestiti e dei suoi cosmetici, se non fosse spaventatissima da sistemi pubblicistici, che potranno fare minore impressione a persone più robuste. Per rimediare, basterebbe un minimo di riguardo da parte di giornalisti che sapessero avvicinarsi senza diventare ossessionanti e scrivere senza screditare. E va detto a questo proposito che quello che può essere scusabile in un popolo giovane, privo del tradizionale rispetto per i diritti dell’individuo, non avrebbe dovuto certo servire come esempio alla vecchia Europa. Non si vuol negare che esistono molti capaci di conciliare l’abilità del cronista con la dignità del pubblicista. Ma è tuttavia opportunissimo ricordare che i mezzi tecnici di comunicazione e di trasmissione, magnifici perfezionamenti della vita sociale, sono abusati se si arriva al freddo coraggio di girare la manovella mentre, poniamo, un aviatore prima di partire per un volo pericoloso bacia per l’ultima volta la moglie e i bam- 238 239 Le migliori realizzazioni del cinema muto avevano creato un genere di spettacolo, in cui l’espressione era data dall’immagine di proiezione intera. In essa la figura umana era soltanto un elemento fra tanti, più o meno importante. Dopo l’avvento del film sonoro, l’onere della rappresentazione si concentrò in grandissima parte sulle spalle dell’attore, inquantoché era lui che presentava il dialogo. Man mano che il film risultava sempre meno l’opera di un regista creatore, l’interesse si concentrò maggiormente sul contributo dell’interprete. Fu sempre più sentita la necessità di trovare attori capaci di sorreggere uno spettacolo col loro fascino personale. Accanto all’“empirismo” del produttore cinematografico americano, che cerca di risolvere il problema girando intorno al mondo per trovare su qualche teatro di prosa o di varietà la grande scoperta per la stagione ventura, sorse in Europa l’idea della scuola cinematografica, ossia della sistematica produzione di attori. Questo nuovo ramo di pedagogia, nel trovare il suo sistema, incontrò parecchie difficoltà: prima di tutto, perché anche il teatro stava ancora passando dall’addestramento puramente pratico all’istituzione di scuole drammatiche e poteva quindi aiutare soltanto minimamente con le proprie esperienze, ma specialmente perché poco chiare e in continuo cambiamento erano le idee sul carattere e la funzione dell’attore cinematografico. La serietà con cui il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma affronta il delicato compito è documentata dall’ultimo numero della rivista «Bianco e Nero», il quale, su duecento pagine, raccoglie un gruppo di significativi estratti di quanto hanno detto sull’arte della recitazione i più competenti attori, scrittori e filosofi, dal Settecento fino ad oggi. Si intende che dopo aver digerito le opinioni, diversissime fra loro, di una trentina di personalità competenti, al lettore gira un po’ la testa e cerca di tirarne una conclusione – compito che del resto gli vien facilitato dai saggi riassuntivi dei compilatori Luigi Chiarini e Umberto Barbaro. Limitiamoci a dare l’una e l’altra delle osservazioni che ci ha suggerite la lettura dell’interessante volume. Volendo addestrare attori, bisogna sapere su quali capacità, psichiche e fisiche, si basi l’opera dell’attore stesso e quale sia la sua funzione nello spettacolo. Le impressionanti contraddizioni che, sfogliando l’istrut- tiva antologia, incontriamo a questo proposito nel pensiero dei cervelli più acuti, si spiegano, in parte, secondo noi, col fatto che i diversi scrittori, nei diversi secoli, adoperano gli stessi concetti con significati diversi. C’è un abisso, per esempio, fra il significato che assume la parola “imitazione” nelle epoche di alta cultura, in cui è sottintesa senz’altro la trasfigurazione artistica della materia reale, e quella “imitazione” puramente meccanica, che fu possibile nella teoria e nella pratica dell’Ottocento. D’altra parte queste contraddizioni si spiegano anche da una terminologia psicologica troppo rudimentale. Di fronte alla “finzione”, per esempio, creata dallo spettacolo nell’attore (e nello spettatore), tale psicologia primitiva – oggi superata dagli scienziati ma ancora viva nel pensiero comune – non vede che due possibilità estreme: o l’attore crede nella parte che interpreta, o non ci crede. Si ritiene, in conseguenza, di decidersi per l’uno o per l’altro di questi casi estremi, ed ecco che sorgono contrasti, apparenti e superflui. Nel n. 44 di «Cinema», Mario Pannunzio afferma che l’attore, come il bambino che gioca, «crede sempre alle proprie finzioni». Ora ci pare evidente che basta osservare un bambino per persuadersi che esso non crede affatto che quel suo pezzo di legno posto sul coperchio di una scatoletta sia veramente un pollo arrosto su un piatto, ma che esso tuttavia si comporta, con una intensità sbalorditiva, come se ci credesse. Il fenomeno psicologico è quindi molto più complesso, nel caso del bambino come in quello dell’attore. Potrebbe sembrare, questa, una discussione puramente teorica, eppure è su questa base che si scatena la lotta fra due dottrine che conducono a sistemi didattici opposti: l’attore, per interpretare bene la sua parte, deve “vivere” il suo personaggio e cioè identificarsi con esso, oppure deve costruire, con mente fredda, tale personaggio, secondo le regole dell’arte, da osservazioni raccolte nella vita reale? Il razionalista Denis Diderot vorrebbe che l’attore fosse un osservatore freddo e tranquillo della vita reale: «molta penetrazione e nessuna sensibilità». Mentre Stanislawskij, il grande regista russo, afferma che bisogna «lasciarsi prendere completamente dal dramma». S’intende che i consigli del Diderot per la formazione del giovane attore sono contrari a quelli dello Stanislawskij. Ora, è sicuro che, citando un esempio di Dubus-Préville, un attore ubriaco non saprà interpretare la parte di un uomo ubriaco, ma è d’altra parte indiscutibile che l’attore freddo, sia pure bravissimo, non riesce a “prendere” il pubblico. La nostra esperienza di spettatori cinematografici ci insegna che il forte effetto suscitato da una Hepburn o da un Gary Cooper non nasce affatto in primo luogo dalle loro capacità interpretative, ma dalla loro semplice presenza, dal contatto intimo che il loro sguardo animato, l’umanità del loro viso e dei loro gesti, crea fra l’anima dell’attore e l’anima del pubblico. Si tratta di una specie di contagio provocato dall’intensa vitalità, dal caldo e sincero interesse per la sorte umana, espressa nell’immagine dell’attore; ed è soltanto su questa 240 241 bini. E la sosta davanti a certi cancelli chiusi potrebbe essere una buona occasione per riflettere se, in fin dei conti, la troppa spensieratezza e violenza non porti per caso al risultato opposto a quello desiderato. L’attore e le stampelle «Cinema», 46, 25 maggio 1938, pp. 335-337 base che l’attore si può mettere a persuaderci con la sua interpretazione. Altrimenti anche la più raffinata ed intelligente tecnica di recitazione rimarrà inefficace. Stabilito ciò, si tratta di comprendere che da questa forte sostanza vitale scaturisce l’interpretazione con spontanea immediatezza, senza in tal modo rinunciare alla tecnica del lavoro artistico. Combattendo contro la “sensibilità” bisogna prima di tutto tener conto della pericolosa confusione che risulta dal non distinguere le emozioni (dell’amore, della collera, della tristezza) da quell’altra sensibilità che è senso di misura e di proporzione, fiuto per i fatti e motivi più caratteristici ed espressivi ecc. L’attore, come ogni artista, ha bisogno dell’uno e dell’altro. Non può rappresentare l’amore non soltanto senza averlo mai sentito, ma senza sentirlo nel momento dell’interpretazione; senonché la nostra anima non è uno strumento talmente primitivo che sentir l’amore rappresentandolo significhi esserne colmo come alla presenza della donna amata. E la tecnica della rappresentazione deve diventare quasi istintiva per essere utilizzabile: imparando a suonare il violino, si comincia col mettere deliberatamente le dita sulle corde e col muovere nel modo opportuno il braccio che aziona l’arco – e siamo nello stato “freddo” di Diderot – ma un grande violinista, durante il suo concerto, è del tutto ispirato dal brano musicale, di cui egli sente, emozionato, il contenuto: la tecnica è allora, se non del tutto dimenticata, almeno comandata completamente dall’espressione da raggiungersi. Lo stesso avviene facendo una poesia, dipingendo un quadro, interpretando una parte. In questo senso va intesa la ricetta del Riccoboni: «Scordare i quattro membri, e forse il quinto, che è la testa»; e se Eleonora Duse scrive: «Chi pretende insegnare l’arte – non ne capisce proprio nulla», è chiaro che per lei o il “mestiere” era un dono innato oppure cosa talmente secondaria in confronto ai veri e propri compiti artistici che non se ne ricordava nemmeno. Insegnare l’arte! Sono senz’altro preziosi l’insegnamento della dizione basato oggi sui principi scientifici della fonetica, e l’“emancipazione del corpo” dovuta alla ginnastica e alla danza moderna, iniziate da Jacques Dalcroze. Ma esiste un insegnamento anche per la parte artistica? Francesco de Sanctis dichiarandosi contro il «dolore tipo, l’amore tipo, il padre tipo» ecc., va certamente troppo oltre se non ammette altro che manifestazione individuale. È appunto l’elemento tipico nelle emozioni, nei caratteri e nei personaggi, che rende possibile l’arte. Perciò le tradizionali norme riguardanti il miglior modo di esprimere lo sdegno o di rappresentare un re non ci sembrano trascurabili per l’allievo anche se, adoperate sul palcoscenico da un attore che non sa superarle, risultano vuote e ridicole. Ma per il resto crediamo che, nell’insegnamento dell’arte, non troppo si possa basarsi sulle regole e le ricette generali. L’insegnamento più prezioso viene dalle correzioni che il maestro applica al lavoro dell’allievo e che, sebbene non sempre espressamente giustificate da norme generali, servono a sviluppare la sensibilità del novizio. Ma a quale fine bisogna addestrare l’attore cinematografico? Qual è la sua funzione nel film? C’è chi afferma che la parte dell’attore nel film sia molto più importante e creativa che nel teatro: mentre l’attore teatrale non è che interprete della parola poetica, quello cinematografico dovrebbe da solo sostituire o largamente integrare il dialogo e dare vita agli accenni approssimativi fissati nella sceneggiatura. Ci sembra utile affermare a questo proposito che l’attore in sé non è uno strumento abbastanza ricco per creare un’opera d’arte. I mezzi dell’attore sono limitatissimi. Non è affatto vero che «non vi è un solo pensiero che non abbia il suo gesto corrispondente ed il suo tono» (Dubus-Préville); ma essendo il corpo umano un oggetto fisico, può esprimere soltanto quei fatti psichici che corrispondono a dati fisici: la sorpresa si può interpretare spalancando gli occhi perché corrisponde alla reazione di chi apre gli occhi per vedere meglio. Si tratta dei fatti psicologici elementari, la cui espressione mimica può essere data, dal grande attore, nel modo più originale e sviluppata fino a raffinatissime sfumature, ma la portata del mezzo rimane sempre quella. Perciò l’arte dell’attore deve completarsi con un altro mezzo. La soluzione trovata dal teatro è quella di far la mimica interprete di un dialogo. Il grande attore (e il grande regista) teatrale che, nell’istintiva voglia di rendere sovrana e indipendente la propria arte, si serve di commedie scadenti per poter recitare quasi “su canovaccio”, potrà produrre spettacoli commoventi ed originalissimi, ma non darà mai con le sole esibizioni del suo corpo e delle sue intonazioni di voce la sostanza sufficiente per una vera opera d’arte. L’altra soluzione è quella del cinema muto. In esso la recitazione dell’attore era completata dai ricchi valori espressivi dell’azione, del montaggio, dell’inquadratura, dell’illuminazione e via dicendo. Le teorie del Pudovkin saranno superate, ma per una ragione che gli fa onore, e cioè perché è superata l’arte cinematografica. Riducendo l’attore a un elemento passivo da animarsi mediante i mezzi specifici del cinema, Pudowkin traeva l’estrema conseguenza dal fatto che l’attore in sé non è un completo strumento d’arte. Ma il povero attore di film sonoro, come deve fare? A favore dell’azione visiva, il dialogo è ridotto a miseri rudimenti. A favore del dialogo, l’azione visiva è ridotta ad una presentazione di attori davanti a sfondi variabili. Né l’uno né l’altro dei due mezzi è abbastanza sfruttato per poter completare, in maniera sufficiente, la recitazione. Anzi è proprio nell’apparizione dell’attore vivo che fidano i due mezzi per salvare lo spettacolo. Di conseguenza, il cinema sonoro sviluppa un tipo di attore ibrido: dalla recitazione troppo prolissa per saper presentare, sobriamente, un dialogo; dalla mimica troppo limitata a semplice accompagnamento di parole per poter sostenere una scena muta. E siccome non torneremo al cinema muto l’attore troverà terra solida soltanto quando l’immagine animata, trasferita sullo schermo dell’apparecchio di televisione, sarà arrivata alla meta a cui si sta avvicinando: al teatro. 242 243 Il nuovo sistema italiano per la cinematografia a colori naturali* «Cinema», 47, 10 giugno 1938, pp. 370-372 Ogni “problema del giorno”, per cui lo spirito umano si sta faticando di trovare una soluzione definitiva, attira magicamente migliaia di pseudo-inventori, cervelli mediocri che per mancanza di autocritica non ammettono obiezioni e spesso anche disgraziati ossessionati da una monomania patologica. È quindi con la massima riserva che si accoglie sempre l’annuncio di un qualunque sistema cosiddetto a colori naturali, dichiarato tale da provocare con un metodo nuovo un considerevole e forse definitivo progresso. Comunque, essendo la cinematografia a colori già entrata nella fase dell’applicazione pratica su larga base industriale, la necessità di arrivare a una effettiva soluzione diventa sempre più scottante. Oggi siamo quindi doppiamente lieti di poter affermare che il sistema brevettato recentemente dal pittore lombardo Carlo Bocca e dallo scrittore e tecnico veneziano Domenico Rudatis (alpinista di fama internazionale) rappresenta, finché possiamo giudicare noi, un vero e proprio uovo di Colombo. Siamo stati fra i primi ad assistere a una dimostrazione pratica del sistema e ci affrettiamo a darne una prima spiegazione che, meglio di ogni altra affermazione, potrà persuadere dell’importanza di questa invenzione italiana. Due sono le particolarità del sistema Bocca-Rudatis che ci inducono a attribuirgli un valore eccezionale: esso rappresenta un logico e rettilineo sviluppo dei risultati finora ottenuti nel campo del cinema a colori; e la soluzione da esso offerto è inoltre di quella straordinaria semplicità che contraddistingue le trovate autentiche. Per comprendere di che cosa si tratta ricordiamoci che l’immagine colorata sullo schermo si può sostanzialmente ottenere in due modi: 1) il fotogramma della pellicola proiettata è colorato in sé; in questo caso il fotogramma consiste di più strati sovrapposti, di cui ognuno porta una delle immagini parziali, per esempio, nella tricromia, l’immagine gialla, l’immagine rossa e l’immagine blu-verde. È questo il principio dei sistemi sottrattivi. Oppure 2) il fotogramma non è colorato. In che modo ottengono i sistemi additivi una immagine colorata sullo schermo da un fotogramma non colorato? Per semplificare, poniamo che l’immagine colorata si debba comporre da tre specie di punti: punti rossi, punti blu e punti verdi, e immaginiamo di voler riprodurre come soggetto una mela rossa davanti ad uno sfondo verde. Facciamo ora, di questo soggetto, tre fotografie. Una attraverso un filtro rosso, l’altra attraverso filtro blu e la terza attraverso filtro verde. Per semplificare ancora lasciamo da parte l’immagine fatta col filtro blu e esaminiamo le altre due: il filtro rosso lascia passare soltanto luce * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, pp. 376-378. 244 rossa e perciò l’immagine fatta, attraverso di esso, del nostro soggetto mostrerà, invertita o stampata, quella mela come una macchia trasparente su sfondo nero. Proiettata attraverso un simile filtro rosso, questa immagine evidentemente ci darà sullo schermo una macchia rossa su sfondo scuro. Al contrario, l’immagine fotografica ottenuta attraverso il filtro verde ci darà una macchia nera su sfondo trasparente; proiettata attraverso il filtro verde, essa produrrà sullo schermo uno sfondo verde con macchia scura centrale. Dalla sovrapposizione delle immagini risulterà la riproduzione completa e colorata del nostro soggetto. Questo è il principio dei sistemi additivi dimostrato per la prima volta nel 1861 da J. Clerk Maxwell. L’effetto sullo schermo nasce dunque dalla fusione di più immagini di cui ognuna corrisponde a un colore fondamentale. Ora, questa fusione può anche avvenire separatamente per ogni punto dell’immagine. Immaginiamo che davanti a ogni “punto” dell’immagine fotografica si trovino tre minuscoli filtri, uno rosso, uno verde, uno blu. Esaminiamo uno dei punti che si trovano in quella parte dell’immagine che riprodurrà la mela rossa e che perciò durante la presa è colpita da sola luce rossa: è ovvio che questa luce rossa attraverserà soltanto il filtrino rosso e impressionerà quindi l’emulsione soltanto sotto di esso, mentre sotto i filtrini blu e verde l’emulsione rimarrà vergine. Dopo l’inversione chimica della pellicola avremo quindi, come fa vedere il disegno A della figura 2, un “buco” trasparente, dietro al filtro rosso, mentre per il resto l’immagine rimane opaca. Potendo passare la luce soltanto attraverso il filtro rosso, questo “punto” dell’immagine avrà color rosso. Questo principio fu realizzato nel 1904 dai fratelli Lumière nella loro celebre lastra autocroma, la quale rappresenta la prima e finora non superata soluzione pratica della fotografia a colori naturali. (Come “filtri” servivano grani di fecola colorati). Senonché il metodo Lumière non si prestava all’applicazione cinematografica. E fu perciò poco tempo dopo che un altro francese, Rodolphe Berthon, propose una ingegnosa modifica: la pellicola lenticolata, brevettata nel 1909. Il nostro disegno B dimostra schematicamente come nel sistema Berthon, i tre filtri sono sostituiti con una lente cilindrica, impressa con matrice di metallo sul supporto di celluloide della pellicola. È minuscola anch’essa giacché entro lo spazio di un millimetro si trovano impresse circa trenta di queste strisce cilindriche. L’immagine fotografica è situata nel piano focale di queste lenti, e la luce di proiezione che attraversa l’immagine viene quindi, dalla lente, deviata secondo le elementari leggi dell’ottica. Il nostro disegno B dimostra come un raggio che attraversa l’immagine in un determinato punto vien lanciato dalla lente in una determinata direzione, ed è ovvio che se il raggio fosse entrato da un altro punto, sarebbe stato lanciato in altra direzione. Anche in questo sistema dunque l’immagine fotografica ha funzione di “limitazione” ossia fa sì che la luce entri soltanto in quel punto da cui la lente la lancerà 245 nella direzione desiderata. In quella direzione, difatti, si trova il filtro appropriato, che “colora” la luce e la manda sullo schermo. In altre parole: il sistema Berthon prevede un unico filtro grande che consiste di tre strisce orizzontali, una rossa, una verde, una blu. La funzione della minuscola lente è quella di mandare la luce attraverso una di queste tre strisce, e l’immagine fotografica pensa a dirigere il processo. L’idea di Berthon ha trovato applicazione pratica nel Kodacolor (1928) e nel sistema Berthon-Siemens (1933), ma malgrado gli enormi capitali investitivi non ha dato finora risultati soddisfacenti, specialmente per quanto riguarda la luminosità della proiezione, la resa di certi colori e la stampa delle copie. A questo punto entrano in scena Bocca e Rudatis con una innovazione degna delle precedenti. (Non ci fermiamo qui sull’originario sistema Bocca basato sul fenomeno della diffrazione, ma descriviamo subito quello attuale che si serve invece della rifrazione). Il reticolo lenticolare di Berthon è uniforme, meccanicamente impresso sulla pellicola, e ha quindi bisogno dell’immagine fotografica perché governi la riproduzione secondo le esigenze individuali del soggetto da riprodursi. Ma se si riuscisse invece a plasmare individualmente le lenti stesse sotto l’influenza del soggetto da riprodursi, in modo che la lente da sola pensasse a dirigere il raggio nella direzione desiderata, allora evidentemente l’immagine fotografica sarebbe diventata superflua e una geniale semplificazione raggiunta! Il disegno C illustra come, nel sistema Bocca-Rudatis, la lente di Berthon è sostituita con una piccola piramide di forma irregolare. È sparita l’immagine fotografica! La luce di proiezione attraversa il supporto della pellicola e allo spigolo di uscita della piramide subisce una “rifrazione” (fenomeno ottico per cui, per esempio, un bastone immerso parzialmente nell’acqua appare piegato) per cui è deviata dalla sua direzione originaria. Basta ora che la posizione ed inclinazione della faccetta rifrangente sia tale da mandare il raggio nella direzione desiderata del nostro filtro perché il problema sia risolto anche senza il concorso selettivo dell’immagine fotografica. Il principio è abbastanza facile da comprendersi, ma sembra impossibile costruire sul piccolo fotogramma della pellicola tante piramidi microscopiche, diverse in ogni punto secondo il colore da trasmettersi! In realtà, la formazione di queste piramidi avviene fulmineamente e meccanicamente. Sarebbe troppo complicata la spiegazione dettagliata del processo che porta questo risultato e ci limitiamo ad alcuni accenni. Il sistema Bocca-Rudatis è, per ora, un sistema di sola proiezione (il che non diminuisce il suo valore). Si parte da una immagine ripresa con un qualunque sistema di selezione attualmente in uso. Dai negativi si passa a delle matrici, nelle quali i rilievi sono ottenuti distruggendo una preesistente reticolatura uniforme impressa sullo strato. Tale distruzione viene modulata secondo le caratteristiche dell’immagine originale. Metodi per trasformare in rilievo immagini fotografiche sono da molto tempo usati dalla tecnica fotografica in quei procedimenti in cui si tratta di stampare l’immagine, per esempio, a colori, sulla carta. Ma Bocca e Rudatis hanno usato ai loro scopi altri metodi del genere, per cui, per esempio, non è adoperata una normale emulsione ma uno speciale strato di gelatina sensibilizzato a cui, dopo l’impressione, basta un semplice lavaggio perché venga fuori la modulazione del rilievo. Il fatto che la modulazione del reticolo non risulta da una incisione meccanica ma da un processo ottico-chimico, permette di ottenere dimensioni microscopiche mai raggiunte con mezzi esclusivamente meccanici. Gli inventori ci fecero vedere al microscopio la pellicola lenticolata tipo Berthon che rivelava delle strisce abbastanza strette. Ma queste strisce apparivano – ci sia permesso questa similitudine – come delle fettuccine larghe accanto a minuscoli granelli di semolino quando, in seguito, vedemmo l’immagine microscopica delle piramidi ottenute col nuovo sistema. Infatti, mentre, come dicevamo prima, nel sistema Siemens-Berthon si hanno circa trenta elementi lenticolari al millimetro, la pellicola Bocca-Rudatis possiede oltre 50.000 elementi rifrangenti per millimetro quadrato. (Ogni lente piramidale consiste di 2-6 faccette, di cui ognuna rappresenta un elemento rifrangente). Con una perfetta messa a punto meccanica, gli inventori promettono di raggiungere circa 300.000 elementi per mm2. Questa inconcepibile finezza degli elementi, che supera quella della normale grana fotografica, permette naturalmente di risolvere una quantità di problemi inerenti alla proiezione cinematografica. Le piramidi sono composte in modo complicato da faccette sferiche e cilindriche. L’altezza della piramide, le curvature delle faccette e la direzione in cui esse sono inclinate, determinano l’intensità, la saturazione e la tinta del colore da formarsi nel corrispondente punto dell’immagine sullo schermo (fig. 1). Guardando a occhio nudo si vede una pellicola completamente trasparente sulla quale appaiono come una leggera smerigliatura le forme del soggetto. Per proiettarla ci si serve di una macchina da proiezione che, a prescindere da un adeguato condensatore e dal filtro, è normalissima: la solita sorgente di luce, il solito obbiettivo. Un proiettore comune raccoglie, come è noto, la luce della sorgente in un fascio che, mettendo un foglio di carta nel piano focale dell’obbiettivo, si può vedere come un piccolo disco molto luminoso, situato nell’asse ottico. Appena si è invece infilata al suo posto nel percorso dei raggi la nostra pellicola si vedono nel piano focale invece di quell’unico disco centrale circa una cinquantina, raggruppati intorno ad esso in forma di stella: mediante la rifrazione, la pellicola ha diviso la luce in tutti questi fasci, che attraversano il filtro in punti differenti (fig. 3). Le strisce colorate di questo filtro non sono parallele come quelle del sistema Berthon ma disposte invece come le razze di una ruota. Per la tricromia, per esempio, questo filtro può consistere di tre strisce diametrali, una rossa, una verde, una blu. Il resto del filtro è trasparente ed incolore, il che ha particolare importanza, perché nel sistema Bocca-Rudatis il bianco non è ottenuto soltanto dalla addizione di tutti i colori ma anche dalla luce diretta non filtrata, precisamente come nei sistemi sottrattivi, i quali da questo fatto traggono il vantaggio di una maggiore luminosità. Infatti la considerevole luminosità è una delle particolarità che distinguono il nuovo sistema. 246 247 Nel centro del filtro vediamo un dischetto opaco previsto per intercettare il fascio centrale ossia non rifratto della luce. Nei punti che corrispondono al nero o a ombre, infatti, la nostra pellicola non forma lenti ma lascia passare la luce senza deviazione. Questo fascio centrale è impedito dal dischetto opaco di colpire lo schermo. L’immagine colorata ottenuta sullo schermo sorprende per la sua naturalezza e per la tranquilla armonia delle tinte. Siamo appunto rimasti sorpresi dal fatto che una maggiore naturalezza porta anche una intonazione esteticamente più piacevole. Per la prima volta forse non abbiamo provato quel fastidio che finora distingueva la visione dei colori riprodotti da quella dei colori naturali e che nasce da immagini stonanti e inverosimili. La tavolozza delle tinte è molto ricca. La pelle umana non dimostra né il color mattone delle immagini sottrattive né la pallidezza mortale di quelle additive, finora viste, ma è animata da mezzetinte modellanti. Mancano due difetti principali: le ombre non sono delle macchie sporche ma colorate, e inoltre non si verifica quell’ibrido cangiar di colore che impediva finora ogni precisa colorazione. Almeno è questa la nostra impressione ottenuta nella prima dimostrazione del sistema. Girando o coprendo parzialmente il filtro si può modificare, indipendentemente, l’intensità e la tinta dei colori e il chiaroscuro. Abbiamo visto un cielo veneziano azzurrissimo che in un attimo si trasformava in un rosso d’incendio e le labbra di una donna diventare spiccatamente verdi. Questo emozionante spettacolo surrealista dimostra la regolazione dei colori, utile per compensare una resa difettosa dei colori naturali, per “riscaldare” o per “raffreddare” l’immagine secondo le intenzioni del regista e per creare un adattamento cromatico fra scene differenti, utilissimo per un montaggio armonico dei film a colori. Questa regolazione non avverrà naturalmente, come nel nostro esperimento, durante la proiezione ma invece durante la preparazione della pellicola originale o matrice, mediante semplici variazioni di orientamento dei rilievi. L’elemento più impressionante del sistema Bocca-Rudatis è forse la “moltiplicazione” delle pellicole. «Adesso faremo una copia», ci dissero gli inventori, e noi rispondevamo: «Dove e con che cosa?» – domanda giustificata se si ricorda che normalmente per fare una copia ci vogliono uno stabilimento chimico, luce rossa, bagni di sviluppo e di fissaggio e così via. E invece, preso uno dei fotogrammi proiettati un momento prima, posto su di esso – in piena luce – un pezzetto di celluloide ammorbidito con qualche goccia di acetone, pressato leggermente coll’indice e poi staccato il celluloide, messo questo nel proiettore abbiamo visto un duplicato fedelissimo dell’immagine proiettata prima. La spiegazione del miracolo? Una volta ottenuta, mediante la stampa ottica, una prima copia della pellicola originale, la moltiplicazione non avviene più fotograficamente. La prima copia serve invece come matrice da cui si tirano duplicati con semplice pressione meccanica, precisamente nel modo in cui si moltiplicano i dischi grammofonici. Quindi le riproduzioni risultano sempre rigorosamente uguali tra loro e resta pertanto eliminato il 248 pericolo, oggi comune anche per il bianco e nero, di rovinare nella stampa delle copie la bellezza e l’espressione dell’originale. Ognuno dei duplicati può servire, da parte sua, come matrice per ottenere ulteriori duplicati. Non conta otticamente la differenza fra rilievo concavo e rilievo convesso. Basterebbe quest’ultima semplificazione per dare al sistema BoccaRudatis un carattere rivoluzionario. Le pellicole si possono ottenere con un qualunque materiale trasparente, non soltanto con la celluloide ma anche, per esempio, col cellophane, molto meno costoso. Né si possono dire terminate le ricerche degli inventori. Forse non commettiamo una indiscrezione se sveliamo che si tenterà di eliminare, nell’avvenire, perfino il filtro colorato ricorrendo invece ai colori spettrali di cui si compone la luce bianca di proiezione. Ma abbiamo già fatto sufficientemente girare la testa se non al pubblico, almeno agli “iniziati”. Basti per stavolta. Il detective soggettista* «Cinema», 50, 25 luglio 1938, pp. 56-58 «C’è poco da dire», esclamò il produttore, affannato dalla corsa che aveva fatto. «Se debbo aspettare finché il nuovo film di Capra arrivi da noi, è troppo tardi per imitarlo. La mia Casa è ben attrezzata, lo so: la preparazione del soggetto e la realizzazione in teatro avviene con rapidità fulminea. Ma in sede di montaggio abbiamo sempre spiacevoli ritardi. Si figuri che solo in questi giorni ho portato a termine il mio film fatto sulla base di Accadde una notte. Naturalmente, nessuno ne vuol più sapere. È inutile: ho assolutamente bisogno di conoscere il film appena cominciato». «Se ne conosce già la trama?», domandò il grande detective fissando il suo cliente con uno sguardo glaciale. «Se la sapessi non sarei venuto da voi», rispose il magnate del cinema. «Non ho potuto ottenere altro che poche fotografie del film, che non mi dicono niente. Ma sono sicurissimo che al vostro acuto spirito sarà facile ricostruire il fatto completo mediante questi documenti fotografici». Il produttore aprì la sua voluminosa borsa e con mano tremante, mise sette fotografie sulla scrivania del poliziotto. «Eccovi il nuovo film di Frank Capra!», esclamò. Il detective accese la tradizionale pipa. «Non sarà tanto facile», disse. «I fatti della vita reale sono ragionevoli e quindi facili da rintracciarsi. Ma le fantasie dei poeti cinematografici seguono vie strane». Senonché dopo aver analizzato attentamente per mezz’ora le fotografie, esaminandone alcuni dettagli al microscopio e trattandole con varie * L’articolo è riprodotto nell’Appendice del volume, cfr. infra, pp. 379-381. 249 sostanze chimiche, gridò: «Ci siamo! Osservate la fotografia numero 1 e ascoltatemi bene». «Lo sapevo», disse il produttore. E tirò fuori un taccuino rilegato in pergamena con incisione d’oro. «Ann, figlia di un ex-capitano di marina in pensione, si è innamorata del giovane James, e vorrebbe sacrificare al suo amore la propria promettente carriera di ballerina», cominciò il detective con una voce che sembrava ipnotizzata. «Molto originale», esclamò il produttore, tutto felice. «Ma come fate a sapere che si tratta di un ex-capitano?». «Osservate il caminetto nel fondo della stanza», rispose il detective irritato, «vi scoprirete, fra altri ninnoli, una piccola testa di marinaio e un battello su quattro rotaie. Ma cercate di non interrompermi! Dunque, la ragazza ama James, ma il padre di lei non è d’accordo: egli vorrebbe fare di sua figlia una celebre e fruttifera ballerina e non vorrebbe darla a un giovane il cui profilo rivela poca intelligenza. (Osservate il giovane in smoking a destra). Ma anche il giovane stesso non è molto persuaso di questo matrimonio. Egli invece è invaghito di Jean, giovane e ricca proprietaria di grandi imprese industriali». «E vi sembra poco intelligente», si permise di obiettare il produttore. «State zitto! Egli non desidera il denaro della ragazza. L’ama sul serio. Senonché Jean, pur essendo attratta dall’affetto di James, si trova sotto la funesta influenza di uno strano professore di psicologia che ha conosciuto durante una sua gita in Europa e che ha portato con sé in America. La fotografia numero 1 vi mostra la scena in cui il professore vorrebbe costringere il padre di Ann a dare in matrimonio la figlia a James per allontanare quest’ultimo da Jean. Jean, spaventata, cerca di stornare il professore dalla sua pazza impresa. Ma il capitano Edward intende di difendersi. La fotografia numero 2 vi rivela un suo satanico progetto. Come vedete, egli ricorre a un terribile scimmione che, anni fa, ha portato a casa dal Borneo come ricordo. Egli decide di far rapire dalla bestia il giovane James facendo cadere il sospetto, con abili intrighi, sul misterioso professore di psicologia». «E pensare che mi avevano detto si trattava di un film allegro e leggero», disse il produttore asciugandosi il sudore. «Il miserabile progetto riesce», continuò il detective. «James è trascinato dallo scimmione su una vecchia nave nel porto, e ivi custodito dalla feroce bestia. Il professore di psicologia finisce in prigione, accusato di rapimento. Torniamo ora alla fotografia numero 1 e osserviamo a destra il regista Frank Capra, che, conoscendo naturalmente il soggetto del film, rivela alla povera mamma di James il malvagio progetto del capitano, prima che quest’ultimo lo abbia concepito». «Scusate, prego», interruppe il produttore molto preoccupato. «Quello lì non è mica Frank Capra. È, se mai, un attore che gli somiglia». «Appunto», rispose il detective imperturbato. «È un tale che interpreta la parte del regista. Andiamo avanti. Nella fotografia numero 3, la mamma di James ha raccontato al marito la sorte del figlio, presentandogli nello stesso tempo un vecchio operaio della loro officina, il quale, molti anni fa, ha fatto fortuna nei teatri di varietà come discobolo. Sarà lui che ucciderà lo scimmione. Il vecchio padre, John, molto contento, offre una collezione di frecce avvelenate, che egli ha a portata di mano. Ma l’operaio Halliwell conosce mezzi migliori. Nella fotografia numero 4 osservate una lancia speciale, riempita di materie esplosive, che egli ha costruito nell’officina con l’aiuto di un fido compagno. Infatti, in una notte tempestosa, egli riesce ad ammazzare la bestia e a liberare James, il quale si precipita a raggiungere la bella industriale Jean nel suo ufficio privato. Quest’ultima, liberata dall’influenza del professore, che si trova in carcere, si abbandona al suo amore incatenando il giovane alla propria scrivania, come potete vedere nella fotografia numero 5. Ma la mamma della povera ballerina, ispirata da un brutto presentimento, entra senza essersi fatta annunciare e scopre la verità. Essa è disperata perché, contraria alle intenzioni del marito, vorrebbe legare Ann all’uomo del suo amore. Per eliminare la rivale di sua figlia, si decide perciò a procurare la libertà al professore di psicologia, rivelando l’innocenza di quest’ultimo a spese del proprio marito. Come risulta dalla fotografia numero 6, tutti si recano al carcere, e James sfrutta l’occasione poco adatta per rassicurare Jean, nuovamente, del suo amore volgendo invece le terga a Ann. Ma intanto il regista Capra, che vedete a sinistra, ha dato un’occhiata alla sceneggiatura sul tavolino accanto a lui, e guarda perciò attentamente il professore, che, in uno stato di estasi, riprende in pieno la sua attività. Infatti, riesce a suggerire a Jean di rinunciare davanti al giudice al povero James – guardate la fotografia numero 7 – il quale si sente nello stesso tempo acchiappato dal pugno ferreo della futura suocera, con grande piacere della piccola ballerina, che vedete a destra…». «Questo è tutto!», concluse dopo una pausa il detective, restituendo le fotografie al produttore e mettendosi subito a riempire con cura un modulo di ricevuta. Il produttore sentì un leggero malessere suscitatogli probabilmente dal fumo della pipa. «E voi siete proprio sicuro che il soggetto del prossimo film di Capra è questo?», chiese. «Non so», rispose il detective, e incollò con energica pressione del pollice un’apposita marca da bollo sulla ricevuta, che porgeva al produttore: «Anzi non lo credo. Ma non vi preoccupate e preparate pure il vostro film su questa base. Nella peggiore delle ipotesi, avrete prodotto, una volta tanto, qualche cosa di molto originale». 250 251 Un lettore ci domanda «Sapere», 86, 31 luglio 1938, p. 66 «Dove sta l’elemento tecnico essenziale del funzionamento del cinematografo dopo che Demeny aveva assicurato i coefficienti tecnici maggiori permettendo la visione delle immagini in moto? Come attuarono praticamente l’invenzione i fratelli Lumière?». [F. Carobbi, Pistoia] trasporto della pellicola mediante la cosiddetta griffa rappresentava, in complesso, tutti gli elementi caratteristici delle macchine ancora oggi in uso; eccetto che la perforazione, che prevedeva un solo buco rotondo per ogni fotogramma, fu in seguito sostituita con la perforazione Edison da quattro buchi; e che nelle attuali macchine da proiezione, il trasporto della pellicola non si effettua a griffa ma invece a croce di Malta. Il cinema documentario e i popoli «Il Ventuno», 3-4, agosto 1938, pp. 36-38 L’invenzione del cinematografo non si può attribuire a una persona sola. I suoi vari elementi tecnici vennero sviluppati da più inventori finché la macchina nella sua forma definitiva fu presentata dai fratelli Lumière. Il più antico degli elementi di cui si serve il cinematografo è quello della proiezione di immagini trasparenti: la lanterna magica risale ai lavori del padre Athanasius Kircher e del prestigiatore Walgenstein nel Seicento. L’illusione dell’immagine animata, basata sull’effetto stroboscopico, è presentata per la prima volta dalla “ruota vivente” di Plateau e di Stampfer (1832): un tamburo rotante sui cui bordi era disegnato il soggetto nelle varie fasi del suo movimento. Dalla stessa epoca data, come è noto, anche l’invenzione della fotografia. Nel 1889, Edison creò il primo modello del suo “cinetoscopio” scatola che permetteva ad un solo spettatore di vedere un’immagine animata prodotta mediante una pellicola le cui dimensioni (formato, perforazione ecc.) sono rimaste invariate fino ad oggi. La pellicola a supporto flessibile di celluloide era nata in quello stesso anno 1889 negli stabilimenti Eastman a Rochester. Nel cinetoscopio di Edison, la pellicola si spostava ancora a trasporto continuo – sistema che, per mancanza di luminosità, non consentiva la proiezione. Georges Demeny, collaboratore del famoso fisiologo Marey, produsse, nel 1891, l’immagine fotografica in movimento di una persona che parla, mediante il suo “monoscopio”, basato ancora sul vecchio principio della ruota vivente, che limita moltissimo il numero delle singole immagini utilizzabili: si trattava di 30 diapositive disposte sulla periferia di un disco rotante. Molto più importante fu l’apparecchio di presa brevettato dal Demeny nel 1893, in cui una pellicola è spostata mediante il cosiddetto trasporto intermittente a schiaffo; manca però la perforazione della pellicola. L’anno dopo, egli perfezionò questo apparecchio introducendo un rullo avvolgitore dentato e servendosi di pellicola perforata. Purtroppo, questa pellicola non era del formato Edison (35 mm di larghezza) ma era largo 60 mm. Altrimenti, sfruttato in tempo, questo apparecchio del Demeny avrebbe potuto prevenire la gloria dei fratelli Lumière, i quali lanciarono nel 1895 un apparecchio chiamato “cinematographe” e destinato alla presa, proiezione e stampa di pellicole. Questa macchina che si serviva di pellicola del formato Edison e che effettuava, per la prima volta, il Il film documentario non è una meccanica registrazione di fatti reali, ma si serve dei metodi dell’arte per dare un’immagine espressiva e caratteristica del nostro mondo nei suoi vari aspetti. Perciò, come le altre opere d’arte figurativa, il film documentario ci parla del popolo da cui esso proviene, in due modi diversi. Ci può presentare, come soggetto, il proprio paese e la vita di esso. Ma non meno istruttiva per la mentalità di un popolo è la maniera in cui i suoi uomini affrontano un qualunque compito, in cui i suoi artisti sentono e trattano un determinato argomento e infine anche la funzione che si vuol dare a un determinato strumento della civiltà. È in questo secondo senso che vogliamo occuparci brevemente del cinema non teatrale. Il film documentario potrebbe sembrare meno capace di presentare l’essenza di un motivo, dato che esso in un modo più rigoroso del film a soggetto si serve della materia reale, poco modificabile e quindi meno adattabile allo scopo di una sintesi artistica, e dato che esso, per forza di cose, trascura i lati intimi e psicologici della vita umana a favore della semplice superficie del mondo d’ogni giorno. In un certo senso, questo è vero, ma d’altra parte è proprio il cinema che ci ha fornito una nuova prova di quella «identità di nocciolo e di buccia» di cui parla Goethe, e se il documentario non ci dà che la buccia, ci dà tuttavia una materia enormemente più autentica di quella che i favoleggiatori dei teatri di posa ci presentano come nocciolo della vita. Infatti, il documentario gode notevolmente del vantaggio di concedere poco lucro: essendo troppo noto il fatto che questo genere di film richiede dei sacrifici finanziari e va perciò coltivato unicamente per ragioni idealistiche, esso fa vita meschina, ma onestissima. Non viene deformato dalla voglia di contentare un fittizio gusto internazionale. Le persone che si occupano di esso sono veri seguaci dell’arte e della cultura; e anche se la produzione di tali film non è sempre sicura da influenze estranee, lo è almeno dalla mania dei produttori cinematografici di modificare i fatti e i problemi per ragioni commerciali. Dopo di che, nessuno si meraviglierà di apprendere che in America un cinema documentario nel senso vero e proprio non esiste. 252 253 Troppo dominato è in quel paese il cinema da una concezione puramente industriale, e troppo preponderante nell’anima soffocata dei suoi abitanti il piacere delle eccitazioni nervose, del thrill, a danno di quella serena curiosità che è invece indispensabile agli amatori dei film culturali. Qualcuno avrà visto quel cortometraggio americano che non era che una catena di incidenti disastrosi: villaggi inondati, dighe rotte dalla tempesta, le nuvole nere dell’olio incendiato, edifici distrutti dal fuoco, automobili di corsa lanciate attraverso gli spettatori in panico, treni spezzettati da un terribile incontro. Ecco il documentario transatlantico nella sua forma estrema ma anche pura. Attenuata, la stessa mentalità si trova per esempio in quei documentari sulla pesca grossa, la caccia dei pescicani che con la coda minacciano la barca e via dicendo. Sono pochi però questi film. Il vero film documentario al di là dell’oceano è il giornale d’attualità, che porta le ultime notizie sensazionali. La situazione contraria la troviamo in Germania, paese che, col suo panteismo e romanticismo, con la sua maniera diciamo biologica di concepire l’uomo come un prodotto organico della natura, era predisposto a diventare la culla del film documentario. Ed è facile a comprendersi perché accanto a meravigliosi film di carattere puramente scientifico, prodotti della paziente ricerca e della precisione tecnica, vi troviamo anche esempi di film prevalentemente lirici che cantano la vita delle bestie e delle piante, i costumi folcloristici, le giornate dei contadini. Con quel realismo duro e fanatico, che troviamo in certe pitture del Grünewald, del Dürer, del Holbein, del Baldung e di tanti altri, non si respingono neanche i lati brutti della vita, anzi si cavano da esse le caratteristiche più forti dell’esistenza mortale, caduca e piena di sofferenze. Inutile osservare, quanto un tale realismo implacabile, una tale adorazione pia delle cose naturali si accordi bene alle migliori capacità della fotografia, mezzo tecnico essenziale del cinema. Alla mentalità dei documentaristi tedeschi corrisponde la reazione del pubblico tedesco, i cui concetti del Bello e del Brutto sono così difficili da capire per un italiano, perché si ispirano non tanto alla perfezione ideale e alla armonia quanto all’intensità della forza vitale nei suoi aspetti positivi e negativi. In Germania, il film documentario rappresenta un elemento integrale del programma cinematografico, e succede spesso che la platea dopo aver osservato con entusiasmo una coppia di rondini che costruisce il proprio nido e imbecca i piccoli, comincia in seguito a seccarsi davanti ad un film giallo mediocre. Onde un enorme incremento della produzione documentaria. Va menzionato, infine, che negli ultimi anni troviamo in Germania vari tentativi di utilizzare il film documentario come mezzo di propaganda: film che non si contentano di presentare dei fatti ma che con tutti i mezzi dell’inquadratura, del ritmo, del montaggio e della musica vogliono suscitare l’ebbrezza dell’entusiasmo. Basta citare i grandi film epici-lirici dedicati alle manifestazioni politiche, e alcuni recenti documentari che si occupano delle autostrade, dei tessuti artificiali ecc. Il grande film sulle Olimpiadi del 1936 va inteso nello stesso senso. Volgendoci all’Italia, troviamo in riguardo al cinema documentario, un atteggiamento che corrisponde a quello che il carattere italiano assume verso le cose naturali. Lo spirito italiano si occupa dei fatti con grande senso di realismo, ma non tanto nel senso della contemplazione passiva quanto della maniera pratica di utilizzarli nel servizio dell’Uomo. Il pensiero italiano deriva dall’Uomo e dai suoi bisogni. La Natura rimane subordinata all’Uomo. Ma anche per quanto riguarda questo Uomo, lo spirito italiano ci sembra rivolto meno all’esistenza empirica, imperfetta, multiforme e casuale, che all’idea, ossia all’ideale. L’arte italiana non è analitica ma offre alla nostalgia umana l’immagine di una perfezione che si vorrebbe raggiungere. Basta accennare a questo fatto per far capire la difficoltà in cui una concezione così elevata si deve trovare di fronte ad un mezzo che sviluppa le sue migliori capacità nella registrazione ed interpretazione fedele dei fatti fisici. Non è per caso che il film italiano a soggetto abbia raggiunto un suo vertice in un’epoca in cui il cinema si valeva di uno stile idealizzante, e per la stessa ragione troviamo le caratteristiche del documentario italiano spesso nei felici tentativi dei suoi operatori di trarre dalla realtà, sia quella di un paesaggio o quella di una cronaca di attualità, notevoli effetti pittorici, inquadrature ben equilibrate, bianchi e neri decorativi. È la tendenza di scoprire nella realtà quella bellezza, o di portare la realtà verso quella bellezza che l’arte latina contrappone all’imperfezione dell’esistenza umana. Il cinema francese ha creato alcuni ottimi film documentari combinando la sensibilità latina per le forme armoniche e gustose con specifiche tendenze verso i soggetti sociali. Va citata anche la caratteristica serie dei film di tre minuti, i quali col rapido e brioso gioco dei disegni animati sanno dare la sintesi di un qualunque problema di attualità. In Russia, il cinema documentario ha dato un indirizzo decisivo a tutta la produzione a soggetto, determinata appunto da un largo impiego di elementi dal vero; senonché il vero e proprio cinema non-teatrale sovietico non si limita al semplice realismo, avendo creato oltre a film di ricerca strettamente scientifica anche, per esempio, i febbrili canti rivoluzionari di un Dziga Vertov. La più significativa impronta, il cinema documentario l’ha avuta recentemente in Inghilterra. All’empirismo inglese non poteva non piacere il nuovo mezzo d’espressione, e indiscutibilmente in quest’ultimi anni l’Inghilterra ha occupato il primo posto nel nostro campo. È una prosperità artistica che sorge su una solida base economica, perché il documentario inglese, invece di cercar rifugio dai mecenati, che per prestigio o per entusiasmo siano pronti a spendere il loro denaro a fondo perduto, si è inquadrato felicemente nel processo produttivo della vita del Paese. L’idea fondamentale fu quella di creare nel cittadino una viva coscienza di tutte quelle forze che collaborano per permettergli una vita comoda, sana e sicura, e da questo compito di descrivere le diverse attività umane, industriali, agricole, organizzative, sanitarie e altre, si è formata anche la base economica di questa produzione cinematografica. Si tratta 254 255 infatti di film pubblicitari, che, pagati da grandi enti statali o privati, divulgano e propagano l’opera di essi, ma senza aver minimamente carattere reclamistico e senza menzionare nemmeno il nome della Casa o del prodotto. I film sui cantieri navali, sulle linee aeree, sulle miniere, sui servizi meteorologici, trasmissioni radiofoniche e tanti altri argomenti, film creati da giovani intellettuali ambiziosi, sono infatti documentari nel miglior senso della parola, anche per quanto riguarda la forma artistica, sobria ma originale e vivace. Non abbiamo potuto scoprire in questi film la profonda analisi sociale che i loro autori, come risulta da certi scritti teorici, intendevano metterci, e dubitiamo del resto se un tale compito sia alla portata dell’immagine cinematografica, ma si tratta di strumenti utilissimi dell’istruzione popolare. Due paesi minori hanno dato risultati notevolissimi nel campo del film documentario. Con grande sensibilità lirica, i cineasti cecoslovacchi descrivono il loro paesaggio e la loro architettura, e in Olanda, un gruppo di avanguardisti intelligenti ha saputo combinare la mentalità pratica e terrestre di quel periodo coll’uso dei più moderni e arditi mezzi del cinema, creando una produzione piuttosto ampia che esalta la costruzione della grande diga, coglie un gioco di effetti ritmici da una fabbrica di apparecchi radio e si immerge col microscopio nel miracoloso mondo dei cristalli. Il cinema documentario mondiale è una orchestra composta di tanti strumenti diversi di cui ognuno con un suo specifico timbro contribuisce a creare questa grande sinfonia cinematografica della nostra vita presente, che è formata dalla natura e dalla civiltà, da aspetti belli e aspetti brutti, da vedute idilliche e dai tempestosi rumori delle macchine, dall’entusiasmo del poeta e dell’uomo d’azione e dalla paziente e spesso fredda registrazione dei fatti. Le rubriche di «Cinema» In questa sezione vengono riportati solo alcuni degli interventi attribuibili ad Arnheim (cfr. par. “Le rubriche di «Cinema»”). Per la rubrica “Capo di Buona Speranza” firmata da Il Nostromo sono stati scelti alcuni passaggi particolarmente significativi. Per le rubriche dedicate alla “Fotografia” (affiancata alla rubrica “Voi fotografate noi pubblichiamo” firmata da Marie Onussen) e alle “Notizie tecniche” riguardanti il cinema (generalmente firmate da Ciak) sono proposti solo gli articoli firmati esplicitamente da Rudolf Arnheim. Fra le recensioni della rubrica “Bianco e Nero” sono proposti solo le recensioni di Candido (cioè Arnheim) e non gli interventi sugli stessi film del suo collega Arpagone (Gianni Puccini). L’elenco completo degli articoli apparsi all’interno di queste riviste e attribuibili, con diverso grado di certezza, ad Arnheim si trova sul sito www.RudolfArnheim.it. 256 Rubrica “Capo di Buona Speranza” (Corrispondenza coi lettori) Aldo Sartorio (Saluzzo) – Studiando la “metamorfosi dei titoli” si potrebbe arrivare ad un vero e proprio trattato di psicologia del noleggiatore cinematografico. Certo, ci sono casi in cui una formula buona ed indovinata è intraducibile: spesso è più facile tradurre un romanzo intero che il suo titolo. Ma in generale si crede di poter dare una maggiore commerciabilità al film cambiandone il titolo nel senso di introdurre qualche concetto suggestivo come l’amore, il sogno, le labbra, le lacrime, il delitto; e si ignora che dare ad un film un nome schematico che non lo distingue dagli altri, significa rendergli un servizio dubbio. Io, per conto mio almeno, mi confondo terribilmente fra i sentieri della felicità e del pino solitario, fra le signore troppo amate o troppo poco amate, fra le sinfonie d’amore, di primavera e di cuori, fra gli angeli azzurri, bianchi e delle tenebre, fra Accadde una notte e Accadde una volta. Mentre ogni nome – e così anche quello di una merce – dovrebbe distinguere una cosa dalle altre. Il titolo poi dovrebb’essere una specie di guida che indichi subito il motivo o il problema centrale del film. Sovente, il titolo originale è scelto benissimo in questo senso, mentre nella traduzione si cerca di spostare l’interesse dal nocciolo interessante ed originale verso elementi secondari di suggestività convenzionale: ricordiamoci di Mister Deeds va in città diventato È arrivata la felicità e de Lo spettro va all’ovest diventato addirittura Il fantasma galante. Curioso anche il caso da Lei citato: Schlussakkord tradotto letteralmente Accordo finale per la Biennale di Venezia, diventa La nona sinfonia nel programma del noleggiatore, per finire come Il grande peccato, dato – evidentemente – che l’annuncio di musica classica poteva far paura. Io invece credo che il nome La nona sinfonia, caratteristico del film, si imporrebbe facilmente alla memoria, mentre Il grande peccato si confonderà con i tanti peccati più o meno divertenti, del passato. («Cinema», 19, 10 aprile 1937, p. 277) Carlo Amodeo (Perugia) – La produzione di film documentari a colori, le cui possibilità Lei mi descrive tanto bene («Immaginiamoci di vedere un angolo dell’Etiopia, una rivista, un paesetto alpino, una corsa automobilistica: ogni quadro caratterizzato dai suoi colori e dalle sue sfumature sarebbe certamente più istruttivo, e colpirebbe la massa del pubblico, che nello stesso tempo comprenderebbe che anche in questo campo non siamo da meno dei maghi di Hollywood») – la produzione di tali film fa naturalmente parte del problema generale: quando si potrà iniziare la produzione normale di film a colori? Finora neanche i “maghi” stanno a un buon punto… Non è ancora deciso quale sistema entrerà nella pratica, e dato che l’apparecchiatura ri- 258 chiede l’investimento di forti capitali, capirà che non è il caso di darsi troppo da fare! Ma o prima o poi il cinema a colori verrà; e certamente saranno proprio i documentari, col più di freschezza, vivacità e verità dato loro dal nuovo mezzo, a consolarci di certi spaventi procuratici, anch’essi, dal colore “naturale”. («Cinema», 21, 10 maggio 1937, p. 387) Nino Pacilli (Milano) – Il valore artistico dei raffinati passaggi di scena, – che sono effetti piuttosto facili –, viene spesso esagerato. Sono curiosi, divertenti, ma spesso solamente formali. Non riesco a rendermi conto perché il passaggio dal tappo che salta da una bottiglia di spumante al proiettile che salta dalla gola di un cannone, debba rendere più logica l’interruzione della continuità temporale di un film (della quale continuità, del resto, si preoccupano molto più i registi e i teorici che non il pubblico). Vediamo ora la Sua proposta di risolvere un passaggio di dieci anni: «Lei è ancora bambina. Sale le scale, corre nella sua camera, salta nel letto. Sul guanciale il visino rimane immobile nel sonno. Cambia quadro. Un viso di signorina immobile nel sonno». Benissimo; ma questo non serve che per sottolineare il salto temporale. La somiglianza dei motivi concentra l’attenzione sul punto in cui si distinguono. L’effetto è dunque proprio contrario. («Cinema», 22, 25 maggio 1937, p. 428) Carlo Ferrari – «Perché quando una bellissima attrice si fa vedere nel bagno, intorno a lei v’è sempre un alone di acqua saponata? Le chiare fresche e dolci acque non sono buone per i bagni cinematografici?». Potrebbe sembrare una domanda puramente retorica oppure troppo ingenua, invece non lo è. Infatti sui dipinti, Venere, Susanna e le loro colleghe fanno da molti secoli il bagno senza sapone. Perché la differenza? In parte, perché la riproduzione meccanica della fotografia riesce soltanto fino ad un certo punto a trasformare in simbolo formale la materia reale. In parte, perché il cinema industriale sceglie i suoi soggetti, le sue luci, inquadrature ecc., per presentare non tanto il Bello ma piuttosto le cose puramente piacevoli. Nel caso estremo del corpo nudo, questo sistema porterebbe ad un effetto evidentemente antiartistico che offenderebbe il pudore. Ma in fondo, la maniera di presentarci i protagonisti di un conflitto drammatico come gente molto carina, molto bene pettinata, provoca già la stessa obbiezione. Il giorno in cui tutti questi pseudodrammi, che si svolgono non nella vita ma nella vetrina del parrucchiere, saranno annegati in un bagno saponato e profumato, sarà giunta l’ora dell’acqua fresca. Ma non si illuda: il giorno è lontano. […] («Cinema», 23, 10 giugno 1937, p. 467) Antonio Laforet (Roma) – Di specialisti in materia di colori naturali ci sarà presto bisogno anche in Italia. Sono interessantissime perciò le 259 Sue indicazioni sui film documentari girati da Lei a colori nel 1920 per Gaumont a Parigi: «… le scene animate che io componevo con le porcellane di Sèvres del XVIII secolo, o quelle di Saxe, o gli smalti translucidi, od i ventagli del XVII e XVIII secolo, che si muovevano insieme a stoffe e veli dai colori smaglianti – che passavano, giravano, s’aprivano e sparivano – era per me come un fantastico teatro a colori in miniatura». Indicazioni importanti perché sembrerebbe che Lei avesse provato allora ciò di cui oggi nessuno si preoccupa: di studiare praticamente i valori formali del colore in movimento. Però avrei bisogno di esempi per capire meglio quel che Lei mi dice delle “leggi fisiche” dei colori. Lei mi cita le “leggi del suono” utilizzate dai musicisti – ma anche in questo caso non si tratta di leggi fisiche ma di leggi dell’armonia, che sono estetiche. Capisco che possa essere utilissimo lo studio delle condizioni fisio-psicologiche: delle leggi del contrasto per esempio; ma principalmente, volendo studiare delle leggi, bisognerebbe ricorrere a quelle estetiche, delle quali, come dicevo l’altra volta, finora abbiamo poche cognizioni. Creda che gli artisti del cromocinema lavorano come i pittori: ossia, chi più chi meno a lume di naso. E non c’è niente di male. Magari seguissero e potessero seguire di più il loro istinto! («Cinema», 24, 25 giugno 1937, p. 503) Carlo Ferrari – […] Ed ecco la Sua trovata tecnica: «Se vuol vedere il comune film piatto quasi a rilievo prenda due binocoli, li adatti ognuno al suo occhio e cerchi di concentrare le due visioni in una: non dico che vedrà l’immagine a rilievo, ma vedrà molto di più che con un solo binocolo». Non posseggo due binocoli. (Ne ho uno solo, incrostato di madreperla: un’eredità della nonna). Perciò non posso far la prova pratica. Teoricamente so che appena non si vede più la cornice dell’immagine, essa sembra più plastica; ma allora basterebbe anche un binocolo solo. Infine, lei mi domanda «perché gli attori non si soffiano mai il naso, o, se lo fanno, perché questo avviene tanto di rado». Nell’arte nulla si riproduce soltanto perché è cosa reale: ogni dettaglio invece deve avere una funzione caratterizzante. Ora, la necessità di soffiarsi il naso, è un piccolo difetto dell’uomo. Perciò, se Lei vuol descrivere l’uomo deficiente (per esempio in un film comico), il fazzoletto sarà utile. Ma quando vuol presentare personaggi idealizzati – ed è questo il caso di tanti film –, o un’azione intima di fronte alla quale i dettagli esteriori perdono ogni importanza, allora ne farà a meno. In un film realistico, l’attrice farà bene a soffiarsi il naso quando piange. In una tragedia di Corneille, questo gesto starebbe male. È una questione stilistica, insomma. Ogni verismo meccanico è sciocco. («Cinema», 25, 10 luglio 1937, p. 29) e in un certo momento finisce col rompersi un’ala. L’apparecchio deve essere certo in miniatura». Sicuro: e l’immagine dell’apparecchio in movimento, ripreso sopra un omogeneo sfondo scuro, si deve sovrapporre, mediante esposizione doppia, all’immagine del cielo ripresa a parte. Badi di tingere il Suo modellino con colore piuttosto chiaro, e lo comandi mediante fili leggeri come un burattino. Per realizzare bene i movimenti, li esegua lentamente e fotografi la scena a cadenza ridotta (acceleratore) compensando in questo modo il rallentamento. – «Vorrei anche sapere come si ottengono quelle linee che avanzano gradatamente in una carta geografica da un punto all’altro, come ad indicare il cammino di una carovana, il percorso di una nave ecc.». Si ottengono come la tecnica del disegno animato. Servendosi del “passo a uno”, di cui, speriamo, disporrà la Sua macchina, Lei allunghi d’un trattino il disegno della linea dopo l’esposizione di ogni singolo fotogramma. In questo modo, il Suo disegno si animerà. («Cinema», 26, 25 luglio 1937, p. 62) Mario Sardo (La Maddalena) – Non mi ha mai molto persuaso il concetto dello svago serale che serve a spazzare dall’anima tutti i pensieri e le impressioni tristi della giornata, eccitando qualche leggero stimolo piacevole ecc. ecc. Deve pensare che attualmente il cinema è quasi l’unica forma efficace ad eccezione della musica, in cui l’arte potrebbe rivolgersi alle masse, e che la funzione dell’arte è di divertire, sì, ma di divertire presentando in una luce chiara e serena gli enigmi della vita, che all’occhio dell’Uomo, non guidato dall’artista, si impostano confusamente e gli sembrano insolubili. Questa gioia di diventar veggenti, mi sembra il migliore rinfresco dopo le piccole e misere occupazioni e preoccupazioni della giornata, non soltanto per l’uomo colto ma proprio anche per quello semplice del popolo, se la sua sensibilità non è stata sistematicamente corrotta da spettacoli assurdi. La voglia dell’uomo semplice di comprendere è fortissima, commovente. È per questo che le sensazioni “gialle”, i sorrisi e le gambe di seta non risolvono il problema. Presentateci tutti i lati della vita, anche quelli torbidi (non certo «sotto aspetti allettanti e seducenti», come Lei chiede giustamente) ma con quell’atteggiamento morale che è naturale ai grandi artisti, e avrete creato lo spettacolo più educativo e allo stesso tempo più ricreativo per l’uomo sano. Si ricordi dell’immediata, spontanea popolarità del signor Deeds, e mi darà ragione. («Cinema», 27, 10 agosto 1937, p. 101) Cinedilettante (Catania) – «Vorrei sapere come si può effettuare il trucco di un aeroplano, che in tempesta con pioggia e lampi, sbanda, Clinio Ferrucci (Roma) – L’unico premio che voglio per le mie risposte è che i miei corrispondenti prendano l’abitudine di scrivermi ogni volta che si imponga loro qualche dubbio o considerazione riguardanti il campo del cinema. Per questo mi fa piacere la Sua lettera, e anche perché la Sua analisi del cinema italiano e di quello americano tocca veramente i punti 260 261 essenziali. Giustamente lei dice che il problema centrale del film italiano è questo: qual è il miglior modo di conciliare il desiderio di successi industriali e commerciali con l’altro di adattare i nostri film al nostro spirito, e fino a che punto il problema è solubile? Per quanto riguarda l’America, mi sembra che le tendenze di quel cinema siano la conseguenza non tanto della speciale e casuale mentalità dei produttori di Hollywood ma del commercio in generale come principio di produzione. La ragione poi perché questi produttori si occupano anche di arte, si spiega, secondo Lei, pel fatto che essi «sicuri del fatto loro nei riguardi della maggioranza del pubblico, hanno portato tutta la loro attenzione sulla minoranza diremo così artistica, cioè su quel settore più elevato del pubblico, che fino a poco tempo fa arricciava il naso al solo sentir parlare di cinematografo». Sarà vero anche questo ma mi pare ci sia un’altra ragione più importante: il cinema industriale, pur producendo secondo certe norme standardizzate, non deve cadere nella monotonia; ha bisogno di un continuo flusso di nuovi effetti. Ora, l’originalità dove si trova? Nell’arte. E perciò l’industriale trae dagli artisti tutte le idee che al contenuto e alla forma dei suoi prodotti potranno fornire nuovi valori commerciali. Che ne dice? («Cinema», 31, 10 ottobre 1937, pp. 247-248) H. G. (Roma) – «Preferisco le trame semplici, correnti, senza significato. Non occorre che uno scenario o una persona o un destino significhino qualche cosa, possono anche non provar niente. È la loro vitalità che conta. Sono una di quelle che vanno a un film per vedere i divi. Non ci si interessa ad un fatto se non si riesce ad immaginare la persona che ne è stata protagonista». La Sua opinione è dunque che l’elemento vitale venga introdotto nel film soltanto dall’attore e che questa vitalità non abbia un suo significato. Eppure la gioia che Lei sente osservando la naturalezza della recitazione – «ecco, così camminano, muovono la testa e proprio così curvano le spalle e aprono le porte le persone reali» – ne rivela il significato: Lei vi trova la realtà purificata, interpretata, spiegata. «Così è la vita», ecco l’unico ed indispensabile significato dell’arte, senza il quale la cosa non interesserebbe neanche Lei. E non creda che questa vitalità significativa possa essere minore nella regia e nello scenario. È un errore comune e naturale quello di accreditare all’attore molto di quel che il film deve al suo inventore e direttore. «Bellissima la maniera di Gary Cooper di trattare i giudici!», si dice, mentre buona parte di questa lode spetta al regista e allo scenarista che hanno ideato le gesta del signor Deeds. («Cinema», 31, 10 ottobre 1937, p. 248) quanto un’azione insufficiente. Una volta accettato il dialogo – di cui non sono affatto amico – bisogna dargli quel che gli spetta. («Cinema», 37, 10 gennaio 1938, p. 34) Guido S. (Torino) – La rivista mensile «Intercine» fu pubblicata, per un anno solo (1935), dall’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa. «Cinema» ne è una specie di successore. Le Sue idee sul documentario, certamente giustissime, non fanno che confermare quanto fu detto su «Cinema» in varie occasioni. – «Io intendo il cinematografo, quello muto, non come una forma di spettacolo ma di fotografia. Il sonoro ha poi portato un’altra forma di cinematografo: la commedia, il teatro sullo schermo. Il cinema vero non è altro che un miglioramento dell’immagine fotografica e come tale il suo scopo dev’essere essenzialmente quello di vedere: di far vedere. Da ciò la cinematografia documentaria». Io queste affermazioni le formulerei così: «Il cinematografo vero, quello muto, è un genere autoctono di spettacolo, basato sulle capacità espressive e narrative dell’immagine fotografica. Il sonoro ha poi messo il cinema al servizio di una forma spettacolare già esistente: quella della commedia teatrale. Il cinema vero non è che un allargamento dell’immagine fotografica e come tale il suo scopo dev’essere essenzialmente quello di vedere: di far vedere. Onde l’importanza dell’elemento documentario». In complesso dunque siamo d’accordo. («Cinema», 44, 25 aprile 1938, p. 285) Udine M. – Limitare il più possibile il dialogo, a favore dell’azione? Lo chiedono molti, eppure il problema non è tanto semplice. Le domando se un dialogo ridotto a saltuarie battute non sia una cosa altrettanto misera Giovanna Torsi (Genova) – Un diretto predecessore del primo piano l’ho potuto constatare giorni fa nel Dottor Caligari (1919), riproiettato dai bravi studenti del Cine-Guf di Roma. Ogni tanto, alla fine di una scena di mezzo campo lungo si vede restringersi un mascherino circolare intorno alla testa di uno degli interpreti. Non crede Lei che questo procedimento potrebbe darLe la desiderata indicazione sul modo in cui è stato raggiunto storicamente il primo piano? L’effetto è quello dello schermo completamente scuro, ad eccezione di un buco circolare in cui si vede isolata quella testa; esso non è molto soddisfacente perché distrugge la cornice rettangolare del quadro, la quale dovrebbe servire come base costante al succedersi delle varie inquadrature. Ma è interessante notare che, evidentemente, il primo piano è nato non tanto dal desiderio di avvicinare il soggetto quanto da quello di isolare un dettaglio significativo per concentrare l’attenzione su di esso; o che, nell’evoluzione del “linguaggio” cinematografico, l’ingegno umano, prima di decidersi a staccare un attore dalla distanza normale, avvicinandolo appunto in primo piano, è ricorso ad un espediente relativamente complicato come quello dell’iride eccentrica; mezzo che, del resto, permette di isolare un dettaglio senza ingrandirlo, il che oggi non ci è possibile. («Cinema», 48, 25 giugno 1938, p. 427) 262 263 Silvio Pappalardi (Vomero) – Non vi parlo di problemi morali perché so che per voi sono come il panno rosso per il toro. Vi parlo invece di fisiologia. Voi affermate: «La stampa e lo schermo, riproducendo il quadro di dolori, di sventure, portano con sé, quantunque con temperato riflesso, il danno del fatto reale ed influiscono sinistramente sulle funzioni del cuore. Anche il pallore ed il rossore che compaiono repentinamente sul viso del lettore e dello spettatore ci danno chiaro a divedere l’influenza vasodilatatrice o vaso-costrittrice della lettura e della visione di avvenimenti e di concetti fuori dell’ordinario». Ammettiamo che sia così; ma ditemi: non avete anche voi fatto l’esperienza che le avventure della vita reale strapazzano ben maggiormente i nervi del povero cuore che non le occasionali sensazioni provocate dai film? E non c’è da lamentarsene, perché la vita veramente salubre sarebbe quella del sanatorio, presentataci per esempio nell’Orizzonte perduto di Capra. Avreste voi piacere di vivere a Sangri-la? Io no: la vita è consumo. Con ciò non escludo che ci siano abusi dei nostri nervi. Ma nel campo del cinema, la produzione si orienta ormai secondo tutto un complesso di prescrizioni atte a evitare effetti del genere. C’è anzi gente che si lamenta della poca efficacia fisiologica di tanto cinema attuale, che non provoca né pallore né rossore. («Cinema», 52, 25 agosto 1938, p. 135) Rubrica “Scienza e tecnica” Pesci d’aprile. Le meraviglie della tecnica* «Cinema», 18, 25 marzo 1937, pp. 217-219 Il doppiaggio dei film non è da considerarsi una soluzione soddisfacente del problema posto, al cinema parlato, dalla divisione delle lingue. Rappresenta perciò un fatto sensazionale che, poche settimane addietro, i tecnici siano riusciti a costruire una macchina da presa che permette di girare, contemporaneamente alla versione originale, altre cinque versioni straniere! Come si vede dalla fig. 1, la macchina è munita di 6 obbiettivi; quello più grande registra, naturalmente, la versione originale (per esempio quella americana), mentre gli altri registrano le versioni italiana, inglese, tedesca, francese e spagnola. La scena viene recitata da attori, poniamo, americani. In ognuno dei cinque obbiettivi minori si trova un filtro ottico, preparato in modo da lasciar passare soltan* L’articolo è riprodotto nell’Appendice al volume, cfr. infra, pp. 382-384. 264 to quegli elementi che corrispondono alla sensibilità dei rispettivi Paesi. Meccanismo ingegnoso, che se basta per la parte ottica non basta però per la parte sonora, dato che il suono passa attraverso i filtri senza subire modifiche. Infatti, sulle sei pellicole corrispondenti ai sei obbiettivi, si registra l’identica colonna sonora. Chi ha visto una colonna sonora, sa che il diagramma del suono non ha caratteristica di nazionalità: si vede una striscia serpeggiante che non è né italiana, né inglese ecc. Immergendo però queste colonne, diciamo così di nazionalità neutra, in un bagno di sviluppo speciale, si riesce a specificarle nel senso desiderato. Il segreto, debitamente brevettato, sta nell’aggiungere ai bagni di sviluppo certi condimenti di carattere spiccatamente nazionale. Così, per esempio, nello sviluppatore per la versione italiana vien messo il sugo di pomodoro, in quello francese la “bouillabaisse”, in quello inglese il tè, in quello tedesco la birra bavarese, e così via. Ritoccati sui positivi eventuali errori di grammatica o sfumature dialettali, si può passare senz’altro alla proiezione, che risulta perfetta. Un altro progresso tecnico di portata imprevedibile rappresenta la registrazione del film su filo, realizzata da Louis Lumière nelle filande di seta lionesi. È ovvio l’enorme risparmio di materiale e di spazio che si ottiene tessendo su filo le immagini e i suoni, rimpiccioliti mediante una specie di microscopio. Ognuno dei quattro rotoli, rappresentati nella fig. 2, contiene la quarta parte di un film, ossia circa 600 metri. La pellicola vergine passa dai rotoli superiori, attraverso speciali organi di registrazione (pure illustrati dalla figura), ai rotoli inferiori. Il filo negativo va poi sviluppato nel solito modo. Per rendersi conto dell’importanza dell’innovazione, basti sapere che per il montaggio, che ha provocato finora tante polemiche e teorie fra registi ed esteti, basteranno ormai semplici sartine, e che le dimensioni delle macchine da presa e da proiezione si ridurranno ben presto a quelle di una scatola di fiammiferi. In seguito anche le sale di proiezione potrebbero ridursi alle misure di una normale stanza, se si riuscisse a ridurre, proporzionalmente, anche gli spettatori. D’altra parte, la piccolezza delle pellicole può portare degli inconvenienti. Ed è già accaduto che l’ultimo film poliziesco di Charlie Chan non ha potuto essere proiettato in tempo, perché la pellicola era sparita. Lo stesso Charlie Chan svolse le indagini del caso e venne a sapere che il prezioso filo impressionato era stato adoperato, per sbaglio, per cucire un nuovo vestito da sera della moglie del direttore della sala di proiezione. Degno di rilievo è infine il fatto che il materiale del filo viene scelto secondo il carattere dei film. I film di Sternberg, per esempio, si registrano su filo di rayon, mentre per quelli di George Cukor è preferibile il cotone. La Lega della Decenza americana, ben nota per le sue campagne contro i film immorali, ha fatto munire i cinematografi degli Stati Uniti di un dispositivo, chiamato Erotoscopio (fig. 3). Si tratta di un telescopio, irradiante forti raggi ultravioletti e quindi invisibili. Mediante questo strumento, un apposito custode è in grado di scoprire eventuali trasgressioni alla morale 265 che avvengano nel compiacente buio della sala. I colpevoli debbono sborsare, durante l’intervallo, una multa, graduata secondo la gravità della colpa. Ci sia consentita una osservazione storica. Sono state lanciate ultimamente dai giornali notizie sensazionali secondo le quali in un istituto biologico di Pechino sarebbe stato trovato il cosiddetto bacillo cinematografico eccitatore del tifo omonimo. Va rilevato perciò che questa scoperta fu fatta già nel 1913 dal famoso batteriologo Paul Ehrlich (fig. 4). Già allora l’Ehrlich si accorse che nel sangue dei frequentatori delle sale cinematografiche circolava un bacillo, assente nel sangue degli altri uomini. (La fig. 5 lo mostra a destra, in confronto con altri microbi). Con acutezza, egli attribuì all’attività di questo pericoloso animaletto la nuova malattia di cui i sintomi erano un tremolio nervoso e il nottambulismo. Avvenuto il contagio, dopo tre giorni, si verificherebbe la “schermofobia”, forte aborrimento di ogni proiezione cinematografica, la quale dopo altre due settimane di incubazione diventerebbe “schermomania” con conseguente sensibile abbassamento di livello nel portamonete dell’ammalato. La terza fase del male, infine, denominata dall’Ehrlich fase attiva, si manifesterebbe nell’incontenibile desiderio di diventare attore, regista o direttore di produzione. Sulla base di questa scoperta, si sta studiando in quell’istituto pechinese, sovvenzionato dalla Società Internazionale dei Direttori di Teatri di Prosa, un vaccino anticinematografico, di cui basterebbero tre iniezioni agli uomini e diciassette alle donne per rendere completamente immune qualunque individuo dalle infezioni dell’immagine animata. Attraversando, durante un viaggio, il piccolo paese di Gross-Afnam, ne abbiamo voluto intervistare rapidamente il personaggio più illustre, il quale deve la sua fama mondiale appunto al cinematografo. Si tratta della signora Emilia Closupper che vive ancora in quella modesta casa, dalla quale la sua ingegnosa trovata, che le ha fruttato parecchi milioni, ha iniziato la sua corsa trionfale nel mondo. Tutti gli iniziati sanno infatti che Emilia Closupper, negli ultimi anni dell’anteguerra inventò il cosiddetto primo piano che fu materialmente impiegato per la prima volta nella sua vecchissima casa. È appunto da una finestra del famoso “primo piano” di questa casa (fig. 6) che la signora ci guarda mentre ci avviciniamo. Ricevuti gentilmente, sediamo in una poltrona comoda, regalata alla Closupper, per motivi d’ordine pubblicitario, dall’instancabile Cecil B. DeMille. Si impone una prima domanda: «Come mai riusciva la gente a costruire delle case prima della Sua bella invenzione? Mi spiego meglio, signora: come si combinavano nei vecchi tempi il pianterreno coll’attico, non avendosi nessuna cognizione del primo piano?». Emilia Closupper sorride: «Non si tratta tanto di un problema costruttivo, ma piuttosto di un’innovazione terminologica. Ricordo ancora il mio babbo buonanima che diceva: “Di sotto abbiamo la sala da pranzo e la cucina, in mezzo le camere da letto, e sopra ci sono le stanzette delle mie figlie!” – spiegazione che, fin dalla mia più tenera età mi sembrava insufficiente e vaga. Fu una rivelazione quando io, diventata padrona della casa, dissi a due registi cinematografici, saliti da me per fotografare il nostro municipio dalle finestre: Eccoci al primo piano! Allora i due registi – un americano, David Wark Griffith, e un italiano, Piero Fosco – non si presero neanche la briga di realizzare la scena che avevano in programma: partivano sull’istante per concretare nei loro stabilimenti le ispirazioni che avevano ricavato da quella mia semplice frase. Ma siccome in quei tempi i mezzi di trasporto erano lenti, riuscii a far brevettare la mia idea prima che si proiettassero i film Cabiria e Intolerance, in cui il pubblico – per la prima volta nella storia – potè ammirare i “primi piani”». Ella tace per un momento, commossa. «Da quell’epoca mi arrivano continuamente assegni e vaglia postali da tutto il mondo: sono i diritti che le case cinematografiche mi pagano per ogni primo piano realizzato». Sempre più incuriositi domandiamo: «Certamente in seguito Lei avrà avuto contatto con molti personaggi interessanti del cinematografo...». La signora Closupper conferma e aggiunge: «Una volta mi è arrivato un vero pazzo, certo Charles Dreyer, regista del film Giovanna d’Arco che si sforzò di persuadermi che bisognava utilizzare soltanto i primi piani e nient’altro. Soltanto primi piani! Era un’idea che, certo, mi conveniva commercialmente; ma il mio buonsenso subito si rivoltò. Come!.. niente pianterreno... niente secondo piano? Una casa senza portone per entrare e senza tetto quando piove! Era pazzo, vi dico, signorino!». E con questa esclamazione ci ha lasciati. Quante volte è stato detto che il cinematografo è un mezzo meccanico, troppo tecnico per concedere l’opera d’arte! Quanti critici hanno affermato che non è possibile arrivare ad un’unità di concezione e di realizzazione con un numero così grande di collaboratori! Eppure siamo sempre lì: macchina da presa, teatro di posa, esercito di collaboratori... Finché, recentemente, è arrivata in America Simone Simon e si è fatta accomodare il naso. Eliminando quel suo naso dritto, sembra non solo che la Simon abbia dato al suo viso quelle proporzioni anonime che l’intenditore chiama “belle”, ma che abbia anche svincolata in se stessa la potenza creativa di quelle armonie cosmiche a cui dobbiamo l’esistenza di tutto ciò che piace all’occhio e che finora, nel caso della Simon, si era vista ostacolata appunto da quel naso ostinato. Le nuove facoltà occulte della già graziosa e ormai bella attrice furono scoperte per caso. Un giorno, Simone Simon stava seduta davanti alla macchina da presa, studiando il copione di un nuovo film (fig. 7), quando, all’improvviso, la macchina si mise a girare. Sviluppato il negativo, si constatava la fedele registrazione del film quale era indicato dalla sceneggiatura – avvenimento, questo, atto a capovolgere tutti i metodi di produzione e a far contenti gli sceneggiatori che vedrebbero una volta tanto realizzato un film come l’hanno scritto. E l’avvenimento smonta anche le obiezioni degli avversari del cinema come arte, perché la pellicola viene concepita e immediatamente realizzata da un unico artista! C’è poi l’enorme risparmio di personale, di macchine, di tempo... Il film completo si registra entro un’ora e mezza! Ma 266 267 c’è un altro grande vantaggio del sistema: come succede spesso, anche le capacità meta-psichiche della piccola Simone Simon tornano a danno di quelle psichiche, cosicché la sua intelligenza ed il suo gusto corrispondono matematicamente a quella mentalità che si vuol raggiungere nella produzione cinematografica e alla quale spesso, purtroppo, non si arriva, dato che fra tanti collaboratori si trova facilmente qualche elemento impuro. Nell’immaginazione miracolosa della nostra artista, invece, qualunque soggetto cinematografico si materializza precisamente in quella forma che piace al pubblico, specialmente i rifacimenti di film già fatti nel passato e che la Simon rievoca nella sua memoria – ciò che coincide magnificamente con l’attuale tendenza universale di dare una nuova perfezionata realizzazione a famosi film, girati molti anni fa. Guardate, per esempio, come Simone è riuscita a rinnovare le Ragazze in uniforme (fig. 8), film di cui ognuno ricorda il crudo realismo e le stravaganze morali. Guardate come tutto è diventato dolce e pacifico e a che cosa sono ridotte le spiacevoli violenze drammatiche dell’originale: guardate i vestiti di seta bianca e i fiori! Film davvero moderno e virginale, dunque, e che garantisce un successo sicuro. Diremo infine che le registrazioni della Simon riescono perfette, salvo qualche piccola velatura quando passa il direttore di produzione o quando Simon ha fame, oppure qualche leggera deviazione quando le viene in mente una buona storiella o qualche cosa di simile. Ma siccome questi sono gli unici pezzi che occorra tagliare dai film di Simone Simon, il sistema rimane sempre molto conveniente. Quando un campo dell’attività umana si trova ancora in quello stato di caos, in cui le acque non sono ancora separate dalla terraferma, c’è sempre pericolo che l’Uomo, desideroso di un ordine definitivo, tenti di anticipare la Creazione, fissandosi su certi concetti, o preconcetti, nella persuasione di aver già trovato la soluzione. Questi prematuri vincoli dogmatici minacciano la libertà dell’evoluzione e degli indirizzi anche nel cinema a colori; e può esser perciò utile che qualcuno, con violenza tempestosa, si opponga a certe tesi, già più o meno accettate, anche se tali interventi siano il più spesso scarsi di elementi positivi e poco chiari nell’esposizione. Ultimamente abbiamo letto alcuni scritti, in parte pubblicati da «Origini» di Antonio Laforet, pittore ed ex-operatore di prese a colori naturali per la Casa Gaumont di Parigi. Il Laforet ha girato film a colori quando noialtri appena cominciavamo a capire il bianconero, e il caso suo è quello dell’esperto che sente, con preciso senso pratico ed artistico, ciò che si dovrebbe fare, ma che, d’altra parte, è troppo lontano dalle cognizioni teorico-scientifiche per poter difendere, con ragioni che reggano, le sue giuste simpatie ed antipatie. Ma vale la pena di accennare ad alcuni dei suoi punti di vista appunto per la violenta spontaneità con cui in essi erompe la voce del buon senso in contrasto con gli errori commessi da altri, dotati di minor istinto naturale e di meno esperienze pratiche, e anche per discutere alcune delle sue ipotesi che potrebbero – anziché chiarire – confondere ancor gli spiriti già piuttosto disorientati. Sostengono molti che la colpa dei risultati poco convincenti sia tutta dei sistemi tecnici. Dice il Laforet, al contrario, che il sistema ideale c’è già, e che il difetto sta unicamente nell’applicazione. Evidentemente, in senso negativo, hanno ragione tutt’e due le parti. La tecnica, oggigiorno, non ci dà ancora i colori naturali, né sappiamo affatto quale sistema avrà il sopravvento. Ci troviamo nella stessa fase in cui, nel caso del sonoro, non si sapeva decidersi fra registrazione su disco e colonna sonora. «Se coloro che da più di trent’anni crearono per primi il procedimento addittivo avessero potuto intuire dove veramente risiedeva la vera grande difficoltà del cinema a colori, è più che certo che il procedimento sottrattivo – venuto dopo – non sarebbe neanche mai nato». Ecco un’affermazione del Laforet assai audace, dato che quando nacque il cinematografo nel 1895 (ossia non trenta, ma più di quaranta anni fa), tanto il sistema addittivo quanto il sottrattivo, creati a pochi anni di distanza l’uno dall’altro, si sviluppavano già da tre decenni pacificamente l’uno accanto all’altro. Infatti, l’esperimento del Maxwell davanti alla Royal Institution, dove mostrò per la prima volta una proiezione tricromica addittiva, è del 1861, mentre l’invenzione del metodo sottrattivo, dovuta a Ducos du Hauron e a Charles Cross, risale al 1868. E non si può neanche dire che il sistema sottrattivo sia da scartare perché «il vero cinema a colori deve essere e sarà – giacché lo può già essere – colore e non colorazione», alludendosi evidentemente al fatto che la pellicola positiva sottrattiva è colorata, mentre quella addittiva è monocroma. Neanche i colori della proiezione addittiva sono “naturali”; sono creati da filtri colorati, e se questo può essere un vantaggio tecnico di grado, non forma certamente una differenza di principio. (Molti meriti si attribuiscono attualmente al sistema addittivo; ma ci sembra che questo, con le sue ottiche complicate e le sue pellicole lenticolate, non abbia ancora quella elegante e schiacciante semplicità che è propria delle soluzioni definitive e che troviamo maggiormente negli attuali sistemi sottrattivi!). Ma lasciando da parte i problemi della pura e semplice registrazione, ci troviamo subito davanti a un fatto al quale potrebbero riferirsi certe giuste obiezioni del Laforet. I tecnici sembrano ancora troppo attaccati al sistema di esaminare la fedeltà della registrazione, confrontando semplicemente per esempio, la lunghezza d’onda dei colori riprodotti con quella dei colori reali, senza pensare che le condizioni psicofisiologiche, nelle quali avviene la proiezione, sono completamente diverse da quelle in cui 268 269 Le leggi del colore «Cinema», 29, 10 settembre 1937, pp. 170-171 osserviamo un soggetto all’aperto. L’ambiente scuro, il taglio dell’immagine, l’ingrandimento e altri fattori fanno sì che colori “giusti” nel senso della lunghezza d’onda sembrino falsi, troppo forti, nella proiezione. Gli effetti del contrasto cromatico sono stati studiati dai fisiologi e formulati in leggi, che è bene conoscere. Tuttavia basta anche l’esperienza pratica di un occhio sensibile per arrivare a tener conto di tali fattori, dal momento che si tratta di dati sensori e artistici, i quali possono essere verificati direttamente ed empiricamente, ossia senza il concorso di conoscenze teoriche. Ecco secondo noi un errore di Laforet, che, come tanti uomini venuti dalla pratica, è troppo posseduto da un rispetto riverenziale per le norme scientifiche. «Senza la perfetta conoscenza delle leggi fisiche dei colori, nessuno saprà né potrà mai fare della cinematografia a colori naturali, qualunque sia la macchina da presa o il procedimento, presenti o futuri». Prima di tutto bisogna chiarire che cosa è fisico e che cosa non lo è. Perché se leggiamo che come «un suono emesso da un violino può fare vibrare una lastra di vetro a distanza, così un colore può far vibrare o anche distruggere un altro colore, vicino o lontano», vediamo subito che qui un fatto estetico, basato su fenomeni psicofisiologici – la cui esistenza non si discute – è attribuito al campo delle onde fisiche, mentre si tratta di pura analogia lirica. Ma non regge neanche il caso dei colori complementari o quello delle caratteristiche fisiche dei suoni. I colori complementari si possono definire fisicamente, ma non risulta da questa definizione una regola per l’applicazione artistica di essi. Le lunghezze d’onda corrispondenti ai suoni stanno fra di loro in certi rapporti aritmetici, ma è inutile dire che «è per legge fisica e non estetica, se due note musicali vanno d’accordo con una terza invece che con qualche altra nota» perché basta ricordare che ci sono tante gamme musicali quante epoche e popoli – con evidenti conseguenze per l’applicazione dei concetti di armonia e disarmonia – e che nessun fatto fisico può aiutarci a spiegare perché la musica di tanti popoli antichi si basi su una gamma di cinque elementi senza semitoni, fondamentalmente diversa da quella nostra attuale, o perché a Giava si ripartisca l’ottava in cinque parti uguali o perché in Giappone ogni classe sociale abbia la sua gamma musicale propria – per non citare che alcuni semplici esempi casuali. È vero che teoricamente, di ogni fenomeno si può determinare lo stimolo fisico e che ad ogni rapporto “fenomenico” deve corrispondere un rapporto fisico. È vero anche che in certi casi elementari l’effetto estetico si può definire con termini quasi matematici (ciò che vale specialmente anche fuori del campo della fisica, per le caratteristiche geometriche delle forme ottiche: cerchio, quadrato, “sezione aurea” ecc.), e vogliamo perfino ammettere che nel senso di una speculazione astratta una tale possibilità di definizioni esattamente scientifiche, possa anche esistere nei confronti di vere e proprie opere d’arte. Ma questa affermazione non ha nessun valore per la pratica – di cui unicamente stiamo parlando – dato che la complicatezza del sistema, provocherebbe difficoltà insuperabili fin nelle opere più semplici (e dato che sarebbe una fatica perfettamente inutile). Gli effetti dell’arte si spiegano, in modo approssimativo, con le leggi estetiche, che si occupano dei fenomeni e non degli stimoli fisici; e per l’attività creatrice, poi, non sono indispensabili neanche queste. Vorremmo dimostrare ancora con un esempio come anche in materia di colori sembri difficile dedurre dai dati fisici le basi della visione psicologica ed estetica. Le otto tinte indicate da Wilhelm Ostwald come gli elementi del cerchio cromatico hanno all’incirca le seguenti lunghezze d’onda (in milionesimi di millimetri): 660, 600, 570, 530, 490, 480, 440, 420 – serie in cui non riusciamo a trovare alcuna regolarità. Ma lasciando da parte la fisica, è ben noto come anche nel campo della pittura questa non abbia potuto crearsi un sistema di regole estetiche come la musica, dato che non costruisce le sue opere con elementi ben definibili: il brano musicale anche più complesso si compone tuttavia di suoni di determinata altezza, acutezza e lunghezza; la pittura invece si serve di gamme continue di colori, e né le sagome, né le aree delle forme sono sottoposte a misure fisse. Sono rimasti senza importanza i tentativi di creare “canoni” matematici per le proporzioni ideali del quadro, del corpo umano ecc., e sono falliti tutti i sistemi di armonia cromatica. (I dipinti con cui l’Ostwald, ideatore del più recente e completo sistema, volle dimostrare il valore delle sue teorie, erano tutt’altro che belli). Intanto i grandi pittori di tutte le epoche, a creare delle opere, delle quali possiamo pur contentarci, si sono serviti unicamente di ciò che, in mancanza di un termine meno equivoco, dobbiamo chiamare il “sentimento artistico”. E non c’è ragione perché nel cinema a colori le cose debbano andare diversamente. Nessuno nega che ci siano regole e trucchi di mestiere, utilissimi e non di natura estetica, come per esempio, in pittura quanto riguarda la preparazione e l’uso delle materie coloranti, o che, per esempio, lo studio dell’anatomia non sia di grande valore. L’addestramento dell’artista facilita enormemente la sua formazione. Ma è anche noto che ciò che si impara negli studi e nelle accademie non consiste tanto in regole o addirittura in “leggi” quanto – e specie se il maestro è valoroso – più che altro in un allenamento dell’occhio e della mano. Se Antonio Laforet si fosse contentato di dire quello che in fondo vuol dire, ossia che senza molta sensibilità ed esperienza artistica non creeranno bei film a colori nemmeno i sistemi tecnici più perfetti e che gli attuali film a colori sono brutti per colpa non tanto del Technicolor ma di quelli che lo adoperano, avrebbe pronunciato una parola decisiva sulla presente situazione della cromocinematografia! Anche noi in «Cinema» abbiamo affermato, tempo fa, che certe tinte sullo schermo risultano false e violente probabilmente non per ragioni tecniche ma perché fra i singoli colori non esisteva nessun rapporto artistico a legarli e fonderli; e che gli stessi effetti brutti e violenti si notano già sul vetro smerigliato della macchina fotografica (che ci offre colori naturali). Ha ragione Laforet quando gli sfugge, suo malgrado, la frase: «Il male è 270 271 Siamo ormai talmente abituati a veder registrati tutti gli avvenimenti, grandi e piccoli, della nostra vita mediante un semplice e rapido scatto di una macchinetta comoda, che ci riesce difficile immaginare quale rivelazione e capovolgimento ha rappresentato, un secolo fa, l’invenzione della fotografia. I ventiquattro anni che Louis Jacques Mandé Daguerre spese per ottenere qualcuna di quelle piccole immagini quasi invisibili, davvero non sono stati scarsi di momenti drammatici, eroici, di disperazione, di sacrificio e di gioioso orgoglio; e lo stesso si può dire di Joseph Nicéphore Niépce, che per quattordici anni è stato il fedele collaboratore di Daguerre e morì, nel 1828, senza aver goduto il frutto di tante fatiche. Bastano i fatti, puri e semplici, per rendere emozionante la lettura dei primi capitoli di una qualunque storia della fotografia. Tuttavia non possediamo, per quanto sappiamo, una autentica e dettagliata descrizione di quello che sono stati, in materia di fotografia, gli ambienti e gli avvenimenti di quegli anni, per quanto riguarda i due protagonisti: gli inventori Daguerre e Niépce. Invece, un caso fortunato ha voluto che il primo pioniere della fotografia in Germania abbia raccontato le sue esperienze a uno dei suoi figli che in seguito diventò uno degli scrittori tedeschi più noti di qualche decennio fa. Basta infatti sfogliare il libro Der Geist meines Vaters (Lo spirito di mio padre) di Max Dauthendey – pubblicato nel 1912 dall’editore Albert Langen di Monaco di Baviera – per trovare delle pagine che con evidente autenticità ci rievocano le strane emozioni di quei giorni, in cui la fotografia sembrava ancora magia o almeno una truffa. Dopo che, nel 1839, la prima memoria sulla nuova invenzione era stata consegnata all’Accademia di Francia, dovevano passare due anni, avanti che la prima “camera” con le lastre sensibili e con l’indicazione scritta dell’uso giungesse in Germania e precisamente all’Istituto ottico di Taubert a Lindenau presso Lipsia. Un giorno, in quell’Istituto si presentò un commesso francese il quale presentò una strana macchina, chiamata camera oscura, con la quale egli affermava che sarebbe stato possibile ottenere meccanicamente il ritratto di qualsiasi persona. Come prova, il commesso fece vedere alcune lastre che, osservate con molta attenzione, mostravano tali immagini, in un grigio debolissimo. Per otto giorni, il direttore dell’Istituto e i suoi principali collaboratori girarono intorno alla scatola magica. Dopo qualche esperimento superficiale e rimasto senza risultato, il vecchio esperto fece sapere al pubblico che si trattava di una “truffa parigina” senza il minimo valore pratico, ideata per rubare i soldi a qualche ingenuo. Proprio in quelle settimane della primavera 1841 lavorava però nell’Istituto Taubert un tecnico ventunenne, impiegato per mettere a punto strumenti ottici, il quale, affascinato dalla nuova macchina, non si dette pace finché non ottenne da un suo zio un prestito di 300 talleri, necessari per comperare la camera oscura dal suo padrone. Deriso e preso in giro da tutti i suoi colleghi, il giovane Karl Dauthendey pagò l’enorme somma e si portò a casa l’apparecchio di Daguerre. Doveva aspettare con ansia le ore libere della domenica per cominciare i suoi esperimenti; ma prima di tutto doveva cambiare casa per trovare un posto sufficientemente illuminato dal sole. Una vedova gli offrì una casetta in un orto, il quale diventò la scena degli esperimenti di Dauthendey. Esperimenti lunghi e quasi disperati, durante i quali il giovane pioniere aveva spesso la voglia di buttare la macchina in un angolo, come aveva fatto il suo padrone. Ma non volendo dare ai colleghi la soddisfazione del suo fallimento, né disilludere lo zio che gli aveva affidato la forte somma di denaro, si sforzò di continuare, malgrado non ci fosse nessuno che gli potesse dire perché la massima cura ed attenzione non bastasse ad ottenere sulle lastre a mercurio quei magici ritratti. Il ragazzo del giardiniere e la proprietaria della casa, “infettati” dal fanatismo di Dauthendey, non si lasciavano spaventare né dal bruciare del sole né dai pizzichi delle zanzare: sedevano fermi davanti alla camera per delle ore intere e consolavano il povero sperimentatore quando i diversi tentativi fallivano. Le indicazioni che accompagnavano la macchina erano scarsissime. Per fare un ritratto – dicevano – bisognava porre la persona, illuminata dalla piena luce solare, davanti alla macchina. Avendo regolato le lenti in modo che sul vetro smerigliato si formasse un’immagine nitida, e avendo sostituito il vetro con la lastra sensibile, la si esponeva un’ora o anche due – secondo l’illuminazione – per “affumicarla” poi, in camera oscura, nei vapori di mercurio. Durata di questo processo di sviluppo: da sperimentarsi. A Parigi esistevano in quell’anno, in tutto, circa dieci dagherrotipie, e il commesso che offrì la macchina in Germania avrà portato al massimo due dei preziosi saggi. Nessuno dunque in Germania possedeva la prova materiale che la nuova invenzione non era una truffa; e i giornali non soltanto ammonivano pubblicamente di non lasciarsi ingannare dal trucco, ma facevano anche obiezioni di carattere morale. Secondo un articolo del «Leipziger Stadtanzeiger», il voler fissare le fugaci immagini che appaiono nello spec- 272 273 che lo scoglio fatale per tutta questa gente sta appunto nei loro occhi». Ma gli occhi, pur obbedendo a certe leggi, non ne conoscono nessuna, e ciò che difetta al cinema a colori non sono le leggi, ma piuttosto il più gran numero possibile di uomini che dispongono dell’esperienza e – non ne dubitiamo – della sensibilità artistica dell’ex-operatore di Gaumont. Rubrica “Fotografia” Memorie della camera oscura «Cinema», 36, 25 dicembre 1937, pp. 433-435 chio rappresentava addirittura un’eresia. «L’uomo creato secondo l’immagine di Dio non può essere fissato come immagine da una macchina fatta dall’uomo». Se mai, un artista geniale, ispirato dalla divinità, poteva osare di riprodurre i tratti umano-divini, senza alcun aiuto di macchine. Ma voler sostituire il genio con una macchina nata dal calcolo, significava pretendere di voler imitare la Creazione. È vero, continuava il giornale, che Dio finora aveva tollerato lo specchio, giocattolo del diavolo; ma probabilmente soltanto perché le donne potessero leggere sul proprio viso i loro pensieri sciocchi e pretenziosi. Ma l’umanità si abbandonerebbe certamente a una terribile vanità se ognuno potesse farsi fare dozzine di suoi ritratti per qualche soldo. Del resto, concludeva l’articolo, se fosse possibile quello che pretendeva il signor Daguerre, ciò sarebbe stato ottenuto senza dubbio fin dall’antichità da importanti uomini come Archimede o Mosè. Ecco quel che il giovane Dauthendey trovava sul giornale, quando la mattina si recò, come al solito, all’Istituto ottico per compiere il suo regolare lavoro. Le ironie dei colleghi erano difficili da sopportare; inoltre, fu necessario chiedere un altro prestito allo zio per poter pagare la pigione e per continuare gli esperimenti. Ma Karl Dauthendey continuò senza disperare. Gli abitanti del quartiere ormai conoscevano il giovanotto che, soprattutto la domenica, si occupava, nel giardino, della sua strana scatola, appoggiata su tre gambe di legno e munita da un breve tubo metallico, che sembrava un piccolo cannone. A distanza di dieci o venti passi dallo strano apparecchio erano sedute delle persone che, con occhi immobili, lo guardavano. Era evidente che fra queste persone e l’apparecchio doveva esistere un rapporto; ma quale? I postiglioni che la mattina e la sera passavano regolarmente, rallentavano il passo per additare con la frusta ai loro viaggiatori il misterioso stregone che spesso nascondeva perfino la testa sotto un panno nero che copriva la parte posteriore della macchina. I ragazzi, che durante tutta la domenica non abbandonavano lo steccato del giardino, tenevano le dita nelle orecchie perché si aspettavano ogni momento un colpo da quel tubo di metallo. E bastava che Dauthendey apparisse dal di sotto di quel suo panno nero perché i bambini, con strilli di paura, si dessero alla fuga. Gli adulti si sfogavano nelle teorie più strambe. Ritenevano che Dauthendey volesse intercettare la luce solare per trasformarla in oro; oppure che l’apparecchio avesse un’influenza magnetica o elettrica, utile per guarire certe malattie. Infatti, una mattina, si presentò nella sua carrozzina un uomo paralizzato che si dichiarava pronto a restare delle ore davanti all’apparecchio perché le lenti potessero raccogliere la luce benefica. Ancora: essendo l’estate molto calda e secca, si dava la colpa alla “camera” che probabilmente attirava troppi raggi solari; e così via. Ma un giorno – e Dauthendey lo considerò il giorno più bello della sua vita – si mostrò sulla lastra a mercurio un triangoletto nitidissimo. Non riuscì subito a spiegarselo, finché poi vi riconobbe il petto della camicia del giardiniere, registrato dallo strato sensibile perché era il punto più chiaro del soggetto. Ecco, finalmente, la prova che era possibile fissare la realtà, e fosse pure il pezzo più modesto di essa! La macchina, dunque, non era una truffa! Bastava determinare con la massima precisione il tempo di esposizione; studiare bene le mescolanze delle materie chimiche, l’influenza del calore dei liquidi, quella dell’umidità dell’aria sulle lastre ecc. Dauthendey abbracciò il giardiniere e ballò con la vedova nei sentieri del giardino. Incoraggiato, ripeteva sempre di nuovo i suoi tentativi, e venne il giorno in cui una servetta col suo soldato, che Dauthendey aveva pregati di entrare e di servire come soggetti, apparvero sulla lastra in figura completa. Fu la prima dagherrotipia tedesca. Le dimensioni delle immagini non superavano quelle di un biglietto da visita. Ma vi si vedevano degli uomini nani, riprodotti con la massima fedeltà, con tutti i dettagli delle rughe, delle pieghe, dei bottoni. Le innumerevoli foglie degli alberi erano rese una per una. Era da meravigliarsi che le persone non si mettessero in moto, non parlassero, non uscissero dal quadro. Dauthendey non osava guardarle per troppo tempo, perché sembrava che quei nanetti, di naturalezza perfetta guardavano colui che li guardava. Non molti anni dopo, nello studio di Karl Dauthendey, che si era trasferito a Pietroburgo, si presentò la generalessa Buturlina ordinando al fotografo un album in cui fossero riuniti i ritratti di tutte le persone della corte dello zar Nicola, di cui la Buturlina era l’amante. Dall’ambiente di corte, la fotografia presto si diffuse anche in quello borghese. Dopo una accanita lotta di artisti intellettuali contro la nuova tecnica, la quale era considerata come una nemica dell’arte e della cultura, alcuni grandi artisti fotografi riuscivano a conquistare alla fotografia la stima che le spettava. Il medico Félix Tournachon di Lione abbandonò la professione per esercitare a Parigi l’arte fotografica servendosi del soprannome di Nadar. Al Nadar dobbiamo quadri di straordinaria sensibilità artistica. Egli non si limitava a fare ritratti, ma produceva anche fotografie che oggi si definirebbero riportaggi. Il più grande artista, però, che fino ad oggi non è stato raggiunto da nessun altro fotografo, fu David Octavius Hill, pittore scozzese, che con grande gusto e con un bellissimo senso delle inquadrature armoniche e degli atteggiamenti artistici, creò ritratti preziosi, fra i quali molti di famosi scienziati e artisti dell’Ottocento. 274 275 Esame di coscienza «Cinema», 44, 25 aprile 1938, pp. 289-290 Ogni volta che arrivano dai vari paesi i lussuosi almanacchi che fanno passare in rivista la produzione fotografica dell’annata, il fotografo dovrebbe compiere una specie di esame di coscienza, analogo a quello a cui l’uomo comune può sentirsi indotto nella notte di San Silvestro o il giorno del suo genetliaco. A che punto stiamo? Quali risultati sono stati ottenuti? C’è o ci può essere un progresso? Quali sono le mete da raggiungersi e quali i limiti naturali non superabili? Per rispondere a queste domande non ci può essere materiale più bello e completo di quello offerto dal Photography Year Book del 1938 pubblicato a cura di T. Korda dalla Cosmopolitan Press di Londra. Ci troviamo davanti a più di mille fotografie, scelte con la massima cura dalla produzione mondiale del 1937 e stampate magnificamente su 320 pagine di carta lucida. Inoltre, in un centinaio di pagine di carta scadente di giornale sono presentate le fotografie pubblicitarie tolte dalla stampa quotidiana. Meno perfetto e meno vasto è l’almanacco Modern Photography 1937-38 diretto da C. G. Holme e pubblicato da The Studio di Londra, ma è completato da elementi utili che mancano a quello citato prima: denominazione del soggetto, dati tecnici delle fotografie riprodotte, cenni sui fotografi collaboratori, un indice che raggruppa le fotografie secondo i paesi di provenienza e, infine, una dozzina di tavole a colori – terribili, ma appunto per questo molto istruttive. Nella fedele riproduzione del nostro mondo, la fotografia monocroma è arrivata a una perfezione difficilmente superabile. Basta guardare la sorprendente e istruttiva bellezza delle prese scientifiche che presentano, e nello stesso tempo interpretano, per esempio, il movimento reso rigido – mediante un’istantanea di un centomillesimo di secondo – della superficie di un liquido su cui cade una goccia, oppure l’immagine microscopica del cuore di un pollo, la testa di una zanzara, le particelle cristalline della polvere. D’altra parte, la tecnica fotografica permette ormai di smaterializzare gli oggetti reali fino a farli divenire una specie di pura materia fotografica: una testa femminile, ben truccata, illuminata con raffinatezza, purificata da ogni elemento casuale e, diciamo, fisiologico mediante i trucchi magici della stampa e del ritocco, stilizzata magari da uno dei nuovi procedimenti come quello che trasforma ogni contorno in linea nera, sembra veramente più creazione della fantasia artistica che non riproduzione di un prodotto di madre natura. È appunto fra questi due punti limite, fra materia reale e materia artistica, che il fotografo, come ogni altro artista, deve trovare la “sua” soluzione. Ogni possibile fotografia trova il suo posto in una gamma che va dall’istantanea fulminea che, senza pretese e possibilità di inquadratura ponderata, fissa la rara curiosità di un uomo mentre salta dall’aeroplano o di un serpente mentre inghiottisce un coniglio, fino alle studiatissime composizioni preparate con pazienza sotto le lampade dello studio. Qual è la differenza essenziale fra pittura e fotografia, ossia fra l’immagine creata dall’uomo e quella fissata meccanicamente dall’obbiettivo e dalla emulsione? Probabilmente questa: che la pittura partendo dalla materia artistica vuole avvicinarsi soltanto fino ad un certo punto a quella reale, mentre al contrario la fotografia parte dalla riproduzione della materia reale e trova quindi la sua base naturale in essa anche quando la trasfigura. Ecco perché un genere fondamentale di fotografie rimane quello che ci presenta l’autentica struttura delle cose vere con tutti gli elementi casuali, superficiali ma tuttavia caratteristici: il maglione stracciato di un vecchio pescatore, una gamba nuda con sottile peluria abbandonata su una stuoia di paglia fino a raggiungere l’erba schiacciata dal peso del corpo umano. L’ebbrezza della verità documentaria, per cui l’occhio si avvicina alle cose umili fino a escogitarne i dettagli quasi microscopici, porta all’estremo quella che era la fatica di certi pittori olandesi e tedeschi i quali copiavano con esattezza fanatica le venature di una foglia o le rughe di un viso senile. Da anni vediamo tante di queste fotografie e non ne siamo ancora sazi. Perché? Probabilmente perché la ricchezza dei dettagli naturali è inesauribile. Non lo è però la loro particolare espressione. E perciò un giorno ne saremo stanchi. Potrebbe sembrare facile eseguire questo tipo di fotografia ed è invece molto arduo. A parte il compito quasi puramente tecnico ma duro di rendere nitidamente la struttura della superficie, c’è anche la necessità di presentare gli oggetti veri in atteggiamenti che non sembrino preparati apposta ma che pure siano caratteristici in un senso universale. Le possibilità creative del fotografo documentarista quasi si risolvono nella scelta del momento e del punto di presa buoni, scelta che normalmente acquista il sapore sportivo di una caccia affannosa e emozionante. Dovendo evitare la poca naturalezza, il documentarista si appoggia su tutto quanto non è devastato dalla coscienza umana: sugli oggetti inanimati, sulle bestie, sugli inconsapevoli bambini, sulle persone semplici e forti, che non si confondono davanti all’obbiettivo. La vera difficoltà comincia di fronte all’uomo cosciente e al soggetto raggruppato consapevolmente. Onde l’invasione di paesaggi suggestivi, di bambini ridenti, di vecchi contadini che fumano la pipa: autentica materia fotografica, ormai però spesso meccanizzata fino a diventare vuota convenzione. Di qui la rarità di ritratti veramente riusciti e di nature morte non convenzionali. Sfogliando gli almanacchi, ci si accorge che non tutti i soggetti sono ugualmente graditi ai nostri documentaristi. Prevale un genere, diciamo, nostalgico: la natura bella o anche cruda ma sempre fresca, l’aria buona, il sole caldo e chiaro, la purezza ingenua. Non crediamo che sia per colpa degli editori se così poche fotografie ci riportano i monotoni grigi della vita industrializzata, le durezze delle grandi città e inoltre tutto quello che potrebbero essere le attualità del giorno, i riflessi visivi dei problemi nostri. Nella pittura, una simile serenità bucolica può essere, fino ad un certo punto, giustificata dal carattere specifico di questa arte. Ma nella fotografia, arte riproduttiva e descrittiva per eccellenza, la fuga dalle manifestazioni della nostra vita moderna riesce un po’ penosa. La fotografia parte, dicevamo, da una riproduzione meccanica della materia reale. Ecco perché è così difficile presentare fotograficamente oggetti o pose che non si incontrano nella vita. Per dimostrare questo, non occorre nemmeno citare casi estremi come certi buffi quadri foto- 276 277 grafici in cui si vede lo scheletro della morte alzare la clessidra sopra il globo terrestre. Errori di questo genere sono ormai diventati rari. Ma si pensi, per esempio, alle difficoltà artistiche che nascono ogni giorno quando si tratta di fotografare attori mentre recitano. La finzione, accettata se proviene dal palcoscenico, risulta troppo spesso ridicola nella fotografia, se la consideriamo rappresentazione della vita reale. Ancora più significativo è forse il problema del corpo nudo. Il nudo è la prova superiore di un buon fotografo, perché si tratta di spiegare forme complicate quasi esclusivamente coll’aiuto di luce e di ombre: la pelle liscia, le forme dolcemente arrotondate offrono pochissimi dettagli strutturali che potrebbero servire come punti di orientamento. E allora molte fotografie del genere risultano poco soddisfacenti. Non solo, ma anche strane e ridicole; e questo appunto perché nella vita reale il corpo nudo non appare sovente. L’aspetto di una polinesiana al bagno potrà risultare piacevolmente naturale ma le spiagge o gli interni e anche i visi troppo personali delle nostre modelle danno alle fotografie del genere uno strano sapore di nudismo come soggetti analoghi non lo avrebbero mai nella pittura. Ecco perché fra tutti i nudi riportati dal Photography Year Book ci sembra meglio riuscito quello che, davanti a sfondo vuoto e con la testa e le gambe fuori campo, appare come un torso astratto. Per le fotografie di moda, la situazione è analoga: la posa affettata e raffinata delle indossatrici parigine non stona affatto se la tecnica fotografica riesce a togliere al soggetto ogni materialità e ad ambientarlo in maniera analoga, magari con un insieme di “alberi” e “monti” evidentemente fatti con cubi di cartapesta e lunghi nastri di carta. Mentre i sorrisi, i gesti convenzionali e i costumi troppo stirati diventano ridicoli se hanno per sfondo sabbia vera e nuvole autentiche. Opportunamente stilizzati, dunque, anche i motivi non veristici possono dare effetti persuasivi. Ma rimangono sempre eccezioni. La formula più felice della fotografia ci sembra sempre quella di portare su un livello formale superiore il soggetto documentario, cioè non preparato. In questo senso ci persuade molto il ritratto di due parigine sfocato fino a sopprimere ogni concretezza: ma come attraverso un velo brillano due paia di pupille scure agli angoli degli occhi, cadono sulle fronti alcune matassine di capelli neri, si rizzano i peli di una pelliccetta chiara; oppure una barca a remi sul mare notturno, fotografia in cui l’acqua è trasformata in un gioco di cerchietti chiari su sfondo nero e la barca con i nove rematori diventata quasi un merletto nero. Tutto questo senza che la scena perda il suo carattere naturale. Invece non servono né le fotografie realistiche e soltanto realistiche in cui l’occhio dello spettatore erra senza la guida di un qualunque motivo formale, né quelle pittoriche e flou o quelle a silhouette in cui è scomparsa l’immediatezza della superficie e assente, d’altra parte, ogni precisa composizione e invenzione formale. Sta per tramontare definitivamente quel certo formalismo estetizzante che si sfogava in inquadrature sforzate, angolazioni nauseatiche, om- bre decorative e deformazioni prospettiche. La forma ormai è allo stretto servizio del soggetto. Si è formato un ottimo mestiere portato avanti in tutti i paesi da bravi fotografi che si mantengono su un livello medio, sicuri di non più cadere negli abissi del dilettantismo e del cattivo gusto, ma d’altra parte impediti, evidentemente dal carattere stesso dello strumento di cui si servono, a raggiungere la grande arte. Sembra ormai provato che la fotografia non è un mezzo adatto per la manifestazione del genio e che i magnifici ritratti del grande ottocentista Hill rappresentano il massimo di quanto si possa ottenere con una tecnica vincolata sempre alla riproduzione meccanica. Ma non per questo perderemo il gusto delle immagini tracciate dalla luce, immagini armoniose, suggestive e istruttive. Oggigiorno non c’è più chi vorrebbe sottrarsi al fascino dell’orbis pictus fotografico, come presentato dagli almanacchi. Concludiamo dicendo che nel Photography Year Book sono anche considerati gli ultimi progressi: la telefotografia, quella a luce polarizzata, le fotografie a serie, i fotocartelloni, e che la parte pubblicitaria offre allo specialista in materia tante idee da rubare quanto basta per compensare tre volte il prezzo del bel volume. 278 279 Rubrica “Bianco e Nero” Vigilia d’armi «Cinema», 14, 25 gennaio 1937, p. 69 Certo nelle precedenti edizioni cinematografiche del romanzo di Claude Farrère (una delle quali di Korda) non era stata raggiunta una drammaticità così intensa come nel film che Marcel l’Herbier ha diretto. È interessante notare che l’esperienza d’avanguardia del regista francese è applicata ad un film industrialmente concepito e che vuole riuscire uno spettacolo gradito ad ogni categoria di pubblico; per raggiungere tale risultato l’Herbier si è valso di un procedimento serrato di racconto visivo, di una buona dosatura di effetti di dettaglio, e soprattutto di un complesso bene affiatato di interpreti; in primo luogo Annabella, che raggiunge nel personaggio della moglie del capitano le più sottili e delicate espressioni: l’ansia, il turbamento, l’affettuoso trasporto verso il marito, il contenuto dolore, sono sentimenti estrinsecati in una gamma di atteggiamenti che portano l’attrice ad una assoluta comunicativa; Victor Francen è altrettanto sobrio e convincente; gli altri, come l’austero e ad un tempo bonario Signoret, il cinico Pierre Renoir, i giovani Vidalin e Toutain formano un buon complesso. La fotografia di Kruger è nelle scene notturne, efficace: in quelle scene dove il nodo drammatico ha il suo punto culminante, per svilupparsi in fine nella scena del processo che costituisce il pezzo forte del film, in cui tutti i collaboratori, dal regista allo sceneggiatore, agli interpreti, sono impegnati a fondo, per far accettare la situazione dopo averla preparata sottilmente, e riuscire a convincere lo spettatore; in questa sequenza ogni primo piano e ogni campo di presa sono, l’uno con l’altro, messi in giusto rapporto. Come già aveva dimostrato con le rudi vicende della Bandera, il cinema francese “industriale ricco” ribadisce con Vigilia d’armi la sua disposizione tecnica e narrativa per le storie ansiose e combattute. Senza mezzi termini, arrivando allo scopo con un racconto serrato e calibrato in tutte le sue parti, qui il regista mette a fuoco i caratteri dei personaggi e i particolari della trama con una chiarezza e una semplicità che sono indici di un mestiere antico e molto agguerrito. È arrivata la felicità «Cinema», 14, 25 gennaio 1937, pp. 69-70 candido e dolce signor Deeds. Gary Cooper, non occorre aggiungerlo, è un ineffabile Deeds. Voglio essere amata «Cinema», 14, 25 gennaio 1937, p. 70 Mi piace la rude semplicità con cui la segretaria si mette a far repulisti in quella stalla di Augia, rendendo così evidente che non tutto ciò che si svolge fra pareti coperte di gobelins preziosi è degno d’essere rispettato e imitato. Fra tanti dialoghi stagnanti, risultano graditi al pubblico i coraggiosi colpi di spazzola e di mattoni dati alla figlia viziata e alla vetrina del magazzino. Claudette Colbert si dimostra più intelligente e risoluta di quel che parrebbe sulle prime. Mi piacciono le scintille fredde negli occhi della bambina quando essa lancia, a tavola, le sue battute scortesi, e anche i ruggiti del “leone affamato” tratti dalla canzone: Parlez-moi d’amour! resa cara a tutti i tifosi del grammofono dalla cantante Lucienne Boyer. L’imperatore della California Frank Capra un tempo pareva avviato a raccontarci biografie (femminili, più spesso che maschili) dense di fatti sofferti e ricche di combattimento. Poi aveva composto alcuni “divertimenti” pieni di garbo e di umore, ma pacifici com’è pacifica la sicura noncuranza di Gable e bonari com’è bonario Walter Connolly (al contrario: prima, Barbara Stanwyck aveva sempre molte domande negli occhi e molti ostacoli da vincere sul suo cammino). In È arrivata la felicità, il regista ha voluto in un certo senso fondere le due esperienze: una “vicenda amara” trasformata in “divertimento”. Ma c’è una tesi, ed essa rimane. Con la sua apparenza festosa e gradevole, il film non rinuncia a dire: badate, il signor Deeds vince perché se lo merita, ma fate attenzione ai suoi nemici: sono essi, i cittadini aridi, che hanno la responsabilità di tanti accadimenti impuri. Di tutta una vita falsa e contraria a ogni senso di giustizia e di umanità. Il signor Deeds invece vive secondo natura. Oh che bello se il suo esempio non rimarrà isolato! Tesi semplice e antica, ma scottante e attuale quant’altre mai. Il racconto scorre molto sciolto e cordiale, e taluni particolari sono di una vivezza e di una freschezza anche più felici di quelli spregiudicati che “amammo” in Accadde una notte. Le vecchiette più “picchiatelle” di tutti coloro ch’esse accusano col divertente epiteto. I camerieri che non debbono inginocchiarsi. Gli scrittori acidi e antipatici che Deeds mette a posto a suon di pugni. Lo psichiatra rigido e cattivo. Il giudice che fatica a mantenere il riserbo e la dignità della propria carica, dinnanzi alle argomentazioni paesane – scarpe grosse cervello fino – e probanti del Ciò che Luis Trenker, spirito più descrittivo che drammatico, riesce a realizzare con singolare intensità è – temporalmente e spazialmente – il senso del vuoto e dell’infinito. Con quell’individualismo estremo che nasce da una filosofia idealistica, egli vede l’uomo solo, nella sua lotta contro le forze naturali e la malvagità degli uomini. Trenker solo è anche il responsabile della produzione dei suoi film, e quindi è sua anche quella unità di concezione e di atmosfera personale che troppo spesso manca ai film prodotti col sistema del taylorismo. Molto caratteristiche quelle lunghe dissolvenze che colgono ogni occasione di passaggio da una sequenza all’altra per dar una trasparenza spirituale alla sostanza materiale della fotografia: quei movimenti gotici da ascensore invisibile che con le ali di un angelo sollevano lo spettatore fra campanili sorgenti e grandi alberi calanti; le infinite carrellate che accompagnano l’intrepido protagonista nelle sue corse attraverso le sabbie. Molto piacevole mi sembra poi il fatto che il dialogo si concentra in pochi nuclei inseriti allo scopo di spiegare nel modo più spiccio i motivi astratti dell’azione; mentre, per il resto, Trenker si mantiene in pieno nel campo del classico film muto presentando all’occhio delle lunghe scene descrittive 280 281 «Cinema», 14, 25 gennaio 1937, p. 70 (come quella dei lavatori dell’oro sulle rive del fiume) o animate dalle cavalcate ardite, dai colpi di rivoltella che ricordano i film western, dal montaggio di pezzi brevi e da quelle fulminee panoramiche che somigliano ai rapidi sguardi del protagonista. Il sentiero della felicità «Cinema», 14, 25 gennaio 1937, pp. 70-71 Le pellicole sull’adolescenza e sulla gioventù sono particolarmente difficili da trattare. Rispetto a quelle che sullo stesso tema ci ha dato fino ad oggi il cinema francese (Jeunesse, Albergo degli studenti) e che s’assomigliano un po’ nello spunto e nello sviluppo narrativo, questo Sentiero della felicità offre una più acuta analisi dei caratteri dei personaggi. La storia della ragazza che, rimasta sola, viene aiutata da un giovane, mentre ella ama un altro che la corrisponde, può dar luogo ad una serie infinita di dettagli: Allégret che ha avuto tra i suoi collaboratori per lo scenario anche Charles Spaak, un uomo fidato del cinema francese, ha esposto la vicenda nella forma più semplice, affidando agli interpreti espressioni e atteggiamenti squisitamente delicati, ambientando l’azione in una atmosfera in superficie gaia, ma profondamente turbata da quella malinconia della giovinezza, che non è mai esplicitamente espressa. Il dramma spirituale del “non detto”, è specialmente raggiunto là dove il movimento scenico e mimico si sostituisce al dialogo che, del resto, è assai sobrio e sufficiente a far intendere sfumature di sentimenti, per prorompere soltanto in un punto – la morte dell’amico – in un tono concitato. L’assieme dei giovanotti è cordiale e disinvolto e Simone Simon è squisita e toccante sia quando il suo giovane corpo è ambientato nella fresca atmosfera dei campi, sia quando il suo volto vuol mostrare il suo turbamento interiore. monitrici, film senza didascalie che giocava felicemente sul brivido misterioso provocato dalle silhouette. Il Robison ha saputo conservare questa tecnica nello Studente di Praga, classico soggetto del “muto”. L’argomento del romanziere tedesco Hanns Heinz Ewers, è infatti molto cinematografico: soggetto tratto dalla psicologia dei primitivi e perciò efficacissimo: «L’uomo primitivo è molto preoccupato della sua ombra. Perdendola, egli si sentirebbe scoperto per sempre. Ciò che colpisce la sua ombra, colpisce lui stesso. Se qualcuno se ne impadronisce, tutto è da temere». Questa constatazione dell’etnologo Lévy-Bruhl spiega il nostro profondo interesse per il simbolo usato dall’Ewers nel rappresentare l’uomo incapace di agire e quindi di vivere. Ero contento di vedere che questa scissione dell’Io (la schizofrenia della psichiatria) è presentata dal Robison senza un fastidioso strumentario di trucchi ultramoderni: con la semplice esposizione doppia egli non oltrepassa il modesto campo del vecchio Georges Méliés. Fiaba senza pretese tecniche o psicologiche, che ci fa tornare in quegli infiniti viottoli notturni del cinema muto, qua e là rischiarati dal riflesso circolare di un pallido lampione; ci riporta l’incubo onnipresente che balza fuori da ciascun angolo scuro e anche le ansie del silenzio: dei due studenti Baldwin, l’uno rimane del tutto muto e l’altro non parla troppo. Va benissimo anche che il vecchio Mefistofele non distrugga il suo rivale in modo diretto ma conservi la propria immaterialità offrendo alla sua vittima soltanto i mezzi e le occasioni per distruggere se stesso. Amore tzigano «Cinema», 15, 10 febbraio 1937, pp. 109-110 Il cinema muto era un mezzo creativo così forte che portava ad una certa originalità anche gli artisti mediocri. Uno di essi è Arthur Robison del quale, oltre un Traditore di atmosfera irlandese non meno densa di quella creata recentemente da John Ford, ricordo molto bene Ombre am- Sir James Matthew Barrie è l’autore della commedia da cui è tratto questo Piccolo ministro, ribattezzato con poca fantasia dai riduttori italiani. Molti han detto: «che brutto soggetto!», senza minimamente rammentarsi delle benemerenze di Ser Giacomo: uno scrittore dickensiano di onesta tempra: egli ha scritto, tra l’altro, commedie ben note come L’ammirabile Crichton e Le medaglie della vecchia signora, nelle quali il burlesco e il sentimentale si fondono con garbo talvolta squisito. E la féerie delicata di Peter Pan? E i racconti scozzesi, dai quali spesso son tratte le sue commedie: affollati di personaggi graziosamente tirati alla caricatura. Nella prima parte di questo film troviamo esempi lampanti della maniera – da non prendere a gabbo, dico io – dello scrittore. Mi piace molto quel parco nel quale i bravi scozzesi rigidi vanno a passeggio la domenica: il loro puritanesimo vorrebbe mortificare anche i fiori e gli alberi, che difatti, come suggestionati da quegli sguardi che ci tengono a sapere di cilicio e di rinuncia diuturna, non nascono così rigogliosi come 282 283 Lo studente di Praga «Cinema», 15, 10 febbraio 1937, p. 109 abbiamo sentito dire accada in Scozia. Invece il bosco in cui domina, novello Puck, Katharine Hepburne-Babbie è verde e ricco. E vi sono spiazzi di luce amabilissimi, che permettono alla fantasia leggiadra e rigogliosa dell’attrice di vagare senza freni: e qui ne godono i suoi piedi leggeri, che vi danzano su. Tutta la recitazione di lei, stavolta, è su un tono fatato e ricco di continue, sorprendenti invenzioni: sottilissime e talvolta impercettibili: cito il breve saluto con la mano che essa fa al “piccolo ministro” quando s’allontana col dottore, per non dar sospetti ai paesani pettegoli; il modo in cui agita la lanterna dinnanzi alla casa dell’amato, modo festoso e felice, senza ritegno e però pudicissimo: le sue corse, lo scialle agitato intorno al collo esile a mo’ di bandiera. La Hepburn a taluni oggetti affida compiti molto importanti: ed essi, comandati da quelle agili mani magiche, la servono con fedeltà sempre utile. Il “materiale plastico” di cui essa si serve è inesauribile. Tutto quello che la circonda è opportuno al suo gioco: guardate come sfiora i rami degli alberi, come “apprezza” le sue vesti, come le sue mani stringono la modesta e onesta spalla dell’innamorato. L’amato vagabondo «Cinema», 15, 10 febbraio 1937, p. 110 que. Laurel e Hardy, separati, agirono molto spesso nei two-reels di Mack Sennett: ebbene, i loro film sono “borghesi” rispetto alla travolgente furia di quelle “comiche”, ma ritengono almeno un poco di quelle trovate meccaniche e pagliaccesche di effetto immediato. Le loro trovate, semmai, sono ancora più meccaniche: esempio evidente, qui, la trasformazione dei due in “misirizzi”, e altrove certi finali da paese dei balocchi. Ma ce n’è altre derivate in pieno dal buon tempo antico: ecco la cabina telefonica, ecco le cadute nell’acqua e le torte sulla faccia; gli inseguimenti affannosi e le vendette cocciute di Stanlio e Ollio. E i tipi di contorno; e le mogli stizzite. Poi i due personaggi hanno una propria consistenza umana, si dica pure ingenua e sommaria. Ma voi sapete bene quel che s’agita nello spaurito cuore di Stanlio e in quello paterno di Ollio. Stanlio è un babbeo dotato di una sua furberia logica e coerente; Ollio è molto più sicuro del fatto suo; ha una cert’aria risoluta che gli viene dal continuo contatto con l’amico: dinnanzi a quella tremebonda irresolutezza, egli ha assunto un ruolo di protettore, e può credere a una sua “importante” fermezza di carattere. Il suo guaio è ch’egli adopera codesta immaginaria fermezza di fronte a tutti gli uomini: e son battute di naso a ogni cantone. Maria di Scozia «Cinema», 16, 25 febbraio 1937, p. 155 La cornice ambientale e scenografica di questo film è di un gusto e di una raffinatezza ammirevoli. In tale atmosfera, di sorprendente freschezza, Maurice Chevalier che canta divertenti canzonette di Mireille e di Heymann è al suo posto; in nessun altro film è stato così sobrio, e si direbbe che Kurt Bernhardt ha inteso più di ogni altro regista, le qualità di Chevalier. L’azione è fluida, e la musica di accompagnamento dovuta, nientemeno, che a Darius Milhaud è attraente al cento per cento. Stan Laurel e Oliver Hardy mi divertono. Non dirò che si tratti di sopraffino divertimento: ma oggi che il cinema comico è relegato un po’ in un angolo (soprattutto da noi: i nostri cari noleggiatori non ci vogliono regalare a nessun costo un film dei Marx e non ci presentano Fields più di una volta ogni due anni), è sempre piacevole un bagno in quelle ac- Il regista John Ford, non potendo impedire che questo film, secondo l’uso comune del cinema parlato, tentasse di far concorrenza al teatro drammatico, ha fatto del suo meglio per farvi entrare anche quelle forti tinte fondamentali con le quali un buon affresco ci dipingerebbe la passione dell’infelice Maria. Al principio la nave, portando Maria in Scozia, si avvicina – è l’ora del crepuscolo – con una lentezza sinistra che veramente ci fa presentire l’arrivo di un tragico destino, e il temporale che accompagna la salita sul patibolo fa veramente scoppiare in scariche elettriche una tensione ossessionante. La sceneggiatura sfrutta poco l’ambiente londinese – ciò che certamente non dispiaceva a Ford, il quale insiste invece su di una Scozia piena di quelle nebbie melanconiche, di quei canti languidi che avevano dimostrato la loro efficacia descrivendo l’Irlanda del Traditore. Buono anche il robusto cinguettio delle cornamuse – specie di leitmotiv della regina scozzese – che fa affondare la voce nemica del predicatore John Knox. La Maria storica fece uccidere suo marito, Lord Darnley, dal proprio amante Bothwell. Lo scenario del film ha voluto discolparla di questo delitto attribuendolo ai lords ribelli della Scozia – ritocco che se anche è stato evidentemente apportato per rendere più “simpatica” la protagonista, può essere considerato lecito dato che esso, 284 285 I nostri parenti «Cinema», 15, 10 febbraio 1937, pp. 110-111 eliminando dal carattere di Maria un tratto contrario a quelli essenziali, serve a semplificare il personaggio ed a renderlo quindi più cinematografico. Katharine Hepburn è degna della sua parte. Il suo viso esprime quel che i balbettii del testo vorrebbero dire. La sua personalità basta da sola per controbilanciare il pathos massiccio delle immagini. Nella sua interpretazione il personaggio di Maria Stuart si spiega essenzialmente in una giovinezza quasi infantile. È infantile l’ingenua fiducia nella giustizia e nell’onestà degli uomini, come anche l’imperturbabile energia nel seguire i propri diritti e desideri. I cavalieri del Texas «Cinema», 16, 25 febbraio 1937, pp. 155-156 Siano rese grazie a Henry Hathaway e ai suoi Lancieri del Bengala, per aver riportato in auge l’aria aperta e il senso western. Chiamo così quel particolare sesto senso del cinema, che il cinema – ahi cieco! – fino a poco tempo fa, pareva aver relegato in soffitta: divenuto elegante e mondano, gli abiti rozzi e i calzoni di cuoio non gli parevan più adatti a vestirlo. Per merito del successo dei Lancieri il nuovo film di Vidor può avere un’aria dernier cri mentre sotto sotto non si cura di nascondere le sue origini plebee, dei tempi in cui non era vergogna respirare a polmoni spalancati e disdegnare le pareti maleodoranti dei teatri di posa. E a me sembra che Vidor oggi non ci abbia tradito. Molto meglio di Notte di nozze, stavolta: e i collegamenti con le opere importanti non sono così allentati come taluno ha detto. Quando Fred MacMurray ha ucciso il “Bandolero” e domanda perdono in ginocchio al Signore, un brivido percorre gli spettatori: è il ricordo di altre preghiere vidoriane più emozionanti ancora, che agisce vivamente su tutti. Perché tutti conoscono e amano Vidor. Difatti ho sentito vicino a me un anonimo che diceva in quel punto: «ecco il Vidor protestante e austero che conoscevamo». Più tardi i critici affermarono: «ma questo in fondo è un Vidor che gioca». E non è vero. Vi par niente che la Casa abbia voluto spender tanti denari per un western, e affidarlo a un regista costoso e celebre come Vidor? Il serio King ha elaborato il soggetto da un popolare romanzo americano, s’è trasportato con una grossa troupe nelle praterie del suo Texas, e in conclusione mi sembra abbia voluto rendere un sereno ed equilibrato omaggio al western: al western con la sua caratteristica “drammaturgia”, con il suo movimento quasi fine a se stesso eppur così ricco (e forse il più importante tra i mezzi d’espressione del cinema), con i suoi modi ingenui e pittoreschi. Qui non manca nulla di ciò che conoscemmo e amammo con tutte le forze. Ci sono i banditi col fazzoletto 286 sotto gli occhi, i pellirosse e le diligenze assaltate: sfondo obbligato di vivissimo effetto; c’è la figlia del maggiore (ch’è come dire dello sceriffo) innamorata dell’eroe; i banditi che si redimono, e il vilain che resta vilain fino alla morte. I cappelli a tese larghe, i calzoni di cuoio. L’inizio è maestoso e descrittivo, a felice imitazione del metodo Lancieri: i due personaggi principali cominciano a delinearsi (e il sorriso guardingo e amaro del terzo ci fa intuire molte cose), caratteri costruiti con chiarezza e cordialità. Il trionfatore del film è Wahoo, lo scherzoso avventuriero dal cuore d’oro sotto lo strato leggero d’adipe: e per Wahoo, Jack Oakie, veramente un attore di prim’ordine. Guardate come muore. Più tardi ci sono due tre scontri elettrizzanti: la trovata del lancio dei pietroni mi par molto bella, le sparatorie da lontano sono implacabili, l’inseguimento finale mozzerà il fiato anche ai maratoneti. Poi provavo una gioia sana e rara nell’osservare il modo pieno di gusto col quale il regista utilizzava la larga e sempre sorprendente visione del campolungo, peculiare d’altronde del western; il piglio semplice e caratteristico del suo stile, con cui tagliava certe scene: l’entrata in campo di Sam nel caffè-tribunale, con le pistole puntate che fanno giustizia sommaria di due nemici dell’eroe, mi pare la più opportuna alla citazione. Effetto limpido e bello: solo una “figura intera” finale – il giustiziere nascosto che si svela di colpo – c’informa dell’accaduto. E la sospensione, creata in modo magistrale coi minimi mezzi. Il mio amore eri tu «Cinema», 16, 25 febbraio 1937, pp. 156-157 Dicano pure gli altri che questo film è melodrammatico, ingenuo e popolare d’accenti e di mosse. Tutti questi rilievi riguardano il soggetto: ch’è facilone, difatti e abborracciato. Ma vi prego di tener conto del modo con cui l’invenzione banale è stata realizzata e fatta diventar cinematografo: cinematografo dal primo all’ultimo fotogramma. Non c’è bisogno di parole più grosse: né il film, modesto e riservato dopo tutto, chiede parole grosse. In tempi di teatro filmato e di commedie allegre e superficiali, io ho visto con gioia una pellicola come questa. Piena di moti e di vicissitudini, non vi dà il tempo non dirò di tossicchiare, ma perfino di tirare il fiato. C’è di più: dopo tanti film uno dopo l’altro vuoti e generici, eccone uno che mette in piedi almeno tre personaggi ricchi di carattere e ben chiari. In primo luogo Suzy, una ragazza che sapete com’è fatta e quali i suoi desideri e i suoi pensieri; affettuosa e birbona, ma soprattutto affettuosa. Una sentimentalona dal cuore grosso così. E nel medesimo stile recita Jean Harlow. Sentimentale e istintiva, con le lacrime 287 vere quando in scena bisogna piangere. Ecco: Jean Harlow è un’attrice che non piange lacrime di glicerina, ma lacrime amare e sincere; e non ride volgendo i pensieri altrove, ma godendo tutta del suo riso. Essa “apprezza” con tutta l’anima e, aggiungerò, con tutto il suo corpo sano e fresco, i sentimenti e le reazioni del personaggio che interpreta. La figura dell’ufficiale francese, anche, ha una sua coerenza ed è costruita con tocchi vivi e persuasivi. E perfettamente identificata, fisicamente, nell’attore Cary Grant: scelto con fine acume. Infine il vecchio padre che attende: Lewis Stone ne fa una creazione indimenticabile. Grande attore. Le scene finali in aeroplano (la raffica di mitraglia accanto all’auto bersagliata!), il mazzo di fiori del nemico, le due sparatorie della spia a bruciapelo: ecco i punti d’acme. E il regista Fitzmaurice? Beh, dategli voi ora i meriti: se mi avete letto con attenzione, non vi sarà difficile. E dell’operatore Ray June è giusto lodare il tono felicemente cronistico e “fedele” della fotografia: sì ch’essa può fondersi agevolmente coi pezzi “veri” (la guerra ecc.) incorporati nel film. La donna del giorno «Cinema», 21, 10 maggio 1937, p. 389 Il poema di Tennyson offriva uno spunto di portata epica per la trasformazione in film. A quest’opera si è accinto Michel Jacoby, fornendo a Michael Curtiz uno scenario cinematografico ricchissimo di elementi di attrazione. Si è voluta riunire una serie di episodi interessanti per espressione spettacolare, e culminanti in una carica finale che se non si conchiude con un consueto lieto fine, secondo la formula più banale, lascia l’amore ai due innamorati, facendo soccombere il protagonista che diviene un piccolo eroe. A questo finale si è accinto con tutto l’amore e con tutta la forza propri ad un regista coscienzioso, Michael Curtiz, regista abilissimo e versatile che in tale sequenza si è dimostrato un conoscitore profondo del ritmo cinematografico, raggiungendo un livello tecnico piuttosto elevato. Questa pagina rimane dunque tra le più felici che il cinematografo abbia offerto in questi ultimi tempi. Con un finale simile, di natura epica, gli episodi precedenti del film hanno una funzione più che altro preparatoria. Ma non bisogna dimenticare l’assedio alla fortezza, la strage delle donne e dei bambini compiuta da Surat Khan, che provocherà poi la vendetta dei Lancieri. In tale strage, come pure nelle scene sentimentali, in quell’amore dei due cugini per la stessa donna, sono primi piani e particolari densi di emotività. A questo contribuisce la prestanza fisica degli interpreti. Prendi l’eloquenza, e torcile il collo... Prendi la poesia, e torcile il collo... Sono gli avvertimenti che gli uomini danno a se medesimi, quando cominciano a sentire il pericolo delle proprie infatuazioni. Ma la cosa si aggrava, se l’America aggiunge a quel ritornello il suo versetto, che suonerebbe: – Prendi la diva, e torcile il collo. – Tanto più dove, ad un’operazione di qualità così barbarica e straziante, ci metta in condizione di dover applaudire. Nella Donna del giorno vediamo ad un certo momento Jean Harlow sulla sedia elettrica del parrucchiere, sotto quel casco miracoloso e sempre incredibile che trasforma i ricci d’acciaio in ricci permanenti. Il volto impiastrato di una crema bruna rivela un residuo tutt’altro che lusinghiero della maschera che ha interessato mezzo mondo. Scherzi a parte, è ammirevole il coraggio con cui il film americano è giunto a trattare le sue dive e a tradurle in prosa. E, per converso, la devozione che le dive dimostrano all’opera loro, impavide di spezzare la magia proverbiale della loro bellezza, ove la sceneggiatura, ove il dinamismo della parte lo richieggano. La donna del giorno appartiene decisamente a quella formula nuova di film che ci attrae con un gioco acrobatico sui margini dell’estetica teatrale. Ogni passo sfiora e scongiura la caduta nel teatro, e intanto il film si salva sempre. In sostanza, questo tipo di commedia cinematografica, prende dal teatro la “situazione” e la trasforma in “movimento di situazioni”. Bisogna pensare, proprio a proposito di questi lavori fatti di nulla, quale organizzazione, quale massa di lavoro preparatorio si nasconda dietro la linea agile, scorrevole, tutta fiorente di ricami leggeri. Perché ogni attimo vuole la sua trovata, e questa arriva sempre, puntuale come un orologio, giusta come l’oro diciotto carati. È difficile che si produca una sproporzione tra ciò che il pubblico si aspetta e ciò che la sceneggiatura, la regia (qui di Jack Conway), l’interpretazione gli danno. Senza contare poi le trovate, che vorremmo chiamare trovate-madri: in questo film, l’arrivo di Jean Harlow vestita da sposa nella più trafelata redazione di un giornale americano; o, cubitale nel suo paradosso e nelle sue conseguenze, la lezione di pesca alle trote. In questa gara di velocità, in cui le invenzioni si inseguono come nuotatori, ora tuffati ed ora emersi nel più animoso croll, un’altra gara s’imposta: quella tra la bruna Myrna Loy e la bionda Jean Harlow, per il cuore sprezzante e virile di William Powell. E diciamo senz’altro che, fino a cinque minuti dallo scioglimento, il pubblico, tra la bruna e la bionda, si gode un mondo a fare l’asino di Buridano. 288 289 La carica dei 600 «Cinema», 16, 25 febbraio 1937, p. 157 Il paradiso delle fanciulle Ramona «Cinema», 21, 10 maggio 1937, p. 389 «Cinema», 21, 10 maggio 1937, pp. 389-390 Il Paradiso delle fanciulle? Un paradiso per lo spettatore. Ci si siede al proprio posto come sulla poltrona di un “rapido” che percorrerà distanze chilometriche, con la massima puntualità e mantenendo il più perfetto orario. La prima forza di questo film è di avere equilibrato le proporzioni delle scene, il rapporto degli episodi, in modo che l’allungamento del metraggio non generi l’impressione del gonfiato e del mastodontico. È il colosso di Rodi che dà l’illusione ottica di essere grande al vero. Può essere simbolico che uno dei gags più felici sia affidato ad un elefante (quello che spruzza Sandow), e non per questo ci rimetta di agilità. Sono parecchi i punti di vista positivi da cui può essere guardata questa biografia cinematografica e romanzata del “grande Ziegfeld”. Ne segnaleremo intanto uno tecnico. Nella sua immensa mole, il Paradiso delle fanciulle porta su scala gigantesca la tendenza, affermatasi negli ultimi grandi film di “rivista”: quella di sostituire i movimenti di scena ai movimenti di macchina. E, preso in campo lungo, denuncia questo movimento. Il torrione bianco su cui si svolge la prima delle “follie” viene avvitato in un “carrello” elicoidale; ma è il torrione stesso che gira fino al momento in cui la macchina riprende lei l’iniziativa e, indietreggiando, continua questo “moto perpetuo”. Così il più lungo, o almeno uno dei più lunghi carrelli che la cinematografia ricordi – d’un metraggio esattamente proporzionale a quello del film – rimane diviso tra il palcoscenico e la macchina. E invero i movimenti di macchina sono troppo gratuiti ed astratti: in certo senso, troppo facili; mentre, passando alla scena, questo movimento acquista di concretezza. Crea un senso di resistenza in una materia che, così fastosa ed irreale, potrebbe perfino generare l’impressione del sogno o della stravaganza. Altro particolare interessante: la sceneggiatura. Che, per aumentare le dimensioni dello spettacolo, non ha infittito le situazioni od i quadri, ma si è limitata ad allargare i ritmi dei dialoghi, ad aprire, per così dire, il compasso di ciascuna scena. Quanto allo spirito del film, non ci sazieremo di ripetere che anche stavolta il cinema americano dà prova di saper riuscire perché crede in ciò che fa. In certi passaggi, la passione di Ziegfeld per le proprie imprese è sentita come la passione di un pioniere, ed è resa con altrettanto entusiasmo e trasporto. Si capisce perfettamente come il pubblico possa esserne travolto. È un trucco propagandistico non molto nobile ma efficace quello di sottolineare la causa “giusta” con dei personaggi simpatici o addirittura belli. Presentare dunque Loretta Young come meticcia indiano-spagnola, significa intercedere per la mescolanza delle razze da parte di tutti quelli a cui piace Loretta Young. Problema che in questo film viene ad essere contaminato da un altro problema: quello della giustizia. Se dunque i bianchi sparano sui pellirosse come se fossero conigli, il loro contegno è condannato dall’esistenza della fanciulla, frutto della parità fra due tipi di abitanti del nostro mondo. Ecco il meccanismo morale di Ramona, film distinto almeno dal fatto di avere una tesi, seppure una tesi semplicista. Non saremo però, in questo caso speciale, troppo severi con quelli che trascurano la tesi in favore della fattura, dato che si tratta di un film a colori. Nell’unica scena del film in cui si sente l’attività di un senso creativo – quella in cui, all’improvviso, cadono dagli alberi di frutta quei ladroncelli di ragazzi come prugne mature – in questa scena si vedono su un tavolo piatti di frutta fresca: mele, ciliege. E ci viene l’acquolina in bocca. Mentre in complesso il colore rende finora l’immagine cinematografica molto meno naturale o molto più artificiosa di quella monocroma, in certi dettagli esso produce una naturalezza stupenda che aumenta notevolmente le capacità documentarie del cinema. Ci sembra che il colore faccia effetto in tutti quei casi in cui esso non rappresenta un complemento quasi automatico della forma: i visi rosa, gli alberi verdi fanno poca impressione; ma la fresca carnagione di un neonato crea un mormorio di stupore nel pubblico; gli ornamenti variopinti sul vestito del prete intensificano e arricchiscono il linguaggio ottico. E accorgersi che il bianco degli occhi della Young è leggermente arrossato, significa veder completato il ritratto della fanciulla dolce e sentimentale con un tocco decisivo. Invece non avrebbe bisogno del colore per impressionarci la florida Katherine DeMille con la sua succosa vitalità, con le sue ampie spalle secentesche e la spontaneità delle sue passioni esplosive. È un’attrice che fa impallidire il Technicolor. La bambola del diavolo «Cinema», 21, 10 maggio 1937, p. 390 Non basta che il critico sia uno spettatore più sensibile, più colto, più cosciente. Proprio nel caso del cinema è necessario che egli non si contenti di apprezzare il prodotto finale ma che, analizzando il processo 290 291 di produzione, riesca a individuare le diverse forze dalla cui coincidenza risulta l’opera. Un film come La bambola del diavolo, per esempio, non dovrebb’essere considerato dal critico un tipico “giallo-orrido”, con trucchi tecnicamente perfetti e il cui scenario è dovuto per caso a un uomo che si conosceva come grande regista: Erich von Stroheim. Bisognava mettere in rilievo invece che qui si trattava di una forte concezione tipicamente stroheimiana, che non poteva essere portata a termine per mancanza della regia personale dell’artista. Possibile che non abbiano suscitato nessun ricordo i motivi satanici della donna zoppa, della serva mentecatta, le caricature dei poliziotti e dei banchieri – sintomi inconfondibili del grande stile di Stroheim? E certe strade di Parigi, velate di nebbie misteriose, non indicavano che si era intromesso qualche cosa al di fuori dei soliti spaventi commerciali di produzione Tod Browning? Era il caso di gridare all’arme per aiutare un grande artista a cui si erano legate le mani. Peccato. Seguendo la flotta «Cinema», 21, 10 maggio 1937, p. 390 Si offenderanno le girls se affermiamo che i film dedicati alla danza e alla musica erano finora troppo femminili? Ce ne accorgiamo in occasione di Seguendo la flotta, film che trasforma il ritmo della disciplina militare in quello gaio dei ballerini. Dopo tanto vino dolce, quello più asciutto fa bene; tanto più che i maschi, per piacere al pubblico, non possono fidare molto sulla propria bellezza: bisogna che sappiano bene il loro mestiere. E lo sanno fare sul serio. Basta citare la danza, non accompagnata da musica – e purtroppo soppressa, per ragioni di metraggio, dai doppiatori – in cui Fred Astaire con i piedi lava la testa al marinaio, se così ci è permesso di esprimerci: il solo ritmo dei passi, i soli movimenti sostituiscono chilometri di colonna sonora coperta di dialogo. rico né in chi li fa né in chi li riceve. A Blasetti è servito per districarsi da foschi ed eroici pensieri (ma v’è subito tornato), al pubblico per divertirsi sulla vicenda d’un equivoco e di duemila lire peregrine nell’ambiente d’una casa di mode. Già s’era detto: Contessa di Parma, il film della moda. Errore. Una frase del genere prevede la tesi e mette tutti in guardia. Ma, chi ha visto il film, è stato man mano preso in un’ombra di serena avventura in cui la moda è servita solo a dare eleganza e a far risaltare l’interessante bellezza – cruda e complessa – di Elisa Cegani, protagonista, e la freschezza di Maria Denis, sfacciatamente maliziosa e carina. Il racconto è costruito bene; le trovate giuocano al momento opportuno e quindi il film corre via, preciso e sicuro, senza dilungarsi, senza insistere su elementi magari suggestivi ma che avrebbero potuto essere dispersivi, con una tecnica attenta e lieve al medesimo tempo. La trovata finale della guida scorrevole è di grande effetto ed è piaciuta molto; meno è piaciuta, ad un pubblico speciale, la satira di certi titolati (lo zampino del più sincero Blasetti). Precisare le scene migliori? Quando un film è congegnato in un modo così serrato non si distinguono. Si può notare che i paesaggi piemontesi che ogni tanto compaiono, sono colti con molta esattezza e suggestione: opachi, lontani, romantici... Antonio Centa, l’attore principale, è stato impiegato in Contessa di Parma in un modo più completo che non nei suoi precedenti film (Ballerine e Squadrone bianco): ha una recitazione tutta scatti ma efficace. Concludendo: con Contessa di Parma Blasetti ha soprattutto mostrato tre cose: un perfezionamento della tecnica in un senso più conciso e più espressivo; un’abilità indiscutibile di manipolare la commedia; una furberia commercialmente redditizia qual è quella di giocare sull’equivoco borghesia come realtà e borghesia come aspirazione. E proprio questa furberia dà la dimostrazione che Blasetti con questo film non si è smentito, perché, al contrario di quanto generalmente avviene per certa cinematografia la sua è una furberia polemica che conclude e conclude positivamente. Contessa di Parma «Cinema», 21, 10 maggio 1937, p. 390 Aldebaran aveva un po’ messo tutti sull’avviso. Attenti, si disse, che Blasetti ci farà qualche scherzo. Eccolo, infatti: Contessa di Parma. Uno scherzo piacevole, di quelli che si accettano perché non lasciano ramma- 292 293 «Bianco e Nero» Principi del montaggio in Renato May, Per una grammatica del montaggio, «Bianco e Nero», 1, 31 gennaio 1938, pp. 37-42 1938 I. – Principi di taglio a) Lunghezza dei pezzi di montaggio: 1. Pezzi lunghi (le singole scene incollate insieme sono relativamente lunghe. Ritmo lento). 2. Pezzi brevi (… tutti relativamente corti. Per lo più scene di movimento rapido, anche come contenuto. Punti salienti dell’azione. Effetto emotivo. Ritmo rapido). 3. Combinazione di pezzi lunghi e brevi (in scene di lunga durata introduzione di una o due scene brevi, o viceversa. Ritmo corrispondente). 4. Combinazione priva di regola (unione di pezzi di varia lunghezza e non particolarmente lunghi o corti. La lunghezza cioè vi sarà determinata dal contenuto, senza particolare effetto ritmico). […] b) Montaggio di intere scene. 1. Successivamente (un’azione è condotta fino alla fine: attaccata ad essa è la successiva, e così via). 2. Intercalatamente (le azioni sono divise in parti intercalate le une alle altre). 3. Interpolazione (…di singole scene o quadri nello svolgimento dell’azione). c) Montaggio interno delle singole scene. 1. Combinazione di un campolungo o totale (ricordare che quest’ultimo è un concetto sempre relativo e che va inteso in sostanza come ripresa di un oggetto che comprenda in sé il primo piano): a) prima un campo totale, poi un particolare di esso (o più d’uno) o primo piano. […] b) passaggio da un particolare o da più particolari al totale che li contiene. […] c) successione priva di regola di campilunghi o totali, e di primi piani. 295 2. Succedersi di particolari (i quali dunque nessuno comprende l’altro). II. – Relazioni di tempo b) Cambiamento di scena. 1. Scene intere. – Succedersi o intercalarsi di scene che avvengono in luoghi diversi. 2. In una stessa scena. – Diverse parti di una stessa scena. c) Indifferente rispetto allo spazio. a) Contemporaneità 1. Di intere scene […] 2. Particolari di un punto di vista di un dato momento (cioè uno dopo l’altro i particolari di uno stesso luogo in uno stesso momento. […] Timoshenko: “montaggio analitico”. Praticamente è inapplicabile). b) Prima e dopo 1. Intere scene che si succedono nel tempo (ed anche inclusione di scene che già hanno avuto luogo – ricordo – o che avranno luogo – previsione –), […] 2. Successione intera di una scena (il succedersi di dettagli che si seguono in ordine di tempo nel corso di una intera azione: per esempio: 1. – Un tale prende un revolver; 2. – Una donna fugge). c) Indifferente rispetto al tempo 1. Intere azioni che non dipendono reciprocamente dal tempo, ma solo dal contenuto. (Per esempio: Ejzenštejn: sparatoria contro i lavoratori, montata insieme all’uccisione dei buoi al macello. Prima? Dopo? Indifferente). 2. Riprese singole che non hanno tra loro relazioni di tempo. (Caso raro nei film narrativi. Ma per esempio cfr. Vertov). 3. Incorporazione di singole riprese in un’azione. (Per esempio: il montaggio di Pudovkin della “gioia del prigioniero”. La relazione è solo di contenuto). III. – Relazioni di spazio IV. – Relazioni di contenuto A) Analogia. 1. Di forma: a) della forma dell’oggetto (esempio: Pudovkin: alla visione del ventre tondeggiante di uno studente segue, forma simile, la gobba di un monte); b) della forma del movimento (esempio: oscillazione di un pendolo, cui seguono oscillazioni di un asse di bilancia). 2. Di senso contenutistico a) singoli oggetti (esempio citato nel Pudovchin: “gioia del prigioniero”: prigioniero – ruscello – uccelli starnazzanti – ragazzo ridente); b) intere scene. (Esempio citato da Ejzenštejn: gli operai sono fucilati, il bue abbattuto). B) Contrasto 1. Di forma a) della forma degli oggetti; per esempio prima un uomo grasso, poi un uomo magro; b) della forma del movimento. Su di un movimento molto rapido uno molto lento. […] 2. Del senso contenutistico: a) Identico ambiente (ma tempo diverso) 1. Scene intere. – Qualcuno torna dopo vent’anni in uno stesso posto. 2. In una stessa scena. – Tempo compresso. Il tempo passa e senza nessuna interruzione si vede quello che avviene dopo in uno stesso luogo. Inattuabile. […] 296 a) singoli oggetti (per esempio un disoccupato affamato ed una vetrina carica di ghiottonerie). […] b) Scene intere. (In casa del ricco – in casa del povero). C) Combinazioni di analogia e di contrasto 297 1. Analogia di forma e contrasto di contenuto. – (Per esempio Timoshenko: la catena ai piedi del condannato e le gambe della ballerina. Oppure: il ricco nel suo scranno; il condannato sulla sedia elettrica); Quando, anni fa, venni in Italia, vidi che circolava fra gli “iniziati”, come il manifesto segreto di una carboneria, un fascicolo poligrafato, redatto da Umberto Barbaro a suggerimento di Emilio Cecchi allora direttore artistico della Cines. Era un breve riassunto del mio libro Film als Kunst (Berlino: Rowohlt 1932; Londra: Faber & Faber 1933), e precisamente della prima ed essenziale metà del libro, che avevo scritto nel 1929. Negli anni successivi pensai più volte di far tradurre il libro per esteso e letteralmente, ma praticamente non lo feci. Sentivo che la “revisione” del testo mi avrebbe convinto di non lasciarne in piedi nemmeno una parola. Avrei voluto scrivere un nuovo libro, e infatti lo scrissi: le varie voci compilate da me per l’Enciclopedia del Cinema di Luciano de Feo rappresenterebbero, messe insieme, il volume ampliato e aggiornato che avrei dovuto sostituire a quella traduzione. Quando cominciai Film als Kunst avevo 25 anni. Esisteva allora uno scarso numero di film “classici”, che poi negli anni seguenti non è del resto aumentato. Ma esisteva inoltre un fatto che oggi non è più: in quasi ogni film della produzione corrente si notavano occasionali stupefacenti accenni alla formazione di un linguaggio artistico del tutto nuovo. (Sento una certa nostalgia nel rileggere gli esempi che citavo di quei tanti film modesti e buffi ma ricchi di una così feconda fantasia visiva). Tuttavia, non da questo materiale di esempi partiva la mia indagine. Mi ero appena laureato in psicologia sperimentale e il mio modo di ragionare sapeva di scienze naturali. Perciò mi sembrava che dovesse esser possibile dedurre in linea teorica le possibilità virtuali di un’arte dalle caratteristiche del suo specifico mezzo d’espressione. Detto in paradosso: credevo che anche se il Cinema non fosse esistito, le sue capacità espressive si sarebbero potute dedurre dall’analisi di ipotetiche immagini fotografiche in movimento. Mi ci provai; e ad illustrare la mia esposizione, mi servivo di esempi che ogni sera coglievo su questo o quello schermo. Ma il mezzo d’espressione del cinema non era la realtà stessa? Quale arte si poteva trarre dalla riproduzione meccanica di una creazione già in sé perfetta? Questo fu il punto di partenza: nel capitolo I, puramente psicologico, descrivevo gli elementi che l’immagine cinematografica aveva in meno su quella reale e che quindi distinguevano il cinema dalla realtà; nel capitolo II, estetico, riprendevo l’esame di quei fattori per dimostrare che proprio le apparenti “manchevolezze” del cinema gli consentivano possibilità creative. Un analogo metodo deduttivo ho adoperato, più tardi, in un mio libro sulla Radio (pubblicato recentemente da Hoepli) e mi augurerei di applicarlo, un giorno, all’arte in generale. Nove anni hanno cambiato molto. Allora si trattava di polemizzare contro quanti negavano possibilità artistiche al cinema. Oggi, al contrario, si vorrebbe a queste stesse persone raccomandare un po’ di modestia e serietà, quando si sbracciano a proclamare il cinema l’unica arte adatta allo spirito moderno, se non quell’“opera d’arte totale” sognata da Richard Wagner. Inoltre, nove anni fa era scusabile anzi didatticamente utile una certa preferenza per le stilizzazioni espressive più pronunciate, cioè a dire per le deformazioni: si trattava di fissare una prima ed elementare grammatica e quindi i casi risultavano i più istruttivi. Dal cinema stereoscopico e di quello a colori, oggi, a differenza di ieri, vedo non soltanto i lati negativi. Ma quello che dicevo della strana scissione dell’artista cinematografico in “regista” e “soggettista” non mi sembra oggi, come si potrebbe credere “superato dalla pratica”, anzi lo reputo vero con anche maggiore fermezza. E il centinaio di pagine dedicato allora al sonoro mi pare oggi, se mai, troppo ottimista. La seconda parte del libro, dalla quale Barbaro cita il capitoletto su “soggettista e regista”, tratta inoltre del modo di “impostare” una trama, e di esprimere con mezzi visivi i sentimenti e pensieri dei personaggi; c’è una psicologia del gag e un’analisi della standardizzazione e della morale del film comune. Per quanto riguarda le 150 pagine iniziali, mi pare che il riassunto di Barbaro, che «Bianco e Nero» qui pubblica, ne conservi gli elementi essenziali: lo scheletro del sistema e una breve enumerazione di alcuni fatti ed esempi basilari. Ai lettori di decidere se quanto segue sia semplicemente un “documento storico”, o se lo scritto abbia ancora qualche utilità pratica. Durante il nostro sviluppo intellettuale, se ci è capitato di occuparci per molto tempo di un dato argomento, si finisce per provare un effetto di “carrello indietro”: il soggetto lentamente si allontana e si rimpicciolisce; si va indebolendo il nostro contatto cordiale e immediato con esso; ma simultaneamente entrano “in campo” tanti altri fenomeni circostanti ma fino allora nascosti, dal che risulta una visione complessiva e una definizione più precisa di quel soggetto prima isolato. Per questo, appunto, sono tanto più grato a «Bianco e Nero» di dare una prossima volta ospitalità anche a un mio recente lavoro che ho tradotto per gli amici italiani, e in cui tento di fissare i fondamenti estetici del film parlato e d’inquadrare, ad un tempo, il Cinema nel sistema delle altre arti, e cioè dell’Arte. Rudolf Arnheim 298 299 2. Analogia di contenuto e contrasto di forma. – (Qualche cosa di questo genere nel film di Buster Keaton: La palla N. 13: egli vede sullo schermo una coppia gigantesca in atto di baciarsi, e nella cabina di proiezione, bacia la sua ragazza). Il film come opera d’arte «Bianco e Nero», 4, aprile 1938, pp. 11-42 I Come la musica, la pittura, la letteratura e la danza, così il cinematografo: i suoi mezzi possono usarsi a produrre arte o no; la cartolina illustrata, la marcetta militare, la novella da rivista settimanale, il balletto a base di esposizione di nudo, non hanno e non vogliono aver niente a che fare coll’arte. E così il film corrente non è cinematografo. Ma non per questo hanno ragione quelle colte e brave persone che negano alla cinematografia la possibilità di produrre arte. Essi dicono: il film non può essere arte perché non è altro che mezzo meccanico per riprodurre la realtà. I sostenitori di questa tesi vengono per lo più dalle esperienze della pittura. Per loro il processo per cui una scena di natura passa attraverso l’occhio e il sistema nervoso di un pittore, e poi alla mano e al pennello, che, colla scelta e l’apposizione dei colori sulla tela, crea infine il quadro, non è meccanico come il processo fotografico per cui i raggi di luce, proiettati da un oggetto e raccolti da un sistema di lenti, provocano alterazioni chimiche su di una emulsione sensibile. Il problema è di stabilire se questo dato di fatto basti a metter fuori dal tempio delle Muse la cinematografia. Vale dunque la pena di rivedere a fondo e sistematicamente la tesi che fotografia e cinematografia siano solo riproduzioni meccaniche della realtà e non abbiano quindi niente a che fare con l’arte. La proiezione dei corpi in superficie Se io mi pongo dinnanzi agli occhi un oggetto qualsiasi, per esempio un cubo, dipende dalla sua posizione la possibilità, per me, di riconoscerne la forma. Se io lo vedo [frontalmente] non posso assolutamente affermare di aver dinnanzi a me un cubo. Io non vedo che una superficie quadrangolare, che, in questo caso, nasconde le altre cinque superfici del cubo, ma che potrebbe benissimo nascondere altre cose: per esempio essa potrebbe essere la base di una piramide, un lato di un foglio di carta e così via. Evidentemente il mio punto di vista non è tale da far risultare le caratteristiche essenziali dell’oggetto. Dunque, se io voglio fotografare un cubo, non basta che io ponga l’oggetto reale dinnanzi alla macchina, bisogna che trovi la posizione adatta. E dunque già da questo primo semplicissimo caso il processo, dato che può esser buono o cattivo, non è puramente meccanico. Un secondo angolo visuale del cubo mostra, invece che una sola superficie di esso, come il primo, tre superfici, e cioè mostra una maggior parte di realtà. Ma non si tratta solo di quantità. Nel film si tratta sempre di trovare una più caratteristica realtà, cosa per la quale non esistono regole: se un uomo sia tutto lui, visto di profilo o di faccia, se sia più 300 importante il palmo o il dorso di una mano, se sia meglio riprendere un monte dal nord o dall’ovest, tutte queste sono cose che non si possono teorizzare, ma che si debbono sentire. Limitazione della profondità spaziale Che i nostri occhi, dato che la retina è superficiale, ritraggano immagini bidimensionali e diano tuttavia impressione stereoscopica è un fatto reso possibile dalla distanza che c’è tra un occhio e l’altro; essi non danno esattamente la stessa immagine, e l’effetto prospettico è dato in buona parte da questa piccola differenza del punto di vista. Altrettanto avviene nel processo fotografico detto stereoscopico, il quale teoricamente può anche essere usato per il film, mediante la visione contemporanea di due pellicole, ma che, come è noto, non può servire a più che ad uno spettatore alla volta. La stereoscopia cinematografica è però nello stadio di esperimento, e da ciò deriva la grande limitatezza prospettica del cinematografo. Il senso di profondità può essere in qualche modo rafforzato mediante movimento e luci, ma basta vedere una sola volta ad un apparecchio stereoscopico per intendere quanto sia superficiale e poco plastico il film normale. Anche questa è una grande differenza tra la realtà ottica e il quadro cinematografico. Nel film di Ruttmann Sinfonia di una grande città son riprese due ferrovie metropolitane di direzione opposta e che passano l’una accanto all’altra. L’impressione che se ne riceve è che i due treni si muovano venendo in avanti l’uno e andando verso il fondo l’altro; ma nel quadro per effetto della proiezione del movimento spaziale in superficie, essi si muovono allo stesso tempo l’uno dal basso verso l’alto e viceversa. L’immagine cinematografica è dunque spaziale e superficiale a un tempo. Per un noto fenomeno di abitudine noi vediamo le grandezze e le forme proporzionate, anche se esse sono a diverse distanze; mentre che, se fotografiamo un uomo i cui piedi siano molto vicini all’obbiettivo, vediamo apparire nella fotografia questi piedi enormi, e se fotografiamo un tavolo rettangolare, il lato più vicino all’obbiettivo apparirà più grande di quello lontano alterando nella riproduzione, la forma dell’oggetto. Tutto ciò dimostra non solo la mancanza di profondità spaziale nel film, ma anche l’irrealtà dell’immagine cinematografica, che è accentuata dall’assenza dei colori e dalla limitazione del campo. Mancanza di colori e illuminazione La riduzione dei colori della natura a bianco e nero altera profondamente l’immagine della realtà. Tutti accettano la convenzione fotografica che mostra una bandiera ad esempio che nella realtà è nera, rossa, dorata, come nera, grigia e 301 bianca; tutti accettano i capelli bianchi per biondi, e le bocche nere per rosse. Una grande importanza ha nella cinematografia, come del resto anche nella realtà, l’illuminazione. Essa rende più o meno chiaramente riconoscibile la forma di un oggetto. Si sa che la superficie montuosa della luna piena è invisibile se il sole l’illumina perpendicolarmente, rendendo cioè impossibili le ombre che, in un’illuminazione laterale, permettono di veder su di essa monti e valli. Per un risalto particolare è inoltre necessario uno sfondo contrastante. Che dunque una fotografia faccia un’impressione invece che un’altra dipende dall’angolo di ripresa, dalla distanza dell’oggetto, e dal fatto che la fonte di luce sia avanti, indietro a destra o a sinistra. Delimitazione del quadro e distanza dall’oggetto Il campo di visione del nostro occhio è limitato. Se noi fissiamo lo sguardo su di un punto vediamo un campo limitato, press’a poco circolare. Praticamente questo fatto non ha nessuna importanza, e la maggior parte degli uomini non ne ha nemmeno conoscenza, proprio perché noi abbiamo la possibilità di muovere gli occhi e la testa e, servendoci in continuazione di questa possibilità, non abbiamo mai a soffrire della limitatezza del nostro campo visivo. Questo fatto dimostra la falsità della tesi di molti teoretici del film che sostengono la limitazione del quadro cinematografico sullo schermo non essere che una riproduzione del campo visivo limitato dalla realtà. Questo è psicologismo falso e sorpassato. Il campo visivo dell’uomo non comporta questa limitazione e noi possiamo vedere un’intera stanza, per quanto il nostro occhio non possa abbracciarla con un’unica inquadratura; perché l’occhio, guardando, non si fissa, ma si muove, e il movimento degli occhi e della testa fa sì che noi possiamo vedere l’intero ambiente come un quadro unico. Non così per il quadro cinematografico o per la fotografia; e nemmeno il muoversi della camera o l’alternarsi dei quadri riescono minimamente a realizzare il campo di vista naturale, come si vedrà in seguito. La limitazione del campo fotografico risulta evidente a ogni spettatore. Il quadro ripreso è visibile per una certa estensione, oltre la quale c’è un limite che esclude il rimanente. È un errore considerare questa limitazione un ostacolo; vedremo che sono gli ostacoli di questo genere quelli che fanno sì che il cinematografo possa produrre opere d’arte. Da questa limitazione dipende il fatto che spesso è difficile rendere fotograficamente le condizioni ambientali di una situazione. Si capisce che un uomo che passeggi e si guardi intorno ha sempre il senso di orientamento del suo corpo perpendicolare al suolo, rispetto a quello che vede. Mentre non è così nella fotografia o nel film. Connessa al taglio del quadro è la distanza dall’oggetto. Quanto più è piccola la porzione di realtà che noi vogliamo riprendere, tanto più vicino deve stare l’apparecchio, e viceversa. Se si vuol prendere un intero 302 gruppo di uomini la macchina deve stare alla distanza di qualche metro, se vogliamo riprendere una sola mano la camera dovrà stare a mezzo metro da essa, per non prendere, oltre alla mano, ciò che le sta intorno. La macchina ha dunque, come un uomo in movimento, la possibilità di vedere un oggetto da vicino o da lontano, particolarità che costituisce un mezzo artistico importantissimo. La grandezza di un oggetto proiettato sullo schermo dipende dunque anzitutto dalla distanza della camera che lo ha ripreso, e poi, naturalmente, anche dall’ingrandimento con cui è proiettato. Il grado di ingrandimento dipende dall’ottica dell’apparecchio di proiezione e dalla distanza di esso dallo schermo e cioè dunque dalla profondità della sala. Un film si può proiettare su di uno schermo piccolo come quello di una lanterna magica e grande come quello di un enorme cinematografo. La grandezza della proiezione non è indifferente, così per esempio i movimenti nelle grandi proiezioni appaiono più rapidi che nelle piccole, perché, nel primo caso, in un tempo uguale, si debbono coprire superfici (schermi) più grandi. Il movimento, che in una grande sala di proiezione risulterà rapido e irrequieto, in una piccola può risultare lento e tranquillo. Dalla maggiore o minore grandezza di proiezione dipende la chiarezza dei particolari: c’è una bella differenza tra il vedere un uomo in modo tale che si possano contargli i brillanti della cravatta e il vederlo come un’apparizione indistinta e approssimativa. Praticamente, per ora, è impossibile proiettare un film in modo tale che tutto il pubblico lo veda nella giusta grandezza di proiezione. Abolizione della continuità spaziale e temporale Nella realtà, per lo spettatore, esiste una continuità spaziale e temporale che non ammette salti. Io posso vedere quello che stanno facendo due uomini in una stanza a quattro metri di distanza; posso modificare questa distanza, posso cioè avvicinarmi, poniamo, di due metri, ma questa variazione non può avvenire con un salto; io debbo cioè percorrere la differenza tra i quattro e i due metri. Posso abbandonare il mio angolo di visuale, ma non posso essere, a un tratto, in strada, senza uscir prima dalla porta e scendere le scale. Altrettanto dicasi per il tempo. Io non posso vedere quello che fanno questi due individui dieci minuti dopo senza che i dieci minuti passino. Non così nel film che può sempre spezzare questa continuità, tanto spaziale che temporale; una scena può esser immediatamente seguita da un’altra che avvenga in un tempo totalmente diverso; una casa può esser vista dalla distanza di cento metri e improvvisamente vicinissima. Io posso essere a Sidney e contemporaneamente – basta che le due scene siano intercalate – a Magdeburgo. Questa possibilità è anzitutto tecnica. In pratica questa libertà è limitata dal fatto che il film rappresenta, per lo più, un’azione che ha la sua unità spaziale e temporale. E ci sono delle regole: una scena deve 303 avvenire in un volger di tempo regolare. Se si è mostrata la figura intera di un uomo che solleva un revolver e spara, non si può, ad essa, far succedere il particolare in primo piano del revolver che si solleva e che esplode. La contemporaneità di due scene può esser spiegata mediante il facile mezzo delle didascalie o del dialogo. Per esempio: «Mentre Elisa lottava così per la vita e per la morte, Edoardo, a San Francisco, prendeva il piroscafo». Oppure: si è fatto sapere che alle 3:40 cominciano le corse ippiche. Si mostra una stanza in cui ci sono individui che se ne interessano; uno di loro estrae un orologio, sono le 3:40. Scena seguente: ippodromo, corse. Nell’interno di una scena la continuità temporale non può essere interrotta. Non solo, come si è detto, non si può ripetere l’azione contemporanea, ma non si può nemmeno escludere alcun tempo. Se io mostro un individuo che va dalla porta alla finestra non posso escludere la parte di mezzo del suo percorso se non per ottenere risultati grotteschi. E quindi, per abolire tutto quello che potrebbe essere superfluo, ci si serve, spesso, dell’inclusione di scene contemporanee, ma che avvengono in altro luogo. In questo modo rimarrà di ogni scena solo quella parte e quei momenti che sono necessari alla narrazione. Sotto questo punto di vista bisogna che, nel soggetto, ogni scena sia tale da contenere, nel minor tempo, tutto il necessario e solo il necessario. Esistono casi in cui queste regole sono, in parte, sospese. Quelli in cui il prima e il dopo non hanno importanza: questo caso si verifica spesso nei film istruttivi, in cui il raccordo è dato dalle cose più che dal tempo. Per esempio: «Non solo i cagnolini, anche i feroci leoni si lasciano addomesticare». Si vede prima l’addestratore di cani, poi il domatore. E casi simili possono verificarsi anche nei film narrativi. Il teatro ha le sue esigenze di realtà e le sue convenzioni: non si può mettere una lampada a petrolio in un salone elegante e non si può mettere un telefono accanto al letto di Desdemona. Ma la scena ha solo tre pareti. La riproduzione è dunque soltanto parziale. Anche nel film la riproduzione è soltanto parziale. Il film dà l’impressione di una riproduzione della realtà, ma non lo è. Si è vista l’abolizione dei colori naturali, la bidimensionalità, la limitazione del campo e ora l’abolizione della continuità spaziale e temporale, operazioni, queste ultime che si effettuano mediante il montaggio. Diversamente che nel teatro, al cinematografo lo spettatore cambia continuamente punto di vista senza che pertanto questa variazione, che a volte è rapidissima, gli dia il mal di mare. Si pensi ad una scena come questa: un individuo è dinnanzi ad una porta e suona il campanello; immediatamente appare un’altra stanza, l’interno della casa, e si vede la donna di servizio (lo spettatore è stato portato attraverso la porta nella casa) la ragazza va ad aprire, vede il visitatore; il visitatore osserva il viso della ragazza. Quanti salti di spazio e di tempo in pochi attimi! Eppure lo spettatore ha l’illusione della realtà. La riproduzione, come si è visto, non è completa, ma l’illusione è completata dalle convenzioni caratteristiche del cinematografo. 304 Abolizione del mondo sensorio non ottico Se io volto la testa si cambia il campo di visuale ed io vedo altri oggetti; ma l’impressione non è che questi oggetti si muovano. Questa è invece l’impressione che mi dà il movimento della camera (carrello e panoramica). Perché la camera non è una parte del corpo dello spettatore, come la testa e gli occhi, e perciò egli non può rendersi conto dei movimenti reali. Per questo, quando l’uso ne è sbagliato egli ha, al contrario, un senso di leggero mal di mare. Abbiamo nel film una relativizzazione del movimento. Per esempio se si riprende un’automobile da un’altra che corra più velocemente, si ha sullo schermo, l’impressione che la prima proceda a ritroso, pur svolgendosi normalmente in avanti la pellicola. Esiste però il mezzo di far risultare quale movimento sia assoluto e quale relativo di quelli che risultano sullo schermo. Se, per esempio, risulta dal quadro che la macchina da presa sta su di un’auto in corsa, cioè se si vedono parti dell’auto stessa immobili allo stesso punto del quadro, mentre in opposizione ad essi il paesaggio si muove, si comprende chiaramente che quello che si muove in realtà è il punto di ripresa su cui si trova la macchina mentre il paesaggio sta fermo. Il film dà anche una relativizzazione delle coordinate spaziali. Se si piazza una camera orizzontalmente su di un letto su cui un uomo sia sdraiato, lo si vede diritto. Per quanto si riferisce agli altri sensi (tutti ricordano che nel film muto, si aveva spesso l’impressione di sentire rumori corrispondenti all’azione, o che la proiezione di una funzione cattolica poteva dare l’impressione dell’odore dell’incenso). Odori, senso dell’equilibrio e senso del tatto si possono percepire non direttamente, ma solo attraverso l’impressione visiva. Da ciò si deduce la regola fondamentale che non debbano mai girarsi scene, azioni o situazioni se esse non si svolgono in modo visivo, o non trovando un corrispondente visivo suggestivo di esse. S’intende che anche in un film muto poteva esserci, ad esempio un colpo di rivoltella: bastava che il direttore mostrasse la rivoltella puntata e, eventualmente, la caduta del colpito. Nel film muto di Sternberg: I docks di New York, il rumore di uno sparo è reso assai bene coll’improvviso volar via degli uccelli spaventati. II Impiego artistico della proiezione dei corpi in superficie Si è detto nella prima parte che esiste un angolo di visuale che mostra una maggior parte di realtà di un altro, ma che questa non è la so- 305 luzione del problema artistico dell’inquadratura, che dipende dall’effetto artistico che si vuol conseguire. Nel film di quindici anni fa, Charlot emigrante, si vede un piroscafo in balìa di un orrendo beccheggio e tutti i passeggeri in preda al mal di mare. Chaplin appare con le spalle rivolte al pubblico, appoggiato al parapetto del piroscafo colla testa ricurva in avanti; tutto il pubblico ha l’impressione che egli renda il suo tributo all’oceano; improvvisamente egli si drizza e si volta e allora si vede che è riuscito a pescare, con un bastone da passeggio, un enorme pesce. L’effetto è ottenuto mediante la posizione della camera; se la scena fosse stata inquadrata dall’acqua, si sarebbe visto subito quello che era intento a fare Charlot e l’effetto di comica sorpresa sarebbe venuto meno. In questo caso non si è cercato di riprendere la scena nel modo più evidente, ma al contrario. Nel film di Dupont Variété si vede Jannings di fronte al giudice di spalle. Ha una giacca da galeotto con sopra un numero. L’effetto che ne risulta è quello di suscitare nello spettatore quest’ovvia sensazione: «Egli non è più un individuo, ma uno dei tanti, un numero». In un film più fantastico si sarebbe potuto ottenere un effetto simile mettendogli un numero al posto della testa, come al posto della testa, in certe caricature di burocrati, si vede un segno di paragrafo. Ma l’efficacia della scena di Dupont sta nell’aver saputo dare un valore ampio e significativo ad una visione pienamente veristica. In alcuni film russi, i capitani dell’industria e i generali sono ripresi dal basso come montagne. Il risultato ottiene il doppio effetto di apparire inconsueto e particolarmente espressivo agli effetti delle intenzioni sociali di quei film. Un effetto importante è quello che fa apparire un oggetto quotidiano come cosa inconsueta e fantastica. Nel film di René Clair Entr’acte c’è la ripresa di una ballerina dal basso, attraverso una lastra di vetro. Si vedono gli orli della veste che si aprono e si chiudono come un fiore e, in essi, la mimica strana e deformata delle gambe. L’effetto è straordinario ma solamente formale: molto maggiore sarebbe stato se avesse avuto un significato o un’intenzione: per esempio quello di mostrare il particolare sapore erotico di quella danza. Spesso irragionevolmente i registi si abbandonano al piacere di trovare qualche inquadratura raffinata, pur indipendentemente dalla sua significazione; cosa assolutamente fuori di posto. Nel bel film di Dreyer Giovanna d’Arco ci sono lunghe discussioni tra i preti e Giovanna. Quelle discussioni avrebbero dovuto essere naturalmente evitate, specie in un film, come quello, muto. Il Dreyer ha tentato di supplire alla mancanza di valore cinematografico di quelle scene mediante inquadrature raffinate; egli ci ha dato dunque una serie di bellissimi ritratti, ma più o meno privi di significato. Si deve tener presente che, nella vita quotidiana, la vista serve agli uomini come mezzo di orientamento: se un uomo entra in un negozio, il commesso guarderà la sua cravatta, per orientarsi sui gusti del cliente, e i suoi vestiti, per calcolarne le possibilità economiche; ma, se quello stesso individuo entra nel suo ufficio, il suo impiegato non si curerà affatto della cravatta, ma dell’espressione del volto, per vedere se per lui, quel giorno, spiri buono o cattivo vento. È noto che molti uomini non sanno se un loro conoscente abbia occhi chiari o scuri, quali siano i quadri esposti nella stanza in cui abitualmente mangiano, se la loro donna di servizio si vesta bene o male. Nell’arte invece non si tratta soltanto di orientarsi ma di essere colpito dall’espressione dei soggetti. L’inquadratura dunque non deve dare semplicemente “le cose”, ma il caratteristico dell’oggetto o della persona inquadrata. La riduzione delle tre dimensioni della realtà alle due dello schermo è una necessità di cui l’artista non può che avvantaggiarsi. Essa gli serve come mezzo per ottenere vari risultati artistici: 306 307 1) Presentando l’oggetto della ripresa in una forma inconsueta, costringe lo spettatore ad una più forte attenzione di quanta non ne occorra per una semplice constatazione di un dato di fatto. L’oggetto ripreso acquista maggiore immediatezza e l’impressione è più viva. 2) Non solo l’attenzione è potenziata: essa è diretta, oltre che sull’oggetto, sulle sue qualità formali. Lo spettatore vede l’oggetto, per quanto non stilizzato, deformato dalla proiezione in superficie dei corpi; e questo effetto che può essere particolarmente artistico, dipende unicamente dalla ben trovata inquadratura. 3) La maggiore attenzione diretta sull’oggetto e sulle sue qualità formali, mette lo spettatore in grado di giudicare del valore caratteristico dell’oggetto presentatogli. Per esempio di giudicare se un tipo sia stato ben scelto («Il vero tipo dell’impiegato!») e se si muova ed agisca coerentemente alle sue qualità. 4) Ma l’inquadratura serve anche come mezzo di espressione e di suggestione di qualche cosa di più ampio. (Il prigioniero visto come numero); ed anche questo risultato ha un suo fascino particolare perché per il conseguimento di esso non è necessario ricorrere a nessuna stilizzazione ma basta la realtà, convenientemente inquadrata. Se in un ambiente ci sono parecchi oggetti, l’uno può nascondere l’altro. Anche questo semplice fatto offre all’artista un buon mezzo per certi effetti artistici. Nel film di Room L’arsenale c’è la scena seguente: un prigioniero è rilasciato dal carcere; lo si vede camminare tra due enormi muri di pietra; in una fessura su di un muro egli trova qualche cosa che da molti anni non gli era dato vedere: un fiorellino che qui serve a simboleggiare, trovata in verità non troppo peregrina, la natura e la libertà; egli coglie il fiore, ha un improvviso impulso di ribellione e si volta verso il carcere, cioè verso la macchina, tendendo minacciosamente il pugno. Cambia inquadratura, la macchina indietreggia di un paio di metri e si piazza dietro l’inferriata del carcere. Si vede dunque l’inferriata che copre tutto il quadro e, oltre essa, la scena di prima, la strada e il prigioniero col pugno teso. È raro trovare un’inquadratura di tanta semplicità altrettanto efficace. Nel film di Pabst Giornale di una donna perduta si vede il commesso di una farmacia che bacia la figliola del farmacista; essi si trovano dinnanzi alla porta della farmacia stessa: dapprima la scena è ripresa dall’interno del negozio, poi dall’esterno, attraverso i vetri della porta. Questo cambiamento di inquadratura non è giustificato. Il risultato è semplicemente decorativo, ma è una ripetizione, e come tale, debole di effetto artistico. Una ripetizione di quel genere sarebbe stata giustificata per esempio dal fatto che un individuo, guardando da fuori verso la porta, avesse visto i due in atto di baciarsi. Un effetto simile a quello già citato di Chaplin è questo, dello stesso attore: Charlot è stato lasciato dalla moglie che non sopporta di vederlo sempre ubriaco; egli volge le spalle all’apparecchio ed ha innanzi a sé un tavolo su cui si vede il ritratto della moglie: le sue spalle sono scosse ininterrottamente, a quel che sembra, da continui singhiozzi, ma quando egli si volta si vede che aveva in mano uno shaker e lo agitava con entrambe le mani per prepararsi un cocktail. L’effetto è di grande efficacia comica. Nel film di Greta Garbo Guerra nelle tenebre si trova la seguente inquadratura; la spia Greta Garbo ha ucciso un generale russo nel suo studio; stanno per entrare quattro soldati; la scena è ripresa in modo che dalla porta non si vede che la spalliera della seggiola e un braccio del generale ucciso; i soldati entrano, Greta Garbo siede col viso rivolto alla porta, e quindi allo spettatore; i soldati chiedono udienza, la Garbo finge di parlare col generale, poi manda via i soldati. Nel film citato L’arsenale si vede una scena simile: i carcerieri entrano nello studio del direttore, che è seduto su di una seggiola, allo stesso modo che il generale nel film della Garbo: in principio si ha l’impressione che nella stanza non ci sia nessuno; appena i carcerieri cominciano a parlare compare il direttore da dietro la seggiola. Qui questo modo di presentazione non è giustificato come nel caso precedente e non ne ha dunque la potente efficacia: è un semplice mezzo decorativo. Spesso però, queste inquadrature ricercate hanno una loro giustificazione, per esempio, quando contribuiscono a dare un’efficacia ambientale; un caso simile si può vedere nella scena delle prove teatrali del film I nuovi signori di Feyder: qui la ripresa è tale che, oltre a risultar più originale di quanto non lo siano le normali inquadrature di scene del genere, viste già più volte, dà allo spettatore l’impressione di essere lui stesso in mezzo alla vita del teatro. Nel film La signora dell’amore di Greta Garbo (regia C. Brown) c’è una scena in cui si vede un padre che parla col figlio; colle spalle alla macchina da presa, molto grande e molto vicino, appare sul davanti lo scuro profilo del padre e, nello sfondo illuminato, il figlio. Quello che dice il padre risulta dai suoi gesti, e, soprattutto dall’espressione del figlio – un modo, molto efficace, di rappresentazione indiretta. 308 309 Impiego artistico dell’abolizione di profondità spaziale Ogni corpo, riprodotto cinematograficamente, risulta a un tempo piatto e plastico. Il paragone tra un film visto all’apparecchio stereoscopico ed un film normale mostra la superiorità del primo sul secondo dal punto di vista plastico; ma è proprio in forza dell’abolizione della profondità spaziale che, nel secondo, si ottengono effetti artistici che son spesso di prim’ordine, per esempio, la grandezza enorme del corpo e la piccolezza della testa. L’effetto citato per cui, nel film di René Clair le vesti di una ballerina si aprono e si chiudono come il calice di un fiore non è proprio dell’oggetto della ripresa, ma dipende dal punto di inquadratura e soprattutto dalla riduzione in superficie dei piani. La stessa mancanza di illusione spaziale si ha in pittura, collo stesso risultato artistico. La mancanza di verità in essa non è mancanza di bellezza, anzi è una delle sue caratteristiche impiegate a scopi artistici. La mancanza di profondità spaziale, nel film serve ad accentuare e a deformare artisticamente le proporzioni reciproche dei diversi oggetti. L’esempio citato sopra, in cui la silhouette di un uomo visto di spalle copre metà del quadro, mentre l’altra metà è occupata dal viso del figlio che lo ascolta se ci fosse nel film una perfetta illusione spaziale, perderebbe nove decimi della sua potenza. Il fatto che un oggetto più vicino appaia ingrandito, ed impicciolito uno più lontano può servire al direttore cinematografico per il raggiungimento di grandi risultati artistici. Tutti conoscono l’effetto che fa, nel film, una locomotiva che avanza verso l’obbiettivo. Il veloce ingrandirsi prospettico rinforza il carattere dinamico del movimento. Nel film di Dreyer Giovanna d’Arco questo mezzo è usato per sottolineare l’improvviso irritarsi di un monaco che s’alza in piedi muovendo in avanti contro l’obbiettivo: in un attimo questo suo movimento in avanti lo fa apparire gigantesco. Un esempio famoso di saggio impiego di questa legge è dato dal film di Pudovkin La fine di San Pietroburgo: due campagnoli, spinti dalla fame, vengono in città, per cercare lavoro. Quanto siano piccoli essi e le loro aspirazioni al cospetto della colossale e potente città che li circonda è mostrato in questo modo: sul davanti un monumento equestre di uno zar e, nello sfondo, un’ampia piazza vuota, su cui, come due formiche, come due punti neri, i due contadini. Se il quadro avesse un forte senso plastico, se cioè la grande distanza tra il monumento e i due uomini risultasse chiaramente, questa differenza di proporzioni non sarebbe così impressionante ed efficace, ma naturale ed insignificante. L’effetto simbolico, simile a quello per cui gli antichi egiziani face- vano, nei loro bassorilievi, enorme il re vincitore e piccoli i suoi nemici, contiene un senso profondo e coerente alle intenzioni della narrazione. Un effetto simile l’ha ottenuto Ejzenštejn nel suo film La linea generale; la sua intenzione era di mostrare come, in un ufficio, l’andamento burocratico pesante ostacoli il normale procedere del lavoro; la camera, piazzata vicinissima alla macchina da scrivere, la fa apparire come gigantesca, ed il rullo di essa muovendosi lentamente copre quasi tutto lo schermo; nel fondo, piccoli piccoli l’impiegato che detta e la dattilografa. Altrettanto è stato fatto con un registro enorme dietro cui quasi scompare un piccolo contabile. Nel film La folla (K. Vidor) si vede questa scena: un ragazzo siede insieme ai suoi compagni, e racconta: «Mio padre dice sempre che... ». In quella egli s’accorge che, attorno al portone di casa sua, s’è formata una ressa e s’è fermata una lettiga; pieno di angosciosi presentimenti, egli si precipita a vedere. Ora la camera è piazzata sull’alto di una scala, e la porta nel fondo appare piccola, mentre le scale si allargano sul davanti del quadro. In basso, accanto alla porta, si accalcano i curiosi; il giovinetto si ficca in mezzo a loro e comincia a salire le scale; in principio è piccolo, poi, a poco a poco, si fa più grande; e alla fine – la folla gli fa largo – egli appare in cima alla scala grande e solo: un figlio che ha perduto il padre. Quello che c’è di grandioso in quest’effetto è la semplicità del mezzo impiegato. Niente è più comune della constatazione di queste deformazioni prospettiche, ma il risultato che se ne può ottenere è spesso, altamente artistico. Qui viene in ballo l’arte dell’operatore. L’autore e il direttore possono aver pensato un effetto simile, occorre che l’operatore sia in grado di renderlo. Bastano a volte differenze di pochi centimetri nella direzione dell’obbiettivo e differenze di mezzo metro nel piazzamento della camera avanti o indietro, per guastare tutto l’effetto. Anche il gioco delle luci ha la sua grande importanza. Basta una eccessiva illuminazione nello sfondo o un’errata posizione di un proiettore per distruggere i risultati pensati. Ai tempi in cui la cinematografia muoveva i primi passi incerti la cura degli operatori era costantemente quella di non far apparire mani e piedi sproporzionati non facendoli mai troppo avvicinare alla camera. Oggi queste deformazioni prospettiche sono riconosciute e impiegate come uno dei più forti mezzi artistici del cinematografo. I tecnici non sono artisti e non si preoccupano di offrire agli artisti nuovi mezzi, ma solo di ottenere o di aumentare la naturalezza della visione. Per un tecnico è importante che il film sia riproduzione della realtà. Egli si preoccupa della mancanza di rumori e di voci, della mancanza di colori, della mancanza di plasticità e quindi lavora al film sonoro, al film stereoscopico, al film a colori. Similmente la pensa il pubblico che preferisce il film parlato al film muto, il film a colori al film normale. Ogni nuovo passo verso l’esattezza di riproduzione della realtà provoca una grande emozione e quindi un grande interessamento di pubblico e successi di cassetta che commuovono gli industriali e li interessano quindi a queste ricerche. Ma queste questioni sono per ora premature. Impiego artistico della illuminazione e dell’abolizione dei colori Se dagli esempi citati si è bene inteso che valore possa avere, agli effetti artistici e simbolici, l’alterazione delle proporzioni degli oggetti, in special modo nelle loro relazioni reciproche, in modo cioè che lo spettatore sia costretto a vederle come significanti, e se si è capito il valore decorativo della proiezione dei corpi in superficie, si considererà ogni sforzo tecnico, per il conseguimento della visione cinematografica plastica e stereoscopica come una ricerca che tende a privare il cinematografo di uno dei suoi più importanti mezzi di realizzazione artistica. Quanto si è detto della mancanza di profondità spaziale vale anche per la mancanza dei colori. Il fatto che l’artista cinematografico sia costretto al bianco e nero gli offre la possibilità di ottenere particolari effetti. Il pittore non riproduce i colori della natura ma li ricrea. Se sia possibile fare altrettanto col film ci dimostrerà l’imminente avvenire. Quello che importa è che la riduzione dei colori a bianco e nero dà la possibilità, con una acconcia illuminazione, di creare immagini ricche di valore decorativo e significativo. Grandi possibilità risiedono nella posizione delle lampade, nelle ombre, nella posizione del sole (per le riprese a luce naturale) nel modo in cui, mediante gli schermi, si diffonde la luce e, mediante i gobbi, si attenuano le ombre. E questi sono tra i mezzi fondamentali della creazione cinematografica. Nel film di Sternberg I docks di New York i due protagonisti del film sono caratterizzati in questo modo dal loro aspetto esteriore: la donna è bianca di viso e di abiti e l’altro, il marinaio, tutto nero. La felice congruenza artistica è data dalla rispondenza della loro personalità interiore a questo loro aspetto esterno. Il mezzo è semplicissimo e addirittura primitivo, il risultato è potente. È chiaro che con un film a colori sarebbe impossibile ottenere l’identico risultato. In un film di Granowsky, la scena di un’operazione di parto rende l’atmosfera mortalmente tranquilla dell’atto chirurgico, mediante il contrasto del grande camice bianco, delle bianche lacche sterilizzate e dell’ovatta coi guanti neri e i neri strumenti del chirurgo. Si pensi al volto delle attrici: all’efficacia di quei bianchi e di quei neri! Ogni frequentatore di prime cinematografiche, presenziate dagli interpreti, sa quanto appaiano stranamente rosei i loro visi. Mentre che i volti stilizzati sullo schermo non sono volti di carne e sangue, ma solo materia artistica, mezzi artistici. Tutti i film di grande classe e, soprattutto, quelli russi e americani, mostrano una enorme efficacia nell’uso del bianco e del nero e delle loro gradazioni. Nel film di Ruttmann Sinfonia di una grande città c’è una 310 311 scena in cui si mostra una strada di Berlino nelle prime ore della mattina; in essa il torbido grigiore mattinale, l’oscurità imprecisa e le scure silhouette degli operai che vanno al lavoro hanno un fascino potente. I film polizieschi hanno rivelato l’impressione che fa un ambiente scuro quando improvvisamente lo illumina il triangolo luminoso di una lampadina tascabile; e sono noti, in genere, gli effetti delle nuvole attorno alla luna, le ombre delle foglie mosse dal vento sul suolo, le luci parallele dei riflettori di una automobile, le nere macchie di sangue sulla pelle bianca, i riflessi tremanti sulle superfici delle acque ecc., effetti che sono possibili solo colla riduzione dei colori al bianco e nero. L’illuminazione serve a dare un particolare aspetto e addirittura una particolare forma ai corpi. Basti ricordare il viso dell’attrice russa Vera Baranovskaja in uno dei film girati in Russia sotto la direzione di Pudovchin e quello che ha assunto nei film girati all’estero, per esempio: Così è la vita o Gas asfissianti e si vedrà con meraviglia che quella signora, che nei film russi appariva piena di forma e quasi ossuta per effetto di ricchi contrasti di luce, nei film stranieri appare priva di espressione e piatta. Tutto ciò dipende dall’illuminazione e dalla tecnica della ripresa. Oppure si consideri Greta Garbo nel film di Pabst La via senza gioia e la si paragoni alla Garbo dei film americani; posto che il film tedesco è di parecchio anteriore e che la tecnica del trucco vi è arretrata, il viso di quella donna straordinaria apparirà irriconoscibile. Nel film tedesco è quasi calcareo, terroso e simile ad una maschera, gli occhi sono privi di espressione e la chioma sembra polverosa. Nei film americani la pelle è liscia, ha uno splendore marmoreo, gli occhi chiari hanno una straordinaria forza di sguardo ed i capelli una luce meravigliosa che li fa apparire elettrici e fosforescenti. Col bianco e nero del film e col sapiente uso delle luci si può ottenere quello che ottengono i pittori: il senso prezioso delle materie. Anche qui bisogna accettare il dato di fatto e servirsene come mezzo artistico. È molto istruttivo un aneddoto che racconta Cecil DeMille: egli, per ottenere un maggior effetto, in una scena di un film di spionaggio, provò a illuminare soltanto la metà del volto della spia, lasciando l’altra metà in ombra. Il risultato gli sembrò straordinario, così che egli se ne servì in più parti del film. Mandata la pellicola all’ufficio commerciale della casa di produzione, il tentativo fu considerato una pazzia: e il DeMille dovette appellarsi a Rembrandt per far passare il suo lavoro. Lanciato come il primo film illuminato alla maniera di Rembrandt, gli incassi furono doppi. L’esempio dimostra che il problema non è quello di eliminare le ombre e ottenere la maggior completezza e verosimiglianza possibile, ma quello di raggiungere la massima espressività. 312 Impiego artistico della delimitazione del quadro e della distanza dell’oggetto Il problema della delimitazione del quadro e conseguentemente quello delle sue dimensioni sono sempre di attualità. Abel Gance ha girato alcune scene del suo Napoleone per uno schermo triplice, ed in America si son fatti e si fanno molti tentativi per ingrandire le dimensioni dello schermo. Questa tendenza ad aumentare la superficie del quadro è da mettere insieme alle tendenze per il film plastico visivo e sonoro; esigenze quantitative più che qualitative. Non è invece mai il più ma il meglio quello che importa. Tutti questi mezzi per avvicinare il film alla realtà non sono che impoverimenti delle sue possibilità a produrre arte. Oltre il problema della grandezza del quadro si è anche posto il problema della fama del quadro stesso. Si sono fatte statistiche sulla forma delle pitture e ricerche di vario genere. Il régisseur russo Ejzenštejn ha sostenuto che la forma più adatta per il quadro cinematografico sia un quadrato, usato come base di un formato reso variabile mediante l’applicazione di mascherini. Ai primordi della cinematografia si riprendevano soltanto campi lunghi e non si facevano mai particolari o primi piani. Le difficoltà da superare per introdurre questi mezzi sono state aspre e tuttavia oggi la rivoluzione è diventata l’ordine e non c’è mediocre direttore che non se ne serva. Nel film di Buster Keaton Io e la scimmia c’è questa scena: di mattina presto si vede l’ufficio che si apre e gli impiegati che arrivano, l’ambiente è diviso da un bancone che separa l’ufficio propriamente detto da un ingresso in cui si ricevono i clienti. Improvvisamente la macchina si muove, scopre un campo appena di poco più grande del precedente, e si vede Buster Keaton, seduto in un angolo con la sua aria impassibile. Egli ha pernottato nell’ufficio per attendere la sua ragazza. Quest’esempio serve a dimostrare che campo totale è un’impressione imprecisa e relativa e che anche un campo totale può, in certi casi, aver funzione di taglio e di particolare. La scena del film di Keaton si sarebbe potuta immaginare diversamente: la ragazza sale le scale, apre la porta dell’ufficio e vede Keaton. Ma l’effetto di sorpresa e di comicità, nel caso citato, deriva dal fatto che lo spettatore crede di aver dinnanzi agli occhi una scena chiusa e completa e, tutto a un tratto, l’ordine e la tranquillità che vi regnavano, si spezzano per l’apparizione del paziente innamorato. Un effetto simile lo ha ottenuto Chaplin nel suo film Gente altolocata; si vede Charlot elegantemente vestito in frak e cilindro, ma se ne vede solo la parte superiore; quando la macchina si abbassa si scopre che egli è in mutande. Anche qui la parte mostrata ha una struttura chiusa, un uomo elegantemente vestito, ma il quadro successivo dà immediatamente un effetto di contrasto e di grottesca comicità. Ora una scena del tutto diversa. Nel film di Sternberg I docks di New 313 York si vede una suicida gettarsi da un piroscafo in acqua. La scena è condotta così: si vede l’acqua in cui si riflette prima il piroscafo e poi la donna che si getta; si vede infine la donna vera precipitare precisamente nello specchio d’acqua che aveva mostrato indirettamente la scena del salto. Questo succedersi della visione diretta a quella indiretta è pieno di efficacia. Molti effetti di questo genere sono però diventati un luogo comune; si pensi alle ombre dei banditi che sfilano silenziosamente e cautamente su di un muro, mostrate invece dei banditi stessi. Ed ora veniamo al primo piano. Il principio è che quanto più piccolo è il particolare che si riprende, tanto più grande esso risulta sullo schermo. Il primo piano non serve all’artista unicamente per mostrare i particolari che diversamente, in un campo lungo o totale, non avrebbero potuto notarsi, per esempio le lacrime su di un viso, o un gattino in un angolo di una stanza. La ripresa di un particolare deve essere del particolare più caratteristico; solo questo la giustifica e la legittima. Nel film di Pabst Giornale di una donna perduta l’ambiente di un collegio è rappresentato in questo modo: si vede il viso arcigno e cattivo dell’istitutrice e poi si vede l’istitutrice che batte ritmicamente il gong; la macchina indietreggia e compaiono, attorno ad una lunga tavolata, le educande, che con esattezza militaresca, portano tutte assieme il cucchiaio alla bocca. In questo caso il centro caratteristico della situazione, atmosfera opprimente e militaresca, è stato colto mediante particolari ben scelti. Nel film già citato I docks di New York c’è una scena d’amore tra un marinaio ed una prostituta. Essi stanno seduti e bevono insieme: niente fa pensare ai loro amori, quando il primo piano mostra una scena quasi oscena: si vede la donna che palpa con piacere il braccio dell’uomo, sconciamente tatuato, i cui muscoli si tumefanno. Questa scena in un campo totale non avrebbe dato lo stesso effetto: il nudo braccio dell’uomo in luogo dell’uomo stesso è una saggia applicazione del principio della parte per il tutto; la donna del marinaio non vede che la forte, nuda e potente maschilità. Esempi di questo genere si possono trovare in qualsiasi film; i piedi di un uomo che sale le scale; di una coppia che si bacia, solo le gambe. Nel film di Feyder I nuovi signori c’è la scena dell’inaugurazione di una colonia operaia; il ministro, che partecipa alla visita ha fretta e cerca di accelerare il passo quanto più può; il corteo è rapidissimo, ad un tratto: primo piano uno dei partecipanti al corteo che si asciuga il sudore. Il particolare scelto è caratteristico della situazione di tutti i partecipanti al corteo. Nel film di Pudovkin La madre la scena del tribunale è introdotta con primi piani fulmineamente rapidi della fredda facciata di pietra dell’edificio, e, una volta, perfino dello stivale della sentinella, strana apparizione nera e pesante, che provoca nello spettatore un’impressione molto coerente alla scena. I russi hanno creato un loro modo particolarmente violento ed effica- ce, di usare i primi piani. Le possibilità della limitazione e del taglio del campo e della distanza della ripresa servono all’artista per ottenere effetti speciali di parte per il tutto, di ottenere una speciale tensione nello spettatore mostrandogli solo quello che è più importante, per accentuare certi aspetti singoli, per dare a qualcuno di essi un significato evocativo e simbolico, per concentrare l’attenzione su di un momento specifico dell’azione. Ma il primo piano ha il suo rovescio. Utilizzato male e senza ragione, esso toglie allo spettatore la possibilità di orientamento ambientale; così avviene in molti film russi e nella Giovanna d’Arco. Coi grossi testoni che appaiono sullo schermo, spesso non si capisce a chi appartengano, dove si svolge l’azione, chi ne siano gli altri componenti. Il disorientamento e la poca comprensività nello spettatore spesso son causati da un uso eccessivo e superfluo di primi piani. Il primo piano è uno dei mezzi caratteristici della cinematografia. S’intende bene che questo mezzo è negato al teatro; se un fiore è il centro dell’azione di una scena, il teatro non può riferircisi se non con la mimica e le parole degli attori. Nel film questo non è necessario, proprio in virtù delle regole della limitazione del campo. La possibilità di cambiare rapidamente e immediatamente la distanza degli oggetti delle riprese permette effetti particolari di relativizzazione di proporzioni. In un film educativo si son viste alcune costruzioni recenti di Berlino e, subito dopo, un modellino di gesso riproducente Roma; le case di Berlino e quelle di Roma apparivano allo spettatore della stessa grandezza. Così nel film Quelli del Basso Reno si vede la rotonda pancetta di uno studente grande come la montagna, di forma simile, che sovrasta Heidelberg. S’intende che l’effetto era ottenuto riprendendo molto da vicino il pancione dello studente e molto da lontano la montagna. Nel film tratto da Casa di bambola di Ibsen, c’è un esempio contrario. Si vede una stanza, ed in essa appare improvvisamente una mano gigantesca che la occupa quasi tutta. Si capisce allora che la stanza era un giocattolo. La scena aveva un valore allusivo nei riguardi dell’azione del film. Ancora una volta dunque una delle pretese manchevolezze del film – la relatività delle proporzioni e lo smarrimento, in alcuni casi, del senso di esse, – risulta come uno dei mezzi artistici caratteristici ed efficaci del cinematografo. 314 315 Impiego artistico dell’abolizione della continuità spaziale e temporale Diversamente che nella realtà, nella visione cinematografica sono possibili salti di tempo e di spazio. Si chiama montaggio l’operazione per cui si uniscono riprese di azioni svoltesi in spazio e tempo diversi. Il montaggio è, delle varie fasi della creazione artistica cinematografica, quella che è stata oggetto di maggiori indagini e approfondimenti, specialmente da parte dei russi. I russi sono i primi che hanno adoperato il montaggio in modo da rivelarne le potenti possibilità artistiche, e sono i primi che hanno tentato di stabilire sistematicamente i principi fondamentali di esso. Pudovchin comincia un suo libro famoso con l’affermazione che «il fondamento dell’arte cinematografica è il montaggio». Noi abbiamo cercato di mostrare, quanto più chiaramente ci è stato possibile, che anche i singoli pezzi di pellicola non sono affatto informe natura e materia informe, ma già prodotto artistico notevolmente differenziato dalla realtà. Si veda l’esempio citato da V. Pudovchin nel suo libro sul Soggetto cinematografico: «Si trattava, per me, di rendere cinematograficamente l’impressione della gioia. La semplice espressione del viso sarebbe rimasta senza effetto. Io ho dunque mostrato solo il gioco delle mani e un primo piano della metà inferiore del volto e della bocca sorridente. Questi pezzi li ho poi montati con un materiale del tutto estraneo all’azione e precisamente con il tumultuoso scorrere di un torrente primaverile, col gioco dei raggi di sole rifranti sulle acque, con animali domestici starnazzanti in un cortile e infine con un ragazzo ridente. In questo modo ho rappresentato la gioia del prigioniero». Anzitutto è caratteristico il fatto che Pudovchin dichiari che la fotografia del viso ridente sarebbe rimasta senza effetto; è interessante questo disprezzo di Pudovchin per il pezzo non montato, per la materia informe (che, bisogna riconoscere, se esiste nella teoria dei russi sul cinematografo, non esiste affatto in pratica, perché essi scelgono ed elaborano sempre saggiamente e finemente il loro materiale). Ed è molto discutibile il fatto che elementi tanto disparati come quelli di cui si è servito Pudovchin per quella scena del suo film (La madre), abbiano potuto fondersi in unità. Quello che nella poesia è sempre possibile, il richiamo associativo delle parole e delle immagini, non lo è nel film (almeno non nel film spettacolare che racconta veristicamente una trama) similitudini e associazioni come ruscello, raggi di sole ecc., non sono presentati astrattamente, ma nella loro concretezza formale e visiva, se non reale almeno fotografica, e quindi, più che giovare al risultato, non possono che nuocergli. Ma è cosa del tutto diversa e legittima il montaggio di pezzi che se non hanno tra loro continuità spaziale, ne hanno una contenutistica. L’abolizione della continuità spaziale, che è uno dei mezzi caratteristici dell’arte cinematografica, deve esser impiegata in modo tale da non creare confusione e disorientamento nello spettatore, cosa che succede a volte anche nelle scene che avvengono in uno stesso ambiente quando il montaggio sia stato condotto malamente; per esempio nel caso che si mostri un personaggio e poi un altro e non si capisca che entrambi sono in uno stesso ambiente, o non risulti la loro reciproca posizione. Pudovkin ha fissato cinque metodi di montaggio che tuttavia costituiscono uno schema poco soddisfacente perché la suddivisione è determinata a volte dal contenuto e a volte dal modo di taglio, e non vi si tien conto della distinzione tra questi due fattori. 1) Il contrasto. («per esempio si vuol mostrare il misero stato di un uomo affamato. Il racconto avrà una efficacia tanto maggiore se contrasterà con scene di spensierata ricchezza»). Abbiamo qui di nuovo la solita strana diffidenza verso il motivo non montato. Della tecnica del taglio non si dice nulla; non si dice se le scene debbano essere intercalate o come disposte. 2) La parallelità. («Questo secondo metodo è simile al primo ma va ancora oltre perché rappresenta le due azioni contrapposte alternativamente in un unico montaggio»). Come si vede l’ordinamento logico è sbagliato. Il metodo del contrasto si riferisce al contenuto, quello della parallelità alla tecnica del taglio. 3) La similitudine. («Il finale del film Sciopero: la fucilazione di operai è interrotta dall’uccisione di un bue in un cortile»). Questa categoria si riferisce di nuovo al contenuto. In teoria è indifferente che i pezzi siano successivi o intercalati – seppure il secondo caso sarà il più efficace. 4) La simultaneità. («Lo svolgersi di due azioni la cui relazione è data dal fatto che esse sono contemporanee. Per esempio il finale di Intolerance e in genere il finale alla Griffith»). Qui si è introdotto un elemento di cui, nei casi precedenti, non si era fatto parola: quello del tempo in cui si svolge l’azione. 5) Il leitmotiv. («Se l’autore vuol sottolineare il tema fondamentale del soggetto può giovarsi del metodo del ricordo. La scena caratteristica è ripetuta più volte). E questo è di nuovo un motivo puramente contenutistico. Timoshenko distingue (nel suo studio Taglio e montaggio del film) 15 diversi modi di montaggio, ma non mette il conto di esaminare qui singolarmente i singoli casi perché questa classificazione poco soddisfacente non è altro che una elencazione di fattori eterogenei1. C’è da notare che i pezzi di montaggio incollati, quando l’operazione è stata condotta rettamente ed è riuscita, non hanno effetto semplicemente di addizione, ma un effetto ben altrimenti forte. Si pensi ad Ejzenštejn. L’esempio citato della sparatoria sui lavoratori e dell’uccisione del bue ha un effetto significante. Il presentare un individuo grasso e poi uno magro può creare l’impressione di un uomo che “dimagrisce”. È noto come il rapido succedersi tende a sovrapporre e a fondere le immagini; e l’esistenza del film, che è presentazione di immagini in movimento, si basa precisamente su questo principio. Se in un quadro si mostra un profilo e nel quadro successivo si mostra lo stesso viso di faccia, si ottiene l’impressione che il viso si sia voltato. C’è una scena, famosa giustamente, di Ejzenštejn in cui si vede un leone di pietra alzarsi e ruggire. Il montaggio è condotto così: 1° monumento: un leone che giace tranquillamente. 2° monumento: un leone che si alza. 3° monumento: un leone in piedi che, colle fauci aperte, rugge e sembra chiedere vendetta. Un effetto analogo è tentato in Così è la vita di Carl Junghans: 1° quadro: la figura di un santo colle braccia incrociate. Quadro 2°: una simile figura con il braccio sollevato. Effetto con significato simbolico: il santo è vivo e dà un segno, un ammonimento. Effetti notevoli si ottengono con quello che si può chiamare montaggio 316 317 nascosto (che spesso non è che uno dei cosiddetti trucchi). Per esempio la sparizione di persone (mezzo usato più di una volta da Charlot e da René Clair). Analoghi sono gli effetti di acceleramento (in un film di W. Basse la scena del popolarsi di un mercato, che nella realtà si svolge in una mezz’ora circa, è data nello spazio di pochi secondi). Che oggetti inanimati si possano far muovere si è visto nell’esempio citato di Ejzenštejn e nell’altro del film Così è la vita, e, in un senso un po’ diverso, nei disegni animati2. Impiego artistico dell’abolizione del mondo sensibile non visivo Abbiamo detto più sopra che l’abolizione del senso di equilibrio e del senso muscolare porta alla conseguenza che il quadro ripreso dalla camera non possa risultare sullo schermo quale nella realtà lo hanno visto gli occhi. Un uomo sa sempre nella realtà se i suoi occhi son rivolti orizzontalmente o se guardano dal basso o dall’alto; egli sa sempre se il suo corpo si muove o sta fermo e, se si muove a quale velocità si muove. Ma lo spettatore di un film non sa mai che angolo di ripresa avesse la macchina se non ne è informato in qualche modo dal contenuto del quadro stesso. Se un oggetto si muove sullo schermo lo spettatore, per un attimo, può credere che l’oggetto si muova effettivamente anche se quel movimento è invece il risultato del muoversi della macchina. Della relativizzazione del movimento si ha un esempio eccellente nel film famoso Il dottor Mabuse in quella scena in cui, per mostrare la potenza di quell’uomo misterioso, se ne mostrava il viso dapprima piccolissimo su di uno sfondo nero, e poi si vedeva il viso avvicinarsi rapidamente sino a diventar gigantesco e a coprire tutto quanto lo schermo. Naturalmente nella ripresa era la macchina che si era avvicinata al viso e non il viso alla macchina. Nel film russo Il documento di Shanghai c’è una scena di corse ippiche. Il campo totale dell’azione coi cavalli e i fantini è intercalato con un primo piano di una bandierina che adorna un cavallo e, sventolando, dà l’impressione del movimento del cavallo stesso. Nel film di Murnau I quattro diavoli si vede la scena di un circo: un cavallo bianco corre intorno all’arena e la camera lo segue in modo che esso sia sempre al centro del quadro e sembri quasi che non si muova, dato che non se ne vedono le gambe: ma nello sfondo tutto il pubblico si muove panoramicamente. Nell’Opera da quattro soldi, Pabst ha usato allo scopo di procurare un tono di favola irreale al suo film, il senso di instabilità del punto di vista che dà il movimento della camera. Effetti importanti si possono ottenere servendosi della relativizzazione delle coordinate spaziali, per esempio la macchina, bene a piombo, inquadra un uomo che sta verticalmente, poi un uomo che giace è ripreso dalla macchina posta anch’essa orizzontalmente. Per esempio si possono sovraimprimere le due riprese, o comunque cavarne risultati utili agli effetti della narrazione. 318 Prima dell’invenzione del “sonoro” molti si lamentavano della manchevolezza e imperfezione del “muto”. Ma essa non costituiva nessuna imperfezione. Chaplin ha dichiarato di recente che nei suoi film egli non ha mai sentito il bisogno di parlare né che gli altri suoi collaboratori parlassero. Non c’è da meravigliarsene perché Charlot sostituisce i dialoghi colla sua perfetta pantomima: egli non dice che la visita di Giorgia lo rallegra, ma crea la famosa “danza dei panini” (Febbre dell’oro); quando fa la predica non parla, ma rievoca indimenticabilmente la storia di Davide e Golia (Pellegrino); quando è commosso e impietosito caccia in tasca alla donna il suo denaro; rinunciando, se ne va via (finale del Circo). Questa incredibile concretezza ottica di ogni scena di Chaplin deve essere ricordata, quando si dice, non senza qualche ragione, che egli è in un certo senso “anticinematografico” e questo per la funzione limitata che ha la camera nei suoi film. Abbiamo già citato l’esempio del film di Sternberg I docks di New York in cui uno sparo provoca una fuga di uccelli. Qui è impiegato uno dei mezzi preferiti dall’arte in genere e non solo dal cinematografo. Quando Dante dice: «quel giorno più non vi leggemmo avanti» evoca indirettamente quello che hanno fatto Francesca e Paolo. Analogo è il mezzo usato da Sternberg, mezzo più potente ed espressivo che se si fosse sentito il colpo. Nel film di Feyder I nuovi signori c’è questa scena: una riunione politica molto tesa. Il pubblico è eccitato e ascolta il discorso demagogico dell’oratore. Per calmare gli animi Susanna ricorre alla musica; e si vedono i visi, che prima eran tutti rivolti all’oratore, placarsi nelle espressioni finché le teste cominciano a muoversi al tempo della musichetta. Anche qui l’effetto visivo è molto più forte che se non si sentisse la musica. Si aggiunga che, se si sente parlare un uomo, la sua espressione e la sua mimica hanno solo la funzione sussidiaria e laterale. Ma se non lo si sente e solo dal movimento delle labbra, dalla dinamica di quei movimenti, di quelli dei muscoli della faccia, delle membra e del corpo si capisce chiaramente quello che egli dice, allora l’immagine diventa dominante e espressiva. Ulteriori mezzi della tecnica cinematografica 1) Movimenti della camera Fino ad ora si è parlato per lo più della camera ferma. Ma come è noto la camera può muoversi in panoramica o in carrello. L’avvicinarsi della camera ottiene l’effetto di un ingrandirsi dell’oggetto della ripresa e l’allontanarsi amplifica il campo di ripresa. È dunque possibile un passaggio dal campo totale o lungo al primo piano e viceversa. La camera può accompagnare l’eroe attraverso stanze, scale, strade, lasciandolo sempre al centro del quadro e di grandezza costante, mentre quello che via via lo circonda scorre panoramicamente. C’è dunque per il film la possibilità, assai rara nel teatro, di mostrare soggettivamente il mondo, cioè dal punto di vista di un individuo. 319 2) Marcia indietro Questo è un effetto raramente in uso nei film narrativi o di recitazione, ma tuttavia notevolissimo ed è uno dei mezzi che maggiormente allontanano il cinematografo dal concetto di “riproduzione della realtà”. Ma, a parte l’uso di questo mezzo per il conseguimento di speciali effetti fantastici, è certo che pezzi di un oggetto rotto che si ricompongono, la mimica di una espressione ripresa all’indietro e simili, sono cose che il più delle volte son state fatte per gioco, ma nelle quali un artista può trovare la capacità di esprimere quello che ha da dire. 3) Accelerazione Se si diminuisce la cadenza di presa si ottiene l’effetto di aumentare la velocità del movimento. Spesso ci si è serviti di questo mezzo per stilizzare il movimento di una grande città. E l’uso di questo mezzo è già stato spesso introdotto in film d’arte. Per esempio nel film di Ejzenštejn La linea generale si mostra la lentezza burocratica, poi l’intervento di un tipo energico che minaccia e batte un pugno sul tavolino, e, conseguenza immediata, il lavoro degli uffici si svolge con un ritmo di rapidità vertiginosa. Nel film Il miracolo dei fiori si mostra con questo mezzo la strana e suggestiva mimica dei fiori, invisibile a occhio nudo. Analogamente si è già mostrato nei film educativi il formarsi dei cristalli ecc. In un film di Jean Renoir questo mezzo è impiegato per mostrare, là del resto immotivatamente, il fiorire di una rosa. 4) Rallentamento Se si aumenta la cadenza di presa si ottiene l’effetto contrario a quello precedentemente citato, e cioè di un rallentamento dei movimenti dell’azione ripresa. Questo mezzo è stato impiegato, fino ad ora, per lo più nel film a carattere educativo ed istruttivo e precisamente per mostrare in modo percepibile le varie fasi di certi movimenti rapidi. In questo modo è possibile analizzare la tecnica di un boxer, di un violinista, l’esplosione di una granata, il salto di un cane ecc. A scopi artistici questo mezzo che oltre a rallentare i movimenti può anche crearne, in un certo senso, di nuovi è stato fino ad ora assai poco impiegato. Esso sembra particolarmente efficace per ottenere effetti di allucinazione e fantomatici. Grandemente interessante dev’essere la ripresa della mimica di una persona ed anche in questo caso è Pudovkin il primo3: nel suo film in lavorazione La vita è bella egli ha impiegato il rallentamento per riprendere il viso in primo piano di un giovane che ride. Nel film di René Clair Entr’acte è usato questo mezzo per riprendere la scena di una folla in lutto che segue un funerale. La scena è efficace per il risultato caricaturale e grottesco. 5) Quadri fissi L’introduzione di una fotografia fissa in un film in movimento può 320 produrre curiosi effetti di irrigidimento. Nel film del Filmstudio 1929 Domenica di Siodmak si vedono degli individui che si fanno fotografare e ne sono inserite le fotografie: il risultato è notevole per il senso di irrigidimento che si ottiene dell’immagine. Si pensi alla moglie di Lot. 6) Iris, dissolvenza, dissolvenza incrociata Servono a stabilire una cesura tra i singoli pezzi di montaggio, a far meno crudo il passaggio da una scena all’altra, a far intendere che cambia il tempo e il luogo dell’azione, a suggerire l’idea dell’addormentarsi o dello svegliarsi, o quella del ricordo. Questi mezzi quando sono saggiamente impiegati integrano il montaggio. 7) Sovraimpressione È un ottimo mezzo per ottenere effetti di caos e di disordine. Il caso è molto noto. Analogo è l’effetto del montaggio simultaneo. Dziga Vertov ha mostrato due o tre volte nello stesso quadro lo stesso oggetto o la stessa scena, per esempio la stessa macchina. Questo mezzo è usato per i doppi ruoli di attori: fa naturalmente un certo effetto vedere Henny Porten cameriera che serve la signora Henny Porten. Paul Morgan in una rivista canta un duetto con se stesso. Molto validamente è stato usato questo mezzo nelle scene di sdoppiamento dello Studente di Praga. In un film del Sovkino (L’uomo che perse la memoria) si vedono un soldato russo ed uno tedesco che si stanno scagliando l’uno contro l’altro colla baionetta, improvvisamente: primo piano: i due hanno la stessa faccia (sono interpretati dallo stesso attore). 8) Lenti speciali Un effetto di riproduzione multipla dell’oggetto si può ottenere mediante lenti speciali. Tuttavia qui il processo è automatico e quindi l’uso può esserne pericoloso. Se ne è servito Granowsky per il suo film Il canto della vita mostrando in uno stesso quadro bicchieri di champagne, teste di morto, etc. Il trucco troppo meccanico risulta facilmente comico. 9) Flou La fotografia sfocata era considerata, un tempo, semplicemente un errore. Oggi si utilizza anche questa, come tante incompletezze ed imperfezioni del film, a scopi artistici. Il flou si usa per mostrare uno stato d’animo soggettivo, per esempio di un ebbro o di uno stupefatto che si risvegli dalla sua narcosi. Ejzenštejn per conferire maggior efficacia alla presentazione di una macchina nel film La linea generale la fa venire lentamente a fuoco. 10) Riflesso Un mezzo efficace può esser quello di riprendere un’azione riflessa 321 in uno specchio o nell’acqua, quando si voglia dare l’impressione della irrealtà o della fuggevolezza. La scena si riflette nell’acqua tranquilla in modo che lo spettatore, ignaro ancora della posizione della camera, la prenda per reale, e, ad un tratto, l’acqua si muove e la scena svanisce. Oppure una sassata rompe il cristallo in cui la scena si rifletteva. Qualche cosa del genere c’è nel film di Granowsy Canto della vita. [...]* Nuovo Laocoonte «Bianco e Nero», 8, 31 agosto 1938, pp. 3-33 riguardo al cinema parlato fossero inesatti o almeno adoperati in modo inesatto. L’evoluzione era giunta ad una fase in cui nel migliore dei casi ci si preoccupava di spiegare il carattere di un fenomeno, senza ormai più chiedersi se tale fenomeno fosse legittimo o meno, bensì considerava addirittura offensivo, distruttivo o conservatore il porre questa domanda. Tanto più urgente ci sembrava tentar di chiarire finalmente la questione. A questo proposito ci mettemmo a esaminare brevemente a quali condizioni fossero possibili opere d’arte basate su più mezzi artistici – parola parlata, immagine in movimento, musica – e quale portata, carattere e valore potessero avere. Il risultato dell’indagine lo applicammo al cinema parlato. Il teatro riesce ad accoppiare immagine e parola Sappi che io ho costruito con miei criterii d’ingrandimento e di annobilimento – nella nuova casa che sotto il nome di schifamondo si distingue dal Vittoriale – una vasta sala del “cinematografo”, attratto da certe possibilità espressive di quella che in su’ principii mi piacque chiamare arte muta. E ti dichiaro subito che appunto io abòmino il cinematografo sonoro, ed ho in uggia le didascalie letterarie che credono comentare il colore e il movimento delle immagini silenziose. * Il paragrafo III – Soggettista e regista è omesso in quanto costituisce una versione sostanzialmente identica del saggio Soggettista e direttore artistico già presente in questo volume, cfr. supra, pp. 96-98. I due elementi la cui gara il cinema parlato non riesce a risolvere in unità, sono evidentemente l’immagine e la parola. Questa gara è un fatto sorprendente, se si pensa che nell’esperienza della vita d’ogni giorno i fattori ottici e sonori sono organicamente fusi in un’unica percezione del mondo. Nella vita pratica quasi mai troviamo disturbata l’immagine dal parlare oppure il parlare dall’immagine. Ma appena seduti la sera davanti allo schermo cinematografico possiamo subito e continuamente constatare disturbi di questo genere. La ragione di tale differenza va probabilmente cercata nel fatto che non siamo abituati a trovare nell’immagine del mondo reale quella precisione formale che nell’opera d’arte, attraverso i dati fenomenici, rappresenta il soggetto e il suo carattere in modo univoco e di massima espressività. Normalmente non cogliamo dalla realtà che vaghi accenni, i quali ci permettono di orientarci. La realtà crea e raggruppa cose e avvenimenti solo come approssimazione alle “idee” pure e autentiche che rappresentano la base del mondo empirico. L’imprecisione di un colore, il disaccordo in una composizione di linee non disturbano la nostra percezione, quand’essa sia limitata a fini pratici; l’impurità linguistica di una frase non ci impedisce di cavare da essa semplicemente il suo senso. Vorremo meravigliarci quindi che, nella vita, anche una combinazione non equilibrata dell’elemento ottico con quello sonoro non susciti, per lo più un disagio? Nell’arte invece, l’espressione indecisa di un corpo, la complessità in sé contraddittoria di un movimento, una parola non appropriata disturbano immediatamente l’impressione, il significato e la bellezza dell’opera. Ecco perché riesce insopportabile anche una combinazione di mezzi che non porti a una serena unità. Non pare probabile che la causa del disagio suscitato dal cinema parlato sia di per sé la combinazione di immagine in movimento e parola parlata; giacché tale accoppiamento sembra giustificato dall’arte del teatro, arte antichissima e molto feconda. L’errore potrebbe invece risiedere nel modo speciale in cui il cinema parlato effettua questa tradizionale combinazione. In 322 323 Gabriele d’Annunzio a Dino Alfieri (15 febbraio 1938) La seguente investigazione è stata suggerita dal senso di disagio da cui l’autore è colpito davanti ad ogni film parlato, e che nessuna abitudine riesce a quietare: dall’impressione che in questo campo qualche cosa non sia in ordine; che vi si presenti qualche cosa la quale per intime contraddizioni di principio debba sempre rimanere incapace di vivere. Il disagio suscitato dai film sonori è provocato, sembra, dal fatto che l’attenzione dello spettatore viene distolta, perché attratta verso due campi opposti: due mezzi combattono per conquistare lo spettatore invece di avvincerlo con forze concordi. Poiché tali mezzi si affaticano a esprimere in modo doppio l’identico soggetto, si crea una sconcertante simultaneità di due voci, ognuna delle quali non può dire che la metà di quanto vorrebbe, perché disturbata dall’altra. Di fronte a questa situazione pratica sorse il bisogno di esaminare teoricamente le leggi estetiche la cui trascuranza rendeva così insoddisfacente tale genere cinematografico; anche perché si precisò sempre di più la sensazione che i principi citati comunemente Per saper giudicare con esattezza le forze che qui agiscono bisogna veder ben chiaro un fatto: l’arricchimento che nasce nell’arte dal concorso di più mezzi non è uguale a quella fusione di percezioni sensorie di ogni specie che caratterizza la nostra immagine del mondo reale. L’unità di tutti questi elementi sensori non è uguale all’unità che l’artista può creare servendosi del concorso di più mezzi. Giacché nell’arte l’eterogeneità degli elementi sensori rende necessarie separazioni fra questi ultimi, separazioni che si possono superare soltanto attraverso una superiore unità. Sarebbe intenzione insensata e inimmaginabile il voler fondere nell’elementare unità di un’opera d’arte elementi visivi e auditivi, per esem- pio parole parlate e corpi in movimento, nell’identico modo con cui una frase si attacca all’altra, un movimento all’altro. L’unità che nella vita “reale” esiste per esempio fra il corpo e la voce di una persona, sarebbe valida nell’opera d’arte soltanto con la premessa di una affinità molto più elementare di questi due fattori, e di rapporti molto più elementari fra di loro. L’artista concepisce e crea la sua immagine spirituale del mondo attraverso “qualità sensorie” immediatamente percepibili, cioè attraverso colori, forme, suoni, movimenti ecc. Mediante l’espressione di questi dati sensori, l’arte figurativa interpreta il significato e il carattere del soggetto. Già nella percezione sensoria deve essere manifesta la più intima essenza dell’argomento. Mediante i rapporti visivi di due corpi, mediante le relazioni fra la loro posizione, dimensione, sagoma ecc., si possono descrivere i rapporti intrinseci fra due oggetti, rappresentati appunto dai due corpi. Su questo piano inferiore, il piano dei fenomeni sensori, però, non può ancora esistere un rapporto fra elementi ottici e acustici. (Volendo spiegarsi in un modo molto crudo: non si può inserire un suono in un dipinto!). Un rapporto di questo genere avviene soltanto su un secondo piano, più alto, su quello delle cosiddette “caratteristiche espressive”, le quali infatti possono essere in comune a più mezzi di espressione. Un rosso vino profondo può avere la stessa espressione di un suono “scuro” del violoncello (mentre tra il rosso e il suono come fenomeni materiali non può essere stabilito nessun rapporto formale reciproco). Ecco perché su questo secondo piano diventa possibile una combinazione artistica fra elementi provenienti da materiali disparati. Una tale combinazione però deve rispettare le separazioni stabilite sul piano inferiore. Essa premette infatti che entro ognuna delle sfere materiali (per esempio entro quella visiva e quella auditiva) si sia formato su quel primo piano un organismo in sé chiuso e completo, il quale rappresenti secondo la sua natura il soggetto integrale della definitiva opera d’arte. Se ora sul secondo piano scompare la “barriera materiale”, i singoli fattori (per esempio quello visivo e quello auditivo) debbono sempre conservare i loro raggruppamenti e le loro separazioni, creati sul primo piano, più elementare, ma possono sfruttare le loro analogie, contrasti ecc. riguardo alla loro espressione, per creare rapporti reciproci fra di loro. Ossia: tutti i movimenti di un gruppo di ballerine rimangono collegati fra di loro e, nel loro complesso, materialmente staccati dalla musica di accompagnamento; così pure nella musica sono collegati tutti gli elementi sonori. Però l’espressione affine delle due sfere permette la loro combinazione in un’unica opera d’arte. Così per esempio un determinato gesto della ballerina avrà un significato e un’espressione simili a quelli di una simultanea figura musicale. Oppure il gesto di un attore risponderà al senso della frase che egli sta pronunciando. Per la combinazione di più mezzi d’espressione in un’opera d’arte si dispone dunque di una forma, la cui particolarità e il cui fascino stanno nel fatto che sul secondo “piano materiale” si crea un collegamento fra organi- 324 325 verità lo stesso teatro occasionalmente è stato accusato di essere in sostanza un ibrido. Si è dimostrato come la storia del teatro viva di un oscillamento fra due atteggiamenti estremi, per cui la creazione totale dell’opera è affidata o all’immagine o alla parola. Potrebbe sembrare dunque che il teatro cerchi continuamente di salvarsi da un intimo conflitto insolubile, piegando verso l’una o l’altra delle due forme espressive più pure che si trovano mescolate in esso; e precisamente verso la sola immagine in movimento (realizzata nella danza) oppure verso la parola parlata pura, realizzata recentemente in maniera insuperabile nella radiocommedia. Ebbene, un tale piegare del teatro verso i mezzi puri non pregiudicherebbe ancora l’ammissibilità estetica della mescolanza. È vero che uno degli impulsi elementari dell’arte tiene conto del desiderio dell’uomo di superare la molteplicità perturbatrice della realtà, in quanto l’arte cerca di creare con i più semplici mezzi possibili un’immagine di questa realtà; ragion per cui ogni mezzo d’espressione che permette da solo di creare delle opere complete non cesserà mai di ribellarsi contro ogni combinazione con altro mezzo. Questa tendenza verso un medium più uniforme e quindi più semplice si verifica dunque anche a teatro. Si cerca di raggiungere gli effetti più elementari e perciò, in un determinato senso, più immediatamente efficaci, della pura immagine o della pura parola, ma l’artista teatrale sente che dalla combinazione del mezzo concreto e più semplice con quello astratto e più complesso possono nascere creazioni più ricche, capaci di “rendere” la vita umana in modo più completo. Perciò egli compie una specie di sacrificio di se stesso, sacrificio che spesso non riuscirà facile appunto all’uomo di puro sangue teatrale: egli impone al proprio istinto la sua volontà di essere un semplice servitore dell’opera poetica, di interpretarla e arricchirla, concretizzandola. Per arrivare a ciò egli deve vincere l’inclinazione, ben viva in se stesso, verso l’opera teatrale assoluta, ossia verso un’arte che si limita alla semplice azione scenica. Una tale arte è rimasta sterile ovunque e ogni volta che si tentò di realizzarla, e dovrà rimanerlo a meno che non si condensi fino a diventare danza oppure arricchisca i propri mezzi di espressione visiva fino a diventare cinematografo. Parallelismo fra creazioni complete e isolate smi, i quali, sul primo piano, sono rigidamente separati fra di loro, completi e in sé chiusi. Ci possono essere ancora altri piani materiali, superiori – ci saranno quasi sempre – ma questi piani sono di carattere meno elementare. Uno di essi riguarda carattere e rapporti degli oggetti rappresentati, in quanto fanno parte del nostro mondo reale; per esempio il rapporto “terrestre” ed effettivo fra corpo umano e voce umana. Quest’ultimo piano è quello più vicino alla vita pratica, e i rapporti creati su di esso sono quindi i più ovvi, dal punto di vista di tale vita pratica. Ma il collegamento che avviene su questo piano, fra elementi provenienti da sfere sensorie diverse, non è sufficiente per rendere omogenei, fondibili e scambiabili questi elementi. La loro eterogeneità sul primo e più elementare piano lo impedisce; e ciò che avviene su questo primo piano è decisivo per tutta l’opera4. Si potrebbe obbiettare che la letteratura si serve di tutti i sensi – della vista, dell’udito, dell’odorato, del tatto ecc. – in libera mescolanza e in una fusione altrettanto inseparabile come quella presentataci dalla quotidiana esperienza pratica. Questo fatto però rappresenta un’obbiezione contro la nostra affermazione soltanto se si è dell’opinione che la parola poetica non sia altro che un semplice espediente per suscitare nella fantasia del lettore immagini mnemoniche, in sostituzione delle immagini dirette che il poeta non è capace di procurare. (Schopenhauer: «Quale definizione più semplice e più esatta della poesia vorrei stabilire quella che la poesia sia l’arte di mettere in azione mediante parole la potenza immaginativa»). Noi altri però non crediamo che la parola poetica sia un semplice mezzo di passaggio per raggiungere la percezione concreta – simile alle parole delle quali l’autore di uno scenario cinematografico, forzatamente, si serve per descrivere le immagini che egli intende comunicare. Per noi, la parola è già la forma definitiva della creazione poetica. Il carattere particolare della letteratura sta, secondo noi, proprio in quella astrattezza della lingua, la quale se denomina un oggetto col nome collettivo della sua specie, lo determina soltanto in un modo generico, e non scende all’individuale concretizzazione di questo oggetto in carne ed ossa. Proprio da questo suo carattere, la letteratura trae i suoi effetti più specifici e più forti. La parola poetica si riferisce direttamente al significato, al carattere, alla struttura degli oggetti, onde la spiritualità della sua visione, l’acutezza e l’essenzialità delle sue descrizioni. Il poeta non è vincolato alla materialità fisica di un ambiente, di qui la leggerezza e la trasparenza delle sue esposizioni e la libertà con cui lega oggetto a oggetto anche se essi, nella realtà, non sono contigui né in senso temporale né in senso spaziale. Per plasmare la propria visione, egli non parte dal fenomeno sensibile ma invece dal nome collettivo, rinunciando a penetrare fino allo strato inferiore della percezione concreta. Ed è proprio per ciò che egli dispone della possibilità di comporre le sue immagini servendosi di elementi che provengono da disparate sfere sensorie senza preoccuparsi se queste combinazioni siano fisicamente realizzabili o, almeno, immaginabili. Volendo, egli utilizza di “vestito” soltanto il concetto astratto del “ricoprire”, di “torre” soltanto l’altezza, di “gigante” soltanto la monumentalità, e soltanto per questo gli è permesso dire ciò che a nessun pittore sarebbe dato di dipingere: «Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese» («Già vestita di nebbia era la quercia, gigante torreggiante», da una poesia di Goethe). Egli opera su quel penultimo piano, sul quale, come dicevamo, anche le opere delle arti visive e auditive scoprono la loro affinità e possono essere riferite l’una all’altra, e perciò è capace di fondere in unità genuina il mugolio del vento, il navigare delle nuvole, il sapore delle foglie fradicie e lo scrosciare delle gocce di pioggia sulla pelle. Senonché anche il poeta, in tutt’altro senso, raggiunge anch’egli il livello dell’immediata concretezza, col vantaggio di poter fruire dei vantaggiosi effetti vivificatori che da essa provengono. È vero che egli non può far vedere, udire, odorare o toccare gli oggetti che evoca, ma le parole con cui li denomina sono suoni, dunque materia auditiva. La espressione delle teorie di vocali e consonanti, il ritmo degli accenti, delle colleganze e separazioni, gli permettono di illustrare in un medium diverso e più concreto quello che egli, allo stesso tempo, dice attraverso concetti. In questo senso, un’opera poetica è già in sé un’opera combinata, alla quale si debbono dunque applicare le nostre regole. 326 327 Le condizioni per l’accoppiamento di più mezzi artistici Ritorniamo alle combinazioni di forme artistiche separate e indipendenti. In una canzone, per esempio, tutto ciò che si vuole esprimere è reso dalle parole ossia dalla poesia, e, una seconda volta ma in altro modo, dalla musica. Ambedue gli elementi sono accordati in modo da formare un’unità, e tuttavia la loro diversità rimane sempre palese. La loro combinazione somiglia a un buon matrimonio, in cui pure da somiglianze e adattamenti nasce un’unità, che però lascia intatta la “personalità” di ognuno dei due componenti. Tale combinazione invece non somiglia al figlio che nasce da quel matrimonio e in cui sono inseparabilmente mescolati ambedue gli elementi. In modo analogo, nella rappresentazione teatrale tanto l’azione visiva quanto il dialogo debbono svolgere, ognuno, l’argomento totale: una lacuna nell’uno degli elementi non si può compensare per mezzo dell’altro. È compito del regista teatrale presentare il contenuto del dialogo anche agli occhi del pubblico, attraverso i colori, le forme e i loro movimenti, il modo e l’aspetto degli attori e la loro recitazione, attraverso la forma spaziale dell’ambiente scenico e la disposizione e gli spostamenti dei corpi in tale spazio. Questo spettacolo visivo non può essere interrotto, a meno che l’interruzione non abbia il carattere di un intervallo limitatore, di una cesura cioè, la quale non segna una sospensione dello spettacolo bensì fa parte di esso. La recitazione e l’azione non debbono mai diventare inespressive e vuote, per colpa, poniamo, del dialogo. Il dialogo più denso non potrebbe compensare agli occhi una tale deficienza: non potrebbe rimediare alla lacuna nella creazione visiva. Nello stesso senso, una sospensione del dialogo è ammessa soltanto in forma di intervallo, non come temporaneo passaggio dell’espressione dalla sfera auditiva in quella visiva. Ci può essere benissimo un contrasto contrappuntistico fra una stasi nell’azione visiva e un simultaneo scambio di battute agitate, oppure fra un momento di silenzio e un significativo episodio di azione muta, ma questo soltanto nel senso in cui il gioco armonico di un brano musicale è arricchito dalle continue entrate e sospensioni delle singole voci, non come sostituzione di uno degli elementi, soppresso, con l’altro. Basta questo per comprendere quanto sia assurda la giustificazione teorica di un uso attualmente prediletto e raccomandato dai registi dalle “pretese artistiche”, ossia quello di affidare l’espressione quasi unicamente all’immagine e di completare col dialogo soltanto occasionalmente lo svolgimento del conflitto drammatico. Il principio formale qui adoperato non è da considerarsi, evidentemente, come parallelismo di due elementi completi e precisamente di uno visivo molto ricco e di uno auditivo molto “poroso” e pieno di intervalli: il dialogo è invece tutt’altro che coerente, consiste di pezzi staccati, separati da interruzioni insormontabili. L’idea è piuttosto quella di far nascere, in determinati momenti importanti, la parola come una specie di condensamento dell’immagine. È del tutto trascurata dunque l’indispensabile distinzione dei mezzi e il risultato è che briciole di dialogo appaiono, con un ridicolo effetto di sorpresa, dal vuoto in cui si librano senza sostegno. (Questo effetto non può dirsi in alcun modo provocato semplicemente dall’interruzione dell’elemento sonoro – una tale interruzione non crea nessun vuoto quando ha una funzione significativa di pausa nell’organismo sonoro – e il disagio non si può evitare riempiendo semplicemente il silenzio con musica o rumori. L’esempio della canzone ci ha dimostrato che già nello stesso campo dell’arte “sonora”, la musica e le parole si possono combinare soltanto se si forma un parallelismo fra due elementi completi e indipendenti, cioè fra “una poesia” e “una melodia” sovrapposte!). Almeno, il dialogo non dovrebbe essere sparso in briciole ma raccolto in singoli complessi, ognuno dei quali fosse un organismo in sé chiuso e senza lacune. Perché allora si potrebbe magari pensare al grande esempio della Nona sinfonia di Beethoven (ripreso più tardi da Gustav Mahler), nella quale, al vertice della composizione, la musica strumentale viene completata da voci umane, e da quel momento l’opera marcia verso la propria fine su una base più larga, più monumentale. Ma nel caso speciale del film parlato nemmeno un tale provvedimento basterebbe, perché rimarrebbe sempre l’ostacolo dell’insormontabile differenza di stile ottico fra scene mute e scene completate da dialogo. L’impossibilità di effettuare una vera e propria fusione di parola e di immagine non risulta palese a tutti dalla pratica esperienza cinematografica, unicamente perché l’immagine sullo schermo non si interrompe mai per “lasciare la parola” al dialogo. L’azione visiva è senza lacune, almeno nel senso estrinseco, non per quanto riguarda la espressione artistica. Ci troviamo davanti a un’azione visiva completa, ogni tanto accompagnata da dialogo, quindi davanti a un parallelismo parziale e per nulla affatto a una fusione. Il difetto elementare sta nella frammentarietà del dialogo. (È vero che, al contrario, si può interrompere il dialogo a favore dell’azione visiva senza che psicologicamente risulti un effetto assurdo. La ragione è che, per quanto riguarda la psicologia dello spettatore, l’interruzione del dialogo non significa ancora una sospensione dello spettacolo sonoro, analoga alla scomparsa dell’immagine dallo schermo. Il silenzio non rappresenta la scomparsa del mondo acustico ma invece lo sfondo neutro di esso: vuoto ma “positivo”, come lo sfondo uniforme di un ritratto fa sempre parte del quadro. Senonché ciò che non disturba in un senso puramente psicologico, può essere inammissibile in un senso artistico). Finché quelle briciole di dialogo non sono altro che una concessione, ridotta al minimo, dell’artista alle richieste dell’industria e del commercio cinematografici, non hanno alcuna importanza teorica. Perché allora l’artista considera la sua opera come un film muto, ossia un film nel senso proprio della parola, ma impuro perché menomato da un principio ostile (il quale impone all’artista il dialogo). Ma se egli crede che basti usare poco dialogo, allontanandosi in questo modo dalla commedia teatrale, per avvicinarsi a un nuovo e autonomo genere d’arte e cioè al “cinema parlato”, allora egli dimostra di possedere poca sensibilità per il suo mestiere. Quanto più scarse sono le parole e quanto più decisamente dunque la rappresentazione è riservata all’immagine, tanto più estranee, disturbanti e ridicole risultano quelle briciole ed è tanto più evidente che si tratta di uso, impuro, dei mezzi del cinema muto e di nient’altro. Un senso artistico più sano dimostrano allora quei più modesti collaboratori dell’industria cinematografica che per il loro quotidiano contatto colla tecnica del cinema sono giunti a una certa comprensione istintiva per le esigenze artistiche di questo mezzo e che, in parte per questa ragione, si servono in modo sempre più completo del “dialogo al cento per cento”. Questo dialogo accompagna il film per tutta la sua durata, più o meno senza lacune, e soddisfa in tale modo a una condizione elementare della combinazione di più mezzi, ossia al parallelismo. Nei film comuni di questa produzione si verifica inoltre un abbandono sempre più radicale dei mezzi d’espressione visivi, conquistati all’epoca del “muto”, e anche questo fenomeno corrisponde, come vedremo, alle condizioni estetiche sorte coll’avvento del sonoro. Senonché lo squilibrio fra immagine e dialogo non è abolito con questo sistema, né esso permette di creare dei film sonori artisticamente soddisfacenti: ci si avvicina sempre di più al teatro, senza potersi decidere a rinunciare in modo rigoroso ai nuovi incanti dell’immagine animata. 328 329 Il dialogo dovrebbe essere completo Comunque, il dialogo completo sarebbe la premessa elementare per qualsiasi uso della parola nel cinema; un dialogo che fosse un’opera d’arte in sé chiusa e senza lacune. Si tratta ora di sapere se questa premessa può essere soddisfatta da un’attività artistica fondamentalmente diversa da quella del teatro. La particolarità di questa nuova forma d’arte potrebbe consistere in una differenza fondamentale fra azione teatrale e azione cinematografica, per quanto riguarda la sola parte visiva. Generalmente non si discute nemmeno che questa differenza esista e sia dimostrata dall’esperienza. E invece non c’è ragione perché i mezzi che distinguono l’immagine cinematografica debbano essere negati all’azione scenica. Indiscutibilmente, il teatro come forma d’arte rimarrebbe quello che è anche se si sostituisse l’attore in carne ed ossa con la sua immagine: la prova pratica si potrà avere con trasmissioni televisive da teatri di prosa. La riduzione dei colori naturali al solo bianco e nero non sarebbe vietata al teatro e non rappresenta, del resto, una caratteristica essenziale del cinema. Gli spostamenti dell’immagine intera – provocati nel cinema dai movimenti della macchina da presa – sono stati raggiunti, recentemente, anche dal teatro a mezzo del palcoscenico girevole e dispositivi simili: entro limiti più modesti, è vero, ma nelle distinzioni di principio il grado non conta. Il teatro dispone pure dell’immagine cinematografica vera e propria, per esempio di ambienti proiettati su uno schermo, come sappiamo da certe messe in scena ultra moderne. Certo, il teatro nella sua forma attuale non saprebbe effettuare il cambio della distanza e dell’angolo, da cui è vista l’azione, soprattutto il cambio a scatto, quel “montaggio” che il cinema vanta come una delle sue particolarità principali; ma non si vede perché al teatro dovrebbe essere rifiutato per principio ciò che per ragioni tecniche esso oggi non può fare (e basta anche qui pensare alla televisione). Il palcoscenico moderno ha allargato le nostre idee sulle possibilità dell’azione teatrale visiva. Del resto, si dovrebbe, finalmente, chiarire bene il fatto che il cinema è arte, sì, ma in nessun modo un’arte speciale del tutto isolata. All’arte dell’immagine fissa su superficie (pittura) e del corpo fisso (scultura) possiamo opporre l’arte dell’immagine in movimento. Quest’ultima però non comprende soltanto il cinematografo ma anche la danza e la pantomima, ed è discutibile se le particolarità del film che derivano dalla registrazione meccanica siano più essenziali delle altre particolarità, che esso ha in comune con la danza, la pantomima e quindi anche con l’azione teatrale. Una cosa almeno è certa: se si trascurano queste particolarità comuni – come si suol fare ad majorem gloriam del cinema – non si può arrivare a una esatta valutazione dell’arte cinematografica. L’arte dell’immagine in movimento è tanto antica quanto le altre arti, è antica come l’umanità stessa, e il cinematografo non è altro che la sua più recente manifestazione; la quale, del resto, potrà raggiungere le più alte vette delle altre arti, e cioè dell’arte, probabilmente soltanto quando si libererà dal vincolo della riproduzione meccanica e quando si presenterà come pura opera dell’uomo, ossia nel film disegnato o dipinto. Fra l’azione scenica e l’immagine cinematografica non passa quindi alcuna distinzione di principio. Perciò possiamo senz’altro applicare al cinema parlato le esperienze che il teatro ha fatto con l’immagine “arricchita”. Quali sono queste esperienze? Esse insegnano che ogni tentativo di un tale arricchimento ottico si è presto dimostrato come una deviazione da una seria arte teatrale. Se si abbonda di macchinari scenografici e di azione, l’immagine distrae dalla parola del poeta invece di interpretarla. Senonché questa affermazione parte dalla premessa che la rappresentazione teatrale non serva che a rendere sonora la parola poetica in una maniera che assicuri alla parola una funzione di primo piano, mentre l’immagine contribuisce soltanto con arricchimenti di carattere secondario. Si tratta ora di sapere se sia possibile arrivare a nuove forme artistiche abbandonando tale premessa. Il pericolo che lo spettatore diventi incapace di seguire con attenzione il dialogo drammatico, sarà evidentemente tanto minore quanto più semplice sarà tale dialogo. Ebbene, l’opera drammatica può, come ogni altra opera d’arte, assumere ogni grado di densità: dall’intricato e pesante pensiero di uno Shakespeare, che propone alla nostra capacità ricettiva compiti quasi insolubili anche quando la recitazione avviene senza alcuna distrazione ottica, ossia senza alcun concorso di azione scenica (per esempio nella trasmissione radiofonica), fino ai dialoghi più sciolti e della più semplice concretezza. Le forme più semplici – che per questo non hanno minore valore artistico – dovrebbero, evidentemente, poter sopportare un complemento visivo più ampio senza rimanerne menomate. Nella storia della letteratura forse non si troveranno molti esempi di siffatto dialogo – ma, teoricamente parlando, potrebbero nascere in maggior numero se al drammaturgo diventasse più familiare l’idea di veder completate le proprie opere da una azione scenica più ricca; anzi, forse egli stesso potrebbe assumersi il compito di creare con ambedue i mezzi, ossia di realizzare da solo la bifronte opera totale. Poniamo che la bilancia si sposti gradualmente a favore dell’azione visiva: si arriverebbe allora, dapprima, a opere in cui parola e azione visiva sarebbero in equilibrio, e infine ad altre, in cui l’immagine avrebbe il predominio mentre il dialogo si accontenterebbe di una funzione secondaria, analoga a quella attualmente affidata all’azione scenica. Opere di quest’ultimo genere realizzerebbero una nuova e autoctona specie d’arte? Un semplice spostamento quantitativo degli elementi potrebbe fare nascere una nuova forma d’arte? Le esibizioni di un corpo di ballo possono essere accompagnate da un solo flauto, e, al contrario, quelle di una ballerina sola possono essere accompagnate da una grande orchestra sinfonica... non per questo cambia il genere d’arte cui appartengono. È vero che non sarebbe tanto urgente la decisione se si trattasse 330 331 È concepibile un accoppiamento di immagine e parola differente da quello teatrale? di una semplice sottospecie del teatro o invece di una particolare forma d’arte, degna di un suo nome proprio. Basterebbe che dal suddetto spostamento degli elementi risultassero nuove possibilità di rappresentare il nostro mondo, che dunque agli artisti si offrisse un nuovo mezzo per esprimere motivi per cui finora non c’era lingua. Tutto dipende, insomma, dal sapere se il genere d’arte da noi teoricamente presupposto abbia capacità di vita o no. Capacità specifiche dei vari mezzi artistici Dicevamo prima che per giustificare l’accoppiamento di più mezzi – per esempio dell’immagine animata e della parola – in un’opera d’arte non basta il fatto che anche nella realtà elementi visivi e sonori appaiano intimamente collegati, anzi come unità inseparabile. Occorrono invece ragioni artistiche per una tale combinazione: essa deve servire per esprimere quanto con un solo mezzo non potrebbe esprimersi. Un’opera d’arte “composta” è, come già abbiamo visto, possibile soltanto se organismi completi, creati dai singoli mezzi, si integrano in forma di parallelismo. Questo “doppio binario” però avrà un suo significato soltanto se i singoli elementi parziali non dicono la stessa cosa, ma si completano nel senso di esprimere in modo diverso un comune soggetto. Ogni mezzo deve parlare del soggetto a modo suo, e le differenze che ne nascono debbono corrispondere a quelle esistenti fra i caratteri dei mezzi stessi. Infatti, i singoli mezzi hanno ognuno un carattere del tutto differente, come già è stato dimostrato nel Laocoonte di Lessing coll’esempio delle arti figurative e della letteratura. Precisando, per esempio, la differenza fra mezzi figurativi e non figurativi, si comprenderà facilmente, che la pittura o la danza – al contrario per esempio della musica – rappresenteranno il contenuto spirituale del soggetto in modo più indiretto e nascosto, rappresentazione sempre legata a un oggetto che lo “esprima”, ma d’altra parte in una forma che corrisponde maggiormente alle nostre esperienze pratiche. La musica invece darà questo stesso contenuto in maniera più immediata, più pura e più forte, perché non ha bisogno di esprimerlo attraverso la rappresentazione di oggetti reali; d’altra parte, l’interpretazione attraverso la musica sarà più astratta, più generica, perché esclude la multiforme abbondanza dei fatti e degli avvenimenti. Ecco perché la musica può completare così felicemente la danza o il film muto: col suo vigore essa trasmette le emozioni e gli umori e altresì gli astratti ritmi dei movimenti, che anche l’immagine vorrebbe rendere ma che essa può rendere soltanto con tutte quelle diffrazioni e offuscamenti inevitabili se si deve attraversare il medium delle cose reali. È inutile bilanciare il valore dei singoli mezzi artistici. Ognuno di noi, secondo il proprio gusto personale, darà la preferenza a qualcuno di essi, ma in generale si può affermare soltanto che ogni mezzo a modo suo raggiunge le vette. Perciò, se consideriamo la parola il mezzo artistico 332 più completo di tutti, ci rendiamo conto del fatto che a questa universalità della parola corrispondono debolezze in alcuni campi, in cui sono invece più efficaci alcuni altri mezzi. Per quanto riguarda il contenuto la parola ha da sola la portata di tutte le altre arti: essa può descrivere gli oggetti reali come immutabili oppure come in continuo movimento; con inimitabile abilità essa può saltare da un luogo all’altro, da un momento di tempo a un altro; con la stessa immediatezza con cui rende il mondo fenomenico dei nostri sensi, essa rappresenta l’intero mondo dell’anima, dell’immaginazione, dell’emozione, della volontà. E non soltanto rappresenta tutti questi fatti esterni e interni ma anche i rapporti emozionali o razionali che l’uomo crea fra di loro: essa può rendere gli oggetti in ogni grado di astrazione, dalla concretezza individuale fino all’acutezza della più rarefatta astrazione; essa può oscillare fra fenomeno e concetto e soddisfare in questo modo ai rapporti più terrestri come a quelli più spirituali, ma soprattutto anche a quel seducente regno intermedio fra fenomeno e concetto, in cui si muove il poeta. L’azione visiva come utile complemento del dialogo drammatico Ma all’una estremità della gamma, che va dal fenomeno al concetto, la parola, come s’è detto sopra, non può superare un determinato grado di approssimazione. Non può spingere la materializzazione fino alla resa della materia stessa: può dire “colore” ma non può dare il colore. Onde la tendenza di completare il dialogo parlato con l’azione scenica, il racconto con le illustrazioni. Allo stesso tempo però comprendiamo che un tale completamento non è indispensabile. Giacché la parola può determinare alla nostra esperienza un qualunque oggetto con ogni precisione necessaria ai fini della poesia. Ciò che manca alla parola è la semplice presentazione materiale di quanto essa descrive in un suo modo particolare, artisticamente del tutto completo. Perciò, una commedia non ha bisogno della messinscena. Tutt’al più, la permette. E perciò è giusto che ambiente e azione scenica si tengano modestamente in secondo piano di fronte all’opera poetica, in sé completa. La rappresentazione è un completamento visivo che lascia al poeta ogni libera possibilità di esprimersi: essa “entra in scena” soltanto quando il poeta ha già terminato la sua opera, senza restrizione e senza riguardo alcuno. Completando, con l’indispensabile discrezione, il dialogo parlato, l’azione scenica aggiunge all’apporto dei concetti quello dell’elemento concreto, caro e benvenuto al pubblico, anche se non necessario nel senso più severo. Essa trasforma in visione diretta quella indiretta e si rivolge, con forme, colori, movimenti e suoni, a quella sensibilità più semplice e più elementare, a cui anche il poeta rende omaggio col suono e ritmo delle sue parole. Suono e immagine sono arte primordiale, più vicina alla natura che la rappresentazione mediante concetti. La pianta si volge al sole, ma non sente ancora il desiderio della luce: biologicamente, 333 L’azione visiva è dunque, nel caso del teatro, una semplice servente della parola ma non si limita, d’altra parte, a ripetere semplicemente quanto dice o potrebbe dire il poeta. L’azione visiva, in quanto rappresenta il soggetto in un modo particolare, non accessibile alla parola, soddisfa alla condizione che bisogna osservare nell’accoppiare più mezzi artistici. Non potrebbe dunque accadere che in certi casi la parola sembrasse all’artista uno strumento insufficiente, quand’egli volesse esprimere cose non esprimibili con la parola ma soltanto con l’immagine visiva? Non potrebbe per lui nascerne quindi la necessità di adoperare oltre alla parola anche l’immagine? L’aspetto esteriore dell’azione che accompagna un dialogo drammatico viene, dal poeta, incluso nell’opera fino a un grado molto variabile. Da un lato estremo c’è il poeta che, affatto concentrato sull’azione interna, non vorrebbe rappresentare altro che l’incontro di forze psichiche espresso nelle parole del dialogo. È probabile che la realtà non produca mai questo caso fino al punto estremo – sebbene la radiocommedia tenda verso opere di questa specie – ma stabilirlo ci serve lo stesso per iniziare su questa base una gamma sulla quale si possano disporre tutti gli altri casi. Partendo infatti da quel punto estremo, si può spiegare come l’opera drammatica includa sempre più elementi dell’azione visiva fino al punto estremo opposto in cui la creazione si serve unicamente della descrizione di azioni esteriori, essendo il drammaturgo diventato, in questo modo, narratore. (Teoricamente possiamo infatti immaginare una specie di racconto basato sulla sola descrizione di fatti esteriori). Ebbene, le leggi dell’arte richiedono che il poeta faccia figurare nella sua opera ogni elemento di azione esterna, che gli sembri essenziale per essa. Ciò evidentemente può succedere in due modi diversi. Il procedi- mento classico dei grandi drammaturghi consiste nell’includere tali elementi nello stesso dialogo. Qua e là però troviamo quasi sempre anche delle “didascalie” ossia indicazioni fuori testo che descrivono l’ambiente e quanto si svolge in esso. Non ci interessa, per il momento, se queste indicazioni siano concisissime, come nelle commedie dei classici, oppure se si allarghino invece verso descrizioni tipo racconto, come succede per alcuni commediografi moderni, nei quali, evidentemente, si è indebolita la sensibilità per la pura e forte forma del dramma. Ci importa invece unicamente il fatto che tali indicazioni non rappresentano affatto necessariamente il passaggio dalla letteratura alla rappresentazione visiva. Abbiamo detto che la creazione drammatica include una visione più o meno concreta dell’ambiente e dell’azione e che nel dialogo spesso si trovano elementi di questo genere. Ma tanto per questi elementi del dialogo quanto per le didascalie, importa che esse realizzino il loro contenuto in una forma definitiva e del tutto letteraria, analoga a quella di un racconto; infatti ci troviamo dinanzi a una invasione di elementi narrativi nella commedia5. D’altra parte, si potrebbe tuttavia immaginare che delle descrizioni sceniche si possano riferire a motivi realizzabili non attraverso la parola ma unicamente mediante rappresentazione visiva e concreta. In questo caso le didascalie non sarebbero forme definitive di carattere letterario ma, come la sceneggiatura di un film, semplici appunti per motivi da realizzarsi con mezzi non-letterari, fissate con parole soltanto come un espediente: per ragioni puramente pratiche. Accennavamo prima al fatto che il poeta può rappresentare sì, a modo suo, i fatti visivi, ma che egli, con questo, non può né vuole sostituire l’arte figurativa. Infatti, anche se un grande poeta descrive un dipinto, non ne risulta un dipinto (né egli lo vorrebbe). Così pure la descrizione in parole, poniamo, di una danza o di un’azione teatrale, risulterà facilmente vaga. Citiamo come esempio un pezzo in cui G. Ch. Lichtenberg descrive l’attore Garrick mentre interpreta Amleto, nella scena dell’apparizione dello spirito paterno: «Garrick si volge improvvisamente intorno e nello stesso momento cade indietro per due o tre passi con le ginocchia insieme spezzate; il suo cappello cade a terra; l’uno e l’altro suo braccio, il sinistro in particolar modo, si sono quasi distesi, la mano è all’altezza del capo, il braccio destro è piegato di più e più bassa la mano, le dita staccate e la bocca aperta; così egli si arresta, come agghiacciato, nell’atto di un grande ma non eccessivo passo, sorretto dai suoi amici, i quali sono più abituati all’apparizione e temono ch’egli cada a terra; nel suo volto l’orrore è espresso in un modo tale che a me, ancor prima che egli cominciasse a parlare, nacque un ripetuto brivido». Questa descrizione è inefficace e quasi ridicola perché Lichtenberg ha voluto deliberatamente fissare un “documento ottico” effimero, fissare cioè un pezzo di arte visiva con mezzi letterari, in mancanza, di un mezzo di conservazione più adatto. Non potrebbe succedere, dunque, che un artista sentisse la necessità 334 335 il gesto precede l’emozione. Nello stesso modo, la musica, la pittura, la scultura, l’architettura, la danza e il cinema si rivolgono al lato più semplice e primordiale dell’anima umana. Ma una volta spiritualizzato dalla parola, l’uomo, è vero, vorrà sempre tenersi aperta – attraverso quelle altre arti – la strada delle fonti antiche, ma ammetterà la loro combinazione con la parola tutt’al più come una semplice e vigorosa interpretazione, come una integrazione possibile ma non necessaria. Essendo un mezzo più concreto e biologicamente più antico, l’immagine può dare effetti più massicci che il meno primitivo ma più delicato figlio del tardivo spirito: la parola. Ecco perché la parola si trova in pericolo quando l’immagine si presenta e soprattutto: l’immagine animata! Una buona messinscena si preoccupa di indebolire il primato dell’azione visiva tenendola a una certa distanza dal pubblico, di dare sommaria imprecisione alle immagini e di mantenere deliberatamente poveri gli avvenimenti che si svolgono sul palcoscenico. L’azione visiva non potrebbe diventare parte integrale dell’opera? di veder completato il suo dialogo drammatico da un ambiente ottico nel quale si svolgesse un’azione? Completato ossia con elementi non-letterari? In questo caso ci troveremmo infatti davanti a un genere di opere fondamentalmente differente. Questa differenza si manifesterebbe intanto nel fatto che l’artista stesso dovrebbe curare personalmente anche questa parte ottica dell’opera, da realizzarsi sul palcoscenico o al cinema, o almeno predisporla nel modo più preciso; giacché non si tratterebbe più di una rappresentazione aggiunta posteriormente all’opera già compiuta, ma della realizzazione dell’“altra metà” di questa opera. Finora gli artisti hanno preferito il mezzo unico L’esperienza ci insegna a questo proposito che i grandi artisti – la cui attività rappresenta, per così dire, l’applicazione pratica delle leggi estetiche – si sono finora dimostrati poco propensi a sfruttare tale possibilità. Shakespeare viveva in contatto quotidiano col mondo del teatro, eppure Goethe ha detto di lui che non è stato un poeta teatrale e che non ha mai pensato al teatro. Infatti non c’è modo più radicale del suo di anticipare con la parola ogni possibile effetto scenico e di rendere, con ciò, impossibile un’adeguata rappresentazione teatrale. Anche le commedie di Molière, di Goethe, di Schiller, di Goldoni – tutta gente di teatro! – sono complete già sulla carta, e altrettanto vale per i classici greci. Certe commedie, in cui le descrizioni dell’ambiente, dei personaggi e dell’azione costituiscono una parte considerevole del dialogo – per esempio il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare oppure la Pentesilea di Kleist – ci sembrano veramente irrealizzabili sulla scena perché la parola poetica produce immagini talmente potenti, surreali e magiche che sembra quasi ridicolo di volerle raggiungere o addirittura perfezionare coi mezzi del palcoscenico. In tutta la storia dell’arte non vediamo che un unico esempio di una certa importanza che dimostri non una aggiunta posteriore di un mezzo all’altro ma, fino a un certo punto, una comune e reciproca creazione dei due mezzi: l’opera lirica. Esaminandola vediamo tuttavia che, praticamente, l’uno di questi clementi, quello musicale, ha decisamente il sopravvento. Il libretto risulta infatti come un semplice ripiego al servizio della musica, elaborato del tutto secondo le esigenze del compositore, spesso di valore letterario appena mediocre, non essenziale per l’intimo contenuto dell’opera e necessario soltanto per spiegare la trama e per rendere possibile la messinscena. (Il caso di Richard Wagner è l’unico importante in cui si tenda a un equilibrio fra musica e libretto, ma si tratta di un artista troppo discusso e troppo influenzato da teorie perché egli da solo possa fornire un’obbiezione valida). Infatti, la creazione dell’opera lirica rappresenta probabilmente non tanto una combinazione di arte musicale e arte letteraria quanto la conquista della drammaticità per la musica, altrimenti limitata al genere lirico. L’opera, nata storica- 336 mente dai tentativi del Quattrocento di aumentare, mediante la musica, i valori drammatici e spettacolari delle tragedie di stile greco, diventa la realizzazione del desiderio di esprimere musicalmente gli impulsi volitivi ed emotivi dell’uomo in azione e le situazioni, contrastanti o armonizzanti, che nascono dalla vita in comune. L’impiego del dialogo è da considerarsi come un mezzo semplicemente tecnico e secondario atto a “rendere udibile” l’uomo, nel modo più naturale, e a sviluppare l’azione al di là di quei motivi elementari che si possono trasmettere mediante la sola immagine animata della pantomima e mediante la sola musica. L’opera lirica è quindi un fenomeno quasi esclusivamente musicale e al dialogo spettano, in essa, pressappoco il valore e la funzione che le “didascalie” avevano nel cinema muto. Ricordiamoci anche che i grandi attori preferiscono commedie mediocri che permettano loro una recitazione quasi su canovaccio, per cui la creazione dello spettacolo rimane essenzialmente riservata all’espressione del corpo e della voce; mentre invece la loro arte diventa facilmente pericolosa per le opere drammatiche di valore. E ricordiamoci infine anche che i grandi danzatori e i grandi creatori di film muti sceglievano e scelgono di solito delle musiche semplici, trasparenti, spesso mediocri. Tutti questi fatti ci insegnano che finora gli artisti hanno dimostrato poca inclinazione e poca capacità di creare opere che si basassero in un senso vero e proprio su più mezzi. È vero che in tutti i casi citati troviamo impiegato più di un mezzo, ma normalmente ognuno di questi mezzi è introdotto da un artista particolare e uno di questi ha la parte decisiva: egli fa prevalere il proprio mezzo, costruendo grazie ad esso una ricca creazione sul tema esposto dall’altro mezzo, secondario, con forme semplici e ridotte. Si intende che, a tutto rigore, non può nascere una perfetta opera d’arte se questo secondo elemento è trascurato fino al punto di essere artisticamente scadente o di essere talmente soffocato dal mezzo dominante da non poter più trasmettere al pubblico il proprio contenuto; giacché l’arte concede, sì, una gerarchia di funzioni, ma non permette che un mezzo, dal momento che è stato dotato di un compito, venga condannato a un’atrofia quantitativa o qualitativa. L’opera potrà quindi veramente riuscire soltanto se l’artista che si serve del mezzo dominante ha la fortuna di procurarsi come elemento secondario un lavoro autenticamente artistico e se egli possiede abbastanza controllo da non soffocarlo. La gerarchia dei mezzi nell’opera d’arte La nostra analisi conduce dunque a un risultato piuttosto negativo per quanto riguarda le forze vitali dell’opera d’arte concepita mediante più mezzi d’espressione. Ogni volta che incontriamo nella storia dell’arte un accoppiamento di più mezzi, l’esame più minuto rivela un deciso sopravvento di uno di questi mezzi. Un solo mezzo si riserva il compito 337 Eventuali vantaggi del dialogo cinematografico di realizzare l’opera ed è aiutato e completato in questo lavoro dagli altri mezzi. I mezzi – e così anche gli artisti stessi – si collegano dunque in una forma gerarchica, della quale un grande esempio ci è dato dagli spettacoli teatrali dell’antichità. In essi la parola poetica domina ma è completata da una rappresentazione nello spazio scenico, la quale accenna appena all’azione drammatica, e inoltre da un commento musicale. Un altro esempio lo possiamo trovare nella cattedrale medioevale – organismo architettonico arricchito dalla pittura e dalla scultura. Il pubblico teatrale e la comunità religiosa realizzano poi il significato vitale della creazione artistica in quanto l’opera d’arte isolata – un prodotto tardivo della civiltà – assume il carattere più vasto di una manifestazione di culto. Le combinazioni gerarchiche dei mezzi d’espressione nascono, nei casi tipici, non come opera di un singolo individuo ma dalla collaborazione di più artisti. (Probabilmente una tale collaborazione, per riuscire veramente, presuppone un’autentica comunanza spirituale, nel senso più universale: l’esistenza di un culto!). Il singolo artista invece tende a concepire il mondo mediante un mezzo unico. Questo risultato storico si spiega con un fatto a cui già prima abbiamo accennato: per concepire e rappresentare artisticamente un soggetto che riguarda la competenza di più mezzi artistici, bisogna ricorrere simultaneamente a più “mondi sensori”, per esempio al mondo dell’occhio e al mondo dell’orecchio. I rapporti fra questi “mondi” diversi avvengono non già sul piano elementare della percezione sensoria ma soltanto su un piano più alto. Ebbene, se è vero che l’unità, i rapporti e il carattere intimo dell’opera d’arte sono sentiti e creati prima di tutto in questa sfera interiore e più concreta, si dubiterà della possibilità di costruire grandi opere d’arte su un fondamento così poco omogeneo com’è quello dell’opera “composta”. La disarmonia provocata dal concorso di più “mondi sensori” si può evitare nell’anima dell’artista creatore se l’opera “composta” nasce dalla collaborazione di più artisti, ognuno dunque dei quali si può limitare a un suo mondo unico. Questa disarmonia potrà però sempre provocarsi nell’anima di colui che riceve, ossia del “pubblico”. Infatti qualcosa del genere si può verificare in quelle opere in cui nessuno dei mezzi concorrenti assorbe decisamente l’attenzione, ma s’incontra invece, pressappoco, un equilibrio fra i mezzi impiegati. Questo avviene in certe canzoni. La canzone è, come l’opera lirica, un genere prevalentemente musicale. Ma quando anche la poesia musicata, ossia il testo, riesce ad attirare l’attenzione, allora ci sembra appunto di poter constatare che l’equilibrio fra musica e poesia ha qualcosa di oscillante, di cangiante, provocato dall’attraente gara indecisa fra due concorrenti che vorrebbero ognuno conquistare l’attenzione del pubblico. Una tale gara fra le arti potrebbe aver l’effetto di impedire al pubblico il più intimo immedesimarsi con la composizione. Forse, in tale caso non si supera il godimento prodotto dal fascino piuttosto formale che nasce dalla consonanza di elementi simili ma pur sempre eterogenei; e l’artista non riesce a dominare del tutto chi lo ascolta. Siamo ora giunti ad alcuni concetti fondamentali che ci possono essere utili per giudicare il cinema parlato. Secondo quanto abbiamo visto, il film parlato, prima di tutto, avrebbe bisogno di un mezzo dominante. Questo mezzo non potrebbe essere che l’immagine animata, giacché il predominio della parola ci porterebbe al teatro. Si tratta ora di sapere se all’arte dell’immagine animata, già sviluppata dal cinema muto, potrebbe riuscire utile o almeno possibile l’uso di un “libretto” simile a quello in cui l’opera lirica trova lo scheletro dell’azione drammatica. Prima di tutto bisogna constatare che, come dicevamo prima, il “libretto” dell’opera lirica (e dei suoi predecessori nella musica ecclesiastica ecc.) ha significato per la musica la conquista di un grande regno nuovo cioè della musica drammatica, del dramma musicale. Nel caso del cinema, invece, il dialogo non apre l’accesso a una nuova specie di opere. Se mai, amplia quella già esistente. È necessario rammentare che i dialoghi del cinema muto, le didascalie, non rappresentavano affatto la base che era indispensabile creare come prima cosa, per poi sviluppare su di essa le immagini. Erano invece un semplice espediente esplicativo aggiunto esteriormente a opere concepite e realizzate mediante immagini. Ma forse al dialogo sonoro non spetta nemmeno una così umile mansione. Ciò che è utile all’opera lirica potrebbe essere nocivo al film. Un vero artista, ossia una persona guidata da una sensibilità sicura per le esigenze del mezzo con cui lavora, si sentirà indotto a “mettere in immagini” un libretto dialogato anziché creare mediante le sole immagini? Il dialogo drammatico, in sé stesso, ha grandi pregi: esso determina ogni fenomeno con l’acutezza dei concetti; il suono della parola aumenta considerevolmente il senso di materialità e di presenza viva dell’azione rappresentata; il dialogo aggiunge ai mezzi dell’attore quello più importante e più ricco. Ma queste preziose facoltà della parola in sé non attrarranno il nostro artista perché il mezzo che lo attrae è l’immagine animata. Gli potrebbe piacere invece di trovare un mezzo tecnico che precisasse il significato delle immagini; che gli risparmiasse giri tortuosi e artificiosi e che gli aprisse un campo di argomenti più esteso. Infatti, il dialogo permette un ampio sviluppo dell’azione esterna e, anche e soprattutto, di quella interna. Un intreccio piuttosto complicato, uno stato d’animo complesso non si possono rappresentare con la sola immagine, a meno che non si voglia esprimere con trovate complicate quanto invece poche parole di dialogo possono rendere in un modo immediato, rapido e generalmente molto più preciso. Perciò, l’introduzione del dialogo parlato ha difatti facilitato decisivamente la tecnica del racconto nel campo del cinema – facilitazione che le didascalie del cinema muto avevano procurata soltanto in modo molto più ristretto. Perciò, da qualcuno il dialogo cinematografico è stato definito come un ripiego per risparmiare tempo, spazio e forze inventive e per poter così riservare 338 339 l’estensione limitata della pellicola e l’energia creativa alle scene salienti dell’azione. Senonché rimane da discutere fino a che punto possano essere giustificati sullo schermo intrecci complicati come quelli sviluppati dalla letteratura nel romanzo e nella commedia teatrale. Prescindendo da criteri artistici, si capisce benissimo perché il grande pubblico ha ricevuto il cinema sonoro con molti consensi. Tale pubblico non desidera altro che partecipare nel modo più immediato possibile ad avvenimenti emozionanti. Il miglior modo per arrivare a ciò è, in un certo senso, una mescolanza di azione visiva e di dialogo. In questa maniera gli avvenimenti esteriori si presentano in modo concreto all’occhio, e allo stesso tempo vengono comunicati nel modo più naturale e diretto, attraverso la parola parlata, opinioni, intenzioni e sentimenti dei personaggi. Inoltre la presenza materiale dell’azione è vivificata enormemente dal suono delle voci e dai rumori. Il fatto che i due mezzi impiegati si menomano a vicenda, conta per il grande pubblico soltanto se questi s’accorge con fastidio che il dialogo ridotto a favore dell’azione visiva non riesce a spiegare sufficientemente la trama o che, al contrario, la scarsezza di azione esterna, provocata dal dialogo, rende il film “noioso”. Tuttavia queste deficienze constatate dal pubblico rappresentano appunto – in forma grossolana – le conseguenze di quelle debolezze che anche l’esteta e l’amico dell’arte rimproverano al cinema parlato. L’esempio dell’opera lirica sembrava giustificare e raccomandare senz’altro l’uso del libretto. Senonché bisogna andar cauti col mettere alla pari l’arte dei suoni e l’arte delle immagini per quanto riguarda i loro rapporti con la parola. Una caratteristica essenziale del dialogo drammatico è quella di limitare l’opera d’arte completamente all’uomo, che discute e agisce. Tale caratteristica corrisponde perfettamente alle esigenze della musica, la quale, come dicevamo, ha creato l’opera lirica appunto per poter rappresentare musicalmente l’uomo in azione drammatica. L’immagine invece già di per sé conta fra i suoi elementi l’uomo anche senza il concorso del dialogo. Ma nell’immagine, l’uomo non ha quel predominio assoluto di cui gode sul palcoscenico. In certe opere pittoriche, è vero, la sua immagine riempie gigantescamente il primo piano, davanti a uno sfondo vuoto o in ogni modo di importanza secondaria. Ma spesso la pittura ci mostra l’uomo inserito nel suo ambiente, il quale gli dà significato e al quale dà significato egli stesso: l’uomo come parte della Creazione, dalla quale può essere isolato soltanto artificialmente. Molte figure di Rembrandt non vivrebbero senza lo spazio crepuscolare che le circonda. All’immagine animata ossia al cinematografo fu, fin dal principio, più vicino il mondo animato dall’uomo anziché l’uomo staccato dal mondo. Perciò al cinema doveva riuscir insopportabile quello stretto limitarsi all’uomo, impostogli dal dialogo. Il luogo in cui si svolge l’azione drammatica è l’anima umana, il cui unico complemento ottico possibile è il corpo umano formato e diretto da sensazioni, sentimenti, volontà e pensiero. L’ambiente è ammesso come semplice sfondo (precisamente come a teatro), giacché anche il dialogo accenna ogni tanto al mondo di fuori. Decisamente, il dialogo pone l’uomo nel centro del film sonoro eliminando con ciò le altre suddette possibilità dell’immagine, care appunto a un moderno modo di vedere il mondo. Questa stessa possibilità di rappresentare l’uomo inserito nel suo ambiente naturale era stata uno dei fattori principali che giustificassero l’esistenza del cinema a fianco del teatro. Naturalmente, anche il film muto aveva spesso mostrato l’uomo in primo piano. Ma esso aveva creato una omogeneità fra uomo muto e oggetto muto, fra uomo vicino e uomo lontano (rispetto allo spettatore): il silenzio generale nell’immagine aveva fatto sì che i rottami di un vaso “parlassero” nel modo identico con cui un personaggio “parlava” al suo prossimo; un uomo che si avvicinava, ancora lontanissimo, su un viale e che appariva sullo schermo come un semplice puntino nero, “parlava” come un altro che agiva in primo piano. Questa omogeneità, lontanissima dalle concezioni del teatro e invece più vicina al carattere della pittura, è annientata nel film parlato. Esso dà la parola all’attore, e giacché l’attore solo può averla, gli oggetti sono spinti verso il fondo, precisamente come sul palcoscenico. Ora, il rendimento ottico dell’uomo in movimento è ristretto, soprattutto se la rappresentazione si deve limitare ad accompagnare dei dialoghi. La mimica dispone di tre possibilità per sfuggire tale limitatezza e per raggiungere invece una forma artistica di sufficiente rendimento. Essa può abbandonare la rappresentazione di azioni e diventare un gioco “assoluto” di movimenti, cioè danza; nel qual caso i gesti e la figura del corpo umano sembra raggiungano un sistema di forme melodiche e armoniche, superiore alle azioni pantomimiche nello stesso senso in cui la musica è superiore a una (ipotetica) arte basata unicamente sulla riproduzione di rumori naturali. La mimica può anche inserirsi nel mondo più ricco dell’immagine animata in genere, che noi conosciamo dal cinematografo. Infine, la mimica può farsi servente della parola drammatica – soluzione realizzata dal teatro. Ma alla pantomima del film parlato è vietata ognuna di queste tre possibilità: non può diventare danza perché la danza non ha bisogno della parola e probabilmente non la sopporta nemmeno; non può sciogliersi nel grande orbis pictus del cinema muto perché il dialogo esclude tutto eccetto l’uomo; e non può diventare serva della parola senza abbandonare se stessa. Per compensare lo scarso rendimento della pantomima, si finirà per ampliare il dialogo, il quale non doveva essere altro che uno scheletro dell’azione. È proprio questa l’evoluzione che in pratica si è potuta constatare. In conseguenza, per ragioni che subito esporremo, la immagine diventa sempre più rigida ed inespressiva, senza che però il dialogo possa raggiungere una densità che gli permetterebbe di rimediare a quel vuoto. 340 341 Il dialogo restringe il mondo del cinematografo Di questo diventa capace soltanto quando esso è diventato predominante, ossia quando si realizza un vero e proprio ritorno al teatro. Il dialogo fa irrigidire l’azione visiva Il dialogo, oltre a limitare il cinema a un’arte di “ritratti drammatici”, ostacola anche l’espressione dell’immagine animata. Il cinema muto quanto più era artistico tanto più aveva evitato di presentare l’uomo mentre parla, per quanto questo sia un motivo importante della vita reale. I suoi attori si esprimevano piuttosto attraverso gli atteggiamenti delle membra e del viso ed erano caratterizzati inoltre dalla posizione della loro immagine entro il quadro dello schermo (per esempio centrale o decentrata), dalle dimensioni di questa immagine (grande o piccola), dall’illuminazione e infine dal contenuto delle immagini e della trama. Invece il complemento ottico del parlare, i monotoni movimenti della bocca, rendevano poco, anzi non potevano che menomare la pantomima altamente espressiva. I movimenti della bocca rappresentano la dimostrazione persuasiva del fatto che l’atto del parlare costringe l’attore ad atteggiamenti otticamente monotoni, insignificanti e spesso ridicoli. È ovvio che la favella non può aggiungersi all’immagine fissa (dipinto, fotografia) ma altrettanto male essa si adattava al cinema muto, i cui mezzi d’espressione somigliavano piuttosto che ad altri a quelli della pittura. L’eliminazione del parlare aveva appunto permesso al cinema muto di elaborare uno stile che abbreviava, sintetizzava le situazioni drammatiche: separarsi e trovarsi insieme, vincere e subire, diventar amici o nemici – tutto ciò era molto felicemente rappresentato con pochi atteggiamenti e rapidi gesti: il semplice alzarsi della testa o del braccio, il semplice cader in terra di una persona davanti a un’altra. Onde si era sviluppato il genere molto cinematografico del racconto ricco di semplici azioni, sostituito poi, coll’avvento del parlato, da una sorta di commedia teatrale, povera di azione esterna ma psicologicamente molto sviluppata. Per l’immagine sullo schermo ciò significa sostituire “l’uomo in azione” col suo forte rendimento ottico, con “l’uomo che parla” otticamente sterile. All’opera lirica, dicevamo, non importa che il dialogo imperni l’intera azione sull’uomo. Non importa nemmeno l’irrigidimento ottico dell’attore. L’opera lirica non vuole altro che esprimere musicalmente l’uomo in azione. Essa attribuisce invece poco valore alle capacità espressive dell’immagine animata sulla scena, la quale per lei rimane un elemento secondario, puramente complementare ed esplicativo. Senza preoccupazioni, essa irrigidisce l’azione scenica a favore delle lunghe arie cantate. In tal modo, il dialogo trova tutto il tempo per farsi pronunciare con comodo, anzi il tempo gli avanza: e per impiegarlo è costretto a infiniti dilatamenti e ripetizioni. Quindi, ciò che menoma il film, non menoma l’opera lirica. 342 Ulteriori confronti col cinema muto Dopo di che, crediamo di aver dimostrato che il dialogo non sia un mezzo adatto per agevolare l’azione cinematografica sullo schermo. La limita e ostacola invece. Le didascalie del cinema muto rappresentavano un’inserzione noiosa fra le immagini, e scomponevano la naturale simultaneità della persona che parla e delle parole da essa pronunciate, presentando parole e immagine successivamente. Ma esse, almeno non si intromettevano nella creazione della scena stessa, e inoltre avevano così poca importanza per la concezione e preparazione del film che spingevano in grado assai più limitato alla scelta di soggetti teatrali, anticinematografici. Erano sempre considerate un ripiego subordinato e perciò difficilmente si pensava ad ampliare la loro parte a scapito dell’azione visiva. Infine, il fatto che non formassero un dialogo continuo ed organico ma apparissero soltanto occasionalmente, quando servivano, non faceva un’impressione troppo assurda, essendo anch’esse, dopo tutto, elementi ottici. Ma a parte ciò, sarebbe errato voler giudicare il cinema parlato mettendolo a confronto con i film muti, i quali si servivano più o meno ampiamente delle didascalie. Giacché questi film non rappresentavano affatto il tipo proprio e definitivo dell’opera d’arte cinematografica, ma invece un tipo incompleto e provvisorio, non ancora svincolato dalla tradizione del teatro e non ancora passato dalla rappresentazione mediante azione e dialogo, a uno stile più lontano dalla realtà e più specificamente cinematografico, nel quale parola e pensiero fossero trascritti in azione visiva. Alcuni dei migliori cineasti di allora avevano potuto dare degli esempi del modo di limitare o di sopprimere addirittura le didascalie. Ma essi non arrivavano a ciò spiegando con sforzati espedienti ottici ciò che altrimenti avrebbero dovuto esprimere con la parola, ma invece scegliendo fin dal principio soggetti e situazioni che permettessero di rendere evidente in maniera completa e naturale il significato dell’azione, mediante il semplice aspetto di persone, di oggetti e di azioni. Erano giunti alla rappresentazione di semplici situazioni fondamentali della vita umana; si servivano moltissimo dell’ambiente per caratterizzare i personaggi; presentavano, insomma, soggetti e immagini che somigliavano molto a quelli della pittura. Con questo autentico tipo di opere cinematografiche, realizzato soltanto in minima parte perché distrutto dall’avvento del cinema sonoro, bisogna confrontare i mezzi d’espressione del film sonoro, non con quei provvisori, impuri tentativi di un giovane genere d’arte. Nemmeno si può affermare che il cinema abbia bisogno della parola per diventare uno strumento d’arte veramente penetrante. Basta pensare alle arti figurative per persuadersi che non ogni arte ha bisogno di raggiungere il pensiero concettuale. Anche le arti figurative – e infatti il cinema è una di esse – hanno il loro modo di cogliere dalla realtà la verità universale; e se esse non presentassero ai nostri occhi i fenomeni reali purificati fino al punto di assumere un valore universale, troveremmo forse maggiore difficoltà nel renderci familiari i concetti astratti. 343 Il cinema parlato rimarrebbe sempre un genere secondario È possibile dunque il film parlato? Ci siamo resi conto del fatto che il dialogo costringe l’azione visiva a mettere in primo piano l’uomo che parla, e che esso irrigidisce e deforma la pantomima sullo schermo. Perciò ci sembra difficile che possa diventar artisticamente fruttifero un genere cinematografico in cui un’azione visiva predominante si basi su un conciso dialogo. Resta a vedere se può rendere di più un tipo di film in cui immagine e parola siano in equilibrio, di modo che una pantomima, abbastanza ricca per soddisfare alle esigenze dell’occhio, venga completata da un dialogo, non troppo esteso per non distruggere l’azione visiva ma tuttavia sviluppato al punto da produrre insieme all’immagine un’opera sostanziale. In senso generale e teorico, non si può rispondere altro in proposito che citare il risultato delle nostre ricerche secondo le quali l’accoppiamento di più mezzi in un’opera d’arte non avviene generalmente sulla base di un equilibrio dei mezzi, ma invece sotto forma di una gamma gerarchica dominata da un mezzo prevalente. Abbiamo rilevato coll’esempio di certi tipi di canzoni, che si può verificare un oscillamento fra mezzi concorrenti quando l’opera totale tenda a un equilibrio fra questi ultimi. Le condizioni che caratterizzano il cinema parlato sono ancora diverse da quelle della canzone, e resterebbe ora a vedere empiricamente se in qualche caso singolo due artisti possano riuscire a rendere armonico un tale equilibrio. Senonché bisogna persuadersi che anche in questo caso non ci troveremmo mai di fronte a un nuovo, importante e fecondo genere artistico, per esempio al famoso “perfezionamento del cinema muto”; ma che si tratterebbe invece di una occasionale forma intermedia sul confine fra cinema e teatro e non realizzabile senza seri sacrifici da ambedue le parti. Una tale forma si definirebbe del resto meglio come un caso limite del teatro, giacché il teatro è sempre una combinazione di immagine e dialogo, mentre nel caso del cinema il dialogo viene aggiunto all’arte dell’immagine animata come un elemento del tutto nuovo e estraneo – e questa classifica sarebbe consigliabile anche se questo nuovo tipo di spettacolo fosse tecnicamente realizzabile soltanto coi mezzi del cinema. (Conta unicamente il carattere estetico dell’opera presentata, non il modo tecnico di produrla!). Né si può discutere che l’attuale produzione cinematografica ci presenti ben pochi sintomi per la nascita di tali esempi persuasivi. Questa produzione tenta invece disperatamente di creare un complesso ricreativo combinando scene di dialogo sviluppatissime e otticamente aride con intermezzi ricchi di azione esterna nello stile, del tutto differente, del cinema muto. Si verifica inoltre, rispetto all’epoca del cinema muto, un impressionante abbassamento di qualità artistica, tanto per la produzione media quanto per il livello dei film “migliori”, la quale certamente non si spiega unicamente con la sempre crescente industrializzazione del cinematografo. Infine: se, qua e là, si riuscisse a creare qualche opera soddisfacente del 344 tipo suaccennato, ciò avrebbe per i rapporti delle arti che in esse interferiscono, ossia per il cinema e il teatro, non maggiore importanza di quella che una occasionale eclissi può avere per i rapporti fra il sole e la luna. La documentazione vince l’arte Le invenzioni tecniche della registrazione meccanica di immagini e di suoni possono essere utili all’umanità in due sensi diversi, a prescindere dalle loro importanti funzioni sociali. Possono servire per conservare fedelmente le creazioni della natura e dell’uomo, e questa applicazione di esse soddisfa a un antichissimo bisogno dell’umanità diventato molto forte specialmente nell’epoca delle scienze naturali, ossia dal Rinascimento in poi. D’altra parte esse possono aumentare i mezzi d’espressione dell’arte, in quanto offrono l’affascinante realismo della rappresentazione meccanicamente fedele e permettono un rapido variare degli ambienti e anche delle posizioni da cui il pubblico segue l’avvenimento. Questi mezzi diventano sempre più adatti alle loro mansioni “documentarie” se all’immagine monocroma e piatta si aggiungono il colore, la plasticità e il suono e se, nel caso della radio, al suono si aggiungono le immagini. Ma circa l’applicazione artistica constatiamo che, per esempio, la registrazione meccanica dei colori naturali aumenta i mezzi d’espressione dell’immagine ma anche la dipendenza della rappresentazione dal soggetto naturale, il che limita ancora di più la libertà creatrice dell’artista. Dell’influenza distruttiva del suono sull’arte dell’immagine abbiamo parlato abbondantemente. Viceversa, l’aggiunta dell’immagine televisiva distrugge le capacità creative del suono senza immagine, nella radiocommedia. Secondo che si parta dal punto di vista dell’arte o da quello della documentazione, si arriva dunque a giudicare diversamente l’utilità dei diversi mezzi di registrazione. Entro certi limiti, la fedeltà meccanica agevola l’arte e l’arte rende più fedele la fedeltà. Oltre a ciò si provocano contrasti fra i due atteggiamenti. Un’epoca artisticamente più dotata della nostra avrebbe potuto salvare e sviluppare i nuovi mezzi artistici, senza venire ostacolata dal contemporaneo perfezionarsi della riproduzione meccanica, realizzato attraverso la registrazione di un numero sempre maggiore di elementi sensibili della realtà. Essa avrebbe potuto conservare il cinema muto accanto al film parlato, la radiocommedia accanto alla televisione. Purtroppo per arrivare a ciò sono insufficienti e i nostri impulsi e la nostra saggezza. Seguendo una teoria estetica nata già nell’antichità ma diventata fatale soltanto in un’epoca di poca sensibilità artistica, crediamo di aumentare l’arte perfezionando l’imitazione. Da ciò nasce una tendenza a moltiplicare sempre di più i mezzi rappresentativi – tendenza che non ha niente in comune con quella di produrre ricche e complesse manifestazioni d’arte, quali il teatro greco o la cattedrale medioevale! Il mezzo meccanico vince l’uomo creativo. Col cinema, l’arte 345 visiva aveva cominciato ad arricchirsi in un modo sognato dall’umanità fin dal suo nascere. L’aggiunta della parola doveva distruggere questa evoluzione. Ma gli uomini non volevano crederci: volevano salvare quanto avevano conquistato, e non rinunciare al nuovo. Senonché nei mezzi stessi adottati agiscono, per così dire, forze più potenti della volontà umana: esse, molto rapidamente, fecero irrigidire l’immagine rendendola semplice serva del dialogo, e spingendo in questo modo lo spettacolo verso la forma più pura raggiungibile sotto le nuove condizioni: cioè verso il teatro. Queste forze causavano un regresso nella direzione di ciò che l’umanità già aveva conquistato, perché essa era ritornata dai nuovi mezzi a quelli primitivi. Nel caso della radiocommedia si potrebbe tutt’al più affermare che ci sia una necessità intrinseca nel fatto che la parola pura della radio non riesca a difendersi contro l’aggiunta fatale dell’immagine; giacché, secondo questa affermazione, la natura umana rifiuterebbe la separazione degli elementi acustici da quelli ottici perché troppo artificiale, troppo contraria ad ogni esperienza naturale. Ma nel caso inverso, cioè in quello della distruzione dell’immagine attraverso il dialogo, una tale obbiezione ci sembrerebbe certamente fuori luogo perché, come dicevamo, il cinema muto nelle sue realizzazioni tipiche si era allontanato dal comune atteggiamento umano di ogni giorno e aveva raggiunto un linguaggio mimico stilizzato, il quale non solo non ispirava alcun bisogno di vederlo completato da dialogo ma anzi non permetteva più una tale aggiunta, precisamente come non la permette la danza. Del resto, il cinema muto, come la danza, pagava il suo tributo all’orecchio servendosi di commento musicale. (E se nonostante ciò quella opinione avesse ragione e se quindi l’immagine muta fosse qualcosa di artificiale, allora, naturalmente, il fatto della inseparabilità di immagine e parola non rappresenterebbe affatto la giustificazione estetica di un cinema parlato, ma soltanto la condanna del cinema muto e della radiocommedia!). Qualcuno troverà sorprendente che l’umanità produca attualmente su larga base innumerevoli opere servendosi di un principio che in confronto con le possibili forme pure rappresenta un così radicale impoverimento artistico. Ma un tale controsenso può sorprendere veramente se avviene in un’epoca in cui anche in tanti altri campi troppa gente vive nell’irreale tenendosi lontana dal sublime compito di realizzare l’Uomo e le creazioni riservate ad esso? Il contrario non sarebbe forse più sorprendente perché illogico? Tuttavia possiamo trovare una grande consolazione nel fatto che le forme ibride e “irreali” non si mantengono, ma si sviluppano irresistibilmente verso forme pure, fossero anche quelle tradizionali: possiamo constatare che indipendentemente dalla sconsideratezza agiscono delle forze intime che, alla lunga, superano ogni errore e ogni incompletezza dirigendo l’attività umana verso il puro, il buono e il vero. 346 NOTE Perché? Se nella stessa scena, basta un’inquadratura che mostri il movimento delle lancette sul quadrante di un orologio; se nella stessa inquadratura, basta una variazione di luce (giorno-notte) che renda il movimento interno del quadro. Cfr. in proposito il saggio di P. Uccello, in questo stesso fascicolo di «Bianco e Nero». 2 La tabella dei principi del taglio e del montaggio del Timoshenko, e quella proposta dall’Arnheim, sono state riportate nel n. l, anno II, di «Bianco e Nero», nel saggio di Renato May: Per una grammatica del montaggio. – N. d. R. 3 Questo mezzo era stato usato nel film Il crollo della Casa Usher di Poe (regia di Epstein). 4 Si intende che il legame fra fatti del “mondo reale” non si esaurisce sempre in un semplice accostamento temporale e spaziale. Nel caso del corpo e della voce di una persona, per esempio, non si tratta di una condizione puramente empirica e casuale fra elementi che, per il resto, non hanno niente a che fare l’uno con l’altro; ma siccome, invece, il corpo e la voce sono manifestazioni di un unico organismo, esiste fra di loro un’intima parentela d’espressione, la quale rende significativo il fatto che proprio quel determinato corpo e quella determinata voce siano empiricamente collegati. In un tale caso dunque, oltre all’estrinseco legame empirico, ce n’è anche uno più essenziale: esso si manifesta attraverso “caratteristiche espressive” comuni ad ambedue gli elementi ed appartiene perciò alla sfera di quel penultimo piano di cui sopra parlavamo. Ma né nell’arte, né nella realtà il rapporto empirico corrisponde sempre anche a una parentela d’espressione, come non esistono rapporti d’espressione soltanto fra fatti empiricamente collegati. 5 La scena finale del Wallenstein di Schiller per esempio, citata da Hegel (vedi «Bianco e Nero», II, 2-3, p. 110) è basata essenzialmente su elementi visivi ma non per questo è “realizzabile” soltanto mediante messinscena teatrale. Essa è realizzata sulla carta in modo altrettanto definitivo del dialogo: Gordon. – O casa del delitto e dell’orrore! (Un corriere viene e reca una lettera). Gordon (gli va incontro). – Che cosa c’è? Questo è il sigillo imperiale. (Egli legge la soprascritta e porge la lettera a Ottavio con uno sguardo di rimprovero). – Al principe Piccolomini. (Ottavio si atterrisce e guarda dolorosamente al cielo). (Cala la tela). 1 347 Appendice bibliografica Scritti sul cinema di Rudolf Arnheim nelle riviste italiane Questa bibliografia dà conto del contributo di Arnheim in ambito cinematografico nelle riviste italiane a partire dagli anni Trenta. Un contributo che si estende per oltre sessant’anni, dalla vigilia del giovanile approdo in Italia, sino a oltre la caduta del Muro di Berlino. Gli articoli e i saggi sono elencati in ordine cronologico. La bibliografia è corredata dall’indicazione delle fonti originali degli articoli e dalle ripubblicazioni in rivista o in volume purché italiani. Le indicazioni fra parentesi si riferiscono alla modalità esatta con cui il rispettivo articolo è stato firmato o siglato. Laddove non segnalato, s’intende per esteso la firma di Rudolf Arnheim. La ricostruzione sopperisce alle molte lacune e inaccuratezze delle bibliografie esistenti, soprattutto rispetto al contesto italiano, e tuttavia paga il debito di essersi originariamente basata su di esse. In particolare: Bibliography of Rudolf Arnheim, dattiloscritto redatto nel 1974 da Mary Arnheim, aggiornato in Rudolf Arnheim: Bibliography of his Writings, 1928-1982 nel 1983 e con ulteriori integrazioni nel 1988 (supplemento 1983-1987) e nel 1991 (supplemento 1983-1990); e Complete Bibliography of Writings on Film, Photo, Press and Radio by Rudolf Arnheim, curata da Helmut H. Diederichs, in Film Essays and Criticism, University of Wisconsin Press, Madison (WI)-London, 1997 e costantemente aggiornata nel forum on-line www.sozpaed.fh-dortmund.de/diederichs/arnforum/ragesv.htm. Non rientrano nell’elenco i molti interventi di Rudolf Arnheim per le rubriche di «Cinema» firmate con gli pseudonimi Il Nostromo, Marie Onussen, Ciak e Candido nell’arco di tempo compreso fra i numeri d’avvio della rivista nell’estate del 1936 e l’estate del 1938. L’attribuzione della paternità di tali pseudonimi ad Arnheim è discussa nel paragrafo “Le rubriche di «Cinema»”. Per quanto il più possibile completa e accurata, questa bibliografia resta suscettibile di integrazioni. Una versione costantemente aggiornata è pubblicata su www.RudolfArnheim.it, sito web che raccoglie studi e ricerche sui rapporti fra Arnheim e il cinema. 349 1932 (R. A.), Espressione Soggettista e direttore artistico «Intercine», 4, aprile 1935, pp. 225-227. Inglese, Expression, pp. 225-227. Francese, L’expression, pp. 225-228. Tedesco, Ausdruck, pp. 228-231. «L’Italia letteraria», 15 maggio 1932, p. 5, traduzione e nota di Umberto Barbaro. Tit. or. “Manuskript und Regie”, in Rudolf Arnheim, Film als Kunst, Ernst Rowholt, Berlin, 1932, pp. 220-223. Nuova traduzione dell’autore con il titolo “Soggettista e regista”, in Id. Il film come opera d’arte, «Bianco e Nero», 4, aprile 1938, pp. 40-42. (R. A.), Espressione «Intercine», 5, maggio 1935, pp. 286-288. Inglese, Expression, pp. 285-287. Francese, L’expression, pp. 285-287. Tedesco, Ausdruck, pp. 290-293. 1933 (R. A.), Espressione Arte riproduttiva «Intercine», 6, giugno 1935, pp. 354-356. Inglese, Expression, pp. 354-356. Francese, L’expression, pp. 354-357. Tedesco, Ausdruck, pp. 358-361. «Cine-Convegno», 2-3, 25 aprile 1933, pp. 33-36. Ora in «Bianco e Nero», 563, gennaio-aprile 2009, pp. 131-133. (R. A.), Espressione Contrappunto sonoro «Intercine», 7, luglio 1935, pp. 407-409. Inglese, Expression, pp. 407-409. Francese, L’expression, pp. 407-408. Tedesco, Ausdruck, pp. 413-415. «La Stampa», 20 giugno 1933, p. 5, traduzione e nota di Umberto Barbaro. Tit. or. Robert Ambach, Geräusche in der linken Hand, «Berliner Tageblatt», 154, 2 aprile 1933. Ora in «Bianco e Nero», 563, gennaio-aprile 2009, pp. 134-135. 1935 Nostro pane quotidiano «Intercine», 1, gennaio 1935, pp. 14-18. Inglese, Our Daily Bread, pp. 14-18. Francese, Notre pain quotidien, pp. 14-18. Spagnolo, Ganarás el pan, pp. 14-18. Tedesco, Unser Täglich brot, pp. 14-18. Il critico cinematografico di domani «Intercine», 8-9, numero speciale per la III mostra internazionale cinematografica, agosto-settembre 1935, pp. 36-37. Edizione internazionale (Tedesco), Der Filmkritiker von morgen, pp. 89-93. Francese, Le critique cinématographique de demain, p. 93. Inglese, Cinematographic Criticism of Tomorrow, p. 94. Poi in «Cinema 60», 85-86, settembre-dicembre 1971, pp. 48-52; e in «Filmcronache», 1, 2005, pp. 22-25, (http:// www.ancci.it/ancci/controller.do?PageId=1547). (R. A.), Espressione (R. A.), Espressione «Intercine», 10, ottobre 1935, pp. 64-66. Edizione internazionale (Francese), L’expression, pp. 41-43. «Intercine», 1, gennaio 1935, pp. 34-37. Inglese, Expression, pp. 35-38. Francese, L’expression, pp. 34-38. Spagnolo, Expression, pp. 34-37. Tedesco, Ausdruck, pp. 35-38. (R. A.), Espressione Vedere lontano «Intercine», 11, novembre 1935, pp. 47-49. Edizione internazionale (Francese), L’expression, pp. 48-49. «Intercine», 2, febbraio 1935, pp. 71-82. Inglese, Seeing Afar Off, pp. 71-82. Francese, Voir loin..., pp. 71-82. Spagnolo, Ver lejons, pp. 71-82. Tedesco, Ein Blick in die Ferne, pp. 71-82. Poi parzialmente in Rudolf Arnheim, Film come arte, Il Saggiatore, Milano, 1960, pp. 207-216; e in Orio Caldiron (a cura di), Storia del cinema italiano, vol. V - 1934/1939, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero, Venezia, 2006, pp. 588-594. (R. A.), Espressione «Intercine», 12, dicembre 1935, pp. 44-46. Edizione internazionale (Francese), L’expression, pp. 43-45. 1936 L’Enciclopedia del cinema «Intercine», 3, marzo 1935, pp. 130-138. Inglese, The Encyclopedia of the Cinema, pp. 130-138. Francese, L’Encyclopédie du cinéma, pp. 130-138. Spagnolo, La Enciclopedia del cinema, pp. 130-138. Tedesco, Die Enzyklopädie des Films, pp. 130-138. Perché sono brutti i film a colori? (R. A.), Espressione (Rodolfo Arnheim), A proposito del cinema a colori «Intercine», 3, marzo 1935, pp. 164-167. Inglese, Expression, pp. 164-167. Francese, L’expression, pp. 164-167. Spagnolo, Expression, pp. 163-166. Tedesco, Ausdruck, pp. 166-169. «Cinema», 2, 25 luglio 1936, pp. 67-68. Poi parzialmente con il titolo Avvenire del colore, «Sequenze», 1, marzo 1949, p. 25. 350 351 «Scenario», 3, 1936, pp. 112-114. Tit. or. Remarks on the Color Film, «Sight and Sound», 16, inverno 1935-36, pp. 160-162. Polarizzazione. La lotta contro i riflessi Uno spettro in tre versioni «Cinema», 7, 10 ottobre 1936, p. 276. «Cinema», 13, 10 gennaio 1937, pp. 22-23. (rnh), Danza macabra (rnh), Analisi d’una ignota «Cinema», 8, 25 ottobre 1936, p. 312. «Cinema», 13, 10 gennaio 1937, pp. 23-24. (rnh), La mano del regista (Candido), Vigilia d’armi, È arrivata la felicità, Voglio essere amata, L’imperatore della California, Il sentiero della felicità «Cinema», 8, 25 ottobre 1936, p. 312. «Cinema», 14, 25 gennaio 1937, pp. 69-71. (rnh), L’uomo invisibile delle attualità (Candido), Lo studente di Praga, Amore tzigano, L’amato vagabondo, I nostri parenti «Cinema», 9, 10 novembre 1936, p. 340. «Cinema», 15, 10 febbraio 1937, pp. 109-111. (rnh), Lux e lumen Gli occhi del cervello «Cinema», 9, 10 novembre 1936, p. 340. «Cinema», 16, 25 febbraio 1937, pp. 148-149. (rnh), Montaggio senza montaggio «Cinema», 9, 10 novembre 1936, p. 343. (Candido), Maria di Scozia, I cavalieri del Texas, Il mio amore eri tu, La carica dei 600 (rnh), Senza parola «Cinema», 16, 25 febbraio 1937, pp. 155-157. «Cinema», 10, 25 novembre 1936, p. 377. Dettagli che non sono dettagli Psicologia del “Gag” «Cinema», 17, 10 marzo 1937, pp. 180-182. «Cinema», 10, 25 novembre 1936, pp. 378-379. (rhn), Pesci d’aprile. Le meraviglie della tecnica Una notte sul Monte Calvo «Cinema», 18, 25 marzo 1937, pp. 217-219. «Cinema», 11, 10 dicembre 1936, pp. 428-429. Poi parzialmente con il titolo Disegni animati e pittura in movimento, in Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano. Antologia di “Cinema” 1936-1943, Marsilio, Padova, 1965, p. 133. Televisione. Domani sarà così (rnh), Dominatrici «Cinema», 11, 10 dicembre 1936, p. 440. «Cinema», 20, 25 aprile 1937, pp. 337-338. (Candido), La donna del giorno, Il paradiso delle fanciulle, Ramona, La bambola del diavolo, Seguendo la flotta, Contessa di Parma «Cinema», 21, 10 maggio 1937, pp. 389-390. (R. Arn.), Uno zio del cinematografo «Cinema», 12, 25 dicembre 1936, p. 457. Poi con il titolo Un pioniere del cinematografo, «Bianco e Nero», 1, gennaio 1937, pp. 116-117. Espressione e bellezza «Cinema», 23, 10 giugno 1937, pp. 443-444. Poi parzialmente in Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano, cit., pp. 133-134. (rnh), Cinema “in persona prima” «Cinema», 12, 25 dicembre 1936, p. 480. Poi parzialmente con il titolo La prima persona, in Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano, cit., p. 132. (R. Arnh), La luce in movimento 1937 Resurrezione del cineasta? «Cinema», 24, 25 giugno 1937, p. 508. «Cinema», 25, 10 luglio 1937, pp. 7-9. (R. Arn), Un pioniere del cinematografo «Bianco e Nero», 1, gennaio 1937, pp. 116-117. Originariamente con il titolo Uno zio del cinematografo, «Cinema», 12, 25 dicembre 1936, p. 457. 352 (R. Arnheim), Le leggi del colore «Cinema», 29, 10 settembre 1937, pp. 170-171. 353 Il paesaggio ispiratore L’attore e le stampelle «Cinema», 32, 25 ottobre 1937, pp. 262-264. Poi parzialmente con il titolo Paesaggio ispiratore e linguaggio, in Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano, cit., pp. 134-135. «Cinema», 46, 25 maggio 1938, pp. 335-337. Poi in «Bianco e Nero», 3, marzo 1939, pp. 98-101; e in Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano, cit., pp. 214-128. (RNH), Ma che cosa è questo cinema? I - Sonoro e muto? (R. A.), Il nuovo sistema italiano per la cinematografia a colori naturali «Cinema», 33, 10 novembre 1937, p. 306. «Cinema», 47, 10 giugno 1938, pp. 370-372. (R.A.), Un mondo più colorato (rnh), Il detective soggettista «Cinema», 34, 25 novembre 1937, p. 337. «Cinema», 50, 25 luglio 1938, pp. 56-58. (rnh), Ma che cos’è questo cinema? II. Bisogna seguire il gusto delle masse? Un lettore ci domanda «Cinema», 34, 25 novembre 1937, pp. 345-346. «Sapere», 86, 31 luglio 1938, p. 66. (RNH), Orizzonte perduto Il cinema documentario e i popoli «Cinema», 34, 25 novembre 1937, p. 34. «Il Ventuno», 3-4, agosto 1938, pp. 36-38. (rnh), Memorie della camera oscura (R. Arnheim), Nuovo Laocoonte «Cinema», 36, 25 dicembre 1937, pp. 433-435. «Cinema», 37, 10 gennaio 1938, p. 14. «Bianco e Nero», 8, 31 agosto 1938, pp. 3-33. Poi parzialmente con il titolo “Film sonoro = teatro?”, in Giovanni Calendoli (a cura di), Cinema e teatro, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1957, pp. 116-119; a sua volta in «Bianco e Nero», 11/12, novembre-dicembre 1972, pp. 45-46. Poi riveduto con il titolo “«Nuovo Laocoonte»: le componenti artistiche e il cinema sonoro”, in Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., pp. 217-242. Poi in Mario Verdone (a cura di), Antologia di Bianco e Nero 1937-1943, cit., pp. 247-282. Il cifrario del successo 1939 1938 (rnh), Una signora mai vista «Cinema», 38, 25 gennaio 1938, p. 44. L’attore e le stampelle Principi del montaggio in Renato May, Per una grammatica del montaggio, «Bianco e Nero», 1, 31 gennaio 1938, pp. 37-42. «Bianco e Nero», 3, marzo 1939, pp. 98-101; ed. or. L’attore e le stampelle, «Cinema», 46, 25 maggio 1938, pp. 335-337. 1948 Il formato ridotto diventerà formato normale? «Cinema», 42, 25 marzo 1938, pp. 190-191. Lettera dagli Stati Uniti «Bianco e Nero», 4, giugno 1948, p. 44. (RNH), La loro vita privata Renato May: Il linguaggio del film «Cinema», 42, 25 marzo 1938, p. 195. «Bianco e Nero», 6, agosto 1948, pp. 56-58 (recensione). Il film come opera d’arte «Bianco e Nero», 4, aprile 1938, pp. 11-42, nota introduttiva dell’autore. Poi in Mario Verdone (a cura di), Antologia di Bianco e Nero 1937-1943, vol. I - Scritti teorici, Edizioni di Bianco e Nero, Roma, 1964, pp. 211-246. 1949 Avvenire del colore «Sequenze», 1, settembre 1949, p. 25. Estratto di A proposito del cinema a colori, «Cinema», 2, 25 luglio 1936, pp. 67-68. Esame di coscienza «Cinema», 44, 25 aprile 1938, pp. 289-290. 354 355 Cinema e psicologia Reazione e progresso nel film giapponese «Cinema», 23, 30 settembre 1949, pp. 161-164. «Cinema Nuovo», 144, marzo-aprile 1960, pp. 109-110. Il cinema e la folla [M, il mostro di Düsserldorf ] «Cinema», 25, 30 ottobre 1949, pp. 219-220. «Il nuovo spettatore cinematografico», 19, febbraio 1961, pp. 176-177. Estratto di Originalità di europeo, «Cinema», 28, 15 dicembre 1949, pp. 316-318. Originalità di europeo «Cinema», 28, 15 dicembre 1949, pp. 316-318. Poi parzialmente in «Il nuovo spettatore cinematografico», 19, febbraio 1961, pp. 176-177. 1970-1978 Tendenza dell’arte occidentale e diminuzione della visività 1950-1961 «Rivista del cinematografo», 6, giugno 1950, p. 19. «Cinema Nuovo», 205, maggio-giugno 1970, pp. 195-204. Tit. or. Melancholy Unshaped, «Journal of Aesthetics and Art Criticism», 3 (21), primavera 1963, pp. 291-297). Poi in Rudolf Arnheim, Verso una psicologia dell’arte, Einaudi, Torino, 1969, pp. 222-234. Ripensando alle cose di allora Ricordando gli anni venti «Rivista del cinema italiano», 1-2, gennaio-febbraio 1953, pp. 93-97. Poi ampliato con il titolo “Nota personale” (1957), in Film come arte, cit., pp. 39-44. «Filmcritica», 283, marzo 1978, pp. 92-96, intervista a cura di Giovanni Spagnoletti. Movimento organico ed inorganico Uno specchio del consumismo la didattica del film in Usa «Rivista del cinema italiano», 9, settembre 1953, pp. 86-91. Poi con il titolo “Una scala di complessità”, in Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1962. «Cinema Nuovo», 252, marzo-aprile 1978, pp. 88-91. Poi in Teresa Aristarco, Nuccio Orto (a cura di), Lo schermo didattico. Un esperimento di alfabetizzazione cinematografica nella scuola dell’obbligo, Dedalo, Bari, 1980, pp. 39-44. Questo è il cinema Lo stile e la donna nell’opera di Stroheim «Cinema Nuovo», 134, luglio-agosto 1958, pp. 50-52. Voce Stroheim, Erich von per l’Enciclopedia del cinema (dattiloscritto originale: “Erich von Stroheim”, 1934). Tit. or. Portrait of an Artist, «Film Culture», 18, aprile 1958, pp. 11-13. L’esito ideologico ultimo approdo del film «Cinema Nuovo», 255, settembre-ottobre 1978, pp. 8-11. 1981-1993 La dittatura del regista e la responsabilità della critica «Cinema Nuovo», 139, maggio-giugno 1959, pp. 220-226. Voce Autore per l’Enciclopedia del cinema (dattiloscritto originale: “Urheber”, 1934). Tit. or. Who is the Author of a Film?, «Film Culture», 16, gennaio 1958, pp. 11-13. Nuova traduzione con il titolo Può essere anche la Garbo, «Cinema Nuovo», 313, maggio 1988, pp. 39-45. Arnheim e il Nostromo «Cinema Nuovo», 274, dicembre 1981, p. 58. Come un tifoso d’oggi amai il cinema in Italia La bomba dei ritrovati tecnici sulla cattedrale cinematografica «Cinema Nuovo», 301, maggio-giugno 1986, pp. 35-36, con una lettera di Rudolf Arnheim a Guido Aristarco datata 23 febbraio 1953. «Cinema Nuovo», 140, luglio-agosto 1959, pp. 320-325, colloquio con Guido Aristarco. Poi parzialmente in Rudolf Arnheim, Film come arte, cit., pp. 30-35. Immagine-avvenimento e durata «Cinema Nuovo», 305, gennaio-febbraio 1987, p. 22. [La passione di Giovanna d’Arco] «Il nuovo spettatore cinematografico», 1, maggio-giugno 1959, p. VI. Estratto di Rudolf Arnheim, Film as Art, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1957, p. 40. [La corazzata Potëmkin] Può essere anche la Garbo «Cinema Nuovo», 313, maggio-giugno 1988, pp. 39-45. Voce Autore per l’Enciclopedia del cinema. Nuova traduzione di La dittatura del regista e la responsabilità della critica, «Cinema Nuovo», 139, maggio-giugno 1959, pp. 220-226. «Il nuovo spettatore cinematografico», 9, marzo 1960, p. 255. Estratto di Rudolf Arnheim, Film, Faber & Faber, London, 1933. 356 357 Estratti da Film als Kunst/Film/Film come arte in Italia Un fedele lettore «Cinema Nuovo», 336, marzo-aprile 1992, pp. 5-6. Le due autenticità del medium fotografico “Estratti da Film als Kunst di Rudolph Arnheim. Edit. Ernst Rowohlt, Berlin 1932, a cura di U. Barbaro (“Cines” 1933)”. «Cinema Nuovo», 344-345, luglio-ottobre 1993, pp. 27-30. Soggettista e direttore artistico, «L’Italia letteraria», 15 maggio 1932, p. 5. Storia di un libro. La vicenda editoriale di Film come arte La lunga e travagliata vicenda di Film als Kunst comincia a Berlino nel 1932. Il libro viene tradotto in Inghilterra nel 1933 e allo stesso tempo bandito in Germania. Nel 1957 lo stesso Arnheim rilancia l’opera in una versione profondamente aggiornata, in cui vengono salvati i primi capitoli di fondazione teorica e stralciata tutta la seconda parte dell’opera originale, sostituita da una collezione di saggi originariamente composti (e in gran parte pubblicati) durante gli anni italiani. È questa nuova versione a essere tradotta e diffusa in tutto il mondo a partire proprio dall’Italia. Film come arte, Il Saggiatore, Milano, 1960 (© 1959), traduzione di Paolo Gobetti di Film as Art, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1957, prefazione di Guido Aristarco; 21 fotografie; nuova traduzione (senza prefazione e senza illustrazioni), Feltrinelli, Milano, 1983. “Principi del montaggio”, in Renato May, Per una grammatica del montaggio, «Bianco e Nero», 1, 31 gennaio 1938, pp. 37-42. Il film come opera d’arte, «Bianco e Nero», 4, aprile 1938, pp. 11-42. Poi in Mario Verdone (a cura di), Antologia di Bianco e Nero 1937-1943, vol. I - Scritti teorici, Edizioni di Bianco e Nero, Roma, 1964. “Immagine reale e immagine filmica” / “Soggettista e regista” / “Film sonoro = teatro?”, in Guido Aristarco (a cura di), L’arte del film. Antologia storico-critica, Bompiani, Milano, 1950, pp. 29-54 / 83-86 / 95-98. “Film sonoro = teatro?”, in Giovanni Calendoli (a cura di), Cinema e teatro, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1957, pp. 116-119. Poi in «Bianco e Nero», 11/12, novembre-dicembre 1972, pp. 45-46. [La passione di Giovanna d’Arco], «Il nuovo spettatore cinematografico», 1, maggio-giugno 1959, p. VI. Il libro è aperto dalla “Nota personale” di Arnheim, datata 1957 (ma anticipata in Italia con il titolo Ripensando alle cose di allora, «Rivista del cinema italiano», 1-2, gennaio-febbraio 1953, pp. 93-97). La prima parte è costituita da Estratti riveduti da Film, ovvero la traduzione inglese di Film als Kunst del 1933: “Il cinema e la realtà”, “Come si fa un film”, “Il contenuto del cinema”, “Il film completo”. La seconda, rinnovata, parte è composta da “Le idee che fecero muovere le immagini” e “Il movimento” (voci originariamente redatte per l’Enciclopedia del cinema), “Vedere lontano” (apparso in forma estesa in «Intercine», 2, febbraio 1935, pp. 71-82) e “«Nuovo Laocoonte»: le componenti artistiche e il cinema sonoro” (già pubblicato in «Bianco e Nero», 8, 31 agosto 1938, pp. 3-33). [La corazzata Potëmkin], «Il nuovo spettatore cinematografico», 9, marzo 1960, p. 255. 358 359 “Il cinema e la realtà” / “I fattori creativi (Come si fa un film)”, in Guido Aristarco (a cura di), Teorici del film. Da Tille ad Arnheim, Celid, Torino, 1980. Arnheim, Cinema, Italia. Bibliografia secondaria Carlo L. Ragghianti, Immagine e parola, «Cinema», 18, 15 luglio 1949, p. 11. Articoli e recensioni Renato May, Colonne sonore, «Bianco e Nero», 12, dicembre 1949, p. 9. In questa bibliografia, necessariamente parziale, sono riportati i riferimenti di articoli e recensioni apparsi sui periodici italiani e inerenti ai rapporti fra Arnheim e il cinema. Per la bibliografia secondaria completa si rimanda alle note al saggio introduttivo. Paolo Milano, Rudolf Arnheim: “Film als Kunst”, «Scenario», 1, febbraio 1932, pp. 59-60. Notizia nella rubrica “Fatti, Opinioni, Commenti”, «Rivista internazionale del cinema educatore», 5, maggio 1933, p. 391. [Edward Kleinlercher], Film als Kunst (Film come arte), «Rivista internazionale del cinema educatore», giugno 1933, p. 499 (recensione). Notizia nella rubrica “Fatti, Opinioni, Commenti”, «Rivista internazionale del cinema educatore», 7, luglio 1933, p. 550. Domenico Meccoli, Posizione di Arnheim. I mezzi formali e il loro significato, «Cinema», 23, 30 settembre 1949, p. 161. Gianni Puccini, I tempi di «Cinema», «Filmcritica», 5, maggio 1951, pp. 151155. Poi con il titolo Storia di «Cinema», in Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano. Antologia di «Cinema» 1936-1943, Marsilio, Padova, 1965, pp. LXXV-LXXXVII. Gianni Puccini, Il venticinque luglio del cinema italiano, «Cinema Nuovo», 24, 1 dicembre 1953, pp. 340-342. Poi in Orio Caldiron (a cura di), Il lungo viaggio del cinema italiano, cit. Guido Aristarco, “Arnheim, Rudolf”, in AA. VV., Enciclopedia dello Spettacolo, vol. I, Le Maschere, Roma, 1954, pp. 938-939. Guido Aristarco, Il teorico senza mani Rudolf Arnheim, «Cinema Nuovo», 136, novembre-dicembre 1958, pp. 217-225. Il convegno di musica cinematografica, «Il popolo d’Italia», 19 maggio 1935. Film as Art, «Sele Arte», marzo-aprile 1959, p. 76 (recensione). Il convegno della “Musica nel film” ha iniziato i suoi lavori, 28 maggio 1935 (Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar, Mediennummer BF000114870). D. L., Film as Art, «Bianco e Nero», 4, aprile 1959, pp. 48-49 (recensione). Giovanni Paolucci, Rudolf Arnheim: un autore fra i più saccheggiati, «Rivista del cinematografo», 12, dicembre 1960, pp. 376-377 (recensione). [Ettore M. Margadonna], «L’eco del mondo», 29 giugno 1935. Renato May, Per una grammatica del montaggio, «Bianco e Nero», 1, 31 gennaio 1938, pp. 37-42. Giorgio Prosperi, Riflessioni sul cinema, «Mercurio», 35, febbraio 1948, pp. 92-97. Mario Verdone, Biblioteca. Letteratura cinematografica in Germania, «Cinema», 4, 15 dicembre 1948, p. 126. Maria Grazia Sacchi, Rudolf Arnheim: il cinema e l’estetica, «Centrofilm», 21, maggio 1961, pp. 3-35. Elio Mercuri, “Film come arte” di R. Arnheim, «Il Contemporaneo», novembre 1961, pp. 148-150 (recensione). E. Baragli, Rudolf Arnheim ed i “fattori differenzianti”, «La civiltà cattolica», 2668, 1961, pp. 405-407. Renato May, Teorica generale del film, «Bianco e Nero», 1, gennaio 1949, p. 38. Ernesto Guidorizzi, Il pensiero critico di Rudolf Arnheim, «Lingua e stile», XI, 3, il Mulino, Bologna, 1976. Nino Ghelli, L’inquadratura e il mondo poetico del regista, «Cinema», 12, 15 aprile 1949, p. 371. Enzo Siciliano, “Il cinema è Chaplin, Stroheim, Fellini”, «Corriere della Sera», 22 marzo 1978. Guido Aristarco, I “mezzi formativi” del cinema, «La Rassegna d’Italia», 5, maggio 1949, pp. 512-522. Giacomo Gambetti, La luna nel pozzo. Arnheim, «Rivista del cinematografo», 6, giugno 1978, p. 238. 360 361 Domenico Meccoli, Ancora su Arnheim e il Nostromo, «Cinema Nuovo», 275, febbraio 1982, p. 29. Luigi Russo, Rudolf Arnheim: “L’arte, gran strumento di conoscenza”, «Giornale di Sicilia», 29 aprile 1983, p. 3. Luisa Bonesio, Pensiero e visione in Rudolf Arnheim, «Paradigmi», settembredicembre 1986, pp. 631-638. Lea Vergine (a cura di), Conversazione con Arnheim, «Alfabeta», 88, settembre 1986, pp. 16-17. Guido Aristarco, Spiegò perché il film è arte, «il Secolo XIX», 3 luglio 1986, p. 3. Helmut H. Diederichs, Thomas Meder, “Foto di gruppo con signora: Rudolf Arnheim in Italia dal 1933 al 1938”, in Klaus Voigt, Rifugio precario. Artisti e intellettuali tedeschi in Italia 1933-1945, Mazzotta, Milano, 1995, pp. 219222. Elio Franzini, “Rudolf Arnheim. Revealing Vision”, «Domus», 805, giugno 1998, pp. 113-114 (recensione). Edoardo Bruno, Il colore, «Filmcritica scuola», 5, gennaio 1999, pp. 2-3. Lorenzo Esposito, Rudolf Arnheim, «Filmcritica scuola», 8, ottobre 1999, pp. 14-15. Pietro Ingrao, Il cinema, «Filmcritica», 500, dicembre 1999, pp. 504-514. Premio Filmcritica Umberto Barbaro, «Filmcritica», 504, aprile 2000, pp. 223224. Ernesto G. Laura, La fervida stagione italiana di Rudolf Arnheim, «Filmcronache», 1, 2005, pp. 14-21, (http://www.ancci.it/ancci/controller. do?PageId=1546). Adriano D’Aloia, La f[i]rma invisibile. Rudolf Arnheim e le rubriche di “Cinema”, «Cineforum», 460, dicembre 2006, pp. 42-46. Lorenzo Pellizzari, Nuccio Lodato (a cura di), Le lune del cinema - 9 giugno 2007, «Cineforum», 467, settembre 2007, p. 89. Edoardo Bruno, Rudolph Arnheim, «Filmcritica», 576/577, giugno-luglio 2007, p. 290. 362 Adriano D’Aloia, “Controversie dello sguardo. La vicenda italiana di Rudolf Arnheim”, in Raffaele De Berti, Massimo Locatelli (a cura di), Figure della modernità nel cinema (1900-1940), ETS, Pisa, 2008, pp. 235-250. Orsola Silvestrini, “Arnheim e il problema del colore”, in Raffaele De Berti, Massimo Locatelli (a cura di), Figure della modernità…, cit., pp. 251-263. Adriano D’Aloia, Diario di un idillio e di una fuga, «Bianco e Nero», 563, gennaio-aprile 2009, pp. 125-128. Convegni e atti Contestualmente alla segnalazione dei convegni in onore di Rudolf Arnheim tenutisi in Italia, sono indicate anche le relative pubblicazioni degli atti, e per ognuna di esse gli interventi che hanno un’attinenza cinematografica o che rimandano agli anni italiani: “Pensiero e visione in Rudolf Arnheim”. Milano, 9-11 giugno 1986. Atti in Augusto Garau (a cura di), Pensiero e visione in Rudolf Arnheim, Franco Angeli, Milano, 1989. Giulio Carlo Argan, “Prefazione”, pp. 7-9. Guido Aristarco, “Arnheim e le conversioni al cinema negli anni ’30”, pp. 22-27. “Intervista di Augusto Garau a Fedele D’Amico”, pp. 69-75. “Rudolf Arnheim: arte e percezione visiva”, Palermo, 19-20 novembre 2004. Atti in Lucia Pizzo Russo (a cura di), Rudolf Arnheim. Arte e percezione visiva, Aesthetica Preprint (Supplementa), Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo, 2005. Ingrid Scharmann, “Ordine, espressione e media nella teoria estetica di Rudolf Arnheim”, pp. 155-165. Lucia Pizzo Russo (a cura di), “Conversazione con Rudolf Arnheim”, pp. 251-290, originariamente in Aesthetica Preprint, 2, Palermo, Centro Internazionale Studi di Estetica, 1983. “Una giornata di studio e una mostra dedicate a Rudolf Arnheim”. Roma, 13 maggio 2005. Atti in Gabriella Bartoli, Stefano Mastandrea (a cura di), Rudolf Arnheim. Una visione dell’arte, Anicia, Roma, 2006. 363 Pietro Ingrao, “Ricordo di Arnheim”, pp. 21-24. Adriano Ossicini, “Con Arnheim un «dialogo» che parte da lontano”, pp. 25-31. Renzo Canestrari, “L’opera di Rudolf Arnheim e la nascita di una vocazione psicologico-scientifica nella cultura italiana degli anni Trenta”, pp. 33-37. Appendice iconografica 364 Indice dei nomi Alberini, Filoteo 149 Albers, Hans 21 Alexeiev, Alex 110, 192-193 Alfieri, Dino 322 Allégret, Marc 282 Allesch, Christian G. 90 Altman, F. 149 Ambach, Robert 23, 31, 75, 350 Anderton 139 Angelini, Alberto 74, 88 Antonioni, Michelangelo 66 Archimede 274 Argan, Giulio Carlo 69, 76, 85-86, 90, 363 Argentieri, Mino 53, 82 Aristarco, Guido 22, 52, 62, 64-67, 78, 80-82, 85-90, 356-363 Aristarco, Teresa 357 Aristofane 190 Armat, Thomas 144 Arnheim, Anna 59 Arnheim, Annette 85 Arnheim, Mary 9, 349 Arnheim-Gay, Mary 82 Arpagone 54, 82-83, 257 Arzner, Dorothy 193-194 Ash, Mitchell G. 72 Astaire, Fred 292 Attolini, Vito 85 Badt, Karl 26 Balázs, Béla 17, 21, 64-65, 73, 87 Baldung, Hans 110, 254 Ball, J. A. 266 Baragli, Enrico 88, 361 Baranovskaja, Vera 312 Barbaro, Umberto 32-33, 55, 60, 75, 240, 298-299, 350, 359 Barbera, Alberto 74 Barrie, James M. 283 384 Barsy, Andor von 133 Bartoli, Gabriella 76, 82, 90, 363 Bartosch, Berthold 191 Basse, Wilfried 73, 318 Beery, Wallace 113 Beethoven, Ludwig van 328 Behrens, Roy R. 72, 75 Berne De Chavannes, P. 37 Bernhardt, Kurt 284 Bertellini, Giorgio 85 Berthon, Rodolphe 245-247 Bitzer, Billy 113 Bitzer, Gottfried W. 143 Blasetti, Alessandro 292-293 Bluemel, Walter 112 Bocca, Carlo 244, 246-249 Boccaccio, Giovanni 199 Bonesio, Luisa 362 Bontempelli, Massimo 37, 39 Boschi, Alberto 74 Bosio, Gastone 75-78 Bothwell, conte di (James Hepburn) 285 Bowles, Paul E. 112 Boyer, Lucienne 281 Boyer, Pierre 218 Bragaglia, Anton Giulio 60 Brahms, Johannes 230 Brooks, Louise 202 Brown, Clarence 308 Browning, Tod 292 Brož, J. 88 Brunetta, Gian Piero 76 Bruno, Edoardo 362 Buchanan, Andrew 219 Busse, Kurt 88 Buturlina, generalessa 275 Cabanne, Christy 21 Caldiron, Orio 80, 82, 85-86, 350, 352-355, 361 385 Calendoli, Giovanni 355, 359 Campbell, Arthur J. 133 Campbell, Malcom 147 Candido 54, 82-83, 257, 349, 353 Canestrari, Renzo 81-82, 90, 364 Capra, Frank 21, 217, 230, 249-251, 264, 280 Caravaggio 226 Cavalcanti, Alberto 39, 135-136 Cecchi, Emilio 33, 55, 62, 298 Cecchi, Suso 62 Cegani, Elisa 293 Centa, Antonio 293 Chan, Charlie 265 Chaplin, Charlie 10, 32, 45, 49, 74, 97, 99, 105, 106, 151, 189, 217, 306, 308, 313, 319 Charell, Erik 111-112 Chevalier, Maurice 284 Chiarini, Luigi 32, 37, 52, 57, 60, 62, 240 Chiaromonte, Nicola 107 Ciak 54, 82, 257, 349 Clair, René 21, 45, 47, 102, 110, 198, 216, 306, 309, 318, 320 Closupper, Emilia 266-267 Cocteau, Jean 189 Colbert, Claudette 197, 281 Colby, Vineta 75 Colman, Ronald 231 Connolly, Walter 280 Conway, Jack 289 Cooke, Allistair 39 Cooper, Gary 241, 262, 281 Corneille, Pierre 260 Corti, Alfonso 114 Costa, Antonio 74 Croce, Benedetto 85 Cross, Charles 269 Curie, Marie 238 Curtiz, Michael 288 d’Almeida, Jean C. 138-139 D’Aloia, Adriano 362-363 d’Amico, Fedele 14, 59, 62, 73-74, 76, 85, 87, 90 D’Amico, Silvio 78 d’Annunzio, Gabriele 322 Daguerre, Louis J. M. 272-274 Dal Monte, Peter 85 Dalcroze, Jacques 242 Dalton, G. F. 132 Dante 319 Darnley, Lord 285 Dauthendey, Karl 273-275 Dauthendey, Max 272 De Amicis, Edmondo 14 De Berti, Raffaele 80, 363 De Feo, Giuseppe 37 De Feo, Luciano 26, 35, 37, 40-42, 48, 50, 75-76 de Sanctis, Francesco 242 Debenedetti, Giacomo 39, 50, 78 Debrie, André 235-236 della Porta, Giovanni Battista 152 Demeny, Georges 252 DeMille, Cecil B. 133-134, 266, 291, 312 DeMille, Katherine 291 Denekamp, A. E. 141 Denis, Maria 293 Deren, Maya 68 Diderot, Denis 41-242 Diederichs, Helmut H. 15, 42, 72-73, 78, 80, 88, 90, 349, 362 Diehl, fratelli 137 Dieterle, Wilhelm 109 Dietrich, Marlene 20, 170 Diodato, Roberto 90 Disney, Walt 106, 110, 151, 178, 191 Döblin, Alfred 97 Donat, Robert 217 Dop, Louis 75 Dorfles, Gillo 68, 90 Dostoevskij , Fëdor M. 151, 165, 187 Dreyer, Charles 19, 267, 306, 309 Du Hauron, Ducos 269 Dubus-Préville, Pierre-Louis 241-243 Dupont, Ewald A. 47, 306 Durbin, Deanna 232 Dürer, Albrecht 254 386 Duse, Eleonora 212-213, 238, 242 Eckardt, Johannes 144 Eckermann, Johann P. 238 Edison, Thomas A. 43, 144, 152, 195, 234, 252-253 Eggeling, Viking 191 Ehrlich, Paul 266 Ejzenštejn, Sergej M. 26, 47, 64-65, 74, 97, 105, 152, 157, 296197, 310, 313, 317-318, 320321 Elms, John D. 149 Engel, Erich 165-166 Epstein, Jean 39, 347 Esposito, Lorenzo 362 Eugeni, Ruggero 85 Ewers, Hanns H. 283 Fairbanks, Douglas 105, 120 Farrère, Claude 279 Feyder, Jacques 308, 314, 319 Fischinger, Oskar 110, 191-192 Fitzmaurice, George 288 Flaherty, Robert J. 21, 105, 219 Ford, John 282, 285 Forst, Willy 151, 183, 216 Fosco, Piero 267 Francen, Victor 279 Franzini, Elio 73, 362 Freddi, Luigi 55, 78 Freeburg, Victor O. 74 Freund, Karl 111-112 Furtwängler, Frank 90 Gable, Clark 280 Gambetti, Giacomo 361 Gance, Abel 19, 313 Garau, Augusto 69, 76, 86-87, 90, 363 Garbo, Greta 21, 158, 225, 237-239, 308, 312 Garnett, Tay 222 Garofalo, Piero 85 Garrick, David 335 Garroni, Emilio 74, 84-85 Ghelli, Nino 88, 360 Giovannetti, Eugenio 191 Glourie, Donald 198 Gobetti, Paolo 64, 358 Goethe, Johann W. 19, 47, 80, 99, 151, 175-176, 238, 253, 327, 336 Goldoni, Carlo 336 Granowsky, Alexis 101, 311, 321 Grant, Cary 288 Granville, Bonita 232 Grathoff, Dirk 73 Grierson, John 77, 167, 218-219 Griffith, David W. 112, 143, 157, 167168, 267, 317 Grigson, Geoffrey 167 Gripe, Fritz 146 Gross, Anthony 110 Grundmann, Uta 90 Gründgens, Gustaf 216 Grünewald, Matthias 254 Guidorizzi, Ernesto 361 Hagemann, Peter 73 Hale, Karl 166 Hamsun, Knut 151 Hancock, Allan G. 136 Harbou, Thea von 19, 21, 97 Hardy, Oliver 284-285 Harlow, Jean 287-289 Harrah, David 88 Hartmann, Paul 216 Hathaway, Henry 286 Hegel, Georg W. F. 347 Hepburn, Katharine 233, 241, 284, 286 Hertz, Heinrich 117 Heymann 284 Hill, David O. 275, 279 Hitler, Adolf 32, 34, 74 Hoepli, Ulrico 41, 48, 77-78 Holbein, Hans 254 Holme, C. G. 276 Hoppin, Hector 110 387 Ibsen, Henrik 315 Ingrao, Pietro 62, 76, 86-87, 90, 362, 364 Ivens, Joris 108 Jacoby, Michel 288 James, F. R. 145 Jannings, Emil 216 Jenkins, C. Francis 144 Joachim 152 Jolson, Al 195 June, Ray 288 Junghans, Carl 317 Kanizsa, Gaetano 69, 84 Karamazov, Dimitri 165 Keaton, Buster 47, 105-106, 113, 189, 225, 298, 313 Kellogg, Edward W. 136 Keown, Eric 198-199 Kircher, Athanasius 192, 252 Kirchmann, Key 90 Kleinlercher, Edward 75, 360 Kleinman, Kent 72-73, 88 Kleist, Heinrich von 336 Klopfer, Eugen 216 Köhler, Wolfgang 10, 27, 72, 84 Korda, Alexander 198, 279 Korda, T. 276 Kracauer, Siegfried 62, 67, 87-89 Kraszna Kraus, Andor 88 Kruger, Jules 280 L’Herbier, Marcel 279 Laforet, Antonio 259, 268-271 Lamb, Charles 215 Lamprecht, Günter 102 Lang, Fritz 19, 47, 63, 97, 231, 272 Laura, Ernesto G. 14, 76-77, 82, 8687, 362 Laurel, Stan 284-285 Lawrence, Viola 194 Le Henaff, René 112 Lebrun, C. 78 Léger, Fernand 189 Legg, Stuart 161 Legrenzi, Paolo 84 Lessing, Gotthold E. 55, 83, 332 Lévy-Bruhl, Lucien 283 Lewin, Kurt 27, 84, 89 Lichtenberg, Georg C. 186, 335 Lieben 152 Liebermann, Max 96 Liesegang, Paul F. 140 Lindberg, Charles 136 Linke, Heinz 134 Lloyd, Harold 113 Locatelli, Massimo 24, 80, 363 Loy, Myrna 289 Lubitsch, Ernst 134, 216, 236 Luccio, Riccardo 84 Luciani, Sebastiano Arturo 60, 78, 86 Lukács, György 74 Lulu di Wedekind 202 Lumière, fratelli 43, 245, 252 Lumière, Louis 76-77, 137-139, 153, 164, 194, 220, 265 MacCann, Richard D. 80 Machatý, Gustav 21, 132, 164 MacMurray, Fred 222, 286 Maggi, Raffaello 168-170 Mahler, Gustav 328 Maitre, A. 141 Malipiero, Gian Francesco 37, 39 Margadonna, Ettore M. 76, 360 Mamoulian, Rouben 102, 158, 166, 198 Mann, Thomas 37, 151 Marey, Étienne-Jules 144, 252 Margrave, Seton 198 Marx, fratelli 284 Masaccio 185 Masereel, Frans 191 Mastandrea, Stefano 76, 82, 90, 363 Maxwell, Clerk J. 117, 245, 269 May, Renato 62, 83, 295, 347, 354, 359-361 McCall, Mary 194 McGuire 149 Mecacci, Luciano 90 388 Meccoli, Domenico 41, 48, 50-53, 63, 76, 81, 86-87, 361-362 Meder, Thomas 362 Mekas, Jonas 68 Méliès, Georges 194, 283 Mercuri, Elio 361 Merleau-Ponty, Marcel 72 Messter, Oskar 152, 194-196 Metelli, Fabio 69 Mida, Massimo 52-53, 81 Milano, Paolo 32, 62, 74, 78, 360 Milhaud, Dariuus 284 Miller, James A. 153 Milner, Victor 134-135 Mittelholzer, Walter 236 Mix, Tom 105 Moholy-Nagy, László 108 Molière 336 Moore, Grace 153 More, Thomas 230 Morgan, Paul 321 Morkovin, Boris V. 84, 218 Morrow, J. F. D. 74 Mosé 274 Münsterberg, Hugo 74 Murnau, Friedrich W. 19, 157, 318 Murray, Mae 15, 20 Mussorgskij, Modest P. 193 Mussolini, Benito 26, 33, 36, 42, 59, 77, 84 Nairne, Campbell 150 Nettinga-Arnheim, Margaret 13, 84 Neumeier, Otto 90 Niépce, Joseph N. 272 Noldan, Sven 215 Nostromo 50-53, 77-78, 81-83, 257, 349 Noxon, G. F. 77 Oakie, Jack 287 Onussen, Marie 53-54, 82, 257, 349 Orto, Nuccio 357 Ossicini, Adriano 90, 364 Ossietzky, Carl von 29, 73-74 Ostwald, Wilhelm 175, 271 Ozu, Yasujiro 66 Pabts, Georg W. 47 Pagnol, Marcel 108-109 Pander, Hans 235 Pannunzio, Mario 241 Panter, Peter 23 Paolucci, Giovanni 361 Pariser, David A. 72, 74 Parker, Claire 110, 192-193 Pasinetti, Francesco 37, 41, 48, 5053, 60, 62 Pasquali, Elio 90 Paulucci, Francesco 236 Pavolini, Corrado 37, 41, 50, 108 Pechstein, Max 96 Pellegrini, Guido 54 Pellizzari, Lorenzo 85, 362 Peterson, James R. 72 Pfenninger, Rudolf 137 Pizzo Russo, Lucia 73, 84, 90, 363 Plateau, Joseph 30, 129, 191, 252 Platone 190 Poe, Edgar A. 347 Polgar, Alfred 17, 23, 89 Pommer, Erich 111 Porten, Henny 321 Powell, William 289 Preisler, Doris 146 Prosperi, Giorgio 88, 360 Prümm, Karl 23-24, 88 Puccini, Gianni 37, 41, 51-52, 54, 62, 77, 82, 86, 257, 361 Pudovkin, Vsevolod I. 32, 47, 64-65, 87, 97, 105, 161, 243, 296297, 309, 314, 316, 320 Ragghianti, Carlo Ludovico 60, 84, 361 Raskolnikov, Rodjon 165, 187-188 Read, Herbert 58, 84 Reich, Jaqueline 85 Reimann, Hans 17 Reinhardt, Max 109, 165 389 Reisch, Walter 151 Rembrandt, Harmenszoon van Rijn 312, 340 Rennahan, Ray 166 Renoir, Jean 21, 45, 320 Renoir, Pierre 279 Riccoboni, Luigi 242 Richardson, F. H. 154 Riefenstahl, Leni 146 Riskin, Robert 230 Robison, Arthur 282-283 Rocco, Alfredo 76 Rodin, Auguste 151 Roland, Manuel 78 Rollmann, Wilhelm 138 Ronchi, Vasco 138, 140-141 Room, Abram 307 Rotha, Paul 37, 39, 74, 219 Rudatis, Domenico 244, 246-249 Russell, Rosalind 194 Russo, Luigi 362 Ruttmann, Walter 191-192, 301, 311 Sacchi, Maria Grazia 361 Sassone, Antonio 78 Scharmann, Ingrid 73, 83, 89-91, 363 Schiller, Friedrich 80, 336, 347 Schlanger, B. 148 Schlenther, Paul 85, 212 Schönhammer, Rainer 90 Schopenhauer, Arthur 326 Schreitmüller, Andreas 91 Semon, Larry 186-187 Sennet, Mack 113, 170, 189-190, 285 Shakespeare, William 151, 165, 167, 331, 336 Sherwood, Robert 198 Siciliano, Enzo 361 Siebert, Jan 91 Sieveking, L. M. 74 Signoret, Simone 279 Silvestrini, Orsola 80, 363 Simon, Simone 267-268, 282 Simonigh, Chiara 74 Sinclair, Upton 105 Siodmak, Robert 321 Sonino, Maria 84 Spagnoletti, Giovanni 67, 73, 357 Spice, Evelyn 219 Spottiswoode, Raymond 16, 160-163, 177 Spaak, Charles 282 Stampfer, Simon 191, 252 Stanislawskij, Kostantin S. 241 Stanwyck, Barbara 280 Stendhal 151 Sternberg, Josef von 20, 73, 100, 107, 152, 170-171, 265, 305, 311, 313, 319 Stone, Lewis 288 Storer, Edward 37 Stroheim, Erich von 45, 47, 66, 79, 87, 157, 216, 292, 356 Stuart, Maria 286 Sullavan, Margaret 208 Swanson, Gloria 113 Taillibert, Christel 75, 78 Tasker, Homer G. 133, 136 Temple, Shirley 232 Tennyson, Alfred 288 Termine, Liborio 74 Theek, Ingebord 182 Theisen, Earl 110 Thun, Rudolf 145 Timoshenko, Semyon K. 32, 296, 298, 317, 347 Todeschini, Ferdinando 142 Toffetti, Sergio 86 Tolomeo 205 Tosi, Virgilio 90 Tournachon, Félix (Nadar) 275 Toutain, Roland 280 Traccis, Sebastiano 90 Trenker, Luis 137, 221, 223, 281 Treptow 204 Tucholsky, Kurt 17, 23, 29 Turigliatto, Roberto 74 390 Twain, Mark 105 Tyndall, John 114 Uccello, Paolo 347 Van Duzer, Leslie 72-73, 88 Verdone, Mario 83, 354-355, 359-360 Vergine, Lea 362 Verstegen, Ian 72, 91 Vertov, Dziga 255, 296, 321 Vidal, Jean 141 Vidalin, Robert 279 Vidor, King 40, 104-107, 221-222, 230, 286, 310 Vogel, Amos 68 Voigt, Klaus 73, 78, 83, 362 Vuillermoz, Émile J.-J. 110, 165 Wagner, Richard 299, 336 Walden, Harry 154 Waley, H. D. 111 Walgenstein 252 Weinberg, Herman G. 143 Wertheimer, Max 27, 72, 83-84, 89 West, Mae 140 Westmore, Percy 149 Wetzel, Kraft 73 Wieman, Mathias 216 Wiene, Robert 45 Wilke, Jürgen 76-77 Wilson, Norman 150 Wolff, Werner 72 Wright, Basil 219 Wundt, Wilhelm M. 27 Young, Loretta 291 Zambarbieri, Daniela 90 Ziegfeld, Florenz 290 Ziliotto 149 Zuckmayer, Carl 97 391 Indice dei film Accadde una notte (It Happened One Night, Frank Capra, 1934) 231, 249, 258, 280 Accadde una volta (Red Salute, Sidney Lanfield, 1935) 258 Accordo finale/La nona sinforia/ Il grande peccato (Schlußakkord, Douglas Sirk, 1936) 258 Acqua morta (Dood water, Gerard Rutten, 1934) 133 [Albergo degli studenti] (Hôtel des étudiants, Viktor Tourjansky, 1932) 282 Aldebaran (Alessandro Blasetti, 1935) 292 Altars of Desire (Christy Cabanne, 1927) 21 Amato vagabondo, L’ (Le vagabond bien-aimé, Kurt Bernhardt, 1936) 284 [Amore di Giovanna Ney, L’] (Die Liebe der Jeanne Ney, Georg W. Pabst, 1927) 132 Amore tzigano (The Little Minister, Richard Wallace, 1934) 283-284 Angèle (Marcel Pagnol, 1934) 108 Angelo azzurro , L’ (Der blaue Engel, Erich von Stroheim, 1930) 170 A me la libertà (A nous la liberté, René Clair, 1932) 21 Arrivo di un treno nella stazione di La Ciotat, L’ (L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, Auguste e Louis Lumière, 1895) 164 Arsenale, L’ (Priwidenje, Kotoroje Ne Woswraschtschajetsja, Abram Room, 1929) 307308 Atlantide (Georg W. Pabst, 1932) 101 Ballerine (Gustav Machatý, 1936) 293 Bambola del diavolo, La (The DevilDoll, Tod Browning, 1936) 291-292 Bandera, La (Julien Duvivier, 1935) 280 Becky Sharp (Rouben Mamoulian, Lowell Sherman, 1935) 166, 178 Birth of a Nation, The (The Clansman, David W. Griffith, 1915) 143 Bohème, La (King Vidor, 1926) 164 Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914) 167 Califfo cicogna, Il (Kalif Storch, Ewald M. Schumacher, 1923) 137 Calunnia, La (These Three, William Wyler, 1936) 232 Cantante pazzo, Il (The Singing Fool, Lloyd Bacon, 1928) 195 [Canto della vita, Il ] (Das Lied vom Leben, Alexis Granowsky, 1931) 101, 321-322 Carica dei 600, La (The Charge of the Light Brigade, Michael Curtiz, 1936) 288 Carovana (Caravan, Erik Charell, 1934) 111 Casa di bambola (Febo Mari, 1919) 315 Casa Rothschild (The House of Rothschild, Alfred L. Werker, 1934) 110-111 393 Cavalieri del Texas, I (The Texas Rangers, King Vidor, 1936) 221, 286-287 Chapeau de paille d’Italie, Un (René Clair, 1927) 21 Charlot emigrante (The Immigrant, Charles Chaplin, 1917) 306 Che cos’è il mondo (Hvad er verden?, Svend Noldan, 1934) 215 [Che cosa sanno dunque gli uomini!] (Was wissen denn Männer, Gerhard Lamprecht, 1933) 102 Cleopatra (Cecil B. DeMille, 1934) 133 Contessa di Parma. La (Alessandro Blasetti, 1937) 292-293 Corazzata Potëmkin, La (Bronenosec Potëmkin, Sergej M. Ejzenštejn, 1925) 26, 168 [Così è la vita] (Takový je zivot, Carl Junghans, 1930) 312, 317318 Crociate, Le (The Crusades, Cecil B. DeMille, 1934) 134 Crollo della Casa Usher, Il (La Chute de la maison Usher, Jean Epstein, 1928) 347 Deserto Rosso (Michelangelo Antonioni, 1964) 66, 88 Devil Is a Woman, The (Josef von Sternberg, 1935) 170 [Docks di New York, I ] (The Docks of New York, Josef von Sternberg, 1928) 170, 305, 311, 313-314, 319 Documento di Shanghai, Il (Shanhkayskiy dokument, Yakov Bliokh, 1928) 318 Donna del giorno, La (Libeled Lady, Jack Conway, 1936) 289 Dottor Mabuse, Il (Dr. Mabuse, der Spieler – Ein Bild der Zeit, Fritz Lang, 1922) 318 Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Rouben Mamoulian, 1931) 109, 198 È arrivata la felicità (Mr. Deeds Goes to Town, Frank Capra, 1936) 231, 258, 280-281 Entr’acte (René Clair, 1924) 21, 306, 320 Estasi (Ekstase, Gustav Machatý, 1933) 132 Fantasma galante, Il (The Ghost Goes West, René Clair, 1935) 198, 217, 258 Febbre dell’oro, La (The Gold Rush, Charles Chaplin, 1925) 319 Figliuol prodigo, Il (Der verlorene Sohn, Luis Trenker, 1934) 137 Fine di San Pietroburgo, La (Konec Sankt-Peterburga, Vsevolod I. Pudovkin, 1927) 168, 309 Folla, La (The Crowd, King Vidor 1928) 310 Fossa degli angeli, La (Carlo Ludovico Bragaglia, 1937) 223 Gabinetto del dottor Caligari, Il (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920) 20, 45, 164, 263 Gas asfissianti (Giftgas, Mikhail Dubson, 1929) 312 [Gente altolocata]/Charlot e la maschera di ferro – Ricchi e vagabondi (The Idle Class, Charlie Chaplin, 1921) 313 Giornale di una donna perduta (Tagebuch einer Verlorenen, Georg W. Pabst, 1929) 308, 314 Golem – Come venne al mondo, Il (Der Golem, wie er in die Welt kam, Paul Wegener, Carl Boese, 1920) 164 394 [Guerra nelle tenebre] (Mata Hari, George Fitzmaurice, 1931) 308 Imperatore della California, L’ (Der Kaiser von Kalifornien, Luis Trenker, 1936) 221, 281282 Informer, The (John Ford, 1935) 164 Intolerance (David W. Griffith, 1916) 113, 267, 317 Io… e la scimmia (The Cameraman, Edward Sedgwick, Buster Keaton, 1928) 313 Jeunesse (Georges Lacombe, 1934) 282 Joie de vivre, La (Anthony Gross, Hector Hoppin, 1934) 191 Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948) 63 Lancieri del Bengala (The Lives of a Bengal Lancer, Henry Hathaway, 1935) 286 Linea generale, La (Staroye i novoye, Sergej M. Ejzenštejn, 1929) 310, 320-321 Love Me Tonight (Rouben Mamoulian, 1932) 102 Madre, La (Mat, Vsevolod I. Pudovkin, 1926) 314, 316 Maria di Scozia (Mary of Scotland, John Ford, 1936) 285-286 Mascherata (Maskerade, Willi Forst, 1934) 151 Mazurka tragica (Mazurka, Willi Forst 1935) 182-183 Menschen am Sonntag (Domenica, Curt Siodmak, Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, Fred Zinnemann, 1929) 321 Metropolis (Fritz Lang, 1927) 19 Milione, Il (Le Million, René Clair, 1931) 21 Mio amore eri tu, Il (Suzy, George Fitzmaurice, 1936) 287288 [Miracolo dei fiori, Il ] (Blumenwunder, I. G. Farben, 1926) 320 Moglie di Craig, La (Craig’s Wife, Dorothy Arzner, 1936) 193 Nana (Jean Renoir, 1926) 21 Nana (Dorothy Arzner, George Fitzmaurice, 1934) 111 Napoleone (Napoléon, Abel Gance, 1927) 19, 313 Nibelunghi: la morte di Sigrfido (Die Nibelungen: Siegfried, Fritz Lang, 1924) 20, 231 Notte sul Monte Calvo, Una (Une nuit sur le mont chauve, Alexander Alexeiev, Claire Parker, 1933) 110, 191, 193 Nostri parenti, I (Our Relations, Harry Lachman, 1936) 284 Nostro pane quotidiano (Our Daily Bread, King Vidor, 1934) 40, 104-106, 230, 284-285 Notte d’amore, Una (One Night of Love, Victor Schertzinger, 1934) 153 Notte di nozze (The Wedding Night, King Vidor, 1935), 286 Notturno (Nocturno, Gustav Machatý, 1934) 21, 164-165 Nuovi signori, I (Les nouveaux messieurs, Jacques Feyder, 1926) 308, 314, 319 Ombre ammonitrici (Schatten – Eine nächtliche Halluzination, Arthur Robison, 1923) 282 Opera da quattro soldi (L’opéra de quat’sous, Georg W. Pabst, 1931) 318 Orizzonte perduto (Lost Horizon, 395 Frank Capra, 229-231, 264 1937) 21, Palla N. 13, La (Sherlock jr., Buster Keaton, 1924) 298 Paradiso delle fanciulle, Il (The Great Ziegfeld, Robert Z. Leonard, 1936) 290 Passione di Giovanna d’Arco, La (La Passion de Jeanne d’Arc, Carl T. Dreyer, 1928) 19, 164, 267, 306, 309, 315 Pellegrino, Il (The Pilgrim, Charles Chaplin, 1923) 319 Petite Marchande d’allumettes, La (Jean Renoir, Jean Tédesco, 1928) 21 Pygmalion (Erich Engel, 1935) 165-166 Quattro diavoli, I (4 Devils, Friedrich W. Murnau, 1928) 318 [Quelli del Basso Reno] (Die vom Niederrhein, Max Obal, 1933) 315 Ragazze in uniforme (Mädchen in Uniform, Leontine Sagan, 1931) 173, 268 Ramona (Henry King, 1936) 291 [Ribelle] (The Rebel, Edwin H. Knopf, Luis Trenker, 1933) 101 Santa e il folle, La (Die Heilige und ihr Narr, Hans Deppe, 1935) 164 Scarlet Empress, The (Josef von Sternberg, 1934) 170 Sciopero! (Stačka, Sergej M. Ejzenštejn, 1925) 317 Seguendo la flotta (Follow the Fleet, Mark Sandrich, 1936) 292 Sentiero della felicità, Il (Les beaux jours, Marc Allégret, 1935) 282 Shanghai Express (Josef von Sternberg, 1932) 20 Show Boat (James Whale 1936) 164 Signora dell’amore, La (Anna Karenina, Clarence Brown, 1935) 308 Sinfonia delle diagonali (Symphonie Diagonale, Viking Eggeling, 1924) 191 Sinfonia di una grande città (Berlin – Symphonie einer Großstadt, Walter Ruttman, 1927) 301, 311 [Sogno di una notte d’estate] (A Midsummer Night’s Dream, William Dieterle, Max Reinhardt, 1935) 109 Sotto i tetti di Parigi (Sous les toits de Paris, René Clair, 1930) 102 Squadrone bianco (Augusto Genina, 1936) 293 Strada della paura, La (Easy street, Charles Chaplin, 1917) 137 Studente di Praga, Lo (Der Student von Prag, Arthur Robison, 1935) 164,208, 282-283, 321 Swing High, Swing Low (Mitchell Leisen, 1937) 222 Tabù (Friedrich W. Murnau, 1931) 19 Telephone Workers (Stuart Legg, 1933) 161 Tempeste sull’Asia (Potomok ChingisKhana, Vsevolod I. Pudovkin, 1928) 132 Traditore, Il (The Informer, Arthur Robison, 1929) 282, 285 Tre ragazze in gamba (Three Smart Girls, Henry Koster, 1936) 232 Uomo invisibile, L’ (The Invisible Man, James Whale, 1933) 109 Varieté (Ewald A. Dupont 1925) 306 Varieté (Nicolas Farkas 1935) 164 Vedova allegra, La (The Merry Widow, Ernst Lubitsch, 1934) 164, 173 Ventaglio di Lady Windermere, Il (Lady Windermere’s Fan, Ernst Lubitsch, 1925) 164 Vergine di Salem, La (Maid of Salem, Frank Lloyd, 1937) 197, 222 Via senza gioia, La (Die freudlose Gasse, Georg W. Pabst, 1925) 312 Vigilia d’armi (Veille d’armes, Marcel L´Herbier, 1935) 279-280 [Vita è bella, La] (Prostoy sluchay, Vsevolod I. Pudovkin, 1932) 320 Vita privata di Enrico VIII, La (The Private Life of Henry VIII, Alexander Korda, 1933) 132 Voglio essere amata (She Married Her Boss, Gregory La Cava, 1935) 281 [Uomo che perse la memoria, L’] (Oblomok imperii, Fridrikh Ermler, 1929) 321 Uomo di Aran, L’ (Man of Aran, Robert J. Flaherty, 1934) 21 396 397 Archivi della teoria del cinema in Italia Rudolf Arnheim. I baffi di Charlot. Scritti italiani sul cinema 1932-1938, a cura di Adriano D’Aloia Prossimi volumi: L’occhio sensibile. Il cinema nel pensiero psicologico del primo Novecento, a cura di Silvio Alovisio L’inquadramento estetico. Cinema, arte e linguaggio nelle teorie italiane tra le due guerre, a cura di Francesco Pitassio Sebastiano Arturo Luciani, Scritti scelti, a cura di Luca Mazzei Cinefilia e cinefobia. La cultura italiana di fronte all’avvento del cinema, a cura di Francesco Casetti Finito di stampare nel mese di dicembre 2009 presso Digital Print Service – Segrate MI
Scaricare