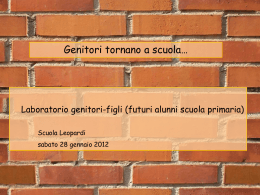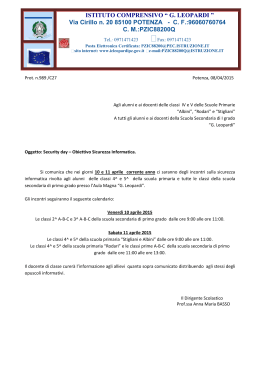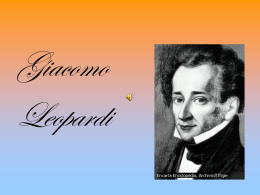10txtI:Layout 1 5-04-2009 17:40 Pagina 323 MARCELLO BERLUCCHI* GIACOMO LEOPARDI E LO SPORT «A UN VINCITORE NEL GIOCO DEL PALLONE»** Tra i ragazzi del liceo dei nostri tempi esisteva una specie di classifica dei poeti e degli scrittori le cui opere erano oggetto di studio o di lettura in aula. In questa classifica Leopardi era ai primi posti nel gradimento, forse perché supremo cantore lirico degli amori e delle incertezze proprie della gioventù d’ogni tempo, o forse per la sua lingua, così solenne e aulica, lontana da quella parlata (anche al suo tempo) ma dal suono eterno e familiare. È inutile dire che, nella stessa classifica, Dante e Manzoni occupavano gli ultimi posti – a rischio di retrocessione, si direbbe nel gergo di oggi. Eppure, l’unico componimento leopardiano ove si parli espressamente di un’attività sportiva (il canto «A un vincitore nel gioco del pallone») non ce lo facevano leggere e se qualcuno ci avesse provato per conto suo, sarebbe stato certamente deluso dallo scorrere dei versi oscuri e, addirittura, impacciati, oltre che pervasi del più nero pessimismo del Poeta, che pure non era certo uno spirito giocondo. * Avvocato, cultore di Letteratura e Storia del Risorgimento italiano. ** Conferenza tenuta il 25 novembre 2005. 10txtI:Layout 1 5-04-2009 324 17:40 Pagina 324 MARCELLO BERLUCCHI [2 A me è sempre rimasta la curiosità di saperne di più su questo «gioco del pallone» e sul «garzon bennato» cui i versi sono indirizzati. Solo recentemente, per uno di quei casi che rendono affascinante la vita, sono riuscito a soddisfare la mia curiosità, scoprendo un mondo che ha la seduzione del tempo che fu trasportato ad oggi. Ma, anzitutto, cos’è questo «gioco del pallone» menzionato nel titolo del canto leopardiano? Si tratta di un’attività sportiva antichissima che appartiene alla famiglia degli sport detti «sferistici» cioè effettuati usando una palla sferica come elemento indispensabile. A questa famiglia appartengono la pallamano delle nostre valli, giocata a mani nude, il tamburello, così diffuso anche ora nel mantovano, nel bresciano, nel cremonese e nel veronese, e la «pelota» basca, con quella paletta ricurva intrecciata di vimini che si è vista tante volte riprodotta in fotografia. Il gioco è organizzato come il tennis, per intenderci, che è il più illustre e famoso di questo genere di sport, e consiste nel colpire la palla con un bracciale di legno di sorbo infilato sul braccio, per fare il punto nel campo avverso. Le squadre sono di tre uomini (come il tamburello) e la vera particolarità di questo gioco col bracciale è nel campo: una superficie di un centinaio di metri, divisa in due con una riga di calcina bianca (non esiste la rete, che è una caratteristica peculiare del solo tennis, non a caso chiamato anticamente «palla corda»). Il fatto è che questa superficie era sempre ai piedi delle mura cittadine, sicché esisteva sempre una sorta di muro di sponda ove far rimbalzare la palla. Ecco, questa caratteristica del gioco di sponda o di rimbalzo, imposta dalla origine storica dei campi di gioco, fuori delle mura, differenzia il pallone a bracciale da altri giochi similari. Nel Rinascimento il gioco, favorito da prìncipi e signori, raggiunse vertici di spettacolarità e notorietà tali da suscitare grande entusiasmo popolare e costituire argomento per com- 10txtI:Layout 1 5-04-2009 3] 17:40 Pagina 325 Giacomo Leopardi e lo sport «A un vincitore nel gioco del pallone» 325 ponimenti letterari e poetici. Perciò Leopardi, che, come vedremo, conosceva benissimo questo sport (anticipo che uno dei sui fratelli lo praticava ed anzi morì per le complicazioni di un infortunio, si direbbe oggi, capitatogli durante una partita), non dovette considerare stravagante dedicargli una sua poesia che andava ad inserirsi in una tradizione storica di genere già ben affermata. Altre notizie interessanti attengono alle denominazioni dei giocatori, tre per ogni squadra, come detto: un battitore, una spalla e un terzino (parola passata pari pari nel calcio). Vi è poi una particolarità: un personaggio (il mandarino) lancia la palla al battitore nel momento in cui questi scende con slancio da un trampolino inclinato per colpire, con maggior forza data dalla velocità della corsa, il pallone col bracciale. Il punteggio (come nel tennis e nel tamburello) va di quindici in quindici e quattro giochi formano un «trampolino» (qualcosa come i «games» e i «set» del tennis). Come nel «base ball» c’è il fuori-campo, che si chiama «volata». Del gioco di rimbalzo sul muro laterale, s’è già detto. La notizia che forse sorprenderà è che fino al 1963 è esistita in Italia una apposita Federazione che faceva svolgere regolarmente dei campionati nazionali, vinti soprattutto da squadre marchigiane (nel 1946, ’47, ’55, ’56, ’57 e ’60). Le altre regioni, oltre le Marche, ove il gioco era diffuso sono la Romagna e il basso Friuli (Pordenone). Dopo un lungo intervallo, dal 1992 si disputa nuovamente un campionato nazionale con squadre di Cesena, Cingoli, Faenza, Mondolfo, Santarcangelo di Romagna e Treia. Ho lasciato per ultima questa cittadina marchigiana della provincia di Macerata, Treia appunto, perché qui occorre un discorso a parte. Treia si considera la patria del gioco del pallone a bracciale e di lì veniva quel Carlo Didimi, sommo asso del gioco, che è il «garzon bennato» dei versi leopardiani. A Treia ogni anno, dal 1978 si celebra la «Disfida del bracciale» nella prima domenica di agosto, un torneo regionale fra le squadre dei quat- 10txtI:Layout 1 5-04-2009 326 17:40 Pagina 326 MARCELLO BERLUCCHI [4 tro quartieri di questa bellissima cittadina turrita, con manifestazioni turistico-sportive che durano tutta la settimana precedente (sfilate in costume). Ho accennato prima alla diffusione del gioco, nello spazio e nel tempo. Anche Goethe lo vide (a Verona) e lo apprezzò nei suoi «Reisebilder» del 1786 con una serie di notazioni da acuto osservatore che meritano di essere riportate: «..... Oggi tornando dall’Arena, un mille passi lontano, potetti assistere ad uno spettacolo pubblico; quattro giovani della nobiltà veronese giocavano al pallone contro quattro vicentini. Si esercitano a questo gioco durante tutto l’anno circa due ore prima del tramonto. Questa volta la presenza degli avversari foresti aveva provocato un concorso straordinario di popolo: quattro o cinquemila spettatori. Non ho visto però alcuna donna, di qualsiasi condizione sociale. Poco prima, accennando all’atteggiamento della folla in simili occasioni, ho descritto l’anfiteatro improvvisato: fu così che vidi qui la gente sedersi l’uno più in alto dell’altro. Cominciai a sentire da lontano un vivace batter di mani che seguiva ogni colpo di una certa importanza. Ad ogni convenevole distanza l’uno dall’altro sono situati due tavolati leggermente inclinati; il giocatore che lancia la palla si tiene in alto con la destra armata d’un largo cerchio di legno a punte. Mentre un altro, nella sua stessa squadra, gli lancia la palla, egli, scendendo, le corre incontro e aumenta così la forza del colpo con cui l’accoglie. Gli avversari cercano di respingerla, e così la palla va da una parte all’altra finché non resta a terra sul campo. Questo gioco dà occasione a degli atteggiamenti degni di essere scolpiti nel marmo. Questi giovani sono ben fatti e robusti, portano una veste bianca corta e aderente. Le due schiere si distinguono solo da un segno di diverso colore. Particolarmente bella è l’attitudine del lanciatore della palla quando scende di corsa dal piano inclinato ed alza il braccio per colpirla; essa ricorda il gladiatore del muro Borghese. Mi 10txtI:Layout 1 5-04-2009 5] 17:40 Pagina 327 Giacomo Leopardi e lo sport «A un vincitore nel gioco del pallone» 327 sembrò strano che si esercitassero in questo gioco presso le vecchie mura della città, in un luogo che non offre alcuna comodità agli spettatori. Perché non giocano nell’antico anfiteatro? Sarebbe uno spazio così adatto e bello per questo gioco!» Non si può far a meno di notare, in questa cristallina pagina del genio di Weimar, la precisione con cui viene descritto il gioco osservato e ammirato. Anzitutto, il fatto che non era uno svago del popolino («quattro giovani della nobiltà veronese»); poi l’assiduità degli allenamenti («si esercitavano a questo gioco tutto l’anno») con l’indicazione dei tempi e della durata («circa due ore prima del tramonto»); anche il gran concorso di folla («quattro o cinquemila spettatori»), rigorosamente maschile («non ho visto però alcuna donna, di qualsiasi condizione sociale») con grande tifo, diremmo noi oggi («cominciai a sentire da lontano un vivace batter di mani che seguiva ogni colpo di una certa importanza»). Infine, la descrizione delle diverse fasi del gioco, particolarmente la battuta iniziale (il servizio, in termini tennistici) con quella sorta di trampolino («due tavolati leggermente inclinati») e l’azione di lancio del «mandarino» («gli lancia la palla») che favorisce lo slancio del battitore (il quale «scendendo, le corre incontro e aumenta così la forza del colpo con cui l’accoglie»). Segue poi l’ammirazione di Goethe per la bellezza estetica del gesto sportivo del battitore («questo gioco dà occasione a degli atteggiamenti degni di essere scolpiti nel marmo») che rievoca la statuaria romana («ricorda il gladiatore del Muro Borghese»). L’ultimo cenno è di rammarico per il fatto che un simile, bellissimo spettacolo si svolgesse «presso le vecchie mura della città» anziché nell’antico anfiteatro (l’Arena) «uno spazio così adatto e bello per questo gioco». E qui forse, l’illustre viaggiatore d’oltralpe non aveva capito il meccanismo sportivo dei giochi di sponda, che può farsi accanto alle vecchie mura e non nell’ovale dell’anfiteatro dell’Arena. L’ultima notazione tecnica riguarda quello che può sembrare un errore cronistico: Goethe parla di quattro componenti della squadra, ma 10txtI:Layout 1 5-04-2009 328 17:40 Pagina 328 MARCELLO BERLUCCHI [6 evidentemente vi comprende, oltre i tre giocatori propriamente detti (lanciatore, spalla e terzino) anche il mandarino, che lancia la palla. Detto così, in breve, del gioco del pallone a bracciale, occorre ora rispondere alla seconda domanda: chi era il destinatario della poesia del Leopardi. Era Carlo Didimi, di nobile famiglia (ricordate Goethe?) nativo di Treia, la cittadina turrita del maceratese di cui ho già detto. Era nato il 6 maggio 1798 da Francesco e Pasqualina Ercolani, appartenenti alla nobiltà locale (non solo di Treia, ma anche di Recanati, Cingoli e Tolentino) che viveva delle rendite dei consistenti possedimenti terrieri (traggo queste notizie dallo studio del prof. A. Meriggi su «Carlo Didimi e i suoi rapporti con Giacomo Leopardi» Macerata 1980). Fin da piccolo mostrò di avere le proprie idee, che potremmo dire anticonformiste – cioè, negli stati pontifici cui appartenevano le Marche, liberali e contrarie al dominio temporale del Papa. Fisicamente era (come risulta dalle descrizioni del tempo) «bello e aitante nella persona, alto e snello, colorito vivo, fronte poco spaziosa, occhio castagno chiaro, assai gentile nelle maniere». Come molti campioni sportivi odierni «non era molto istruito». Comunque «nel giocare a pallone emulò e superò i più distinti del tempo». E qui è interessante ricordare i nomi (e i soprannomi!) degli altri campioni di allora, che si misuravano con lui. C’era Luigi Donati di Faenza (detto «il diavoletto») e suo fratello Angelo Donati (detto «il diavolone»), c’era un altro «diavoletto» (appellativo evidentemente diffuso) Ercole Sansone, c’era Massimo Domenico da Sacile, Angelo Pacini ed altri. L’esordio del nostro campione avvenne, a 20 anni, sullo sferisterio di Treia, sua città natale, giusto allora inaugurato – ma la sua fama esplose in tutta Italia quando Carlo Didimi battè uno dopo l’altro i più forti campioni del momento, come a Forlì nel 1823 quando sconfisse il friulano Massimo Domeni- 10txtI:Layout 1 5-04-2009 7] 17:40 Pagina 329 Giacomo Leopardi e lo sport «A un vincitore nel gioco del pallone» 329 co, i fratelli Donati ed Ercole Sansone. Le cronache narrano che sfidò, da solo, Sansone e uno dei due Donati, battendoli in un match forse poco ortodosso ma sicuramente spettacolare. Carlo Didimi (in questo sì, simile a molti assi odierni) era un ottimo amministratore dei suoi talenti sportivi: nella Storia di Macerata si legge che il 29 maggio 1830 richiese ai deputati (gli organizzatori) la bella somma di 600 scudi di ingaggio per venire ad esibirsi nel nuovissimo sferisterio cittadino (quello ove oggi c’è un noto festival operistico estivo) con la esplicita motivazione «essendo assai forti le spese e potendosi poco contare sull’introito della piazza di Macerata». I maligni dicevano che questa... praticità derivasse dal motto di famiglia «non fidere aliena laude» (cioè non fidarti della lode altrui) sicché egli preferiva sostanziosi «cachet» alla effimera gloria, anche per mantenere i suoi figli. Il ruolo nel quale eccelleva era quello del battitore ed i suoi «fuori campo» (le sue «volate») furono ricordate addirittura con una lapide nei diversi sferisteri ove giocò (Verona, Pisa, Livorno, Rimini, Perugia, Spoleto, Cesena, Milano e Genova). Abbiamo ricordato che l’appellativo «diavolo» con accrescitivi (diavolone) e diminutivi (diavoletto) era abbastanza diffuso fra diversi giocatori. Per lui, considerato il migliore in assoluto, ci fu chi disse che se gli altri erano il diavolo, Carlo Didimi... era Dio. Agli appassionati di storia del calcio tornerà alla memoria l’appellativo («figlio di Dio») di Renzo De Vecchi, mitico terzino del Genoa e della nazionale degli Anni Dieci. Dove si vede che l’iperbole in campo sportivo, non è solo del giornalismo di oggi! Ma non si trattava solo di un asso del gioco del pallone. Egli infatti fu anche un grande patriota, capo dei cospiratori della città di Treia che diffondevano gli ideali di patria e libertà nazionale, contro il potere pontificio. Con un suo compagno di squadra, Luigi Butironi, partecipò agli ideali ed alle manifestazioni mazziniane, divenne carbonaro ed utilizzò i suoi viaggi per le attività sportive al fine di avvicinare i patrioti e le associazioni carbonare dell’Italia centrale. 10txtI:Layout 1 5-04-2009 330 17:40 Pagina 330 MARCELLO BERLUCCHI [8 Dopo il fallimento dei moti rivoluzionari del 1831, quando egli, insieme a quattro giovani di Treia prese parte alla marcia su Roma, la polizia pontificia lo definì «fanatico fautore e partigiano dei liberali» e nel 1839 a Tolentino (ove si era trasferito) venne anche perseguitato per questo. L’ascesa al soglio del marchigiano Pio IX (cardinale Mastai Ferretti) portò un clima di distensione di cui approfittò anche il nostro; l’età aveva molto rallentato l’attività sportiva (aveva allora giusto 50 anni) ma non la sua passione politica (fu amministratore comunale dal 1847 al ’49). Carlo Didimi morì a Treia il 4 giugno 1877 all’età di 79 anni. A questo punto viene da chiedersi: ma Leopardi conosceva Carlo Didimi? Certamente sì e non solo per la dedica del carme ma proprio per ragioni storiche ed affettive. Fra i titoli patrizi di Carlo Didimi c’era anche Recanati, come abbiamo visto e in quella cittadina il gioco del pallone, come in tutte le Marche, era una gloria locale. Per di più Recanati aveva una sua propria squadra con nomi allora famosi (Vincenzo e Lucio Tarducci e Cesare Pierini) che si batterono più volte con quelli di Treia (Butironi e Fortunati, capitanati dall’asso Didimi) nello sferisterio cittadino e sugli altri campi. Uno dei giovani fratelli del poeta, Luigi, giocava con la squadra locale ed anzi, come detto, morì in seguito ad un incidente occorsogli durante il gioco. Si potrebbe anche pensare che Giacomo, oltre alla personale conoscenza del gioco del bracciale e del suo più celebre campione del tempo, (che tra l’altro era suo coetaneo) ne ammirasse anche la prestanza fisica e il successo – due doti che la Natura («madre di parto e di voler matrigna») non gli aveva certamente concesso. Ricordiamo infatti che il contino Leopardi non era certo bello o vigoroso («un gobbetto» lo definì crudelmente una donna fiorentina da lui ammirata e cantata come Aspasia, la Fanny Targioni Tozzetti). Da ultimo, si può ricordare che la dedica della canzone a Carlo Didimi, il più celebre campione sportivo del tempo, ne 10txtI:Layout 1 5-04-2009 9] 17:40 Pagina 331 Giacomo Leopardi e lo sport «A un vincitore nel gioco del pallone» 331 accresce la fama: le altre canzoni del libretto edito a Bologna nel 1821 sono dedicate ai vertici la prima all’Italia, la seconda a Dante Alighieri, la terza al cardinale Angelo Mai, letterato ed erudito, la quarta alla sorella Paolina e per essa a tutte le donne d’Italia, la quinta al «magnanimo campion» come rappresentativo (nel pensiero del poeta) della gioventù nazionale come doveva essere, cioè forte, gagliarda e vincitrice. Osserviamo, di sfuggita, che le cose sono oggi molto cambiate per cui nessun poeta (senza imbarazzanti paragoni con l’immenso Leopardi) dedicherebbe un componimento a quegli assi dei diversi sport le cui gesta ci vengono quotidianamente propinate dai diversi mezzi d’informazione. Ma anche in questo Leopardi, sulle orme del grande Pindaro, è diverso ed unico. A questo punto, ho parlato di tutto fuorché della canzone «A un vincitore nel gioco del pallone» che conviene ora esaminare un po’ più da vicino. La poesia non è di lettura facile, anche per la lingua sempre aulica ma talvolta oscura e per la ricchezza dei rimandi storici, bisognosi di chiarimenti. La canzone si compone di un esordio, diretto al «garzon bennato» poi definito «magnanimo campion» con un cenno molto bello al successo anche popolare di Carlo Didimi («te l’echeggiante Arena e il circo, e te fremendo appella ai fatti illustri il popolar favore») e poi introduce subito il tema di fondo: la pratica sportiva è preparazione alla gloria, come i Greci vincitori dei Persiani a Maratona erano gli stessi che avevano cinto il lauro olimpico. Par di sentire qui, trasfusa in versi una eco neppur troppo lontana della frase famosa del duca di Wellington dopo la vittoria di Waterloo il cui merito, disse, doveva farsi risalire alla disciplina sportiva imparata dagli Inglesi sui campi verdi di Eton. Solo sei anni erano passati da allora (1815-1821). Trabocca a questo punto tutto il pessimismo del Poeta («altro che gioco son l’opre dei mortali? A noi di lieti inganni e di felici ombre soccorse natura stessa») che lascia poi il posto ad 10txtI:Layout 1 5-04-2009 332 17:40 Pagina 332 MARCELLO BERLUCCHI [10 una fosca predizione sul futuro. Se le cose vanno avanti così, cioè se l’amor di patria non si risveglierà, l’Italia diventerà un deserto «e l’atro bosco mormorerà fra le alte mura». Triste sarebbe «o buon garzone» sopravvivere alla patria infelice, perché le tue glorie sarebbero passate invano. Si inserisce qui una delle più desolate negazioni della felicità riscontrabili in Leopardi: «nostra vita a che val? solo a spregiarla» e l’unica felicità è quando ci si avvicina al «varco letéo» (cioè al passaggio del fiume Lete che segnava il confine della memoria e dell’Ade, nella mitologia greca). Così si chiude, su un tono basso di ostinato pessimismo la canzone che pure si era aperta con l’eco dei fragorosi applausi al campione e degli schiocchi delle «volate» giù dal trampolino. Tutto un altro tono, logicamente, rispetto alle odi di Pindaro dedicate ai vincitori nei giochi di Olimpia. Ma della poesia greca Leopardi, studioso attentissimo, aveva assorbito l’eleganza della forma – non la serenità cristallina del pensiero. «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2005, Brescia 2008.
Scaricare