I L Q SIMONA VINCI N D I C Il sequel di "Tre metri sopra il cielo" conquista subito la testa delle classifiche. Moccia si conferma l’autore più vicino alla sensibilità dei giovani. pagina Punti che ritengo attuali nell’Introduzione di Leonardo Sciascia alla Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni per le edizioni Sellerio (Palermo 1981) I I FEDERICO MOCCIA Romanzo fulminante e raggelante sull’amore, i suoi fini e i suoi esiti. Cosa rimane quando tutto finisce? In "Stanza 411" una visione e vera della vita. ANDREA CAMILLERI U 11 pagina N A L E D E I ISABELLA SANTACROCE La storia del rapporto di odio tra figlia e madre dentro una costrizione claustrofobica del senso della famiglia. "Zoo" segna il ritorno di una dark lady. 4 pagina 60006 1euro ( Stilos 9 771826 069007 Anno VIII n. 6 14-27 marzo 2006 L I B pagina ...i cattivi governi, quando si trovano di fronte a situazioni che non sanno o non possono risolvere, e nemmeno si provano ad affrontare, hanno sempre avuto la risorsa del nemico esterno cui far carico di ogni disagio e di ogni calamità… Considerazione attualissima che non riguarda solamente l’Italia. L’attuale nostro governo, quando si è reso conto che non solo non avrebbe potuto tener fede alle promesse elettorali ma che non era in grado di risolvere, sia pure in minima parte, la crisi economica, ha trovato ben due fattori esterni e uno interno sui quali scaricare la responsabilità. I due fattori esterni sono stati l’attacco terroristico alle torri gemelle di New York che ha provocato una violenta ondata d’urto sull’economia mondiale e l’introduzione dell’euro. Il nemico interno è rappresentato dai comunisti che hanno impedito ostruzionisticamente le riforme che il governo voleva attuare. Ma basterà pensare, in quest’ultimo caso, alla preponderanza numerica della maggioranza rispetto all’opposizione che esiste in Parlamento e in Senato per far subito balzare agli occhi l’inconsistenza e la pretestuosità dell’argomento. E non è stato pretestuoso l’attacco americano allo «stato canaglia» dell’Irak? È stato utile infatti risolvere la crisi dell’economia americana. Attualità di Sciascia …quei giudici furono burocrati del Male e sapendo di farlo… I giudici milanesi Monti e Visconti erano «uomini di cui tutta Milano venerava l’integrità, l’illibatezza, l’ingegno, l’amore pel bene pubblico, lo spirito di sacrificio e il grande coraggio civile. Eppure si prestarono a mandare a morte degli innocenti dopo averli a lungo torturati. Secondo me il problema non esiste in quanto non c’è contraddizione tra le doti personali dei giudici e il loro agire pubblico. Erano giudici politici in quanto direttamente designati dal Senato di Milano, la massima autorità politica che aveva tutto l’interesse a sostenere la tesi dell’esistenza degli untori. Monti e Visconti si comportarono come si comporteranno in seguito i giudici fascisti, i giudici nazisti, i giudici bolscevichi. Tutti cre- dettero di agire in nome del bene pubblico. Ma, per tornare all’attualità, oggi si fa un gran parlare di toghe rosse e di magistrati di parte. Voler pensare che certi processi, certe sentenze nel nostro paese siano stati determinati da magistrati di parte è pura propaganda politica. Un caso per tutti, quello di Borsellino verso il quale agli inizi Sciascia non fu certamente tenero. Sbagliando in pieno. Solo dopo post mortem apprendemmo quali erano le idee politiche di quel magistrato, ma da come agì da magistrato non si poté certo desumerne l’idea politica alla quale credeva. Questo è importante: non la fede politica del magistrato, ma che quella fede politica non stinga mai sull’esercizio della giustizia. Domanda: Sciascia sarebbe stato d’accordo sulla se- Manzoni fu un autore importante per Sciascia: sul piano della riscrittura, con La strega e il capitano (1985), e sul piano della critica e del pensiero, con l’introduzione alla Storia della Colonna Infame (Sellerio, 1981). «Più vicini che all’illuminista ci sentiamo oggi al cattolico. Pietro Verri guarda all’oscurità dei tempi e alle istituzioni, Manzoni alle responsabilità individuali», scriveva Sciascia che leggeva la Colonna Infame anche per spiegare il presente e la «più bruciante attualità» (le leggi sui pentiti). Ancor più bruciante nel 1985, quando, dopo il caso Tortora, l’opera introdotta da Sciascia era distribuita con "L’Espresso". Il testo di Camilleri che Stilos pubblica, commento a margine dei brani dell’introduzione sciasciana sui passi di sempre «bruciante attualità», è stato letto a «L’enciclopedia di Leonardo Sciascia. Caos, ordine e caso», il ciclo di incontri promossi dagli Amici di Sciascia e tenuti al Liceo Visconti di Roma. In calendario il 4 aprile un nuovo incontro su «Majorana e i limiti della ricerca», con E. Recami e R. Caputo. (Pietro Milone) ) Padre Matteo su due fronti: un tesoro misterioso e la sua malattia. Scaglia chiude la trilogia della Terra Santa con un titolo che parla anche di se stesso. L’ossessione di Sciascia per la malagiustizia, la tortura, la violenza di stato è la stessa di Camilleri. Che in una ideale fotografia possono benissimo ritrovarsi non solo insieme ma coetanei: a prova di un sentire comune che è anche un senso congiunto di etica e moralità In due attorno alla Colonna infame I FRANCO SCAGLIA 10 QUESTO TESTO R parazione delle carriere? Credo di sì. Lo sarebbe stato ancora sapendo che i pm sarebbero stati guidati dal potere politico? Credo di no. …La tortura c’è ancora. E il fascismo c’è sempre… Affermazioni incontrovertibili. In Italia, la Diaz, la caserma Bolzaneto. All’estero: Abu Ghraib, Guantanamo. E basterà leggere le continue denunzie di Amnesty. Ma c’è un episodio da ricordare che riguarda Sciascia uomo politico. Il 9 marzo 1982 un investigatore della polizia di Stato, in un’intervista a "La Repubblica", ammetteva che dei terroristi, vale a dire dei brigatisti, erano stati torturati per cavare loro delle informazioni (lo stesso di quello che fanno gli americani in Irak). Un’interpellanza parlamentare, firmata tra gli 3 altri da Sciascia, chiedeva al Ministro dell’interno Rognoni, «se, alla luce di queste rivelazioni, non risulti alquanto azzardata la sua espressione di non programmate violenze a definire i casi di tortura». Nella seduta del 23 marzo 1982, l’onorevole Sciascia veniva invitato a prendere la parola su quanto detto dal Ministro. E tra l’altro Sciascia diceva: «In Italia basta che si cerchi la verità perché si venga accusati di convergere col terrorismo. Non si converge assolutamente col terrorismo quando si agita il problema della tortura». Ma qui da noi chi ha denunziato i fatti di Genova non è stato da una certa parte politica definito come un fiancheggiatore dei blackbloc e dei noglobal? …il moralismo, termine oggi in disgrazia, che come una goccia d’acqua si vaporizza se cade sulle roventi ingiustizie dei nostri anni… La questione morale che venne sollevata da Berlinguer e che ogni tanto viene rispolverata, in realtà credo che sia stata una questione da sempre in disgrazia e non solo da oggi. Soprattutto presso la politica. Vedi Crispi, Mussolini, ecc. Non c’è discussione politica dove alla parola moralismo non venga assegnata una valenza peggiorativa. Dire di uno che è un moralista equivale a ingiuriarlo. Allora, la legge sul falso in bilancio, la legge sul rientro dei capitali illegalmente esportati, la legge sull’abbreviazione dei termini di prescrizione, i condoni di tutti i generi, sono leggi che possono dirsi morali? E chi li definisce immorali è un moralista? Oppure si pongono in una zona estranea ad ogni etica politica? E questa mancanza di etica politica quanto stinge, quanto macchia la coscienza etica individuale? …di fronte alle leggi sul terrorismo e alla semi-impunità che promettono ai terroristi impropriamente detti pentiti… Punto dolentissimo. Qui Sciascia si riferisce ai pentiti politici e non a quelli di mafia. Ma per gli investigatori non c’era altra strada per ottenere dei risultati di fronte a strutture eversive blindate. Certo è un problema di gestione, come lo è stato, e continua ad esserlo, per i cosiddetti pentiti di mafia. Perché è indubbio che la promessa dell’impunità o della semi-impunità può far dire a ogni pentito la stessa terribile frase del Mora: «Vostra Signoria veda quello che vole che dica, lo dirò». S t los pagina 2 Nella foto l’inglese Dan Brown, autore del contestato Il codice da Vinci, accusato di ripetere testi altrui ENZO VERRENGIA a un lato Michael Baigent e Richard Leigh, da un altro Dan Brown: in mezzo la primogenitura di un’idea ritenuta blasfema dal clero cattolico e dalla comunità dei credenti. Quella che è il nocciolo de Il codice da Vinci: Gesù non muore sulla croce, sposa la Maddalena e lei fugge dalla Palestina, approda sulle sponde francesi dove partorisce un figlio di sangue reale, il sang royal contratto in «sangraal» e poi «graal». Se non altro, lo strascico avuto in tribunale costituisce una riprova di quella verità sul mondo angloamericano già ravvisata da Alexis de Tocqueville sul versante propriamente americano ed annotata tra le pagine del suo Viaggio negli Stati Uniti: la litigiosità giudiziaria dalla quale deriva lo strapotere degli avvocati. La civiltà anglofona, da un lato e dall’altro dell’Atlantico è sempre incline a intentare cause, per un motivo o per l’altro. Non certo per coscienza civile, rispetto delle regole e senso della legalità. Al contrario, inglesi e americani hanno un forte attaccamento al denaro, considerato la vera chiave di accesso universale. Gli Stati Uniti, poi, poggiano sull’anarchia del dollaro, detta «liberismo» e sancita dai padri fondatori, in larga parte massoni, dunque usciti dalle file della borghesia più bottegaia. Quindi, ogni occasione è buona per cavarne soldi. L’abbondanza di processi, comunque, paralizza i rapporti umani, sociali ed economici. Tutti hanno paura di compiere azioni che espongano al rischio di una costosa vertenza giudiziaria con relativi esborsi di parcelle agli avvocati e condanne ad esosi indennizzi. Non si tratta di coscienza civile e sviluppato rigore normativo. È solo un voler cavare profitto dagli inghippi forensi. Di qui il successo di un personaggio come Perry Mason e i primati di vendite raggiunti dai legal thriller di Scott Turow, John Grisham e Philip Margolin. Ma, a proposito di libri, che succede quando nelle terre del facile ricorso in aule, anche la creatività narrativa sia considerata un territorio soggetto alle norme monetarie. Così non può sfuggire la possibilità di lucrare sulle fortune di vendita arrise a un romanzo perfino più mediocre di Va’ dove ti porta il cuore, a riprova che inseguire il lettore comune significa appiattirsi praticamente rasoterra. A partire, dunque, dal fatto che non si discute della primogenitura di un capolavoro, si riprendano le fila della vicenda. Nel 1979 la Bbc trasmette un documentario intitolato L’ombra dei Templari. Lo firmano Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln. L’opera s’incentra sul rapporto possibile che lega il vecchio e risaputo mistero di Rennes-le-Château, il segreto dei Templari e la ricerca del Graal. Già molti libri sono stati scritti sul curato Bérenger Saunière. Fu lui a trovare D ROCCO BRINDISI a sposa sentiva freddo alle gambe. Se le carezzava. La colpa era dei cani con il fiato gelido che si affacciavano alla porta. A niente valeva la folla degli invitati, il fuoco acceso, il sugo fumante della pecora fatta a pezzi, la brace dove arrostivano i peperoni, il sanguinaccio. Erano quei cani con la lebbra della tristezza, la loro innocenza, l’orrore di non capire niente di quella festa degli uomini… Si sarebbe fatta tutti i balli per riscaldarsi, ma gli sposi non devono ballare troppo, stanno seduti alla tavola grande per essere guardati, complimentati. La sposa cominciò a bere, il vino era fresco, scendeva meglio dell’acqua, e lei chiudeva gli occhi a ogni bicchiere. Così scomparvero quelle fitte alle gambe, e il freddo che veniva dalla follia dei cani. Anche lo sposo beveva, e più beveva più s’acquietava il suo cuore in una speranza dolcissima, quella di avere delle mani per carezzare… Era notte, quando la sposa mormorò qualcosa nell’orecchio dello sposo, e lui, a sentire la sua bocca così vicina, si mise a piangere per la contentezza, un pianto che durò un secondo e che la sposa non vide. Lo sposo attraversò la stanza, avvolto dall’odore di carne alla brace; uscì sulla porta, chiamò i cani, gli fece strada vicino al fuoco, dove, con gli occhi spersi, e dopo qualche esitazione, si accucciarono, fiduciosi. Quando il vino affiorò sull’ombelico dell’angelo, gli sposi si avviarono verso casa con gli occhi lucidi, tremanti di allegrezza e di sonno; e il pensiero era uno: di toccare quello che avevano L POLEMICHE . La letteratura è piena di remake, di copie di modelli, di prestiti e debiti. Brown ha semplicemente acquisito materiali non narrativi per inserirli in una storia d’invenzione. Così fanno tutti. Lo fa da anni anche Alfredo Castelli, l’autore di "Martin Mystère". E lo ha fatto pure Eco Dan Brown plagiatore? No, ha letto troppi libri qualcosa nella vecchia cappella di Rennes e fondarvi la sua ricchezza personale, ma anche un’esistenza dalle dubbie frequentazioni e la contiguità alle logge occulte. Circa i Templari, l’origine delle loro ricchezze va da sempre cercata nei traffici bancari e commerciali con l’oriente. Sul Graal, infine, ogni parola di troppo sarebbe uno spreco. La tesi di Baigent, Leigh e Lincoln, ripresa da studi e ricerche di varia affidabilità, è che il curato Saunière avrebbe trovato a Rennes le prove che Gesù non fosse morto sulla croce e che i suoi discendenti fossero i Merovingi. Custodi della verità, i Templari, capaci di profittarne anche dinanzi alle gerarchie ecclesiastiche, salvo poi subirne le conseguenza con la terribile persecuzione scatenata contro di loro venerdì 13 ottobre 1307, una data successivamente ritenuta poco propizia. La novità in queste affermazioni sta soprattutto nel canale scelto per la loro prima sortita. Vedere in televisione un documentario che piccona le basi della fede cattolica è spiazzante. Perfino in un Paese, la Gran Bretagna, a maggioranza anglicana. Ma, si sa, l’arcivescovo di Canterbury non mette in discussione la sacralità del Cristo, bensì la rappresentatività del Papa, cui gli inglesi sostituiscono la Corona, dai tempi di Enrico VIII, che si staccò da Roma solo perché non otteneva la dispensa per risposarsi. Il clamore provocato da Baigent, Leigh e Lincoln fu rilevante, ma circoscritto e teologi e conservatori. Non abbastanza per capitalizzarvi. Così nel 1982 esce il loro libro Il Santo Graal, tradotto poi anche in Italia. Questo ottiene qualche attenzione in più. Paradossalmente grazie al romanzo di Umberto Eco Il pendolo di Foucault, che di Templari, complotti universali e analoghe amenità si fa beffe, o quantomeno demistifica dietrologie, esoterismi vari e propensioni per l’occulto. Il Gran Semiologo sostiene che, a volerlo cercare, esiste un legame più o meno tra tutte le cose. Dipende, però, dalle interpretazioni arbitrarie. La fisica quantistica, d’altronde, ha stabilito da tempo che il punto di vista dell’osservatore condiziona i fenomeni osservati. Dan Brown, a sua volta, riprende le ipotesi di Baigent, Leigh e Lincoln per Il codice da Vinci, nel quale il segreto sulla discendenza da Gesù scatena una caccia a uomini e oggetti senza esclusione di cadaveri. Gli americani non possono mai evitare di proiettare dovunque la loro sindrome di Dodge City, maturata nel Far West, dove l’unica regola di convivenza era la capacità di uccidere prima di essere uccisi. Ora, a parte la discutibile filosofia che sta dietro il genere stesso del thriller, Brown ha semplicemente acquisito materiali non narrativi per inserirli in una storia d’invenzione. Questo significa semplicemente documentarsi. Lo fa da anni Alfredo Castelli, l’autore di Martin Mystère, il «detective dell’impossibile» cui peraltro porta una somiglianza sospetta (e questa sì suscettibile di rimbrotti) il professor ANTICIPAZIONI. Un racconto della prossima raccolta La prima notte di vino sempre sfiorato, di far prendere pace alla bocca, alle mani… La sposa voleva arrendersi al sonno, ma il cuore se ne andava in mezzo alle gambe, e lei, anche per questo, rideva. Si lasciò cadere sulla sponda del letto, che gli sembrò un po’ troppo alto, al punto che pensò di non farcela a salire. Si vergognava di togliersi le scarpe davanti allo sposo. Il ragazzo si girò verso la finestra, perché aveva vergogna a guardarla mentre la sposa si toglieva le scarpe: gli batteva il cuore; e mentre stava in quella meraviglia si accorse che nevicava: - Sta nevicando! sussurrò. La sposa si alzò di scatto, stringendo la scarpa che si era appena tolta; e siccome le mattonelle erano gelate, fece due saltelli e poggiò il piede scalzo sul piede dello sposo, e sentì la gioia del piede arrivare al cervello. La lampada a olio mandava una bella luce. Intravvide qualche fiocco di neve, carezzò la lampada a olio, per Stilos Una pubblicazione Domenico Sanfilippo Editore rubarle un po’di calore, tornò a sedersi, si tolse l’altra scarpa, si arrampicò sul letto, stordita di felicità; cercò di spogliarsi sotto le coperte, ma era troppo scomodo, le coperte erano pesanti e toglievano il fiato. Finì che scoppiò a ridere e la sua risata fece palpitare quello che lo sposo aveva sotto la pancia. La sposa capì che non sarebbe mai riuscita a spogliarsi dentro il letto; sbuffò, in silenzio, cantò la strofa di una canzone a bocca chiusa e rimise i piedi a terra. Si sfilò la gonna e con quella coprì la lampada. Si tolse le mutande, che aveva soggezione a chiamare «mutandine» e si nascose tra le lenzuola. Alla fine rimasero ignudi, tutti e due, e la sposa, che teneva più coraggio, aprì gli occhi, glielo vide, un istante, e rise; e, ridendo, si girò, senza accorgersene, in modo che lo sposo, riaprendo gli occhi, vide la sua schiena e quello che, forse, non avrebbe più guardato in vita sua, perché mai avrebbe avuto la forza di chiederle: - Voltati! -. Mentre stava nel timore che a furia di tenere a mente quella spasa di luce, si poteva offendere la bocca riccia e nascosta che la sposa teneva in mezzo alle gambe, se lo vide, e se lo guardò, teso come una mazza, e non se lo riusciva a nascondere né a piegarlo con le mani o a spaventarlo con le parole; e ci piazzò sopra la coppola che stava meglio che su un attaccapanni, e intanto fissava il culo bianco della sposa e lo teneva a mente senza parole, e anche se non lo pensava col nome, quello era proprio un culo di ragazza; non l’avrebbe pensato con un altro nome o soprannome, con la paura di farlo sparire, di fargli scordare la sua meraviglia di stare al mondo. E quale ragazza ha mai pensato di coprirsi la linea che sta là in mezzo, precisa come un’ombra? Avete mai visto una ragazza portarsi le mani dietro, per rendere invisibile Direttore responsabile Mario Ciancio Sanfilippo Coordinatore Gianni Bonina Registrazione Tribunale di Catania n. 11/99 del 24/4/99 Spedizione in Abb. Post. Art. 2 comma 20b legge 662/96 Stampa I.E.S srl Catania Anno VIII, n. 6 14-27 marzo 2006 REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE E TIPOGRAFIA Viale Odorico da Pordenone 50 - 95126 Catania email: [email protected] - tel: 095.330544 Concessionaria pubblicità Pubblikompass tel.: 02.24424611 email: [email protected] Robert Langdon, protagonista de Il codice da Vinci. Perciò, se ogni autore dovesse rinunciare a trarre l’ispirazione da fonti di ricerca, avremmo una letteratura priva di basi verosimili, fiabe e basta. La documentazione si insegna nelle università americane ai corsi di scrittura creativa. Certo, alcuni, come Michael Crichton, citano perfino la bibliografia in appendice ai loro romanzi. Altri confidano nei ringraziamenti dei debiti verso altri per gli spunti di partenza. Brown, tuttavia, non poteva riferirsi unicamente al lavoro di Baigent, Leigh e Lincoln, perché loro stessi avevano operato su deduzioni, o illazioni, di studiosi disparati, compresi alcuni teologi non ortodossi. Lo stesso Umberto Eco nomina a volte la poligenesi letteraria, che si può spiegare agevolmente. Dati i presupposti che si creano in un clima e in ambito culturale specifico, in molti posso arrivare per caso alla stessa idea. Eco fu peraltro accusato di plagio da uno scrittore greco-cipriota, che perdette la causa contro di lui, e da un inglese, che non pare sia arrivato alle vie legali. Talvolta, ispirarsi a un’altra opera, è del resto intenzionale. Gran parte della fiction post-moderna ripropone canoni e luoghi comuni di ciò che l’ha preceduta. Molto cinema degli anni ’80, specie quello di Spielberg, era dichiarato omaggio al passato. Indiana Jones, per esempio, voleva essere un James Bond senza i gadget. Prima ancora, quando Jules Verne giunse alla fama e al mito con i suoi Viaggi straordinari, molti si provarono ad imitarlo. Lui stesso riprese l’idea del sottomarino da un romanzo di Aristide Roger. E i marziani di Herbert George Wells in La guerra dei mondi arrivano sulla Terra su «proiettili» sparati dal pianeta rosso come quello di Verne in Dalla Terra alla Luna. Stephen King sottrae a Robert Sheckley l’idea di un gioco televisivo del futuro, che anticipa i reality show, nel quale i protagonisti devono sfuggire a bande di criminali. Il racconto originale si chiama Il prezzo del pericolo. King ne fa un romanzo, "The Running Man", l’uomo in corsa, che diviene un film miliardario con Schwarzenegger. Di solito, i presunti detentori dell’idea originale si fanno avanti quando la copia ha successo. Allora, varrebbero due principi. Il primo, forse cinico eppure sostanziale è: «Ubi maior, minor cessat». Il secondo, più articolato, merita qualche frase di più. Il circuito delle costruzioni fantastiche dovrebbe essere frequentabile da tutti. Ognuno è in grado di rielaborare concetti, situazioni e personaggi altrui. Solo pochi riescono a migliorare il prodotto. Più che arroccarsi egoisticamente nella proprietà di un’idea, chiunque dovrebbe avvertire quasi un moto d’orgoglio nel vedervi attingere qualcun altro. Fermo restante che partire da un’ipotesi già resa pubblica per farne un romanzo, come Dan Brown, non significa saccheggiare indebitamente risorse creative. quello che è invisibile solo a lei? I poeti che lo fanno somigliare a qualcos’altro sono scemi. E quando si abbracciarono, sotto le coperte, tremando di freddo e di commozione, che fuori nevicava, e il vento gelava le dita degli angeli che volevano prendere appunti di quel culo… due compagni degli sposi, che sognavano da tempo quello scherzo, infilarono nel buco dei gatti, quello che si chiamava "attarùl", nella mezza porta, in basso, una paletta colma di brace viva dove avevano poggiato un peperoncino maligno, che prese fuoco e cacciò un fumo che soffocava i racconti con le catene e la luna. Gli sposi, che stavano assaggiando la contentezza loro, cacciavano lacrime come Giovanni e Maddalena sotto la croce. Lo sposo vide per un istante la pelle della sposa dorata dalla lampada; ma, siccome la cosa si risolveva a peggio, scapparono via, con un lenzuolo addosso; e appena ripresero fiato, si fermarono a guardare la neve, che era grossa e tiepida e bella. Questo testo fa parte del libro La figliola che si fidanzò con un racconto (pp. 174, euro 12) in uscita il 25 marzo da Empirìa Abbonamenti Annuale 20 euro Conto corrente postale n. 218958 intestato a: Amministrazione Stilos Viale O. da Pordenone, 50 - 95126 Catania Distribuzione nazionale Parrini & C. S.p.a. Catone sguardi e riguardi ANDREA CARRARO BOWLES RITROVATO Non avevo mai letto Il tè nel deserto di Paul Bowles, ma ho visto il film di Bertolucci. Ricordavo, per frammenti, scene molto intense ma anche di un gusto, come dire, internazionale. Ho quindi approfittato della ristampa Feltrinelli. Il libro è bello, e leggerlo non significa solo effettuare un viaggio avventuroso e spiazzante nelle terre aride e desolate del Magreb. Bowles ha una prosa di classica ispirazione - ci senti dentro Hemingway ma anche Richard Yates - una prosa sorvegliatissima, votata alla chiarezza espressiva ma senza negarsi agli slanci cromatici e alle accensioni visionarie. Nella prima parte del libro segui le sorti di una tipica coppia americana (Port, scrittore, lei, Kit, viaggiatrice e basta, entrambi con una personalità sfaccettata) e di un amico George Tunner, di carattere più convenzionale. Siamo in terra africana nel secondo dopoguerra. Lei lo tradisce segretamente con Tunner, durante un viaggio molto alcolico in treno. Intanto il marito viaggia in automobile con certi inglesi madre e figlio effeminato - strani e intrusivi. I sensi di colpa di lei sono in qualche modo complementari a quelli di lui che nell’intimo sa di aver messo la moglie fra le braccia dell’amico, quasi per testare lo stato del suo matrimonio. Beninteso, non ci sono qui in gioco i classici valori di una coppia borghese di quell’epoca. O almeno non solo quelli. Port è uno scrittore in avaria di ispirazione che cerca se stesso in terra d’Africa e il senso del suo viaggiare ha certo a che fare con la sua professione. Lei vuole farlo felice, ma non ne è capace. Quei luoghi inospitali non le piacciono. Kit si sentirebbe meglio se potesse fare la viaggiatrice in Italia, in Grecia… La vera svolta del libro è la morte di lui, di Port, che a un certo punto, durante l’ennesimo scomodo spostamento in pullman da un luogo all’altro del deserto, smette quasi di parlare. Le sue condizioni appaiono subito gravissime. Kit, la sposa, gli è accanto, assiste alla sua torpida e fatale malattia, ma con la mente è altrove, e sono solo i morsi del senso di colpa che la trattengono. Con uno stratagemma si sono liberati dell’amico ed ora sono davvero soli. L’uomo giace in una stalla addormentato, buttato per terra con una mano abbandonata su una merda di cammello. Non ha la forza neppure di spostare la mano. Fuori da quel capanno il vento rovente del deserto annichilisce e schiaccia. Di lì a non molto l’uomo morirà. E il punto di vista della storia diventerà quello di Kit. Prima c’erano due protagonisti, ora ce n’è uno solo. L’occhio di Bowles ruota su Kit, la quale Kit scappa, inutilmente le autorità algerine la stanno cercando, la giovane donna si aggrega a una carovana e diventa la schiava-amante di un arabo piuttosto ricco che la porta - travestita da ragazzo - a palazzo dove ha già tre concubine. Lei vive segregata in una stanza. Lui si fa vivo solo per prendersi del piacere. Kit è vestita da uomo, ma viene presto scoperta dalle concubine, che l’aiutano a scappare in cambio di qualche monile. Alla fine la prendono per matta, non sappiamo se lo sia, ma certo è che la sua esistenza è segnata a fuoco dall’esperienza africana che ha appena vissuto. Il libro ha molti strati come tutti i capolavori. Per certi versi è gemello de Lo straniero di Camus. Anche Kit e Port sono stranieri in un mondo culturalmente distante e sembrano disposti a entrare in una velenosa simbiosi con l’ambiente, assorbirne il veleno, l’eros malato. S t los autori italiani oro di Mosè , di Franco Scaglia, chiude la trilogia su Gerusalemme che ha per protagonista Padre Matteo - l’Abuna Michele al quale ha dedicato un breve e intenso ritratto recentemente pubblicato dalla Bompiani. I due titoli precedenti sono stati Il custode dell’acqua e Il gabbiano di sale, anch’essi pubblicati dalla Piemme. In questo terzo romanzo Scaglia alleggerisce la trama e affonda la narrazione nel tema della malattia («il morbo di Burger» che tormenta padre Matteo: malattia che incancrenisce le dita). Padre Matteo, rischiando di perdere le mani, rischia di interrompere la sua ricerca religiosa, perché è archeologo, perché la sua fede si alimenta delle scoperte archeologiche, e viceversa. Rispetto ai romanzi precedenti, in L’oro di Mosè il linguaggio è accelerato, i temi più urgenti, lo stile più sciolto. Pur facendo parte di un continuum narratologico, questo titolo corona il percorso della trilogia con una accentuazione marcata del tratto diegetico e una sensibilità maggiore che si traduce in una voce più lirica. Si tratta indubbiamente del miglior romanzo di Scaglia. Stilos lo ha intervistato. Padre Matteo, in questo romanzo della trilogia della fede e della pace, sembra stanco, in crisi. La malattia che lo tormenta, poi, acuisce questo clima di crisi. Ho voluto raccontare il suo rapporto, che poi in parte è il mio rapporto, con la Terra Santa, perché Padre Matteo ci vive da tanto tempo, ha tanto sperato, e ora le speranze sono di meno, e quindi la malattia scatena anche una crisi generale, perché Padre Matteo è un uomo stanco. L’equazione fede uguale archeologia, in questo terzo libro, è in crisi. Lo si capirà anche in tutto lo svolgimento del libro. Il finale è proprio un discorso di crisi dell’archeologia. Lei utilizza generi popolari, dal thriller al giallo, eppure, a una seconda lettura, i suoi romanzi hanno la costruzione narrativa e la linearità linguistica della letteratura biblica. Ìn L’oro di Mosè poi la malattia alle dita mette a dura prova la fede di Padre Matteo. È un affondo «corporale» nel cuore della fede. Come mai ha chiuso la trilogia con un romanzo così viscerale e tormentato, e così poco di genere? Io sento in modo terribile il passare degli anni. Mi sentivo giovane fino a poco tempo fa: ora, nel giro di pochi anni, tutto è cambiato. La malattia è quasi un discorso sulla mia non-gioventù. Da anni volevo raccontare questa esperienza terribile della mia vita, ovvero il fatto di aver avuto il morbo di Burger. È stata un’esperienza che mi ha segnato, e io desideravo molto trovare il modo di raccontarla. Ci ho pensato per anni, e fare un racconto tutto sulla malattia non mi convinceva. Avevo deciso di non fare il terzo libro su Padre Matteo, ma mi sono convinto a scriverlo quando ho capito che potevo finalmente raccontare questo tema. Questo è un romanzo scritto in otto mesi. Un romanzo del quale sono molto soddisfatto, e dico questo senza paura, perché molti conoscono la mia perenne insoddisfazione. In questo romanzo mi sono dato molto, perché ho raccontato una parte di me, la parte più intima della mia vita, la parte più nascosta, della quale avevo paura. Raccontare la propria malattia è un’esperienza forte. Lei ha praticato il culto della trama, i suoi romanzi sono architetture complesse e tentacolari. In L’oro di Mosè invece la trama è più semplice, l’urgenza di scrivere ha travolto il L’ FRANCO SCAGLIA . Con "L’oro di Mosè" si chiude la trilogia sulla Terra Santa. Qui Padre Matteo è colpito dal morbo di Burger, che incancrenisce le dita delle mani, lo stesso male che ha colpito l’autore e del quale si è deciso a parlare una volta guarito. «Volevo farlo da tempo» Narrando la mia malattia ho preso l’ultimo farmaco VIVE A ROMA. DIRETTORE AVAGLIANO. "LAGONEGRO" (L’ANCORA DEL MEDITERRANEO, 2005) ANDREA DI CONSOLI primato del disegno. È un cambiamento radicale, quasi inaspettato. È un cambiamento che si avvertirà anche nei prossimi libri. So già bene ciò che farò, e tutto sarà più personale, ovviamente sempre mantenendo la struttura del romanzo, che io amo moltissimo, ma andrò molto più sulla sfera personale. Quindi il terzo Padre Matteo per me è una svolta, c’è molta più ironia degli altri, perché la malattia fa crescere persino l’ironia, diventa quasi una forma di disperazione, oppure un modo per guardare le cose con un occhio meno coinvolto. Si chiude, quindi, la trilogia. Cinque anni di fedeltà alla prospettiva francescana, a Gerusalemme, a quella terra magica a cui ha dedicato energie e fantasie. Come valuta, oggi, i tre libri? Un errore C di A paternità T A L O G O IL LIBRO FRANCO SCAGLIA "L’oro di Mosé" pp. 302, euro 17,50 Piemme, 2006 Alla scoperta di un tesoro L’archeologo Padre Matteo scopre alcuni scheletri che portano uno strano collare con impresse misteriose incisioni. Sono la via che porta a un tesoro nascosto in Terra Santa. Padre Matteo si impegna nella soluzione del mistero nonostante l’afflizione che una malattia gli procura e riesce ad arrivare a un passo dal fantomatico tesoro. Ma le cose prenderanno una piega inaspettata. GIAN MARIO VILLALTA "Vita della mia vita" pp. 215, euro 18,50 Mondadori, 2006 Già autore di Tuo figlio, Gian Mario Villalta (un esordio da poeta) è stato sempre attratto dal tema della paternità, con tutte le implicazioni che questo stato comporta, anche quelle legate alla fecondazione. E così quando Giò, protagonista del racconto insieme a Marilina, apprende da questa che aspetta un bambino, si sente al colmo della gioia. Ma il bambino non è suo, è di un donatore. Siciliani deportati nei lager pagina Nella foto Franco Scaglia, autore per Piemme di L’oro di Mosè Scrivere una trilogia è una cosa che ogni scrittore vorrebbe fare. Io però non ero partito dall’idea di fare una trilogia. Io sono convinto che il primo romanzo, Il custode dell’acqua, nonostante il successo in libreria e nonostante il Supercampiello, sia il meno bello dei tre. Era la storia di un frate archeologico che si trova coinvolto in una storia di spionaggio. Il secondo, Il gabbiano di sale, che ho amato molto, è invece molto faticoso, complesso, e purtroppo non ha avuto il successo del primo. Il terzo è il migliore dei tre, perché è un romanzo «di pancia». L’oro di Mosè è un romanzo sulla malattia, e quindi un romanzo a trama ridotta. È meno episodico. Il tema costante è la malattia, che toglie anche episodicità al romanzo. Il tema della malattia è vero, è reale, perché io passavo varie ore della mia giornata in ospedale, con l’ago infilato nel braccio per un’ora. Avevo mille pensieri, mille angosce. Padre Matteo è vissuto su un equilibrio tra fede e archeologia, perché attraverso la fede lui fa l’archeologo, e viceversa. Nel momento in cui le mani entrano in GIOVANNA D’AMICO "I siciliani deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti" pp. 395, euro 20 Sellerio, 2006 Uno studio che pone fine ad una falsa convinzione: che i siciliani, per via dello sbarco degli Alleati nel 1943, fossero rimasti immuni dalla terribile esperienza dei campi di concentramento. A sgombrare il campo di tali pregiudizi è la D’Amico, dottore di ricerca all’università di Trento, che ha raccolto i dati di 761 persone finite nella rete concentrazionaria di Himmler e delle SS. crisi, e sta per perderle, a quel punto entra in crisi tutto. È un meccanismo semplice, ma la vita, anche se uno la complica, rimane terribilmente semplice. Rimane il fatto che per L’oro di Mosè ho usato gli schemi più classici: doppia trama, due situazioni parallele e il colpevole che è quello che meno ti aspetti. I lettori saranno spaventati a leggere un libro così duro: un libro, appunto, sulla malattia? Vorrei dirle che il tema della malattia poi alla fine paga. Il più bel film dell’anno scorso, Million Dollar Baby, è una storia di una tristezza enorme, quindi il mercato lo si può anche conquistare usando la parola malattia. Ci sono determinati temi che hanno una tale anima, un tale spessore, che poi il pubblico li accetta. Io punto molto sull’anima. L’elemento disturbante è talmente vero che credo possa attirare il pubblico come un qualcosa che può capitare. I suoi romanzi sono pienamente incastonati in quella tragedia senza fine che è la questione israelo-palestinese. Come vede la vittoria di Hamas? È nota la sua «equivicinanza», il suo equilibrio nel valutare le ragioni e i torti di entrambi. Io la vedo in modo diverso dalla maggioranza, perché secondo me Hamas ha vinto in quanto la popolazione palestinese era stufa di Fatah, del non-governo e delle ruberie. Hamas ha fatto anche un lavoro di assistenza sociale con i poveri. Io difendo la volontà di democrazia che c’è in Palestina, perché è una nazione, ha legittimamente cambiato governo, e quindi non c’è scandalo se ha vinto Hamas. La vittoria di Hamas non è la vittoria del terrorismo, ma di una speranza di cambiamento. Io credo che bisogna assolutamente vedere il muro, bisogna raccontare il muro, perché il muro ammazza le coscienze. A Betlemme il muro divide le case. È fatto con una rozzezza totale, ed è un orrore che gli israeliani lo abbiano fatto. Parole molto dure contro Israele, eppure Sharon, nel giro di pochi mesi, ha finché ha potuto invertito la rotta, rinnegando, tutto sommato, la politica di un’intera vita. Ma no, i coloni occupano tutta la Cisgiordania. Io sono equidistante, e sono grande amico degli ebrei, ma le azioni degli israeliani e del governo sono azioni che non sono accettabili, da questo punto di vista sono molto critico. Non puoi tenere la gente in un ghetto, perché poi si ribella. Io non sto dicendo che hanno torto gli israeliani, sto dicendo che è un’enorme miopia politica del governo. Non faccio un discorso filopalestinese, attenzione. Però spero che in Israele possa vincere Perez, un sindacalista di cui mi dicono un gran bene. Ora Sharon è un grande statista, ma lui è quello di Sabra e Chatila. Mi auguro che vinca Perez, o perlomeno quelli che si muovono nel solco di Rabin. Ora, però, lei abbandona la Terra Santa. Non le mancheranno i suoi personaggi e Gerusalemme, la città più bella e controversa del mondo? Non è un abbandono, è solo una parentesi. Ora ho bisogno di staccare, perché sono troppo colpito emotivamente. Dopo quest’ultimo viaggio, il muro mi ha massacrato, e quindi devo fare una sosta, altrimenti farei un Matteo molto duro, e quindi è bene che io abbandoni la città, che faccia qualcos’altro. È anche un fatto di salute mentale. Quando Vidigal, personaggio dei miei romanzi, dice che il muro separa le coscienze e rende infelici tutte le persone, ecco, in quel momento esprime il mio pensiero. 3 V O C I ASTI GIOCANDO NELLA PRIMAVERA Giocolieri e artisti di strada, scrittori, giovani e bambini in prima persona nella realizzazione pratica dei libri che verranno distribuiti gratuitamente durante la Fiera del Libro di Torino di maggio. In armonia con il tema che guiderà quest’anno «Passepartout», durante la consueta «Festa di primavera» organizzata ad Asti dalla Biblioteca Astense, che si terrà dal 20 marzo 2006. Il tema è il «Gioco» e i bambini potranno personalmente dipingere le copertine dei libri e realizzare i segnalibri in tessuto per Sedani, il concorso letterario che fa parte di «Dappertout», sezione giovane del Festival di letteratura «Passepartout». Sedani, che si sta rivelando uno degli eventi più interessanti nel panorama letterario creativo in Italia, vanta incipit di racconti di personaggi quali Margherita Oggero, Alessandro Bergonzoni, Giulio Mozzi e altri ancora. Il pubblico spazia da intere scolaresche a insegnanti, l’età varia dagli otto anni a sessanta e oltre, la provenienza da centri culturali esteri come Dublino, Cordoba e Atene alle nostre università. Informazioni www.bibliotecaastense.it GRINZANE CAVOUR SALONE DEL LIBRO DI VIAGGIO A CATANIA Un altro viaggio del Premio Grinzane Cavour è stato organizzato in collaborazione con il Salone del libro di viaggio a Catania dal 24 al 26 febbraio scorsi. Un tema, il viaggio, che il Grinzane ha sempre privilegiato e che è l’emblema stesso del suo itinerario geografico (le parti del mondo in cui è giunto) e del suo percorso letterario tra gli immaginari di scrittori italiani ed internazionali. Nell’ambito dell’evento, dedicato alla letteratura, al turismo e allo scambio culturale tra editori specializzati, librerie, istituzioni pubbliche ed enti privati, il tema del viaggio è stato al centro di un incontro coordinato da Sergio Buonadonna, cui hanno partecipato Roberto Alajmo, Silvana Grasso, Raffaele Nigro, Roberto Pazzi e Romana Petri. Da Palermo, «capace di grandi dolcezze e di grandi efferatezze», secondo Alajmo, alla discesa agli inferi di Silvana Grasso, un viaggio che è «disío» in una Sicilia che non è più Sicilia, sino all’idea di viaggio di Raffaele Nigro, un mondo in viaggio che «viene verso di noi sotto forma di immigrati» e allarga l’idea della meridionalità e della meridianità. E, ancora, il viaggio secondo Roberto Pazzi: una discesa nell’interiorità, ma pure nella responsabilità della poesia e della letteratura, tra citazioni dotte e lirismo, tra visionarietà e dissacrazione, cercando l’altrove. E viaggio sempre, ma come spostamento baricentrico di interessi esistenziali e letterari, tra Italia, Portogallo e Azzorre, quello di Romana Petri, per la quale raccontare è attraversare. 4 amore ai tempi del liceo, Federico Moccia lo racconta attraverso una lingua rapida, accattivante, che invita a riconoscersi, a partecipare emotivamente. Tre metri sopra il cielo (2004) e il nuovo Ho voglia di te, appena pubblicato e già in cima alle classifiche dei bestseller, vanno a costituire un modernissimo Bildungsroman sfrondato da eccessi di letterarietà. Né giovani Törless né però «fuori di testa» esagerati à la Bret Easton Ellis: i personaggi di Moccia càpita di incontrarli sugli autobus e all’uscita da scuola - pantaloni a vita bassa, idee confuse, sogni molto romantici. Lontani anni luce dai Porci con le ali, che ormai già mostrano solo le rughe, i protagonisti inventati dallo scrittore romano fanno sesso ma sognando l’amore eterno; sbattono il naso contro le complicazioni del reale e ne sperimentano il dolore. Bello, ruvido, scafato, Step; bella e impaurita lei, Babi: così li avevamo lasciati. Lei appena persa la verginità; lui a prendere le distanze da bravate, pugni e corse in moto nel cuore della notte e di Roma. Passa il tempo, si continua a crescere. Step eccolo là, più maturo e deciso: di Babi sogna ancora corpo e sorriso - ma poi nella sua vita irrompe Gin e la storia prende tutt’altra piega. Babi è lontana, diversa; il lieto fine atteso, sperato non sembra possibile. Perché la vita va così, sembra dire l’autore: ci coglie sempre alla sprovvista. Ho voglia di te è un romanzo appassionato, un’istantanea di gruppo: raccoglie voci, gesti, musica e altre verità di questo tempo. Stilos ha intervistato l’autore. Sia Tre metri sopra il cielo sia Ho voglia di te hanno una voce, uno stile rapido, cinematografico (e adesso riconoscibile) che i lettori hanno imparato ad amare. È stato difficile, faticoso trovare il tono? Mi ha fatto piacere che molti lettori del primo e del secondo romanzo abbiano sentito vicino questo tipo di scrittura, che è nata in modo molto naturale. Sono stato e sono un lettore appassionato e vorace, e forse lo stile dei miei romanzi, come accade per molti scrittori, è nato come il risultato di letture amate e metabolizzate nel tempo. Il piglio della cronaca, la rapidità dello sceneggiatore, la sfumatura della poesia, uniti a una attenta ricerca di immagini e alla semplicità linguistica, hanno dato forma e sostanza a pagine che non vogliono mai «spiegare» le cose, ma piuttosto «farle vedere». Così, alternando dialoghi serrati a scene più descrittive (mai troppo lunghe, per non far pesare troppo l’attesa dell’azione), è nata una scrittura naturale, immediata. Per certi aspetti anche «imprecisa», se vogliamo. Ma se avessi puntato sulla letterarietà, sarebbe stato difficile arrivare a giovani nati e cresciuti tra fumetti, cinema e televisione, abituati cioè a pensare e «sentire» con e attraverso le immagini. Hai avuto presenti alcuni modelli, alcune letture della tua formazione? Sicuramente Fitzgerald e Hemingway, che ho amato moltissimo: li ho avuti sempre presenti, ma luminosi e lontani come costellazioni. Mettersi sulla lunghezza onda degli stati d’animo adolescenziali ha si- L’ ALESSANDRO AGOSTINELLI uando arrivi a Livorno pensi di capire tutto in cinque minuti. C’è una specie di ebbrezza iniziale che ti segna e ti dice che qui tutto è facile. Puoi venire a Livorno per una vita è pensare per sempre che sei nel posto più semplice del mondo. Ma io ora lo so: non è così. Livorno è una città difficile, perché i suoi abitanti sembrano gente alla mano, ma dentro sono fieri delle loro cose e dei loro segreti, che guai a chi glieli tocca. Questa città ne ha vista di gente promettere, e allora se ne sta lì accogliente e teatrale, becera e sorniona, come le sue vecchine che vanno al mercato con le ciabatte, e i suoi gatti che si nascondono tra gli scafi delle barchette dell’Arci Pesca. Un giorno d’inverno c’è arrivato Jack Hirschman, perché al telefono gli avevo raccontato che Livorno è città di popolo e che lui, unico poeta comunista americano (che poi sarebbe una contraddizione in termini), si sarebbe certo trovato bene. Jack è nato a New York, ma ha vissuto molta parte della sua vita in California, a San Francisco. E Livorno ha subito conquistato il suo temperamento da vecchio fricchettone, con le bettole unte, piene di vino e di umanità, col porto che nonostante la tecnologia gronda ancora fatica e lavoro operaio. Q S t los FEDERICO MOCCIA . «A giudicare dalle valanghe di commenti e opinioni espresse dai lettori, il successo deriva dall’avere svegliato o risvegliato nei giovani (ma non solo in loro) il desiderio di confronto con una realtà concreta, con alcuni aspetti e problemi del loro vissuto» IL LIBRO FEDERICO MOCCIA "Ho voglia di te" pp. 415, euro 16 Feltrinelli, 2006 Il ritorno di Step e degli altri romani Nulla si conserva e tutto si trasforma. Su questa regola riprende la vita funambolica e inquieta di Step, interprete del teen ager di oggi e araldo di una generazione che scopre come il passato sia funzionale al presente e disponga il futuro. Tornano i protagonisti di Tre metri sopra il cielo: Babi, Schello, Lucone, la banda dei Budokani; torna Roma e la sua vita verde. Le mie finestre riaperte sulle camere dei ragazzi VIVE A ROMA. "UN PICCOLO GRANDE NOVECENTO" (MANNI), "HO SOGNATO UNA STA- ZIONE" (LATERZA) PAOLO DI PAOLO gnificato, credo, mescolare con sapienza pezzi di autobiografia e «fotografie» del presente. Hai provato a raccontare una realtà condivisa (e condivisibile) e ci sei riuscito. Quali sono state le tappe di questa «ricostruzione»? Chiunque voglia raccontare il mondo, al cinema o in letteratura, va continuamente in cerca di suggestioni, intuizioni, suggerimenti della realtà nella realtà. Prima di scrivere Tre metri sopra il cielo ho osservato attentamente il mondo giovanile, ho tentato di riviverne situazioni e tormenti cercando racconti, confessioni, dettagli. Ho osservato, ascoltato, letto. Ho cercato di pensare (ripensare) me stesso in alcune situazioni, volevo rivivere lo smarrimento, l’entusiasmo, il dolore e le incertezze che provoca il primo amore. Così ogni storia, ogni racconto còlto per strada, o in autobus, diventava come una finestra aperta sulla camera di una ragazza o di un ragazzo che impara a crescere. A quella finestra lui e lei stanno affacciati immaginando il futuro, sentendo che arriverà, certo, ma forse non sarà come lo vorrebbero. Scrivendo questi due libri ho tentato un immedesimazione, un camminare fianco a fianco con i personaggi, condividendone i passi, la difficoltà delle scelte, sentendole bruciare come loro sulla pelle. Poi naturalmente ci sono stati romanzi che mi hanno suggestionato: molti romanzi di formazione americani, molte «vite spericolate» in forma di romanzo, da Leavitt a Easton Ellis, mi hanno aiutato, magari inconsapevolmente, a definire alcune atmosfere. Per esempio ricordo che mi colpì molto Le mille luci di New York di Jay McInerney: e forse la scritta sulla metropolitana con cui quel romanzo comincia mi ha portato a concentrarmi sull’idea della scritta d’amore sul ponte, «Io e te tre metri sopra il cielo». Sei riuscito a fare entrare in libreria ragazzi che ci entravano molto di rado; sei riuscito a coinvolgere una fascia d’età molto distante dai libri. Mi sembra un risultato già straordinario. Eppure i critici letterari non ti amano, o peggio ti ignorano, relegando Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te nella categoria dei «fenomeni sociologici». Se per fenomeno sociologico si intende una moda, non sono d’accordo. Senza dubbio durante l’adolescenza molte scelte (nell’abbigliamento, nel linguaggio e quindi anche nelle letture) si compiono seguendo una moda: è capitato anche a me. Ma credo che il successo di Tre metri sopra il cielo e di Ho voglia di te, a giudicare dalle valanghe di commenti e opinioni espresse dai lettori, derivi dall’avere svegliato o risvegliato nei giovani (ma non solo in loro) il desiderio di confronto con una realtà concreta, con alcuni aspetti e problemi del loro vissuto che, nella distensione della pagina scritta, consentono una riflessione e una condivisione forse più profonda rispetto a quella spesso proposta da altri mezzi di comunicazione. Altrimenti sarebbe difficile spiegare anche tutta l’attesa creatasi per la pubblicazione del nuovo romanzo. A proposito di attese, aspettative, desideri di lieto fine: quanto ti hanno influenzato nella scrittura? Quanto ti ha influenzato il rapporto con i lettori (spesso anche spettatori del film), con le loro voci, le loro proteste e richieste? Scrivere Ho voglia di te è stato difficilissimo proprio perché avvertivo il peso del confronto con Tre metri sopra il cielo. Temevo di essere troppo guidato dalle aspettative del pubblico. Ho cercato di procedere con onestà, evitando facili approdi. Potrei dire che ho cercato di essere fedele all’imprevedibile della vita, che spesso disattende sogni e volontà. Ho costruito questa nuova storia mettendoci quell’equilibrio e quell’attenzione che si Viaggio con Hirschman nella città toscana Il comunista di Livorno Magari, invece che a San Francisco Jack ha pensato di trovarsi dall’altra parte della baia, a Oakland, e questo ha forse contribuito a rendere felice l’incontro tra il poeta e la città. Infatti, per chi ancora non se ne fosse accorto la Toscana è la California d’Europa, tanto che proprio a sud di Livorno c’è un paese che si chiama appunto La California - tanto per gradire. Si diceva che Jack è nato nella "grande mela" e, nonostante sia ormai pienamente californiano, è ancora attaccato alla sua città di origine, a cui ha dedicato una poesia che ha letto pure sul porto livornese e dice così: «È grande / È brutta / La odio / L’amo / Sono libero /…/ È sporca / È così dolce / La adoro / Rimango / Non me ne andrò mai / È in me / È così crudele / La odio / L’amo / È mia / Ne sono il proprietario / È mia / Di nuovo e ancora / Dico di odiare la guerra / L’amo / È disgustosa / È spaventosa / L’amo / Non ci andrò». Alcune di queste arie Jack ha detto di averle sentite attraversando la città toscana, per venire a fare il suo reading poetico dentro lo scenario suggestivo della Fortezza Vecchia, una specie di castello fortificato sul mare, in mezzo al porto, alle navi sui moli, alle gru che spostano container, all’odore di acciaio, grasso e motori che si respira nell’area portuale livornese. Jack ha reso magica una serata invernale dentro alla Sala Canaviglia della Fortezza, con circa 250 persone che erano venute al festival letterario «Mangiarsi le Parole» per ascoltare la poesia, la sua poesia dalla sua voce. I livornesi e i toscani che sono corsi lì hanno certo respirato un’atmosfera familiare quando Hirschman ha letto la poesia Interludio umano, fraintendimento e geniale incontro con una sconosciuta: «Lei stava appoggiata / al muro vicino / all’Hotel Tevere con in mano / un bicchiere di plastica / quando iniziò a piovere. / Ho cercato una moneta, le sono / andato vicino / e l’ho fatta cadere nel bicchiere. / Cadde sul fondo / di un’aranciata. / Sono arrossito, ho guardato / i suoi occhi devastati e la pelle / e i capelli diventati prematuramente / grigi, e ho detto che / mi dispiaceva, che avevo pensato / avesse bisogno di soldi. / "Ne ho bisogno", rispose / e sorrise "Stavo / solo bevendo / qualcosa". / E restammo così / a ridere assieme / mentre guardavamo le gocce di pioggia cadere / sul lago d’arancia / sopra la moneta che affondava». Chissà se Jack avrà pensato dei versi per Livorno, per quella Fortezza, per la magia di quella serata piena di stelle e di fumacchi e sirene di navi che arrivavano e partivano dal porto. Certamente avrà capito, aiutato anche da Sopra Federico Moccia, autore per Feltrinelli di Ho voglia di te. In basso l’americano Jack Hirschman usa in cucina. Una cena riuscita dipende dalla giusta successione delle portate, da dosi bilanciate di ingredienti ma anche di atmosfere. Così ha preso corpo una sorta di «thriller sentimentale» in cui i cambiamenti dei personaggi, anche imprevedibili, creano curiosità e partecipazione emotiva. A Babi e a Step e a Pollo e a Gin ecc. migliaia e migliaia di lettori si sono affezionati e stanno affezionandosi come ci si affeziona a atleti o personaggi tv. Li sentono vivi, veri. Tu che rapporto hai con i tuoi personaggi? Li senti «figli», compagni di strada, o solo creature di carta e inchiostro? Il mio sguardo sui personaggi non è uno sguardo dall’alto. Non sto mai sopra di loro, non li osservo come si osserva un paesaggio da un aereo. Li vedo, li sento come parte di me: a volte sono un po’ voyeur, a volte sono un’ombra. Ma in ogni caso cammino con loro, mi sdoppio in loro, e insieme a loro soffro, godo, mi emoziono, provo il tormento di ogni scelta, il dolore dell’irreparabile, l’entusiasmo dell’amore, il divertimento del gioco. Scrivere un romanzo è una scuola dello sguardo, perché sei costretto a ragionare e a vedere il mondo con gli occhi degli altri. Devi lasciare spazio ai sentimenti degli altri, fare in modo che ti attraversino, ti sorprendano, ti colgano alla sprovvista. L’amore e il sesso: gli eterni problemi adolescenziali. C’è chi ha rimproverato al tuo nuovo libro uno spazio maggiore dato al sesso a scapito dell’amore (basta leggere i commenti su Internet). Quasi che, a dispetto di molte statistiche e trionfi di memorie erotiche, le ragazze italiane (e forse anche parecchi ragazzi) affidino alla storia d’amore con la esse maiuscola (quella assoluta, quella di Babi e Step) gran parte dei loro sogni. Prima del sesso, l’amore, sempre e soprattutto l’amore? Questa reazione mi ha sorpreso. In Tre metri sopra il cielo la vita di coppia - quindi anche la complicità sessuale di Step e Babi - era affidata all’immaginazione dei lettori. Ho preferito sfumare, limitarmi a suggerire senza indugiare troppo. In Ho voglia di te sicuramente l’eros è più presente, fin dal sogno a occhi aperti di Step nelle prime pagine del romanzo. Ma perché distinguere tra l’amore e il sesso? Ho l’impressione che i giovanissimi - forse influenzati dalle immagini televisive di una sessualità meccanica, automatica - spesso facciano fatica ad avvertire come la gioia dell’intesa di coppia stia proprio in una integrazione di amore e sesso. Il confine non c’è, non dovrebbe esserci: resiste quell’amore che non separa, che gioca, che cerca il piacere dell’altro in ogni direzione. Il mio intento in Ho voglia di te era proprio quello di suggerire questa allegria e leggerezza dell’amore unito a un eros mai brutale o meccanico. C’è un episodio, una frase, uno sguardo che ti porti dietro da una delle cento presentazioni che hai fatto in giro per l’Italia? un’immagine di questo Paese (dei suoi giovani) osservato sui banchi di scuola? Mi porto dietro l’immagine di solitudini che improvvisamente sorridevano nell’avere trovato per compagno di viaggio (inatteso) un romanzo. qualche buona bottiglia di vino rosso che parlare di Livorno significa parlare dei livornesi, perché questo posto è contraddistinto più dalla comunità che dalla forma fisica urbana. Guardare i livornesi significa accostarsi a un mondo di scoglio, che sta pettoruto in faccia al vento. E la sporcizia di certi luoghi di questa città, l’erba che ancora cresce sui marciapiedi, rasente i muri, e sui cigli delle strade è come la realizzazione di quella poetica delle povere cose che tanta letteratura italiana del Novecento ha cercato di raccontare. Fare come ha fatto il poeta americano, cioè guardare Livorno dalla parte della terra significa cercare di capire quei domenicali pittori languidi che ripetono monotoni sulla tela il filo dell’orizzonte di sempre, quel limite più scuro tra mare e cielo, e un’ala del gabbiano. Ma spostarsi in mare, verso la Gorgona pallida, e girarsi d’improvviso verso terra, apre una prospettiva nuova della città. Il colpo d’occhio sul porto, su quelle gru alte, e sulle navi sbuffanti, dice che l’ambivalenza di questa città, aperta e chiusa al tempo stesso, è data proprio dalla sua essenza di mercato continuo in bilico sul Tirreno, in una possibilità di girare lo sguardo, in due direzioni differenti e assolute. Chissà che cosa ne pensa adesso Jack Hirschaman. Ora che è tornato in quell’altra California, quella vera. Ossigeno pagina sguardi e riguardi BENEDETTA CENTOVALLI CLONATI E PLAGIATI Per Il codice Da Vinci (giocattolo da 40 milioni di copie, tradotto in 44 lingue), Dan Brown e il suo editore americano sono accusati di plagio da due storici inglesi. Ma il discorso che ci interessa fare qui è un altro. Di plagio si parla sempre più spesso, a volte senza un vero motivo. Lo si è volutamente confuso con la parodia come nel caso di alcune riscritture ironiche e dissacranti di successi di qualche anno fa (il caso di Luttazzi che «rilegge» Va’dove ti porta il cuore). La storia della letteratura è una lunga storia di paternità e di parricidi, di maestri e di amici. La letteratura nasce e cresce debitrice verso la tradizione. Non c’è letteratura senza «plagio». Le cover letterarie non sono una novità. Eppure nella nostra epoca tardomoderna le ragioni che spingono un autore a citare o a rifare sono forse più complesse di un tempo. Distinguerei oggi due motivazioni di fondo che possono indurre chi scrive a replicare un modello. Non sono motivazioni in alternativa tra di loro ma piuttosto una la conseguenza dell’altra. La prima deriva dalla convinzione che ogni fenomeno artistico sia frutto oramai solo di una ripetizione essendo tutto già stato scritto, detto, fatto. Questa convinzione è figlia del postmoderno e dalla sua filosofia terminale. Un’estetica del postumo, della fine, della morte della letteratura. Una filosofia in saldo per una cultura al buio. Su questa liberalizzazione della ripetizione e della citazione da parte del postmoderno il mercato ha potuto consolidare il proprio impero massmediatico, si è appropriato di questa libertà riconosciuta sviluppando spinte sempre più forti a clonare tutti i modelli che hanno avuto successo. E la clonazione è diventata la cifra della nostra epoca. Ma questa clonazione, cioè la copia di modelli e di format di successo, non ha più nulla a che fare con la questione dei maestri e con la trasmissione della cultura. La clonazione, svincolata da qualsiasi debito contratto con il tempo, rifugge dall’autocertificazione, dai propri dati originari, e si muta in plagio, copia rubata, replica oscura e reticente di un originale. Nella filologia i codici che riportano uno stesso manoscritto si chiamano testimoni, ecco noi abbiamo perduto proprio la capacità e la responsabilità di testimoniare a favore di una continua e falsa innovazione. Il plagio come moderno mestiere dell’innovatore. Un paradosso per recuperare l’illusione del nuovo, la trappola dell’up-todate. La trappola del ricominciare senza cominciare davvero. La cancellazione della possibilità di un vero incipit, di un esordio. Quell’Ur-Text che oggi cerchiamo di dimenticare con la ripetizione - quell’Ur che evoca l’inizio, la storia e la possibilità di futuro - è il custode della nostra capacità di creare. Attraverso il plagio è proprio la spinta creativa ad essere castrata, nella copia il mondo della creazione si spenge a favore di ciò che l’esperienza conosce e riconosce senza sforzo. Negando l’evoluzione dell’esperienza si impedisce la possibilità di reinventare il mondo, di moltiplicarlo, di tenerlo vivo fuori dalle gabbie. L’enorme successo in questi ultimi anni del romanzo di genere, dopo decenni di veto insensato su questo tipo di narrativa seriale, non è il risultato di una laica apertura culturale, ma di un calcolo preciso che ha reso possibile una revisione della borsa valori a favore solo di quella letteratura che non riscrive i modelli del giallo, dello storico o del rosa ma là dentro si eclissa e scompare. S t los autori italiani GIOVANNI MACCARI a ristampa di L’editore rientra in un vasto programma di ripensamento critico degli anni Settanta che incontra in questi ultimi anni (apripista il volume Settanta di Marco Belpoliti, Einaudi 2000) l’interesse di vasti settori, dagli storici ai sociologi. L’editore del titolo (il libro esce per la prima volta nel 1989) è Giangiacomo Feltinelli, morto sotto un traliccio di Segrate nel marzo 1972, durante un tentativo fallito di sabotaggio. Si tratta di un fatto tra i più noti e controversi nella storia convulsa e a sua volta controversa di quell’inizio degli anni Settanta, alle soglie e in qualche modo all’origine della svolta armata di una parte del «movimento». Echi letterari anche a caldo non erano mancati - penso ad esempio a una poesia di Raboni, Notizie false e tendenziose, confluita nella sua raccolta più «politica», Cadenza d’inganno del 1974 ma in quel clima avvelenato dai sospetti e arroventato dallo scontro ideologico era stato soprattutto il rumore mediatico a farla da padrone, i servizi giornalistici e gli indugi pettegoli sulla figura della vittima, con la sua indole contraddittoria (miliardario e comunista) ed il profilo maniacale al limite della fissazione di certe sue teorie (il pericolo imminente del colpo di stato reazionario). In questo senso Feltrinelli diviene un’icona, il simbolo di un potere d’interdizione del sistema esercitato non solo sul terreno della reazione poliziesca o della «strategia della tensione» (la morte dell’editore si dimostrerà fra l’altro effettivamente avvenuta per cause accidentali) ma legato al possesso degli organismi di comunicazione e quindi alla capacità di fabbricare intorno a un evento il rumore di cui si diceva; in definitiva, nell’ottica del movimento, legato alla sua capacità di fabbricare menzogna. È una dimostrazione quasi letterale, sul piano pratico, delle teorie letterarie avanguardiste a cui Balestrini non ha mai smesso di aderire. Non a caso nella sua prefazione Aldo Nove ricorre a Rolandh Barthes, il quale affermando che «il mito è sempre di destra», ricordava altresì che «mito significa semplicemente parola». Chi narra insomma è sempre il vincitore (il sistema di destra), chi produce significati si trova giocoforza invischiato in un linguaggio che non è più suo di quanto sia del sistema. Sono le idee ben note del Gruppo 63 coi suoi agganci italiani ed esteri, so- NANNI BALESTRINI . La stagione delle tensioni e le angosce di Giangiacomo Feltrinelli in un libro che, riedito, dice oggi in godibilità più di quanto gli riuscì alla sua prima uscita. Una prova letteraria che rimanda al Gruppo 63 e chiude i conti anche con l’epica del «movimento» L GIORGIO ARICÒ l di là del Tago, proprio di fronte a Lisbona, vi è un piccolo centro rivierasco con un nome attraente, Porto Brandao. Di sera, dalla piazza dei Mercatores, luogo rinomato della Lisbona manuelina, se ne intravedono oltre il fiume le luci, tremolanti ed azzurrognole. Ma il fascino finisce lì; in pieno giorno dopo una breve traversata a bordo di un vecchio battello anseatico degli anni Cinquanta Porto Brandao si disvela per quello che è: con ancora negli occhi la magnificenza barocca di Lisbona qui sembra di essere approdati in tutt’altra parte del mondo, tra residuati di vecchie fabbriche in abbandono, capannoni da archelogia industriale, un bizzarro edificio di legno assolutamente contrastante. In questo luogo si conclude il libro di Vanni Ronsisvalle che lo adotta come titolo. Se si vuole, un racconto anomalo: intanto per i materiali narrativi di cui è costituito, e che proprio nel sottolineare queste scelte (scenario dell’epilogo e titolo del libro) ne ribadisce il senso, la diversità. Dopo una traversata febbrile attraverso splendori e cadute, genialità e pervertimenti della cultura della seconda metà del Novecento, in un rincorrersi di grandi nomi e testimoni eccezionali, circa duecento personaggi incontrati in Europa ed in Asia, negli Stati Uniti ed in Sud America, in luoghi improbabili dell’Africa approda in questa desolazione; la ragione è geometrica, speculare. Tutti questi incontri intarsiati in un’unica narrazione sono il back stage di documentari e incontri realizzati a capo di una équipe televisiva; film tv realizzati in oltre quarant’anni; così Porto Brandao è la metafora di un approdo definitivo anche filosoficamente, perché Porto Brandao è un’immensa discarica di vecchi televisori, A IL LIBRO NANNI BALESTRINI "L’editore" pp. 135, euro 13 DeriveApprodi, 2006 Anni Settanta prime prove I primi anni Settanta scaldarono, con il caso Feltrinelli, i primi vagiti del «movimento» che avrebbe portato alla strategia della tensione. La figura di un editore calata nel fondo del suo tempo di cui fu interprete. Resti di avanguardia dagli anni avvelenati L’ A U T O R E: U N P R O F I L O La neoavanguardia, la militanza politica, la televisione PIERO SORRENTINO n una delle sue foto più conosciute, Nanni Balestrini sta con un braccio su un computer sul quale compare il titolo ("Macchina per paesaggi") della prima poesia interamente generata da un calcolatore artificiale. Quella foto è una sintesi appropriata dell’attività poetica di Balestrini, avanguardista pugnace nato a Milano il 2 luglio 1935. La sua vicenda letteraria comincia nei primi anni Cinquanta, quando pubblica le prime poesie sulla rivista "Mac Espace" di Gillo Dorfles. Negli stessi anni diventa redattore del "Verri". Nel 1960 lavora presso Bompiani. Nel 1961 esce la sua prima raccolta di poesie, Il sasso appeso (Scheiwiller), da dove si inizia un complesso periodo di sperimentazione letteraria a più livelli: nello stesso anno figura I assieme a Porta, Sanguineti, Giuliani e altri nella celebre antologia I novissimi. Poesie per gli anni Sessanta. Nel ’63 è nel comitato che organizza il convegno di Palermo che darà il nome al Gruppo 63. In quegli anni lascia Bompiani e approda in Feltrinelli, dove pubblica la raccolta Come si agisce. Nel 1966 esce il suo primo romanzo, Tristano. Nel 1969 partecipa al convegno «Poesia Concreta» e, assieme ad alcuni intellettuali come Toni Negri e Oreste Scalzone, fonda il gruppo extraparlamentare denominato «Potere Operaio». Contemporaneamente pubblica la rivista "Compagni". Nel 1971 esce Vogliamo tutto, romanzo che diverrà uno dei manifesti della sinistra. Quando l’editore Feltrinelli, in circostanze drammatiche, rimane ucciso in seguito a un’esplosione sotto un traliccio di Segrate, lascia la casa editrice. Attivo nel corso degli anni Settanta con «Autonomia Operaia», sarà anche incriminato nel cosiddetto processo del 7 Aprile (1979): fuggito in Francia per sottrarsi al mandato di cattura, sarà assolto e rientrerà in Italia nel 1984. Negli ultimi anni, Balestrini ha esplorato a fondo il medium televisivo, prima col canale Raisat poi su Cult tv con il contenitore culturale "Millepiani". L’aspetto militante politico della sua multiforme produzione (comprendente anche le arti figurative, la poesia visiva, il teatro) sembra quello che maggiormente interessa le edizioni DeriveApprodi, che hanno prodotto ristampe dei romanzi (o antiromanzi) più accesi in questo senso: Vogliamo tutto, 1971; La violenza illustrata, 1976), fino alle prove più recenti come Gli invisibili, 1987 e L’editore, 1989. Interviste VANNI RONSISVALLE. I viaggi per la Rai VANNI RONSISVALLE "Porto Brandao" pp. 199, euro 13 Eri, 2005 Dentro la valigia lugubri totem rottamati, morti, impilati in un immenso capannone sconnesso; a significare la fine di un’epoca, una fine di cui non ci si accorge, che forse viene artatamente tenuta nascosta; quella intuita da grandi pensatori come Popper e Steiner; alla fine delle riprese Ronsisvalle in tutti questi anni ha consegnato ad un breve appunto da bloc notes ciò che non sarebbe mai andato in onda; la verità su personaggi e situazioni storiche al di là di ciò che sarebbe rimasto nella memoria collettiva di un grande scrittore, di un’imperatrice, di un tiranno, di un filosofo. Stilos lo ha intervistato. Raccolti gli appunti, come ha dato loro forma letetraria? Prima di un libro vi è sempre qualche altra cosa…Vera o inventata: i manoscritti trovati per caso, il biscottino intinto nel the. Collodi scrisse Pinocchio perché inciampò in un pezzo di legno. Insomma vi è sempre qualcosa prima: il prima di Porto Brandao va rintracciato in quelle annotazioni impressionistiche. Il libro ha funzionato per mettere ordine in quei testi; venne da sé la forma letteraria a cui non avevo pensato accumulandoli senza sorveglianze stilistiche. Pound è uno dei duecento personaggi con Sartre, Aragon, Gunther Grass, Rafael Alberti, Saramago raccolti in quegli appunti. Perché ha lui per la foto di copertina? Perché in quella fotografia vi è un uomo vecchio e vinto accanto ad un uomo giovane e perplesso: su come la grandezza possa essere tutt’uno con la pochezza del contingente. Pound era il simbolo vivente di tutto questo. Qua- rant’anni addietro conteneva già il senso di questo libro. E poi vi è un’altra ragione, privata: quando giravamo a Sant’Ambrogio (a due passi da dove gli americani lo arrestarono per alto tradimento) affacciandomi sul golfo del Tigullio dove era annegato Shelley, Pound venne al dunque comparendomi alle spalle: «Mare e silenzio» sussurrò, come dire: ecco tutto ciò che rimane veramente e vi sarà sempre. Per dirla con Feuerbach, un libro finisce per avere un sottofondo, un flusso che scorre sotto tutto quanto appare sulla pagina, a volte persino più di uno; questo vi è anche in Porto Brandao? In certo senso sì; al primo livello: senza averci pensato ad un tratto ti accorgi di avere scritto un romanzo cervantino. Laddove il personaggio in io, l’io narrante nell’accezione consacrata dalle tipologie tradizionali in alternativa alla terza persona, non necessariamente è assimilabile al Cavaliere dalla Trista Figura mentre l’altro che lo accompagna, con cui ha spesso diverbi, è dispensatore di saggezza, sen- so pratico; cioè un Sacho Panza nei panni di un moderno cameraman. E volendo percepire i livelli meno espliciti? Vi è un genere di narrazione/saggio che in Italia è stato poco praticato, quel genere di testo, ha scritto Calvino, dove si racconta di scrittori, di artisti, di gente speciale realmente vissuta; delle loro discussioni ed idee, alla Mann, alla Huxley. Non so, comunque sarebbe il risultato di un processo involontario; come dire che il libro si è, appunto, scritto da solo lentissimamente, in quei taccuini: dopo l’incontro con persone diversamente importanti tornavo in albergo come riempito di qualcosa che non volevo perdere. Ed ecco il momento della scrittura. Quanto ad altri improbabili sottofondi potrei accennare ad un episodio: non avevo assolutamente pensato di mettere la mia vita in prospettiva; vita su due versanti; quello della letteratura e quello della tv. Ma esistono anche lettori/critici amichevolmente sospettosi; uno ne ha scritto come di «un testo intensamente letterario truccato da reportage giornalistico». È sbagliato; è che la letteratura è ovunque. Ed è spontanea per chi ci crede. Quante idee non ti vengono guardando le insegne dei negozi. E Spoon River non è un bellissimo poema, così costruito tutto con le scritte sulle tombe di una cittadina americana? Redazionalmente poi l’editore preferì sottintendere che l’origine del libro era la ricorrenza dei cinquant’anni della tv in Italia. Ma quelle sono strategie editoriali, con cui ho scarsa dimestichezza; anche se questo è il prattutto francesi, assunte da Balestrini con singolare coerenza e mai sopito spirito antagonista. Quanto alla loro applicazione, esse producono in lui la tecnica del collage, sperimentata sia in prosa che in poesia lungo tutto l’arco della sua carriera. Anche ne L’editore questa tecnica straniante è utilizzata e anzi, sempre secondo Nove, «portata al suo esito più radicale»: brani giornalistici di «Montanelli e Bocca» sono montati senza soluzione di continuità (e senza punteggiatura) con brani da Sotto il vulcano di Malcom Lowry, con referti d’autopsia e documenti giudiziari, il tutto mescolato alle analisi dei quattro «compagni» intenti a rivisitare nel 1989 i fatti e le conseguenze dei fatti del 1972. Ne risulta un organismo complesso e - per chi fosse all’oscuro dei molteplici rimandi, alieno al gergo intellettual-giovanile anni Settanta - scarsamente intelligibile, ossia appunto straniante e sottilmente angoscioso. Il che costituisce quantomeno un risultato letterario, e forse anche «politico», nel senso della carica critica che un simile metodo porta con sé. Ma una volta pronunciato questo no alla struttura romanzesca e alle forme stabilite della lingua, se ci si chiede cosa resta al lettore suddetto (ignaro dei rimandi ecc.), la risposta è che un testo del genere non prevede o comunque non si rivolge a un lettore siffatto: poiché postula un noi che è insieme protagonista e fruitore della scrittura - un noi avvertito e coinvolto nell’operazione contrapposto a un loro volutamente escluso, rappresentato dall’establishment e chi in esso si riconosce. Si tornerebbe così ad una vecchia obiezione mossa alla neovanguardia, ossia il carattere essenzialmente settario della sua proposta, laddove il senso ultimo della letteratura starebbe appunto nell’abbattimento delle divisioni, nella sua mira tendenziale di rivolgersi a tutti indiscriminatamente. Ma si tratta in effetti di un’obiezione vecchia, valida in un contesto caratterizzato dalle opposizioni e dagli scontri dialettici fra correnti letterarie; un’obiezione che se aveva perduto già un parte consistente della sua ragion d’essere all’altezza del 1989, non ne conserva più quasi nessuna oggi, nel presente clima di postmoderno diffuso, quando tutte le proposte e tutti i generi hanno la solita valenza e si dispongono a parlare sul medesimo piano. I libri come L’editore, e questo in particolare per la misura alta della sua riuscita, diventano misteriosamente più leggibili di un tempo (il prefatore definisce non a torto «godibile» questa scrittura), anche in virtù di un loro aspetto per così dire archeologico, come reperti autentici di un’epoca arrivata fino a noi sull’onda della menzogna, accompagnata da una fitta cortina di mistificazioni. mio quindicesimo libro ed ho passato la vita a frequentare editori. Oltre a ciò che ha amalgamato in un’unica tessitura narrativa, come appunto in quei ritratti seicenteschi di Aubrey citati in quarta di copertina, da queste persone diversamente eccezionali ha tratto qualcosa di personale? A volte accade per semplice contagio, trasfusioni di idee, di filosofie… Ho avuto sempre molto tempo per convivere con i miei personaggi in carne ed ossa: dai carteggi iniziali ai tempi lunghi delle riprese. Per Pound durarono sei mesi; per il poeta siciliano Lucio Piccolo dormii nella sua casa di Capo d’Orlando ventotto notti in compagnia di illustri fantasmi, come suo cugino l’autore del Gattopardo di cui occupavo il letto; per l’imperatrice Zita d’Absburgo in ritiro conventuale dove lei si era segregata. Normale immedesimarsi provvisoriamente; si tratta di sensibilità. Ma nessuno che mi abbia dato la ricetta della felicità: anche se spesso ho incontrato, ho lavorato su gente molto fortunata, baciata dal successo e dal denaro. Può servire questo filosoficamente, come lei dice? Ed i luoghi? Vi è tutta una letteratura intorno all’influenza del viaggiare sugli scrittori. Mamma Rai mi ha mandato in capo al mondo… L’inviato culturale è quel tipo di giornalismo più coccolato, comodo e costoso che si possa praticare. Mi è accaduto spesso per rendere meglio l’idea di affidarmi ad un giochino verbale: ho abitato spesso in una valigia. E non sempre in coppia, non sempre potendo contare sulla saggezza dello scudiero-cameraman. Ma c’è un sacco di mondo che non ho visto. Per esempio la Patagonia… Se lei mi chiedesse, perché no la Patagonia? Ma perché vi era già stato Chatwin. Io cosa sarei andato a fare? 5 Finisterre VIVE A FIRENZE E SVOLGE UN DOTTORATO A MACERATA. DEL 2003 UNA SUA MONOGRAFIA SU PONTIGGIA pagina Sopra Nanni Balestrini, autore per DeriveApprodi di L’editore. In basso Vanni Ronsisvalle, che dalla Eri ha pubblicato Porto Brandao ARNALDO COLASANTI CONTRO STEINER Amo George Steiner e lo considero un maestro. Amo l’Europa, la sua infinita biblioteca. So bene che Steiner è un modello di riflessione morale e che le sue passioni, le «grandi idee umane», restano ciò che dà più senso alla dignità della lettura. Ma forse, proprio per questo, so anche che la lezione al Nexus Institute di Amsterdam, Una certa idea di Europa (Garzanti), possiede un errore, un che di rovinoso. È un libro falso che sta lì a contorcersi in una triste mediocrità. L’avvio era stato travolgente. Per Steiner l’Europa sono i suoi «cafés», le terre «umanizzate da piedi e mani», quella «pietas mai estinta» che rimette qualsiasi angolo nella lente segreta della memoria. L’Europa, dunque, è «una storia di due città»: Atene e Gerusalemme, gli imperativi della ragione e quelli della fede. A tutto questo però, conclude, si oppone un suicidio: la nostra odierna stanchezza di europei; il declino dell’Europa rispetto al modello asiatico-americano di consumo e di omologazione, la cosiddetta «fine della storia». Ecco, siamo a metà libro. Siamo nel punto preciso in cui una riflessione tocca il suo apice drammatico, da cui o spicca il volo o rovina. George Steiner non teme nulla, va avanti, fa bene: ora promette ora dichiara «cosa dobbiamo fare», quello che ancora potrebbe essere il compito dello spirito europeo rispetto al nuovo Impero, ai nuovi fondamentalismi assassini, che per Steiner hanno nome e cognome, ovvero il Sud e il MidWest americano, l’Islam, l’incognita cinese. Formidabile. Come davanti al cadavere coperto di ferite, Steiner è Marlon Brando, sembra il Marco Antonio pudico e lucido che parla di vita e di morte: chi svela, a noi popolo europeo, cosa dobbiamo, cosa ancora possiamo sperare. Ma proprio a questo punto, come per uno stupidissimo black out, tutto si spegne. Le promesse si sgonfiano, i sipari crollano nella polvere, il libro finisce di botto. Basta, non ci sono altre spiegazioni: le paginette di proposta, le soluzioni di George Steiner sono incredibilmente banali, modeste, di un’ingenuità sciocca. Ma è possibile scrivere ancora che la forza dell’Europa sarà finalmente la pratica di un «umanesimo laico»? Che il nuovo destino europeo sarà una «tolleranza finora inedita» perché figlia di un «agnosticismo, se non di ateismo» che permetterà un cambiamento profondo nella storia dell’Europa? Il grande Steiner diventa piccolo piccolo. Se non fosse tutto perdutamente tragico, verrebbe da ridere. Steiner si fa le mèches come una vecchia signora. Riciccia, re nudo di una genialità nuda e incartapecorita (ma dove sei Curtius?) l’Europa di Montaigne ed Erasmo, di Voltaire e Kant. Usa gli scacciapensieri. Come se poi non fossero stati proprio quegli autori, col loro cinismo, la vischiosa accortezza, col moralismo e la brutale ironia, ad estenuare per davvero Atene e Gerusalemme, la spiritualità segreta delle due città. Sicuro, rispetto alla notte di San Bartolomeo la tolleranza è tutto. Ma rispetto a certi figli (liberalismo, nazionalismo, opinionismo, laicità) un giorno andrà pure detto che il mito intoccabile dell’illuministica tolleranza ci ha donato solo veleni, dico l’indifferenza borghese, il colonialismo, i tribunali e i conformismi, la gabbia di Pound, Guantanamo, le dittature dei mercati e il crollo della scuola, l’orrore dei giovani d’oggi, una esistenza spuria da «call center». Bah, è proprio finita, se anche George Steiner diventa un lillipuziano. 6 S t los IL LIBRO GIANLUCA MOROZZI PAOLO ALBERTI "Le avventure di zio Savoldi" pp. 222, euro 14 Fernandel, 2006 Nella foto Gianluca Morozzi che con Paolo Alberti ha scritto per Fernandel Le avventure di zio Savoldi GIANLUCA MOROZZI . Una raccolta di racconti in coppia con Paolo Alberti: «Il nostro è un libro che non parla del calcio come metafora della vita, ma dell’epica in minore che vede al suo centro il vero tifoso. Il libro narra di quello che accade a un tifoso che esce di casa per andare allo stadio» Diogene pagina autori italiani SOSSIO GIAMETTA Amare la squadra fino in fondo LE PRIME E ULTIME COSE Una manciata di racconti sul calcio per raccontare con piglio appassionato, ma senza la prosopopea delle trasmissioni calcistiche, cosa vuol dire amare una squadra sino in fondo (e poi scavare). Come sempre Morozzi, qui coadiuvato dalla penna del suo amico e tifoso Paolo Alberti, sostiene la narrazione - ora più dilatata ora costretta in pochissime pagine - con una vena ironico-grottesca sempre più affinata. Al centro di questa passione i personaggi già conosciuti nei romanzi Luglio, agosto, settembre nero e L’era del porco. Il calcio dalla parte dei tifosi I riti della tribù del Bologna ianluca Morozzi è a tutti gli effetti una inarrestabile macchina narrativa. Macina storie con una costanza impressionante, accontentando un pubblico che, di volta in volta, diventa sempre più vasto. Inoltre, come ha scritto Marcello D’Alessandra proprio su Stilos, Morozzi ha dalla sua una «disinvoltura divertita e coinvolgente con cui sa raccontare un paesaggio umano», che lo rende immediatamente prossimo al lettore, senza alcuna mediazione o artificio. Dopo l’esordio con Despero, nel 2001 per Fernandel, la strada di Morozzi è stato un veloce progredire nell’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. Dal 2002 al 2005 sono venuti alla luce Luglio, agosto, settembre nero, Dieci cose che ho fatto ma che non posso credere di aver fatto, però le ho fatte e Accecati dalla luce, tutti per Fernandel. Con Guanda invece sono usciti il noir citazionista Blackout, a breve anche film, e L’era del porco. Ora siamo a Le avventure di zio Savoldi, raccolta di racconti scritta in collaborazione con Paolo Alberti. Qui il calcio la fa da padrone. Ma il mondo del pallone non è visto dalla parte dei giocatori, bensì da quella dei tifosi, di quei tifosi che vanno allo stadio per fare festa, per arrabbiarsi e esultare. La coppia Morozzi-Alberti tratteggia una inusitata epica collegandola strettamente alla loro squadra del cuore: il Bologna. Squadra di molte rabbie e, poche, soddisfazioni. Il tema del calcio potrebbe apparire come ampiamente sfruttato, invece resta una miniera inesauribile di storie per le mille angolazioni da cui è possibile raccontarlo, proprio come ci viene ampiamente dimostrato dai due autori. I racconti del libro (più l’appendice dedicata alla nascita del gruppo ultrà delle Molle Cariche) sfiorano più volte l’aneddoto, in alcuni casi si fanno quasi aforistici, però funzionano perfettamente, come fossero i giocatori di una squadra che lavorano all’unisono per mettere il pallone nella rete avversaria. Quel che fanno Morozzi e Alberti è proprio questo: giocano con onestà, e portano a casa il risultato. Stilos ha intervistato Morozzi. I personaggi che si incontrano nei suoi lsempre una situazione di instabilità, con quel loro schivare il lavoro e la famiglia. Fanno parte di una tua personale visione del mondo? È una mia cifra stilistica. Ho scelto di liberarli da determinati vincoli che potrebbero limitarne i movimenti. Poi, me li vedo proprio così. Mi servono personaggi un po’irrequieti e un po’in movimento. Certo, non è che chi ha una famiglia non possa esserlo, ma a me servono non troppo cristallizzati nelle situazioni, li voglio abbastanza fluidi. Quindi meglio che non abbiano un lavoro e una famiglia. Lo stesso zio Savoldi che dà il titolo al libro fa parte di questa caratterizzazione. Ho pensato a un personaggio di una certa età, G VIVE E LAVORA A BOLOGNA NELL’EDITORIA. "RESISTENZA60" (FERNANDEL, 2005) SERGIO ROTINO con una bella pancia da birra, una fidanzata storica che non sposa mai, che gioca a biliardo con gli amici e millanta amicizie con glorie passate del calcio bolognese. Perché chiamarlo proprio Savoldi? Quel nome gli calzava a pennello, ma non ha riferimenti diretti a Beppe Savoldi. Aggiungo che il racconto dove appare lo «zio» l’ho scritto per "il Domani", quotidiano di area bolognese. Ora dà il titolo al libro perché quando l’ho ripreso e l’ho ampliato mi è sembrato spiegasse bene il progetto e fosse bello di per sé. Avete raccolto nel libro anche altri racconti già pubblicati altrove? Sì, alcuni sono usciti su riviste e quotidiani. Per Le avventure di zio Savoldi ho ripescato dei racconti e ne ho scritti di nuovi. Così come ha fatto Alberti. Nel frattempo portavo avanti L’era del porco. Anche per questo i personaggi di quel romanzo compaiono ne Le avventure di zio Savoldi? Il filone narrativo spesso era coincidente. Per esempio, alla fine del racconto "Il giardiniere" si fa un piccolo riferimento a L’era del porco. Cronologicamente si capisce che il racconto segue il romanzo. Comunque buona parte dei racconti è stato pensato e scritto ancora prima, a ridosso di Luglio agosto settembre nero. Come è nata a lei e Alberti l’idea di scrivere un libro di fiction che parlasse di calcio ma dalla parte dei tifosi? C’è sempre stata questa tensione a scrivere in coppia. Già dieci anni fa abbiamo scritto a quattro mani alcuni racconti, e quattro anni fa un bruttissimo romanzo sul calcio, fortunatamente rimasto incompiuto, che vedeva come protagonisti i personaggi de L’era del porco e al suo centro la passione di Lajos per Cruz… che all’epoca tutto Per odio C e per A amore T A L O G O sembrava fuorché un centravanti. Il romanzo è rimasto nel cassetto insieme con l’idea di fare qualcosa insieme fino a un anno fa… Come sia nata l’idea del romanzo e poi dei racconti di ambientazione calcistica, non ricordo. Probabilmente durante una sessione di fantacalcio, dovendo scrivere qualcosa su Cruz. È da questo giocatore che credo sia sempre partito tutto. Abbiamo così deciso di trasformare il vecchio romanzo in una raccolta di racconti. Del vecchio tentativo sono rimasti alcuni frammenti e il racconto lungo Il giardiniere. Ma non era più lineare riragionare il romanzo? No, proprio non funzionava. Invece, la struttura a racconti era molto più agile, soprattutto ci liberava dal vincolo di una scrittura a quattro mani troppo stretta. In che senso? Nel romanzo ci alternavamo sulla pagina, qui siamo stati più liberi. Ognuno scriveva i racconti e solo successivamente ce li si scambiava, ci si ragionava sopra, li si correggeva e ritoccava quando era necessario, e si cercava di inserirli nella strutture del libro. In realtà nello scriverli abbiamo usato metodi molto vari. Direi che ci sono tre tipi di racconti: quelli scritti solo da me; altri racconti in cui il soggetto è mio e la sceneggiatura di Alberti; altri ancora sono di Alberti, ma lo sviluppo è mio. In "Novecento(nove)2" l’incipit è mio, il resto è tutta farina di Alberti, mentre "Toccare il fondo" è scritto da Alberti ma basandosi su una storia che è accaduta a me. Quando abbiamo terminato di selezionare il materiale per il libro, ho uniformato lo stile. L’appendice è tutta di Alberti, perché racconta come è stato fondato il gruppo di ultrà del Bologna. Come avete lavorato dopo aver scritto i racconti e prima che lei li uniformasse? Come ho detto prima ce li passavamo, e ci scambiavamo pareri… Abbiamo lavorato in questo modo per un anno. Ci siamo corretti, compendiati a vicenda, abbiamo riempito vicendevolmente dei vuoti, soprattutto sul versante calcistico, com’era giusto che fosse. GIORGIO DI RIENZO "Lettere d’amore di un giudice corrotto" pp. 234, euro 16 Marsilio, 2006 Durante il restauro di una dimora signorile a Torino, in una nicchia segreta vengono ritrovati due ritratti, un diario e un mazzetto di lettere. Portano la data del 1889 e svelano un amore proibito e un omicidio. È una storia vera, ma Giorgio Di Rienzo l’ha ricevuta in dono da alcuni amici, proprietari dell’immobile da ristrutturare; e ha pensato, dopo aver consultato anche le carte processuali, di trasformarla in un romanzo, con un intreccio bipartito che lascia intatte le lettere e la ricostruzione dell’ambiente di sfondo. Anche se l’ultima parola, per quella piccola dose di esperienza acquisita sul campo, l’ho sempre avuta io. Il racconto introduttivo con Rain man, personaggio che conosce a menadito nomi e formazioni calcistiche, parla di voi due? No, Rain man è solo un personaggio. Alberti ha una cultura molto più vasta e articolata del semplice conoscere vita, morte e miracoli del calcio. Siamo amici da sempre e condividiamo alcune passioni, fra cui quella per la squadra di calcio del Bologna. Cambia poco fra noi che Alberti sia un ultrà e io un tifoso che va negli anelli più alti della curva. Perché invece di centrare i vostri racconti sui momenti più felici della vostra squadra di calcio avete deciso di narrarne i passaggi più depressivi? Abbiamo pensato che qualsiasi tifoso avrebbe amato e si sarebbe divertito di più a leggere le sfortune di una squadra che non fosse la sua - o anche della sua - piuttosto che conoscere le magnifiche sorti e progressive di una signora del calcio come, per esempio, la Juventus. Io leggerei volentieri un libro scritto da due tifosi del Genoa sulle disavventure della loro squadra, per dire. È quindi più bello raccontare del Bologna che perde a Leffe per 2 a 0. Inoltre ti diverti di più e un po’esorcizzi. Alla fine, al tifoso avversario non importa nulla che tu abbia vinto col Milan a San Siro, è più interessato a leggere di quando hai sofferto. Come mai avete deciso di accostare i racconti in una sequenza non cronologica? È stata una mia idea. Ho preferito mettere in evidenza gli aspetti diciamo «contenutistici» dei racconti, il perché così accostati funzionassero fra loro ed entrassero in risonanza, piuttosto che dare forza alla cronologia degli avvenimenti. Poi alcuni di essi abbracciano un cospicuo numero di anni se non di decenni, e non avremmo potuto inserirli con esattezza da nessuna parte se avessimo deciso per la sequenza cronologica. Nel libro gli ultras sono tutti o quasi persone che cercano nella partita il momento catartico del gol, tutta un’altra cosa dai personaggi violenti che oggi assediano dall’interno gli stadi. Una immagine romantica, forse, totalmente distonica da quella proposta da John King in Fedeli alla tribù, uscito qualche anno addietro. Il nostro è un libro che non parla del calcio come metafora della vita, non parla di nostalgia del pallone con le cuciture laterali ecc., parla dell’epica in minore che vede al suo centro il vero tifoso. Il libro narra di questo, di quello che accade a un tifoso che esce di casa per andare allo stadio, vede giocare la sua squadra, si esalta o se ne addolora, e torna a casa. Non ci interessava descrivere il lato peggiore del tifo, assolutamente. La logica è per Nietzsche una macchina autoaffermativa che rende pensabile la realtà, che per Nietzsche non è pensabile. Tra pensiero e realtà, egli dice, non c’è passaggio, non c’è ponte: i concetti, creati all’interno, ricadono all’interno, sono sempre e solo immagini, prodotte nel caso migliore con vago senso imitativo. Egli accetta evidentemente (come tutti) la teoria scolastica della conoscenza dell’«adaequatio rei et intellectus», cioè della corrispondenza dell’idea all’ideato. Solo che essa non è quella giusta. Quella giusta, basandosi sulla solidarietà dell’uomo con la natura, afferma che le idee non sono un rispecchiamento della realtà, ma sono esse stesse la realtà, una realtà ideale che è identica alla realtà materiale, per cui la mente non crea le idee ma le riceve. Nietzsche batte e ribatte, e con lui i suoi seguaci pedissequi, che la logica si fonda su cose uguali, ma che non esistono cose uguali. Non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, aveva già detto Eraclito. È vero. E ciò ci nega la conoscenza della realtà ultima, sicché va bene dire, come ha detto Nietzsche, che «da Copernico in poi l’uomo scivola dal centro verso una x», tenendo conto che il nichilismo è solo l’ultimo copernicanesimo, il copernicanesimo dello spirito. È vero che conoscere la realtà ultima interessa molto all’uomo e al filosofo in particolare: farebbe comodo a tutti. Ma a una riflessione rigorosa questo desiderio si rivela frutto di un titanismo, che in quanto dismisura va superato. Nietzsche stesso ha riconosciuto che si può vivere una vita piena senza conoscere le cose prime e ultime. Questo è stato sempre il suo indirizzo antimetafisico e in ciò egli ha paragonato gli uomini, con un paragone non si sa quanto felice, alle formiche, che possono vivere la loro vita di buone formiche senza bisogno di conoscere le prime e ultime cose. Per vivere una vita umana piena, però, la logica funziona. Perché nel campo intraumano, che è grande quanto il mondo, le cose disuguali contengono tante uguaglianze o uguagliabilità da soddisfare ampiamente i bisogni sia della logica sia dell’uomo. I frutti di ciò sono sotto gli occhi di tutti, tanto nella vita quanto nella filosofia e nella scienza. Per fare esempi evidenti: grazie alla logica e ai soli calcoli, fatti prima dell’esperienza, l’uomo esce dal suo ambiente naturale, va negli abissi, va sulla luna, manda sonde su Marte e fa tante di quelle cose, che se non ci fosse passaggio tra pensiero e realtà non potrebbe neanche sognarsi di fare. Così anche, pur ignorando la realtà profonda dei corpi, l’uomo allarga continuamente il campo della medicina, che è un campo di conoscenza della realtà chiaramente fondato sull’uguaglianza/uguagliabilità dei corpi, risanando i malati e allungando la vita degli uomini. Le foglie delle querce sono tutte dissimili tra loro; ma agli uomini non interessano magari nella loro individualità bensì nel loro genere e tutte, essendo diverse dalle foglie delle viti e da quelle dei faggi, come queste cadono in autunno per essere sostituite da altre nuove a primavera, al pari degli uomini. Ma gli uomini stessi, non hanno, pur differentissimi tra loro, moltissime cose in comune? Ne hanno in realtà tante e tanto importanti che la comunanza e la solidarietà possono superare di gran lunga differenze e divergenze. È il caso di dare importanza anche in questo senso alla caratterizzazione heideggeriana dell’uomo come «essere-nel-mondo». autori italiani S t los pagina Nella foto Carlo Sgorlon, autore per Mondadori di Il velo di Maya 7 u uno sfondo sospeso tra il reale e il fantastico, in cui la malìa oniriNon credo sia hybris. Cercare di penetrare il mistero è molto umano, purché avca à la Marquez sottende la concretezza spesso tragica delle vicenvenga in una cornice di misura e non di prometeismo rabbioso. Ma in certi terde storiche, si snoda la vicenda di Jacopo d’Artegna, dotato di un preritori della conoscenza, come la fisica, siamo giunti al limite estremo, e ormai coce talento musicale e di un udito prodigioso (sorprendente al pari ci restano solo le ipotesi di lavoro e le teorie. Sono ancora possibili progressi codell’olfatto di Jean Baptiste Crenouille di Il profumo di Suskind). Innoscitivi nella medicina, nell’economia, nella tecnologia. Anche nell’astronauvaso dal «daimon della musica», dallo stesso «spiritello subsannante» dei grantica, ma soltanto per fini di orgoglio e di primato, non certo di utilità. di compositori come Mozart, Jacopo è protagonista di una sorta di «apprendiLa cortina di mistero, come in altre sue opere, avvolge soprattutto le donstato stregonesco» nei meandri più misteriosi della vita, ammaliato dall’incanne. Cosa accomuna Alice, Desirée e Marisol ad altre enigmatiche figure cotesimo di un altro «daimon», quello dell’eros. me Rabal ed Eva? Dal fascino conturbante dell’insegnante di canto, Alice, alla grazia naturale delIl mio protagonista ritiene che la musica è donna. Nemmeno lui sa perché. Forla nomade Desirée, da cui attinge «voglia di vivere e creare», dall’esuberante se anche la musica, come l’Eros, o meglio l’Amore, è un modo di risalire ai miMarisol, che coniuga «l’aspetto cupo di tragedie lontane e l’impetuosità vitasteri e alle forze ignote del cosmo. Nella scala del reale ciò che per noi è solitalissima del suo carattere argentino» alla giovane e talentuosa Arletty, le donne mente diviso tende a fondersi in un amalgama arcano. Molti dei miei personagcostellano la vita di Jacopo e l’intera narrativa sgorloniana: si pensi alla vitalità gi, tra cui quelli da lei ricordati, si sentono affini alla misteriosa sostanza della traboccante di Rabal, che irrompe con la sua forza immaginifica in La luna conatura. Soprattutto le donne, più istintive e intuitive dell’uomo, più legato invelor ametista (1972), o alla misteriosa Eva in La fontana di Lorena (1990). Ince alla razionalità, e purtroppo a tutte le forme della competizione e della lotta. sostituibile fonte d’ispirazione e appiglio nella frenesia quotidiana per il «sonLe donne sono magiche perché la natura è magica, ossia misteriosa. nambulesco» Jacopo, eterea e concreta al tempo stesso, la donna incarna meSi può credere ancora nel sovrannaturale in un’epoca di dominio della taforicamente l’anello tra la realtà visibile e quella sovrannaturale, cui sembra scienza e della tecnologia? L’uno è negazione dell’altro, o sono conciliabili? spontaneamente connessa, perché «simbolo di un mondo dal duplice volto in Per me non c’è nessun baratro tra naturale e sovrannaturale, si tratta soltanto di cui si riunivano il qui e l’altrove nel medesimo tempo». due facce della medesima realtà, dove tutto si mescola e si concilia. Il sovranIl «daimon» della musica e quello dell’eterno femminino, dunque, avviluppanaturale è semplicemente la parte sconosciuta del reale, quella che la scienza e ti in un’unità imprescindibile, che si rivela attraverso un’intuizione illuminanla tecnologia non sono riuscite ancora a spiegare. Einstein ha ipotizzato quattro te come un’epifania: «La musica è donna» perché «forse, per sentire e vivere dimensioni del reale. Fantappié sedici. Zichichi quarantatré. profondamente la musica, bisognava inserirsi dentro le forze universali delle viLo spiritualismo che pervade la sua opera esclude un dio, un demiurgo? La ta, di cui l’eros era quella dominante». La donna, insomma, come simbolo tanrealtà è regolata dal caos o dalla necessità? gibile, dalla fisicità spesso destabilizzante, di quell’«Altrove» cui il composiL’esame obiettivo della realtà ci induce a dare una risposta ambigua. Il mondo tore tenta di dare forma concreta attraverso un progetto bizzarro, dirigere un’ora volte sembra rispondere a un piano prestabilito, altre volte sembra dominato chestra tutta al femminile. Jacopo così diventa, come gli altri protagonisti deldal caso e dal caos. l’opera di Sgorlon, un punto di riferimento, il fulcro intorno a cui si imbastiscoRitorna nel suo libro l’esortazione a un rapporto armonico tra uomo e nano le vite degli altri personaggi. tura, incrinato dall’irrompere della civiltà di massa. Come può l’uomo reÈ un «profeta», Jacopo, uno «sciamano» visionario alla Blake, che non si piecuperarlo? È cambiato qualcosa nella sua concezione di questo rapporto ga al culto dilagante della ragione e si rifugia in una dimensione popolata da sugrispetto ai suoi esordi? Penso a Il vento nel vigneto. gestioni arcane e inafferrabili, forse perché pulsa nelle sue vene quel «quid zinUn rapporto armonico ci renderebbe meno infelici e disperati. E sarebbe l’unigaresco» della nonna boema violinico modo per salvare la Terra, che le sta. Jacopo disdegna le soluzioni proprevisioni ecologiche vedono avviata vocatorie della musica d’avanguar- CARLO SGORLON . Un uomo con uno straordinario talento musicale e una smodata attrazione per alla catastrofe. Solo indirettamente la dia, ridotta a sterile virtuosismo («una colpa è della civiltà di massa. La caucittà del futuro, concepita in modi per- le donne. «Siamo figli del tempo e della precarietà. Dobbiamo farci bastare il provvisorio e cercare di sa diretta è l’eccesso di produzione fettamente razionali, di cui si parla industriale, la bomba demografica, con grande ammirazione, ma poi nes- dimenticare che tutto è destinato alla fine. Fratellanza, solidarietà, spirito alpino sono molto vivi da l’ingordigia sterminata degli uomini. suno vuole andare ad abitarvi») e, nodei miei esordi sono camnoi, e lungo tutto l’arco delle montagne. Speriamo che tutto ciò duri finché ci sarà il genere umano» Dall’epoca vello Faust - che però non cede alle biati piuttosto il mio gusto, la mia poeforze del male -, lascia fluire attratica. Nel 1960 risentivo un po’ di Casverso il suo corpo l’ispirazione musisola. Oggi ritengo di non sentire apercale che «veniva dall’arcano altrove tamente di nessuno. delle sue fantasie, qualcosa che era un E il musicista, l’artista? È creatore, "nonluogo" e un "nontempo", di cui o solo strumento, «ponte», attravernulla sapeva», ma che lo induceva naso cui la sua arte fluisce per poi turalmente a «dipanare i suoi cento diffondersi? gomitoli musicali, custoditi negli inviTutti noi, artisti e non, possediamo fasibili spartiti della mente». Una musicoltà e talenti che vengono da lontano: ca, dunque, che affonda le sue radici in dagli antenati, dalle eredità ancestrali quegli «archetipi sonori» che richiadalla natura, dalla vita, dalla terra, dalmano le idee platoniche, le forme anle stelle, dall’universo, che a sua volta cestrali che Jung distingue nell’imè legato a origini misteriose. VIVE A CATANIA. SVOLGE UN IL LIBRO maginario collettivo inconscio, fonte Jacopo si definisce un profeta, stregato dal mondo nomade e zingaresco, amDOTTORATO IN GEOGRAFIA A CARLO SGORLON del pathos dell’arte universale. maliato dai travestimenti teatrali. Artista romantico in preda allo streben? LINGUE DI CATANIA "Il velo di Maya" Ma tutto è avvolto da uno strato di meCerto, è legato anche al romanticismo tedesco. A Schelling in particolare, per il pp. 307, euro 17,50 re illusioni: la fascinazione impalpabiquale non c’era differenza assoluta tra materia e spirito. Il filosofo romantico e Mondadori, 2006 le delle note, quella indecifrabile delpanteista aveva intuito che, in fondo, tutto è spirito. Infatti, come insegna la fiTERESA GRAZIANO l’eros, la realtà tutta è cinta da quello sica moderna, la materia è quasi vuota e inesistente. Esistono piuttosto le forze che Schopenhauer definisce il velo di cosmiche, in varie forme. Solo le particelle sono materia, fornita di massa e dimensione spaziale. Il resto è energia incorporea. Maya, che separa l’uomo dal noumeno kantiano, la vera essenza dell’essere: perJacopo sostiene che l’emozione suscitata dalla musica sia frutto di archesino la musica, linfa vitale per Jacopo, non è che «una vibrazione dell’aria, un Affresco corale, romanzo di formazione, avventura picaretipi. Si può parlare anche di archetipi nella scrittura? soffio, un niente, un vento lieve che diventava ai sensi degli uomini più splensca, viaggio iniziatico dai contorni misteriosi, favola che si Credo che dentro di noi ci siano archetipi musicali ai quali obbedisce in qualche dido di una fatamorgana». Le sorprendenti vicende di Jacopo - e le riflessioni tinge di tocchi magici e suggestioni surreali, celebrazione delmodo la musica classica. Le dissonanze, le pause eccessive, le rotture di stile, gli agrodolci dell’autore - si dipanano fino all’epilogo attraverso una scrittura che la musica e dell’eros, omaggio vibrante e commosso allo spiartifici dei codici musicali intellettualistici sono rifiutate dal nostro istinto. Altrasuda il gusto del racconto tradizionale, che si trastulla con metafore surreali, rito alpino e, infine, malinconica meditazione sull’illusorietà meno in generale. Anche nella narrativa vi sono archetipi e, per così dire, regoma sa anche ricordare con intenso realismo lirico la tragedia della ritirata degli di ogni azione umana: in Il velo di Maya si intessono temi rile universali, a cui un narratore non può sottrarsi se non al prezzo di scrivere coAlpini dalla Russia, riconoscendo esplicitamente l’eredità - letteraria, umana correnti dell’opera sgorloniana, ammantati da una patina se noiose e scostanti. delle opere di Rigoni Stern e Bedeschi. sottile di malinconia che non preclude però la leggerezza La dialettica tra musica classica tradizionale e musica d’avanguardia doSgorlon rievoca, infatti, quell’«avventura terribile, ma anche sconfinata e leggioiosa del raccontare attraverso una scrittura fluida e densa mina il libro. Può considerarsi come metafora di un’altra dialettica, quelgendaria, come fosse la guerra di Troia» attraverso le ferite non ancora rimaral tempo stesso. la tra narrativa tradizionale e narrativa sperimentale? ginate del padre di Jacopo, Ranieri. Sopravvissuto alla tragedia, sebbene mai del No. È metafora soltanto di se stessa. Però il problema esiste anche in letteratututto tornato, Ranieri consacra la sua vita al progetto di un Tempio Ossario che ra e nelle arti figurative, anzi nelle arti in genere, come ho già sostenuto in La foneterni il nome dei morti perché «nei suoi strani spazi mentali l’esistenza delle persone nel ricordo e nelle parole aveva quasi la medesima consistenza della loro energie cosmiche e alle particelle. Altrimenti impazziremmo. Conosco molti fi- tana di Lorena e Il regno dell’uomo. Non condanno l’avanguardia, ma non la vita reale»: ma «anche il Tempio Ossario rientrava nella logica del mito e del- sici che si dedicano anche ad attività molto concrete, per esempio la politica, pro- sento. Per molti artisti, specie figurativi, l’arte è oggi solo una trovata. Per me è uno strano ossimoro. Invenzione, novità, ma anche tradizione, legata al nostro prio per non vivere soltanto d’astrazione. l’illusione». Stilos ne ha parlato con l’autore. Il velo di Maya, dunque, avvolge la realtà. Che senso ha questo sforzo osti- Anche la musica, anche l’eros, dunque, ammantati dal velo. Dono degli dei gusto profondo, che viene dal Dna o da chissà dove. È dunque possibile una narrativa che sia innovativa pur restando nel solnato di ricordare la tragedia, se tutto è destinato a scomparire, inghiottito o meri inganni? Senza dubbio doni divini. Per il D’Annunzio, in un apologo famoso, l’illusio- co della tradizione? dall’oblio? O il senso di fratellanza dello spirito alpino sopravvive? Noi uomini siamo figli del tempo e della precarietà. Dobbiamo farci bastare il ne era il tesoro dei poveri. Esistenzialisticamente parlando, tutti gli uomini so- Certo. Ogni narratore è diverso dall’altro, come non ci sono due firme uguali. Ovviamente, un narratore è tanto più importante quanto più è nuovo, pur risponprovvisorio, e cercare di dimenticare che tutto è destinato alla fine. Fratellanza, no poveri. solidarietà, spirito alpino sono molto vivi da noi, e lungo tutto l’arco delle mon- Ammesso che l’uomo possa cogliere l’essenza, sarebbe una conquista du- dendo ai canoni della naturalezza, e quanto più in rapporto con l’universale. ratura? Fonte di felicità, o di quell’eterna insoddisfazione che induceva Anche la scrittura, come la musica, è fatta di «infiniti nulla», avvolta dal vetagne. Speriamo che tutto ciò duri finché ci sarà il genere umano. Le facoltà umane non possono cogliere la vera essenza che si cela dietro il Schopenhauer a considerare la vita un pendolo oscillante tra la noia e il do- lo di Maya? La musica e la scrittura sono attività tipicamente umane, che ci realizzano. Senlore? velo. La musica, l’arte, possono, invece, squarciarlo? Gli artisti, e in genere la gente che riflette in profondità sulle cose, vedono più Difficile dirlo. È certo che l’uomo più ha - anche nel campo della conoscenza - za dubbio però sono attività relative. Quindi non sono né infiniti nulla, né raggiungimenti assoluti. La nostalgia di assoluto e di infinito ci accompagnerà per lontano degli altri. Ma più conoscenze abbiamo sul reale, e più il velo di Maya e più vorrebbe avere. resiste, al massimo si sposta all’indietro. Anche il velo è però necessario, renden- Tentare di squarciare il velo è sinonimo di hybris? O, d’altra parte, accet- sempre: la metafora di questa situazione umana è suggerita in alcuni quadri metafisici di De Chirico, intitolati appunto Nostalgia d’infinito. do più accettabile la nostra esistenza. Non possiamo vivere solo pensando alle tarlo è sinonimo di passività rinunciataria? S Il demone per la musica è donna ma note ed eros sono solo illusioni Anche un omaggio allo spirito alpino autori italiani pagina 8 R e c e n s i o n i ANNA MARIA MORI . «Di fronte a un’identità per ANNA MARIA MORI cui ho pagato un prezzo per tutta la vita ho voluto "Nata in Istria" restituire a me stessa se non l’orgoglio almeno la pp. 290, euro 16 Rizzoli, 2006 pienezza di poter dire: sono nata in Istria» VIVE A GENOVA. È STATO PER MOLTI ANNI CAPO DELLE PAGINE CULTURALI DEL "SECOLO XIX" SERGIO BUONADONNA n silenzio durato mezzo secolo, il pudore di evitare le domande insidiose, il marchio di fascista. Così migliaia di esuli istriani hanno vissuto il dopoguerra, «rintanati» in molte regioni italiane ad aspettare che diritti e identità potessero coincidere. È capitato purtroppo anche a chi - per condizione o professione - avrebbe potuto smarcarsi. Ma certe convinzioni sono dure a morire e in tanti ne hanno fatto le spese. La vicenda personale di Anna Maria Mori non è diversa, nonostante la sua apprezzata attività di giornalista ed i suoi libri-inchiesta sulle donne, i giovani e gli esclusi dal lavoro. Ma c’era e pesava un’esclusione più forte: l’essere istriana, tacendo le proprie origini per evitare discussioni. Il tempo, se non ha sanato le ferite, sta almeno facendo giustizia. Così dopo Bora del 1999, scritto con Nelide MIlani, con cui Anna Maria Mori dava voce alle donne istriane, adesso con Nata in Istria, non ha più bisogno di nascondersi, ma ha potuto raccontare con l’amore del ricordo, la passione per la propria terra d’origine abbandonata piccolina con i propri genitori alla fine della Seconda guerra mondiale, e la ricerca di molte verità: che significa essere istriani, parlare il dialetto istro-veneto, e perfino riproporre la propria cucina (in Italia come a New York, dove una esule ha messo in piedi un ristorante che odora di strucoli e sugo di gallina. Questo e molto di più c’è in Nata in Istria per compensare anche un’assenza che pesa nella condizione dell’esule: la propria geografia. «Quella ammette Anna Maria Mori - mi manca. E ho cercato in qualche modo di riprendremela». Stilos l’ha intervistata. Com’è nato questo libro che racconta di un pudore vinto e porta alla luce una memoria rimossa? La mia è un’operazione dichiarata e consapevole fin dall’inizio. Mi produce grande malessere il fatto che dopo sessant’anni si commemorino le foibe, ma se io dico Istria, cinquanta milioni di italiani rispondono foibe e non sanno altro. Ci vanno in vacanza e tornano dicendo «sono stato in Croazia», così infierendo ancora su questa disgraziata terra trasformandola in un enorme cimitero e in un monumento ai caduti. L’operazione consapevole è stata perciò quella di gettare un granellino agli italiani e ricordare che oltre alle foibe c’è una bellezza che pochi attribuiscono all’Istria, pensando quasi tutti che sia Slovenia e Croazia. Perciò mi è piaciuto raccontare questa terra in maniera qua e là anche leggendaria: la sua storia, la sua natura, la sua cucina perché la cucina racconta i passaggi di poteri, di storie, di invasioni, di amalgama di culture: un piccolo vademecum agli italiani che non sanno. E ne è soddisfatta? Penso di aver fatto anche un’altra operazione inconsapevole su di me. Di fronte a un’identità per cui ho pagato un prezzo per tutta la vita, un’identità negata, di cui sono stata costretta perfino a vergognarmi, ho voluto restituire a me stessa se non l’orgoglio almeno la pienezza di poter dire: sono nata in Istria che è una terra bellissima, disgraziata ma bellissima. Ma terra di italiani diversi. Sì, lo diceva Quarantotti Gambini: sono un italiano diverso, irrimediabilmente diverso. Io ho evitato per una vita la mia identità, figlia di un padre liberal-anarchico che - ammalatosi precocemente - non ha potuto proseguire la sua carriera di capitano di Marina mercantile, e che per poter avere un altro posto pubblico avrebbe dovuto prendere la tessera del Fascio, ciò che non ha voluto fare. Non ha mai chiesto la casa perché eravamo profughi, né sovvenzioni, né abbiamo mai fatto parte di associazioni. Povero papà, per questo suo orgoglio ha sempre rifiutato la pensione di invalidità che pure gli sarebbe spettata. Ed io mi sento figlia della sua disobbedienza, che ho vissuto rimanendo sempre distante rispetto alla destra ma anche rispetto ai luoghi comuni della sinistra. Nel libro lei rivive i suoi ricordi di bambina attraverso sapori, dolcezze, affetti. In che modo tutto questo ha attraversato la sua vita? È sempre stata la mia parte privata. Io parlo perfettamente il dialetto istroveneto perché l’ho sempre parlato con S t los U La mia Istria delle foibe bellissima e disgraziata SECONDA LETTURA Una terra di confine fatta di tanti drammi individuali « se la bellezza che hai fissato VIVE A TRIESTE. "IL MASCHIO te e quelle ad esse intrecciate in narrazioni dove i ricordi personali si nella tua prima memoria inECOLOGICO" (1994), "IL CIEsommavano al dramma collettivo di fantile fosse, insieme a quelLO SULLA PROVENZA" (2004) quei fiumi di italiani che sulle navi la del volto di tua madre, quella delgiunsero a Trieste o di quegli istriani la terra in cui sei nato, e che, senza sache rimasero in Istria, imparando a perlo e volerlo consapevolmente, MARINA TOROSSI TEVINI dimenticare l’italiano, i loro nomi, le continuerai a cercare per tutto il resto loro radici. Destini diversi, ma analodella vita?" È intorno al tema della bellezza di una terra violentata dalla storia che ruota il li- ghi nella tragedia che li attraversò. bro di Anna Maria Mori, intessuto di ricordi personali e Il viaggio in Istria della Mori parte da Trieste. È una Triedi storie collettive, di sapori e di odori e di una profonda ste a due passi dalla tragedia e sempre un po’ a mezz’aria, una Trieste in cui la gente «passeggia piano, calma, nostalgia per ciò che è andato perduto. Anna Maria Mori, giornalista di "Repubblica", molto at- e sembra lontana, persino indifferente rispetto alle tragetiva in campo culturale e sociale, è nata a Pola e come tan- die globali». ti ha avuto in sorte un terribile strappo dalla terra natale. Ma il libro è rivolto soprattutto a quelli che non sono trieNata in Istria è un viaggio nella memoria, nella storia e stini, a quegli italiani «per cui l’Istria è non meno lontanei sentimenti. L’autrice lo concepisce come un dono al- na e sconosciuta della Patagonia di Chatwin». L’Istria, la sua terra amata. Le parole hanno un grande potere nel ora croata, si reclamizza come luogo turistico a buon merbene e nel male e raccontare significa «ridare a una ter- cato e d’estate richiama turisti variopinti per il solito tura e al suo popolo martoriato e misconosciuto il giusto or- rismo «cannibalico» e banalizzante. Turisti che considegoglio dell’appartenenza», l’identità, la dignità negata e rano solo la geografia dei luoghi e non sanno, e forse non vogliono neppure sapere, la storia dei luoghi, intrisa di perduta. «Gli istriani hanno bisogno di parole che raccontino, che sofferenza, di violenza e soprattutto di una complessità dicano la verità», che ricostruiscano non solo la loro sto- che frastorna. A questa parte d’Italia l’autrice sente il deria, ma la storia intera della loro terra, l’Istria, così bella siderio di raccontare almeno un po’del dolore e delle viche piacque a molti, ai greci, agli antichi romani che vi cende storiche che stanno dietro a quel mare bellissimo costruirono ville sontuose, ai turchi, ai bizantini, agli im- e narra con parole struggenti le condizioni dei profughi peratori austroungarici, alla repubblica di Venezia e «pur- nei campi di Opicina ammassati in baracche di lamiera, troppo piacque anche al fascismo e poi al comunismo del ma anche la sofferenza di quelli che sono rimasti in una maresciallo Tito ed è piaciuta, e piace, alla Slovenia e al- terra che velocemente si è snaturata davanti ai loro occhi, la Croazia», piacque e piace ma, come succede talvolta rendendoli esuli in patria. alle donne, non per amore: «Quel triangolino di terra è Quello che muove il mondo, scrive Anna Maria Mori è talmente bello e speciale che ha spesso indotto alla vio- la paura e la speranza. Qualcosa accomuna gli odierni lenza» ed è divenuto nella storia terra di conquista, di do- esodi dai paesi del Terzo mondo a quello degli esuli domini e di predomini. Troppi dominanti e troppi domina- po la guerra. Non si può vivere senza speranza; se queti, troppa grandezza e troppa povertà, troppe razze e lin- sta viene a mancare ci si ammala o ci si uccide. La speranza è in qualche modo imparentata con l’amore, ed è gue e culture diverse tra loro. Il libro è articolato in sette capitoli che focalizzano l’at- forse ciò che oggi manca di più. Abbiamo alle spalle un tenzione su argomenti diversi, ma tra loro profonda- passato recente di storie terribili, i cui caratteri restano mente connessi: dal rapporto con la madre al ricordo dei ancora non del tutto chiari ma che addensano su di noi cibi della cucina istriana; dalle tante storie di istriani che ombre inquietanti e non ci permettono la serenità e in hanno scelto di rimanere e sono stati delusi, al dolore de- qualche modo la speranza. gli esuli, alle lacerazioni che accomunarono tutti, gli an- Ci sono tante Istrie. L’Istria di Tomizza che offriva neldati e i rimasti, perché su tutti la storia passò con esiti de- la sua casa vicino a Matarada un bicchiere di Malvasia vastanti. I tanti drammi personali che la Mori racconta e un piatto di buzolai (biscotti istriani), l’Istria italianishanno in comune l’essere testimonianza di cosa può la sima sulla costa e slava a due passi, verso l’interno, l’Istoria nei punti in cui il territorio è più fragile, nei luoghi stria dei tanti paesi: Montona, Rovigno, che sembra un di confine insomma, dove a ogni soffio di guerra l’iden- presepe sul mare, veneto nelle sue case chiese campieltità è minacciata. «Forse l’unico modo per neutralizzare li, Orsera i cui abitanti nel 1936 erano quasi seimila e ora il potere letale dei confini è sentirsi e mettersi sempre dal- sono meno della metà e gli italiani sono pressoché l’altra parte» aveva scritto Claudio Magris in Microcosmi scomparsi, l’Istria di Albona, città fortezza sorta su un antico castelliere, l’Istria di Salvore divenuta un campo (che la Mori cita nel capitolo "Frontiere"). All’Istria Anna Maria Mori aveva già dedicato Bora, profughi nella recente guerra degli anni Novanta, e infiscritto nel 1999 a quatto mani con Nelida Milani. Entram- ne l’Istria di Pola, la città natale della scrittrice che in be le scrittrici, dal destino molto diverso, in quell’opera questo viaggio la ritrova profondamente mutata e diveoffrirono la loro straordinaria capacità affabulatoria per nuta - come l’autrice osserva con amarezza - «una città testimoniare un passato terribile, raccontando le loro vi- balcanica». E mia madre, con grandi sorrisi ironici della mia famiglia che lo considera una stupidaggine ma io appena prendo il telefono e parlo con qualcuno a Trieste, mi esprimo in dialetto. È la mia infanzia. Se qualcuno oggi mi chiede quali sono i miei piatti preferiti, rispondo i crauti, il maiale affumicato e lo strudel. Di più, sento il doverismo istriano, cioè il senso del dovere fortissimo, il valore della responsabilità personale, il senso morale che è al di sopra delle ragioni politiche, che mi sono portata nei rapporti umani e di lavoro. Come dice Freud: ognuno si porta dietro la sua impostazione. C’è stato un episodio determinante nella sua infanzia? Più d’uno con quel che abbiamo passato, ma ricordo in particolare quello del rosso d’uovo, una cosa oggi impensabile. Da ragazzina avevo una piccola anoressia che poi è diventata bulimia e quindi mia madre cercava di darmi l’uovo crudo delle nostre galline e io l’ho sputato. Lei lo ha ripreso da terra e me lo ha riinfilato in bocca. Le lascio immaginare quello che ho provato, ma così ho imparato. Poi c’è la vicenda del pianoforte, che ho cominciato a studiare quando avevo quattro anni. Mio padre si metteva accanto a me con la sveglia, dovevo fare un’ora di solfeggio, un’ora di esercizi Clementi. Poi sono arrivata al liceo classico e non ce la facevo a studiare cinque ore di pianoforte e sei per il liceo. Così mio padre mi ha detto che il pianoforte non era un diverti- Nella foto Anna Maria Mori, autrice per Rizzoli di Nata in Istria mento, o lo studi o lo vendo. Lo ha venduto. Io sono figlia di questa impostazione e del mai dimenticato olio di fegato di merluzzo. Ogni tanto ancora oggi si sente esiliata in casa? Mi sento un po’ in esilio dappertutto, ma non tornerei in Istria. Però per esempio, voglio bene a Roma che mi ha accolto come non mi ha accolto Firenze, perché nella sua sovrana indifferenza Roma lascia vivere, non giudica. Però dopo tanti anni che ci vivo avrei cambiato volentieri città di nuovo. L’esodo è un fatto politico, di cronaca, storico, è una cosa ferma nel tempo, l’esilio è una dimensione psicologica che ti entra dentro e con la quale convivi per il resto della tua vita e ti senti un po’in esilio dappertutto. Lei scrive spesso questa frase «storia, storie» , seguita dai puntini, come dire che il suo libro mescola la grande storia con il privato di tante persone. Ha voluto raccontare una memoria della storia? Sì forse è l’idea degli Annales di fare storia raccontando anche le piccole storie della gente. Per me è stato straordinario quel racconto che ho raccolto in Istria di una coppia mista, lei italiana, lui croato, lei fa gli spaghetti con il sugo alla bolognese e domanda al bambino che ha tra l’altro un nome americano, «tu come la vuoi la pasta?» e lui risponde «come papà, con il sugo e sopra lo yogurt». Una risposta che racconta più di mille trattati. Non ci sono solo voci di donne in Nata in Istria e questa per lei è una novità. Dovendo raccontare un piccolo popolo ho parlato con uomini e donne e ho garantito a tutti l’anonimato perché fossero più sinceri e non avessero paura perché, checché se ne dica, lì c’è ancora tanta paura. C’era una donna che aveva voglia di incontrarmi e che aveva avuto infoibate la madre e la sorella, ma non ce l’ha fatta; alla fine mi ha mandato a dire di no, non ce la faceva anche per paura. Che cosa ancora non è stato detto di Goli Otok e di Pvrc? Ma di Goli Otok è stato detto un po’ tutto. Eligio Zanini che lì è stato internato ha scritto un libro Martin Muma, che ormai circola in fotocopie perché non si trova più, dove racconta questo orrore pazzesco. Io ho ripreso le testimonianze che riguardano il chiodo. Di che si tratta: tra questi disgraziati internati nel lager di Tito circolava un chiodo che quando uno decideva di suicidarsi veniva piantato nel muro. Il prigioniero prendeva la rincorsa da lontano e si infilava questo chiodo nella gola per morire. Cose mostruose, riprese benissimo, sia pure in una forma fantastica, da Claudio Magris in Alla cieca. Quanto al campo di Pvrc ne ha parlato un curioso personaggio che si accreditava come ex ufficiale dell’armata jugoslava. Diceva «io non so niente di politica, ma c’era un altro campo di sole donne a Prvc». Sarebbe interessante andare a vedere, perché di Goli Otok è uscito molto poco: i sopravvissuti erano stati terrorizzati, non dovevano parlare, a rischio della vita e, non hanno parlato. E chi è ancora vivo e sa, non parla. Oggi la Slovenia è ormai prossima all’ingresso nell’Unione europea, si parla sempre più insistentemente anche della Croazia, ma in che modo può sorgere quest’unione se i contrasti non sono ancora sanati psicologicamente e permane la politica discriminatoria nei confronti della minoranza italiana che la Croazia conduce in Istria? Lavorando su di me e su questo tema ormai da una quindicina di anni mi sono fatta un’idea, discutibile, soggettiva: questi popoli hanno convissuto quando c’era sopra di loro un padrone altro. Sotto l’Austria-Ungheria andava benissimo, nonostante gli irredentismi italiani; mia madre mi raccontava sempre che a Lussinpiccolo, dove era nata, c’era la scuola croata, quella austriaca e quella italiana; Vienna governava un po’ come l’impero romano. La dittatura di Tito ha tenuto unite le diverse etnie, ma appena è arrivata la democrazia e sono nate le repubbliche si sono scannati. Anche in Slovenia ancora oggi, ci sono diecimila cittadini apolidi che Lubiana non vuole riconoscere. È incredibile, succede nella più «moderna» Slovenia. La Croazia non vuole l’aliscafo con Trieste, si oppone a qualunque collegamento semplice, il fatto che tutti possano acquistare una casa lì tranne gli italiani, è una follia. E ancor oggi quando vai in Croazia, senti comunque aria di fascisti. Il suo libro si sofferma in modo affascinante su Trieste. Perché? Ian Morris ha scritto quel magnifico libro che è Trieste o di nessun luogo, opera che - scritta da un inglese - ha uno sguardo sereno e oggettivo sulla città. Trieste è bellissima, non sembra Italia; così almeno deve sembrare a un turista straniero che abbia visitato Napoli, Roma, Firenze. Non a caso Trieste era chiamata la piccola Vienna. È una città ammaliante con una luce nordica e una delle piazze più belle del mondo, Piazza dell’Unità, dove però appena ci stai più di una settimana ti accorgi che i rancori non sono mai sopiti, ci si confronta ancora su cose non risolte, su opposti estremismi stupidi, come sono sempre gli estremismi. Insomma è una città non facilissima. Questa è l’identità di frontiera o è una particolare identità di frontiera? Credo che siano le identità di frontiera in generale e condivido quella frase di Magris che ho scelto da Microcosmi «appena uno viene fuori da un confine è bene che faccia un passo più in là». Non so se la frontiera sia una ricchezza, ma una maledizione di sicuro. Il libro ogni tanto viaggia attraverso gli scrittori e c’è una frase della Yourcenar che è molto significativa: «Di tanto in tanto verrà anche l’ordine». Sostanzialmente così è stato, no? Credo nell’Europa e penso che un’entità sopranazionale restituirà un equilibrio a quest’area che vive uno squilibrio ancora forte. L’Europa deve andare a vedere che cosa succede, deve regolare le cose, non può solo accettare a braccia aperte senza dire nulla anche di fronte all’aperto sostegno che c’è ancora in Croazia verso criminali di guerra come il generale Ante Gotovina. Fra l’altro la condizione degli italiani che sono rimasti è tuttora difficile se non in alcuni casi più complessa dopo la divisione dell’ex Jugoslavia. È molto difficile per alcuni, altri sono furbi. Il problema è doppio, e devo dire una cosa impopolare, forse impolitica: da una parte c’è l’ideologia, dall’altra ci sono le sovvenzioni che corrompono come sempre accade. C’è una corsa alle sovvenzioni e c’è il grande potere di chi le gestisce. Che succede all’italiano che oggi va in Istria e trova una geografia politica diversa, ammesso che lo sappia? Non lo sa, non sa nulla. Va a nuotare in questo mare che sembra veramente le Maldive, mangia l’aragosta o gli scampi alla busara ed è convinto di trovarsi in un posto che è sempre stato Croazia e che non ha un legame con la nostra storia. E non vede, perché basta guardare i campanili che sono uguali a quelli di San Marco. L’anno scorso a Bologna io mi sono sentita fare la solita domanda dal pubblico: dov’erano gli italiani in Istria prima della guerra ’15-18? E mi arrabbio, e dico «ragazzi studiate la storia. Lasciamo stare Roma, ma Venezia non vi dice niente?» Cinque secoli di Venezia, tant’è che la prima operazione dopo l’annessione alla Jugoslavia è stato lo scalpellamento gigante dei leoni di Venezia, anche in Dalmazia. Uno sfregio. Il suo libro è anche un viaggio fra gli autori a cui più si sente culturalmente legata. Per esempio Tomizza. Io ero molto sua amica e ho tentennato prima di scrivere il capitolo su di lui, su questo suo io diviso: da che parte stare. Su questo suo sentirsi sempre maltrattato: non gli bastava mai niente, non gli bastava il Campiello, si sentiva sempre emarginato. E a un certo punto col suo Pranzo di Babette irrompe Karen Blixen. Perché? Perché lei è proprio il simbolo di una donna esule che attraverso il cibo ricostruisce la sua vita come le donne istriane che cucinano i pranzi di nozze riproponendo la cucina istriana proprio come la Babette di Karen Blixen con il suo pranzo mirabolante, il pranzo della vita. La forza della bellezza restituisce la dignità? Mi piacerebbe, è una speranza. Certo la bellezza è un segno distintivo in più. Invece tutto quello che ha raccontato l’Istria fino ad oggi è un segno meno. E quindi è la violenza, le foibe, l’esodo, i campi profughi. Il Giorno del Ricordo quest’anno celebrato per la seconda volta il 10 febbraio serve? Credo di sì, è importante. Sono contenta che questa decisione sia stata votata all’unanimità, che non sia stata una scelta di parte, che serve per ricominciare un discorso che non sia solo quello delle foibe, ma dell’Istria perché l’Istria - ricordiamocelo - non è solo una foiba. autori italiani S t los pagina Paola Calvetti, autrice per Bompiani di Perché tu mi hai sorriso 9 i cerca la verità ad ogni costo nell’ultimo romanzo di Paola CalvetUn legame da autentica fanatica, la amo di un amore monolitico, privo di discerti. Perché tu mi hai sorriso ha le tinte di un giallo. Vi si trovano avnimento. Ma ci è arrivato prima il grande Michael Cunningham con "The vicinate tre generazioni, nonna, figlia, nipote, ma l’elemento centraHours": non potrei mai nemmeno osare avvicinarmi a tale perfezione stilistica le è la figlia, con la sua ricerca di indizi a carico della madre, nelle sei e narrativa. Rileggendola, ho trovato quella lettera e mi è sembrata una bella episettimane trascorse accanto a lei in attesa della fine. Un vecchio forgrafe. In tutti i miei romanzi si addensano le mie passioni. L’addio era una ditepiano ritrovato tra gli oggetti da buttare e sottoposto a restauro diventa simchiarazione d’amore a Colette, ne racconto il funerale così come l’ho letto sui bolo di un nuovo percorso, in un tentativo di ricostruzione dei rapporti. giornali dell’epoca. In Né con te né senza di te c’è Proust: la mia visita all’HoMa se da una parte ci sarà di nuovo la musica, dall’altra si individua una protel di Cabourg nel novembre del 2002, fu un vero e proprio pellegrinaggio. Ho gressiva e forte dissociazione, che trasforma Nora in un carnefice, nel momenla fortuna di essere pubblicata da un grande editore, ne approfitto per infilare nei to stesso in cui osserva e accudisce la madre, «bella - nella sofferenza - come romanzi quelle parti di me che altrimenti resterebbero nella mia libreria. Sono il Cristo del Mantegna». Infatti una pregressa depressione personale con latenpassioni condivise da molti lettori, l’ho scoperto presentando i romanzi in giti istinti infanticidi, rimossa, riaffiora, in una forma di transfert sulla madre moro per l’Italia e adesso anche sul sito www.paolacalvetti.it dove mi scrivono. rente, lasciando Nora a combattere tra desiderio di vendetta e amore filiale. Attraverso la protagonista di Perché tu mi hai sorriso, Nora, il romanzo si Un romanzo, quello della Calvetti, costruito con sapiente e studiata varietà di apre su un fenomeno così drammaticamente diffuso oggi, l’infanticidio. Le registri, con una trama che si arricchisce come per accumulo di elementi tratti conclusioni dell’avvocato di difesa, Michele, ne danno una spiegazione a da un cappello a cilindro, dove il realismo crudo delle situazioni sfiora talora livello psicologico e scientifico. Ci sono dei casi di cronaca particolari a cui il parossismo. Stilos ha intervistato l’autrice (direttore della comunicazione al si è ispirata? Touring Club e finalista al Bancarella con L’amore segreto del 1999) che con No, non in particolare. Il reato di infanticidio esiste da sempre. Nel romanzo, questo titolo si è attestata ai primi posti nella vendita di narrativa in Italia. in un dialogo tra Nora e Michele, è il marito a spiegarle che in epoca vittoriaTra i suoi romanzi, L’amore segreto (1999), finalista al premio Bancarella, na era «utilizzato» come strumento di controllo demografico. Certo, come maL’addio (2000), Né con te né senza di te (2004), Perché tu mi hai sorriso, c’è dre di due ragazzi, ogni volta che le cronache ci informano dell’ennesimo inun ritorno di tematiche a lei particolarmente care? fanticidio o figlicidio la mia coscienza ne è turbata. Nel romanzo Nora trova Quello che lega i miei quattro romanzi è la musica: ce n’è ovunque, sparsa qua le prove dell’infanticidio materno, ma il suo è un accanimento mentale. Sarà e là tra le pagine. La Quarta Sinfonia di Johannes Brahms è lo spunto per L’aMichele a svelare al lettore la verità. more segreto, La Traviata lo è de L’addio, Springsteen, Mahler, Prokoviev e RaNora, la protagonista di Perché tu mi hai sorriso, osserva la madre nel suo chmaninov «suonano» in Né con te né senza di te. Perché tu mi hai sorriso ha percorso verso la chiusura della vita, sembra volerla leggere come un’ouna vera e propria colonna sonora: ogni capitolo è «intestato» con una canzopera d’arte: è volontà di conoscere la madre o anche volontà di conoscene, schegge di vetro nelle quali la madre Nora e Fanny, la figlia quattordicenre se stessa, nel personale rapporto con la propria figlia adolescente? ne, rispecchiano le loro esistenze. È la musica di tre generazioni. Non è un vezUn lettore mi ha chiesto per quale motivo alla domanda «Perché non hai uczo letterario quello della musica nei miei romanzi, ma il riflesso di una passiociso me?» la mamma risponde «Perché tu mi hai sorriso» se in effetti non esine vera. La musica è la mia compagnia, è il mio conforto, ne ascolto sempre, ste nessun infanticidio, nessuna gemella, nessun segreto. Perché la mamma non quando posso e allora... la metto nei libri. Dal punto di vista narrativo sono quatusa le sue ultime forze per rassicurare la figlia, per dirle «guarda che non c’è tro storie completamente diverse: le accomuna il desiderio di scavare nei sennessuna sorella, le conclusioni cui sei arrivata sono sbagliate, ti assicuro che timenti, osservare la realtà con la lente d’ingrandimento filtrata dal sentire innon esiste nessuna bambina morta a pesare sulla mia coscienza»? La verità è teriore. Non sono una sentimentale, ma un’«apprendista permanente». Come che la risposta data dalla madre è l’unica ad avere il potere di sbloccare la fiNora. glia. Negare una gemella soffocata nella culla sarebbe come negare la capacità La musica è un elemento che accompagna anche e soprattutto quest’ulticreativa di Nora espresse nel suo delirio, deridere le sue facoltà di generare anmo romanzo. E il recupero del forche se espresse soltanto nell’idea di tepiano attraverso il restauro ne è il un fatto che non è mai accaduto, simbolo concreto. Ma quanto è for- PAOLA CALVETTI . Una madre e una figlia, finalmente e incidentalmente, una di fronte all’altra in un avrebbe significato insultare il suo te questp legame? ventre. Capìto questo, la madre non Non concepisco le mie giornate senza testa a testa risolutivo. Il momento della verità assume il carattere della rivelazione, dello sconcerto, può che negare la propria verità, enmusica. La scoperta dell’iPod (me trare in quella della figlia e regalarle l’ha regalato due anni fa mio figlio dell’evento inaudibile. Un noir d’altra maniera, a tinte cangianti e con un andamento che ha il passo di una nuova vita, mettendola di nuovo Davide) mi ha viziata ancora di più. al mondo. La madre è il punto di conLavorando alla Scala avevo un privi- una partitura musicale. In un gesto minimo il certificato di salvezza e il salvacondotto per la vita tatto tra l’animato e l’inanimato (il legio: all’ufficio stampa avevamo un fortepiano), tra il controllore e il coninterruttore che ci collegava con il trollato, tra la vita e la morte. Chi, per palcoscenico. Beh, stava sempre accesalvare una figlia, non si confesseso. Ascoltavo Mozart e Verdi e i conrebbe un omicida? certi e tutti i grandi cantanti e i grandi Questo romanzo può essere visto direttori dal vivo. Una pacchia. anche come una lunga lettera alla Nell’ultimo romanzo, Perché tu mi madre e nello stesso tempo una auhai sorriso, si coglie una spiccata catoanalisi interiore, una forma di pacità di analisi psicologica e una confessione a se stessa? acutezza di osservazione relativa ai Un maestro di scherma, del quale non rapporti madre-figlia: quanto inciricordo il nome, un giorno mi disse de l’esperienza di vita privata sulla che il segreto della spada consiste in creazione dei personaggi? questo: toccare senza essere toccati. Mutando il verbo e i concetti, mi è tornaVIVE A LUCCA. "LA BICI AL IL LIBRO Grazie per quello che prendo come un ta in mente questa frase pensando a Nora (la figlia) e a sua madre, mentre scriCANCELLO" (BARONI), "E COPAOLA CALVETTI complimento: spiccata capacità di vevo il romanzo e immaginavo il loro «dialogo». In fondo la vera «tensione» MINCIÒ A SOGNARE A COLORI" "Perché tu mi analisi psicologica, detto a una persodella figlia è quella di controllare la mamma, ma senza essere controllata. No(DEL CERRO) hai sorriso" na (prima che autrice) che si sente abra vuole sapere, vuole conoscere e guidare i movimenti, le azioni, i pensieri pp. 209, euro 14,50 bastanza spesso disarticolata e pasticstessi di chi la circonda: a partire da Michele e dal suo cellulare, dalla inafferMARISA CECCHETTI Bompiani, 2006 ciona con la propria esistenza, è un rabile Fanny per arrivare agli studenti di storia dell’arte che abbandona per decomplimento. Ho perso mia madre dicarsi al restauro. Tutto è sempre stato senza risultato. Iniziando da Alessandieci anni fa. Improvvisamente. Non ho mai voluto indagare nel mistero della dro, l’amore della giovinezza, maestro di tutto l’incontrollabile che si sottrae mia relazione con lei, non ho mai voluto trovare un senso ad un rapporto che nel modo più sfuggente e cioè sparendo, Nora sviluppa una controllo di sucLei è Nora Cogliati, che ha smesso di insegnare per dedicarsi al redi per sé è ancestrale e impenetrabile. Non mi aspettavo il successo di vendita cesso soltanto sulle cose, sugli oggetti inanimati: il restauro e, nel momento in stauro. Quindici anni di matrimonio con Michele, avvocato penalidel romanzo, ma lo attribuisco anche al tema che, con il massimo del garbo e cui arriva alla villa, la madre ammalata. Con le cose non ci si confronta. È un sta, una figlia che attraversa la fase inquieta dell’adolescenza, qualdella delicatezza, ho scelto di affrontare. Il romanzo è venuto da sé: i personagrapporto unidirezionale basato su stimoli e reazioni, non sul dialogo, sulla riche chiarezza da cercare anche per sé. L’altra è la madre, Luisa Brigi crescono da soli, mi creda, mentre li scrivo. Il lavoro, dopo la prima stesusposta. Che pure arriva, inaspettata, liberatoria, solo nel finale. vio Cogliati, colpita da una malattia degenerativa che ne ostacola ra, è di limatura sul linguaggio, ma il cosiddetto «scavo psicologico» avviene Il tema della famiglia è più centrale qui che in altri titoli. Ma l’amore è visempre di più i movimenti e la parola. Nella villa di campagna fuori prima, come se avessi stratificato dentro uno stato di attesa, che la scrittura lasto nel suo aspetto più conflittuale. Milano dove si è trasferita, in estate, per stare accanto alla madre, scia emergere a livello inconscio. Forse questo romanzo è un tentativo interioDa professoressa triste a restauratrice soddisfatta, da moglie sentimentale e fementre fa ordine tra le vecchie cose, Nora scopre un inquietante cerre di dialogo immaginario con mia madre. Forse. rita, da madre infelice a figlia onnipotente, c’è un forte elemento di diversità tificato di nascita, un po’ macchiato, che diventa oggetto di una indaIn alcuni punti chiave entrano nella trama storie d’amore di personaggi in Nora, rispetto alle protagoniste degli altri miei romanzi: l’incapacità di creagine ossessiva e crudele nei confronti della madre, costretta ad celebri del passato, a consolidare, per analogia, una elemento del racconre. Nora, infatti, non crea, non genera, non forgia. Vera, in Né con te né senza ascoltare senza poter dare alcuna spiegazione. Si materializza l’ipoto stesso. Esiste per caso una Paola Calvetti che amava catalogare storie di te, era una creatrice: scriveva racconti, inventata bambine, vedeva arlecchitesi di una gemella mai conosciuto. I dubbi e le ombre che hanno d’amore fin da bambina? ni, e si completava nel gesto creatore più misterioso, quello del dare la morte. oscurato la figura materna si chiariranno solo dopo la sua morte. Sì, catalogavo le storie d’amore, esattamente come si possono collezionare carNora è invischiata in un’impotenza totale che le permette soltanto di consertoline o francobolli. Mi intrigavano da ragazzina, e più erano complicate, travare, di studiare, di vivisezionare il mondo; ma da lei non nasce nulla. Ecco giche, più mi appassionavano. Le riassumevo su piccoli fogli a quadretti, prospiegati i suoi problemi di madre, la sua morbosa attenzione per un fortepiaprio come nel romanzo. Li ho ritrovati, un giorno, durante un trasloco. Così le no, che del resto non sa suonare: Nora non sa creare la musica, sa soltanto ho fatte trovare a Nora nello stanzone della nonna, assieme al fortepiano e… a ascoltarla. L’atto di nascita ritrovato e ciò che ne consegue altro non è se non Senso vietato tanti altri oggetti. Non ho memoria, ricordo molto poco della mia infanzia e ogni la rivincita di Nora, che le permette di liberarsi della macchia che le appesandi Massimo Onofri ritaglio, o fotografia, o scritto mi aiuta a ricordare. Adesso non ho più paura deltisce il cuore: inventandosi una storia (quella della gemella) Nora torna finalla memoria. È stata Elisabetta Sgarbi, in fase di editing, a consigliarmi di insemente a vivere, appropriandosi di quella facoltà di generare che per qualche rirle nel romanzo, a consigliarmi di «spargerle» qua e là tra le pagine, come farmotivo (il motivo c’è e si vede, il motivo è Alessandro, il primo amore, il fan(Antonio Socci 2) falle infilzate sul muro. tasma annientatore che blocca ogni tensione alla gioia), che le è sempre stata Un elemento costante di questo ultimo romanzo è la ricerca della verità e negata. Forse, la frase che più riassume l’amore in tutto il romanzo è molto Chi rompe paga la condanna della bugia si individua fin dalla prima pagina, dal carteggio semplicemente una: «L’unità di misura dell’amore è la perdita. Chi l’ha cone i Socci sono suoi Virginia Woolf-Sybil: qual è il suo legame con la produzione della Woolf? fusa con la felicità è un imbecille». S Il passato ha il volto della madre Basta un sorriso per salvare la vita La scoperta in una casa fuori Milano pagina 10 S t los GIANNI BONINA Interviste ISABELLA SANTACROCE . Romanzo di cattiva na confessione da comprendere come una preghiera affranta e composta, o il grido disperato di dolore di un’anima infelice e malnata, è il diario di una diciottenne scritto quando tutto è compiuto, quando non rimane che spiegare a sé e agli altri ciò che è stato e perché: la germinazione di un odio verso la madre che brucia ogni alternativa di vita e che diventa esso stesso ragione di vita come di morte. Un odio cui fa da contrappunto l’amore viscerale per il padre, alimentato per accumulo di quello sottratto alla madre nel gioco di travaso tra due mondi opposti: da un lato il pieno di realtà catafratta in cui vive la madre, da un altro il pieno di irrealtà entropica che il padre esperisce. «Mio padre era un uomo senza realtà. Mia madre era l’opposto, lei era la realtà stessa» dice la ragazza che si sente chiusa dentro uno zoo, in una gabbia vista come una trappola. Tra reale e irreale, tra una donna impegnata nella sua attività di commerciante e un uomo che dipinge fiori e vive in funzione dell’arte, la figlia sceglie l’ideale, la vita che a 9 anni la rende già adulta e che le promette mondi inimmaginati e la possibilità di cogliere l’attimo: «La felicità è una visione per me in quel momento e io voglio la migliore, voglio il film». Quando il padre muore «porta via le istruzioni su come trattare la figlia» che rimane sola nello «zoo» alla mercé della madre, della quale prova inutilmente a guadagnare l’affetto: «Io l’amavo, una madre si ama sempre, anche la mia, anche la più terribile, anche quando si odia. Lei, figura insostituibile, madre e mostro, violenta presenza, mancanza continua». Ma può solo odiarla, mortalmente, soprattutto dopo l’incidente che la rende per sempre paralitica a causa della madre che la spinge giù per le scale al culmine di una lite. Causa o colpa? Su questo discrimine si gioca la vicenda che lega madre e figlia e decide le sorti di entrambe. Stilos ne ha parlato con la Santacroce. Zoo è un congegno di disfacimento della famiglia. Il tema della famiglia mai era stato da lei affrontato in termini così diretti e risoluti. Per la prima volta punto una luce forte su questa macchia scura che è la famiglia. Lo devo all’incontro con la protagonista della storia che ho conosciuto grazie a una amica. È stata lei stessa durante questo incontro a chiedermi di raccontarla. Ci siamo frequentate per un mese, è stata un’esperienza nuova per me e importante. Sono diventata quella figlia scrivendo Zoo. Anche io ho finito per distruggere e distruggermi. Lei accoglie le ragioni della figlia che racconta la sua diseducazione all’amore e la sua formazione tanatologica. Solo alla fine sembra ascoltare anche le ragioni della madre, carnefice e vittima. Ed è in realtà difficile darle torto. Però l’epilogo è segnato: non c’è ravvedimento nel disegno della figlia. Non era giusto ci fosse, non era possibile: la realtà è completamente diversa dal sogno. In Zoo la realtà c’è tutta, ho combattuto contro di lei per dieci mesi scrivendo il libro. Perché alla fine figlia e madre, ammettendosi che si sono sempre odiate, sfiorano o consumano l’incesto? È una unione di corpi estranei o un’ultima comunione di spiriti? L’odio della figlia è disperazione piena di amore. Lei ha sempre cercato l’amore di quella madre, fino alla fine. Lei voleva ritornare dentro sua madre, nel suo ventre, quel ventre che l’ha sputata fuori dimenticandola. Per questo violenta sua madre, per enorme astinenza. Poche le figure presenti anche in questo romanzo, tutte problematiche e disturbate da differenti mal di vivere. Ma quella che sembra la più lucida, cioè la figlia, non è anche la più malata? A un certo punto dice: «Faccio più schifo di lei», parlando della madre. La figlia è come quegli animaletti lasciati soli dentro una gabbia su cui i proprietari dello zoo infieriscono di continuo. Anche l’animaletto più innocuo finisce per diventare feroce. La figura del padre giganteggia in positività d’animo e amore filiale. Ma è morbosamente geloso della figlia, forse anche innamorato. Non sappiamo se hanno avuto approcci sessuali, ma tutto farebbe supporlo, benché il romanzo su questo taccia. «È’ mio padre l’uomo della mia vita» dice la figlia. L’eccessiva morbosità di un padre ISABELLA SANTACROCE "Zoo" pp. 125, euro 12,50 Fazi, 2006 formazione, di divisione di coscienze, di cuori strappati, di odio il cui peso è uguale a quello dell’amore. Una storia nerissima e delicata U Così la famiglia diventa uno zoo di anime morte SECONDA LETTURA Confessioni di ragazza da uno stato di claustrofobia sabella Santacroce è una scrittriVIVE A MILANO. "LE COSE CO- suoi sogni artistici destinati a rimanere tali, rimanendo prima indifferente ce che da sempre fa animatamenME STANNO" (BALDINI CAe poi addirittura negando con evidente discutere, che separa nettamenSTOLDI DALAI, 2003), "CATTIte fastidio gli slanci bisognosi di una te gli estimatori dai detrattori; per VO SANGUE" (BALDINI, 2005) figlia che silenziosamente chiede cui è forse impossibile, per i lettori e amore e attenzioni, sempre regolari critici, accoglierla come si fa con la FRANZ KRAUSPENHAAR mente umiliandola. maggioranza degli scrittori, ovvero Se lo «zoo» senza entrata né uscita in una innocua metà del guado, imbracciando comodamente la benevolenza in saldo di una allestito dalla scrittrice è caravanserraglio umano abbasostanziale indifferenza. In Zoo quasi si dimentica del stanza consueto nel mondo della letteratura, se certi ripassato, abbandonando lo stile fluorescente e originale da flessi neri delle ombre profonde di questi vivi sentimenprosatrice si potrebbe dire «dark» dei suoi libri preceden- talmente agonizzanti se non morti ci sembra di averli ti per avventurarsi nel filone d’oro di una scrittura in cer- già adocchiati tante volte in altre opere letterarie e cito senso più secca e funzionale ma anche arresa, che si ab- nematografiche, è però anche vero che la Santacroce bandona a se stessa nel letto delle sue proprie righe spes- dimostra una notevole abilità nell’allestire le scene so lapidarie, divenendo pertanto molto funzionale alla vi- della sua rappresentazione, nello scegliere i costumi più cenda, narrata fin dall’inizio con una tensione quasi inso- appropriati, nel modulare le grida disperate provenienti da gole riarse dal rancore all’interno di un accesissistenibile che si nutre di una passività latente. Una scrittura catturante che non lascia al lettore un attimo mo silenzio, nel tenere sempre costante, senza sbalzi, la di tregua, che il lettore lo incalza sempre, non nasconden- temperatura di questo infernale piccolo mondo di dogli nulla, regalandogli senza inutili pudori una vicenda ghiaccio. di follia familiare sedimentata negli anni, con un anda- Un piccolo mondo contemporaneo terribile e potentemento circolare continuamente interrotto da un punto; mente circoscritto, così che tutto quello che vive fuori tant’è che, navigando con gli occhi e la mente in questa da quel mondo viene reso dalla scrittrice - anche qui scrittura spesso abbacinante nella sua apparente sempli- con maestria- soltanto come sfocato sfondo, e che fin cità, m’è sembrato per tutta la durata del libro di assiste- dall’inizio è descritto con ossessiva precisione; anche, re al propagarsi breve di piccoli cerchi concentrici prodot- o forse soprattutto, nel tracciare una personalissima carti dal lancio continuo e sempre preciso di piccoli sassi in tografia dei sentimenti: «Se penso alla mia vita, vedo un movimento senza passi, uno scivolare verso dove mi uno stagno nero. Il romanzo ha qualche debito, a mio avviso, nei confron- hanno spinto»; così, in una frase che troviamo nelle priti della prosa tagliente e allo stesso tempo morbida di una me pagine, la scrittrice riassume, del suo personaggio, Marguerite Duras; e l’ambientazione claustrofobica, nel l’insanabile dolore passato, presente e futuro. piccolo impero del male di vivere all’interno di una fami- Il romanzo è tutto uno scivolare sinuoso e senza posa glia borghese apparentemente normale, forse deve qual- nelle profondità del male di vivere, negli inferi dei sencosa, o comunque è molto simile, alle ossessive, psicopa- timenti, in un regno dell’estremo assolutamente creditogene narrazioni in un interno borderline del premio No- bile, forse già avvenuto, vissuto mille volte in mille famiglie diverse. Il «famiglie io vi odio» di André Gide bel Elfriede Jelinek. Per poco più di 120 serratissime pagine che sono indiscu- rintrona pertanto sempre valido, sempre più drammatibilmente di confessione a cuore aperto, mai intervalla- ticamente attuale col suo messaggio di soda caustica fite da capitoli, Isabella Santacroce traccia con la sua ma- no alle profondità del lettore, alla sua coscienza dagli tita per gli occhi (occhi grandi, quelli della sua protagoni- occhi sbarrati, che non puo’ quindi rimanere indifferensta io narrante senza nome - «vorrei essere forte e invece te a questo circo quasi bergmaniano dei rapporti umasono una donna che barcolla sopra la propria mente», co- ni organizzato nel monologo ossessivo costruito dalsì descriverà il proprio stato di sofferenza psichica a metà l’autrice con una sapiente opera di regia. del libro) il disegno di una storia chiusa, senza sbocchi, Il padre morirà presto di ictus, e nella dolente e arrabdominata dal demone invincibile della violenza psicolo- biata rievocazione filiale, che in seguito si alternerà per gica, della claustrofobia, dell’assenza di speranza, dell’o- tutto il libro ad annotazioni si può dire in presa diretta sul momento presente che va avvitandosi sempre più dio, del rancore, della sessualità repressa, dell’incesto. In una città anch’essa senza nome, una famiglia qualun- velocemente verso la tragedia finale, tale lutto sarà per que (padre impiegato part-time e pittore per hobby, ma- la protagonista la ferita più insanabile, ovviamente dodre negoziante d’abbigliamento, figlia unica timida dal- po la negazione dell’amore da parte della madre, la vela bassa autostima e vittima della fragrante bellezza ma- ra coprotagonista di questa storia tragica, il motore rinterna) si arrende giorno dopo giorno alla propria infeli- ghiante dal quale si diramano i fili d’acciaio tesi che avcità che, si scoprirà nel finale, è nata con essa, si puo’di- viluppano tutta questa profonda, insopportabile infelire fin dal suo sboccio; la figlia ripercorre, folle di ranco- cità: negli anni seguenti si consumerà infatti il regolare e profondamente nostalgica di un amore materno mento di conti fra le due donne, e la figlia, così, ribalmai ricevuto, le tappe mai compiutamente demarcate di terà gradatamente ma con ferrea determinazione l’equiquesto malato rapporto a tre, nel quale il padre ha sem- librio dei loro rapporti, in una sorta di contrappasso, fapre dimostrato una colposa fragilità, una sorda arrende- tale fino alla tragedia. volezza che si maschera di una dolcezza che in qualche Alla lettura di questo romanzo sono arrivato posso dimodo è diventata una comoda abitudine, un abito psico- re «vergine», cioè senza aver letto che pochi stralci dellogico che è in fin dei conti nient’altro che la morbida co- le opere precedenti dell’autrice; e dunque, se esso non razza protettiva di un uomo colpevolmente debole; men- puo’ di certo rappresentare ai miei occhi una conferma, tre la madre tiene in pugno il bastone del comando in una ha però rappresentato senza alcun dubbio la gradita sortirannia familiare che si sviluppa tra gli estenuanti estre- presa, e quindi la scoperta, di una scrittrice italiana dalmi di urla di disprezzo e di comando e momenti di assur- l’indiscutibile talento, una «prosatrice di altissima quada esaltazione, odiando tutto e tutti, in particolar modo lità», come ebbe a dichiarare un critico dello spessore disprezzando il marito che corre rifugiandosi dietro ai di Cesare Garboli. I Isabella Santacroce, autrice per Fazi di Zoo, fotografata da Rosangela Betti verso una figlia alza sbarre da cui è difficile uscire. La sua furiosa gelosia ha allontanato la figlia dalla vita lasciandola sola con lui, e così quel padre è diventato l’unico uomo della sua vita. Io l’ho detestato quando in hotel la stringe nel letto sussurrandole tesoro. Questo è violentissimo per una figlia: avere un padre addosso che ti tratta come un amante. Il diallele thanatos-eros forma il motivo conduttore. Ma il tema della morte sembra essere più pervasivo. Le pagine del lutto e del dolore dopo la morte del padre sono tra le più sentite e intense. La morte è più potente dell’amore. Del resto la morte non fa certo ingresso per la prima volta nella sua cosmogonia. Luminal è dedicato a trentadue suicidi celebri. Nel libro ci sono moltissime morti ma sembrano tutti parti. La nascita è l’abbandono per eccellenza e anche l’abbandono meno doloroso è pieno di morte. In un certo senso Luminal è un inno alla vita. Un tema parallelo o compenetrato nel primo è quello della bipolarità odio-amore. La figlia ama la madre quanto la odia. E viceversa. Fino al parossismo, come lei ha voluto dimostrare. In Lover ho scritto: «L’ho odiato d’amore a prima vista». Come la vita è piena di morte, così l’amore è pieno di odio. Zoo è titolo che suggerisce l’idea dell’isolamento per opera altrui, dunque della prigione. Eppure il sentimento dominante nella figlia è quello dell’autoesclusione, come se fosse lei a volersi chiudere. La figlia nasce prigioniera e vive prigioniera, neppure sa cosa vuol dire essere libera, non sa come si fa. Gli unici momenti in cui le viene permesso di uscire dalla gabbia è quando deve andare a scuola e anche lì è il padre ad accompagnarla e poi ad attenderla all’uscita. I suoi compagni ridono di questo, vedono quel padre portarla via, quasi scappare con lei ogni volta. Lei parlando della scuola dice: «Solo lì ho lasciato la mia gabbia, voli brevi, senza aria». Mi pare sia la prima volta che non ci siano nomi propri ma solo nomi comuni. Ha voluto dare un senso di significato generale alle condizioni individuali? Nessuno ha un nome: non volevo inventare nomi e non era giusto chiamarli con i loro veri nomi. In Zoo loro si chiamano padre, madre e figlia. Io li ho chiusi dentro un libro, per sempre. In ottobre, intervistata da Stilos sul suo successivo romanzo, diceva di Zoo che era curiosa di vedere se qualcuno avrebbe pensato che i suoi libri sono senza trama. Questa volta, in realtà, è proprio sulla trama che ha lavorato. Nei miei libri c’è sempre stata una trama, ma costruivo i romanzi in maniera inconsueta, quindi questo spiazzava. Con Zoo sono stata più generosa: ho voluto condurre il lettore dentro la storia con delicatezza, per mano. Portarlo dolcemente nella violenza di questa famiglia all’apparenza tranquilla, fargli scoprire la malattia che nasconde dovunque. Si può ritenere Zoo un ritorno alla sua prima maniera, quella per intenderci della «trilogia dello spavento»? No, Zoo non è un ritorno a nulla. Non sono mai ritornata indietro scrivendo, perché guardo sempre in fondo, dove non c’è nessuno. Voglio andare verso l’alto, dove non sono mai stata. Per me la scrittura e prima di tutto rivolta. Sfido la realtà, voglio essere più forte di lei. Però c’è il ritorno alla prima persona e dunque al racconto autodiegetico. Insomma sembrerebbe aver rimesso gli abiti della dark lady. Io non ho mai indossato abiti da dark lady e non so cosa voglia dire essere una dark lady. So cosa vuol dire essere Isabella: vuol dire avere l’inquietudine ovunque, come una scure nel buio. In Zoo è la figlia che parla, una ragazzina di diciotto anni prigioniera di una famiglia che finisce per distruggerla. Certamente comunque, quanto allo stile, Lovers e Dark Demonia appaiono distanti, pur essendo i più recenti, se si esclude la parentesi di Revolver. Ogni libro è solo e lontano dagli altri, così come deve essere. Ogni storia ha bisogno di un linguaggio diverso per essere raccontata. In ognuno di essi però punto una luce forte sulle zone scure dell’esistenza, le tiro fuori così e le porgo al lettore sperando non si spaventi, che le guardi negli occhi. Eccebombo autori italiani AURELIO GRIMALDI LA TECNICA KUBRICK Qualcuno ha mai sentito parlare dello scrittore Lionel White? Io no. È l’autore del romanzo "Clean break" dal quale Stanley Kubrick trasse la sceneggiatura del film Rapina a mano armata del 1955 (titolo originale "The killing"). Sia chiaro: non appartengo al numerosissimo club di sostenitori giuggiolosi di mr. Kubrick. Shining non lo sopporto proprio, Eyes wide shut mi pare un assai mediocre film, di Full metal jacket ammiro la prima parte ma trovo insignificante la seconda; ma mi inchino davanti al magnifico 2001: Odissea nello spazio, e giù il cappello davanti al suo secondo e terzo film: appunto Rapina a mano armata e Orizzonti di gloria del 1957. Rapina a mano armata l’ho rivisto in questi giorni per motivi tecnici. Anche gli appassionati di letteratura devono sapere che un nodo insuperato (dunque di matrice anche filosofica) della regia cinematografica è il modo di raccontare i dialoghi tra due personaggi. La maggioranza dei registi adoperano il comodo sistema del campo-controcampo. Inquadratura sul personaggio A quando parla, e controinquadratura del personaggio B quando risponde. Ogni regista al mondo si è chiesto se e quando modificare questo sistema elementare senza adoperare l’altrettanto tradizionale piano a 2: macchina da presa che inquadra entrambi i personaggi, costretti però ad essere visti di profilo. In Rapina a mano armata Kubrick, al suo secondo film, decide di adottare, il più spesso possibile, e sempre quando racconta i dialoghi tra due personaggi chiave dell’accattivante vicenda - il debole cassiere e la bionda moglie traditrice e puttanella - il piano sequenza. Che è la ripresa senza stacchi: il contrario del campocontrocampo, che è tutto un continuo «tagliare». In procinto di girare il mio film Anita, mi sono voluto ripassare questa tecnica di non facile applicazione. Rapina a mano armata è dotato di una forza narrativa sconvolgente (e quanti meriti vanno attribuiti al da-me-sconosciuto scrittore Lionel White?) pur nella freddezza del suo stile, ed offre alcune originalissime scelte. La vicenda è narrata in terza persona! È la scelta dell’85% delle opere letterarie (il restante 15% opta per la prima persona), giammai di un’opera cinematografica! Non ricordo altri grandi film che usano questa tecnica rarissima e inaudita. Seconda originalità: sceneggiatura ad andate e ritorno. Rapina a mano armata racconta l’ardita rapina che un gruppo di eterogenei dilettanti organizza alle scommesse dei cavalli. La rapina riesce, ma… Il celebratissimo Quentin Tarantino, nel suo film d’esordio Le iene (che resta ancora oggi il suo più riuscito) ha copiato, tale e quale, l’idea di base e la maniera di raccontarla. Toglie la voce fuori campo in terza persona e la sostituisce con i suoi amati cartelli informativi. Ci aggiunge il suo tocco di geniale variantistica narrativa, e fa una copia identica ma originale di quel bellissimo film. Kubrick e Tarantino restano due artisti assai differenti. E la «copia» di Tarantino serve per realizzare un film a modo suo personale e riuscito. Oggi ci sono tanti aspiranti «tarantineschi» che si sbizzarriscono in sceneggiature piene di andate e ritorno temporali. E non sanno, poverini, di essere figliocci di mr. Kubrick! Rapina a mano armata di Stanley Kubrick (1955) dal romanzo "Clean break" di Lionel White. pagina 11 elle recensioni riguardanti l’ultimo, convincente libro di Simona Vinci, quella di Angiola Codacci-Pisanelli apparsa su "L’Espresso" mi pare la più azzeccata. Vi si dice in sintesi che Stanza 411 è una storia d’amore analizzata con lo sguardo di un entomologo, e quel sentimento è descritto come una lucciola, qualcosa che di sera brilla e affascina i cuori più sensibili, ma che durante il giorno rivela la propria natura di semplice insetto, in fondo un po’ repellente. La metafora della lucciola ci ha ricordato il quinto capitolo di Le confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull di Thomas Mann, quando è rievocata la sera in cui il protagonista, un ragazzo di soli 14 anni, venne portato dal padre per la prima volta a teatro a Wiesbaden. Il giovane rimase impressionato da tanta bellezza: i profumi inebrianti e gli abiti delle signore, i dipinti fastosi, l’orchestra, gli stucchi alle pareti. Il teatro gli apparve come «il tempio del piacere». Ma il vero centro dell’attenzione era l’attore-cantante Muller-Rosé, la cui bravura e il cui fascino seppero abbagliare tutto il pubblico, e «benché fosse vestito di nero pareva irradiasse luce». Calato il sipario, il padre di Felix lo condusse nel camerino per congratularsi con l’artista, e qui «al fanciullo si offrì una vista ributtante e indimenticabile». La lucciola che sul palcoscenico era stata capace di una magica fosforescenza ora si era trasformata in un insetto schifoso, maleodorante e pieno di pustole. Ecco, forse per Simona Vinci l’amore è proprio questo: un inganno necessario e consapevole, un’istituzione indispensabile all’economia della vita. Stanza 411 è una parabola cruda e amara sul rapporto fra l’uomo e la donna, il dietro le quinte del mito dell’anima gemella e dell’ideale romantico dell’amore. Scritto sotto forma di una lettera che lei rivolge a lui dopo che tutto è finito, sulla falsariga dell’epistola ovidiana di Fedra a Ippolito, l’ultima opera di Simona Vinci scava impietosamente nelle ossessioni e nelle nevrosi che costellano ogni relazione sentimentale, e che spesso ne determinano il fallimento. Attraverso la loro scelta di fondersi l’uno nell’altro, non rispettando l’irriducibile individualità di ciascuno, lui e lei compiono fatalmente il destino di solitudine che portano in sé. L’amore è come il Pantheon, uno splendido tempio oggi sconsacrato e visitato solo dai turisti del sentimento; e la separazione finale è vissuta come un’orrenda mutilazione, che però non impedisce di continuare a vivere, a soffrire e a sperare di nuovo, perché le funzioni vitali non sono state compromesse. Stilos ne ha parlato con l’autrice. In passato hai dichiarato che i tuoi libri nascono da un’immagine che ti ossessiona, sulla quale poi si impernia tutta la narrazione. È anche il caso di Stanza 411? Questo è un testo un po’ diverso dalle cose che ho scritto fino ad ora. È nato per intima necessità e solo in seguito ho sentito che avrebbe potuto diventare un testo pubblico, che poteva parlare anche a qualcun altro che non fossi io. Ma certamente, l’immagine del Pantheon, della sua cupola aperta al cielo, che torna varie volte nel corso del libro, è uno dei nuclei attorno ai quali ruota tutto il libro. Ogni volta che sono a Roma, e dunque spesso, esco di casa, cammino e prima o dopo mi ritrovo lì, al Pantheon. Però, da quando ho finito di scrivere Stanza 411 non ci sono più entrata. S t los autori italiani D Interviste SIMONA VINCI "Stanza 411" pp. 121, euro 10,80 Einaudi, 2006 Simona Vinci, autrice di Stanza 411, uscito da Einaudi SIMONA VINCI . «Ci sono amori che si strutturano dentro una casa, una vita precisa, delle abitudini, dei percorsi tracciati. A me interessava vedere la fase che viene prima e come e perché spesso accade che le cose finiscano, si disintegrino prima ancora di diventare solide» Ma quando le cose finiscono che cosa ci rimane dell’amore? VIVE A MONZA. SCRIVE PER RIVISTE ACCADEMICHE ED È MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE ISPANISTI ITALIANI SERGIO GARUFI I protagonisti del romanzo sono una donna e un uomo senza nome, e la loro storia d’amore è una parabola esemplare nella sua essenzialità. La scarsità di dettagli deittici corrisponde alla volontà di dare alla storia una valenza paradigmatica? Sì, questo, che non è un vero e proprio romanzo ma che rientra nel genere delle epistole - come è esplicitato dalle citazioni iniziali tratte dalle Eroidi di Ovidio - voleva essere una specie di movimento sul tema dell’amore. Non una storia specifica, o meglio, non solo una storia specifica, ma anche una storia più generale, una sorta di archetipo dell’incontro tra un uomo e una donna, seguendone le tappe obbligate, ma mescolando i tempi. La storia sembra svilupparsi attorno ad alcuni luoghi simbolo: il Pantheon, l’Albergo Nazionale, un hotel sulla tangenziale, la Stazione Termini; tutti luoghi di transito, posti di passaggio, come se l’amore fosse un sentimento che ci è concesso abitare solo per brevi periodi, e sempre in qualità di ospiti, mai come padroni di casa. Ci sono amori che si strutturano dentro una casa, una vita precisa, delle abitudini, dei percorsi tracciati. A me interessava vedere la fase che viene prima e come e perché spesso accade che le cose finiscano, si disintegrino prima ancora di diventare solide. Ho pensato molto a quella definizione di Zygmunt Baumann, l’amore liquido nella società occidentale contemporanea: è come se vivessimo in un eterno presente, o in un eterno futuro, incapaci di sopportare il peso della storia, delle cose conquistate e che poi vanno protette, fatte crescere, viviamo con l’idea che sia possibile consumare tutto rapidamente e ricominciare da capo, un giorno dopo l’altro, senza renderci conto che questo non ci rende affatto più liberi, come crediamo, anzi ci costringe a reiterare all’infinito lo stesso modello. È una prigione liquida, ma pur sempre una prigione. Vale per il capitalismo economico, vale per il vecchio modello di famiglia, e di matrimonio o coppia, vale per tutto. Hai affermato di aver scritto il libro pensando a Ultimo tango a Parigi, il film di Bertolucci che a sua volta s’ispirò ai nudi racchiusi in quattro muri di Francis Bacon. Stanza 411 è allora un controcanto all’inno alla carnalità? La carnalità non ha un solo lato, mi interessava l’ombra, la parte nascosta, quella più fragile. Quello che resta quando le cose finiscono. Molti film, assieme a molti libri, hanno accompagnato la stesura di questo testo, ad esempio In the mood for love e 2046 di Wong Kar Wai... La protagonista si riconosce in certe figure di Giacometti, nell’illusione del movimento che queste evocano, perché «prendiamo treni, e aerei, facciamo traslochi, cambiamo amori e siamo sempre nello stesso identico punto». È un’idea che ricorda la Regina Rossa di Lewis Carroll, che SECONDA LETTURA Corpi, umori, oggetti e stanze: ecco la nuova categoria dei personaggi PAOLO DI PAOLO se il «personaggio-uomo», da cui per tempo si congedò (provvisoriamente) Giacomo Debenedetti, fosse diventato in questi ultimi anni un «personaggio-corpo» - uno che non si svela più soltanto scoperchiando la testa, affondando le parole nei tormenti della psiche, ma mettendosi a nudo anche, soprattutto fisicamente, affidato all’esibizione di forme e verità anatomiche? Nella narrativa recente, italiana e straniera, si incrociano parecchi personaggi che tutta intera, in misura diversa, esprimono - attraverso atti e discorsi - la tragedia del corpo nella contemporaneità. Non solo essi sembrano riscattare le infinite possibilità della narrazione, ma riescono a esistere (resistere) oltre la pagina, oltre la loro storia. Così accade che, libro dopo libro, Simona Vinci abbia concentrato sguardo e stile sul «residuo ultimo della vitalità e del possesso»: il corpo, appunto. Fin dall’esordio di Dei bambini non si sa niente (1997), la sua scrittura acida, rallentata ha sostanziato pagine di tensione estrema, tragiche e ossessive. I corpi di Simona Vinci stanno male, chiedono al tempo di essere guariti, ma le ferite non si ricuciono facilmente: restano segni che bruciano vene, vagine - e anche molte speranze. Nell’ultimo breve romanzo, Stanza 411, la storia comincia proprio da un guardarsi, nudi, allo specchio. C’è una donna che scrive a voce una lettera, con lo strazio e l’abbandono delle Heroides di Ovidio, citato in epigrafe. C’è uno specchio, e l’occhiata che lo anima: e seni, pancia, costole, musco- E li, tendini. «Non c’è mai modo di nascondersi, ma questo l’ho imparato soltanto adesso» dice la donna senza nome. E séguita a scrutarsi, ad aspettare un «tu» che le permetta di sentirsi in salvo. Sulla superficie di tale attesa galleggiano (è un romanzo, questo, di acqua e di vento) i brandelli di una storia d’amore - i luoghi (tutte le stanze), gli oggetti che in esse via via si depositavano («una stratificazione di materiali diversi»), i gesti; e il sesso. «Usami, ti ho detto inginocchiandomi sul letto, la faccia affondata in un cuscino, le braccia dietro di me, i polsi incrociati sulla curva della schiena. Usami. Dimentica chi sono, dimentica le mie parole, le mie lettere, il mio nome, dimentica tutto». Vinci ha scritto di una storia d’amore qualunque, che rappresenta ogni storia d’amore possibile. L’ha fatto calandola con precisione dolente e pignola in questo tempo, di Tavor ingoiati per dormire, di gocce di Lexotan sotto la lingua, di distanze a cui è complicato fare fronte. Due esseri umani si incontrano, si sfiorano, si toccano, fanno l’amore, godono e ridono; poi si distraggono, cominciano ad allontanarsi senza accorgersene. Perché càpita questo? Lei gli dice: usami; ma è di sesso che parla: il resto le fa paura (la vita le fa paura). Lei fiuta, sa che lui va anche con altre («tu sei un uomo che ha avuto molte donne. Le sento sulle tue mani, queste altre, sui polpastrelli, sulla lingua (…) Sei un uomo abituato a scopare puttane»). Lei guarda dalla finestra le ragazze dei marciapiedi, e si chiede cosa sognano la notte, che cosa ricordano (sono pagine molto belle). Lei (come forse ogni donna) ride in segreto di lui, della sua erezio- ne concentrata e orgogliosa. Lei, muovendosi sopra di lui, un giorno scoppia a ridere, dice «scusami, devo fare pipì», si stacca da lui, lo sente tremare di rabbia: sente aprirsi «una distanza terribile». Allora più avanti le torna in mente una frase di Fassbinder quando dice che «non ci fu più un noi», non ci fu più dalla prima insignificante divergenza d’opinioni. Un amore può finire così? Quando, guardando il suo uomo accanto, una sposa si chiede all’improvviso «ma chi cazzo è questo? Chi sei? E io, che ci faccio qui?». Stanza 411 irrita e disturba, come ammette all’inizio la stessa voce narrante, perché si approssima alla verità particolare e perciò universale di una storia amorosa che coinvolge corpi, umori, oggetti e stanze. Non vorremmo ascoltare ma ascoltiamo - come i mugolii altrui di là dalle pareti. Qui vento e pioggia fanno tremare la pelle, fanno venire voglia di stringersi o di picchiarsi - e perciò di amarsi, «malgrado tutto», come scrive l’autrice, «contro ogni logica, contro ogni convenienza, ogni riflessione, ogni senso, ogni buon senso». Mentre il mondo continua a esistere nonostante ogni fine, ogni catastrofe personale - e tutto lo schifo e la meraviglia di essersi aspettati così tanto senza avere niente, infine, da aspettare. Il romanzo di Simona Vinci, più paradigmatico e forse definitivo di qualunque trattato filosofico-sociologico sull’amore odierno, sul suo «retrogusto di lampone avariato», dice tutto questo; e lo dice con una lingua crudele e sorvegliata, specchiandoci nei suoi personaggi-corpo, nudi - che un po’siamo anche noi. quando si sposta è sempre seguita dal paesaggio circostante, quasi a rappresentare l’impossibilità di fuggire da se stessi e dai propri problemi. L’attesa dell’altro è anche la speranza di cambiare grazie alla sua sola presenza? Mi viene da pensare al Principe Azzurro atteso da generazioni di donne, quell’idea malsana che quando quel Qualcuno fosse arrivato allora le cose finalmente sarebbero cambiate, la vita vera cominciata. È un mito antichissimo e duro a morire. Il vero Altro che attendiamo di incontrare immagino non possa essere altrove che in noi stessi, gli altri in carne ed ossa possono solo aiutarci a incontrarlo. Ed è già, mi pare, tantissimo. Una delle pagine più intense e toccanti di tutto il libro è l’invettiva sul denaro, con il ricordo dei litigi fra i genitori di lei. I rapporti di forza, di qualunque natura siano, sono inevitabili nelle relazioni sentimentali? Il denaro purtroppo è tutto. Ogni rapporto è una transazione commerciale. Il denaro permea tutti gli aspetti della nostra società, è la schiavitù peggiore di tutte, è il denaro e solo quello a dare o togliere potere, ed è una cosa orribile, inaccettabile e temo, ineludibile. Bisogna farci i conti costantemente. Il titolo sembra alludere alla camera delle torture di 1984 di Orwell. È il lato oscuro dell’amore, quello ritratto nella stanza 411? Sì, esattamente. Nella camera 101 di Orwell ciascuno rivive la propria peggiore paura. Forse, la Stanza 411 è la mia personale camera della tortura. Una parte di me crede così tanto all’assoluto dell’amore che per la paura di esserne delusa l’ha trasformato in un orrore. Due elementi ricorrenti del libro sono la nudità e lo specchio, lo sguardo ossessivo di lei che verifica di continuo la propria capacità di suscitare desiderio. Che il senso di inadeguatezza sia la vera, immedicabile sofferenza che chiediamo a ogni partner di sanare? Io credo piuttosto che all’altro, al partner amoroso, chiediamo di restituirci un’immagine profonda di noi stessi. L’altro ci dice qualcosa sulla nostra identità, ci aiuta a scoprirla, a definirla, a metterla in discussione. Io senza tu non esiste. Ma Noi è la cosa più terribile di tutte, perché è un annullamento di sé, una specie di violenza. Io e tu dovrebbero avvicinarsi, non fondersi. «Gli inizi raccontano già tutto, a saperli e volerli guardare». È perché si son detti subito la verità, ciascuno la propria verità inconciliabile con quella dell’altro, che era destino che la relazione finisse? No, la relazione finisce perché non si è stati in grado di sostenere l’alterità dell’altro. Di rispettare i suoi tempi, la sua storia, la sua visione del mondo, il suo carattere, la sua unicità. Certi rapporti cominciano subito sotto un influsso marziano. Sono amori che somigliano alla battaglia, allo scontro cruento. Il conflitto è già evidente dall’inizio, e riuscire a dinsinnescarlo è praticamente impossibile. Stai già scrivendo qualcosa di nuovo? Sì, in realtà quando è nato Stanza 411 stavo già da un po’ lavorando a un romanzo e per un periodo ho continuato a lavorare in parallelo a tutti e due; adesso sto per terminarlo. È un romanzo ambientato in Emilia Romagna e uno dei temi centrali è proprio il Paesaggio, il paesaggio italiano rovinato, distrutto dagli interessi economici e attraversato da esseri umani che a quel paesaggio somigliano molto... Sempre di soldi si parla, alla fine. pagina 12 ilvia Bortoli è fra le traduttrici dal tedesco più conosciute in Italia. Ha vinto due volte il Premio Monselice (nel ’76 per la traduzione delle Lettere alla moglie di Alban Berg e nel 2004 per il Meridiano dedicato a Theodor Fontane). È anche poetessa (Tutti i fiumi, Anterem, 2002) e narratrice (recente la pubblicazione dei racconti Percezioni variabili, Manni, 2005). Con Stilos ha parlato del suo mestiere di traduttrice: Perché hai cominciato a fare traduzione? Non so se ho mai cominciato a «fare» la traduttrice e in un certo senso spero di no. Ho cominciato al liceo perché volevo tradurre i poeti che leggevo, in particolare Baudelaire. Allora il tedesco non lo conoscevo abbastanza per arrischiarmi. Più tardi, all’università, grazie a Bianca Tarozzi ho conosciuto Gianni Scalia che aveva appena fondato "Per la critica» e ho cominciato a tradurre qualche pezzo per la rivista; poi Ferruccio Masini mi ha proposto di tradurre per Feltrinelli le lettere di Alban Berg con cui ho vinto l’opera prima al Monselice, in giuria c’era Cases e ho cominciato a collaborare con Einaudi. Quindi a lavorare per l’editoria in fondo ho cominciato per caso. Ma forse traduco perché mia madre mi leggeva una favola o una filastrocca a voce alta ogni sera per farmi addormentare e visto che durava poco ho imparato a leggere appena ho potuto per prolungare il piacere; e se si legge capita anche di volere imitare. Scrivevo orribili poesie, molto tristi e lamentose, e quando ho scoperto magnifiche poesie in altre lingue ho cercato di trasportarle nella mia. Diciamo che ho cominciato a tradurre perché ero spinta da un moto amoroso nei confronti della poesia. Amavo il suono delle parole e che fossero «ben disposte» e molto dopo ho cominciato a capire cosa fosse lo stile, ma molto dopo. Che rapporto esiste fra la tua produzione di scrittrice e il tuo lavoro di traduzione, se ne esiste uno? Nessuno, credo. Traduco perché scrivo, certo, ma il rapporto tra traduzione e scrittura finisce qui. Qualcuno mi ha detto che «si sente» in quello che scrivo l’influenza della letteratura tedesca: tenderei a negarlo, non è quella che mi ha influenzato di più. Mi ha influenzato intellettualmente nell’età adulta, come ha influenzato tutta la mia generazione. Io avevo vent’anni nel ’68 e allora la cultura tedesca era per molti versi cruciale, ma nel profondo le mie radici stanno nella grande triade Dante-Leopardi-Montale e nelle letture dell’adolescenza: Montaigne, de Sevigné, Michelet, Tolstoj, Proust, e i poeti, come ho detto; ma insomma non c’è un solo tedesco. In ogni caso tengo ben separate le due cose e sono sempre stata molto attenta a non tradurre autori che in qualche modo potessero colonizzarmi. E poi la scrittura della traduzione è diversa dalla scrittura autoriale. Nasce in altro modo. Una è nobilmente servile, in fondo, è un grande gesto di generosità nei confronti di un autore, e anche di desiderio, e se ne viene ripagati. Ma quando si scrive per sé la lingua nasce da altre radici, nasce «con». Il traduttore non concresce col testo, lavora a cose fatte e inizia anche lui naturalmente un’opera, ma che comporta contraintes di natura molto diversa da quelle di un autore. Poi, più in generale, sono stata influenzata da tutte le letture fatte e dunque anche dalla traduzione e dalle traduzioni degli altri, dagli incontri, dalle cose viste, dal mondo. Si traduce abbastanza, in Italia? E qual è la qualità media delle traduzioni di narrativa, se si può dirla? In Italia si traduce molto, certo, e non dal tedesco, prevalentemente dall’inglese e dall’angloamericano, come tutti sappiamo, e da quel mondo a sua volta linguisticamente e molto produttivamente colonizzato dalla cultura anglosassone che ci ha dato Naipaul e gli altri. Noi italiani, e gli europei in genere, siamo ormai minoranze marginali, non c’è dubbio. Ma a parte questo, leggere libri tradotti ha fatto sempre parte di una cultura viva e reattiva. È la qualità delle traduzioni a essere bassa, lo dico da lettrice molto prima che da traduttrice. E includerei le traduzioni di saggistica, quasi sempre peggiori di quelle di narrativa. Ma la colpa è solo in parte dei traduttori, spesso persone che tradurranno quel libro e nient’altro, che praticano una lingua scolastica e non sanno cosa sia lo stile, terrorizzati all’idea di abbandonare il testo d’origine, o anime liete che del testo d’origine non sanno che farsene. Il redattore di una casa editrice abbastanza commerciale per il quale anni fa ho fatto un paio di tradu- S t los primo piano S BORTOLI «Italiani marginali» VIVE A SANREMO. COLLABORA CON "L’INDICE DEI LIBRI", "LA REPUBBLICA" E RIVISTE ON LINE GIOVANNI CHOUKHADARIAN zioni mi ha detto che amava molto i traduttori dilettanti, in particolare studenti e «signore», perché «esagerano»: se un personaggio apriva una bottiglia di whisky gliela facevano stappare coi denti, se un altro si faceva un taglietto colavano litri di sangue e il lettore si divertiva di più. Ma a parte il caso che cito e che è stato un momento di sincerità, nessun editore ammetterà mai di non «fare molta attenzione alla traduzione», anzi, è un titolo di merito che si attribuiscono in molti, ma si tratta di una doppia morale, quella che si dice di praticare e quella che si pratica effettivamente. Ci sono case editrici che dicono ipocritamente di badare al livello delle traduzioni e poi non investono tempo né denaro, non conoscono il significato della parola «cura». Un traduttore al quale si dà poco tempo farà un cattivo lavoro, un traduttore malpagato cercherà di fare due libri nello stesso periodo in cui potrebbe farne ragionevolmente uno e lo darà a una redazione dove redattori indaffarati gli dedicheranno una lettura superficiale, se pure. Un bravo traduttore che si vedrà pagato come un traduttore mediocre, che non vedrà riconosciuta la propria eccellenza, se ce l’ha, perderà la voglia di lavorare bene, se non lavora per sé. Il guaio è che quelli davvero bravi lavorano sempre prima di tutto per sé e dunque finiscono per non mettere neppure alle corde gli editori. E un revisore esterno pagato un euro lordo a cartella che revisione farà? Un euro lordo a cartella vuol dire che per fare cinquanta euro al giorno, lordi, un essere umano dovrà rivedere cinquanta cartelle da duemila battute ogni giorno che dio manda in terra. Quindi sparare sul livello delle traduzioni è sacrosanto e nel contempo profondamente ingiusto. Che tipo di attenzione critica riceve un traduttore e quale vorrebbe? Attenzione critica nessuna. Attenzione critica è quella di cui possiamo vedere un esempio nella Prima lezione di stilistica di Mengaldo, al capitolo che si intitola per l’appunto "Traduzioni". Credo che nessun traduttore contemporaneo abbia avuto un simile onore. Ci sono letture attente, a volte, se il traduttore è stimato, ma purtroppo, e questo conforta molto il traduttore mediocre e abitua a essere poco esigenti, l’aggettivo «ottimo» sui giornali si spreca anche in casi che si vorrebbero invece censurare. «Ottimamente tradotto», «egregiamente tradotto», «ottima traduzione di», ho let- to addirittura di una «traduzione autoriale» per un semi-lavorato dove un testo pieno di vere «stranezze» fingeva di avere accolto «l’estraneo», tanto per utilizzare parole che avevano un senso ma lo stanno perdendo per il cattivo uso che se ne fa. A nessun traduttore di narrativa anche banale o modesto è stata negata prima o poi, se lavora con una certa continuità ed è sopravvissuto alla fame, una lode anche esagerata, ma quasi sempre generica. E poi ci sono invece giornali come "la Repubblica" che quando recensiscono un libro non citano quasi mai il traduttore. Insomma, si passa dall’esagerazione al silenzio, un’attenzione seria non c’è quasi mai. Naturalmente la maggior parte dei traduttori si lamenta perché non viene citata, e quando finalmente gli capita si appunta alla giacca queste lodi fatte con lo stampino, ma non vedo come ci sia da essere soddisfatti di genericità in cui si fa di tutta l’erba un fascio. Ho visto all’opera l’attenzione critica quasi soltanto nei casi di stroncature, allora si vedono recensori armati di enormi lenti di ingrandimento e gigantesche matite prevalentemente blu. A parte Theodor Fontane, che hai tradotto per intero (a proposito: perché?), ci sono autori di cui ti sei innamorata. Non mi sono innamorata di Fontane, né di altri. La relazione che si stabilisce tra un autore e il suo traduttore è di altro genere, l’amore è cieco, il traduttore non lo è mai, anzi, è spasmodicamente attento. Almeno per quanto mi riguarda è l’atto traduttorio in sé che mi attira, il passare da una lingua all’altra. Le lingue pensano diversamente, ed è la ragione della loro teorica intraducibilità, ma è anche il lato affascinante di questo strano mestiere. In ogni caso la lingua di Fontane è una lingua estremamente viva, scintillante, lieve, intraducibile come è intraducibile la poesia, una vera sfida, perduta come si perdono sempre queste sfide. All’inizio il numero dei romanzi non doveva essere tanto alto, poi si è deciso di fare quelli che compaiono nell’edizione dei Meridiani e a quel punto non ne avrei ceduto una parte a un altro traduttore. Esistono età per iniziare a tradurre ed età per smettere? Età per iniziare a tradurre non ce ne sono, se intendiamo quella pratica personale della traduzione che affina il talento e la comprensione critica della poesia. L’età per pubblicare dovrebbe essere quella di una certa maturità, e ognuno ha la sua. L’età per smettere, mah, si dovrebbe smettere di tradurre per l’editoria quando si perde il contatto con la lingua viva della propria comunità, direi, ma anche qui, come per l’inizio, l’età non vale quando si traduce per sé. Io sto tentando di tradurre una poesia di Rilke da più di vent’anni, ogni tanto la riprendo, la peggioro un po’, poi la rimetto via e aspetto, magari a novant’anni ci riuscirò. Che cosa vuol dire studiare con un personaggio come Mittner? E, in particolare, qual è il ricordo umano che ne serbi? Ah, Mittner! Era il terrore. Mittner aveva in onore solo l’intelligenza critica, unica porta verso la letteratura. Un essere umano doveva dimostrare di esserne all’altezza e uno studente non era un essere umano. E men che umane le donne, buone solo a tenere la casa e a far figli. Dopo che ai suoi occhi avevo smesso da un pezzo di far parte di quel mondo amorfo mi aveva detto che ci si sposa per non dover stirare i pantaloni mettendoli sotto il materasso. Provava per noi disprezzo e aveva la convinzione di avere di fronte solo menti ottuse. E per la legge del contrappasso uscivano da quell’istituto prevalentemente studentesse diligentissime e non geniali, perfette insegnanti di liceo dalla mente ordinata che erano riuscite in qualche modo a «reggere». Ma Mittner era leggendario, era l’istanza più alta, indiscutibile, la nostra ammirazione e devozione per lui erano assolute. Amavamo invece di amore e gratitudine Gaetano Cozzi, lo storico. Era paraplegico e non potendo stare a lungo seduto in carrozzella raccoglieva nel suo salotto a San Barnaba un gruppetto di noi per continuare a darci i suoi insegnamenti steso sul divano. Gaetano Cozzi mi ha insegnato cos’è la ricerca, mi ha fatto capire che cosa vuol dire leggere un testo e interrogarlo. Di Mittner ricordo invece i seminari del terz’anno sugli Schiflieder di Lenau. Li considerava uno dei cicli più belli della poesia tedesca e li aveva offerti alla nostra pochezza critica senza nessuna indicazione che non fosse quella di averlo visto al lavoro su Heine sul quale aveva tenuto un corso monografico l’anno precedente. Ci provammo, ma avevamo vent’anni, lui raccolse in silenzio le nostre misere prove e la settimana successiva ce le rese piene di segni blu e senza una parola di commento, disse solo «rifare» e noi rifacemmo, una, due, tre, quattro volte, sempre quelle stesse magnifiche poesie per quattro settimane di fila. Non le ho mai più rilette. Se Mittner è stato un maestro lo è stato per la sua eccellenza di studioso, per l’esempio, non certo per il suo pedagogico amore per noi. Credo anzi che sia stato molto più maestro per chi gli era lontano. Ho sentito una germanista sostenere che aveva gli occhi azzurri, in realtà erano nocciola, ma avevano cambiato colore per vie mitologiche. Solo più tardi ho conosciuto anche la sua curiosità umana, la sua timidezza e la sua disponibilità a farsi sorprendere, ma la capacità di ascolto passava sempre e solo dalla porta strettissima della stima e del riconoscimento. Credo che Lingua e letteratura tedesca sia stata l’unica materia ai cui esami poteva accadere che un assistente, Goetz Beck, si dondolasse all’indietro sulla sedia a rischio di cadere per uscire dal campo visivo dell’ordinario e suggerire. Eppure Mittner sapeva che la scuola può spezzare le anime, lo sapeva se non altro grazie a Rilke e al Törless di Musil. Mi vedeva leggere per ore e cominciò a guardare cosa leggevo. Poi cominciò a chiedermi perché leggessi proprio quei testi. Non parlavamo ancora di letteratura, ma cominciavamo a scambiarci scarni commenti. Che perdessi il mio tempo a leggere Mörike gli sembrava incomprensibile. Le cartoline di Altenberg gli sembravano irrilevanti, anche se lo trovava simpatico, «un minore» disse guardando gli scaffali con aria un po’ sprezzante. Non ci guardava mai in faccia. Passarono i mesi, lentamente si era compiuto sotto i suoi occhi il mio passaggio dall’informe all’umano, preparavo gli esami per l’altra università sotto i suoi occhi e veniva a vedere su che libri studiavo e come» sottolineavo. Vedevo che voleva dirmi qualcosa, mi girava intorno e non sapeva come dirlo, e finalmente un giorno non si trattenne più, si chinò sulla pagina che stavo leggendo e disse con forza: «molto ben sottolineato». Era il massimo, il complimento più esplicito che fosse riuscito a immaginare, voleva che tornassi a studiare con lui ed era il suo modo per farmelo capire e poco dopo, quando il professore con cui stavo studiando all’improvviso morì e fu sostituito da una donna, visto che io non prendevo l’iniziativa, si fece coraggio, venne da me e mi disse guardando gli scaffali: «senta, non può restare lì, quella donna è troppo stupida». E così tornai e feci la tesi con lui. pagina Nella foto centrale un disegno di Michele Ciaffoncini Sottopagati, superimpegnati, a volte demotivati, in qualche caso incompetenti: i traduttori italiani vivono con difficoltà la loro condizione di interpreti. Stilos ha intervistato un uomo e una donna, due tra i nostri principali e più qualificati traduttori: Silvia Bortoli e Vittorio Curtoni. Due modi di vedere il mestiere. Anzi lo stesso sguardo e la stessa convinzione: tradurre è bello, difficile e appassionante. Ma occorre talento TRADURRE OGGI La lezione dei maestri, da Borges a Kundera a Steiner Ma come si supera l’effetto di alterità? I SERGIO GARUFI n un recente articolo apparso sulla rivista letteraria "Sud", Milan Kundera lamenta che lo studio dei grandi classici del Novecento sia ormai appannaggio esclusivo degli specialisti. Lasciando Proust ai francesisti e Joyce agli anglisti si condannano questi autori a una sorta di «provincialismo culturale», perché in questo modo li si priva del contesto sovranazionale in cui si sono formati. Tutto questo, a suo dire, nasce dal pregiudizio che uno scrittore sia pienamente comprensibile solo leggendolo nella sua madrelingua. A questo punto lo scrittore boemo si chiede se «un’opera letteraria sia del tutto traducibile», per poi rispondere, in sostanza, che «la letteratura universale può esistere solo se esiste una traduzione fedele». Dopo aver elencato alcuni incontestabili esempi di infedeltà semantiche, relativi soprattutto ai titoli di opere di Proust, Denon e Broch, Kundera ne individua i responsabili tra i funzionari editoriali, che impongono ai traduttori di usare uno stile scorrevole perché offre maggiori garanzie di incontrare i gusti di un pubblico pigro e poco esigente; e termina infine il suo intervento lanciando «un appello urgente in difesa della traduzione in quanto arte della fedeltà». Ora, forse non è corretto proporre una riflessione sul tema delle traduzioni facendo a mia volta una traduzione, anzi, una traduzione di una traduzione - perché la mia «riformulazione» (o riassunto, o parafrasi) dello scritto di Kundera, che per la tassonomia di Jakobson è una «traduzione endolinguistica», si basa su una traduzione italiana di Massimo Rizzante -, ma motivi di spazio e di ragionevolezza m’impediscono di fare altrimenti. Diamo quindi per scontato che in questi passaggi il senso del pensiero di Kundera sia stato sostanzialmente rispettato, e approfondiamo alcuni spunti che questo testo ci ha stimolato. In merito all’incipit, ossia al fatto che Proust e Joyce nella pratica universitaria siano studiati solo dagli specialisti, ci permettiamo di evidenziare come la comparatistica sia materia accademica da più di mezzo secolo, e alcuni fra i suoi cattedratici più illustri, come per esempio George Steiner, abbiano ormai da diversi anni acquisito una fama e un’autorevolezza che superano abbondantemente la ristretta cerchia degli appassionati del genere. È noto, e per certi versi pure comprensibile, che fra specialisti e generalisti non corra sempre buon sangue, tuttavia esistono tali e tante eccezioni che farne una regola d’incomunicabilità parrebbe francamente eccessivo. La casta degli ispanoamericanisti, per dirne una, fu la prima a riconoscere che i saggi di Gerard Genette e Maurice Blanchot riguardanti Borges erano tra le analisi più profonde e brillanti che siano mai state scritte sull’opera dell’argentino; e forse la loro originalità nasceva proprio da questo sguardo esterno, meno coinvolto, capace insomma di coglierne le più segrete connessioni, non necessariamente tutte ispanoamericane. Borges, con la sua nota anglofilia, appartiene infatti alla letteratura di lingua spagnola non meno che a quella di lingua inglese. E forse la critica letteraria, nella sua essenza più profonda, non è altro che una formidabile macchina analogica, la cui produzione di senso avviene proprio per accostamento, rintracciando le parentele profonde che legano un autore all’altro e che possono benissimo prescindere dai confini linguistici o nazionali. In questo senso, José Lambert arrivava addirittura a sostenere provocatoriamente che la letteratura è meno una storia che una geografia, invitando così gli studiosi a tracciare una nuova mappa delle letterature le cui frontiere non coincidessero automaticamente con la carta delle nazioni o degli idiomi. Una cartografia simbolica e tematica, dunque, a partire da quell’inesauribile deposito archetipico di immagini e storie che sono i miti classici, a cui continuamente si attinge. Esempi superbi di Stoffgeschichte (tematologia) sono Mimesis di Erich Auerbach e La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica di Mario Praz. Per Northrop Frye tutti i temi possibili appartengono a una grande famiglia interconnessa, e vi è una narrazione-matrice, una sorta di mito elementare, da lui definito come «la storia della perdita e della riconquista dell’identità dell’eroe», alla base di gran parte della letteratura mondiale. Nel concetto goethiano di Weltliteratur, le traduzioni assumono un ruolo e una funzione di scambio fondamentali: sono lo strumento di questo dialogo ininterrotto e necessario fra culture diverse. Dialogo non di rado afflitto da equivoci e malintesi, ma la cui ambiguità è un fatto costitutivo del linguaggio, prima ancora che della traduzione. Il divieto ebraico di formulare il nome di Dio non fu imposto solo affinché non si delimitasse l’illimitato, ma anche per la consapevolezza che la lingua in qualche modo corrompe il pensiero, lo snatura. Tradurre equivale a tradire perché le parole sono portatrici di un senso e di un suono; e se la fedeltà al livello semantico è la meno impervia, quella al livello fonico è sempre impossibile. «Nessun problema è tanto intimamente connesso alla letteratura e al suo modesto mistero quanto quello che propone una traduzione», scrisse Borges nel suo saggio giovanile intitolato Le versioni omeriche. In Dopo Babele, forse uno dei trattati più interessanti di traduttologia, non a caso opera di un non specialista come Steiner, l’autore ha segnalato come l’effetto straniante di alterità persista perfino in scrittori bilingui quali Beckett e Nabokov, che curarono personalmente la traduzione dei loro testi. Lewis Carroll poi, con i suoi paradossi logici, giocò sulla indebita commistione di questi livelli, mostrandoci come il ramo di un albero possa abbaiare perché in inglese si pronuncia «bau», o come i fiori riposino perché aiuola nella sua lingua è letto di fiori. In ogni caso, l’illusione di una completa sinonimia, di una perfetta corrispondenza semantica si è infranta definitivamente con il racconto Pierre Menard autore del Chisciotte di Borges, in cui l’esatta trascrizione, parola per parola, di un brano del capolavoro cervantino ad opera di quel poeta simbolista, a distanza di secoli assume un significato totalmente diverso. Trecento anni dopo, la collazione fra i due testi evidenzia come lo stile naturale dell’ingenio lego è diventato un arcaismo tronfio e pomposo, appunto anacronistico. Per tacere del fatto che lo stesso Cervantes presentò il suo libro come una traduzione dall’arabo, chissà quanto fedele. Fino a che scarseggeranno scrittori come Landolfi - definito da Montale «magnifico traduttore dal russo e da altre lingue, quando scriveva in proprio non faceva altro che tradursi, nascondendo in sé l’originale» -, l’unico modo di rispettare l’autentico spirito di un testo straniero sarà quello di intenderlo come se fosse stato pensato e scritto nel nostro idioma. Umberto Eco, aderendo al concetto di fedeltà abusiva, tradusse gli impossibili Esercizi di stile di Raymond Queneau apportando sostanziali e arbitrarie modifiche all’originale. In questo caso l’autore dell’originale perde la piena titolarità dei propri enunciati e alla traduzione viene conferito uno statuto autonomo, svincolato da ogni legame di dipendenza e subordinazione; come succede in fondo nel teatro, in cui l’interpretazione è incoraggiata più che tollerata. L’esempio dell’editore austriaco Federmeier, che, d’accordo con gli autori, presenta una collana di poesie deliberatamente priva del testo originale a fronte, va proprio in questa direzione. Come scrive Armando Gnisci, «la letteratura è il luogo comune delle differenze», e la comprensione di un testo inizia proprio con la consapevolezza di questa differenza resistente. Ogni traduzione non può che essere palinsesto, riscrittura, e come tale ha il compito di valorizzare le differenze, non di sopprimerle; opponendosi sia all’omologazione autoritaria del linguaggio editoriale che all’addomesticamento dei turiferari della fedeltà letterale. ittorio Curtoni (redattore e direttore di storiche testate, da ultima la rinata "Robot", scrittore, animatore di convegni e sagace testimone di mutamenti che, dal costume e dall’etica, passano alla cultura) è anche splendido traduttore. In tale veste, spazia dalla fantascienza alla letteratura angloamericana di ogni tipo. Curtoni è figura in qualche modo centrale di una modernità avanzata che sa coniugare generi e fare virtuosa commistione di passioni soddisfacendo la parte migliore della vasta istanza postmoderna. La sua biografia è una coerente crescita verso un punto cacuminale di equilibrio tra gusti e mode, tendenze e tradizione. Nasce a San Pietro in Cerro (Piacenza) il 28 luglio 1949. Alla metà degli anni Sessanta fonda, con Luigi Naviglio, la fanzine di fantascienza "Nuovi Orizzonti", dove pubblica i primi racconti e articoli. Dalla fine del 1969 cura con Gianni Montanari il quindicinale "Galassia" e lo "Science Fiction Book Club", storica collana nella quale appaiono in Italia Roger Zelazny, Samuel Delany, Barry Malzberg, Thomas Disch, Michael Moorcock. Lavora poi all’Armenia, dirigendo il mensile di fantascienza "Robot" . Successivamente cura i periodici "Aliens", "Omicron", la prima edizione italiana de "La rivista di Isaac Asimov" ed altre collane librarie. Nel 1978 comincia a fare in prevalenza traduzioni dall’inglese, ma seguita a firmare articoli, saggi e scrive oltre cinquanta racconti di fantascienza, tradotti anche in Francia e in Germania. I migliori, dal 1971 a oggi, sono raccolti in Retrofuturo (Shake Edizioni Underground). Altra sua antologia è Ciao futuro (Urania, Mondadori). Stilos lo ha intervistato sul difficile eppure stimolante compito di volgere narrativa da una lingua all’altra. Partiamo dal punto di vista del lettore. Si apre un libro, per esempio, di David Ellis, autore di thriller che lei traduce da un lustro. La trama avvince, la scrittura è un flusso trascinante d’interesse, con scarti e deviazioni che trasformano la fruizione del libro in una gradevole avventura mentale. C’è un solo problema: non si tratta delle parole e delle frasi di David Ellis, ma di Vittorio Curtoni. Come si può metterla? La si può mettere in maniera molto semplice: quando un traduttore capace ha a che fare col testo di un autore capace, l’incontro può essere proficuo per entrambi. Lei mi cita Ellis, e concordo. È un signore che sa scrivere di suo, senza bisogno che sia io a prestargli soccorso. Ha un ritmo notevole, un ottimo senso della sceneggiatura, un lessico variegato. Scrive per il piacere di scrivere (mi ha raccontato quando ci siamo conosciuti) dall’età di dieci anni, e si vede. Esattamente come me, en passant. Le mie equivalenze da traduttore sono elementari. Testo originale piatto uguale traduzione piatta. Testo originale rutilante uguale traduzione rutilante. Con tutte le possibili sfumature intermedie. Il traduttore deve sapere il fatto suo nella lingua d’arrivo, ma se parte da un testo moscio non c’è verso, si resta al palo. D’altronde, non sarà compito del traduttore risollevare un libro sgonfio, giusto? Lei una volta rievocava la frustrazione di un grande traduttore e scrittore, Luciano Bianciardi, che, alla fine di una giornata sul testo di un altro, si ritrovava pagine piene di cose non sue… E già. Bianciardi, nume tutelare della bistrattata categoria. È un ovvio dato di V CURTONI «Leggere e scrivere» VIVE TRA PESCARA E FOGGIA. IMMINENTE IL NUOVO ROMANZO DA AVAGLIANO "COMPLOTTARIO" ENZO VERRENGIA fatto che dopo avere trascorso quelle cinque o sei ore al giorno a lavorare su un testo altrui non sia così impellente la spinta a scrivere cose proprie. Non credo che i macellai si portino a casa la carne da tagliare la sera, per diletto, o che gli elettricisti si divertano a cambiare lampadine nel condominio. Per essere traduttore a tempo pieno e scrittore nel tempo libero, cioè per lavorare di continuo sulle parole e sulle idee, occorre una tempra eroica. Bianciardi ne era fornito molto più di me. Io mi svacco davanti alla televisione satellitare e cerco di svuotare il cervello, il che non è sempre semplice. Ma allora è tradurre o riscrivere. E nel passaggio, cosa si acquista e cosa si perde? È scrivere. Per essere un buon traduttore devi prima di tutto essere un buon scrittore. Che sia stato, per anni, un grande lettore, onnivoro, voracissimo, insaziabile. Questa è a mio giudizio una conditio sine qua non. Le differenze maggiori tra testo di partenza e testo d’arrivo, sempre se continuiamo a parlare di inglese e italiano, cioè della mia esperienza di lavoro, stanno nelle strutture sintattiche, notevolmente diverse: un autore come Bradbury è capace di imbastire una frase armoniosa a base di otto aggettivi, dieci gerundi, e un solo verbo reggente. Provate a lasciarla così in italiano e vedete cosa accade… Poi, ovvio, ogni scrittore e ogni traduttore hanno la propria lingua personale, il proprio idioletto per usare un termine colto. C’è solo da sperare che siano entrambi in gamba. L’italiano è una lingua ben più articolata. Non solo rispetto all’inglese, ma anche ad altre consorelle neolatine (il francese e lo spagnolo). Questo allarga i confini dell’espressione o semplicemente complica il lavoro del traduttore? Se non ricordo male, la linguistica distingue tra lingue sintetiche come l’inglese e lingue analitiche come l’italiano. Scrivere in una lingua analitica significa avere a disposizione un repertorio sintattico e lessicale molto ampio, in teoria. In pratica, la mia impressione è che negli ultimi decenni l’italiano si sia assai improverito sotto entrambi i profili, avviandosi verso una lingua media di notevole piattezza. Alla quale il traduttore, volente o nolente, deve attenersi. Se no, chi è abituato all’italiano televisivo come potrà mai riuscire a leggere un libro tradotto in maniera troppo «fiorita»? Non ci sono più le mezze stagioni, non c’è più religione, e non c’è più nemmeno l’italiano di una volta. Amen. Restiamo all’inglese, in particolare. I rapporti con la letteratura angloamericana non sono mai stati buoni per l’Italia del classicismo spesso ipertrofico. Almeno fino a Pavese e Vittorini, che hanno trovato un linguaggio adeguato per trasporre Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Fitzerald e Saroyan. Oggi, però, la contiguità con la cultura d’Oltreoceano è aumentata, certi giri di frase hanno acquisito una chiarezza che sfuggiva ai tempi di 13 "Americana", la storica antologia curata da Vittorini per la Medusa. Non ritiene, dunque, che bisognerebbe ritradurre certi classici, più che proporre novità a oltranza? Direi che sarebbe opportuno fare entrambe le cose, mentre oggi si tende ad agire molto sulle novità e assai meno sui classici. E, con le novità, non sarebbe male scremare le scelte con parecchi granelli di sale in più. Ma tant’è, se prevale (e prevale) la logica del vendere per vendere, del best-seller litigato tra gli editori, che ci si può aspettare? Approfondendo: lei è un esecutore delle politiche editoriali, pure potrebbe azzardare qualche ipotesi sui criteri di scelta delle novità straniere da proporre in italiano? Non può essere solo il successo commerciale, perché vi sono libri, per nulla contestualizzati, che hanno molto successo all’estero e da noi nessuno traduce, come The Age of Spiritual Machines, di Ray Kurzweil, un saggio sull’evoluzione dei computer scritto nel 1998, che qui non è mai apparso. Vedi sopra. A certi livelli, si cerca principalmente il libro che venderà, e non è detto che chi deve decidere sia sempre in grado di fare previsioni perfette. Se gli editor di una casa editrice pensano che una certa opera sia inadatta al pubblico italiano, cioè che non abbia potenziale di vendita, nessuno la pubblicherà. Poi, da molti anni, vige nella nostra editoria la devastante mania dell’inquadrare per generi, categorie, etichette, sicché magari uno trova il libro bellissimo che però non è esattamente né questa cosa né codesta né quell’altra, e se un editore non ha la collana «giusta» per metterlo, non lo accetta. Sono esperienze che ho vissuto non di rado sulla mia pelle. Quanti anni ha dovuto aspettare un grande come Jonathan Carroll per essere tradotto in Italia? L’avevo proposto a un nostro editore un decennio fa o giù di lì, però la sua è una narrativa eccentrica, non esattamente inquadrabile. In parole povere, non c’era la collana adatta per ospitarlo. Per fortuna, qualcun altro si è accorto di lui. Lei, lo confermava del resto poc’anzi, è soprattutto uno scrittore, al quale si deve l’evoluzione della fantascienza verso mete stilistiche e spessori di contenuti prima riservati alla letteratura non di genere. Che apporto le dànno gli strumenti culturali acquisiti nella sua scrittura quando deve rendere quella degli altri? Troppo buono. Non credo di meritare tanto. Com’è vero che tutte le esperienze di vita (se si è dotati del cervello capace di analizzarle ed elaborarle, s’intende) contribuiscono a farci crescere, cambiare, rendendoci esseri in continuo fieri e dialetticamente dotati di sintesi solo provvisorie; così ogni esperienza di scrittura può servire a migliorarci e come autori e come traduttori. Sono due mestieri a vasi comunicanti: il flusso è continuo, l’irrigazione reciproca. O almeno, lo spero. D’altronde, io sono un autodidatta, nessuno mi ha insegnato a scrivere, non ho mai letto manuali tecnici per aspiranti autori che ai tempi della mia formazione nemmeno esistevano; però, ehi, ho avuto la fortuna di incontrare le parole stampate di signori come Kurt Vonnegut, James Ballard, Theodore Sturgeon, Philip Dick, e J. D. Salinger, Albert Camus, Jean Paul Sartre, Heinrich Boll… Viva l’autodidattica, se a insegnarti il fai-da-te sono penne simili. pagina 14 e è vero che la musica trasmette passioni, è anche vero che le parole ricavate dalla musica possono aiutare a sentire con più forza passioni e sentimenti contenuti nelle note. Di Verdi come di Mozart, o come di chiunque abbia parlato coi segni del pentagramma. In questi saggi mozartiani di Massimo Mila (l’indimenticato musicologo venuto a mancare nel 1988), che ora vengono raccolti in volume dalla vedova Anna Giubertoni nel 250° della nascita di Mozart, la gioia della scrittura pulita si somma al rigore morale di chi sa coniugare lo studio con lo stile della vita e insieme riconoscerli nell’arte della musica e nel genio di Mozart. Di questi saggi Anna Mila Giubertoni ha parlato con Stilos. Cosa ha rappresentato Mozart per Massimo Mila? Una rinascita, non soltanto nel senso musicologico, ma anche nell’impegno civile. Dopo i cinque anni di carcere per antifascismo (1935-1940), nel 1941, in occasione del centocinquantenario della morte, Mila fu tra i promotori di una nuova lettura di Mozart, fuori dagli stereotipi reazionari di un Settecento incipriato così come dalle ambiguità di un demonismo che molto si prestava alle mistificazioni. Il valore di Mozart, la sua «modernità», consisteva invece, nel Settecento come nel Novecento, nel suo richiamo ai valori dell’«umanità». Negli anni della Seconda guerra mondiale, in tempi di atrocità, bombardamenti e miserie, Mozart significava, per Mila, la speranza in una Europa fondata su quei valori umani di cui la sua musica era altissima incarnazione. I saggi mozartiani, tra il 1941 e 1945, furono scritti in condizioni proibitive, mentre Mila era in libertà vigilata e poi, dal 1943, comandante partigiano della Terza Zona, nel Canavese. Negli anni successivi alla Liberazione, Mozart fu costantemente presente negli studi musicologici di Mila, fino all’ultimo saggio, nel 1987, un anno prima della morte. Per Mila Mozart fu sempre un compagno di strada dell’uomo moderno, un punto di riferimento «in avanti», amato anche per le sue dissonanze da compositori del Novecento come Ferruccio Busoni o Luigi Dallapiccola. A Mila non piace Il flauto magico, e in generale non lo attrae il cosiddetto «demoniaco» del maestro salisburghese. Come mai? Non è che a Mila non piacesse Il flauto magico. Il suo non è un giudizio così assoluto. Non è la partitura, ma sono le implicazioni massoniche e misteriche che lo lasciano indifferente. Non sono quelle implicazioni a costituire il valore della musica di Mozart. Certo, Mozart era stato un uomo dei suoi tempi, e la massoneria, cui era affiliato, aveva avuto un ruolo importante nella diffusione dell’illuminismo. Ma S Memorie C di guerra A in Etiopia T A L O G O S t los autori italiani Interviste MASSIMO MILA "Mozart. Saggi 19411987" pp. 374, euro 12,50 Einaudi, 2006 Anna Giubertoni, vedova di Massimo Mila, all’inaugurazione di un circolo mozartiano a Rovereto ANNA GIUBERTONI . La vedova dello studioso parla dei saggi sul grande compositore e ricorda la passione: «Sognava in Mozart la rinascita di un’Europa più civile in un mondo più umano» Gioia mozartiana di Mila diritto a cercare la felicità VIVE A LENTINI (SIRACUSA). GIÀ PRESIDE DI LICEI. "I FILI STRAPPATI" (IRIDE, 2005) ALFIO SIRACUSANO la modernità di Mozart va ben oltre il trovarobato esoterico delle logge massoniche. La presenza dei rituali e degli ideali massonici nel Flauto magico è indubbia, ma va storicizzata, a rischio altrimenti di diventare restrittiva. Cosa fu per Mila la gioia mozartiana? L’espressione del diritto alla ricerca della felicità. E Le nozze di Figaro ne sono la celebrazione. Tenga conto che nel 1776 la prima formulazione dei Diritti dell’Uomo, che precede quella francese e su cui si fonda la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, contempla il diritto alla ricerca della felicità, the pursuit of happiness. Questo è un bel pensiero, ma nei saggi non l’ho trovato. Ma Mila lo sapeva benissimo, e ne aveva fatto la chiave della sua Lettura delle Nozze di Figaro, pubblicata da Einaudi nel 1979, che ha infatti come sottotitolo "Mozart e la ricerca della felicità". Con quale criterio sono stati raccolti questi saggi? Tra i moltissimi scritti, ho raccolto anche quelli, mai prima pubblicati in volume, nei quali più si evidenzia la cifra stilistica che Mila privilegiava nella sua lettura di Mozart: il continuum di una apertura alla «modernità», dal Settecento al Novecento e oltre. Per Mila la storia della musica, o della cultura in genere, non procede per salti bruschi, il grande compositore non rende obsoleti i grandi compositori che sono venuti prima di lui, per poi essere a sua volta «superato» dai successivi. C’è un filo rosso che da Mozart arriva a Dallapiccola e oltre. Massimo Mila fu partigiano, uomo di sinistra, in un certo senso «rivoluzionario». E tuttavia di Mozart sembra ammirare il senso aristocratico NICOLA LABANCA "Una guerra per l’impero" pp. 479, euro 24 Il Mulino, 2005 Tra memoria ufficiale, memorie strozzate da nostalgie o rancori, amnesie storiche e ambigui silenzi, la campagna di Etiopia (1935-36) costituisce una pagina quasi dimenticata che Labanca, docente di Storia contemporanea a Siena, rilegge organicamente: la guerra d’Etiopia, la prima voluta e vinta da Mussolini, quella che avrebbe dovuto spostare l’Italia «sul piano dell’Impero», dice molto del regime fascista che l’aveva scatenata. dell’arte, depositaria di un suo ruolo catartico che la salva dall’insulto dei tempi, appunto, rivoluzionari. Come si conciliano, nell’idea di Mozart, questi due aspetti? Si conciliano eccome! La cultura non è come la nutella da spalmare qua e là, a seconda delle mode. La cultura è innanzitutto fatica. È impegno individuale, una ricerca continua fuori da preconcetti o schemi ideologici. La «rivoluzione» dell’artista implica, in ogni caso, la fatica del mestiere ben fatto, e nel contempo il gusto «aristocratico» sta precisamente nella «sprezzatura», nel senso di levità, l’understatement, con cui si supera quella fatica e non la si fa pesare. Alto artigianato? La cultura implica l’artigianato, anche se non si esaurisce certo in esso. Ma il «mestiere», per l’artista, è alla base di quella che Thomas Mann definiva «nobiltà dello spirito». Durante l’infanzia Mozart impara il «mestiere», grazie alla pedagogia musicale di suo padre, Leopold. Una disciplina durissima che gli consentirà tanta maggiore libertà di composizione. Il mondo cantato in versi Nel Programma per un circolo mozartiano, scritto nel pieno della barbarie bellica, Mozart diventa metafora di un mondo migliore, la bellezza serena della pace dopo la bruttura della guerra. Quanto di questo messaggio ritiene attuale? Il messaggio è attuale, oggi come ieri. Il guaio è che non è stato attuato. Nel 1942, sotto i bombardamenti, Mila sognava in Mozart la rinascita di un’Europa civile, in un mondo più umano. Mila era tra i pochissimi che da sempre avevano detto a chiare lettere no alla dittatura fascista, pagando il suo impegno in «Giustizia e Libertà» con una condanna a sette anni di carcere. Era molto mozartiano, questo suo coraggio, molto simile al no del Don Giovanni, personaggio che a Mila piaceva moltissimo, cui era per molti aspetti affine nel libertinismo del pensiero. Nel Programma per un circolo mozartiano, l’aspirazione ad una armoniosa serenità del vivere civile è fondata sul diritto/dovere di dire di no, non soltanto alle dittature ma anche alla trascuratezza, al pressappochismo, al carrierismo, al menefreghismo: caratteristiche più che mai attuali e «trasversali», ai nostri giorni come a quelli di ieri. Mila fu musicologo finissimo e finissimo letterato. Ma anche scrittore «cartesiano», per la chiarezza del suo stile. Di queste tre qualità, ma ne ebbe certamente anche altre, quale considera il suo lascito più autentico? Ma le tre cose sono inscindibili. La scrittura per Mila non è un accessorio, la chiarezza del suo stile si ispira non tanto a Cartesio quanto alla clarté di Voltaire, autore da lui amatissimo, cui era legato dal gusto per l’ironia, o meglio, dell’autoironia. Il dovere primario del musicologo, così come del letterato, è di far chiarezza nelle proprie idee, spingerne la comprensione al limite estremo: non sono ammissibili gli escamotages ideologico-accademicoautoreferenziali di una scrittura che se ne infischia del lettore, oggi come ieri. Spesso Mila contrappone Mozart a Beethoven, che di volta in volta sono FRANCO MARCOALDI "Animali in versi" pp. 95, euro 11 Einaudi, 2006 Forse perché è «sulle spalle degli animali che ricade il peso dell’origine, il marchio dell’istinto, il pregio dell’immediato", il «racconto oggettivo della vita senza note a margine e commento» inizia dagli animali. Animali cantati in versi intessuti di evocazioni, citazioni e riscritture: non solo cani, gatti e buoi, ma anche scorpioni, rospi, lucertole, zanzare, barbagianni e scimmie, in un bestiario poetico raccolto da Franco Marcoaldi. Notazioni bibliche ai scettici apparsi il passato o l’avvenire, il richiamo alla civiltà o il presagio di barbarie. Lei, che certo ha conosciuto meglio il suo pensiero, può dirci cosa in realtà ne pensava lui di questa contrapposizione? Le contrapposizioni di Mila non erano mai tifo per l’uno o per l’altro, sul tipo Juve contro Toro (anche se Mila teneva per il Toro). Quindi niente Verdi contro Wagner o cose di questo genere. Semplicemente va detto che nell’uso, parola orribile, che si può fare di Mozart rispetto a Wagner o a Beethoven non era prevista la retorica. Per Mozart non c’è alcuna possibilità di retorica. Per questo il nazismo non poté farsene icona. Mozart è immune dalla retorica. Cosa che non si può dire per Beethoven o per Wagner. Wagner sicuramente più di Beethoven. Ma anche per quest’ultimo, guardi. Ci fu chi ne fece. Basti pensare all’enfasi eroico-nazional-popolare di certi spettacoli in piazza con relative adunate oceaniche, oggi come ieri. Mila storicizza Mozart, del quale peraltro, dice, si conosce si e no un terzo dell’opera. Non so se è ancora così. Questa raccolta di saggi nella ricorrenza dei 250 anni dalla nascita di Mozart può essere considerata un invito ad approfondire lo studio del musicista? Credo che Mozart non abbia certo bisogno di inviti all’approfondimento. Semmai il genetliaco può indurre a riflettere sul come e perché Mozart, come ogni grande genio, vede alternarsi fasi di interpretazione, per cui un’epoca ne privilegia un aspetto per tralasciarne un altro e così via. Nel 1941 Massimo Mila è stato tra i protagonisti della «riscoperta» di Mozart nel segno della sua modernità e «contemporaneità» con i compositori del Novecento. Quanto al famoso catalogo Koechel, si sa quanto Mila non amasse la catalogizzazione, che implica bizantinismi numerici e conseguenti forzature. Altra cosa è lo studio e la ricerca di manoscritti e spartiti autografi. Un aspetto appassionante e non solo per ricchi collezionisti. Basti pensare alla vicenda tragica dei preziosissimi autografi mozartiani raccolti da Stefan Zweig e allo scempio conseguente la sua rovinosa fuga da Salisburgo, nel 1938, per sottrarsi all’Anschluss nazista: tutti conosciamo la tragica fine di Zweig, il suicidio insieme con la giovane moglie. La vicenda degli autografi mozartiani di Zweig è molto meno nota anche se alquanto avvincente. E un pensiero di gratitudine va a studiosi come Albi Rosenthal che, in fuga dalla Germania nazista, si prodigò nel rintracciare e recuperare proprio quegli autografi mozartiani, ora esposti per il 250°, alla British Library, a Londra. Ma questa è un’altra storia, che a Mila però sarebbe piaciuta. MAIMONIDE "La guida dei perplessi" pp. 803, euro 12,90 Utet, 2005 Gli studi su Mosè Maimonide sono stati negli ultimi anni particolarmente numerosi soprattutto in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte dell’autore, nato nel 1204 e molto seguìto in Europa tra il 1200 e il 1500, forse per il fatto che avrebbe potuto conoscere Avicenna. La sua Guida dei perplessi, considerata l’opera più significativa e più celebre della filosofia ebraica medioevale, è un testo di esegesi «filosofica» della "Bibbia". V O C I PREMI A DAVID GROSSMAN Il «TERRA D’OTRANTO» David Grossman e Monsignor Vincenzo Paglia sono i vincitori della seconda edizione del Premio Grinzane - Terra d’Otranto, un premio internazionale sul tema del dialogo, della tolleranza, della solidarietà e dell’integrazione, istituito dalla Regione Puglia e dal Premio Grinzane Cavour, con la collaborazione della Città di Otranto. Sarà nuovamente il castello Aragonese di Otranto lo scenario della cerimonia di premiazione che avrà luogo sabato 18 marzo alle 10,30. Per la prima sezione il premio è stato attribuito all’israeliano David Grossman che «attraverso libri-inchiesta sulla questione palestinese, diversi libri per ragazzi e numerosissimi articoli sulla crisi mediorientale, si è sempre schierato per la pace e la tolleranza ed ha contribuito a rafforzare l’idea che la cultura può rappresentare un terreno d’incontro e confronto fra mondi, linguaggi e anche religioni differenti». Per la seconda sezione il riconoscimento è andato a monsignor Vincenzo Paglia per la sua attività presso l’Associazione "Uomini e Religioni" della Comunità di Sant’Egidio e anch’egli tenace propugnatore del dialogo interraziale. POESIA BANDITO CONCORSO PREMIO DI HAIKU Bandito il Premio letterario nazionale di poesia Haiku con il patrocinio delle Ambasciate del Giappone a Roma e alla Santa Sede. Il Premio è aperto a tutti ed è gratuito. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 10 haiku inediti. Non sono ammesse le opere che abbiano già partecipato l’anno scorso. I testi dovranno rispettare la metrica del haiku: tre versi di 57-5 sillabe, ma non è necessaria la rima. Per garantire l’anonimato i testi dovranno essere inviati in 7 copie di cui 6 anonime più una con nome, indirizzo, telefono; la copia firmata sarà inserita in una busta chiusa da spedire insieme alla altre 6 alla Associazione Amici del Haiku, c/o Edizioni Empirìa, via Baccina 79, Roma 00184. Il materiale deve pervenire entro il 15 aprile. La premiazione avrà luogo a Roma il 7 giugno alle 17, all’Istituto Giapponese di Cultura. Per informazioni telefonare al numero 06.69940850. OCTAVIA BUTLER DOPO LA SCOMPARSA IL SUO ULTIMO ROMANZO Di Octavia Butler, scrittrice afroamericana scomparsa il 24 febbraio all’età di 58 anni, la Fanucci pubblicherà il suo ultimo romanzo, Fledgling, ritenuto di genere gotico: di una storia di vampiri fa uno specchio deformante con cui guardare le contraddizioni del proprio Paese. Della Butler, autrice di 12 romanzi, la Fanucci ha anche pubblicato La parabola del seminatoree La parabola dei talenti. autori italiani COSTANZA DE SETA DOMENICO CACOPARDO . Un nuovo giallo dell’investigatore che ama l disincanto si addice ad Italo Agrò, il magistrato ancora protagonista del nuovo libro di Cacopardo, un libro dal titolo gentile per una storia «politica» di giustizia utopica, la stessa nel cui nome il procuratore della Repubblica siciliano combatte contro i giochi clientelari e il sistema della corruzione. Ed è un Cacopardo altrettanto disincantato, che si dice «liberato» come scrittore dopo Virginia, «liberazione» che ha propiziato un diverso coinvolgimento narrativo. Stilos lo ha intervistato. Nuova indagine perAgrò, un’indagine che non è più un’endiadi ma un entimema o un sillogismo zoppo. E l’inchiesta rimarrà un sillogismo zoppo o avrà una soluzione? L’inchiesta avrà alcune soluzioni, tutte figlie di un entimema o sillogismo zoppo che dir si voglia. Come sempre, nella vita, ogni soluzione è provvisoria. Noi che «sappiamo» di diritto diciamo «allo stato degli atti». Ma gli atti spesso mutano strada facendo, le vittime diventano carnefici e dunque, forse ha ragione Nietzsche de La gaia scienza, Idilli di Messina. L’uomo, l’essere normale inferiore al superuomo, vede solo il presente e non sa immaginare o guidare il futuro. Ecco, Agrò, come me, vede un presente sconfortante e le sue speranze sono ridotte al lumicino. Del resto, sempre Nietzsche, nello stesso libro, sostiene che le spiegazioni «mistiche» passano per profonde e in realtà non sono nemmeno spiegazioni. E, parlando terra terra, il presente è questo che vediamo intorno a noi. E, come noi, lo vede Italo Agrò, dal suo osservatorio privilegiato di un’aula di giustizia. Sostiene Torquato Tasso, nella Gerusalemme, che «Or, se tu se’vil serva, è il tuo servaggio (non ti lagnar) giustizia, e non oltraggio». Dunque, alla prostrazione attuale, all’echeggiare di stolide parole d’ordine, possiamo solo rispondere, noi scrittori, con la scrittura, raccontando l’Italia come è, come siamo. Dal delitto apparentemente passionale a intrighi spionistici e politici che toccano alti vertici del potere: anche questa storia del dottorAgrò non si smentisce. Ma qui le cose sembrano complicarsi e Agrò si trova a dover scegliere. Ha avuto in mente qualcuno e qualche situazione cui ispirarsi? Ma... lo debbo proprio dire? Certo, penso a me stesso e a ciò che dovrei fare e non ho ancora fatto. Ma non diciamo troppo, altrimenti si capisce troppo, appunto. Quasimodo e che si è trasferito a Viterbo da procuratore della Repubblica. Ancora i poteri forti e trasversali intramano una vicenda a tinte nere nella quale lo scrittore siciliano si cala quasi in prima persona I GENNARO CESARO ualche tempo fa, trovandomi a soggiornare a Lucca, un oscuro sortilegio mi fece conoscere, del tutto fortuitamente, una persona, che - tra una chiacchiera e l’altra mi confidò di possedere una ghiotta reliquia pascoliana: tre lettere inedite del poeta alla padrona di casa, un’antenata del mio interlocutore. Aderendo molto affabilmente a una mia richiesta, l’uomo mi portò nella sua dimora e da un antico, alquanto sbiadito canterano cavò fuori le tre preziose missive, conservate assai gelosamente in una cartellina di plastica, consentendomi di trascriverne il contenuto. È un Pascoli alle prese con la più cruda e partecipe quotidianità quello proposto dalle lettere in questione. Com’è agevole constatare, infatti, il testo appare improntato da questioni di contabilità spicciola e da oggetti di arredo domestico: le piccole cose tipiche dell’umile universo pascoliano. La prima lettera è datata Barga 27 luglio 1908 ed è indirizzata, alla signora Edvige Rossi, la padrona della casa bolognese presa in affitto dal poeta e ubicata al n. 702 della Salita dell’Osservanza, fuori di Porta d’Azeglio. II poeta si mostra anche sensibile a certi disguidi gastrici del signor Eugenio Rossi, marito della padrona di casa. «Gentile Signora, eccoci, dopo quasi un mese!, a dar notizia di noi, anzi al nostro solito, a chiedere qualche cosa. Vorremmo dal signor Eugenio che: 1) ci scrivesse il quanto e il quando della rata di pigione di agosto. Quanto dobbiamo, quando lo dobbiamo. Le carte nostre sono costì e non ci ricordiamo nulla; 2) ci mandasse quell’orologio a pendolo grande che combinammo, insieme con quattro di quei candelieri da giardino che reggono al vento. Dica a suo marito di stare ben attento nell’acquistare l’acqua Janos, che sia quella naturale: una bottiglia può bastare. Ma sarebbe meglio che ne prendesse due, se pure non preferisce il vecchio buon olio paesano di ri- Q IL LIBRO DOMENICO CACOPARDO "L’accademia di vicolo Baciadonne" pp. 352, euro 17,50 Baldini Castoldi Dalai, 2006 Doppio delitto quattro anni fa 2002: Italo Agrò, divenuto procuratore della repubblica a Viterbo indaga sul delitto dell’ambasciatore in pensione Claudio Raminelli del Vischio e della giovane moglie ceca. Disincantato come Agrò ho la mia idea di giustizia Il titolo del libro si rivela un riferimento ad un elemento piuttosto marginale della storia. Quale significato ha allora? Un omaggio all’accademia nella quale sedicenne ho cercato vanamente di imparare a ballare. Forse era una scusa per corteggiare le frequentatrici della scuola. Comunque, l’accademia si rivela risolutiva, per l’intuito di Italo Agrò, per un pezzo del puzzle. Il racconto ha più di un riferimento ai precedenti romanzi e, in particolare, a La mano del Pomarancio. Che tipo è il detective Puccio Ballarò e in che rapporto è con Agrò? Puccio Ballarò mi diverte. È un simpatico cialtrone, che però, al di là delle arie da cialtrone, ha capacità investigative vere. Una specie di Marlowe dei poveri, di Antillo in provincia di Messina. Io ci tornai per dare un’occhiata prima di uscire con La mano del Pomarancio. Chiesi chi fosse il santo protettore del paese e un tipo con l’aria addormentata, lì nel bar fumoso, mi rispose: Sant’Onofrio. L’addormentato mi fregò. Sant’Onofrio non è il protettore di Antillo. La Madonna protegge il villaggio peloritano e i suoi devoti abitanti. E perché scegliere Viterbo e la Tuscia, come teatro della scena? Ho scelto Viterbo e il Viterbese perché li conosco bene. Ci sono stato dal 1947 al 1954. Ci sono tornato spessissimo. Ho i miei compagni di scuola. E, poi, è una realtà molto statica, nella quale gli avvenimenti hanno ritmi pastorali. Insomma, un po’ di mortaretti nella quiete viterbese potrebbero essere stimolanti. Di Viterbo è il mio amico Massimo Onofri, il critico del presente e del futuro. Vorrò vedere la sua faccia, dopo la lettura dell’Accademia di vicolo Baciadonne. In cosa questa provincia differisce da quella siciliana cui idealmente, nei ricordi e nei pensieri, si riferisce la persona di Agrò? Meno di quel che si possa pensare. Poiché, è vero, qui non c’è la mafia, ma tuttavia c’è un potere solido, consolidato e senza ricambi. Sempre lo stesso. Sostanziale e non formale. Oltre che la provincia peloritana della Sicilia, sempre presente nelle sue storie, Ungheria ed Est tornano spesso nei suoi racconti e anche in questo non si fa eccezione. Li ama particolarmente? La presenza della Sicilia come dell’Ungheria dipende da fattori affettivi. Come i miei lettori affezionati sanno, la famiglia di mia madre viene dall’Ungheria. E amo quel paese (sono in partenza per un ciclo di conferenze, sto cercando casa a Pecs per le mie ricerche su Tidavar Kokca, il pittore di Taormina). Amo anche la Cechia, soprattutto Praga, anche se è diventata, cosa che non è accaduta a Budapest, una specie di grande mall americano. A Praga vivono 26 mila statunitensi. Questo dell’Accademia del vicolo Baciadonne, tra «gli Agrò» protagonisti della sua scena narrativa, sembra più profondo ma anche più disilluso. È così che le piace? Sì. Forse perché incipit senilitas. E, poi, l’Italia delle illusioni e delle speranze non è finita con la fine del sogno europeo? Però ama sempre citare Quasimodo, i cui versi sembrano un modo di leggere e interpretare una realtà sulla quale il magistrato non si fa alcuna illusione. È così. In fondo, a questo punto della vita, compio settant’anni in aprile, il dolore del mestiere di vivere nella società incivile prevale sul pensiero marxista che mi ha ispirato per tanti anni e che è presente nell’undicesima tesi su Feuerbach: «I filosofi hanno cercato di interpretare il mondo. Oggi si tratta di mutarlo». Dunque l’utopia della giustizia rimane tale. L’ho sempre scritto: la giustizia della quale si parla è la giustizia con la g minuscola, la giustizia convenzionale, che ha sempre un appello nella coscienza delle persone. È una giustizia sulla base dei risultati processuali. Ma, nella mente delle persone, specie nelle piccole comunità, la verità vera si fa sempre strada. Perciò siamo di fronte ad un Agrò cresciuto, anche se disincantato, ma con nuove certezze, anche sentimentali. Significa che Agrò come personaggio ha già avuto la sua evoluzione e dunque potrebbe essere lasciato andare? Agrò non è Montalbano: non è una gag per fare soldi. È una metafora, un transfert e, perciò, può morire e vivere ancora. Dipenderà dal mio estro, dalle cose della vita e del mio paese, l’Italia, se tornerà a essere protagonista e, come Ulisse, a viaggiare per il bel paese, mettendone in luce porcherie e delizie. Per il momento ho altri progetti: un romanzo sul passaggio di Michelangelo Merisi da Messina, tra il dicembre del 1608 e il luglio del 1609. Un passaggio fondamentale per la storia dell’arte e per l’evoluzione della pittura caravaggesca. E poi la seconda parte di Giacarandà, che si intitolerà L’ombra della Poinziana. E, mentre i due romanzi che ho detto sono scritti e pronti alla pubblicazione che avverrà con i ritmi imposti dal mio agente e dal mio editore, sto lavorando alla storia del mercante di santini che ha fatto capolino in Virginia. Una specie di autobiografia critica a cui tengo molto. Il romanzo conclusivo, se campo abbastanza per terminarlo. Un testamento, forse un addio. INEDITI. Ritrovate a Lucca tre missive di quotidiana attività Pascoli, lettere alla padrona di casa cino, il quale, nella dose di tre oncie, può far passare un’indigestione anche peggiore della sua. Mi creda suo Giovanni Pascoli». La seconda missiva è del 1° marzo 1909: «Egregia Signora, avemmo a suo tempo i candelieri magici e l’orologio. L’orologio arrivò piuttosto male in salute, ma noi (ella sarà lieto di apprenderlo) lo affidammo alle cure di un…..padre cappuccino; non perché gli raccomandasse l’anima, ma perché gliela accomodasse. E così fece il buon padre, e ora l’orologio è sulla scala che suona soave e piano le ore, e ha tanto bene recuperato la salute che corre sin troppo e passa avanti tutti gli orologi e campane accoccolati in questa valle. Ma la troppa salute non guasta, e noi facilmente otterremo dal vispo ragazzo un po’ di scavallamento. E grazie grazie grazie al buon e cortese signor Eugenio e a lei. Mi creda suo Giovanni Pascoli». L’ultima lettera senza data è screziata da un malinteso tra il poeta e il signor Eugenio in relazione all’abitudine dell’illustre fittavolo di tener aperte le finestre dell’appartamento specie di sera, per troppo tempo a giudizio del marito della padrona. Pascoli minaccia addirittura di cambiare casa: «Egregia Signora, appena c’era un raggio di sole, io per l’addietro aprivo la porta-finestra della stanza nuova. In giorni ventilati come questo aprivo anche la finestra. Così ho sempre fatto chiudendo poi con ogni diligenza, a sera. Oggi sarebbe giorno di apertura… Ma il signor Rossi ieri e l’altrieri e prima ancora ha affermato che l’umidità di quella stanza proviene dall’aver aperte porta e finestre. Sicché non so come fare. Vorrei (come gli dissi due volte) che venisse a far aprire e far chiudere. Io volevo sapere, co- sì all’orecchio confidenzialmente, quanto sarebbe stato l’aumento per me, press’a poco, perché avendo qualche occasione di mutar casa, se l’aumento mi fosse parso non soverchio, non volevo perderla. Ella, fondandosi su i diritti contrattuali dei padroni di casa, non l’ha finora detto, per sua gentilezza: me lo dirà prima della data in uso. A me dispiace di essere stato indiscreto. D’altra parte, quando mi comunicherà l’aumento, le mie occasioni possono essere svanite. In tali circostanze il meglio che io possa fare è di disdire sin d’ora il mio appartamento e di pregarla di voler significare al pubblico sin d’ora che quell’appartamento è da locare. Così è molto probabile che le inevitabili visite e il conseguente contratto con il nuovo affittuario siano già compiuti, quando tornerò. Poiché lei sa, campando io del solo mio lavoro ed essendo questo lavoro assiduo e duro, troverei molto imbarazzante dare udienza a tanti che verrebbero a vedere il quartierino. E separiamoci da buoni amici. Ella (io sospetto, e il sospetto mi avvelenerebbe il piacere di restare dove sono stato assai bene quattro anni e dove resterò sino al prossimo maggio) non si sente libero nel proporre l’aumento. E io non voglio esserle d’ostacolo. Mi saluti la signora e mi creda suo Giovanni Pascoli». Col tempo le incomprensioni andarono svaporando e così il poeta continuò a occupare l’appartamento bolognese in piena serenità e totale appagamento, insieme con l’appiccicosa sorella tuttofare Mariù, morendovi il 6 aprile 1912. Quanto a Castelvecchio - oggi non a caso Castelvecchio-Pascoli c’è da dire che la villa estiva ubicata nella suggestiva frazione di Barga era stata per il poeta romagnolo quel che si suol eufemisticamente chiamare la patria del cuore. A dimostrarlo lampantemente è il fatto che lì volle essere sepolto. Ne è riprova altresì l’eponi- ma raccolta di versi I canti di Castelvecchio (1903). In quest’opera che rappresentò una tappa piuttosto rilevante nel processo evolutivo nella poetica pascoliana, c’è una composizione intitolata non a caso "L’ora di Barga", che fa assai egregiamente il punto sullo stato d’animo del poeta romagnolo negli anni della sua permanenza in terra toscana. Le sette sestine e rima alterna di cui consta ci danno il senso di un armonioso connubio tra la complessa interiorità dell’autore e l’appagante gradevolezza dell’ambiente. Il Pascoli si trova davanti alla sua abitazione in Castelvecchio, precisamente nel cantuccio che dà sull’orto e il vento gli reca il suono dell’ora scoccata sul quadrante del campanile del tranquillo borgo lucchese. Il poeta si sente come rapito da un sibillino richiamo, ma il suo animo è assediato da malinconici presagi in quanto, per induzione analogica, quei ritocchi gli fanno pensare al momento della morte. I quinari che animano le sestine sono scandite da una ponderata gradazione di pathos. In quell’ora occidua lo spirito del Pascoli è tutto un intenso rimescolio di pensieri, convergenti fatalmente sull’ineludibile arcano che popola le cose. Nella smorta luce del crepuscolo il paesaggio di Barga assume contorni quasi spettrali e il diffuso silenzio innesca nel cuore del poeta il sentimento di un imminente approdo oltremondano. Evento che si verificò tra anni dopo quei coinvolgenti presagi. Resta soltanto da rammentare, a mo’ di corollario, che il poeta aveva potuto acquistare la casetta di Barga grazie ai proventi derivatigli dalla vendita delle medaglie d’oro vinte all’annuale premio di poesia latina di Amsterdam. pagina 15 Capoverso Nella foto in alto Domenico Cacopardo che da Baldini ha pubblicato L’accademia di vicolo Baciadonne. In basso Giovanni Pascoli a Barga con la sorella Maria e un amico IDOLINA LANDOLFI Nâzim Hikmet, Poesie d’amore. Fotografie di Robert Doisneau, Oscar Mondadori, pp. 286, euro 15. Nella «classica» traduzione di Joyce Lussu, che firma anche una breve nota finale, il prezioso volumetto si compone di alcuni capitoli, tra cui le poesie dal carcere, quelle dall’esilio, i poemetti, le poesie sulla morte. L’amore informa di sé ogni frammento; è l’amore che salva il poeta dai disastri della vita, e dalla tentazione di cedere le armi. «Grazie a te - scrive in un testo del 1960 - non lascio entrare la morte vestita di veli molli / che bussa alla mia porta cantando le sue canzoni /e incitandomi al gran riposo». Nato nel 1902 a Salonicco da una ricca famiglia, si sposta presto in varie città, Aleppo, Mosca, dove compie gli studi universitari. Abbraccia toto corde il credo comunista, nel 1924 è tra coloro che montano la guardia alla salma di Lenin. Per le sue idee è incarcerato in Turchia per tredici anni, dapprima condannato all’impiccagione. Nel 1951 lascia definitivamente la patria, poi luogo della nostalgia sempre rivisto con gli occhi della mente, e si trasferisce a Mosca, dove muore, da solo, nel giugno del 1963. Del resto la sua storia egli narra in una lunga poesia autobiografica, "Sono nato nel 1902", dove il secco elenco delle vicende ben mette in luce la paradossalità di certi comportamenti umani: «Quando avevo trent’anni hanno chiesto / la mia impiccagione / a quarantotto mi hanno proposto / per la medaglia della pace»; e la sua coerenza di uomo mai sceso a compromessi. Perseguitato lui e bandite le sue opere dalla patria, diviene post mortem, come spesso accade, il poeta nazionale, uno dei fari della cultura turca. Molti amori sono qui esemplati: per la sua terra, il cui volto si sovrappone spesso a quello della donna amata, d’altro e medesimo canto «sua unica patria»: «Come sei bella, Dio mio, come sei bella / L’aria e l’acqua di Istanbul nel tuo sorriso / La voluttà della mia città nel tuo sguardo». Nel suo fare poetico si fonde la tradizione della lirica arabo-persiana (così nelle prime prove) alla più moderna versificazione, accanto ai maestri del simbolismo e del futurismo russi. Sono liriche in cui confluisce, variamente rivisitato, tutto l’immaginario d’oriente; e ancor più, forse, in quelle scritte dall’altrove (non uso a bella posta la parola esilio), quando i luoghi si tingono del colore favoloso della memoria, divengono sogni e visioni. Sfilano il puro idillio di un sogno, in cui la donna passa tra i rami, «come la luna / tra una nuvola e l’altra», e scene che affiorano da un’anima sempre protesa verso la vita: «Hai posato il piede nella mia cella / e il cemento è divenuto prato / hai riso / e rose hanno fiorito le sbarre». Prigione abitata a tratti dai fantasmi del passato, dagli amici morti (come nella bellissima "Della morte", del 1946); e dalla nera signora in persona, che lo ha guatato l’intera sua vita, prima dall’ombra del patibolo, poi dal suo stesso petto, in cui un cuore incerto e bizzarro più volte parve arrestarsi; in "Angina pectoris", del 1948, è proprio lui, il rosso organo, il personaggio protagonista, lacerato tra cento destini, colpito a morte tante volte. «Io non ho paura di morire / ma morire mi secca / è una questione d’amor proprio»; ma seguiterà la sua forza nel figlio, Mehmet, al quale, nella struggente "Forse la mia ultima lettera a Mehmet", rammenta la propria esistenza, all’insegna di una superiore dignità: quella, invincibile, del poeta. pagina 16 PATRIZIA DANZÈ « ucire assieme tutte le parole amore per farne una lunga filastrocca: un ghirigoro che sapesse abbracciare il mondo, come la linea dell’equatore riesce ad abbracciare la terra». Una filastrocca che Roberto Cotroneo canta nel suo ultimo bel libro, una linea netta e preziosa ricamata sulla pagina dove si posano leggere e intense tutte le parole di «questo amore». Questo amore (questo e non un altro, questo amore che a tutti appartiene perché a tutti può essere rivelato e svelato) vive nella «semplice» storia di Cotroneo ricordando a tutti la sua umanità, la sua poesia e la sua lingua. Una lingua dimenticata per un sentimento dimenticato o svilito, una lingua che ritrova nella forma castigata la bellezza che è vita e scorre chiara come un respiro, il respiro dell’anima, il respiro della poesia. È una bella immagine dell’amore, senza compromessi e senza approssimazioni, quella che ci dà Cotroneo; assieme ad una storia cui non nuoce l’economia della trama e che mentre si gusta per le sue atmosfere, le sue intime fantasie e i suoi rimandi letterari, non cela nella sua semplice complessità la presenza di un nodo segreto sospeso sino alla fine e infine sciolto. Stilos lo ha intervistato. Sin dal titolo il suo romanzo rimanda ad un sintagma, «questo amore», ricorrente nella poesia come nella canzone. La presenza forte del dimostrativo non è certo casuale, anche se l’espressione può risultare ovvia e abusata. Come è da intendersi dunque «questo amore»? Si deve intendere con la consapevolezza di una cosa. L’amore del mio libro è l’amore di Anna e di Edo. E solo perché avviene questo può essere anche l’amore di tutti quelli che leggono, e l’amore di altri ancora. L’universale passa proprio dal dimostrativo. «Questo amore» diventa così un dimostrativo universale. La possibilità che «questo» sia un «questo» che vale per tutti. Lei stesso ha rivelato che «questo» libro, o, meglio, l’idea di «questa» storia che sembra levitare su un’altra dimensione, è nata da una storia vera. Difficile parlare di una storia vera quando poi la scrivi in un romanzo. C’è una storia di Anna ed Edo che ha fatto da punto di partenza del mio romanzo. È una storia d’amore. Ed è una storia di assenza. Loro sono due librai, lui era un calciatore, e si chiamava Edo C Interviste LUCIA T. INGROSSO "La morte fa notizia" pp. 288, euro 15 Pendragon, 2005 n giallo tutto italiano, ambientato in una Milano autunnale: fa sempre piacere ritrovare luoghi conosciuti fra le pagine dei romanzi, dove seguire, come nel caso di La morte fa notizia, di Lucia Tilde Ingrosso, i personaggi coinvolti nella morte, che appare subito sospetta, di Linda, una studentessa, appena assunta in un’agenzia di pubbliche relazioni in cui lavora anche la bellissima Alessandra. Alle indagini di Sebastiano Rizzo, ispettore della squadra mobile, si aggiungono quelle di un trio investigativo alle prime armi, ma non meno efficiente. Giocato sul veloce alternarsi di diversi punti di vista colti con occhio cinematografico, La morte fa notizia è un romanzo dal rit- U S t los autori italiani Sopra Roberto Cotroneo, autore per Mondadori di Questo amore. Sotto Lucia T. Ingrosso, che da Pendragon ha pubblicato La morte fa notizia ROBERTO COTRONEO . Sentimenti forti, emozioni dolorose, percezioni assolute. Qui è l’anima protagonista, la fisicità delle persone declina. «C’è identità, c’è memoria, c’è poesia. E poi c’è luce, e poi c’è il mare, e poi ci sono le paure, la perdita, il pensare, e gli oggetti e i ricordi e i libri che si sfogliano con il vento. E c’è la sabbia, e ci sono i suoni, e ci sono certi colori, certi profumi di agrumi» La mia definizione dell’amore? È un «dimostrativo» universale Palmieri. Poi il resto ho dovuto farlo vivere dentro la mia sensibilità e nelle parole della mia immaginazione. La storia dalla quale ha preso spunto era così speciale e intensa come nel libro o è stata per lei solo un’immagine di partenza? Entrambe le cose. Era un’immagine di partenza molto intensa. Come se fosse possibile descrivere l’amore, descrivere l’amore come un paesaggio o un disegno. Dunque, quella da lei «raccontata» per immagini e pensieri è la storia di un amore o la storia di un’anima? No, è la storia di un amore, proprio perché tutte le storie d’amore sono storie di un’anima. Ma soprattutto sono le storie ad avere un’anima, i personaggi forti. Ma quante storie ci ha voluto dire con questo suo romanzo? O quante storie possiamo decifrare leggendo? È molto difficile per me rispondere a questa domanda. Ci sono mille storie da decifrare nel mio libro. Diversi livelli di lettura. Io conosco diversi modi di leggerlo. Ma sono convinto che i miei valgono come quelli degli altri. Ognuno in questo romanzo potrà trovare quello che cerca davvero. Questo amore può essere la poesia? No, la poesia è un medicamento per i dolori dell’anima. Ma è interessante questa domanda. Chissà, si potrebbe pensare anche al fatto che «questo amore» sia un amore di tracce e di citazioni poetiche. Calcio e libri: un’accoppiata insolita. Come ha deciso di metterli insieme in un personaggio e, soprattutto, in un amore? Mah... il calcio è tante cose. I libri anche. Solo che il calcio ormai ha perso la sua aura romantica ed è solo chiacchiere ossessive sui dettagli, non c’è IL LIBRO ROBERTO COTRONEO "Questo amore" pp. 137, euro 16 Mondadori, 2006 Un male misterioso porta via la memoria Nelle stanze dell’amore abitate da Edo e Anna un giorno arriva il dolore. Arriva sotto forma di un male misterioso che porta via la memoria, ma non la speranza dell’attesa. Edo, un giovane calciatore con la passione dei libri, e Anna, una giovane insegnante, si innamorano, si sposano e aprono una libreria. Lì, tra quelle pareti e quegli scaffali la parola amore corre da una copertina all’altra e vive ogni giorno, concreto e umano, tra Edo, Anna, e le loro due «stelline», le piccole figlie Laura e Margherita. Ma un giorno Edo scompare e Anna inizia ad aspettarlo. Ma è proprio vero che Edo è scomparso? È un sogno, un incubo o c’è una verità diversa per Anna che attende? niente di più letterario di un campetto di periferia, pieno di polvere e di quel rumore sordo del pallone di cuoio quando parte un tiro. La libreria di Anna e Edo è una finestra sul mondo, è un viaggio, è un continente o un arcipelago. Eppure sembra essere anche un luogo chiuso al mondo, alla barbarie del mondo. Crede che sia così anche il romanzo in genere? Credo che i romanzi siano degli arcipelagi aperti. Una libreria è sempre un approdo e un porto di mare. La libreria di Anna ed Edo, è un luogo facile da raggiungere, perché dentro ognuno di noi c’è una bussola che ci permette di navigare per i libri. Nella storia da lei narrata si toccano temi profondi, come ad esempio quello della vita oltre la morte e del- la morte oltre la vita, o l’altro della perdita dell’identità. Eppure, riporta il risvolto di copertina, è una «storia semplice». Ma cosa è semplice? Il suo intreccio, la sua ambientazione o il suo senso? O forse ancora i personaggi e la situazione, poco «romanzeschi»? Quando ho scritto che è una storia semplice volevo soprattutto ingannare certi critici. I lettori sanno che non è una storia semplice, ma che è una storia profondissima. Ma sanno che alla fine una semplicità gli rimarrà addosso in questa storia. Peccato che per me la semplicità non è semplificazione, ma è una qualità, diciamo così, etica e morale. Potevo scrivere un libro coltissimo che potesse essere letto anche da un uomo che sa appena leggere e scrivere? Potevo entrare nel cuore e nei sentimenti di un sofisticato filologo e di un contadino? O è un’utopia? Questa è la scommessa di questo amore. Spero di averla vinta. L’identità, la memoria, la poesia, sono tre motivi-cardine del suo romanzo. La storia d’amore sembra quasi un pretesto per dare ad essi un corpo narrativo. Quanto era importante per lei la trattazione di questi temi? No la storia d’amore non è un pretesto. È il testo. Poi attorno c’è identità, c’è memoria, c’è poesia. E poi c’è luce, e poi c’è il mare, e poi ci sono le paure, la perdita, il pensare, e gli oggetti e i ricordi e i libri che si sfogliano con il vento. E c’è la sabbia, io adoro quando la sabbia disegna linee in apparenza prive di senso, e ci sono i suoni, e ci sono certi colori, certi profumi di agrumi. No, nessun pretesto. Parafrasando una pagina del mio libro: le sembra un pretesto l’amore? Se Anna è la memoria e Edo l’iden- LUCIA T. INGROSSO. Un giallo nel mondo milanese dell’etichetta Pubbliche relazioni. Di menzogne VIVE A MILANO, INSEGNANTE, COLLABORA CON DIVERSI SITI WEB LIDIA GUALDONI mo serrato dove, nella migliore tradizione, non mancano i colpi di scena e il concludersi della vicenda con il più inaspettato dei serial killer. Lucia T. Ingrosso lavora come giornalista economica di una nota rivista e vive a Milano. Stilos l’ha intervistata. Giornalista e scrittrice: quale delle due carriere vorresti veder privilegiata? Non posso rispondere entrambe? Fare la scrittrice dà la sensazione di scrivere cose più durature, che non invecchiano da un mese all’altro e che suscitano emozioni più profonde di un semplice articolo. Fare la giornalista però mette in contatto con persone e realtà diverse. E tutto questo fornisce ottime fonti di ispirazione. Direi che queste due professioni (o forse dovrei dire passioni) si alimentano a vicenda. Mi sembra che molti giovani autori scelgano il genere giallo/thriller per il loro esordio: sai spiegarne i motivi? Qual è stata la tua esperienza? Ho sempre amato i gialli. Da ragazzina ho letto tutti i romanzi di Agatha Christie. E la mia formazione è proseguita negli anni con maestri indiscussi come l’americano Cornell Woolrich e il milanese Renato Olivieri. Trovo che scrivere un giallo sia un ottimo espediente per rendere una storia interessante. Si dà al lettore un motivo di curiosità (scoprire l’assassino) e questo permette di descrivere ambienti, psicologie e situazioni senza che questo risulti troppo «pesante» o fine a se stesso. Nell’ideare un giallo c’è una parte di letteratura e una di logica (ideare il meccanismo narrativo con tanto di indizi, false piste, sospetti, colpi di scena..). È una sfida molto stimolante, per chi scrive prima che per chi legge. Rispetto ai nomi internazionali più affermati, quali elementi peculiari ti sembra di poter evidenziare in questa produzione? Nel mio giallo l’omicidio non avviene all’inizio, ma a un terzo del libro. Fino a quel momento la tensione è assicurata dai pensieri (minacciosi) del serial killer e dalle premonizioni della prossima vittima. Questo perché volevo inquadrare bene le psicologie dei personaggi, compresa quella di chi verrà ucciso. Il tutto senza ricorrere a flashback o ricordi di altri, ma presentando i protagonisti nella loro quotidianità. La morte fa notizia è il primo thriller ambientato nel mondo delle pubbliche relazioni. La scelta non è casuale: il tema centrale è quello dell’abitudine che spesso si ha di mentire (per varie ragioni: paura, egocentrismo, ignoranza). E, nell’ambiente delle pr, la menzogna ha anche una valen- tità, o viceversa, qual è il momento in cui, nel loro rincorrersi, si identificano completamente? Questo non lo so. Anzi, forse lo so. Edo e Anna non si identificano mai. Proprio per questo possiamo distinguerli così bene anche nell’assenza. Non sono mai la stessa persona. Non è un rapporto fusionale. Non si rincorrono, giocano una partita nel dolore di cui hanno i codici soltanto loro. Nel suo romanzo forse non è tanto l’epilogo che conta. È invece nel corpus della storia che, complice la poesia, e cioè «la memoria della vita», bisogna individuare la logica del romanzo? Questo è vero. L’epilogo non fa il romanzo. Ma l’epilogo è stupefacente, lo deve ammettere, il lettore non se lo aspetta. E questa è un’altra curiosità di un romanzo, che è assieme un romanzo lirico dove per molte pagine la trama sembra contare quel che conta. Ma poi alla fine prende una piega da romanzo con plot. Da romanzo con il colpo di scena. In realtà sono vere tutte e due le cose. Perché non ho calcolato nulla. Quello doveva essere Questo amore e questo è stato. Bisogna ammettere che l’epilogo è stupefacente, ma, se si sottraggono dalla sua storia tutte le storie d’amore letterarie e le allusioni alla poesia, cosa resta? Resta il dolore. È quello che mi ha detto Roberto Benigni al telefono. Era colpito e impressionato dal mio libro. Lo ha letto tutto d’un fiato, e mi ha detto una cosa che lui ha intuito più di tutti. «Hai scritto un libro potente, ma soprattutto dolorosissimo». Aveva ragione, se si sottraggono le cose che lei dice, sempre che mai si possano sottrarre, rimane il dolore, con la sua funzione di catarsi. C’è poco da fare, la scommessa dei prossimi anni è proprio dentro tutto questo. L’amore è il nodo più forte che un intellettuale deve affrontare oggi. Proprio perché lo abbiamo riempito di luoghi comuni rosa, o svuotato completamente in un nichilismo incerto. Roland Barthes lo aveva capito molto bene, ma aveva poggiato il suo saggio, Frammenti di un discorso amoroso interamente nell’ambito del linguaggio. La psicoanalisi ci ha spiegato che l’amore è solo una proiezione di se stessi nell’altro, e la letteratura ha trasformato l’amore in un genere. La verità è che l’amore sovrintende a una teologia affascinante che abbiamo rimosso e dimenticato. Da qui dobbiamo partire. Scrivendo e capendo fin dove è possibile. za quasi «professionale» (si abbellisce la realtà per rendere l’azienda o il prodotto più appetibile agli occhi dei media). E sarà proprio la cattiva abitudine di camuffare la verità a ostacolare le indagini. Nel libro si racconta poi Milano, città ideale come scenario di un giallo, da angolazioni del tutto inedite. Il finale sembra lasciare aperta la possibilità di nuove indagini del poliziotto Sebastiano Rizzo: ci sarà un seguito? In realtà, c’è un prequel. Cioè la prima indagine di Sebastiano Rizzo, impegnato a scoprire l’assassino di un giovane avvocato alla vigilia delle nozze e di sua madre, sei anni prima, in Costa Azzurra. Qui Rizzo è molto più protagonista e addirittura al centro di una contrastata storia d’amore. Questo romanzo è pronto. In lavorazione, invece, l’ultima storia della «trilogia di Rizzo». Qui il bel poliziotto indagherà su un misterioso omicidio avvenuto in un albergo del centro di Milano. ingolare personaggio quello di Maeve Brennan: nata a Dublino, a 17 anni seguì a Washington il padre, primo ambasciatore negli Usa per l’Irlanda. Sposatasi con lo scrittore St Clair McKelway, con cui condivise cinque brevi anni di vita matrimoniale e molto alcool, collaborò per trent’anni al "New Yorker", con articoli, racconti, recensioni (tra i primi libri di cui si occupò la traduzione inglese di Menzogna e sortilegio della Morante; grande successo ebbe con la rubrica "The Talk of the Town", rapidi scorci di vita newyorkese). Donna di straordinaria e altera bellezza, fece di se stessa un personaggio, come testimoniano le foto scattatele da Karl Bissinger. Affetta da malattia mentale, visse gli ultimi anni in una solitudine che l’amico editor William Mawell definì insanabile: «Durante gli ultimi dieci anni della sua vita entrava e usciva dalla realtà in un modo che ti spezzava il cuore, e che soltanto gli ospedali possono affrontare». È morta, settantasettenne, a New York, nel 1993. In vita la Brennan pubblicò solo due volumi di racconti: "In and Out of Never-Never Land" nel 1969 e "Christmas Eve" nel 1974; postume sono uscite le raccolte "The Rose Garden" e "The Springs of Affection". Nel 1997, nell’archivio della Notre Dame University dell’Indiana, tra le carte di una casa editrice newyorkese, viene ritrovato il dattiloscritto del racconto lungo (o romanzo breve) "The Estate", pubblicato negli Usa nel 2000, uscito in Italia nel 2005, nella collana "Scrittori contemporanei Original" della Bur, col titolo La visitatrice (in copertina il bellissimo profilo della Brennan). È un romanzo (databile agli anni Quaranta) tutto al femminile: protagonista la ventiduenne Anastasia che, lasciata Parigi poco dopo la morte della madre, ritorna a Dublino, nella casa da cui si era allontanata sei anni prima seguendo la donna in fuga dal marito e dalla suocera. Anche il padre è ormai morto: nella casa sono rimaste solo la nonna paterna e Katharine, la domestica. Il ritorno rappresenta per la giovane Anastasia il tentativo di recuperare la propria identità famigliare, ma il riavvicinamento è destinato a fallire: alla nonna la nipote ricorda troppo doloro- S S t los MAEVE BRENNAN . Una nonna che non ha mai perdonato la nuora di essere scappata di casa, determinando la morte del figlio. E una nipote che, andata via con la madre, decide di tornare da lei. Ma l’incontro tra le due donne si rivela impossibile, reso difficile dal rancore e dai ricordi IL LIBRO MAEVE BRENNAN "La visitatrice" Trad. Ada Arduini pp. 112, euro 7,20 Rizzoli Bur, 2005 La casa di Dublino e la nonna paterna Dopo sei anni e la perdita dei genitori, Anastasia, venti anni, torna a Dublino, in casa della nonna paterna. Che però la rifiuta. La trama si sviluppa tra la casa avita e la città. Tornare è come partire verso il proprio passato VIVE A MILANO. INSEGNA IN UN LICEO E ALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA ANNA LONGONI samente il tradimento della nuora, quella fuga che è stata la causa della morte dell’adorato figlio. Anastasia è tornata per restare ma lei, con altera durezza, la tiene a distanza costringendola ad allontanarsi. Gli eventi narrati sono minimi, ciò che conta sono i particolari; gli spazi sono quello chiuso, claustrofobico, pregno del ricordo dei morti, della casa e quel- pagina Nella foto in alto Maeve Brennan, autrice per Rizzoli di La visitatrice. In basso Elizabeth Bishop, della quale Adelphi ha pubblicato Miracolo a colazione lo aperto ma ugualmente grigio e negativo della città; la linearità narrativa è talora sostituita dall’accostamento, bruscamente ellittico, di brevi immagini, qualche volta destinate a rimanere irrelate, flash del passato ma anche del presente i cui eventi si succedono con bruschi trapassi. Il racconto si apre con la protagonista colta sul postale che la sta riportando a Dublino, mentre si accende una sigaretta, e con il fuggevole incontro (che il lettore è portato ingannevolmente ad assumere come l’inizio di una vicenda romanzesca) con un uomo che le chiede un fiammifero: una richiesta che la distoglie dalle sue riflessioni o meglio che la spinge verso i ricordi del suo breve passato. Nelle prime tre pagine si raccolgono già le informazioni essenziali sul personaggio e soprattutto emerge il tema dominante, quello della solitudine e dell’estraneità. Se allo sconosciuto, che come lei sta ritornando, il giorno dell’arrivo a Dublino appare identico a quello in cui era partito, Anastasia, al contrario, ha l’improvvisa, profetica, percezione che il suo ritorno assomigli a una partenza: e il capovolgimento si registrerà anche nel finale, dove l’allontanamento cui la costringe la nonna si trasforma in un ritorno che vede Anastasia, improvvisamente determinata e sicura, cantare a piedi nudi di fronte alle finestre della casa che l’ha rifiutata, e sa- lutare le due donne come se fossero affacciate all’oblò di un piroscafo, loro sì, dunque, in partenza. Ritrovarsi a Dublino significa così per la giovane soprattutto compiere un viaggio dentro se stessa, in uno straziante recupero memoriale, per conquistare la propria identità. Per questo al racconto del presente si alternano pagine del passato: la rapida descrizione di un interno parigino e l’immagine di un uomo sconfitto dal rifiuto della moglie e della figlia; lo scambio di sguardi tra una donna immobile e una ragazzina (poche righe per descrivere la lacerazione di un gesto contemporaneamente d’amore e di abbandono); le scene d’infanzia, già così cariche di una tensione destinata a lasciare tutti i personaggi in una disperata solitudine: soli sono il padre abbandonato, le due donne a Parigi, la nonna e la sua domestica. Alla solitudine di queste ultime due si intreccia anche quella di un terzo personaggio, la signorina Kilbride, dai tratti, forse, eccessivamente macchiettistici: una delle poche persone che erano state amiche della madre di Anastasia, è l’unica che ancora frequenta la casa della nonna. È una donna ormai anziana, dalla vita tristissima vissuta sotto il controllo asfissiante della madre. Consolata dall’unico vezzo di una parrucca di capelli scuri, vive del patetico ricordo di un lontano fidanzato, amato per breve tempo di nascosto dalla madre, presto morto in un incidente. Ad Anastasia la donna, ormai molto malata, chiederà di infilarle al dito, nella bara, l’anello che lui le aveva regalato (e per pudore mai portato al dito). Anastasia, alla morte della donna, decide invece di gettarlo in una cava, quasi rifiutandosi di divenire complice di una malinconica ipocrisia: un gesto di ribellione di cui però subito si pente, come se vi leggesse la stessa mancanza d’amore, la stessa durezza di chi la sta rifiutando. La visitatrice è un racconto di grande fascino, con un finale sospeso, che si blocca nella forza di un gesto ribelle, e che si regge sulla seduzione, come ben evidenzia Paula Fox (prefatrice dell’edizione italiana) di ciò che viene taciuto, di ciò che chi racconta volutamente trascura preferendo soffermarsi su eloquenti dettagli. R e c e n s i o n i ELIZABETH BISHOP. La raccolta lirica più completa uscita in Italia ELIZABETH BISHOP "Miracolo a colazione" Trad. Damiano Abeni pp. 288, euro 27Adelphi, 2005 « odesto qual era / si riteneva un mero / specchio dimidiato, / altrimenti perché / ritrovarsi sdoppiato? / Lo specchio deve estendersi / lungo l’asse / centrale o meglio il bordo. Se non fosse / per un dubbio sulla parte / che resta / dentro o fuori / lo specchio. Non c’è margine / d’errore / ma neanche prova certa. / E se la testa / è riflessa a metà, / il pensiero, pensa, ne risentirà». Se mettiamo a confronto questi versi di Elizabeth Bishop, poetessa americana (1911-1979) amica di Robert Lowell, ammiratrice di Pound e dei metafisici inglesi (in testa Hopkins ed Herbert), allieva di Marianne Moore, con i versi dello Specchio della sua contemporanea Plath, è subito evidente la grande distanza che passa tra l’atmosfera dell’esperienza confessional, che pure conta l’amico Lowell tra gli esponenti principali, e l’aria rarefatta e appartata che si respira tra i versi di questa poetessa bizzarra e giramondo. «Sono esatto e d’argento, privo di preconcetti. / Qualunque cosa io veda subito l’inghiottisco. / Tale e quale senza ombra di amore o disgusto. / Io non sono crudele, ma soltanto veritiero» recita invece lo Specchio plathiano, superficie incondizionata che, al pari della parola confessionale, riflette gli oggetti dell’esperienza nella loro interezza, senza lasciare ombre o scarti. Rispetto ai costumi confessional, nella poesia di Elizabeth Bishop le cose stanno in tutt’altro modo: gli specchi riflettono per metà i loro oggetti, la terra fa ombra all’acqua, l’Uomo falena emerge da un’apertura sotto il marciapiede, le città mostrano la loro immagine più veritiera solo se osservate all’inverso, schiere di uccelli disegnano lettere impalpabili sulle scogliere; possiamo dire che essa è animata da un movimento centrifugo che punta all’occultamento piuttosto che alla resa esplicita, al pudore della sottrazione piuttosto che alla rifrazione diretta. Di questa singolare esperienza di scrittura è ora disponibile il catalogo più M Surrealismo della vita quotidiana VIVE A PALERMO. SVOLGE UN DOTTORATO IN ITALIANISTICA A PALERMO MARILENA RENDA ampio che il pubblico italiano abbia mai avuto a disposizione: Miracolo a colazione (traduzione di Damiano Abeni, Riccardo Duranti e Ottavio Fatica) è infatti la raccolta pressoché completa della produzione poetica di Elizabeth Bishop, poetessa della quale, finché visse, venne riconosciuta specialmente l’attività lirica (del 1983 sono i "Complete Poems 1929-1979") nonostante il ricco epistolario e l’intensa produzione in prosa (quasi interamente inedita alla sua morte, avvenuta nel 1979, e raccolta in "The Collected Prose" del 1984), pressoché sconosciuta in Italia, la cui pubblicazione getterebbe una luce definitiva sul valore della sua opera. Quattro volumi esili, che testimoniano una ricerca che si svolge tutta in profondità e a caccia del mot juste, e alla cui complessità purtroppo (lo diciamo nonostante l’indubbio merito dell’operazione) una traduzione che va in direzione del linguaggio quotidiano e dell’attenuazione delle asperità del testo non rende spesso dovuta giustizia. Infine però, rispetto alle precedenti raccolte (vale la pena citare Dai libri di geografia, uscito per le cure di Bianca Tarozzi per Salvatore Sciascia nel 1993, in cui la scintillante traduzione e la complessiva visione critica scontavano purtroppo una scelta antologica risicata, oltre che il pionieristico L’arte di perdere, prima edizione italiana, pubblicata da Rusconi e curata da Margherita Guidacci), Miracolo a colazione permette di comprendere la sottile maestria di una poetessa che preferiva le quinte alla scena aperta, che visse singolarmente appartata, osservando il mondo dai molteplici punti d’osservazione che il suo incessante vagabondare scelse per lei. Voce dell’«inappartenenza costituti- va», la sua poesia, come testimoniato già dai titoli dei volumi ("North & South" del 1946, "ACold Spring!", del 1955, e infine "Questions of travel e Geography III", rispettivamente del 1965 e 1976), è tutta una descrizione minuziosa dei paesaggi di viaggio e dei loro contorni. La perfezione delle immagini - dei quadri visivi - non è mai separata però da un’emozione che è la felicità della scoperta di un luogo succedaneo di casa (è questo infatti l’interrogativo per eccellenza, la domanda che contrappunta il viaggio, come in "Questions of travel": «Pensa al lungo viaggio di ritorno. / Meglio per noi restare a casa e col pensiero essere qui? / Dove saremmo oggi? / È giusto osservare stranieri / che recitano nel più strano dei teatri? / Quale puerilità ci induce finché abbiamo in corpo / un alito di vita a convolare all’altro capo / del pianeta per vedere il sole?»), ma è pure la baluginante rivelazione di quello che l’autrice definisce, in una lettera ad Anne Stevenson, «scorci di quel surrealismo della vita quotidiana, che è sempre il più riuscito, inaspettati momenti di empatia»; momenti che catturano «una visione periferica di quel qualcosa che non si può mai vedere di prospetto ma che sembra avere un’importanza enorme». La verità balenante tra le pieghe dell’understatement della Bishop, di quel suo oscillare - come è stato detto - tra homely e unheimlich, è forse la verità di un’identità sessuale, familiare e culturale mai pienamente raggiunta; verità di una perdita «delle figure parentali, della casa del sé», di cui i versi di "One Art" esibiscono piena e disincantata consapevolezza: «Ho perso due città, belle. E, più vasti, / altri regni, due fiumi, un continente. / Mi mancano, ma non è poi un disastro. / Anche perdere te (la voce, il gesto / amato) non mi smentirà. È evidente: / l’arte di perdere fin troppo presto / s’impara, e sembra (scrivilo!) un disastro». Molto si è detto sulla reticenza, sulla singolare elusività di questa scrittura che sembra non arrivare mai in profondità ma preferisce nascondere il proprio mistero in superficie. Di fatto, la «visione periferica», la dislocazione dello sguardo ai margini del paesaggio, ai bordi della natura, nelle vene degli oggetti è la condizione che rende possibile - non funziona così anche per l’incessante dislocarsi del soggetto poetante negli angoli più remoti della Terra? - l’esercizio della visione stessa. Ogni dettaglio è allora segnale e occultamento di un segreto inconfessabile che non può essere guardato «di prospetto» ma solo diluito e confinato tra le pieghe della descrizione. Come in Sestina, in cui il nitore della descrizione della cucina in cui siedono Elisabeth bambina e la nonna all’ora del tè non arriva a nascondere la sensazione di dolore e solitudine causata dalla perdita dei genitori; la pioggia sulla casa, la danza delle gocce sulla teiera, il vapore sulla tazza, i bottoni del vestito dell’uomo disegnato dalla bambina sono i dettagli concreti che rinviano al tema conduttore e segreto della poesia: quelle lacrime che la nonna tenta di ricacciare indietro leggendo l’almanacco alla bambina: «Tempo di piantar lacrime, dice l’almanacco. / La nonna canta per la meravigliosa stufa / e la bimba disegna un’altra imperscrutabile casa». Ci sono cose che non sono fatte per essere viste, come il monumento dell’omonima poesia, e come le lacrime di Sestina. Come vuole la logica dell’inversione che è propria della Bishop, ci sono cose che bisogna guardare all’incontrario se si vuole vederle. Come le città e i paesaggi, la cui immagine «[…] cresce in fondo agli occhi aperti / invertita e distorta» ("Love Lies Sleeping"); vista al rovescio, la città espone come un guanto gli orli, i rappezzamenti, le cuciture e rivela allo sguardo dell’osservatore il suo cuore nascosto. È solo allora che l’occhio del viaggiatore coglie la segreta corrispondenza tra i segni e le cose, tra paesaggio e testo (direbbe Clifford Geertz): le forme al neon dell’orizzonte urbano pulsano come «lettere, rosa e gialle», mentre le miriadi di uccelli appollaiati sulle scogliere sembrano «scarabocchiati […] in fitte schiere di n nere» ("Large Bad Picture"). Come di Edwin Boomer, di mestiere raccoglitore di fogli sulla spiaggia, trasparente controfigura della Bishop nel racconto Il mare e la sua costa (tradotto sempre da Damiano Abeni e uscito su "Linea d’ombra" n° 121) si poteva dire che si fosse dato al «sacerdozio», tanta era «l’intensità della sua concentrazione sulla vita delle lettere», anche per la Bishop mappatura e scrittura arrivano a coincidere, e i segni di cui è cosparsa la superficie del mondo è all’infinito che sono decifrabili: «Forse perché gli insetti degli eserciti dei caratteri a stampa tanto tenacemente gli assediavano gli occhi, o perché era davvero così, il mondo, l’intero mondo a lui visibile […] gli parve fosse stampato anch’esso». 17 Trovarobe autori stranieri GIULIO MOZZI IN TRENO CON DANTE La verità è che da settimane e settimane non leggo un libro. Per «libro» intendo un «libro stampato»: cioè un testo che non solo sia stato scritto, ma sia stato anche scelto da una casa editrice e ritenuto degno di pubblicazione. Invece, in queste settimane ho letta una ventina di dattiloscritti. Non li ho «sfogliati» o «guardati»: li ho proprio «letti»: facendo anche note a margine, pensandoci su, discutendone con altre persone, eccetera. Li ho letti, in somma, così come leggerei un libro che mi sta molto a cuore, un libro importante, un libro del quale mi interessa discutere con altri, eccetera. Di questa ventina di dattiloscritti - a loro volta selezionati da una massa di circa quattrocento - solo uno diventerà un «libro». Solo uno, cioè, diventerà un oggetto che qualcuno potrà comperare in libreria fidandosi del fatto che qualcun altro - la casa editrice, le persone che ci lavorano dentro lo ha letto, valutato, approvato e ritenuto degno di essere letto anche da altri. Adesso non ne posso più. Ho bisogno, per qualche altra settimana, di leggere testi sicuri, ai quali io possa accostarmi con fiducia, con un confortevole pregiudizio positivo. Devo disintossicarmi. Non che quei trenta dattiloscritti fossero tutti brutti; tutt’altro; probabilmente tre o quattro sono degni di diventare un libro: se ne pubblichiamo solo uno, e non tre o quattro, è semplicemente perché possiamo fare solo un certo numero di libri l’anno, e dentro questo certo numero possiamo fare un certo, piccolo numero di «esordi». Dovendo disintossicarmi, quindi, l’altro giorno, nel fare la borsa per andare a Milano, ci ho messa dentro la Divina Commedia. Avrei potuto metterci dentro Il ritorno a casa di Enrico Metz di Claudio Piersanti, appena uscito da Feltrinelli; o Dicono di Clelia di Remo Bassini, Mursia; Piersanti è uno scrittore del quale mi fido ciecamente, nel senso che ogni suo libro mi è sembrato bello e interessante (soprattutto Luisa e il silenzio); Remo Bassini è una persona amabile e gentile, e di leggere questo suo romanzo sono veramente curioso; eppure, no, dovevo disintossicarmi sul serio, e allora nella borsa ci ho messa dentroLa Divina Commedia. Così succede, l’altro giorno, che sono in treno, e sto leggendo il "Paradiso". Giusto mentre leggo: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse; / Minerva spira, e conducemi Appollo, / e nove Muse mi dimostran l’Orse» (Par., ii, 7-9), il mio vicino (un signore grosso con i capelli corti e rossi, impegnato fino a un momento prima a leggere "la Repubblica") mi dice: «Scusi, quella è La Divina Commedia?». «Sì», dico. «Ma lei - dice il signore grosso - è uno studioso?». Ci penso un attimo. «No», dico. «Ma allora - dice il signore grosso - mi scusi per la domanda, ma perché la legge?». «Ma perché mi piace». «Le piace?», dice il signore grosso. «Sì», dico. «Ma lei, e mi scusi ancora», dice il signore grosso, «l’ha anche già letta?». «Sì, è un libro che ho letto e riletto, che rileggo periodicamente. Appunto: mi piace, e molto». «Ah, bene. Grazie. Mi scusi». E se ne torna alla lettura di "Repubblica". A questo punto, però, sono io che ho da fare delle domande. «Mi dica - dico - ma perché il fatto che io legga La Divina commedia la incuriosisce tanto?». «Ma, niente. È che non l’avevo mai visto fare». «Non ha mai visto nessuno leggere La Divina commedia?», dico. «No, è che non avevo ma visto nessuno leggerla perché gli piace». pagina 18 « e miniere non prendevano il nome da Bakerton; era Bakerton a prenderlo dalle miniere. È una distinzione importante. Spiega l’ordine delle cose». È ambientata nella cittadina mineraria di Bakerton in Pennsylvania la saga famigliare della scrittrice americana Jennifer Haigh, in quel ventennio tra gli anni ’40 e i ’60 che è teatro di un progressivo cambiamento epocale. Come cambia il significato stesso delle due «torri» di scorie di carbone che sono il punto di riferimento della città: emanano un odore di fiammiferi accesi e nei giorni di vento mandano un bagliore arancione, ma sono un segno vitale, perché è dalle miniere di carbone che dipende il benessere della città. È solo alla fine che prevale il senso di oscura minaccia che hanno sempre avuto, dopo che c’è stato un lungo sciopero, dopo che sono morte dieci persone e uno dei pozzi viene chiuso, e intanto nelle case le cucine a carbone vengono rimpiazzate dai fornelli elettrici e ovunque l’impiego del carbone diminuisce, sostituito da altre fonti di energia. I minatori sono disoccupati, i negozi chiudono e «la città si consumava come una saponetta. Ogni anno più piccola e meno riconoscibile». In una cittadina di immigrati che conducono vite separate, dove i polacchi abitano a Polish Hill e gli italiani a Little Italy, i morti polacchi sono sepolti nel cimitero di St.Casimir e gli italiani a Mount Carmel, la famiglia Novak è un’eccezione: Stanley Novak è polacco e sua moglie Rose è italiana. Hanno cinque figli, la più piccola ha solo tre mesi quando muore Stanley, una delle tante vittime della polvere di carbone che riempie i polmoni. C’è, in ognuno dei figli, il desiderio di evadere, di farsi un’altra vita lontano da Bakerton: quando il maggiore ritorna dalla guerra si iscrive all’università e sposa una ragazza ricca di Philadelphia; Dorothy va a lavorare a Washington; Joyce si arruola nel corpo femminile dell’esercito; Sandy emigra in California e la più giovane, Lucy, frequenta un corso per infermiere a Pittsburgh. Eppure ritornano tutti a casa, a Bakerton, anche se non sempre il ritorno sa di sconfitta. Dorothy torna perché vinta dalla solitudine della grande città. Ma si torna anche perché si prova rimpianto per una vita che scorre più lenta e più umana, perché qualcuno deve prendersi cura della madre, perché (è il caso di Sandy che gioca a poker) si è in fuga e ci si vuole nascondere o perché quello che conta veramente è il primo amore, come avviene a Lucy. Con uno stile sobrio, frasi brevi e incisive, un occhio attento ai dettagli, dialoghi spontanei e squarci di moderna poesia, attraverso l’alternanza di gioie e dolori delle vicende quotidiane di una famiglia, Jennifer Haigh dipinge il ritratto di un’America giovane che guarda al futuro, dove il successo è a portata di mano di chi si industria- finché dura il sogno e non ci si risveglia. Stilos ha intervistato Jennifer Haigh che vive a Boston e ha vinto il Pen Hemingway Award 2004 con il suo primo romanzo, Mrs. Kimble, pubblicato da Tropea lo scorso anno. Mrs Kimble era la storia di un uomo e di tre donne, una storia più convenzionale di amore e tradimento. In Torri di Bakerton c’è l’affresco di un’intera città dietro la vita di una famiglia: che cosa l’ha indotta ad L JENNIFER HAIGH . «È il libro che ho sempre saputo che avrei scritto. Ma sapevo anche che non poteva essere il mio primo romanzo. Mi spaventava l’ampiezza della storia e il senso di obbligo che sentivo verso il soggetto». Una storia di minatori, di morte ma anche di amore e di resurrezione alla vita Scappare da Bakerton e sognare di ritornarci LIGURE, VIVE A MILANO. TRADUTTRICE, SCRIVE PER UNA RIVISTA WEB MARILIA PICCONE IL LIBRO JENNIFER HAIGH "Torri di Bakerton" pp. 272, euro 15 Tropea, 2006 Nel paese del carbone Nella cittadina di Bakerton tutti lavorano nelle miniere di carbone: si vive e si muore di carbone. Il polacco Stanley Novak muore lasciando la moglie e cinque figli. Le vicende della sua famiglia tra il 1940 e il 1960 riflettono la crescita della città e di tutta l’America tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio di quella del Vietnam. ampliare la sua visuale di narratrice? Sapevo da tanto che avrei scritto Torri di Bakerton. In un certo senso è il libro che ho sempre saputo che avrei scritto. Ma sapevo anche che non poteva essere il mio primo romanzo. Mi spaventava l’ampiezza della storia e il senso di obbligo che sentivo verso il soggetto. Bakerton, la cittadina in cui è ambientato il romanzo, è un luogo a me molto caro e per me era importante farlo apparire nella luce giusta, rendere giustizia alla città e alle persone. Scrivere un primo romanzo è di per sé una sfida sufficiente, senza aggiungerci altre pressioni. Volevo iniziare con una storia minore, meno complessa. Mrs Kimble è la storia di tre donne, un romanzo in cui il luogo non è importante. È ambientato in Virginia e in Florida ma, in realtà, si svolge nei giardini e nelle cucine, avrebbe potuto essere ovunque. Mi sembrava di poter gestire meglio il romanzo. Dopo Mrs. Kimble mi sono sentita pronta ad affrontare Torri di Bakerton. Descrive Bakerton come se fosse un luogo che conosce molto bene: è così? Sì, Bakerton è modellata sulla città dove sono cresciuta, Barnesboro in Pennsylvania - anche se sono nata molto dopo e la città era cambiata tantissimo nel frattempo. La mia idea di Bakerton negli anni ’40 e ’50 viene in gran parte da mio padre, che è nato nel 1931 e aveva una memoria incredibile per i dettagli. Non avrei mai potuto scrivere il romanzo senza di lui. Il libro è dedicato a suo padre e il cognome sembra polacco: la sua famiglia fa parte della comunità polacca di cui si parla nel libro? C’è qualcosa della storia della sua famiglia nel romanzo? La mia famiglia viene dall’Ucraina e nella mia città c’era una comunità ucraina piuttosto numerosa. Entrambi i miei nonni erano minatori e immigranti, perciò in questo aspetto la mia famiglia è simile ai Novak. Alcuni dei miei zii hanno combattuto nella Seconda guerra mondiale, ma sarebbe difficile trovare una famiglia americana di quella generazione i cui figli non lo abbiano fatto. Ci sono altri personaggi ispirati a persone vere che lei ha conosciuto? No, anche se conosco molti scrittori che prendono molto a prestito dalla loro stessa vita, o da quella di amici, ma io non ho un istinto autobiografico. Mi sembra riduttivo: se baso un personaggio su qualcuno che conosco, mi sento legata a quello che so di quella persona nella vita vera. E allora la mia immaginazione si blocca e mi ritrovo incapace di pensare al personaggio che fa o dice cose che non farebbe o direbbe nella vita. Perché ha scelto di ambientare la storia negli anni ’40 e ’50? Forse perché era un’epoca di grandi cambiamenti sia nell’economia, sia nei costumi e nella morale? In parte sì. La società americana è cambiata in maniera drammatica negli anni dopo la guerra. I soldati che avevano combattuto in Europa o nel Pacifico ritornarono con una più ampia visione del mondo, molte donne si trovarono a lavorare fuori casa per la prima volta, in lavori militari e industriali. Quelle esperienze cambiarono la società per sempre. Dopo anni di lontananza, molti matrimoni si sciolsero e aumentò vertiginosamente il numero dei divorzi. Tante donne non furono disposte a rinunciare al lavoro e allo stipendio. Fu per molti aspetti un’epoca di abbondanza ed era interessante scriverne. Nella mia città, a Barnesboro, gli anni ’40 e ’50 furono un periodo particolarmente vivo e ricco di eventi. Negli anni in cui crescevo, gli anni ’70, le miniere di carbone erano già in declino, ma la gente parlava molto del passato, degli anni in cui le miniere lavoravano al massimo e la città prosperava. Ricordo di aver desiderato viaggiare indietro nel tempo per vedere se la vita era veramente bella come dicevano i miei parenti più anziani. Suppongo che Torri di Bakerton sia il mio tentativo di fare proprio quello. Polacchi e italiani hanno una buona intesa nel romanzo, sembrano quasi rappresentare una perfezione idealistica del vivere insieme di immigranti di origine diversa. Era la religione che contribuiva a legarli insieme? Nella mia città i polacchi e gli italiani andavano d’accordo perché si trovavano nella stessa situazione: erano arrivati negli Stati Uniti più o meno nello stesso tempo e, come immigranti recenti, dovevano affrontare le stesse difficoltà. La prima generazione di immigrati polacchi e italiani lavorava fianco a fianco nelle miniere, ma restavano separati socialmente. Con il passare del tempo, integrandosi, le cose cambiarono. Nel romanzo il matrimonio tra Rose e Stanley Novak è considerato straordinario perché lei è italiana e lui è polacco. Qualche anno dopo questi matrimoni diventarono comuni E, parlando di religione, è la stretta educazione cattolica che condiziona l’atteggiamento di Dorothy e di Joyce nei confronti dell’amore e degli uomini? Assolutamente sì. Sono cresciute in una famiglia che frequenta la chiesa, la madre è una donna molto devota che si scandalizza perché l’uomo amato da Dorothy è divorziato. Joyce è anche traumatizzata dall’esperienza dell’amica d’infanzia Irene, che resta incinta senza essere sposata e mantiene segreta la gravidanza. Questo spiega in parte perché Joyce veda l’amore come qualcosa di rischioso e di peri- R e c e n s i o n i MATILDE ASENSI. Caccia al tesoro in "Iacobus" MATILDE ASENSI "Iacobus" Trad. Andrea Carlo Cappi pp. 396, euro 18 Sonzogno, 2005 LIDIA GUALDONI opo Il nome della rosa difficilmente ci sono stati monaci investigatori, usciti dalla fantasia di altri autori, in grado almeno di reggere il confronto con Gugliemo da Baskerville ed il novizio Adso da Melk. Ma se qualcuno poteva riuscire nell’arduo intento di creare personaggi altrettanto accattivanti, non poteva che essere la spagnola Matilde Asensi, nel suo Iacobus. Si tratta in realtà del secondo romanzo di quella che in patria viene definita «la regina del best-seller di qualità», pubblicato in Italia dopo il successo di L’ultimo Catone. La Asensi, che ci ha abituato ad un genere storico-investigativo basato su ricerche accurate ed una profonda cultura, immagina che nel 1315 al nobile Garcélan de Born, monaco cavaliere dell’ordine degli Ospitalieri, sia assegnato da Papa Giovanni XXII il dif- D Templari, l’ultima storia ficile compito di indagare sulle morti dell’inquisitore Guglielmo di Nogaret, del re di Francia Filippo IV e di Papa Clemente V, ovvero dei tre principali accusatori dei Templari. Il papa sospetta infatti che alcuni superstiti di questo ordine, ormai sciolto da anni, siano gli artefici di quelle morti, di trame ordite contro i più alti rappresentanti del cattolicesimo e dell’occultamento di un prezioso quanto enorme tesoro che, come vuole la leggenda, dovrebbe custodire anche l’Arca dell’Alleanza. Accompagnato dal giovane Jonás, un quattordicenne novizio mauriziano, che ancora ignora di essere suo figlio illegittimo, Garcélan, che non per nulla viene chiamato «il Perquisitore», riesce a portare a termine con successo la delicata missione. Figura alquanto moderna per vastità di vedute e di interessi, egli fa ricorso a rigorose deduzioni logiche, alle conoscenze di anatomia, di medicina e di L’ A U T R I C E Grande esperta dell’età medievale Matilde Asensi è nata in Spagna, ad Alicante, nel 1962. Ha lavorato per importanti network radiofonici. Finalista e vincitrice di importanti premi letterari per le sue raccolte di racconti, nel 1999 si è imposta con il suo primo romanzo, "El salón de ámbar", cui hanno fatto seguito una serie di testi che ne hanno confermato il talento narrativo. Dello scorso anno è L’ultimo Catone (Sonzogno), in cui il Purgatorio di Dante offre la chiave interpretativa di un mistero che ha origini remote. psicologia, nonché alla capacità di risolvere enigmi legati alla simbologia religiosa, ad alfabeti segreti ed a linguaggi cifrati, così da riuscire a scoprire i veri colpevoli in un tempo relativamente breve. Ma proprio quando crede di poter far ritorno alla sua isola, Rodi, per dedicarsi alla medicina ed all’educazione del figlio, eccolo chiamato ad un nuova e ancora più pericolosa missione: ritrovare il tesoro che i Templari hanno nascosto, così come lui stesso ha scoperto, lungo la via che dalla Francia ripercorre il Cammino di Santiago, il cammino dell’Apostolo Giacomo - Iacobus - in Spagna. Una serie di intrighi e di cospirazioni ad alti livelli - che rappresentano le contraddizioni e il fascino di un’epoca di importanti cambiamenti -, nuove identità e nuovi compagni di viaggio seguiranno i due protagonisti tra mille insidie e innumerevoli segni criptici da Nella foto Jennifer Haigh, autrice per Tropea di Torri di Bakerton coloso, e Joyce non è il tipo di persona che tollera il rischio. Sia nelle Torri di Bakertonche in Mrs. Kimble sono le donne che hanno la parte migliore: possono non essere sempre personaggi positivi ma hanno più empatia e sono più generose degli uomini. Crede che siano veramente così? O è leggermente prevenuta nei confronti degli uomini? Non penso che le donne siano più gentili o migliori degli uomini, anche se capisco perché mi fa questa domanda: in entrambi i miei libri le donne sembrano certamente essere migliori. È in gioco il potere del punto di vista: entrambi i romanzi sono scritti in gran parte dal punto di vista femminile ed è naturale che il lettore si identifichi con loro. Se dovessi riscriverli dal punto di vista maschile, è probabile che il lettore percepirebbe le cose in maniera diversa. Il personaggio di Charlie in Mrs. Kimble, per esempio, è molto sensibile e per me è il vero eroe del libro. Il lettore si sente attratto da lui perché è a conoscenza dei suoi sentimenti più profondi, delle sue paure e delle sue delusioni. Penso che qualunque personaggio possa rendersi simpatico se il lettore lo capisce a fondo. Si è resa conto fin dall’inizio di quale simbolo potente potessero essere le due torri di scorie? No, non immediatamente. Mentre scrivevo la prima stesura del libro, la mia preoccupazione principale era di dare una descrizione molto concreta della città, perché le caratteristiche ambientali sono importanti per dare un’idea di che cosa voglia dire abitare lì. La città mineraria in cui sono cresciuta aveva parecchi cumuli come le Torri, impressionanti da vedere ed emananti un odore caratteristico e sgradevole. Mentre proseguivo la scrittura e pensavo a come cambiava la città con il tempo, era logico che le Torri sarebbero diventate più alte a mano a mano che veniva estratto più carbone, e mi sono resa conto che erano un ottimo barometro per quello che stava accadendo a Bakerton, il sorgere e il cadere della città. L’ambientazione della storia, la vita dei minatori, le loro malattie, i tempi duri dello sciopero, mi hanno ricordato la stessa ambientazione del romanzo Figli e amanti di D.H.Lawrence. Quali sono gli scrittori che ama di più? Sono anche quelli che hanno maggiormente influenzato la sua scrittura? Adoro Lawrence. Ho letto tutti i suoi romanzi quando ero giovane e sono rimasta colpita dal rispetto e dall’amore verso i personaggi di cui scriveva, dal suo riconoscere la loro dignità fondamentale nonostante lo squallore delle condizioni in cui vivevano. Visto il luogo in cui crescevo io, non potevo che apprezzare questo e spero che la stessa qualità emerga nei miei romanzi. Mi piace molto anche Faulkner, forse il più grande scrittore della vita nelle piccole città di tutti i tempi. I suoi romanzi sono squisiti singolarmente ma ognuno è parte di un lavoro più ampio, la raffigurazione della città immaginaria del Sud americano. E ammiro molto un altro scrittore del Sud, William Styron. Mi piace scrivere delle famiglie, in un certo senso mi sembrano le uniche storie che valga la pena di raccontare, e il romanzo di Styron "Lie down in darkness" è forse la più bella storia di una famiglia che abbia mai letto. interpretare, fino all’epilogo, dove non manca un pizzico di romanticismo, ma sempre degno della migliore tradizione del romanzo storico-poliziesco. Certo, rispetto a Il nome della rosa, cui si faceva riferimento, il testo della Asensi si presenta più semplice. In esso prevale infatti l’aspetto investigativo, adatto ad una lettura più lineare, mentre il romanzo di Eco si presta a diverse chiavi interpretative. Ma è bene sottolineare come l’autrice spagnola sia riuscita nell’intento di ricostruire una vicenda dai tratti del tutto plausibili, perfettamente equilibrata fra finzione e realtà storica. Un risultato ottenuto anche grazie alla narrazione elegante e ad un eloquio sì desueto, ma per nulla inadatto alla situazione, attraverso il quale si esprime in prima persona il narratore, Garcélan stesso. A questo si aggiunge l’abilità nel tratteggiare città e paesaggi, monumenti e siti religiosi di grande suggestione. E l’ironia con cui spesso vengono descritti i rapporti fra padre e figlio - un giovane che per indole ed età dimostra ripetutamente di non avere le idee chiare sul proprio futuro, ma un grande entusiasmo verso ogni nuova esperienza -, non mancherà di provocare il sorriso del lettore. Altro S t los autori stranieri WALTER PEDULLÀ STRONCARE COSA? E allora il narratore ha urlato con tutto lo spazio che gli poteva offrire un quotidiano da mezzo milione di copie: «Stroncatemi, ma spiegatemi le vostre ragioni, critici prolissi e inutili che vi limitate a dare una improvvisa coltellata in un passaggio del discorso che non mi riguarda. Una recensione che ingrassa un altro contiene una goccia di veleno che uccide me. Meglio il coltello che gira lungamente nella piaga ». Un colpo d’astuzia: «Parliamo tanto di me», propose Zavattini, candido esordiente. È solo un episodio dell’eterna guerra fra scrittori e critici. Stroncature ce ne sono sempre state. E ce ne sono anche ora, anzi sono le preferite dai lettori, non meno maligni dei critici. Forse sono diminuite da quando l’autore ha potuto scegliersi fra i tanti collaboratori del giornale il recensore più benevolo. Altri tempi quelli in cui il titolare della rubrica era uno solo nel giornale, giudice unico che contava soprattutto sul prestigio derivante dalla paura che suscitava e che lo rendeva più autonomo e responsabile. Le pagine-libri prima salvarono e poi uccisero la critica militante. Divenuta troppo indulgente, rifiorì in virtù di editori che facevano propaganda ai loro libri con la frase più favorevole della recensione, ma appassì per aver mangiato la polpetta avvelenata. Il pluralismo post-moderno fu come il Giubileo che si replica ogni giorno. Cancellò i peccati, mandando tutti in paradiso: anche perché non c’era più un criterio oggettivo di giudizio. Dio perdonò a tutti le loro opere. Nell’alternanza di potere fra Dio e Satana, ci fu invece un periodo in cui la recensione arrivò a coincidere con la stroncatura. Una ventina d’anni fa il direttore di un settimanale chiedeva articoli di critica letteraria, purché tirassero il collo al libro da recensire. Mors tua, vita mea: così poteva vivere la critica militante: ammazzando con linguaggio efferato il testo sottoposto al suo giudizio. Recensioni autoreferenziali quanto può esserlo l’aggressività degli animali affamati di cibo o d’amore. Sangue invece dell’inchiostro: si vedeva più la carne cruentata dell’autore che non il suo pallido stile. Rissa da osteria che finì in tv: un’imitazione di un chiassoso programma post-sportivo. Chiamatela pure critica etologica: per distinguerla da quella ideologica, con cui si fa i propri interessi una cultura, una politica, un’estetica o una poetica. Negli anni Cinquanta non mancavano le stroncature per gusto o vendetta personale, ma erano più numerose quelle che si abbattevano su opere nostalgiche di ermetismo, neoclassicismo, nonché realismo magico o altro novecentismo monolinguista. Si dette una spinta propulsiva in direzione di linguaggi bassi, alternativa ai filisteismi cattolici e alla declamazione fascista. Negli anni Sessanta si frequentò la stroncatura per liberare il campo dalla gramigna: quella che magari da un altro punto di vista era il fior fiore della narrativa di quel decennio. I neorealisti, e non solo loro, parvero d’ostacolo al rinnovamento di una letteratura bloccata sull’elegia che fa nuotare nel pianto e perdona ogni paralisi culturale. Gli Scapigliati lombardi dissero: «Manzoni è immortale, ma è l’ora di gridare morte ai manzoniani!». Uno se una nuova estetica o teoria letteraria non ce l’ha, non se la può dare. E tuttavia non basta nemmeno il coraggio. Manca il cervello poderoso o manca l’iniziativa della Storia? Se non ci sono risposte, torniamo alla stroncatura. Quella che stronca non una sola opera ma un’intera cultura. PATRIZIA DANZÈ n’oasi nel deserto della solitudine (metafora del deserto geografico che circonda la Siria e ne spiega la storia) è l’amore di Rana e di Farid, un amore proibito vissuto nel cuore di una Damasco moderna e primitiva, solare e oscura, un amore che occupa le quasi mille pagine del romanzo di Rafik Schami. Figlio di un fornaio, nato nel 1946 nel quartiere cristiano-aramaico damasceno, Schami nel 1971 è fuggito dalla sua Damasco, la «città più bella del mondo» come ama dire, e si è rifugiato in Germania, dove ha studiato chimica ad Heidelberg e dove ha iniziato a scrivere quel che aveva in mente da ragazzo: la storia di un amore che sopravvive alle difficoltà. Oggi tra i più noti scrittori di lingua tedesca (i suoi romanzi tradotti in tutto il mondo hanno vinto numerosi premi) spera che col tempo il suo Lato oscuro dell’amore possa essere pubblicato anche in Siria dove attualmente è censurato. Stilos lo ha intervistato. La gestazione di questo suo romanzo, come lei stesso dice in appendice, è stata molto lunga. Ma qual è stata la genesi originaria? Nel 1962, quando avevo sedici anni, assistetti all’omicidio di una giovane musulmana colpevole di aver amato un uomo cristiano. Da quel fatto, e dalla riflessione che probabilmente non valeva la pena morire per quell’uomo che era un gigolò, fui spinto a scrivere dell’amore, di tutti i tipi di amore proibito in Arabia. Avevo una grande urgenza di scrivere perché temevo sempre che qualcun altro mi precedesse e potesse avere la mia stessa idea, però tutti i tentativi che feci per mettere su una storia, tra il 1965 e il 1967, fallirono. Apparentemente avevo abbandonato il mio progetto, ma una sera mia madre mi raccontò quella che sostanzialmente è diventata nel romanzo la storia di Rana, il suo amore proibito, e la sua fuga. Dopo circa tre ore, tanto durò il racconto, mi misi a trascrivere quello che avevo ascoltato, sicuro che quella fosse la «mia» storia. Ma fu solo all’inizio degli anni Ottanta, quando ero già ad Heidelberg, che mi misi a fare ricerche, a cercare materiale per il mio romanzo. Alla fine dell’86 era pronta la prima versione ma il romanzo non funzionava. Era come se mancasse qualcosa. Solo nel ’95 capii cosa ci voleva. E cosa ci voleva? Deve sapere che per tre estati a Damasco ero andato da un vecchio maestro calligrafo che era anche un mosaicista. Ricordo che raccoglieva avanzi di marmi e di mattonelle colorati, poi li sminuzzava in pezzettini piccolissimi e li riponeva in un centinaio di ciotole che formavano a guardarle un insieme incredibile di colori. Poi procedeva così. Disegnava su un foglio l’immagine a matita e quindi componeva sull’immagine le tessere del mosaico. Alla fine il risultato era un’immagine di colore e di vita. Capii dunque che così doveva essere la mia storia, una storia a mosaico, formata da mille e una tessera, una storia frammentata come è la nostra vita in Arabia, ma unita e viva a guardarla da lontano, proprio come è un mosaico. E’ una tecnica che ricorda la novellistica orientale. Vi si è ispirato? Forse sì, Le mille e una notte e La U S t los IL LIBRO RAFIK SCHAMI "Il lato oscuro dell’amore" Trad. Rossella Zeni pp. 856, euro 22 Garzanti, 2006 Le lotte feroci tra clan rivali Quello di Rana e di Farid è un grande amore proibito, perché i due giovani appartengono a due famiglie nemiche, gli Shahin e i Mushtak. E attraverso le lotte feroci tra i due clan scorre un secolo di storia del Medio Oriente, da quando la Siria passa sotto il protettorato francese sino al colpo di stato del ’61. Per Rana e Farid l’amore sembra un lusso senza speranza. È il 1970 e la fuga è l’unica possibilità per vivere. RAFIK SCHAMI . In una Siria primitiva, la cui vita è scandita dai ritmi del deserto, che è all’origine della formazione dei clan al potere, l’amore proibito di due giovani che sfidano il loro mondo insemprato e immutabile, governato da logiche arcaiche, di un irriducibile fondamentalismo La storia di un amore che sfida l’intolleranza Bibbia sono stati senz’altro dei modelli cui ho fatto riferimento per raccontare: in particolar modo le prime per strutturare il racconto nel racconto e la cornice esterna dentro la quale viene «costruita» la struttura a mosaico, per raggiungere quell’effetto che io chiamo il «colore delle parole». L’episodio cui si è ispirato per il suo romanzo è accaduto nel 1962 a Damasco, ma lei nel ’70 è andato via. Perché? Sì, esattamente, proprio come Farid, il protagonista. Diciamo che sono andato via per motivi politici, nel senso che capii che il dispotismo politico e la censura non mi avrebbero permesso di vivere. Non avrei potuto scrivere come volevo, la censura avrebbe tagliato quello che scrivevo. La realtà è che mi sentivo soffocare e, poi, non volevo fare il servizio militare e rischiare di andare a combattere per cose in cui non credevo. Il personaggio di Farid dunque è lei stesso? E la voce narrante chi è? Non proprio, è una mescolanza di diverse biografie. Farid mi è molto vicino, ma io non sono Farid. Quanto alla voce narrante è un amico di Farid, è un po’ più anziano e lo conosce bene. A volte gli è molto vicino, altre lo guarda a distanza e lo descrive in modo molto duro, perché Farid non è certo un santo, né era mia intenzione farlo sembrare tale. Quanto la storia narrata è autobio- grafica? La famiglia d’origine di Claire, la madre di Farid, è veneziana. E il nonno di Claire, Antonio Sciamico, era forse suo nonno? No, la mia famiglia proviene da un paese cristiano, ma non da Venezia. In questo la storia è pura invenzione. Venezia è entrata nella narrazione perché ha sempre avuto rapporti con la mia terra. Dal suo romanzo sembra quasi che la storia della Siria sia stata più travagliata nel Novecento che durante l’impero ottomano e che sia a Damasco che a Beirut si vivesse in maniera moderna ed emancipata. C’è uno spartiacque ben preciso nella storia della Siria. Quasi alla fine dell’impero ottomano è stato scoperto il petrolio, e ancor prima che gli arabi potessero gestire la nuova ricchezza le grandi famiglie si sono spartite il potere, copiando gli europei sia nei costumi che nell’organizzazione politica dello Stato. Ma, sebbene in Siria già nell’XI secolo vi fosse una forma di democrazia, quella carmatica, che era di fatto una sorta di socialismo primitivo, il fatto di voler copiare la democrazia di tipo occidentale non ha retto ai colpi di stato delle famiglie saudite. Si sono succeduti i clan familiari al potere; la stessa penisola saudita porta il nome di una famiglia, Saud, diventata potentissima. Da allora insieme con i colpi di stato si è imposta la cultura del clan, ed è accaduto, come in Iraq, che da un lato la dittatura ha distrutto il paese, e dall’altro i fondamentalisti, pur contro la dittatura, ma menzogneri come questa, non sono stati in grado di provvedere alle necessità del paese e alla sua crescita. La cultura del clan è stata quindi rovinosa per il paese. Ma quali sono le radici di questa cultura? Il deserto è alle radici della cultura del clan ed è il fondamento della cultura di ogni arabo. Una persona da sola non è in grado di sopravvivere nel deserto. E dunque si sono formati i clan che, in realtà, sono nati con una matrice positiva, se si pensa al ruolo degli anziani e all’ordine che bisognava rispettare nel clan, pena l’espulsione dalla comunità. Ho già parlato della repubblica dei Carmati nell’XI secolo, che era una sorta di democrazia consultiva nella società araba del deserto; immaginiamola nell’età moderna e applichiamola sia alle monarchie che alle repubbliche. Il risultato è un Saddam Hussein in Iraq o un Assad nella Siria di oggi, la cui famiglia ricopre tutte le cariche più importanti dello Stato, servizi segreti compresi, e domina ininterrottamente dal ’61: la mentalità del clan si applica benissimo a una dittatura a partito unico che pure mostra le apparenze di una democrazia. Ma è una cultura e una mentalità che è rimasta incollata al passato e che io non condivido affatto. Le faide familiari della sua storia so- R e c e n s i o n i HELGA SCHNEIDER. Un giorno trascorso nel bunker HELGA SCHNEIDER "Io, piccola ospite del führer" Trad. pp. XV-131, eruo 10,80 Einaudi, 2006 GIUSEPPE GIGLIO nverno 1945: gelido, secco, l’ultimo prima della disfatta. Berlino è spettrale, deserta, devastata dalle bombe: «Non ci sono che ruderi, facciate pericolanti, squarci di muri che si aprono su macerie», tra il lezzo dei cadaveri in decomposizione; la popolazione è stipata nelle cantine-rifugio, dove si usano i libri al posto della carta igienica e ci si deve accontentare di qualche tozzo di pane ammuffito e di rare patate rovinate dal gelo, sotto la luce livida delle candele di sego, che «rendono tutte le facce smorte». Helga, sette anni, infagottata in un inadeguato cappottino color cioccolata (ma Helga non ha mai visto una cioccolata), con le scarpe ormai troppo strette, attende uno sgangherato bus che la condurrà - assieme al fratellino Peter e ad altri bambini «privilegiati» accompagnati dalle madri o da parenti - nell’inaccessibile bunker sotto quel che I Una bambina con Hitler resta della Reichskanzlei, la Cancelleria. Lì, in quell’estremo avamposto di illusioni ad oltranza, in quel labirinto di angusti budelli male illuminati e ammorbati dalla puzza incessante di marcio, muffa e diesel, i piccoli ospiti del Führer (oggetto della micidiale, narcotizzante propaganda nazista) incontreranno il grande artefice del Terzo Reich e della «guerra totale», allietati dalla promessa di piccoli-grandi tesori dimenticati (le salsicce di fegato, il dentifricio, la carta igienica), ma costretti a docili automi. Il bus arranca in un paesaggio infernale, tra posti di blocco, buche, fiamme, polvere e cenere, sotto un cielo che Helga vede «rosso, come se stesse sanguinando», in una Berlino che «sta morendo d’incendi». Scorrono veloci le pagine di quest’ultimo, intenso libro della Schneider: un racconto bruciante, giocato sul filo tagliente e impietoso del recupero memoriale. La memoria della bambina, con il suo gioioso HELGA SCHNEIDER Testimonianze dalla drammaticità Helga Schneider è nata in Slesia ed è cresciuta in Germania e in Austria. Dal 1963 vive a Bologna e scrive in italiano. È autrice di romanzi dominati dal tema della drammatica esperienza di vita (attraverso il nazismo e i suoi orrori), spesso raccontata secondo la prospettiva dei bambini; il suo romanzo d’esordio, Il rogo di Berlino, (Adelphi,1995), è stato un caso editoriale. bagaglio di innocenza (spesso violentata), che passa tra le fitte intercapedini della coscienza della scrittrice, instancabile testimone di un mondo che aveva scoperto popolato da mostri. Una scrittura semplice, snella, che dipana l’intreccio tra i ricordi, le sensazioni, le suggestioni della bambina, cui costantemente si accavallano, in incastri agili ed efficaci, interferenze della scrittrice: scorci di gioventù, note storiche, fenomeni di costume, persino pagine del diario di Goebbels; a dar forma, di rimando in rimando, a variegate figure (o epifanie?) del mosaico memoriale di Helga. Figure che illuminano nitidamente quegli anni bui: l’amatissimo nonno acquisito (il padre della matrigna, una donna che non l’accetta e che la interna in collegio); Maria, la coraggiosa nonna paterna che scrive fiabe e che Helga vuole emulare; Emi, l’amichetta del collegio, che Helga vede morire sotto un mitragliamento aereo, durante una pagina Nella foto il siriano Rafik Schami, autore per Garzanti di Il lato oscuro dell’amore no però tra cristiani e cristiani. Il mondo musulmano è appena sfiorato. Da cosa proviene la sua reticenza? Forse sarebbe stato esotico oppure avrebbe soddisfatto i desideri di molti che io parlassi di faide tra cristiani e musulmani. Ho voluto appositamente parlare degli scontri tra cristiani e cristiani, perché è la realtà che io conosco di più. Anche in Germania è tuttora forte l’odio tra cattolici e ortodossi, che non si sono messi ancora d’accordo su quando Gesù risorge. Però tra le famiglie cristiane vigono gli stessi tabù morali, come quello della virginità, che hanno uguale valenza presso i musulmani. Sì, perché i cristiani che vivono in Oriente sono immersi in una cultura arabo-islamica, nella parte malata di quella società che dà valore agli stessi principi assurdi secondo i quali la difesa della verginità, ad esempio, rappresenta la difesa del proprio onore, dell’onore di un intero clan familiare. Amore e morte, erotismo e brutalità, umorismo e tragedia sono aspetti contrari che convivono nel suo romanzo. Un motivo letterario o anche una visione della vita? I contrari diametralmente opposti non sono solo un topos letterario ma rispondono senz’altro ad una visione della vita, visione che consegue alle mie esperienze dove questi contrari sono strettamente intrecciati. Nel mondo arabo vi sono molte coppie di questo tipo e non solo coppie, anche molte famiglie, nelle quali l’affetto può trasformarsi in vendetta sanguinaria, anzi l’affetto può essere confuso con la vendetta. È solo di pochi mesi fa un episodio raccapricciante accaduto in Germania: una donna araba è stata assassinata dalla propria madre partita dalla Siria con il pretesto di andarla a trovare e in realtà con la consegna di lavare l’onore della famiglia con il sangue. Credo che la condizione femminile sia oggi peggiorata con i fondamentalisti, così come è accaduto in Iran. Nel suo romanzo è rappresentata la questione palestinese. Cosa ha da rimproverarsi la Siria al riguardo? Ha da rimproverarsi il fatto di ospitare Hamas e i fondamentalisti, di abusare dei palestinesi, e di usare i palestinesi del Libano e fomentare i trecentocinquantamila palestinesi presenti nel territorio per i propri interessi. Il suo romanzo ha una struttura circolare. In primis vi è la storia d’amore. Poi nel secondo capitolo inizia l’inchiesta del commissario Barudi alla ricerca dell’omicidio di un personaggio eccellente, indagine che viene ripresa solo dopo 800 pagine, alla fine del libro. Ma chi è il commissario Barudi? Più che circolare il mio romanzo è a onde sinusoidali. E ciò risponde a quella tecnica a mosaico di cui parlavo prima. Ogni storia è in realtà conclusa in sé e apporta un colore e una sfumatura. La struttura è frammentaria come la nostra vita, come noi stessi. Quanto a Barudi è un personaggio che ho voluto inserire di proposito perché la sua indagine durata quanto tutto il romanzo faccia scoprire alla fine un omicida insospettabile. Ma averlo scoperto non gli gioverà, gli costerà il trasferimento in un luogo oscuro e dimenticato. Barudi ha dimenticato di non trovarsi in Inghilterra, ha dimenticato di essere in Siria. E questa è la Siria. spigolatura; il padre: un uomo debole e assente, un pittore allineato al regime e costretto alla guerra; la madre, una donna arida, fanatica del nazismo, che abbandona la famiglia e diventa un’aguzzina in un campo di sterminio; zia Hilde, impiegata al ministero della propaganda, un posto che, sebbene pesantemente bombardato, «le garantiva ancora uno stipendio, relazioni sociali e gratificazioni professionali»… Con la consueta felicità narrativa, la Schneider apre una piccola finestra da cui guardare le proprie cose («le stesse cose ritornano», scriveva Musil), il proprio passato; per ritrovarlo e dargli un senso. Ed è un continuo emergere, dal flusso dei ricordi o dai dialoghi dei personaggi, di numerose tracce di vita dissepolte: la guerra, gli stupri, la morte violenta, le camere a gas, l’impossibilità del perdono, il rifiuto dell’odio, la banalità del male (nella normalità dell’ipocrisia, del cinismo, dell’odio feroce); e ancora: l’omertà assurta a difesa, il dolore dell’assenza (l’amore della madre), i ragazzi schedati, annullati nella Jungvolk e nella Hitlerjugend (la gioventù che «fece paura al mondo»), un intero popolo ubriacato da un folle sogno di grandezza. 19 Occidente autori stranieri VANNI RONSISVALLE LE GIRAFFE PIANGONO? 1954. Sbarcai da solo in una delle isole Eolie, l’ultima, la più ad est e lontana dalla Sicilia, la prima che si incontra arrivandovi da Napoli. Avevo con me una Payllard, cinepresa a 16 mm. con carica a molla. E una macchina per scrivere Lettera 22. Era un esperimento rivoluzionario: filmare e scrivere, scrivere e filmare. Dormii in una di quelle case abbandonate dagli strombolani per emigrare preferibilmente in Australia. Lì erano rimasti in pochissimi, vendevano capperi ed affrontavano sulle barche a remi tante miglia di mare in cerca di pesce. L’esperimento me lo aveva suggerito Vittorio Veltroni, il direttore del primo Tg della Rai.Tornato a Roma portai quei rotolini da 30m. a sviluppare alla Microstampa e vi incontrai un altro free-lance, ma lui già onusto di gloria avventurosa, Folco Quilici, che però nel binomio scrittura ed immagini si dedicava di più a queste ultime. 1964. Una giovane donna di Como, con un cognome celebre tra i grandi setaioli di quella città, sbarcò anche lei alle Eolie in compagnia del marito che sapeva disegnare case, imparò a progettarne tante a Panarea in puro stile eoliano, una la comprò il grande pittore cileno Sebastian Matta. Di lì a poco le isole Eolie non furono più le stesse. Agli avventurosi ragazzi tedeschi e francesi con pochi soldi si aggiunsero ricchi signori lombardi, per non parlare di intellettuali non ancora radical chic, ma sul punto di diventarlo. Vi trascorrevano giorni meravigliosi, instaurando rapporti con i nativi. Riconoscente al momento di tornarsene a Milano, il commendator B. regalò a don Letterio pescatore e coltivatore di una piccola vigna di uva Malvasia, una zappa «anatomica» disegnata cioè secondo modernissimi dettati ergonomici. Una zappa così bella che don Letterio l’appese al muro con nastri rossi ed un cartellino, «Ricordo del commendatore B.». 1998. Alexander MC Call Smith, scrittore inglese nato però nello Zimbawe, scrive il libro che lo renderà celebre, le lacrime della giraffa. A pagina 136, nell’edizione italiana pubblicata anni dopo da Guanda, si racconta del nero signor Badule che aveva un padre usciere al tribunale inglese del Botwana. Il giudice britannico a capo di quel tribunale gli regalò una zappa, con impresso a fuoco sul manico di legno «All’usciere di prima classe Badule, leale servitore di Sua Maestà, da parte del giudice Maclean, magistrato dell’Alta Corte». 2005. Ho appena finito di riunire su un libro ciò che di involontariamente romanzesco può capitare ad un uomo a cui è capitato di vivere un mestiere non sedentario. E mandando all’incontrario il nastro nella moviola, rivedo Ghirma, il capo della scorta con cui a bordo di una jepp traversavamo l’Etiopia diretti ad Awash, che si lamentava delle condizioni in cui era ridotta la grande strada costruita nel 1936 dagli italiani. Ne parla Evelyne Waugh nel suo libro su quell’impresa. Secondo Ghirma gli italiani sarebbero dovuti tornare a prendersi cura di quella strada che avevano costruito. «Sulle nostre strade circolano ora delle Mercedes, belle macchine di seconda mano che ci arrivano dall’Europa; è un peccato che debbano essere così tribolate mettendo a rischio le sospensioni». S t los schede libri pagina 20 LUCA CAGNOLATI. Fratelli nel sogno, pp. 243, euro 13, Editing 2005 Un giallo d’esordio ambientato in un futuro prossimo, nel quale, alla maniera di Pynchon, si scoprono le tracce di un complotto mondiale, ordito dal Potere stesso che ormai asserve tutto e tutti. Contro di esso, in un vortice di colpi di scena, combattono quattro ragazzi, giustizieri più che ribelli. AMINATA FOFANA. La luna che mi seguiva, pp. 256, euro 14,50, Einaudi 2006 C’è tutto il fascino di un mondo magico, suggestivamente ritrovato nella scrittura, nel libro di Aminata Fofana, nata in Guinea e cresciuta in una tribù, ma divenuta cittadina del mondo. Oggi che vive a Roma, ricorda il nonno sciamano, il villaggio, la natura misteriosa e sacra e le avventure. JON KABAT-ZINN. Riprendere i sensi, pp. 610, euro 22, trad. Diana Petech, Corbaccio 2006 Laureato in biologia molecolare, Kabat-Zinn ha fondato la Clinica per la riduzione dello stress e il Centro per la consapevolezza all’università del Massachusetts. Dell’avventura di guarire noi stessi con la pratica della consapevolezza parla in questo libro scientifico/narrativo. DIEGO MORMORIO. La regina nuda, pp. 157, euro 17, Il Saggiatore, 2006 Maria Sofia di Wittelsbach, l’affascinante ex regina di Napoli e sorella dell’imperatrice Sissi, si trovò al centro di uno scandalo, quando era a Roma in esilio, per alcune fotografie oscene. La storia di un complotto, di un’impostura ripercorsa da Mormorio, saggista e storico della fotografia. SUSAN GLASPELL. Una giuria di sole donne, pp. 82, euro 6, trad. Roberto Serrai, Sellerio 2006 Un poliziesco al femminile, scritto nel 1917 da una donna scrittrice, giornalista e attivista dei diritti civili, e con due investigatrici come personaggi, due mogli che conducono, parallelamente a quella ufficiale dello sceriffo, l’indagine per un delitto commesso. ALMANACCO ELFRIEDE JELINEK ibretto impetuoso, costruito in forma di monologo, Bambiland potrebbe ascriversi al teatro. Questo testo di Elfriede Jelinek si regge su un equilibrio dissonante che si addice al discorso sulla guerra che l’autrice, premio Nobel nel 2004, conduce con lucidità irriverente nei riguardi di ogni tentativo di giustificare gli eventi bellici, da qualsiasi prospettiva siano osservati. Le opere della scrittrice austriaca sono pervase da un sentimento amaro della realtà. La Jelinek è incline a coglierne le radici conflittuali, sia quelle che determinano la lotta tra i sessi che quelle che scatenano le guerre della nostra epoca. Sono stati tradotti diversi suoi libri; recentemente è uscito Voracità (Frassinelli), un romanzo in cui il tema dell’amore (se è lecito ancora chiamarlo così) assume tinte grottesche divenendo quasi bieca violenza. La scrittrice ha dato la prova migliore del suo stile nel libro "I figli dei morti", tuttora poco conosciuto in Italia, con una mescolanza di linguaggi, tratti dalla Tv, dalla pubblicità, dal cinema ed anche dalla politica. Bambiland è coerente con le tematiche delle altre sue opere e mantiene le medesime scelte linguistiche. Potremmo aggiungere che in questo libro l’ironico sarcasmo giunge al punto più inquietante con la perdita di senso del linguaggio. Un continuo variare dei punti di vista mette a dura prova la lin- L Iraq, denuncia dell’orrore della guerra gua che rivela orribili vuoti nell’Io, specialmente per quanto concerne il senso di responsabilità e il principio di riconoscimento di sé e dell’altro. Il discorso travalica dall’individuale al collettivo: l’altro è fonte di pericolo e, in quanto tale, nemico. Il libro diviene strumento di denuncia dell’assurdità della guerra in Iraq. Come l’individuo e il valore della vita scompaiono nel conflitto, allo stesso modo il linguaggio diventa ambiguo gioco: segno privo di referente, oppure assume l’espressività di una maschera tragica. Nel fare ciò l’autrice si lascia tentare dai temi dell’antico teatro greco, ma non può rinnovarne il grande pathos e il valore catartico. Scrive Jelinek: «O terra babilonese, superbo asilo di splendore, di ricchezza che già da tempo voi non potete realmente distribuire, niente sangue per il petrolio, niente soldi per il cibo, niente di nien- Luci e ombre del processo contro Andreotti ELFRIEDE JELINEK "Bambiland" Trad. pp. 72, euro 8,50 Einaudi, 2005 te…..Tutte rovinano le schiere dei barbari, e la telecamera lo registra». Di fronte alle vittime della guerra in Iraq e al cinismo della politica, le pagine di Bambiland acquistano rilievo per il loro accento provocatorio e paradossale. Le parole sono ora lontane dai media, appaiono in un testo letterario, con ironia e rasentando l’assurdo, perché private del loro contesto abituale. Accanto ad esse risultano dissonanti i riferimenti ai Persiani di Eschilo che rappresentavano una concezione del mondo arcaica in cui la LIVIO PEPINO "Andreotti la mafia i processi" pp. 160, euro 12 Ega, 2005 osì Corrado Stajano commentava la sentenza-ordinanza 8 novembre 1985 dell’Ufficio istruzione di Palermo nel maxiprocesso alla mafia istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: «Si legge la sentenza con angoscia profonda, con sofferenza, con vergogna anche, se si pensa ai distinguo intellettuali di quanti sono stati pronti in questi anni ad assolvere i governanti ritenendoli vittime della mafia e non, piuttosto, protettori, complici, responsabili oggettivi, e in alcuni casi soggettivi, di una situazione intollerabile». E ancora oggi angoscia, sofferenza e vergogna ci assalgono di fronte alla ricostruzione del processo Andreotti fatta da Livio Pepino nel suo ultimo libro Andreotti. La mafia. I processi. Come il Cavaliere di Dürer, imperturbabili continuiamo il nostro cammino verso la cittadella della libertà e della democrazia ignorando la Morte e il Diavolo, coscienti che alla mafia non si possono fare sconti e che non possiamo arretrare di un solo millimetro. Scrive la sentenza: «I fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss»; e conclude: «Dovendo esprimere una valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano interpretarsi come una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino una vera e propria partecipazione alla associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo». Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte d’appello dopo un processo durato ben dodici anni, e dichiara estinto per prescrizione il reato di associazione per delinquere commesso fino al 1980 e per il periodo successivo conferma l’assoluzione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo con sentenza 23 ottobre 1999 «per insufficienza della prova sulla commissione del fatto». La successiva sentenza della Corte di cassazione 15 ottobre 2004 ha osservato che «esausitività, razionalità e consequenzialità delle argomentazioni rendono la sentenza d’appello non censurabile in sede di legittimità». Se le parole hanno ancora un senso, prescrizione non vuol dire innocenza, ma estinzione di un reato, che nel caso specifico è partecipazione ad associazione mafiosa. Tuttavia, pur trovandoci di fronte ad una sentenza considerata «esaustiva razionale e consequenziale», l’accusa nei confronti di Andreotti è stata giudicata da più parti scandalosa e inverosimile. In particolare l’attenzione si è concentrata esclusivamente sulla testimonianza del collaboratore di giustizia Baldassarre (Balduccio) Di Maggio (autista di Totò Riina) il quale dichiarava che nel 1987 in casa di Ignazio Salvo, presente anche Lima, avvenne un incontro tra il sen. Andreotti e il capo di Cosa nostra Riina, e che nell’occasione i due si baciarono. Ad essere considerata inverosimile è la possibilità che un uomo delle istituzioni, ed in più dell’importanza di Andreotti, possa avere intrattenuto rapporti con la mafia. Livio Pepino, attraverso un’accurata documentazione, affronta il problema del rapporto diretto tra mafia e classe dirigente del Paese, e si chiede se questo rapporto sia o no verosimile. Le conclusioni sono presto tratte: «La mafia è un intreccio, una costellazione in cui coesistono e si relazionano personaggi di estrazione sociale, livello culturale, immagine esterna eterogenei. E ciò contribuisce a renderla non uno strumento ma una componente del potere». Massimo Sestili guerra è spiegabile all’interno di un universo religioso. Bambiland non può essere ricondotto ad un genere letterario. È un ibrido: possiede la vis polemica del pamphlet, la carica del teatro d’avanguardia, il nonsense beckettiano. Le risonanze dei versi tragici dei Persiani, anche se vaghe, conferiscono ad alcune parti quella particolare patina d’antico che solo la sedimentazione del tempo imprime ad un testo. Antico e contemporaneo dunque, ma senza che questo comporti l’insorgere di una rinnovata armonia, della speranza, o di un ordine superiore. Nessun’elevazione. Per Jelinek una dissoluzione totale è in atto e riguarda il mondo esterno e le sue morali, i contenuti e le forme del linguaggio. Per questo Jelinek è più vicina ai temi di Ingeborg Bachmann, piuttosto che a Thomas Berhnard, o a Peter Handke; l’incomunicabilità tra i sessi, la protesta contro qualsiasi forma di «violenza», dalla più clamorosa a quella più subdola, sono argomenti comuni ad entrambe. Tuttavia il mondo intimistico e fortemente soggettivo della Bachmann lascia spazio, negli ultimi anni della sua vita, all’utopia. Jelinek invece non si lascia illudere né da sogni né da un’interpretazione meno pessimista del reale che non le sembra riconducibile a criteri di razionalità. Francesca Nardone MARCELLO VENEZIANI. La sposa invisibile, pp.176, euro 11,50, Fazi 2006 Questo libro è un viaggio d’amore tra donne metafisiche, effimere e carnali alla ricerca della sposa invisibile che si nasconde dietro mille volti. Tra autobiografia ed immaginazione, l’autore mette in gioco le parti più profonde di sé e del proprio complesso rapporto con l’universo femminile. PARIDE GAIDELLA. Viaggio, pp. 84, euro 8, Maremmi Editori 2006 Un viaggiatore solitario, attento e curioso, attraversa in auto la Svizzera, la Germania e l’Austria, preso dal vivo di paesaggi mozzafiato e personaggi memorabili, alla ricerca di quell’equilibrio fra uomo e natura custodito dalle vette delle Alpi Centrali. SAMIR KASSIR. L’infelicità araba, pp. 91, euro 8, Einaudi 2006 L’ultimo libro del leader del movimento di liberazione del Libano da parte della Siria, impegno pagato con la vita in un attentato del giugno scorso. È anche il primo suo libro uscito in Italia, rappresenta un «manifesto» delle istanze di emancipazione e libertà del mondo arabo che si è trasformato adesso in un testamento spirituale sulla rinascita panaraba e islamica in senso moderno. C SABINA COLLOREDO La paura è in attesa sull’isola La Colloredo dice di aver inseguito la paura, oltre che la fantasia, per scrivere questo thriller «viaggiante» che alla fine si è fermato sulla piccolissima isola di Tristan da Cunha. Qui, richiamati dalla voce dell’isola, sbarcano Tom, Peter ed Elena: sono felici ma li aspetta la paura. SABINA COLLOREDO "La voce dell’isola" pp. 256, euro 16 Nord, 2006 FABRIZIO RIZZI Confronto con due modelli di donna Ennesimo romanzo psicologico, giocato sullo scavo interiore e sulla ricerca d’una autenticità che tutti i protagonisti di Fabrizio Rizzi perseguono a ogni costo sia pur attraverso scelte dolorose, Nemesi, figlia della notte (pp. 90, euro 11,50, Clinamen, 2005) racconta di un viaggio agli inferi privati narrato da un misantropo giunto alla soglia della mezza età e al tempo dei bilanci esistenziali che forse per lui non sarebbe scattato se due avvenimenti non l’avessero scosso dal torpore d’una vita grigia e inconsapevole. Sorte ha voluto che egli sia stato nominato giudice popolare in un efferato processo per omicidio in cui è imputata una nigeriana e, al contempo, che la figlia single abbia deciso di avere accanto solo lui al momento di partorire in casa. Così per l’uomo è l’occasione di confrontarsi con il mondo femminile che egli confessa non aver mai conosciuto; nello specifico con due figure speculari di donna: l’una che incarna nel suo immaginario l’archetipo positivo della femmina dispensatrice di vita; l’altra che ne rappresenta l’aspetto negativo e mortifero. Ma il nostro «intellettuale di provincia» inizialmente cercherà il confronto con esse facendo leva sulla razionalità e appellandosi ai paradigmi di una visione del mondo maschile e logocentrica che non gli consentiranno tuttavia di comprendere perché sua figlia si esponga all’azzardo di un parto rischioso e soprattutto perché la nigeriana, che non appare folle né malvagia, abbia ucciso l’amata sorella incinta (e con lei il nascituro). Tenterà allora di calarsi nelle «miniere dell’anima» altrui non con la supponenza di illuminarle a giorno ma di abitarne l’oscurità fino a scorgere in essa tracce di quella traccia di senso che a tutta prima pareva assente. Francesco Roat BONETTI-FIORUCCI Immigrati tra formazione e negazione Un titolo volutamente provocatorio per coloro che, come gli immigrati, vengono considerati, assai spesso, «cittadini di seconda classe». Prefazione di Francesco Susi, interventi di Sergio Bonetti, Massimiliano Fiorucci, Oliviero Forti, Tommaso Cumbo, Marco Catorcio. SERGIO BONETTI MASSIMILIANO FIORUCCI (cura) "Uomini senza qualità" pp. 191, euro 18,50 Guerini e Associati, 2006 L’ALMANACCO DEL RAMO D’ORO Trieste, il senso del confine e oltre È uscito nell’ottobre 2005 il settimo numero della rivista quadrimestrale di poesia e cultura "L’almanacco del ramo d’oro" (Il ramo d’oro editore, pp 199, euro 12). Nata a Trieste, questa rivista di critica e poesia vuole raccogliere il senso di appartenere a una terra di confine e il rapporto con le diverse realtà culturali e linguistiche che qui si affacciano per attraversare e superare culture e letterature diverse, scavalcando barriere troppo rigide. Volontà dichiarata della rivista è contribuire a salvaguardare una trasmissione plurima decentralizzata e plurilingue dei testi poetici con la consapevolezza che, in un mondo globalizzato, negli interstizi e nei margini si trovano spesso innovative esperienze. Ma "L’almanacco del ramo d’oro" intende anche uscire dai circuiti limitati di una circolazione regionale o transfrontaliera e porsi in rapporto con le realtà che formano il tessuto umano e culturale dell’Europa e del Mediterraneo. A questo scopo dunque a partire da questo numero, la rivista si allarga dalla «storica» redazione di Trieste (costituita da Daria Betocchi, Roberto Dedenaro, Claudio Grisancich, Gabriella Musetti, Jolka Milic) alle redazioni di Roma (che vede attivi Alessio Brandoloni e Biancamaria Frabotta) e a quella di Milano (che può contare sul contributo di Mario Benedetti, Mario Santagostini, Mary Barbara Tolusso). Ogni numero è caratterizzato da un tema attorno al quale vertono saggi, interventi, testi creativi. Il tema di questo numero è «Traduzioni & straduzioni» e sono presenti, tra gli altri, contributi di Ljilijana Avirovic, Clotilde Barbarulli, Merima Hamulic Trbojevi?, Vincenzo della Mea. Afferma Jolka Milic: «Il traduttore deve avere in sé qualcosa di demoniaco, deve gareggiare con l’autore». Marina Torossi Tevini S t los schede libri Un circolo come ritrovo e come libreria pagina 21 AGNESE DE DONATO "Via Repetta 67" pp. 135, euro 14 Dedalo 2006 ALMANACCO Celebrazione di un processo quasi dal vero ANDREA FALCETTA "L’ultimo comma. I ladri di bambini" pp. 176, euro 12 Pixel Group, 2005 Agnese De Donato / Andrea Falcetta lla fine degli anni ’50 e nel corso dei ’60 la televisione non si era ancora trasformata nella «piazza telematica» che avrebbe svuotato le strade e le piazze vere e allontanato fra loro le persone. Allora lo scambio di idee avveniva con persone reali e in spazi reali. Uno di questi spazi a Roma, era il Tridente, cioè quell’area circoscritta fra via di Ripetta, il Corso e via del Babuino che si irradia verso piazza del Popolo e in senso inverso si restringe verso il cuore della Roma creativa. Qui nacque la libreria «Il ferro di cavallo», sulla armoniosa piazza omonima dove han sede il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti. E dove, una notte del 1957 passeggiando con il fratello Diego editore e con un cugino penalista Agnese De Donato disse: «Qui mi piacerebbe aprire una libreria» e, come nelle favole, vide un cartello «affittasi». Detto fatto: lavori frenetici trasformarono un negozio di pasta e fagioli nell’accogliente fuga di tre locali uno dentro l’altro che costituivano la libreria. Più che un luogo, ricorda l’architetto Franco Purini, fu una situazione, uno stato d’animo. Furono anni felici, turbinosi, un breve piccolo Montparnasse dove tutti si conoscevano in un andirivieni sia all’interno che all’esterno del locale, sul marciapiede. Non era una libreria come un’altra, Einaudi a via Veneto, o Hoepli o Paravia ad esempio, che erano luoghi commerciali e basta. Qui il commercio era scarso: si vendevano all’inizio libri d’arte, che però venivano ripagati dagli artisti con le loro opere non sempre convincenti per pagare gli editori, oppure gli acquirenti segnavano il loro debito su un libricino e pagavano ogni tanto mille lire ma ne dovevano altre tremila. Agnese, bella come una star del cinema, vitale e generosa ma anche pratica, ne fu l’anima: senza di lei non si sarebbe potuto immaginare quel concorso a tutte le ore del giorno e a volte della notte di intellettuali e di artisti di prima grandezza, un «Pantheon dei vivi» e all’intorno figure meno conosciute che ascoltavano e imparavano da quelle conversazioni, una vera scuola di cultura per molti giovani. Ma era Agnese, una signora che girava su una jeep tinta di rosa, che correva alle Mille Miglia e aveva preso il brevetto da pilota d’aviazione, era lei la persona adatta a tutto ciò? Bisogna allora dire qualcosa sulla sua origine familiare. Figlia di un noto avvocato di Bari allievo di Croce, antifascista e anticonformista, che quando c’era il sole prendeva i suoi 6 figli e li portava in barca e niente scuola; sorella di un editore che pubblicò per primo le opere di Fosco Maraini, e di Gigliola, massima studiosa di Carlo Levi. Il «Circolo degli Scipioni» venivano definiti a Bari. Con qualche invidia. Per la loro libertà. Non aleggia su di loro nemmeno l’ombra del provincialismo. E semmai in Agnese uno spirito ribelle. Quello spirito che ben si accordò con quello delle avanguardie di quegli anni. La libreria fece infatti da sponsor ai poeti «Novissimi», festeggiando alla grande l’uscita della prima edizione nel ’61, e al Gruppo A 63. Manganelli, Germano Lombardi, Pagliarani, Arbasino, Balestrini, Perilli, Porta, Eco, Furio Colombo, Guglielmi, Giuliani, insomma tutti. E anche se in anticipo sui tempi, alla pop art americana, Rauschenberg, De Kooning, Klein, che dovevano attendere il 1964 a Venezia per venire ufficializzati. Come successe agli artisti visivi che oggi fanno soldi a palate ma allora erano invendibili, Burri, e Schifano. Non una parola di più. E accanto ai nuovi i vecchi grandi poeti, anch’essi avanguardia, Ungaretti, Sinisgalli, Tzara, Pound, Guillen, De Libero, e poi scrittori come Pasolini, Moravia, Ripellino, Carlo Levi, Bernari, Berto, Frassineti, Bertolucci, Natalia Ginzburg. E critici d’arte e letterari. E musicisti, e architetti e cineasti. Confluivano alla libreria senza appuntamento, sicuri di trovarsi tra amici, guardavano, si facevano guardare, recitavano se stessi, talvolta compravano libri, bevevano molto, la libreria faceva in qualche modo anche da bar. Ad Agnese venne poi l’idea di presentare i libri in uscita, i vient de parâitre della libreria parigina «La Hune», che in Italia non si usava ancora. Molti di questi personaggi confluivano poi, come una galassia, da Rosati, al Bolognese, da Cesaretto e in varie trattorie dei dintorni, nelle varie gallerie d’arte; circolava un’aria solidale che è difficile descrivere, il denaro non contava tanto. «Niente calcoli solo invenzioni, incontri e stupori allegri» ricorda Alfredo Giuliani. Come quando il geniale Antonio Mallardi, alla domanda di Vanni Scheiwiller se gli piacessero i suoi minuscoli libri di poesie, ne prese uno e se lo mangiò, letteralmente. Il «niente calcoli», questa allegra e giocosa finanza però portò nel 1966 a un tale stato di debiti che Agnese dovette chiudere e riparare in via Gregoriana appoggiandosi a una delle due gallerie del suo terzo marito. Nel frattempo erano nati i suoi tre bellissimi e biondissimi bambini, ma lei trovò il modo di istituire premi come quello per l’opera più sperimentale dell’anno, vinto un anno da Antonio Pizzuto, un altro da Germano Lombardi (che fu incoronato di alloro); e di organizzare due mostre sul Liberty che allora non era noto ai più. La prima esponeva lampade Tiffany, Gallé, Daum... la seconda Affiches 1900-1920 di Mucha, Grasset, Berthon. Tutti questi fatti sono riemersi da una vecchia valigia impolverata che da 35 anni giaceva in una soffitta, un tuffo al cuore per Agnese che vede rivivere in queste fotografie straordinarie la sua gioventù e quella degli altri quasi tutti con i capelli neri. Certo un dolore, ma più che di nostalgia di un’età perduta, c’è l’amarezza di considerare la differenza fra quei tempi e gli attuali (di cui parlavo all’inizio) e non si tratta di laudare tempus actum, così, perché andato. I Sessanta furono anni di grande respiro, di grande ottimismo nonostante il muro di Berlino, la guerra fredda, il Vietnam. Si era in ascesa. Valeva la pena raccontarli in questo piccolo libro. Vanna Gazzola Stacchini Folco Portinari / George Steiner Scorribande a ostacoli nella cultura GEORGE STEINER "La barbarie dell’ignoranza" pp.102, euro12 Nottetempo, 2005 roppo spesso, quando ci si imbatte davanti ad un libro-intervista, si paventa l’inevitabile iattura del dejà vu-dejà lu. Lo si apre temendo la riproposizione stantia della solita commedia delle parti in cui intervistato ed intervistatore si dividono, con rigida osservanza del copione, i ruoli che talvolta scimmiottano, sia pur sotto altre maschere, quelli tipici della dialettica «servo-padrone»: l’intervistatore, schiacciato e compres(s)o dalla esimia personalità dell’intervistato, assume una posizione dove garbo, cortesia e dedizione alla causa del Grande Scrittore si compendiano in una arrendevolezza quasi supina. Ma questo smilzo e bel libretto scantona, in maniera abbastanza clamorosa, dalla ritualità di questa messa in scena perché l’intervistatore, eccitato più che imbarazzato dall’intelligenza e cultura di un partner quale George Steiner, preferisce imbastire con l’illustre accademico un dialogo accalorato, vivace e polemico, che assume, per alcune pagine, i tratti di un appassionante duello intellettuale. Questa originale figura di intervistatore-duellante è Antoine Spire, a lungo redattore capo del "Matin de Paris" e produttore di format per "France Culture": i nodi del contendere che lo inducono ad assalti ripetuti contro l’"auctoritas" del Maestro, talvolta in punta di fioretto, talvolta con sciabolate ben assestate, sono essenzialmente due. La prima è l’accusa di elitarismo, motivata dal fatto che, secondo Spire, tutto il corpus dell’opera steineriana, più che essere testimonianza di «una cultura esigente, crudele, che richiede molto impegno», assume la forma di un ostacolo insormontabile, che misura qualche migliaio di pagine e che, sostanzialmente, non solo per questo «comporta la chiusura dell’accesso alla cultura per milioni di persone». Al lettore scoprire come Steiner sa parare questo affondo e come sagacemente muove al contrattacco. Il secondo assalto ( che sembra più virulento rispetto all’altro) è il giudizio sulla personalità e filosofia heideggeriana: va detto che entrambi, sia pur con motivazioni non coincidenti, condannano le simpatie filo-naziste ed antisemite del filosofo di Essere e tempo («Martin Heidegger era il più grande dei pensatori ed il più piccolo degli uomini» sbotta Steiner). Ma, quando si passa all’analisi della sua produzione filosofica, mentre Steiner ne sottolinea la sua incommensurabile grandezza («Ci vorranno generazioni, se non secoli, per circoscrivere il problema Heidegger») Spire mena fendenti, attaccando, fra l’altro, la sua «fuga dalla realtà, il suo ritrarsi nel mondo del linguaggio»: i toni si fanno accesi e vivi, le voci si danno l’una sull’altra, rumore di lame che s’incrociano. Ma poi, il rispetto e la stima reciproci e la capacità di riconoscimento delle ragioni dell’altro riprendono il sopravvento: ed allora si può tornare a godere la luminosa profondità delle riflessioni di Steiner, il suo disinvolto florilegio di sentenze, apoftegmi, memorabilia, le sue vertiginose e lucide scorribande fra filosofia, musica, didattica, politica, ideologia, non senza qualche struggente ed indimenticabile ritratto della propria bildung. Linnio Accorroni T n celebre verso di Saba dà il titolo a una stringata antologia dedicata a un argomento apparentemente vastissimo come il calcio, a cura e con una penetrante introduzione di Folco Portinari. L’assunto di quest’ultimo, piuttosto curioso date le circostanze ma pienamente condivisibile è che «non esiste né può esistere una letteratura sportiva contemporanea per la banalissima ragione che non esiste più lo sport, inteso come gioco gratuito». Oggi lo sport, si sa, è un mestiere estremamente lucroso per chi lo pratica a livello professionistico, mentre i suoi ritmi e persino le sue regole sono dettate chiaramente non dallo spirito del gioco ma dalle leggi di mercato. Cosa di cui l’introduttore non si scandalizza affatto, pur reclamando una maggiore chiarezza intorno alla questione. Se lo sport è diventato «un’altra cosa», la «colpa» della letteratura è di non essersene accorta, o di aver finto di non accorgersene, arrestan- U Il calcio come gioco e metafora dosi così alla descrizione di un gioco che è solo la punta del fenomeno che rappresenta, la superficie inerte e per così dire meccanica della cosa intera. La poesia, di cui pure si presentano illustri esemplari - dalle Cinque poesie di Saba a Buffalo di Montale (alla rubrica ciclismo), a Raboni, Cucchi, Buffoni, lo stesso Portinari - la poesia tratta il gioco del calcio come un serbatoio di significati altri, non sportivi ma esistenziali o sentimentali; perciò al di là dei risultati non è poesia sportiva, ma semmai una poesia che prende a pretesto lo sport per altri fini. Quanto alla prosa giornalistica, essa è ndrea Falcetta, giornalista giudiziario noto come «Zorro», è un avvocato, un uomo onesto e un radicale, e il combinato di queste caratteristiche ne fa un soggetto di quelli che si è soliti definire scomodi. Perché non c’è nulla di più scomodo di uno che crede in ciò che fa. In questo libretto fa anche lo scrittore, raccontandoci una storia vissuta da avvocato, con l’animo del radicale e con l’impegno dell’uomo onesto. Una storia di ordinaria malagiustizia, con nomi di comodo ma sicuramente vera, collocata dentro l’universo della giurisdizione minorile dove allignano anche interessi non esattamente commendevoli di ricerca del profitto a spese di coloro che dovrebbero essere oggetto di protezione: i bambini appunto. Bambini rubati alle famiglie con la complicità di prezzolati assistenti sociali, disinvolti giudici di tribunali minorili, biechi procacciatori di affari per organizzazioni di case accoglienza che lucravano, quando la vicenda si è svolta (e cioè pochi anni fa), ben 300 mila lire di retta giornaliera. Con giri di affari miliardari. È la storia di un processo. Un’assistente sociale relaziona al giudice del tribunale dei minori che una bambina subisce maltrattamenti dai genitori, avanza addirittura il sospetto di molestie sessuali da parte del padre appoggiandosi a un disegno (mai esibito) della bambina, e il tribunale sottrae la bambina ai genitori affidandola a una di queste case. Lo fa applicando l’ultimo comma dell’art. 330 del Codice civile: «Per gravi motivi il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare». E, che è anche più grave, «inaudita altera parte». Cioè in regime di arbitrio assoluto, coi giudici, che dovrebbero garantire il rispetto delle leggi, di fatto «legibus soluti». L’avvocato Manfredi Balestra (è il nome che nel libro si dà Falcetta), assunta la difesa dei genitori della bambina, riesce a svelare l’imbroglio e la storia finisce bene, la bambina torna a casa dai genitori e gli imbroglioni pagano. Rimane però l’amarezza di una vicenda di bassa cucina giocata sulla pelle e sui sentimenti di Daria, la bambina cui nessuno potrà più restituire i mesi passati in cattività, lontana da papà e mamma. E l’indignazione dell’avvocato-scrittore poggia tutta su questa amarezza. Il libro non è però solo il racconto di un caso sconcio assunto a paradigma di stortura del sistema, sottolineata peraltro dall’introduzione di Silvia Tortora, figlia del celebre Enzo, e a malapena addolcito da una delicata storia d’amore. È anche una specie di roman social, di romanzo politico, una sorta di discesa agli inferi giudiziari, una specie di viaggio nel mondo dei tribunali raccontato con amara ironia ab interiore re, dove la res è un universo di alieni, i diecimila e passa avvocati di Roma, che si aggirano nelle aule giudiziarie, perennemente alle prese con bolli e comparse e repertori e ruoli e udienze affollate e giudici distratti e cancellerie chiuse e clienti smarriti e leggi contraddittorie interpretabili in mille guise, dove anche si aggirano esponenti dei servizi, dove i carabinieri si fanno la guerra tra di loro, sigla contro sigla. Dove il parcheggio dell’auto è un problema giudiziario, le file vocianti la regola, la confusione la normalità. Dove le vittime designate sono i cittadini che cercano giustizia, e raramente la trovano. O, se capita che la trovino, la trovano irrimediabilmente tardi. Un mondo che ci tocca tutti e che è tra le prime emergenze del paese. E la cui denuncia è la ragione sociale di questo libro. Livio Matteucci FOLCO PORTINARI "Il portiere caduto alla difesa" pp. 135, euro 10 Manni, 2005 genere ancillare della letteratura. Il versante eroicomico della rappresentazione sportiva non sembra essere troppo nelle corde del curatore, che lo considera il rovescio di una rappresentazione epica comunque sfocata, per i motivi cui si accennava sopra. I brani antologizzati di Campanile e Benni in effetti mostrano un po’ la corda degli anni, come dire che si aveva l’impressione di ricordarli più divertenti. Disposta in ordine cronologico, con un chiaro squilibrio tra i due sport a favore del calcio, l’antologia si spinge fino ai giorni nostri, Aldo Nove, Giuliana Oliviero e Franco Bernini sono gli ultimi prosatori; il pezzo di Bernini con una mimesi dialettale-sociologica tarantina notevolmente vivace. Chiudono il libro due mirabili poesie recenti di Vecchioni, Alberto Bevilacqua e Mario Luzi, con un componimento ciclistico 2005 che deve essere fra gli ultimi della sua vita longeva. Giovanni Maccari A stata appiattita e sconfitta dall’avvento dell’immagine, della televisione, per cui in effetti rimane ben poco da raccontare. Fa la parte del leone in questo campo il vecchio Gianni Brera, di cui si antologizza uno strepitoso Ritratto breve di Fausto Coppi e altri brani diversamente riusciti (anche il commento a Italia-Germania 4-3) ma comunque di un livello incomparabile a quanto si scrive oggi. Da segnalare ancora, sul versante polemico a cui l’antologia vuole tenersi attaccata, un brano di Pasolini sul calcio come linguaggio (sistema di segni), con una bacchettata al giornalismo come sotto- pagina 22 S t los schede libri SAMI MICHAEL "Una tromba nello uadi" Trad. Shulim Vogelmann pp. 270, euro 15 Giuntina, 2005 Il tratto comune della estraneità difficile trovare un altro paese in cui la realtà sociale sia così complessa e variegata come in Israele, dove convivono - e non pacificamente - israeliani ebrei e israeliani arabi, arabi musulmani e arabi cristiani, ebrei sefarditi e ashkenaziti, ortodossi e laici, ebrei «sabra», nati in Israele, e ebrei rientrati dalla diaspora, in una babele di lingue su cui si impone un ebraico reinventato e piegato alle necessità del mondo moderno. Non ci stupisce quindi la contrastata storia d’amore del romanzo dello scrittore israeliano Sami Michael, Una tromba nello uadi: non sono due famiglie rivali come i Montecchi e i Capuleti che si oppongono all’unione, né il colore della pelle, come per Otello e Desdemona, né la differenza di ceto, come per l’Isabella di Boccaccio e di Keats, ma il fatto che Huda sia araba e Alex sia ebreo. Una storia d’amore che possiamo paragonare ad altre che abbiamo letto nelle letterature di paesi diversi, eppure ci sono dei tratti che rendono differente il romanzo di Sami Michael. Prima di tutto la voce dell’io narrante, perché non è comune che uno scrittore uomo si faccia interprete di una ragazza, e in maniera così sensibile da non creare alcuna dissonanza. E poi l’ambientazione, la ricchezza di personaggi, ognuno con una sua storia di cui Huda ci può raccontare solo una parte: un nonno che forse è innamorato della nuora, la mamma che apparteneva ad una famiglia ricca e che è rimasta sola, vedova con due figlie, la sorella Mary, bella e civetta tanto quanto Huda è ritrosa e solitaria, il prepotente padrone di casa Abu Nachla e il figlio Zuhair da cui Mary aspetta un figlio - che però farà passare per il figlio del tonto cugino per bene che la sposa. E infine Alex, di cui Huda si innamora, e i suoi genitori, profughi dalla Russia. In questa piccola comunità che vive alla periferia di Haifa nello uadi, il letto secco del torrente ai margini del quale sorgono le abitazioni fatiscenti degli arabi, il tratto comune è quello dell’estraneità, della provenienza da un altro luogo in cui le usanze e la lingua sono diverse, e della nostalgia per un mondo che non si rivedrà più: così per il nonno che è arrivato dall’Egitto e così per Alex, che una decisione dei genitori ha forzato ad immigrare in Israele e che si ritrova a balbettare in ebraico e a combattere per una patria che non sente ancora come sua. Così per il cugino Wahid che abita in un villaggio retrogrado in cui valgono ancora norme severe di comportamento per uomini e donne e che non si rende neppure conto di venire sedotto credendo di sedurre la trasgressiva Mary. La musica della tromba di Alex fa da colonna sonora al romanzo, con le note che volano lontano, verso la Russia rimpianta, che echeggiano nello uadi con una forza pacificatrice. Perché l’amore tra Huda e Alex non riguarda solo loro, non può isolarli da una realtà in cui Alex che parte per la guerra non è più Alex, ma l’ebreo che uccide uno dei tanti cugini arabi di Huda. Quello che si avverte è un attrito continuo: arabi ed ebrei vivono fianco a fianco, magari nello stesso ufficio, come succede a Huda, chiacchierano e bevono caffè insieme finché non succede qualcosa e il collega o l’amico diventano il nemico. Ha sempre una nota di tristezza il suono di una tromba, ce l’ha anche quella di Alex. E non può avere un finale felice la storia di Alex e di Huda. Marilia Piccone ALMANACCO Lucio Felici / Patrick Fogli Jenna Jameson / Sami Michael Stefano Zangrando È L’AUTORE. Michael è nato a Bagdad nel 1926. Nel 1948 fu costretto a fuggire in Iran e poi in Israele. Ha scritto articoli di letteratura per un settimanale arabo e per 25 anni ha lavorato per il ministero dell’Agricoltura, al confine con la Siria. Nei suoi romanzi, ambientati a Bagdad o in Israele, Michael esplora i rapporti interraziali. un buon esordio quello del bolzanino Stefano Zangrando, classe 1973, autore di questo Il libro di Egon, una sorta di «quaderno berlinese» redatto dal protagonista alter ego dell’autore, Egon Ventura, che già nel nome conserva quell’identità provvisoria, tesa tra due culture - il nome di battesimo tedesco, il cognome italiano - che sarà il filo rosso che terrà saldo tutto il romanzo, che potremmo identificare anche come «diario di un italofono di frontiera alla ricerca dell’estasi». È dunque con uno spirito che si schiude al nuovo della metropoli tedesca, promettente stimoli culturali e conoscenze inedite, che Egon si affaccia per l’appunto per le strade e le case e le istituzioni - perlopiù culturalidi una Berlino da tempo riunificata, nuova capitale europea, tesa tra antico e moderno, tra tradizione e futuro, tra rispetto della forma e informalità tipicamente giovanile. E anche la lingua che Zangrando usa con padronanza in questa sua peregrinazione dell’anima, vestendo i panni per lui quanto mai familiari del giovane studente Egon Ventura, è una bella lingua di frontiera dei significati e dei rimandi e dei toni, che si barcamena assai bene tra letterarietà - con incisioni forse a volte un po’ troppo insistite nella filosofia, in quel che insomma s’è faticosamente ma anche gioiosamente imparato- e informalità, soprat- È Goethe Institut come riparo comune tutto delle situazioni. L’inizio si congiunge con l’arrivo del provinciale e speranzoso Ventura a Berlino, e per i primi gustosi capitoli l’autore fa muovere il suo protagonista ancora spaesato in questo nuovo mondo pieno di promesse usando il tentativo di distacco della terza persona; non troppo a lungo durerà però il buon uso di questo escamotage, perché Zangrando-Ventura svelerà presto se stesso e inizierà, dopo opportuno avvertimento al lettore stringendo con questi un patto ben esplicitato, a usare con la stessa disinvoltura dell’inizio una prima persona comunque più confacente alle esigenze del suo raccontare, sospeso tra illuminazioni culturali e vivide scoperte umane. Il libro, di pregevole e scorrevole lettura, è diviso in brevi capitoli, i quali sono a loro volta racchiusi in sette «parti» che, con esclusione della prima e dell’ultima, denominate "Primi passi" e "Le cose più belle e importanti", sembrano provenire, non so bene se per caso o per scelta deliberata dell’autore, dalla mente di un copy anni ’80 alle prese La caccia ad un arci-assassino PATRICK FOGLI "Lentamente prima di morire" pp. 446, euro 16,50 Piemme, 2006 egni particolari: una trama ad orologeria. Con il thriller Lentamente prima di morire Patrick Fogli, 34 anni, aggiunge la sua voce al già fitto coro di scrittori di gialli e noir che, da Loriano Macchiavelli in poi, hanno contribuito a smontare l’immagine di una Bologna paciosa e accogliente per rivelarci una città densa di ombre sotto i famosi portici. Perfino John Grisham, nell’ultimo The Broker, ha spostato l’azione dagli Stati Uniti sotto le Due Torri: ci sarà un motivo. E del resto - ce l’ha ricordato più volte Carlo Lucarelli - l’ex isola felice di Bologna è stata anche teatro di tragedie come la strage alla stazione e i delitti della Uno Bianca. Ma per completare l’elenco dei «padri» del romanzo di Fogli, bisogna citare altri due scrittori che hanno avuto un ruolo effettivo nel suo esordio sulla scena letteraria: Eraldo Baldini, che per primo ha incoraggiato il giovane autore a dare fiato e sostanza a quello che inizialmente era solo un breve racconto, e Luigi Bernardi, che l’ha seguito e consigliato nella stesura. Detto questo, l’opera prima di Fogli cammina spedita sulle sue gambe. E mostra una sorprendente maturità di mestiere nella costruzione del racconto. Che ruota intorno a un commissario di polizia, Gabriele Riccardi, e alla sua «caccia» al killer mafioso Gaspare Nunia, evaso da un carcere di massima sicurezza. Ma il vero arci-assassino è un terzo personaggio: un uomo senza volto, che negli ambienti della malavita chiamano «lo Scienziato». È lui il burattinaio che tira i fili della trama. Le sue vittime, uccise da veleni sconosciuti e ingegnose trappole, sembrano sempre morte per cause naturali. Le sue motivazioni di vendetta e la sua identità si sveleranno poco a poco, fino al crescendo conclusivo. Fogli scrive con ritmo serrato, disseminando la storia di false piste che sfidano il lettore e non lo mettono mai un passo avanti all’investigatore. Inoltre, ed è un altro pregio, i personaggi non sono «figurine» bidimensionali ma persone. Convincono i motivi del loro agire: un po’ meno i dialoghi, a tratti forzati. «Buoni» e «cattivi» del romanzo non sono interamente tali, ma dicono sempre la cosa giusta al momento giusto. Un retrogusto «da telefilm» che si sente forse un po’ troppo: ma fa parte, come la nitida divisione in scene, dell’immaginario largamente visivo e cinematografico sul quale si sono formati tanti scrittori delle ultime generazioni. E alla fine i conti tornano: resta una storia che sa intrattenere, un po’ gialla, un po’ gotica e un po’ medical thriller (molti capitoli ruotano intorno all’ospedale dove Alice, la fidanzata del poliziotto, è ricoverata per un misterioso coma). Sullo sfondo Bologna, dove «nelle mura di casa succedono cose tremende». Una città che «ti guarda e ti giudica in silenzio, senza dire niente. Senza che tu te ne accorga. E a un certo punto ti tira fuori il conto da pagare». Luca Baldazzi S STEFANO ZANGRANDO "Il libro di Egon" pp. 237, euro 12 Greco & Greco, 2005 con la campagna pubblicitaria per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di Berlino: " Berlino è vita", "Berlino è amore", "Berlino è nostalgia", "Berlino è cultura", "Berlino è festa". Se poi così non è stato è però chiaro, già leggendo a partire da questa titolazione, che l’autore ha voluto fin nei titoli manifestare l’intento di parlare di un macrocosmo nel quale, come in un grande imbuto spirituale, cultura, amore, vita, festa e non ultima la nostalgia (sentimento che nella lingua tedesca viene descritto da ben due parole, Sehnsucht - che descrive il sentimento privato - e Nostalgie, che descrive il sentimento storico) vengono riempite dalle pulsanti vite di giovani entusiasti e baldanzosi provenienti da diversi paesi del mondo, tutti accomunati sotto la campana di vetro, o guscio protettivo culturale, del Goethe Institut, vera e propria istituzione culturale, di nome e di fatto, di importanza planetaria. Ventura è infatti a Berlino per una vacanza-studio presso l’istituto, una vacanza-studio di forma- zione che sarà anche occasione imperdibile - e destinata a tracciare un solco profondo nel suo spirito - per venire a contatto con giovani e meno giovani di altre culture, per aprirsi al mondo, per imbeversi di interessanti e preziose novità tra tradizione, storia, tensione verso il futuro. Non esiste una vera e propria trama: Egon trascorre il breve tempo del suo soggiorno berlinese, alla fine del 2000, tra bar, ristoranti, aule dell’istituto, il museo Linden nel quale conoscerà la frustrazione del «ragazzo di bottega» straniero, la casa di Zoe, la compagna di classe australiana che Egon ama senza essere ricambiato. Ciò che Egon ama è però l’ideale dell’«amare bene», perché egli è un innamorato sostanzialmente dell’amore; e il suo soggiorno è una navigazione promettente ma non sempre facile nel mare tempestoso della giovinezza, nella quale ogni cosa è ancora da guadagnare, da vedere, da provare, in una parola da vivere. Le avventure del protagonista sono lacerti di storie minime; e qui, se da una parte puo’mancare la tensione da parte del lettore ad appassionarsi a queste storie del tutto sprovviste di colpi di scena, c’è però sottesa la volontà dell’autore di non barare, di mostrare una storia plausibile ancorché non particolarmente densa di importanti avvenimenti. Franz Krauspenhaar JENNA JAMESON "Vita da pornostar" Trad. Ira Rubini pp. 464, euro 19 Sonzogno, 2006 Escalation verso un impero sistono anche i libri-giocattolo, immesso sul mercato per arrivare anche a quel pubblico, sempre più numeroso, che non sa a cosa serva la scrittura. A volte, però, questi esemplari diventano oggetti di culto per i lettori buongustai. Accadde ai due volumi di Hollywood Babylonia, di Kenneth Anger, usciti negli Stati Uniti come provocazione a base di fotografie e gossip truculento su Hollywood e subito immancabili nelle biblioteche degli appassionati di cinema e costume. Succederà anche a Vita da pornostar, di Jenna Jameson? Forse. Ma intanto si sfogli il volume con meno sguardi alle foto e alle illustrazioni di corredo e più attenzione al testo. Perché l’autobiografia di una regina dell’hardcore si presta ad un’analisi ben più articolata sull’essenza stessa di quel modello americano che vorrebbe imporsi, anche manu militari, a tutto il resto del pianeta. Intanto l’autrice si chiama in realtà Jenna Massoli, con un cognome di origine italiana del tipo a volte improbabile che si ritrova fra gli emigrati. Non è un dato secondario. Tutt’altro. Costituisce un primo indice molto ricorrente al di là dell’Atlantico: il travaso di culture. O meglio, lo sradicamento. Qualcosa che deve contare parecchio nel formare famiglie allo sbando, nelle quali si forma un senso distorto della tradizione avvilita a luogo comune. Si veda quando la Jameson dichiara che, in quanto di stirpe italiana, tende ad essere pelosetta. Ha mai visto certe bionde peninsulari di ascendenze normanne, che non hanno bisogno della ceretta? Poi vengono le tappe obbligate della formazione imposta da una società che si fonda soltanto su due regole: il denaro e la sopraffazione. La Jameson oscilla di continuo fra questi due poli, subendoli o imponendoli. Le cattive condizioni economiche del padre, che ha speso tutto per curare invano la moglie malata di cancro, sfaldano un nucleo familiare già fragile in partenza. Jenna e il fratello Tony vagano per gli Stati Uniti, reame per eccellenza dei non-luoghi, come li definisce Marc Augé. Case mobili, paesi di provincia senza un passato, motel. La logica continuazione abitativa per chi, come la Jameson, è nata a Las Vegas. Sullo sfondo delle sue vicende personali, a base di insicurezze, dolori, voglia di rivalsa, è netto lo scenario di un Paese dove non esistono le fondamenta etiche sulle quali può sorgere una civiltà. L’occidente europeo ha avuto millenni per forgiarsi. Gli americani sono ancora gli infanti della storia. Così anche il sesso rientra nei loro giochi di imitazione. Lo si capisce leggendo ciò che la Jameson scrive degli uomini che incontra. Altro che Jane Austen! Questa donna fa un reportage sul campo, ed è un campo di bambini che fingono di guerreggiare e si feriscono sul serio. Da ballerina di Las Vegas a interprete di pellicole a luci rosse, dinanzi a lei sfilano sempre e solo individui patetici, imbottiti di televisione e carboidrati. L’homo americanus è questo. Straordinario il modo con cui si può, negli Stati Uniti, creare mitologie in technicolor. Tanto che la sincerità della Jameson e l’assoluta crudezza della narrazione finisce per essere più avvincente del repertorio iconografico. A patto che si consideri il tutto come un massiccio antibiotico contro ogni possibilità di credere ancora nel mito americano. Vita da pornostar è l’affresco di una gigantesca fiera della vanità che si svolge oltreoceano e arriva al resto del mondo con i colori artificiali dei media. Enzo Verrengia E L’AUTRICE. Jenna Jameson nasce a Las Vegas come Jenna Massoli e vaga da un capo all’altro degli Stati Uniti al seguito del padre, dopo aver perduto precocemente la madre, con un fratello tossicodipendente. Comincia a esibirsi in pedana, a Las Vegas. Dopo alcune esperienze di foto per adulti, recita in film hardcore e fonda un impero multimediale. Favole antiche e disperati affetti testi variamente esegetici, che si susseguono a una ritmo quasi frenetico, attestano sempre più l’assoluta, inesorcizzabile labirinticità dell’opera leopardiana, a cui ben si confà l’etichetta di una storia infinita e infinitamente coinvolgente. Parlare di sabbie mobili non è del tutto fuori posto, considerata l’inafferrabilità di una produzione letteraria maledettamente sfaccettata e polisemica, sempre pronta a sfuggire alla lente ricognitiva del più smaliziato studioso. In questa ottica appare inserito il saggio L’Olimpo abbandonato di Lucio Felici, recentemente pubblicato da Marsilio. L’autore è un benemerito degli studi leopardiani e questa sua diuturna ricerca si è scheggiata in un numero imprecisato di approdi interpretativi e di circostanziate verifiche e puntualizzazioni che hanno contribuito alquanto ad arricchire la ricerca leopardiana. È un Leopardi spiritualmente teso tra «favole antiche» e «disperati affetti» quello che si staglia e si configura nelle pagine di questo libro. I LUCIO FELICI "L’Olimpo abbandonato» pp. 232, euro 18 Marsilio, 2005 In altri termini, un Leopardi, che - distante dai classicisti e dai romantici reinterpreta i miti in chiave antropologica e ontologica, chiamandoli, alla maniera di G. B. Vico, «favole antiche» e inserendosi nel travagliato dibattito sulla morte e resurrezione degli dei. Nella sua visione, il tramonto dei miti coincide con la perdita della fantasia creativa. Tuttavia, la consapevolezza del mortificante smacco esistenziale, al quale l’uomo appare condannalo, non approda a uno sterile nichilismo, per il semplice fatto che lascia aperto uno spiraglio sulla possibile nascita di una nuova mitopoiesi. Nelle pagine del libro di Felici è come si sentisse il grido lacerante di Giacomo da Recanati, ancora adolescente come creatura abbandonata dalle «favole antiche» e orgogliosamente conscio della propria, inespugnabile caducità, esistenziale, ma soprattutto ancora ignaro degli altri e assai più deleteri abbandoni, che si abbatteranno su di lui di lì a pochi anni. Gennaro Cesaro S t los schede libri La possibilità dei nomi e della vita GIANCARLO PONTIGGIA "Bosco del tempo" pp. 139, euro 12 Guanda, 2005 23 ALMANACCO Alfred Andersch / Emiliano Gucci è continuità e c’è iato fra il primo e il secondo tempo della poesia di Giancarlo Pontiggia, fra i versi di Con parole remote (il libro del suo intenso esordio nel 1998) e quelli di Bosco del tempo (la raccolta uscita, ancora presso Guanda, nella seconda metà del 2005). L’esperienza originaria della parola poetica aveva coinciso per Pontiggia con l’epifania miracolosa dei «nomi». I «nomi felici», pronunziati dal poietés in un’estate calda e assoluta, in un giugno azzurro e solare, nel quale il sacerdote delle "Muse trova con una energia adamitica il suono che fissa e che salva. Il poeta di Con parole remote è un sereno «custode dei nomi e dei semi», uno che si appoggia con forza quieta sopra una tradizione millenaria («preservo memorie non mie») per riconferire senso al mondo colto (o meglio riapparso) prima della catastrofe, al di là di ogni distruzione possibile. Si trattava insomma, nel ’98, di dare forma e voce ad una via poetica decisa a non seguire né le piste troppo battute di un novecentismo di matrice romantica (come saprà bene il Pontiggia saggista di Contro il Romanticismo) affondato nelle sabbie mobili di una parola posta al di là di ogni «io» e di ogni «tu», al di là di ogni codice e di ogni concreta esperienza vissuta -, né i percorsi alternativi del discorso o del racconto in versi spinto fino alla semplicità colloquiale; una via alla poìesis capace di attingere nella pronunzia del puro nome la sostanza del mondo, un mondo compreso e contemplato però nel confine ’offertoci’ dai classici (e riguadagnato da un poeta già da tempo antichista di valore). In Bosco del tempo risuona ancora l’eco dolce di quella stagione di sogno, posta «alle foci / di un tempo errante, favoloso», quando «tutto il mondo era divino» (Muse). Ma si tratta del riflesso sonoro di un tempo ormai consumato. Il secondo libro di Pontiggia si affaccia dichiaratamente infatti, sin dal principio, sopra una condizione nuova («Fin qui gli sciami ronzanti le volte / porose del cielo», quando «l’estate era immensa»; «Ma ora nuvole / basse e ferrigne […] e il tempo / che s’impigra […] Niente è più misero della vita che si perde», Pensieri, in autunno), come una consapevole rottura, già presentita d’altronde nel componimento eponimo (e finale) di Con parole remote («Quando dal cielo premono / scuri segnali / sulla città piagata / […] / quando ogni nome è notte / […] / il tempo è acqua / e la tua storia vacua / chi farà luce?»). Se il tempo del primo libro scandiva «i comandi sulle cose», con i suoi «fiammanti cancelli», la sua forza, la sua fissità mai disperata, il tempo del Bosco è la «pietra» che «stride» e consuma, la macina impietosa (e la molle rete) che mette radicalmente in questione la salvezza annunziata dal sacerdote delle Muse. Da qui scaturisce in Bosco del tempo un movimento determinato e fascinoso condotto nell’io interiore del poeta, nella sua storia, rivisitata alla luce della domanda inquietante sulla possibilità del nulla: dei nomi e della vita. La compattezza estrema di questo libro, la sua integrità e il suo vigore, nascono da una volontà di rilettura rigorosa dell’itinerario intimo e quasi imperscrutabile che ha condotto il poeta alla parola e lo ha come consegnato al verso. A partire dall’inizio nascosto e sommessamente folgorante («Canto ciò che fu prima e ciò che venne», Origini), dalla discesa originaria nella «stanza ombrosa» dove si è incontrato il nome «salvo, tutelare» (Occhi), fino all’«era gloriosa, inaudita» di un’infanzia che ora si scopre però già visitata dalla «forma scura, molle, straniera», sotterraneo rimando al «tempo molle che si sfalda» (L’infanzia tace); dalla «privata, dolorosa arcadia» di un’adolescenza contigua al senso di «un tempo semplice, inviolato» (Severa adolescenza), alla consapevolezza amara dell’avvento di un inverno duro e faticoso, dell’immersione impensabile in una «storia avara, immerdata», in un «bosco di frananti ore» (Nell’ombroso dove). Antonio Sichera Giancarlo Pontiggia / Helen Sheehy C’ L’AUTORE. Giancarlo Pontiggia è nato a Seregno nel 1952. Intellettuale, poeta e traduttore, ha pubblicato per Guanda nel 1998 la raccolta Con parole remote (premio Montale 1998), e per Medusa nel 2002 il volume di saggi Contro il Romanticismo. Vive a Milano, dove insegna italiano e latino al Liceo Manzoni. Come salvare il nostro amore pagina EMILIANO GUCCI "Sto da cani" pp. 252, euro 13,50 Lain Fazi, 2006 l trentenne Emiliano Gucci giunge alla sua seconda prova narrativa con Sto da cani, romanzo che segue l’esordio di Donne e topi, entrambi pubblicati da Lain, sottodivisione di Fazi editore. Libri, quelli di Lain, che da Io ti attacco nel sangue di Clara Nubile ai fumetti underground (Pop gun world e Ursula), passando per la struggente storia d’amore Due ragazze, dell’autrice turca Perihan Magden, si fanno apprezzare per il sapore di fondo che accomuna le pubblicazioni più convincenti della collana. Per quello sguardo privo di cinismo postmoderno con il quale gli autori Lain guardano ai sentimenti. Ed Emiliano Gucci non è da meno: sebbene il giovane autore non possieda la leggerezza di tocco e la fantasia di Martin Millar (Fate a New York), o la penna pirotecnica della già citata Magden, è riuscito comunque a scrivere un romanzo fresco e godibile. Il linguaggio di Gucci è realistico e colloquiale, e non si adagia in un minimalismo d’accattonaggio. Replica il parlato, forse, ma il risultato non è piatto, inespressivo, e si concretizza in una scrittura che punta alla nitidezza delle immagini e che in questa nitidezza raggiunge il suo miglior risultato. Un uomo abbandonato dalla moglie alle prese con un debito e con un viaggiopremio, con l’ennesima fuga dalla realtà; un ragazzo che si sta lasciando sfuggire di mano l’amore e sta per barattarlo con un soggiorno in una località balneare alla moda; una donna che, quando le sembrava di avere perso ogni possibilità di costruirsi una vita amorosa, incontra qualcuno, ma questo qualcuno nasconde un segreto (che non riveliamo). Sono questi i protagonisti di Sto da cani, persone normali che si trovano sul punto di perdere tutto quello che hanno, di abbandonare la via della felicità, di rassegnarsi a una vita priva di amore. Come se questo fosse possibile. Ma tra un passaggio in un sala scommesse e una spedizione punitiva contro un vecchio datore di lavoro, attraverso incontri con vecchiette distratte che scambiano la cassa di una libreria per l’attrezzatura di un arrotino (!) e rendez vous con i picchiatori di un malavitoso, l’autore ci fa capire che per quanti masochistici sforzi si possano fare non è possibile rassegnarsi al dolore e alla solitudine. Ed è per questo che le tre storie di Sto da cani trovano il loro felice svolgimento, perché come dice lo stesso Emiliano Gucci «è così che va l’amore». I L’AUTORE. Emiliano Gucci, Firenze 1975, ex operaio, magazziniere, cassiere, disegnatore di cartoni animati, musicista punk-rock e scrittore. Sto da cani narra tre storie d’amore e sopravvivenza, tre crisi esistenziali che potrebbero prendere una brutta piega. Quella di Lorenzo, commesso di libreria, ed Elisa, studentessa; quella di Giampiero, ex scommettitore che deve ricostruire la sua vita dopo essere stato abbandonato dalla moglie; e quella di Roberta, donna solitaria ormai rassegnata a una vita arida. Alfio Siracusano Il potere evocativo delle parole ALFIO SIRACUSANO "I fili strappati" pp. 166, euro 12 Iride, 2005 opo La piazza negata e La piazza rossa, ancora una volta la Sicilia domina incontrastata le vicende narrate da Alfio Siracusano, che denuncia l’inutilità di ogni speranza con amaro disincanto, ma anche con lucido rigore razionale, strumento di un pensiero che scava dentro se stesso senza disdegnare l’artificio retorico e le suggestioni letterarie per interpretare fatti invischiati nelle trame di poteri apparenti e occulti. L’autore intesse una storia di fili che si avviluppano in intricate vicende di mafia e omertà, sullo sfondo di una Sicilia violentata da una solarità accecante - e inquietante, a tratti - rivelandosi, al di là delle tinte teocritee, il teatro insanguinato di morti che si inanellano in una spirale incomprensibile. Franco Floresti torna dopo molti anni nella sua città, intorpidita dalla «fatale necessità» di verghiana memoria, illanguidita nella «rassegnata saggezza di chi vive nella stagnazione eterna dei tempi e delle speranze». Immutata nel lancinante ripetersi di gesti eterni, è una Sicilia che si crogiola voluttuosamente nel proprio dormiveglia, contaminata dalla «malattia della volontà» delle pagine lampedusane: la stessa che infetta il protagonista «a ogni snodo dell’esistere», «quando la mente s’intorpidiva dentro spirali di parole senza suono, che finivano con l’appagarsi di se stesse». Già, parole. Perché, nonostante l’arrotolarsi e srotolarsi della trama intorno a morti ammazzati e inspiegabili sparizioni, sul romanzo regna il potere evocativo - ma spesso illusorio - delle parole: quelle degli amati autori del passato, quelle dal sapore antico delle litanie religiose che inebriano la folla, o ancora, le parole dal potere salvifico - metaforico, letterale - che il protagonista, vittima di un sequestro, congegna in una lettera affinché il destinatario possa «cogliere il detto del non detto». Quest’ultime parole, «scarne» come quelle che modulano l’azione poliziesca, s’intrecciano con altre finemente cesellate, incastonate in dotte divagazioni, o con quelle che evocano una Sicilia senza consistenza nonostante la tragica concretezza dei suoi cadaveri. Ridotta a cassa di risonanza di parole senza senso. Che «rotolano monotone, in suono rassegnato», meri significanti separati dal loro significato: è il «parlare astratto dei siciliani», una «filigrana inesausta di parole mute». O di parole altisonanti, che infarciscono discorsi da rifilare al popolo assetato di ideologie, illudendolo di poter «piegare la boria di un potente», sebbene la loro forza corrosiva si stemperi nell’impatto con la realtà, perché «l’utopia, quando non è solo sogno filosofico, e si misura con la realtà degli uomini, è sempre una scommessa» (e quella comunista è una scommessa persa, l’unica reazione è la stessa delusione del Candido sciasciano). In questa «altra Sicilia», martoriata dalla nuova mafia (che «non è più quella della lupara ma ha anche i suoi poeti e i suoi esteti»), l’unico rimedio sembrerebbe la parola. «Ma se la parola è sola, può parlare a se stessa e non può trasformare il mondo, a che serve?» Non resta che il silenzio: quello pietrificante del lutto, di «compiaciuta acquiescenza» dell’omertà. «Attorno a noi non c’era altro che silenzio, e il silenzio continuava ad essere strumento, e cornice, della condanna. Anche le parole udite prima, e che erano cornice di sempre, erano silenzio, o conferma di silenzio, quello irritante di tutti. Scritto nell’aria, nei fatti, nella storia. Nei pensieri e nelle scelte rassegnate della condanna». Teresa Graziano D el libro che la critica teatrale americana Helen Sheehy ha dedicato a Eleonora Duse, attrice, artista, e soprattutto donna dei suoi tempi e eterna musa, letteratura e memoria storica dialogano mirabilmente tra di loro, tra documenti, citazioni, aneddoti, brani di lettere, descrizioni che plasmano pagina su pagina questa creatura forte e lieve, angelo e sirena del Mediterraneo. «Tra i lunghi capelli scuri risaltavo le ciocche color bronzo illuminate dal sole. Nei momenti di quiete, i suoi lineamenti marcati - i grandi occhi neri dalle palpebre pesanti, gli zigomi alti e ampi sopra la mascella quadrata, il naso aristocratico e la bocca generosa - facevano pensare alla purezza della scultura classica». Come un adagio mozartiano, incontriamo Elonora a quattordici anni esordire in un palchetto allestito dentro l’Arena di Verona per rivivere il dramma eterno di Giulietta, e percepire le parole che scorrevano «quasi involontarie», accompagnate dal «rombo continuo delle vene», mentre i petali di rosa scendevano lenti fino all’amato «come se denudasse il suo cuore», e sullo sfondo, le campane che echeggiavano il loro rumore «quasi marino». Si sentiva l’eroina di Shakesperare, e ogni parola «pareva passare a traverso tutto il calore del mio sangue. Non v’era fibra di me che non desse un suono all’armonia». In quella messinscena fermentava tutta la grazia appassionata della Duse, attrice che vive il suo ruolo senza confini e vuole creare un nuovo linguaggio, incarnando personaggi come fossero anime vive: nella sua recitazione - osserva acutamente l’autrice - «non c’era nulla di fisso… c’era solo un essere umano, vivo, sempre mutevole, e in definitiva, tragico». Pensava a sé stessa come ad una «figlia del mare», di quell’Adriatico che va da Chioggia a Venezia, di quel Veneto asburgico da dove - dopo la nascita a Vigevano nell’ottobre 1858 prese il largo con il teatro che era la sua N La nera ombra del nazismo emplice, raffinato, energico, pieno di umanità, filigranato da un’inquietudine cui sottende un’urgenza morale, nel gran teatro delle follie e delle contraddizioni della società occidentale. Ecco la cifra dell’ultimo romanzo breve di Andersch, sintesi lieve tra letteratura ed éngagément. Il padre di un assassino è il preside Himmler (il Rex, come lo chiamano tutti), del Ginnasio Wittelsbach, a Monaco di Baviera. «Educato in una scuola di parte dell’ultra-montanismo bavarese», il Rex è il padre non di un assassino qualsiasi ma di Heinrich Himmler, «l’uomo secondo solo a Hitler», «il più grande sterminatore di vite umane». Un giorno di maggio del 1928, il Rex, «signore e padrone della scuola», si materializza all’interno della «sua» Quarta B: ha deciso di tenere una lezione di greco, imponendosi a sorpresa sullo «smorto e noioso Kandlbinder», lo scialbo docente di greco di quella classe. Il preside - che porta «occhiali cerchiati d’oro dietro i quali gli occhi azzurri osservavano taglienti», che «ha un’aria maledettamente cordiale e linda, come la sua camicia bianca», che sa tutto sul rendimento degli alunni - trascina la classe su un percorso ad ostacoli micidiale: gioca come il gatto coi topi, senza risparmiare niente e nessuno, neppure la grammatica. Comincia con Kandlbinder, gradualmente riducendolo ad essere «solo un’ombra davanti alla lavagna nera»: prima con false lusinghe, poi con un «signor Kandlbinder», fino a farlo sentire annientato «dall’accusa di un totale fallimento pedagogico«. «Tz, tz, tz!», fa più volte il Rex nella lunga requisitoria, con «quel suo famoso schiocco di lingua che suonava sempre come un colpo di frusta ed escludeva ogni replica». Anche il primo della classe diventa una facile pedina contro Kandlbinder. E il gioco al massacro continua: Konrad Greiff, spocchioso rampollo di nobile famiglia, stupidamente orgoglioso, è istigato con sottile abilità dal Rex a reagire furiosamente: «Io sono un barone von Greiff e lei per me non è nient’altro che un signor Himmler!», sbraiterà Konrad, offrendo al serafico e imperturbabile preside una ghiotta occasione per espellerlo dalla scuola. Poi il Rex si avvicina a Franz Kien, il protagonista del racconto, studente pigro ma sensibilissimo (aspirante scrittore, legge Karl May e Shakespeare), di famiglia protestante, figlio di un ufficiale ferito gravemente nella Grande Guerra e decorato, ora spezzato dalla malattia e caduto in miseria. Quando si ferma accanto a Franz, il Rex ha il «passo di un cacciatore che ha udito uno scricchiolio nel sottobosco»: e subito gli intima di scrivere sulla lavagna, in greco naturalmente, «È meritorio lodare la patria»; ben sapendo che Franz non vi riuscirà, solo per esibire i pezzi migliori del «tesoro del proprio sapere», fino all’eliminazione (Franz verrà bocciato, non espulso; non cade nella trappola del Rex, a base di sterili nozionismi, sottili e feroci provocazioni, come quella sul padre malato che non può pagargli la scuola) dell’ultima preda. La più coriacea, dotata delle migliori difese: l’intelligenza critica, la grande sensibilità, il fervido intuito. Tra realtà e invenzione, Andersch, libero dietro lo schermo della terza persona, fa guizzare Franz Kien - il suo alter ego, e già protagonista di altre cinque storie, «tentativi di scrivere un’autobiografia sotto forma di racconti», come spiega lo stesso autore nell’utilissima Postfazione - in un microuniverso reazionario: avvelenato dal sadismo e dallo scintillio del Rex, con sullo sfondo una società su cui già si proietta la nera ombra del nazismo, cui il titolo del romanzo allude. Ma c’è come una controluce ad opporsi a tutto ciò. È il pensiero di Franz: lucido, vigile, agile, scaldato dal candore di un ragazzo di quattordici anni; un pensiero (cui l’autore concede anche la prima persona) che viaggia avvinghiato alla cruda realtà di quell’interminabile ora di terrore che Andersch trasforma in una finestra aperta sulla società di allora e di oggi. Per riflettere sugli sconvolgimenti psicologici dei ragazzi, sull’inquietudine e i disorientamenti di chi, come Franz, si chiede quanto sia utile un certo modello scolastico. E ancora: sui rapporti padre-figlio, sulla tolleranza, sull’ipocrisia, sul perbenismo, sulle maschere sociali, su Klein padre, che aveva messo in guardia suo figlio dal vecchio Himmler, ma anche circa gli ebrei... «Heinrich Himmler […] è uscito da una famiglia della vecchia borghesia di buone tradizioni e di cultura umanistica. Ciò significa forse che la cultura umanistica non […] difende da nulla?», dubita Andersch nella Postfazione; lui s’è tratto d’impaccio con la «storia di un ragazzo che non ha voglia di studiare», che avrebbe voluto raccontare a suo padre di essersi accorto che "sulla via di casa nessuno dei suoi compagni si unì a lui", e che si addormenta tra le pagine di Kurdistan selvaggio. Giuseppe Giglio S HELEN SHEEHY "Eleonora Duse. La donna, le passioni, la leggenda" Trad. Elisabetta Valdrè pp.387, euro 18, 50 Mondadori, 2006 Incarnare personaggi anime vive nave «la plancia instabile sotto i suoi piedi, l’aria che respirava, la luce in cui si muoveva». Eleonora Giulia Amalia, nata dalla coppia di attori Duse-Lagunaz, che attraversa le strade del mondo da zingara che mendica e recita, che impara i gesti per vivere, e che vive nei gesti che le daranno quella naturalezza intensa e commovente che porterà nei massimi teatri del mondo, tanto che gli americani conieranno il termine doozy per indicare un caso di successo stupefante. Le pagine della biografia si bevono come sorsi di acqua di fonte, con radiosi squarci che arrivano dalla grande storia, quella di una creatura dagli occhi lucenti che davanti a una bimba annegata incontra la morte, la fragilità della vita, il respiro dei fiori recisi sul petto, e che di quella fragilità umana porterà i segni addosso, in ogni messa in scena.Lei, interprete dalla sensibilità «plastica», era Giulietta, Pia dè Tolomei, Gaspara Stampa, Francesca di Rimini, La Gioconda e Nora, la Locandiera e la Signora delle Camelie, Hedda Gabler e la Figlia di Iorio. In loro portava la bellezza «palpitante», spontanea, sensuale della sua carica carismatica, dei suoi silenzi parlati che rabbrividivano il pubblico. ALFRED ANDERSCH "Il padre di un assassino" Trad. Amina Pandolfi pp. 128, euro 10 Marcos Y Marcos, 2005 La «mistica sacerdotessa dell’arte» volle essere tante donne, e rivivere i loro slanci vitali, i loro drammi, la loro passione, in modo «straordinariamente semplice», senza usare trucchi, senza cerone e parrucche, vestendo costumi austeri: «se ti vesti di lana o velluto, di saio o d’oro finto, è lo stesso», diceva, lei che voleva solo penetrare «di dentro codesta umanità che te ne presta le spoglie». Voleva farsi strumento della parola, come fece interpretando la protagonista di Cenere di Grazia Deledda, l’unico film a cui partecipò, che volle con grande tenacia, che scrisse e che interpretò - in un suggestivo filo «mediterraneo» che univa Adriatico, Sardegna e Sicilia sotto la regia del divo d’epoca, il regista e attore messinese Febo Mari. «Devi essere solo te stessa. Amore e dolore insieme, madre e figlio in un intreccio di luce e ombra, e, intorno, nessun colore» le scrisse la Deledda, che forse capì come nella scelta della Duse pesasse il distacco dalla figlioletta Enrichetta, come nella Rosalia del film e del piccolo Anania. Ancora oggi, nella storia del cinema, si ricorda come memorabile il sorriso della Duse nella scena del ritorno del figlio, inginocchiata come una Maddalena, che L’AUTRICE. Helen Sheehy, nativa dell’Oklahoma e residente nel Connecticut, è una delle massime storiche del teatro contemporaneo, specializzata in ritratti femminili, con particolare attenzione a figure pionieristiche. Ha scritto le biografie di Margo Jones, produttrice teatrale fondatrice dei primi teatri stabili Usa, e di Eva Le Gallienne (1899-1991) una delle attrici preferite da Ibsen. commosse Colette e tanti spettatori dell’epoca. Il critico del "New York Times", John Corbin, si doleva come «nessuna generazione futura saprà che cosa ammiriamo nell’arte di Elonora Duse perché essa esiste solo interiormente ed è cosa dello spirito». La cantante e amica Alice Nielsen rimase colpita dalla luce «chiara, ultraterrena» che emanava dal suo viso «formando quasi un’aureola attorno al suo capo avvolto dal turbante» che la rendeva «una santa dei tempi antichi». Una santa, che a mani giunte, ringrazia Dio della grazia d’arte ricevuta, come sembra evincersi nella toccante copertina. Con questa biografia, splendidamente tradotta, Helen Sheehy ci ricorda come Eleonora divenne toscana, dove trascorreva le vacanze, napoletana come la grande amica Matilde Serao, americana, dove trionfò superando la fama della Bernhardt e ebbe la copertina di "Time", e dove morì, a Pittsburgh, il 21 aprile 1924; ma soprattutto veneziana, dove tornava felice di sentire l’aria di casa, riuscendo ad essere sempre cittadina del mondo. Aveva un cuore che percepiva i drammi del mondo, come quando aiutò e sostenne i reduci di Caporetto vendendo i suoi cimeli, uscendo tutte le mattine in mezzo a loro, sentendo dentro «i loro discorsi, il loro silenzio, il coro dei loro pensieri, il luogo nascosto del cuore». Divenne dannunziana per sensuale vitalismo, per amore e per disamore, fu ammirata da tanti scrittori, da Arrigo Boito, suo grande amore, a Papini, Aleramo e Claudel, che ne riconoscevano anche la dote di letterata raffinata. Ma rimase sempre una creatura d’acqua, salata e ondulatoria, pronta a approdare - in un «alternarsi di finali e nuovi inizi» - sulla sua spiaggia, con i polmoni desiderosi d’aria da respirare e da regalare, come dono d’eterna arte di donna.Una donna-mistero, la Donna del mare. Sergio Di Giacomo pagina 24 S t los narrazioni inedite Pablo Picasso: "L’appuntamento" (1900), Mosca. Museo Puskin (particolare) er sempre" fa parte di una raccolta di venti storie sul mistero e sugli equivoci dell’amore che spinge uomini e donne a cercarsi, a ingannarsi, a lasciarsi in una trafila ciclica senza fine. Ogni racconto è dedicato a uno scrittore che mi è particolarmente caro, senza necessariamente far riferimento ai suoi temi o ai suoi modi. Una dedica in assoluta libertà. Questo è dedicato a Luigi Pirandello. P " I «Guardami ancora» le disse. «I tuoi occhi… sì, sono farfalle come quelli di una bambina». Aveva steso la sua mano ad afferrare quella di lei che, incerta, gliela aveva consegnata. «Volano in giro a caso, posandosi dove qualcosa a un tratto pare attirarli. Per levarsi di nuovo, subito dopo». Ma lei non aveva detto ancora niente. Lo guardava che la stava fissando. Aveva un’espressione molto vaga. Se non assente, distratta comunque dietro a qualcosa che non lo riguardava. Per quanto la stringesse, si librava in aria volteggiando e frullando le sue ali. Era un soffio a trascinarla via. «Hai due occhi di velluto viola» le ripeteva, pensando che il qualcosa di esitante in lei aveva l’effetto dell’incantamento. Lui sorrideva ignaro. E la ragione dell’attrazione era il sorriso che aleggiava sulle sue labbra. Largo e avvolgente. Sprigionava una luce alla quale era impossibile opporre resistenza. E lei, infatti, non aveva resistito. II «Perché poi due persone stanno insieme?» lei si chiedeva. «Che cosa mai le lega al punto che non possono lasciarsi? Da quali vincoli sono tenute insieme? I figli? La casa? L’abitudine?» No, c’erano fili molto più sottili che cucivano due vite tra di loro. Mesi e anni assieme, ad affrontare giorno per giorno tutto quello che di bello e di brutto capitava. Un carico di sofferenza e di felicità, depositato al fondo e che nessun risentimento, nessuna delusione poteva cancellare. Qualcosa che magari diventava poi mitologia: la leggenda della propria vita. Ma che, qualunque fosse… illusione o fantasia, impediva che il filo si spezzasse. Anche se lo si tagliava, si riannodava lui da solo. E lo si recideva per verificarne proprio la tenuta. Troncandolo, eccolo lì che si saldava ancora. Fissava, intanto, le sue labbra sorridenti. C’era un riflesso chiaro che brillava su quel viso. Cosa poteva, lui, saperne dell’intreccio che la vita le aveva intessuto attorno? E che filo pensava di intrecciare lui a quella trama? III Sentiva che la presenza delle donne era per lui una necessità assoluta. Vivere senza di loro sarebbe stato come ballare senza la musica o come mangiare senza il vino. Erano loro a dargli stimolo, a dargli ispirazione. Erano il sale della vita. Non loro in senso astratto o come una pluralità indistinta, ma come presenze vive prese singolarmente una per una. La bionda grassa che incontrava ogni mattina, con il cordiale suo sorriso pieno di vita. La portiera del palazzo, sempre protesa ben oltre il proprio sguardo. Poi, la barista che gli serviva il suo caffè macchiato, annunciandoglielo allegra: «Pronta, la schiuma, per il dottore». E lei, naturalmente. Le sue spalle slanciate, la sua gola che palpitava di un tremito di intesa con le narici e con le labbra. Cosa aveva addosso che non poteva fare a meno di pro- Un uomo innamorato di una donna dalla quale crede di non essere ricambiato. Ma così non è. E una donna che si dona a lui per amore con tutta se stessa. A chiedersi entrambi cosa sia quello che succede loro? E interrogarsi sulla durata di un legame e su quello che viene dopo il sesso Possedere per sempre? Una follia degli uomini VIVE A TREVISO. "PREPARATIVI PER LA PARTENZA" (MARSILIO, 2003), "LA GIOIA E IL LUTTO" (MARSILIO, 2001) PAOLO RUFFILLI vare ammirazione e amore verso di lei? Se ne era innamorato di lontano. Credeva che con lei non ci fosse però niente da fare. La vedeva soddisfatta della sua vita, tutta impegnata a organizzarla e a difenderla dagli altri. Fredda rispetto a quello che non le apparteneva. E, invece, lei lo ricambiava. Era evidente che aveva solo finto di non provare niente. Adesso ce l’aveva lì, al suo fianco. La poteva stringere e baciare. E gli sembrava incredibile che due persone potessero essere felici come stava capitando a loro. IV Lui dormiva con la testa che teneva girata verso l’altro lato. I capelli scuri sembravano più un’ombra che capelli. L’orecchio, di un color mattone denso, era diverso dal chiarore che gli brillava sopra il collo. E la sua schiena aveva un leggerissimo sussulto che andava ondulando nel senso opposto all’espansione del respiro. Il corpo vivo era un miracolo al quale non si sarebbe abituata mai. Pur sapendone i limiti e le fragilità, e conoscendone le debolezze. Vi palpitava dentro il più grande dei segreti. O era l’aria che vi entrava ad animarlo di magia? Un’aria che era piena di potenze inconoscibili e di forze oscure. L’aria che dava vita alle forme. In fondo, era così. Da che l’uomo era in grado di pensare e riusciva ad esprimere il pensiero, si sentiva sfiorare da un mistero impenetrabile ai suoi sensi che restavano imperfetti. Cercava, con l’intelligenza, di far fronte al- l’impotenza dei suoi organi. E la ragione non era sufficiente, serviva l’amore per conoscere la vita dal di dentro. Ma che cos’era poi l’amore? Non avrebbe saputo trovare le parole per spiegarlo. Ne aveva però il senso ben presente addosso. L’essere parte di qualcuno o di qualcosa, il ritrovarsi senza più distacco legati a un nodo che non poteva più essere sciolto. V Aveva tremato, accarezzandola leggero sopra le vesti. E lei gli aveva preso la mano, guidandola più in basso. Gliela aveva trattenuta nella morsa tra le gambe, fissandolo con uno sguardo dispettoso per poi lasciarla andare. «Ma… vuoi?» le aveva chiesto guardandola perplesso. «Perché? Ti sembra forse che non voglia?» aveva lei risposto con un sorriso che gli era parso un altro enigma da svelare. Le era scivolato addosso, timoroso. Lei rispondeva a tempo e dava certi strappi, nell’aggrapparsi a lui. Tutto era sempre meno complicato di quan- Storia C di un A emigrante T A L O G O to apparisse nella realtà. Sembrava che piacesse pure a lei. Cos’era mai l’amore? Un salto? Una fatalità? Nel farlo, gli era però apparso una piacevole normalità. «È bello stare così, mentre fa buio, tra le tue braccia» pensava intanto che lei da dietro lo abbracciava. Il meglio dell’amore cominciava per lui dopo l’amplesso. Che spasimo lungo, che gioia senza altri confini… Il cuore non batteva più così veloce, il sangue non scorreva più tumultuoso e una pace appagante lo invadeva. C’era qualcosa di una vita superiore, felice e smemorata, in quello stato. Che fosse, quella, la condizione beata degli dei? Pensandolo, sorrise. VI Guardava il fitto delle foglie scure e gli squarci di azzurro che si vedevano tra loro. Un fiore giallo le cadde addosso. Ognuno dei suoi petali splendeva e la linguetta nel centro gli dava forma di campana. Le parve, a un tratto, che avesse un suo tin tin. Ma, sorridendo, pensò alla suggestione e agli effetti che era in grado di creare. Come in amore, del resto, succedeva di ELENA GIANINI BELOTTI "Pane amaro" pp. 385, euro 18,50 Rizzoli, 2006 Un pane amaro è quello che mangia Gildo, quarto di dieci figli, in America, dove è arrivato dal Bergamasco ai primi del Novecento. Lì, nel paese dell’abbondanza, il mite Gildo lavora duramente come manovale per la costruzione di ferrovie e strade, ma affronta fatica, soprusi, ingiustizie con la consolazione di una fisarmonica, ereditata da un compagno sfortunato. Passano gli anni e sembra che proprio con la musica il giovane possa riscattarsi dalla vergognosa povertà dei suoi connazionali. vedere quello che non c’era e di scoprire a un tratto quello che era a vista. Aveva sposato suo marito e poi, ora, lo aveva anche tradito. E, come non bastasse, sentiva che lo amava proprio mentre lo tradiva. Anzi, era lui soltanto che lei amava. Eppure l’altro l’aveva attratta e conquistata, spingendola a tradire. Non era affatto un seduttore. Non si era approfittato. Se mai, era stata lei a servirsi di lui e del suo corpo. Sentiva bene che lui le stava dando amore. E che era pieno di premure e di attenzione. Lo guardò mentre giaceva sul suo fianco, abbandonato. Nella penombra era più bianco e luminoso. Cos’è che aveva fatto? Come era complicata… la vita o lei? Ma tutto si intrecciava ed era, insieme, semplice e innocente. VII Il sole era già caduto nel tramonto. C’erano a ovest grandi masse di nuvole rosa frantumate e larghi fasci di luce che le attraversavano da parte a parte. L’azzurro in alto sbiadiva e diventava oro pallido. La luce declinava, tingendo il cielo di un lilla che andava intanto incupendo là lontano. E, sullo sfondo, la città spiccava netta e scura come metallo. Gli parve ostile e dura, e chiuse gli occhi, ricordandosi che lei aveva già un marito e una famiglia. Un lavoro, una casa e un’altra vita. «O strada dove avviandomi mi guardo attorno, credo che tu non sia tutto quello che si vede qui» si era messo a recitare tra sé i versi di chissà quale poesia. C’erano sempre deviazioni e, al bivio, si poteva prendere la via più lunga e più sicura oppure l’invitante scorciatoia che faceva impantanare. C’era un agguato dove meno uno lo aspettava e un nemico mascherato dietro la porta. La vita portava in campo i suoi eventi inaspettati che scombinavano i piani e travolgevano i progetti, lasciando sbigottiti. Però c’era anche la sorpresa di un regalo… Riaprendo gli occhi, pensò che in quei fasci di luce c’era qualcosa che parlava della gioia senza fine che la vita gli stava regalando. E quel qualcosa era sdraiato alle sue spalle. Avrebbe potuto subito vederlo, girandosi appena sopra il fianco. Ma non lo fece, per timore di svegliarla mentre supponeva stesse sognando di loro due e della vita che li aspettava in comune nel futuro. VIII «Perché è eccitante stare svegli mentre è lui che dorme?» si chiedeva. E lì, da sveglia, non si pentiva. Non si sentiva affatto in colpa. Lo aveva amato un’ora, e forse anche di più. Lo aveva amato, amando intanto suo marito. «Sarai mia per sempre?» le aveva chiesto lui, mentre le circondava con le sue braccia il collo e la stringeva a sé. Per sempre, già. «La gioia e la pretesa di possedere qualcuno in esclusiva… una follia degli uomini» pensava. Lui non c’entrava proprio. Era lei che aveva bisogno di qualcuno che la scoprisse in una parte che nessun altro conosceva e le chiedesse di essere quella lì per sempre. E, nel dirle proprio «Per sempre», per sempre la salvasse da se stessa e da quella parte oscura che pregava: andiamo via, lontano, per una vita nuova tutta per noi… Qualcuno che la salvasse dunque dal fuggire e le ridesse il senso delle cose, che durano poco rinnovandosi ogni giorno: la casa, i figli, suo marito. Per non restare preda di un fantasma, per non vivere morendo la sua vita vera. (a Luigi Pirandello) © Ruffilli per Silos, "Per sempre" V O C I GIANFRANCESCO TURANO LA SFIDA DI CALCIO TRA RICCHI E POVERI La Flaccovio pubblicherà a fine marzo il romanzo Catenaccio! (pp. 336, euro 16,50) del giornalista e scrittore Gianfrancesco Turano. Un libro sul calcio tra ingaggi milionari, modelle bellissime, auto di lusso. L’allenatore più esonerato della storia del calcio sta per appendere la tuta al chiodo dopo 999 partite, quando il barone Uto Sombrero di Cirrocumulo gli propone la sfida del secolo: una selezione di ricchi, sostenitori del calcio moderno votato all’offensiva, giocherà contro i «morti di fame» di mister Litaliano, accomunati dalla fede nel difensivismo catenacciaro e dalla fedina penale sporca. Turano, calabrese, è inviato de "Il Mondo" e per Flaccovio ha già scritto Ragù di capra, entrato in semifinale al Premio Scerbanenco. GIUSEPPE COSTA DUE ANNI DI GUERRA IN UN DIARIO Due anni cruciali nella storia di rapallo come anche nella vita nazionale. E Rapallo 1944-1945. Diario di due anni di guerra (pp. 103, euro 12) è il titolo del libro di Giuseppe (Pippo) Costa, edito dalla De Ferrari. nel diario di Costa i grandi eventi bellici si mescolano alla quotidianità: il tempo, i prezzi delle derrate alimentari, i compleanni dei fratelli, la radio svizzera da cui si sente il concerto di Mozart, Anna che fa l’interprete, le malattie… Un insieme di «piccoli fatti» che l’autore annota giorno dopo giorno nelle pagine del suo diario, in modo asciutto e lucido, con sguardo disincantato sulle violenze di tutte le parti in conflitto e con estrema precisione nella descrizione delle operazioni belliche in ricordo del servizio prestato durante la prima guerra mondiale. Nella prefazione al libro Gian Luigi Croce annota: «C’erano una volta uomini come questo che costituiscono occasioni per interrogarci a fondo sul valore delle scelte che sono inevitabili». Giuseppe Costa prestò servizio nella guerra del ’15-’18 sul Pasubio come tenente di artiglieria da montagna. FUMETTI LA VITA QUOTIDIANA DI JAMES KOCHALKA Arrivano anche in Italia i diari a fumetti di James Kochalka. Fernadel pubblica Sketchbook Diaries n. 1 (pp. 192, euro 12). Anche chi non condivide in questo momento l’immagine pubblica dell’America resterà colpito dalle strisce di James Kochalka, uno dei disegnatori più promettenti della nuova generazione di fumettisti americani. Con la serie dei suoi diari a fumetti Kochalka ha creato un universo parallelo nel quale raccontare con tenerezza, ironia e a volte crudo realismo la propria vita quotidiana.
Scarica



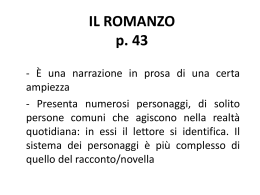


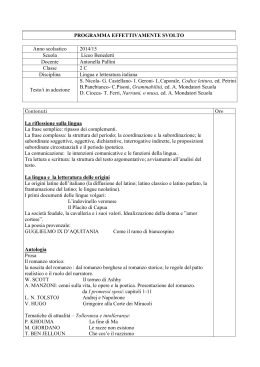

![Italo Calvino [h]](http://s2.diazilla.com/store/data/000054582_1-6f09ede360492035ba514f55116a45aa-260x520.png)
