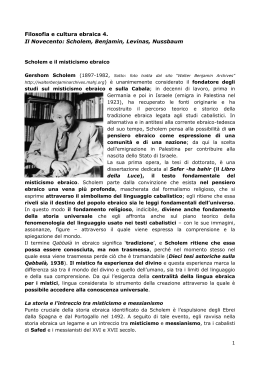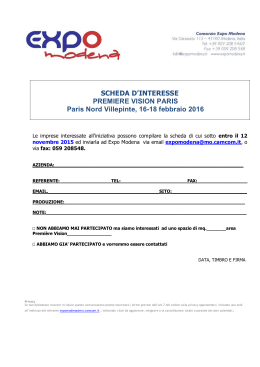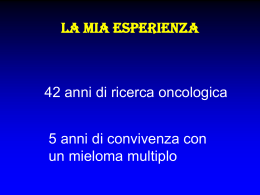UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
FILOSOFIA E TEORIA DELLE SCIENZE UMANE
CICLO XXIII
TRAUMA, PASSIONE, SOSTITUZIONE.
IL PENSIERO DI EMMANUEL LEVINAS, DALL’ESPERIENZA
DELLA SOFFERENZA ALLA SOGGETTIVITÀ ETICA
TUTOR
CHIAR.MO PROF. ROBERTO MANCINI
COORDINATORE
CHIAR.MO PROF. LUIGI ALICI
ANNO 2012
DOTTORANDO
DOTT. ALESSANDRO PARIS
Senza dubbio la retorica del detto può sommergere
l’etica della prossimità; ma proprio nella misura in cui questa prossimità riesce a mantenersi nel discorso, si delinea il circolo entro il
quale assume significato il «mondo della vita», ed entro cui si svolgono i discorsi quotidiani, dai quali l’eloquenza è esclusa,
e che essi rendono ridicola.
Emmanuel Levinas,
Fuori dal soggetto tr. it., p. 151.
La Shoah?
È un argomento di cui non si parla!
Da un colloquio con un
amico. Citato in S. MALKA,
Emmanuel Levinas, la vita
e la traccia, tr. it., p. 205.
3
4
INDICE
Avvertenza bibliografica...............................................................................................7
Introduzione .................................................................................................................9
Capitolo I - L’esperienza della prigionia....................................................................13
1. Il rapporto tra opera e biografia......................................................................15
2. Elaborazione e racconto postumi....................................................................21
3. L’esperienza del prigioniero nei Carnets........................................................32
4. L’esperienza ebraica negli Écrits sur la captivité...........................................57
Capitolo II - Shoah e trauma.......................................................................................79
1. La Shoah come margine della filosofia negli scritti di Emmanuel Levinas..................................................................................................................81
2. L’interpretazione della Shoah nei testi levinassiani........................................88
3. Il trauma e la sindrome del sopravvissuto: interpretazioni psicoanalitiche................................................................................................................133
4. Esperienza e trauma: l’avvio del pensiero in Heidegger e Levinas................................................................................................................153
Capitolo III - La Passione come figura dell’umano..................................................165
1. Dalla passione d’Israele alla passione del soggetto.................................167
2. La nozione di «figura» e lo schematismo storico in Kant........................171
3. «Figura» e storia, tra Kant e Levinas.......................................................178
4. Libertà, violenza e istituzione: ruolo e limiti dello Stato.........................181
5. Messianismo e soggettività .....................................................................197
6. L’umanesimo del «servo sofferente».......................................................202
5
7. La Passione come eidos della santità e testimonianza esemplare del Bene..............................................................................................................205
8. La Shoah: enigma e senso........................................................................209
9. Passione, passività, pazienza....................................................................221
Capitolo IV - La soggettività etica come approche e sostituzione............................225
1. Contesto storico-biografico di La sostituzione............................................227
2. La soggettività etica come Sensibilità e prossimità......................................230
3. Lo schema del sacrificio talmudico e la dinamica dell’approche.................238
4. La sostituzione..............................................................................................245
4.1 La ricorrenza...........................................................................................250
4.2 Responsabilità, sostituzione, espiazione.................................................259
5. Il terzo e i limiti del sacrificio.......................................................................277
Conclusione...............................................................................................................287
Bibliografia................................................................................................................291
6
AVVERTENZA BIBLIOGRAFICA
I testi levinassiani maggiormente citati sono stati abbreviati nel modo che segue.
Quando ci è parso necessario, abbiamo segnalato le variazioni rispetto alla versione
italiana, sulla base del testo originale. Le traduzioni dei testi dal francese non precedentemente tradotti sono nostre.
AE
Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, tr. it. S. Petrosino
e M. T. Aiello, Jaca Book, Milano 1983.
AV
L’aldilà del versetto. Letture e discorsi talmudici, tr. it. di G.
Lissa, Guida, Napoli 1986.
CCAI
Carnets de captivité et autres inédits, (Œuvres 1), a c. di R.
Calin e C. Chalier, Bernard Grasset/Imec, Paris 2009.
DL
Difficile libertà, tr. it. di S. Facioni, Jaca Book, Milano 2004.
DVI
Di Dio che viene all’idea, tr. it. G. Zennaro, Jaca Book, Milano
1983.
DMT
Dio, la morte e il tempo, tr. it. di S. Petrosino, Jaca Book, Milano
1996.
EI
Etica e infinito, tr. it. di F. Riva, Città Aperta, Troina (En)
2008.
EE
Dall’esistenza all’esistente, tr. it. di F. Sossi, Marietti, Genova
1986.
FS
Fuori dal soggetto, tr. it. di F.P. Ciglia, Marietti, Genova 1992.
NP
Nomi propri, tr. it. di F.P. Ciglia, Marietti, Casale Monferrato
1984.
NODN Nell’ora delle nazioni, tr. it. di S. Facioni, Jaca Book, Milano
2008.
QLT
Quattro letture talmudiche, tr. it. di A. Moscato, il melangolo,
Genova 2000.
SEHH
Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, tr. it. di F. Sossi,
Raffaello Cortina, Milano 1998.
DSS
Dal sacro al santo, tr. it. di O. Nobile Ventura, Città Nuova,
Roma 1985.
7
TA
Il tempo e l’altro, tr. it. di F.P. Ciglia, il melangolo, Genova
2001.
TI
Totalità e infinito, tr. it. di A. Dell’Asta, Jaca Book, Milano
19902.
THI
La teoria dell’intuizione nella filosofia di Husserl, tr. it. di V.
Perego, Jaca Book, Milano 2002.
TN
Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, tr. it. di E. Baccarini, Jaca
Book, Milano 1998.
UAU
Umanesimo dell’altro uomo, tr. it. di A. Moscato, il melango
lo, Genova 1985.
HERNE AA.VV., Lévinas, Le Cahier de l’Herne, a c. di C. Chalier e
M. Abensour, Éd. de l’Herne, Paris 1991, 2006.
8
Introduzione
Il presente lavoro intende sondare il rapporto intercorrente fra trauma e soggettività etica nel pensiero di Levinas, facendo valere la circolarità ermeneutica tra
esperienze pre-filosofiche e concettualità filosofica, e sempre ricordando la modalità
specifica del testo levinassiano, che non si attende una lettura univocizzante e conclusiva, ma che invita il lettore a leggere e rileggere continuamente lo scritto per
trarne sollecitazione e rispondere in prima persona al suo interrogare.
Il presente lavoro ha inteso inquadrare nella sua prospettiva di «margine», in
senso derridiano, l’esperienza anche biografica dell’autore, sedimentata negli scritti,
e sondare la pertinenza del nesso trauma-passione-sostituzione, valendosi tanto delle
prospettive della fenomenologia, quanto di quelle della spiritualità ebraica e della
psicoanalisi.
I testi levinassiani indagati sulla base di questo fuoco tematico vanno dagli
inediti della prigionia (Carnets), recentemente resi accessibili al pubblico, attraverso
i primi scritti immediatamente postbellici, fino a guadagnare l’approccio all’opera
Altrimenti che essere, di cui, per stessa ammissione dell’autore, il capitolo IV intitolato La sostituzione costituisce il germe e in qualche modo il vertice Non ci siamo
soffermati in modo particolare sulle Letture talmudiche (ad eccezione di Difficile Libertà, per il suo carattere liminare tra le due produzioni) intendendo invece indagare
prevalentemente le opere cosiddette filosofiche, per sondare il tipo di lettura proposta
proprio laddove Levinas si misura più direttamente con la scuola proveniente da
Atene.
Uno dei motivi che hanno avviato la nostra ricerca è il costante uso, nel testo
maggiore, di un lessico di natura “traumatologica”: ci siamo chiesti quanto questo
lessico fosse debitore, oltre che di un ripensamento della tradizione filosofica, specie
fenomenologica, soprattutto di quelle che lo stesso autore chiama «esperienze prefilosofiche», e abbiamo cercato di mostrare come esse assumano un valore non solo
di inizio o principio del gesto speculativo, ma anche di orizzonte e sfondo dello stesso suo costituirsi.
9
Ricostruendo l’esperienza filosofica di Levinas, troviamo la traccia, sedimentata nei testi, di questo sfondo e orizzonte; abbiamo dunque ritenuto necessario metterla al centro della nostra indagine, per tentare di decifrare quello che, troppo spesso, da margine del testo, diventa negli interpreti margine al testo, cioè nota a piè di
pagina.
L’interrogazione sul male storico, significato nell’evento della Shoah ebraica
– la cui universalità esemplare abbiamo cercato adeguatamente di inquadrare alla luce della modalità in cui Levinas ricostruisce il senso dell’umano nella situazione, che
qui si dischiude, di disumanizzazione estrema e di crollo del mondo e dell’esistenza
–, ha sempre inquietato anche noi. Di fronte a Levinas, essa ci ha invitato ad un difficile e talvolta laborioso percorso di scavo dei testi, dei concetti e del lessico levinassiani, ad una loro lettura-attraverso, per così dire, al fine di sondare un campo delicato e di confine, quello del dolore personale e universale, con cui non può non misurarsi non solo ogni interrogazione filosofica ma anche la semplice domanda dell’uomo quotidiano.
Si è cercato di evitare il duplice pericolo di appiattire il nostro studio sulla dimensione biografica, senza lasciare adeguatamente risaltare quella filosofica, e viceversa, di ridurre troppo lo spessore ineludibile del dato pre-filosofico ed esistentivo,
attorno al quale il pensiero e la scrittura del nostro autore è andata a costituirsi.
Nella lettura dei testi abbiamo cercato di essere più aderenti possibile alla precisione terminologica e alla contestualizzazione storica, cercando il meno possibile di
far parlare il testo quando esso taceva, e segnalando invece quando e come, nello
sfondo opaco dell’indicibile, il tentativo di rispondere fosse tentato.
I concetti e i termini «che si fanno eco» lungo i testi levinassiani, in particolare in Altrimenti che essere, rendevano quasi obbligatoria la ricostruzione di una rete
di significati intorno a un nucleo comune: il trauma; questo è stato il tentativo più
specificamente speculativo del presente lavoro. L’atteggiamento ricostruttivo, del
quale ci siamo valsi soprattutto nella ricognizione dei testi dei Carnets, non ha indugiato in questioni storico-filosofiche o filologiche, ma ha cercato sempre di mantenersi nella linea del confronto con la nostra ipotesi di lavoro iniziale: la rilevanza e la
circolarità tra pre-filosofico e filosofico, e la risposta al trauma personale e collettivo
10
che ha segnato il Novecento, ma che resta purtroppo sempre possibilità
dell’inumano.
L'evento-Auschwitz, il cui nome è taciuto tematicamente – almeno in AE –
ma la cui traccia continuamente riaffiora e il cui spessore di (non) luogo ermeneutico
risalta con una «evidenza che cava gli occhi», acquista, a nostro avviso, la portata di
trauma, buco (trou, da cui traumatisme) nei testi, e nella storia e memoria
dell’umanità. Esso non appare trasparente a una razionalizzazione – segna anzi il vertice dell’incapacità di assunzione da parte della coscienza rappresentativa – ma incombe al pensiero e alla carne sofferente, come enigma rispetto al quale si è costretti
a interpretarsi.
Il buco-trauma della Shoah non «appare», ma «compare», come segno esemplare del volto di altri, e dell’eidos della soggettività etica, quell'uno-per-l’altro che
(ri)significa il senso del mondo e dell’umanità. Nella struttura della soggettività etica
delineata da Levinas, risalta, come mostreremo, il ruolo di una peculiare valenza sacrificale, che abbiamo cercato di inquadrare e ricostruire alla luce del significato e
dell’interpretazione del termine approche, che traduce l’ebraico korbàn.
Auschwitz è quindi il «nome» in cui si concreta la scrittura del disastro
(Blanchot), che costringe all’interruzione la penna e il pensiero che pretenda di arrivare sino alla ripresa dell’(auto) controllo – e del controllo assoluto del segno che
voglia arrischiarvisi. Auschwitz come segno barrato del Bene, che non tanto mi invita, ma piuttosto mi bracca e costringe a rispondere – responsabilità per e davanti a
altri, senza possibile uscita di sicurezza, esposizione nell’offerta: me come dono di
vita.
Nel primo capitolo cercheremo di marcare il significato dell’esperienza biografica di prigionia e, confrontandoci con i testi dei Carnets, di ricostruire
l’autocomprensione filosofica di essa. In questo lavoro di scavo ci sarà utile la prospettiva psicoanalitica, oltre a quella fenomenologica ed ebraica, con la quale cercheremo di leggere alcuni punti e articolare alcune categorie usate dall’autore. Nel secondo capitolo, ricostruiremo la nozione di trauma relativamente alla Shoah, sia nella
lettura che ne dà Levinas, sia nel confronto con le prospettive filosofiche ed ebraiche.
Analizzeremo poi il concetto di trauma anche dal punto di vista psicoanalitico e fenomenologico, in relazione alla nozione di esperienza, onde collocare nel suo esatto
11
contesto, tecnico e lessicale, il senso della lettura che abbiamo tentato. Nel terzo capitolo, cercheremo di interpretare la nozione di Passione mostrando in che modo Levinas rilegga attraverso questa categoria la Shoah. Utile sarà in questo senso un confronto con la prospettiva kantiana dello schematismo storico, rispetto al quale tenteremo di istituire un confronto con la nozione di «figura dell’umano» in Levinas. Nel
quarto capitolo, indagheremo infine la nozione di soggettività etica, incentrandoci
sull’analisi del IV capitolo di Altrimenti che essere. A questo proposito sarà quindi
indagato il tema del sacrificio, già toccato anche nel secondo capitolo, cercando di
rilevarne la peculiare rilettura levinassiana di questo tema, e il suo carattere paradossalmente “antisacrificale”.
12
I. L’ESPERIENZA DELLA PRIGIONIA
13
14
1. Il rapporto tra opera e biografia
Quanto è rilevante la concreta biografia di un autore per comprendere la sua
opera? E, più specificatamente, quanto è rilevante l’esperienza pre-filosofica di Levinas per comprendere Altrimenti che essere [AE]? Si tratta, relativamente all’opera, di
qualcosa di estrinseco, o la biografia deve valere come un presupposto ineludibile per
interpretare il testo?
E se è proprio il testo a non tematizzare esplicitamente il suo presupposto prefilosofico, ma ad alludervi preliminarmente – memoriale e testimonianza la duplice
epigrafe di AE –, come il sasso deposto sulla tomba di un defunto nella tradizione
ebraica che vieta l’oblio, non apparirà dunque una forzatura interpretare il testo alla
luce di questo «non detto», quasi che lo scritto stesso fosse l’unica possibile testimonianza. Elie Wiesel parla delle parole testimoniali della scrittura utilizzando questa
suggestiva metafora: «Ma per me lo scrivere è piuttosto una matzevà, un’invisibile
pietra tombale, eretta alla memoria dei morti senza sepoltura. Ogni parola corrisponde a un volto, a una preghiera, avendo l’uno bisogno dell’altro per non cadere nell’oblio»1. Scrittura come testimonianza mai completamente esauribile dunque, in cui il
testo stesso non è “l’ultimo detto possibile”, ma va piuttosto percorso, attraversato,
letto-e-riletto.
L’approccio al testo levinassiano implica spaesamento, in quanto si tratta di
un’opera «inabitabile», come suggestivamente suggerisce François-David Sebbah2, o
abitabile sempre provvisoriamente. Esso invita – o forse costringe –, infatti, a una
continua rilettura al quadrato, se così si può dire. Occorre leggere ciò che viene detto-scritto, poi rileggere, e questo solo per quanto concerne il lettore. Dal versante del
testo, ciò che viene detto è continuamente il disdetto e ri-detto di un dire che, come
tale, solo nella lettura e rilettura può udirsi. E ogni qual volta si cerca di ridurre in poche idee liofilizzate questo testo inabitabile, si rischia di trarne solo qualcosa di formale, astratto e scheletrico. Da qui emerge forse l’impressione che il lettore può cogliere, d’inadeguatezza, d’incapacità di interpretare, di dovere sempre di nuovo co1
Cfr. Le chant des morts, Éditions du Seuil, Paris 1966; tr. it. di D. Vogelmann, L’ebreo errante, Giuntina, Firenze 1983, p. 15.
2
«Il testo si rende in senso stretto, inabitabile» (L’aggettivo è di F. D. SEBBAH, Cfr. MALKA,
S., Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, Jean-Claudie Lattes, Paris 2002; tr. it. di C. Polledri, La vita
e la traccia, Jaca Book, Milano 2003).
15
minciare da capo, di non comprendere mai completamente, di dover rinviare a chissà
quando una comprensione totale.
Ma potrebbe essere che questa comprensione totale sia intenzionalmente interdetta, attraverso una strategia scrittoria che la renda impossibile. Forse non si tratta
solo della polivocità pluralistica intrinseca al concetto ebraico di verità, ma della necessità di una lettura che non è possibile se non come una continua approssimazione
al testo, e che non è traducibile se non come una continua approssimazione ad Altri.
«Approssimarsi» è il termine in cui il traduttore di AE volge il francese «approche»,
termine chiave del lessico levinassiano, traduzione buberiana-rosenzweigiana dell’ebraico korbàn come Levinas stesso segnala: «invece di sacrificio egli [Buber] ricorda
mirabilmente l’idea della prossimità contenuta nel termine ebraico di korbàn traducendolo con “l’approssimarsi”»3.
Approche, come avremo modo di vedere4, dice molto più che un semplice “farsi prossimo”, indica lo stesso dinamismo costitutivo del soggetto come «soggezione»
e «sostituzione», «uno-per-l’altro», «espiazione» (sacrificale nonviolenta), (ri)costituzione del senso: «altrimenti che essere».
Ma il dove e il come della lettura di un testo è ininfluente rispetto alla sua interpretazione? È cioè indifferente che un’esegesi avvenga in un’aula universitaria per
una lezione, o che il libro sia compulsato da uno studente per preparare un esame o
per scrivere una tesi, oppure che sia studiato e meditato comunitariamente, magari in
una yeshivà (come proponeva Benny Lévy5), o magari da soli, nel luogo la cui assenza-presente esso tace (rimane per ora impregiudicato se intenzionalmente6 o meno),
ma implica come orizzonte ineludibile di senso? Non stiamo soltanto pensando alla
considerazione, più volte ribadita da Levinas, secondo la quale «ogni lettore è, a suo
modo, scriba»7 del testo, del quale «l’unicità di ogni ascolto porterebbe in sé il segreto»8, per cui «i molteplici sensi [del testo] sono persone molteplici»9. Stiamo piutto3
Martin Buber, FS, p. 17.
Vedi infra cap. IV par. 3.
5
«Bisognerebbe leggere l’autore di Totalitè et Infini come si legge la Mišnàh!» (citato in S.
MALKA, Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, Jean-Claudie Lattes, Paris 2002; tr. it. di C. Polledri,
La vita e la traccia, Jaca Book, Milano 2003, p. 232.
6
«Quello che non ha desiderato dire non l’ha detto, e ciò che ha trattenuto era senza dubbio
volontario», afferma Malka (S. MALKA, op. cit., p. 267).
7
AV, p. 217.
8
Ivi, p. 218.
9
Ibidem.
4
16
sto pensando al Sitz im Leben dell’opera, l'ambiente nel quale il testo è cresciuto.
«Leggere Altrimenti che essere ad Auschwitz» potrebbe non essere solo un titolo infelice. Infatti, studiare l’opera di Levinas, e soprattutto AE, come risposta-responsabilità all’evento della Shoah significa non solo valorizzare la chiave ebraica del pensiero levinassiano, ma porlo radicalmente in una prospettiva di assunzione responsabile dell’evento: permanere nella domanda filosofica posta dal trauma e rispondervi
attraverso un’etica della sostituzione che arriva all’espiazione: «Espiazione addossata
a me senza la possibilità di trarmi indietro e grazie alla quale si esaspera nella sua insostituibilità invece di alienarsi la mia unicità di io»10.
Il problema di cui stiamo parlando è stato già posto da Adriaan Peperzak in
questi termini:
«È impossibile comprendere la filosofia di Levinas, come del resto qualunque filosofia, isolandola dal contesto della sua vita pre-filosofica (esperienze, convinzioni, eventi e clima spirituale) in cui si radica. E tuttavia, l’interprete di una filosofia non deve discuterne esplicitamente i presupposti filosofici e non-filosofici, se egli e la maggioranza dei lettori li condividono con
l’autore del testo da interpretare. Si può considerare a buon diritto il pensiero
di Levinas come espressione del clima culturale del nostro tempo, comune a
tutti coloro che – formati all’interno delle tradizioni della cultura greco-occidentale – ne hanno vissuto la crisi contemporanea, e hanno sofferto e subito le
guerre e le persecuzioni del XX secolo»11.
Quest’affermazione di Peperzak, che sembra sussumere lo specifico ebraico di
Levinas entro un vissuto comune a una generazione, è certo in parte mitigata dalla
successiva constatazione del «significato primordiale che egli attribuisce alla sua etica – e in un senso specifico alla religione – e [alla] sua identità ebraica»12. Ma tale
sussunzione (nel «clima intellettuale del nostro tempo») è, a nostro avviso, per lo
meno sintomatica di una rimozione della specificità del trauma autobiografico che sta
10
NP, p. 6.
«Introduzione a Altrimenti che essere», in E. LEVINAS – A. PEPERZAK, Etica come filosofia
prima, Guerini e Associati, Milano 1989, p. 113.
12
Ivi, p. 114.
11
17
dietro l’opera levinassiana. E che questo diniego sia involontario, è ovviamente segno del pericolo a cui si espone l’interpretazione accademica (ma anche extraaccademica) che non solo tenda a scindere il “filosofo” dallo “scrittore confessionale”, ma che, attraverso questa scissione, creda di salvaguardarne maggiormente
l’universale validità filosofica, temendo forse che l’enfasi posta sul rapporto con la
Shoah (e in generale con l’ebraismo) possa depotenziare il valore filosofico
dell’autore, riducendolo solo in un ambito strettamente confessionale.
La rilevanza di questo problema è segnalata, nell’ambito del pensiero ebraico,
da un pensatore come Shmuel Trigano, in un saggio scritto nel 1996, in occasione di
un convegno svoltosi presso l'Università Sorbonne di Parigi in omaggio al filosofo
appena scomparso, intitolato Levinas et le projet de la philosophie-juive13. Trigano,
infatti, pur riconoscendo gli «ebraismi» della lingua e i «filosofemi ebraici» del pensiero levinassiano, critica quella che presume un’operazione di universalizzazione,
operata da Levinas, nel soggetto etico, del particolarismo dell’elezione e della responsabilità di Israele14:
«In Levinas, il gesto dell’elezione (nonostante la sua forte connotazione
giudaico-contemporanea – la Shoah, e non classica – d’ostaggio e di persecuzione) non è più quella del popolo dell’alleanza, ma quella di ogni uomo che
si trova così chiamato ed eletto perché è una creatura. “Ciascuno deve agire
come se fosse il Messia”»15.
Proprio tale processo di «universalizzazione della singolarità ebraica», si chiede Trigano, «non deriverà forse in definitiva dall’esperienza della Catastrofe? All’indomani della Shoah c’era come un obbligo di “mantenere nel perseguitato la sua essenza umana”»16. Trigano conclude dunque il suo saggio rilevando che «con Levinas
abbiamo senza dubbio… il grande pensiero filosofico del dopo- Shoah».
Tale giudizio, se da una parte colloca Levinas nel versante dei filosofi toutcourt, dall’altra, proprio rilevando il carattere di risposta universale a un evento sin13
AA.VV., Emmanuel Levinas, «Rue Descartes», (1aed. PUF, Paris 1998), PUF Quadrige, Paris
2006, pp. 141-164.
14
Ivi, p. 159.
15
DL, p.117.
16
AA.VV., Emmanuel Levinas, cit. p. 164.
18
golare-ebraico (dopo lo «shock della Shoah»17), contesta a Levinas di non rendere
conto specificamente del carattere di questa singolarità, tanto da suscitare la domanda se abbia ancora posto nel suo pensiero una nozione assiale della teologia biblicoebraica come quella di Berìt/Alleanza18. Lasciando in questa sede sospesa tale questione, che richiederebbe una ricognizione minuziosamente filologica delle fonti
ebraiche nel pensiero levinassiano, vogliamo invece notare come il fulcro della lettura di Trigano19 consista nel rilevare come il pensiero di Levinas si situi nella tonalità
emotiva di uno shock post-traumatico, e quindi come l’evento- Shoah – che per lui
significa l’avvento del Nazismo nel 1933, la guerra, la prigionia e la morte dei familiari – debba costituire il luogo ermeneutico principale per orientare la lettura
dell’opera.
La pertinenza della necessità di un’interpretazione dell’opera levinassiana alla
luce della Shoah rischierebbe d’altronde di essere qualcosa di estrinseco se non si
giustificasse, con rigore e pertinenza teoretica, quale Sitz im Leben fondamentale per
l’esegesi generale della sua opera.
Stéphane Mosès, allievo e amico di Levinas, e uno dei suoi interpreti più acuti,
parlando dei tempi della propria formazione in Francia, racconta:
«Il clima di quell’epoca [metà anni’50] era estremamente diverso da
quello di oggi. Per esempio c’era una rimozione assoluta della Shoah, sia da
parte ebraica sia da parte non ebraica. Io stesso ho scoperto la realtà della
Shoah solo più tardi. Nessuno ne parlava, forse non vi si pensava più!»20.
Abbiamo testimonianza di un analogo comportamento di Levinas, nei ricordi
delle persone a lui più vicine, gli amici e i figli. Nonostante egli dovesse portare il
duplice ricordo della prigionia, durata cinque anni, e dello sterminio dell’intera famiglia, come rileva Salomon Malka, «non ne parlerà mai. Solo qualche riga discreta in
17
Ivi, p. 161.
Cfr. Ivi, pp. 162-163.
19
La lettura di Trigano non a caso presuppone una differente scena del pensiero ebraico contemporaneo, che si misura più attentamente con lo Stato d’Israele e la sua storia recente, mentre Levinas manterrebbe a questo proposito un atteggiamento tipico dell’ebraismo della diaspora.
20
S. MOSÈS, Un retour au judaïsme. Entretiens avec Victor Malka, Edition du Seuil, Paris
2008; tr. it. di O. Di Grazia, Un ritorno all’ebraismo. Colloquio con Victor Malka, Claudiana, Torino
2009, p. 27.
18
19
dedica ad AE»21. Come se la Shoah fosse un evento che non poteva essere «predicato
ma solo sopportato»22.
Certamente Levinas non fu un teologo o un filosofo della Shoah, nel senso che
in lui l’evento sia stato fatto oggetto di tematizzazione esplicita. La nostra ipotesi è
che gli eventi traumatici legati alla Shoah ne costituiscano l’orizzonte, nel senso metodologico in cui Levinas interpreta la fenomenologia di Husserl:
«Il metodo consiste anche nello scoprire gli orizzonti insospettati in cui
si situa il reale appreso in questo modo dal pensiero rappresentativo, ma anche dalla vita concreta, antepredicativa […] Tendere la mano, voltare il capo,
parlare una lingua, essere la “sedimentazione” di una storia: tutto ciò condiziona trascendentalmente la contemplazione e il contemplato»23.
Se la contemplazione si traduce in un detto, il suo orizzonte insospettato riposa
in un non detto, o almeno in un non-esplicitamente-detto, che però condiziona trascendentalmente il dire e il modo del dire. Tale orizzonte insospettato, condizione
dell’esperienza e dell’espressione, è costituito a nostro avviso da un duplice trauma:
uno personale (l’esperienza della prigionia e del lutto familiare), e uno collettivo,
quello dell’ebraismo mondiale e dell’intera umanità. Vedremo successivamente in
che modo l’esasperazione linguistica di AE tradurrà quest’orizzonte insospettato, in
quella che Paul Ricoeur ha chiamato tropologia revulsiva24. Ma le radici di questa
tropologia – che analizzeremo in maniera dettagliata studiando il IV capitolo di AE
intitolato La sostituzione, che a detta dell’autore costituisce la parte centrale attorno
alla quale il libro si è andato sviluppando – si possono cogliere lungo l’itinerario biobibliografico levinassiano, sia a partire dalla ricostruzione indiretta, o diretta ma non
21
S. MALKA, Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, Jean-Claudie Lattes, Paris 2002; tr. it. di
C. Polledri, La vita e la traccia, Jaca Book, Milano 2003, p. 88.
22
Ivi, p. 90.
23
DL, p. 362.
24
Autrement. Lecture d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas, PUF,
Paris 1997; tr. it di I. Bertoletti, Altrimenti. Lettura di Altrimenti che essere o al di là dell’essenza di
Emmanuel Levinas, Morcelliana, Brescia 2007, p. 33.
20
coeva, sia a partire dall’esperienza sedimentata in alcuni testi contenuti nei Carnets
de captivité et autres inédites25.
2. Elaborazione e racconto postumi
Prima della pubblicazione di questi documenti, la nostra conoscenza del periodo della prigionia poteva valersi degli studi biografici di Marie-Anne Lescourret26 e
Salomon Malka27 oltre che delle testimonianze dello stesso Levinas, tra le quali ricordiamo soprattutto la lunga intervista a François Poirié28 e il suggestivo articolo Il
nome di un cane o il diritto naturale (1975), contenuto in DL29.
Il libro di Marie-Anne Lescourret sintetizza magistralmente i testi in cui Levinas riferisce della sua prigionia, mentre il libro di Salomon Malka scava più in profondità, ricostruendo il contesto storico con l’ausilio di interviste a compagni e testimoni di Levinas. Come ricorda l’autore, ricostruire gli anni della guerra di Emmanuel Levinas presenta un «doppio ostacolo: coloro che non hanno conosciuto l’esperienza del campo soffrono nel venirne a conoscenza, coloro che l’hanno conosciuta
soffrono nel parlarne. Tra i due, restano le testimonianze e la traccia, a volte invisibile o quasi, che non smette di ossessionare l’opera»30.
La prigionia di Levinas durò 5 anni, dal 18 giugno 1940 al 18 aprile del 1945.
Dapprima egli fu recluso nel Frontstalag 133 di Rennes (dal novembre 1940 al gennaio 1941), poi, fino all’aprile 1941, nel Frontstalag 132 di Laval; ritornò quindi a
Rennes fino al dicembre 1941, poi fino al marzo 1942 a Laval; di nuovo a Rennes
fino all’aprile 1942, poi nel Frontstalag 141 di Vesoul, fino al giugno 194231. Da
questa data in poi, fu trasferito in Germania e la prigionia si svolse nello Stalag XIB,
25
E. LEVINAS, Carnets de captivité suivi de Écrits sur la captivité et Notes philosophiques diverses (Œvres I), a c. di R. Calin e C. Chalier, Bernard Grasset/Imec, Paris 2009. D’ora in poi citato
CCAI.
26
Cfr. M.-A. LESCOURRET, Emmanuel Levinas, Flammarion, Paris 1994, pp.119-128.
27
Cfr. S. MALKA, op. cit., pp.75-91.
28
Cfr. F. POIRIÉ, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, La Manufacture, Lyon 1987, pp. 84-87.
29
DL, pp. 191- 194, l’articolo originale fu dapprima pubblicato in una raccolta dal titolo Celui
qui ne peut se servir des mots, Fata Morgana, Montpellier 1975.
30
S. MALKA, op. cit., p. 75.
31
Traiamo questi dettagli dalla Notice sur les Carnets de Captivité di RODOLPHE CALIN, cfr.
CCAI, p. 50.
21
presso Fallingsbotel, tra Brema e Hannover, dove erano detenuti circa trentaduemila
del milione e seicentomila soldati prigionieri della Wehrmacht dopo la sconfitta dell’esercito francese. L’aiutante-capo Emmanuel Levinas svolgeva il ruolo di interprete
di tedesco e russo nella 10a Armata, protetto quindi dall’uniforme francese, ma discriminato in quanto ebreo.
Nello Stalag c’era il campo centrale e i Kommandos, ripartiti in un raggio di
cinquanta chilometri. In uno di questi insieme ad altri ebrei, in un Kommando, un
campo forestale di 70 elementi, divisi in due baracche, Levinas lavorò come boscaiolo, dalle 6.30 alle 18.30 d’ogni giorno.
Malka riporta le testimonianze di altri prigionieri che raccontano della durezza
del lavoro quotidiana: «Duri, a volte sono molto duri i lavori nella foresta, soprattutto
quando si svolgono durante il grande freddo continentale tedesco…Risveglio brutale
alle 6.30 del mattino, adunata alle 7.30; distribuzione di asce e seghe; un’ora o due di
marcia nel buio dell’inverno per recarsi al cantiere […] abbattere, segare, tagliare gli
alberi per la lavorazione, le mani intirizzite nei guanti che bisogna rattoppare accuratamente la sera...»32.
La fatica del lavoro, il dolore del bisogno, sono queste esperienze che dovettero
ispirare le pagine del libro che Levinas redasse in gran parte proprio nello Stalag, e
che pubblicò dopo la guerra (1947), col titolo Dall’esistenza all’esistente33 [EE]. La
descrizione fenomenologica della fatica del lavoro34 sembra modellata sul duro sforzo del boscaiolo-forzato:
«L’intorpidimento della fatica è molto caratteristico. È un’impossibilità
di seguire, una sfasatura costante e crescente dell’essere rispetto a ciò che resta attaccato, come una mano che a poco a poco lascia ciò che tiene e a cui
tiene. Più che esserne una causa, il lavoro è questo allentamento stesso. […]
Una mano che tiene ciò che lascia anche quando lo ha abbandonato e resta
ancora una contrazione35. In effetti ci può essere soltanto nello sforzo e nel la32
S. MALKA, Op. cit, pp.79- 8.0
De l’existence à l’existant, Fontaine, Paris 1947; Vrin, Paris 1963, rist. 1990 ; tr. it. di F.
Sossi, Dall’esistenza all’esistente, Marietti 1820, Milano 20043.
34
Cfr. EE, pp. 23-24.
35
Esperienza che ha ben presente chiunque abbia lavorato tagliando legna, o anche semplicemente raccogliendola per ardere.
33
22
voro. […] questa sfasatura dell’essere rispetto a se stesso, che per noi è la caratteristica principale della fatica, e che costituisce l’avvento della coscienza…»36.
Lo sforzo della fatica non ha nulla di ludico (poiché il gioco implica la cessazione “festiva” della fatica), e nel lavoro non vi è gioia. La sua trasfigurazione in
«mistica del lavoro» è già «un innalzamento al di sopra dello sforzo propriamente
detto»37, da parte di chi osserva dal di fuori, o lo contempla esteticamente da lontano.
Esso ha una sua temporalità peculiare: «La durata dello sforzo è interamente fatta
d’arresti, ed è proprio questo il senso in cui lo sforzo segue passo passo l’opera che
compie. Nella durata esso assume l’istante, spezzando e riannodando il filo del tempo»38.
La dialettica della fatica, arretramento rispetto all’istante che si sta per assumere e già impegno nel presente, coincide con il presente stesso, «che è costituito dalla
presa in carico del presente»39. È dunque proprio attraverso la fatica del lavoro duro,
coatto e forzato, proprio di un prigioniero di guerra 40, che, dischiudendosi il presente, può spiccare l’apparizione di un soggetto alle prese con l’esistenza, che è in relazione ad essa e che l’assume.
Il ruolo centrale svolto dalla fatica del lavoro nella costituzione dell’ipostasi
che esce dalla corrente anonima dell’il y a, emerge ancora più chiaramente nelle conferenze tenute nel 1946/7 – contemporaneamente all’uscita di EE, presso il Collège
Philosophique fondato da Jean Wahl, lezioni che prenderanno il titolo di Il Tempo e
l’Altro [TA]41– che articolano talora diversamente il materiale redatto durante la prigionia. Leggiamo infatti :
36
EE, p. 24.
Ivi, p. 26.
38
Ivi, p. 27.
39
Ivi, p. 27.
40
«Lo sforzo quindi condanna…ed è condanna in quanto assume pienamente l’istante e in
quanto nell’istante si scontra con la serietà dell’eternità» (Ibidem).
41
Le temps et l’autre, in J. WAHL ET AL., Le Choix, Le monde, L’Existence («Cahier du Collège
Philosophique»), B. Artaud, Paris-Grenoble 1948, 125-196 ; 2a Ed. Fata Morgana, Montpellier 1979;
3a Ed., PUF, Paris 1983; tr. it. a c. di F.P. Ciglia, Il tempo e l’altro, il melangolo, Genova 1987.
37
23
«Nella pena, nel dolore, nella sofferenza, ritroviamo, allo stato puro,
l’irrevocabilità [le definitif42] che costituisce la tragedia della solitudine […].
Due punti devono essere sottolineati: è sul dolore del bisogno e del lavoro, e
non sull’angoscia del nulla, che si baserà la prosecuzione della nostra analisi
della solitudine»43.
Interessante notare la distanza con l’analisi heideggeriana, da un duplice punto
di vista: innanzitutto perché Heidegger coglie nell’angoscia la tonalità emotiva fondamentale che singolarizza il Dasein e lo apre al poter essere più proprio, attraverso
l’assunzione della propria possibilità di poter essere un tutto. Levinas, invece, coglie
la nascita dell’ipostasi nel lavoro e nella fatica, dunque in una quotidianità priva di
ogni autenticità e distacco. Secondariamente perché Heidegger, malgrado il tentativo
di ermeneutica esistenziale, parla e scrive sempre come colui che si pone e in alto e
al fuori dalla condizione che contempla, non partecipa al lavoro di cui parla. Levinas,
invece, sta testimoniando ciò che ha patito su di sé, sulla sua pelle e sulle sue mani,
quella condizione di quasi-schiavitù, di passività radicale in cui non si può più potere
né assumere la propria morte, che proprio in quella situazione si annuncia: «Questo
modo caratteristico della morte di annunciarsi nella sofferenza, è un’esperienza della
passività del soggetto44. [….] Nella sofferenza c’è questo rovesciamento dell’attività
del soggetto in passività»45.
A conferma di quanto stiamo dicendo, potremmo citare quanto si legge in un
appunto delle Notes philosophiques diverses, precisamente in quello che i curatori
notano come il Frammento 206: «Ciò in cui io differisco da Heidegger: Non si tratta
di uscire dalla Alltäglichkeit verso l’esperienza autentica, ma di seguire l’uomo della
Alltäglichkeit nella sua <pena?> <stessa?>»46. Il tema della quotidianità, e in essa
della sofferenza, della fatica, del lavoro è dunque oggetto di uno scavo che non accetta il sorvolo di uno sguardo panoramico e disinteressato.
La posizione strategica della fenomenologia della fatica del lavoro nella costituzione dell’esistente e nella sua fuoriuscita dall’anonimità dell’il y a è dunque
42
43
44
45
46
Le temps et l'autre, PUF, Paris 1983, p. 55.
TA, p. 40-41, cn.
TA, p. 42.
Ivi, p. 43.
CCAI, p. 328-329.
24
un’implicita testimonianza biografica, poiché Levinas descrive fenomenologicamente ciò di cui ha fatto esperienza, nei suoi lavori direttamente filosofici degli anni tra il
1940 e il 1945.
Tuttavia l’impressione che si ha leggendo i testi più direttamente autobiografici
è che quando ricostruisce la sua esperienza egli tenda pudicamente a minimizzare
l’aspetto del lavoro e della fatica, e anche complessivamente del trauma dell’internamento, presentando una condizione quasi idealizzata del periodo della propria cattività:
«Non era un periodo di torture. Si andava al lavoro nella foresta, si passava le giornate nella foresta. Sostenuti materialmente dai pacchi, moralmente
dalle lettere, come tutti i prigionieri francesi. Vita alla quale si strappava del
tempo libero per la lettura. Contatti fraterni tra ambienti sociali e culturali assai
differenti. Arrivavano libri, non si sa da dove. Gente abituata ai mestieri manuali leggeva Anatole France e Proust. E questa maniera di coltivarsi e di parlare di letture a lavoro era molto bella…»47.
Quasi una condizione monastica o da “ritiro spirituale”, si direbbe, nel quale il
prigioniero aveva tempo libero (loisirs) per leggere: «Hegel, beninteso. Ma anche
molti testi filosofici di ogni provenienza. Cose che non avevo tempo di leggere in altri tempi: Proust più che mai, ma anche gli autori del XVIII secolo, Diderot, Rousseau e poi gli autori che non sono in alcun programma»48. Viene in mente
l’immagine delle yeshivòt dell’Europa precedente alla Seconda guerra mondiale, e
probabilmente nella elaborazione dell’esperienza levinassiana questo orizzonte o filtro interpretativo dovette essere presente49, a rimarcare il senso del valore dello studio al fine della sopravvivenza50: «questa relativa immunità di prigionieri di guerra
47
F. POIRIÉ, op. cit. p 85.
Ivi, p. 86.
49
Marc-Alain Ouaknin ricostruisce in tratti brevi e suggestivi l’ambiente tipico di questi luoghi
di studio, vere e proprie accademie talmudiche, presenti in Polonia, Russia Marocco, senza grandi
distinzioni tra loro. «Può esserci un giovane di vent’anni e un uomo di quaranta. Il sapere qui non ha
età…» (Cfr. M.-A. OUAKNIN, Invitation au Talmud, Flammarion, Paris 2001; tr. it. di R. Salvatori,
Invito al Talmud, Bollati Boringhieri, Genova 2009 [pp.19-28] p. 20).
50
«Lo studio! Una questione di vita o di morte! E adesso ascoltate, ascoltate questa parola!»
(ivi, p.23).
48
25
…creava un universo equilibrato: poca gente molto colta, ma tutti leggevano, tutti
ponevano delle domande»51.
Tuttavia è indubbio che, malgrado il filtro di una configurazione retrospettiva
dell’esperienza volta a rimuovere i tratti traumatici, i documenti che possediamo, raccolti in CCAI, testimoniano della possibilità, per il prigioniero, di ore sottratte al lavoro (ore serali e notturne, presumibilmente) in cui leggere, scrivere meditare e finanche scrivere, l’abbozzo di due romanzi (La Dame de chez Wepler ed Eros52) e di
un saggio di filosofia. Ma questo lo vedremo dettagliatamente nel paragrafo successivo.
C’è però una prima significativa eccezione, in questa rievocazione quasi idilliaca, nel breve articolo intitolato Il nome di un cane o il diritto naturale53. Questo testo, pubblicato in origine in una raccolta dal titolo Celui qui ne peut se servir des
mots in onore del pittore Bram Van Velde, descrive l’esperienza di riconoscimento
dell’umanità dei prigionieri ebrei - «internati nel campo forestale che aveva numero
1492, come l’anno dell’espulsione degli ebrei spagnoli sotto Ferdinando V il cattolico54» -, da parte di un cane randagio, Bobby. A differenza degli uomini «cosiddetti
liberi…, che incrociavamo e che ci facevano lavorare o ci davano degli ordini o magari un sorriso [… e] ci spogliavano della nostra pelle umana»55, il cane, «l’ultimo
kantiano della Germania nazista»56, riconosce l’umanità dei prigionieri.
L’alienazione a cui riduce lo sguardo dell’altro (in questo caso i contadini tedeschi), ricorda molto da vicino l’episodio raccontato da Primo Levi in Se questo è un
uomo, relativo all’esame di chimica da lui subito da parte del Doktor Pannwitz, quando lo Häftling 174 517 si sentì osservato come un essere non appartenente alla stessa
specie umana:
«[…] quello sguardo non corse fra due uomini; e se io sapessi spiegare
a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di
51
52
53
54
55
56
Ivi, p. 20.
R. CALIN e C. CHALIER, «Préface», CCAI, p. 14.
DL, 191-194.
DL, p. 193.
Ivi, p. 193.
Ivi, p. 194.
26
vetro di un acquario tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l’essenza della grande follia della terza Germania»57.
Lo sguardo oggettivante, in cui, come direbbe Sartre, «io mi vivo come fissato
in mezzo al mondo, come in pericolo, come irrimediabile»58, aliena il prigioniero
dalla sua umanità, costituendolo come un essere senza difesa, al servizio schiavistico
di «una libertà che non è la propria libertà»59, in cui si concreta la macchina infernale
dell’industria concentrazionaria nazionalsocialista.
L’animale invece riconosce in un prigioniero l’umanità e, a differenza del cane
di Ulisse, qui non avviene il riconoscimento di un padrone che torna a casa, ma l' epifania del volto in uno schiavo in esilio60, in un esule in un nessun-dove che ricorda
quello degli ebrei in Esodo («Il suo amicale abbaiare […] era nato nel silenzio dei
guaiti lungo le rive del Nilo»61), il cui spaesamento e affaticamento abbrutente è solo
parzialmente mitigato dal sentimento interiore residuo della propria dignità di uomini: «Un piccolo mormorio interiore – forza e miseria dei perseguitati – ci ricordava la
nostra essenza di esseri dotati di ragione»62.
Il cane non ri-conosce, propriamente parlando, se tale ri-conoscimento si deve
qualificare come identificazione inglobante e riduzione all’immanenza dell’ego: il
cane non ha cogito. Tuttavia, attraverso il suo abbaiare festante, è «capace di trascen-
57
P. LEVI, Opere, Vol. I, Einaudi, Torino 1987, p. 109.
J.-P. SARTRE, L’être et le neant, Gallimard, Paris 1943; tr. it. di G. Del Bo, rev. di F. Fergnani e M. Lazzari, NET, Milano 2002, p. 315.
59
Ivi, p. 314.
60
«Ci sarebbe molto da dire su questa allusione all’Egitto che Levinas oppone alla Grecia,
all’Odissea e a Itaca, dove il cane che riconobbe Ulisse lo fece nel luogo del ritorno e della nostalgia,
verso una patria, mentre il kantiano lanciava il suo “abbaiare amico” nel deserto. “Qui si tratta di nessun dove”» (J. DERRIDA, L’animal que donc je suis, Galilée, Paris 2006; tr. it. di M. Zannini,
L’animale che dunque sono, Jaca Book, Milano 2006, p. 167).
61
DL, p. 194.
62
DL, p. 193.
58
27
denza»63, pur essendo privo di logos e forse64 anche di volto, e quindi, ossimoricamente, «kantiano» ma «senza la capacità di universalizzare le sue massime»65.
L’articolo di Levinas non ci interessa qui dal punto di vista della questione se
l’animale abbia o non abbia un volto – analisi che è stata del resto magistralmente discussa da Jacques Derrida66– ma per l’accenno alla disumanizzazione dei prigionieri.
Sembra quasi che la paradossalità del riconoscimento da parte del cane riveli, più che
il «transfert agli animali dell’idea di sofferenza»67 (col quale, attraverso una «trasposizione analogica», noi diventiamo sensibili alla sofferenza animale68), una «proiezione attiva o immedesimazione»69 di uno stato d’animo interno in un oggetto esterno – un cane randagio, che oggi c’è e domani d’improvviso scomparirà – che permette di prendere in qualche modo coscienza della propria condizione di dis-umanità:
«Nella Germania nazista eravamo in settanta in un campo forestale per prigionieri di
guerra israeliti. […] Eravamo soltanto quasi uomini, un gruppo di scimmie… (une
bande de singes)»70.
Il testo levinassiano continua descrivendo l’essenza di questa disumanizzazione, nell’impossibilità di vivere una vita veramente umana, nell’essere senza linguaggio, fuori dal mondo:
63
J. DERRIDA, op. cit. p. 170.
Interrogato circa la questione se l’animale abbia un volto, Levinas rispondeva, a Cerisy La
Salle nel 1986: «Non posso dire in che momento voi avete il diritto di essere chiamati volto. Il volto
umano è assolutamente differente , ed è solo dopo che noi scopriamo il volto dell’animale. […] è necessaria un’analisi più specifica.» (J. Derrida, Op. Cit., p. 159). L’analisi di Derrida, tentata magistralmente in questo libro, perviene alla risposta che «mai che io sappia Levinas evoca lo sguardo
dell’animot come sguardo di un volto nudo e invulnerabile» (ivi, p. 158).
65
«[…] troppo “altro” per essere nostro fratello» (J. DERRIDA, op. cit., p. 171). Derrida contesta la visione ancora specista del primato dell’umano sull’animale, per cui Levinas identifica ancora
l’animale nella linea della tradizione cartesiana, «come una macchina che non parla, che non ha accesso al senso, che tutt’al più può imitare dei significanti senza significato, “una specie di scimmia” dal
“parlare scimmiesco”, appunto ciò cui i nazisti avrebbero voluto ridurre i prigionieri ebrei» (ivi, p
171). Questa lettura è supportata, significativamente, dall’analisi della costruzione grammaticale e
sintattica del testo levinassiano, in cui la retorica dei punti esclamativi, e della reiterazione (ben 11
volte appare il «no!») sembra connotare una continua «denegazione» (cfr. ivi, p. 168). Il merito e il
metodo della lettura derridiana ci paiono persuasivi, e ci hanno ispirato lungo la stesura di questo lavoro.
66
J. DERRIDA, op. cit., pp. 158-171.
67
Come scrive Derrida, Levinas «insiste sul carattere originario, paradigmatico, “prototipico”
dell’etica in quanto umana, […] soltanto dopo con una trasposizione analogica, noi diventiamo sensibili alla sofferenza animale» (Ivi p. 160).
68
Ibidem.
69
Interpretata in senso junghiano; Cfr. voce «Proiezione», in U. GALIMBERTI, Dizionario di
Psicologia, Utet, Torino 20062, p. 699.
70
DL, p. 193.
64
28
«Ma non eravamo più nel mondo. Il nostro andare e venire, le nostre
pene e le nostre risa, le malattie e le distrazioni, il lavoro nelle mani e l’angoscia negli occhi, le lettere che arrivavano dalla Francia e quelle inviate alle famiglie, tutto accadeva tra parentesi. Esseri paralizzati nella loro specie. Esseri
senza linguaggio, nonostante le parole. Il razzismo non è un concetto biologico; l’antisemitismo è l’archetipo di ogni internamento. L’oppressione sociale
stessa non fa che imitare questo modello: reclude in una classe, priva dell’espressione, condanna ai “significanti senza significato”, e dunque alle violenze e alle lotte»71.
L’antisemitismo come archetipo di ogni internamento definisce qui, ben prima
di un semplice episodio di violenza storica, l’essenza o struttura stessa di una società
violenta, ingiusta, classista e fondata sullo sfruttamento, i cui membri sono consegnati all’incomunicabilità e all’animalità, ridotti a essere una «banda di scimmie» senza
un vero linguaggio significante; senza discorso, quindi senza possibile etica.
Il mutismo, il senso di precarietà72 e l’antagonismo «allergico» di egoismi –
che in Altrimenti che essere diventerà la cifra stessa dell’essere o essenza come
«estremo sincronismo della guerra»73– vengono descritti in questo testo attraverso il
filtro dell’orizzonte fenomenologico concreto del campo di internamento. Questa pagina ricorda da vicino quelle di Primo Levi in Se questo è un uomo, in cui lo scrittore
torinese analizza, quasi come un «etnologo nel lager»74, la vita del microcosmo concentrazionario:
«Si rinchiudano tra fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di
vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che
71
Ibidem, ccnn.
«È paradossale, tutto era provvisorio in qualche modo, ci si chiedeva a cosa ciò servisse e se se
ne sarebbe usciti fuori», F. POIRIÉ, op. cit., p. 86
73
AE, p. 7.
74
L’aggettivo è di Stefano Levi della Torre (S. LEVI DELLA TORRE, «Primo Levi etnologo», in
Zone di turbolenza. Intrecci, somiglianze, conflitti. Feltrinelli, Milano 2003, pp. 142-151).
72
29
cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell’animale uomo
di fronte alla lotta per la vita»75.
Se la fenomenologia è per Levinas «la restituzione delle nozioni all’orizzonte
del loro apparire, orizzonte misconosciuto, dimenticato o spostato nell’ostensione
dell’oggetto, nella sua nozione, nello sguardo assorbito della sola nozione»76, è evidente che la descrizione fenomenologica della vita nel campo, delineata nel testo del
cane Bobby attraverso poche pennellate, definisca sia l’essenza dell’oppressione sociale sia la nozione dell’essere come guerra che emergerà in AE.
Il contesto della prigionia rappresenta, a nostro avviso, quello che Levinas
chiama, in un’intervista a Laura Ghidini, «l’indicazione della messa in scena delle
idee con le quali lavoriamo»77, messa in scena che è «figura in cui le astrazioni [sc.
quelle idee] si concretizzano»78.
Il passo che abbiamo qui analizzato costituisce evidentemente una rilettura della prigionia molto più aspra e drammatica di quanto accada invece nella ricostruzione
consegnata all’intervista con François Poirè, dove, come abbiamo già visto, viene
molto enfatizzata la relativa possibilità di una vita quasi normale, (la fatica massacrante e le umiliazioni vengono però presagite tra le righe e nei dettagli del testo79),
in cui si poteva studiare – sia letteratura e filosofia sia il Talmud80–, pregare81, estraniarsi per scrivere82, resistere83, ascoltare alla radio i bollettini di guerra, oltre che le
75
P. LEVI, Se questo è un uomo, in Opere I, cit., p. 88.
AE, p. 226. In seguito Levinas dirà anche: «Bisogna sempre risalire all’intero orizzonte dei
pensieri e delle intenzioni che mirano all’oggettività, ma che sono da essa offuscati e fatti dimenticare.
La fenomenologia è il richiamo a questi pensieri, a queste intenzioni scordate; piena coscienza, ritorno
alle intenzioni sottintese – fraintese – del pensiero che è al mondo» (EI, p. 56).
77
L. GHIDINI, Dialogo con Emmanuel Lévinas, Morcelliana, Brescia 1987, p. 91.
78
«Le dirò in due parole ciò che intendo per fenomenologia: per me è la ricerca della figura
nella quale le astrazioni si concretizzano. È una formula un po’ stupida. Come se tutte le idee con le
quali lavoriamo non avessero l’indicazione della loro messa in scena..come a teatro. Quando si legge
un’opera teatrale, essa è astratta; diventa concreta quando qualcuno le dice che lì c’è un divano, che
non avete visto, lì c’è un telefono…» (ibidem).
79
Cfr. S. MALKA, op. cit., p. 85.
80
Ibidem.
81
«Spesso preghiere ardenti salivano dal Kommando, verso il Dio d’Israele. […] ma soprattutto
ricordo con emozione tutte quelle feste che, come puntini luminosi, rischiaravano la notte della nostra
prigionia», racconta il rabbino Ernest Gugenheim, compagno di prigionia di Levinas, nell’autunno del
1945 (S. MALKA, op. cit., p 84).
82
«Léon Jakubovitz aveva quasi novanta anni quando l’ho incontrato. [...] Egli ricorda che Levinas aveva un piccolo quaderno dove scribacchiava di tanto in tanto. Che a volta leggeva loro dei
testi dei quali non capivano un granché. Che era un po’ chiuso e stava un po’ in disparte» (ivi, pp. 8788, ccnn).
76
30
vaghe notizie di quanto avveniva altrove; a soli cinquanta chilometri da Fallingsbotel
vi era il campo di Bergen-Belsen, più lontani erano i campi in Polonia:
«FP - Non arrivava alcun rumore fino a voi, dei campi di sterminio?
EL - Non subito, ma un poco più tardi sì, alla fine qualcosa è filtrato, pur lentamente. Ma tutto quel che i nostri famigliari avevano vissuto non era conosciuto. Tutti gli orrori dei campi erano inimmaginabili»84.
Salomon Malka riporta alcune testimonianze di altri internati, che confermano
questa consapevolezza dell’esistenza dei campi di sterminio85. Ovviamente, l’idea di
ciò che realmente potesse accadere era inadeguata: inimmaginabile l’esatta portata
della catastrofe. Tuttavia essa fu chiara ben presto a Levinas, appena egli fu tornato
in Francia, e a cominciare dalla sorte della propria famiglia. Ma prima trattare il modo in cui Levinas si misuri con il trauma dello sterminio, è opportuno ripercorrere i
testi contemporanei all’esperienza di prigionia, presenti nei Carnets e negli altri inediti.
83
Ivi, p. 81.
F. POIRÉ, op. cit., p 86.
85
«Jacques Laurent è categorico: “sapevamo dell’esistenza dei forni crematori. Il vitto era unto
e circolavano delle battute di cattivo gusto sulla possibile origine di questo grasso”» (S. MALKA, op.
cit., p. 83).
84
31
3. L’esperienza del prigioniero nei Carnets
Pour nous les événements c’est
vraiment la base – de la vie.
C’est notre vie interieure.
(CCAI, p. 108)
Nel 2009 è iniziata la pubblicazione delle Opere complete di Emmanuel Levinas, attraverso l’apparizione del primo volume dal titolo Carnets de captivité et autres inédites86 [CCAI]. Questo volume raccoglie taccuini di appunti e testi inediti anteriori o contemporanei di Totalità e infinito [TI].
Il volume in oggetto è composto di tre sezioni: I) Carnets de captivité propriamente detti (1940/45, pp. 49-198); II) Écrits sur la captivité et Hommage à Bergson
1945/6, pp. 199-219); III) Notes philosophiques diverses, (il cui arco temporale di
composizione si estende presumibilmente87 dal periodo immediatamente successivo
alla liberazione sino ai primi anni ’60, pp. 221-478). Completa il volume un capitolo
di Note (IV, pp. 479-499).
I Carnets de captivité costituiscono per noi un documento prezioso, perché ci
permettono di cogliere in statu nascendi, e quasi in contemporanea con gli eventi vissuti, il modo in cui avviene l’elaborazione dell’esperienza personale. I sette quaderni
(nell’originale manoscritto, di piccolo formato88) che compongono questa prima sezione (molto probabilmente con l’eccezione del primo risalente al 193789), comprendono infatti spunti e pensieri filosofici, materiali preparatori per due romanzi, citazioni letterarie e poesie, annotazioni critiche, citazioni bibliche e talmudiche spesso in
86
E. LEVINAS, Carnets de captivité suivi de Écrits sur la captivité et Notes philosophiques diverses (Œvres I), a c. di R. Calin e C. Chalier, Bernard Grasset/Imec, Paris 2009.
87
Cfr. «Notices sur les Notes Philosophiques diverses», a c. di R. CALIN, in CCAI, pp. 24-26.
88
«Più ragioni spiegano la scelta di quaderni di piccolo formato come supporto di scrittura. La
penuria di carta, poi la necessità di sfuggire alle perquisizioni; infine, la possibilità, così offerta, di
portare con sé questi quaderni e di scrivere ovunque. Le condizioni di scrittura poco favorevoli, nelle
quali Levinas venne a trovarsi, spiegano senza dubbio come la grafia assai ben leggibile del filosofo
diventi talora quasi illeggibile» (ivi, p. 49).
89
Cfr. Ivi, p. 51, nota.
32
ebraico, ma anche elenchi di indirizzi, memoranda, liste di libri. I curatori di questo
volume, Rodolphe Calin e Caterine Chalier, non hanno incluso in questa raccolta i
manoscritti veri e propri di EE, ma vi sono tuttavia presenti tracce di pensieri preparatori a quest’opera.
La seconda sezione del volume comprende tre documenti: 1. Captivitè (pp.
201-203, copia dattiloscritta di cui ignoriamo sia la destinazione sia la data di stesura,
ma ragionevolmente contemporanea degli altri due testi)90; 2) La spiritualité chez le
prisonier Israélite (pp. 205-8, copia dattiloscritta, già apparsa, in forma tronca, nel
Magazine de France91); L’expérience juive du prisonier (pp. 209-215, testo di una
trasmissione radiofonica92); Hommage à Bergson (pp. 217-219, testo dattiloscritto
inedito).
La terza sezione, Notes philosophique diverses, comprende quaderni e fogli
sciolti, raccolti in fascicoli e cartelle, nei quali l’autore ha appuntato pensieri, schemi,
idee, citazioni, che avrebbero costituito materiale per le sue opere. Nonostante la datazione sia difficile da stabilire, i curatori hanno individuato come arco temporale di
questo materiale il periodo antecedente, o di poco successivo, alla pubblicazione di
TI.
Per il nostro studio, riteniamo opportuno soffermarci inizialmente sulle prime
due sezioni, cercando di cogliere i tratti originari che descrivono l’esperienza della
prigionia e la sua interpretazione filosofica. È tuttavia un peccato, per una migliore
ricostruzione biografica, che ci manchino le contemporanee lettere di Levinas alla
moglie, ancora inedite93.
Nel Préface94 ai Carnets i curatori rilevano che gli scritti della prigionia contengono materiali di un triplice ambito: filosofico, letterario e critico95. Malgrado la
diversità di generi, tutti i contenuti riguarderebbero un medesimo oggetto, la prigionia stessa96. Secondo i curatori, Levinas avrebbe progettato due romanzi, iniziati in
prigionia (di cui si trovano tracce negli inediti, sino al periodo della pubblicazione di
90
Ivi, p. 201.
Ivi, p. 205.
92
Di cui non è possibile ricostruire dettagliatamente l’emittente. Per il dettaglio, cfr.: CCAI p.
209, nota a.
93
Così ci segnala Rodolphe Calin, (R. CALIN, «Notice sur les carnets de captivité», CCAI p.
50).
94
CCAI, p. 13-40.
95
Ivi, p. 131, rif. p. 74.
96
Ibidem: «Ciò che dona unità a questi taccuini è la prigionia stessa».
91
33
TI): La Dame de Chez Wepler, e un altro originariamente chiamato Triste opulence,
romanzo ebraico di prigionia97,(ma che potrebbe poi essere stato intitolato Eros98), il
cui tema sarebbe proprio la sconfitta bellica e la prigionia. In questo romanzo si narrerebbe, infatti, della vicenda di un’interprete, alter ego dell’autore, che, partito per la
guerra, viene fatto prigioniero dapprima in Francia, poi in Germania, per ritornare
infine in patria dopo cinque anni di prigionia.
Calin e Chalier ritengono «sorprendente e inquietante che delle persone reali
con le quali Levinas abbia condiviso la prigionia e le scene di vita in prigionia siano
qui, nello stesso tempo, personaggi e situazioni di un romanzo sulla prigionia. Che la
dura realtà della prigionia vi sia fin dall’inizio tenuta a distanza per diventare quella
di un romanzo. Ma questa derealizazzione non ha nulla di accidentale…»99.
A nostro avviso, tuttavia, i due curatori non approfondiscono ulteriormente il
motivo per cui Levinas compia tale trasfigurazione romanzata dell' esperienza personale, ma si limitano a segnalare soltanto come in questi testi emergano elementi che
confluiranno nella sua successiva speculazione. A noi sembra che una possibile spiegazione di quest’atteggiamento di Levinas possa rinvenirsi nella necessità di elaborare, tenere a distanza e padroneggiare la propria esperienza traumatica: guerra,
sconfitta della Francia, imprigionamento, lavoro forzato, ansia per il destino della
moglie e della figlia, e per quello dei parenti rimasti in Lituania; preoccupazione per
la sorte della guerra, voci ricorrenti di massacri collettivi che si compivano sugli
ebrei, etc.
I frammenti contenuti nei Carnets non hanno dunque la caratteristica di “diari
di prigionia”, perché gli appunti in prima persona della vita quotidiana del prigioniero sono davvero sporadici rispetto a quelli di genere letterario o filosofico, e «quando
sono evocati episodi di situazioni vissute, lo sono spesso in maniera molto epurata»100, diremmo fenomenologicamente stilizzata, quasi che il pensatore vi assumesse
una posizione di distacco emotivo101 o isolamento dell’affetto102, in cui cioè la di-
97
CCAI, pp. 13-14.
Ivi, nota, p. 15.
99
CCAI, p. 16, ccnn.
100
Ibidem.
101
Cfr. B. BETTELHEIM, The Informed Heart. Autonomy in a Mass Age, The Free Press, a Corporation; tr. it. di P. Bertolucci, Il cuore vigile. Autonomia individuale e società di massa, Adelphi,
Milano 1988, p. 221-226. In senso analogo spesso Betthelheim ricorre al termine scissione.
98
34
mensione affettiva di quell’esperienza o di quei vissuti venisse scissa dalla loro dimensione cognitiva. Bruno Bettelheim, che visse un’esperienza di internamento in un
campo di concentramento nazista, afferma in Sopravvivere103 come l’isolamento
dell’affetto costituisca per i prigionieri una difesa psicodinamica privilegiata, che
consente loro di salvaguardare la propria integrità psicologica personale:
«Questo senso di distacco, questo negare la realtà della situazione in cui i
prigionieri si trovavano, potrebbe essere considerato un meccanismo di sicurezza volto a salvaguardare l’identità della loro personalità. Molti prigionieri si
comportavano come se la vita del campo di concentramento non avesse alcuna
relazione con la loro vera vita...»104.
Possiamo tuttavia trovare nei Carnets de captivité delle eccezioni a questa regola, passi cioè dove emerge il carattere più prettamente diaristico, e in cui Levinas i
si esprime in prima persona, come nel seguente frammento quasi programmatico dal
punto di vista filosofico:
«In Jankélévitch il fatto dell’il y a appare unicamente come il peso
dell’esistenza per la persona – come la noia. Quello che è importante per me,
[chez moi] è il piano stesso dell’il y a. Cioè non l’inesplicabilità dell’esistenza
– (la Geworfenheit) – ma l’impossibilità di morire»105.
Abbiamo anche note di carattere più quotidiano, che indubbiamente potevano
anche servire per una trasposizione narrativa, oppure spunti e riflessioni relative alla
vita in prigionia che costituiranno oggetto, come vedremo successivamente, di ulte-
102
«Un modo in cui le persone possono gestire l’angoscia e altri stati mentali dolorosi consiste
nell’isolare il sentimento dalla conoscenza. Più tecnicamente, l’aspetto affettivo di un’esperienza o di
un’idea viene separato dalla sua dimensione cognitiva» (N. MCWILLIAMS, Psychoanalytic diagnosis.
Under standing personality structure in the clinical process, The Guilford Press – New York, London
1994, tr. it. di G. Baldaccini e L. Riommi Baldaccini, a c. di L. Sarno e V. Caretti, La diagnosi psiconalitica. Struttura della personalità e processo clinico, Astrolabio, Roma 1999, p. 143).
103
B. BETTELHEIM, Surviving and Other Essays, tr. it. di A. Bottini, Sopravvivere e altri saggi,
SE, Milano 2005.
104
Ivi, p. 79.
105
CCAI, p. 68.
35
riore elaborazione: «Aspetto dei prigionieri in Germania. Vita monacale o morale.
Anche i vecchi hanno qualcosa d’innocente e puro»106.
La note riportano talora dettagli della vita del campo, la condivisione del pasto con un compagno quasi costretta ad un esposizione pubblica di una intimità:
«Kommando – l’intimità abietta che creano le razioni a due [les dînettes]: “tu mangi questo, quest’altro si conserva per domani” etc. Come un’intimità sessuale vista dal di fuori. Disgusto, <atteggiamento> piccolo borghese,
egoismo, etc. etc.»107.
Ma il pasto può diventare anche meditazione filosofica sulla ricostituzione del
senso: «Il “serio” del mangiare la realtà, la spaventosa realtà che si ricuce»108.
Talvolta emerge chiaro il desiderio di un’accurata attenzione, di un vigile stare all’erta, fin nei più minuti dettagli quotidiani: «Il fatto di mettere la propria vita in storia:
tenere dei piccoli quaderni dove si menzionano dei “menù”, segnare il numero dei
chilometri fatti; si giungerebbe a fare le statistiche di tutto: tanti biscotti mangiati,
etc. etc.»109
L’espressione della propria tonalità emotiva può prendere spunto dalla meditazione di un evento storico, quasi a connotare una parentela di condizione esistenziale:
«Il terrore compreso nella sua disumanità. Maria Antonietta separata dai
suoi figlioletti che attende il patibolo – non c’è più ragione superiore, storica
o d’altro genere – che giustifichi questo. Non in nome di una pietà superiore
106
Ivi, p. 70.
Ivi, p. 72
108
Ibidem.
109
Ivi, p. 74. Questo passo ci ricorda l’incipit del romanzo di Sartre, La nausea: «La miglior
cosa sarebbe scrivere gli avvenimenti giorno per giorno. Tenere un diario per vederci chiaro. Non lasciar sfuggire le sfumature, i piccoli fatti anche se non sembrano avere alcuna importanza, e soprattutto classificarli. Bisogna dire come io vedo questa tavola, la via, le persone, il mio pacchetto di tabacco, poiché è questo che è cambiato…» (J.P. SARTRE, La nausée, Gallimard, Paris 1938; tr. it. di B.
Fonzi, La nausea, Einaudi, Torino 1947, p. 11). Levinas aveva letto questo libro prima della prigionia? Dai Carnets non c’è dato saperlo.
107
36
e universale, ma in nome della mia sofferenza personale io <lo> comprendo.
Niente giustifica il terrore»110.
Qui ci pare emergano chiaramente due dati emotivi di natura traumatica: la separazione dai propri cari (nel caso di Levinas, dalla moglie e dalla figlia) e l’attesa
incombente della morte. Del resto, poco dopo, nello stesso quaderno troviamo una
confessione personale quasi esplicita: «Credo che si prepari un grande avvenimento,
che la mia vita stia per cambiare; ascolto come in un vuoto indeterminato [j’écoute
dans le vague], ho lo sguardo perso nell’oscurità, non trovo più piacere nei i miei lavori».111 La frase j’écoute dans le vague rende l’idea di un orecchio teso ad ascoltare
qualcosa di indistinguibile, il brusio di fondo che si ode nel silenzio di una notte del
campo. Levinas descriverà in seguito questo concetto attraverso l’immagine di ciò
che si sente «quando si avvicina l’orecchio ad una conchiglia vuota»112.
Significativamente, i curatori ci dicono che questo passo, tratto dal secondo
quaderno, nell’originale manoscritto è barrato con una croce; barratura che forse
esprime il pudore da parte del filosofo di rivelare a se stesso questa condizione di
precarietà, di angoscioso timore per un’imminente catastrofe («un grande avvenimento»).
Sarà lo stesso filosofo a confessare a François Poirié, in sede di racconto rievocativo, il senso di imminente catastrofe e precarietà vissuta dai prigionieri ebrei,
quasi come se si attendesse da un momento all’altro un possibile esito esiziale: «è paradossale, tutto era in qualche modo provvisorio. Ci si domandava da un momento
all’altro se servisse a qualcosa, e se se ne sarebbe usciti»113.
Ma la notazione che trasmette la tonalità emotiva di ansia estrema e connota il
senso di una ferita (etimologicamente: trauma) difficilmente riparabile nella vita del
filosofo è la seguente: «Questo risuonerà per sempre nella mia vita: la disperazione
della nonna separata da Simone, da R<aissa>. Niente arriverà a cancellarlo. Come
una scheggia nella mia carne ormai»114.
110
111
112
113
114
Ibidem, ccnn.
Ivi, p. 75.
EI, p. 66.
F. POIRIÉ, Op. Cit., p. 84.
CCAI, p. 99.
37
I curatori dei Carnets segnalano la circostanza a cui si allude. Levinas evoca
qui l’arresto della suocera Malka Frida Lewy, che sarà in seguito deportata. Simone
(nata nel 1935), figlia di Emmanuel e Raissa, era allora nascosta presso le suore di
san Vincenzo de Paoli, e sarebbe stata raggiunta poco tempo dopo dalla madre. Le
due donne vi sarebbero restate sino alla Liberazione115.
È evidente che la scena dello strappo di una nonna alla nipotina, aggiunto dal
senso di ansia per la sorte della moglie e della figlia costituisca, coscientemente in
questo caso, un sentimento di costante turbamento che dovette accompagnare la permanenza forzata nello Stalag. Il legame con la moglie Raissa emerge d’altronde, sia
pure trasfigurato letterariamente, nei frequenti frammenti e nelle citazioni di natura
letteraria (da Proust, Ariosto, etc.116), ma soprattutto dalle frequentissime citazioni
dall’Epistolario di Leon Bloy alla fidanzata117.
Levinas, come tutti i prigionieri, aveva la possibilità di comunicare tramite lettera con i propri cari. Non essendo tuttavia a nostra disposizione l’epistolario di Levinas con la moglie, non possiamo adeguatamente scandagliare né il grado di questa
trasfigurazione letteraria, né soprattutto l’intensità con la quale il prigioniero trasmetteva le sue notizie e ne chiedeva a sua volta. Possiamo solo ricavare informazioni a
riguardo dal libro di Salomon Malka, dal quale risulta, tra l’altro, che Raissa dovette
interessarsi presso le competenti autorità francesi per la conferma della pratica di naturalizzazione del marito118.
Per ritornare ai Carnets, non mancano tuttavia annotazioni di tenore meno cupo, dettagli di vita quotidiana quasi normale (come in un passo segnato in calce dalla
data di una festività ebraica119), o descrizioni paesaggistiche, rare ma significative
come quadri impressionisti120. Numerosi frammenti, dal secondo Carnet in poi (il
115
CCAI, p. 403, nota.
Non è nostro interesse, in questa circostanza, indagare le opere lette e citate in questi taccuini
da Levinas, ma questa ricostruzione sarebbe senz’altro interessante per render conto, a livello filologico oltre che filosofico, di molti riferimenti letterari presenti nelle successive opere levinassiane.
117
Cfr. L. BLOY, Lettres à sa fiancée, Stock, Paris 1922; tr. it. di G. Vigini, Lettere alla fidanzata, Aragno, Torino 2001.
118
S. MALKA, op. cit., pp. 76-77.
119
«Simhatt-Torah del 4 ottobre. Trattore. Nebbia. Panne. Russi – canti – Yvan, la gioia di
Goldf davanti al nome di Yvan. L’intensità di certe frasi banali in certe situazioni. <Jaruch?> e il suo
entusiasmo davanti l’arco della porta del paese con le sue iscrizioni» (CCAI, pp. 77-78).
120
Ad es.: «Ottobre – Carboniera. Paesaggio desolato – astratto, albero senza atmosfera come
su un disegno infantile – Poi paesaggi di foreste di betulle giovani e rade. Come giovani donne»
(CCAI, p. 78).
116
38
primo non contiene riferimenti diretti alla prigionia)121, reiterano una metafora che
molto pertinentemente potremmo annettere all’ambito traumatico: l’immagine della
chute de la draperie, la caduta del drappo, l’addobbo o tendaggio di lana che ricopre
la nudità delle mura di un mobile o delle murature di una casa e rende ufficiale o autorevole il contesto che ricopre. Vediamo alcuni passi:
«Triste opulence
La sera ad Alençon
La gerarchia crolla
Le tinte [o tinture] cadono
Le maschere impallidiscono
I costumi cadono»122
«I drappi che cadono nella mia scena di Alençon concernono anche le
cose. Le cose si decompongono, perdono il loro senso: le foreste diventano alberi – tutto ciò che significava foresta nella letteratura francese scompare. Decomposizione ulteriore degli elementi – pezzi di legno che restano dopo la partenza del circo sulla scena – il trono è un pezzo di legno, i gioielli dei frammenti di vetro etc. Ma non voglio semplicemente parlare della fine delle illusioni;
ma piuttosto della fine del senso. (Il senso stesso come illusione). Forma concreta di questa situazione: le case vuote e il soggiorno in queste case. Formag-
121
Non risulta, come anche notano i curatori, che nel primo Carnet (CCAI, pp. 51-60) ci siano
riferimenti alla prigionia; dunque esso deve essere anteriore, come del resto lascia supporre
l’intestazione del frontespizio, che riporta la data 1937. Tuttavia, rimarchevoli sono alcune notazioni
sui concetti di allegorismo-simbolismo e nudità. Nell’ebraismo non c’è nozione di allegoria, «(terzo
ordine tra il sensibile e lo spirituale). Raffigurazione ebraica opposta a prefigurazione greca o allegoria. Contro l’universalismo greco» (p. 51); «Spogliare dalla forma = rendere nudo» (p. 52); «Il boxeur
è vestito quando è nudo» (p. 53); «Filosofia – si occupa del senso – senso non è simbolo» (p. 55);
«L’antisemitismo [utilizza] il potere dell’astrazione» (p. 58); «Non c’è simbolismo o allegorismo in
Rodin» (p. 59 – da questo passo evinciamo che “simbolismo” e “allegorismo” sono per Levinas sinonimi). Notevole è anche, a nostro avviso, l’uso del concetto di personalità-persona legato a quello di
solitudine (che connoterebbe l’ “esistenzialità” della sua filosofia [cfr. p. 53]), e a quello di responsabilità verso tutto l’universo, che sarà frequentemente presente nell’opera successiva: «Personalità –
solitudine, responsabile dell’intero universo. Creando la persona – Dio ha dovuto dirle ciò che ella
aveva da fare» (p. 53); «Personalità – persona» (p. 53); «Perché l’intellettualismo, anche quando
l’intelletto impegna tutto l’essere non è esistenzialismo? Perché l’intelligenza [è] depersonalizzazione» (p. 54).
122
CCAI, p. 109.
39
gio e champagne alle cinque del mattino. Sviscerare questa idea della “perdita
di senso”. E della solitudine che ne risulta»123.
«Il drappo della situazione»124 «il tema della degradazione delle cose ad
Alençon…»125 «I drappi sfolgoravano».126
La «chute du draperie» (la caduta del drappo che denota l’ufficialità del contesto), la spoliazione di una casa che resta disadorna dopo il saccheggio e la deportazione dei suoi occupanti, la sconfitta militare e il tracollo della Francia, patria di
accoglienza e asilo per generazioni di esuli: tutte queste immagini rappresentano per
Levinas la fine del senso, la disgregazione dell’essere, del Sé, l' angoscia primordiale.
Come affermano Calin e Chalier, «è la caduta stessa della realtà, è la realtà che
perde di colpo la sua consistenza, la sua sostanzialità, la sua stessa stabilità»127. Si
tratta di una serie di immagini, racchiuse in quella della caduta del drappo, che dicono il crollo o la frantumazione del mondo («le monde cassé»). È possibile rilevare da
una duplice indizio quanto sia fondamentale questo plesso concettuale legato al mondo in frantumi. Il primo indizio ci è fornito dal lavoro archivistico dei curatori degli
inediti, che ci segnalano che le cartelle dove Levinas teneva collocati i fogli preparatori di EE, portano semplicemente il titolo: «monde cassé»128 (ricordiamo inoltre che
lo stesso sintagma marceliano ricorre nel testo definitivo di EE, dove Levinas parla
di «mondo infranto o mondo rovesciato»129); il secondo indizio è il notissimo passo
di EE:
123
Ivi, p. 132.
Ivi, p. 135.
125
Ivi, p. 137.
126
Ivi, p. 141.
127
Ivi, p. 17.
128
Ivi, p. 20.
129
EE, p. 15. Ricordiamo che questo è il titolo di un famoso dramma in quattro atti, scritto nel
1932 da Gabriel Marcel (G. MARCEL, Le monde cassé, Desclée de Brouwer, Paris 1933; ed. it. in ID.,
Teatro, a c. di Passeri Pignoni, tr. di G. Zanobetti, Abete, Roma 1973). Qui il sintagma «mondo in
frantumi» appare sulla bocca della protagonista, Cristiana, per esprimere la improvvisa presa di coscienza della perdita di orientamento esistenziale, in un contesto storico di crollo e mobilitazione epocale; un altro personaggio, Lorenzo, esclama: «Noi assistiamo a un gigantesco trasloco; una disgregazione totale dell’uomo si compie sotto gli occhi della società presa dal panico» (p. 203). Nel tentativo
di sfuggire a questo disagio esistenziale («una specie di inquietudine, di voglia di fuggire, come se si
potesse fuggire da se stessi, come se si portasse con se stessi tutto ciò che si detesta e di cui non si può
fare a meno» [p. 171]), Denise – amica di Cristiana – compirà la scelta del suicidio. Il dramma si conclude con la confessione, da parte della protagonista, della necessità di evadere da se stessi, nella presa
124
40
«Immaginiamo il ritorno al nulla di tutti gli esseri: cose e persone. Non è
possibile situare questo ritorno al nulla al di fuori di ogni evento. Ma il nulla
stesso? Qualcosa accade, non fosse altro che la notte e il silenzio […]. Indicheremo questa consumazione impersonale, anonima, ma inestinguibile dell’essere, che mormora al fondo del nulla stesso, con il termine di il y a»130.
Nel passo parallelo, contenuto in Il tempo e l'altro [TA], notiamo inserita una
frase che si ricollega in maniera più esplicita al concetto di cassure du monde: «Immaginiamo il ritorno al nulla di tutte le cose, esseri e persone. Incontreremo forse il
puro nulla? Dopo questa distruzione immaginaria di tutte le cose, rimane non qualcosa, ma il fatto che c’è [il y a]»131.
Caterine Chalier ha accuratamente sviluppato questo tema, chiarendo in questa
immagine l’eco biblica del tohu wa-bohu («turbamento e vuoto»132), «il vuoto assoluto anteriore alla creazione, irriducibile al niente»133, il caos dell’informe e caotico
brusio di fondo del il y a «il cui sfioramento è l’orrore»134. Lo stesso Levinas, del resto, suggeriva questa lettura nell’intervista a Philippe Nemo: «Non che ci sia questa o
quella cosa determinata, ma è aperta la stessa scena dell’essere: il y a. Nel vuoto assoluto che si può immaginare prima della creazione – il y a».135 Come suggerisce Caterine Chalier, Levinas è stato senz’altro influenzato dall’interpretazione di Rashi di
Troyes, che nel suo Commento alla Genesi così traduce e commenta il versetto di Gn
1, 2:
«Ora la terra era turbamento e vuoto [...] Turbamento e vuoto (tohu-wabohu) – Il termine tohu significa «stupore» e «tubamento», perché un uomo sadi coscienza di un’essenziale condizione di comunione umana: «Noi non siamo soli…nessuno è solo…, c’è una comunione dei peccatori…c’è una comunione dei santi..» (p. 226).
130
EE, p. 50.
131
TA, p. 22, cn.
132
Così Rashi di Troyes traduce il passo di Gn 1, 2.; Cfr. RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi, Pref. di P. De Benedetti, Intr. e tr. di L. Cattani, Marietti, Genova-Milano 2005 (rist.), p. 5. Tra le
traduzioni possibili, si vedano le due seguenti: «La terra era sterminata e vuota..» (Bibbia Ebraica.
Pentateuco e Haftarot, a c. di Rav D. Disegni, Giuntina, Torino 1998); «... la terra era informe e deserta» (tr. CEI, 1971).
133
C. CHALIER, Lévinas. L’utopie de l’humaine, Albin Michel, Paris 1992, p. 42.
134
EE, p. 52.
135
EI, p. 66.
41
rebbe rimasto stupito e turbato per il vuoto che era sulla terra. Tohu è estordison [stupore] in lingua locale [fr. medievale]. Bohu: la parola significa “vuoto”
e “deserto” »136.
Quasi con le stesse parole di Levinas, vogliamo notarlo, Primo Levi segnala,
in un celebre passo de I sommersi e i salvati, il «disagio incessante che inquinava il
sonno e che non ha nome137» di cui soffrivano i prigionieri, sentimento in cui «forse
sarebbe più giusto riconoscere l’angoscia atavica, quella di cui si sente l’eco nel secondo versetto della Genesi: l’angoscia inscritta in ognuno del tohu-wa-bohu, dell’universo deserto e vuoto, schiacciato sotto lo spirito di Dio, ma da cui lo spirito dell’uomo è assente: non ancora nato o già spento138». Ricordiamo come anche Levinas
tematizzi e descriva fenomenologicamente l’insonnia (il leviano «disagio incessante
che inquina il sonno e che non ha un nome»), tonalità emotiva che manifesta l’il y a
come nudo fatto d’essere, la «vigilanza assolutamente priva di oggetti»139 che opprime, e da cui non si può evadere.
E benché Levinas, in una nota di EE, segnali di aver tratto spunto, per la descrizione dell’il y a, da Thomas l’obscur di Maurice Blanchot – nel quale «la presenza
dell’assenza, la notte, la dissoluzione del soggetto […] sono mirabilmente descritti140» -, ci sembra opportuno considerare questa esperienza pre-filosofica come assolutamente coerente con il proprio personale vissuto traumatico concentrazionario.
Relativamente al passo sopracitato141, quello che qui ci interessa non è tanto
notare il pur presente debito levinassiano rispetto al paragrafo 49 di Ideen I di Husserl142, quanto piuttosto di rilevarne anche la matrice biografica. D’altra parte ci sem136
RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi, cit. p. 5.
P. LEVI, I Sommersi e i salvati, in Opere, Vol. I, cit., p. 717.
138
Ibidem.
139
EE, p. 59.
140
EE, p. 56, nota.
141
EE, p. 40.
142
Francesco Paolo Ciglia sottolinea opportunamente l’importanza della lettura del par. 49 delle
Ideen per il successivo sviluppo della riflessione levinassiana, e in particolare per l’elaborazione del
concetto di il y a; Cfr. F.P. CIGLIA, Un passo fuori dall'uomo. La genesi del pensiero di Lévinas, CEDAM, Padova 1988. pp. 55-60. Ci pare assai interessante, e supportata da un’escussione comparativa
dei testi più strettamente fenomenologici del Nostro, la proposta di Stefano Bancalari circa la necessità di invertire la testuale “narrazione” levinassiana, per cui dall'esistenza verrebbe fuori l'esistente in
quanto ipostasi, al fine di render conto del modo in cui effettivamente funzioni la logica interna della
argomentazione levinassiana (dall'esistente all'esistenza, appunto): «Sia da Le temps et l’autre, che da
De l’existence à l’existant risulta chiaramente che l’il y a, “indice di un metodo in cui il pensiero è
137
42
bra che «l’antica ossessione per la fine del mondo143», con la quale Levinas conclude
il primo capoverso del primo capitolo di EE, non sia solo un’operazione metodologica messa in atto dalla coscienza (e che richiama da vicino l’ipotesi di una «coscienza
senza mondo»144 husserliana), ma la sua nascita latente proprio nello shock traumatico della prigionia.
Le frequenti immagini, attestate nei Carnets, di frattura/caduta/disintegrazione
totale del mondo, ci paiono esprimere metaforicamente – attraverso le immagini narrative del crollo del drappo, o quelle filosofiche del ritorno al nulla, o quelle religioso-messianiche della fine del mondo – il senso inconscio della minaccia di un crollo
del Sé, o per lo meno di una pericolosa crisi in cui l’integrazione del Sé venga messa
a dura prova. Si tratta di immagini che hanno un carattere ricorrente e quasi onirico,
perché solo nel sogno e nella narrazione simbolica si può avere abbastanza distacco
per padroneggiare il peso eccessivo del trauma, per distanziarselo e quindi elaborarlo. Queste, inoltre, come immagini, possono oltrepassare la censura della repressione
(Unterdrückung, cosciente)145 o della rimozione (Verdrängung, inconscia)146 ed essere dette. Dire, raccontare e poi testimoniare, è il modo per elaborare la nevrosi traumatica, ed in questo senso il racconto viene segnalato dalla attuale letteratura clinica
invitato al di là dell’intuizione”, non è una condizione originaria che precede realmente il sorgere
dell’ipostasi, ma è il frutto di una peculiare operazione metodologica messa in atto dalla coscienza che
richiama da vicino l’ipotesi di una coscienza senza mondo e che ha tutti i tratti di quanto, con termine
husserliano, potremmo definire una “variazione immaginativa”. […] L’il y a si presenta innanzitutto
come il vincolo contro cui cozza la facoltà, che sembrerebbe priva di vincoli per definizione,
dell’immaginazione. È il limite ultimo della possibilità di variazione eidetica; è ciò che emerge per
contraccolpo dal tentativo dell’immaginazione di esercitare fino in fondo quel potere di negazione
della realtà, che la definisce nella sua indipendenza rispetto ad essa[…]», S. BANCALARI, «Apriori o
alterità. Il mito dell'ipostasi nel primo Levinas», in L'altro e il tempo. Studi di fenomenologia, a c. di
E. FERRARIO, Guerini e Associati, Milano, 2004, pp. 111-129.
143
EE, p. 15.
144
«Si può […] certamente pensare che l’esperienza, a causa dei suoi conflitti, si dissolva in
parvenza, e non soltanto in casi singoli; […] si può anche pensare che nell’esperire brulichino conflitti
insanabili non solo per noi, ma insanabili in se stessi, che l’esperienza si mostri all’improvviso riluttante di fronte alla nostra pretesa di conservare la concordanza tra le posizioni di cose, che la sua connessione perda le regole fisse che ordinano gli adombramenti, le apprensioni, le manifestazioni – che
non ci sia più un mondo» (E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, l. I, Martinus Nijhoff, Den Haag 1976, tr. it. di V. Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro primo. Introduzione alla fenomenologia pura,
Einaudi, Torino 2006, pp. 119-20).
145
««Rimozione è l’operazione con cui il soggetto cerca di respingere o di mantenere
nell’inconscio rappresentazioni (pensieri, immagini, ricordi) legati a una pulsione» (J. LAPLANCHE- J.B. PONTALIS, Vocabulaire de la psychanlyse, PUF, Paris 1967; ed. it. a c. di G. Fua, Enciclopedia
della psicoanalisi, t. II, Laterza, Roma-Bari 2009 (rist.); pp. 547-552).
146
«Repressione è l’operazione psichica che tende a far scomparire dalla coscienza un contenuto
spiacevole o inopportuno, idea affetto, ecc» (ivi, pp. 537-538).
43
come modo terapeutico privilegiato per superare il DPTS (Disturbo post traumatico
da stress)147. Ma su questo tema dovremo ritornare in seguito148. Il meccanismo della
metaforizzazione viene chiamato da Freud simbolizzazione149 ed è proprio della produzione onirica come dinamica prettamente inconscia, avente un carattere difensivo e
regressivo.
Cerchiamo ancora di analizzare questa immagine della «frattura del mondo»,
chiedendoci cosa possa rappresentare. Se usiamo la terminologia della psicologia del
Sé di Heinz Kohut, per il quale il Sé è «un reale centro indipendente di iniziativa e un
polo di percezioni e esperienze»150, possiamo ipotizzare che l’immagine della distruzione del mondo rappresenti la proiezione di una desoggettivazione interiore, cioè
della perdita di unità del Sé151. Depersonalizzazione causata dal trauma e simboleg147
e ss.
Cfr. C. MUCCI, Il dolore estremo. Il trauma da Freud alla Shoah, Borla, Roma 2008, pp. 91
148
V. infra, cap. II par. 3.
La simbolizzazione, come processo di formazione di immagini manifeste che si riferiscono
ad un contenuto latente insopportabile e quindi rimosso, è inizialmente individuata da Freud
nell’Interpretazione dei sogni (1899; Cfr. S. FREUD, Opere, cit., Vol. 3, pp. 322-71) e poi in Introduzione alla psicoanalisi (1915-17; Cfr. S. FREUD, Opere, cit., Vol. 8, pp. 321-40) come dinamica prettamente inconscia avente un carattere difensivo e regressivo. Ogni simbolo celerebbe, infatti, un simbolizzato rimosso che è compito dello psicoanalista portare alla luce. Melanie Klein, invece, pensa che
la simbolizzazione non sia un fenomeno regressivo e difensivo ma un processo che ben esprime la
capacità umana di sublimazione, che è una potenzialità insita in tutti gli esseri umani, ma che può svilupparsi o meno a seconda delle esperienze che il soggetto fa durante la sua vita.M. KLEIN, Formazione dei simboli nello sviuppo dell’io, in Scritti 1921-1958, Bollati Boringhieri, Torino 2006: «Il simbolismo non è solo la base di tutte le fantasie e le sublimazioni ma qualcosa di più: è su di esso che si
edifica il rapporto del soggetto con il mondo esterno con la realtà nel suo complesso». Su questo tema,
si veda anche O. FENICHEL, The psychoanalytic Theory of Neurosis, W.W. Norton & Co., New York
1934; tr. it. di C. Gastaldi, Trattato di Psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Astrolabio, Roma
1951 (rist.), p. 60: «Gli adulti possono usare un’idea conscia come simbolo per esprimere un’idea inconscia spiacevole;[…] Il simbolo è conscio, l’idea simbolica è inconscia».
150
H. KOHUT, The restoration of the Self, International University Press, New York 1977; tr. it.
di S. Adamo Tatafiore, La guarigione del Sé, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 95. Come afferma
Paolo Migone, «il Sé di Kohut è un entità autonoma, priva di conflitto in se stessa, che appartiene a un
livello di astrazione diverso dalla struttura tripartita Io/es/Super-io poiché viene concepito come il
centro della psiche e sovraordinato a Io/Es/Super-io[…] il concetto di conflitto intrapsichico che è
centrale in psicoanalisi [“dell’Io” o “delle pulsioni”] è strettamente legato a quello di pulsione, cioè
all’Es, che appunto entra in conflitto con altre strutture, come ad esempio quella di Super-io. Ed è per
questo che Kohut, coerentemente, nega l’esistenza autonoma delle pulsioni, e afferma che le loro manifestazioni […] sono già di per sé dei “prodotti di disintegrazione” della libido narcisistica nel momento in cui il soggetto (il Sé) entra in un rapporto non empatico e frustrante con le figure parentali
(gli oggetti)» («Psicologia del Sé», in AA.VV., Psiche. Dizionario storico di psicologia, psichiatria,
psicoanalisi, neuroscienze, Vol. II, Einaudi, Torino 2009, p. 876).
151
Vogliamo specificare che se ci serviamo della definizione kohutiana del lemma “Sé”, è per
circostanziare il tipo di approccio ai testi levinassiani della prigionia che stiamo svolgendo; ciò non
vuol dire che seguiamo integralmente la terminologia e la descrizione psicodinamica di Heinz Kohut o
che attribuiamo a Levinas intenzioni “psicoanalitiche”. In altre circostanze, in riferimento ai testi, faremo uso di concetti estratti da altri contesti teorici, di volta in volta specificati, sapendo bene del resto
quanto viga in ambito psicoanalitico (e ovviamente filosofico) una polisemia terminologica che troppo
149
44
giata nella creazione filosofico-letteraria attraverso l’immagine della frattura del
mondo, come derealizzazione e ricaduta nell’insensatezza.
Questa dinamica risulterebbe d’altronde tipica dell’esperienza poetica, come
suggerisce Giorgio Agamben parlando della trasfigurazione poetico-narrativa del vissuto traumatico152. La soggettivazione del vissuto desoggettivante dell’il y a nell’ipostasi, viene d’altronde testimoniata testualmente in un frammento del quinto Carnet,
dove leggiamo: «Hypostase – comme terme par lequel je pourrai remplacer la notion de subjectivité»153. Ci pare questa la prima occorrenza del termine «ipostasi»
nell'opera levinassiana, termine che come sappiamo sarà centrale in EE e TA. Qualche passo prima, nel manoscritto, appare un ennesimo frammento descrivente la «caduta del drappo».
Se la soggettività “spunta” dopo questa frattura universale, l’ipostasi è la nascita dell’esistente dall’esistenza (da un il y a anonimo), che ha anche il compito di
ripristinare l’integrazione del Sé e “tenere in piedi” la soggettività postraumatica,
quella almeno che avrebbe sufficientemente forza per riprendersi e non soccombere
alla totale disintegrazione. Tale occorrenza era piuttosto comune, come possiamo ricavare dalla letteratura concentrazionaria (per quanto riguardava però i veri e propri
campi di sterminio) a quanti erano chiamati con l’appellativo di “musulmano”154.
Vogliamo soffermarci ora su di un brano assai significativo, che ci permetterà
di collegarci con la corrispettiva tematica trattata in EE. Ci riferiamo al tema dell’il y
a che emerge in una pagina dei Carnets. Possiamo identificarne l’ unità tematica collegandolo ad un passo quasi analogo, che tuttavia ricorre in un testo di circa quaranspesso, non essendo chiarita, dà adito a vere e proprie confusioni. Questo non significa pretendere,
d'altra parte, sempre e comunque una univocazione concettuale e semantica; tanto più avendo a che
fare con un pensiero come quello di Levinas, che fa del “dire altrimenti”, e dell’anfibolia, la propria
cifra speculativa.
152
«Che l’atto di creazione poetica, anzi, forse ogni atto di parola implichi qualcosa come una
desoggetivazione, è patrimonio comune della nostra tradizione letteraria (“musa” è il nome che da
sempre i poeti hanno dato a questa desoggetivazione) (G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz.
L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri, Torino 2007 [1a ed. 1998], p. 105).
153
«Ipostasi come termine con il quale potrei sostituire la nozione di soggettività» (CCAI p.
146).
154
«Il cosiddetto Muselmann come nel linguaggio veniva chiamato il prigioniero che aveva abbandonato ogni speranza ed era stato abbandonato dai compagni, non possedeva più un ambito di consapevolezza in cui bene e male, nobiltà e bassezza, spiritualità e non spiritualità, potessero confrontarsi. Era un cadavere ambulante, un fascio di funzioni fisiche ormai in agonia» (J. AMERY, Janseits von
Shuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Szczesny Verlag, München 1966; tr. it
di E. Ganni, Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 38). Su questo tema, si
veda soprattutto G. AGAMBEN, op. cit., pp. 37-80; cfr. P. LEVI, Se questo è un uomo, in Opere I, cit.,
pp. 89-93.
45
t’anni dopo, precisamente nel colloquio di Levinas con Philippe Nemo (che verrà
pubblicata con il titolo Etica ed Infinito nel 1982 [EI]).
Confrontiamo dunque i due passi in questione:
«Dormire. Si sente il brusio della gente che continua a vivere. È un’agitazione che sottolinea la calma del dormiente [c’est une agitation qui
souligne la sagesse du dormeur]. Come il brusio del mare»155. [1942?]
«Per me “il y a” è il fenomeno dell’essere impersonale. La mia riflessione su questo argomento prende il via da ricordi dell’infanzia: si dorme
soli, per gli adulti la vita continua; il bambino percepisce il silenzio della
sua cameretta come “brusio”»156.[1982]
Abbiamo tradotto con «calma» il sostantivo usato da Levinas «sagesse» [«du
dormeur»]. In questo caso, il termine designa l’atteggiamento del bambino giudizioso, assennato, che dorme nel caldo tepore del suo letto, mentre fuori gli adulti continuano la loro vita ordinaria. Ci suggerisce l’idea di un caldo riparo, di un guscio nel
quale l’identità si raccoglie, sfuggendo alla disgregazione della vita di veglia coatta,
cui l’insonnia dell’adulto inevitabilmente condanna.
Il tema del sonno come (ri)costituzione dell’ipostasi, (la cui disgregazione è
data dall’insonnia che annuncia l’il y a), ricorre in un luogo centrale di EE, in cui avviene la nascita dell’ipostasi. «La coscienza del soggetto pensante – con il suo potere
di evanescenza di sonno e di inconscio – è proprio la rottura dell’insonnia dell’essere
anonimo, la possibilità di “sospendere”, di sfuggire a questo dovere di coribante, di
avere per sé un rifugio per potersi ritirare dall’essere»157.
Nel passo dei Carnets che abbiamo sopra citato, il contrasto con «un’agitazione» dei grandi che continuano il loro trambusto quotidiano sottolinea la sagesse del
bambino dormiente. Ma se invece che con «calma», traduciamo con «saggezza», allora il passo acquista un significato più profondo. Dormire, riposare, sospendere il
ritmo profano (che a ben guardare non è nemmeno un ritmo, ma una danza frenetica
155
156
157
CCAI, p.79.
EI, p. 65.
EE, p. 59.
46
«da coribante»158), significa essere saggi riposando su un luogo: «La coscienza sorge
a partire dal riposo, dalla posizione, a partire da questa relazione esclusiva con il luogo»159.
Luogo interiore, che è anche (insieme) il luogo massimamente esteriore160, e
che fonda e rivela la coscienza nella sua integrità come saggia, in quanto le dà la propria unità di ipostasi. Come dirà più tardi Levinas nella Prefazione alle cinque letture
talmudiche pubblicate con il titolo Dal sacro al santo [DSS]161, la saggezza ebraica
si fonda sul suolo dei testi in cui è depositata la Torah e che risvegliano all’umano162.
Saggezza traduce l’ebraico Hokmàh, che si raggiunge attraverso lo studiopratica della Torah, e rappresenta la vocazione all’unicità di un’elezione: «essa incombe sull’unicità di chi pensa, come se, al di là di ogni contingenza, la sua identità,
logicamente ingiustificabile, e indiscernibile di monade, venisse eletta»163.
L’immagine del bambino calmo-saggio, che dorme mentre gli adulti continuano freneticamente a vivere nell’ossessione della veglia, immagine nata all’interno
del campo – come testimonia inequivocabilmente il Carnet – è rievocata retrospettivamente dopo quarant’anni come un ricordo d’infanzia, rimuovendo la circostanza
concreta della sua genesi. Questo fatto non è, crediamo, senza significato. Possiamo
ipotizzare, infatti, che l’esperienza spersonalizzante del campo di lavoro abbia suscitato l’idea dell’anonimato dell’essere e, a partire dal pathos della cattività abbia rafforzato il desiderio di evasione (tema che del resto era presente in Levinas, ricordiamo il famoso studio Dell’evasione del 1935164) e che la cessazione di quel lavoro –
nel sonno, e prima nello studio, come vedremo tra poco trattando dello Shabbat –
fosse vissuta come una ricostituzione dell’identità del soggetto. Che il sonno sia la
forma privilegiata di quello che in psicoanalisi si chiama ritiro primitivo, il meccani158
«All’il y a manca il ritmo» (EE, p. 60).
EE, p. 64.
160
HaMaqòm (il Luogo) era un sinonimo del Nome di Dio, secondo il Talmud. Cfr. E.E. URBACH, Les sages d’Israël. Conceptions et croyances des maîtres du Talmud, tr. fr. dall’ebraico di M.J. Jolivet Cerf-Verdier, Paris 1996, pp. 73-75.
161
Du Sacré au Saint, Cinq Nouvelles lectures talmudiques, Éditions de Minuit, Paris 1977; tr. it. di
O. Nobile Ventura, Dal sacro al santo, Città Nuova, Roma 1985.
162
«Ciò che ci sta a cuore, è certamente interrogare questi testi – ai quali è legata, come a un
suolo (comme à un sol), la saggezza ebraica – in funzione dei nostri problemi di uomini moderni»
(DSS, p. 23, tr. modificata, cn).
163
ON, p. 208.
164
De l’évasion, «Recherches Philosophiques», V, 1935-36, pp. 373-392, riedito in volume da
J. ROLLAND, Fata Morgana, Montpellier 1982; Le Livre de Poche, Paris 1998; tr. it di D. Ceccon,
Dell’evasione, Cronopio, Napoli 2008.
159
47
smo psichico volto a mantenere coeso il Sé attraverso una regressione narcisistica
dagli effetti disgreganti provenienti dalla realtà, è acquisizione comune nella letteratura psicoanalitica165.
Levinas sembra quasi suggerircelo nelle pagine di EE che trattando del sonno,
quando rievoca l’episodio biblico del profeta Giona166. Malgrado l’eterogeneità del
quadro teorico e delle finalità specifiche rispetto al pensiero psicoanalitico (mirante
alla terapia e non a un interesse etico - filosofico), si riscontra un’interessante analogia tra la descrizione fenomenologica del sonno fatta dal filosofo lituano e quella avviata dalla riflessione postfreudiana. Sigmund Freud nel Supplemento metapsicologico alla teoria del sogno (1915) sostiene che il sonno ripristina lo stato del narcisismo
primitivo: «dal punto di vista somatico, – il sonno – è una riattivazione del soggiorno
nel grembo materno, dal momento che ne realizza le condizioni di riposo, calore e
assenza di stimoli […] Lo stato psichico del dormiente è caratterizzato da un ritrarsi
pressoché completo dal mondo circostante e da una cessazione d’interesse per il medesimo»167. Spesso si constata che il dormiente acquista una posizione fetale. Nello
stato di sonno perciò «la regressione che riguarda lo sviluppo della libido […] giunge
fino al ripristino del narcisismo primitivo»168.
Sviluppando e rielaborando la teoria di Freud, Béla Grunberger, in uno dei
più importanti studi sul narcisismo, afferma significativamente che è proprio basandosi sullo studio del sonno che Freud avrebbe elaborato il concetto di narcisismo: il
165
Il ritiro primitivo è una difesa comune sia al bambino che all’adulto in situazioni di stress
emotivo, come afferma Nancy Mc Williams: «Il bambino sovrastimolato o in preda a forti tensioni
spesso semplicemente si addormenta. Il ritiro psicologico in uno stato di coscienza è una risposta auto
protettiva automatica osservabile nel piccolo dell’uomo. Versioni adulte dello stesso processo sono
osservabili in persone che si sottraggono a situazioni sociali o impersonali, sostituendo lo stimolo del
proprio mondo fantastico interiore alle tensioni della relazione con gli altri. […] Il vantaggio principale del ritiro primitivo come strategia difensiva è che, mentre implica una fuga psicologia dalla realtà
richiede scarsa distorsione della realtà stessa». Questa forma di difesa ha vari gradi, e nella sua estremità più funzionale «si trovano persone di notevole creatività: artisti, scrittori, teorici della scienza,
filosofi, mistici e altri ‘spettatori’ di grande talento, cui la capacità di tenersi fuori dalle convenzioni
ordinarie conferisce un’attitudine speciale all’osservazione» (N. MCWILLIAMS, Psychoanalytic diagnosis. Under standing personality structure in the clinical process, The Guilford Press – New York,
London 1994, tr. it. di G. Baldaccini e L. Riommi Baldaccini, a c. di L. Sarno e V. Caretti, La diagnosi psiconalitica. Struttura della personalità e processo clinico, Astrolabio, Roma 1999, pp. 121-122).
166
«Quando il biblico Giona, eroe dell’evasione impossibile, evocatore del nulla e della morte,
constata in mezzo agli elementi scatenati lo scacco della propria fuga e la fatalità della propria missione, scende nella stiva della barca e si addormenta» (EE, p. 61).
167
S. FREUD, Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre (1915), «Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse», vol. 4(6), 277-287 (1917); tr. it. di R. Colorni, Supplemento meta
psicologico alla teoria del sogno, in Opere, Vol. 8, Bollati Borighieri, 2008, p. 89.
168
Ivi, p. 90.
48
ritiro degli investimenti libidici dal mondo circostante avrebbe origine o
dall’esaurimento energetico (nel caso di normale sonno notturno) o dal desiderio di
fuga dalla realtà (nel caso di sonno indotto da stress), perciò il dormiente si immergerebbe nella regressione narcisistica per ripristinare l’unità del Sé169.
È interessante a questo proposito sottolineare l’analogia con quanto afferma
Levinas circa il sonno in EE, sia relativamente al suo carattere (ri)costitutivo – restaurativo e riparativo, ma anche per la prima volta generativo – dell’identità del
soggetto, sia per il carattere di regressione a un livello perinatale, protettivo e fetale,
quasi in un guscio. Leggiamo infatti in EE:
«Il sonno ristabilisce la relazione del luogo come base […]. Dormendo è come se entrassimo in contatto con le virtù protettrici del luogo. Coricandoci,
rannicchiandoci in un angolo per dormire, ci abbandoniamo a un luogo – a un
luogo che diviene il nostro rifugio in quanto base. Colui che si risveglia si
trova rinchiuso nella sua immobilità come un uovo nel proprio guscio [comme
un oeuf dans sa coquille]. […] È a partire dal riposo, a partire dalla posizione,
che viene la coscienza, a partire da questa relazione unica con il luogo, che
viene la coscienza. […] essa è un impegno nell’essere che consiste nel mantenersi precisamente nel non impegno del sonno. […] la coscienza è qui»170.
Si chiarisce forse quello che Levinas, poco prima delle righe che abbiamo appena citato, aveva chiamato il «paradosso della definizione della coscienza attraverso
l’inconscio»171. Ad una prima superficiale lettura di questo passo, potremmo essere
indotti a identificare la coscienza con l’inconscio; ma a ben guardare non si tratta di
questo. Il sonno è lo stato che dischiude la possibilità in cui la coscienza, nella vicinanza con l’inconscio, «in questa comunicazione col suo contrario, nel suo stesso
slancio si stanca e si interrompe, fa ricorso contro se stessa.[…] Si raggiunge in un
ritardo contro di sé, in cui, nella semplicità del suo colpo, effettua un rinculo, un con169
«Durante il sonno il soggetto ritira i suoi investimenti libidici dal mondo circostante […], il
bisogno di dormire coincide con un momento di esaurimento energetico, oppure con un desiderio di
fuga dalla realtà. […] il dormiente, dopo aver chiuso gli occhi […] si immerge nella regressione narcisistica» (B. GRUNBERGER, Le narcisisme, Payot, Paris 1971; tr. it. di F. Barale e S. Uccelli di Nemi, Il
narcisismo. Saggio di psicoanalisi, Einaudi, Torino 1998, p. 29).
170
EE, p. 63-64. Ccnn, tranne «è».
171
EE, p. 61.
49
traccolpo»172. Si tratta di un’uscita in una profondità soggiacente in cui essa «se la
svigni dall’interno» [fuir le camp par l’intérieur173] nascendo «per contraccolpo».
Nel sonno è possibile dunque l’evasione dall’ossessionante vigilanza dell’il y a, nella
quale il mondo è in frantumi e il Sé è disgregato: «non c’è un io che veglia, è la notte
stessa che veglia. Ciò [ça] veglia»174.
La coscienza si costituisce in quanto il sonno ristabilisce la relazione con la
base (il luogo) e la fonda come sostanza, «cioè come qualcosa che si pone»175. Tale
luogo è sia il letto in cui ci corichiamo, sia anche il nostro corpo, non riassorbibile a
sua volta in coscienza e sapere176; ma è anche, ci pare, l’elemento psichico che confina col corporeo, come l’Es della seconda topica freudiana, aperto da una parte verso il somatico dall’altra verso la coscienza177. Proprio evadendo dalla prigione – reale
e metaforica – a contatto con l’inconscio-corporeo, quindi, «è» o nasce la coscienza.
È un «nascere da se stessa»178 dell’ipostasi, a partire dal contraccolpo
dell’abbandono a un luogo come base, o meglio «come un guscio» (coquille). Il guscio è il luogo in cui si esce dall’il y a, ma nello stesso tempo si evade dall’interno,
verso la solitudine dell’ipostasi.
La metafora del guscio è dunque protezione dal «fuori» ma nello stesso tempo costituzione del «dentro». Levinas afferma che nell’il y a non è possibile trovare
un riparo: «siamo esposti»179. L’anonimo brusio dell’il y a circonda un panorama in172
Ibidem.
«Di svignarsela dall’interno», dirà Levinas, citando il poeta Vorges de Jules Romains. (Cfr.
EE, p. 61). Molto significativo è a nostro avviso il fatto che tale frase, nell’originale francese, suoni
«fuir le camp par l’intérieur», che evidentemente non è priva di qualche legame – sia pure inconscio –
con il campo di prigionia. Cfr. De l’existence à l’existant, Vrin, 1990 (1a ed. 1963) Paris, p. 116.
174
EE, p. 60.
175
EE, p. 62.
176
Cfr. G. FERRETTI, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier. Torino 1996, pp.81 e ss.
177
Per una dettagliata seppur sintetica esposizione di questa tematica, cfr. A. LUCHETTI, «Topiche», in Psiche, Vol. 2, Einaudi, Torino 20092 (pp. 1098-1103). Si suole normalmente distinguere nella metapsicologia freudiana due topiche ovvero schemi rappresentativi strutturati spazialmente
dell’apparato psichico. La prima topica sarebbe presente a partire da L’interpretazione dei sogni
(1899), e comprenderebbe l’Inconscio, il preconscio (il latente) e la coscienza. La seconda sarebbe
elaborata a partire dagli anni 1920 (e trova la sua esposizione più compiuta nell’opera L’Io e l’Es
[1922]), e schematizza l’apparato psichico come suddiviso in tre provincie, l’Es (il polo pulsionale
dell’apparato psichico ed è costituito da rappresentati inconsci delle pulsioni), l’Io e il Super io (la
coscienza morale). A differenza dalla prima topica, nella seconda topica «l’Es non ricopre tutta la porzione inconscia dello psichismo, giacché anche l’Io è in parte sistematicamente inconscio»(ivi, p.
1099), come pure il Super-Io, il quale «discende dal complesso edipico al suo tramonto oltre che dalla
prolungata dipendenza infantile»(ibidem).
178
EE, p. 69.
179
EE, p. 51.
173
50
forme, in cui le cose e gli esseri appaiono come allucinazioni fantasmatiche, una
«realtà allucinante»180, come Levinas appunta nel settimo Carnet. E proprio nei Carnets, precisamente nel quarto, troviamo una descrizione che rende bene questa derealizzazione:
«Fantasmi – essi compiono gesti in una realtà senza realtà – non solamente assenza d’oggetti ma assenza di progresso, di compimento. L’anno di
prigionia – i gesti quotidiani sono questo. Visione di tutte queste foreste, di
tutte queste case scalcinate, abitate da noi …»181.
Come dirà in EE, questo panorama informe come una «città irreale, inventata,
che troviamo dopo un viaggio faticoso182», o anche, potremmo aggiungere, dopo una
giornata estenuante di lavoro forzato in prigionia. È questo caos, questa vertigine183
che rende giustificata, a nostro avviso, l’evocazione della nozione di shock traumatico, in cui si avverte in un sentimento di disgregazione del sé, che l’ipostasi ricostituirà:
«L’antitesi della posizione non è la libertà di un soggetto sospeso in
aria, ma la distruzione del soggetto, la disintegrazione dell’ipostasi. Su questo punto ci sembra che, malgrado un linguaggio elementare, la psicologia fisiologistica, la quale partendo da emozioni shock presentava le emozioni in
generale come rottura dell’equilibrio sia riuscita a cogliere la vera natura
dell’affettività in modo più fedele di quanto abbiano fatto le analisi fenomenologiche che malgrado tutto mantengono in essa un carattere di comprensione e, di conseguenza, di apprensione […]. L’emozione è un modo di mantenersi perdendo la base. Al fondo è l’insinuarsi stesso della vertigine in essa, il
180
CCAI, p. 171.
CCAI, p. 126.
182
«Si può parlare di notti in pieno giorno. […]. È la città irreale, inventata, che troviamo dopo
un viaggio faticoso; le cose e gli esseri ci colpiscono come se non fossero più un mondo, galleggiano
nel caos della loro esistenza. Ed è anche la realtà “fantastica” e “allucinante” che I poeti come Rimbaud ci presentano anche quando nominano le cose più familiari, gli esseri più abituali»; EE p. 52.
183
«Il cosmos esplode e lascia che si dischiuda il caos, cioè l’abisso, l’assenza di luogo, l’il y
a», EE, p. 64.
181
51
fatto di trovarsi al di sopra di un vuoto. Il mondo delle forme si apre come un
abisso senza fondo».184
Questo passo è molto importante, perché permette a Levinas di valorizzare, a
partire dal concetto di emozioni-shock, l’opzione «fisiologistica» che dice «in un linguaggio elementare» la genesi dell’emozionale a partire da un trauma originario: l’emozione è una «rottura di un equilibrio» che fora la coscienza dall’esterno e che
quindi non può tradursi in comprensione o affezione, in quanto non è padroneggiabile: «L’emozione non mette in questione esperienza, ma la soggettività del soggetto;
gli impedisce di raccogliersi, di reagire, di essere qualcuno»185.
La coscienza nasce ponendosi sulla base di questo inconscio-traumatico, riprendendosi come per contraccolpo. L’ipostasi è una difesa, un riparo. Potremmo
quasi pensare al concetto di «Io» nel Freud di L’Io e l’Es, dove esso è l’istanza psichica che ha l’ingrato compito di mediare tra le richieste pulsionali e la realtà ambientale. Ma in Levinas la valenza difensiva dell’ipostasi, in quanto essa è guscio e
protezione dalla disgregazione costituita dall’ il y a, non riesce a guadagnare la salvezza integrale. Essa costituisce infatti un’evasione ancora provvisoria, perché è a
sua volta ancora una prigione che come un guscio di una lumaca l’io si porta sempre
con sé e vi è irremissibilmente inchiodato (rivé): «Essere io comporta un incatenamento a sé, un impossibilità di disfarsene»186.
All’ipostasi manca cioè la salvezza data dall’altro, e questa è possibile solo se
l’ipostazi riesce a sganciarsi dall’istantaneo eterno presente in cui è inviluppata, nella
sua solitudine. La sua temporalità è quella dell’istante puntuale inchiodato a sé (essa
«è» qui): per la “vera” evasione occorrerà guadagnare una temporalità concreta che è
insieme socialità.
L’evasione, la trascendenza, cioè, pur iniziata come costituzione dell’ipostasi
dal contraccolpo difensivo sul fondale anonimo dell’il y a, non è ancora compiuta
veramente finché nell’ipostasi rimane una nostalgia solipsistica, in cui essa resti prigioniera del desiderio di ritorno a sé187: «La nostalgia dell’evasione nessun cielo sco184
185
186
187
EE, p. 64.
Ibidem. (p. 64)
EE, p. 80.
«L’ “io” e il “presente” sono il movimento del riferirsi a sé che costituisce l’identità» (EE, p
73).
52
nosciuto, nessuna nuova terra riuscirà mai a soddisfar[la] perché nei nostri viaggi
portiamo sempre con noi noi stessi»188. Nell’ipostasi la libertà è solo un pensiero,
un’astrazione, e il sonno quindi è «solo una fuga e non evasione»189, come nel caso
già ricordato del profeta Giona. La vera libertà, la vera evasione dalla prigione consiste nel guadagno di un tempo di redenzione, in cui il presente sia riparato190in se
stesso, e possa rinascere come «altro». La trascendenza dell’evasione non è dunque
né uno spaesamento, né un al di là, ma un «altrove che in sé»191, una apertura verso
l’altro: «La personalità dell’essere è il suo bisogno del tempo come di una misteriosa
fecondità nell’istante stesso attraverso cui ricomincia come altro»192.
Possiamo quindi concludere che l’ipostasi sia una personalità astratta, mentre
la personalità concreta e integrale sia quella che vive nella socialità-intersoggettività.
L’intersoggettività originariamente asimmetrica e sociale, come diacronia del tempo,
potrà far evadere l’ipostasi dal proprio imprigionamento solipsistico nel presente e
farla nascere come soggettività temporale concreta: «Non è forse vero che la socialità, più che essere la fonte della nostra rappresentazione del tempo, è il tempo stesso?»193.
La descrizione di EE si chiude tratteggiando i contorni della temporalità concreta (che sarà sviluppata ulteriormente già in TA e infine in TI) nel tempo dell’eros
e «delle geniture» (come lo chiama Stéphane Mosès194). La fecondità renderà possibile la vera trascendenza, come un’uscita da sé senza ritornare a sé, nel «figlio».
188
EE, p. 80. Per questo tema del guscio, si leggano i seguenti passi tratti dai Carnets: «I rifugiati che partono con i carretti più assurdi – incapaci di partire soli, di restare soli. «Come la lumaca
che porta il suo guscio» (CCAI p. 104); «Il cielo come un guscio» (ivi, p. 105); W. [personaggio di
Eros] non può «rientrare nel suo guscio» (ivi, p. 111). Ricordiamo, a questo proposito, che anche Primo Levi parla degli «uomini-guscio» (Cfr. G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz, op. cit., p. 40);
Per il tema del guscio, si veda anche: G. BACHELARD, La poétique de l’espace, PUF, Paris 1957; tr. it.
di E. Catalano, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari 1975, 2006, pp. 135-165. Si veda ancora, sul tema del rapporto tra nostalgia e soggettività: J. KASPER, Trauma e nostalgia. Per una lettura
del concetto di Heimat, Marietti, Genova-Milano 2009, pp. 126-127; A. PRETE, (a c. di), Nostalgia.
Storia di un sentimento, Cortina, Milano 1992.
189
EE, p.81.
190
«Réparé»: traduciamo «riparato» e non «recuperato», come nella versione italiana (EE, p.
82).
191
EE, p. 84.
192
EE, p. 85.
193
EE, p. 85.
194
S. MOSÈS, Au-delà de la guerre. Trois études sur Levinas, Éditions de l’éclat, Paris-Tel Aviv
2004; tr. it. D. Di Cesare, Al di là della guerra. Tre saggi su Levinas, il melangolo, Genova 2007, p.
13.
53
Evidentemente dentro lo Stalag questa evasione in una realtà quotidiana non
era possibile, ma, tornato in Francia, Levinas avviò il suo pensiero, a partire da questo cantiere, sulla via che lo avrebbe portato alla prima grande sintesi speculativa, TI
(1961).
Se abbiamo seguito l’andamento di EE è perche ci interessava cogliere i germi della costituzione dell’ipostasi collegandoli all’esperienza sedimentata nei Carnets. Ma un’altra annotazione può ulteriormente contribuire allo studio di questa genesi. Nel primo Carnet troviamo infatti una annotazione che ci pare molto pregna di significato: «Riduzione = [ »שבתShabbat] 195.
Nell’articolo L’Opera di Edmund Husserl, apparso sulla «Revue Philosophique» nel gennaio-febbraio del 1940 (ed ora contenuto in SEHH), condensante magistralmente il pensiero del padre della fenomenologia, Levinas descrive la riduzione
come
«una violenza che l’uomo fa a se stesso per potersi ritrovare come
pensiero puro […] e si scopre come coscienza trascendentale. La riduzione
fenomenologica è dunque un’operazione attraverso la quale lo spirito sospende la validità della tesi naturale dell’esistenza per analizzare il senso nel
pensiero che l’ha costituita e che, a sua volta non è una parte del mondo ma
viene prima del mondo»196.
Nello stesso senso, abbiamo visto in EE l’ipostasi sospendere, far cessare,
l’insonnia dell’il y a, per costituirsi come un ritiro, un riparo («guscio» [coquille]) in
cui stare. La riduzione fenomenologica dunque è epoché, sospensione dell’atteggiamento naturale onde permettere di «cogliere gli orizzonti insospettati in cui si situa il
reale»197. Circa la possibile analogia semantica tra il termine greco di epoché e quello
ebraico di Shabbat, Artur Green sostiene: «La radice ebraica della parola Shabbat significa “cessare o desistere”. […] due eventi sono celebrati nello Shabbat, uno è la
creazione del mondo da parte di Dio […] ma Shabbat commemora anche l’esodo
195
196
197
CCAI, p. 59.
SEHH, pp. 38-39.
«Firma» [«Signature»], in DL, p. 362.
54
dall’Egitto»198. È, ci sembra, in questa duplice prospettiva che lo Shabbat rappresenta per Levinas la via per costituire il senso, come primo «esodo» dall’essere. Proprio
un frammento del primo Carnet orienta verso questa direzione di interpretazione:
«Salut n’est pas l’être [la salvezza non è l’essere]»199. Significativo è che lo stesso
Carnet si chiuda con la citazione della «creazione continua [come] nascita nella inerzia (paresse) dell’essere»200. Ma in cosa consiste esattamente questa sospensione,
questo Shabbat? Innanzitutto esso è una possibilità di un tempo liberato dall’essere:
«La bontà del tempo, avere tempo. Se l’eternità è sottratta alla morte – la sua
definitività ha qualcosa di morto, di cadaverico. Ma il tempo non è solamente
la possibilità di riparare – e per conseguenza qualcosa, in rapporto al male –
ma la gioia positiva dell’oziare. […] É la felicità stessa di vivere, di fare una
storia, di vivere una storia. Perder tempo (flâner), andare, ritornare sui propri
passi. La felicità di vivere non è la felicità di essere. L’essere è cadavere»201.
Un tempo libero per lo studio: miracolosamente, la prigionia costituisce (nella
trasfigurazione levinassiana) un’esperienza di Shabbat. Questo carattere sabbatico
della prigionia torna in un altro frammento: «Aspetto dei prigionieri in Germania.
Vita monacale o morale. Persino i vecchi hanno qualcosa d’innocente e di puro […]
la gioia positiva del tempo libero»202.
Come suggerisce Haim Baharier203 «la radice della parola Shabbat è […]
shav ‘ritorno’»; declinando questo significato, in base a quanto siamo venuti dicendo,
Shabbàt denota dunque il movimento che dall’esterno va verso l’interiorità, il riguadagnare l’unità psichica dopo che vi è stata una disgregazione. Detto in termini
levinassiani: evasione dall’essere (il ya) attraverso l’ipostasi, che però deve ulteriormente compiersi nella vita intersoggettivamente concreta.
198
A. GREEN, These are the Words, Jewish Light Publishing, Woodstock, Vermont 1999; tr. it.
di R. Volponi, Queste sono le parole. Un dizionario della vita spirituale ebraica, Giuntina, Firenze
2002 [pp. 313-315] p. 313.
199
CCAI, p. 52.
200
Ivi, p. 60.
201
Ivi, p. 69.
202
Ivi, p. 70.
203
H. BAHARIER, La genesi spiegata da mia figlia, Garzanti, Milano 2006, p. 73.
55
Lo Shabbat è esattamente questa dinamica della sospensione del ritmo profano, cessazione, ritiro e ritorno in sé, costituzione dell’ipostasi, al fine di (ri)acquistare
uno spirito che possa cogliere il senso dell’opera della Creazione. Il Sabato, precisamente in questo senso, rappresenta perciò la sintesi dell’ebraismo. È un tempo di studio (della Torah204) il quale deve però dar corso al rapporto etico, così come
l’ipostasi deve farsi personalità concreta (temporalizzata e intersoggettiva), e per essere tale deve evadere anche da se stessa.
In tutti questi sensi, ci pare, lo Shabbat sintetizza il giudaismo come categoria ontologica pregna di significati, e può costituire per il pensiero, come Levinas annota, il nucleo antinomico rispetto alla categoria «pagana» di Dasein. Troviamo infatti nei Carnets due notazioni fondamentali a questo riguardo, che orienteranno, nella direzione suaccennata, la successiva interpretazione del ruolo filosofico del giudaismo nel pensiero levinassiano, e ci permetteranno, più immediatamente ai fini della
nostra esposizione, di esibire l’auto-interpretazione levinassiana dell’esperienza del
carcere. In una pagina dei Carnets, Levinas annota infatti: «Partire dal Dasein o partire dal G. [Giudaismo]»205. E poco dopo scrive: «Giudaismo come categoria».206
Evidentemente, qui è in gioco un confronto con il pensiero di Heidegger, dove il «giudaismo» è fatto valere come struttura ontologico esistenziale, la cui estasi
temporale privilegiata sarà il passato immemoriale dell’eteroaffezione traumatica che
è anche «elezione del Bene» (AE), propria di quella che, negli ultimi testi, Levinas
chiamerà la «coscienza non intenzionale». Questo accenno, oltre a condensare una
pluralità di questioni su cui dovremo ritornare, andrà ad essere annodato con il problema della rilettura in chiave «sacrificale», o testimoniale sino al martirio, della
esperienza di prigionia – e nel caso di Levinas, nella sua forma incompiuta, sospesa e
differita –ma più in generale della «passione» del popolo ebraico. Così, il giudaismo,
nell’interpretazione levinasiana, sarà universalizzato fino a diventare la categoria
dell’«umanesimo dell’altro uomo».
204
Per Levinas, lo Shabbàt rappresenta il simbolo dell’ebraismo in quanto condensante la stessa
essenza della pratica delle mitzvoth: «L’originalità dell’ebraismo sta nell’assoggettarsi alla maniera di
vivere di cui vi parlerà, molto meglio di me, Léon Askenazi: nelle minime azioni pratiche, un tempo di
sosta tra noi e la natura, per compiere una mitzvah, un comandamento» (QLT, p. 146).
205
CCAI, p. 75.
206
Ibidem.
56
4. L’esperienza ebraica negli Écrits sur la captivité
La seconda sezione del primo volume delle Opere comprende quattro documenti in cui confluisce, rielaborato, molto del materiale precedente dei Carnet. Tali
documenti sono: 1. Captivité (pp. 201-203: copia dattiloscritta di cui ignoriamo la
data di composizione e la destinazione) 2. La spiritualité chez le prisonier Israélite
(pp. 205-208: copia dattiloscritta, apparsa, in forma tronca, nel Magazine de France207); 3. L’expérience juive du prisonnier (pp. 209-215: testo di una trasmissione
radiofonica208); 4. Hommage à Bergson (pp. 217-219: testo dattiloscritto inedito).
Questi testi sono molto importanti perché leggono globalmente l’esperienza
personale della propria prigionia all’interno della tragedia più generale del popolo
ebraico durante gli anni della guerra, e forniscono un primo tentativo di risposta al
problema posto da questa sofferenza. Coglieremo la pointe di questo conferimento di
senso all’esperienza vissuta, nella evocazione del Qiddùsh ha-Shem (santificazione
del nome), termine che nel giudaismo usualmente denota il martirio, il cui differimento e rinvio permette al prigioniero di acquisire un atteggiamento morale in cui
consiste la sua «spiritualità».
L’elaborazione del trauma traccia il proprio limite indicibile proprio al di qua
dell’attestazione testimoniale ultima, indicandola contestualmente come orizzonte
che conferisce senso alla propria esperienza di morte sospesa e prorogata. Proprio
l’evocazione del sentimento di sospensione, di rinvio, di proroga della morte testimoniale come santificazione del Nome permetterà a Levinas di connotare la tonalità
emotiva vissuta dal prigioniero ebreo superstite, consentendo una metaforizzazione
possibile all’esperienza della prigionia, attraverso l’evocazione dell’episodio biblico
dell’aqedah di Isacco.
Apparentemente, il riferimento alla peculiarità ebraica della prigionia sembra
assente dal primo testo, che si intitola semplicemente Captivitè,209 senza ulteriore
specificazione, quasi che Levinas volesse descrivervi semplicemente la esperienza
207
Ivi, p. 205.
Di cui non è possibile ricostruire dettagliatamente l’emittente. Per il dettaglio, cfr. CCAI, p.
209, nota a.
209
CCAI, pp. 201-203, la traduzione dei testi è mia.
208
57
universale di tutti prigionieri di guerra alleati. Infatti, i richiami espliciti al carattere
strettamente ebraico dell’esperienza sembrano mancare, quasi a suggerire una possibile destinazione aconfessionale del documento, o forse una intenzionale messa entro
parentesi del suo tratto particolaristico ebraico, al fine di cogliere e significare i tratti
fenomenologici di un’esperienza universalmente umana.
Captivité si apre con il richiamo alla necessità di de-romaticizzare e de-retorizzare il racconto della prigionia. Evidentemente, rapporti più o meno dettagliati dovevano già circolare nel periodo immediatamente successivo alla Liberazione, e il
loro tono declamatorio poteva gettare una luce retorica, venata di pathos eroico, al
carattere peculiare dell’internamento.
«Si è detto tutto della prigionia: il grigiore del filo spinato nei kommandos, le mattine nebbiose in cui ci si avvia al lavoro. Abbandono. Umidità.
Freddo. O il sole di primavera che vi prendeva in giro. Il conto perduto dei
giorni passati e dei giorni a venire. Qualcosa compensa questa miseria? Si è
creato attorno alla prigionia un romanticismo che sa un po’ di retorica»210.
In pochi tratti, Levinas sintetizza la miseria quotidiana con la sua colorazione
di fondo («il grigiore») e la sua tonalità emotiva dominante, la noia carica d’ansia
(«il conto perduto dei giorni»).
«La sofferenza risveglia le anime, e benché i prigionieri non abbiano
conosciuto gli orrori di Buchenwald, vi fu una grande sofferenza negli Stalags
e negli Oflags. Ma in cinque anni, la vita nei campi si organizzò. Si stabilirono delle regole – consuetudini, costumi – e delle abitudini, il conforto dei poveri. Allora, pur senza eliminare una specie di fraternità latente, vennero fuori
i difetti umani: egoismi, meschinità, resse e conflitti. I prigionieri non sono
stati milioni di santi protesi verso la perfezione, milioni di saggi che meditavano sul passato e sul futuro, ma milioni di esseri umani che hanno vissuto un
presente eccezionale»211.
210
211
CCAI, p. 201.
Ibidem.
58
L’accenno agli «orrori di Buchenwald» getta luce sull’orizzonte entro cui
questa descrizione si inserisce, e la riserva che tale accenno comporta, tende a segnalare che qui si testimonia di qualcosa di diverso rispetto allo sterminio. Levinas ci
sembra dunque cosciente del limite di dicibilità di quanto racconta, quasi relegasse
all’indicibile ciò che oltrepassa quel che «non abbiamo conosciuto».
Tenuto presente questo, non ci sembra azzardato affermare che questo testo si
potrebbe prestare, di primo acchito, ad una lettura «edificante» dell’internamento.
Leggiamo infatti:
«Per quanto possa sembrare paradossale, essi hanno conosciuto, nella chiusa
distesa dei campi, un’ampiezza di vita maggiore e, sotto gli occhi delle sentinelle, una insospettata libertà. Non sono stati borghesi; e questa è la loro vera
avventura, il loro vero romanticismo. Il borghese è un uomo installato [installé]. Non può sottrarsi alla serietà della sua vita. La sua attività quotidiana è la
realtà vera. La sua casa, il suo ufficio, il suo cinema, i suoi vicini, sono i punti
cardinali della sua esistenza. Sul mondo, sul vasto mondo, egli non apre che il
giornale, e lo apre come una finestra. Resta spettatore»212.
Levinas cerca di individuare nella prigionia una realtà in cui, attraverso un’esperienza limite («milioni di internati hanno vissuto un presente eccezionale»), degli
uomini hanno vissuto la possibilità di una evasione dal cerchio dell’esistenza borghese, inchiodata all’orizzonte di insediamento, radicamento, stabilizzazione nel ristretto
ambito della propria casa, del proprio ufficio, delle proprie relazioni di buon vicinato.
Il participio passato francese installé, con cui il testo connota la condizione del borghese, potrebbe essere anche reso con «sistemato», «radicato», «stabilizzato»; esso
segnala una situazione di radicamento, di contro ad una condizione di nomadismo ed
esilio, in cui l’esperienza di prigionia annuncia una dimensione di partecipazione attiva all’esistenza che pare mobilitare la staticità e l'indifferenza a cui è consegnata
l’esistenza borghese gravitante attorno al perimetro stesso del orizzonte cosmicostorico.
212
Ivi, pp. 201-202.
59
Si opera così un ribaltamento di piano, per cui la condizione di vera reclusione risulta essere quella del borghese installato, mentre al prigioniero si apre un orizzonte insospettato di vita liberata. Tale liberazione è però segnata da un senso latente
di estrema precarietà esistentiva: «Il prigioniero, come un credente, viveva nell’al di
là. Non ha mai preso sul serio il ristretto quadro della sua vita. Durante cinque anni,
malgrado il suo insediamento, egli era sempre sul punto di partire»213.
Quest’ultima affermazione (il prigioniero era «malgrado il suo insediamento,
sempre sul punto di partire») suggerisce un sottofondo emotivo di ansia, che rivela il
senso profondo della mortalità e precarietà di una estistenza affidata a un gioco
esterno rispetto alla propria progettualità. Il prigioniero: «si sentiva impegnato in un
gioco che sorpassava infinitamente quel mondo di apparenze. Il suo vero destino, la
sua vera salvezza, si facevano altrove. Nei bollettini. Erano avvenimenti di scala
mondiale»214.
Proprio questa condizione precaria permette un risveglio a una libertà insospettata, la possibilità di vivere, come un credente, «nell’al di là» rispetto al radicamento locale e identitario e alla logica proprietaria. Il senso di passività, per cui «il
suo destino si giocava altrove», affidava il prigioniero all’attesa dei «bollettini», in
cui egli rimetteva la propria sorte a quella degli eventi bellici che si svolgevano su
scala non più locale ma mondiale.
E in questo elemento di universalizzazione attraverso la sofferenza, il singolo
si apriva all’universale destino dell’umanità nella crisi dell’epoca bellica:
«E poi, vi fu una spoliazione che restituì il senso dell’essenzialità.
Non sempre povertà, non sempre fame, ma più nulla di strettamente privato.
Tutti gli spazi del quotidiano erano divenuti collettivi. Restava il letto: tre metri cubi, limitati dai letti del vostro vicino di sinistra e di destra e del vostro
vicino di sopra. Si possedeva. Ma la proprietà non era il vostro padrone, non
era più sacra. La mano sacrilega della guardia poteva sfogliare persino le vostre lettere, e quasi frugare nell’intimità dei vostri ricordi. Ma noi abbiamo
scoperto che non ne morivamo»215.
213
214
215
Ibidem.
Ivi, p. 202.
Ibidem.
60
L’esperienza di spoliazione restituiva al prigioniero il senso della essenzialità,
mentre la forzata mancanza di privatezza lo costringeva ad una condizione di esposizione, in una dimensione collettiva. Questa essenzializzazione, sborghesizzazione
della vita, e questa collettivizzazione forzata, sono enfatizzate da una affermazione
singolare: «abbiamo scoperto che non ne morivamo».
Non si trattava di mera sopravvivenza, ma di un incremento di senso della
stessa vita, ridotta all’essenziale. Ci si apriva ad una dimensione diversa, dove la dimensione del «terra terra», cioè di estrema materialità prosaica ed «elementale»
dell’esistenza, non limitava quest’ultima in un perimetro di animalità. Tale esistenza
terrestre non diventava cioè «la Vita», ma invitava invece a individuare il senso ultimo di essa in una dimensione trascendente, dove non fosse «l’avere» a contare, ma
«l’essere»:
«Abbiamo imparato la differenza tra avere ed essere. Abbiamo imparato di quanto poco spazio e di quante poche cose ci sia bisogno per vivere.
Abbiamo imparato la libertà. Ecco le vere esperienze della prigionia. Sofferenze, disperazione, lutti – certo. Ma al di là di questo, un ritmo nuovo della
vita»216.
Tutto il testo è pervaso da una parte dal richiamo alla terrestrità, (materiale e
antiromantica) della vita dei campi, non negando gli aspetti di sofferenza, disperazione, miseria e anche conflittualità tra umani in condizione di bisogno. Ma, d’altra
parte, Levinas è attento a cogliere come, proprio entro e attraverso questa terrestrità,
fosse resa esperibile una qualità davvero umana, un diverso ritmo dell’esistenza, quasi una dimensione di trascendenza nell’immanenza. Poche righe prima, Levinas scrive infatti: «Si dimenticherà una vita interamente terra-terra ma dove il terra-terra non
è mai diventato Vita?»
Proprio questa tensione tra immanenza, in cui l’esistenza del prigioniero è sequestrata entro l’orizzonte del campo, e trascendenza che quello stesso perimetro paradossalmente dischiude, ci pare il fuoco di questa attribuzione di senso all’esperien216
Ivi, p. 203.
61
za appena vissuta. La trascendenza nell’immanenza viene da ultimo suggellata dalla
frase finale con la quale si chiude il documento: «Avevamo messo piede su un altro
pianeta, respirando un’atmosfera composta di una miscela sconosciuta, e maneggiando una materia che non aveva più peso»217.
Più sopra abbiano rilevato l’apparente assenza, in questo documento, del carattere «ebraico» della prigionia. Potremmo essere indotti a pensare, in realtà, che
l’enfasi posta sul carattere precario, nomadico ed esilico, della vita in prigionia possa
essere un’eco di una erranza che contraddistingue – nello sguardo egemonico della
visione occidentale-cristiana – la categoria del giudaismo diasporico. Ma sarebbe una
notazione del tutto estrinseca al significato più profondo che, a nostro avviso, qui
contraddistingue il carattere in cui rinvenire il «giudaismo come categoria» di questo
documento.
In fondo, benché non esplicitato, l’elemento che rende autenticamente il rapporto tra giudaismo ed esperienza di prigionia è proprio la qualità stessa dell’esperienza universale dell’umano come libertà posta sotto sequestro, che Levinas consegna a questa testimonianza. Non si tratta, a ben guardare, semplicemente di una lettura edificante di un’esperienza che altrimenti potrebbe mostrarsi eroica o pietistica,
ma proprio del guadagno di un’evasione da un inchiodamento immanente, nel paradossale rapporto, cioè, tra l'immanenza claustrale della prigionia e l’apertura che essa
permetteva su uno «spazio più ampio di libertà»: «Per quanto possa sembrare paradossale, i prigionieri hanno conosciuto nella chiusa distesa dei campi, un’ampiezza di
vita più larga e, sotto gli occhi delle sentinelle, una insospettata libertà».
Per illuminare questo tipo di lettura ci sarà utile richiamare alcuni riferimenti
filosofici. Il primo riferimento è a quel pensatore che Levinas stesso considera uno
dei maggiori filosofi del suo tempo, e che non esita a considerare, nell’omaggio che
compare tra gli inediti, come il massimo esponente della rinascita della filosofia durante e dopo la crisi europea218: Henri Bergson.
217
Ivi, pp. 201-202.
Con Bergson, «la filosofia risuscitò. Così l’influenza del bergsonismo su tutte le forme della
vita spirituale è incalcolabile. In Francia, specialmente, essa ha giocato un ruolo considerevole sia
nella rinascita dello spirito religioso, sia nelle arti, sia nelle meditazioni epistemologiche. Nel mondo,
essa è all’origine di tutti gli sforzi fatti dall’uomo al fine di comprendersi in mezzo alle cose – ma quel
che è più importante ancora, al fine di situarsi nel mezzo dei suoi propri prodotti, nel mezzo delle verità» («Hommage à Bergson», CCAI p. 219).
218
62
Il nesso tra essenzialità e libertà, infatti, richiama da vicino Le due fonti della
morale e della religione219 di Bergson. Proprio in questo libro, pubblicato nel 1932,
vediamo infatti il pensatore francese suggerire come possibile soluzione del “disagio
nella civiltà” europea, con tutto il suo carico di paralizzante e disumanizzante ipertrofia scientista, il recupero di una dimensione di ascetismo e semplicità di vita, di etica
dell’austerità attraverso la quale peraltro superare le impasse economiche di un progressivo sfruttamento delle risorse naturali220. Seguendo questa suggestione, ci sembra che il recupero della libertà e la liberazione dal macchinismo tecnico-scientifico,
rese possibili dal ritorno ad una dimensione di essenzialità, avrebbe trovato per Levinas una verosimile praticabilità proprio nell’esperienza dei campi di prigionia, nel
momento di universale deflagrazione di quel modello di sviluppo storico e industriale, con la Seconda guerra mondiale.
Altri riferimenti che permettono di illuminare il documento che abbiamo
commentato sono costituiti da alcuni testi anteriori all’esperienza bellica. Il primo testo è nel saggio Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo221, nel quale, come è
noto, Levinas afferma come nell’hitlerismo si compendi un atteggiamento di esaltazione dell’incatenamento («essere inchiodati »: être rivé222) dell’uomo al proprio
corpo, sinonimo di terrestrità biologico-pulsionale, con la conseguente perdita della
libertà, ovvero della capacità di distanziarsene al fine di assumere una decisione morale (capacità che Levinas considera invece propria della tradizione di pensiero della
219
H. BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, Paris 1932; tr. it. di A.
Pessina, Le due fonti della morale e della religione, Laterza, Roma Bari 19982. Di questo accostamente ci assumiamo la responsabilità. Malgrado le numerose citazioni rinvenibili nei testi levinassiani, di Bergson teorico della durata e dell’intuizione, e il riconoscimento esplicito della propria debito
nei suoi confronti contenuto in EI (pp. 53-54), ci sembra che a deporre a favore dell’influenza, in questo specifico passo, di questo specifico libro, sia il tenore generale dell’enfasi verso il rapporto tra
essenzialità della vita e libertà, nonché il richiamo ad una dimensione di vita che proprio nel rapporto
con il sensibile - pensato forse già nel senso della consumazione e del godimento (cfr. AE p. 93, nota),
acquista il suo spessore. Tale opera è citata in DL (p. 120), sia pure in riferimento al rapporto tra morale chiusa e morale aperta.
220
Cfr. H. BERGON, Op. cit, pp. 222-225.
221
Quelques réflexions sur la philosophie de l’Hitlerisme, in «Esprit», II, 1934, 199-208; tr. it.
di A. Cavalletti, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1996.
222
Cfr. G. AGAMBEN, «Introduzione», Ivi, p. 8: «La categoria che orienta qui l’analisi è quella
dell’essere consegnati senza scampo a se stessi o a una situazione, o, come Levinas dice, dell’être rivé
(letteralmente essere inchiodati o appiattiti su qualcosa; river indica il gesto di ribattere un chiodo per
conficcarlo completamente nel legno). Ora questo vero e proprio terminus technicus della prima officina levinassiana compare significativamente nel testo sull’hitlerismo per definire significativamente
la novità del rapporto dell’uomo nazista con la sua corporeità».
63
cultura liberale occidentale223). Questo incatenamento comporta la fondazione di una
civiltà a base consanguinea224, la consegna ad una volontà di potenza espansiva e
predatoria225, il pervertimento dell’idea di universalismo morale in una nuova forma
di totalizzazione inglobante: «la guerra, la conquista»226. Significativamente, l’esito
conseguente di questa ‘filosofia’ nazionalsocialista preconizzato da Levinas è la
messa in causa della stessa «umanità dell’uomo»227.
Alla luce di questo passo, prende spessore la testimonianza dell’esperienza di
libertà (e quindi di umanità), la paradossale attestazione di un «al di là» rispetto all’immanenza dell’elementale, da cui pure si dipendeva, con la quale, come abbiamo
visto sopra, Levinas legge, nel testo Captivité, l’esperienza di prigionia.
Stessa segnalazione dell’inevitabile imprigionamento nell’orizzonte mondano, e della capacità radicale di «uscire dal mondo» tipica del paganesimo, è portata
da Levinas in un articolo del 1935, pubblicato nella rivista «Paix et droit»
dell’Alliance israélite universelle, ed intitolato L’actualité de Maimonide228. Qui leggiamo infatti: «Il paganesimo è un’impotenza radicale ad uscire dal mondo [une impuissance radicale de sortir du monde…] in questo mondo bastante a se stesso, chiuso su se stesso, il pagano è recluso [enfermé]»229. Prende sempre più plausibilità
l’ipotesi, da noi sopra proposta, di una dialettica tra incatenamento della condizione
borghese-pagana e paradossale libertà della condizione di prigionia, dove questa è
identificata, in questo testo implicitamente e in quelli che vedremo subito dopo esplicitamente, come figura della riacquisizione di una nuova dimensione della vita, dopo
il pervertimento, prima filosofico e poi storico, dell’umanità dell’uomo230.
223
«L’essenza dell’uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incatenamento. Essere veramente se stessi, non significa risollevarsi al di sopra delle contingenze, sempre estranee alla libertà
dell’Io: ma al contrario, prendere coscienza dell’incatenamento originale, ineluttabile, unico al nostro
corpo; significa soprattutto accettare questo incatenamento» (ivi, p. 32).
224
«Da questa concretizzazione dello spirito deriva immediatamente una società a base consanguinea. E allora se la razza non esiste bisogna inventarla!» (ibidem).
225
«Ci sarà una modificazione dell’idea stessa di universalità. Essa dovrà far posto all’idea di
espansione» (ivi, p. 34).
226
Ivi, p. 35.
227
Ibidem.
228
«L’actualité de Maimonide», (1935), in HERNE, pp. 142-144.
229
Ivi, p. 144.
230
Nel testo L’expérience juive du prisonnier, le esperienze intellettuali che avevano egemonizzato la cultura occidentale dei primi anni del secolo XX sono segnalate da Levinas come intrinsecamente pagane: wagnerismo, gobinismo, nietzschismo, (oltre che nazionalsocialismo, e forse anche
heideggerismo). In esse vi sarebbe una capovolgimento dei valori tra bene e male, e quindi un pervertimento dell’umanità dell’uomo (cfr. CCAI, p. 214).
64
Il terzo testo che vogliamo segnalare, e che ci permetterà di transitare ai successivi documenti della prigionia, è una citazione tratta da un articolo sempre del
1935231, intitolato L’inspiration religieuse de l’Alliance 232, nel quale Levinas dichiara che proprio le prove alle quali l’hitlerismo sta costringendo gli ebrei tedeschi dischiudono una situazione d’eccezionalità senza precedenti, perché risvegliano il senso dell’appartenenza degli ebrei del mondo al giudaismo. Si tratta di un risveglio per
nulla dolce, ma di un brusco destarsi nella coscienza del destino ebraico: «La sorte
patetica d’essere ebrei diventa una fatalità. Non se ne può più sfuggire. L’ebreo è
ineluttabilmente inchiodato (rivé) al proprio giudaismo»233.
Questa notazione ci permette di passare all’analisi dei due successivi documenti, La spiritualité chez le prisonnier Israélite e L’expérience juive du prisonier.
Se in Captivité abbiamo notato un “giudaismo anonimo” come qualità più propria
dell’umano dischiusa dall’esperienza della prigionia, dobbiamo ora rilevare come –
nei due testi in questione – questa qualità acquisisca il proprio nome proprio, e il giudaismo venga indicato esplicitamente come figura in cui prende «concretezza»234 la
stessa universale essenza umana.
In La spiritualité chez le prisonnier Israélite, è l’esperienza traumatica a risvegliare la coscienza ebraica secolarizzata e restituirla all’orizzonte della propria
particolarità, e poi, attraverso quella stessa particolarità ebraica in cui esemplarmente
si compendia una sofferenza e angoscia universale, a farle guadagnare il senso del
comune destino umano, a ridonarle cioè la misura di un autentica universalità. Gli
individui imprigionati, i prigionieri di guerra, hanno esperito «quei risvegli di soprassalto, in cui quella vita banale e dispersa apparve come un impegno, come un destino, come un assoluto»235. E tali risvegli, innescati da una «una sofferenza centrale236», sono caratterizzati dall’improvvisa presa di consapevolezza del proprio giudaismo, nel quale «l’umiliazione riprese il sapore biblico di elezione»237. Una consa-
231
Anno, come ricordiamo, delle Leggi di Norimberga.
«L’inspiration religieuse de l’Alliance» (1935), in HERNE, pp. 144-146.
233
Ivi, p. 144.
234
Intendiamo riferirci con questo termine al noto concetto levinassiano di «fenomenologia»
come «ricerca della figura nella quale le astrazioni si concretizzano» (cfr. supra, nota 78)
235
CCAI, p. 205.
236
Ibidem.
237
Ivi, p. 206.
232
65
pevolezza a cui il prigioniero era «costretto», e nel quale egli si è sentito parte di un
intero popolo che subiva una persecuzione esiziale in quello stesso momento:
«Quel che conferiva a questa esperienza il proprio patetico, è il partecipare alle prove subite da tutti gli israeliti nei paesi occupati dalla Germania.
Ben presto la notizia delle persecuzioni razziali, delle deportazioni, delle camere a gas e dei forni crematori, si sparse in quelle piccole collettività ancora
protette dall’uniforme. La sorte personale di ciascuno si trovò solidale con
una vecchia eredità di lacrime e di sofferenze. Si amplificò, si ingrandì»238.
Lo spessore della propria particolare sofferenza si stemperava, da una parte,
perché si misurava con la grandezza dell’eredità storica della sofferenza ebraica e
con il carattere mondiale del momento presente dello sterminio, dal quale il prigioniero di guerra si sentiva risparmiato ma solo precariamente, infatti: «La Convenzione di Ginevra – in cui tanti prigionieri non ebrei hanno trovato quella protezione dell’individuo che li restituiva agli orizzonti della civiltà – appariva solo come una ben
fragile garanzia, nello scatenamento della propaganda tedesca»239.
Però, d'altra parte, non si trattava solo di un esperienza di annullamento della
propria personale individualità entro un orizzonte collettivo, ma anche di
un’esperienza di estrema solitudine e derelizione, vissuta come elemento integrante
di una discriminazione entro il perimetro stesso del campo di prigionia: «Gli altri
parlavano di riforma, di scambio, di liberazione – l’israelita si sapeva in un mondo
duro, senza tenerezza, senza paternità. Egli esisteva, senza alcun soccorso umano»240.
Questa descrizione, che potrebbe trovare diverse analogie nei racconti di prigionia degli scampati allo sterminio, permette di rilevare due elementi che a nostro
avviso assumono particolare importanza. Innanzitutto vi è la percezione di trovarsi in
una linea di confine col grado minimo dell’umano, al di fuori del riparo di qualunque
«civiltà» e di barriera di istituzioni civili che impediscono lo scatenamento oltre ogni
misura della violenza bellica del paganesimo nazista. Secondariamente, vi è una con-
238
239
240
Ivi, pp. 206-207.
Ivi, p. 207.
Ibidem.
66
notazione speciale della qualità che rende umana tale civiltà, di contro a chi ne è privo, e cioè il fatto che tale mondo sia «duro, senza tenerezza, senza paternità».
Di nuovo, ritroviamo la minaccia inquietante dell’il y a, il barbaro scatenarsi
delle forze elementali che non permettono un riparo (una «dimora», dirà Levinas in
TI) nè la possibilità di una relazione etica intersoggettiva.
Ma nella frase sopra riportata vi è ancora qualcosa che aggiunge intensità
all’esperienza di deserto vissuta in prigionia. L’israelita in cattività sperimenta
l’assenza di paternità, ovvero l’assenza di Dio. Ricordiamo l’ossessivo richiamo, che
abbiamo precedentemente notato241, dell’immagine simil-onirica della «caduta del
drappo», quale evocazione di una denudazione radicale, evocante il concetto di morte
del Padre (di ogni paternità: «soccorso umano», ma anche, ci pare, divino)242.
La descrizione di Levinas sembra poi sfociare, come suggerisce Danielle Cohen-Levinas, in una «meditazione sulla morte243», in questo richiamando «singolarmente e tragicamente l’esperienza vissuta da Franz Rosenzweig, dalla quale è uscita
la Stella della redenzione»244. Leggiamo infatti:
«[Il prigioniero] assumeva da solo il peso della propria esistenza. Era
solo con la morte. Non concepiva in alcun momento che quella avventura potesse finire con la “liberazione dei prigionieri”, come prevedeva con serenità
la Convenzione di Ginevra. Nessuna illusione nel caso di una vittoria tedesca;
e nel caso sperato della sua disfatta, non sarebbe stato forse egli la vittima già
designata della vendetta della disperazione? Morte certamente prossima, ma
sempre futura, che non aveva perduto niente della sua angoscia – ma planava
241
V. supra cap. I par. 3.
Nell’Interpretazione dei sogni di Freud, l’immagine di nudità richiama sempre il contesto
edipico di antagonismo con la figura paterna, in cui il sognante si avverte come inerme ed esposto.
L’assenza di paternità divina e umana è qui fatta valere da Levinas come esito estremo della paganizzazione operata dalla furia nazista.
243
Cfr. D. COHEN-LEVINAS, «Seul avec la mort», AA.VV,. Levinas et l’expérience del la captivité, Atti del Colloquio del 4 Ottobre 2010, a c. di D. Cohen-Levinas, Lethielleux, Paris 2011 (pp. 1317), p. 16.
244
Ivi, p. 15. Notiamo tuttavia che, nei documenti che stiamo leggendo, il nome del filosofo
ebreo tedesco non risulta presente, benché, come suggeriscono i curatori del I volume degli inediti,
citando peraltro altre opere successive di Levinas, la nozione di «giudaismo come categoria» possa
essere frutto anche di un’influenza rosenzweigiana (Cfr. CCAI, p. 481, nota).
242
67
come un’ombra familiare sugli atti e sulle iniziative. L’esistenza quotidiana si
svolgeva al crocevia della vita e del nulla»245.
Sembrerebbe quasi delinearsi la figura del Dasein heideggeriano, risvegliato
al suo poter-essere-più-proprio grazie all’angoscia della morte, se non fosse che la
morte qui non promette nessuna autenticità all’esistenza, ma invece ne enfatizza sino
all’estremo esattamente il contrario, la perdita di ogni possibile costituzione di senso
in base a una progettualità autonoma. Qui la funzione della morte, o meglio della angoscia della morte (avvertita come certa, ma sempre differita), è piuttosto la pointe
dell’esperienza traumatica della prigionia, e spinge non già a isolare, ma piuttosto a
richiamare al ripristino di una relazione interumana. Relazione innanzitutto con gli
altri compagni, magari anche nella modalità fenomenologicamente difettiva della discrezione246, ma che sembra aprirsi ulteriormente sino a quella con l’intera umanità
sofferente.
Ma nell’intervallo dischiuso tra la certezza della morte e la sua dilazione si
poteva aprire – non per tutti, certamente247 – lo spazio per quella che Levinas chiama
«spiritualità». Ad una prima lettura del testo in oggetto, si sarebbe indotti a pensare
trattarsi semplicemente del recupero della fede ebraica, ovvero del ritorno alla tradizione dei padri. Che questa lettura sia anche plausibile, e supportabile testualmente,
non v’è dubbio. Magari potrebbe anche rinvenirsi un accenno al valore del misticismo, che Bergson individuava, nelle Due fonti, come modalità atta a risvegliare un’
autentica qualità umana nella crisi scientista della civiltà occidentale. Ma, a leggere
meglio la chiusa di questo documento testimoniale, possiamo scorgervi, involuto e
forse contratto, un implicito nesso tra religione ebraica e umanesimo (dell’altro uomo) in quanto religione tout court. A questa interpretazione conduce anche il riferimento testuale a quanto, qualche anno dopo, Levinas avrebbe scritto in TI: «Noi
245
CCAI, p. 207.
«Il prigioniero israelita passava, con il suo tormento e la sua saggezza segreti, accanto ai compagni non ebrei, che non sospettavano forse i paesaggi che egli portava dentro di sé» (CCAI, p. 207) .
247
«Vocazioni personali si manifestarono, ma esse non sempre trascinarono le collettività. Le
masse mancavano forse di strumenti di culto interiore. Come Robinson, avevano intrapreso la loro
installazione materiale e spirituale con gli utensili trovati nella stiva delle loro barche arenate. Come i
{falsi} viaggiatori che in Cina, in Egitto o a Honolulu ritrovano le sigarette e i liquori dei loro paesi
d’origine, i prigionieri traversarono la Germania e i cinque anni di prigionia con i loro libri, le loro
canzoni e i loro argomenti religiosi del tempo precedente alla guerra. Essi non erano più all’altezza
della realtà che si era aperta davanti ai loro occhi» (Ibidem).
246
68
proponiamo di chiamare religione il legame che si stabilisce tra il Medesimo e l’Altro, senza costituire una totalità»248. Acquista quindi maggiore intellegibilità la chiusa del documento di cui ci stiamo occupando, che recita:
«Ma può essere che l’emozione non si trasformi in cultura se non assai
lentamente, e che il dopoguerra vedrà lo sbocciare in culto, in misticismo, in
arte di quelle emozioni che lungi dall’essere un ammasso di stati d’animo
sgradevoli sono {raffigurate} come un compendio del nostro destino d’uomo
nella sua angoscia e nella sua sofferenza fondamentale, cioè nella sua religiosità»249.
Tale risveglio, operato dall’esperienza della derelizione della prigionia a partire dalla certezza della morte – preparata ma sempre aggiornata/differita –, e
nell’attesa della sua consumazione, assume quindi i tratti del recupero di una relazione con l’essenza stessa dell’uomo, che nel suo destino di angoscia e sofferenza è
chiamato alla relazione-religione con l’Altro (religione intesa nella sua accezione
etimologica risalente al re-ligare250). Le «emozioni che sono [raffigurate] come un
compendio del nostro destino d’uomo», significano, come abbiamo più d’una volta
ricordato, la messa in rilievo in cui l’astrazione ideale, l' essenza dell’essere umano,
assume concretezza. Laddove in TI troveremo accenni apparentemente ellittici, come
ad esempio: «un’acuta esperienza dell’umano […] nel ventesimo secolo»251, dovremo ricordarci, d’ora in poi, il contesto fattuale autobiografico in cui l’autore esperì
quella esperienza-limite acuta dell’umano che abbiamo fin qui ripercorso.
Spiritualità interinale (nell’intervallo252 tra certezza e consumazione della
morte), essa dischiude la dimensione etica interumana che è, insieme, il recupero del-
248
TI, p. 38.
CCAI, p. 208. Nella trascrizione leggiamo: «[…] religiosità naturale» [sic].
250
Per questa particolare interpretazione del lemma religio, nella sua duplice possibile etimologia (relegere e religare), si vedano le illuminanti considerazioni contenute nel saggio di M.M. OLIVETTI, «Filosofia della religione», in AA. VV., La filosofia, Le filosofie speciali, Utet, Torino 1995, pp.
143-146.
251
TI, p. 33.
252
Il tema della coscienza della morte continuamente aggiornata, come intervallo in cui si dischiude la relazione etica, è presente in vari luoghi di Totalità e Infinito. Cfr., ad esempio: «Ma sapere
e avere coscienza significa avere tempo per evitare e prevenire l’istante dell’inumanità. Proprio questo
aggiornamento [noi abbiamo tradotto dilazione] dell’ora del tradimento presuppone il disinteresse
249
69
la «tradizione dei Padri». Ma anche spiritualità emergente dall’abisso del male, che
assume i connotati di una vera e propria esperienza di Passione.
Significativamente, tale termine ricorre nell’ultimo documento che dobbiamo
ora considerare, L’expérience juive du prisonier, dove esso viene scritto, barrato e
sostituito con quello, forse meno connotato religiosamente ma più fenomenologicamente, di passività253: «Nella passività (passione) [sic] totale dell’abbandono, nel
distacco da tutti i legami – sentirsi come tra le mani del Signore, avvertire la sua presenza»254.
Il termine «passione», congiunto o meno con «del popolo ebraico», avrà una
ricorrenza non marginale in Levinas, sulla quale ritorneremo nel terzo capitolo di
questo studio255; esso ci sembra qui presentarsi in un contesto essenziale. La sua cancellazione e sostituzione con quello più neutro di passività, ha a nostro avviso il significato di enfatizzare maggiormente il riferimento a un contesto biblico, il Capitolo
53 di Isaia, riferimento nel quale prende corpo quello che recentemente Dan Arbib ha
chiamato lo «schema emozionale»256 della prigionia, ovvero il concetto dell’elezione
della sofferenza.
Il testo in questione rappresenta una sintesi magistrale di quasi tutti i temi
principali che abbiamo avuto modo di rilevare nella nostra disamina critica dei Carnets, e a ben vedere compendia tutte le successive rievocazioni che lo stesso protagonista di quegli eventi avrebbe poi prodotto, nelle interviste e testi che abbiamo già
considerato nei primi paragrafi di questo capitolo: il senso della derelizione della prigionia, della durezza del lavoro e della monotonia dei giorni, della partecipazione ad
un comune destino universale in cui, malgrado la segregazione, il prigioniero israelita poteva sentirsi parte di un destino di sofferenza universale. La peculiare e privilegiata condizione di poter godere, pur entro questo spazio di cattività, di momenti di
della bontà…» (TI, p. 33); «La coscienza della morte è la coscienza del continuo aggiornamento della
morte, nella fondamentale ignoranza della sua data» (TI, p. 138, ccnn).
253
CCAI, p. 213, nota.
254
CCAI, p. 213.
255
La seconda ricorrenza, cruciale, la troviamo in uno scritto del 1957, «Una religione da adulti», ora contenuto in Difficile libertà: «Tra i milioni di esseri umani che vi trovarono miseria e morte,
gli ebrei hanno fatto l’esperienza unica di derelizione totale. Hanno conosciuto una condizione inferiore a quella delle cose, un’esperienza di passività totale, un’esperienza di Passione. Il capitolo 53 di
Isaia ha consumato tutto il suo significato, per loro» (DL, p. 28, ccnn).
256
D. ARBIB, «“L’élection de la souffrance”. La captivité de l’Israélite comme “schema émotionnele”», in AA.VV., Levinas et l’expérience de la captivité, cit., pp. 31-47.
70
meditazione sulle proprie sofferenze, con le «difese»257 della moralizzazione e della
razionalizzazione: «Quando la sofferenza fisica non è morale, essa fa spazio a ragioni
morali, si permette il lusso di pensieri di consolazione»258.
Ma l’avvertimento della segregazione razziale, pur entro un comune destino
di reclusione condivisa, prevale, e la prigionia diventa qui «una coscienza del giudaismo acuta come uno spasmo [aiuguë comme une crispation]259», aggiungendo «un
significato particolare260» alle sofferenze che il prigioniero condivideva con i suoi
compagni non ebrei. La sorte comune dei correligionari europei era nota:
«Molto presto le notizie delle persecuzioni, che schiacciavano gli
israeliti in tutti i paesi occupati, avevano raggiunto i campi. Lettere indirizzate
ai genitori, alle mogli, alle sorelle, tornavano indietro con la scritta: partito
senza lasciare indirizzo. Coglievamo l’eufemismo. Il giorno di arrivo del corriere diventava giorno di angoscia. Si conobbe in Germania, molto prima che
in Francia, la sorte di tutti questi “partiti senza lasciare indirizzo”. Sapevamo
dello sterminio in massa degli ebrei in Europa orientale. Non abbiamo mai
desolidarizzato»261.
Il particolare della sparizione dei cari attraverso la non risposta ad una lettera,
simboleggia affettivamente, con i tratti di una acutezza estrema, la morte di altri come incapacità di rispondere, il silenzio che rimane al sopravvissuto e che tramuta la
propria sopravvivenza in responsabilità e memoria262. Il concetto di solidarietà è un
enfasi della relazione che oltrepassa il patire-con; nodo impossibile da rescindere,
eteroaffezione traumatica che costituisce la soggettività del superstite come sopportante il carico della vita degli scomparsi; come abbiamo già letto: «Gli ebrei prigionieri si sentivano beneficiari di un differimento [sursitaires] della morte, che planava sulle loro risa come un’ombra familiare».
257
In senso psicoanalitico.
CCAI, p. 209.
259
Ivi, p. 210.
260
Ibidem.
261
Ibidem.
262
In una lezione alla Sorbonne del 1975, Levinas alluderà ai morti come «partiti senza lasciare
un recapito» (DMT, p. 50).
258
71
Il senso della dilazione della morte e dell’essere superstiti, come vedremo, caratterizza uno sfondo affettivo che non possiamo relegare tra parentesi, ma che influenzerà in maniera fondamentale l’ulteriore speculazione levinassiana. In questo
testo esso appare come un germe, trasfigurato quasi subito in una prospettiva religiosa. Levinas, infatti, racconta di come, nonostante la condizione di emancipazione e
secolarizzazione di molti ebrei prigionieri, l’inerzia forzata del campo avesse indotto
in essi la paradossale possibilità di exercitia spiritualia atti a far assumere comunque
un contegno, un punto di vista, rispetto al senso della tragedia che su di essi gravava:
l’attesa del martirio. I prigionieri, infatti, erano strappati dalla propria precedente
quotidianità, per essere condotti al cospetto della propria solitudine e finitezza essenziale:
«Una condizione senza mondo esterno; nessun legame con
quell’insieme di regole, di usi fissati, e autorità riconosciute che si chiamano
civiltà; l’individuo, di fronte a un domani carico di ignoto e di minacce senza
alcun soccorso umano, non è forse una solitudine davanti a Dio, anche se per
orgoglio o pregiudizio egli non osa pronunciare il suo nome? Situazione che
era comune ai prigionieri e ai deportati; ma se per il deportato il martirio era
immediato, il prigioniero aveva il tempo di prepararvisi»263.
La differenza tra il deportato e il prigioniero viene qui ad imporsi per la prima volta nei testi levinassiani, a denotare una differenza accidentale pur in una comunione essenziale di destino: il martirio. Tale termine appare qui, ci sembra, per la
prima volta nelle carte della prigionia; esso sarà, poco dopo, ulteriormente specificato, con l’evocazione della sua denominazione ebraica: Qiddùsh-ha-Shem.
L’idea del «lasso di tempo», del «frat-tempo», dell’intervallo tra la coscienza
della morte e la sua consumazione, costituirà oggetto di ulteriore riflessione, come
vedremo, nei successivi testi levinassiani, ma è indubbio che il luogo della sua primitiva genesi deve essere collocato all’interno di una lettura della propria esperienza di
prigionia. Come già abbiamo notato commentando precedentemente le testimonianze, sia quelle immediatamente consegnate ai Carnets sia quelle riferite in seguito ai
263
CCAI, p. 211, ccnn.
72
suoi interlocutori, sembra che Levinas accompagni sempre la sua esperienza di prigionia con quella della possibilità di una sospensione sabbatica del flusso d’esistenza
feriale, al fine di riacquisire una coscienza. É indubbio che questo documento che
stiamo leggendo espliciti ampliamente questa circostanza: «Tra l’uomo e la sua sofferenza c’era come un intervallo, che permetteva di assumere un atteggiamento dinanzi al dolore, prima di esserne afferrati e dilaniati. In questo intervallo, s’introduce
la meditazione; è qui che ha inizio la vita spirituale»264.
Vita spirituale non immediatamente sinonimo di vita religiosa, ma comunque
già possibilità di interrogazione sul senso del proprio dolore. Dato però il carattere
specifico in cui si attua questo «brusco risveglio della coscienza», tale interrogazione
non poteva essere disgiunta dalla considerazione del senso peculiare della sofferenza
ebraica.
La costrizione esterna costituiva dunque una possibilità inaudita di ritrovamento dell’essenza storica del popolo ebraico, attraverso l’interrogazione sul senso
del proprio dolore. La condizione di prigionia costituiva una testimonianza forzata di
Teshuvàh, di conversione e ritorno al giudaismo. È interessante che l’essenza del giudaismo sia qui ricapitolata da Levinas attraverso il filtro di un luogo biblico di eccezionale spessore simbolico, cioè quello della «Aqedah (legamento) di Isacco», noto
nell’ambito cristiano come il «sacrificio di Abramo»:
«Quel che io amo di più, leggendo il racconto biblico di Abramo che
va ad immolare Isacco, è immaginarmi i tre giorni nei quali padre e figlio
camminano verso il luogo indicato dal Signore, nei quali essi hanno tutto il
tempo per misurare l’evento in cui sono impegnati; il silenzio di quei tre giorni, rotto soltanto nell’ultima tappa da una domanda del figlio e dalla risposta
del padre, con tutto quello che il dialogo lascia sottinteso. È grazie a tali "ritardi di strada" [delais de route] che la prova diventa feconda. È in virtù di
tutto quello che la miseria del prigioniero aveva di sopportabile, che essa è
potuta diventare una presa di coscienza del giudaismo, germe possibile di una
264
Ibidem.
73
futura vita ebraica che il deportato, da parte sua, ha conosciuto come tortura,
come morte e come Qiddùsh-ha-Shem».265
Quel che ci interessa qui valutare non è tanto il senso della peculiare lettura
levinassiana del passo in questione (sulla quale torneremo nell'ultimo capitolo),
quanto piuttosto l’automatismo della connessione tra senso della propria esperienza e
questo specifico brano biblico. È indubbio che Levinas voglia far risaltare maggiormente l’aspetto della «prova», nell’analogia tra esperienza vissuta personale-collettiva e racconto biblico. Ma non è senza conseguenze, a nostro avviso, che l’elemento
della prova si inserisca all’interno del quadro di un racconto di sacrificio (sia pure di
«sacrificio interrotto»).
Al di là di qualunque considerazione ulteriore, che dovremo portare nel prosieguo della nostra trattazione, circa il peculiare senso che in Levinas attribuisce alla
categoria di sacrificio, alla luce della sua recezione dello specifico significato nella
tradizione rabbinica, è indubbio che l’occorrenza di una tale costellazione simbolica
costituisca un indizio indubitabile della sua centralità, almeno implicita, nel quadro
del suo pensiero. Lasciando alla successiva trattazione la necessaria elucidazione di
questa ipotesi, ci pare però, in questa sede, almeno opportuno rilevare la funzione
dell’evocazione del brano, per descrivere sia il carattere di «prova», attraversata dai
prigionieri ebrei superstiti, sia soprattutto la modalità della lettura dell’intera esperienza dello sterminio.
È infatti ormai chiaro che in questo testo Levinas si stia misurando non solo
con la prigionia, ma soprattutto con lo sterminio, ovvero con la prima come eccezione del secondo. Questo documento è quindi il primo testo in cui appare il confronto
di Levinas con il senso di quella che poi sarà chiamata Shoah. Essa viene interpretata
come tortura, morte e Qiddùsh-ha-Shem, mentre l’esperienza dei prigionieri viene interpretata come dilazione del Qiddùsh-ha-Shem e, in quanto tale, come prova.
Notiamo di sfuggita che il nome Auschwitz non è ancora menzionato (esso
sarà portato per la prima volta in Hommage à Berson - 1946)266, ma è evidente il ten-
265
Ivi, p. 211.
«Auschwitz gli fu risparmiata», dice Levinas riferendosi a Bergson, di cui scrive un elogio
funebre (CCAI, p. 219).
266
74
tativo, almeno implicito, di rendere conto della totalità di quell’esperienza attraverso
le categorie di prova e martirio.
Nell’orizzonte del martirio, e come sua dilazione e attesa, è dunque descritta,
nel testo che stiamo leggendo, la vita dei prigionieri. Non tutti certo riscoprirono la
fede ebraica, ma tutti furono costretti a scontrarsi con la persecuzione che si venivastoricamente compiendo nei loro confronti.
«Noi avevamo dunque il tempo di chinarci sulle nostre sventure, di interrogarci; alcuni andarono più lontano. Costretti al loro giudaismo, vi cercarono rifugio. La storia ebraica, l’ebraico, la Bibbia, parvero degni d’interesse
e di studio. E anche gli uffici religiosi divennero possibili. […] Voglio raccontarvi qualcuno di questi momenti eccezionali, vissuti durante quegli uffici
di prigionia, in cui tutto il significato, tutto il contenuto, del giudaismo apparve come in un compendio. Eviterò di profondermi in un facile lirismo
sull’atmosfera di quei culti. Una riunione di dieci volontari in una camera, in
mezzo ai letti illuminati dalle lampade a petrolio – quando c’era del petrolio –
o, da lampade ad acetilene, quando non ce n’era. Ma allora bisognava che
l’ufficio non fosse troppo lungo, perché la fiamma di una lampada ad acetilene si spegne presto, soprattutto nelle vecchie lanterne di bicicletta che si utilizzavano, e che erano sempre guaste. La fine del rito nell’oscurità. Non parlerò molto dei sorrisi sarcastici di quanti non vi prendevano parte, per obbligo
verso le proprie convinzioni e la loro appartenenza al XX secolo. Sempre uffici serali, perché dall’alba bisognava andare al lavoro. Tutti quegli uffici della sera, senza indomani. Tutti quei Maariv267 mai seguiti da Chacerith268. Tutti quei riti crepuscolari. Recita rapida di antiche preghiere. Ed ecco alcuni fedeli che, mormorandole a fior di labbra, rimandano nel loro spirito il senso di
quelle vecchie formule»269.
La metafora dei culti serali senza la certezza del mattino, rende ovviamente il
senso di angoscia per l'incombere della morte, la certezza di essere condannati in at267
268
269
Preghiera della sera.
Preghiera del mattino.
CCAI, p. 211.
75
tesa del compimento della sentenza, da un momento all’altro. Trauma estremo, che
Levinas tenta di elaborare attraverso il suo inserimento simbolico in uno schema
emozionale biblico: il capovolgimento della sofferenza in elezione.
Levinas non omette il dubbio, la lacerazione, la tragedia che accompagna la
prova. Ma egli non manca di rilevare quanto il rito, nella sua semplicità quasi meccanica, possa tranquillizzare al di là della consapevolezza del suo spessore teologico.
Le «vecchie formule» mormorate quasi macchinalmente, possono anche coabitare
con il dubbio estremo sulla presenza di Dio e sul suo potere nella storia, dinanzi alla
fede biblica della fedeltà di Dio nei confronti di Israele, e del trionfo del debole:
«Eravamo nel periodo dei grandi successi tedeschi […] la forza nel
suo trionfo più brutale, in quel trionfo che fa dubitare di tutto ciò che si era insegnato sul Bene e sul Male, su di un mondo governato da una Misericordia.
Qualcuno l’ha detto: bisogna credere che Dio non sia buono o che non sia potente. E le antiche formule liturgiche, raccontano storie inverosimili: Dio che
ama Israele con un amore eterno, il Signore che ci salva dalle mani di tutti i
tiranni – la potenza di Faraone inghiottita dai flutti e i canti di giubilo di Israele. Tutte quelle preghiere ebraiche, ripetizione infaticabile di un credo nel
trionfo del debole. Che pensare di questi discorsi antiquati quando, nel 1940 o
nel 1941, si è prigionieri israeliti in Germania, e quando li si comprende? Con
un’aria sdegnata, chiudere il libro di preghiere e andarsene via, ritenendo blasfemo chi si affretta a pregare? Ripetere quelle cose senza pensarvi, senza
credervi, con l’indulgenza che si può avere per l’ingenuità degli anni antichi;
pensare che quelle cose erano morte, e che si era senza dottrina e senza verità,
come si era senza protezione e senza futuro? Dal fondo dell’abisso implorare
il Signore, come Giona?»270.
Levinas a questo punto inserisce un elemento ulteriore, come abbiamo accennato, cioè l’elemento del capovolgimento della sofferenza in elezione. Questo capovolgimento avviene dal fondo del dolore, ed è descritto come un passo al di là, un
270
Ibidem.
76
trascendimento
oltre
l’invocazione,
una
percezione
del
nucleo
biblico
dell’associazione sofferenza/redenzione in cui, a suo dire, si compendia il giudaismo:
«Ma si poteva percorrere, per un istante, un breve istante, un gradino
ancora e uscire dal cerchio magico in cui ci si aggirava. Si poteva trovare una
terribile conferma a quell’amore di Dio nel dolore e nel dubbio stesso. Nella
passività (passione) [sic] totale dell’abbandono, nel distacco da tutti i legami
– sentirsi come tra le mani del Signore, avvertire la sua presenza. Nel bruciore
della sofferenza scorgere la fiamma del bacio divino. Scoprire il misterioso
capovolgimento della sofferenza suprema in felicità. Cos’è dunque in fin dei
conti il giudaismo [...], se non l’esperienza, a partire da Isaia, a partire da
Giobbe, di questo possibile capovolgimento – prima della speranza, al fondo
della disperazione –, del dolore in felicità; la scoperta nella sofferenza stessa
dei segni dell’elezione?»271
Continuando la sua trattazione, egli descrive la mutazione del contesto mondiale e il capovolgimento delle sorti belliche, così che, alla fine, quelle stesse interpretazioni paradossali e mistiche, con cui alcuni prigionieri fondandosi sui testi avevano dato un senso escatologico e messianico alla propria sofferenza, poterono essere di nuovo realizzate, e il senso letterale delle antiche promesse bibliche poteva essere ritrovato nella sua semplicità ingenua e infantile. Gli ebrei potevano dunque
nuovamente leggere «un testo arcaico e [...] prender[lo] alla lettera, senza adattarvi
un’interpretazione, senza cercarvi un significato simbolico…»272; ma soprattutto potevano di nuovo ritornare chiaramente a discernere il bene dal male, dopo la «confusione delle lingue» della filosofia e i cataclismi della storia che avevano rischiato di
confonderli273.
271
Ivi, pp. 213.
Ivi, p. 214.
273
«E quella stessa verità, quella verità insegnata dall’infanzia, per la quale l’ingiusto e il forte
soccombono e invece il debole e il povero sono salvati e trionfano, apparve meravigliosa nella sua
semplicità. Dopo molti anni, in cui il bene e il male si scambiarono di posto, e si cominciava ad abituarsi, dopo anni di wagnerismo, di nietzschismo, di gobinismo, da cui noi stessi eravamo stati minati,
ritornare alla verità dei sei anni di età, vederla confermata dagli avvenimenti mondiali – questo vi taglia il respiro, vi prende alla gola. Il Bene ridiventa Bene, il male, male. La lugubre mascherata è finita» (Ibidem).
272
77
Il documento si chiude ricordando che la storia verrà di nuovo a scompigliare
le coscienze e le esistenze, e che, in definitiva, il senso più profondo della fede ebraica riposa non sul precario ristabilimento dell’ordine e della pace, ma esattamente su
quel nucleo simbolico che i prigionieri avevano vissuto, per un istante e oltre il cerchio storico, nella percezione dell'elezione nella sofferenza.
Possiamo qui scorgere forse in filigrana il nucleo di quei pensieri che porteranno Levinas a parlare, nella Prefazione di Totalità e infinito, di «escatologia profetica»274 o di «soggettività tratta dalla visione escatologica che opponiamo
all’ontologismo della guerra»275.
Il documento appena analizzato rappresenta indubbiamente uno dei maggiori
contributi che la pubblicazione degli inediti ci consente di acquisire sulla elaborazione del successivo pensiero di Levinas. Basti solo ricordare quella che egli chiamerà
«religione da adulti» o «religione senza promessa», e che declinerà in senso etico.
Abbiamo finora analizzato il plesso traumatico relativo all’esperienza della
prigionia, dovremo ora volgerci alla considerazione del trauma della Shoah nei testi
di Levinas, tema che per altro abbiamo già visto affiorare sullo sfondo quanto siamo
venuti dicendo nello studio dei documenti di questo paragrafo, e in particolare
dell’ultimo appena considerato.
274
275
TI, p. 20.
TI, p. 23-24.
78
II. LA SHOAH E IL TRAUMA
79
Propriamente parlando,
le grandi «esperienze» della nostra vita
non sono mai state vissute
(SEHH, p. 245)
80
1. La Shoah come margine della filosofia negli scritti di Emmanuel Levinas
Normalmente si allegano le notizie biografiche nelle note in calce ai testi.
Leggendo gli articoli o i saggi su Levinas, ciò si riscontra assai di frequente, quasi
che l’estensore del saggio temesse altrimenti di passare ad un altro genere letterario,
la biografia appunto, in cui i testi figurassero da appendici. Si potrà obiettare che ribaltare l’uso sarebbe altrettanto unilaterale: si uscirebbe, infatti, dal campo filosofico,
e persino da quello storico-filologico, per collocarsi nel mero biografismo. Abbiamo
fin qui cercato di tentare una terza strada, mostrando come alcune categorie del pensiero levinassiano si comprendano meglio, acquistino un «riempimento» o una «concretizzazione» – tenendo sempre presente la circolarità di questo rinvio vicendevole
–
1
, se stagliate nell’orizzonte o sullo sfondo di un'esperienza singolarmente esemplare,
che, benché non tematizzata, anzi proprio perché non tematizzata, doni al testo il
proprio margine2.
Come è noto, questo lemma derridiano è riferito innanzitutto al problematico
concetto di limite della filosofia, ovvero al problema del «pensare il suo [della filosofia] altro: ciò che la limita e di cui essa rileva [reléve]3», quasi che la filosofia stessa
vivesse nel rapporto problematico, nella frontiera o nel crinale, dell’altro, limite che
1
Sul tema del rapporto di circolarità tra «struttura formale» e «concretizzazione» o «riempimento», in cui quella struttura formale «si produce», scrive Giovanni Ferretti: «Non si tratta di elaborare, quasi a priori, una struttura formale per trovarne la “concretizzazione” nella realtà (fenomenologicamente si direbbe: il “riempimento di significato”), bensì di un procedere circolare, che a partire
dall’esperienza vissuta cerca di dire circolarmente, nel modo più rigoroso possibile, la struttura formale, per poi tornare a chiarificare, con tale guida, l’esperienza in questione. Con la coscienza però che la
costante disequazione tra esperienza in senso forte e sua tematizzazione concettuale, impone di ripercorrere sempre di nuovo il circolo, arricchendo da vari punti di vista la descrizione concettuale, e nello
stesso tempo evidenziandone i limiti, al fine di indirizzare all’origine non più tematizzabile del senso,
a ciò che ha messo in moto la stessa riflessione concettuale che ha cercato di dire tale origine» (G.
FERRETTI, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier, Torino 1996, p. 118).
2
Sul tema del margine (marge) referenza obbligata è ovviamente l’opera di J. DERRIDA,
Marges – de la philosophie, Éditions de Minuit, Paris 1972 ; tr. it. di M. Iofrida, Margini – della filosofia, Einaudi, Torino 1997. Più specificamente, onde segnalare la posta in gioco strategica di questo
termine, vorrei qui riportare la seguente citazione, che mi sembra assai conferente con quanto orienta
la mia lettura di Levinas, ovvero quella di interpretare alcuni filosofemi come «sintomi… di qualcosa
che non ha potuto presentarsi nella storia della filosofia, e che, d’altra parte, non è presente in nessun
luogo…» (J. DERRIDA. Positions, Éditions de Minuit, Paris 1972; tr. it. di M. Chiappini e G. Sertoli,
Posizioni. Scene, atti, figure della disseminazione, Ombre Corte, Verona 1999, p. 15).
3
J. DERRIDA, Marges – de la philosophie, tr. it. cit., p. 6.
81
non può varcare, ma che in un certo senso deve varcare perché esso potrebbe «riserva[re] sempre un colpo in più al sapere filosofico»4. Intendiamo utilizzare questo
termine metaforico riferendoci innanzitutto al margine come limite del testo.
Il margine rende possibile, delimitandolo, l’apparizione del testo (scritto), ma
rende anche ostensibile, demarcandola, la sua interruzione, oltre la quale appare lo
spazio vuoto del non-scritto. Posti dinnanzi al problema dell’esperienza della Shoah,
ci troviamo nella situazione di muoverci in questo particolare margine, col rischio di
dire troppo o troppo poco, al fine di rischiarare il senso del testo.
La situazione è resa ancora più complicata dal fatto che mentre per la prigionia potevamo godere di dirette testimonianze dell’autore, anche precedenti ai documenti recentemente resi accessibili, (testimonianze certamente reticenti rispetto alla
peculiarità personale del vissuto, e talora razionalizzanti e moralizzanti – nel senso
psicoanalitico accennato nel primo capitolo – al fine anche di rendere possibile un
“padroneggiamento” e quindi una parziale e sempre reiterabile dicibilità), in questo
caso manca quasi del tutto una narrazione esplicita del vissuto traumatico dello sterminio, e vige invece una consegna del silenzio sulle emozioni e memorie, comune
del resto a una intera generazione.
D’altronde nemmeno il diario era destinato a essere pubblico, secondo una
tradizione accademica che relega in secondo piano o tende ad espellere dal discorso
filosofico propriamente detto gli elementi esistentivi e biografici, onde concentrarsi,
per dirla con Hegel, sulla «universalità astratta del concetto» (basti ricordare il motto
baconiano posto in epigrafe alla seconda edizione della Critica della ragion pura:
«De nobis ipsis silemus...»)5.
E tuttavia, il rapporto tra vita (e/o biografia) e pensiero, in Levinas, era già
forte nella sua giovinezza, come rivela la testimonianza del suo amico Maurice Blanchot, che ricorda come tra loro la filosofia fosse considerata una «compagna clandestina», oggetto di una «amicizia» che, se da una parte essi sentivano dovesse limitarsi
nelle proprie pretese, d'altra parte permeava e ossessionava «di giorno e di notte» le
loro esistenze, caratterizzandosi come la passione di un legame ambivalente, difficile
4
5
Ibidem.
Critica della ragion pura, tr. it. di P. Chiodi, Utet, Torino 2005, p. 37.
82
comunque da snodare6. Come afferma Massimo Giuliani, «va dunque posta la domanda se quello stare-a-latere, l’esser “a piè di pagina” in funzione pre-discorsiva e
quasi an-archica, non sia stato in qualche modo voluto e pianificato dallo stesso filosofo7»; cercheremo di rispondere a questa questione meta-critica nelle pagine successive, anche attraverso un rispettoso accostamento di alcune problematiche relative
alla rielaborazione della memoria traumatica.
Ma vorremmo anche, in questo contesto, prima di avviare una ricognizione di
alcuni testi levinassiani vertenti direttamente sulla Shoah, precisare un elemento che,
se non adeguatamente posto in chiaro, potrebbe dare adito a un fraintendimento essenziale sulla nostra ricerca. Vorremmo, cioè, evitare due estremi: da una parte escludere il portato biografico dalla testualità filosofica, dall’altra appiattire questa a quello. Nel primo caso infatti, si correrebbe il rischio di ridurre l’universalità della proposta levinassiana, nel secondo caso di non cogliere che questa universalità passa per la
particolarità esemplare di un vissuto, non soltanto personale, ma anche di una intera
generazione.
Pensiamo cioè di enucleare un contesto-sfondo, quasi una Lebenswelt 8. Intendiamo qui il termine «mondo della vita» in una accezione assai generale, quale ad
esempio quella che fornisce Remo Bodei, di «sfera di quanto non viene esplicitamen-
6
«Ma aggiungerò […] che da quando, più di cinquant’anni fa, […] ho incontrato Emmanuel
Levinas, una specie di evidenza mi ha persuaso che la filosofia era la vita stessa […] La filosofia sarebbe stata la nostra compagna di sempre, di giorno, di notte, magari perdendo il suo nome, diventando letteratura, sapere, non-sapere, o assentandosi: la nostra amica clandestina, di cui rispettavamo –
amavamo – ciò che non ci permetteva di restare legati ad essa, pur presentendo che in noi non c’era
nulla di desto, nulla di vigile sin nel sonno che non fosse dovuto alla sua difficile amicizia. La filosofia o l’amicizia. Ma appunto la filosofia non è affatto un allegoria» (M. Blanchot, Écrits politiques.
Guerre d’Algérie, mai 68, etc. 1958-1993, Lignes Éditions Léo Scheer, Paris 2003; tr. it di C. Colangelo, Nostra compagnia clandestina. Scritti politici (1958-1993), Cronopio, Napoli 2004, p. 147-48).
7
«Più che imperdonabile, irredimibile. E tuttavia», Comunicazione al Convegno Levinas e la
Shoah, Genova, Centro Primo Levi – 15 maggio 2011.
8
Per un’adeguata ricostruzione di questo lemma husserliano, in se stesso aporetico, ci è utile
segnalare il saggio di S. BANCALARI, Intersoggettività e mondo della vita. Husserl e il problema della
fenomenologia, CEDAM, Padova 2003. Come spiega Bancalari, l’aporeticità di questo concetto, il
mondo della vita, dipende dal fatto che da una parte esso viene definito in Krisis come il «puro mondo
della percezione», ovvero il nocciolo intuitivo universale e transculturale che può fungere da fondamento delle scienze perché «ha già, prescientificamente, le medesime strutture», ma d’altra parte esso
viene definito anche come l’orizzonte radicalmente intersoggettivo e culturalmente determinato, che è
di fatto dato in una molteplicità di Lebenwelten. Tale seconda accezione della Lebenwelt (orizzontesfondo dossico-storico) potrebbe coincidere con quella «esperienza pre-filosofica» di cui parla Levinas.
83
te tematizzato, che rimane sullo sfondo e permette a ciò che di volta in volta diciamo
o pensiamo di campeggiare sul non detto o sull’impensato»9.
Ma riteniamo anche che qualsiasi proposta filosofica non sia e non debba essere disincarnata da un concreto esperienziale ineludibilmente storicizzato (da Levinas chiamato il pre-filosofico) che costituisce la «messa in scena», la «concretizzazione» del suo contenuto concettuale.
Non si tratta assolutamente di delineare una sorta di agiografia filosofica di
un autore, in questo caso Emmanuel Levinas, perché così facendo si rischierebbe di
depotenziarne la proposta filosofica originale e universale. Forse (ma non ne siamo
sino in fondo convinti) neppure la categoria di testimone della Shoah si addice a Levinas, sia per il mero dato biografico del non essere stato egli stesso recluso in un
campo di sterminio, sia anche perché in lui non è esplicitamente esibita l’intenzione
di narrare direttamente una propria contingenza biografica trasparente all’esperienza
catastrofica del giudaismo europeo del Novecento.
Discorso ben diverso è quello relativo alla categoria di testimonianza, che acquisterà un significato peculiare e interno al pensiero levinassiano, in maniera certo
non disgiungibile dall’evento- Shoah, ma che potrebbe reggere di fronte ad altre
espressioni di quel «male radicale» di cui la storia porta il tragico carico10. In questo
contesto, non è neppure nostra intenzione discutere del complesso e dibattuto tema
dell’unicità della Shoah-Olocausto, come problema in quanto tale11.
Sarà nostro compito ineludibile, invece, ricostruire il senso e la natura della
Shoah-Olocausto12 per Levinas, proprio come sfondo-orizzonte entro cui collocare la
portata universale del suo pensiero etico.
9
R. BODEI, La filosofia nel Novecento, Donzelli, Roma 2006, p. 151.
Cfr. AE, pp. 187-191.
11
Per questo tema, si rimanda al libro di EMIL FACKENHEIM, To mend the World. Foundations of
Post-Holocaust Jewish Thought, 1982, 1989, 1994 by E. L. Fackenheim; tr. it. di M. Doni, TiqqunRiparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah, a c. M. Giuliani, Medusa, Milano 2010; ID., «Holocaust», in AA.VV., Contemporary Jewish Religious Thought (1987), tr. it., intr. e
postf. di M. Giuliani, Olocausto, Morcelliana, Brescia 2011.
12
Assumiamo i termini Auschwitz/Shoah/Olocausto come sinonimi, pur essendo consapevoli
del dibattito storico-filosofico e religioso attorno al problema della definizione del genocidio ebraico.
Per quanto riguarda la scelta del termine, oggi è maggiormente in uso quello di Shoah, indicante, come dice R. Di Segni, «il turbine che tutto travolge», mentre Olocausto «deriva dal greco per assonanza
all’ebraico biblico ‘olah e indica la vittima sacrificale interamente bruciata sull’altare. Il termine viene
usato per indicare che la vittima, cioè il popolo ebraico, è stato interamente (o quasi) distrutto; ma a
parte il fatto che l’annientamento, per quanto di dimensioni mostruose […] non è stato totale, la definizione comporta un interpretazione di tipo sacrificale dell’evento, ed è criticata da molti: per la sua
10
84
Si tratterà di percorrere, attraverso i testi delimitati dai margini, la via che
permette a quegli stessi testi di dire sempre di nuovo il loro senso, in maniera esemplarmente universale e mai esauribile13.
L’universalismo a cui ci invita la filosofia di Levinas non è mai disgiunto dal
particolarismo al limite della individuazione dell’io-nome-e-cognome, responsabile
insostituibilmente per altri. Per questa ragione, il rapporto tra vita e dottrina del nostro pensatore ci è sembrata uno dei temi più urgenti per un confronto critico con il
nostro autore. A questo proposito, è assai significativo il fatto che, già dalla sua primissima opera, La teoria dell’intuizione nella fenomenologia di Husserl, scritta per
la tesi di terzo ciclo a Strasburgo e pubblicata nel 1930, Levinas scrivesse:
«La vita, in cui bisogna cercare l’origine del reale – degli oggetti della percezione come degli oggetti delle scienze – rivela un carattere storico, nel senso in
cui si dice che “ogni uomo ha una sua storia”. […] Questa storicità, d’altra parte,
non è una proprietà seconda dell’uomo, che all’inizio esisterebbe e in seguito di-
connotazione teologica troppo forte ed esclusiva, e perché in ogni caso la definizione dell’evento non
deve contenere già un’interpretazione» (R. DI SEGNI, voce «Olocausto», in Enciclopedia filosofica,
Bompiani, Milano 2006, Vol. 8, p. 8088. Per la voce Shoah, v. anche, ivi, Vol. 11, pp. 10576-10578,
M. GIULIANI, «Shoah», e «Auschwitz nel pensiero ebraico. Frammenti dalle “teologie
dell’Olocausto»). In numerose interviste Elie Wiesel ha spiegato che l'utilizzo della parola Olocausto
(usata probabilmente per primo da lui) nasceva da una analogia tra il sacrificio di Isacco e la distruzione degli ebrei, ma egli in seguito vi preferì il termine Shoah. Lo stesso autore ha recentemente ritrattato la sua precedente preferenza per il secondo termine (che indicherebbe, nella Bibbia, una distruzione dovuta a eventi naturali), ritornando a preferire il primo (in riferimento al fumo dei forni che
va verso l’alto). Olocausto è tuttora maggiormente in uso nel contesto anglo-americano, mentre in
ambito europeo e israeliano si preferisce Shoah (Cfr. E. WIESEL- PH. DE SAINT-CHERON, Le mal et
l’exil: dix ans après, Nouvelle cité, Montrouge 1999; tr. it. di I. Landolfi, Il Male e l’esilio, dieci anni
dopo, Baldini & Castoldi, Milano 2001, p. 153). Dal punto di vista generale, ci sentiamo di preferire il
termine Shoah, condividendo quanto afferma Fakenheim: «Holocaust – Olocausto – è il termine maggiormente usato [in contesto anglo americano] oggi per indicare le politiche persecutorie contro il
popolo ebraico da parte della Germania nazista dal 1933 al 1945, anzitutto nella stessa Germania e in
seguito nell’Europa occupata dai nazisti, che culminarono nei campi di sterminio e nell’assassinio di
quasi sei milioni di ebrei. Nondimeno, il termine ebraico Shoah – distruzione totale – resta il più adeguato, dal momento che “olocausto” designa anche un sacrificio offerto sul fuoco [di quelli che venivano offerti nel Tempio di Gerusalemme]. È vero che, come gli officianti dell’antico culto di Moloch,
i nazisti tedeschi e i loro accoliti non tedeschi ad Auschwitz gettavano tra le fiamme i bambini ancora
vivi. Tuttavia non erano i loro figli che essi sacrificavano ma quelli degli ebrei, e per un atto non di
sacrificio ma di mero assassinio» (E. FAKENHEIM, «Holocaust», tr. it. cit., p. 17).
13
Condividiamo quanto scrive Roberto Mancini: «La riflessione di Levinas, disattende le aspettative di una comprensione lineare, che possa chiarire tutto solo in base all’esplicitazione delle sue
coordinate di fondo» (R. MANCINI, L’amore politico, Cittadella, Assisi 2006, p. 268).
85
verrebbe temporale e storico, ma la storicità e la temporalità formano la sostanzialità stessa della sua sostanza»14.
Come è noto, in questo libro Levinas, ispirandosi a Heidegger e Bergson, critica
sia l’intellettualismo husserliano, dal punto di vista della preminenza della conoscenza teoretico-rappresentativa come presupposto di ogni altro atto intenzionale, sia
l’atteggiamento sovrastorico della teoria di Husserl, che non coglierebbe la sostanzialità stessa dell’uomo in quanto storicità e temporalità15.
Ciò che però noi vogliamo sottolineare nel testo sopra citato, oltre la più volte notata vicinanza con la filosofia heideggeriana, è l’accenno alla singolarità della storia
di ogni uomo. Non si tratta qui, ci pare, del neutro Dasein, soggetto universale e anonimo dotato di storicità e temporalità, ma di quel singolo e irripetibile essere umano
la cui caratteristica è di avere una propria storia, e dunque un proprio nome.
Risuona cioè, in questo testo, dietro l’accenno alla singolarità, l’eco della categoria kierkegaardiana di singolo, che diventerà successivamente in Levinas, attraverso
la mediazione della Stella delle Redenzione16 di Franz Rosenzweig (avvenuta, secondo i biografi, a partire dal 193517), la categoria di nome proprio. Questa originale ripresa della categoria della singolarità idio-onomastica rosenzweighiana, assume tuttavia in Levinas una gravità eterocentrata, essendo il nome proprio, nome sempre
dell’altro, identità dell’indiscernibile nome e volto propri di Altri (Autrui)18. Nel libro
Nomi propri, Levinas scrive:
«I nomi propri – parole per mezzo delle quali si designa, ma per mezzo
delle quali si interpella l’altro uomo [Autrui] – non sono forse le prime parole
14
THI, p. 172, cn.
Cfr., G. FERRETTI, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier, Torino 1996, pp. 53-54.
16
Per Rosenzweig, infatti, ad un certo punto della storia del pensiero – e soprattutto con Kierkegaard e Nietzsche – «l’uomo nella pura e semplice singolarità della sua essenza individuale, nel suo
essere contrassegnato da nome e cognome, uscì dal mondo che si sapeva accessibile al pensiero, uscì
dal Tutto della filosofia» (F. ROSENZWEIG, Der Stern der Erlösung, Nijhoff, La Haye 1981; tr. it. di G.
Bonora, La stella della redenzione, (1a ed. Marietti, Genova 1988) Vita e Pensiero, Milano 20052, p.
10).
17
Cfr. S. MALKA, Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, tr. it. cit., p. 72.
18
Condividiamo quanto scrive F.P. Ciglia: «Si può forse caratterizzare l’intero itinerario filosofico di Emmanuel Levinas come un’ “insonne” ricerca dell’Altro, che – volto e nome proprio – è
sempre, innanzitutto, l’altro uomo» (F. P. CIGLIA, «Introduzione. Emmanuel Levinas o la non disperante crisi della “presenza”», in NP, p. VII).
15
86
che ogni linguaggio presuppone, persino quello che si ritrae nel silenzio del
puro pensiero – che sia quello a generare quest’ultimo oppure ad esserne generato – o che si isola nella scrittura? Il linguaggio ha forse mai – e persino
nel suo ritrarsi – cessato di rispondere ad altri uomini o di attenderli?»19
La raccolta di cui si compone Nomi Propri racchiude articoli nei quali
l’autore si confronta, nominandoli, con alcuni interlocutori «in un faccia a faccia in
cui, – scrive Ciglia20– mentre l’Altro si manifesta, l’interrogante si svela». Nomi di
persona «il cui dire significa un volto»21 – nomi e volti, però, mai tematizzabili, ma
sempre solo approssimabili (il Dire essendo approche: «un varco dallo Stesso
all’Altro, che è non-indifferenza dell’uno per l’altro»22).
In un universo culturale («la modernità»23) nel quale Levinas intravede la crisi di ogni valore umanistico e della stessa possibilità di accesso ad una significazione
autentica, dietro al mero gioco dei significanti (egli si riferisce al contesto strutturalistico), i nomi propri sono «ciò che resiste alla dissoluzione del senso, ed aiuta a parlare»24; il parlare essendo inteso come Dire «del Dono e del sacrificio»25.
Questo ultimo rilievo, forse, ci consente di comprendere come l’intenzione
levinassiana, pur non essendo in nessun caso auto-biografica, se accuratamente percorsa, non possa non esibire, nel dispiegamento della relazione interlocutiva, il dire e
il parlare dei e ai nomi propri.
E se ogni nome proprio è un volto «che parla»26 – e questo «discorso […] in
ogni istante disfa la forma che offre»27–, se cioè il nome-volto proprio non è mai
esauribile in un inglobamento tematizzante da parte del Medesimo ma sollecita ad
una relazione etica, allora proprio la questione dell’ostensione memoriale e testimoniale del nome proprio (e dei nomi propri) assumerà un portata centrale nella risposta alla Shoah, e costituirà una prospettiva ermeneutica ineludibile per approssimarsi ai testi, e soprattutto al testo cardine, Altrimenti che essere.
19
E. LEVINAS, «Prefazione all’edizione italiana», in NP, p. XIX.
NP, p. VII.
21
NP, p. 4.
22
NP, p. 5.
23
NP, p. 4.
24
Ibidem.
25
Ivi, p. 5-6.
26
TI, p. 64.
27
Ibidem.
20
87
AE, come vedremo, allude, designa e sollecita la referenza alla Shoah, pur
non tematizzandola, e lo fa nello sfondo della memoria e della testimonianza dei nomi propri dei morti. Il libro infatti si apre con la rievocazione dei milioni di senza
nome «vittime dello stesso odio dell'altro uomo, dello stesso antisemitismo»28, e allega subito dopo, in ebraico, i nomi propri dei familari (del firmatario del libro), per
poi concludersi con l’evocazione di quel Nome proprio impronunciabile, se non alla
terza persona, Illeità, che, come «Pro-nome, segna con il suo sigillo tutto ciò che può
portare un nome»29. Il Nome (Infinito) non è tematizzabile, nè «si annuncia nella testimonianza come tema»30, ma «viene a me [come] la mia propria parola»31, nella
«singolare obbedienza all'ordine di arrendersi»32: nella mia insostituibile testimonianza per i nomi e i volti propri degli altri.
2. L’interpretazione della Shoah nei testi levinassiani
È evidente che solo uno studio filologico, quale sarà possibile dopo la pubblicazione dell’intero corpus degli inediti, potrà adeguatamente istruire una ricostruzione
di un repertorio completo di luoghi in cui appaiano, nell’opera levinassiana, referenze a termini quali Auschwitz, Shoah, Olocausto. Rimandiamo, a questo proposito,
quanto afferma Jean-Luc Marion, nella Prefazione generale al primo volume delle
Œuvres, circa la modalità con la quale saranno pubblicati gli inediti, insieme cronologica e tematica33. Nel momento in cui scriviamo, ha forse quindi solo un significato
provvisoriamente ricostruttivo il fatto che la prima occorrenza del termine «Auschwitz» si trovi in un testo, rimasto allora inedito, contenuto nel volume I delle Œu-
28
AE, p. V.
AE, p. 229. «Sul nome di Dio» è il titolo di un saggio, assolutamente fondamentale, contenuto
in ADV (pp. 197-211), in cui Levinas si domanda: «La trascendenza del Nome di Dio in rapporto a
ogni tematizzazione non si trasforma in cancellazione, e questa cancellazione non è il comandamento
stesso che mi obbliga nei confronti dell’altro uomo?» (ivi, p. 207). Levinas sostiene la tesi paradossale
secondo la quale, mentre i nomi e cognomi umani devono essere ricordati, il nome (proprio) di Dio
non deve, né può esserlo, perché questo ricordo-tematizzazione significherebbe di fatto l’assassinio
degli uomini.
30
Ivi, p. 187.
31
Ivi, p. 188.
32
Ivi, p. 189.
33
J.-L. MARION, «Préface générale», in CCAI, p. VII.
29
88
vres: «Auschwitz gli fu risparmiata», dice Levinas riferendosi a Bergson, di cui traccia un elogio funebre34.
Ma una simile ricostruzione, che comunque potrebbe essere tentata in base alle
opere pubblicate (includendo in esse le numerose interviste), non è nelle nostre intenzioni. Piuttosto vogliamo delineare, attraverso testi a nostro avviso più significativi,
il profilo di una (polivoca) interpretazione filosofica della Shoah.
Possiamo però certamente dare per acquisito, sulla base dell’analisi iniziata nel
precedente capitolo, che tale interpretazione si vada dipanando a partire da quella che
abbiamo visto germinare nei testi della prigionia precedentemente esaminati, sia
quindi lo sfondo non detto dei testi immediatamente successivi, acquisisca spessore
dallo studio talmudico intrapreso con Shushani35 negli anni 1947-49, confluisca dapprima a vario modo nei testi confessionali, essendo invece piuttosto latente in quelli
accademici e in Totalità e infinito, per poi riaffiorare e dare i suoi frutti più maturi
quale ispirazione profonda dagli anni della scrittura di Altrimenti che essere, sino all’ultima fase della vita e dell’opera del filosofo.
Per la questione della periodizzazione dell’opera levinassiana, è nota la posizione
di Jacques Rolland, che ne distingue quattro periodi:
«Il primo va dal primo saggio sull’evasione (1935) agli scritti dell’immediato
dopoguerra (EE, TA) e pone capo a una nozione di essere già profondamente
estranea alla meditazione di Heidegger. La seconda culmina con TI (1961)
che interpreta l’essente come uomo e più precisamente come altro uomo. Nel
1974 appare AE, che domina dall’alto la terza parte e riprende di nuovo
l’ispirazione incompiuta della precedente. Mi pare innegabile che il libro sia
scritto sull’onda delle obiezioni radicali di Derrida (Violenza e Metafisica,
1963) e, in qualche modo, come una “risposta” ad esse. Si distingue infine
una fase che comincia verso la fine degli anni settanta…»36.
34
«Hommage à Bergson», in CCAI, p. 219.
Sulla originalissima figura di questo pensatore e Talmudista, si si veda di S. MALKA, Monsieur
Chouchani. L’énigme d’un maître du XXe siécle, J.C. Lattès, Paris 1994; sul rapporto di Shushani con
Levinas, cfr. ivi, pp. 109-119.
36
Cfr. J. ROLLAND, «Surenchère de l’étique» («Préface»), in Étique comme philosophie première, Rivage poche/Petit Bibliothèque, Paris 1998, p. 13.
35
89
In questa ultima fase, dominerebbe un rilancio iperbolico dell’etica a partire
dalla fondamentale esigenza di «rispondere al proprio diritto ad essere» in base al timore per la morte di altri.
Rispetto a questa periodizzazione, ci sembra però troppo unilaterale l’enfasi
posta sulla risposta a Derrida in cui, secondo Rolland, si leggerebbe la peculiare «difficoltà» del lessico di AE. Riteniamo invece, come cercheremo di mostrare, che molto importante sia anche, rispetto a AE e alle opere successive, l’elaborazione (in senso psicodinamico), del trauma della Shoah, proprio attraverso la peculiarità di un linguaggio «tropologicamente revulsivo» (Ricoeur), o se vogliamo traumatologico, che
del resto si mantiene anche nelle opere successive ad AE. In questa prospettiva, condividiamo sostanzialmente l’opinione di Stéphane Mosès, che ravvisa una sorta di
«scarto di tono o, in ogni caso, un lampante cambiamento» tra i due libri maggiori,
TI e AE, opera in cui «Levinas rinuncia a una visione ottimistica per una procedura
rigorosa, fatta di una spiritualità difficile e quasi masochistica. Improvvisamente è la
Shoah a delimitare tutto il suo pensiero, e poco importa che la Shoah non sia
l’oggetto di una riflessione sistematica…»37.
Come abbiamo cercato di mostrare nel primo capitolo, non è del tutto esatto affermare che Levinas scoprì la realtà dello sterminio dopo il ritorno dalla guerra, perché la presenza dei campi di sterminio era già nota dentro gli Stalag, a lui come agli
altri internati ebrei, come testimoniano gli scritti della prigionia già visti; è invece
vero che ne scoprì subito dopo la esatta e mostruosa portata cosmico-storica, nonché
immediatamente biografica, non appena venne a conoscere l’uccisione dei suoi cari
rimasti in Lituania38.
Subito dopo la liberazione dalla prigionia, infatti, (il 18 aprile del 1945 le truppe
alleate liberarono il suo Stalag), Emmanuel apprese l’orrore di ciò che era successo
in Lituania: tutta la sua famiglia, a Kaunas, era stata assassinata attraverso una sventagliata di mitragliatrice.
37
S. MOSÈS, Un retour au judaïsme. Entretiens avec Victor Malka, Éditions du Seuil, Paris
2008; tr. it. di O. Di Grazia, Un ritorno all’ebraismo. Colloqui con Victor Malka, Claudiana, Torino
2009, p. 91.
38
Su tutto questo ci ragguagliano le biografie di Lescourret (M.-A. LESCOURRET, Emmanuel
Levinas, Flammarion, Paris 1994, p. 125-27) e Malka (S. MALKA, Emmanuel Lévinas. La vie et la
trace, Jean-Claudie Lattes, Paris 2002; tr. it. di C. Polledri, La vita e la traccia, Jaca Book, Milano
2003, pp. 87-91.)
90
Un testo del 1961, che a sua volta cita una comunicazione di Jankélévitch, pare
riportarci un’eco diretta di quel tragico evento: «Abbiamo in comune di essere tutti
qui dei sopravvissuti. […] non si sa come! … una distrazione della Gestapo…[…]
Siamo passati, siamo arrivati dopo l’ultima sventagliata. Nelle nostre vite ci sono
state tragedie terribili che ci hanno segnato per sempre e che ci rendono differenti dagli altri…»39. Il dramma biografico potrebbe essere esemplarmente universale, nella
sua singolarità, rispetto a tanti altri sopravvissuti. Quello che qui conta è la risposta
nei testi che Levinas ne ha dato, e come ne ha operato una trasfigurazione filosofica40.
Per testi, intendiamo metodologicamente non distinguere, quanto a genere o destinazione, quelli filosofici da quelli confessionali, quelli accademici da quelli colloquiali, cioè le interviste.
Quanto a queste, non crediamo sia un caso che sia stato lo stesso Levinas a consentire la pubblicazione, anche nei suoi libri più strettamente filosofici, di alcune interviste41. In Levinas infatti, le interviste hanno un valore strategico, soprattutto quelle più strettamente filosofiche, i colloqui filosofici (si pensi a quelli contenuti in Di
Dio che viene all’idea, Tra noi, o Trascendenza e intelligibilità); essi si incaricano di
esibire un ri-dire e un disdire o chiarificare, sotto forma dialogica, il detto-scritto filosofico, e in questo consiste, per l’autore, una caratteristica essenziale del linguaggio filosofico, se non del linguaggio tout-court, come egli scrive all’inizio di Totalità
e Infinito42. Era infatti chiaro allo stesso Levinas che, dopo un lungo periodo in cui il
proprio pensiero si era costruito al di fuori dei circuiti accademici (se si esclude il
circolo di Wahl), in una relativa solitudine intellettuale – in cui, come ci ricorda
Malka, si «cercava non solo un pensiero, ma anche una lingua decisamente nuova»43
39
«Il pensiero ebraico oggi», pubblicato originariamente nella rivista l’Arche, nel 1961, ora in
DL, p. 203, cn.
40
È inoltre chiaro che il trauma era già stato preavvertito da Levinas, con la consapevolezza
della rottura di civiltà che si inaugurava con la «filosofia hitleriana», a partire dal 1933, data in cui
Hitler aveva preso il potere: l’anno seguente Levinas scriveva Quelques réflexions sur la philosophie
de l’Hitlerisme («Esprit», II, 1934, 199-208; tr. it. di A. Cavalletti, Alcune riflessioni sulla filosofia
dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1996).
41
Si pensi, a titolo d’esempio, DDVI che contiene un capitolo intitolato «Domande e risposte»
(pp. 103-123), o ai colloqui contenuti nelle pagine 251-262 e 267-278 di TN.
42
TI, p. 28: «…essa sta nell’essenza del linguaggio che consiste nel disfare, ad ogni istante, la
sua frase con la prefazione o l’esegesi, nel disdire il detto, nel tentare di ridire senza complimenti ciò
che è già stato mal inteso nell’inevitabile cerimoniale in cui si compiace il detto».
43
S. MALKA, op. cit., p. 153.
91
–, una volta raggiunta negli anni ‘80 la celebrità, ne urgesse un bisogno divulgativo e
chiarificatore.
A questo compito assolveranno soprattutto le due grandi interviste con Philippe
Nemo (1982)44 e François Poirié (1987)45 che, oltre al valore prezioso di introduzioni
generali all’opera, costituiscono anche le prime testimonianze autobiografiche su un
filosofo fino allora semisconosciuto al grande pubblico. Proprio nella seconda di
queste interviste, Levinas, solitamente molto riservato su questo aspetto, dichiara
apertamente la propria esperienza:
«Io non sono stato ad Auschwitz, ma in definitiva vi ho perduto tutta
la mia famiglia. Mi domando ancora adesso se non ci sia uno strano insegnamento – che Dio mi perdoni se dico: un insegnamento di Auschwitz –, secondo il quale l’inizio [commencement] della fede non è affatto la promessa, e la
fede non è di conseguenza qualcosa che si può predicare, perché è difficile
predicare – cioè proporre agli altri – qualcosa senza promessa. Ma lo si può
predicare a se stessi, si può chiederlo a sé: non dico che io arrivi sempre ad
accettarlo. Bisogna ricordare tutto ciò che le dicevo sulla simmetria e la dissimmetria: sopportare Auschwitz senza rinnegare Dio, forse è permesso di
chiederlo a se stessi. Ma forse ancora: non ci sarebbe proprio in questo atteggiamento l’offesa di contraddire la disperazione di quelli che andavano verso
la morte? Ci si può chiedere se anche a sé stessi sia possibile permettersi di
dire questo: una religione senza promessa»46.
Di questo testo colpiscono due elementi. Per rilevarli, ci occorre prima inserire il passo citato nel contesto in cui Levinas parla di Auschwitz, e cioè la risposta alla
domanda di F. Poirié: «Quale rapporto aveva lei con il giudaismo al momento in cui
ha incontrato Shushani?»47. Levinas risponderà, subito dopo le parole che abbiamo
citato, in questo modo: «Certamente la storia dell’Olocausto ha giocato un ruolo mol44
E. LEVINAS, Ethique et Infini. Dialogue avec Philippe Nemo, Fayard et Radio France, Paris
1982; Le livre de Poche, Paris 1986; tr. it. a c. di F. Riva, Etica e Infinito, Città Aperta, Troina 2008.
[EI]
45
F. POIRIÉ, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, La Manufacture, Lyon 1987.
46
Ivi, p. 130, ccnn.
47
Ibidem.
92
to più grande nel mio giudaismo che l’incontro con quest’uomo, ma l’incontro con
quest’uomo mi ha ridato fiducia nei libri»48.
Viene qui chiarito dunque che non fu Shushani a fare riscoprire il giudaismo,
come molte volte si è detto, a un Levinas che dopo l’infanzia e l’adolescenza avrebbe
abbracciato la professione di filosofo, ma semmai Shushani lo aiutò a ridonargli un
metodo per riscoprire la fiducia nei libri, e nei Libri (Talmud e Bibbia), che Auschwitz gli aveva fatto perdere o che comunque aveva messo seriamente in crisi, insieme a quella nella «ingenuità» letterale del loro contenuto di «promessa».
Abbiamo visto precedentemente come proprio la consapevolezza della patente contraddizione tra le antiche promesse bibliche e la tragicità dell’ora presente
esperita nel campo fosse uno dei temi cardini e che ritornano più volte nello scritto
L’expérience juive du prisonier, che abbiamo esaminato nel quarto paragrafo del
primo capitolo. Ma mentre lo scritto del 1945 poteva chiudersi con il recupero del
senso letterale di quelle promesse, nella loro semplicità ingenua e infantile, quasi che
la vittoria degli Alleati contro Hitler le avesse inverate, nel testo dell’intervista che
abbiamo sopra riportato domina il sentimento di un’impossibilità radicale di ritornare
a quella fede «ingenua e infantile».
Levinas, nel passo che stiamo commentando, evoca direttamente cosa rappresenti in concreto per lui Auschwitz: la scomparsa della propria famiglia; questa tragedia gli ha fatto non già perdere la fede, bensì cambiarne il principio e fondamento
(commencement): d'ora in poi non sarà più la «promessa», ovvero l’illusione «infantile» che Dio venga in soccorso degli uomini negli accadimenti storici, ma la pratica
delle mizvoth (il che, tradotto in chiave filosofica, significa l’etica) a costituire il fulcro della fede.
Accedere ad una fede «da adulti» significa iniziare da una fedeltà-responsabilità all’umano nell’altro uomo, senza la promessa che Dio si sostituisca a noi nel
«compimento», e sino al limite scandaloso della stessa idea che possa esserci un
compimento (messianico). In questo senso, dirà Levinas, «ognuno deve agire come
se fosse il Messia […] Il messianismo non è la certezza della venuta di un uomo che
arresta la storia: è il mio potere di sopportare la sofferenza di ognuno. È l’istante in
48
Ibidem.
93
cui riconosco questo potere e la mia responsabilità universale»49. Come lo stesso Levinas dirà altrove «per essere degni dell’era messianica bisogna ammettere che
l’etica ha un senso, anche senza le promesse del Messia»50 e, nel testo che stiamo
leggendo, tale è la modalità principale di sopportare Auschwitz senza rinnegare Dio.
Levinas custodisce questa propria risposta entro una riserva: essa non può essere
predicata, ovvero non può valere per gli altri ma solo per me. Il richiamo
all’asimmetria, qui appena accennato ma che diventerà via via onnipresente nella sua
opera, suggerisce l’esigenza di un’insostituibilità, di una non cedibilità ad altri del
gravame di questa pazienza. Si tratta come lo stesso Levinas dirà in molti luoghi, ma
che ci piace qui citare da un testo del 1957 intitolato Una religione da adulti, di
un’«elezione che non è fatta di privilegi ma di responsabilità»51 in cui «io non sono
uguale agli altri […] ma mi vedo obbligato dallo sguardo d’altri e di conseguenza
sono molto più esigente verso me stesso che verso gli altri»52.
Quanto abbiamo detto costituisce la prima notazione che ci premeva rilevare.
Ma, ed è questa la seconda notazione, nelle ultime righe del testo appare una riserva,
uno scrupolo che interrompe la buona coscienza di un etsi Deus (ontotheologicus)
non daretur e contraddice il potenziale di unilateralità insito nella prima risposta: c’è
una «seconda opinione che senza che si opponga alla prima rivela un altro aspetto
dell’idea»53. Essa è segnalata da un «ma forse ancora», che rivela la necessità di ulteriore scarto nell’assunzione dell’evento Auschwitz, in uno scrupolo, nella cattiva
coscienza che una soluzione unilaterale quale quella di un etica senza promessa predicata a se stessi può comportare. Essa infatti potrebbe «contraddire la disperazione
49
«Testi messianici», DL, p. 117.
EI, p. 108. Per comprendere il senso del messianismo in Levinas, occorre leggere soprattutto
i «Testi messianici», contenuti in DL, pp. 83-124. Toccheremo in seguito questo aspetto del pensiero
levinassiano (cfr. infra, cap. III, par. 5). Per un ulteriore approfondimento su questo tema si vedano:
AA.VV, Messianisme, «Cahiers d’Études Lévinassiennes», n. 4/ 2005; F. CAMERA, «Dal particolare
all’universale. Emmanuel Levinas e l’idea messianica», in Responsabilità di fronte alla storia. La
filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, a c. di M. Durante, il melangolo, Genova 2008;
D. GENTILI, «Etiche e politiche del messianismo: Emmanuel Lévinas e Jacques Derrida», in Il Messianismo ebraico, a c. di I. Bahbout, D. Gentili, T. Tagliacozzo, Giuntina, Firenze 2009 pp.13-32. Per
il concetto generale di messianismo ebraico, si vedano anche: D. BANON, Le messianisme, PUF, Paris
1998; tr. it. di V. Lucattini Vogelmann, Il messianismo, Giuntina, Firenze 2000; G. Scholem, The
Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.
M. 1971; tr. it. di R. Donatoni e E. Zevi, L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica, Adelphi, Milano 2008.
51
«Una religione da adulti», in DL, p. 39.
52
Ibidem.
53
«Testi messianici», in DL, p. 92.
50
94
di coloro che andarono a morte» ad Auschwitz», perchè nella presunzione di non
predicare che a se stessi, si potrebbe correre il rischio di non tenere abbastanza conto
della mostruosità dell’evento e di non farsi sufficientemente carico del rispetto verso
i morti nella disperazione. In fondo, una «religione senza promessa», si espone al
rischio di essere un’elevazione interiore, una forma raffinatissima di teodicea e quindi «cultura», di soluzione del problema-Auschwitz in un senso sublimatamente narcisistico.
Senza questa estrema riserva, richiamo alla necessità di accompagnare qualsiasi risposta con la preoccupazione ossessiva per la sua parzialità, con l’ombra tragica del non senso (l’ il y a), qualunque risposta diventerebbe ideologia, cultura, e
quindi «offesa di contraddire la disperazione di quelli che andavano verso la morte»,
e rifiuto di accollarsi la «responsabilità della responsabilità dell’altro».
Forse questa stessa consapevolezza è presente anche in un passo quasi contemporaneo al testo della intervista a Poirié, e precisamente del 1986: «L’incessante
possibilità del mostruoso, attestata dal fatto di Auschwitz – attuale sino alla fine dei
tempi –, simbolo o modello o riflesso del nostro secolo di orrore planetario, ci suggerisce il pensiero ossessivo che la riduzione del sensato all’assurdo è probabilmente
anche la determinazione filosofica dell’idea di cultura»54.
In fondo, anche una «cultura della Shoah», che si attesti in qualsiasi risposta
unilaterale, rischierebbe di compiere la stessa riduzione del potere della domanda
suscitata dalla Shoah; ma è lo stesso Levinas, collocandosi sulla scia dei maestri talmudici, a segnalare come spesso le domande (e le risposte) contraddittorie riflettano
[almeno] «due posizioni tra le quali il pensiero oscilla eternamente […ed] è importante che entrambe le posizioni appartengono al pensiero ebraico, perché entrambe le
concezioni esprimono l’uomo»55.
Come abbiamo visto commentando il passo della intervista a Poirié, lo scrupolo e il dubbio psicologico dell’uomo Levinas sulla propria risposta alla Shoah non
sono che un esempio di un modello ermeneutico che non cerca la sintesi, cara al pen54
«Determinazione filosofica dell’idea di cultura», in E. LEVINAS – A. PEPERZAK, Etica come
filosofia prima, a c. di F. Ciaramelli, Guerini e Associati, Napoli 1989, p. 62; testo originale: Détermination philosophique de l’idée de culture, AA.VV. Philosophie et culture/Philosophy and Culture,
Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie, Éd. du Befroi/ Ed. Montmorency, Montréal 1986,
pp. 73-82.
55
DL, p. 89
95
siero speculativo occidentale, ma cerca nei testi «la contraddizione e s’aspetta dal
lettore invenzione e audacia»56, e la cui cifra affettiva è l’attivazione di uno stato di
permanente interrogazione che si traduce nella mobilitazione, mai paga, verso una
esistenza oblativa unita alla richiesta di giustizia per le vittime. Sarebbe vano quindi
cercare risposte nette e univoche nel pensiero levinassiano, e quando si volesse forzare le risposte, ciò che si guadagnerebbe in sintesi si perderebbe in scavo filosofico.
Con questo non vogliamo dire tuttavia che Levinas non ricorra a determinate
strutture concettuali tipiche del pensiero «dopo Auschwitz» (e non solo del pensiero
ebraico) per confrontarsi con l’evento-Shoah, ma che anche esse debbano essere abbordare con molta accortezza, seguendo con prudenza, nella lettura dei suoi testi, la
loro strategia argomentativa di continuo disturbo-spiazzamento, che procede per reiterate affermazioni e interruzioni, negazioni e riserve, così da inquietare un lettore
frettoloso che, cercando una disambiguazione o una coerenza definitiva, sia indotto a
concludere seccamente in una direzione piuttosto che in un’altra.
Forse anche il problema della “collocazione” del pensiero levinassiano, al di
là o al di qua del discrimine accademico e/o confessionale, risente di questa difficoltà
suscitata dai suoi testi. Forse il modo per accostare il testo levinassiano è di lasciarlo
“lievitare” nella propria ambiguità, e percorrerlo lasciandosi perturbare dal traumatismo che vi è sedimentato, cercando di resistere alla tentazione del compimento, della definizione ultimativa, e accettandone la strategia dell’interruzione e del rilancio
iperbolico della domanda.
Questa coscienza dell’interruzione, cui costringe la lettura e l’ermeneutica dei
testi levinassiani, è del resto sollecitata dalla corrispondenza con «l’interruzione della
propria perseveranza ontologica cui costringe il volto dell’altro uomo»57. Si tratta di
un dérangement58 («disturbo», «sconvolgimento» o «scompiglio», a seconda delle
traduzioni) che si prova di fronte al testo e alla difficoltà di abitarlo in maniera paci-
56
QLT, p. 28.
«Dall’uno all’altro. Trascendenza e tempo» (1982), in TN, p. 184.
58
Per l’uso di questo termine, cfr. E. LEVINAS, Énigme et phénomène, in En Découvrant
l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 2006 (dalla 2a ed. 1967) pp. 283-302.
57
96
fica, che segnala una «filosofia della rottura»59 o una «fenomenologia dell’interruzione»60 come «ermeneutica della sollecitazione»61.
Come vedremo, l’esempio più lampante di questo spiazzamento o disturbo interpretativo – che solo «suscitando delle correlazioni tra diversi elementi e l’insieme»62 può essere compreso e mantenuto –, si prova prendendo atto dell’uso frequentissimo della categoria di «Passione», che in Levinas è assolutamente dominante
per dire il fatto della Shoah, e la cui interpretazione pone più di un problema, di ordine non solo interreligioso ma anche etico-filosofico. Tuttavia, siccome vi dedicheremo un intero capitolo, e questo sarà parte integrante del nostro tentativo di interpretazione della soggettività etica levinassiana, vorremo prima percorrere altri luoghi in
cui l’autore esibisce tre categorie religiose in cui il pensiero della tradizione ebraica
ha tentato una decifrazione del senso della persecuzione storica del popolo ebraico,
quelle dell’hester panim, dello tzimtzum e del riv 63.
Ma prima di proseguire, vorremmo ancora fermarci a cercare di chiarire quale
ruolo intercorre in Levinas tra il linguaggio religioso, l’uso di metafore religiose, e la
concettualità filosofica. Questo problema si incrocia e sovrappone con quello del
rapporto tra esperienza pre-filosofica e concettualità filosofica, rapporto, come già
abbiamo visto, di circolarità, essenziale a quello che Levinas stesso afferma essere il
suo metodo fenomenologico. Infatti, in un colloquio del 1988, egli afferma:
59
«Autrement que penser avec Levinas, une philosophie de la rupture», in M. DE SAINT CHEEntretiens avec Emmanuel Levinas 1983-1994, 2a ed., Livre de Poche, Paris 2010, pp. 127-134.
60
Come suggerisce David Sebbah, forse la strategia dell’«interruzione della fenomenologia»
costituisce per Levinas il proprio metodo autenticamente fenomenologico: «Levinas ci insegna che
l’etica è interruzione della fenomenologia, ma ci insegna anche che l’interruzione della fenomenologia
costituisce per così dire il cuore del fenomenonologico come tale – e non il suo al di là definitivo. Per
Levinas distaccarsi dalla fenomenologia avrà sempre il significato di esserle fedeli», F.-D. SEBBAH,
Lévinas, Les belles Lettres, Paris 20033, p. 132.
61
«Singolare metodo di esegesi! Sollecitazione del testo, se ce n’è una. Ma anche tentativo di
animare il testo per mezzo di corrispondenze e di echi» (QLT, p. 104, tr. modificata). Il concetto di
ermeneutica della sollecitazione è stato magistralmente sviluppato da David Banon: D. BANON, La
Lecture infinie. Les voies de l’intérpretation midrachique, Édition du Seuil, Paris 1987; tr. it. di G.
Regalzi, La lettura infinita. Il Midrash e le vie dell’interpretazione nella tradizione ebraica, Jaca
Book, Milano 2009 (in particolare nelle pp.145-158).
62
L’ermeneutica della sollecitazione «suscita delle correlazioni tra diversi elementi e
l’insieme, condizionando l’intellegibilità della parte con quella del tutto» (D. BANON, op. cit., p. 145).
Questo ci pare il modo più acuto e rispettoso per leggere Levinas, poichè si inserisce nel metodo levinassiano di lettura della Bibbia e del Talmud.
63
Per la ricognizione generale delle varie posizioni teologiche relative alla teologia
dell’Olocausto, cfr. M. GIULIANI, Auschwitz nel pensiero ebraico. Frammenti dalle «teologie
dell’Olocausto», Morcelliana, Brescia 1999 (contiene una bibliografia su questo tema, alle pp. 199206).
RON,
97
«Io uso apparentemente una terminologia religiosa: parlo dell’unicità dell’io
a partire dall’elezione alla quale gli sarebbe difficile sottrarsi, poiché lo costituisce, di un debito nell’io, più vecchio di ogni prestito. Questo modo di affrontare una nozione facendo valere la concretezza di una situazione in cui
essa originariamente prende senso, mi sembra essenziale alla fenomenologia»64.
Ci pare che tale affermazione ci aiuti a comprendere la non estrinsecità tra i
due ruoli in cui una certa tradizione accademica ha classificato Levinas: il fenomenologo e il talmudista o pensatore religioso.
Dal momento che Levinas stesso afferma che la terminologia teologica, il linguaggio simbolico religioso, è la concretizzazione delle nozioni della propria concettualità filosofica, e che, d'altra parte, essa trae da quella la propria «messa in scena», non è più necessario tutto quell’apparato di schermi, riserve e talora idiosincrasie che impediscono di prendere sul serio la simbolica biblico-religiosa tipica del linguaggio strettamente filosofico di Levinas, cercando di depurarla e quasi neutralizzarla in base a un supposto “nucleo duro” fenomenologico.
Non vogliamo dire che le lezioni talmudiche non siano significanti anche di
per sé come esempio di ermeneutica strettamente confessionale, né che opere come
Totalità e infinito e Altrimenti che essere non rientrino in un altro genere letterario, la
filosofia senza altra denominazione. Vogliamo solo dichiarare il modo in cui ci stiamo muovendo, e cioè non quello di commentare filosoficamente un’opera religiosa,
quale potrebbe essere una delle Letture talmudiche, ma di comprendere la profonda
circolarità tra concettualità filosofica, simbolica religiosa e esperienza-pre-filosofica
proprio nelle opere cosiddette filosofiche. Questo giustifica anche il motivo per cui
non prendiamo come fuoco del nostro studio i commentari talmudici levinassiani e le
opere cosiddette confessionali, ad eccezione di Difficile Libertà65, che riteniamo tuttavia un testo in cui emerge in maniera preponderante, sia pure con una prevalenza
64
«L’altro, utopia e giustizia», in TN, p. 272, ccnn.
Difficile Liberté. Essais sur le Judaïsme, Albin Michel, Paris 1963; 2a ed. rifusa e completata, ivi 1976; 3a ed. conforme alla 2a, Le Livre de Poche, Paris 1984; tr. it. di S. Facioni, Difficile Libertà, Jaka Book, Milano 2004. [DL]
65
98
del versante religioso (e politico-religioso), appunto questa circolarità tra vita–filosofia–ebraismo (religione). É proprio in DL (che contiene testi che vanno dal dopoguerra ai primi anni settanta) che vedremo l’autore cercare di dé-visager il fatto della
Shoah.
Chiarito questo, torniamo al linguaggio religioso e analizziamo le prime due
categorie suaccennate, lo hester panim, e lo tzimtzum.
Tzimtzum è un termine di ascendenza midrashica, poi ripreso nella dottrina
qabbalistica, designante l’autocontrazione di Dio che ha luogo prima della creazione,
affinché qualcosa di non divino potesse esistere. Il concetto fu reso famoso dagli insegnamenti di Ytzaq Luria (1534-1572)66, e in esso alcuni interpreti hanno ravvisato
un mito sulle origini del male: «l’autoesclusione di Dio dal vuoto permette al male di
far crescere le sue prime radici, mentre Dio rimane trascendente nei confronti di quel
male»67.
La successiva tradizione chassidica interpretò questo concetto in chiave essenzialmente psicologica: l’anima dell’uomo, una parte del “Dio che è in alto”, ha
necessità di spazio per poter sviluppare la sua identità separata, «Dio pertanto “si ritira” dalla mente o diventa a noi invisibile, così che abbiamo lo spazio per poter diventare persone degne di servire Dio per la nostra libera scelta»68.
Come scrive Paolo De Benedetti, lo tzimtzum è un modo di «pensare in maniera non punitiva il nascondimento del volto di Dio» 69, che la tradizione ebraica, in
base a Dt 31, 19 («e io in quel giorno nasconderò il mio volto»), identifica con l’appellativo di ha-Mistattèr («colui che si nasconde», Is 45, 15). Ed è proprio in questo
senso, ci pare, che il nostro autore utilizza la metafora del nascondimento di Dio, in
un testo emblematico, in qualche modo, dell’uso levinassiano della categoria in questione.
66
Cfr. G. SHOLEM, Die jüdische Mystic in ihren Hauptsrömungen, (1a ed. Rhein-Verlag, Zürich
1957; Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2000; tr. it. G. Rosso, Le grandi correnti della mistica ebraica, (1a
ed. il melangolo, Genova 1986) Einaudi, Torino 1993, pp. 268 e ss.
67
A. GREEN, These are the Words, Jewish Light Publishing, Woodstock, Vermont 1999; tr. it.
di R. Volponi, Queste sono le parole. Un dizionario della vita spirituale ebraica, Giuntina, Firenze
2002, p. 63.
68
Ibidem.
69
P. DE BENEDETTI, Quale Dio? Una domanda dalla storia, Morcelliana, Brescia 1999, p. 46.
99
Tale testo, del 195570, si intitola Amare la Torah più di Dio, ed è una recensione di un libretto presentato come un originale documento scritto durante le ultime
ore della resistenza del ghetto di Varsavia, e ritrovato nascosto tra i mattoni di una
casa, dove «l’ultimo sopravvissuto della sua famiglia consegna i suoi ultimi pensieri…in una finzione letteraria, in cui ognuna delle nostre vite di sopravvissuti si riconosce vertiginosamente»71.
Il titolo di questo libretto è Yossl Rakover si rivolge a Dio72. Levinas parla di
«finzione letteraria», perché il documento in questione fu in realtà scritto da Zvi Kolitz in ijddish, e pubblicato nel 1946 in Argentina, attribuito ad un anonimo estensore
ebreo polacco quale ricordo e testimonianza della Shoah.
Il dovere della memoria («zakhor», «ricorda!») è un comandamento della Torah, e implica il divieto di dimenticare fatti collettivi o eventi personali che abbiano
un risvolto collettivo. Come afferma Paul Ricoeur, se non bisogna dimenticare è per
due ragioni: la prima è quella di «resistere all’universale rovina che minaccia le tracce stesse degli eventi»73, la seconda è di «continuare a onorare le vittime della violenza storica»74.
In questo senso, la tradizione ebraica ha prescritto la memoria come comandamento religioso, testimonianza del quale si trova sia in fonti bibliche, sia talmudiche, sia liturgiche75. Nel documento di Zvi Kolitz, leggiamo: «Dio ha nascosto il
suo volto al mondo e in questo modo ha consegnato gli uomini ai loro istinti selvaggi; ritengo quindi assai naturale, purtroppo, che quando la furia degli istinti domina il
mondo, chi rappresenta la santità debba essere la prima vittima»76.
Dopo aver brevemente accennato al carattere del documento in questione, Levinas scrive un’affermazione perentoria, cioè di non voler «far spettacolo della Pas-
70
Pronunciato durante il programma radiofonico Écoute Israël, il 29 aprile 1955 (ora in DL, p
179).
71
DL, p. 180.
Z. KOLITZ, Yossl Rakover si rivolge a Dio, tr. it. di A. L. Callow, Adelphi, Milano 1997.
73
P. RICOEUR, Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen, Wallstein
Verlag, Göttingen 1998; tr. it. di N. Salomon, Ricordare, Dimenticare, perdonare. L’enigma del
passato, Il Mulino, Bologna 2004, p. 82.
74
Ibidem.
75
Si veda, a questo riguardo: Y. H., YERUSHALMI, Zakhor:Jewish History and Jewish Memory,
University of Washington Press, Seattle and London 1982; tr. it. di D. Fink, Zakhor. Storia ebraica e
memoria ebraica, Pratiche Editrice, Parma 1983.
76
Z. KOLITZ, Yossl Rakover si rivolge a Dio, cit., p. 17, cn.
72
100
sione delle Passioni [la Shoah] ricavando da tali grida inumane una misera gloria
d’autore e di regista»77.
Questa affermazione rivela la reticenza personale a descrivere in termini esatti, a raccontare nel dettaglio, quei tragici eventi. In questo pudore della memoria, caratterizzato, come vedremo, anche da motivi di natura psicologica, in Levinas ovviamente si riverbera il clima culturale di quegli anni.
La letteratura e la memorialistica sulla Shoah iniziò infatti a diffondersi, in
Francia e non solo, a partire dalla fine degli anni ’5078, e crebbe via via sino ad imporsi come un genere culturale e storiografico a sé stante, a partire dall’enorme clamore suscitato dal processo Eichmann del 1960, di cui è testimonianza l’avvio di un
dibattito pubblico ad opera di Hannah Arendt, con libro La banalità del male79.
Levinas pone al centro del suo articolo una domanda centrale, cui corrisponde
una risposta apparentemente obbligata:
«Che significa questa sofferenza d’innocenti? Non testimonia forse di un
mondo senza Dio, una terra in cui solo l’uomo misura il bene e il male. La
reazione più semplice, la più comune, consisterebbe nel finire nell’ateismo.
Una reazione sana a tutti quelli a cui un dio, un po’ elementare in verità, fino
a quel momento distribuiva premi, infliggeva punizioni o perdonava colpe e,
con la sua bontà, trattava gli uomini come eterni bambini»80.
77
DL, p. 180.
Per la Francia, il libro di Robert Antelme L'Espèce humaine fu un esempio emblematico di
questa tardiva recezione, o pubblicità, del tema in oggetto. Inizialmente pubblicato nel 1947, a partire
dal 1957, data della seconda edizione, fu ripreso dalla critica, studiato, premiato e infine considerato
come un classico della letteratura nata dai campi di sterminio. La nuit di Elie Wiesel, apparve in Francia nel 1955. Fondamentale fu anche la pubblicazione, nel 1959 di Le Dernier des Justes, ad opera di
André Schwarz-Bart. Del 1985 è il maggiore documentario mai prodotto sul tema, di Claude Lanzman, Shoah. Iniziato nel 1974, questo si può considerare il contributo che rese il tema dell’Olocausto
all'ordine del giorno nella discussione pubblica francese. La traduzione francese di Se questo è un uomo di Primo Levi sarà invece tardiva (1987). Per una ricostruzione di alcuni motivi della ricezione alla
ricezione della Shoah da parte della cultura, rimandiamo all’opera di ENZO TRAVERSO, La Shoah e gli
intellettuali, Il Mulino, Bologna 2004.
79
H. ARENDT, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1a ed. 1965); tr. it. di
P. Bernardini, La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 1964. Per gli effetti del libro della Arendt, cfr. I. ZERTAL, Ha’ Umah ve Ha’Mavet, Historia, Zikaron, Politika, Dvir
Piblishing House 2002; tr. it. di P. Arlorio, Israele e la Shoah. La nazione e il culto della tragedia,
Einaudi, Torino 2001.
80
DL, p. 180.
78
101
La domanda sul dolore degli innocenti, propria della teodicea, pone in causa
l’ingenua fede verso un dio «da bambini», cui sembra connesso però non solo
l’atteggiamento infantile, ma che quello apparentemente demitologgizzante della ontoteologia81. Levinas risponde dunque preventivamente ad ogni possibile lettura punitiva del significato della Shoah, facendo eco, nei secoli, alla risposta di Giobbe ai
suoi interlocutori che gli avevano imputato di essere punito per colpe meritate.
Questo tipo di risposta, a prima vista scandalosa, è pure stata allegata da alcuni pensatori ebrei, che hanno visto in Auschwitz la giusta punizione di Dio per i peccati del suo popolo. Si pensi, per fare solo un esempio, a Yoel M. Teitelbaum, che in
due libri del 1959 e del 1967, individua nella Shoah un castigo di Dio per la volontà
degli ebrei di volere la ricostruzione di uno stato ebraico, ovvero per l’impresa sionista. La Shoah, in questa lettura, sarebbe la punizione inflitta da Dio ai figli di Israele,
per mezzo degli idolatri, i sionisti, resisi colpevoli di aver voluto «forzare la fine», e
dei nazisti, accomunati, gli uni e gli altri, nello stesso rango di strumenti divini di punizione82.
Ma Levinas contesta, ci pare, anche un’altra lettura, che sempre in ambito
ebraico, questa volta chassidico, è stata ed è tuttora portata della Shoah, quella cioè
che lega la Catastrofe al concetto di chevle mashiac («doglie del messia»), come se la
sofferenza ebraica fosse servita per far terminare la Galut (esilio) e far affrettare il ritorno nella terra promessa attraverso la costruzione dello Stato di Israele83.
Il fatto però che Levinas neghi tanto una visione punitiva quanto una provvidenzialistico-redentiva alla Shoah, non vuol significare che, almeno in questo testo,
egli consideri la sofferenza della Shoah come destituita di qualunque significato. Se
81
Anche se in questo testo ciò non è non è esplicitato, Levinas lascerà intendere chiaramente,
come vedremo, che l’idolo o ipostasi razionale della tradizione metafisica fa tutt’uno con un dio a cui
è connessa una logica di premio-castigo, un dio, dunque, inserito in una economia di scambio.
82
Cfr. M. GIULIANI, Auschwitz nel pensiero ebraico. Frammenti dalle “teologie dell’Olocausto”, Morcelliana, Brescia 1998, pp. 169-173. Più dettagliatamente i sionisti avrebbero trasgredito
due dei tre scongiuri che secondo una interpretazione talmudica del cantico dei cantici, Dio avrebbe
imposto agli Israeliti: Il primo vieta Israele di «salire una montagna», (ovvero di ricostruire prima del
tempo lo Stato di Israele); il secondo di rivoltarsi contro le nazioni del mondo (questo sarebbe avvenuto con la volontà israeliana di entrare in guerra, dal '48 in poi per difendere Israele dall’attacco arabo.
Tale lettura rifletterebbe, come dice Aviezer Ravinski «il conflitto interiore che molti ebrei ortodossi
(charedim) vivono nello stato d’Israele» (Cfr. M. GIULIANI, op. cit., p. 171). Su questa lettura cfr. A.
RAVINTZKY, Ha-qetz ha-megulle u-medinat ha-Yehudim, Am Oved, Tel Aviv 1993, tr. it. di E.Z. Merlo, La fine svelata e lo Stato degli Ebrei. Messianismo, sionismo e radicalismo religioso in Israele,
Marietti 1820, Genova-Milano 2007.
83
Cfr. M. GIULIANI, op. cit., pp. 153 e ss.
102
infatti non è un errore negare il «Dio da bambini», è perché il vero significato del
monoteismo si rivela attraverso una fedeltà alla Torah di chi assume, nella solitudine,
tutto il peso della assenza di tale dio: «Un Dio per adulti si manifesta esattamente nel
vuoto di un cielo infantile»84. Ed è in questo contesto che Levinas introduce la figura
religiosa dell’hester panim («nascondimento del volto»):
«Il Dio che nasconde il volto non è un’astrazione da teologo, né
un’immagine da poeta. Rappresenta l’ora in cui l’uomo giusto non trova alcun appiglio fuori di lui, in cui nessuna istituzione lo protegge, in cui è rifiutata anche la consolazione della presenza divina nel sentimento religioso infantile, in cui l’individuo può trionfare solo nella sua coscienza, vale a dire
necessariamente nella sofferenza»85.
Molto è stato scritto su questa visione della fede ebraica di Levinas, che come
si può leggere dalle righe successive dell’articolo in oggetto, assume un registro semantico così radicale da divenire fedeltà alla Torah al di sopra di Dio stesso86 (si
pensi ad esempio agli studi preziosi di Caterine Chalier, Shmuel Wygoda, David Banon87), dove evidentemente la suddetta affermazione è da intendersi in senso iperbolico, giacché il dio che è al di sotto della Torah sarebbe il dio infantile, mentre il Dio
da adulti è quello che, invece di collocarsi in un rapporto che «non è una comunione
sentimentale nell’amore di un Dio incarnato», si dona in «un rapporto tra spiriti, attraverso la mediazione di un insegnamento, attraverso la Torah»88.
Ma qui ci interessa approfondire il nesso che la categoria religiosa del nascondimento di Dio ha con Auschwitz, mediato dalla relazione con la sofferenza. Nel
capoverso successivo a quello sopra citato, Levinas afferma quale sia il senso ebraico
della sofferenza:
84
DL, p. 180.
Ivi, p. 181.
86
Yossel dice ad un certo punto: «Lo amo, ma amo ancor di più la sua Torah […] E se anche
fossi deluso da lui e come disincantato, non smetterei comunque di osservare i precetti della Torah».
(cit. in DL, p. 182).
87
V. infra, Bibliografia.
88
DL, p. 181.
85
103
«Significato tipicamente ebraico della sofferenza, che in nessun momento assume il valore di un’espiazione mistica per i peccati del mondo. Sofferenza è la posizione delle vittime in un mondo disastrato, vale a dire in un
mondo in cui il bene non riesce a trionfare. Essa rivela un Dio che, rinunciando ad ogni pietosa manifestazione, fa appello alla piena maturità dell’uomo
totalmente responsabile»89.
Dunque, in questo testo la sofferenza non è presentata come «espiazione mistica per i peccati del mondo», nel senso di un “pagamento” che possa compensare
una colpa propria o altrui, o universalmente gravante sull’umanità90. Espiazione, in
altri termini, intesa nel senso di un sacrificio volontario, che attraverso l’accettazione
della violenza su di sé possa valere come riscatto, riparazione, debito da pagare verso
un Dio adirato per colpe umane.
Da questo punto di vista, ci pare molto pertinente la lettura proposta da Roberto Mancini sulla visione non sacrificale di Levinas, nel senso in cui il sacrificio è
interpretato e declinato nell’opera di Girard, cioè della vittimizzazione riparatrice ed
espiatrice91.
Che Levinas sia alieno da questa lettura economico-riparatoria del valore della sofferenza, e quindi da una lettura sacrificale nel senso girardiano, è altresì confermato da una esplicita pagina contenuta in Umanesimo dell’altro uomo (1972, ma che
contiene testi che vanno dal ’61 al ‘70). Qui Levinas dichiara che la «perdita di unità» che la cultura contemporanea avverte quale cifra del tempo presente, è assunta e
proclamata come «il paradosso della morte di Dio. Sicché la crisi del senso è sentita
dai contemporanei come crisi del monoteismo»92. Ma qual era la visione del monoteismo che la cultura occidentale aveva ereditato dalla grecità, e che è entrata in crisi? Levinas risponde:
89
DL, p. 181, ccnn.
«Qualche anno dopo, Levinas giunge sino a dire: «Non che si debba pensare ad
un’espiazione mistica compiuta eucaristicamente», riferendosi più direttamente alla visione teologica
Cristiana della passione di Cristo («Dall’ascesa del nichilismo all’ebreo carnale» [1968], in DL p.
280).
91
«Che cosa vuol dire espiazione? Benché l’autore sia convinto del valore positivo di una categoria pure così compromessa con la religione del sacro, non mi pare che egli si riferisca all’espiare
come a un pagare. Il registro semantico della categoria, più che economico, è giuridico» (R. MANCINI,
L’amore politico, cit., p. 278).
92
«Il significato e il senso», in UAU, p. 62.
90
104
«Un dio interveniva nella storia umana come una forza, sovrana, certo, invisibile all’occhio senza potersi dimostrare con la ragione, sovrannaturale, quindi, o trascendente; ma il suo intervento si collocava in un sistema di
reciprocità di scambi. Sistema che si sviluppava attorno ad un uomo preoccupato di sé. Il dio trascendente il mondo restava unito al mondo nell’unità di
un’economia93 […] una religione come questa […] e un dio siffatto hanno
perso influenza sugli uomini»94.
La constatazione della perdita dell’influenza della religione, e di un «dio» che
entra nel circuito sociale quale partner di un rapporto «economico» di reciproci
scambi, contrasta inoltre con l’interpretazione che dello schema del sacrificio avevano dato H. Hubert e M. Mauss; considerando la vittima scarificale come ipostatizzazione della società stessa, i due studiosi pensavano che il sacrifico consistesse
«nello stabilire una comunicazione fra il mondo sacro e il mondo profano mediante
l’intermediario di una vittima, vale a dire di una cosa distrutta nel corso della cerimonia»95.
Ma il significato del termine «espiazione» in Levinas (soprattutto in AE),
esclude l'idea del riscatto di tipo economico; esso è legato piuttosto alla peculiarità
del senso ebraico del «sacrificio espiatorio» che, in quanto interrotto con la caduta
del Tempio, cedette il passo, nel giudaismo rabbinico, ad una pratica religiosa caratterizzata dai tre pilastri della preghiera, del digiuno e dell’elemosina, cioè alla supererogazione etica96.
La sofferenza, continua il nostro testo, è «la posizione delle vittime in un
mondo disastrato», e disastrato non per accidens, quasi che nella Shoah, o in ogni altra tragedia storica, si palesasse un’eccezione a una regola di sostanziale positività
93
Ibidem.
Ivi, p. 83.
95
H. HUBERT- M. MAUSS, Essai sur la nature du sacrifice, «L’année sociologique» 1898 (pp.
29-138), tr. it. di V. Meneghetti Minelli, Saggio sul sacrificio, Morcelliana, Brescia 20022, p.86.
96
«La pratica religiosa degli ebrei, proprio come quella dei cristiani, si definisce ora [sc. dopo
la caduta del Secondo Tempio, nel 70 d. C.], per lo meno in teoria, attraverso la supererogazione: la
nuova pratica può sicuramente sostituire i sacrifici; a essere apprezzate da Dio sono la contrizione del
cuore e l’intenzione, l’una e l’altra per natura invisibili» (G.G. STROUMSA, La fin du sacrifice. Les
mutations religieuses de l’Antiquité tardive, Odile Jacob, Paris 2005; tr. it. di V. Zini, La fine del sacrificio. Le mutazioni religiose della tarda antichità, Einaudi, Torino 2006, p 73).
94
105
dell’andamento storico, bensì, ci pare, per essenza stessa della storia, che, in quanto
completamente nella disponibilità dell’uomo, costituisce lo stesso «disastro» che
apre la (dis)misura della responsabilità di ogni «giusto sofferente» (anche non ebreo).
Contro ogni «lettura edificante»97 di Levinas, Stéphane Mosès ha ribadito che
il pensiero levinassiano si apre con «un terribile realismo, una coscienza acutissima
della tragicità della storia»98. Lévinas avrebbe fatto, sulla scia di Rosenzweig, «riferimento ad Hegel per interpretare la guerra come evento metafisico fondamentalmente agonale del reale, dunque della Ragione stessa»99. Leggendo le prime pagine di
Totalità e infinito, non si può che confermare tale giudizio100; in esse Levinas «delinea una fenomenologia della guerra in cui le esperienze concrete che la caratterizzano sono ricondotte alla loro essenza»101, e in cui «la visione dell’essere che si rivela
nella guerra si fissa nel concetto di totalità che domina la filosofia occidentale. In essa gli individui sono ridotti ad essere i portatori di forze che li comandano a loro insaputa»102. In questa visione, Levinas va oltre Rosenzweig, pur condividendone – per
opposizione – la visione della storia di ispirazione hegeliana, e va oltre perché, ad avviso di Mòses, situandosi all’interno della stessa logica hegeliana, egli smaschera
l’illusione di una protesta dell’io contro questa totalità, quale «proclamazione della
morale a partire dal soggettivismo puro dell’io»103.
Ma c’è un ultimo punto degno di nota, nel brano che stiamo commentando: la
sofferenza ha un valore di rivelazione su Dio stesso. Un Dio che, come Levinas aveva scritto in un testo precedente, «si è svuotato [e] ha creato qualcuno a cui poter parlare»104. «Svuotamento» o anche «contrazione» di Dio è la traduzione di quello che
la tradizione ebraica denomina «tzimtzum». Già nei testi degli anni ’50-60, contenuti
97
S. MOSÈS, Au-delà de la guerre. Trois études sur Levinas, Éditions de l’éclat, Paris-Tel Aviv
2007; tr. it. di D. Di Cesare, Al di là della Guerra. Tre saggi su Levinas, il melangolo, Genova 2007,
p. 7.
98
Ibidem.
99
Ivi, p. 36
100
«La lucidità, apertura dello spirito sul vero non consiste forse nell’intravvedere la possibilità
permanente della guerra? […] L’essere si rivela al pensiero filosofico come guerra […] In essa la realtà fa a pezzi le parole e le immagini che la nascondono e finisce con l’imporsi nella sua nudità e nella
sua durezza. Dura realtà (anche se suona come un pleonasmo), dura lezione delle cose, la guerra si
produce come l’esperienza pura dell’essere puro nello stesso istante in cui brucia con le sue folgori i
veli dell’illusione» (TI, p. 19).
101
S. Mosès, Au-delà de la guerre. Trois études sur Levinas, tr. it. cit., p. 37.
102
TI, p. 20.
103
TI, p. 23.
104
«Simone Weil contro la Bibbia» (1952), in DL, p. 178.
106
in DL, la figura teologica dello tzimtzum è evocata da Levinas in stretta connessione
con il tema della responsabilità (come hanno magistralmente mostrato Catherine
Chalier105 e Stéphane Mosès106), attraverso la mediazione dell’opera di Haïm di Volozin (1759-21). A colui che Levinas chiama «l’ultimo grande talmudista», lo stesso
filosofo lituano dedicherà successivamente tre importanti contributi: un apposito
saggio contenuto in Al di là del versetto [ADV]107 (originalmente apparso nel 1978);
una conferenza romana per l’«Istituto Castelli» (Ebraismo e kenosi [1985], confluita
poi in Nell’ora delle nazioni [NODN]108); ed infine, una Préface alla traduzione
francese della sua opera maggiore: Nefech ha-haïm («L’anima della vita»)109.
Secondo l’interpretazione levinassiana del Voloziner, «l’ebreo deve rendere
conto ed è responsabile di tutto l’edificio della creazione»110, proprio perché Dio si è
svuotato del suo potere e lo ha costituito come «una testa dura che sopporta
l’universo»111, capace quindi di una «responsabilità universale».
La contrazione (o kenosi) di Dio, è un evento originario insieme cosmologico
ed etico: «Dio si contrae prima ancora della creazione del mondo, per far posto, affianco a sé, all’altro da sé»112. Nella propria interiorità «non narcisista»113, l’uomo
porta dunque da solo la responsabilità del mondo, attraverso la pratica delle mizvoth,
dunque attraverso «l’etica».
Levinas interpreta, per il tramite del particolare («l’ebreo»), questo compito
come riuardante ogni singolo soggetto: «ogni uomo, in rapporto a tutti gli altri, ogni
uomo come soggetto»114, in funzione della condotta del quale, quindi, «Dio si associa
ai mondi oppure se ne ritira [...] L’uomo risponde dell’universo! L’uomo risponde di
altri [...dalla sua fedeltà o infedeltà alla Torah dipende...] la salvezza e la rovina dei
105
C. CHALIER, L’âme de la vie. Lévinas, lecteur de R. Haïm de Volozin, Aa.Vv., Lévinas, Le
Cahier de l’Herne, a c. di C. Chalier e M. Abensour, Éd. De l’Herne, Paris 1991, 2006.
387-397
106
S. MOSES, Un retour au judaïsme. Entretiens avec Victor Malka, Éditions du Seuil, Paris
2008; tr. it di O. Di Grazia, Un ritorno all’ebraismo. Colloqui con Victor Malka, Claudiana, Torino
2009, pp. 97-98; 99-109.
107
«A immagine di Dio» secondo Rabbì Chaim Voloziner, ADV, pp.237-255.
108
NODN, pp. 131-149.
109
R. HAÏM DE VOLOZINE, L’âme de la vie, tr. fr. e cura di B. Gross, Verdier, Paris 1986.
110
«Carte d’identità» (1963), DL, p. 76.
111
Ibidem.
112
ADV, p. 255.
113
ADV, p. 249.
114
NODN, p. 141.
107
mondi»115, cosicché «l’essere è, attraverso l’etica e l’uomo»116. «Più importante
dell’onnipotenza di Dio è la subordinazione di tale potenza al consenso etico
dell’uomo»117. La fedeltà alla Torah ebraica non sarebbe altro che la figura particolare in cui si concreta fenomenologicamente l’originaria e universale responsabilità
etica di ogni uomo, in qualunque religione, etnia o cultura egli si trovi; Levinas stesso segnala che quando Haïm di Volozin parla di «Israele», intende riferirsi all’intero
insieme del genere umano davanti a Dio118.
E dunque, riprendendo il nostro discorso, i due concetti ebraici di hester panim e tzimtzum risultano strettamente collegati, rivelanti entrambi, da una parte, una
verità su Dio e, dall’altra, la «posizione» (o condizione) antropologico-storica
dell’uomo. Circa il carattere di questa sofferenza, tuttavia, ci pare che vi sia, nei testi
di questi anni (i primi anni ‘50), una certa ambivalenza; infatti, pur essendo nettamente preponderante la definizione di essa come «passione», vi è almeno un luogo in
cui la sofferenza non viene qualificata come passione ma come «atto».
Leggiamo infatti sempre nel testo da cui abbiamo tratto la ultima citazione
(Simone Weil contro la Bibbia), contenente una dura polemica verso la pensatrice
francese, codesta affermazione:
«La sofferenza non possiede alcun effetto magico119. Non è a causa
della sofferenza che il giusto che soffre vale, ma a motivo della giustizia che
sfida la sofferenza. Sofferenza e morte sono termini della passione umana, ma
la vita non è passione. La vita è atto, la vita è nella storia. Storia che non discende dal peccato, ma dalla creazione dell’uomo»120.
115
Ivi, p. 142.
Ivi, p. 143
117
Ibidem. Nello stesso saggio del 1985 troviamo un’affermazione importantissima, su cui torneremo: «La sofferenza di Dio che soffre nella sofferenza dell’io» (NODN, p. 147)
118
«Occorre ammettere questa convenzione, l’umanità autentica è sempre sinonimo di Israele in
questo testo pensato ed esposto teologicamente. Sinonimo che non ha niente di “razzista” in un’opera
riferita alle Scritture, come la nozione di Israele non ha niente di esclusivo nel suo impiego corrente, e
significa un ordine aperto a tutte le adesioni» (ADV, p. 245, nota).
119
Anche questa ci pare un’allusione allo schema interpretativo di Hubert e Mauss, circa il contesto magico dello schema sacrificale, secondo il quale la sua forma fondamentale è una «azione magica
puramente oggettiva, accompagnata dalla distruzione del dono sacrificale» (J. HENNINGER, «Sacrificio», in The Encyclopedia of Religion, Mcmillan Publishing Company, New York 1986, ed. it.,
AA.VV., Enciclopedia delle religioni. Il rito. Oggetti, atti, cerimonie, Jaca Book-Citta Nuova, RomaMilano 1994, vol. 8, p. 531).
120
Ibidem, ccnn.
116
108
Qui ci pare che Levinas voglia stigmatizzare un atteggiamento, o almeno una
lettura, gnosticheggiante del cristianesimo da parte della Weil, ma più in generale di
un certo esistenzialismo, anche cristiano, atteggiamento che si ritrova anche, come
vedremo più oltre, nell’interpretazione dell’esistenza che lo stesso Levinas (e anche
Hans Jonas)121 individua in Heidegger, segnatamente nel concetto di Geworfenheit,
come «essere gettato» in una situazione ontologicamente negativa, a causa di una
colpa originaria.
«La vita è atto, la vita è nella storia», vuol significare che, quantunque sia la
storia a manifestarsi come essenzialmente violenta, la vita in sé non ha i caratteri di
negatività che una coscienza gnostica potrebbe intravedervi, essendo originariamente
creazione di un Dio che ha dato la stessa storia nella responsabilità dell’uomo, e in
quanto tale sempre esposta alla violenza dell’essere; caratterizzato, quest’ultimo, sia
dall’elemento della totalità speculativa sia dall’insensatezza dell’il y a. Pochi anni
dopo della stesura del testo che stiamo vedendo, in TI, Levinas ribadirà questo concetto, associandolo a quello di «godimento»: «Vivere è godere della vita. Disperare
della vita ha senso solo perché la vita è originariamente felicità. La sofferenza è un
venir meno della felicità, non è esatto dire che la felicità è un’assenza di sofferenza.
[…] La felicità è attuazione…»122.
E proprio per questo motivo, la storia è il luogo dove può rivelarsi la qualità
dell’uomo giusto che, in ragione della fedeltà alla Torah (e al volto), sfida la sofferenza attraverso il suo stesso soffrire. La posizione della giustizia come sofferenza
del giusto, sarà uno dei temi cardini del pensiero tardo di Levinas, soprattutto in AE e
DDVI, ma ci pare che già nei testi degli anni ’50-‘60 esso sia presente, come abbiamo avuto modo di constatare dalla analisi di Amare la Torah più di Dio (ma lo si potrebbe facilmente mostrare percorrendo altri testi contenuti in DL).
121
H. JONAS, The gnostic Religion. The message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, Beacon Press, Boston, 1a ed. 1958, tr. it. di R. Farina, Lo gnosticismo, SEI, Torino (1a ed.
1973) rist. 1991, p. 335-352. Jonas legge tutto l’esistenzialismo nichilista, nel quale intravede anche la
posizione heideggeriana di Sein und Zeit, come espressione dello neognosticismo; si veda per esempio
codesta affermazione: «Ci ritorna alla mente […] la Geworfenheit di Heidegger, “essere stati gettati”,
che per lui è un carattere fondamentale del Dasein, dell’autoesperienza dell’esistenza. Il termine è
originariamente gnostico. Nella letteratura mandea è un termine che ricorre di continuo: la vita è stata
gettata nel mondo, la luce nella tenebra, l’anima nel corpo. Essa esprime la violenza originaria che mi
è stata fatta nel farmi essere dove sono e quello che sono, la passività di emergere senza possibilità di
scelta in un mondo esistente che non è stato fatto da me e la cui legge non è la mia» (ivi, p. 349).
122
TI, p. 115, cn.
109
L’analisi di questo stesso articolo ci permette di cogliere un altro elemento
interpretativo, qui appena accennato, ma che diventerà nell’opera di Elie Wiesel123
(anch’egli allievo di Shushani, nello stesso arco temporale di Levinas124) la cifra ermeneutica più importante per rispondere all’evento Shoah: il tema del riv, la contesa
o lite giudiziaria con Dio. Leggiamo infatti:
«Nascondere il volto per esigere dall’uomo – sovrumanamente – tutto,
aver creato un uomo capace di rispondere, capace di affrontare il suo Dio da
creditore e non come sempre da debitore: grandezza davvero divina»125. E
ancora: «Amare la Torah più di Dio, vuol dire precisamente accedere a un
Dio personale contro il quale ci si può rivoltare, per il quale si può morire»126.
«Rispondere» a Dio, «affrontar[lo] da creditore», «rivoltar[si]» contro di lui
«morire per» lui: sono questi gli elementi di un registro semantico giudiziario, segnatamente di una contensa giudiziaria; questo tema è presente in tutta la storia
dell’ebraismo, sin dai testi biblici (si pensi a Gn 18, 23-24127; Ger 20, 7.9128 o Gb 31,
35129), attraverso i testi haggadici, sino allo chassidismo, dove «assume la forma di
un processo: processo nel quale Dio è regolarmente condannato dal tribunale, al quale si sottomette» (De Benedetti)130.
Elie Wiesel, come ricordiamo, nel suo testo teatrale Il Processo di Shamgorod
131
ambientato durante un pogrom avvenuto nel 1649 nell’omonimo villaggio
123
Per l'interpretazione della Shoah da parte di Wiesel, si vedano: M. GIULIANI, Auschwitz nel
pensiero ebraico…, cit., pp. 69-74; P. DE BENEDETTI, op. cit., pp. 27-49.
124
Sul rapporto di Shushani con Wiesel, cfr. S. MALKA, Monsieur Chouchani…, cit., pp. 49-57.
125
DL, p. 182, cn.
126
Ivi, p. 183, cn.
127
Si tratta della discussione di Abramo con Dio in favore di Sodoma: «Davvero sterminerai il
giusto con l’empio? […] Lungi da te il far morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato
come l’empio; lungi da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» (tr. CEI,
1971).
128
«Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me […] Mi dicevo “non penserò
più a lui, non parlerò più in suo nome!”» (tr. CEI, 1971).
129
«Ecco qui la mia firma! L’Onnipotente mi risponda!» (tr. CEI, 1971).
130
P. DE BENEDETTI, op. cit., p 42.
131
E. WIESEL, Le Procès de Shamgorod tel qu’il se deroulà le 25 fevrier 1649, Éditions du
Seuil, Paris 1979; tr. it. di D. Vogelmann, Il processo di Shamgorod (così come si svolse il 25 febbraio
1649), Giuntina, Firenze 1982.
110
dell’Europa orientale, allestisce una lite giudiziaria dove paradossalmente la figura
dell’avvocato difensore di Dio è Sam (il Satana, ritornato sotto forma di un giovane e
intelligente straniero).
Anche nel testo di Zvi Kolitz, commentato da Levinas, questa posizione dialettica e polemica con Dio è molto presente, e caratterizza un atteggiamento egualmente lontano dalla «comunione calda e quasi sensibile con il divino [che]
dall’orgoglio disperato dell’ateo132», un atteggiamento che rivendica quindi
un’eguaglianza di partnership tra l’uomo e Dio, mediata dalla Torah.
Il fatto che l’uomo possa costituirsi, in questo rapporto, «da creditore e non
come sempre da debitore» ribadisce ancora, vale la pena di notarlo, la lontananza di
Levinas da uno schema colpa-espiazione, che caratterizza invece, con il suo carico di
violenza, l’impianto sacrificale-espiatorio proposto da Girard, dietro il quale questo
pensatore individua la vendetta133. Come è noto, tale meccanismo è in atto anche in
certe letture del Sacrificio della Croce, segnatamente nello schema anselmiano contenuto del Cur Deus homo, che ha avuto una vasta diffusione nella teologia cristiana;
secondo questo schema la morte di Cristo ha redento l’umanità, poiché egli ha volontariamente espiato la colpa in cui essa era caduta, «come atto supremo di soddisfazione vicaria con cui egli rimedia alle offesa inferta a Dio e ne ristabilisce
l’onore»134. Anche se nell’articolo di Levinas, tutto interno ad una lettura ebraica del
tema del male, non si fa esplicitamente riferimento alla polemica contro la visione
della Croce di una prevalente tradizione teologica cristiana, l’autore ne è certamente
consapevole, e ci pare che, implicitamente, vi si opponga.
Il tema del riv ci suggerisce un altro accostamento, che riteniamo non inopportuno segnalare, con il pensiero di un filosofo ben noto a Levinas, e del quale
osiamo pensare una certa influenza, ancora tutta da studiare135, sul Nostro. Intendiamo riferirci a Lev Šestov, di cui Levinas, in un articolo apparso in una rivista di studi
132
DL, p. 183.
Cfr. R. GIRARD, La violence et le sacré, Grasset, Paris 1972, tr. it. di O. Fatica e E. Czerkl,
La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980, pp. 30,36: «Funzione del sacrificio è quello di placare le
violenze intestine alla comunità e di placare i conflitti. […] Il sacrificio impedisce lo svilupparsi dei
germi della violenza. Aiuta gli uomini a tenere a bada la vendetta».
134
G. FORNARI, Da Dioniso a Cristo. Conoscenza e sacrificio nel mondo greco e nella civiltà
occidentale, Marietti, Genova 2006, p. 261.
135
Per un primo tentativo in questa direzione, cfr. N. MONSEU, La concretezza del soggetto. Sestov, Levinas e il problema dell’affettività, «Humanitas», 64(3/2009), Morcelliana, Brescia, pp. 455464.
133
111
ebraici nel 1937136, raccomandava la lettura, come di un pensatore che «pone di nuovo al centro i problemi della salvezza, ossia il messaggio stesso del giudaismo»137.
Il carattere “agonale” del pensiero šestoviano dovette sicuramente influenzare
l’approccio al tema della teodicea da parte di Levinas, anche se quest’ultimo si sarebbe decisamente allontanato tanto dalla recisa critica operata dal russo al pensiero
husserliano, quanto dalla presunzione šestoviana di porre il desiderio solipsistico
come perno per il superamento del «possibile» in direzione dell’«impossibile», segno
evidente, per Levinas, di un debito šestoviano verso la «volontà di potenza» di matrice nietscheana.
In una conferenza del 27 gennaio 1959, tenuta presso il Collège philosophique e intitolata Au-delà du possible, Levinas scrive infatti: «Al di là del possibile: noi
non rivendichiamo, come Kierkegaard o Šestov l’impossibile. Rivendicare
l’impossibile è infatti ancora aggrapparsi al potere sperando di trasformare
l’impossibile in possibile»138. Se Levinas non accentua questo carattere agonale
dell’io, come del resto Mosès rileva relativamente a Rosenzweig, è perché vi vede
connesso ancora il carattere di violenza e di potere totalitario tipica del logos di matrice greca, contro il quale l’io pretenderebbe di opporre un contro-potere, nella «fiducia priva di ragione» (déraisonable) di poterlo sovrastare, non rendendosi conto
tuttavia di rimanere entro la stessa logica violenta del logos-Anànke (per usare una
terminologia šestoviana).
Prendendo in prestito da Eric Weil l’uso della categoria di violenza connessa
all’individualità empirica desiderante139 (benché se ne distanzi poi circa il diverso
apprezzamento del termine «ragione», che il primo usa esattamente come sinonimo
di «discorso» non violento140), Levinas mostra che è la stessa logica della ragione
136
E. LEVINAS, Leon Chestov. Kierkegaard et la philosophie existentielle (Vox clamantis in deserto) – traduit du russe par T. Rageot e B. de Schloezer – Paris Vrin, 1936, «Revue des Études juives», julliet-décembre 1937, pp. 139-141.
137
Continua Levinas, «ciò con una maniera più radicale che mai, poiché la filosofia esistenziale
fa esplodere la sintesi dello spirito greco e dello spirito giudeo-cristiano che il Medioevo credeva di
aver compiuto» (ivi, p. 141).
138
E. LEVINAS, Parole et silence, et autres conférences inédites, (Œuvres 2), a c. di R. Calin e
C. Chalier, Grasset & Fasquelle/Imec, Paris 2009, p. 303.
139
«Dobbiamo all’importante tesi di Eric Weil (Logique de la philosophie, Vrin, Paris 1951)
[…] l’impiego sistematico e forte del termine violenza nella sua opposizione al discorso. Attribuiamo
tuttavia a questo termine un senso differente…» (Etica e spirito [1951], DL p. 21, nota).
140
Basti leggere questo passo di Eric Weil per cogliere il senso della sua “tesi”, la quale postula
il superamento della violenza solipsistica, nell’accesso alla ragione come «discorso», in un quadro di
simmetria di fronte a principi comuni; Levinas, invece, manterrà sempre (sin dall’articolo del 1951) il
112
totalizzante – con il suo fondo di volontà di potenza – ciò rispetto a cui occorre tentare una trascendenza, e che l’unico modo per operarla è costituito dalla relazione etica
con il volto, essendo la violenza connessa alla «solitudine» solipsistica della ragione
tematizzante 141, che «neutralizza l’altro e lo ingloba»142.
Benché dunque si tratti solo di uno spunto, quello del riv, ci pare indubbio
che proprio il documento Yossl Rakover si rivolge a Dio – «questo “falso” che ci sopravvivrà, come uno dei veri e propri documenti del nostro tempo», scrive Paul Badde143 – sia stato una fonte di ispirazione decisiva per tutto il successivo pensiero levinassiano144.
Molti anni dopo, precisamente nel 1982, Levinas ritornerà quasi tematicamente sul tema della Shoah, in un testo intitolato La sofferenza inutile, ora contenuto
nella raccolta Tra noi [TN]145. Il saggio si apre con una fenomenologia della sofferenza, caratterizzata come un
«malgrado-la coscienza, l’inassumibile […] coscienza a rovescio, ‘che
opera’non come presa ma come repulsione […] rinnegamento e rifiuto di senso che si impone come qualità sensibile»146. La sofferenza, continua Levinas,
«è passività […], il luogo dove la passività significa in maniera originaria
[…], è più profondamente passiva della recettività dei nostri sensi che è già
attività dell’accoglienza che diventa immediatamente percezione. Nella soffeprincipio dell’asimmetria della relazione etica: «La ragione è una possibilità dell’uomo: possibilità,
ciò designa quel che l’uomo può, e può, e l’uomo può certamente essere ragionevole, almeno voler
essere ragionevole.[…] Noi sappiamo che l’atra possibilità è la violenza. Violenza dell’uomo che non
accetta il discorso che vuole unico non solo per lui, ma per tutti, e tenta di rendere realmente unico per
mezzo della soppressione reale di tutti coloro che fanno altri discorsi. Violenza dell’uomo che si afferma nel suo essere così com’è per lui stesso, che vuole esprimersi solo come si sente […]e contro il
quale nessuna contraddizione è immaginabile perché non conosce principi comuni…» (E. WEIL, Logique de la philosophie, Vrin, Paris 1985; tr. it. di L. Sichirollo, Logica della filosofia, Il Mulino, Bologna 1997, p. 83).
141
Etica e spirito (1951), in DL, p. 24: «Il violento non esce da sé. Il violento prende, possiede.
Il possesso nega l’esistenza indipendente. […] La violenza è sovranità ma solitudine».
142
TI, p. 41.
143
Z. KOLITZ, Yossl Rakover si rivolge a Dio, tr. it. di A. L. Callow e R. C. Guarneri, Adelphi,
Milano 1997, p. 22.
144
Basti leggere questa frase, che potrebbe essere tranquillamente attribuita a Lévinas, e di cui
supponiamo, addirittura, un’influenza diretta circa il titolo della raccolta di scritti pubblicata nel 1963,
con il titolo Difficile libertà: «Sono fiero del mio essere ebreo. Perché essere ebreo è un arte. Perché
essere ebreo è difficile» (Z. KOLITZ, Yossl Rakover si rivolge a Dio, cit., p. 22, cn).
145
TN, pp. 123-135. Articolo originariamente apparso in «Giornale di metafisica», n. 4, 1982,
pp. 13-26.
146
Ivi, p. 123.
113
renza, la sensibilità è vulnerabilità, più passiva della recettività. Essa è prova,
più passiva dell’esperienza»147.
La sofferenza pura, come non libertà-originaria in cui il soggetto è «inchiodato» al proprio patire, si concretizza nel «non, che emerge come male, più negativo di
ogni non apofantico»148. È proprio la sofferenza, quindi, a costituire il carattere del
male come «non, negativo sino al non senso»149. Infatti, «ogni male si riferisce alla
sofferenza [...esso] è l’esplosione come articolazione più profonda dell’assurdità […]
Sofferenza per ‘nulla’ fondo insensato», che e si concretizza fenomenicamente in
situazioni empiriche dove il dolore «si isola nella coscienza o assorbe il resto della
coscienza»150.
Levinas esemplifica questo dolore per nulla, attraverso l’isolamento in sé cui
un semplice dolore costringe i pazienti affetti da nevralgie croniche o malattie terminali. Un semplice mal di denti cronico, infatti, sino alle strazianti sofferenze connesse
ad un cancro testimoniano di questa insensatezza, di questo ‘per nulla’ esibito dal
dolore, nella sua essenziale inassumibilità, cioè nel non poter essere in qualche modo
preso in carico attivamente, sopportato, padroneggiato dalla coscienza.
«Inassumibilità» che diventa «insensatezza», perché è non integrabilità
«nell’unità di un ordine e di un senso»151, e questo non solo per colui che abbia perduto le facoltà mentali (per il quale si pone il mio dovere di alleviare la sua sofferenza attraverso «una terapia del dolore»152), ma anche per chi senta esplodere attraverso
il dolore la capacità di dominare le proprie facoltà mentali. Ma se il male è insensato
«in me», non deve essere insensato «in altri»: «Il male della sofferenza – passività
estrema, impotenza, abbandono e solitudine, [è] l’apertura originaria verso la benevolenza di altri153».
É precisamente qui che Levinas scorge la categoria antropologica della cura
medica, come responsabilità «primordiale, irriducibile, etica» che apre un «al di là
147
148
149
150
151
152
153
Ivi, p. 124.
Ibidem.
Ivi, p. 125.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, p. 126.
114
nell’interumano»154. Levinas fonda su questo appello della sofferenza altrui, la necessità della tecnica medica «e di ogni tecnologia in generale155», criticando la stigmatizzazione della tecnica di Heidegger e di altri filosofi, che non coglierebbero in
essa la possibilità di «nutrire gli uomini e alleviare le loro sofferenze»156.
Qui il filosofo lituano cita, in nota, un apologo talmudico che esemplifica
quanto viene dicendo, circa il contemporaneo riconoscimento della della propria sofferenza come inutile e insensata, e insieme come apertura di un senso diverso, che
essa annuncia : «Rav Hiya ben Abba cadde malato e Rav Yohanan lo andò a visitare.
Egli chiese: – le tue sofferenze ti si addicono? – Né esse né le ricompense che esse
promettono. – Dammi la tua mano, disse allora il visitatore al malato»157.
La disperazione intrinseca ed inconsolabile del malato, che insieme si chiude
in sé e chiede aiuto all’altro uomo, è dunque anche appello alla non-indifferenza altrui e quindi è struttura originaria della (ri)costituzione del senso come sofferenza per
la sofferenza dell’altro. C’è però, secondo Levinas, una radicale differenza tra la sofferenza in altri, che è per me imperdonabile perché sollecita la mia cura e il mio aiuto, e la sofferenza in me, di per sé inutile, ma che può acquisire un senso solo attraverso la mia espiazione per l’altro158. Non riusciremmo però a comprendere come la
sofferenza, ad esempio, di un mal di denti cronico, né a maggior ragione la sofferenza di un cancro, possa slittare di piano, ed essere assunta come sofferenza o espiazione per l’altro. Il discorso di Levinas non sarebbe apparentemente logico, evidentemente, se non presupponesse un palinsesto più profondo, che implica l’analisi già
percorsa in AE, di cui questo testo evidentemente accenna solo le conclusioni.
154
Ibidem.
Ibidem.
156
Ibidem.
157
(Trattato Berakhot del Talmud babilonese, p. 5b) cit., ivi, p. 126.
158
«La giusta sofferenza in me per la sofferenza ingiustificabile di altri, apre sulla sofferenza la
prospettiva etica dell’inter-umano. In questa prospettiva, c’è una differenza radicale tra la sofferenza
in altri in cui essa è, per me, imperdonabile e mi sollecita e mi invoca e la sofferenza in me, la mia
propria avventura della sofferenza la cui inutilità costitutiva può acquistare un senso, il solo di cui la
sofferenza sia suscettibile, diventando una sofferenza per la sofferenza, fosse anche inesorabile, di
qualcun altro» (ivi, p. 127) Il termine «espiazione» non ricorre nel testo, ma come spesso accade in
Levinas, è in nota che si chiarifica il significato del discorso. Non si tratta infatti di una sofferenza in
generale, ma della «mia» sofferenza: «è come sofferenza in me e non come sofferenza generale, che la
sofferenza è benvenuta [cda], testimoniata nella tradizione spirituale dell'umanità può significare
un’idea vera: la sofferenza espiatrice del giusto che soffre per gli altri, la sofferenza che illumina, la
sofferenza che è cercata dai personaggi di Dostoevskij. Penso anche alla tradizione religiosa ebraica
che mi è familiare, all’ “io sono malato d’amore” del Cantico dei cantici, alla sofferenza di cui parlano alcuni testi talmudici e che chiamano “Yessurin chel Ahava” sofferenze per amore , a cui si lega
il tema dell'espiazione per gli altri» (ivi, p. 127 nota).
155
115
La fenomenologia della sofferenza, in effetti, giocata su di un piano solipsistico, o anche intersoggettivamente duale (non tenendo conto del terzo), non potrebbe reggere all’accusa di fallacia, se si facesse notare, ad esempio, che già il considerare la sofferenza come passività iperbolica ne esclude la possibilità di un capovolgimento in attività, sia pure come semplice accettazione di essa, e che quindi
«l’ambiguità»»159 che la sofferenza mette in risalto (giusta in me, ingiusta nell’altro)
non potrebbe valere come perno su cui fondare un’obbligazione etica per l’altro, se
non postulando contemporaneamente un qualche merito per sé, sia pure in senso mistico o oltremondano. È lo stesso Levinas ad accennare a tentativi di dare senso alla
sofferenza solipsistica, poche righe dopo: «la pena di soffrire può guadagnare il senso di una pena che merita e spera una retribuzione e perde, così sembra, la sua caratteristica di inutile»160; e ancora: «[essa] può essere sensata come mezzo in vista di un
fine»161; e infine, essa potrebbe valere come «il prezzo della ragione o di un affinamento spirituale»162, valendo così come il prezzo di una edificazione.
Non si capisce bene, in verità, se Levinas esprima questi modi di «dare senso
alla sofferenza» come di per sè validi, o se invece, come è più probabile vista la maniera retorica in cui elenca queste possibili “soluzioni”, egli li rubrichi a modi in cui
la sofferenza non sarebbe espressa nella sua forma pura, di gratuità insensata. Il prosieguo del testo ci fa propendere per questa seconda ipotesi, di modo che cogliamo in
Levinas una certa riserva anche entro il proprio discorso, una delimitazione del referente verso il quale esso si indirizza, che non è tanto la sofferenza in qualche modo
già sensata, quanto la sofferenza pura, insensata e gratuita.
Che la sofferenza pura non possa avere un senso solipsistico, è abbastanza
evidente: ciò equivarrebbe a riguadagnare, magari in modo più alto, un ritorno narcisistico su di sé, a darvi quindi un senso che sia un’espiazione per colpe personali,
magari non consapevoli. Ma se così fosse, il senso della sofferenza rimarrebbe immanente al solus ipse, e non sarebbe guadagnato in un «al di là interumano». E il
senso rimarrebbe anche immanente dal punto di vista teologico, perché il «dio» che
ne emergerebbe sarebbe in fondo colui che richiede al singolo una prova, il cui pre-
159
160
161
162
Ivi, p. 127.
Ivi, p. 128.
Ibidem.
Ibidem.
116
mio connesso al suo superamento vincolerebbe entrambi, Dio e l’uomo, in un rapporto economico “pagano” di reciproco scambio.
Ma proprio mirando a questa sofferenza pura si pone il problema sopra accennato, di come possa la sofferenza di un cancro o persino di un mal di denti poter
valere come sofferenza per l’altro. Se ammettiamo che anche questa sofferenza privata sia già espiazione per l’altro, dobbiamo pensare che essa sia in qualche modo di
per sé espiazione, e l’unica possibilità logicamente comprensibile è che essa sia sempre nello stesso tempo “immeritata” (insensata) e “meritata” (sensata e giusta in sé, e,
così, già apertura alla sofferenza dell’altro, come «sofferenza per amore»163). Ma se è
così, al fondo del discorso levinassiano si avverte un profondo «senso di colpa del
sopravvissuto», al cospetto di un’enorme sofferenza (e morte) altrui, per cui l’io già
esistendo, cioè perseverando nell’essere, è colpevole in quanto sopravvissuto alla
morte insensata di altri: come Levinas dirà, più tardi, in EI, «si tratta della domanda
che va posta fino in fondo […] Essendo, persistendo nell’essere, io non uccido? […]
Essendo nel mondo, non occupo il posto di qualcuno?»164.
Dovremmo approfondire questa questione della colpa del sopravvissuto, (e lo
faremo nel paragrafo successivo), ma certo la continuazione del testo che stiamo leggendo contiene un salto logico che non terrebbe altrimenti, salto verso una prospettiva in cui si passa bruscamente dalla sofferenza solipsistica alla sofferenza per altri.
Per disambiguare questo salto occorre tornare leggermente indietro nel nostro testo, al punto che ne costituisce il suo vero snodo, quello in cui il senso della
sofferenza inutile si apre alla dimensione storica, dischiudendo il problema connesso
della fine di ogni possibile teodicea, sulla base degli eventi tragici accaduti nel secolo
XX, a partire dalla quale occorre prestare:
«attenzione alla sofferenza altrui che, attraverso la crudeltà del nostro
secolo malgrado queste crudeltà, a causa di queste crudeltà può affermarsi
come il nodo stesso della soggettività al punto di trovarsi elevata a supremo
principio etico – il solo che non sia possibile contestare – e fino a guidare le
speranze e la disciplina pratiche di vasti gruppi umani. Attenzione e azione
che incombono agli uomini – al loro io – in maniera così ineluttabile e così di163
164
Ivi, p. 127, nota.
EI, pp. 112, 113.
117
retta che non è loro possibile, senza decadere, aspettarle da un Dio onnipotente» 165.
Qui entra in gioco il terzo, la società, ma vi entra nel suo decorso storico, soprattutto recente: l’esperienza comune attesta «nella storia una cattiveria e una cattiva
volontà»166. Il male storico si rivela insensato poiché tocca gli inermi e gli innocenti.
La critica al meccanismo teodiceale dell’assunzione e sopportazione della sofferenza,
secondo il paradigma colpa-espiazione (nel senso comune di tale termine) che
l’umanità aveva escogitato per scagionare Dio dai mali della storia, viene individuata
da Levinas come insegnamento obbligato degli orrori del secolo ventesimo. È avvenuto, a suo dire, un evento epocale: «Forse il fatto più rivoluzionario del XX secolo –
ma anche un evento della storia Santa – è la distruzione di ogni equilibrio tra teodicea esplicita ed implicita del pensiero occidentale e le forme che la sofferenza e il
suo male attingono nello svolgimento stesso di questo secolo»167.
Levinas non si riferisce solo all’Olocausto, che pure cita con questo nome, ma
anche agli altri eventi del “secolo tragico”, le due guerre mondiali, i totalitarismi di
destra e di sinistra, Hiroshima, i Gulag, i genocidi della Cambogia (noi potremmo aggiungere anche quelli della guerra nell’ex Jugoslavia, e del Ruanda, e mentre scriviamo la catastrofe umanitaria che si sta compiendo nel Corno d’Africa). Ma egli individua come paradigma di ogni sofferenza insensata il genocidio ebraico, che non investe solo la coscienza ebraica stessa, ma la coscienza umana universale:
«Forse non è un sentimento soggettivo che, tra tutti questi eventi,
l’Olocausto del popolo ebraico sotto la dominazione di Hitler ci appaia il paradigma di questa sofferenza umana gratuita, dove il male apparve nel suo errore diabolico. La sproporzione tra la sofferenza e ogni teodicea apparve ad
Auschwitz con una chiarezza che cava gli occhi. La sua possibilità mette in
questione la fede tradizionale millenaria»168.
165
166
167
168
Ivi, p. 127, ccnn.
Ivi, p. 128.
TN. p. 130.
Ibidem, ccnn.
118
Levinas cita, in questo punto, il pensatore ebreo Emil Fackenheim, di cui legge e condivide il saggio La presenza di Dio nella storia (1970)169; ed è interessante
notare come la sua lettura ne universalizzi l’istanza ebraica della fedeltà particolare
alla legge, trasfigurandola, sulla base dell’evento-Auschwitz, a paradigma di ogni
orrore storico, come comandamento universale dell’interumano alla «non-indifferenza degli uni verso gli altri, senza preoccupazione di reciprocità».
Fackenheim, com’è noto, pone un interdetto fondamentale sul meccanismo
teodiceale, segnatamente ebraico, invitando a sospendere qualunque risposta ad Auschwitz data attraverso gli schemi classici del pensiero rabbinico, quello di peccatocastigo («siamo puniti per i nostri peccati»), di martirio volontario, dell’impotenza di
Dio, e dell’esilio di Dio con il suo popolo170.
Reclamando un mantenimento della tradizionale fede ebraica nella presenza
di Dio nella storia, e quindi postulando una rinuncia a qualsiasi attesa di salvazione
guadagnata in un al di là sovrastorico quale ricompensa per le sofferenze inaudite
della Shoah, Fackenheim, insieme a Wiesel, vedrà in Auschwitz «un nuovo Sinai»171,
nel quale si ode la voce imperativa che comanda per gli ebrei un 614° precetto: sopravvivere come ebrei, nella propria singolarità ebraica, rappresentare «tutta
169
E.L. FACKENHEIM, God’s Presence in History. Jewish Affirmations and Philosophical Reflections, Ney York University Press, New York 1070; tr. it. di F. Savoldi, La presenza di Dio nella
storia. Saggio di teologia ebraica, Queriniana, Brescia 1977.
170
Fackenheim rileva come il silenzio teologico, nell’immediato periodo post-eventum, significava indubbiamente assumersi la responsabilità di salvaguardare 4000 anni di storia ebraica, ma ora,
egli afferma, è diventato necessario parlare e confrontarsi criticamente con le vecchie riposte midrashiche. Cominciare a parlare di Auschwitz, significa mettere radicalmente in questione innanzitutto il
vecchio schema di peccato ed espiazione perché, «comunque noi giriamo e rigiriamo, tale dottrina in
risposta ad Auschwitz, diventa un’assurdità religiosa e addirittura un sacrilegio» (op. cit., p. 97). Così
pure, deve essere sospesa l’interpretazione tratta dall’idea di martirio; il misdrash trasfigura, infatti, «il
sacrificio di Isacco da parte di Abramo fino a far risaltare il martirio. Isacco non era un bambino, ma
uomo adulto di trentasette anni, e non era tanto una vittima riluttante quanto un martire consapevole
per il qiddush ha-Shem, la santificazione del nome divino». «Ad Auschwitz», continua Fackenheim,
«non ci fu scelta; vecchi e giovani, fedeli e non fedeli furono sterminati senza discriminazione Ma vi
può essere martirio quando non vi è scelta?» (ivi, p. 99). Ma anche se si assume che la fedeltà a Dio
con cui gli ebrei credenti morivano durante l’Olocausto valga come testimonianza, «le nazioni idolatriche, non Dio, avevano bisogno della [loro] testimonianza» (ivi, p. 100). Fackenheim contesta poi
altre due possibili risposte all’Olocausto, il richiamo all’impotenza divina e il tema del «Dio per così
dire impotente che va in esilio con il suo popolo». La prima risposta viene contestata perché: «nel
midrash il timore di Dio esiste ancora tra le nazioni [pagane], e Israele sopravvive, anche se impotente
e disperso tra le nazioni. Nell’Europa nazista invece il timore di Dio era scomparso e gli ebrei venivano braccati senza pietà o scrupoli» (ivi, p. 103). Puntare tutto sull’impotenza divina significherebbe,
poi, o diventare cristiani (rinviare all’al di là un riscatto del male), oppure perdere la presenza di Dio
nella storia: in entrambi i casi vorrebbe dire rinnegare l’ebraismo. La seconda possibile risposta fa
appello al fatto che l’esilio implica sempre un ritorno, ma, obietta Fackenheim, «nel midrash, Dio va
in esilio con il suo popolo e ritorna con esso; da Auschwitz non c’è stato ritorno» (ibidem).
171
E.L. FACKEHNHEIM, op. cit., p. 112.
119
l’umanità quando essi affermano la loro ebraicità e negano la negazione nazista»172;
vivere per raccontare-testimoniare ciò che è stato onde impedirne il ripetersi in altre
o nelle medesime forme; resistere «ai demoni di Auschwitz […], e continuare a lottare con Dio [riv] 173 e insieme [alleanza] a Dio, in tutti i possibili modi rivoluzionari»174, contro l’idolatria antiumanistica.
La vita, la resistenza e la testimonianza degli ebrei sono dunque, secondo
Fackenheim, comandati dalla Shoah : «L’ebreo dopo Auschwitz è un testimone per la
resistenza. […] egli testimonia che noi possiamo resistere, perché dobbiamo resistere; e che dobbiamo resistere perché ci è comandato di resistere»175. La resistenza al
male è dunque per Fackhenheim un comandamento, ed è questo l’unico modo in cui
Dio è presente nella storia, in e dopo Auschwitz: il Dio ebraico è un Dio che resta
«spogliato di tutto meno che del potere che comanda»176.
Levinas, pur accettando il pensiero fackenheimiano, ne amplia la portata. La
«voce imperativa» non affetta soltanto l’ebreo, ma l’intera umanità, ogni uomo che
sia testimone qualunque orrore storico, anche se questo orrore trova in Auschwitz il
proprio paradigma universale e insuperabile, come esempio della sofferenza pura. E
se la resistenza al male si coniugava nel pensatore ebreo-canadese, almeno nel libro
citato da Levinas, con l’esaltazione del particolarismo ebraico, e persino con il sionismo politico, Levinas, oltre a distaccarsene attraverso l’ampliamento del dovere
all’intera umanità, sembra riabilitare, come abbiamo visto e come avremo modo di
vedere, la categoria tradizionale di martirio (Qiddush ha-Shem): dove la sofferenza
per la sofferenza di altri diventa l’unica modalità di testimonianza (discreta e non
predicatoria) di un Dio esigente.
Tale martirio, pensato come sostituzione originaria, è però implicato nella
stessa carne dell’io, ne costituisce la stessa ricorrenza anteriore a qualunque azione e
passione fenomenica. A questo punto, il testo non può che alludere alle analisi e alle
concatenazioni fenomenologiche che Levinas aveva descritto nel suo libro capitale,
172
Ivi, p. 114.
Fackenheim assume in questo testo la prospettiva del riv fatta propria da Wiesel, il «chiamare in causa Dio contro Dio […] hai tradito il patto? Noi non lo tradiremo! Vuoi che gli ebrei non abbiano più a sopravvivere? Noi sopravviveremo come ebrei migliori, più fedeli, più devoti![…] È troppo tardi per la venuta del messia? Noi persisteremo senza speranza e ricreeremo la speranza» (ivi. p
117).
174
Ivi, p. 117, ccnn.
175
Ivi, p. 125.
176
«...questo potere però è inevitabile» (ivi, p 117).
173
120
AE. Tale allusione colma l'apparente salto logico che abbiamo prima notato nel passaggio dalla fenomenologia della sofferenza pura individuale alla comune esperienza
storica dell’orrore indicibile dell’Olocausto.
Nel testo che abbiamo ora commentato, queste connessioni sono solo implicite, ma senza tenere presente il decorso fenomenologico di AE l’effetto sarebbe quello
di un buco nel testo.
«Accusarsi soffrendo è senza dubbio la ricorrenza dell’io a sé. Forse è così
che il per-l’altro – il rapporto più diretto ad altri – è l’avventura più profonda
della soggettività, la sua intimità ultima. Ma questa intimità è possibile solo
come discrezione. Essa non potrebbe portarsi ad esempio, raccontarsi come
discorso edificante. Non potrebbe, senza pervertirsi, diventare predicazione»177.
Partiamo dall’ultima frase. Tale «avventura dell’io come apertura al per-altro
nella sofferenza», non potrebbe predicarsi ad altri, dice Levinas; e questo, non solo
per timore di ostentazione, ma fondamentalmente perché la sofferenza non può essere esigita simmetricamente e reciprocamente da altri verso di me, pena la destituzione del proprio essere «significazione» pre-originaria, come Levinas dirà in AE.
Ma è la prima frase che racchiude tutto il senso del discorso: la sofferenza pura, «l’accusarsi soffrendo» si svela come la stessa «ricorrenza dell’io a sé»; l’ identificazione dell’io a sé preoriginaria, cioè, ben prima di qualunque relazione empirica
o trascendentale, si svela come la stessa incarnazione. Essa è segnata da un «accusarsi soffrendo», poiché già l’io è responsabile della morte di altri, è già-sempre sopravvissuto e colpevole per questa morte.
Il tema della ricorrenza, sul quale ritorneremo dettagliatamente nel quaro capitolo, è sviluppato ampliamente in AE, dove esso è declinato secondo un’escalation
concettuale di connessioni fenomenologiche che rivelano la cifra stessa della corporeità, quella di un soggetto che è sostituzione originaria. Come scrive Giovanni Ferretti, «la nozione di soggetto incarnato non è un concetto biologico, dato che in questo caso il biologico stesso è sottomesso a una struttura più alta: l’espropriazione di
177
TN, p. 133.
121
sé. Un esposizione che lungi da alienare, rende veramente se stessi»178. Si tratta dunque, in questa sofferenza pura dell’incarnazione, di un principium individuationis179
che vede nel dolore per altro, e dunque nella responsabilità per questo dolore, lo
schema di significazione originaria rispetto a qualunque dolore empirico o storicamente constatabile180.
Su questa dinamica profonda della soggettività ci soffermeremo successivamente in maniera più dettagliata. Tornando ora alla Shoah, dobbiamo infine analizzare gli ultimi tre testi a nostro avviso meritevoli di considerazione.
Il primo testo si collega direttamente con l’esposizione autobiografica di Levinas, anzi ne è un epilogo. Si tratta di Signature [Firma] del 1963, testo allegato alla
prima edizione di Difficile Libertà. Il secondo è invece l'introduzione al libro Nomi
Propri del 1976, prologo che ha il valore di un epitaffio per tutti i morti e che si intitola Senza nome. Il terzo testo, L’assimilazione oggi (1954) è anteriore agli altri due,
ma contiene in nuce la sintesi della visione levinassiana della Shoah.
Signature [Firma] 181è un testo autobiografico, posto dall’autore nella seconda
edizione di Difficile Libertà (1976), nel quale, in poche pagine, egli ci offre una propria autopresentazione. Il racconto della propria vita vi è riportato nella prima pagina, cadenzato come un repertorio nel quale sono scandite senza omissione le più importanti esperienze esistentive e culturali dell’autore.
Ma prima di analizzare la seconda parte, dove egli dipana i nodi del suo percorso filosofico, troviamo scritte queste righe che dicono, «in un linguaggio che parla
chiaramente dell’attualità» (come ricorda l’esergo al testo, una conversazione colta al
178
G. FERRETTI, La filosofia di Levinas.., cit. p. 245. Sul tema della ricorrenza come incarnazione, si legga la seguente frase di Levinas citata da Didier Franck: «La ricorrenza in cui si accusa il
soggetto nella sua pelle, e che non ha senso che come responsabilità riguardo ad altri, è incarnazione.
Come e perchè? Procedendo da “un’irrecusabile esigenza dell’altro”, la ricorrenza è “dovere debordante il mio essere, dovere che si fa debito e passività estrema al di qua della tranquillità, ancora del
tutto relativa, nell’inerzia e materialità delle cose in riposo, inquietudine e pazienza che sopportano al
di qua dell’azione e della passione; dovuto debordante l’avere ma che rende possibile il donare”» (D.
FRANCK, L’un-pour-l’autre. Levinas et la signification, PUF, Paris 2008, p. 139, rif. da AE, p. 137, tr.
modificata).
179
«La responsabilità è un’individuazione, un principio di individuazione. Riguardo al famoso
problema ‘l’uomo è individuato per mezzo della materia o della forma?’, io sostengo l’individuazione
per mezzo della responsabilità per altri» (Filosofia giustizia, amore. Conversazione con E. Levinas, tr.
it. di R. Cristin, «aut aut» n. 209-210, 1985, p. 8).
180
Un’individuazione, come Levinas chiarirà in Di Dio che viene all’idea, «dell’io responsabile
nella sua non interscambiabilità di responsabile che è un’ “elezione”, [...dove] io sono chiamato come
unico» (DDVI, p. 212).
181
DL, pp. 361-366.
122
volo nella metropolitana): «Questo disparato inventario è una biografia: dominata dal
presentimento e dal ricordo dell’orrore nazista»182.
Non si parla del «presente», e non perché l’esperienza presente non intacchi
la carne di Levinas, ma perché, più profondamente, essa non può essere «detta», essendo il detto sempre tematizzazione e presentificazione, laddove l’orrore, in quanto
dolore puro, è inassumibile nel presente, ma si rileva après coup sempre come trauma immemorabile che dispiega la stessa diacronia irrecuperabile del tempo.
Con il termine «presentimento» si allude all’avvertimento anticipatorio dell’orrore, da Levinas stesso presagito già nel 1933 al tempo della ascesa al potere di
Hitler, e individuato nel carattere pagano e antiumano di una «filosofia hitleriana»183.
Con «ricordo», Levinas ci sembra intendere la testimoniale memoria per la
morte di altri, prossimi e parenti, in cui quell’orrore si è manifestato. In due righe,
egli allude a ciò che non può essere detto, ma solo presentito o ricordato; questo nonpoter-essere-detto si riferisce a un non-potersi-assumere del trauma, ed è insieme
l’apertura di una temporalità diversa da quella descritta da Husserl, dove il «presente
vivente», malgrado sia originariamente non prodotto dalla coscienza intenzionale,
verrebbe poi tematizzato dalla coscienza nella «ritenzione», e così rientrerebbe
nell’ordine della coscienza stessa, senza oltrepassare «l’immanenza del Medesimo»184. In tale non assumibilità nell’immanenza del presente, a partire dal patire refrattario a ogni sincronizzazione che è sedimentato nel trauma, patire che si amplia
182
Ivi, p. 362, ccnn.
Cfr. Quelques réflexions sur la philosophie de l’Hitlerisme, in «Esprit», II, 1934, 199-208 ;
tr. it. di A. Cavalletti, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1996.
184
Come è noto, nelle Lezioni per una fenomenologia interna del tempo, Husserl aveva individuato nella Urimpression o «presente vivente» l’origine assoluta della temporalità, che non deriverebbe da alcuna costituzione intenzionale. Levinas afferma che pur superando il primato del teorico, questa tesi non supererebbe quella del primato della coscienza. «Lo stesso “presente vivente” verrebbe
tematizzato dalla coscienza nella “ritenzione” e così rientrerebbe nell’ordine della coscienza, senza
portare al di là dell’immanenza del Medesimo» (G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 211).
Ferretti allega la citazione seguente che ben sintetizza la posizione di Levinas a riguardo: «Che questa
coscienza originariamente non-oggettivante e non-oggettivata nel pensiero vivente, sia tematizzabile e
tematizzata nella ritenzione senza perdere alcunché del suo ruolo temporale che conferisce individuazione, significa che la non-intenzionalità della proto impressione rientra nell’ordine, non conduce aldi-là-del-Medesimo, né al-di-là-dell’origine. Nulla di incognito s’introduce nel Medesimo per interrompere il flusso del tempo e la coscienza che si produce nelle forme di questo flusso. […] il tempo
della sensibilità è, in Husserl, il tempo del recuperabile. Che la non-intenzionalità della protoimpressione non sia perdita di coscienza, che nulla possa arrivare all’essere clandestinamente, che
nulla possa strappare il filo della coscienza, significa escludere la tempo la diacronia irriducibile di
cui il presente studio tenta di far valere la significazione dietro la messa in mostra dell’essere» (AE, p.
42).
183
123
man mano che vi si risponde, emerge il carattere stesso del dire come corrispondenza
etica della testimonianza nel presentimento e nel ricordo.
Tale corrispondenza ci pare sia segnalata da Levinas stesso nel prosieguo nel
testo, sia nell’abbozzo di spiegazione fornito della propria opere, di cui egli racconta,
sia nell’indicazione del loro telos: la descrizione fenomenologica della figura della
soggettività come responsabilità, il cui «senso ultimo consiste nella passività assoluta
del sé: come il fatto di sostituirsi all’altro»185.
Dischiudendosi tra il presentimento (il futuro), e il ricordo (il passato), la coscienza etica (che «non è una varietà particolarmente raccomandabile della coscienza, ma la contrazione [tzimtzum], il ritrarsi in sé, la sistole della coscienza»186)
esibisce dunque un non potersi esperire originario del trauma che la affetta sino alla
contrazione, e che non può essere mai tematizzato-presentificato; ecco il motivo perché Levinas, forse, non interpone «e dell’esperienza [mia]», tra «presentimento» e
«ricordo» dell’orrore, ma indichi anche un non potervisi sottrarre, un non potere non
rispondervi, costituendo, la soggettività così delineata, negli atti presentificanti del
suo asimmetrico soffrire-per-gli altri, «lo scarto irriducibile che si apre tra il non presente e ogni rappresentabile, scarto che a suo modo […] segnala il responsabile187».
Come se il soggetto traumatico-responsabile, che presente e ricorda, fosse
nell’intervallo, o meglio costituisse, nel suo agire etico, lo stesso intervallo o scarto
del presente, in quanto «attualità» che interrompe la storia e sola può conferirle un
senso188.
Ma se è così, non si può non notare che «l’orrore nazista», conclusosi nella
Shoah, assume in questo testo il carattere di luogo e tempo paradigmatico in cui si
185
DL, p. 366.
Ivi, p. 365.
187
AE, p. 15, tr. modificata.
188
Verrebbe fatto di pensare un’analogia con lo jetztzeit benjaminiano: «La storia è oggetto di
una costruzione il cui luogo non è il tempo omogeneo e vuoto, ma il tempo carico di attualità» (W.
BENJAMIN, Schriften, Surkamp Verlag, Berlin 1955; tr. it. di R. Solmi, Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1962, p. 83). Sul confronto tra i due pensatori, relativamente a questo tema, si
veda D. GENTILI, Etiche e politiche del messianismo: Emmanuel Levinas e Jacques Derrida, in I.
BAHBOUT, D. GENTILI, D. TAGLIACOZZO (a c. di), Il messianismo ebraico, Giuntina, Firenze 2009 (pp
107-116), p. 112: «Anche Benjamin considera il messianismo dell’individuo e dell’interiorità in termini non dissimili da Levinas: “l’immediata intensità messianica del cuore, del singolo uomo interiore, procede attraverso l’infelicità, nel senso del soffrire” (La frase citata è tratta da W. BENJAMIN,
Theologish-politisces Fragment, ID., Gesammelte Schriften, II/1, SurKamp Verlag, Frankfurt a. M.
1974; tr. it. di G. Bonola e M. Ranchetti, Frammento teologico politico, in ID, Sul concetto di storia,
p. 255).
186
124
concreta l’«elezione della sofferenza» come rivelazione del Bene. Vedremo in seguito, in sede di analisi di AE, come la nozione di trauma sia annodata, se non addirittura equivocamente sovrapposta, con quella dell’elezione del «Bene che investe la libertà mia prima che io lo ami»189 e che «non potrebbe farsi presente, né rappresentarsi». Come se l’orrore nazista fosse anche la «rivelazione» del Bene! Cercheremo di
problematizzare e rispondere, nel terzo e quarto capitolo del nostro studio, a questo
scandaloso paradosso.
Indubbiamente, quindi, queste due righe di Signature-Firma che siamo venuti
leggendo e che abbiamo cercato di commentare, costituiscono lo sfondo in cui si pone l’intero pensiero successivo dell’autore. Ci pare inoltre che lo stesso titolo del testo, in francese Signature, evochi la nozione di materia signata hic et nunc, con cui,
secondo Tommaso d’Aquino, si individualizza la persona umana rispetto al genere190. In questo senso, «l’orrore nazista» individua e segna, con il suo stigma traumatico, sia la biografia sia l’opera di Levinas e viene trasfigurato come signature universale per ogni singolo e insostituibile essere umano191.
189
AE, p. 15, nota.
«Sed quia individuationis principium materia est ex hoc, forte videretur quod essentia, que
materiam in se complectitur simul et formam, sit tantum particularis et non universalis […]. Et ideo
sciendum est quod materia non quolibet modo accepta est individationis principium, sed solum materia signata; et dico materiam signatam que sub determinatis dimensionibus consideratur Hec autem
materia in diffinitione que est hominis in quantum est homo non ponitur, sed poneretur in diffinitione
Sortis si sortes diffinitiones haberet […] In diffinitione autem hominis ponitur materia non signata:
non enim in diffinitione hominis ponitur hoc os et hec caro, sed os et caro absolute quae sunt materia
hominis non signata. [Poiché il principio d’individuazione è la materia, forse sembrerebbe derivare da
ciò che l’essenza, la quale comprende in sé nello stesso tempo la materia e la forma, sia soltanto particolare e non universale; […] Si deve però sapere che non la materia comunque intesa è il principio di
individuazione, ma soltanto la materia segnata. E chiamo materia segnata quella che viene considerata
sotto determinate dimensioni. Ora, questa materia non si pone nella definizione dell’uomo in quanto
uomo, ma si porrebbe nella definizione di Socrate se Socrate avesse una definizione. Quindi nella definizione dell’uomo non si pone questo osso e questa carne in modo assoluto, che sono materia non
segnata dell’uomo. Così dunque è chiaro che l’essenza dell’uomo e l’essenza di Socrate non differiscono se non come segnato e non segnato]» (L'edizione qui seguita è: S. TOMMASO D'AQUINO, I fondamenti dell'ontologia tomista. Il trattato «De ente et essentia», a c. di D. Lorenz, ESD, Bologna
1992, pp. 132-137. Si veda, a questo proposito, R. PIETROSANTI, L’individuazione delle sostanze corporee
e
personali
nel
pensiero
di
Tommaso
d'Aquino,
(2004),
http://mondodomani.org/dialegesthai/rp02.htm#nota37).
191
Notiamo tuttavia che, in AE, Levinas sembra negare che l’individuazione dell’unico proceda
dalla materia signata hic et nunc; il principio d’invidivuazione consisterebbe nell’«univocità del convocato» (AE, p. 131, nota); ciò non toglie che, nell’economia del discorso che stiamo facendo, si possa far valere, come materia signata, la storia singolare dell’individuo, proprio perché essa è attraversata dall'esperienza del trauma e dunque sollecitata dalla pluralità di convocazioni empiriche entro le
quali egli ha udito la convocazione individualizzante del Bene non fenomenizzabile.
190
125
Venendo al secondo testo, Senza nome, vogliamo notare preliminarmente il
suo carattere epitaffiale. Epitaffio, perché siamo di fronte alla percezione della morte
di altri, e testimoniamo, con la loro memoria, la sofferenza per la nostra sopravvivenza . E Senza nome è senz’altro il testo levinassiano più conosciuto sulla Shoah,
tra tutti quelli nel quali il nostro si confronta, allude, sollecita il lettore ad accostarsi,
con silenzio e rispetto, a questo evento, invitando a corrispondervi a livello etico.
Togliere il volto, togliere il nome, privare qualcuno dell’identità personale è esattamente quello che accadde ad Auschwitz. Qui, come è noto, i nomi propri vennero
cancellati, e al loro posto c’erano i numeri matricolari tatuati sul braccio, a segnalare
l’anonimità di un processo “industriale” di produzione di morte 192.
Questo testo «si apre con un grido terrificante al di sopra dell’abisso e nel
quale si riconoscono dalle intonazioni vicine a quelle di primo Levi»193, dove si constata la tragicità del secolo Ventesimo, e, in esso, l’unicità dell’«abbandono» patito
dalle vittime ebraiche. «Abbandono» che segnala la solitudine degli ebrei sterminati
in un mondo tecnologicamente e culturalmente evoluto che sembrava ignorare le loro
grida, in un tempo in cui «i giudizi vacillanti sul bene e sul male trovavano un criterio soltanto all’interno delle pieghe nascoste della coscienza soggettiva194», dove si
constatava l’«interregno o [la] fine delle Istituzioni, [...] come se perfino l’essere fosse rimasto sospeso».
Notiamo anche in questo testo (edito originariamente nel 1966 con il titolo
Honneur sans drapeau [Onore senza bandiera]) la ripetizione del tema della caduta
dell’ufficialità che avevamo visto negli inediti della prigionia attraverso la metafora
della «caduta del drappo», qui rappresentata dall’onore reso ad un morto senza la
bandiera, in un contesto, quindi, di disgregazione del contesto statuale,
quell’hegeliano «Spirito oggettivo» in cui la ragione regola le relazioni umane.
Il brano ci pare recuperi, anche testualmente, delle annotazioni di cui solo
ora, dopo la pubblicazione dei Carnets, possiamo attribuire la scrittura nel periodo
del’internamento. Quasi letteralmente, infatti, leggiamo a pagina 158 dei Carnets la
192
Si ricordi quanto scrive Primo Levi sui prigionieri ridotti a numeri: «Null Achtzehn. Non si
chiama altri che così. Zero Diciotto, le ultime tre cifre del suo numero di matricola: come se ognuno si
fosse reso conto che solo un uomo è degno di avere un nome, e che Null Achtzehn non è più un uomo»
(P. LEVI, Se questo è un uomo, Opere I, Einaudi, Torino 1987, p. 37).
193
S. MALKA, Emmanuel Levinas. La vie et la trace, tr. it. cit. p. 91.
194
«Senza nome», in NP, p. 155.
126
seguente immagine: «E già un vento glaciale percorre le stanze decenti e lussose,
strappa le tappezzerie [draperies] e i quadri, spegne le luci, dirocca i muri, riduce a
brandelli i vestiti, e porta con sé le grida e le urla d’implacabili folle». Se, come già
constatato, ricordiamo che in vari luoghi dei Carnets questa immagine è connessa a
quella della «fine del mondo»195 o «fine del senso196», di cui Levinas parla anche in
sede di apertura di EE197, e che questo stesso plesso terminologico-concettuale è esibito come allusione alla Shoah, possiamo trarre la conclusione che già nella prima
parte della sua produzione postbellica Levinas si muovesse nell’orizzonte
dell’evento-Shoah, pensato come fine del senso.
Auschwitz è un orizzonte traumatico-catastrofico, in cui ogni identità umana
e sociale è perduta, ma di più, in cui è perduta o sospesa la stessa consistenza ontologica e si sprofonda di nuovo nell’il y a attraverso una disintegrazione del sé e del
mondo198. Tale è il senso profondo della Catastrofe, quasi che la creazione stessa fosse stata cancellata e il mondo ricadesse nell’insensatezza del biblico tohu wa-bohu.
In questo contesto di disgregazione ontico-ontologica, regnava la distruzione di ogni
possibilità di sostegno e riconoscibilità pubblica e ufficiale: i silenzi delle istituzioni,
degli intellettuali e delle chiese – ricorda Levinas – riecheggiavano le «“cadenze serrate” del primo capitolo delle Lamentazioni […] e il lamento del rituale del Kippur:
“Né gran sacerdote per offrir sacrifici, né altare per deporvi i nostri olocausti”»199. E
poi leggiamo il passo centrale:
«Quando si ha questo tumore della memoria, vent’anni non possono cambiarvi nulla. Senza dubbio la morte verrà presto ad annullare l’ingiustificato
privilegio di esser sopravvissuti a sei milioni di morti. Ma anche se durante
questa dilazione gratuita, le occupazioni e le distrazioni della vita riempivano
di nuovo la vita, anche se tutti i valori disprezzati – o antidiluviani – rientrano
in vigore, anche se tutte le parole, che si pensa appartenessero a lingue morte,
riappaiono nei giornali e nei libri, anche se molti dei diritti caduti in prescri195
CCAI, p. 132.
Ivi, pp. 123.
197
V. supra cap.1, par. 3.
198
Torneremo su questo tema in sede di discussione degli effetti dello stato psichico indotto dal
trauma. Cfr. infra, cap. II, par. 3.
199
CCAI, p. 156.
196
127
zione trovano di nuovo istituzioni e forza pubblica per proteggerli, nulla ha
potuto colmare, neppure coprire, l’abisso spalancato. Vi si ritorna soltanto un
po’ meno di frequente dagli angoli riposti della nostra dispersione quotidiana,
e la vertigine che afferra sull’orlo dell’abisso è sempre la stessa»200 .
Questo passo, sul quale potrebbero scriversi diversi libri, esibisce insieme il
trauma personale e generazionale, la percezione di una dilazione della morte insita
nella propria sopravvivenza rispetto agli sterminati. La «dilazione gratuita» (scil. casuale) della morte è percepita come un «privilegio ingiustificato». Tale tonalità emotiva fa da sfondo alla continuazione della esistenza del sopravvissuto, esistenza che si
caratterizza come una dispersione «nelle distrazioni e nelle occupazioni che riempiono di nuovo la vita», ma che non valgono a far dimenticare «la vertigine che afferra
sull’orlo dell’abisso».
La vita quotidiana è come un manoscritto nelle faglie del quale appare un palinsesto incancellabile, ma che solo momentaneamente si può rimuovere. Levinas
dice infatti: «vi si ritorna un po’ meno di frequente»; ma questa riserva, lungi
dall’attenuare la qualità del vissuto traumatico, ne enfatizza la radicale insuperabilità,
o se vogliamo l’attenuarsi solo altalenante dei suoi sintomi. Sintomi di una «malattia
del ricordo», tanto è vero che, per contrappunto, in relazione a chi non l’ha provata
(«l’umanità la cui memoria non è malata dei propri ricordi201»), Levinas si domanda
poi se valga la pena di «ostinarsi a farla entrare in questa vertigine [e se ] i nostri figli
che nacquero all’indomani della liberazione e che appartengono già a questa umanità
[…] potrebbero comprendere questa sensazione di caos e di vuoto»202
Pesa su queste parole un senso di profondo disincanto rispetto ai possibili
tentativi fatti per educare o coscientizzare quella parte di umanità che non è stata investita dalla distruzione, e soprattutto le nuove generazioni, estranee al sentimento di
trauma collettivo dei sopravvissuti. Levinas sa che ciò è probabilmente impossibile:
non è possibile empatizzare con un trauma così sconvolgente, al punto da non essere
comunicabile. Non è a livello di compassione, o di condivisione di sentimenti, che si
può cercare di trarre un insegnamento ostensibile per chi non ha vissuto quel trauma.
200
201
202
Ibidem, ccnn.
Ibidem.
Ibidem.
128
Prima dell’insegnamento, occorre il ricordo, la perseveranza nell’identità
ebraica e la richiesta di giustizia «senza prescrizione» contro i colpevoli, nonché la
diffidenza verso l’umanità che creda in un progresso soltanto tecnologico203. Sovente
non si riporta questo passo nella sua integrità, ma ci sembra necessario riproporlo,
anche per segnalare che su questo presupposto ineludibile Levinas e Fackhenheim
sono concordi. Leggiamo, infatti:
«Al di là dell’incomunicabile emozione di questa Passione, in cui tutto fu
compiuto [Olocausto], che cosa si deve e che cosa si può trasmettere
vent’anni dopo, sotto forma di insegnamento? Ricordare di nuovo il difficile
destino e ebraico e l’indurimento della nostra cervice? Esigere una giustizia
senza passione e prescrizione e diffidare di una umanità le cui istituzioni e le
cui tecniche soltanto condizionano il progresso? Certo.»204.
Se il sentimento di trauma collettivo non è comunicabile, è per lo meno auspicabile che si possa però trarre un insegnamento universale dall’esperienza della
Shoah. Levinas indica questo insegnamento in tre possibili direzioni:
«Per vivere in maniera umana gli uomini hanno bisogno di molto ma molto
meno meno rispetto a ciò che offrono le magnifiche civiltà in cui vivono: ecco la prima verità […] Ma – seconda verità – nelle ore decisive, quando la
caducità di tanti valori si svela, tutta la dignità umana consiste nel credere al
loro ritorno; [e infine] terza verità: è necessario insegnare alle generazioni
nuove la forza necessaria per essere forti nell’isolamento e tutto ciò che una
fragile coscienza è in quel caso chiamata a contenere […] comportarsi in pieno caos come se il mondo non si fosse disintegrato […] aprire un nuovo ac203
Levinas non è pregiudizialmente contrario alla tecnica ma piuttosto la considera come uno
strumento che può essere usato bene, se rimane nel suo statuto di mezzo per aiutare l'umanità, o male,
se diventa un fine ipostatizzato ad idolo disumanizzante. Sul rapporto con la tecnica e sulla relativa
critica ad Heidegger, Levinas dice parole molto chiare in un bellissimo saggio del 1961, «Heidegger,
Gagarin e noi», in DL, pp. 289-292, dove stigmatizza «l’eterna seduzione del paganesimo…il sacro
che filtra attraverso il mondo» (ivi, p. 291), in un pensiero, quello heideggeriano, in cui si vuole rifiutare la tecnica per radicarsi nel culto della terra e nell’apertura di un mondo che solo l’opera d’arte può
svelare. E tuttavia a questo pensiero Levinas oppone ancora una volta «il giudaismo», che «non ha
sublimato gli idoli ma ne ha preteso la distruzione: come la tecnica, ha demistificato l’universo. Ha
tolto l’incantesimo della natura […] ma ha scoperto l’uomo nella nudità del suo volto» (ivi, p. 292).
204
«Senza nome», in NP, p. 156.
129
cesso ai testi ebraici e restituire alla vita interiore un nuovo privilegio. La vita
interiore: si ha quasi vergogna a pronunciare, davanti a tanti realismi ed oggettivismi, l’espressione insignificante»205.
Dunque: a) richiamo ad un’essenzialità ed austerità di vita; b) capacità di resistere nella speranza verso i valori umani; c) primato della vita interiore rispetto alla
disgregazione del senso, e anche, come lo stesso Levinas dice nella fine del suo testo,
rispetto alla civiltà e alle istituzioni statuali, nei confronti delle quali, essa, in quanto
soggettività etica, è una «condizione [che sta] al di qua»206, e che quindi deve informare di se quelle civiltà e quelle istituzioni.
La «vita interiore207», non è un «pensiero devoto» ma elezione della Bene
nella soggettività etica, ribadirà Levinas in molti luoghi nelle sue opere successive; è
la condizione mai riducibile in cui le istituzioni, gli stati, la giustizia “razionali” (di
cui pure c’è necessità) acquisiscono la loro misura veramente umana e rispondono
dell’evento impronunciabile con cui la stessa umanità, sempre a rischio di ricadere
nel «vuoto e nel caos», non può fare a meno di misurarsi.
Veniamo ora all’ultimo testo, L’assimilazione oggi. Parlando del tema
dell’assimilazione del popolo ebraico della diaspora, caratterizzata sempre da persecuzione e discriminazione, e dell’ideale sionista, concretizzatosi nella costruzione
dello Stato d’Israele (1948), Levinas sembra a prima vista individuare una possibile
trasfigurazione della sofferenza in un insegnamento verso l’umanità in generale.
Ma dietro l’apparente compensazione del sogno sionista, rispetto alla Passione storica del popolo culminante in Auschwitz, si cela l’impossibilità di un detto che
compiutamente espliciti, senza tradirlo, il senso di questa smisurata sofferenza, insieme troppo piccola e troppo grande per affrancarsi dal suo statuto enigmatico, sofferenza nel cui non-luogo si traccia la «voce di un silenzio sottile208», di un Passag-
205
Ivi, pp. 156-157.
Ivi, p. 159.
207
«La vera vita interiore non è un pensiero devoto o rivoluzionario che ci giunge in un mondo
ben saldo, ma l’obbligo di dar riparo all’intera umanità dell’uomo nella capanna, esposta a tutti i venti,
della coscienza» (ivi, p. 158).
208
«Gli disse: ‘Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore’. Ed ecco che il Signore passò.
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il
Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il
terremoto ci fu una folgore, ma il Signore non era nella folgore. Dopo la folgore, ci fu una voce di
206
130
gio che invita a uscire dalla caverna (di Elia, nel testo biblico) coperti da un mantello,
«voce di un silenzio sottile» verso cui la preghiera, questo «quasi-riferimento a un
Dio innominabile, [questo] originario pensare all’Assente209», pre-origina qualunque
intenzionalità dossica e tematizzante, dischiudendo la possibilità di una «piccola bontà» che possa, per testimoniale interruzione e contestazione del disordine storico, corrispondere, nel dire etico, al «Dio sofferente per la sofferenza dell’io»210. Il riferimento alla rivelazione di Dio del primo libro dei Re è significativa, in questo passo
che sintetizza, ci sembra, l’intera lettura levinassiana della Shoah:
«Ci sono disperazioni che le parole non potrebbero raccontare ma
che mandano in frantumi il silenzio che le custodisce senza per questo spezzarlo, come se un qualche dio che passava in incognito avesse rubato il segreto. L’intollerabile intensità del vissuto è un fantasma del dio o è il suo
fuggitivo passare? Come in una colpa non confessata, il rimorso è forse già il
bruciare dello sguardo che ha saputo. Il vissuto è troppo piccolo per il suo
senso. L’ambiguità o l’enigma della situazione è più religioso delle soluzioni
proposte. […] la persecuzione nazista e il sogno sionista sono eventi religiosi.
[…] La Passione in cui tutto si è compiuto e l’audacia di un nuovo inizio […]
sono stati percepiti come i segni della stessa elezione o della stessa maledizione, vale a dire dello stesso destino eccezionale. I contemporanei conserveranno una ferita nel fianco: erano troppo vicini al Proibito e all’Indicibile.
Hanno avuto torto a sopravvivere? Qualunque sia stato il pensiero di questa
generazione – rivolta, negazione, dubbio o certezza gloriosamente confermata
nelle umiliazioni – esso portava il sigillo della prova estrema. Per l’intera
umanità acquistò significato uscendo dall’ordine»211.
Consideriamo questa ultima domanda: «Hanno avuto il torto di sopravvivere?». Come spesso accade Levinas lascia sotto forma interrogativa le questioni essenziali, che non hanno possibilità di risposta se non nel rilancio con cui non possiasilenzio sottile. Come la udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna» (1 Re, 11-13, tr. CEI 1971).
209
ADV, p. 251, nota.
210
NODN, p. 147.
211
«L’assimilazione oggi» (1954), in DL, pp. 325-326, ccnn.
131
mo fare a meno di riproporle sempre, in quanto ogni tentativo di risposta (il detto)
viene a depotenziare il senso originario che esse, come domande, donano
all’esistenza. Come gli aveva probabilmente insegnato Shushani, il cui incontro ci è
narrato da un comune allievo Elie Wiesel, la forza delle domande oltrepassa la chiarezza delle risposte e «le parole svaniscono nella notte senza arricchirla […]: l’uomo
si definisce per ciò che lo inquieta, non attraverso quello che lo rassicura»212.
Vogliamo ora indagare questo senso di colpa, che Levinas come ogni sopravvissuto di tutti gli eventi tragici catastrofici ha sempre condiviso, perché esso ci sembra un tema fondamentale per cogliere la cifra traumatologica del discorso levinassiano, da AE in poi.
212
«È questo tutto ciò che trovi da dire? Che è bello? Imbecille, della bellezza me ne infischio,
non è che apparenza e scena: le parole svaniscono nella notte senza arricchirla .Quand’è che capirai
che una bella risposta non è nulla? Nient’altro che illusione. L’uomo si definisce per ciò che lo inquieta e non per ciò che lo rassicura. Quand’è che capirai che vivevi e cercavi nell’errore, perché Dio
significa movimento e non spiegazione?» (E. WIESEL, Le chant des morts, Éditions du Seuil, Paris
1966, tr. it. di D. Vogelmann, L’ebreo errante, Giuntina, Firenze 1983, p. 104, ccnn).
132
3. Il trauma e la sindrome del sopravvissuto: interpretazioni psicoanalitiche.
Vergogna di non essere morti, ce l'ho anch'io: è
stupido ma ce l’ho. É difficile spiegarla. É
l’impressione che gli altri siano morti al tuo posto; di essere vivi gratis, per un privilegio che
non hai meritato, per un sopruso che hai fatto ai
morti. Essere vivi non è una colpa, ma noi la
sentiamo come una colpa (Primo Levi)213.
In questo paragrafo intendiamo esplorare l’ipotesi che la difesa privilegiata
contro il trauma catastrofico, determinante tra i suoi sintomi maggiori un senso di
colpa costante, sia la difesa morale, e che in Levinas questa categoria sia centrale per
comprendere lo sfondo fondamentale del suo pensiero. Una sterminata bibliografia è
dedicata al versante fenomenologico del pensiero levinassiano, ma ancora scarsa,
soprattutto in Italia, è una lettura di esso che ponga adeguatamente in rilievo
l’elemento in questione.
Il concetto di difesa morale, che cercheremo di mostrare come esito del trauma, è stato elaborato dallo psicanalista scozzese Ronald Fairbairn, e costituisce un
elemento chiave di un assetto teorico-clinico che, sulla scia della scuola inglese delle
relazioni oggettuali, si pone come un importante apporto innovatore rispetto alla teoria classica delle pulsioni, sostenuta a partire dal 1897-1905 da Sigmund Freud. Su
questa base, dopo aver brevemente ricostruito il decorso freudiano del concetto di
trauma, cercheremo di delineare, sulla scorta degli studi di Felicity de Zulueta e Henry Kristal, un concetto di trauma che ci aiuti a comprendere un po’ meglio alcuni
elementi che emergono nei testi levinassiani.
È opportuno però chiarire in via preliminare che il nostro intento non è di
“psicanalizzare Levinas”, facendo indebite illazioni sulla personalità dell’autore, ciò
che non sarebbe possibile né corretto da un punto di vista scientifico214. Ma ci pare
213
Se non ora, quando?, Einaudi, Torino 1992, p. 219.
Su questo tema, ci sembrano importanti le considerazioni della psicanalista italiana Clara Mucci, che afferma: «Vorrei iniziare con lo sgombrare il campo da un fraintendimento che pesa sulla critica letteraria psicoanalitica dai tempi di Freud, il quale in realtà è stato il primo a compiere
quest’errore, quello di analizzare il testo psicoanalizzando il suo autore o, addirittura, tentando di ana214
133
legittimo, invece, interpretare le sue testimonianze (che abbiamo visto precedentemente) come sintomi di qualcosa che aiuti a comprendere un po’ meglio non già la
sua psicologia personale, ma il modo con la quale l’esperienza si è sedimentata nei
testi è ha condizionato il suo pensiero etico, soprattutto nell’ultima fase del suo percorso.
Il concetto di trauma è giustamente considerato un vero e proprio Shibbolet
della psicoanalisi215, uno dei criteri discriminanti rispetto ai quali si articolano i suoi
vari orientamenti clinici e teorici nel contemporaneo. Come scrive Antonio Semi, il
termine trauma, dal greco ferita, «appartiene a una famiglia lessicale derivata dalla
radice tro-, che contiene il significato di “forare” o “bucare”. Anche nel francese attuale trou equivale a “buco”. Trauma è dunque una discontinuità, e traumatico è un
evento che la induce»216.
Il potere dirompente di eventi esterni sull’attività psichica, e più in generale
sull’individuo, era stata individuato nella psichiatria e nella psicologia medica, mentre in psicoanalisi «la storia del concetto di trauma si intreccia con la storia stessa
della costruzione della teoria psicoanalitica»217, che non possiamo in questa sede ricostruire dettagliatamente ma che ripercorreremo solo nelle sue linee essenziali218.
lizzare i personaggi delle opere in questione. È veramente ora, come da più parti si è protestato […],
di non considerare più la psicoanalisi come uno strumento da “applicare” alla letteratura, da usare per
dissezionare, esaminare e “decrittare rebus”. Casomai dobbiamo parlare di “implicazioni”, di somiglianze formali (cioè legate alla forma): è ormai un dato di fatto che la mente e il testo condividano
una stessa logica formale, retorica, come insigni linguisti, psicoanalisti e critici letterari hanno osservato al riguardo. […] È la mente che funziona come un testo; e il testo porta i segni di quelle repressioni che sono dovute a meccanismi mentali, inconsci, come condensazione e spostamento, che segnano sia il sogno che la figuralità del testo» (C. MUCCI, Psicoanalisi, letteratura, testimonianza: parola e narrazione come etica, da Freud alla Shoah, «Rivista di letterature moderne e comparate», vol.
64, n. 1[2011], p. 53).
215
G. SACERDOTI-A.A. SEMI, Trauma as a Shibboleth in Psychoanalysis?, «International Journal of Psyco-analysys», 70 (1989), pp. 95-103.
216
A.A. SEMI, «Trauma», in AA.VV., Psiche, Dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, vol. II (L-Z), Einaudi, Torino 2007 (pp. 1116-1121), p. 1116.
217
Ibidem.
218
Entro la sterminata letteratura sull’origine e lo sviluppo del concetto di trauma in psicoanalisi, ci siamo serviti soprattutto, oltre che del già citato articolo di Antonio Semi, dei seguenti studi:
AA.VV, L’ombra del trauma. Sui limiti della simbolizzazione, «Quaderno del Centro Psicoanalitico di
Roma», n. 3, Franco Angeli, Roma 2009; AA.VV (a c. di R. Williams), Trauma e relazioni. Le prospettive scientifiche e cliniche contemporanee, Cortina, Milano 2009; M. MASUD. R. KAHN, The privacy of the Self, Hogart Press, London 1974; tr. it. di C. Ranchetti Varon e E. Sagitario, Lo spazio
privato del sé, Bollati Boringhieri, Torino 1979; F. DE ZULUETA, From Pain to Violence, Second edition, Whurr Publishers Limited, London 2006; tr. it. di C. Pessina Azzoni e M. Luci, Dal dolore alla
violenza. Le origine traumatiche dell’aggressività, 2a ed., Cortina, Milano 2009; C. MUCCI, Il dolore
estremo. Il trauma da Freud alla Shoah, Borla, Roma 2008.
134
Come è noto, Sigmund Freud riprese da Charchot l’entità nosografica di
«isteria traumatica», che il medico francese aveva incluso tra le varie forme di isteria,
implicando una eziologia traumatico-meccanica, e la chiamò, sulla scorta di Hermann Oppenheim «nevrosi traumatica». Con lo svilupparsi della società industriale,
si constatava che frequenti erano gli incidenti ferroviari e lavorativi nei grandi cantieri. Alcuni di questi non comportavano lesioni fisiche apparenti, ma presentavano un
grave shock con confusione mentale e agitazione, a cui seguiva una seconda fase con
l’insediarsi di sintomi quali paralisi, tremori, anestesie, afasie, disturbi della vista e
dell’udito, amnesie e attacchi, ossia la ripetizione dell’incidente in stati alterati di coscienza, o in sogni ricorrenti.
Sulla base di queste constatazioni, Freud, nella prima fase del suo pensiero,
postulò che il ricordo del trauma agisse come un corpo estraneo efficiente anche molto tempo dopo l’intrusione nella vita del paziente. Non si trattava di una ingenua
concezione “meccanica” degli effetti psichici del trauma, giacché l’intensità della
patologia dipendeva dalle particolari condizioni e dalla storia individuale del soggetto, dal suo decorso psichico infantile, puberale e postpuberale e quindi dai particolari
assetti psichici sui quali l’evento traumatico andava ad impattare.
Nel 1893 Freud, insieme a Breuer219, aveva attribuito i sintomi dei pazienti
isterici alla memoria del trauma, che agisce come un corpo estraneo stabilmente al
lavoro nell’inconscio. Questa memoria, non disponibile consciamente per il paziente,
sarebbe resa cosciente in sede di ipnosi grazie al metodo catartico, potendo così essere adeguatamente abreagito l’insieme di sintomi ad essa connessi. Il malato, perciò,
«soffrirebbe per lo più di ricordi»220, e l’esperienza scatenante, di qualunque natura
sia, costituirebbe il trauma: «può agire come trauma qualsiasi esperienza provochi
effetti penosi del terrore, dell’angoscia, della vergogna, del dolore psichico e dipende
ovviamente dalla sensibilità della persona colpita»221. In questo quadro è evidente
219
S. FREUD, «Sul meccanismo psichico dei fenomeni isterici», in Opere, vol. 1, Bollati Borighieri, Torino 2009, pp-175-188 (Per le citazioni freudiane ci serviamo dell’edizione in 12 voll.,
[1967-1993], a c. di C.L. Musatti, alla quale rinviamo per i dettagli bibliografici). Freud affermava:
«Che nell’isteria traumatica sia l’infortunio ad aver provocato la malattia è ovvio, e così pure il nesso
causale è evidente quando, negli attacchi isterici, dalle dichiarazioni degli ammalati si apprende che
essi in ogni attacco rivivono in modo allucinatorio sempre lo stesso avvenimento che aveva provocato
il primo attacco. […] Nella nevrosi traumatica non la lesione fisica, in sé modesta, è la vera causa della malattia, ma lo spavento, il trauma psichico» (ivi, vol. 1, p. 177).
220
Ivi, p. 179
221
Ivi, p. 177.
135
che, benché non si specifici di quale evento – o serie di eventi cumulativi –, si possa
trattare, l’accadimento causale esterno deve sussistere, e il ruolo svolto
dall’economia psichica consiste nel contenere l’energia da esso scatenata; laddove
infatti la disposizione psichica soggettiva non riesca a padroneggiare gli stimoli provenienti dall’esterno, essi si fisseranno causando la patologia.
La nevrosi traumatica può dipendere da due serie di fattori: innanzitutto dal
fatto che il paziente non ha sufficientemente reagito al trauma, «con tutta una gamma
di riflessi volontari o involontari come la vendetta o il pianto, aventi un “effetto catartico” (“scaricare il rancore”, sfogarsi col pianto”222)», oppure facendo entrare
l’evento traumatogeno «nel grande complesso dell’associazione, affiancandosi ad
altre esperienze che eventualmente lo contraddicano223» (come quando nel corso di
un grave pericolo di morte corso in mare si affiancano all’affetto derivante dal trauma gli altri affetti suscitati dall’aiuto prestatoci, col che la rappresentazione traumatica subisce un affievolimento nel ricordo successivo).
Questo scarico parziale si verifica tuttavia ordinariamente nella persona normale, mentre nell’isterico Freud constata un «fatto sorprendente: […] le esperienze
traumatiche sono del tutto assenti dalla memoria [cosciente] dei malati nel loro stato
psichico ordinario o sono presenti soltanto in forma assai sommaria224». È cioè avvenuta cioè una rimozione225, per fattori riguardanti il contenuto dei ricordi (un lutto
insuperabile o un evento particolarmente increscioso che si vuole dimenticare)226;
oppure si è prodotta, per fattori interni al soggetto, una dissociazione nella coscienza,
sicché «nell’isteria sarebbero presenti gruppi di rappresentazioni sorte in stati ipnoidi
che, escluse dai rapporti associativi con le altre rappresentazioni, ma associabili tra
loro, rappresentano un rudimento più o meno altamente organizzato di una seconda
coscienza, di una condition seconde»227. Le difese maggiori dal trauma sarebbero
222
Ivi, p. 179.
Ivi, p. 180.
224
Ivi, pp. 180-181, corsivo nel testo.
225
Appare in questo testo per la prima volta il termine «rimuovere» [verdrängen], come effetto
di inibizione cosciente (ivi, p. 181, nota 2).
226
«..o perché la natura del trauma escludeva una reazione, come la perdita apparentemente insostituibile di una persona amata, o perché le condizioni sociali rendevano impossibile una reazione, o
perché si trattava di cose che il paziente voleva dimenticare e perciò intenzionalmente rimuoveva dal
suo pensiero cosciente, inibendole e reprimendole» (ivi, p. 181).
227
Ivi, p. 186. La cura consisterebbe dunque nell’eliminare l’efficienza della rappresentazione
originariamente non abreagita in quanto «l’affetto incapsulato sfocerebbe nel discorso, permettendo la
223
136
dunque la rimozione e la dissociazione, benché questa seconda sia meno enfatizzata
nell’analisi freudiana, e sarà maggiormente posta al centro della teoria delle relazioni
oggettuali di matrice anglosassone.
È in questo primo contesto clinico-teorico che si farà strada, di là a qualche
anno, quella che gli studiosi di Freud chiamano la teoria della seduzione infantile,
secondo la quale l’eziologia della nevrosi, ben al di là di un trauma qualsiasi, sarebbe
da rinvenire in uno specifico trauma infantile di natura sessuale: «L’esperienza clinica e l’abbandono del metodo catartico conducono infatti Freud, nell’arco degli anni
1893-1897, a ritenere provata l’esistenza di un trauma sessuale avvenuto
nell’infanzia dei pazienti nevrotici a opera di adulti seduttori»228.
Secondo questa teoria, il trauma occasionale avrebbe solo la funzione di risvegliare il trauma primario, catalizzando après coup, in occasione di eventi anche
apparentemente insignificanti, un reinvestimento incontrollabile delle tracce mnestiche dell’accadimento infantile229. In questo quadro, già l’aspetto materiale esterno
del trauma occasionale perde la sua centralità, diventando solo l’attivatore di fantasmi, da esso attivati nell’afflusso di eccitazione pulsionale. Successivamente, a partire dal 1895 in privato (con la famosa minuta M a Fliess230), e in pubblico nel 1905,
Freud abbandonerà l’ipotesi della seduzione traumatica, per orientarsi verso una concezione implicante la perdita del «mito dell’innocenza infantile», con la conseguente
correzione associativa traendola nella coscienza normale […] o annullandola mediante suggestione
del medico» (ivi, p. 187).
228
A. SEMI, art. cit, p. 1118.
229
«L’evento traumatico susciterebbe quindi nell’Io una difesa patologica […] la rimozione.
L’azione del trauma è scomposta in vari elementi e suppone l’esistenza di almeno due elementi: in una
prima scena, detta di seduzione, il bambino subisce un approccio sessuale da parte dell’adulto, senza
che ciò gli provochi un’eccitazione sessuale; una seconda scena, spesso apparentemente anodina, che
si svolge dopo la pubertà rievoca per qualche tratto associativo la prima. Il ricordo della prima evoca
un afflusso di eccitazioni sessuali che travolge le difese dell’Io. Sebbene Freud chiami trauma la prima
scena, è evidente che, dal punto di vista strettamente economico, tale valore gli è conferito solo posteriormente; inoltre, è solo come ricordo che la prima scena diventa patogena, in quanto provoca un
afflusso di eccitazioni interne. Contemporaneamente[…] si attenua l’idea del trauma fisico, in quanto
la seconda scena non agisce per energia propria ma solo risvegliando un’eccitazione di origine endogena. In questo senso, la concezione di Freud apre già la via all’idea secondo cui gli eventi esterni
traggono la loro efficacia dai fantasmi da essi attivati e dall’afflusso di eccitazione pulsionale che essi
provocano» (voce: «trauma», J. LAPLANCHE - J.-B. PONTALIS, Vocabulaire de la psychanlyse, PUF,
Paris 1967; ed. it. a c. di G. Fua, Enciclopedia della psicoanalisi, 2 Voll., Laterza, Roma-Bari 20088;
Vol. II , pp. 657-658).
230
Opere, Vol. 2, cit., pp. 61-63. Due anni dopo, sempre in una lettera a Fliess (minuta K),
Freud elaborerà la nozione di Nachträglichteit, tradotta in francese con après coup, secondo la quale il
trauma nasce sempre a posteriori, in occasione di un avvenimento anche apparentemente irrilevante,
perché nel nevrotico «troviamo sempre che viene rimosso un ricordo il quale diventa un trauma solamente più tardi» (ivi, p. 51).
137
elaborazione di un modello metapsicologico in cui il trauma sarà collegato alla forza
e all’urgenza delle pulsioni libidiche intrapsichiche sovrastanti, e alla lotta che l’Io
conduce verso di esse.
Tra il 1915 e il 1926, e in particolare con il saggio Al di là del principio di
piacere (1920), studiando i pazienti affetti da traumi di guerra, nei cui sogni ritorna
ossessivamente l’esperienza traumatica patogena, Freud supererà la concezione monopulsionale implicità nell’Interpreazione dei sogni, e legata alla sola libido, per postulare un dualismo pulsionale: da una parte starebbero le pulsioni dell’Io, che spingono verso la morte, e caratterizzano gli aspetti di aggressività individuale e sociale,
e dall’altra le pulsioni sessuali, che spingono verso la socialità e in più in generale
verso la continuazione della vita.
Con la formulazione, a partire dal 1922, della seconda topica (Io, Es, SuperIo), secondo Masud Kahn: la «base teorica del concetto di trauma diventa esclusivamente intersistemica e pulsionale»231. L’ultima fase dello sviluppo freudiano della
teoria del trauma sarebbe quella che matura tra il 1925 e il 1939. Infatti, in Inibizione, sintomo, angoscia (1925), Freud distinguerà tra «situazioni traumatiche» e «situazioni di pericolo», corrispondenti a due diversi tipi di angoscia, l’angoscia automatica e l’angoscia come segnale dell’avvicinarsi del trauma.
L'angoscia automatica è determinata dal verificarsi di una situazione traumatica, la cui essenza è «un’esperienza d’impotenza» da parte dell’Io nei confronti di un
accumulo di eccitazione (tali esperienze sono: «nascita, perdita della madre in quanto
oggetto, perdita del pene, perdita dell’amore dell’oggetto, perdita dell’amore del Super-io»)232 ; la situazione di pericolo, invece, è una riproduzione anticipatoria e attenuata del trauma, quando già esso è previsto e atteso sapendo di che si tratta; tale ripetizione è prodotta nella speranza di poterne attenuare autonomamente lo sviluppo233. Secondo Kahn, il ruolo dell’ambiente (madre) e il bisogno di aiuto esterno in
231
M. MASUD. R. KAHN, The privacy of the Self, tr. it. cit., p. 42.
Ivi, p. 43.
233
«Chiamiamo traumatica una situazione vissuta d’impotenza; abbiamo allora un buon motivo
per distinguere la situazione traumatica dalla situazione di pericolo. È ora un progresso importante
nella nostra autoconservazione se una tale situazione traumatica d’impotenza non è solo vagamente
attesa, ma prevista e aspettata sapendo di che si tratta. La situazione nella quale sono contenuti gli
elementi che determinano una simile aspettativa può chiamarsi la situazione di pericolo, ed è in essa
che viene dato il segnale di angoscia. Ciò significa: io mi aspetto che si verifichi una situazione
d’impotenza; oppure: la situazione presente mi ricorda una delle situazioni traumatiche precedentemente vissute. Perciò io anticipo questo trauma e mi comporto come se esso fosse già presente, fintan232
138
situazioni d’impotenza diventeranno centrali, in quest’ultima fase del pensiero freudiano, per il concetto di trauma, così da «[integrare in] una teoria unitaria le origini
intrapsichica, intersistemica e ambientale»234.
Altri studiosi hanno invece maggiormente enfatizzato la svolta avvenuta nel
1897, come quella in cui, da un primitivo concetto di trauma legato al condizionamento di un fattore causale esterno, implicito nella teoria della seduzione, si sarebbe
passati ad una visione del trauma legato alla teoria delle pulsioni intrapsichiche, e
quindi ad un ridimensionamento, se non ad una vera e propria esclusione,
dell’elemento ambientale. La continua elaborazione del pensiero freudiano mostrerebbe infatti, pur nell’oscillazione e nell’ambivalenza teorica circa l’apporto eziologico del fattore ambientale nella patologia nevrotica, un deciso sviluppo nella direzione del carattere endogeno della genesi del trauma: «l’evento materiale (la cosiddetta «scena primaria»235), non è necessario, ma soprattutto, qualora esso si sia realmente verificato in tutta la sua rilevanza, verrà comunque, “cannibalizzato dal fantasma”236, e sarà quindi subordinato ad esso»237.
Il ricordo del fatto da parte del paziente, in sogno o in analisi, non sarebbe
una “menzogna”, ma una verità psichica dell’inconscio, che assumerebbe un valore
di realtà pari a quello della realtà materiale e storica: «Insomma sarebbe la realtà psi-
toché c’è tempo ancora di respingerlo. L’angoscia è dunque da un lato l’aspettazione del trauma,
dall’altro la ripetizione attenuata di esso. I due caratteri che ci hanno colpito a proposito dell’angoscia
scaturirono dunque da fonti diverse. La relazione d’angoscia con l’attesa appartiene alla situazione di
pericolo, la sua indeterminatezza e mancanza d’oggetto appartengono alla situazione traumatica
d’impotenza, situazione che viene anticipata nella situazione di pericolo. In base allo svolgimento
della serie angoscia-pericolo-impotenza (trauma), possiamo riassumere così l’esposizione precedente:
la situazione di pericolo è la situazione riconosciuta, ricordata, attesa, d’impotenza. L’angoscia è la
reazione originaria all’impotenza vissuta nel trauma, reazione la quale, in seguito, è riprodotta nella
situazione di pericolo come segnale d’allarme. L’io, che ha vissuto passivamente il trauma, ripete ora
attivamente una riproduzione attenuata dello stesso, nella speranza di poterne orientare autonomamente lo sviluppo («Inibizione, sintomo, angoscia», in Opere, vol. 10, cit., pp. 311-312).
234
M. KAHN, op. cit., p. 43.
235
Nella «Lezione 23. Le vie per la formazione dei sintomi» (Opere, Vol. 8, cit., pp. 514-531),
Freud sostiene che il bambino avrebbe assistito al coitus a tergo ‘more ferarum’ dei genitori, e ciò gli
avrebbe fatto capire che l’ipotesi angosciosa dell’evirazione non sarebbe una vuota minaccia (ivi. p.
525). Pur rimanendo Freud oscillante circa l’effettiva realtà materiale di tale evento, e supponendo
dapprima in ipotesi subordinata che il bambino sia stato testimone non di un coito tra genitori ma tra
animali, che egli avrebbe in seguito spostato sui genitori come se avesse presunto che anche i genitori
lo facessero in quel modo, successivamente Freud concluderà la discussione sul valore di realtà della
scena primaria con un non liquet.
236
A. GREEN, «La realtà psichica: estensione e limiti», in C. GENOVESE (a c. di), La realtà psichica, Borla, Roma 2000.
237
C. GENOVESE, «Il trauma psichico: il percorso freudiano, la sua eredità e le sue vicissitudini», in AA.VV., L’impronta del trauma. Sui limiti della simbolizzazione, cit., p. 201.
139
chica a conferire una valenza traumatica all’evento, il quale non costituirà più né una
condizione sufficiente, ma da questo momento in poi neppure necessaria»238
all’insorgere della nevrosi.
Resterebbe tuttavia, in Freud, caratteristica del concetto (dai contorni sfumati)
di trauma una duplice concezione: in prima istanza, esso costituisce «un apporto improvviso e dirompente di energia psichica, al quale l’apparato psichico deve rispondere con un continuo controinvestimento energetico»; e, in seconda istanza, «il concetto di fissazione dell’evento traumatico, pur nella sua non soddisfacente determinatezza teorica [non sarà mai abbandonato da Freud]»239.
In questo quadro, per il pensatore viennese, che l’evento traumatico sia reale
o fantasmatico rimarrà sempre effettivamente aporetico, mentre l’idea che l’Io subisca una breccia, proveniente dall’interno del sistema psichico o dall’esterno, rimarrà
costante, come si può constatare anche dalla seguente citazione tratta da Al di là del
principio di piacere (1920, sebbene questo testo, come ripetiamo, inauguri la teoria
del dualismo pulsionale Eros-Thanatos):
«Chiamiamo “traumatici” quegli eccitamenti che provengono
dall’esterno [dell’Io] e sono abbastanza forti da spezzare lo scudo protettivo.
Penso che il concetto di trauma implichi quest’idea di una breccia inferta alla
barriera proiettiva che di norma respinge efficacemente gli stimoli dannosi.
Un evento come il trauma esterno provocherà certamente un enorme disturbo
nell’economia energetica dell’organismo, e mobiliterà tutti i possibili mezzi
di difesa»240.
Nel suo classico Trattato di psicoanalisi (1934), vero testo di scuola per generazioni di clinici, Otto Fenichel presenterà un concetto di trauma abbastanza largo,
tale da integrare in una teoria generale delle pulsioni l’elemento intrusivo degli «stimoli esterni», la funzione fondamentale dell’apparato psichico consistendo nella
reintegrazione dell’equilibrio da essi provocato, dapprima attraverso lo scarico
dell’eccitamento, poi attraverso l’associazione, da ultimo attraverso la combinazione
238
239
240
Ivi, p. 200.
A.A. SEMI, art. cit., p. 1119.
S. FREUD, Opere, Vol. 9, cit., p. 215.
140
di scarico e controllo. «Ogni volta – dice Fenichel – che viene a mancare uno stato di
equilibrio relativo, si verifica uno stato di emergenza: un flusso di eccitazione troppo
forte in una data unità di tempo è l’esempio più semplice di tale emergenza»241.
Tuttavia, se il trauma vero e proprio, scrive Fenichel, è un «concetto relativo242», esso costituisce il paradigma genetico dello statuto difensivo dell’Io: «l’Io
può considerarsi un mezzo sviluppatosi allo scopo di evitare stadi traumatici»243.
Con questo rilievo, Fenichel pone il trauma come il fattore costitutivo della coscienza
(anche se l’Io non è esaurito dalla coscienza, essendo in parte inconscio), benché costitutivo per antifrasi e dialetticamente, nella continua lotta intrapresa dall’io contro
le brecce traumatizzanti che tendono a disgregarlo. Resta in non liquet, anche in Fenichel, se l’elemento scatenante l’insorgenza traumatica sia esterno-materiale o
esterno-fantasmatico, anche se tutto induce a ritenere, dal prosieguo del testo, che
Fenichel si muova nell’ambito di una psicogenesi endogena del trauma, dove evidentemente prevale l’approccio intersistemico, l’afflusso di eccitazioni sovrastanti l’Io
potendo provenire dall’Es o dal Super-io.
Fu Karl Abhahm, già nel 1907, ad enfatizzare l’elemento fantasmatico endogeno nella psicogenesi del trauma, univochizzando gli ambivalenti sviluppi della teoria freudiana; egli infatti ipotizza che l’evento materiale, quando si verifica nella realtà, sia esso stesso prodotto dalla fantasia inconscia 244.
A questa interpretazione si oppose invece Sàndor Ferenczi, che tornò a valorizzare l’elemento della realtà materiale (specie relativamente all’abuso infantile) su
quella fantasmatica, ovvero l’apporto determinante dell’ambiente circostante al soggetto nell’insorgenza del trauma, che sarebbe poi riattivato, in sede di analisi, dalla
relazione paziente-analista. Su questo punto, oltre su altre importanti questioni nella
241
O. FENICHEL, The psychoanalytic Theory of Neurosis, W.W. Norton & Co., New York 1934,
tr. it. di C. Gastaldi, Trattato di Psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Astrolabio, Roma 1951
(rist.), p. 136.
242
« […] fattori di economia psichica, previe esperienze, condizioni anteriori o contemporanee
al trauma determinano quale grado di eccitazione superi la capacità individuale» (Ibidem).
243
Ibidem, cdA.
244
«Addurrò in particolare la prova che in gran numero di casi il trauma è voluto dall’inconscio
del bambino, e che in questo dobbiamo scorgere una forma di attività sessuale infantile. […] Ritengo
[…] giustificato in generale ravvisare nella sete di stimoli sessuali, che conduce all’abbandono a
traumi sessuali, una specie anormale di attività sessuale. È singolare che l’incontriamo proprio nella
preistoria di individui nevrotici o malati mentali, nella cui vita successiva anormalità sessuali si trovano a iosa» (K. ABRAHM, Il significato di traumi sessuali della fanciullezza per la sintomatologia della
dementia praecox, in Opere, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino 1975, pp. 370, 375).
141
gestione del dialogo psicoanalitico (che per Ferenczi doveva valorizzare l’elemento
empatico-relazionale analista-paziente, di contro all’atteggiamento neutrale e quasi
insensibile che secondo il suo maestro l’analista avrebbe dovuto mantenere), Ferenczi ruppe com’è noto con Freud. Ne abbiamo testimonianza negli scritti del 19271928
245
, e nel Diario Clinico246. È soprattutto nell’articolo Confusione di lingue tra
gli adulti e il bambino (1932), che Ferenczi richiamerà la necessità di ritornare ad
una causalità esogena nella genesi del trauma, data l’insoddisfazione, in sede clinica,
dell’approccio pulsionale. Egli scrive infatti: «La ricerca scarsamente approfondita
del fattore esogeno comporta il rischio che, basandosi esclusivamente sulla predisposizione e sulla costituzione, si diano spiegazioni affrettate dei vari casi»247.
Ferenczi pone l’accento sulla necessità di non disconoscere la sofferenza del
paziente, attraverso la minimizzazione del suo racconto di abuso, o la riconduzione
di quest’ultimo ad una ipotesi fantasmatica. L’analista, operando una minimizzazione
della verità del racconto del paziente, non farebbe cioè che ripetere le condizioni familiari in cui si è prodotto l’abuso, sovrapponendo il proprio discorso a quello del
paziente. Si opererebbe così una «confusione delle lingue», nella quale, invece di un
ascolto e di un aiuto empatico, l’analista proietterebbe il proprio assetto teorico pregiudiziale sulla peculiare storia del paziente, con ciò impedendo realmente
l’abreazione dei sintomi.
Alla base di questo atteggiamento, ci sarebbe, secondo Ferenczi, la paura inconscia da parte dell’analista dei propri vissuti infantili, con la connessa incapacità di
elaborare la propria immagine idealizzata dei genitori: di fatto, fantasmizzando
l’evento di abuso, l’analista rifiuterebbe di misurarsi col proprio personale vissuto
traumatico, per l’incapacità, dovuta ad un’incompleta analisi personale, di elaborarlo248. Instaurando invece una relazione fiduciale con il paziente, l’analista potrà do245
Scritti contenuti nel IV volume delle Opere, recentemente pubblicato in italiano (S. FERENCPsychalayse 4, Œuvres completes, Tome IV: 1927-1933, Payot, Paris 1982; tr. it. di M. Novelletto
Celletti, E. Ponsi Franchetti, L. Resele e P. Rizzi, Opere, Volume IV (1927-1933), Cortina, Milano
2002).
246
S. FERENCZI, Journal clinique, Payot, Paris 1958; tr. it. di S. Sella Tournon, Diario Clinico,
Cortina, Milano 1988.
247
Opere, Volume IV (1927-1933), cit., p. 91. La relazione, presentata al XII congresso
dell’Associazione psicoanalitica internazionale, tenutasi a Wiesbaden nel settembre del 1932, costituì,
per le idee ivi condensate circa il contenuto e il metodo della psicoanalisi, il principale motivo della
rottura con Freud.
248
Illuminante ci pare questo passo, (ma se ne potrebbero citare altri), tratto da una annotazione
del 4.11.1932: «La traumatogenesi è [supposta come] nota; il dubbio, cioè se si tratta di realtà o fantaZI,
142
nargli quella comprensione e tenerezza che gli sono mancate, «stabilendo [così] un
contrasto tra il presente [terapeutico] e l’intollerabile passato traumatogeno»249, e
consentendo la guarigione. Era evidente che questo significasse una rottura radicale
con l’assetto terapeutico di Freud, ma anche il guadagno di una prospettiva che
avrebbe in seguito riscosso un successo tale da imporsi oggi come una delle più
avanzate e continuamente riprese nella costellazione psicoanalitica postfreudiana.
Al di là della genesi degli specifici traumi sessuali, Ferenczi apriva infatti la
teoria e pratica psicoanalitiche ad «un concetto di trauma implicante qualsiasi deprivazione, cumulativa o improvvisa, dovuta a eccesso-difetto di sollecitudine»250, circa
la crescita dei bambini, e più in generale di tutti i pazienti soggetti a trauma: dai nevrotici di guerra mortificati nell’amore di sé, ai rifugiati o i deportati denegati nella
loro dignità umana, alle vittime di attacchi terroristici, sino alle vittime di qualunque
abuso ed emarginazione da parte della società.
Si apriva cioè un orizzonte di studio e cura «sulle perturbazioni ambientali
che la specie e l’individuo, nel progredire filoontogenetico mirano a liquidare»251,
ipotizzando una supposta causalità deterministica di tipo dualistico-pulsionale e dunque una sostanziale impossibilità di mutare la supposta «natura umana» e il suo divenire storico. Ecco perché Ferenczi può considerarsi lo snodo in cui si avvia una svolta nella considerazione del trauma, da un punto di vista pulsionale a un punto di vista
relazionale, svolta che avrebbe comunque aperto due vie che, con varie accentuazioni, caratterizzano il panorama psicoanalitico attuale.
Il modello relazionale, iniziato da Ferenczi e ripreso da autori quali Balint
(suo allievo diretto), Winnicot e Kohut, per non citare che i più noti, perviene, secondo Felicity De Zulueta, ad una «definizione del trauma psicologico come “im-
sia, resta o può tornare (anche se tutto indica la realtà). Teoria della fantasia = una scappatoia alla realizzazione (la stessa cosa per gli analisti che resistono). [Gli analisti] preferiscono ammettere che la
loro (e quella degli esseri umani) mente (memoria) non sia attendibile piuttosto che credere che tali
cose possano realmente essere accadute a questo tipo di persone. (Autosacrificio della propria integrità mentale per salvare i genitori!)» (Opere, Volume IV (1927-1933), cit., p. 256, cdA). Quest’ultima
frase segnala il dispositivo di difesa all’opera tanto nel paziente quanto nell’analista, volto a negare
realtà ad un evento abusante, attraverso lo spostamento della sua insorgenza ad un sovraccarico pulsionale interno, al fine di negare l’intollerabilità emotiva dell’azione dannosa da parte dei genitori o
degli altri attori della violenza e non scalfire l’ideale del Sé, che si è costituito mediante la successiva
l’identificazione introiettata di essi.
249
Ivi, p. 94.
250
F. BORGOGNO, «Ferecnzi, Sàndor», in Psiche, Vol. I, cit., (pp. 430-436) p. 433.
251
Ibidem.
143
provviso, incontrollabile sconvolgimento dei legami di affiliazione” [...], in quanto
riconosce l’importanza delle relazioni di attaccamento, e quindi delle loro manifestazioni sociali, psicobiologiche, emotive e cognitive»252.
Lo sviluppo del concetto di trauma, dal paradigma pulsionale a quello relazionale, è magistralmente ricostruito dalla De Zulueta, nel libro Dal dolore alla violenza (2006), che individua nella dicotomia tra i due approcci al trauma una questione di fondo; sono qui in gioco due visioni essenzialmente diverse della natura umana,
relativamente al problema della violenza e all’aggressività:
«nel primo approccio [bipolarismo pulsionale eros-thanathos] per
l’esistenza umana è fondamentale la ricerca del piacere individuale e il bisogno di scaricare i nostri istinti […]; coloro che invece sostengono un modello
relazionale-oggettuale considerano di capitale importanza per il benessere
psicologico e fisico il bisogno dell’ “altro”: gli esseri umani non esistono al di
fuori della società. Ciò che porta frustrazione, autodistruzione e violenza sono
le relazioni insoddisfacenti»253.
La pensatrice inglese mostra come il modello pulsionale consideri la violenza
e l’aggressività, da cui derivano i traumi, in qualche modo come condizioni permanenti della specie umana, e individua nella teoria del dualismo pulsionale freudiana
l’esito conseguente di una visione pessimista sulla genesi della violenza storica, vista
come dato ineluttabile della specie, visione che a suo avviso tradurrebbe in linguaggio psicoanalitico il concetto teologico di peccato originale di Agostino. La violenza
sarebbe pensata, cioè, come intrinseca alla storia umana, in conseguenza di una colpa
originaria: dunque la violenza che il traumatizzato percepisce dipenderebbe, in definitiva, da lui. Dietro questo atteggiamento agirebbe il dispositivo psicologico della
difesa morale elaborato da Ronald Fairbairn.
Lo psicoanalista scozzese si schierò infatti apertamente contro la teoria pulsionale freudiana, nella convinzione che l’uomo fosse essenzialmente alla ricerca
dell’oggetto (relazione intersoggettiva) e non del piacere. Egli supponeva infatti che
252
253
F. DE ZULUETA, op. cit., p. 219.
Ivi, p. 161.
144
«tutte le relazioni oggettuali precoci del bambino [siano] basate
sull’identificazione, e che questa dinamica spieg[hi] come i bambini si vergognino e si sentano cattivi quando hanno genitori cattivi; questi ultimi non solo
sono interiorizzati, ma sono anche così interiormente malvagi come oggetti
interni che devono essere rimossi. Il motivo principale per il quale il bambino
interiorizza i propri genitori come oggetti cattivi è perché ne ha bisogno. Infatti, quanto più i genitori lo trascurano, tanto più gli sono necessari»254.
A questo punto Fairbairn fa entrare in gioco la difesa morale (chiamata anche
«difesa del Super-io o difesa del senso di colpa»255): il bambino preferirebbe vedere
se stesso come “cattivo” per poter rendere “buoni” i suoi oggetti. Fairbairn ne deduce
che il “fenomeno della colpa” deve essere considerato come appartenente alla categoria delle difese256. Con questo concetto, Fairbairn oltrepassa decisamente la visione endogena del trauma postulata dalla teoria pulsionale, e ne spiega anche la genesi
inconscia: chi adotta il modello pulsionale, cioè incolpa se stesso per spiegare la violenza ambientale, non fa che difendersi dall’oggetto stesso da cui gli deriva la propria
identità (nevrotica), e, nel caso che egli sia uno psicanalista, sta semplicemente rifiutandosi di vedere la realtà fattuale per paura di fare i conti con i propri oggetti-sé cattivi interiorizzati.
Come dicevamo, il concetto di difesa morale fairbairniana, il senso di colpa
per la violenza dell’altro abusante, si rivela nel libro della De Zulueta come un dispositivo psichico chiave per comprendere la genesi della visione della natura umana
come intrinsecamente cattiva (implicita nel concetto di pulsione di morte confliggente con quello di piacere e di vita - eros).
Chi adotta la difesa morale, sta cercando in fondo di “consolarsi” nei confronti di una realtà ambientale e storica che crede impossibile da superare, attribuendone
ideologicamente la causa ad un’essenza umana irrimediabilmente permanente. Es254
«É soprattutto il bisogno che il bambino ha dei suoi genitori, per quanto cattivi gli possano
apparire, che lo spinge a interiorizzare gli oggetti cattivi; e poiché questo bisogno resta aderente a essi
nell’inconscio egli non riesce a staccarsi da essi. È inoltre il suo bisogno di loro che conferisce agli
oggetti cattivi il loro vero potere su di lui» (W.R.D. FAIRBAIRN, Psycoanalytic Studies of the Personality, Routledge & Keagan, London 1952; tr. it. di A. Bencini Bariatti, Studi psicoanalitici sulla personalità, Bollati Boringhieri, Milano 1985, p. 95 [cit. in F. DE ZULUETA, op. cit., p. 152]).
255
W.R.D. FAIRBAIRN, op. cit., p. 92.
256
Ivi, p. 93 (cit. in F. DE ZULUETA, op. cit., p. 153).
145
sendo questo meccanismo difensivo sempre in funzione nella specie homo sapiens,
poiché connesso al bisogno di lunghe cure parentali senza le quali il piccolo non potrebbe superare la sua totale impotenza rispetto all’ambiente, ed essendo prevalso –
nella maggior parte delle culture storiche, e soprattutto in quella occidentale – un
modello genitoriale violento e abusante, la difesa morale si sarebbe rivelata predominante, come base di tutte le visioni che ritengono l’aggressività e la violenza insite
nel genere umano.
Da qui deriverebbe la connessione con l’idea di peccato originale elaborata da
sant’Agostino. Secondo la De Zulueta, infatti, la dottrina di Agostino «risponde alla
soluzione che molti di noi si danno quasi istintivamente davanti alla sofferenza.
[Questo schema], infatti, riconosce e simultaneamente nega l’impotenza [connessa
alla sofferenza], assolve il sofferente sul piano personale, incolpando Adamo ed Eva,
inoltre lo rassicura che il dolore e la morte sono innaturali, rispondendo al nostro bisogno di essere liberi dal dolore»257.
L’uso della difesa morale sarebbe in fondo un dispositivo psicologico “antropodiceale”, e «il bisogno di sentirsi in colpa, piuttosto che vittima impotente del destino, rivelerebbe quanto sia profonda la necessità di proteggersi dalla totale impotenza che è uno stato simie all’annientamento psicologico»258; come infatti affermava
Ferenczi: «Lo “shock” equivale all’annientamento della coscienza di sé, della capacità di resistere, di agire e di pensare in difesa del proprio Sé»259. Tuttavia, la regressione indotta dal trauma, riattivata dai colpi inferti dal presente, eviterebbe al modello basato sull’autoaccusa di elaborare realisticamente il trauma, deresponsabilizzando
il soggetto e consolandolo nell’assunzione “pacificante” dell’inevitabilità del destino.
La proposta della De Zulueta, che non possiamo qui seguire nel dettaglio, integra il modello relazionale all’interno di un discorso di clinica sociale dove sono
fatte valere le teorie e le pratiche di ricostruzione dei legami interumani, la cui rescissione e il cui non corretto mantenimento hanno causato lo scatenarsi dell’aggressività
e della violenza traumatica storica. Nel far questo, la pensatrice inglese si misura con
i traumi che hanno attraversato l’umanità nella contemporaneità, e soprattutto quelli
in cui tale aggressività e violenza hanno superato il limite soggettivo e hanno fatto
257
258
259
F. DE ZULUETA, op. cit., p. 33.
Ibidem.
S. FERENCZI, Opere, Vol. IV, cit., p. 101.
146
epoca configurandosi come traumi collettivi sociali e transgenerazionale: le guerre, le
catastrofi naturali e i genocidi.
Lo studio e la clinica dei traumi collettivi è particolarmente avanzato nel
momento presente. Constatiamo infatti un’evoluzione che, a partire dal modello della
nevrosi traumatica (1870-1920), attraverso quello (tra la fine della prima e l’ inizio
della seconda guerra mondiale) incentrato sulle nevrosi di guerra (shell-shock), per il
quale si era utilizzato il concetto neurologico di stress260, ha portato all’introduzione
di una specifica entità nosografica, quella di «disturbo postraumatico da stress»
(PTSD- Posttraumatic Stress disorder)261, introdotta a partire dal 1980 nel DSM III
dell’Associazione psichiatrica americana. La formulazione diagnostica del disturbo
posttraumatico da stress deriva principalmente dagli studi condotti su soggetti sopravvissuti ad avvenimenti traumatici relativamente circoscritti: guerre, calamità,
violenze sessuali, ma si applica anche a vittime di catastrofi naturali, incidenti stradali, molestie sul lavoro, a quanti assistono malati terminali e vivono lutti familiari.
Questa entità nosografica venne però originariamente introdotta a seguito degli studi
sui sopravvissuti alla Shoah, e fu inserita nel manuale diagnostico americano «soprattutto per dare una risposta medica, sociale e politica al gran numero di veterani
della guerra del Vietnam»262. Molti degli studiosi coinvolti erano stati a loro volta
soggetti traumatizzati, per lo più in conseguenza della Shoah. Uno di questi sopravvissuti al genocidio nazista, a sua volta psichiatra, E. Rappaport263, si lamentava della
tendenza a interpretare i traumi sofferti dalle vittime della Shoah secondo lo schema
classico della nevrosi traumatica, ossia minimizzando il ruolo degli eventi esterni a
favore della predisposizione psichica dei soggetti. Ricordi intrusivi, dissociazione,
depressione, sindromi di evitamento, sregolazione degli affetti e somatizzazione,
erano sintomi che permanevano a lungo, spesso lungo tutta la vita dei sopravvissuti.
Secondo la nuova edizione del DSM (DSM-IV, 1994), un evento traumatico è così
definito: «un avvenimento provoca un trauma a chi ne è coinvolto quando implica
una grave minaccia per la sua vita o una gravissima lesione della sua integrità psico260
Cfr. H. SPIEGEL, War Stress and Neurotic Illness, Hoeber, New York 1947.
Cfr. C. BONOMI, Introduzione storica all’idea di trauma psichico, Presentazione del Centro
di Psicotraumatologia, Firenze, 19 maggio 2001(http://carlobonomi.it/_articoli_consultabili.html).
262
C. BONOMI, art. cit., p. 5.
263
E. A. RAPPAPORT, Beyond Traumatic Neurosis – A Psycoanalytic Study of Late reactions to
the Concentrations Camp Trauma, «Int. J. Psycho-Anal.», n. 4, 1968. pp. 719-731 .
261
147
fisica, i cui effetti permangono nel tempo anche per l’intersa esistenza del soggetto»264.
Tra questi sintomi, soprattutto i sentimenti depressivi, il senso di colpa del
sopravvissuto, l’evitamento di discorsi sulla Shoah265, nonché quello di luoghi, circostanze e persone che richiamino in qualche modo, sono caratteristici dei reduci dai
campi di concentramento e di sterminio (a questo proposito, non possiamo astenerci
dal rilevare, la circostanza biografica di Levinas, relativa al suo giuramento di non
mettere mai più piede in Germania)266. Proprio per curare questo tipo di pazienti, è
tuttora in discussione l’introduzione di una nuova categoria nosografica, quella di
Disturbo da stress complesso o da trauma catastrofico (DSE-NAS, disturbi da stress
estremo non altrimenti specificato), poiché la formulazione diagnostica del disturbo
post-traumatico da stress si indirizza verso soggetti sopravvissuti ad avvenimenti
traumatici circoscritti, mentre traumi prolungati e ripetuti (vittime di relazioni di controllo coercitivo, di abusi sessuali e violenze familiari protratte, di sette religiose, di
campi di concentramento e di lavoro forzato, nonché sopravvissuti a lager di sterminio) manifestano una serie di caratteristiche sintomatologiche comuni maggiormente
specifiche rispetto a quelle, abbastanza più fluttuanti e non specifiche267 del PTSD.
Tra i sintomi ricorrenti, è stata frequentemente constatata in sede clinica la presenza
264
«La sintomatologia del DPTS, il cui nucleo essenziale è il vissuto di un’incontenibile paura
associata a una sensazione di totale impotenza, si esprime con un esasperato e incessante rivissuto
dell’esperienza o delle esperienze traumatiche che vengono rievocate in modo irresistibile e compulsivo, come se l’evento o gli eventi passati fossero continuamente presenti e attuali .[…] Chi ne soffre
tende a riattualizzare il trauma subito in diversi modi: attraverso sogni ricorrenti, ricordi ossessivi e
imperativi, flashbacks, o iperattività in occasione di anniversari o in vicinanza di luoghi che ricordino
il trauma. Ciò interferisce profondamente con l’attività quotidiana, interrompendo la continuità
dell’esperienza di vita dei pazienti. analogamente, i sintomi di evitamento si manifestano con la difficoltà a ricordare in tutto o in parte l’esperienza del trauma, perdita d’interesse per le attività normali,
sentimenti di distacco e di chiusura in se stessi, pessimismo circa il futuro, obnubilamento emotico e
sentimenti di anedonia e disinteresse, sentimenti depressivi, anestesia affettiva, riduzione di espressione, attivo evitamento di luoghi, circostanze e persone che richiamino il trauma in qualche modo» (G.
NERI, Disturbo postraumatico da stress, AAVV, Psiche, Vol I, cit., p 340).
265
Come racconta Salomon Malka, un amico di Levinas, Bernard Dupuy, motivando la sua impossibilità di recarsi un giorno a un incontro con Levinas perché impegnato a tenere una conferenza
sulla Shoah, si sentì rispendere dal filosofo: «la Shoah? È un argomento di cui non si parla!» (S.
MALKA, Emmanuel Levinas. La vie et la trace, tr. it. cit., p. 205).
266
«In risposta ad un invito di recarsi in Germania, Levinas disse un giorno [a Bernard Casper]:
“Lei lo sa cos’è un voto religioso? È la possibilità per me di essere in tranquillità con la mia psiche.
Io naturalmente ho rispettato questo voto”» (S. MALKA, E. Levinas, la vie et la trace, tr. it. cit., p.
208).
267
Cfr. J.L. HERMAN, «Il disturbo post-traumatico da stress complesso. La sindrome degli individui sopravvissuti a traumi prolungati e ripetuti», in Trauma e relazioni, cit. pp. 269-284, contenente
una vasta bibliografia specifica.
148
costante della cosiddetta «sindrome del sopravvissuto», a cui si stanno tuttora dedicando soprattutto studiosi francesi268 e americani. Per Robert J. Lifton, che ha studiato in particolare i sopravvissuti del Vietnam e di Hiroshima e Nagasaki, il sopravvissuto «è uno che è venuto a contatto con la morte ed è rimasto vivo. [...] porta sempre
dietro di sé lo stigma della morte, il senso di colpa per essere vivo, l’ottudimento affettivo e psichico, le problematiche del significato dell’esistenza e sul come definire
la propria esperienza»269. «La domanda che il sopravvissuto si pone sarebbe sempre:
“perché sono rimasto vivo io, quando lui, lei, loro sono morti?”; e la risposta che si
dà è: “se fossi morto io al posto loro, forse lui, lei, loro sarebbero vivi”»270.
L’attestazione di questo sentimento di colpa del sopravvissuto, di essere morto al posto di altri, si riscontra in quasi tutte le testimonianze di deportati o sopravvissuti ad un evento catastrofico continuato e complesso. Insieme a tale senso di colpa si
riscontra spesso anche un’incapacità costitutiva a simbolizzare il proprio trauma e a
raccontarlo, giacché l’esperienza traumatica ha comportato la morte o distruzione
dell’esperienza.
L’inesperibilità stessa dell’esperienza è correlativa alla sua incompleta simbolizzazione e dicibilità, quasi che il vero testimone legittimato a raccontare fosse colui
che è morto o «sommerso» (P. Levi), e che, quindi, inevitabilmente, il superstite
debba testimoniare e raccontare in sua vece271. Il maggiore studioso degli effetti dei
traumi connessi alla Shoah è senza altro Henry Krystal, che ha raccolto i risultati di
numerosi casi clinici da lui analizzati, nonché degli studi pionieristici di Betthelheim
e Rappaport272.
I sopravvissuti sembrano affetti, anche dopo molti decenni, da depressione
cronica, giacché hanno perso la “fiducia fondamentale” e presentano alessitimia
268
In particolare ricordiamo, in riferimento al genocidio armeno, J. ALTOUNIAN, La survivance.
Traduire le trauma collectif, Dunod Paris 2000; ID., L’intraduisible. Deuil, mémoire, transmission,
Dunod, Paris 2005.
269
R.J. LIFTON, Undestanding the Traumatized Self. Imagery, Symbolization, and trasformation, in AA.VV, Human Adaptation to Extreme Stress. From Holocaust to Vietnam, New York and
London, Plenum Press, pp. 7-31.
270
C. MUCCI, Il dolore estremo, cit., p. 124.
271
Cfr. G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri, Milano 1998 (pp. 127- 154, in particolare p. 153).
272
Per una ricostruzione dettagliata di questi studi, rinviamo a C. MUCCI, Il dolore estremo, cit.,
pp. 115-184.
149
(“non avere parole per le emozioni”273), accompagnata da anedonia (incapacità di
provare emozioni) che li rende per altro difficilmente trattabili psicoanaliticamente. I
sintomi del trauma catastrofico delineati da Krystal, oltre a quelli emotivi e costituenti la sindrome del sopravvissuto, comprendono anche problemi di depressione cronica, stili di vita masochistici, ansia costante e disturbi psicosomatici.
Tali sintomi riemergono, nei soggetti che da giovani avevano vissuto un
trauma, con il pensionamento e in genere con il raggiungimento di uno stato di vita
che permetta una riflessione sul passato, cessando le occupazioni che li tenevano occupati durante la vita attiva. Ciò provoca acute sofferenze, relative ad esempio ad
autoaccuse e sensi di colpa (survivor guilt), e rafforzando un particolare stile di difesa dal proprio passato che non consente di accettarlo: «accettare il proprio passato
può sembrare addirittura un modo per sancire la vittoria postuma di Hitler e del nazismo»274; in particolare, «l’autointegrazione appare per i sopravvissuti opposta esattamente a quella che appare loro come l’unica giustificazione per la loro sopravvivenza: il portare testimonianza»275.
La particolare incapacità da parte dei sopravvissuti, di de-idealizzare il proprio sé infantile e i propri genitori, connessa alla ricerca di perfezione e all’incapacità
di accettare i propri limiti negativi, non consentirebbe inoltre a questi pazienti di elaborare il proprio lutto. Ultima caratteristica che si riscontra in questi soggetti postraumatici è la ricerca del senso della propria vita nella commemorazione e nella
testimonianza per i morti. Come scrive Henry Krystal:
«Un residuo comune della sopravvivenza a una distruzione di massa è
la sensazione che il significato della propria vita consista interamente nel
commemorare coloro che sono periti. Laddove i parenti perduti e gli altri siano stati vittime di un nemico esterno, queste reazioni diventano ancora più
obbligate e sono rafforzate dal bisogno di affrontare l’aggressività cronica residua. Il modello “monumento” o “testimonianza contro il male” diventa, una
273
Si veda: H. KRYSTAL, Integration & Self-Healing: Affect, Trauma, Alexithymia, The analytic
Press, Hilldsale, New Jersey 1993, tr. it. di L. Perez, Affetto, trauma, alessitimia, Magi, Roma 2007.
274
C. MUCCI, Il dolore estremo, cit., p.137.
275
Ivi, p. 137
150
volta instauratasi nelle vite dei sopravvissuti, lo strumento per smaltire una
parte del senso di colpa del sopravvissuto»276.
Abbiamo ricostruito questo quadro psicoanalitico perché riteniamo che il modello della «difesa morale», come dispositivo psicologico difensivo, dell’autoaccusa
per la morte dell’altro implicita nel mio essere vivo, e sino all’iperbole della «responsabilità per la responsabilità del persecutore» (AE), possa costituire un punto di
vista interessante – anche se non l’unico, dovendosi integrare con l’impianto fenomenologico del pensiero levinassiano e con il ripensamento dell’ontoteologia – per
comprendere una struttura profonda che anima il discorso levinassiano. Se l’identità
del sé è costituita come sostituzione originaria, memoriale, testimoniale e vicaria per
l’altro, e la colpa cresce in misura della assunzione di questa responsabilità, ci dovremo chiedere se Levinas non stia, a suo modo, esibendo anche una difesa estrema
rispetto alla propria personale esperienza traumatica, e perciò quale valore di universalità possa avere il suo discorso. E dovremo chiederci anche che significato possa
avere il fatto che il primo caso dell’io sia il «me», cioè l’accusativo assoluto, e se
questo accusativo, prima di suscitare diverse problematiche fenomenologiche circa lo
statuto del «da dove» della sua «assolutezza»277, non costituisca anche una traccia
indelebile della costituzione del sé come risposta a un trauma che fu anche già (e
sempre) storico, prima di essere detto, nella testualità levinassiana, come «anarchico».
Noi che leggiamo Levinas non siamo, nella maggioranza dei casi, se non in
un senso lato e analogico278, sopravvissuti e superstiti, e il discorso levinassiano ci
risulta molto duro, «ai limiti del masochismo», come afferma Stéphane Mòses.
276
H. KRISTAL, op. cit., p. 215.
Come suggerisce Didier Franck, si tratterebbe di mettere sotto accusa lo stesso dinamismo
dell’essere accusata e perseguitata della soggettività etica: «L’accusa dell’uno per l’altro è dunque
dramma a partire dal quale ogni categoria ontologica significa in quanto tale. Tuttavia, per concepire
questa, e l’identità delle cose a partire dall’uno-per-l’altro, a partire dal soggetto, non bisogna comprendere l’identità di quest’ultimo a partire da un accusativo assoluto che, in qualche modo, sia per il
soggetto ciò che la categoria è per le cose, a partire dunque dalla messa sotto accusa dell’uno- perl’altro? “Accusa senza fondamento, certo, anteriore ad ogni movimento della volontà, accusa ossessionante e persecutrice” [Levinas]» (D. FRANCK, L’un-pour l’autre. Levinas et la signification, PUF,
Paris 2008, pp. 143-144).
278
«Siamo superstiti sia perché sopravvissuti a ondate di male che hanno travolto milioni di individui, sia perché nessuno di noi ha saputo evitare l’offesa del male agito, assunto come strumento e
via di autoaffermazione.[…] Proprio nel constatare con amarezza questa situazione affiora del resto
277
151
C’è da chiederci, però, se veramente potremmo comprendere la via che Levinas suggerisce, cogliere il senso (dell’umano e dell’essere) nell’uno-per-l’altro della
sostituzione e solo così considerare il male come irriducibile alla persona umana,
senza, da una parte, approssimarci alla costellazione psicologica di chi, come lui, ha
vissuto traumi catastrofici in prima persona, e d’altra parte senza cercare di farci inquietare e sollecitare dal modo in cui il suo discorso scandaloso (e edificante279) interroga la nostra vita e soggettività, invitandola a misurarsi e resistere, nei confronti
dello spettacolo oggettivo di continue ferite nel corpo dell’umanità che quotidianamente constatiamo, con l’impegno in prima persona, senza delega né ricompensa, per
sanare e curare le relazioni che la violenza e la morte hanno interrotto, così che queste relazioni annodino di nuovo i vivi e i morti nei legami della vita280. C’è da chiederci se cioè l’universalità dell’insegnamento levinassiano, che peraltro rende problematica la possibilità di una soggettività trascendentale pensata nel senso costituente, non sia piuttosto da cogliere nello stesso approche al testo. Avvicinandoci, senza
mai pretendere di poterlo esaurire, al testo levinassiano che pensa la soggettività nel
suo strato estremo, potremmo forse istituire una universalità per analogia, che tenga
insieme unicità ed esemplarità (della Shoah, ma anche di ogni esperienza ineludibilmente soggettiva del trauma), in modo da farlo valere come fondamentale insegnamento etico universale.
Ma prima di volgersi verso questi e altri interrogativi, nei due capitoli successivi, dove cercheremo di trarre le conseguenze teoretiche del percorso fin qui avviato
–, dobbiamo soffermarci ancora sulla peculiare concezione del nesso traumaesperienza esibito nei testi del nostro autore da un punto di vista filosofico. Il trauma
come dispositivo attivante l’interrogazione filosofica e postulante una risposta etica
dovrà essere ora analizzato attraverso l’analisi dell’elaborazione progressiva del concetto di esperienza nella filosofia levinassiana anteriore a AE, e sarà questo l’intento
del paragrafo seguente.
un’irriducibilità. La creatura umana è irriducibile al male» (R. MANCINI, L’amore politico, cit., p.
36).
279
«L’associazione di edificazione e di scandalo è un tópos del pensiero religioso ebraico e poi
cristiano.» (M.M. OLIVETTI, Analogia del soggetto, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 89)
280
É il termine con cui si conclude l’epigrafe in ebraico di AE, benedizione tradizionale nel culto funebre ebraico.
152
4. Esperienza e trauma: l’avvio del pensiero in Heidegger e Levinas
In uno dei primi paragrafi dei Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit281, testo del corso tenuto a Friburgo nel semestre invernale 1929-30,
Heidegger prospetta il senso preliminare della filosofia:
«Filosofia: una discussione e un dialogo ultimi dell’uomo, che lo attraversano afferrandolo totalmente e costantemente. Ma cos’è l’uomo, se nel
fondo della sua essenza, filosofa, e che cos’è questo filosofare? Cosa siamo
noi in tutto questo? Dove vogliamo andare? Siamo forse un giorno casualmente incappati in un universo? Novalis afferma in un frammento: “La filosofia è propriamente nostalgia, un impulso a essere a casa propria ovunque”
282 283
» .
Il testo originale di Novalis, citato da Heidegger, recita: Die Philosophie ist
eigentlich Heimweh – Trieb überall zu Hause zu sein; il traduttore Ervino Pocar rende così il passo in italiano: «A rigore la filosofia è nostalgia, il desiderio di trovarsi
dappertutto come a casa propria», traducendo il termine “trieb” con “desiderio”, evidentemente con l’intento di esplicitare la tonalità emotiva propria di un impulso al
rimpatrio, piuttosto che di una passione sedentaria per lo “stare a casa”.
Torniamo al testo heideggeriano, che prosegue:
«Una definizione singolare, naturalmente romantica. Nostalgia: esiste
ancora, oggi qualcosa del genere? (…) Sostiamo un attimo e domandiamoci:
cosa vuol dire l’affermazione che la filosofia è nostalgia? È lo stesso Novalis
a chiarirlo: “Un impulso a essere dovunque a casa propria”. La filosofia può
considerarsi una tale inclinazione, se e solo se noi che filosofiamo, non ci
281
Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 1983; tr. it. di P. Coriando, Concetti fondamentali della metafisica. Mondofinitezza-solitudine, il melangolo, Genova 1999, par. 7 b, p. 10.
282
NOVALIS, Schriften, Bd. 2, Fr. 21, p. 179, Hg. L Minor, Jena 1923; tr. it. di E. Pocar, Frammenti, (1a ed. Rizzoli, Milano 1976) BUR, Milano 20087: «A rigore la filosofia è nostalgia, il desiderio di trovarsi dappertutto come a casa propria», fr. 24, p. 41.
283
M. HEIDEGGER, Die Grundbegriffe …, tr. it. cit., pp. 10-11.
153
sentiamo ovunque a casa nostra che cosa si rivolge il desiderio proprio di
quest’inclinazione? A essere ovunque a casa propria: che significa? Non semplicemente qui o là, e neppure in qualunque luogo o in tutti insieme l’uno dopo l’altro, bensì: essere a casa propria ovunque significa essere sempre e allo
stesso tempo nella totalità. […] questo “nella totalità” è il mondo »284.
Dunque, secondo Heidegger, la filosofia si pone sotto la cifra di un essere a
casa, dimorare nella totalità, o anche, qualora non lo si sia ancora, del desiderio di ritornarvi. Hans Jonas rileva in quest’atmosfera speculativa l’affinità con il pensiero
gnostico: la nostalgia come motore della filosofia, sarebbe questo «sentimento primario […] di una totale frattura tra l’uomo e ciò in cui si trova collocato, il mondo»285.
E poche righe dopo, aggiunge:
«Una famosa formula della scuola valentiniana riassume il contenuto
della gnosi: “Ciò che ci rende liberi è la conoscenza di chi eravamo, che cosa
siamo divenuti; donde eravamo, dove siamo stati gettati […] Ci ritorna alla
mente […] la Geworfenheit di Heidegger “essere stati gettati”, che per lui è il
carattere fondamentale del Dasein, dell’autoesperienza dell’esistenza. Il termine, per quanto mi è dato di giudicare, è originariamente gnostico»286.
Questa parentela tra l’antico gnosticismo e il pensiero heideggeriano (estensibile, secondo Jonas, anche all’esistenzialismo) si rivelerebbe inoltre in un dualismo
tra uomo «autentico» e physis, natura come creazione di un demiurgo inferiore, implicante quindi un deprezzamento della bontà del mondo e sollecitante un’urgenza di
evasione per ritornare nella patria celeste, ove «esistere in modo autentico»;
l’ànthropos pneumatikòs deve diventare legge a se stesso, secondo il potere della sua
conoscenza, al di sopra delle leggi del cosmo inferiore. La vera casa dello pneuma-
284
Ivi, p. 11.
H. JONAS, The gnostic Religion. The message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, Beacon Press, Boston 1958, tr. it. di R. Farina, Lo gnosticismo, SEI, Torino (1a ed. 1973)
rist. 1991, p. 341.
286
Ivi, p. 349.
285
154
tikòs non sarebbe dunque il mondo creato, ma la totalità speculativa che «segna il
risveglio dell’io interiore dal sonno o dall’ubriacatura del mondo»287.
Abbiamo già sopra accennato a questa vicinanza di interpretazione tra Levinas e Jonas relativamente al pensiero heideggeriano. Accennare all’interpretazione
jonasiana del pensiero heideggeriano, facendo specificamente riferimento a una citazione contenuta in lezioni risalenti al 1929-30, potrebbe sembrare a prima vista non
pertinente, nell’ambito di un lavoro dedicato specificamente a Emmanuel Levinas.
Eppure, due ragioni rendono necessario quest’accostamento. La prima è la
constatazione di un dato anagrafico: tanto Levinas quanto Jonas avevano seguito
Heidegger, restandone prima affascinati, e poi turbati dalla sua adesione al nazismo.
Levinas, com’è noto, aveva soggiornato per due semestri a Friburgo, per seguire i
corsi di Husserl, nell’estate 1928, e poi, durante l’inverno 1928-29, le lezioni di Heidegger (dunque non aveva fatto in tempo a seguire il corso cui ci stiamo riferendo).
L’iniziale infatuazione levinassiana per Heidegger, a prescindere dalla singolare prospettiva assunta dal Nostro nella sua tesi di dottorato sull’intuizione in Husserl, viene riportata in un articolo apparso nel 1931, dal significativo titolo Friburg,
Husserl et la Phénoménologie288, con queste parole «La sua cattedra [di Husserl] è
passata a Martin Heidegger, il suo discepolo più originale, il cui nome è al giorno
d’oggi la gloria della Germania [cn]. Di una potenza intellettuale eccezionale, il suo
insegnamento e le sue opere forniscono la migliore prova della fecondità del metodo
fenomenologico»289. Poche righe dopo, Levinas dà conto delle particolari circostanze
in cui si svolgeva l’insegnamento del maestro: «…già un successo considerevole
manifesta il suo straordinario prestigio: per assicurarmi un posto a sedere al suo corso che aveva luogo alle cinque del pomeriggio, in una delle aule più grandi
dell’Università, dovevo occuparlo, al più tardi, alle dieci del mattino».290 Infine, dopo aver enumerato la provenienza internazionale dell’auditorio, Levinas racconta un
episodio particolare. Recandosi in treno verso Friburgo, aveva incontrato uno studen287
Ivi, p. 344.
288
«Friburg, Husserl et la phénoménologie», (ed. or. «Revue d’Allemagne et de pays de langue
allemande», 1931, 5e annèe, n. 43, 15 maggio, pp. 403-414), ora in Les imprévus de l’histoire, (1a ed.
Fata Morgana, Paris 1994) Le livre de Poche, Paris 20003, pp. 81-91.
289
290
Ivi, p. 91, cn.
Ibidem.
155
te tedesco che gli aveva comunicato il suo stesso luogo di destinazione con queste
parole: «Sto andando dal più grande filosofo del mondo»291.
Salomon Malka rileva il momento esatto in cui avvenne, per Levinas, la disillusione nei confronti di Heidegger (pur se sempre continuato ad ammirare quale
autore di Sein und Zeit292). Dopo lo shock dell’avvento di Hitler al potere, nel 1933,
si sarebbe reso evidente il «tradimento di Heidegger»293: fu chiara ben presto al giovane filosofo ebreo-lituano, ben prima del libro di Farias294 (che avrebbe precisato, a
suo dire, solo «qualche dettaglio»295), l’adesione del filosofo tedesco al nazionalsocialismo.
La seconda ragione che rende a nostro avviso necessario l’accostamento tra
Jonas e Levinas, è la singolare ed ebraica valorizzazione, operata da entrambi,
dell’intenzionalità di bene insita nell’atto creatore del mondo da parte di Dio; mondo,
però, affidato completamente nelle mani dell’uomo. Non si tratterebbe dunque di vedere nel mondo un luogo di esilio, da cui fuggire anelando alla vera patria, ma il deserto dell’Esodo in cui portare la legge da Dio rivelata. Se la filosofia heideggeriana
reclama la nostalgia come sua tonalità emotiva fondamentale, tale filosofia rimarrà
tuttavia radicata alla «terra», in un’ambivalenza tipica di quello che Levinas chiama
giustamente «paganesimo». D’altra parte, proprio valorizzando il «desiderio» metafisico come non nostalgico, Levinas, come è noto perverrà al rifiuto del radicamento
pagano, in vista di un approdo, mai “proprietario”, a una terra in cui non si è mai stati, in un modo di abitare ospitale verso l’alterità.
Tra i molti e capitali motivi che rilevano la frattura tra Levinas e Heidegger
vorremmo segnalarne uno, proprio prendendo spunto dal testo sopra citato dei
Grundbegriffe. In EI (1982), libro contenente una serie di dialoghi con Philippe Ne-
291
Ibidem.
«Nonostante tutto l’orrore che un giorno venne ad associarsi al nome di Heidegger – e che nulla arriverà a dissipare – niente ha potuto cancellare dalla mia mente la convinzione che Sein und Zeit
del 1927 sia imprescrittibile, allo stesso titolo di pochissimi altri libri eterni della storia della filosofia
– anche se in disaccordo tra loro» (TN, p. 234).
293
S. MALKA, Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, Jean-Claudie Lattes, Paris 2002; tr. it. di C.
Polledri, La vita e la traccia, Jaca Book, Milano 2003, p. 159. Secondo Levinas questa vicinanza col
nazismo sarebbe stata presente in Heidegger «forse anche prima del 1933» (Ibidem; citazione tratta da
un intervista di Levinas in «Le Nouvel Observateur», 22 gennaio 1988).
294
V. FARIAS, Heidegger et le nazisme, Verdier, Paris 1987; tr. it. di M. Marchetti e P. Amari,
Heidegger e il nazismo, Bollati Boringhieri, Torino 1988.
295
V. FARIAS, Heidegger et le nazisme, Verdier, Paris 1987; tr. it. di M. Marchetti e P. Amari,
Heidegger e il nazismo, Bollati Boringhieri, Torino 1988.
292
156
mo, Emmanuel Levinas dichiara che è un altro l’«inizio» della filosofia, non cioè il
sentimento di spaesamento rispetto a una patria o a un’origine, ma un’eteroaffezione
iniziale, il sentirsi perforati nell’io, in una parola: il «trauma»:
«Probabilmente il pensiero comincia con traumi o brancolamenti cui
non si sa neppure dare una forma verbale: una separazione, una scena di violenza, un’improvvisa coscienza della monotonia del tempo. Poi leggendo i libri non necessariamente filosofici – questi shock iniziali diventano domande
e problemi, danno a pensare»296..
Per Heidegger, dunque, l’inizio del filosofare è segnato dalla nostalgia, dal
dolore per il ritorno, dal desiderio d’installazione, di stasi; è un movimento
dell’«essere-sospinti», contemporaneo all’«essere da sempre mossi-verso la totalità»
che pone capo alla finitezza (in quanto «noi stessi siamo questo essere in-cammino,
questo passaggio, questo “né l’una né l’altra cosa”»297); ma è un essere sospinti, riferiti e mossi verso una totalità autoctona e solipsistica: tale movimento «si compie in
ultima analisi nella solitudine, nella quale l’uomo sarà sempre e soltanto un singolo»298.
Al contrario, per Levinas, l’inizio del filosofare è avviato da un traumatismo,
cioè da una perforazione del soggetto isolato, e dispiega un movimento esodico senza-ritorno, un diatopico e diacronico uno-per-l’altro (AE), termine-interminabile utopico dell’etica come filosofia prima.
Vogliamo ora soffermarci sul termine «trauma», che traduce il francese
«traumatisme», ricorrente 19 volte nel testo originale di AE
299
. Nel Trésor de la
300
langue française , alla voce traumatisme leggiamo: «un violento shock emotivo
che provoca nel soggetto un ébranlement durable». Oppure, secondo significato, si
296
E. LEVINAS, Ethique et Infini. Dialogue avec Philippe Nemo, Fayard et Radio France, Paris
1982; Le Livre de Poche, Paris 1986 ; tr. it. di F. Riva, Città Aperta, Troina 2008, p. 49. (D’ora in poi
EI). Traduzione leggermente modificata da Armido Rizzi (Cfr. BOURETZ, P., Témoins du futur. Philosophie et messianisme, Éditions Gallimard, Paris 2003, tr. it. di A. Rizzi, Testimoni del futuro.
Filosofia e messianismo nel Novecento, Città Aperta Edizioni, Troina [En] 2009, p. 598).
297
M. Heidegger, Grunbegriffe…, tr. it. cit, 11-12.
298
Ibidem.
299
Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Le livre de Poche, Paris 1996 pp: 10, 26, 31, 64,
65 (nota), 81, 85, 174, 177, 194, 195 (nota), 196, 197, 198, 212, 225, 227, 228, 231.
300
CNRS, Gallimard, Paris 1994, voce «traumatisme».
157
tratta di «ogni evento brutale subìto, che comporti per il soggetto che ne è vittima
trasformazioni più o meno profonde, più o meno reversibili301». Il lessico francese
distingue traumatisme da trauma, ma ravvisa la sinonimia nel caso in cui il termine
sia riferito all’ambito psicoanalitico, riportando come esempio la traduzione del noto
saggio di Otto Rank Das Trauma der Geburt appunto con Traumatisme de la naissance.
Il lemma «traumatisme» è in AE un vero e proprio terminus technicus. I traduttori italiani di Levinas rendono traumatisme indifferentemente con «trauma» o
con «traumatismo». In TI invece, il termine in oggetto è quasi assente, se non in una
ricorrenza cruciale. Qui infatti, nel paragrafo intitolato Discorso ed etica, leggiamo:
«Le discours est ainsi experience de quelque chose d’absolument étranger:
“connaissance” ou “expérience” pure, traumatisme de l’étonnement»302. La traduzione di Adriano Dell’Asta suona: «Così il discorso è esperienza di qualcosa di assolutamente estraneo, “conoscenza” o “esperienza” pura, trauma dello stupore».
Il volto «parla»303, la sua espressione è insegnamento; l’esperienza assoluta
non è svelamento ma rivelazione; tale espressione non è effrazione, come nel caso in
cui l’altro sia incontrato attraverso l’opera304 (opera che significa il suo autore sempre alla terza persona), ma è pur sempre inversione della conoscenza oggettivante.
Quindi se non è effrazione, quasi che il volto derubasse l’io penetrandovi, è
un’inabitazione dell’Infinito che eleva e nello stesso tempo mantiene l’io separato:
«socialità», «religione», «faccia a faccia»: «essa annuncia una società e nello stesso
tempo permette di mantenere un io separato»305.
L’esperienza non è dunque né commestione inglobante dell’io narcisista nei
confronti dell’altro, né effrazione da parte dell’altro nei confronti dell’io. Né puro
stupore, né puro trauma dunque, ma, ossimoricamente appunto, «trauma dello stupore».
Un trauma “non traumatico”, in un certo senso, che educa ma non paralizza
l’io, che giudica la coscienza ma per risvegliarla alla responsabilità. Il termine
«trauma», per come ci sembra usarlo Levinas in TI nel luogo sopra citato, ricorda
301
Ibidem.
TI, p. 72, cdA.
303
TI, p. 64.
304
TI, p. 65.
305
TI, p. 66.
302
158
quanto dice Aristotele circa lo «stupore» come origine del filosofare306. Ma esso può
forse voler alludere anche al contraccolpo che si riceve dal brusco risveglio della
propria coscienza di fronte all’investimento del volto dell’altro, che la desta ed edifica e ne inaugura il gesto filosofico (contestando così l’interdizione hegeliana a parlare in termini di edificazione della conoscenza filosofica307). «Trauma», in questo caso, non è neppure, ci sembra, la tonalità emotiva che si vive, secondo Heidegger, di
fronte alla domanda: «perché vi è in generale l’essente e non il nulla?»308; nè è
l’interrogativo disperato con cui Rosenzweig apre la Stella: «Dalla morte, dal timore
della morte prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il Tutto»309.
Ponendo in relazione il termine «trauma» con quello di «esperienza», si nota
dunque la loro stretta connessione e sovrapponibilità con il senso di principio o avvio
del pensiero.
Il significato del termine «esperienza» deve essere approfondito ulteriormente. Come rileva Sthephan Strasser, sono presenti in Levinas «diverse teorie relative
alla natura dell’esperienza»310, che non sono solo soggette a modificazioni e radicalizzazioni, ma «implicano talune contraddizioni»311.
306
«Infatti gli uomini, sia nel nostro tempo, sia dapprincipio hanno preso dalla meraviglia
[thàuma] lo spunto per filosofare, poiché dapprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano a portata di mano e non di cui sapevano rendersi conto...» (ARISTOTELE, Metafisica (I [A], 2, 982 b), tr. it.
di A. Russo, Laterza, Roma-Bari 19904, p. 8). Anche ignoriamo quanto sia filologicamente fondata, ci
sembra suggestiva la traduzione che del termine thàuma fornisce Emanuele Severino, che invece di
tradurlo, come di solito, con “meraviglia”, usa una parafrasi, che lo annette al registro semantico
dell’inquietante e dunque del traumatico: «Tuttavia la parola thàuma, che traduciamo con “meraviglia”, ha un significato molto più intenso: indica anche lo stupore attonito di fronte a ciò che è strano,
imprevedibile, orrendo, mostruoso. Se infatti non si conoscono le “cause” di ciò che accade – se ciò
che accade non rientra nella spiegazione del mondo della quale l’uomo di volta in volta si ritrova in
possesso -, allora l’accadimento delle cose è l’inquietante e diventa fonte di ogni terrore e di ogni
angoscia. E anche di ogni dolore, perché la sofferenza è insopportabile quando non è spiegabile e si
avventa sull’uomo, imprevedibile e senza ragioni» (E. SEVERINO, La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia contemporanea, Bur, Milano 2006 (1a ed 1996), p. 9, ccnn.
307
«Ma la filosofia deve ben guardarsi dal voler produrre edificazione» (G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, tr. it. di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze, 19909, p. 7).
308
Tonalità emotiva che, come afferma Heidegger, «risorge in certi momenti di cupa disperazione, quando ogni consistenza delle cose sembra venir meno e ogni significato oscurarsi» (M. HEIDEGGER, Einfürung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag, Tubingen 1966; tr. it. di G. Masi, Mursia, Milano 19688, p. 13).
309
F. ROSENZWEIG, Der Stern der Erlosung, Nijhoff, La Haye 1981; tr. it di G. Bonora, La stella della redenzione, (1a ed. Marietti Genova 1988) Vita e Pensiero, Milano 20052, p. 3. (Tale timore
della morte sarà trasfigurato, come vedremo, in AE e nella successiva produzione levinassiana [soprattutto in DMT], in «timore della morte dell'altro»).
310
«Seguendo la fenomenologia husserliana, l’esperienza non rinvia né a impressioni sensibili, né
a una sintesi a priori, né a un risultato d’induzioni, ma ha a che fare con qualcosa che si è subìto o
vissuto e che permette di scoprire un senso nuovo. Questa scoperta non ha necessariamente il carattere
di un sapere. I fenomenologi esistenzialisti hanno richiamato l’attenzione sul carattere rivelativo di
159
É abbastanza evidente, sia dai primi scritti, che l’esperienza non coincide con
l’oggettivazione e la tematizzazione; tale nozione sembra designare in Levinas dapprima l’apertura conoscitiva verso la verità e il divino. In La filosofia e l’idea di infinito, del 1957, infatti, Levinas scrive: «La vera esperienza deve portarci persino al di
là della Natura che ci circonda […]. La verità indicherebbe allora la meta finale di un
movimento che parte da un mondo intimo e familiare […] verso l’estraneo, verso un
là, come ha detto Platone»312.
La nozione di esperienza, in Levinas, estende poi ulteriormente il suo campo
semantico, oltrepassando il significato di conoscenza certa e univoca: «essa può essere esperienza di una traccia»313, la quale ha la caratteristica che chi la segue non ritorna più al punto di partenza, come l’Ulisse omerico, ma, come l’Abramo biblico, si
avvia per una
«esperienza eteronoma […] che non può convertirsi in categoria e il
cui movimento verso l’Altro non viene recuperato nell’identificazione, non
ritorna al punto di partenza. Ma tale esperienza non c’è data forse da ciò che
banalmente si chiama bontà e dall’opera…? Pensata radicalmente, l’Opera è,
infatti, un movimento dello stesso verso l’Altro che non ritorna mai allo Stesso»314.
Strasser rileva inoltre come, in un testo del 1965, Levinas si riconosca in quei
fenomenologi che, pur non compiendo la riduzione fenomenologica secondo le regole di Husserl, «considerano l’esperienza come fonte di significati. È illuminante prima di essere probante»315 . Ulteriore radicalizzazione si produrrà nella Prefazione a
certe esperienze emozionali: pensiamo all’angoscia in Heidegger, alla nausée in Sartre, all’espoir in
Marcel. In nessuno di essi “esperienza” significa oggettivazione e tematizzazione di un essente. Siamo
dunque tentati di paragonare il désir di cui parla Levinas con le esperienze che Heidegger, Sartre,
Marcel hanno descritto» (S. STRASSER, Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie
d’Emmanuel Levinas, «Revue Philosophique de Louvain» 75/1977, [pp. 101-125] p. 122).
311
Ibidem.
312
La philosophie et l’ideée de l’Infini, «Revue de métaphysique et de morale», LXII, 1957,
(241-253), ora in En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1949, 2 ed. aumentata 1967, 2006; tr. it. di F. Sossi, Scoprire l’esistenza con Husserl et Heidegger, Cortina, Milano
1998; pp. 189-204, p. 189. [SEHH]
313
S. STRASSER, art. cit., p. 122.
314
Cfr. La trace de l’autre («Tijdschrift voor Filosofie», n.3, 1963), ora in SEHH p. 219
315
Intentionalité et sensation («Revue international de Philosophie», Bruxelles, 1965, 1-2), ora
in SEHH p. 186, cdL.
160
Umanesimo dell’altro uomo (1972), dove Levinas arriverà a scrivere: «Si tratta piuttosto del mettere in questione l’esperienza come scaturigine del senso»316. Condividendo lo sconcerto di Strasser circa l’uso del termine «esperienza» in Levinas, e
convenendo con lui nel rilievo circa la non stretta coerenza sistematica del suo pensiero, e talora, anche se in minor misura, del suo lessico – portato della necessità del
continuo disdire (dédire) e ridire (redire) il «detto» –, possiamo concludere dunque
che il termine «esperienza» non presenti, in Levinas, un significato univoco. Si giungerà infine, nelle ultime opere, a un rifiuto del termine in oggetto, come luogo del
senso. Esempio emblematico di questo rifiuto è il seguente testo, con cui Levinas
apre il saggio Trascendenza e intelligibilità (1984):
«È nello psichismo umano inteso come sapere – spinto sino alla coscienza di sé – che la filosofia che ci è stata trasmessa situa il luogo naturale
del sensato e l’origine della filosofia stessa […] L’attenzione del filosofo si
rivolge al vissuto umano che si riconosce come esperienza e dichiara di essere tale, vale a dire si lascia legittimamente convertire in insegnamenti, in lezioni di cose, nella loro scoperta o nella loro presenza»317 .
E tuttavia, il termine esperienza, verrà conservato in un senso “impuro” e non
tematizzante, tendente al pre-filosofico. Per quanto egli affermi, in Signature-Firma,
che le «analisi stesse [di AE] rimandano non all’esperienza in cui un soggetto tematizza sempre ciò che eguaglia, ma alla trascendenza in cui risponde di quanto le sue
intenzioni non hanno misurato»318, è proprio l’esperienza-inesperibile (cioè non tematizzabile) del trauma a caratterizzare e a individuare la soggettività etica.
In virtù di queste considerazioni, potremmo riarticolare il rapporto tra esperienza e trauma, o meglio interpretare il trauma come esperienza non nel senso contestato da Levinas, laddove essa sarebbe debitrice del sapere tematizzante della tradizione «che ci è stata trasmessa», ma nel senso quasi-quotidiano e ingenuo del termine: «esperienza pre-filosofica» quale concreta serie vissuti che hanno condizionato e
316
Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, Paris 1972; tr. it. di A. Moscato, Umanesimo
dell’altro uomo, il melangolo, Genova (1985) 1998, p. 25, cn.
317
Trascendence et intellegibilitè, Labor et Fides, Genève (1aed. 1984) 1996; tr. it. di F. Camera, Trascendenza e intellegibilità, Marietti 1820, Milano 20092, p. 13, cn.
318
DL p. 366.
161
sollecitato la produzione levinassiana, e hanno altresì reso necessaria l’enfasi posta
sul termine traumatismo-trauma nella sua opera maggiore, AE.
Del resto, le esperienze prefisolofiche sono ricordate in diverse interviste di
Levinas. Vi è però una «esperienza» su cui vige un silenzio, un diniego, ma che tuttavia emerge, non può non trasparire in tutto ciò che Levinas scrive. Sarà essa la ragione dell’uso di termini quali sostituzione, trauma, ostaggio, persecuzione, soggezione, approche, espiazione, sacrificio, testimonianza…nome. «Nome» è il termine
con cui si conclude AE, ma è anche il quello con cui si apre. E non parliamo del testo, ma della sua epigrafe. La duplice dedica:
«Alla memoria degli esseri più vicini tra sei milioni di uomini assassinati dai nazionalsocialisti, accanto ai milioni e milioni di uomini di ogni confessione e di ogni nazione, vittime dello stesso odio dell’altro uomo, dello
stesso antisemitismo»319.
Uomini che sono numeri senza nome («milioni e milioni»), ai quali l’opera è
dedicata, al fine di sottrarrli all’oblio e all’anonimato cui l’essere inevitabilmente li
consegna. Ma non solo questi: nella parte ebraica dell’esergo, i nomi propri sono
iscritti, e si tratta dei genitori, fratelli, dei parenti stretti di Levinas:
«Alla memoria di mio padre e maestro, Rabbi Yehiel figlio di Abraham Halévy, di mia madre e guida Dvora, figlia di Rabbi Mosè, dei miei fratelli, Dov, figlio di Rabbi Yehiel Halévy, e Aminadab, figlio di Rabbi Yehiel
Halévy, di mio suocero Rabbi Shmuel, figlio di Rabbi Gershon Halévy, e di
mia suocera Malka, figlia di Rabbi Haim. Che la loro anima sia sepolta nei
legami della vita»320.
In AE Levinas tenta forse, oltre alla ricerca del senso della soggettività etica,
anche una «scrittura del disastro»321. Cerca, cioè di dire il trauma del logos come det-
319
AE p. V.
Ibidem.
321
È, come noto, titolo questo di un’opera di Maurice Blanchot scritta sull’eco di AE, e che può
essere letta come un tentativo di contrappunto, attraverso una scrittura aforistica, dell’andamento sin320
162
to: e la Shoah è il trauma. Essa è la possibilità del mostruoso che accad(d)e di notte.
Notte, come metafora dell’il y a sempre incombente, ma anche tempo nel quale tuttavia «si dovrà ricordare l’uscita dall’Egitto»322. Il trauma è la traccia pre-originaria,
che non si può conoscere-tematizzare, nemmeno dai suoi effetti. Traccia già-sempre
passata, che lascia un buco (trou) nell’esperienza, e nel testo che cercherebbe invano
«mantenerla». Trauma-traccia che avvia il pensiero verso l’etica, nell’apertura della
nudità ossessionante del volto. Il volto dell’altro è questo buco («gli Altri sono un
puro buco nel mondo»323): nudità non tematizzabile ma ossessionante nella percezione (non riflessiva, ma che gli incombe nella stessa misura della sua comparizione)
della sua mortalità; “esperienza” (pre-esperienziale in senso tematico) in cui l’io si
sente colpevole di essere sopravvissuto «al suo posto». Affetto da questa ossessione,
l’io (je) è assediato e messo in questione. E la questione non sarà quella di «essere o
non essere», ma: «che diritto ho io di essere»? Se la Shoah è il trauma, essa è quindi
anche, paradosslamente (e vedremo in seguito come), segno, traccia e volto in cui si
manifesta una possibilità dell’umano come «altrimenti-che-essere».
Prima di avviarci però ad approfondire questo plesso problematico e paradossale, dobbiamo fermarci a chiarire la nostra prospettiva sin qui seguita. Da quanto
siamo venuti dicendo lungo questo capitolo, non possiamo certo affermare in maniera semplificatoria che i postumi psicologici della tragedia siano diventati sic et simpliciter “filosofia dell’ossessione per l’altro”. Un tale giudizio, oltre ad essere illegittimo dal punto di vista filosofico e scientifico (avremmo giustamente disatteso
l’assunto dell’impossibilità di “psicanalizzare Levinas”), andrebbe incontro al pericolo di una doppia riduzione: una riduzione psicologistica di un pensiero che deve tenere conto soprattutto della particolare torsione che alla fenomenologia husserliana Levinas fa percorrere, superandola e insieme rimanendovi a suo modo fedele. E una
riduzione della portata universale, esemplarmente universale, di un pensiero che cerca di delinerare l’orizzonte del senso in una possibilità etica universale.
copato del testo maggiore di Levinas (L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980, tr. it. di F. Sossi,
La scrittura del disastro, SE, Milano 1990).
322
Al di là del ricordo, TN, p. 90. E ancora: «Ma nella notte, in questa debolezza, è possibile
trovare la possibilità, nell’insensato, di un senso che però non potrebbe garantire la fondazione di un
mondo. Ma nella notte, in questa debolezza, forze invisibili si lasciano intendere […] attraverso
l’inumano, le straordinarie spinte della misericordia sopravvivono, andando da unicità umana a unicità
umana, indipendentemente e come a dispetto delle strutture – politiche ed ecclesiastiche – a cui erano
esposte da sempre» (ivi, p. 101).
323
UAU, p. 89.
163
Possiamo semmai affermare, più sobriamente, che il trauma subito, nella sua
singolarità, come del resto la stessa formazione e riflessione ebraica (il complesso
dell’esperienza ebraica) sia stato per Levinas l’apertura rivelativa o l’evento rivelatore di una verità universale, della verità dell’uomo in universale, che egli cerca di
esprimere con categorie filosofiche universali, fenomenologicamente indagate e chiarificate. Se abbiamo soprattutto insistito, quindi, in questo capitolo, sull’elemento
della singolarità psicologico-ebraica è per riportare nel testo (e non, come accade di
solito, nella nota a piè di pagina) quello che ci pareva essenziale alla sua comprensione.
Tale percorso ci è stato suggerito dalla ricerca avviata da Elisabeth Weber,
nel libro Verfolgung und Trauma: Zu Emmanuel Levinas “Autrement qu’etre ou au
delà de l’essence”(Passagen-Verlag, Wien 1990). Rispetto a questo volume, che ha
indubbiamente sollecitato la nostra ricerca e di cui condividiamo l’impianto interpretativo, abbiamo posto tuttavia maggiormente l’attenzione sui testi precedenti ad AE,
e ovviamente sugli inediti che la studiosa austriaca non aveva potuto considerare,
mentre abbiamo meno valorizzato la vicinanza con il pensiero di Jacques Lacan, il
che avrebbe richiesto un lavoro a se stante.
Anche il bel libro recentemente uscito di Orietta Ombrosi324 indica la necessità di uno scavo nella dimensione psicologico-biografica, senza tuttavia percorrerla.
Ci è parso dunque opportuno muoverci in questa direzione. Mentre infatti normalmente, tra gli interpreti, si rilevava l’incidenza della singolarità ebraica per l’accesso
levinassiano all’universale umano, noi abbiamo dunque cercato di far emergere anche l’incidenza del trauma personale e collettivo della Shoah, con tutte le categorie
sopra mostrate.
La circolarità tra esperienza biografica e categorie di pensiero, sostenuta da
Levinas, ci ha orientati in questa direzione. É proprio dalla categoria interpretativa di
Passione che dovremo partire per mostrare il passaggio dalla particolarità ebraica alla
singolarità (o meglio all’unicità) esemplare del soggetto, operata in AE.
324
«Di conseguenza, la mia lettura vorrebbe suggerire che non bisogna mettere da parte il trauma personale dell’autore riguardo alle persecuzioni hitleriane…» (O. OMBROSI, L’umano ritrovato.
Saggio su Emmanuel Levinas Marietti, Genova-Milano 2010, p. 190).
164
III. LA PASSIONE COME FIGURA DELL’UMANO
165
166
1. Dalla passione d’Israele alla passione del soggetto
Nel ripercorrere le categorie religioso-filosofiche con le quali Levinas cerca
di confrontarsi con l’evento Shoah, abbiamo precedentemente accennato a quella che
senz’altro risulta costantemente evocata nei testi confessionali, mentre meno ricorrente è, come vedremo, in Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, cioè quella di
«Passione».
Come ha giustamente rilevato Marie-Anne Lescourret, l’assimilazione della
Shoah alla Passione (scritta sempre in maiuscolo1) «interviene in molte occorrenze
lungo l’intera opera di Levinas»2, di cui la studiosa riporta un significativo repertorio. In questo paragrafo metteremo a fuoco il termine «Passione», per poi concentrarci su quello di «sostituzione», in sede d’interpretazione del IV capitolo di AE.
Abbiamo già rilevato nel primo capitolo del nostro studio, nel testo L’expérience
juive du prisonier, la cancellazione del termine «passione» e la sua sostituzione con
quello di «passività»3. Tale sostituzione implica un passaggio da un registro religioso
ad uno fenomenologico-etico, per segnalare la passività totale dell’abbandono alla
violenza. Già nel testo giovanile, infatti, questa biffure (cancellazione con un tratto di
penna che fa ancora vedere la parola cancellata4), implicante, almeno potenzialmente
una, somiglianza dei due termini e una loro sovrapponibilità semantica, non era probabilmente casuale.
Si passava da un registro religioso ad uno fenomenologico con l’intenzione, forse, di evitare l’equivoco per il quale il termine in oggetto fosse compreso come denotante una sofferenza in qualche modo assunta, quindi che si configurasse come il
frutto di una scelta consapevole. Si trattava piuttosto di indicare, nella sofferenza patita dal popolo ebraico, quella che sarebbe stata poi chiamata un’«esposizione» senza
1
L’orizzonte del pensiero di Levinas è da lui stesso dichiarato come quello che si apre a partire da questa «Passione scritta con la P maiuscola»: «Io penso nel tormento (forse ancora incompiuto)
comune all’umanità di questo secolo ma in cui gli Ebrei hanno vissuto in sovrappiù la Passione di
Auschwitz (io scrivo Passione con una P maiuscola)» (in «Les Nouveau Cahiers», n° 67, 1981-82, p.
32).
2
M.-A. LESCOURRET, Emmanuel Levinas, Flammarion, Paris 1994, p. 387.
3
«Nella passività (passione) [sic] totale dell’abbandono, nel distacco da tutti i legami – sentirsi
come tra le mani del Signore, avvertire la sua presenza». (CCAI, p. 213, nota).
4
FS, p. 182; nota di F.P. Ciglia all’articolo levinassiano dedicato a Michel Leiris, «La trascendenza delle parole. A proposito delle Biffures» (in FS, pp. 153-160).
167
assunzione preliminare, nella quale fosse in gioco la stessa testimonianza profetica
dei martiri, quale traccia della sofferenza di Dio stesso5. Se tuttavia, in quel testo, si
trattava di uno spunto non ulteriormente elaborato, la ratio di quella scelta semantica
sarà quasi costantemente mantenuta in AE, dove però il termine ricorre assai raramente (cinque volte, nel capitolo IV6), sia pure in luoghi centrali, e sempre come sinonimo di «sostituzione».
Il passaggio da «Passione» a «passività» nella produzione levinassiana, dalla fine
degli anni ’60 in poi, sarà circolare, oggetto cioè di un rinvio vicendevole, in collegamento anche con il termine «pazienza» (che designa l’«enfasi della passività»7, ed
è riferito alla diacronia irrecuperabile della relazione etica).
Il termine «pazienza» era stato evocato da Levinas nella conferenza Al di là del
possibile, tenuta il 27 gennaio 1959 presso il Collège philosophique di Jean Wahl ed
ora disponibile nel secondo volume delle Opere8. Qui, riprendendo e ampliando le
analisi di EE e TA, Levinas rifletteva sul tema della morte, rilevando: «la pazienza è
la passività in senso eminente9», che risulta implicata nella sofferenza per la mortalità di autrui come senso più profondo rispetto all’attesa della morte per sé10; pazienza nella quale si rivela, dunque, la vera struttura fenomenologico-temporale del
moi11.
Tornando al termine «Passione», possiamo notare che nell’articolo Un Dio Uo12
mo? , riportante una conferenza tenuta nel 1968 (quindi contemporanea a quella sul-
5
«Sofferenza di Dio che soffre nella sofferenza dell’io» («Ebraismo e kénosi», in NODN, p. 14).
Cfr. AE, pp. 127, 128, 141, 146, 161 (ed. Le Livre de Poche, pp. 161, 162, 179, 185, 203).
7
DMT, p. 48.
8
Parole et silence, et autres conférences inédites, (Œuvres 2), a c. di R. Calin e C. Chalier, Grasset &
Fasquelle/Imec, Paris 2009, pp. 302-318.
9
Ivi, p. 308.
10
«Franz Rosenzweig ha potuto scrivere che la morte è essenzialmente il fatto di altri; che l’Altro è
colui che, per eccellenza, muore. La mia morte non si deduce che per analogia alla morte di altri» (ivi,
p. 304).
11
«L’ultimo fondamento della pazienza è una responsabilità infinita davanti l’infinito dell’altro, la
quale si compie come bontà e per conseguenza come me» (ivi, p. 310). Catherine Chalier, commentando questa conferenza, rileva giustamente: «Il “moi” umano non si caratterizza dunque attraverso la
sua lotta contro l’imprevedibilità della morte o attraverso la fiducia nella propria immortalità, ma attraverso la pazienza di cui esso fa prova di fronte all’infinito di altri» (ivi, p. 59). Queste considerazioni saranno ampliate soprattutto nelle lezioni alla Sorbonne del 1976 (DMT).
12
«Un Dieu Homme?», in Qui est Jésus-Christ?, Desclée de Brouwer, Paris 1968, pp. 186-192; ora in
Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, B. Grasset, Paris 1991, pp. 69-76; tr. it. di E. Baccarini, Tra
noi. Saggi sul pensare all’altro, Jaca Book, Milano 1998, pp. 85-92. [TN]
6
168
la La sostituzione13 del 30 novembre 1967, germe originario di AE), Levinas dapprima usa «Passione» come enfasi di «passività», per dire l’«espiazione»14, ma poi,
verso la fine del testo, usa i termini «passività», «Passione», «pazienza» come sinonimi, ad indicare la caratteristica della soggettività indeclinabile nell’«evento della sostituzione»15.
In un testo del 1981, apparso come Prefazione alla traduzione italiana della
raccolta di scritti talmudici, pubblicata nel 1982 con il titolo L’al di là del versetto,
(testo poi incluso anche in TN, col titolo Dall’etica all’esegesi16), Levinas allude ad
una passione esemplare, nei termini di una «figura nella quale si mostra un modo essenziale dell’umano». Leggiamo e commentiamo il seguente passo:
«La nostra ricerca tenta di risalire alle strutture o modalità di una realtà spirituale che vi si presta, vi consente e vi tende addirittura. Queste strutture o modalità sono dissimulate sotto la coscienza, rappresentativa e concettuale, già avvinta dall’interesse per il mondo e perciò assorbita dall’essere. Ma
benché dissimulate esse si lasciano discernere in una fenomenologia che, attenta agli orizzonti del cosciente, è proprio per questo […] fenomenologia anteriore alla teologia che assume questi appoggi come premesse. Il fatto di
Israele, le sue Scritture e le loro interpretazioni – ma anche la tormentata linea
tracciata, attraverso la storia, dalla Passione di Israele […] costituiscono una
figura nella quale si mostra un modo essenziale dell’umano e nella quale, prima di ogni teologia e di ogni mitologia, Dio viene all’idea. Sfida di un rovesciamento ontologico! La perseveranza originaria dell’essere nel suo essere
[…] si capovol[ge] in “tu non ucciderai” […] in non indifferenza dell’uno nei
13
Conferenza tenuta il 30 Novembre 1967 presso la Facoltà universitaria «St. Louis» di Bruxelles, poi
pubblicata nella «Revue Philosophique de Louvain» (vol. 66 [1968], pp. 487-508), con il titolo La
Substitution, e quindi confluita, con modifiche e ampliamenti, nel IV capitolo di AE.
14
«Il problema comporta, d’altro canto, e come producentesi da questa passività spinta dalla
Passione al suo limite ultimo, l’idea di espiazione per gli altri…» («Un Dio uomo?», in TN, p. 86, cn).
15
«É l’infinita passività o passione o pazienza dell’io, il suo sé, l’unicità eccezionale alla quale
egli è ricondotto, che è questo incessante evento di sostituzione, per l’essere il fatto di svuotarsi del
suo essere» (ivi, p. 92, cn).
16
TN, pp. 125-129. Precedentemente il testo era stato pubblicato anche nella rivista «Le Nouveau Cahiers», n° 82, 1982.
169
confronti dell’altro; non indifferenza nei confronti dell’altro, […] non-indifferenza nei confronti dell’assolutamente altro, nei confronti di altri [autrui]»17.
Levinas tiene qui a precisare che intende cogliere, attraverso i testi e la tragica
storia ebraica, i significati puri18 che orientano un’ermeneutica dell’umano in relazione alla trascendenza intersoggettiva e teologica. Queste strutture fenomenologicoantropologiche sarebbero oggetto, cioè, di uno studio preliminare rispetto a quello
della teologia o del pensiero religioso propriamente detto; e il lavoro fenomenologico
riuscirebbe a cogliere, al di sotto dell’evidenza dei contenuti testuali e della coscienza semelfattiva degli eventi storici (e, in particolare, al di là della consapevolezza con
la quale gli uomini li hanno vissuti), la testura etica esemplarmente universale che ne
dischiude il senso.
L’analisi fenomenologica, risalendo dal Detto testuale-evenemenziale al Dire
etico, andrebbe coniugata con l’ermeneutica della sollecitazione dei testi, istituendo
così una circolarità etico-esegesi inesauribile e sempre da approfondire. La ricerca di
significati puri, propria della fenomenologia, pur abbandonando il paradigma egologico della fondazione, trova spunto e origine nella fonte religiosa biblico-talmudica
(e questo percorso sarà tentato dal Nostro soprattutto nelle Letture talmudiche), e
quindi rende plausibile, in una «razionalità e concettualità di tipo totalmente nuovo»19, una traduzione di essa ad un livello filosofico capace di reggere anche indipendentemente dal rimando religioso (ed è la via percorsa dall’autore nelle opere più
strettamente filosofiche). Come scrive Roberto Mancini, si dispiega cioè nell’opera
levinassiana una circolarità ermeneutica in cui «si delinea un tipo di correlazione tra
l’etico e il biblico che pone l’accento sul primo ordine semantico, traendo poi da esso
17
«Etica ed esegesi», in ADV, p. 54 (cfr. anche in NODN, p. 126), cn.
«Il nostro metodo presuppone che le varie epoche della storia possano comunicare tra loro intorno a significati pensabili, quali che siano le variazioni del materiale significativo che li suggerisce»
(QLT, p. 29). Riprendiamo questo termine da R. MANCINI, Il servizio dell’interpretazione. Modelli di
ermeneutica nel pensiero contemporaneo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010, p. 95.
19
O. DEKENS, Politique de l’autre homme. Levinas et la fonction politique de la philosophie,
Ellipses, Paris 2003, p. 14 (Cit. in R. MANCINI, L’amore politico. Sulla via della nonviolenza con
Gandhi, Capitini e Levinas, Cittadella, Assisi 2005, p. 226).
18
170
la chiave per la trasfigurazione della metafisica, dell’antropologia, della politica e
dell’economia»20.
Sia i testi della tradizione sia gli eventi della storia ebraica sono studiati da Levinas in base alla peculiare ermeneutica della sollecitazione che egli propone a partire
dalla propria etica, potendo essere quindi interpretati come segni, figure, esempi, testimonianze particolari, in cui «si mostra [esemplarmente, appunto] un modo essenziale dell’umano».
2. La nozione di «figura» e lo schematismo storico in Kant
Per comprendere meglio il senso del passo che abbiamo sopra riportato, riteniamo utile soffermarci su alcune categorie concettuali kantiane, prendendo spunto dalle
suggestioni interpretative di Virgilio Melchiorre legate al concetto di «schematismo
storico» in Kant21.
Se, come suggerisce Melchiorre, intendiamo per figura22 «una esibizione [Darstellung] di [..un’] idea secondo leggi della libertà, attraverso un esempio nell’esperienza23», ritroveremo quella che Kant nella Critica del Giudizio chiama «esibizione»
o «ipotiposi simbolica». Essa si produce «quando ad un concetto che può essere pensato solo dalla ragione, e a cui non può essere adeguata alcuna intuizione sensibile,
20
R. MANCINI, L’amore politico, cit. pp. 229-230. In un altro luogo, Mancini scrive: «Il Bene
dà senso e orientamento al modo di leggere la Scrittura, mentre la Scrittura come rivelazione divina dà
senso e orientamento al modo di intendere il Bene stesso» (R. MANCINI, Il servizio
dell’interpretazione..., cit., p. 108).
21
V. MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale. Linee per una nuova lettura di Kant,
Mursia, Milano 1991. Si vedano in particolare le pp. 112-155.
22
Ivi, p. 137.
23
«Eine dieser gemäß organisirte bürgerliche Gesellschaft ist die Darstellung derselben nach
Freiheitsgesetzen durch ein Beispiel in der Erfahrung (respublica phaenomenon)» [«Una società civile
organizzata secondo tale norma è l’esibizione di quella secondo leggi della libertà, attraverso un
esempio nell’esperienza (respublica phaenomenon) »] (Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, AK VII p. 91; tr. it. di S. Gonnelli, «Se il genere umano sia in
costante progresso verso il meglio», in Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari 2004, p.
234).
171
viene sottoposta un’intuizione, nei cui confronti il procedimento del Giudizio è soltanto analogo a quello dello schematismo»)24.
Proporremo qui di interpretare il significato di «figura» adottato da Levinas alla
luce del concetto kantiano di «ipotiposi simbolica». Ci sembra però necessario, a
questo fine, ricostruire il contesto generale in cui Kant inserisce tale termine, che è
quello della considerazione filosofica della storia.
Come è noto, nel saggio Se il genere umano sia in costante progresso verso il
meglio (1798), Kant si pone il problema di come sia possibile pensare un progresso
dell’umanità nella storia. Si tratta, più propriamente, di poter formulare un giudizio
storico, nell’orizzonte della speranza, che permetta una «leggibilità25» della storia,
nel suo piano empirico, al fine di rinvenirvi una possibile finalità globale, ravvisando
cioè «una numenicità che è insieme essenza e fine [della storia]»26, e indagando «il
senso di un rapporto dialettico fra [tale] finalità fenomenica e [gli] accadimenti storici»27. Questa «presenza noumenica», però, non andrà riconosciuta tanto nella consapevolezza interiore degli attori storici28, quanto dal filosofo che ricerca «nella concreta effettualità storica»29 un senso intellegibile. Il problema, nota Melchiorre, è
24
«L’ipotiposi (esibizione, subiectum sub aspectum), in quanto è qualcosa di sensibile, è duplice; schematica, quando l’intuizione corrispondente ad un concetto dell’intelletto è data a priori; simbolica, quando ad un concetto che può essere pensato solo dalla ragione, e a cui non può essere adeguata alcuna intuizione sensibile, viene sottoposta un’intuizione, nei cui confronti il procedimento del
Giudizio è soltanto analogo a quello dello schematismo. […] Tutte le intuizioni che sono sottoposte a
concetti a priori sono dunque o schemi o simboli, e le prime contengono esibizioni dirette del concetto, le seconde indirette. Le prime procedono dimostrativamente, le seconde per mezzo di una analogia
[…] in cui il Giudizio compie un doppio ufficio, in primo luogo di applicare il concetto all’oggetto di
una intuizione sensibile, e poi, in secondo luogo, di applicare la semplice regola della riflessione su
questa intuizione ad un oggetto del tutto diverso, di cui il primo non è che un simbolo» (I. KANT, Kritik der Urtheilskraft, 1790, AK V; tr. it. di A. Gargiulo, rev. di V. Verra, Critica del Giudizio, Laterza,
Roma-Bari, 1992, pp. 172-173).
25
V. MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale, cit., p. 134.
26
Ivi, p. 127
27
Ibidem.
28
«Kant parla di una finalità ignota alle stesse coscienze storiche, ma iscritta comunque nella
loro vita: un “disegno della natura”» (ivi, p. 126). Questa teoria, molto simile a quella vichiana della
Provedenza e a quella hegeliana dell’astuzia della ragione, è specialmente attestata nel seguente passo: «I singoli uomini, ma anche i popoli interi, pensano poco al fatto che, mentre proseguono i loro
scopi, ciascuno a proprio senno e spesso l’uno contro l’altro, procedono senza accorgersene verso lo
stesso scopo della natura, che pure è a loro sconosciuto, come fosse il loro filo conduttore, e lavorano
al suo promuovimento, per il quale avrebbero assai scarso interesse anche se quello scopo fosse loro
noto» (I. KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht,1874, AK VIII, tr.
it. di F. Gonnelli, «Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico», in Scritti di storia,
politica e diritto, cit., pp. 29-30).
29
Ivi, p. 134.
172
d’altra parte analogo a quello che nella Critica del Giudizio Kant solleva circa la
pensabilità di una finalità in seno alla natura.
Come è noto, nella terza Critica Kant distingue tra giudizio determinante e riflettente, e deputa quest’ultimo a cogliere, pur senza funzioni conoscitive, un senso globale in chiave finalistica alla natura. In analogia a ciò, Kant parlerà inoltre, nella Religione nei limiti della sola ragione (1793), di «fede riflettente»30, quella per cui il
credente possa sperare in un aiuto divino sovrannaturale, sulla via del superamento
del «male radicale» come compimento della propria autonoma conversione etica31.
Come nota ancora Melchiorre, pare plausibile affermare che la fede riflettente sia
anche quella che trova, nell’epoca illuministica, la possibilità di un suo progressivo
darsi empirico; attraverso il rinnovamento delle comunità storiche, nella loro particolarità, si attuerebbe «un continuo avvicinamento a quella chiesa che riunisce tutti gli
uomini per sempre e che costituisce la rappresentazione visibile (lo schema) di un regno invisibile di Dio sulla terra»32. Nella progressiva depurazione – in senso demitizzante e anti-idolatrico – delle comunità ecclesiali, la stessa fede riflettente renderebbe possibile cogliere, nel darsi storico-testuale del «Maestro dell’Evangelo», l’esempio e il modello imitativo dell’ideale morale.
Analogamente dunque, dal punto di vista filosofico-storico, Kant, cerca di individuare un giudizio riflettente sulla base del quale pensare, entro la datità empirica che
pur attesta in modo sconfortante la costante precarietà e conflittualità degli eventi
storici, un disegno naturale di progresso morale «via via emergente all’interno delle
30
I. KANT, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, AK VI; tr. it. di M.M.
Olivetti, La religione nei limiti della sola ragione, Laterza, Roma-Bari, 19953, p. 57.
31
La «fede riflettente» è termine improntato al «giudizio riflettente» della Critica del Giudizio.
Il giudizio riflettente non permette di estendere la nostra conoscenza oggettiva (come quello determinante, che sussume nell’universale il particolare), ma solo «di risalire dal particolare della natura
all’universale», e si riferisce «a un convergere armonico delle nostre facoltà conoscitive ed etiche con
i nostri sentimenti; convergere che indica problematicamente verso una realtà oggettiva ulteriore, non
afferrabile né determinabile con la conoscenza intellettiva, ma che può spiegare tale armonico convergere» (G. FERRETTI, Ontologia e teologia in Kant, Rosenberg & Sellier, Torino 1997, p. 194 nota).
«La fede riflettente nasce infatti per riflessione su di una situazione storica contingente in cui si trova
la soggettività umana. Lungi dal poter estendere e determinare la nostra coscienza del mondo “oggettivo”, essa comporta inoltre il riferimento ad un evento non dovuto, legato alla libertà dell’essere supremo. Tale fede, più che una fede razionalmente fondata, va quindi intesa come un’ “umile fiducia”
nell’aiuto divino, che Dio non può far mancare a chi si impegna nella conversione etica secondo le sue
forze» (ivi, pp. 190-191).
32
I. KANT, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, tr. it. cit., p. 145.
173
contraddizioni storiche, anzi nonostante queste»33, tale da esibire anche, in un evento
concreto, l’ideale regolativo che presiede al senso globale della storia.
Tale noumeno regolativo sarà dunque «una società ideale in cui il massimo di libertà personale coincida con la libertà di tutti»34, cioè, su di un piano giuridico-pratico, una respublica noumenon, implicante in ultimo l’idea di una federazione mondiale di stati di diritto, che realizzi la cessazione della guerra e la «pace perpetua».
Ma perché è possibile pensare, si domanda Kant, questo plausibile «chiliasmo»35? Secondo il filosofo tedesco, esso deve essere pensato, dato che senza un
ideale regolatore come regno dei fini la storia sarebbe soltanto «una farsa»36. Tale
noumeno è cioè implicato nel postulato razionale della libertà, e nel suo aspirare al
bene sommo, essendo tale piano coincidente con quello del dovere morale37.
Questo ideale, però, non potrà essere né dedotto a posteriori dall’esperienza storica, né semplicemente applicato a priori a essa. Occorre, cioè un medium che colleghi il piano empirico-storico con quello trascendentale-morale, e questo dovrà essere
un evento che, per il suo carattere indimenticabile («un fatto del genere non si dimentica più»38), possa costituirsi in figura, schema, segno nel quale si esibisca esemplarmente quell’idea, e così possa anche attivare l’«entusiasmo» morale nell’opinione
pubblica cosmopolitica39.
33
V. MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale, cit. p. 127.
Ivi, p. 112.
35
«Si vede bene che anche la filosofia può avere il proprio chiliasmo, ma tale che l’idea che
essa ne ha può promuovere l’attuazione, sebbene da molto lontano, e che dunque non ha più nulla di
esaltato», I. KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, tr. it. cit., p. 39.
36
I. KANT, Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, tr.
it. cit., p. 226; cfr. anche: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber
nicht für die Praxis, 1793 AK VIII; «Sul detto comune: Questo può essere giusto in teoria, ma non
vale per la prassi», in Scritti di storia politica e diritto, tr. it. cit., p.154.
37
«Io potrò dunque supporre che […il genere umano] sia […] pensato in progresso verso il
meglio riguardo al fine morale della sua esistenza, e che questo progresso venga talvolta sì interrotto,
ma mai fermato. Non ho necessità di dimostrare questa presupposizione: il suo avversario ha l’onere
della prova. Infatti io trovo sostegno sul mio dovere innato di agire …» (I. KANT, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, tr. it. cit., p. 154).
38
«Infatti un tale fenomeno, nella storia degli uomini, non si dimentica più, poiché ha rivelato
una disposizione e una facoltà di miglioramento nella natura umana, quali nessun politico avrebbe
potuto arguire dal corso delle cose fino a quel momento» (ivi, p. 231).
39
«È soltanto l’atteggiamento di pensiero degli spettatori che, in questo gioco di grandi trasformazioni, si scopre pubblicamente e rende manifesta una tanto universale e tuttavia disinteressata
partecipazione al gioco di coloro che giocano da una parte contro quelli che giocano dall’altra […] ma
così dimostra un carattere del genere umano nella sua totalità (a causa della sua universalità) e insieme
il suo carattere morale…» (ivi, p. 228).
34
174
L’evento esemplare acquisisce dunque carattere rivelativo dell’ideale morale,
svolgendo un ruolo regolativo per l’agire (attraverso il suo carattere di esempio e
l’entusiasmo che suscita in relazione quell’ideale40), e insieme un ruolo valutativo
del corso storico nel suo andamento progressivo.
Sorge dunque, in Kant, il problema se si possa rinvenire nella storia un evento in
grado di valere come «segno (signum rememorativum, demonstrativum, prognosticum)41», tale da legittimare una possibile visione storica «pronosticante42» in chiave
di progresso giuridico-morale dell’umanità.
Tale «segno» dovrà essere pensato, in senso riflettente, anche come motivo di
speranza razionale, cioè quale causa finale, in consequentiam veniens, della prassi
storica che, avviandosi sulla base di quella realizzazione, proseguirà il suo corso attraverso concretizzazioni istituzionali sempre più conformi all’ideale, in un andamento asintotico verso il compimento dell’ideale regolativo stesso. Dal punto di vista
storico-teologico, un analogo ruolo svolgerà, come è noto, nella Religione, la chiesa
cristiana (affrancata illuministicamente dai suoi elementi superstiziosi), chiesa che
predica l’imitazione del «Maestro del Vangelo» – e dunque anche della la sua Passio
– come modello morale43.
Mentre Kant afferma che dal punto di vista empirico un evento di tal genere non
possa conoscersi, d’altra parte rileva, in un certo senso, che esso non possa neppure
non pensarsi. Esso non può darsi, cioè, alla ragione conoscitiva, all’intelletto, in
quanto l’esperienza, unificata dall’intelletto in giudizi conoscitivi, non può che constatare il carattere sempre precario di ogni evento storico, indice di una «indaffarata
stoltezza» umana nella storia44.
40
«..il vero entusiasmo si riferisce sempre e soltanto all’ideale, e precisamente all’ideale morale, come è il concetto del diritto, e non può essere attribuito all’interesse egoistico» (I. KANT, Ob das
menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, tr. it. cit, p. 230).
41
Ivi, p. 228.
42
Ivi, p. 227.
43
Come rileva Melchiorre, «nella Religione, Kant aveva parlato in modo simile di un “tutto
morale assoluto”, il regno futuro di Dio che costituisce la meta o il compito finale della ragion storica,
e aveva indicato le sue possibili anticipazioni solo in quelle “società parziali” che di quel tutto possono costituire “una rappresentazione o uno schema”» (V. MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale, cit., pp. 114-115).
44
«Il carattere della nostra specie è un’indaffarata stoltezza: affrettarsi sulla via del bene, ma su
di essa non perseverare, bensì rovesciare il piano del progresso per non essere legati neppure a un singolo fine […], costruire per poi distruggere, e imporre a se stessi lo sforzo disperato di spingere in
salita la pietra di Sisifo per poi farla rotolare di nuovo giù» (I. KANT, Ob das menschliche Geschlecht
im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, tr. it. cit, p. 226).
175
Ma un simile evento non può non essere «pensato», proprio in virtù
dell’esigenza della facoltà del giudizio di collegare in un’unità sistematica superiore
ai dati empirici la serie diacronica dei fenomeni storici. Sono gli eventi storicoempirici stessi, infatti, che suggeriscono un possibile progresso, non dei singoli individui ma dell’umanità intesa come totalità. Se è vero, infatti, che il singolo agisce
sempre «come se fosse solo» nel perseguimento dei propri bisogni istintuali, egli tuttavia, in base alla propria «insocievole socievolezza»45, si troverà costretto ad unirsi
in una comunità giuridica avente leggi costrittive, al fine di garantirsi la propria incolumità .
La stessa ragione si serve dunque dell’istinto per realizzarsi, e il filosofo non
può non constatare che, attraverso la creazione di istituzioni razionali collettive, sia
pure particolari, costringenti in base a legalità dapprima «in un qualche popolo», l’individuo è costretto a fare quello che, d’altra parte, avrebbe dovuto fare in base alla
sola ragione.
Non si tratta di un mutamento nella qualità interiore dell’azione morale, ma
della realizzazione esterna di una legalità che permetta quell’azione46. È la stessa natura, cioè, che in base ad una dialettica storica trasforma il negativo della guerra in
uno strumento di provvidenziale positività. La storia empirica, infatti, attesta una permanente conflittualità, eppure, «nel gioco di questo antagonismo, persino la guerra
con tutte le sue negatività ha un ruolo positivo: essa minaccia la civiltà e costringe
alla difesa, ma perché la difesa sia efficace e solidale è necessario che gli uomini si
riconoscano in ruoli di reciproca solidarietà [...e] che le tendenze solipsistiche e tiranniche cedano il passo agli istituti democratici»47.
Lo stesso egoismo istintuale costringe quindi gli uomini a cercare una cessazione della guerra per trovare la pace, e quindi a sottoporsi a leggi statutarie. Le istituzioni saranno dunque un segno empirico e particolare che rivela di per sé un progresso verso l’attuazione dell’ideale giuridico-morale universale dell’umanità (mai
45
I. KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, tr. it. cit., p. 33.
«La via del progresso legale è solo la via con cui la natura può raggiunger tutti gli altri suoi
fini nei riguardi della nostra specie» (V. MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale, cit., p. 128).
47
Ivi, pp. 128-129.
46
176
però attuabile pienamente48), e dunque che permette la pensabilità – nell’orizzonte di
«tempi infiniti»49 – di un progressivo avvicinamento all’ideale.
Il progresso non avviene nel senso di un mutamento della qualità o di un aumento della quantità di moralità dell’intenzione, come se l’atteggiamento interiore
potesse progredire, ma nel senso di un «aumento dei prodotti della sua legalità in
azioni conformi al dovere, qualsiasi siano i moventi che le determinano»50. I rapporti
giuridici esterni, realizzati esemplarmente in una rivoluzione, instaurano costruzioni
giuridico-statuali aventi anche la funzione di rivelare la moralità nel suo carattere
puro, nel senso cioè che essi rinviano l’uomo «ad una costituzione e ad una sua facoltà d’essere causa del suo progresso verso il meglio e (giacché deve essere l’atto di
un essere dotato di libertà), creatore di tale progresso»51.
Il giudizio riflettente, in sede storica, potrà dunque rinvenire in un evento che
hanno un carattere epocale e indimenticabile (un fatto del genere «non si dimentica
più»52), l’esibizione dell’ideale morale assoluto. Un evento di tal fatta è, secondo
Kant, la Rivoluzione Francese, proprio perché essa, nonostante il suo carico di violenza che ha comportato, ha comunque mostrato al pubblico dell’umanità, con il suo
richiamo all’autogoverno e al bando della guerra offensiva, lo schema dell’ideale.
In questo evento, dunque, è possibile individuare l’esempio di una società politica
che esibisca l’ideale regolativo e a priori di una repubblica perfetta («respublica noumenon»): «Una società civile organizzata secondo tale norma è l’esibizione di quella
secondo leggi della libertà, attraverso un esempio nell’esperienza (respublica phaenomenon)»53.
48
«L’idea sublime – ma mai attuabile completamente – di una comunità morale, si rimpicciolisce tanto nelle mani dell’uomo, da ridursi infine ad un’istituzione, che, pur potendo rappresentare con
purezza, al massimo, solo la forma di tale idea, è invece – per quanto riguarda i mezzi atti a costituire
un Tutto di tale genere – molto limitata, essendo subordinata alle condizioni della natura umana sensibile» (I. KANT, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, tr. it. cit., p.107).
49
I. KANT, Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, tr.
it. cit. p. 232.
50
Ivi, p. 234.
51
Ivi, pp. 227-228.
52
«Infatti un tale fenomeno, nella storia degli uomini, non si dimentica più, poiché ha rivelato
una disposizione e una facoltà di miglioramento nella natura umana, quali nessun politico avrebbe
potuto arguire dal corso delle cose fino a quel momento. […] Infatti quell’avvenimento è troppo grande, troppo legato all’interesse dell’umanità e troppo esteso nel suo influsso sul mondo in tutte le sue
parti, perché non debba essere riportato alla memoria dei popoli […] e risvegliato al fine di ripetere
nuovi tentativi della stessa specie» (ivi, pp. 231-232).
53
I. KANT, Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, tr.
it. cit. p. 234.
177
Questa esibizione o figura, è simbolica, svolge cioè il ruolo di schema storico
mediatore tra l’idea sovrasensibile e il piano temporale-effettuale54; e lo stesso ideale
sovrasensibile, quale eschaton storico, andrà inteso non come dolce sogno utopico55
da sperare nell’attesa che accada da solo, ma come ideale regolativo non solo pensabile ma anche oggetto di dovere nella prassi storica universale56, prassi esposta sempre tuttavia alla precarietà e alla contingenza, data la sua origine nella libertà umana.
3. «Figura» e storia, tra Kant e Levinas
Vediamo ora in quale senso la visione levinassiana possa essere accostabile a
quella kantiana, e in quale senso invece se ne distacchi.
In via preliminare, usando la terminologia kantiana, potremmo dire che a «passione d’Israele» sia figura nel senso di esibizione [Darstellung] simbolica. In tale figura, sembrano esibirsi57 una serie di strutture o modalità fenomenologiche che non
potendo esporsi58 dal punto di vista concettuale, poiché anteriori al piano rappresentativo, possono appunto sono valere come corrispondenti, prestantisi-a e tendenti
verso una «realtà spirituale», come loro criterio di valutazione e di orientamento morale.
Tale realtà spirituale, per Levinas, è la santità, come eidos dell’umano. La Passione di Israele sarebbe cioè exemplum della santità, nel senso, specificato da Kant
nella Metafisica dei Costumi, di Exempel (esempio-modello morale) e non di Bei54
«Ricordiamo ancora che lo schema viene considerato da Kant non solo come una mediazione dell’universale con l’esistente, ma più precisamente con l’esistente inteso nella tua temporalità» (V.
MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale, cit., p. 136).
55
«Sperare che un giorno, per quanto tardi, una forma di Stato come qui la si pensa [utopico]
venga portato a compimento è un dolce sogno, ma avvicinarsi sempre ad essa non è solo pensabile,
bensì, nella misura in cui possa accordarsi con la legge morale, è un dovere; non del cittadino, ma del
capo dello Stato» (I. KANT, Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, tr. it. cit., p. 235 nota, cn).
56
Cfr. V. MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale, cit., p. 113.
57
Per Kant, «esibire» (darstellen, da cui Darstellung) significa «porre accanto al concetto
un’intuizione corrispondente» (Kritik der Urtheilskraft, 1790 AK V; tr. it. di A. Gargiulo, rev. di V.
Verra, Critica del Giudizio, Laterza, Bari 1992, p.78).
58
Per Kant, «esporre (exponieren) significa riportare una rappresentazione dell’immaginazione
ai concetti e, in questo senso, “l’idea estetica” si può chiamare una rappresentazione inesponibile
dell’immaginazione, perché è una intuizione (dell’immaginazione) alla quale non si può mai trovare
un concetto adeguato» (Kritik der Urtheilskraft, tr. it. cit. p. 322; cfr. ivi, pp. 164-165).
178
spiel (esempio teorico o retorico)59. Tale «realtà spirituale», secondo Levinas, fa
tutt’uno con «un modo essenziale dell’umano», è «l’ideale della santità contrario alle
leggi dell’essere60», il capovolgimento del conatus essendi in non-indifferenza verso
altri, nel comandamento «non uccidere». Essa sarebbe inoltre anche il solo modo in
cui Dio «viene all’idea» (la sua «rivelazione»).
Ma per supportare tale interpretazione, coglierne i punti di forza ed eventualmente i limiti, dovremo approfondire, parallelamente a come abbiamo fatto per Kant,
la visione levinassiana della storia.
La vicinanza tra Kant e Levinas, circa la considerazione della storia nella sua tragicità, è ampliamente constatabile dai testi, come pure è constatabile la loro comune
prospettiva, per la quale l’unica pensabile speranza è da rinvenire sul piano etico:
«l’anonimo svolgersi della storia, quando la morale non la guida – dice Levinas – è
solo una serie di crimini ripetuti a catena»61.
Tuttavia Levinas ci pare maggiormente accentuare la diastasi tra piano ideale morale e piano storico evenemenziale, e rifiutare quindi qualsiasi concessione ad una
lettura in qualche modo “provvidenzialistica” della storia. Ci riferiamo alla possibilità, ammessa da Kant, per la quale la natura indirizzi o faccia accedere gli uomini –
malgrado le loro intenzioni consapevoli – ad un progressivo realizzarsi dell’ideale
morale (che mai si attua, ma che è asintoticamente percorribile e riflessivamente pensabile). Abbiamo visto, infatti, che per Kant, nella storia, è la stessa «natura» che in
un certo senso costringe gli uomini a darsi strutture razionali di tipo statuale per attuare l’autogoverno ed evitare progressivamente la guerra62. La stessa guerra acquisisce in Kant una paradossale valenza positiva, perché costringe gli uomini e i popoli
59
«L’Exempel è un caso particolare di una regola pratica, in quanto questa rappresenta
un’azione come praticabile o impraticabile. Il Beispiel all’opposto è il particolare (concretum) rappresentato come contenuto nell’universale secondo concetti (abstractum), e l’esposizione puramente teorica di un concetto» (I. KANT, Die Metaphysik der Sitten, 1797 AK VI; tr. it. di G. Vidari, rev. di N.
Merker, Metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 52 nota).
60
TN, p. 149.
61
DL, p. 282.
62
Si legga ad esempio questa frase, contenuta in un saggio kantiano del 1786: «Se ora ci chiediamo come questo progresso verso il meglio possa essere mantenuto e anche accelerato, allora si
vede subito che questo risultato, che si trova in definitivamente lontano, non dipenderà tanto da ciò
che noi facciamo, ma invece da ciò che la natura umana farà in noi e con noi per costringerci ad un
percorso a cui da soli non ci adatteremmo facilmente» (Über den Gemeinspruch: Das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, tr. it. cit, p. 156, ccda).
179
«alla risoluzione di sottomettersi alla coazione che la ragione stessa gli prescrive come mezzo, e cioè a leggi pubbliche, e ad entrare in una costituzione statale»63.
Levinas non pensa invece che i fatti storici possano di per sé concorrere ad un
progresso morale, come pure rifiuta di concedere che le tragedie e le insensatezze
storiche abbiano il ruolo di costringere in qualunque modo la violenza storica a depotenziarsi.
Il piano morale è per Levinas è quello che permette di attraversare e sopportare la
storia e nello stesso tempo emettere un giudizio su di essa64. Nelle prime pagine di
TI, la possibilità di un giudizio sulla storia diventa la possibilità di pensare, contrariamente ad ogni «evidenza filosofica», l’ontologia della pace come trascendenza in
qualche modo irrompente nella storia stessa:
«Lo straordinario fenomeno dell’escatologia profetica non si preoccupa certo di ottenere un diritto di cittadinanza nel pensiero, assimilandosi ad
un’evidenza filosofica. […] La sua vera importanza è altrove. Essa non introduce un sistema teologico nella totalità, essa non consiste nell’insegnare l’orientamento della storia. L’escatologia mette in relazione con l’essere, al di là
della totalità e della storia, e non con l’essere al di là del passato e del presente. […] Essa è relazione con un sovrappiù sempre esterno alla totalità […]
Questo al di là della totalità e dell’esperienza oggettiva, non si descrive tuttavia in maniera puramente negativa. Esso si riflette all’interno della totalità e
della storia, all’interno dell’esperienza. L’escatologia, in quanto “al di là” della storia sottrae gli esseri alla giurisdizione della storia e del futuro – li colloca nella loro responsabilità e li chiama ad essa. Sottoponendo al giudizio la
storia nel suo insieme, al di fuori appunto delle guerre che ne segnano la fine,
esso restituisce ad ogni istante, in quello stesso istante, il suo significato concluso: tutte le cause sono mature per essere ascoltate. Non è il giudizio ultimo
63
Il passo kantiano continua come segue: «…e così anche la miseria che segue alle guerre
permanenti nelle quali gli stati a loro volta tentano di distruggersi e soggiogarsi a vicenda deve infine
condurli anche loro malgrado a entrare in una costituzione cosmopolitica» (ibidem).
64
Levinas rinviene nel giudaismo rabbinico la fonte di questa ermeneutica della storia: «I profeti del giudaismo […] indicano il bene e il male senza preoccuparsi del senso della storia. Forse essere un popolo eterno significa questo: non profetizzare immediatamente come fa la dialettica, ma distinguere la propria destra dalla propria sinistra» (DL, p. 277); e ancora: «Essere ebreo significa non
sottomettere la Legge di giustizia all’implacabile corso degli eventi, denunciandoli come controsenso
e follia» (ivi, p. 282); cfr. anche TI, pp. 20-21.
180
quello che conta, ma il giudizio di tutti gli istanti nel tempo in cui si giudicano
i vivi»65.
Il giudizio è possibile sulla storia in ogni momento, e la resistenza etica è tale
proprio perché nella storia si dà la continua minaccia di un possibile ritorno al non
senso.66 La guerra «come gesto dell’essere» non è sovrastabile storicamente in modo
progressivamente definitivo, e in luogo dell’ideale morale come noumeno regolativo,
di cui schema sarebbero, secondo Kant, le particolari realizzazioni storiche, Levinas
indica come unico oggetto di speranza la stessa testimonianza del Bene, che eleggendo le singole soggettività irrompe enigmaticamente nel piano dell’essere, senza tuttavia che tale emergenza-interruzione fondi una permanente stabilità ontologica e istituzionale.
4. Libertà, violenza e istituzione: ruolo e limiti dello Stato.
Levinas tuttavia riconosce, entro un certo limite, una plausibile validità alla dinamica kantiana di sospensione della violenza attuata dalla ragione nella Legge e nello
Stato; nel saggio Libertà e comando del 1953, egli infatti scrive:
«La libertà consiste nell’istituire fuori di sé un ordine della ragione:
nell’affidare il ragionevole allo scritto, nel ricorrere a un’istituzione. La libertà nel suo timore della tirannide, ha per esito l’istituzione, un impegno della
libertà in nome della libertà, uno Stato. La libertà, come obbedienza alla legge, dipende certo dall’universalità della massima, ma anche dall’incorrutibilità dell’esistenza esterna della legge [quella che Kant chiama «legalità»], e in
65
TI, pp. 20-21, cn.
In AE, la stessa gratuità del non senso sempre incombente rende possibile la santità come testimonianza del Bene, come vedremo tra poco.
66
181
tal modo si trova a riparo dal cedimento oggettivo, al riparo dal sentimento»67.
Quest’affermazione giunge al termine di un’analisi fenomenologica del comandare, nella quale esso è descritto dapprima come un «agire su una volontà»
esterna. Ora, paradossalmente – dice Levinas, l’eteronomia del comando si muta in
autonomia, giacché chi comanda, per farsi obbedire, ha bisogno del riconoscimento
razionale del suo comando da parte dell’altro, dunque egli deve in un certo senso «fare la volontà di chi obbedisce»68. Qualora chi riceve il comando dovesse constatarne
l’irrazionalità, potrebbe certo accettare la morte pur di restare libero, ma proprio per
questo conserverebbe sempre, nella sua libertà di pensiero, «un potere illimitato di
rifiuto»69. Tuttavia Levinas constata che nella realtà empirica è difficile mantenere
questa superiore libertà di pensiero, e che la stessa razionalità potrebbe essere affetta
da una minaccia di morte di un tiranno, divenendo così «ragione turbata»70.
Ricordandosi delle esperienze totalitarie appena vissute, Levinas sembra alludere qui a quei meccanismi di coercizione che, attraverso «risorse infinite»71, pervertono la stessa coscienza razionale come potere di disobbedire al comando. Senza
arrivare alla figura del musulmano evocata da Primo Levi, potremmo pensare già solo ai cittadini della Germania nazionalsocialista o della Russia sovietica: «Che sia
possibile creare un animo da schiavo non è solo la più toccante esperienza dell’uomo
moderno, ma forse la confutazione stessa della libertà umana»72.
Quest’ultimo rilievo ci porta a una paradossale conseguenza: la potenza del
tiranno è talmente forte, e la sua efficacia così globale, da non trovare più di fronte a
sé un altro soggetto capace di obbedire o disobbedire, ma «solo una materia offerta
alla violenza»73; «nessuno gli sta di fronte: il tiranno non ha mai comandato, è sem-
67
«Libertà e comando», in E. LEVINAS- A. PEPERZAK, Etica come filosofia prima, Guerini e
Associati, Milano 1989, p. 18, tr. it. di F. Ciaramelli. Ed. originale: Liberté et commandement, «Revue
de métaphysique et morale», LVIII (1953); Le Livre de Poche, Paris 1999.
68
Ivi, p. 15; se ne deduce quindi che «la libertà del comandare non è una forza cieca, ma un
pensiero ragionevole» (ivi, p. 16).
69
Ibidem.
70
Ibidem.
71
Ivi, p. 17.
72
Ibidem.
73
Ivi, p. 18.
182
pre stato solo»74. Giunto a questo, punto Levinas suggerisce che la libertà è il potere
di «prevedere il proprio cedimento e di premunirsi contro di esso»75, e introduce il
passo che abbiamo sopra riportato, nel quale egli illustra la posizione kantiana di una
legalità che realizzi e protegga empiricamente la libertà, pur non essendo
quest’ultima per principio determinabile solo in base alla massima universalizzabile
della volontà.
Tuttavia Levinas ritiene che anche lo Stato originariamente razionale possa
(e di fatto così accade) tramutarsi in un meccanismo coercitivo e violento, ponendosi
come un ordine neutro in cui la «volontà vivente76» dei singoli «non si riconosce
più»77. Certo, in prima istanza sembra che proprio nello Stato si realizzi quella situazione in cui «il comando sia condizione della libertà»78, nel senso che la legge scritta,
realizzando una traduzione della «previsione razionale del proprio cedimento», impedirà con un comando universale l’esercizio di una tirannide particolare di qualcuno
su tutti altri. Ma, a ben guardare, la stessa «azione tirannica o violenta», che «consiste nell’agire come se si fosse soli» 79 è in realtà mantenuta da parte dello Stato, proprio perché esso è improntato alla figura universale-totalizzante della ragione.
Qualsiasi istituzione statuale che si basi cioè su una ragione universale, e
quindi impersonale, disconoscerà una «ragione prima della ragione, che rende umani
sia il discorso razionale sia la ragione impersonale»80; lo Stato, cioè, disconoscerà «il
discorso come situazione del faccia a faccia»81, o anche «una possibilità d’intesa diretta tra singoli [entente directe entre particuliers82] […] un rapporto di singolo a
singolo prima dell’istituzione della legge»83.
È proprio la solitudine o autorefenzialità della ragione, in sostanza, a rivelarsi
come violenza, in quanto essa non riconosce fuori di sé un’alterità radicalmente altra,
e, quando la riconosce, lo fa solo per inglobarla entro di sé. In questo senso, l’uni-
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, p. 19.
Ivi, p. 20.
Ivi, p. 19.
Ivi, p. 22.
Ivi, p. 21.
Ibidem, cn.
Liberté et commandement, Le Livre de Poche, Paris 1999, p. 42.
Ibidem, cn.
183
versalità della ragione, come globalizzazione totalitaria di ogni alterità, è proprio
l’indice e la figura di questa violenza.
La violenza latente nell’istituzione razionale, secondo Levinas, dovrà essere
dunque limitata e corretta dalla «situazione» interlocutiva originaria del «faccia a
faccia» etico. Per chiarire questo, egli istituisce un’analogia tra lavoro e guerra: entrambe agiscono plasmando una materia inerte, rifiutano la possibilità stessa di
un’interruzione del loro potere e ignorano il fatto che una realtà gli è opposta; esse in
definitiva
«non guarda[no] in faccia a ciò a cui si applica l’azione». […] La faccia, il volto [la face, le visage84] è il fatto che una realtà mi è opposta; opposta
non nelle sue manifestazioni, ma nella sua maniera d’essere, cioè, se così si
può dire, ontologicamente opposta. Il volto è ciò che mi resiste per la sua opposizione, e non quel che mi si oppone per la resistenza. Voglio dire che
quest’opposizione non si rivela ostacolando la mia libertà: è un’opposizione
anteriore alla mia libertà e la mette in moto. Non è ciò a cui mi oppongo, ma
ciò che si oppone a me. È un’opposizione inscritta nella sua presenza a me.
L’opposizione del volto, che non è opposizione di una forza, non è ostilità. È
un’opposizione pacifica: ma in essa la pace non è in alcun modo una guerra
sospesa, una violenza semplicemente trattenuta. Al contrario, la violenza
consiste nell’ignorare quest’opposizione»85.
Pur non utilizzando più un linguaggio ontologico, Levinas riprenderà quest’analisi nella sua opera maggiore. Anche in AE, infatti, possiamo rinvenire la traccia
dell’idea kantiana della ragione istituzionalizzata in Stato come sospensione della
guerra, ma Levinas dichiara subito che questo tentativo “diplomatico” di interruzione
della guerra non è che la riproposizione ad un livello più ampio della stessa dinamica
violenta, ed è quindi incapace a far cessare la guerra quale fenomeno originario
dell’essere:
84
85
Liberté et commandement, cit., p. 47.
Ivi, pp. 22-23, ccnn.
184
«Esse è interesse. L’essenza è interessamento. […] Positivamente, esso si conferma come conatus degli enti. L’interessamento si drammatizza negli egoismi in lotta gli uni contro gli altri, tutti contro tutti, nella molteplicità
di egoismi allergici che sono in guerra gli uni contro gli altri […]. L’essere è
così l’estremo sincronismo della guerra. […] ma l’essenza non si muta forse
nell’altro dell’essenza attraverso la pace in cui regna la Ragione che sospende
lo scontro immediato tra gli esseri? […] Lo scontro in cui, tutti contro tutti,
sono tutti con tutti, diviene limitazione reciproca e determinazione di una materia. Ma il persistere nell’essere, l’interessamento, continua attraverso la
compensazione che, nell’avvenire, deve equilibrare le concessioni pazientemente e politicamente consentite nell’immediato. […] Niente è gratuito. La
massa permane e l’interessamento rimane. La trascendenza è fittizia e la pace
instabile. Essa non resiste agli interessi»86.
«La massa permane», ovvero non è interrotta dal faccia a faccia etico. In questo
richiamo alla «massa» Levinas allude, ci sembra, alla degenerazione, insita nella loro
essenza, degli stati moderni in stati totalitari; egli sta evocando lo spettro della violenza storica del Novecento nella sua dimensione più originariamente collegata alla
struttura totalitaria di una ragione neutra e impersonale.
A ben guardare, dunque si rivela che in qualsiasi Stato, per il suo carattere di
esercizio del monopolio della forza e la sua struttura formale universale, è sempre
latente la violenza insita nell’essere87. Anche nello Stato, o in una federazione di Stati che sospendano la guerra, essa infatti non cesserà mai definitivamente, perché
l’uomo rimarrà sempre esposto all’assurdo, al non senso, all’ il y a, che sembra ritornare, non solo entro il caos anomico e antagonisticamente allergico dell’umanità prestatuale, ma anche e soprattutto nelle istituzioni razionali più avanzate.
Non che Levinas neghi l’esigenza dello Stato, proprio perché il rapporto diacronico altri-io non si fenomenizza senza il terzo (il terzo è già inscritto nel volto d’altri)
ed è quindi sempre necessario, sul piano dell’essere, riportare l’originario dinamismo
86
AE, p. 7.
«Vi è una parte di violenza nello Stato, che però può comportare la giustizia. Ciò non vuol
dire che non bisogna evitarla, per quanto sia possibile. Tutto ciò che la sostituisce nella vita tra gli
stati, tutto ciò che si può lasciare alla negoziazione, alla parola, è assolutamente essenziale, ma non si
può dire che non vi sia qualche violenza legittima» (TN, p. 140).
87
185
etico metaontologico; ma Levinas critica ogni elevazione dello Stato a termine finale
della storia e ad attuazione completa, reale o possibile, del Bene. Per Levinas non è
realizzabile cioè un «regno di Dio» in terra: un’incarnazione definitiva del Bene è
«impossibile»88, prima ancora che per ragioni di carattere confessionale (il pensiero
ebraico nega l’incarnazione di Dio), perché l’incarnazione del Bene come incarnazione definitiva dell’universale, in quanto partecipe del meccanismo totalizzante del
logos, sarebbe ipso facto una universalizzazione della violenza.
Il Bene, dunque, non può essere compiutamente realizzato e universalizzato in
Stato, perché ciò coinciderebbe – sembra suggerirci Levinas in AE – con la sua riduzione ad idolo mondano, con la violenza assoluta e idolatrica di una ragione totalitaria istituzionalizza; totalitarismo e violenza in nome del Bene: «L’idolatria è senza
dubbio lo Stato, il prototipo dell’idolatria, poiché lo Stato adora di essere un Idolo»89.
Anche una traduzione diretta dell’utopia della nonviolenza, (un Detto che traducesse unilateralmente l’ambivalenza trascendente del Dire, ma soprattutto che deresponsabilizzasse i singoli dall’annodare di volta in volta legami di pace con i loro
prossimi), se imposta istituzionalmente, sarebbe forse violenta, almeno quella che
non pensasse anche le forme di una resistenza al male perpretato contro le vittime
della storia90. Occorre infatti che la nonviolenza, come base del rapporto etico originario, non si traduca in un «senza difesa» delle vittime, ma che insieme minimizzi la
violenza insita nella «guerra contro la guerra stessa» nella stessa difesa dei deboli dai
violenti, all’interno e all’esterno della società.
La nonviolenza è di volta in volta un mio (del moi) compito indelegabile, in
quanto io, insostituibile e indeclinabile soggetto investito dal volto, sono di volta in
volta chiamato a correggere la violenza dell’istituzione: questa elezione, di me come
88
«Separandosi da ogni presente memorabile – passato che non fu mai presente – esso
[l’infinito] lascia la traccia della sua impossibile incarnazione e della sua dismisura nella mia prossimità con il prossimo…» (AE, p. 202, cn); si veda anche questo passo: «Non c’è nessuna necessità di
riferirsi per questo a un avvenimento in cui il non-luogo, facendosi luogo, sarebbe entrato eccezionalmente negli spazi della storia» (AE, p. 228).
89
DSS, p. 131.
90
Sulle sul carattere le aporie e i limiti della concezione nonviolenta di Levinas, insiste particolarmente ROBERTO MANCINI (Cfr. L’amore politico, cit., pp. 264-266). La nonviolenza è esigita sempre da parte dell’ogni volta unico soggetto, e non può essere delegata o pretesa dagli altri: «Il nostro
tempo non ha certo bisogno di essere convinto del valore della nonviolenza. Ma gli manca una rinnovata riflessione sulla passività, su una certa debolezza che non è viltà, su una certa pazienza che non
bisogna predicare agli altri, in cui l’Io deve mantenersi e che non può esser considerata in termini negativi, come semplice rovescio della finitezza» (DL, p. 213; trad. leggermente modificata).
186
unico responsabile per tutti, è l’utopia dell’umano91; utopismo che non può essere
rimproverato di fuga dalla storia92, perché anzi mi chiama ad entrarvi e a non delegare ad altri o alle istituzioni la ricerca della pace: «la pace con l’altro è prima di tutto
affar mio»93, al di là del popolo a cui appartengo, e allo Stato, per quanto razionale e
«di diritto», di cui mi trovi a far parte94.
È certamente vero che nel discorso levinassiano «si può avvertire una certa provvisorietà di indicazioni, nonostante la perentorietà delle tesi esposte95», circa le modalità concrete della praticabilità storico-istituzionale della nonviolenza, ma la nostra
impressione, leggendo i testi di Levinas, è che il suo pensiero sia combattuto tra
l’enormità della richiesta mia etica di fronte al volto dell’altro, fosse pure il carnefice, e la non accettabilità, o l’impossibilità a concedere una deroga all’obbligo sempre-mio della difesa violenta del «senza-difesa» delle vittime. Ne troviamo traccia
soprattutto nell’ultima fase del pensiero levinassiano, in cui questo dilemma emerge
in maniera meno dissimulata e più drammatica, proprio al cospetto del trauma della
Shoah. Rispondendo al vescovo Hemmerle, in un colloquio del 1987, Levinas afferma infatti:
«Il senza-difesa è costato molta sofferenza umana. […] Voi lo sapete,
non comprendo più, oggi, dopo Auschwitz, il senza-difesa.[…] Il senso di Auschwitz sarebbe una sofferenza senza alcuna promessa, completamente gratuita. Ma allora io mi rivolto, pensando che tutto ciò ha un prezzo troppo alto
non soltanto per il buon Dio, ma per l’umanità. È questa la mia critica, o la
mia non comprensione, del senza-difesa: la Kénosi dell’impotenza costa troppo cara agli uomini! […] Senza-difesa che non è solo di Dio, ma che è anche
senza-difesa delle vittime!»96.
91
AE, p. 57.
AE, p. 228.
93
AE p. 174, cn. Che dal punto di vista del sapere questo tentativo paia «incerto», non toglie
che debba essere tentato, poiché io sono ostaggio della pace: «pace, di conseguenza, sotto la mia responsabilità, pace di cui io sono ostaggio, pace che sono il solo a costruire, correndo un bel rischio,
pericolosamente; pericolo che al sapere apparirà come incertezza, mentre è la trascendenza stessa,
prima della certezza e dell’incertezza, le quali non sorgono che nel sapere» (AE, p. 208).
94
Cfr. ivi, p. 228.
95
R. MANCINI, L’amore politico, cit., p. 264.
96
NODN, p. 184. Probabilmente qui Levinas polemizza anche contro una certa visione della
«Croce del Cristo che si è trovato alla fine a condurre le armate dei Crociati! E non è sceso dalla croce
per arrestare gli assassini» (Ibidem). A nostro avviso il vero senso della frase che abbiamo riportato è
92
187
Qui ci pare che la posizione levinassiana neghi un malinteso pacifismo assoluto,
speculare, per opposizione, ad un giustizialismo e bellicismo altrettanto assoluti. Del
resto, anche nella Bibbia, notava Levinas in un articolo del 195297, si affronta il dilemma morale di una violenza in qualche modo «giusta». Contestando l’accusa di
inumanità e violenza mossa da Simone Weil nei confronti dell’Antico Testamento
(quella che per gli Ebrei è la Bibbia), in cui Dio avrebbe «ordinato agli uomini di
commettere atti di ingiustizia e crudeltà»98 (in riferimento soprattutto all’episodio
dello sterminio delle nazioni cananee durante la conquista della terra promessa) Levinas commenta che anche gli Ebrei sono «disgustati da tanta crudeltà99», e poi aggiunge:
«La cosa straordinaria è che la coscienza ebraica vi [nella Bibbia] ha
imparato l’orrore assoluto del sangue, mentre da più di duemila anni la dottrina della nonviolenza non ha arrestato il mondo dalla sua corsa naturale
alla violenza. […] Forse la dura legge dell’Antico Testamento non è una dottrina di dolcezza […]. Probabilmente è nella natura dello spirito che un Dio
severo e un uomo libero preparino un ordine migliore di quello che una Bontà
Infinita preparerebbe per un uomo malvagio»100.
Levinas sembra quindi egualmente stigmatizzare la nonviolenza assoluta come
una violenza “giustizialista” egualmente astratta e assoluta. In fondo, ripete Levinas,
una nonviolenza assoluta che non tenesse conto del male perpetrato verso le vittime
nella concretezza della storia, si ribalterebbe in «amore del male stesso»101. Si renderà invece necessario pensare che: «la soppressione del male attraverso la violenza
lo scandalo, il senso di rivolta provato dall’autore, di fronte all’idea che un malinteso pacifismo possa
aver permesso di fatto il massacro di tanti innocenti nella circostanza storica della Shoah.
97
«Simone Weil contro la Bibbia», in DL, pp. 169-178.
98
Ivi, p. 175.
99
Ibidem.
100
Ivi, p. 175. E poi aggiunge: «Soltanto un Dio che mantiene il principio della legge può praticamente addolcirne il rigore e oltrepassare in una legge orale l’inevitabile durezza della Scrittura»;
tale legge orale è «eternamente contemporanea a quella scritta» (ibidem), ed è quindi compito
dell’interpretazione di addolcire le dure norme che la Scrittura contiene, alla luce del rapporto concreto con la molteplicità dei volti, tra i quali ci saranno tanto quelli delle vittime quanto quelli dei carnefici.
101
Ivi, p. 176.
188
significa che il male stesso è preso sul serio, e invece la possibilità del perdono infinito invita al male infinito»102.
Gli stessi testi difficili della Bibbia, dove sembra che Dio comandi la “guerra santa” contro i nemici, dovranno perciò essere interpretati, dice Levinas, alla luce
dell’esigenza della giustizia nei confronti delle vittime, e mai della vendetta da parte
dei sopravvissuti; e ciononostante, la «cattiva coscienza», informata dalla carità, avvertirà in questo bisogno di giustizia sempre anche un elemento ineludibile di violenza: «la violenza è originariamente giustificata come difesa dell’altro, del prossimo
(fosse anche mio parente, o il mio popolo), ma è sempre violenza per qualcuno»103.
Che poi la «dura giustizia» della punizione del colpevole possa essere «addolcita» dal richiamo alla compassione verso lo stesso colpevole, non toglie difficoltà ma
anzi amplifica il problema di una lotta contro il male avviata dalla stessa esigenza
etica che attiene al comandamento del «non uccidere».
Riprendendo il filo del nostro discorso circa la necessità dell’istituzione, ribadiamo dunque che, per Levinas, ogni Stato, per sua inevitabile forma universalizzante,
in quanto è nell’essere104, partecipa della forma violenta della ragione ontologica.
Dunque, se qualunque fenomenizzazione dell’ideale morale è già una sua traduzione e forse anche una contaminazione – poiché esso nel piano empirico non può
mai darsi in purezza –, la violenza dell’istituzione, che permette tra l’altro di rendere
giustizia alle vittime e di restaurare provvisoriamente l’ordine guastato, dovrà sempre
essere corretta da quello stesso richiamo immemoriale e non tematizzabile del rapporto etico preoriginario.
Se lo Stato e le istituzioni cosmopolitiche non sono penetrate dal richiamo al
«faccia a faccia» etico, quell’uno-per-l’altro in cui «si produce»[se produit]105, come
origine nel presente, la traccia del Bene –, essi espongono al fallimento la stessa ricerca di giustizia. La violenza in nome del Bene tenderà a farsi totalitaria, a oltrepassare sempre il limite ogni volta da imporgli, ad inglobare la stessa significazione che
l’aveva giustificata, e a rinascere dietro ogni tentativo fatto «in buona coscienza» di
102
Ibidem.
AT, p. 145.
104
«L’essere – malgrado o a causa della sua finitezza – ha un’essenza inglobante, assorbente,
rinchiudente» (AE, p. 169).
105
AE, p. 14.
103
189
ritenerla sempre la minima violenza necessaria; infatti: «all’equità stessa della giustizia interessa inglobare la significazione che l’aveva dettata»106.
Si tratta in definitiva anche di un problema di filosofia politica, come il nostro autore afferma verso la fine di AE: «Il vero problema per noi occidentali non consiste
tanto nel rifiutare la violenza, quanto nell’interrogarci a proposito di una lotta contro
la violenza che – senza languire nella non resistenza al male – possa evitare
l’istituzione della violenza a partire da quella lotta stessa»107.
Con un realismo che tiene conto della storia e dei suoi orrori, e del desiderio di
giustizia dei sopravvissuti nella pietà che essi provano per i morti, Levinas assume
quindi la necessità di mantenere una violenza controllata e istituzionalizzata, inevitabilmente connessa alla sanzione giuridica dei colpevoli. Ma in ultimo, anche questa
violenza controllata si dovrà accusare come violenza: «Per il poco di umanità che
orna la terra è necessario un allentamento dell’essenza al secondo grado: nella giusta
guerra alla guerra, tremare – ancora fremere – in ogni istante, a causa di questa
giustizia stessa»108.
Dunque qualsiasi forma di giustizia avrà in se inevitabilmente un residuo ineludibile di violenza, che la «carità» potrà riconoscere, col «fremito» del non potervisi
sottrarre per difendere il terzo, ma anche con lo sforzo, se non di cancellarla – ciò
che è impossibile –, almeno di minimizzarla sempre più. Il rapporto ambivalente tra
nonviolenza e giusta violenza, che emerge nei testi levinassiani, appare dunque come
uno dei segni caratteristici di un pensiero che tenta di tradurre il carattere ambiguo o
equivoco della stessa trascendenza: è impossibile prescrivere soluzioni definitive e a
priori, in una direzione o in un’altra, ma occorre applicare nel concreto la critica della violenza alle singole decisioni assunte nella necessaria lotta contro il male.
Nell’ultima fase del suo pensiero, forse alla luce anche della constatazione delle
contraddizioni insite nella storia del neonato Stato ebraico, Levinas accentuerà il proprio pessimismo nei confronti di ogni forma statuale in quanto tale, parlando talvolta
di «piccola bontà»109, di cui fa prova il singolo al di là del contesto istituzionale e
106
107
108
109
AE, p. 114 nota.
AE, p. 219.
AE, p. 229, cdL.
Cfr. Ad esempio, NODN, pp. 100-104; .
190
storico in cui egli si trovi a vivere110. Ovviamente, il carattere totalitario e violento
dello Stato risalterà maggiormente proprio all’interno delle condizioni inumane di un
regime di guerra e di totalitarismo; e in questo senso Levinas ama citare il libro di
Vasilij Grossman, Vita e destino111, dove la «piccola bontà» vi è descritta in questi
termini: «essa è la bontà dell’uomo per l’altro uomo, una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie. La bontà illogica, potremmo chiamarla. La bontà degli uomini al di là del bene religioso e sociale»112.
Tuttavia, pur essendo presente anche in AE sempre la possibilità che il bene si dimostri come emergenza esterna e dissonante rispetto alle istituzioni, e spesso anche
ad esse conflittuale, Levinas aveva individuato, al tempo della scrittura della sua opera maggiore, la possibilità di istituzionalizzazione precaria del bene proprio in quelle
istituzioni. Il pessimismo nei confronti dello Stato ci sembra moderato, in AE, dall’analisi fenomenologica della soggettività etica, che non è mai chiusa in un rapporto
bipolare, ma è sempre anche aperta alla terzialità, cioè alla pluralità dei volti.
«Ma tutto si mostra per la giustizia»113afferma perentoriamente il Nostro: tutto
accade cioè come se occorresse riportare nell’essere questo non-luogo utopico della
pace, costituito dalla significazione o dal Dire, in modo che l’essere stesso diventi
«funzione di giustizia»114, sia cioè in qualche modo – precariamente e di volta in volta – riscattato dal suo carattere di ingiustizia. Ciò sarà possibile perché la tematizzazione, la coscienza, la simmetria e la necessità della comparazione, sono già inscritti
nella dinamica stessa del mostrarsi del volto: al di sopra dello strato profondo della
soggettività – il me all’accusativo inevitabilmente e asimmetricamente votato ad una
110
Anche in AE troviamo forse una traccia di questo dinamismo della «piccola bontà», quando
Levinas parla del «per della fraternità umana al di fuori da ogni sistema prestabilito» (AE, p. 121).
111
Testo originale: Жизнь и судба, L’Âge d’homme and the Estate of Vassili Grossman, Paris
1992, tr. it. di C. Zonghetti, Vita e destino, Adelphi, Milano 2008.
112
Ivi, p. 388. Si legga ancora: «E dunque al di là del bene grande e minaccioso esiste la bontà
di tutti i giorni. La bontà della vecchia che porta un pezzo di pane a un prigioniero, la bontà del soldato che fa bere alla sua borraccia un soldato ferito, la bontà della gioventù che ha pietà della vecchiaia,
la bontà del contadino che nasconde un vecchio ebreo nel fienile. La bontà delle guardie che, a rischio
della propria libertà, fanno avere a mogli e madri – non ai loro sodali, questo no – le lettere dei prigionieri» (Ibidem). Frasi come queste, lette in un libro che per avventura si riuscì a pubblicare in Francia
nel 1980, e scritte da un dissidente ebreo-russo che narrava la condizione inumana dei campi di sterminio nazisti e dei gulag staliniani nell’orizzonte totalitario comune ai due regimi, dovevano risuonare
assai prossime a Levinas che aveva presagito e poi vissuto un’esperienza analoga, in prima persona
durante la prigionia, e per trasfert familiare e collettivo dai racconti dei sopravvissuti.
113
AE, p. 203, cda.
114
Ibidem, poche righe sopra.
191
pro-esistenza fino-alla-fine, fino all’«espiazione» 115 – vi è «la società, la quale ha
inizio con l’ingresso [permanente] del terzo uomo»116.
«Il terzo – dice Levinas – introduce una contraddizione nel Dire la cui significazione dinanzi all’altro andava, fino ad allora, in un senso unico. È, di per sé, limite
alla responsabilità, nascita del problema: che cosa devo fare con giustizia? Problema
di coscienza»117. È proprio con il terzo, cioè, che si rivela «l’essenza come sincronia:
l’insieme-in-un-luogo»118, e che quindi «la prossimità assume un senso nuovo nello
spazio della contiguità»119, diventa cioè prossimità concreta e fenomenica, in cui insistono i concreti enti insieme analoghi a me e differenti, che sono i terzi. E, contemporaneamente a questo dischiudersi del luogo, emerge la coscienza, l’Io, che deve
«comparare gli incomparabili, tematizzare la non-relazione con il volto (che non è
fenomeno) nella relazione con i volti (nel terzo, il volto si fenomenizza in pluralità di
volti120, quindi, se ben comprendiamo Levinas, sul piano empirico concreto, l’altro
concreto è sempre il terzo). Il me che ancora non è coscienza, accusato «senza parole»121, si eleva a concetto di Io [coscienza] attraverso il terzo122. L’apparizione del
terzo, la società, richiede dunque, per lo stesso slancio della soggettività etica, una
fenomenizzazione precaria del Bene, potremmo dire il suo “attendamento”, nel farsi
delle istituzione politiche; l'istituzionalizzazione costituisce infatti la possibilità di
avvento della giustizia nel piano dell’essere: di contro all’«essenza nella guerra» vi
deve infatti essere, scrive Levinas in AE, anche un’ «essenza nella la pace»123, che
possa riscattarla.
Ma proprio per l’impossibilità di un’incarnazione definitiva del Bene, la pace sarà sempre precaria sul piano fenomenico-istituzionale, e sarà necessario, di volta in
volta storicamente da parte dei singoli, correggere il residuo di violenza insito nel-
115
AE, p. 19, passim.
AE, p. 114 nota.
117
AE, p. 197, cn.
118
Ibidem.
119
Ibidem.
120
Assumiamo questa interpretazione da Marco Maria Olivetti: «“Altri” non è tema, non è fenomeno, ma il “terzo” sì, lo è. Attraverso il terzo quella che Levinas chiama “relazione sociale” (cioè
la relazione tra il soggetto e l’altro) diviene da immediata mediata e si trasforma da “faccia a faccia”
in società, nel senso collettivo, e se si vuole sistemico del termine» (M.M. OLIVETTI, Analogia del
soggetto, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 90).
121
«Il soggetto che riposa in sé è disarcionato da un’accusa senza parole» (AE, p. 160).
122
Torneremo più dettagliatamente sulla questione del terzo nel successivo capitolo.
123
AE, p. 8.
116
192
l’essere e nell’istituzione, attraverso il rimando a un «al di là dello Stato nello Stato124», cioè alla preoriginale e atematica diacronia dell’«eccezione» costituita dal
per-l’altro125, al quale la soggettività etica del me, ogni volta unica e insostituibile,
non può derogare126.
Tra l’ordine caotico violento e inglobante dell’essere, e il dis-ordine anarchico
della significazione, «l’io è ad un crocevia»127 perché, «sotto il peso di tutte le responsabilità128», accetta anche la responsabilità della limitazione inevitabile di questa
stessa responsabilità infinita, consentendo l’apparire fenomenico – nel presente –di
un ordine statuale e, in esso, di un residuo inevitabile di violenza.
L’ordine della giustizia, per essere tale, dovrà cioè sempre riportarsi a quello della carità (chesed)129, e anzi la «autentica giustizia»130 presupporrà questo richiamo
sempre da richiamare: «l’amore deve sempre sorvegliare la giustizia»131.
Per esprimerci in termini levinassiani, ogni Detto (ogni istituzionalizzazione)
deve essere sempre ridotto al Dire, ma questo stesso Dire esigerà a sua volta una manifestazione in un Detto: «Tutto – infatti – si mostra per la giustizia». Occorrerà
quindi che questo Detto sia rischiato
132
(ad esempio, attraverso l’annodamento di re-
lazioni fraterne nel per-dono, l’istituzionalizzazione di relazioni giuridiche etc.), e
anche il ri-detto (le riforme sociali, ad esempio) e il disdetto (le rivoluzioni, i cambi
di regime ...).
La prassi politica concreta sarà dunque continuamente da inventare e da rischiare,
sulla base di questa contestazione permanente di ogni «ideale» che si volesse stabilmente e razionalmente incarnato, criticando la tentazione del messianismo politico di
124
È il titolo di una conferenza del 1988, tenuta al 29° Colloquio degli Intellettuali ebrei francesi. Cfr. NLT, pp. 45-77.
125
Seguendo l’insegnamento di Haïm di Volozin, Levinas suggerisce che in questo «altro da
me» è incluso l’intero universo: «L’anacoresi “nella sua pelle”, il presente saggio vuole suggerirlo, è
un movimento dell’Io in sé, fuori dell’ordine. L’uscita di questo scavo sotterraneo, del pieno nel pieno, conduce a una regione in cui, nell’Altro, tutto il peso dell’essere si porta e si sopporta» (AE, p.
136 n.ota); O ancora: «Il Sé è Sub-jectum: è sotto il peso dell’universo – responsabile di tutto» (ivi, p.
145); «Sopportare l’universo – carico opprimente ma disagio divino» (ivi, p. 154), ccnn.
126
Cfr. G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 194.
127
AE, p. 151nota.
128
Ibidem.
129
NLT, p. 77.
130
Ibidem.
131
TN, p. 142, cn.
132
Questo rischio è «un pericolo che al sapere apparirà come incertezza» (AE, p. 208).
193
natura apocalittica che individui nell’istituzionalizzazione del Bene il compimento e
la fine della storia.
Anche la filosofia, secondo Levinas, proprio per essere «saggezza dell’amore»,
dovrà intendersi primariamente come una teoria politica della giustizia (o anche come «amore politico»), cioè come teoria critica della prassi nella fenomenizzazione
dell’ideale, sia esso morale, giuridico, politico ed economico.
Risulterà forse chiaro, da quello che siamo venuti dicendo, come Levinas neghi
che l’orizzonte del Bene sia un ideale regolativo che in qualche modo si possa fenomenizzare in istituzioni storiche, ma piuttosto suggerisca che esso è la contestazione
permanente di ogni possibile presentificazione definitiva, essendo nello stesso tempo
utopia mobilitante di ogni storicizzazione umana.
L’oltrepassamento dell’ontoteologia, ancora presente nell’idea kantiana di ragion
pratica, verrà da Levinas portato fino in fondo, senza per questo cadere in un nichilismo che annulli la possibilità di un «umanesimo dell’altro uomo».
Se il Bene non può realizzarsi nel presente è perché è sempre-già passato, è assente, e la traccia che esso lascia è orma di un passaggio e di una assenza rispetto alla
quale ogni puntualizzazione-presentificazione, insieme impossibile e necessaria, avviata dalla chiamata del dolore e della sofferenza di altri, è inevitabilmente «in ritardo», sollecitata, o meglio pressata a rispondere concretamente di un’interpellazione
pre-originale del Bene che, come la stessa diacronia del tempo, non può mai essere
sincronizzata definitivamente, fissata «plasticamente», ma solo precariamente, interinalmente: avviata preoriginariamente dal passato e pro-tesa verso quel Bene stesso
infinitamente a-venire. Mai un tempio o un palazzo imperiale che sfidi l’eternità, ma
una tenda nel deserto, di schiavi liberati dal Bene, dove si “attenda” enigmaticamente
la Gloria.
Ogni incarnazione provvisoria del Bene nega dunque per principio l’idea di una
stasi definitiva del tempo –sempre pensato da Levinas come diacronia irreversibile –;
la presentificazione avviene, infatti, nell’intervallo mai sincronizzabile che è il presente, tra un passato immemoriale e un futuro aperto dalla stessa pro-tensione verso
quel Bene che immemorialmente mi ha eletto e inviato; (e après coup) Bene che non
è mai assumibile o anticipabile, ma che proprio nella mia risposta in ritardo mostra il
suo carattere di speranza.
194
Il rapporto tra storia e ideale non potrà dunque mai configurarsi come quello tra
un tempo eracliteo e l’inossidabile eternità sovra-fenomenica dell’Idea che verrebbe
a compierlo: «Il compimento morale è immorale. Il compimento della moralità è assurdo come l’immobilizzazione del tempo che esso suppone»133.
Nella concretezza della prassi responsabile e dell’istituzionalizzazione precaria,
si lascia intendere il Dire preoriginale, il Bene: questo «lasciarsi intendere» è il darsi
come figura, segno, indicazione, testimonianza, (il signum rememorativum, demonstrativum, prognosticum di cui parlava Kant), come Levinas sembra suggerire in
questo passo di AE:
«La responsabilità per altri è il luogo in cui si colloca [se place] il non-luogo
della soggettività e in cui si perde il privilegio della questione: dove? Il tempo
del detto e dell’essenza vi lascia intendere il dire preoriginale, risponde alla
trascendenza, alla diacronia, allo scarto irriducibile che qui si apre tra il nonpresente e ogni rappresentabile, scarto che a suo modo segnala [fait signe au]
il responsabile»134.
Se il tempo del detto è la storia concreta e fenomenica, quella in cui si collocano i
volti, il terzo come origine dell’apparire135 dei multipli «contemporanei»136 – e sorge
quindi l’esigenza razionale di comparare, istituzionalizzare, fondare leggi universalistiche –, questo intervallo è anche il luogo in cui si colloca la fraternità responsabile
– del singolo e della società – come segno enigmatico del Bene. La concretezza stessa della prassi responsabile etico-giuridica, sia singola che delle istituzioni, si annuncia sempre in questo intervallo, interim, «scarto» o «frat-tempo»137 (entretemps) in
cui la responsabilità originaria, l’elezione non fenomenica del Bene, si puntualizza e
presentifica (si fa presente, fenomeno non-indifferente alla durata) segnalandosi nel
segno che il responsabile stesso è; facendosi segno [figura], senza che questo frattempo, presentificazione puntuale, si immobilizzi mai in eterno presente, come
133
134
135
DL, p. 109.
AE, p. 15, trad. leggermente modificata.
«L’apparizione del terzo è l’origine stessa dell’apparire, cioè l’origine dell’origine» (AE, p.
200).
136
La contemporaneità del multiplo si annoda intorno alla diacronia dei due (AE, p. 199).
«Non-luogo, frat-tempo o contrat-tempo (o malheur) al di qua dell’essere e al di qua del nulla tematizzabile come essere» (AE, p. 136, trad. modificata)
137
195
«ideale plastico» di una storia che così verrebbe a compiersi – quasi fosse un’«opera
d’arte indifferente alla durata»138 –, ma donando-si, nella protensione verso il Bene,
come apertura del futuro.
Lo Stato, procedendo da questa “fondazione” etica preoriginaria, non sarà mai
dunque presenza (o onni-presenza) plastica, ma a sua volta frattempo, presenza precaria, «piccolo Stato»139, anti-idolo: l’esigenza dell’amore e della giustizia, egualmente contenute nell’elezione infinita e immemoriale del Bene, si declineranno in
istituzioni che, per la loro stessa dipendenza-dal e protensione-verso il Bene preoriginario – nel rapporto del faccia a faccia etico –, non saranno indifferenti alla temporalità stessa della vita degli uomini, nella loro precarietà e mortalità.
Si percepisce, notiamolo di passaggio, in questa critica levinassiana dello Stato
come «opera d’arte plastica indifferente alla durata», una neppur tanto velata polemica verso Heidegger, che in L’origine dell’opera d’arte aveva segnalato, tra i «vari
modi in cui la verità si istituisce nell’ente», l’istituzione statuale: «Un altro modo in
cui la verità è-presente è l’azione che fonda uno Stato»140(1935!).
Se Kant, riprendendo il filo della nostra comparazione, faceva valere il Bene
come ideale regolativo che si anticipa storicamente in eventi esemplarmente significanti a livello universale, è perché lo pensa ancora in chiave di presenza assoluta, eterna e sottratta alla temporalità.
Per Levinas invece, proprio perché connesso al «segreto più profondo» della
diacronia dell’intrigo etico, l’elezione da parte del Bene, individuando il soggetto,
dispiega una relazione dell’unico-per-l’altro di oblatività infinita, e potenzialmente
sempre irrecuperabile e “a perdere”, se non intervenisse il terzo a interromperla e limitarla, e così ad affettare la puntualità dell’istante – intervallo, interim o frattempo –
in cui di volta in volta si traduce concretamente la responsabilità memoriale pro-tesa
(come futuro messianico) verso il Bene.
138
Applichiamo allo Stato, la critica che Levinas muove all’opera d’arte come esibizione di un
«ideale plastico indifferente alla durata», nel noto articolo «La realtà e la sua ombra» (1948, ora in
NP, 174-190). Sul tema del rapporto tra soggettività e «frattempo», si veda l’interessante articolo di
PIERRE HAYAT, La critique de la préminence du présent. Subjectivité et «entretemps» d’après
Levinas, «Revue Philosophique de Louvain» 107(2), 2009, pp. 301-317.
139
In questo modo, peraltro, Levinas crede di poter ravvisare il senso dello Stato d’Israele ricostruito nel 1948, non esente, anch’esso, delle aporie nascenti circa l’esigenza di un uso minimale della
violenza, sia pure intesa come esigenza di difesa (DL, p. 270).
140
M. HEIDEGGER, Der Ursprung des Kunstwerkes, in Holzwege, Klostermann, Frankfurt a. M.
1950; tr. it. di P. Chiodi, «L’origine dell’opera d’arte», in Sentieri interrotti, La nuova Italia, Firenze,
1989, p. 46.
196
5. Messianismo e soggettività.
Ma il politico è l’ultimo, o è piuttosto «in subordine»141? La speranza razionale
che Levinas e Kant pensano a partire dalla dimensione etica, può trovare declinazione esclusivamente in un miglioramento, sempre da tentare, delle condizioni sociali e
politiche dell’umanità, o piuttosto la pazienza, «che significa – come afferma acutamente Rodolphe Calin142 – a un tempo passività e attesa», deve essere piuttosto pensata come speranza di un intervento risolutore esterno alla storia?
La risposta a questa domanda non può non richiedere un approfondimento della
particolare lettura filosofica levinassiana del tema del messianismo. È infatti proprio
in relazione a questa tematica che Levinas scrive, nel 1960-61, un commentario talmudico – ora contenuto in DL143 – relativo ad alcuni passi del Trattato talmudico
Sanhedrin.
Riflettendo sul messianismo, nozione chiave del giudaismo, Levinas distingue
«epoca messianica», da «mondo futuro». La prima, piuttosto che fine della storia, è il
«compimento delle profezie e promessa di un’umanità liberata e migliore»144; la seconda consiste invece nel «privilegio di chi attende il Signore […]; si tratta di un ordine personale e intimo, esterno ai compimenti della storia»145.
Circa l’epoca messianica, si tratta di individuarne le condizioni, e il giudaismo,
dice Levinas, conosce, tra diverse e pluralistiche posizioni, anche quella che abbiamo
visto potersi attribuire a Kant: «Per Rabbi Yohanan il problema politico è risolto nello stesso tempo che il problema sociale, e la loro soluzione è nelle mani dell’uomo:
dipende dal suo potere morale. Ci sarebbe un passaggio naturale dell’attività morale
verso i tempi messianici»146, dipendente in sostanza dal merito umano. L’oggetto delle promesse profetiche riguarderebbe tutti gli uomini.
141
Politica in subordine! è il titolo di un articolo apparso nella primavera del 1980, su «Temps
modernes», e ora contenuto in ADV, pp. 277-290.
142
R. CALIN, Levinas et l’excepition du soi, PUF, Paris 2005, p. 209.
143
«Testi messianici», DL, pp. 83-124.
144
Ivi, p. 85.
145
Ibidem. «I tempi messianici fanno parte della storia, con tutte le sue responsabilità. Il “mondo futuro” è “dopo”: riguarda la persona, la sua salvezza, il suo rapporto con Dio e, qui, è fuori dalla
nostra prospettiva» (A. CHIAPPINI, Amare la Torah più di Dio. Emmanuel Lévinas lettore del Talmud,
Giuntina, Firenze 1999, p. 225).
146
Ivi, p. 89, cn.
197
Un’altra posizione è invece quella di Rabbi Šmuel, il quale secondo Levinas «nega espressamente il rapporto tra la venuta del Messia e il merito147»: per questa posizione,
«ciò che è importante è la categoria di un evento che viene da fuori. Poco importa che questo “da fuori” sia l’azione di Dio o una rivoluzione politica distinta
dalla morale [...] Per Šmuel qualcosa di estraneo all’individuo morale esiste,
qualcosa che deve essere primariamente distrutto perché arrivino i tempi messianici. Il Messia è prima di tutto tale rottura»148.
L’evento messianico comporterebbe cioè «un elemento irrazionale»149, verrebbe
ad interrompere la violenza politicarispetto alla quale la stessa libertà umana sarebbe
di per sé impotente: «Šmuel inserisce tra l’impresa morale, la libertà umana e il compimento del bene, un ostacolo di tipo radicalmente nuovo: la violenza politica che
deve essere superata dall’evento messianico»150.
Quanto al mondo futuro, anche esso è oggetto di una discussione pluralistica,
perché per alcuni – rappresentati da Rabbi Chiia ben Abba – esso sarebbe dato in
premio esclusivo ai giusti «senza colpa […], senza dramma, sottratti alle contraddizioni del mondo»151 – in cui Levinas intravede «l’ideale di uno spirito disincarnato e
pieno di grazia»152, «una purezza senza macchia e una perfezione senza storia»153–; i
«pentiti», d'altro canto, sarebbero oggetto delle profezie relative ai tempi messianici,
di cui i giusti già godono, mentre sarebbero esclusi dal mondo futuro154.
Per altri dottori talmudici invece, rappresentati da Rabbi Abbu, i «pentiti», cioè
coloro che siano ritornati al Bene dopo uno sforzo morale, non solo sarebbero resi
partecipi del mondo futuro, ma anzi guadagnerebbero una posizione superiore rispetto ai giusti senza colpa, come «gli operai della undicesima ora» del Vangelo155.
147
Ivi, p. 90, cn.
Ibidem.
149
Ibidem.
150
Ibidem.
151
Ivi, p. 88.
152
Ibidem.
153
Ivi, p. 91.
154
Cfr. ivi, p. 90
155
Levinas cita il passo esatto di Rabbi Abhu: «nel luogo in cui si trovano i pentiti i giusti non
possono stare» (ivi, p. 90) e commenta: «Il vantaggio concesso ai pentiti rispetto ai giusti senza colpa
evoca la felix culpa e imbonisce il nostro gusto patetico, la nostra sensibilità nutrita di cristianesimo e
148
198
Levinas ricorda che queste due posizioni antagoniste rappresentano «un dialogo
eterno della coscienza umana»156, e nota che nel Talmud esiste sempre una «seconda
opinione»: «senza che si opponga necessariamente alla prima, essa rivela un altro
aspetto dell’idea»157.
Quanto al rapporto tra mondo futuro e tempi messianici, Levinas riporta un repertorio di citazioni, tra loro in contrasto, e, pur cercando di «mettere in guardia dal facile gioco di antitesi a cui si abbandonano i pensatori preoccupati di riassumere le pretese opzioni del pensiero giudaico»158–, egli tuttavia propende per una visione minimalista del messianismo, rappresentata da una affermazione di un certo159 Rabbi Hillel, secondo la quale «non c’è Messia per Israele. Israele ne ha già gustato all’epoca
del re Ezechia»160. Quest’affermazione, «di una audacia smisurata»161 – nota Levinas, sarebbe stata respinta dalla maggioritaria tradizione rabbinica, e tuttavia, secondo la struttura del pensiero talmudico, «una tesi valida non si cancella, ma permane
come uno dei poli di un pensiero che circola insieme al polo opposto»162.
Il significato della affermazione di Rabbi Hillel consisterebbe cioè nella sfiducia
nei confronti dell’idea messianica pensata come redenzione politico-sociale apportata
da un Messia-re; questa posizione sembra essere quella sostenuta da Levinas163. Un
tale messia politico «sarebbe già venuto», apparterrebbe, cioè, al «passato mitico» di
Israele, mentre ora «Israele spera qualcosa di meglio dall’essere salvato da un Messia»164.
Levinas suggerisce che anche nel caso della frase di Rabbi Hillel potrebbero valere diverse interpretazioni, anche tra loro coimplicate, ma egli parteggia per quella
«sostenuta anche da Jankélévitch, [secondo la quale] se l’ordine morale è incessante
Dostoevskij» (Ibidem). Il testo in questione è tratto da una conferenza tenuta di fronte a intellettuali
ebrei francesi.
156
Ivi, p. 91.
157
Ivi, p. 92.
158
Ivi, p. 89.
159
Come specifica lo stesso Levinas, non si tratta di Hillel il Grande.
160
Ivi, p. 108.
161
Ivi, p. 109.
162
Ivi, p. 109.
163
Non riteniamo corretto affermare tuttavia che «Levinas svaluta l’importanza del messianismo
politico, e apocalittico, all’interno dello spirito autenticamente ebraico» (D. GENTILI, Etiche e politiche del messianismo: Emmanuel Lévinas e Jacques Derrida, in I. BAHBOUT - D. GENTILI-T. TAGLIACOZZO, Il messianismo ebraico, Giuntina Firenze 2009, p. 110). Ci sembra piuttosto corretto affermare invece che Levinas, pur assumendo la presenza, nell’ambito del giudaismo, di varie posizioni relativamente a questa problematica, parteggi maggiormente per quella minimalista.
164
DL, p. 109.
199
perfezionamento, allora esso è sempre in cammino e non è mai compiuto. Il compimento morale è immorale»165.
Proprio in questo contesto, Levinas puntualizza una cosa fondamentale, che cioè
non sta conferendo «al termine “Israele” un senso solo etnico»166, non si sta riferendo
cioè «soltanto all’Israele storico»167. Il nazionalismo di Israele, dice Levinas, «sicuramente esiste ma non possiede in nessun modo un senso nazionalista. Nel particolarismo ebraico si esprime una certa nozione di universalità»168.
Il messianismo ancora politico che sarebbe superato, secondo Hillel-Levinas,
avrebbe quindi una duplice particolarità: in primo luogo, sarebbe una salvezza per
procura169, sia il Messia un semplice uomo sia egli un re; in secondo luogo, tale salvezza, circoscritta ad una singola nazione, non potrebbe essere universale. La salvezza attraverso un messia politico non sarebbe dunque «quella per cui ognuno si
salva individualmente […]: non [sarebbe] ancora la salvezza suprema che si apre
all’essere umano»170.
Il senso profondo di questa prospettiva è che Israele, essendo un popolo che non
si aspetta più un messia politico, sarebbe l’esempio rivolto a tutti (il particolare per
l’universale) di «un’esistenza in cui niente viene fatto per delega, in cui ognuno partecipa interamente a ciò che ha scelto e in cui ognuno è interamente presente alla
propria scelta. Relazione diretta – senza mediazione politica – tra l’uomo e Dio […].
Il giudaismo non si fa portatore di una dottrina della fine della storia che domina il
destino individuale»171.
Emerge già quindi, in questo testo del 1960-61, la nozione d’indelegabilità della
responsabilità etica che troveremo in AE, connessa qui però al carattere esemplare di
«Israele» nei confronti della speranza etica universale. Attendersi una salvezza per
procura, e pensare nel messia storico un vendicatore delle offese dei deboli, afferma
inoltre Levinas, vorrebbe dire costituirsi già giusti, e non rendersi conto che «gli uomini non sono solo vittime dell’ingiustizia: ne sono la causa»172; in questo senso il
165
166
167
168
169
170
171
172
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, p. 110.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, pp. 110-111.
Ivi, p. 119.
200
messianismo «non è la certezza della venuta di un uomo che arresta la storia: è il mio
potere di sopportare la sofferenza di ognuno»173 .
Portare la sofferenza, sop-portarla, come unico modo per disinnescarne la logica
di sopraffazione, e dunque di resistere e lottare contro la guerra stessa, è allora il
compito messianico di volta in volta sempre da pro-tenere in prima persona, e da non
delegare ad altri. E se è vero che in AE il télos della soggettività etica, intesa come
«santità», non sarà la salvezza personale oltremondana (anche se Levinas non riterrà
di per sé «vergognoso» un tale pensiero174), è nondimeno vero che attraverso l’etica,
nell’elezione del Bene, il soggetto è in qualche modo salvato; la salvezza verrà pensata cioè, in AE, come liberazione, sradicamento del soggetto morale dall’esse «nella
sua sostanza egoistica, fino al supremo dis-inter-esse»175. Scrive infatti Levinas a
questo proposito: «nella significazione sono liberato in quanto unico»176.
A questo punto, è possibile delineare complessivamente il nuovo significato che
Levinas conferisce al messianismo. Il giudaismo, secondo Levinas, ha insegnato una
visione non mitica della storia, innanzitutto oltrepassando la concezione apocalittica
e politica del Messia: «Il giudaismo dunque supererebbe già la nozione di un messia
mitico che si presenta alla fine della storia, e concepisce invece il messianismo come
una vocazione personale degli uomini»177. Come afferma Dario Gentili, «La distinzione radicale tra epoca messianica e mondo futuro consente a Levinas di radicare in
quest’ultimo l’istanza etica per porla così al di là del messianismo politico e dello
Stato-nazione»178.
Ciò a cui mira l’escatologia levinassiana, e dunque la speranza razionale intesa a
livello pratico come quella kantiana, è il «mondo futuro» dell’individuo, pensato non
come al di là oltremondano, ma come irruzione e interruzione morale del qui-e-ora
che rompe con l’egoismo del conatus essendi, rivelando il senso dell’umano e della
storia nell’indeclinabile uno-per-l’altro della soggettività etica stessa. E se questo
«senso», l’inserzione della salvezza nella storia, «è possibile in ogni momento»,
173
Ivi, p. 117.
«Santità che il presente studio tenta di sviluppare non per predicare qualche via di salvezza
(che del resto non sarebbe vergognoso ricercare)…» (AE, p. 75).
175
G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 194.
176
AE, p. 175; E ancora: «La significazione è la liberazione etica del Sé attraverso la sostituzione all’altro» (AE, p. 205).
177
Ivi, p. 115.
178
D. GENTILI, Etiche e politiche del messianismo…, Cit., p. 113.
174
201
l’evento della soggettività etica sarà dunque la stessa possibilità messianica quale
unico orizzonte di speranza:
«Il Messia sono io ed essere Io è essere Messia. Si vede dunque che il Messia
è il giusto che soffre, che egli ha preso su di sé le sofferenze degli altri. D’altra
parte chi prende su di sé le sofferenze degli altri se non colui che dice Io?
L’ipseità stessa è definita da questo non sottrarsi al peso che impone la sofferenza
d’altri. Tutte le persone sono Messia. […] Il messianismo non è la certezza della
venuta di un uomo che arresta la storia: è il mio potere di sopportare la sofferenza di ognuno. È l’istante in cui riconosco questo potere e la mia responsabilità
universale»179.
6. L’umanesimo del «servo sofferente»
Il Messia dunque è l’uomo che soffre per la mortalità di altri, investito della responsabilità universale del carico delle altrui sofferenze, e così patisce al posto dell’altro, invertendo il conatus ontologico. Il «servo sofferente» del Capitolo 53 di Isaia
assume in Levinas un ruolo emblematico, tanto che l’autore ne parlerà come la figura
che annuncia un nuovo umanesimo, appunto l' «umanesimo del servo sofferente»180.
Nei famosi versetti biblici di Isaia si legge infatti:
«Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne
avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è
addossato i nostri dolori. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato
per le nostre iniquità […]»181.
179
DL, p. 116-117, cn.
DL, p. 213. Il richiamo di questa figura biblica di Isaia 53 ricorre altrove nei testi levinasiani.
Cfr. ad es.: «Il Capitolo 53 di Isaia ha consumato tutto il significato per loro [gli ebrei] (DL, p. 28);
DL, p. 114; UAU, p. 78;
181
Is 53, 3-5, tr. CEI, cn. Per l’interpretazione levinassiana della figura del «servo sofferente» in
una prospettiva ebraica, si veda I. KAJON, «Auschwitz come esperimento cruciale. Il «servo sofferen180
202
È significativo constatare come in TI Levinas delinei con questi tratti il volto
di autrui, mentre in AE sembri descrivere così prevalentemente il soggetto etico. Ma
a ben vedere, le due prospettive non si escludono a vicenda, perché in fondo appartengono ad un’unica “logica” di esistenza partecipe del Bene, come donazione di sé
nella sostituzione ad altri, attraverso l’assunzione del dolore e della sofferenza in cui
altri, forando la dura scorza del mio egoismo, si dà a me.
Ma soprattutto la figura biblica del «servo sofferente» permette di essere applicata al popolo di Israele, secondo una lunga tradizione interpretativa che Levinas
fa propria: in questo senso, ci pare, il Nostro interpreta la Passione ebraica182, cioè in
quanto esempio particolare di un eidos etico universale183, in cui può risaltare un
nuovo senso dell’umano: «L’umanesimo del servo sofferente – la storia d’Israele –
invita a una nuova antropologia, ad una nova storiografia e, forse, attraverso la fine
del “trionfalismo” occidentale, a una nuova storia»184.
Di contro all’«umanesimo dei superbi»185, la storia e la Passione di Israele,
lette alla luce di questa figura biblica, diventano «simbolo concreto dell’umanità che
impara a conoscersi, e una prefigurazione provvidenziale della futura umanità messianica»186; dove evidentemente, data la comprensione levinasiana del messianismo
che abbiamo sopra mostrato, l’aggettivo «messianica» diventa sinonimo di «etica».
Il messianismo ebraico sarebbe dunque esattamente un particolarismo che
cerca un’universalità, la quale a sua volta richiede, per mostrarsi, di effondersi sino a
perdere la propria caratteristica formale. Levinas parla di una «difficile universalità,
nella fraternità necessaria all’estensione logica del genere Uomo187». Tale universalità, cioè, richiede l’effusività da parte della particolarità, o meglio dell’unicità, quale
“polo diffusore” del Bene. Messianismo dunque come universalismo effusivo188 del
te» (Isaia 49-59) nell’interpretazione di André Néher ed Emmanuel Levinas», in E. Baccarini – L.
Thorson (a c. di), Il bene e il male dopo Auschwitz. Implicazioni etico-teologiche per l’oggi, Atti del
simposio internazionale (Roma 22-25 Settembre 1997) pp. 273-285.
182
Ricordiamo tale interpretazione suggerita dal testo L’expérience juive du prisonier che abbiamo commentato sopra, nel primo capitolo.
183
NODN, p. 192.
184
DL, p. 213.
185
Ibidem.
186
Ibidem.
187
NODN, p. 129.
188
Proponiamo questo termine, ispirandoci, con una certa libertà, ad una definizione di ALAIN
BADIOU (Saint Paul. La fundation de l’universalisme, PUF, Paris 1997; tr. it. di F. Ferrari e A. Mosca-
203
per-l’altro da parte dell’eletto a portare il peso di tutto e di tutti; questo dinamismo
troverà esemplificazione particolare nella passione ebraica, e singolare nella elezione che costituisce il principio d’individuazione etica dell’ogni volta unico e insostituibile sub-jectum.
Il popolo ebraico, nella sua Passione storica testimonierebbe così, nel particolare, questa dinamica di estroversione per l’universale, questo «in sé come nella
traccia del suo esilio»189. La verità universale dell’umano si darà, afferma esplicitamente Levinas, «a chi è pronto interiormente all’idea che essa non è universale nel
senso logico del termine»190, richiede cioè l’impegno continuo indelegabile ad accettarla come propria verità, nella forma dell’un(ic)o per-l’altro, e non già predicarla
come richiesta-esigita dall’altro, sia questi pensato come una figura mitico-religiosa,
o un altro uomo, o lo Stato.
La Passione di Israele è infine ultimamente una «passione di innocenti affinché sia pensabile un’umanità riconciliata»191, ed «esempio» dell’«ideale della santità
contrario alle leggi dell’essere»192, che «può scombinar[la]. Per molto? Per un momento?»193. La domanda non riceve una risposta definitiva, perché è aperta dalla
stesso stessa diacronia dell’elezione del Bene, che di volta in volta può rischiosamente e precariamente fenomenizzarsi, come abbiamo visto, nei tempi storici, senza però
incarnarsi o istituzionalizzarsi definitivamente. L’elezione poi, non è certo un privilegio, ma un iperbole della responsabilità. Pensata dapprima come quella «particolare» del popolo ebraico, e poi intesa come caratteristica di ogni soggettività etica,
l’elezione è cioè declinata da Levinas, come «un sovrappiù di obblighi attraverso i
quali si pronuncia l’io della coscienza morale»194.
ti, San Paolo. La fondazione dell’universalismo, Cronopio, Napoli 1999) che pensa l’universalismo
come il per-tutti dell’Uno: «l’Uno-verità procede in direzione di tutti […] Non si dà Uno se non per
tutti» (ivi, p. 126) .
189
AE, p. 174.
190
DL, p. 120.
191
NODN, p. 97.
192
«Filosofia, giustizia, amore», in TN, p. 149.
193
Ibidem.
194
DL, p. 221.
204
7. La Passione come eidos della santità e testimonianza esemplare del Bene
Troviamo nei testi levinassiani una frase che sintetizza la ricerca del filosofo
come mirante a descrivere «l’essere ebreo in ogni uomo, e la sua eco nel singolare e
nel particolare».195 L’essere ebreo in ogni uomo è l’eidos della soggettività etica:
«l’eco nel particolare» denota il suo riferirsi alla particolarità storica del popolo
ebraico, mentre «la sua eco nel singolare» denota la soggettività etica dell’ogni volta
unico e indiscernibile essere umano.
La passione di Israele è dunque «figura» come esempio di quella possibilità
umana che è chiamata, da AE in poi, «santità»; e proprio in questa accezione, ci pare, l’esistenza ebraica viene definita da Levinas come «una categoria dell’essere»196.
«Ideale della santità»197 che rompe con l’essere e con la natura e con la loro
logica di dominio e violenza, permanendo tuttavia nell’essere e nella ragione e capovolgendone il (non)senso. In questa prospettiva, non è possibile per Levinas accettare
la tesi kantiana sopra ricordata, che cioè la natura anticipi attraverso la legalità di istituzioni razionali l’approssimazione verso il bene. La santità è rottura rispetto alla natura e all’essere, ma anche loro restituzione sempre-da-restituire – come intervallo o
frattempo, che punteggia la diacronia del Dire – a una “logica” di dono e perdono198.
Ma proprio perché rottura e restituzione non fondano una possibilità di istituzionalizzazione stabile, essendo il rischio del ritorno della violenza sempre una reale
e continua minaccia, la santità come «profezia» sarà anche critica permanente di ogni
utopia politico-messianica, proprio segnalandosi, nello stesso tempo, come orizzonte
mobile e mobilitante della politica e delle sue intraprese; queste saranno sempre da
controllare alla luce dell’ «utopia dell’umano», mentre ogni possibile “utopia
dell’inumano” – connessa all’anonimato idolatrico e neutralizzante dell’essere – che
voglia darsi un luogo definitivo (voglia farsi cioè «figura plastica», Stato, istituzione,
idolo, regno millenario), escluderà e violenterà le differenze dell’alterità.
195
NODN, p. 192.
DL, p. 229. Cfr. anche: NODN, p. 135. Come abbiamo già mostrato nel primo capitolo, è nei
Carnets che troviamo una annotazione che costituisce la prima traccia di questo concetto: «Giudaismo
come categoria» (CCAI, p. 75).
197
«Filosofia, giustizia, amore», in TN, p. 149.
198
Sulla santità come perdono dell’essere irremissibile, sono illuminanti le pagine di CHATERINE CHALIER, Lévinas. L’utopie de l’humaine, Albin Michel, Paris 1992, pp. 44-46.
196
205
Proprio perché esempio del Bene, «segno dato all’altro»199, «testimonianza»,
«Dire senza detto»200, «scarto che a suo modo segnala [fait signe au] il responsabile»201, la Passione di Israele, la Shoah, è figura dell’umano anche nello stesso tempo
come trauma, buco e ferita nell’essere; essa è cioè paradossalmente rivelazione e
«kénosi dell’Infinito».
Quest’ultimo termine emerge in diversi scritti levinassiani in riferimento alla categoria di Passione; nella kénosi etica si annuncia anche il tema teologico della kénosi di Dio (ad esempio, oltre che nel già citato Un Dio uomo?, nei saggi Dall’etica
all’esegesi [1982]202, Ebraismo e Kénosi [1985]203 e Trascendenza e Intellegibilità204).
Il volto che comanda «tu non ucciderai», e che istituisce la “relazione” etica,
(asimmetrica e asincronica), è infatti: «rivelazione – congiuntura o kénosi – nella
quale è pensata con concretezza la verità “astratta” del monoteismo, e insieme è pensato il “luogo” nel quale l’infinito discende dalle “altezze celesti” della sua assolutezza e dalle altezze dei sovramondi – e nel quale per l’appunto “viene all’idea”»205.
Questo accostamento tra «Passione» e «kénosis» ci permette di segnalare (qui
solo incidentalmente, non essendo oggetto diretto del nostro studio) il rapporto di
possibile prossimità – senza commistione – ravvisabile tra l’interpretazione della
Shoah come Passione e quella della Passione del Figlio206 nella teologia cristiana. Il
tema è stato approfondito soprattutto da studiosi cattolici207, per lo più concordi nel
199
200
201
202
Cfr. ad es.: AE, pp. 185, 189.
AE, p. 189.
AE, p. 15, trad. modificata.
NODN, pp. 125-129 (ed. or.: De l’éthique à l’exégèse, «Les Nouveaux Cahiers», n. 82,
1982).
203
NODN, p. 131-149 (ed. or.: «Archivio di filosofia», 2-3, 1985).
Trascendence et intellegibilitè, Labor et Fides, Genève (1a ed. 1984) 1996; tr. it. di F. Camera, Marietti 1820, Milano 2009.
205
ADV, p. 55; anche NODN, p. 127. Si veda anche questa citazione: «Il fatto di Israele, le sue
Scritture e le loro interpretazioni – ma anche la tormentata linea attraverso la storia tracciata dalla Passione di Israele a motivo della permanenza, nella fedeltà, all’ispirazione o al profetismo delle sue
Scritture -, costituiscono una figura in cui si mostra un modo primordiale dell’umano e in cui, prima di
ogni teologia e fuori da qualsiasi mitologia, Dio viene all’Idea. Sfida di un rovesciamento ontologico!» (NODN, p. 126).
206
Su questo tema insiste particolarmente Didier Franck, che giunge persino a rinvenire
un’impronta evangelica, tratta da Mt 8, 20 («Il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo»), nel seguente passo di AE: «Il perseguitato è espulso dal suo luogo e non ha che sé a sé, non ha nulla al
mondo su cui posare il capo» (AE, p. 152).
207
Tra gli studi che abbiamo tenuto maggiormente presente, segnaliamo: G. FERRETTI, Trascendenza teologica non violenta in Emmanuel Levinas, «Teoria», XXVI/2006/2, pp.77-97; F.P. CIGLIA, Fra umiliazione e sostituzione. La «fenomenologia» levinasiana del Dio Uomo, «Teoria»,
204
206
ritenere che esso sia fatto valere da Levinas come caratterizzante sia il piano storico
del popolo di Israele sia il singolo e indeclinabile soggetto nella sua relazione con altri, ove la presa in carico delle sofferenze, e finanche delle colpe altrui, è descritta
come depotenziamento e inversione della carica di violenza insita nel piano dell’essere208.
Come rileva Francis Guibal, questa analogia tra la kénosi pensata da Levinas e la
kénosi cristiana «è compresa secondo un orientamento più etico-spirituale che ontoteo-logico»209.
Proprio a questo proposito, è sorprendente rilevare la vicinanza di Levinas – segnalata da Giovanni Ferretti210 – con la visione teologica di un martire del nazionalsocialismo come Dietrich Bonhoeffer, pur con le dovute differenze circa il ruolo
svolto, in questo teologo, dalla figura del Cristo, dalla quale Levinas prende le distanze per ragioni di carattere confessionale: «Per Levinas, se si può parlare di kénosi
di Dio, non se ne può parlare in riferimento ad un individuo storico particolare, bensì
solo in riferimento al popolo d’Israele» (Ferretti)211.
Levinas stesso, del resto non rifiuta l’accostamento del suo «ideale di santità»
con la cristiana «follia della croce»212, e riconosce che la sua accettazione della kénosi gli avrebbe procurato «sovente delle obiezioni nell’ambiente ebraico»213; tuttavia
pensando l’incarnazione di Dio come quella della Torah piuttosto che come quella
del Figlio, Levinas non accetterà mai, come è noto, la lettura cristologica cristiana.
L’analogia tra la visione di Levinas – che egli trae dalla congiunzione della sua
interpretazione della fenomenologia con l’esegesi della tradizione rabbinica – e quelXXVI/2006/2, pp. 99-136; S. PETROSINO, Incarnazioni. Cristo e il cristianesimo nell’interpretazione
di Lévinas, «Teoria», XXVI/2006/2, pp. 137-154; D. FRANCK, L’un-pour-l’autre. Levinas et la signification, PUF, Paris 2008, pp.132-136; G. SANSONETTI, Emmanuel Levinas. Tra filosofia e profezia, Il
margine, Trento 2009, pp. 117-128; F. GUIBAL, La gloire en exil. La témoignage philosophique
d’Emmanuel Levinas, Cerf, Paris 2004, pp. 34-35;
208
Molto suggestiva ci è sembrata la rilettura della passione di Gesù, alla luce del pensiero levinassiano, offerta da CARMINE DI SANTE in La passione di Gesù. Rivelazione della nonviolenza, Città
Aperta, Troina (En) 2007.
209
F. GUIBAL, La gloire en exil., cit. p. 34.
210
G. FERRETTI, «Passione per la vita e vita come passione. Sintonie e differenze tra Bonhoeffer
e Levinas», in Il bene al-di-là dell’essere. Temi e problemi levinassiani, Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 2003, pp.181-211.
211
Ivi, p. 208.
212
«Follia della croce?» –gli domandano in una intervista filosofica del 1982 R. Fornet e A.
Gomez – «Sì, certo. Se vuole, ciò si addice all’idea che ho appena espresso, e ci sono equivalenti nel
pensiero ebraico, c’è la stessa storia del popolo ebraico» («Filosofia, giustizia, amore», in TN, p. 149).
213
Transcendence et intellegibilitè, Labor et Fides, Genève (1984) 1996; tr. it. di F. Camera,
Trascendenza e intelligibilità, Marietti, Milano 2009, p. 49.
207
la di Bonhoeffer – che questi articola in base all’interpretazione della tradizione cristiana nel contesto di un mondo «diventato adulto» –, è sorprendente, perché indica i
tratti di una comune schema etico dell’umano, nella forma del sopportare-per-l’altro
in nome e in «rappresentanza» del Bene; schema, e per noi questo aspetto non è secondario, che i due pensatori hanno elaborato in una comune congiuntura storica.
Levinas certo non accetterebbe il termine «rappresentanza», troppo vicino a quello di
«rappresentazione», né il termine «comunione col bene», ma certo accetta e usa (lo
vedremo nel paragrafo successivo) il termine sostituzione (vicaria) per indicare
l’eidos dell’umano. A questo proposito, la posizione più vicina a quella di Levinas
che un cristiano possa pensare risalta indubbiamente, a nostro avviso, se si meditano
le seguenti parole di Bonhoeffer: «La comunità di Gesù Cristo sta in sostituzione vicaria per il mondo davanti a Dio in quanto si pone nella sequela sotto la croce. Dio è
un Dio del portare. […] per cui anche chi è alla sua sequela è chiamato a portare.
[…] così il portare di chi è alla sequela è comunione con Cristo»214.
Tornando al testo da cui abbiamo avviato questa lunga riflessione (la «Prefazione» di ADV)215, Levinas spiega come il suo intento sia mostrare il «notevole ruolo
che spetta al fatto di Israele inteso nella dimensione di eccezione, relativamente alla
formazione e all’espressione dell’universale»216, un universale tuttavia non pensato
astrattamente, o in maniera totalizzante, ma in modo tale da mantenere insieme la
singolarità irripetibile dell’evento e il suo valore esemplare-universale.
Un’universalità dunque non logico-formale, ma esemplare, attraverso la particolarità di un evento irripetibile, «in grado di unire le persone senza ridurle a quella
astrazione che sacrifica la loro unicità di unico al genere; […] un universale nel quale
l’universalità sarà accostata nell’amore»217. E, quasi a rimarcare che per «Passione»
per eccellenza Levinas intenda, esemplarità nell’esemplarità, la Shoah, Levinas torna
a ribadire, al termine di questo stesso testo, che sta riferendosi al «Passato della Passione di Israele sotto Adolf Hitler»218.
214
D. BONHOEFFER, Nachfolge, Chr. Kaiser Verlag, Munchen 1989; tr. it. di M. C. Laurenzi,
Sequela, Queriniana, Brescia 1997, p. 82.
215
V. supra, par. 1 di questo capitolo.
216
ADV, p. 53.
217
Ibidem.
218
Ivi, p. 57.
208
In tale Passione, dunque, il Bene è «entrato» nella storia, vi entrato però assentandosi e lasciando la sua traccia immemoriale nella testimonianza etica, memorabile
e memoranda, dei pazienti, di coloro cioè che hanno portato, nella propria, la sofferenza degli altri. La passione è perciò testimonianza esemplare del Bene: la Passione
di Israele sotto Hitler, particolarmente esemplare; la passione dell’ogni volta unico
soggetto, singolarmente esemplare; esse costituiscono lo schema etico della «soggettività come persecuzione e martirio»219. Passione anche come rivelazione, perché in
essa il «paziente» avverte inoltre coscientemente la lontananza di Dio proprio mentre
testimonia nella propria carne sofferente il darsi enigmatico della Sua traccia:
«l’Infinito non appare a colui che ne fa testimonianza, ma al contrario, è la testimonianza che appartiene alla gloria dell’Infinito»220.
8. La Shoah: enigma e senso
La testimonianza della Passione, come traccia dell'Infinito, è anche «enigma»221.
Proprio il suo carattere enigmatico si espone all’«equivoco», rende cioè possibile
tanto una sua interpretazione come di oggettiva sofferenza senza senso, quanto quella
di una «sofferenza per amore»222 che, proprio grazie al «per niente» di quel patire,
contesta l’insensatezza sempre latente nella realtà fenomenica.
Risalta così, dinanzi al «per nulla» del soffrire-per, «l’enfasi del senso»223, quel
sovrappiù di significazione portato al mondo dal testimone: «Per non riassorbirsi in
senso [ontologico-razionale], la pazienza della passività deve essere sempre alla fine,
219
AE, pp. 97, 183.
AE, p. 184.
221
Sulla nozione di enigma, si vedano le seguenti citazioni: «L’Enigma, irruzione di un senso
che sconvolge il fenomeno, ma del tutto disposto a ritrarsi come un estraneo indesiderabile, a meno
che non si tenda l’orecchio a quei passi che si allontanano, è la trascendenza stessa, la prossimità
dell’altro in quanto altro» («Enigma e fenomeno», in SEHH p. 247); «Alla trascendenza è necessaria
l’ambiguità» (AE, p. 191); «Il Dire, in forza del suo potere d’equivocazione – cioè in forza
dell’enigma di cui detiene il segreto – sfugge all’épos dell’essenza che lo ingloba, e significa al di là
secondo una significazione che esita tra l’al di là e il ritorno all’épos dell’essenza. Equivoco o enigma,
potere ineliminabile del Dire e modalità della trascendenza» (AE, pp. 13-14, cn); e ancora: «É in forza della sua ambivalenza sempre enigmatica che l’infinito o trascendente non si lascia raccogliere»
(AE, p. 202).
222
Torneremo in seguito su questo termine.
223
AE, p. 64.
220
209
oltrepassata da una sofferenza insensata, “per niente”, attraverso una sofferenza di
pura sciagura»224.
La figura dell’umano non può mai tuttavia diventare «tema». Qualunque forma di
«riempimento» dell’intenzione segnitiva, in questo caso, sarebbe infatti in realtà riproposizione della dinamica di inglobamento tipica della ragione rappresentativa e
quindi, nel ritorno nostalgico all’Uno pensato come semplice-presenza, perdita della
trascendenza stessa del Bene.
Levinas è consapevole, portandone lo stigma nella sua carne viva, che ogni lettura lineare dell’evento-Shoah è per sempre interdetta alla coscienza dell’uomo che
onestamente si fermi a considerare quell’evento nella sua inumana mostruosità. Del
resto, se vi si volesse pensare un qualunque senso razionale, è Levinas stesso a ribadirne l’insondabilità: «Per me l’olocausto è un evento di significato ancora inesauribile»225 .
Il suo «significato inesauribile» implica la permanente esposizione al dubbio sulla totale irriducibilità a qualunque senso o schema razionale e/o teologico (lo abbiamo già sufficientemente mostrato nel capitolo precedente), e quindi postula il silenzio come unica risposta adeguata. Da questo punto di vista, come ha giustamente affermato André Neher226, Auschwitz deve rimanere «indefinitamente in-comprensibile»227, perché ogni com-prensione sarebbe già idolatria verso Dio e violenza verso le vittime.
Si potranno anche pertinentemente evocare le parole di Maurice Blanchot, che recano – e non per caso, data anche una comune amicizia – accenti molto prossimi a
quelli levinassiani, e che in coerenza con la saturazione del non-senso rivelatasi nell’evento, esigono, dopo-Auschwitz, il «silenzio» quale unico orizzonte nel quale
d’ora innanzi sarà costretto a inchiodarsi il pensiero rappresentativo:
224
AE, p. 192.
AT, p. 137.
226
Non possiamo qui non richiamare (senza tuttavia poterne in questa sede sondarne la profondità) la descrizione della «fenomenologia del silenzio» di Auschwitz, nelle stupende pagine di ANDRÉ
NEHER: L’exil de la parole. Du silence biblique au silence d’Auschwitz, Éditions du Seuil, Paris 1970;
tr. it. di G. Cestari, L’esilio della Parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Marietti, Milano 2005, in particolare pp. 151-158.
227
Ivi, p. 153.
225
210
«L’Olocausto, evento assoluto della storia, storicamente datato, questa
completa consumazione [tout-brûlure] dove tutta la storia si è consumata nel
fuoco, dove il movimento del Senso si è inabissato, dove il dono, senza perdono, senza consenso, è crollato senza dare [donner] luogo a niente che possa
affermarsi, negarsi, dono della passività stessa, dono di ciò che non si può
donare. Come custodirlo, fosse solo nel pensiero, come fare del pensiero ciò
che custodirebbe l’Olocausto in cui tutto si è perduto, compreso il pensiero
custode? Nell’intensità mortale, il silenzio sfuggente del grido senza numero»228 .
Ma proprio per onorare la memoria delle vittime senza numero, Levinas ci suggerisce che l’evento, che sempre è anche un «fallimento bruto, [una] morte del tutto
mortale [oggetto di una] partecipazione metaebraica»229, è anche enigma che induce
a pensare e praticare, con speranza, un altrimenti che senso.
In quanto enigma, dicevamo, la Passione è sempre infatti esposta ad una interpretazione ambivalente: da una parte, può essere ridotta – in senso non fenomenologico
– ad episodio, emblematico delle tante sofferenze inutili, insensate sotto qualunque
aspetto, di cui è costellata la storia, un’evenienza gratuita di un storia dove l’umano è
solo orma sulla spiaggia destinata a cancellarsi senza memoria; dall’altra, può essere
ridotta – in senso questa volta fenomenologico230 – a figura in cui si esibisce l’eidos
dell’umano come altrimenti-che-senso umanizzante dell’essere e della storia.
Particolarmente felice ci sembra, a questo riguardo, la proposta di Stéphanie Lahlache, che descrive proprio con il termine «umanizzazione» il dinamismo oblativo
di incarnazione o kénosi del soggetto nella sofferenza, in cui l’unico si identifica
quanto più si espropria da sé per l’altro: l’umanesimo dell’altro uomo è quindi pensabile come per l’altro uomo, cioè come dinamismo di umanizzazione. La passione
del soggetto, lungi dall’essere un arrendersi insignificante e fatalistico al male, è si-
228
M. BLANCHOT, L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980, p. 80.
«[…] partecipazione fisica di tutto il popolo zigano, di tanti individui non ebrei, cristiani e
marxisti che morirono della morte degli ebrei; partecipazione morale dell’umanità intera con la pregnanza di ciò che Auschwitz inaugurò nella storia…» (A. NÉHER, L’exil de la parole, tr. it. cit., p. 53)
230
Per lo meno di una fenomenologia come la pratica Levinas.
229
211
gnum demonstrativum di lotta e resistenza contro l’inumano che appare nell’essere
231
.
In tale prospettiva, la sofferenza «per nulla» che in Auschwitz spicca – il suo no-
n-senso razionale, l’esposizione all’il y a che vi si mostra come distruzione universale in un notturno e nebbioso spessore di silenzio umano e divino – potrà essere interpretata come figura dell’eidos etico, cioè del Dire o della santità umana, prima di essere eventualmente232 anche pensata, nella testimonianza dei pazienti, come la kénosis dell’Infinito: «enigma di un Dio che parla nell’uomo e di un uomo che non conta
su nessun Dio»233; «rivelazione» intesa come «venuta di Dio all’Idea» di ciascun
uomo, nello stesso evento della nascita latente della soggettività etica, secondo la descrizione fenomenologica che Levinas approfondisce particolarmente in Di Dio che
viene all’idea234.
Pensare tuttavia univocamente (cioè riportare a un detto razionalmente unilaterale) Auschwitz come Passione, senza mantenersi nello statuto di ambiguità propria
della trascendenza, significherebbe già tradire il suo valore di enigma: «deportarla»
ad un ordine logico-razionale, e quindi dichiarare la testimonianza dei «martiri» come priva di qualunque razionalità (folle); oppure, al contrario, connotarla di un significato onto-teo-logico, e magari dogmaticamente negativo – ritenere, ad esempio, la
passione della Shoah come “figura della verità del non-senso” significherebbe non
uscire «dal gioco della determinazione reciproca»
235
in cui si rimandano vicende-
volmente i termini di tutte le possibili diadi di cui è costellata la tradizione metafisica
– ; o, per finire, declinarla in chiave religioso-salvifica (pensandola cioè come martirio necessario – magari messianicamente necessario! – ad una storia della salvezza, il
che costituirebbe, a nostro avviso, una pura e semplice mostruosità).
È proprio per il carattere esemplarmente enigmatico di questa Passione, in cui si
esibisce la trascendenza, che talora troviamo in Levinas, accanto alla sua connotazio231
Cfr. S. LAHACHE, «Le messianisme dans la pensée d’Emmanuel Levinas», in Emmanuel Levinas, Philosophie et judaïsme, In Press Éditions, Paris 2002 (pp. 349-361), p. 360.
232
Nel testo da cui abbiamo avviato la nostra esposizione (la «Prefazione» di ADV, p. 54), Levinas tiene a precisare che il suo punto di vista vuole prescindere dalla teologia e dalla mitologia, ma
cerca piuttosto di utilizzare categorie della teologia e della mitologia solo come termini per denotare
lo stesso esito dello scavo di natura fenomenologica che altrove (in AE e DDVI) ha percorso più analiticamente.
233
AE, p. 192.
234
Soprattutto nel saggio «Dio e la filosofia» (ed or. Dieu et la Philosophie, «Le Nouveau
Commerce», n° 31, 1975), in DDVI, pp. 77-101.
235
M.M. OLIVETTI, Analogia del soggetto, cit., p. 74.
212
ne di «martirio», delle affermazioni che tendono a negare la plausibilità di tale termine236. Alla luce di una razionalità lineare ego-logica, la Passione non potrebbe essere
infatti ritenuta un martirio volontario, né un sacrificio esigibile da me e/o dagli altri:
non è infatti esigibile da me perché ciò significherebbe una resa senza condizioni al
male predicabile quale modello morale narcisistico, di tipo stoico (sottomissione all’anànke, razionale o irrazionale che sia) o masochistico (da un punto di vista più
specificamente clinico); non è esigibile da altri, perché, per conseguenza logica, essa
si tradurrebbe in abominevole predicazione del «sacrificio umano», modello esposto
facilmente al sospetto girardiano di esigenza di vendetta per sanare una crisi mimetica, e di fatto ripetizione dello schema antisemita dei nazisti237.
Pensare nella Passione l’«enfasi del senso»238, un altrimenti che senso significa
assumerla appunto come schema etico, di un’etica intesa non come moralismo precettistico, ma come «utopia dell’umano»: ineludibile e personale costituzione della
mia soggettività che invece di lasciarsi sopraffare dall’anonimato insensato dell’il y
a, lotta contro di esso e lo fa sop-portando la sofferenza e l’ingiustizia che patisce
suo malgrado – quella sempre-mia sofferenza che mi inchioda immediatamente alla
insostituibile responsabilità per altri – e solo così può sperare praticamente
un’inversione della logica di dominio e di violenza inscritta nel gesto distruttore e
disgregante dell’il y a.
La vita come passione del giusto innocente per-e-in nome della passione per la
vita di tutti239 è il senso iperbolico dell’umano, nel non senso razionale dell’essere:
tutto ciò si dice nella Shoah come figura.
La passione degli innocenti, quale dispositivo nonviolento di inversione del conatus, è invito e segno rivolto ai superstiti a iniziare e continuare una lotta nonviolenta
236
Valga per tutti questo passo: «La grande idea etica – la più grande – dell’esistenza per il
prossimo […] non può essere pensata fino ad esigere l’esistenza di un popolo martire…» (ADV, p.
67, cn). Il contesto testuale in cui Levinas usa questo termine, ritenendolo inappropriato, è però quello
della considerazione del «popolo d’Israele» non già come figura esemplarmente universale
dell’«unico», ma come società concreta dei prossimi, rispetto alla quale io devo tener sempre presente
che predicare il martirio significherebbe, per me ebreo, non tenere in conto della giustizia che devo ai
miei prossimi: «La mia famiglia e il mio popolo sono, malgrado i pronomi possessivi, i miei “altri”,
come gli stranieri; ed essi esigono giustizia e protezione» (Ibidem).
237
Ipotesi tanto più abominevole quando più si pensi che è stata inverata, nel caso della Shoah,
dalle teorie antisemite dei massacratori, che pensavano il popolo di Israele come capro espiatorio da
sacrificare per ricomporre una ‘crisi’ da loro ritenuta di livello planetario.
238
AE, p. 64.
239
Secondo la felice formula usata da Giovanni Ferretti (cfr. G. FERRETTI, «Passione per la vita
e vita come passione…», cit.)
213
per l’umanizzazione, lotta che nella sua stessa forma di vita-come-passione come
passione- per-la-vita permetta di non cedere allo sconforto della «presa in giro»240 da
parte della morale: essa non varrebbe la pena, altrimenti, di fronte alla farsa insensata
della storia. Ma non si è «presi in giro dalla morale» se si riconosce il valore della
santità per l’umano nella lotta contro l’ingiustizia: «Le influenze, i complessi e
l’occultamento che ricoprono l’umano, non alterano questa santità, ma consacrano
questa lotta per l’uomo sfruttato»241.
Questo riconoscimento dovrà però compiersi nella stessa imitazione dell’evento
di cui io sono superstite. Che io viva, significa infatti che sono superstite, sempre superstite, anche quando le vittime sono ancora potenziali (e già a partire da un’economia di sfruttamento si annuncia il gesto del persecutore): il comando o comandamento del «non uccidere» risuona nella Passione di Israele come volto in cui si esibisce esemplarmente la Passione di ogni volto: nella sofferenza e derelizione dell’abbandono dei testimoni si ode «la voce di un silenzio sottile»; dunque quel volto sarà
anche «figura nella verità» di Dio (Rosenzweig)242.
Il comando del volto non può valere che per me che mi avverto superstite, in nessun modo può diventare un precetto esigibile da altri. La morte e mortalità d’altri mi
ingiunge, mi comanda di non cedere all’inerzia della corrente dell’essere (conatus è
un termine mutuato dal principio di inerzia della fisica moderna), di non delegare
all’Altro (natura o mio simile) l’impegno in prima persona per l’umanizzazione; impegno non assunto liberamente, ma nel quale sono coinvolto mio malgrado, e del
quale après-coup si mostra, non a me ma agli altri, la sua significazione: «La significanza del Dire non rinvia all’impegno, è l’impegno che suppone il Dire»243.
Entro la tragicità degli accadimenti storici, e attraverso il constatabile non senso
fenomenico della storia, la Passione come santità – esposizione a una fedeltà al Bene
nel dono di sé fino alla morte per gli altri – potrà dunque anche valere (e ciò non è
240
TI, p. 19.
AE, p. 75, cn.
242
Non doveva essere lontano, al Levinas lettore della Stella, il senso profondo di queste parole
scritte da Franz Rosenzweig ante-eventum, ma che osiamo pensare come non irriferibili anche ad esso: «Ciò che è eterno era divenuto figura nella verità. E la verità non è altro che il volto di questa figura.[…] La stella della redenzione è divenuta volto che mi guarda e da cui io guardo. Non Dio, ma la
verità di Dio mi è divenuta specchio[…] Così quel santuario nel quale egli ha permesso che lo contemplassi doveva essere una porzione di sovra-mondo dentro al mondo, una vita al di là della vita» (F.
ROSENZWEIG, Der Stern der Erlosung, Nijhoff, La Haye 1981; tr. it. di G. Bonora, La stella della redenzione, (1a ed. Marietti, Genova 1988) Vita e Pensiero, Milano 20052, pp. 427, 434).
243
AE, p. 65.
241
214
scontato, poiché dipende dalla libertà umana) come piccola speranza – piccola perché priva delle attese messianiche di un Regno di Dio in terra “piovuto” dall’alto, e
tale da non «soddisfare» il desiderio infantile di un riscatto magico della storia.
La Passione come santità è sì passività, ma proprio così anche lotta e resistenza
«imposta con buona violenza» alla ego-logica che regge l’«ordine» – anche nel senso
di comando – dell’esse: «Il dire che stupisce [étonant – stupore e orrore: tremendum
et fascinans] – della responsabilità per altri è, contro “venti e maree” dell’essere,
un’interruzione dell’essenza, un disinteressamento imposto con buona violenza» 244.
Come Levinas afferma in un “passo difficile” di AE, nella passione del soggetto
si rivela la stessa elezione e riscatto del Bene. Nel suo statuto di enigma, infatti, il
dolore patito, lungi dall’essere un puro fenomeno enteropatico e autistico, diventa
senso offerto ad altri, perché il soggetto coinvolto nel suo dolore, prima di ogni scelta, è riscattato e liberato proprio così dall’ordine e dal meccanismo dello scontro di
forze che si verifica nel mondo della rappresentazione e dell’ontologia245:
«Poiché il Bene non potrebbe entrare in un presente né rappresentarsi, ma proprio
in quanto Bene, riscatta la violenza della propria alterità, dovesse [dût-il] il soggetto
soffrire del crescere di questa violenza sempre più esigente»246.
Questa Passione-santità è dunque ri-significazione della sofferenza proprio in
quanto inversione del ssignificato “naturale” della sofferenza insensata in dono del
senso per altri, e come tale è speranza. Tale speranza corrisponderà al carattere kantianamente prognosticum del signum, se essa sarà assunta praticamente non come
244
AE, p. 55, tr. modificata, cn.
«La “violenza” che il Bene fa al soggetto, eleggendolo alla responsabilità (sostituzione,
ostaggio etc.) prima che egli possa fare una qualsiasi scelta, prima di ogni suo presa di coscienza, è
una violenza che il Bene “riscatta” continuamente, in quanto non si pone a livello dello scontro di
forze che si verifica nel mondo della rappresentazione o dell’ontologia (il Bene non è un carnefice
concreto che si contrappone all’io nel piano dell’essere! Come non lo è il volto dell’altro che mi ingiunge di non ucciderlo!). Il Bene è Bene proprio perché mi destina all’altro, ad esserne responsabile,
prossimo etc., investendo la mia libertà prima di ogni mia scelta» (G. FERRETTI, comunicazione personale).
246
AE, p. 20-21. Il testo originale riporta: «Car le Bien ne saurait entrer dans un présent ni se
mettre en représentation, mais Bien précisément, il rachète la violence de son altérité, le sujet dût-il
souffrir de par l’accroissement de cette violence toujours plus exigeante», (ed. Le livre de Poche, Paris
2006, p. 32). Ci discostiamo qui dalla versione italiana corrente, che oltre a interporre un punto e virgola laddove c’è solo una virgola, rende a nostro avviso erroneamente al condizionale quella che è una
proposizione concessiva, facendo quasi intendere che il Bene risparmi qualcosa al soggetto e non invece che la stessa elezione attraverso la sofferenza costituisca proprio la liberazione che inverte il conatus, ri-significando il dolore in dono puro del senso nel per-altri; elezione della sofferenza, sofferenza per amore in cui -in fondo- Dio partecipa la propria somiglianza all’uomo.
245
215
nostalgica rappresentazione di un “ritorno a casa” nel per sé247– nell’economia egologica, narcisistica-infantile e violenta, in cui ogni Altro è ridotto allo Stesso248–, ma
come liberazione e affrancamento del sé nel dispiegare l’esodo interminabile del peraltri:
«La significazione come uno-per-l’altro, senza assunzione dell’altro da parte
dell’uno, nella passività, suppone la possibilità del puro non-senso invadente e
minacciante la significazione. […] Il per-l’altro (o il senso) arriva sino all’attraverso-l’altro. Solo così il per-altro – passività più passiva di ogni passività – si
astiene dal per sé»249.
Tale ideale di santità, da un punto di vista della onto-logica lineare, è dunque
«senza perché»250; è la «follia ai confini della ragione»251 che può pervadere una ragione affetta dal Bene, e dischiudere così l’unico senso di speranza possibile per il
dolore insensato, e per quello apparso nell’enorme e mostruosa follia storica della
Shoah. Levinas ne parla come di uno «psichismo che è già psicosi252» attinente alla
sfera affettiva non riducibile a coscienza253, e traducibile cioè in una profonda eteroaffezione traumatica254: quella che si annuncia, peraltro, anche come «possibilità
247
«Il soggetto del dire si approssima al prossimo esprimendosi, espellendosi (nel senso letterale del termine) fuori da ogni luogo, non abitando più, non calpestando più nessun suolo» (AE, p. 62).
248
Dinamica che Levinas mostra inerente alla tradizione occidentale che pensa da Parmenide ad
Heidegger, l’identità come identificazione, dallo Spirito assoluto di Hegel, sino all’essere pensato da
Nietszche come volontà di potenza, o da Heidegger come Lichtung.
249
AE, p. 64.
250
Cfr. il titolo del libro di AGATA ZIELINSKI, Levinas. La responsabilità est sans pourquoi,
PUF, Paris 2004, che richiama il noto verso di Angelus Silesius: «La rosa è senza perché».
251
AE, p. 64.
252
AE, p.«Lo psichismo, l’uno-per-l’altro può essere possessione e psicosi; l’anima è già un
grano di follia» (AE,p. 86n.)
253
Cercheremo di mostrare nell’ultimo capitolo i possibili punti di convergenza e di distanza
dalla visione psicoanalitica.
254
Ci discostiamo dalla posizione di Andriano Fabris che, in un articolo critico verso Levinas,
afferma:«La presenza di un fatto [dell’imperativo del volto], il mero imporsi di esso, non è per nulla
in grado di coinvolgermi [cn.;…] non riesce, insomma, a giustificare un cambio di prospettiva, di
mentalità, di orizzonte»» (A. FABRIS, Levinas e il senso dell’etica, «Teoria» XXVI/2006/2 [pp.203212] p. 211). Benché l’autore specifichi di intendere il termine «fatto» in analogia al kantiano Faktum
der Vernunft («che è, di volta in volta, la legge morale, la presenza della legge morale in noi, la coscienza di quella stessa legge»), forse occorrerebbe maggiormente rilevare, a nostro avviso, che Levinas non caratterizza l’imperativo del volto come «fenomeno presente alla coscienza», ma specifica
ripetutamente che questa etero-affezione è anarchica, prefenomenica, non coscia («non conscio, compreso come non volontario della persecuzione; cfr. AE, p. 153 n.); Lo je costituito da questa affezione
del volto non è l’io empirico, «semfattività di un esemplare unico tale quale si manifesta nel Detto»
216
psicologica255» dinanzi alla morte delle vittime perseguitate nella «cattiva coscienza», per Levinas superstite, nata dalla memoria ossessionante delle vittime.
La Passione è anche perciò signum rememorativum, perché il suo ricordo, vietando l’oblio, la riconosce come un evento in qualche modo epocale.
Ma in che senso epocale? Se per Kant la Rivoluzione francese era figura come
signum ramemorativum, in quanto prefigurazione dell’ideale da cui trarre insegnamento per il futuro della prassi storica, non potremmo certo pensare alla Shoah come
qualcosa del genere. Il ricordo empirico di tale evento deve sempre rimanere sotto la
cifra dell’orrore traumatico.
A meno che non pensassimo a un’inversione della finalità, a una eterogenesi dei
fini storici, come se la Shoah potesse servire a instaurare, per effetto reagente, una
spiritualità condivisa dei diritti umani. Ma ciò vorrebbe dire assumere l’evento inglobandolo in una visione storica dialettica di tipo hegeliano, cioè pensare il negativo
come tolto in una cultura e in una serie di istituzioni che tentino di impedirne il ritorno.
Oppure, pur rifiutando una dialettica di tipo hegeliano, potremmo fondare sul factum brutum della Shoah un positivismo della rivelazione giuridica, ove, dalla semplice constatazione che in essa si sia realizzato il limite estremo e non oltrepassabile
dell’inumano, rivendicassimo la necessità di trarne un insegnamento sotto forma di
imperativo della sua non ripetizione. Forse è quanto suggerisce Adorno: «Hitler ha
imposto agli uomini nella loro condizione di illibertà un nuovo imperativo categorico: pensare e agire in modo che Auschwitz non si ripeta, che non accada niente di
simile»256. Una siffatta prospettiva – anche se non fosse esattamente nell’intenzione
di Adorno, nulla ci impedirebbe di poterla leggere in questo modo – correrebbe il rischio di pensare la Shoah egualmente come modello, ma come un modello nella
(AE, p. 73), ma lo strato preoriginario della ricorrenza come non sostituzione, sottostante al soggetto
empirico semelfattivo, e che affetta come «cattiva coscienza» la stessa coscienza empirica. Quanto al
«non coinvolgimento», abbiamo cercato di riflettere, nel nostro lavoro, sulla portata dell’esperienze
pre-filosofiche, che costituiscono, nella circolarità tipica del pensiero levinasiano, un fattore mobilitante dello stesso pensiero rappresentativo, talché lo stesso «non-fatto» del volto si può rivelare circolarmente après-coup nel fatto empirico della morte degli altri, e reciprocamente, la morte empirica di
altri contiene già la traccia del volto «non fenomenico».
255
«L’idea che sono responsabile del male fatto dall’altro – idea rifiutata, respinta, sebbene psicologicamente possibile – ci porta al senso della soggettività» (Domande e risposte, in DDVI, p. 108)
cn.
256
T. W. ADORNO, Negative Dialektik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1966; tr. it. di S. Petrucciani, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 2004, p. 328.
217
forma di un contro-ideale negativo a cui opporre, con la volontà, un imperativo ipotetico e non categorico, funzionale cioè alla mera sopravvivenza della specie.
Inoltre, perché dovremmo pensare proprio alla Shoah come limite estremo dell’inumano? Chi ci garantirebbe, sul piano empirico, che quel limite, che abbiamo pensato come inoltrepassabile, non possa essere di nuovo oltrepassato, in un olocausto
nucleare o ambientale, ad esempio?
Forse nella prospettiva levinassiana, l’epocalità non andrebbe pensata primariamente in senso meramente empirico, ma istituendo una circolarità tra l’aspetto pre-filosofico e quello filosofico-fenomenologico, in modo da assumere il ricordo dell’evento-Auschwitz come quello in cui si fa memoria, contemporaneamente, tanto
dell’emergere puro del non senso (l’evidenza dell’essere come il y a) quanto della
possibilità del darsi enigmatico del senso (la traccia del Bene come uno-per-altro).
Se infatti, con Levinas, ricordiamo nella Shoah la Passione come figura dell’umano, non è perché in essa si diede solo il male, ma perché in essa alcuni uomini
portarono quel male per noi superstiti, cioè, ad Auschwitz vi furono dei santi che ci
mostrarono la possibilità della santità, l’eidos del bene.
Che questo eidos sia lontano dalla pratica della maggioranza degli uomini, è certo
ammesso da Levinas, ma egli pensa in prima istanza che per lo meno questo esso
possa essere riconoscibile, che possa essere ammirato, che cioè la santità sia valutabile come valore inoppugnabile, perché sia possibile una speranza dell’umano. Leggiamo infatti in un colloquio del 1985: «Non ho mai preteso di descrivere la realtà
umana nel suo immediato apparire, ma ciò che la depravazione umana stessa non può
cancellare: la vocazione umana alla santità. Non affermo la santità umana, dico che
l’uomo non può contestare il supremo valore della santità»257.
In un’altra intervista di due anni dopo, al suo interlocutore che obiettava che la
santità è molto lontana dalla maggioranza degli uomini, Levinas rispondeva: «E tuttavia la santità è la suprema perfezione, e non dico che tutti gli uomini siano dei santi! Ma basta che, talvolta, vi siano dei santi, e soprattutto che la santità sia sempre
ammirata, anche da coloro che ne sembrano lontani»258.
La difficile e impervia prospettiva di Levinas ci sembra perciò quella di mantenere insieme, nello stesso evento, la pensabilità di entrambi i significati puri, senza
257
258
Alterità e trascendenza, cit., pp. 150-151.
«Entretiens avec Roger-Pol Droit», in Les Imprévus de l’histoire, Le Livre de Poche, p. 182.
218
mai tuttavia rappresentarli sincronicamente coimplicati, sul modello di una dialettica
della compresenza degli opposti di tipo schellinghiano o junghiano: il Bene non è
mai compresente col male; se la trascendenza è ambivalente, lo è proprio perché è separata, non perché è contaminata con l’essere. È separata innanzitutto perché non è
mai presente: è la stessa diacronia del tempo.
Solo l’essere non investito dal Bene è univoco, perché in fondo è identità inglobante, presente o onnipresente, perseveranza del presente come pulsione di sopravvivenza che è pulsione naturale di morti-ficazione dell’altro. I due significati puri non
devo pensarli con-presenti nell’evento; ma di più, non li devo semplicemente rappresentare tout court, ma piuttosto devo far valere con la mia propria prassi etica quel
Bene, come varco, trauma, intervallo aperto nel piano dell’essere, «frattempo» in cui
enigmaticamente il Bene si mostra come trascendenza per-altri. Ma ciò può accadere
solo se io non delego i martiri a significarlo al mio posto, ma se io per primo, sentendomi coinvolto nell’evento, lotto contro il non senso della persecuzione che le vittime hanno subito, sostituendomi a loro nell’iniziare e continuare la pratica della carità
e della giustizia.
L’atteggiamento dei martiri pazienti, la (quasi) non temporalità di quell’accadere
insensato, inchiodato cioè al presente senza-inizio e anonimo dell’il y a, sarebbe così
significata e risignificata da me istituendo una significazione in ipostasi, un per-altri
del sempre-mio essere-per, che renda après-coup poi anche pensabile, come evento
non del tutto insensato, la loro sventura.
La memoria della Passione non sarebbe memoriale e sacramento del primato etico del Bene, senza questa continua risignificazione da parte mia, da puro trauma insanabile dell’umano, in figura in me come testimone dell’umano. Senza tale coinvolgimento, questo evento rimarrà sempre di per sé insignificante e imperdonabile, non
avendo in se stesso possibilità di una significazione eterologa che lo risignifichi da
fuori, magari «nella nell’attesa della venuta» di un messia oltremondano che lo riscatti onticamente, trasustanziandolo magicamente in un “bene” empirico: allora sì
veramente che la storia sarebbe una farsa.
Levinas ha una visione della storia totalmente dis-incantata; rinuncia a qualsiasi
ruolo «provvidenziale», in senso meramente evenemenziale della Shoah: nessuna garanzia che gli uomini imparino qualcosa dalla lezione dei fatti, anzi piuttosto ci si po219
trebbe aspettare il contrario. Non si tratta di imparare cognitivamente una lezione, si
tratta di obbedire a un comando prima di averlo udito.
È proprio perché non è mai empiricamente, e in nessun altro senso concettuale,
segno e figura, che l’evento in sé può diventa significante in un’economia di Bene; se
però i superstiti assumono la piena e indelegabile responsabilità di non farlo assurgere a «figura plastica» di una pura durata del male .
Solo un evento insensato e incomprensibile potrà dunque comandare senza essere compreso se non «nell’eco della mia risposta». Solo inserendomi nell’imitazione
dei giusti innocenti, il senso esibito da quell’evento «significherà» per le generazioni
future. Altrimenti, se visto con gli occhi del mero pensiero, alla luce del primato della rappresentazione teorica, esso rimarrà rivelazione al grado puro dell’il y a: trauma
dove se ne paralizzerà nell’eterno presente il suo «sordo e anonimo brusio».
Attraverso la pratica dell’amore e della giustizia, costituendosi in segno dato-adaltri, la soggettività responsabile può invece mostrare l’accesso alla rivelazione del
Bene al grado puro in quel ammasso caotico ed enigmatico, e rendere così meno insensato quell’abisso di male.
In fondo, quindi, qualunque senso rappresentativo possa pensarsi, qualunque
teoria di Auschwitz,qualunque lezione di Auschwitz intesa in senso meramente cognitivo, è fallimentare. Andando al di là di quanto sembra suggerire Levinas, riteniamo giusto supporre che anche qualora non disgiungessimo l’orrore supremo per la
morte degli innocenti dall’ammirazione per il valore della loro santità, non faremo
che pensare ancora un senso tematico, rappresentativo e quindi ultimamente violento,
se non altro perché fatto sulle spalle delle vittime innocenti; ripetendo così, se non il
gesto degli assassini, almeno lo sfondo di indifferenza che ne permise l’operato.
Nel memoriale della Shoah, il mio ricordo delle vittime onorerà la noninsignificanza della loro sofferenza, constatandone la gratuità senza senso, proprio se
io mi inserisco e mi lascio coinvolgere nella dinamica etica dischiusa da quella significazione. La possibilità della venuta enigmatica del senso nella storia e nell’essere, è
la mia indelegabile responsabilità di superstite, che ri-costituisce di volta in volta il
senso consumato, riconoscendomi eccezione, l’eccezione di eletto che non può assumere l’elezione perché fortunosamente scampato all’ultimo appello, e che, già
sempre coinvolto, non dà segno ma si fa segno del Bene.
220
Il tentativo meno oltraggioso di onorare i morti non è solo, o forse non è per nulla, il pensarli come testimoni – malgrado la loro intenzione – dell’«altrimenti che essere», ma il non delegare a loro la rappresentanza di quella Passione, il vivere sulla
mia carne la loro memoria bruciante, come mia Passione: «un altrimenti che essere
che se ne va in per l’altro, che brucia-per l’altro consumando le basi di ogni posizione per sé e di ogni sostanzializzazione che prenderebbe corpo grazie a questa consumazione, fino alle ceneri di questa consumazione in cui tutto rischia di rinascere…»259. Indubbiamente questo passo di AE è, oltre che un’evocazione del Cantico
dei cantici, anche una allusione all’Olo-causto, proprio nel suo significato etimologico del termine.
L’Olocausto come Passione è quindi figura di quella santità che Levinas, in AE,
afferma di aver tentato di «sviluppare, per rendere conto dell’impossibile indifferenza riguardo all’umano»260 in un mondo che, dopo Auschwitz, sembra aver perso la
possibilità stessa del senso, le parole della sua pensabilità e il valore di qualunque
sforzo o impegno per la pace e la giustizia, arrendendosi a un silenzio di notte e nebbia, sull’uomo e su Dio, echeggiante attraverso la retorica di «parole in disseminazione»261.
9. Passione, passività, pazienza
La categoria di «Passione», che abbiamo fin qui illustrato, ci permette di illuminare il passaggio al tema della sostituzione nel testo capitale di Levinas, quale dinamica di «nascita latente» della soggettività.
Levinas opera infatti, in AE, una traslazione dell’ambito d’uso di questo termine,
dal suo luogo di ricorrenza originario – quello religioso legato al ripensamento della
figura del «servo sofferente» nella passione delle vittime della Shoah –, a quello filosofico-etico, relativo alla condizione (o meglio «in-condizione») della soggettività. Si
259
260
261
AE, p. 64.
AE, p. 75.
Ibidem.
221
passa cioè in AE, dalla Passione di Israele, alla passione-passività-pazienza del soggetto.
Come abbiamo già accennato all’inizio di questo capitolo, Levinas vuole evitare
il pericolo che il termine «passione» possa interpretarsi nel senso di una sofferenza
assunta, da parte di una coscienza già costituita: una passio activa. È per questo motivo, supponiamo – e non per una presunta allergia all’uso “cristiano” del termine –
che il termine «Passione» ricorrerà molto sporadicamente in AE, e precisamente cinque volte262.
Esso è usato in questo senso solo nel IV capitolo del libro. Una volta il termine vi
ricorrerà in endiadi con «patire» (p. 161), una seconda volta in congiunzione con
«passività»263.Negli altri tre casi264, il termine ricorre da solo, sempre come sinonimo
di «passività più passiva di ogni passività»265, a indicare che in nessun modo questa
passione è assumibile266, sebbene sia esposizione alla sofferenza e pazienza.
Pazienza come «lunghezza del tempo»267 e “pazienza d’altri” (genitivo equivoco), dove altri è non solo la causa del mio soffrire ma ne diventa il beneficiario: è un
soffrire che mi inchioda alla mia responsabilità insostituibile, costituendo anche la
mia identità indiscernibile. Soggettività-soggezione di ostaggio del prossimo, davanti
a cui l’io «compare» (comparizione giudiziaria), anche se non «appare» (essendo non
fenomenico, ma preoriginale e anteriore ad ogni rappresentazione e tematizzazione)268.
Nelle contemporanee lezioni universitarie, Dio la morte e il tempo, Levinas sintetizza molto chiaramente il dinamismo passione-sostituzione: «Nel soffrire attraverso
[par] la colpa dell’altro spunta il soffrire per [pour] la colpa dell’altro. Soffrire per
[pour] gli altri soffrendo attraverso [par] gli altri»269.
262
Il termine ricorre in altri due casi, in AE, questa volta nel senso di sofferenza volontaria, e
sempre con l’esplicita indicazione che nella dinamica di costituzione della soggettività l’assunzione
come libertà di scelta non è ciò di cui sta parlando.
263
«La passività o la Passione del Sé» (AE p. 146).
264
«Come può tale Passione aver luogo nel tempo e nella coscienza?» (AE, p. 128); «Passione
infinita della responsabilità che va, nel suo ritorno su di sé, più lontano della sua identità» (ivi, p.
141); «…L’assunzione della sofferenza e delle colpe degli altri non eccede in niente la passività, essa
è Passione» (ivi, p. 161).
265
AE, passim.
266
Cfr. ad es. DMT, p. 249: «Questa passione non è un’assunzione».
267
«Una pura pazienza, un puro subire, un risveglio che è risveglio rispetto al prossimo, una subitaneità che diventa la prossimità del prossimo» (DMT, p. 193).
268
«Davanti al prossimo io compaio piuttosto che apparire» (DDVI, p. 95).
269
DMT, p. 244.
222
Altri è colui grazie al quale, in vista del quale e al posto del quale io soffro, nell’elezione del Bene: la stessa causa, a cagione della quale io soffro, s’inverte in «fine270: fine tuttavia mai rappresentabile o tematizzabile come “interesse”, ma sempre
come termine che dispiega un futuro di umanizzazione. La soggettività pensata come
sostituzione – ma «sostituzione nella separazione, cioè responsabilità»271 – e significazione costituisce cioè l’eccezione, lo scarto, il frat-tempo e il contrattempo in cui
dovrà mostrarsi il senso dell’umano nell’essere.
La biffure, barratura/bivio, scelta/biforcazione tra due parole, sarà operata, nel
IV capitolo di AE, non più tra i termini «passione» e «passività», come
nell’annotazione scritta nei Carnets da cui siamo partiti in questo capitolo, ma tra
«passione» e «sostituzione». Nel particolare stile di pensiero e di scrittura di Levinas,
dove l’ambivalenza corrisponde allo stesso dinamismo della trascendenza, e dove i
termini, i concetti, le figure «si fanno eco», i due lemmi in questione rimarranno però
sempre correlabili e dunque, non a caso, sostituibili.
270
271
«A rigore altri è “fine”, io sono ostaggio…» (AE, p. 161).
AE, p. 69.
223
224
IV. LA SOGGETTIVITÀ ETICA COME APPROCHE-SOSTITUZIONE
NN. Se io sono vulnerabile, come Lei sottolinea nei suoi
libri, come posso essere responsabile? Se si soffre non si
può far nulla.[…]
E.L. […] Lei dice: nella sofferenza non si può far nulla.
Ma è sicuro che il soffrire si ferma a se stesso? Quando si
soffre a causa di qualcuno, la vulnerabilità è anche soffrire per qualcuno. È di questa trasformazione dell’ “a causa di” in “per”, è di questa sostituzione che si tratta. […]
L’idea che sono responsabile del male fatto dall’altro –
idea rifiutata, respinta, sebbene psicologicamente possibile – ci porta al senso della soggettività1.
Eideticamente: essa [la comunicazione] non è possibile
che nel sacrificio che è l’approche a colui di cui si è responsabile. La comunicazione con altri non può essere
trascendente che come vita pericolosa, come bel rischio
da correre. Queste parole assumono il loro senso forte
quando, invece di designare soltanto la mancanza di certezza, esprimono la gratuità del sacrificio 2.
Approche paradossale perché con esso la distanza cresce
a misura dell’approche e più si è vicini più si è lontani3.
1
«Domande e risposte», in DDVI, pp. 107-108, cn.
AE, p. 151.
3
DMT, p. 233, tr. modificata.
2
226
1. Contesto storico-biografico di La sostituzione
Il capitolo IV di AE rappresenta un’elaborazione di una conferenza tenuta il
30 novembre del 1967 a Bruxelles, e poi pubblicata nella «Revue philosophique de
Louvain» nell’ottobre del 1968. Segnalare queste date non ci pare inutile, perché
crediamo non sia un caso che proprio a partire da questi anni si vada intensificando,
nell’opera di Levinas, sia dal punto di vista del linguaggio che del contenuto,
un’accentuazione parossistica del registro «traumatologico», con tutte le annesse nozioni «che si fanno eco» (trauma, denucleazione, ostaggio, ossessione, persecuzione,
sacrificio, espiazione), quasi a evocare lo sfondo dell’Evento attraverso un palinsesto.
Si può senz’altro attribuire una delle ragioni della differenza nel lessico e nei
contenuti tra le due opere maggiori (TI e AE) all’impatto e alla risposta alle critiche
di Derrida, contenute nel celebre saggio del 1964 Violenza e metafisica4. Si può
d’altronde anche supporre, come suggerisce Salomon Malka, che la congiuntura biografica del riconoscimento pubblico e istituzionale avrebbe liberato Levinas, nella
scrittura di AE, dalle inibizioni “accademiche” che lo avevano portato, mentre componeva TI, a «mascherare eventualmente certe radici ebraiche o talmudiche»5, consegnandole prevalentemente agli scritti di esegesi religiosa.
Ma la nostra impressione, suffragata dal dato cronologico, è che si possa anche ipotizzare la non indifferenza dell’autore rispetto ad un evenienza storica peculiare, un evento cioè che sconvolse la coscienza degli Ebrei in diaspora e residenti in
Israele, e che fece entrare nel discorso pubblico la Shoah, fino allora mantenuta entro
il riserbo di una discrezione familiare e personale, quando non addirittura entro una
rimozione. Ci riferiamo alla Guerra dei Sei Giorni (5-10 Giugno 1967), preceduta dal
dibattito relativo al processo Eichmann (1960-63), dove, per la prima volta dopo la
Seconda guerra mondiale, venne usato politicamente il discorso sulla Shoah come
minaccia ancora presente. La Guerra dei Sei Giorni fece entrare nella coscienza pubblica, non solo ebraica ma innanzitutto ebraica – come illustra la storica israeliana
4
Violence et métaphysique, essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas, «Revue de Métaphysique et de Morale», 1964, nn. 3 e 4; ora in L’écriture et la differénce, Éditions du Seuil, Paris 1967; tr.
it. di Gianni Pozzi, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 20023
5
S. MALKA, Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, Jean-Claudie Lattes, Paris 2002; tr. it. di
C. Polledri, La vita e la traccia, Jaca Book, Milano 2003, p. 255.
227
Idit Zerthal – il discorso della Shoah come funzionale ad una narrazione collettiva,
che vedeva «un nesso teleologico tra tragedia e morte della Diaspora ebraica, da una
parte, e fondazione e diritto all’esistenza dello Stato d’Israele, dall’altra, comprese le
sue pratiche quotidiane, in particolare quelle militari»6.
Ci pare quindi opportuno congiungere a questi elementi quanto abbiamo precedentemente rilevato circa il carattere “ritornante”, dopo lunghi anni, del trauma a
livello psicologico7, richiamando il dato biografico su quanto il rapporto con la memoria e la testimonianza della Shoah – a partire dal 1967 – nella vita e nell’opera di
Levinas abbia inciso sul “secondo tempo” della sua produzione.
Sarà opportuno tuttavia ribadire (anche se vi abbiamo molto insistito precedentemente) come anche gli elementi che erano stati presenti soltanto negli scritti
relativi alla tradizione talmudica si fossero già riversati – benché sottotraccia – nella
sua opera più strettamente filosofica, così da rendere per certi aspetti inappropriata
una differenziazione del Levinas “filosofo” dal Levinas “talmudista”. Gli articoli
contenuti in Difficile Libertà, ad esempio, rivelano una sempre maggiore consapevolezza non solo del carattere epocale della Shoah, per il giudaismo e l’umanità, ma
della possibilità unica di rispondervi attraverso un atteggiamento in qualche modo –
e vedremo in che senso – sacrificale. Il germe di tale plesso concettuale, e anche forse dell’intera concezione della soggettività in AE, potremmo rinvenirlo in un articolo
pubblicato nel 1968 e ora contenuto in DL8, intitolato L’ebreo carnale. Alla fine di
questo testo leggiamo infatti:
«Ma forse l’ultima essenza di Israele, la sua essenza di carne anteriore
alla libertà, che avrà segnato la sua storia – storia manifestamente universale
– storia per tutti, visibile per chiunque –, forse quest’essenza ultima ha a che
fare con la sua innata disposizione al sacrificio involontario, alla sua esposizione alla persecuzione. […] Essere perseguitato, essere colpevole senza aver
6
ZERTAL, I., Ha’ Umah ve Ha’Mavet, Historia, Zikaron, Politika, Dvir Piblishing House
2002, tr. It P. Arlorio, Israele e la Shoah. La nazione e il culto della tragedia, Einaudi, Torino 2001,
p.114.
7
Come già segnalato sopra (Cfr. supra, Cap. II. Par. 3) i sintomi riemergono, nei soggetti che
da giovani avevano vissuto un trauma, con il pensionamento e/o in genere il raggiungimento di uno
stato di vita che permetta una riflessione sul passato, provocando acute sofferenze, relative ad esempio
ad autoaccuse e senso di colpa (surivors guilt) e rafforzando un particolare stile di «difesa» dal proprio
passato che non consente di accettarlo.
8
DL, pp. 269-280.
228
commesso alcuna colpa, non è il peccato originale ma il rovescio di una responsabilità – responsabilità per l’Altro – più antica di qualsiasi peccato: universalità invisibile! Rovescio di un’elezione che pone l’io prima ancora che
sia libero di assumere tale elezione»9.
Abbiamo già notato, nel capitolo precedente, che questi termini, dapprima riferiti al popolo d’Israele nel suo carattere esemplare saranno caratterizzati, nella successiva produzione levinassiana, come cifra del soggetto umano.
La memoria e la testimonianza della Shoah continueranno dunque a parlare,
attraverso le nozioni e il lessico delle opere più strettamente filosofiche, quali Umanesimo dell’altro uomo, e poi le lezioni universitarie – contemporanee ad AE – Dio
la morte il tempo, sino agli ultimi saggi, contenuti nella raccolta Tra noi, soprattutto
La sofferenza inutile del 198210 e Morire per (1987), testo in cui troviamo evocata la
nozione di «etica del sacrificio»11, come sinonimo di «santità» contenuta in AE.
È tuttavia nel testo che ci accingiamo a commentare, La Substitution, e che si
inserisce in quell’orizzonte storico-biografico a cui abbiamo appena accennato, che
Levinas presenta in maniera paradigmatica la propria concezione della soggettività
come passione e sostituzione, indissolubilmente connessa con lo sfondo del trauma.
9
Ivi, p. 280. ccnn, tranne «io».
Saggio nel quale, come abbiamo già notato nel Secondo capitolo, viene significativamente
citata l’opera di Emil Fackenheim, dedicata al ripensamento della Shoah per la fede ebraica.
11
TN, p. 243.
10
229
2.
Soggettività come sensibilità e prossimità
Per illustrare il senso della soggettività etica come emerge dal capitolo IV di
AE, dobbiamo segnalare i caratteri che lo scavo fenomenologico della soggettività
aveva guadagnato nel capitolo precedente del libro. Nel terzo capitolo di AE, infatti,
Levinas aveva trattato della soggettività come sensibilità (passività e vulnerabilità
rispetto ad altri) e prossimità (nell’approche12 ad altri); nel IV capitolo egli si appresta a trattare della sostituzione, esasperando i tratti di questa soggettività, secondo il
noto modello della «enfasi», dell’«esagerazione» e dell’«iperbole»13, sì che essa viene a delinearsi come «assunzione delle stesse responsabilità altrui, sino ad espiarle al
suo posto»14.
Sul tema della sensibilità, Levinas aveva sottolineato la sua irriducibilità
all’opera della conoscenza, attraverso il suo carattere di «soggettivazione del soggetto», nel duplice carattere di godimento [jouissance] e di vulnerabilità. Se in TI la
sensibilità, insieme sensazione e sentimento, era per lo più individuata come godimento, in AE viene individuata alla base del godimento la vulnerabilità, o «esposizione alla ferita nel godimento»15. La vulnerabilità, infatti, in quanto esposizione ad
altri malgrado sé, «suppone il godimento altrimenti che come sua antitesi»16. Leggiamo in un passo cruciale del terzo capitolo di AE:
«Senza l’egoismo che si compiace in se stesso la sofferenza [della
vulnerabilità, l’esposizione alla ferita] non avrebbe senso, così come perderebbe la passività della pazienza se non fosse in ogni momento un eccedere
del senso attraverso il non-senso. Il godimento e la singolarizzazione della
sensibilità in un io tolgono alla passività suprema della sensibilità – alla sua
vulnerabilità, alla sua esposizione all’altro – l’anonimato della passività insi12
Dato il suo carattere peculiare di termine tecnico, come specificheremo più avanti, preferiamo,
nella maggior parte dei casi, usare il termine approche senza tradurlo.
13
Sul particolare carattere della nuova grammatica etica di Levinas in AE, ed in particolare
sull’enfasi e l’iperbole, si veda S. PETROSINO, Fondamento ed esasperazione. Saggio sul pensare di
Levinas, Marietti, Genova 1992, pp. 69-84.
14
G. FERRETTI, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier, Torino
1996, p. 236.
15
AE, p. 81
16
Ivi, pp. 80-81.
230
gnificante e inerte; la possibilità, nella sofferenza, di “soffrire per niente”,
impedisce che in essa la passività diventi atto. E così il per-l’altro contraria il
soggetto e al tempo stesso lo intacca nella sua intimità; attraverso il dolore. Il
godimento […] è la condizione del per-l’altro della sensibilità e della sua vulnerabilità in quanto esposizione ad Altri. Quest’ultima ha senso solo come
“prendersi cura del bisogno dell’altro”, delle sue infelicità e delle sue colpe,
come donare. Ma il donare ha senso solo come strapparsi da sé malgrado sé e
non soltanto senza io; […] strapparsi dalla compiacenza in sé del godimento;
strappare il pane dalla propria bocca. Solo un soggetto che mangia può esser
per-altro e significare […] la passività della ferita – l’emorragia” del perl’altro – è lo strappare del boccone di pane dalla bocca che lo gusta in pieno
godimento»17.
Come esposizione originaria ad altri, la vulnerabilità dunque «non annulla il
godimento, ma presuppone l’ipseità dell’io godente di sé, senza il quale la passività
della ferita non affetterebbe che una “superficie indifferente”18, anonima»19.
La sensibilità dunque si specifica ulteriormente, attraverso la vulnerabilità,
come esposizione ad altri, in cui avviene un’inversione del conatus, esposizione come un essere-stato-offerto-senza-ritegno20 [avoir-été-offert-sans-retenue], ovvero
offerta passiva altri «che non è affatto la generosità dell’offrirsi che sarebbe atto»,
ma la stessa non iniziativa della sensibilità. L’esposizione pre-originale, «più antica
di ogni presente, non è una passività contemporanea e contro-partita di un atto, ma
l’al di qua del libero e del non libero che è l’anarchia del Bene».
Questo dinamismo della sensibilità dunque non ha nulla del dinamismo della
conoscenza, «recettività teorica a distanza [che] ricade in contatto, [e] ritorna, come
attraverso l’ambiguità del bacio, dal prendere all’essere preso»21. L’inversione, dal
prendere al donare malgrado-sé, è specificata ulteriormente come quella dinamica in
17
18
93).
19
20
21
AE, pp. 92-93.
«Malgrado sé, certo, ma non affatto come affezione di una superficie indifferente» (AE, p.
R. CALIN – F.D. SEBBAH, Le vocabulaire de Lévinas, Ellipses, Paris 2002, p. 53.
«Retenue», secondo Le Petit Robert, significa anche «discrezione», «misura», «riserva».
AE, p. 94.
231
cui la stessa sensibilità diventa maternità, «portare per eccellenza [che] porta ancora
la responsabilità per il perseguitare del persecutore»22.
La soggettività della sensibilità dunque, come incarnazione, è «un abbandono
senza ritorno, maternità, corpo che soffre per l’altro, corpo come passività e rinuncia,
puro subire»23; ma Levinas non cessa di ricordare che questa esposizione, che offre
significanza (baille signifiance), non si compie a livello empirico, perché, a tale livello, il soggetto può ben rifiutarsi di donare, cioè può «affermarsi animalescamente nel
proprio conatus e nella propria gioia»24. Ma questa ambiguità, condizione della stessa vulnerabilità, è la stessa coimplicazione di godimento e di vulnerabilità, perché «è
nella misura in cui la sensibilità si compiace in sé stessa – “si aggroviglia su di sé”,
“è io”- che, nella benevolenza per l’altro, resta per l’altro malgrado sé».
L’ambivalenza per cui, cioè, si può donare «solo il pane che si gusta dalla propria
bocca», rende possibile il fatto empirico che si possa anche non donare quel pane; ma
l’atto empirico del donare non sarebbe possibile se l’io, ben prima della propria volontà, e della coscienza che prenda del proprio donare, non fosse già individuato come offerta, esposizione pre-originaria, dalla ferita immemoriale da parte dell’altro
che lo costituisce come soggettività incarnata votata alla donazione-significazione.
Lo stesso «contatto», in cui si compie la sensibilità, non sarà mai possesso inglobante, ma sempre approssimarsi (approche) che tanto più determina un incremento di
prossimità quanto più aumenta la separazione e la distanza dall’altro, come avviene
nella carezza. Se dunque la coscienza di sé è un’odissea, un cammino del ritorno, la
sensibilità come vulnerabilità è esodo da sé verso l’altro avviato preoriginalmente dal
Bene: «incessante alienazione dell’io»25 – alienazione senza schiavitù, perché anteriore ad un sé già costituito e alienazione liberante, in quanto costituisce la stessa
possibilità dell’affrancamento dall’essere e – nell’individuazione dell’io come significazione – la (ri)costituzione del senso nell’essere.
La soggettività etica è dunque esodo, dove il sé non si perde, né si cancella –
ma viene identificato dall’esterno, guadagnando preoriginalmente il proprio spessore
di segno del Bene. Il sé non si cancella annullandosi, ma, come nella biffure, essendo
22
23
24
25
Ibidem.
AE, p. 99.
Ibidem.
Ivi, p. 98.
232
sostituzione da e per altri, senza tuttavia potersi sottrarre alla propria individualità
unica ed eletta in tal modo individuata; da una parte, infatti, è proprio il sé di godimento-vulnerabilità a rendere possibile l’estroversione verso-altri, d’altra parte, il sé
ha in questo dinamismo la propria «nascita latente», cioè tanto più acquista la propria
ipseità quanto più incrementa la sua estroversione.
Per denotare un dono di sé che non sia l’atto dell’offrirsi di un io già costituito, ma offerta di sé-malgrado sé, Levinas, come abbiamo visto, usa il sintagma «essere-stato-offerto-senza ritegno», in cui «essere stato» implica il carattere immemoriale
del passato dell’elezione da parte del Bene; «offerto», denota soprattutto il carattere
di passività estrema in cui, nell’incarnazione come sensibilità, la soggettività è costituita preoriginariamente come espiazione per altri. Nello strato più profondo della
soggettività, il moi o lo je, sembra esibirsi cioè lo schema di un’offerta espiatoria in
cui l’io indeclinabile è-stato-offerto-per altri.
Per delineare ulteriormente il profilo fenomenologico di una dinamica sacrificale, occorre ancora sondare il modo in cui Levinas nella restante parte del terzo capitolo (par. 6, La prossimità), approfondisce il senso della sensibilità-vulnerabilità
come «prossimità», cioè come l’«approssimarsi ad altri e di altri sino
all’ossessione»26. In effetti, la prossimità non viene descritta come una semplice contiguità spaziale ma come fondamento stesso della spazialità, in base alla peculiare
riduzione fenomenologica dal Detto al Dire che egli utilizza in AE; cioè come dinamica di approssimazione costitutiva della stessa soggettività, approssimazione ad altri fino all’ossessione: «La significazione propria della soggettività è la prossimità.
[…] La soggettività non precede la prossimità per poi impegnarsi successivamente in
essa. È, al contrario, nella prossimità, che è rapporto e termine, che si annoda ogni
impegno»27.
Il soggetto che si approssima ad altri non può mai impadronirsene, né è dapprima coinvolto in un atteggiamento rappresentativo per poi impegnarsi nel rapporto
etico; è invece, nel suo strato profondo, preoriginalmente e non rappresentativamente
ossessionato da altri, al di qua della coscienza di questa ossessione: «La prossimità
26
27
G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 236.
AE, p. 106.
233
non si risolve nella coscienza che un essere prenderebbe di un altro essere ritenuto
vicino in quanto sotto i suoi occhi»28.
Ossessione è dunque investimento da parte dal prossimo nello stesso essere io
indeclinabile, al di là o al di qua dell’Io autocratico, “proprietario-autoctono”, della
rappresentazione. Come segnala Didier Franck, «il termine obsession deriva dal latino obsessio e denota originariamente l’assedio di una piazzaforte»29. Levinas scriverà nel capitolo quarto di AE che si tratta di una «relazione irriducibile alla coscienza:
«Irriducibile alla coscienza, anche se la sconvolge […] l’ossessione traversa la coscienza in controcorrente, iscrivendosi in essa come straniera/estranea [étrangère]»30.
Oltre all’elemento di anteriorità alla coscienza rappresentativa (e quindi confinante
con l’inconscio, anche se non inteso in senso freudiano, ma vi ritorneremo), ci interessa rilevare questo elemento di estraneità-stranierità che l’ossessione designa, assedio che fora preoriginalmente il castello autoctono dell’Io, depone il Soggetto e lo
rende «soggettità»31 alla prima persona: «non si può più dire che è il Me (Moi) o l’Io
(Je). Bisogna ormai parlare in prima persona»32.
Io “posseduto”, «ostaggio» di altri, dunque. Levinas segnala che con «ossessione» non vuole designare la prossimità «come unità dialettica dell’unità e della differenza»33, cioè una relazione che riassorbirebbe, ad un livello più alto, questa effrazione da parte dello straniero nell’Io già costituito come installato nella rappresentazione, ma la stessa «nascita latente» della soggettività in una continua inquietudine,
mai colma perché non in grado di assorbire la non fenomenalità del volto.
La prossimità ad altri come ossessione «non è uno stato, una quiete, ma precisamente inquietudine, non luogo, fuori luogo della quiete che sconvolge la calma
della quiete della non-ubiquità dell’essere che diviene quiete in un luogo, sempre, di
conseguenza, insufficiente prossimità, come un abbraccio [etreinte]»34. Notiamo in
questo ultimo lemma, la possibile e ambivalente allusione al linguaggio erotico e a
28
Ivi, p. 104.
«Assediata, questa si trova allora e fin dentro le proprie mura, dipendente da una potenza
straniera. La coscienza può dunque essere detta ossessionata quando essa è in se stessa assegnata a e
investita da quello che essa non potrebbe fare né rifare suo, da altri» (D. FRANCK, L’un-pour-l’autre,
cit. p. 131).
30
AE, p. 126.
31
Ivi, p. 104.
32
Ivi, p. 102.
33
Ivi, p. 103.
34
Ibidem.
29
234
quello militare, laddove etreinte è sì la stretta della mano o l’abbraccio, ma può essere la stretta di un esercito, a mo’ di morsa, sempre più vicino attorno ad una piazzaforte35. Questa ossessione incessante, «in cui la differenza freme come non-indifferenza»36,e mai estinguibile, giacché «il prossimo non colma l’approssimarsi»37, designa un dinamismo di prossimità «mai abbastanza prossima»: la prossimità è lo stesso
soggetto che si approssima; il soggetto è fatto sempre più prossimo ad altri dallo
stesso investimento-elezione con cui il Bene lo invia immemorialmente; si tratta di
una dinamica paradossale e al di là della logica formale: lo stesso traumatismo con
cui altri mi ossessiona è il dinamismo con cui il sé si approssima ad altri.
Il termine usato da Levinas per designare il senso profondo della prossimità è
è «approche». Si tratta di un vero e proprio terminus technicus, di cui la felice traduzione italiana, «approssimarsi», denota insieme il carattere di avvicinamento mai arrestabile, e nello stesso tempo di essere-fatto-sempre-più-prossimo, vicino, senza però che il contatto diventi fusione; vicinanza in cui «il prossimo è fratello»38, che mi
guarda e riguarda dall’alto, e nello stesso tempo dal “basso” di una miseria in cui la
sua mortalità si rivela di colpo come bisognosa della mia cura.
L’approssimarsi non giunge mai ad annullare la separazione: anzi paradossalmente la prossimità tanto più si restringe quanto più l’altro è costituito da questo
stesso dinamismo come separato e nella relazione asimmetrica e asincronica
dell’uno-per-l’altro è singolarizzato come altri. Se è giusto dire che l’ossessione con
cui l’altro mi assedia è anche quella con io mi sento investito, convocato anteriormente ad ogni scelta previa di assumere questa convocazione – ed eletto da questo
assedio sempre più incombente, e che mai ha termine –, bisognerà anche notare che
propriamente il dinamismo dell’approche è innanzitutto un movimento a senso unico, che per quanto non abbia origine in me, ma in altri, va da me ad altri – esposizione che è già mia assegnazione insostituibile – in una direzione di altezza.
Il volto infatti è sempre più in alto di me, e mi parla da una altezza che è la
stessa irreversibilità del passato che mi convoca e sollecita: quindi approche vuol
35
Nel Petit Robert, alla voce «Étreinte» leggiamo: «Action d’étreindre; pression exercée pa ce
qui etreint. L’étreinte d’une main. L’armée reserre son étreinte autour de l’ennemi».
36
AE, p. 103.
37
AE, p. 113.
38
Ivi, p. 108.
235
dire essere-consegnato, essere-offerto verso l’altro-in alto39. Già in TI, il carattere del
volto era connotato da questa altezza o maestà del prossimo, e insieme dalla sua miseria, povertà e stranierità che mi coinvolge ad ospitarlo; in AE questo dinamismo di
ospitalità si estremizza fino a diventare quello dell’ostaggio, e della persecuzione con
la quale il Bene mi assedia e mi chiama ad uscire verso altri. Rispetto a questo mio
(sempre mio) essere consegnato e offerto preoriginalmente, «il prossimo mi concerne
prima di ogni assunzione, prima di ogni impegno consentito e rifiutato […] Mi ordina prima di essere conosciuto. Relazione di parentela “al di fuori di ogni biologia”»40. Si tratta dunque di una «fraternità» non biologica né naturale o istintiva, caratterizzata dall’obbedienza a un comando rispetto al quale io sono
«sempre in ritardo, costituito nella in-condizione in una fraternità irrescindibile: la prossimità è «l’impossibilità dell’allontanarsi […]. Nell’approche io sono di colpo servitore del mio prossimo, già in ritardo e colpevole di
ritardo. Sono come ordinato dal di fuori – traumaticamente comandato – senza interiorizzare attraverso la rappresentazione e il concetto l’autorità (altezza) che mi comanda. Senza chiedermi che cosa è essa dunque per me? Da dove viene il suo diritto di comandare? Che cosa ho fatto per essere di colpo debitore?»41.
Il debito non è coscienza del debito, o complesso di colpa (sarebbe già inserito o inseribile nel piano della rappresentazione), ma etero-affezione traumatica costitutiva, nata «in un passato più profondo di tutto ciò che sono in grado di raccogliere
attraverso la memoria, la storiografia, dominare attraverso l’a priori: in un tempo prima dell’inizio»42. E questo passato mi pressa con una estrema urgenza in cui «io non
ho tempo di fare fronte»43, sino a braccarmi, a perseguitarmi senza che io possa tro-
39
40
41
42
43
Dinamica che ricorda il «legamento di Isacco», come vedremo nel paragrafo precedente.
AE, p. 108.
Ibidem, cn.
Ivi, p. 110.
Ivi, p. 109.
236
vare un riparo, un guscio. Ostaggio è inoltre il prigioniero di guerra, come ricorda
Jacques Rolland in una nota di commento al testo di DMT44.
Se non c’è possibilità di difesa, si vive il trauma senza assumerlo, e il trauma
dell’etero-affezione in cui avviene il «disvelamento del volto», è lo stesso colpo che
«mi colpisce prima di colpirmi»45, in cui altri «sfugge alla rappresentazione; è la defezione stessa della fenomenalità»46. Il volto si rivela come «nudità–non forma– abbandono di sé, invecchiamento, morire»47. L’altro è il perseguitato e io sono perseguitato dall’altro: la «relazione bifida e bifocale»48 dello strato preoriginale moi-jepour l’autre, denota una singolarità che non si costituisce in un contesto idilliaco, ma
sempre nell’orizzonte di un trauma, nella “notte e nebbia” confinante con l’il y a, di
un non-luogo in cui si è continuamente «esposti», perché non c’è possibilità di fuga e
riparo. Se altri non è un persecutore empirico, bensì il volto la cui mortalità si disvela
nello stesso gesto in cui mi comanda di prendermene cura, è pur vero che il contesto
lessicale e l’ambientazione concettuale, in cui Levinas «mette in scena» la descrizione della relazione asimmetrica della prossimità, disegnano i tratti di un campo di
concentramento, in cui si vive in una costante situazione di insonnia, di follia e di
persecuzione.
È opportuno a questo punto segnalare e cercare di approfondire un elemento a
nostro avviso fondamentale, che cioè l’intrigo preoriginale della soggettività come
prossimità e persecuzione delinea anche i tratti di un contesto sacrificale: il sé dischiuso dalla prossimità come ossessione appare come offerta di sé per l’altro in un
«offrirsi che è sofferenza e bontà malgrado se stessa»49, e l’approche è dunque individuabile come una offerta sacrificale, espiatoria e sostitutiva, che invece di costituire un orizzonte di violenza si inverte in dono di vita e di pace, fraternità e umanizzazione. Per supportare questa interpretazione, e specificare quindi in che senso approche è sacrificio (inteso in maniera peculiare), riteniamo opportuno soffermarci sugli
elementi che costituiscono la specificità del sacrificio nell’ebraismo, e che senz’altro
devono aver condizionato l’interpretazione levinassiana.
44
«Si tenga presente che in latino “ostaggio” si dice obses e sta ad indicare l’ostaggio prigioniero di guerra», DMT, p. 191, nota.
45
Ivi, p. 110.
46
Ibidem.
47
Ibidem.
48
Ivi, p. 103.
49
AE, p. 69.
237
3. Lo schema del sacrificio talmudico e la dinamica dell’approche
Secondo Adin Steinsaltz, nonostante il Talmud babilonese dedichi un intero
Ordine ai sacrifici (l’ordine Qodashìm50), non vi si trovano spiegazioni sistematiche
di questi precetti (mitzvot)51; è tuttavia possibile individuare tre «aspetti base: il dono,
la sostituzione e l’avvicinamento »52.
Il dono consiste nella «rinuncia da parte
dell’uomo a qualcosa che gli appartiene per donarlo al creatore»53. Nella sostituzione
è in gioco invece lo stesso sacrificante, infatti: «il sacrificio offerto rappresenta un
sostituto dell’auto-sacrificio o della morte […] poiché in realtà lui stesso avrebbe dovuto essere posto sull’altare per morire»54. A questo proposito, Steisnalz ricorda che
il sacrificio non ha di per sé funzione purificatoria, se non dopo che il sacrificante
abbia fatto la teshuvah (conversione e ritorno a Dio).
Il terzo elemento, l’avvicinamento, consiste nel fatto che questo sacramento è
«un rito attraverso il quale ci si pone in relazione con il Signore […] il portare un sacrificio è un atto che mette in contatto e unisce al Signore, mentre gli uomini […]
partecipano simbolicamente a quel pasto»55. Steinsalz ricorda inoltre che la «regola
generale è che l’uomo non deve offrire un sacrificio per un peccato compiuto consapevolmente […] i sacrifici vengono offerti solo per i peccati non intenzionali»56, poiché, mentre per i peccati intenzionali l’uomo deve essere giudicato da un tribunale
terreno, e l’espiazione non può avvenire attraverso un sacrificio, per quelli non intenzionali, l’uomo, non essendo totalmente consapevole, «deve chiedere perdono [a
Dio] nel momento in cui ne diventa consapevole»57. Più sopra lo stesso Steinsalz
aveva spiegato che per quanto, dopo la caduta del Secondo Tempio, il rituale sacrifi50
Per una dettagliata ripartizione degli Ordini e dei Trattati del Talmud, cfr: A. STEINSALTZ,
Ha-Talmud lakòl, Gerusalemme 1997; tr. it. di S. Servi e D. Liberanome, a. c di S. Servi, Cos’è il
Talmud, Giuntina, Firenze 2004, pp. 349-361.
51
«Una mitzvah o precetto è un’azione attraverso la quale viene data agli uomini la possibilità
di adempiere la volontà di Dio. Questa volontà è inerente alla Creazione stessa perché Dio ha creato
un mondo che non è ancora perfetto. La ragione d’essere della mitzvah è che a noi è lasciato un compito, un lavoro che ci renderà” soci di Dio nella creazione del mondo”» (A. Green, These are the
Words, Jewish Light Publishing, Woodstock, Vermont 1999; tr. it. di R. Volponi, Queste sono le parole. Un dizionario della vita spirituale ebraica, Giuntina, Firenze 2002, p. 133).
52
A. STEINSALZT, op. cit., p. 229, ccnn.
53
Ibidem.
54
Ibidem.
55
Ivi, p. 230.
56
Ivi, p. 232.
57
Ibidem.
238
cale fosse terminato, per l’ebreo ortodosso vale ancora la regola secondo la quale
«Colui che studia le leggi dei sacrifici è come se ne avesse offerto egli stesso (TB,
Menachot, 110a)»58.
Lo schema che abbiamo brevemente presentato già permette di rinvenire una
analogia con i tratti con cui Levinas descrive la soggettività etica: dono (offerta di sé
per altri), sostituzione (l’uno per l’altro come essenza della significazione) e avvicinamento: approche. L’interpretazione spirituale del sacrificio come supererogazione
etica, come abbiamo già segnalato59, divenne comune nel giudaismo rabbinico, e in
questo senso Levinas la recepisce.
Benché il concetto di sacrificio oscilli tra due polarità, l’offerta e l’uccisione
60
, Levinas, spiritualizzandone il significato, accentua maggiormente il senso
dell’offerta di sé, tale però che essa, nello strato primario della soggettività etica, non
è mai volontaria. Si viene offerti, più che ci si offre, questo è il senso profondo della
«passività più passiva di ogni passività». E si viene offerti come sostituti espiatori,
ma non già di sé stessi, sostituendo l’animale all’auto-uccisione, bensì dell’altro, affinché l’altro non muoia. In questo consiste il profondo ripensamento della categoria
sacrificale che, disancorata da un’economia di scambio, si connota completamente di
quella della gratuità etica. Il terzo elemento, l’approche, diventa determinante, e connota praticamente il senso profondo della soggettività: essa è caratterizzata da cima a
fondo dal dinamismo di approssimazione –avvicinamento verso altri e verso l’alto,
dove questa altezza è il volto che mi ri-guarda, ma è anche l’Illeità, essendo il volto
nella traccia dell’Illeità. A rigore è proprio il Bene o l'Illeità che, attraverso il volto
del prossimo, mi comanda l’approssimarmi61:
«L’appello-comando alla responsabilità […] non mi proviene tanto dal
volto altrui inteso come soggetto che liberamente e volontariamente mi può
comandare – il che mi alienerebbe invece di individuarmi nel proprio Io – ma
58
Ivi, p. 228.
Cfr. supra, Cap. II. par. 2.
60
Come ricorda Cristiano Grottanelli, il dibattito sulla teoria del sacrificio si è incentrato su
una duplice linea, quella della teoria dell’offerta e quella della teoria dell’uccisione (C. GROTTANELLI,
Il sacrificio, Laterza, Roma Bari 1999, p. 8).
61
Notiamo incidentalmente che nella corrente traduzione italiana di AE questo dinamismo
dell’approssimarsi a («approche d’autrui») viene talvolta reso meno comprensibile dalla frequente
traduzione «approssimarsi di», laddove propriamente chi si approssima ad altri sono io, pur sollecitato
dal comando-appello del Bene attraverso il volto di altri.
59
239
dal Bene stesso, assolutamente trascendente, che mi elegge alla responsabilità
prima ancora che io possa porre degli atti di libera scelta»62.
A ben vedere, dunque, non si tratta di un sacrificar-si, dove la dimensione attiva risulti anteriore a quella passiva, ma, al di là della attività e della passività empiriche-coscenziali, di un essere sacrificato. Il soggetto, infatti, in quanto ostaggio
dell’altro, responsabile di tutto e di tutti, «non potrebbe in nessun caso essere un
“soggetto che si sacrifica”. […] Perché – come dice Cohen –, per Levinas, non lo si
ripeterà mai abbastanza, è sempre dall’altro, dopo e a partire dall’altro, che il sacrificio è inteso. Il sacrificio non dona niente, è donato, e, secondo la parola di Levinas, è
“imposto”»63.
Notiamo infatti che è lo stesso Levinas a rilevare, già nelle prime pagine di
AE, questo aspetto fondamentale di passività estrema, che tuttavia non è alienazione;
infatti egli chiarisce che, in questo essere-offerto-per gli altri del soggetto, «il Bene
riscatta la violenza della sua alterità»64, affrancando il soggetto dalla schiavitù
dell’esse e costituendolo nella sua stessa esistenza incarnata, «sacrificata più che sacrificantesi», come donare umanizzante per gli altri:
«Questo sradicamento da sé [del soggetto], in seno alla propria unità,
questa assoluta non coincidenza, questa diacronia dell’istante significa come
l’uno-penetrato-dall’altro. Il dolore, questo rovescio della pelle, è nudità più
nuda di ogni spoliazione: esistenza di sacrificio imposto – sacrificata piuttosto che sacrificantesi, perché precisamente costretta all’avversità o alla dolenza del dolore – è senza condizione»65.
Il dinamismo della soggettività, avviato dall’elezione-appello del Bene attraverso il volto, si temporalizza a partire dalla diacronia irreversibile del passato; la
«diacronia dell’istante», che costituisce il soggetto come l’intervallo o frattempo tra
passato e futuro, ha il senso di un donare incessante e infinito che riproduce la stessa
62
G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 256.
J. COHEN, Alternances de la métaphysique. Essais su Emmanuel Levinas, Éditions Galilée,
Paris 2009, pp. 84-85.
64
AE, p. 21.
65
Ivi, p. 63. Traduzione leggermente modificata.
63
240
lunghezza del tempo. Benché il termine «sacrificio imposto» sia in sé violento, non
bisogna mai intenderlo come frutto di una violenza sul piano empirico, quasi che
l’altro fosse un carnefice o un persecutore empirico, ma sempre a livello dello strato
preoriginale del me/sè all’accusativo; in questo modo, paradossalmente, la violenza
viene riscattata, tramutandosi in donazione nonviolenta di vita per gli altri, nella stessa liberazione del sé.
Certo, a questo livello, in questo strato della soggettività etica, la richiesta da
parte dell’altro si caratterizza come «smisurata»; ma, a livello empirico-coscenziale,
essa dovrà essere moderata e limitata dalla presenza, nello stesso volto di altri, del
terzo, che la tempererà permettendo peraltro anche l’amore ben regolato di me stesso
come un terzo. Tuttavia, ci pare che già a livello dello je o del moi, il termine «imposizione» o «violenza», riferiti all’affetto del Bene – che, come specifica Levinas in
un testo contemporaneo ad AE, non è mai causa empirica66 –, siano fatti valere in
senso iperbolico, sì da far supporre che solo il Bene possa comandare, imporre e violentare in modo che questo comando, imposizione e violenza si riscattino in libertà,
gratuità, nonviolenza.
La violenza empirica che io o altri possiamo patire da un persecutore in carne
e ossa, acquisterà dunque senso nella misura in cui, attraverso una resistenza nonviolenta, l’abnegazione di questo patire-per si tradurrà in una lotta contro quella stessa
violenza, in nome della «violenza» dell’imposizione del Bene che ha già riscattato il
nostro incatenamento al non senso. L’oblazione, l’essere consegnato per gli altri, sarà
dunque figura concreta dell’eidos della santità e acquisterà la funzione di riscattare
dal non senso sia il dolore di altri sia il mio stesso dolore 67.
La dinamica sacrificale appena ricordata, in cui l’approche si produce come
essere-offerto per altri e verso l’alto, è del resto confermata dallo stesso Levinas che,
come abbiamo più sopra ricordato68, in riferimento alla traduzione della Bibbia di
Buber e Rosenzweig afferma: «invece di sacrificio egli [Buber] ricorda mirabilmente
66
«A scanso di equivoci non si deve però pensare al bene come ad una causa esterna il cui effetto sarebbe la mia situazione di responsabilità. Ciò sarebbe ritornare all’ontologia. […] “La passività
inconvertibile in presente, non è semplicemente effetto di un bene, che sarebbe così ricostruito a titolo
di causa di tale effetto; proprio in questa passività è il bene, esso che, propriamente parlando, non ha
bisogno di essere e non è, se non per bontà” [UAU, p.108]» (G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit.
p. 256-257).
67
Si vedano, a questo proposito, le considerazioni svolte nel Capitolo precedente di questo lavoro (cfr. supra, III, par. 8 e 9).
68
Cfr. supra, Cap. I. par. 1.
241
l’idea della prossimità contenuta nel termine ebraico di korban traducendolo con
l’approssimarsi [approche]»69. La traduzione buberiana fa valere in korban la radice
ebraica krv(b), matrice di lemmi denotanti relazioni di prossimità70. Ricordiamo a
questo proposito il passo, su cui ritorneremo nell’ultimo paragrafo, di Enigma e fenomeno (1965) in cui Levinas scrive: «il sacrificio è la norma e il criterio
dell’approche»71.
Questa dinamica di innalzamento avvicinante in cui, nell’approche, il soggetto è coinvolto, ci fa pensare all’episodio biblico dell’ «Aqedah (legamento) di Isacco», nella interpretazione datane da Rashi di Troyes, che così traduce e commenta il
passo di Gn 22, 1-2:
«Ora avvenne che dopo queste parole, Dio tentò Abramo e gli disse:
“Abramo!” Rispose: “Eccomi”. Riprese: “prendi, ti prego tuo figlio, il tuo
unigenito, quello che ami, Isacco e vattene nel territorio di Moria, e fallo salire là in olocausto, su di un monte che io ti dirò» [Rashi commenta]: «Fallo
salire là in olocausto – Dio non gli disse: “Immolalo”. Infatti, il Santo, benedetto egli sia, non voleva che Abramo immolasse Isacco, ma soltanto che lo
facesse salire sul monte, per prepararlo come un olocausto. E dopo che egli lo
fece salire, Dio gli disse di farlo discendere»72.
Dio comanda Abramo chiamandolo per nome, e lui risponde a questa chiamata identificandosi come convocato: «Eccomi». L’invito è di far salire ed esporre a
Dio il figlio, preparandolo come un sacrificio. Jacques Rolland rileva che l’ambiguità
della radice ebraica ola, «suscettibile di generare sia “sacrificare” sia “salire”, avrebbe dato vita ad una interpretazione dell’episodio in senso sacrificale, intendendo in
questo caso sacrificio con richiesta di uccisione, mentre l’episodio andrebbe riletto a
69
«Martin Buber», in FS, p. 17.
Silvana Rabinovich fa notare che la radice ebraica krv (dove la b e la v sono due differenti
letture della lettera bet) significa «prossimità», e che quindi la traduzione buberiana, che Levinas fa
propria, denota più il carattere di santità dell’«approche» che non il carattere di sacralità del «sacrificio»; Cfr. S. RABINOVICH, Quand le dire revient de l’exil, Rue Descartes- Emmanuel Levinas, PUF,
Paris, 2006, p 103. Suggestive, in questa prospettiva, sono le considerazioni svolte da ELISABETH WEBER, «Approche: Rispa, Esther», in HERNE, pp.454-463
71
SEHH, p. 250.
72
RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi, Intr. e tr. di Luigi Cattani, Marietti, Genova 2005,
pp. 170-171, ccnn.
70
242
aprtire dal secondo significato, come se cioè «la salita-discesa indica[sse] il senso
non sacrificale dell’episodio»73. «Padre e figlio sono dunque saliti [sul monte che è
Gerusalemme] per prostarsi, prima di ridiscendere»74. Prostandosi davanti a Dio,
l’uomo «non si inchina a nulla che gli sia inferiore», ma «china il capo rinunciando a
quanto vi è della dimensione del “prendere nel “vedere”»75, dunque al carattere idolatrico della conoscenza rappresentativa di Dio stesso. La prostrazione sul monte di
Dio, come «gesto che realizza l’obbedienza […] la messa in scena della sua essenza»76, significa dunque proprio l’interruzione del carattere violento e idolatrico del
sacrificio, la sua risignificazione di offerta del figlio da parte del padre, cioè
l’instaurazione della dinamica di inversione del conatus idolatrico esibito dal gesto
della disobbedienza come visione (di Dio).
Questa suggestiva interpretazione, suggerita dal testo di Rashi, ha a nostro
avviso la capacità di porre in rilievo che nel gesto del portare in alto e scendere, interrotto dal prostrarsi, si realizza una dinamica antisacrificale, o meglio di interruzione del sacrificio proprio nello stesso gesto sacrificale. Se nel figlio si realizza
l’apertura al futuro, il korbàn come far salire e far scendere, approssimare il figlio, è
a ben vedere l’approssimarsi del padre stesso al Bene invisibile, nella sua soggettività
individuata e inquietata dalla chiamata del Bene.
Che Levinas fosse avvertito della difficoltà di una lettura equivocabile del
concetto di sacrificio in senso violento e idolatrico, può essere peraltro dedotto dalla
stessa ricorrenza in AE del termine «approche» (55 volte), molto maggiore di quella
di «sacrifice» (13 volte). L’attenzione al lessico e la scrupolosa cura con la quale Levinas organizza il suo testo, ci paiono mostrare come Levinas abbia voluto evitare la
critica di un ricorso ad una categoria afferente al «sacro», anziché al «santo», per delineare il senso più profondo della soggettività, e, se così si può dire, indicare il senso
del senso come prossimità-fraternità, figliolanza-paternità (ma anche maternità) inevadibili.
Da questo punto di vista, il riscatto del soggetto dalla dimensione egoistica
dell’essere – capovolgimento del conatus in non-indifferenza verso altri – avviene
73
74
75
76
S. PETROSINO, Il sacrificio sospeso, Jaca Book, Milano 2000, p. 30.
Ivi, p. 32.
Ivi, p. 33.
Ibidem.
243
nel foro più profondo della identità personale, e costituisce la stessa creaturalità della
persona, nella fraternità, e nella paternità-maternità dell’incarnazione personale: «La
prossimità è il soggetto che si approssima […] l’approssimarsi è precisamente
un’implicazione dell’approssimante nella fraternità»77. Il termine «implicazione» allude qui al concetto di «legame»78, inteso come alleanza che si annoda nella fraternità; infatti, poche righe dopo questa stessa affermazione, Levinas ribadisce che il soggetto come coscienza, l’Io padrone in casa sua dell’appercezione trascendentale,
«non ha alcun legame con ciò di cui ha coscienza»79.
Se la stessa carne del soggetto, che «io nome-e-cognome» sono, è dunque investita da un patire che è già offerta, lo stesso patire soggettivo consapevole potrà
essere anche risignificato (potrà, ma non è detto che lo diventi consapevolmente, certo) come senso di offerta e dono per i molteplici altri empirici (i volti in cui si mostra
il Volto invisibile), perché, a livello profondo, era già una offerta preoriginale di senso e di bontà80.
Potremmo dunque parlare, in riferimento alla dinamica dell’approche, di una
sacrificalità desacralizzata81, salvo però ricordare che una traduzione in termini teoretico-speculativi del complesso discorso di Levinas, fondato sul metodo del «dire e
disdire», si presta al rischio di una fissazione univoca di un dinamismo concettuale
che deve essere sempre mantenuto in uno statuto aporetico, anche da parte del lettore, in base al richiamo levinassiano allo «scetticismo» come costante critica imma-
77
AE, p. 102.
Ibidem, poche righe sopra.
79
Ibidem.
80
Levinas intende con «pre-originale» o «anarchico» l’anteriore all’origine che è l’Io
dell’appercezione trascendentale. Quando l’Io si costituisce come origine, è già tuttavia stato inquietato e forato dalla pre-originale elezione e investimento del Bene, e dunque dovrà, in base a questa inquietudine, usare della coscienza e della volontà con giustizia, dato che a questo livello ha da comparare, misurare, rappresentare in relazione al terzo.
81
A questo riguardo, ci sembra di condividere la prospettiva di Carmine Di Sante, che, anche
in riferimento a Levinas, oltre che più generalmente ai testi biblici (si pensi al Levitico, ad es.) e talmudici, invita a non «liquidare il linguaggio sacrificale ed espiatorio come residuo mitico senza alcun
significato» ma a riconoscervi, attraverso la spiritualizzazione del suo significato specificamente
ebraico, un valore ancora prezioso per il fondamento di un’etica e di una spiritualità non narcisista. Di
Sante individua cinque significati nel sacrificio ebraico: a) «il riconoscimento della Signoria di Dio
sulla cosa che si sta sacrificando»; b) «La comunione [verticale] con Dio», quella che abbiamo chiamato avvicinamento; c) «la comunione “orizzontale”» con gli altri. «Se la cosa è dono di Dio, essa
non può essere posseduta ma condivisa»; d) «l’instaurazione della morte dell’io», un io di dominio e
di violenza; e) «L’instaurazione della sofferenza espiatrice [come] sofferenza creatrice originaria» (C.
DI SANTE, Parola e Terra. Per una teologia dell’ebraismo, Marietti, Genova 1990, pp. 166-167).
78
244
nente al logos in cui si disdice continuamente la presunta plasticità formale guadagnata nel detto filosofico.
La cifra perturbante del lessico levinassiano sollecita d’altronde il lettore alla
stessa inquietudine dell’interrogare, richiedendo uno scavo continuo del testo e una
sua esegesi che lascino impregiudicato il suo spessore di ambivalenza come orizzonte dell’altrimenti, senza mai pretendere di fissare in una frase o in una chiave concettuale unilaterale la portata traumatizzante e sollecitante, eticamente, in esso sedimentata, ma semmai lasciandosi «inquietare» e «mantenere svegli» dallo stesso approche al testo. Sulla base del costante riferimento alla morte e miseria di altri, che è
apparsa in Auschwitz come il simbolo stesso del volto, Levinas, infatti, ricorda:
«L’umanità meno ebbra e la più lucida del nostro tempo […] non ha nella sua quiete,
altra inquietudine né altra insonnia di quelle che le vengono dalla miseria degli altri e
in cui l’insonnia non è che l’assoluta impossibilità di sottrarsi e distrarsi»82.
Il capitolo IV di AE, a nostro avviso, si comprende nell’orizzonte di questo
sfondo pre-filosofico, il trauma di Auschwitz come enorme «buco» [trou, da cui
traumatisme83] nella crosta dell’essere, e nella razionalità come storia che una coscienza universale possa totalizzare; ma sfondo e orizzonte di cui abbiamo cercato,
lungo i capitoli del nostro lavoro, di delineare la portata ineludibile per l’approssimazione al testo in cui si sedimenta il trauma e si tenta di corrispondervi eticamente.
4. La sostituzione
«Questo capitolo fu il germe della presente opera», scrive Levinas nella prima
nota al IV capitolo di AE; potremmo aggiungere che, oltre che il germe, ne costituisce il vertice e in qualche modo anche la sintesi. Già l’esergo orienta nella prospettiva del contenuto. L’autore riporta un verso di Paul Celan, precisamente della poesia
Lob der Ferne [Elogio della lontananza], tratto dalla raccolta Mohn und Gedächtnis84
82
AE, p. 116.
Cfr. supra, II. par. 2 e 3.
84
P. CELAN, Mohn und Gedächtnis, Deutsche Verlags-Anstald GmbH, Stuttgart, 1952/1982, tr.
it. di G. Bevilacqua, Poesie, Mondadori, Milano 1997, p. 51.
83
245
[Papavero e memoria] del 1952 : «Ich bin du, wenn ich ich bin» [«Io sono tu, quando
io sono io»].
Nel verso citato, il richiamo costante alla memoria della Shoah, alla quale è
dedicata la raccolta del poeta rumeno, segnala la cifra più profonda della soggettività,
la sostituzione che accade nel cuore stesso dell’io. Il fatto che Levinas abbia scelto
questa citazione, in luogo di quella, per certi versi analoga, del giovane Rimbaud
(«Je est un autre»), non è sicuramente senza ragione. Da una parte Levinas infatti
doveva avvertire una profonda consonanza con l’esperienza umana e poetica di Celan –, al quale dedica nel 1972 un profondo saggio85 –; d’altra parte, il contenuto
stesso del verso significa, più che una identificazione statica, un carattere di evento
che avviene nella soggettività, segnalato dalla congiunzione temporale «quando». La
sostituzione è implicita nella temporalità della soggettività, diacronia non sincronizzabile in cui si traduce la stessa infinizione del tempo. Inoltre la frase di Celan si presta maggiormente a rilevare il carattere di non-alienazione di questa sostituzione, carattere che invece è ancora latente nella formulazione rimbaldiana in cui sembra che
un io già costituito venga violentato da un altro a sua volta già costituito; qui, invece,
l’io e l’altro vengono costituiti originariamente e «per la prima volta» dalla stessa
dinamica della soggettività come approche-sostituzione86.
Proprio alla nozione di soggettività etica è dedicato questo capitolo fondamentale di AE, attraverso un’analisi che, se nell’economia del libro approfondisce
sino all’estremo le nozioni già delineate in precedenza, di sensibilità e prossimità,
d’altra parte inizia proprio dalla nozione di soggettività come «coscienza» e identità
di sé, che attraverso la molteplicità dei profili fenomenici cerca sempre di guadagnare il possesso dell’alterità, nel ritorno rappresentativo inglobante:
«Nella relazione con gli esseri, che si chiama coscienza, identifichiamo questi esseri attraverso la dispersione dei profili in cui essi appaiono; nella
coscienza di sé ci identifichiamo attraverso la molteplicità delle fasi temporali: come se la vita soggettiva, nelle forme della coscienza, consistesse, per
85
Paul Celan. De l’être à l’autre in «La Revue des Belles-Lettres», n°2-3, 1972, p. 193-199;
poi confluito nella raccolta Noms propres, Fata Morgana, Paris 1976, tr. it. di F.P. Ciglia, «Paul Celan.
Dall’essere all’altro», in Nomi Propri, Marietti, Casale Monferrato 1984, pp. 45-54.
86
«”Io è un altro” – ma senza l’alienazione rimbaldiana…» (AE, p. 148).
246
l’essere stesso, nel perdersi e nel ritrovarsi per possedersi, mostrandosi, proponendosi come tema, esponendosi nella verità»87.
L’identificazione della coscienza di sé avviene attraverso la mediazione del detto,
kerigma della rappresentazione, cioè di un «principio ideale» che unifica il molteplice disperso dell’apparire. Se in generale la critica di Levinas si rivolge tanto alla concezione tradizionale del soggetto come sostanza, quanto a quella idealistica del soggetto come coscienza, più in particolare questo processo – nel quale l’altro, anche
l’altro «essere empirico, è avvicinato attraverso l’idealità del logos»88–, corrisponde
alla descrizione che nelle Idee II e nelle Meditazioni cartesiane, Husserl aveva fornito dell’individuazione (sia degli oggetti materiali sia dello stesso io)89.
La coscienza intenzionale dunque non esce realmente da sé, né è attraversata
da qualcosa di radicalmente estraneo che la “ferisca” o “traumatizzi”, ma «si distanzia da sé per potersi meglio possedere. E in questo percorso della coscienza è l’essere
stesso che diviene se stesso, fino ad identificarsi o uguagliarsi totalmente con se stesso»90. L’essere stesso, l’essenza, è dunque ciò che nell’evento della coscienza intenzionale propriamente s’identifica91, che «gioca» a perdersi per subito ritrovarsi, rimanendo in realtà autoctono e proprietario, nel presente in cui sincronizza ogni sfasatura temporale: «Ciò che si compie nel e attraverso la coscienza intenzionale si offre
alla protensione, e si allontana da sé nella ritenzione per essere, attraverso lo scarto,
identificato e posseduto. Questo gioco nell’essere è la coscienza stessa: presenza a sé
attraverso la differenza che è, ad un tempo, perdita di sé e ritrovo nella verità»92.
Questo cammino di universalizzazione da parte dell’Io assoluto è però in realtà una perdita del sé e dell’altro indeclinabili, poiché li vota ad una neutralizzazione
in nome della verità anonima e disumanizzante della verità razionale. L’Io stesso,
87
AE, p. 123.
Ibidem.
89
Come sintetizza Ferretti, «Husserl sostiene che l’io è il “polo ideale” con cui identifichiamo
molteplici intenzionalità della coscienza, sia passate che future, non diversamente da come l’oggetto
intenzionale è il “polo ideale” con cui identifichiamo le molteplici percezioni, attuali o potenziali, di
un oggetto» (G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 237, nota.).
90
Ivi, pp. 237-238.
91
«Perdersi e ritrovarsi a partire da un principio ideale - da un’arché nella sua esposizione tematica: così l’essere svolge il proprio percorso di essere» (AE, p. 124).
92
AE, p. 127.
88
247
così configurato, non sarebbe veramente la vivente e carnale soggettività indeclinabile, ma sempre una «astrazione» o una maschera neutra e impersonale:
«L’identità dell’io (Je) si ridurrebbe così al ripiegamento dell’essenza
su se stessa. L’io (Je) o il se stesso che sembrerebbe esserne il soggetto o la
condizione [si pensi a Fichte o ad Hegel], il se stesso [la singola coscienza]
che si configura ente tra gli enti, si ridurrebbe in verità ad un’astrazione prelevata dal processo concreto della Coscienza di Sé o dall’«ostensione» dell’essere nella storia o nella distensione del tempo in cui, attraverso rotture e ritrovamenti, l’essere si mostra a se stesso […] Il tempo, l’Essenza, l’Essenza come tempo, sarebbe l’assoluto stesso del Ritorno a Sé. La molteplicità di soggetti unici, “enti”, immediatamente, empiricamente incontrati, procederebbe
da questa coscienza di sé universale dello Spirito: briciole di polvere raccolte
sul suo cammino o gocce di sudore che brillano sulla sua fronte, a causa del
lavoro negativo che esso avrà compiuto, momenti dimenticabili di cui non
conta che l’identità dovuta alla loro posizione nel sistema e che si riassorbe
nel Tutto del Sistema»93.
Questo passo, che in brevi tratti condensa il percorso “antitotalitario” di TI,
innestandolo nella descrizione della soggettività etica come (non)luogo di occorrenza
del senso propria di AE, mostra bene il punto debole della dinamica di inglobamento
e fagocitazione – potremmo parlare psicoanaliticamente di pulsione narcisistica o
orale – e insieme di cancellazione della molteplicità come singolarità dell’uno e
dell’altro, che è implicata nell’assunto di base dell’idealismo: l’Io come neutro che
pone se stesso e in questo atto dispiega una falsa alterità solo per ritrovarsi alla fine
del processo come proprio e appropriante frutto con-cresciuto, è un gioco che immola e sacrifica idolatricamente i nomi e i volti dei singoli, perché non riesce mai veramente ad esserne toccato o affetto. L’incontro dei singoli empirici, come quello con
l’alterità logica, in realtà non è neppure un vero incontro; a ben vedere l’Io incontra
solo Se stesso, non è capace di nascere, di separasi da sé, né di generare e donare la
vita: è eterno e mortifero, identità narcisistica incapace di relazione, se non attraverso
93
AE, pp. 129-130.
248
l’identificazione proiettiva di un sé solipsistico. Forse c’è in questo passo anche il
richiamo ai campi: la schiavitù concentrazionaria («briciole di polvere», «gocce di
sudore»), l’automatismo procedurale nel quale la ragione burocratica pare «svolgere
il suo compito», la consegna del silenzio (il silenzio di un logos autistico), l’oblio al
quale questa «coscienza di sé universale» pare consegnare i volti e i nomi delle vittime. Ma più che nelle immagini, e oltre alle allusioni che pure si possono cogliere
tra le righe, lo spessore della Shoah è sedimentato nel lessico estremamente traumatologico col quale Levinas delinea il suo pensiero.
Il cammino precedente di AE ha mostrato che l’unico modo per pensare un al
di là di questa violenza, esibita ed esplosa a partire dal logos totalitario, consiste nell’abbandonare la volontà di ritorno all’origine costituita dall’essere-coscienza; e ciò
accade quando si descrive la soggettività come in origine sensibilità e prossimità,
soggettività nella quale avviene la Passione o l’eteroaffezione traumatica e immemoriale che avvia il dinamismo dell’approche verso altri e ricostituisce il «senso» come
significazione («l’uno-per- l’altro»).
Occorrerà adesso domandarsi come sia possibile pensare questo trauma,
«Passione», trauma-passione anarchica, anzi anarchia stessa, che è persecuzione ma
che individua la soggettività come unica ed eletta per altri – nell’ approssimarsi in
cui altri la ossessiona senza che questo movimento possa mai trovar quiete, «eterno
riposo94», letargia –; e occorrerà pensarla non a partire dalla coscienza stessa, quasi
che nella coscienza si nascondesse un’origine latente a sua volta intenzionale; occorrerà, infine, anche pensare la contrazione di sé – evasione-da-sé prodotta dal traumapassione, come non riassorbibile di nuovo in una coscienza, magari spiritualizzata e
sublimata, sedata o farmacolizzata.
Questa soggettività può essere solo un’ipseità corporea e impastata di materialità, allertata e vigile, costituita dalla struttura anti-sacrificale del salire e scendere
nella responsabilità davanti e per il volto d’altri, fosse pure il persecutore.
Si tratta dunque di oltrepassare l’orizzonte della coscienza rappresentativa,
come attività e intenzionalità, libertà e dominio95; Levinas si chiede a questo punto
94
AE, p. 131.
«Il per sé della coscienza è il potere stesso che l’essere esercita su di sé, la sua volontà, il suo
principato.[…] La dominazione è nella coscienza come tale» (AE, p. 127).
95
249
come possa aver luogo questa passività e ossessione, se la coscienza come intenzionalità è la caratteristica prima del soggetto:
«Com’è possibile, nella coscienza, un patire o una Passione la cui fonte attiva non cada – in alcun modo – nella coscienza? Bisogna insistere su
questa esteriorità. Essa non è oggettiva o spaziale, recuperabile nell’immanenza per sottomettersi all’ordine – e nell’ordine – della coscienza, ma, ossessiva, è non tematizzabile e, nel senso che abbiamo definito, anarchica. È all’interno di una responsabilità che non si giustifica in forza di nessun precedente impegno – nella responsabilità per altri, in una situazione etica – che disegna la struttura meta-ontologica e meta-logica di questa Anarchia che disfa
il logos […] Come può una tale Passione avere luogo e tempo nella coscienza?»96 .
Per tentare una risposta a queste domande, Levinas elabora le nozioni di ricorrenza e di sostituzione, passando per quelle di ossessione e persecuzione, al fine
di risolvere il problema dell’individuazione o ipseità del sé.
4.1. La ricorrenza
La coscienza rappresentativa riposa sempre su una «condizione soggettiva»,
suppone cioè un’identità preliminare che si chiama me o io (moi–je). Tale identità
«ricorre» preliminarmente ad ogni momento coscienziale intenzionale tematizzante e
sincronizzante97, precedendo il ritorno a sé della coscienza senza tuttavia assomigliarvi, quasi come un «suono udibile nella propria eco»98. Gli stessi verbi pronomi96
AE, pp. 127-128. Si avverte in questa domanda l’obiezione di fondo dell’idealismo: «Come
sarebbe infatti possibile, alla coscienza che è l’orizzonte ultimo del pensiero, pensare l’impensato,
ossia ciò che radicalmente la trascende? Ed anche se ciò che la “tocca” non fosse una rappresentazione, ma un’affezione, un sentimento di gioia o di dolore, un ordine, come può esso divenire mio senza
che io ne prenda coscienza e quindi in qualche modo lo pensi o lo tematizzi» (G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 240).
97
«La ricorrenza irrescindibile de se stesso nel soggetto è anteriore ad ogni distinzione tra momenti che potrebbero offrirsi ad un’attività sintetizzante dell’identificazione e della raccolta – richiamo o attesa» (AE, p 130).
98
AE, p. 132.
250
nali con cui si designano le varie articolazioni e fasi della coscienza portano la traccia dell’io o del se stesso nel «si» che in essi ricorre99. Questo «si» però non è innanzitutto al nominativo, ma all’accusativo, accusato, ossessionato perseguitato e così
costituito significante, già a partire dai verbi pronominali che recano traccia di questa
sua estrema fissione o torsione. Il «si» che ricorre nei verbi pronominali «mantener-si
perder-si ritrovar-si»100, d’altronde, non è la prima persona grammaticale o logica, il
primo caso di una declinazione, un Io al nominativo da cui parte la serie, ma prima di
tutto un sé di una passività estrema che caratterizza la cifra della sua «creaturalità».
L’irrecusabile convocazione della responsabilità, che lo identifica, gli viene
dall’esterno: «Il se stesso non è nato di sua propria iniziativa […] Il si […] non è un
risultato, ma la matrice delle relazioni, o degli avvenimenti, che esprimono questi
verbi pronominali»101.
La ricorrenza è «più passata di ogni passato memorabile, di ogni passato convertibile in presente»102; in essa il se stesso è creatura, che tuttavia non può ritornare
alla sua origine: «creatura orfana di nascita e atea, che senza dubbio ignora il suo
creatore, perché se lo conoscesse [rappresentativamente e tematicamente] recupererebbe ancora il proprio inizio103.
Non nato di sua iniziativa, il se stesso viene costituito dalla stessa assegnazione da parte dell’altro e per l’altro; è ipostasi, persona, che tuttavia «si ipostatizza altrimenti»: «esso si annoda indissolubilmente in una responsabilità per gli altri. Intrigo anarchico, perché non è il rovescio di qualche libertà, di qualche libero impegno
preso in un presente o in un passato memorabili, né un’alienazione da schiavo, malgrado la gestazione dell’altro nel medesimo che questa responsabilità per altri significa»104.
Questa ultima affermazione significa che la creaturalità, il non essere nato di
propria iniziativa ma l’essere stato costituito dall’altro è, paradossalmente, a sua volta declinabile come «maternità». Il termine «matrice», infatti, che designa la funzio99
«Tutto ciò che suggeriscono i verbi come lasciarsi andare, consumarsi, esiliarsi, attraverso la
loro forma pronominale, non è un atto di riflessione su di sé, di cura di sé – in nessun modo atto – ma
modalità della passività che, attraverso la sostituzione è al di là di ogni passività. In sé come nella
traccia del suo esilio – vale a dire come puro sradicamento da sé» (AE, p. 174).
100
Ivi, p. 130
101
Ibidem.
102
Ivi, p. 131.
103
Ibidem.
104
Ivi, p. 132.
251
ne della ricorrenza105, indica certo il carattere preliminare in cui il se stesso si trova
rispetto ad ogni atto di coscienza o di volontà, ma si approfondisce ulteriormente
come la stessa «vulnerabilità di cui la maternità, nel suo integrale “per l’altro” è
l’ultimo senso»106.
Vulnerabilità costitutiva dunque dello strato più profondo del soggetto, quello
per empirico e pre-logico, cioè non collocato ancora nel piano dell’ordine del fenomeno e del discorso: «il se stesso non entra nel gioco di esposizioni e dissimulazioni
che si chiama fenomeno»107. Per questo, Levinas afferma che il soggetto-persona
unico e eletto, è «indeclinabile […] indicibile e quindi ingiustificabile»108, ovvero
non deducibile in base ad una arché (la coscienza universale e libera), in quanto originariamente ostaggio.
La ricorrenza è segnata dall’accusativo della persecuzione: «Vittima di una
persecuzione che paralizza ogni assunzione che potrebbe svegliarsi in esso per porlo
per sé, passività del legame [attachement] già annodata come irreversibilmente passata, al di là di ogni memoria, di ogni richiamo»109. Il sé in ricorrenza è quindi affetto
da un legame-attaccamento con cui è legato completamente, in quanto incarnazione110 intesa non in senso biologico ma schematico111, a partire da un passato della
convocazione-assegnazione-invio del Bene, non riconducibile a coscienza. Levinas
specifica che non si tratta dell’inconscio in senso freudiano, che egli interpreta come
“rimosso”, suscettibile di per sé di essere portato a coscienza:
«Qui non si tratta di discendere verso l’inconscio [inconscient] che,
definito in modo puramente negativo in rapporto al conscio, conserva la struttura del sapere di sé […], di una ricerca di sé, fosse anche smarrita su delle
vie ostruite; inconscio che resta gioco della coscienza in cui l’Analisi intende
105
«L’evocazione della maternità in questa metafora [della matrice] ci suggerisce proprio il
senso del se stesso» (AE, p. 131).
106
Ivi, p. 135.
107
Ivi, p. 130.
108
Ivi, p. 134.
109
Ivi, p. 131.
110
«Ricorrenza che è “incarnazione” e in cui il corpo per il quale il dare è possibile rende altro
senza alienare, poiché questo altro è il cuore – e la bontà – del medesimo, l’ispirazione o lo psichismo
stesso dell’anima» (ivi, p. 137).
111
«Il soggetto incarnato non è un concetto biologico. Lo schema che designa la corporeità, sottomette il biologico stesso a una struttura più alta: espropriazione…» (Ibidem).
252
assicurare la realizzazione – contro i turbamenti provocati dai desideri rimossi
– in nome delle regole stesse di quel gioco…»112.
Il rapporto di Levinas con la psicoanalisi è certamente complesso113, perché
da una parte egli ne rifiuta la concettualità, a partire dalla contestazione della visione
«pagana» dell’Edipo (che rifiutando l’onore al Padre postulerebbe invece un rapporto
concorrenziale con la madre), così come rifiuta l’idea della topologia psichica freudiana come “struttura” condizionante la libertà; d’altra parte però, come ha notato tra
gli altri Derrida114, egli utilizza frequentemente il lessico psicoanalitico: oltre al termine trauma, e, come abbiamo visto inconscio, Levinas parla dello je-moi come
«psichismo che è già psicosi», il quale patisce un’ossessione da altri tale da sfasarlo
rispetto a sé o fissionarlo115 scinderlo [Spaltung]; poco oltre parlerà di «transfert [che
è] la soggettività stessa»116, transfert come traslazione nella quale l’«a causa di» altri
dell’essere perseguitato «è già per altri» del donare.
Questo rapporto ambivalente tra Levinas e la psicoanalisi non è solo ravvisabile nel rifiuto della teoria e nella contemporanea assunzione di una certa terminologia psicoanalitica, ma forse è anche interno allo stesso modo di pensare e di scrivere
112
Ivi, p. 128, nota.
Tra gli studi specifici su questo tema segnaliamo: P. BERCHERIE –M. NEUHAUS, Levinas et la
psycanalyse. Enquête sur une aversion, L’Harmattan, Paris 2005 (che ci sembra per la verità un po’
troppo tranchant rispetto all’«incomprensione levinassiana della psicoanalisi»); G.-F. DUPORTAIL,
Intentionalité et Trauma. Levinas et Lacan, L’Harmattan, Paris 2005 (che confronta analiticamente la
struttura della soggettività etica levinassiana con la complessa elaborazione lacaniana, rilevando sorprendenti analogie); gli articoli contenuti, in un apposito dossier, nella rivista «Le Coq-Heron» n. 171,
4/2002: C. CHALIER, Désir et appel, Lévinas et la psychanalise, pp. 13-25 (molto interessante, soprattutto perché approfondisce la delineazione del desiderio in TI istituendo una triangolazione con Freud
e Bonhoeffer); M. JUFFÈ, Genèse du sujet et altérité, chez Nicolas Abrahm et Emmanuel Lévinas, pp.
26- 46 (che confronta soprattutto la la genesi della nevrosi traumatica in Abrahm con la struttura
traumatologica della soggettività levinassiana); E. LANDA, Lévinas, le rêve et la psychanalyse: une
vignette, à partir des Quatre lectures Talmudiques, pp. 57-59 (che partendo dall’analisi di un sogno
contenuta in una pagina del Talmud, mostra un caso di interpretazione psicoanalitica da parte di Levinas); M. SCHNEIDER, La proximité chez Lévinas et le Nebenmensch freudien, «Lévinas, Le Cahier de
l’Herne», a c. di C. Chalier e M. Abensour, Éd. De l’Herne, Paris 1991, 2006, pp.431-443.
114
Derrida parla di una «complicità più profonda dell’abisso che Levinas vuole mettere tra il suo
pensiero e la psicoanalisi» (J. DERRIDA, «En ce moment même dans cet ouvrage me voici», in
AA.VV., Textes pour Emmanuel Lévinas, J.-M. Place, Paris 1980, pp. 21-60; ripreso in Psyché, Éditions du Seuil, Paris 1987, pp. 159-202; tr. it. di R. Balzarotti, «In questo medesimo momento in
quest’opera eccomi», in Psyché, Jaca Book, Milano 2008, pp. 173-224; p. 218.
115
Il se stesso, nella ricorrenza è «rifugiato o esiliato nella propria pienezza fino all’esplosione e
alla fissione» (AE, p.130). È bensì vero che Levinas si riferisce qui esplicitamente alla concezione
propria della fisica atomica contemporanea, ma il termine fissione si presta anche ad evocare la scissione e disgregazione procurate dal trauma.
116
AE, p. 139.
113
253
levinassiano. È suggestiva, a questo proposito, l’ipotesi di Simon Critchley che suggerisce potersi istituire un accostamento tra Levinas e Freud (almeno il Freud di Al di
là del principio di piacere, che studia le nevrosi traumatiche di guerra ed elabora il
concetto di «coazione a ripetere»); Critchley scrive:
«Bisogna dire innanzitutto che niente, nelle intenzioni, di Levinas può
giustificare un tale accostamento, ma come molto spesso nelle sue opere le
sue intenzioni sono in contraddizione con il suo testo. A mio avviso, per ritrovare la radicalità e la possibilità stessa del testo levinassiano, bisogna leggerlo contro le sue resistenze e le sue negazioni»117.
Non si tratta, si badi, di rilevare il fatto, ovvio a chi si accosti ad AE, dell’uso
frequentissimo della negazione per determinare il concetto, fatto che Adorno giudicherebbe sospetto118 perché, come afferma Freud della Verneinug, essa nega coscientemente quello contro cui resiste inconsciamente e che in realtà vorrebbe affermare119; infatti, la modalità dello stile levinassiano è tale la negazione, e spesso la negazione della negazione, è usata per dischiudere l’ambiguità stessa nella cui tensione
irriducibile vive ogni elemento della sua concettualità, quasi che Levinas dicesse: «la
tal cosa non è così, né così, ma così e insieme non così».
Si tratta piuttosto – è questa la lettura di Critchley alla quale in parte ci siamo
anche noi inspirati lungo il nostro lavoro – di approfondire, e in un certo senso decostruire, attraverso l’accostamento alle categorie psicoanalitiche, alcune articolazioni,
dinamiche e schemi con i quali viene descritta la soggettività etica.
117
S. CRITCHLEY, «Le traumatisme originel – Levinas avec la psychanalyse», in «Rue Descartes»-Emmanuel Levinas, PUF, Paris 2006 (pp. 165-174), p. 174.
118
«Ora, in questa specie di criptoterminologia contemporanea – come vorrei chiamarla – […]
voi troverete continuamente una figura assai caratteristica: la negazione. Basta aprire un testo di Husserl o di Heidegger, per ritrovare continuamente la negazione terminologica: si dice dunque che per
amor del cielo questo concetto non è questo e quest’altro, […] per ritrovare continuamente questa
assicurazione, che un termine non è quello che si potrebbe pensare se ci si attenesse semplicemente e
un po’ ingenuamente al primo e naturale significato del termine stesso. Non posso rinunciare, in questo caso come psicologo, ad inculcarvi una certa diffidenza nei confronti di questa abitudine. In un
bellissimo testo sulla negazione Freud ci ha insegnato che in genere il gesto troppo zelante della negazione indica che proprio ciò che è negato è tuttavia presente nella realtà psicologica, celato dietro di
esso…» (T.W. ADORNO, Philosophische Terminologie, Surkamp Verlag, Franfurt a. M. 1973, tr. it. di
A. Solmi, Termonologia filosofica, Einaudi 2007, p. 24).
119
Cfr. S. FREUD, Die Verneinung (1925), tr. it. di E. Fachinelli, «La negazione», in Opere, Vol.
10, a c. di C. Musatti, Bollati Boringhieri, Torino 1978, pp. 197-201.
254
Critchley supporta la sua interpretazione in base al confronto con la prima
versione120 del capitolo, contenete frasi ed espressioni che la redazione in volume ha
ammorbidito o cancellato per renderle più omogenee con il resto dell’opera. Se già il
capitolo IV costituisce il centro e il cuore di AE, la sua prima redazione ne costituisce in qualche modo «il centro del centro»121. In essa si mostra, secondo Critchley,
«la logica traumatizzante della sostituzione, una logica assai severa, quasi masochista, dove io sono responsabile per la persecuzione che subisco, e dove io sono anche
responsabile per il mio persecutore. Nessuno può essere sostituito a me, ma io sono
pronto a sostituirmi all’altro ed anche a morire al suo posto»122.
Il termine «traumatismo originale», che in AE IV non ritrova, ma che è invece presente nella prima edizione del testo123, denota lo stesso carattere della «soggettività etica», che quindi come afferma Critchley, «si costituisce o è costituita in un
rapporto di transfert con un traumatismo originale»124.
Traumatismo che non investe solo la psiche, ma che è la signature individuante del sé come corpo proprio. Non però come una materia indeterminata segnata
da una forma determinante, infatti
«la singolarità del soggetto non è l’unicità dell’apax e che a questa
unità procurerebbe un nome proprio e un posto nel discorso. L’identità del se
stesso non è l’inerzia di una quiddità individuata attraverso una differenza
specifica ultima inerente al corpo o al carattere, né grazie all’unicità di una
congiuntura naturale o storica. Essa è nell’unicità del convocato»125.
Questo passo, che apparentemente andrebbe contro una certa enfasi che abbiamo posto nei confronti dell’esperienza individuante attraverso il trauma, sembra a
nostro avviso invece potersi leggere come un incremento del carattere di unicità del
se stesso. Esso è infatti nel movimento in-intenzionale, e non nella quiete statica di
un evento accaduto «una volta soltanto». Il trauma permane, a individuare tutto il
120
La substitution, «Revue Philosophique de Louvain», Vol. 66 (1968), pp. 487-508.
S. CRITCHLEY, op. cit., p. 171.
122
Ibidem.
123
La substitution, cit., p. 501.
124
S. CRITCHLEY, op.cit., p. 172.
125
AE, p. 131.
121
255
movimento della ricorrenza, che anche quando si inverte in sostituzione resta movimento di infinizione senza quiete, inquietudine. Il se stesso non ha un nome proprio,
ma in un certo senso è transitivamente questo nome proprio, è l’evento della nominazione propria come consegna del nome proprio alle generazioni successive; il nome
proprio non ha «un posto una volta per tutte nel discorso», inteso come logos statico,
ma inaugura il discorso come significazione. E lo continua a inaugurare sempre e per
sempre, dal momento in cui viene consegnato a quando viene trasmesso e sopravvive, nell’al di là della propria morte, nel prossimo. Si diviene sempre più propri
nell’espropriarsi sempre di più per gli altri. Questo meccanismo di equivocazione
infinita, a partire dall’altro che è il «primo venuto», continua a permanere nel dinamismo della consegna di sé senza mai fissarsi sulla propria tomba, come su una lapide condannata all’oblio. L’individuazione inoltre non dipende da una qualità distintiva che ne farebbe un unicum, perché questa qualità, in quanto riposante su un polo di
universalità anonima (la materia), farebbe sì che quel polo di universalità precedesse
la costituzione del sé; la signature stessa non è dunque né forma né materia, ma
evento del trauma subito che individua il sé, contrae tutto il sé e così lo riscatta in
dono offerente, in «dono del potere del dono», in generazione e bontà senza quiete,
come nella stessa corporeità propria.
Ma «il corpo non è solamente l’immagine o la figura; è innanzitutto l’in sé
stesso e la contrazione dell’ipseità»126. E in nota, Levinas scrive: «Il corpo non è né
l’ostacolo opposto all’anima, né la tomba che la imprigiona, ma ciò attraverso cui
essa è la suscettibilità stessa – ciò che si ferisce e si immola, - il Sé»127. Nel testo della nota di AE, a queste parole si aggiunge:
«Passività estrema dell’incarnazione – essere esposto alla malattia, alla sofferenza e alla morte, è essere esposto alla compassione e, Sé, al dono
che costa. Al di qua dello zero dell’inerzia e del nulla, nel deficit d’esser in sé
e non nell’essere, precisamente senza luogo dove posare il capo, nel non luogo e, così senza condizione, il se stesso si mostrerà portatore del mondo – il
126
127
La substitution, cit., p. 496; AE, p. 136.
La substitution, cit., p. 496 nota.
256
portante, il sofferente, fallimento del riposo e della patria, e correlativo della
persecuzione – sostituzione all’altro»128.
Il sé esiliaco, che nella ricorrenza è coazione non schiavistica ma liberante,
nella sua propria e indeclinabile corporeità è abitato da questo immemorabile dinamismo del sopportare come donare; è creaturalità come pura bontà, «dono che costa»
appunto, poiché senza alcun tipo di possibile contraccambio: «Nel soffrire attraverso
la colpa dell’altro affligge il soffrire per la colpa degli altri – il sopportare: il per
l’altro conserva tutta la pazienza del subire imposto dall’altro»129.
Questa delineazione della soggettività etica, già prima di essere ulteriormente
delineata come sostituzione, è caratterizzata a partire dalla ricorrenza, come legata
dal trauma originale e ossessivo che gli proviene da altri – e attraverso altri
dall’Altro (l’Illeità, il Bene) –; legata, anzi costretta in una legatura o legamento che
la avviluppa totalmente, come corpo proprio contratto e fissionato nella sofferenza,
in sé infinitamente e inarrestabilmente sfasato, scisso ed esplodente per altri.
L’abbiamo già scoperta come «se stesso», unico e indeclinabile ed eletto, matrice preliminare di ogni azione e relazione di sopportazione, maternità e generatività,
senza a sua volta essere origine o arché (coscienza come principio), ma radicalmente
ostaggio perseguitato. Ora leggiamo:
«nella esposizione alle ferite e agli oltraggi, nel sentire della responsabilità, il se stesso è provocato come irrimpiazzabile, come votato, senza dimissioni possibili, agli altri e, così, come incarnato per l’ “offrirsi” – per soffrire e per dare – e così unico e di colpo nella passività […] uno ridotto a sé
come contratto come espulso in sé fuori dall’essere»130.
Riteniamo i precedenti termini posti in corsivo come riferibili tanto
all’immagine di un deportato, quanto a quella del padre-attraverso-il-figlio
nell’episodio biblico del «legamento di Isacco». In esso, a ben vedere, si compie il
128
129
130
AE, p. 136.
AE, p. 158.
AE, p. 132.
257
transfert del padre e del figlio131: esponendo il figlio come suo unico e amato, il padre a ben vedere espone se stesso in ciò che ha di più profondo, nella sua stessa generatività; e innalzandolo al di sopra del meccanismo di morte dell’essere, lo genera
veramente come libero. Nell’obbedienza del padre, il figlio è liberato dal dominio
egoistico dell’essere, reso a sua volta capace di oltrepassare tale meccanismo di morte e di creare a sua volta la vita; il figlio, legato, costretto, offerto ed esposto, innalzato e fatto scendere (inspirazione ed espirazione del polmone, anfibolia del sé stesso)
è dunque costituito in sé come donato che dona.
La violenza della costrizione del Bene si riscatta e si muta in nonviolenza dell’umanizzazione, e la stessa relazione che dal Bene, attraverso il padre, va al figlio è
l’inversione della sacrificalità mortifera in dinamica dell’approche come matrice di
ogni relazione umana e umanizzante, altrimenti che nel gesto biologico della perseveranza agonica e allergica dell’essere.
Il figlio unico e insostituibile, paradossalmente, è così in grado di sostituirsi:
nell’approche il sé è fatto nascere come creatura unica e riscattata-liberata rispetto
all’esse; costituita come ipseità indeclinabile, matrice di senso, come sopportante
l’intero universo132 e dono di senso umanizzante ai rapporti umani – «possibilità di
ogni sacrificio per altri»133; sostituzione, come nodo che annoda e ripara senza fine la
rete di rinvii che articolano la nuova grammatica e sintassi – etica – dell’essere in un
senso autrement da quello della raccolta/radura luminosa (Lichtung) e mortifera
dell’essenza.
131
E notiamolo, ciò che si mostra in questa «scena primaria», costituita dal «legamento di Isacco», è la completa antitesi del complesso edipico freudiano, dove padre e figlio sono concorrenti – in
un rapporto ambivalente di amore e odio – per ottenere libidicamente la madre.
132
«Sopportare l’universo – carico opprimente ma disagio divino» (AE, p. 154).
133
AE, p. 144.
258
4.2. Responsabilità, sostituzione, espiazione
Continuando la sua esposizione, Levinas si domanda se questa ricorrenza,
«questo ripiegamento passivo non coincida con la passività anarchica dell’ossessione»134.
A differenza degli enti, che sono identificati attraverso il «kerigma del logos»
ordinatore, che richiama sotto la categoria unificante il molteplice della materia individuandolo come fenomeno, nell’ossessione il soggetto è individuato precategorialmente come «accusato». È dunque un sé all’accusativo, talmente accusato da essere
«ridotto a se […] nella sua pelle135». Ma questa contrazione esasperata
dell’ossessione, lungi dal ridurre il sé a «un punto zero […] come se la soggettività
del soggetto non significasse niente»136, lo espropria e lo fa «svuota[re] fino a perdersi»137, fino all’espulsione da sé, e così lo rende sostituzione per l’altro:
«L’ingombrarsi da sé e la sofferenza della costrizione nella propria pelle, meglio delle metafore, seguono il tropo esatto di un’alterazione dell’essenza che si sovverte – o
si inverte – in una ricorrenza in cui l’espulsione di sé è la sua sostituzione
all’altro»138
La ricorrenza dunque è «l’ultimo segreto dell’incarnazione del soggetto139»,
«soggettività di una passività senza fondo, tessuta di convocazione […] Passività del
trauma, ma del trauma che impedisce la propria rappresentazione, del trauma assordante che recide il filo della coscienza che avrebbe dovuto accoglierlo nel suo presente: passività della persecuzione»140. Ma per essere denominata «integrale o assoluta», questa passività deve essere tale che «il perseguitato sia in grado di rispondere
del proprio persecutore»141.
È molto importante rilevare come in queste pagine il volto dell’altro si caratterizzato non più soltanto come indigenza del bisogno e altezza che comanda (come
accadeva in TI), ma anche come «malvagità» che costringe il soggetto a contrarsi a
134
135
136
137
138
139
140
141
Ivi, p. 137.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, pp. 138-139.
Ivi, p. 139, cn.
Ibidem, cn.
259
tal punto in sé da diventare unico, di nascere come unico su cui grava il peso di tutta
la violenza dell’«universo», e dunque anche del persecutore142; leggiamo infatti:
«Il volto del prossimo nel suo odio persecutore può, attraverso questa
malvagità stessa, ossessionare pietoso [obseder pitoyable – tale da suscitare
pietà] – equivoco o enigma che senza sottrarsi, solo il perseguitato privato di
ogni riferimento (in quanto privato di ogni ricorso e di ogni soccorso – ed è
questa la sua unicità e identità di unico!) è in grado di sopportare»143.
Ritroviamo in questa frase le stesse descrizioni che la letteratura concentrazionaria riserva agli internati dei lager, e possiamo certo ricordare le frasi analoghe
con le quali lo stesso Levinas aveva delineato nei Carnets la condizione di prigionia
144
, caratterizzata da isolamento e riduzione allo stato zero dell’umano. Levinas sem-
bra suggerire che è proprio questa condizione di estremo abbandono e derelizione a
non essere insignificante, ma a costituire la stessa origine della significazione. Siccome il soggetto etico sopporta tutto, nel sostituirsi (ri)significa tutto in maniera nuova; la sostituzione quindi è «la significanza145 stessa della significazione»146.
La condizione del perseguitato, dell’internato, del deportato è, ci pare, la
messa in scena della struttura eidetica in cui si mostra il nucleo profondo dell’umano
come relazione asimmetrica, quella soggettività etica traumatizzata in grado di sostituirsi per prima, di portare la responsabilità dello stesso persecutore. Il transfert già
accennato, in cui avviene il passaggio dalla persecuzione subita alla responsabilità
per il persecutore, dall’ «a causa di-» al «per-» o «a vantaggio di», in cui cioè
l’«ossessione si inverte in espiazione», è lo strato profondo della soggettività, il nu142
Su questo elemento si appunta la critica di Paul Ricoeur, che scrive: «Il parossismo
dell’iperbole mi sembra dipendere dall’ipotesi estrema – e perfino scandalosa – che l’Altro non è più
qui, il maestro di giustizia, come in Totalità e infinito, ma colui che offende, il quale, proprio in quanto tale, non postula meno il gesto che perdona e che espia» (P. RICOEUR, Soi-même comme un autre,
Éditions du Seuil, Paris 1990; tr. it. di D. Iannotta, Sé come un altro, Jaca Book, Milano (1993) 20054
p. 454). Questa affermazione ci pare doversi temperare con la considerazione per la quale l’altro qui
non è l’altro empirico, ma altri, il volto, che è insieme paradossalmente il persecutore e il perseguitato. Solo con l’avvento del terzo si può disambiguare questo statuto paradossale di altri, ed esercitare la
“giusta misura” nell’iperbole.
143
Ibidem, ccnn.
144
Si veda più sopra, nel Cap. I, i paragrafi dedicati alla descrizione della condizione dei prigionieri ebrei nei campi.
145
E anche l’origine pre-originale.
146
AE, p. 124.
260
cleo di bontà e creaturalità costitutiva della persona indeclinabile, che la pone nella
relazione originaria come origine (passiva) della relazione con gli altri.
Malgrado le accuse di masochismo che sovente si rivolgono a questa prospettiva levinassiana, dobbiamo notare che qui non si tratta né di una «fusione della pulsione di morte con la libido rivolta contro il soggetto che la esprime», né del «rivolgersi sul soggetto di un sadismo originariamente eterodiretto»147: se il detto di questo
dinamismo potrebbe dare l’impressione di una pulsione autodistruttiva o di ricerca
della sofferenza, dobbiamo ribadire ancora una volta che, a questo strato della soggettività – propriamente parlando, non tematizzabile ma ostensibile solo in termini
etici – la stessa dimensione corporea e pulsionale è completamente segnata dal paradossale movimento di contrazione-esplosione innescato dalla accusa-convocazione
immemoriale. La «nascita latente» della soggettività non si pone a livello della struttura psichica cosciente, e neppure al livello di un «inconscio» caratterizzato dalla fusione tra pulsione di morte e pulsione libidica, come pensa Freud: la soggettività, entro il suo nucleo profondo, è e rimane relazione con la vita e promessa di vita, e la
sofferenza – l’essere offerto nel portare la responsabilità d’altri – è lo schema stesso
della vita generativa come relazione umanizzante.
Se quindi la soggettività come intenzionalità
«si fonda sull’autoaffezione in quanto auto rivelazione, origine di un
discorso impersonale. La ricorrenza del sé nella responsabilità-per-gli-altri,
ossessione persecutrice, va al contrario dell’intenzionalità, tanto che la responsabilità per gli altri non potrebbe mai significare volontà altruista, istinto
di “benevolenza naturale”, o amore [pulsione erotica]»148.
L’individuazione della soggettività, unica e indeclinabile – al punto che gli
stessi nomi con cui la si designa (io, me, soggetto) sono solo «pro-nomi» e maschere
prese in prestito dall’essere per poterla dire – gli viene dall’esteriorità dell’altro, ed è
già inscritta nel dinamismo della sua ricorrenza, anteriore ad ogni presa di coscienza
successiva che la costituirà poi bisognosa di limitare e comparare questo «dovere che
147
Le due definizioni tra virgolette caratterizzano rispettivamente il masochismo primario e secondario (Cfr. voce «masochismo», in U. GALIMBERTI, Dizionario di psicologia, Utet, 2006, p. 556).
148
AE, p. 140.
261
si fa debito»149, di ritenerlo sproporzionato e meritevole di ripresa in rispetto di sé e
«giustizia per sé».
Sarebbe dunque erroneo pensare che tale sofferenza sia istinto di morte masochistico (inserito nel meccanismo biologico pulsionale) o, peggio, volontà cosciente
di punizione. Per illustrare questa dinamica, Levinas cita un passo biblico, tratto da
Lamentazioni 3, 30: «Presenti la faccia a chi lo percuote e sappia saziarsi anche di
oltraggi»; l’autore specifica che questo «chiedere nella sofferenza subita altra sofferenza»150 non significa «far intervenire l’atto che sarebbe l’esposizione dell’altra
guancia»151. Non si tratta di un gesto volontario, e nemmeno involontario, ma di una
dinamica «anteriore alla libertà e alla non libertà» che individua il sé come unico:
«La persecuzione non viene ad aggiungersi alla soggettività del soggetto e alla sua
vulnerabilità; essa è il movimento stesso della ricorrenza. La soggettività come
l’altro nel medesimo – come ispirazione – è la messa in questione di ogni affermazione “per sé”»152.
Lo strato profondo della soggettività è dunque la responsabilità come «l’essere in questione sotto forma di esposizione totale all’offesa»153. La nozione di responsabilità non deve qui essere intesa come la risposta di un soggetto già costituito davanti ad un prossimo già costituito, ma come la stessa dinamica che fa nascere il
soggetto come in grado di far nascere, e che individua l’altro come altro da sé già
come bisognoso di essere preso in carico e messo al mondo.
Una definizione della struttura della responsabilità viene data da Levinas nelle pagine iniziali di AE, a partire dalla modalità del darsi dell’Infinito:
«Tuttavia gli attributi negativi che enunciano l’al di là dell’essenza,
divengono positività nella responsabilità, risposta che risponde a una provocazione non tematizzabile, cioè non-vocazione, trauma; ma rispondente prima
di ogni comprensione, di un debito contratto prima di ogni libertà, prima di
ogni coscienza, prima di ogni presente; ma risposta che risponde come se l’invisibile che si assenta dal presente [se passe de présente], lasciasse una trac149
150
151
152
153
Ivi, p. 137.
Ivi, p. 139.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
262
cia per il fatto stesso di assentarsi dal presente [de se passer de present].
Traccia che risplende come volto del prossimo nell’ambiguità di colui davanti
al quale (o al quale, senza paternalismo alcuno) e di colui del quale io [je] rispondo, enigma o eccezione del volto, giudice e parte»154.
Si noti che la responsabilità viene detta al gerundio («rispondendo»), dunque
si tratta di un evento temporale, di un presente transitivo temporalizzato a partire da
un passato immemorabile in cui avviene la convocazione obbligante, e costituente, in
questo stesso dinamismo del rispondere, la prosecuzione del dinamismo di bene della
creatura-investita dall’elezione del per-altri.
La struttura (quasi) formale della responsabilità è così costituita: si tratta di
un rispondere davanti al volto, al volto, e del volto, il quale volto è ambiguamente
insieme giudice e parte in causa. Dunque la responsabilità non è solo imputazione, o
imputabilità da parte dell’altro, ma anche nello stesso tempo assegnazione
dell’obbligo di difesa dell’altro: Io (nome e cognome proprio) avvengo come imputato dal e difensore del prossimo. La soggettività come responsabilità-approche è appunto questa ambiguità di essere da una parte in colpa-davanti-a, e imputato daparte-di, e insieme (nello stesso frat-tempo) in difesa del prossimo: di essere fra. Ecco la sostituzione: l’inversione dell’a causa di in per l’altro: la biffure dell’uno unico
per l’altro; dove l’uno-unico si barra155 senza scomparire o cancellarsi, ma proprio
sottoscrivendosi, e l’altro appare inscritto e sovrascritto all’uno e unico: il per- è la
biffure stessa, nel suo carattere diacronico e dia-topico.
«Sostituzione» implica anche l’inversione di persecuzione in espiazione, con
tutti i concetti implicati in questo termine, nel contesto ebraico: purificazione, eliminazione del peccato, annullamento di una sentenza, perdono, riconciliazione, propiziazione etc.156. La soggettività etica, come uno-per-l’altro, è temporalmente questo
154
AE, p. 26, tr. modificata.
Non abbiamo trovato una traduzione italiana precisa per rendere il termine francese; proponiamo il termine ‘barratura’, in cui ‘barrare’ è l’atto con cui si traccia una linea sopra una parola in
modo tale che essa si possa ancora leggere.
156
Il termine espiazione, nella tradizione d’Israele, è connesso indissolubilmente al concetto di
sacrificio, implica perdono e riconciliazione verticale ed orizzontale, cancellazione delle colpe e ricostituzione di un rapporto di alleanza, redenzione, come è significato nella festa principale del giudaismo: «Lo yom kippùr, il giorno dell’espiazione, è nel giudaismo la “festa delle feste” perché riassume
e simbolizza l’intero ebraismo e la sua ontologia paradossale[…] Di origine postesilica, il testo biblico
fondamentale che fissa il significato e la modalità della festa è il capitolo 16 del Levitico […] il v. 30:
155
263
fra-tempo, intervallo e interim in cui passa l’infinito: l’approche-responsabilitàsostituzione, dove l’io indeclinabile avviene come il frat-tempo che si costituisce
man mano che risponde e «si allontana man mano che si approssima», senza mai riprendersi o coincidere con l’altro perché la risposta è infinita, è traduzione, testimonianza, segno della rivelazione del Dio invisibile157. Levinas scrive, a questo riguardo:
«positività della responsabilità che traduce l’Infinito, ne permette il
passaggio, sconvolgendo l’ordine dell’interessamento [dell’essere come conatus essendi egoistico e autistico]: man mano che sono prese, le responsabilità si moltiplicano. Non si tratta di un sollen che comanda la ricerca
all’infinito di un ideale. L’infinità dell’infinito vive all’indietro [à rebours]. Il
debito si accresce nella misura in cui esso si salda. Scarto [frattempo, contrattempo] che merita forse il nome di gloria [la modalità del darsi-assentarsi
dell’Infinito]. La positività dell’Infinito è la conversione in responsabilità,
nell’approche ad altri, della risposta all’Infinito non tematizzabile, oltrepassante gloriosamente ogni capacità, manifestante, come in controsenso, la sua
dismisura nell’approche al prossimo, che obbedisce alla sua misura. La soggettività al di qua o al di là del libero e del non libero – obbligata nei confronti del prossimo – è il punto di rottura dell’essenza, ecceduta dall’Infinito»158.
“In quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi”. Letteralmente: “poichè in quel giorno sarà fatta
propiziazione per voi (yekapper ‘alekhem) per purificarvi (letaher)”. Yekapper deriva dalla radice kpr
che al piel vuol dire “togliere”, “cancellare”, “pulire”, “lavare”, “detergere”, “coprire”, “eliminare”,
“mondare”, “estirpare”, “annullare una sentenza”, “ritirare una denuncia ecc.» (C. DI SANTE, Parola e
terra, cit., pp. 151, 153).
157
È abbastanza facile scorgere dietro questa ambientazione un chiasma tra l’episodio biblico
del passaggio di Dio come “epifania” della Gloria in Es 33, 18-23 e il «legamento di Isacco» di Gn 22,
2-23: [Mosè] gli disse, mostrami il tuo Kavod [la tua Gloria]. Rispose, “farò passare davanti a te tutto
il mio splendore e proclamerò il mio Nome: Signore davanti a te”[…] e soggiunse: “ma ma tu non
potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi erestare vivo”. Proseguì il Signore, “ecco
un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, e quando passerà il mio Kavod, io ti porrò nella cavità
della rupe e ti coprirò con la mano, finchè sarò passato. Poi toglierò la mia mano e vedrai le mie spalle
(mi vedrai dopo, in ritardo, di dietro, come traduce Paolo De Benedetti) ma il mio volto non si può
vedere»; qui il passaggio sulla rupe è segnalato dal rapporto con l’anteriorità, con il ritardo irrecuperabile, con la visione del «dietro» che avvia una spazialità diatopica tutta coestensiva con una temporalità diacronica. Il Legamento di Isacco si muove parimenti tra la chiamata da parte di Dio la riposta
individuante di Abramo: «hinneni», [eccomi]. Per Levinas, «la parola Io significa eccomi, rispondente
di tutto e di tutti» (AE, p. 143). Sull’evocazione del passo di Es 33, cfr. «La traccia dell’altro», in
SEHH, p. 233.
158
AE, pp. 126-127. tr. modificata, cc.n.
264
Chiarito in che senso Levinas intenda responsabilità, comprendiamo anche
che la sofferenza che caratterizza preoriginalmente il se stesso non può mai essere
masochismo, patologia egoistica dell’inversione di un odio originario dell’altro in
odio di sé; il se stesso è totalmente sotto la cifra dell’amore159, affezione da parte
dell’altro e per l’altro come apertura del tempo delle relazioni umanizzanti, temporalizzazione di una temporalità «a misura» dell’«altro uomo».
In questa sofferenza offerta, che mai dunque è masochismo, ci pare che Levinas rilegga in modo originale il tema ebraico della sofferenza per amore160. Di Rabbi
Aqiba è detto nel Talmud che «è stato messo a morte in quanto segno, secondo le
parole: Così Ezechiele sarà per voi un segno; quando ciò si produrrà…voi saprete
che Io sono il Signore YHVH (Ez 24, 24)161. La sofferenza viene accetta dal pio
israelita come offerta espiatoria e insieme segno profetico della presenza (assente:
Gloria) di Dio, benché possa essere, e sia talora di fatto interpretata dagli altri come
sacrificio autoimposto162. Levinas poteva trovare anche in Hermann Cohen, autore
che con lui condivideva la doppia appartenenza al mondo dei filosofi e a quello dei
giudaisti, la descrizione del valore messianico e riconciliatorio della sofferenza, descritta dal filosofo tedesco in questi termini: «La sofferenza è la condizione preliminare della redenzione. Questa è però la liberazione da tutte le scorie della dimensione
empirica dell’uomo e l’innalzamento al momento ideale in cui l’uomo si trasforma in
Sé»163.
Levinas specifica sempre, però, che la sofferenza, costituente il se stesso come «per-altri», non ha affatto un valore magico: «non si tratta di trarre dalla sofferen159
Per quanto Levinas non usi frequentemente questo termine, talora esso viene usato con la
giunta di «senza concupiscenza», per denotare il carattere non erotico-fusionale o istintivo-biologico
di questo dinamismo etico.
160
Una trattazione approfondita di questa tematica, attraverso l’analisi e la discussione delle
fonti rabbiniche, ci porterebbe troppo lontano dall’oggetto proprio del nostro studio; rimandiamo perciò al monumentale lavoro di EPHRAIM E. URBACH, Les sages d’Israël. Conceptions et croyances des
maîtres du Talmud, tr fr. dall’ebraico di M-J. Jolivet, Cerf-Verdier, Paris 1996, in particolare le pp.
459-465.
161
Ivi, p. 460.
162
Ivi, p. 461.
163
H. COHEN, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Nach dem Manuscript des
Verffassers neu durchgearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Bruno Strauss, Frankfurt a.
M., Kauffmann, 1929, tr. it. di A. Poma, Religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo, San Paolo,
Milano 1994, 356-357. Per uno studio comparativo del pensiero di Levinas con quello di Cohen, cfr.
R. GOETSCHEL, «Levinas et Hermann Cohen. Du Myte à la sainteté», in AA.VV., Emmanuel Levinas.
Prophetic Inspiration and philosophy, Atti del Convegno internazionale per il Centenario della nascita
(Roma, 24-27 Maggio 2006), a c. di I. Kaion, E. Baccarini, F. Brezzi, J. Hansel, Giuntina, Firenze
2008.
265
za una qualche virtù magica di riscatto»164, si tratta invece di «passare, nel trauma
della persecuzione, dall’oltraggio subito alla responsabilità per il persecutore e, in
questo senso, dalla sofferenza [in qualche modo vista ancora come “per sé”] alla
espiazione per altri»165.
Il soggetto individuato come unico, è ostaggio [otage] e posseduto [obsedée
de responsabilités, dal latino obses: ossessionato da altri, ma anche prigioniero di
guerra166] – senza essere mai, si badi bene, “in grado di” assumere coscientemente
questa persecuzione167 – ma è anche tale, proprio in quanto ostaggio, da essere il sostituto, di farsi cioè carico, in virtù di questo stesso trauma persecutorio, della violenza del persecutore.
La persona umana indeclinabile, alla quale ognuno può riferirsi come la sua
propria168, è segnata da una responsabilità che non può essere delegata ad altri né
esigita come reciprocabile, il che significherebbe «predicare il sacrificio umano»169.
Tale soggettività non è ontologica ma etica, e dal punto di vista ontologico
non è né pensabile né sensata: è precisamente al di là del senso rappresentativo, essendo, proprio così, matrice di un senso altro dal piano logico-ontologico. Dal punto
di vista logico essa è infatti paradossale, perché non ha la struttura formale dell’identità come dell’A=A, uguaglianza del riposo di un io che eguaglia se stesso ritornando
in sé, ma è una «unicità senza identità»170 un «sé sfasato da sé»171, una scissione senza alienazione (poiché proprio questa passività da parte dell’altro mi costituisce come
libero dal meccanismo anonimo dell’essere, nello stesso gesto del costituirmi come
servitore e generatore della vita di altri). Identità paradossale che solo se la si com164
AE, p. 139.
Ibidem.
166
Cfr. DMT, p. 191.
167
Nelle lezioni alla Sorbonne (1975-76), di poco successive alla pubblicazione di AE (1974),
Levinas specificherà ulteriormente che questo dare che è dire «è un modo di consegnarsi. Tale consegnarsi non è l’esito di un impegno preliminare, di una responsabilità misurata, ma è quanto si esprime
nella parola ostaggio. Che vuol dire sostituzione» (DMT, p. 247, cn).
168
«L’identità del soggetto che emerge è di carattere talmente singolare che ciascuno può ritenere tale accusa e responsabilità unicamente riferita a sé, come dell’unico e dell’eletto» (G. FERRETTI,
Il bene al-di-là dell’essere. Temi e problemi levinassiani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma
2003).
169
«Identità non di un’anima in generale, ma di me, poiché solo in me l’innocenza può essere
accusata senza assurdità. Accusare l’innocenza dell’altro, domandare all’altro più di quanto egli deve,
è criminale (AE, p. 141-142, nota); e ancora: «L’io della responsabilità è me e non un altro, io a cui si
vorrebbe accoppiare un’anima gemella dalla quale si esigerebbe sostituzione e sacrificio. Ora, dire che
Altri deve sacrificarsi agli altri, sarebbe predicare il sacrificio umano» (AE, p. 159).
170
AE, p. 72.
171
AE, p. 144.
165
266
prendesse a livello tematico o empirico sembrerebbe schizofrenica: poiché esplode
nello stesso momento che implode, certo, ma per annodarsi in relazione o religione172, e fondare, in quanto significazione e comunicazione originaria, ogni possibile
comunicazione e significazione empirica.
Non si tratta dunque, nella soggettività così delineata, della coscienza trascendentale, dell’Io, o dell’Esserci costituito heideggerianamente come Cura, ma proprio
della loro «preistoria», quella in cui la soggettività è tessuta da cima a fondo di approche-sostituzione-responsabilità:
«Perché Altri mi riguarda? Che è Ecuba per me? Sono io il custode di
mio fratello? – queste domande non hanno senso se si è già presupposto che
l’Io ha cura solo di sé, se è solo cura di sé. In questa ipotesi, in effetti, resta
incomprensibile come il fuori-dall’Io assoluto – Altri – mi riguardi. Ora, nella “preistoria” dell’Io posto per sé, parla una responsabilità. Il sé è da cima
a fondo ostaggio, più anticamente dell’Ego, prima dei principi. Non si tratta
per il Sé, nel suo essere, di essere. Al di là dell’egoismo e dell’altruismo c’è
la religiosità di sé»173.
Proprio in riferimento alla sostituzione come struttura della soggettività, Levinas approfondisce la critica ad Heidegger, soprattutto in DMT e in Morire per174, in
cui parla esplicitamente di «etica del sacrificio» che si qualifica «non [come] una
vita post-mortem, ma la dismisura del sacrificio, la santità nella carità e nella misericordia175.
172
Levinas riprende l’etimologia di religione dal verbo latino religare, come relazione asimmetrica che mette in contatto i separati senza che tale contatto li dissolva in unità, ma anzi che li costituisce separati proprio «assolvendoli» nella relazione.
173
Ivi, p. 148.
174
In TN, pp. 233-244.
175
«L’etica del sacrificio non arriva a scuotere il rigore dell’essere e dell’ontologia
dell’autentico. […] Il sacrificio non saprebbe trovare luogo in un ordine diviso tra l’autentico e
l’inautentico. La relazione ad altri nel sacrificio in cui la morte dell’altro preoccupa l’esser-ci prima
della propria morte, non indica forse proprio un al di là dell’ontologia – o un prima dell’ontologia –
determinando – o rivelando – una responsabilità per l’altrop e tramite essa un ‘io’ umano che non è
l’identità sostanziale di un soggetto, né l’Eigentlichkeit nella ‘meteità’ dell’essere. L’io di colui che è
eletto a rispondere è così identico a sé e così il se stesso.[…] non una vita post-mortem, ma la dismisura del sacrificio, la santità nella carità e nella misericordia» (TN, p. 243).
267
Mentre per Heidegger «la possibilità della morte è per l’esserci […] la sua
possibilità più propria […], incedibile[…], isolante [ed] estrema»176, per Levinas la
soggettività è immemorialmente affetta dalla morte dell’altro, e costituita così nella
relazione originaria con l’altro proprio nella morte: «La morte, la morte d’altri – è
l’emozione per eccellenza, l’affezione per eccellenza»177, «un’affezione più passiva
di un trauma […] passività al di là dello shock. Fissione più urtante [affectante] della
presenza, a priori più a priori»178, e per nulla «un sapere di seconda mano»179.
Il riferimento diretto rispetto al quale Levinas interpreta questo nuovo rapporto con la morte d’altri è il paragrafo 47 di Essere e tempo, in cui la sostituzione rispetto al morire di altri, il sacrificio per altri, è vista come modo inautentico e deiettivo della possibilità per l’esserci di essere un tutto. Questa sostituibilità o sostituzione,
secondo Heidegger, non può infatti mai avvenire per l’esserci in se stesso, nella sua
autenticità, ma sempre in un certo senso in una forma secondaria, nella modalità quotidiana dell’esserci in quanto «essere assieme presso le cose»; in questo senso inautentico, dice Heidegger, in qualche modo «qui è possibile che l’esserci sia l’altro».
Ma se si intende questa sostituzione come assunzione del morire dell’altro
nella propria stessa ipseità, allora per l’esserci ciò non può avvenire. Si può solo «sacrificarsi per l’altro in una data cosa, mai sacrificare se stesso per l’altro, morire la
morte dell’altro»180. Per Levinas, invece «la morte d’altri che muore mi intacca [affecte] nella mia stessa identità di io responsabile – identità non sostanziale, non semplice coerenza dei diversi atti di identificazione. È il mio essere intaccato [affection]
176
DMT, p. 94.
DMT, p. 50.
178
Ibidem.
179
IIbidem.
180
«Tra le possibilità di essere assieme [Miteinandersein] nel mondo c’è certamente anche
quella della sostituibilità [Vertretbarkeit] di un Esserci con un altro. […] Conformemente al suo senso, tale sostituzione è però sempre una sostituzione [Vertretung] “in” [in] e “presso” [bei] qualcosa,
cioè nel prendersi cura di qualcosa. L’Esserci quotidiano si comprende, innanzitutto e per lo più, a
partire da ciò di cui si prende cura. “Si è” ciò di cui ci si occupa. Nel quadro di un siffatto essere, cioè
nell’immedesimazione dell’essere-assieme [Miteinandersein] quotidiano con un “mondo” di cui ci si
prende cura, la sostituibilità non solo è possibile in linea generale, ma è parte costitutiva dell’essereassieme. “Qui” è possibile, e anche necessario, che un esserci, entro certi limiti, “sia” l’altro. […] Viceversa questa possibilità di sostituzione è irrimediabilmente votata al fallimento quando sia in gioco
la possibilità di essere che è costituita dal giungere ala fine da parte dell’esserci, e che, come tale gli
conferisce la sua totalità. Nessuno può assumersi il morire di un altro. Ognuno può, sì, “morire per un
altro”. Ma ciò significa sempre: sacrificarsi per un altro in una determinata cosa . Ma questo morire
per…non può mai significare che all’altro sia così sottratta la propria morte» (M. HEIDEGGER, Sein
und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1993, p. 239; tr. it. di P. Chiodi, rev. di F. Volpi, Essere e
tempo, Longanesi, Milano 2006, p. 288).
177
268
dalla morte d’altri ad essere la mia relazione con la sua morte, ad essere, nella mia
relazione, la mia deferenza a qualcuno che non risponde più; è già una colpevolezza
– colpevolezza del sopravvissuto»181 .
Questa colpevolezza o colpa del sopravvissuto, che è la stesso per-l’altro del
soggetto, specifica Levinas – ed è un punto a nostro avviso centrale –, «non potrebbe
essere interpretata come complesso di colpa, né come benevolenza naturale (come un
«divino istinto») – e nemmeno come tendenza al sacrificio. Questa libertà finita, che
ontologicamente non ha senso, è rottura dell’inlacerabile essanza dell’essere»182.
Non si tratta di un “complesso” di colpa, poiché non è una struttura psichica
che vincoli il soggetto e ne costituisca una patologia isolante. Se è «seme di follia» o
«psicosi», lo è solo in senso figurato, non certo esperibile clinicamente: lungi
dall’isolare, infatti, pone in relazione, è matrice stessa della relazione asimmetrica e
asincrona, e proprio per questo tale in cui i termini, l’io e l’altro, «si assolvono» nella
relazione, senza esserne inglobati.
La «colpevolezza» non è neppure «benevolenza naturale», cioè pulsione biologica ed erotica, poiché a livello «naturale» o biologico si constata una continua lotta e conflittualità prevaricatoria ove ogni ente cerca e si sforza (conat) di sopravanzare e sopravvivere all’altro. Questo senso di colpa non è nemmeno – ultimo rilievo –
tendenza al sacrificio: ma anzi è «dovere», costrizione che si oppone a qualsiasi piano inclinato pulsionale in cui il soggetto sia trascinato naturalmente al sacrificio: in
questo caso, sarebbe masochismo, e dunque ancora ritorno narcisistico su di sé.
La «sacrificalità» della struttura del «per l’altro» che si estremizza nel «morire-per», non è dunque una dinamica empirica e ontologica (a livello ontologico «non
ha senso», poiché su questo piano non potrebbe apparire che come contraddittoria
con il conatus proprio dell’«essanza», dinamismo – evento – dell’essere), benché
possa talora mostrarsi come paradossale possibilità psicologica183. Sul piano empirico, infatti, accanto all’altro c’è sempre il terzo, e si pone il problema della giustizia
181
DMT, p. 54.
DMT, p. 244.
183
Si tratta di una di quelle «paradossali possibilità psicologiche di mettersi al posto di un altro»
(AE, p. 183). In un altro testo, Levinas scrive: «È proprio certo che la formula di Rimbaud: “Io è un
altro”, significhi soltanto alterazione, tradimento di sé, estraneità a sé medesimo, e asservimento a
questo estraneo? È certo che anche la più umile esperienza, quella di chi si mette nei panni degli altri
– come dire si accusa del male e del dolore dell’altro – non sia già animata dal senso più eminente
secondo il quale “io è un altro”?» (UAU, pp. 125-126).
182
269
per gli altri e anche per sé, ma soprattutto se questa struttura sacrificale della soggettività viene tematizzata-detta, non può che essere tradita, invertita nel suo profondo
senso meta-ontologico. Si tratta precisamente di una rottura dell’«inlacerabile essanza dell’essere», dunque della nascita di un senso nuovo, al di là di quello ontologico
del Detto.
Il tradimento in cui tale struttura incorrerebbe se fosse tematizzata e compresa a livello ontologico, e a livello empirico dove c’è il terzo, si mostrerebbe ancora di
più nel fatto che essa non potrebbe essere sottratta al sospetto di una mentalità sacrificale, postulante la necessità della vittimizzazione dell’ altro (e di me come altro che
a livello empirico anche io sono, in quanto a mia volta terzo dell’altro), come riscatto
espiatorio per riguadagnare la coesione di una società in crisi mimetica (Girard), o
per saziare il bisogno di sangue di una divinità adirata (come in una certa interpretazione cristiana della Croce). Conveniamo dunque con Ferretti in questo giudizio:
«Nonostante la forte insistenza sulla sostituzione sacrificale quale struttura stessa
dell’io in Levinas non troviamo quindi tracce della “mentalità sacrificale” con cui si
giustifica il sacrificio di alcuni – gli altri – per il bene di tutti»184.
Se è proprio nel suo nucleo preempirico e prefenomenico, in cui esplode la
struttura dell’appercezione trascendentale, che la soggettività è sostituzione, ciò vorrà
dire che la possibilità concreta della bontà empirica ma anche della cattiveria empirica riposeranno già su una preliminare bontà creaturale: io sono incarnato e individuato come unico, sempre a partire dal trauma dell’altro che è la stessa elezione del Bene, la quale, lungi dal chiudermi in un solipsismo autistico ed allergico, fonda la stessa possibilità di relazione e comunicazione, anche dietro le sue eventuali modalità
difettive della chiusura e della incomunicabilità.
«Al di là dell’egoismo e dell’altruismo c’è la religiosità di sé»; religiosità di
sé come approche-sostituzione, che è la struttura stessa della soggettività nel suo nucleo individuante pre-concettuale e pre-coscienziale, quello che «riposa nella notte
d’inconscio»185. «L’egoismo non è il primo né l’ultimo»; certo si può ben essere
egoisti, ma lo si è sempre a partire da questa identità originaria costituita come altruistica. Ed è grazie a questo nucleo relazionale, che dall’altro va a me e da me va
all’altro in maniera diacronica e non sincronizzabile, che è possibile anche quella
184
185
G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 247, nota.
Cfr., AE, p. 155 nota; v. anche p. 153 nota.
270
«piccola bontà», come gentilezza quotidiana del far passare un altro per una porta
prima di sé: «È a causa della condizione di ostaggio che nel mondo ci può essere pietà, compassione, perdono e prossimità. Anche la più piccola cosa, anche il semplice
“dopo-di-voi-Signore”. L’incondizione di ostaggio non è il caso limite della solidarietà, ma la condizione di ogni solidarietà»186.
Se nell’approche-sostituzione il soggetto è costituito come colpevole, ciò gli
deriva dall’originario essere intaccato dalla mortalità dell’altro, ed essere sempre sopravvissuto, già nato come sopravvissuto. Colpa del sopravvissuto dunque, ma colpa
che è anche innocenza: «Io non ho fatto nulla e sono sempre stato in causa»187.
La creaturalità del soggetto non è originariamente una caduta da uno stadio
anteriore di felicità, ma investimento ed elezione stessa da parte del Bene. Non si
tratta, nella colpevolezza del soggetto, di un peccato originale o di una colpa anteriore, come nel caso della gnosi e anche della Geworfenheit heideggeriana; essere colpevole senza aver commesso nulla, non significa essere colpevoli dell’essere o
dell’esistere, ma della colpa della morte dell’altro, rispetto alla quale, come dice Silvano Petrosino il sé è costituito come «originario essere associato all’altro e alla sua
mortalità»188; associato in una affezione pre-originaria, anteriore al costituirsi della
coscienza come volontà e libertà.
Se infatti, come abbiamo visto, altri è insieme giudice e parte, io devo essere
insieme colpevole e innocente per difenderlo. La sostituzione è sostituzione dell’innocente al colpevole, espiazione come sopportazione su di sé delle colpe dell’altro:
«L’unicità di sé è il fatto stesso di portare la colpa d’altri»189; e ancora: «La parola Io
significa eccomi, rispondente di tutto e di tutti»190. L’io cioè si identifica con se stesso nell’offrirsi senza riserve ad altri, fino a sostituirsi a lui portando la responsabilità
delle sue stesse colpe. Anzi, fino a sentirsi responsabile di tutto e tutti, quasi raccogliendo in unità sulle sue spalle l’universo:
186
AE, pp. 147-148, cn.
Ivi, p. 143.
188
S. PETROSINO, «Narcisismo e idolatria. Sul contributo levinassiano alla pensabilità della trascendenza», in DMT, p. 22. Si legga anche la seguente affermazione di Levinas: «È della morte
dell’altro che sono responsabile al punto da includermi nella morte. In termini forse più accettabili:
“sono responsabile dell’altro in quanto egli è mortale”. La morte dell’altro: questa è la morte prima»
(DMT, p. 86).
189
AE, p. 140.
190
Ivi, p. 143.
187
271
«Il Sé è Subjectum, è sotto il peso dell’universo, responsabile di tutto.
L’unità dell’universo non è ciò che il mio sguardo abbraccia nella sua unità
d’appercezione, ma ciò che da tutte le parti mi incombe, mi riguarda nei due
sensi del termine, mi accusa, è mio affare. In questo senso, l’idea che mi si
cerchi negli spazi intersiderali, non è una finzione della fantascienza, ma
esprime la passività del Sé»191.
«Ciascuno di noi è colpevole davanti a tutti e per tutti ed io più degli altri»192,
scrive Levinas citando un passo dostoevskijano tratto dai Fratelli Karamazov, dove
l’affermazione è messa sulla bocca del vulcanico e inquieto Ivan193.
In questo senso di elezione, il soggetto è elevato, innalzato: «La prossimità
del prossimo nel suo traumatismo non mi urta solamente, ma mi esalta e mi eleva e,
nel senso letterale del termine, mi ispira»194. Il sé come incarnazione, è incarnato
come corpo proprio, vive nell’inquietudine del costante contrattempo della inspirazione e della respirazione, in cui da una parte si contrae fino all’estremo, si angoscia,
in senso etimologico del termine195 – astriction (contrazione-legamento)196 – e qui
potremmo rinvenire anche traccia dello tzimtzum del Voloziner197; e, d’altra parte, il
sé «esplode» verso l’altro e verso l’alto, evade da sé sostituendosi ad altri ed espian191
AE, p. 145
Notiamo solo che l’apparente dinamica “paranoide” – una persecuzione universale che si
muta in una responsabilità universale, «per tutti» (AE, p. 145) – che qui potrebbe essere scorta, è nelle
intezioni di Levinas esattamente il contrario di un meccanismo delirante, chiuso nel sospetto e nella
gelosia, fantasticante di un complotto universale. Certo però che, a una lettura superficiale, che non
seguisse la rigorosa argomentazione levinasiana e dimenticasse che qui Levinas sta parlando del nucleo generativo della soggettività, e non della soggettività empirica e fenomenica, di cui lo stesso autore dirà della necessaria limitazione alla quale, con l’ingresso del terzo, il soggetto deve commisurarsi questa, come altre scene, potrebbe essere accusata esattamente di delirio di persecuzione e quindi di
onnipotenza di un io debole.
193
Passo da cui Levinas forse trae la struttura stessa della responsabilità che abbiamo sopra mostrato, come il davanti a – per; cfr. F. M. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, tr.it di A. Polledro, Garzanti, Milano 1981, II parte, libro VI, cap. II, p. 307.
194
AE, p. 157.
195
Levinas, in polemica con Heidegger, sottolinea che il senso vero di angoscia non è
l’esistenziale essere-per-la-morte ma è astriction (neologismo coniato da Levinas), costrizione fino
allo spasmo, senza via di fuga, perché «responsabilità più forte della morte» (AE, p. 135, nota 10).
196
«L’eccomi significa astriction» (DMT, p. 256). Silvano Petrosino rileva che questo neologismo formato da Levinas «deriva dal latino abstringere: azione di stringere, chiudere, legare, legare
moralmente, vincolare, obbligare». Anche qui si ritrova traccia del «legamento di Isacco» (Cfr. DMT,
p. 256, nota).
197
C. Chalier sottolinea che tutta la dinamica della soggettività etica è caratterizzata dalla rilettura levinasiana del senso dello tzimtzum secondo Haim di Volozin; Cfr. C. CHALIER. La Trace de
l’infini. Emmanuel Levinas et la source hébraïque, Cerf, Paris 2002, pp. 21-41.
192
272
do per altri: l’io è se stesso solo nella costante esposizione ad altri, nel suo integrale
essere per altri, cioè come sostituzione-espiazione pre-originaria. Benché lo stesso
Levinas ammetta che l’atto d’espiazione possa anche essere una possibilità psicologica, e anche storica
198
, egli specifica che essa non è da intendersi innanzitutto in
senso volontaristico, né implica fusione con l’altro, cioè una cancellazione totale del
se stesso; anche questa dinamica, dove l’inglobamento fosse nell’altro senza mantenere l’identità del sé, sarebbe ancora ritorno alla dinamica di dominio del conatus essendi: è proprio in quanto ipseità indeclinabile che
«l’io non è un ente capace di espiare per gli altri: l’Io è questa espiazione originale – involontaria – poiché anteriore all’iniziativa della volontà
[…] L’individuazione o sovra individuazione dell’io […] consiste, per me, ad
essere riguardo a tutto ciò che è solo perché sono per riguardo a tutto ciò che
è – è l’espiazione dell’essere»199.
Dobbiamo notare ancora una volta che in questo termine “espiazione” risuona
tutto lo spessore ebraico della radice radice ‘kpr’, da cui deriva kippur («espiazione»,
redenzione, riconciliazione, perdono), cioè il carattere anche del perdono come riconciliazione, perdono rispetto all’irremissibile il y a («essere-senza-perdono») che
si mostra, nota Chaterine Chalier, come il biblico tohu wa-bohu200.
Le ultime due caratteristiche della soggettività etica sono la comunicazione e
la libertà finita. La struttura stessa della soggettività, come uno-per-l’altro della sostituzione, rende possibile fondare la trascendenza comunicativa del linguaggio; «linguaggio originario»201, anteriore ai segni in cui esso si articola a livello sincronico.
198
La soggettività etica come santità, come abbiamo visto nel capitolo precedente, può concretizzarsi anche storicamente, con il gesto oblativo-sostitutivo di persone che muoiono per altri, sostituendosi al loro posto. Episodi di questo genere sono descritti in molti libri che parlano
dell’Olocausto; in ambito cristiano possiamo ricordare padre Massimiliano Kolbe.
199
AE, pp. 148-149.
200
Cfr. supra, cap. I. par. 1. Notiamo per inciso qui che se traduciamo tale termine biblico, tohu
wa-bohu con «vuoto», vi risuona il senso di vuoto o foro-buco (tro) nell’essere costituito dal volto
come non-fenomeno. Se dunque il volto è un vuoto nell’essere, e la Shoah è un vuoto nell’essere, esso
è nello stesso tempo l’emergenza stessa del non senso (il y a) e nello stesso frat-tempo, e scandalosamente per la razionalità rappresentativa, la significazione stessa di un senso al di là di quello mortifero
dell’esse-logos.
201
«L’etico […] indica un rivolgimento della soggettività aperta sugli esseri […] in soggettività
che entra in contatto con una singolarità che esclude l’identificazione nell’ideale, la tematizzazione e
la rappresentazione, con una singolarità assoluta e in quanto tale irrappresentabile. È questo linguag-
273
Lo stesso linguaggio usato nel libro (AE) da Levinas per descrivere i caratteri della
soggettività è improntato alla dinamica dell’approche-sostituzione: «Il linguaggio
etico a cui la fenomenologia è ricorsa per marcare la propria interruzione, non scaturisce dall’intervento etico applicato alle descrizioni. È il senso stesso dell’approche,
che mette fine al sapere. Nessun linguaggio che non sia etico è in grado di eguagliare
il paradosso in cui entra la descrizione fenomenologica…»202.
Nella sostituzione avviene una «doppia comunicazione»203, quella dell’uno
all’altro e quella dell’altro all’uno. Ma le due relazioni non hanno lo stesso senso.
L’approche all’altro da parte del se stesso non è reversibile né simmetrico o sicrono.
L’omogeneità, sincronia e reversibilità deriveranno solo dall’apparizione del terzo,
col concretarsi in presenza della temporalità-spazialità originaria. Levinas specifica
inoltre che la propria posizione non presuppone una concezione spiritualista, in cui la
comunicazione originaria avverrebbe prima della sostituzione, in un dialogo anteriore dell’io con se stesso, e in un ritorno nostalgico all’origine: responsabilità degli altri, il rapporto con il non-io precede ogni rapporto dell’io con se stesso204.
D’altra parte, non si tratta nemmeno di postulare, come fanno le filosofie del
dialogo, un noi originario anteriore al costituirsi dei termini della relazione io-tu205.
Si tratta invece dell’evento dell’origine della comunicazione nella stessa dinamica
dell’approche-sostituzione, in cui «l’io, sostituzione nella solidità dell’identico – […]
è solidarietà che comincia col portare ad Altri testimonianza di se stessa, e così, innanzitutto, comunicazione della comunicazione, segno della donazione del segno e
per nulla trasmissione di una qualunque cosa in un’apertura»206. La relazione intergio originario, fondamento dell’altro.[…] Il contatto è tenerezza e responsabilità» («Linguaggio e
prossimità», in SEHH, pp. 262-263). In nota, nello stesso testo, Levinas fornisce una definizione di
etica: «Chiamiamo etica una relazione i cui termini non siano uniti da una sintesi dell’intelletto, né
dalla relazione tra il soggetto e l’oggetto e in cui, tuttavia, un termine pesi, o sia importante, o abbia
significato per l’altro, i cui termini siano legati da un intrigo non esauribile né districabile dal sapere»
(ibidem).
202
AE, p. 118, nota. Levinas scrive, nell’ultimo capitolo della seconda edizione di SEHH pubblicato nel 1967, dunque esattamente contemporaneo della prima versione di La substitution letta a
Bruxelles: «Il linguaggio etico a cui abbiamo fatto ricorso non deriva da una particolare esperienza
morale, indipendentemente dalla descrizione fatta finora. Deriva dal senso stesso dell’avvicinamento
[approche] che rompe con il sapere, del volto che rompe con il fenomeno» (SEHH, p. 273).
203
G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 248; cfr. AE, p. 149, nota.
204
Cfr. AE, p. 149, nota.
205
«Questa posizione, concepisce la comunicazione originale come quella empirica, cioè come
manifestazione dell’uno all’altro. Il che significa presupporre ciò che si intendeva fondare» (G. FERRETTI, La filosofia di Levinas, cit., p. 253).
206
AE, p. 150.
274
soggettiva originale dischiude cioè l’apertura del dialogo ben prima del costituirsi di
uno spazio simmetrico e sincronico in cui instistano i segni in un sistema significante.
L’ultima caratteristica della soggettività etica è di essere una liberta finita.
Scrive Levinas: «L’anteriorità della responsabilità sulla libertà rende certo finita la libertà, ma non ne sopprime la dignità, anzi permette di coglierne il senso autentico
nella “gratuità”»207. Gratuità senza contropartita, ma proprio per questo libertà e affrancamento rispetto al meccanismo egoistico e “interessato” del conatus essendi. In
questa elezione-convocazione del Bene, che avviene attraverso la stessa persecuzione
da parte di altri, il se stesso, soggettività indeclinabile, è affrancato dal meccanismo
utilitaristico e dominatorio dell’essere. È dunque libero, ma senza che questa libertà
possa contare su un ritorno su di sé, su una contropartita, per esempio attraverso
l’assunzione di un merito o di una retribuzione nell’al di là.
Criticando la posizione fichtiana, per cui la libertà o è infinita o è nulla, Levinas mostra, nell’ultima parte del capitolo, come la pretesa idealistica di una visione
panoramica rispetto alla totalità – quasi che l’io «avesse assistito alla creazione del
mondo»208 –, e anche la pretesa heideggeriana che il mondo sia un progetto proprio
dell’esserci non sfuggono all’impresa di dominio e perseveranza del conatus essendi.
Il soggetto è libero in quanto creatura non infinita, ma che in sé ha questa convocazione immemoriale da parte dell’Infinito che ne costituisce la stessa struttura temporale; è creatura, dunque da una parte non si auto-costituisce ma viene creata da questa
elezione immemoriale – «dal Bene a me: convocazione», relazione che sopravvive
alla morte di Dio»209 –; d’altra parte, è differente dall’essere proprio in questa stessa
sostituzione, come non-indifferenza ad altri.
La rilettura levinassiana della heideggeriana differenza ontologica come nonindifferenza etica, permette dunque di affermare lo scarto della trascendenza del soggetto etico rispetto alla finitezza logico-empirica, l’esserne in qualche modo «al di là
e al di qua», in un certo senso differente, e dunque permette di affermarne la dignità
di una finitudine in cui «passa» l’infinito; e d’altra parte e insieme, tale rilettura permette di collocare nella giusta prospettiva etica la stessa finitudine del soggetto, che
207
208
209
AE, p. 156.
Levinas cita l’episodio biblico del dialogo di Dio con Giobbe (cfr. AE, p. 154).
AE, p. 155.
275
nella sostituzione non può mai identificarsi o assorbirsi nell’infinito, ma è appunto
risvegliato e fatto nascere dal non potersi sottrarre alla sua piena responsabilità.
La responsabilità del se stesso, infatti, può essere pensata come libertà finita
solo se viene pensata come «non prima, né iniziale», bensì anteriore alla libertà e alla
non libertà; nella creaturalità del soggetto eletto dal Bene si mostra il carattere paradossale di questa libertà:
«Nella sua [del se stesso] passività, si cancella la distinzione tra “essere accusato” e “accusare”. La ricorrenza del soggetto non è così né la libertà
del possesso di sé attraverso la riflessione, né la libertà del gioco in cui mi
credo questo e quello attraversando le trasformazioni sotto le maschere del
carnevale della storia»210.
La libertà del «dono che costa», costituita dall’investitura Bene, è
«un’esigenza che viene dall’altro, al di là dell’attivo dei miei poteri, per aprire un
“deficit” senza limiti, in cui si disperde senza contare – liberamente – il Sé».211 Senza
cioè «fare di conto» in senso economico, quasi come un ragioniere che tenga scrupolosamente i propri registri contabili cercando di sanare il bilancio tra entrate e uscite.
È dunque questa struttura paradossale della soggettività etica che nell’approche può farsi dono di vita, e che «conferisce un senso alla morte»:
«L’approche, nella misura in cui è sacrificio, conferisce un senso alla
morte […] In essa la vita non si misura più attraverso l’essere e la morte non
può più introdurvi l’assurdo. Nessuno è abbastanza ipocrita da pretendere di
aver tolto alla morte il suo dardo – neanche i promettitori delle religioni – ma
possiamo avere delle responsabilità e dei legami attraverso i quali la morte
assume un senso – fin dall’inizio. […] Il senso non si misura con l’essere o il
non-essere perché l’essere, al contrario, si determina a partire dal senso»212.
210
211
212
AE, p. 158.
Ibidem.
AE, pp. 162-163.
276
Si tratta, nell’«uno-per-l’altro» della soggettività etica, della possibile prospettiva di una speranza «non nostalgica»213 (nostalgia che spera un ritorno su di sé,
in termini di persistenza della propria presenza nell’«eterno riposo» dell’identico,
oppure di sopravvivenza come identità personale dopo la propria morte). Una speranza, cioè, etica: «essere per l’al di là della propria morte»214, e in questo modo di
essere per la vita di altri.
5.
Il terzo e i limiti del sacrificio
Dalla responsabilità al problema
Questa è la via
(AE, p. 201).
Questo paragrafo conclusivo coglie il tema del terzo non dal punto di vista
generale, il che richiederebbe un capitolo o un lavoro a sé, ma dal punto di vista della
questione dei «limiti del sacrificio».
La soggettività etica che abbiamo appena illustrato deve essere intesa come il
nucleo profondo e non fenomenico dell’essere umano come relazione. Essa è emersa,
lungo le pagine di AE, attraverso un’operazione fenomenologica di «riduzione dal
Detto al Dire». Al livello del “mondo della vita”, non ancora fenomenologicamente
ridotto, non incontriamo mai la diade originaria tu-io, ma sempre l’intrigo tu-terzoio, ove ognuno dei termini della relazione è mediato dal secondo, sicchè io sono il
terzo del terzo, e sono, a mia volta, terzo del secondo, e anche terzo rispetto a me
(donde l’esigenza anche di giustizia per me) in una «contemporaneità del multiplo
che si annoda però – dice Levinas – sempre intorno alla diacronia dei due»215. Se il
volto, il prossimo non appare, ma compare, l’altro concreto invece appare come il
213
Ricaviamo questa definizione da M.M. OLIVETTI, Analogia del soggetto, p. 117; per la delineazione olivettiana di questo concetto, si veda soprattutto il capitolo L’equivoco metafisico (ivi, pp.
167-199).
214
SEHH, p. 220, tr. modificata.
215
AE, p. 199.
277
terzo, e «l’apparizione del terzo è l’origine stessa dell’apparire, l’origine
dell’origine»216; questa origine è la «coscienza», che appunto «nasce con la presenza
del terzo»217 . Coscienza che «è l’ingresso del terzo – ingresso permanente –
nell’intimità del faccia a faccia», che si costituisce come relazione implicante il multiplo, la società, il sistema linguistico; coscienza il cui «fondamento è la giustizia»218.
Sicchè, nel piano fenomenico concreto, l’altro che appare non è più altri, ma
“un” altro. In questo piano «non c’è» il volto, ma ci sono (presenza) i volti che si mostrano però sempre nell’orizzonte assente della sua comparizione. Infatti «il terzo
non turba empiricamente la prossimità, poichè il volto è volto dei volti, volto e visibile»219. Dunque il volto nel terzo si rende visibile; il che vuol dire che il terzo, in
qualche modo, come altro empirico, porta la traccia della «comparizione» originaria
del volto invisibile. La coscienza, fondata dalla giustizia, dovrà calcolare, commisurare, «limitare» l’approche-sostituzione, nel suo dinamismo d’«infinizione
dell’infinito» senza termine.
Sul tema del terzo si sono talora esercitate critiche che individuano il discorso levinassiano come non coerente con la delineazione della soggettività etica “duale”, e quindi che individuano nel tema del terzo un cespite che si inserirebbe solo “a
cose fatte” nel discorso dell’autore220. Ma il discorso levinassiano inserisce
l’emergenza del terzo all’interno di un’argomentazione cogente, in base alla necessità di pensare la giustizia221 e dunque anche la simmetrizzazione e la raccolta, nella
concreta fenomenicità intersoggettiva, delle articolazioni paradossali della soggettività supererogatoria.
Con l’apparire del terzo ci spostiamo – o meglio ritorniamo – dal piano della
riduzione fenomenologica a quello del mondo-della-vita pre-filosofico. Ma ciò non
216
AE, p. 200.
Ibidem.
218
AE, p. 200.
219
Ibidem.
220
Si veda L. SESTA, «Per tutti e per tutto, e io più degli altri». Orizzonte e limiti della responsabilità in Levinas in M. DURANTE (a c. di) Responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, il melangolo, Genova 2008, pp. 33-52; T. BEDORF, Riflessioni su
soggettività e terzietà. Prospettiva etica e normatività, ivi, pp.141-156.
221
Stéphane Mosès fa giustamente notare che mentre in TI la giustizia «era fondata sul rapporto
personale e asimmetrico del maestro col discepolo», in AE essa è «dedotta dalla dimensione universale del rapporto con il terzo» (S. MOSÈS, «Autour de la question du tiers», in D. COHEN-LEVINAS – B.
CLEMENT (a c. di), Emmanuel Levinas et les territoires de la pensée, PUF, Paris 2007, [pp. 235-244]
p. 240).
217
278
significa che tra i due piani intercorra un rapporto di autenticità-inautenticità. Il piano
quotidiano e in qualche modo primo, ed è precisamente in questo piano che deve tradursi la chiamata del Bene, quel piano in cui l’unicità dell’eletto si fenomenizza nella
singolarità signata hic et nunc della mia persona integrale, e l’unicità di altri si fenomenizza nella molteplicità di individui che incontro nella mia vita e con cui sono in
relazione.
Il cammino percorso nel libro ha descritto come, nei molteplici che incontro
e che mi «disturbano», io posso venir turbato sempre dal comparire del volto, cioè di
autrui. Dunque anche le relazioni fenomeniche pre-filosofiche non possono più pensarsi alla luce di una coscienza trascendentale inglobante. La coscienza nata dall’apparizione del terzo porterà sempre in sé l’inquietudine del trauma originario, sarà
sempre «cattiva coscienza».
Cattiva coscienza che, come rimorso, mi coglie anche nelle relazioni di giustizia, si segnala come richiamo a quel debito preoriginario che mi indentifica come
unico per tutti gli altri. La buona coscienza non è mai tanto buona da occultare, al
fondo di sé, un richiamo al rimorso costituito dal debito pre-originario, dal trauma inconscio. Ecco perché, in qualche modo, l’apparire della coscienza, della presenza e
della molteplicità, «procedono dal disinteressamento»222. La coscienza dunque nasce
come cattiva coscienza, investita di un senso di colpa permanente, che si avverte come senzo di sopravvivenza rispetto alla morte e mortalità degli altri empirici.
Se gli altri empirici sono i terzi, e in essi il volto (invisibile) si fa visibile, allora nelle relazioni empiriche si annuncia, sempre, in contrattempo, anche il passaggio (l’assenza, la Gloria) dell’infinito223.
La «presenza» del volto non è possibile, ma la presenza dei volti sì. E non è
così per una decadenza nell’inautentico, rispetto alla quale il rapporto soggettivo originario uno-per-l’altro sarebbe l’autentico, ma perché nel dinamismo stesso della
soggettività etica nel volto di altri appare il terzo, cioè si mostrano i molteplici volti.
222
AE, p. 199.
Secondo Jacques Rolland, è proprio a partire dal terzo che si costituisce l’Io come Moi, di
cui Levinas avrebbe parlato in TI, distinto dallo je e dal moi, che ne sarebbero la preistoria; preistoria
di cui tratterebbe AE. Ipotesi affascinante, anche non ci sembra sempre supportabile in base ai testi,
giacchè Levinas usa indiscriminatamente, in AE, la scrittura je o Je, moi o Moi. (Cfr. J. ROLLAND,
«Un chemin de pensée, Totalitè et Infini – Autrement qu’être», in AA.VV., Emmanuel Levinas, «Rue
Descartes», PUF 2006, 39-54; ID., Parcours de l’autrement. Lecture d’Emmanuel Lévinas, PUF, Paris
1999, pp. 27-60).
223
279
Nasce l’esigenza di trasferire sul piano empirico questo dinamismo di bene, e non lo
si può fare se non attraverso una coscienza che misuri, calcoli, sincronizzi ed eguagli:
«La via attraverso la quale il logos, da questa situazione originaria, si eleva al concetto di Io, passa per il terzo»224.
Levinas specifica, nel V capitolo di AE, che la struttura della coscienza volente e calcolante secondo giustizia non è decadenza o degradazione della responsabilità, quasi che “per cause di forza maggiore” il movimento oblativo della responsabilità infinita preoriginaria non potesse portarsi fino in fondo, in quanto interrotto da
una necessità empirica o logica, e quindi fosse costretto a limitarsi nel senso di depotenziarsi o «neutralizzarsi»:
«in nessun modo la giustizia è una degradazione dell’ossessione, una
degenerazione del per l’altro, una diminuzione, una limitazione della responsabilità anarchica, una «neutralizzazione» della gloria dell’infinito, degenerazione che si produrrebbe man mano che, per ragioni empiriche il duo divenisse trio: ma la contemporaneità del multiplo si annoda attrorno alla diacronia
di due»225.
Abbiamo già indicato che, in Levinas, non bisogna mai pensare separati i due
piani, quello pre-filosofico e quello filosofico, ma piuttosto coimplicati, in una circolarità che si produce in una contaminazione continua di livelli mai definitivamente
depurabile. Lo stesso sforzo di identificare, al di là del concreto darsi fenomenico del
Detto, un Dire preoriginale, è continuamente esposto al tropismo immobilizzante e
universalizzante di quello stesso Detto. Dal punto di vista empirico, la coscienza si
vedrà sempre segnata da una profonda inquietudine, da un senso di colpa, che è il richiamo alla propria elezione pre-originaria creaturale come disinteressamento, e la
rivelerà nello stesso tempo come inquietudine e debito permanente.
Se la temporalità originaria è diacronia non sincronizzabile, la temporalità
quotidiana, alla luce della quale appaiono i molteplici «volti» – istanti nell’orizzonte
fenomenico e sistemico-linguistico–, è caratterizzata dalla presenza dei sincroni nella
sintopia – assente – della società. E la soggettività, da ipseità indicibile, indeclinabile
224
225
AE, p. 160.
AE, p. 199.
280
e irrappresentabile, si ritrova come prima persona nel sistema linguistico, che interloquisce con la seconda persona, ma che senza la terza, come società e linguaggio,
non potrebbe significare.
Ne consegue, per la persona “pre-filosofica” (il concreto soggetto empirico),
che se mentre nello strato preoriginale il debito mai contratto con cui essa consegnata
e votata alla donazione incessante faceva escludere la possibilità del ritorno su di sè,
qui, in qualche modo, c’è un ritorno mediato dal terzo: essendo io istante nella società, come terzo del secondo e secondo del primo e così via, debbo anche considerarmi
come terzo di me stesso; debbo dunque anche «grazie a Dio» reclamare una «giustizia per me»226. Non si tratta però dell’amore di sé erotico-narcisistico, ma di «amore
senza concupiscenza» come giustizia per sé, ove cioè la stessa relazione di ritorno in
me non è mai solipsistica, ma mediata sempre dall’universalizzazione del terzo. Io
stesso ritorno nella mia coscienza non più come me stesso, ma come terzo attraversato dalla giustizia. Cioè, propriamente, non ritorno a casa mia, o nella mia terra, torno invece come straniero tra stranieri, in una casa e una terra non mie, ma affidatemi
dal Bene.
La limitazione della responsabilità, o il «limite del sacrificio», rileva inoltre
dal fatto che il terzo «appare» nel non «apparire» del Volto. Apparire vuol dire fenomenicizzarsi, ma anche mostrarsi, rivolgersi concretamente. E, su questo piano, il
persecutore non sarà mai altri pre-empirico, nel cui volto io scorgo il richiamo del
Bene, ma sempre il persecutore del prossimo. Se cioè il terzo non esistesse sempre
anche come prossimo del prossimo, io «dovrei tutto» all’altro, ma dal mmento in cui
il terzo appare, questo perdono infinito nel sacrificio e nella sostituzione ad altri, e
nell’assumermi persino le sue colpe si traduce (o si tradisce), data la struttura sistemica e sincronica della società, in un danno al prossimo, in inversione della giustizia.
La persona integrale sembra dunque con-costituita da due elementi: da una
parte, da una profondità abitata dall’elezione-persecuzione e votata alla responsabilità infinita e al sacrificio di sé, e, dall’altra, dalla coscienza, che proprio in virtù dell’approfondimento della nozione di volto ha scorto in esso l’istanza del terzo e quindi
la necessità della giustizia.
226
AE, p. 198.
281
Ma occorrerà ancora disdire l’apparente solidità di questa struttura. Essa ha di
nuovo bisogno di una «interruzione». Così tematizzata, infatti, la struttura integrale
della persona sembrerebbe costituita da un doppio livello, in una polarità quasi schizofrenica, o in un double bind: il primo livello, che ne costituirebbe il nucleo, abitato
dall’elezione dell’Infinito e quindi votato alla responsabilità interminabile, sin anche
del persecutore; e il secondo, che ne costituirebbe la manifestazione fenomenica, che
farebbe i conti con la molteplicità in cui si manifesta il volto, ricercando quindi la
giustizia come responsabilità verso il prossimo del prossimo e cercando di tradurre in
istituzioni giuste quel dinamismo originario; istituzioni che saranno necessariamente
quelle di una responsabilità limitata.
Ma questa configurazione formale dei rapporti viene in realtà contraddetta da
una duplice inquietudine. La prima inquietudine consiste nel fatto che nella stessa
ricerca della giustizia permane un senso di continua insoddisfazione, poiché le istituzioni, dovendo sottoporsi all’universalizzazione simmetrizzante e neutralizzante (in
senso anonimo), prendono in prestito la loro forma, il loro typos, dalla ragione non
intaccata dall’eteroaffezione preoriginaria della relazione asimmetrica: risorge così la
«forma plastica» che rischia continuamente di assorbire e cristallizzare il dinamismo
originario del Bene – che quelle istituzioni cercavano di tradurre – in un sistema di
coercizione e iniquità. Dinanzi a questo pericolo, Levinas pensa sempre alla possibilità di una critica «anarchica» (questa volta quasi in senso politico), che faccia valere
il senso profetico del Bene, cercando di ricondurle al loro legame con il preoriginario.
In fondo, l’istituzionalizzazione è necessaria alla giustizia, ma un conto è pensare le istituzioni sulla base dell’analisi hobbesiana della limitazione della violenza
naturale (impresa che, come abbiamo già visto nel capitolo precedente, Levinas ritiene impossibile), un altro conto è pensarle come limitazione della responsabilità infinita. In questo secondo caso infatti, potranno essere contestate e rivoluzionate, o riformate in nome della stessa esigenza di giustizia abitata dalla carità:
«Che differenza c’è tra le istituzioni che nascono da una limitazione
della violenza e quelle che nascono da una limitazione della responsabilità?
282
Almeno questa: nel secondo caso ci si può ribellare contro le istituzioni in
nome di ciò che ha dato loro origine»227.
Ma c’è ancora una seconda inquietudine, un’inquietudine dell’inquietudine,
se così si può dire, che pervade la persona nella stessa propria integralità. È il fatto
cioè, che si continua ad avvertire sempre nello stesso foro della coscienza giusta la
minaccia del non senso. Questa minaccia, da una parte è la stessa condizione della
gratuità, dall’altra è iscritta sempre nella consapevolezza della necessità della limitazione del sacrificio, vista come un decadimento rispetto all’impellenza della supererogazione.
Soprattutto nell’ultima fase della produzione levinassiana, «la colpevolezza
del sopravvissuto» ritorna spesso, come designante a contrario il senso della responsabilità infinita che sempre più tende a essere reclamata come la vera soggettività etica; quasi che nella coscienza, nata dall’apparire del terzo, si costituisse in qualche modo una resa al male.
Troviamo traccia di questo pessimismo di fondo, in una lunga intervista, mentre scriviamo ancora inedita in Italia, che il filosofo lituano intrattenne verso gli ultimi anni della sua vita con Michael De Saint Cheron228. Vi leggiamo infatti:
«MSC– Lei ha scritto che l’etica non è una branca della filosofia ma la
filosofia prima. Quando si citano queste parole, alcuni filosofi gli oppongono
il fatto che questo «dis-inter-essamento» di fronte a sé e questo interesse per
l’altro non sono che un altro interessamento per se stessi, un egoismo sublime, potrebbe dirsi. Che risponde lei a questa critica?
E.L - Questo s’inscrive nella storia della santità. La santità è questa responsabilità che io evoco. Le ragioni per le quali non andiamo sino al limite [jusqu’au bout], costruiamo degli stati, abbiamo un’etica limitante questo sacrificio, provengono probabilmente dal fatto che siamo infedeli alla condizione
227
DMT, p. 250.
M. DE SAINT CHERON, Entretiens avec Emmanuel Levinas 1992-1994: Suivis de Levinas
entre philosophie et pensée juive, LGF, Le Livre de Poche, Paris 2010.
228
283
morale dell’uomo. Non che non arriviamo a intenderlo, ma che il sacrificio è
sempre incompleto»229.
In questo passo, Levinas pare esprimersi come se, in fondo, il momento della
politica, e dunque della giustizia e della comparazione, fosse un’infedeltà alla condizione più originaria di ingiustizia subita e asimmetrica che costituisce la vocazione
umana alla santità. Tale affermazione sembra però contraddetta, poche righe dopo,
perchè Levinas dice che in realtà non si tratta di infedeltà, ma della necessità, di fronte all’apparire del terzo, di introdurre il dinamismo del bene all’interno delle istituzioni, di farlo quindi emergere contro l’inerzia del conatus essendi che invece permane nelle istituzioni “puramente” razionali, non contaminate da questa impurità
dell’origine.
Resta comunque, nello sfondo di questa intervista, l’allusione alla santità come segno del Bene, nel senso in cui abbiamo cercato di mostrarla nel capitolo III del
nostro studio. L’impressione complessiva dunque sembra quella di enfatizzare il
prezzo che questo «dono che costa», in quanto testimonianza del Bene, esige
dall’uomo:
«MSC: Come definirebbe la santità?
EL: C’è dunque il bene e il male contemporaneamente. Mi spiego: accettare
la santità è certamente compiere qualcosa di positivo, ma d’altra parte questo
positivo è fino in fondo niente, nel senso che ciò non ha niente di un guadagno. […] L’ultima santità consiste nell’accettare la giustizia o la morte senza
resistenza, accettare questo niente e tuttavia nello stesso tempo avere questo
riflesso di bontà, di valore. La santità non è nella categoria delle cose morali.
[…] Questo vuol dire che la mia responsabilità per altri arriva sino a sopportare l’ingiustizia che la condizione d’ostaggio comporta. […] Che la santità
sia un approche a Dio questo è evidente, e molto più che le apparizioni dette
gloriose di Dio. Questo concetto d’ostaggio è certo un modo singolare di
promettere ai giusti d’essere felici»230.
229
230
Ivi, p. 30.
Ivi, pp. 30; 36-37.
284
Nel passo sopra riportato, sembra dunque che Levinas porti sino all’iperbole
l’esigenza
di
responsabilità
considerata
come
santità,
nell’accettazione
dell’ingiustizia: la struttura sacrificale dell’approche qui emerge nella sua cifra
“scandalosamente” profetica.
La domanda successiva dell’interrogante è da dove Levinas abbia ricavato il
concetto di ostaggio. Trascriviamo integralmente la risposta perché la riteniamo significativa rispetto alla prospettiva che ha orientato il nostro studio, e in qualche modo tale da valere come sua conclusione:
«E.L - il termine “ostaggio”, lo conosco dal periodo della persecuzione nazista. Si faceva di voi un ostaggio, vi si puniva per qualcun altro. Per me
questo termine non ha altro significato, salvo che riceve nel contesto un significato che può essere glorioso. Questa miseria dell’ostaggio ha una certa gloria, nella misura in cui chi è ostaggio, sa che corre il rischio di essere ucciso
per un altro. Tuttavia, in questa condizione d’ostaggio, che io chiamo “incondizione d’ostaggio”, non c’è, al di là del destino drammatico, una dignità suprema?
MSC - è una dignità da ricercare? […]
EL: Morire per il Nome di Dio è una nozione frequente, in ogni caso, nella
bibbia ebraica […] Lei sa bene che nella lingua ebraica il termine qadòsh si
applica a Dio, che è qadòsh, “santo”, ma si applica egualmente agli uomini, i
qedoshìm, i santi. È un’antica tradizione che risale all’epoca del Talmud. A
meno che non si supponga che non vi sia la carità, che vi sia solo la giustizia
nel giudaismo. La formula liturgica h’essed shel émet, “amore della verità”, è
la Carità. Tutta l’originalità della santità, oltre a molte altre qualità, è che essa
è anche la più grande miseria. È la forza di voler il bene altrui nella miseria
che può venir da lui»231.
Il tema del Qiddùsh ha-shem, che avevamo visto nello scritto sulla prigionia
ebraica, torna qui a designare la cifra della santità come vocazione profonda del soggetto. Là avevamo descritto come Levinas pensasse i sopravvissuti come i sursitaires
231
Ivi, p. 38.
285
della morte, e pensasse la morte dei prigionieri come testimonianza del Qiddùsh hashem. In questa dilazione della morte, che è sempre sopravvivenza rispetto ai morti,
si avverte dunque un senso di colpevolezza – mai traducibile in un “complesso di
colpa” poiché in questo senso essa sarebbe inserita in un sistema di strutture psichiche già costituite –, che segna la tonalità emotiva in cui ci è sembrato che Levinas
situi la soggettività etica come approche-sostituzione. Se non si può facilmente rubricare questo pathos dell’essere sopravvissuti a “motore mobile” della soggettività
etica, non per questo occorrerà minimizzare il continuo riaffiorare lungo i testi levinassiani, soprattutto gli ultimi, di questo richiamo alla persistenza di un debito preoriginario.
Attraverso l’esperienza della Shoah, il debito si mette in mostra, e accompagna la dinamica fenomenologica dell’uno-per-l’altro. Forse senza misurare il peso di
questa esperienza pre-filosofica, per l’autore, si potrebbe capire la ragione di tante
critiche a Levinas, che trovano esagerato quanto egli richiede al soggetto. Ma speriamo di aver mostrato come una lettura dell’opera di Levinas senza il «margine»
costituito dalla Shoah, lettura pur legittima d’altronde, rischierebbe di mancare lo
sforzo più autentico del nostro autore, di misurarsi con l’evento e di rispondere rilanciando la domanda di senso, in debito per altri. La prima domanda della filosofia,
non è più perché c’è l’essere e non piuttosto il nulla, ma “che diritto io ho di sopravvivere”?
Forse sopravvivere ha senso se diventa inter-vivere, vivere nell’interim o
nell’intervallo del «per», senza pensare una chiusura dell’intervallo, né una chiusura
del libro – Altrimenti che essere – che cerca di mantenere insonne il lettore che vorrebbe, come Giona, addormentarsi, chiudere il libro e riporlo nello scaffale, sfuggire
alla dismisura della responsabilità dell’elezione, pari solo alla dismisura dell’EventoAuschwitz. Non si tratta dell’unica possibile interpretazione, ne siamo convinti, ma
del modo in cui noi abbiamo provato l’approche all’opera di Levinas.
Il presente studio ha cercato di mostrarne le ragioni.
286
CONCLUSIONE
Il presente studio ha inteso indagare l’opera levinassiana cercando di mettere
in rilievo il legame intercorrente tra esperienze pre-filosofiche e concettualità fenomenologica, e facendo valere la peculiare circolarità che «a partire dall’esperienza
vissuta cerca di dire nel modo più rigoroso possibile, la struttura formale, per poi tornare a chiarificare, con tale guida, l’esperienza in questione» (Ferretti).
L’oggetto della nostra indagine è stato specificamente il rapporto tra esperienza del trauma (prigionia e Shoah) e la particolare concezione levinassiana della
soggettività etica come approche, passione e sostituzione emergente in Altrimenti
che essere. Per indagare questo rapporto, si è cercato di evitare un duplice pericolo:
da una parte quello di scadere nel mero biografismo, o peggio in una riduzione psicologistica dell’opera levinassiana; dall’altra, quello di far valere troppo poco questo
sfondo pre-filosofico, depauperandone la ricchezza potenziale per una interpretazione di spessore filosofico, e relegando entro le note del testo i rimandi, spesso enigmatici e allusivi, che un lessico, una semantica, e una «tropologia revulsiva» (Ricoeur) –
qual è quella di Altrimenti che essere –, lasciano chiaramente risuonare nella mente
del lettore.
La prospettiva generale nella quale si è mosso il lavoro è stata quella di affrontare l’interpretazione dei testi levinassiani valendoci di un confronto con un triplice ordine di letteratura critica: quella fenomenologica, quella ebraica, e quella psicoanalitica. Dal punto di vista delle opere levinassiane studiate, tuttavia, non si è inteso confrontarsi in prima istanza ed esplicitamente con le «Letture talmudiche», ma
si sono tematizzate le opere più strettamente filosofiche (cercando di problematizzare
tuttavia il rapporto tra i due tipi di produzione levinassiana). Questo perché abbiamo
ritenuto che proprio nelle opere filosofiche, e soprattutto in Altrimenti che essere, si
sedimentasse il debito dell’esperienza pre-filosofica, la cui cifra di enigma e margine
risalta tanto più quanto meno vi appare esplicitamente tematizzata.
287
La recente pubblicazione degli inediti della prigionia (Carnets) ci ha permesso di sondare un campo finora poco esplorato, alla luce del quale assumono maggiore
ricchezza taluni aspetti, prettamente filosofici, della elaborazione successiva. Il Primo capitolo (L’esperienza della prigionia) ha quindi indagato i Carnets recentemente pubblicati, tenendo sempre presente sia la produzione appena successiva (quella
degli anni ‘40 e ‘50) sia lo sviluppo che, nelle note e dei documenti inediti, quel
germinale “cantiere filosofico” avrebbe ulteriormente prodotto.
Il Secondo capitolo (Shoah e trauma) ha inteso approfondire il tema della
Shoah come “margine” (in senso derridiano) del pensiero levinassiano, attraverso
una triplice prospettiva: il confronto con le interpretazioni filosofiche e teologiche
della Shoah; l’elaborazione del concetto di trauma nella letteratura psicoanalitica,
anche al fine di situare questo termine nel suo contesto di ricorrenza originario, e infine lo statuto filosofico del concetto di «trauma» e «esperienza» (anche alla luce di
un confronto con il tema dell’avvio del pensiero), nello sviluppo fenomenologico del
Nostro. Non si è trattato – in questo capitolo – di un’intenzione meramente ricostruttiva, ma piuttosto della delineazione dello sfondo teoretico che rendesse possibile
orientare la problematizzazione della domanda interpretativa che la lettura di Levinas
ci aveva suscitato: quanto incide l’esperienza del trauma nella elaborazione della
nuova figura della soggettività come persecuzione, soggezione, passione, sostituzione?
Il Terzo capitolo, intitolato La Passione come figura dell’umano, ha inteso
misurarsi teoreticamente con il concetto di eidos della santità quale emerge soprattutto in AE, cercando anche un confronto con la visione della speranza pensabile nella
storia da parte di Kant (quello che Melchiorre chiama «schematismo storico»). In
questa direzione, si è indagata la peculiare connessione tra «messianismo», come è
inteso da Levinas, con la soggettività etica, per proporre una possibile risposta
all’evento Shoah. Questo capitolo ha inteso ulteriormente supportare, con precisi riferimenti testuali, quanto il pensiero levinassiano fosse debitore del trauma
dell’Olocausto, cercando di individuare una proposta teoretica che illustrasse il particolare valore di «esemplarità» che Levinas vi riconosce, denominandola Passione.
Nel IV capitolo (La soggettività etica come approche-sostituzione) abbiamo
tenuto sempre come sfondo il Quarto capitolo di Altrimenti che essere, intitolato «La
288
sostituzione», sulla base dell’esegesi del quale si è cercato di proporre una delineazione della soggettività etica alla luce dell’approfondimento tentato nella parte precedente del nostro studio.
Questo capitolo ha inteso dar conto della peculiare concezione della soggettività etica, facendo tesoro del cammino precedente, e cioè valorizzando la particolare cifra paradossale e iperbolica in cui si concreta questa soggettività come passività
– passione – sostituzione; paradossale perché non è una semplice resa al male, ma un
tentativo di ricostituire un senso nel contesto della disgregazione assoluta dell’il y a,
che in Auschwitz è apparsa in maniera iperbolica. L’esergo di AE, la dedica alle vittime della Shoah, inaugura il tentativo di delineazione di una soggettività come ricostituzione del senso che è parsa là sprofondare, consegnando all’oblio i volti e i nomi
propri delle vittime. Il lessico “traumatologico” di AE trova dunque la sua origine e
la sua profondità se inserito nell’orizzonte della risposta etica innanzitutto alla sofferenza «per nulla» degli innocenti che, nell’evento Shoah, trova la sua esemplarità
universale.
In particolare, questo ultimo capitolo intende chiarificare il significato di un
termine chiave in AE, quello di approche, facendo particolarmente valere la significativa sovrapponibilità semantica – segnalata del resto dall’autore – con il termine
korbàn, che traduce una delle dimensioni del «sacrificio» (termine che cerchiamo di
problematizzare adeguatamente) inteso, a partire da uno schema etico e in maniera
nonviolenta, sempre come dono umanizzante di sé all’altro, che è contemporaneamente testimonianza della traccia dell’Illeità in cui avviene l’inversione del conatus
essendi e la liberazione della soggettività del sè.
Proprio il carattere peculiare della dimensione del dono di sé –malgrado sé,
che emerge nello strato profondo dello psichismo (lo je o moi, affetto da un trauma
preoriginale, tanto più ossessionante quanto più cresce questo approche – avvicinamento verso l’altro e verso l’alto – nei confronti del volto, in cui si manifesta la mortalità del prossimo) indica l’eidos fenomenologico della soggettività etica come «santità», tema centrale di AE.
La questione inoltre dei limiti del sacrificio, – emergente con l’apparizione
del terzo e quindi con lo strato della riflessione filosofica sul dinamismo profondo
dello psichismo – che nel nostro studio abbiamo toccato in conclusione, senza però
289
approfondirla (ciò che avrebbe richiesto uno studio a sé), può mostrare la via in cui
orientare una praticabilità dell’etica concreta, quella in cui appare la società e quindi
si rende necessaria la ricerca della giustizia e del diritto. La concreta prassi etica responsabile dovrà essere intessuta sempre del rimando all’eidos della santità, e dovrà
vivere nel fremito di questo rimando; essa non sarà mai quindi rubricabile a semplice
esasperazione «masochistica» del senso di colpa del sopravvissuto, come in primissima istanza una lettura frettolosamente «psicoanalitica» potrebbe dar adito a pensare. D’altra parte, non si possono neppure eludere i frequenti richiami alla «colpevolezza» che, secondo Levinas, affetta lo strato più profondo dello psichismo: rispetto a
questo, il richiamo allo studio della genesi e del decorso psicoanalitico del concetto
di trauma, connesso alle esperienze soggettive e collettive, ha cercato di fornire un
ausilio interpretativo che riteniamo non inutile.
Il contributo teoretico che si è inteso apportare agli studi levinassiani è stato
dunque quello dell’affondo del plesso trauma-passione-sostituzione, dove il trattino
non solo congiunge i termini, ma li annoda in un intrigo non disambiguabileo «liofilizzabile» in un detto etico definitivo.
Un’etica prescrittiva o precettistica, che ben difficilmente si potrebbe trarre
dall’opera levinassiana, pagherebbe comunque il prezzo troppo alto della perdita
dell’autentico spessore del dire tradotto nel libro che abbiamo cercato di interpretare.
In esso la profonda ed equivoca congiuntura della soggettività etica emerge come
attraverso una biffure: barratura che rivela, alza e sottoscrive il segno barrato con cui
la soggettività si avvicina al Bene, ma che anche costringe a non interrompere il domandare, bensì a rilanciarlo e intensificarlo. Nonostante-e-attraverso il silenzio in cui
risuona l’eco, oltre che del «grido senza numero» (Blanchot) anche del nostro – del
mio – interrogarmi sulla sofferenza innocente, per resistervi: bisogna cercare il senso
del male e della sofferenza dell’altro in me, e di me nell’altro, quella sofferenza gratuita rispetto alla quale la mia vita è sempre quella di un sopravvissuto, che è votato a
risponderne.
290
BIBLIOGRAFIA
1. OPERE DI LEVINAS
La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Alcan, Paris 1930; successive edizioni Vrin, Paris; a c. di S. Petrosino, tr. it. di F. Perego, La teoria
dell’intuizione nella fenomenologia di Husserl, Jaka Book, Milano 2002.
- Quelques réflexions sur la philosophie de l’Hitlerisme, «Esprit», II, 1934, 199-208;
tr. it. di A. Cavalletti, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1996.
- De l’évasion, in «Recherches Philosophiques», V, 1935-36, 373-392, riedito in volume da J. ROLLAND, Fata Morgana, Montpellier 1982; Le Livre de poche,
Paris 1998; tr. it di D. Ceccon, Dell’evasione, Cronopio, Napoli 2008.
- Leon Chestov. Kierkegaard et la philosophie existentielle (Vox clamantis in deserto) – traduit du russe par T. Rageot e B. de Schloezer – Vrin, Paris 1936,
«Revue des Études juives», julliet-décembre 1937, pp. 139-141.
- De l’existence à l’existant, Fontaine, Paris 1947; Vrin, Paris 1963, rist. 1990; tr. it.
di F. Sossi, Dall’esistenza all’esistente, Marietti 1820, Milano 20043.
- Le temps et l’autre, in J. Wahl et al., Le Choix, Le monde, L’Existence («Cahier du
Collège Philosophique»), B. Artaud, Paris-Grenoble 1948, 125-196; 2 Ed. Fata Morgana, Montpellier 1979; 3 ed. PUf, Paris 1983;.tr. it. di F.P. Ciglia, Il
tempo e l’altro, il melangolo, Genova 1987.
- En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1949, 2a Ed. aumentata 1967, 2006 ; tr. it. di F. Sossi, Scoprire l’esistenza con Husserl et
Heidegger, Raffaello Cortina, Milano 1998.
- Totalitè et Infini. Essai sur l’extériorité, Nijhof, Den Haag 1961, Le Livre de poche, Paris 1990; tr. it. di A. Dall’Asta, Totalità e infinito, Jaka Book, Milano
1980, 2 ed. con Introduzione di S. Petrosino, ivi 1990.
291
- Difficile Liberté. Essais sur le Judaïsme, Albin Michel, Paris 1963; 2 ed. rifusa e
completata, ivi 1976; 3a Ed. conforme alla 2a, Le Livre de poche, Paris 1984;
tr. it a c. di S. Facioni, Difficile Libertà, Jaka Book, Milano 2004.
- Quatres Lectures Talmudiques, Èditions de Minuit, Paris 1968; tr. it. di A. Moscato, Quattro letture talmudiche, il melangolo, Genova 1985.
- Humanisme de l’autre homme, Fata Mogana, Montpellier 1972; tr. it. di A. Moscato, il melangolo, Genova 1985.
- Autrement qu’ être ou au-delà de l’essence, Nijhof, Den Haag 1974, 1978, Le Livre
de poche Paris 1978, 2006; tr. it. di S. Petrosino e M.T. Aiello, Altrimenti che
essere o al di là dell’essenza, Jaka Book, Milano 1983.
- Sur Maurice Blanchot, Fata Morgana, Montpellier 1975; tr. it. di A. Ponzio, a c. di
F. Fistetti, Su Blanchot, Palomar, Bari 1994.
- Nomes Propres, Fata Morgana, Paris 1976, Le livre de poche, Paris 1987; tr. it. e
intr. di F.P. Ciglia, Nomi propri, Marietti, Casale Monferrato, 1984.
- Du Sacré au Saint, Cinq Nouvelles Lectures Talmudiques, Minuit, Paris 1977; tr. it.
di O. Nobile Ventura, Dal sacro al santo, Città Nuova, Roma 1985.
- De Dieu qui vient à l’Idée, Vrin, Paris 1982, 2 ed. rivista e aumentata con una nuova Préface, ivi 1986; ed. Le livre de poche-Vrin, Paris 1992; tr. it. della 1a ed.
a c. di G. Zennaro, a c. di S. Petrosino, Di Dio che viene all’idea, Jaka Book,
Milano 1983.
- Ethique et Infini. Dialogue avec Philippe Nemo, Fayard et Radio France, Paris
1982; Le livre de poche Paris 1986; tr. it. a c. di F. Riva, Etica e Infinito, Città
Aperta, Troina 2008.
- L’au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques, Minuit, Paris 1982.
- Trascendence et intellegibilitè, Labor et Fides, Genève (1984) 1996; tr. it. di F. Camera, Marietti 1820, Milano 20092.
- (con A. PEPERZAK) Etica come filosofia prima, a c. di F. Ciaramelli, Guerini e
Associati, Napoli 1989.
- Hors Sujet, Fata Morgana, Montpellier 1987, Le livre de poche, Paris 1997; tr. it. di
F.P. Ciglia, Fuori dal Soggetto, Marietti, Milano 1992.
- A l’heure des nations, Minuit, Paris 1988; tr.it. di S. Facioni, Nell’ora delle nazioni,
Jaca Book, Milano 2008.
292
- Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Grasset, Paris 1991; tr.it. di E. Baccarini,
Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, Jaca Book, Milano 1998.
- Dieu, la mort et le Temps, Établissement du texte, notes et postface de J. ROLLAND,
Grasset, Paris 1993 ; tr. it. di S. Petrosino, Dio, la morte e il tempo, Jaca
Book, Milano 1996.
- Libertè et commandement, a c. di P. HAYAT, Fata Morgana, Montpellier 1994.
- Les imprevus de l’Histoire, a c. di P. HAYAt, Fata Morgana, Paris 1994.
- Alteritè et transcendendance, a c. di P. HAYAT, Fata Morgana, Paris 1995, Le Livre
de poche, Paris 2008; tr. it. di S. Regazzoni, Alterità e trascendenza, il melangolo, Genova 2006.
- Nouvelles Lectures Talmudiques, Minuit, Paris 1996; tr. it. di. B. Caimi, Nuove letture talmudiche, SE, Milano 2004.
- Carnet de captivitè suivi de Écrits sur la captivité et Notes philosophiques diverses,
(ŒUVRES 1), a c. di R. CALIN e C. CHALIER, Grasset & Fasquelle/Imec, Paris
2009.
- Parole et silence, et autres conférences inédites, (Œuvres 2), a c. di R. CALIN e C.
CHALIER, Grasset & Fasquelle/Imec, Paris 2009.
2. OPERE COLLETTANEE SU LEVINAS
AA.VV., Textes pour Levinas, a c. di F. LARUELLE E J-M. PLACE, PUF, Paris 1980.
AA.VV., A partire da Levinas, la passività del soggetto, l’ombra dell’essere, l’enigma dell’etica, «aut aut», n. 209-210, 1985.
AA.VV., Intorno a Levinas, a c. di P. A. ROVATTI, Unicopli, Milano 1987.
AA.VV., Lévinas, Le Cahier de l’Herne, a c. di C. CHALIER e M. ABENSOUR, Éd. De
l’Herne, Paris 1991, 2006.
AA.VV., E. Lévinas. L’étique comme philosophie première, Atti del Colloquio di Cerisy-la-Salle (23 Agosto - 2 Settembre 1986), a c. di J. GREISCH e J. ROLLAND,
La Nuit Surveillée, Cerf, Paris 1993.
293
AA.VV, Messianisme, «Cahiers d’Études Lévinassiennes», n. 4/ 2005.
AA.VV., Emmanuel Levinas, «Rue Descartes», (1a ed. PUF, Paris 1998), PUF, Paris
2006.
AA.VV., Levinas, a c. di D. COHEN-LEVINAS, Bayard, Paris 2006
AA.VV., Levinas in Italia, «Teoria», XXVI/2/2006.
AA.VV., Emmanuel Levinas et les territoires de la pensée, a c. di D. COHEN-LEVINAS
e B. CLEMENT, PUF, Paris 2007.
AA.VV., Emmanuel Levinas. Prophetic Inspiration and philosophy, Atti del Convegno internazionale per il centenario della nascita (Roma, 24-27 maggio 2006),
a c. di I. KAION, E. BACCARINI, F. BREZZI, J. HANSEL, Giuntina, Firenze 2008.
AA.VV., La responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra
alterità e terzietà, a c. di M. DURANTE, il melangolo, Genova 2008.
AA.VV,. Levinas et l’expérience de la captivité, Actes du Colloque 4 Octobre 2010, a
c. di D. COHEN-LEVINAS, Lethielleux, Paris 2011.
3. OPERE O ARTICOLI DI ALTRI AUTORI
AA.VV., Psiche, Dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, 2 voll., Einaudi, Torino 2006-2007.
AA.VV., Trauma e relazioni. Le prospettive scientifiche e cliniche contemporanee, a
c. di R. Williams, Raffaello Cortina, Milano 2009.
AA.VV, L’ombra del trauma. Sui limiti della simbolizzazione, «Quaderno del Centro
Psicoanalitico di Roma» – N. 3, Franco Angeli, Roma 2009
ABRAHAM, K., Opere, Vol 1, a c. di J. Cremerius, Bollati Borighieri, Torino 1997
(1aed. 1975).
ADORNO, T. W., Negative Dialektik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1966; tr.
it. di S. Petrucciani, Dialettica negativa, Einaudi, Torino2004.
-
Philosophische Terminologie, Surkamp Verlag, Franfurt am Main 1973, tr. it. A,
Solmi, Termonologia filosofica, Einaudi 2007.
AGAMBEN, G., Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri, Torino 1998.
294
ALICI, L., Il terzo escluso, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2004.
AMERY, J., Janseits von Shuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Szczesny Verlag, München 1966; tr. it. di E. Ganni, Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
ARENDT, H., Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1a ed. 1965),
tr. it. di P. Bernardini, La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 1964.
ARISTOTELE, Metafisica, tr. it. di A. Russo, Laterza, Roma-Bari 19904.
BACCARINI, E., Levinas. Soggettività e Infinito, Studium, Roma 1999.
BACHELARD, G. La poétique de l’espace, PUF, Paris 1957; tr. it di E. Catalano, La
poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari 1975, 2006.
BADIOU, A., Saint Paul. La fundation de l’universalisme, PUF, Paris 1997; tr. it. di F.
Ferrari e A. Moscati, Cronopio, Napoli 1999.
BAHBOUT, I., GENTILI, D., TAGLIACOZZO, T., (a c. di) Il messianismo ebraico, Giuntina, Firenze 2009.
BAILLHACHE, G., Le sujet chez Emmanuel Lévinas. Fragilité et subjectivité, PUF, Paris 1994.
BANON, D., La Lecture infinie. Les voies de l’intérpretation midrachique, Édition du
Seuil, Paris 1987; tr. it. di G. Regalzi, La lettura infinita. Il Midrash e le vie
dell’interpretazione nella tradizione ebraica, Jaca Book, Milano 2009.
- Le messianisme, PUF, Paris 1998 ; tr. it. di V. Lucattini Vogelmann, Il messianismo, Giuntina, Firenze 2000.
BAR-ZVI, M., Être et Exil. Philosophie de la Nation Juive, Les Provinciales-Cerf, Paris 2006.
BENJAMIN, W., Schriften, Surkamp Verlag, Berlino 1955; tr. it. di R. Solmi, Angelus
novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1962.
BENSUSSAN, G., Qu’est-ce que la philosophie juive?, Desclée De Brouwer, Paris
2003.
-
Étique et expérience. Levinas politique, La Phocide, Strasbourg 2008 ; tr. it. di S.
Geraci, Etica ed esperienza. Levinas politico, Mimesis, Milano- Udine, 2010.
BERCHERIE, P., - NEUHAUS, M., Levinas et la psycanalyse. Enquête sur une aversion,
L’Harmattan, Paris 2005.
295
BERGSON, H., Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, Paris 1932, tr. it.
di A. Pessina, Le due fonti della morale e della religione, Laterza, Roma Bari
19982.
BETTELHEIM, B., The Informed Heart. Autonomy in a Mass Age, The Free Press, a
Corporation ; tr. it. di P. Bertolucci, Il cuore vigile. Autonomia individuale e
società di massa, Adelphi, Milano 1988.
- Surviving and Other Essays, tr. it. di A. Bottini, Sopravvivere e altri saggi, SE, Milano 2005.
BLANCHOT, M., L’entretien infini, Gallimard, Paris 1969; tr. it. di R. Ferrara, L’infinito intrattenimento, Einaudi, Torino 1977.
- L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980, tr. it. di F. Sossi, La scrittura del disastro, SE, Milano 1990.
- Écrits politiques. Guerre d’Algérie, mai 68, etc. 1958-1993, Lignes Éditions Léo
Scheer, Paris 2003; tr.it di C. Colangelo, Nostra compagnia clandestina.
Scritti politici (1058-1993), Cronopio, Napoli 2004.
BODEI, R., La filosofia nel Novecento, Donzelli, Roma 2006.
BONHÖFFER, D., Nachfolge, Kaiser Verlag, München 1937; tr. it. di M.C. Laurenzi,
Sequela, in Opere, Vol. IV, Queriniana, Brescia 1997.
BORSATO, B., L’alterità come etica: una lettura di Emmanuel Levinas, EDB, Bologna 1995.
BOURETZ, P., Témoins du futur. Philosophie et messianisme, Éditions Gallimard, Paris 2003, tr. it. di A. Rizzi, Testimoni del futuro. Filosofia e messianismo nel
Novecento, Città Aperta Edizioni, Troina (En) 2009.
BURG, A., Victory over Hitler (Lenazeach et Hitler), Myskal – Yedioth Ahronoth
Books and Chemed Books, Tel Aviv 2007; tr. it. di E. Loeventhal, Sconfiggere Hitler. Per un nuovo universalismo e umanesimo ebraico, Neri Pozza,
Vicenza 2008.
CALIN, R., Levinas et l’exception du soi, PUF, Paris 2005.
CALIN, R.– SEBBAH., F.-D., Le vocabulaire de Lévinas, Ellipses, Paris 2002.
CAMERA, F., L’ermeneutica tra Heidegger e Levinas, Morcelliana, Brescia 2001.
CANZI, C. – RONCHI, V., Genealogia di Totalità e Infinito, ExCogita Editore, Milano
2004.
296
CHALIER, C., Lévinas. L’utopie de l’humaine, Albin Michel, Paris 1992.
- La Trace de l’infini. Emmanuel Levinas et la source hébraïque, Cerf, Paris 2002.
- Désir et appel, Lévinas et la psychanalise, «Le Coq-Heron» n. 171, 4/2002, pp. 1325.
CHIAPPINI, A., Amare la Torah più di Dio. Emmanuel Lévinas lettore del Talmud,
Giuntina, Firenze 1999.
CIGLIA, F. P., Un passo fuori dall'uomo. La genesi del pensiero di Lévinas, CEDAM,
Padova 1988.
- Fenomenologie dell'umano. Sondaggi eccentrici sul pensiero di Lévinas, Bulzoni,
Roma 1996.
- Fra umiliazione e sostituzione. La «fenomenologia» levinasiana del Dio Uomo,
«Teoria», XXVI/2006/2, pp. 99-136.
- Fra Atene e Gerusalemme. Il “nuovo pensiero” di Franz Rosenzweig, Marietti
1820, Genova-Milano 2009.
CIARAMELLI, F., Transcendance et étique. Essai sur Lévinas, Ousia, Bruxelles 1989.
- La distruzione del desiderio. Il narcisismo nell’epoca del consumo di massa, Edizioni Dedalo, Bari 2000.
CLEMENTE, L.F., Un idealismo senza ragione. La fenomenologia e le origini del pensiero di Emmanuel Lévinas, Ombre Corte, Verona 2008.
COHEN, H., Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Nach dem Manuscript des Verffassers neu durchgearbeitet und mit einem Nachwort versehen
von Bruno Strauss, Frankfurt a. M., Kauffmann, 1929, tr. it. di A. Poma, Religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo, San Paolo, Milano 1994.
COHEN, J., Alternances de la métaphysique. Essais su Emmanuel Levinas, Éditions
Galilée, Paris 2009.
COHEN-LEVINAS, D.-CLÉMENT, B., (a c. di), Emmanuel Levinas et le territoires de la
pensée, PUF, Paris 2007.
D’ABBIERO, M. (a c. di), Desiderio e filosofia. Descartes, Hegel, Freud, Heidegger,
Sartre, Kojeve, Battaille, Caillois, Lacan, Derrida, Guerini e Associati, Milano 2003.
DE BENEDETTI, P., Quale Dio? Una domanda dalla storia, Morcelliana, Brescia
1999.
297
DERRIDA, J., La Voix et le phénomene, PUF, Paris 1967 ; tr. it. di G. Dalmasso, La
voce e il fenomeno, Jaca Book (1a ed. it. 1968), 5a ed. it. 2010.
- Marges – de la philosophie, Éditions de Minuit, Paris 1972; tr. it. di M. Iofrida,
Margini – della filosofia, Einaudi, Torino 1997.
- Abraham, l’autre, Éditions Galilée, Paris 2003; tr. it. di T. Silla, Abramo l’altro,
Cronopio, Napoli 2005.
- L’écriture et la differénce, Éditions du Seuil, Paris 1967; tr. it. di Gianni Pozzi, La
scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 20023.
- Adieu à Emmanuel Levinas, Éditions Galilée, Paris 1997; tr. it. di S. Petrosino e M.
Odorici, Addio a Emmanuel Lévinas, Jaca Book, Milano 1998.
- L’animal que donc je suis, Éditions Galilée, Paris 2006; tr. it. di M. Zannini, L’animale che dunque sono, Jaca Book, Milano 2006.
J. DERRIDA, «En ce moment même dans cet ouvrage me voici», in AA.VV., Textes
pour Emmanuel Lévinas, J.-M. Place, Paris 1980, pp. 21-60; ripreso in Psyché, Éditions du Seuil, Paris 1987, pp. 159-202; tr. it. di R. Balzarotti, «In
questo medesimo momento in quest’opera eccomi», in Psyché, Jaca Book,
Milano 2008, pp. 173-224.
DI SANTE, C., Parola e Terra. Per una teologia dell’ebraismo, Marietti, Genova
1990.
- La passione di Gesù. Rivelazione della nonviolenza, Città Aperta, Troina (En)
2007.
DUPORTAIL, G.-F., Intentionalité et Trauma. Levinas et Lacan, L’Harmattan, Paris
2005.
DURANTE, M. (a c. di), La responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà, il melangolo, Genova 2008.
DUVAL, R, Exode et altérité, «Revue de sciences philosophiques et théologiques»,
LIX, 1975, n. 2, pp. 217-241.
FABRIS, A., Levinas e il senso dell’etica, «Teoria» XXVI/2006/2.
FACKENHEIM, E. L., God’s Presence in History. Jewish Affirmations and Philosophical Reflections, Ney York University Press, New York 1070; tr. it. di F. Savoldi, La presenza di Dio nella storia. Saggio di teologia ebraica, Queriniana, Brescia 1977.
298
- To
mend
the
World.
Foundations
of
Post-Holocaust
Jewish
Thought,
1982,1989,1994 by E. L. Fackenheim; tr. it. di M. Doni, Tiqqun- Riparare il
mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah, a c. di M. Giuliani,
Medusa, Milano 2010.
- «Holocaust», in AA.VV., Contemporary Jewish Religious Thought (1987), tr. it. Introduzione e postfazione di Massimo Giuliani, Olocausto, Morcelliana, Brescia 2011.
FAIRBAIRN, W.R.D., Psycoanalytic Studies of the Personality, Routledge & Keagan,
London 1952; tr. it. di A. Bencini Bariatti, Studi psicoanalitici sulla personalità, Bollati Boringhieri, Milano 1985.
FENICHEL, O., The psychoanalytic Theory of Neurosis, W.W. Norton & Co., New
York 1934, tr. it. di C. Gastaldi, Trattato di Psicoanalisi delle nevrosi e delle
psicosi, Astrolabio, Roma 19512.
FERENCZI, S., Journal clinique, Payot, Paris 1958; tr. it. di S. Sella Tournon, Diario
Clinico, Raffaello Cortina, Milano 1988.
- Psychalayse 4, Œuvres completes, Tome IV: 1927-1933, Payot, Paris 1982, tr. it. di
M. Novelletto Celletti, E. Ponsi Franchetti, L. Resele e P. Rizzi, Opere,
Volume Quarto (1927-1933), Raffaello Cortina, Milano 2002.
FERRETTI, G., La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier,
Torino 1996.
- Il bene al-di-là dell’essere. Temi e problemi levinassiani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma 2003.
- Ontologia e teologia in Kant, Rosenberg & Sellier, Torino 1997.
- Trascendenza
teologica
non
violenta
in
Emmanuel
Levinas,
«Teoria»,
XXVI/2006/2, pp. 77-97.
FORNARI, G., Da Dioniso a Cristo. Conoscenza e sacrificio nel mondo greco e nella
civiltà occidentale, Marietti, Genova 2006.
FRANCK, D., L’un-pour-l’autre. Levinas et la signification, PUF, Paris2008.
FRANKL, V.E., Uno psicologo nei lager, Ares, Milano 2009.
FREUD, S., Opere, 12 Voll., a c. di C. L. Musatti, Bollati Borinhieri, Torino (1a ed.
1967-1993) 2008.
299
GIRARD, R., La violence et le sacré, Grasset, Paris 1972, tr. it. di O. Fatica e E. Czerkl, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980.
- Des choses cachées depuis la fondations du monde, Grasset & Fasquelle, Paris
1978; tr. it. di R. Damiani, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi, Milano 20054.
- Le Bouc émissaire, Grasset, Paris, 1982; tr. it di Ch. Leverd e F. Bovoli, Il capro
espiatorio, Adelphi, Milano 1987.
GIULIANI, M., Auschwitz nel pensiero ebraico. Frammenti dalle “teologie dell’Olocausto”, Morcelliana, Brescia 1998.
- Levinas e il giudaismo, ovvero al di là della filosofia, «Studia Patavina. Rivista di
scienze religiose», n.3/2000.
- Il pensiero ebraico contemporaneo. Un profilo storico-filosofico, Morcelliana, Brescia 2003.
GHEDINI, L., Dialogo con Emmanuel Lévinas, Morcelliana, Brescia 1987.
GROSSMAN, D., `Ayen `erekh : "Ahava", Keter, Yerushalayim 1986; tr. it. di G. Sciloni, Vedi alla voce amore, Oscar Mondadori, Milano 20107.
GROSSMAN, V., Җизнь и cyдьба, L’Age d’Homme and the Estate of Vassili Grossman 1980-1992, tr. it Vita e destino, tr. it. di C. Zonghetti, Adelphi, Milano
2008.
GREEN, A., These are the Words, Jewish Light Publishing, Woodstock, Vermont
1999; tr. it. di R. Volponi, Queste sono le parole. Un dizionario della vita spirituale ebraica, Giuntina, Firenze 2002.
GUIBAL, F., La Glorie en exil. Le témoignage philosophique d’Emmanuel Levinas,
Cerf, Paris 2004.
HAÏM DI VOLOZIN, Nefesh ha-haïm; tr. fr. di B. Gross, L’âme de la vie (con Préface
di E. Levinas) Verdier, Paris 1986.
HAYAT, P., La critique de la préminence du présent. Subjectivité et «entretemps»
d’après Levinas, «Revue Philosophique de Louvain» 107(2), 2009, pp. 301317
HEGEL, G.W.F., Der Geist des Christentums und sein Schicksal (1799/1800), Lo spirito del cristianesimo e il suo destino, in Scritti teologici giovanili, tr. it. di G.
Vaccaro e E. Mirri, Guida, Napoli 1977.
300
- Die Phänomenologie des Geistes, Goebhardt, Bamberg - Wurzburg 1907; tr. it. di
E. De Negri, Fenomenologia dello spirito, La Nuova Italia, Firenze, (1a Ed. it.
1960) 19909.
HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1927; tr. it. di P.
Chiodi riv. da F. Volpi, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2006
- Der Ursprung des Kunstwerkes, in Holzwege, Klostermann, Frankfurt am Main
1950, tr. it. di P. Chiodi, L’origine dell’opera d’arte, in Sentieri interrotti, La nuova
Italia, Firenze, 1989.
- Einfürung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1966; tr. it. di G.
Masi, Mursia, Milano 19688.
- Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 1983, tr. it. di P. Coriando, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo-finitezza-solitudine, il melangolo, Genova
1999.
- Vortäge und Aufsäze, Günther Neske Verlag, Pfullingen 1957, tr. it. di G. Vattimo,
Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1991.
HESCHEL, A.J, God in Search of Man. A philosophy of Judaism, Farrar, Straus &
Giroux, New York 1955; tr. it. di E. Mortara Di Veroli, Dio in cerca
dell’uomo. Una filosofia dell’ebraismo, Borla, Roma 1980.
HÖFFE, O., Immanuel Kant, C.H. Beck, München 1983; tr. it. di S. Carboncini, a c. di
V. Verra, Immanuel Kant, Il Mulino, Bologna 1986.
HOUSSET, E., L’interioritè d’exil. Le soi au risque de l’altérité, Cerf, Paris 2008.
HUSSERL, E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Libro I, Martinus Nijhoff, Den Haag 1976, tr. it. di V. Costa, Idee
per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro primo.
Introduzione alla fenomenologia pura, Einaudi, Torino 2006.
JANKELEVITCH, V., L’irréversible et la nostalgie, Flammarion, Paris 1974.
- La mort, Flammarion, Paris 1977 ; tr. it. di V. Zini, La morte, (a c. di E. Lisciani
Petrini), Einaudi, Torino 2009.
- Sources, Éditions du Seuil, Paris 1984; tr. it. parziale di D. Vogelmann, La coscienza ebraica, Giuntina, Firenze 1995.
301
- Pardonner?, Éditions du Seuil, Paris 1986, tr. it. di D. Vogelmann, Perdonare?,
Giuntina, Firenze, 20043.
JONAS, H., The gnostic Religion. The message of the Alien God and the Beginnings of
Christianity, Beacon Press, Boston, 1a ed. 1958, tr. it. di R. Farina, Lo gnosticismo, SEI, Torino (1a ed. 1973) 1991.
JUFFÈ, M. Genèse du sujet et altérité, chez Nicolas Abrahm et Ennamuel Lévinas,
«Le Coq-Heron» n. 171, 4/2002, pp. 26-46.
KAHN, M. MASUD.R. The privacy of the Self, Hogart Press, London 1974, tr.it. di C.
Ranchetti Varon e E. Sagitario, Lo spazio privato del sé, Bollati Boringhieri,
Torino 1979.
KAJON, I. (a c. di), Storia della filosofia ebraica, CEDAM, Padova 1993.
- Auschwitz come esperimento cruciale. Il «servo sofferente» (Isaia 49-59)
nell’interpretazione di André Néher ed Emmanuel Levinas, in Il bene e il male dopo Auscwitz. Implicazioni etico-teologiche per l’oggi, Atti del simposio
internazionale (Roma 22-25 Settembre 1997), a c. di E. Baccarini – L. Thorson, pp. 273-285.
- Il pensiero ebraico del novecento, Donzelli, Roma 2002.
KAJON, I., BACCARINI, E., BREZZI, F., HANSEL, J. (a c. di) Emmanuel Levinas. Prophetic Inspiration and Philosophy. Atti del convegno internazionale per il
Centenario della nascita. Roma, 24-27 maggio 2006, Giuntina, Firenze 2008.
KANT, I., Kritik der Urtheilskraft, AK V; tr. it. di A. Gargiulo rev. di V. Verra, Critica del Giudizio, Laterza, Roma-Bari, 1992.
- Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, AK VI; tr. it. di M.M.
Olivetti, La religione nei limiti della sola ragione, Laterza, Roma-Bari, 19953.
- Der Streit der Fakultäten, Zweiter Abschnitt. Der Streit der philosophischen Facultät mit der juristischen, Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschlecht im
beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, AK VII; tr. it. Se il genere umano sia in
costante progresso verso il meglio, in Scritti di storia, politica e diritto, a .c. di S.
Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 2004.
KASPER, J., Trauma e nostalgia. Per una lettura del concetto di Heimat, Marietti,
Genova-Milano 2009.
KLEIN, M., Scritti 1921-1958, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
302
KRYSTAL, H., Integration & Self-Healing: Affect, Trauma, Alexithymia, The analytic
Press, Hilldsale, New Jersey 1993, tr. it. di L. Perez, Affetto, trauma, alessitimia, Magi, Roma 2007.
KRISTEVA, J., Au risque de la pensée, Éditions de l’Aube, Paris 2001; tr. it. di E.
Convento, Il rischio del pensare, il melangolo, Genova 2006.
- Au commencement était l’amour. Psychanalyse et foi, Hachette, Paris 1985, tr. it di
L. Xella, In principio era l’amore. Psicoanalisi e fede, SE, Milano 2001.
LABATE, S., La sapienza dell’amore. In dialogo con Emmanuel Levinas, Cittadella
Editrice, Assisi 2000.
- La verità buona. Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Cittadella
Editrice, Assisi 2004.
LACAN, J., Le seminaire de Jacques lacan. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris 1973; tr. it. di A. Di Ciaccia, M. Daubresse e A. Succetti, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali
della psicoanalisi 1964., Einaudi, Torino (1a ed. 1979) 2003.
LAPLANCHE, J. - PONTALIS, J.-B., Vocabulaire de la psychanlyse, PUF, Paris 1967;
ed. it. a c. di G. Fua, Enciclopedia della psicoanalisi, 2 Voll., Laterza, RomaBari 20088.
LANDA, E. Lévinas, le rêve et la psychanalyse: une vignette, à partir des Quatre lectures Talmudiques, «Le Coq-Heron» n. 171, 4/2002, pp. 57-59
LESCOURRET, M.-A., Emmanuel Levinas, Flammarion, Paris 1994.
LEVI, P., Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati, in Opere I, Einaudi,
Torino 1987.
- Se non ora quando?, Einaudi, Torino1992.
LEVI DELLA TORRE, S., Essere fuori luogo. Il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno,
Donzelli, Roma 1995.
- Zone di turbolenza. Intrecci, somiglianze, conflitti, Feltrinelli, Milano 2003.
LEVY, B. Visage continu. La pensée du retour chez Emmanuel Lévinas, Verdier, Paris 1998.
LÖWY, M., Rédemption et utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale. Un
étude d’affinité élective, PUF, Paris 1988 ; tr. it. di D. Bidussa, Redenzione e
303
utopia. Figure della cultura ebraica mitteleuropea, Bollati Boringhieri, Torino 1992.
LORENZ, D., I fondamenti dell’ontologia tomista: Il trattato De ente et essentia, ESD,
Bologna 1992.
MALKA, S., Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, Jean-Claudie Lattes, Paris 2002 ;
tr. it. di C. Polledri, La vita e la traccia, Jaca Book, Milano 2003.
- Lire Lévinas, Cerf, Paris 1984; tr. it. di E. Baccarini Leggere Lévinas, Queriniana,
Brescia 1986
MANCINI, R., Esistenza e gratuità. Antropologia della condivisione. (1a ed. 1996),
Cittadella Editrice, Assisi 2009.
- L’amore politico. Sulla via della non violenza con Gandhi, Capitini e Levinas, Cittadella Editrice, Assisi 2005.
- Il servizio dell’interpretazione. Modelli di ermeneutica nel pensiero contemporaneo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010.
MARION, J.-L., L’idole et la distance, Grasset, Paris 1977; tr. it. di A. Dell’Asta, L’idolo e la distanza, Jaca Book, Milano 1979.
- Dieu sans l’être, (1982), PUF, Paris 1982, tr. it. di A. Dall’Asta e C. Canullo, Dio
senza essere, Jaca Book (1a ed. 1987), Milano 2008 2a ed. aggiornata e aumentata.
- (a c. di) Positivité et transcendance. Etudes su Lévinas et la phénoménologie, PUF,
Paris 2000.
MARCOLUNGO, F.G., Etica e metafisica in Emmanuel Lévinas, IPL, Milano 1995.
MARCEL, G., Le monde cassé, Desclée de Brouwer, Paris 1933; ed. it. in ID., Teatro,
a c. di Passeri Pignoni, tr. di G. Zanobetti, Abete, Roma 1973.
MCWILLIAMS, N., Psychoanalytic diagnosis. Under standing personality structure in
the clinical process, The Guilford Press – New York, London 1994, tr. it. di
G. Baldaccini e L. Riommi Baldaccini, a c. di L. Sarno e V. Caretti, La diagnosi psiconalitica. Struttura della personalità e processo clinico, Astrolabio,
Roma 1999.
MEGHNAGI, D., Ricomporre l’infranto. L’esperienza dei sopravvissuti alla Shoah,
Marsilio, Venezia 2005.
304
MELCHIORRE, V., Analogia e analisi trascendentale. Linee per una nuova lettura di
Kant, Mursia, Milano 1991.
MERLEAU-PONTY, M., Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945; tr.
it. di A. Bonomi Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 20032.
- Le visible et l’invisible, Éditions Gallimard, Paris 1964; tr. it. di A. Bonomi, nuova
edizione a c. di M. Carbone, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 2007.
- MOSÈS, S., Au-delà de la guerre. Trois études sur Levinas, Éditions de l’éclat, Paris-Tel Aviv 2007; tr. it. di D. Di Cesare, Al di là della Guerra. Tre saggi su
Levinas, il melangolo, Genova 2007.
- Un retour au judaïsme. Entretiens avec Victor Malka, Éditions du Seuil, Paris
2008; tr. it. di O. Di Grazia, Un ritorno all’ebraismo. Colloqui con Victor
Malka, Claudiana, Torino 2009.
MUCCI, C., Il dolore estremo. Il trauma da Freud alla Shoah, Borla, Roma 2008.
- Psicoanalisi, letteratura, testimonianza: parola e narrazione come etica, da Freud
alla Shoah, «Rivista di letterature moderne e comparate», vol. 64, n. 1, 2011,
51-70.
NARBONNE, J.-M., Lévinas et l’Héritage grec, suivi de Cent’ans de Néoplatonisme en
France par WAYNE HANKEY, Vrin, Paris 2004.
NEHER, A., L’exil de la parole. Du silence biblique au silence d’Auschwitz, Éditions
du Seuil, Paris 1970; tr. it. di G. Cestari, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Marietti, Genova 1983.
- Clefs pour le joudaïsme, Éditions Seghers, Paris 1977; tr. it. di E. Piattelli, Chiavi
per l’ebraismo, Marietti, Genova 1988.
NEMO, PH., Job et l’excès du mal, Albin Michel, Paris 20012; tr. it. di T. di Blasio,
Giobbe e l’eccesso del male. Con un contributo di Emmanuel Levinas (tr. it.
di S. Petrosino Trascendenza e male), Citta Nuova, Roma 2009.
NOVALIS, Schriften, Bd. 2, Fr. 21, 179, Hg. L Minor, Jena 1923; tr. it. di E. Pocar,
Frammenti, (1a ed. Rizzoli, Milano1976) BUR, Milano 20087.
OLIVETTI, M.M., Analogia del soggetto, Laterza, Roma-Bari 1992.
- «Filosofia della religione», in AA. VV., La filosofia, Le filosofie speciali, Utet, Torino 1995.
305
OMBROSI, O., L’umano ritrovato. Saggio su Emmanuel Levinas, Marietti, Genova
2010.
OUAKNIN, M.-A., Le livre brûlé. Philosophie du Talmud, Lieu Commun, Paris 1986;
tr. it. di E. Zevi, Il libro bruciato. Filosofia della tradizione ebraica, ECIG,
Genova 2000.
- Invitation au Talmud, Flammarion, Paris 2001; tr. it. di R. Salvatori, Invito al Talmud, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
PASCAL, B., Pensées, Pensieri, a c. di P. Serini, Einaudi, Torino 1962.
PETROSINO, S., La verità nomade. Introduzione a Emmanuel Levinas, Jaca Book, Milano 1980.
- Fondamento ed esasperazione, Saggio sul pensare di Emmanuel Levinas, Marietti,
Genova 1992.
- Incarnazioni. Cristo e il cristianesimo nell’interpretazione di Lévinas, «Teoria»,
XXVI/2006/2, pp. 137-154;
- (con ROLLAND, J.) La Vérité nomade. Introduction à Emmanuel Lévinas, La Découverte, Paris 1984.
- Il sacrificio sospeso. Lettera ad un amico, Jaca Book, Milano 2000.
- La scena umana. Grazie a Derrida e Lévinas, Jaca Book, Milano 2010.
PLATONE, Tutti gli scritti, a c. di G. Reale, Rusconi, Milano 1991.
PLOTINO, Enneadi, a c. di G., tr. di R. Radice, Mondadori, Milano 2002.
POIRIÉ, F., Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, La Manufacture, Lyon 1987.
PONZIO, A., Responsabilità e alterità in E. Lévinas, Jaca Book, Milano 1995.
PRETE, A., (a c. di), Nostalgia. Storia di un sentimento, Raffaello Cortina, Milano
1992.
RANK, O., Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für Psychoanalyse, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1924; tr. it. di E. Ponsi, Il trauma
della nascita, sua importanza per la psicoanalisi, SugarCo, Milano 1990.
RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi, Prefazione di P. De Benedetti, Introduzione e tr. it. di L. Cattani, Marietti 1820, Genova-Milano 2005.
- Commento all’Esodo, introduzione e tr. it. di S. J. Serra, Marietti, Genova-Milano
2009.
306
- Commento ai Numeri, introduzione e tr. it. di L. Cattani, Marietti, Genova-Milano
2009.
RAVINTZKY, A., Ha-qetz ha-megulle u-medinat ha-Yehudim, Am Oved, Tel Aviv
1993, tr. it. di E.Z. Merlo, La fine svelata e lo Stato degli Ebrei. Messianismo,
sionismo e radicalismo religioso in Israele, Marietti 1820, Genova-Milano
2007.
RICOEUR, P., Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, Paris 1990, tr. it. di D.
Iannotta, Sé come un altro, Jaca Book, 19935.
- Autrement. Lecture d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas, PUF, Paris 1997; tr. it. di I. Bertoletti, Altrimenti. Lettura di Altrimenti
che essere o al di là dell’essenza di Emmanuel Levinas, Morcelliana, Brescia
2007.
ROVATTI, P.A., Intorno a Lévinas, Unicopli, Milano 1987.
ROLLAND, J., «Sortir de l’être par une nouvelle voie», introduzione a E. LEVINAS, De
l’evasion, Fata Morgana Paris 1982, tr. it. di P. Turina, «Uscire dall’essere
per una nuova via», in E. Lévinas, in Dell’evasione, Cronopio, Napoli 2008,
71-109.
- Un chemin de pensée, Totalitè et Infini – Autrement qu’être, in AA.VV., Emmanuel
Levinas, «Rue Descartes», PUF 2006, 39-54.
- Parcours de l’autrement, PUF, Paris 2000.
ROSENZWEIG, F., Der Stern der Erlösung, Nijhoff, La Haye 1981; tr. it di G. Bonora,
La stella della redenzione, (1a ed. Marietti, Genova 1988) Vita e Pensiero,
Milano 20052.
SACERDOTI,G., SEMI, A.A., Trauma as a Shibboleth in Psychoanalysis?, «International Journal of Psyco-analysis», 70 (1989), pp. 95-103.
SAINT CHERON, M. DE, Entretiens avec Emmanuel Levinas 1992-1994 : Suivis de
Levinas entre philosophie et pensée juive, LGF, Le livre de poche, Paris
2010.
SALVAREZZA, F., Emmanuel Lévinas, Bruno Mondadori, Milano 2003.
SALANSKIS, J-M., Levinas vivant, Les Belles Lettres, Paris 2006.
SANSONETTI, G., Emmanuel Levinas. Tra filosofia e profezia, Il Margine, Trento
2009.
307
SARTRE, J.-P., La nausée, Gallimard, Paris 1938; tr. it. di B. Fonzi, La nausea, Einaudi, Torino 1947.
- Réflexions sur la question juive, Gallimard, Paris 1946, tr. it. di I. Weiss, intr. di F.
Gentili, L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica (1a ed. 1954),
Mondadori, Milano 1990.
SEBBAH, F.-D., Lévinas. Ambiguïtés de l’altérité, Les Belles Lettres, Paris 2003.
SEGEV, T., The seventh Million. The Israelis and the Holocaust, (trasl. by H. Weizman), Hill & Wang, New York 1992; tr. it. di C. Lazzari, Il settimo milione.
Come l’Olocausto ha segnato la storia d’Israele, Mondadori, Milano 2001.
SEVERINO, E., La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia contemporanea (1a
ed. Rusconi, Milano 1996) Bur, Milano 2006.
SHOLEM, G., Die jüdische Mystic in ihren Hauptsrömungen, (1a ed. Rhein-Verlag,
Zürich 1957) Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2000; tr. it. G. Rosso, Le grandi correnti della mistica ebraica, (1a ed., il melangolo, Genova 1986) Einaudi, Torino 1993.
- The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality, Schocken
Books New York 1971, tr. it. R. Donadoni, E. Zevi, L’idea messianica nel’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica, Adelphi, Milano 2008.
SCHNEIDER, M. La proximité chez Lévinas et le Nebenmensch freudien, «Lévinas,
Le Cahier de l’Herne», a c. di C. Chalier e M. Abensour, Éd. De l’Herne, Paris 1991, 2006, pp. 431-443.
SOLOVEITCHIK, J. B., Reflections of the Rav, Ktav, Hoboken, N.J. 1979,1993; tr. it di
A. Bernardi, Riflessioni sull’ebraismo, a c. di Abraham R. Besdin, ed. it. a c.
di A.M. Somekh, Giuntina, Firenze 1998.
STEINSALTZ, A., Ha-Talmud lakòl, Gerusalemme 1997; tr. it. di S. Servi e D. Liberanome, a.c di S. Servi, Cos’è il Talmud, Giuntina, Firenze 2004.
STRASSER, S. Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie d’Emmanuel Levinas, «Revue Philosophique de Louvain» 75/1977 (pp. 101-125).
STROUMSA, G.G., La fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive, Odile Jacob, Paris 2005; tr. it. di V. Zini, La fine del sacrificio. Le mutazioni religiose della tarda antichità, Einaudi, Torino 2006.
308
TARTER, S., Evento e ospitalità. Lévinas, Derrida e la questione straniera, Cittadella
Editrice, Assisi 2004.
THAYSE, J.-L., Eros et féconditè chez le jeune Levinas, L’Harmattan, Paris 1998.
TRAVERSO, E., La Shoah e gli intellettuali, Il Mulino, Bologna 2004.
URBACH, E.E., Les sages d’Israël. Conceptions et croyances des maîtres du Talmud,
tr. francese dall’ebraico di M-J. Jolivet, Cerf/Verdier, Paris 1996.
VECCHIO, S. (a c. di), Nostalgia. Scritti psicoanalitici, Lubrina, Bergamo 1989.
WAHL, J., Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, PUF, Paris
1951, tr. it. di F. Occhetto, La coscienza infelice nella filosofia di Hegel, (1a
ed. Isedi 1972) Laterza, Roma-Bari 1994.
MUCCI, C., Il dolore estremo. Il trauma da Freud alla Shoah, Borla, Roma 2008.
WEBER, E., Verfolgung und Trauma: zu E. Levinas “Autrement qu’être ou au-delà de
l’essence”, Passagen-Verlag, Wien 1990.
WEIL, E., Logique de la philosophie, Vrin, Paris 1985; tr. it. a c. di L. Sichirollo, Logica della filosofia, Il Mulino, Bologna 1997.
WHITE, R.B., GILLIAND, R.M, Elements of psychopathology. The mechanisms of defense, Grune & Stratton, New York-San Francisco-London 1975; tr. it. di A.
Giuliani, I meccanismi di difesa, Astrolabio 1977.
WIESEL, E., La nuit, Éditions de Minuit, Paris 1957; tr. it. di D. Vogelmann, La notte,
Giuntina, Firenze 1980.
- Le chant des morts, Éditions du Seuil, Paris 1966; tr. it. di D. Vogelmann, L’ebreo
errante, Giuntina, Firenze 1983.
- Le mal et l’exil: dix ans après, (con PH. DE SAINT-CHERON), Nouvelle cité, Montrouge 1999; tr. it. di I. Landolfi, Il Male e l’esilio, dieci anni dopo, Baldini &
Castoldi, Milano 2001.
YERUSHALMI, Y.H., Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, University of
Washington Press, Seattle and London 1982; tr. it. di D. Fink, Zakhor. Storia
ebraica e memoria ebraica, Pratiche Editrice, Parma 1983.
- Freud’s Moses: Judaism Terminable and Interminable, Yale University Press, New
Haven 1991; tr. it. di G. Bona, Il Mosè di Freud. Giudaismo terminabile e interminabile, Einaudi, Torino 1996.
309
ZARADER, M., La dette impensèe. Heidegger et l’héritage hébraïque, Éditions du
Seuil, Paris 1990; tr. It di M. Marassi, Il debito impensato. Heidegger e l’eredità ebraica, Vita e Pensiero, Milano 1995.
ZERTAL, I., Ha’Umah ve Ha’Mavet, Historia, Zikaron, Politika, Dvir Piblishing
House 2002, tr. it. P. Arlorio, Israele e la Shoah. La nazione e il culto della
tragedia, Einaudi, Torino 2001.
ZIELINSKI, A., Levinas. La responsabilité est sans pourquoi, PUF, Paris 2004.
ZULUETA, F. DE, From Pain to Violence, Second edition, Whurr Publishers Limited,
London 2006, tr. it. di C. Pessina Azzoni e M. Luci, Dal dolore alla violenza.
Le origine traumatiche dell’aggressività, 2a ed., Raffaello Cortina, Milano
2009.
ZVI KOLITZ, Yossl Rakover si rivolge a Dio, tr. it. di A. L. Callow e R. C. Guarneri,
Adelphi, Milano 1997.
310
Scaricare