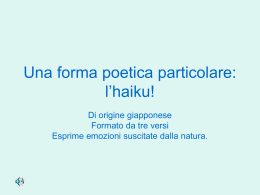Nota dei Curatori Giovannino Guareschi, ovvero l'autore contemporaneo italiano più tradotto nel mondo, ovvero il Grande Sconosciuto. Amato dai lettori e ignorato dalla critica, l'inventore di don Camillo ha visto consumarsi sulla sua pelle il destino che tocca con frequenza a chi ha successo. Scorretto politicamente, scorretto letterariamente, per alcuni fu scorretto persino teologicamente. Ma il tempo e gli studi cominciano a mostrarsi galantuomini con l'illustre figlio della Bassa Padana, morto nel lontano 1968. Questo volume vuole mettere in evidenza la naturale ispirazione cattolica del narrare guareschiano. Vuole mostrare che la scorrettezza teologica, come talvolta accade, è solo correttezza evangelica. Ogni capitolo è formato da tre parti: un passo del Vangelo; un racconto della saga di Mondo piccolo; la riflessione di un commentatore. La terza parte non serve a giustificare l'accostamento tra il racconto evangelico e il racconto guareschiano, che risulta evidente senza mediazioni. Serve, piuttosto, a mostrare cosa quell'accostamento possa produrre nella testa, nel cuore e nell'anima di un lettore attento. Così, ogni commentatore ha messo sulla pagina qualcosa di sé. Guareschi è stato un compagno di strada, di meditazione: un amico con cui parlare e di cui parlare. Nulla di più, nulla di meno. Ma è quanto di meglio possa fare uno scrittore che lavori veramente per i suoi lettori. Alessandro Gnocchi Mario Palmaro Prefazione di Alessandro Pronzato Metti sul pulpito uno scrittore coi baffi... Posso assicurare che funziona anche in chiesa. L'ho verificato io stesso in parecchie occasioni. Mi dicono che pure un Eccellentissimo Vescovo non ha esitato a compiere l'esperimento, con risultati soddisfacenti e alto indice di gradimento. Metti un uomo munito di baffi corvini, che indossa una camicia a quadrettoni e un giubbone di fustagno, sa maneggiare la penna da artigiano scafato, conosce come pochi l'arte di raccontare, porta nell'inseparabile sacca da prigioniero un considerevole capitale di cose della vita. Ebbene, quest'uomo, in arte Giovannino Guareschi, in chiesa funziona benissimo. Io ci ho provato una prima volta alle Roncole, il primo maggio di qualche anno fa, nell'abituale celebrazione dell'anniversario della sua nascita. Ho finto di parlare di lui. Ma, a un certo punto, l'ho costretto di prepotenza a salire sul pulpito e a discorrere lui della vita, del senso della vita, e degli ideali che dovrebbero ispirarla. Posso garantire che i colpi sono andati tutti a segno. Si dirà che, in un'occasione come quella, non ci voleva molto a catturare l'attenzione di simpatizzanti, devoti e "patiti" di Guareschi. Posso obiettare, tuttavia, che ci ho riprovato poco dopo in territorio svizzero, nella chiesa di un paese non lontano dal rifugio scelto da Guareschi per evadere da certe meschinità e cattiverie italiche. Ero stato invitato a predicare un "ottavario" consacrato da una lunga tradizione. Ho subito avvertito il parroco e i fedeli che saremmo stati in due: il sermone andava spartito in parti uguali tra il prete e un uomo dotato di baffi corvini, camicia a quadrettoni e giubbotto di fustagno. Ho così proposto una ricognizione nel territorio desolato delle virtù e dei valori perduti (il progresso corre e, per non avere ingombri inutili, ha sganciato l'anima, parcheggiandola chissà dove...). Per otto sere si è parlato di onestà, coscienza, fedeltà, spirito di sacrificio, dignità, speranza, umiltà, coerenza. Dopo dieci minuti di mie disquisizioni, aprivo il Breviario di don Camillo1, e lasciavo parlare lui, Giovannino (don Camillo) Guareschi. Di colpo il livello dell'attenzione del pubblico saliva a vista d'occhio. La predica laica avrebbe potuto proseguire per tre quarti d'ora, senza provocare il minimo segno di insofferenza. Come volevasi dimostrare: anche in chiesa Guareschi funziona. Ne era convinto pure papa Giovanni XXIII, il quale aveva pensato a una rivoluzionaria stesura del Catechismo, affidata a un "vero scrittore popolare" affiancato da un bravo teologo. Don Giovanni Rossi, artefice della Pro Civitate Cristiana, aveva buttato lì il nome di Giovannino Guareschi e il Pontefice si era mostrato d'accordissimo. Venne perciò sondata la sua disponibilità. Da principio Guareschi diede del matto a don Giovanni Rossi. L'idea lo terrorizzava, e lui non si riteneva all'altezza del compito. Poi ci aveva ripensato, e quasi quasi la proposta lo solleticava. Alle risposte tradizionali del Catechismo lui avrebbe aggiunto una specie di apologo: «Un giorno don Camillo...». Purtroppo nei palazzi vaticani, ormai, non tirava un'aria favorevole per lo scrittore della Bassa. Si era messa di mezzo la politica, con l'appoggio dell'ottusità e dei pregiudizi di alcuni ometti, per cui il progetto abortì2. Ora, grazie a questo volume ideato e messo insieme da uno sperimentato navigatore nel mondo guareschiano come Alessan1 Rizzoli, Milano 1994. 2 Tutta la vicenda è stata ricostruita puntigliosamente con ampia documentazione da Giorgio Pillon in Segreti incontri, Serarcangeli, Roma 1995. dro Gnocchi e dal giovane "collega" Mario Palmaro, viene realizzato non un Catechismo, ma addirittura una specie di Vangelo ritagliato da alcuni racconti di Giovannino Guareschi, letti, interpretati e scavati, con acutezza e finezza, da vari esegeti di mano sicura e di vista aguzza. Una tonaca, anzi una porpora, e quattro laici, tutti impegnati a rintracciare il sottofondo religioso e le provocazioni evangeliche di Guareschi, a setacciarne le perle ad alto contenuto di fede. Giovannino, da questi scampoli significativi, si rivela un ottimo teologo, anche se — per fortuna sua e nostra — non nel senso classico e intellettualistico del termine. Se teologo, secondo il detto della spiritualità d'Oriente, è "colui che prega", Guareschi può rivendicare con pieno merito tale titolo. Lui, come sottolinea Giorgio Torelli, attraverso il travestimento del suo "pretone", dialoga in continuazione col Crocifisso. Oggi si parla molto di teologia narrativa. Ma tutto rimane a livello di teorizzazione. Giovannino Guareschi, quasi sicuramente, non sapeva neppure che esistesse una teologia narrativa. In compenso ce ne ha offerto esempi stupendi, oserei dire strepitosi, in numerose sue pagine. Guareschi presenta un cristianesimo serio, "tradizionale" nel senso migliore del termine, senza alcuna concessione alle mode e alle ideologie correnti. E senza cupezza, anzi con evidenti venature umoristiche. La sua è, essenzialmente, una "teologia della speranza". Personalmente, avrei inserito nella raccolta (sempre che non ci fossero, come è probabile, motivi di spazio) i due bellissimi racconti che hanno quali protagonisti "il romagnolo" (Civil e la banda) e il carrettiere Giaron (Menelik), una variazione "padana" dell'episodio biblico dell'asina di Balaam (cf Nm 22). Due espressioni, tra innumerevoli altre, della salvezza dei perduti. Due manifestazioni struggenti di quella pietas cristiana che intride tutto il discorso di Guareschi e che affiora regolarmente nella pastorale di don Camillo, un prete che, a dispetto di qualche intemperanza verbale e manesca, secondo i dati emersi in un recente sondaggio, tutti vorrebbero avere quale parroco. Per Guareschi non esistono individui irrecuperabili. Il suo don Camillo è un prete "sospettoso", ossia uno che non si lascia impressionare dalla crosta delle apparenze, delle parole o parolacce o addirittura bestemmie, ma sospetta il buono che c'è in ogni uomo, sospetta la nostalgia segreta di Dio che tormenta il cuore anche dei più incalliti e dichiarati miscredenti, sospetta l'esistenza di un terreno pulito, intatto, addirittura sotto i mucchi di immondizia accumulati nel corso di certe esistenze sgangherate. Don Camillo, in parecchie occasioni, diventa l'interprete più convincente di quel Gesù di Nazaret che è venuto a cercare chi è perduto (cf Mc 2, 17). Guareschi elabora, senza darlo esplicitamente a vedere, e senza eppure proporselo, una sua teologia che procede per intuizioni, folgorazioni, e si sviluppa in un discorso piano, strutturato sul filo di una logica elementare ma ferrea. Lui coglie, con fiuto sicuro, la sostanza del messaggio evangelico, fa emergere i punti qualificanti dell'esistenza cristiana (basti pensare ai temi del perdono e della responsabilità individuale, al ripudio totale della parola odio), rimanendo saldamente ancorato alla concretezza. Il tutto inscritto in un terreno di religiosità autentica permeata di umanità, e con abbondanti spruzzate di buonsenso. In Don Camillo, il Vangelo dei semplici vien fuori soprattutto il problema del linguaggio (cui accenna il cardinal Giacomo Biffi nel suo intervento). Da un'interpretazione della parola di Dio in chiave devozionale, moralistica e dolciastra, tipica di un passato che non è nemmeno del tutto passato, si è arrivati, oggi, a una lettura evangelica di tipo esasperatamente intellettualistico, freddo, arido, con un linguaggio impervio, precluso alla gente comune. Guareschi osa mettere allo scoperto il cuore, i sentimenti, e soprattutto ha il coraggio della chiarezza. Lui, per essere profondo, non ha bisogno di ricorrere ad astruserie o virtuosismi dialettici, esibiti, con evidente quanto insopportabile compiacimento, in un linguaggio oscuro, e spesso criptico. Giò, la collaboratrice domestica (mai esistita) di casa Guareschi, muove al proprio padrone, cui dà del "lui", un rimprovero che, a pensarci bene, rappresenta un grosso elogio: Lui non mi piace come scrive […]. Intanto lui adopera delle parole che tutti conoscono per dire delle cose che tutti capiscono e, allora, dove a va a finire la cultura?3 Va a finire sotto i tacchi di Giovannino, che possiede una cultura di tutto rispetto, ma riesce a camuffarla sotto le vesti della modestia, e perfino a dimenticarla. Guareschi ha una scrittura che si impone per l'immediatezza, la spontaneità, la scorrevolezza, la naturalezza, l'incisività. Una scrittura che può facilmente essere trasferita nel parlato, senza che si avvertano scarti. La predica, sovente, come è stato da più parti denunciato, rappresenta «un vero tormento dei fedeli»4. Personalmente resto convinto che il grosso e più temibile nemico della verità non sia tanto l'errore quanto la noia. Con Guareschi non si corre certo questo rischio. E poi, nel non troppo esaltante panorama della letteratura italiana di ispirazione cristiana, esangue, malata di psicologismo e di tormenti interiori fasulli, usa a "ricamar bellurie", ignorare un narratore del calibro di Giovannino Guareschi, scrittore sanguigno, ricco di umori, portatore sano di provocazioni evangeliche, capace di raccontare la fede dei semplici, è un lusso che proprio non possiamo permetterci. Lasciamo pure che certi letterati schizzinosi (i cui libri stanno a distanze lunari dalle tirature vertiginose del "padre" di don Camillo) neghino a Guareschi, con una ostinazione degna di miglior causa, la patente di scrittore. D'altra parte, lui non si curava per nulla dei giudizi sprezzanti dei critici di professione, sovente attanagliati dai morsi dell'invidia. 3 G. Guareschi, Vita con Giò, "La gloria di Montassù", Rizzoli, Milano 1995. 4 Cf lo stimolante volumetto che raccoglie diverse voci, intitolato appunto La predica tormento dei fedeli, La Locusta, Vicenza 1994. Prendiamo atto, sia pure con dispetto, che nelle antologie che circolano nelle scuole trovano posto romanzieri da quattro soldi, incapaci, nel loro vuoto abissale, di proporre ai giovani ideali che si levino di una spanna dalla cinghia dei pantaloni, e si continua a dare l'ostracismo all'autore di quel capolavoro assoluto che è Diario clandestino. Ma almeno noi riconosciamogli il titolo di uomo vero e di cristiano coerente, anche se un po' ruvido (il che non guasta, anzi). Dunque. Rendiamoci conto, finalmente, anche grazie alla provocazione di questi capitoli singolari e assai coinvolgenti, che l'uomo munito di baffi corvini, sperimentato artigiano della penna, il quale ha qualcosa da dire e sa dirlo con uno stile inconfondibile, può funzionare anche in chiesa. Eccome. Giovannino Guareschi GIACOMONE riletto da Giacomo Biffi DAL VANGELO DI MARCO (15, 21) Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Giacomone Il vecchio Giacomone aveva bottega nella città bassa. Una stanzaccia con un banco da falegname, una stufetta di ghisa e una cassa. Dentro la cassa, Giacomone teneva un materasso di crine che, la sera, cavava fuori e distendeva sul banco: e lì dormiva. Anche il mangiare non era un problema serio per Giacomone, perché con un pezzo di pane e una crosta di formaggio tirava avanti una giornata: il problema era il bere. Giacomone, infatti, aveva uno stomaco di quel tipo che usava tempo addietro: quando, cioè, c'era gente che riusciva a trovare dentro una pinta di vino il nutrimento necessario per vivere sani e svelti come un pesce. Forse perché, allora, non avevano ancora inventato le calorie, le proteine, le vitamine e le altre porcherie che complicano la vita d'oggi giorno. Giacomone, quindi, finiva sbronzo la sua giornata: d'estate dormiva sulla prima panchina che gli capitava davanti. D'inverno, dormiva sul banco. E, siccome il banco era lungo ma stretto e alto, Giacomone, agitandosi, correva il rischio di cascare per terra: allora, prima di chiudere gli occhi, si avvolgeva nel tabarro serrandone i lembi fra le ganasce della morsa. Così poteva rigirarsi senza il pericolo di sbattere la zucca contro i ciottoli del pavimento. Giacomone accettava soltanto lavori di concetto: riparazioni di sedie, di cornici, di bigonci e roba del genere. La falegnameria pesante non l'interessava. E, per falegnameria pesante, egli intendeva ogni lavoro che implicasse l'uso della pialla, dello scalpello, della sega. Egli ammetteva soltanto l'uso della colla, della carta vetrata, del martello e del cacciavite. Anche perché non possedeva altri strumenti. Giacomone, però, trattava anche il ramo commerciale e, quando qualcuno voleva sbarazzarsi di qualche vecchio mobile, lo mandava a chiamare. Ma si trattava sempre di bagattelle da quattro soldi e c'era poco da stare allegri. Un affare eccezionale gli capitò fra le mani quando morì la vecchia che abitava al primo piano della casa dirimpetto alla sua bottega. Aveva la casa zeppa di roba tenuta bene e toccò ogni cosa a un nipote che, prima ancora di entrare nella casa, si preoccupò di sapere dove avrebbe potuto vendere tutto e subito. Giacomone si incaricò della faccenda e in una settimana riuscì a collocare la mercanzia. Alla fine, rimase nell'appartamento soltanto un gran Crocifisso di quasi un metro e mezzo con un Cristo di legno scolpito. «E quello?» domandò l'erede a Giacomone indicandogli il Crocifisso. «Credevo che lo teneste» rispose Giacomone. «Non saprei dove metterlo» spiegò l'erede. «Vedete di darlo via. Pare molto antico. C'è il caso che sia una cosa di valore». Giacomone aveva visto ben pochi Crocifissi in vita sua: comunque era pronto a giurare che, quello, era il più brutto Crocifisso dell'universo. Si caricò il crocione in spalla e andò in giro ma nessuno lo voleva. Tentò il giorno dopo e fu la stessa cosa. Allora arrivò fino e casa dell'erede e gli disse che se voleva vendere il Crocifisso si arrangiasse lui. «Tenetevelo» rispose l'erede. «Io non voglio più saperne niente. Se vi va di regalarlo regalatelo. Se riuscirete a smerciarlo, meglio per voi: soldi vostri». Giacomone si tenne il Crocifisso in bottega e, il primo giorno che si trovò senza soldi, se lo caricò in spalla e andò in giro a offrirlo. Girò fino a tardi e, prima di tornare in bottega, entrò nell'osteria del Moro. Appoggiò il Crocifisso al muro e, sedutosi a un tavolo, comandò un mezzo di vino rosso. «Giacomone» gli rispose l'oste «dovete già pagarmi dodici mezzi. Pagate i dodici e poi vi porto il vino». «Domani pago tutto» spiegò Giacomone. «Sono in parola con una signora di Borgo delle Colonne. È un Cristo antico, roba artistica, e saranno soldi grossi». L'oste guardò il Cristo e si grattò perplesso la zucca: «Io non me ne intendo» borbottò «ma ho l'idea che un Cristo più brutto di quello lì non ci sia in tutto l'universo». «La roba antica più è brutta e più è bella» rispose Giacomo-ne. «Voi guardate le sculture e le pitture del Battistero e poi ditemi se sono più belle di questo Cristo». L'oste portò il vino, e poi ne portò ancora perché Giacomo-ne aveva una tale fame che avrebbe bevuto una damigiana di barbera. L'osteria si riempì di gente e il povero Cristo sentì discorsi da far venire i capelli ricci a un brigadiere dei carabinieri pettinato «all'umberta». A mezzanotte Giacomone tornò in bottega col suo Cristo in spalla e, siccome due o tre volte si trovò a un pelo dal cadere lungo disteso perché quel peso lo sbilanciava, tirò fuori di sotto il vino che aveva nello stomaco delle bestemmie lunghe come racconti. La storia del Cristo si ripeté i giorni seguenti: e ogni sera Giacomone faceva tappa a un'osteria diversa e passò tutte le osterie dove era conosciuto. Così continuò fino a quando, una notte, la pattuglia agguantò Giacomone che, col Cristo in spalla, navigava verso casa rotolando come una nave sbattuta dalla burrasca. Portarono Giacomone in guardina e il Cristo, appoggiato a un muro della stanza del corpo di guardia, ebbe agio di ascoltare le spiritose storie che rallegravano di solito i questurini di servizio notturno. La mattina Giacomone fu portato davanti al commissario che gli disse subito che non facesse lo spiritoso e spiegasse dove avesse rubato quel Crocifisso. «Me l'hanno dato da vendere» affermò Giacomone e diede il nome e l'indirizzo del nipote della vecchia signora morta. Lo rimisero in camera di sicurezza e, verso sera, lo tirarono fuori un'altra volta. «Il Crocifisso è vostro» gli disse il commissario «e va bene. Però questo schifo deve finire. Quando andate all'osteria, lasciate a casa il Cristo. La prima volta che vi pesco ancora vi sbatto dentro». Fu, quella, una triste sera per il Cristo: perché Giacomone se la prese con Lui e gli disse roba da chiodi. Si ubriacò senza Cristo ma, alle tre del mattino, si alzò, si caricò il Cristo in spalla e, raggiunta per vicoletti oscuri la periferia, si diede alla campagna. «Vedrai se questa volta non riesco a rifilarTi a qualche disgraziato di villano o di parroco!» disse Giacomone al Cristo. Era autunno e incominciava a far fresco, la mattina: Giacomone s'era buttato addosso il tabarro e così, col grande Crocifisso in spalla e il passo affaticato, aveva l'aria di uno che viene da molto lontano. All'alba, passò davanti a una casa isolata: una vecchia era nell'orto e, vedendo Giacomone con la croce in spalla, si segnò. «Pellegrino!» disse la vecchia. «Volete una scodella di latte caldo?» Giacomone si fermò. «Andate a Roma?» s'informò la vecchia. Giacomone fece segno di sì con la testa. «Da dove venite?» «Friuli» rispose Giacomone. La vecchia allargò le braccia in atto di sgomento e gli ripeté che entrasse a bagnarsi le labbra con qualcosa. Giacomone entrò. Il latte, a guardarlo, gli faceva nausea: poi lo assaggiò ed era buono. Mangiò mezza micca di pane fresco e continuò la sua strada. Schivò le strade provinciali; prese scorciatoie attraverso i campi e batté le case isolate. «Passo di qui perché la strada è piena di sassi e di polvere e ho i piedi che mi sanguinano e gli occhi che mi piangono» spiegava Giacomone quando traversava qualche aia. «E poi ho fatto il voto così. Vado a Roma in pellegrinaggio. Vengo dal Friuli». Una scodella di vino e un pezzo di pane non glieli negava nessuno. Giacomone metteva il pane in saccoccia, beveva il vino e riprendeva la sua strada. Di notte smaltiva la sua sbronza sotto qualche capanna, in mezzo ai campi. In seguito era diventato più furbo: s'era procurato una specie di grossa borraccia da due litri. Non beveva il vino quando glielo davano, lo versava dentro la borraccia: «Mi servirà stànotte se ho freddo o mi viene la debolezza» spiegava. Poi, appena arrivato fuori tiro, si attaccava al collo della borraccia e pompava. Però faceva le cose per bene in modo da trovarsi la sera con la borraccia piena. Allora, quando si era procurato il ricovero, scolava la borraccia e perfezionava la sbornia. Il freddo incominciò a farsi sentire, ma, quando Giacomone aveva fatto il pieno, era come se avesse un termosifone acceso dentro la pancia. E via col suo povero Cristo in spalla. «Vado a Roma, vengo dal Friuli», spiegava Giacomone. E quando era sborniato e traballava, la gente diceva: «Poveretto, com'è stanco!» E poi gli era cresciuta la barba e pareva un romito davvero. Giacomone, che aveva la testa sulle spalle, aveva fatto in modo di gironzolare tutt'attorno alla città: ma l'uomo propone e il vino dispone. Così andò a finire che perdette la bussola e si trovò, un bel giorno, a camminare su una strada che non finiva mai di andare in su. Voleva tornare indietro e rimanere al piano: poi pensò che gli conveniva approfittare di quelle giornate ancora di bel tempo per passare il monte. Di là avrebbe trovato il mare e, al mare, freddo che sia, fa sempre caldo. Camminò passando da una sbronza all'altra, sempre evitando la strada perché aveva paura di imbattersi nei carabinieri: prendeva i sentieri e questo gli permetteva di battere le case isolate. L'ultima sbronza fu straordinaria perché capitò in una casa dove si faceva un banchetto di nozze e lo rimpinzarono di mangiare e di vino fino agli occhi. Oramai era quasi arrivato al passo. La notte dormì in una baita e, la mattina dopo, si svegliò tardi, verso il mezzogiorno: affacciatosi alla porta della baracca si trovò in mezzo a un deserto bianco con mezza gamba di neve. E continuava a nevicare. «Se mi fermo qui rimango bloccato e crepo di fame o di freddo» pensò Giacomone e, caricatosi il Cristo in spalla, si mise in cammino. Secondo i suoi conti, dopo un'ora avrebbe dovuto arrivare e un certo paese. Aveva ancora la testa annebbiata per il gran vino bevuto il giorno prima, e poi la neve fa perdere l'orizzonte. Si trovò, sul tardo pomeriggio, sperduto fra la neve. E continuava a nevicare. Si fermò al riparo di un grosso sasso. La sbornia gli era passata completamente. Non aveva mai avuto il cervello così pulito. Si guardò attorno e non c'era che neve, e neve veniva giù dal cielo. Guardò il Cristo appoggiato alla roccia. «In che pasticcio Vi ho messo, Gesù» disse. «E siete tutto nudo...» Giacomone spazzò via col fazzoletto la neve che si era appiccicata sul Crocifisso. Poi si cavò il tabarro e, con esso, coperse il Cristo. Il giorno dopo trovarono Giacomone che dormiva il suo eterno sonno, rannicchiato ai piedi del Cristo. E la gente non capiva come mai Giacomone si fosse tolto il tabarro per coprire il Cristo. Il vecchio prete del paese rimase a lungo a guardare quella strana faccenda. Poi fece seppellire Giacomone nel piccolo cimitero del paesino e fece incidere sulla pietra queste parole: Qui giace un cristiano e non sappiamo il suo nome ma Dio lo sa perché è scritto nel libro dei Beati. Insolita canonizzazione di Giacomo Biffi La scrittura di Guareschi — anzi sarebbe forse più pertinente dire il suo "discorrere" — più che a scegliere le parole con arte o a enunciare in modo rigoroso dei concetti, mira ad arrivare direttamente alle cose. Certo le parole, senza essere mai ricercate, sono sempre splendidamente efficaci e proprie; i concetti, offerti senza inutili compiacimenti, sono tutti limpidi e giusti. Ma ciò che si vuol raggiungere non è tanto un'ammirevole esposizione di idee né una qualche originale virtuosità terminologica, quanto una "comunione con le cose". Forse nasce da qui il caso insolito e curioso di un autore che sa conquistare la simpatia e l'apprezzamento di milioni di uomini di ogni ceto sociale e di ogni latitudine, ma ha sempre faticato a farsi prendere sul serio dagli "addetti ai lavori" letterari. Guareschi ama, ricerca e in ogni pagina insegue ciò che è "reale". E questa, a ben riflettere, è la ragione della sua oggettiva, intrinseca e quasi involontaria religiosità: perché — non dobbiamo mai dimenticarlo nonostante l'allergia della cultura dominante — tra tutti i "reali" il più "reale" è Dio. E non solo Dio, ma anche Cristo nel quale — ci rivela san Paolo — «tutte le cose sussistono» (cf Col 1, 17). Così capita di scoprire in questi racconti folgorazioni teologiche degne dei più profondi pensatori cristiani. Per esempio, alla lettura del difficile e tormentato rapporto di Giacomone con il grande Crocifisso che gli è venuto inopinatamente a incombere sugli omeri e sulla vita, viene in mente quel che dice sant'Ambrogio a proposito del Cireneo, il quale, senza averlo minimamente previsto e senza averlo affatto voluto, è entrato da protagonista indimenticabile — lui fino ad allora sconosciuto e del tutto disinteressato — nel dramma più decisivo della storia: Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna... a portare la croce (Mc 15, 21). Commenta dunque l'acuto e umanissimo vescovo di Milano: 11 Vincitore innalzi ormai il suo trionfo! Sulle sue spalle viene imposta la croce come un trionfo, e — l'abbia portata Simone o l'abbia portata lui stesso — è sempre Cristo che porta la croce nell'uomo e l'uomo nel Cristo (Commento a Luca, X, 107). Anche Giacomone porta a spasso il suo molesto fardello, cercando di liberarsene. Ma nella verità profonda delle cose proprio questo suo compagno scomodo e opprimente "lo porta": cioè gli dà la forza di reggerne il peso e di continuare a camminare. Anzi, lo guida e lo spinge su strade inattese, lo assimila progressivamente a sé e lo trasforma — da uomo senza ideali (che non fosse quello di assicurarsi la sua razione quotidiana di vino) — in un pellegrino proteso verso la santa Città degli apostoli. Un'avventura spirituale come questa è incomprensibile al "mondo", e particolarmente al mondo ufficiale della cultura e del potere. «Questo schifo deve finire» gli dice infatti il commissario, che pure l'aveva riconosciuto non perseguibile. Invece le vecchine capiscono: sono sostanzialmente della stessa stoffa di Giacomone, semplici come lui. E non solo capiscono, ma senza volerlo gli rivelano la sua indole più autentica e la sua altissima "vocazione". Sono loro a farsi concrete collaboratrici della grazia nell'operare un prodigio: l'interiore elevazione di questo ubriacone che da sé solo non aveva né progetti né speranza. All'alba passò davanti a una casa isolata: una vecchia era nell'orto e, vedendo Giacomone con la croce in spalla, si segnò. «Pellegrino!» disse la vecchia. (...1 Andate a Roma?» E...) Giacomone fece cenno di sì con la testa. «Beati i poveri in ispirito, perché di essi è il Regno dei cieli» (Mt 5, 3), aveva detto Gesù. Giacomone non poteva nemmeno sospettarlo, ma lui era uno di questi principi ereditari in incognito. Il suo Salvatore però lo sapeva e — per una strada inedita, che non si trova descritta nei trattati teologici — va a raggiungerlo dove egli si trova e piano piano lo conduce al vertice della gioia e della gloria. Non è soltanto un'evoluzione interiore: a poco a poco si muta anche il cuore di Giacomone. All'inizio il Cristo — «il più brutto Crocifisso dell'universo» — è per lui solo un oggetto indesiderato e ingombrante, da vendere il più in fretta possibile a finanziamento di qualche bevuta. Poi adagio adagio diventa "qualcuno"; diventa una persona concreta e viva con cui si può anche litigare. «Giacomone se la prese con lui e gli disse roba da chiodi». È la libertà di parlare e di insolentirsi che c'è tra gli amici sicuri. Come? Il Figlio di Dio amico e quasi complice di un "beone"? I ben pensanti si stupiscono; ma perché non si ricordano più che anche il Figlio di Dio ha accettato di essere messo tra coloro cui piace più il vino dell'acqua: «Ecco un mangione e un beone» (cf Mt 11, 19), dicevano ai suoi tempi di lui. Alla fine Cristo non è più solo un amico. È un fratello da aiutare, da difendere, da amare: Giacomone spazzò via col fazzoletto la neve che si era appiccicata sul Crocifisso. Poi si cavò il tabarro e, con esso, coperse il Cristo. Giacomone arriva così ai vertici della santità ed è ormai pronto per entrare nel Regno, secondo la promessa di colui che davvero non manca mai di parola: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché E...) ero nudo e mi avete vestito (Mt 25, 34.36). L'ortodossia di Guareschi è ineccepibile: non si dimentica neppure del necessario intervento della Chiesa nelle peripezie dello spirito umano. È il cattolicesimo che egli attinge con naturalezza dalla storia e dalla cultura antica del nostro popolo, dal quale è sempre stato ben attento a non estraniarsi. Non basta la "gente" a cogliere in modo esauriente il senso della misteriosa vicenda di Giacomone: La gente non capiva come mai Giacomone si fosse tolto il tabarro per coprire il Cristo. Ci vuole il giudizio della Chiesa, rappresentata al livello più vicino e diretto che è quello parrocchiale: Il vecchio prete del paese rimase a lungo a guardare quella strana faccenda. Poi fece seppellire Giacomone nel piccolo cimitero del paesino e fece incidere sulla pietra queste parole: Qui giace un cristiano e non sappiamo il suo nome ma Dio lo sa perché è scritto nel libro dei Beati. Era per Giacomone una sorta di canonizzazione, una canonizzazione anomala senza dubbio, ma è lecito pensare che sia stata valida e preziosa come quelle che di solito si fanno nella basilica di San Pietro in Vaticano. Giovannino Guareschi ALL’”ANONIMA” riletto da Giacomo Biffi DAL VANGELO DI MATTEO (5, 37) Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno. All'”Anonima" Fioccava che Dio la mandava, ma lo Smilzo, piuttosto di usare l'ombrello, simbolo della reazione borghese e clericale, si sarebbe fatto scannare. D'altra parte, se si fosse messo il cappello, come sarebbe entrato? Tenendoselo in testa o cavandoselo? "Entrare in casa di un nemico del popolo tenendo il cappello in testa è, sì, un atto fiero, adeguato alla dignità del popolo: però è provocatorio. Entrare in casa di un nemico del popolo togliendosi il cappello non è un atto provocatorio, però è servile e umiliante: quindi dannoso alla causa del popolo. L'unico modo per conservare la propria dignità senza, per questo, assumere atteggiamenti provocatori è quello di andare in casa dei nemici del popolo senza mettersi il cappello. Si serve la causa del popolo anche prendendo un raffreddore. Ogni azione rivoluzionaria comporta dei sacrifici". Così pensò lo Smilzo e perciò, quando entrò in canonica, era fiero senza essere provocatorio: però aveva la testa piena di neve. «Ciao, Gennaio» gli disse don Camillo. «Nevica anche sul partito?» «Può darsi» rispose con voce ferma lo Smilzo. «Però presto verrà il sole anche per il Partito». «C'è scritto sul Solitario Piacentino?» si informò don Camillo. Lo Smilzo assunse un'aria notevolmente annoiata. «Dice il capo che, se nel Piano Marshall non esiste nessuna clausola in contrario, vorrebbe parlarvi». «Bene» rispose don Camillo. «Digli pure che io non ho cambiato casa: abito sempre qui». Lo Smilzo ebbe un risolino, di quelli tutti da una parte e col singhiozzino sotterraneo. «Fin che dural... A ogni modo, siccome si tratta di cose strettamente personali e siccome voi non volete andare da lui, mentre la sua dignità non gli permette di venire qui a riverirvi, il capo ha organizzato un incontro in campo neutro. Vi aspetta all'"Anonima"». L'"Anonima" era un gran baraccone fuori dal paese: un tempo era stato una fabbrica di salsa di pomodoro. Roba impiantata nel 1908 e che aveva funzionato per una decina d'anni. E siccome sul frontale c'era scritto «Società Anonima Conserve Alimentari» la gente trovò che l'"Anonima" rendeva l'idea meglio di tutto il resto e con tal nome battezzò la baracca. Ora la fabbrica, abbandonata da anni e annorum, funzionava semplicemente da ricordo di giovinezza per i più vecchi e da "centrale giochi" per i più giovani. Don Camillo infilò gli stivaloni e andò a pestar neve e lo Smilzo lo seguì, ma, duecento metri prima di arrivare, si fermò e tornò indietro. «Così nero in mezzo alla neve fate un bell'effetto» osservò lo Smilzo quando fu lontano una ventina di metri. «Stareste proprio bene in Siberia. Vi terremo presente reverendo». «Tu invece staresti bene all'Inferno» borbottò don Camillo. Peppone era ad aspettarlo sotto una tettoia e aveva acceso un bel fuoco e si stava scaldando, seduto su una cassa sgangherata. Don Camillo spinse col piede una cassa vicino al fuoco e si mise a sedere di fronte a Peppone. Rimasero lì un bel po' ad arrostirsi le mani in silenzio. Poi Peppone levò la testa e disse con voce aggressiva: «Qui bisogna venire a una conclusione. È una storia che non può funzionare». «Quale storia?» si informò don Camillo. «E quale deve essere? Quella della Messa!» spiegò sgarbatoPeppone. «Ecco: i compagni hanno apprezzato molto il vostro gesto della Vigilia di Natale. Il fatto del clero che esce dal suo isolamento e va a bussare alla porta del popolo ha un valore. Sta a significare che Dio capisce finalmente l'importanza del popolo e allora va lui a cercare il popolo. Dio fa un'autocritica, riconosce le sue deviazioni ideologiche e il popolo allora apre la porta a Dio e gli perdona. Dio insomma diventa veramente democratico: non più il popolo che deve andare alla Casa di Dio,ma Dio che va alla Casa del Popolo». Don Camillo tirò su uno stecco dal fuoco e si accese il sigaro. «Siete una manica di porci» disse don Camillo con calma. «Approfittate di uno stupido come il sottoscritto, che in un momento di debolezza ha commesso una fesseria, per gonfiarvi di boria e bestemmiare il nome di Dio». Peppone lo guardò perplesso. «Non avete commesso nessuna fesseria, reverendo. C'è scritto sui vostri libri che il buon pastore lascia il gregge nell'ovile e poi va in giro di notte a cercare la pecorella smarrita». Don Camillo scosse il capo. «Sì, ma non c'è scritto che poi la pecorella, per ricompensarlo, gli dice le eresie che hai detto tu. Voi non siete delle pecorelle: siete una mandria di bufali. Io non sono venuto a dire la Messa alla vostra Casa del Popolo perché c'era il Padreterno che vi cercava. Io sono venuto per aiutare voi a cercare Dio, per aiutarvi a ritrovarlo. Dio non ha bisogno di voi, siete voi che avete bisogno di Dio». «Io non avevo intenzione di offendervi» obiettò Peppone. «E neanche mi hai offeso» replicò duramente don Camillo. «Però hai fatto ben di peggio: hai offeso Dio!» Peppone fece un gesto d'impazienza. «Reverendo» esclamò «non ricominciamo la solita storia di buttare in politica tutto! Lasciamo stare la tattica del vittimismo! Non facciamo ragionamenti abulici!» Don Camillo guardò preoccupato Peppone. «Cosa intendi per "ragionamenti abulici"?» domandò. Peppone si strinse nelle spalle. «Cosa intendo per ragionamenti abulici? E cosa volete che voglia dire? Ragionamenti abulici! Ragionamenti così, insomma!» concluse agitando le braccia. Don Camillo scosse il capo. «Se intendi dire una cosa di quel genere, allora "abulico" è un aggettivo che non va bene. "Abulico" significa...» Peppone fece un'alzata di spalle e lo interruppe: «Reverendo, l'importante è che ci si capisca! Non è il caso di fare delle discussioni di letteratura. Tanto, la letteratura è una porca faccenda che serve soltanto per imbrogliare le idee, perché va a finire che uno, invece di dire quello che vorrebbe dire lui, dice quello che vuole la grammatica e l'analisi logica. E, a un bel momento, non ci capisce più dentro niente neanche quello che parla. Se io, porcaccio mondo, nei comizi potessi fare dei discorsi in dialetto, me la sbrigherei in metà tempo e difficilmente direi delle stupidaggini. Perché, quando uno fa un discorso, prima di tutto bisogna che capisca lui quello che dice. Se io parlo come mi ha fatto mia madre capisco tutto quello che dico. Perché, caro reverendo, mia madre mi ha fatto in dialetto, mica in italiano. Ma così, vigliacco mondo, va a finire che, dopo aver fatto un discorso, uno deve farsi spiegare da un altro quello che ha detto!» «Adesso parli giusto» osservò don Camillo. «Lo so. E tutti parlerebbero giusto se non ci fosse questa porca letteratura che complica sempre di più le cose. Perché, se ci sono cento cose, ci devono essere duemila modi per dire queste cento cose? Ci sono i nomi scientifici, e va bene: quelli servono per gli specializzati. Ma gli altri debbono usare soltanto le parole che capiscono. Si fa un comitato di galantuomini di tutte le categorie, si piglia il vocabolario, si cancellano tutte le parole inutili e se uno, dopo, usa in pubblico qualcuna di queste parole proibite lo si prende e lo si schiaffa dentro come quelli che tentano di spacciare moneta falsa. I signori poeti si lamenteranno perché non trovano più la rima? Noi gli risponderemo che facciano le poesie senza rima. Un povero diavolo ha almeno il diritto di sapere quello che dice. Perché io ho parlato poco fa di discorsi abulici? Perché io, questa sporcaccionata di parola, l'ho letta o sentita da qualche parte e, siccome si presenta bene, mi è piaciuta e mi è rimasta appiccicata al cervello». «Capisco, ma perché l'hai usata se non la conoscevi che di vista?» «Non l'ho usata io! È stata lei che ha usato me! Io volevo dirvi: "Non diciamo delle vaccate, reverendo!", e mi pareva, così, dall'aspetto, che "abulico" significasse sempre roba bovina ma detta in modo più pulito, più distinto. Più letterario insomma!» Peppone era triste e sospirò: «Forse era giusto se dicevo "discorsi bucolici" invece che "discorsi abulici" ». Don Camillo scosse il capo: «In "bucolico" il bestiame c'entra molto di più che in "abulico". Però, nel senso di "discorsi a vacca" o "vaccate", il "bucolico" non funziona. Dai retta a me: anche quando parli nei comizi devi dire soltanto le parole che sai». «Il guaio è che ne so poche». «Anche se tu ne sapessi metà, basterebbero. Ha bisogno di molte parole chi deve mascherare la sua mancanza di idee o chi deve mascherare le sue intenzioni. Credi tu che Gesù Cristo adoperasse più parole di quante ne puoi adoperare tu? Eppure riusciva a farsi capire da tutti e abbastanza bene, mi pare». Peppone si strinse nelle spalle e sospirò: «Altri tempi, reverendo. Altro tipo di propaganda!» Allora don Camillo cavò dal fuoco un mezzo travicello infuocato e lo brandì minaccioso. «O la pianti di bestemmiare, o ti vernicio a fuoco il muso. Se mi hai fatto venir qui per sentire le tue bestemmie, hai sbagliato indirizzo. Si può sapere una buona volta che cosa vuoi da me?» Peppone esitò un poco poi si rinfrancò: «Reverendo, qui bisogna sistemare la faccenda: quello che è detto è detto e poi ci sono delle ragioni speciali e indietro non si torna. Noi in chiesa non ci possiamo venire più. D'altra parte siamo gente battezzata. Quindi...» «Quindi?» «Ieri sera abbiamo fatto una seduta straordinaria. Non ne mancava neanche uno e abbiamo deciso di proporvi la carica di cappellano della sezione». «Cioè?» «Cioè voi, la domenica, dovreste venire a fare una Messa speciale per noi. Diciamo una Messa di Partito». Don Camillo lo guardò. «Io non faccio il barbiere» rispose. «Sono i barbieri che fanno il servizio a domicilio. Alla vostra Casa del Popolo io non ci metterò più piede vita natural durante». «Non alla Casa del Popolo. Non si potrebbe neanche perché ci sarebbero delle interferenze politiche. Voi verreste qui: sotto quelle tre tettoie ci stiamo tutti. Qui siamo in campo neutrale: la distanza da qui alla Casa del Popolo è uguale alla distanza da qui alla chiesa. Dio è dappertutto e quindi Lui resta dov'è e nessuno gli dà dei fastidi: ci muoviamo noi e ci incontriamo a metà strada. Gli uomini si muovono e il Padreterno sta fermo. Insomma: se la montagna non vuole andare a Maometto e Maometto non vuole andare alla montagna, Maometto e la montagna vanno tutt'e due all'"Anonima" e buonanotte suonatori». Don Camillo si alzò. «Ci penserò» disse andandosene. Peppone rimase solo vicino al fuoco che ardeva sotto la tettoia della vecchia fabbrica abbandonata. "Se il Padreterno non è un fazioso" pensò "deve capire che queste storie non le facciamo per lui". Poi pensò alla faccenda dell'"abulico" e sospirò. "Peccato dover rinunciare a una così bella parola. Quella, per esempio, la si potrebbe mantenere nell'elenco delle parole permesse". Peppone il teologo di Giacomo Biffi L'epopea di Mondo piccolo — un piccolo mondo che ci viene offerto primariamente come cifra e quasi miniatura del più grande conflitto di idee, di mentalità, di interessi che ha segnato e dominato gran parte del secolo XX, ma poi diventa anche raffigurazione sorridente dell'intera commedia esistenziale — trova qui uno dei suoi più affascinanti capitoli. Ma a lettura finita c'è spazio, voglia e, si direbbe, necessità di qualche considerazione approfondita. Lo consente e quasi lo esige lo spessore di questa prosa; uno spessore che la levità della narrazione non riesce a celare, se non forse ai fruitori più disattenti. * In questo racconto viene affrontato esplicitamente il problema — serio e rilevante per Guareschi — del rapporto tra il servizio alla verità e la tirannia delle esigenze letterarie. Peppone l'avverte come qualcosa di intrigante e addirittura di angoscioso. «La letteratura [egli dice] è una porca faccenda che serve soltanto per imbrogliare le idee, perché va a finire che uno, invece di dire quello che vorrebbe lui, dice quello che vuole la grammatica e l'analisi logica». «Adesso parli giusto» osservò don Camillo [che qui è senza dubbio portavoce dell'autore]. «Ha bisogno di molte parole [dice più avanti don Camillo] chi deve mascherare la sua mancanza di idee o chi deve mascherare le sua intenzioni». La proposta di Peppone è di cancellare dal vocabolario tutte le parole che sono in più: ce ne sono troppe rispetto al numero delle cose da dire. Al momento egli non ci pensa, ma in fondo il suo è lo stesso parere di Gesù Cristo che ha detto: «Sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno" (Mt 5, 37). Bisogna riconoscere che dal tempo di Guareschi nell'uso del linguaggio c'è stato perfino un peggioramento. Sicché oggi l'inizio obbligato della nostra redenzione sociale sarebbe quello di cominciare a chiamare le cose soltanto con il loro nome, senza camuffamenti e senza quelle inutili prolissità che spesso finiscono coll'essere messe a servizio dell'ambiguità e della confusione. È per esempio strano (ma non tanto) che la famosa legge 194 — con la quale si è legalizzato e pubblicamente finanziato l'aborto — si intitoli con bella ipocrisia Legge per la tutela della maternità o che ci si dimentichi che, per indicare la convivenza more uxorio di due persone non sposate, la lingua italiana abbia già la parola "concubinato", senza che ci sia bisogno di perifrasi come "unioni di fatto" o "unioni affettive". «Se io parlo come mi ha fatto mia madre capisco tutto quello che dico» esclama nostalgicamente lo schietto capopopolo emiliano, che si vede invece costretto a misurarsi e a compromettersi con termini che gli sono estranei e incomprensibili, per nobilitare letterariamente il suo dire. E deve essere per lui un disagio non piccolo il dover ascoltare e ripetere nell'indottrinamento di partito vocaboli come "alienazione", "plusvalore", "materialismo dialettico", in omaggio a Carlo Marx. «Credi tu che Gesù Cristo adoperasse più parole di quante ne puoi adoperare tu?» gli fa notare l'implacabile curato. Peppone tenta di schermirsi: «Altri tempi, altro tipo di propaganda»; ma in realtà sa anche lui che qui don Camillo ci ha preso. Perché la lamentela gli viene proprio dal ricordo dello stile usato dal Figlio di Dio, il quale sapeva introdurre nel suo dire le cose più semplici e comuni, e così gli riusciva di far capire le grandi e ineffabili verità del Padre che ci ama e del Regno che ci aspetta anche al suo pubblico di pescatori, di pastori, di contadini. * Un'attenzione a parte merita la "teologia di Peppone". Essa suscita le ovvie critiche del suo antagonista, che in seminario aveva studiato sui testi classici e approvati; eppure io vorrei tentare di difenderla. Certo, dire che «Dio fa autocritica, riconosce le sue deviazioni [...] e diventa veramente democratico» a prima vista scandalizza e fa gridare alla bestemmia. Ma questo linguaggio racchiude qualche valore, che cercherò di mettere in luce facendo ricorso a una "autorità" di tutto rispetto. Il cardinal Newman distingue — ed è uno dei più originali dei suoi non sempre facili pensieri — l'"assenso nozionale" dall'"assenso reale": il primo termina ai concetti e non li oltrepassa, il secondo arriva alla realtà (e qualifica il vero atto di fede). Se io mi limito ad asserire che Dio è l'essere perfettissimo, l'eterno, il santo, l'onnisciente, eccetera, mi esprimo in maniera ineccepibile; ma il mio rischia di essere solo un "assenso nozionale", e non è detto che sia salvifico. Peppone invece, a ben guardare, parla di Dio come parla dei compagni coi quali ha quotidianamente a che fare; vale a dire, prende sul serio Dio come una persona viva e concreta. Il suo è un "assenso reale", e può essere l'avvio di una relazione religiosa trasformante. E si capisce allora come egli possa chiedere a questo Dio proprio come lo chiederebbe a un suo conoscente o a un suo amico — di favorire l'incontro delle parti, collocandosi tra loro (topograficamente, senza compromettere nessuna verità) a mezza strada. Così — rileva il teologo Peppone — «gli uomini si muovono e il Padreterno sta fermo». Non bisogna dimenticare che si tratta soltanto di una bega tra la parrocchia e la sezione del partito. Però vi è sottintesa una questione annosa e addirittura secolare, che affligge molti italiani: la questione di mettere d'accordo il loro antico cuore cattolico (che sa di aver bisogno non solo della predicazione del Vangelo, ma anche dei sacramenti e degli altri riti) e il loro antico animo anticlericale (per il quale sono convinti che ai preti non bisogna mai darla vinta del tutto). Perciò si può sperare che in questo caso Dio non si rifiuti equanimemente di dare una mano. «Se il Padreterno non è fazioso» pensa Peppone utilizzando ancora una volta l'"assenso reale" «deve capire che queste storie non le facciamo per lui». * Vorrei aggiungere un'ultima riflessione sul "dialogo": un tema vivissimo in questi decenni, tanto che sembra essere percepito dall'odierna cristianità quasi come un dogma di fede. Ma non è un dogma di fede. Piuttosto è una ovvietà: è evidente che bisogna dialogare sempre con tutti, se si vuole evangelizzare efficacemente. Quelli di Guareschi sono senza dubbio personaggi "preconciliari", ma nessuno potrebbe affermare che non ci sia dialogo fra don Camillo e Peppone. Il dialogo è anzi la sostanza stessa della loro leggendaria vicenda. Ogni giorno essi si incontrano, si confrontano, misurano con straordinaria libertà di spirito le loro rispettive convinzioni. Ma don Camillo — che non solo è un irriducibile annunciatore del Vangelo ma anche un leale e appassionato rappresentante della Chiesa — non si sogna neppure di pensare che per dialogare efficacemente bisogna, come oggi si sente dire, «guardare a ciò che ci unisce e non a ciò che ci divide». Egli sembra ben persuaso che sia vero il contrario, almeno quando quello che ci differenzia e ci contrappone non è motivato e connotato dal capriccio e dal puntiglio, ma dall'amore per la verità e la giustizia. Diversamente, non ci sarebbe più nemmeno dialogo autentico e pastoralmente proficuo; ci sarebbe solo una cortese chiacchiera da salotto. Appunto per questo il dialogo come è tratteggiato da Guareschi appare evangelicamente giusto e fruttuoso. La salvezza dei fratelli non verrà dalla capacità degli uomini di Chiesa di schivare con mondana eleganza ciò che può inquietare e pungere una pace delle coscienze obiettivamente infondata .e non generata dalla verità; potrà venire solo da una limpida e coraggiosa testimonianza resa, per amore del prossimo, alla luce di Dio. Giovannino Guareschi NOTTURNO CON CAMPANE riletto da Giovanni Lugaresi DAL VANGELO DI LUCA (15, 7) Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. Notturno con campane Da un pezzo don Camillo si sentiva due occhi addosso. Volgendosi all'improvviso, quando camminava sulla strada o fra i campi, non vedeva nessuno ma era sicuro che se avesse cercato dietro alla siepe o in mezzo ai cespugli avrebbe trovato gli occhi e il resto. Uscito un paio di volte, la sera, avendo avvertito un fruscio dietro la porta di casa, intravide un'ombra. «Lascialo fare» gli aveva risposto il Cristo dall'altare quando don Camillo gli aveva chiesto consiglio. «Due occhi non hanno mai fatto del male a nessuno». «Bisognerebbe sapere se i due occhi viaggiano da soli o in compagnia di un terzo occhio, per esempio calibro 9» sospirò don Camillo. «È un particolare che ha la sua importanza». «Niente può intaccare una coscienza tranquilla, don Camillo» . «Lo so, Gesù» sospirò ancora don Camillo. «Il guaio è che di solito la gente che si comporta così non spara sulla coscienza ma fra le spalle». Don Camillo non fece niente, però, e passò ancora del tempo e una sera tardi egli era solo in canonica e stava leggendo, quando "sentì" improvvisamente gli occhi. Ed erano tre: e sollevando lentamente il capo, don Camillo vide dapprima l'occhio nero di una pistola e poi incontrò gli occhi del Biondo. «Debbo alzare le mani?» chiese tranquillo don Camillo. «Non voglio farvi niente» rispose il Biondo riponendo la pistola nella tasca della giacca. «Avevo paura che vi spaventaste vedendomi all'improvviso e vi metteste a gridare». «Capisco» rispose don Camillo. «Non hai pensato che bussando alla porta avresti evitato tutto questo lavoro?» Il Biondo non rispose e andò ad appoggiarsi al davanzale della finestra. Poi si volse d'improvviso e si mise a sedere davanti al tavolino di don Camillo. Aveva i capelli scomposti, gli occhi con profonde occhiaie e la fronte piena di sudore. «Don Camillo» disse il Biondo fra i denti «quello della casa dell'argine l'ho fatto fuori io». Don Camillo accese il toscano. «Quello dell'argine?» disse tranquillo. «Be', roba vecchia, roba a sfondo politico. Roba che rientra nell'amnistia. Di che ti preoccupi? Sei a posto con la legge». Il Biondo alzò le spalle. «Me ne frego dell'amnistia» disse con rabbia. «Io tutte le notti appena spengo la luce me lo sento vicino al letto». «Chi?» «Quello là. Io non riesco a capire cosa sia questa faccenda!» Don Camillo soffiò in aria il fumo azzurro del sigaro. «Niente, Biondo» rispose sorridendo. «Dai retta: dormi con la luce accesa». Il Biondo balzò in piedi. «Voi dovete andare a prendere in giro quel cretino di Peppone» gridò. «Mica me!» Don Camillo scosse il capo. «Prima di tutto Peppone non è un cretino, secondariamente io per te non posso fare nient'altro». «Se c'è da comprare delle candele o da fare delle offerte per la chiesa, io pago» gridò il Biondo. «Però voi dovete assolvermi. Del resto io con la legge sono già a posto». «Siamo d'accordo, figliolo» disse con dolcezza don Camillo. «Il guaio è che l'amnistia per le coscienze non l'hanno fatta. Quindi qui si continua ancora col sistema di prima e per essere assolti occorre pentirsi e poi dimostrare di essere pentiti e poi fare in modo di meritare di essere perdonati. Roba lunga». Il Biondo ghignò. «Pentirmi? Pentirmi di aver fatto fuori quello là? Mi dispiace di averne fatto fuori uno solo!» «È un ramo nel quale sono completamente incompetente. D'altra parte, se la tua coscienza ti dice che hai fatto bene, tu sei a posto» disse don Camillo aprendo un libro e mettendolo davanti al Biondo. «Vedi, noi abbiamo dei regolamenti molto precisi senza esclusione per il movente politico. Quinto non ammazzare. Settimo non rubare». «Cosa c'entra questo?» chiese il Biondo con voce misteriosa. «Niente» lo rassicurò don Camillo. «Mi pareva proprio che tu mi avessi detto che, con la scusa della politica, tu lo avevi fatto fuori per prendergli i soldi». «Non l'ho detto! » gridò il Biondo cacciando fuori la pistola e puntandola contro il viso di don Camillo. «Non l'ho detto, ma è vero! Sì che è vero e se voi avete il coraggio di raccontarlo a qualcuno io vi fulmino! » «Noi queste cose non le diciamo neppure al Padreterno» lo rassicurò don Camillo. «Tanto Egli le sa meglio di tutti». Il Biondo parve calmarsi. Aperse la mano e guardò la pistola. «Bella testa!» esclamò ridendo. «Non mi ero neanche accorto che c'è la sicura». Girò il pirolino e mise il colpo in canna. «Don Camillo» disse il Biondo con voce strana. «Io sono stufo di vedere quello là vicino al mio letto. Qui i casi sono due: o mi assolvete o vi sparo». La pistola gli tremava leggermente nella mano e don Camillo impallidì e guardò il Biondo negli occhi. «Gesù» disse mentalmente don Camillo «questo cane è rabbioso e sparerà. Un'assoluzione concessa in condizioni simili non vale niente. Che faccio?» «Se hai paura assolvilo» rispose la voce del Cristo. Don Camillo incrociò le braccia sul petto. «No, Biondo» disse don Camillo. Il Biondo strinse i denti. «Don Camillo, datemi l'assoluzione o sparo!» «No». Il Biondo fece scattare il grilletto e il grilletto scattò. Ma il colpo non partì. Allora don Camillo lo fece partire lui, un colpo: e il colpo partì e arrivò giusto al segno perché i cazzotti di don Camillo non facevano mai cilecca. Poi si buttò sul campanile e, alle undici di notte, scampanò a festa per venti minuti. E tutti dissero che don Camillo era diventato matto: tutti meno il Cristo dell'altare che scosse il capo sorridendo, e il Biondo che, correndo attraverso i campi come pazzo, era arrivato in riva al fiume e stava per buttarsi nell'acqua nera; ma il suono delle campane lo raggiunse e lo fermò. E il Biondo tornò indietro perché aveva udito come una voce nuova per lui. E questo fu il vero miracolo perché una pistola che fa cilecca è un fatto di questo mondo, ma la faccenda di un prete che si mette a scampanare a festa alle undici di notte è roba davvero dell'altro mondo. Una voce nuova di Giovanni Lugaresi C'è una parola che attraversa tutte le vicende di don Camillo o, meglio, lo spirito, l'anima di questa parola, anche se non è che Giovannino Guareschi vi si soffermi con particolari sottolineature, anche perché è nelle cose, nei fatti, nei comportamenti. Ed è la parola "fedeltà". Con tutti i suoi limiti di uomo, con le malizie e le... scorrettezze che il grosso parroco della Bassa pone nella lotta politica contro l'antagonista Peppone, va tuttavia osservato che alla fedeltà al suo ministero, al suo essere prete, alla "sostanza" del suo essere prete, egli non viene mai meno. Costi quel che può costare. Una fedeltà nella quale ci imbattiamo spesso, ma che assume un suo alto spessore, che balza evidente in modo particolare in questo racconto, dove, a rischio della vita, don Camillo sa dire «no», ed è un «no» fermo, motivato a... norma di Vangelo. Nella consapevolezza piena che debba essere quello del «síc, sic; aut, aut», e che ci sono delle circostanze nelle quali viene il momento di testimoniare in maniera totale e definitiva, di rischiare tutto per mantenere fede a questo precetto di Gesù Cristo, per testimoniarlo, appunto, usque ad mortem. E quindi, di fronte al Biondo che lo minaccia con la pistola perché vuole l'assoluzione dai peccati (o meglio dal peccato contro il comandamento "non uccidere"), pur non essendosi per nulla pentito, ecco il rifiuto di don Camillo, che ci porta dritti agli Atti degli Apostoli (20, 24-25): Ma io non temo nulla e non considero preziosa la mia vita, pur di compiere il mio corso [.. .] e il ministero il quale ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testificar il Vangelo della grazia di Dio e a un passo ben preciso del Vangelo di san Luca (12, 4-9): A voi amici miei io dico: non temete quelli che uccidono il corpo, ma dopo non possono fare null'altro. Vi farò vedere invece chi dovete temere: Colui che dopo avere tolto la vita, ha potere di gettare nella Geenna. Sì, vi ripeto, temete Lui. Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure uno solo di essi non è dimenticato davanti a Dio. Invece persino i capelli della vostra testa sono contati tutti. Rassicuratevi quindi: voi valete molto più dei passeri. A voi io dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, sarà a sua volta riconosciuto dal Figlio dell'uomo davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà sconfessato davanti agli angeli di Dio. Come si vede, nel racconto guareschiano don Camillo dimostra di conoscere (e di applicare) l'insegnamento divino davanti agli uomini non temendo per la propria vita, anzi mettendola in gioco per la necessità del pentimento, del ravvedimento da parte del Biondo, giusto il passo ancora di Luca (13, 1-5) che così conclude: «Se non vi ravvedete, perirete tutti...» Non è che don Camillo voglia fare l'eroe a tutti i costi: ma, messo di fronte a una scelta senza scampo, ascolta la voce del Cristo, cioè della propria coscienza, e decide. Ma la decisione ferma di don Camillo posto di fronte a una scelta definitiva richiama anche un passo della Imitazione di Cristo, testo che sappiamo far parte dei "libri della fede" di Guareschi: Non badare troppo a chi t'è amico e a chi t'è nemico; preoccupati invece di questo, che in ogni cosa ti sia amico il Signore. Conserva pura la tua coscienza e Dio ti difenderà sempre. Sappi, infatti, che, se Dio vuol aiutare una sua creatura, non c'è avversità che possa nuocerle. E ci porta anche alla Seconda Lettera di san Paolo ai Corinti (4, 13): «Ho creduto, per questo ho parlato». Il grosso prete della Bassa ha fede ed è in virtù della fede che si è espresso come si è espresso. Quanto al Biondo, un altro passo del Vangelo di Luca (6, 2738) sottolinea l'amore per i nemici e la misericordia, soprattutto laddove Gesù dice: «Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati...», che è condizione indispensabile per ricevere l'assoluzione dal sacerdote e ritrovare la vera pace della propria coscienza, quella pace della quale il Biondo non gode certo, se la notte si sveglia con il pensiero all'uomo che ha assassinato. La situazione del giovane che ha ucciso, volendo farsi giustizia da solo, secondo quel che lui riteneva fosse opportuno fare, rimanda a un passo paolino della Lettera ai Romani (10, 3), dove leggiamo che, «non volendo riconoscere la giustizia di Dio», si cerca poi di «stabilire la propria», che è fallace e spesso legata a sentimenti che con la giustizia nulla hanno a che fare... L'azione, nel racconto guareschiano, vede poi il colpo andare a vuoto per l'inceppamento dell'arma, e quindi andare a segno, invece, il cazzotto di don Camillo, che provoca la fuga disperata del Biondo, durante la quale egli sentirà il suono di una campana: quello scampanare notturno che fa chiedere alla gente del paese se don Camillo non sia ammattito. È come il richiamo del canto del gallo — sempre nel Vangelo di Luca (22, 54-62) — a Pietro tre volte rinnegatore, che gli fa versare amare lacrime, ma lo fa anche pentire: «... e, uscito in strada, pianse amaramente». Sono infatti quei suoni a fermare la corsa del Biondo e a segnarne il ravvedimento. L'epilogo del racconto è nella voce nuova udita dal Biondo: con il suono delle campane (un suono che percorre tanta parte del Mondo piccolo di Guareschi), appunto, che sono la voce di Dio. È il peccatore che si ravvede, è la "pecorella smarrita" ritrovata dal pastore, e dunque, sempre seguendo Luca (15, 7): Vi assicuro che allo stesso modo sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede e non per novantanove giusti che hanno bisogno di ravvedimento. Sarà la stessa gioia che proverà don Camillo per il pentimento del Biondo, anche se nel racconto Guareschi non ce lo dice. Giovannino Guareschi NEL PAESE DEL MELODRAMMA riletto da Giovanni Lugaresi DAL VANGELO DI LUCA (10, 30-37) Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno". Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». Nel paese del melodramma Le galline aspettavano che la campana suonasse il mezzogiorno e, intanto, provavano la voce per il solito coro. Quell'estate, il sole ce l'aveva messa tutta e spesso si sentiva dire o si leggeva di gente che, mentre traversava una piazza o camminava per la strada, era cascata per terra — come una pera cotta — ammazzata dal caldo. Tutti si tenevano lontani il più possibile dall'asfalto e, sulla provinciale, si vedeva soltanto un disgraziato che viaggiava a cavalcioni di una scassata motoleggera. A mezzo chilometro dal paese il motore smise di ronzare: starnutì e si fermò. L'uomo scese di sella e continuò la strada a piedi, spingendo il suo motociclo. Non si chinò neppure a guardare il motore perché sapeva perfettamente dov'era il guasto. Guasto grosso, il più grosso dei guasti: mancava la benzina e pur se il distributore fosse stato a lato della strada, il motociclista avrebbe dovuto continuare pedibus calcantibus ugualmente in quanto non aveva un ghello in saccoccia. Mentre sudando procedeva per la strada deserta, l'uomo si guardava attorno per veder di trovare un'ombra: ma non c'erano piante, ai lati della strada. E anche a poter scavalcare il fosso per entrare nei campi, di là si sarebbero trovate soltanto stoppie bruciate. Era un tratto di strada maledetto, quello lì, e, più avanti, dove cominciavano i campi alberati, avevano messo le siepi di rete metallica. L'uomo continuò; si sentiva una gran confusione dentro la testa (forse debolezza per via delle febbri dei due giorni precedenti, forse debolezza per via che non aveva mangiato da quindici ore) e aveva paura che il sole gli azzeccasse una botta sul cervello. Arrancò disperatamente e allorché, finalmente, riuscì a raggiungere la Maestà che sorgeva a cinquanta metri dalle prime case del paese, gli parve di essere scampato miracolosamente a un grosso pericolo. La cappelletta dava un minimo d'ombra e, per goderla, bisognava rimanere appiccicati al muro tanto era stretta: l'uomo si addossò al muro e gli venne in mente di essere un naufrago aggrappato a una magra zattera. Una zattera verticale. Oramai il mezzogiorno stava per suonare e incominciava a passar gente per la strada: l'uomo pensò che non poteva rimanere lì, non poteva farsi vedere dalla gente in quella strana situazione. Perfino i ragazzini dell'asilo la sapevano lunga, in fatto di motoleggere, e poco che fosse rimasto lì, qualcuno si sarebbe fermato a domandare che accidente avesse la motoleggera e a dar consigli e a offrire aiuto. Si tolse dall'ombra, tirò su la moto e riprese deciso la strada. Ma, fatti pochi passi, si rese conto che, scassato com'era, non doveva neanche sognarselo di arrivare a piedi fino a casa sua. Abitava in città a trentacinque chilometri di distanza. Si trattava di guadagnar tempo e, soprattutto, si trattava di riuscire a sbarazzarsi della moto. Allentò la valvola del pneumatico anteriore e, quando la copertura fu afflosciata, si rimise in viaggio. Suonava la campana del mezzogiorno allorché l'uomo arrivava davanti all'officina di Peppone. Peppone stava ancora smartellando: l'uomo entrò con la moto nel grande stanzone affumicato. «Per cortesia» disse «gliela lascio qui. Con comodo mi guardi il pneumatico dietro. Non so se sia bucato o se si tratti della valvola che perde. Tornerò nel pomeriggio, sul tardi perché ho da fare in paese». Tirò fuori dalla borsa del portapacchi una busta di cuoio molto spelacchiata e se ne andò. Gli pareva di aver fatto un grosso colpo: "Intanto, fino a stasera alle cinque o alle sei, sono a posto. La moto è al sicuro, non m'impiccia, non mi mette in imbarazzo e io posso pensare tranquillamente al modo di rimediare i quattrini che mi occorrono". In realtà aveva aggravato la faccenda perché, se prima occorrevano solo i quattrini per la benzina, adesso occorrevano anche i quattrini che bisognava dare al meccanico per il disturbo di aver tenuta una mezza giornata la moto e di aver controllato il pneumatico. A ogni modo si trattava di poca roba. L'importante, la cosa urgente e necessaria era, adesso, di riuscire a sottrarsi alla curiosità della gente. Il forestiero, in un paese piccolo, fa spicco, specialmente quando lo si veda gironzolare in su e in giù proprio nell'ora in cui tutti vanno a mangiare. Uscì dall'abitato e, alla prima carrareccia, svoltò deciso e si buttò a sedere all'ombra della siepe. C'era un fossetto con un po' d'acqua ferma: si lavò le mani e, inumidito il fazzoletto, si ripulì la faccia. Si ravviò i capelli e, strappato un ciuffo d'erba, si tolse la polvere dalle scarpe. La barba se l'era fatta la mattina col rasoio che portava sempre con sé, dentro la borsa della moto: adesso era di nuovo a posto e poteva presentarsi dignitosamente dovunque avesse voluto. Quand'era ancora impolverato, spettinato, pieno di sudore e con quella dannata moto da trascinarsi dietro come una croce, era sicuro che il guaio stava tutto nel disordine della sua persona e nell'impiccio che gli dava la macchina: rimediato al disordine e scomparso l'impiccio, ogni cosa avrebbe ripreso a funzionare perfettamente. Adesso si accorgeva che la situazione era peggiorata. A chi presentarsi di bel mezzogiorno? A chi andare a offrire lucido da scarpe e saponette? E poi, anche ammettendo che fosse riuscito a far firmare qualche ordinazione, chi gli avrebbe dato dei quattrini d'anticipo su merce di cui aveva visto soltanto il campione? Già da quattro anni faceva quel mestiere. La guerra l'aveva portato via dalla vita a ventidue anni e quando, dopo cinque anni, egli era ritornato, non aveva più trovato nessuno a casa sua. Non aveva più trovato nessuno e niente: neanche la casa. Un mucchio di calcinacci nudi e crudi perché la gente aveva rubato tutto quello che non era calcinaccio, perfino i mattoni rimasti interi. Gli avevano dato quattro soldi di danni di guerra, e con questi e con gli altri quattro soldi che aveva avuto dal distretto come liquidazione dei due anni di prigionia in Germania si era comprato qualche vestito, un po' di biancheria e le carabattole necessarie per poter abitare una stanzaccia rimediata Dio sa come. La motoleggera non era sua; la noleggiava di volta in volta, e gli facevano un buon prezzo: una ditta di quint'ordine lo aveva assunto come produttore. Batteva le piazze attorno alla città, per un raggio di quaranta chilometri. Da quattro anni andava in giro a offrire cattivo sapone e pessimo lucido da scarpe a gente che aveva quasi sempre le botteghe piene zeppe di sapone finissimo e di lucido eccellente: faceva dei trattamenti di favore mangiandosi metà della provvigione, pur di riuscire a vendere qualcosa. In principio disponeva di una piccola scorta e allora il gioco gli riusciva. «Se lei fa questa ordinazione» diceva «riceverà una fattura di milleottocento lire. È già un ottimo affare ma io, siccome voglio farmi una solida clientela, intendo lavorare soltanto per la pubblicità. Così, per dimostrare coi fatti che lei incomincia a guadagnare prima ancora di vendere la merce, io le do subito trecento lire in contanti e lei verrà a pagare non milleotto ma millecinque». L'idea di ricevere dei quattrini da chi le vende roba è, per una certa categoria di persone, piuttosto simpatica, e in principio la faccenda funzionò. Poi, quando fu finita la scorta, il lavoro diventò ancora più duro e adesso, ogni volta che fermava il macinino davanti a una botteguccia di campagna, l'uomo si sentiva mancare il cuore. E quando spingeva la maniglia di un uscio a vetri e il campanello suonava, gli veniva la voglia di saltar sulla macchina e di scappar via. E mentre attendeva che qualcuno arrivasse in bottega pensava: "Questa volta non mi andrà liscia. Quando sapranno chi sono e quello che voglio mi cacceranno fuori a calci". Nessuno invece Io aveva mai preso a calci: nessuno lo aveva mai maltrattato. Forse perché era un bell'uomo e con un portamento da signore anche se i suoi abiti non valevano che pochi soldi. Forse perché tutti i bottegai erano oramai abituati a ricevere visite di produttori, e rispondevano di no con l'indifferenza data dalla lunga abitudine. Ma egli avrebbe quasi desiderato che lo insultassero, che gli rispondessero di mangiarseli lui il suo schifoso sapone e il suo ripugnante fango per scarpe. Forse allora avrebbe trovato la forza di piantar lì e di darsi da fare da qualche altra parte. Invece il tran tran era continuato: ma adesso qualcosa di eccezionale stava succedendo. A Castelletto, tre giorni prima, una febbre da cavallo lo aveva costretto a rimanere a letto in un albergaccio, e quando si era alzato i pochi quattrini che aveva in saccoccia gli erano appena appena bastati per pagare la camera e il mangiare. Il conto faceva duemilasettanta ed egli ne aveva duemila soltanto: ma la padrona, visti i due biglietti da mille aveva detto che bastava così. Un miracolo. Che però non si era ripetuto quando, a dieci chilometri da Castelletto, il serbatoio della motoleggera era rimasto vuoto. E adesso egli era lì, seduto all'ombra della siepe in riva al fossatello pieno di acqua morta, a pensare al modo di riempire il serbatoio e di tornare a casa. Di tornare a casa senza una lira e senza aver guadagnato un centesimo di provvigione. Vendere qualcosa? Non possedeva niente: la moto apparteneva al noleggiatore e, anche a impegnarla soltanto, c'era da andare in galera. Un rimedio peggiore del male. Ripensò ai giorni della guerra e della prigionia: come era bella la vita, allora, ancora piena di speranze. Guardò l'acqua morta del fossatello; levò gli occhi e si ricordò di una cosa molto importante: oltre l'argine c'era il fiume. Il fiume che lì si allargava e pareva immenso. Pensò a quell'acqua e gli parve che l'aspettasse. Provò quasi una gioia. Il fiume ampio e profondo. Si alzò e la testa prese a girargli. Si incamminò verso l'argine lontano, ma c'era qualcosa che l'aveva uncinato allo stomaco e lo teneva lì. Era fame. Fame disperata. E la fame lo teneva agganciato alla vita. "Fin che desidererò di mangiare come lo desidero adesso non troverò mai la forza di buttarmi nel fiume. Voglio mangiare, inzepparmi lo stomaco di cibo e di vino". Aveva bisogno di mangiare ma soprattutto di bere. Riempirsi di vino. Rientrò nella strada e si avviò verso il paese. L'osteria della Frasca era lì a duecento metri, una casetta isolata col pergolato davanti. "Mangiare e bere va bene, ma pagare?" Quel pensiero lo fece ridere: un uomo che, fra un'ora al massimo, sarà morto, deve proprio preoccuparsi di una cosa del genere. Un moribondo che si angustia: "Chi pagherà i miei funerali se sono solo al mondo?" E poi l'avventura lo divertiva: non aveva mai fatto una cosa così, non era mai partito allo sbaraglio in questo modo. Tanta gente aveva avuto mille avventure di tal genere nella vita e se ne gloriava. Anche lui l'avrebbe avuta la sua avventura e si sarebbe accontentato di raccontarla a se stesso, prima di buttarsi nell'acqua. Entrò nell'osteria pieno di allegria: lo interessava straordinariamente sapere come sarebbe finita la storia del desinare a sbafo. Si sedette ma non si tolse la giacca. Ci teneva a non perdere quota neppure all'ultimo giro. «Vorrei mangiare» disse con voce sicura all'oste. «Datemi tutto quel che c'è di pronto». L'oste della Frasca era un omaccio sgraziato dal principio alla fine. Un uomo che non aveva mai riso, in vita sua, perché anche se l'avesse voluto, non ci sarebbe mai riuscito tanto aveva duri e tirati i muscoli delle mascelle. Lo chiamavano Ganassa, per dir ganascia, e i suoi movimenti erano lenti e tardi. Le volte che lo tiravano a cimento e doveva mettere in moto le mani, non dava cazzotti come fanno tutti gli altri cristiani: levava il pugno e lo mollava giù come una martellata. «Minestra col lardo, salame e frittata con le cipolle» spiegò Ganassa con voce cupa. «Va bene. Portate subito del vino». Arrivò la minestra e, più che mangiarla, il giovanotto la fumò. Poi si buttò sulla frittata e sul salame. Faceva un caldo da crepare e il vino era fresco: lo bevve come fosse gazzosa e la sbornia gli scoppiò tutta d'un colpo. Per un momento parve all'uomo che la testa gli si spaccasse e gli venne il terrore di non potersi più muovere di lì: poi dolcemente sentì mancarsi il cuore e si addormentò. * «Passata?» La voce aspra di Ganassa lo risvegliò. La testa non gli girava più ma aveva la bocca arida. Mandò giù mezza caraffa d'acqua. «Che ore sono?» domandò all'oste. «Le sette». L'angoscia lo prese: pensò alla motocicletta senza benzina, pensò al desinare e al vino da pagare. La faccia cupa di Ganassa e le sue mani enormi gli fecero paura. Poi pensò al fiume, al grande fiume che aspettava e, improvvisamente, si sentì tranquillo. Tutto a posto. Si fece portare un grosso bicchiere di grappa e lo cacciò giù e Ganassa lo stette a guardare. «Conto» disse l'uomo. Ganassa prese un pezzetto di gesso e scarabocchiò qualcosa su di un tavolo. Il giovanotto vedeva muoversi quella manaccia dalle dita grosse come bastoni. Ma cosa importava? Tutto sarebbe finito nell'acqua del grande fiume. «Seicentodieci» disse alla fine Ganassa tirando su la testa. Il giovanotto esitò un momento poi disse: «Mi dispiace molto». Ganassa non capì. «Non è né molto né poco» replicò con tono minaccioso. «È il prezzo giusto. Se vuol controllare controlli». Il giovanotto sospirò. «Non parlo del prezzo. Dico che mi dispiace molto per il fatto che io non ho le seicentodieci lire». Ganassa si avvicinò lentamente e, arrivato al tavolo, appoggiò i pugni micidiali sulla tovaglia e si protese verso il giovanotto. «Non avete le seicentodieci lire?» «No». «E quanto avete?» «Niente» spiegò il giovane. La cosa sembrò enorme a Ganassa che rimase qualche istante come sbalordito. «E senza un centesimo in tasca voi siete entrato qui e vi siete fatto servire tutto quel che vi ho dato!» ruggì mentre gli occhi gli diventavano sempre più piccoli. Il giovanotto allargò le braccia. Ganassa ansimava, adesso. «A me non mi ha mai preso per il bavero nessuno» disse Ganassa scostando con una zampata la tavola. Il giovanotto non si levò neppure in piedi. La cosa non gli interessava e attese. Ganassa avanzò d'un passo, agguantò con la sinistra il giovanotto per gli stracci del petto e lo tirò su. Il giovanotto attese che la mano destra si mettesse in moto ma, in quell'istante, una voce si levò: «Ganassa, non ti mettere nei guai per seicento lire». Ganassa allentò le dita e si volse: «Io gli ho dato da mangiare» disse. «Io non sono che un disgraziato e tu lo sai. Perché, se non aveva neanche un centesimo, è venuto proprio a imbrogliare me?» «Sono entrato nella prima osteria che ho incontrato» spiegò il giovanotto e Ganassa strinse i pugni: «Perché, quando siete entrato, non avete detto che eravate senza soldi e che avevate fame? Qualcosa ve l'avrei data lo stesso». «Non ho mai chiesto la carità in vita mia» spiegò il giovanotto. «E poi avevo bisogno di vino, molto vino». Ganassa aveva finito tutto il suo repertorio di argomentazioni. «Basta!» ruggì. «Non uscite di qui sé non mi date qualcosa per rifarmi il danno». In un angolo della stanzaccia tre o quattro uomini stavano seduti a un tavolo giocando alle carte. Smisero definitivamente di giocare e stettero ad aspettare. Ganassa era lanciato e di sicuro sarebbe saltato fuori un macello. Il giovanotto pensò al grande fiume che lo aspettava e sentì quasi un malvagio piacere per quel che gli stava accadendo. Come se succedesse a un altro. Si frugò in tasca poi mostrò a Ganassa le poche cianfrusaglie racimolate. «Non c'è niente di buono» spiegò. «Se volete che vi lasci la giacca!» «Non voglio stracci!» grugnì Ganassa. «Ho questa borsa, la matita stilografica...» «Non voglio stupidaggini! » grugnì ancora più feroce Ga-nassa. Il giovanotto si guardò addosso poi allargò le braccia: «Non so cosa darvi» disse. «Per quanto io pensi non so cosa darvi. Non posso neanche farvi una cambiale perché so che non potrei pagare mai...» Gli occhi gli caddero sulla parete di fianco e vide i quadretti con le solite vecchie oleografie da osteria di campagna: Otello che sta per strozzare Desdemona, Rigoletto che col braccio levato urla: «Cortigiani vil razza dannata» e via discorrendo. Allora si ricordò di una vecchia storia di prigionia, di quando cioè, per avere dai tedeschi un paio di zoccoli di legno, aveva dovuto cantare O sole mio, e si volse verso Ganassa: «Sentite» disse «io non so cosa darvi. Se volete posso farvi una cantata». Quando gli venne in mente che, a dire una cosa del genere, significava dare il via all'oste per il macello, era troppo tardi: Ganassa aveva già stretto i pugni e già si avanzava implacabile. «Volete pagarmi con una cantata?» domandò Ganassa giunto a un passo da lui. «Quand'ero in prigionia, un tedesco per una cantata mi ha dato un paio di zoccoli, una trancia di pane così, e una sigaretta». Ganassa rimase un istante perplesso poi indietreggiò e andò a infilarsi dietro il banco. «Avanti» disse Ganassa. Il giovanotto fece di sì con la testa e si schiarì la gola. Intanto si guardava attorno e scoperse, appeso sopra la porta, un quadro con dentro la faccia malgarbata del Peppino di quelle parti. Guardò intensamente, disperatamente quell'immagine cercandone gli occhi e, alla fine, li trovò e non li mollò più. Erano due occhi piccoli ma che sfavillavano nell'ombra come due diamanti. Il giovanotto attese il cenno e quando l'ebbe da un barbaglio guizzato fuor dall'ombra, attaccò qualcosa di Verdi. Continuò a cantare mai abbandonando quegli occhi e sentì uscirsi di bocca una voce che non gli pareva neppure la sua e, negli acuti, il fiato che non trovava nei polmoni lo cacciava fuori dal cuore. Il vino? La grappa? Il miraggio del grande fiume che aspettava? Cantò e, quando vide spegnersi le due gemme dell'ombra, capì che aveva finito di cantare. Ganassa era lì, coi gomiti sul banco, il testone stretto tra le manacce pelose e non tirava neanche il fiato. E i tre o quattro del gruppetto in fondo alla sala pareva si fossero messi d'accordo con Ganassa. Il giovanotto si mosse e si avviò verso la porta perché il fiume lo aspettava. Quando passò davanti al banco, Ganassa si riscosse: si levò su, aperse il cassetto e vi frugò dentro e depose sul marmo trecentonovanta lire. «Signore, il resto delle mille lire» disse con voce cupa Ga-nassa. Il giovanotto si volse e rimase come incantato da quel gesto straordinario. Poi l'atmosfera del melodramma prese anche lui e sorridendo rispose: «Resto mancia!» «Grazie, signore» rispose Ganassa. E nei suoi occhi brillò un lampo di meraviglia perché non aveva mai ricevuto in vita sua una mancia così grossa. Fuori, il sole aveva finito di assassinare i campi e ora si apprestava lentamente a mettere in scena un tramonto degno del cielo lirico della Forza del destino. Il giovanotto arrivò in riva all'acqua. Ma l'acqua lo respingeva. Tutto era uguale, ma tutto era cambiato, adesso. «Ecco la macchina». Il giovanotto si volse: Peppone stava dietro lui e teneva la motoleggera per il manubrio. Il giovane voleva dir qualcosa ma Peppone non gliene lasciò il tempo. «Tutto a posto» spiegò. «La gomma e la benzina». Il giovane allargò le braccia ma Peppone scosse il capo: «Stia comodo, sono già pagato di tutto: ero all'osteria anch'io ». Si incamminarono verso la discesa che portava alla strada provinciale. «Come ho cantato?» domandò il giovanotto. «Non lo so» rispose Peppone. «Non pareva neanche una voce. Non ho un'idea di che accidenti sembrasse. Sono cose che si sentono ma non si capiscono». Il giovanotto sospirò: «Ero pieno zeppo di vino...» «Ma che vino!» borbottò Peppone. «Non diciamo stupidaggini. So ben io la roba che può venir fuori da sotto il vino». Il giovanotto notò qualcosa nella forcella anteriore della motoleggera e si chinò. «Non ho fatto a tempo a riverniciarla» spiegò Peppone. «Era incrinata da tutt'e due le parti e l'ho saldata. Se aveste fatto ancora cinquecento metri, vi sareste accoppato. Vi è mancata la benzina al momento giusto». Il giovanotto impallidì e incominciarono a tremargli le mani: «È impossibile!» esclamò. «Sì, ma oggi è destino che succedano soltanto cose impossibili» replicò Peppone. Poi tacque un istante e concluse: «Giovanotto, dicano quel che vogliono, ma, politica a parte, il Padreterno è sempre il Padreterno». Il giovanotto saltò sulla macchina e, percorsi i primi tre metri della discesa, il motore già ronzava. E Peppone stette lì a sentire il ronzio del motore e gli pareva un poema sinfonico che, lentamente, si sciogliesse e svanisse nell'aria. Due buoni samaritani di Giovanni Lugaresi C'è un "buon samaritano" anche nella Bassa guareschiana. Anzi, in questo racconto, ce ne sono due: Peppone e il grezzo oste che, di fronte a una realtà che non sospettava, rivela la sua pronta, buona disposizione ad aiutare chi era disperatamente nel bisogno. E, quanto al personaggio della parabola evangelica soccorso con sollecitudine e grande amorevolezza in queste pagine del Mondo piccolo di Guareschi, egli non è un bastonato dai briganti che lo hanno aggredito, bensì un bastonato dai casi della vita, che lo hanno portato a un punto tale di disperazione da indurlo al pensiero di farla finita. È uno degli elementi più forti — questo — che balza evidente in questo racconto. Ma, prendiamola da lontano, per così dire. Per sottolineare come nella pagina di Giovannino Guareschi ci si imbatta, di quando in quando, in situazioni che traggono origine da vicende personali, fra le quali quella della prigionia non può certo mancare, visto e considerato il segno che lasciò nell'esistenza dello scrittore. È il caso di questo "capitolo", in cui sono ben presenti i temi della speranza, dopo il tempo del lager, della disperazione per una condizione di vita che peggiora sempre più, ma anche quello della Provvidenza. La quale si può manifestare come e quando vuole, nelle circostanze più disparate, ancorché inaspettata, a risolvere una situazione drammatica e, apparentemente, per lo meno fino a un certo punto, senza via d'uscita. Il "buon samaritano" è intanto nell'espressione dell'oste, dopo la rabbia per essere stato — così pensava lui — "raggirato" da chi aveva ben mangiato e abbondantemente bevuto, dichiarando poi di non avere in tasca nemmeno una lira, e quindi di non esser in grado di poter pagare il conto: Perché, quando siete entrato, non avete detto che eravate senza soldi e che avevate fame? Qualcosa ve l'avrei dato lo stesso... E qui eccoci al passo evangelico di Matteo (25, 34-40): Allora il Re si rivolgerà a quelli di destra: «Venite voi, i benedetti del Padre mio, entrate in possesso del regno per voi preparato fin dalla creazione del mondo. Poiché io ebbi fame e voi mi sfamaste, ebbi sete e mi dissetaste, fui forestiero e mi alloggiaste, nudo e mi vestiste, infermo e vi prendeste cura di me, in carcere e mi visitaste». Allora i giusti osserveranno: «Signore, quando mai ti vedemmo affamato e ti nutrimmo, assetato e ti dissetammo? Quando ti vedemmo forestiero e ti alloggiammo, nudo e ti vestimmo? Quando ti trovammo infermo o in carcere ti visitammo?» E il re risponderà loro: «Sì, vi assicuro: quanto faceste a uno dei più piccoli dei miei fratelli, lo faceste a me...» È dunque un'opera di misericordia corporale, di fede, quella che era nelle intenzioni dell'oste, e poi una predisposizione dell'animo a mettere qualcosa del suo in comune con lo sventurato rappresentante di commercio, come del resto leggiamo negli Atti degli Apostoli (5, 32-35): La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune. La parte finale del racconto è poi tutta nella vicenda dell'amore del prossimo, giusta la parabola del buon Samaritano (Lc 10, 30-37), con quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti «che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto», con quel che segue. Sappiamo che in diversi passarono, ma si guardarono bene dal prestargli aiuto. Soltanto un Samaritano ebbe pietà di lui, lo soccorse, lo medicò, lo portò nell'albergo, eccetera eccetera. E non diversamente dal buon Samaritano, alla fine, nel racconto di Guareschi, si comportano sia l'oste, che dà al rappresentante di commercio un resto del conto che non gli spetta, sia Peppone, con quel suo grande cuore che conosciamo, il quale mette a posto la motocicletta, ne fa pure pieno di benzina il serbatoio e non chiede in pagamento nemmeno una lira. Con un di più di richiamo a un altro passo del Vangelo di Luca (6, 45), dove si parla dell'«uomo buono» che «dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori il bene...». Ecco, sia l'oste, sia Peppone sono uomini buoni che dal buon tesoro del loro cuore sanno esprimere il bene. C'è poi, nella stupenda cantata del protagonista (grazie alla quale può "saldare" il conto dell'osteria e quello del meccanico Peppone) che tiene fissi gli occhi su quelli del ritratto di Giuseppe Verdi mentre si esibisce, addirittura un richiamo alla visione e alla liberazione di cui leggiamo negli Atti degli Apostoli (16, 25-26): Or, in su la mezzanotte, Paolo e Sila, facendo orazione, cantavano inni a Dio; e i prigionieri li udivano. E si fece un gran terremoto, talché i fondamenti della prigione furono scrollati; e in quello istante tutte le porte si apersero, e i legami di tutti si sciolsero... Così è di fronte al canto del protagonista: si aprono le porte della solidarietà, si sciolgono i nodi della disperazione. E in fondo in fondo, ecco un altro richiamo di fede nella conclusione del racconto. Per un caso (o Provvidenza?!) la benzina era mancata al momento giusto, sì da evitare un incidente che avrebbe potuto essere mortale. Così, le coincidenze (l'azione della Provvidenza? sono due: il protagonista viene salvato da un incidente stradale prima, dalle sue intenzioni di farla finita togliendosi la vita, poi. Ed è ancora un passo di san Paolo che ci sovviene: «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte dov'è il tuo pungiglione?» (1 Cor 15, 55). I due "buoni samaritani" l'oste e Peppone hanno adempiuto la legge, perché hanno dimostrato di amare il loro prossimo: infatti, sempre secondo l'Apostolo, «il compimento della legge è l'amore» (Rm 13, 8). Giovannino Guareschi LE LAMPADE E LA LUCE riletto da Giorgio Torelli DAL VANGELO DI LUCA (11, 33-36) Nessuno accende una lucerna e la mette in luogo nascosto o sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce. La lucerna del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce; ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se il tuo corpo è tutto luminoso senza avere alcuna parte nelle tenebre, tutto sarà luminoso, come quando la lucerna ti illumina con il suo bagliore. Le lampade e la luce Don Camillo guardò in su verso il Cristo dell'altar maggiore e disse: «Gesù, al mondo ci sono troppe cose che non funzionano». «Non mi pare» rispose il Cristo. «Al mondo ci sono soltanto gli uomini che non funzionano. Per il resto ogni cosa funziona perfettamente». Don Camillo camminò un po' in su e in giù, poi si fermò davanti all'altare. «Gesù» disse «se io comincio a contare: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e vado avanti per un milione di anni sempre a contare, ci arrivo in fondo?» «No» rispose il Cristo. «Tu, così facendo, sei come l'uomo che, segnato un gran cerchio per terra, comincia a camminare attorno a esso dicendo: "Voglio vedere quando arrivo alla fine". Non ci arriveresti mai». Don Camillo, che oramai mentalmente si era messo a camminare su quel gran cerchio, si sentiva l'affanno che di solito prova chi, per un istante, tenta di affacciarsi alla finestrella che dà sull'infinito. «Eppure» insisté don Camillo «io dico che anche il numero deve avere una fine. Soltanto Dio è eterno e infinito e, se il numero non avesse una fine, sarebbe eterno e infinito come Dio». «Don Camillo, perché ce l'hai tanto coi numeri?» «Perché, secondo me, gli uomini non funzionano più proprio a causa dei numeri. Essi hanno scoperto il numero e ne hanno fatto il supremo regolatore dell'universo». Quando don Camillo innestava la quarta era un guaio. Andò avanti un bel pezzo, poi chiuse la saracinesca e camminò in su e in giù per la chiesa deserta. Tornò a fermarsi davanti al Cristo: «Gesù, questo rifugiarsi degli uomini nella magia del numero non è invece un disperato tentativo di giustificare la loro esistenza di esseri pensanti?» Tacque un istante angosciato. «Gesù, le idee sono dunque finite? Gli uomini hanno dunque pensato tutto il pensabile?» «Don Camillo, cosa intendi tu per idea?» «Idea, per me, povero prete di campagna, è una lampada che si accende nella notte profonda dell'ignoranza umana e mette in luce un nuovo aspetto della grandezza del Creatore». Il Cristo sorrise. «Con le tue lampade non sei lontano dal vero, povero prete di campagna. Cento uomini erano chiusi in una immensa stanza buia e ognuno d'essi aveva una lampada spenta. Uno accese la sua lampada ed ecco che gli uomini poterono guardarsi in viso e conoscersi. Un altro accese la sua lampada e scopersero un oggetto vicino, e mano a mano che si accendevano altre lampade, nuove cose venivano in luce sempre più lontane e alla fine tutti ebbero la loro lampada accesa e conobbero ogni cosa che era nella immensa stanza, e ogni cosa era bella e buona e meravigliosa. Intendimi, don Camillo: cento erano le lampade, ma non erano cento le idee. L'idea era una sola; la luce delle cento lampade, perché soltanto accendendo tutte le cento lampade si potevano vedere tutte le cose della grande stanza e scoprirne i dettagli. E ogni fiammella non era che la centesima parte di una sola luce, la centesima parte di una sola idea. L'idea dell'esistenza e della eterna grandezza del Creatore. Come se un uomo avesse spezzato in cento pezzi una statuetta e ne avesse affidato un pezzo a ciascuno di cento uomini. Non erano cento immagini di una statua, ma le cento frazioni di una unica statua. E i cento uomini si cercarono, tentarono di far combaciare i cento frammenti e nacquero mille e mille statue deformi prima che ogni pezzo riuscisse a combaciare perfettamente con gli altri pezzi. Ma, alla fine, la statua era ricomposta. Intendimi, don Camillo: ogni uomo accese la sua lampada e la luce delle cento lampade era la Verità, la Rivelazione. Ciò doveva appagarli. Ma ognuno invece credette che il merito delle belle cose che egli vedeva non fosse del Creatore di esse, ma della sua lampada che poteva far sorgere dalle tenebre del niente le belle cose. E chi si fermò per adorare la lampada, chi andò da una parte e chi dall'altra, e la gran luce si immiserì in cento minime fiammelle ognuna delle quali poteva illuminare soltanto un particolare della Verità. Intendimi, don Camillo: è necessario che le cento lampade si riuniscano ancora per ritrovare la luce della Verità. Essi oggi vagano sfiduciati ognuno al fioco lume della sua lampada e tutto sembra loro buio intorno e triste e malinconico e, non potendo illuminare l'insieme, si aggrappano al minuto particolare cavato fuori dall'ombra dal loro pallido lume. Non esistono le idee: esiste una sola Idea, una sola Verità che è l'insieme di mille e mille parti. Ma essi non la possono vedere più. Le idee non sono finite, perché una sola Idea esiste ed è eterna: ma bisogna che ognuno torni indietro e si ritrovi con gli altri, al centro della immensa sala». Don Camillo allargò le braccia. «Gesù, indietro non si torna...» sospirò. «Questi disgraziati usano l'olio delle loro lucerne per ungere i loro mitra o le loro sporche macchine». Il Cristo sorrise: «Nel Regno dei Cieli l'olio scorre a fiumi, don Camillo». Serenata per il Creatore di Giorgio Torelli Il racconto appena letto conferma la regola del foglio bianco, inteso come specchio di chi vi affidi le parole in successione, e come autoritratto — quasi sempre involontario — di chi pratichi la pena dello scrivere e vi si sottoponga. Il foglio candido attrae mentre respinge. Provoca sconcerti che vanno disciplinati. Assume il fascino del vuoto in cui chi si appresti a comporre — intendo a dipanare il tema vagheggiato vorrebbe perfino precipitare per sottrarsi alla prova del pensare con ordine. Costa molto il cimento di arredare il riquadro di carta con l'architettura obbligata delle proposizioni. Scrivere adagio. Con ritmo. Possibilmente in solitudine e con il precetto interiore di spiegarsi come si convenga. Questo è quel che si vorrebbe — sempre — da parte di chi ha uso professionale o volontario della penna, della macchina per scrivere o — adesso — dello schermo di computer. E questo è quello che si sarà prefisso anche Guareschi, il più laborioso dei senzaregole, giornalista e scrittore anche notturno, uso ai rigori della disciplina dopo averla maledetta: governare il foglio pulito, abbacinante, tentatore e despota; fronteggiare il foglio, riguardato come territorio di cui impossessarsi per deporgli in grembo — alla buon'ora parole pescate nel pozzo. Come chiunque abbia uso di queste liturgie di lavoro, Guareschi — riesco bene a immaginarlo — si sarà seduto al cospetto dell'Olivettí e avrà radunato le forze per procedere alla battitura e dunque al deposito delle parole in fila indiana. Sembrano momenti di routine, ma non lo sono mai. Perché le parole che lo scrivente (o lo scrittore) va pensando si prendono subito delle libertà. Balzano fuori anche a sorpresa. Richiamano il corredo o l'esca di verbi e aggettivi che non sembravano in programma. Imboccano curve impreviste e, talora, pare che evadano dal seminato mentale di chi scrive per andare a parare dove il loro regista non avrebbe sospettato. Il fascino, il richiamo, l'occasione del foglio bianco è tutta qui: che un uomo siede davanti alla carta vergine con la decisione interiore di condurre al pascolo un certo armento di parole. E poi finisce per fare tutt'altro, visto che così — in quel momento, di quel giorno — gli vien sorgivamente di fare. E anche perché le voci interiori si sovrappongono come vogliono ai progetti pensati. E danno luogo a novità che insorgono dal di dentro, dall'immenso repertorio che ognuno sa e non sa di possedere. In questo racconto, Guareschi si svela perfino a se stesso: ecco il gioco dello specchio. E si dipinge: ecco l'autoritratto. Lo fa non perché quel giorno si sia seduto — lui con le idee chiare — per scrivere esattamente quel che poi ha scritto. Ma perché, quel mattino o quella sera di grazia, l'insieme che gli urgeva dentro è stato, più che sollecitato, improvvisamente costretto dal nitore del foglio a precisarsi. Intraprendendo il dialogo tra don Camillo e il Cristo — così credo io —, Guareschi non aveva in mente (battuta dopo battuta) l'intera trama del loro dirsi. S'è solo proposto il tema che gli ronzava in mente. E l'ha portato a conclusione, ponendo via via a se stesso le domande da mettere in bocca a don Camillo; e cercando, proprio nel segreto di se medesimo, le risposte che poi ha fatto scendere dal Gesù della croce. In sintesi: Guareschi, quel giorno, nel chiostro del foglio vísà-vis, nel perimetro di carta riservato alla sincerità — quando se ne senta l'urgenza e tutto sia confacente al rivelarsi — ha rilasciato una riflessione che gli stava dentro, ma molto dentro, fin dal suo primo considerare le cose per metterle in parole. Ci sono bellissime pagine di uomini che hanno volato alto senza averne l'intento, ma lasciando sgorgare dal loro stesso tesoro d'esperienza quanto non poteva più rimanere magma e dunque, un bel giorno, decideva di manifestarsi. Guareschi scrive di Dio, muovendo i fili di don Camillo. E intanto cresce nel novero del racconto fino a una consapevolezza rasserenante, fino a poter dire: «Don Camillo c'est moi». Giovannino il battezzato (anche lui lungo un fiumé come Giovanni il Battezzatore) vede, sente sgorgare dal suo indaffararsi sulla carta le parole definitive, quelle che sembrano proprio mobilitare la voce del Signore: «Va', Giovannino, la tua fede ti ha salvato». Giovannino batte coi tasti, ed eccola là — linda — la sua testimonianza di fede: Non esistono le idee: esiste una sola Idea, una sola Verità che è l'insieme di mille e mille parti. È il Guareschi più alto, lui polemista, sciabolatore, ombroso, appartato, contadino, umorevole, schietto, deciso, onesto. Lo specchio del foglio di carta — l'autoritratto — offre senza riserve il Giovannino creato che fa la serenata al Creatore, e improvvisa da par suo. Parla alla luce. Le telegrafa col ticchettio di un'artigianale Olivetti di campagna. Giovannino Guareschi SUL FIUME riletto da Giorgio Torelli DAL VANGELO DI LUCA (12, 22-32) Poi disse ai discepoli: «Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete! Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede? Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia: di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno». Sul fiume In quei paesi là, in riva al fiume, nella gran piana dove il sole battente addormenta la gente di giorno e le zanzare la tengono sveglia di notte, sono tutti un po' balenghi e allora bisogna aspettarsene di ogni qualità. Don Camillo sentiva che qualcosa non funzionava, in paese, ma per quanto si fosse dato da fare per grattare la crosta di mistero che da un po' di tempo si era formata attorno a Peppone e alla sua banda di scatenati, non aveva potuto sapere un accidente di niente e questo lo innervosiva. Cosa stavano combinando dietro al sipario di ferro? Ma poi, improvvisamente, il sipario d'acciaio si sbullonò e si seppe tutto e allora a don Camillo venne un fegato grosso come uno zaino affardellato. E tutto era spiegato in un manifesto appiccicato ai muri: COMITATO PER LA PACE «Cittadini! Nubi guerresche si addensano nel cielo tempestoso la quale ogni padre e madre di famiglia vedono la rovina irreparabile deí teneri figli e delle case. Le potenze plutocratiche si sono coallizate in cuí noi vediamo le loro reprobe intenzione di mettere il mondo a ferro e a fuoco. Poppoli pacifichi e umani, lavorano tenacemente per la Pace: ma la coallizíone bruta insidia subdola e allora leviamo a Dio la preghiera e facciamone interprete la Santa Madre del Divino Operaio di Nazaret venuto ín terra terrore dei tiranni e difesa del Proletario oppresso. Il Comitato comunale per la Pace organizza quindi per la sera del giorno di sabato 7 maggio, una pubblica solenne Processione Popolare con la Venerata immagine della MADONNA DELLA PACE! Sono vietate ogni intromettenza politica di alcun genere comprese bandiere e rappresentanze. Cittadini! Preparatevi ad accogliere degnamente la MADONNA DELLA PACE illuminando le finestre e adornando le case per affidare la preghiera di pace alla Santa Avvocata dei poveri. Il Comitato com. per la Pace. C'era scritto così e don Camillo lesse e partì a saetta verso il municipio. Peppone, che, nel suo ufficio, stava firmando non so che carte, lo ricevette con molta calma. «Cos'è quel manifesto?» gorgogliò don Camillo. «È un manifesto» spiegò Peppone. «Con tanto di marca da bollo e permesso di affissione». «E cosa significa?» «Significa quello che dice. Se lo avete letto lo sapete». Don Camillo mandò giù, ma era come spingere un tappo dentro una bottiglia piena. «Non permetteremo mai che voi combiniate una simile pagliacciata!» Peppone lo guardò curiosamente. «Pagliacciata un corteo di brava gente che porta in processione una statua della Madonna? E voi non le portate a spasso le vostre Madonne e i vostri Santi?» Don Camillo ripeté che non avrebbe mai permesso simile sacrilegio e allora Peppone trasse un gran foglio con disegnata la disposizione del corteo. Davanti, bambini e bambine, poi donne, poi, portata a spalle da quattro operai, la statua della Madonna della Pace. Ai lati e dietro, la guardia d'onore alla Madonna: lavoratori con fiaccole. Dietro, le autorità comunali, braccianti e popolazione. La banda avrebbe suonato esclusivamente l'Inno della Pace fatto fare apposta in città. «Io non ci vedo nessun sacrilegio» concluse Peppone. «Vi diciamo niente noi quando voi portate in processione i vostri Santi? Avete forse il monopolio della Madonna, voi?» Don Camillo si era calmato. «Peppone, dammi retta: non immischiare le cose divine alla politica. Porta in processione chi vuoi, ma lascia le Madonne e i Santi ai preti. Io ho forse mai portato in processione la statua di Stalin?» Peppone era sicuro di sé. «Il paragone non funziona: Stalin è un uomo, ma la Madonna è un Dio e Dio non è mica soltanto vostro. Per dire Messa bisogna avere la patente da prete, siamo d'accordo: ma per portare a spasso la statua della Madonna, purché tutto sia fatto col dovuto rispetto, lo può fare ogni cristiano che sia battezzato». Peppone si era alzato e, avvicinatosi a una porta, l'aveva aperta. «Ecco» disse «non è una Madonna regolamentare?» In mezzo alla stanza, su un piedistallo coperto da un rosso velluto, c'era la statua della Madonna. Ed era una bellissima statua uscita dal migliore magazzino di arredi sacri della città. Teneva in braccio un Bambinello di ottima fattura e con la mano libera reggeva leggiadramente una candidissima colomba che aveva un ramoscello d'olivo nel becco. Don Camillo chi sa cosa avrebbe pagato per averla lui, in chiesa, una Madonnina così bella, e, per un istante, la stette a guardare a bocca aperta. Poi, al pensiero della Madonnina portata in giro per le strade a far reclame al partito di Peppone, strinse i denti. «Questo corteo non si deve fare e non si farà! » disse con rabbia. La disgrazia era che, alla Casa del Popolo, esisteva una biblioteca circolante e così Peppone, inquinato dalla letteratura, rispose solennemente: «Se voi vi pare di parlare come il Griso, io non mi sento di fare il don Chisciotte!» Si trattava di una maledetta confusione tra don Abbondio e l'eroe di Cervantes e la risposta perdette molto del suo sapore: a ogni modo Peppone si era spiegato. E la guerra cominciò. Don Camillo, una volta lanciatosi, era un Panzer: parlò in pubblico e in privato. Scrisse esposti, lettere, verbali. Andò a disturbare mezzo mondo ma, alla fine, la spuntò: e il Comitato per la Pace fu perentoriamente invitato a lasciare la Madonna estranea al Patto Atlantico. Peppone era duro da piegare, ma dovette piegarsi. Peppone si piegò: però, quando una settimana dopo si cominciò a vociferare in paese dell'arrivo della Madonna della Fontana, affermò perentorio: «Di dove non è passata la Madonna della Pace, non passerà la Madonna della Fontana». Qualcuno parlò a lungo a Peppone: gli descrisse lo stato miserando delle prigioni cittadine, gli rammentò i suoi doveri di padre di famiglia, di cristiano e di sindaco. Ma Peppone sapeva quel che diceva. «Qui la religione non c'entra. Qui è una faccenda privata tra noi e il prete. Voi potete chiamare duemila guardie con carri armati e cannoni, ma il pasticcio succederà lo stesso e il morto ci scapperà fuori anche se io mi opponessi. Io vi ho avvertito per dovere di coscienza. Conosco i miei uomini». Le pallottole hanno bisogno di poco spazio per viaggiare e bisogna tener presente che in quei paesi là, in riva al fiume, sono tutti un po' balenghi. Don Camillo ci pensò quindi sopra parecchio. Poi andò a confidarsi col Cristo dell'altare. «Gesù, se fossi sicuro che per far la processione deve scapparci fuori un morto e che quel morto sarò io, non esiterei un secondo. Ma chi mi dà questa sicurezza? Devo allora cedere a questa minaccia? Se fossi sicuro che, cedendo a questa minaccia, il solo danneggiato moralmente son io, non esiterei un istante a cedere. Ma chi mi dà questa sicurezza? Non posso rifiutarmi di cedere, conoscendo il pericolo cui esporrei qualche innocente. Non posso cedere conoscendo il danno morale che verrebbe alla Chiesa da questo atto che la gente interpreterebbe come paura, come viltà». Il Cristo Crocifisso sorrise. «Un uomo aveva due figli gemelli che erano la sua unica ricchezza e un giorno, mentre attraversava un ponticello, questo si ruppe e tutt'e tre caddero nei gorghi. E l'uomo era in grado di trarre a salvamento un solo figlio per volta e non sapeva quale portare a riva, perché salvando l'uno perdeva l'altro. Allora, per non perderli entrambi, ne portò verso la riva uno e l'altro lo affidò a Dio. Ed ecco affiorare un enorme pesce che sospinge il bambinello alla riva e così entrambi i figli furono salvi e fu salva anche l'anima dell'uomo che aveva avuta fede in Dio. Don Camillo: quando un dubbio tormentoso ti afferra, interroga la tua coscienza e se la tua coscienza non ti sa rispondere interroga la tua fede in Dio». Don Camillo non aveva bisogno di interrogare la sua fede. «La Madonna della Fontana passerà per queste strade e non sarà versato sangue di innocenti» disse don Camillo. «Sei tanto sicuro di te?» «Sono tanto sicuro di Voi». Il fiume si era gonfiato e la pioggia cadeva ancora a barili. Anche i torrenti e i canali si erano gonfiati e si davano arie da Rio de la Plata. Passerelle e ponticelli erano stati travolti: come si poteva organizzare un pellegrinaggio da Comune a Comune in quelle condizioni? Il parroco di Fontana ebbe allora un'idea. Fontana era l'ultimo paese a monte, in riva al fiume; la Madonna sarebbe stata portata fino al fiume: qui l'avrebbero caricata su una grossa chiatta addobbata e illuminata e tutta la gente dei paesi sarebbe venuta sugli argini con ceri e fiaccole. E la Madonna sarebbe passata, la prima sera di calma, rasente alla riva sinistra, poi, arrivata al ponte della ferrovia, sarebbe tornata su risalendo la corrente rasente la riva di destra. C'era chi avrebbe procurato il rimorchiatore e un gran corteggio di barche infiorate e illuminate avrebbe seguito la gran barca con la Madonna. Sarebbe stato uno spettacolo meraviglioso, come un enorme Canal Grande, con mille e mille luci nella notte. Ogni parroco avrebbe portati i suoi parrocchiani sull'argine o avrebbe seguito in barca assieme a essi la Madonna. La gente si esaltò da matti a pensare al grande fiume illuminato e alla Madonna sulla barca infiorata. E continuava a piovere, ma la gente andò a piantar pali lungo l'argine; sui pali avrebbero poi messo dei trofei di frasche e di fiori e, da palo a palo, fili con palloncini colorati: roba di chilometri, da sistemare all'ultimo minuto. Il fiume si era gonfiato e premeva per un buon metro d'altezza contro gli argini ma, quando finalmente una mattina smise di piovere e parve che il cielo si tranquillizzasse, e si decise di fare la straordinaria processione, la gente corse sugli argini e, quando cadde la sera, si accesero i lampioncini e fu una cosa da scrivere sui libri tanto era bella. Ed ecco che la barca sfolgorante con la Madonna lascia Fontana. La corrente è forte, ma, dietro la chiatta, c'è agganciato il rimorchiatore che lavora a macchina indietro e regola il passo. Segue il corteggio delle barche che, costeggiando, si arrangiano. Passa la piccola flotta con la gran barca piena di luce in testa da paese a paese: la gente è tutta sugli argini. Oramai ha già toccato il paese vicino a quello di don Camillo, ma don Camillo non è sull'argine ad aspettare la Madonna: l'argine è deserto. Nella mattinata è saltata fuori una infiltrazione; l'acqua si è scavato un buco sotto l'argine e rapidamente il buco si è ingrossato: alle sei di sera c'è mezzo metro di acqua in paese. Alle sette sono ottanta centimetri. Le bestie sono state portate tutte al di là del secondo argine e, nelle case, la gente è salita al primo piano. L'argine è deserto e buio davanti al paese e alle nove l'acqua nel borgo è alta un metro. Ma non può più salire perché l'acqua in paese ha raggiunto il livello del fiume. L'argine emerge dall'acqua circa un metro ma sotto, per tre o quattro metri, è tutto vuoto, perché l'acqua ha mangiato tutto. Così, quando la gran barca della Madonna arriva, l'onda basta a buttar giù quell'inutile terra e la chiatta entra piena di luci nel borgo e tutti sono alle finestre, e non c'è lume in paese che non sia acceso. I paesi lungo il fiume sono semplici: due lunghe file di case perpendicolari all'argine, in fondo la piazza e la chiesa. La gran chiatta navigò lungo quel Canal Grande. Navigò maestosa nelle strade dove non era passata la Madonna della Pace e andò a fermarsi davanti alla chiesa. Qui la aspettava don Camillo, vestito dei suoi più bei paramenti, e dentro l'acqua fino a mezza vita. Dietro di lui, dentro l'acqua fino alla cintola, c'erano il sindaco Peppone col Consiglio comunale al completo. E la chiesa era illuminata, e il Cristo si specchiava nell'acqua che lambiva l'altare maggiore. Poi, il giorno dopo, come per miracolo, il fiume si ritirò nel suo letto e, davanti a un fatto come questo, il Comitato per la Pace non poté fare a meno di regalare a don Camillo la statua della Madonna della Pace. Amen. Tutto in una consonante di Giorgio Torelli Anche in questo racconto, il Crocifisso dà il "tu" a don Camillo. Ma don Camillo gli si rivolge con il "voi" a tutto tondo, riservato ai padri qui in terra e al Padre che sta nei cieli. Tutte le preghiere, le petizioni, le suppliche, gli abbandoni e gl'inni cristiani di un tempo neanche lontano da noi prevedevano il "voi" del rispetto e delle distanze mantenute. Dunque, don Camillo, che dobbiamo immaginarci perennemente a schiuma frenata ma comunque in linea con i precetti, non svicola mai nel confidenziale appena gli occorra di trovarsi a tu per tu col Crocifisso che parla. Mantiehe impeccabilmente l'etichetta. Non eccede. In pratica, visto che il Crocifisso gli riserva affabilità e attenzione, vuota il sacco come meglio gli piaccia. Poi l'affranca col "voi". Amen. Ne nasce la domanda: visto che ogni scrittore usa un personaggio di sua invenzione per esprimersi liberamente sotto diverse spoglie, siamo autorizzati a pensare che i pensieri del signor parroco della Bassa fossero sempre gli stessi del loro autore e che Guareschi, il Giovannino intento a sagomare un altro racconto, amasse davvero parlare con Dio per interposto don Camillo? Io dico di sì. Dico che Guareschi esercitasse soprattutto nella scrittura il suo sentirsi dalla parte del Risorto, mai attribuendo al Crocifisso frasi diverse da quelle che il filtro e l'esercizio della sua stessa coscienza proponessero. In sostanza io dico che Guareschi sia stato uomo di preghiera. E stimo che abbia manifestato, proprio attraverso le urgenze di un don Camillo, la sua continua voglia di dialogo con l'Altissimo fatto croce. Le stesse avventure di don Camillo, in veste nera esagitata, sono sottilmente piene di devozioni col "voi" alla maniera dell'uomo Guareschi. Don Camillo trabocca. È una gran figura di carta e di celluloide, ha la bazza di Fernandel, si rimbocca perfino le maniche della talare per fare a cazzotti con Peppone. L'intrattenimento c'è tutto, mai visto un parroco così simpatico e battagliero. Ma le proposizioni di Camillo, quando è l'ora di parlare al Padre, combaciano con Guareschi. E il Padre che replica a Camillo, dal legno di una croce di parrocchia, dice quel che Giovannino sente di sentire. Un uomo pensoso e serio — Giovannino, appunto — ci fa credere che i colloqui tra un prete accerchiato e l'Altissimo coi chiodi siano solo avvenuti in quel Mondo piccolo che ha per indirizzo la Fantasia. Mentre è vero il contrario. I colloqui rappresentano esattamente l'abitudine, la voglia e la determinazione dello scrittore, solitario e amareggiato, di fermare tutto attorno a sé e di entrare in confidenza — sempre adottando il più "voi" tra tutti i "voi" tributati — con il Dio che gli preme, gli urge, gli si rivolge invitante e provocatorio. Tutti sanno come il Guareschi delle Roncole si facesse compagnia da solo. Ma solo non è mai stato. Lo svela la sua autobiografia attraverso i racconti. Non può sentirsi orfano un uomo maturo, navigato, segnato duramente dall'esperienza e dalla fragilità assordante del successo, che un giorno scrive le righe di Sul fiume, per esempio, e fa chiedere dal Crocifisso a don Camillo: «Sei tanto sicuro di te?». Don Camillo replica, ma non è lui. È Guareschi che, sul foglio, risponde: «Sono tanto sicuro di Voi». C'è la "V" maiuscola, naturalmente, il massimo che si possa fare sulla carta per dire tutto in una consonante. Giovannino Guareschi MAI TARDI riletto da Alessandro Gnocchi DAL VANGELO DI LUCA (15, 11-24) Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Mai tardi Giacomo Dacò era uno di quegli uomini che non si commuoverebbero neanche al cospetto del diluvio universale. Uno di quei tipi che non danno soddisfazione a nessuno, neanche alla morte, perché sono indifferenti perfino verso se stessi e, ammesso che ci pensino, l'idea di dover diventare terra da boccali non li interessa che come fatto da tener presente agli effetti amministrativi. La marcia dei Dacò era incominciata, ternporibus illis, quando un Dacò s'era trovato a morire con tre biolche di terra sue, e le aveva lasciate al figlio. Il figlio ne aveva conquistate altre venti e il figlio del figlio ancora trenta e via discorrendo, fino ad arrivare a Giacomo che a ottant'anni aveva fatto di Campolungo un podere di trecento biolche e, oltre a Campolungo, possedeva un caseificio con annesso allevamento di maiali, una fabbrica di conserva di pomodoro e due mulini. Il vecchio Dacò aveva combinato le cose per bene: considerando che il podere di Campolungo era facile da dividere in due, si avevano cinque blocchi di roba, di valore uguale l'uno all'altro, di modo che, essendo cinque i figli a ereditare, non avrebbero avuto motivo di litigare. A meno che, si capisce, non fosse entrato in ballo il diseredato. Carlino, il diseredato, era l'ultimo dei sei figli di Giacomo Dacò e il quarto dei maschi perché, dopo Marco, Giorgio e Antonio e prima di arrivare a Carlino, la moglie di Giacomo Dacò aveva commesso l'errore di mettere al mondo due gemelle: Clementina e Maria. Errore nel senso che Giacomo Dacò, appena se le era viste presentare dalla levatrice, aveva incominciato a urlare che una partaccia di quel genere non se l'aspettava da sua moglie. Anzitutto perché, in una famiglia seria, non ci devono essere figli di sesso femminile che servono soltanto a dare dei fastidi. Secondariamente perché, se una donna proprio vuol fare la sciocchezza, ha come minimo l'obbligo di contenersi nei limiti della decenza e non scodellare due femmine in una volta sola. Naturalmente, alla prima occasione, Giacomo aveva maritato le figlie. Poi, mano a mano che i figli si sposavano, siccome la confusione non gli piaceva, se li era tolti dai piedi: a Marco aveva dato il caseificio, a Giorgio la fabbrica di conserva, ad Antonio i molini, tenendo per sé Campolungo. Quando gli era morta la moglie, Giacomo si era trovato completamente solo perché Carlino, già da parecchi anni, aveva tagliato la corda. Ma Giacomo Dacò era un formidabile lottatore. A ottant'anni, dunque, il vecchio Dacò andò a far compagnia alla moglie, ma tutti erano tranquillissimi perché si sapeva che i tre fratelli avrebbero tenuto quello che già avevano e Campolungo sarebbe stato diviso tra le due sorelle. Carlino, a parte il fatto che era stato diseredato, era Carlino: uno che piuttosto di piegare la testa se la faceva spaccare. Questa storia di Carlino era incominciata quando il ragazzo aveva toccato i dodici anni. Il padre stava vicino ai cinquantatré: le due ragazze, Marco e Giorgio avevano già messa su casa per conto loro. Oltre a Carlino, rimaneva soltanto Antonio a Campolungo: ma anche lui, fra qualche anno, se ne sarebbe andato. Perciò allorché Carlino finì la quinta elementare il vecchio disse: «Bene: adesso mettiti a lavorare e cerca di guadagnarti il pane come ho fatto io e come hanno fatto tutti i tuoi fratelli». Ma allora, per la prima volta nella sua vita, la vecchia alzò la voce. «No» esclamò. «Gli altri sono tutti degli zucconi. Carlino invece è intelligente e deve studiare!» Il vecchio rimase sbalordito davanti a quella rivoluzione. Stavano a tavola: agguantò la scodella ancora piena di minestra e la buttò contro il muro. «Qui comando io!» gridò. «E se a qualcuno non gli piace, quella è la porta!» La vecchia si alzò e, senza neanche dire mezza parola, uscì. Il vecchio, Carlino e il fratello rimasero lì dove si trovavano e passarono dieci o quindici minuti senza che, nella stanza, si udisse un respiro. Poi, d'improvviso, il vecchio si alzò, si lanciò nell'andito e si trovò davanti sua moglie che, vestita con l'antico abito nero della festa e tenendo un fagotto in mano, stava avviandosi verso la porta che dava nell'aia. «Cosa fai?» domandò imbestialito il vecchio Giacomo. «Non mi piace e me ne vado» rispose asciutta la moglie. Era anche la prima volta che il vecchio trovava, in casa, qualcuno che avesse il coraggio di puntare i piedi, e perdette la calma. Agguantò la moglie per un braccio e prese a scuoterla rudemente. Ma continuò poco perché un urlo straziante della donna risuonò: «Carlino!» • Il vecchio si volse e, in fondo all'andito, c'era Carlino con la doppietta fra le mani. Il padre e il figlio si guardarono per qualche minuto: e nessuno disse parola. Né di quel fatto si parlò più in seguito. La vita riprese normale: la vecchia ritornò umile e silenziosa, Carlino continuò a lavorare nella stalla e nei campi come aveva sempre fatto anche prima, nel tempo che la scuola gli lasciava libero. Arrivò così la fine di settembre e, una sera, finita la cena, il vecchio Giacomo cavò di saccoccia una busta e la porse ad Antonio: «Domattina alle sei prendi il tram. Qui ci sono l'indirizzo della scuola, le bollette pagate per l'iscrizione e il libretto dell'abbonamento tranviario. Per questa volta lo accompagni tu e poi lo aspetti e lo riporti indietro. Da dopodomani si arrangerà da solo». Carlino incominciò così la sua spola fra il paese e la città e continuò imperterrito senza che il vecchio sembrasse accorgersi di lui. Nei giorni di mezza vacanza o di vacanza intera, Carlino aiutava il fratello e i famigli nei lavori della stalla o dei campi. Studiava di sera e ciò gli costava una fatica bestiale ma non gliene importava niente. Giunse la fine del primo anno di scuola tecnica e il vecchio Giacomo se ne accorse soltanto perché vide che Carlino non andava più in città e s'era dedicato completamente al lavoro. Non domandò niente e, siccome in casa Dacò si parlava soltanto quando si era interrogati, nessuno gli disse niente. Solamente che, dopo quindici giorni dal ritorno totale di Carlino ai campi, la vecchia disse a tavola: «Antonio, domattina attacca la cavalla e portami in città». Il vecchio levò la testa e guardò la moglie con occhi sbalorditi. Era la prima volta che la donna avanzava delle pretese del genere. Non urlò. «Qui stiamo diventando matti!» si limitò a brontolare. La vecchia tornò nel pomeriggio, sotto un sole che spaccava le pietre. Carlino stava dormicchiando sotto una pianta: la madre andò a trovarlo e, appena gli si fu seduta vicino, incominciò a piangere. «E allora?» domandò Carlino. La madre si frugò nel corsetto e cavò fuori un bigliettino. «Li ha copiati Tonino e poi li abbiamo fatti controllare dal bidello» spiegò fra i singhiozzi. Carlino scorse rapidamente il foglietto. «Ma sono stato promosso in tutto!» esclamò. «Lo so» gemette la donna. Poi gli fece, singhiozzando, tutta la descrizione dell'avventura e quello che dicevano gli altri quando leggevano i voti, e cosa le aveva detto il bidello, e come era l'atrio della scuola e via discorrendo. Poi concluse: «Pensa quando lo saprà lui! » Il ragazzo saltò su inviperito: «Voi dovete dirglielo soltanto se ve lo domanda. Anzi, non dovete dirgli niente. Se gli interessa, vada in città a vedere. Io non gli debbo niente: io i soldi delle tasse e del viaggio me li guadagno lavorando nei campi. Che crepi!» Ma al vecchio Giacomo interessava soltanto che Carlino facesse il suo lavoro. Capiva soltanto il lavoro e quando il ragazzo, venuto l'autunno, riprese la spola, borbottò: «Ricomincia la storia!» Antonio, giunto ai ventisette anni, si sposò andandosene anche lui per conto suo, come era la regola, e il vecchio Giacomo disse alla moglie: «Il ragazzo si è divertito abbastanza: adesso ha sedici anni e può aiutarmi a tener su la baracca». «Sta facendo il secondo anno e deve continuare fino in fondo. Quando avrà preso il diploma di geometra allora se ne riparlerà» replicò la donna. Il vecchio sghignazzò: «Geometra! Quello diventa geometra quando io divento Vescovo. E poi, cosa gli serve il diploma? Per voltare la paglia alle vacche?» Carlino continuò a studiare e siccome, appena aveva un momento di libertà, si scannava nei campi, il vecchio si limitava a borbottare. E così fino alla Pasqua del 1930. Arrivarono le vacanze di Pasqua e Carlino, che oramai aveva diciotto anni e due braccia da uomo di trenta, siccome uno dei vaccari s'era ammalato, lo rimpiazzò. E accadde che un pomeriggio, mentre stava scarriolando letame dalla stalla alla concimaia, un'automobile si venne a fermare nell'aia e ne scesero due giovincelli e tre ragazze. Schiamazzavano come oche e il vecchio Giacomo, col forcone in spalla, si fece avanti. «Abita qui il signor Carlo Dacò?» domandò uno dei giovincelli. «Il signor Carlo Dacò è lì che sta facendo scuola guida con la "Balilla"» rispose il vecchio indicando la porta della stalla. In quel momento Carlino uscì, vestito come il più strapazzato dei bovari e spingendo una carriola con sopra mezza tonnellata di letame fresco e gocciolante. I due giovincelli e le tre ragazze gli lanciarono un grande urlo e Carlino, vedendosi la squadra comparire improvvisamente davanti, mollò le stanghe della carriola e rimase lì come un baccalà. «E allora, è questo il modo di accogliere gli amici che vengono dalla città a farti visita?» gridò uno dei giovincelli. «Non ci dici proprio niente?» «Il signor Carlo Dacò non ha tempo di chiacchierare!» rispose con voce dura il vecchio che si era avvicinato. «Qui si lavora». Carlino levò di scatto la testa: «Sono miei compagni di scuola» spiegò. «Anche quelle lì?» domandò ironico il vecchio indicando le tre ragazze. «Certo!» rispose Carlino. Il vecchio considerò con palese disgusto le giovinette, poi si rivolse a quella che pareva la più anziana delle tre: «A pitturarvi le labbra e le unghie ve lo insegnano a scuola o prendete lezione privata da qualche sgualdrina del varietà?» disse con voce aggressiva. La ragazza arrossì e le vennero le lacrime agli occhi per la rabbia e per l'umiliazione. Vennero le lacrime agli occhi anche a Carlino: ma vedendosi sporco e misero vicino a quella carriola piena di letame, si sentì tanto ridicolo da non avere neanche il coraggio di parlare. «Vedi di spicciarti perché dopo devi mungere!» disse il vecchio Giacomo andandosene. I due giovincelli e le tre ragazze si incamminarono verso la macchina e Carlino li raggiunse. «Mi dispiace» balbettò «dovevate avvertirmi». «Non credevamo che, a trenta chilometri dalla città, ci fossero subito gli zulù!» replicò seccamente la più smilza delle tre ragazze». «Tu dovevi avvertire che hai un padre idrofobo! » aggiunse la seconda salendo in macchina. Ma Carlino pareva preoccuparsi soltanto della terza ragazza: la più alta e la più donna, quella alla quale il vecchio aveva detto le sue insolenze. «Franca, ascoltami un momento!» balbettò Carlino afferrandole un braccio per impedirle di salire. «Lasciami! Non vedi che mi insudici il vestito con le tue manacce sporche?» rispose l'altra sottraendosi alla stretta. La macchina partì e Carlino rimase lì a guardarla allontanarsi. «Be'? Ti spicci?» La voce del padre lo riscosse: si volse di scatto stringendo i pugni, ma si trovò faccia a faccia con sua madre. «Mamma!» disse Carlino. «Questa volta lo ammazzo!» La vecchia gli asciugò il sudore col fazzoletto. «La più grande deve avere una simpatia speciale per te» sussurrò. Carlino si irrigidì muggendo. «L'ho capito subito» sussurrò la vecchia. «Anche lui, vedi, se ne è accorto». Si udì il vecchio sbraitare ancora dalla stalla e allora la donna impugnò le stanghe della carretta piena di letame. Ma Carlino subito le fu alle spalle e la tolse di lì. «Devo prendere il diploma!» ruggì prendendo a spingere la carriola. La sera, a tavola, il vecchio Giacomo attaccò subito. «Se ne stiano a casa loro» esclamò «non vengano a disturbare chi lavora». Carlino tirò il fiato lungo. «Mi avete fatto fare una figura schifosa» disse cupo, tenendo gli occhi fissi sulla tovaglia. «Potevate evitare di offendere quella povera ragazza. Se si pittura le unghie che male vi fa?» «A me niente. Per conto mio si può pitturare anche il sedere. Fin che uno sta a casa sua fa i comodi suoi. Quando viene a casa mia deve essere di mio gradimento se no se ne va. Stiano nel loro mondo, quei mammalucchi! Ognuno ha il mondo suo. Io non mi sognerei mai di andare in casa di un cittadino con una carretta di letame. Quando entrano qui, le loro porcherie le lascino fuori. Bella roba!» «Non deve piacere a voi!» disse aggressivo Carlino. «Basta che piaccia a me». «Chi? Quella disgraziata pitturata come un burattone da giostra? È quella là la famosa patente da geometra? Non è mercanzia che fa per te. Il tuo mondo è qui. Villano sei nato e villano creperai». Carlino non rispose: continuava a guardare la tovaglia ma sentiva gli occhi di sua madre fissi su di lui ed era come se li vedesse. Gli ultimi due anni furono un inferno: alla fine Carlino ebbe il suo diploma di geometra. Ma il servizio militare gli capitò subito addosso tra capo e collo e pareva che Iddio glielo avesse mandato, tanto desiderava potersi staccare per un po' da Campolungo. Non volle licenze: sapeva che sua madre era contenta che stesse lontano da Campolungo e gli bastava. Nessuno gli scrisse da casa. Mai egli scrisse a casa. Finito il corso allievi ufficiali, domandò di fare subito il servizio di prima nomina e, quando da allievo ufficiale finalmente passò sottotenente, allora a casa ci tornò. Era in artiglieria pesante campale e, in quei tempi, gli ufficiali non erano vestiti da gasisti come succede adesso con la scoperta del panno color camomilla e della giubba infilata dentro le brache. Allora gli ufficiali erano vestiti da ufficiali, e quelli d'artiglieria avevano un tabarro azzurro che pareva tagliato dal più bel capitolo del Risorgimento. Carlino, col tabarro azzurro, aveva l'imponenza di un armadio a tre ante e alla gente del paese parve che fosse arrivato Napoleone. Appena se lo trovò davanti, la vecchia Dacò spalancò gli occhi e allargò le braccia e stette a contemplarsi estatica il suo Carlino come se si trattasse della Madonna. Quando poi vide che aveva anche la sciabola luccicante, si mise a piangere perché quella era una consolazione troppo forte per lei. Il vecchio Giacomo, vedendo Carlino, si toccò con un dito la tesa del cappello. La mancanza di rispetto che aveva per il figlio non riusciva a fargli dimenticare il profondo rispetto che aveva per il Regio Esercito. Però non disse niente e, siccome non se la sentiva di ordinare a un ufficiale di andare a rigovernare la stalla, rimase lontano da casa per tutti e dieci i giorni della licenza di Carlino. Finito il servizio di prima nomina, Carlino tornò a Campo-lungo e, una volta che l'ebbe visto in borghese, il vecchio ritornò quello di prima. «Adesso non ci sono più scuse» disse. «Mettiti a lavorare e fa il tuo dovere». «Adesso prima di tutto mi sposo» rispose calmo Carlino. Il vecchio lo squadrò come se avesse davanti un pazzo scatenato «Ti sposi?» «Sì e, se non vi dispiace, sposo la disgraziata pitturata come un burattone da giostra che avete insultato quella volta. Se vi dispiace, la sposo lo stesso». Il vecchio Giacomo Dacò era sui sessantaquattro anni, Carlino sui ventitré: l'età era di parecchio diversa, ma la testardaggine uguale. «Se hai il coraggio di fare una stupidaggine come questa, tu esci di qui e non ci rientri mai più, fin che son vivo» disse il vecchio. «Me ne vado e non metterò più piede qui dentro fin che non siate morto» rispose Carlino. «Neanche quando sarò morto! » urlò il vecchio. «Ti diseredo». «Non ho bisogno dei vostri stracci per guadagnarmi la vita!» replicò il giovane. «Voi siete nato villano e morirete villano. Io sono nato villano ma villano non morirò». Carlino si avviò verso l'uscita; arrivato sulla porta della cucina si volse: «E se mia madre vuol venire con me, adesso, domani o quando le sembra meglio, non ha che da alzare un dito. Troppe gliene avete fatte patire, vecchio pazzo!» La vecchia scosse il capo: «No, no, vai pure, Carlino, e Dio ti benedica. Io sto bene qui». * Carlino andò e il vecchio Dacò rimase solo con la moglie. Non parlò mai più di Carlino. Come se non fosse mai esistito. Né la vecchia entrò mai in argomento: la vecchia aveva nel suo vecchio armadio di noce la mantella azzurra e la sciabola luccicante del suo Carlino e questo le bastava ampiamente. Ogni tanto si chiudeva nella camera, spazzolava la mantella, la lisciava con la mano, lucidava la sciabola, e stava lì a rimirarsi quella roba come lo spettacolo più straordinario del mondo. Quando poi Carlino le mandò due grandi fotografie, una sua a braccetto con la moglie, e una del bambino, la gioia della vecchia non ebbe limiti. E una volta che perdette le due fotografie pareva diventata matta, e non si capiva cosa avesse perché non aveva detto a nessuno di aver ricevuto le due fotografie. Quando le ritrovò, la vecchia si confidò col buon Dio: «Gesù, Vi ringrazio di avermi fatto la grazia». La vecchia morì dieci anni dopo la partenza di Carlino. Morì dolcemente, con le due fotografie strette sul petto, tanto strette che gliele lasciarono e le misero dentro la cassa. E, quando si sentì mancare, volle che spalancassero i battenti del vecchio armadio di noce che era lì, davanti al letto, e fino all'ultimo continuò a guardare la mantella azzurra e la sciabola luccicante di Carlino. Il vecchio, seppellita le moglie, richiuse l'armadio e tirò avanti da solo per altri sei anni, fino ad arrivare agli ottanta. In quel tempo nessuno osò mai parlargli di Carlino. Soltanto una volta don Camillo cercò, con bel garbo, di entrare in argomento e il vecchio lo interruppe: «Ahh!» urlò come se gli avessero nominato una gran porcheria. Poi sputò per terra. Arrivato agli ottanta giusti, una notte morì. E la mattina alle sei già la gente di Campolungo era in allarme: «Se a quest'ora non lo si è ancora sentito urlare, i casi sono due: o è diventato matto o è morto» dissero i famigli di Campolungo. Alle sette entrarono nella camera del vecchio passando dalla finestra e lo trovarono disteso sopra le coperte del letto secco come un chiodo, con la solita faccia cattiva, e vestito completamente di nuovo. Aveva fatto tutto da solo per non aver bisogno di nessuno. Aveva capito che era arrivato il momento, aveva trovato la forza di vestirsi da morto. Si era sdraiato sul letto della vecchia. La gente rimase sbalordita; un uomo così faceva paura anche dopo morto: difatti il vecchio Dacò, sdraiatosi sul letto, aveva anche trovato la forza di mettersi il Crocifisso sul petto e di incrociarvi sopra le lunghe mani ossute. Non lo toccarono. I figli e le figlie gli passarono davanti senza piangere. Scossero il capo e poi se ne andarono perché sapevano di avergli sempre dato fastidio da vivo e non volevano dargliene da morto. E poi questa era la sua volontà: «Fin che sono in casa mia, lasciatemi solo». Il testamento fu aperto subito perché così il vecchio aveva dato ordine al notaio di fare, e non si trattava davvero d'un romanzo: «Lascio il caseificio e annessi a mio figlio Marco. Lascio la fabbrica di conserva e annessi a mio figlio Giorgio. Lascio due molini e annessi a mio figlio Antonio. Lascio il podere di Campo-lungo, con tutto quello che c'è dentro niente escluso, a mio figlio Carlo detto Carlino. Mio figlio Carlo verserà in contanti, entro cinque anni, a mia figlia Clementina e a mia figlia Maria, in parti uguali, la somma globale di lire... rappresentanti il valore di metà di Campolungo». I mariti delle due donne mugugnarono ma le mogli saltarono loro sulla voce: «State zitti. Non dategli soddisfazione!» Venne la sera e rimase a vegliare il vecchio soltanto Giusà, il vaccaro di novant'anni, e se ne andò verso la mezzanotte, quando venne a dargli il cambio Carlino. * Carlino aveva trentanove anni e s'era fatto massiccio come era il padre ai suoi bei tempi. Guardò il vecchio rigido e freddo disteso sul letto e nei suoi occhi c'era soltanto rancore. Camminò in su e in giù parecchio poi si fermò e squadrò il vecchio: «Villano siete nato e villano siete morto!» esclamò con voce acre Carlino. «Ma io villano non morirò. Vi conosco bene e il trucco non vi riuscirà. Volete cavarvi la soddisfazione, dunque! "Lascio Campolungo a mio figlio Carlo, con tutto quello che c'è dentro e col gravame dei quattrini da dare alle donne". Così Carlino, per la bramosia di avere Campolungo, molla tutti i suoi affari e viene qui a curare la proprietà!» Si chinò sul morto e gridò: «E invece io, domani, vendo Campolungo con tutto quello che c'è dentro, pago quel che devo alle donne e mi godo i quattrini in città, alla vostra salute! Troppo furbo siete, ma vi è scappata una distrazione: perché non c'è la clausola che, se io vendo Campolungo, perdo l'eredità. Secondo il testamento io debbo semplicemente dare tot lire alle donne». Camminò in su e in giù un poco, poi si volse verso il vecchio. «E poi, cosa me ne importa dei vostri quattrini?» esclamò. «Ho detto che mi sarei fatta la mia strada da solo e ce l'ho cavata! Sì, anche se voi non vi siete mai degnato di accorgervi che io mi sono guadagnata una professione, la professione ce l'ho!» Trasse di saccoccia un foglio di carta intestata e lo mostrò al vecchio: «Ecco qui: "Studio tecnico geometra Carlo Dacò — Via Faina 12 — telefoni 45273 e 45280". Due telefoni, una segretaria, due aiutanti e una clientela, anche se voi non lo sapete!» Cavò di tasca il libretto degli assegni: «Ecco, questi sono i soldi che ho in banca e li ho guadagnati io! E i muri dell'appartamento e dello studio sono miei! E ho l'Aurelia giù! Me ne infischio dei vostri quattrini! Teneteveli. Io vi faccio vedere che vendo Campolungo e poi i soldi li passo agli altri disgraziati dei vostri figli. Sì: quelli sono disgraziati. E voi lo sapete, tanto è vero che la pupilla dei vostri occhi, il famoso Campolungo, la avete lasciata a me! A me che, quando avevo dodici anni, vi ho puntato contro lo schioppo. L'avete avuta paura, eh, quella volta?» Carlino andò a guardar fuori dalla finestra e la luna batteva sull'aia deserta. «Sì, è inutile che facciate il bullo» disse volgendosi all'improvviso. «Quella volta avete avuto paura! Avete fatto passare una vita infernale a mia madre. L'avete terrorizzata al punto che non ha neanche avuto il coraggio di venire via con me. Vi farò vedere chi sono io! Tutto vendo! E non voglio neanche un centesimo dei vostri soldi maledetti! All'inferno Campolungo con tutto quello che c'è dentro!» Volse le spalle al vecchio e si trovò davanti l'armadione di noce. L'aperse e gli apparve la sua mantella azzurra e la sciabola luccicante. «Lo so» disse appressandosi al capezzale. «Lo so che lei ha voluto che lo aprissero per vedere fino all'ultimo la mia mantella e la mia sciabola. Lo so che è morta lì dove state voi adesso. Ma se credete di prendermi col sentimento, sbagliate. Mia madre è una cosa e voi siete un'altra. E Campolungo rappresenta voi, non rappresenta mia madre. Campolungo significa tutto quello che c'è di brutto nella mia vita e in quella di mia madre. Sia maledetta questa terra e sia maledetta questa casa!» Il vecchio giaceva immobile come un pezzo di ghiaccio e la fiamma delle candele era anche essa ferma, come gelata. Carlino andò a chiudere con violenza l'armadio. «Sì, poi l'ho sposata quella che voi avete insultata chiamandola pitturata come un burattone da fiera. E ne sono contentissimo! E anche se a voi non è mai importato niente, ho anche un figlio, bellissimo e intelligentissimo, che non è nato villano e non morirà villano neanche lui. E si farà una strada come me la sono fatta io! Non avrà mai un padre come l'ho avuto io. Un padre che mi ha sempre umiliato davanti a tutti. Un padre che mi ha sempre considerato un imbecille e che, non essendo riuscito a fare di me un cafone da vivo, tenta di riuscirci da morto...» Nella stanza vicina c'era lo studio del vecchio. Un camerino piccolo piccolo con un grosso stipo e una sedia. Abbassandolo, l'ampio sportello funzionava da scrittoio. Carlino aperse lo stipo e si sedette. Registri, cartelle con contratti, ricevute: tutto spaventosamente in ordine. Tutto spaventosamente chiaro. Soltanto un uomo che, al posto del cuore, ha un motore da sveglia e che non ha nel cervello la minima fantasia può essere così ordinato e preciso. Carlino respinse con disgusto registri e cartelle. Poi c'erano delle grandi buste gonfie di carte e legate con una funicella. Su ogni busta la specifica del contenuto: «Libri e quaderni delle scuole elementari del figlio Carlo, dal l'anno... all'anno...»; «Documenti delle scuole tecniche del figlio Carlo, dall'anno... all'anno...» Carlino sciolse la funicella e rovesciò il contenuto della busta sullo scrittoio: ogni cosa era ordinata e portava una annotazione con la data e il numero progressivo. Brutta copia della domanda di ammissione, ricevuta tassa di iscrizione, ricevuta abbonamento tranviario, ricevute tasse frequenza. Ogni anno costituiva un blocchetto a parte, e ogni blocchetto finiva con un foglietto scritto a matita contenente le votazioni finali ricopiate dagli albi della scuola. La stessa mano che aveva scritto materie e voti, aveva poi aggiunto in altro carattere: «Promosso alla classe superiore». L'ultimo blocco era il più voluminoso perché comprendeva anche una copia del famoso quadro ricordo dei laureandi o dei diplomandi che si vede esposto, sotto gli esami, in più d'una vetrina di città. Inoltre c'era una copia del giornale che portava l'elenco dei diplomati. E il nome di Carlo Dacò era sottolineato in rosso. La terza busta, quella che portava l'intestazione: «Servizio militare del figlio Carlo Sottotenente del Regio Esercito, Arma di Artiglieria, Specialità Pesante Campale», era la più magra perché conteneva soltanto un numero della Gazzetta Emiliana. La notizia sottolineata era: «Ieri il 4° Pesante Campale è partito per il campo». La quarta busta portava la specifica: «Attività pubblicistica del figlio Carlo». Dentro c'erano tre copie del Corriere del Po, e in ognuna era stato segnato in rosso un articoletto di mezza colonna circa. Era roba abbastanza recente: Carlino aveva avuto una breve polemica con qualcuno dal quale era stato tirato in ballo per via di certi progetti di case coloniche. Niente di straordinario. In uno degli articoletti di Carlino, era sottolineata in rosso la frase: «Ma la colpa delle agitazioni che oggi sconvolgono la vita nelle nostre campagne è prima di tutto degli agrari che costringono i loro sottoposti a vivere in case spesso miserabili». La stessa matita rossa aveva scritto in margine: «Asino!». L'ultima busta conteneva due piuttosto sbiadite riproduzioni fotografiche delle due fotografie che la vecchia Dacò un giorno aveva smarrito. E la intestazione della busta spiegava: «Fotografie del figlio Carlo, e del di lui figlio nato il... e battezzato col nome di Giacomo». Carlino balzò in piedi e passò nella stanza del vecchio. «Sì» gridò abbrancandosi alla cornice del letto. «Giacomo! Si chiama Giacomo Dacò anche se nelle partecipazioni ho fatto stampare Mino Dacò. Siete andato all'anagrafe, è vero? Per umiliarmi ancora! Ma, piantatevelo in mente, non sono stato io! È stata una trovata di quella cretina di mia moglie. È lei che a mia insaputa l'ha chiamato Giacomo. Serpente l'avrei chiamato io, piuttosto che dargli il vostro nome a mio figlio! Voi le avevate detto se prendeva lezioni private da una sgualdrina, quella volta, ma lei, per la bramosia dei quattrini, gli ha dato il vostro nome. Ma io vi farò crepare di rabbia tutt'e due, voi e lei: perché domani venderò Campolungo e regalerò via tutti i soldi! Soltanto una donna senza dignità, dopo aver ricevuto un'offesa simile, può compiere un gesto così venale». Carlino sudava e aveva la voce roca. Ansimava e continuava a camminare in su e in giù per la stanza, davanti al letto del vecchio. «Sono affari miei!» rantolò a un tratto. «L'ho sposata io e deve piacere a me, non a voi! E la vita che faccio me la sono scelta io e deve piacere a me... A Campolungo crepateci voi... Io domani vendo tutto, con tutto quello che c'è dentro... Tenetevi i vostri soldi e la vostra terra... Io non sono come quella poveretta di mia mamma... Ho l'Aurelia, giù: fra venti minuti posso essere in città... In città ho il mio lavoro, il mio avvenire, la mia famiglia... Qui non ho niente...» Il vecchio continuava a giacere immobile e il suo viso aveva un'espressione dura, quasi spietata. Carlino si fermò e si abbrancò ancora alla cornice del letto: «Non m'avete mai fatto paura da vivo, e non mi farete certo paura da morto!» ansimò. «Andate a comandare al cimitero! Qui comando io! Il padrone sono io! Venderò tutto! Me ne vado, già mi sono rovinato abbastanza il fegato con voi. Se non sapete la strada del cimitero, ve la insegneranno». Lasciò la stanza ed era l'alba. I vaccari lavoravano già. Carlino si tolse la giacca e, agguantato un forcale, entrò nella stalla. Poco dopo ne usciva spingendo una gran carriola piena di letame fresco e gocciolante. Passando davanti all'Aurelia ripensò a quando il vecchio aveva detto: «Il signor Carlo Dacò è lì che sta facendo scuola guida con la "Balilla"». "Te li faccio vedere io la canasta e il tè delle cinque" disse fra se ripensando alla ragazza dalle labbra pitturate come un mascherone di giostra. "Arriva qui a Campolungo e poi te ne accorgi!" Quando ebbe rovesciato il letame nel mucchio non tornò alla stalla: lasciò la carriola e continuò a camminare diritto, fino al fiume. Andò a sedersi su un sasso in riva all'acqua. E, ripensando al vecchio disteso sul letto nella grande stanza muta e deserta, per la prima volta nella sua vita sentì pietà per il padre, e questo gli mise nel cuore un'angoscia sottile e penetrante. E gli vennero alle labbra sommesse parole di preghiera: «Gesù, aiutatemi: fate che questa angoscia mai mi abbandoni e mi segua per tutta la vita. Fatemi soffrire come egli deve aver sofferto e nessuno mai lo seppe». Caddero le parole sull'acqua che le portò lontano: ma Dio ne aveva già preso nota. E Campolungo fu salvo, con tutto quello che c'era dentro: la mantella azzurra; le buste coi documenti del figlio Carlo e la vita perduta di un uomo che amò uno dei suoi figli fino al punto di dimenticare gli altri suoi figli, e fino al punto di odiare se stesso. Ci attenderà una festa di Alessandro Gnocchi Nient'altro che amore. Nient'altro che la nostalgia di un bene più grande travolge il cuore di Carlino. Accade tutto nelle ultime righe di un racconto che, per pagine e pagine, sembra rifiutare di incamminarsi verso la conclusione. L'ordigno letterario guareschiano, ancora una volta, esplode al momento giusto: quando la storia rischierebbe di diventare troppo lunga, se non decidesse di tornare sui suoi passi in cerca del suo vero significato. Se non fosse così, riuscirebbe difficile rileggere un racconto come Mai tardi. Se quel giovanotto, nelle ultime battute, non ricambiasse l'abbraccio del padre, sarebbe troppo ripugnante per meritare l'affetto del lettore. Se non chiedesse al Signore l'angoscia che Io renderà per sempre simile al vecchio steso sul letto, avrebbe gettato la sua vita fuori dalla pagina e dal mondo. Invece, sorpreso dall'amore, Carlino redime la sua storia e compie un piccolo miracolo. Costringe anche il passeggero più distratto a riprendere il racconto cominciando dal fondo. Forza il lettore a riconsiderare i suoi sentimenti e le sue decisioni alla luce dell'amore che gli ha stravolto il cuore. Come accade nella parabola del figlio prodigo. Riesce difficile pensare a questo brano del Vangelo senza contemplare l'amore sterminato del padre che ne è il compimento. Addirittura, sembra meno grave la colpa di quel giovane, vedendola sciogliersi dentro l'abbraccio del padre. Ma questa non è solo sapienza letteraria. E neppure è solo capacità di dare forma ai grandi temi evangelici. Guareschi ha messo molto del suo nella storia di Carlino. Si è rivelato più di quanto abbia fatto altre volte. Perché Carlino è lui. Giacomo Dacò è suo padre, Primo Augusto. L'incomprensione dell'erede di Campo lungo è la stessa che lui provò per il padre fino alla sua morte. Fino a quando scoprì le tracce della pazienza con cui Primo Augusto aveva seguito la sua vita. Documenti scolastici, quaderni, ricevute, diari, ritagli di giornale: come Carlino. All'improvviso quel padre lontano riuscì a fare il nido nel cuore dello scrittore. Per amare, non è mai tardi. Una prova umana e letteraria non facile. Certamente incomprensibile per gran parte della cultura moderna, ossessionata dal complesso antipaterno partorito dalla congregazione dei lumi, allevato da Freud e suicidato dalla debolezza del pensiero contemporaneo. Se avesse voluto fare l'intellettuale, Guareschi se la sarebbe cavata a buon mercato invocando gli esempi di Cartesio o di Rousseau, le follie di certi personaggi di Dostoevskij o di Kafka. Invece, preferì, semplicemente, leggere il Vangelo. E se si vuole trovare un parente letterario a questa storia viene da pensare all'Ulisse di Joyce, la storia lunghissima di un figlio che cerca un padre e di un padre che cerca un figlio. Dopo la morte del suo vecchio genitore, lo scrittore irlandese confessò: «Lo humor di "Ulisse" è suo, la gente di "Ulisse" sono i suoi amici. Il libro è il suo ritratto sputato». Ed è come se Guareschi parlasse di Mondo piccolo. A tutto questo fanno eco alcuni critici americani sostenendo che le grandi opere della letteratura, alla fine, sono soltanto la riscrittura della parabola del figlio prodigo. In ogni caso, lo è l'opera guareschiana e Mai tardi lo illustra in maniera didascalica. Sono troppe e troppo evidenti le sovrapposizioni di questo racconto con il brano evangelico. E se alcune vanno privilegiate, si trovano tutte nel finale, dove il rincorrersi dei sentimenti e delle esigenze dello spirito partoriscono un altro uomo. Come il figlio prodigo, Carlino, al culmine della crisi, si rende conto di aver perso tutto. Non le ricchezze materiali, ma qualcosa che può servire ancora di più. I suoi ricordi, la sua infanzia, la sua anima bambina. Lo capisce quando scova i documenti custoditi da Giacomo. E il vecchio è lì, steso sul letto. Ma, forse, è ancora più lontano del padre della parabola. C'è un universo tra lui e Carlino. Però, al colmo di questa separazione, il protagonista di Mai tardi incontra un dolore troppo forte: inspiegabile e insopportabile. Non c'è teoria, non c'è aspirazione, non c'è istinto che lo giustifichi. È il momento di cambiare rotta e fare ritorno a casa. Sembra scritto per lui uno dei passi fondamentali della parabola: Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Rientrato in sé, il figlio prodigo ricomincia a contemplare la sua casa alla presenza dell'immagine di suo padre. Come Carlino, che riprende a contemplare la sua infanzia e i suoi ricordi alla presenza di un vecchio morto col quale pensa di non poter più parlare. Ma la nostalgia per la propria casa e la propria storia è solo l'imbocco di un sentiero tortuoso, il cui approdo non è affatto scontato. Carlino non ha ancora compreso il mistero dell'amore, della gratuità del bene. Decide di tornare al cospetto del padre per mendicare ciò che gli spetta, la sua infanzia e i suoi ricordi. Come il figlio prodigo, è disposto a farsi servo pur di averlo: Lasciò la stanza ed era l'alba. I vaccari lavoravano già. Carlino si tolse la giacca e, agguantato il forcale, entrò nella stalla. Poco dopo ne usciva spingendo una gran carriola piena di letame fresco e gocciolante. Un signorino di città che spinge una carriola carica di letame: potrebbe sembrare l'immagine più alta del pentimento, dell'umiliazione, della conversione. E, invece, quel giovanotto sta lottando contro l'ultima tentazione. Quella di essersi scoperto in peccato e infliggersi da solo la punizione. Quella di ergere, ancora una volta, se stesso a giudice della propria esistenza. Di sentirsi, ancora una volta, padrone della propria vita e del mondo. È la tentazione di una religiosità atea, fatta di morale, quando non di moralismo, ma priva di Dio: il dramma dell'uomo moderno. In questa fase, dice padre Rupnik, in una bellissima meditazione sulla parabola del figlio prodigo, si proiettano sullo schermo della propria ragione proclami grandi e santi, ma è lo stesso "Io" autoaffermativo a gestire tutto. Carlino, da solo, non riesce a trovare la strada giusta, così come non vi era riuscito il figlio prodigo. Tocca ai padri portare a compimento queste due storie. Quando era ancora lontano [racconta il Vangelo] il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Proprio come aveva fatto, di nascosto, per tutta la vita il vecchio Giacomo. Come aveva fatto, per tutta la vita, Primo Augusto, pur con tutte le titubanze che può covare il cuore di un uomo. L'ostinazione di affermare se stessi viene vinta dall'amore. Un bene gratuito e immeritato che costringe ad alzare lo sguardo e trovarsi al cospetto dell'altro: del proprio padre e di Dio. Sconvolti dall'amore, questi due giovani rientrano, finalmente, in se stessi e mutano per sempre la loro vita. Imparano ad affermarsi sacrificandosi, a realizzare se stessi rinunciando. Imparano ad amare. Sentono nella propria carne e nella propria anima ciò che nessun pensiero solo umano è mai riuscito a concepire: l'Assoluto nel frammento, il Santo fra i peccatori, la Vita nella morte. Solo allora, Carlino abbandona la carriola che faceva da trono al suo Io fatto di letame gocciolante. E parla col Signore e gli chiede di diventare come suo padre. Solo qui, a poche righe dalla conclusione, Carlino si converte e capisce di doversi lasciare amare senza meritare di essere amato, di lasciarsi salvare senza averne alcun diritto. Senza avere un solo punto di sostegno in se stesso. Anzi, trovando nel suo cuore un abisso che può essere riempito solo dalla sofferenza e dall'angoscia: Gesù, aiutatemi: fate che questa angoscia mai mi abbandoni e mi segua per tutta la vita. Fatemi soffrire come egli deve aver sofferto e nessuno mai lo seppe. L'amore nella sofferenza: un altro mistero che l'uomo non potrà mai spiegare senza il Padre rivelato da Cristo. L'unico Padre che sa veramente dare alle sue creature ciò di cui hanno bisogno. Scrive in proposito don Alessandro Pronzato: Adesso finalmente sappiamo cosa ci aspetta quando torniamo a Lui, pentiti delle tante sciocchezze che abbiamo commesso. Ci aspetta una festa. È quella che racconta Guareschi dopo la conversione di Carlino: Caddero le parole sull'acqua che le portò lontano: ma Dio aveva già preso nota. E Campolungo fu salvo, con tutto quello che c'era dentro: la mantella azzurra; le buste dei documenti del figlio Carlo e la vita perduta di un uomo che amò uno dei suoi figli fino al punto di dimenticare gli altri suoi figli, e fino al punto di odiare se stesso. Nella relazione con il suo Creatore, il mondo diventa una festa per gli uomini e per le cose, che vengono trasfigurati e vivono la loro bellezza e la loro bontà: la loro verità. Una festa promessa fin dal principio dei tempi e a cui le creature sono sempre invitate, come in un racconto che non si deve mai cessare di scrivere, di vivere e di tramandare nel nome del Padre. «La tradizione è una bellezza che conserviamo», dice in un passo fulminante Ezra Pound, che si era innamorato del «Don Camillo» e avrebbe voluto tradurlo negli Stati Uniti. Non è «mai tardi» per contemplarla, gli fa eco Guareschi. Giovannino Guareschi GIALLO E ROSA riletto da Alessandro Gnocchi DAL VANGELO DI LUCA (2, 25-32) Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo, che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Giallo e rosa La finestra attraverso la quale avevano sparato dava sul campicello di proprietà della chiesa e il maresciallo e don Camillo stavano dietro la cappelletta studiando la faccenda. «Ecco qui la prova» disse il maresciallo indicando quattro buchi che spiccavano sull'intonaco chiaro, a un paio di spanne sotto il davanzale della finestrella famosa. Tolse di tasca un coltellino, frugò in uno dei buchi e alla fine venne fuori qualcosa. «Secondo me la faccenda è semplice» spiegò il maresciallo. «Il tipo era appostato lontano e ha sparato una raffica di mitra contro la finestra illuminata. Quattro palle sono finite qui nel muro, una ha bucato il vetro ed è entrata». Don Camillo scosse il capo. «Vi ho detto che era un colpo di pistola e sparato da qui. Non sono ancora tanto rimbambito da non saper distinguere un colpo di pistola da una raffica di mitra! Prima è stato sparato un colpo di pistola e da qui, dopo è stata sparata una raffica di mitra da più lontano». «Si dovrebbe trovare il bossolo qui vicino, allora! » ribatté il maresciallo. «E il bossolo non c'è». Don Camillo scosse le spalle. «Ci vorrebbe il critico musicale della Scala per saper distinguere dalla tonalità se un colpo viene sparato con una pistola a ripetizione o con un revolver a tamburo! Se quello ha sparato con un revolver a tamburo, il bossolo se l'è portato via». Il maresciallo cominciò a braccare tutt'attorno e alla fine trovò qualcosa sul tronco d'uno dei ciliegi piantati a cinque o sei metri di fianco alla chiesa. «Una delle pallottole ha tagliato la corteccia» disse. E la cosa era evidente. Si grattò la zucca perplesso. «Bah» borbottò alla fine «facciamo pure il poliziotto scientifico!» Prese un palo e lo piantò per terra, rasente al muro, davanti a uno dei buchi nell'intonaco; poi prese a camminare per il campo e, ogni tanto, si voltava e, stringendo un occhio, mirava il tronco del ciliegio colpito dalla palla e si spostava a destra o a sinistra fino a quando il tronco non copriva il palo piantato sotto il muro. Così, a un bel momento, si trovò davanti alla siepe e, al di là della siepe, c'erano il fosso e una carrareccia. Don Camillo lo raggiunse e uno da una parte e uno dall'altra della siepe cominciarono a braccare per terra. Dovettero cercare ben poco perché don Camillo, dopo cinque minuti, disse: «Ecco qui» e si trattava di un bossolo di mitra. Poi trovarono gli altri tre. «Questo prova quanto dico io» esclamò il maresciallo. «Il tipo ha sparato da qui contro la finestra». Don Camillo scosse la testa. «Io non me ne intendo di mitra» disse don Camillo «ma so che negli altri fucili le pallottole non fanno le curve. Guardate un po' voi». Sopraggiunse un carabiniere il quale avvertì il maresciallo che in paese tutti erano calmi. «Grazie tanto!» osservò don Camillo. «Mica hanno sparato contro di loro. Hanno sparato a me!» Il maresciallo si fece dare il moschetto dal carabiniere e, coricatosi per terra, lo puntò contro il primo vetro della finestra della cappella, dove press'a poco ricordava che c'era il buco della pallottola. «Se sparaste, dove andrebbe a finire?» domandò don Camillo. Era un calcolo da ragazzini; partendo da lì e dovendo passare attraverso la finestrina della cappella, una pallottola sarebbe al massimo arrivata a sbattere la testa contro il primo confessionale a destra, a tre metri dalla porta della chiesa. «A meno che non fosse una pallottola ammaestrata, quella non poteva passare per l'altare neanche se si scannava! » concluse il maresciallo. «11 che significa, don Camillo, che quando in una faccenda ci siete immischiato voi son pasticci da strapparsi i capelli! Non vi bastava che fosse uno solo a spararvi? Nossignore: ne vuole due. Uno che gli spara da dietro la finestra e uno che gli spara da dietro una siepe lontana centocinquanta metri». «Be', io sono fatto così» rispose don Camillo. «Non bado a spese! » * La sera Peppone radunò alla sede tutto lo stato maggiore e i fiduciari delle frazioni del Comune. Peppone era cupo. «Compagni» disse «un nuovo fatto è venuto a complicare la situazione locale. Un ignoto ha sparato questa notte contro il cosiddetto parroco e la reazione approfitta di questo episodio per rialzare il capo e gettare nuovo fango sul Partito. La reazione, vile come sempre, non ha il coraggio di parlare chiaro, ma, come abbiamo saputo, mormora negli angolini e ci accusa della responsabilità di questo attentato!» Il Lungo alzò una mano e Peppone gli fece cenno che poteva parlare. «Prima di tutto» disse il Lungo «si potrebbe dire alla signora reazione la quale cominci a dimostrarci che c'è stato l'attentato contro il prete. Perché, fino a questo momento, è soltanto lui a dirlo. E siccome non c'erano testimoni, può benissimo essere stato il signor reverendo in persona a sparare la revolverata per poter scrivere sul suo sporco giornale delle infamità contro di noi! Cominciamo col tirar fuori le prove!» «Bene!» approvò il consesso. «Il Lungo ha ragione!» Peppone riprese la parola. «Un momento! Quello che dice il Lungo è giusto, ma non dobbiamo escludere la possibilità che il fatto sia vero. Conoscendo anche il carattere di don Camillo, non si può dire, onestamente, che sia uno che usi dei sistemi ambigui...» «Compagno Peppone» interruppe Spocchia, il capocellula di Molinetto. «Ricordati che chi è prete è sempre prete! Tu ti lasci fregare dai sentimentalismi! Se tu avessi dato retta a me, il suo sporco giornale non sarebbe uscito e oggi il Partito non avrebbe avuto il danno delle infami insinuazioni a proposito del suicidio del Pizzi! Nessuna pietà contro i nemici del popolo! Chi ha pietà dei nemici del popolo tradisce il popolo!» Peppone picchiò un pugno sul tavolo. «Non ho nessun bisogno che tu mi dia delle lezioni di morale!» urlò. Lo Spocchia non si impressionò. «Intanto, se invece di opporti ci avessi lasciato fare quando si poteva fare» gridò «adesso non avremmo ancora tra i piedi un sacco di mascalzoni reazionari! Io...» Lo Spocchia era un giovane sui venticinque anni, magro, con gran capelli all'indietro, ondulati in cima alla testa e tirati a lucido dalle parti e che finivano in una specie di cresta di dietro, come usano i cafoni del Nord e i bulli di Trastevere. Aveva gli occhi piccoli e le labbra sottili. Peppone gli si avvicinò aggressivo. «Tu sei un cretino!» gli disse guardandolo in faccia. L'altro impallidì, ma stette zitto. Ritornato al tavolo, Peppone riprese a parlare. «Approfittando di un episodio che si basa sulla semplice affermazione di un prete» continuò «la reazione tenta nuove speculazioni ai danni del popolo. Bisogna che i compagni siano, oggi, decisi come non mai. Alle ignobili insinuazioni...» A un tratto gli accadde una strana cosa che non gli era capitata mai. Peppone si ascoltò. Gli pareva che lui, Peppone, fosse laggiù in fondo e ascoltasse quello che Peppone stava dicendo. («... la carne venduta, la reazione assoldata daí nemici del proletariato, gli agrari affamatori...») Peppone si ascoltava e via via gli pareva di ascoltare un altro. («... la cricca sabauda... Il clero falso... Il governo nero... L'America... La plutocrazia...») "Cosa vuol dire plutocrazia? Perché quello là parla di plutocrazia se non sa neanche cosa vuol dire?" pensava Peppone. Si guardò attorno e vide facce che quasi non riconosceva. Occhi ambigui, e i più ambigui erano quelli del giovane Spocchia. Pensò al Brusco, il fedelissimo, e cercò i suoi occhi, ma il Brusco era là in fondo a braccia conserte e con la testa bassa. («... ma sappiano i nostri nemici che lo spirito della Resistenza non è indebolito in noi. Le armi che un giorno impugnammo per difendere la libertà...») Ora Peppone si sentì che egli stava urlando come impazzito. Poi l'applauso lo fece rientrare in se stesso. «Così va bene» gli sussurrò lo Spocchia mentre stavano uscendo. «Tu lo sai, Peppone: basta un fischio e si comincia. I miei ragazzi sono pronti. Anche fra un'ora». «Bravo, bravo! » rispose Peppone battendogli la mano sulla spalla. Ma gli avrebbe volentieri stritolata la zucca. Chi sa poi perché. Rimasero soli lui e il Brusco e stettero zitti un bel po'. «Ebbene!» gridò a un bel momento Peppone. «Sei diventato scemo? Non mi dici neanche se ho parlato bene o no?» «Hai parlato benissimo» rispose il Brusco. «Benissimo. Meglio di tutte le altre volte». Poi fra i due ripiombò la cortina del silenzio. Peppone faceva dei conti su un registro: a un tratto afferrò un fermacarte di cristallo, lo scagliò con violenza per terra e urlò con rabbia una bestemmia lunga, complicata, esasperata. Il Brusco lo guardò. «Una macchia d'inchiostro!» spiegò Peppone chiudendo il registro. «Le solite penne di quel ladro del Barchini» osservò il Brusco guardandosi bene dal far notare a Peppone che, siccome Peppone stava scrivendo col lapis, la faccenda della macchia d'inchiostro non quadrava. Quando furono fuori, nella notte, e si trovarono al crocicchio, Peppone stette lì come se volesse dire qualcosa al Brusco. Poi tagliò corto: «Allora ci vediamo domani». «Domani, capo. Buona notte». «Ciao, Brusco». * Si era oramai sotto Natale e bisognava tirar fuori d'urgenza dalla cassetta le statuette del Presepe, ripulirle, ritoccarle col colore, riparare le ammaccature. Ed era già tardi, ma don Camillo stava ancora lavorando in canonica. Sentì bussare alla finestra e, poco dopo, andò ad aprire perché si trattava di Peppone. Peppone si sedette mentre don Camillo riprendeva le sue faccende e tutt'e due tacquero per un bel po'. «Vecchio Dio!» esclamò a un tratto Peppone con rabbia. «Non avevi altro posto che venire in canonica per bestemmiare?» si informò calmo don Camillo. «Non potevi bestemmiare mentre eri alla sede?» «Non si può più neanche bestemmiare, in sede!» borbottò Peppone. «Perché, anche se uno bestemmia, deve dare delle spiegazioni». Don Camillo prese a ritoccare con la biacca la barba di San Giuseppe. «In questo porco mondo un galantuomo non può più vivere! » esclamò Peppone dopo un po'. «E cosa ti interessa?» domandò don Camillo. «Sei forse diventato un galantuomo?» «Lo sono sempre stato». «Oh bella! Non l'avrei mai immaginato». Don Camillo cominciò a ritoccare la barba di San Giuseppe. Poi passò a ritoccargli la veste. «Ne avete ancora per molto tempo?» si informò Peppone con ira. «Se mi dai una mano in poco si finisce» Peppone era meccanico e aveva mani grandi come badili e dita enormi che facevano fatica a piegarsi. Però, quando uno aveva un cronometro da accomodare, bisognava che andasse da Peppone. Perché, è così, sono proprio gli uomini grossi che son fatti per le cose piccolissime. Filettava la carrozzeria delle macchine e i raggi delle ruote dei barrocci come uno del mestiere. «Figuratevi! Adesso mi metto a pitturare i santi!» borbottò. «Non mi avrete mica preso per il sagrestano!» Don Camillo pescò in fondo alla cassetta e tirò su un affari-no rosa, grosso quanto un passerotto, ed era proprio il Bambinello. Peppone si trovò in mano la statuetta senza sapere come e allora prese un pennellino e cominciò a lavorare di fino. Lui di qua e don Camillo di là dalla tavola, senza potersi vedere in faccia perché c'era, fra loro, il barbaglio della lucerna. «È un mondo porco» disse Peppone. «Non ci si può fidare di nessuno, se uno vuol dire qualcosa. Non mi fido neppure di me stesso». Don Camillo era assorbitissimo dal suo lavoro: c'era da rifare tutto il viso della Madonna. Roba fine. «E di me ti fidi?», chiese don Camillo con indifferenza. «Non lo so». «Prova a dirmi qualcosa, così vedi». Peppone finì gli occhi del Bambinello: la cosa più difficile Poi rinfrescò il rosso delle piccole labbra. «Vorrei piantare lì tutto» disse Peppone. «Ma non si può». «Chi te lo impedisce?» «Impedirmelo? Io piglio una stanga di ferro e faccio fuori un reggimento». «Hai paura?» «Mai avuto paura al mondo!» «Io sì, Peppone. Qualche volta ho paura». Peppone intinse il pennello. «Be', qualche volta anch'io» disse Peppone. E appena si sentì. Don Camillo sospirò anche lui. «La pallottola mi è passata a quattro dita dalla fronte» raccontò don Camillo. «Se non avessi tirato indietro la testa proprio in quel momento, ci rimanevo secco. È stato un miracolo». Ora Peppone aveva finito il viso del bambinello e stava ripassando il rosa del corpo. «Mi dispiace di averlo sbagliato» borbottò Peppone. «Ma ero troppo lontano e c'erano di mezzo i ciliegi». Don Camillo fermò il pennello. «Me l'aspettavo» spiegò Peppone. «Da tre notti avevo mandato il Brusco a girare attorno alla casa del Pizzi per via che l'altro non facesse fuori il ragazzo. Il ragazzo deve aver visto chi ha sparato dalla finestra contro suo padre e l'altro lo sa. Io intanto giravo attorno a casa vostra. Perché ero sicuro che l'altro sapeva che anche voi sapete chi ha sparato sul. Pizzi». «L'altro chi?» «Non lo so» rispose Peppone. «Io l'ho visto di lontano avvicinarsi alla finestra della cappelletta. Ma non potevo sparargli prima che facesse qualcosa. Appena ha sparato ho sparato anch'io. L'ho sbagliato». «Sia ringraziato Dio» sospirò don Camillo. «So come spari e allora posso dire che sono stati due i miracoli». «Chi sarà? Lo sapete soltanto voi e il ragazzo chi è». Don Camillo parlò lentamente. «Sì, Peppone, lo so, ma nessuna cosa al mondo può farmi violare il segreto della confessione». Peppone sospirò e continuò a pitturare. «C'è qualcosa che non va» sospirò a un tratto. «Mi pare che tutti mi guardino con altri occhi, adesso. Tutti, anche il Brusco». «Anche al Brusco sembrerà così, e anche agli altri. A tutti gli altri. Ognuno ha paura dell'altro e ognuno, quando parla, è come se sentisse di doversi sempre difendere». «Perché questo?» «Non facciamo della politica, Peppone». Peppone sospirò ancora. «Mi sento come in galera» disse cupo. «C'è sempre una porta per scappare da ogni galera di questa terra» rispose don Camillo. «Le galere sono soltanto per il corpo. E il corpo conta poco». Oramai il Bambinello era finito e, fresco di colore e così rosa e chiaro, pareva che brillasse in mezzo alla enorme mano scura di Peppone. Peppone lo guardò e gli parve di sentir sulla palma il tepore di quel piccolo corpo. E dimenticò la galera. Depose con delicatezza il Bambinello rosa sulla tavola e don Camillo gli mise vicino la Madonna. «Il mio bambino sta imparando la poesia di Natale» annunciò con fierezza Peppone. «Sento che tutte le sere sua madre gliela ripassa prima che si addormenti. È un fenomeno». «Lo so» ammise don Camillo. «Anche la poesia per il Vescovo l'aveva imparata a meraviglia». Peppone si irrigidì. «Quella è stata una delle vostre più grosse mascalzonate!» esclamò. «Quella me la dovete pagare». «A pagare e a morire si fa sempre a tempo» ribatté don Camillo. Poi, vicino alla Madonna curva sul Bambinello, pose la statuetta del somarello. «Questo è il figlio di Peppone, questa la moglie di Peppone e questo è Peppone» disse don Camillo toccando per ultimo il somarello. «E questo è don Camillo!» esclamò Peppone prendendo la statuetta del bue e ponendola vicino al gruppo. «Bah! Fra bestie ci si comprende sempre» concluse don Camillo. Uscendo, Peppone si ritrovò nella cupa notte padana, ma oramai era tranquillissimo perché sentiva ancora nel cavo della mano il tepore del Bambinello rosa. Poi udì risuonarsi all'orecchio le parole della poesia che ormai sapeva a memoria. «Quando, la sera della Vigilia, me la dirà, sarà una cosa magnifica!» si rallegrò. «Anche quando comanderà la democrazia proletaria le poesie bisognerà lasciarle stare. Anzi, renderle obbligatorie! » Il fiume scorreva placido e lento, lì a due passi, sotto l'argine, ed era anche lui una poesia cominciata quando era cominciato il mondo e che ancora continuava. E per arrotondare e levigare il più piccolo dei miliardi di sassi in fondo all'acqua, c'eran voluti mille anni. E soltanto fra venti generazioni l'acqua avrà levigato un nuovo sassetto. E fra mille anni la gente correrà a seimila chilometri l'ora su macchine a razzo superatomico e per far cosa? Per arrivare in fondo all'anno e rimanere a bocca aperta davanti allo stesso Bambinello di gesso che, una di queste sere, il compagno Peppone ha ripitturato col pennellino. Credo, dunque rido di Alessandro Gnocchi Un uomo giusto ritagliato nella stoffa malgarbata della Bassa. Un povero di Dio che cerca le storie del Cielo tra quelle portate a valle dal grande fiume. Un Simeone padano sorpreso dalla gioia. E forse non bastano queste giravolte per restituire tutti i suoi colori al Peppone disegnato in questo racconto. Come in tanti altri racconti, anche qui, Guareschi ha limato e rimpicciolito il mondo fino a comprimerlo in un puntino: la trappola letteraria per catturare l'universo e popolarlo con le sue creature e il loro bisogno dell'eterno. Ritrovato questo amore aurorale per la vita, Peppone varca la soglia della canonica, si affaccia sulla cupa notte padana e si trova davanti un mondo nuovo. Redento dalla paura che lo soffocava dopo l'assassinio del Pizzi. Il tepore con cui il Bambinello rosa si è scavato un posto sulla sua mano porta una luce nuova nella vita del grosso sindaco e della sua gente. Il peccato commesso da un assassino sconosciuto tiene facilmente sotto il suo giogo un paese intero, riesce a rallentare la vita e farne una caricatura deturpata dalla colpa: fino a quando il Bambinello viene alla luce e si fa cullare dalla mano di Peppone. A prima vista, un fabbro della Bassa somiglia poco a un vecchio sacerdote ebreo vissuto quasi duemila anni prima. Ma basta grattare solo un po' la crosta del racconto guareschiano per trovare analogie che ne mostrano l'amicizia spirituale. Come Simeone, anche Peppone, mosso da una forza più grande di lui, va al tempio. Come Simeone, tiene il Bambinello fra le mani, e conta poco che il suo sia di gesso. Come Simeone, lascia esplodere la sua gioia in un cantico, la poesia di Natale del figlio che sente risuonare nell'anima: «Quando, la sera della Vigilia, me la dirà, sarà una cosa magnifica!» si rallegrò. «Anche quando comanderà la democrazia proletaria le poesie bisognerà lasciarle stare. Anzi, renderle obbligatorie!» Nel suo racconto, san Luca non si attarda e descrivere l'emozione di un vecchio che sa di tenere in braccio il suo Dio fatto uomo. E lo scrittore emiliano parla solo del tepore depositato sulla mano di un Peppone che dimentica la galera. Eppure, ogni lettore vorrebbe provare, o almeno conoscere, una scheggia della loro gioia. Guareschi preferisce indicare quale sia la condizione essenziale per vivere quella gioia. Preferisce dire che ci arriva solo chi, come il vecchio Simeone, dentro il cuore ha la capacità di stupirsi. Basta scorrere poche righe e arrivare al termine del racconto: E fra mille anni la gente correrà a seimila chilometri l'ora su macchine a razzo superatomico e per far cosa? Per arrivare in fondo all'anno e rimanere a bocca aperta davanti allo stesso Bambinello di gesso che, una di queste sere, il compagno Peppone ha ripitturato col pennellino. Il cuore della fede cristiana non è fatto di ragionamenti straordinari, di formule sotto radice quadrata, e neppure di ponderose costruzioni teologiche o di dotti commenti alle Scritture. Non è un'invenzione filosofica. È l'incontro con Qualcuno davanti al quale non ci si vergogna di rimanere a bocca aperta. È la scoperta di un uomo, non l'infatuazione per un'idea. Per questo, Gregorio di Nissa insegna che i concetti creano gli idoli e solo lo stupore conosce. E Guareschi non si stanca mai di dire che la cultura, lasciata a se stessa, costringe gli uomini a vivere in maniera artificiale amareggiando, oltre la vita, anche la morte. L'atmosfera in cui affoga il paese di Peppone in Giallo e rosa è frutto della cultura degli idoli. La gente applica la propria ragione alla soluzione di un giallo. Tutti si chiedono chi ha osato uccidere. Ognuno sospetta il suo vicino. Persino fra Peppone e il Brusco si è eretto un muro. Tutti, presi dalla ricerca dell'assassino, scordano la pietà. Nessuno si occupa più del morto. La ragione, fecondata da se stessa, ha partorito l'idolo: la galera, come dice Peppone. Solo don Camillo sfugge a questo gioco perverso. Lui sa già chi è il colpevole, non ha bisogno di ragionare a vuoto. Lo ha appreso in un frangente che la ragione, da sola, non riuscirà mai a capire: la confessione. Conosce l'assassino, ma sa anche che non conta nulla. Conta solo che, di lì a pochi giorni, Gesù Bambino tornerà a nascere nel mondo. Chi saprà stupirsi di quel miracolo si sveglierà da un brutto sogno. Si rimetterà, ancora una volta, nella luce giusta per trovare il senso della vita. Come gli apostoli, saprà rispondere, senza tanti discorsi, al Dio fatto uomo che ritiene sufficiente dire soltanto: «Seguimi». Poche parole tra vecchi amici. Il dialogo fra Peppone e don Camillo è di una dolcezza raramente raggiungibile. Eppure è asciutto, non ha una frase di troppo, un concetto di troppo. Persino le emozioni sono misurate. Comincia quando deve cominciare e finisce quando deve finire. Ma è sempre sostenuto dalla presenza di una gioia e una serenità che, senza sforzo, riportano in superficie il lato solare della vita. Quello su cui neppure la cupa notte padana può avere la meglio. In queste pagine si scopre l'origine cristiana dell'umorismo guareschiano. Anzi, si fanno evidenti le ragioni di chi rinviene nell'umorismo le tracce di un incontro col Vangelo. Nelle sue storie, Dio non disdegna di sovvertire i piani dell'uomo. Ama spesso andargli incontro in maniera inaspettata, secondo logiche solo sue, come nell'incarnazione. Dal punto di vista narrativo, questa dinamica del ribaltamento si traduce in umorismo. Nella capacità di sorridere della condizione umana tentando di aderire alla logica di Dio. Non è un esercizio semplice. Richiede umiltà, merce rara tra gli uomini. Per questo, coloro che sanno veramente ridere, nelle Scritture, sono i poveri del Signore. E Simeone è una di queste figure. Nella prospettiva guareschiana, la sua breve apparizione nel Vangelo può essere letta anche come un quadretto umoristico. Dopo aver atteso per anni il Messia, questo vecchio ebreo se lo trova tra le braccia, piccolo e indifeso. Il contrario di come lo immaginava il suo popolo. Ma quello è il suo Dio e, in quel momento, potrebbe brandirlo come uno scettro e cedere alla tentazione di sentirsi l'uomo più potente della terra. Potrebbe decidere di chiedere qualunque cosa al suo Signore e ridurlo alla logica degli uomini. Invece, intuisce di non avere più bisogno di nulla. La tentazione dell'onnipotenza cede alla libertà di chi chiede che la sua vita corra senza inciampo verso la sua fine, verso la sua fonte: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Non può esservi ribaltamento di prospettiva più radicale e umoristico di questo. Allo stesso modo, Peppone, potrebbe usare il Bambinello di gesso per acquisire un sapere potente. Potrebbe farne uno strumento magico per scoprire l'assassino, restaurare l'ordine infranto e ripristinare il potere perduto. E invece, varcata la soglia della canonica, entra nella notte padana e riesce solo a ripetere la poesia di Natale di suo figlio. Non ha più dubbi. Sarà la poesia, sarà l'incontro stupito con Cristo bambino, a restaurare il vero ordine: che non è mai umano. Non si può immaginare nulla di più lontano dal dramma senza redenzione di cui è intriso un passaggio del Caino di George Byron. In un dialogo col demonio, il fratricida chiede: «Dimmi, sei felice?». «No» risponde il demonio «però sono potente». Caino è prigioniero di un idolo che seduce molti uomini. E Guareschi sa che la sola via per vincerlo è la croce. Bisogna salirvi e, da lassù, contemplare gli eventi umani per quel poco che valgono. Poi ridere contagiati dall'allegria di Dio. Scossi dalla gioia di chi sa di essere figlio di Dio. Di chi sa, come Simeone, che solo Dio poteva sorprendere il mondo con lo scherzo più grande: farsi figlio dell'uomo. Giovannino Guareschi LO SCHERZO riletto da Alessandro Gnocchi DAL VANGELO DI MATTEO (5, 3) Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Lo scherzo Peppone, quando vide che quelli dello stato maggiore c'erano tutti, fece chiudere col catenaccio la porta e tirò fuori di sotto la scrivania una valigetta rossa. Lo Smilzo, il Brusco, il Bigio, il Lungo e compagnia bella guardarono perplessi l'arnese ma, come Peppone ebbe sollevato il coperchio, lo Smilzo esclamò: «Un radiogrammofono portatile!» «Già» rispose Peppone innestando una spina in una presa di corrente e poi armeggiando attorno alle manopole del congegno. «Ma il disco dove si mette?» s'informò il Bigio. «La novità consiste che il radiogrammofono non è a disco» spiegò Peppone. «Invece del disco c'è un filo d'acciaio con incisa la musica». «Non sanno più cosa inventare!» borbottò il Brusco. «Be', facci sentire qualcosa!» disse il Lungo. «Subito» rispose Peppone continuando ad armeggiare attorno alle manopole. Si udì un fruscio, poi dalla cassettina incominciò a uscire la voce del Bigio, poi quella di Peppone e via discorrendo. Insomma, tutta la conversazione di poco prima. «Non è straordinario?» domandò Peppone trionfante. Si trattava di un comune magnetofono a filo, ma, laggiù alla Bassa, quelle porcherie elettriche non erano ancora conosciute. Peppone spiegò che, una volta registrata la voce sul filo, la si poteva mantenere incisa per riudirla quando si voleva. Oppure si poteva cancellare l'incisione e servirsi del filo per nuove registrazioni. Tutti provarono a parlar dentro il piccolo microfono per poi riascoltare la propria voce: alla fine domandarono a cosa potesse servire praticamente quel gingillo. «A registrare i discorsi degli avversari per avere il documento di quel che hanno detto, a registrare i nostri discorsi per poi farne l'autocritica e correggere i difetti della voce. Oppure per registrare una trasmissione alla radio». Peppone accese l'apparecchio radio, lo lasciò funzionare dieci minuti, riavvolse il filo rapidamente girando la manopola della marcia indietro e, pochi istanti dopo, il magnetofono ripeteva esattamente quello che aveva ascoltato dalla radio. E tutto alla perfezione, parole e musiche. Discussero a lungo sulle possibilità dell'apparecchio e, a un tratto, lo Smilzo ebbe un'idea: «Ho in mente uno scherzo straordinario! Si registra sul filo un bel pezzo di trasmissione normale della radio poi, quando arriva il segnale dell'uccellino, si spegne la radio e si dice dentro il microfono una notizia inventata da noi. Poi, invece della radio, si innesta nell'altoparlante dello spaccio il magnetofono e nessuno si accorge del trucco e, quando arriva la notizia, tutti la bevono perché, subito dopo la notizia, si incide un altro pezzo di trasmissione». Quelli della banda si misero a sghignazzare divertiti e Peppone esclamò: «Ciro degli Oppi! » Non ci fu bisogno di dire altro. Tutti avevano già capito! * Ciro degli Oppi, uno della banda di Peppone, era un rabbioso del totocalcio. Non c'era sabato che Ciro non compilasse una schedina e questo non significa niente perché c'è gente che, di schede, ne spara dieci o venti tutte le settimane. Ciro era un rabbioso del totocalcio perché, ogni sabato, appena consegnata la sua scheda, incominciava immediatamente a pensare che cosa avrebbe fatto coi soldi vinti. E così, arrivato il pomeriggio della domenica, quando la radio dello spaccio dava i risultati delle partite, risultati completamente diversi da quelli pronosticati da Ciro, Ciro si arrabbiava non come uno che non ha vinto, ma come uno che ha vinto e poi gli hanno rubato i soldi della vincita. Tutte le domeniche pomeriggio, allo spaccio della Casa del Popolo, c'era lo spettacolo di Ciro imbestialito come un'intera gabbia di leopardi idrofobi. Pochi minuti prima che la radio trasmettesse le notizie sportive, Ciro si alzava dal suo tavolino e andava ad appoggiarsi al banco col libretto delle partite già pronto nella sinistra e il lapis nella destra. Lo scherzo da fare a Ciro era semplicemente quello di truccare la trasmissione trasmettendo una notizia con i risultati corrispondenti alla scheda compilata da Ciro. Il Lungo funzionava anche da banconiere dello spaccio e, oltre a mescere vino e bibite, teneva la ricevitoria del totocalcio: quindi non era davvero difficile sapere cosa avesse pronosticato Ciro ogni sabato sera. Studiarono nei minimi particolari la faccenda, registrarono la trasmissione normale di canzonette e annunci commerciali, poi il sabato sera, avuta la lista precisa dei pronostici di Ciro, interpolarono la notizia, aggiunsero un altro pezzo di trasmissione, collegarono l'altoparlante dello spaccio con l'apparecchio di registrazione e provarono, a volume ridotto, l'effetto. «Straordinario!» esclamò Peppone. «Se non lo sapessi ci cascherei anche io!» E arrivò il pomeriggio della domenica: Ciro all'ora solita comparve e, sedutosi al solito tavolino, ordinò la solita bottiglia di vino. L'altoparlante trasmetteva regolare musica della radio e continuò a trasmetterla fin quando, arrivato il momento buono, Peppone, che stava facendo una scopa seduto a un tavolino vicino a quello di Ciro, non si mise a urlare come un maledetto per via delle stupidaggini che combinava il Bigio, suo compagno di gioco. Il Bigio urlò più di lui: intanto, nell'altra stanza, lo Smilzo approfittava del putiferio per staccare la radio e attaccare al cavo dell'altoparlante il magnetofono. Nessuno si accorse di niente perché la radio marciava a volume ridotto e il putiferio in sala era infernale. Ritornò la calma e, mano a mano che i minuti passavano, Ciro diventava sempre più nervoso. Ed ecco che, a un bel momento, Ciro si alzò e appressatosi al banco tirò fuori libretto e lapis. Ogni cosa era stata studiata al minuto secondo e, all'ora precisa, la voce della radio annunciò: «Notizie sportive...» Tutti in sala chiusero il becco e, nel più completo silenzio, l'altoparlante incominciò a snocciolare i risultati delle partite. Ciro, come tutte le altre volte, prendeva febbrilmente nota e, quando ebbe finito di trascrivere i risultati, li confrontò coi pronostici della sua schedina e, sbarrati gli occhi, incominciò ad ansimare. «Ah... Ah... Ah...» non riusciva a parlare e tutti gli si fecero attorno preoccupati. «Ciro, cosa ti succede?» Ciro sventolò con mano tremante la scheda e altri tre o quattro che avevano preso nota dei risultati controllarono. «Vecchio mondo, stavolta ha proprio vinto!» gridarono. Ciro agguantò una bottiglia di cognac che stava lì sul banco, ne tracannò una sorsata che non finiva più poi urlò: «È finita la naja! È finita la naja!» Schizzò fuori dallo spaccio e schiamazzando scomparve. «A momenti avevo paura che gli venisse un colpo!» osservò Peppone. «Adesso quando saprà che era uno scherzo!» «Uno scherzo? Ma l'ha detto la radio!» replicò qualcuno. Peppone andò a prendere il magnetofono e spiegò la faccenda. Naturalmente l'interesse per quella cassetta straordinaria che registrava le voci sul filo d'acciaio fece dimenticare a tutti il povero Ciro, perché ognuno voleva provare a parlare dentro il microfono per poi risentire la propria voce. Ma, a un tratto, entrò nello spaccio un ragazzino ansimante: «Ciro è diventato matto!» gridò lanciando l'allarme. Ciro abitava in una casupola isolata fuori dal paese e Peppone, seguito da tutta la banda, si avviò di corsa per vedere cosa fosse successo. Trovarono Ciro che, continuando a urlare: «È finita la naja!», stava ballando una danza selvaggia attorno a un rogo che fiammeggiava in mezzo al cortiletto. La moglie di Ciro, terrorizzata, lo stava a guardare da una finestra del primo piano. Quando vide Peppone e soci, corse giù e spiegò con voce agitata: «È arrivato a casa come un maledetto, gridava quel che grida adesso: che la naja è finita, che finalmente i milioni sono arrivati. È salito e ha buttato giù tutto: letto, sedie, tavola, buffet. Poi ha rovesciato sul mucchio un bidone di petrolio e gli ha dato fuoco!» La poveretta afferrò per un braccio Peppone: «Guardate, guardate!» Ciro, agguantati due materassi, stava per buttarli tra le fiamme, ma Peppone e gli altri gli furono d'un balzo addosso e gli strapparono i materassi di mano. «Ciro, stai diventando matto?» gli domandò Peppone afferrandolo per un braccio. «Matto? Matto perché brucio quelle porcherie?» urlò Ciro. «Adesso i milioni ci sono! Pochi o tanti ma ci sono! È finita la naja... Ho vinto!» Voleva finire il lavoro incominciato, bruciare ogni cosa. Un pasticcio grosso. Chi se la sentiva di spiegargli come stesse la faccenda? Ci pensò la moglie di Ciro che, dopo aver parlottato con qualcuno del gruppo, si avvicinò al marito e gli gridò: «Ciro, smettila di fare lo stupido! Non capisci che è stato uno scherzo? Non hai vinto niente». Ciro si mise a ridere: «Uno scherzo! Ho sentito io la radio! Ho controllato io i risultati e li hanno controllati gli altri!» «Ciro, calmati» borbottò Peppone. «È stato uno scherzo davvero». «Ma la radio...» «C'era il trucco del magnetofono. Poi ti spiegherò, vedrai...» Ciro si calmò istantaneamente. Guardò negli occhi Peppone, poi tutti gli altri della banda. «Uno scherzo... Soltanto uno scherzo...» sussurrò scuotendo il capo. Fissò a lungo il falò nel quale stavano crepitando i frantumi dei suoi poveri mobili. Si asciugò il sudore che gli bagnava la fronte. Guardò ancora negli occhi Peppone: «Che siano gli altri, che siano gli sfruttatori del popolo a prendere in giro la mia miseria, sta bene... Ma che siate voi, no! » Trasse lentamente di tasca il portafogli e toltane la tessera del partito la buttò nel fuoco. Nessuno ebbe il coraggio di muoversi. «Dimenticatevi che io sono al mondo! » esclamò con voce dura volgendo le spalle a Peppone e rientrando in casa seguito dalla moglie. Peppone rimase lì muto e immobile a rimirare il fuoco per qualche istante, poi fece dietro front e assieme agli altri si avviò lentamente verso il paese. «È stato uno scherzo cretino» disse poco prima di arrivare in paese. «Ma chi poteva immaginare che l'avrebbe presa così?... Smilzo, tu...» Lo Smilzo che stava sul chi vive fece rapidamente un balzo indietro e portò il sedere a distanza di sicurezza. «Capo, io non ne ho colpa! » protestò. «Io ho proposto lo scherzo, tu hai pensato a Ciro». «Lasciamo perdere!» tagliò corto Peppone. «Nessuno sa niente, nessuno ha visto niente, d'accordo? Se lo sanno in federazione continuano sei mesi a darci dei cretini... Lo cancelliamo dai quadri e lo sostituiamo senza tante storie. E poi c'è il caso che gli passi...» * Non gli passò, a Ciro. E non poteva neanche passargli perché, per colpa di quello scherzo stupido, Ciro aveva bruciato tutti i suoi mobili e la storia di quel falò ridicolo e triste circolava in tutto il Comune. Non gli passò, a Ciro. E, quando a suo fratello nacque il secondo figlio, lo volle tenere lui a battesimo come padrino. Appena se lo vide comparire davanti in chiesa, don Camillo gli domandò brusco: «Come mai hai il coraggio di presentarti qui?» «Reverendo, non trovate delle storie» rispose Ciro. «Adesso sono in regola: ho bruciato la tessera e faccio per conto mio». Don Camillo scosse il capo: «Già: sei tornato cristiano per ripicco. Non per intima persuasione. Hai smesso di fare il brigante non per amor dell'onestà ma in odio al tuo capobanda. Se non ti avessero fatto lo scherzo della finta vincita, saresti ancora tra loro». Ciro degli Oppi si guardò attorno: «Reverendo: se avessi voluto rimanere fra loro lo potevo fare benissimo». «Sì, dopo il magnifico scherzo di farti bruciare tutti i mobili e di renderti ridicolo fino al Polo Nord!» «I mobili li ho voluti bruciare io per avere un pretesto buono per togliermi dal partito senza storie e complicazioni. Lo sapevo benissimo che si trattava di uno scherzo. La sera prima avevo sentito tutto dal corridoio della sede. Anche il comunicato falso». Don Camillo borbottò: «La cosa cambia...» «Comunque, reverendo, non occorre che voi lo diciate in giro. L'importante è che lo sappia quello là». Il Cristo dell'altar maggiore difatti lo sapeva e non si offese sentendosi chiamare «quello là». C'è fior di 'gente pia che bacia i gradini dell'altare e chiama Gesù «Nostro Signore Gesù Cristo», ma che, per amor di Gesù, non sacrificherebbe neanche un bottone. Ciro degli Oppi lo chiamava come lo chiamava ma, per amor di Gesù, aveva sacrificato anche il letto e dormiva per terra. E, pur dormendo per terra, faceva sonni dolci e tranquilli come se avesse vinto davvero un miliardo al totocalcio. Un santo da quattro soldi di Alessandro Gnocchi Povero e solo. Ciro degli Oppi non potrebbe essere più rivoltante agli occhi del mondo. Denudato dal fuoco demente che si è mangiato la sua baracca e la sua dignità. Indecifrabile e scandaloso come la danza che disegna attorno al falò. Povero in spirito, sentenzia il mondo. E lo lascia a se stesso, nell'inferno dei rinnegati, incapace persino di capire uno scherzo: «Lasciamo perdere!» tagliò corto Peppone. «Nessuno sa niente, nessuno ha visto niente, d'accordo? Se lo sanno in federazione continuano sei mesi a darci dei cretini... Lo cancelliamo dai quadri e lo sostituiamo senza tante storie. E poi c'è il caso che gli passi...» Povero in spirito, dice il Signore. E, come nel Discorso della montagna, gli promette il regno dei cieli. Va bene così: lacero, solo e spogliato di tutto. Provvisto di un linguaggio che non sa dire neppure il necessario su Dio e scandalizza don Camillo: «L'importante è che lo sappia quello là». E sta parlando del Cristo crocifisso dell'altare maggiore. Il vero Ciro non è quello che vedono Peppone e i suoi compagni dopo avergli giocato lo scherzo della finta vincita al totocalcio. E non è quello che don Camillo, preso per un momento dal rigore formalista, pensa di incontrare in chiesa al battesimo del nipote. Ciro degli Oppi è quello che attendeva con pazienza l'occasione giusta per mollare tutto e darsi al Signore. Anche a costo di essere preso per pazzo. La povertà di spirito non è facile da decifrare. Se non ci si lascia condurre per mano da una visione soprannaturale, si possono commettere molte ingiustizie in suo nome. Prima fra tutte quella di pensare che l'orizzonte del Vangelo sia la miseria. E, dunque, bearsi delle disgrazie del prossimo. Violentare la dignità dei poveri per il gusto di contemplare l'esercizio della propria bontà. Guareschi, invece, insegna che la cifra del povero evangelico è la fiducia totale in Dio: C'è fior di gente pia che bacia i gradini dell'altare e chiama Gesù «Nostro Signore Gesù Cristo», ma che, per amor di Gesù, non sacrificherebbe neanche un bottone. Ciro degli Oppi lo chiamava come lo chiamava ma, per amor di Gesù, aveva sacrificato anche il letto e dormiva per terra. E, pur dormendo per terra, faceva sonni dolci e tranquilli come se avesse vinto davvero un miliardo al totocalcio. Batte qui, nel finale, il cuore del racconto. In una nota che lo scrittore ha voluto appena sussurrare per caricarla quanto possibile di suggestione. Dopo aver lasciato il partito e stracciato la tessera, Ciro potrebbe rimettere insieme il suo patrimonio e rientrare nel consesso civile. Invece, continua a dormire per terra. Non si compra neanche il letto, perché ciò che conta sta da un'altra parte. Come i veri poveri del Signore, come Giobbe, come san Francesco, come Madre Teresa, sa che quella ricchezza non ha uguali. Un cerimonioso giornalista, per soprendere la piccola suora di Calcutta, disse che non sarebbe stato tra i rifiuti umani di quella città neppure per tutto l'oro del mondo. «Ma io lo faccio per molto di più», lo fulminò lei, e pensava all'amore di Dio. Ciro ha scoperto lo stesso tesoro. Per questo balla, incompreso, attorno al fuoco. La sua, però, non è una danza sfrenata, dionisiaca. Non ha nulla a che fare con le danze folli di riti arcaici in cui l'uomo si fa padrone del mondo. Col suo ballo misurato, quest'uomo dice di essere felice perché il mondo non è suo e mai potrà esserlo. Dice la gioia di dover ringraziare ogni volta che i suoi occhi si posano su qualcosa: sui mobili di casa e sul fuoco che li brucia. Ma è un fuoco amico, che non sa di distruzione, quello di Ciro. Ricorda quello a cui si rivolse san Francesco in tutta amicizia quando, quasi cieco, pensarono di operarlo agli occhi. Nel momento in cui il ferro rovente fu tolto dal forno, il santo gli andò incontro e disse: «Fratello Fuoco, Dio ti creò bellissimo, possente e utile, ti prego di essermi cortese». Commenta Chesterton: Se vi è qualcosa che può essere chiamato arte di vivere, a me pare che un simile momento sia uno dei suoi capolavori. Nel correre di Ciro attorno al falò si legge una gentilezza e una pacatezza che ricordano questa vicenda francescana. Un'arte di vivere che sa stare distante tanto dalla furia primordiale e informe dei padroni della Terra, quanto dalla tiepidezza degli imbelli. Un'esplosione tutta cristiana che, anche nel momento della gioia, sa di dover rendere conto a Dio. Lontano da quell'avarizia che offusca le realtà soprannaturali e trasforma tutto in calcolo: gli uomini, le cose, i sentimenti, il destino. Lontano da quell'avarizia che travolge tutti, poveri e ricchi, affamati -e-sazi. La cruna dell'ago deve impensierire tanto il ricco che irride il povero, quanto il povero che invidia il ricco. Per anni, Ciro aveva fatto parte di questa seconda specie. Era dannato quanto e più di un ricco crapulone, dice Guareschi: ... era un rabbioso del totocalcio. Non c'era sabato che Ciro non compilasse una schedina e questo non significa niente perché c'è gente che, di schedine, ne spara dieci o venti tutte le settimane. Ciro era un rabbioso del totocalcio perché, ogni sabato, appena consegnata la sua scheda, incominciava immediatamente a pensare che cosa avrebbe fatto coi soldi vinti. Il peccato non stava solo nel tentare avidamente la sorte. Stava, soprattutto, nel disegno di farsi padrone del mondo. Nella rabbia con cui «incominciava immediatamente a pensare cosa avrebbe fatto con i soldi vinti». Ciro, col suo orgoglio, perpetuava il peccato d'origine. Tradiva l'intelligenza esaltandosi davanti al «diventerete come Dio» sussurrato dal demonio. Ma poi cambia strada. Senza clamore. Guareschi non racconta una conversione improvvisa. Il rabbioso del totocalcio depone tutta la smania che metteva nel sognare il suo potere sulle cose e aspetta. Si ferma in attesa del pretesto buono per togliersi dal partito senza storie e complicazioni. Non ha cambiato soltanto il progetto, ha cambiato anche lo stile. La gentilezza francescana nata attorno al falò si è presa tutta la sua vita. Da rabbioso che era, Ciro è diventato un mistico che balbetta il linguaggio di Dio, ma dorme felice per terra. Un mistico che non sa neppure di avere nel sangue tanto san Francesco e tanto san Tommaso da mettere in crisi un plotone di teologi. Un mistico che non somiglia affatto a quelli tanto in voga, in arrivo dall'Oriente: troppo scettici per essere materialisti, troppo spirituali per bruciare i loro letti. Questo povero di spirito, come Francesco, come Tommaso, è impregnato di sano materialismo cristiano. Ama tutte le cose perché ha inteso che vengono da Dio e, dunque, sono buone. Solo l'uomo può pervertirle perdendoci il cuore. Ma da questo pericolo ci si può riparare abbracciando la croce. Senza essersi preso la briga di studiare il Vangelo, Ciro ha saputo legare il Discorso della montagna al discorso di un'altra montagna: il discorso del Calvario. Lassù, Gesù ha riconsegnato il suo spirito nelle mani del Padre e ha insegnato cosa significa veramente essere poveri. Ciro sa che la croce fa male perché ha deciso di sentirla nella sua carne. Però sa anche che rende santi. E sa che esiste un antidoto alla tentazione della ricchezza: ma non è la miseria, è la santità. Giovannino Guareschi CINQUE PIÙ CINQUE riletto da Mario Palmaro DAL VANGELO DI GIOVANNI (11, 32-36) Maria, dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!» Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!» Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Vedi come lo amava!» Cinque più cinque Le cose si erano guastate forte per via della politica e, pur senza che fosse successo niente di speciale, Peppone, quando incontrava don Camillo, faceva una smorfia di disgusto e voltava la faccia da un'altra parte. Poi, durante un discorso in piazza, Peppone aveva fatto delle allusioni offensive a don Camillo e lo aveva chiamato «il corvaccio del cancelliere». In seguito, avendo don Camillo risposto per le rime sul giornaletto della parrocchia, una notte gli scaricarono davanti alla porta della canonica un biroccio di letame, sì che alla mattina dovette uscire con una scala dalla finestra. E sul mucchio c'era un cartello: «Don Camillo, concimati la zucca». Di qui cominciò una polemica verbale, giornalistica e murale così accesa e violenta che c'era in giro sempre più un maledetto odor di legnate. E dopo l'ultima replica di don Camillo attraverso il giornaletto, la gente disse: «Se quelli di Peppone non rispondono ci siamo». E quelli di Peppone non risposero, anzi si chiusero in un silenzio preoccupante e pareva l'attimo che precede il temporale. * Una sera don Camillo stava in chiesa assorto nelle sue preghiere, quando udì cigolare la porticina del campanile e non fece neppure a tempo a levarsi in piedi che Peppone gli stava dinanzi. Peppone aveva il viso tetro e teneva una mano dietro la schiena. Pareva ubriaco e i capelli gli ciondolavano sulla fronte. Don Camillo con la coda dell'occhio mirò un candelabro che gli stava a fianco e, calcolata bene la distanza, si alzò in piedi con un balzo all'indietro e si trovò con la mano stretta attorno al pesante arnese di bronzo. Peppone strinse le mascelle e guardò negli occhi don Camillo e don Camillo aveva tutti i nervi tesi ed era sicuro che, appena Peppone avesse mostrato quello che celava dietro le spalle, il candelabro sarebbe partito come una saetta. Lentamente Peppone trasse la mano da dietro la schiena e porse a don Camillo un grosso pacco stretto e lungo. Don Camillo pieno di sospetto non accennò ad allungare la mano e allora Peppone, deposto il pacco sulla balaustra dell'altare, strappò la carta blu, e apparvero cinque lunghe torce di cera grosse come un palo da vigna. «Sta morendo» spiegò con voce cupa Peppone. Allora don Camillo si ricordò che qualcuno gli aveva detto che il bambino di Peppone da quattro o cinque giorni stava male, ma don Camillo non ci aveva fatto molto caso credendo si trattasse di cosa da poco. E ora capiva il silenzio di Peppone e la mancata replica. «Sta morendo» disse Peppone. «Accendetele subito». Don Camillo andò in sagrestia a prendere dei candelabri e, infilate le cinque grosse torce di cera, si accinse a disporle davanti al Cristo. «No» disse con rancore Peppone «quello lì è uno della vostra congrega. Accendetele davanti a quella là che non fa della politica». Don Camillo a sentir chiamare «quella là» la Madonna strinse i denti e sentì una voglia matta di rompere la testa a Peppone. Ma tacque e andò a disporre le candele accese davanti alla statua della Vergine, nella cappelletta a sinistra. Si volse verso Peppone. «Diteglielo!» ordinò con voce dura Peppone. Allora don Camillo si inginocchiò e sottovoce disse alla Madonna che quelle cinque grosse candele gliele offriva Peppone perché aiutasse il suo bambino che stava male. Quando si rialzò Peppone era scomparso. Passando davanti all'altar maggiore don Camillo si segnò rapidamente e tentò di sgattaiolare via, ma la voce del Cristo lo fermò. «Don Camillo, cos'hai?» Don Camillo allargò le braccia umiliatissimo. «Mi dispiace» disse «che abbia bestemmiato così, quel disgraziato. Né io ho trovato la forza di dirgli niente. Come si fa a fare delle discussioni con un uomo che ha perso la testa perché gli muore il figlio?» «Hai fatto benissimo» rispose il Cristo. «La politica è una maledetta faccenda» spiegò don Camillo. «Voi non dovete avervene a male, non dovete essere severo con lui». «E perché dovrei giudicarlo male?» sussurrò il Cristo. «Egli onorando la Madre mia mi riempie il cuore di dolcezza. Mi spiace un po' che l'abbia chiamata "quella là"». Don Camillo scosse il capo. «Avete inteso male» protestò. «Egli ha detto: "Accendetele tutte davanti alla Beata Vergine Santissima che sta in quella cappella là". Figuratevi! Se avesse avuto il coraggio di dire una cosa simile, figli o non figli, lo avrei cacciato fuori a pedate!» «Ho proprio piacere che sia così» rispose sorridendo il Cristo. «Proprio piacere. Però parlando di me ha detto "quello lì"». «Non lo si può negare» disse don Camillo. «A ogni modo io sono convinto che egli lo ha detto per fare un affronto a me, non a Voi. Lo giurerei, tanto ne sono convinto». Don Camillo uscì e dopo tre quarti d'ora rientrò pieno di orgasmo. «Ve l'avevo detto?» gridò sciorinando un pacco sulla balaustra. «Mi ha portato cinque candele da accendere anche a Voi! Cosa ne dite?» «È molto bello tutto questo» rispose sorridendo il Cristo. «Sono più piccolette delle altre» spiegò don Camillo, «ma in queste cose quella che conta è l'intenzione. E poi dovete tener presente che Peppone non è ricco e, con tutte le spese di medicine e dottori, si è inguaiato fino agli occhi». «Tutto ciò è molto bello» ripete il Cristo. Presto le cinque candele furono accese e pareva che fossero cinquanta tanto splendevano. «Si direbbe persino che mandino più luce delle altre» osservò don Camillo. E veramente mandavano molta più luce delle altre perché erano cinque candele che don Camillo era corso a comprare in paese facendo venir giù dal letto il droghiere e dando soltanto un acconto perché don Camillo era povero in canna. E tutto questo il Cristo lo sapeva benissimo e non disse niente, ma una lagrima scivolò giù dai suoi occhi e rigò di un filo d'argento il legno nero della croce e questo voleva dire che il bambino di Peppone era salvo. E così fu. Bugiardo per amore di Mario Palmaro Le lacrime di Gesù salvano. Salvano Lazzaro, l'amico morto ormai da quattro giorni. E salvano il figlio di Peppone, che «sta morendo». La goccia che «riga di un filo d'argento il legno nero della croce» sgorga da quegli stessi occhi che hanno visto con angoscia la pietra rotolata davanti al sepolcro di Lazzaro. Molte lacrime sono cadute nella polvere di Betania, scaldata dal sole tiepido della primavera di Galilea, così come molte hanno bagnato la terra scura e rigogliosa della Bassa. Lacrime, infinite lacrime che cadono e continuano a cadere nella polvere del mondo. Se fosse soltanto per quelle lacrime, tutta la storia dell'umanità potrebbe essere riassunta nei versi, tremendi, di Baudelaire, che prega una divinità lontana, impassibile: ... l'ardente singhiozzo che rotola di età in età, e viene a morire sulla riva della tua eternità. Ma le lacrime di Betania sono diverse: sono le lacrime di Dio. Di un Dio che si commuove per l'uomo, soffre per lui, partecipa alle sue sorti, entra nella storia. Ci entra da uomo, bello e virile: di fronte alla sua commozione, la gente tutt'intorno si meraviglia perché Gesù possiede il pudore del re capace di soffrire per il suo popolo senza gesti plateali, senza commozioni da baraccone. «Vedi come l'amava!» esclamano i più, conquistati da quelle lacrime. Non si potrebbe immaginare nulla di più diverso dalle capricciose divinità pagane, dai sanguinari idoli dei popoli del Medioriente o dell'America Latina. Nulla di più diverso dal dio di Cartesio, il grande architetto che dà un colpetto al mondo per metterlo in movimento e poi scompare nell'infinito. Il dio fabbricato dagli intellettuali, dai filosofi, dal "secolo dei lumi". Ma nella storia irrompe Gesù di Nazaret, e da quel momento l'uomo sa che nemmeno una lacrima cadrà nella polvere senza essere, misteriosamente, elevata fino al punto più alto della creazione. Arriva la salvezza, ma non dalla sofferenza, quanto piuttosto nella sofferenza. Quando Peppone entra nella chiesa di don Camillo, ha già dato fondo alla sua riserva di dolore: ha il volto ubriacato dalle lacrime della moglie, che si può immaginare indaffarata intorno al figlioletto nel tentativo di liberarlo dalla malattia. Nelle parole di Peppone convivono, in quella verità acrobatica che è il paradosso, rassegnazione e speranza. Certificano l'ineluttabile che si sta abbattendo sulla sua casa, la giovanissima vita del suo bambino che ormai scivola via, imprendibile, senza che le sue forti braccia da fabbro possano trattenerla. Eppure, c'è ancora un gesto da compiere, subito, senza perdere un istante: accendere le candele, e farle presentare a Maria Vergine da don Camillo. Vi è una densissima, perfetta catechesi cattolica in queste poche righe guareschiane: innanzitutto, la fede schietta e genuina dei semplici. Quello di Guareschi è un mondo nel quale la fede, talvolta, si pesa a chili. I chili delle «cinque lunghe torce di cera grosse come un palo di vigna» che Peppone ha portato al suo parroco. Una fede che appare di grana spessa, e che invece si rivela preghiera intensissima e raffinata, perché si colloca sulla lunghezza d'onda del Dio cristiano: la parola si fa orazione nell'uomo che esprime tutto se stesso, con la sua ingenua, grossolana, ma autentica nostalgia del Creatore. La gente che si muove dentro Mondo piccolo ha poche, granitiche sicurezze: Peppone entra nella chiesa con la determinazione di chi è certo, certissimo che Gesù e Maria sono davvero lì presenti, così come è sicuro che nella pancia del suo camion ci sia un motore che lo fa camminare. «Quello lì» e «quella là», li chiama Peppone, e sembra di sentirlo parlare nella musicale lingua della bassa, che Guareschi traduce quasi "per Pentecoste" al lettore di ogni latitudine. Ed è già preghiera. È come se Peppone avesse fatto irruzione, rumorosamente e con malgarbo, nella casa di Nazaret: ha bisogno di parlare a Maria, subito, e le si rivolge con un tono che indisporrebbe chiunque. Chiunque, tranne Gesù. Formidabile catechesi guareschiana: a Gesù si va e si ritorna sempre attraverso Maria. È lei a ben guardare la protagonista silenziosa di questa favola vera raccontata dal grande fiume. «Non hanno più vino», dirà alle nozze di Cana. Questa volta sembra sussurrare a suo Figlio: «Guarda, Peppone non ha più lacrime: salva il suo bambino, restituisciglielo». È un dialogo misterioso che Guareschi non racconta, perché da buon conoscitore dei Vangeli sa che non è nello stile di Maria parlare troppo, mettersi in mostra, agire da protagonista. La Theotòkos, la Madre di Dio, la nemica di tutte le eresie, il punto di incontro fra cielo e terra, sa riconoscere sotto la dura scorza di Peppone la sorgente di una fede di bambino. È molto triste pensare come in certe teologie, e perfino in alcune ecclesiologie, Maria non trovi più posto, perché la fede è ormai ridotta a un'astrazione. E un'astrazione non ha bisogno di una Madre. Non basta: il sindaco "rosso", nemico dei preti e della Chiesa, affida proprio al sacerdote il compito di comunicare con la Vergine. Come dire: non c'è Cristo senza Maria e non c'è Cristo al di fuori della Chiesa. «Quella là che non fa politica», la chiama con accento quasi sprezzante Peppone, e il lettore si aspetterebbe a questo punto una sorta di ribaltamento della narrazione, uno scarto che rimetta le cose a posto e dia voce a don Camillo per uscire dalla logica della fede misurata a colpi di cera. E invece grandissimo è Guareschi nel toccare le corde più profonde della spiritualità e, dunque, della nostra intima dimensione umana: il pretone inizia una disperata, commovente gara della menzogna per nascondere al suo Gesù le parole oltraggiose di Peppone. Il Cristo dell'altare maggiore sa, ovviamente, tutta la verità, ma sta al gioco: vuole vedere che cosa frulla nella testa di quel prete della Bassa dalle grosse mani. Gesù rivive la scena di Betania, rivede Marta che gli viene incontro e che lo ammonisce: «Signore, già puzza... è di quattro giorni». Un'avvertenza che a quei tempi suonava come irreversibile sigillo. Pare fosse comune credenza fra i Giudei che l'anima del defunto si aggirasse per tre giorni attorno alla salma, sperando di penetrarvi di nuovo; ma il quarto giorno, cominciando la decomposizione, essa se ne allontanasse per sempre. Tuttavia Cristo riascolta anche altre parole di Marta, parole di fede: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Ricompare sulla scena don Camillo, e ancora una volta la fede è faccenda di candele: il pretone non ha nessuna intenzione di abbandonare il sentiero tracciato dalla sua maldestra pecorella, che ha affidato ai ceri il suo grido di aiuto lanciato verso colei che è Salus infirmorum. Le nuove candele andranno all'altar maggiore, anche in riparazione dello "sgarbo" indirizzato al Cristo da Peppone. Sembrano fare più luce, questa volta, perché don Camillo le ha segretamente acquistate dal droghiere, roba di prima qualità che la parrocchia non si può permettere. Ma i cinque ceri mandano fiammelle più vivaci anche perché sono alimentate da un vero e proprio atto di santità, quella santità che nasce dal voler fare ogni volta le stesse cose con più amore. Un supplemento d'amore che colma la differenza fra l'inarrivabile prezzo dei ceri superlusso e le magre finanze del parroco di Mondo piccolo. Don Camillo e Peppone si affidano totalmente alle mani della Provvidenza, compiendo il gesto più logico e razionale che un uomo possa fare. Sarebbe ragionevole — si chiede Edith Stein — il bambino che vivesse con il timore continuo che la madre lo lasciasse cadere? Il Cristo dell'altare maggiore adesso piange, profondamente commosso all'idea che quel suo prete ami così follemente il suo gregge a tal punto da mentire al suo Signore. Don Camillo compie così un atto di autentica oblazione: non offre al Cristo la vita — quella, tanto, è già del Signore — quanto piuttosto le sue miserie. L'unica cosa di cui ciascuno abbia davvero l'esclusiva proprietà. Gesù vede tutto questo, e piange profondamente commosso. Il Cristo dell'altare maggiore ha visto sfilare davanti a sé un numero infinito di anime, ma questo tipo umano non gli era ancora capitato, nemmeno nella variegata squadretta dei primi discepoli: pubblicani, ladruncoli, traditori, rinnegatori. Ma il bugiardo per amore dei fratelli, mai. Sta qui il vero miracolo che esige, prepotentemente, un altro miracolo. E il figlio di Peppone, come Lazzaro, è salvo. Giovannino Guareschi LA TRATTORIA riletto da Mario Palmaro DAL VANGELO DI LUCA (12, 35-41) Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» La trattoria I1 territorio del Comune arrivava, dalla parte di mezzogiorno, fino allo Stivone, un torrente da quattro soldi ma che correva tra due alti argini perché andava a buttarsi nel grande fiume e, durante le piene, c'era il grave pericolo del rigurgito. Dall'altra riva del torrente incominciava il territorio del Comune di Castelpiano e, in linea d'aria, tra il nostro borgo e quello di Castelpiano c'erano sette chilometri. Però, se uno voleva arrivarci per via di terra, doveva sciropparsi quasi dodici chilometri. Guardando la faccenda dall'alto, ci si rendeva conto facilmente che la prima idea di chi, temporibus illis, aveva aperto la strada, era stata appunto quella di unire i due centri con un gran rettifilo. E difatti la strada, partita da Castelpiano, proseguiva per ben tre chilometri puntando decisa alla meta. Sennonché, dopo questi tremila metri, la strada svoltava a sinistra e poi a destra e poi ancora a sinistra e via discorrendo, perdendosi in una tale schifezza di curve e controcurve da compiere in otto chilometri un percorso che poteva a regola di logica esser compiuto soltanto in tre. Arrivata al Fabbricone, la strada smetteva di far la matta e, allineatasi sui primi tre chilometri, percorreva gli ultimi mille metri e arrivava rinsavita alla meta. Naturalmente esisteva un antichissimo progetto di rettifica: un progetto elementare che, dal punto di vista della spesa, rimaneva ampiamente nei limiti del possibile. Si trattava semplicemente di aprire tre chilometri di strada e di costruire un ponte sullo Stivone, a Casalta. Il progetto, che per un sacco d'anni aveva servito semplicemente da argomento per la propaganda elettorale, nel 1933 era stato messo finalmente in atto: il ponte era stato studiato in ogni suo particolare e il tracciato della rettifica era stato regolarmente picchettato. E dal picchettamento era risultato che, passato il nuovo ponte sullo Stivone, la strada sarebbe passata a tre metri precisi dalla facciata della casa colonica del Folini. Il Folini aveva allora quarant'anni e, aiutato soltanto dalla moglie, conduceva le quindici biolche di terra di Casalta: era un lavoro da ammazzarsi e il Folini, che non ne poteva più e che vedeva la sua donna consumarsi come una candela, appena ebbe visti i picchetti piantati attraverso i suoi campi dai geometri e quando ebbe ricevuto, dalla pubblicazione del progetto definitivo, conferma che la strada sarebbe passata davanti a casa sua, non ci pensò sopra neanche un minuto: si tenne la casa e una fetta di area fabbricabile da tutt'e due i lati della futura strada, e vendette il resto. «È arrivato il nostro momento» spiegò alla moglie. «Arrangiamo per bene la casa e ne tiriamo fuori una trattoria in gamba. L'area fabbricabile lungo la strada rimane nostra, così evitiamo che qualcuno apra vicino a noi un'altra trattoria per farci concorrenza. Tutto il traffico, appena finita la rettifica, passerà di qui: il mercato di Castelpiano è il più importante della zona e noi potremo vivere senza doverci scannare». Anche alla donna l'idea di aprire una trattoria faceva gola parecchio: liquidato tutto quello che c'era da liquidare, il Folini e la moglie incominciarono la trasformazione della casa. Il padre della donna era muratore: da qualche tempo non lavorava più perché aveva passato i sessanta ma, dato il caso speciale, riprese la cazzuola: lo Stivone stava lì a due passi per la sabbia e la ghiaia e il Folini s'era tenuto il cavallo e il carretto. Aiutato dalla figlia e dal genero che funzionavano da manovali, il vecchio si mise all'opera. Ci impiegarono più d'un anno per sistemare la faccenda, ma la cosa riuscì bene parecchio. E, quando anche i serramenti, il mobilio, la cucina, la cantina eccetera, furono a posto, il Folini impostò il problema più importante: «Come la chiamiamo?» Il vecchio non aveva idee in proposito ma, sollecitato, suggerì di chiamarla «Trattoria Garibaldi». La moglie del Folini bocciò la proposta perché non voleva che all'impresa fosse mischiata la politica. Per lei «Cucina casalinga» sarebbe andato perfettamente. Il Folini era difficile da accontentare e don Camillo che, in tenuta da cacciatore, era arrivato lì Dio sa come, trovò i due a discutere animatamente. «Litigate?» domandò. «No, stiamo cercando il nome». «Che nome?» «Il nome del locale». Don Camillo non sapeva niente e allora, dopo aver ottenuta l'assicurazione che non ne avrebbe parlato ad anima viva, i Folini gli fecero visitare la casa. «Reverendo, non vi pare una bella idea?» disse alla fine il Folini. «Bella idea certamente» borbottò don Camillo. «Però, io avrei incominciato una volta fatta la strada». «La faranno, è questione di mesi» replicò il Folini. «E allora sarà un colpo grosso». Correva l'anno 1934: nel 1939 il padre della moglie del Folini morì senza aver avuto la consolazione di vedere incominciati i lavori della nuova strada. Nessuno l'aveva più in mente, la rettifica. Poi scoppiò la guerra e i Folini non ebbero più neppure il coraggio di pensare che la rettifica potesse essere iniziata prima della fine del flagello. «Bisognerà aver pazienza» diceva il Folini. «Finita la guerra ogni cosa andrà al suo posto». Intanto già da parecchi anni il Folini, finiti i soldarelli, si arrangiava come bracciante. Tutte le mattine andava al lavoro e, prima di mettersi in cammino attraverso i campi, diceva alla moglie: «Mi raccomando». «Non ci pensare» rispondeva la donna. E, partito il marito, incominciava a spazzare e lucidare e spolverare. Il fatto che la "Trattoria del Sole" sorgesse in mezzo a una boscaglia, nel posto più desolato e deserto della terra, non aveva nessuna importanza. La strada non c'era ma l'avrebbero fatta finita la guerra, e allora ogni cosa doveva essere perfettamente à posto. * Ful si inabissò dentro un macchione di gaggie e don Camillo lo seguì schiantando i rami come un carro armato. Dopo un lungo e faticoso andare, don Camillo sbucò in una radura. Una fascia di tappeto verde e soffice. Un rettangolo esattamente squadrato, con una linda casetta verso il mezzo d'uno dei lati lunghi. S'incamminò verso la casa e un vecchio coi baffi bianchi apparve e gli venne incontro. «Guarda un po', Folini! Vi credevo morto chi sa dove. Come mai non vi siete mai più fatto vedere in chiesa? Eppure eravate un buon cristiano». «Lo sono ancora, reverendo. Ma non ho un minuto di tempo». «E cosa fate di bello?» «Lavoro un po' dappertutto e il poco tempo che mi resta me lo porta via l'esercizio. Bisogna pure che dia una mano a quella poveretta di mia moglie». Don Camillo guardò perplesso il Folini. «Non capisco bene di che esercizio parlate». «La trattoria» spiegò il Folini. Erano arrivati alla casa che aveva sul davanti un bel pergolato con sotto le tavole e le panche pitturate di verde. «Reverendo, vi ricordate quando vi ho mostrato il locale vent'anni fa? Guardate un po' adesso!» Don Camillo seguì il Folini e si trovò in una bella sala pitturata di fresco con un alto zoccolo di legno lucido tutt'attorno alle pareti, le tendine a scacchi bianchi e rossi alle finestre, i tavolini ben disposti e, su ognuno di essi, un vasetto di fiori di campo. Dirimpetto all'entrata un grande banco dietro al quale c'era una scansia piena di bottiglie. «Non avete l'idea dei sacrifici che ci è costato, ma non bisogna lasciarsi superare dai tempi se si vuol andare avanti. Adesso la gente esige cose semplici, allegre, moderne. Ho già pronto anche tutto l'impianto elettrico compreso il ventilatore e l'aspiratore per il fumo: quando faranno la strada metteranno di sicuro la linea e così io non avrò che da allacciarmi». Passarono in cucina. «Vedete, reverendo? Mattonelle bianche, cucina economica e cucina a bombola di gas. E anche il suo bravo frigorifero elettrico. Ho già pagato cinque rate. È dura ma ce la caverò». Apparve una vecchia piccola e un po' curva, con un fazzoletto sui capelli e un candido grembiale davanti. «Avete visto reverendo?» disse la vecchia. «E del gioco delle bocce cosa ve ne pare?» Uscirono: dietro la casa vi era un ampio giardino con un grande pergolato e con due giochi di bocce affiancati, lisci come biliardi. «Sono vent'anni che ci sacrifichiamo» spiegò il Folini «ma c'è la soddisfazione di avere un locale che non ha concorrenti in tutta la zona. Se mi va bene un certo affaretto e prendo la mediazione, metteremo qui fuori tutta l'illuminazione con dei tubi bianchi moderni che fanno una luce meravigliosa e consumano metà delle altre lampade». «Prima delle lampade bianche» esclamò severamente la vecchina «devi sistemare il pozzo. Quello sì che è necessario!» «Bella roba!» ridacchiò il Folini «il pozzo è fatto, la pompa funziona, mancano soltanto il serbatoio e la conduttura fino alla cucina, al lavandino e al gabinetto di decenza». Si rivolse a don Camillo: «Ne avremo uno di quelli moderni, di smalto bianco e con l'acqua, all'inglese. Se si vuol lavorare bisogna fare così». «Reverendo, accomodatevi» disse la vecchia. «Preferite un bicchiere di vino bianco o rosso? «Abbiamo del vino di vent'anni» spiegò trionfalmente il vecchio. «Non lo trovate da nessuna parte». «Grazie, niente vino. Soltanto un bicchiere d'acqua». La vecchia si allontanò e don Camillo si sedette a un tavolo sotto il pergolato. Non sapeva cosa dire. Anzi, non sapeva neppure se fosse opportuno o meno parlare. «Folini» disse alla fine «è bellissimo tutto quello che mi avete fatto vedere. Però io, se fossi in voi, adesso lascerei le cose come stanno e riprenderei quando avessero incominciati i lavori della nuova strada». Il Folini fece segno di no scuotendo la testa: «In commercio bisogna essere come a caccia: sempre col fucile carico, pronto a sparare. Il giorno in cui cominciano i lavori noi dobbiamo essere in grado di aprire l'esercizio. Così ci facciamo subito dei clienti con gli operai della strada, con gli ingegneri del ponte e via discorrendo». Don Camillo sospirò: «Folini, ragionate un momentino. Sono vent'anni che voi e vostra moglie state dando il sangue per questa trattoria. E da vent'anni voi aspettate inutilmente che incomincino i lavori della strada. Folini: e se non li incominciassero mai?» La vecchia era arrivata, silenziosa come un'ombra: depose davanti a don Camillo il vassoio di ottone luccicante con la brocca piena d'acqua fresca e il bicchiere. «Reverendo» disse la vecchia «l'importante è aver fede. Noi non chiediamo niente di impossibile. Se fanno le strade bucando le montagne, perché non dovrebbero fare tre chilometri di strada attraverso i campi? Se in questi vent'anni ci fossimo messi a sbadilare io e il mio uomo, l'avremmo già fatta noi da soli questa benedetta strada. Noi siamo sicuri che la Divina Provvidenza ci aiuterà e fra poco incominceranno i lavori della strada. Non è vero?» «Sicurissimo!» esclamò con vivacità il vecchio al quale era rivolta l'ultima domanda. Oramai è questione di mesi, al massimo!» Don Camillo bevve la sua acqua e si alzò. «Aspettate, reverendo, vi vado a cogliere quattro pere» disse il Folini. «Un minuto soltanto». Quando il vecchio si fu allontanato, la donna si appressò a don Camillo: «Per l'amor di Dio, reverendo» sussurrò «non gli mettete dei dubbi a quel poveruomo. Sono vent'anni che vive soltanto per la sua trattoria. Non me lo fate morire di crepacuore». La vecchia disparve silenziosa e poco dopo arrivò il Folini col cestello delle pere. Uscirono assieme nella radura soffice e verde, camminarono in silenzio fino all'inizio del sentiero nella boscaglia di gaggìe: «Reverendo» sussurrò il Folini «non vi fate più sentire a parlar così. Quella poveretta vive soltanto nella speranza che facciano la strada. Non avvelenatele l'anima». * «Gesù» esclamò impetuosamente don Camillo quando fu davanti al Cristo dell'altar maggiore «volete vedere l'uomo più cretino del mondo?» Si pestò due manate sul petto e spiegò: «Eccolo qui!» «Chi si umilia sarà esaltato» rispose sorridendo il Cristo. Don Camillo era furibondo: «Gesù» implorò «fatemi una grazia. Mettetemi in condizioni di prendermi a calci da solo». «Non posso assecondare insani propositi di violenza. Non ti maltrattare, don Camillo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ama te stesso come il prossimo tuo». «No, Signore, io non posso amare un cretino come don Camillo ! » «Al contrario, don Camillo: amalo più d'ogni altro perché egli, che crede di insegnare la via della fede agli altri, talvolta esce di strada e non se ne avvede». Don Camillo protestò fieramente: «Signore, sono stupido, sì, ma la strada della fede la conosco bene!» «Chi si esalta sarà umiliato: alla prima occasione spiegagli anche questo a don Camillo» sussurrò il Cristo. A dire il vero, l'occasione non si fece aspettare: verso le cinque del pomeriggio lo Smilzo venne ad appiccicare al muro della canonica un manifesto. Don Camillo se ne accorse subito e balzò fuori con intenti piuttosto bellicosi. «Cittadini» incominciava il manifesto «l'amministrazione democratica ha l'orgoglio di annunciarvi che una vostra grande aspirazione sta per diventare realtà. Domani avranno inizio i lavori per la rettifica della strada di Castelpiano...» «Guarda e impara, pezzo di stupido!» esclamò don Camillo. Lo Smilzo che s'era fermato a guardare a distanza prudenziale domandò: «Come dite, reverendo? C'è qualcosa che non vi va?» «Non parlo con te». «De gustibus non disputoribus» affermò lo Smilzo risalendo in bicicletta. «C'è anche gente che si diverte a parlare da sola». «Gesù» disse don Camillo quando fu arrivato di corsa davanti all'altar maggiore. «Bisogna che io vada subito a portare quel manifesto ai Folini!» «Non occorre» rispose il Cristo. «Essi non hanno mai avuto dubbi. Sempre hanno fermamente pensato che la strada sarebbe stata fatta. Ti hanno parlato a quel modo solo perché sapevano che tu non potevi credere in una fede così profonda. Sapevano che tu li avresti giudicati pazzi». Don Camillo abbassò il capo: «Gesù» balbettò «in una cosa del genere, come si fa a capire se si tratta di fissazione o di fede nella Divina Provvidenza?» «Son cose che non si possono capire ma si possono solo sentire. Impara a diffidare del buon senso, don Camillo. Molte volte esso è soltanto senso comune». Don Camillo si allontanò rattristato. Ma ben presto pensò alla radura verde in mezzo alla boscaglia di gaggìa. Pensò alla strada che avrebbe tagliato la boscaglia e la radura verde e si sentì il cuore leggero. Misterioso, imprevedibile Amore di Mario Palmaro Don Camillo assomiglia spesso a Simon Pietro il pescatore: non sempre coglie subito la verità, ma si confonde, inciampa, fraintende le parole del Maestro. Come il "primo Papa", così anche il pretone della Bassa resta spiazzato di fronte all'imprevedibile amore del suo Cristo. No, non è un prete "esistenzialista", divorato dal dubbio, paralizzato da qualche disputa teologica o dal demone del relativismo. Don Camillo è sacerdote solido, con i piedi ben piantati in terra e il cuore rivolto alla croce. Ma anche a lui, come al pescatore di Galilea dalle grosse mani callose, capita di non riuscire a comprendere Gesù: «Signore, questa parabola la dici solo per noi o per tutti?» Don Camillo non solo ascolta le parabole, ma gli capita di finirci dentro, perché il Mondo piccolo in cui Guareschi lo fa muovere è, spesso, una grande parabola ambientata nello scenario della Bassa. Per cui, quando il prete si imbatte nel Folini, e nella sua granitica certezza che un giorno una strada verrà costruita davanti alla sua trattoria, lo giudica un pazzo sognatore. Non si accorge, don Camillo, di essere inciampato nella fede. Nella fede fatta carne e sangue, nella prudente vigilanza dei servi che attendono «sempre pronti, con i fianchi cinti e le lucerne accese» il ritorno del loro padrone. Quello del Folini non è un sogno, per la semplice ragione che egli crede non «nella strada», ma nel fatto certissimo che «la Divina Provvidenza mi aiuterà». Quello del Folini non è un sogno, perché la sua speranza non è alimentata dalle sirene di qualche ideologia alla moda che predica la salvezza del mondo a colpi di riforme sociali: «Se in questi vent'anni ci fossimo messi a sbadilare io e il mio uomo [dice con lucido realismo la moglie del Folinil , l'avremmo già fatta noi da soli questa benedetta strada. Il punto allora è un altro: scommettere la vita non sulle "strutture' costruite dagli uomini, ma piuttosto sulla certezza che chi si affida nelle mani del Padre non può restare deluso, anche a dispetto dell'inefficienza e della dabbenaggine di quelle stesse strutture. Chi persevera riceverà una grande gioia. Il padrone di cui parla il Vangelo di Luca parte avvertendo la servitù che si reca a una festa di nozze, e dunque farà ritorno a notte inoltrata. Ma i servi fedeli lo aspetteranno in piedi, perché non vogliono farlo attendere alla porta nemmeno un istante. Per loro il padrone compirà una cosa straordinaria: li farà sedere a mensa e li servirà. Il Folini tira a lucido la sua trattoria, perché in fondo sta preparando la casa all'arrivo del padrone, e per quel momento «ogni cosa deve essere perfettamente a posto». Quando sia quell'ora, nessuno lo sa. Non a caso Guareschi sceglie di individuare il centro del racconto, il cuore della vicenda, nella casa: la casa è, come scrive Chesterton, «il luogo della libertà». È in essa che avvengono gli incontri più sorprendenti della vita di Cristo: è in una casa che Gesù incontra i peccatori, che converte la donna di facili costumi, che catechizza Marta, che tocca il cuore del pubblicano. È sull'uscio di una casa che il padre attende il ritorno del figliuol prodigo. Ed è in questa casa della Bassa, lontana dalle piste battute dagli uomini, «pitturata di fresco e con le tendine a scacchi bianchi e rossi alle finestre e i tavolini ben disposti»; è in questa casa che il Folini aspetta la sua strada, il suo Cristo. Costruire una trattoria in mezzo alla boscaglia: il senso comune fa scuotere il testone di don Camillo, in segno di compatimento. E come non dargli ragione? Eppure, il Folini ha il coraggio del vero apostolo il quale — per dirla con Josèmaria Escrivà — sa bene che non ci sono vie tracciate per voi, ma le traccerete, attraverso le montagne, col battere dei vostri passi. Ci vuole il coraggio di tracciare strade con il proprio cammino, quando le strade ancora non esistono perché, come scrive il profeta Isaia, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Guareschi sembra qui ricordarci un tema a lui molto caro, tipicamente cristiano: la capacità del credente di saper gettare lo sguardo "oltre". Oltre l'apparenza, oltre la difficoltà del momento presente, oltre il buio dentro il quale le nostre vite sembrano talvolta immerse. Il buio della sofferenza, della prigionia, dell'abbandono. Due anni di lager, un anno di prigione, il disprezzo e l'odio di una larga fetta della cultura dominante, hanno insegnato a Giovannino l'assoluta necessità di saper "guardare oltre". È la virtù teologale della speranza, che illumina ogni parola della prosa guareschiana. Il peccato contro la speranza — scrive Bernanos — è il più mortale di tutti e forse il meglio accolto e il più accarezzato, perché ci vuole molto tempo per riconoscerlo e la tristezza che lo annuncia e lo precede è così dolce. La speranza del Folini nasce dalla perseveranza nel saper guardare oltre. Nasce dalla capacità propriamente "cattolica" che ha accomunato generazioni e generazioni di uomini semplici ma dalla fede salda che, pure impregnati di quotidianità, sono riusciti a vedere lontano, al di là della storia. Il Folini impartisce una lezione di "sana presbiopia" alla cultura moderna, che è invece afflitta da un cronico stato di miopia permanente: vede soltanto vicino, solo la quotidianità, assolutizzando quelle "ombre che passano" che sono i nostri giorni. L'homo tecnologicus macina gli avvenimenti e i fatti dentro il gigantesco tritacarne delle emozioni, dimentica presto ciò che è accaduto e si disinteressa di ciò che gli accadrà domani, disperato prigioniero dell'oggi. Questo uomo non costruirà mai nessuna trattoria sul limitare del bosco, perché questo tipo di uomo non attende più la costruzione della strada. Nella sua casa ci si comporta come il servo infedele, e non sarà un giorno felice quello in cui il padrone farà ritorno all'improvviso, come il ladro che arriva quando nessuno lo attende. Il senso comune, travestito da buon senso, si diverte a farsi beffe dell'uomo, come ricorda il Cristo dell'altar maggiore al suo povero don Camillo. E così, appare molto più sensato vivere come se il padrone di casa non dovesse più far ritorno, e tutt'al più confidare, per quel giorno sciagurato, che quel Dio sia bonario, perfino un po' bonaccione, uno con il quale si trova sempre un compromesso, e alla fin fine tutto s'aggiusta. Ma quello di Guareschi è un Dio che va preso tremendamente sul serio: proprio perché è amore, è tremendamente esigente. È un Dio difficile, perché, come scrive Alessandro Pronzato, se fosse facile non sarebbe trascendente, non sarebbe più Dio. Quando l'uomo si illude di arrivare fino a Lui arrampicandosi sui gradini delle proprie capacità e della propria mente, Dio si diverte a dare un calcio alla sua scala pretenziosa togliendogliela brutalmente di sotto i piedi. Ma il Folini e sua moglie hanno scommesso la loro vita su un atto di fede pura, dove non c'è spazio né per l'orgoglio, né per il ricatto, e neppure per il dubbio. Poche pagine della letteratura descrivono un amore sponsale così robusto come quello che Guareschi tratteggia nelle confidenze che i due vecchi affidano a don Camillo: la scommessa dell'uno è diventata la ragione di vita dell'altro. C'è, nella loro reciproca richiesta di complicità a don Camillo, il pudore della fede autentica. Ma c'è, ancor di più, l'essenza stessa del matrimonio secondo la Chiesa: non un contratto, che implica solo uno scambio di servizi e di favori; ma un'alleanza, che esige uno scambio di persone attraverso il quale i due diventano uno. Che poi è l'essenza stessa del matrimonio secondo Guareschi, come spiega bene don Camillo in un altro racconto della saga: «Ragazzi, il matrimonio non è una burletta. È una cosa che si fa in dieci minuti, ma dura tutta una vita. È un atto grave, solenne, anche se viene celebrato nel modo più modesto e semplice. Il matrimonio non è uno zabaione nel quale si prendono due uova, si sbattono assieme e in dieci minuti tutto è fatto». Amore misterioso che costringe a vedere il mondo attraverso gli occhi dell'altro. Per cui, quando finalmente si diffonde la notizia che davvero la strada si farà, e don Camillo vorrebbe correre a dirlo al Folini, è il Cristo a fermare il suo pretone e a rivelargli che sarebbe fatica sprecata: i due vecchi da sempre sapevano che quell'avvenimento, motivo stesso di un'esistenza, sarebbe certamente capitato. Solo allora don Camillo si sente «il cuore leggero», perché i suoi occhi finalmente vedono la fede nella pecorella del suo gregge. Le favole di Guareschi fanno pensare a certe novelle medievali, che associano il gusto del paradosso alla passione per la verità su Dio e sull'uomo. La Trattoria fa tornare alla mente quel pellegrino giunto lungo il suo viaggio in una cava di pietre, dove si lavora per la costruzione di una grande chiesa. Incontra un uomo al lavoro, gli chiede che cosa stia facendo e si sente rispondere: «Sto spaccando dei sassi». Accanto a lui, un altro operaio è impegnato nella medesima occupazione, ma risponde con gioia: «Sto costruendo una cattedrale». Giovannino Guareschi IL SANGUE NON È ACQUA riletto da Mario Palmaro DAL VANGELO DI GIOVANNI (4, 7-15) Arrivò una donna di Samarìa ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Il sangue non è acqua Alle Ghiaie tutto funzionava bene fino a quando c'era abbondanza d'acqua: appena arrivava l'asciutto, ogni cosa intristiva rapidamente e, se il Bacchi non riusciva a comprare l'acqua, il guaio diveniva irreparabile. Il Bacchi possedeva altra terra, disponeva di quattrini ed era stato, nella zona, il primo a pensare di scavare un pozzo per l'irrigazione: ma, per quanto avesse seppellito soldi e tubi di ferro nella terra delle Ghiaie, d'acqua non se n'era vista un goccio. Alle Ghiaie non c'era acqua: lo sapevano anche i gatti. E il pozzo che serviva per gli uomini e per le bestie, nel pieno dell'estate si asciugava. Il Bacchi, però, non aveva mollato: il pozzo d'irrigazione era diventato il suo pallino, e alle Ghiaie era un continuo viavai di tecnici e di praticoni. Appena il Bacchi sentiva parlare di qualche rabdomante, lo mandava a chiamare subito e, oramai, si poteva dire che le Ghiaie fossero state saggiate centimetro per centimetro. Il Bacchi non badava a spese ed era disposto a tutto. «Se mi dicessero che l'acqua è sotto il pavimento della cucina o della stalla» affermava «ci sto a buttar giù la casa e a rifarla da un'altra parte!» Ma alle Ghiaie d'acqua non ce n'era: i rabdomanti più famosi, quelli che a colpo sicuro dicevano: «L'acqua è qui sotto a tanti metri di profondità», dopo aver girato in su e in giù le Ghiaie, concludevano tutti che, all'infuori della vena del pozzo di casa, una vena superficiale da quattro soldi, alle Ghiaie non avevano sentito niente di niente. Mai capitato un caso simile. Quell'anno il secco fu tremendo e alle Ghiaie la roba bruciò tutta nei campi: il Bacchi era fuori dalla grazia di Dio e così, quando qualcuno gli mostrò un giornale illustrato nel quale si parlava di un rabdomante straordinario che abitava nei pressi di Roma e che aveva trovato l'acqua dove nessuno era mai riuscito a trovarla, non ci pensò sopra neanche un minuto e si mise in viaggio. Trovò un signore sui cinquant'anni molto serio e molto occupato nei suoi studi e nei suoi affari e si sentì rispondere garbatamente ma decisamente di no. Troppo lontano, troppo tempo da perdere. Il Bacchi offrì quattrini, ma non si trattava d'una questione di quattrini: il rabdomante non aveva bisogno di quattrini e non aveva mai accettato quattrini per le sue ricerche. «Quando cerco l'acqua» spiegò «io non faccio un lavoro. Io non ci metto niente di mio. Dio mi ha fornito di un sesto senso non perché io ne faccia una speculazione, ma perché lo usi a favore degli uomini che questo sesto senso non posseggono. Sarebbe come se io capitassi in un paese di ciechi e volessi approfittare del fatto che ho gli occhi buoni per cavare quattrini da chi ha la disgrazia di non potere usare degli occhi suoi». Il Bacchi raccontò la sua storia e concluse con le lagrime agli occhi: «Sono vecchio, oramai: fatemi vedere l'acqua alle Ghiaie, prima di morire. Ve lo chiedo come una grazia. Non è una questione di quattrini neanche la mia: le Ghiaie le ho create io, e, a vederle così, è come se avessi tirato su faticosamente un figlio e poi mi diventasse paralitico nelle gambe». Il professore sospirò e rispose: «Non si può negare una consolazione a un vecchio che ha lavorato tutta la vita. Verrò». * Il professore arrivò la settimana dopo e il Bacchi, quando lo vide, quasi lo abbracciava. Il professore andò a tagliare da un salice il rametto che faceva al caso suo e si mise subito al lavoro. Aveva un metodo di ricerca più organico degli altri rabdomanti, lo si capiva facilmente. E si capiva pure che era un uomo molto istruito, un vero signore il quale, pur senza darsi arie, incuteva soggezione. Volle che gli indicassero i confini precisi del podere, poi fece un lungo interrogatorio a Peppone. Peppone era lì perché alle Ghiaie gli assaggi dei pozzi li aveva fatti tutti lui e perché, nella zona, era l'unico che avesse l'attrezzatura e la competenza necessarie per impiantare un pozzo d'irrigazione. Peppone riferì i risultati di tutte le esperienze alle Ghiaie e nei poderi della plaga concludendo: «Alle Ghiaie l'acqua non c'è: sono pronto a giocarmi il collo». Il professore guardò il collo taurino di Peppone e scosse il capo: «Se lei mette a repentaglio un collo così, significa proprio che è sicuro. Comunque, nella vita non si può mai essere troppo sicuri». In verità i fatti diedero ragione a Peppone perché, dopo ore e ore di ricerche il professore si arrese. «Escludo, per quel tanto che può valere il mio giudizio, che esistano vene d'acqua di qualche importanza in questo podere». Il Bacchi aveva una faccia così triste che metteva nel cuore la malinconia; il professore lo guardò, poi disse: «Adesso sono stanco e non posso più continuare. Riprenderemo le ricerche domattina». *** Peppone fu il primo ad arrivare: c'era in ballo, sia pur soltanto simbolicamente, il suo collo, e la cosa lo appassionava. E poi il professore, quell'uomo di poche parole lo affascinava perché aveva negli occhi qualcosa di speciale. Le ricerche ripresero metodiche, quasi ossessionanti tanto erano pignole. Ma, quando al campanile stava per suonare il mezzogiorno, il professore non aveva trovato niente di più del giorno prima. Il sole picchiava come un maledetto e, prima di tornare alla fattoria, il professore sentì il bisogno di riposarsi un po' all'ombra. Erano arrivati al limite ovest delle Ghiaie, dove il podere aveva, come linea di confine, un canalaccio sassoso, più una pietraia che un canale, e, proprio sulla riva del canalaccio, lì a far la sentinella, levava le sue antiche fronde un olmo secolare. Il Bacchi e Peppone si avviarono verso l'ombra precedendo il professore. Ma il professore non li raggiunse perché, arrivato al limite dell'ombra, si fermò come se gli avessero inchiodato d'improvviso i piedi per terra. Pareva in preda a una sofferenza acuta che gli faceva serrare la mascella e tendere tutti i muscoli. Il rametto di salice, di cui teneva strette fra le mani le estremità, pareva diventato vivo e si era messo a girare. Il professore si allontanò, ritornò indietro e, arrivato di nuovo al punto di prima, si fermò di scatto coi piedi incollati per terra. Ripeté la prova cinque, sei volte, partendo sempre da luoghi diversi, e sempre, arrivato al punto famoso, rimaneva coi freni bloccati. Allora segnò il punto con un sasso e vi fece tutt'attorno dei giri sempre più stretti: ma il bastoncello non dava più segno di vita. Riprese a muoversi quando il professore tornò sul punto segnato col sasso. «Qui l'acqua c'è» disse il professore. «C'è e non molto profonda». Peppone scosse il capo: «Non è possibile: qui saranno passati trenta rabdomanti e non hanno mai sentito niente di niente!» esclamò. «Proprio qui in questo punto?» si informò il professore indicando il sasso. «Proprio in questo punto non lo posso dire» rispose Peppone. «Però vicini ci sono passati di sicuro. E, se ci fosse stata la vena, l'acqua l'avrebbero sentita di sicuro. Era gente in gamba: li ho visti io trovare l'acqua anche nei posti più difficili». Il professore guardò il sasso: «Il fatto è che qui non c'è nessuna vena: ho girato tutt'attorno. Però lì, in quel punto, l'acqua c'è!» Peppone allargò le braccia: «Allora significa che l'acqua non proviene dalla terra ma dallo Spirito Santo. Perché, se venisse dalla terra, da qualche vena dovrebbe pure arrivare». «Qui, in questo punto, l'acqua c'è» affermò il professore. «Può darsi che io non senta la vena perché passa profondissima. Può darsi che si tratti di una vena d'acqua saliente che qui, in questo punto, ha trovato terreno poroso ed è filtrata verso l'alto. Fate conto che una tubatura dell'acquedotto passi a tre o quattrocento metri sottoterra e qui, in questo punto, abbiano innestato un tubetto che porta l'acqua in su, fino a pochi metri dalla superficie. Comunque, sia quel che sia, io dico che qui sotto, a pochi metri, l'acqua c'è». Il Bacchi, che fino a quel momento s'era limitato a guardare a bocca spalancata ora il professore ora Peppone, si levò e incominciò a gridare: «L'acqua! L'acqua! Presto! Presto!» Peppone lo calmò: «Se c'è, nessuno ve la porta via, quindi possiamo fare le cose con grande calma. Tanto più che non è proprio il caso di gridare che l'acqua c'è prima d'averla vista. Oggi, verso le quattro, io vengo con gli arnesi e si incomincia. Poi continuiamo anche tutta notte. Per il momento state zitto: se incominciate a urlare che l'acqua c'è e poi non la si trova, sarà peggio delle altre volte perché vi prenderanno anche in giro». Il Bacchi si allontanò malvolentieri: e prima di andarsene voleva piantare un fittone al posto del sasso per essere più sicuro, ma il professore non glielo permise. Anzi, buttò via pure il sasso. «Oggi, tornando, ritroverò il punto. Se non lo ritrovo, significa che adesso ho sbagliato». * Alle quattro si trovarono in parecchi attorno all'olmo. Il Bacchi coi figli, Peppone coi suoi tre aiutanti, gli spesati del podere, gli affittuari dei poderi confinanti. Quando il professore apparve si ritirarono al margine del canalaccio per non impicciare. Il professore si avvicinò, camminando rapidamente, all'olmo e a un tratto eccolo inchiodato. «È proprio qui» disse. «Potete incominciare». Il terreno era sassoso: grossi ciottoli affioravano e, prima di far lavorare il mazzapicchio, fu necessario togliere lo strato di sassi. Gli uomini si misero all'opera e, per un buon metro e mezzo di profondità, continuarono sempre a cavar ciottoli. Poi si incominciò a trovare terra ghiaiosa. Ma qui il lavoro venne subito interrotto. «Nessuno si muova e nessuno tocchi niente fin che non è arrivato il maresciallo» ordinò con voce tonante Peppone. E la gente si ritrasse. Arrivò il maresciallo con due carabinieri e il medico. Un secondo dopo arrivò pure don Camillo assieme al resto del paese. Il maresciallo e il medico discesero nella buca. «Un mucchietto d'ossa con un po' di stracci grigioverdi» spiegò il maresciallo a Peppone e a don Camillo, ritornando su dalla buca. «Foro alla nuca» aggiunse il medico sopraggiungendo. «Roba del 1945, probabilmente». «Politica!» commentò don Camillo. «Guerra!» replicò a denti stretti Peppone. Ci fu qualche istante di silenzio. Poi il Bacchi scosse il capo e disse: «Chi sa chi è, poveretto!» «Gli abbiamo trovato addosso soltanto questo» rispose il maresciallo mostrando una sottile catenella d'oro con medaglia. Sfregò la medaglietta fra l'indice e il pollice per pulirla dal terriccio. «Pare ci sia inciso qualcosa» disse il maresciallo: «8 febbraio 1929». «Sedici anni!» esclamò don Camillo. «Maresciallo... mi pare ci sia inciso anche un nome». Il maresciallo trasse di tasca una piccola lente e considerò la medaglietta: «Cesare Deppi» spiegò. «Chi sa mai di dov'è!» «Borgodeste» disse la voce del professore. E tutti volsero gli occhi verso di lui. «Scusi, come fa a saperlo?» balbettò il maresciallo. Il professore allargò le braccia e scosse malinconicamente il capo. «Non ho dimenticato le generalità di mio figlio» rispose. «Tanto più che era figlio unico. Io stavo in guerra e al principio del 1945 il ragazzo scappò di casa per arruolarsi. Non se n'è più saputo niente. L'avevano mandato al Nord e non è più tornato. Sua madre lo aspetta ancora». «Dovrà poi passare da me per l'inchiesta» disse il maresciallo al professore. «Inchiesta?» sospirò il professore. «È morto. Ecco tutto. Ora potrà riposare in terra benedetta e sua madre saprà dove inginocchiarsi per piangere». * Il professore rimase al paese due giorni e, prima di andarsene, volle rivedere la buca vicino all'olmo. Peppone e il Bacchi lo accompagnarono e stettero a guardare in silenzio. «Tutti i rabdomanti son passati di qui e nessuno ha sentito niente» disse a un tratto il professore. «Ma io ho sentito qualcosa perché questa terra era bagnata del sangue di mio figlio». Scosse il capo mestamente, poi aggiunse: «Il sangue non è acqua». La parola gli ricordò il Bacchi: il professore si volse verso il vecchio. «Non ha importanza, non ha importanza» balbettò il Bacchi. «Invece ha importanza» replicò il professore. E, strappato un rametto di salice, lo impugnò e discese nella buca. «Non sento più quello che sentivo prima» spiegò. «Non era l'acqua, era lui che io sentivo...» Peppone non ebbe neppure il coraggio di pensare: "Avevo o no ragione io?" Il professore continuò: «Era lui che sentivo così violentemente. Però l'acqua c'è. Non a pochi metri come dicevo. A pochi metri c'era lui... L'acqua c'è verso i duecento metri... Chi ha fede la trova». * Il Bacchi aveva fede: tutti gli dissero che era un pazzo scatenato quando incominciò a far conficcare tubi nella terra, vicino all'olmo Aveva fede e poi capiva che era necessario trovare l'acqua: non per l'irrigazione, ma per qualcosa d'altro che egli non riusciva a spiegarsi ma che era molto importante. L'acqua fu trovata a centonovanta metri e, quando il Bacchi vide uscire quel torrente tumultuoso dal tubo da venti centimetri di diametro, gli venne la febbre e dovette mettersi a letto. Gli operai lavorarono giorno e notte ma, dieci giorni dopo, il pozzo era pronto con tutta la sua casetta dei comandi elettrici. Una casetta in mattoni a faccia vista, che pareva un piccolo fortino. E un cannone pareva il grosso tubo che sbucava fuori dal muro ai piedi del quale incominciava il canale di cemento che avrebbe portata l'acqua al fosso grande del sistema d'irrigazione. Il Bacchi volle che alla inaugurazione del pozzo ci fossero tutti e, prima di tutti, il professore. 11 professore venne accompagnato dalla moglie, e fu la moglie del professore ad abbassare il coltello del motore. L'acqua uscì con violenza. Un torrente di acqua limpida e fresca e, appena la vide, il Bacchi capì qual era la cosa importante e fece il discorso inaugurale: «Ecco l'acqua che purifica tutto e lava la terra dalle macchie di sangue e, assieme alle macchie di sangue della terra, va via l'odio dagli animi. Amen». Si fece avanti don Camillo che benedisse l'acqua. Allora la moglie del professore bagnò la punta delle dita della mano destra nell'acqua che sgorgava dal tubo e si segnò. Anche il professore toccò l'acqua e si segnò. La gente — e c'era tutto il paese — stava lì a guardare trattenendo il fiato, e si udiva soltanto lo scrosciare dell'acqua, ma pareva una musica. * Don Camillo andava spesso a guardare lo spettacolo dell'acqua che sgorgava dal pozzo del Bacchi. E ogni volta, tornandosene, si portava una borraccia d'acqua fresca e, prima di rincasare, andava al cimitero a innaffiare con quell'acqua i fiori dell'aiuola sotto la quale riposava in pace il ragazzo assassinato dalla guerra civile. «È la tua acqua» mormorava don Camillo. «Acqua benedetta». E un pomeriggio d'agosto, arrivato al pozzo, trovò un uomo che, seduto su una sponda del canale di cemento, stava immobile a guardare l'acqua. Don Camillo lo riconobbe: era uno della banda di Peppone, un giovanotto di venticinque o ventisei anni. Guardava l'acqua e, quando don Camillo gli apparve davanti dall'altra parte del condotto di cemento, levò per un momento lo sguardo e subito lo riabbassò. Ma bastò quell'istante perché don Camillo si accorgesse che quegli occhi non erano i soliti occhi della solita gente. Don Camillo si sedette sulla sponda del condotto e stette ad aspettare. Voi non conoscete i pomeriggi d'agosto della Bassa. Là, in mezzo ai campi deserti pieni di sole, ogni cosa sa di favola e, se il Demonio apparisse scarlatto e ghignante in mezzo a una piana di stoppia bruciata, sembrerebbe la cosa più naturale del mondo. Don Camillo aspettava e, a un tratto, il giovanotto disse come parlando a se stesso: «Sangue! Questa non è acqua ma sangue». «Acqua» replicò sottovoce don Camillo. «Sangue!» ripeté il giovanotto sempre ad occhi bassi. «Sangue. Lo so ben io perché è il suo sangue...» «Acqua» sussurrò mite don Camillo. «Sangue!» ansimò il giovanotto guardando con orrore il canale gonfio d'acqua. «Il suo sangue. Lo so ben io che l'ho toccato quando quel sangue era ancora caldo... Ho eseguito un ordine... Credevamo che fosse una spia... Io sono a posto perché ho eseguito un ordine... Io ho sentito quello che ha detto suo padre... Ho visto quel che ha fatto sua madre qui... Sangue. Questa non è acqua, è sangue». «Acqua» insisté dolcemente don Camillo. «Prova a toccarla». Il giovane ritrasse inorridito la mano. Ma don Camillo ancora insisté con voce suadente. E il giovane, lentamente, esitando, appressò la mano all'acqua. «Immergila tutta la mano» sussurrò don Camillo. «Il Bacchi aveva ragione: l'acqua purifica, lava le macchie di sangue, cancella l'odio». Il giovane immerse la mano nell'acqua gelata. E aveva tutti i nervi tesi da spezzarsi. A un tratto gli occhi gli si riempirono di pianto e due lagrime gli scivolarono sulle guance e andarono a cadere nell'acqua. Il giovane ritrasse la mano e la guardò gocciolare. Poi, d'un tratto, si riscosse come se si fosse svegliato da un sogno e guardò con gli occhi sbalorditi don Camillo. «Stai tranquillo» lo rassicurò don Camillo. «Dio soltanto sa quel che è successo. Se pure è successo qualcosa». Il giovane si alzò e se ne andò. Fatti pochi passi si volse a guardare il tubo del pozzo. «Acqua» gli disse don Camillo. «Non sangue. Acqua benedetta». Il giovane riprese il cammino, passò fra i ciottoli roventi del canalaccio, scomparve fra le gaggìe. Don Camillo riempì d'acqua fresca la solita borraccia per innaffiare l'aiuola fiorita sotto la quale riposava in pace il ragazzo assassinato dalla guerra civile. E, mentre riempiva la borraccia, mormorava: «Chi sa mai dove sono andate a finire quelle due lagrime che io poco fa ho visto scivolare nell'acqua!» Ma Dio lo sapeva e fece entrare le due lagrime nella borraccia, assieme all'acqua. Sinfonia di acqua e di fuoco di Mario Palmaro Il sangue non è acqua ricorda, più che una novella, una sinfonia in sei movimenti, ciascuno dei quali sviluppa una precisa riflessione sull'uomo e sul senso del vivere. Una sinfonia nella quale lo scrosciare dell'acqua — come scrive Guareschi — pare una musica. Acqua e fuoco, ristoro e calura sono le due tonalità dominanti che si rincorrono dentro la grande sinfonia della vita e del Vangelo: l'acqua fresca e ristoratrice che Gesù vorrebbe attingere al pozzo di Giacobbe, in un afoso mezzogiorno di maggio della sua terra, e l'acqua viva che la Samaritana domanda al suo misterioso interlocutore. L'acqua che il Bacchi cerca, con ostinazione, nel suo podere rinsecchito, e l'acqua viva che sgorga dalla stessa terra che ha custodito il figlio del professore, in un pomeriggio d'agosto della Bassa. E poi il caldo opprimente. Nella scena del pentimento del giovane assassino, così come nell'incontro fra Gesù e la donna di Samaria, il sole picchia le sue poderose martellate sulle teste degli uomini. Una simbologia che rinvia all'esperienza del deserto, dentro la quale l'uomo, rimasto solo con se stesso, riscopre la sua più vera identità: quella di pellegrino assetato lungo le strade del mondo. Ciò che abbellisce il deserto — scrive Antoine de Saint Exupéry è che nasconde un pozzo in qualche luogo. Guareschi concentra qui tutta la sua "teologia della speranza", che in questo racconto si sublima attraverso il rovesciamento repentino delle apparenze e delle aspettative più "ragionevoli". Giovannino ci insegna che vi è sempre, sul palcoscenico della vita, qualche cosa che "viene dopo", che potrebbe accadere, e che può intervenire a dare un senso a ciò che ne appare del tutto privo. È capitato così alla Samaritana, che quel giorno ritorna al pozzo compiendo il gesto di sempre, di un'intera vita, uguale a ieri e a ieri l'altro. E anche domani, e la prossima settimana, per lei sarebbe stato sempre lo stesso camminare da Sichem fino al pozzo, con la polvere che si appiccica al corpo sudato, il pensiero rivolto alla fresca penombra della casa dove però la attende un uomo, l'ennesimo, che nemmeno la ama. Ma al pozzo, inaspettatamente, quel giorno tutto sarebbe cambiato. Eccolo, finalmente smascherato, il segreto della gioia che si respira a pieni polmoni per le vie di Mondo piccolo: a ogni istante è possibile scoprire un pozzo nascosto dentro il deserto dei nostri giorni. Nella Bassa di Peppone e don Camillo in fondo a ogni pagina può accadere ciò che si legge nella Lettera agli Ebrei: capita che alcuni, praticando l'ospitalità, abbiano accolto degli angeli senza saperlo (cf Eb 13, 2). ln Mondo piccolo si incontrano angeli: nulla a che vedere, per carità, con gli zuccherosi bambocci della New Age, immaginari prestigiatori della felicità; quelli di Guareschi sono autentici "annunciatori" della lieta novella, che non irrompono sulla scena con fragorosi squilli di tromba, ma preferiscono usare il linguaggio della concretezza caro a questa terra. L'unico lessico, del resto, che una testa dura come quella del Bacchi riesca a intendere. Nessuno di noi sa quando possa manifestarsi un simile squarcio di luce nel grigiore della quotidianità, ma è proprio questa nostra "ignoranza inevitabile" che rende importanti tutti i momenti della vita, anche quelli che sembrano senza valore. Così capita in questa storia incredibile — eppure molto più "vera" di quanto si possa immaginare — che prende le mosse dalla fissazione di un uomo come il Bacchi, «che non badava a spese ed era disposto a tutto». Il primo movimento della sinfonia guareschiana si apre con un dialogo, serrato, fra padri "in incognito": da un lato il professore, che ha avuto — ma lo scopriremo soltanto più tardi — un figlio ucciso durante la guerra civile; dall'altra il Bacchi, che un figlio invisibile ce l'ha, ed è il suo podere delle Ghiaie. Un figlio difficile, che non è capace di superare da solo la siccità della malattia, le asprezze del vivere: «... è come se avessi tirato su faticosamente un figlio e poi mi diventasse paralitico nelle gambe». Eppure il Bacchi «non aveva mollato», convinto che, scavando in profondità, nel cuore di quel podere che amava come un figlio, l'acqua della vita doveva esserci senz'altro. «Se mi dicessero che l'acqua è sotto il pavimento della cucina o della stalla» affermava il Bacchi «ci sto a buttar giù la casa e a rifarla da un'altra parte». Il secondo movimento musicale, rapidissimo, dà fiato alla voce della dea ragione, del realismo, della disillusione: alle Ghiaie — Peppone ci si gioca il collo — l'acqua non c'è. Come in certi dialoghi del Vangelo, la nostra ottusa contabilità di uomini, che non sanno spiccare il volo oltre l'apparenza, disegna i confini della realtà giudicata possibile: di qui sono passati trenta rabdomanti — sentenzia Peppone — e non hanno sentito niente, e dunque l'acqua non c'è, non ci può essere. Ed è il preludio al terzo movimento, nel quale l'acqua disvela la sua presenza: ancora non s'è manifestata agli occhi, ma il professore «la sente», e il lettore ormai ha capito che presto la vedrà zampillare. Il Bacchi e il professore sembrano soltanto due padri ostinati, che cercano l'acqua per puntiglio personale; ma Guareschi, con un battito d'ali dei suoi, trasfigura la testardaggine dei due vecchi in fede pura. «L'acqua c'è» sentenzia a un certo punto il rabdomante «... chi ha fede la trova». E al Bacchi quella fede non manca, al punto che trovare l'acqua dentro il ventre delle Ghiaie diventa la missione di una vita: non per l'irrigazione, ma per qualcosa che egli non riusciva a spiegarsi ma che era molto importante. Viene in mente il tenente Drogo di Buzzati, che trascorre la vita nell'attesa di un avvenimento capace di togliere la sete di significato che sta dentro il suo cuore. Ma, mentre nel Deserto dei tartari quell'attesa resta drammaticamente vana, in Mondo piccolo ogni storia narrata si conclude nell'eucatastrofe, nella liberatoria certezza che, alla fine, chi ha cercato trova. E il primo a trovare ciò che da anni stava cercando è, sorprendentemente, il professore: dalla terra rimossa vengono fuori i poveri resti di un giovane soldato ucciso, Cesare Deppi, il figlio del rabdomante. Ed è il quarto movimento, quello della pietà. Guareschi trae qui ispirazione da un fatto realmente accaduto, di cui aveva parlato sulle pagine del Candido del 20 luglio 1952: Il sangue non è acqua apparirà sempre su Candido per la prima volta qualche settimana dopo, il 17 agosto dello stesso anno. Il 28 aprile del 1945 a Rovetta, cittadina delle montagne bergamasche, 43 giovani della Guardia Nazionale Repubblicana vengono fucilati da reparti partigiani. 11 gruppo — per lo più ragazzi fra i 15 e i 18 anni — si era arreso senza combattere due giorni prima, consegnando spontaneamente le armi a un ufficiale dell'esercito che collaborava con gli alleati. Il più giovane fra le vittime si chiamava Carlo Banci, aveva 15 anni ed era addetto al posto di medicazione del battaglione. Guareschi pubblica sul suo giornale la lettera del padre di Carlo, che chiede giustizia per il suo unico figlio, accompagnata dalla testimonianza del parroco di Rovetta, don Giuseppe Bravi, che ha fatto di tutto per impedire la terribile strage, ma senza successo. Una storia straziante che Guareschi decide di gettare in quella finzione così terribilmente vera che è Mondo piccolo. Per una ragione semplice: perché non può finire così, non può accadere che l'odio bestiale sia l'ultimo sigillo della realtà. Bisogna, quella realtà, darla in mano a Peppone e don Camillo, al Bacchi e al professore perché le restituiscano lineamenti umani. È il momento della pietà: il vecchio padre spezza la spirale dell'odio e della vendetta con un atto che non cancella la colpa, ma offre il perdono: «Un'inchiesta? È morto. Ecco tutto. Ora potrà riposare in terra benedetta e sua madre saprà dove inginocchiarsi per piangere». Era questo il "pozzo nel deserto", l'acqua viva che un numero sconfinato di uomini aveva ardentemente desiderato, uomini che Guareschi conosceva bene: i soldati dispersi ai quattro angoli del mondo, le vittime del "triangolo rosso", i prigionieri dei lager. E poi i genitori a casa, le madri e i padri consumati dall'attesa di una parola definitiva, di un posto dove poter andare a posare un fiore e intrecciare il dialogo più vero: quello con i propri morti. Dunque il professore ha trovato la sua acqua, richiamato dal sangue del figlio, ma non dimentica — ed è il quinto movimento — che il Bacchi sta ancora cercando. E l'acqua, abbondante «come un torrente, limpida e fresca», c'è davvero. Quest'acqua ha qualche cosa di speciale perché, come intuisce il Bacchi, essa purifica tutto e lava la terra dalle macchie di sangue e, assieme alle macchie di sangue della terra, va via l'odio dagli animi. Quando la gente di Mondo piccolo prega, va dritta al cuore della fede. Qui, il pensiero del lettore subito corre a un altro passo del Vangelo di Giovanni (19, 34): Uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco e ne uscì subito sangue e acqua. Tutta la creazione si contrae in questi due elementi, segni di un Dio che non ha più nulla da dare per la salvezza del mondo, perché tutto ha dato. Questa salvezza non è una vicenda arcana, diluita negli spazi siderali, ma è quanto mai vicina all'uomo, tanto da segnarne le ore e i giorni, e da essere per ognuno la causa più profonda dell'inquietudine, dell'arsura, della sete di chi vuole un sorso di "acqua viva". Fu così per la Samaritana. È così per il giovane la cui mano ha ucciso, e per il quale l'acqua del pozzo del Bacchi è sangue. La Samaritana desidera ardentemente quell'acqua; il giovane della banda di Peppone ne è terrorizzato, ma insieme attratto. È il sesto e ultimo movimento della sinfonia guareschiana: è l'ora del pentimento. Lo scenario nel quale si svolge il dialogo fra don Camillo e l'omicida ci viene tratteggiato in poche pennellate magistrali, che possono venir fuori solo dalla mano di un grande scrittore: Voi non conoscete i pomeriggi d'agosto della Bassa. Là, in mezzo ai campi deserti, pieni di sole, ogni cosa sa di favola e, se il demonio apparisse scarlatto e ghignante in mezzo a una piana di stoppia bruciata, sembrerebbe la cosa più naturale del mondo. Il diavolo in questa scena c'è davvero, nascosto chissà dove ma furiosamente impegnato a combattere per tenersi stretta l'anima del giovane: il maligno incombe, standosene «accovacciato alla porta», come scrive la Genesi, pronto a ghermire le sue prede. Ma questa volta non può far nulla. Don Camillo agisce bran. dendo l'arma potentissima di un'acqua che è stata benedetta, e per questo motivo insiste affinché il giovane la tocchi, e bagni tutta la sua mano. È la "carnalità" della fede in Cristo, nella quale i sacramenti si rendono presenti attraverso la materia: la potenza dell'infinito si rende manifesta nella — apparente — insignificanza della finitezza di un banalissimo composto di molecole. Eppure, è questa misteriosa potenza a sciogliere la disperazione del giovane in un pianto liberatorio. Le lacrime dell'assassino porteranno alla povera vittima il definitivo sigillo del pentimento: a pensarci bene, sono — le lacrime — qualcosa dentro cui l'acqua e il sangue si danno appuntamento. E, come scrive Guareschi, Dio tutto questo lo sa. Elenco delle fonti Giacomone, da "Candido" n. 4 del 27.1.1952 All'"Anonima", da "Candido" n. 3 del 16.1.1949 Notturno con campane, da "Candido" n. 22 del 31.5.1947 Nel paese del melodramma, da "Candido" n. 30 del 27.7.1952 Le lampade e la luce, da "Candido" n. 5 del 30.1.1949 Sul fiume, da "Candido" n. 21 del 22.5.1949 Mai tardi, da "Candido" n. 11 del 16.3.1952 Giallo e rosa, da "Candido" n. 51 del 21.12.1947 Lo scherzo, da "Candido" n. 6 dell'8.2.1953 Cinque più cinque, da "Candido" n. 28 del 13.7.1947 La trattoria, da "Candido" n. 29 del 19.7.1953 Il sangue non è acqua, da "Candido" n. 33 del 17.8.1952
Scaricare