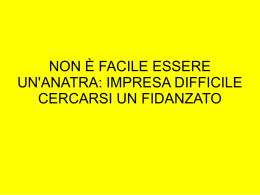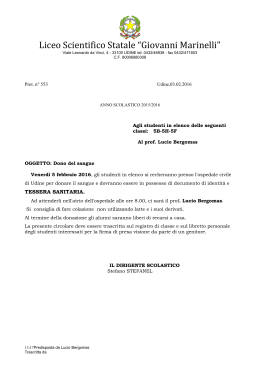Una esigua parte di vita Sono andata a vedere l’acqua. Per me l'acqua si identifica con l'idea di vacanza, anche se quella vera ha l’acqua del mio fiume. La spiaggia era deserta e scura, la superficie sembrava ferma, poi si allargava e si allungava fino al punto in cui si confondeva con il cielo. È incantevole il mare a settembre inoltrato. Il vuoto di persone rende il tempo più lungo e più largo, per far posto a sè. Tra vita, tempo sprecato e tempo vissuto tento sempre di fare chiarezza in astratto. Questo, nel mio intento, voglio che sia tempo 77 vissuto. Tale pensiero, che mi è più frequente nell’antitesi (questa non è vita), si riferisce ad una frase di Seneca che ricordo così: Minima est pars vitae qua vivimus, ceterum non vita est sed tempus, che è poi la dedica ad un libretto di incisioni della Vienna fine Ottocento che mi regalò Lucio, parentesi della mia vita. La sua scrittura esatta è questa: Exigua pars vitae, qua vivimus. Ceterum quidem omne spatium non vita sed tempus est. L'ho riletta in treno, nel volumetto della BUR acquistato alla stazione, avendo dimenticato il ‘De Brevitate vitae’ sul tavolo d’ingresso, così bene in evidenza da non vederlo. Era tempo che lo rileggessi. E capisco che non cambia nulla la mia versione a memoria. Semmai è il concetto di tempo, opaco succedersi di ore, di negozi e di affanni. Il vero tempo Seneca lo chiamava otium, questo sì termine intraducibile nella nostra lingua e sospetto. dove finalmente sono venuta a rendergli giustizia (tu non ti sei degnato di guardare dentro di te, di ascoltarti). Ma per quella frase, scritta da Lucio, io l'ho amato in altro modo, che non è né degno né legittimo, perché l’ho amato per interposta persona, anche se lo conoscevo prima e meglio di lui. E mi rammarico che per tanti anni sia stato Lucio il mio esegeta verso quell’altro Lucio, Anneo Seneca, troppo alto nella sua saggezza perché io, allora giovane e per definizione immortale, fossi consapevole che il tempo, oltre che limitato, è variabile a seconda dell’uso. Quella dedica voleva rappresentare, con parole importanti, il significato del nostro incontro. Continuo a volere che Lucio lo credesse, non importa per quanto tempo. Che ami Seneca, voce del mio doppio e guru inascoltato, qualunque sia il peso che ha avuto sul mio agire, è talmente legittimo e degno che non può che venirmene un effetto positivo, come quello che ha operato qui, Ho incontrato Lucio all’inizio degli anni Sessanta, in una scuola di paese, dove facevamo entrambi il nostro tirocinio di insegnanti. La sede era una vecchia canonica adattata, ma non per questo inefficiente. Ci stavamo bene, ci sentivamo un pò come pionieri, la scuola viveva nel limbo di sempre, ma noi credevamo che contasse il nostro entu- 78 79 siasmo e che il nostro modo un pò ingenuo e non tanto professionale di insegnare fosse riscattato da qualche scintilla che si accendeva. Non avevamo studiato tecniche dell'apprendimento o frequentato un tirocinio pedagogico. Il canovaccio era il nostro precedente percorso scolastico sul quale operavamo, ognuno a proprio modo, le modifiche per quanto non ci era piaciuto. Inoltre eravamo giovani, andavamo spesso al cinema e prendevamo le difficoltà logistiche come un inesauribile set, senza confondere le favole americane con la nostra concreta capacità di arrangiarci. La vecchia canonica adibita all’uso era un edificio a due piani, con belle finestre alte e alti soffitti che davano alle classi un dignitoso respiro. D’estate c’era un'ottima circolazione d’aria, le finestre di dietro erano aperte sui campi. D’inverno, avendo noi una sola stufa per aula e venendo queste accese al mattino e abbandonate all’una, subito dopo le vacanze natalizie la temperatura non saliva oltre i dodici gradi. La bidella, che era il nostro vero capo, si occupava di accendere le stufe, suonava la campanella e rassicurava la Preside sulla nostra puntualità. Abitavamo quasi tutti nello stesso paese, una mia allieva era sua nipote, altri tre ragazzi della sua famiglia stavano in diverse classi, maschili e femminili naturalmente, ancora separate. E poi c’erano il Parroco che era il padrone di casa e copriva le ore di religione, l’insegnante di disegno che abitava di fronte a casa mia e sognava di affermarsi come pittore. Il professore di matematica, invece, proveniva dalla città, era l’unico con una lunga esperienza, principi molto solidi, temuto dai ragazzi. Ogni tanto giungeva all’improvviso, in ispezione, la Preside della scuola media da cui si dipendeva e che aveva sede in città. “Arriva arriva” sibilava la bidella, infilando veloce la testa nelle classi, quando scorgeva la Seicento bianca che sobbalzava davanti all’ingresso. Doveva avere uno strano concetto di noi insegnanti, ma le eravamo tutti grati per la sua protezione. I ragazzi si mettevano all’erta e anche noi, che applicavamo metodi non proprio ortodossi, come quando le lezioni di scienze si svolgevano all’aperto, in giro per i campi del paese, o si andava in latteria a vedere come si faceva il formaggio ed erano i ragazzi che ci istruivano, per non parlare 80 81 delle lezioni di disegno, tutte fuori, tempo permettendo, e quando faceva molto freddo tre classi in una sola stanza. Stavamo studiando l’Iliade, una mattina, e mettendo a punto la recita che ci eravamo inventati. C’erano da assegnare le parti ai maschi, ma avevamo fatto venire anche le bambine, la parte di Elena era la più ambita e così davamo loro il turno, perché Cassandra faceva paura, di Ecuba non sapevano come impostare la voce, e il coro doveva comprenderle quasi tutte per non fare dei torti. Credo che la bidella, quel giorno, abbia ritenuto inutile avvertirci, non avremmo potuto rientrare nei ranghi, la Preside era già sulla porta e ci inchiodò: tre professori e cinquanta ragazzi, ammutoliti. Fummo convocati nella sala insegnanti, sei metri quadri ricavati nel corridoio, in cima alle scale del primo piano, dove per nostra fortuna la temperatura era di poco superiore allo zero non avendo, la sala insegnanti, la stufa. Così ci andò abbastanza bene e i rimproveri furono solo verbali, senza conseguenze peggiori. Anzi, la Preside decise che avrebbe provveduto ad allungare il tempo dell’alimentazione delle stufe in modo che non avessimo più scuse, poi, per quella promiscuità che da un punto di vista didattico poteva generare solo confusione e perdita di tempo. Stabilì che avremmo appeso un termometro in ogni classe e le avremmo comunicato giornalmente la temperatura, con una telefonata puntuale alle nove. Fui io l’incaricata. Ogni mattina, tra la prima e la seconda ora, facevo il giro delle classi e rilevavo i gradi usando una seggiola perché il termometro era stato appeso al chiodo del crocefisso, un pò troppo in alto, ma il Parroco non voleva altri buchi nel muro. Il bollettino meteorologico fu motivo di incontri quotidiani, anche divertenti, finché un giorno ‘più non vi leggemmo avanti’ perché la temperatura diventava meno rigida, era un febbraio secco e pieno di sole, e Lucio prese a parlarmi dei problemi di Mario, un nostro alunno svogliato e irrequieto, e delle difficoltà che aveva in famiglia. Così a Mario fu assegnata la parte di Achille; suo padre, che faceva il lattoniere, ci diede una mano nella realizzazione di elmi e scudi, sua madre ci aiutò a cucire tuniche per la recita che ci stava tanto a cuore e Lucio ed io ci innamorammo. 82 83 Non ricordo - la mia memoria elude con l’oblio - quando fu che Lucio mi disse le parole fatali, forse non me le disse subito o non le disse mai. Ricordo invece due scene, nettamente. La prima, all’uscita dal cinema parrocchiale dove di pomeriggio tenevamo le prove, con i ragazzi che vociavano intorno, i colleghi che dicevano di aver fatto troppo tardi, le auto sgangherate che si mettevano in moto, io che mi avvicino alla Cinquecento blu, infilo le chiavi, apro la portiera (controvento, allora), scarico libri, fogli (la sceneggiatura), la borsa, mi volto per entrare e Lucio che trattiene la porta e mi chiede: “Hai fretta?” “Sì... no.” “Non molta.” Ecco il suo sorriso, sempre appena accennato e appena ironico. “Chiudi la macchina - mi dice - andiamo con la mia a bere qualcosa.” Non risposi, lo seguii. Salendo sulla sua vettura notai un particolare che mi era sfuggito: i mignoli delle sue mani restavano sempre piegati a metà. La seconda è di qualche tempo dopo. Eravamo nel cortile della scuola e il fotografo sistemava le panche per la foto di fine anno. Le bambine erano eccitate, perché di foto allora ne circolavano poche. Le più alte dietro, tu scendi, vieni in prima fila, ecco lei professore venga qui, al centro, anche lei signor Parroco, un momento (dicono le ragazze che la vogliono vicina) manca la bidella, dov’è la bidella? Mi sposto, cercando di fare qualcosa che mi giustifichi, dico: sistematevi un pò, siete tutte in disordine, rassetto un ciuffo, raddrizzo un collettino bianco, mi sollecitano a rientrare e io mi faccio spazio tra Lucio e il collega di francese. Le gambe mi tremano, non lo sfioro neppure, stringo le braccia davanti, il fotografo dice: sorridete! Sarà l’unica immagine stampata che potrò conservare. 84 85 La recita riuscì bene a giudizio di tutti, non parliamo poi dei ragazzi che avevano vissuto quei mesi con eccitazione. Fu così convincente il risultato che la Preside propose delle repliche per le classi seconde di città che vennero trasportate in paese da un pullman noleggiato appositamente. Ma il debutto fu il vero momento felice, non credevamo ai nostri occhi e alle nostre orec- chie. Fino alla prova finale c’era qualcuno che si ingarbugliava o dimenticava le battute, il fondale scivolava di sbieco, il duello tra Ettore e Achille sembrava una parodia di pupi. Quel giorno invece, come per la vera gente di teatro, che sente il pubblico e ne trae la spinta a dare il meglio di sè, tutto si svolse con una convinzione che non si sarebbe più ripetuta. Ettore combatté il duello con la consapevolezza del suo infausto destino mentre Mario infieriva, Achille predestinato e finalmente vincente, per vendicare l’amico perduto e riscattare la sua ingloriosa carriera scolastica. La fine della scuola fu un giorno triste. Le vacanze ci avrebbero separati. Mai vissi le vacanze con tanto desiderio che finissero. Ero al mare con la mia bambina, che quell’estate tolse le rotelle alla bicicletta e imparò a stare in equilibrio su due ruote. Incontrai Lucio, e non per caso, proprio in una di queste strade storte che erano state progettate con l’intento di non rivelare la natura costruita. Era ancora un luogo di grande seduzione la pineta che occultava gli uomini come gli uccelli e gli scoiattoli. Lucio mi chiese di raggiungerlo verso sera, sullo sperone di spiaggia alla foce del fiume, allora abbandonata e deserta. Ci andai, affidando il mio bambino ad una parente con una scusa tanto impacciata e inverosimile da sollevare sospetti sulla mia persona. Non ricordo nulla di quei momenti passati a camminare sulla sabbia, soltanto che era calda sotto i piedi nudi e che il tempo si riduceva, come se già non fossi più lì un attimo dopo esserci arrivata. Lo spreco del presente, che ho praticato tutta la vita, arrivò con Lucio a momenti di totale annullamento. Mi diede una lettera. Arrivata a casa, il mio piccolino reclamava attenzioni, tutti avevano qualcosa da dirmi, 86 87 Gli applausi furono lunghi e sinceri, non importa per quali ragioni. Genitori, fratelli e amici, seduti in platea, avevano motivi diversi per battere le mani, molti di loro non avranno capito granché del dramma rappresentato, ma l’orgoglio di sentire i loro figli capaci di recitare litanie in rima con tanta scioltezza e di compiere gesti rituali oltre la loro goffaggine di adolescenti, li lasciò stupefatti: qualcuno intuì che la loro infanzia era finita. sembrava che due ore di assenza avessero rivoluzionato il mondo familiare e io diedi loro quello che si aspettavano, lavai, asciugai, preparai la cena, ascoltai, risposi, andai a dormire, aspettando nel cuore della notte di potermi chiudere in bagno. La lettera cominciava così: “Elisa mia, sei mia perché sei sempre presente nei miei pensieri...” il resto è bianco, eppure credevo di saperne le parole a memoria, mentre la bruciavo, un anno dopo. Quando la scuola riaprì, alcuni dei colleghi mancavano. Il severo professore di matematica era stato trasferito alla sede centrale, in città. Il professore di disegno, che aveva dipinto la quadriremi dello spettacolo, era stato nominato al liceo. Neppure Lucio c’era, aveva finito la sua esperienza di supplente ed era stato assunto in una grande azienda. C’erano la bidella, il suo caffè delle dieci e i ragazzi, cresciuti come le piante che filano nella bella stagione. Solo un’immagine mi viene incontro, piena di fuoco, i larici del bellunese che Lucio volle portarmi a vedere un giorno d’autunno. Mi disse che voleva regalarmi un giorno diverso e non mi diede neppure un bacio, quel giorno, quasi a riscattare la tristezza degli incontri nascosti. Ebbi anche una vigilia di Natale in stile hollywoodiano. Per tutto il giorno era sceso un leggero nevischio e quando ci incontrammo la neve cadeva così fitta, a fiocchi così grandi che i lampioni facevano fatica ad illuminare le strade, le auto andavano pianissimo e tutto era quasi pronto per fermarsi. Cominciò un periodo di sotterfugi e rivedo immagini oblique: non mi restituiscono nulla delle attese e delle emozioni che traboccavano fino a togliermi il respiro. Infatti, dopo dieci mesi il tempo era scaduto. Che lo spazio per la nostra storia fosse effimero lo sapevo dall’inizio. Non ho mai avuto la percezione di quello che pensasse veramente Lucio del breve e già consumato futuro. Non domandavo, per vigliaccheria. Non facevamo progetti, neppure su quando rivederci. Un senso di fine che per me aveva i connotati del buio, pesava ormai anche sui gesti abituali. Solo una volta, dopo quella vigilia di Natale che segnò il culmine irreale di una storia non reale, mi disse con franchezza 88 89 e inconsapevole crudeltà che non si poteva dare un senso alla nostra vicenda, io una donna sposata e con una figlia, lui che voleva costruirsi una famiglia. Mi stava preparando, come poteva, alla decisione già presa. Ho un’immagine in bianco e nero: sono sola per strada, è sera, fa un freddo di ghiaccio. La fine è stata consumata. Mi sono sempre rifiutata di esorcizzare quel dolore. Voglio bene a quella ragazza straniata che non sapeva dove stare e si sentiva da buttare via. Che scriveva sull’agenda pensieri smozzicati, di una veglia funebre da vivere in silenzio, senza il conforto di amici o parenti, e di una malattia del corpo che la impallidiva come un cero spento. Neppure la mia nonna avrebbe potuto capire. E se lei non poteva capire, avevo commesso un imperdonabile errore. Diceva che si resiste a tutto, ai piccoli come ai grandi dolori. Ma come, non me l’ha mai rivelato. bello e alla luce favorisse la mia voglia di vivere), durante un consiglio di classe che era di una noia mortale per il grigiore dei presenti, il Preside, uomo di esperienza - lo affermava sempre, per questo lo ricordo - si mise a disputare sulle donne, sulle loro fragilità, e finì col parlare di fedeltà e infedeltà, facendo le dovute distinzioni tra quella maschile e quella femminile. Il campionario di banalità espresse con sicurezza avrebbe fatto la fortuna di uno di quegli stupidari non ancora di moda. Poi disse le sue parole definitive: “E per le donne una cosa è certa, il primo tradimento è quello difficile, poi vanno via lisce come l’olio.” Qualche anno dopo, un giorno di maggio (è significativo che fosse maggio, che fiorissero le mie amate rose, che la stagione volgendo al Portarsi dentro, per anni, una storia finita è come viaggiare con una cambiale scaduta che speri ancora di incassare. Neppure i danni di guerra sono previsti se i guasti alle cose non sono dimostrabili, non parliamo di quelli alle persone che se rimangono vive possono ringraziare il loro santo protettore: rimboccarsi le maniche e ricominciare daccapo. È che si perdono anni, prima di sapere esattamente quali sono i diritti che non hai e intanto il 90 91 tempo se ne va. Oggi, però, è una splendente giornata d’autunno. Ci sono colori rossi in un’ultima fiammata, la più accesa prima del cadere delle foglie, tra verdi scuri che si appoggiano sull’azzurro. Posso goderne, senza fretta, senza domani, immersa in questo presente interamente mio. Raccolgo le mie cose, chiudo le finestre e le porte, porto la valigia fino al cancello e lo accosto alle mie spalle. La pineta profuma. “Tu non ti sei degnato di guardare dentro di te, di ascoltarti”, mi ripete il maestro. Poco per volta, maestro. Ho tentato. Ritenterò. 92
Scaricare