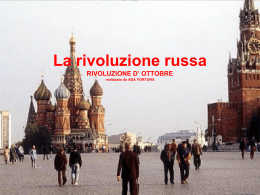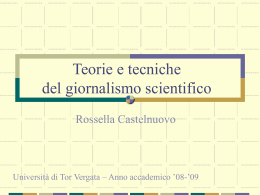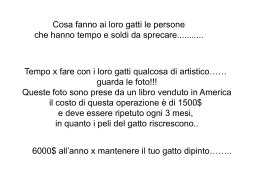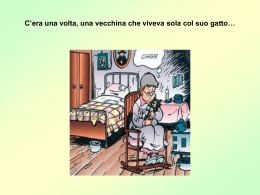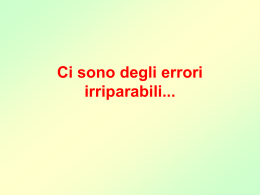CAPITOLO I
1. Introduzione
Negli ultimi anni l’attenzione degli slavisti si è rivolta alla
definizione dei rapporti tra la cultura italiana del primo dopoguerra e
l’interesse nei confronti della Russia e delle culture slave. In tutto ciò ha
avuto fin dall’inizio un ruolo determinante la stampa periodica,
strumento di particolare utilità e importanza prima e dopo l’avvento del
Fascismo, in stretto rapporto con altri organi dell’editoria1.
Particolarmente difficile si presentava alla fine della prima guerra
mondiale la ripresa economica e istituzionale dell’Italia. L’immane
sforzo economico sostenuto negli anni del conflitto aveva prodotto un
enorme deficit, che rendeva impossibile la ripresa a breve termine e,
quindi, la soluzione a una serie di problemi: la crisi industriale, il
reinserimento dei reduci nel lavoro, la corresponsione di risarcimenti e
pensioni, la produzione da riavviare su nuove basi. A tutto ciò si
aggiungeva il senso di malcontento e di insoddisfazione dilagante fra la
popolazione, sempre più delusa dalla nuova realtà del dopoguerra e
incapace di affrontarne le difficoltà. Sul fronte della politica erano
evidenti alcune contraddizioni: da un lato le classi dirigenti italiane
continuavano ad agire avendo come punto di riferimento lo Stato,
identificato col potere esecutivo, dall’altro, nasceva una nuova forza
politica, il partito popolare, che insieme a quello socialista erano la
testimonianza del cambiamento rispetto al passato, ma su base ancora da
definire. La mancanza di partiti politici organizzati e l’assunzione da
parte dei giornali e della stampa della funzione sostitutiva di essi
confermavano, poi, il momento d’instabilità vissuto dal paese2. Tutto ciò
avrebbe di lì a poco contribuito alla nascita del Fascismo. Era necessario
un “ritorno all’ordine”, un restauro dell’assetto sociale e politico
perturbato dalle esperienze avanguardistiche tipiche del periodo
prebellico, culminate nelle sperimentazioni del Futurismo, e per far ciò
bisognava appellarsi alla tradizione. Il lento processo verso la
formazione dello Stato liberale si accompagnava ad un’apertura alle
culture straniere, nel caso specifico, a quelle slave, a cui contribuirono
alcuni importanti avvenimenti di carattere geo-politico: il crollo dei tre
grandi imperi del passato, austro-ungarico, germanico e russo, la
conseguente formazione di nuovi Stati e ‘nazioni’, Polonia,
1
Per approfondimenti rimando a: Eugenio Ragni, Cultura e letteratura. Dal primo
dopoguerra alla seconda guerra mondiale, in Storia della letteratura italiana a cura di
Enrico Malato, Salerno Editrice, pp. 287-435; Luisa Mangoni, Il fascismo. I. Il primo
dopoguerra: le difficoltà di orientarsi in Letteratura italiana. Volume primo. Il
letterato e le istituzioni, Einaudi, pp. 521-548.
2
Cfr. Luisa Mangoni, Op. cit., p. 521.
1
Cecoslovacchia e Jugoslavia tripartita, e l’insorgenza della rivoluzione e
della guerra civile in Russia.
All’inizio del secolo le letterature slave mantenevano ancora un
ruolo subordinato rispetto alle altre culture europee, legato all’attività di
studiosi e traduttori basata sulla mediazione della cultura francese. A
Napoli venne istituita la prima cattedra italiana di lingua russa nel 1836
e a partire dal 1870 si registra in Italia un costante incremento delle
traduzioni italiane di autori russi. In seguito, nonostante il pubblico dei
lettori avesse accolto con entusiasmo le traduzioni dei grandi classici
dell’Ottocento, non veniva ancora riconosciuta una posizione ufficiale a
tale fenomeno culturale, costringendolo ad un ruolo secondario.
Con la Rivoluzione del 1917 l’interesse per la Russia aumentò
sensibilmente, in ambito storico-letterario e soprattutto politico ed
economico, con un incremento di studiosi della lingua e cultura russa e
di pubblicazioni. A. F. Formiggini nel 1918, sul primo numero del
periodico “L’Italia che scrive”, sottolinea la diffusione di traduzioni in
italiano di autori stranieri;3 nel caso specifico degli autori russi e di altri
paesi slavi il fenomeno non è da considerarsi casuale, ma riferito, oltre ai
fatti già accennati, a eventi significativi del panorama culturale: la
nascita di una slavistica accademica e l’apertura dell’editoria italiana alle
culture dell’Europa orientale. E’ qui opportuno analizzare da vicino i
fenomeni.
2. Il contesto culturale
La slavistica accademica in Italia nasce nei primi anni Venti del
Novecento, anche se, a ben vedere, non vi fu una vera svolta nelle
iniziative della politica italiana per aiutare il ceto intellettuale ad
orientare gli studi verso l’Europa orientale. Quanto fu fatto, per
iniziativa un po’ di singoli studiosi e un po’ di singole istituzioni, dette
comunque buoni frutti.4 Come è ben noto, si possono considerare due
eventi come prima tappa del processo di formazione degli studi
accademici. Uno di essi è la nascita nel 1920 di “Russia”, rivista di
Ettore Lo Gatto, la prima in Italia ad essere interamente dedicata alla
Russia, i cui articoli riguardavano questioni letterarie ma anche relative
alla filosofia, all’arte e alla storia del paese, cui si avvicendò dal 1926 la
3
“(. . . ) un bollettino bibliografico mi dice che dal 1914 ad oggi [aprile 1918] sono
uscite almeno una cinquantina di opere letterarie tradotte da tutte le lingue, edite un po’
da tutti i migliori editori italiani”. “L’Italia che scrive”, anno I, n. 1, aprile 1918, p. 8.
4
Sull’’eclettismo’ e il ‘militantismo’ dell’esordiente slavistica italiana e i suoi rapporti
con una slavistica cosìddetta ‘militante’ rimando a: Cesare G. De Michelis, Domenico
Ciampoli studioso di letterature slave, in AA.VV., Domenico Ciampoli, Atti del
convegno di studi. Atessa, 21-22 marzo 1981, Lanciano, Carabba, 1982, pp. 103-121;
Id., Panorama della letteratura russa in Italia, in Vittorio Strada (a cura di), I russi e
l’Italia, Milano, Scheiwiller, 1995, p. 298.
2
“Rivista di letterature slave”. Un’aspetto peculiare di “Russia” era il
numero elevato di traduzioni di prima mano, e in versione integrale, di
testi russi, fino ad allora inediti in italiano5.
Il secondo evento fu l’inaugurazione a Padova della prima
cattedra di Filologia slava, affidata a Giovanni Maver (1891-1970), cui
seguì l’anno successivo la creazione a Roma dell’Istituto per l’Europa
Orientale (I.p.E.O.)6. L’Istituto, presieduto da Francesco Ruffini e
diretto da Ettore Lo Gatto, si proponeva di sviluppare e diffondere con
metodi scientifici gli studi relativi all’Europa orientale e aveva creato a
Roma una sede, dove gli abitanti degli Stati appartenenti a quell’area
geografica, nonché studiosi e interessati al mondo slavo potessero
incontrarsi e conoscersi. A tale scopo fu istituita una biblioteca,
fondamentale per chi intendesse intraprendere studi su basi serie e
documentarie, e successivamente creata una rivista ufficiale dell’Istituto,
“L’Europa Orientale”, trimestrale di letteratura, politica, economia e
società. La rivista comprendeva tre sezioni di studi, dedicate
rispettivamente all’area slava, baltica e ugro-finnica, e assunse fin da
principio un carattere scientifico7.
Analizziamo, adesso, i rapporti tra regime fascista e ricezione della
cultura russa.
3. La ricezione della letteratura russa sotto il Fascismo
Nel periodo compreso fra le due guerre il regime fascista e la
censura di Stato furono decisivi; il governo cercò di estendere il
controllo sulla quasi totalità della produzione editoriale dell’epoca,
applicando una legislazione censoria, che negli anni divenne sempre più
severa. Nell’analisi dei rapporti diplomatici fra l’Italia fascista e
l’Unione Sovietica e delle inevitabili ripercussioni sulla cultura del
tempo è fondamentale distinguere due periodi. Il primo decennio fu
caratterizzato da rapporti di collaborazione economica e intesa
5
Gli studi dedicati a “Russia” sono numerosi. Mi limito qui ad elencare i principali:
Ettore Lo Gatto, La rivista “Russia in “Rassegna sovietica”, 1977, 4, pp. 95-98;
Gabriele Mazzitelli, Gli indici di “Russia”, in Ibid., 1979, 2, pp. 168-182; Id.,
Intervista a Ettore Lo Gatto, in Ibid., 1982, 3, pp. 87-101; Id., La rivista “Russia”
nella storia della slavistica italiana, in “Ibid.”, 1982, 4, pp 147-154. Una guida
bibliografica ai traduttori italiani e russi attivi in questo periodo è, poi, il saggio di
Claudia Scandura Letteratura russa in Italia. Un secolo di traduzioni, Roma, Bulzoni
Editore, 2002, pp. 11-20.
6
Cfr. Jan Ślaski, Giovanni Maver e gli inizi della slavistica universitaria italiana a
Padova, in Rossana Benacchio e Luigi Magarotto (a cura di), Studi slavistici in onore
di Natalino Radovitch, Padova, CLEUP, 1996, pp. 307-329.
7
Per la storia dell’Istituto e della sua attività rimando a: Il fondo I.p.E.O. nella
Biblioteca dell’Istituto di Filologia Slava dell’Università “La Sapienza” di Roma in
Gabriele Mazzitelli, Slavica biblioteconomica, Firenze University Press, 2007, pp. 2549.
3
diplomatica con la Russia, nonostante l’antibolscevismo della politica
mussoliniana, orientata a combattere il suo nemico interno, il
comunismo: questa fase culmina nel “Patto di non aggressione e
amicizia” tra Italia e URSS, firmato a Roma il 2 giugno del 1933. Nel
corso degli anni ci furono diverse occasioni di conoscenza reciproca fra i
due paesi, con una serie di pubblicazioni italiane dedicate alla Russia e
con l’attività divulgativa sulla cultura e la storia russa portata avanti
dall’Istituto per l’Europa Orientale, che, nel frattempo, mantenne un
ruolo centrale nella diffusione delle notizie legate al mondo slavo. La
collaborazione nasceva dalla speranza, da parte italiana, che un accordo
con l’Unione Sovietica avrebbe facilitato l’occupazione dei Balcani8.
A partire dagli anni Trenta i rapporti tra Italia fascista e Unione
Sovietica cambiarono radicalmente. All’apertura diplomatica, che aveva
caratterizzato il periodo precedente, si sostituì una certa diffidenza; la
guerra d’Etiopia, l’intervento in Spagna e l’avvicinamento della
Germania nazista avevano portato l’Italia ad aderire al Patto
Anticomintern nel 1937, una scelta accolta con entusiasmo fra i membri
dell’intelligencija fascista e filofascista, che fino ad allora avevano
considerato la Russia un paese lontano dall’Europa e dall’Occidente.
Tali avvenimenti, però, non ebbero alcun effetto sulla diffusione della
cultura russa in Italia, se non verso la fine del decennio, poco prima
dello scoppio della seconda guerra mondiale, quando, cioè, il
rafforzamento della politica autarchica del regime e la censura di Stato
limitarono in maniera significativa la diffusione delle culture straniere in
Italia9.
Negli anni Venti e nei primi anni Trenta, gli effetti della censura di
Stato nei confronti dell’editoria erano stati piuttosto blandi. Maggiore
controllo venne invece esercitato sulla stampa periodica, totalmente
‘imbavagliata’ dal regime fin dai primi anni. Il panorama era piuttosto
variegato e comprendeva testate autonome e di diverso orientamento
editoriale e ideologico, e altre, completamente allineate col regime se
non, addirittura, dipendenti economicamente da esso. Un ambito in cui
editori e scrittori potevano esprimersi con relativa libertà era quello delle
letterature straniere; la censura, nei primi anni, era rivolta a opere solo
‘esplicitamente’ antifasciste e dai contenuti ‘sovversivi’, che rivelassero
un’ideologia non allineata col Fascismo10. Tuttavia, la letteratura non
8
Per approfondire i rapporti diplomatici Fascismo e URSS rimando a: Giorgio
Petracchi, “Il colosso dai piedi d’argilla”: L’U.R.S.S. nell’immagine del fascismo, in
Ennio Di Nolfo, Romain Raniero, Brunello Vigezzi (a cura di), L’Italia e la politica di
potenza in Europa (1938-1940), Milano, Marzorati, 1985, pp. 151-152; Giuseppe Carlo
Marini, L’anarchia della cultura. Intellettuali e fascismo negli anni Trenta, Roma,
Editori Riuniti, 1983.
9
Cfr. Gianfranco Pedullà, Gli anni del fascismo: imprenditoria privata e intervento
statale, in Gabriele Turi (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea,
Firenza, Giunti, 1997.
10
Nell’ambito della letteratura, una circolare diramata a tutti i prefetti del Regno il 20
maggio 1929 per ordine del ministro dell’Interno Agostino Iraci limitava la
4
restò del tutto fuori dalle mire censorie, soprattutto a partire dal 1934;
una circolare firmata da Mussolini imponeva agli editori di trasmettere
alla Prefettura e al Governo di Roma tre copie di ogni pubblicazione,
pena il sequestro dell’opera ‘incriminata’. Fino a quella data il vaglio dei
libri era stato affidato ai singoli prefetti di provincia, che potevano
impedire la pubblicazione di un’opera considerata ideologicamente
pericolosa ma nessun controllo era previsto da parte delle autorità
romane. Tale misura a carattere generale fu accompagnata da altre due
restrizioni, sempre nell’ambito della letteratura straniera: il divieto per i
giornali di pubblicare in terza pagine romanzi a puntate e la campagna
contro le traduzioni portata avanti dal settimanale romano “Quadrivio”,
diretto da Telesio Interlandi, apertamente schierato col regime, fatti che
di lì a poco sarebbero sfociati nelle azioni di bonifica volute dal
Ministero della Cultura Popolare (Minculpop)11.
Con una circolare ministeriale emanata nel 1938 il Minculpop
instaurava una censura preventiva sulla letteratura tradotta; gli editori
erano, così, tenuti a trasmettere il testo originale dell’opera che
s’intendeva pubblicare ad esclusione dei testi ‘scientifici’ e dei classici
della letteratura. La censura tendeva a colpire maggiormente gli autori
contemporanei. In seguito a tale provvedimento il numero delle
traduzioni dal russo, che aveva registrato un forte incremento nel
quadriennio 1928-1931, continuò a diminuire, fino a raggiungere il
punto più basso nel triennio 1938-1940.
E’ difficile definire con esattezza le ragioni di tale crisi
nell’editoria, anche se certamente possono considerarsi responsabili
l’aumento del prezzo della carta, conseguenza delle sanzioni
internazionali che colpirono l’Italia all’epoca della guerra d’Etiopia e
della crisi economica alla fine della seconda guerra mondiale, e il fatto
che la maggior parte dei classici dell’Ottocento russo erano già stati
tradotti. Non meno difficile è individuare i criteri in base ai quali il
Minculpop sequestrava i testi, anche se recenti studi ne hanno
circolazione di traduzioni di classici russi dell’Ottocento, considerati fortemente
marcati da un’ideologia egualitaria e comunitarista del tutto contraria alla propaganda
del regime. La circolare evidenzia il ruolo svolto dalle case editrici a vocazione
popolare nella diffusione della letteratura russa e apre uno spiraglio sulla ricezione
della stessa fra gli strati popolari. Rimando a: Laurent Béghin, Da Gobetti a Ginzburg.
Diffusione e ricezione della cultura russa nella Torino del primo dopoguerra,
Bruxelles-Rome, Istituto Storico Belga di Roma, 2007, p. 107.
11
Cito da un articolo di Interlandi: “Noi accogliamo troppi francesi, troppi inglesi,
troppi americani, troppi russi: più del decente, se si pensa che non siamo né una
colonia, né un protettorato, né un paese senza letteratura e senza genio. 256 opere
tradotte da lingue straniere, in un trimestre; è troppo. L’Italia finirà coll’imbastardire il
suo gusto”. Vedi Telesio Interlandi, Non abbiamo bisogno, “Quadrivio. Grande
settimanale illustrato di Roma”, X, 24, 8 aprile 1934, p. 1. Per approfondimenti
rimando inoltre a: Patrizia Ferrara, Maria Giannetto, Il Ministero della cultura
popolare. Il Ministero delle poste e telegrafi, in Guido Melis (a cura di),
L’amministrazione centrale pubblica dall’Unità alla Repubblica. Le strutture e i
dirigenti, V, Bologna, Il Mulino, 1992.
5
individuati almeno tre. Il primo, dettato da ragione di ordine morale,
cercava di colpire ogni rappresentazione della donna che si allontanasse
da quella proposta dal regime, che la confinava nel ruolo di moglie e
madre, motivo per cui, ad esempio, fu ordinato il sequestro di La Fossa,
traduzione italiana del romanzo Jama di Aleksandr Kuprin, eseguita da
Ettore Lo Gatto nel 1921, un romanzo per le sue crude descrizioni del
mondo della prostituzione. Il secondo criterio, di ordine politico, veniva
applicato alle opere dal forte contenuto ideologico; tali erano considerati
gli scritti di Lenin, Stalin e Trockij, nonché il romanzo di Maksim
Gor’kij Mat’ (La Madre). L’ultimo criterio era di natura razziale, legato
all’applicazione delle leggi antisemite del 1938 e agli effetti sull’editoria
italiana. Fra i testi russi sequestrati c’è per esempio Il secondo giorno,
traduzione italiana del romanzo dello scrittore di origini ebraiche Il’ja
Erenburg Den’ vtoroj, più una serie di scrittori russi, le cui opere erano
oggetto di censura fra cui Raissa Ol’kienizkaia-Naldi, Grigorij Zinov’ev,
Lev Trockij e Ossip Felyne. Col passare degli anni il numero delle
traduzioni diminuì sensibilmente, nonostante le case editrici
continuassero a pubblicare opere di letteratura russa anche di autori
tradizionalmente invisi al regime come Gor’kij, Berdjaev, Šestov,
quest’ultimo di origine ebraica, e Michail Šolochov, di cui furono
pubblicate due versioni italiane della prima parte di Tichij Don, la prima
eseguita da Maria Rakovska ed Ettore Fabietti per la Bompiani, la
seconda ad opera di Natalia Bavestro per le edizioni Garzanti.
Il vaglio critico dei censori, a cui erano sottoposti i testi, lasciava
però qualche spazio di libertà agli editori; solo dopo la caduta di
Mussolini e con l’avvento della Repubblica Sociale la censura operò un
taglio drastico alle pubblicazioni e, nel contempo, una revisione generale
della produzione editoriale italiana posteriore al 191412.
4. L’editoria
L’attività di riviste e case editrici, nel ventennio 1922-1943, è
chiamata a un costante confronto con la politica del governo, il quale si
valse appunto dell’editoria come strumento privilegiato per la
costruzione del consenso. Fra le case editrici d’anteguerra che
continuavano a pubblicare dopo il 1918 alcune continuavano a licenziare
regolarmente traduzioni di scrittori russi perpetuando la loro attività di
mediazione culturale avviata prima della Grande guerra. Fra le più
operose ricordiamo Treves, Sonzogno e Carabba13.
12
Censura fascista e letteratura russa in Laurent Béghin, Op. cit., pp. 101-119.
Sulla storia dell’editoria italiana si veda: Gabriele Turi (a cura di), Storia
dell'editoria italiana nell'Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 1997; Alberto Cadioli,
Giuliano Vigini, Storia dell’editoria italiana, Milano, Editrice Bibliografica, 2008.
13
6
La milanese Treves, rivolta a un pubblico colto e per molti anni la
casa editrice con la più alta quota di mercato, continuò a pubblicare
versioni dal russo fino a quando, agli inizi degli anni Trenta, mutati i
gusti del pubblico, entrò in crisi e fu assorbita dal consorzio TrevesTreccani-Tuminelli nel 1931, per poi essere acquisita definitivamente da
Aldo Garzanti nel 1938. Molto più costante fu l’attività di Sonzogno,
che nel dopoguerra non smise d’interessarsi agli scrittori russi,
registrando, fra gli altri, il catalogo più ricco di tutta l’editoria italiana
dell’epoca in fatto di letteratura russa. In quegli anni l’autore
maggiormente tradotto dalla casa editrice, rivolta maggiormente a un
pubblico popolare, fu Andreev, e non più Tolstoj come in precedenza,
con ventisei lavori sia di narrativa che di teatro, curati principalmente da
Cesare Castelli e Decio Cinti. Seguono, poi, Dostoevskij, Čechov,
Gogol’, Gor’kij, Puškin e Turgenev. La maggior parte delle traduzioni
venivano eseguite da versioni francesi poco attendibili ad eccezione di
alcune, che, invece, si basavano su testi originali russi14. Le traduzioni
pubblicate da Carabba furono, invece, considerate serie e
filologicamente attendibili: la casa editrice di Lanciano fece tradurre fino
al 1940 più di venti scrittori russi, proponendo accanto ai classici
dell’Ottocento autori meno conosciuti come Griboedov, Ostrovskij,
Majkov e Leskov, più alcuni prosatori contemporanei come Kuprin e
Sejfullina, Bunin e Bulgakov. Con le sue cinquanta versioni dal russo,
Carabba occupava il terzo posto nell’editoria italiana dopo Sonzogno e
Slavia.
Fra le più importanti iniziative editoriali riguardanti la letteratura
russa nel periodo anteriore alla Seconda guerra mondiale si ricorda la
casa editrice fiorentina Vallecchi, che, oltre a pubblicare diverse riviste
letterarie, “Leonardo”, “La Voce”, “Lacerba” e “Il Selvaggio”, stampò
venticinque volumi di autori russi, soprattutto negli anni Venti e Trenta,
giovandosi della collaborazione di validi traduttori come Clemente
Rebora, Carlo Grabher, Ettore Lo Gatto, Enrico Damiani, Boris
Jakovenko. Meno rilevante fu, invece, l’attività di traduzione dal russo
di altre grandi case editrici fiorentine sorte prima della Grande Guerra
come Bemporad, il cui nome fu arianizzato in “Marzocco” dopo le leggi
razziali del 1918, Salani, Sansoni, e la milanese Mondadori, che dal
1926 al 1942 pubblicò solo ventuno titoli di autori russi. Fra le case
editrici popolari più attive del dopoguerra, oltre alla già menzionata
Sonzogno, si ricordano Bietti e Bairon, specializzate nella divulgazione
di traduzioni economiche di romanzi stranieri; il successo editoriale del
settore, dovuto soprattutto ai bassi costi per la pubblicazione di un’opera
straniera rispetto ad una italiana, si manifesta già alla fine dell’Ottocento
14
Mi riferisco, fra gli altri, a Federigo Verdinois, prima della guerra, Piero Gobetti e
Ada Prospero negli anni Venti e Rinaldo Küfferle negli anni Trenta.
7
e si protrae fino al dopoguerra, favorendo la diffusione in Italia dei
romanzi d’appendice15.
Un posto di rilievo nel panorama editoriale italiano fra le due
guerre spetta a “Slavia” (“Società editrice di autori stranieri in versioni
integrali”), fondata a Torino nel 1926 da Alfredo Polledro16, sua moglie
Rachele Gutman e l’avvocato Mario Lorenzoni. L’editrice inaugurò in
nove anni quattro collane: “Il Genio Russo” (1926), “Il Genio Slavo”
(1928), ”Scrittori Slavi” (1929) e “Occidente” (1931)17. “Il Genio
Russo” iniziò nel 1926 con la pubblicazione de I Fratelli Karamazov,
tradotto dal russo da Alfredo Polledro18. La collana era dedicata alla
letteratura russa dell’Ottocento e proponeva opere in versione integrale
di Dostoevskij, Tolstoj, Turgenev, Gogol’ e Čechov. Ad ognuno dei
prosatori citati corrispondeva una serie specifica. L’intenzione di
Polledro era quella di mettere la cultura italiana al livello delle altre
nazioni europee per quanto riguarda la conoscenza della letteratura
russa, proponendo versioni dal russo. Dal 1926 al 1934 furono pubblicati
in totale trentanove titoli, in particolare nove opere di Dostoevskij,
undici di Tolstoj, otto di Turgenev, tre di Gogol’ e otto di Čechov.
“Il Genio Slavo” si ispirava agli stessi criteri della prima collana,
con la differenza che vi si pubblicavano scritti di autori russi e di altri
paesi slavi, suddivisi in cinque sezioni: russa, con la sezione speciale
intitolata “Narratori sovietici”; polacca; cecoslovacca; serba, croata e
slovena; bulgara. Di fatto, però, la nuova collana si rivelò un
completamento de “Il Genio Russo”, dal momento che gran parte delle
pubblicazioni si riferivano alla cultura russa. “Il Genio Slavo” aveva due
precisi obiettivi: colmare la scarsa conoscenza in Italia delle letterature
slave e promuovere la cultura di un’area geografica, l’Europa orientale,
15
Cfr. Giovanni Ragone, Editoria, letteratura e comunicazione, in Alberto Asor Rosa
(a cura di), Letteratura italiana. Storia e geografia. Volume III. L’età contemporanea,
Torino, Einaudi, 1989, p. 1073.
16
Nei due panorami degli studi slavistici in Italia (Ettore Lo Gatto, Gli studi slavi in
Italia, in “Rivista di letterature slave”, Anno II, fasc. II, settembre 1927 e Giovanni
Maver, La slavistica italiana nel decennio passato e i suoi compiti futuri, in “Rivista di
letterature slave”, Anno VI, fasc. I-III, gennaio-giugno 1931) a Polledro veniva
riservato il posto di primo editore. La slavistica italiana, nonostante i contatti iniziali
con personaggi come Piero Gobetti e Leone Ginzburg, i quali avevano un rapporto
organico con il resto della cultura nazionale, ha avuto sempre la tendenza a configurarsi
come un settore chiuso e specialistico, riservato a pochi adepti. Col passare degli anni
si era instaurato un dialogo fecondo tra gli specialisti, che andavano fondando a livello
accademico la disciplina, e una cultura parallela definita ‘militante’.
17
La collana “Occidente”, diretta dal figlio Alfredo Polledro, Luigi, era dedicata alla
pubblicazione di opere narrative e drammatiche moderne di autori provenienti da una
larga area geografica, che comprendeva l’Europa, ad esclusione dei paesi slavi, e le due
Americhe. Cr. Laurent Béghin, Op. cit., p. 280.
18
Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamàzov, romanzo in quattro parti e un epilogo, unica
versione integrale e conforme al testo russo con note di Alfredo Polledro, 4 voll.,
Torino, Slavia, 1926, “Il Genio Russo”, 1-4, serie I, 1-4, 1926.
8
con cui recentemente Mussolini aveva stretto legami di amicizia e
collaborazione, in linea con l’ambizioso progetto di espansione politica
dell’Italia in Europa e nel mondo. Nel 1929 la casa editrice varò
“Scrittori Slavi”, terza collana di studi critico-biografici dedicata agli
autori già ospitati nelle precedenti collane, di cui la stessa doveva essere
complemento.
Gli studi dedicati alla storia di Slavia hanno spesso evidenziato il
legame della casa editrice con la cultura torinese contemporanea: da una
parte l’esperienza gobettiana, da cui sembra in qualche modo prendere
forma, dall’altra l’iniziativa einaudiana di cui costituirà uno dei canali di
accostamento alla letteratura russa19. Nell’editoriale del primo numero
Polledro afferma che le opere degli scrittori russi sono patrimonio
dell’umanità, conosciuto in Europa occidentale grazie al volume di
Eugène-Melchior de Vogüé sul Roman russe del 1886, e condanna
fermamente tutte quelle pratiche traduttive, dubbie e fuorvianti, nate
sulla base della mediazione francese, di cui si è già parlato:
[La nostra colpa] è consistita innanzitutto nell’accettare a occhi
chiusi le traduzioni in ogni modo deturpate e mutile che di Dostoevskij e
degli altri sommi russi ci venivano di Francia: traduzioni arruffianate
secondo il capriccio della moda parigina, condite con le droghe e i
pigmenti della cucina letteraria franciosa, depauperate in cambio di
20
sostanza vitale e di originalità .
L’idea, piuttosto diffusa, del primitivismo degli autori russi, in
particolare di Dostoevskij, era diventata un parametro per sancire una
diversità che si interpretava in termini di inferiorità culturale e che,
pertanto, autorizzava a intervenire sui testi, manipolandoli e
omologandoli alla cultura di arrivo, adeguandoli ai parametri
dell’Europa occidentale. In Italia, in una situazione di dipendenza
culturale rispetto alla Francia, tutto questo si riproponeva costantemente,
sia con la circolazione di testi in francese, che venivano puntualmente
recensiti sui più importanti periodici letterari, sia con la pubblicazione di
versioni italiane dal francese pubblicate all’interno di collane rivolte a
un ampio pubblico di lettori. Era stato il caso di Sonzogno, e
prim’ancora di Treves, che nella collana “Biblioteca Amena” aveva
pubblicato i romanzi di Tolstoj e Dostoevskij, ritraducendoli dal
19
Per approfondimenti sulla storia della casa editrice rimando a: Piero Cazzola, La
casa editrice “Slavia” di Torino, antesignana delle traduzioni letterarie di classici
russi negli anni Venti-Trenta, in Aa. Vv., La traduzione letteraria dal russo nelle
lingue romanze e dalle lingue romanze in russo. Contributi al Convegno di Gargnano,
settembre 1978, Milano, Cisalpino-Goliardica,1979, pp. 506-515; A. D’Orsi, Fra
Gobetti ed Einaudi. L’editoria giovane torinese, “Piemonte vivo”, novembre 1988, pp.
12-22; Sergio Adamo, La casa editrice Slavia, in Luisa Finocchi, Ada Gigli Marchetti
(a cura di) Editori e lettori. La produzione libraria in Itala nella prima metà del
Novecento, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 53-98.
20
Vedi A. Polledro, Presentazione, in Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, 1926,
vol. I, p. VI.
9
francese, spesso lasciando intatte le presentazioni fatte da Vogüé ma con
qualche variazione del testo fonte. Alcuni traduttori dichiaravano di
tradurre direttamente dal russo, ma fino a quando non si sviluppò in
Italia una scuola autonoma di slavistica la conoscenza di questa lingua
era generalmente molto scarsa. Ciò, purtroppo, contribuì non poco a
mantenere vive pratiche traduttive che legittimavano un accostamento
superficiale al testo. Presentando “Il Genio Russo”, Polledro aveva
espresso la necessità di una “corretta esegesi” testuale e aveva preso atto
con soddisfazione del crescente numero di traduttori preparati e
competenti. Con Polledro sembrava, così, imporsi il paradigma di un
editore impegnato in una progettualità culturale seria e rigorosa, scandita
dall’impegno costante, in cui si poteva riconoscere l’editore ideale di cui
parlava Piero Gobetti21.
Sarebbe sbagliato sostenere che dopo la rivoluzione d’ottobre la
letteratura russa fu recepita esclusivamente in funzione del bolscevismo
e dell’antifascismo, né si può interpretare l’iniziativa di Polledro come
un esplicito schieramento politico; basti pensare che le scelte dei classici
operate nell’Italia fascista coincidevano quasi sempre con quelle fatte in
Unione Sovietica negli anni Venti e Trenta. Slavia mirava a valorizzare
il testo nella lingua originale e le traduzioni in italiano venivano sempre
considerate nuove creazioni, che cercavano di mantenere le peculiarità
dell’originale. Ad esempio, l’abitudine di aggiungere ad ogni volume
tradotto una tabella con la spiegazione dei criteri di trascrizione adottati,
la pratica frequente di non tradurre i termini che non avevano un
corrispondente diretto in italiano, ma facevano riferimento al contesto
culturale di partenza, l’adozione di uno stile che riproducesse quanto più
possibile la sintassi del russo, confermano l’attenzione di Slavia a
preservare il testo.
Con la traduzione de I fratelli Karamazov Polledro aveva in
qualche modo dettato i parametri, a cui si sarebbero attenuti gli altri
collaboratori; l’obiettivo era quello di riuscire ad articolare l’accettabilità
del testo all’interno della cultura italiana tramite la valorizzazione del
contesto di partenza. La strategia contrastava con l’affermazione
dell’italianità inseguita dal Fascismo e di ciò si accorse ben presto la
stampa vicina al regime, che avviò una serie di attacchi alle scelte
editoriali di Slavia. Nel 1930 la rivista “Il popolo di Roma” pubblicò un
intervento dal titolo Che c’importa del genio slavo?:
Bisogna pensare che i cinque massimi scrittori che
costituiscono la grande letteratura russa del secolo scorso erano già
conosciutissimi in Italia attraverso centinaia di traduzioni in milioni di
copie. Queste traduzioni della “Slavia” saranno complete, ma sono in un
italiano piuttosto dubbio e molto compassionevole […] E’ molto utile
21
Vedi A. Polledro, Op. cit., p. XI. Sulla biografia di Piero Gobetti (1901-1926)
rimando a Paolo Spriano, Gramsci e Gobetti. Introduzione alla vita e alle opere,
Torino, Einaudi, 1977. Per gli scritti dedicati alla Russia vedi Gli scritti sulla Russia, in
Laurent Béghin, Op. cit., pp. 171-209.
10
secondo noi conoscere le letterature straniere, specialmente nei loro
capolavori essenziali, ma base fondamentale della cultura di ogni italiano
deve essere la letteratura nostra la quale non ha nulla da invidiare a
nessun’altra, anzi per quanto si studi e si conosca si trovano sempre in essa i
fondamenti delle letterature d’ogni paese con in più la luce del Genio
latino22.
Al contrario, sulla stampa non specializzata la casa editrice aveva
già ricevuto ampio consenso, un’attenzione che Polledro aveva suscitato
e pianificato con l’invio di libri-omaggio e la distribuzione di cataloghi e
di materiale pubblicitario. Nel 1927 la rivista “Nuova Antologia” aveva
ben accolto l’uscita dei primi sei volumi di “Il Genio Russo”,
sottolineandone la novità, e nelle pagine de “La Cultura” Enrico
Damiani aveva parlato di una grande opera editoriale dedicata alla
letteratura russa23. Tra i primi periodici a dare la notizia della prima
versione integrale de I fratelli Karamazov era stata la “La Fiera
letteraria”24, seguita, appunto, da “La Cultura”, con un crescente
interesse verso Dostoevskij, sfociato più tardi nei numerosi articoli
dedicati al cinquantenario della morte dello scrittore25.
Fino alla fine del conflitto mondiale, il mercato del libro aveva
continuato a soffrire duramente a causa di una crisi iniziata già a fine
Ottocento. Essa era insorta da un lato in forza dell’incremento delle
tirature di giornali e quotidiani; dall’altro a causa della forte
importazione di cultura straniera. Inoltre, la situazione del settore
editoriale italiano era frammentaria e disomogenea, con una
preponderanza al nord del paese di case editrici26. La nascita o il
rinnovamento di molte di esse e l’attività di nuovi giovani intellettuali,
attraverso la pubblicazione di numerose collane dedicate alle traduzioni
di libri stranieri, s’impose nonostante le censure del potere, che tuttavia
promosse e stimolò molte attività culturali, pur condizionandole alla
propaganda e alla dottrina. Venti di novità e suggestioni esterne
riuscirono comunque a penetrare nella penisola, innovando una
tradizione culturale e letteraria, legata al secolo precedente e ai suoi
protagonisti. I lettori italiani vennero così sensibilizzati rispetto ad
avvenimenti, che accadevano in realtà politico-culturali poco conosciute,
come quella russa. Ciò avvenne in primo luogo con la letteratura di
guerra, la rivoluzione russa e altre realtà dell’Europa centro-orientale,
venute alla ribalta attraverso i resoconti degli avvenimenti bellici da
poco cessati, attraverso saggi e traduzioni di romanzi, inizialmente più
22
M. Carli, Che c’importa del “genio” slavo?, “Il popolo di Roma”, anno VII, s. II, n.
155, 1 luglio 1930, p. 3.
23
Cfr. “La Cultura”, anno IX, fasc. II, febbraio 1930.
24
Cfr. “La Fiera letteraria”, anno II, n. 44, 31 ottobre 1926.
25
Vedi Bibliografia ragionata.
26
Enrico Decleva, Un panorama in evoluzione, in Storia dell’editoria nell’Italia
contemporanea, a cura di Gabriele Turi, Maria Iolanda Palazzolo et alii, Firenze,
Giunti, 1997, p. 248.
11
liberi e poi sempre più condizionati dall’ideologia e dalla politica
fascista. Il pubblico dei lettori, molto più ampio, diversificato e colto
rispetto al secolo precedente, era desideroso ormai di leggere le opere
straniere in forma corretta e completa, rifiutando traduzioni mutilate e
grezzamente adattate come nell’Ottocento. A ciò avrebbe di lì a poco
contribuito anche l’istituzione delle prime cattedre universitarie,
dedicate all’insegnamento delle lingue e letterature slave.
Per la letteratura russa, un vero e proprio interesse si risvegliò nel
pubblico italiano e negli intellettuali fin dall’inizio degli anni Venti; gli
autori del periodo pre-sovietico, già considerati “classici”, ebbero
maggiore risonanza e diffusione. Si tese, poi, a recepire i rivoluzionari
contemporanei sotto una categoria unitaria, saldamente legata alla nuova
realtà politica dell’URSS27.
Sulla presenza di articoli dedicati a questi autori e, più in generale,
alle culture slave in alcune riviste italiane del periodo è dedicato il
capitolo successivo.
27
Cfr. G. Tortorelli, La letteratura straniera nelle pagine de “L’Italia che scrive” e “I
Libri del Giorno”, in Ada Gigli Marchetti, Luisa Finocchi, Stampa e piccola editoria
tra le due guerre, Milano, FrancoAngeli, 1997, pp. 157-160.
12
CAPITOLO II.
I periodici
Analizzeremo ora un gruppo rappresentativo di riviste italiane di
ambito storico-letterario attive nel periodo compreso tra il 1918 e il
1940. Esse sono: “L’Italia che scrive”, “I libri del giorno”, “Leonardo.
Rassegna mensile della coltura italiana”, “La Cultura”, “La Fiera
letteraria”, “La Nuova Italia”, “Lo Spettatore italiano”, “Critica
fascista”, “Pegaso”, “Pan”, “Quadrivio”, “Solaria”. L’indagine, condotta
attraverso un censimento sistematico di tutte le annate, sia delle riviste
culturali, sia delle ‘rassegne bibliografiche’, porta in primo piano
principalmente l’attività pubblicistica dei ‘padri fondatori’ della
slavistica italiana come Ettore Lo Gatto, Giovanni Maver, Enrico
Damiani28 e Aurelio Palmieri29, autori di elzeviri, recensioni, saggi, e di
alcune altre personalità della cultura italiana; le informazioni ottenute
dallo spoglio delle riviste hanno permesso apprezzarne lo sviluppo anche
nell’autarchica epoca fascista, con una immutata predisposizione da
parte del pubblico di lettori a recepire messaggi, mode e novità, in
ambito letterario, provenienti dall’estero30.
In questo periodo l’attività pionieristica di Ettore Lo Gatto è quasi
solitaria: soltanto nella seconda metà degli anni Venti, diventando
28
Tra i padre fondatori della slavistica italiana insieme a Ettore Lo Gatto e Giovanni
Maver, nonché studioso di letteratura russa, polacca e bulgara, Damiani autore del
volume Avviamento agli studi slavistici in Italia, uscito nel 1941, utile strumento per
chi sia interessato alla storia della slavistica italiana. Rimando a: Enrico Damiani. Un
profilo bibliografico, in Gabriele Mazzitelli, Op. cit.,pp. 93-98.
29
Teologo e orientalista, Palmieri conosceva un’incredibile quantità di lingue, tra cui il
russo, il polacco e il neogreco, frutto di frequenti soggiorni all’estero, e fu direttore per
la sezione slava dell’I.p.E.O. Su Palmieri esiste un’ampia bibliografia, mi limito qui ad
alcuni riferimenti: Bibliografia degli scritti di Aurelio Palmieri a cura di Ettore Lo
Gatto, “L’Europa Orientale”, 10-11, 1926; S. Mercanzin, Aurelio Palmieri e il suo
contributo alla conoscenza dell’Oriente cristiano e in particolare della Chiesa russa.
Un pioniere dell’ecumenismo (dissertazione), Roma, PIO, 1988; G. M. Croce, André
Szeptyckyj et Aurelio Palmieri d’après leur correspondance inédite (1907-1914), in
Eukosmia. Studi miscellanei per il 75° di Vincenzo Poggi S.J. a.c. di V. Ruggieri e L.
Pirelli, Soveria Mannelli, 2003, pp. 159-168 – La Badia greca di Grottaferrata e la
rivista “Roma e l’Oriente”. Cattolicesimo e ortodossia fra unionismo ed ecumenismo
(1799-1923), Città del Vaticano, 1999, vol. II, pp. 15-25; Andrzej Zieliński, Paolo
Emilio Pavolini e Aurelio Palmieri, due grandi polonofili italiani, in Le letterature
straniere nell’Italia dell’entre-deux-guerres. Atti del Convegno di Milano 26, 27
febbraio e 1 marzo 2003, a cura di Edoardo Esposito, Lecce, PensaMultimedia, 2004,
pp. 255-268.
30
Cfr. Lucia Tonini Steidl, La divulgazione della cultura russa in Italia: letture e
lettori al Gabinetto G. P. Vieusseux, in: Editori e lettori. La produzione libraria in
Italia nella prima metà del Novecento, a cura di Luisa Finocchi e Ada Gigli Marchetti,
Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 297-298.
13
professore, troverà colleghi, coi quali condividerà parte degli studi31.
Naturalmente, i presupposti che favorirono tale fortunata attività
pubblicistica si ridussero progressivamente dopo il 1925. Pur
continuando, infatti, a mantenere rapporti commerciali e diplomatici con
la Russia, in Italia si condannò il pensiero sociale e politico proveniente
dal paese dei Soviet, finendo per ‘fascistizzare’ testate e periodici in
tutto il paese. Proprio in quell’anno Lo Gatto inaugurò due importanti
progetti editoriali di studi slavistici su riviste specializzate come
“L’Europa Orientale” e “Rivista di letterature slave”, concludendo la sua
prima fase di approccio sperimentale, essenzialmente autonomo e
autodidatta, alla slavistica. Per accedere ai libri russi in lingua,
difficilmente reperibili, o in traduzione francese e inglese, lo slavista
utilizzò inizialmente mezzi ad immediata disposizione come il Gabinetto
Vieusseux di Firenze32, ricco di una selezione articolata di opere russe in
francese, tra cui scritti politici di Gor’kij, Kerenskij, pagine di
memorialistica dell’emigrazione e dell’“esilio bianco”, scritti filosofici
di Solov’ëv e Berdjaev nonché opere di nuovi autori come Babel’,
Erenburg, Zamjatin, Kuprin e Andreev. Attraverso l’Istituto per l’Europa
Orientale, Lo Gatto potè compiere viaggi in Polonia, Cecoslovacchia e
Jugoslavia, vivendo da protagonista molte vicende legate alle relazioni
italo-russe33.
I primi a lodarne i meriti furono Giovanni Papini, Giuseppe
Prezzolini, Piero Gobetti, Clemente Rèbora, Giovanni Maver, il filosofo
Augusto Guzzo e il musicista Vittorio Gui; la sua fama fu dovuta oltre
che ai lavori di natura divulgativa, ai saggi e alle monografie pubblicate
in quegli anni e le sue traduzioni, lodate dall’amico ed editore Alfredo
Polledro, superavano vecchi stereotipi delle tesi ottocentesche del De
Vogüé, che condizionavano ancora le politiche culturali ed editoriali in
Francia e in Italia, considerando “primitivi” gli scrittori russi e così
giustificando rielaborazioni e infedeltà traduttive nell’approccio alle loro
opere. Polledro, inoltre, stimò sempre Lo Gatto per le sue capacità di
retto interprete della lingua russa, la cui attività di traduzione, secondo
31
Cfr. Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Vedi infra.
I volumi custoditi dall’Archivio Storico del Gabinetto Vieusseux di Firenze si
rivelarono di straordinaria importanza per la diffusione della cultura russa alla fine
dell’Ottocento. Rimando a Lucia Tonini Steidl, La divulgazione della cultura russa in
Italia: letture e lettori al Gabinetto G. P. Vieusseux, in Editori e lettori, cit, pp. 282298.
33
Si vedano: Sergio Adamo, Op. cit., p. 88; Gabriele Mazzitelli, Le cinque annate di
“Russia”, “Rassegna sovietica”, 34 (1983), n. 2, p. 164; Vittorio Strada, Il fascino
slavo, in: Storia dell’editoria d’Europa, Secondo Volume, Firenze, Shakespeare &
Company Futura s.r.l., 1994, p. 122; Gianfranco Tortorelli, L’Italia che scrive (Op.
cit.), p. 83; Nicola Tranfaglia, Vittoria Albertina, Storia degli editori italiani.
Dall’Unità alla fine degli Anni Sessanta, Bari, Gius. Laterza & Figli 2007, p. 324.
Ettore Lo Gatto, Op, cit., p. 12 e Sante Graciotti, A Lo Gatto, il suo istituto di slavistica
di Roma, in Studi in onore di Ettore Lo Gatto, cit., p. XXIII.
32
14
un apprezzamento di Vjačeslav Ivanov, era “non solo fedele ma anche
artistica”34.
Tornando alle riviste, se “Russia” influì nel diffondere
direttamente le ricerche logattiane in ambito specialistico, la
collaborazione a periodici come “I libri del giorno”, “L’Italia che scrive”
e “Leonardo. Rassegna mensile della cultura italiana” rese il nome del
russista noto a un pubblico più vasto, contribuendo, almeno in Italia, alla
sua affermazione di studioso. Tale esperienza costituì per Lo Gatto
l’occasione di mettere a frutto il lavoro svolto durante il suo primo
decennio di ricerche, offrendo ai lettori un compendio degli studi
specialistici pubblicati su “Russia” e maturati nell’ambito dell’attività
culturale presso l’I.p.E.O.
Procedo, dunque, con l’analisi delle singole riviste, inserendo alla
fine alcuni grafici esemplificativi, che forniscono al lettore un quadro
d’insieme.
LE RIVISTE DI RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
1.“L’Italia che scrive” (1918-1938)
Il primo gruppo di riviste oggetto della nostra analisi è quello dei
‘bollettini bibliografici’ tra i quali un posto di rilievo merita senz’altro
“L’Italia che scrive. Rassegna per coloro che leggono”, diretta dal 1918
al 1938 da Angelo Maria Formiggini, modenese di origine ebraica che,
sulla base di studi eclettici, cercava percorsi editoriali alternativi rispetto
alle consolidate esperienze di altre case editrici attive nel nord Italia35. Il
programma della rivista era stato presentato da Formiggini un anno
prima della sua pubblicazione al “Congresso del Libro” tenutosi a
Milano nel 1917, poi confermato in un bollettino editoriale del febbraio
1918. L’esordio, ripetuto ogni anno dal direttore e pubblicato sull’intera
prima pagina della rivista, conteneva in sintesi i principi su cui il
periodico si fondava: il legame tra il libro e la vita culturale della
nazione, dove l’editoria occupava una posizione rilevante; la
collaborazione tra quanti vivono per il libro – autori, editori, librai, detti
“operatori del libro” – e i “consumatori”, cioè il pubblico di lettori; il
tentativo di colmare una lacuna informativa nell’editoria italiana
offrendo una rivista bibliografica ampia negli intenti e nei risultati,
capace di stimolare nuove energie36.
34
Enrico Decleva, Op. cit., p. 285.
Uno studio sulla rivista è stato eseguito da Sara Mazzucchelli nella sua tesi di
Dottorato La letteratura russa in Italia nell’editoria dell’entre-deux-guerres (19191939), Milano 2005.
36
Cfr. A. F. Formiggini, Esordio, “L’Italia che scrive”, anno I, n. 1, aprile 1918.
35
15
La rivista risentì fortemente del difficile momento attraversato
dall’Italia nel primo dopoguerra: il passaggio alla dittatura, la
riorganizzazione dello stato fascista, le leggi speciali del 1925, la
persecuzione razziale. Fra i collaboratori si ricordano Ernesto Buonaiuti,
Giuseppe Prezzolini, Felice e Attilio Momigliano, Ettore Lo Gatto,
Domenico Fava e Marino Parenti, di cui parla lo stesso Formiggini al
termine dell’annata 1938 nell’Indice sintetico (1918-1938), suddiviso in
varie sezioni: ‘profili’, ‘case editrici italiane’, ‘istituti di cultura’,
‘articoli vari’, ‘miniera aneddotica’, ‘confidenze degli autori’,
‘istantanee allo specchio’ e ‘recensioni’.
Il nucleo centrale del bollettino era rappresentato dalla rubrica
‘Notizie bibliografiche’, che costituiva il motivo stesso per il quale la
rivista era stata concepita. Col procedere delle annate aumentarono i
profili di letterati e critici della letteratura, mentre furono drasticamente
ridotti quelli relativi a uomini politici e intellettuali impegnati nella vita
civile; tale fenomeno era probabilmente dovuto alle evidenti difficoltà,
in piena era fascista, di pubblicare in prima pagina, e in una rivista con
un’alta tiratura come questa, articoli su personaggi del mondo politico37.
La presenza sulle sue pagine di Franco Ciarlantini, scrittore,
organizzatore nel 1925 del Congresso degli editori e, per alcuni anni,
portavoce del regime, può considerarsi un segnale dell’influenza del
Fascismo nelle scelte editoriali del periodico38.
Sul primo numero de “L’Italia che scrive” Formiggini presenta la
rubrica ‘Letterature straniere in Italia’, che avrà un posto in tutti i numeri
successivi:
La guerra sorprese l’Italia nel pieno svolgimento di una febbrile
attività per la rievocazione dei suoi valori culturali. Erano sorti nuovi
editori […] E naturalmente, poiché la produzione patria non poteva già
più bastare alle moltiplicate esigenze del pubblico, s’importava dalle
letterature straniere: non sempre il meglio, purtroppo, ma […] molti
capolavori ignorati o mal noti riuscivano a oltrepassare i confini e a
trovare degna veste italiana39.
Nello stesso articolo si sottolinea anche il fatto che, pur nelle
difficoltà determinate dalla guerra, il processo di diffusione delle
letterature straniere in Italia non si era arrestato completamente e nel
periodo 1914-1919 un bollettino bibliografico riportava il dato di:
37
Sui rapporti di Formiggini con gli editori, la Società generale delle Messaggerie
italiane e la Lir (Librerie italiane riunite) rimando a: Editoria e storia dell’editoria
negli articoli di Angelo Fortunato Formiggini in Gianfranco Tortorelli, L’Italia che
scrive 1918-1938. L’editoria nell’esperienza di A.F.Formiggini, Ed. FrancoAngeli,
1996, pp. 35-49.
38
Rimando a: Dal 1925 al 1938: i conti con il regime fascista in Gianfranco
Tortorelli, Op. cit., pp. 49-55.
39
Cfr. ‘Letterature straniere in Italia’, ”L’Italia che scrive”, anno I, n. 1, 1918, p. 8.
16
almeno una cinquantina di opere letterarie tradotte da tutte le
lingue, edite un po’ da tutti i migliori editori italiani40.
Tra il 1918 e il 1919 sono rari i riferimenti alla letteratura russa e,
quando ci sono, si limitano a titoli citati nella rubrica ‘Recentissime’; a
partire dal 1920, con una certa regolarità, si incontrano titoli di autori
russi tradotti, e non solo qui ma anche, e con un sempre maggiore
spazio, nella rubrica ‘Notizie bibliografiche – Letterature straniere in
Italia’, in cui vengono pubblicati interventi e recensioni di alcuni dei
maggiori conoscitori ed esperti di letteratura russa dell’epoca.
Tra il 1920 e il 1921 si leggono alcune recensioni di Corrado
Pavolini, in particolare una riguardante i primi quattro volumi della
“Collezione di autori stranieri” diretta da Ettore Lo Gatto per l’“Editrice
Italiana”, collana di traduzioni, eseguite dal testo originale e corredate da
notizie su vita e opere degli autori, definita:
una collezione che si presenta bene. La scelta giudiziosa, le
prefazioni accurate e sostanziose, le traduzioni ben fatte, sebbene con
qualche disuguaglianza, forse per mancanza di più accurate revisioni da
parte del direttore41.
Le recensioni di opere letterarie russe presenti nei fascicoli del
1921 sono nel complesso 12, di cui 7 firmate da Lo Gatto. Si tratta di
opere di Dostoevskij, Sologub, Krylov, Majkov, Mamin-Sibirjak,
Felyne, Andreev e Kuprin, pubblicate da varie case editrici italiane, fra
cui le milanesi Quintieri, Sonzogno e R. Caddeo, la palermitana
Sandron, la romana R. Carra, la veneziana L’Estremo Oriente e la R.
Carabba di Lanciano.
A partire dal numero di agosto del 1921 sarà Ettore Lo Gatto a
recensire e presentare con attenzione le opere della letteratura russa
tradotte e pubblicate in Italia.42 Il giovane slavista era stato presentato da
Paolo Emilio Pavolini43 alcuni mesi prima tra le colonne del periodico,
in occasione della nascita di “Russia”, fondata, diretta e redatta dallo
stesso Lo Gatto44:
40
Ibidem.
Vedi Bibliografia ragionata.
42
Sulla collaborazione di Ettore Lo Gatto rimando a: Gianfranco Tortorelli, “L’Italia
che scrive” (Op. cit.), pp. 84-104.
43
Paolo Emilio Pavolini (1864-1942). Filologo, linguista, accademico d’Italia e
orientalista. Durante gli anni in cui insegnava a Bologna, venne a contatto con la
cultura polacca e prese parte, in seguito, a numerosi convegni e incontri sulle relazioni
culturali italo-polacche, in Italia e in Polonia. Fra i lavori che Pavolini dedicò alla
Polonia merita una particolare attenzione la prima versione poetica apparsa in Italia di
un’opera di Juliusz Słowacki, Il padre degli appestati, pubblicata nel 1925. Infine, fu
Presidente del Gabinetto “Vieusseux” e collaborò occasionalmente al periodico
“L’Italia che scrive”. Cfr. Andrzej Zieliński, Op. cit.
44
Per la bibliografia sulla rivista cfr. n. 5.
41
17
Ma un più chiaro segno del vivo interesse per la produzione
intellettuale di quell’immenso e infelice paese, ancora in preda a
convulsioni di cui si presenta ormai non lontana la guarigione, è il sorgere
di una rivista bimestrale esclusivamente destinata a saggi critici sui
principali scrittori, a traduzioni totali o parziali di loro opere, a recensioni
e notizie bibliografiche, specialmente di libri italiani che si occupano
della Russia. La rivista si intitola Russia; la dirige, e in massima parte la
redige, un giovane e operosissimo studioso, il dr. Ettore Lo Gatto, la cui
sicura conoscenza della lingua russa risulta da numerose ed eccellenti
traduzioni e studi critici, nella sua rivista e fuori della rivista45.
Le numerose recensioni e i vari interventi di Lo Gatto sulle pagine
del periodico sono caretterizzate da osservazioni precise e graffianti, con
particolare attenzione alla resa del traduttore e alle scelte editoriali e, al
tempo stesso, mai prive di una nota di entusiasmo per il reale incremento
del patrimonio letterario russo.
Il debutto come recensore sulla rivista vide Lo Gatto impegnato in
un interessante confronto tra i volumi di Kuprin e Andreev, tradotti dalla
Duchessa D’Andria, Piero Gobetti e Ada Prospero, Carlo Staffetti e
Boris Gurevich. Relativamente a Gobetti, Lo Gatto presenta ai lettori,
nella rubrica ‘Letterature straniere in Italia’, il giovane autore della
traduzione, eseguita direttamente dall’originale russo, Figlio dell’uomo
di Andreev, ed accenna a una nascente schiera di giovani traduttori:
Alla lamentata mancanza di buone traduzioni italiane di libri russi,
vanno ponendo riparo da qualche anno alcuni giovani scrittori […] I
traduttori dal russo cominciano dunque a formare una piccola schiera e il
loro lavoro merita attenzione e simpatia […] Viene in prima linea fra i
nuovi traduttori il giovanissimo Piero Gobetti. Bisogna dir subito che le
traduzioni del Gobetti si distinguono da quelle degli altri per la precisa e
profonda padronanza della lingua russa46.
Gli interventi di Lo Gatto continuano con due recensioni sul
numero di dicembre; si tratta del commento alle traduzioni di F. M.
Dostoevskij Cuor debole e Il piccolo eroe eseguita da Ol’ga Resnevič e
pubblicata nel centenario della nascita dello scrittore, di cui si
sottolineano le primissime righe, utili ad evidenziare alcun aspetti del
panorama editoriale del tempo:
E’ il primo volume dei tanti annunziati, di traduzioni dirette dal
russo da pubblicarsi in occasione del centenario di F. Dostoevskij47.
Mentre in Germania si sono moltiplicate le edizioni e le traduzioni del
grande russo, in Italia si osa appena, da parte degli editori, di pubblicare
qualche piccolo volumetto come per tastare il terreno se ci si può
45
Cfr. “L’Italia che scrive”, anno IV, n. 6, giugno 1921, p. 117.
Cfr. “Ibidem”, anno IV, n. 8, agosto 1921, pp. 167-168.
47
“Della Resnevič s’annunziano le traduzioni de “I demoni” presso Vallecchi e de
“L’Idiota” presso la “Libreria della Voce.” Cfr. Ettore Lo Gatto, “L’Italia che scrive”,
anno VI, n. 12, dicembre 1921, p. 249.
46
18
finalmente decidere a dare delle traduzioni complete e decenti de “I
fratelli Karamazov” e de “I demoni48.
Nella recensione che segue, viene di nuovo evidenziata una cattiva
scelta editoriale riguardante l’opera di M. Gor’kij, La mia infanzia,
pubblicata dalla casa editrice “Avanti”, la quale non è tradotta
direttamente dall’originale russo ma da una precedente versione tedesca
e francese, come scrive il recensore:
Peccato che la traduzione, che si sforza di essere fedele,
seguendo quella tedesca e francese, non sia fatta direttamente dal russo.
Siccome quella tedesca è però fedelissima, anche questa italiana non
risente troppo di essere una ritraduzione49.
I difetti riscontrati vengono definiti “piccolezze”, che lasciano
comunque accettabile la lettura della traduzione. Non altrettanto
indulgente si mostrerà, però, Lo Gatto nella successiva recensione,
datata 1922, sempre nei riguardi di una versione condotta non
sull’originale: è il caso di Pop, una delle opere di Andreev pubblicate in
quegli anni nella traduzione di Decio Cinti:
Il “Pop” è tra i racconti più interessanti dell’Andreiev, ma nella
traduzione non è più Andreiev. Il Cinti conosce certamente bene il
francese e l’italiano, ma la lingua di Andreiev, mi si permetta di
affermarlo decisamente, non la conosce. Chi vuole un racconto qualunque
per ammazzare il tempo prenda pure la traduzione del Cinti. E’ migliore
di tante altre fatte con lo stesso sistema. Ma chi vuol leggere Andreiev,
senza conoscere il russo, non può fare a meno di rivolgersi alle traduzioni
del Rèbora, che se non è sempre fedele alla lettera, è così stupendamente
fedele allo spirito, all’anima dello scrittore russo; e a quelle di Gobetti50.
Sempre nel 1922, il numero di recensioni di opere della letteratura
russa aumenta: gli interventi pubblicati sono in tutto 16, di cui 14
recensioni a firma di Lo Gatto, una di Paolo Emilio Pavolini e un
articolo di Aurelio Palmieri51. Di particolare interesse è l’ampio
contributo di Palmieri, pubblicato sul numero di marzo, dal titolo Le
letterature straniere in Italia. La letteratura russa. Si tratta di una
rassegna bibliografica di opere e scrittori russi, con particolare
riferimento all’attività di Lo Gatto e alla nascita della rivista “Russia”,
che “sin dal suo inizio colmava una lacuna nella cultura letteraria
italiana”. Nell’intervento di Palmieri, fra i diffusori delle versioni dal
russo in Italia prima di Lo Gatto vengono menzionati Federigo
48
Cfr. “Ibidem”.
“Ibidem”.
50
Ettore Lo Gatto, recensione a: Leonida Andreiev. Il Pope. Romanzo. Trad. di Decio
Cinti. Milano, Facchi ed. – Anfissa. Dramma in quattro atti. Trad. letterale dal russo di
B. Gurevich e M. R. Venezia, Ed. “L’Estremo Oriente”, “Ibidem”, anno V, n.2,
febbraio 1922, p. 28.
51
Vedi Bibliografia ragionata.
49
19
Verdinois, Domenico Ciampoli, Eva Amendola, Umberto Norsa, Sergej
Jastrebcov, Ardengo Soffici e Pasquale Gastaldi-Millelire. Il bilancio si
conclude con un augurio dell’autore per un sempre maggiore sviluppo
della conoscenza della letteratura russa fra i lettori italiani:
Chi scrive queste pagine ricorda sempre con commozione il giorno
in cui ricevé a New York il primo fascicolo della Russia, una rivista di
letteratura, storia e filosofia russa, ideata, sostenuta con gravi sacrifici
economici, e redatta in massima parte dal Lo Gatto. La “Russia” sin dal
suo inizio colmava una lacuna nella cultura letteraria italiana, e nelle
ottime traduzioni di Lo Gatto rivelava al pubblico italiano documenti
ignoti per la storia del pensiero russo e nuove manifestazioni artistiche
[…] Tante traduzioni dal russo nel breve volgere di due anni ci fanno
sperare che la letteratura russa non sarà più un libro chiuso per l’Italia52.
Nello stesso numero di marzo è pubblicata una recensione di P. E.
Pavolini sul volume di storia della letteratura russa di P. Kropotkin53. Per
quanto riguarda le recensioni firmate da Lo Gatto nel 1922, grande
spazio è dato ai classici della letteratura russa dell’Ottocento:
Dostoevskij, Tolstoj, Gogol’ e Lermontov. Protagonista assoluto è
Leonid Andreev, del quale si contano tre recensioni di volumi pubblicati
da tre differenti case editrici, “L’Estremo Oriente”, “Apollo” e “Avanti”,
rispettivamente nei mesi di febbraio, agosto e novembre dello stesso
anno54; fra gli altri contributi si notano anche le dure osservazioni sulle
traduzioni di Tolstoj, scrittore già conosciuto in Italia ma spesso non in
veste integrale. Nell’occasione, Lo Gatto richiama nuovamente i
traduttori al rispetto per il testo originale nella resa in italiano, fattore
che implica la vicinanza allo stile e alla lingua dell’autore:
Debbo prima di tutto premettere che nessuno più di me può
accogliere con soddisfazione le traduzioni di opere russe fatte
dall’originale, perché sono ormai più di due anni che quotidianamente
insisto sulla necessità che anche in Italia si diffonda la convinzione che
tutte, indistintamente, le opere letterarie straniere debbono essere tradotte
direttamente dalla lingua in cui sono state scritte e con sentimento di
rispetto, se non d’amore, verso l’autore55.
Il 1923 è un’annata meno ricca di riferimenti alla letteratura russa,
i contributi sono presenti solamente in cinque numeri della rivista56. La
52
Aurelio Palmieri, La letteratura russa in ‘Letterature straniere in Italia’, “Ibidem”,
anno V, n. 3, marzo, 1922, pp. 37-38.
53
Cfr. P. E. Pavolini, recensione a: P. Krapotkin, Ideali e realtà nella letteratura russa.
Trad. di E. Lo Gatto. Napoli, Ricciardi, 1921, pp. XV-375, “Ibidem”, p. 47.
54
Vedi Bibliografia ragionata.
55
Cfr. Ettore Lo Gatto, recensione a: Leone Tolstoi. Opere postume, tradotte da Luigi
Grillo e Boris Gurevich. Bologna, Casa Editrice Apollo, pp. 458, L. 8,50, “Ibidem”,
anno V, n. 8, agosto 1922, p. 150.
56
Si tratta dei numeri 4, 6, 7, 10 e 11, con complessivi 13 articoli di cui 11 a firma di
Lo Gatto.
20
copiosa e indefessa attività pubblicistica di Lo Gatto viene subito
sottolineata da P. E. Pavolini nella sua recensione al volume Saggi di
letteratura russa, pubblicato dall’I.p.E.O.:
Le giornate di E. Lo Gatto devono essere di quarantotto ore. Non
capirei, altrimenti, come in pochissimi anni abbia potuto darci, e continui
a darci, accanto ad un copiosissimo, incessato lavoro di traduttore, non
pochi saggi critici ed una rivista, Russia, di cui egli è direttore e nello
stesso tempo collaboratore principalissimo. E le traduzioni sono accurate
e gli studi, tutt’altro che superficiali, comprendono le più cospicue
manifestazioni dello spirito russo, non solo letterarie, ma e storiche e
filosofiche e religiose e politiche57.
Degna di nota è, poi, una recensione positiva di Lo Gatto nei
riguardi della traduzione del racconto di Gogol’ Kak possorilsja Ivan
Ivanovič s Ivanom Nikiforovičem, ritenuta non solo fedele, ma ottima, e
frutto della sempre più diffusa professionalità dei traduttori italiani:
Le traduzioni fatte direttamente dal russo non sono più
un’eccezione in Italia. In un primo tempo alle traduzioni fatte sui
riadattamenti francesi (i quali per fortuna sono ormai un passato anche
per la Francia) successero traduzioni fatte da russi e adattate nella forma
da italiani ignari del russo, insomma dei canovacci riveduti e corretti, che
qualche volta tuttavia riuscivano bene; oggi si hanno finalmente
traduzioni che italiani da soli, con eccellente conoscenza delle due lingue,
tentano e fanno: vere traduzioni artistiche, fedeli ed eleganti nello stesso
tempo.
Nello stesso anno viene pubblicato dall’editore Stock il volume
Poesia russa della rivoluzione, in cui Lo Gatto presenta al pubblico
italiano uno studio sulla poesia russa contemporanea, ricco di notizie
interessanti e citazioni non facilmente reperibili in un’epoca in cui gli
sconvolgimenti politici, culturali e artistici provocati dalla rivoluzione
fanno ancora sentire i loro effetti. Nonostante l’autore, nell’introduzione,
riveli di non avere avuto alcuna pretesa di fornire uno studio completo
ed esauriente sul tema, il recensore, Enrico Damiani, scrive:
Ma il volumetto del Lo Gatto, senza pretese scientifiche, offre
quanto di meglio si poteva offrire oggi sul tema della poesia russa del
periodo rivoluzionario: un quadro sintetico, per somme linee, delle
condizioni in cui s’è trovata in Russia la letteratura in generale e la poesia
in particolare in questi anni turbinosi, un’intelligente scelta di liriche e
poesie varie, letteralmente tradotte, sobri ma esurienti cenni sui singoli
autori e osservazioni critiche sull’opera di tutti e di ciascuno58.
57
P. E. Pavolini, recensione a: E. Lo Gatto. Saggi sulla cultura russa. Pubblicazione
dell’Istituto per l’Europa Orientale, Prima serie, III, Napoli, Ricciardi 1923, pp. 174, L.
8, “Ibidem”, anno VI, 8, p. 141.
58
E. Damiani, recensione a: E. Lo Gatto, Poesia russa della rivoluzione. Roma, A.
Stock, 1923, pp. 123, L. 7, “Ibidem”, anno VI, 11, novembre, 1923, p. 200.
21
Anche il 1924 presenta pochi interventi sulla letteratura russa,
cinque in tutto, di cui solamente uno firmato da Ettore Lo Gatto e
pubblicato sul numero di febbraio:
Il Grabher è forse il migliore fra i recenti traduttori dal russo. E’ in
lui costante l’amore per l’opera d’arte che affronta, e questo lo fa
guardingo […] Sono tanto più lieto di elogiare questa sua ultima fatica, in
quanto che una mia traduzione dello stesso dramma è pronta presso
l’editore da tempo, ed io conosco perciò bene il testo che il Grabher ha
affrontato59.
Con queste recensioni termina la collaborazione di Lo Gatto alla
rivista “L’Italia che scrive”, tuttavia la letteratura russa continuerà ad
avere spazio tra le colonne del mensile con articoli di vari collaboratori
ed esperti.
Seguono infatti, nello stesso numero di febbraio, due recensioni su
due traduzioni di Lo Gatto, firmate nuovamente da Damiani. Il primo
titolo recensito è quello di Fëdor Kuz’mič Sologub, autore già
pubblicato in Italia, ma che il pubblico non ha potuto ancora conoscere
in tutta la sua grandezza:
La fama di Fiodor Sollogub è ancora, in Italia, assai inferiore ai
veri meriti letterari di lui. I suoi scritti – prosa e poesia – non avevano
trovato finora tra noi traduttori o, peggio ancora, avevano trovato qualche
traduttore indegno, la cui profanazione del testo originale non aveva certo
giovato a far bene conoscere ed amare fra noi il grande scrittore russo60.
Il secondo volume recensito è quello di Aleksandr Nikolaevič
Ostrovskij, presentato da Lo Gatto al pubblico italiano in occasione del
centenario della nascita, attraverso una delle sue opere migliori, Les, con
una traduzione fedele e in grado di riproporre tutto il sapore del
linguaggio originale:
La versione di questa commedia di Ostrovskij, che il Lo Gatto ha
voluto dare alla luce proprio nel centenario della nascita di lui, ha il
pregio non lieve di essere la prima autentica che compaia in Italia d’una
delle migliori commedie di Ostrovskij61.
Il numero 8 della settima annata della rivista (1924) ospita una
notizia, tra le altre, il cui breve contenuto è lapidario ed è relativo alla
legge sulla stampa, la quale avrà conseguenze, che gradualmente
59
E. Lo Gatto, recensione a: A. Cecov. Ivanov, dramma in 4 atti. Traduzione di Carlo
Grabher, Firenze, Vallecchi Editore, 1923, “Ibidem”,Anno VII, 2, febbraio, p. 31.
60
Cfr. Enrico Damiani, recensione a: Fiodor Sollogub. Il demone meschino.
Traduzione dal russo di Ettore Lo Gatto. Foligno, Campitelli, 1923, “Ibidem”.
61
Cfr. Enrico Damiani, recensione a: Alessandro N. Ostrovskij. La Foresta
(Commedia in cinque atti). Traduzione di Ettore Lo Gatto. Napoli, Ricciardi, 1923, pp.
VIII-135, “Ibidem”.
22
investiranno l’editoria. La nota rivela che il clima culturale sta
cambiando:
Italia: La libertà di stampa concessa dal re Carlo Alberto nel 1848
è stata soppressa.62
Nel 1925 sia gli autori dei contributi, sia i generi rappresentati sono
vari, con una preponderanza di testi teatrali. In particolare, per la sezione
‘Letterature straniere in Italia’, si segnala la recensione di Aldo Gabrielli
ai primi sei volumetti della “Collezione del teatro” pubblicata dalla casa
editrice Alpes di Milano, con opere di Čechov, Minskij, Poljakov, Blok,
Sologub e Arcybašev63. Seguono due contributi di Adriano Tilgher, uno
sul dramma Tri sestry di Čechov, l’altro sulla commedia di Turgenev
Mesjac v derevne64. In questi contributi manca, però, una caratteristica,
finora riscontrabile solo negli articoli firmati da Lo Gatto, e cioè la
presenza di riferimenti tra un’opera e l’altra di uno stesso autore, ovvero
l’inquadramento di un’opera nel quadro generale della produzione di un
determinato scrittore. La cosa si ripeterà d’ora in poi per le successive
annate del periodico.
Una menzione particolare merita il 1926 per un avvenimento
importante nell’editoria italiana e cioè la nascita della casa editrice
Slavia. A darne notizia tra le colonne della rivista sono le inserzioni
pubblicitarie. Nel numero di ottobre 1926 vengono presentati i primi
quattro volumi della collana “Il Genio Russo” con la prima versione
integrale di Brat’ja Karamazovy65. Si segnala, inoltre, una lunga e
positiva recensione, firmata Alberto Neppi, al volume di Aurelio Zanco
dedicato all’epistolario di Čechov. Il contributo comincia con le seguenti
parole di Zanco:
L’epistolario, quando non diventi un esercizio retorico di tipo
senechiano, è la forma più immediata di autobiografia.
Poi aggiunge:
62
Anno VII, 8, agosto 1924, p. 152.
Cfr. Aldo Gabrielli, recensione a: Anton Cecov. Lo zio Vania; M.N. Minski, Che
cosa cerchi?; S. Poliacov. Il labirinto (Dramma in 4 atti), Milano, “Alpes”, “Ibidem”,
anno VIII, 3, marzo, 1925, p. 52; Id., recensione a: Alessandro Blok. La rosa e la croce
(dramma in 4 atti); Teodoro Sollogub. Gli ostaggi della vita (dramma in 4 atti); P. M.
Arzybaschev. La Gelosia (dramma in 5 atti), “Ibidem”, 9, settembre, 1925, p. 180.
64
Cfr. Adriano Tilgher, recensione a: Anton Cecov. Le tre sorelle. Dramma in quattro
atti. Traduzione e introduzione di B. Iakovenko. Firenze, Vallecchi, pp. 82, “Ibidem”,
anno VIII, 5, maggio, 1925, p. 101; Id., recensione a: Ivan Serghieievic Turgheniev.
Un mese in campagna. Commedia in cinque atti. Intr. e trad. di E. Damiani. Firenze,
Vallecchi, 1925, “Ibidem”, 6, giugno, 1925, p. 120.
65
Cfr. Documenti.
63
23
le lettere lasciate dal grande scrittore tunguso (così amava definirsi,
scherzosamente, Céhov) sono piene di materia vitale, profonda come la
vita; giacché in esse ogni parola è un segno che s’incide66.
La prima recensione a un volume edito da Slavia si legge nel
maggio 1927 a firma di Paolo Vita Finzi67. Viene commentata la
raccolta di I. S. Turgenev Scene e commedie, tradotta da Rinaldo
Küfferle68, la prima della III serie dedicata allo scrittore. Il recensore,
considerando “mirabile” la traduzione, raccomanda ai lettori il volume:
Chi ancora non conosce la melanconica grazia di queste operette, o
le ha lette nelle infedeli e scadenti versioni (quasi sempre dal tedesco o
dal francese) che sinora invadevano il nostro mercato librario, farà bene
ad acquistare il bel volume69.
Sullo stesso numero della rivista si legge un’ampia inserzione
pubblicitaria di Slavia, che presenta un bilancio della collezione “Il
Genio Russo”70; le novità in uscita ivi segnalate sono le versioni
integrali della raccolta di novelle di Gogol’ Mirgorod e di Il villaggio di
Stepančikovo e i suoi abitanti, fino ad allora inedito in Italia.
La brillante iniziativa di Polledro, ovvero la fondazione di Slavia, è
lodata da Enrico Damiani, il quale, stilando un “Bilancio Consuntivo”
sugli “Studi Slavi” nel numero di giugno dello stesso anno, scrive a
conclusione del contributo:
Meritevole di particolare rilievo è la recentissima nascita a
Torino d’una casa editrice: “Slavia”, la quale, sotto la direzione di A.
Polledro, si propone addirittura il programma titanico di dar gradualmente
alla luce le opere complete dei massimi scrittori russi (in seguito forse di
altri scrittori slavi) in scrupolose traduzioni integrali. E questa casa
editrice ha già brillantemente compiuto il primo passo nella sua splendida
via, pubblicando l’ottima traduzione dei “Fratelli Karamazov”, dei
racconti di Tolstoi e delle commedie di Turgheniev […] il cammino che
si è già riusciti a percorrere in Italia, nel volgere di pochissimi anni, è
66
Cfr. Alberto Neppi, recensione a: Aurelio Zanco, A. P. Céhov dal suo epistolario.
Firenze, “La Voce”, 1925, pp. 171, “Ibidem”, anno IX, gennaio, 1, p. 10.
67
Paolo Vita Finzi (1899-1986). Diplomatico e scrittore, fu Console nel Caucaso
sovietico ed esperto alla Conferenza di Stresa per l’Europa Orientale, nonché attivo
collaboratore di numerosi periodici italiani fra i quali “Nuova Antologia”. Cfr. Stefano
Baldi – Pasquale Baldocci, La penna del diplomatico. I libri scritti dai diplomatici
italiani dal dopoguerra ad oggi. Milano, FrancoAngeli, 2006 (Scheda bibliografica
consultabile su http://baldi.diplomacy.edu/diplo/biogra/vita-finzi_bio.htm).
68
Rinaldo Küfferle (1903-1955) apparteneva alla schiera di traduttori di origine russa
attivi in Italia presso numerose case editrici, compresa Slavia, insieme a Boris
Jakovenko, Raissa Olkienizkaia-Naldi, Valentina Dolghin-Badoglio, Anna Ruska e
Maria Karklina. Fu uno dei più prolifici traduttori dal russo di tutto il primo
dopoguerra, traducendo scrittori classici e dell’emigrazione. Cfr. I traduttori della
Slavia, in Laurent Béghin, Op. cit., pp. 299-315 e Silvia Colorini Schwarz, Ricordo di
Rinaldo Küfferle, in “Antroposofia”, 1958, 2, pp. 48-56.
69
Cfr. Paolo Vita Finzi, "L’Italia che scrive”, anno X, 5, maggio 1927, p. 110.
70
Cfr. Colonna centrale, “Ibidem”, anno X, n. 5, maggio 1927, p. 119.
24
grande e tale da legittimare le migliori speranze per una sempre crescente
affermazione della nostra cultura nazionale anche nel campo vasto,
multiforme e possente degli studi slavi.71
L’articolo di Damiani si sofferma su avvenimenti di particolare
importanza per la diffusione delle letterature slave in Italia: l’istituzione
della cattedra di Filologia slava a Padova affidata a Giovanni Maver,
l’incarico di Letteratura russa presso l’Università di Napoli a Ettore Lo
Gatto e la già affermata cattedra di Lingua e letteratura polacca a Roma
affidata a Roman Pollak. Vengono, inoltre, segnalate le principali
pubblicazioni in lingua italiana a partire dal 1925. Nel campo delle
traduzioni, accanto a una serie di opere di autori russi si leggono i nomi
dei traduttori maggiormente attivi: A. Polledro, E. Lo Gatto, E. Damiani,
R. Küfferle, E. Cadei, G. Gandolfi, B. Jakovenko, A. Prospero. Subito
dopo la Russia, la Polonia risulta il paese che ha fornito il maggior
numero di capolavori ai traduttori, fra i quali si menzionano M. A.
Kulczycka, A. Palmieri, J. Gromska, Cl. Garosci, E. Lo Gatto e lo stesso
Damiani:
Fra gli altri paesi slavi, la Polonia è, dopo la Russia, quella che ha
fornito, in quest’anno, la maggior messe di capolavori ai traduttori.
Per quanto concerne le letterature slave meridionali, la letteratura
bulgara fa la parte maggiore:
Fra le letterature slave meridionali tengono il campo per la prima
volta quest’anno opere bulgare, tradotte quasi tutte dal sottoscritto.
Alla fine si conclude con una nota ottimistica sul futuro della
slavistica italiana:
Il fervore negli studi slavi non accenna a diminuire. Tutt’altro.
Sostenuti dal crescente interesse del pubblico, gli studiosi e gli specialisti
si fanno d’anno in anno men rari […] Se è dunque lungo e arduo il
cammino che ancora ci rimane, il cammino che si è riusciti a percorrere in
Italia, nel volgere di pochissimi anni, è grande e tale da legittimare le
migliori speranze per una sempre crescente affermazione della nostra
cultura nazionale anche nel campo vasto, multiforme e possente degli
studi slavi72.
Una nuova collaborazione alla rivista inizia col numero di
settembre del 1927 e si tratta di Leonardo Kociemski73. La sua prima
71
E. Damiani, Gli studi slavi, in ‘Bilanci consuntivi’, “Ibidem”, anno X, n. 6, giugno
1927, pp. 123-124.
72
Ibidem.
73
Nato in Polonia nel 1882, Leonardo Kociemski risiedeva in Italia dal 1912. Medico
di formazione, fece una carriera di giornalista e di letterato. E’ autore di una raccolta di
novelle La liquidazione dell’amore (1919), di vari drammi (L’abisso, 1921) e di un
25
recensione riguarda ancora una volta le più recenti pubblicazioni di
Slavia: i due racconti di Lev Tolstoj, I cosacchi e L’incursione, e i
romanzi brevi di Čechov, Il Duello e Tre anni. Oltre a soffermarsi
sull’indefessa opera dei traduttori e la rilevanza delle opere scelte per la
pubblicazione, Kociemski ribadisce il ruolo centrale della casa editrice
nella ricezione della cultura russa in Italia:
La Casa Editrice “Slavia” permette ai numerosi cultori delle lettere
russe, attraverso il suo nobilissimo sforzo che viene altamente apprezzato
dagli intellettuali d’Italia come testimoniano alcuni volumi totalmente
esauriti in un brevissimo spazio di tempo, di constatare fino a che punto
la veste interiore di alcuni scrittori è stata mascherata dagli abusi nella
traslazione arbitraria. E bisogna ripetere che gli originali dovevano
effettivamente essere ammirabili se nelle mai abbastanza deprecate
traduzioni sono riusciti ad affermarsi e conquistare il pubblico.74
L’ultima recensione pubblicata nel 1927 riguarda un volume di
racconti di Čechov, un segno della generale preferenza per gli autori
russi considerati “classici”:
Il volume di racconti, presentato dalla signora Malavasi Arpshofen,
non aggiunge molto alla fama, ormai ben consolidata, del celebre scrittore
russo le cui opere maggiori sono state tradotte ed illustrate dalla critica e
le cui commedie han conosciuto parecchi palcoscenici d’Italia75.
Kociemski sottolinea, poi, l’accurata veste editoriale e tipografica
della collezione di scrittori stranieri della casa editrice Apollo di
Bologna, aggiungendo qualche osservazione critica sulla traduzione:
Una lode particolare merita la casa editrice bolognese “Apollo”, la
quale presenta questa sua nuova collezione di scrittori stranieri in una
veste molto decorosa, adattando al testo bellissimi caratteri tipografici che
non stancano l’occhio; questa signorilità editoriale potrebbe tuttavia esser
completata con una maggiore cura nei riguardi della versione presentata,
per sfuggire le pecche non gravi senza dubbio, che rivelano, almeno
apparentemente, una certa inesperienza della traduttrice76.
saggio su La Polonia e la difesa della civiltà occidentale (1930). Politicamente sembra
aver coltivato posizioni filofasciste. Su Kociemski rimando a: Giovanni Casati,
Dizionario degli scrittori d’Italia. Dalle origini ai viventi, Milano, Ghirlanda, 19251934, s.v.; Antonello Venturi, Rivoluzionari russi in Italia 1917-1921, Milano,
Feltrinelli, 1979, p. 173 e Jerzy Borejsza, Il fascismo e l’Europa orientale. Dalla
propaganda all’aggressione, Roma-Bari, Laterza, 1981, p. 145.
74
Leonardo Kociemski, recensione a: Lev Tolstoi. I cosacchi e L’incursione. Prima
versione integrale e conforme al testo russo con note di Boris Jakovenko. Collezione
del Genio russo, Slavia – Anton Cecov. Il duello e Tre anni. Prima versione integrale e
conforme al testo russo con note di Giovanni Faccioli. Collezione del Genio russo,
Slavia,“Ibidem”, anno X, n. 9, settembre 1927, p. 203.
75
Leonardo Kociemski, recensione a: Anton Cecov, Racconti agrodolci. Traduzione
dal testo russo di Olga Malavasi Arpshofen. Bologna, Casa Editrice “Apollo”, pp. 217,
“Ibidem”, anno X, 12, dicembre, 1927, p. 276.
76
“Ibidem”.
26
Il primo numero del 1928 si apre con due recensioni di Kociemski
al romanzo breve di Fëdor Sologub Più dolce del veleno e alla raccolta
Macchie di sole di Arkadij Averčenko77. Nei numeri seguenti ritornano
frequentemente recensioni di opere edite da Slavia. L’ampio commento
alla traduzione in tre volumi di Besy firmata da Alfredo Polledro termina
con un riferimento alla crisi del libro e qualche dato sulla casa editrice:
Non è la prima volta che parliamo delle versioni dal russo di
Alfredo Polledro e ci sembrerebbe ridicolo ripetere le lodi che esse
meritano […] Giusta ne è la ricompensa da parte del pubblico che ha
accordato un indiscusso successo all’ardua impresa della “Slavia” i cui
primi dodici volumi sono stati rapidamente esauriti, mentre continuano
insistenti richieste per la ristampa. Ciò significa che bisogna rivedere
molti tra i giudizi intorno alla cosiddetta crisi del libro in Italia e che il
pubblico italiano intende incoraggiare e premiare degnamente ogni nobile
sforzo per arricchire le lettere italiane con versioni fedeli ed adeguate ai
criteri artistici dei lettori78.
Nel 1928 si festeggia il centenario della nascita di Lev Tolstoj con
un ampio numero di edizioni di opere pubblicate per l’occasione. La
rivista riporta le recensioni di Resurrezione e di Memorie: Infanzia,
Adolescenza, Giovinezza, insistendo ancora una volta sulle versioni
originali:
Spesso, anzi, troppo spesso, incontriamo ancora delle traduzioni
dal russo, che ci allontanano dall’originale, non parliamo poi di Leone
Tolstoj le cui opere, nella maggior parte dei casi ed in quasi tutte le lingue
occidentali, sono state veramente perseguitate dai traduttori poco
scrupolosi e privi della essenziale dote, cioè della conoscenza diretta
dell’originale russo […] lo stesso Lo Gatto a pagina 38 del presente libro
ci fornisce altre, per quanto relativamente minori, prove dell’arbitrarietà
dei traduttori, parlando della traduzione fatta dalla duchessa d’Andria dei
tre racconti tolstojani in parola.79
L’evento editoriale più importante in occasione del centenario
tolstojano è forse la pubblicazione da parte di Slavia del capolavoro di
Tolstoj Guerra e pace: è la prima volta che viene edita in lingua italiana,
e in versione integrale, l’opera dello scrittore russo. Un annuncio
pubblicitario apparso sul numero di maggio della rivista annuncia
l’uscita del romanzo e, nell’occasione, spiega ai lettori la scelta
commerciale della casa editrice allo scopo di contenere i prezzi dei
77
Cfr. Leonardo Kociemski, recensione a: Arcadio Avercenko. Macchie di sole.
Traduzione dal russo di Iris Felyne. Milano, „Alpes”, 1927, pp. 300, “Ibidem”, anno
XI, 1, gennaio, 1928, p. 16.
78
Cfr.: “LA CRISI DEL LIBRO NON ESISTE per le collezioni ben fatte, interessanti
e organiche come “IL GENIO RUSSO”, civetta pubblicitaria, Anno XI, n. 3, marzo
1928, p. 83.
79
Leonardo Kociemski, “Ibidem”, anno XI, 6, giugno 1928, p. 157.
27
propri volumi80. Kociemski ne parla di nuovo in una recensione qualche
mese più tardi, sottolineando il fatto che anche l’Italia partecipa
brillantemente alle celebrazioni che in tutto il mondo vengono fatte per il
centenario. Non manca un’osservazione alla traduttrice, ancora la
Duchessa d’Andria:
Ci sembra accurata e diligente la versione italiana della
Duchessa d’Andria, che ha compiuto altre traduzioni delle opere
tolstojane negli ultimi anni; però ci sentiamo in dovere di far osservare
che la sua diligenza è talvolta troppo spinta alla pedissequa fedeltà
all’originale, il che è un pregio ma è altresì un difetto perché va – sia pure
in misura minima – a detrimento del testo italiano.81
Un’altra pubblicazione segnalata più volte nella rivista a partire dal
numero di giugno del 1928 è la Storia della Letteratura russa di Ettore
Lo Gatto. Le recensioni all’opera si leggono nella rubrica ‘Critica e
Storia letteraria’ e sono firmate da P. E. Pavolini; annunciando l’uscita
del primo e del secondo volume, Pavolini si sofferma sui contenuti, che
“forniscono ai lettori italiani un’opera seria e attendibile”82. Sulla stampa
italiana e straniera si avvicendano ottime recensioni, riportate anche in
un annuncio pubblicitario dell’Istituto per l’Europa Orientale; si rimarca
l’utilità dell’opera di Lo Gatto nel contribuire a colmare una lacuna nella
conoscenza della Russia contemporanea.
Nel 1929 “L’Italia che scrive” entra nel vivo del dibattito sulle
traduzioni: nel numero di marzo, un paragrafo dal titolo Traduzioni offre
spunti interessanti. Formiggini, l’autore dell’articolo, con lo stile vivace
e acuto che lo contraddistingue, fa riferimento al “battagliero periodico
milanese “Il Torchio”, sulle cui pagine si sono avvicendati i pareri di
alcuni esperti:
E’ stato detto dai più che queste [le traduzioni] soffocano la
produzione indigena ossia la letteratura nazionale, e sono stati escogitati
vari provvedimenti. C’è, per esempio, chi ha detto: perché gli editori
pubblicano traduzioni invece che libri di autori italiani? Perché spendono
meno e ne vendono di più. Dunque il rimedio è facile: mettiamo un dazio
doganale, come si fa per le automobili, in guisa che il pubblicare un libro
tradotto costi di più che il pubblicare un libro italiano83.
Alla questione fa riferimento anche Leonardo Kociemski, con una
recensione al romanzo di I. A. Gončarov Oblomov, tradotto da Ettore Lo
Gatto per “Il Genio Slavo”. Da una traduzione rimaneggiata e tagliata
80
Cfr. “L’Italia che scrive”, anno XI, n. 10, ottobre 1928, p. 264.
Leonardo Kociemski, recensione a: Lev Tolstoi. Guerra e Pace. Romanzo. Versione
integrale e conforme al testo russo con note della Duchessa d’Andria. (Collezione «Il
Genio Russo»). Torino, Slavia, 1928. Edizione del centenario Tolstojano in sei volumi.
Ciascun volume L. 12, p. 87-88, “Ibidem”, anno XII, dicembre, 1929, pp. 87-88.
82
Vedi Bibliografia ragionata.
83
Cfr. A. F. Formiggini, Traduzioni, “Ibidem”, anno XII, n. 2, febbraio 1929, p. 36.
81
28
dell’opera di Gončarov erano sorte polemiche che avevano portato ad
una vera e propria ‘campagna’ contro questo tipo di rielaborazione,
molto diffusa all’epoca, e con l’effetto di destare curiosità e interesse fra
i lettori.
Le recensioni del numero di maggio nella rubrica ‘Letterature
straniere in Italia’ ripropongono il tema; tre nuove pubblicazioni
sorprendono Kociemski per la correttezza e la precisione dell’edizione.
Nel caso di La felicità domestica di Tolstoj, Kociemski scrive:
Confessiamo di aver iniziato la lettura di questo volume con la
consueta diffidenza del recensore abituato ormai alla fioritura stilistica
che orna la maggioranza delle traduzioni dalle lingue difficili e poco
conosciute: bastarono però le prime pagine ad indurci a leggere e gustare
fino in fondo la eccellente versione dovuta ad Erme Cadei.”84
Per gli altri due volumi recensiti da Kociemski, rispettivamente di
Kuprin e di Dostoevskij85, si tratta in entrambi i casi di una riedizione
senza i tagli e gli arbitrii che avevano caratterizzato le edizioni
precedenti, “malvezzo”, per usare le parole del recensore, che ricorre
spesso fra gli editori italiani86. In altre occasioni Kociemski valuta molto
positivamente l’apporto delle traduzioni di opere scarsamente note in
Italia, ad esempio gli scritti di Nikolaj Leskov, di cui negli anni Venti,
prima della recensione di La donna bellicosa, erano state pubblicate solo
altre due opere in lingua italiana, nel 1925 e nel 192787. Il continuo
riferimento del recensore alle scelte operate da traduttori e editori, oltre
ad essere un bilancio del decennio passato, costituisce quasi un invito
affinché questi si occupino in futuro di autori contemporanei e meno
noti, ma significativi, per una completa conoscenza della letteratura
russa in Italia.
Traendo alcune conclusioni, il primo decennio di pubblicazione
dell’“Italia che scrive” (1918-1929), registra la presenza in Italia dei
principali scrittori russi dell’Ottocento, in particolare Dostoevskij,
Tolstoj, Čechov, ed è determinata dal gran numero di traduzioni
pubblicate in quel periodo. Dal punto di vista meramente quantitativo, si
contano in tutto 116 recensioni, dedicate sia ad opere letterarie che a
storie della letteratura russa e antologie. In particolare, si contano 5
antologie letterarie, dalle raccolte di fiabe popolari alle poesie della
84
Leonardo Kociemski, recensione a: L. Tolstoj, La felicità domestica. Trad. di E.
Cadei, Milano, Prof. G. De Agostini, 1928. Cfr., Anno XII, 5, maggio 1929, p. 161.
85
Cfr. Leonardo Kociemski, recensione a: A. Kuprin, La fossa, Nuova versione
completa. Trad. di Ettore Lo Gatto, Milano, Monanni, 1928; F. Dostoevskij, I fratelli
Karamazov. Romanzo in quattro parti e un epilogo, Torino, Slavia, 4 voll, 1928,
“Ibidem”, XII, 5, maggio, 1929, p. 161.
86
Cfr. Ibidem.
87
Cfr. N. S. Leskov, L’angelo suggellato, trad. Ettore Lo Gatto, Roma, Stock, 1925.
“Scrittori russi”, n. 2; N. S. Leskov, Il brigante d’Ascalona e Sceramur (Un
avvenimento nel carcere di Erode), trad. A. Polledro, Lanciano, Carabba, 1927.
“Scrittori italiani e stranieri”, n. 267.
29
rivoluzione, dai racconti umoristici alle novelle; 5 saggi di critica
letteraria, tutti firmati da Ettore Lo Gatto, a partire dai brevi Saggi sulla
cultura russa del 1923 fino ai cinque volumi della Storia della
Letteratura Russa, pubblicati a partire dal 1928. I grandi scrittori classici
sono oggetto del 50% dei contributi: in primo luogo le opere di
Dostoevskij, di cui sono pubblicate 13 recensioni, Tolstoj e Čechov. Non
tutti i classici vantano la stessa presenza nella rivista; in 11 annate,
infatti, troviamo solo una recensione a Lermontov, Leskov e Puškin. A
questo proposito è facile condividere l’opinione di Leonardo Kociemski,
pubblicata nel mese di luglio del 1929:
In Italia [...], quasi esclusivamente, si conoscono le opere dei
principali scrittori della Russia prebellica, mentre tutta la serie di scrittori
minori, ma non perciò meno interessanti, non è stata mai fatta conoscere.
Noi abbiamo più volte deplorato la moltiplicazione delle traduzioni di una
stessa opera, indicando ai traduttori la necessità di far conoscere gli
scrittori sconosciuti, invece di dedicarsi alla fatica spesso infruttuosa in
tutti i sensi, di tradurre le opere già tradotte88.
Per quanto concerne gli scrittori della Russia “prebellica” tra le
colonne dell’“Italia che scrive” si possono trovare anche autori non
considerati “classici”. Primo fra tutti Leonid Andreev, del quale vengono
recensite, in 8 articoli differenti, ben 12 opere tra il 1919 e il 1924; egli è
anche l’autore che apre l’elenco delle recensioni di opere letterarie russe
con la traduzione di Clemente Rebora (Lazzaro e altre novelle
pubblicata nel 1919 e commentata da Corrado Pavolini)89. Nonostante
che le pubblicazioni dello scrittore russo saranno frequenti per tutto il
decennio, il periodico non riproporrà più recensioni sulle sue traduzioni.
Altri contributi riguardano autori contemporanei; si tratta di un
numero non elevato, che rispecchia il panorama editoriale dell’epoca. Si
incontrano i nomi degli scrittori dell’emigrazione A. I. Kuprin, O.
Felyne, N. N. Evrejnov, I. Bunin; ancora inferiore è il numero di
recensioni relative ad opere di autori sovietici, di cui si leggono
solamente articoli di L. N. Lunc, A. T. Averčenko, V. G. Korolenko e I.
Šmelëv. Le opere dei contemporanei vengono pubblicate da case editrici
di Milano, Roma e Firenze90. Per quanto riguarda i recensori, Ettore Lo
Gatto domina tra le firme della rubrica ‘Letterature Straniere in Italia’
88
L. Kociemski, recensione a: Nikolaj Leskov. La donna bellicosa. Racconti. Prima
versione dal russo con pref. e note di Maria Silvestri-Lapenna, anno XII, n. 7, luglio
1929, p. 222.
89
Su Clemente Rebora traduttore dal russo rimando a: Giuseppe Ghini, Rebora e
Andreev, in Clemente Rebora nella cultura italiana ed europea. Atti del Convegno,
Rovereto, 3-5 ottobre 1991, a cura di Giuseppe Beschin, Gualtiero De Santi e Enrico
Grandesso, Roma, Editori Riuniti, 1993, pp. 341-358 e Id., Clemente Rebora traduttore
dal russo, in “Lingua e stile”, XXV, 1990, 1, pp. 57-83.
90
In particolare, le case editrici Alpes e Delta di Milano pubblicarono più di un’opera
di scrittori russi contemporanei. Vedi Bibliografia ragionata.
30
nelle prime annate; dal 1921, anno in cui inizia una regolare
collaborazione, al 1924 si contano 31 recensioni.
A partire dal 1924 si avvicendano vari collaboratori, tra cui Enrico
Damiani e Paolo Emilio Pavolini, fino al numero di settembre del 1927,
quando, cioè, Leonardo Kociemski diventerà così attivo nella rivista da
contare, in due sole annate, 22 interventi a sua firma.
Durante il passaggio dagli anni Venti agli anni Trenta, con
l’intensificarsi delle misure censorie, la situazione cambia radicalmente.
L’interesse per la Russia si attenua gradualmente a partire dal 1931,
annata in cui gli interventi sul tema si fanno meno frequenti. Sono
ampiamente rappresentati gli autori contemporanei, e, al contrario di
quanto accadeva negli anni Venti, molto di più dei “classici”. Le
recensioni, per un totale di 16, sono distribuite lungo tutto l’anno e sono,
in parte, descrizioni delle opere firmate da Kociemski, ad eccezione di
La mia vita di L. Trockij.
Su quest’ultima opera autobiografica “dell’organizzatore
dell’esercito rosso” Kociemski esprime con maggior chiarezza il suo
giudizio:
Leone Trozkij […] rivela grandi qualità di polemica scagliandosi
contro i suoi avversari, ma nell’insieme il volume lascia, soprattutto ed
essenzialmente, l’impressione di un’autodifesa, se non addirittura di una
autoapologia […]. Leone Trotzkij poteva dare di più e di meglio91.
Degni di nota i giudizi di Enrico Damiani, tra cui quello a
proposito della nuova collana curata da Ettore Lo Gatto “La rivoluzione
russa nei suoi scrittori”, pubblicata a Roma dall’“Anonima Romana
Editoriale”. Damiani, commentando la prima uscita della collezione, si
sofferma sull’interesse che negli ultimi anni destano le opere degli
scrittori sovietici, riconoscendoli continuatori della tradizione letteraria
russa:
La rivoluzione russa, nella colossale valanga di distruzione
generale che ha rovesciato sul popolo dell’ex-Impero moscovita, non ha
affatto travolto con sé e schiacciata la letteratura. Ha impresso la sua
impronta sanguinosa alla nuova produzione letteraria, le ha dato in certo
modo il volto della rivoluzione stessa, ha, se vogliamo, originato tutta una
nuova letteratura, ma bisogna riconoscere che questa nuova letteratura
non è affatto, dal punto di vista artistico, indegna erede della precedente.92
La caratteristica di questa nuova letteratura sovietica, secondo
Damiani, è il “realismo” prevalente nelle opere:
91
Leonardo Kociemski, recensione a: Leone Trozkij, La mia vita. Traduzione di
Ervino Pocar. Milano, Mondadori, 1930, pp. 526, “L’Italia che scrive”, anno XIV, n.
4, aprile 1931, p. 116.
92
Enrico Damiani, recensione a: Mihail Bulgàkov. La guardia bianca. Romanzo.
Traduzione dal russo e introduzione di Ettore Lo Gatto (Collezione “La rivoluzione
russa nei suoi scrittori”), “Ibidem”, anno XIV, n. 3, marzo 1931, p. 85.
31
E, dato il carattere prevalentemente realistico che caratterizza tale
letteratura della rivoluzione, erede anche in questo della gloriosa
tradizione del secolo scorso, la produzione dei prosatori sovietici […]
acquista un valore particolarissimo anche e specialmente come
documentazione dell’epoca e degli avvenimenti tragici che la
caratterizzano […] Questo spiega l’interesse che l’opera di questi scrittori
viene già da qualche anno destando fuori della Russia e il rapido
moltiplicarsi di versioni dei loro scritti in lingue straniere” 93
Il primo numero della collana è La guardia bianca di Michail
Bulgakov, allora poco noto in Italia: si tratta del primo volume dello
scrittore tradotto in italiano. In questa versione, integrale e rivelatrice
dello stile originale dello scrittore, Lo Gatto inserisce una prefazione
sulla figura di “uno degli autori più discussi dalla critica sovietica” e
sulla sua opera di “scrittore neo-borghese”. Gli altri scrittori sovietici
presentati nel 1931 sono L. Sejfullina, di cui vengono recensite,
separatamente, Virinea, nel numero di febbraio e Il burrone delle
Betulle94 in quello di maggio; L. Lunc, con una recensione di due opere
tradotte nuovamente da Ettore Lo Gatto95, per un’altra collana
dell’Anonima Romana Editoriale, la “Collezione del Teatro russo
contemporaneo”; infine N. Kolokolov, con la traduzione definita
“eccellente”, eseguita da Olga Resnevič Signorelli, Miele e sangue, edita
da Mondadori96.
Per quanto riguarda gli autori dell’emigrazione, tra le recensioni
del 1931 troviamo solo A. Kuprin, che aveva però raggiunto la notorietà
nel periodo pre-rivoluzionario. Di questo autore vengono presentate due
raccolte di racconti: Il mal di mare e altri racconti editi da Carabba e
L’uomo della strada di Slavia, entrambe novità per l’editoria italiana,
come sottolinea Enrico Damiani:
Da qualche tempo Kuprin sembra aver singolare fortuna in Italia.
Queste due raccolte di suoi lavori che vengono alla luce quasi
contemporaneamente, aggiunte all’altra, apparsa or sono pochi mesi, nelle
edizioni dello stesso R. Carabba (Il capitano Rybnikov, etc…), sono, per la
sapienza della scelta compiuta e per la generale bontà delle versioni,
sufficienti, insieme con la “Fossa”, già da vari anni tradotta e pubblicata, a
dare al lettore italiano un quadro esauriente della fisionomia e dell’arte dello
scrittore”97.
93
Cfr. Ibidem.
L. Sejfullina, Virinea, trad. dal russo di R. Olkienizkaia Naldi, Lanciano, Carabba,
1930. “Collezione: Antichi e moderni”; - Il burrone delle Betulle, prima trad. dal russo
e note di A. Ruska, con pref. di A. Polledro. Torino, Slavia, 1931.
95
L. Lunts, Fuori legge: tragedia in 5 atti, trad. di E. Lo Gatto, introd. di M. Gorkij; La città della verità: dramma in 3 atti, trad. dal russo e introd. di Ettore Lo Gatto,
Roma, Anonima Romana Editoriale. “Collezione del teatro russo contemporaneo”.
96
N. Kolokolov, Miele e sangue, trad. di O. Resnevic, Milano, Mondadori, 1931.
Collezione: “I romanzi della guerra”.
97
Enrico Damiani, recensione a: A. Kuprin. Il mal di mare e altri racconti. Tradotti
dall’originale russo da Maria Rakowska e Giuseppe Pochettino (Collezione «Antichi e
94
32
Il 1932 registra un forte calo delle recensioni di opere letterarie
russe, solo 7 pubblicate in tutta l’annata. Ivan S. Turgenev è l’unico
autore “classico” tra quelli recensiti, con due contributi sulle traduzioni
Nido di Nobili e Lo spadaccino, pubblicate sui numeri di luglio e
dicembre e firmate da Enrico Damiani98. Il regista e teorico del teatro N.
Evrejnov, nel 1922 già da alcuni anni emigrato a Parigi, era stato
presentato ai lettori de “L’Italia che scrive” per la prima volta nel
gennaio 1930 da Kociemski con l’opera Il teatro della guerra eterna,
dramma noto al pubblico italiano grazie alla sua rappresentazione a
Milano da parte della compagnia di Tat’jana Pavlovna. Ancora una volta
ampio spazio viene concesso agli autori sovietici, recensiti nei numeri di
maggio e settembre, con un autore non allineato ai canoni della cultura
sovietica contemporanea, Vladimir Lidin, di cui Kociemski scrive:
Lo scrittore […] non è considerato dalla critica ufficiale del suo
paese come un vero rappresentante della nuova letteratura russa, ma solo
come un “Poputčik” ossia “Compagno di strada” […] Vladimiro Lidin è
uno dei più interessanti scrittori della Russia odierna, e, nonostante le
riserve della critica ufficiale, che derivano a parere nostro da ragioni che
nulla hanno a che fare con la letteratura, come tale diverrà fra i più noti
anche all’estero” 99
Contrariamente a Lidin, un altro scrittore, Isaak Babel’, viene
definito da Enrico Damiani “uno dei maggiori rappresentanti della
letteratura sovietica”. La traduzione italiana di Konarmija, di Renato
Poggioli100, segue di alcuni anni l’edizione integrale russa del 1926, che
Moderni», N. 72), Lanciano, R. Carabba, 1930. Un vol. di pp. 197. L. 6 – L’ uomo
della strada. Racconti. Versione integrale dal russo di Silvio Polledro. Con saggio
introduttivo di Pjotr Pilskij (Collezione «Il Genio Slavo», N. 18. Serie russa, N. 11).
Torino, «Slavia», 1931. Un vol. di pp. XX-297, “Ibidem”, anno XIV, n. 8, agosto,
1931, p. 232.
98
Vedi Bibliografia ragionata.
99
Cfr. Leonardo Kociemski, recensione a: V. Lidin. Apostata. Romanzo. Traduzione
autorizzata dal russo di Nina Romanowsky. Milano, Alberto Corticelli, pp. 316, anno
XV, n. 5, maggio 1932, p. 150.
100
Nel primo dopoguerra Poggioli collaborò con diverse riviste letterarie italiane, tra
cui “Solaria”, “Letteratura”, “Pègaso”, “Pan”, “Scenario”, “Nuova Antologia” e
“Riviste di letterature slave”. Sulla sua collaborazione a “Scenario” rimando alla
Bibliografia ragionata. Per approfondimenti vedi: Ettore Lo Gatto, Renato Poggioli, in
“Il tempo”, 14 maggio 1963; Marcel Bataillon, Renato Poggioli, in “Revue de
littérature comparée”, XXXVII, 1963, 3, pp. 491-492; Luigi Berti, Ricordo per Renato
Poggioli, in “Inventario”, XVIII, gennaio-dicembre 1963, pp. 1-7; Dante Della Terza,
Da Vienna a Baltimora. La diaspora degli intellettuali europei negli Stati Uniti
d’America, Roma, Editori Riuniti, 1987, pp. 123-195; Laurent Béghin, Gli esordi di
uno slavista comparatista sotto il fascismo: gli anni di formazione di Renato Poggioli
(1928-1938), in Daniela Rizzi e Andrej Shishkin (a cura di), Archivio russoitaliano/Russko-ital’janskij archiv, IV, Salerno, “Europa orientalis”, 2005, pp. 395446; Laurent Béghin, Bibliografia di Renato Poggioli (1928-1938), in Daniela Rizzi e
Andrej Shishkin, Op. cit.
33
aveva fatto conoscere in Unione Sovietica lo scrittore di origine ebraica,
ma era stata, comunque, preceduta da traduzioni e studi critici:
Babel’ non era del tutto nuovo al lettore italiano. Alcuni di questi
stessi racconti erano stati tradotti dal Lo Gatto nella rivista “Russia”, sette
anni or sono. Il nome di Babel’, è registrato, la sua opera è segnalata in
più d’uno degli studi, ormai numerosi venuti alla luce in Italia, da alcuni
anni a questa parte, sulla letteratura russa sovietica. Ma questa versione
del Poggioli, veramente bella, integrale, accurata fino allo scrupolo in
ogni dettaglio, è la prima completa presentazione diretta dello scrittore
attraverso ciò che la sua arte ci ha dato di più caratteristico e significativo.
Fra tante produzioni sovietiche, tradotte in italiano, è questa, a mio
parere, la più tipica sia pel contenuto che per lo stile e per lo spirito che la
anima. Il giovane Renato Poggioli, che ha ormai già un suo nome in Italia
per tante belle cose pensate e scritte e tradotte con vera maestria nel
campo delle lettere russe (e di altre lettere slave), s’è rivelato ancora una
volta all’altezza del suo compito, anche quando, come in questo caso, il
compito presentava difficoltà non comuni.101
Il 1933 si apre con la recensione di un altro autore contemporaneo,
Pantelejmon Romanov, pubblicata sul numero di gennaio, la seconda a
distanza di pochi anni. Sullo stesso numero dell’annata un’intera pagina
è dedicata alla pubblicità di un nuovo volume edito nella Collana “I
classici del ridere”, pubblicata dallo stesso editore del periodico
Formiggini. Si tratta di La disgrazia di essere intelligente di A. S.
Griboedov, tradotta da Leone Pacini Savoy102; la nota pubblicitaria
riporta un commento di G. Lo Curzio, pubblicato su “Il giornale di
Sicilia” del 4 dicembre 1932. Ad essa seguirà, nel numero successivo,
una recensione di Enrico Damiani. Di Griboedov esisteva già una
versione italiana pubblicata dall’editore G. Carabba nel 1925, una
traduzione in versi a cura di Federigo Verdinois.
L’annata successiva, la XVII della rivista, che esibisce una veste
grafica rinnovata, presenta recensioni di opere russe e sovietiche firmate
solo dal Damiani, anche se nelle stesse colonne del periodico
s’incontrano articoli di Lo Gatto e di Kociemski, che continuano a
collaborare per la rubrica “Notizie bibliografiche”, il primo con
recensioni a opere di letteratura finlandese, il secondo con interventi
sulla letteratura ungherese. Il 1933 fu anche l’anno in cui uno scrittore
russo emigrato, Ivan Bunin, fu insignito del Premio Nobel per la
letteratura; nel numero di novembre del 1933 già un breve annuncio di
Slavia pubblicizzava la seconda edizione di Il villaggio, unica traduzione
integrale, eseguita da Valentina Dolghin Badoglio, con prefazione di
Renato Poggioli. La stessa pubblicità viene presentata qualche mese più
101
E. Damiani, recensione a: I. Babel’, L’armata a cavallo. Traduzione dal russo di
Renato Poggioli. Torino, Frassinelli, 1932, “Ibidem”, anno XV, n. 9, settembre 1932,
p. 260.
102
Cfr. A. S. Griboedov, La disgrazia di essere intelligente, trad. di L. Pacini Savoj,
Roma, A. F. Formiggini, 1932.
34
tardi, nel febbraio 1934, in una breve recensione, ma si tratta già della
terza edizione del volume:
Il recente conferimento del premio Nobel a Bunin ha richiamato
l’attenzione generale sull’esule scrittore russo. Ma il suo nome e la sua
opera erano già noti da tempo anche in Italia, dove versioni di qualcuna
delle sue opere principali avevano già avuto meritata fortuna. Sopra tutto
questo suo romanzo: “Il villaggio” (“o Campagna”), che vede oggi la luce
in una terza edizione per cura della “Slavia” di Torino […] La versione è
buona, scorrevole, disinvolta. La prefazione di Poggioli ottima e limpida
nella sua concisa completezza.103
A questa ne seguirà una quarta, sempre nel 1934, indice del grande
interesse del pubblico italiano per lo scrittore. Nel numero di aprile si
ripropone ancora l’opera di Bunin con Signore di San Francesco,
raccolta di 10 racconti tradotta da Alfredo Polledro per la collezione “Il
Genio Slavo”:
La popolarità che il recente premio Nobel per la letteratura ha dato
al nome di Bunin ha consigliato la casa ed. Slavia a dare prontamente alla
luce, a poche settimane di distanza dalla 3 edizione della “Campagna”, un
altro volume di Bunin, contenente una scelta di dieci sue novelle, che lo
stesso editore Polledro ha egregiamente tradotto con la sua abituale
competenza e sapienza […] I racconti di Bunin sono quadri dal vero, che
avvincono più per la forza delle loro tinte naturali che per l’interesse della
trama. In questo si palesa precisamente la maggiore caratteristica e la
forza dello scrittore.”104
L’ultima recensione relativa a opere russe del 1934, pubblicata nel
mese di luglio, riguarda l’antologia Russia rossa che ride. Novelle e
aneddoti sovietici, curata da Alfredo Polledro. Damiani scrive:
La rivoluzione ha mutato uomini e forme e aspetti di vita, ma non
il tono della vita, non il male della vita, non l’atteggiamento degli spiriti
verso la vita […] venticinque novelle umoristiche “tratte da sette autori
diversi per temperamento, per mentalità e per stile della Russia Sovietica
(Zòs’cenko, Romànov, Jàkovlev, Njevjèrov, Sejfùllina, Bàbel, Kozyrjòv)
e i cinquanta aneddoti che le intercalano sono eloquente conferma di
questa verità. Val la pena di leggerli, perché sono documenti non solo
letterari, ma psicologici, storici, sociali, e come tali rivestono un interesse
particolare anche per chi non s’occupi di lettere russe105.
103
E. Damiani, recensione a: Ivan Bunin, Il villaggio (Campagna). Romanzo. Prima
versione integrale dal russo e note di Valentina Dolghin Badoglio. Con pref. di Renato
Poggioli (Coll. “Il Genio Slavo”). Torino, “Slavia”, pp. 304, “Ibidem”, anno XVII, n.
2, febbraio 1934, p. 58.
104
E. Damiani, recensione a: Ivan Bunin, Il Signore di San Francisco. Racconti. Prima
versione dal russo con note di Alfredo Polledro (Coll. “Il Genio Slavo”). Torino,
Slavia, 1934, “Ibidem”, anno XVII, n. 4, aprile 1934, p. 121.
105
E, Damiani, recensione a: Russia rossa che ride. Novelle e aneddoti sovietici. Trad.
e notizie sugli autori di Alfredo Polledro. Pref. di Lorenzo Gigli. Torino, Slavia,
“Ibidem”, anno XVII, n. 7, luglio 1934, p. 214.
35
Fra le ultime annate della rivista relative al periodo in esame è
degna di nota quella del 1937, in cui si celebra il centenario della morte
di Puškin, a cui sono dedicate due recensioni di Paolo Emilio Pavolini,
autore di tutti i contributi russistici dell’anno; oltre a Puškin, anche
Tolstoj si legge tra le colonne del periodico insieme ad Alja
Rachmanova, scrittrice ancora poco nota ai lettori italiani, già presentata
in precedenza per la prima volta da Damiani.
Verso la fine del numero si leggono pochi articoli di letteratura
russa; l’ultimo è una recensione di Damiani al volume sulle liriche di
Puškin, tradotte in versi da Giovanni Gandolfi e introdotte da Giovanni
Maver. Lo slavista esalta la traduzione di Gandolfi, riconoscendo
l’indubbia difficoltà nel tradurre in versi un grande scrittore come
Puškin:
Come avviene in tutti i lavori del genere, non tutte le versioni
possono riuscire ugualmente convincenti nella loro forma italiana, perché
il Gandolfi traduce in versi e il tradurre in versi un grande poeta straniero
è sempre un’impresa di colossale difficoltà. Ma al Gandolfi non mancano
talento e maestria in questo genere di lavori ed egli riesce sovente a
mantenersi aderente all’originale quanto le esigenze del metro e le
diversità delle due lingue possono consentirlo senza offendere la forma
d’arte. Così che le sue versioni si leggono in generale con piacere e con
profitto106.
Fra tutti i contributi slavistici presenti nella rivista, la seconda
cultura slava maggiormente rappresentata, dopo la russa, è quella
polacca. Collaborarono a questa sezione di studi Leonardo Kociemski,
Paolo Emilio Pavolini ed Enrico Damiani.
Pavolini occupa il 1926 con quattro recensioni. La prima è un
breve contributo sulla concezione che Giovanni Maver aveva dell’arte
poetica di Juliusz Słowacki con un approfondimento sul tema
dell’“imitazione” letteraria, che lo slavista espone nei sui Saggi critici su
Juliusz Słowacki. La seconda parte del volume si sofferma sull’influenza
di alcuni grandi scrittori del passato nella poesia di Słowacki, tra i quali
Dante, Shakespeare e Andrzej Towiański107. Gli altri contributi sono
tutti relativi al mese di luglio, fra i quali uno dedicato ancora una volta a
Słowacki. Questa volta Pavolini introduce due operette dello scrittore
polacco, Jan Bielecki e Genezis z Ducha, nella traduzione italiana di
Aurelio Palmieri, di cui il recensore sottolinea la limpida e fedele
aderenza al testo originale:
106
E. Damiani, recensione a: Alessandro S. Puskin. Le liriche. Trad. di Giovanni
Gandolfi. Introduzione di Giovanni Maver. Lanciano, G. Carabba, pp. VIII-114. L.5, p.
304, “Ibidem”, XXIII, 11-12, novembre-dicembre, 1940.
107
Cfr. P. E. Pavolini, recensione a: G. Maver, Saggi scritici su Juliusz Slowacki.
Padova, Libr. Edit. Draghi, 1925; “Ibidem”, anno IX, 3, marzo, p. 50, 1926.
36
Queste due operette, tradotte dal P. con molta fedeltà e limpidezza,
segnano due punti estremi della ricca e varia produzione del grande poeta
polacco.
Soffermandosi sul poemetto Genezis z Ducha, “sublime visione
dialogica delle origini e degli svolgimenti della creazione”, l’A. mette in
evidenza i lati oscuri nella storia del testo, che il traduttore ha cercato di
chiarire avvalendosi di note e citazioni tratte da opere scientifiche:
Testo spesso oscuro e difficile agli stessi Polacchi; il traduttore ha
ben provveduto ad illustrarlo con note e con citazioni da opere
scientifiche (specialmente del nostro Stoppani), giovandosi altresì
dell’opera capitale del Pawlikowski Mystika Słowackiego108.
Gli altri due contributi riguardano Zygmunt Krasiński e Adam
Mickiewicz, che con Słowacki completano la ‘trilogia’ dei poeti
romantici. Nel primo caso si tratta della recensione alla traduzione
italiana del dramma Nie-Boska komedia, introdotta dal prof. Roman
Pollak; Pavolini esalta il lavoro “coscienzioso ed efficace” svolto dalla
traduttrice Maria Antonietta Kulczycka:
Ampia lode va data alla traduttrice, italiana di nascita ma per
ragioni di discendenza e di soggiorno esimia conoscitrice della lingua
polacca, per il suo lavoro coscienzioso ed efficace109.
Quanto a Mickiewicz, presenta un volume, Canti, che contiene
quattro fra le più note composizioni del “vate” polacco: Svitez, Sonety
krymskie, Farys e i sette quadri di Epizod, facendo notare la scelta di
Damiani di tradurre in prosa letterale:
Mentre in altre pregievoli versioni da poeti russi e polacchi il
Damiani ha conservato la forma metrica, ha tradotto in prosa letterale
questi Canti: e per più rigorosa fedeltà, e per porgere un più efficace aiuto
agli studiosi di questa bellissima fra le lingue slave110.
Nell’annata successiva della rivista, Damiani completa la figura
artistica di Zygmunt Krasiński con una diffusa recensione, pari a quasi
due colonne, al secondo dei capolavori dello scrittore, Iridion, per la
prima volta in traduzione italiana. Il poema è una rappresentazione
allegorica dell’inferno attraversato dalla Polonia nel corso della sua
108
P. E. Pavolini, recensione a: Jan Bielecki. La Genesi dello Spirito. Traduz. dal
polacco con proemio e note di A. Palmieri. Roma, Anonima Romana Editoriale, 1925,
pp. 109, “Ibidem”, anno IX, 7, luglio, 1926, p. 152.
109
P. E. Pavolini, recensione a: S. Krasinski, La non Divina Commedia. Trad. dal
polacco e note di M. Antonietta Kulczycka, con proemio del prof. R. Pollak. Roma,
Anonima Romana Editoriale, 1926, pp. 171, “Ibidem”, anno IX, 7, luglio, 1926, p. 152.
110
P. E. Pavolini, recensione a: A. Mickiewicz, Canti, trad. dal testo polacco da E.
Damiani, con pref. di R. Pollak, seguiti da uno studio del traduttore. Firenze, Vallecchi,
1926, pp. 162, “Ibidem”, anno IX, 7, luglio, 1926, p. 152.
37
storia e, al tempo stesso, la raffigurazione simbolica del martirio subito
dal popolo polacco sotto il giogo moscovita. Insieme a Nie-Boska
komedia, seppure con trame totalmente differenti, nacque da una
concezione:
L’”Iridione”, il secondo dei capolavori di Sigismondo Krasinski, si
riconnette idealmente col primo: “La Non divina Commedia”, sol di
pochi anni anteriore. Le due grandi opere, pur così profondamente diverse
nella trama nacquero da una concezione fondamentale comune: la visione
del crollo del regno di Satana, l’aspettazione della giustizia divina.
Furono entrambe dettate al poeta dal dolore disperato per lo strazio della
patria oppressa e smembrata […] L’inferno di Krasiński è l’inferno della
sua Polonia martoriata.
Dopo una dettagliata esposizione della trama, Damiani definisce
l’edizione italiana del testo “ottima sotto ogni aspetto”:
L’edizione italiana del poema, che era ancora completamente
ignorato fra noi, è ottima sotto ogni aspetto: diligente e fedele la versione,
buona la forma, bella la veste editoriale111.
Fra i restanti contributi polonistici firmati da Kociemski, i più
significativi sono uno su Władysław Reymont, l’altro su Stefan
Żeromski. Di Reymont l’A. segnala, in una breve recensione, il primo
volume del celebre romanzo Chłopy , meglio conosciuto come “l’epopea
contadina”, con qualche nota di disappunto per la scelta del traduttore,
Baniamino Aurora, di trascrivere il nome dello scrittore polacco
seguendo grafia e pronuncia russe:
Non comprendiamo bene per quale ragione il nome di battesimo
dell’autore sia stato storpiato e russificato, poiché, secondo la grafia
polacca, esso avrebbe dovuto essere trascritto Wladyslaw e secondo il
corrispondente nome italiano Ladislao. Mentre così, come lo vediamo
sulla copertina, Wladislaw, esso appare trascritto secondo la grafia e
conformamente alla pronunzia russa112.
Qualche anno più tardi, nel 1931, viene pubblicata la recensione di
Kociemski a Ceneri, prima versione integrale dal polacco fra le edizioni
di Slavia del romanzo di Żeromski Popioły. Il contributo costituisce una
lunga e dettagliata analisi del capolavoro dello scrittore polacco, da poco
scomparso, ancora poco noto in Italia se non per una raccolta di novelle
e alcuni articoli di Ettore Lo Gatto e dello stesso Kociemski:
111
E. Damiani, recensione a: Sigismondo Krasinski, Iridione. Prima versione italiana
di Clotilde Garosci. Introduzione di Cristina Agosti-Garosci. Pubblicazione della
Sezione Romana dell’Associazione “Adamo Mickiewicz”. Roma, 1926, “Ibidem”,
anno X, 8, agosto, 1927, pp. 182-183.
112
Leonardo Kociemski, recensione a: Wladislaw St. Reymont. I contadini. Romanzo.
Vol. I- L’Autunno. Prefazione di Taddeo Zielinski. Traduzione dal polacco di
Beniamino Aurora. Aquila, Casa Editrice Vecchioni, “Ibidem”, anno XI, 4, aprile,
1928, p. 100.
38
L’autore è presso che ignoto al gran pubblico al quale sarà sfuggita
certamente una piccola raccolta di novelle pubblicata dieci anni or sono
da Rinaldo Caddeo nella traduzione del sottoscritto, come saranno
sfuggiti gli studi e gli articoli di Ettore Lo Gatto e del sottoscritto intorno
allo Zeromski, scritti per commemorarlo all’epoca della sua prematura
morte. Sarebbe troppo lunga la definizione del posto spettante allo
Zeromski nel quadro della letteratura contemporanea polacca e perciò
dobbiamo rimandare il lettore agli studi ed agli articoli suaccennati.
Il recensore conclude il suo intervento invitando i lettori ad una
riflessione:
Ci sembra giusta l’osservazione contenuta nell’introduzione circa
l’utilità delle ricerche delle divergenze fra “Le Ceneri” e “Guerra e Pace”
di Tolstoj: esse servirebbero per spiegare a coloro che ignorano le
differenze tra la Polonia e la Russia, fino a che punto esiste l’abisso
spirituale tra coloro che accettarono la guida di Roma sulle rive della
Vistola e coloro che ricercarono a Bisanzio il contenuto ideale della loro
vita113.
Infine, merita una menzione un ampio contributo di Luigi Salvini
che, presentando il volume Sonetti di Crimea ed altre poesie di Adam
Mickiewicz a cura di Mieczystaw Brahmer ed Enrico Damiani, fa una
lunga e dettagliata rassegna delle varie edizioni di Poezye del vate
polacco a partire da quella curata dallo stesso Damiani nel 1926 per la
collana “Classici Moderni” della Vallecchi. Particolarmente interessante
il riferimento a saggi e studi di Roman Pollak ed Ettore Lo Gatto,
pubblicati su riviste italiane e dedicati a Mickiewicz, con cui Salvini
auspica, infine, la nascita di una bibliografia italiana dei suoi scritti:
Non è qui il caso di continuare le citazioni. Ma mi sembra che se il
successo meritato arriderà all’iniziativa ed avremo una seconda edizione
di questo lavoro del Damiani e del Brahmer, l’opportunità di una
bibliografia italiana potrà venire esaminata dagli autori114.
I contributi relativi alla cultura ceca sono in tutto cinque. Il primo,
pubblicato nel numero di settembre del 1923, è la recensione di Damiani
a due racconti dello scrittore e giornalista Karel Matĕj Čapek-Chod in
versione italiana, Favola candida e Xⁿ Yⁿ=Zⁿ (La formula di Fermat), di
cui lo slavista loda la traduzione dal ceco eseguita da Maeia
113
Leonardo Kociemski, recensione a: Stefano Zeromski. Ceneri. Romanzo. Prima
traduzione integrale dal polacco con introduzione e note di Cristina Agosti Garosci e
Clotilde Garosci. Torino, “Slavia” 1930, 2 voll., “Ibidem”, anno XIV, 3, marzo, 1931,
pp. 85-86.
114
Luigi Salvini, recensione a: Adam Mickiewicz, Sonetti di Crimea ed altre poesie.
Testo polacco con introduzione, note e dizionario per uso degli studiosi italiani a cura
di Mieczystaw Brahmer ed Enrico Damiani. Roma, Istituto per l’Europa Orientale
(I.p.E.O.), 1939-XVII, pp. 114, “Ibidem”, anno XXII, 2, febbraio, 1939, pp. 56-57.
39
Voltrubova115. Allo scrittore ceco è poi dedicato un contributo di Enrico
Caprile del mese di maggio del 1932, che è la presentazione del romanzo
La Turbina, edizione italiana di Jolanda Torraca Vesela per Slavia. Il
romanzo, insignito del Premio lettarario di Stato cecoslovacco, viene
introdotto dalla studiosa dopo una breve descrizione di Čapek-Chod
come figura di primo piano nella letteratura boema moderna, influenzata
dal romanzo psico-sociale russo e francese. Caprile, infine, ne loda la
traduzione italiana e l’ottima introduzione critico-bibliografica116.
Al noto drammaturgo Karel Čapek sono, invece, dedicati due
contributi. Il primo, pubblicato a settembre dell’anno successivo, cioè il
1924, è di Bartoš Vlček, che presenta i diari di viaggio di Čapek, noto in
Italia attraverso il dramma La Vita pubblicato da Mondadori. I diari,
nella versione originale ceca Italské listy (Lettere italiane), sono un
dettagliato resoconto del viaggio in Italia, dove Čapek non si limita alla
descrizione di musei e gallerie d’arte ma registra la quotidianità dei
piccoli borghi e delle viuzze. Vlček ne sottolinea la semplicità dello
stile, “a metà tra poesia in prosa e giornalismo”117. Il secondo, nel
fascicolo di novembre del 1926, è a firma di Aldo Gabrielli ed è la
recensione alla celebre commedia di Čapek in versione italiana L’affare
Makropulos, tradotta dal ceco da Taulero Zulberti. Gabrielli sottolinea lo
scrupoloso studio critico alla base del lavoro118.
L’ultimo contributo della rivista sulla cultura ceca è quello a firma
di Hilda Montesi Festa su Babička (La nonna), romanzo della scrittrice
boema Božena Ňemcová sulle virtù campagnole di una buona
vecchietta, destinato a giovani lettori119.
E’ qui opportuno un breve ragguaglio sulla ricezione della
letteratura ceca in Italia nel primo dopoguerra.
Dal 1925, anno in cui comparve la prima traduzione in volume di
Babička di Božena Ňemcová, fino alla Seconda guerra mondiale,
qualunque proposta editoriale doveva sottostare, come per la letteratura
russa, alle norme della censura fascista. Fino al 1938, infatti, vengono
pubblicati soprattutto libri di autori dell’Ottocento come Božena
Ňemcová, Karel Matej Čapek-Chod, Jan Neruda, Julius Zeyer, e una
115
Enrico Damiani, recensione a: Capek Chod C., Favola Candida - Xⁿ Yⁿ=Zⁿ (La
formula di Fermat). Traduzione dal ceco di Maria Voltrubova. Con una notizia di B.
Chiurlo. Udine, Libreria Editrice Udinese, 1927. Un vol., pp. 63. L. 3 (Biblioteca
italiana e straniera diretta da B. Chiurlo e G. Lorenzoni, Serie III, n° 6), “Ibidem” anno
VI, 9, settembre, 1923, p. 203.
116
Enrico Caprile, recensione a: K. M. Ciapek-Chod. La Turbina. Traduzione ed
introd. di J. Torraca Vesela. Torino, “Slavia”, 1931, 2 voll., “Ibidem”, anno XV, 5,
maggio, 1932, p. 150.
117
Bartos Vlcek, recensione a:Karel Capek, Italské listy (Lettere italiane). Praha,
Edizione “Aventinum”, “Ibidem”, anno VII, 9, settembre, p. 167.
118
Aldo Gabrielli, recensione a: Karel Ciapek, L’affare Makropulos. Traduzione e
introduzione di Taulero Zulberti. Milano, Casa Editrice Alpes, 1926, “Ibidem”, anno
IX, novembre, 11, p. 243.
119
Hilda Montesi Festa, recensione a: Božena Ňemcova, La nonna (Babička). Milano,
L. F. Cpgliati, 1925, “Ibidem”, anno IX, 1, gennaio, 1926, p. 10.
40
prima versione poetica di Maggio, il grande poema di Karel Hynek
Macha. Ma anche considerando tutte le limitazioni imposte dalla censura
è evidente che da questa prima scelta restarono fuori nomi non meno
importanti dell'Ottocento letterario ceco come Vitĕzslav Hálek, Karel
Havlíček Borovský, a Jiří Karásek e Jakub Arbes, le cui prime
traduzioni, II diavolo alla tortura e II cervello di Newton, sono uscite
soltanto, rispettivamente, nel 1990 e nel 1995. Del resto, attraverso le
maglie della censura, durante il ventennio fascista, riuscirono a passare,
e con più di un titolo ciascuno, sia il democratico Karel Čapek, che, oltre
ad essere lo scrittore ceco candidato al premio Nobel, era amico e
collaboratore di T.G. Masaryk, presidente della democratica Repubblica
cecoslovacca, sia il comunista Ivan Olbracht.
Tra i primi traduttori dal ceco attivi in Italia nel primo dopoguerra
vanno ricordati Jolanda Torraca Vesela, Tommaso Zulberti, Marie
Votrubova, Riccardo Selvi, Umberto Urbani e Wolfango Giusti120.
Gli ultimi contributi slavistici ne “L’Italia che scrive” sono
dedicati alla cultura serbo-croata, bulgara e ucraina. Nel primo caso,
Leonardo Kociemski interviene nel numero di aprile del 1928 con la
recensione a La leggenda di S. Cristoforo, romanzo del poeta dalmata
Vladimir Nazor, ancora poco noto fra gli slavisti italiani, nella
traduzione italiana dal serbo-croato dello stesso autore121. Lo stesso
Kociemski è anche l’autore di due recensioni, pubblicate a settembre
dello stesso anno: una al volume di Enrico Damiani, in cui lo slavista
riproduce la conferenza dell’Associazione Artistica Internazionale sulla
promozione della cultura bulgara, tenutasi in Italia in occasione del
cinquantenario dell’indipendenza della Bulgaria, l’altra alla raccolta del
poeta bulgaro Penčo Slavejkov, tradotta in versi italiani dallo stesso
Damiani122. Infine, alla cultura ucraina è riservata la recensione di
Ettore Lo Gatto di Marussia, racconto della scrittrice Maria Markovič
Vovčok, destinato a un pubblico infantile123.
120
Per approfondimenti rimando a: Dario Massimi, La diffusione della cultura
letteraria ceca in Italia in “La Nuova rivista italiana di Praga”, 1, 2000 (sito:
http://vulgo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Aladiffusione-della-cultura-letteraria-ceca-in-italia&catid=95%3Atraduzioni).
121
Leonardo Kociemski, recensione a: Vladimir Nazor, La leggenda di S. Cristoforo.
Romanzo. Traduzione dal serbo-croato dell’autore. Prefazione di Umberto UrbanazUrbani. Aquila, Casa Editrice Vecchioni, 1928, “Ibidem”, anno XI, 4, aprile, 1928, p.
100
122
Leonardo Kociemski, recensione a: Enrico Damiani, Gli albori della letteratura e
del riscatto nazionale in Bulgaria. Roma, Anonima Romana Editoriale, MCMXXVIII
– Penco Slavèjkov, Canti epici e lirici, scelti e volti in versi italiani sul testo bulgaro da
E. D. Venezia, “La Nuova Italia” Editrice, 1928, “Ibidem”, anno XI, 9, settembre, p.
294.
123
Ettore Lo Gatto, recensione a: Marco Vovzog. Marussia. Leggenda ucraina.
Riduzione di Maria Ettlinger-Fano. Paravia editore, “Ibidem”, anno V, 4, aprile, 1922,
p. 70.
41
I numerosi interventi permettono di osservare un’evoluzione nelle
proposte dei recensori ai lettori italiani. Analizzando i dati complessivi
relativi alla cultura russa, si evince una decisa maggioranza di opere
prerivoluzionarie riscontrata per le recensioni degli anni Venti, in gran
parte su autori dell’Ottocento e scrittori e poeti dell’inizio del ventesimo
secolo, seguita negli anni Trenta da un forte calo, che lascia spazio a una
maggiore presenza di autori contemporanei. Si è, infatti, riscontrata una
certa omogeneità nelle recensioni, riferite anche ad autori sovietici e
dell’emigrazione.
Valutando complessivamente la presenza della cultura russa nella
rivista durante il periodo 1918-1940 si nota come fra gli autori recensiti
siano più ricorrenti i “classici” dell’Ottocento, quasi tutti prosatori,
soprattutto Dostoevskij, Tolstoj, Čechov e Turgenev, e molto meno i
contemporanei come Kuprin, Sologub, Evrejnov e Gor’kij.
Sintetizzando tutto in un grafico si conclude:
Dostoevskij
Tolstoj
Čechov
Turgenev
Andreev
Kuprin
Gogol'
Puškin
Blok
Sologub
Felyne
Lermontov
Ostrovskij
Gončarov
Romanov
Bulgakov
Bunin
Saltykov-Ščedrin
Krylov
Gor'kij
Merežkovskij
Solov'ëv
Garšin
Zajcev
Arcybašev
Korolenko
Averčenko
Leskov
Aldanov
Veresaev
Sejfullina
Lunc
Evrejnov
Lidin
Babel'
Griboedov
Jakovlev
42
Particolarmente interessante è notare come la presenza delle
culture russa e polacca sia nettamente superiore a quella di altre culture
slave:
Russa
Polacca
Ceca
Serbocroata
Bulgara
165; 81%
1; 0%
1; 0% 1; 0% 5; 2%
33; 17%
2. “I libri del giorno” (1918-1929)
Il secondo periodico specializzato nell’informazione bibliografica,
nel commento e nella recensione di libri, nonché nella divulgazione dei
dibattiti culturali è “I libri del giorno. Rassegna mensile internazionale”.
La testata, edita a Milano dai fratelli Treves e uscita regolarmente in esili
fascicoletti mensili tra l’aprile 1918 e il dicembre 1929, si proponeva di
conciliare le caratteristiche dell’agile bollettino informativo, concepito
per ragguagliare rapidamente sulle novità letterarie del momento, con
più concrete strategie di autopromozione della casa editrice, a quel
tempo tra le più vivaci nell’editoria italiana. Fondatore e direttore fu
Giovanni Beltrami, ma la direzione nel 1923 passò a Valentino Piccoli,
che vi rimase fino alla cessazione delle uscite nel 1929124. Giornalista
vicino al regime fascista, Piccoli non compromise tuttavia il carattere
aperto della rivista, lasciando spazio al libero dibattito nelle sezioni
dedicate alle letterature europee così come a problematiche di natura
storica e filosofica.
124
Cfr. Indice Bibliografico italiano, 4° edizione corretta ed ampliata (2007), a cura di
Tommaso Nappo, München, K. G. Saur, II 466, 200-206.
43
Ucraina
Sulle pagine della rivista, furono combattuti molti stereotipi legati
al regime, specialmente nelle rubriche dedicate alle letterature straniere.
Anche dopo le leggi speciali per la stampa del 1925-1926 queste
rubriche continuarono ad esistere, ciascuna affidata a uno specialista
della materia in qualità di recensore principale, rimasto quasi sempre lo
stesso fino al 1929. Tra i più accreditati meritano una menzione Lavinia
Mazzucchetti per la Germania, Arrigo Cajumi per la Francia, Piero
Rèbora per l’Inghilterra ed Ettore Lo Gatto per la Russia. Nelle pagine
del periodico trovano spazio recensioni a volumi editi in lingua
originale, che non sempre avrebbero riscosso popolarità in traduzione
italiana. La non facile reperibilità di queste novità editoriali da parte dei
lettori indusse i recensori a svolgere lavori descrittivi ampi e dettagliati;
inoltre, la fortuna del periodico si configurò fin da subito come risposta
milanese a “L’Italia che scrive”, che si occupava con un taglio simile
degli stessi contenuti. Le due riviste, antagoniste fra loro e innovative
dal punto di vista degli argomenti trattati, servivano un settore del
mercato librario ed editoriale che, con la conclusione della Prima Guerra
Mondiale, stava attraversando una fase di rinnovato interesse per l’arte e
la letteratura; la concorrenza fra i due periodici era più intellettuale che
commerciale, entrambi avevano l’obiettivo di diffondere e promuovere
le culture straniere in Italia125.
Tra i collaboratori della rivista figurano nomi fra i più stimati
nell’editoria italiana: Giuseppe Antonio Borgese, Antonio Baldini e l’ex
‘vociano’ Giuseppe Prezzolini. Nelle primissime annate, in particolare
dal 1918 al 1920, l’interesse per il mondo slavo rimane ancora modesto,
orientato o verso questioni di stringente attualità, il bolscevismo, o verso
la storia della Russia, parallelamente all’evolversi della situazione sociopolitica nel paese. Le segnalazioni bibliografiche relative all’area slava
sono limitate a sporadici riferimenti alla narrativa russa, collocate prima
nel ‘Bollettino bibliografico’ in fondo a ciascun fascicolo, poi nella
rubrica fissa ‘Libri di cui si parla’. Curatori ‘ufficiali’ della sezione slava
sono, a partire dal 1921, Ettore Lo Gatto per ‘Russia’, ‘Bulgaria’ e
‘Polonia’, Giovanni Maver per le ‘Letterature slave meridionali’,
‘Bulgaria’ e ‘Polonia’, e Aurelio Palmieri solo per la ‘Polonia’.
Ettore Lo Gatto collaborò dalla prima all’ultima annata con un
grande vantaggio per la conoscenza di scrittori e prosatori russi, e slavi,
da parte del pubblico. Le sue recensioni furono sempre puntuali e quasi
sempre anticipatrici nel considerare opere di autori ancora poco noti in
patria che presto sarebbero assurti con fama al panorama letterario
internazionale. Lo slavista non si limitò a recensire gli autori russi ma
125
Per approfondimenti sulla rivista rimando a: G. Tortorelli, Una rivista per l’editoria
“I libri del giorno” 1918-1929, in Id., Parole di carta. Studi di storia dell’editoria,
Ravenna, Longo, 1992; F. Tortorelli, Op. cit., pp. 80-122; Id., La letteratura straniera
nelle pagine de “L’Italia che scrive” e “I libri del giorno”, in Luisa Finocchi, Ada
Gigli Marchetti (a cura di), Stampa e piccola editoria tra le due guerre, Milano,
FrancoAngeli, 1997, pp. 157-196.
44
insieme ad altri giornalisti, studiosi e letterati illustrò il mondo slavo nel
suo complesso e l’Europa orientale. I risultati della ricerca hanno
accertato che la collaborazione dello slavista al periodico è ben più
prolungata di quella segnalata nella bibliografia di Lo Gatto presente nel
volume Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver (Roma, G.
C.
Sansoni, 1962), al cui interno veniva testualmente riferito:
“Collaborazione mensile alla rivista “I Libri del Giorno”, Milano,
Treves, dal luglio 1921 al settembre 1925 (su argomenti di letteratura
russa)”126.
La bibliografia indicava, dunque, come data di termine dell’attività
di Lo Gatto il mese di settembre del 1925, laddove nello stesso anno
l’ultimo intervento si colloca al mese di novembre127. Genericamente
ascritta al quinquennio in questione, tale collaborazione non era stata
finora studiata e approfondita, in assenza, tra l’altro, di un indice degli
interventi dello studioso in ogni mensilità del periodico; inoltre, non
venivano menzionati altri contributi dello slavista su altri periodici come
“Leonardo. Rassegna bibliografica mensile” e “L’Italia che scrive”,
contemporanei e complementari a quelli su “I Libri del Giorno”.
Sebbene con frequenza minore che nel quinquennio oggetto di studio, la
collaborazione si estese in generale fino al 1929, ultimo anno di
pubblicazione del periodico. Solo recentemente, infatti, è stata compilata
una bibliografia completa dei contributi di Lo Gatto presenti in ciascuna
annata128.
Dal punto di vista storico il quinquennio 1921-1925 coincide con
un periodo di crescita dell’editoria italiana, seppur difficoltosa e
graduale, ed è in questa fase che Lo Gatto collabora a riviste di
letteratura e bibliografia, non limitate ad un unico campo d’indagine e di
rilevante interesse culturale. Qui si distinse nello scoprire scrittori
emergenti molto prima della loro consacrazione internazionale, e come
altri curatori delle rassegne estere’ ne “I libri del giorno” mostrò una
particolare attenzione alla qualità delle traduzioni dei libri recensiti,
segnalando criticamente e con scrupolosi commenti il valore delle
trasposizioni129. In un articolo di novembre del 1925, Lo Gatto proclama
la sua dichiarazione programmatica sull’arte della traduzione. Scrivendo
a proposito di una recente traduzione poetica dell’Evgenij Onegin, uscita
126
Mi riferisco qui al saggio introduttivo Quarant’anni di slavistica italiana
nell’opera di E. Lo Gatto e G. Maver, ivi, pp. 1-21. Oltre a questa bibliografia, finora
la più documentata e aggiornata sull’autore, cfr. pure Studi in onore di Ettore Lo Gatto
(Roma, Bulzoni, 1980) a cura di Antonella D’Amelia.
127
Cfr. Ettore Lo Gatto, Otokar Brezina, “I libri del giorno”, anno XII, 11, novembre
1928, pp. 662-664,.
128
Cfr. Cristiano Diddi, La slavistica italiana del primo dopoguerra nella rivista “I
libri del giorno” (1918-1929), “Europa Orientalis” 27 (2008), pp. 209-234. Vedi
Appendice. Bibliografia di Ettore Lo Gatto, Giovanni Maver e Aurelio Palmieri in “I
libri del giorno”.
129
Gianfranco Tortorelli, Op. cit., pp. 170-183.
45
per la collezione polacca di letteratura universale “Biblioteka
Narodowa”, lo slavista commenta:
La traduzione è sempre traduzione, e la freschezza dell’ispirazione
dell’originale non l’avrà mai neanche il più ispirato dei traduttori, perché la
sua ispirazione è, vuoi o non vuoi, di seconda mano. Tuttavia alcune
traduzioni sono possibili e possono riuscir bene, se al traduttore non faccia
difetto il buon senso130.
Fiducioso che la cultura italiana potesse aggiornarsi velocemente
sulla nuove tendenze letterarie dell’epoca e mosso da un particolare
entusiasmo per gli studi slavistici, Lo Gatto sembrava, a volte, dare per
scontato alcuni argomenti trattati. A uno sguardo attento, lo slavista
menziona un gran numero di artisti e letterati russi, case editrici e riviste
attive in tutta Europa omettendo, spesso, i nomi propri degli autori, col
rischio di renderne dubbia l’identificazione da parte dei lettori, sia per
frequenti omonimie, sia per scelte traslitterative diverse. Altre volte si ha
l’impressione che alcuni tratti di storia letteraria russa richiedano da
parte sua una maggiore delucidazione in quanto ‘oscuri’ o, comunque,
non sempre accessibili ai non specialisti. Bisogna, però, considerare che
nonostante l’invidiabile preparazione documentaria accumulata da Lo
Gatto nel corso degli anni, egli poteva accedere a un numero limitato di
fonti in un panorama editoriale europeo in crisi. Di conseguenza, lo
studioso non riusciva sempre a distinguere, per quanto riguarda la
letteratura russa contemporanea, un autore ‘rilevante’ da un altro
‘minore’, includendo così una considerevole quantità di informazioni
apparentemente superflue, e tuttavia di grande valore documentario in
un settore di studi ancora poco conosciuto in Italia. A quell’epoca, poi,
mancavano studi specialistici in ambito slavistico, avviati solo più tardi
proprio da lui e da Giovanni Maver, e i suoi scritti tradivano spesso un
pensiero politico filosocialista. Come sostiene Gianfranco Tortorelli
il tono usato nelle sue recensioni è garbato, espositivo, perfino
dimesso, anche quando serve ad esprimere dubbi sull’attività o sulle
opere di altri personaggi del panorama letterario italiano, traduttori,
recensori e critici. Nei suoi scritti è sempre presente una certa
disponibilità al confronto e al dialogo, cercando sempre di assecondare le
aspettative del pubblico, un atteggiamento da considerarsi perfettamente
in linea con la scelte editoriali de “I libri del giorno.131
I primi contributi, pubblicati da Lo Gatto nel 1921, descrivono
l’attività editoriale dei profughi russi all’estero, spesso appartenenti alla
borghesia, e a quell’intelligencija lontana dalle masse contadine, che era
il motore intellettuale e progressista della Russia. Citando le varie
130
Ettore Lo Gatto, Puškin in polacco, in ‘Polonia’, “Ibidem”, anno VIII, 11,
novembre, 1925, pp. 604-606.
131
Gianfranco Tortorelli, La letteratura straniera nelle pagine de “L’Italia che scrive”
e “I Libri del Giorno” (Op. cit.), p. 171.
46
colonie in esilio, in Italia e all’estero, Lo Gatto descrive i circoli letterari
e documenta l’attività delle loro case editrici, fra le quali “Ladyšnikov” a
Berlino, “Naša reč’” a Praga, “Novaja Russkaja Žizn’” in Finlandia e
“Svoboda” a Varsavia, recensendone monografie, almanacchi e riviste.
Nella stessa annata, Lorenzo Gigli celebra il centenario della nascita di
Dostoevskij con un ampio articolo, che approfondisce il rapporto tra
estetica e vita nelle opere dello scrittore, confrontando la sua biografia
con quella di Gogol’, da cui fa derivare la natura stessa dell’arte
narrativa dostoevskiana132.
Un secondo filone di studi che occupa gli articoli di Lo Gatto
riguarda la poesia contemporanea nella rubrica ‘Libri di cui si parla’.
Nei vari contributi lo slavista fornisce particolari preziosi sulla vita e le
opere dei singoli protagonisti; attento sia ai fenomeni legati alla
rivoluzione e all’attività politica di partito, sia alle vecchie guardie
letterarie prerivoluzionarie, ne commenta le opere anche in contrasto con
le opinioni della critica letteraria russa dell’epoca. Nei primi due articoli
Lo Gatto sottolinea la scarsa conoscenza in Italia della poesia russa
contemporanea, fenomeno già evidente prima della guerra mondiale, e
cita le fonti disponibili, dal “Parnaso russo”, edito a Lipsia, alle varie
antologie pubblicate a Praga e a Costantinopoli. Nell’annata successiva
vengono presi in esame una serie di studi dedicati a poeti bolscevicofuturisti come Jaroslavskij, poeti contadini come Kljuev e Esenin, e
alcuni rappresentanti della poesia simbolista in particolare Ivanov e
Brjusov. A partire dal 1923 la rubrica è occupata da articoli dedicati a
scrittori contemporanei: il primo di essi traccia un bilancio dell’attività
letteraria in Russia dal 1918 al 1922, citando gli studi dei critici letterari
dell’epoca. Seguono, negli anni successivi, una serie di interventi di
vario contenuto all’interno della medesima rubrica. Per quanto riguarda
la poesia, Lo Gatto menziona varie antologie uscite in italiano e in altre
lingue straniere, presentando la nuova letteratura russa come l’opera di
giovani scrittori “soviettisti”, alcuni dei quali nulla hanno a che fare col
bolscevismo, ed elencando, fra gli altri, l’attività creativa di Brjusov,
Vjačeslav e Vsevolod Ivanov, Belyj, Esenin, Majakovskij, e i
Serapionovy brat’ja Zoščenko e Tichonov. Si tratta di un gruppo di
scrittori dei quali si occupavano in quel periodo le riviste
dell’emigrazione “Volja Rossii”, organo dei socialisti rivoluzionari, con
articoli di Mark Slonim, e “Sovremennye Zapiski”, con saggi di Osorgin
e Stepun. Fra i romanzieri e i novellieri vengono approfondite le
personalità di Bunin, Sologub, Gor’kij, Babel’, Leonov, Sejfullina e
Remizov133. Sempre a proposito della poesia, una particolare attenzione
viene riservata a Puškin in occasione di alcuni studi scientifici in suo
132
Cfr. Lorenzo Gigli, Il centenario di Dostoevskij, “I libri del giorno”, anno IV, 12,
dicembre, 1921, pp. 632-636.
133
Cfr. Ettore Lo Gatto, Letteratura narrativa, in ‘Libri di cui si parla’ – Russia, “I
libri del giorno”, anno VIII, n. 8, agosto, 1925, pp. 434-436.
47
onore. Alla sua opera sono dedicati alcuni articoli, uno di essi esamina le
ristampe di saggi di recente pubblicazione134.
Significativo fu l’impulso dato agli studi dostoevskiani a partire
dal 1921, anno in cui fu celebrato il centenario della nascita di
Dostoevskij, di cui Lo Gatto recensì opere in lingue inedite, senza
tralasciare le buone traduzioni disponibili in italiano135. Nel primo
articolo dedicato all’opera di Dostoevskij, Lo Gatto ricorda le
pubblicazioni degli scritti già uscite alla vigilia delle celebrazioni del
centenario. A fronte delle annunciate versioni italiane di quasi tutte le
opere eseguite direttamente sui testi originali, lo studioso evidenzia
come solo alcune siano state portate a compimento. Si tratta di un
volumetto di traduzioni contenente Slaboe serdce e Malen’kij geroj,
tradotti da Ol’ga Resnevič Signorelli nei “Quaderni della Voce”, e il
primo volume del Dnevnik pisatel’ja, tradotto dallo stesso Lo Gatto in
uscita per le edizioni I.p.E.O136. A questo seguono altri contributi
dedicati a scritti e frammenti inediti, tratti da opere varie; in particolare
uno di essi, pubblicato nell’agosto 1922, dove lo slavista sottolinea la
notizia apparsa sui giornali dell’epoca, e ignorata da buona parte dei
lettori, relativa alla scoperta di una cassa contenente manoscritti di
Dostoevskij e trasportata a Mosca per lo spoglio. Chiudono l’articolo
alcune citazioni da taccuini e frammenti tratti da capitoli inediti di Besy,
da poco in ristampa a Berlino137. Un altro avvenimento importante
celebrato nel 1924 fu il centenario della morte di Byron: Lo Gatto per la
Russia e Palmieri per la Polonia parlarono dell’influenza del
romanticismo inglese su scrittori russi, Puškin e Žukovskij, e polacchi,
Malczewski, Słowacki, Mickiewicz e Krasiński138.
Tra i pensatori, critici e filosofi russi di cui Lo Gatto menziona
opere autografe o studi dedicati vi sono fra gli altri Berdjaev, Solov’ëv,
Korolenko, N. K. Michajlovskij, N. O. Losskij e S. Frank, noto per le
numerose conferenze sulla filosofia tenute a Roma. Per la filosofia
cosiddetta “pubblicistica” o “letteraria” figurano anche Vjačeslav Ivanov
e Geršenzon, per la storia della Russia Ključevskij e Platonov139.
Infine, concludendo sulla collaborazione di Lo Gatto alla rivista
dal 1926 al 1929, oltre agli articoli dedicati a Gor’kij, Aldanov e
Arcybašev, lo slavista traccia un bilancio delle recenti pubblicazioni
degli scritti di Tolstoj. Tali pubblicazioni hanno accompagnato in Russia
le celebrazioni del primo centenario della nascita dello scrittore, svoltesi
134
Cfr. Ettore Lo Gatto, Puskininana, “Ibidem” - Russia, pp. 548-550.
Vedi infra.
136
Cfr. Ettore Lo Gatto, Dostoevskij in Italia, “Ibidem”, anno V, n.1, gennaio, 1922,
pp. 7-9.
137
Cfr. Ettore Lo Gatto, Dostoevskij inedito, “Ibidem”, anno V, n. 8, agosto, 1922, pp.
433-435.
138
Cfr. Ettore Lo Gatto, Byron e la Russia, pp. 175-175 – Aurelio Palmieri, Byron e la
Polonia, pp. 177-180, “Ibidem”, anno VII, n. 4, aprile, 1924.
139
Cfr, Ettore Lo Gatto, Libri di storia, “Ibidem”, anno VIII, n. 3, marzo, 1925, pp.
148-149.
135
48
nel settembre del 1928, in attesa dell’Opera omnia in 92 volumi
annunciata dalla casa editrice governativa140. L’articolo era stato già
preceduto da un altro contributo di Mario Parodi sul centenario,
pubblicato nell’annata precedente141.
Per “I libri del giorno” Lo Gatto curò, saltuariamente, alcune
sezioni relative ad altre letterature slave. Per quanto concerne la
bulgara, lo slavista evidenzia la poesia popolare moderna di Ivan Vazov
e Penčo Slavejkov e l’apertura europeista di Petko Todorov, Pjejo
Javorov e Kiril Hristov. Quanto alla letteratura polacca, viene
approfondita la figura di Władysław Stanisław Reymont142.
Fra i numerosi contributi di Aurelio Palmieri dedicati alla
letteratura polacca, oltre alle note d’informazione bibliografica e agli
articoli sulla biografia e le opere dei poeti romantici Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki143, e degli scrittori Jan Kasprowicz e Stefan Żeromski,
ne vanno segnalati due in particolare. Il primo illustra il panorama
culturale della Polonia con la nascita di nuove riviste letterarie, il
secondo ripercorre le tappe che condussero alla genesi dell’edizione
definitiva di tutti gli scritti di Słowacki con un’interessante introduzione
sulla storia dell’Ossolineum, la biblioteca privata di Józef Maksymilian
Ossoliński a Leopoli, sede di preziosi manoscritti e autografi delle
principali opere dello scrittore144.
Restando in ambito polonostico, è interessante sottolineare un
significativo incremento di contributi tra il 1927 e il 1929 firmati da
Giovanni Maver, che nel 1929 ricopre a Roma la prima cattedra italiana
di lingua e letteratura polacca. In particolare, sono degni di menzione
due recensioni ai volumi di Michał Janik, Dzieje Polaków na Syberii,
basato sulle memorie e sulle osservazioni di alcuni polacchi esuli in
Siberia, protagonisti della prima e seconda ondata rivoluzionaria del
1831 e del 1863, e di Stella Olgierd, Novellieri polacchi, con prefazione
di Giovanni Papini, recente pubblicazione sull’arte narrativa degli ultimi
anni in Polonia. Con l’eleganza espositiva e il sottile garbo che
contraddistinguono gli scritti di Maver, lo slavista riesce a descrivere le
140
Cfr. Ettore Lo Gatto, Tolstoiana, in ‘Rassegne Estere’ – Russia, “Ibidem”, anno XII,
n. 4, aprile, 1929, pp. 244-245.
Cfr. Mario Parodi, I cento anni di Leone Tolstoi, “Ibidem”, anno XI, n. 9, settembre,
1928, pp. 536-538.
141
Vedi Bibliografia ragionata.
142
Cfr. e.[ttore] l.[o] g.[atto], Ladislao Stanislao Reymont, in ‘Libri di cui si parla’ –
Polonia, “I libri del giorno”, anno VII, n. 12, dicembre, 1924, p. 659.
143
Di Mickiewicz e Słowacki Palmieri tornò a occuparsi anche sulle pagine di “Europa
Orientale”, rivista ufficiale dell’I.p.E.O., di cui fu direttore per la sezione slava. Cfr.
Aurelio Palmieri, L’opera culturale dell’Istituto per l’Europa Orientale, “La Vita
italiana”, XIII, 1925, pp. 150-151.
144
Cfr. Aurelio Palmieri, Le nuove riviste letterarie in ‘Libri di cui si parla’ – Polonia,
“Ibidem”, anno VI, n. 11, novembre, 1923 – Id., L’edizione “autentica” delle opere di
G. Slowacki, “Ibidem”, anno IX, n. 1, gennaio, 1926, pp. 602-604.
49
principali caratteristiche della letteratura polacca del XIX secolo,
distinguendola da quella russa per la costante presenza di temi patriottici
dall’età romantica a quella contemporanea145.
Nella sezione dedicata alle letterature slave meridionali, oltre ai
numerosi interventi sulla poesia slovena, croata e serba di scrittori
classici, Prešeren e Ivan Cankar, e personalità ‘minori’, Radičević e
Preradović, Giovanni Maver riserva uno spazio al teatro croato, con uno
sguardo speciale ai drammi di J. Kosor (Požar strasti), M. Begović
(Svadbeni let – Božji čoviek), del giovane Miroslav Krleža (Vučjak) e del
raguseo Ivo Vojnović146. Alcuni scrittori dell’area slavo-meridionale, mi
riferisco a Oton Župančič e Ivo Vojnović, saranno poi approfonditi sulle
pagine di “Rivista di letterature slave” e “L’Europa Orientale”147.
Volendo, infine, dare una rappresentazione visiva in termini
percentuali della presenza delle singole culture slave nella rivista “I libri
del giorno”, uniamo un grafico esemplificativo.
Russa
Polacca
Croata
Bulgara
5; 2%
5; 2%
Slovena
Ucraina
4; 2% 3; 1%
1; 0%
39; 15%
203; 78%
Per quanto riguarda la presenza di autori appartenenti alla cultura
russa il grafico successivo mostra un’evidente preponderanza di
contributi dedicati a Dostoevskij, Tolstoj, Gor’kij e Puškin.
145
Cfr. Giovanni Maver, I polacchi in Siberia, pp. 53-54, in ‘Rassegne Estere’ –
Polonia, , “Ibidem”, anno XII, n. 1, gennaio, 1929 – Id., Narratori polacchi, “Ibidem”,
annoXII, n. 5, maggio, 1929, pp. 305-307.
146
Cfr. Giovanni Maver, Alcuni drammi croati, in ‘Libri di cui si parla’ – Letterature
slave meridionali, “Ibidem”, anno VIII, n. 3, marzo, 1925, pp. 152-153.
147
Per approfondimenti sulla produzione slavistica di Giovanni Maver nella rivista “I
libri del giorno” rimando a: Cristiano Diddi, Op. cit., pp. 218-228.
50
Dostoevskij
Tolstoj
Gor'kij
Puškin
Andreev
Čechov
Sologub
Merežkovskij
Lermontov
Solov'ëv
Turgenev
Arcybašev
Blok
Korolenko
Kuprin
Muratov
Zajcev
Apuchtin
Gumilëv
Achmatova
Gončarov
Brjusov
Lunc
Nekrasov
Leskov
Griboedov
Esenin
Cvetaeva
Saltykov-Ščedrin
Aldanov
Felyne
3. “Leonardo. Rassegna mensile della coltura italiana” (19251929).
Il terzo periodico oggetto di analisi è “Leonardo. Rassegna mensile
della coltura italiana”, rivista pubblicata sotto gli auspici dell’“Istituto
nazionale fascista di cultura”. Giovanni Gentile la strutturò nel 1925,
ispirandosi al modello editoriale dell’“Italia che scrive” e affidandone la
direzione al figlio Federico, già collaboratore dei “I libri del giorno”,
51
rivista che la stessa “Leonardo” assorbì nel 1929 per riunire le principali
rassegne bibliografiche dell’epoca148.
La collaborazione di Ettore Lo Gatto a “Leonardo”, come per
“L’Italia che scrive” e “I libri del giorno”, è stata sempre accompagnata
da un senso di responsabilità etica e morale da parte dello slavista,
consapevole di collaborare a una testata fascista pur senza condividerne
necessariamente la dottrina. Nonostante la mancanza di notizie esplicite
sul pensiero politico di Lo Gatto in quegli anni, la sua attività
nell’’I.p.E.O. testimonia la distanza dall’ideologia comunista,
confermata dall’amicizia con scrittori esiliati e uomini politici oppositori
del regime sovietico, mentre altri contesti rivelano una certa vicinanza al
Fascismo e a personalità come Amedeo Giannini e Giovanni Gentile149.
Considerando, però, che Lo Gatto fu più volte definito da colleghi e
allievi “un ricercatore e uno studioso militante e attivista”150, possiamo
supporre che egli anteponesse al di sopra di tutto l’attività di esploratore
e divulgatore della civiltà letteraria russa in Italia. Probabilmente, se si
fosse schierato apertamente contro il Fascismo, non sarebbe più stato in
grado di svolgere il suo lavoro, privando di fatto l’Italia del suo
importante contributo alla cultura. Secondo Stefano Santoro, studioso
dei rapporti tra Fascismo ed Europa orientale, “il fascismo di Lo Gatto
era solo di facciata ma non di fede; il suo atteggiamento era quello dello
studioso costretto a convivere col regime per mantenere la sua posizione
accademica”151.
I primi articoli firmati da Lo Gatto per “Leonardo” riguardano la
cultura russa e polacca. Nel primo, pubblicato nel mese di gennaio del
1925, lo slavista, parlando di Pavel Muratov, lo include nella schiera di
artisti e scrittori russi emigrati che hanno fatto conoscere l’Italia in
148
“Uno dei criteri che informano oggi il rinnovamento della nostra cultura è quello di
evitare, quanto più è possibile, gli sdoppiamenti di attività parallele. Per questo, si è
giustamente notata che era in Italia una troppo vasta fioritura di periodici bibliografici.
Dopo i primi due, sorti contemporaneamente nel 1918, “I Libri del Giorno” e “Italia
che scrive”, ogni ente, ogni regione, ha voluto avere la sua rivista bibliografica; si è
giunti quasi a un certo punto in cui la bibliografia ha sembrato avere la prevalenza sulla
stessa attività originale. Era quindi necessario che alcuni dei principali organismi
bibliografici, già affini per tendenze culturali e politiche, si raccogliessero in un ente
unico”. Da Congedo, in ‘I libri del giorno”, a. XII, n. 12; cfr. Nicola Tranfaglia, Storia
degli editori italiani. Dall’Unità alla fine degli Anni Sessanta, Tranfaglia Nicola,
Vittoria Albertina, Bari, Gius. Laterza & Figli, 2007, p. 324.
149
Vedi la collaborazione di Lo Gatto a “I libri del giorno”, periodico diretto da
Valentino Piccoli, firmatario del manifesto degli intellettuali fascisti insieme a Ettore
Romagnoli. Rimando a: Gianfranco Tortorelli, Una rivista per l’editoria, in: Op. cit., p.
67, e Gabriele Mazzitelli, Intervista a Ettore Lo Gatto, “Rassegna sovietica”, 33
(1982), n. 2, pp. 92-93.
150
Cfr.; Ettore Lo Gatto, I miei incontri con la Russia, Milano, Mursia, 1976, p. 27;
Gabriele Mazzitelli, Op. cit.
151
Cfr. Stefano Santoro, L’Italia e l’Europa orientale: diplomazia culturale e
propaganda, 1918-1943, presentazione di Marco Palla, Milano, Franco Angeli, 2005.
52
Russia, fra i quali anche Zajcev, Osorgin e Baltrušajtis. Menziona, poi,
la rivista “Sofija”, diretta da Muratov, e i tre volumi di Obrazy Italii
sulla storia dell’arte italiana152. Nel secondo, elogia le buone traduzioni
dal russo eseguite da Carlo Grabher, riferendosi, in particolare, ai
drammi di Čechov. Segue una recensione positiva alle recenti traduzioni
italiane di Grażina e Pan Tadeusz di Adam Mickiewicz, eseguite da
Aurelio Palmieri e Clotilde Garosci153. Gli articoli si trovano pubblicati
nel fascicolo di apertura della rivista154. La prima annata prosegue con
una serie di recensioni di Grabher a traduzioni di opere di Čechov,
Sologub e Lunc, eseguite da Lo Gatto e da Boris Jakovenko.
Nelle annate successive, oltre a segnalazioni bibliografiche di
novità editoriali su classici russi dell’Ottocento, Tolstoj, Dostoevskij e
Čechov, occupano le pagine vari contributi di Enrico Damiani. Nel 1926
viene pubblicata una recensione alla neonata “Rivista di letterature
slave”, di cui lo slavista sottolinea il carattere divulgativo e
documentario comune a “Russia”; in particolare, viene analizzato il
primo volume in uscita, dedicato al giubileo letterario di Jan Kasprowicz
e al cinquantesimo anniversario della morte del poeta-patriota bulgaro
Hristo Botev155. Il 1927 si apre con una recensione di Damiani alla
versione italiana del romanzo di Reymont Chłopy, eseguita da Aurora
Beniamino, opera in quattro volumi con una dotta introduzione del prof.
Zieliński. Un po’ fuori dagli schemi espositivi di Damiani, la recensione
alla collana “Il Genio Slavo” presenta due osservazioni critiche: la
mancanza di caratteri tipografici speciali per rendere i segni diacritici
delle lingue slave e la scelta di un’immagine tipicamente moscovita a
emblema dell’intera collana156. Sempre nel 1927, sono degni di
menzione altri due articoli di Damiani: la recensione all’edizione
polacca del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, edizione fino ad
allora ignota in Italia e considerata la migliore fra quelle straniere, e la
presentazione del volume di Lo Gatto dedicato alla letteratura
“soviettista” come nuovo fenomeno postrivoluzionario in Russia. La
collaborazione di Damiani a “Leonardo” si conclude con la recensione
alla nuova, ampliata edizione di La Bulgaria. Rassegna geograficostorica di Carlo Dell’Acqua157, considerato prezioso strumento di
152
Cfr. Ettore Lo Gatto, Italianizzati all’estero: Paolo Muratov, con un ritratto dello
scrittore, “Leonardo. Rassegna mensile della coltura italiana”, anno I, 1, 20 gennaio,
1925, pp. 10-11.
153
Cfr. Ettore Lo Gatto, recensione a: Adamo Mickiewicz, Grazina (…) – Pan Taddeo
Soplitza (…), “Ibidem”, anno I, 1, 20 gennaio, 1925, p. 21.
154
Vedi Bibliografia ragionata.
155
Cfr. E. Damiani, recensione a: Rivista di letterature slave. Diretta da Ettore Lo
Gatto. Anno I, giugno 1926, vol. I, fasc. I-II (Roma, Anonima Romana Editoriale),
“Ibidem”, anno II, n. 10, 20 ottobre, 1926, pp. 278-279.
156
Cfr. E. Damiani, recensione a: “Il Genio Slavo”, Casa Editrice “Slavia”, Torino in
‘Letterature slave’, p. 62, in “Ibidem”, anno VII, n. 1, 20 gennaio, 1929.
157
Cfr. E. Damiani, recensione a: Carlo Dell’Acqua, La Nazione Bulgara, 2° edizione.
Milano-Sofia, Ed. dell’”Opera Italiana pro Orientale”, 1929, pp. 175 – Id., recensione
53
divulgazione, e con la presentazione del nuovo studio critico di Grabher
su Čechov.
I grafici che seguono rappresentano l’incidenza della cultura russa
e delle altre culture slave nel periodico, con una chiara maggioranza di
contributi russistici e, in seconda battuta, polonistici:
Russa
Polacca
Bulgara
5; 6%
Serbocroata
1; 1%
4; 5% 1; 1%
Ceca
Slovacca
Ucraina
1; 1%
11; 13%
64; 73%
Relativamente ai contributi sulla cultura russa, un grafico
evidenzia la netta maggioranza di articoli dedicati a Tolstoj, Dostoevskij
e Čechov, e una minoranza relativa a scrittori contemporanei, fra i quali,
più degli altri, Sologub e Gor’kij.
Tolstoj
Dostoevskij
Čechov
Sologub
Gor'kij
Turgenev
Erenburg
Šmelëv
Andreev
Lunc
Amfiteatrov
Merežkovskij
Arcybašev
Puškin
Gončarov
Sejfullina
Ostrovskij
Felyne
Evrejnov
Gogol'
a: Carlo Grabher, Anton Cechov, Roma-Torino, pp. 120, “Ibidem”, anno VII, n. 11-12,
20 dicembre, 1929, pp. 299-300.
54
LE RIVISTE LETTERARIE
1. “La Cultura” (1921-1928)
Fondata a Roma nel 1882 da Ruggero Bonghi, “La Cultura. Rivista
mensile di filosofia, lettere e arti” è stata protagonista di una storia
piuttosto travagliata. Nata inizialmente come bollettino bibliografico per
l’informazione delle ultime novità librarie, la testata subì numerose
trasformazioni fino a diventare, sotto la direzione di Cesare De Lollis dal
1921 al 1928, un prestigioso mensile dedicato prevalentemente alle
discipline umanistiche, che annoverava tra i collaboratori Leone
Ginzburg, Giulio Carlo Argan, Massimo Mila e Giorgio Agosti. Tra il
1921 e il 1935, anno in cui venne soppresso dal regime, il periodico
ricoprì un ruolo centrale nella cultura italiana, proponendosi come guida
per il pubblico dei lettori. Dopo la direzione di De Lollis, “La Cultura”,
sotto la direzione di Ferdinando Neri, si schierò ancora più apertamente
contro il regime, ribadendo la propria apertura europea, in contrasto col
nazionalismo culturale imposto dal regime.
Il carattere discretamente antifascista del periodico si rivelò in più
occasioni attaverso stroncature a personaggi della cultura ufficiale e
stoccate a intellettuali simpatizzanti del regime come Ardegno Soffici e
Giovanni Papini. Conclusa la direzione di Neri, nel 1934 la testata fu
rilevata da Einaudi. Già nell’articolo di apertura De Lollis dava alla
rivista un’impronta di originalità e di intelligente eclettismo con spiccata
apertura internazionale; egli tentava di equilibrare metodi e meriti del
positivismo con le esigenze più valide dell’idealismo crociano,
affrontando, fra gli altri, temi di scottante attualità come la riforma degli
studi.
Per quanto concerne la presenza delle culture straniere,
l’attenzione dei critici e dei collaboratori si conferma attraverso le varie
annate; a differenza di altre riviste, periodici come questo avevano un
carattere divulgativo oltre che strettamente letterario e si rivolgevano a
un pubblico di lettori colti158. Procedo con l’analisi degli articoli.
Nella storia del periodico sono ben distinguibili due fasi: la prima
sotto la direzione di De Lollis dal 1921 al 1928, la seconda dal 1929 al
1935 coincidente con l’arrivo, fra i collaboratori, del giovane Leone
Ginzburg159. Come si è già accennato, negli anni Venti la testata mostrò
158
Per approfondimenti sulla storia del periodico “La Cultura” rinvio a: Gennaro
Sasso, Variazioni sulla storia di una rivista italiana “La Cultura” (1921-1928),
Bologna, Il Mulino, 1990; “La Cultura” (1921-1928), presentazione di Umberto
Bosco, introduzione di Alfredo Luzi, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1971; Laurent
Béghin, Op. cit., pp. 353-360.
159
Su Ginzburg esistono numerosi studi, fra i più seri segnalo: Angelo D’Orsi, Un
suscitatore di cultura, in L’itinerario di Leone Ginzburg, a cura di Nicola Tranfaglia,
Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pp. 68-111 e Leone Ginzburg suscitatore, in Id.,
Intellettuali nel Novecento italiano, Torino, Einaudi, 2001, pp. 305-356. Per uno studio
55
fin da subito una particolare attenzione alle culture straniere, fra le quali
anche le culture slave trovarono il loro spazio, in particolare quella russa
e serbocroata, un po’ meno la cultura polacca.
Il primo volume si apre con un breve contributo di Nicola Festa
sulla biografia di Radiščev, vista in relazione alla trama del romanzo
Putešestvie iz Peterburga v Moskvu160; seguono due articoli di Aurelio
Palmieri e uno firmato da Giuseppe Toffanin. Nel primo Palmieri si
occupa del suo principale campo d’interesse, ossia le questioni religiose
legate all’ortodossia; lo slavista descrive il volume di Lo Gatto I
problemi della letteratura russa, presentandolo come saggio sulla
spiritualità russa dal XVII secolo in poi e concludendo con alcune
osservazioni sulle sette religiose161. Il secondo contributo costituisce una
cronaca della produzione scientifica e letteraria in Russia al tempo della
censura bolscevica e delle difficoltà economiche che gli intellettuali
erano costretti ad affrontare.162 A questo segue un articolo sulla
letteratura slovena e, in particolare, sull’opera del poeta Simon
Gregorčič (1844-1906), che evidenzia alcune analogie con gli scritti di
France Prešeren, cui il poeta sloveno sembrò ispirarsi163. La
collaborazione di Palmieri si conclude con una recensione al volume di
Lo Gatto, che contiene alcuni saggi sulla cultura russa, dedicati alla
questione della servitù della gleba e alla biografia di Herzen164.
Nel 1924 si leggono solo due contributi russistici, uno di Otto
Cuzzer sul significato che il pessimismo radicale di Čechov può
assumere nei drammi165, l’altro di Ettore Lo Gatto sulla fortuna critica di
Byron in Russia durante il regno di Alessandro I e sulla presenza del
byronismo negli scritti di alcuni autori russi di epoca romantica166. Dalla
fine del 1924 al 1927 scrivono articoli sulle culture slave Enrico
Damiani e Arturo Cronia167. I contributi di Cronia sono tutti dedicati alla
specifico sull’attività di Leone Ginzburg russista e la sua collaborazione ad alcune
riviste italiane, in particolare “La Cultura”, “La Nuova Italia” e “Pegaso”, rimando al
recente volume di Laurent Béghin, Op. cit., pp. 403-446.
160
Cfr. Nicola Festa, Radisc’cev, “La Cultura”, vol. I, 2, 15 dicembre, 1921, pp. 80-81.
161
Cfr. Aurelio Palmieri, recensione a: E. Lo Gatto, I problemi della letteratura russa.
Napoli, Ricciardi, 1921, “Ibidem”, vol. I, 7, 15 maggio, 1922, pp. 328-329.
162
Cfr. Aurelio Palmieri, Le riviste scientifiche della Russia bolscevica, “Ibidem”, vol.
I, 11, 15 settembre, 1922, pp. 509-512.
163
Cfr. Aurelio Palmieri, Il poeta sloveno dell’Isonzo Simone Gregorcic, “La Cultura”,
vol. II, 6, 15 aprile, 1923, pp. 261-267.
164
Cfr. Aurelio Palmieri, recensione a: Ettore Lo Gatto, Saggi sulla cultura russa,
Napoli, Ricciardi, 1923, “Ibidem”, vol. II, 9, 15 luglio, 1923, pp. 425-426.
165
Cfr. Otto Cuzzer, Il pessimismo di Anton Cecof, vol. III, 3, 15 gennaio, 1924, pp.
115-119.
166
Cfr. Ettore Lo Gatto, Byron in Russia, vol. III, 6, 15 aprile, 1924, pp. 283-287. Si
può notare che lo stesso argomento è trattato contemporaneamente da Lo Gatto su “I
libri del giorno”. Cfr. nota 138.
167
Sull’attività slavistica di Arturo Cronia (1896-1967), relativa soprattutto agli studi
serbocroatistici, rimando alle voce dedicata allo slavista da Sergio Cella sul Dizionario
Biografico
(cit.)
sul
sito
http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/Ban
56
storia della civiltà letteraria dei serbi e dei croati e alla formazione dello
slavo ecclesiastico, a partire dalla missione evangelizzatrice di Cirillo e
Metodio in Moravia e Bulgaria, fino alla diffusione del movimento
politico-filosofico degli enciclopedisti francesi nel XVIII secolo, dalla
Croazia, terra divisa dal separatismo interno, alla Bosnia e alla
Dalmazia. L’articolo che chiude la sezione è dedicato alla nascita di una
letteratura serbocroata postbellica, in particolare a due giovani scrittori
impegnati a ritrarre la crudeltà della guerra, Miroslav Krleža e Miloš
Crnjanski168. Damiani firma due articoli sulla letteratura polacca e uno
su quella bulgara; parlando della prima, lo slavista traccia un profilo biobibliografico di Stefan Żeromski e Władysław Reymont nell’anno della
loro morte, analizzando i romanzi Ludzie bezdomni e Doktór Piotr di
Żeromski e Chłopy di Reymont169. L’altro contributo polonistico è un
omaggio al poeta Juliusz Słowacki, di cui viene rievocata l’attività
letteraria in occasione della morte e dell’arrivo a Cracovia, presso il
castello di Wawel, delle sue spoglie, custodite per anni a Parigi nel
cimitero di Montmartre170. Per quanto concerne la cultura bulgara,
Damiani scrive sulla personalità di Hristo Botev in occasione della
celebrazione a Sofia del cinquantesimo anniversario della morte171. Fra
le ricorrenze importanti, bisogna menzionare anche l’unico articolo
russistico di Damiani, pubblicato nel 1926 e dedicato al centenario della
nascita di Michail Saltykov-Ščedrin. Damiani mette in evidenza il forte
accento polemico degli scritti satirici rivolti ai rappresentanti della
società russa del tempo172. Il 1928 si chiude con la recensione di Milan
Rešetar al primo volume della Storia della letteratura russa di Ettore Lo
Gatto, professore di letterature slave presso la Regia Università di
Napoli173.
A partire dal 1929 la rivista si arricchisce, come si è anticipato
sopra, della collaborazione di Leone Ginzburg. L’articolo di esordio è
una breve presentazione del volume curato e tradotto da Lo Gatto sul
romanzo di Gončarov Oblomov, con un’introduzione sulla nascita del
caDati/Dizionario_Biografico_degli_Italiani/VOL31/DIZIONARIO_BIOGRAFICO_
DEGLI_ITALIANI_Vol31_050475.xml.
168
Cfr. Arturo Cronia, Appunti di letteratura serbo-croata, “Ibidem”, 11, 15 settembre,
1927, pp. 494-507.
169
Cfr. Enrico Damiani, Due grandi prosatori polacchi: Zeromski e Reymont (in
occasione della loro morte), “Ibidem”, vol. V, anno II, fasc. 3, 15 gennaio 1926, pp.
128-133.
170
Cfr. Enrico Damiani, Slowacki, “Ibidem”, vol. VI, anno III, fasc. 10, 15 agosto,
1927, pp. 460-462.
171
Cfr. Enrico Damiani, Un grande anniversario bulgaro: La morte di Cristo Bòtev,
“Ibidem”, vol. V, anno II, fasc. 8, 15 giugno, 1926, pp. 363-366.
172
Cfr. Enrico Damiani, Un centenario nella letteratura russa. Michele Saltykov
S’cedrìn, “Ibidem”, vol. VI, fasc. 2, 15 dicembre, 1926, pp. 55-56.
173
Cfr. M. Rešetar, recensione a: E. Lo Gatto, Storia della letteratura russa I. Roma,
Anonima Romana Editoriale, 1928, pp. XI-291. L. 20, “Ibidem”, vol. VII, fasc. 9-10, 1
ottobre, 1927, pp. 418-419.
57
romanzo in Russia174. A questo seguono due articoli di rilievo. Il primo è
la recensione al volume di Vladimir Pozner dedicato alla letteratura
russa e pubblicato in francese nel 1929, di cui Ginzburg sottolinea
l’assoluto equilibrio di giudizio nell’esaminare l’opera di circa cinquanta
scrittori contemporanei, fra cui Korolenko, Andreev, Blok e
Merežkovskij175; nel secondo, Ginzburg ricorda un articolo di André
Mazon apparso sulla “Revue des Deux Mondes” nel 1929 in cui lo
slavista annunciava il ritrovamento di alcuni frammenti lirici in prosa di
Turgenev fra le carte di Pauline Vardot176.
Nell’annata successiva, tutti i contributi di Ginzburg riguardano i
prosatori classici dell’Ottocento, in particolare Leskov, Čechov, Tolstoj,
Gogol’ e Gončarov. Apre la serie un ampio e dettagliato saggio sugli
scritti di Nikolaj Leskov; nella prima parte del contributo vengono
menzionate le più recenti pubblicazioni a partire dalla terza edizione
delle opere complete apparsa sulla rivista pietroburghese “Niva” fra il
1902 e il 1903, nella seconda parte vengono descritti i romanzi Ovcebyk
del 1862 e Sceramùr, uscito a puntate sul giornale reazionario “Novoe
Vremja” nel 1879177. Un altro ampio articolo di Ginzburg è la biografia
artistica di Garšin, una rassegna di tutte le opere tradotte in italiano e
pubblicate dal Literaturnyj Fond a Pietroburgo nel 1909. Muovendo
dalle osservazioni critiche di Michajlovskij sullo scrittore, Ginzburg
espone il contenuto dei romanzi Krasnyj cvetok e Četyre dnja178. Oltre
ad articoli sui racconti di Čechov, sul saggio di Enrico Pappacena
dedicato all’opera di Gogol’ e sulla personalità di Gončarov, è degno di
nota un articolo che affronta una questione particolarmente scottante nei
dibattiti culturali in Russia, lo scontro ideologico tra ‘europeisti’, a
sostegno dell’origine slavo-occidentale della Russia, ed ‘eurasiatici’,
sostenitori della sua natura asiatica179.
Il fascicolo di febbraio del 1931 è senz’altro speciale per il
periodico, che celebra il cinquantesimo anniversario della morte di
Fëdor Dostoevskij. Inaugurato da una versione, curata da Alfredo
Polledro, di Polzunkov, racconto fino ad allora inedito in italiano, il
fascicolo contiene non solo contributi dovuti ad alcuni dei più validi
esponenti della slavistica italiana di quegli anni (Ettore Lo Gatto,
174
Cfr. Leone Ginzburg, recensione a: I. A. Gonciarov, Oblòmov (versione integrale
con prefazione e note di E. Lo Gatto), Torino, Slavia, “Ibidem”, anno VIII, fasc. IV,
aprile, pp. 239-240.
175
Cfr. Leone Ginzburg, Letteratura russa contemporanea, “Ibidem”, anno VIII, fasc.
IX, settembre, pp. 568-569.
176
Cfr. Leone Ginzburg, Turgenev inedito, “Ibidem”, anno VIII, fasc. XII, dicembre, p.
766.
177
Cfr. Leone Ginzburg, Scrittori russi dell’800: Nicola Ljeskòv, “Ibidem”, anno IX,
fasc. I, gennaio, 1930, pp. 24-39.
178
Cfr. Leone Ginzburg, Scrittori russi dell’800: Gàrscin, “Ibidem”, fasc. IV, aprile,
1930, pp. 268-277.
179
Cfr. Leone Ginzburg, Storia russa recente, “Ibidem”, anno IX, fasc. VIII, agosto,
1930, pp. 679-686.
58
Wolfango Giusti, Enrico Damiani e lo stesso Ginzburg), ma anche
articoli firmati da autorevoli critici e studiosi russi emigrati come
Dmitrij Svjatopolk-Mirskij180, Vladimir Pozner e Alfred Bem181. Nel
primo articolo Ginzburg affronta la distinzione tra ‘classicità’ e
‘classicismo’ nell’opera di Dostoevskij; successivamente presenta il
volume di Leonid Grossman dedicato al 1850, anno cruciale nella vita di
Dostoevskij soprattutto per l’esperienza del servizio militare e dei lavori
forzati in Siberia. L’ultimo contributo è un breve articolo sulla biografia
di Anna Grigor’evna Dostoevskaja182.
Ettore Lo Gatto ricostruisce le varie edizioni dell’epistolario dello
scrittore, dal primo gruppo di cinquanta lettere, frammentarie e lacunose,
pubblicate da Strachov e Miller nel 1883183, alle raccolte complete di
Dolinin184, relative al periodo compreso tra il 1832 e il 1871,
fondamentali per la ricostruzione cronologica della biografia di
Dostoevskij. Vladimir Pozner analizza le influenze che vari generi
letterari hanno avuto sugli scritti di Dostoevskij: dall’influenza del
romanzo gotico in Selo Stepančikovo i ego obitateli, a quella del
romanzo d’avventura in Podrostok, Idiot e Belye noči. Dall’analisi di
Pozner sono esclusi Besy e Prestuplenie i nakazanie, dei quali a quei
giorni si conosceva ancora troppo poco sullo stile. Alfred Bem affronta
la questione dell’influsso contrastante e decisivo di Gogol’ e della
“scuola naturale” nelle prime opere di Dostoevskij, in particolare Bednye
ljudi. Sempre in tema di influenze, Wolfango Giusti cerca di scorgere
alcune analogie tra i personaggi di Cervantes e quelli di Dostoevskij,
partendo dall’innata predisposizione dello scrittore russo a creare
180
Dal 1926 al 1928 il principe Dmitrij Petrovič Svjatopolk-Mirskij (1890-1939) fu
uno dei principali redattori di “Versty”, rivista parigina che provava qualche simpatia
per le tesi degli eurasisti e dei smenovechovcy e che pubblicò numerosi testi di autori
sovietici (Babel’, Belyj, Pasternak, Tynjanov). Col passar del tempo Mirskij si avvicinò
sempre di più al marxismo e nel 1931 finì coll’aderire al partito comunista inglese. Un
anno dopo tornò in Russia e, nonostante i vari attacchi di cui fu vittima per via della
sua origine sociale e del suo passato di emigrato, vi esplicò un’intensa attività
letteraria. Fu arrestato nel 1937 e deportato in Siberia, dove morì nel 1939. Si veda
Ol’ga Kaznina, Russkie v Anglii. Russkaja emigracija v kontekste russko-anglijskich
literaturnych svjazej v pervoj polovine XX veka, Moskva, Nasledie, 1997, pp. 119-162.
181
Alfred Ljudvigovič Bem (1886-1945) fu un importante protagonista
dell’emigrazione russa. Lasciò la Russia nel 1919 e si stabilì prima a Belgrado, poi a
Varsavia. Nel 1922 si recò in Cecoslovacchia e diventò professore di russo
all’Università Carlo IV di Praga. Nel primo dopoguerra s’impose come uno dei
maggiori specialisti di Fëdor Dostoevskij, di cui proponeva una lettura psicanalitica. Fu
anche l’iniziatore del “Giorno della cultura russa” (Den’ russkoj kul’tury), celebrato, a
partire dal 1925, ogni 8 giugno in tutta l’emigrazione. Arrestato a Praga il 16 maggio
del 1945 fu poi fucilato dal NKVD qualche mese dopo. Sull’argomento rinvio a Miluša
Bubeniková, Bem, Al’fred Ljudvigovič in Literaturnaja enciklopedija Russkogo
Zarubež’ja 1918-1940. T. I. Pisateli Russkogo Zarubež’ja, Moskva, ROSSPEN, 2000.
182
Rimando alla Bibliografia ragionata.
183
Orest Miller – Nikolaj Strachov, Biografija, pis’ma i zametki iz zapisnoj knižki
Dostoevskogo, S. Peterburg, 1883.
184
A. S. Dolinin, F. M. Dostoevskij. Stat’i i materialy, S. Peterburg, 1922.
59
‘antieroi’. In particolare, il ‘donchisciottismo’ di Devuškin in Bednye
ljudi, del signor Goljadkin in Dvojnik e del principe Myškin in Idiot.
L’articolo di Damiani è una cronologia degli studi dostoevskiani in
Italia, iniziati in ritardo rispetto al resto d’Europa a causa dello scarso
numero di conoscitori del russo nel nostro paese; lo slavista fa partire la
sua indagine dalla prima ‘notizia’ sullo scrittore, contenuta nel
Dizionario Biografico degli scrittori viventi di Angelo De Gubernatis,
fino alla traduzione delle prime due parti di Unižennye i oskorblënnye,
eseguita da Domenico Ciampoli nel 1893. Zino Zini185, infine, mette in
evidenza alcune mende stilistiche nella traduzione in francese di un ciclo
di conferenze tenute nel seminario della “Libera Accademia di cultura
spirituale” di Mosca nel 1920-1921, in cui Berdjaev cerca di dimostrare
come Dostoevskij possa considerarsi filosofo prim’ancora che
scrittore186.
Nel fascicolo di aprile del 1931 è degno di menzione un breve
articolo di Ginzburg sulla personalità di Vasilij Rozanov187; qui
Ginzburg opera una stroncatura alla recensione che Giuseppe Raimondi
fa della traduzione francese dei suoi scritti, eseguita da Vladimir Pozner
e Boris de Schloezer e pubblicata nel numero di febbraio di “Solaria”188.
A giugno, oltre a un articolo in cui lo studioso confronta la traduzione di
alcuni scritti di Tolstoj, eseguita da Leonardo Kociemski, con quella di
Giovanni Faccioli per la collana “IL Genio Russo”189, Ginzburg dedica
ancora due contributi a Dostoevskij: nel primo, riassume alcuni saggi
apparsi sul numero di maggio della rivista “Slavische Rundschau” di
Praga sulla fortuna critica dello scrittore in Francia e in Inghilterra190,
l’altro è la recensione al saggio di André Levinson sulla vita di
Dostoevskij, pubblicato in Francia, dove Ginzburg evidenzia la
mancanza di stile mostrata da Levinson nel riferire particolari di relativa
importanza documentaria.
Le ultime annate della rivista ospitano esclusivamente contributi di
Leone Ginzburg. Descrivo i più significativi.
185
Zino Zini (1868-1937) fu uno dei più autorevoli traduttori dellla casa editrice
“Slavia”, oltre che letterato e filosofo. Curò due traduzioni di autori russi, la Steppa di
Čechov e Fumo di Turgenev. Per approfondimenti rimando agli studi di Giancarlo
Bergami e di Norberto Bobbio a lui dedicati. Cfr. Laurent Béghin, Op. cit., p. 316.
186
Sui contributi rimando alla Bibliografia ragionata (Vol. II).
187
Cfr. Leone Ginzburg, Rozanov, o della competenza, “Ibidem”, fasc. V, maggio,
anno X, 1931, p. 435.
188
Cfr. Giuseppe Raimondi, recensione a: V.V.Rozanov, L’ Apocalypse de nôtre
temps, précédé de Esseulement, Librairie Polon, Paris, 1930, “ Solaria “, anno VI, 2,
febbraio, 1931, pp. 67-68.
189
Cfr. Leone Ginzburg, recensione a: Anton Cechov, Il duello - Tre anni - La corista
– Lo Studente – Sul mare, traduzione di Leonardo Kociemski, Mondadori, “Biblioteca
Romantica”, IX, Milano 1931, pp. 363, “La Cultura”, anno X, fasc. VI, giugno, 1931,
pp. 500-504.
190
Cfr. Leone Ginzburg, La fortuna di Dostoevskij in Occidente, anno XI, fasc. VI,
giugno, 1931, pp. 516-517.
60
Il primo è una recensione a due volumi della storia della letteratura
russa di Ettore Lo Gatto. Lo studioso ne mette in evidenza la struttura,
composta da un manuale bibliografico di facile consultazione e da una
specifica trattazione monografica191. Segue un ampio articolo, che
riassume interventi critici di Ginzburg su alcune pubblicazioni minori
dedicate a Dostoevskij in occasione del recente cinquantenario della
morte, preziosi per una interpretazione metodologica e filologica del
testo e della psicologia dei singoli personaggi192. Particolarmente
interessante è, poi, la segnalazione bibliografica degli studi filologici di
André Mazon, docente al Collège de France, sulle byline, raccolti in un
saggio pubblicato nel 1932 sulla “Revue des Cours et Conférences” con
la storia della critica e un’utile bibliografia di riferimento193.
Prima di concludere con la collaborazione di Ginzburg a “La
Cultura”, vorrei soffermarmi sul ‘rigore filologico’ dello studioso, più
volte dimostrata negli articoli, tanto più evidente e significativa se si
tiene conto che, all’epoca, alle culture slave, quasi del tutto inesplorate,
si dedicavano studiosi seri ma anche dilettanti, che Ginzburg cercava di
‘smascherare’. E’ il caso di André Maurois, slavista francese, accusato
in maniera inappellabile da Ginzburg di non conoscere il russo:
André Maurois non sa il russo […]. Che il Turgenev sia un poeta,
piccolo o grande, e che perciò non si possa parlarne senza essersi prima
messi a contatto con la sua espressione più genuina, col testo originale
delle sue opere, pare che non gli sia venuto in mente; sicché tanto meno
gli è passato per il capo di domandarne indulgenza per l’ardimento di
questa forzata approssimazione194.
Tale scrupolo filologico non si limitava a semplice pignoleria, ma
rispondeva alla necessità di dare un immagine più obiettiva della Russia
e della sua cultura, una visione del paese che fosse priva di quei
pregiudizi, che ne avevano impedito la giusta comprensione. La più
feroce stroncatura di Ginzburg può certamente considerarsi quella fatta
alla traduzione di alcuni scritti di Čechov eseguita da Leonardo
Kociemski195. Paragonando la versione di Kociemski a quella eseguita
da Giovanni Faccioli e pubblicata da Slavia, Ginzburg scrive:
191
Cfr. Leone Ginzburg, Una storia della letteratura russa (recensione a: E. Lo Gatto,
Storia della letteratura russa , voll. III e IV. La letteratura moderna, Anonima
Romana Editoriale, Roma 1929, 1931), “La Cultura”, anno XI, fasc. II, aprile-giugno,
1932, pp. 383-385.
192
Cfr. Leone Gizburg, Alcuni scritti su Dostoevskij (…), pp. 594-601, in “Ibidem”,
anno XI, fasc. III, luglio-settembre, 1932, pp. 594-601.
193
Leone Ginzburg, Lo studio delle byline, “Ibidem”, anno XI, fasc. III, lugliosettembre, 1932 , pp. 617-618.
194
Leone Ginzburg, Turgenev in Francia (...), “Ibidem”, vol. X, fasc. V, maggio, 1931,
pp. 517-518.
195
Vedi Infra.
61
La versione di Faccioli e il suo “valore filologico” sembra che
siano stati l’incubo del signor Kociemski; il quale ha cercato, soprattutto,
di non tradurre come aveva tradotto il Faccioli e di ignorare ogni forma di
filologia196.
Gli articoli slavistici si concludono con saggi e recensioni su temi
di scottante attualità. Mi riferisco, fra gli altri, agli articoli Gli studenti e
il bolscevismo, sugli effetti del nuovo fenomeno politico-sociale nella
vita e nel pensiero dei giovani studenti russi, e I sovieti e la religione, sul
controverso rapporto tra ‘ideologia’ e ‘religione’ in Russia197.
Dando una rappresentazione visiva, anche nel caso di “La Cultura”
si può notare la netta preponderanza di articoli e recensioni sulla cultura
russa come mostra il seguente grafico:
Russa
7; 10%
Serbocroata
Polacca
Bulgara
3; 4% 1; 1%
57; 85%
Ancora una volta, gli autori maggiormente rappresentati sono i
“classici” dell’Ottocento Dostoevskij, Turgenev, Gogol’, Čechov e
Tolstoj:
196
Rimando alla nota 148.
Cfr. (S.a.), Gli studenti e il bolscevismo, “Ibidem”, anno II, vol. II, fasc. 1, 15
novembre 1922, p. 47; A. Pincherle, I sovieti e la religione, “Ibidem”, anno V, fasc. 8,
15 giugno 1926, pp. 378-379.
197
62
Dostoevskij
Turgenev
Gogol'
Čechov
Tolstoj
Gončarov
Radiščev
Saltykov-Ščedrin
Leskov
Garšin
Rozanov
Gor'kij
Griboedov
2. “La Fiera letteraria” (1925-1929)
Nel momento in cui il Fascismo si imponeva nel campo culturale
con l’emanazione delle leggi liberticide sulla libertà di stampa, nel
dicembre del 1925 nasceva a Milano la “Fiera letteraria” (1925-1929).
Come si legge nell’editoriale di apertura del direttore Umberto Fracchia,
si tratta di un settimanale completo e scrupoloso nell’esattezza delle
notizie e dell’informazione, risultato di tutte le forze letterarie di
qualsiasi tendenza. La “Fiera” doveva diventare un giornale “simile ad
ogni altro giornale”, e nello stesso tempo lontano dalla tradizione del
giornalismo letterario italiano coi suoi fogli di tendenza e di polemica;
l’elzeviro doveva alternarsi alla notizia, la critica e la saggistica alla
narrativa e ai versi, il panorama informativo al dibattito a più voci. Il
63
titolo del giornale s’ispirava alla “fiera” come luogo di incontro e
scambio di idee, in contrapposizione al “tempio” solenne in cui la
tradizione aveva confinato il letterato. Oltre a Fracchia, collaborarono al
periodico Giovan Battista Angioletti, più tardi anche redattore e
condirettore, Arnaldo Frateili, responsabile della redazione romana nel
primo anno di vita della rivista, Curzio Malaparte, condirettore della
testata dal 18 marzo 1928, e Giovanni Titta Rosa, capo-redattore e
assiduo collaboratore anche dopo il trasferimento a Roma della rivista.
Nei tre numeri pubblicati durante il 1925 si leggono, distribuiti in sei
pagine, articoli dedicati ad autori e opere di letteratura, frammenti di
cronaca sugli avvenimenti del mondo letterario, rubriche e molte
recensioni. Fin dal primo anno, il periodico si arricchisce della rubrica
‘Rivista delle riviste straniere’, interessante panoramica sui periodici
europei, e della sezione dei libri stranieri tradotti, curata da Giovan
Battista Angioletti. Alla sezione dedicata al teatro, che accoglie
principalmente la critica delle prime rappresentazioni teatrali romane e
milanesi, curata da Silvio D’Amico, Arnaldo Frateili e Riccardo
Bacchelli, collaboreranno Chiarelli, Alberto Bragaglia, Marinetti,
Petrolini, Depero e Savinio, rispondendo a un’ampia richiesta fra il
pubblico di lettori.198 Fra gli autori di articoli slavistici che
collaborarono alla rivista una menzione merita Rinaldo Küfferle199. Già
nel primo numero della rivista Küfferle mostra in più articoli una
particolare chiarezza espositiva, contraddistinta dall’incisività
dell’enunciato e da una vena critica, a tratti polemica, che lo portano a
prendere le distanze dal testo oggetto della sua analisi. Esempio di ciò è
la recensione alla traduzione dell’Evgenij Onegin di Puškin, firmata da
Lo Gatto, dove egli evidenzia alcune forzature stilistiche, che a suo
parere tradirebbero la fedeltà all’originale200. A questa segue una breve
198
Per approfondimenti sulla storia della rivista rimando a: Aveto A., Merlanti F. (a
cura di), Umberto Fracchia: i giorni e le opere, Firenze, Società editrice fiorentina,
2006; Bartalena I., La Fiera letteraria negli anni 1949 e 1950: l'erudizione oltre
l'impegno, Roma, Aracne, 2009; Bellezza E., Franceschini M, Piaggio R. (a cura di),
Umberto Fracchia direttore della "Fiera Letteraria" negli anni 1926-26. Catalogo
regesto del carteggio tra Umberto Fracchia ed i collaboratori della Fiera, posseduto
dalla Biblioteca Universitaria di Genova, Genova, 1987; De Paolis P., La storia de "La
Fiera letteraria", Rapallo, Ipotesi, 1981; Falqui E., Il 13 dicembre 1925 usciva la
prima "Fiera". "Esistere nel tempo", “La Fiera letteraria” n. 1 (1965); Mattioli C., La
"Fiera letteraria" dal 1925 al 1929, “La Rassegna della letteratura italiana”, n.2-3
(1987), pp. 394-403.
199
Di origine italo-lituana, Rinaldo Küfferle (1903-1955) fu uno dei più prolifici
traduttori dal russo di tutto il primo dopoguerra. Tradusse scrittori classici, in
particolare Puškin, ma anche numerosi contemporanei appartenenti all’emigrazione
come Merežkovskij, Bunin, Amfiteatrov e soprattutto Zajcev e Aldanov. Sulla
biografia di Küfferle rimando a: Chi è? Dizionario degli italiani d’oggi, Roma,
Cenacolo, 1940 e al paragrafo a lui dedicato nel volume di Laurent Béghin, Op. cit.,
pp. 311-312 (vedi in Traduttori di origine russa).
200
Cfr. Rinaldo Küfferle, recensione a: Alessandro Pusckin, Eugenio Onièghin.
Traduzione, introduzione e note di Ettore Lo Gatto. G. C. Sansoni editore, Firenze,
“Ibidem”, anno II, 3, 17 gennaio, 1926, p. 6.
64
nota polemica su come Lo Gatto aveva accolto una sua precedente
recensione in un articolo pubblicato nel primo numero di “Russia”, una
nota di contrappunto di Küfferle, che conferma l’acceso confronto tra i
due studiosi, particolarmente esuberanti nel campo delle traduzioni201.
Nel mese di febbraio dello stesso anno, Küfferle prosegue con
recensioni e interventi critici, dalla presentazione del libretto del
dramma di Musorgskij Chovanščina alla raccolta di novelle umoristiche
di Čechov, Averčenko e Kuprin, rilevandone alcuni aspetti
contradditori202. A partire dal mese di luglio gli interventi di Küfferle si
fanno più sporadici pur mantenendo un profilo critico, basato su una
approfondita conoscenza dei testi, che gli permette osservazioni
meditate e attente. Nel fascicolo n. 30 del 25 luglio il critico presenta
l’antologia in due volumi curata da Giovanni Gandolfi e dedicata alle
liriche di Puškin e Lermontov, evidenziando l’attenta analisi stilistica
dei testi eseguita da Gandolfi203; in un altro contributo del mese di
settembre, Küfferle adotta per la prima volta uno stile espositivo
piuttosto ‘affabulatorio’, molto vicino al racconto, per descrivere
l’incontro avvenuto con l’esule russo Aleksandr Amfiteatrov nella sua
casa di Levanto. La seconda parte dell’articolo è dedicata alla ricezione
di Amfiteatrov in Russia e ai modelli letterari, ai quali questi si è
sempre ispirato.204
Un filone di studi ben rappresentato a partire dal 1926 è quello sul
teatro. Lo inaugura una breve segnalazione del 31 gennaio, a cura della
redazione del periodico, sulle rappresentazioni teatrali della compagnia
di Georges Pitoëff205 in cartellone al teatro di Torino per il mese di
febbraio dello stesso anno. Segue un intervento di Riccardo Bacchelli
sulla compagnia teatrale formata da Georges e Ljudmila Pitoëff, in
particolare sugli allestimenti teatrali italiani di una commedia di Claude
Anet, Mademoiselle Bourrat, dove la parte principale sembra adattarsi
perfettamente alla personalità di Ljudmila, e di La Dame aux Camélias
di Alexandre Dumas, in cui, secondo Bacchelli, l’arte scenica di
Georges si esprime al meglio in veste di direttore e scenografo206. Due
articoli del mese di marzo elogiano le doti artistiche di Ida Rubinštejn,
ballerina e mima di scuola russa, figlia delle grandi tradizioni del teatro
francese, ed è arricchito da un bel disegno-ritratto della Rubinštejn ne
201
Cfr. Rinaldo Küfferle, Traduzione in versi, in ‘Note polemiche’, “Ibidem”, anno II,
7, 14 febbraio, 1926, p. 6.
202
Rimando alla Bibliografia ragionata.
203
Cfr. Rinaldo Küfferle, I lirici russi del secolo aureo, “Ibidem”, anno II, 30, 25
luglio, 1926, p. 5.
204
Cfr. Rinaldo Küfferle, Alessandro Amfiteatrov, “Ibidem”, anno II, 38, 19 settembre,
1926, p. 5.
205
Su Georges Pitoëff rimando al sito: http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=794.
206
Cfr. Riccardo Bacchelli, I Pitoëff in Italia, “Ibidem”, anno II, 8, 21 febbraio, 1926,
p. 4.
65
L’Idiot rappresentato al Teatro Manzoni di Milano207. Nei mesi di
maggio e giugno sono Arnaldo Frateili e Raissa Olkienizkaia Naldi208 a
occuparsi di teatro, Frateili con una recensione alla commedia di
Čechov Il topo, dove ne riassume la trama e ne evidenzia alcune
caratteristiche tipiche del genere della pochade, che concilia il
divertimento con l’insegnamento morale, e la Naldi con un articolo
sulla portata innovativa dell’arte di Evrejnov, la cui fama resta legata,
nel ricordo degli intellettuali russi, agli allestimenti scenici brillanti,
stilizzati e grotteschi del Teatro Antico e dello Specchio Obliquo. Nei
mesi di ottobre e novembre vengono pubblicati due contributi di
Bacchelli e uno di Tat’jana Pavlova209. I primi, relativi al mese di
ottobre, sono la recensione alla rappresentazione di una commedia degli
equivoci di Evrejnov Ciò che più importa al Teatro Manzoni di Milano,
di cui viene elogiata la recitazione degli attori Racca, Cimara e Olivieri,
e la presentazione della messinscena al Teatro Arcimboldi dell’atto di
Čechov Storienko, descritto da Bacchelli come “burlesco, beffardo e
spregiudicato”210. La Pavlova interviene con un contributo del mese di
dicembre, che traccia un bilancio sullo stato del teatro e sugli effetti
causati dall’avvento del cinematografo, deleteri sulla qualità e
sull’innovazione delle rappresentazioni211.
La sezione dedicata al teatro prosegue e si chiude nell’annata
successiva con tre articoli. Ignazio Balla illustra le caratteristiche del
teatro di Sergej Djagilev e della sua messinscena, resa celebre dalla
perfetta sincronia tra scenografia, coreografia e musica; Riccardo
Bacchelli evidenzia la grazia e il talento di Georges e Ljudmila Pitoëff
nella messinscena di Revizor di Gogol’ e L’indigent di Vildrac e, infine,
207
Cfr. Riccardo Bacchelli, Ida Rubenstein, (Le Martyre de Saint Sebastien, Teatro alla
Scala – La Dame aux Camélias, L’Idiot, Teatro Manzoni), con disegno-ritratto di Ida
Rubenstein in L’Idiot, p. 4, “La Fiera letteraria”, anno II, n. 8, 21 febbraio, 1926; Id.,
“L’Idiot” di Nozière e Bienstock (Milano, Teatro Manzoni, 12 marzo), con fotografia
di Ida Rubenstein in “L’Idiot”, p. 4, “Ibidem”, anno II, n. 12, 12 marzo, 1926.
208
Raissa Grigor’evna Olkienickaja Naldi (1886-1971) fu autrice di circa tredici
versioni dal russo negli anni del primo dopoguerra; tradusse soprattutto autori moderni,
Sejfullina, Zoščenko, Merežkovskij, con una preferenza per i drammaturghi. Per una
biografia completa rimando a: Laurent Béghin, Op. cit., pp. 312-314 (Traduttori di
origine russa) e al sito http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=298.
209
Su Tatjana Pavlova Zeitman rimando al sito:
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=278.
210
Cfr. Renato Bacchelli, “Ciò che più importa”. 2 atti di N. Ievrieinov. Milano,
Manzoni, 4 ottobre; Id., “Storienko”. 3 quadri di Wassili Cetof (Milano, Arcimboldi, 4
ottobre), “Ibidem”, anno II, 41, 10 ottobre, 1926. Cfr. anche Laura Piccolo, “Novità
agli indipendenti”: russi reali e russi immaginari in scena, in Archivio russo-italiano /
Russko-ital’janskij archiv, V. Russi in Italia, Antonella d’Amelia, Cristiano Diddi (a
cura di), Salerno, 2009, pp. 210-235.
211
Cfr. Tatiana Pavlova, La salvezza del Teatro è nel Teatro. Altre risposte al nostro
referendum sull’Arte Drammatica, “Ibidem”, anno II, 51, 19 dicembre, 1926, p. 6.
66
Ja Ruskaja212 con un articolo tratto dal volume La danza come modo di
essere, nel quale l’A. riassume la storia del balletto russo a partire dai
primi anni del Novecento, quando a dominare la scena era il teatro di
Mosca coi maestri italiani e francesi, che introducevano la maniera
coreografica occidentale, fino al rinnovamento introdotto dalla
compagnia di Djagilev213. Il 1927 registra una maggioranza di
contributi firmati da Giacomo Prampolini214 e Giovanni Comisso215.
Prampolini esordisce con la presentazione di una recente antologia di
autobiografie dal titolo Pisatel’ relativa a prosatori russi contemporanei
di ogni età ed etnia, di cui vengono tracciati dettagliati profili, curata da
Vladimir Lidin216. Seguono poi una serie di brevi contributi che
informano i lettori su fatti di cronaca, passata e presente, nel mondo
letterario slavo; le notizie vengono prese da celebri riviste diffuse in
Europa, dal “Literarische Welt” di Berlino, di cui Prampolini riporta
un’inchiesta sulla tragica morte di Puškin, alla rivista letteraria croata di
Zagabria “Vijenac”, che, secondo una nota di Bruno Neri per la rubrica
‘Meridiano Jugoslavo’, pubblica un articolo sulla “crisi del libro”. La
collaborazione di Prampolini prosegue anche nell’annata successiva.
212
Evgenija Borisenko (1902-1970) si afferma in Italia come danzatrice, coreografa e
insegnante di danza, interprete di spettacoli, molti dei quali diretti da Anton Giulio
Bragaglia al Teatro degli Indipendenti di Roma da lui fondato. Il nome d’arte “Ja
Ruskaja” le viene dato dallo stesso Bragaglia per sfruttare la moda dei danzatori russi
lanciata da Djagilev e che imperversava in tutta Europa negli anni ’20. Per
approfondimenti su Borisenko rimando a Laura Piccolo, “Novità agli indipendenti”:
russi
reali
e
immaginari
in
scena,
cit.,
e
al
sito:
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=158.
213
Cfr. Ignazio Balla, I balli russi (Milano, Alla Scala, 10 gennaio), p. 5; Riccardo
Bacchelli, A Milano, p. 5; Ja Ruskaja, Splendori e miserie del balletto russo, “Ibidem”,
anno III, 1927, p. 5.
214
Nato a Milano nel 1898, Giacomo Prampolini (si laurea in lettere e in
giurisprudenza. Noto negli ambienti letterari per la vastissima padronanza delle lingue,
sia classiche sia moderne, concentra gran parte della sua attività di critico e saggista
nella redazione di ampi repertori sulla letteratura mondiale, ma è anche poeta, lettore e
traduttore
di
testi
stranieri.
Unico curatore della Storia universale della letteratura, uscita una prima volta per
UTET tra il 1932 e il 1938 in cinque volumi e ripubblicata nel dopoguerra in sette
volumi, Prampolini è autore anche de La mitologia nella vita dei popoli (1938) e delle
Letterature nel mondo (1956). Muore a Pisa nel 1975. Rimando al sito
http://www.fondazionemondadori.it/livre/02_I_lettori/07_Prampolini_01.html.
215
Giovanni Comisso (1895-1969), dopo un intensa attività pubblicistica in Italia e
all’estero, si affermò negli ambienti culturali italiani. Trovò ospitalità, per i suoi
racconti, su “La Fiera letteraria”,” Solaria”, “Pegaso”, “L’Illustrazione italiana” ed
ebbe modo di dare alle stampe opere come Giorni di guerra, Il delitto di Fausto
Diamante, Storia di un patrimonio. Inoltre, strinse altri rapporti culturali, incontrando
nel 1931 a Parigi, introdotto da De Pisis, il gruppo di artisti italiani che vi operavano,
affascinati dal movimento surrealista e si dedicò a iniziative di vario genere, come
un'associazione, istituita nel 1928 e della quale faceva parte anche Bacchelli, per la
conoscenza delle opere di Ippolito Nievo. Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, s.v.
216
Cfr. Giacomo Prampolini, Indice letterario della Russia d’oggi. La Rivoluzione ha
creato nuovi scrittori?, con due fotografie di Vsevolod Ivanof a Scisckov, “Ibidem”,
anno III, . 3, 16 gennaio, 1927, p. 6.
67
Oltre a due brevi ma importanti notizie sulla pubblicazione di un
sonetto di Leopold Staff, vincitore del premio polacco per la poesia,
sulla rivista di Varsavia “Skamander”, e la biografia del pittore e
scrittore polacco Stanisław Ignacy Witkiewicz, Prampolini firma due
interessanti contributi: il primo dedicato alla gioventù russa, definita dal
filosofo Berdjaev nelle pagine dell’”Europäische Revue” “gioventù
antropologica” rispetto alla vecchia intelligencija e alle classi sociali
dell’anteguerra, il secondo sull’arte letteraria di Tolstoj217. Allo scrittore
di Jasnaja Poljana sarà dedicato l’intero fascicolo n. 38 del 16 settembre
in occasione del centenario della nascita218.
Il fascicolo speciale su Lev Tolstoj si apre con un contributo di
Umberto Fracchia su Tolstoj, uomo e artista; Fracchia realizza un
ritratto dello scrittore, partendo da banali caratteristiche fisiche e
procedendo gradualmente verso la descrizione del “dissidio interiore tra
l’ironico e il grottesco” vissuta nella vita e nelle opere. L’articolo è
anche per l’A. un occasione di riflessione sulla vastità dell’opera
tolstoiana, a cui si affianca un’incredibile quantità di studi in suo onore
prodotti in poco più di mezzo secolo. Arricchisce il contributo un
ritratto di Tolstoj, eseguito da Anselmo Bucci, che cerca di
rappresentarlo in tutta la sua “terribile grandezza”.
Fra gli articoli e le notizie bibliografiche che seguono, alcuni
sono particolarmente degni di nota. Emilio Cecchi ricorda
un’importante iniziativa presa dal governo russo in occasione del
centenario, ossia l’edizione completa delle opere a cura del Gosizdat
(Edizioni di Stato), che per l’occasione ha istituito un Comitato di
redazione presieduto da Lunačarskij. Olga Resnevič Signorelli presenta
una raccolta di brevi frammenti tratti dai diari inediti di Tolstoj a partire
dal primo del 1843, dove lo scrittore esprime il disagio della bruttezza
fisica, uno stato d’animo ricorrente nei primi scritti, pubblicati a partire
dal 1852. Dmitrij Merežkovskij espone alcuni episodi di vita quotidiana
tratti da articoli e diari, testimonianza rispetto quasi religioso di Tolstoj
per la natura. Angioletti, infine, mette a confronto Tolstoj e Flaubert per
quanto concerne la diversa concezione dell’arte; Tolstoj sosteneva che,
più che rappresentarla, l’arte andasse ‘vissuta’, lasciando un’impronta
indelebile nell’esistenza umana, Flaubert, al contrario, considerava
l’arte pura rappresentazione.
Nell’ultimo anno di pubblicazione della “Fiera letteraria”, prima
di cambiare il nome in “Italia letteraria”, di orientamento più
marcatamente filo-fascista, va notata, nel mese di maggio, la presenza di
Leone Ginzburg fra i nuovi collaboratori, con la prima versione
217
Cfr. Giacomo Prampolini, La nuova gioventù russa; Tolstoj, l’artista, “Ibidem”,
anno IV, 10, 4 marzo, 1928, pp. 5 e 8.
218
Rimando all’intero fascicolo della rivista. Vedi Bibliografia ragionata.
68
integrale e conforme al testo originale di Smert’ Nikolaja Levina di
Tolstoj, d’imminente pubblicazione per i tipi della Slavia219. Segue nel
mese di settembre un interessante articolo di Marco Slonim sulla
biografia di Anton Čechov, in occasione del XXV anniversario della
morte, un contributo, che registra un ritorno d’interesse di critici e
letterati con pubblicazioni e rassegne bibliografiche a lui dedicate220.
Umberto Barbaro, nella sezione ‘Letterature straniere’, traccia un
profilo artistico degli scrittori Karl Čapek, di cui si citano frammenti del
romanzo Krakatik e i Trapné povidky, tradotti da Wolfang Giusti per “Il
Genio Slavo” nel 1929, Boris Pil’njak, di cui Corrado Perris ha tradotto
Oltre le foreste sempre per i tipi de “Il Genio Slavo” nel ’29, e Il’ja
Erenburg, il cui romanzo Ljubov’ Žanny Nej è stato tradotto e curato da
Lia Neanova per il “Corbaccio”, collezione “Volga221”. Chiude i
contributi slavistici del periodico un articolo di Marco Slonim, che
traccia un bilancio dell’attività letteraria degli scrittori russi emigrati dal
1918 al 1924, con uno sguardo sulla produzione letteraria
contemporanea di Bunin, Bal’mont, Kuprin, Zajcev, Aldanov, Muratov,
Merežkovskij, Chodasevič, Remizov e Cvetaeva222.
Volendo sintetizzare in cifre la presenza delle culture slave nella
rivista “La Fiera letteraria” è possibile riscontrare una netta
preponderanza di articoli sulla cultura russa, seguiti dai contributi sulla
cultura polacca:
219
Cfr. Leone Ginzburg, traduzione: Leone Tolstoi, La morte di Nicola Levin,
“Ibidem”, anno V, 19, 12 maggio, 1929, p. 4. Su L. Ginzburg cfr. più avanti n. 174.
220
Cfr. Marco Slonim, Nel XXV anniversario della morte di Cecoff. L’interprete della
vita borghese, “Ibidem”, anno V, 35, 1 settembre, 1929, p. 4.
221
Cfr. Umberto Barbaro, Due Russi e un Cèco in ‘Letterature straniere’, “Ibidem”,
anno V, 44, 3 novembre, 1929, p. 2.
222
Cfr. Marco Slonim, La nuova letteratura degli emigrati rusi, “Ibidem”, anno V, 45,
10 novembre, 1929, p. 6.
69
Russa
Polacca
13; 9%
Ceca
Serba
4; 3%
15; 10%
117; 78%
Relativamente alla cultura russa, si evince una netta maggioranza
di articoli dedicati ai classici dell’Ottocento, in particolare Tolstoj,
Puškin e Čechov:
Tolstoj
Gor'kij
Puškin
Amfiteatrov
Čechov
Dostoevskij
Esenin
Gogol'
Kuprin
Turgenev
Mussorgskij
Stravinskij
Evrejnov
Pil'njak
Muratov
Arcybašev
Blok
Vinnicenko
Avarčenko
Lermontov
Sejfullina
Bulgakov
Saltykov-Ščedrin
Erenburg
70
3. “La Nuova Italia: rassegna critica mensile della cultura italiana e
straniera ” (1930-1943)
“La Nuova Italia” fu fondata a Firenze nel 1930 da Luigi Russo,
docente di letteratura italiana, e su iniziativa della casa editrice da cui
deriva il nome. L’editoriale con cui Russo inaugurò la rivista non
lasciava dubbi sul programma: doveva essere la “reincarnazione
spirituale” e “genuina metempsicosi” del vecchio “Leonardo”,
perseguendo un “fine critico e di affiatamento culturale”, non
“meramente bibliografico”, in polemica con l’orientamento che avrebbe
assunto il futuro “Leonardo” diretto da Federico Gentile nella nuova
veste di “rassegna bibliografica”223:
Noi non saremo costretti a fare i mercanti di libri buoni e cattivi,
a servire degli interessi sotto la specie della cultura, a mettere avanti delle
rassegne che poi, come è oggi di moda, riescono solo a mal dissimulati
bollettini librari. La nostra rivista vuole avere, come si diceva, carattere
rigorosamente critico: non la critica della piccola ragione, s’intende, che è
scetticismo e impotenza morale, ironia estetica della decadenza, senso
dell’errore in particolare e disconoscimento della bontà dell’insieme; la
critica frammentaria, centrifuga e dispersiva; ma quella che il De Meis
chiamava la critica della grande Ragione, che è lume, riflessione, potenza,
che si avvale ma non si inceppa nel particolare, la critica che discute non
per negare ma per essere essa stessa incremento di vita e di fede […]224.
L’obiettivo era quello di offrire al pubblico una raccolta di saggi
di varia natura ma anche aggiornamenti bibliografici su quanto veniva
stampato in Italia e all’estero, tutto questo all’insegna del rigore critico.
Rispetto al passato era in atto un radicale cambiamento, per cui non era
più la cultura italiana ad avere un spazio esclusivo di approfondimento,
ma anche le culture straniere, un modo per superare, culturalmente, i
confini nazionali disegnati dalla “fondazione Leonardo” e dal suo
periodico225.
La presenza di contributi e segnalazioni bibliografiche sul mondo
slavo nella rivista si fa più massiccia tra il 1930 e il 1933, seguita subito
dopo da un calo sensibile a partire dal 1934, dovuto, evidentemente, al
graduale intensificarsi delle misure censorie del regime. Fin dal 1930
sono presenti contributi firmati da slavisti come Leone Pacini Savoj226
223
Per i contributi slavistici di “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile” rimando
alla Bibliografia ragionata.
224
Luigi Russo, Io dico seguitando…, “La Nuova Italia”, I, 1930, p. 2.
225
Per ulteriori approfondimenti sulla rivista rimando a Simona Giusti, Una casa
editrice negli anni del fascismo La Nuova Italia (1926-1943), Firenze, Leo Olschki
Editore, 1983.
226
Leone Pacini Savoj insegnò lingua e letteratura russa presso l’Istituto Universitario
Orientale di Napoli, di cui fu rettore dal 1956 al 1958. Come Wolf Giusti, oltre che di
russistica si occupò di boemistica e pubblicò numerose versioni di poeti cechi e
slovacchi. Cfr. ad es. Rossana Platone, Leone Pacini Savoj, in “Ricerche slavistiche”,
XXXVII, 1990, pp. 525-527.
71
ed Enrico Damiani, affiancati, a partire dal 1932, da Arturo Cronia. Il
primo contributo di Savoj è la recensione al saggio di Ključevskij sul
profilo storico e psicologico di Boris Godunov. Nell’articolo, dopo
un’interessante introduzione sulla politica russa contemporanea, lo
slavista coglie l’occasione per proporre un’immagine di Godunov
diversa da quella notoriamente conosciuta, che lo descriveva come un
astuto impostore, un uomo violento e sanguinario, confutando, in
proposito, le convinzioni espresse dallo stesso Ključevskij e dal filosofo
Solov’ëv227.
Seguono vari contributi di Leone Ginzburg per la rubrica ‘Letterature
slave’. Il primo di essi è la presentazione di un volume, che contiene
dieci racconti di Pantelejmon Romanov, cinque dei quali costruiti
intorno al tema del libero amore, considerato “inevitabile e naturale” ma
allo stesso tempo “bestialmente ripugnante”. Accompagnato dalla nota
critica che lo contraddistingue, Ginzburg esalta la traduzione dal russo
eseguita da Margherita Silvestri-Lapenna228. Particolarmente severa è,
invece, la recensione che lo studioso fa alla monografia di Turgenev
scritta da Damiani, evidenziando alcuni limiti dello slavista
nell’esposizione dei meriti artistici dello scrittore229. L’ultimo contributo
di Ginzburg nel primo anno della rivista è la recensione a quella che
egli definisce l’opera più significativa del teatro “neo-borghese”
sovietico, I giorni della famiglia Turbin di Michail Bulgakov, tradotto
da Lo Gatto come La guardia bianca, titolo allora diffuso fra gli
emigrati russi. Chiude l’annata un’interessante presentazione di Damiani
al volume di Roman Pollak Pagine di cultura e lettaratura polacca, una
raccolta di articoli e saggi tratti da conferenze e lezioni tenute dal prof.
Pollak nel corso dei cinque anni d’insegnamento a Roma 230 .
Nella prima parte del 1931 due articoli sono degni di menzione. Un
contributo di Ginzburg descrive l’arte narrativa di Konstantin Fedin, un
intellettuale che, secondo lo studioso, vive la poesia come espressione
dello spirito, condividendo l’opinione della critica marxista che
227
Cfr. Leone Pacini Savoj, recensione a: Boris Godunov, Tsar de Russie (1598-1603),
Paris, Payot, pp. 270, “ Ibidem “, anno I, 3, 20 marzo 1930, p. 121.
228
Cfr. Leone Ginzburg, recensione a: Pantelejmon Romanov, Amore. Prima versione
integrale dal russo con prefazione e note di Margherita Silvestri - Lapenna. Torino,
“Slavia”, 1930, pp. 330, L. 11, “La Nuova Italia”, anno I, n. 6, 20 giugno 1930, pp.
253-254. Sull’attività di Margherita Silvestri-Lapenna traduttrice rimando a Laurent
Béghin, Op. cit., p. 321.
229
Cfr. Leone Ginzburg, recensione a: E. Damiani, Ivan Turghénjev. I.p.E.O., Roma,
Slavia, Torino, 1930, pp. 158, “Ibidem”, anno I, n. 9, 20 settembre, p. 383.
230
Roman Pollak (1886-1972) fu il primo docente di letteratura polacca all’Università
di Roma, poi delegato del Ministero della Pubblica Istruzione polacco nonché
sostenitore dell’Istituto di Cultura Polacca “Attilio Begey”. Sull’Istituto rinvio a
Krystyna Jaworska, La tradizione polonistica in Piemonte e l’Istituto di Cultura
polacca “Attilio Begey”, in Id. (a cura di), La Polonia, il Piemonte e l’Italia. Omaggio
a Marina Bersano Begey, Atti del Convegno Marina Bersano Begey, intellettuale
piemontese e polonista, Torino, 12 dicembre 1994, Alessandria, Edizioni dell’Orso,
1998, pp. 249-278.
72
giudicava la sua opera “espressione della mentalità piccolo-borghese
dell’intelligencija”231. Segue, nell’articolo, una nota polemica dello
stesso Ginzburg alla recensione di Aldo Capasso al romanzo Brat’ja di
Fedin pubblicata da “Solaria” nel 1930, dove Capasso avrebbe giudicato
superficialmente lo scrittore russo, evidenziando eccessivamente alcuni
difetti strutturali del romanzo232. Nel numero di marzo segue subito la
replica di Capasso, che esprime il suo disappunto in un ampio
articolo233.
La seconda parte dell’annata è occupata da due recensioni di Pacini
Savoj, una alla versione integrale del racconto di Čechov La camera n.6,
eseguita da Giovanni Faccioli, in cui l’A. descrive la psicologia dei
singoli personaggi, evidenziandone il pessimismo esistenziale, l’altra
alla versione integrale eseguita dalla Duchessa d’Andria del volume di
racconti di Tolstoj, particolarmente apprezzata da Savoj. Lo slavista si
sofferma, poi, sulla straordinaria capacità di Tolstoj di unire poesia e
autobiografia in un unico testo234.
Il 1923 si apre con un’interessante e lunga recensione di Arturo Cronia
al volume di Milos Weingart, tradotto dal ceco da Wolf Giusti235, sulla
storia della slavistica. È degna di nota l’osservazione di Cronia sui
propositi della disciplina che, se in teoria, e secondo una concezione
panslavista, può definirsi una scienza storico-comparativa delle lingue e
letterature slave, studiate dal punto di vista dei rapporti reciproci, nella
pratica si tratta di un “complesso di scienze relative a singoli aspetti
della civiltà slava”236. Nello stesso anno Leone Pacini Savoj presenta il
volume di Cronia sul poeta ceco Petr Bezruč, pseudonimo di Vladimir
Vašek, definito il “bardo moravo” per le continue invettive politiche. Il
saggio di Cronia viene considerato da Savoj il più completo mai
231
Sulla storia e il pensiero dell’intelligencija in Russia rimando al saggio di Piero
Gobetti, Paradosso dello spirito russo e altri scritti sulla letteratura russa.
Introduzione di Vittorio Strada, Torino, Einaudi, 1976.
232
Cfr. Leone Ginzburg, Nota su Konstantin Fedin, in ‘Uomini del Novecento’,
“Ibidem”, anno II, 20 gennaio, n. 1, 1931, pp. 13-15.
233
Cfr. Aldo Capasso, III. – Critica sui testi e critica sulle traduzioni, “Ibidem”, anno
II, n. 3, 20 marzo 1931, pp. 119-120.
234
Cfr. L. Savoj, recensione a: A. Cechov: La camera N°6. Racconto. Versione
integrale con note di G. Faccioli. Slavia, Torino, pp. 280. L. 10,– Id., recensione a: L.
Tolstoj: Due usseri. Racconti. Versione integrale con note della Duchessa di Andria.
Slavia, Torino, pp. 331, L. 11, “Ibidem”, anno II, n. 8, 20 agosto 1931, pp. 318-320.
235
Sullo slavista rimando a Laura Satta Boschian, Ricordo di Wolf Giusti (1901-1980),
in “Ricerche slavistiche”, vol. XXIX-XXXVI, 1982-1984, pp. 7-9. Cfr. anche F.
Cantini (a c. di), Wolf Giusti (1901-1980). Bibliografia, “eSamizdat”, I (2003), 181211.
236
Cfr. Arturo Cronia, recensione a: Milos Weingart, Introduzione bibliografica allo
studio della slavistica, traduzione dal ceco di W. Giusti, Udine-Tolmezzo, 1929,
“Biblioteca italiana e straniera’ diretta da R. Chiurlo, “Ibidem”, anno III, 20 gennaio, n.
1, 1932, pp. 32-34.
73
realizzato su Bezruč237. Damiani è presente con tre articoli, di cui uno
sulla traduzione del romanzo di Vladimir Lidin L’Apostata eseguita da
Nina Romanovsky238. Seguono la recensione alla traduzione integrale
dallo sloveno del dramma di Ivan Cankar Il re di Betainova, eseguita da
Bartolomeo Calvi, di cui Damiani evidenzia la rara e specifica
competenza nel presentare la giovane letteratura slovena, ancora poco
nota in Italia; e un’interessante storia delle traduzioni italiane delle opere
di Juliusz Słowacki, da Paolo Emilio Pavolini a Giovanni Maver, con
una nota di elogio per la fedele versione in prosa dei poemi drammatici
Kordjan e Mazeppa, eseguita da Clotilde Garosci239.
Dal 1933 al 1938 si registrano, in totale, tre articoli di Pacini Savoj
sul teatro boemo, considerato elemento chiave della rinascita culturale
nazionale, e sugli scrittori russi Alfred Bem e Leonid Leonov. Per
quanto riguarda il teatro ceco contemporaneo, Savoj lo descrive come
“specchio della società”, il cui obiettivo è quello di ridestare dal
“torpore” il popolo imborghesitosi sotto la schiavitù, e al tempo stesso
un “campo di prova” per la nuova lingua letteraria ceca, depauperata da
barbarismi e idiotismi. L’opera di rinascita del giovane teatro
drammatico viene affidata ai buditelé (ridestatori), nome col quale
vengono chiamati i primi drammaturghi dell’epoca240. Gli altri due
contributi sono la recensione al saggio di Alfred Bem dedicato
all’evoluzione psicologica e caratteriale del personaggio dostoevskiano
di Stavrogin attraverso parallelismi coi protagonisti di Žitie velikogo
grešnika, Ateizm e Besy, e la presentazione critica del volume di racconti
di Leonid Leonov tradotto per la prima volta dal russo da Anna Ruska
con la prefazione di Alfredo Polledro, particolarmente apprezzata da
Savoj per concisione e chiarezza espositiva241.
237
Cfr. L. Savoj, recensione a: A. Cronia, Petr Bezruč, I. p. E. O., Roma, 1932, pp.
122, L. 5, “Ibidem”, anno III, 20 settembre, n. 9, 1932, p. 358.
238
Sulla Romanovsky rimando alle considerazioni di E. Lo Gatto in Gli studi slavi in
Italia (Op. cit.), p. 464.
239
Cfr. E. Damiani, recensione a: Ivan Cankar, Il Re di Betainova. Dramma in tre atti.
Traduzione integrale dallo sloveno e studio critico di Bartolomeo Calvi. Torino,
Società Editrice Internazionale, 1929. Un vol. in 16, pp. 119, L.8 – Id., recensione a:
Giulio Slowacki, Kordjan; Mazeppa. A cura di Clotilde Garosci. Torino, Unione
Tipografica Editrice, 1932. Un vol. in 16 di pp. 317 (collana “I Grandi Scrittori
Stranieri” diretta da Arturo Feltrinelli), “Ibidem”, anno III, n. 12, 20 dicembre, 1932, p.
476. Rimando alla collaborazione di Clotilde Garosci per la collana della Utet “I grandi
scrittori stranieri” nella sezione dedicata alle traduzioni dal polacco. Cfr. Laurent
Béghin, Op. cit., pp. 340-342.
240
Cfr. Leone Savoj, Il teatro boemo e il paradosso del teatro senza tragedia,
“Ibidem”, anno V, n. 3, 20 marzo, 1933, pp. 88-91.
241
Cfr. Leone Savoj, recensione a: A. L. Bem, Evoljutsija obraza Stavroghina. Trudy
V. S”jezda Akad. Organ zagran I. Sofia, 1931 – Id., recensione a: Leonid Leonov,
L’avventura d’Ivan. Racconti, in ‘Letterature straniere’. Prima traduzione dal russo di
Anna Ruska, con prefazione di Alfredo Polledro. Torino, “Slavia”, 1931, L. 10.
Collezione “Il Genio Slavo”, 1931, “Ibidem”, anno V, n. 3, 20 marzo, 1933, pp. 196199.
74
Nel 1939 Damiani è presente nella sezione ‘Filologia slava’ con
due importanti saggi critici; un bilancio consuntivo delle pubblicazioni
relative alla lingua e letteratura russa del 1938, nel quale lo slavista
mette in evidenza il numero maggiore di titoli pubblicati l’anno
precedente come conseguenza delle celebrazioni per il centenario della
morte di Puškin, e una rassegna bibliografica relativa all’ultimo biennio
di pubblicazioni sulle altre culture slave242. Lo slavista chiude la sua
collaborazione a “La Nuova Italia” con la presentazione di un’antologia
di scrittori bulgari contemporanei, curata da Luigi Salvini.
Nell’antologia, Damiani e lo stesso Salvini classificano gli scrittori in
due correnti letterarie: “verista”, la cui prosa viene definita “scarna e
concisa”, e “idillico-melanconica”, più pittoresca e celebrativa. Le
traduzioni dal bulgaro sono eseguite da Vittorio Zincone, Luigi Salvini,
Roberto Weiss di Londrone, Enrico Lapenna e lo stesso Damiani243.
Concludo con un’esemplificazione grafica della presenza delle
sigole culture slave nella rivista “La Nuova Italia”, dov’è evidente una
prevalenza dei contributi russistici:
Russa
Polacca
Ceca e slovacca
Slovena
Ucraina
112; 85%
1; 1%
1; 1%
12; 9%
5; 4%
Il secondo grafico illustra la presenza degli autori russi e sovietici,
ancora una volta con una netta preferenza per i classici dell’Ottocento
Dostoevskij, Tolstoj, Turgenev, Čechov, Gogol’ e Puškin:
242
Cfr. FILOLOGIA SLAVA – Russia, a cura di Enrico Damiani, Bilancio consuntivo
del 1938, “Ibidem”, anno X, aprile-maggio, n. 4-5, p. 148 – Id., Le altre letterature
slave, “Ibidem”, anno X, n. 6, 20 giugno, 1939, pp. 181-182.
243
Cfr. E. Damiani, recensione a: Narratori bulgari. A cura di Luigi Salvini. Roma,
Istituto per le relazioni culturali con l’Estero, 1939, pp. XXXVII-294 (Collezione
“Stelle dell’Orsa”, Scrittori Stranieri, a cura di Luigi Salvini e di Bino Sanminiatelli),
“Ibidem”, anno XII, n. 10, 20 dicembre, 1941, pp. 335-337.
75
Dostoevskij
Tolstoj
Turgenev
Čechov
Gor'kij
Gogol'
Bulgakov
Puškin
Romanov
Zajcev
Lidin
Babel'
Veresaev
Remizov
Erenburg
Neverov
Andreev
Fedin
Leskov
Merežkovski
Sejfullina
Felyne
Garin
Kuprin
Evrejnov
Arcybašev
Garšin
Erenburg
Šmelëv
Leonov
4. “Lo Spettatore italiano” (1924)
I tentativi di connotare ideologicamente il Fascismo durante la
fase storica del movimento compresa tra il 1918 e il 1925 giungono nel
1925 alla formazione del Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da
Giovanno Gentile, dove lo si dichiara “movimento politico morale”.
Successivamente, superata l’opposizione parlamentare dell’Aventino e
stabilizzatosi in ‘regime’, il Fascismo mira alla gestione e alla diffusione
del consenso. Dall’ottobre 1922 al 1925 vivere il Fascismo
culturalmente senza concepirlo più, com’era accaduto in passato, in
termini di violenza, illegalità e squadrismo ma come ‘rivoluzione
intellettuale’, è un tema ricorrente, spesso dibattuto nelle riviste ufficiali
come “Gerarchia”, fondata da Mussolini nel 1922, “Cultura fascista”,
organo dell’Istituto Nazionale di Cultura Fascista, “Educazione fascista”
(1923), la rivista di Gentile, trasformata poi in “Civiltà fascista”, e
“Critica fascista”, fondata da Giuseppe Bottai nel 1923244. Il periodico di
Bottai uscì regolarmente e senza interruzioni per vent’anni, inizialmente
affiancato da “Lo Spettatore italiano. Rivista letteraria dell’Italia nuova”
e da “Primato”.
244
Cfr. Renato Bertacchini, Le riviste del Novecento. Introduzione e guida allo studio
dei periodici italiani. Storia, ideologia e cultura, Firenze, Le Monnier, 1979, pp. 139145.
76
Prima di passare a “Critica fascista”, osserviamo la presenza di
alcuni slavisti nel supplemento “Lo Spettatore italiano”.
La rivista, il cui sottotilolo è già una dichiarazione programmatica,
“Rivista letteraria dell’Italia nuova”, nasce a Roma il 1° maggio 1924 ed
esce con una periodicità quindicinale il 1° e il 15 di ogni mese; ne sono
responsabili Giuseppe Bottai, ideatore nonché direttore politico e
finanziario, e Arnaldo Frateili, che si occupa della conduzione pratica e
dei rapporti con i collaboratori. Creato per affiancare come rivista
letteraria “Critica fascista” e con l’intento di avere a Roma l’equivalente
della parigina “Nouvelle Revue Française”, “Lo Spettatore italiano” ha
avuto vita difficile fin dall’inizio, sia per la scarsa disponibilità di fondi,
sia per i vari impegni di Bottai nella particolare e difficile situazione
politica, determinata dal “delitto Matteotti”. Il foglio romano, che vive
proprio in quel periodo, dopo aver interrotto la regolare periodicità
quindicinale, chiude col dodicesimo numero del 15 ottobre. Gran parte
della rivista è occupata da numerose sezioni e rubriche: la “Rassegna del
libro italiano”, curata tra gli altri da Alberto Cecchi per la narrativa e da
Corrado Pavolini per la poesia, la “Rassegna drammatica”, a cura di
Stefano Landi e Umberto Fracchia, la “Rassegna tecnica teatrale” di
Anton Giulio Bragaglia, la “Rassegna musicale” di Mario Labroca e la
“Rassegna delle letterature straniere”, dove la sezione dedicata alla
letteratura russa è curata da Ettore Lo Gatto.
Gli interventi di Lo Gatto sono tutti dedicati alla letteratura russa
post-rivoluzionaria, tranne un articolo sul Futurismo245. Il primo
contributo dello slavista può considerarsi l’‘editoriale’ di tutti gli altri
contributi dell’anno; Lo Gatto presenta la nuova stagione letteraria russa
in patria e all’estero, sviluppatasi nelle sue forme migliori fra i membri
della classe colta fuori dalla Russia. L’articolo si compone di due parti;
nella prima, vengono descritte le caratteristiche della cultura letteraria
negli ultimi anni, in particolare dal 1918 al 1923, distinguendo scrittori
rimasti in Russia a sostegno della rivoluzione come Gor’kij, Brjusov,
Sologub, Blok e Belyj, e scrittori esuli, che ripresero la loro attività
culturale all’estero, mossi a lasciare il paese di origine dalla guerra
civile, dalle persecuzioni, dal forte disagio morale in cui vivevano e dal
rifiuto categorico di asservire la letteratura alla causa rivoluzionaria. Lo
Gatto descrive l’attività letteraria di scrittori noti già prima della
rivoluzione come Merežkovskij, Bunin, Kuprin e Aleksej Tolstoj,
citando alcune
riviste letterarie sorte nei principali centri
dell’emigrazione russa di Parigi, Praga e Berlino246. Nella seconda parte
del contributo, esamina da vicino due fenomeni culturali, che si
svilupparono dal 1918 al 1921, l’immaginismo e il futurismo, in un
245
Sui rapporti tra Futurismo italiano e russo rimando al recente saggio di Cesare G.
De Michelis, L’avanguardia trasversale. Il futurismo tra Italia e Russia, Venezia,
Marsilio, 2009.
246
Per quanto concerne i russi emigrati in Italia, rimando al Dizionario
dell’emigrazione russa in Italia. Vedi il sito http://www.russinitalia.it/dizionario.php.
77
periodo in cui gli scrittori rimasti in patria dovevano tacere a causa della
mancanza di libertà di stampa. L’articolo si conclude con un’attenta
riflessione dello slavista sulla nuova stagione letteraria russa, erede del
classicismo dell’Ottocento247.
Proseguendo con le annate, un lungo articolo è dedicato all’attività
artistica e all’impegno civile di Maksim Gor’kij, dagli anni della
Rivoluzione al soggiorno italiano di Capri, attraverso un percorso fra le
varie pubblicazioni dello scrittore, dai progetti più ambiziosi, come i
volumi della grande letteratura mondiale, mai completati, alle opere
‘minori’ pubblicate dalla “Casa editrice governativa” di Mosca248. Nel
mese di luglio Lo Gatto dedica un lungo articolo al teatro. Dopo una
breve introduzione sull’importanza del teatro in Russia come alta
manifestazione della vita intellettuale e culturale, lo slavista espone le
teorie di V. Šeršenevič:
Di tutte le manifestazioni della vita culturale, intellettuale,
letteraria, l’unica che abbia avuto sin dai primi giorni della rivoluzione un posto
d’onore indiscusso e sicuro è stato il teatro […] Le ragioni di questa preferenza
[…] furono di recente assai bene riassunti da uno degli scrittori che la
rivoluzione ha messo molto in evidenza, ma il cui valore e il cui significato non
va al di là della mediocrità: V. Scerscenevic. L’arte, scrive il Scerscenevic in
uno studio appunto sul teatro rivoluzionario – è sopratutto uno strumento di
propaganda […]249.
Dopo quello di Lo Gatto, completano la sezione altri due articoli.
Il primo è una breve recensione di Stefano Landi alla rappresentazione
de Il giardino dei ciliegi di Čechov al Teatro Manzoni di Milano, messa
a confronto con quella di Dal tuo al mio di Giovanni Verga al Teatro
Argentina di Roma250; il secondo, un articolo sulla tecnica del teatro
russo contemporaneo. L’autore, K(?) Mociulski, descrive il delicato
passaggio avvenuto in Russia dal vecchio al nuovo teatro, nato in
reazione al naturalismo e rappresentato da Mejerchol’d. Nella prima
parte del contributo si descrivono i principi teorici sui quali si basa la
nuova concezione artistica, finalizzata a riportare sul palcoscenico la
pura ‘convenzionalità’ della rappresentazione, allontanandosi dal
realismo del passato. Nella seconda parte, viene descritta la nuova
“messinscena” in cui il protagonista non è più l’autore drammatico ma il
direttore artistico, che decide le tecniche sceniche basandosi su un
‘canone’ semplice e variabile. Infine, l’articolo si chiude con la
descrizione dell’ultima messa in scena teatrale allestita da Mejerchol’d a
247
Cfr. Ettore Lo Gatto, Gli scrittori della rivoluzione, in ‘Rassegna di letterature
straniere’, “Lo Spettatore italiano”, 1, 1 maggio, pp. 64-68.
248
Cfr. E. Lo Gatto, L’ultimo Gorkij, “Ibidem”, 4, 15 giugno, pp. 325-332.
249
E. Lo Gatto, Il teatro della rivoluzione, in ‘Rassegna di letterature straniere’,
“Ibidem”, 6, 15 luglio, 1924, pp. 556-560.
250
Cfr. Stefano Landi, Di Cécov e di Verga, “Ibidem”, 4, 15 giugno, pp. 378-383.
78
Mosca relativa a La Foresta di Ostrovskij251. La presenza di Lo Gatto
nella rivista si conclude con un saggio sull’importanza storico-culturale
delle riviste del XIX secolo nella storia della cultura russa. Dopo averne
descritte alcune, “Otečestvennye Zapiski”, “Russkoe Bogatstvo”,
“Sovremennik”, lo slavista analizza da vicino il genere pubblicistico del
“tolstyj žurnal”, che alla vigilia della guerra rappresentava ancora il
modello editoriale seguito dagli esuli russi a Parigi:
Alla vigilia della guerra il “tolstyj zhurnal” era la regola
editoriale di tal genere di pubblicazioni e se qualche rivista speciale di piccoli
gruppi più o meno eclettici si presentava smilza accanto ai fascicoloni dalle
molte centinaia di pagine del “Vjestnik Evropy” (il messaggero d’Europa) e
delle “Russkija Zapiski” (cito a caso i primi titoli che mi vengono alla mente)
rappresentava precisamente quella tale eccezione che …confermava la regola252.
Aurelio Palmieri è presente nello “Spettatore italiano” con tre
contributi, di cui uno sulla storia della cultura e della lingua
georgiana253. Nel primo fascicolo lo slavista interviene con la
presentazione dell’epistolario dello scrittore polacco Adam Mickiewicz,
una raccolta di ventisei lettere sconosciute per oltre un secolo e custodite
nell’Archivio della Società dei Filomati, società letteraria e patriottica
fondata a Vilnius dallo stesso Mickiewicz nel 1817. Palmieri si sofferma
sul primo volume di scritti, indirizzati agli amici della Società che
subirono con lui la politica repressiva del regime zarista di Nicola I, e ne
sottolinea l’importanza storico-documentaria254. Nel secondo articolo
traccia una breve storia delle teorie linguistiche e culturali che hanno
sostenuto nei secoli l’esistenza di una lingua e letteratura ruteno-ucraina
autonoma rispetto alle altre culture slave, dalla grammatica della lingua
ruteno-ucraina di Smal-Stocky e Gartner, edita a Vienna nel 1913, alla
Storia dell’Ucraina di Mikhajl Hruščevs’kij255. L’ultimo contributo è
una breve rassegna di studi critici sulla lingua e la cultura georgiana;
Palmieri si sofferma sulla raccolta di leggende agiografiche, edita da
Sabinin nel 1882, la cui fonte storica è la celebre storia della Georgia
curata da Korneli Kekelidze256.
I contributi slavistici della rivista si chiudono con due articoli.
Arturo Cronia passa in rassegna gli scritti della letteratura ceca dedicati a
251
Cfr. K. Mociulski, La tecnica del teatro russo contemporaneo, in ‘Rassegna di
letterature straniere’, “Ibidem”, 12, 15 ottobre, pp. 399-402.
252
E. Lo Gatto, Op. cit., p. 185.
253
Cfr. Aurelio Palmieri, Il Paradiso della Georgia, in ‘Rassegna del libro italiano’,
“Ibidem”, 12, 15 ottobre, pp. 390-393. Sui contenuti dell’articolo rimando alla
Bibliografia ragionata.
254
Cfr. Aurelio Palmieri, La corrispondenza di Adamo Mickiewicz, in ‘Rassegna di
letterature straniere’, ‘Ibidem”, 5, 1 luglio, 1924, pp. 465-472.
255
Cfr. Aurelio Palmieri, La storia letteraria della Rutenia, in ‘Rassegna di letterature
straniere’, ‘Ibidem’, 7, 1 agosto, 1924, pp. 69-75.
256
Cfr. Aurelio Palmieri, Il paradiso della Georgia, in ‘Rassegna del libro italiano’,
“Ibidem”, 12, 15 ottobre, 1924, pp. 390-393.
79
diari e itinerari di viaggio di scrittori e artisti cechi in Italia, dalle prime
testimonianze alla più recente pubblicazione di Karl Čapek “Lettere
italiane”257. Umberto Urbanaz-Urbani258 enumera le correnti letterarie in
Slovenia negli ultimi anni del XX secolo dalla neoromantica,
rappresentata da Cankar, Kette, Josip Murn-Aleksandrov e Župančič,
alla cattolica di Medved, Finzingar, Pregelj, Sardenko e Meskó259.
5. “Critica fascista” (1923-1943)
Nel primo numero di “Critica fascista”, l’editoriale Proponimenti e
l’appello ai giovani dichiarano la finalità della rivista e i punti base della
sua “opposizione fedele”: promuovere l’elaborazione sistematica
dell’ideologia fascista al vaglio interno di una volontà e di una “forza
critica”; proporre, dopo la prima ondata rivoluzionaria e squadrista, il
ricambio di una “nuova élite dirigente”; valorizzare le “fresche energie”
dei giovani, consentire loro di ripensare il Fascismo per immetterli
coscientemente nella vita politica del regime:
Questa Rivista nasce sopra tutto per incoraggiare e animare le
fresche energie, che sono una particolare ricchezza del Fascismo, e che
sarebbe sommo delitto lasciare intristire, anzi tempo, nei miasmi della
demagogia variopinta […]
La rivista, a cui collaborarono tra gli altri Massimo
Bontempelli, Giuliano Della Volpe, e Giovanni Gentile, conosce una
prima fase di crescita dal 1923 al 1932, seguita da un lento declino nel
periodo successivo. Le questioni di scottante attualità vengono affrontate
nelle prime annate del periodico, dal 1923 al 1926, soprattutto sul
rapporto tra lo Stato e il partito fascista, anche con articoli sulle relazioni
diplomatiche dell’Italia fascista con l’Europa, in particolare con i paesi
slavi.
In un clima di ostilità verso la Russia, la nuova classe
dirigente sovietica e le utopie prodotte dal bolscevismo, s’inseriscono
bene alcuni articoli di attualità. Aurelio Palmieri, l’unico slavista a
collaborare al periodico, analizza la personalità di Lenin260.
257
Cfr. Arturo Cronia, Peculiarità céche: gli itinerari. Itinerari italiani, ‘Ibidem’, 1011, 15 settembre-1 ottobre, 1924, pp. 302-308.
258
Su Umberto Urbanez-Urbani, specilista del serbo-croato e dello sloveno e
traduttore per la Slavia, rimando a Julius Skarlandt, Italský slavista Umberto Urbani, in
“Slovanský Přehled”, XXI, 9, 15 novembre 1929, pp. 719-720.
259
Cfr. Umberto Urbanez-Urbani, Il romanzo cattolico nella Slovenia, in ‘Rassegna di
letterature straniere’, ‘Ibidem’, 12, 15 ottobre, 1924, pp. 394-398.
260
Cfr. Aurelio Palmieri, Nicola Lenin (Vladimiro Ilic Ulianov), “Critica fascista”,
anno II, 4, 15 febbraio, 1924, pp. 334-337.
80
Successivamente, intervengono Erminio Mariani261 e Oscar Randi262.
Dopo un’introduzione sulle caratteristiche geo-politiche della Russia e
sulla sua economia, Randi si sofferma sull’influenza del Fascismo in
Russia e negli Stati baltici263. Particolarmente critico verso il
bolscevismo, Erminio Mariani fa poi un bilancio negativo dell’economia
nell’URSS, sia sul fronte del mercato interno, in crisi perché attaccato
dalla concorrenza privata, sia su quello estero dominato dal
monopolio264. Lo stesso prosegue poi con un contributo, che descrive le
fasi dell’insurrezione organizzata dal Maresciallo Piłsudski per
contrastare l’avanzata in Polonia di Trockij e dei rivoluzionari
bolscevichi nel 1920, in un momento delicato per la Polonia, che
attendeva stabilità politica ed economica dopo il patto di Versailles265.
Gli articoli del 1927 sono tutti saggi quasi interamente dedicati
al decimo anniversario della rivoluzione russa; da Michele Pirone266, che
nel suo articolo ne analizza i risvolti sul piano politico ed economico,
all’intervento di Eugenio Anagnin sull’impatto travolgente che la
rivoluzione ha avuto sulla geografia della Russia e sul popolo,
preservandone, però, spiritualità e fede “messianica”267. Seguono, infine,
altri articoli di Oscar Randi su alcuni aspetti dell’imperialismo nella exJugoslavia e sulle cause storiche, politiche ed economiche della nascita
del Fascismo in Cecoslovacchia268.
A partire dal 1931 la maggior parte dei contributi, ancora una
volta di stringente attualità, sono dedicati alla politica e all’economica
261
Studioso della storia della Russia e dei fatti politici dell’URSS, Mariani era stato
addetto commerciale a Pietrogrado nel 1917-1918, e poi ancora a Mosca per buona
parte degli anni Venti. Per approfondimenti cfr. Giorgio Petracchi, La Russia
rivoluzionaria nella politica italiana, 1917-1925, Roma-Bari, Laterza, 1982.
262
Nato a Zara nel 1876, Oscar Randi fu un pubblicista esperto del mondo balcanico.
Dopo la fine del primo conflitto mondiale divenne funzionario dell’ufficio stampa del
Ministero degli esteri, passando in seguito a quello del Ministero della cultura
popolare). Collaborò a riviste quali “L’Europa Orientale” con vari articoli sulla
personalità di Nicola Pašić e sulla storia diplomatica della Dalmazia, facendosi
conoscere, più in generale, con due studi dedicati alla Jugoslavia (1922), a cura
dell’I.p.E.O., e ai Balcani (1939), per la casa editrice “Dante Alighieri”. Nazionalista
convinto, diede il proprio sostegno al revisionismo e all’imperialismo fascisti verso la
Jugoslavia. Su Randi si veda T. Chiaroni, I Diari di Oscar Randi, “Rivista dalmatica”,
51 (1980), n. 1-2, pp. 21-23 e Stefano Santoro, Op. cit., p. 142.
263
Cfr. Oscar Randi, L’eco del fascismo nella Russia e negli Stati Baltici, “Critica
fascista”, anno III, 8, 15 aprile, 1925, pp. 145-148.
264
Cfr. Erminio Mariani, La pratica bolscevica, “Critica fascista”, anno IV, 3, 1
febbraio, 1926, pp. 44-46.
265
Cfr. Erminio Mariani, L’insurrezione militare del Maresciallo Pilsudski, “Ibidem”,
anno IV, 11, 1 giugno, 1926, pp. 209-211.
266
Cfr. Michele Pirone, Nel decimo anno della rivoluzione russa, “Ibidem”, anno V, 3,
1 febbraio, pp. 48-50.
267
Cfr. Eugenio Anagnin, I conflitti spirituali nella Russia moderna II, “Ibidem”, anno
V, 7, 1 aprile, 1927, pp. 131-132. Su Anagnin (Evgenij Arkad’evič Anan’in) cfr. anche
il sito http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=262.
268
Per questi contributi rimando alla Bibliografia ragionata.
81
dell’URSS e sono tutti a firma di Tommaso Napolitano269. Lo studioso
affronta diverse tematiche: dal sistema penale sovietico a questioni
inerenti la moralità e la spiritualità nella letteratura russa, con
un’attenzione particolare alla politica interna sovietica e al rapporto del
sistema politico con la gioventù di quegli anni. Mi limito ad osservare
gli articoli più significativi.
Nel 1932 Napolitano scrive, a proposito del sistema penale
sovietico, una breve storia della pena di morte in Russia. Partendo dal
dibattito sulla legalità, l’A. espone le teorie di Marx, applicate alla
società russa da Plechanov verso la fine del XIX secolo e relative alla
corrispondenza tra istituzioni giuridiche e impianto economico.
Conclude il suo percorso storico citando la recente concezione
“organicistica” dello Stato bolscevico che, negando la legittimità della
pena capitale, ne decreta l’abolizione durante il governo di Kerenskij270.
Lo stesso Napolitano affronta poi la questione della ‘moralità’ in Russia
dopo l’avvento del comunismo, evidenziando come la crisi dei valori
legati alla famiglia, la possibilità di contrarre più matrimoni e
l’assunzione da parte dello Stato di oneri spettanti, un tempo, ai genitori
abbiano modificato radicalmente la vita sociale, scatenando una
polemica che coinvolge scrittori come Romanov, Pil’njak e Nikitin271.
Sul piano del confronto tra Fascismo e Bolscevismo, Napolitano
confronta il sistema penale italiano con quello sovietico in materia di
difesa del lavoro da alcune azioni sociali sempre più diffuse e
‘destabilizzanti’ come, ad esempio, lo sciopero dei lavoratori; mentre
nell’Italia fascista il lavoro viene proclamato ‘dovere sociale’ nella
Russia bolscevica esso viene ridotto a puro mezzo di sopravvivenza272.
Nel fascicolo di novembre del 1932, in occasione del quindicesimo
anniversario della rivoluzione d’ottobre, Napolitano ricostruisce la storia
del Partito Comunista dell’URSS, cercando di dimostrare come, in
passato, solo i russi e gli americani siano arrivati a conseguenze estreme
in campo sociale e politico273.
Dal 1933 i contribuiti di Napolitano riguardano principalmente
i problemi legati alla libertà di stampa in Russia e il rapporto della
269
Tommaso Napolitano (1905-1994) fu giurista e professore di Istituzioni giuridiche e
sociali dell’Europa orientale, al suo nome è intitolata una parte del fondo slavo
custodito nella Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele” di Roma. Il fondo
Napolitano comprende un gran numero di monografie e periodici in gran parte in
lingua russa e con un taglio specificamente giuridico-politico. Per approfondimenti sul
fondo
slavo
della
biblioteca
rimando
al
sito
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/189/fondo-slavo.
270
Cfr. Tommaso Napolitano, La morte nel sistema penale sovietico, “Ibidem”, anno
X, 3, 1° febbraio, 1932. pp. 59-60.
271
Cfr. Tommaso Napolitano, I problemi morali nella letteratura sovietica, “Ibidem”,
anno X, 4, 15 febbraio, 1932, pp. 76-78.
272
Id., La difesa penale del lavoro in Russia, “Ibidem”, anno X, 13, 1° luglio, 1932, pp.
256-258.
273
Id., Quindici anni di regime bolscevico, “Ibidem”, anno X, 22, 15 novembre, pp.
424-425.
82
politica con i giovani274. L’articolo più rappresentativo sulla stampa
sovietica è quello del numero di gennaio del 1933; Napolitano si
sofferma sulle modalità di diffusione della stampa e sulla necessità che
essa rifletta lo spirito della rivoluzione. Conclude i suoi interventi con un
ultimo e riassuntivo articolo nel fascicolo di novembre del 1940: dopo
una lunga introduzione sulla natura delle tre rivoluzioni proletarie del
secolo, bolscevica, fascista e nazista, Napolitano analizza da vicino la
recente riforma dell’apparato statale dell’URSS, interpretandola come
definitiva sostituzione del vecchio principio democratico-liberale
promosso da Lenin. Le fonti documentarie citate nel contributo sono
tratte da un libro scritto dallo stesso e che dà il titolo all’articolo275.
Concludendo con un grafico, la presenza delle culture slave
nella rivista “Critica fascista” comprende, oltre a un buon numero di
articoli russistici, una discreta presenza di articoli dedicati alle culture
della ex-Jugoslavia, un fenomeno dovuto alle continue trasformazioni
geo-politiche di quei territori. Oltre agli articoli di Oscar Randi, altri
giovani collaboratori della rivista si occuparono degli Stati balcanici.
Silvio Delich, ad esempio, in un suo contributo del 1924 chiarisce alcuni
punti riguardo alla crisi della Jugoslavia a partire dalla formazione dei
tre nuovi Stati subito dopo la prima guerra mondiale, Serbia, Croazia e
Slovenia, soffermandosi sull’armistizio di Villa Giusti del 4 novembre
1918. L’armistizio, ribadisce Delich, agevolò la formazione dell’unione
croato-sloveno-serba dopo la dissoluzione dell’Austria-Ungheria, ma
non riuscì ad impedire la lenta crisi politica in atto al suo interno276:
274
Su questo tema rimando agli articoli di Id., I giovani ed il regime nell’U.R.S.S.,
“Ibidem”, anno XIII, 10, 15 marzo, 1935, 204-205 e Destino della gioventù sovietica in
‘Giovinezza nel mondo’, “Ibidem”, anno XVII, 10, 15 marzo, 1938, pp. 157-159.
275
Id., La metamorfosi del bolscevismo, “Ibidem”, anno XIX, 2, 15 novembre, pp. 2830.
276
Cfr. Silvio Delich, La crisi jugoslava, “Ibidem”, anno II, 9, 1° maggio, 1924, pp.
439-440.
83
Russa
Serbocroata e slovena
Ceca
Polacca
Bulgara
3; 3%
8; 8%
1; 1%
24; 25%
61; 63%
6. “Pègaso. Rassegna di lettere e arti” (1929-1933)
Come “Critica fascista” anche “Pègaso. Rassegna di lettere ed arti”
(1922-1933) e “Pan. Rassegna di lettere arte e musica” (1933-1935),
entrarono nell’agone culturale in perfetto allineamento col regime277.
Fondate e dirette da Ugo Ojetti, che inaugurava “Pègaso” con una lettera
indirizzata a “Sua Eccellenza Benito Mussolini”, i due mensili, uno la
continuazione dell’altro, ponevano in campo due principi inderogabili:
lo “stile fascista” e l’“ordine” 278. A parte le diverse specializzazioni e
scelte editoriali, gli orientamenti delle due riviste ojettiane sono molto
simili. Oltre al comune lealismo nei confronti del regime, professano
entrambe una moderata, eclettica tolleranza, un buon gusto che, mentre
privilegia l’italianità delle arti e il culto dell’Humanitas, rifiuta le forme
irrazionali, sperimentali e avanguardistiche dell’arte novecentesca, dal
futurismo alla psicanalisi.
Edita prima da Le Monnier a Firenze, poi (1932-33) dalla TrevesTreccani-Tuminelli a Milano, “Pègaso” si occupa quasi esclusivamente
di letteratura, privilegiando la narrativa italiana moderna e
contemporanea e la saggistica. Nella sezione dedicata alle letterature
straniere, tutti i contributi sulla letteratura russa, unica cultura slava
277
Sulle riviste di Ojetti rimando a Giorgio Pullini, Pègaso, Pan, Treviso, Canova,
1976; Renato Bertacchini, Lo stile fascista dei periodici ojettiani “Pègaso” e “Pan”,
in Id., Op. cit., pp. 152-155; Valeria Minervini, Le riviste di Ojetti, in Le letterature
straniere nell’Italia dell’”entre-deux-guerres”. Spogli e studi a cura di Edoardo
Esposito, Lecce, Pensa Multimedia, 2004, pp. 383-403.
278
Nella lettera Ojetti si preoccupava dello stile fascista destinato a sorgere in arte e in
letteratura sul denominatore comune dell’ordine. Cfr. Renato Bertacchini, Op. cit., p.
153.
84
presente nella rivista, sono firmati da Leone Ginzburg, tranne quello di
apertura firmato da Mario Labroca279 su Igor’ Stravinskij e un saggio di
Renato Poggioli sul teatro russo nell’ultima annata280. Dopo la breve
introduzione sull’arte di Stravinskij e su alcuni successi come l’Oepidus
e il balletto di Apollo Musagete, Labroca cerca di definire l’originalità
artistica del compositore russo, individuandola nella straordinaria
creazione di melodie, contrappunti e ritmi all’interno di un tessuto
musicale totalmente nuovo nella tradizione popolare russa281.
Il primo articolo di Leone Ginzburg è dedicato alla celebrazione in
Russia del cinquantenario della morte di Dostoevskij, di cui lo slavista
sottolinea il “tono minore” rispetto ai festeggiamenti annunciati a Praga.
Sulla base di fonti documentarie, fra cui l’epistolario curato da A. S.
Dolinin, Ginzburg ripercorre le principali tappe di un filone di studi che,
a partire dal 1921 e grazie all’apertura al pubblico degli archivi storici
con manoscritti fino ad allora ignoti, hanno contribuito a fare chiarezza
sulla vita dello scrittore:
Dalla Russia vien la notizia della pubblicazione di lettere inedite,
di abbozzi ignorati; ma la celebrazione del cinquantenario dostoevskiano,
per quel che se ne sa fino adesso, sembra mantenuta volutamente in tono
minore. Non per nulla il Gorbačëv, presentando al pubblico sovietico,
qualche anno fa, l’epistolario del Dostoevskij edito per la prima volta con
metodo scientifico dal Dolinin, aveva dovuto quasi giustificarsi, invocare
i principi marxistici, e perfino azzardare l’ipotesi d’un aiuto che da quella
pubblicazione poteva venire alla campagna antireligiosa. A Praga, invece,
roccaforte degli scienziati russi dell’antico regime e pur sempre centro del
panslavismo, si annunciano non solo raccolte commemorative di scritti
critici, ma solenni sedute accademiche e rappresentazioni di gala di
romanzi del Dostoevskij ridotti per le scene282.
279
Mario Labroca nacque il 23 novembre del 1896 a Roma. Dopo gli studi classici e la
partecipazione alla prima guerra mondial Labroca divenne allievo di Otorino Respighi
e di Gian Francesco Malipiero, diplomandosi poi in composizione al conservatorio di
Parma nel 1921. Nel 1922 a Berlino compose i Ritmi di marcia, per pianoforte solo,
dedicati a G. Sommi Picenardi, pubblicati a Vienna nel 1926 dalla Universal-Edition.
Sempre nel 1922, su invito di A. Frateili, iniziò l'attività giornalistica scrivendo per
“L’Idea nazionale” di Roma. Collaborò anche a “Il Tevere” (1926-28), “Il Lavoro
fascista” (1929-36), “Scenario” (1932-1943), divenendo uno dei più noti e stimati
critici musicali italiani. Morì a Roma il 1° luglio del 1973. Per approfondimenti cfr.
Dizionario
Biografico
(cit.)
sul
sito
http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/Ban
caDati/Dizionario_Biografico_degli_Italiani/VOL63/DIZIONARIO_BIOGRAFICO_
DEGLI_ITALIANI_Vol63_018429.xml.
280
Cfr. Renato Poggioli, Quadrumvirato del palcoscenico russo, “Pègaso”, anno V, 5,
maggio, 1933, p. 570.
281
Cfr. Mario Labroca, Strawinski musicista classico, “Ibidem”, anno I, 1, gennaio,
1929, pp. 61-64.
282
Leone Ginzburg, Contributo alle celebrazioni di Dostoevskij, “Ibidem”, anno III, 4,
aprile, 1931, pp. 385-407.
85
In un successivo contributo viene presentato il volume, edito a
Berlino nel 1931, sulla storia della rivoluzione russa283, in particolare
sulla nascita del “soviet”, il consiglio di deputati direttamente
rappresentato da operai, soldati e contadini, osservato come un
fenomeno legato alla necessità storica. Il volume prosegue con
l’esaltazione della personalità di Trockij e della sua concezione della
storia, di cui Ginzburg sottolinea l’eccessiva impostazione “marxistica e
antiborghese”:
E’ vero che il concetto informatore del libro – il progressivo
affermarsi dell’idea del “soviet” (il “consiglio” dei deputati, degli operai,
dei soldati, e poi anche dei contadini), più per l’inevitabile pressione delle
circostanze che per diretto volere di uomini – contribuisce a
un’esaltazione della personalità di Trockij, che di quella idea fu, se non
l’autore, almeno l’eroe eponimo284.
Il 1932 si apre con una recensione al volume di memorie di
Elisabetta Naryškin-Kurakin, di cui lo slavista sottolinea l’importanza
documentaria per il periodo storico compreso tra la rivoluzione francese
del 1848 e la rivoluzione russa del 1917, ma non rinuncia alla severità di
giudizio quando considera poco attendibili i dati, attribuendone la
responsabilità al curatore, e “barbarica” la traduzione dal tedesco
eseguita da Luigi Baldini:
Dalla rivoluzione francese del 1848 alla rivoluzione russa del 1917
sono settant’anni di storia che la Naryškina, morta da poco a Parigi, s’è
vista scorrer dinanzi, spettatrice di prima fila fra le più attente, curiose e
schiette […] Tanto più spiacevole, dunque, che il testo sia scorretto e
poco attendibile per colpa, presumibilmente, di René Fülöp-Müller, il
quale incitò l’autrice a riordinar queste pagine, che se ne fece a Vienna
primo Editore, e di Luigi Baldini, barbarico traduttore dal tedesco d’un
testo non sappiamo se russo o francese.285
Il contributo di ottobre si divide in due parti: nella prima viene
presentata la traduzione di Konarmija di Babel’, eseguita da Renato
Poggioli, di cui Ginzburg esalta la straordinaria capacità nel rendere in
italiano espressioni e termini russi di solito poco accessibili, riuscendo a
superare ostacoli linguistici legati alla resa di espressioni dialettali o
termini stranieri che, nella traduzione, secondo lo stesso Poggioli,
acquisterebbero una valenza maggiore rispetto al testo originale:
283
L. Trockij, Istorija russkoj revoljucii. I. Fervral’skaja revolucija, Berlin, Gram’t
1931.
284
Leone Ginzburg, Trotskij storico della rivoluzione, “Ibidem”, anno III, 10, ottobre,
1931, pp. 436-450.
285
Leone Ginzburg, recensione a: Elisabetta Narischkin-Kurakin, Sotto tre Zar.
Memorie di una Marescialla di corte, Firenze, Bemporad, 1931, “Ibidem”, anno IV, 1,
gennaio, 1932, pp. 125-128.
86
Chi conosca la finezza del traduttore non può che
immaginarselo lieto di lettori così esigenti. Infatti, salvo qualche
distrazione […] e qualche sbadataggine più comica che grave […]
s’ha da ammirare di continuo l’abilità ed il buongusto da cui egli
stesso è sorretto nella sua lotta con ostacoli linguistici dei più
impreveduti.
Nella seconda parte, Ginzburg evidenzia alcuni aspetti
distintivi dell’epicità di Babel’, tema già ampiamente affrontato in
precedenza da Poggioli su “Rivista di letterature slave”286.
Ma s’è discorso molto dell’“epicità” del Babel’, degli
elementi che la formerebbero; e il Poggioli, più che non in questa
prefazione, vi si è fermato a lungo in un articolo della “Rivista di
letterature slave” […] Viene spontaneo di considerar questi racconti
come parti di un vasto quadro d’imprese guerresche, di
un’”epopea”.287
La collaborazione di Leone Ginzburg a “Pègaso” si conclude con
un articolo sulla diffusione in Russia di romanzi ambientati ai tempi del
piano quinquennale sovietico, testimonianza di una nuova corrente
letteraria rappresentata da romanzieri come Leonid Leonov (Sot’), Boris
Pil’njak (Volga vpadaet v Kaspijskoe more), Vsevolod Ivanov
(Putešestvie v stranu, kotoroj eščë net), Marietta Šaginjan
(Gidrocentral’):
Quando apparvero finalmente i romanzi, che avevano per sfondo
il piano quinquennale, i critici russi segnalarono la nascita d’una nuova
corrente letteraria: dai cosìddetti “compagni di strada” (poputčiki) s’erano
staccati, e s’avvicinavano alla posizione degli scrittori “proletari”,
romanzieri come Leonid Leonov e Marietta Šaginjan […] Non è da oggi
che la letteratura russa s’avvia a essere proletaria, nel senso che s’è
chiarito; e per lungo tempo ancora essa si occuperà del proletariato, cioè
degli individui che ne sono gli esponenti, perché lo servono o ne vengono
distinti.288
286
Cfr. Renato Poggioli, Un’epopea rossa: “Konarmija” di I. Babel’, “Rivista di
letterature slave”, anno V, fasc. IV, luglio-agosto 1930, pp. 295-302; Id., Op. cit.
(continuazione), “Ibidem”, fasc. VI, novembre-dicembre 1930, pp. 471-480; Id., Op.
cit. (continuazione e fine), “Ibidem”, anno VI, fasc. IV, luglio-agosto, pp. 261-274.
287
Leone Ginzburg, recensione a: Isacco Babel, L’armata a cavallo. Traduzione dal
russo di Renato Poggioli, Biblioteca Europea, diretta da Franco Antonicelli, ed.
Frassinelli, Torino 1932, “Ibidem”, anno IV, 10, ottobre, 1932, pp. 504-506.
288
Leone Ginzburg, I romanzi del piano quinquennale, “Ibidem”, anno IV, 12,
dicembre, 1932, pp. 738-743.
87
7. “Pan. Rassegna di lettere arte e musica” (1933-1935)
A differenza di “Pegaso”, la rivista “Pan”, redatta da De Robertis e
da Guido Piovene per i tipi dell’editore milanese Rizzoli, allarga i suoi
interessi alla letteratura classica greca e latina, alla storia, alle arti
figurative. La graduale sostituzione della cultura di attualità con la
“cultura in senso più storicistico ed erudito” spiega le preferenze
filologiche della rivista289.
Renato Poggioli collabora con una serie di contributi che sono
continui aggiornamenti sulle novità editoriali in Russia nell’ambito
storico-letterario. Fra le segnalazioni più importanti ricordiamo quella di
febbraio del 1934 relativa all’edizione definitiva del Polnoe sobranie di
Tolstoj, con l’epistolario dal 1899 al 1900 e 250 lettere, fino ad allora
inedite, pubblicata in Russia dalle “edizioni di Stato”290, e quella relativa
al mese di luglio del 1935 sulla pubblicazione del quinto volume della
Storia della letteratura russa di Ettore Lo Gatto per le edizioni della
Anonima Romana Editoriale (Roma), quasi interamente dedicato a
di Guido
Gogol’291. Particolarmente interessante è l’intervento
Maggiorino Gatti292, dove l’autore descrive il saggio di Arnold Haskell
sulla vita di Sergej Djagilev, la cui morte spostò definitivamente il
centro di rappresentazione teatrale d’Europa da Parigi a Londra. Gatti
coglie l’occasione per ripercorrere la storia del balletto russo dalla
celebre scuola di danza fondata a Pietroburgo da Petipa nel 1847 al
“gusto d’inizio secolo” inaugurato da Djagilev fino all’evoluzione della
danza nelle forme dell’arte figurativa dal 1909 al 1929293. Ultimo
intervento sulla cultura russa è, infine, un articolo di Vladimir Weidlé
289
Renato Bertacchini, Lo stile fascista dei periodici ojettiani “Pègaso” e “Pan”, in
Op. cit., p. 152-154.
290
Renato Poggioli, ‘Notizie’, Letteratura russa, “Pan”, anno II, 2, febbraio, 1934, p.
479.
291
Id., ‘Notizie’, Letteratura russa, “Ibidem”, anno III, 7, luglio, 1935, p. 479.
292
Guido Maggiorino (Guido Maria) Gatti 1892-1973. Dal 1914 al 1915 fu redattore
capo del settimanale “La Riforma musicale”, fondato l’anno prima da C. Scaglia e C.E.
Croce. Iniziativa pregevole fu quella di promuovere, accanto al settimanale, una
collana di piccole monografie critiche, intitolata I grandi musicisti. “La Riforma
musicale” fu sospesa durante il periodo bellico, e ripresa per brevissimo tempo nel
1918. Nel 1920 Gatti, in collaborazione con la Fabbrica italiana pianoforti, fondò la
rivista mensile “Il Pianoforte”, pubblicata fino al 1927. Sulle pagine del periodico si
dibattevano problemi di attualità come la crisi dell’opera, l’atonalismo, la nuova
musica francese, il ruolo della musica nella cultura italiana. Dopo una lunga attività
pubblicistica dal 1953 al 1955 fu presidente dell’Accademia filarmonica romana. Per
approfondimenti
cfr.
Dizionario
(cit.)
sul
sito
http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/Ban
caDati/Dizionario_Biografico_degli_Italiani/VOL52/DIZIONARIO_BIOGRAFICO_
DEGLI_ITALIANI_Vol52_014280.xml.
293
Cfr. Guido M. Gatti, Adrian Stokes, To-night the Ballet; Russian Ballets. – Faber &
Faber, London, 1934. Sc. 3/6; Russian ballets – id., id., Sc. 7/6; Arnold L. Haskell,
Balletomania- Gollancz, London, 1935. Sc. 18; Diaghilev: his artistic and private
Llife. – id., id., id. Sc. 12/6, “Ibidem”, anno III, 11, novembre, 1935, pp. 392-395.
88
sugli effetti che la rivoluzione del 1917 ha avuto sulla cultura e sulla
letteratura dei primi anni del secolo. Nel suo saggio Weidlé osserva un
fenomeno piuttosto controverso: mentre la letteratura russa
dell’Ottocento è riuscita a sopravvivere e a consolidarsi sia in Russia che
tra gli emigrati, il regime ha imposto dal 1928-29 una letteratura
all’ordine del partito, definibile ‘sovietica’, che per la sua negazione dei
valori di libertà e creatività, inscindibili dall’attività letteraria, equivale a
una ‘non-letteratura’294.
8. “Quadrivio: grande settimanale illustrato di Roma” (1933-1943)
Nel 1933 Giuseppe Bottai aveva affiancato a “Critica fascista” una
rivista dal titolo “Grande settimanale letterario illustrato di Roma”,
pubblicato per più di dieci anni dal 6 agosto 1933 al 18 luglio 1943. Di
grande formato e di notevole modernità grafica, il periodico, diretto da
Telesio Interlandi e con redattore capo il giovane Vitaliano Brancati, non
nasconde la propria vicinanza al Fascismo, esponendo subito in esergo
motti mussoliniani e, in prima pagina, articoli di Giovanni Gentile e
Gioacchino Volpe. Alla rivista collaborarono prestigiose firme
dell’epoca come Montale, Moravia, Bonsanti, Bontempelli, Falqui e
Capasso. In un primo tempo, non tutti i collaboratori di “Quadrivio”
erano perfettamente allineati all’ideologia fascista, solo intellettuali
minori di partito cercavano di coniugare arte e propaganda politica.
Successivamente, con la campagna d’Etiopia e il crescente
antisemitismo, la rivista si allineò entusiasticamente alla propaganda di
regime, sacrificando sempre di più la letteratura alla politica. La
violenza degli attacchi alla letteratura e alla cultura in generale infastidì
ben presto non pochi collaboratori, compreso Bottai, che aveva
promosso il periodico con l’obiettivo di sottrarre le migliori firme
dell’intelligencija italiana agli interessi della politica e del potere295.
Nonostante lo schieramento filofascista di “Quadrivio”, la cultura
trova comunque uno spazio con articoli che indagano nell’ambito della
letteratura e del teatro. Per la Russia, le firme più frequenti sono Ettore
Settanni, Riccardo Miceli, Gino Sottochiesa, Giuseppe Donnini296 e
294
Cfr. Wladimir Weidlé, Letteratura sovietica e letteratura russa, “Ibidem”, anno III,
12, dicembre, 1935, pp. 411-417.
295
Eugenio Ragni, Op. cit., pp. 350-351.
296
Giuseppe Donnini (1901-1982). La prima, importante pubblicazione sulla
letteratura russa arriva nel 1936, quando per la casa editrice Vallecchi di Firenze esce a
stampa il saggio Dostojevskij vivente. Negli anni ’50 ritrova vecchie amicizie del
periodo universitario come Renato Poggioli, Tommaso Landolfi ed Eugenio Garin ed
instaura un sodalizio professionale con Carlo Betocchi e Mario Luzi. Dal 1954 al 1956
collabora alla rivista “Il Nuovo Corriere” diretta da Romano Bilenchi, pubblicandovi
numerosi articoli e traduzioni su Tolstoj, Cechov, Gor’kij, Turgenev, Kozevnikov e
Pavlenko. Rimando al sito http://www.pequodedizioni.it/schede/donnini.html.
89
Tommaso Landolfi297. Nelle prime annate comprese fra il 1933 e il
1936, il filone più interessante è quello sul teatro russo. Nel fascicolo di
agosto del 1934 Corrado Sofia riassume alcune esperienze teatrali della
Russia comunista, riproponendo l’opinione dell’ex-ambasciatore
dell’URSS a Roma Platon Michajlovič Keržencev riguardo alla rinascita
del teatro. Secondo Keržencev, la lotta della Russia sovietica contro i
nemici esterni e interni aveva fatto rinascere fra le classi lavoratrici una
vitalità e una creatività rivoluzionaria, al punto che, in ambito teatrale,
questa energia si trasformava in una diretta e spontanea partecipazione
degli spettatori alla scena, stravolgendo la vecchia concezione ‘statica’
del teatro borghese298. Nella stessa annata, Tommaso Napolitano espone
le ragioni della fortuna critica del teatro di Pirandello, membro della
fascista Accademia d’Italia, nella Russia sovietica e i motivi che
avevano condotto alla pubblicazione a Mosca, in una splendida edizione,
della migliore produzione teatrale dell’artista299. Chiude la sezione
dedicata al teatro un interessante saggio di Sigfrido Wolfango sul teatro
di Aleksandr Tairov300. In riferimento alle celebrazioni del 25 dicembre
1934 in Russia per il ventesimo anniversario della fondazione del
Kamernyj Teatr, il contributo ripercorre la storia del “teatro della
rivolta”, i cui principi artistici si opponevano al naturalismo dell’arte e
alla convenzione delle forme teatrali, legati alla tradizione, con un nuovo
interesse per tematiche di attualità301.
Alla sezione sul teatro si affiancano numerosi articoli dedicati a
Tolstoj; alcuni di essi sono firmati da Tat’jana Suchotina-Tolstaja302,
figlia del celebre scrittore, che, raggruppando memorie d’infanzia e
aneddoti di vita quotidiana della sua famiglia, fornisce un materiale di
straordinaria importanza storico-documentaria. Interessante dal punto di
vista filologico è, poi, la ricostruzione del romanzo Vojna i mir sulla
base delle note del “diario intimo” e su qualche estratto dalla
corrispondenza con gli amici. L’articolo è arrichito da varie fotografie
d’epoca e da un disegno olografo di Tolstoj303.
Il quarto anno di pubblicazione della rivista si apre con un
contributo firmato dalla redazione dove si commenta positivamente la
297
Sull’attività di Landolfi rimando a Eugenio Ragni, I percorsi inquietanti di
Tommaso Landolfi, in Op. cit., pp. 386-393 e PERA Pia, Tommaso Landolfi nello
specchio russo, in Tarcisio TARQUINI (a cura di), Landolfi libro per libro,
introduzione di Walter Pedullà, Alatri, Hetea, 1988, pp. 33-45.
298
Cfr. Corrado Sofia, Esperimenti del teatro russo, “Quadrivio”, anno II, 43, 19
agosto, 1934, p. 9.
299
Cfr. Tomaso Napolitano, Il teatro di Pirandello nell’U.R.S.S., “Ibidem”, 3, 18
novembre, anno II, 1934, p. 4
300
Su Tairov cfr. http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=652.
301
Cfr. Sigfrido Wolfango, Il teatro di Tairov, “Ibidem”, anno III, 19, 10 marzo, 1935,
p. 4.
302
Rimando al sito http://www.russinitalia.it/archiviodettaglio.php?id=91.
303
Cfr. Tatiana Soukhotine-Tolstoi, Guerra e Pace e i suoi critici, “Ibidem”, anno II,
40, 29 luglio, 1934, pp. 1-2.
90
recente trasposizione cinematografica del romanzo Anna Karenina, in
particolare tre scene tratte dal film Il banchetto dei cosacchi. Le
citazioni dal romanzo, a cui si fa spesso riferimento, sono riportate dalla
traduzione italiana, eseguita da Leone Ginzburg e pubblicata nella
collezione “Il Genio Russo” di Slavia del 1929304. L’annata si chiude
con due interessanti contributi, uno su Tolstoj di Erme Cadei, l’altro di
Giorgio Nodi su Dmitrij Merežkovskij. Erme Cadei presenta due
frammenti relativi alla composizione di Anna Karenina, fino ad allora
inediti sia in Italia che in Russia, copia degli originali conservati
nell’archivio del museo tosltoiano di Mosca. Cadei ne annuncia, poi, la
futura pubblicazione in appendice alla nuova traduzione italiana del
romanzo eseguita da Ossip Felyne305, in uscita a gennaio all’interno
della collana “Biblioteca romantica” della Mondadori. Giorgio Nodi
riassume il contenuto dell’intervista rilasciata a Merežkovskij quando lo
scrittore si trovava a Roma insieme alla moglie Zinaida Gippius306. In
occasione dell’incontro, Merežkovskij esprimeva alcune opinioni sulla
letteratura italiana, rivelando, in particolare, la sua profonda
ammirazione per Dante307.
Fra i collaboratori illustri merita una menzione Tommaso Landolfi,
che interviene con la recensione al volume del celebre pittore Nikolaj
Gay. Il volume contiene 64 lettere inedite di Tolstoj, testimonianza del
rapporto di amicizia tra lo scrittore russo e il figlio di Gay, nella versione
italiana eseguita da M. Bonfantini e G. Zamboni308. Qualche mese più
tardi lo stesso Landolfi è autore di un bell’articolo sulla letteratura critica
di Puškin, sviluppatasi negli ultimi anni con scritti di Pisarev,
Merežkovskij e Mirskij. Particolarmente interessanti sono le illustrazioni
di Kuzmin, realizzate per la versione italiana dell’Evgenij Onegin
eseguita da Ettore Lo Gatto, che imitano la “graziosa maniera di
disegnare” di Puškin309. In un articolo dello stesso fascicolo Alberto
Viviani fa un’attenta e approfondita descrizione della personalità di
Ettore Lo Gatto, ne sottolinea le doti artistiche nelle vesti di traduttore e
poeta, richiamando alla memoria dei lettori la versione dell’Evgenij
Onegin eseguita nel 1937 per la casa editrice Bompiani310.
304
Cfr. Redazione, Da Clarence Brown a Tolstoj, “Ibidem”, anno IV, 11, 12 gennaio,
1936, p. 8.
305
Sulla biografia di Osip Abramovič Blinderman (pseud. Ossip Felyne) rimando al
sito http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=150.
306
Sulla biografia di Dmitrij Merežkovskij e della moglie Zinaida Gippius rimando ai
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=256
/
siti
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=257.
307
Cfr. Giorgio Nodi, Merejkowski a Roma, “Ibidem”, anno IV, 9, 27 dicembre 1936,
p. 2.
308
Cfr. Tommaso Landolfi, Inediti di Tolstoi, “Ibidem”, anno V, 36, 4 luglio, 1937, p.
6.
309
Cfr. Tommaso Landolfi, Pusckin e i suoi esegeti, “Ibidem”, anno V, 45, 5
settembre, 1937, p. 3.
310
Cfr. Alberto Viviani, L’Onegin in italiano, “Ibidem”, anno V, 45, 5 settembre,
1937, pp. 3-4.
91
La redazione del periodico torna a firmare un contributo nel 1938
in occasione del secondo anniversario della morte di Maksim Gor’kij,
avvenuta a Mosca nel 1936 di ritorno dalla Crimea. Si descrivono le
circostanze del suo ‘assassinio’, reso noto con l’arresto di Jagoda e il
conseguente processo a suo carico, sulla base di informazioni tratte
dall’incartamento giudiziario311. Alla fine dell’annata Giuseppe Donnini
presenta il volume di Oskar von Riesemann sulla vita e l’opera del
compositore russo Modest Petrovič Musorgskij. Nella sua analisi critica
del saggio, Donnini evidenzia la capacità di Riesemann di conciliare
l’analisi scientifica delle opere del compositore, eseguita sulla base di
fonti autorevoli, con l’intensa descrizione dell’ambiente artistico che ne
fece da sfondo312.
Per quanto concerne gli altri contributi slavistici, uno spazio di
rilievo viene riservato alla cultura polacca. Inaugura la sezione Ettore
Settanni, che nel fascicolo di marzo del 1934 riassume in breve la storia
della Polonia dalle origini alla I guerra mondiale attraverso i suoi
simboli civili, religiosi e militari, soffermandosi un po’ di più
sull’attività diplomatica del maresciallo Józef Piłsudski. L’articolo è
arricchito da una foto d’epoca di Piłsudski e da alcuni brani tratti da
opere rappresentative della letteratura polacca, Chłopy di Władysław
Reymont e Teoria jedności narodowej e Panslawism di Adam
Mickiewicz313. Nel fascicolo di giugno del 1939 Gino Sottochiesa
contribuisce con un articolo di cronaca contemporanea dove, sulla base
di alcune recenti informazioni inviate da Varsavia ai circoli ebraici di
tutta Europa, vengono riassunti i punti del programma politico, proposto
dai circoli ‘giudaico-massonici’ di Parigi, Londra e Washington e messo
in atto dalla comunità ebraica in Polonia314. È degno di menzione, infine,
l’ampio contributo di Riccardo Miceli sulla storia degli Slavi e del
popolo polacco315. Infine, oltre a una serie di articoli sulla storia di
Bulgaria e Croazia, Giuseppe Donnini presenta un recente volume,
curato da Luigi Salvini316, sulla poesia croata dell’Ottocento. Nel suo
profilo Salvini si sofferma su alcuni nomi, Petar Preradović, Ivan
Mažuranić, Silvije Strahimir Kranjčević, August Harambašić e August
Šenoa, con un appendice finale sull’attività divulgativa e traduttiva dei
poeti italiani Ungaretti, Montale e Cardarelli condotta da alcuni
311
Cfr. Come Massimo Gorki fu assassinato di… morte naturale, “Ibidem”, anno VI,
36, 3 luglio, 1938, pp. 1-3.
312
Cfr. Giuseppe Donnini, Mussorgskij, il Dioniso della steppa, “Ibidem”, anno VI, 51,
16 ottobre, 1938, p. 5.
313
Cfr. Ettore Settanni, Polonia d’oggi, “Ibidem”, anno II, 22, 25 marzo, 1934, pp. 5-6.
314
Cfr. Gino Sottochiesa, La Polonia polveriera ebraica, “Ibidem”, anno VII, 24, 11
giugno, 1939, p. 6.
315
Cfr. Riccardo Miceli, La Polonia. Strana storia di uno strano popolo, “Ibidem”,
anno VII, 37, 10 settembre, 1939, p. 4.
316
Sullo slavista rimando alla monografia di Giuseppe Dell’Agata, Luigi Salvini 19101957. Studioso ed interprete di letterature e culture d’Europa, Pisa, Tipografia Editrice
Pisana, 2000.
92
italianisti croati. Arricchiscono il volume più di cento liriche tratte dalle
raccolte di alcuni fra i più noti poeti croati, da Antun Gustav Matoš a
Vinko Bos, tradotte per la prima volta in italiano. Donnini esalta, infine,
la capacità di “raccoglitore’ di testi e di traduttore mostrata da Salvini317.
In conclusione, fra le culture slave “Quadrivio” mostra fin da
subito una preferenza per la cultura russa e polacca, anche se uno spazio
non trascurabile viene riservato alle vicende storiche della ex-Jugoslavia
e alle culture che ne fanno parte come mostra il grafico.
Russa
Polacca
Bulgara
4; 6%
Serbocroata
5; 7%
1; 1%
Ceca
Ucraina
1; 1%
6; 8%
54; 77%
Quanto alla cultura letteraria russa, lo spoglio delle singole annate
registra una maggioranza di articoli su scrittori dell’Ottocento, in
particolare Tolstoj. Il grafico ne da una rappresentazione visiva.
317
Cfr. Giuseppe Donnini, Poeti croati moderni. Recensione a: Poeti croati moderni a
cura di Luigi Salvini. Collezione “Stelle dell’Orsa”, Garzanti, Milano 1942, sotto gli
auspici dell’Istituto per le Relazioni Culturali con l’Estero, “Ibidem”, anno X, 44, 30
agosto, 1942, p. 4.
93
Tolstoj
Gogol'
Gor'kij
Dostoevskij
Puškin
Merežkovskij
Erenburg
Musorgskij
1; 4%
2; 7% 1; 4%
2; 7%
11; 41%
2; 7%
3; 11%
5; 19%
9. “Solaria” (1926-1934)
Nel decennio che vede lo sviluppo e la definitiva affermazione del
Fascismo in Italia “Solaria” occupa una posizione particolare nel più
ampio progetto culturale di apertura alle culture europee avviato dalla
rivista “‘900”.
Nei due anni che precedono la fondazione del periodico la
situazione politica italiana aveva subito una profonda trasformazione;
superata la crisi politica determinata dal delitto Matteotti, Mussolini era
riuscito ad ottenere il pieno consenso popolare. In questo clima
particolarmente favorevole al regime e quasi ai limiti delle leggi
liberticide sulla libertà di stampa, nasce a Firenze, con periodicità
mensile, la rivista “Solaria”, fondata e diretta da Alberto Carocci. Il
titolo fa riferimento all’utopica “città del sole” di Tommaso Campanella
e intende sottolineare il programma della rivista: la fondazione di una
moderna civiltà letteraria che, a metà fra avanguardia e classicità, si apra
alle culture straniere, acquisendole alla tradizione italiana. Il modello
letterario ricorrente è Dostoevskij, ma anche Proust, Joyce, Kafka e
Mann rientrano nelle scelte programmatiche del periodico. Nell’ambito
del rapporto con politica e potere, la rivista si opponeva tanto alla
subordinazione della letteratura al Fascismo quanto alle angustie
dell’autarchismo letterario, due caratteristiche comuni a gran parte delle
riviste dell’epoca e alla cultura idealistica di stampo crociano. Nel 1929
si associò nella direzione Giansiro Ferrata, sostituito un anno più tardi da
Alessandro Bonsanti. Dal 1926 al 1934 nelle pagine di “Solaria” furono
ospitati alcuni tra i migliori nomi della cultura italiana tra i quali
94
Vittorini, Gadda, Contini, Montale, Saba, Bacchelli e Renato
Poggioli318.
La collaborazione di Poggioli segue perfettamente la linea di
pensiero della rivista, che puntava alla ricerca di voci poetiche nuove in
nome dello sperimentalismo e dell’apertura. Nel caso specifico della
letteratura russa, è molto indicativa la scelta di affrontare autori come
Vladimir Majakovskij, considerato uno dei “padri” dell’avanguardia
europea, e Sergej Esenin, simbolo di una cultura sprovincializzata e di
frontiera. Il primo contributo di Poggioli è, infatti, un profilo artistico di
Majakovskij, poeta ufficiale della rivoluzione, morto suicida come
Esenin, dotato di “un senso potente e volgare della propria personalità” e
di una concezione teatrale della “vita trascorsa in un’”atmosfera di
trionfo, d’applausi e di réclame”:
Quasi nessuno dei critici russi che s’è occupato prima della sua
morte dell’opera di Majakovskij, ha tralasciato di notare che la sua era la
poesia di un uomo alto quasi due metri e pieno di forza fisica e di salute.
Ora che egli è morto per sua mano, soltanto cinqu’anni dopo il povero
Jesènin che morì come lui […] qualche critico dell’emigrazione osserverà
con maligna compiacenza ch’egli faceva la voce grossa per nascondere
un suo nuovo mal du siècle […] figura imponente, collo di toro, voce
stentorea. E con in più le sue qualità morali: un senso potente e volgare
della sua personalità, potente perché gode della massa che la sua
eloquenza trascina e volgare perché non può vivere al di fuori di
quest’atmosfera di trionfo, d’applausi e di réclame319.
Sulla ricezione di Majakovskij in Russia nell’ambito del Futurismo
Poggioli scrive:
[…] per spiegarsi invece gli applausi che Majakòvskij riceveva
dal pubblico russo, bisogna dire che il futurismo che divenne nei primi
anni di governo sovietico la poesia ufficiale della Nuova Russia, era
ormai un futurismo addomesticato e programmatico, che riduceva tutte le
sue innovazioni linguistico-tipografiche all’abuso delle interiezioni e dei
punti esclamativi […] Anzi questi futuristi scrivevano per lo più in versi
quasi tradizionali e rimati, e tra loro Majakòvskij, col suo verso libero
cadenzato e sobrio, il migliore che si sia fatto in Russia […] poteva parere
anche un estremista320.
Il secondo autore affrontato da Poggioli è Puškin. Nel suo
contributo, pubblicato nel mese di febbraio del 1932, lo studioso
ripercorre la produzione in prosa dello scrittore, partendo dalla
recensione alla traduzione di Pikovaja dama, Dubrovskij e Povesti
318
Per approfondimenti sulla rivista rimando a Giorgio Luti, La letteratura nel
ventennio fascista. Cronache letterarie tra le due guerre: 1920-1940, Bari, La Nuova
Italia, 1995, pp. 75-142; Eugenio Ragni, Op. cit.,pp. 342-344.
319
Renato Poggioli, Vladimiro Majakovskij, “Solaria”, anno V, 7-8, luglio-agosto,
1930, pp. 55-58.
320
“Ibidem”.
95
Belkina, eseguita da Leone Ginzburg321. Viene particolarmente
apprezzata l’accurata ed elegante traduzione, la cui grazia, di solito,
sfugge “fra le maglie della rete del traduttore”, e l’equilibrata prefazione,
dove Ginzburg mostra di “aver capito benissimo come su uno scrittore
come Puškin sia più facile scrivere una biblioteca che un volume”:
Una grazia così disinvolta e segreta, un’eleganza così
poco appariscente, sfuggono quasi sempre fra le maglie della rete
del traduttore, mentre il Ginzburg è riuscito a seguirle quasi in ogni
giro e spesso, ad imprigionarle […] Ma più ancora lo lodo per il
tatto e l’equilibrio della prefazione. Egli ha capito benissimo come
su uno scrittore come Puskin sia più facile scrivere una biblioteca
che un volume, e un libro più che un articolo o una prefazione322.
Poggioli evidenzia, infine, una peculiarità presente anche
nell’Evgenij Onegin e in buona parte della produzione letteraria europea
del primo Ottocento: l’epigrafe impiegata come parte integrante del
testo. Nel suo volume Ginzburg la rende “pedina” di un’abile ‘gioco
letterario’:
Puskin è uno degli scrittori che più hanno sacrificato alla
moda delle citazioni epigrafiche, tolte talora non solo da autori
minori o dimenticati, ma anche da carteggi privati e conversazioni
mondane […] Vecchie e buone cose di pessimo gusto, modeste
pedine di cui Puskin si vale in un giuoco letteratissimo e pieno di
maestrìa. In queste novelle esse fanno vero e proprio corpo col
testo, che senza di esse sarebbe, non dico mutilato, ma certo più
disadorno e scolorito323.
L’ultimo contributo di Poggioli è una rassegna critica delle
personalità artistiche e letterarie che hanno reso grande la Russia e che,
molto spesso, hanno vissuto la loro epoca nella solitudine e
nell’incomprensione. Partendo da Dostoevskij, di cui Poggioli ricorda il
recente cinquantenario della morte, vengono in breve menzionate le
esperienze artistiche, e la ricezione, di personaggi della letteratura come
Tolstoj, Belyj, Ivanov, Blok, e del teatro, Djagilev e Bakst, concludendo
con la poetessa Anna Achmatova324.
Giansiro Ferrata collabora alla sezione dedicata alla Russia con tre
articoli. Il primo è del gennaio 1928; si tratta di una recensione agli
appunti di viaggio di Luc Durtain e Georges Duhamel durante il loro
soggiorno in Russia. Ferrata distingue chiaramente la prima parte del
volume, in cui Durtain descrive la “vecchia, eterna Russia, caos di
321
Alessandro S. Puskin, La Donna di Picche. Trad., pref. e note di L. Ginzburg,
“Slavia”, Torino, 1932.
322
Renato Poggioli, In margine alla prosa di Puškin, “Ibidem”, anno VII, 2, febbraio,
1932, pp. 43-50.
323
“Ibidem”.
324
Cfr. Renato Poggioli, Gli esiliati della cultura, “Ibidem”, anno VIII, 1, gennaio,
1933, pp. 45-54.
96
continenti e civiltà, sentinella d’Oriente e d’Occidente”, e la seconda,
dedicata alla nuova immagine di una Russia “rivoluzionaria e
trasformatrice dei valori sociali”, di cui Duhamel fa un lucido resoconto
molto vicino alla cronaca325. Alla fine dello stesso anno, nel numero di
dicembre, Ferrata ritorna con un breve saggio su Lev Tolstoj nel
centenario della sua nascita, con una rilettura degli scritti, dedicati alle
teorie sulla creazione artistica, composti nell’ultimo periodo dallo
scrittore. Nella seconda parte, prosegue con un costante parallelo
Tolstoj-Dostoevskij:
Chi è più russo - Dostoevskij o Tolstoi? Il primo sembra subito
spuntarla coll’autorità delle due lauree, l’“intellettuale” e la popolare.
Eppure! C’è stata un po’ di civetteria degli Slavi nel luogo comune:
Dostoevskij = maximum dell’anima slava? […] Oggi, che i Karamazoff
sono un tesoro comune a tutto il mondo, l’ambizione sfuma mentre più
giustificata sarebbe probabilmente un’altra, poter cioè solamente i Russi
comprendere fino all’ultimo, nei suoi trascorsi e nei suoi parossismi, il
genio di Tolstoi […] Capisco che un Russo si inebri di più di passare per
un Ivan Karamazoff, per un Raskolnikoff, che per un Lévine o un Pietro
Bezukof; in realtà, credo che quest’ultimi lo impersonifichino ben più
sovente326.
In tutta la rivista a Tolstoj vengono dedicati altri due articoli. Leo
Ferrero presenta la traduzione in francese di Vojna i mir, eseguita da
Louis Cousserandot, confrontandola con una precedente di Bienstock:
Nonostante una certa pesantezza di stile, questa ottima
traduzione, arricchita da una lunga introduzione storica e da molte note, è
destinata a sostituire definitivamente la traduzione di Bienstock, illeggibile,
e, a quanto mi dicono i russi, piena di scorrettezze e di errori .327
Nello stesso anno, Angelo Barile evidenzia alcuni aspetti del
pensiero filosofico e della tecnica narrativa che avvicinano gli scritti di
Goethe a quelli di Tolstoj, partendo dalle parole di Giansiro Ferrata:
Giansiro Ferrata ha indicato acutamente una vicinanza fra
Goethe e Tolstoi nel loro amor della pratica, nella passione del reale,
dell’utile. E’ una vicinanza delle più attraenti. Un raccordo Goethe-Tolstoi,
su questo o su altro binario, passa sempre in qualche nodo vitale, verso il
centro dei nostri umani interessi. E certamente ci tocca. Se poi ci aiuta
325
Cfr. Giansiro Ferrata, recensione a: Geroges Duhamel, Le Voyage de Moscou,
Mercure de France, “Ibidem”, anno III, 1, gennaio, pp. 57-58.
326
Giansiro Ferrata, Centenario di Tolstoi. Zibaldone, “Ibidem”, anno III, 12,
dicembre, 1928, pp. 42-45.
327
Leo Ferrero, recensione a: Leon Tolstoi, La Guerre et la Paix (4 voll.) – Nouvelle
traduction par Louis Cousserandot – Payot, Paris, “Ibidem”, anno VII, 4, aprile, 1932,
pp. 62-64.
97
soltanto a riconoscere le vere distanze, e a rivelare come son grandi, questo
è ancora un modo di avvicinarle328.
L’ultima annata ospita due contributi di Giacomo Antonini su
Gogol’ e Remizov. Nel primo caso, Antonini rivisita la biografia dello
scrittore alla luce del dissidio interiore tra sogno e realtà vissuto
dall’artista nel corso della carriera letteraria e sulla base di recenti e ben
documentati studi condotti da Boris de Schloezer. Gli studi di Schloezer,
secondo l’autore, renderebbero giustizia allo scrittore, riconoscendo alla
sua arte quei meriti che, spesso, gran parte della critica aveva ignorato:
Nikolai Gogol è fuori della sua patria, il meno noto dei grandi
romanzieri russi dell’Ottocento. Benché l’opera sua sia stata tradotta nelle
maggiori lingue europee […] egli non ha mai goduto la popolarità di un
Dostoevskij, di un Tolstoi od anche di un Cechov […] Solo i russi e gli
specializzati nello studio della letteratura russa continuano a considerarlo
come un maestro, fra i più grandi della letteratura dell’Ottocento. E sono
senza dubbio loro che in questo caso hanno ragione. La biografia di
Gogol pubblicata recentemente da Boris de Schloezer riconferma ancora
una volta con ricchezza d’argomenti questa opinione329.
Quanto
all’articolo
su
Remizov,
Antonini
sottolinea
l’atteggiamento irriverente, spesso ostile, mostrato dalla critica letteraria
contemporane, in Russia come in Europa, nei confronti della sua opera.
In particolare, l’autore si sofferma sui racconti di contenuto miticoleggendario e popolaresco, e sull’influenza esercitata su di lui dalla
lettura dei testi sacri, delle antiche leggende redatte in lingua slava, dei
racconti popolari e delle saghe. Introduce il saggio un preambolo sugli
scrittori che, come Remizov, sono stati “incompresi” dalla critica:
Il meno che si possa dire parlando di Remizov è ch’egli non
occupa ancora nella letteratura europea d’oggi il posto importante che gli
spetta di diritto. Non molti conoscono il suo nome, pochissimi conoscono
la sua opera […] Gli esempi da citare sarebbero troppi, basti ricordare
Lermontov, la cui grande importanza come narratore è stata riconosciuta
solo negli ultimi decenni, Pisemsky non ancora giustamente valutato,
Sleptsov pressoché ignoto, ed infine l’errore più grave e più
imperdonabile: la congiura del silenzio fatta intorno a Leskov, uno dei più
grandi scrittori dell’Ottocento.330
Da uno sguardo d’insieme sugli autori rappresentati nella rivista si
conclude che, oltre alla significativa presenza, già evidenziata, di
Vladimir Majakovskij, viene concesso ampio spazio a Tolstoj, di cui si
328
Angelo Barile, Raccordo Goethe-Tolstoi, “Ibidem”, anno VII, 7-8, luglio-agosto,
1932, pp. 46-49.
329
Giacomo Antonini, Gogol, “Ibidem”, anno IX, 2, marzo-aprile, 1934, pp. 38-51.
330
Giacomo Antonini, Appunti su Remizov, “Ibidem”, anno IX, 4, luglio-agosto, 1934,
pp. 84-89.
98
celebra il centenario della nascita. Il grafico ne da una rappresentazione
sintetica.
Tolstoj
Mandel'štam
Evrejnov
Fedin
Puškin
Gogol'
Majakovskij
Remizov
1; 8%
1; 8%
Rozanov
3; 26%
1; 8%
1; 8%
1; 8%
2; 18%
1; 8%
1; 8%
A margine delle riviste fin qui analizzate, è opportuno osservare
nell’insieme gli altri periodici, di cui è stato fatto lo spoglio ma che solo
in piccola parte registrano la presenza di contributi sulle culture slave.
Le testate, anche se non permettono un’analisi approfondita e articolata,
riescono però ad integrare quanto detto finora sull’attività di alcuni
protagonisti della cultura italiana dell’epoca.
Oltre alle numerose segnalazioni bibliografiche presenti in “Nuova
Antologia” (1917-1926), alcuni slavisti hanno collaborato a riviste, che
concedono ampio spazio ad ambiti culturali non necessariamente
d’interesse storico-letterario. Una di esse è, ad esempio, “Scenario.
Rivista delle arti della scena” (1932-1943), diretta da Silvio D’Amico e
Nicola De Pirro e totalmente dedicata al teatro. Dal 1932 al 1936 Ettore
Lo Gatto è presente con una serie di articoli sull’attività teatrale in
Russia in quegli anni, mettendone in evidenza il costante rapporto con la
politica di Stalin e la relativa propaganda ‘ideologico-borghese’. Tale
collaborazione è parallela a “L’Europa Orientale”, dove Lo Gatto,
occupandosi di questioni relative alla politica e alla società dell’URSS,
dedica, però, solamente un articolo al teatro russo331. Nel secondo
periodo di pubblicazione della rivista è, invece, evidente la costante
collaborazione di Renato Poggioli con una serie di ampi articoli, che
sono un bilancio della stagione teatrale nel 1937 e nel 1938 in Polonia e
in Cecoslovacchia, a testimonianza dei continui soggiorni dello slavista
in quei paesi332.
331
Cfr. Ettore Lo Gatto, Sulla messa in scena de “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij
(In difesa del “diavolo”), “L’Europa Orientale”, anno XVI, fasc. III-IV, marzo-aprile,
1936, pp 149-154.
332
Per i singoli contributi di Poggioli e Lo Gatto rimando alla Bibliografia ragionata.
99
Lo Gatto collaborò anche ad un altro periodico, che si
distingueva per l’eslcusivo interesse verso questioni di natura religiosa e
filosofica e per l’apertura culturale. Si tratta di “Bilychnis. Rivista
mensile illustrata di studi religiosi” (1912-1931), giornale ufficiale della
Chiesa Battista di Roma, il cui titolo, come spiegato nell’“Introduzione”
al numero del 1912, indicava la doppia lucerna, simbolo dei due lumi
della scienza e della fede. Lo slavista vi collabora assiduamente a partire
dal 1921 con articoli di attualità, sui movimenti ereticali e sulle sette
religiose diffuse in quegli anni in Russia, e con saggi sulla storia del
pensiero filosofico russo e sulla religiosità di Dostoevskij. La maggior
parte dei contributi di Lo Gatto sono, però, dedicati alla rassegna
bibliografica delle riviste di cultura diffuse in Russia dal 1922 al 1930,
un interesse che proseguirà poi con la collaborazione all’“Almanacco
letterario” (1925-1933), dove lo stesso Lo Gatto, dal 1927 al 1933,
riferirà ogni anno sui principali eventi letterari del paese333.
A queste si aggiungono riviste che nel periodo 1918-1940
presentano solo qualche sporadico contributo sulle culture slave, come
“’900” (1926-1929), “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile” (19301947), “La Riforma letteraria” (1936-1939), “Il Marzocco” (1896-1932),
“Campo di Marte” (1938-1939), “Frontespizio” (1929-1940), “La
Ronda” (1919-1923), “La Lettura” (1901-1946) “Galleria” (1924), “Il
Selvaggio” (1924-1943), “L’Orto” (1931-1939), “L’Italia letteraria”
(1923-1924), “Occidente” (1932-1935)334, e riviste, invece, il cui spoglio
non ha prodotto alcun risultato come “La Raccolta” (1918-1919), “La
Libra” (1929-1930), “La Chimera” (1934-1935), “Lunario siciliano”
(1927-1931) e “Primo Tempo” (1922-1923).
Fra i periodici italiani del dopoguerra ci sono anche le testate
specializzate nello studio delle culture slave, già menzionate nella parte
introduttiva del presente lavoro. Mi riferisco a “Russia”, “Rivista di
letterature slave” e “L’Europa Orientale”, che, però, non rientrano nella
nostra analisi.
Conclusioni
Negli anni fra le due guerre in Italia nacquero case editrici e
collane specializzate nella pubblicazione di autori russi, si
moltiplicarono le traduzioni fedeli e integrali nonché i saggi, specialistici
e non, su argomenti di cultura russa. Fra le numerose iniziative editoriali
una delle più interessanti fu senz’altro la casa editrice Slavia di Torino,
quasi interamente dedicata alle letterature slave, che pubblicò nell’arco
di otto anni (1926-1934) un cospicuo numero di volumi tradotti dal russo
333
334
Vedi Bibliografia ragionata.
Vedi Bibliografia ragionata.
100
e divenne uno dei maggiori focolai di diffusione degli autori russi in
Italia. In ambito accademico nacque la rivista “Russia” (1920), fondata
da Ettore Lo Gatto, la prima in Italia ad essere interamente dedicata alla
Russia.
Per meglio stimare l’evoluzione degli studi slavistici nel periodo
fra le due guerre, parallelamente allo studio delle riviste specialistiche
“Russia”, “L’Europa Orientale” e “Rivista di letterature slave”, è stato
opportuno rivolgere l’attenzione alla stampa periodica non accademica. I
periodici italiani d’impostazione non slavistica che sono stati presi in
considerazione nel presente lavoro hanno permesso di evidenziare il
ruolo significativo degli slavisti ma anche, più in generale, di
intellettuali e studiosi, che si sono occupati di ‘cose slave’, all’interno
del panorama culturale italiano. Le informazioni raccolte con lo spoglio
dei singoli periodici si sono rivelate preziose poiché hanno permesso di
integrare il quadro professionale accademico degli slavisti ancora oggi in
via di definizione.
I più attivi collaboratori alle riviste si rivelano essere Enrico
Damiani, Aurelio Palmieri, Giovanni Maver, Renato Poggioli, Leone
Pacini Savoj e, soprattutto, Ettore Lo Gatto, che si conferma il più
esuberante sia come traduttore, sia come recensore e saggista. A questi si
affianca, poi, una schiera di studiosi fra i quali il giornalista polacco
Leonardo Kociemski, il giurista Tommaso Napolitano, autore di
numerosi contributi sul sistema giuridico dell’URSS, Alfred Bem,
russista e figura importante dell’emigrazione russa nonché uno fra i
maggiori specialisti di Fëdor Dostoevskij, Rinaldo Küfferle e Raissa
Olkienizkaia-Naldi, fra i traduttori di origine russa, e Oscar Randi, noto
pubblicista ed esperto del mondo balcanico.
La scelta delle testate si è basata non solo sulla quantità di
contributi slavistici riscontrabili nelle singole annate, decisamente
maggiore rispetto ad altre riviste dell’epoca, e sull’importanza che hanno
avuto nella storia della cultura italiana del Novecento, ma soprattutto sul
fatto che alcune di esse coprono quasi totalmente l’arco temporale in
oggetto, dal 1918 al 1940, permettendo di apprezzare meglio
l’evoluzione delle proposte degli autori, recensori e saggisti, ai lettori
italiani, in parallelo coi principali fatti dell’epoca. In particolare, mi
riferisco a “L’Italia che scrive” (1918-1940), “I libri del giorno” (19181929), “La Cultura” (1921-1935), “Critica fascista” (1923-1942), “La
Nuova Italia” (1930-1943) e “Quadrivio” (1933-1943), riviste che hanno
rivelato una presenza di contributi relativi alla cultura russa e polacca
più o meno costante in tutte le annate, con picchi di interesse, in
occasione di celebrazioni legate a ricorrenze e anniversari particolari, e
con un forte calo negli anni Trenta, causato, nel caso specifico della
cultura russa, dal graduale intensificarsi dell’ostilità del regime fascista
verso l’Unione Sovietica e, dunque, verso la sua cultura.
Il grafico seguente, che illustra l’evoluzione della cultura russa nei
suddetti periodici, conferma la netta presenza di contributi a metà degli
101
anni Venti e nei primissimi anni Trenta, dovuta soprattutto a ricorrenze
come il centenario della nascita di Tolstoj nel 1928 e il cinquantenario
della morte di Dostoevskij nel 1931, registrando un forte calo dal 1935
al 1940, nella fase, cioè, di massima intensità della censura fascista.
"L'Italia che scrive"
"I libri del giorno"
"La Cultura"
"Critica fascista"
"La Nuova Italia"
"Quadrivio"
50
40
30
20
10
0
1915
1920
1925
1930
1935
Analizzeremo più specificamente gli spogli dei singoli periodici nella
seconda parte del lavoro dedicata alla Bibliografia ragionata.
102
1940
A. FONTI
•
“Almanacco letterario” (Milano, Roma, 1925-1933)
•
“Bilychnis. Rivista mensile illustrata di studi religiosi” (Ascoli
Piceno, 1912-1931)
•
“Campo di Marte. Quindicinale di azione letteraria e artistica”
(Firenze, 1938-1939)
•
“La Chimera: rassegna mensile di poesia contemporanea”
(Palermo, 1934)
•
“Critica fascista. Rivista quindicinale del fascismo” (Roma,
1923-1943)
•
“La Fiera letteraria: giornale settimanale di lettere, scienze ed
arti” (Milano, 1925-1929)
•
“Il Frontespizio: rassegna mensile” (Firenze, 1929-1940)
•
“Galleria: rivista mensile del corriere italiano” (Roma, 1924)
•
“Il Giornale della libreria: organo ufficiale dell’ associazione
italiana editori” (Milano, 1921-1987)
•
“L’ Italia che scrive. Rassegna per coloro che leggono” (Roma,
1918-1978)
•
“L’ Italia letteraria: rivista mensile” (Firenze, 1923-1924)
•
“Leonardo. Rassegna bibliografica mensile” (Milano, Roma
1930-1947)
•
“Leonardo. Rassegna della coltura italiana” (Roma, 1925-1947)
•
“La Lettura: rivista mensile del Corriere della sera” (Milano,
1901-1946)
•
“La libra” (Novara, 1928-1930)
•
“I libri del giorno: rassegna mensile internazionale” (1918-1929)
•
“Lirica: quaderni della poesia europea ed americana” (Genova,
1934)
•
“Lunario Siciliano: periodico letterario” (Enna, 1927-1931)
103
•
“Il Marzocco” (1896-1932)
•
“I nostri quaderni: rivista di pensiero e di poesia” (Roma, 1924-
1929)
•
“Nuova antologia di lettere, scienze ed arti” (Roma, 1866-1926)
•
“La Nuova Italia: rassegna critica mensile della cultura italiana e
straniera” (Perugia, Venezia, 1930-1943)
•
“Occidente: sintesi dell’ attivita’ letteraria nel mondo” (Roma,
1932-1935)
•
“Le opere e i giorni: rassegna mensile di politica, lettere, arti”
(Genova, 1922-1938)
•
“L’Orto: rivista di lettere e arte” (Bologna, 1931-1939)
•
“Pan: rassegna di lettere, arti e musica” (Milano, Firenze, Roma,
1933-1935)
•
“Pègaso. Rivista di lettere e arti” (Firenze, 1929-1933)
•
“Primo tempo: rivista letteraria mensile” (Torino, 1922-1923)
•
“Quadrivio: grande settimanale letterario illustrato di Roma”
(1933-1943)
•
“La Raccolta: periodico mensile” (Bologna, 1918-)
•
“La Riforma letteraria” (Firenze, 1936-1939)
•
“Rivista di sintesi letteraria” (Torino, 1934-1937)
•
“La Ronda letteraria mensile” (Roma, 1919-1923)
•
“Scenario. Rivista mensile delle arti, della scena” (Milano,
Roma, 1932-1943, 1949-)
•
“Il Selvaggio” (Roma, 1924-1943)
•
Solaria (Firenze, 1926-1934)
•
“Lo Spettatore italiano: Rivista letteraria dell’ Italia nuova”
(Roma, 1924)
•
“900. Cahiers d’Italie et d’Europe “ (Roma, 1926-1929)
•
“La Cultura. Rivista mensile di filosofia, lettere, arte” (Roma,
1882-1936)
104
B. BIBLIOGRAFIA CRITICA
ACCAME BOBBIO Aurelia, Le riviste del primo novecento, Brescia,
La Scuola, 1985.
ADAMO Sergia, Dostoevskij in Italia. Il dibattito sulle riviste 18691945, Passian di Prato, Campanotto, 1998.
ID., Leone Ginzburg e le traduzioni dal russo, in “Il Risorgimento.
Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea”, LIV, 2,
2000, pp. 231-288.
BALDI Stefano – BALDOCCI Pasquale, La penna del diplomatico. I
libri scritti dai diplomatici italiani dal dopoguerra ad oggi. Milano,
FrancoAngeli, 2006.
BALSAMO Luigi e CREMANTE Renzo (a cura di), A. F. Formiggini
un editoredel Novecento, Bologna, Il Mulino, 1981.
BARILE Laura, Elite e divulgazione nell’editoria italiana dall’Unità al
fascismo, Bologna, Clueb, 1991.
BATAILLON, Marcel, Renato Poggioli, in “Revue de littérature
comparée” XXXVII, 1963, 3, pp. 491-492.
BÉGHIN Laurent, Gli esordi di uno slavista comparatista sotto il
fascismo: gli anni di formazione di Renato Poggioli (1928-1938); ID.,
Bibliografia di Renato Poggioli (1928-1938) in Daniela Rizzi e Andrej
Shishkin (a cura di), Archivio russo-italiano/Russko-ital’janskij archiv,
IV, Salerno, “Europa orientalis”, 2005, pp. 395-446.
BÉGHIN Laurent, Da Gobetti a Ginzburg. Diffusione e ricezione della
cultura russa nella Torino del primo dopoguerra, Roma-Bruxelles,
Istituto Storico Belga di Roma, 2007.
BERGAMI Giancarlo, Zino Zini, in “Belfagor”, XXVII, fasc. VI, 30
novembre 1972, pp. 678-703.
ID., Zino Zini tra testimonianza intellettuale e impegno politico, “Studi
piemontesi”, IX, 1, marzo 1980, pp. 167-181.
BERTACCHINI Renato, Le riviste del Novecento. Introduzione allo
studio dei periodici italiani. Storia, ideologia e cultura, Firenze, Le
Monnier, 1980.
105
BERTI Luigi, Ricordo per Renato Poggioli, in “Inventario”, XVIII,
gennaio-dicembre 1963, pp. 1-7.
BÖHMIG Michaela, Alcune recenti pubblicazioni sull’emigrazione
russa, in “Ricerche slavistiche”, vol. XLIII, 1996, pp. 499-504.
BOREJSZA, W. Jerzy, Il fascismo e l’Europa orientale. Dalla
propaganda all’aggressione, Roma-Bari, Laterza, 1981.
BOSCO, Umberto (a cura di), “La Cultura” (1921-1928), introduzione
di Alfredo Luzi, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1971.
BRIOSI Sandro, Il problema della letteratura in “Solaria”, Milano,
Mursia, 1976.
BROGI
BERCOFF
Giovanna,
DELL’AGATA
Giuseppe,
MARCHESANI Pietro, PICCHIO Riccardo (a cura di), La Slavistica in
Italia. Cinquant’anni di studi (1940-1990). Roma, Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, Divisione Editoria, 1994.
CADIOLI Alberto, VIGINI Giuliano, Storia dell’editoria italiana
dall’Unità ad oggi, Milano, Ed. bibliografica, 2008.
CANNISTRARO Philip V., La fabbrica del consenso. Fascismo e mass
media, prefazione di Renzo De Felice, Roma-Bari, Laterza 1975.
CANTINI F. (a c. di), Wolf Giusti (1901-1980). Bibliografia,
“eSamizdat”, I (2003), 181-211.
CAPELLI Anna, BROGGINI Renata, Antisemitismo in Europa negli
anni Trenta. Legislazioni a confronto. Milano, FrancoAngeli, 2002.
CAZZOLA, Piero, La casa editrice “Slavia” di Torino, antesignana
delle traduzioni letterarie di classici russi negli anni Venti-Trenta, in
Aa. Vv., La traduzione letteraria dal russo nelle lingue romanze e dalle
lingue romanze in russo. Contributi al Convegno di Gargano, settembre
1978, Milano, Cisalpino-Goliardica,1979, pp. 506-515.
CESARI Maurizio, La censura nel periodo fascista, Napoli Liguori,
1978.
CRONIA Arturo, La conoscenza del mondo slavo in Italia. Bilancio
storico-bibliografico di un millennio, Padova, Officine grafiche Stediv,
1958.
106
D’AMELIA Antonella (a cura di), Studi in onore di Ettore Lo Gatto,
Roma, Bulzoni, 1980.
ID., Un maestro della slavistica italiana: Ettore Lo Gatto, in “Europa
Orientalis”, VI, 1987, pp. 329-382.
Д’АМЕЛИЯ Антонелла (составитель), Этторе ло Гатто и русская
культура. Выставка книг и документов, Москва 1990.
DAMIANI Enrico, Avviamento agli studi slavistici in Italia, Milano,
Mondadori, 1941.
DELL’AGATA, Giuseppe, Luigi Salvini 1910-1957. Studioso ed
interprete di letterature e culture d’Europa, Pisa, Tipografia Editrice
Pisana, 2000.
DELL’AGATA Giuseppe, Le riviste slavistiche italiane tra le due
guerre mondiali, in Contributi italiani al XIV Congresso Internazionale
degli Slavisti (Ohrid, 10.16 settembre), a cura di A. Alberti, S. Garzonio,
N. Marcialis, B. Sulpasso, Firenze, FUP, 2008, pp. 367-401.
DE LUCA Paolo, Ettore Lo Gatto giornalista: la collaborazione ai
“Libri del giorno” 1921-1925, “Slavia”, anno XIX, 2, aprile-giugno,
2010, pp. 137-158.
DE MICHELIS Cesare G., Domenico Ciampoli studioso di letterature
slave, in AA.VV., Domenico Ciampoli, Atti del convegno di studi.
Atessa, 21-22 marzo 1981, Lanciano, Carabba, 1982, pp. 103-121.
ID., Panorama della letteratura russa in Italia, in Vittorio Strada (a cura
di), I russi e l’Italia, Milano, Scheiwiller, 1995, p. 298.
ID., L’avanguardia trasversale. Il futurismo tra Italia e Russia, Venezia,
Marsilio, 2009.
DIDDI Cristiano, La slavistica italiana del primo dopoguerra nella
rivista “I libri del giorno” (1918-1929), Europa Orientalis 27 (2008),
pp. 209-234.
DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO DEGLI ITALIANI (D.B.I.), Istituto
della Enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani, Catanzaro Roma, 2005.
ESPOSITO Edoardo (a cura di), Le letterature straniere nell’Italia
dell’entre-deux-guerres. Atti del Convegno di Milano 26, 27 febbraio e
1 marzo 2003; ID., Spogli e Studi. Lecce, Pensa Multimedia, 2004.
107
FABIANO Silvana, Bibliografia generale degli autori russi e sovietici
in lingua italiana, in “Rassegna sovietica”, 1980, 1-2-3-4-5-6, pp. 180188, 159-178, 107-133, 140-151, 167-184, 141-195.
ID., Gli autori russi e sovietici nei periodici italiani, “Rassegna
sovietica”, 1981, 1-3-4-6, pp. 167-168, 206-213, 176-186, 160-184.
FABRE Giorgio, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, con
una prefazione di Michele Sarfatti, Torino, Silvio Zamorani, 1998.
FATTORELLO Francesco, Giornali e riviste, in Notizie introduttive e
sussidi bibliografici. 2ed., Milano, Marzorati, 1958-60, vol. III.
FERRARA Patrizia, GIANNETTO Maria, Il Ministero della cultura
popolare. Il Ministero delle poste e telegrafi, in Guido Melis (a cura di),
L’amministrazione centrale pubblica dall’Unità alla Repubblica. Le
strutture e i dirigenti, V, Bologna, Il Mulino, 1992.
FINOCCHI Luisa, MARCHETTI Ada Gigli (a cura di), Editori e lettori.
La produzione libraria in Italia nella prima metà del Novecento,
redazione e apparati a cura di Patrizia Landi, Franco Angeli, 2000.
GHINI Giuseppe, Clemente Rebora traduttore dal russo, in “Lingua e
stile”, XXV, 1990, 1, pp. 57-83.
GIULIANI Rita, La fortuna di Leonid Andreev in Italia, in “Europa
Orientalis”, I, 1982, pp. 45-52.
GIUSTI Simona, Una casa editrice negli anni del fascismo: La Nuova
Italia (1926-1943). Firenze, Leo S. Olschki, 1983.
GRACIOTTI Sante, Ricordo di Giovanni Maver, “Ricerche slavistiche”,
vol. XXXVIII, 1991, pp. 5-12.
HERMET Augusto, La ventura delle riviste (1903-1940), Firenze,
Vallecchi, 1941.
INNAMORATI Giuliano, Tra critici e riviste del Novecento, Firenze,
Nuovedizioni Vallecchi, 1973.
LANGELLA Giuseppe, Il secolo delle riviste. Lo statuto letterario dal
Baretti a Primato, Milano, Vita e Pensiero, 1982.
108
LATTARULO Leonardo, ZAGRA Giuliana (a cura di), I periodici del
Fondo Falqui (1902-1943), Roma, 1991.
LO GATTO Ettore, Gli studi slavi in Italia, “Rivista di letterature
slave”, II, 1927, 3, pp. 455-468.
ID., I miei incontri con la Russia, Milano, Mursia, 1976.
ID., La rivista “Russia”, “Rassegna sovietica”, 4, 1977, pp. 94-98.
LO GATTO MAVER Anjuta, Le lettere di Ettore Lo Gatto a Giovanni
Maver (1920-1931), “Europa Orientalis”, XV (1996), 2, pp. 289-382.
LUTI Giorgio, Critici, movimenti e riviste del '900 letterario italiano,
Roma, NIS, 1986.
ID., Letteratura del ventennio fascista. Cronache letteraria tra le due
guerre: 1920-1940, Firenze, La Nuova Italia, 1972.
MANACORDA Giuliano, Dalla Ronda al Baretti, Latina, Di Mambro,
1972.
MANGONI Luisa, Il fascismo. I. Il primo dopoguerra: le difficoltà di
orientarsi in Letteratura italiana. Volume primo. Il letterato e le
istituzioni, Torino, Einaudi, pp. 521-548.
MASSIMI Dario, La diffusione della cultura letteraria ceca in Italia,
“La Nuova rivista italiana di Praga”, 1, 2000.
MAZZITELLI, Gabriele, Gli indici di “Russia”, in “Rassegna
sovietica”, 1979, 2, pp. 168-182.
ID., Intervista a Ettore Lo Gatto, “Rassegna sovietica”, 33 (1982), n. 2,
pp. 92-93.
ID., La rivista “Russia” nella storia della slavistica italiana, in
“Rassegna sovietica”, 1982, 3, pp. 200-212.
ID., Enrico Damiani. Un profilo biografico, in “Cultura del testo”, II,
1996, 5, pp. 69-75.
ID., Slavica Biblioteconomica, Firenze University Press, 2007.
MAZZUCCHELLI Sara, La letteratura russa in Italia nell’editoria
dell’entre-deux-guerres (1919-1939). [Tesi di dottorato in Letterature
109
slave moderne e contemporanee (ciclo XVIII) inedita] Università degli
Studi di Milano, anno accademico 2004/2005 (relatrice: Elda Garetto).
MESSINA Giuseppe L., Le traduzioni dal russo nel 1920/1943, in
“Belfagor”, IV, 1949, pp. 693-703.
PERA Pia, Tommaso Landolfi nello specchio russo, in Tarcisio
TARQUINI (a cura di), Landolfi libro per libro, introduzione di Walter
Pedullà, Alatri, Hetea, 1988, pp. 33-45.
PETRACCHI Giorgio, La Russia rivoluzionaria nella politica italiana.
Le relazioni italo-sovietiche 1917-1925, prefazione di Renzo De Felice,
Bari, Laterza, 1982.
ID., “Il colosso dai piedi d’argilla”: L’U.R.S.S. nell’immagine del
fascismo, in Ennio Di Nolfo, Romain Raniero, Brunello Vigezzi (a cura
di), L’Italia e la politica di potenza in Europa (1938-1940), Milano,
Marzorati, 1985, pp. 151-152.
PICCHIO Riccardo, Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, in Gianni
GRANA (a cura di), Letteratura italiana. I critici. Storia monografica
della filologia e della critica moderna in Italia, vol. IV, Milano,
Marzorati, 1970, pp. 3005-3027.
ID., Quarant’anni di slavistica italiana nell’opera di E. Lo Gatto e G.
Maver, in Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Roma,
G. C. Sansoni, 1962.
PICCOLO Laura, “Novità agli indipendenti”: russi reali e russi
immaginari in scena, in Archivio russo-italiano / Russko-ital’janskij
archiv, V. Russi in Italia, Antonella d’Amelia, Cristiano Diddi (a cura
di), Salerno, 2009, pp. 210-235.
PISCOPO Ugo, Riviste e movimenti culturali del Novecento, Napoli,
Ferraro, 1978.
PULLINI Giorgio, Pègaso, Pan, Treviso, Canova, 1976.
QUARANTA Mario, Le riviste giovanili del periodo fascista, Treviso
Canova, 1977.
RAGNI Eugenio, Cultura e letteratura. Dal primo dopoguerra alla
seconda guerra mondiale, in Storia della letteratura italiana a cura di
Enrico Malato, Salerno Editrice, pp. 287-435.
110
RAGONE, Giovanni, Editoria, letteratura e comunicazione, in
ALBERTO ASOR ROSA (a cura di), Letteratura italiana. Storia e
geografia. Volume III. L’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1989, p.
1073.
RENTON Bruce, La letteratura russa in Italia, “Rassegna sovietica”,
1960, 6 e 1961, 1-3, 4 e 5, pp. 40-59, 48-80, 27-69, 67-94, 36-70.
RUSSO Umberto, Giovanni Amendola, Eva Kühn e la casa editrice
Rocco Carabba, in “Rivista abruzzese”, XXXV, 1982, 4, pp. 181-190.
SANTORO Stefano, L’Italia e l’Europa orientale: diplomazia culturale
e propaganda, 1918-1943, presentazione di Marco Palla, Milano, Franco
Angeli, 2005.
SASSO Gennaro, Variazioni sulla storia di una rivista italiana “La
Cultura” (1882-1935), Bologna, Il Mulino, 1990.
SATTA BOSCHIAN Laura, Ricordo di Wolf Giusti (1901-1980), in
“Ricerche slavistiche”, vol. XXIX-XXXVI, 1982-1984, pp. 7-9.
SCANDURA Claudia, L’emigrazione russa in Italia: 1917-1940,
“Europa orientalis”, XIV, 1995, 2, pp. 341-366.
ID., La letteratura russa in Italia: un secolo di traduzioni, Roma,
Bulzoni, 2002.
SCHWARZ COLORNI Silvia, Ricordo di Rinaldo Küfferle, in
“Antroposofia”, 1958, 2, pp. 48-56.
ŚLASKI Jan, Giovanni Maver e gli inizi della slavistica universitaria
italiana a Padova, in Rossana Benacchio e Luigi Magarotto (a cura di),
Studi slavistici in onore di Natalino Radovitch, Padova, CLEUP, 1996,
pp. 307-329.
TAMBORRA ANGELO, Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917, Bari,
Laterza, 1977.
TORTORELLI Gianfranco, Una rivista per l’editoria “I libri del
giorno” 1918-1929 in ID., Parole di carta. Studi di storia dell’editoria,
Ravenna, Longo, 1992.
ID., “L’Italia che scrive” 1918-1938. L’editoria nell’esperienza di A.F.
Formiggini, Milano, Franco Angeli, 1996.
111
ID., La letteratura straniera nelle pagine de “L’Italia che scrive” e “I
Libri del Giorno”, in: ADA GIGLI MARCHETTI Ada, LUISA
FINOCCHI, Stampa e piccola editoria tra le due guerre, Milano,
FrancoAngeli, 1997.
TRANFAGLIA Nicola e ALBERTINA Vittoria (a cura di), Storia degli
editori italiani. Dall’Unità alla fine degli Anni Sessanta, Bari, Gius.
Laterza & Figli, 2007.
TURI Gabriele (a cura di), Storia dell'editoria italiana nell'Italia
contemporanea, Firenze, Giunti, 1997.
VENTURI, Antonello, L’emigrazione rivoluzionaria russa in Italia
(1906-1921), in: I russi e l’Italia, a cura di Vittorio Strada, Milano, Libri
Scheiwiller per Banco Ambrosiano Veneto, 1995.
VETTORI Vittorio, Riviste italiane del Novecento, Roma, Gismondi,
1958.
WILDOVÁ TOSI Alena, Bibliografia degli studi italiani sulla
Cecoslovacchia, Roma, Bulzoni, 1980.
ZUCARO Domenico (a cura di), Leone Ginzburg. Scritti, Torino,
Einaudi, 2000.
ZUNINO Pier Giorgio, L’ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori
nella stabilizzazione del regime, Bologna, Il Mulino, 1985.
C. SITOGRAFIA
http://www.russinitalia.it/
http://circe.lett.unitn.it/main_page.html
http://www.treccani.it/Portale/ricerche/searchBiografie.html
112
Parte II
Bibliografia ragionata dei periodici
113
Prefazione
La presente bibliografia ragionata è il risultato dello spoglio sistematico
dei periodici. I records bibliografici sono stati ordinati seguendo l’ordine cronologico
di ogni testata; ad ogni singolo contributo segue un breve abstract, che spiega il
termine ‘ragionata’. I nomi degli autori e delle opere nei records sono stati trascritti
nella forma originaria mentre negli abstract la traslitterazione degli alfabeti slavi
rispetta la trascrizione scientifica internazionale.
114
“L’Italia che scrive. Rassegna per coloro che leggono”
(A. F. Formiggini, 1918-1940)
Anno 1918
I, 4:
• Mario Ferrara, recensione a: I. W. Bienstok, Rasputin, La fine d’un
regime. Milano, Treves, pp. 58-59.
L’A. presenta il libro come una cronaca contemporanea, che ritrae il periodo
storico compreso tra l’ascesa di Nicola II e la sua abdicazione attraverso i personaggi
protagonisti dell’epoca, funzionari, “ministri ladri”, “governatori ignoranti”.
I, 5:
• Alberto Mortera, recensione a: General Filareti, La Rivoluzione russa
e la guerra dei popoli. Saggio con prefazione di Ettore Romagnoli.
Napoli, Casa Editrice “Elpis”, 1917. L. 2, p. 73.
Il saggio di Filareti, scritto durante il governo Kerenskij, è definito un
componimento ben argomentato e stilisticamente colorito, nel quale l’A. prevede i moti
separatisti e il prolungamento della guerra fino alla fine del 1918 come diretta e
naturale conseguenza delle defezioni dai corpi di cavalleria dei generali Krymov,
Kerenskij e Kornilov in favore del partito bolscevico.
Anno 1920
III, 6:
• P. E. Pavolini, recensione a: Ettore Lo Gatto su A. Cecof, Lo zio
Vania. Dramma, pp. 95 - Salticof-Scedrin, Lo spleen dei nobili, pp. VIII159 - A. J. Kuprin, Il delirio, pp. II-158 - F. Dostoievskii, Lettere dal
sottosuolo, pp. VII-128 - S. Przybyszevski, Il giudizio. Romanzo, pp.
XV-151, pp. 89-90.
L’A. presenta la nuova ‘Collezione di autori stranieri’ diretta da Ettore Lo Gatto
e dedicata ai maggiori scrittori moderni slavi e nordici, sottolineandone le accurate
prefazioni e le attente traduzioni.
III, 8:
• Giorgio Falco, recensione a: Vladimiro Zenzinov, Dallo Zarismo al
Bolscevismo. Ricordi di un rivoluzionario russo. Prefazione di Leonida
Bissolati. Roma, 1920 - Marco Slonim, Il bolscevismo visto da un Russo.
Le Monnier, Firenze, 1920, pp. VII-100, L. 6,50, p. 124.
Un volume di facile lettura, che narra come la minoranza bolscevica abbia
115
imposto la dittatura del proletariato delle fabbriche a discapito del proletariato agricolo
e della borghesia.
III, 9:
• Giorgio Falco, recensione a: A. O. Olivetti, Bolscevismo, Comunismo
e Sindacalismo. Milano, Editrice “Rivista Nazionale”, 1919 - Ezio
Mancini, Fino al bolscevismo, Milano, Soc. Ed., Albrighi e Segati, pp.
120, L. 3, p. 135.
L’autore del saggio sostiene che il futuro della società e del proletariato è il
sindacalismo e non il comunismo.
Anno 1921
IV, 3:
• Corrado Pavolini, recensione a: F. Dostojewski. L’Eterno marito.
Trad. di Corrado Alvaro. Milano, Quintieri, 1921,pp. 234, L. 7 - F.
Sologub. Il piccolo diavool, pp. 260, L. 7 – Novelle russe. Milano,
Quintieri, 1921, 2 voll., p. 51.
Breve segnalazione bibliografica dei primi volumi delle due collezioni di
letteratura ‘Grandi romanzieri del mondo’ e ‘Grandi novellieri del mondo’.
IV, 4:
• Francesco Cazzamini Mussi, recensione a: Giovanni Krylov. Le
Favole. Versione interlineare dal russo di U. Norsa. “Biblioteca dei
Popoli” diretta da P. E. Pavolini. R. Sandron, Palermo, 1921, pp. 75-76.
L’A. elogia la traduzione di Norsa considerandola la migliore realizzata in Italia e
paragonandola a quella di Verdinois, pubblicata nel 1906 dalla “Biblioteca Universale
Sonzogno”.
• P. E. Pavolini, recensione a: A. N. Majkov, Schizzi di Roma. Album
napoletano. Trad. di N. Festa. Lanciano, R. Carabba, 16, p. 76.
L’A. ricorda l’opera letteraria di Majkov e presenta la traduzione in prosa di due
raccolte poetiche a cura Nicola Festa, lodandone la fedeltà al testo originale ed
evidenziando alcune mende stilistiche relative alla rima e al ritmo.
IV, 6:
• P. E. Pavolini, Italia e Paesi slavi, pp. 117-118.
Nella rubrica l’A., dopo aver accennato al costante incremento di traduzioni
italiane di romanzi e scritti russi, presenta la nascente rivista bimestrale “Russia”
116
diretta da Ettore Lo Gatto.
IV, 7:
• l’ x (la Redazione), L’Istituto per l’Europa Orientale, p. 139.
L’articolo presenta l’Istituto per l’Europa Orientale e l’Istituto per l’Oriente,
illustrandone gli scopi fondanti e gli organi costitutivi; il primo si propone la creazione
a Roma di una biblioteca, una sala di lettura e una rivista di carattere scientifico e
divulgativo sulla vita sociale e culturale dei paesi dell’Europa Orientale; l’altro ha,
invece, lo scopo di diffondere e sviluppare la conoscenza del mondo islamico.
IV, 8:
• Corrado Pavolini, recensione a: Alessandro Blok. Canti bolscevichi.
Milano, Quintieri, 1920, pp. 64, L. 6; Gli Sciti-Dodici. Larionof e
Gonciarova. Tredici disegni. Ed. “Rassegna Internazionale”, 1920, L. 8,
p. 144.
Breve segnalazione bibliografica relativa a due libere traduzioni dal russo.
• E. Lo Gatto, recensione a: Leonida Andreief. Il Pensiero – Le
Maschere nere. Drammi. Prima traduzione italiana dall’originale russo,
con intr. della Duchessa d’Andria. Milano, Casa Ed. R. Caddeo e C. (s.
d. ma 1921), pp. 184, L. 6 - id., Figlio dell’ uomo e altre novelle.
Tradotto direttamente dal russo da P. Gobetti e A. Prospero. Milano,
Sonzogno, (s. d.), “Biblioteca Universale”; id., Quello che prende gli
schiaffi. Dramma in 4 atti. Traduzione letterale dal russo di Carlo
Staffetti e Boris Gurevich. Venezia, Ed. l’ Estremo Oriente, 1921, pp.
160, L. 6,50; A. I. Kuprin. Allez! Tradotto direttamente dal russo da P.
Gobetti e A. Prospero, “La Voce”, Soc. An. Ed., 1921 (con uno studio su
Kuprin di Pietro Pilschi e una nota critica di P. Gobetti), p. 110, L. 4, pp.
167-168.
L’A. introduce le sue osservazioni critiche sulle traduzioni di Leonid Andreev e
Aleksandr Kuprin con qualche cenno alla nascente scuola italiana di giovani traduttori
dal russo. Viene menzionato Piero Gobetti, di cui lo slavista analizza la traduzione di
Syn čelovečeskij (1909) di Andreev, evidenziandone qualche menda stilistica. Parole
di apprezzamento sono, poi, riservate alle traduzioni firmate da Staffetti, Gurevich e la
Duchessa d’Andria.
IV, 11:
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Demetrio Mamin Sibiriak. I lottatori
(Scene della vita sugli Urali). Trad. dal russo di E. Lo Gatto. Milano, L.
Potenza ed., 1921, p. 227.
Nel contributo l’A. definisce Mamin-Sibirjak “giornalista in cerca di emozioni e
impressioni nonché acuto analizzatore del proprio ambiente sociale, gli Urali e la
Siberia”.
117
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Leonida Andreiev. Savva (Ignis sanat).
Dramma in 4 atti. prima traduzione italiana fatta direttamente dal russo
da Piero Gobetti e Ada Prospero. Collezione “Moderni”, 6, Ferrara, A.
Taddei ed., 1921, pp. 174, L. 5, pp. 227-228.
Si tratta di un’attenta analisi psicologica dello stile di Andreev dove la “frenesia
della forma”, alla base della sua concezione mistica dell’arte, trova perfetta
corrispondenza nello spirito moderno. L’A. elogia la traduzione di Gobetti.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Ossip Felyne. Il Bivio. Versione dal
russo e pref. di Federigo Verdinois. Roma, Ed. M. Carra, 1921,pp. 314,
L. 7, p. 228.
Dopo aver descritto il contenuto del romanzo individuandone il personaggio
principale in Li, l’A. traccia un profilo psicologico di Felyne e loda la fedeltà
all’originale russo della traduzione di Verdinois, pur riscontrandone alcune mende
stilistiche.
IV, 12:
• E. Lo Gatto, recensione a: F. M. Dostoievski, Cuor debole; Il piccolo
eroe. Tradotti direttamente dal russo a cura di Olga Resnevic. Quaderni
della “Voce”, 54, 1921, p. 249.
Elogio delle traduzioni di Olga Resnevič Signorelli in questo piccolo volume
dedicato a Dostoevskij; si sottolinea in particolare la semplicità e la fedeltà al testo
russo originale, facendo notare qualche errore d’interpretazione. Si annunciano future
traduzioni della Resnevič.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Massimo Gorki. La mia infanzia.
Traduzione italiana di Kallisia. Milano, Società editrice “Avanti”, 1921,
p. 249.
Profilo psicologico del “fanciullo russo, che riflette in sé il mondo” e di cui si rievoca
l’infanzia, un’analisi intensa di Maksim Gor’kij. Qualche osservazione dell’A. sulla
traduzione fatta dal tedesco.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: S. Przybyszewski. Per la felicità.
Dramma in tre atti. Prima traduzione italiana dall’originale polacco di L.
Kociemski. “Collezione universale”, 14. Milano, R. Caddeo e C.
Editore, s. d. ma 1921, p. 249.
Breve storia delle traduzioni italiane delle opere di Stanisław Przybyszewski, poco
noto in Italia, ma già celebrato in Germania e Polonia, a partire dalla prima, eseguita da
Ofelia Szretter nel 1906 per la rivista “Rinascimento” e relativa al dramma Złote runo
(1901), fino alla traduzione di Das Große Glück (1897), firmata da Leonard Kociemski
e apprezzata dallo stesso A.
Anno 1922
V, 2:
118
• E. Lo Gatto, recensione a: Leonida Andreiev. Il Pope. Romanzo. Trad.
di Decio Cinti. Milano, Facchi ed. – Anfissa. Dramma in quattro atti.
Trad. letterale dal russo di B. Gurevich e M. R. Venezia, Ed. “L’Estremo
Oriente”, p. 28.
Nel primo caso, l’A. critica apertamente la traduzione di Andreev firmata da Cinti,
evidenziando alcune ‘spie stilistiche’ che ne tradiscono la mediazione dal francese; nel
secondo, viene espresso un giudizio soddisfacente sulla traduzione di Gurevich, anche
se ancora lontane da quelle di Piero Gobetti e Clemente Rebora.
V, 3:
• Aurelio Palmieri, La letteratura russa in ‘Letterature straniere in
Italia’, pp. 37-38.
Nella sua rassegna bibliografica, l’A. traccia un profilo storico e psicologico dello
‘scrittore russo’ attraverso le opere del passato. Partendo da un articolo di A. Jaščenko,
apparso nel 1921 sulla rivista “Russkaja kniga” pubblicata a Berlino, lo slavista mette
in risalto il fascino mistico della letteratura russa, citando una serie di traduzioni e
edizioni italiane di classici curate da Ettore Lo Gatto, Domenico Ciampoli, Eva
Amendola e Umberto Norsa.
• P. E. Pavolini, recensione a: P. Krapotkin. Ideali e realtà nella
letteratura russa in ‘Letterature straniere in Italia’. Trad. di E. Lo Gatto.
Napoli, Ricciardi, 1921, L. 16, p. 47.
L’A. descrive il volume, lodandone sia l’approccio obiettivo e imparziale dell’autore
sia la fedele traduzione firmata da Lo Gatto.
V, 4:
• E. Lo Gatto, recensione a: D. Mereskowsky, La morte di Paolo I.
Dramma in 5 atti a cura della Duchessa d’ Andria. Milano, Ed. R.
Caddeo e C. (s. d. ma 1922), p. 70.
In assenza del testo russo originale, l’A. rivede la traduzione firmata dalla Duchessa
d’Andria sulla base di precedenti versioni di altri drammi di Merežkovskij.
• E. Lo Gatto, recensione a: Marco Wovzog. Marussia. Leggenda
ucraina. Riduzione di Maria Ettlinger-Fano. Illustrazioni di Fabio Fabbi.
G. B. Paravia editore (s. d. ma 1921), p. 70.
Riduzione italiana, destinata al pubblico infantile, di un racconto della scrittrice
ucraina Maria Markovič Vovčok, presentata da Lo Gatto come “scrittrice di
second’ordine, con un senso delicato della vita popolare e dell’anima infantile”. Per
saperne di più l’A rimanda alla Storia della letteraruta russa di Krapotkin e agli
Articoli critici di letteratura russa di Dostoevskij.
119
• E. Lo Gatto, recensione a: F. Dostoievski, L’orfana (“Nietoc’ka
Nesvanova”). Trad. di Federigo Verdinois. Firenze, Soc. An. Editrice
“La Voce”, 1922, pp. 288. L. 10,50, p. 70.
Secondo l’A. si tratta di una delle più riuscite traduzioni di Verdinois, superiore
anche alle precedenti versioni francesi conosciute dal pubblico.
• E. Lo Gatto, recensione a: Nicola Gogol. Tarass Bulba e Le veglie
alla fattoria di Dicanca. Versione di F. Verdinois, 2° edizione. Napoli,
Editore Giannini, pp. 41. L. 7, p. 70.
L’A. coglie l’occasione per elogiare ancora una volta le traduzioni di Verdinois e la
sua abilità nel superare ogni ostacolo d’interpretazione della lingua di Gogol’,
riuscendo a creare un testo originale.
V, 6:
• E. Lo Gatto, recensione a: Vladimiro Soloviòf. I fondamenti spirituali
della vita. Trad. dal russo con introduzione di A. Palmieri. Bologna,
Nicola Zanichelli, 1922, pp. 200. L. 10, p. 109.
Con la traduzione di Aurelio Palmieri il pubblico occidentale viene a contatto con
l’attualità del pensiero di Vladimir Solov’ëv.
• E. Lo Gatto, recensione a: M. Lermontov, “Mzyri”ed altri poemetti.
Trad. di Virgilio Narducci. Napoli, R. Ricciardi, 1922, pp. 100. L. 5, p.
109.
Dopo una breve introduzione sui poemetti di Lermontov, l’A. sottolinea la fedeltà al
testo originale nella traduzione firmata da Virgilio Narducci, lodandone la bellezza di
stile e la robustezza espressiva.
• E. Lo Gatto, recensione a: F. Dostojevskij, Articoli critici di
letteratura russa. Trad. di Ettore Lo Gatto. Napoli, Riccardo Ricciardi
Editore, 1922,. L. 10, pp. 300, p. 109.
L’A. presenta gli scritti critici, introduttivi alla futura pubblicazione del Dnevnik
pisatelja, definendoli come il debutto di Dostoevskij nell’attività giornalistica ed
evidenziandone la chiara impronta ideologica.
• E. Lo Gatto, recensione a: L. Kociemski, Abisso. Dramma in quattro
quadri con prefazione di Casimiro Wronowski. Milano, R. Caddeo e C.
1921, pp. 64, L. 2.00, pp. 109-110.
Si tratta dell’analisi di un testo, considerato scorrevole e di piacevole lettura, che
rimanda ai contenuti di Il giudizio di Stanisław Przybyszewski e che, nonostante la
stessa definizione dell’autore di ‘dramma’, risulta poco rappresentabile per la sua
frammentarietà.
V, 8:
• E. Lo Gatto, recensione a: Leone Tolstoi. Opere postume, tradotte da
Luigi Grillo e Boris Gurevich. Bologna, Casa Editrice Apollo, pp. 458,
L. 8,50, p. 150.
L’A. insiste sulla necessità di tradurre direttamente dal testo originale; nel caso
specifico, lo studioso critica le traduzioni eseguite da Russo e Gurevich,
120
evidenziandone la scarsa fedeltà e la mancanza di limpidezza espressiva. Il volume
contiene i racconti: Každi Murat, Padre Sergij, Dopo il ballo, Aleša il vaso, la
commedia Tutto il bene viene da lei e il dramma E la luce risplende nelle tenebre.
E. Lo Gatto, recensione a: Leonida Andreief. Diario di Satana. Trad.
direttamente dal russo da T. Interlandi e B. Gurevich. Bologna, Casa
Editrice Apollo, pp. 260, L. 7, pp. 150-151.
•
L’A. considera la versione italiana firmata da Interlandi discreta e, pur non avendo
letto il testo originale, ne valorizza la chiarezza espositiva, fondamentale per
trasmettere il messaggio escatologico del romanzo incentrato sul ruolo del ‘bene’ e del
‘male’ nella società.
• E. Lo Gatto, recensione a: Nicola Gogol, Il Cappotto. Versione, note,
annotazioni di Clemente Rebora. Milano, Il Convegno editoriale, 1922,
pp. 104, L. 6, p. 151.
L’A. loda la fedele traduzione italiana, eseguita da Rebora, di Šinel’, di cui esisteva
solo la “lacunosa” traduzione di Domenico Ciampoli.
V, 10:
• E. Lo Gatto, recensione a: L. Tolstoj. Kreutzerova Sonata. Traduzione
dal testo russo di Leonardo Kociemski. Milano, Caddeo (s. d.).
‘Collezione universale’, pp. 144, L. 4.00, pp. 62-63, p. 185.
Il giudizio critico dell’A. sulla traduzione evidenzia la capacità di Kociemski di
riprodurre stile e pensiero in lingua italiana pur essendo di origine straniera.
• E. Lo Gatto, recensione a: A. Cèchof. Zio Giovanni. Scene della vita
di campagna, in 4 atti. Trad. dal russo di Odoardo Campa. “Comoedia”.
Mondadori ed., 1922, p. 185.
L’A. evidenzia alcune mende stilistiche relative alla traduzione del dramma di
Čechov firmata da Campa, sottolineando che si tratta di lacune rilevanti dal punto di
vista letterario ma meno significative per la messinscena teatrale.
V, 11:
• E. Lo Gatto, recensione a: Leonida Andrejeff. Padre Vassili. Trad.
italiana di Cesare Castelli. Milano, Società editrice “Avanti!”, 1922, pp.
148, L. 6, p. 206.
L’A. introduce la figura di Cesare Castelli, rappresentante esclusivo della casa
editrice Ladyšnikov di Berlino, a cui scrittori come Andreev e Gor’kij avevavo affidato
le loro opere per preservare i diritti di autore. Viene evidenziata la buona traduzione del
romanzo di Andreev, basata su una precedente versione tedesca.
• E. Lo Gatto, recensione a: Vsevolod Garscin, Il veleno della vita.
Trad. di E. Getzel. Napoli, Editore Dr. Gennaro Giannini, 1922, p. 206.
L’A. presenta la traduzione di Garšin come un lavoro fedele all’originale e di
particolare sagacia espressiva; edita da Giannini e fino a quel momento poco nota al
pubblico, costituirebbe un “trucco editoriale” dal momento che si tratta di una vecchia
traduzione con una copertina rinnovata.
121
Anno 1923
VI, 1:
• Corrado Pavolini, recensione a: Leone Kochnitzki, La quinta stagione.
Trad. di Alberto Luchini. Bologna, Zanichelli, 1922, pp. 260. L. 10, pp.
9-10.
L’A. loda la versione italiana del romanzo di Lev Kocznicki, diario sentimentale
dell’occupazione legionaria di Fiume, alla quale lo scrittore, ebreo di padre russo e
madre polacca, ha partecipato in prima persona.
• P. E. Pavolini, recensione a: Panteon literatury wszechs’wiatowej w
opracowaniu A. Langego i A. Toma. Ed. del “Libro polacco”. Varsavia,
s. a., pp. 285, p. 10.
Breve presentazione della raccolta dedicata alle letterature di tutte le epoche, curata
dagli scrittori e traduttori Antonio Lange e Alfredo Tom, composta di 80 fascicoli di
cui i primi cinque dedicati alla letteratura italiana. L’A. sottolinea il prezioso contributo
che tale opera fornisce alla conoscenza della letteratura e della cultura italiana in
Polonia.
VI, 4:
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Teodoro Dostoievski. Delitto e castigo.
Trad. di F. Verdinois. Lanciano, G. Carabba Editore, 1923, 4 voll., pp.
782, L. 16, p. 66.
La traduzione di Verdinois viene particolarmente apprezzata dallo slavista, che ne
rileva alcuni limiti sul modo di trasmettere il pensiero dell’autore. Secondo l’A.,
Verdinois semplifica il ‘periodo’ di Dostojevskij, liberandolo da inutili ripetizioni e
prolissità, prendendo a modello la precedente traduzione di Bednye ljudi, ma al tempo
stesso non rende pienamente lo stile dello scrittore.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Augusto Cieszkowski. Padre nostro.
Trad. dal polacco di Aurelio Palmieri. Bologna, N. Zanichelli, 1923, p.
66.
L’A. elogia Palmieri per aver fatto conoscere in Italia il filosofo polacco August
Cieszkowski attraverso la collezione ‘Maestri della vita spirituale’. La traduzione di
Ojcze nasz eseguita dallo slavista, l’unica completa in Occidente, è stata arricchita da
una bibliografia sulla vita e le opere di Cieszkowski e un indice delle fonti consultate.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Ossip Félyne. Maledizione. Novelle.
Roma, Maglione e Strini, 1923, pp. 172, pp. 66-67.
Edizione di una raccolta di novelle di Felyne che l’A. considera “graziosa e limpida”
pur evidenziando l’ingiusta trascuratezza del traduttore, Federico Verdinois, da parte
dell’editore.
• P. A. Strakcsz, recensione a: Jan Ptaśnik. Kultura Wloska Wieków
Srednich w Polsce (La cultura italiana del Medioevo in Polonia).
122
Varsavia, 1922, “Bibljoteka Polska”, pp. 223, p. 67.
Si tratta di un minuzioso e approfondito studio sui secolari rapporti di amicizia
italo-polacca curato dal prof. Ptaśnik. Il libro descrive l’attività degli italiani in Polonia,
legati pontifici, commercianti e ambasciatori pressi i re polacchi, fra cui Filippo
Callimaco Buonaccorsi. L’A. presenta il volume evidenziandone sobrietà ed
esaustività.
VI, 5:
• E. Lo Gatto, recensione a: S. Zeromski. Gli echi del bosco. A cura di
L. Kociemski. Milano Collezione universale Caddeo, s. d. ma 1923, pp.
112. L. 4, p. 87.
Elogio dell’A. a Leonardo Kociemski per l’attività di traduttore dal polacco e dal
russo, confermata in questa serie di racconti di Stefan Żeromski.
VI, 6:
• E. Lo Gatto, recensione a: I. S. Turgheniev. L’avventura del tenente
Jergunov. Trad. dal russo di E. Damiani, nella collezione “Poeti e
prosatori stranieri”. Firenze, Le Monnier Editore, 1922, p. 107.
L’A. loda la traduzione di Damiani, confrontandola con le altre realizzate in
precedenza, e ne sottolinea l’accuratezza nella scelta dei racconti e nell’introduzione.
• E. Lo Gatto, recensione a: Ivan Turghéniev, Le poesie in prosa. Trad.
e introd. di E. Damiani. Lanciano, G. Carabba ed., 1923, p. 108.
Dopo le precedenti traduzioni delle poesie in prosa di Turgenev questa di
Damiani viene considerata dall’A. una fra le migliori. L’unica raccomandazione fatta al
traduttore è quella di “rendere sempre la parola russa con la sua immediata
corrispondente italiana”.
• E. Lo Gatto, recensione a: Antonio Céchof. Per la strada. Trad. dal
russo di A. Coidulova e Raffaello Franchi. Firenze, Vallecchi ed., 1923,
p. 108.
L’A. evidenzia l’attendibilità della traduzione nonostante la presenza di qualche
menda stilistica.
• E. Lo Gatto, recensione a: Boris Zaitsev. Italjia. Sobranje socinenji.
Vol. VII, Ed. Grgebin. Pietroburgo-Berlino, 1923, pp. 182, p. 108.
Il volume decanta l’Italia, passando in rassegna i luoghi più suggestivi del Paese e
rievocandone le vicende storiche. L’A. apprezza il sincero entusiasmo con cui Zajcev
tratta la materia.
• E. Lo Gatto, recensione a: P. Muratov. Egerija. Ed. Grgebin. Berlino,
1923, p. 108.
L’A. presenta il romanzo di Muratov, quasi interamente dedicato all’Italia, scritto in
Russia in pieno periodo rivoluzionario e ricco di descrizioni e dettagli tipici dello stile
“un po’ antiquato” dello scrittore.
123
• E. Lo Gatto, recensione a: B. Griftsov. Rim (Roma), con 35
illustrazioni; nella collezione “Centri culturali d’ Europa”. Mosca, 1916,
pp. 256, 2° ediz., p. 108.
Il libro, chiaro tributo alla città di Roma, viene presentato dall’A. come la necessità
da parte di Grifcov di esprimere l’enorme stima nei confronti dell’Italia, della sua storia
e della sua lingua.
VI, 8:
• P. E. Pavolini, recensione a: E. Lo Gatto. Saggi sulla cultura russa.
Pubblicazione dell’Istituto per l’Europa Orientale, Prima Serie, III,
Napoli, Ricciardi 1923, pp. 174, L. 8, p. 141.
Dopo una riflessione sull’incessante e straordinaria attività pubblicistica di Lo
Gatto segue una breve sintesi sul contenuto del volume, che comprende un saggio sul
teatro di Čechov, l’oblomovismo, la vita e le opere di Alessandro Herzen, Korolenko e
la fortuna di Dante in Russia.
VI, 10:
• E. Lo Gatto, recensione a: Nicola Gogol. Come Ivan Ivanovic
questionò con Ivan Nikiforovic. Prima trad. italiana dal russo di Carlo
Grabher. Roma, Libreria di scienze e lettere, 1922, pp. 80, L. 4,50, p.
183.
L’A. loda la traduzione di Grabher inserendola fra le più fedeli al testo originale
con una riflessione sul crescente numero di traduzioni dal russo eseguite da italiani, che
conoscono bene la lingua e che sostituiscono sempre di più quelle basate su
riadattamenti francesi.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Novelle russe. Versione di Teresita
Frigo. Milano, A. Vallardi Ed., 1922, pp. 320, L.7, p. 183.
Lo slavista presenta la raccolta di novelle, criticandone la scelta di contenuto
considerata “limitata a scrittori russi secondari”.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Leone Tolstoj. Il diavolo, opera
postuma. Trad. dal testo originale russo e introd. a cura di E. Damiani.
Firenze, Vallecchi, 1923, pp. 99. L.3,50, p. 183.
Il breve romanzo di Tolstoj conferma l’influenza del pensiero religioso sulle sue
concezioni artistiche e, come afferma l’A., “la nitida traduzione di Damiani esprime
chiaramente quest’influenza”.
VI, 11:
• E. Damiani, recensione a: E. Lo Gatto. Poesia russa della rivoluzione.
Roma, A. Stock, 1923, pp. 123, L. 7, p. 200.
L’A. presenta il volume definendo “uno dei più completi studi sulla letteratura
russa del periodo rivoluzionario” sia per le fonti cui attinge, sia per l’ampia quantità di
notizie sulla cultura dell’epoca, includendo un intelligente compendio di liriche tradotte
letteralmente dal russo, che lo slavista ha raccolto e riordinato.
124
Anno 1924
VII, 1:
• E. Lo Gatto, recensione a: Aleksander Brückner, Mitologia slava, con
una prefazione originale dell’autore. Trad. dal polacco e note di Julia
Dicksteinowna. Bologna, Zanichelli, editore, 1923, pp. 280. L. 16, p. 31.
Il volume, inserito da Pettazzoni nella sua Storia delle religioni, costituisce per
l’A. un accurato e minuzioso studio sulla mitologia slava, corredato da abbondanti note
esplicative della traduttrice. Lo slavista lamenta, però, la mancanza in Italia di
precedenti studi nel settore, che aiuterebbero a comprendere la natura di alcune
questioni sollevate da Brückner.
VII, 2:
• Ettore Lo Gatto, recensione a: A. Cecov. Ivanov, dramma in 4 atti.
Traduzione di Carlo Grabher, con una introduzione. Firenze, Vallecchi
Editore, 1923. Pagg. 90, L. 3, 50, p. 31.
L’A. continua ad elogiare le traduzioni di Grabher e nel caso specifico presenta un
dramma di Čechov, Ivanov, in una precedente traduzione dello stesso Grabher presso
l’editore Vallecchi.
• E. Damiani, recensione a: Fiodor Sollogub. Il demone meschino
(Romanzo). Traduzione dal russo di E. Lo Gatto. Foligno, Campitelli,
1923, 2 vol, pag. complessive XVII-354. L. 14, p. 31.
L’A. evidenzia l’aspetto innovativo della traduzione rispetto a precedenti, lacunose
e poco attendibili.
• E. Damiani, recensione a: Alessandro N. Ostrovskij. La Foresta
(Commedia in cinque atti). Traduzione di Ettore Lo Gatto. Napoli,
Ricciardi, 1923, pp. VIII-135. L. 7, p. 31.
La versione della commedia di Ostrovskij eseguita da Lo Gatto viene presentata
dall’A. come la prima autentica apparsa in Italia e capace di conciliare la fedeltà
d’interpretazione del testo con una buna forma in lingua italiana.
VII, 9:
• Cesare Botti, recensione a: Francesco Losini. Lérmontof, (profilo).
Roma, Formiggini, 1924, pp. 80, con ritratto, L. 3,50, p. 162.
Il volume presenta la travagliata vicenda biografica di Lermontov, con un profilo
nitido della personalità e della sensibilità poetica che lo accomunava a Byron e un
costante rimando alla sua produzione letteraria.
• P. E. Pavolini, recensione a: A. Ostrowski, I lupi e le pecore. Trad. di
E. Damiani. Lanciano, Carabba, 1924, pp. 212. legato. L. 4, p. 167.
Breve intervento critico sulla commedia di Ostrovskij, tradotta da Damiani, e
sull’intera produzione teatrale.
125
• Bartos Vlcek: recensione a: Karel Capek, Italské listy (Lettere
italiane). Praha, Edizione “Aventinum”, Kč 13.50, p. 167.
Diario di viaggio del drammaturgo ceco noto in Italia attraverso il dramma La
Vita degli insetti scritto insieme al fratello Josef e pubblicato dalla collana “Comoedia”
di Mondadori. Attraversando l’Italia, Čapek non si limita alla descrizione di musei e
gallerie d’arte ma registra la quotidianità dei piccoli borghi e delle viuzze di paese.
L’A. ne sottolinea lo stile semplice a metà tra poesia in prosa e giornalismo.
Anno 1925
VIII, 2:
• P. E. Pavolini, recensione a: La principessa Ranocchio e altre fiabe
popolari russe raccolte e trad. da Gabriella Brenzini Berson. Firenze,
Salani, 1942, pp. 278, p. 29.
Raccolta anonima di novelle con un delizioso repertorio iconografico.
P. E. Pavolini, recensione a: Anissia. Storia di una contadina russa,
narrata da lei medesima, rivista e corretta da L. Tolstoi e tradotta dal
testo originale da Gabriella Brenzini Berson. Firenze, Salani, 1924, pp.
256, p. 29.
•
L’A. presenta il volume dedicato alla biografia di una contadina, realmente esistita,
redatta in forma di racconto e contenuta nella raccolta Posrednik per l’educazione dei
contadini.
• P. E. Pavolini, recensione a: A. Cècov. Il giardino dei ciliegi.
Traduzione dal russo con introduzione di C. Grabher. Firenze, Vallecchi,
1924, pp. 81, L. 3,50, p. 29.
Nel suo intervento critico l’A. elogia l’introduzione, riassuntiva del pensiero e
dell’arte narrativa di Čechov, e l’analisi dei singoli personaggi della commedia.
VIII, 3:
• Aldo Gabrielli, recensione a: Anton Cecov. Lo zio Vania (scene di vita
campagnola, in 4 atti), pp. 94, L. 4; M. N. Minski. Che cosa cerchi?
(Mistero in 1 atto), pp. 80; L. 4. Milano, «Alpes», 1925; S. Poliacov. Il
labirinto (Dramma in 4 atti), pp. 80. Milano, «Alpes», 1925
(“Collezione del Teatro” nn. 1, 2, 3), p. 52.
L’A. presenta la collezione dedicata al teatro russo di cui escono i primi tre volumi
contenenti ciascuno una produzione teatrale completa e significativa, di contenuto
vario e che descrive le caratteristiche del teatro di quegli anni. Il volume è, inoltre,
arricchito dalle traduzioni di Raissa Olkienizkaja Naldi e da succinte prefazioni.
VIII, 5:
126
• Adriano Tilgher, recensione a: Anton Cekov. Le tre sorelle. Dramma
in quattro atti. Traduzione e introduzione di B. Iakovenko. («Сlassici
moderni»). Firenze, Vallecchi, pp. 82, p. 101.
L’A. raccomanda ai lettori della rivista la traduzione del dramma di Čechov
eseguita da Jakovenko, definendola più precisa e aderente al testo originale rispetto a
quella esistente, a cura di Jastrebcov e Soffici.
VIII, 6:
• Adriano Tilgher, recensione a: Ivan Serghieievic Turgheniev. Un mese
in campagna. Commedia in cinque atti. Introduzione e traduzione dal
testo russo di Enrico Damiani (Classici moderni). Firenze, Vallecchi,
1925, pp. 134. L. 4, p. 120.
Si tratta del più ampio lavoro drammatico mai scritto da Turgenev, composto fuori
dagli schemi artificiali del dramma francese e ricco di personaggi, che lo accomunano
ai drammi di Čechov.
VIII, 9:
• Aldo Gabrielli, recensione a: Alessandro Blok. La rosa e la croce
(dramma in 4 atti), pp. 136, L. 6; Teodoro Sollogub. Gli ostaggi della
vita (dramma in 5 atti), pp. 202, L. 6; P. M. Arzybaschev. La Gelosia
(dramma in 5 atti), pp. 160, L. 6, Milano, «Alpes», 1925 («Collezione
del Teatro», n. 4, 5, 6), p. 180.
I tre nuovi volumi della collezione dedicata al teatro russo sono presentati da
Raissa Olkienizkaja Naldi con una breve descrizione della personalità di ciascun artista
e sono da lei tradotti, secondo Gabrielli, con “indiscutibile abilità e limpidezza
espressiva”.
• Adriano Tilgher, recensione a: Critici letterari russi a cura di Ettore
Lo Gatto, Foligno, Franco Campitelli, 1925, pp. 290, p. 180.
Pur riconoscendo e lodando lo sforzo di Lo Gatto per realizzare una storia della
letteratura russa attraverso la critica letteraria di ogni periodo, l’A. ridimensiona la
portata innovativa del volume e ne definisce la sua ricezione in Italia rispetto alla
diffusione fra i lettori russi.
VIII, 10:
• Alberto Neppi, recensione a: Ivan Turgheniew. Demetrio Rudin,
romanzo, traduzione e prefazione di Angiolo Lanza. Milano, Giuseppe
Morreale, 1925, pp. VII-241. L. 6, p. 194.
Secondo l’A. il racconto possiede solo l’impalcatura esterna del romanzo ed è la
descrizione psicologica, e a tratti ironica, del protagonista Dmitrij Rudin. Viene
elogiata la traduzione firmata da Lanza e criticato l’apparato critico-introduttivo.
VIII, 12:
127
• P. E. Pavolini, recensione a: O. Cuzzer. Dostoievsky. Roma, Stock,
1925, pp. 131. L. 10, p. 235.
Si tratta del primo volume italiano, e in lingua italiana, su Dostojevskij dopo la
traduzione di Maria Letizia Lumbroso della biografia e due precedenti articoli di Papini
e Prezzolini. L’A. presenta il volume definendolo un’occasione unica per conoscere da
vicino l’opera del celebre scrittore, la cui complessità viene più volte sottolineata da
Cuzzer.
Anno 1926
IX, 1:
• Alberto Neppi, recensione a: Aurelio Zanco. A. P. Céhov dal suo
epistolario. Firenze, «La Voce», 1925, pp. 171. L. 10, p. 10.
L’A. sottolinea l’accurata scelta dall’epistolario di Čechov fatta da Zanco, operando
un’attento lavoro informativo sull’artista che attinge a diverse fonti, fra cui gli studi di
Izmajlov.
• Hilda Montesi Festa, recensione a: Božena Ňemcová, La nonna
(Babička). Milano, L. F. Cogliati, 1925, pp. 283, L. 14, p. 10.
Romanzo della scrittrice boema dedicato alle virtù campagnole di una buona
vecchietta, destinato a ragazzi e adulti.
IX, 3:
• P. E. Pavolini, recensione a: G. Maver. Saggi critici su Juliusz
Slowacki. Padova, Libr. Edit. A. Draghi, 1925, pp.62, p. 50.
Breve contributo sulla concezione di Maver riguardo all’arte poetica di Słowacki,
in particolare sull’influenza di Byron, Shakespeare, Dante, Towiański e Calderon.
IX, 5:
• P. E. Pavolini, recensione a: E. Lo Gatto. Studi di letterature slave.
Volume primo. Roma, Anonima Romana Editoriale, 1925, pp. VIII-220.
L. 10, p. 99.
L’A. presenta il volume di Lo Gatto pubblicato su “Russia” e dedicato quasi
esclusivamente alla letteratura russa contemporanea con un saggio su Reymont e
un’appendice sulle traduzioni polacche di Puškin, sottolineandone le numerose
informazioni bibliografiche e le lucide analisi stilistiche.
IX, 7:
• P. E. Pavolini, recensione a: S. Krasinski. La non Divina Commedia.
Traduz. dal polacco e note di M. Antonietta Kulczycka, con proemio del
prof. R. Pollak. Roma, Anonima Editoriale Romana, 1926, pp. 171. L.
128
7,50, p. 152.
Citando gli studi di Brückner e Björnson sul capolavoro giovanile di Zygmunt
Krasiński, l’A. loda la traduttrice, italiana di origine polacca, per il suo lavoro
“coscenzioso ed efficace”.
• P. E. Pavolini, recensione a: A. Mickiewicz. Canti, trad. dal testo
polacco da E. Damiani, con pref. di R. Pollak, seguiti da uno studio del
traduttore. Firenze, Vallecchi, 1926, pp. 162. L. 6,50, p. 152.
Si tratta di quattro fra le maggiori composizioni del poeta polacco, Svitez, Sonety
krymskie, Farys, i sette quadri di Epizod. L’A. sottolinea come Damiani, a differenza di
altre versioni eseguite da poeti russi e polacchi, abbia qui tradotto in prosa letterale
anziché conservare la forma metrica sia per maggiore fedeltà al testo originale, sia per
facilitarne la comprensione.
• P. E. Pavolini, recensione a: G. Slowacki. Jan Bielecki. La Genesi
dello Spirito. Traduz. dal polacco con proemio e note di A. Palmieri.
Roma, Anonima Romana Editoriale, 1925, pp. 109, p. 152.
L’A. sottolinea la fedeltà e la limpidezza espressiva con cui Palmieri ha tradotto
queste due operette di Słowacki; la prima, giovanile, del 1830 pervasa di byronismo, la
seconda, poemetto in prosa, opera matura sulla creazione e sull’affermarsi dello spirito
sulla materia, arricchita dall’autore da note esplicative e citazioni da opere scientifiche,
in particolare Mistyka Słowackiego di Jan Gwalbert Pawlikowski.
• P. E. Pavolini, recensione a: L. A. Mei. La sposa dello Zar. Trad.
poetica dal testo russo di E. Damiani. Roma, Maglione e Strini, 1926,
pp. 222, L. 10, p. 152.
Il volume (titolo originale: Ivan IV), incentrato su un episodio storicamente
documentato del regno dello zar, presenta al pubblico italiano il dramma di uno
scrittore russo contemporaneo poco noto rispetto a Turgenev, Tolstoj e Dostoevskij
nella fedele ed elegante traduzione di Damiani.
IX, 11:
• P. E. Pavolini, recensione a: Lirici russi del secolo aureo. Traduz. di
G. Gandolfi. Lanciano, G. Carabba, 1926, 2 voll. Di pp. IV-191 e 180.
L. 8, p. 243.
L’A. elogia la traduzione del verso russo eseguita da Gandolfi, fedele
riproduzione della disposizione delle rime e della varietà del metro, che restituisce la
dolcezza del suono e la vaghezza del ritmo proprie della lirica russa. Si segnala la
scarsità di note esplicative.
• Aldo Gabrielli, recensione a: Karel Ciapek, L’affare Makropulos.
Traduzione e introduzione di Taulero Zulberti. (VIII volume della
Collezione del Teatro). Milano, Casa Editrice Alpes, 1926. L. 6, p. 243.
Si tratta di uno dei più rappresentativi volumetti della “Collezione del Teatro”
della Casa Editrice milanese dedicati alla commedia di Čapek, che ha riscosso successo
incontrastato in Italia e all’estero. L’A. sottolinea l’attenta traduzione del testo
originale eseguita da Zulberti e lo studio scrupoloso che la precede.
129
Anno 1927
X, 4:
• E. Formiggini Santamaria, recensione a: W. Korolienko. Il vecchio
campanaro (trad. di B. Jakovenko). Firenze, Vallecchi, 1926, pp. 168, p.
81.
Presentando il volume di Korolenko, Finzi coglie l’occasione per sottolineare come
opere che richiedono maturità e ricchezza di sentimenti vengano considerate semplice
letteratura per l’infanzia o l’adolescenza.
X, 5:
• Paolo Vita Finzi, recensione a: Ivan Turghéniev. Scene e commedie.
Versione integrale con note di Rinaldo Küfferle. Torino, “Slavia”, 1927,
L. 11, p. 110.
Invito dell’A. a leggere le operette di Turgenev nella fedele traduzione italiana di
Rinaldo Küfferle, che sostituisce le precedenti versioni francesi e tedesche poco
attendibili.
X, 6:
• E. Damiani, Gli studi slavi, in ‘Bilanci consuntivi’, pp. 123-124.
Alla luce di un considerevole incremento degli studi dedicati alle culture slave e
all’aumento degli specialisti nel settore riscontrabile in Italia negli ultimi anni, l’A.
traccia un bilancio delle traduzioni letterarie, soprattuto da autori russi, polacchi e
bulgari, e di scritti originali, la maggior parte dei quali pubblicati in riviste sorte
nell’ultimo anno. In rilievo la nascita di “Rivista di letterature slave” e della casa
editrice Slavia.
X, 8:
• E. Damiani, recensione a: Sigismondo Krasinski. Iridione. Prima
versione italiana di Clotilde Garosci. Introduzione di Cristina AgostiGarosci. Pubblicazione della Sezione Romana dell‘ Associazione
«Adamo Mickievicz». Roma, 1926. Deposito principale presso la
Libreria Signorelli (Edizione a cura del Conte Isidoro Czosnowski), pp.
230. L. 9, pp. 182-183.
Secondo fra i grandi capolavori di Zigmunt Krasiński dopo Nie-Boska Komedia
(1835), Iridion è una raffigurazione simbolica del martirio del popolo polacco sotto il
giogo moscovita. L’A. elogia la fedele traduzione italiana, la buona forma e la bella
veste editoriale, arricchita da un’esauriente introduzione sull’opera e la personalità di
Krasiński.
130
• Paolo Vita-Finzi, recensione a: Alessandro Blok. L’ Amore, la Poesia
e lo Stato. Dialogo. Roma, ediz. di «Fede», s. d. (1926), pp. 24. L. 1,25.
Si tratta di un dialogo composto da Blok nel 1907 in piena atmosfera
rivoluzionaria, che l’A. presenta ai lettori mettendone in evidenza la buona prefazione
di Paolo Flores sulla concezione mistica del poeta bolscevico.
• Paolo Vita-Finzi, recensione a: M. E. Saltykov – Scedrin. Favole e
racconti innocenti. Roma, Stock, 1927, pp. 204. L. 10, pp. 183-184.
Il volume, introdotto da una lunga e accurata prefazione di Lo Gatto sull’opera di
Ščedrin, è una raccolta di favole che sbeffeggiano i mali della società moscovita
nell’età delle riforme sociali avviate da Alessandro II, dalla viltà e brutalità dei
governanti all’”ingenuità utopistica e chiacchierona” dell’intelligencija.
X, 9:
• Leonard Kociemski, recensione a: Adolf Dygasinski. Le Feste della
vita. Romanzo tradotto dal polacco da Enrico Damiani e Roman Pollak.
Introduzione di Ladislao Wolert. Milano, Casa Editrice “Alpes”, 1927,
pp. 286. L. 10, p. 203.
L’A. elogia la traduzione dal polacco eseguita da Damiani e Pollak e l’originale
veste editoriale della casa editrice Alpes, con qualche critica alla trascrizione dei nomi,
non sempre foneticamente esatta, e di espressioni, che non sempre rendono la
semplicità dello stile di Dygasiński. Un appunto, infine, al prof. Wolert per non aver
presentato lo scrittore polacco sullo sfondo dell’epoca in cui visse e operò.
• L. Kociemski, recensione a: Lev Tolstoj. I cosacchi e L’ incursione.
Prima versione integrale e conforme al testo russo con note di Boris
Jakovenko. Collezione del Genio russo, Serie II, N. 2. Torino, edizioni
Slavia, 1927, pp. 280. L. 11 - Anton Cechov. Il duello e Tre anni. Prima
versione integrale e conforme al testo russo con note di Giovanni
Faccioli. Collezione del Genio russo, Serie V, N. 1. Torino, edizione
Slavia, 1927, pp. 286. L. 11, p. 203.
Pur riconoscendo il valore del grandioso piano editoriale di Alfredo Polledro e
l’impegno di pubblicare solo traduzioni fedeli all’originale, l’A. evidenzia alcune
mende stilistiche nelle traduzioni di Jakovenko e Faccioli.
• Enrico Damiani, recensione a: Capek Chod C., Favola candida – Xⁿ
Yⁿ=Zⁿ (La formula di Femat). Traduzione dal ceko di Maria Voltrubova.
Con una notizia di B. Chiurlo. Udine, Libreria Editrice Udinese, 1927.
Un vol., pp. 63. L. 3 (Biblioteca italiana e straniera diretta da B. Chiurlo
e G. Lorenzoni, Serie III, N.6), p. 203.
Si tratta di due racconti dello scrittore ceco. Il primo, la storia di un umile
ragazzo che, dotato di uno speciale talento musicale, riesce a trarre da un rozzo violino
una musica celestiale; il secondo, la triste fine di un giovane che, dopo aver trascorso la
vita alla ricerca di una dimostrazione matematica che avrebbe dovuto fruttargli
ricchezza, muore in guerra. L’A. ne loda la traduzione dal ceco.
X, 12:
131
• Leonard Kociemski, recensione a: Fjodor Dostojevskij. Il villaggio di
Stepancikovo e i suoi abitanti. Romanzo umoristico. Prima versione
integrale dal russo, con note di Alfredo Polledro. Torino, Edizioni
«Slavia», Serie I, N. 5, 1927, pp. 320. L. 11, p. 275.
Breve introduzione critica al romanzo che rivela al pubblico di lettori un
Dostojevskij “umorista” con particolare riferimento all’accurata e fedele traduzione.
• Leonard Kociemski, recensione a: Anton Cecov. Racconti agrodolci.
Traduzione dal testo russo di Olga Malavasi Arpshofen. Bologna Casa
Editrice «Apollo», pp. 217. L. 10,50, p. 276.
Dopo un’attenta presentazione della tecnica narrativa e delle caratteristiche tipiche
dei personaggi di Čechov, l’A. loda la veste grafica del volume, evidenziando, però,
alcune mende stilistiche nella traduzione.
Anno 1928
XI, 1:
• L. Kociemski, recensione a: Fjodor Sollogub. Più dolce del veleno.
Traduzione dal russo di Sergio Topf. Prefazione di Mario Speranza.
Aquila, Casa editrice Vecchioni, 1927, p. 16.
Breve presentazione del volume curato da Mario Speranza per la celebre ‘Collana
di scrittori italiani e stranieri’ e dedicato al romanzo di Sologub, che racchiude tutta la
visione tragica e pessimistica dello scrittore.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Arcadio Avercenko. Macchie di
sole. Traduzione dal russo di Iris Félyne. Milano, «Alpes», 1927, pp.
300. L. 13,50, p. 16.
Dopo aver fatto conoscere al pubblico italiano l’umorista russo Averčenko con un
piccolo volume di racconti e novelle dal titolo Rasskazy jumorističeskie, Iris Felyne
presenta Macchie di sole, apparso in Russia poco prima della guerra e noto in ambiente
slavo mediante le traduzioni in polacco, bulgaro, serbo. L’A considera ottima la
traduzione e decorosa la veste tipografica.
P. E. Pavolini, recensione a: Rozice Sv. Franciska poslovenil in uvod
napisal Alojzij Res. V. Gorici, 1927, pp. XII-176, p. 16.
•
Dopo il bel volume in lingua slovena su Dante uscito in occasione del centenario
del poeta, Res pubblica una traduzione dei Fioretti di San Francesco. L’A. ne evidenzia
le note esplicative e la breve bibliografia di complemento.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Arturo Lancellotti. Tolstoi intimo.
L’ uomo, l’ artista, il pensatore. Roma, Prof. P. Maglione Editore, 1928,
pp. 266. L. 14, p. 288.
L’A. specifica che il titolo del volume delude il lettore poiché solo in minima parte
descrive momenti legati alla vita intima dello scrittore preferendo, invece, riassumere
la trama dei suoi più celebri romanzi.
XI, 2:
132
• E. Damiani, recensione a: Otto Cuzzer. Leone Tolstoj. Roma,
Anonima Romana Editoriale, 1928. Un vol., di pp. 79, L. 7 (Pubbl. dell’
Istituto per l’ Europa Orientale), p. 38:
Giudizio positivo dell’A. sul volume dedicato a Tolstoj; pur senza aggiungere
nulla di nuovo a quanto si conosceva già del celebre scrittore, lo slavista riconosce il
valore divulgativo del saggio, scritto in una forma concisa e ricco di note esplicative ed
osservazioni personali di Cuzzer.
XI, 3:
• L. Kociemski, recensione a: Fjodor Dostoevskij. I Demoni (Bjesy).
Romanzo in tre parti. Seguito dalla Confessione di Stavroghin. Prima
versione integrale e conforme al testo russo con note di Alfredo Polledro
(Collezione «Il Genio russo»). Torino, «Slavia», voll.3. L. 38, pp. 71-72.
Dopo una analisi psicologica dei personaggi del romanzo di Dostojevskij, l’A.
continua a lodare le traduzioni dal russo firmate da Polledro, esaltandone la scrupolosa
e fedele aderenza al testo originale. Un merito viene, infine, riconosciuto, alla Casa
editrice Slavia, i cui primi dodici volumi sono stati esauriti e di cui si chiede già la
ristampa.
XI, 4:
L. Kociemski, recensione a: Wladislaw St. Reymont. I contadini.
Romanzo. Vol. I – L’ Autunno. Prefazione di Taddeo Zielinski.
Traduzione dal polacco di Beniamino Aurora (Premio Nobel 1924).
Aquila, Casa Editrice Vecchioni, (Collezione di scrittori italiani e
stranieri diretta da Mario Speranza), pp. 421, L. 12, p. 100.
•
Breve segnalazione del primo volume del romanzo Chłopy di Władysław
Reymont meglio conosciuto ai lettori come “l’epopea contadina”. L’A. elogia la
dignitosa veste editoriale con qualche appunto sulla scelta di Aurora di trascrivere il
nome dello scrittore polacco seguendo grafia e pronuncia russe.
L. Kociemski, recensione a: Vladimir Nazor. La leggenda di S.
Cristoforo. Romanzo. Traduzione dal serbo-croato dell’autore.
Prefazione di Umberto Urbanaz-Urbani. Aquila, Casa Editrice
Vecchioni, 1928, pp. 100. L. 5, p. 100:
•
Breve presentazione del romanzo del dalmata Vladimir Nazor, ancora poco noto
fra gli slavisti italiani come gran parte della letteratura serbo-croata e slovena. L’A.
esalta la traduzione italiana firmata dallo stesso Nazor.
XI, 5:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Lev Tolstoj. Resurrezione
(Voskresjènje). Romanzo in tre parti. Versione integrale e conforme al
133
testo russo con note di Valentina Dolghin – Badoglio. Collezione «Il
Genio Russo». Torino, Slavia, 1928, pp. 333 e 320, voll. 2, L. 24, p. 129.
Nell’anno di celebrazione del centenario della nascita di Lev Tolstoj l’A.
presenta il romanzo dello scrittore pubblicato per la collezione “Il Genio Russo”
sottolineandone l’ottima traduzione italiana eseguita da Valentina Dolghin-Badoglio ed
evidenziando alcuni tratti tipici dei personaggi.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Fjodor Dostojevskij. Gli Ossessi.
Romanzo. Traduzione dal russo di Olga Resnevic. Con prefazione e
cenni biografici. Foligno, Campitelli, 1928, 3 voll. L. 32, p. 129.
L’A. sottolinea la fedele e accurata traduzione, completata con alcuni frammenti
recentemente pubblicati dall’Archivio centrale sovietico e conservati dalla moglie di
Dostoevskij, e segnala l’ampia notizia bio-bibliografica sullo scrittore che precede il
romanzo.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Antonio Ferdinando Ossendowski,
L’Aquilessa. Romanzo della vita dei montanari dell‘Alto Atlante.
Traduzione autorizzata dall’originale polacco di Alessandro Koltonski.
Milano, Morreale, 1928, pp. 246. L. 9 - Id., L’Ombra dell’Oriente
Tenebroso (Dietro le quinte della vita russa). Unica traduzione
autorizzata (dall’ originale polacco) a cura di Alessandro Koltonski.
Milano, Morreale, pp. 238. L. 9, pp. 129-130.
Dopo precedenti lavori del prof. Ossendowski, l’editore Morreale pubblica adesso
due volumi; il primo introduce il lettore nella pittoresca quotidianità dei montanari
dell’Alto Atlante, descrivendone usanze e costumi, il secondo, frutto di un’esperienza
di vita dello stesso autore, fa conoscere in profondità la Russia e il suo popolo, dai
palazzi imperiali ai villaggi della Russia Centrale, con particolare attenzione agli
avvenimenti accaduti dopo 1917.
XI, 6:
• P. E. Pavolini, recensione a: E. Lo Gatto. Storia della letteratura
russa. Vol. I. Roma, Anonima Romana Editoriale, 1928, pp. XII-294. L.
20 (Pubblicazione dell’ «Istituto per l’ Europa orientale»), p. 150.
L’A. presenta il primo dei quattro volumi di Lo Gatto, dedicati alla storia della
letteratura russa, relativo al periodo che va dalle origini a tutto il secolo XVI,
annunciandolo come il primo lavoro del genere in Italia dopo le storie letterarie di
Krapotkin [Kropotkin] del 1920 e di Veselovskij, tradotto da Damiani, del 1927. Il
critico sottolinea la preparazione scientifica e la profonda erudizione con cui lo slavista
affronta la sezione dedicata alla letteratura orale.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Leone Tolstoj. Memorie: Infanzia,
Adolescenza, Giovinezza. Traduzione, introduzione, note, analisi,
biografia e bibliografia a cura di Ettore Lo Gatto. Firenze, Le Monnier,
pp. 340. L. 10, p. 157.
Il volume presenta l’ennesima traduzione di scritti tolstojani. L’A. coglie
l’occasione per elogiare ancora una volta la fedele traduzione dal russo di Lo Gatto
che, in una pagina del suo volume, fornisce alcune prove dell’’arbitrarietà’ di certi
traduttori poco scrupolosi, che si allontanano dal testo originale.
134
• Leonardo Kociemski, recensione a: Anton Cechov. La mia vita e altri
racconti. Versione integrale e conforme al testo russo con note di G.
Faccioli. Torino, «Slavia», 1928, pp. 292, L. 11, p. 158.
Un altro volume dedicato a traduzioni dal russo arricchisce la collana “Il Genio
Russo”; l’A. ne loda la versione italiana firmata da Giovanni Faccioli e corredata da
note esplicativa pur evidenziando l’assenza di un’introduzione bio-bibliografica.
XI, 8:
• E. Damiani, recensione a: Casimiro Andrea Czyzowski. Maciek I, re
dell’ aria. Traduzione autorizzata dal polacco di Irena M. Boni.
Bologna, L. Cappelli, 1928, di pp. 125. L. 5, pp. 209-210.
Si tratta di un originale romanzo moderno per bambini, la storia fantastica e
avventurosa di un piccolo eroe che guida un aeroplano e sfida pericoli per eseguire
un’importante e delicata missione militare per conto del padre malato: recapitare
alcune missive segrete al re di Romania e al califfo turco. Ottima, secondo l’A., la
forma italiana.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Lev Tolstoi. La tempesta di neve
ed altri racconti. Versione integrale e fedele di Ada Prospero. “Il Genio
Russo”. Torino, Casa Editrice «Slavia», 1928, II edizione, pp. 300. L.
11, p. 215.
Si tratta della ristampa di cinque racconti per onorare il centenario della nascita
dello scrittore che, secondo l’A., come tutte le seconde edizioni prodotte da Slavia, è
più curata della precedente.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Ivan Turgheniev. Padri e figli.
Romanzo. Versione integrale e conforme il testo russo con note di
Giuseppe Pochettino. (Collezione “Il Genio Russo”). Torino, Casa
Editrice “Slavia”, 1928, pp. 265, L. 10, p. 215.
Presentando il volume l’A. coglie l’occasione per lodare ulteriormente la casa
editrice Slavia per la sua organizzazione e per la scelta dei criteri artistici adottati dai
collaboratori. Infine, considera fedele la versione italiana firmata da Pochettino.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Ivan Gonciaroff. Oblomof. Unica
traduzione di Olga Malavasi-Arpshofen. Bologna, Cappelli, 1928
(Collezione “Collana d’oro”), pp. 286, L. 4,95, p. 216.
Dura critica dell’A. alla versione ridotta del romanzo di Gončarov pubblicato,
dopo un’attesa durata sessant’anni, con la soppressione di interi capitoli e con una
schematica e povera presentazione bio-bibliografica dell’autore.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Anton Cècov. Lavori drammatici
in un atto. Teatro completo. Vol I. Traduzione dal russo di Carlo
Grabher. Firenze, Vallecchi, 1928, pp. 146, L. 6,50, p. 216.
Breve presentazone di otto lavori teatrali minori, egregiamente tradotti da Carlo
Grabher, editi in un’ottima veste grafica e ritenuti fondamentali per la comprensione di
alcuni aspetti rappresentativi del teatro di Čechov.
XI, 9:
135
• L. Kociemski, recensione a: E. Lo Gatto, Letteratura Slave:
Letteratura russa. (Collezione «Omna», N. 1). Roma, Paolo Cremonese,
1928, p. 233:
L’A. presenta il volume che apre la nuova collana di cultura generale a cura di
Paolo Cremonese e che, sulle orme del precedente, costituisce un importante strumento
di consultazione bibliografica per chi voglia orientarsi fra gli scrittori russi di Ottocento
e Novecento.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Enrico Damiani, Gli albori della
letteratura e del riscatto nazionale in Bulgaria. Roma, Anonima
Romana Editoriale, MCMXXVIII, pp. 28. L. 3 – Penco Slavèjkov, Canti
epici e lirici, scelti e volti in versi italiani sul testo bulgaro da E. D. con
introduzione biografico-critica e note. Venezia, «La Nuova Italia»
Editrice, 1928, pp. 50. L. 8, p. 294.
Nel primo volume, Damiani riproduce l’interessante conferenza tenuta
all’Associazione Artistica Internazionale in occasione del cinquantenario
dell’indipendenza della Bulgaria con l’intento di promuovere la conoscenza della
produzione letteraria bulgara quasi del tutto sconosciuta in Italia. Il secondo è, invece,
una raccolta del poeta bulgaro Slavejkov, la cui traduzione in italiano viene elogiata
dall’A.
XI, 12:
• P. E. Pavolini, recensione a: E. Lo Gatto, Storia della letteratura
russa. Vol. Secondo. Le origini della letteratura moderna. Roma,
Anonima Romana Editoriale, 1928, pp. 293. L. 20, p. 314.
L’A. presenta il secondo volume di Lo Gatto sulla storia della letteratura russa,
ampiamente documentato e ricco di fonti autentiche, dedicato al periodo che va da
Pietro il Grande a Caterina II e alle grandi riforme culturali della versificazione con
Tredjakovskij, del teatro con Sumarokov e della lingua letteraria con Lomonosov.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Alessandro Pusckin. Teatro. Boris
Godunov, Il cavaliere avaro, Mozart e Salieri, Il convitato di pietra,
L’ondina. Traduzione in versi e introduzione di Rinaldo Küfferle.
Milano, Società editrice «Unitas», MCM XXVIII, pp. 300. L. 18, p. 320.
Il volume presentato dall’A. compendia quasi tutta la produzione teatrale di
Puškin, che ha dovuto attendere ben dieci anni prima di trovare un editore; il critico ne
mette in risalto l’ottima traduzione di Rinaldo Küfferle e l’esaustiva introduzione
critica.
Anno 1929
XII, 1:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Alessio Tolstoi. Il principe
Serebriany. Trad. di Muzio Demaldé e di A. Jakhontov. Firenze, Salani,
136
pp. 432. L. 5, p. 18.
Presentazione del romanzo del conte Tolstoj in una versione italiana considerata
dai curatori scrupolosa, che affronta un periodo storico decisivo per la storia della
Russia e del suo impero sorto dal piccolo ducato di Moscovia vassallo dei tartari.
XII, 3:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Lev Tolstoi. Guerra e Pace.
Romanzo. Versione integrale e conforme al testo russo con note della
Duchessa d’ Andria. (Collezione «Il Genio Russo»). Torino, «Slavia»,
1928. Edizione del centenario Tolstojano in sei volumi. Ciascun volume
L. 12, p. 87-88 :
L’A. presenta il volume definendolo una grande edizione del romanzo di Tolstoj,
dignitosa sia nell’accurata veste grafica che nella diligente traduzione dal russo,
fedelissima, secondo il critico, al testo originale.
XII, 4:
• P. E. Pavolini, recensione a: E. Lo Gatto. Storia della letteratura
russa, Volume terzo: «La letteratura moderna», I. Roma, Anon. Rom.
Edit., 1929, pp. 336. L. 20, p. 116.
L’A. presenta ai lettori il terzo volume della storia della letteratura russa di Ettore
Lo Gatto dedicato all’età moderna e al periodo che va da Alessandro I a Nicola I,
prevedendo la futura pubblicazione di ulteriori due volumi a chiusura dell’intera opera.
• Leonardo Kociemski, recensione a: I. A. Gonciarov. Oblomov.
Romanzo. Unica versione integrale con prefazione e note di Ettore Lo
Gatto. Voll. 2, Torino, «Slavia» (Collezione de «Il Genio Slavo»), 1928,
pp. 221-XXIIIe 207. L. 24, p. 124.
La traduzione dell’Oblomov firmata da Lo Gatto è fra i primi volumi della
nuovissima collezione “Il Genio Slavo” ed è considerata dall’A. un’“elegante e
diligente” versione integrale del celebre romanzo di Gončarov.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Benito Mussolini. Rzym
starozytny na morzu. Z originalu przelozyla Franciszka Szyfmanowna.
Warszawa, 1928. Nakladem Ksiegarni F. Hoesicka. Str. 84. Zl. 6. (Roma
antica sul mare. Dall’originale ha tradotto Francesca Szyfman.), p. 124.
Versione polacca della conferenza tenuta dall’On. Mussolini a Perugia, in
occasione dell’inaugurazione dell’Università Italiana per Stranieri. L’A. sottolinea
l’attenta traduzione in polacco eseguita dalla signorina Szyfmanowna, ottima
conoscitrice e divulgatrice della letteratura italiana in Polonia.
XII, 5:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Leone Tolstoj. La felicità
domestica. Trad. di E. Cadei. Milano, 1928, Prof. G. De Agostini, pp.
94, L. 3,50, p. 161.
L’A. presenta il volume, parte della collezione De Agostini “I grandi prosatori”,
137
lodando l’eccellente traduzione firmata da Erme Cadei.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Alessandro Kuprin. La fossa.
Nuova edizione completa. Trad. di E. Lo Gatto. Milano, Monanni, 1928,
pp. 324, L. 4, p. 161.
Versione integale del romanzo di Kuprin in un’edizione rinnovata a cura di Lo
Gatto; Kociemski ne sottolinea l’assoluta fedeltà all’originale rispetto ad alcune
precedenti edizioni ridotte e parziali.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Enrico Damiani, I narratori della
Polonia d’ oggi (Piccola Biblioteca Slava. A cura di Ettore Lo Gatto).
Roma, Istituto per l’ Europa Orientale, 1929, pp. 87. L. 10, p. 161.
Nel volume di Damiani vengono presentati dodici scrittori polacchi, sconosciuti
in Italia, attraverso alcuni tra i più significativi brani tratti dalle loro opere. L’A.
considera il compendio utile e prezioso per chiunque s’interessi alle letterature slave.
• Paolo Vita – Finzi, recensione a: Fiodor Dostojevskij. I fratelli
Karamazov. Romanzo in quattro parti e un epilogo. Torino, Slavia, 4
voll., L. 48, p. 161.
Si tratta della prima traduzione integrale del celebre romanzo di Dostoevskij di
cui l’A. elogia l’ottima traduzione dal russo firmata da Polledro.
XII, 6:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Venceslao Sieroszewski. Il
Diavolo straniero. Romanzo. Prima versione dal polacco con prefazione
e note di Janina Gromska («Il Genio Slavo»). Torino, «Slavia», 1929,
pp. 308. L. 10, p. 192.
Breve presentazione del volume che meglio rappresenta uno dei più noti autori
polacchi, Wacław Sieroszewski. Il romanzo, come nella maggior parte delle sue opere,
narra il fascino e il mistero dell’Estremo Oriente frutto di un’esperienza di vita fatta
dall’autore in quei luoghi. L’A. loda l’ottima traduzione italiana firmata da Janina
Gromska.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Fjodor Dostojevskij. Le notti
bianche. Nietocka Njezvanona. Versione integrale dal russo con note di
Leone Savoj. Torino, “Slavia” (Collezione «Il Genio russo», 1929,
pp.312, L. 11, p. 192.
Breve nota bibliografica dell’A. sulla pubblicazione del romanzo di Dostoevskij
in una piacevole e scorrevole traduzione italiana.
XII, 7:
• L. Kociemski, recensione a: Nikolaj Ljeskov. La donna bellicosa.
Racconti. Prima versione dal russo con pref. e note di Maria Silvestri–
Lapenna ("Il genio slavo”). Torino, Casa Editrice «Slavia», 1929, pp.
332. L. 11, p. 222.
Breve presentazione del romanzo di Leskov con un’eccellente traduzione italiana
138
firmata da Maria Silvestri-Lapenna.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Fiodor Dostoevskij, La voce
sotterranea; Ivan Bunin, Il villaggio; Ivan Schmeliov, Memorie di un
cameriere; Massimo Gorkij, Varenka Olessova (Collezione «Scrittori
italiani e stranieri» in versioni originali e dirette). Milano, S. A. E.
«Delta», 1928-29. Ogni volume lire 2, p. 222
Breve segnalazione bibliografica dell’A., che coglie l’occasione per segnalare ai
lettori l’interessante iniziativa della Casa editrice milanese “Delta”, meritevole di aver
saputo conciliare il costo editoriale, piuttosto modesto, con le esigenze estetiche della
veste grafica.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Wincenty Rzymowski. Sygnaly
historji (I segnali della storia). Warszawa, 1929, Nakladem ksiegarni F.
Hoesicka, pp. 222, p. 222.
Raccolta di studi e articoli dello studioso e critico polacco Rzymowski dedicati
alla letteratura italiana.
XII, 11:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Marco Slonim. Storia delle
rivoluzioni in Russia. Casa Editrice Monanni, Milano, 1929, pp. 286. L.
10, p. 323.
Breve nota bibliografica sulla seconda edizione del saggio di Slonim sulla
rivoluzione russa, utile per comprendere i fatti che portarono all’affermazione del
bolscevismo. L’A. considera molto dignitosa la veste editoriale.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Fjodor Dostojevskij. Lettere.
(Collezione «Cultura dell’anima». Traduzione e prefazione di Olga
Resnevic. R. Carabba, Lanciano, pp. 146. L. 5, p. 326.
Volume dedicato alle lettere scritte da Dostoevskij durante il soggiorno in Siberia
e successivi al suo arresto nel 1849. L’A. ne evidenzia l’eccellente traduzione di Olga
Resnevič e il breve profilo biografico introduttivo.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Juljusz Kaden – Bandrowski. La
città di mia madre. Traduzione di Enrico Damiani. «La Nuova Italia»
Editrice, Perugia, 1929, pp. 150, L. 10, p. 326.
Breve presentazione del romanzo autobiografico di Juliusz Kaden-Bandrowski
dedicato alle memorie della prima infanzia.
XII, 12:
• Gius. A. Andriulli, recensione a: Ferdinando A. Ossendowski, Lenin,
traduzione dall’originale polacco e introduzione di Leonardo Kociemski.
Milano, «Corbaccio», 1929, pp. 775 con 26 illustrazioni. L. 30, p. 354.
Il volume di Ossendowski sulla vita di Lenin viene presentato sall’A. come un
“romanzo tout court”, a sfondo storico e con tono polemico, accattivante alla lettura ma
lontano dalla sostanza dei fatti, spesso arbitraria e poco verosimile.
139
Anno 1930
XIII, 1:
• P. E. Pavolini, recensione a: M. Weingart, Introduzione bibliografica
allo studio della Slavistica. Traduz. dal ceco di W. Giusti. Udine, Libr.
Editr. «Aquileia», 1929, pp. 95, p. 10.
Breve segnalazione bibliografica di un recente e utile manuale di consultazione e
orientamento nella slavistica contemporanea.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Kazimierz Wierzynski. Lauro
Olimpico. Poesie tradotte dal testo polacco da Enrico Damiani. «La
Nuova Italia» Editrice, Venezia 1929, pp. 345. L. 6, p. 18.
Si tratta di quindici poesie premiate con medaglia d’oro alla IX Olimipiade, di cui
l’A. elogia la bella e fedele traduzione dal polacco eseguita da Damiani.
• Leonardo Kociemski, Anton Cechov. La camera N. 6. Racconti.
Versione integrale dal russo con note di G. Faccioli. Torini, Slavia,
1929, pp. 280. L. 10, p. 19.
Breve presentazione del volume di racconti di Čechov, abilmente tradotti in
italiano da Giovannio Faccioli per Slavia.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Fjodor Dostojevskij. Un brutto
aneddoto. Traduzione di Iris Felyne. Milano, Edizioni “Maia”, 1929, pp.
188. L. 5, p. 19.
Breve riassunto del racconto, che costituisce un quadro fedele dell’ambiente
burocratico dell’epoca attraverso l’analisi dei rapporti che intercorrevano tra ‘superiori’
e ‘sudditi’. L’A. considera eccellente la versione italiana eseguita da Iris Felyne.
• Paolo Vita – Finzi, recensione a: Anton Cechov. Era lei!…Novelle
umoristiche. Versione integrale dal russo di Giovanni Faccioli. Torino,
Slavia, 1929. L. 11, p. 19.
Raccolta di più di cinquanta novelle umoristiche di Čechov, edite per la celebre
collezione “Il Genio russo”. Paolo Vita-Finzi fa notare l’assenza di una prefazione biobibliografica al volume e di un’ esatta indicazione delle fonti.
XIII, 3:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Nicola Gogol. Le veglie alla
fattoria presso Dikagnka. Racconti. Versione integrale dal russo con
note di V. Dolghin – Badoglio. «Slavia», Torino, 1929, pp. 314, L.11, p.
76.
Brevissima nota bibliografica di Kociemski relativa al volume delle Veglie di
Gogol’, di cui il critico elogia l’ottima traduzione.
XIII, 4:
140
• L. Kociemski, recensione a: Fjodor Dostojevskij. Il sogno dello zio.
Romanzo Umoristico. Prima versione integrale dal russo di Alfredo
Polledro. Torino, «Slavia» («Il Genio Russo»), 1930, pp. 268. L. 10.
Il volume, curato e tradotto da Polledro, si distingue sia per il il rigore filologico,
sia per l’elevato valore artistico, arricchendo ulteriormente l’intensa attività editoriale
di Slavia.
• L. Kociemski, recensione a: Marco Aldanov. Sant’ Elena piccola
isola. Romanzo. Traduzione dall’originale e introduzione di Rinaldo
Kufferle. (Biblioteca Russa a cura di Rinaldo Kufferle). Milano, Bietti,
1930, pp. 205. L. 5, p. 106.
L’A. presenta il volume con una brevissima introduzione sulla tecnica narrativa di
Aldanov e sulla capacità di conciliare la storia con la fantasia, sottolineando l’ottima
traduzione di Küfferle.
L. Kociemski, recensione a: Leonardo Da Vinci. O malarstvie (Della
pittura), wybor i przeklad Leopolda Staffa – Sw. Franciszek z Assyzu.
Kwiatki (Fioretti) Wybor i przeklad L. Staffa. «Pantheon»
Wydawnictwo J. Mortkowicza, p. 106.
•
Breve introduzione dell’A. alla personalità di Leopold Staff, poeta nonché abile
traduttore di opere letterarie dall’italiano.
XIII, 8:
• L. Kociemski, recensione a: Carlo Grabher. Anton Cechov (Collezione
di Monografie di Scrittori Slavi diretta da Ettore Lo Gatto). Istituto per
L’ Europa Orientale e «Slavia», 1929, pp. 120. L. 6, p.273.
Breve presentazione della monografia di Grabher sul teatro di Čechov, opera che
inaugura un’intera collana di monografie edite da Slavia, di cui l’A. sottolinea la
puntuale menzione di tutte le opere teatrali del drammaturgo.
XIII, 9:
• P. E. Pavolini, recensione a: E. Pappacena. Gogol (1809-1852).
Milano, “Corbaccio”, 1930, pp. 719. L. 16, pp. 295-296.
L’A. evidenzia la singolarità del saggio di Pappacena sulla biografia e le opere
dello scrittore russo, che non rispetta l’ordine cronologico degli eventi ma
approfondisce quelli più rilevanti, con un riferimento all’accurata scelta delle fonti
operata dal critico.
• L. Kociemski, recensione a: Enrico Damiani. Ivan Turghenjev
(Collezione di monografie «Scrittori slavi»). I. p. E. O., Roma – Torino,
“Slavia”, 1930, pp. 156. L. 6, p. 296.
Breve segnalazione bibliografica della monografia dedicata a Turgenev dopo
quella di Čechov, che aveva inaugurato la collana; una sola osservazione viene fatta
dall’A. a proposito della mancanza di un elenco bibliografico delle opere dello
scrittore.
141
• Leonardo Kociemski, V. Veresajev. Nel vicolo cieco. Romanzo.
Traduzione di Paola Broggi Picardi. Voll. 2. Milano, Treves. L. 10, p.
302.
Nel romanzo Veresaev descrive la vicenda biografica di un rivoluzionario,
Sartanov, che, reso estraneo alla rivoluzione dal carattere stesso del movimento, ne
scopre la tragedia umana. L’A. elogia la traduzione italiana.
• L. Kociemski, recensione a: E. Isvolsky, A. Kascina. Giovinezza
rossa. Romanzo. Tradotto dal russo da R. Olkienizkaja Naldi.
(Collezione «I romanzi della vita moderna»). Firenze, Bemporad 1930,
pp. 232. L. 8,50, p. 302.
Romanzo documentario sulla vita privata della gioventù femmnile nel dopoguerra
della Russia sovietica; ottima e scorrevole, secondo Kociemski, la traduzione firmata
dalla Naldi.
• P. E. Pavolini, recensione a: J. Parandowski. Dwie wiosny. Lwów,
Wydawnictwo Zakl. Nar. Im. Ossolinskich, (s. a.). 8, pp. VII-177, p.
302.
Breve presentazione del volume del poeta classicista polacco Jan Parandowski
attraverso gli ultimi due capitoli, L’isola del Sole, dedicato alla Sicilia e ai suoi due
maggiori centri di cultura, Palermo e Siracusa, e La casa sopra la vigna, dedicato a
Capri.
• L. Kociemski, recensione a: Marja Walewska. Polacy w Paryžú,
Florencji iDreznie. Nakladem ksiegarni F. Hoesicka, Warszawa 1930 (I
Polacchi a Parigi, Firenze e Dresda).
Studio della contessa Marja Przezdziecka Walewska sulla vita degli esuli
polacchi dopo l’insurrezione del 1830 a Roma e Firenze. L’A. segnala il volume perché
ricco di molti riferimenti alla cultura italiana del periodo compreso fra la prima e la
seconda metà del XIX secolo.
• E. Formiggini – Santamaria, recensione a: M. Sibiriak. Storie d’
animali parlanti, pp. 92, p. 320:
Breve segnalazione bibliografica relativa alla raccolta di apologhi di Sibirjak sulle
continue delusioni che riserva la vita.
XIII, 10:
• L. Kociemski, recensione a: P. Romanov. Amore. Novelle. Prima
versione dal russo con prefazione e note di Margherita Silvestri
Lapenna. (Collezione «Il Genio slavo» Torino, «Slavia», 1930, pp. 330.
L. 11, p. 327.
Romanzo sul cambiamento dei rapporti sociali in Russia durante il regime
bolscevico. Particolarmente lodata dall’A. la traduzione italiana.
Anno 1931
142
XIV, 1:
• L. Kociemski, recensione a: Rocco Cartoscelli. Andreieff, Roma,
Casa del Libro Editrice, 1930, pp. 100. L. 6, p. 12:
Breve intervento dell’A. sul saggio di Cartoscelli, considerato dal critico uno
studio accurato ma privo di originalità, rivolto più alle trame delle opere dello scrittore
e drammaturgo russo che al loro significato.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Casimiro Waliszewski. Ivan il
Terribile. Traduzione di M. I. Ussi («Collezione storica») Milano,
«Corbaccio», 1930, pp. 413, illustr. E tavole. L. 22, p. 15.
Biografia dello zar Ivan il Terribile, fondatore dell’Impero e difensore
dell’ortodossia, scritta dallo storico polacco Waliszewski già autore di una monografia
su Caterina II. L’A. considera la traduzione firmata da di Ussi buona e aderente
all’originale.
• Leonardo Kociemski, recensione a: A. T. Vassiljev. La polizia segreta
degli zar. L’ Ochrana. Traduzione autorizzata di E. Pocar. Milano,
Mondadori, 1930, con 47 illustrazioni, pp. 268. L. 30, p. 15.
Il volume rappresenta il tentativo di Vassilev di riabilitare agli occhi dei lettori
la polizia segreta dello zar nota come “Ochrana”. Kociemski ne considera scorrevole
la traduzione dal russo e mette in evidenza la mancanza di obiettività dell’autore in
alcune parti della sua argomentazione.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Lev Tolstoj. Infanzia.
Adolescenza. Giovinezza. Ricordi d’Infanzia. Racconti autobiografici.
Prima versione integrale dal russo con note di Raissa Olkienizkaja –
Naldi (Collezione «Il Genio russo»). Slavia, Torino, 1930, 2 voll., pp.
258 e 296. L. 20, p. 21.
A distanza di anni dalle precedenti versioni firmate dalla Duchessa D’Andria, e
successivamente da Ettore Lo Gatto, la traduzione dei racconti di Tolstoj della Naldi
per Slavia viene considerata, oltre che definitiva, perfettamente aderente al testo
originale.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Alessandro Nevièrov. Taschkent,
Paese di cuccagna: romanzo. Traduzione di Mario Giuliàncolo. Ferrara,
Edizioni Schifanoia, 1930, pp. 240. L. 10, p. 21.
Volume dedicato agli effetti deleteri della società “soviettista” sulla vita
dell’infanzia e sui legami di famiglia. La traduzione dal russo viene considerata fedele
al testo originale.
XIV, 3:
• E. Damiani, recensione a: Mihail Bulgàkov. La guardia bianca.
Romanzo. Traduzione dal russo e introduzione di Ettore Lo Gatto
(Collezione «La Rivoluzione russa nei suoi scrittori», a cura di E. Lo
Gatto, N. 1), Roma, 1930, di pagine XVI- 320. L. 12, p. 85.
143
Dopo una breve introduzione sui rapporti tra la rivoluzione bolscevica e la nuova
letteratura di stampo realista che essa ha generato, l’A. presenta il romanzo tradotto da
Lo Gatto per la nuova collana di prosatori sovietici, sottolineandone la prefazione, che
descrive chiaramente la personalità di Bulgakov, e la versione integrale fedele al testo
originale.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Stefano Zeromski. Ceneri.
Romanzo. Prima traduzione integrale dal polacco con introduzione e
note di Cristina Agosti Garosci e Clotilde Garosci (Collezione «Il Genio
slavo» Serie polacca). Torino, «Slavia» 1930, 2 voll. L. 25, pp. 85-86.
Analisi del romanzo di Stefan Żeromski, scomparso pochi anni prima e ancora
poco noto in Italia, se non per una raccolta di novelle pubblicata da Rinaldo Caddeo e
alcuni articoli di Ettore Lo Gatto e dello stesso Kociemski. Se confrontato con Vojna i
mir di Tolstoj, Popioły servirebbe a far luce sulle divergenze religiose e spirituali tra
Polonia e Russia.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Solomon Poliakof. Il Messia senza
popolo. Romanzo. Traduzione integrale dal russo di Valentina
Preobragenska. Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1930, pp. 316. L.
10, p. 86.
Breve segnalazione bibliografica di Kociemski del volume che, tradotto in dieci
lingue, narra la vicenda d’amore riferita alla storica personalità di Sabbatai Zevi,
proclamatosi Messia del popolo d’Israele nel XII secolo.
XIV, 4:
• Enzo Palmieri, recensione a: Valentino Bulgakov. Leone Tolstoj
nell’ultimo anno della sua vita. Traduzione dal russo di V. Dolghin –
Badoglio. Foligno, Campitelli, 1931, pp. 523. L. 20, p. 116.
Si tratta di un’attenta analisi del volume sulla personalità complessa di Tolstoj
nell’ultimo anno di vita quando Bulgakov era suo ‘segretario particolare’. L’A.
evidenzia l’attenzione con cui viene descritta la quotidianità di Tolstoj uomo e artista.
• L. Kociemski, recensione a: Leone Trozkij. La mia vita. Traduzione di
Ervino Pocar. Con 13 illustrazioni. Milano, Mondadori (Collezione “Le
scie”), 1930, pp. 526. L. 40, p. 116.
Il volume viene presentato dal critico come un’autoapologia di Trockij attraverso
il confronto con la personalità di Lenin-Uljanov, dove il celebre organizzatore
dell’esercito rosso rivela indubbie qualità di narratore.
XIV, 5:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Ivan Turghenjev. Nido di nobili.
Romanzo. Versione integrale dal russo con nota di Maria Karklina («Il
Genio russo») «Slavia», Torino, 1931, un vol. di pp. 270. L. 10, p. 149.
Breve segnalazione bibliografica del romanzo di Turgenev nella versione italiana
di Maria Karklina, di cui l’A. evidenzia la perfetta aderenza al testo originale.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Lidja Sejfulina, Il burrone delle
144
Betulle. Prima traduzione dal russo e note di A. Ruska, con pref. di A.
Polledro. Torino, «Slavia», 1931, pp. 288. L. 10, p. 149.
Polledro introduce il volume con una chiara presentazione della scrittrice, ben
inserita nella pleiade dei letterati nuovi, affermando che nei suoi racconti domina il
senso di amarezza e velata delusione nei confronti della nuova realtà apportata dal
regime bolscevico.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Fjodor Dostojevskij. Delitto e
Castigo. Romanzo. Prima traduzione integrale dal russo e note di
Alfredo Polledro. Torino, «Slavia», voll. 2, pp. 332 e 324. L. 24, p. 149.
Breve interervento dell’A. sul celebre romanzo di Dostojevskij, di cui segnala la
fedele traduzione di Polledro.
• Leonardo Kociemski, recensione a: E. A. Nagrodscaia, Tatiana
Alexandrovna. Traduzione integrale dal russo di Marussia Grigorieva e
Mario Visetti. Milano, Edizioni «La Prora», pp. 307. L. 9, p. 149:
Romanzo sulla complicata psiche della donna russa, di piacevole lettura ma,
secondo l’A., senza particolari meriti artistici.
XIV, 6:
• Enrico Damiani, recensione a: Michele A. Bulgakof. Le uova fatali.
Romanzo. Traduzione dall’ originale russo di Umberto Barbaro e Liubof
Uspienscaia. Lanciano, R. Carabba, 1931 («Antichi e moderni»), pp.
157. L. 6, p. 182.
L’A. presenta lo scrittore russo, già introdotto da Ettore Lo Gatto nella “Rivista
di letterature slave” del 1929 e da Valentina Dolghin-Badoglio nella sua traduzione del
volume su Tolstoj del 1931, attraverso il celebre romanzo.
• L. Kociemski, recensione a: Benito Mussolini. Pamietnik z czasow
wojny. Przeklad autoryzowany Jozefa Birkenmajera. Z 19 ilustracjami.
Poznan, pp. 191. Widawnictwo Polskie R. Wegnera. (B. M. Il mio diario
di guerra. Trad. autorizzata di G. Birkenmajer), p. 182.
L’A. presenta la traduzione polacca delle memorie di Mussolini quando si trovava
sul fronte di guerra, lodandone la veste editoriale e il ricco repertorio fotografico. Un
appunto viene mosso all’assenza di note illustrative intorno agli avvenimenti svoltisi
nelle zone di guerra di cui parla Mussolini.
XIV, 7:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Elisabeth Narischkin Kurakin.
Sotto tre czar. Memorie di una Marescialla di corte, pubblicate da R.
Fülop Miller. Traduzione dal tedesco di Luigi Bandini. Con 38
illustrazioni. Firenze, R. Bemporad & F. o Editori, 1931, pp. 252. L. 15,
p. 204.
Saggio sulle figure più rappresentative del XIX secolo alla vigilia del crollo della
monarchia russa, una storia romanzesca non falsata di cui l’A. sottolinea l’ottima
145
traduzione e l’interessante veste editoriale.
XIV, 8:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Sergio Platonov. Boris Godunov.
Traduzione autorizzata di M. I. Ussi. Milano, Edizioni Corbaccio.
(Collezione storica), 1931, pp. 252. L. 15, p. 227.
Interessante monografia su una delle principali figure del medioevo russo, passato
alla storia come “bieco tiranno e intrigante canaglia”, di cui Platonov rivela con un
ottimo metodo d’indagine e in sintesi la lungimirante opera di statista e monarca
intelligente, capace d’imporsi e di superare l’incomprensione generale dei bojari e
l’invidia dei principi.
• Enrico Damiani, recensione a: A. Kuprin. Il mal di mare e altri
racconti. Tradotti dall’ originale russo da Maria Rakowska e Giuseppe
Pochettino (Collezione «Antichi e Moderni», N. 72), Lanciano, R.
Carabba, 1930. Un vol. di pp. 197. L. 6 – L’ uomo della strada.
Racconti. Versione integrale dal russo di Silvio Polledro. Con saggio
introduttivo di Pjotr Pilskij (Collezione «Il Genio Slavo», N. 18. Serie
russa, N. 11). Torino, «Slavia», 1931. Un vol. di pp. XX-297.L. 10, p.
232.
Doppia raccolta di scritti di Kuprin, editi quasi contemporaneamente, che insieme
al racconto Jama, già da anni tradotto e pubblicato, forniscono al lettore un quadro
completo della personalità dell’artista; l’introduzione, tratta dalle opere del critico
Pilskij, è secondo l’A. la più originale che sia mai stata scritta.
• L. Kociemski, recensione a: Wladislaw Reymont. La morte del bosco.
Novelle. Prima versione dal polacco con prefazione e note di Janina
Gromska. («Il Genio slavo»). «Slavia», Torino, 1931, pp. 306. L.10, p.
232.
Breve segnalazione del volume che contiene undici novelle di Reymont,
prematuramente scomparso dopo il conseguimento del premio Nobel. L’A. loda
l’ottima traduzione di Janina Gromka e l’interessante introduzione ricca di un
notiziario bio-bibliografico.
XIV, 9:
Leonardo Kociemski, recensione a: Casimir Tetmajer. L’Angelo della
morte. Traduzione integrale dal polacco di M. Grigorieva e M. Visetti.
Milano, Edizioni «La Prora», pp. 340. L. 9, p. 255:
•
Breve presentazione del romanzo di Kazimierz Tetmajer tradotto in italiano
piuttosto tardi, dopo la traduzione di Bezdna di Leonid Andreev eseguita da Maria
Rygier. L’A. segnala la fedele traduzione e la curata veste grafica.
• Leonardo Kociemski, recensione a: A. Verbitscaia. Guai ai caduti.
Guai ai viandanti. Trad. integrale dal russo di M. Grigorieva e M.
Visetti. Milano, «a Prora» pp. 333. L. 9, p. 255:
146
Fedele ricostruzione della vita intima di una donna incompresa e ribelle
nell’ambiente piccolo-borghese della Russia zarista.
XIV, 11:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Leone Lunts. Fuori legge:
tragedia in 5 atti. Traduzione di Ettore Lo Gatto, prefazione di M. Gorkij
– La città della verità: dramma in 3 atti. Trad. dal russo e introd. di
Ettore Lo Gatto. Roma, Anonima Romana Editoriale, ‘Collezione del
Teatro russo contemporaneo’, p. 317.
I volumi tradotti e curati da Lo Gatto, secondo l’A., non riescono a rendere la
totalità di Lunc drammaturgo e fondatore del circolo letterario sovietico dei “Fratelli
Serapioni”, tuttavia trasmettono la convinzione dello scrittore di dover mantenere la
tradizione letteraria russa indipendente da qualsiasi ideologia politica.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Nicola Kolokolov. Miele e
sangue. Traduzione di Olga Resnevic. Collezione «I romanzi della
guerra», Milano, Mondadori, 1931, pp. 300. L. 10, p. 317.
L’A. presenta il volume dedicato al periodo più interessante nella storia della
Russia zarista, la dichiarazione di guerra del 1914, antivigilia della rivoluzione
bolscevica, evidenziando il realismo con cui Kolokolov descrive i tragici eventi. Un
particolare elogio alla traduzione italiana di Olga Resnevič.
Anno 1932
XV, 3:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Nicola Evreinov. Il teatro della
guerra eterna. Dramma in tre atti e quattro quadri. «Collezione del
teatro comico e drammatico». Firenze, «Nemi», pp. 140. L. 3, p. 87.
Breve contributo sul teatro di Evreinov, innovativo nella Russia prebolscevica, e
sul dramma che dà il titolo al volume e che fa parte di una trilogia teatrale insieme alla
commedia Samoe glavnoe e al dramma Korabl’ pravednych, più volte rappresentato in
Italia col pieno consenso della critica.
XV, 5:
• Enrico Caprile, recensione a: K. M. Ciapek-Chod. La Turbina.
Traduzione ed introd. di J. Torraca Vesela. Torino, «Slavia», 1931, 2
voll., pp. XIII-307 e 307, L. 20, p. 150.
Breve introduzione a Čapek–Chod come figura di primo piano nella letteratura
boema moderna, influenzata dal romanzo psico-sociale russo e francese. Segue la
presentazione del romanzo Turbína, insignito del Premio letterario di Stato
cecoslovacco, meticoloso nelle descrizioni dei personaggi e avvincente nei suoi tratti
barocchi e fantastici. Lode, infine, alla traduzione italiana arrichita da un’introduzione
critico-bibliografica.
147
• L. Kociemski, recensione a: V. Lidin. Apostata. Romanzo. Traduzione
autorizzata dal russo di Nina Romanowsky. Milano, Alberto Corticelli,
1932, pp. 316. L. 10, p. 150.
Breve presentazione di Lidin, considerato dalla critica più un “compagno di
strada” che rappresentante della nuova letteratura, e del suo romanzo, tradotto da Nina
Romanovskaja, che descrive aspetti vari della Russia sovietica.
XV, 7:
• Enrico Damiani, recensione a: Ivan Turghènjev. Nido di Nobili. A
cura di Leone Ginzburg. Torino, Unione Tipografico – Editrice
Torinese. Un. Vol. di pag. 218. L. 10 (Collezione «I Grandi Scrittori
stranieri» di Arturo Farinelli dell’ Accademia d’ Italia).
L’A. presenta una nuova versione del capolavoro di Turgenev dopo la precedente
edizione di Slavia; se ne individuano le tematiche sociali comuni ad altri romanzi dello
scrittore russo, come la condanna della servitù della gleba. Un cenno, infine, alla breve
prefazione curata da Leone Ginzburg.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Henryk Sienkiewicz. L’organista
di Ponikla. Racconti. Prima traduzione integrale dal polacco di Maria
Karklina con prefazione di Alfredo Polledro e note («Il Genio slavo»).
Torino, «Slavia», 1932, pp. 303. L. 10, p. 212.
Presentazione della raccolta del celebre romanziere all’inizio della sua carriera;
l’A. evidenzia la buona versione dal polacco eseguita da Maria Karklina e l’ottima
introduzione di Polledro.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Ks. Dr. Tadeusz Kruszynski. Zloty
okres sztuki sycylijeskiej. Warszawa – Krakow, Ksiegarnia J.
Czerneckiego, pp. 126,p. 212.
Il volume dello storico d’arte Krusiński, dedicato al „secolo d’oro“ dell’arte
siciliana, contiene un saggio che guida il lettore polacco alla ricerca dei documenti
artistici sparsi negli edifici religiosi e civili dell’isola, evidenziando l’opera del
Fascismo per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico della Sicilia.
XV, 9:
• E. Formiggini Santamaria, recensione a: N. Polonskaja. Le rose rosse
(fiabe). Milano, Corticelli, 1931, pp. 123, illstr., p. 255.
Contributo dell’A. sul volume di fiabe di N. Polonskaja, di cui sottolinea
l’elegante veste grafica.
• Enrico Damiani, recensione a: I. Babel. L’ armata a cavallo.
Traduzione dal russo di Renato Poggioli. Torino, Frassinelli Tipografo
Editore, 1932, pp. XXVIII-241. L. 15, p. 260.
L’A. presenta la prima edizione italiana integrale dei trentaquattro brevi racconti
di Babel’ che ritraggono con realismo la vita negli anni tragici della rivoluzione. Lo
slavista ne mette in rilievo l‘ottima traduzione e l’originale veste tipografica.
148
• Leonardo Kociemski, recensione a: Giuseppe Ruggiero. Canti
popolari dei buriati di Alar. Traduzione e note – Napoli, Edizione E. V.
A., 1932, pp. 56. L. 10, p. 260.
Contributo sul saggio di Ruggiero, premiato dal Regio Istituto Orientale di
Napoli, che cerca di trasmettere il fascino primitivo e il sentimento nostalgico dei canti
buriati in una veste tipografica sobria ed elegante.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Luigi Salvini. Canti popolari
polacchi. Traduzione, introduzione e note per cura dell’Istituto per
l’Europa Orientale, pp. 114. L. 5, pp. 260-261.
Lode dell’A. a Luigi Salvini, meritevole di aver finalmente fatto conoscere in
Italia i canti popolari polacchi in una diligente traduzione italiana arricchita da
un’esauriente introduzione critica.
XV, 12:
• Enrico Damiani, recensione a: Ivan Turghènjev. Lo spadaccino.
Racconti. Prima versione integrale e conforme al testo russo di Maria
Kàrklina. Torino, «Slavia», 1932, pp. 277. L. 10 (Collezione «Il Genio
russo»), pp. 352-353.
Si tratta di quattro racconti scritti durante il primo periodo dell’attività letteraria
fra il 1846 e il 1850, che Damiani presenta come ulteriore conferma di Turgenev
“psicologo dell’animo umano” e “pittore della quotidianità”.
• Leonardo Kociemski, recensione a: Giovanni Gentile, Reforma
wychowania. (La riforma dell’educazione). Bibljoteka przekladow
pedagogicznych. Lwow-Warszawa, Ksiaznica Atlas, 1932, p. 353.
Traduzione polacca delle conferenze tenute dal sen. Gentile al corso
pedagogico a Trieste nel 1919. Il volume è stato accolto favorevolmente dalla critica
letteraria in Polonia.
Anno 1933
XVI, 1:
• Leonardo Kociemski, recensione a: Panteleimon Romanov. Tre paia
di calze di seta. Romanzo russo. Traduzione dal russo di Lia Neanova e
Iris Felyne. Milano, Bietti, pp. 252. L. 5, pp. 22-23.
Breve contributo sul romanzo dello scrittore della Russia sovietica
maggiormente legato alla tradizione e le cui opere sono una realistica testimonianza del
travaglio vissuto dal popolo russo durante la rivoluzione. Il critico considera
particolarmente fedele la traduzione dal russo eseguita da Lia Neanova.
XVI, 2:
149
• Enrico Damiani, recensione a: A. S. Gribojèdov. La disgrazia di
essere intelligente. Traduzione e prefazione di L. Savoj, con disegni di
Pietro Parigi. Roma, A. F. Formiggini, 1932, pp. 249. L. 10. «Сlassici
del ridere» n° 93, pp. 54-55.
L’A. presenta la commedia di Gridoedov come un ulteriore esempio della
diffusione in Italia di traduzioni dal russo eseguite direttamente dall’originale e
confronta la versione poetica di Verdinois, risalente a qualche anno prima, con quella
di Savoj considerata più fedele; il critico menziona, infine, l’ampia presentazione dello
stesso Savoj al volume.
XVI, 5:
• E. Formiggini-Santamaria, recensione a: M. Konopnicka. Canzoni per
bambini. Torino, Paravia, 1932-33, p. 62, L. 6,50, p. 145.
Collezione di vecchi e nuovi scritti per fanciulli di M. Konopnicka pubblicati
negli ultimi anni.
XVI, 12:
• Enrico Damiani, recensione a: Lev Tolstoj. La tempesta di neve.
Traduzione di Ada Prospero, 3° edizione riveduta (Collezione «Il Genio
Russo», vol. 5°, Serie II, 1). Torino, «Slavia», pp 264. L. 6, p. 361.
Contributo sull’ultima edizione del volume di racconti, migliorata rispetto alla
prima. Il volume contiene: Smert’ Ivana Il’iča, Metel’, Polikùska, Cholstomjèr, Al’bert.
Anno 1934
XVII, 1:
• Enrico Damiani, recensione a: F. Dostojevskij. Il sosia. Racconti.
Prima traduzione integrale e conforme al testo russo, con note di Carol
Straneo. Collezione: «Il Genio Russo», vol. 55, Serie I, 16. Torino,
«Slavia», pp. 259. L. 8, p. 24.
Il volume presentato contiene uno fra i lavori più audaci e meno fortunati di
Dostoevskij sulla personalità umana; l’A. ne evidenzia la scorrevole e fedele traduzione
firmata da Carol Straneo.
• Enrico Damiani, recensione a: Mieczyslaw Brahmer. Wlochy.
(“Bibljoteka Szkoly Powszechnej”, N° 79). Lwów, Wyd. Ksiazek
Szkolnych, 1933, pp. 34. Zl. 0,50, pp. 24-25.
Volume dedicato alla cultura italiana e ai suoi rapporti con la Polonia, parte di una
collana intesa a presentare in forma semplice e per mezzo di piccole monografie gli
argomenti principali della cultura polacca e universale.
XVII, 2:
150
• Enrico Damiani, recensione a: Anton Cechov. Un delitto. Racconti.
Prima versione integrale e conforme al testo russo, con note di Giovanni
Faccioli (Collezione “Il Genio russo”, 56, serie V, 8). Torino, “Slavia”,
1934, pp. 325. L. 10, p. 58.
Breve contributo sul volume di racconti di Čechov di cui l’A. evidenzia la
buona versione di Faccioli e la decorosa edizione a stampa curata di Slavia.
• Enrico Damiani, recensione a: Ivan Bunin, Il villaggio (Campagna).
Romanzo. Prima versione integrale dal russo e note di Valentina
Dolghin Badoglio. Con pref. di Renato Poggioli III ed. (Collezione “Il
Genio Slavo”, 12, serie russa 8). Torino, “Slavia”, pp. 304. L. 10, p. 58.
L’A. presenta il romanzo di Bunin, opera solida e organica nella sua descrizione
realistica della società russa dell’anteguerra, evidenziandone la buona e scorrevole
traduzione di Valentina Badoglio e la limpida prefazione di Poggioli.
XVII, 3:
• Enrico Damiani, recensione a: Alessandra Tolstoj. La mia vita col
padre. Trad. autorizzata dall’originale russo di Nina Kessler. Milano,
Corticelli, 1933, pp. 446, L. 22, p. 90.
A parte qualche menda stilistica rilevata nella traduzione dall’originale russo,
eseguita in parte sul manoscritto, relativa a singoli termini, l’A. evidenzia la precisione
con la quale la figlia di Tolstoj ha annotato episodi di vita privata del padre. L’edizione
viene considerata buona e decorosa.
VII, 4:
• E. Damiani, recensione a: Ivan Bunin. Il Signore di San Francisco.
Racconti. Prima versione dal russo con note di Alfredo Polledro (Coll.
“Il Genio Slavo”, 28, Serie Russa, 17). Torino, «Slavia», 1934, pp. 285.
L. 10, p. 121.
A distanza di qualche settimana dalla 3° edizione di Derevnja edita da Slavia
l’A. presenta un altro volume contenente dieci racconti di Bunin, tradotti da Polledro, a
testimonianza della popolarità suscitata dallo scrittore russo, recentemente insignito del
premio Nobel.
XVII, 7:
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Grigol Robakidze. Le trecce di Medea.
Traduzione di Ervino Pocar. Milano, Sperling e Kupfer («Pandora» Voci
di tutti i popoli, 4), 1934, pp. 222. L. 10, p. 214.
L’A. sottolinea l’influenza della letteratura russa, di Byron e dell’Odissea nel
romanzo dello scrittore georgiano.
• Enrico Damiani, recensione a: Lev Tolstoj. Il cadavere vivente.
151
Drammi e commedie. Prima versione integrale e fedele della Duchessa
D’Andria. Torino, «Slavia», 1934. Un vol. di pp. 355. L. 10, p.214.
L’A. menziona il terzo volume dell’edizione completa delle opere postume di
Tolstoj pubblicata da Slavia, una raccolta di scritti a sfondo sociale dove tematiche di
natura psicologica s’intrecciano con episodi autobiografici.
• Enrico Damiani, recensione a: Russia rossa che ride. Novelle e
aneddoti sovietici. Trad. e notizie sugli autori di Alfredo Polledro. Pref.
di Lorenzo Gigli. Torino, «Slavia». Un vol. di pp. XV-352. L. 10, p.
214.
La presentazione del volume curato da Polledro viene preceduta da un breve
intervento dell’autore sul significato del “riso” nella cultura popolare russa. La raccolta
contiene venticinque novelle rappresentative della natura tragicomica dell’umorismo
russo, alternate con cinquanta piccoli aneddoti.
Anno 1935
XVIII (1935), 1:
• E. Formiggini Santamaria, recensione a: A. Jakovliev. Il cacciatore in
pelliccia. S. d., pp.50. L. 1,50 - L. Tolstoi. Il prigioniero del Caucaso ed
altri racconti. S. d., pp. 121. L. 2,50. Milano, «Est», p. 13.
L’A. presenta due volumi di racconti ben adattabili alla letteratura per l’infanzia;
nel primo caso si tratta delle avventure di un piccolo orso bianco che vive sul pack e fa
le prime esperienze di vita fuori dalla tana di ghiaccio; nel secondo, oltre alla vicenda
di un russo fatto prigioniero dai Tatari, si tratta di una raccolta di parabole e novelle a
spunto evangelico.
• Giovanni Costa, recensione a: N. Moscardelli. Dostoievski. Modena
Guanda, 1935, pp. 464. L. 15, p. 249.
L’A. introduce il saggio su Dostoevskij con un riferimento alla personalità
dell’autore, la cui “sensibilità cristiana” e l’”accorato senso di umanità” gli permettono
di accostarsi all’animo e alla filosofia dello scrittore russo.
XVIII, 3:
• E. Damiani, recensione a: Alja Rachmanowa. Studenti, amore, Ceka e
morte. Traduzione di B. Giachetti – Sorteni. Firenze, Bemporad, 1935,
un vol. di pp. 381. L. 10, p. 56.
Si tratta delle memorie di una studentessa russa di buona famiglia, che ricorda gli
orrori della rivoluzione narrandoli con incisività e brevità. L’A. evidenzia l’abuso del
‘passato remoto’ nella traduzione eseguita da Giachetti.
XVIII, 12:
• E. Damiani, recensione a: Giuseppe Donnini. Dostojevsij vivente.
Firenze, Vallecchi, 1936, pp. 324. L. 10 p. 299.
Il volume di Donnini non dice nulla di nuovo su Dostoevskij ma fornisce un
chiaro quadro d’insieme della vita e della produzione letteraria dell’artista. L’A.
evidenzia qualche pecca grammaticale e alcune scorrettezze nella trascrizione dei nomi
152
russi.
Anno 1937
XX, 6:
• E. Damiani, recensione a: Nicola Ottokar. Breve storia della Russia.
Linee generali. Bari, Laterza, 1936, pp. 423. L. 25, p. 130.
L’A. presenta il volume definendola un’“pera di valore divulgativo, scritta in
una forma scorrevole e destinata al grande pubblico”, limitandosi a qualche
osservazione sul criterio seguito per la trascrizione dei nomi russi, non priva di difetti.
• P. E. Pavolini, recensione a: A. Pusckin. Il “Boris Godunov” e le
tragedie minori, Trad. e introd. di Rinaldo Küfferle. Milano, Mondatori,
1936, pp. XXXVI-303, s.i.p., p. 137.
Breve contributo sul volume dedicato alle tragedie di Puškin nel primo centenario
dalla sua morte, di cui si segnala la fedele traduzione firmata da Küfferle.
• P. E. Pavolini, recensione a: L. Tolstoi. Anna Karenina. Traduzione di
Ossip Felyne. Milano, Mondatori, 1936, 2 voll., complessive pp. 1222,
(«Biblioteca Romantica», XLII), p. 170.
L’A. segnala il volume per la fedele traduzione firmata da Ossip Felyne e per la
presenza di due frammenti inediti di Tolstoj.
• Benedetto Migliore, recensione a: Ivan Olbracht. Nikola Sciuhaj il
masnadiero. Romanzo. Traduzione del ceco di Giacomo Prampolini.
Milano, Mondadori, Collezione «Medusa», n. 75, 1936, pp. 231. L. 10,
p. 203.
Romanzo sulla leggenda di Nikolaj Ščuhaj, il boscaiolo della Russia subcarpatica, divenuto prima disertore e poi brigante per ribellione, masnadiero protetto
dalle streghe, in cui, secondo l’A., “la natura elementare delle passioni dei protagonisti
si mescola alle forze primordiali della natura assumendo aspetti quasi mistici”.
XX, 8:
• P. E. Pavolini, recensione a: Alessandra Rachmanowa. Matrimoni
nella bufera rossa. Diario di una donna russa. Trad. di B. Giachetti
Sorteni, Firenze, Bemporad, 1936, pp. 355. L. 10, p. 203.
Si tratta del diario di una donna vissuta nei tempi difficili della Russia comunista
in un clima di terrore e di odio, un volume segnalato dall’A. per la semplicità con cui
la Rachmanova decrive la vita dell’epoca.
XX, 9:
• P. E. Pavolini, recensione a: A. Puskin. Eugenio Oneghin. Versione
poetica e note di E. Lo Gatto. Roma, Bompiani, 1937, pp. 329. L. 60, p.
153
237.
Nel centenario della morte di Puškin l’A. presenta la versione dell’Onegin firmata
da Lo Gatto, elogiando la feconda attività pubblicistica dello slavista, di cui riconosce
le doti artistiche nel riprodurre in italiano la poesia dell’originale testo russo.
XX, 12:
• Giuseppe Mormino, recensione a: Leonard Kociemski, Il Generale
Smigly Rydz. Roma, «La Volontà d’ Italia», 1936, pp. 39. L. 2.50, p.
332:
Breve biografia del generale Edvard Smigly Rydz, ispettore generale delle forze
armate della Polonia durante la I guerra mondiale e attore di fatti militari che
condussero l’esercito polacco alla vittoria sulle preponderanti armate bolsceviche. L’A.
sottolinea la persuasiva chiarezza nell’esposizione dei fatti.
Anno 1938
XXI, 1:
• Gino Bandini, recensione a: Marcoff Alexis. Stalin dittatore della
Russia sovietica. Trad. di C. Boselli. Milano, Bietti, 1937, pp. 316. L.
10, p. 25.
L’A. segnala il volume sulla vita di Stalin evidenziandone l’attualità e
l’abbondanza delle informazioni fornite al lettore.
XXI, 3:
• E. Damiani, recensione a: Anton Cekhov. Novelle. A cura della
Duchessa D’ Andria. Torino, U.T.E.T., 1937, pp. 188, L. 9, p. 93.
Il volume contiene dodici novelle di Čechov, rappresentative della singolare arte
dello scrittore; l’A. evidenzia l’umorismo, che fa da sfondo ad ognuna di esse e che le
accomuna alla narrativa di Pirandello.
XXI, 10:
• Gino Bandini, recensione a: La vita intima dell’ ultimo Zar. Carteggio
inedito fra Nicola II e l’Imperatrice Madre Maria Feodorovna, scelto da
E. T. Bing. Trad. e comm. da A. Damiano. Milano, Mondadori, 1938,
pp. XVIII-318. L. 20, pp. 276-277.
L’A. presenta il volume, citando impressioni ed episodi tratti dal carteggio
personale dello zar con la madre nel periodo tra il 1879 e il 1917 e sottolineando la
fedele traduzione firmata da Damiani.
Anno 1939
154
XXII, 2:
• Luigi Salvini, recensione a: Adam Mickiewicz, Sonetti di Crimea ed
altre poesie. Testo polacco con introduzione, note e dizionario per uso
degli studiosi italiani a cura di Mieczystaw Brahmer ed Enrico Damiani.
Roma, Istituto per l’ Europa Orientale, 1939-XVII, pp. 114. L. 10, pp.
56-57.
Rassegna delle varie edizioni di Poezye di Mickiewicz a partire da quella curata
da Damiani nel 1926 per i “Classici Moderni” della Vallecchi. L’A. conclude il
contributo menzionando saggi e studi di Roman Pollak e di Ettore Lo Gatto, pubblicati
su riviste italiane di slavistica e dedicati al poeta, auspicando la nascita di una
bibliografia italiana degli scritti.
Anno 1940
XXIII, 1:
• Salvatore Rosati, recensione a: Maria Kuncewiczowa. La straniera.
Trad. di R. Poggioli. Milano, Mondatori («Medusa»), 1939, pp. 300. L.
12, p. 16.
Breve riassuno introduttivo del romanzo, la cui trama, costruita attorno a una
donna fallita che trova la serenità nella morte, lo accomuna ad altri dello stesso genere.
XXIII, 8-9:
• Luigi Salvini, recensione a: Brian-Chaninov, Storia della Russia.
Milano, Garzanti, 1940, pp. 419. L. 25, pp. 222-223.
L’A. presenta ai lettori la quarta opera dedicata alla storia della Russia, elegante
ed accurata, dopo le precedenti tre a cura, rispettivamente, di Otokar, Hederström e
Šmurlo. Il volume si distingue dagli altri per l’impostazione, concedendo poco spazio
alle questioni legate all’origine del popolo russo. Qualche osservazione viene fatta a
proposito dell’incerta trascrizione dei nomi russi e della totale assenza di fatti e
riferimenti relativi all’Italia.
• Giuseppe Bronzini, recensione a: Guido Manacorda, Il bolscevismo.
Firenze, Sansoni, 1940, pp. 347. L. 20, p. 223.
Si tratta di un volume sul complesso fenomeno del bolscevismo analizzato da uno
fra i maggiori conoscitori di culture slave; la prima parte indaga il marxismo come suo
fondamento teorico, evidenziandone alcune contraddizioni, la seconda approfondisce la
psicologia del popolo russo, pervasa di “slancio mistico e fede messianica”.
XXIII, 10:
• Giovanni Ferretti, recensione a: Giuseppe Mazzini, Lettere slave. Con
prefazione di Fabrizio Canfora. Bari, Laterza, 1939, pp. 136. L. 10
155
(«Biblioteca di cultura moderna» n. 338), p. 254.
L’A. presenta un saggio di Mazzini, pubblicato per la prima volta nel 1857 sulla
rivista “Italia e popolo”, in cui si configurava una “nuova Europa”, che potesse
comprendere i popoli slavi, considerandolo un valido documento di attualità.
XXIII, 11-12:
• Enrico Damiani, recensione a: Alessandro S. Puskin. Le liriche.
Trad. di Giovanni Gandolfi. Introduzione di Giovanni Maver. Lanciano,
G. Carabba, pp. VIII-114. L.5, p. 304.
Presentando il volume, l’A. elogia il talento e la maestria di Gandolfi nel tradurre
in versi le 43 poesie di Puškin che compongono la raccolta. Si segnala, inoltre, l’ottima
introduzione di Maver pubblicata dall’I.p.E.O. nel 1937.
“I libri del giorno” (Giovanni Beltrami, 1918-1929)
Anno I (1918)
n.1, aprile:
• ‘Bollettino bibliografico’: Bienstock J. W. Rasputin – Paris, Michel,
frs 4.50, p. 32.
“La Corte di Russia con la sua mescolanza di proteismo e di depravazione, gli
intrighi e i tradimenti delle forze tenebrose che circondavano il trono e che la figura di
Rasputin domina. Lavoro storico”.
n.2, maggio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Mickiewicz A. Gli Slavi. – Milano, Libreria
Editrice Milanese. Un vol. in-16, pp. 179, L. 3, p. 90.
“Prefazione. Il Messianismo. La tradizione. L’idea del dovere. Della proprietà.
L’ideale della Repubblica di Polonia. L’antipatia della Chiesa per lo spirito nuovo.
L’importanza della tradizione slava. Che cosa è la parola. Misteri della parola. Della
vita vera e della vita apparente. Dell’entusiasmo. Le condizioni della Chiesa. La Chiesa
ufficiale e la dottrina. Il Maestro. I Barbari. L’Uomo. L’Ecce Homo. Gli Slavi, i
Polacchi, Napoleone. Riassumendo”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Murat L. (Princesse). Raspoutin et l’aube
sanglante. – Paris, frs 4, 75, p. 90.
“Libro nuovo interessantissimo, assai documentato, dove l’A. racconta delle
diverse tappe del suo viaggio dalla Russia in Francia, quando già si intravvedevano le
prime minacce di rivoluzione. Belle descrizioni di paesaggi di Norvegia, Svezia e
Russia”.
156
• ‘Bollettino bibliografico’: Rambaud Alfred, Hisyoire de la Russie. –
Paris, Hachette, 1918. Un vol. in-16, frs. 7, p. 90.
“Storia della Russia dalle sue origini al giorno d’oggi. III edizione, accresciuta
dal supplemento sino al marzo 1917, di E. Haumant”;
n. 3, giugno:
• Civetta pubblicitaria su J. W. Bienstock, Rasputin. La fine di un
regime, Milano, Treves, Editori, 1918, Lire 5 (frontespizio);
• ‘Bollettino bibliografico’: Ruiz Amado S. J. P. Ramòn, Russie (Les
dangers mortels de la révolution). In-16, pp. 246 – Paris, Payot, fr. 4.
“Critica politica scritta da un anonimo, il quale, preso nell’ingranaggio della vita
economica, politica e sociale russa, ha osservato tutta la vita della Russia molto da
vicino”;
n. 4, luglio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Harper Florence Mac Leod. Runaway
Russia. In-8, pp. IX-321, illustrato. – Nova York, Century Co., p. 204.
“La Rivoluzione Russa veduta dagli occhi di una donna americana che trovavasi
come corrispondente presso Kerenski”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Litvinoff Maxim. The Bolshevik Revolution:
It’s Rise and Meaning. With foreword by E.C.Fairchild. In-16, pp. 54 –
London, British Socialist Party, 1 sh., p. 204.
“L’A. è il plenipotenziario mandato dal governo rivoluzionario russo a Londra”
‘Bollettino bibliografico’: Wilton Rob. Russia’s Agony. In-8, pp. XII356. Illustrato, con una carta – Nova York, Longmans, doll. 4,80, p. 204.
•
“L’A. visse per oltre quattordici anni in Russia ed in relazione con molti
personaggi del gran dramma russo, del quale narra gli antefatti risalendo mezzo secolo
indietro”.
n. 5, agosto:
• ‘Bollettino bibliografico’: Lieven Wilth, Das rote Russland. Augenbli
–cks-Bilder aus d. Tagen d. grossen russ. Revolution. Tagebuchblätter.
In-8, pp. 212, con 16 tavole e un facsimile. – Berlin, Scherl, p. 262.
“La rivoluzione russa nel diario di uno spettatore”.
n. 6, settembre:
• ‘Bollettino bibliografico’: Clapier Génina. La Serbie légendaire. In-16,
pp. 274- Paris, Delagrave, fr. 3,50, p. 318.
“Avant dire. Hommage à la Serbie. Qu’est-ce que l’âme Serbe ? Cycle di
Kossovo. Cycle de Marko Ktaliévitch. Chants héroïques divers. Les haïdouks.
Chansons de femmes. Heures historiques. Fleures des Balkans”.
157
n. 7, ottobre :
• Gheorgov Ivan. Die bulgar. Nation u. d. Weltkrieg. Gesammelte
Aufsätze. Mit. e Vorw. v. M. d. R. Dr. G. Stresemann. In-8, pp. XVI304, con un ritr. – Berlin, Hofmann, p. 374.
“pubblicazione di una Società tedesco-bulgara di Berlino. Il G. professa filosofia
all’Università di Sofia”.
n. 9, dicembre:
• Andrea Gustarelli, recensione a: I Bolsceviki, di M. Perwoukhine, con
prefazione del prof. E. Schmurlo dell‘Accademia delle Scienze di
Pietroburgo- Bologna, Zanichelli, L.3, pp. 464-465.
L’A. evidenzia l’impronta esplicitamente anti-bolscevica del libro di Michail
Pervuchin, il quale cerca di dimostrare come i bolscevichi, “nelle tre tendenze
marxista, leninista e trockista”, tramassero contro la salute della Russia e quanto
fallimentari fossero le loro teorie utopistiche sull’espropriazione e sulla concessione
della libertà ai lavoratori privi di una coscienza sociale.
• ‘Bollettino bibliografico’: Aksakov S. Le Burrasque et Perachino. In16, pp. 32 – Paris, Libre russe-française Rodstein. Fr. 1, p. 480.
“è il vol. I della serie 52 delle Lectures russes accentuées (contes choisis)
edizione diretta dalla professoressa Olga Klionoff”.
‘Bollettino bibliografico’: Perwoukhine M. I bolsceviki, con
prefazione del prof. E. Scmurlo, dell’Accademia delle Scienze di
Pietrogrado. In-16, pp. 174 – Bologna, Zanichelli, L. 3, p. 486.
“ se ne parla a pg. 464”.
•
• ‘Bollettino bibliografico’: Zabughin Vladimiro. Il Gigante folle.
Istantanee della Rivoluzione Russa. Con prefazione del sen. V. Scialoja.
IN-8, pp. 200 – Firenze, Bemporad, L. 3, 80, p. 486.
“Prologo. Viaggiando cogli emigrati. Pietrogrado, la città dei cinque governi.
Saturnali di guerra. Giallo-azzurro o…giallo-nero? Un’oasi latina. Laude della pazzia.
Il crollo. Congedo”.
• “Bollettino bibliografico’: Domergue Gabriel. La Russie rouge. In-16,
pp. 284 – Paris, Perrin, fr. 4,75, p. 486.
“La dictature. La terreur bolchéviste. La trahison. Le réveil”.
Anno II (1919)
n. 1, gennaio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Drew A.N. Russia: a Study. In-16, pp. 228.
– London, Simpkin, p. 47.
158
• ‘Bollettino bibliografico’: MeCabe Joseph. The Romance of the
Romanoffs. In-8, pp. IX-391. –London, Allen und Unwin, p. 48.
“E’ un volume documentatissimo sulle reali origini della caduta dell’autocrazia
imperiale russa, della quale espone vivamente la brutalità, la corruzione, e tutto il
sordido macchinario governativo”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Schelking Eugene de. Recollections of a
Russian diplomat; the suicide of monarchies (William II and Nicolas II).
In-16, pp. 14-327, illustr. – New York, Macmillan, d. 2,50, p. 48.
“Comprende la storia di Nicola II e dei suoi ministri, e delle loro relazioni con
l’Imperatore di Germania, I loro intrighi negli affari balcanici, I negoziati precedenti
all’entrata in guerra della Romania, la Corte russa sotto l’influenza di Rasputin e la
Rivoluzione russa. L’autore appartenne per molti anni alla diplomazia russa”.
n. 3, marzo:
• ‘Bollettino bibliografico’: Crusenstolpe (von) Magnus J. Russische
Hofgeschichten. Unter benutzung zeit genöss. Original-Dokumente
bearb., eingel. u. mit zahlreichen Anmerkungen hrsg. Von Joachim
Delbrück. III. Band. In-8, pp. 371, con 36 inc. fuori testo. – München,
Müller, p. 160.
“L’opera è in corso di pubblicazione dal 1914; consterà di cinque volumi”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Tolstoi Leo. Tagebuch d. Jugend. 1. Band
(1847-1852). Von Wladimir Tschertkow autorisierte, vollständige
Ausgabe. In-8, pp. XIII-292, con un ritratto e una tavoletta genealogica.
– München, Müller, p. 161.
n. 4, aprile:
• ‘Bollettino bibliografico’: Antonelli Etienne. La Russie Bolcheviste.
In-16, pp. 278. – Paris, Grasset, fr. 3,50, p. 215.
“La doctrine. Les hommes. La propriété. Le régime industriel. Politique
intérieure et politique extérieure. Textes officiels”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Boissière, Bolchevisme et Judaisme, par un
Russe. In- 8, pp. 22 – Paris, Giard et Brière, p. 216.
n. 5, maggio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Polledro Alfredo. Antologia Russa. In-16,
pp. 144. Torino, Lattes, L. 6, p. 270.
• ‘Bollettino bibliografico’: Dumas Charles. La Verité sur les
Bolscheviki. Documents et Notes d’un témoin. In-18, pp. 144. – Paris,
Ed. France-Slave, p. 274.
159
• ‘Bollettino bibliografico’: Vaucher Robert. L’Enfer Bolschevik à
Petrograd. Sous la Commune et la Terreur-Rouge. In-16, pp. 438. –
Paris, Perrin, fr. 5, p. 275.
“in preparazione l’edizione italiana. Fratelli Treves ed., Milano”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Waliszewski K. La Pologne inconnue.
Pages d’histoire et d’actualité. In-16, pp. 279 – Paris, Armand Colin, fr.
4,50, p. 275.
n. 6, giugno:
• ‘Bollettino bibliografico’: Guyon Bruno. Grammatica teorico-pratica
della lingua serba. M. H. pp. XL-584. – Milano, Hoepli, L. 12,50, P.
322.
• ‘Bollettino bibliografico’: Dostojewski
Fedor Michajlovic.
Autobiographische Schriften (Sämtliche Werke. Unter Mitarbeiterschaft
v. Dmitri Mereschkowski, hrsg. Von Moeller, Piper, p. 324.
“Con questo XI volume si compie l’edizione tedesca delle opere del D., in corso
di pubblicazione dal 1907 e che comprende 22 volumi”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Marino Gaetano, Leone Tolstoi (Dramma
religioso). In-8, pp. 39. – Roma, Ausonia, L. 1,80, p. 325.
n. 8, agosto:
• ‘Bollettino bibliografico’: Vaucher Roberto. L’Inferno Bolscevico.
Traduzione di G. Darsenne, unica autorizzata. In-16, pp. 376. – Milano,
Fratelli Treves, L. 6.
“Se ne parla a pg. 415”.
n. 9, settembre:
‘Bollettino bibliografico’: Lermontoff M. Liriche scelte. Dal russo. In16, pp. 186. – Milano, Risorgimento, L. 4, p. 487.
• ‘Bollettino bibliografico’: Ranelletti avv. E. La italianità della
Dalmazia. Conferenza dell’11-3-1919 – L. 2, p. 494.
‘Bollettino bibliografico’: Freytagh-Loringhoven (Freiherr von) Axel.
Gescichte d. russischen Revolution. 1. Teil. In-8, pp. 211. – München,
Lehmann, p. 494.
•
Anno III (1920)
N. 1, gennaio:
160
• ‘Bollettino bibliografico’: Bienstock J. W. Et Ch. Martel. Guerre et
Paix. Pièce en cinq actes et dix tableaux, d’après le roman du comte
L.N.Tolstoi. In-18, pp. 288 – Paris, Payot et C., fr. 5, p. 44.
n.2, febbraio:
• ‘Bollettino bibliografico’ : Mancini Ezio, Fino al Bolscevismo. In-16,
pp. 158 – Milano, Albrighi e Segati, L. 2,50, p. 107.
E’ la storia retrospettiva delle vicende della Russia dall’ante-guerra all’esplosione
del Bolscevismo.
n. 3, marzo:
• ‘Bollettino bibliografico’: Malone Colonel M. P., The Russian
Republic. In-16, pp. 179 – London, Allen un Unwin, p. 161.
n. 4, aprile:
• ‘Bollettino bibliografico’: Marco Slonim, Il bolscevismo visto da un
russo. In-16, pp. 219. – Firenze, Le Monnier, L. 6,50, p. 216.
n. 5, maggio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Andrejew Leonid. Die Lüge. Ausgewälte
Erzählungen (Die Uebertragung ins Deutsche besorgte Nadja
Hornstein). In-8, pp. 149. – Dresden, Minden, p. 269.
• ‘Bollettino bibliografico’: Brückner Alexander, Polonische
Literaturgeschichte. In-8, pp. 122 – Berlin, Vereinigung wissenchaftl. –
Verleger, p. 270.
Volume della “Sammlung Göschen”.
n. 7, luglio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Landau-Aldanov A., Lenin. Traduzione di
Attilio Rovinelli. In-16, pp. 124, con copertina illustrata da ritratto di
Lenin. – Milano, Sonzogno, L. 5, p. 385.
“L’autore dichiarasi socialista, anti-rivoluzionario ed anti-militarista; e fa di
Lenin un quadro non apologetico ma, a quanto pare, abbastanza obbiettivo”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Bienstock J. W. Histoire du mouvement
révolutionnaire en Russie. In-8, pp. 380 – Lausanne, Payot, fr. 12, p.
385.
“Fa vedere come, considerando tutte le circostanze e l’evoluzione storica
compiutasi in Russia durante un secolo, il bolscevismo, inesplicabile alla tregua delle
“teorie pure”, si spieghi in realtà perfettamente”.
n. 8, agosto:
161
• ‘Bollettino bibliografico’: Italia e Russia. Rivista mensile (bilingue)
dei rapporti economici, tecnici e sociali fra l’Italia e i paesi russi.
Direttore Carlo Merlin. In-8, a 2 colonne, pp. 26 e copertina. Abb.
Annuo, L. 12, p. 441.
n. 9, settembre:
• ‘Bollettino bibliografico’: Gray E. Come Lenin conquistò la Russia.
In-16, pp. 96. – Firenze, Bemporad, L.3, P. 496.
• ‘Bollettino bibliografico’: Calleja Rafael. Rusia. Espejo saludable para
uso de pobre y de ricos. In-8, pp. 514 – Madrid, Jiménez y Molina, ps. 5,
p. 497.
• ‘Bollettino bibliografico’: Miliukov, Pavel Nikolaevich. Bolshevism:
an international danger; its doctrines and its practice through war and
revolution. In-8, pp. 3030. – New York, Scribner, d. 4, p. 497.
“Traccia l’evoluzione del bolscevismo da dottrina astratta a pratico esperimento”.
n. 10, ottobre:
• ‘Bollettino bibliografico’: Proudhon P. G. La Guerra e la Pace, pagine
scelte con una introduzione, a cura di Piero Jahier. In-16, pp. 190 –
Lanciano, Carabba, L. 3, p. 553.
“E’ il n. 78 della Collezione “Cultura dell’Anima”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Gray E. M. Come Lenin conquistò la
Russia. In-16, pp. 96. – Firenze, Bemporad, L. 3.
“Biblioteca di Studi Rivoluzionari diretta da E.M. Gray”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Paladini Carlo. Lenin. In-16, pp. 100, con
copertina a coloro con ritratto. Firenze, Bemporad, L.3, p. 554.
n. 11, novembre:
• ‘Bollettino bibliografico’: Italia e Russia(v. sopra), p. 607.
• ‘Bollettino bibliografico’: Russia. Rivista di letteratura, storia e
filosofia. In-8, pp. 80 con copertina. Direttore: Ettore Lo Gatto, p. 608.
• ‘Bollettino bibliografico’: Dostojewski A. Dostojewski. Geschildert v.
seine Tochter. – München, Reinhardt, p. 611.
n. 12, dicembre:
• ‘Bollettino bibliografico’: Blok A., Canti bolscevichi. In-8, pp. 112,
con copertina illustrata. – Milano, Quintieri, L. 6, p. 654.
• ‘Bollettino bibliografico’: Cècof Antonio. Il Monaco nero. Traduzione
162
di Ettore Lo Gatto. In-8, pp. 48. – Napoli, “Russia”, L. 2,50 – Il
racconto di uno sconosciuto. Traduzione di Ettore Lo Gatto. In-8, pp. 96
– Napoli, “Russia”. – La steppa. Trad. di Olga Resnevic. In-16, pp. 172,
con copertina illustrata. – Roma, “La Voce”, L. 4, P. 654.
• ‘Bollettino bibliografico’: Anzilotti Antonio. Italiani e Jugoslavi nel
Risorgimento. In-16, pp. 118 – Roma, “La Voce”, L. 5, p. 658.
“Con un’eccellente documentazione dedotta da Cavour, da Correnti, da Cattaneo,
da Valussi, da Antonini, da Bonfiglio, dal Combi, è qui fatta una illustrazione storica
dei rapporti italo-jugoslavi, utilissima anche ora dopo il trattato di Rapallo, che ha
messo gli uni e gli altri sulla saggia via della collaborazione”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Kociemski Leonardo. Pilsudski: uomo –
opera- carattere. In- 16, pp. 28, p. 658.
• ‘Bollettino bibliografico’: Dostoiewski Teodoro, Discorso su Puskin.
Traduzione di Ettore Lo Gatto. In-8, pp. 32 – Napoli, “Russia”, L. 2, p.
659.
• ‘Bollettino bibliografico’: Lenin N. La grande iniziativa. – L’eroismo
dell’operaio russo nel fronte interno (I sabati comunisti). In-16, pp. 32,
n. 19 dei “Documenti dela Rivoluzione” – Milano, Soc. Ed. “Avanti”, p.
659.
• ‘Bollettino bibliografico’: Olivetti A.O. Bolscevismo, Comunismo e
Sindacalismo. In-16, Milano, Casa Ed. Risorgimento, L. 3, p. 659.
Anno IV (1921)
n. 3, marzo:
• Bollettino bibliografico’:Dostojewski. L’eterno marito. A cura di C.
Alvaro. In-16, pp. 234, con copertina illustrata – Milano, Quintieri, L. 7,
p. 155.
• ‘Bollettino bibliografico’: Novelle russe, a cura di Corrado Alvaro,
Milano, Quintieri, p. 155.
• ‘Bollettino bibliografico’: Sollogub Fedor. Il piccolo diavolo.
Romanzo a cura di C. Alvaro. In-16, pp. 260, con copertina illustrata –
Milano, Quintieri, L. 7, P. 155.
n. 5, maggio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Mereskowski Demetrio. Giuseppe Pilsudski.
Traduzione autorizzata dal russo. In-16, pp. 16 – Milano, “Polpresse”, p.
271.
163
n. 6, giugno:
• ‘Bollettino bibliografico’: Gorki Massimo, Ricordi su Leone Tolstoi,
versione letterale dal russo di Odoiardo Campa. In-16, pp. 88 – Firenze,
“La Voce”, L. 4.
“Ne parlò G. A. Borgese ne “Il libri del giorno” di maggio scorso”.
n. 8, agosto:
• Ettore Lo Gatto, (Russia). Attività editoriale dei profughi russi, pp.
431-432.
L’A. descrive in breve l’attività editoriale all’estero soffermandosi su alcune
località: Berlino, dove nacque la più ricca casa editrice russa, Parigi, la cui attività
editoriale era concentrata sulla rivista “Sovremennye zapiski”, Stoccolma e le
pubblicazioni della casa editrice “Severnye Ogni”, Praga, dove sorse “Naša reč’”, la
prima casa editrice in grado di fare concorrenza economica alla Ladyšnikov di Berlino,
Sofia e Costantinopoli.
n. 9, settembre:
•
Pompeo Falcone, Il misticismo e L. Andreief, pp. 464-467.
L’A. si sofferma a lungo sul pensiero religioso di Leonid Andreev partendo
dall’analisi che ne fa Dino Provenzal nel saggio Una vittima del dubbio: Leonida
Andreief (Roma, casa editrice “Bilychnis”).
n. 10, ottobre:
• Lorenzo Gigli, Krapòtkin, pp. 516-518.
L’A. ripercorre la vicenda biografica del principe Krapotkin, discepolo di Bakunin,
morto di recente a Dmitrovo, presso Mosca, guida spirituale del movimento bolscevico
della ‘prima ora’ e autore dei saggi Reči buntovščika (1885) e Chleb i volja (1892).
• Ettore Lo Gatto, (Russia) Riviste e giornali, pp. 541-543.
L’A. fa un bilancio delle pubblicazioni periodiche dei profughi russi,
richiamandosi a un precedente articolo sull’argomento. Fra le riviste menziona “Novaja
Russkaja Žizn’” edita in Finlandia, “Svoboda” di Varsavia con la collaborazione di
Dmitrij Mereškovskij, “Russkaja Mysl’” in Jugoslavia, “Segodnja” in Lettonia. Fra i
giornali si citano “Rassvet” di Vladivostok e “Volja Rossii” pubblicato a Praga.
n. 11, novembre:
• Ettore Lo Gatto, Poesia contemporanea, pp. 597-598.
L’A. sottolinea la scarsa conoscenza della poesia russa contemporanea in Italia
registrabile già prima della guerra mondiale. Secondo lo slavista, l’unica eccezione è
rappresentata dall’Antologie des poètes russes (ed. Crès-Paris) di Chuzeville. L’articolo
prosegue con la citazione delle fonti europee disponibili per la conoscenza della poesia
russa dell’anteguerra, dal “Parnaso russo”, edito a Lipsia, alle varie antologie
pubblicate a Praga e a Costantinopoli.
164
n. 12, dicembre:
•
Lorenzo Gigli, Il centenario di Dostoievskij, pp. 632-636.
A cento anni dalla nascita dello scrittore l’A. approfondisce il rapporto tra
estetica e vita nelle opere, confrontando la sua biografia con quella di Gogol’ cui si
sarebbe ispirato.
• ‘Bollettino bibliografico’: Lo Gatto Ettore. I problemi della letteratura
russa. In-8, pp. 132 – Napoli, Ricciardi, L. 5, p. 661.
“chi segue nelle nostre pagine gli articoli di Ettore Lo Gatto può facilmente
figurarsi il valore del contenuto di questo suo volume storico-artistico”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Kropotkin. La morale anarchica. Prefazione
di Gallerini, con un ritratto dell’autore. In-16 – Milano, Casa Editrice
Sociale, L.2, p. 663.
Anno V (1922)
n.1, gennaio:
• Ettore Lo Gatto, Dostojevskij in Italia, pp. 7-9.
Si ricordano gli scritti pubblicati alla vigilia delle celebrazioni del centenario
della nascita. L’A. evidenzia come solo alcune delle traduzioni integrali dal russo siano
state portate a termine: un volumetto di traduzioni contenente Slaboe serdce e
Malen’kij geroj, firmate da Olga Resnevič Signorelli nei “Quaderni della Voce”, e il
primo volume di Dnevnik pisatel’ja, tradotto dallo stesso Lo Gatto e in uscita per le
edizioni I. p. E. O.
• Ettore Lo Gatto, (Russia) Poeti contemporanei in ‘Libri di cui si parla’
pp. 35-36.
Facendo riferimento a precedenti contributi su poeti contemporanei bolscevicofuturisti come Jaroslavskij e ‘contadini’ come Kljuev e Esenin, l’A. analizza da vicino
la poesia melanconica e nostalgica di Ivanov e Brjusov.
n.2, febbraio:
•
E. Lo Gatto, Vladimiro Korolenko (uomo escrittore), pp. 64-66.
A un mese dalla morte dello scrittore l’A. ne ricorda l’attività artistica non solo in
quanto rappresentante della letteratura novellistica contemporana e giornalista di
successo ma, soprattutto, come un uomo solidale con quanti avevano sofferto in Russia
la carestìa nel 1891.
n.3, marzo:
• ‘Bollettino
bibliografico’:
Eliasberg
165
Alexander.
Russische
Literaturgeschichte in Einzelporträts. Mit e. Geleitwort von Dmitrij
Serg. Mereshkowskij. In-8, pp. X-192, Munchen, Beck, p. 160.
• ‘Bollettino bibliografico’: Frenkel Wladimiro. Amore e Bolscevismo.
Talmud e Khamstvo. In-16, pp. 80 – Roma, “La Rapida”, L. 4, p. 162.
n.4, aprile
• Ettore Lo Gatto, (Russia) Libri e riviste in edizioni bolsceviche, pp.
208-209 in ‘Libri di cui si parla’.
L’A. menziona le principali riviste pubblicate dal governo sovietico,
raggruppandole in riviste come “Kniga i revoljucija” e “Pečat’ i revoljucija” con
pretese e finalità scientifiche, altre come “Chudožestvennoe Slovo”e “Proletarskaja
Kul’tura”, concentrate sulla poesia russa contemporanea. Lo Gatto, infine, sottolinea
come la maggior parte delle pubblicazioni sia finalizzata alla propaganda.
n.5, maggio:
• ‘Bollettino bibliografico’: Kociemski L., Abisso. Dramma con
prefazione di Casimiro Wronowski. In-16, pp. 120 – Milano, Caddeo, L.
2, p. 271.
• ‘Bollettino bibliografico’: Mereskowski D. La morte di Paolo I.
Dramma. Prima traduzione italiana della Duchessa d’Andria
Capecelatro. In-16, pp. 120 – Milano, Caddeo, L. 4, p. 271.
n.6, giugno:
• Ettore Lo Gatto, Dmitrij Meresckovskij e i suoi ultimi libri, pp. 322323 in ‘Libri di cui si parla’ – Russia.
L’A. introduce Merežkovskij presentando la sua meno nota attività di critico,
pensatore e polemista. Vengono menzionate alcune fra le più recenti opere dedicate
alla spiritualità russa.
• ‘Bollettino bibliografico’: Brückner Alexander. Geschichte der
polonischen Literatur. 2., völlig veränderte Auflage. In-8, pp. VII-328. –
Leipzig, Amelang, p. 328.
n.8, agosto:
• Ettore Lo Gatto, Dostojevskij inedito, pp. 433-435.
L’A. sottolinea la notizia apparsa sui giornali dell’epoca e ignorata da buona parte
dei lettori relativa alla scoperta di una cassa contenente manoscritti di Dostojevskij
trovata nella Russia meridionale e trasportata a Mosca per lo spoglio e,
successivamente, per la stampa. Seguono una serie di citazioni da taccuini e frammenti
tratti da capitoli inediti di Besy.
166
n. 9, settembre:
• Aurelio Palmieri, La rinascenza letteraria polacca è Adamo
Mickiewicz, pp. 489-491.
In occasione della recente esposizione internazionale del libro svoltasi a Firenze,
che annovera volumi della celebre casa editrice “Zawadzki” di Vilna, l’A. traccia una
biografia di Mickiewicz dagli anni dell’infanzia trascorsi in Lituania, luogo di nascita,
dove frequentava l’umile scuola dei Domenicani di Nowogrodek, alla produzione
giovanile, sottolineando l’influenza del teatro e della lirica di Schiller.
• Lorenzo Gigli, Dostoievschi critico, pp. 491-492.
L’A. introduce il volume di Lo Gatto in cui vengono raccolti gli Stat’i o russkoj
literature pubblicati nel 1861 su “Vremja” e di cui fornisce la prima traduzione
integrale. Si sottolinea l’importanza divulgativa del volume, fondamentale sia per la
conoscenza del pensiero di Dostoevskij, sia per aver un quadro completo delle
condizioni della letteratura russa del tempo.
• ‘Bollettino bibliografico’: Andrijéff Leonida. Padre Vassili. In-8, pp.
148, con copertina illustrata. Milano, Società “Avanti”, p. 495.
• ‘Bollettino bibliografico’: Slonim Marco. Da Pietro il Grande a Lenin.
Storia del movimento rivoluzionario russo 1700-1917. 1 edizione. In-16,
pp. 304 – Milano, “Vita e Pensiero”., L. 5, p. 499.
n.10, ottobre:
• Ettore Lo Gatto, Poesia moderna, pp. 544-545 in ‘Libri di cui di parla’
– Bulgaria.
Dopo una breve introduzione in cui l’A. racconta le sue prime esperienze
pubblicistiche con la letteratura e la cultura popolare bulgara, relative alle poesie di
Ivan Vazov e di Penčo Slavejkov, lo slavista traccia una storia delle pubblicazioni sulla
poesia popolare citando, fra le altre, la raccolta di giovani poeti contemporanei a cura
di A. Angelov e M. Arnaudov Bălgarskata narodna poezija.
‘Bollettino bibliografico’: Andreief Leonida. Il diario di Satana. Con
copertina di Interlandi. – Bologna, Casa Editrice Apollo (Biblioteca
nordica).
•
“Tradotto direttamente dal russo da Telesio Interlandi e da Boris Gurevich, questo
diario, finito nel 1919, ci rivela uno degli aspetti più tipici dell’arte del grande scrittore
che, come è noto, fu uno di coloro che, attraverso le opere, profetizzarono l’avvento
della guerra mondiale. Assai accurata ne è la traduzione che rende con profonda
efficacia le originalissime pagine di questo libro che la morte dell’autore lasciò
incompiuto”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Tolstoj L. Kreutzerova sonata, a cura di L.
Koisemski. In-16, pp. 144, Milano, Caddeo, L. 4, P. 551.
• Ettore Lo Gatto, Scrittori contemporanei, pp. 545-547 in ‘Libri di cui
si parla’ – Russia.
L’A. segnala l’interesse della critica letteraria europea dell’epoca per due scrittori,
167
Ivan Alekseevič Bunin, attivo già prima della guerra e poco noto nella stessa Russia, e
Fëdor Sologub, di cui si trovava già tradotto in molte lingue occidentali il capolavoro
Melkij Bes.
n. 11, novembre:
Ettore Lo Gatto, Dostojevskij inedito, pp. 602-603 in ‘Libri di cui si
parla’ – Russia.
•
L’A. traccia una breve storia dei capitoli inediti del romanzo Besy partendo dalla
prima pubblicazione a stampa sul “Russkij vestnik” nel 1871-1872, quando lo scrittore
tolse tre capitoli che erano già stati composti in tipografia. L’A. indaga le cause, ancora
poco note, di tale episodio.
• ‘Bollettino bibliografico’: Alexandra Fedorovna. Die letzte Zarin. Ihre
Briefe an Nikolaus Iiu. Ihre Tagebuchbläter von 1914 bis zur
Ermordung. Hrsg. U. eingeleitet von Joachim Kühn. In-8, pp. 257.
Berlin, Ullstein, p. 610.
n.12, dicembre:
• Lorenzo Gigli, I problemi della letteratura russa, pp. 656-658 in ‘Libri
di cui si parla’ – Russia.
Partendo da una formula resa celebre da Kropotkin nel suo saggio Idealy i
dejstvitel’nost’ v russkoj literature, secondo cui “il popolo russo va giudicato non
secondo ciò che è ma secondo ciò che vorrebbe essere”, l’A. pone la questione della
ricerca del vero carattere della letteratura russa che, in passato, molti studiosi hanno
tentato di risolvere.
• ‘Bollettino bibliografico’: Moszkowski Alexander. Die Inseln der
Weisheit. Geschichte d. abenteurl. Entdeckungsfahrt. In-8, pp. 283 –
Berlin, Fontane, p. 664.
• ‘Bollettino bibliografico’: Dostoyewsky Aimée. Dostoyewsky nei
ricordi di sua figlia. Traduzione di Maria Laetitia Lumbroso. In-16, pp.
VIII-266 – Milano, Fratelli Treves editori, L. 15, p. 666.
Anno VI (1923)
n.1, gennaio:
• Cesarino Giardini, Dostoyewsky intimo, pp. 12-14.
Biografia dello scrittore attraverso le opere.
• Ettore Lo Gatto, Dostojevskij inedito, in ‘Libri di cui si parla’ –
Russia, pp. 43-44.
Quattro articoli-feuilletons pubblicati dallo scrittore sul “Peterburgskij Vestnik”
168
del 1847. Gli articoli possono considerarsi inediti dal momento che non sono entrati a
far parte di nessuna raccolta delle opere complete di Dostoevskij.
n.2, febbraio:
• Aurelio Palmieri, La lirica slovena, pp. 66-68.
Dopo aver introdotto i fatti storici legati alla formazione dell’Illiria (Carinzia,
Istria, Ragusa, Croazia civile, Croazia militare) in seguito al Trattato di Vienna del
1809 con cui si cedeva alla Francia di Napoleone la Venezia-Giulia, Palmieri sottolinea
l’influenza del ‘nazionalismo illirico’, già presente prima della costituzione del nuovo
Stato (1809-1813), nella letteratura slovena.
• ‘Bollettino bibliografico’: Frenkel Vladimiro. Russi ed Ebrei. –
“Pensando a te”, In-16, pp. 93 – Napoli, Industrie Grafiche Italia
Meridionale, L. 5, p. 104.
•
Ettore Lo Gatto, Massimo Gorkij e la rivoluzione, pp. 98-99.
Si ricorda il trentesimo anniversario dell’inizio dell’attività letteraria di Maksim
Gor’kij. Per l’occasione l’A. cita una serie di articoli che la stampa russa, sia in Patria
che all’estero, ha dedicato all’argomento, pubblicati sulla rivista di Berlino “Novaja
russkaja kniga”.
n.3, marzo:
• Cesarino Giardini, recensione a: Articoli critici di letteratura russa, di
F. Dostojevsky, trad. di Ettore Lo Gatto. In –8, pp. XI-295 – Napoli,
Riccardo Ricciardi, editore, 1922, L. 10 – Mzyri ed altri poemetti, di M.
Lermontov, traduzione di Virgilio Narducci, prefazione di E. Lo Gatto.
In-8, pp. XII-92 – Napoli, Riccardo Ricciardi, editore, 1922, L.5
(Pubblicazioni dell’ Istituto per l’Europa Orientale in Roma, prima serie:
Letteratura, arte, filosofia, v. I e II), pp. 154-155.
Nella prima parte del contributo l’A. presenta le traduzioni, firmate da Lo Gatto,
dei cinque articoli di Dostoevskij pubblicati nel giornale “Vremja” tra il 1861 e il
1866, prima e dopo la cerimonia inaugurale a Mosca del monumento a Puškin
avvenuta nel giugno del 1880, Nella seconda parte si descrive il volume dedicato alla
poesia di Lermontov, di cui l’A. elogia la traduzione di Narducci.
• ‘Bollettino bibliografico’: Kuprine Alexandre, La Bracelet de Grenats.
Roman traduit du russe par Henri Mongault. In-16, pp. 297. – Paris,
Editions Bossard, fr. 5,50 – Le Duel. Roman traduit du russe par Hneri
Mongault. In-16, pp. 330 – Paris, Editions Bossard, fr. 5,50, p. 161;
• ‘Bollettino bibliografico’: Sologub Fedor. Le Démon Mesquin. Roman
traduit du russe par H. Pernot et L. Sthal, préface de M. Jean Chuzeville,
avec un portrait. In-16, pp. 308 – Paris, edition Bossard, fr. 7,50, p. 162 ;
• ‘Bollettino bibliografico’ : Tchekhov Anton. Les Mouijks. Traduit du
russe par Denis Roche (seule traduction autorisée par l’auteur). In-16 –
Paris, Plon-Nourrit, fr. 7 , p. 162.
169
n. 4, aprile:
Ettore Lo Gatto, Scritti su Bakunin, in ‘Libri di cui si parla’ – Russia,
pp. 208-210.
•
L’A. evidenzia come gli anni 1919-1921 siano stati caratterizzati da un
significativo numero di pubblicazioni e studi su Bakunin. Di tutto ciò ne fanno un
resoconto dettagliato due articoli pubblicati in Russia nel 1921, uno su “Pečat’ i
revolucija”, l’altro su “Izvestija”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Olkienizkaia Naldi Raissa. Lo Specchio. In8, pp. 130 – Ferrara, Taddei, L. 6, p. 215.
• ‘Bollettino bibliografico’: Amfiteatroff Ilaria. Negli artigli dei Sovieti.
In-8, pp. 168 – Milano, ediz. De l’”Eroica”, L. 8 – Altra (L’) Sponda,
Trieste Gastone Mioni, L. 50, p. 220.
n. 5, maggio:
• Ettore Lo Gatto, Scrittori contemporanei in ‘Libri di cui si parla’Russia, pp. 266-267.
Bilancio dell’attività letteraria in Russia negli anni dal 1918 al 1922. E’ rilevante
la considerazione che il direttore della rivista bibliografica “Novaja russkaja kniga” fa
nel suo resoconto finale del 1922, osservando che gli anni di piena attività letteraria
sono stati solo due, 1921 e 1922, considerando che il 1918 è stato interamente dedicato
alla rivoluzione e il biennio 1919-20 alla crisi intellettuale dell’intelligencija.
• ‘Bollettino bibliografico’: Stepanow G. Storia della Russia dalle
origini ai nostri giorni. In-16, pp. IX-141 – Firenze, Ed. A. Vallecchi, L.
8, p. 277.
n. 6, giugno:
Ettore Lo Gatto, Scrittori contemporanei. Gli almanacchi, pp. 321323.
•
L’A. analizza un tipo di rivista molto diffusa in Russia, l’almanacco letterario, e ne
sottolinea gli aspetti che lo contraddistinguono dagli almanacchi nel resto d’Europa.
Secondo lo slavista si tratta di una rivista letteraria priva di periodicità e con una
grande varietà di argomenti. Fra gli almanacchi diffusi in Russia prima della guerra e
dopo la rivoluzione si citano rispettivamente “Znanie” e “Serapionovye brat’ja”.
n. 8, agosto:
• ‘Bollettino bibliografico’: Dobromilof Caterina. La Dominatrice.
Romanzo, trad. da Liudmila Petrovna Osierin. In-16, pp.239 – Perugia,
Tipografia G. Guerra, L. 10, p. 442.
• ‘Bollettino bibliografico’: Tolstoi Leone: Il diavolo, opera postuma,
trad. e introd. di E. Damiani. In-16, pp. VII-99 – Firenze, Vallecchi edit.,
L. 3,50, p. 442.
170
n.9, settembre:
•
Ettore Lo Gatto, Blok e la rivoluzione, pp. 492-494.
L’articolo analizza il legame di Blok con la Rivoluzione russa attraverso i suoi
scritti.
n. 10, ottobre:
• Ettore Lo Gatto, Un libro russo dall’ Italia – Zaitsev romanziere – L’
enigma di Tolstoj, pp. 545-547.
Dopo aver ricordato precedenti articoli dedicati al rapporto di alcuni scrittori russi
con l’Italia, in particolare Obrazy Italii di Pavel Muratov, l’A. menziona altre
personalità del panorama letterario russo che hanno dimostrato il loro amore nei
confronti del Paese e della sua cultura fra i quali Aleksandr Blok, Andrej Belyj, Boris
Zajcev, di cui si segnala il romanzo Dal’nij kraj, Kuzmin, la principessa Volkonskaja,
Odoevskij, Baratynskij e i fratelli Turgenev.
n. 11, novembre:
• Aurelio Palmieri, Le nuove riviste letterarie in ‘Libri di cui si parla’ –
Polonia, pp. 602-604.
L’A. illustra il panorama culturale e letterario contemporaneo della Polonia che,
dopo i fatti politici recenti, apre una nuova fase d’interesse letterario rivolta al
classicismo, considerato fonte di rieducazione dell’anima polacca. Espressione di tale
cambiamento sono le riviste letterarie: “Biblioteka Warszawka” a Varsavia, “Przegląd
polski” a Cracovia, “Przegląd Tygodnikny”, “Niwa”, “Tygondik Illustrowany” e il
mensile “Przegląd Wszechpolski” fondato da S. Kozicki nel 1922.
Ettore Lo Gatto, Poesia del passato: Alessio N. Apuchtin – Poesia
contemporanea: N. Gumiljov, pp. 604-606.
•
La prima parte del contributo è dedicato alla biografia di Aleksej Apuchtin,
poeta russo indipendente dagli scrittori appartenente al “settimo decennio”, un circolo
di letterati impegnati in questioni sociali e politiche, e che trova, invece, la sua
espressione solo più tardi. La seconda parte si concentra sulla produzione poetica russa
degli ultimi trent’anni, in particolare i simbolisti, fra i quali si ricorda Gumilëv.
•
“Notizie e curiosità”, p. 615.
Nota informativa sulla nascita della rivista bimestrale “Gli annali del libro” per
la ‘Camera centrale del libro’ esistente a Mosca dal 1920.
• ‘Bollettino bibliografico’: Andreieff Leonida. I sette peccati.
Traduzione di Decio Cinti. In-16, pp. 95 – Milano, Sonzogno edit., L. 1,
p. 611.
• ‘Bollettino bibliografico’: Cekov Antonio. Il racconto d’uno
sconosciuto. Traduzione di Fausto Malcovati. In-16, pp. 92. – Milano,
Sonzogno, L. 1, p. 611.
• ‘Bollettino bibliografico’: Gorki Maxim. Printre straini, amintiri (tr.
Sarina Cassvau Pass). In-8, p. 288 – Bucarets, I. Branisteanu, lei 30, p.
611.
171
• ‘Bollettinoi bibliografico’: Tolstoi Leo. Cadavrul viu (trad. Gr.
Avakiansi P. Florentiu). In-16, pp. 95 – Bucarest, Ed. “Cultura
Nationala”, lei 35, p. 612.
• ‘Bollettino bibliografico’: Lo Gatto Ettore. Poesia russa della
rivoluzione. In-16, pp. 123 – Roma, A. Stock, L. 7, p. 612.
• ‘Bollettino bibliografico’: Gorki Maxime. Souvenirs de ma vie
littéraire. I-16, pp. XVIII-285- Paris, « Aux éditions du Sagittaire »
« E’ il secondo volume della « Collection de la Revue Européenne »;
• ‘Bollettino bibliografico’ : Kenn Odette. My adventures in Bolshevik
Russia. In-12, pp. 319 – New York, Dodd Mead, doll. 7, p. 614.
n. 12, dicembre:
• ‘Bollettino bibliografico’: Gorki Maxime: Souvenirs de ma vie
littéraire. In-16, pp. 285, “Aux editions du Sagittaire” – Paris, chez
Simon Kra, fr. 10.
“Dopo il successo europeo del Souvenir d’enfance del Gorki, pubblicati prima in
puntate su la Revue de Paris, poi in volume e tradotti recentemente anche in italiano,
questo nuovo libro di ricordi gorkiani verrà accolto con vivo interesse, La versione
francese è di Michel Dumesnil de Gramont; e il testo originale, scritto in russo, è
tuttora inedito. Questo volume –ricco di osservazioni profonde e di intense evocazioni
di vita – non contiene solo i ricordi letterari ma è occupato per la massima parte dalla
vita dello scrittore considerata i tutte le sue manifestazioni, e specialmente sul faticoso
e complicato processo d’autoformazione spirituale”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Tolstoi Leone. Infanzia e adolescenza.
Versione integrale dall’originale russo a cura della Duchessa D’Andria.
In-16, pp. XVII-627. – Firenze, Sansoni edit., L. 7, p. 667.
Anno VII (1924)
n. 1, gennaio:
• Ettore Lo Gatto, Poeti contemporanei. Anna Achmatova, pp. 38-41.
Dopo aver ricordato precedenti contributi dedicati alla poetessa russa nonché
l’antologia di poesia d’imminente uscita, curata da Raissa Olkienizkaia Naldi, Lo Gatto
fa un’attenta analisi della più recente produzione poetica della Achmatova riportando e
commentando alcuni versi dai volumi Čotki, Anno Domini MCMXXI, Belaja Staja,
Večer.
• ‘Bollettino bibliografico’: Naldi Olkienizkaia Raissa. Antologia dei
poeti russi del XX secolo. In-16, pp. XVI-254 – Milano, Fratelli Treves
edit., L. 9, p. 51.
• ‘Bollettino bibliografico’: Dostojewski Fedor Michailovic. Tagebuch
eines Schriftsellers. Hrsg. U. übertragen von Alexander Eliasberg. Band
IV (Scluss): Juli 1877 bis Januar 1881. Munchen, Musarion-Verlag, p.
172
105.
• ‘Bollettino bibliografico’: Gorki Mxim. Gesammelte Werke (deutsch).
Reihe 1 and 8 – Berlin, Ladyschnikow: Munchen, Wolff, p. 107.
n.2, febbraio:
Ettore Lo Gatto, La stampa e la rivoluzione in ‘ Libri di cui si parla’ –
Russia, pp. 100-101.
•
L’A. descrive una rivista bibliografica in pubblicazione a Mosca da tre anni, in
particolare la sezione dedicata all’arte del libro e all’organizzazione bibliografica in
Russia. Lo slavista coglie anche l’occasione per evidenziare come negli ultimi anni ci
fosse una ripresa editoriale, dovuta in parte alla riammissione delle case editrici private
un tempo abolite. Di questa ripresa, specie nel 1923, “Pečat’ i revolucija” e “I libri del
giorno” avevano già ampiamente scritto.
n.3, marzo:
• Ettore Lo Gatto, La filosofia russa, pp. 122-124.
L’A. traccia un profilo del pensiero filosofico in Russia a partire dalla
conferenza tenuta del prof. Simeon Frank, docente presso l’Istituto scientifico russo di
Berlino, il quale cercava di dimostrare come alla base della filosofia russa ci fosse una
perfetta corrispondenza tra pensiero e azione.
• Aurelio Palmieri, Storie della letteratura – Mickiewicz, pp. 150-152 in
‘Libri di cui si parla’ – Polonia.
Nella prima parte del contributo l’A. menziona alcune “storie della letteratura
polacca contemporanea” dove evidente è il ritorno al classicismo. In particolare l’A.
cita la prima serie della “Biblioteka Narodowa” nei cui volumi figurano i nomi di
Kochanowski, Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, Zaleski, Fredry, Ujeski, e il volume di
Stanisław Lam, Polska literatura współczesna: charakterystyki i wypisy, edito a
Poznań nel 1924.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Antologia dei poeti russi del XX secolo,
di Raissa Naldi Olkienizkaja. Milano, Fratelli Treves, edit., 1924. In-16,
p. XVI-254. L. 9 – Diario di Leone Tolstoi (1895-1899). Traduzione di
Valentina Dolghin dall’orig. Russo. Milano, Trevese edit., L. 10, pp.
152-153.
L’A. loda entrambi i volumi, sottolineandone le fedelissime traduzioni dal
russo eseguite dalla Naldi e da Valentina Dolghin, l’elegante forma italiana e la
partecipazione personale nella traduzione.
• Giovanni Maver, Letterature slave meridionali. I quattro poeti sloveni,
in ‘Libri di cui si parla’ – Russia, pp153-154.
L’A. dedica il suo contributo all’opera di quattro poeti-compagni, Cankar,
Kette, Zupančič e Murn, considerandoli il simbolo di una rinascita della poesia
slovena, in particolare Cankar e Zupančič. Di ciascuno di essi è rimasto solo un volume
di componimenti.
• ‘Bollettino bibliografico’: Sienkiewicz E. Quo vadis? Illustrazioni
originali di Jan Styka, nuova traduzione del prof. Enrico Salvadori,
173
introd. del prof. Orazio Marucchi. Settoma edizione riveduta e correttaIn-12, pp. XXXII-413 – Torino, Libreria Editrice Internazionale, L. 10,
p. 160.
“E’ una bella edizione del fortunatissimo romanzo del Sienkiewicz. La versione
del Salvadori, chiara ed efficace, è fatta ad uso della gioventù e delle famiglie.
L’introduzione storico-archeologica del Marucchi giova ad inquadrare scientificamente
il romanzo. Il Marucchi osserva anche alcune manchevlezze di quest’opera, ed avrebbe
potuto forse mettere anche in più rilievo quanto manierismo retorico, assente dal vero
spirito della romanità, tolga valore d’arte al racconto el Sienkiewicz. L’edizione è
arricchita anche d’una pianta topografica di Roma ai tempi di Nerone. Suggestive ed
accurate sono le illustrazioni”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Tolstoi Leone. Diario (1895-1899). Trad. di
Valentina Dolghin, dall’originale russo. In-16, pp. XIV-219 – Milano,
Fratelli Treves editori, L. 10, p. 160.
n.4, aprile:
• E. Lo Gatto, Byron e la Russia, pp. 174-175:
L’A. sottolinea il relativo ritardo col quale la Russia ha conosciuto l’opera di
Byron e cita due poeti rappresentanti del byronismo, Puškin e Lermontov.
• Aurelio Palmieri, Byron e la Polonia, pp. 177-180.
L’A. presenta il volume di Marian Zdziechowski, Byron i jego wiek: studya
porównawczo-literackie (t. II, Cracovia, 1897), dedicato al byronismo presente nelle
letterature ceca, slovacca, russa e polacca, in occasione del centenario del poeta
inglese. In particolare, Zdziechowski approfondisce l’influsso di Byron nel
romanticismo polacco di Anton Malczewski, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz e
Krasiński.
• Ettore Lo Gatto, La stampa e la rivoluzione in ‘Libri di cui si parla’ –
Russia pp. 211-212.
Richiamandosi a un articolo di Frice sul libro di Sakulin Literatura i socializm,
pubblicato su “Piečat’ i revolucija” nel 1923, l’A. ne espone il contenuto.
n. 5, maggio:
• Ettore Lo Gatto, “I tre dialoghi” di V. Solovjov, pp. 266-267.
L’A. evidenzia come nonostante nella Russia sovietica il nome del celebre
filosofo russo venisse messo da parte la sua fama, sia in patria che all’estero, rimanesse
intatta, grazie anche alla ristampa di opere da parte di case editrici russe e non.
n. 6, giugno :
• Aurelio Palmieri, recensione a: Chefs-d’oeuvre, de Adam Mickiewicz,
traduits par lui-même et par ses fils avec une notice sur la vie de
l’auteur par Ladislas Mickiewicz, pp. 445. – Paris – Bossard, édit., pp.
322-323.
L’A. presenta la seconda edizione, di recente pubblicazione, delle opere di Adam
Mickiewicz, curata dal figlio Ladysław, curatore della biblioteca Mickiewicz a Parigi.
174
La raccolta comprende la traduzione del poema Grażyna, Conrad Wallenrod, le quattro
parti di Dziady,e i Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.
n. 7, luglio:
• Ettore Lo Gatto, La Russia dei contadini – recensione a: La mia vita,
racconto dettato da una contadina russa a T. A. Kuzminskaia, riveduto e
corretto da Leone Tolstoi. Proemio, traduzione e note di C. Salomon. In16, pp. 208 – Milano, Fratelli Treves editori, L. 6, PP. 376-378.
Nella prima parte del contributo Lo Gatto cita una serie di pubblicazioni dedicate
alla storia dei contadini in Russia, una classe sociale centrale nella storia civile e
letteraria del paese, dal saggio di Semevskij, Krestjane v carstvovanie imperatristy
Ekateriny II (Pietroburgo, 1881), all’opera di Masaryk, Russland und Europa
(Diederisch Verlag, Jena).
• ‘Bollettino bibliografico’: Mickiewicz Adamo. Grazyna, novella
lituana. Traduzione dal polacco con proemio e note di Roman Pollak.
In-16, pp. IX-135 – Napoli, Ricciardi edit., L. 8 – Poezje. Tom drugi.
Wiersze z lat 1825-1855 – Kraków, Krakowska Spólka Wydawnicza, p.
383.
n.8, agosto:
• Ettore Lo Gatto, Libri di storia, pp. 435-436 in ‘Libri di cui si parla’ –
Russia.
In occasione della ripresa degli studi scientifici presso le università russe
all’estero (Praga, Berlino) e le facoltà russe in università straniere (Londra, Parigi), l’A.
menziona una serie di recenti pubblicazioni sulla storia della Russia, mettendo in
rilievo quelle edite dalla casa editrice “Plamja” di Praga.
n. 10, ottobre:
• Stefania Kalinowska, recensione a: Grazyna, novella lituana di Adamo
Mickiewicz, traduzione dal polacco di Aurelio Palmieri, con prefazione
di R. Pollak. In-16, pp. IX-135. Napoli, Riccardo Ricciardi, editore, L.9,
pp. 546-547 in ‘Libri dicui si parla’ – Polonia.
L’A. elogia la traduzione, considerata seria e fedele al testo originale, firmata da
Palmieri, di cui si possedevano solo parziali edizioni francesi.
• Ettore Lo Gatto, Scritti recenti su Puskin, in ‘Libri di cui si parla’ –
Russia, pp. 546-548.
L’A. sottolinea come la ripresa degli studi scientifici fosse più marcata nelle
università russe all’estero, o in facoltà russe presso università straniere, dove il diritto
allo studio veniva considerato ‘inviolabile’, piuttosto che nella stessa Russia sotto il
regime sovietico.
n. 11-novembre:
• Ettore Lo Gatto, Libri di diritto – Libri di filosofia, in ‘Libri di cui si
parla’ – Russia, pp. 603-605
175
Si parla della fondazione di un’università russa a Praga, considerata il maggiore
centro culturale degli emigrati russi.
n.12, dicembre:
• e. [Ettore] l. [Lo] g.[Gatto], Ladislao Stanislao Reymont in ‘Libri di
cui si parla’ – Polonia, p. 659.
Biografia dello scrittore polacco in occasione del conferimento del premio Nobel
per la letteratura.
Anno VIII (1925)
n. 1, gennaio:
• Ettore Lo Gatto, Un libro sull’Italia, in ‘Libri di cui si parla’ Russia,
pp. 41-42.
Critica all’opera di Paolo Muratov Obrazy Italii nella sua edizione definitiva.
• Giovanni Maver, Serbia, p. 44 in ‘Libri di cui si parla’.
L’A. dedica il contributo alla rinascita della poesia serba tra il XIX secolo e il
XX secolo, partendo dal volume di Jovan Skerlić, Istorija nove srpske književnosti
(Belgrado, edit. G. Kon, 1921).
n.2, febbraio:
• Aurelio Palmieri, La lirica giovanile di Jan Kasprowicz, pp. 72-73.
Il contributo è dedicato alla biografia e all’opera di Jan Kasprowicz, in particolare
alla produzione poetica giovanile a partire dalla prima raccolta, Poezje, del 1880.
• Mario Buzzichini, Antologia della vita spirituale, di A. Mickiewicz,
traduzione di Aurelio Palmieri. In-16, pp. 209 – Roma, Istituto Romano
Editoriale, L. 10 in ‘Libri di cui si parla’ – Polonia, p. 96.
L’A. presenta il volume sull’infanzia e l’adolescenza di Mickiewicz, di cui elogia
non solo la fedele traduzione eseguita da Palmieri ma anche le ottanta pagine
introduttive sulla figura del poeta polacco e sul “misticismo” dei suoi versi,
considerando le poesie religiose e le lettere il suo vero patrimonio spirituale.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: La fontana di Bakhcisarai, di
Aleksander Serghieievic Puskin, tradotta da Enrico Damiani. In-16, pp.
68 – Firenze, Vellecchi, L.3,50, pp. 97-98.
L’A. critica la traduzione firmata da Damiani, denunciando la mancanza di ciò
che una traduzione dovrebbe sempre avere, ossia la corrispondenza tra contenuto e
forma. Tuttavia loda la pazienza e il coraggio mostrati dallo slavista nel tentativo di
conservare le stesse caratteristiche ritmiche del testo originale.
n.3, marzo:
• Ettore Lo Gatto, Libri di storia, pp. 148-149.
176
L’A evidenzia come le pubblicazioni di storia siano una parte preponderante
dell’attività editoriale russa all’estero e quanto il loro significativo aumento registrabile
negli ultimi anni sia dovuto da un lato ai bisogni scolastici, dall’altro al crescente
desiderio di recuperare la coscienza storica. Fra le pubblicazioni l’A. menziona
l’Introduzione alla storia russa di Šmurlo e la ristampa in Russia del Kurs russkoj
istorii di Ključevskij.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Roman i Zizn (Il romanzo e la vita),
Sviluppo della personalità creativa di Goncarov (1812-1857) di E. A.
Ljatskij. Vol. I, pp. 392 – Praga, Edit. “Plamja", p. 148.
L’A. presenta il secondo importante lavoro di E. A. Ljackij su Gončarov, dopo la
prima bibliografia delle sue opere pubblicata a Stoccolma nel 1920 e considerata una
mirabile ricostruzione della vita e dello spirito dell’autore di Oblomov.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Dostojewskij in der Werstersche kritick.
(D. nella critica occidentale), di J. M. Romein, pp. 225 – Haarlem, H. D.
Tjenk Willink & Zoon, p. 149.
Breve presentazione del volume dedicato alla ricezione di Dostoevskij in
Occidente.
• Ettore Lo Gatto, Garcon!…par Ivan Chmèlov. Roman, traduit du
russe par Henri Mongault, pp. 292 – Pris, Bossard in ‘Libri di cui si
parla’ – Russia, p. 149.
L’A. presenta brevemente il romanzo di Ivan Šmelëv, tradotto in francese e
contenuto nella importante raccolta dell’editore Bossard „Collection des textes
intégraux de la Littérature russe“, evidenziando l’impronta naturalistica e la capacità
dell’autore di riprodurre la parlata dei contadini e il dialetto cittadino.
• Aurelio Palmieri, Lo sviluppo della cultura ukraina in ‘Libri di cui si
parla’ – Ukraina, pp 149-151.
L’A. traccia le tappe fondamentali dello sviluppo della lingua e della cultura
ucraina a partire dalle origini della lessicografia nel XVI secolo (Lavrentij Zyzanij
Tustanovskij, Scienza della lettura e della comprensione delle lettere slave) fino al
periodo immediatamente antecedente la prima guerra mondiale, quando poco o nulla si
conosceva di quella cultura. Palmieri sottolinea, poi, la rinascita editoriale in lingua
ucraina presso la casa editrice di Berlino Ukrainskoe Slovo.
• Giovanni Maver, Alcuni drammi croati, in ‘Libri di cui si parla’ Letterature slave meridionali, pp. 152-153.
L’A. presenta brevemente alcune opere drammatiche croate, poco note in
Occidente, considerandole un esempio di riscatto del dramma croato dalla scarsa
considerazione da parte della critica. Si tratta di Požar strasti di J. Kosor, Svadbeni let
e Božji čoviek, di Milan Begović e Vučjak di Miroslav Krleža.
‘Bollettino bibliografico’: Slowacki Juliusz. Dziela wszystkie. Pod
redakcja Juljusza Kleinera. Dzial pierwszy. Utwory wydane za zycia
poety. Bibliografje opracowal Wiktor Hahn. Stz. XXXIV-483. – Lwów,
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, zl. 16, p. 160.
• ‘Bollettino bibliografico’: Lo Gatto Ettore. Critici letterari russi. In16, pp. 288 – Foligno, F. Campitelli ed., L. 18, P. 160.
• ‘Bolettino bibliografico’: Tyrghèniev Serghièvic Ivàn. Un mese in
•
177
campagna. Introduzione e traduzione dal russo di Enrico Damiani. In16, pp. 135. – Firenze, Vallecchi edit., L. 4, p. 162.
n.4, aprile:
• Aurelio Palmieri, Bibliografia polacca in ‘Libri di cui si parla’ –
Polonia, pp. 207-209.
L’A. dedica il contributo alla tradizione bibliografica polacca, più volte interrotta
dai continui saccheggi dei russi, a partire dalla splendida biblioteca “Zaluska”, fondata
dal vescovo di Kiev Józef Zaluski, primo bibliografo polacco, e custodita in una sala
della Biblioteca Imperiale di Pietrogrado.
n. 5, maggio:
• Ettore Lo Gatto, Valerio Brjussov in ‘Libri di cui si parla’ – Russia,
pp. 265-267.
In occasione della morte di Valerij Brjusov, Lo Gatto traccia un profilo biografico
del poeta legato al decadentismo e al simbolismo, sottolineandone l’anima aristocratica
nonostante l’adesione al governo di contadini e operai.
‘Bollettino bibliografico’: Cèkov Anton. Le tre novelle, dramma in
quattrro atti, trad. e introd. di B. Jakovenko, In -16, pp. 82, Firenze,
Vallecchi ed., L. 3, p. 275.
•
n. 6, giugno:
• Ettore Lo Gatto, Dostojevskij, pp. 320-321.
Si tratta della recensione all’edizione tedesca Piper di Monaco delle memorie della
moglie di Dostojevskij, ulteriore testimonianza della vita dello scrittore in aggiunta al
diario della figlia, di cui esisteva già un’edizione italiana a cura dei fratelli Treves di
Milano, e alla biografia a cura di Hoffmann.
• Marziano Bernardi, recensione a: Critici letterari russi, a cura di E. Lo
Gatto. In –16, pp. 288 – Foligno, Campitelli, editore, L. 18, pp. 321-322.
L’A. si sofferma sul fatto che il saggio non pretende di essere una storia compiuta
della critica letteraria russa nel suo svolgimento dalle origini ad oggi ma una guida alla
comprensione delle sue fondamentali tappe dalla metà del XIX secolo in poi,
mettendone in evidenza i protagonisti.
‘Bollettino bibliografico’: Borowy Waclaw. O “Przepiòrecze”
Zeromskiego. Str. 27 – Warszawa, “Nasza Ksiegarnia”, zl. 0,80, p. 328;
• ‘Bollettino bibliografico’: Cankar Ivan. Il sevo Bartolo e il suo diritto.
Trad. dallo sloveno di I. Regent e G. Sussek. In-16, pp. 123 – Trisete,
Casa editrice “Parnaso”, L. 7, P. 329.
• ‘Bollettino bibliografico’: Lunts Leone. Fuori legge. Trad. di Ettore
Lo Gatto, pref. di M. Gorkij. In-16, pp. 178. – Roma, Istituo Romano
Editoriale, L. 7,50, p. 330.
• ‘Bollettino bibliografico’: Waliszewski K. La Russie il y a cent ans. Le
•
178
règne d’Alexander I. Tome III: La Faillite d’un régime et le premier
assaut révolutionnaire. In-8 – Paris, Plon-Nourrit, fr. 20, p. 354.
N.7, luglio:
• Aurelio Palmieri, La risurrezione della Polonia, pp. 353-355.
Recensione all’omonimo volume di Francesco Tommasini edito da Treves e di cui
l’A. fornisce una dettagliata descrizione dei nove capitoli che lo compongono,
introdotti da una breve e chiara sintesi della storia antica della Polonia.
• Ettore Lo Gatto, Nicola K. Michajlovskij, in ‘Libri d cui si parla’ –
Russia, pp. 380-381.
In occasione del 25° anniversario della morte del pensatore e scrittore, l’A. ne
ricorda l’attività letteraria di rappresentante di un’intera generazione di intellettuali
che, vicini alle idee di Lavrov, seguivano l’indirizzo filosofico del “subbiettivismo
sociologico”.
n.8, agosto:
• Aurelio Palmieri, La filosofia polacca, pp. 433-435 in ‘Libri di cui si
parla – Polonia.
Nella prima parte l’A definisce gli aspetti che rendono ‘nazionale’ e circoscritto il
pensiero filosofico in Polonia menzionando Giuseppe Maria Hoëne Wronski (17781853), Giuseppe Goluchowski (1797-1858), August Czeszkowski (1814-1894),
Bronisław Trentkowski (1808-1899), Karl Libelt (1807-1875) e Józef Kremer (18061875). Nella seconda parte si descrive la biografia di Maria Hoëne Wronski.
• Ettore Lo Gatto, Letteratura narrativa, in ‘Libri di cui si parla –
Russia, pp. 434-436.
L’A. descrive il carattere della nuova letteratura russa, opera di giovani scrittori
‘soviettisti’ e di cui si occupavano in quel periodo le riviste dell’emigrazione “Volja
Rossii”, organo dei socialisti rivoluzionari, con articoli di Marco Slonim, e
“Sovremennye Zapiski” di Parigi, con saggi di Osorgin e Stepun. Si tratta di scrittori
come Babel’, Leonov, Sejfullina, Zoščenko, Pil’njak e Vsevold Ivanov.
• ‘Bollettino biliografico’: Dostoïevskij. Les possedés, suivis de La
Confession de Stavrognine. Seule traduction intégrale et conforme au
texte russe par Jean Chuzeville. 3 vol. In-16. pp. 337; 410; 420. – Paris,
Ed. Bossard, fr. 27, p. 442.
“Quest’opera tormentata e complessa, che preannunzia il travaglio sociale da
cui scaturì la rivoluzione russa, fu chiamata “il più politico romanzo di Dostoïevskij.
Ed è anche uno dei più profondi dal punto di vista filosofico. L’editore avverte che
questa è la prima olta che il famoso romanzo appare in francese nel suo testo integrale,
e la versione che ne ha dato Jean Chuzeville si legge con piacere, mentre cerca di
accostarsi – per quanto è possibile in una lingua tanto diversa – ai principali caratteri
dello stile di Dostoïevskij”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Nekrasof Nicola. Poesie, tradotte dal russo
da V. Narducci. In-16, pp. 135 – Roma, Istituto Romano Editoriale, L.
7,50, p. 443.
179
• ‘Bollettino bibliografico’: Arzybaschev M. La gelosia. Dramma in
cinque atti, traduz. Di Raissa Olkijeniskaja Naldi. In-16, pp. 158 –
Milano, “Alpes”, L. 6, p. 443.
• ‘Bollettino bibliografico’: Blok Alessandro. La rosa e la croce. ,
traduz. Di Raissa Olkjeniskaja Naldi. In-16, pp. 136 – Milano, “Alpes”,
L. 6, p. 443.
• ‘Bollettino bibliografico’: Sollogub T. Gli ostaggi della vita. Dramma
in cinque atti trad. di Raissa Olkjeniskaja Naldi. In-16, pp. 200 – Milano,
“Alpes”, L. 6, p. 444.
• ‘Bollettino bibliografico’: Vojnovic Ivo. La signora del girasole, trad.
dal serbo di A. Voltolina e U. Urbanaz-Urbani. In- 16, pp. 168 – Roma,
Istituto Romano Editoriale, L. 10, p. 444.
n.9, settembre:
• Ettore Lo Gatto, Da Lord Byron ai poeti slavi, pp. 461-463.
L’articolo affronta il tema dell’influenza del byronismo nelle letterature slave, in
particolare nel periodo romantico delle letterature russa, polacca e ceca.
• Giovanni Maver, Poeti bulgari in ‘Letterature slave meridionali’, pp.
492-493.
L’A. descrive il contenuto di un saggio sulla moderna letteratura bulgara pubblicato
su “Rivista di cultura” (anno VI, fasc. 3-4, pp. 61-156). Il saggio contiene poesie di
Penčo Slavejkov (Mikel Andželo, Inseparabili, Kărvava pesen) ed altre di Javorov,
Trajanov, Liliev, Gabe e Debeljanov, tre brevi racconti di Ivan Vazov, Todorov ed
Elin-Pelin, e due articoli, uno di Bojan Penev Duchăt na Bălgarskata literatura, l’altro
di A. Balabanov Bălgarski ezik.
• ‘Bollettino bibliografico’: Gorki Massimo. Fra la gente, versione di
Erme Cadei. In-16, pp. 378 – Milano, Società Editrice “Avanti”, L. 9, p.
498.
• ‘Bollettino bibliografico’: Guranowski Mieczyslaw. Ofiara Krwi. Str.
191 – Warszawa, F. Hoesick, p. 498.
n.10, ottobre:
• Ettore Lo Gatto, Puskiniana in ‘Russia’, pp. 548-550.
L’A esamina le ristampe di due saggi dedicati all’opera di Puškin curati
rispettivamente da Ovsjaniko-Kulikovskij e Kotljarevskij, evidenziandone una lacuna
presente anche in altre pubblicazioni: la mancanza di una bibliografia cronologica
completa delle opere.
n. 11 novembre:
• Ettore Lo Gatto, Puškin in polacco, in ‘Polonia’, pp. 604-606.
L’A. presenta la recente traduzione poetica dell’Onegin di Puškin uscita per la
180
celebre collana polacca di letteratura universale “Biblioteka Narodowa”, ristampa di
un’edizione curata dallo scrittore e poeta Leon Belmont, di cui lo slavista elogia
l’impeccabile traduzione con ampia prefazione di Wacław Lednicki.
n.12, dicembre:
• m.b. (?), recensione a: Jan Bielecki e La Genesi dallo spirito, di Giulio
Slowacki. Trad. dal polacco con proemio e note di Aurelio Palmieri . In16, pp. 107 – Anonima Romana Editoriale, L. 6, pp. 661-662.
L’A. presenta due scritti fondamentali per comprendere il passaggio di Słowacki
dal byronismo (Jan Bielecki) all’influenza di Mickiewicz (Genezis z Ducha) e, infine,
elogia l’ottima introduzione critica sui processi spirituali dello scrittore polacco.
• ‘Bollettino bibliografico’: Ljskov Nicola. L’angelo suggellato. Prima
traduzione dal russo e introduzione di Ettore Lo Gatto. In-16, pp. 166 –
Roma, Cada Editrice Alberto Stock. L. 9, P. 667.
Anno IX (1926)
n.1, gennaio:
• Aurelio Palmieri, L’edizione “autentica” delle opere di G. Slowacki,
pp. 42-44 in ‘libri di cui si parla’ – Polonia.
Dopo una breve storia sulla nascita della biblioteca privata di Józef Maksymilian
Ossoliński a Leopoli (Ossolineum), sede di preziosi manoscritti e autografi, e
dell’Istituzione Universitaria che la ospitò dietro un editto dell’imperatore Francesco I,
l’A. ripercorre le tappe che condussero alla genesi di un’edizione definitiva degli scritti
di Słowacki, concepita nel 1920 dal dottor Ludovico Bernacki, direttore
dell’Ossolineum e realizzata solo nel 1924.
n.2, febbraio:
• Ettore Lo Gatto, Che disgrazia l’ ingegno!, pp. 101-103.
L’A. menziona l’edizione critica di Gore ot uma di Griboedov curata da E. A.
Ljackij, che, rivalutando la commedia alla luce degli ultimi studi, rielabora il rapporto
Čackij-Griboedov per scovarne il significato storico non solo nell’ambiente
immaginario creato dal poeta ma anche in quello dove egli stesso maturò come artista.
n.3, marzo:
• Aurelio Palmieri, Stefano Zeromski, pp. 153-154 in ‘Libri di cui si
parla’ –Polonia.
Ricordando la morte di due celebri scrittori polacchi avvenuta l’anno precedente,
Stefan Żeromski e Władisław Reymont, l’A. ripercorre le principali tappe della
biografia di Żeromski.
• Ettore Lo Gatto, Sergio Esenin, pp. 154-156, in ‘Libri di cui si parla’ –
Russia.
181
Biografia dello scrittore.
n.5, maggio:
• Ettore Lo Gatto, Marina Zvjetaeva, pp. 242-243.
Parlando della biografia artistica di Marina Zvetaeva l’A. sottolinea come la
poetessa fosse ampiamente conosciuta e apprezzata solo dopo la guerra e la
rivoluzione. Il nome della Cvetaeva è presente nella rivista “Sovremennye Zapiski”
insieme a quello di Anna Achmatova nella sezione dedicata alla letteratura
dell’emigrazione.
• Giovanni Cesari, recensione a: Alessandro Puškin, di Eugenio
Onjéghin, Traduzione, introduzione e note di Ettore Lo Gatto, In-16, pp.
XXIV-273 – Firenze, Sansoni, editore, L. 10, pp. 266-268.
L’A. presenta il volume lodando la fedele e scorrevole traduzione dal russo
firmata da Lo Gatto.
• Giovanni Maver, recensione a: Storia di letteratura slave, volume
primo, di Ettore Lo Gatto, pp. 220, Roma, Anonima Romana Editoriale,
L. 10, p. 267.
L’A. sottolinea come la raccolta di saggi di Lo Gatto sulle letterature slave non
abbiano più il carattere prevalentemente informativo come in precedenza ma anche
documentario e scientifico con un particolare riferimento ai saggi su Mickiewicz,
Puškin e Saltykov.
n. 6, giugno:
• Aurelio Palmieri, Il sonetto polacco, pp. 298-299.
Recensione al volume di Władysław Folkierski, Sonet polski. Wybór tekstow
(Biblioteka Narodowa, Krakow, 1926) sulla storia del sonetto in Polonia con una ricca
scelta di componimenti, dai primi di Jan Kochanowski, Nikolaj Szarzyński, Sebastian
Grabowiecki e Andrzej Morsztyn ai più recenti sonetti di Francisza Nowicka e
Kazimira Zawistowka.
• Ettore Lo Gatto, Studi di poesia in ‘Libri di cui si parla’ – Russia, pp.
323-325.
Recensione al volume del prof. Bizilli Studi sulla poesia, in particolare al saggio
intitolato La poesia in Puškin sul passaggio del verso russo dalla misura di due ‘piedi’
a quella di tre con un impoverimento del ritmo. Il saggio affronta pure il ritorno della
poesia russa alle sue fonti, il canto popolare e la prosa ritmica. Il contributo si chiude
con un piccolo trattato sulla differenza tra poesia letteraria e canto popolare in Russia e
in Occidente.
n. 7, luglio:
• Stefania Kalinowska, Stanislao Wyspianski, pp. 350-351.
Profilo di Stanysław Wyspiański, letterato e artista polacco, di cui l’A. mette in
evidenza le principali caratteristiche: cultura greca, intuito artistico e sentimento
patriottico.
n. 9, settembre:
182
• Ettore Lo Gatto, Turgenev e l’Italia, pp. 469-471:
L’A. descrive le due occasioni in cui Turgenev fu in Italia, la prima in piena
giovinezza e la seconda intorno ai quarant’anni. La rievocazione fa riferimento al
volumetto critico di I. M. Greves, Turgenev e l’ Italia.
• Ettore Lo Gatto, recensioni a: Zapadnye literatury i slavjanstvo, di E.
V. Aničkov. Due volumi, pp. 135, 286 – Praga, “Plamja”, pp. 495-496.
L’A. presente i primi due volumi dell’opera generale del prof. E.V. Aničkov
dell’Università di Belgrado dedicata ai rapporti tra letterature occidentali e mondo
slavo nei confronti della tradizione tra l’XI e il XVIII secolo, anticipando un terzo
volume dedicato al XIX secolo. L’opera viene considerata a metà tra scientifica e
divulgativa.
• Ettore Lo Gatto, recensione a: Puškin, Sbornik pervyj, a cura di N. K.
Piksanov. In-16, pp. 370 – Mosca, Ed. governativa; Puškin, Stati i
materialy, a cura di M. P. Aleksjeev. Facsicolo I, on-16, pp. 80 –
Odessa, Ed. governativa - Puškin v zizni: charakter, nastroenija,
naruznost, odezda, obstanovka, di V. Varesaev. Fasc. I, in-16, pp. 146 –
Mosca, “Novaja Moskva”, pp. 495-496.
Presentazione di un volume che è parte di un’ampia raccolta di memorie, articoli,
e materiali, frutto di studi vari su Puškin condotti da Varesaev. I contenuti sono
ordinati cronologicamente, fino al soggiorno dello scrittore a Odessa, e
sistematicamente, per materia, seguendo le indicazioni dei sottotitoli del libro. L’A.
sottolinea come il volume rientri in una serie di pubblicazioni su Puškin, in forte
incrementate negli ultimi anni.
n.10, ottobre:
• Stefania Kalinowska, Jan Kasprowicz, pp. 532-533:
Ricordando la personalità di Jan Kasprowicz scomparso quest’anno l’A. ne
ripercorre le principali tappe della carriera artistica.
• Clemente Rébora, recensione a: Lirici russi del secolo aureo.
Traduzione di G. Gandolfi. Due volumi, in-18, pp. 370. Collezione
“Scrittori italiani e stranieri” – Lanciano, G. Carabba, editore, L. 8, pp.
553-554.
Breve presentazione del volume dedicato alla poesia russa dell’Ottocento con
riferimento ai recedenti lavori di Raissa Olkienizkaia Naldi, Antologia dei poeti russi
del XX secolo (Milano, Treves, 1924) ed Ettore Lo Gatto, Poesia russa della
rivoluzione (Roma, stock editore, 1924).
n. 11, novembre:
• Ettore Lo Gatto, Dostojevskij e l’ Occidente, pp. 586-588.
Recensione allo studio di Grossman su Dostojevskij del 1926, Dostojevkij i
Evropa, dedicato alla storia dei rapporti tra lo scrittore russo e l’Europa fatta di
entusiasmi alternati a delusioni, come quella avuta durante il suo soggiorno dal 1867 al
183
1871.
• Aurelio Palmieri, La letteratura polacca, in ‘Libri di cui si parla’ –
Polonia, pp. 607-608.
L’A. riassume le principali opere dedicate alla storia della letteratura polacca nel
primo ventennio del XX secolo menzionando i volumi di Stanisław Tarnowski, Piotr
Chmielowski, Gabriel Korbut, Manfred Kridl, Stanisław Lam, Stanisław Bakczyński e,
soprattutto, l’opera di Aleksandr Brückner.
n. 12, dicembre:
• Ettore Lo Gatto, Henryk Sienkiewicz, pp. 638-639.
Biografia dello scrittore.
Anno X (1927)
n.1, gennaio:
•
Ettore Lo Gatto, Gli Artamànov, in, pp. 53-54.
L’A. racconta la personale conoscenza con Gor’kij mentre lavorava al romanzo
Artamanovy. Lo slavista sottolinea il tono epico nella descrizione del tempo a grandi
linee, abbracciando più di mezzo secolo dalle riforme alla rivoluzione, e della vita
quotidiana, che va oltre la dimensione delle ore e supera la sfera individuale dello
scrittore per rappresentare quella di intere generazioni.
n.3, marzo:
Ettore Lo Gatto, “I Fratelli Karamazov nella critica del tempo”,
‘Rassegne straniere’, Russia, pp. 164-166.
L’A. si sofferma sulla questione centrale del romanzo di cui la critica social-
•
psicologica si occupò maggiormente al tempo della sua composizione, ovvero la
cosiddetta “karamazovščina”, cioè “sfrenatezza morale e spirituale” di cui i
Karamazov, in particolare Dmitrij, erano una personificazione.
• Bollettino bibliografico: Gorki Massimo. Noterelle, a cura di Erme
Cadei – In- 16, pp. 360, Milano, ed. Morreale, p. 163.
n. 4, aprile:
• Ettore Lo Gatto, Michele Arzybascev, pp. 189-190.
Biografia dello scrittore.
• Ettore Lo Gatto, Il ritorno di Prus in ‘Libri di cui si parla’ – Polonia,
p. 218.
L’autore sottolinea il rinnovato interesse della critica per le opere di Bolesław
Prus testimoniato dalla recente pubblicazione e ristampa di una serie di volumi, alcuni
dei quali appartengono a eminenti storici della letteratura polacca come Konstanty
Wojcjechowski, Luswik Włodek e Feliks Araszkiewicz.
184
n. 5, maggio:
• Stefania Kalinowska, Micinski e l’anima polacca, pp. 247-248.
Biografia dello scrittore.
• Mario Buzzichini, recensione a: Favole e racconti innocenti, di M. E.
Saltykov-Scedrin. Prima traduzione dal russo di Ettore Lo Gatto. In-16,
di pp. 201 – Roma, Ed. Alberto Stok, L. 10, in ‘Libri di cui si parla’ –
Russia, p. 275.
L’A. evidenzia una certa sproporzione fra la presentazione che Lo Gatto fa
dell’autore in 55 pagine di introduzione al testo, ricca di date e nomi, e l’esiguo numero
di scritti contenuti nella raccolta.
n. 7, luglio:
• Giovanni Maver, recensione a: Stefano Zeromski (studio critico), di E.
Lo Gatto. In-16, pp. 62 – Roma, “A. R. E. “, L. 5 in ‘Libri di cui si parla’
– Polonia, p. 388.
L’A. si sofferma su alcune costanti nella letteratura polacca contemporanea,
particolarmente legata al patriottismo e al martirologio della Polonia, fonti
d’ispirazione che hanno prodotto splendide pagine di letteratura, ma anche limitato la
sua diffusione fuori dai confini nazionali come nel caso dell’opera di Stefan Żeromski.
n. 8, agosto:
• Ettore Lo Gatto, Lirici bulgari in ‘Letterature slave meridionali’, pp.
389-390.
Breve compendio di studi su alcuni poeti bulgari e sul loro contributo nel processi
di apertura della letteratura bulgara alle correnti letterarie europee, in particolare al
simbolismo e al romanticismo (byronismo). Vengono menzionati fra gli altri Pjejo
Javorov, scomparso nel 1914, Penčo Slavejkov, Petko Todorov, Ivan Vazov e Kiril
Hristov.
• Stefania Kalinowska, Slowacki in Polonia, pp. 415-416.
Breve contributo sulla fortuna di Słowacki in Polonia e sugli studi a lui dedicati;
• Ettore Lo Gatto Problemi di poetica, in ‘Libri di cui si parla’ – Russia,
pp. 444-446:
L’A. raccogli qui una serie di studi pubblicati recentemente in Russia e dedicati
alla poetica.
n. 11, novembre:
• f. d. l., La Pologne restaurée, di Casimiro Smogorzewski. In-8, pp.
200 – Parigi, Edizione Gebethner e Wolff in ‘Libri di cui si parla’ –
Polonia, pp. 611-612.
L’A. presenta il volume, pubblicato in francese e dedicato al periodo storico che
ha segnato la rinascita della Polonia, un’opera complessa se si considera la rapidità con
185
la quale i fatti storici si sono susseguiti. Partendo dallo scoppio della guerra nel 1914,
quando il paese era diviso tra rivoluzionari, guidati da Piłsudski, e ‘opportunisti’, alla
guida di Roman Dmowski, il libro esamina la politica estera della Polonia, i suoi
rapporti col Vaticano e con la Francia.
• Giovanni Maver, Poeti serbi, croati e sloveni in ‘Libri di cui si parla’ –
Letterature slave meridionali, pp. 612-614.
Recensione al volume di I. Kusar Poety jugoslavi del rinascimento, raccolta di
componimenti appartenenti ad alcuni fra i migliori poeti serbi, croati e sloveni della
metà del XIX secolo.
n. 12, dicembre:
• Ettore Lo Gatto, Akhenaton, gioia del sole (D. Mereshkowsky), pp.
635-637.
Recensione all’edizione dei romanzi Messija, Radost’ solnca, Roždenie bogov.
Tutankamon na Krite, nella traduzione di Nina Romanowsky. L’A. si limita a
descriverne la trama.
• Ettore Lo Gatto, La letteratura classica e i soviety- Le letture di Lenin,
in ‘Libri di cui si parla’ – Russia, pp. 664-666.
L’A. espone il contenuto di diversi saggi pubblicati in quegli anni e dedicati al
rapporto tra la critica marxistica russa e la letteratura classica del glorioso XIX secolo.
• Giovanni Maver, Un croato traduttore di se stesso, in ‘Letterature
slave meridionali’, pp. 666-667.
Recensione al volume di poesie di Vladimir Nazor tradotte da lui stesso.
Anno XI (1928)
n. 1, gennaio:
• Trim, Amori di Russia lontana, in ‘Tra il libro e la vita’, pp. 24-25.
Presentando il volume Ivan Turgenev, Scene e Commedie, a cura di Rinaldo
Küfferle per le edizioni Slavia, l’A. definisce le principali caratteristiche del popolo
russo, in particolare la capacità, comune agli italiani, di adattarsi facilmente ad ogni
luogo e situazione e di portarsi dietro la memoria del proprio paese.
n. 3, marzo:
• Ettore Lo Gatto, I romanzi storici di M. A. Aldanov, pp. 174-176.
L’A. descrive la personalità di Aldanov nella doppia veste di ‘scrittore’ e
‘artista’ alla luce del rapporto Aldanov-Tolstoj più volte indagato dalla critica.
• Augusto Vicinelli, recensione a: La tempesta di neve, di Leone Tolstoi,
a cura di Ada Prospero. In-16, pp. 250 – Torino, Ed. Slavia, L. 11 in
‘Rassegne estere’– Russia, pp. 176-177.
186
Recensione al volume curato da Ada Prospero su cinque novelle di Tolstoj,
scritte dal 1856 al 1886, che costituiscono un breviario della vita spirituale dell’artista.
• G. F. Cecchini, recensione a: Studi di letterature slave, di Ettore Lo
Gatto. In-16, pp. 189 – Roma, Anonima Romana Editoriale, L. 10 in
‘Rassegne estere’ -Letterature slave, pp. 177-178.
L’A. presenta il volume di Lo Gatto dedicato alla letteratura ceca, polacca e russa,
in particolare la biografia e le opere di Julius Zeyer (1841-1901), Jan Kasprowicz, gli
Inni, Bolesław Prus e Stefan Żeromski, più un saggio magistrale, La letteratura russa
nella letteratura mondiale, prolusione di Lo Gatto al corso ufficiale di letteratura russa
presso l’Università di Napoli nell’anno accademico 1926-1927.
n. 5, maggio:
• Dionisio Colombini, Dalmazia, in ‘Tra il libro e la vita’, pp. 284-285.
presentazione del volume di recente pubblicazione sulla storia, geografia e
politica della Dalmazia. Il saggio, a cura di Antonio D’Alia, già console d’Italia a Zara,
comprende una prima parte storica, che analizza il periodo dalle dominazioni medievali
agli Asburgo fino alla formazione della Jugoslavia e a importanti avvenimenti come il
Trattato di Rapallo e l’accordo di Roma, e una seconda parte ricca di informazioni
sull’economia.
n. 8, agosto:
• Giovanni Maver, Una storia italiana della letteratura russa, in
‘Rassegne estere’, pp. 502-503.
L’A. presenta i primi due volumi della Storia della letteratura russa di Lo Gatto
pubblicati dall’Anonima Romana Editoriale e dedicati al periodo compreso tra le
origini e il XVIII secolo. L’A. evidenzia la straordinaria competenza mostrata dallo
slavista nell’affrontare ogni secolo della letteratura.
• ‘Bollettino bibliografico’: Gorki Massimo. Racconti del ’22-’24.
Versione diretta dal russo di Erme Cadei. In -16, pp. 289 – Milano,
Fratelli Treves edit., L. 12, p. 506.
• ‘Bollettino bibliografico’: Tolstoj L. Guerra e pace. Due volumi. Ina6, pp. 345; 390 – Torino, “Slavia”, 1924, p. 507.
n. 9, settembre:
• Stefania Kalinowska, Stanislao Przybyszewski, pp. 534-535.
Biografia dello scrittore.
• Mario Parodi, I cento anni di Leone Tolstoi, pp. 536-538.
A cento anni dalla nascita Parodi traccia un profilo biografico dell’artista.
• Giovanni Maver, Sangue impuro in ‘Rassegne Estere’ – Letterature
slave meridionali, p. 570.
L’A. presenta la traduzione italiana del romanzo di Borisav Stanković Nečista krv,
187
firmata da Umberto Urbanaz-Urbani per Treves-Zanichelli. Il romanzo, ambientato
nella Serbia meridionale dove da secoli s’incrociano religioni e razze diverse, viene
definito l’“opera più poderosa che la letteratura serba abbia prodotto negli ultimi dieci
anni”.
• ‘Bollettino bibliografico’: Lukomskij G. K., Mobilier et Décoration
des anciens palais impériaux russes. 84 tav. – Paris, G. Van Oest édit.,
fr. 250, p. 571.
• ‘Bollettino bibliografico’ : Cechov A. La mia vita. In-16, pp. 292 –
Torino, “Slavia”, L. 11, p. 573.
Anno XII (1929)
n. 1, gennaio:
• Giovanni Maver, I polacchi in Siberia, in ‘Rassegne Estere’ – Polonia,
pp. 53-54
Si tratta della recensione al volume di Michał Janik, Dzieje Polaków na Syberii.
(Kraków, Krakowska Społka Wydawnicza), basato sulle memorie e sulle osservazioni
degli stessi polacchi esuli in Siberia, protagonisti della prima e della seconda ondata
rivoluzionaria nel 1831 e nel 1863.
• ‘Bollettino
bibliografico’: Lo Gatto Ettore, Letteratura Soviettista. In16, pp. 167 – Roma, Istituto per l’Europa Orientale, L. 15, p. 56.
‘Bollettino bibliografico’: Kehler Henning, Croniques Russes. Les
premieres temps du bolchevisme (1917-1919). Traduite du danois par E.
Ch. Dunau e J. Gateau. In-16 – Paris, Perrin et Cie, fr. 12, p. 60.
•
• ‘Bollettino bibliografico’: Koch-Weser Erich, Russlandvon heute. Das
Reisetagebuch eines Politikers. In-8 – Dresden, Reissner.
n. 2, febbraio:
• Giovanni Maver, recensione a: Scrittori jugoslavi, di Umberto
Urbanaz-Urbani. Prefazione di P. Popovic. In-16, pp. 210 – Trieste,
Casa Editrice Parnaso, L. 13,50 in ‘Rassegne Estere’ – Letterature slave
meridionali, p. 116.
Presentazione di una raccolta di quindici articoli, già pubblicati su vari giornali e
riviste, dedicati ad altrettanti scrittori serbi e croati dal romanticismo ad oggi, ad
esclusione della letteratura slovena, prevista nel secondo volume dell’opera.
n. 3, marzo:
• Annibale Carena, La Russia agricola, di Valentino Crea. In-16, pp.
188 – Milano, Libreria d’ Italia, L. 5, p. 181.
Presentazione del volume di Crea, parte di una collezione di studi sui problemi
188
culturali e politici del mondo contemporaneo, edizioni Libreria d’Italia. Il saggio
intende dimostrare come l’economia della Russia, dalle sue forme primitive a quelle
più moderne, sia una logica successione di sistemi economici fino alla N.E.P.
annunciata da Lenin nel 1917.
n. 4, aprile:
• Ettore Lo Gatto, Tolstoiana, in ‘Rassegne Estere’ – Russia, pp. 244245.
L’A. fa un bilancio delle recenti pubblicazioni degli scritti di Tolstoj che in
Russia hanno accompagnato, seppure con un certo ritardo, le celebrazioni del primo
centenario della nascita avvenute nel settembre 1928 in attesa della grande Opera
omnia in 92 volumi annunciata dalla casa editrice governativa.
n. 5, maggio:
• Giovanni Maver, Narratori polacchi, in ‘Rassegne Estere’ – Polonia,
pp. 305-307.
Dopo una breve introduzione sulle caratteristiche della letteratura polacca del
XIX secolo, distinguibile da quella russa per la costante presenza di temi patriottici
dall’età romantica alla contemporanea, l’A. sottolinea la graduale trasformazione
dell’arte narrativa avvenuta in Polonia negli ultimi anni presentando alcune recenti
pubblicazioni, fra le quali un volume sulle novelle di Stefan Żeromski.
•
Ettore Lo Gatto, Memorie letterarie, pp. 307-309.
L’A. dedica il contributo alle numerose Memorie di cui è ricca la letteratura
russa, in particolare quelle di Puškin, Tolstoj e Turgenev.
• Annibale Carena, recensione a: L’avvenire religioso russo nel pensiero
di Vladimiro Soloviev, di Mons. Michele D’ Herbigny. In-16, pp. 338 –
Brescia, Marcelliana, L. 12, in ‘Rassegne Estere’ – Russia, p.309.
L’A. presenta il volume sul pensiero del filosofo russo, evidenziandone la buona
traduzione e la curata veste editoriale.
• ‘Bollettino bibliografico’: Pozner Vladimir. Littérature russe. Coll.
Panoramas des littératures contemporaines – Paris, S. Kra, édit., fr. 20,
p. 312.
• ‘Bollettino bibliografico’ : Felyne Ossip. In due con l’Ombra. In-16,
pp. 252 – Milano, Fratelli Treves edit., L. 10, p. 312.
n. 8, agosto:
• Ettore Lo Gatto, Scrittori visti dai contemporanei, in ‘Rassegne
Estere’ – Russia, pp. 502-503.
L’A. prosegue la sua rassegna di Memorie nella letteratura russa partendo da
quelle di Vissarion Belinskij.
• ‘Bollettino bibliografico’: Rhys Williams Albert, The Russian Land.
189
In-16, pp. 286 – London, Geoffrey Bles.
• ‘Bollettino
bibliografico’:
Sakazow
Iwan.
Bulgarische
Wirtschaftsgeschichte. Aus dem Bulgarischen ubertragen von Otto
Mueller-Neudorf. In-8, Berlin d Gruyter.
• ‘Bollettino bibliografico’: Trachtenberg Alexander. Lenin. Parte I and
II. The Revolution of 1917: from the March Revolution to teh July Days.
Translated by Joshua Kunitz and Moissaye J. Olgin. – London, Martin
Lawrence.
n. 10, ottobre:
• Giovanni Maver, Il Mondo Slavo, pp. 596-598.
L’A. confronta i due grandi volumi sulla storia e la cultura degli slavi: il primo è
l’opera di Aleksander Brückner, Zarys Dziejów literatur i języków literackich
słowianskich, edito a Leopoli nel 1929 e fortemente polemico nei confronti della
corrente di pensiero che sostiene l’autonomia e la peculiarità di ogni cultura slava, il
secondo è il saggio di Frank Wollman Slovesnost Slovanu a favore dell’unità culturale
panslava.
• Annibale Carena, recensione a: La Pologne, l’ Allemagne et le
“Corridor”, di Casimir Smogorzewski. In-16, pp. 225 – Parigi, Edit.
Gebethner e Wolff, L. 10, p. 631.
L’A. presenta il volume del noto storico e studioso polacco, che intende
dimostrare come gli attuali confini polacco-tedeschi, legati alla questione del
„Corridoio di Danzica“, siano legittimi. Dal punto di vista dei polacchi in nessun
distretto della Polonia i tedeschi sono in maggioranza e l’appartenenza di Danzica e
della Pomerania alla Polonia è indiscussa nonostante la Germania reclami entrambe le
regioni.
• Bollettino bibliografico’: Lo Gatto Ettore, Dall’epica alla cronaca
nella Russia soviettista. In-16, PP. 213- Roma, Stab. Tipogr. Riccardo
Garroni, L. 15, p. 633.
n. 11, novembre:
• Ettore Lo Gatto, Otokar Brezina, pp. 662-664.
In memoria del poeta ceco, pseudonimo di Vaclav Zabavy, scomparso lo scorso marzo
e considerato il creatore del movimento modernista in Cecoslovacchia, l’A. descrive le
principali caratteristiche della sua poesia, dai tratti mistici e simbolistici della prima
raccolta Tajmné dalky de 1895 alla cultura filosofica platonica e neo-platonica di
successive raccolte come Svitani na zapade (1896), Vetry od polu (1897) e Svatitele
chramu (1899).
• ‘Bollettino bibliografico’: Ossendowski F.A. Lenin. Trad.
dall’originale polacco e introduzione di leonardo Kociemski. In-8,
Milano, ed. Corbaccio, L. 30;
190
n. 12, dicembre:
• Giovanni Maver, recensione a: Maria Konopnicka, Italia. Liriche.
Versione in prosa e introduzione di Cristina Agosti Garosci e di Clotilde
Garosci. In-16, pp. 187- Roma, Istituto per l’ Europa Orientale, pp. 757758.
Presentazione del volume sulle liriche composte in Italia da Maria Konopnicka,
di cui l’A. elogia l’ottima introduzione di Cristina e Clotilde Garosci.
“Leonardo. Rassegna mensile della cultura italiana pubblicata
sotto gli auspici della Fondazione Leonardo” (Luigi Russo,
1925-1929)
Anno I (1925)
20 gennaio, n. 1:
• Ettore Lo Gatto, Italianizzati all’estero: Paolo Muratov, con un ritratto
dello scrittore, pp. 10-11.
L’A. include Pavel Muratov all’interno della schiera di artisti e scrittori russi, che
negli ultimi anni hanno fatto conoscere l’Italia in Russia, fra i quali anche Zajcev,
Osorgin, Baltrušajtis e, in particolare, menziona la rivista d’arte da lui diretta “Sofija”, i
tre volumi di Obrazy Italii sulla storia dell’arte italiana e l’intensa attività di italianista
presso lo Studio italiano di Mosca di cui fu Presidente e co-fondatore insieme a
Odoardo Campa.
Ettore Lo Gatto, recensione a: Adamo Mickiewicz, Grazina. Novella
lituana. Traduzione dal polacco con proemio e note di Aurelio Palmieri
ed uno studio di Roman Pollak. (Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa
Orientale in Roma. 1° serie, VII). Napoli, Ricciardi, 1924, pagg. 133, L.
8 – Antologia della vita spirituale. Traduzione di Aurelio Palmieri.
Roma, Istituto Romano Editoriale, 1925, pagg. 208, L. 10 – Pan Taddeo
Soplitza. Traduzione di Clotilde Garosci. Introduzione di C. Agosti
•
191
Garosci. Lanciano, Carabba, s. d. ma 1924, pagg. XVI, 159, 193. Ogni
volume L. 4.
-Rivista di cultura. Numero speciale dedicato a Mickiewicz. (Anno V,
fasc. 5-7). Roma, Maglione e Strini, pagg. 100, L. 7, p. 21.
Presentazione della raccolta di testi e dell’accurata bibliografia sulla fortuna
critica di Mickiewicz in Italia, curata da Roman Pollak ed Enrico Damiani per un
numero speciale della “Rivista di cultura”. In particolare, l’A. si sofferma sulle più
recenti traduzioni italiane di Grażyna e Pan Tadeusz, firmate rispettivamente da
Aurelio Palmieri e Clotilde Garosci e considerate tra le migliori esistenti, e gli studi
introduttivi ricchi di notizie e riferimenti vari.
• E. Lo Gatto, recensione a: A. Cecov, Ivànov e Il giardino dei ciliegi.
Traduzioni di C. Grabher , Vallecchi, Firenze, 1924, p. 21.
Come già in precedenza anche qui Lo Gatto elogia le buone traduzioni dal russo
eseguite da Carlo Grabher grazie alla padronanza di italiano e russo, e considera queste
il completamento della conoscenza, che il pubblico italiano aveva già del teatro di
Čechov.
20 dicembre, n. 12:
• Carlo Grabher, recensione a: A. Cekov, Le tre sorelle. Dramma in 4
atti. Traduzione e introduzione di B. Jacovenko. Vellecchi, Firenze,
1925, L. 3, pp. 277-278.
Confrontando questa traduzione con altre già firmate in passato da Jakovenko,
l’A. sottolinea la maggiore aderenza al testo originale.
Carlo Grabher, recensione a: Fiodor Sollogub, Il dèmone meschino.
Trad. dal russo di E. Lo Gatto. F. Campitelli ed., Foligno.
•
L’A. analizza il romanzo di Sologub, sviscerandone la doppia natura descrittiva e
poetica; composto nel primo periodo della produzione artistica, Melkij bes è intriso di
profondo pessimismo da cui scaturisce un mondo interiore notturno e caotico.
• Carlo Grabher, recensione a: Leone Lunts, Fuori legge. Tragedia.
Trad. dal russo di E. Lo Gatto. Pref. di Massimo Gorkij. Istituto Romano
Editoriale, 1925, L. 8, 25, p. 278.
Dopo una lunga introduzione sul percorso artistico di Lev Natanovič Lunc,
animatore dei Serapionovy brat’ja, e sul ruolo della fabula nella narrazione, l’A.
analizza il dramma Vne zakona, individuando nell’eccessivo tecnicismo dell’intreccio
l’unico difetto di rilievo.
Anno II (1926)
20 marzo, n. 3:
• Carlo Grabher, recensione a: Aurelio Zanco, A. P. Cèhov dal suo
epistolario. Firenze, Soc. An. Editrice “La Voce”, 1925, pp. 171, L. 11,
p. 74.
Pur lodando la scorrevolezza e la cura dei dettagli di Zanco nella raccolta
epistolare di Čechov, l’A. evidenzia alcune imperfezioni; in alcuni tratti assume,
192
secondo l’A., un carattere aneddotico a causa di troppi particolari e descrizioni
superflue, sulle quali Zanco spesso indugia e che impediscono un’organica visione
d’insieme.
20 ottobre, n. 10:
• E. Damiani, recensione a: Rivista di letterature slave. Diretta da Ettore
Lo Gatto. Anno I, giugno 1926, vol. I, fasc. I-II (Roma, Anonima
Romana Editoriale), pp. 278-279.
L’A. introduce la “Rivista di letterature slave” evidenziandone il carattere
divulgativo e documentario che la accomuna a “Russia”, di cui costituisce il seguito. In
particolare, lo slavista analizza da vicino il primo volume in uscita, ampiamente
dedicato alla Polonia, dove si festeggia il giubileo letterario di Jan Kasprowicz, e alla
Bulgaria, che celebra il nobile poeta-patriota Hristo Botev nel cinquantesimo
anniversario della sua morte.
Anno IV (1928)
20 gennaio, n. 1:
‘Bollettino bibliografico’:
• Cècov A.: Lavori drammatici in un atto. Trad. e introd. di C. Grabher.
Firenze, Vallecchi, 1928, pp. 144, L. 6,50, p. 31;
20 febbraio, n. 2:
• E. Damiani, recensione a: Wladislaw St. Reymont, I contadini.
Romanzo. Vol. I: L’Autunno in ‘Letterature slave’. Pref. del prof.
Taddeo Zielinski dell’ Università di Varsavia. Trad. dal polacco di
Aurora Beniamino, unica autorizzata dall’ autore. Aquila, Vecchioni,
1927, L. 12, pp. XXXII-423.
L’A. elogia l’impresa compiuta dalla Beniamino nel tentativo di tradurre la grandiosa
epopea di Reymont che gli fruttò il Nobel del 1924. A parte la mole dell’opera,
costituita da quattro grossi volumi, il linguaggio ripreso dalla vita dei campi rende
particolarmente difficile l’adattamento alla lingua italiana. La dotta introduzione di
Zieliński riproduce una conferenza tenuta dallo stesso a Roma (v. Collezione di
scrittori italiani e stranieri diretta da Mario Speranza).
• E. Damiani, recensione a: Fjodor Sollogub, Più dolce del veleno in
‘Letterature slave’. Trad. dal russo di Sergio Topf., pref. di Mario
Speranza. Aquila, Vecchioni, 1927. Un vol. in –16° di pag. 133, L. 5,
pp. 53-54.
L’A. critica negativamente sia il testo originale di Sologub, definito “letteratura
193
malata” e “storia senza senso”, sia la traduzione italiana di Topf.
Bollettino bibliografico:
• Reymont W. St.: I contadini. Aquila, Vecchioni, 1928, L. 12, p. 63.
20 marzo, n. 3:
‘Bollettino bibliografico’
• Tolstoj L.: Resurrezione. Trad. di V. Dolghin-Badoglio. Torino,
Slavia, 1928, 2 voll., L. 24, p. 96.
20 aprile, n. 4:
‘Bollettino bibliografico’
• Gorki M.: La spia. Romanzo della rivoluzione. Seconda edizione.
Trad. di C. Castelli. Milano, Monanni, 1928, pp. 271, L. 4, p. 127.
• Ossendowski F.: L’aquilessa. Romanzo. Trad. di A. Koltonski.
Milano, Morreale, 1928, pp. 246, L. 9, p. 127.
20 maggio-20 giugno, n. 5-6:
• E. Damiani, recensione a: Leone Tolstoj, Memorie, Infanzia,
Adolescenza, Giovinezza. Traduzione, introduzione, note, analisi,
biografia e bibliografia a cura di Ettore Lo Gatto. Firenze, Le Monnier,
1927 in ‘I grandi autori stranieri tradotti e annotati’, collezione diretta da
L. De Anna. Un vol. in-16° di pg. 341, L. 10, p. 166.
L’A. elogia l’edizione italiana delle Memorie di Tolstoj, sottolineandone la
scrupolosa traduzione, la bella forma italiana, l’accurata veste tipografica e le ricche
notizie bibliografiche.
• E. Damiani, recensione a: Fjodor Dostojevskij, Gli ossessi. Romanzo.
Trad. dal russo di Olga Resnevic, con prefazione e cenni biografici.
Foligno, Campitelli, 1927, 3 volumi di complessive pagine 1150, L. 35,
p. 166.
L’A. elogia l’ottima traduzione italiana di Olga Resnevič Signorelli, scrittrice
russa italianizzata, già nota in Italia per le belle versioni da autori russi.
• E. Damiani, recensione a: Maurycy Mann, Najnowsze prady
umyslowe zachodniej Europy. II. Wlochy. Warszawa, Wydawnictwo
194
Kola Historykòw S. U. W., 1928, pp. 166-167.
‘Bollettino bibliografico’
• Dostoïevskij F.: Umiliati e offesi. Romanzo. Trad. di O. Felyne, L.
Neanova e C. Giardini. Milano, Casa ed. Alpes, 1928, pp. 442, L. 15, p.
191.
• Turghèniev I.: Padri e figli. Romanzo. Vers. con note di G, Pochettino.
Torino, Slavia, 1928, pp. 265, L. 10 (Il Genio russo), p 191.
20 luglio, n. 7:
‘Bollettino bibliografico’:
• Amfiteatroff A.: Goldoni e la commedia russa (in “Rivista d’Italia”,
giugno, 1928), p. 222.
• Mereshkowski D.: L’ombra di colui che viene. Romanzo. Trad. di N.
Romanowsky. Milano, Treves, 1928, L. 12, p. 223.
• Stankovic B.: Sangue impuro. Romanzo, Trad. di U. Urbani. Trieste,
Treves-Zanichelli, 1928, pp. 244, L. 10, p. 223.
• Tolstoj L.: La tempesta di neve e altri racconti Trad. di A. Prospero,
2° ed., Torino, Slavia, 1928, pp. 300, p. 223.
20 agosto, n. 8:
• E. Damiani, recensione a: Bohuslav Cerny, Carlo Ongaro. Dalle
Dalle origini a tutto il secolo XVI. Vol. II. Roma, A. R. E., 1928; Id.,
Corso pratico elementare della lingua cecoslovacca, Secondo il metodo
del Prof. Dott. Lamm, Milano, Hoepli, 1928, p. 250.
Breve presentazione della struttura del volume, organizzato in cinquanta lezioni
con relativi esercizi di lettura, arricchito da abbondanti esemplificazioni e da un
minuscolo vocabolario ceco-italiano. L’A. sottolinea l’importanza che questo primo
volume di grammatica ceca riveste nel progresso degli studi slavistici in Italia.
‘Bollettino bibliografico’:
• Artzybascev M.: Al limite estremo. Romanzo. Trad. di M. Salviati.
Milano, Monanni, 1928, pp. 294, L. 4, p. 255.
• Tolstoi A.: Il principe Serebriany. Firenze, Salani, 1928, pp. 434, L. 5,
p. 255.
• Tolstoi A.: Guerra e pace. Vers. di Duchessa d’Andria. Vol. I e II.
Torino, Slavia, 1928, L. 5, p. 255.
20 settembre, n. 9:
195
• E. Damiani, recensione a: Martino Kukucin, Cronache della casa
triste. Con uno studio di Wolfango Giusti sulla letteratura slovacca.
Udine, Libreria Editrice “Aquileja”, 1928 in “Bibliteca italiana e
straniera” diretta da B. Chiurlo e G. Lorenzoni. Un vol. di 104 pag., p.
279.
L’A. presenta il volume evidenziandone i due pregi fondamentali: il primo è quello
di presentare un autentico lavoro slovacco, considerato capolavoro di una letteratura
ancora poco nota in Italia, il secondo è il saggio schematico sulla letteratura slovacca,
che il traduttore fa precedere al racconto di Kukucin.
‘Bollettino bibliografico’
• Czyzowski C.A.: Maciek I, re dell’aria. Trad. Di I.M.Boni. Bologna,
Cappelli, 1928, pp. 125, L. 5, p. 286.
• Slavèjkov P.: Canti epici e lirici, scelti e volti in versi italiani da E.
Damiani, 2° ediz., Venezia, Casa editr. La Nuova Italia, 1928, pp.
XVIII-59, Lire 4,80, p. 186.
• Stankovic B.: Sangue impuro. Romanzo. Trieste, Treves-Zanichelli,
1928, pp. 244, L. 10, p. 286.
20 ottobre, n. 10:
‘Bollettino bibliografico’
• Gorki M.: Racconti del ’22-’24. Versione di E. Cadei. Milano, Treves,
1928, pp. 289, L. 12, p. 319.
• Tolstoi L.: I quattro libri di lettura. Traduzione di A. Treves. Milano,
Monanni, 1928, pp. 335, L. 4, p. 319.
20 novembre, n. 11:
‘Bollettino bibliografico’
• Sollogùb F.: Più dolce del veleno. Romanzo. Trad. di S. Topf. Aquila,
Vecchioni, 1928, L. 5, p. 351.
• Tolstoi L.: Guerra e pace. Trad. di Duchessa d’Andria. Torino, Slavia,
1928, L. 72.
• Tolstoi L.: L’ultimo Tolstoi. Opere postume. Trad. da L. Grillo e B.
Gurevich. Bologn, Casa ed. Apollo, 1928, pp. 458, L. 13,50, P. 351.
20 dicembre, n. 12:
196
• E. Damiani, recensione a: Lukasz Gòrnicki, Dworzanin polski.
Oprocowal Roman Pollak: Krakow, “Krakowska Spol-a Wydawnicza”,
1928. “Biblioteka Narodowa”, Serja I, n. 109 (Il Cortegiano polacco.
Introduzione e commento di Roman Pollak) in ‘Letteratura polacca’, P.
371.
L’A. presenta l’edizione polacca del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, fino ad
allora ignota in Italia, e considerata dagli studiosi la più importante fra le edizioni
straniere dell’opera sia per la bellezza letteraria ed artistica della lingua, sia per la
nobiltà della forma. L’A. si sofferma sulla dettagliata introduzione storico-critica di
Roman Pollak sulla società polacca e italiana dell’epoca.
• E. Damiani, recensione a: Novellieri polacchi. A cura di Stella
Olgierd. Prefazione di Giovanni Papini. Milano, “Alpes”, 1929, un vol.
in-8 di pp. XI-370, lire 20, p. 372-373.
Nella presentazione del volume l’A. mette subito in evidenza l’assoluta mancanza
di organicità interna dell’antologia, dove si ritrovano ammassati ventuno autori
polacchi contemporanei, viventi e recentemente scomparsi, eterogenei sia per
importanza letteraria che per vastità di produzione letteraria, ciascuno dei quali
introdotti da una novella.
• E. Damiani, recensione a: Arturo Lancellotti, Tolstoi intimo. Roma,
Maglione, 1928. Un vol. in-16° di pag. 274, L. 14 in ‘Letteratura russa’,
pp. 373-375.
L’A. presenta il volume di Lancellotti che non conosceva il russo e si basava su
versioni e studi stranieri. Ne consiglia la lettura a quanti poco o nulla conoscono del
grande scrittore.
• E. Damiani, recensione a: Ettore Lo Gatto: Letteratura soviettista.
Roma, Istituto per l’Europa Orientale, 1928. “Piccola Biblioteca Slava”
a cura di E. Lo Gatto, n. 2. Un vol. in -8, di pp. VIII-167, L. 15, p. 374375.
Il contributo si divide in due parti. Nella prima l’A. definisce il concetto di
“letteratura soviettista” come nuovo fenomeno letterario postrivoluzionario, riportando
la stessa definizione data da Lo Gatto di “letteratura figlia della rivoluzione
bolscevica”. Nella seconda parte si descrive la struttura del volume diviso in XIV
capitoli.
‘Bollettino bibliografico’
• Pusckin A.: Teatro. Trad. in versi di R. Küfferle. Milano, Casa ed.
Unitas, 1928, pp. XVIII-300, l. 18, p. 383.
Anno VII (1929)
20 gennaio, n. 1:
‘Bollettino bibliografico’
197
• Thurneysen E.: Dostojewski. Roma, Casa ed. Doxa, 1928, L. 10, p. 30.
• Gonciarov I. A.: Oblòmov. Romanzo. Trad. integrale con pref. e note
di E. Lo Gatto. Torino, Slavia, 1928, 2 voll., L. 24 (Il Genio slavo), p.
31.
• Krasnoff: Dall’aquila imperiale alla bandiera rossa. Firenze, Salani,
1928, pp. 300, L. 8, p. 31.
• Seifulina L.: Humus. Milano, Monanni, 1928, L. 4, p. 31;
• Tolstoi L.: Guerra e pace. Trad. d. Duchessa d’Andria. Voll. V e VI,
Torino, Slavia, 1928, L. 24, p. 31.
• Zeromscki S.: Tutto e nulla, e altre novelle. Vers, italiana con introd. e
note di C. Agosti Garosci e C. Garosci. Torino, Slavia, 1928, pp. XVI318, L. 10 (Il Genio slavo), p. 31.
20 febbraio-marzo, n. 2:
• E. Damiani, recensione a: ‘Il Genio Slavo’, Casa Editrice “Slavia”,
Torino in ‘Letterature slave’, p. 62.
L’A. presenta la nuova collana della casa editrice torinese dedicata a una serie di
opere scelte di grandi prosatori slavi e, a differenza de “Il Genio Russo”, destinata a
contenere le opere complete dei cinque massimi prosatori russi. Vengono fatte due
osservazioni: la mancanza di caratteri tipografici speciali necessari per rendere i segni
diacritici delle lingue slave e la scelta di un’immagine tipicamente moscovita, con
cupole e croci, a emblema di una collana dedicata, invece, al popolo slavo in generale.
• E. Damiani, recensione a: Alessandro Ostrovskij, Anche i più savii
cadono nel laccio. Commedia. Traduzione di C. Perris. Lanciano, G.
Carabba, 1928. Un vol. in 16 di pp. VIII-178, L. 5 (Collezione “Scrittori
italiani e stranieri”), p. 62.
L’A. presenta la commedia di Ostrovskij, una satira rivolta alla società russa del
tempo, di cui evidenzia la fedele e scorrevole traduzione italiana firmata da Perris.
• E. Damiani, recensione a: Bogdana K. Dòciova: Pod siànkata na
pìnite (All’ombra dei pini). Sofia, Bogìnovi, 1928. Un vol. in 16, di pp.
416 con illustrazioni, p. 63.
Breve presentazione del diario di viaggio composto dalla scrittrice bulgara
durante il soggiorno in Italia.
‘Bollettino bibliografico’:
Lo Gatto G.: Storia della letteratura russa. Vol. III. La letteratura
moderna. Roma, Anonima Romana Editrice, 1929, pp. 336, L. 20, p. 91.
• Cechov A.: Era lei! Novelle umoristiche. Torino, Slavia, 1929, L. 11,
p. 91.
• Dostojevskij F.: Le notti bianche. Racconti. Torino, Slavia, 1929, L.
11, p. 91.
• Sieroszewski V.: Il diavolo straniero. Trad. di Y. Gromska. Torino,
Slavia, 1929, pp. 310, L. 10, p. 91.
•
198
•
Tolstoi L.: Diario intimo. Milano, Mondadori, 1929. L. 30, p. 91.
20 aprile, n. 4:
L. Savoj, recensione a: F. Dostojevskij, Le notti bianche, Njetocka
Njezvanova, Ed. Slavia, Torino, 1929 in ‘Letteratura russa’. L. 11 – pp.
116-117.
L’A. richiama l’attenzione del lettore su alcune imprecisioni presenti nella
traduzione italiana del testo originale.
‘Bollettino bibliografico’:
• Felyne O.: In due con l’ombra. Milano, Treves, 1929, L. 12, p. 123.
20 maggio-giugno, n. 5-6:
• E. Damiani, recensione a: Nicola Jevreinov, Il teatro nella vita. Pref.
di Silvio d’ Amico. Traduzione e cura di Tatrangelo. Milano, “Alpes”,
1929, in-16°, Lire 12, in ‘Letterature slave’, p. 301.
L’A. loda il testo originale di Jevreinov sull’istinto alla “teatralità” presente
nell’uomo contemporaneo ma ne critica la forma italiana adottata nella traduzione.
• E. Damiani, recensione a: Karalambich Petkof, L’ape maschio. Trad.
dal bulgaro di Gianni Nencioni. Milano, “Alpes”, 1929, un vol. in-16°,
pag. 243, Lire 10, in ‘Letterature slave’, pp. 153-155.
Stroncatura al volume, che contiene tre novelle tradotte dal bulgaro da Nencioni;
oltre a non riconoscere il nome dello scrittore Petkov, considerandolo pura invenzione
letteraria, l’A. giudica il tessuto narrativo delle novelle “incoerente, assurdo, triviale e
senza alcuna forma artistica”.
‘Bollettino bibliografico’:
• Dostojevscky F.: Le notti bianche. Trad. di G. Bach. Milano,
Morreale, 1929, L. 8, p. 171.
• Ehrenburg E.: L’amore di Gianna Rey. Romanzo. Trad. di L. Neanova.
Milano, Casa ed. Corbaccio, 1929, L. 15, p. 171.
• Scemeliov I.: Al piede dei monti. Trad. di O. Féline. Milano, Casa ed.
Corbaccio, 1929, L. 10, p. 171.
• Tolstoi L.: Anna Karenina. Vers. di L. Ginzburg. Torino, Slavia, 1929,
4 voll., Lire 48, p. 171.
20 luglio-agosto, n. 7-8:
• E. Damiani, recensione a: Rinaldo Küfferle, Leone Tolstoj maestro
elementare. Roma, I.p.E.O., 1929 in ‘Piccola Biblioteca Slava’ a cura di
199
E. Lo Gatto, p. 200.
Il volume curato da Küfferle, secondo l’A., riprende il tema dei metodi
pedagogici di Tolstoj, già affrontato da Giulio Vitali nel volume Leone Tolstoj
pedagogista in occasione del suo centenario.
• E. Damiani, recensione a: Angelo Focarile, Bulgaria d’oggi. Nei suoi
aspetti sociali, economici, commerciali, finanziari. Milano, Hoepli,
1929, un vol. in-16°, pp. XII-371, L. 25, pp. 200-201.
L’A. presenta il volume come un ampio e organico studio sulle attuali
condizioni socio-economiche della Bulgaria, un’opera mai realizzata in precedenza, di
grandi proporzioni e suddivisa in capitoli dedicati all’industria, al commercio,
all’artigianato del Paese. Evidenziando alcune mende stilistiche, ci si sofferma sulla
limitata bibliografia di riferimento.
‘Bollettino bibliografico’:
• Dostojewsky F.: Un brutto aneddoto. Milano, Casa ed. Maia, 1929,
pp. 192, L. 5, P. 207.
• Gogol N.: Le veglie alla fattoria presso Dikaguka. Torino, Slavia,
1929, pp. 320, L. 11, p. 207.
• Krassnoff P.N., Comprendere è perdonare. Firenze, Salani, 1929, pp.
342, L. 9, p. 207.
• Turghenjev J.: Le memorie di un cacciatore. Trad. di R. Olkienizkaia
Naldi. Torino, Slavia, 1929, 2 voll., L. 22, p. 207.
• Andreyew L.: Il vecchio studente. Commedia in 4 atti. Milano,
Sonzogno, 1929, pp. 128, L. 4, p. 211.
• Andreyew L.: Sava, ramma in 4 atti. Milano, Sonzogno, 1929, pp. 159,
L. 4, p. 211.
• Céchov A.: Teatro completo.Vol. II (Liescij, Il Gabbiano, Zio Vania).
Trad. di C. Grabher. Firenze, Vallecchi, 1929, pp. 200, L. 8, p. 211.
• Céchov A.: La steppa. Trad. di B. Jakovenko. Lanciano, Carabba,
1929, pp. 172, L. 5, p. 211.
• Petkoff K.: L’ape maschio. Milano, Casa ed. Alpes, 1929, pp. 248, L.
10, p. 212.
• Reymont W.: I contadini. Romanzo. Vol. II. L’inverno. Trad. di A.
Beniamino. Aquila, Vecchioni, 1929, pp. 451, L. 12, p. 212.
• Zulawski J.: Eros e Psiche. Romanzo scenico. Trad. di S. Kalinowska,
Lanciano, Carabba, 1929, pp. VII-207, L. 5, p. 212.
20 settembre-ottobre, n. 9-10:
• E. Damiani, recensione a: Maria Konopnicka, Italia. Liriche. Versione
in prosa e introduzione di Cristina Agosti Garosci e di Clotilde Garosci,
I. p. E. O., 1929 (‘Piccola Biblioteca Slava’ a cura di E. Lo Gatto, vol.
X), pp. 248-249.
L’A. presenta la raccolta di liriche della Konopnicka, ancora poco nota in Italia,
lodandone la fedele e non facile traduzione dal polacco eseguita dalle sorelle Garosci e
200
l’ottima introduzione critico-biografica.
‘Bollettino bibliografico’:
Dostojevskij F.: Un brutto aneddoto. Trad. di I. Felyne. Milano, ed.
Maia, 1929, pp. 187, Lire 5, p. 259.
• Ehrenburg E.: L’amore di Gianna Ney. Milano, Soc. editrice
Corbaccio, 1929, pp. 520, Lire 15, p. 259.
• Krassnoff P.: L’amazzone del deserto. Firenze, Salani, 1929, pp. 266,
L. 10, p. 259.
• Damiani E.: Rapporti di cultura fra Italia e Bulgaria (in Il giornale d.
politica e d. letteratura, settembre 1929), p. 262.
• Lo Gatto E.: L’Italia nelle letterature slave. I (in Nuova Antologia, 16
settembre 1929), p. 263.
• Cechov A.: Il duello. Tre anni. Trad. di G. Faccioli, Torino, Slavia,
1929, L. 10, p. 263.
• Ciapek C.: Racconti tormentosi. Trad. di W. Giusti. Torino, Slavia,
1929, L. 8, p. 263.
• Dostojevskij F.: Netoscka Nezvànova. Romanzo. Trad. di Maria
Grigorieva e M. Visetti. Milano, Ediz. “Delta”, 1929, pp. 264, L. 2, p.
263.
•
20 novembre-dicembre, n. 11-12:
LETTERATURE SLAVE:
• E. Damiani, recensione a: Carlo Dell’Acqua, La Nazione Bulgara, 2°
edizione. Milano-Sofia, Ed. dell’ «Opera Italiana pro Orientale», 1929
(Deposito esclusivo Libreria Fratelli Treves dell’A.L.I. in Milano). Un
vol. di pp. 175, L. 10, pp. 299-300.
Si tratta della nuova edizione, ampliata e aggiornata, del precedente volume di
Dell’Acqua intitolato La Bulgaria. Rassegna geografico-storica. Il volume si divide in
tre parti: una rassegna sulla geografia e l’economia della Bulgaria, la seconda parte
sulla storia e la terza che comprende la nuova sezione dedicata all’arte e alla letteratura.
Nel complesso l’opera viene considerata dall’A. un importante strumento di
divulgazione.
• E. Damiani, recensione a: Carlo Grabher, Anton Cechov. RomaTorino, pp. 120, L. 6, pp. 299-300.
E’ la prima delle cinque monografie dedicate dalla casa editrice Slavia ai
cinque grandi prosatori russi; l’A. loda il volume definendolo uno dei migliori studi
critici su Čechov e apprezzandone la traduzione italiana.
‘Bollettino bibliografico’
• Cechov A.: La camera n. 6. Trad. di G. Faccioli. Torino, Slavia, 1929,
L. 10 (Genio russo), p. 319.
• Scemeliov I.: Al piede dei monti. Romanzo. Trad. di O. Felyne.
201
Milano, Casa ed. Corbaccio, 1929, pp. 246, L. 10, p. 319.
• Tolstoi L.: Due usseri. Trad. della Duchessa di Andria. Torino, Slavia,
1929, L. 11, p. 319.
“La Cultura” [(Ruggero Borghi (1882-1921), Cesare De Lollis
(1921-1928), Cesare Pavese (1932)]
Vol. I (1921-1922)
Fasc. 2, 15 dicembre 1921:
• Nicola Festa, Radisc’cev, pp. 80-81.
L’articolo espone la singolare vicenda biografica di Radiščev particolarmente
connessa alla trama del celebre romanzo Putešestvie iz Peterburga v Moskvu, denuncia
dei mali e della corruzione, che affliggevano la Russia alla fine del XVIII secolo.
Fasc. 7, 15 maggio 1922:
• A. Palmieri, recensione a: E. Lo Gatto, I problemi della letteratura
russa. Napoli, Ricciardi, 1921, pp. XIII-132, pp. 328-329.
L’A. descrive il volume dedicato alla spiritualità russa, lodandone l’impostazione
teorica e lo sforzo fatto dall’autore per esporre una materia tanto complessa quanto
controversa. Nella prima parte del suo saggio Lo Gatto affronta problemi di moralità e
religisità in Russia dal XVII secolo in poi; nella seconda, ripiega su questioni sociali e
politiche. Alcune osservazioni dell’A. sulle sette religiose russe concludono il
202
contributo.
Fasc. 10, 15 agosto:
• Giuseppe Toffanin, recensione a: F. Dostojevsky, Articoli critici di
letteratura russa, trad. di Ettore Lo Gatto, Napoli. Ricciardi, 1922, p.
295, pp. 469-471.
L’A. analizza gli articoli critici di Dostojevskij, evidenziandone le doti
giornalistiche nelle dispute relative all’annosa questione sulla finalità della crezione
artistica. Senza rinnegare lo scopo civile di ogni forma d’arte e rimanendo ancorato allo
slavismo ortodosso, nei suoi Stat’i Dostojevskij prende posizione a fianco degli “esteti
puri”, che rivendicano l’assoluta e incondizionata libertà di espressione.
Fasc. 11, 15 settembre:
• Aurelio Palmieri, Le riviste scientifiche della Russia bolscevica, pp.
509-512.
Il contributo costituisce una cronaca della quantità e della qualità della
produzione scientifica e letteraria registrata in Russia al tempo della censura bolscevica
e della difficile realtà in cui erano costretti ad operare gli intellettuali. Fra le
pubblicazioni maggiormente diffuse si citano gli Sborniki e le riviste scientifiche, meno
costose da pubblicare e destinate a un più ampio numero di lettori rispetto alle
monografie.
Vol. II (1922-1923)
Fasc. 1, 15 novembre:
• S.a. Gli studenti e il bolscevismo, p. 47.
Breve articolo che descrive gli effetti prodotti dalla nuova realtà socio-politica in
Russia sul pensiero e sulla vita degli studenti.
Fasc. 6, 15 aprile:
• Aurelio Palmieri, Il poeta sloveno dell’Isonzo Simone Gregorcic, pp.
261-267.
Il contributo è la biografia di Simon Gregorčič (1844-1906) sulla base di fonti
letterarie slovene. Si evidenzia l’importanza del suo lavoro e, più in generale, le
peculiarità della letteratura slovena. Viene, poi, sottolineato che nella poesia lirica
Gregorčič s’ispirò più volte all’opera di France Prešeren, con alcune considerazioni a
margine della traduzione integrale del poema Soči (Isonzo).
Fasc. 9, 15 luglio:
• Aurelio Palmieri, recensione a: Ettore Lo Gatto, Saggi sulla cultura
russa, Napoli, R. Ricciardi, 1923, pp. 174, pp. 425-426.
L’A. elogia il volume di Lo Gatto facendone precedere la scheda critica da un
breve profilo dello slavista con riferimento al volume, già qui recensito, I problemi
della letteratura russa (v. 1922, I, pp. 328-329). Si tratta di sei saggi, l’A. considera
203
migliori quelli dedicati alla questione della servitù della gleba, affrontata nella
letteratura, e alla vita e le idee di Herzen.
Fasc. 11, 15 settembre:
• Giovanni Maver, Esiste una letteratura jugoslava?, pp. 506-512.
L’A. traccia un breve profilo storico-critico della letteratura in area serbo-croata e
slovena, evidenziando come il ‘centro’ d’interesse linguistico e letterario si sia sempre
spostato all’interno della ex-jugoslavia, rendendo pressoché impossibile la definizione
di letteratura o cultura ‘jugoslava’.
Vol. III (1923-1924)
Fasc. 3, 15 gennaio 1924:
• Otto Cuzzer, Il pessimismo di Anton Cecof, pp. 115-119.
Saggio sulle sfumature di significato che il pessimismo radicale di Čechov può
assumere nei drammi; in particolare, l’A. evidenzia come lo scrittore riesca a conciliare
il concetto di pessimismo esistenziale dei personaggi con l’esaltazione della legge
morale, unica fonte di serenità.
Fasc. 6, 15 aprile 1924:
• E. Lo Gatto, Byron in Russia, pp. 283-287.
L’A. sottolinea la fortuna critica che Byron ebbe in Russia a partire dalla sua prima
comparsa in pieno regno di Alessandro I, fenomeno dovuto, probabilmente, al
momento storico particolarmente faverovele ad accogliere idee liberali, e si sofferma
ad analizzare l’influenza che lo scrittore inglese ha avuto su alcuni scrittori russi di
epoca romantica e postromantica.
(Anno IV)
Fasc. 2, 15 dicembre 1924:
• Arturo Cronia, Appunti di letteratura serbo-croata. Il periodo dello
slavo ecclesiastico, pp. 72-80.
L’A. percorre
le tappe fondamentali nella formazione delle distinte civiltà
letterarie dei serbi e dei croati e nella nascita dello slavo ecclesiastico a partire dalla
missione evangelizzatrice in Moravia e Bulgaria di Cirillo e Metodio, i cui discepoli,
espulsi dai confini moravi e perseguitati dagli ungheresi, cercarono rifugio nella
penisola balcanica.
204
Fasc. 6, 15 maggio 1925:
• Arturo Cronia, Appunti di letteratura serbo-croata. Letterature
provinciali, pp. 307-314.
Il contributo sottolinea l’aspetto ‘provinciale’ delle nascenti tradizioni letterarie di
Croazia, Bosnia e Slovenia, isolate in singole provincie e limitate a singoli scrittori se
confrontate con la fiorente letteratura dalmato-ragusea.
Fasc. 8, 15 giugno 1925:
• Roman Pollak, Mickiewicz e la Russia, pp.349-358.
Il contributo si apre con l’esposizione delle opinioni che in Russia alcuni scrittori e
personaggi di rilievo nella cultura del tempo avevano del loro paese, considerazioni
spesso discordi. Si prosegue con l’opinione espressa da Adam Mickiewicz, le cui
osservazioni sono considerate dagli studiosi così perspicaci e dettagliate da costituire
documenti storici.
Vol. V (1925)
Fasc. 1, 15 novembre 1925:
• Arturo Cronia, Appunti di letteratura Serbo-Croata. Risorgimento
letterario, pp. 25-29.
L‘A. analizza la diffusione del movimento politico-filosofico degli enciclopedisti
francesi nel XVIII sec. fra i serbi e i croati, che familiarizzarono col razionalismo
francese e con l’illuminismo solo quando le riforme radicali di Maria Teresa d’AustriaUngheria e Giuseppe II diedero un’impronta politica alle nuove correnti culturali.
Fasc. 2, 15 dicembre 1925:
• Arturo Cronia, Appunti di letteratura Serbo-Croata. Risorgimento
letterario, pp. 71-77.
Sulla ricezioine delle nuove dottrine filosofiche illuministiche in Croazia, divisa da
vecchie tradizioni culturali e da barriere di separatismo, in Bosnia, dove la popolazione
è in preda all’abbandono generale e pochi francescani cercano di custodire i loro
monasteri, e in Dalmazia, che nel XVIII sec. era ancora sotto l’influenza della
controriforma cattolica e la cui produzione letteraria si limita a poche opere di
edificazione morale.
Fasc. 3, 15 gennaio 1926:
• Enrico Damiani, Due grandi prosatori polacchi: Zeromski e Reymont
(in occasione della loro morte), pp. 128-133.
Sui maggiori rappresentanti della letteratura polacca contemporanea, Stefan
205
Żeromski e Władysław Reymont, in occasione della loro morte. L’A. ne individua le
principali carateristiche della loro forma letteraria e dello stile attraverso alcune opere: i
romanzi Ludzie bezdomni, Raggio, Donna forte e Doktór Piotr per Žeromski e
l’epopea in prosa Chłopy per Reymont.
Fasc. 4, 15 febbraio 1926:
• Arturo Cronia, Appunti di letteratura serbo-croata. La letteratura
della nazione risorta, pp. 168-174.
Dopo la rivoluzione del 1848 e la nascita del movimento “illirico” fra i croati si
delinea nelle sue varie forme di espressione una nuova letteratura improntata al
romanticismo. L’A. fornisce qualche esempio di questa rinascita culturale nei Balcani
percorrendo vari generi letterari, epica, dramma, commedia e poesia.
Fasc. 7, 15 maggio 1926:
• Arturo Cronia, Appunti di letteratura serbo-croata. Ancora della
letteratura della nazione risorta, pp. 320-325.
Dopo aver illustrato la rinascita letteraria fra i Croati, l’A analizza gli effetti del
moto rivoluzionario del 1850 sulla cultura serba, le cui caratteristiche si rivelano simili
a quanto già accaduto in Croazia in relazione all’influenza del romanticismo. I generi
letterari presi in esame sono la lirica, il dramma, la novella e il romanzo.
Fasc., 8, 15 giugno 1926:
• Enrico Damiani, Un grande anniversario bulgaro: La morte di Cristo
Bòtev, pp. 363-366.
In occasione della celebrazione a Sofia del cinquantesimo anniversario della morte
di Christo Bòtev l’A. traccia un profilo della personalità dello scrittore bulgaro sia nel
campo dell’impegno politico che nell’attività letteraria.
• A. Pincherle, I soviety e la religione, pp. 378-379.
L’A. cerca di affrontare il difficile e controverso rapporto tra ‘ideologia’ e
‘religione’ in Russia;
Vol. VI (1926-1927)
Fasc. 2, 15 dicembre 1926:
• Enrico Damiani, Un centenario nella letteratura russa. Michele
Saltykòv S’cedrìn, pp. 55-56.
Contributo dedicato, nel centenario della sua nascita, a Michail Saltykov Ščedrin,
la cui attività letteraria iniziò nel 1847 fra polemiche varie e reazioni della censura
zarista. Attraverso gli scritti satirici Ščedrin, nella forma del racconto, della novella e
del dialogo, attaccava ogni ‘tipo’ rappresentativo della società russa, mettendone in
rilievo aspetti più o meno ridicoli.
206
Fasc. 10, 15 agosto 1927:
• Romano Pollak, Giovanni Kasprowicz, p. 458.
Breve contributo sul poeta polacco da poco scomparso;
• Enrico Damiani, Slowacki, pp. 460-462.
Contributo dedicato al poeta Juliusz Słowacki in occasione dell’arrivo a Cracovia
delle spoglie, custodite per anni a Parigi nel cimitero di Montmartre. A Cracovia le
spoglie sono state tumulate nel castello di Wawel, “Pantheon” polacco, insieme alle
tombe di Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz e i re della Polonia.
Fasc. 11, 15 settembre 1927:
• Arturo Cronia, Appunti di letteratura serbo-croata. Versuo nuovi
orizzonti, pp. 494-507.
Saggio conclusivo di Cronia sulla rinascita letteraria nei Balcani. Nonostante non
si possa ancora parlare di una letteratura jugoslava si possono però trarre alcune
conclusioni sulla letteratura serbo-croata postbellica, dalla cui frammentarietà
emergono, in particolare, due giovani scrittori: Miroslav Krleža e Miloš Crnjanski,
entrambi impegnati a ritrarre le crudeltà della guerra.
Vol. VII (1927-1928)
Fasc. 9-10, 1 ottobre:
• M. Resetar, recensione a: E. Lo Gatto, Storia della letteratura russa. I.
Roma, Anonima Romana Editoriale, 1928, pp. XI-291. L. 20, pp. 418419.
Rešetar presenta il primo volume della poderosa Storia della letteratura russa di
Lo Gatto XIV della I serie di pubblicazioni dell’I.p.E.O. Il volume copre un periodo
compreso fra le origini e il XVI secolo poiché lo slavista scorge proprio nel secolo
successivo tutti gli elementi della modernità. Degna di menzione, per l’A., la sezione
finale dedicata alla letteratura orale del folklore russo.
Anno VIII – 1929
Fasc. IV, aprile:
• Leone Ginzburg, recensione a: I. A. Gonciarov, Oblòmov (versione
integrale con prefazione e note di E. Lo Gatto, Torino, Slavia, L. 24, pp.
239-240.
Dopo una breve introduzione sulla nascita del romanzo in Russia in un periodo di
profonde trasformazoni sociali, l’A. presenta il volume di Lo Gatto su Oblòmov di
Gonciaròv, sottolineando la capacità dello slavista di trasmettere il concetto di
‘oblomivismo’ identificato sia in un fenomeno sociale, sia in una personale condizione
esistenziale dell’autore.
207
Fasc. IX, settembre:
• Leone Ginzburg, recensione a: Ivan Turgenev, Memorie di un
cacciatore, versione integrale dal russo di Raissa Olkienizkaia-Naldi,
Slavia, Torino 1929, 2 voll. di pp. 334 e 317, p. 568.
Breve segnalazione bibliografica della prima versione italiana del romanzo di
Turgenev, pubblicato nel 1852 e considerato una requisitoria contro gli ordinamenti
statali esistenti in Russia, di cui l’A. sottolinea la fedeltà al testo originale.
• Leone Ginzburg, Letteratura russa contemporanea, pp. 568-569.
Recensione al volume di Vladimir Pozner dedicato alla letteratura russa e
pubblicato in francese nel 1929, di cui l’A. sottolinea l’assoluto equilibrio di giudizio
con cui viene esaminata l’opera di circa cinquanta scrittori contemporanei fra cui
Korolenko, Andreev, Blok e Merežkovskij.
Fasc. XII, dicembre:
• Leone Ginzburg, Riabilitazione di Boris Godunov, pp. 765-766.
Recensione all’edizione francese del saggio di Sergej Platonov Boris Godunov,
curata da H. de Witte nel 1929. La monografia, divisa in carriera, politica e tragedia
personale di Godunov, è un tentativo di riscatto di un personaggio spesso calunniato
dalla critica storica. Viene, infine, evidenziata l’attenta traduzione dal russo eseguita da
de Witte.
• Leone Ginzburg, Turgenev inedito, p. 766.
L’A. ricorda un articolo di André Mazon apparso sulla “Revue des Deux
Mondes” del 15 novembre 1929 in cui lo slavista annunciava il ritrovamento di alcuni
frammenti lirici in prosa di Turgenev fra le carte di Pauline Vardot.
Anno IX - 1930
Fasc. I, gennaio:
• Leone Ginzburg, Scrittori russi dell’800: Nicola Ljeskòv, pp. 24-39.
L’articolo si divide in due parti: nella prima vengono menzionate le più recenti
publicazioni sulle opere di Nikolaj Semënovič Leskov a partire dalla terza edizione
delle opere complete apparsa sulla rivista pietroburghese “Niva” fra il 1902 e il 1903
per la casa editrice Adolf Marks e preceduta da un ampio studio critico di
Sementkovskij; nella seconda, si espone il contenuto dei romanzi Ovcebyk del 1863 e
Sceramùr.
• Leone Ginzburg, Un saggio su Cechov, pp. 73-74.
Breve contributo sul recente volume di Carlo Grabher dedicato a Čechov e
pubblicato su “Scrittori slavi”, collezione di monografie sugli scrittori dei secoli XIX e
XX diretta da Lo Gatto, e su altri saggi in cui Grabher si conferma abile traduttore.
208
Fasc. II, febbraio:
• Leone Ginzburg, I racconti autobiografici del Tolstoj, pp. 953-955.
Il contributo riprende e commenta alcuni passi tratti dai racconti autobiografici di
Tolstoj pubblicati da Slavia nel 1930 per la collezione “Genio Russo”, in particolare i
Ricordi d’infanzia (1903-1906), rimasti a lungo inediti in italiano.
Fasc. III, marzo:
• Leone Ginzburg, recensione a: Viktor Sklovskij, Materjal i stil’ v
romane L’va Tolstogo «Vojna i Mir», Federacija, Moskva s.a., pp. 249,
pp. 236-237.
il contributo, riprendendo il giudizio espresso da Poljak e pubblicato su “Krasnaja
Nov’” (1929, n.I), critica il volume di Šklovskij su fonti e stile in Vojna i mir,
evidenziandone difetti di costruzione, disordini nell’esposizione e superficialità
nell’analisi di alcuni fenomeni linguistici, pur riconoscendo, però, le acute osservazioni
dell’autore e l’attendibilità delle informazioni;
Fasc. IV, aprile:
• Leone Ginzburg, Scrittori russi dell’ 800: Gàrscin, pp. 268-277.
Biografia critica dello scrittore e attraverso le opere tradotte quasi tutte in italiano
e pubblicate dal Literaturnyj Fond a Pietrogrado nel 1909. Muovendo dalle
osservazioni critiche di Michajlovskij su Garšin, Ginzburg espone il contenuto dei
romanzi Krasnyj cvetok e Četyre dnja, arricchendolo di numerose note esplicative.
• Leone Ginzburg, Pietro il Grande, pp. 308-309.
Recensione al volume di Ključevskij Kurs russkoj istorii, tradotto in francese da
H. de Witte nel 1930. Il saggio si compone di dieci lezioni sulla storia della società
russa con particolare attenzione al periodo di riforme statali compreso tra la rivolta del
1682 e la morte di Pietro il Grande nel 1725, una fase storica considerata da
Ključevskij decisiva per lo sviluppo degli avvenimenti futuri.
Fasc. V, maggio:
• Leone Ginzburg, Formalisti e marxisti, pp. 398-399.
Breve contributo sui princìpi che giustificarono la lotta per rendere di stampo
marxista anche la critica letteraria in Russia e gli attacchi alla scuola dei formalisti,
considerati esponenti di un idealismo reazionario contrario al proletariato e al regime,
pubblicati sulle riviste “Literaturnaja Gazeta”, “Proletarskij muzykan” e “Krasnaja
Nov’”.
Fasc. VI, giugno:
• Leone Ginzburg, Letteratura russa e letterati italiani, pp. 472-473.
breve contributo sulla traduzione di tre racconti di Čechov, Step’, Skučnaja istorija
e Supruga, pubblicata nel 1930 dalla “Slavia” per la collana “Il Genio Russo” nella
versione integrale di Zino Zini, di cui lo studioso evidenzia la fedeltà al testo originale;
209
Fasc. VIII, agosto:
• Leone Ginzburg, Storia russa recente, pp. 679-686.
L’A. affronta una delle questioni che animavano i dibattiti culturali in Russia e che
si riferiva alla ‘natura’ delle sue origini. L’antico contrasto fra “occidentalisti” e
“slavofili” si era trasformato, in pieno regime bolscevico, in uno scontro tra
“europeisti”, a sostegno di una matrice slavo-occidentale della Russia, ed “eurasiatici”,
sostenitori di una sua origine esclusivamente asiatica;
Fasc. X, ottobre:
• Leone Ginzburg, Un libro su Gogol’. Recensione a: Enrico Pappacena,
Gogol, Corbaccio, Milano 1930, pp. 718, pp. 878-879.
Breve contributo dedicato all’opera di Gogol’ e alle considerazioni di Enrico
Pappacena riguardo al suo volume dedicato allo scrittore russo, un saggio di natura più
divulgativa che letteraria, definito “introduzione agli scritti”.
Fasc. XII, dicembre:
• Leone Ginzburg, Scrittori russi dell’ 800: Gonciaròv, pp. 989-999.
L’A. presenta il saggio di Gončarov Meglio tardi che mai pubblicato a
Pietroburgo nel 1899 in un’edizione “Marks” delle Opere Complete. Il saggio, oltre a
contenere la dichiarazione programmatica degli scopi dello scrittore, riporta il giudizio
che Belinskij aveva dato su di lui in un articolo pubblicato su “Sovremennik” del 1848
dal titolo Sguardo sulla letteratura russa del 1847.
Anno X- 1931
Fasc. II, febbraio:
• A. Polledro, traduzione: Fjodor Dostojevskij, Polzunkòv (Racconto
inedito), pp. 81-95.
• Leone Ginzburg, Classicità di Dostojevskij, pp. 96-99.
Partendo da un saggio di Piero Gobetti intitolato Dostoievschi classico e pubblicato
in Paradosso dello spirito russo, l’A. affronta la distinzione tra ‘classicità’ e
‘classicismo’: la classicità, in Dostoevskij, possiede non solo l’equilibrio e la stabilità
del classicismo letterario ma anche alcune qualità filosofiche e psicologiche, che
sfociano nell’indagine e nella ricostruzione poetica della personalità;
D. S. Mirsky, Il posto del Dostojevskij nella letteratura russa, pp.100115.
•
L’articolo indaga vari aspetti della personalità di Dostoevskij e della sua fortuna
critica.
Nella prima parte si confrontano vita e pensiero di Apollon Grigorev e Fëdor
Dostoevskij, principali rappresentati della generazione letteraria nota come “uomini
degli anni quaranta”, si analizza, poi, il pensiero dello scrittore.
• Ettore Lo Gatto, L’ epistolario di Dostojevskij, pp. 116-127.
L’A. ricostruisce le varie edizioni dell’epistolario dal primo gruppo di circa
210
cinquanta lettere, frammentarie e lacunose, pubblicate da Strachov e Miller nel 1883,
alle raccolte complete di Dolinin, relative al periodo compreso tra il 1832 e il 1871, e di
Belčikov e Pereverzev, che arrivano fino al 1880. Vengono pure menzionate le lettere
del 1860 decisive per la ricostruzione della genesi dei romanzi Prestuplenie i nakazanie
e Besy.
• Vladimir Pozner, Dostojevskij e il romanzo di avventure, pp. 128-150.
Analisi delle influenze che vari generi di romanzo hanno avuto sugli scritti di
Dostoevskij: il romanzo gotico (Selo Stepančikovo i ego obitateli), il romanzo
d’avventura (Podrostok, Idiot, Belye noči)), il romanzo fantastico (Besy), il romanzo
poliziesco (Brat’ja Karamazovy), il romanzo psicologico (Prestuplenie i nakazanie), il
romanzo biografico (Dnevnik pisatelja).
• Alfred Bém, Il superamento di Gogol (Per la comprensione delle
prime opere del Dostojevskij), pp. 151-170.
L’A. affronta la questione dell’influsso, contrastante e decisivo, di Gogol’ e
della “scuola naturale” nelle prime opere di Dostoevskij, in particolare in Bednye ljudi,
e del suo definitivo superamento nel romanzo del 1847 Chozjajka.
• Wolfango Giusti, Sul “donchisciottismo” di alcuni personaggi del
Dostojevskij, pp. 171-179.
L’A. distingue l’influsso diretto di Cervantes sui personaggi di Dostoevskij
dall’innata predisposizione dello scrittore russo a creare ‘antieroi’; il
‘donchisciottismo’ di Devuškin (Bednye ljudi), del signor Goljadkin (Dvojnik), e del
principe Myškin (Idiot) si discosta da quello del celebre personaggio di Cervantes
poiché cerca di dimostrare la superiorità dell’uomo malato rispetto al sano, frutto del
positivismo occidentale.
• Enrico Damiani, Gli studi dostojevskiani in Italia, pp. 180-185.
L’A. traccia una cronologia degli studi dostoevskiani in Italia, iniziati in
ritardo rispetto al resto d’Europa a causa dello scarso numero di conoscitori del russo,
partendo dalla prima ‘notizia’ di Dostojevskij nell’anno della sua stessa morte (1881)
pubblicata nel Dizionario Biografico degli scrittori viventi di Angelo De Gubernatis
fino alla traduzione delle prime due parti di Unižennye i oskorblënnye firmata da
Domenico Ciampoli nel 1893.
• Zino Zini, recensione a: Nicolas Berdiaff, L’esprit de Dostoïevski.
Traduit du russe par Lucienne Julien Cain. Paris, Edition Saint-Michel,
1929, pp. 274, frs. 15, pp. 186-189.
Traduzione in francese di un ciclo di conferenze tenute nel seminario della
“Libera Accademia di cultura spirituale” di Mosca nel 1920-1921, che l’A. considera
poco fedele al testo originale ma rispettosa del senso generale. Qui Berdjaev cerca di
dimostrare che Dostojevskij è pensatore e filosofo prim’ancora di essere scrittore.
• Leone Ginzburg, Dostoevskij sul cammino della vita. Recensione a:
Leonid Grossman, Dostojevskij na zhisnennom puti. I. Moskva,
« Nikitinskie Subbòtniki », 1928, pp. 226, pp. 190-192.
Volume dedicato al 1850, anno d’inizio di un’interessante fase biografica dello
scrittore, che comprende quattro anni di lavoro forzato a Omsk e cinque anni di
servizio militare a Semipalatinsk in Siberia. Nell’analisi dell’A., sia nella scelta che
nella disposizione del materiale, è rispecchiata l’immagine di Dostoevskij comune a
quella data dallo studioso Leonid Grossman.
211
• Leone Ginzburg, Una traduzione italiana di «Delitto e castigo».
Recensione a: Fjodor Dostoevskij, Delitto e castigo, prima traduzione
integrale dal russo e note di Alfredo Polledro, «Slavia», Torino 1930, 2
voll. di pp. 333 e 325, p. 195.
Breve contributo dell’A. sulla traduzione eseguita da Alfredo Polledro del celebre
romanzo, conosciuto in Italia e in Francia in versioni fedeli all’originale solo nel
dopoguerra.
• Leone Ginzburg, Anna Grigor’evna Dostoevskaja. (Recensione a:
Dostoïevski, par sa femme Anna Grigòrjevna Dostoïewskaïa, traduit du
russe par André Beucler, n.r.f., Paris 1930, pp. 446), pp. 195-198.
Volume dedicato alla vita di Dostoevskij e concentrato maggiormente sul
personaggio di Anna Grigor’evna Dostoevskaja attraverso le memorie. Ginzburg
evidenzia la trascrizione errata di molti nomi russi nella traduzione in francese.
Fasc. IV, aprile:
• Leone Ginzburg, Le memorie del generale A. Vasil’ev, pp. 358-360.
Alcune considerazioni sulle memorie di un celebre reazionario, per qualche anno a
capo della polizia segreta russa comunemente detta Ochrana, qui considerate dall’A.
fondamentali per comprendere idee e principi di una classe sociale da sempre oggetto
di pregiudizi e false convinzioni.
Fasc. V, maggio:
• Leone Ginzburg, Rozanov, o della competenza, p. 435.
Breve articolo sulla complessa personalità di Vassilij Rozanov approfondita e
analizzata, secondo l’A., con estrema competenza da Vladimir Pozner e Boris de
Schloezer, autori di una finissima traduzione in francese di due suoi scritti. La
recensione che Giuseppe Raimondi fa alla traduzione, pubblicata sul numero di
febbraio di “Solaria”, viene qui stroncata dall’A.
Fasc. VI, giugno:
• Leone Ginzburg, recensione a: Anton Cechov, Il duello – Tre anni –
La corista – Lo Studente – Sul mare, traduzione di Leonardo Kociemski,
Mondadori, «Biblioteca Romantica», IX, Milano 1931, pp. 363, pp. 500504.
Confronto fra la traduzione di alcuni scritti di Tolstoj firmata da Leonardo Kociemski
nel suo volume edito da Mondadori per la collezione “Biblioteca Romantica” nel 1931,
e quella di Giovanni Faccioli per la collana “Il Genio Russo” .
• Leone Ginzburg, La fortuna di Dostoevskij in Occidente, pp. 516-517.
Il contributo riassume il contenuto di alcuni saggi apparsi sul numero di maggio di
“Slavische Rundschau” a Praga nel 1931 a cura di D. S. Mirskij sulla fortuna critica di
Dostoevskij in Francia e Inghilterra, nonché altri saggi a cura di Gerhard Gesemann
sulla ricezione dello scrittore russo in Germania.
• Leone Ginzburg, Turgenev in Francia. (Recensione a: André Maurois,
212
Tourguéniev, Grasset, Paris 1931, pp. 248), pp. 517-518.
Breve contributo sul volume di Andrè Maurois dedicato alla biografia di Turgenev,
che raccoglie gli atti di quattro conferenze sul tema tenute dallo slavista a Parigi per la
Société des Conférences l’anno precedente e di cui l’A. contesta l’impostazione critica,
considerandola unilateralmente a favore dello scrittore.
Fasc. VII, luglio:
• Leone Ginzburg, Stile, romanzo ed epopea nel “Tara Bul’ba”.
(Recensione a: Nicola Festa, Storia, romanzo ed epopea nel «Taras
Bul’ba» di Gogol’, «Convivium» marzo-aprile, 1931, p. 590).
Contributo sulla competenza di Nicola Festa nel campo della letteratura russa, in
particolare si fa riferimento al breve saggio dedicato a Gogol’ e pubblicato su
“Convivium” lo stesso anno.
Fasc. VIII, agosto:
• Leone Ginzburg, Quarant’ anni di Gorkij, pp. 637-641.
L’A. presenta il saggio in tre volumi sul romanzo di Gor’kij Sorok let – Žizn’
Klima Samgina, tradotto da Erme Cadei per la Casa Editrice Mondadori nel 1931, di
cui sottolinea la perfetta aderenza al testo originale.
Fasc. X, ottobre:
• Leone Ginzburg, Un Dostoevskij patetico (Recensione a: André
Levinson, La vie pathétique de Dostoïevsky. Plon, Paris 1931, pp. 272),
pp. 835-836.
Recensione al saggio di André Levinson dedicato alla vita di Dostoevskij e
pubblicato in francese sulla rivista “Plon” in occasione del cinquantenario dell’autore,
prima biografia dello scrittore basata sulla conoscenza diretta delle più recenti fonti
documentarie. L’A. ne mette in evidenza la mancanza di stile e di buongusto nel
riferire particolari di scarsa importanza.
Fasc. XII, dicembre:
• Leone Ginzburg, Urss 1931, pp. 994-995.
Breve segnalazione di un articolo pubblicato sul numero di novembre della
rivista “Nouvel Age” a cura di Vladimir Pozner e dedicato alla letteratura russa
contemporanea con un cenno all’antologia di prose d’arte curata da Olga Resnevič
Signorelli per “L’Italiano”.
Anno XI – 1932
Fasc. II, aprile-giugno:
• Leone Ginzburg, Una storia della letteratura russa (Recensione a:
Ettore Lo Gatto, Storia della letteratura russa, voll. III e IV. La
letteratura moderna, Anonima Romana Editoriale, Roma 1929, 1931),
213
pp. 383-385.
Recensione ai voll. III e IV della Storia della letteratura russa di E. Lo Gatto
dedicati all’età moderna e, in particolare, a Puškin, Lermontov e Belinskij. Ginzburg
mette in risalto la struttura dell’opera, che comprende sia il manuale di facile
consultazione che la specifica trattazione monografica.
Fasc. III, luglio-settembre:
• Leone Ginzburg, Alcuni scritti su Dostoevskij (Recensione a: F.
Losini, F. M. Dostoevskij, Formiggini, «Profili» n. 114, Roma 1931, pp.
84 - Feodoro Dostoevskij, I Demoni, traduzione di Rinaldo Küfferle,
Mondadori, «Biblioteca Romantica» XII, Milano 1931, 2 voll. di pp.
1084 – Alfred Bem, «Gore ot uma» v tvorcestve Dosoevskogo [ «I guai
dell’ingegno» nell’opera del D.], estr. della rivista «Slavia» di Praga, X,
1931, pp. 88-108; Id., Sumerki geroja [Crepuscolo dell’ eroe], estr. dei
«Naucnye trudy Russkogo Narodnago Universiteta v Prage», vol. IV
(1931), Scienze storico-filologiche, pp. 158-172 – Mario Robertazzi,
Classicità del Dostoevskij, nel «Convegno» del 25 ottobre 1931, pp.
445-475), pp. 594-601.
Si tratta di una serie di interventi critici di Ginzburg su alcune pubblicazioni
minori dedicate a Dostoevskij in occasione del recente cinquantenario della sua morte.
Gli interventi forniscono al lettore alcune possibili chiavi d’interpretazione
metodologica e filologica relative allo stile del testo e alla psicologia dei personaggi.
• Leone Ginzburg, Lo studio delle byline, pp. 617-618.
Breve segnalazione degli studi filologici di André Mazon, professore del Collège
de France, sulle byline, culminati in una saggio pubblicato nel 1932 sulla “Revue des
Cours et Conférences” con una storia della critica e un’utile bibliografia di riferimento.
• Leone Ginzburg, La versione gogoliana di Nicola Festa (Recensione
a: Gogol’, Taras Bu’lba. Piccolo mondo antico. Una vecchia amicizia
troncata, traduzione di Nicola Festa, Mondadori, Milano 1932, pp. 391,
«Biblioteca Romantica»-XIX), pp. 627-629.
In riferimento a un precedente articolo, qui pubblicato, relativo alle traduzioni
dell’opera di Gogol’, eseguiti da Nicola Festa, l’A. ne cita alcune, evidenziando pregi
d’interpretazione e mende stilistiche del traduttore.
Fasc. IV, ottobre – dicembre:
• Leone Ginzburg, Garibaldi e Herzen, pp. 726-749.
Alcuni passi tratti dai carteggi tra Garibaldi, Mazzini e lo scrittore russo Herzen,
particolarmente interessanti, secondo gli studiosi italiani, in funzione del ‘dissidio’
ideologico Mazzini-Garibaldi.
• Leone Ginzburg, «Mozart e Salieri», o della metodologia, pp. 856857.
Brevi osservazioni di Ginzburg su alcune scelte metodologiche operate dallo
studioso V. A. Francev nel tentativo di ricostruire la storia creativa del dramma
puškiniano sulla base di un articolo pubblicato sulla rivista “Slavia” di Praga nel 1931
e dedicato al rapporto fra legge morale e creazione artistica.
214
• Leone Ginzburg, Manoscritti parigini di Turgenev, pp. 862-864.
L’A. segnala l’ultima pubblicazione degli inediti di Turgenev a cura di E. Semënov
nel “Mercure de France”, che raccoglie le lettere scritte in francese alla figlia Pauline
nel corso di trent’anni.
Anno XII- 1933
Fasc. II, aprile-giugno:
• Leone Ginzburg, recensione a: A.S.Gribojèdov, La disgrazia di essere
intelligente.Traduzione e introduzione di L. Savoj. Roma, Formiggini,
1932, pp. 249, L. 10, pp. 447-453.
L’A. sottolinea come Savoj nel presentare la commedia di Griboedov in una
nuova versione non solo abbia riportato parte di quella recentemente eseguita da
Federico Verdinois ma si sia anche limitato a ribadire opinioni e concetti sullo scrittore
più volte espressi in passato dalla critica russa.
Fasc. IV, ottobre-dicembre:
• Leone Ginzburg, «Guerra e pace», Tolstoj e Proudhon, pp. 965-967.
Il contributo riassume il saggio, che Nicolas Brian-Chaninov avrebbe dovuto
pubblicare per la collana “Malfére” della rivista “Grands événements littéraires” nel
1931, relativo alle circostanze in cui nacque e fu dato alle stampe La Guerre et la Paix
de Léon N. Tolstoj con un particolare accenno all’incontro di Tolstoj con Proudhon a
Bruxelles nel 1861.
• Leone Ginzburg, Due storici russi, pp. 967-968.
Alcuni brani tratti dall’articolo di Pavel Miljukov, pubblicato nel LI volume delle
“Sovremënnyja Zapiski” di Parigi, con personali ricordi dell’A. su due insigni storici
russi recentemente scomparsi, Aleksandr Aleksandrovič Kizevetter e Sergej Fëdorovič
Platonov.
215
“La Fiera letteraria” (Umberto Fracchia, 1925-1929)
Anno I (1925)
N° 1, 13 dicembre:
• La Redazione, “La gioventù di Gorki” in ‘Rivista delle riviste
straniere’, p. 4.
Breve segnalazione bibiliografica di alcuni documenti inediti su episodi di
vita privata di Maksim Gor’kij pubblicati nel “Parižskij Vestnik” del 6 dicembre
1925, compresa l’origine dello pseudonimo dello scrittore Aleksej Maksimovič
Peškov.
• La Redazione, “un’illustre scomparso” in ‘Rivista delle riviste
straniere’, p. 4.
Breve notizia della morte di Stefan Żeromski, a cui le “Wiadomości
Literackie” di Varsavia tributano un omaggio.
• S.a. La morte di L. St. Reymont, p. 6 con ritratto.
Breve notizia della morte di Władisław Stanisław Reymont a distanza di pochi
giorni dalla scomparsa di Stefan Żeromski: lo scrittore polacco era stato da poco
insignito del premio Nobel per Chłopy (I contadini). Alla biografia segue una
bibliografia delle opere con la segnalazione della traduzione di Sprawiedliwie (E’
giusto!) firmata da Lo Gatto.
• Giacomo Prampolini, traduzione: Ladislao Stanislao Reymont, Al
taglio dei boschi. Racconto di Ladislao Stanislao Reymont, p. 6.
N° 2, 20 dicembre:
• La Redazione, Lettere di Puškin ignorate (Nostro servizio
particolare), p. 4:
Breve notizia del ritrovamento a Leningrado nell’archivio del palazzo dei
principi Jussupov di alcune lettere di Puškin risalenti agli anni 1828-1831 e
indirizzate alla principessa Chitrova, figlia del generale Kutuzov.
Anno II (1926)
N° 1, 3 gennaio:
• Redazione, “Effigi di Zeromski”, p. 4.
Breve notiza della pubblicazione di diciotto effigi, fotografie e medaglioni di
Żeromski su “Wiadomości Literackie”.
216
• Umberto Barbaro, traduzione: Leonida Zavadoskij, Sul lago
bianco, p. 6.
N° 2, 10 gennaio:
• Umberto Barbaro, traduzione: Leonida Zavadoskij, Sul lago
bianco, p. 4.
N° 3, 17 gennaio:
• Rinaldo Küfferle, recensione a: Alessandro Pusckin, Eugenio
Onièghin – Traduzione, introduzione e note di Ettore Lo Gatto. G. C.
Sansoni editore, Firenze, L. 10, p. 6.
L’A. si sofferma su alcuni aspetti della traduzione di Lo Gatto, facendo notare
alcune forzature stilistiche, che, a volte, tradiscono la fedeltà del testo originale.
N° 4, 24 gennaio:
• Aurelio Palmieri, Il genio purificatore di Zeromski, con schizzoritratto, p. 4.
L’A. tributa un saggio allo scrittore polacco; lo slavista ripercorre le tappe più
significative della sua carriera, annoverandolo fra i tre maggiori rappresentanti della
letteratura nazionale insieme a Władysław Reymont, cantore della campagna
polacca, e Jan Kasprowicz, considerato il “Carducci mistico” della Polonia. Al
saggio segue una bibliografia delle opere.
• Giacomo Prampolini, traduzione: Stefano Zeromski, Crepuscolo, p.
4.
• Un viaggio nella Russia dei Soviety, a cura dello scrittore catalano
Jaume Pi i Sunyer sulla “Revista de Catalunya” in ‘Rivista delle
riviste straniere’, p. 5.
Breve descrizione della Russia sovietica, raccontata da uno scrittore catalano,
professore delegato al giubileo dell’Accademia delle Scienze di Leningrado, che
focalizza l’attenzione sui tragici effetti prodotti dalla crisi della nobiltà e del
vecchio sistema capitalistico.
N° 5, 31 gennaio:
• La Redazione, Giorgio Pitoëff a Torino (Nostro servizio
particolare), p. 4.
Notizia su alcune rappresentazioni teatrali della compagnia di Giorgio Pitoëff
(Georgij Ivanovič Pitoev) in cartellone al teatro di Torino per il mese di febbraio
del 1926.
• La Redazione, Gli scritti di T. G. Masaryk (Nostro servizio
217
particolare), p. 7.
Notizia della pubblicazione di un’edizione completa degli scritti del
Presidente della Repubblica ceca T. G. Masaryk per la casa editrice “Cin” di Praga.
N° 6, 7 febbraio:
• La Redazione, “Panorami critici”,
straniere’, p. 4.
in ‘Rivista delle Riviste
Recensione di John Heyduk al libro Di oggi e di domani sulla rivista
“Kritika” di Praga. Dal volume Heyduk riporta la suddivisione della lirica ceca del
dopoguerra in due periodi: poesia proletaria e poetismo.
• La Redazione, La morte del poeta Vlcek (Nostro servizio
particolare), p. 5:
Notizia della morte del giovane traduttore di opere italiane nonché divulgatore
della cultura italiana in Cecoslovacchia Bartoš Vlček.
• Aldo Gabrielli, recensione a: Gustavo Meyrink, Il Golem (Franco
Canpitelli, Editore, Foligno, 1926, 2 volumi, Lire 9 ciascuno) in
‘Libri stranieri tradotti’, p. 6.
L’A. presenta il volume, già ampiamente apprezzato in Germania, nella fedele
traduzione di Enrico Rocca, tracciando un profilo psicologico e artistico dello
scrittore ceco Gustav Meyrink. Scrittore originale a metà tra la farsa e la tragedia,
Meyrink si definisce meglio identificandolo coi suoi ‘incubi esistenziali’ di cui la
leggenda del Golem, caso esemplare di sdoppiamento della personalità, è sintesi.
N° 7, 14 febbraio:
• Rinaldo Küfferle, Traduzione in versi, in ‘Note polemiche’, p. 6.
Breve nota polemica dell’A. su come Lo Gatto, nel primo numero di “Russia”,
aveva accolto una sua recensione alla traduzione italiana dell’Evgenij Onegin di
Puškin pubblicata su “La Fiera Letteraria” del 17 gennaio 1926.
• Breve informazione bibliografica sugli Studi di letterature slave di
Ettore Lo Gatto. Vol. I, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1925, p.
VIII, 220, L. 10, dedicati a Puškin, Mickiewicz, Reymont, SaltykovŠčedrin, Čechov e alla poesia russa contemporanea, p. 6.
N° 8, 21 febbraio:
• Riccardo Bacchelli, I Pitoëff in Italia con fotografia di Giorgio
Pitoeff nel II atto di Enrico IV, p. 4.
Alcuni allestimenti italiani di Giorgio e Ljudmila Pitoëff, in particolare
Mademoiselle Buorrat, commedia di Claude Anet, dove la parte principale si adatta
perfettamente alla personalità di Ljudmila, e La Dame aux Camélias di Alexandre
Dumas, in cui l’arte scenica di Giorgio si esprime al meglio in veste di direttore e
scenografo.
218
• La Redazione, ‘Rivista delle Riviste straniere’,– Intervista con un
poeta, p. 4.
Breve notizia di un’intervista a Juljan Tuwim, pubblicata dalle “Wiadomości
Literackie” di Varsavia, nella quale il poeta esprime la sua preferenza per i toni
melanconici dell’autunno.
• Giacomo Prampolini, traduzione: Paolo Muratov, La Valchiria, p.
5:
Fra gli scrittori russi contemporanei Muratov si distingue per la profonda
conoscenza della cultura e dell’arte del nostro paese come si evince da alcune
opere, frutto di diversi soggiorni in Italia. Si ricordano i tre volumi di Obrazy Italii,
articoli e saggi apparsi in riviste varie prima e dopo la guerra, due raccolte di
novelle del 1918 e 1922 e il romanzo Egerija del 1923.
N° 9, 28 febbraio:
• Rinaldo Küfferle, M.P. Mussorgski, Kovantscina. Il libretto, con un
ritratto dell’artista, p. 4.
Breve storia del libretto del dramma di Musorgskij, che dalla primitiva stesura
del 1872 proposta al musicista da Vladimir Stasov subì alcune modifiche dallo
stesso compositore, che eliminò parecchie scene e ridusse i personaggi, e da
Rimskij-Korsakov, che orchestrò alcune scene.
• Pino di Valmarana, La musica, p. 4.
Breve sguardo sul panorama musicale in Russia alla fine del XIX secolo,
così come si presentava dopo l’apporto innovativo della scuola russa di Glinka, e
sulla svolta data dal cosìddetto “gruppo dei cinque”, fra i quali Musorgskij; nel caso
specifico del dramma popolare Chovanščina la scena teatrale musicata dai nuovi
artisti si avvaleva di una grande semplicità tecnica unita ad un’intensa
partecipazione emotiva dei personaggi.
• Rinaldo Küfferle, recensione a: Alfredo Polledro, Risate russe. S.
Lattes e C. Editori, Torino, L. 9,50 in ‘I libri della settimana. Scrittori
russi’, p. 6.
Il volume raccoglie alcune fra le più celebri novelle umoristiche di Čechov,
Averčenko, Kuprin e altri; l’A. presenta la raccolta associandone l’entusiasmo col
quale era solito affrontare questo genere di letture in gioventù e rilevando aspetti
contradditori, poco coerenti col titolo assegnato dal curatore.
N° 11, 14 marzo:
• Riccardo Bacchelli, Ida Rubenstein, (Le Martyre de Saint
Sebastien, Teatro alla Scala – La Dame aux Camélias, L’ Idiot,
Teatro Manzoni), con disegno-ritratto di Ida Rubenstein in L’ Idiot, p.
4.
Sulle doti artistiche di Ida Rubenštejn, ballerina e mima di scuola russa, figlia
delle grandi tradizioni accademiche della Francia teatrale.
219
• Rinaldo Küfferle, Un cenno su Saltikòf, con fotografia d’epoca, p.
5.
L’A. ripercorre le tappe fondamentali della vita artistica dello scrittore, erede di
una nuova coscienza sociale diffusa in Russia nella seconda metà del XIX secolo e
già presente con Griboedov, che portò a una politica di riforme e al progetto di
occidentalizzazione del Paese.
• Rinaldo Küfferle, traduzione di: Michele Saltikòf, Il Giornalista
impostore e il lettore credulo. Versione direttamente dal russo, p. 6.
N° 12, 21 marzo:
• Riccardo Bacchelli, “L’ Idiot” di Nozière e Bienstok (Milano,
Teatro Manzoni, 12 marzo), con fotografia di Ida Rubenstein in
“L’Idiot” (Figurino di L. Bakst), p. 4.
Recensione a “L’Idiot” con la compagnia di Ida Rubenštejn, la cui
messinscena di oggetti, abiti e gesti viene considerata dal critico “uno studio
perfetto di armonia e di costume,” espressione della Russia del secolo scorso.
• Riccardo Bacchelli, “I Nemici” di M. Artzibacef, (Milano, Teatro
Olympia, 15 marzo), p. 4.
Stroncatura alla messinscena de “I Nemici”, prodotta della compagnia teatrale
di Alda Borelli e considerata “insipida”, “volgare”, priva di abilità teatrale e ricca di
situazioni e battute noiose e ripetitive.
• Riccardo Bacchelli, “Tilla”, di Francesco Herczeg (Teatro
Manzoni, 16 marzo), p. 4.
L’A. descrive il carattere del personaggio di Tilla, dall’omonimo dramma di
Herczeg, donna capricciosa, sregolata e spregiudicata, molto distante da personalità
come Mirandolina di Goldoni o Madame Bovary di Flaubert.
N° 13, 28 marzo:
• La Redazione, Bontempelli presentato ai russi, in ‘Rivista delle
Riviste straniere’, p. 4.
Breve notizia di alcuni articoli di Pavel Muratov pubblicati su “Zveno”,
settimanale russo di letteratura stampato a Parigi, dedicati all’opera di Massimo
Bontempelli.
• F., “Maeterlinck e Turghieniew”, p. 6.
Sul teatro romano di Bragaglia e, in particolare, sulla recitazione di Carlo Duse
nel Socrate immaginario e di Vera d’Angara, proveniente dal teatro dei Pitoëff e
che a Roma ha recitato per la prima volta in italiano interpretando la Morte di
Tantagile di Maëterlink e la commedia di Turgenev La provinciale.
220
N° 14, 4 aprile:
• Rinaldo Küfferle, recensione a: Adamo Mickiewicz, Canti,
Vallecchi, Firenze, L. 6,50, in ‘I libri della settimana. Il caso
Mickiewicz’, traduzione di Enrico Damiani, p. 6.
N° 15, 11 aprile:
• Su ‘Rivista delle riviste straniere’, direttore responsabile Umberto
Fracchia.
Sergio Iesenin:
Breve contributo su un articolo pubblicato nel primo numero della
bizzarra rivista ceca “Q” e dedicato alla più diffusa versione della morte dello
scrittore russo Esenin, avvenuta a Leningrado il 27 dicembre 1925;
Poeti serbi:
A proposito di alcuni saggi della nuova poesia serba pubblicati dalla
rivista “Misao” di Belgrado diretta da Siniša Pandurović che fra gli altri ha
contribuito a far conoscere Radoslav Dragutinović e M. Nastasiević;
N° 19, 9 maggio:
• G. Prampolini, recensione a: Ivan Cankar, Il servo Bartolo e i suoi
Diritti, Gorizia, traduzione di G. Lorenzoni, Gorizia, Tipo Paternolli,
L. 5, p. 8 - La bella Vida, Libreria Editrice Udinese, Udine, L. 3,
traduzione di G. Lorenzoni, p. 5.
• Janina Gromska, traduzione: Boleslaw Prus, Il Panciotto, p. 6.
N° 20, 16 maggio:
• Hans Liebe, “Pétrouchka” di Strawinski (Milano, alla Scala, 9
maggio), in ‘La Musica’, p. 4.
Breve recensione a Petruška, presentata a Milano all’apertura annuale
dell’Accademia nazionale di musica, una tragicommedia delle maschere in cui
Stravinskij, descrivendo la folla che si accalca fra giostre e teatrini di una
Pietroburgo romantica e provinciale, riesce a ricreare le atmosfere della ‘danza
collettiva’.
• ‘Informazioni bibliografiche’, Dostoevskij Teodoro, Il sosia:
romanzo Pietroburghese, traduzione di B. Jakovenco. Lanciano,
Carabba, 1925, p. 199.
N° 21, 23 maggio:
221
• Arnaldo Frateili, recensione a: “Il topo”, di Cetoff (Roma, Agli
Indipendenti, 16 maggio), in ‘Prime rappresentazioni’, p. 4.
L’A. riassume la trama della commedia evidenziandone i tratti comuni al
genere della pochade filosofica con un problema centrale rovesciato, un genere raro
e prezioso perché concilia il divertimento con l’insegnamento morale.
• Hans Liebe, “L’ Usignolo” di Strawinski (Milano, alla Scala, 14
Maggio), in ‘La Musica’, p. 4.
Descrizione della scena teatrale di Stravinskij, con particolare riferimento
alla qualità dell’orchestra, la professionalità dei solisti e dei cori, l’interpretazione
dell’“usignolo” da parte di Laura Pasini e la splendide scene ideate da Rovescalli.
• Rinaldo Küfferle, recensione a: Massimo Gorki, L’ Albergo dei
Poveri, ecc… (Mondadori, Milano, L. 15), p. 6.
L’A. segnala il volume facendo notare che il vero titolo del dramma di
Gor’kij, pubblicato insieme ad altri due in una brutta traduzione anonima dal
tedesco, è Na dne.
• S.a.“Rinasce il teatro storico?” in ‘Rivista delle Riviste straniere’,
p. 6.
Due brevi notizie: la prima relativa alla stesura di un dramma sulla vita di
Esenin scritta dai russi C. Leonidov e R. Irnev, la seconda sulla rappresentazione a
Mosca del dramma di M. Bulgakov Belaja gvardija, ambientato all’epoca
dell’etmano Petljura.
• S.a.“Un quadro di Raffaello” in ‘Rivista delle Riviste straniere’, p.
6.
Notizia sul ritrovamento negli Urali di un quadro di Raffaello considerato
smarrito, La Madonna del popolo, e che probabilmente era stato portato dalla
favorita di Nicola I, la Demidova, nella fabbrica di famiglia a Nižnyj Tagil.
• S.a.“Teatro e Cine nei Soviety” in ‘Rivista delle Riviste straniere’,
p. 6.
Breve notizia, diffusa da una corrispondenza da Mosca alle “Wiadomości
Literackie” di Varsavia, sull’incremento del numero di teatri e di pellicole
cinematografiche nella Russia sovietica; la rivista evidenzia come in tutte le
democrazie di ‘massa’ caratteristica comune sia la ‘teatralità’, con la differenza che
in Russia le pellicole cinematografiche sono di contenuto storico e di propaganda
comunista.
• S.a.“Due poeti cechi” in ‘Rivista delle riviste straniere’, p. 6.
Breve segnalazione della canzone del mio maggio di Jan B. Čapek
pubblicata su “Kritika” di Praga, e di canzone della morte di Jaroslav Seifert sulla
rivista “Pasmo”, sempre di Praga.
222
N° 22, 30 maggio:
• S.a.‘Notiziario estero’ – Mosca, p. 5.
Nota informativa sull’uscita del secondo volume dell’Enciclopedia dei Soviet
di stampo marxista.
• ‘Informazioni bibliografiche’, Teatro: Raissa Olkienizkaja Naldi,
traduzione: Arzibascev P. M., La Gelosia: dramma in 5 atti, Milano,
Casa Editrice Alpes, 1925, p. 158, L. 6.
Tragedia che costituisce la prima parte del trittico di Arcybašev incentrato sui
rapporti fra i sessi e sulla critica spietata all’istituto del matrimonio.
• ‘Informazioni bibliografiche’, Teatro: Raissa Olkienizkaja Naldi,
traduzione: Alessandro Blok, La rosa e la croce, dramma in 4 atti,
Milano, Casa ed. Alpes, 1925, p. 136, L. 6.
L’azione delle drammatiche scene si svolge nel 1208 al tempo della crociata
contro gli Albigesi in Linguadoca e Bretagna.
N° 23, 6 giugno:
• Arnaldo Frateili, “Menzogne di Winnicenko” (Roma, Valle, 31
maggio), p. 4.
Presentazione della commedia di Vinnicenko con una descrizione della trama,
che l’A. riconduce al genere russo dell’“incubo”, sottolineando alcuni aspetti come
l’ambiente grigio e desolato in cui si svolge l’azione e certe note nostalgiche.
• I.[ris] F[elyne]., Piccola guida di Avercenko, p. 5.
Breve introduzione critica all’arte narrativa di Averčenko, lontana dalla
‘desolata malinconia’ comune a molti scrittori russi e vicina alla caricatura, alla
bonaria ironia e all’umorismo brillante.
• Iris Felyne, traduzione: Arcadio Avercenko, Una moglie modello.
Racconto di A.A., p. 5.
N° 24, 13 giugno:
• R.[aissa] O.[lkienitzkaja] N.[aldi], L’arte teatrale moderna
nell’opera di N. Ievrieinov, p. 4 con fotografia di Evreinov:
L’articolo sottolinea la portata innovativa nell’opera teatrale di N. Evreinov, la
cui fama resta legata, nel ricordo degli intelletuali russi, agli allestimenti scenici
brillanti, stilizzati e grotteschi del Teatro Antico e dello Specchio Obliquo;
Evreinov non creò una vera scuola o compagnia, ma il suo concetto di
“teatralizzazione della vita” si affermò come modello per la produzione teatrale.
223
N° 25, 20 giugno:
• Giuseppe Ravegnani, L’ultima maniera di Gorkij in ‘Cronache
delle letterature straniere. Scrittori europei’, con un ritratto di B.
Grigoriew, p. 5.
L’A. analizza l’ultimo periodo artistico dello scrittore russo a partire dal
1918, anno in cui sembrava ormai completamente decaduta la creatività e
l’ispirazione artistica. Sulla base di studi critici, si traccia un profilo psicologico
dello scrittore a partire dai racconti brevi e dagli scritti autobiografici fino a Gor’kij
novelliere e saggista dell’ultimo periodo, caratterizzato da un ritorno all’ispirazione
e all’obiettività.
• S.a.“Voci della lirica ceca” in ‘Rivista delle Riviste straniere’, p. 6:
Notizia della pubblicazione sul settimanale di Praga “Kritik” della poesia
Marzo di František Křelina e di Romanza nordica di Karel Erban.
• S.a.“Casanova e Cagliostro” (“Wiadomości Literackie”) in
‘Rivista delle Riviste straniere’, p. 6.
Notizia diffusa dalla rivista di Varsavia “Wiadomości Literackie” relativa alla
pubblicazione di un’opera postuma di Casanova conforme all’unico manoscritto
conservato al Museo Nazionale Ceco; lo scritto sarebbe, però, attribuibile a
Cagliostro, di cui lo stesso Casanova si considerava rivale.
N° 27, 4 luglio:
• S.a.“Come si scrivono i versi” in ‘Rivista delle Riviste straniere’, p.
7.
Breve notizia su “Wiadomości Literackie” dell’imminente pubblicazione in
Russia di un manuale di versificazione di Vladimir Majakovskij, secondo cui per la
creazione poetica sono necessarie cinque cose: impulso sociale, conoscenza della
classe sociale che si vuole rappresentare, linguaggio adeguato, organizzazione del
lavoro con strumenti necessari e mezzi per "lavorare le parole”.
• S.a.“Notiziole russe” in ‘Riviste delle Riviste straniere’, p. 7.
Notizia sul quotidiano politico del partito comunista per i contadini “Krasnaja
Gazeta” dell’imminente pubblicazione in Russia di una collezione di classici
letterari russi e stranieri raccolti in antologie essenziali e in volumetti economici.
L’iniziativa è del “commissario del popolo” per il Proletlkul’t Anatolij Lunačarskij.
N° 28, 11 luglio:
• G. Prampolini, recensione a: Sigismondo Krasinski, La non divina
commedia, traduzione di M. Antonietta Kulczycka (“Anonima
Romana Editoriale”. L. 7, 50).
Presentazione di un volumetto, dodicesimo di una collezione di scrittori
stranieri promossa dall’I.p.E.O., che ha finora pubblicato in traduzione italiana
autori polacchi, serbi, rumeni, bulgari. Il volume, considerato dall’A. ben tradotto,
contiene il capolavoro di Krasiński insieme a Iridion ed è corredato da note
esplicative e da un’ampia bibliografia.
224
N° 29, 18 luglio:
• S.a.“Intorno a un dramma di Tolstoj” in ‘Rivista delle Riviste
straniere’, p. 7.
Breve notizia pubblicata su “Wiadomości Literackie” della recente
pubblicazione a Mosca dell’epistolario di Pobedonoscev contenente una
interessante lettera sulle vicende del dramma Vlast’ t’my (Il potere delle tenebre),
composto da Tolstoj nel 1886 e più volte oggetto della censura zarista.
• S.a.“Poeti cechi” in ‘Rivista delle Riviste straniere’, p. 7.
Notizia della pubblicazione della lirica Riviera di Konstantin Biebl sulla rivista
“Host” di Praga.
• S.a.“Nei teatri dei Soviety” in ‘Rivista delle Riviste straniere’, p. 7.
Il settimanale letterario russo «Zveno» di Praga annuncia le imminenti
rappresentazioni previste per la prossima stagione teatrale in Russia, menzionando
fra gli altri Boris Godunov e Tristano e Isotta al “Bol’shoj teatr” di Mosca, Velluto
a brandelli di Lunačarskij e Vojna i mir di Tolstoj al “Malyj teatr”.
N° 30, 25 luglio:
• Rinaldo Küfferle, I lirici russi del secolo aureo, con due fotografie
di Puškin e Lermontov, p. 5.
Presentazione dell’antologia in due volumi curata da Giovanni Gandolfi per
la Casa Editrice Lanciano-Carabba e in gran parte dedicata alle liriche di Puškin e
Lermontov. L’A. sottolinea l’attenta analisi stilistica eseguita da Gandolfi nel
delicato lavoro di traduzione della poesia lirica, ben più complessa rispetto a quello
sulla poesia drammatica e narrativa.
N° 31, 1° agosto:
• Carlo Grabher, Turgheniev e il suo teatro, con una fotografia, p. 6:
Profilo dello scrittore russo, a partire dallo stile narrativo, molto vicino al
‘realismo’ di Gogol’ e al ‘romanticismo’ di Puškin; nel personaggio di Bazarov,
protagonista di Otcy i deti, è rappresentata la crisi del romanticismo russo in favore
di un ritorno al sentimentalismo romantico di vecchio stampo.
N° 32, 8 agosto:
• Cesare Padovani, Tolstoi e il suo diario intimo, p. 8.
L’A. analizza alcune pagine tratte dal primo volume, l’unico finora pubblicato,
del diario di Tolstoj dal 1853 al 1855, da quando, cioè, lo scrittore si era arruolato
come sottufficiale nel Caucaso per sfuggire ai debiti e alla vita dissipata di Mosca.
Completa il saggio qualche osservazione sulle contraddizioni interne del diario.
N° 33, 15 agosto:
225
• S.a.‘Rivista delle Riviste straniere’, “Intorno a Iesienin”, p. 7.
Breve nota in memoria del poeta russo suicida, oggetto di uno studio di
Vladimir Chodasevič pubblicato su “Sovremennye Zapiski” a Parigi, dove si
analizzano le fonti dei suoi scritti orientati alla celebrazione della Russia contadina,
la “Rus”, anziché la “Rossija” degli zar;
N° 35, 29 agosto
• S.a.‘Rivista delle Riviste straniere’, “Suoni della lirica ceca”, p. 7.
Pubblicazione di due brevi liriche del poeta ceco Josef Hora sulla rivista
“Host” di Praga.
N° 37, 12 settembre:
• S.a. Fra Tolstoi e Turghenief in ‘Rivista delle riviste straniere’, p. 7.
Breve notizia della pubblicazione in Russia di una lettera che Tolstoj inviò a
Turgenev rispondendo alle accuse dello scrittore, suo rivale; l’episodio cui si
riferisce il carteggio avvenne nel 1869 mentre i due si trovavano ospiti a casa del
poeta Fet.
N° 38, 19 settembre:
• Rinaldo Küfferle, Alessandro Amfiteatrov, con una fotografia, in
‘Scrittori stranieri in Italia’, p. 5.
L’A. riassume i principali momenti della sua conversazione con Amfiteatrov
a casa dello scrittore nei pressi di Levanto. L’articolo si divide in due parti,
‘l’uomo’ e ‘lo scrittore’, e, dopo un’introduzione descrittiva e molto vicina al
racconto, prosegue in forma dialogica, riferendo sulla ricezione dello scrittore in
Russia e sugli autori russi preferiti dallo stesso.
N° 40, 3 ottobre:
• Henri Mongault, Gli anni di Gogol in Italia, con una fotografia, p.
5.
N° 41, 10 ottobre:
• Riccardo Bacchelli, “Ciò che più importa”. 2 atti di N. Ievrieinov.
Milano, Manzoni, 4 ottobre, con una fotografia di Evreinov, p. 6.
L’A. presenta l’opera di Evreinov come una “commedia degli equivoci brillante,
mossa, sbrigliata, ricca di scherzo e illuminazioni”. La rappresentazione,
nell’insieme, viene considerata ben concertata, in particolare viene lodata la
recitazione degli attori Racca, Cimara e Olivieri.
• Riccardo Bacchelli, “Storienko”. 3 quadri di Wassili Cetof
(Milano, Arcimboldi, 4 ottobre).
L’atto di Čechov è descritto da Bacchelli come “burlesco, beffardo e
spregiudicato”, lodevole viene considerata la recitazione degli attori Rossana Masi
226
e Franco Becci.
• La Redazione, “Per Iesienin” in ‘Rivista delle riviste russe’, p. 7:
Notizia diffusa dalle “Wiadomości Literackie” secondo cui la lega panrussa
dei letterati di Mosca e il comitato “Per eternare la memoria” di Esenin avrebbero
mandato una delegazione al villaggio natale del poeta per una presa di possesso da
parte dell’ente governativo per lo sviluppo. La delegazione avrebbe scoperto che i
parenti del poeta possedevano tratti somatici più ‘slavi’ ché ‘mongoli’.
N° 42, 17 ottobre:
• Jlo Zn. De’ Franceschi, Piccolo panorama del romanzo ceco.
Scalata alle nuvole, p. 5.
L’A. cerca qui di delineare la fisionomia del romanzo ceco “d’ambiente”
attraverso un percorso che lo fa confluire nel genere del ‘romanzo etico’ con
Růžena Svobodová.
N° 43, 24 ottobre:
• O. Skarbek Tlucowski, Il poeta Kasprowicz in ‘Rivista delle riviste
straniere’ con una fotografia di Federico Pautsch, p. 5.
Ricordo della personalità artistica e dell’opera letteraria del poeta polacco Jan
Kasprowicz, scomparso insieme ad altri due grandi rappresentanti della letteratura
polacca contemporanea, Władysław Reymont e Stefan Żeromski. Fra i primi
componimenti poetici di Kasprowicz si ricordano Świat się kończy (1891), Miłość
(1895), Krzak dzikiej róży (1898).
• S.a.“Tolstoiana”in ‘Rivista delle Rivista straniere’, p. 7.
Breve notizia sul ritrovamento negli archivi di Tula di parecchie lettere di
Tolstoj degli anni 1870-1880, documenti preziosi che forniscono importanti
chiarimenti sulla sua vita religiosa, nonché sugli intrighi e le persecuzioni della
polizia segreta e della Chiesa russa nei confronti del poeta.
• La Redazione, “Briusof e Pilniak” in ‘Rivista delle Riviste
straniere’, p. 7:
Due brevi notizie diffuse da “Wiadomości Literackie”: la prima sul
ritrovamento tra le carte lasciate dal poeta di una lettera risalente al 1913, mai
inviata al destinatario e pubblicata sul “Novyj Mir” di Mosca, nella quale lo
scrivente risponde alle richieste di una madre di far impiegare il figlio presso la
redazione di una qualsiasi rivista; la seconda relativa alla pubblicazione del nuovo
dramma di Boris Pil’njak.
N° 44, 31 ottobre:
• Rinaldo Küfferle, I fratelli Karamazov. Recensione a: Fjodor
Dostojevskij, I Fratelli Karamazov, romanzo in quattro parti e un
epilogo, Slavia, Torino. Unica versione integrale e conforme al testo
227
russo con note di Alfredo Polledro, p. 5- Fotografia.
Presentazione del volume per la collezione “Il Genio russo”. L’A. evidenzia
l’attento e scrupoloso lavoro di traduzione, “specchio limpido” del testo originale.
Il pubblico di lettori poteva contare fino ad allora sulla versione ridotta e
sintetizzata di Mangault e Laval nella Collection des textes integreux e quella di
Polledro costituisce la prima attendibile versione dal russo.
N° 45, 7 novembre:
• S.a.“Omaggio a Kodowiecki” in ‘Rivista delle Riviste straniere’ p.
7.
Notizia della pubblicazione sul “Literarische Welt” di Berlino di un lungo
articolo sul celebre disegnatore di Danzica Daniil Chodowiecki in occasione del
secondo centenario della sua nascita. Nel 1707 Chodowiecki fu nominato direttore
dell’Accademia di Berlino.
• S.a.“Voci della lirica serba” in ‘Rivista delle Riviste straniere’ p.
7.
Notizia della pubblicazione su “Misao” di Belgrado di poesie di Ivo I.
Antičević (Giorni grevi), Jovan Radulović (Conchiglia), Dušan Čukić (Messaggio).
N° 48, 28 novembre:
• Rinaldo Küfferle, L’ultimo romanzo di Gorkij. Recensione a:
Massimo Gorkij, Gli Artamanov romanzo. Versione dal manoscritto
russo a cura di Erme Cadei. F.lli Treves, Milano. L. 12, p. 5.
Si riassume la trama del romanzo evidenziandone le parti più significative. In
apertura, una breve prefazione dà un giudizio sulla traduzione di Ermes Cadei,
considerata fedele all’originale e capace di trasmetterne il senso generale,
nonostante alcune mende stilistiche dovute, secondo l’A., a espressioni dialettali o a
incertezze di linguaggio.
N° 51, 19 dicembre:
• Bruno Neri, Meridiano jugoslavo, p. 5.
Notizie varie su personaggi della cultura italiana in Jugoslavia e della cultura
balcanica in Italia. Breve cenno alla nascita a Belgrado della rivista “Savremeni
pregled”, diretta da G. Glisić e Marino Tartaglia, corrispettivo della “Fiera
letteraria”.
• Tatiana Pavlova, La salvezza del Teatro è nel Teatro. Altre risposte
al nostro referendum sull’ Arte Drammatica, p. 6.
Breve contributo della Pavlova sulla crisi del teatro e sugli effetti deleteri
causati dall’avvento del cinematografo; la celebre attrice non intravede una vera e
propria crisi della produzione teatrale, piuttosto il venir meno della consapevolezza
che il teatro è un organismo dinamico e che, per sopravvivere, ha bisogno di qualità
e innovazione.
228
• La Redazione, Korolenko redattore in ‘Rivista delle Riviste
straniere’, p. 7.
Breve nota sul profilo professionale di Korolenko, redattore del “Severnyj
Vestnik”, secondo cui era possibile rendere ‘pubblicabile’ anche un manoscritto
considerato ‘cattivo’ poiché mentre la forma letteraria si acquisisce col tempo, il
pensiero di uno scrittore traspare anche sotto una goffa espressione.
Anno III (1927)
n. 3, 16 gennaio:
• Ignazio Balla, I balli russi (Milano, Alla Scala, 10 gennaio), p. 5:
Breve contributo sulla qualità del teatro di Djagilev, sulla grazia e flessuosità di
danzatori e danzatrici e sulla perfetta sincronia tra scenografia, coreografia e
musica, che rendono la messinscena della celebre scuola russa una forma d’arte.
• Giacomo Prampolini, Indice letterario della Russia d’oggi. La
Rivoluzione ha creato nuovi scrittori?, con due fotografie di
Vsevolod Ivanof e Scisckov, p. 6.
Presentazione di una recente antologia di autobiografie dal titolo Pisatel’
pubblicata a Mosca dalla casa editrice “Sovremennye voprosy”. La raccolta
contiene autobiografie di prosatori russi contemporanei e, come avverte il curatore
Vladimir Lidin, doveva servire per la compilazione di una più ampia antologia
dedicata alla produzione letteraria della nuova Russia.
• ‘ Meridiano jugoslavo’ a cura di Bruno Neri, p. 6.
Breve rassegna delle novità letterarie in uscita, o in previsione di pubblicazione,
per il prossimo anno: Milan Begović e la sua commedia Božij čovjek, il novelliere e
commediografo serbo Branislav G. Nušić e il suo dramma musicale La signora del
ministro, Ahmed Muradbegović e la commedia Il cane arrabbiato, Iosip Kulundzić
e la sua commedia Il volto, Gjuro Vilović e il romanzo Krvatia.
n. 12, 20 marzo:
• Riccardo Bacchelli, A Milano, con foto di Massimo Gorki dal
ritratto di B. Grigoriew e disegno di Pavil di Giorgio Pitoef, p. 5.
Osservazioni critiche dell’A. ad alcune rappresentazioni in scena al Teatro
Arcimboldi di Milano; in particolare, ci si sofferma sugli attori Giorgio Pitoëff in
scena nel Revizor di Gogol’, e Ljudmila Pitoëff nell’interpretazione di
Mademoiselle Bourrat ne L’indigent di Ch. Vildrac.
n. 13, 27 marzo:
• S.a.“Lirica slava” a cura di Giacomo Prampolini in ‘Rivista delle
Riviste straniere’, p. 7.
Breve notizia della pubblicazione sulla rivista “Host” di Praga della prima parte
di un trittico intitolato Giorni di Jozef Hora.
229
• S.a.“Intorno alla morte di Pusckin” a cura di Giacomo Prampolini
in
• S.a.‘Rivista delle Riviste straniere’, p. 7.
Nota informativa tratta da “Literärische Welt” di Berlino sulla tragica morte di
Puškin.
n. 15, 10 aprile:
• “Lirica Polacca” a cura di Giacomo Prampolini in ‘Rivista delle
Riviste straniere’, p. 7.
Breve notizia della pubblicazione sulla rivista “Wiadomości Literackie” di
Varsavia da un volume di imminente pubblicazione due poesie di Stefan Napierski.
n. 16, 17 aprile:
• Giacomo Prampolini, Meridiano di Praga, p. 6.
Breve rassegna delle più recenti pubblicazioni di letteratura ceca; in particolare
si segnalano le ultime pubblicazioni della collezione “Odeon” curata da Jan Fromek
di Praga, che alterna traduzioni da scrittori francesi contemporanei con opere di
giovani scrittori cechi, e il nuovo volume di Jaroslav Seifert dal titolo Slavik zpiva
spatne (L’usignolo canta male), tratto dal celebre aforisma di Cocteau.
n. 18, 1 maggio:
• ‘Meridiano Jugoslavo’ a cura di Bruno Neri, p. 6.
Breve rassegna sulla recente attività letteraria nella ex Jugoslavia con
un’introduzione sull’inchiesta condotta dall’unica rivista letteraria croata di
Zagabria “Vijenac” relativa alla crisi del libro, attribuibile anche al fatto che lo
scarso numero di lettori si divide in tre gruppi: i serbi, che non vogliono
abbandonare l’alfabeto cirillico, i croati e gli sloveni con la loro lingua ancora poco
conosciuta.
• Giacomo Prampolini, “Intervista con Sejfullina”, in ‘Rivista delle
Riviste straniere’, p. 7.
Alcuni brani dell’intervista rilasciata a un redattore di “Literarni Noviny” di
Praga, nella quale la scrittrice parla del forte incremento della lettura negli anni
post-rivoluzionari e della maggiore attenzione degli scrittori allo studio della lingua
e dei classici nazionali.
n. 21, 22 maggio:
• Ja Ruskaia, Splendori e miserie del balletto russo, p. 5 con due
fotografie.
Articolo tratto dal volume La danza come modo di essere, nel quale si
riassume la storia del balletto russo a partire dai primi anni del Novecento, quando
a dominare la scena era il Teatro di Mosca coi maestri italiani e francesi che
portavano sulla scena la maniera coreografica occidentale. Il rinnovamento arrivò
230
con la compagnia di Djagilev, che assunse forme espressive tipiche della danza
popolare e del costume nazionale, come in Tamara e Cleopatra.
• Giacomo Prampolini,
l’“Innocente”, p. 6.
Santi
italo-russi.
San
Procopio
Prendendo spunto da un saggio di Boris Zajcev sulla vita di Sergej Radonežskij,
riformatore del monachesimo russo nel XIV secolo, l’A. rivolge l’attenzione alla
figura del primo ‘jurodivyj’ (‘folle in Cristo’) beatificato dalla Chiesa ortodossa
russa, San Procopio di Ustjug, confrontandola con quella di S. Francesco d’Assisi.
• “Una commedia di Gogol” a cura di G. Prampolini in ‘Rivista delle
Riviste straniere’, p. 7.
Breve contributo su una notizia riportata da “Literarni Noviny” di Praga
relativa alla pubblicazione della storia di Revizor da parte dello scrittore russo
Sivirjakov in occasione del settantacinquesimo anniversario della morte di Gogol’.
n. 22, 29 maggio:
• Giovanni Comisso, Le arti plastiche nella nuova Russia, p. 4.
L’articolo è ricavato da un’intervista con Boris Ternovec, membro
dell’Accademia delle Scienze e dell’Arte di Mosca e Direttore del Museo d’Arte
Moderna, in visita a Milano per organizzare la Sezione U.R.S.S. all’Esposizione
d’Arti Decorative di Monza presieduta dal prof. Pietro Kogan. Dopo aver parlato
dell’influenza di Picasso e della pittura francese in Russia, Ternovec evidenzia la
nascita di giovani scultori vicini all’arte pittorica .
n. 23, 5 giugno:
• Giacomo Prampolini, Březina, poeta ceco, p. 6.
Breve
introduzione dell’A. alle origini della letteratura ceca e alle
caratteristiche fonetiche del ceco, seguita dalla biografia del poeta Vaclav Jebary,
nato in un villaggio moravo nel 1868, meglio conosciuto come Otokar Březina.
L’A. si sofferma sulla sua opera composta da cinque esili volumetti di versi
composti dal 1896 al 1901, raccolti in un libro di circa duecento pagine, più una
raccolta di saggi.
n. 25, 19 giugno:
• Giovanni Comisso, L’arte letteraria in Russia, con disegno di
Pietro Kogan di Villani Marchi, p. 6.
Intervista al prof. Pëtr Kogan, incaricato dal governo dell’U.R.S.S. di
presiedere la Commisione all’Esposizione Universale di Monza, che riferisce sugli
sviluppi della poesia e della prosa narrativa in Russia dopo la Rivoluzione. Kogan
individua due periodi: “romantico”, dall’ottobre del 1917 fino all’emanazione della
Nuova Economia Politica (1922-1923), e “verista”, dalla N.E.P. all’anno in corso.
• “Lirica polacca”, a cura di G. Prampolini per ‘Rivista delle Riviste
231
straniere’, p. 7.
Viene qui riproposta una poesia pubblicata in passato nell’ultimo fascicolo della
rivista dei giovani poeti polacchi “Skamander”. Si tratta del Cieco nel giardino di
Włodzimierz Slobodnik.
n. 28, 10 luglio:
• Giovanni Comisso, L’organizzazione degli artisti in Russia.
Intervista col professore Pietro Kogan, Preidente dell’Accademia di
Scienze ed Arti di Mosca. III, p. 6.
Riassunto dell’intervista a Pëtr Kogan, che descrive le organizzazioni di
artisti nella Russia sovietica, in particolare dei nuovi scrittori rivoluzionari. A
differenza della prima generazione, essi non emigrarono a Parigi e Berlino ma
rimasero in Russia formando vari gruppi riuniti in un’unica “Federazione di
scrittori sovietici” (F.S.P.). La seconda parte dell’intervista è dedicata all’attività
editoriale che in Russia è rappresentata ufficialmente dal Gosizdat.
n. 30, 24 luglio:
• Giovanni Comisso, Il teatro in Russia, p. 5.
Sintesi dell’intervista a Vladimir Morič, rappresentante della Sezione russa alla
Mostra di Venezia, che nel suo discorso sottolinea come in Russia, anche negli anni
più difficili di fame e guerra civile, il teatro non abbia mai arrestato il suo sviluppo,
favorito dal governo sovietico fin dall’inizio della Rivoluzione d’ottobre con una
politica mirata alla conservazione della tradizione, alla tutela dei centri di cultura e
al sostegno al teatro nuovo.
n. 31, 31 luglio:
• Alessandro Amfiteatrof, Luci ed ombre sulla vita letteraria in
Russia, p. 6.
Lettera che Amfiteatrov, esule in Italia, scrisse al Direttore della rivista,
facendo alcune osservazioni su quanto dichiarato dal prof. Kogan e da Vladimir
Morič nell’intervista con Giovanni Comisso a proposito dei nuovi scrittori sovietici;
la lettera è accompagnata da un documento in versione integrale, l’Appello degli
scrittori russi agli scrittori di tutto il mondo, pubblicato dalla rivista “Novoe
Vremja”, che cerca di far chiarezza sulla reale situazione dell’attività letteraria in
Russia.
• Giacomo Prampolini, “Slowacki” in ‘Rivista delle Riviste
straniere’, p. 7;
n. 32, 7 agosto.
In occasione dell’arrivo in Polonia delle ceneri di Juliusz Słowacki da Parigi
la rivista “Wiadomości Literackie” di Varsavia raccoglie le testimonianze di affetto
e ricordo da parte di giovani poeti. Vengono qui riprodotti i versi di Jòzef Wittlin in
traduzione italiana.
• Rinaldo Küfferle, recensione a: Nikolaj Gogol, Mirgorod. Versione
232
di Alfredo Polledro; Taràs Bùlba. Versione di Leone Ginzburg. Coll.
Il Genio Russo, Slavia, Torino, L. 11, p. 6:
Presentazione del volume pubblicato da Slavia in occasione del
settantacinquesimo anniversario della morte di Gogol’: si evidenzia la traduzione
fedele del racconto Povest’ o tom, kak possorilsja Ivan Ivanovič s Ivanom
Nikiforovičem, firmata da Polledro e del grandioso ‘affresco epico’ Taras Bul’ba a
cura di Ginzburg.
n. 39, 25 settembre:
• Rinaldo Küfferle, Diario di Tolstoi (1853-1865), in ‘Il libro di cui si
parla’, con un ritratto riprodotto da un’incisione in legno di Bryden,
p. 2.
Breve nota bibliografica del volume Diario di Tolstoi (1853-1865). Traduzione
di Nina Romanowsky dall’originale russo. Milano, F.lli Treves Editori, 1927. L.
15.40.
n. 40, 2 ottobre:
• Giacomo Prampolini, Echi di Russia, p. 7.
Segnalazione tratta dal periodico catalano “L’amic de les arts” sulla
pubblicazione per le edizioni di Stato dell’U.R.S.S. di varie raccolte di častuški
(canzoni popolari).
n. 41, 9 ottobre:
• G.T.R., Maria Lednicka, in ‘Visite ed artisti’, p. 4.
Breve studio critico sulla statua di San Francesco, eseguita dalla scultrice
polacca Maria Lednicka per incarico del marchese Paulucci de’ Calboli.
n. 44, 30 ottobre:
• Rinaldo Küfferle, Boris Pilniak, p. 3.
L’articolo informa sulla ricezione di Pil’njak in Russia basandosi su un
resoconto della rivista “Krasnyj bibliotekar’” filtrato dalla censura di Stato.
Anno IV (1928)
n. 5, 29 gennaio:
• Rinaldo Küfferle, Tolstoi narra se stesso, p. 8.
Presentazione del volume Leone Tolstoj, Infanzia, Adolescenza, Goivinezza,
curato da Ettore Lo Gatto, ed. Le Monnier, 1927. L’A. sottolinea l’accurata scelta
dei brani, la ricca introduzione storico-critica, la nitida notizia biografica e l’utile
bibliografia finale.
233
n. 10, 4 marzo:
• Giacomo Prampolini, La nuova gioventù russa, p. 5.
Sintesi del discorso di Berdjaev sulla nuova gioventù russa nelle pagine di
“Europäische Revue”, definita dal filosofo “gioventù antropologica” rispetto alla
vecchia “intelligencija” e alle classi sociali dell’anteguerra.
n. 14, 1 aprile:
• Vice, recensione a: “La moneta falsa”, dramma in tre atti di
Massimo Gorki –Milano, Teatro Olympia con una fotografia di M.
Gorkij, p. 6.
Breve critica al dramma di Čechov rappresentato dalla compagnia di Tat’jana
Pavlova; la rappresentazione viene giudicata nel complesso fiacca nel tono e di
poco spessore; considerate valide, invece, le recitazioni dei singoli personaggi.
• Giacomo Prampolini, Tolstoi, l’artista, p. 8.
Si tratta di parte di uno studio di Stefan Zweig sulla personalità artistica di
Tolstoj, pubblicato su “Literärische Welt” e fino ad allora rimasto inedito. Ciascun
capolavoro dello scrittore russo viene definito dal critco “un’opera d’arte che
raggiunge la sua massima altezza espressiva quando non rivela il suo divenire e fa
sentire unicamente la sua esistenza come nuda realtà”.
n. 17, 22 aprile:
• Alessandro Amfiteatroff, Al di là della Terra. Racconto di A. A.
Illustrazioni di M. Villani-Marchi, p. 5.
N. 18, 29 aprile:
• Alessandro Amfiteatroff, Al di là della Terra. Racconto di A.A.
Illustrazioni di M. Villani-Marchi (continuazione e fine), p. 5.
• Uno slavista sul «Genio Russo». Enrico Damiani, in una civetta
pubblicitaria su “Il Genio Russo” - Breve segnalazione pubblicitaria
dell’ultima pubblicazione di Anton Čechov, La mia vita e altri
racconti. Versione di Giovanni Faccioli, pp. 300, Lire 11.
Breve nota bibliografica pubblicata in passato su “Leonardo” e relativa alla
collana editoriale “Il Genio Russo”.
N. 19, 6 maggio:
• Giacomo Prampolini, “Lirica polacca”, p. 6.
Breve notizia della pubblicazione di un sonetto di Leopold Staff, vincitore del
premio polacco per la poesia, sull’ultimo fascicolo della rivista trimestrale di poesia
di Varsavia “Skamander”, i cui versi vengono qui tradotti in prosa.
234
N. 25, 17 giugno:
• Giacomo Prampolini, Witkiewicz, p. 6.
Biografia del celebre pittore e scrittore polacco Stanisław Ignacy Witkiewicz,
personaggio rivoluzionario nell’arte, esponente dell’antirealismo e della “forma
pura”, autore del recente romanzo (Pożegnanie jesieni, 1927). L’A. lo mette in
parallelo con Wyspiański.
N. 38, 16 settembre, dedicato interamente a Tolstoj:
• Umberto Fracchia, Tributo italiano a Leone Tolstoi 1828-1928, con
un disegno-ritratto di Anselmo Bucci, p. 1.
Sull’opera di Lev Tolstoj in occasione del centenario della nascita. Dopo una
dettagliata descrizione fisica dello scrittore, il critico ne traccia un profilo
psicologico. Fra gli scritti l’A. si sofferma su Vojna i mir e Anna Karenina.
• Emilio Cecchi, L’edizione sovietica, p. 1.
Tra le diverse iniziative sorte in Russia in occasione del centenario di Tolstoj
Cecchi menziona l’edizione completa delle opere a cura del Gosizdat (Edizioni di
Stato), che per l’occasione ha istituito un Comitato di redazione presieduto da
Lunačarskij. Gli scritti sono classificabili in due gruppi: il primo comprende il
corpus di scritti formatosi a partire dal 1880; il secondo riunisce manoscritti ceduti
negli anni ’80 dalla moglie di Tolstoj al Museo Storico di Mosca.
• Emilio Cecchi, Considerazioni attuali, pp. 1-2.
L’arte e il messaggio morale di Tolstoj restano immortalati nelle sue opere a
distanza di anni, con un’attualità che pochi scrittori del passato possono vantare e
con una forza espressiva che supera anche la mancata conoscenza del russo. Al
tempo stesso, però, l’A. ammette che leggere le sue opere senza conoscerne la
lingua originale toglie sempre qualcosa alla comprensione generale del testo.
• Marco Slonim, Tolstoi nell’arte russa, con un immagine della
maschera presa sul letto di morte e ritratto ovale, p. 2.
Su una serie di questioni di natura filosofica ed estetica relative al celebre
scrittore in occasione dall’anniversario della nascita. Come afferma il critico, capita
raramente che una data contingente come un anniversario invece di proporre
vecchie teorie su un personaggio o di suscitare noia e malcontento stimoli il
dibattito culturale, mantenendo vivo l’interesse del pubblico e della critica come nel
caso specifico dello scrittore russo.
• S.a.“amico all’osteria”, Un ragazzo a Iasnaia Poliana, p. 2.
Memorie di un amico di Lev Tolstoj redatte in forma epistolare e indirizzate a un
certo Angioletti, che nell’autunno del 1900 accompagnò due suoi amici russi a
conoscere lo scrittore nella sua residenza di Jasnaja Poljana.
• Olga Resnevic Signorelli, Dai diari inediti di Tolstoj, p. 2.
Raccolta di brevi frammenti tratti dai diari inediti di Tolstoj a partire dal
primo del 1843, dove lo scrittore esprime il dissidio interiore della bruttezza fisica,
235
uno stato d’animo espresso più tardi nelle prime opere, pubblicate a partire dal
1852. Seguono i diari del 1855 e del 1856.
• Alfredo Gargiulo, Leone Tolstoi in mezzo a noi, p. 3.
Tributo a Tolstoj ‘uomo’; l’A. descrive la complessa personalità dell’artista
partendo dall’ansia, più volte confessata dallo scrittore e dovuta all’incapacità di
esprimere adeguatamente il pensiero con le parole. Segue poi una lunga analisi dei
tre ‘dèmoni’ che perseguitavano il suo animo e dai quali non riusciva a liberarsi:
passione per il gioco, sensualità e vanità.
• Sergio Solmi, Naturalità di Tolstoi, p. 3.
In Tolstoj i momenti di crisi e di allontanamento dall’arte sono sempre apparsi
all’A. tappe fondamentali della sua crescita interiore, espressione di una naturalezza
espressiva riconducibile alla prima fase dell attività letteraria.
• G. Titta Rosa, Commento a Ivan Iljic, con fotografia di Tolstoi nei
campi di Jasnaia Poliana, p. 3.
Analisi di alcuni passi della novella di Tolstoj con commento a margine.
• Demetrio Merezkovski, Uomo, bestia, giglio: creatura di Dio. Un
aspetto ideale tolstoiano secondo Merezkovski. Traduzione dal russo
di Alfredo Polledro, p. 4.
Alcuni episodi di vita quotidiana tratti da articoli e diari di Lev Tolstoj, che
Merežkovskij ricorda e sottolinea, considerandole pagine rappresentative di un
particolare, smisurato e quasi religioso rispetto dello scrittore per la natura.
• Rinaldo Küfferle, Postille al Centenario, con disegno di L. Tolstoi
e la figlia Alessandra, p. 4.
L’A. ricorda in breve alcuni aspetti del rapporto di Tolstoj col Cristianesimo,
soprattutto il disagio vissuto dall’artista nel tentativo di condurre un’esistenza
lontano dall’orgoglio, dalla lussuria e dalla pigrizia. La sua vita viene, infine,
paragonata a un oceano cosparso di isole con riferimento ai capolavori Vojna i mir,
Anna Karenina e Voskresenie.
• Due episodi di Guerra e Pace. La fine di un traditore – La morte
del principe Andrej, pp. 7-8.
• Giuseppe Raimondi, La felicità domestica di Tolstoi, con fotografia
di Tolstoi e la figlia Alessandra, p. 7.
Racconto scritto da Tolstoj nel 1858; l’A. ne mette in evidenza il tono
nostalgico col quale lo scrittore mette insieme ricordi di vita familiare dove anche
gli elementi della natura fanno da perfetta cornice.
• Arrigo Cajumi, Libri di lettura, p. 7.
236
Recensione del volume di Charles Salomon, Quatre livres de lectur (Parigi
1928), molto utile, secondo l’A., a far conoscere il celebre scrittore russo in veste di
‘educatore’ e di artista creativo e vitale.
• G. B. Angioletti, Immagine di Tolstoi e di Flaubert, p. 8.
Confronto fra Tolstoj e Flaubert relativamente alla diversa concezione che i
due scrittori avevano dell’arte; secondo Tolstoj più che rappresentare l’arte era
necessario, nella vita, agire e lasciare un’impronta indelebile della propria
esistenza. Flaubert, al contrario, sosteneva che l’arte fosse pura rappresentazione.
N. 39, 23 settembre:
• Giovanni Papini, Polonia, pp. 1-2.
Segnalazione dell’imminente pubblicazione per i tipi della Casa editrice Alpes
dell’antologia “Novellieri Polacchi” compilata da Stella Olglerd, a cui Giovanni
Papini scrisse la prefazione qui pubblicata.
• Mario Casalino, recensione a: Borisav Stankovic, Sangue impuro.
Traduzione dal serbo di Umberto Urbani. – Trieste, Libreria Treves
Zanichelli. Lire 10, p. 7.
Breve segnalazione bibliografica del volume di Stankovič.
• Giacomo Prampolini, «Itinerario verso Tolstoi», in ‘La Stampa
Estera’, p. 8.
Sull’interesse che l’anniversario della nascita di Tolstoj continua a suscitare in
diversi Paesi, invogliando scrittori e critici a una ‘sana competizione’ sul tema. Fra
gli altri l’A. ricorda il “propos” di Alain su “Nuovelle Revue Frainçaise”, che
suggerisce un percorso di lettura attraverso i tre romanzi più significativi: Vojna i
mir, Anna Karenina e Voskresenie.
N. 46, 11 novembre:
• Rinaldo Küfferle, recensione a: Ettore Lo Gatto, Storia della
Letteratura Russa. Vol. I: Dalle origini a tutto il secolo XVI. Vol. II:
Le origini della letteratura moderna. – Roma, Anonima Romana
Editoriale, 1928. – Ogni volume L. 20, p. 9.
Presentazione del volume nella sua doppia forma di saggio letterario storicocritico e libro di lettura facilmente accessibile ai non specialisti con le sue note
introduttive. L’A. ne descrive il contenuto, particolarmente interessante, che va
dall’epos popolare alle indicazioni bibliografiche sui singoli autori.
Anno V (1929)
N. 3, 20 gennaio:
237
• Giacomo Prampolini, recensione a: Massimo Gorki, Racconti del
’22-’24. –Milano. Fratelli Treves Editori. L. 12.
I Rasskazy, a eccezione de L’eremita, più vicino alla tradizionale maniera di
Gor’kij, rappresentano una svolta nello stile e nella tecnica narrativa. Il critico ne
loda la traduzione dal russo eseguita da Erme Cadei per la fedeltà al testo originale
e la perizia nello stile.
N. 10, 10 marzo:
• Giacomo Prampolini, Intorno alla letteratura russa in ‘La Stampa
Estera’, p. 8.
I brani qui riproposti sono tratti da un articolo su “La Revista” di Barcellona,
che nel suo ultimo “quaderno” pubblica un racconto di Tolstoj, preceduto da alcune
considerazioni di Alfred Gallard sulla letteratura russa e sul contributo di ogni
scrittore alla definizione del carattere e dell’anima del popolo russo.
N. 12, 24 marzo:
• Cesare Meano, A Torino. I Pitoeff. in ‘Cronache delle scene’, p. 6,
con ritratto caricaturale di Ludmila Pitoeff.
In occasione del ritorno a Torino della compagnia teatrale di Giorgio e Ludmila
Pitoëff l’A. traccia un profilo della loro arte teatrale, definita ‘primitiva’, e ne
evidenzia aspetti positivi, l’assoluta fedeltà al testo originale e la semplicità della
messinscena, e negativi, come alcuni allestimenti considerati “inopportuni”.
• Dedalus, La moglie di Tolstoi (v. “Rivista d’Italia”, ultimo fascicolo
del 15 dicembre 1928) in ‘Rassegna della Stampa’, p. 8.
Brani scelti da uno scritto di Maksim Gor’kij, pubblicato nell’ultimo fascicolo
di “Rivista d’Italia” del 15 dicembre 1928 nella versione di Erme Cadei, dedicato
alla moglie di Lev Tolstoj Sofija Andreevna.
N. 15, 14 aprile (“L’Italia letteraria”):
• Umberto Fracchia, Ricordo di Kuprin, p. 1.
Memorie sulla personalità di Kuprin e sull’arte narrativa evidente nei racconti
Jama, Poedinok, Granatovyj braslet. L’A. ricorda l’incontro con lo scrittore
avvenuto l’anno precedente nella sua casa di Parigi dopo l’espatrio e, soprattutto, la
promessa fatta da Kuprin di far pubblicare in traduzione italiana Štabs-kapitan
Rybnikov.
• Giacomo Prampolini, traduzione: Il Capitano Rybnikov. Racconto
di Alessandro Kuprin -I parte, con una vignetta/disegno, p. 3.
N. 16, 21 aprile:
• Giacomo Prampolini, traduzione: Il Capitano Rybnikov –II parte.
Traduzione dal russo di Giacomo Prampolini, pp. 3-4.
238
N. 19, 12 maggio:
• Leone Ginzburg, traduzione: Leone Tolstoi, La morte di Nicola
Levin – Una nuova traduzione integrale di “Anna Karenina” – Da
“Anna Karenina”, parte V, cap. XX. Prima versione italiana
conforme al testo originale di, d’imminente pubblicazione da parte
della Casa Ed. «Slavia» di Torino nella collezione “Il Genio Russo”,
p. 4.
N. 25, 23 giugno:
• Raissa Olkienizkaja Naldi, traduzione: Ivan Turgheniev, Il mio
vicino Radilow. Dalla prima traduzione italiana delle “Memorie di un
cacciatore” di Turghenjev, che la Casa Ed. Slavia di Torino
pubblicherà prossimamente. Voll. 31-32 della collezione «IL Genio
Russo», p. 2.
N. 26, 30 giugno:
• Mirror, Curzio Malaparte di ritorno dalla Russia: La Nuova
letteratura dei Sovieti, con disegno/ritratto di Pietro Lazzari, p. 1.
Rassegna critica su scrittori e letterati in Russia di Curzio Malaparte, l’unico
direttore di un giornale italiano, la Stampa, che ha sentito la necessità di recarsi in
Russia per indagare sulla realtà politica del paese. Malaparte affronta una serie di
tematiche: il genere letterario più apprezzato dal pubblico di lettori, novellistica e
attualità, il rapporto tra bolscevismo e letteratura, le Edizioni di Stato, la condizione
degli scrittori e i loro rapporti con la politica, e la lista dei libri proibiti dalla
censura, raggruppati in tre categorie controrivoluzionari, pornografici e religiosi.
N. 28, 14 luglio:
• Enrico Falqui, Il dramma della libertà in Russia, p. 5.
L’A. riferisce l’opinione espressa da Curzio Malaparte in un articolo sulla
Stampa intorno al concetto di ‘libertà collettiva’ diffuso in Russia, un’idea che,
secondo Malaparte, senza la coscienza individuale rischia di trasformarsi in una
‘schiavitù’ liberamente accettata dal popolo.
N. 29, 21 luglio:
• Umberto Barbaro, Rileggendo Anna Karenina, p. 2.
Rilettura del romanzo e della personalità artistica di Lev Tolstoj. Partendo dallo
scontro tra ‘ideale’ e ‘reale’, ricorrente nei suoi scritti, l’A. sviluppa il concetto
tolstojano di ‘amore individuale’ e ‘amore universale’ sinonimi di ‘libertà’, facendo
riferimento, in particolare, al romanzo Anna Karenina.
• Enrico Falqui, Destino della nobiltà russa, in ‘ Rassegna della
Stampa’, p. 7.
Alcune considerazioni di Curzio Malaparte sulla condizione della nobiltà nella
“Russia dei Soviet”, pubblicate sulla Stampa, alla luce della lotta di classe
239
all’interno del regime bolscevico.
N. 31, 4 agosto:
• Enrico Falqui, La borghesia russa, in ‘ Rassegna della Stampa’, p.
5.
Sulla condizione della borghesia in Russia. L’A. ripropone l’opinione espressa
da Curzio Malaparte sulla Stampa secondo cui la borghesia in Russia sarebbe stata
privata della libertà di espressione al pari della nobiltà.
N. 35, 1 settembre:
• Marco Slonim, Nel XXV anniversario della morte di Cecoff.
L’interprete della vita borghese, con un ritratto di A.P. Cécoff del
1899 e una fotografia di Cécoff e sua moglie del 1902, p. 4.
L’A. ripercorre la vicenda biografica di Anton Čechov e sottolinea come, dopo
un ventennio di fortuna critica delle sue opere sui palcoscenici d’Europa e
d’America, si assista in Russia, in occasione del XXV anniversario della sua morte,
a un ritorno d’interesse di critici e letterati con pubblicazioni varie e rassegne
bibliografiche a lui dedicate.
• Anton Giulio Bragaglia, Serge de Diaghileff con un ritratto di
Savina, allieva di Diaghileff, p. 5.
Sulla biografia di Sergej Djagilev, rinnovatore del balletto russo e straordinario
interprete di un nuovo stile coreografico. Dopo una prima parte dedicata alla
poliedricità dell’arte di D., l’A. sottolinea l’influenza che su di lui ebbe il grande
maestro Enrico Cecchetti, per diversi anni direttore dell’Accademia Imperiale di
Ballo dopo un’intera generazione rappresentata dalla scuola francese di M. Petipà.
• Umberto Barbaro, M. Atanassievic Bulgacof in ‘Scrittori sovietici’
con una fotografia, p. 8.
Riassunto della trama fantastica del racconto di Michail Bulgakov Rokovye
jajca di cui l’A. sottolinea la satira politica e sociale. Al contributo segue la
biografia dello scrittore.
N. 39, 29 settembre:
• Alberto Spaini, A Capri con Jakovlieff, con autoritratto, p. 4.
Sulla grande esposizione di pitture capresi presentata a Parigi dal pittore russo
Vladimir Jakovlev nel 1929.
N. 43, 27 ottobre:
• Wolfango Giusti, Meridiano di Praga, p. 6.
breve rassegna sulla condizione del teatro di Praga, sull’ultimo libro di Karl
Čapek e sul Congresso slavistico.
240
N. 44, 3 novembre:
• Umberto Barbaro, Due Russi e un Cèco in ‘Letterature straniere’
con 3 ritratti di Borìs Pilniak, Elia Erenburg e Carlo Ciapek, p. 2.
Sul profilo artistico degli scrittori Karl Čapek, di cui si citano R.U.R., Vĕc
Makropulos, i frammenti del romanzo Krakatik e i Trapné povidky tradotti da
Wolfango Giusti per “Il Genio Slavo” nel 1929, Boris Pil’njak, di cui Corrado
Perris ha tradotto Oltre le foreste per i tipi di “Il Genio Slavo” nel 1929, e Il’ja
Erenburg, il cui romanzo Ljubov’ Žanny Nej è stato tradotto e curato da Lia
Neanova per i tipi “Corbaccio”, collezione “Volga”;
N. 45, 10 novembre:
• Marco Slonim, La nuova letteratura degli emigrati russi con 3
fotografie di B. Zaitzeff, M. Zveetajeva, A. Remizov, p. 6.
Bilancio dell’attività letteraria degli scrittori russi emigrati con alcune cifre
indicative relative al periodo che va dal 1918 al 1924 (92 giornali quotidiani, 326
riviste settimanali o mensili e circa 4200 libri pubblicati dalle case editrici russe di
Parigi, Berlino, Praga, Riga e Belgrado) e uno sguardo alla produzione letteraria
contemporanea di Bunin, Bal’mont, Kuprin, Zajcev, Aldanov, Muratov,
Merežkovskij, Chodasevič, Remizov, Cvetaeva.
241
“La Nuova Italia: rassegna critica mensile della cultura
italiana e straniera” (Luigi Russo, 1930-1943)
Anno I (1930)
20 gennaio, n. 1:
‘Bollettino bibliografico’:
• Chechov A., La camera n. 6. Trad. di G. Faccioli. Torino, Slavia,
1929, L. 10 (Genio russo), p. 41.
20 marzo, n. 3:
• L. Savoj, recensione a: V. O. Ključevskij, Boris Godounov, Tsar de
Russie (1598-1603 ), Payot, Paris, pp. 270, Fg. 25, p. 121.
L’A. presenta il volume dedicato al profilo storico e psicologico di Boris Godunov,
dandone un’immagine un po’ diversa da quella tramandata dalla tradizione, e sfatando
le vecchie convinzioni di Solov’ëv o Ključevskij che lo descrivevano come astuto
impostore, uomo violento e sanguinario. Introduce la monografia un saggio storico
sulla situazione politica interna della Russia dell’epoca.
Bollettino bibliografico:
• Dostoievskij F., Il sogno dello zio. Traduzione di A. Polledro. Torino,
Slavia, 1930, L. 10, p. 129.
• Gogol N. V., Taras Bulba. Romanzo, Traduzioone di B. Jakovenko.
Milano, Morreale, 1930, L. 8, p. 129.
• Turgheniev I., Il re Lear delle steppe. Racconti. Trad. di M. Karklina.
Torino, Slavia, 1930, p. 129.
20 aprile, n. 4:
‘Bollettino bibliografico’:
• Kiedrzynski S., Non bisogna meravogliarsi di niente. Trad. di L.
Kociemski. Perugia-Venezia, La Nuova Italia, 1930, pp. 128, p. 173.
• Romanov, P.: Amore, Novelle. Torino, Slavia, 1930, L. 11, p. 173.
• Veresaiev A., Nel vicolo cieco. Romanzo. Trad. di P. Broggi-Picardi.
Milano, Treves, 1930, L. 10.
• Zaichev B., Ricamo d’oro. Trad., introd. e note di Rinaldo Kufferle.
Milano, Casa ed. Corbaccio, 1930, pp. 450, L. 14.
20 maggio, n. 5:
‘Bollettino bibliografico’:
• Nurigian G.: Grammatica bulgara ad uso degli italiani, Milano,
242
Hoepli, 1930, pp. XII-264, L. 20, p. 216.
• Isvolski E. e A. Kascina: Giovinezza rossa. Romanzo. Firenze,
Bemporad, 1930, L. 8, p. 217.
• Trotzki L.: La Mia vita. Tentativo di autobiografia. Milano,
Mondadori, 1930, L. 40, p. 218.
20 giugno, n. 6:
• Leone Ginzburg, recensione a: Pantelejmon Romànov, Amore. Prima
versione dal russo con prefazione e note di Margherita Silvestri
Lapenna. Torino, «Slavia», 1930, pp. 330, L. 11, pp. 253-254.
L’A. presenta il volume, che contiene dieci racconti, cinque dei quali sono costruiti
intorno al tema del libero amore, inevitabile e naturale ma nello stesso tempo
bestialmente ripugnante. I racconti sono: Vesna, Ljubov’, Pravo na žizn’, ili problema
bespartijnosti, Čërnye bliny, U paroma. Particolarmente apprezzata, infine, la
traduzione eseguita da Margherita Silvestri-Lapenna.
‘Bollettino bibliografico’:
• Pappacena E., Gogol (1809-1852). Milano, ed. Corbaccio, 1930, pp.
720, L. 16, p. 260.
• Ossendowski F.A.: Il Capitano bianco. Trad. di L. Kociemski, Milano,
Ediz. Corbaccio, 1930, pp. 416, L. 12, p. 261.
• Zaitsev B.: La vendicatrice. Romanzo, Milano, Bietti, 1930, L. 5, p.
261.
20 luglio, n. 7:
‘Bollettino bibliografico’:
• Remizov A.: Sorelle in Cristo. Romanzo. Trad. di R. Poggioli. Torino,
Slavia, 1930, L. 10, p. 305.
• Krzyzanowski J.: Polish romantic Literature. London, Allen, 1930, pp.
317, p. 304.
20 agosto:
‘Bollettino bibliografico’:
• Dostoievski F.: Lo spirito sotterraneo. Milano, Bietti, 1930, pp. 240,
L. 4, p. 349.
• Ehrenburg E.: Nel vicolo Protocny. Milano, Soc. ed. Corbaccio, 1930,
pp. 336, L. 12, p. 349.
• Tzenoff G.: Die Abstammung der Bulgaren un die Urheimat der
Slaven. Berlin, De Gruyter, 1930, pp. XI-358, p. 350.
20 settembre, n. 9:
• LETTERATURE SLAVE: E. Damiani, recensione a: Romano Pollak,
Pagine di cultura e letteratura polacca. Roma, I.p.E.O., 1930 (Piccola
Biblioteca Slava) a cura di E. Lo Gatto, vol. XI, Un vol. di pp. 215, pp.
382-383.
Il volume raccoglie articoli e saggi sulla cultura letteraria polacca, tratti da
243
conferenze e lezioni accademiche tenute dal prof. Pollak nel corso dei cinque anni di
insegnamento a Roma.
• Leone Ginzburg, recensione a: E. Damiani, Ivan Turghénjev. I.p.E.O.,
Roma, Slavia, Torino, 1930, pp. 158, p. 383.
Nella sua presentazione del volume su Turgenev, l’A. riconosce l’entusiasmo con
cui Damiani presenta la biografia dello scrittore russo sotto il profilo politico-sociale
ma ne riconosce i limiti nell’esposizione dei suoi meriti artistici.
• Leone Ginzburg, recensione a: E. Isvolsky. A. Kascina, Giovinezza
rossa, tradotto dal russo da Raissa Olkienizkaia Naldi. Firenze, R.
Bemporad e Figlio in “I Romanzi della vita moderna”, 1930 di pp. 233,
pp. 383-384.
L’A. presenta un volume che, oltre ad essere un romanzo, è una disquisizione
sull’”ambiente sociale” e sulla “psicologia collettiva”, una viva testimoninza di vita
della nuova gioventù russa, scritta da Elena Izvolskaja e Anna Kašina per il lettore
occidentale. Un elogio, infine, al ricco apparato documentario di immagini.
‘Bollettino bibliografico’:
• Bulgakov M.: La guardia bianca. Trad. di E. Lo Gatto. Roma, Are,
1930, pp. XIV-325, L. 12, p. 393.
• Naidienov S.: I figli di Vaniuscin. Dramma in 4 atti. Trad. di L.
Churgin. Torino, Formica, 1930, pp. 220, L. 10, p. 393.
• Neviérov A.: Taschkent, paese di cuccagna. Trad. di M. Giuliàncolo.
Ferrara, Ediz. Schifanoia, 1930, Lire 5,50, pp. 256.
• Jachimiecki Z.: Frédéric Chopin et son oeuvre, Paris, Delagrave,
1930, pp. 423, p. 394.
• Kròupskaia N.: Souvenirs sur Lenine. Paris, Impr. Centrale, 1930, pp.
208, Fr. 9, p. 394.
20 ottobre, n. 10 :
‘Bollettino bibliografico’ :
• Dostoiewsky F. : Povera Gente. Trad. di A. Potkin e F. Vitaliano.
Milano, Sonzogno, 1930, pp. 252, L. 4, p. 437.
• Turghenjev: Alla vigilia. Romanzo. Traduz. di S. Polledro. Torino,
Slavia, 1930, L. 10, p. 437.
• Waliszenski C.: Ivan il terribile. Trad. di M. I. Ussi. Milano, Ediz.
Corbaccio, 1930, pp. 416, L. 22, p. 438.
20 novembre, n. 11:
‘Bollettino bibliografico’:
• Tourguénev J.: Manuscrits parisiens. Notices et extraits par A. Mazon.
Paris, Champion, 1930, pp. 203, p. 479.
• Damiani E. : Ivan Turgheniev. Studio critico biografico. Torino,
Slavia, 1930, pp. 158, L. 6, p. 480.
244
• Andreiew L.: I sette impiccati. Trad. di L. Tacconi, Bologna, Cappelli,
1930, pp. 194, L. 4,95, p. 481.
• Smurlo E.: Storia della Russia dalle origini alla rivoluzione, Roma,
Are, 1930, pp. 192, L. 50, p. 482.
• Vassiljev A.T.: La polizia segreta degli Zar. Milano, Mondadori,
1930, pp. X-179, L. 15, p. 482.
20 dicembre, n. 12:
• Leone Ginzburg, recensione a: S. Tretjakòv, Ryci, Kitàj! (Ruggisci,
Cina!), in Letterature straniere’, Moskva, Gosudarstvennoje Izdàtelstvo,
1930, pp. 96, pp. 525-526.
L’A. presenta il dramma di Tredjakov definendolo il “simbolo del teatro sovietico
di propaganda”.
• Leone Ginzburg, recensione a: Michaìl Bulgàkov, La guardia bianca.
Romanzo, traduzione e introduzione di E. Lo Gatto, in ‘Letterature
straniere’,Anonima Romana Editoriale, 1930, pp- 525-526.
Recensione a I giorni della famiglia Turbìn, fortunata riduzione teatrale di un
romanzo che Lo Gatto ha tradotto col titolo diffuso fra gli emigrati russi La guardia
bianca e che viene qui definita l’opera più significativa del teatro “neo-borghese”
sovietico.
‘Bollettino bibliografico’:
• Zerowski S.: Ceneri. Torino, Slavia, 1930, L. 25, p. 533.
Anno II (1931)
20 gennaio, n. 1:
• Leone Ginzburg, Uomini del Novecento. Nota su Konstantin Fèdin, p.
13-15.
Nella prima parte l’A. descrive l’arte di Fedin. Nella seconda, si descrive la trama
dei due romanzi, Goroda i gody e Brat’ja, e di alcuni racconti, Anna Timofeevna,
Transvaal, Staryj. Chiude il contributo un riferimento in nota alla recensione fatta da
Aldo Capasso su “Solaria” (novembre, 1930) alla traduzione italiana Fratelli, edizione
Slavia, 1929, a cura di Valentina Dolghin Badoglio e con prefazione di Alfredo
Polledro, in cui Capasso avrebbe giudicato superficialmente lo scrittore russo.
‘Bollettino bibliografico’:
• Lyeskov N.: Tempi antichi nel villaggio di Plodomasovo. Trad.
Silvestri-Lapenna. Lanciano, Carabba, 1930, pp. VII-177, L. 5, p. 41, p.
41.
• Merezkovski D.: Napoleone. Trad. di R. Olkienizkaja Naldi. Firenze,
Bemporad, 1930, pp. 500, L. 35, p. 42.
245
20 febbraio, n. 2:
‘Bollettino bibliografico’:
• Gorki M.: Quarant’anni. Romanzo. Milano, Mondadori, 1931, pp.
268, L. 25, p. 83.
• Krasnoff P. N.: Tutto passa. Romanzo storico. Firenze, Salani, 1931,
pp. 523, L. 9, p. 83.
• Nagrodscaia I. A.: Tatiana Alexandrovna. Milano, Casa ed. La Propra,
1931, pp. 307, L. 9, p. 83.
20 marzo, n. 3:
• Leone Ginzburg, recensione a: Jevghénij Lann, Literatùrnaja
mistifikàtsija, Moskvà, Gosudàrtsvennoje Izdàtelstvo, 1930, pp. 232,
rubli 1,78, pp. 113-114.
L’A. presenta il volume di Lann che, denunciando l’assenza di una trattazione
organica dell’argomento sia in Russia che nel resto d’Europa, tenta di sistematizzare e
selezionare i casi più evidenti di ‘mistificazione letteraria’, inquadrandoli storicamente
e seguendo il metodo critico marxistico dell’ “analisi sociologica”.
• Aldo Capasso, III. – Critica sui testi e critica sulle traduzioni, pp. 119120.
Replica polemica dell’A. alla considerazione espressa da Ginzburg nella ‘Nuova
Italia” di gennaio 1931 sul fatto che, in una recensione a Fedin fatta su “Solaria”,
Capasso avrebbe evidenziato nel romanzo Brat’ja alcuni difetti strutturali dovuti a una
mancanza di coesione interna, un giudizio considerato da Ginzburg affrettato e
superficiale.
‘Bollettino bibliografico’:
• Cecof: Tre anni; Il duello; Sul mare; La corista; Lo studente. Trad. di
L. Kociemski. Milano, Mandodori, 1931, L. 20, p. 125.
• Dostoievski F.: Delitto e Castigo. Milano, Sonzogno, 1931, L. 12, p.
125.
• Gorki M.: L’adolescente. Milano, Sonzogno, 1931, pp. 256, L. 8, p.
125.
20 aprile, n. 4:
‘Bollettino bibliografico’:
• Cechov A.: Il monaco nero. Racconti. Trad. di G. Faccioli. Torino,
Slavia, 1931, pp. 282, L. 10, p. 166.
• Dostoiewskij F.: Il sogno dello zio. Milano, Bietti, 1931, pp. 256, L. 5,
p. 166.
• Dostoiewskij F.: Memorie dalla casa dei morti. Trad. di N.
Romanowsky. Lanciano, Carabba, 1931, L. 15, p. 166.
• Gogol N.: Taras Bulba. Romanzo. Milano, Sonzogno, 1931, pp. 208,
L. 4, p. 167.
246
• Gorki M.: Confessione. Romanzo. Trad. di M. Salviati. Milano,
Monanni, 1931, pp. 321, p. 167.
• Seifullina L.: Il burrone delle betulle. Racconti. Trad. di A. Rusca.
Tprino, Slavia, 1931, pp. 288, L. 10, p. 167.
• Tolstoi L.: Padre Sergio. Racconti. Trad. d. Duchessa di Andria.
Torino, Slavia, 1931, pp. 284, L. 10, p. 167.
• Turgheniev I.: Nido di nobili. Romanzo. Trad. di M.Karklina. Torino,
Slavia, 1931, pp. 270, L. 10, p. 167.
• Bulgakof V.: Leone Tolstoi nell’ultimo nno di sua vita. Trad. di V.
Dolghin. Foligno, Campitelli, 1931, pp. 523, L. 20, p. 167.
• Mirsky D.: Russia. A Social history. London, Cresset Press, 1931, pp.
312, p. 168.
• Narischkin Kurakin E.: Sotto tre zar. Firenze, Bemporad, 1931, L. 15,
p. 168.
20 maggio, n. 5:
‘Bolletino bliografico’:
• Scipcovensky M.: La Bulgaria. Milano, Alpes, 1931, pp. 400, L. 35,
p. 210.
20 giugno, n. 6:
‘Bollettino bibligrafico’:
• Felyne O.: Cuori inutili. Novelle. Milano, Morreale, 1931, pp. 250, L.
10, p. 251.
• Bulgakof M. A.: Le uova fatali. Romanzo. Trad. di U. Barbaro e U.
Liubof. Lanciano, Carabba, 1931, pp. 155, L. 6, p. 251.
• Garin N. G., L’infanzia di Tioma. Trad. di R. Pirola Pomaranta.
Firenze, Vallecchi, 1931, pp. 245, L. 3, p. 251.
• Kuprin .: Il braccialetto di granati. Milano, Bietti, 1931, pp. 132, L. 4,
p. 251.
• Horty: L’ultima Zarina. Bologna, Cappelli, 1931, pp.180, L. 5, p. 252.
• Tzankoff Z.: La vita segreta della Zarina tragica. Milano, L’editoriale
mod., 1931, pp. 309, L. 15, p. 252.
20 luglio, n. 7:
• Leone Ginzburg, Lombroso, Freud e la critica, p. 287.
L’A. riporta alcuni giudizi sull’epilessia di Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstoj. Il
primo è quello dato da Sigmund Freud nella sua prefazione alla versione tedesca di
abbozzi inediti di Brat’ja Karamazovy, dove Freud sostiene che quella di Dostoevskij
doveva essere un istero-epilessia; il secondo giudizio è quello del prof. A. M.
Evlachov, che, sulla base di alcuni studi di Cesare Lombroso, intende dimostrare che
Tolstoj era un epilettico ‘atipico’.
247
‘Bollettino bibliografico’:
• Lo Gatto E.: Note di storia e di letteratura russa. Roma, Ist. Europa
Orientale, 1931, pp. 99, L. 5, p. 292.
• Lo Gatto E.: Storia della letteratura russa. Vol. IV. Roma, ARE,
1931, pp. 276, L. 20, p. 292.
• Lo Gatto E.: Studi di letterature slave. Vol. 3°. Roma, Are, 1931, pp.
228, L. 10, p. 292.
• Czapska M.: La vie de Mickiewicz. Paris, Plon, 1931, pp. 320. p. 294.
• Levinson A. : La vie pathétique de Dostoievski. Paris, Plon, 1931, pp.
270, p. 294.
• Rollin H. : La Révolution russe. Vol. I-II. Paris, Delagrave, 1931, 2
voll., p. 294.
20 agosto, n. 8:
• L. Savoj, recensione a: A. Cechov: La camera N°6. Racconto.
Versione integrale con note di G. Faccioli. Slavia, Torino, pp. 280. L.
10, pp. 318-319.
L’A descrive la psicologia dei personaggi, evidenziandone pessimismo e
scetticismo; ci si sofferma sul protagonista, Andrej Efimič, e su alcune divagazioni
teoriche di Čechov, che provocherebbero la rottura dell’unità narrativa.
• L. Savoi, recensione a: L. Tolstoj: Due usseri. Racconti. Versione
integrale con note della Duchessa di Andria. Slavia, Torino, pp. 331, L.
11, pp. 319-320.
Nel suo commento al volume l’A. approfondisce una peculiarità dell’arte
narrativa di Tolstoj, ossia la straordinaria capacità, già evidente in Kazaki, di unire
poesia e realtà autobiografica. Particolarmente apprezzata la fedele traduzione firmata
dalla Duchessa d’Andria.
20 settembre, n. 9:
‘Bollettino bibliografico’:
• Amfiteatrov A. e R. Küfferle: Intorno al Samovar. Milano, Bompiani,
1931, pp. 280, L. 10, p. 377.
• Chapek-Chod K. M.: La turbina. Trad. di J. Torraca Vesela. Torino,
Slavia, 1931, L. 20, p. 377.
• Gorki M.: Nella steppa. Milano, Bietti, 1931, pp. 256, L. 3, 50, p. 377.
• Dostoievskaia A. G.: Dostoïewskj. Trad. da russe par Beucler. Paris,
Gallimard, 1931, pp. 467, p. 378.
20 ottobre, n. 10:
‘Bollettino bibliografico’:
• Tolstoi L.: Guerra e Pace. Romanzo. Milano, Bietti, 1931, 3 voll., L.
12,p. 419.
• Tolstoi L.: Hagi Murat, Milano, Bietti, 1931, pp. 368, L. 3, 50, p. 419.
248
20 dicembre, n. 12:
• E. Damiani, recensione a: N. I. Kòlokov: Miele e sangue. Traduzione
di Olga Resnevic. Milano, Mondadori, 1931. Un vol. di p. 297, L. 10, p.
486.
Breve presentazione del volume di cui l’A. segnala l’ottima versione
dall’originale firmata da Olga Resnevič Signorelli.
‘Bollettino bibliografico’:
Cecof: Tre anni; Il duello; Sul mare; La corista; Lo studente. Trad. di
L. Kociemski. Milano, Mondadori, 1931, L. 20, p. 125.
• Dostoievski F.: Delitto e Castigo. Milano, Snzogno, 1931, L. 12, p.
125.
• Bienstock Y.W.: Rasputin. Trad. di G. Darsume. Milano, Treves,
1931, pp. 288, L. 10, p. 126.
• Kocemski L.: La Polonia e la difesa della civiltà occidentale. Roma,
Formiggini, 1931, pp. 42, L. 5, p. 126.
• Krupskaia N. K.: Lenin. Paris, Ediciones Europa-America, 1931, pp.
286, Ps. 5, p. 126.
Anno III (1932)
20 gennaio, n. 1:
• Arturo Cronia, recensione a: Milos Weingart, Introduzione
bibliografica allo studio della slavistica, traduzione dal ceco di W.
Giusti, Udine-Tolmezzo, 1929, “Biblioteca italiana e straniera” diretta
da R. Chiurlo, pp. 32-34.
Si tratta di una lunga recensione al volume dedicato alla slavistica. Degna di nota
è l’osservazione dell’A. sui propositi della disciplina, che, se in teoria può definirsi una
“scienza storico-comparativa delle lingue e letterarie slave”, studiate dal punto di vista
dei rapporti reciproci, nella pratica si tratta di un complesso di scienze relative a singoli
aspetti della civiltà slava; di conseguenza, sostiene lo slavista, amplificarne il concetto
condurrebbe al vecchio e romantico panslavismo.
‘Bollettino bibliografico’:
• Cechov A.: La casa col mezzanino. Trad. di G. Fagioli. Torino,
Slavia, 1931, pp. 306, L. 10, p. 41.
• Dostoievski F.: I demoni. Vol. I, II. Milano, Bietti, 1931, pp. 720, L. 7,
p. 41.
• Evreinof N. Il teatro della guerra eterna. Dramma, Firenze, Nemi,
1931, pp. 140, L. 3, p. 41.
• Puskin A.: La donna di picche. Racconti. Torino, Slavia, 1932, pp.
300,L. 10, p. 41.
• Tolstoi L.: Come perisce l’amore. Trad. della Duchessa di Andria.
Torino, Slavia, 1931, pp. 300, L. 10, p. 41.
249
20 febbraio, n. 2:
‘ Bollettino bibliografico’:
• Arzybascev M.: I selvaggi. Firenze, Bemporad, 1932, pp. 113, L. 3,75,
p. 83.
• Gelicovscaia V.P.: Com’ero da bimba. Trad. di M. Chiara. Lanciano,
Carabba, 1932, pp. 400, L. 12, p. 83.
• Lidin V.: Apostata. Romanzo. Traduzione di R. Romanowsky. Milano,
Corticelli, 1932, pp. 315, L. 10, p. 83.
• Odoievtzev I: Le ali nere. Trad. di E. Vocalupolos. Firenze,
Bemporad, 1932, pp. 323, L. 8,50, p. 83.
• Pavolini: Antologia della poesia contemporanea polacca. Lanciano,
Carabba, 1932, pp. 236, L. 6, p. 83.
20 luglio, n. 7:
• Leone Savoj, recensione a: K. M. Ciapek-Chod, La Turbina, in
‘Letterature straniere’. Traduzione di J. Torraca Vesela. Slavia ed.
Torino, 1931, 2 voll., L. 20, pp. 280-281.
Breve presentazione del romanzo con una lode particolare alla traduzione in
italiano firmata dalla Vesela e considerata fedele.
• S.a. recensione a: Fiodor Dostojewskij, Umiliati e offesi, Romanzo.
Versione integrale e diretta dal russo di Giuseppe Donnini. Firenze,
Biblioteca Vallecchi, volumi 2, 1931, L. 2, p. 281.
Il recensore loda qui la capacità di Donnini di rendere la spigliatezza del dialogo di
cui è permeato il testo e apprezza la scelta lessicale, tutta toscana, nella traduzione in
italiano;
• Enrico Damiani, recensione a: Maria Bersano Begey, Storia del
martire di Mosca di Kazimiera Illakowicz. Torino, Società Editrice
Internazionale, 1931, pp. 281-282.
L’A. evidenzia la capacità della giovane polonista, nel suo primo lavoro pubblicato
in Italia, di rendere l’arte e il temperamento della “Illakowiczówna”, rappresentativa
della moderna poesia polacca, che nel poemetto sul “martire di Mosca” vuole esaltare
la nobile figura del sacerdote Budkiewicz, caduto in Russia vittima dell’odio
bolscevico in nome della fede e della Patria.
• Enrico Damiani, recensione a: Vsjévolod Gàrscin, Il fiore rosso.
Racconti. Prima traduzione integrale dal russo di Silvio Polledro. Con
prefazione di Leone Ginzburg. Torino, “Slavia”, 1932 (Coll. “Il Genio
Slavo”), pp. 303, pp. 282-283.
L’A. presenta l’opera di Garšin inserendola nella scuola realistica di Turgenev,
Tolstoj e Dostojevskij e descrivendo la parziale scelta di scritti operata da Alfredo
Polledro per le sue traduzioni.
20 agosto, n. 8:
250
Bollettino bibliografico:
• Gogol N.: Tarass Bul’ba. Trad. di N. Festa. Milano, Mondadori, 1932,
pp. 400, L. 20, p. 325.
20 settembre, n. 9:
• L. Savoj, recensione a: A. Cronia, Petr Bezruč, I. p. E. O. , Roma,
1932, pp. 122, L. 5, p. 358.
Nella sua presentazione del volume l’A. descrive la personalità complessa e
problematica di Petr Bezruč (pseudonimo di Vladimir Vašek), definito il “bardo
moravo” per le sue continue invettive contro gli oppressori e gli oppressi del proprio
paese, mettendo in evidenza che è più facile definire la sua arte considerando il
pensiero anziché l’ispirazione poetica, spesso alimentata da questioni sociali e
politiche. Il saggio di Cronia viene considerato il più completo mai realizzato su
Bezruč;
• E. Damiani, recensione a: Zayer Giulio, Jan Maria Plojhar. Romanzo.
Versione di Umberto Urbani, autorizzata dall’Accademia di Praga.
Prefazione di Anna Lauermannovà-Mikschovà. Trieste, Edizioni
C.E.L.V., 1932, pp. 358-359.
L’A. presenta il romanzo di Zayer, genere romantico della letteratura ceca, frutto
dell’arte narrativa di uno dei più autorevoli rappresentanti della corrente
“cosmopolitica”. Creatasi intorno alla celebre rivista “Lumìr”, fondata da Neruda nel
1873, essa si distingueva dalle due correnti letterarie allora dominanti, quella
panslavistica e quella storico-patriottica, nella ricerca di nuove fonti d’ispirazione al di
fuori del mondo slavo, nel caso specifico di Zayer, in Italia.
• E. Damiani, recensione a: Wladimir Lidin, Apostata. Traduzione
autorizzata dal russo di Nina Romanowsky. Milano, Corticelli, 1932, pp.
315, pp. 359-360.
Breve presentazione di Vladimir Lidin, rappresentante dei poputčiki o ‘compagni di
strada’.
‘Bollettino bibliografico’:
• Babel’ J.: L’armata a cavallo. Trad. di Renato Poggioli. Torino,
Frassinelli, 1932, pp. XXVIII-241, L. 15, p. 365.
• Turgheniev I.: Lo spadaccino. Racconti inediti. Trad. di M. Karklina.
Torino, Slavia, 1932, L. 10, p. 365.
20 ottobre, n. 10:
• L. Savoj, recensione a: I. Babel, L’Armata a cavallo, in ‘Letterature
straniere’. Traduzione dal russo e introduzione di R. Poggioli,
Frassinelli, Torino, pp. 399-400.
L’A., oltre a definire la traduzione la migliore fra quelle eseguite in passato da
Poggioli, sottolinea l’abilità dello slavista nel rendere il contrasto tra espressionismo e
251
miniaturismo, aspetto tipico dei racconti di Babel’.
20 novembre, n. 11:
• E. Damiani, recensione a: Ivan Cankar, Il Re di Betainova. Dramma in
tre atti. Traduzione integrale dallo sloveno e studio critico di Bartolomeo
Calvi. Torino, Società Editrice Internazionale, 1929. Un vol. in 16, pp.
119, L. 8, p. 438.
L’A. sottolinea la competenza di Calvi nel presentare uno dei maggiori esponenti
della giovane letteratura slovena, ancora poco nota in Italia, con la traduzione integrale
di un dramma fantastico, scritto ai tempi della dominazione austriaca, che riflette
pienamente l’atmosfera dell’epoca.
20 dicembre, n. 12:
• E, Damiani, recensione a: Giulio Slowachi, Kordjan; Mazeppa. A cura
di Clotilde Garosci. Torino, Unione Tipografica Editrice, 1932. Un vol.
in 16 do pp. 317 (collana “I Grandi Scrittori Stranieri” diretta da Arturo
Feltrinelli), p. 476.
Dopo una breve introduzione su Juliusz Słowacki e sulla difficoltà di
trasmettere la profondità del suo pensiero traducendolo da una lingua ricca e complessa
come il polacco, l’A. traccia una breve storia delle traduzioni italiane delle sue opere,
da P. E. Pavolini a G. Maver, e sottolinea il contributo innovativo dato da Clotilde
Garosci nel presentare i due poemi drammatici ancora poco noti in Italia. L’A. loda la
fedele versione italiana della Garosci.
Anno IV (1933)
20 marzo, n. 3:
• L. Savoj, Il teatro boemo e il paradosso del teatro senza tragedia, pp.
88-91.
L’A. descrive le caratteristiche del teatro ceco contemporaneo, considerato
elemento centrale della rinascita culturale nazionale. Anziché specchio della società il
giovane teatro drammatico ceco ne è lo stimolo principale, di qui il nome di buditelé
(ridestatori) dato ai primi drammaturghi, che cercavano di ridestare dal ‘torpore’ il
popolo imborghesitosi sotto la schiavitù.
‘Bollettino bibliografico’:
• Ehrenburg E.: L’amore di Gianni Ney. Romanzo. Milano, Ed.
Corbaccio, 1933, L. 5, p. 113.
20 aprile, n. 4:
‘Bollettino bibliografico’:
• Nikitin N.: La spia bianca. Romanzo. Milano, Ed. Corbaccio, 1933, L.
12,p. 151.
252
• Smeliov J.: Memoria di un cameriere. Milano, Bietti, 1933, pp. 304, L.
3,50, p. 151.
20 maggio, n. 5:
• Leone Savoj, recensione a: A.L. Bem, Evolutsija obraza Stavroghina.
Trudy V. S’jezda Akad. Organ zagran I. Sofia, 1931, pp. 196-198.
L’A. presenta il volume dedicato all’evoluzione psicologica e caratteriale del
personaggio di Stavrogin attraverso un parallellismo coi protagonisti di Žitie velikogo
grešnika, Ateizm e Besy.
Leone Savoj, recensione a: Leonìd Leònov, L’avventura d’Ivan.
Racconti, in ‘Letterature straniere’. Prima traduzione dal russo di Anna
Ruska, con prefazione di Alfredo Polledro. Torino, “Slavia”, 1931, L.
10. Collezione “Il Genio Slavo”, 1931, pp. 198-199.
•
Dopo aver esposto il contenuto del racconto Fine di un uomo meschino, già
tradotto da Lo Gatto per la rivista “Russia”, l’A. apprezza la succinta e lucida
prefazione di Polledro all’intera raccolta;
20 luglio, n. 7:
Bollettino bibliografico:
• Dostojevski: Il giocatore. Milano, Baldini e Castoldi, 1933, pp. 240, L.
3,50, p. 235.
‘Bollettino bibliografico’:
• Cronia A.: Per la storia della slavistica in Italia. Appunti storicobibliografici. Zara, Schönfeld, 1933, pp. 135, L. 16, p. 322.
• Dostoievski F.: Il sosia. Torino, Slavia, 1933, pp. 257, L. 8, p. 323.
• Dostoievski F.: Lo spirito sotterraneo. Romanzo. Milano, Sonzogno,
L. 8, p. 323.
• Gorki M.: Gli Artamonov. Tad. di E. Cadei. Milano, Treves, 1933°,
1933, pp. 250, L. 4, p. 323.
Anno V (1934)
20 febbraio, n. 2:
‘Bollettino bibliografico’:Puskin A.: La bella principessa e i sette
cavalieri. Lanciano, Carabba, 1934, pp. 60, L. 6,50, p. 79.
20 giugno, 6:
‘Bollettino bibliografico’:
• Russia rossa che ride. Novelle e aneddoti sovietici. Trad. di A.
Polledro. Torino, Slavia, 1934, pp. 352, L. 10, p. 214.
253
20 ottobre, n. 10:
‘Bollettino bibliografico’:
• Russia rossa che ride. Torino, Slavia, 1934, pp. 300, L. 10, p. 339;
• Tolstoi: La morte di Ivan Ilijc, La suonata a Kreutzer. Traduzione
della Duchessa d’Andria. Torino, Utet, 1934, pp.196, L. 10, p. 339.
• Tolstoi L.: Il cadavere vivente. Torino, Slavia, 1934, L. 10, p. 339.
20 novembre, n. 11:
‘Bollettino bibliografico’:
• Krakowski E.: Histoire de la Pologne. Paris, Denoël et Steele, 1934,
pp. 360, Fr. 20, p. 330.
Anno IX (1938)
20 settembre, n. 9:
• Dante di Sarra, recensione a: Euhen Onatsky, Grammatica ucraina in
‘Filologia slava’. R. Istituto superiore orientale, Napoli, pp. 290, p. 270.
Breve introduzione critica alla prima grammatica ucraìna apparsa in Italia.
Anno X (1939)
20 aprile-maggio, n. 4-5:
• FILOLOGIA SLAVA, a cura di Enrico Damiani. Russia. Bilancio
consuntivo del 1938, p. 148.
L’A. traccia un bilancio consuntivo delle pubblicazioni relative alla lingua e
letteratura russa del 1938, sottolineandone la portata inferiore rispetto a quelle del
1937, più numerose grazie alla celebrazione per il centenario della morte di Puškin.
20 giugno, n. 6:
• FILOLOGIA SLAVA, a cura di Enrico Damiani. Le altre letterature
slave (cfr. fascicolo precedente), pp. 181-182.
L’A. prosegue la rassegna bibliografica relativa all’ultimo biennio di pubblicazioni
su culture slave diverse dalla russa (polacca, cecoslovacca, jugoslava, bulgara, ucraìna)
Anno XI (1940)
20 gennaio, n. 1:
254
• E. Damiani, recensione a: Alja Rachmànova, Lattaia a Ottakring.
Traduzione di B. Giachetti-Sorteni, Firenze, Bemporad, 1937, pp. 285,
L. 10, pp. 10-11.
Descrizione del racconto della Rachmanova.
20 marzo-aprile, n. 3-4:
• Leone Savoj, recensione a: A. Puškin, Eugenio Oneghin. Versione e
note di E. Lo Gatto, Milano, Bompiani, 1937, pp. 326, L. 60, pp. 74-76.
L’A. loda la capacità di Lo Gatto di rendere nella traduzione la garbatezza di
certe soluzioni ritmiche, l’umorismo del sottile giro di frase, il gioco di parola e la rima
segnalando, poi, l’introduzione di Vjačeslav Ivanov all’edizione critica.
• Dante di Sarra, recensione a: Enrico Damiani, Italianska gramatika za
Balgari. Sofia, Cipev, 1937, pp. 216, p. 76.
Breve descrizione della grammatica italiana per i bulgari.
Anno XII (1941)
20 maggio, n. 5:
• Enrico Damiani, recensione a: Alja Rachmanowa, Leone Tolstoi.
Tragedia del suo matrimonio. Versione dal tedesco di Anita Rho.
Milano, Sperling e Kupfer, 1939, pp. 383, con illustrazioni fuori testo. L.
18, p. 143.
Dopo un breve introduzione sulla Rachmanova, scrittrice dell’emigrazione già
nota in Italia con vari volumi su memorie e impressioni a sfondo autobiografico relativi
agli eventi che sconvolsero la Russia dopo la prima guerra mondiale, l’A. presenta il
volume come una novità rispetto alla già collaudata forma narrativa della scrittrice.
Viene qui ripercorsa la vita di Tolstoj dal suo amore per Sofia Bers alla morte.
20 dicembre, n. 12:
• E. Damiani, recensione a: Narratori bulgari. A cura di Luigi Salvini.
Roma, Istituto per le Relazioni culturali con l’Estero, 1939, pp.
XXXVII-294 (Collezione “Stelle dell’Orsa”, Scrittori Stranieri, a cura di
Luigi Salvini e di Bino Sanminiatelli), pp. 335-337.
L’A. presenta qui l’antologia di scrittori bulgari contemporanei, inseriti da lui
stesso e da Luigi Salvini all’interno di due correnti letterarie: una verista, la cui prosa
viene definita dall’A. “scarna e concisa”, l’altra idillico-melanconica, pittoresca e
celebrativa. Le traduzioni dal bulgaro sono eseguita da Vittorio Zincone, Luigi Salvini,
Roberto Weiss di Londrone, Enrico Lapenna e lo stesso Damiani.
255
“Lo Spettatore italiano” (Giuseppe Bottai, 1924)
Fasc. 1 – 1 maggio:
• Ettore Lo Gatto, Gli scrittori della rivoluzione, in ‘Rassegna di
letterature straniere’, pp. 64-68.
L’articolo di Lo Gatto si compone di due parti. Nella prima, lo slavista descrive le
caratteristiche della cultura letteraria russa negli ultimi anni, precisamente dal 1918 al
1923, distinguendo gli scrittori rimasti in Russia a sostegno della Rivoluzione come
Gor’kij, Brjusov, Sologub, Blok, Belyj, e quelli costretti ad emigrare dalla guerra civile
e dal clima di decadenza morale e culturale in patria come Merežkovskij, Bunin,
Kuprin. Nella seconda si definiscono i legami tra rivoluzione e rinascita letteraria.
Fasc. 3 – 1 giugno:
• Ettore Lo Gatto, Il futurismo in Russia e Wladimir Majakowskij, in
‘Rassegna di letterature straniere’, pp. 271-277.
A quindici anni dalla pubblicazione del Manifesto di Marinetti, Lo Gatto traccia un
bilancio dei vari programmi e propositi della schiera futurista dal 1909 al 1914 in
Russia, dai primi versi ego-futuristi di Igor’ Severjanin nel 1911 ai cubofuturisti vicini
a Marinetti e rappresentati dai fratelli Burljukov, Viktor Chlebnikov e Vladimir
Majakovskij.
Fascc. 4 – 15 giugno:
• Ettore Lo Gatto, L’ ultimo Gorkij, pp. 325-332.
Dopo una breve descrizione dell’attività artistica e dell’impegno civile di Maksim
Gor’kij in Russia negli anni della Rivoluzione e in Germania, l’A. introduce il pensiero
ideologico del celebre scrittore, che in quegli anni viveva a Sorrento. Lo slavista cita
alcune fra le numerose pubblicazioni dello scrittore a partire dal progetto ambizioso, e
mai completato, dei volumi sulla letteratura mondiale, con la collaborazione del
governo russo e di alcuni scienziati e critici dell’epoca.
• Stefano Landi, Di Cécov e di Verga – recensione, pp. 378-383.
Alcune osservazioni sulla rappresentazone de Il giardino dei ciliegi di Čechov in
scena al Teatro Manzoni di Milano, rappresentato dalla Compagnia di Maria Melato, e
de Dal tuo al mio di Giovanni Verga, in scena già in passato al Teatro Argentina di
Roma con la ‘Compagnia Mediterranea’ diretta da Nino Martoglio.
Fasc. 5 – 1 luglio:
• Aurelio Palmieri, La corrispondenza di Adamo Mickiewicz, in
‘Rassegna di letterature straniere, pp. 465-472.
Si tratta dell’epistolario di Adam Mickiewicz, un raccolta di ventisei lettere
ignorate per quasi un secolo e custodite nell’Archivio della Società dei Filomati, o
‘amanti del sapere’. Il primo volume delle lettere fu edito a Cracovia nel 1913 da
Władysław Mickiewicz, figlio del poeta, e conteneva missive indirizzate agli amici
della Società, che con lui subirono la tirannìa del regime zarista. L’A. ne sottolinea
l’importanza storico-documentaria.
256
• Stefano Landi, Leonida Andreiev: “Il professore Storizin”, in
‘Rassegna Drammatica’, pp. 481-483.
Breve recensione alla rappresentazone de Il professor Storizin di Leonida Andreev
in prima assoluta in Italia a cura di Carini, che una rivista letteraria diretta da Ercole
Reggio aveva pubblicato un paio d’anni prima col titolo Il cieco. Il dramma si aggiunge
a precedenti rappresentazioni teatrali, Anfissa, Quello che prende gli schiaffi e La vita
dell’uomo.
Fasc. 6 – 15 luglio:
• E. Lo Gatto, Il teatro della rivoluzione, in ‘Rassegna di letterature
straniere’, pp. 556-560.
Dopo una breve introduzione sull’importanza del teatro in Russia, a partire dalla
Rivoluzione, descritto come più alta manifestazione della vita intellettuale e culturale,
l’A espone le teorie di V. Šeršenevič sulla preferenza accordata dal governo
rivoluzionario a tale forma d’arte come ‘strumento di propaganda’. Si prosegue
distinguendo ‘teatri imperiali’ e ‘teatri popolari’ allo scoppio della Rivoluzione,
individuandone i destinatari, operai e membri dell’esercito rosso, ed illustrandone i vari
repertori. Cenni al teatro sperimentale di Mejerchol’d.
Fasc. 7 – 1 agosto:
• Aurelio Palmieri, La storia letteraria della Rutenia, in ‘Rassegna di
letterature straniere’, pp. 69-75.
Breve storia delle varie teorie linguistiche e culturali, che hanno avallato
l’esistenza di una lingua e letteratura ruteno-ucraina come retaggio culturale autonomo
rispetto ad altre culture slave, soprattutto quella russa, partendo dalla Grammatik der
rutenischen jukrainischen Sprache di Smal-Stocky e Gartner, edita a Vienna nel 1913,
fino alla Storia dell’Ucraina di Mikhajl Hruscevceskij, professore all’Università di
Leopoli e promotore dell’Accademia “Taras Ševčenko”.
Fasc. 08-09 – 15 agosto-1 settembre:
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe, in ‘Rassegna di letterature straniere’,
pp. 184-193.
Dopo una breve introduzione sull’importanza delle riviste nel XIX secolo per la
cultura intellettuale dell’epoca, citando “Otečestvennye Zapiski”, “Russkoe
Bogatstvo”, “Sovremennik”, l’A. analizza da vicino il “tolstyj žurnal”, rivista di un
centinaio di pagine, che alla vigilia della guerra rappresentava il modello editorale di
riferimento per gli esuli russi di Parigi.
Fasc.10-11 – 15 settembre-1 ottobre:
• Arturo Cronja, Peculiarità céche: gli itinerari. Itinerari italiani, pp.
302-308.
Rassegna di scritti della letteratura ceca di tutti i tempi dedicati a “itinerari” o
“diari di viaggio” in Italia. Al periodo antico appartengono trascrizioni e traduzioni da
classici dell’odeporica, dal De Situ universi orbis di Pomponio Mela alla Descriptio
Romanae Urbis di Rufo Sesto. Fra gli altri si menzionano i Viaggi di Giovanni
Mandeville in traduzione e gli “itinerari italiani” dell’’800 di Pollák, Kollár e Palacky,
257
fino alle “Lettere italiane” di Karl Čapek.
Fasc. 12 – 15 ottobre:
• Aurelio Palmieri, Il Paradiso della Georgia, in ‘Rassegna del libro
italiano’, pp. 390-393.
Dopo una breve rassegna della letteratura prodotta sulla lingua e la cultura
georgiana, citando le rare grammatiche di Marie Félicité Brosset (1824-1879) e di
padre Francesco Maggio, che nel 1670 pubblicava a Roma i suoi Syntagma linguarum
orientalium quae in Georgiae regionibus audientur, l’A. si sofferma sulla raccolta di
leggende agiografiche edita da Sabinin nel 1882 dal titolo Sakhartwelos Samotzké (Il
Paradiso della Georgia). L’opera desume il materiale storico da una celebre cronaca,
fondamento della storia della Georgia, Karthuli literaturis istoria curata da Koornelius
Kakelidze.
• Umberto Urbanaz-Urbani, Il romanzo cattolico nella Slovenia, in
‘Rassegna di letterature straniere’, pp. 394-398.
Breve rassegna delle correnti letterarie in Slovenia negli ultimi anni del XIX
secolo, in particolare la corrente neoromantico-simbolica, conosciuta come “moderna”,
rappresentata da Cankar, Kette, Marn-Aleksandrov e Zupancič, e quella cattolica
rappresentata da Medved, Finzingar, Pregelj, Sardenko e Mesko. Di Mesko l’A.
descrive, infine, il romanzo Na Poljani, il cui intreccio ne fa l’epopea della Slovenia.
• K. Mociulski, La tecnica del teatro russo contemporaneo, in
‘Rassegna di letterature straniere’, pp. 399-402.
L’A. descrive il delicato passaggio in Russia dal vecchio al nuovo Teatro, nato
come reazione al naturalismo, portato alla perfezione dal Teatro Artistico di Mosca e
rappresentato da Mejerchol’d. Nella prima parte Mociulski descrive i principi teorici
sui quali si base la nuova concezione artistica, finalizzata a riportare sul palcoscenico la
pura “convenzionalità” della rappresentazione. Nella seconda, si descrive la nuova
“messa in scena” in cui il protagonista non è più l’autore drammatico ma il direttore
artistico.
258
“Critica fascista” (Giuseppe Bottai, 1923-1943)
Anno I, 1923
N° 10, 1° novembre:
• R. Cantalupo, Masaryk a Parigi, pp. 192-193.
Cronaca della visita ufficiale del Presidente dello Stato cecolslovacco Masaryk
e del Ministro degli Esteri Benes, otto giorni trascorsi tra ‘forma’, brindisi all’Eliseo,
cortei militari per le strade della capitale francese e conferenza stampa al Quai d’Orsay,
e ‘sostanza’, colloquio di Benes con Poincaré sui rapporti generali della Piccola Intesa
con la Francia, della Boemia con Polonia ed Ungheria e sulla questione del dominio
dell’Adriatico, sollevata dal patto di Londra del 1915.
Anno II (1924)
N° 4, 15 febbraio:
• Aurelio Palmieri, Nicola Lenin (Vladimiro Ilic Ulianov), pp. 334-337.
In questo profilo della personalità di Lenin, partendo dalla considerazione che il
pensiero russo è sempre stato asservito al ‘genio’ di altre nazioni e che la ricerca di
un’identità slava ‘autoctona’ è stata un’idea perseguita da Ivan il Terribile in poi, l’A.
sottolinea la natura eclettica, ‘poco russa’, della sua educazione morale e intellettuale.
N °9, 1° maggio:
• Silvio Delich, La crisi jugoslava, pp. 439-440.
L’A. chiarisce alcuni punti riguardo alla crisi dello Stato jugoslavo a partire dalla
formazione dei tre nuovi Stati subito dopo la prima guerra mondiale, Serbia, Croazia e
Slovenia, e dall’armistizio di Villa Giusti del 4 novembre 1918, che da un lato
determinò lo sfacelo militare dell’Austria-Ungheria, rendendo possibile l’unione
croato-sloveno-serba, dall’altro non riuscì ad impedire la lenta crisi politica al suo
interno.
Anno III (1925)
N° 2, 15 gennaio:
• V. M. Grazianova, traduzione: Leone Trozki, Insegnamenti della
Rivoluzione Russa (Ottobre 1917), pp. 23-25.
Traduzione sintetica della prefazione di Lev Trockij al II volume di 1917, dove si
descrivono le caratteristiche storiche e ideologiche del Bolscevismo.
259
N° 3, 1° febbraio:
• V. M. Grazianova, traduzione: Leone Trotzki, Gli insegnamenti della
Rivoluzione Russa (Ottobre 1917). Continuazione e fine del precedente.,
pp. 42-44.
Continuazione dell’articolo precedente.
N° 8, 15 aprile:
• Oscar Randi, L’eco del fascismo nella Russia e negli Stati Baltici, pp.
145-148.
Dopo una lunga introduzione sulla natura geo-politica della Russia e sul suo
sistema agrario fondato sulla proprietà comune, l’A. si sofferma sull’aspetto
“camaleontico” della politica russa. Di qui lo spunto per fare alcune osservazioni sulla
ricezione del fascismo nella Russia bolscevica, i cui princìpi furono introdotti dai russi,
profughi del regime zarista e residenti a Costantinopoli e nella ex- Jugoslavia.
N° 11, 1° giugno:
• Giulio Benedetti, L’Italia in Dalmazia, pp. 204-206.
Descrizione degli eventi militari e strategici che caratterizzarono gli anni
dell’armistizio italo - dalmata.
N° 12, 15 giugno:
• Silvio Delich, Il destino della Russia, pp. 228-229.
Con l’approvazione da parte della Camera dei deputati del Trattato italo - russo
del 7 febbraio 1924 la politica russa entra nel dibattito pubblico. L’A. parte da questo
avvenimento per allargare l’analisi alla natura della Russia come territorio euroasiatico, destinato a cercare un equilibrio fra Oriente e Occidente.
N° 19, 1° ottobre:
• Erminio Mariani, La recente crisi del Partito comunista russo, pp.
364-366.
Sulle caratteristiche storiche e ideologiche del bolscevismo russo (si rimanda a:
V. M. Grazianova, traduzione: Leone Trotzki, Gli insegnamenti della Rivoluzione
Russa).
260
N° 24, 15 dicembre:
• Augusto De Marsanich, traduzione: Giorgio Drobnik, Il fascismo in
Polonia, pp. 471-472.
L’A. descrive le circostanze storiche e sociologiche, che furono particolarmente
favorevoli alla diffusione del fascismo in Polonia con l’opposizione dei conservatori e
dei gruppi socialisti e liberali. Il saggio si chiude con un cenno agli studi teorici sul
Fascismo condotti da uomini politici e intellettuali polacchi, in particolare, il deputato
Stanisław Kozicki.
Anno IV (1926)
N° 3, 1° febbraio:
• Erminio Mariani, La pratica bolscevica, pp. 44-46.
Analisi di alcuni aspetti della nuova realtà ecomonica in Russia sotto il regime
bolscevico: dopo la rivoluzione e la distribuzione delle terre ai contadini riemerge la
classe borghese, il mercato interno è in crisi, perché attaccato dalla concorrenza
privata, mentre in quello estero domina il principio del monopolio.
N° 4, 1° febbraio:
• Oscar Randi, Il Fascismo e la Jugoslavia, pp. 70-71.
Nel suo articolo, l’A. cerca di rilevare motivazioni e circostanze storiche utili a
sradicare il vecchio pregiudizio secondo cui il Fascismo non avrebbe incontrato i favori
del popolo jugoslavo perché considerato un probabile focolaio di nazionalismo e
imperialismo.
N° 11, 1° giugno:
• E. Mariani, L’insurrezione militare del Maresciallo Pilsudski, pp. 209211.
Si descrivono le singole fasi dell’insurrezione organizzata dal Maresciallo
Piłsudski per contrastare l’avanzata di Trockij e dei rivoluzionari bolscevichi nel 1920
alle porte di Varsavia in un momento particolarmente delicato per la Polonia, che
attendeva una stabilità politica ed economica dopo il patto di Versailles.
N° 24, 15 dicembre:
261
• Enrico Massis, La verità sulla Russia dei Sovieti, pp. 462-464.
L’A. ricostruisce la storia del popolo russo e della Russia considerando la
rivoluzione del 1917 “il momento di svolta, che ha liberato il paese da un lungo
“equivoco storico”: parafrasando Trubeckoj e Čaadaev, la Russia non ha mai accettato
di essere contaminata dalle idee e dal progresso provenienti dall’Occidente.
Anno V (1927)
N° 1, 1° gennaio:
• Oscar Randi, La Jugoslavia dopo la morte di Nicola Pasic, pp. 10-12.
Bilancio della politica del serbo Nicola Pasič nella ex- Jugoslavia; statista di rilievo
nei Balcani, l’A. lo paragona a Cavour e Giolitti. Dopo la sua scomparsa, l’A. prevede
due possibili direzioni per la politica interna della regione: maggiore stabilità fra Serbi,
Croati e Sloveni oppure inasprimento delle già esistenti divisioni interne.
N° 3, 1° febbraio:
• Michele Pirone, Nel decimo anno della rivoluzione russa, pp. 48-50.
In occasione del decimo anniversario della Rivoluzione, l’A. passa in rassegna i
principali avvenimenti accaduti in Russia dal 1917, analizzandone alcuni aspetti: la
posizione internazionale della Russia, la sua politica estera, le condizioni economiche.
N° 4, 15 febbraio:
• Michele Pirone, Nel decimo
(Continuazione e fine), pp. 70-71.
anno
della
rivoluzione
russa
Analisi della politica economica in Russia nell’ultimo decennio, suddiviso in tre
periodi: il comunismo di guerra, la N. E. P. e l’industrializzazione.
N° 6, 15 marzo:
• Eugenio Anagnin, I conflitti spirituali nella Russia moderna, pp. 106107.
Sul costante paradosso che in età moderna caratterizza la Russia, arretrata
economicamente, con una società feudale e arcaica legata alla tradizione bizantino ortodossa, ma al tempo stesso rivoluzionaria e innovatrice in campo religioso.
N° 7, 1° aprile:
262
• Eugenio Anagnin, I conflitti spirituali nella Russia moderna II., pp.
131-132.
In riferimento a un suo precedente articolo, l’A. evidenzia l’impatto travolgente,
che la Rivoluzione ha avuto sulla realtà politica e geografica della Russia,
ridefinendone i confini territoriali, senza però cancellare la spiritualità “messianica e
antieuropea” del suo popolo, spesso considerata ‘ragion d’essere’ della rivoluzione
medesima.
N° 8, 15 aprile:
• Oscar Randi, L’imperialismo jugoslavo, pp. 148-149.
L’A. traccia un bilancio delle imprese militari di Serbi, Croati e Sloveni a partire
dall’insperata fortuna delle milizie serbe durante la prima guerra mondiale, che li rese
dominatori di una vasta regione compresa tra le Alpi, l’Adriatico, il Danubio e l’Egeo.
N° 19, 1° ottobre:
• Oscar Randi, Le elezioni jugoslave, pp. 369-370.
Bilancio delle elezioni generali da quando esiste la Jugoslavia, dalla prima nel
1920 all’ultima nel 1927, con un quadro dettagliato dei singoli partiti politici capeggiati
dai “Radicali serbi” e dai “Democratici jugoslavi”.
N° 22, 15 novembre:
• Oscar Randi, Il fascismo cecoslovacco, pp. 429-432.
Si indagano le cause storiche, politiche, ed economiche della nascita del
fascismo in Cecoslovacchia nel 1926.
N° 23, 1° dicembre:
• Oscar Randi, Il fascismo cecoslovacco. Continuazione, pp. 452-453.
N° 24, 15 dicembre:
• Oscar Randi, Fascismo cecoslovacco. Continuazione e fine, pp. 470473.
Anno VI (1928)
263
N° 21, 15 novembre:
• Il Doganiere, Neoplatonismo bolscevico in ‘Dogana’, p. 411.
Critica al lungo articolo di A. O. Olivetti sulla “Conquista dello Stato”, in cui si
afferma che Lenin e Trockij sono “neo-platonici”, contrariamente alla vera natura del
bolscevismo, legato al ‘culto della materia’ e, dunque, più vicino alle idee aristoteliche.
Tale considerazione, secondo l’autore, sarebbe frutto di un eccessivo “liberalismo delle
idee”.
N° 23, 1° dicembre:
• O. Olivetti, A proposito di neoplatonismo bolscevico, pp. 452-453:
Sulle possibili implicazioni filosofiche del ‘materialismo’ su cui si fonda
l’ideologia bolscevica in relazione alle teorie neoplatoniche.
Anno VII (1929)
N° 3, 1° febbraio:
• Umberto Nani, Il colpo di stato in Jugoslavia, pp. 59-60.
Anno IX (1931)
N° 3, 1° febbraio:
• Oscar Randi, L’ idea fascista in Cecoslovacchia, p. 49.
L’A. traccia un bilancio dell’attività politica, che negli ultimi anni ha
caratterizzato il Fascismo cecoslovacco, giunto al momento di decidere se mantenersi
come movimento apolitico sovranazionale o “scendere in campo” come “partito reale”;
ostacolato dal Ministro degli Esteri Benes e dal Presidente Masaryk, il partito fascista
si era allontanato dall’area nazionaldemocratica e s’indeboliva sempre di più, anche a
causa della mancanza di una guida in grado di risollevarlo.
N° 8, 15 aprile:
• Tommaso Napolitano, Il caso del compagno Polonski, pp. 152-153.
Si tratta del celebre caso sollevato in Russia dal critico e giornalista Wacław
Połoński a proposito di alcuni suoi giudizi fortemente critici e di condanna nei
confronti di una raccolta di novelle dal titolo Problemy seksa (I problemi del sesso) di
Pantelejmon Romanov. Il saggio di Połoński, pubblicato sulla rivista di Leningrado “O
sovremennoj literature”, considerava l’opera di Romanov “corrotta e perversa”.
264
N° 13, 1° luglio:
• Carlo Lozzi, Russia e Finlandia, pp. 255-256.
L’A. ripercorre la storia dei rapporti diplomatici e militari tra Russia e Finlandia,
contrassegnati da continui dissidi e guerre territoriali. Una recente dimostrazione
navale nel golfo di Finlandia da parte della flotta bolscevica e dell’Esercito rosso nel
giorno di “Pentecoste” viene qui interpretata come un’ulteriore prova di tale ostilità.
Nà 16, 15 agosto:
• Tommaso Napolitano, Nuovi orientamenti della letteratura russa, pp.
318-319.
L’A. passa in rassegna alcuni esempi di letteratura “pornografica”, un
cambiamento radicale rispetto a un tipo di letteratura fortemente ‘politica’ e ‘moralista
come quella russa, dove il tema della sessualità era sempre stato affrontato parlando
piuttosto di ‘sensualità’ e quello dell’‘amore’ attraverso la sublimazione religiosa dei
sentimenti.
N° 18, 15 settembre:
• Umberto Nani, Il nuovo regime in Jugoslavia, pp. 347-348:
Sulla nuova Costituzione, redatta dopo quella precedente di “San Vito, concessa
dal re Alessandro di Jugoslavia ai popoli dell’“Unione” dopo un periodo dittatoriale
durato due anni e mezzo.
• Ernesto Brunetta, Influenza di Mosca, pp. 352-353.
Si espongono le ragioni che rendono la dittatura bolscevica un modello da
imitare nel resto d’Europa, una forma di garanzia di giustizia e benessere per tutti i
popoli. L’A. ripercorre la storia del popolo russo dall’abolizione della servitù della
gleba nel 1861-63 al Bolscevismo.
N° 21, 1° novembre:
• Mario Rivoire, Una discussione. Affinità ed antitesi fra Roma e
Mosca, pp. 413-414.
Vengono esaminati i termini di una questione aperta, in precedenza, da un articolo
di Sergio Panunzio, che si fonda su due precise teorie filosofiche: la prima è che
l’antitesi ideologica e politica tra Roma e Mosca non può implicare ragioni di carattere
economico, la seconda, che tale antitesi esiste, invece, tra ‘spirito’ e ‘materia’, dal
momento che il fascismo è religione dello spirito e il comunismo religione della
materia.
265
N° 22, 15 novembre:
• Alberto Luchini, Obbiezioni al neo-moscovitismo (Lettere a Bottai
sulla moscofilia) in ‘Una discussione: Roma o Mosca?’, pp. 432-434.
Aperta critica alle nuove tendenze di pensiero filobolsceviche diffuse in un’ala del
fascismo. L’A. difende le sue teorie con una serie di affermazioni che partono da un
principio di base: mentre la Rivoluzione fascista può vantarsi di essere stata generata
dalla vittoria dello Stato italiano, la rivoluzione bolscevica è stata generata dalla
disfatta dell’Impero plurinazionale russo e da una catastrofe militare.
• Bruno Spampanato, Roma o Mosca o la vecchia Europa?, pp. 434435.
Vengono chiariti i principi secondo cui esisterebbe un’antinomia concettuale e
filosofica tra la vecchia Europa dal regime liberaldemocratico e i nuovi regimi creati
dal Fascismo e dal Bolscevismo, antieuropei e conservatori.
N° 23, 1° dicembre:
• Luciano Ingianni, Roma e Mosca. Nettissima antitesi, pp. 455-457.
Viene qui ripresa la questione dell’antitesi Roma - Mosca, già affrontata in
precedenza nella rivista, riguardo al possibile superamento dell’opposizione FascismoBolscevismo sia sul piano economico-sociale, come sostenuto da Panunzio, sia su
quello spirituale.
• Armando Tosti, L’ abisso, pp. 457-459:
Partendo dall’antitesi Roma - Mosca, l’A. mette a confronto l’azione
rivoluzionaria di due “agitatori di masse e di idee”, Benito Mussolini e Giorgio Sorel,
teorico del sindacalismo rivoluzionario in Francia.
N° 24, 15 dicembre:
• Mario Da Silva, Il “compagno” Koba detto Stalin, pp. 476-477.
Biografia di Josif Vissarënovič Džugašvili, nato nel 1879 a Gori, piccolo villaggio
della Georgia, cospiratore e agitatore socialista, chiamato dai suoi compagni di lotta
“Koba” dal nome dell’eroe di un dramma cavalleresco georgiano.
Anno X (1932)
N° 3, 1° febbraio:
266
• Tomaso Napolitano, La morte nel sistema penale sovietico, pp. 59-60.
Breve storia della pena di morte in Russia; partendo dal dibattito sulla sua
‘legalità’ l’A. espone le teorie di Marx, applicate alla società slava da Plechanov verso
la fine del XIX secolo e relative alla corrispondenza tra istituzioni giuridiche e
impianto economico, per concludere con la recente concezione “organicistica” dello
Stato bolscevico che, negando la legittimità della pena capitale, ne decreta l’abolizione
durante la dittatura di Kerenskij.
N° 4, 15 febbraio:
• Tomaso Napolitano, I problemi morali nella letteratura sovietica, pp.
76-78.
Sulla questione della ‘moralità’ in Russia dopo l’avvento del Comunismo; la crisi
dei valori legati alla famiglia, la possibilità di contrarre più matrimoni e l’assunzione
da parte dello stato di oneri spettanti un tempo ai genitori avevano radicalmente
modificato la società, scatenando una polemica che in ambito letterario coinvolgeva
scrittori come Romanov, Pil’niak e Nikitin.
N° 6, 15 marzo:
• Tomaso Napolitano, I delitti contro l’economia nell’ U.R.S.S., pp. 113115.
Approfondimento di alcune norme particolarmente severe del codice penale
sovietico relative alla tutela dell’economia dell’U.R.S.S; si tratta di una rigida riforma
istituzionale alla base di un più ampio progetto di rinnovamento socio-economico in
atto in Russia, finalizzato a trasformare il paese da prevalentemente agricolo a
industriale.
N° 7, 1° aprile:
• P. M. Bandi, Bolscevismo romanzato, p. 137.
Breve nota sulle più recenti pubblicazioni in Italia sulla Rivoluzione russa, dalle
biografie di Lenin e Stalin alle Memorie di Trockij.
N° 9, 1° maggio:
• G. Macaluso-Aleo, La Russia e l’Islam, pp. 174-175.
L’A. descrive la politica imperialistica della Russia verso l’Estremo Oriente e
verso l’Oriente islamico, paragonandola a quella adottata ai tempi degli zar, orientata
alla conquista di Costantinopoli e del Golfo Persico. In particolare, viene analizzata la
politica economica nei confronti di Persia, Arabia, Egitto, basata sul dumping.
267
N° 10, 15 maggio:
• Giuseppe Biscottini, Orizzonti della politica jugoslava, p. 198.
L’A. cerca di tracciare un bilancio della politica jugoslava a partire dallo Statuto
del 3 settembre 1932, documento che assicurava stabilità alla regione in politica estera
dando l’idea di un regime costituzionale ma che, di fatto, non esprimeva i mutamenti in
atto nel sistema di Governo jugoslavo. La crisi istituzionale era stata generata dal
fallimento della politica del Generale Živcovič .
N° 11, 1° giugno:
• Il Doganiere, Del bolscevismo borghese, pp. 210-211.
Breve intervento di propaganda fascista anti-bolscevica.
N° 13, 1° luglio:
• Tomaso Napolitano, La difesa penale del lavoro in Russia, pp. 256258.
Confronto del sistema penale italiano con quello sovietico in materia di difesa del
lavoro da alcune azioni sociali sempre più diffuse e ‘destabilizzanti’ come lo sciopero
dei lavorati; mentre nell’Italia fascista il lavoro viene proclamato “dovere sociale” nella
Russia bolscevica esso viene ridotto a puro mezzo di sopravvivenza.
Nà 14, 15 luglio:
• Oscar Randi, Il nuovo ministero nella Jugoslavia, pp. 274-275.
Sul nuovo assetto di Governo dopo Živcovič nella ex - Jugoslavia alla guida
del nuovo Presidente del Consiglio, l’avv. Milan Srkšić, già rappresentante dell’ala più
avanzata dell’irredentismo serbo contro la dominazione austro-ungarica. Dopo
l’abolizione della Costituzione nel 1929 da parte del re Alessandro I, Srkšić fu indicato
come l’ideatore e il legislatore della dittatura jugoslava.
N° 15, 1° agosto:
• Tomaso Napolitano, La riforma penale nell’U.R.S.S., p. 287-289. (v.
articolo precedente);
N° 16, 15 agosto:
268
• Umberto Nani, Rapporto sulla Jugoslavia, pp. 316-318.
Cronaca dei principali avvenimenti, che hanno caratterizzato i primi tredici anni
di vita dello Stato jugoslavo.
N° 17, 1° settembre:
• Carlo Giglio, Diplomazia sovietica, p. 329.
Riflessione sul peso diplomatico che la Russia ha assunto di recente nel
mondo, puntando sul dialogo con paesi come la Turchia, l’Afganistan e la Persia, dove
è difficile esportare l’ideologia comunista ma è possibile l’accordo diplomatico.
• Il Doganiere, Il vero pericolo russo, pp. 330-331.
Breve intervento propagandistico sul “pericolo”, che la nascente gioventù
bolscevica rappresenta per l’Europa.
N° 22, 15 novembre:
• Tomaso Napolitano, Quindici anni di regime bolscevico, pp. 424-425.
Con una ricostruzione storica del Partito Comunista dell’U.R.S.S, in occasione del
quindicesimo anniversario della rivoluzione d’ottobre, l’A. cerca di dimostrare come
solo due popoli, russo e americano, siano arrivati a conseguenze estreme in campo
sociale e politico.
Anno XI (1933)
N° 1, 1° gennaio:
• Tomaso Napolitano, La stampa nell’U.R.S.S. Giornalismo di politica,
pp. 6-7.
Sul problema della diffusione della stampa sovietica e sulla necessità che essa
rifletta lo spirito della Rivoluzione; al recente ‘Congresso degli scrittori proletari’ di
Mosca sia i dirigenti del Partito che i rappresentanti di Governo avevano proposto la
questione evidenziando l’esistenza in Russia di un “giornalismo di provincia” lontano
da quello considerato “ufficiale”.
N° 4, 15 febbraio:
• Manlio Pompei, Roma dopo Mosca, pp. 74-75.
Si tratta di un resoconto di viaggio nell’Italia fascista e nella Russia sovietica
tratto dal libro di Emile Schreider Roma dopo Mosca (edizioni “Plon”, Roma).
269
N° 5, 1° marzo:
• Tomaso Napolitano, La seconda “piatiliotka” (1933-1937), pp. 88-89.
Esame delle due ‘risoluzioni’ presentate il 3 gennaio 1933 dal Comitato Centrale e
dalla Commissione Centrale di Controllo del Partito Comunista Panfederale, riuniti in
seduta plenaria per discutere i risultati della prima “pjatiljotka” e il fondamento
politico-economico da assegnare al nuovo piano quinquennale.
N° 9, 1° maggio:
• Tomaso Napolitano, La stampa nell’ U.R.S.S. Il giornalismo ufficiale,
pp. 179-180.
Sui principi a cui la nuova stampa di regime doveva ispirarsi per “educare le
masse”, interpretando lo spirito del discorso pronunciato da Lenin in uno dei primi
Congressi del Partito.
N° 24, 15 dicembre:
• Tomaso Napolitano, La politica sociale dei Sovieti, pp. 468-469.
Esame degli effetti che le scelte operate dalla politica comunista in Russia hanno
avuto, negli anni, sulle classi sociali.
Anno XII (1934)
N° 19, 1° ottobre:
• Tomaso Napolitano, Problemi dell’ U.R.S.S., pp. 375-377.
Sulla libertà di stampa in Russia durante il regime sovietico e sulla funzione
sociale della Pravda come interprete della condizione delle classi sociali.
N° 4, 15 dicembre:
• Tomaso Napolitano, Polemiche nell’ U.R.S.S. La riforma sociale, pp.
81-82.
L’A. sottolinea la portata rivoluzionaria della riforma sociale avviata dal Partito
comunista nell’U.R.S.S, una riforma accusata di essere “poco bolscevica e molto
borghese”. La nuova politica dei salari, le severe sanzioni contro gli operai, le misure
per snellire l’apparato burocratico avvicinano la riforma alla borghesia, come
270
annunciato da un’“Ordinanza” della Direzione Centrale del Partito pubblicata dalla
Pravda qualche mese prima.
Anno XIII (1935)
N° 10, 15 marzo:
• Tomaso Napolitano, I giovani ed il regime nell’ U.R.S.S., pp. 204-205.
Sulla gioventù sovietica della seconda “pjatiljotka”, animata da una fattiva
volontà di ricostruzione dopo il difficile periodo caratterizzato da contrasti interni al
Partito Comunista; per questa gioventù, come per Trockij, il Partito è costituito dalla
massa operaia e contadina e non dal vecchio blocco di teorici marxisti-leninisti.
N° 3, 1° dicembre:
• Tomaso Napolitano, La proprietà pubblica nell’ U.R.S.S., pp. 44-46.
Sulla natura della proprietà pubblica in Russia e sul suo rapporto col sistema
economico di pianificazione collettiva.
Anno XIV (1936)
N° 10, 15 marzo:
• Corrado Sofia, Lettere dalla Jugoslavia. Belgrado e le sanzioni, pp.
157-158.
Sulle pesanti sanzioni economiche prevista già da quattro mesi per la Jugoslavia.
N° 20, 15 agosto:
• Corrado Sofia, Lettere dalla Jugoslavia, pp. 317-318.
Sui nuovi orientamenti del mercato italiano in Jugoslavia.
N° 21, 1° settembre:
• Il Doganiere, Machiavelli e la cattiva coscienza del Bolscevismo, p.
328.
Sulla condanna a morte del “compagno” Zinovev, reo di possedere un saggio di
Machiavelli considerato “antibolscevico”.
271
N° 24, 15 ottobre:
• Giovanni Engely, Mosca non disarma, pp. 378-379.
Sulla politica degli armamenti del regime sovietico.
N° 2, 15 novembre:
• Agostino Nasti, L’età del ferro della Russia –[recensione a: W. H.
Chamberlin, L’ età del ferro della Russia, ed. Einaudi], p. 28.
Il volume è una cronaca del Bolscevismo in quanto “errore storico e filosofico”.
Anno XV (1937)
N° 7, 1° febbraio:
• Romano Bilenchi, Fascismo e bolscevismo, pp. 99-101.
Confronto tra Fascismo e Bolscevismo alla luce degli ultimi avvenimenti storici.
N° 10, 15 marzo:
• Corrado Sofia, Lettera dalla Jugoslavia, pp. 161-162.
Sulla politica della Francia nei confronti della Jugoslavia.
• Agostino Nasti, L’Italia, il bolscevismo, la Russia, pp. 162-163:
Confronto tra Fascismo e Bolscevismo alla luce degli ultimi avvenimenti storici.
N° 11, 1° aprile:
• Berto Ricci Stoccate, Mosca e il Direttorio, p. 170:
Sull’organizzazione statale e burocratica nella Russia dei Soviet.
N° 16, 15 giugno:
272
• Amor Bava, Lettera dall’America del Nord. La Russia Sovietica e
l’opinione americana, pp. 283-285.
L’A. osserva come negli ultimi anni sia accresciuto l’interesse dell’opinione
pubblica americana nei confronti degli avvenimenti politici della Russia sovietica, dai
processi di Mosca anti - trockisti alle altisonanti riforme costituzionali, un interesse
ravvivato anche dalla presenza di Trockij in Messico e di numerosi comitati in sua
difesa nell’antagonismo con Stalin.
N° 17, 1° luglio:
• G. Solari-Bozzi, Lettera da Praga: Orientamenti spirituali della
Cecoslovacchia, pp. 299-300.
Sul ruolo della gioventù nella formazione dello Stato jugoslavo.
N° 18, 15 luglio:
• Tomaso Napolitano, Panorami europei - Il “fascismo di Stalin”, pp.
317-319.
Sul contrasto ideologico tra Stalin e Trockij basato sulla possibilità per il primo di
costruire il socialismo all’interno di un solo Paese, senza assegnare allo Stato scopi e
funzioni internazionali, e sulla negazione, da parte dell’altro, di tale possibilità.
N° 22, 15 settembre:
• G. Solari-Bozzi, Lettera da Praga. I giovani e l’ avvenire dello Stato,
pp. 379-380.
N° 23, 1° ottobre:
• Corrado Sofia, Lettera dalla Jugoslavia. Sei mesi di amicizia, pp. 395396.
Bilancio dei rapporti diplomatici tra Italia e Jugoslavia a distanza di sei mesi dagli
accordi del 25 marzo.
• Tomaso Napolitano, Il “fascismo” di Stalin ovvero l’U.R.S.S. e noi in
‘Panorami europei’, pp. 395-398.
N° 3, 1° dicembre:
273
• G. A. Longo, Il problema della Cecoslovacchia in ‘Libri letti’recensione a: Aspects du problème tchécoslovaque, par Charles Vietz,
Genève, Société d’Edition Indépendante, p. 45.
Presentazione del volume di Charles Vietz come importante documento sulle
origini, gli sviluppi e le finalità del programma di Governo per la Cecoslovacchia,
annunciato dal deputato comunista Slansky e finalizzato a rendere il paese “baluardo
dell’Unione Sovietica e della rivoluzione proletaria nell’Europa centrale.
Anno XVI (1938)
N° 6, 15 gennaio:
• Pier Fausto Palumbo, Bolscevismo e Cattolicesimo. La posizione
leniniana del problema religioso, pp. 95-96.
L’A. si sofferma qui sulla concezione che Lenin e il bolscevismo avevano della
religione con alcune osservazioni sull’origine della Rivoluzione, legata più a una
maggioranza numerica di adepti che a un ‘credo’ religioso e ideologico e fondata sul
materialismo, caro al popolo russo e alla sua proverbiale apatia.
N° 11, 1° aprile:
• Pier Fausto Palumbo, Religione e bolscevismo. Il programma
bolscevico della lotta antireligiosa, pp. 182-183.
L’A. evidenzia le due principali teorie alla base della lotta alla religione avviata dal
bolscevismo: la prima considera la religione una forma di idealismo o di pensiero
filosofico da combattere perché lontano dalla realtà, la seconda, invece, la identifica in
una forma di ’’oppressione sociale’.
• Corrado Sofia, Lettera dalla Jugoslavia. L’ italiano alle porte di casa,
pp. 186-187.
L’A. riconosce il significativo contributo dell’Italia, considerata modello
d’ispirazione nella lotta per la libertà in età risorgimentale, nella formazione degli Stati
jugoslavi di Serbia, Croazia e Slovenia.
N° 19, 1° agosto:
• G. Solari Bozzi, Lettere da Praga. Le insopprimibili nazionalità, pp.
298-299.
274
Sulla questione del ‘regime minoritario’ in Cecoslovacchia e sulla lotta delle
‘nazionalità’ interne su questioni di razza e cultura presente nella Repubblica già fin
dalla sua nascita nel 1918 e a lungo ignorato dal resto d’Europa.
n° 22, 15 settembre:
• Corrado Sofia, Lettera dalla Jugoslavia. L’ accordo di Bled, pp. 346347.
Sui patti bilaterali presi a Bled rispettivamente fra l’Ungheria e i tre Stati della
Piccola Intesa.
N° 24, 15 ottobre:
• Tomaso Napolitano, Il bolscevismo contro l’Europa. Monaco e
Mosca, pp. 379-381.
Sull’influenza di Monaco e della politica tedesca nei rapporti tra l’U.R.S.S. e le
grandi democrazie.
Anno XVII (1939)
N° 9, 1° marzo:
• G. Solari Bozzi, La nuova Cecoslovacchia in Lettera dalla
Cecoslovacchia, pp. 139-140.
Sulla superamento della crisi economica in Cecoslovacchia.
N° 10, 15 marzo:
• Tomaso Napolitano, Destino della gioventù sovietica in ‘Giovinezza
nel mondo’, pp. 157-159.
Sui principali avvenimenti di politica interna dell’anno corrente: lo scandalo nel
comitato centrale del Komsomol’ e la morte di Nikolaj Ivanovič Jezov, capo della
GHEPEU nonché successore di Jagoda al Commissariato per l’Interno dell’U.R.S.S.
N° 23, 1° ottobre:
275
• Emilio Canevari, Cause della disfatta polacca in ‘La guerra in
Europa’, pp. 372-374.
Sulla disfatta militare polacca contro la Germania nazional-socialista.
• Corrado Sofia, La neutralità dei Balcani in ‘Lettera dalla Jugoslavia’,
pp. 371-372.
N° 24, 15 ottobre:
• Emilio Canevari, Considerazioni sulla campagna di Polonia in ‘La
guerra in Europa’, pp. 390-392 (Continuazione del precedente articolo
sul n° 23 della rivista).
N° 2, 15 novembre:
• Corrado Sofia, Le rivendicazioni prendono una strada falsa, p. 28 in
‘Lettera dalla Jugoslavia’.
N° 3, 1° dicembre:
• Tomaso Napolitano, Logica del patto tedesco-sovietico, pp. 43-44.
Anno XVIII (1940)
N° 8, 15 febbraio:
• Corrado Sofia, Lettera dalla Jugoslavia’. Balcani e bacino
Danubiano, p. 139.
N° 11, 1° aprile:
• Aldo Airoldi, La pace di Mosca e le vicende della coalizione, p. 186.
N° 13, 1° maggio:
• N., Bolscevismo – recensione in ‘Libri letti’, p. 221.
N° 19, 1° agosto:
276
• Corrado Sofia, ‘Lettera dalla Jugoslavia’. Nei Balcani, p. 315.
N° 20, 15 agosto:
• Aldo Airoldi, Revisionismo balcanico in ‘Meridiano di Roma’, p. 330.
N° 2, 15 novembre:
• Tomaso Napolitano, Le metamorfosi del bolscevismo, pp. 28-30.
Dopo una lunga introduzione critica sulla natura delle tre rivoluzioni proletarie
del secolo, la Bolscevica, la Fascista e la Nazista, Napolitano si sofferma sulla recente
riforma dell’apparato statale dell’U.R.S.S., interpretandola come totale e definitiva
sostituzione del vecchio principio democratico - liberale promosso da Lenin. Fonti e
documenti citati nell’articolo sono tratti dal volume: T. Napolitano, Le Metamorfosi del
Bolscevismo, ediz. Bocca, pp. XXIII-312, 1940 –XVIII.
N° 4, 15 dicembre:
• Luigi Saporito, La Bulgaria e l’ Italia in ‘Lettera dalla Bulgaria’, pp.
59-60.
Sui rapporti diplomatici tra Bulgaria e Italia da Crispi a Mussolini, in particolare,
sulle iniziative imprenditoriali italiane degli ultimi anni, finalizzate a sostenere e
consolidare la situazione economico-sociale in Bulgaria attraverso il potenziamento del
settore industriale e agricolo.
Anno XIX (1941)
N° 19, 1° agosto:
• Guido De Luca, Il moto antistorico del bolscevismo, pp. 299-300.
Sugli aspetti “antistorici” del Bolscevismo riscontrabili nelle insanabili
contraddizioni della dottrina leninista e nella totale inadeguatezza della classe politica
sotto il regime.
N° 3, 1° dicembre:
• P. F. Palumbo, Russia contemporanea, pp. 46-47.
Breve rassegna delle principali iniziative culturali italiane relative alla storia e
alla cultura russa negli ultimi anni, motivate da un interesse acutizzato dalla
rivoluzione bolscevica. Partendo dallo studio sul Bolscevismo di un emigrato russo in
277
Italia, Vladimir Zabugin, l’A. cita contributi di scrittori emigrati e semplici viaggiatori,
tecnici, giornalisti e uomini politici che, scampati al regime, ne raccontavano la realtà.
Una menzione particolare agli studi di E. Lo Gatto e A. Palmieri.
278
“Quadrivio. Grande settimanale illustrato di Roma”
(Giuseppe Bottai, 1933-1943)
Anno I – 1933
N. 4, 27 agosto:
• ‘Taccuino bibliografico settimanale’ – ‘Filologia’: Androvic Giovanni,
Grammatica della lingua jugo-slava (croata e serba), Milano, Hoepli, p.
370, L. 18, p. 9.
N. 2, 29 ottobre:
• ‘Notizie teatrali’ – Breve notizia sull’imminente apertura a Mosca del
‘Piccolo Teatro della Cultura’.
N. 3, 5 novembre:
• I vincitori di Praga. Racconto di Francesco Formigani, p. 2.
N. 7, 3 dicembre:
• ‘Libri ricevuti’ – ‘Traduzioni’: Fjodor Dostojevskij, Il Sosia
(Racconti). Trad. integrale e conforme al testo russo con note di Carol
Straneo. Editore «Slavia», Torino, 1933 – XI. L. 8.
Anno II – 1934
N. 22, 25 marzo:
• Ettore Settanni, Polonia d’oggi, pp. 5-6.
Il contributo riassume in breve la storia della Polonia, attraverso i suoi simboli
civili, religiosi e militari, fino alla I guerra mondiale e all’attività diplomatica e militare
del maresciallo Józef Piłsudski. L’articolo è arricchito da una foto d’epoca di Piłsudski
e da alcuni testi tradotti da Aurora Beniamino: un brano tratto da Chłopy di Władysław
Reymont e la Teoria jedności narodowej e Panslavism di Adam Mickiewicz.
N. 25, 15 aprile:
• Ettore Lo Gatto, Il paradosso di Mosca, p. 7.
Il contributo è un’attenta riflessione sul ruolo che Mosca capitale riveste
nell’U.R.S.S. E’ una città dove l’innovazione si scontra fortemente con la tradizione,
dando vita a una cosiddetta “tragedia interiore” per la Russia bolscevica. Il paese non
riflette pienamente le aspirazioni del nuovo governo dei Soviet perché legato a un
passato cui non intende rinunciare.
N. 34, 17 giugno:
• Giuseppe Marussig, La filosofia degli scrittori russi, p. 2:
279
N. 35, 24 giugno:
• Giuseppe Marussig, La filosofia degli scrittori russi. Continuazione
del numero precedente, p. 4
N. 40, 29 luglio:
• Tatiana Soukhotine-Tolstoi, Guerra e Pace e i suoi critici, p. 1, con un
fotogramma.
Sono le memorie di Tat’jana Tolstoj, figlia dello scrittore, relative ai cinque anni
di continuo e incessante lavoro alla stesura di Vojna i mir. A causa dell’esiguo numero
di appunti rimasti, la ricostruzione del romanzo si basa esclusivamente sulle note del
“diario intimo” e su qualche estratto dalla corrispondenza con gli amici.
• Tatiana Soukhotine-Tolstoi, Guerra e Pace e i suoi critici,
continuazione della prima pagina con tre fotografie d’epoca, p. 3.
N. 41, 5 agosto:
Tatiana Soukhotine-Tolstoi, Guerra e Pace e i suoi critici, pp. 1-2, con
una foto d’epoca e un disegno olografo.
•
• Salvatore Valitutti, Gioventù russa, p. 4:
Recensione al saggio di Klaus Menhert Inchiesta su la gioventù sovietica. (Ediz.
accresciuta dall’autore – Milano, Casa ed. A. Corticelli, 1935, pp. 225) in cui Menhert
disegna un ritratto di quella generazione, entusiasta della rivoluzione e lontana dalla
memoria storica nazionale, che allo scoppio della guerra non aveva superato i vent’anni
e che aveva un’età compresa tra i 18 e i 36 anni.
N. 43, 19 agosto:
• Corrado Sofia, Esperimenti del teatro russo con una scena tratta dal
dramma “Il treno blindato” di Leonov, p. 9.
L’A. rissume alcune esperienze teatrali nella Russia comunista che tendono a
giustificare l’affermazione dell’ex-ambasciatore dell’U.R.S.S a Roma Platon
Michajlovič Keržencev, secondo cui la rivoluzione in Russia aveva condotto al
risveglio della creatività e della grinta reazionaria nelle masse lavoratrici, cui
corrispondeva, in ambito teatrale, una diretta e spontanea partecipazione degli
spettatori al canto e all’azione scenica.
N. 52, 21 ottobre:
• Vinicio Paladini, Tre canzoni su Lenin, p. 2.
Recensione al film del celebre direttore cinematografico Dziga Vertov,
sostenitore del cinema documentario. Il film, che costituisce un prezioso documeno
sulla rivoluzione e sulla formazione di uno Stato intorno alla figura di Lenin, si avvale
di fonti autorevoli sulla sua vita e sulla diretta esperienza di operai e contadini che,
nel film, si raccontano.
N. 1, 4 novembre:
• M. G., Maternità e infanzia in Russia, p. 9:
Recensione al volume del giovane magistrato fascista Tommaso Napolitano su
quanto è stato fatto in Russia a favore della maternità e dell’infanzia. Il libro,
280
presentato come uno studio serio e documentato, viene considerato fra i migliori lavori
di “colui, che ha fatto conoscere in Italia il Diritto Penale sovietico”.
N. 3, 18 novembre:
• Tomaso Napolitano, Il teatro di Pirandello nell’U.R.S.S., con una
fotografia di Pirandello a Buenos Aires, p. 4.
L’A. espone le ragioni della fortuna critica di Pirandello, membro della fascista
Accademia d’Italia, nella Russia sovietica, e le motivazioni che hanno indotto
l’Accademia Comunista di Mosca a pubblicare in una splendida edizione la migliore
produzione teatrale dell’artista.
Anno III – 1935
N. 14, 3 febbraio:
• Enrico Emanuelli, Ragazzi a Mosca. Racconto, pp. 5-6.
N. 19, 10 marzo:
• Sigfrido Wolfango, Il teatro di Tairov con una fotografia di A. Tairov
e un bozzetto per le scene di “Notti Egiziane”, p. 4.
In riferimento alle celebrazioni del 25 dicembre 1934 in Russia per il ventesimo
anniversario della fondazione del Kamernyj Teatr di Aleksandr Tajrov l’articolo ne
traccia una breve storia come “teatro della rivolta”, contrario al naturalismo dell’arte e
alla convenzione delle forme teatrali, legata alla tradizione, e impegnato nell’affrontare
i grandi problemi sociali.
N. 2, 10 novembre:
• Tatiana Soukhotine-Tolstoi, La bacchetta verde. Scritti in occasione
del 25° anniversario della morte di L. Tolstoj, p. 1.
Breve aneddoto di vita familiare riferito a una bacchetta verde che il piccolo
Nicola, primogenito della famiglia Tolstoj, confidò ai fratelli di aver seppellito nella
foresta di Jasnaja Poljana e che sembrava possedere doti miracolose.
N. 4, 24 novembre:
• Tatiana Soukhotine-Tolstoi, L’anno della gran carestia in casa di
Leone Tolstoi con due foto d’epoca. Scritti in occasione del 25°
anniversario della morte di L. Tolstoj, p. 1 e 3.
Memorie di Tat’jana Souchotina-Tolstaja su episodi di vita privata risalenti al
periodo in cui si trovava con la madre e la sorella Maria nella provincia di Rjazan’,
un’area particolarmente colpita dalla terribile carestia che imperversava in Russia nel
1892.
Anno IV-1936
281
N. 11, 12 gennaio:
• S.a. Da Clarence Brown a Tolstoi con tre fotogrammi tratti dal film
con Greta Garbo, p. 8.
Nell’articolo si commenta positivamente la recente trasposizione cinematografica
del romanzo di Tolstoj Anna Karenina, in particolare tre scene tratte dal film Il
banchetto di cosacchi con cui inizia la pellicola, la scena in cui Anna Karenina, di
ritorno da Mosca, abbraccia il figlio, e uno dei tanti dialoghi tra Anna e Vronskij. Le
citazioni sono dalla traduzione italiana del romanzo firmata da Leone Ginzburg per
Slavia (“Il Genio Russo”, Torino, 1929).
N. 19, 8 marzo:
• La Redazione: Leone Tolstoi, Diario per me solo, con due fotografie
d’epoca, p. 2.
Si tratta di alcuni appunti personali, presi in fretta da Tolstoj durante i tre mesi che
ne precedettero la morte, che compongono il Dnevnik.
N. 28, 10 maggio:
• T. Z., traduzione: Dacci il nostro giornale quotidiano di Carel Ciapek,
p. 4.
N. 35, 28 giugno:
• Antonio Miclavio, traduzione: Il Giardiniere. Racconto inedito di
Massimo Gorki, traduzione eseguita direttamente dal russo, con una foto
d’epoca di Gor’kij e Tolstoj, p. 4.
• Antonio Miclavio, traduzione: Quattro poesie, traduzione eseguita
direttamente dal russo, p. 4.
• Corrado Sofia, Quando il grande scrittore russo chiedeva aiuto al sole
di Sorrento, p. 4.
L’articolo racconta l’intervista rilasciata a Sorrento da Maksim Gor’kij a Corrado
Sofia.
• Ugo Ojetti, Gorki aneddotico in Cose viste. Tomo primo, 1925, p. 4.
Brevi memorie personali di Ojetti sulla personalità di Gor’kij e sulle sue opinioni
intorno all’Italia e alla cultura italiana.
N. 39, 26 luglio:
• Principe N. Gewakhov, 1917. L’ anno della tormenta, p. 4
(Continuazione).
N. 40, 2 agosto:
• Principe N. Gewakhov, ex Sottosegretario di Stato e Vice-procuratore
del Santo Sinodo, 1917. L’anno della tormenta. La rivoluzione russa
vista da un alto funzionario del regime zarista, p. 6 (Continuazione)
N. 41, 9 agosto:
• Principe N. Gewakhov, ex Sottosegretario di Stato e Vice-procuratore
282
del Santo Sinodo, 1917. L’anno della tormenta. La rivoluzione russa
vista da un alto funzionario del regime zarista, p. 6 (Continuazione)
N. 42, 16 agosto:
• Principe N. Gewakhov, ex Sottosegretario di Stato e Vice-procuratore
del Santo Sinodo, 1917. L’anno della tormenta. La rivoluzione russa
vista da un alto funzionario del regime zarista, p. 6 (Continuazione)
N. 43, 23 agosto:
• Principe N. Gewakhov, ex Sottosegretario di Stato e Vice-procuratore
del Santo Sinodo, 1917. L’anno della tormenta. La rivoluzione russa
vista da un alto funzionario del regime zarista, p. 6 (Continuazione)
N. 9, 27 dicembre:
• Giorgio Nodi, Merejkowski a Roma con un disegno, p. 2.
Il contributo riassume un’intervista rilasciata a Dmitrij Merežkovskij mentre si
trovava a Roma insieme alla moglie Zinaida Gippius nel suo appartamento del
quartiere Ludovisi e nella quale lo scrittore russo esprimeva alcune sue opinioni sulla
cultura letteraria italiana, in particolare su Dante;
• Erme Cadei, traduzione: Leone Tolstoi, Due frammenti inediti di
“Anna Karenina” (Continua).
Si tratta di due frammenti relativi alla composizione del romanzo Anna Karenina,
in Italia fino a quel momento inediti e non ancora pubblicati in Russia, tradotti in
italiano da Erme Cadei sulla copia degli originali conservati al museo tolstoiano di
Mosca. L’A. ne annuncia la futura pubblicazione in appendice alla nuova traduzione
italiana del romanzo firmata da Ossip Felyne e prevista all’interno della collana
Mondadori “Biblioteca romantica”.
Anno V- 1937
N. 10, 2 gennaio:
• Erme Cadei, traduzione: Leone Tolstoi, L’incubo di Anna Karenina, p.
2.
N. 18, 28 febbraio:
• Francesco Jovine, La vita ardente e dolorosa di Dostojewski, p. 8.
L’A. presenta il volume di N. Moscardelli dedicato alla vita dello scrittore, edito a
Milano da Sperling e Küpper, invitando il lettore a non lasciarsi trarre in inganno
dall’apparente semplicità con la quale si affronta l’argomento. Si tratta di un lavoro
accurato dove la sapiente distribuzione dei brani e l’impiego delle fonti aiutano il
lettore a definire meglio la personalità di Dostoevskij.
N. 36, 4 luglio:
• Tommaso Landolfi, Inediti di Tolstoi, p. 6.
283
L’A. presenta il volume di Nikolaj Gay I miei rapporti con Tolstoi e la sua
famiglia, edito dalla casa editrice Sansoni di Firenze nel 1936, in cui sono pubblicate
64 lettere inedite di Lev Tolstoj, indirizzate al figlio del celebre pittore, nella
traduzione di M. Bonfantini e G. Zamboni.
N. 45, 5 settembre:
• Tommaso Landolfi, Pusckin e i suoi esegeti, con una serie di
illustrazioni di Kuzmin realizzate per la versione italiana dell’Eugenio
Oneghin eseguita da Ettore Lo Gatto, graziosa imitazione della maniera
di disegnare di Pusckin, p. 3.
Bilancio della letteratura critica su Puškin sviluppatasi negli ultimi anni da Pisarev
e Merežkovskij a Mirskij.
• Alberto Viviani, L’Oneghin in italiano, p. 3 e 4.
Dopo un’approfondita descrizione della personalità di Ettore Lo Gatto e del suo
prezioso contributo alla cultura italiana, Viviani sottolinea le sue doti artistiche nel
ruolo di traduttore ma anche di poeta, rifacendosi alla celebre versione dell’Evgenij
Onegin eseguita nel 1937 per la Bompiani.
• G. B., La Polonia contro il bolscevismo. Recensione a: Adamo Koc:
La Polonia contro il bolscevismo. Introduzione e traduzione dal polacco
di Leonardo Kociemski. Firenze, G. Beltrami Editore, 1937, A. XV, L.
3, p. 4.
Anno VI- 1938
N. 15, 6 febbraio:
• Arnaldo Frateili, Il vivaio degli Ebrei in Polonia con fotografie
d’epoca a Wilno, pp. 1-2.
N. 24, 10 aprile:
• Francesco Bruno, Polonia, frontiera d’Europa, p. 7.
N. 32, 5 giugno:
• Giuseppe Donnini, Tolstoi e Dostoievskij visti da Merezkovskij, p. 7.
N. 36, 3 luglio:
• S.a. Come Massimo Gorki fu assassinato di…morte naturale, con due
foto d’ epoca. Dall’incartamento giudiziario del processo Yagoda, pp. 1
e 3.
In occasione del secondo anniversario della morte di Gor’kij avvenuta a Mosca nel
giugno del 1936, quando lo scrittore rientrava dalla Crimea, dove aveva trascorso
l’inverno, l’articolo descrive nei dettagli le circostanze del suo assassinio reso noto con
284
l’arresto di Jagoda e il conseguente processo.
N. 39, 24 luglio:
• Carlo Magi-Spinetti, Lo zar non è morto, con una fotografia del
maresciallo Tukacewski dello Stato durante la visita da lui fatta a Parigi
in rappresentanza dello Stato Maggiore Sovietico prima di essere
processato e fucilato, p. 8.
Il contributo descrive le personalità di Lenin e Stalin, riportando alcuni brani tratti
dai seguenti volumi: Essad Bey Lenin, Milano, Treves, (non viene indicata la data) e
Essad Bey, Giustizia rossa. I processi politici nell’U.R.S.S., Firenze, Sansoni, (non
viene indicata la data).
N. 47, 18 settembre:
• Nené Centonze, Il piccolo Gesù di Praga, con disegni di Gentilini, p.
3. Racconto.
N. 51, 16 ottobre:
• Giuseppe Donnini, Mussorgskij, il Dioniso della steppa, con 2 ritratti
dell’ artista, p. 5.
L’A. presenta il volume di Oskar von Riesemann Mussorgskij. La vita e le Opere.
(Torino, G. B. Paravia, 1938), sottolineando la capacità di Riesemann di conciliare
l’analisi scientifica della vita e delle opere del celebre musicista, sulla base
d’importanti e corpose fonti, con una partecipata e intensa descrizione dell’ambiente
spirituale e artistico, che ne fa da sfondo.
Anno VII- 1939
N. 10, 1 gennaio:
• Francesco Capiello, Avventura in Bulgaria con illustrazioni di
Gentiloni, racconto, pp. 5-6.
N. 6, 5 febbraio:
• Nicola Gogol, Roma con disegni di Gentilini, pp. 5-6. (continuazione)
N. 7, 12 febbraio:
• Nicola Gogol, Roma con disegni di Tamburi, pp. 3-4. (continuazione)
N. 8, 19 febbraio:
• Nicola Gogol, Roma con disegni di Tamburi, p. 5 (continuazione)
N. 9, 26 febbraio.
• Nicola Gogol, Roma con illustrazoni di Gentilini, p. 5 (continuazione).
N. 10, 5 marzo:
• Nicola Gogol, Roma con illustrazioni di Gentilini, pp. 5 e 7 (Fine).
285
N. 24, 11 giugno:
• Gino Sottochiesa, La Polonia polveriera ebraica con una caricatura
antisemita polacca, p. 6.
Sulla base di recenti informazioni inviate da Varsavia ai circoli ebraici di tutta
Europa, l’A. riassume in breve i punti del programma politico, proposti dai circoli della
massoneria ‘giudaico-internazionale’ di Parigi, Londra e Washington, e messi in atto
dalla comunità ebraica della Polonia: 1. rafforzare la lotta all’antisemitismo facendo
leva sui sentimenti anthitleriani e antifascisti degli ambienti democratici polacchi, 2.
facilitare l’afflusso di capitali internazionali ebraici in Polonia; 3. presentare la Russia
sovietica come il naturale difensore della Polonia e rafforzare i rapporti diplomatici con
essa; 4. far credere che l’attuale governo staliniano rappresenti le tendenze demonazionaliste contro quelle internazionaliste di Trockij; 5. far pressione sul Governo di
Varsavia affinché non scenda a compromessi con la Germania sulla questione di
Danzica; 6. organizzare al più presto i partiti democratici per farli salire al Governo
polacco.
N. 35, 27 agosto:
• Gino Sottochiesa, Il misterioso Dante di Merejkovski, p. 2.
L’A. presenta il volume di Merežkovskij dedicato alla figura di Dante e
recentemente tradotto in italiano da Rinaldo Küfferle per Zanichelli. Dopo aver
sottolineato la fedeltà della traduzione, il critico evidenzia l’eccessiva laboriosità dello
scrittore russo nel descrivere la personalità di Dante.
N. 37, 10 settembre:
• Riccardo Miceli, La Polonia. Strana storia di uno strano popolo, con
una foto del sepolcro di re Casimiro III nel duomo di Cracovia, il duomo
di Cracovia com’era nel ‘400 e un antico sigillo della città di Cracovia,
p. 4.
Breve storia degli Slavi e del popolo polacco.
Anno VIII – 1940
N. 24, 7 aprile:
• Leonida Baroni, Tolstoi in pace e in guerra, con foto d’epoca, p. 4.
N. 38, 14 luglio:
• D.D.S., In Boemia, Moravia e Slovacchia, p. 6.
Si tratta della presentazione del volume di Lo Gatto pubblicato dalla Società
Nazionale “Dante Aighieri” per la Civiltà Italiana nel mondo nel 1939 e considerato la
più informata, ampia ed esauriente pubblicazione sull’argomento apparsa in Italia,
realizzata con un raffinato stile espositivo e arricchita da considerevoli fonti
documentarie.
N. 37, 15 dicembre:
286
• Riccardo Miceli, Il viandante e la morte con fotografie d’epoca di
Tolstoj, p. 5.
Attraverso una serie di ricostruzioni e di paralleli con la vicenda biografica di
personaggi insigni del passato l’articolo indaga le ragioni che condussero Tolstoj alla
fuga da casa e dalla famiglia e cerca di fare chiarezza sul mistero, che avvolge la sua
morte avvenuta nel 1910 in una piccola stazione ferroviaria della Russia.
Anno IX- 1941
N. 18, 2 marzo:
• Konstantin Velickov, Quando la Bulgaria divenne un nuovo mondo
con una fotografia di Padre Paisij, fondatore della moderna letteratura
bulgara, pp. 1e 4.
Breve storia della Bulgaria.
• Enrico Damiani, traduzione: Konstantin Velickov, Canti bulgari, p. 4.
N. 25, 20 aprile:
• Riccardo Miceli, Dalmazia italiana, p. 3.
Contributo sulle radici italiane e sulla presenza della cultura italiana in
Dalmazia.
• S.a. Monumento del fanatismo jugoslavo, (s.n.p.).
N. 43, 24 agosto:
• Franco Gismondi, Stalin regista, con l’effige di Stalin tratta da un
manifesto dell’Ucraina meridionale, p. 1.
Articolo particolarmente critico nei confronti del nuovo provvedimento adottato
da Stalin per liquidare la N.E.P. introdotta da Lenin nel 1922 e relativo al pagamento
delle tasse arretrate e all’emissione di nuovi prestiti bancari.
N. 44, 31 agosto:
• La Redazione, Ukraina spazio vitale, con una cartina geografica e una
foto di costumi popolari ucraini, pp. 3 e 6.
Breve storia dell’Ucraina dalla campagna di Russia di Napoleone alla I guerra
mondiale.
N. 51, 19 ottobre:
• Franco Gismondi, Documenti della “tolleranza” religiosa in Russia,
p. 1.
L’A. ripropone alcuni brani, tratti dal saggio dello scrittore americano Eugene
287
Lyons, edito in italiano dai Fratelli Bocca a Milano nel 1940, che si riferiscono a ciò
che il Presidente americano Roosvelt, in occasione di un celebre discorso, definì
“tolleranza religiosa in Russia”.
N. 56, 23 novembre:
• Gino Sottochiesa, Gli architetti italiani in Russia con fotografie di
monumenti architettonici in Russia, p. 6.
Sulle tracce lasciate in Russia dagli architetti italiani, con particolare riferimento
agli artisti del Cremlino Aristotele Fioravanti, Pietro Antonio Solari e Marco Ruffo, e
di San Pietroburgo, Mario Fontana, Domenico Trezzini e Bartolomeo Rastrelli.
Anno X-1942
N. 29, 17 maggio:
• La Redazione, Ilia Eremburg, Londra vista da uno scrittore russo: Ilia
Eremburg, pp. 1 e 3.
Si tratta di ricordi personali dello scrittore su aspetti di vita quotidiana a Londra
con una dettagliata e ampia descrizione di alcuni quartieri della città.
N. 31, 31 maggio:
• Gino Sottochiesa, Il mostro bolscevico, pp. 1-2.
L’A. traccia un profilo negativo del bolscevismo, definendolo un movimento
dall‘“atavica e primigenia natura antimorale e materialistica, il cui filone moscovita è
costituito dal un congenito e insopprimibile russismo fatto di barbarie tartarica e spirito
antieuropeo”.
• R. [iccardo] Mic. [eli], Russia malassata, p. 1.
•
L’A. descrive lo scontro fra le truppe antibolsceviche dell’Asse e l’esercito di
Timošenko a Karkov, conclusosi con la sconfitta dell’esercito di Stalin e dal quale la
Russia uscì “malassata”, cioé stemperata nella resistenza al nemico.
N. 44, 30 agosto:
• Giuseppe Donnini, Poeti croati moderni. Recensione a: Poeti croati
moderni a cura di Luigi Salvini. Collezione «Stelle dell’Orsa», Garzanti,
Milano 1942, sotto gli auspici dell’Istituo per le Relazioni Culturali con
l’Estero, p. 4.
L’A. presenta il recente volume sulla poesia croata dell’Ottocento curato da Luigi
Salvini. Nel suo profilo storico-critico il critico si sofferma su alcuni nomi, Petar
Preradović, Ivan Mažuranić, Silvije Strahimir Kranjčević, August Harambašić e
August Šenoa, con un approfondimento sull’attività divulgativa e traduttiva dei poeti
italiani Ungaretti, Montale e Cardarelli ad opera di alcuni italianisti croati. L’A. elogia
le traduzioni di Salvini.
288
Anno X – 1943
N. 16, 14 febbraio:
• Lorenzo Buonacorsi, Panorama delle amicizie. La Bulgaria, pp. 1-2.
Profilo storico, geografico e politico della Bulgaria con una parte dedicata al canto
popolare.
N. 19, 7 marzo:
• R.[iccardo] Mic.[eli], Mete della Russia, pp. 1-2.
Dopo una breve introduzione sul fallimento delle teorie di Vico e Herder relative
all’opportunità di stabilire leggi storiche, che regolino il comportamento degli uomini,
l’autore cerca di provare come in certi casi, applicando il criterio della
somglianza/analogia alla storia dei singoli popoli, si possa ricavare una teoria che
giustifichi l’origine del bolscevismo dall’imperialismo zarista.
N. 36, 4 luglio:
• Lorenzo Buonacorsi, La Croazia, pp. 1 e 4.
Breve storia della Croazia.
289
“Pègaso” (Ugo Ojetti, 1929-1933)
I - 1929
Fasc. 1 – gennaio:
• Mario Labroca, Strawinski musicista classico, pag. 61-64.
Dopo una breve introduzione sull’arte di Igor’ Stravinskij e sui recenti successi
del Concerto per piano e orchestra, l’Oedipus e il balletto Apollo Musagete, l’A. cerca
di definire l’originalità del compositore russo individuandola nella straordinaria
creazione di melodie, di contrappunti e ritmi e nel tessuto connettivo di una musica,
che va oltre certi aspetti esteriori a lui più volte riconosciuti come la tematica popolare
russa e l’anima grottesca.
III – 1931
Fasc. 4 – aprile:
• Leone Ginzburg, Contributo alla celebrazione di Dostoevskij, pag.
385-407.
In occasione del cinquantenario della morte dello scrittore, l’articolo ripercorre le
principali tappe di un filone di studi, che a partire dal 1921, grazie all’apertura al
pubblico degli archivi storici e di manoscritti fino ad allora inaccessibili, hanno
contribuito a fare chiarezza su aspetti oscuri della sua vita privata e a sfatarne alcuni
miti. In particolare, l’A. fa riferimento al secondo volume dell’epistolario a cura di A.S.
Dolinin, edito a Mosca nel 1930.
Fasc. 7 – luglio:
• Ugo Ojetti, Paderewski alla Scala, pag. 91-92.
Breve nota informativa sul concerto del 21 giugno eseguito all’età di settantuno
anni dal compositore polacco Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) al Teatro alla Scala
di Milano.
Fasc. 10 – ottobre:
• S.a. La notte del 12 marzo 1917 a Pietrogrado. Racconto, pp. 425427.
• Leone Ginzburg, Trotskij storico della rivoluzione, pp. 436-450.
Presentazione del volume, edito a Berlino nel 1931, sulla storia della rivoluzione
russa, in particolare sulla nascita del “soviet”, consiglio dei deputati direttamente
rappresentato da operai, soldati e contadini, presentato come fenomeno legato a una
necessità storica. Il volume prosegue con l’esaltazione della personalità di Trockij e
della sua concezione della storia, di cui l’A. sottolinea l’eccessiva impostazione
290
marxista e antiborghese.
IV - 1932
Fasc.1 – gennaio:
• Leone Ginzburg, recensione a: Elisabetta Narischkin – Kurakin, Sotto
tre Zar. Memorie di una Marescialla di corte, Firenze, Bemporad, 1931,
pp. 125-128.
Memorie di Elisabetta Naryškin, nobildonna russa morta recentemente a Parigi,
pubblicate da R. Fülop-Müller e tradotte da Luigi Bandini all’interno della collana “La
storia romanzesca”. L’A. ne sottolinea l’importanza documentaria per il periodo che va
dalla rivoluzione francese del 1848 alla rivoluzione russa del 1917.
Fasc. 2 – febbraio:
• S. a. Larissa (A Pietrogrado, nel novembre 1917), racconto, pp. 162171.
Fasc. 7 –luglio:
• S. a. Hotel Astoria (Pietrogrado 1916-1917), racconto, pp. 75-99.
Fasc. 10 – ottobre:
• Leone Ginzburg, recensione a: Isacco Babel, L’armata a cavallo.
Traduzione dal russo di Renato Poggioli, Biblioteca Europea, diretta da
Franco Antonicelli, ed. Frassinelli, Torino 1932, pp. 504-506.
Nella recensione si sottolinea la straordinaria capacità di Poggioli di rendere in
italiano espressioni e termini russi poco accessibili, superando gli ostacoli della resa di
vocaboli dialettali o di parole straniere che, tradotte in italiano, acquistano una
maggiore rilevanza. Nella seconda parte, l’A. evidenzia alcuni aspetti dell’“epicità” di
Babel’, tema già affrontato in precedenza dallo slavista in un articolo pubblicato sulla
“Rivista di letterature slave”335.
Fasc. 11 – novembre:
• Eugenio Giovannetti, Plotyka o L’ Anti-Hollywood, pag. 606-612.
Il contributo è dedicato all’inaugurazione della nuova città del cinema statale in
Russia, Plotyka, denominata anche l’Anti-Hollywood. L’evento inaugura una nuova
era del cinema sovietico, da quest’anno non più strumento di propaganda ma parte
integrante del “piano quinquennale”.
Fasc. 12 – dicembre:
335
Cfr. Renato Poggioli, Un’epopea rossa: “Konarmija di I.
Babel’”, “Rivista di letterature slave”, anno V, fasc. IV,
luglio-agosto1930, pp. 295-302; Id., “Ibidem”, anno V, fasc.
VI, novembre-dicembre 1930, pp. 471-480 (continuazione);
Id., “Ibidem”, anno VI, fasc. IV, luglio-agosto 1931, pp. 261274.
291
• Anonimo, Pagliari Augusto, mio amico (A Pietrogrado, nel novembre
1917), pag. 674-685.
• Leone Ginzburg, I romanzi del piano quinquennale, pp. 738-743.
Sulla comparsa in Russia dei romanzi ambientati al tempo del “piano
quinquennale”, una nuova corrente letteraria rappresentata da Leonid Leonov (Sot’),
Boris Pil’njak (Volga vpadaet v Kaspijskoe more), Vsevolod Ivanov (Putešestvie v
stranu, kotoroj eščë net), Marietta Šaginjan, (Gidrocentral’).
V - 1933
Fasc. 05 – maggio:
• Renato Poggioli, Quadrumvirato del palcoscenico russo, pg. 570
292
“Pan. Rassegna di lettere arte e musica” (Ugo Ojetti, 19331935)
Anno II 1934
Fasc. 2 –febbraio:
• Renato Poggioli, ‘Notizie’. Letteratura russa, p. 479.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente in Russia. Si
menzionano: l’edizione definitiva del Polnoe sobranie di Tolstoj con l’epistolario dal
1899 al 1900 più circa 250 lettere inedite, edizioni di Stato; Polnoe sobranie di V.
Garšin con un epistolario; un racconto di Černyševskij, un saggio di G. Čulkov
dedicato a Fëdor Tjutčev, la biografia dedicata dallo storico e critico S. Reisser ad
Artur Bennie, protagonista di Zagadočnyj čelovek di Leskov; Polnoe sobranie di
Velimir Chlebnikov, a cura del Sindacato degli Scrittori di Leningrado; il romanzo
Podrostok di Levin; il secondo volume della raccolta periodica di saggi su Dostoevskij
a cura di Alfredo Polledro per le edizioni “Orbis” di Praga più vari studi sullo scrittore
di Alfred Bem e Jiří Horák; notizia del premio Nobel a Ivan Bunin.
Fasc. 3 – marzo:
• Guido M. Gatti, Il mito di Nijinsky, con disegni di Paul Iribe e Maxime
Dethomas, racconto, pp. 567-575.
Fasc. 4 – aprile:
• Renato Poggioli, ‘Notizie’. Letteratura russa, p. 795.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente in Russia.
Ricordo di Andrej Belyj, di cui si segnala la sua ultima opera Načalo veka uscita a
stampa nel 1933 per le edizioni di Stato; volume in tedesco su Vasilij Žukovskij scritto
da Ellis (Lev) Kobylinskij, filosofo e scrittore dell’emigrazione, discepolo di Solov’ëv;
pubblicazione dell’edizione praghese della prima raccolta completa di versi inediti di
A. Chomjakov, fondatore della dottrina slavofila, curata dal prof. Francev per la
“Orbis”; numero speciale della rivista moscovita Literaturnoe nasledstvo dedicato alla
letteratura russa del ‘700 a cura dell’ex- principe Mirskij; ultimo romanzo di M.
Zoščenko Vozvraščënnaja molodost’ pubblicato a puntate su “Zvezda”.
Fasc. 5 – maggio:
• S.a. Nikita: Pietrogrado 1917, racconto, pp. 99-120.
Fasc. 6 – giugno:
• S.a. Nikita: Pietrogrado 1917, continuazione e fine, pag. 242-266.
• Renato Poggioli, ‘Notizie’. Letteratura russa, p. 319.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente.
Pubblicazione a San Pietroburgo del racconto satirico sulla corte di Nicola I di Juryj
Tynjanov Molodoj Vituščišnikov; un’autobiografia di Michail Prišvin pubblicata a
293
Mosca; il nuovo romanzo di Vsevolod Ivanov Pochoždenija fakira pubblicato a puntate
su “Literaturnaja Gazeta”; i Rasskazy znamenosca Ilina di Fëdor Raskol’nikov,
documento lirico sulla flotta della Marina rossa, pubblicato a Mosca e San Pietroburgo;
pubblicazione a Mosca del primo volume della raccolta completa di opere e lettere
inedite di Michail Bakunin.
Fasc. 8 –agosto:
• Renato Poggioli, ‘Notizie'. Letteratura russa, p. 635.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente.
Pubblicazione per le collezioni di “Payot” di una Histoire de la littérature russe, frutto
della collaborazione di tre autorevoli critici emigrati, M. Hofmann, G. Lozinskij e C.
Močulskij, già docenti presso l’Università di San Pietroburgo; ritrovamento e
pubblicazione a San Pietroburgo della seconda parte, completamente inedita, del
Rossijskij Gilblaz, ili Pochoždenija knjazja Gavrily Simonoviča Čistjakova di Vasilij
Trofimovič Narežnyj da parte delle edizioni di Stato” nella redazione completa;
pubblicazione della seconda parte di Pëtr I di Aleksej Tolstoj; pubblicazione
dell’Opera Poetica di Boris Pasternak per la “Casa Editrice degli Scrittori di
Leningrado”; pubblicazione a San Pietroburgo del recente volume di Benedikt Livšic
Polutoraglazyj strelec; nell’ultimo fascicolo del “Convegno” Alessandro Pellegrini
tributa un omaggio al poeta russso Vjačeslav Ivanov, rifugiato in Italia e convertito al
Cattolicesimo, noto in Europa dopo la Rivoluzione.
Fasc. 11 – novembre:
• Guido Piovene, Venceslao Ivanov, Numero unico della Rivista «Il
Convegno», Milano, 1934, L. 12, pp. 463-465.
Profilo sul pensiero filosofico dello scrittore sulla base di un fascicolo pubblicato
in suo onore, compilato da Alessandro Pellegrini e contenete alcune poesie in
traduzione italiana. Il pensiero di Ivanov viene riassunto in due considerazioni: che nel
mondo moderno il culto dell’antico sarebbe rinato due volte, nel Rinascimento italiano
e nel Romanticismo, mentre una terza ‘rinascita’ spetterebbe alla razza slava; e che la
cultura può considerarsi “libera” finché mantiene un legame con spiritualità e
religiosità.
Anno III 1935
Fasc. 02 – febbraio:
• E. Vittorini, Russia rossa che ride. Novelle e aneddoti sovietici di
Lorenzo Gigli, pag. 310.
Fasc. 5 maggio:
• Renato Poggioli, ‘Notizie’. Letteratura russa, p. 155.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente: A.C. Makiev,
Il Dio della guerra, il barone Ungern, pubblicato a Shanghai, sulla guerra civile in
Siberia e Mongolia, e Lesnik (Il guardaboschi); Sergej Sergeev Zienskij, Il rumore
della Foresta; La fidanzata di Puškin, Scrittori Riuniti, Leningrado; Abram Efros, Il
teatro Kamernyj ed i suoi artisti, Soc. Gen,. Teatrale Russa, Mosca, pubblicazione in
occasione del ventesimo anniversario del Tetaro Kamernyj di Aleksandr Tajrov; Ivan
294
Bunin (Premio Nobel 1934), Opera Completa, Petropoli, Parigi; Igor’ Stravinskij,
Ricordi (Chronique de ma vie), Parigi, Denoel & Steele.
Fasc. 7 – luglio:
• Renato Poggioli, ‘Notizie’. Letteratura russa, p. 479.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente.
Pubblicazione del quinto volume di Storia della letteratura russa di E. Lo Gatto,
edizioni A. R E., Roma, dedicato maggiormente a Gogol’; per le edizioni Akademija di
Mosca pubblicazione delle poesie e dell’epistolario di Alexandr Odoevskij e delle
poesie di Pëtr Andreevič Vjazemskij; pubblicazione del dramma Pëtr Velikij di Aleksej
Tolstoj per le edizioni Scrittori Riuniti di San Pietroburgo; pubblicazione del romanzo
di Boris Pil’njak Roždenie čeloveka per le edizioni Novyj Mir di Mosca.
Fasc. 09 – settembre:
• Renato Poggioli, ‘Notizie’. Letteratura russa, p. 159.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente.
Pubblicazione dei drammi e delle tragedie di Lermontov per le edizioni Akademija di
Mosca; volume di Vladimir Boutčik Bibliografie des oeuvres littéraires russes traduits
en française, pubblicato dalla Librairie Orobitg di Parigi; Michail Osorgin, I Libri degli
Epiloghi, Maison du livre, Paris.
Fasc. 11 – novembre:
• Guido M. Gatti, Adrian Stokes, To-night the Ballet; Russian Ballets. –
Faber & Faber, London, 1934. Sc. 3/6; Russian ballets – id., id., Sc. 7/6;
Arnold L. Haskell, Balletomania- Gollancz, London, 1935. Sc. 18;
Diaghilev: his artistic and private Llife. – id., id., id. Sc. 12/6, pp. 392395.
L’A. presenta il volume di Adrian Stokes partendo dalla definizione di ‘balletto’
come risultato del rapporto tra musica e danza (coreografia), tempo e ritmo
(sincronismo) ed espressione (illustrazione mimica). Poi passa alla descrizione del
saggio di Haskell sulla vita di Sergej Djagilev, dopo il quale il centro di
rappresentazione teatrale si era spostato da Parigi a Londra.
• Renato Poggioli, ‘Notizie’. Letteratura russa, p. 400.
Brevi notizie bibliografiche sulle novità editoriali dell’anno corrente.
Pubblicazione del primo volume di abbozzi e quaderni di Fëdor Dostojevskij nella sua
edizione definitiva per le edizioni Akademija di Mosca; nota informativa sul
venticinquesimo anniversario della morte di Lev Tolstoi festeggiato a novembre in
Russia; pubblicazione del romanzo Guljaščie ljudi di Aleksej Pavlovič Čapygin per le
edizioni “Goslitizdat” di Mosca; nota informativa sulla morte improvvisa di Boris
Poplavskij, poeta e narratore dell’emigrazione, autore del romanzo Apollon
Bezobrazov, con una biografia del poeta.
Fasc. 12 – dicembre:
• Wladimir Weidlé, Letteratura sovietica e letteratura russa, pp. 411417.
295
Analisi degli effetti che la rivoluzione del 1917 ha avuto sulla letteratura e sulla
cultura russa dei primi anni del secolo. In particolare, il critico evidenzia una
contraddizione interna al fenomeno: mentre la letteratura russa dell’Ottocento è riuscita
a sopravvivere e a consolidarsi, il regime sovietico ha imposto dal 1928-29 una
letteratura all’ordine del partito, che per la sua negazione dei valori di libertà e
creatività, inscindibili dall’attività letteraria, equivale a una “non-letteratura”.
296
“Solaria” (Alberto Carocci, 1926-1934)
III - 1928
Fasc. 1- gennaio:
• Giansiro Ferrata, recensione a : Georges Duhamel, Le Voyage de
Moscou, Mercure de France, pp. 57-58.
L’A. presenta il volume sul viaggio di Luc Durtain e Georges Duhamel in Russia
definendolo “una dettagliata analisi del paese”, un resoconto sui questioni irrisolte e
dilemmi ancora vivi, che ha i contorni della cronacha, lontana dalla retorica e dalle
false credenze. Il volume, secondo Ferrata, ha il merito di far emergere la vera anima
russa.
Fasc. 12 – dicembre:
• Giansiro Ferrata, Centenario di Tolstoi. Zibaldone, pp. 42-45.
L’articolo è dedicato allo scrittore nel centenario della sua nascita attraverso una
rilettura degli scritti dedicati alle teorie sulla creazione artistica, composti nell’ultimo
periodo, e in costante parallelo con la vita di Dostojevskij.
IV - 1929
Fasc. 06 – giugno:
• Giansiro Ferrata, recensione a: Nicola Evreinoff, Il teatro nella vita,
Alpes, Milano, 1929, p. 60.
Breve contributo sul saggio di Evreinov dedicato al teatro, considerato dallo
scrittore “terapia dei mali dell’anima” ed “espressione dei rari attimi di libertà, che la
vita riserva all’uomo”.
V -1930
Fasc. 7-8 – luglio-agosto:
• Renato Poggioli, Vladimiro Majakovskj, pp. 55-58.
Profilo di Vladimir Majakovskij, artista e poeta ufficiale della Rivoluzione,
suicida come Esenin, con un potente senso della personalità e una concezione teatrale
della vita trascorsa in una “costante atmosfera di trionfi e applausi”.
Fasc. 11 – novembre:
• Aldo Capasso, recension a: K. Fedin, I fratelli. Torino, Slavia.
Traduzione di Valentina Dolghini Badoglio, 2 voll., L. 20, pp. 55-59.
L’A. presenta Brat’ja di Konstantin Fedin, esponendo la trama dei capitoli
principali e sottolineando l’evidente influenza della tecnica narrativa di Dostoevskij
297
nella prima parte del romanzo.
VI - 1931
Fasc. 1, gennaio:
• R. Poggioli, traduzione: Osip Mandel’štam, Sole e miele, p. 37.
• R. Poggioli, traduzione: Osip Mandel’štam, Phèdre, p. 38.
Fasc. 2- febbraio:
• Elio Vittorini, recensione a: Curzio Malaparte, Intelligenza di Lenin,
Treves Editori, Milano, pp. 56-60.
Il volume di Malaparte presenta la Russia di Lenin, bolscevica e rivoluzionaria, a
confronto con l’Europa di Candide, liberale e borghese, ancorata ai miti della
rivoluzione francese. L’A. considera il saggio un “ ritratto morale della Russia
contemporanea sotto forma di commedia intellettuale”.
• Giuseppe Raimondi, recensione a : V. V. Rozanov, L’ Apocalypse de
nôtre temps, précédé de Esseulement, Librairie Polon, Paris, 1930 ; 15
franchi, pp. 67-68.
L’A. paragona Rozanov al protagonista della prima parte del romanzo di
Dostoevskij Zapiski iz podpol’ja, considerandolo un “personaggio mistico,
autobiografico, lirico e apocalittico”; poi, segnala l’introduzione al volume a cura di
Boris de Schloezer, dove si cerca di chiarire la figura di Rozanov collocandola a metà
tra scrittore e filosofo.
VII - 1932
Fasc. 2 – febbraio:
• Renato Poggioli, In margine alla prosa di Puškin, pp. 43-50.
Nell’articolo, che è una recensione alla raccolta di novelle tradotte da Leone
Ginzburg, l’A. ripercorre la produzione in prosa di Puškin, evidenziandone una
peculiarità, presente anche nell’Onegin e in buona parte della produzione letteraria
europea del primo Ottocento: l’epigrafe intesa come parte integrante del testo.
Fasc. 4 – aprile:
• Leo Ferrero, recensione a: Leon Tolstoi, La Guerre et la Paix (4 voll.)
– Nouvelle traduction par Louis Cousserandot – Payot, Paris, pp. 62-64.
Nella presentazione del volume in lingua francese, l’A. sottolinea l’ottima
traduzione dal russo, confrontandola con una precedente firmata da Bienstock, e
l’interessante introduzione storica.
Fasc. 7-8 – luglio-agosto:
• Angelo Barile, Raccordo Goethe-Tolstoi, pp. 46-49.
Breve intervento su alcuni aspetti del pensiero filosofico e della tecnica
narrativa, che avvicinano gli scritti di Goethe a quelli di Tolstoj.
298
VIII - 1933
Fasc. 1 – gennaio:
• Renato Poggioli, Gli esiliati della cultura, pp. 45-54.
Nella prima parte l’A. illustra la scena culturale presente in Russia all’inizio del
secolo, menzionando il teatro di Djagilev, le scenografie di Bakst, la pittura di
Vrubel’, l’estetismo di Brjusov, il misticismo di Merežkovskij. Nella seconda parte
approfondisce il percorso artistico dei simbolisti Belyj, Ivanov, Blok fino ad Anna
Achmatova.
IX - 1934
Fasc. 2 – marzo-aprile:
Giacomo Antonini, Gogol, pp. 38-51.
La biografia di Gogol’, rivisitata da Antonini alla luce del continuo dissidio
interiore tra sogno e realtà vissuto dall’artista nel corso della sua carriera e sulla base
degli studi condotti da Boris de Schloezer.
Fasc. 4 – luglio-agosto:
• Giacomo Antonini, Appunti su Remizov, pp. 84-89.
Enucleando i momenti più significativi della complessa vicenda biografia di
Remizov, l’A. evidenzia l’atteggiamento irriverente mostrato dalla critica letteraria
contemporanea nei confronti delle sue opere, soffermandosi sui racconti di contenuto
popolaresco e mitico-leggendario.
299
300
“Leonardo. Rassegna
Gentile, 1930-1947)
bibliografica
mensile”
(Federico
Anno I (1930)
Fasc. 10, ottobre:
• E. Damiani, recensione a: Enrico Pappacena, Gogol (Opera-Vita). In16. pp. 718 – Milano, Corbaccio, L. 16, p. 640.
L’A. presenta il volume come “un’opera modesta di modeste pretese”, un grosso
zibaldone di notizie sullo scrittore, sulle sue opere, minuziosamente analizzate e
sviscerate nei contenuti, e anche sulla critica letteraria dell’epoca ma prolisso nei
dettegli e ricco di considerazioni e riflessioni personali, a volte inopportune. Evidenzia,
poi, alcuni errori di trascrizione.
Fasc. 12, dicembre:
• E. Damiani, recensione a: A. Kuprin, Il capitano Rìbnicov ed altri
racconti. Tradotti dall’originale russo da Maria Rakowska e Giuseppe
Pochettino. Vol. I. In-16, di pp. 175. Lanciano, R. Carabba, L. 6, pp.
802-803.
Si tratta di un volumetto con tre racconti di Kuprin molto diversi l’uno dall’altro:
il primo narra di un ufficiale giapponese, Rybnikov, che si traveste da capitano russo
per compiere azioni di spionaggio; il secondo, Olessia, in cui fa capolino l’elemento
soprannaturale della tradizione popolare come in alcuni romanzi di Turgenev; l’ultimo
è una specie di bozzetto a sfondo psicologico. Giudizio positivo dell’A. sia per
l’apparato critico-introduttivo, sia per la veste grafica;
Anno II (1931)
Fasc. 5, maggio:
• Cesare Spellanzon, La Russia e la rivoluzione bolscevica nei libri più
recenti, pp. 193-196.
Rassegna delle maggiori pubblicazioni sulla rivoluzione bolscevica. Il critico si
sofferma sulle memorie di Alessandro Kerenskij, pubblicate per la collezione “Payot” e
destinate a fornire un prezioso materiale per la storia della prima guerra mondiale e per
i primi mesi della rivoluzione, immediatamente anteriori al trionfo del bolscevismo.
• Wolfango Giusti, Dostoievskij e il tipo slavo, pp. 197-198.
L’A. ridimensiona l’immagine di Dostoevskij come “stereotipo dell’anima slava”,
molto diffusa in Occidente. Partendo dalla considerazione che l’identità slava non
esiste se non in alcune somiglianze fra le lingue, l’A. riconduce la “slavofilia” di
Dostoevskij agli ideali dell’autocrazia ortodossa russa.
Fasc. 12 , dicembre:
301
• Wolfango Giusti, recensione a: K. M. Ciapek-Chod, La turbina, vol.
II; trad. in italiano da Jolanda Torraca Vesela – Torino, Slavia, 1931, pp.
558-559.
Breve segnalazione bibliografica del romanzo dello scrittore ceco, di cui l’A.
loda la traduzione italiana firmata da Jolanda Vesela.
• Renato Poggioli, recensione a: Eugenio Zamjatin, Mister Kemble (La
società degli onorevoli campanari). In-16. Trad. di C. Perris, introd. di
E. Lo Gatto. Collezione “Teatro Russo Contemporaneo”, I. – Roma,
Anonima Romana Editoriale, 1931. L. 5, pp. 561-562.
L’A. presenta il volume, lodandone sia la traduzione, nonostante gli errori nella
trascrizione dei nomi inglesi in cirillico, sia l’introduzione di Lo Gatto.
Anno III (1932)
Fasc. 10, ottobre:
• Renato Poggioli, recensione a: Wolfango Giusti, Aspetti della poesia
polacca contemporanea in “Piccola Biblioteca Slava”, XXIII. Roma,
Istituto per l’ Europa Orientale, 1932, in-16, L. 5, pp. 446-447.
Si tratta di una rassegna di autori e generi della poesia polacca contemporanea, di
cui l’A. evidenzia il validissimo apparato critico-introduttivo di Wolf Giusti.
Fasc. 11, novembre:
• Carlo Morandi, recensione a: Rodolfo Mosca, Russia 1932. Milano,
Agnelli, 1932, pp. 258, s.i.p., pp. 514-515.
Il volume viene inserito dall’A. all’interno di recenti studi, il cui pregio è quello di
creare una continuità tra il presente e il passato della Russia, sottolineando aspetti
positivi e negativi lasciati in eredità dalla Rivoluzione.
Anno IV (1933)
Fasc. 2, febbraio:
• Lila Jahn, recensione a: Ivan Turghéniev, Lo Spadaccino. Racconti.
Torino, Slavia, 1932, in-16, pp. 277, L. 10, p. 75.
L’A. presenta l’ottavo volume delle opere complete di I. Turgenev edite dalla
Slavia; le novelle contenute e tradotte da Maria Karklina, composte tra il 1846 e il
1850, sono Lo Spadaccino, Tre ritratti, Pjetuškov, Diario di un uomo superfluo..
Fasc. 8, agosto-settembre:
• Carlo Morandi, recensione a: Aldo Mandrilli, Tra manicomio e
bolscevismo (1917-1920). Milano, Mondadori “Libri Verdi”, 1933, pp.
304, L. 6, p. 394.
L’A. presenta il volume dividendolo in due parti: la prima, dal titolo Come mi
302
liberai dalla prigionia, di puro interesse letterario, è generalmente considerata dalla
critica la migliore dal punto di vista artistico; la seconda, Quello che ho visto della
catastrofe russa, più frammentaria e meno elaborata. Il saggio è arricchito da una
pregevole documentazione fotografica.
Fasc. 11, dicembre:
• Delio Cantimori, recensione a: Gaetano Ciocca, Giudizio sul
Bolscevismo (Come è finito il Piano quinquennale) –. Milano,
Bompiani, ‘Libri scelti’, vol. XXII, 1933-XI, in-8, pp. 274, L. 12, pp.
542-543.
Il volume affronta una serie di argomenti fra i quali alcune discussioni
sull’americanismo, sulle fabbriche, sulla “povertà di Stato” e continui confronti fra
bolscevismo e liberalismo. Nella sua presentazione, l’A. evidenzia alcune
contraddizioni tra quello che Ciocca stesso annuncia nella prefazione e ciò che di fatto
sarà oggetto di analisi.
Anno V (1934)
Fasc. 3, marzo :
• Giacomo Antonini, recensione a: Ilya Ehrenbourg, Le deuxième jour
de la Création. Parigi, Gallimard, 1933, in-16 gr., pp. 367, Frs. 15, pp.
133-135.
L’intreccio del romanzo presentato dall’A. si basa sull’epocale cambiamento
apportato dalla Rivoluzione, che se ha mantenuto il pregiudizio di classe come ‘dogma’
della società ne ha pure stravolto le caratteristiche. La Rivoluzione bolscevica ha,
infatti, comportato il difficile passaggio dall’intelligencija, impersonata da Volodja, al
proletariato, rappresentato da Kolka Rjanov.
Anno VI (1935)
Fasc. 3, marzo:
• Giacomo Antonini, recensione a: Mikhail Cholokhov, Terres
défrichées. Parigi, Ed. Soc. Int., 1934, in-16, pp. 463, Frs. 15 pp. 127129.
L’A. fornisce una dettagliata descrizione del romanzo in un periodo piuttosto
critico per la letteratura russa, quando gli scrittori erano costretti a contribuire alla
riuscita del “piano quinquennale”. Il romanzo, ambientato nella regione del Don,
rappresenta una terza fase nella storia dei cosacchi: il passaggio dal regime zarista,
sotto il quale godevano di privilegi, al Comunismo.
• Giuseppe Zamboni, recensione a: Renato Poggioli, La Violetta
notturna. Antologia di poeti russi del Novecento. Lanciano, G. Carabba
ed., 1933, in-16, pp. 166, L. 7, pp. 130-132.
L’A. restituisce a Poggioli il merito di aver contribuito a colmare una lacuna nella
conoscenza della letteratura russa moderna in Italia. Dopo l’antologia di G. Gandolfi
303
del 1925, questa costituisce la seconda grande raccolta di liriche, frutto di uno studio
attento del ritmo e della rima del verso russo.
Anno VII (1936)
Fasc. 1, gennaio:
• Mario Apollonio, recensione a: Nino Berrini, L’ ultimo degli Zar. La
tragedia della famiglia imperiale russa. Azione drammatica in quattro
atti e un epilogo. Milano, Mondadori, 1934, in 16, pp. 235, L. 10, pp.
27-28.
Si tratta della rievocazione di avvenimenti passati ancora vicini nel tempo ma già
inquadrati in un periodo storico lontano e superato.
Anno IX (1938)
Fasc. 2, febbraio:
• Arturo Pompeati, recensione a: Essad Bey, Nicola II: Splendore e
decadenza dell’ ultimo Zar. Firenze, Bemporad, 1936, in 16, pp. 330,
L.18, pp. 65-66.
Il volume di Bey viene presentato non come la storia della Russia sotto l’ultimo zar
ma semplicemente come la biografia del Sovrano, arricchita da un ampio e ben
ricostruito sfondo storico.
304
“Scenario. Rivista mensile delle arti della scena” (Nicola De
Pirro, Rizzoli Editori & comp., 1932-1943)
Anno I - 1932
n. 1, gennaio 1932:
Ettore Lo Gatto, Il teatro come strumento della Rivoluzione, più due
schizzi – Mejerhold in costume di Pierrot e Isacco Rabinovic: Schizzo di
costume teatrale, pp. 51-53.
•
Bilancio dell’attività teatrale negli anni 1930-1931. Alla luce del nuovo indirizzo
ideologico in Russia, Lo Gatto riassume l’attività di Ščeglov, Janovskij, Katajev,
Ščimkevič, Nikitin, Mejerchol’d, Pogodin e Vachtangov, sottolineando la “vittoria”
della messinscena sul repertorio artistico e il costante rapporto con la politica di Stalin
e con la propaganda.
olga resnevic, recensione a: Boris Zachava: Vachtangov e il suo
Studio. Ed. Tea-Kino, Mosca, 1930, pp. 60-61.
•
L’A. segnala questo volume come un importante tributo di Zachava al suo
maestro-pedagogo teatrale Evgenij Bogratjonovič Vachtangov e agli insegnamenti
sulla personalità artistica.
• olga resnevic, Sul “Revisore” di Gogol, pp. 65.
L’A. risponde al “signor d’Amico” a proposito della storica incomprensione
teatrale del Revizor di Gogol’.
n. 4, aprile:
Eugenio Zamjatin, Il teatro sovietico, versione italiana autorizzata di
Renato Poggioli, pp. 17-24.
•
Poggioli introduce il discorso che Zamjatin pronunciò in diverse capitali europee,
evidenziando la ‘spregiudicatezza’ con cui lo scrittore giudica il teatro russo
contemporaneo. L’articolo è arricchito da un ritratto di Zamjatin opera di Annenkov,
una caricatura di Mejerchol’d, una scena di Kabale und Liebe. Ein Bürgerliche
Trauerspiel di Schiller nella versione del teatro “Vachtangov” e una scena dal film
sovietico Rispondiamo.
n. 5, maggio:
Ettore Lo Gatto, Memorie e biografie di attori russi, pp. 52-54,
fotografie di attori.
•
Recensione al volume di V. Lidin Teatral’naja Rossija (Mosca, ed.
“Sovremennye problemy”), che raccoglie alcune fra le più importanti testimonianze
biografiche di attori russi che hanno segnato la loro epoca. In particolare, l’A. si
sofferma su Michail Semjоnovič Ščepkin, le cui Memorie furono pubblicate nel 1914 a
cura di Derman in un’edizione del 1928 e di cui l’A. ricorda i rapporti con scrittori del
tempo come Griboedov, Gogol’, Puškin, Vasilij Karatygin.
n. 9, settembre:
305
• R. Poggioli, Panorama del teatro boemo, pp. 5-15.
L’A. fornisce un panorama del teatro boemo del Novecento, evidenziandone i
principali aspetti che ne accompagnano lo sviluppo. Tra i protagonisti vengono
menzionati: Jaroslav Hilbert (1871-1936), František Langer (1888-1965), Karel Čapek
e suo fratello Josef (1887-1945) e la coppia Voskovec-Werich col “Teatro liberato”
(Osvobozené divadlo).
n. 10, ottobre:
•
Ettore Lo Gatto, I cent’anni del teatro Aleksandrinskij, pp. 23-29.
Sul centenario della nascita del Teatro Aleksandrinskij di San Pietroburgo. L’A.
ne dà una testimonianza diretta, apprezzandone alcuni aspetti come le scelte operate
nella scenografia delle rappresentazioni inaugurali e nel restauro di parti del teatro,
riportate alla forma originaria dei tempi dello zarismo, e criticandone altri come
l’orientamento politico dato alla manifestazione. L’articolo è arricchito da fotografie di
allestimenti teatrali e ritratti di scrittori e attori celebri di Ottocento e Novecento.
n. 11, novembre:
•
Sergio Kara-Murza, La Duse in Russia, pp. 23-30.
L’articolo riporcorre le tappe dell'attività teatrale di Eleonora Duse in Russia, dal
primo viaggio nel 1891-92 all’ultimo nel 1908. Come sostiene l’attrice nelle sue
Memorie, “i russi son gente, che senza indecisione vuol trasformare in fatti le proprie
parole, e soffre dell’impossibilità di risolvere questo problema in tutta la sua
sovrumana complessità. Di qui la commovente bellezza spirituale dei Russi, la loro
affascinante sincerità e spontaneità”.
Ettore Lo Gatto, Bilancio 1931-1932. L’ eterno problema: teatropulpito o teatro-arte?, pp. 43-48.
•
Alcuni giudizi personali dell’A. a proposito delle considerazioni fatte dal critico
sovietico Litovskij sull’incremento in Russia delle rappresentazioni drammatiche e sul
miglioramento della qualità artistica. L’A. scorge nel repertorio di quegli anni la
costante presenza di vecchie tematiche come la crisi dell’intelligencija nella
Rivoluzione e la vittoria dell’industrializzazione. L’articolo è arricchito da fotografie di
numerosi allestimenti.
n. 12, dicembre:
• Renato Poggioli, Corriere della Cecoslovacchia, pp. 48-51.
Anno II - 1933
n. 1, gennaio:
•
Peter Scharoff, Confessioni di un regista russo in Italia, pp. 21-25.
Testimonianza dell’attore Pëtr Šarov su quanto percepito all’estero del teatro
drammatico italiano, la cui crisi viene spesso identificata nelle precarie condizioni di
lavoro, in difetti di amministrazione e nell’abitudine degli italiani a “distruggere
l’incanto della scena”, arrivando in ritardo agli spettacoli o facendo rumore per i
corridori, malcostume diffuso anche in palcoscenico fra gli attori. Foto di scena tratte
306
da Djadja Vanja, Revizor, Brat’ja Karamazovy.
n. 12, dicembre:
• Sergio Kara-Murza, Maria Taglioni in Russia, pp. 647-652.
Anno V - 1936
n. 9, settembre:
Ettore Lo Gatto, Massimo Gorkij drammaturgo (1868-1936), pp. 435438.
•
La fama di Gor’kij drammaturgo è legata a quella del Teatro di Stanislavskij, sul
cui palcoscenico furono più volte rappresentate le sue opere, in Russia e all’estero; le
principali fonti d’ispirazione risiedono nel Teatro di Nemirovič-Dančenko e nei
drammi di Čechov. Protagonista è la piccola borghesia, non il proletariato.
n.11, novembre:
•
Tatiana Pavlova, Gorkij in Italia, pp. 525-526.
Ritratto di Gor’kij dal punto di vista fisico e psicologico.
Anno VI - 1937
n. 1, gennaio:
• Renato Poggioli, Scenario di Cecoslovacchia, con un ricco repertorio
fotografico di scenografie e costumi di scena, pp. 24-30.
L’A. descrive il progetto teatrale della compagnia diretta dal regista E.F.Burian,
successore della scuola di Hilar, e dei tecnici di scena M. Kowril, J. Novotny e J.
Raban, un’attività, che ha dato vita al “Teatro del Lavoro”, fondato sul concetto di
rappresentazione teatrale come risultato di varie “esperienze di mestiere”.
n. 4, aprile:
• Renato Poggioli, Scenario di Polonia, con fotografie di alcune ribalte
di scena a Varsavia, pp. 180-183.
Bilancio della stagione teatrale di Varsavia con la descrizione degli spettacoli
allestiti al Teatro Nazionale: la “tragedia repubblicana” di Schiller Die Verschwörung
des Fiesco zu Genua, Le Mariage de Figaro di Beaumarchais con la regia di Węgierko,
le Commedie sgradevoli e le Commedie per Puritani di G. B. Shaw, particolarmente
apprezzato in Polonia anche grazie alla traduzione dei suoi drammi eseguita da
Sobienowski.
n. 6, giugno:
307
• Renato Poggioli, Scenario di Polonia, con alcune ribalte di scena, pp.
284-288.
Bilancio dell’attività teatrale in Polonia. L’A. sottolinea lo straordinario successo
del teatro fra il pubblico polacco registrato negli ultimi anni. Segreto di tale successo
sembra essere la tendenza a riadattare il testo teatrale originario e l’esempio più
rappresentativo viene considerato il rifacimento della vecchia farsa Il Soldato della
Regina del Madagascar eseguito dal poeta Julian Tuwim al “Teatro Estivo” di
Varsavia. Si menzionano anche il Višnëvy sad di Čechov al “Teatro Polacco”, Il
Corsaro e la Lady di G. B. Shaw al “Teatro Nazionale” per la regia di Ordiński,
Horsztynski di Juliusz Słowacki coi costumi di Węgrzyn e Solski, Lidé na kře di Vilém
Werner e Unordnung und frühes Leid di Thomas Mann.
n. 8, agosto:
• Renato Poggioli, Scenario di Cecoslovacchia, con alcune ribalte di
scena a Praga, pp. 388-392.
Rassegna della stagione teatrale a Praga dedicata al teatro shakespeariano: la
versione francese di Hamlet di Jules Laforgue Hamlet ou les suites de la pitié filiale,
vera novità per il pubblico praghese non ancora abituato alla parodia dei testi teatrali, e
Romeo e Giulietta, del regista Svonoda al “Teatro da Camera”.
n. 9, settembre:
• Renato Poggioli, Wyspianski, o l’utopia del dramma polacco, con un
ricco repertorio di ribalte e messinscena teatrali, pp. 430-434.
Dopo un breve introduzione sulla natura “antiteatrale” del genio slavo, dove si
conferma il “puro gioco scenico”, e sul romanticismo polacco rappresentato da
Mickiewicz, Słowacki e Krasiński, l’A. traccia la biografia artistica di Stanisław
Wyspiański, pittore e drammaturgo, scenografo e costumista, considerato il fondatore
del teatro in Polonia.
n. 12, dicembre:
• Renato Poggioli, Scenario di Polonia, con foto di alcune ribalte del
Teatro Nazionale di Varsavia, pp. 596-599.
Descrizione di alcuni spettacoli della stagione teatrale di Varsavia; Ženit’ba,
commedia di Gogol’, messa in scena dalla Compagnia del Teatro “Ateneum”, La vita è
sogno di Pedro Calderon de la Barca, al Teatro Nazionale, e Gli Amici, una delle più
belle commedie di Aleksander Fredro, considerato il “Goldoni” polacco, in scena al
Teatro Estivo.
Anno VII - 1938
n. 1, gennaio:
• Renato Poggioli, Scenario di Cecoslovacchia, con alcune ribalte di
scena, pp. 25-27.
Alcuni spettacoli in scena al Teatro Nazionale di Praga, di cui Poggioli descrive
messinscena e contenuto; in particolare vengono segnalati il dramma Gospoda
308
Glembajevi di Miroslav Krleža, noto per aver introdotto in Jugoslavia il futurismo di
Marinetti, la commedia Noc na Karlštejně di Jaroslav Vrchlický in occasione del
venticinquesimo anniversario della morte, Škola základ života, commedia di Jaroslav
Zak, e Lanciatore di grani, poemetto drammatico di Jean Gono.
• Renato Poggioli (Balcanicus), Scenario di Bulgaria, con alcune scene
dal Teatro di Stato di Sofia, pp. 28-29.
Bilancio dell’attività teatrale in Bulgaria, caratterizzata da una maggiore attenzione
al teatro da parte dello Stato. Poggioli ne indaga le ragioni, individuandole nel
progressivo allontanamento dalle forme del teatro russo e nella volontà di dare un
significato etico alla rappresentazione.
n. 2, febbraio:
• Renato Poggioli, Scenario di Polonia, con alcune scene dal Teatro
polacco di Varsavia, pp. 76-80.
Bilancio dell’attività teatrale in Polonia, segnata dal più grande successo della
stagione di Zygmunt Nowakowski al Teatro Polacco Gałązka rozmarynu, epopea della
lotta delle legioni polacche che, guidate dal maresciallo Piłsudski, decisero di
combattere a fianco degli Imperi Centrali per combattere la Russia zarista.
n. 3, marzo:
• Corrado Sofia, Scenario di Jugoslavia, con reperotio fotografico, pp.
127-128.
Bilancio dell’attività teatrale. L’A. ricorda Branislav Nušić, primo commediografo
a portare sulla scena la borghesia di Belgrado, in occasione della sua recente
scomparsa. Nušić a Belgrado e Krleža a Zagabria furono i maggiori rappresentanti del
teatro jugoslavo.
n. 5, maggio:
• Renato Poggioli, Scenario di Polonia, pp. 268-272.
Nel suo bilancio dell’attività teatrale in Polonia, l’A. include il dramma Balladyna
di Juliusz Słowacki in scena al Teatro Nazionale di Varsavia e la romantica e
shakespeariana riduzione teatrale di Anna Karenina di Aleksandr Volkov.
• Cècus, Scenario di Cecoslovacchia, pp. 272-273.
Nel bilancio della stagione teatrale si ricordano: Bílá nemoc e Matka, col tema di
Ecuba e Niobe, di Karel Čapek, Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, e
la commedia del drammaturgo romantico tedesco Georg Büchner Leonce und Lena.;
309
“La Lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera” (19011946)
Anno XVIII (1918)
n. 11, novembre:
• Carlo Errera, La resurrezione della Serbia, con un ricco repertorio
fotografico, pp. 789-794.
Cronaca della situazione politica ed economica della Serbia alla fine della
Prima guerra mondiale.
Anno XIX (1919)
n. 1, gennaio:
• M. Campigli, Soldati italiani in Russia, con alcune fotografie di
ufficiali del corpo di spedizione italiano, pp. 35-40.
Cronaca della convivenza dei soldati italiani con l’esercito russo a Murmansk
durante la I guerra mondiale, quando a loro era affidata la difesa del porto della città
contro gli attacchi di tedeschi e finlandesi.
n. 4, aprile:
• M. Campigli, I candori della Russia Rossa, con un ricco repertorio di
immagini. Racconto, pp. 255-260.
n. 10, ottobre:
• Saverio Nasalli Rocca, L’esercito dello zar prima dell’ultima guerra,
con un ricco repertorio di immagini, pp. 741-748.
Descrizione dell’esercito di Nicola II com’era organizzato poco prima della
“Grande Guerra”.
Anno XX (1920)
n. 8, 1 agosto:
• Térésah, La festa dei Sokol a Praga. Racconto, pp. 533-550.
Anno XXIII (1923)
n. 1., gennaio:
• La Redazione, Resoconto di viaggio di Italo Zingarelli in Russia, pp.
310
57-64.
Sulla Russia del dopoguerra: sono evidenziati il contrasto tra brutture e bellezze
artistiche e le “emergenze sociali”, tra cui la mortalità e la miseria, in un percorso che
va da Mosca alle desolate regioni meridionali della Crimea.
XXIV 1924
n. 3, marzo:
•
Lorenzo Gigli, Scrittori russi in esilio, pp 211-217.
Riassunto di una parte del diario di Zinaida Gippius Merežkovskij, pubblicato in
francese a Parigi insieme ad alcune note di Dmitrij Merekžovskij, dopo la fuga dal
regime bolscevico. Nel diario si legge la cronaca del secondo semestre del 1919 con
notizie preziose sulla vita di scrittori e artisti russi.
Anno XXV (1925)
n. 12, dicembre:
• Nina Romanowski, traduzione: Leone Tolstoi, Frammeni di un
romanzo storico sull’epoca di Pietro I, pp. 881-893.
La traduzione è corredata da qualche nota esplicativa e da illustrazioni di G.
Abkhasi.
Anno XXVI (1926)
n. 7, luglio:
• Alessandro Koltonski, La Polonia e la sua letteratura. Stefano
Zeromski e Ladislao Reymont, pp. 536-544.
L’A. ripercorre le fasi principali della storia letteraria polacca dalle origini fino al
romanticismo e alla lirica contemporanea, descrivendola come “un alternarsi di
impegno sociale e di libera manifestazione poetica”. Un tributo particolare viene
riservato a Stefan Żeromski e Władysław Reymont, morti entrambi nel 1925.
Anno XXVIII (1928)
n. 7, luglio:
• Silvio D’Amico, Tatiana Pàvlova, con foto di scena e costumi, pp.
509-514.
L’A. ripercorre la carriera artistica di Tat’jana Pavlova in Italia fin dagli esordi in
teatro nel 1923-1924 con riferimento ai giudizi della critica, che le rimproverava
l’“esotismo” e la “pessima dizione italiana”, e al consenso del pubblico. L’autore
sottolinea le doti artistiche nella mimica, nell’impianto scenico, semplice ma
suggestivo, e nei costumi, ricordando scenografie di celebri opere, dal Mečta ljubvi di
Kosorotov a Fröken Julie di August Strindberg.
311
Anno XXIX (1929)
n. 10, ottobre:
• N. D’Agostini, Scenografia e idee del teatro russo d’ oggi, pp. 765772.
Sul teatro russo contemporaneo. Alla luce del binomio teatro-politica l’A.
evidenzia come la forma teatrale abbia conservato un aspetto “propagandistico e
sovversivo”, mai esclusivamente legato all’espressione letteraria. Anche se con
variazioni rispetto al passato, le rappresentazioni del periodo zarista sono sopravvissute
alla furia distruttrice del bolscevismo. L’A. descrive, infine, le tecniche sceniche della
scuola del “Teatro d’Arte” di Mosca di Stanislavskij e Mejerchol’d-Evreinov.
Anno XXXV (1935)
n. 1, gennaio:
• Guido Salvini, Attori russi, pp. 62-68.
Oltre a tracciare un quadro del teatro russo contemporaneo attraverso le scuole di
Mejerchol’d e Stanislavskij, l’A. ne individua alcune caratteristiche, dai programmi
ufficiali agli spettacoli introdotti da discorsi solenni, pronunciati in maniera
propagandistica e con toni polemici nei confronti di altre scuole e compagnie teatrali.
Segue un breve ritratto dell’“attore russo” e del suo rapporto col teatro. L’articolo è
arricchito dalle fotografie di attori.
Anno XXXVI (1936)
n. 8, agosto:
• Alberto Francini, Per le vie di Leningrado e di Mosca, pp. 688-694.
Si racconta la vita della gente comune per le strade di Mosca e San Pietroburgo in
una versione molto diversa da quella trasmessa dalla stampa dell’epoca. Accanto ai
sontuosi palazzi e ai fasti dei Soviet, narrati dalla cronaca ufficiale e dalle statistiche, ci
sono le vetrine polverose delle botteghe e le immagini, definite dall’A. “decadenti”,
dell’abbigliamento e degli edifici. L’articolo è corredato da fotografie di alcuni
passanti.
Anno XXXVII (1937)
n. 2, febbraio:
•
Mario Missiroli, Il brindisi di Stalin, pp. 111-117.
Sulla questione dei bassi salari dei lavoratori in Russia. Prendendo spunto da un
celebre brindisi col quale Stalin augurava ‘salute’ a tutti i bolscevichi, membri e non
del partito, l’A. sottolinea la trasformazione istituzionale del bolscevismo in atto nel
312
Paese alla luce di provvedimenti statali come il ridimensionamento della posizione di
privilegio del proletariato e l’abolizione di vecchi organismi politici.
313
“Bilychnis” (Chiesa Battista di Roma, 1912-1931)
Vol. I, 1912
Fasc. VI, novembre-dicembre:
• Joh. Lover, Andrea Towianski (1799-1878), pp. 554-559.
Biografia con un profilo di Towianski e una descrizione della sua dottrina religiosa.
Vol. III, 1914
(I semestre)
Fasc. II, febbraio:
• Giulio Vitali, Tolstoi pedagogista, pp. 147-152, con tre fotografie di
Tolstoj.
L’articolo rappresenta l’anticipazione di un volume uscito successivamente per
l’editore Sandron di Palermo; il tema era già stato trattato dall’A. in un precedente
saggio (1911), di cui sono qui riprodotte alcune pagine tolte dal capitolo “Lavoro
manuale e le scuole nuove”.
Vol. IV, 1914
(II semestre)
Fasc. VII, luglio:
• Eduardo Taglialatela, Leone Tolstoi pedagogista, pp. 67-69.
L’articolo approfondisce la figura di Giulio Vitali, studioso delle dottrine
filosofiche e letterarie di Tolstoj, e costituisce l’analisi del suo ultimo saggio Leone
Tolstoj pedagogista (Palermo, Sandron, 1914).
Vol. VII, 1916
(I semestre)
Fasc. VI, giugno:
• Giovanni Pioli, La Chiesa russa e la riunione delle Chiese. pp. 483485.
Articolo del Cerkovnyj Vestnik di Pietrogrado sulla necessità di riconciliare russi e
polacchi dopo l’emanazione dell’Ukaz imperiale dello zar, che annunciava l’autonomia
della Polonia, nonché il riavvicinamento delle due confessioni religiose, anticipando,
così, l’unione delle due Chiese.
• Giovanni Pioli, Benefici effettivi della temperanza in Russia, p. 485.
Un importante articolo del generale Aleksej Polivanov, Ministro della Guerra in
Russia, apparso sul “New Republic”, giornale di Westerville, per far conoscere negli
Stati Uniti i risultati positivi scaturiti dal decreto di proibizione dello spaccio di liquori
alcolici, emanato in Russia fin dall’inizio della guerra.
314
Vol. VIII, 1916
(II semestre)
Fasc. VIII, agosto:
• Ivan Liabooka, La tradizione bizantina nell’antica teologia russa, pp.
104-114.
Recensione allo studio dello storico russo Ioann Sokolov su Bisanzio, pubblicato
sulla rivista interconfessionale “The Constructive Quarterly” fondata a New York da
Silas Mc Bee nel 1913. Lo studio evidenzia il ruolo fondamentale della città nella
formazione dell’ortodossia ecumenica fra le Chiese autocefale e ne ribadisce l’eredità
spirituale e culturale lasciata alla Russia.
Vol. IX, 1917
(I semestre)
Fasc. I, gennaio:
• E. Amendola, Il pensiero religioso e filosofico di F. Dostoievsky, pp.
5-10:
Breve raccolta dei principali pensieri religiosi e filosofici dello scrittore russo tratti
dalle sue opere e legati insieme da un’analisi della natura mistica dello spirito religioso
russo.
Fasc. III, marzo:
• E. Amendola, Il pensiero religioso e filosofico di F. Dostoievsky.
Traduzione. Parte prima, pp. 202-218.
Brani scelti tradotti dal testo russo delle opere di Dostoevskij.
Fasc. IV, aprile:
• E. Amendola, Il pensiero religioso e filosofico di F. Dostoievsky.
Traduzione. Parte seconda, pp. 262-277.
Continuazione del precedente.
Fasc. V-VI, maggio-giugno:
• S. Bridget, Andrea Towiański e l’anima della Polonia, pp. 342-348.
Storia del pensiero religioso di Towiański e della penetrazione dei Gesuiti in
Polonia.
Vol. X, 1917
(II semestre)
Vol. XI, 1918
315
(I semestre)
Fasc. I, gennaio:
• Giovanni Pioli, Il pensiero dei sionisti russi, pp. 62-63.
L’A. riporta alcuni passi del Rapporto sulla Palestina, il discorso pronunciato dal
condottiero sionista M. M. Ussiškin alla conferenza dei sionisti russi e pubblicato su
Ha’am (Il popolo), quotidiano ebraico di Mosca.
• Giovanni Pioli, Il sionismo in Polonia, pp. 63-64.
Fasc. III-IV, marzo-aprile:
• Antonio De Stefano, A proposito di un libro recente. Psicologia russa,
pp. 167-169.
L’A. presenta il recente volume di Francesco Losini su Turgenev (ed.:
Formiggini – Collezione ‘Profili’, 1918) e, partendo dal profilo artistico e psicologico
dello scrittore e dall’analisi di alcune sue opere, cerca di interpretare il difficile
momento storico attraversato dalla Russia in questi anni, divisa fra tradizione e
innovazione.
• Eva Amendola, traduzione di: F. Dostoievsky, La tentazione. Pagine
russe, pp. 170-177.
• Giovanni Pioli, Messianismo slavo, pp. 225-226.
L’A. riproduce alcuni estratti dal corso di lingua e letteratura slava tenuto al
Collège de France di Parigi da Adam Mickiewicz negli anni 1840-1844; il brano è
un’esaltazione di tutti quei tratti, che contribuiscono a definire l’anima slava, dalla
religiosità agli usi e costumi, in un clima di particolare ‘simpatia’ della società parigina
nei confronti dei profughi polacchi e del mondo slavo in generale.
Fasc. V, maggio:
• G. Adami, La Boemia protestante saluta l’alba di una era nuova, pp.
311-312.
XII (1918)
(II semestre)
Fasc. I, gennaio:
• Mario Rossi, Giovanni Hus, l’eroe della nazione boema, pp. 2-10.
Fasc. II-III-IV-V.VI.VII-VIII (mancanti!)
Fasc. XI-XII, novembre-dicembre:
• Raoul Allier, Il Cristianesimo e la Serbia, pp. 276-278.
316
XIII, 1919
(I semestre)
Fasc. III, marzo:
• La Redazione, traduzione di: Massimo Gorki, Natale (Spigolature), p.
233.
Fasc. V, maggio:
• Paolo Emilio Pavolini, Poesia religiosa polacca, pp. 363-368.
XV, 1920
(I semestre)
Fasc. V-VI, maggio-giugno:
• Dott. D. G. Whittinghill, traduzione: Eugenio Trubetskoy, L’utopia
bolscevica e il movimento religioso in Russia, pp. 321-333.
Articolo del principe Evgenij Trubeckoj, professore di diritto all’Università di
Mosca, pubblicato dall’“Hibbert Journal” nel gennaio dello stesso anno.
XVI, 1920
(II semestre)
Fasc. X, ottobre:
• La Redazione, Chiesa ortodossa in Russia secondo Bielinski, pp. 307308.
Prima edizione parziale in italiano della lettera di Belinskij a Gogol’ del 15 luglio
1847, ripresa dalla rivista “Russia”.
XVII, 1921
(I semestre)
Fasc. V, maggio:
• M. Bersano Begey, La missione spirituale di Napoleone secondo
Andrea Towianski, pp. 320-326.
Fasc. VI, giugno:
• E. Lo Gatto, La Russia e il suo problema religioso, pp. 373-381.
L’articolo tratta della religiosità in Russia, con un’attenzione particolare al
crescente fenomeno delle sette religiose. Si citano i “vecchi credenti”, le teorie di
Merežkovskij su alcune peculiarità del popolo russo nonché aspetti del pensiero
317
religioso di Dostoevskij.
XIX (1922)
(I semestre)
Fasc. II-III, febbraio-marzo:
• G. [iovanni] P. [ioli], Questioni religiose in Cecoslovacchia, pp. 113114.
• G. [iovanni] P. [ioli], Il nuovo movimento religioso in Russia, in ‘Note
e commenti’ pp. 115-116.
Breve sintesi dell’articolo di Boris Sokolov, pubblicato su “Poslednye Novosti”,
sul nuovo movimento religioso in Russia, indipendente e lontano dalla vecchia Chiesa
ortodossa, da lui conosciuto attraverso la frequentazione dei capi del movimento a
Mosca e Pietroburgo, le adunanze di culto e i dibattiti.
Fasc. IV, aprile:
I. L. , Il protestantesimo in Polonia, pp. 183-184.
Fasc. VI, giugno:
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe in ‘Rivista delle riviste’, pp. 376-380.
Rassegna della stampa dei profughi russi all’estero: si citano riviste come
“Sovremennye Zapiski”, “Russkaja Mysl’”, “Volja Rossii”, “Smena vech” e “Detinec”,
dedicate allo studio dei problemi religiosi in Russia.
Vol. XX
(II semestre)
Fasc. X, ottobre:
• P. G., La vita odierna della Chiesa Ortodossa Russa, pp. 187-198.
Si ripercorrono i principali momenti della lotta antireligiosa sotto il bolscevsmo nei
tre anni di guerra civile in Russia dal 1918 al 1920, partendo dalla descrizione del
pensiero e della personalità di Fëdor Dostoevskij e Vladimir Solov’ëv.
• G. Roberti, La Chiesa Serba Ortodossa (Storia delle religioni), pp.
240-241.
Fasc. XII, dicembre:
• E. Lo Gatto, Riviste russe, pp. 401-408.
Serie di saggi dell’A.: La filosofia russa e il suo destino, La filosofia nella Russia
soviettista, Dostojevskij e Spengler, La Chiesa e il bolscevismo, Il patriarca Ticone e il
potere soviettista, Il mondo dell’ icona russa, Usi babilonesi ed usi russi.
Vol. XXI, 1923
318
Fasc. I-II, gennaio-febbraio:
• G. Ferretti, L’ateismo ufficiale in Russia, in ‘Note e commenti’, pp.
38-39.
Sulla nascita della nuova rivista “Pod znamenem Marksisma” (1923) fondata in
Russia dai più noti teorici della rivoluzione. Dal manifesto, dettato dallo stesso Lenin,
obiettivo della rivista è la celebrazione del materialismo militante attraverso la
propaganda ateista (v. “Ordine Nuovo” del 10 settembre 1923).
• M. V. Vinciguerra, La Chiesa cecoslovacca, in ‘ Cronache’, pp. 41-50;
Fasc. V, maggio:
• P.[ioli] G. [iovanni], La Chiesa vivente in Russia, pp. 287-297.
Il titolo fa riferimento a una conferenza tenutasi nel monastero della Trinità di
Mosca il 12 giugno 1922 presieduta del vescovo Antonij, dove si annunciava il declino
Chiesa ufficiale in contrasto con la fede del popolo russo, eterno custode della
tradizione e dei valori del cristianesimo primitivo.
Fasc. VI, giugno:
• E. Lo Gatto, Riviste russe, pp. 420-427.
Raccolta di brevi saggi dell’A.: Intorno alla nave dell’ ortodossìa, L’ Apocalissi
di Rozanov, La crisi dell’ intellighenzia e la nuova ideologia. Chiude l’articolo una
rassegna di studi dedicati a Berdjaev.
Vol. XXII, 1924
Fasc. XI-XII, novembre-dicembre:
• C. Z., recensione a: Henrich Felix Scmid, Die Nomokanonübersetzung des Methodius [...] in ‘Cristianesimo slavo’, pp. 398-399.
Vol. XXIII, 1924
Fasc. II-III, febbraio-marzo:
• E. Lo Gatto, Per la storia del movimento battista in Russia, pp. 85-96.
L’A. raccoglie alcuni documenti sulle varie persecuzioni dei movimenti ereticali in
Russia, una questione di cui avrebbe dovuto occuparsi Ivan Liabooka, come da lui
stesso annunciato in un articolo sulle origini dei battisti, pubblicato su “Bilychnis”
(ottobre, 1915).
• E. Lo Gatto, Riviste russe, pp. 141-149.
Fasc. V, maggio:
• Piero Chiminelli, recensione a: Augusto Ieskowski, Padre Nostro.
Trad. dal polacco di A. Palmieri. Bologna, Zanichelli, 1923, pp. 384385.
319
Fasc. VI, giugno:
• M. Almedingen, I missionari buddisti in Russia, pp. 430-433.
L’articolo sottolinea il momento di crisi della fede e della religiosità ortodossa in
Russia, un clima favorevole alla diffusione di altri ‘credi’ religiosi, in particolare il
buddismo.
Vol. XXIV, 1924
(II semestre)
Fasc. VII, luglio:
• Raffaele Corso, Le statistiche ufficiali della Chiesa Nazionale
Cecolsovacca, pp. 35-38.
Fasc. X, ottobre:
• M. E. Almedingen, La religione russa di oggi, traduzione di Ettore Lo
Gatto, pp. 199-203.
Il saggio cerca di individuare le cause e i momenti più significativi della crisi
della Chiesa e della spiritualità ortodossa in Russia.
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe, pp. 236-244.
Raccolta di saggi di L.G.: L’ unità della Chiesa, Sull’ architettura religiosa in
Russia, Natura e origine della rivoluzione russa, Lenin e Gorkij, Kropotkin e la
rivoluzione, Puškin come storico, Tipi di concezioni filosofiche.
• E. Lo Gatto, Riviste russe in ‘Rivista delle riviste’, pp. 236-244. Fasc.
XI, novembre:
• Luigi Tonelli, Il testamento spirituale di Dostojewski, pp. 332-334.
L’A. descrive il romanzo di Dostoevskij alla luce della recente traduzione francese,
eseguita per i tipi della casa editrice Bossard di Parigi.
Fasc. XII, dicembre:
• A. Tomaszewski, La Chiesa nazionale polacca, pp. 375-383.
• L., L’odierna cultura religiosa russa, pp. 429-440.
Vol. XXV, 1925
(I semestre)
Fasc. III, marzo:
• Piero Chiminelli, recensione a: Bernard Leib, Rome, Kiev et Byzance
à la fin du XI° siècle: rapports religieux des Latin et des Gréco-Russes
sous le pontificat d’Urbain II (1088-1099). Paris, Picard, 1924, pp.
XXXII-356, in ‘Cristianesimo slavo’, pp. 163-164.
Fasc. V, maggio:
320
• E. Lo Gatto, Riviste russe, pp. 322-327.
Raccolta di saggi di L.G.: L’ arte e il popolo, La letteratura russa dell’emigrazione,
Pietro il Grande e lo slavismo.
Vol. XXVII, 1926
(I semestre)
Fasc. III, marzo:
• E. Lo Gatto, Riviste russe in ‘Rivista delle Riviste’, pp. 213-222;
Vol. XXIX, 1927
(I semestre)
Fasc. I, gennaio 1927:
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe, pp. 36-43.
Raccolta di saggi di L.G.: L’ Unione cristiana e la cultura teosofica nella
prospettiva ortodossa da un articolo omonimo di Nikolaj Glubokovskij in “Put’”,
organo del pensiero russo, edizione dell’ Accademia religiosa filosofica di Parigi,
giugno-luglio 1926; La religione e la scienza nella coscienza contemporanea da un
omonimo articolo di S. Frank in “Put’”, giugno-luglio 1926; Alcune considerazioni su
Joseph de Maistre e la Massoneria dal punto di vista russo da un articolo di N.
Berdjaev in “Put’”, giugno-luglio 1926; L’intelletto dell’ uomo primitivo e dell’
europeo colto da un articolo del prof. Losskij in “Sovremennyja Zapiski”, num.
XXVIII del 1926; L’etica e la religione da un articolo di G. D. Gurvič in
“Sovremennye Zapiski” (XXIX)-1926; Sull’ideologia del nuovo ebraismo da un
articolo di M. Bejlinson in “Sovremennye Zapiski” XXX-1926; Interessanti notizie
sull’ arresto e l’ esilio del metropolita Szepticki da un articolo di D. Dorošenko in “Na
čužoj storone -vol. XIII”; Tolstoj maestro di fede da un articolo di P. Boborykin in “Na
čužoj storone” -vol. XIII».
Fasc. V, maggio:
• Ettore Lo Gatto, Il problema religioso in Dostojevskij, pp. 333-346.
Dopo aver tentato di definire la personalità di Dostoevskij artista’ e ‘pensatore’,
Lo Gatto richiama l’attenzione del lettore sulla spinosa questione dell’esistenza di Dio
più volte affrontata dallo scrittore in diverse opere, in particolare viene preso in esame
il romanzo I fratelli Karamazov.
Fasc. VI, giugno:
• Ettore Lo Gatto, traduzione di: V. Solovjov, La Risurrezione di Cristo
(Lettera inedita a Leone Tolstoi , pp. 393-396.
Vol XXX, 1927
(II semestre)
Fasc. VII, luglio:
321
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe, pp. 40-48.
Raccolta dei saggi: I torbidi nella Chiesa e la libertà di coscienza (Articolo di N.
Berdjaev in “Put’”, ottobre-novembre, 1926, Parigi); Intorno al bene dell’Anticristo
(Articolo di N. S. Arsenjev in “Put’” ottobre-novembre, 1926, Parigi); Pensieri sul
senso religioso del Nazionalismo (Articolo di N. A. Klepnin in «Put’», gennaio 1927);
La scienza della religione e l’ apologetica cristiana (Articolo di N. Berdjaev, in “Put’”
gennaio 1927); Il cristianesimo e l’idea della monarchia (Articolo di N. Alekseev in
“Put’”, gennaio 1927); Proudhon e l’ età moderna (Articolo di G. D. Gurvič in
“Sovremennyja Zapiski”, n. XXX, 1927; I Sanniti (Articolo di M. Rostovсev in
“Sovremennyja Zapiski”, XXX, 1927).
Fasc. VIII-IX, ag.-sett.:
• Ettore Lo Gatto, L’idea filosofico-religiosa russa da Skovorodà a
Solovjòv, pp. 77-90.
Partendo dalle idee di Berdjaev sullo slavofilismo e sulla mancanza di un sistema
filosofico russo, l’A. ripercorre l’evoluzione del pensiero di alcuni pensatori dalla metà
del secolo XVIII con Gregorio Savič Skovorodà fino a Vladimir Solov’ëv.
Vol. XXXI, 1928
(I semestre)
Fasc. III, marzo:
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe, pp. 213-219.
Raccolta dei saggi: Il problema della teodicea (da un articolo di N. Berdjaev nel
fasc. VII (aprile) della rivista “Put’”, 1927; I rapporti tra il popolo russo e lo Stato da
un articolo di N. Alekseev nel fasc. VIII di “Put’”; Il problema dello stato cristiano da
un articolo di N. Berdjaev in “Sovremennyja Zapiski”, volume XXXI-1927;
Considerazioni intorno alla Russia (da un articolo di Fëdor Stepun in “Put’” vol.
XXXII e XXXIII).
• Ettore Lo Gatto, recensioni a: L. Berg, Novye religioznye puti
russkago ducha, Mainz, Matthias-Grunewald-Verlag, 1926, p. 206;
Martin Winkler, Peter Jakovlevič Čaadaev. Ein Beitrag zur russischen
Geistesgeschichte des XIX Jahrhunderts, Berlin, Ost-Europa-Verlag,
1927, pagine 106; F. Goetz, Der Philosoph W. Solowioff und das
Judentum, Riga, Buchdruckerei „Splendid“, 1927, p. 88; Joh.
Ackermann, Tolstoi und das Neue Testament, Leipzig, G. B. Teubner,
1927, pag. 128, pp. 231-234.
• E. Lo Gatto, recensioni in ‘Problemi dello spirito russo’, pp. 231-234.
Vol. XXXIII, 1929
(I semestre)
322
Fasc. I, gennaio:
• V. G. Galati, Dostojevskij, pp. 23-28.
Dopo una breve introduzione sulla natura della spiritualità russa, l’A. traccia un
profilo di Dostoevskij scrittore e uomo di fede.
Fasc. V, maggio:
• La Redazione, traduzione: Eug. Kagarov, Costumanze popolari russe,
pp. 363-367.
Articolo sull’uso dell’ex-voto nel mondo mediterraneo e in Russia con riferimento
all’origine magica dell’‘oggetto’ offerto, più una descrizione del ‘passaggio sotto le
icone’ in confronto con gli usi di altri popoli.
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe, pp. 391-397.
Raccolta dei saggi: L’influenza della Chiesa sulla cultura russa da un articolo di A.
Kartscev nel fasc. IX di “Put’” del 1928; Il problema metafisico della libertà da un
articolo di N. Berdjaev nel fasc. IX di “Put’” del 1928; Quel che non può essere creato
dall’evoluzione, da un articolo del prof. N. Losskij nel fasc. XXXIII-1927 di
“Sovremennye Zapiski”; Le nuove correnti russe da un articolo di V.V. Zenkovskij nel
fasc. XXXIII.1927 di “Sovremennye Zapiski”; La tragedia del bene ne “I fratelli
Karamazov” di Dostoievskij nel fasc. XXXV- 1928 di “Sovremennye Zapiski”; Il
problema della vita e della morte nell’arte di L. Tolstoi da un articolo di Pëtr
Michajlovič Bitsilli (o Bicilli) nel fasc. XXXVI-1928 di “Sovremennye Zapiski”.
Fasc. VI, giugno:
• Giovanni Costa, Scrittori slavi, pp. 497-500.
L’articolo associa il successo della casa editrice Slavia al carattere peculiare delle
culture e letterature legate al mondo slavo di cui la casa editrice si occupava in quegli
anni.
Vol. XXXV, 1930
(II semestre)
Fasc. 8-9, agosto-settembre:
• P. F. e Giovanni Pioli, Chiesa e Stato nella Russia sovietica, pp. 114116.
Traduzione di Argomento e di singoli capitoli di un ampio studio di Alexander de
Roubetz, intitolato La Chiesa della Russia sovietica e pubblicato dall’Annuario
svedese di Storia Ecclesiastica (Kyrkohistorisk Arsskrift) nel 1928, relativo a ricerche
sullo status giuridico della Chiesa russa.
• Ettore Lo Gatto, Riviste russe, pp. 125-135.
Raccolta dei seguenti saggi: Il sistema del dualismo culturale da un articolo di V.
Zenkovskij nel fasc. XXVIII dei “Sovremennye Zapiski”; Inizio e sviluppo del periodo
323
dei torbidi nella Chiesa russa con particolare riguardo alle conseguenze del Concilio
di Karlovac (Karlstadt) da un articolo di I. Stratonoj nei fasc. XII, XIV e XV della
rivista “Put’” del 1929; I rapporti tra la Chiesa e lo Stato soviettista da un articolo di
N. Timašev nel fasc. X di “Put’”; Il senso religioso della rivoluzione in “Sovremennyja
Zapiski”, fasc. XL del1929; Il carattere del pensiero religioso russo del secolo XIX da
un articolo di N. Berdjaev nel fasc. XVII di “Sovremennyja Zapiski” del 1930; La
dottrina dell’“Urgrund” e della libertà in Böhme da un articolo di Berdjaev in «Put’»
fasc. XX del 1930; Il concetto di “Sobornost’” da un articolo di Florovskij su
«Sobornost’» e l’ Eucarestia» nel fasc. XIX del 1929 di “Put’”; L’ attuale situazione
culturale nella Russia soviettista da un articolo del prof. Fjodotov in “Sovremennyja
Zapiski”, fasc. XLI del 1930; Tolstoj nell’U.R.S.S. e nell’emigrazione da articoli di V.
Polonskij in “Pecat’ i revoljuсija” di settembre 1928, Frice in “Proletarskaja
revoljuсija” di aprile 1928, M. Aldanov in “Sovremennyje Zapiski” di ottobre 1928, E.
Ljackij in “Sbornik russkago Instituta v Prage” del 1929.
324
“Il Marzocco” (Adolfo Orvieto, 1896-1932)
Anno XXIII (1918)
n. 1, 6 gennaio:
• Bernardino Barbadoro, Defezioni russe, p. 2.
L’articolo rievoca i principali avvenimenti della guerra dei sette anni, che strinse
il primo assedio intorno alla famiglia degli Hohenzöllern, sottolineando alcune
analogie col conflitto mondiale in atto all’epoca. In particolare, un episodio avvenuto
nel corso del quarto anno di guerra (1762), la defezione della Russia dalla Convenzione
di San Pietroburgo firmata con Prussia e Inghilterra, sembra avere un triste ricorso
storico.
n. 14, 7 aprile:
•
A. Faggi, Tolstoi e le grandi guerre, pp. 2-3.
Partendo dalla vicenda biografica di L. Tolstoj, in particolare dal suo viaggio nel
Caucaso all’età di 23 anni nel 1851, l’A. elabora un percorso artistico dello scrittore.
Analizzando tre opere, Kazaki, Scene dall’assedio di Sebastopoli e Vojna i mir, ci si
sofferma sul tema della guerra e sul fatto che per Tolstoj la ricostruzione dell’artista è
superiore a quella dello storico: “lo storico vede e analizza l’individuo nella storia,
l’artista osserva la storia negli uomini”.
n. 38, 22 settembre:
Niccolò Rodolico, Martirio di Serbi e di Jugoslavi, p.39
n. 46, 17 novembre:
• Antonio Muñoz, Collezioni d’arte in Russia. I Il museo Alessandro III
di Pietrogrado, p. 2.
Un bilancio dei danni al patrimonio artistico di Pietrogrado in seguito al
turbolento periodo rivoluzionario. Dopo aver ricordato i saccheggi ai palazzi
principeschi e agli edifici pubblici e privati, trasformati in prigioni o dati alle fiamme,
l’A. descrive l’architettura del Museo Alessandro III, opera di Carlo Rossi,
soffermandosi al pianterreno e alla collezione di dipinti bizantini e slavi.
• Giuseppe Ortolani, Un grido italiano della Polonia nel Settecento, p.
3.
n. 47, 24 novembre:
• Lorenzo Gigli, I bolsceviki, p. 4.
325
n. 50, 15 dicembre:
• Antonio Muñoz, Collezioni d’arte in Russia. II Il museo Alessandro III
di Pietrogrado, pp. 2-3.
Dopo una breve nota informativa sui saccheggi artistici organizzati dai bolscevichi
in Russia per ordine di Lenin col trasferimento di gran parte del patrimonio di palazzi e
musei all’estero, soprattutto in Svezia, Muñoz continua la descrizione delle sale del
museo dell’Imperatore Alessandro III e, in particolare, dei piani superiori dedicati
all’arte russa a partire dal XVII sec.
n. 52, 29 dicembre:
•
Antonio Muñoz, III L’ Ermitage, p. 3.
Dopo il museo Alessandro III, l’A. descrive i tesori artistici del Palazzo d’Inverno,
le cui sale sono note col nome di Ermitage. Il museo raccoglie un cospicuo numero di
opere provenienti da collezioni private e acquistate all’estero, frutto dell’amore per il
lusso e della raffinatezza, che caratterizzava l’alta società russa del Settecento.
Anno XXIV (1919)
n. 6, 9 febbraio:
•
A. Faggi, Le Memorie di Massimo Gorki, pp. 1-2.
L’A. espone il contenuto delle Memorie autobiografiche di Maksim Gor’kij,
pubblicate dalla “Revue de Paris”, sottolineandone lo spessore psicologico. Le
Memorie, descrivendo la prima fase di Gor’kij rivoluzionario, presentano al lettore un
quadro dettagliato della Rivoluzione.
n. 39, 28 settembre:
•
A. Faggi, Andreieff il pessimista, pp. 2-3.
Partendo dalla notizia diffusa dalla stampa dell’epoca della scomparsa di
Leonida Andreev nella sua casa in Finlandia, l’A. traccia un profilo dello scrittore,
seguace delle idee, che avrebbero condotto alla rivoluzione del 1917, evidenziando il
pessimismo nelle sue opere.
Anno XXVI (1921)
n. 27, 1 luglio:
•
A. Faggi, “Quello” di L. Andreieff, p. 1.
Nell’articolo si richiama l’attenzione del lettore al successo editoriale, che in
Italia registravano in quegli anni i drammi di Leonida Andreev. Soffermandosi
sull’edizione italiana di Quello che prende gli schiaffi a cura di Carlo Staffetti e Boris
Gurevič, l’A. evidenzia alcune analogie fra questo dramma e Redivivo, romanzo dello
scrittore milanese contemporaneo De Marchi.
n. 45, 6 novembre:
326
• A. Faggi, Dostojewsky e il suo centenario (3,5 coll.), p. 1.
In occasione del centenario della nascita di Dostoevskij, l’A. traccia un profilo
dello scrittore vissuto tra il 1821 e il 1881, un’occasione per rievocarlo in un periodo
particolarmente difficile nella storia della Russia. Partendo dalla pubblicazione del suo
primo romanzo Bednye ljudi nel 1845, accolto positivamente dalla critica del tempo
rappresentata da Belinskij, l’A. si sofferma sull’aspetto psicologico dei romanzi
Prestuplenie i nakazanie e Besy.
Anno XXVII (1922)
n. 16, 16 aprile:
A. Faggi, recensione a: Ettore Lo Gatto, Ideale e Realtà nella
letteratura russa, Napoli, Ricciardi 1921, p. 3.
•
Il titolo del volume presentato da Lo Gatto si riferisce a un libro del principe Pëtr
Krapotkin, famoso anarchico russo, tratto da una serie di conferenze da lui tenute
presso l’Istituto Lowel di Boston nel 1901, di cui l’A. aveva già parlato sulle pagine del
“Marzocco” in occasione della sua morte. Lo Gatto lo presenta qui in traduzione con
un’appendice sulle versioni italiane di opere russe, a dimostrazione del crescente
interesse del pubblico italiano per la letteratura russa.
n. 23, 4 giugno:
• Faggi, Goethe e Tolstoi, p. 1 (3,5 coll).
L’A. sottolinea il ruolo decisivo che i due scrittori hanno avuto nella storia delle
rispettive culture di appartenenza, evidenziandone aspetti comuni sia nella finalità
pedagogica e formativa dei loro scritti, sia nel ‘misticismo cristiano’ ugualmente
condiviso.
n. 48, 26 novembre:
• EX LIBRIS: Dostoyewsky nei ricordi di sua figlia, p. 1.
Si tratta di una breve sintesi del contenuto di un volume di recente pubblicazione,
che la figlia di Dostojevskij ha dedicato al padre e che è uscito in ottima veste italiana
nel 1922 a Milano per Treves. Il volume si propone non solo di rivelari ai lettori aspetti
intimi e fino ad allora poco conosciuti della vita dello scrittore ma anche di definire e
valutare l’azione sociale di un uomo, che ha sempre tratto dal suo popolo i motivi
dell’ispirazione artistica.
Anno XXVIII (1923)
n. 27, 8 luglio:
• Lina Muñoz Gasparini, Ricordi di Praga, p. 3.
n. 34, 26 agosto:
327
• Lector, EX LIBRIS: La verità su Tolstoi nei ricordi del figlio, p. 2.
n. 46, 18 novembre:
• A. Faggi, Anton Cècov e il suo teatro (3 coll.), pp. 1-2.
Si tratta di un’analisi della produzione teatrale di Čechov meno nota rispetto alla
narrativa. Partendo dal primo dramma pubblicato nel 1889 Ivanov, riproposto per la
prima volta in veste italiana nella traduzione di Carlo Grabher per Vallecchi, l’A.
ripercorre la critica dell teatro cechoviano, basandosi principalmente sui giudizi
negativi espressi da Waliszewski nella Storia della letteratura russa.
Anno XXIX (1924)
n. 44, 2 novembre:
• A. Faggi, Schiller e Dostojewski, pp. 1-2.
Anno XXXI (1926)
n. 46, 14 novembre:
• EX LIBRIS, Dostoievski e il demone del gioco, p. 2.
Anno XXXIII (1928)
n. 37, 9 settembre:
• A. Faggi, Tolstoi e Shakespeare (3,5 coll.), p. 1.
L’A. evidenzia come in occasione del centenario della nascita di Lev Tolstoj si
siano intensificati gli studi dedicati allo scrittore. Il critico ricorda la sua opera
presentando l’edizione tedesca di uno studio sugli scritti suoi e di Shakespeare a
confronto (Leo N. Tolstoi, Shakespeare, eine kritische Studie, Hannover, 1906),
contenente anche l’articolo di Ernest Crosby L’atteggiamento dello Shakespeare
davanti alle classi lavoratrici.
Anno XXXIV (1929)
n. 42, 20 ottobre:
• A. Faggi, Oblomov e l’oblomivismo, p. 1.
L’A. inizia con un elogio alla casa editrice Slavia e alle sue collezioni “Il Genio
russo” e “Il Genio slavo”; poi descrive il romanzo di Gončarov Oblomov, edito sempre
328
da Slavia con traduzioni e note di Lo Gatto, affermando che per troppo tempo la
conoscenza della letteratura russa si era limitata alla “triade Turgenev-TolstojDostojevskij”.
n. 51, 22 dicembre:
• A. Faggi, Turghenief e i suoi poemi in prosa, 3,5 coll, p. 1.
Anno XXXV (1930)
n. 26, 6 luglio:
• A. Faggi, Turgheniev e Shakespeare, p. 2.
Anno XXXVI (1931)
n. 20, 17 maggio:
• Marginalia – s.n., Storia, romanzo ed epopea nel Taras Bulba di
Gogol, p.3-4.
L’articolo approfondisce l’analisi che Nicola Festa fa di Taras Bul’ba nel suo
Convivium, evidenziando il passaggio da ‘romanzo’ ad ‘epopea’ e confrontando l’opera
di Manzoni con quella di Gogol’.
329
“Il Selvaggio” (Mino Maccari, 1924-1943)
II 1925
Fasc. 8-9 – 14 marzo:
• Didimo Chierico, La riforma della Legislazione Ecclesiastica e la
cagnara massonico-bolscevica, pag. 2.
Fasc. 11 – 1 aprile:
• La Redazione, Nikolaj Lenin, Viva Lenin!, pag. 1.
IV 1927
Fasc. 22 – 30 novembre:
• La Redazione, Fedor Dostoevskij, Gli Ebrei – status in statu, pag. 87
V 1928
Fasc. 10 – 30 maggio:
• L’Abbordatore, Sindacalismo e bolscevismo, p. 38.
Breve contributo sul ‘pericolo’ di una sopravalutazione del lavoro fisico
rispetto a quello intellettuale.
Fasc. 14 – 30 luglio:
• Domenico Pistolenza, Propagandisti di Bolscevismo, p. 53.
Breve contributo sul comportamento opportunista e materialista di alcuni fascisti,
che sulla questione delle “stime” dei proprietari terrieri, nonostante la ‘tessera’ del
partito, strumentalizzano i contadini.
VII 1931
Fasc. 1 – 30 gennaio:
• Merlo Bianco, “Dalmazia”, p. 4.
Fasc. 14 – 15 settembre:
• Antonio Miclavio, traduzione: Grigorij Aleksandrov, Notturno e fuga,
p. 55.
Fasc. 15 – 30 settembre:
330
• Antonio Miclavio, I komsomoljzi, p. 58.
Sulla nascita dei giovani comunisti russi, i komsomol’cy: si presenta un libro edito
da Driboj – Leningrad, Lettere di un komsomolec in attiività di servizio, scritto in
forma epistolare da Pëtr Šalašev e Konstantin Malikovskij. Le lettere sono firmate dal
komsomolec in servizio Konstantin Gračev, che scrive ad un suo amico comunista.
IX 1932
Fasc. 4 – 15 giugno:
• Antonio Miclavio, traduzione: Sergej Aleksandrovic Esenin, Ritorno
al paese nativo, pag. 31.
Fasc. 12 – 31 dicembre:
• Francesco Lanza, Il cane e il Soviet, p. 79.
Impressioni di viaggio di Francesco Lanza durante un soggiorno a Mosca.
• Antonio Miclavio, traduzione: Anonimo, Due poesie popolari serbe, p.
81.
X 1933
Fasc. 1 – 15 gennaio:
• Olga Resnevic, traduzione: Vsevolod Yvanov, Tumuli, pp. 3-5.
Fasc. 7 – 31 ottobre:
• “O.(lga) R.(esnevič) S.(ignorelli)”, traduzione: Panteleimon Romanov,
Il viaggio di Agafija Psenitsyna, pp. 52-53.
XI 1934
Fasc. 9 – 15 agosto:
• Antonio Miclavio traduzione: Anna Baklanova, Una serva, p. 46.
Fasc. 10 – 30 settembre:
• “O.(lga) R.(esnevič) S.(ignorelli)
Romanov, Soldato, p. 60.
331
”,
traduzione:
Pantelejmon
XIII 1936
Fasc. 5-6 – 15 giugno:
• Taddeusz Zielinski, L’antico e noi, p. 19;
XVII 1940
Fasc.2 – 15 aprile:
• Kinopa, Icconcorsussi, p. 16. (manifesto)
332
“Almanacco letterario” (Edizioni Mondadori,1925-1933)
Anno 1926
Gennaio:
• Francesco Chiesa, Il premio Nobel per la letteratura, con un ritratto e
il fac-simile di una pagina autografa, pp. 15-18.
L’A. traccia la biografia dello scrittore polacco Władysław Stanisław Reymont,
morto nel 1925, a cui è stato assegnato il premio Nobel nel 1924, segnalando la
pubblicazione a Varsavia dell’Opera Omnia di circa 20 volumi per la casa editrice
Gebethner e Wolff e la traduzione in italiano di Sprawiedliwie (1899) firmata da Ettore
Lo Gatto (E’ giusto!).
Dicembre:
• Redazione, Letterature slave, balcaniche e nordiche in ‘Appendice’,
pp. 343-345.
Breve nota biografica di Valerij Brjusov. Vengono menzionate opere di Babel’ e
varie traduzioni in italiano di opere di autori russi. Fra gli autori più tradotti si
ricordano: Tolstoj, Turgenev, Čecov e Gor’kij. Si cita, infine, il volume di Lo Gatto
Critici letterari russi.
Anno 1927
Luglio:
• Ettore Lo Gatto, L’annata letteraria in Russia, con disegni di Anton
Čechov, Sergej Esenin, Anna Achmatova, E. Zamjatin e Maksim Gor’kij
realizzati da Annenkov, pp. 170-177.
L’A. riassume gli avvenimenti più significativi della produzione letteraria in Russia
dopo la rivoluzione ‘soviettista’; in particolare si sofferma sulla rinascita del romanzo e
sulla pubblicazione delle opere complete di giovani, promettenti scrittori come
Pantelejmon Romanov (Rus), Konstantin Fedin (Goroda i Gody) e Leonid Leonov
(Barsuki).
Anno 1928
Agosto:
• E. Lo Gatto, L’annata letteraria in Russia, , con ritratti di Lev Tolstoj,
Maksim Gor’kij e Annenkov, pp. 152-159
Nella prima parte l’A. indaga il rapporto tra editori, critica ufficiale e pubblico
333
nella Russia “soviettista”, nella seconda fa un bilancio dell’attività letteraria di scrittori,
le cui opere vengono considerate “espressione di equilibrio tra contenuto di argomento
socio-politico e forma artistica”. Si menzionano Il ladro di Leonid Leonov, I fratelli di
Fedin, Il rinnegato di Lidin e La casa aperta di Ivnjev, scritto sul modello di Gli
Artamanov di Gor’kij.
Anno 1929
Luglio:
• E. Lo Gatto, L’annata letteraria in Russia, con ritratti di Michail
Kolzov, Michail Zoščenko, Lev Tolstoj, Boris Pil’niak, Isaak Babel’,
Efim Zozulja, pp. 247-252.
Ricordando il decimo anniversario della rivoluzione, l’A. traccia un bilancio
della produzione letteraria in Russia citando, in particolare, gli articoli di Leznev
apparsi sulla rivista “Pečat’ i revolucija” e i volumi sulla storia della letteratura russa
contemporanea di Kogan e Voronskij. Un breve paragrafo è, infine, dedicato al
centenario della morte di Lev Tolstoj.
Anno 1930
Ottobre:
• E. Lo Gatto, L’annata letteraria in Russia, pp. 251-260, con ritratti di
Dostojevskij, Puškin, Veresajev, Pil’njak, E. Zozulja, P. Romanov e
Aleksej Tolstoj.
Si esamina la questione dell’“ordinazione sociale”, già discussa in Russia prima
dell’avvento del marxismo, e relativa all’impegno civile e sociale che lo scrittore
doveva assumere nell’esercizio dell’attività letteraria.
Anno 1931
Ottobre:
• E. Lo Gatto, L’annata letteraria in Russia, pp. 250-259, con ritratti di
Puškin, Erenburg, Kataev, Repin, Bulgakov.
Oltre a proseguire il discorso sull’“ordinazione sociale” già affrontato l’A. cita
una serie di studi relativi alla scuola formalista: la storia della letteratura russa di Pavel
Sakulin, gli studi etnografici di Boris Sokolov e la Storia della Russia di Platonov.
Vengono, poi, menzionati alcuni scrittori dell’emigrazione.
Anno 1932
Ottobre:
• E. Lo Gatto, L’annata letteraria in Russia, con ritratti e fotografie, pp.
310-319
L’A. esamina l’evento culturale più importante del 1931, la letteratura dei
“poputčiki”, o “compagni di strada”, in un periodo difficile per la realizzazione del
piano quinquennale; fra gli altri si menzionano Pil’njak, Leonov, Lidin, Šiškov,
334
Platonov, Slonimskij, Tichonov, Malyškin. Un cenno, infine, alla letteratura
dell’emigrazione.
Anno 1933
Ottobre:
• E. Lo Gatto, L’annata letteraria nell’ U.R.S.S., pp. 284-288.
L’A. sottolinea l’importanza storica del provvedimento preso dal partito comunista
sovietico col quale si liquidavano le varie associazioni di scrittori proletari assicurando
tutti alla ‘causa socialista’ e alla diretta sorveglianza del partito.
“Campo di Marte” (1938-39)
I 1938
Fasc. 1:
• Beniamino Dal Fabbro, Poesie di Essenin, pag. 2.
Breve presentazione del volume di poesie di Esenin tradotte da Giacomo
Prampolini Canto liturgico e altre poesie.
II 1939
Fasc. 9 – 1-15 maggio:
• Renato Poggioli, traduzione: Alessandro Puskin, La plebe, pag. 3.
335
“Frontespizio” (1929-1940)
II 1930 - VIII
Fasc. 3 – marzo:
• Roberto Weiss, Santa Russia, pag. 8.
• Vjaceslav Ivanov, Quattro poesie, pag. 5.
III 1931 - IX
Fasc. 7 – luglio:
• S.a. Otokar Brêzina, pag.4.
Breve paragrafo introduttivo su Otokar Březina e sulla sua attività letteraria, la
cui maggiore eredità è rappresentata da cinque libri di versi, che ne documentano il
tormentato processo spirituale. Vieni qui pubblicata la traduzione dal ceco di una lirica
tratta dal terzo libro Vetry od polu.
• L. Savoj, traduzione: Otokar Brêzina, Quando dal tuo amore, pag.4.
IV 1932
Fasc. 4 – aprile:
• La Redazione Venceslao Ivanov, p. 3.
Breve nota informativa sulla biografia di Vjačeslav Ivanov, già pubblicata sul
fascicolo di settembre 1930 della rivista. Insegnante nell’Almo Collegio Borromeo di
Pavia, Ivanov viene considerato uno dei più sapienti e profondi scrittori della Russia
moderna.
Rinaldo Küfferle, traduzione: Venceslao Ivanov, Cappella votiva – La
via d’Emmaus – Il corno alpino, p. 3.
•
• Odoskopos, Rerum divinarum speculum historiale. Nota bibliografica
su: Leone L. Tolstoi, La verité sur mon père. Paris, 1923. Citazione di
brani tratti dalle pagine 185 e 186.
Fasc. 6 – giugno:
• Carlo Bo, Note su Tolstoj, pp. 4-6.
Si tratta di una biografia ragionata e commentata dello scrittore fatta da Bo sulla
base di alcune fonti documentarie e attraverso il continuo confronto con scritti di autori
contemporanei. Fra le fonti Tichon Polner e la sua Prefazione al Journal inédit de
Tolstoi, la nota bibliografica di Odoskopos su “Frontespizio” (aprile, 1932) e gli studi
336
di Jean Cassou riuniti nel volume Grandeur et infamie de Tolstoï.
Fasc. 9 – settembre:
•
La Redazione, Vladimiro Soloviev, p. 4.
Breve paragrafo sulla biografia di Vladimir Solov’ëv.
• S.a. traduzione: Vladimir Soloviev, Leggenda russa, pp. 4-5, con
ritratto.
V 1933
Fasc. 9 – settembre:
• Giovanni Papini, Russi e filosofi, pag. 4.
VI 1934
Fasc. 11 – novembre:
• Antonio Miotto, Sulla religiosità bolscevica, pp. 17-19.
Partendo dalla presentazione del saggio di René Martel Le mouvements
antireligieux en U.R.S.S (Ed. Rivière, Paris, 1933), l’A. riassume le due principali
scuole di pensiero sulla religiosità dei russi: la prima, rappresentata da studiosi che
hanno visto in essa una semplice manifestazione del mito popolare; la seconda,
condivisa da Martel, fortemente antireligiosa e filobolscevica, che considera tale
religiosità non solo un “errore di psicologia sociale” ma anche una “volgare
menzogna”.
VII 1935
Fasc. 8 – agosto:
• Renato Poggioli, traduzione: Sergio Jessenin, L’acero antico, pag. 7
con disegno di Ottone Rosai.
Fasc. 10 – ottobre:
• Rodolfo Paoli, Interpreti di Dostojewski, pag. 7-9, con disegno di
Ottone Rosai.
Dopo una breve premessa sulla recente diffusione in Italia di traduzioni di classici
eseguite direttamente dal russo per iniziativa di Slavia, Paoli evidenzia come negli
ultimi anni si registri un incremento significativo di biografie e studi completi dedicati
a Tolstoj, Dostoevskij e Čechov, presentando due volumi significativi: Delfino Cinelli,
Tolstoi (Treves, Milano, 1934) e Nicola Moscardelli, Dostoievski (Guanda editore,
1933).
337
VIII 1936
Fasc. 10 – ottobre:
• Rodolfo Paoli, Ancora Dostojewski, pp. 20-21.
A distanza di meno di un anno dalla sua recensione a un volume su Dostojevskij di
Nicola Moscardelli (Guanda, 1935), l’A. continua l’analisi dello scrittore prendendo in
esame il volume di Giuseppe Donnini Dostojewski vivente (Vallecchi, 1936). Dopo
aver sottolineato la fortuna di Dostoevskij in Italia, Paoli confronta le due monografie
evidenziando in Donnini una maggiore attenzione ai fatti biografici piuttosto che a una
descrizione del profilo morale e psicologico dello scrittore.
Fasc. 11 – novembre;
• Giovanni Papini, Chiose alla Russia rossa, pp. 1-3.
L’A. ricostruisce gli aspetti fondanti dell’ideologia bolscevica. Secondo il critico
nemmeno il bolscevismo è riuscito ad annientare i due principali “morbi nazionali”
tipici della psicologia russa, il nichilismo indiscriminante e crudele e la totale apatia
esistenziale, rappresentabili con due personaggi della letteratura: Bazarov di Turgenev
e Oblomov di Gončarov.
IX 1937
Fasc. 1 – gennaio:
• Opifex, Cattolicesimo e Bolscevismo, pag. 41.
Fasc. 2 – febbraio:
• Opifex, Cattolicesimo e Bolscevismo, parte seconda, pag. 92.
Fasc. 3 – marzo:
• Rodolfo Paoli, L’ultimo Berdjaev, pp. 217-222.
Nel suo intervento l’A. introduce la figura di Berdjaev, scrittore poco e mal
conosciuto in Italia, prendendo in esame due recenti volumi a lui dedicati: Il
cristianesimo e la vita scociale, con prefazione di Edmondo Cione (Bari, Laterza,
1936) e Il problema del Comunismo, tradotto dal francese da Pietro Cenini (Vittorio
Gatti, Brescia, 1937).
Fasc. 6 – giugno:
• Ivan Turghenjev, A Carlo Bo, pag. 417.
Fasc. 8 – agosto:
338
• Luigi Calvini, Ulas Samcjuk, pag. 589-592.
Fasc. 12 – dicembre:
• Carlo Betocchi, Concilio italo-croato, pag. 941.
XII 1940
Fasc. 4 – aprile:
• Rodolfo Paoli, Diagnosi del Bolscevismo, pp. 234-237.
Si tratta della recensione al volume di Guido Manacorda Bolscevismo (Sansoni,
Firenze, 1940). L’A. evidenzia la chiara e precisa esposizione dei principi marxisti e la
sottile e accurata analisi degli elementi storici e dottrinali, che ne determinano la
formulazione.
05 – maggio:
• Leone Savoy, Il dramma religioso di Gogol, pp. 296-304.
Savoj ripercorre il pensiero religioso e spirituale di Gogol’ attraverso le sue opere
partendo dalle prime esperienze dell’adolescenza testimoniate dalle Confessioni,
quando avvertiva già di dover realizzare qualcosa di “utile” all’umanità inseguendo
l’arte e la giustizia, fino alla composizione di Revizor e le Mërtvye duši.
“Galleria. Rivista mensile illustrata del ”Corriere italiano”
(Ardegno Soffici, 1924)
Fasc. 3 – marzo:
• S.a. Anton Ceckov, Un cane di razza, pag. 13.
Fasc. 5 – maggio:
• Raissa Naldi, traduzione: Aleksandr Sergeevic Puskin, Il poeta, pag.
50.
339
“La Riforma letteraria” (Alberto Carocci e Giacomo Noventa,
1936-1939)
I 1936
Fasc. 2-3 – dicembre/gennaio:
• Anonimo, André Gide, Retour de l’ U.R.S.S. (recensione), pag. 130.
IV 1939
Fasc. 6 - 30 – giugno:
• La Riforma Letteraria (La Redazione), Il pensiero russo dal
decabrismo alla guerra mondiale, pag. 10.
Si tratta della presentazione del volume di W. Giusti Il pensiero politico russo
dal decabrismo alla guerra mondiale ( Milano, 1939) inserito nella collana diretta da
Gioacchino Volpe. Il volume viene lodato per le chiare note esplicative e per la
decisione dell’autore di esporre le principali caratteristiche dei movimenti
rivoluzionari, che minacciavano la struttura socio-politica della Russia nell’800, dal
primo movimento liberale del dicembre 1825 ai preludi del bolscevismo.
“La Ronda” (Dir. Aurelio E. Saffi, 1919-1923)
I 1919
Fasc. 1 – aprile:
• Marcello Cora, Ritorni inutili a inutili paesi: I. Paesi slavi del Nord,
pp. 54-57.
Descrizione del tipico paesaggio slavo, dalle pianure polacche alla Siberia, con
una caratterizzazione al negativo del “gelido inverno” del Nord.
Fasc. 2 – maggio:
• r.[iccardo] b.[acchelli], Étienne Antonelli, La Russie Bolchéviste. Paris,
Bernard Grasset, 3 fr. 50, 1919, 3me edition – recensione, p. 75.
Presentazione del volume come documento della cultura storica dei francesi e
testimonianza dei fatti accaduti nella Russia bolscevica, un saggio orientato, secondo
l’A., a giustificare la tesi aprioristica che il bolscevismo risponde a una precisa
necessità storica.
Fasc. 3 – giugno:
340
• Marcello Cora, Ritorni inutili a inutili paesi: II. Russia, Ungherìa, pp.
47-50.
Descrizione del paesaggio siberiano e ungherese, ricco di riferimenti al passato di
quelle terre, dominate da tatari, magiari e slavi nonché crocevia di culture e popoli
diversi.
Fasc. 4 – luglio/agosto:
• a.[urelio] e.[milio] s.[affi], recensione a: Leonida Andreief. Lazzaro e
altre novelle. Russia. Traduzione di C. Rèbora, Firenze, Vallecchi, 1919
– Sotto il giogo della guerra. Traduzione di Lydia e Francesco Paresce,
Firenze, Vallecchi, 1919, pp. 77-80.
Il volume è considerato rappresentativo non solo della tecnica narrativa di Andreev
ma anche della sua appartenenza, oltre che alla letteratura russa, alla tradizione europea
e borghese di Zola, Maupassant e Maeterlinck.
Fasc. 8 – 9 dicembre:
• e.[milio] c.[ecchi], recensione a: Leonida Andreieff. I sette impiccati.
Traduzione di Decio Cinti. Ed. Sonzogno, Milano; – Id., Giuda
Iscariota. Traduzione di Decio Cinti. Ed. Sonzogno, Milano, pp. 80-82.
L’A. evidenzia la morale che sta alla base sia del primo che del secondo volume,
relativa al senso della vita e alla necessità di osservare la realtà con la giusta distanza,
cogliendo ciò che è essenziale e tralasciando tutto il resto. Breve cenno, infine, al
significato della ‘prigione’ come ‘luogo mentale’ e condizione esistenziale.
II 1920
02 – febbraio:
• Anonimo, Amici della Russia. Società italiana per lo studio delle
civiltà slave, pp. 73-75.
Breve notizia sulla probabile costituzione di una società italiana per lo studio della
cultura russa a Roma o a Firenze, di cui vengono citati i principali articoli statutari.
L’iniziativa nasce dalla necessità di allacciare concreti rapporti culturali con la Russia
alla luce degli epocali cambiamenti apportati dalla Rivoluzione, incoraggiando
traduzioni di autori russi in italiano e borse di studio per giovani studiosi italiani in
Russia.
Fasc. 4-aprile:
• Bruno Barilli, Delirama: Balli russi, pp. 41-43.
Descrizione della compagnia dei “Balletti russi” di Djagilev, con riferimento ai
suoi aspetti peculiari e distintivi rispetto alla tradizione europea; in particolare, si
menziona la ballerina Ljubov’ Černičeva nella sua interpretazione di Cleopatra, e i
ballerini de Il principe Igor’.
Fasc. 5 –maggio:
341
• Aurelio E. Saffi, Divagazione su Nicola Gogol, pp. 35-40.
L’A. descrive l’arte di Gogol’, resa celebre da due aspetti peculiari: l’elemento
fantastico-naturale e fiabesco, presente nelle novelle ucraine, e quello umano-satirico,
caratteristico delle commedie e delle altre novelle, dove protagonista è la burocrazia
russa.
Fasc. 8/9 – agosto/settembre:
• e.[milio] c.[ecchi], recensione a: Reminiscences of Leo Nicolayevitch
Tolstoi. Authorized Translation by S.S. Koteliansky and Leonard Woolf.
Published by the Hogarth Press, Paradise Road, Richmond, 1920, pp.
110-112.
Breve descrizione del libretto con le note, che Maksim Gor’kij era solito scrivere
subito dopo le sue conversazioni con Lev Tolstoj, soprattutto quelle relative al difficile
periodo di convalescenza trascorso in Crimea dopo una grave malattia.
III 1921
Fasc. 6 – giugno:
• C. E. Suckert (Curzio Malaparte) recensione a: M. Gorki. Ricordi su
Leone Tolstoi, Firenze, «La Voce» 1921, pp. 66-70.
Il libro viene presentato come un’accurata e scrupolosa analisi dell’opera di
Tolstoj e delle sua complessa personalità; si sottolinea la piena comprensione di
Gor’kij del genio e dell’arte tolstojana e si evidenziano altresì contraddizioni e ‘limiti’
di giudizio.
Fasc. 8/9 – agosto-settembre:
• La Redazione, traduzione (a cura della stessa Redazione?): Valentin
Bulgakov, Pagine inedite di un diario su Tolstoj, pp. 29-44.
Pagine inedite tratte dal libro di Bulgakov, segretario personale di Tolstoj durante
l’ultimo anno di vita dello scrittore di Jasnaja Poljana .
Fasc. 10 – ottobre:
• Riccardo Bacchelli, Omaggio al conte Tolstoi, pp. 5-14.
L’A. espone le sue personali impressioni sulla personalità e l’arte di Tolstoj con
riferimenti precisi a episodi e personaggi di Vojna i mir, Anna Karenina e Voskresenie,
evidenziando la capacità dello scrittore di immortalare nei romanzi la quotidianità
senza mai giudicarla.
IV 1922
Fasc. 1 – gennaio:
• g.u. (Giuseppe Ungaretti?), A proposito di un saggio su Dostojevski,
pp. 68-69.
Riassunto di un saggio di Jacques Rivière uscito il 1 febbraio sulla “Nouvelle
342
Revue Française”, dove lo stile e l’arte di Dostoevskij, spesso poco o mal compresa
daslla critica letteraria, vengono ricondotti più al ‘disordine mentale’ e alla ‘follia
creativa’ dello scrittore che al risultato di un’indagine psicologica della sua personalità.
Fasc. 3/4 – marzo/aprile:
• Ardegno Soffici, Osservazioni intorno alla letteratura russa, pp. 2536.
Sugli aspetti e gli autori della letteratura russa più rappresentativi. Vengono
menzionati Turgenev, di cui si sottolinea la produzione letteraria “provinciale e
mondana”, Dostoevskij, la cui grandezza viene più identificata con la dote straordinaria
di “psichiatra-psicologo” che in quella di “artista-scrittore”, e Tolstoj, vera
incarnazione dello spirito russo, nonché ottimo romanziere e “artista della parola”.
Fasc. 7/8 – luglio/agosto:
• Thomas Mann, Goethe e Tolstoi, pp. 71-84.
Partendo da episodi di vita privata di un certo Giulio Stöterer, insegnante vissuto a
Weimar dal 1812 al 1905 a pochi passi dalla casa di Goethe, Mann descrive le
personalità di Goethe e Tolstoj, conosciuti personalmente dallo stesso Stöterer a
distanza di tempo e in due diverse occasioni.
Fasc. 9-10 – settembre-ottobre:
• Léon Tolstoi, A che fine?: Racconto del tempo dell’insurrezione
polacca, pp. 44-73.
Breve introduzione critica della Redazione al racconto di Tolstoj in traduzione
italiana dopo la precedente versione, pubblicata nel 1906 a Firenze presso la Nuova
rassegna di letterature moderne;
Fasc. 12 – dicembre:
• Riccardo Bacchelli, Paradosso su Tolstoi e su Dostoievschi, pag. 5580.
Analisi dell’opera letteraria di Tolstoj e Dostoevskij attraverso paralleli e
confronti con scrittori europei e personaggi storici passati e presenti. Si tratta di un
approccio critico ai due personaggi, che l’A. considera ‘necessario’ in mancanza di
un’adeguata conoscenza della letteratura russa.
343
“Le Opere e i Giorni. Rassegna mensile di politica, lettere,
arti, etc.” (Mario Maria Martini, 1922-1938)
Anno I (1922)
n. 1, 1 marzo 1922:
• Gubello Mèmmoli, La politica internazionale nel 1921, pp. 15-21.
L’articolo fa un bilancio dei rapporti diplomatici tra la Russia e i Paesi
dell’Europa occidentale negli anni 1921 e 1922, registrando una politica fallimentare
per quanto concerne le relazioni con l’Oriente europeo, fondamentali per la
ricostruzione europea. Ciascuna delle parti ha mantenuto le proprie posizioni e l’unico
segno di cambiamento è da considerarsi la decisione presa a Cannes dalle grandi
potenze alleate d’invitare la Russia alla Conferenza di Genova.
• Giulio Benedetti, Aspetti e incognite della crisi jugoslava, pp. 22-27.
Breve storia dei rapporti diplomatici e politici fra gli Stati, che compongono la
Jugoslavia dalla formazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni al Trattato di
Rapallo, che portò alla parziale soluzione della crisi italo-jugoslava e al persistente
rifiuto da parte del governo di Belgrado di un accordo con l’Italia per la città di Fiume.
n. 3, 1 maggio:
• Waldemaro Jollos, La letteratura russa d’oggi, pp. 46-51.
L’A. mette in evidenzia come la produzione letteraria della Russia si ancora viva
nonostante l’opinione comune di una letteratura russa ormai spenta, rappresentata da
scrittori non più in grado di produrre. Secondo l’opinione di molti, l’eredità dei grandi
scrittori di fine Ottocento sarebbe sopravvissuta perché sono ‘sopravvissute’ le tristi
condizioni del popolo russo, lasciando il posto alla decadenza.
n. 6, 1 agosto:
• Ivan Wassiljeff, La Germania nuova vista da un russo, pp. 3-8.
Impressioni e considerazioni intorno alla Germania del dopoguerra di un cittadino
russo, Ivan Vasilev, vissuto a lungo in quel paese prima dello scoppio della guerra.
Vasilev sottolinea il profondo cambiamento nelle istituzioni, nella vita pubblica e nella
cultura della Germania e, soprattutto, il delicato passaggio dall’ordine e dal militarismo
alla libertà e alla democrazia. Tutto ciò viene attribuito all’influenza dello spirito
russo-asiatico.
• Renzo Bianchi, Moussorgski, pp. 52-55.
Partendo dalla constatazione che l’arte di Musorgskij non può considerarsi
“anello di una catena” all’interno del panorama musicale russo ma pura “rivelazione”,
espressione autentica dell’anima di un popolo, l’A. traccia una biografia del
compositore.
n. 7, 1 settembre:
344
• Renzo Bianchi, Moussorgski, pp. 53-58 (continuazione).
Anno II (1923)
n. 8, 1 agosto:
• Renzo Bianchi, Le origini dell’opera russa, pp. 54-58.
L’articolo descrive i grandi periodi della storia della musica in Russia,
riproponendo la suddivisione di Beregovskij: 1. vecchi canti popolari e poemi epici
divulgativi - 2. instaurazione del cristianesimo (fine X sec.) - 3. influenza della musica
italiana (sec. XII) - 4. risveglio della musica nazionale avviato da Glinka.
n. 10, 1 ottobre:
•
Renzo Bianchi, Glinka, pp. 52-56.
Biografia del celebre compositore russo.
Anno III (1924)
n. 4, 1 aprile:
• Ivan Wassiljeff, L’eredità di Lenin, pp. 3-9.
Bilancio della situazione socio-politica in Russia dopo la morte di Lenin, la cui
azione politico-rivoluzionaria sopravvive nella volontà del popolo e nella necessità di
avviare una rivoluzione sociale che, lontana dagli slanci rivoluzionari della ‘prima ora’
e a due anni dalla Conferenza di Genova, possa ristabilire l’ordine e rilanciare
l’economia del paese.
n. 7, 1 luglio:
• Mario Vinciguerra, Russia europea, pp. 3-7.
L’A. ripercorre le principali tappe verso la graduale apertura diplomatica della
Russia all’Europa, sottolineando il passaggio dalla Russia imperiale extra-europea e
asiatica a quella europea sempre più presente sulla scena internazionale in un percorso
che include il Trattato di Versailles, il Trattato di Rapallo e la Conferenza di Genova
del 1922.
n. 10, 1 ottobre:
• Giulio Benedetti, Il fermento nei Balcani e l’attività della Russia
soviettista, pp. 3-6.
L’articolo si sofferma sulle reazioni politiche degli Stati membri della Piccola
Intesa alla possibilità di un ‘risveglio’ dell’Unione Sovietica e alle conseguenze che ciò
comporterebbe nelle relazioni fra i Paesi sorti dopo la crisi dell’impero asburgico.
Stessa sorte rischierebbero anche Romania, relativamente alla questione sulla
Bessarabia, Cecoslovacchia e Jugoslavia.
345
• Iwan Wassiljeff, Nel paese dei Soviet: apparenze e realtà, pp. 7-11.
L’articolo indaga le cause di un’apparente tranquillità riscontrabile, negli ultimi
tempi, nella politica russa e sulle sue possibili interpretazioni. Lo stesso alone di
mistero sembra avvolgere la clamorosa adesione al Bolscevismo da parte di Boris
Savinkov, storico nemico del regime, che a differenza della maggior parte degli
emigrati russi ha continuato la resistenza armata.
Anno V (1926)
n. 3, 1 marzo:
• Taulero Zulberti, traduzione: T. G. Masaryk (Presidente della
Repubblica Cecoslovacca), Roma aeterna (Roma: dicembre 1914gennaio 1915), pp.m 3-11.
Si tratta del secondo capitolo delle Memorie del Presidente della Repubblica
cecoslovacca T. G. Masaryk durante il suo soggiorno romano, fino a quel momento
pubblicate solamente in lingua ceca col titolo Světové Revoluce (La rivoluzione del
Mondo) e basate su un diario frammentario.
n. 4, 1 aprile:
• Jvan Wassilieff, La terza fase del bolscevismo in Russia, pp. 3-8.
Nell’articolo vengono riassunte le fasi del bolscevismo: la prima, caratterizzata
dall’aperta ostilità all’Europa e al capitalismo, che coincise col periodo del comunismo
integrale, dell’emigrazione e della guerra civile; la seconda, guidata da Stalin, Sinovev
e Kamenev, segnata da un avvicinamento al sistema capitalistico e dal riconoscimento
de jure da parte dei maggiori stati europei; e la terza fase, che inaugura la
‘ricostruzione’.
• Cesare Spellanzon, Stefano Radic, pp. 9-12.
Profilo di Stefan Radić, uomo politico e oratore, fondatore del partito dei
contadini in Croazia con un chiaro programma antiserbo e repubblicano,
particolarmente attivo negli ultimi anni caratterizzati da un’assoluta opposizione alla
politica acentratrice della Serbia.
• Alberto Lombroso, Per la Dalmazia italiana (A proposito delle
Memorie del Presidente Masaryk) (lettera), pp. 13-17.
• Michele Lièrmontoff, “Ascik-Kerib” (Fiaba turca), traduzione di
Rinaldo Küfferle, pp. 18-25.
n. 7, 1 luglio:
• Jwan Vassjlieff, Il Trattato russo-tedesco e le sue conseguenze, pp. 36.
Nell’articolo si sottolinea l’importanza storica del Trattato di Berlino tra Germania
e Russia. Dopo il Patto di Locarno e l’entrata della Germania nella ‘Società delle
Nazioni’, la Russia rischiava di rimanere politicamente isolata: a Berlino il Ministro
degli Esteri russo Čičerin riuscì a tenere la Russia saldamente ancorata all’Europa,
346
scongiurando l’egemonia anglosassone.
n. 10, 1 ottobre:
• Cesare Spellanzon, Stambuliski e la politica bulgara, pp. 3-14.
Fatti storici relativi alla Bulgaria dalla fine della prima guerra mondiale al
Trattato di pace firmato a Sèvres nel 1920 fra le potenze alleate e la Turchia, comprese
le questioni aperte, che interessarono la politica di Stambulski, relative al dominio della
Tracia, occupata di fatto dalla Grecia ma ambita dalla Bulgaria, e all’egemonia sul
mare Egeo.
Anno VI (1927)
n. 5, 1 maggio:
• ‘Commenti e Notizie di Lettere’. Russia, pp. 59-60.
Breve notizia della pubblicazione sul giornale “Slovo” di Riga di un episodio
autobiografico in cui lo scrittore russo Tajgin riferisce sul suo primo incontro con
l’autore di Boris Godunov.
n. 6, 1 giugno:
• ‘Commenti e Notizie di Lettere’. Russia, pp. 63-64.
Breve notizia della decisione del Governo di Mosca di pubblicare in occasione del
settantacinquesimo anniversario della morte di Gogol’ tutti i suoi scritti, compresi
alcuni completamente inediti rintracciati presso privati o rinvenuti in archivi pubblici.
n. 10, 1 ottobre:
Giulio Melegari (Ambnasciatore Onorario di Sua Maestà il Re),
Settantacinque anni di Governo femminile in Russia nel settecento, pp.
22-35.
•
Si ricorda come la monarchia russa nel Settecento fosse un Governo composto
quasi esclusivamente da donne, succedutesi sul trono dei Romanov: Caterina I, Anna di
Curlandia, Elisabetta e la breve reggenza della Principessa Anna di Brunswik. Un
simile caso nella storia si era riscontrato con la lunga serie di Imperatrici bizantine, le
varie Irene, Zoe e Eudossie, per la successione al trono dell’Impero d’Oriente.
Anno VII (1928)
n. 2, 1 febbraio:
•
Lorenzo Gigli, Il martirio di Sollogub, pp. 54-57.
Si ricorda il sacrificio e l’abnegazione dei rappresentanti della generazione
letteraria d’anteguerra durante la fervida e dignitosa opposizione al bolscevismo, in
particolare quella di Fëdor Kuz’mič Sologub, pseudonimo dello scrittore Teternikov.
Fra gli esiliati si menzionano Merežkovskij, Kuprin, Bunin, Šestov, Grebenščikov,
Bal’mont, Aleksej Tolstoj, Remisov, Muratov.
347
n. 3, 1 marzo:
• Ivan Vassilieff, Il duello Trotzki-Stalin e la situazione russa, pp. 8-14.
L’articolo sottolinea come la lotta fra le due personalità non fosse spiegabile con
le sole ragioni di una personale avversità e divergenza di opinioni ma originasse dal
fatto che in Russia non potevano conciliarsi teoria e pratica del bolscevismo.
• ‘Commenti e Notizie di Lettere’. Russia: Lettere inedite di Turghenieff
, pp. 72-77.
Si pubblicano alcuni frammenti del diario di Turgenev rinvenuti in un archivio
storico privato di Mosca e relativi al periodo più triste della sua vita.
n. 5, 1 maggio:
• ‘Commenti e Notizie di Lettere’. Russia, pp. 89-90.
Breve notizia della pubblicazione in Russia per la ‘Casa Editrice Statale’ di un
interessante libro di memorie del notissimo giornalista e scrittore Jeronim Jassinskij, il
quale conobbe personalmente Dostoevskij e Turgenev, apprendendo da quest’ultimo
alcuni bizzarri aneddoti di vita quotidiana di cui fu protagonista Dostoevskij.
n. 7, 1 luglio:
Jwan Wassilieff, La nuova crisi del bolscevismo russo. Il processo di
Donez a Mosca, pp. 3-11.
•
L’articolo espone le circostanze e le ragioni, che condussero al processo di
Donec; nell’omonima regione russa, bacino minerario di carbone e ferro, era stato
sventato un piano controrivoluzionario ai danni della Repubblica Sovietica. La stampa
russa dell’epoca raccontava che ingegneri e tecnici, istigati dagli ex- proprietari delle
miniere, avevano compiuto una serie di atti di sabotaggio, inondando i pozzi e
bloccandone l’attività.
n. 8, 1 agosto:
• Lorenzo Gigli, Massimo Gorki, pp. 39-46.
L’A. traccia un profilo biografico dello scrittore, di cui si celebrava in Russia il
sessantesimo anno di vita con un vasto programma di eventi e con l’edizione di Stato in
venti volumi delle opere complete.
• S.a. ‘Notizie e Commenti di Lettere’. Russia, pp. 80-81.
Breve notizia della pubblicazione sul prossimo fascicolo di “Krasnyj Archiv” di
sei lettere inedite che Fëdor Dostoevskij scrisse in Siberia, dov’era stato esiliato; viene
qui riprodotta la lattera indirizzata al fratello Miša che reca la data del 9 ottobre 1859.
n. 10, 1 ottobre:
• Iwan Wassiljew, La “Eterna Amica” di Dostoievski, pp. 56-60.
Il contributo è dedicato ad Apollinarija Prokof’ievna Suslov, personaggio molto
caro a Dostoievskij, in occasione della pubblicazione di un suo libro di memorie uscito
a Mosca col titolo Gody moich otnošenij s Dostoevskim.
348
n. 12, 1 dicembre:
• Ivan Wassiljeff, La situazione in Russia. La dissoluzione del partito
comunista, pp. 7-13.
Alla vigilia delle elezioni per i Soviet in Russia, si ricorda l’opposizione di Trockij
alla politica del partito comunista diretta da Stalin e la nuova “opposizione di destra” al
suo governo.
Anno VIII (1929)
n. 6, 1 giugno:
• S.a. Notizie e Commenti di Lettere: Tra gli scritti inediti di Arkady
Avarcenko, pp. 84-85.
Frammenti tratti da alcuni scritti inediti di Arkadij Averčenko.
n. 7, 1 luglio:
• Umberto Nani, Aspetti della questione bulgara, pp. 3-7.
In riferimento alle due grandi ricorrenze nazionali festeggiate dal popolo bulgaro lo
scorso maggio, il millenario del grande regno bulgaro dell’alto medioevo e il 50°
anniversario della liberazione dell’attuale Bulgaria dal giogo turco, l’A. evidenzia la
questione ancora aperta della Macedonia contesa da greci, serbi e bulgari. I greci
rivendicano la regione basandosi su motivazioni religiose, i serbi su ragioni politiche e
i bulgari su argomentazioni etniche.
• S.a. ‘Notizie e Commenti di Lettere’. Russia: Anatolio Lunaciarski,
biografia, p. 70.
n. 8, 1 agosto:
• Olga Malavasi Arpshofen, traduzione: Enrico Sienkiewicz, Janko il
musicista (Novella), pp. 25-30.
Anno IX (1930)
n. 1, 1 gennaio:
• Ivan Vassilieff, Aspetti del terrore bolscevico: Stalin al potere, pp. 412.
L’articolo traccia un profilo del dittatore sulla base delle rivelazioni di
Besedovskij, Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Sovietica a Parigi. Nella
sua descrizione, Besedovskij riferisce aspetti esteriori e aneddoti di vita quotidiana di
Stalin descrivendo, ad esempio, la sua ‘perfidia’ nel preparare l’archivio segreto con la
documentazione di tutti i ‘peccati’ piccoli e grandi dei compagni di partito ai tempi
dello zarismo,
349
n. 4, 1 aprile:
• Cesare Giulio Viola, Ritratto di donna russa (novella), pp. 48-52.
n. 8, 1 agosto:
•
G. M. Sangiorgi, La politica estera della Russia bolscevica, pp. 29-39.
Rassegna dei principali avvenimenti nella politica estera nella Russia bolscevica,
in particolare i protocolli di Mosca del 1928 e Litvinov, firmato a Mosca nel 1929 tra
Russia, Polonia, Romania, Estonia e Lettonia, e gli accordi politico-economici con
l’Inghilterra.
Anno X (1931)
n. 2, febbraio:
• Cesare Spellanzon, La Bulgaria nell’ora presente, pp. 3-9.
Dopo il matrimonio di Re Boris III con Giovanna di Savoia, evento di rilievo
internazionale insieme al trattato di Neuilly-sur Seine, l’A. descrive la situazione
politico-diplomatica della Bulgaria indipendente, appena uscita da un lungo periodo di
isolamento, soffermandosi sulla personalità di Boris e sulla sua importante opera di
ricostruzione del Paese.
Anno XI (1932)
n. 4, aprile:
Rodolfo Mosca, Prospettive per l’edificazione della città sovietica, pp.
3-9.
•
Nell’articolo si analizza la situazione socio-economica dell’U.R.S.S. alla luce del
programma d’azione del “Piano Quinquennale”.
n. 9, 1 settembre:
•
Carlo Lozzi, Gorkij e il bolscevismo, pp. 31-35.
L’A. descrive le fasi più significative dell’adesione dello scrittore russo alla causa
rivoluzionaria antizarista. Nella sua analisi, Lozzi sottolinea la sensibilità dello scrittore
verso i nuovi problemi socio-economici, che la rivoluzione del 1917 ha portato insieme
alla caduta del regime zarista, nonché i contrasti ideologici con Lenin e Trockij.
Anno XIII (1933)
350
n. 2, febbraio:
• Umberto Nani, La crisi jugoslava, pp. 10-16.
L’A. descrive la crisi dello Stato jugoslavo degli ultimi anni nei suoi aspetti
politici, col fallimento della dittatura di re Alessandro con l’abolizione dei partiti e
della libertà costituzionale, nazionali, con la continua lotta interna tra serbi e croatosloveni, ed econimici, col brusco calo delle importazioni.
n. 7, 1 luglio:
• Balticus, La politica scolastica dei Soviet, pp. 3-8.
Sulla base di un saggio di Siegbert Riethmeister, profondo conoscitore
dell’Unione Sovietica, l’A. traccia un bilancio di quanto si è fatto in Russia nel campo
scolastico in quindici anni di regime, evidenziando le radicali modifiche ai programmi
pratici d’insegnamento a partire dal 1917 con effetti disastrosi sulla formazione degli
studenti.
n. 12, 1 dicembre:
• Sergio Wassilieff, Tra Pietroburgo e Leningrado, pp. 3-13.
Vasilev descrive le trasformazioni edilizie e architettoniche della città
avvenute sotto il regime bolscevico.
Anno XIV (1934)
n. 1, 1 gennaio:
• Vito Augusto Martini, Jugoslavia e Dalmazia, pp. 3-8.
L’A. esprime, nei toni di una chiara propaganda fascista, il proprio dissenso nei
confronti della decisione presa dall’Italia col trattato di Rapallo di rinunciare alla
sovranità in Dalmazia, appellandosi all’’italianità’ da sempre riconosciuta a quella
regione della Jugoslavia, che i nazionalisti slavofili e alcuni intellettuali italiani come
Gaetano Salvemini hanno sempre negato.
n. 2, 1 febbraio:
Sergio Wassilieff (alias, Balticus), La stampa nella Russia dei Soviet,
pp.19-25.
•
Sui rapporti tra la stampa sovietica e quella zarista; la prima, non riconoscendosi
in una tradizione comune con la stampa zarista, riconduceva le proprie origini a quella
rivoluzionaria e clandestina dell’anteguerra, nonostante il più antico giornale russo
fosse “Vedomosti” fondato da Pietro il Grande.
•
Germanicus, Il film tedesco e l’esempio russo, pp. 59-62.
L’A. mette in evidenza come il modello cinematografico russo, tecnica, sistema
d’arte e metodo di lavoro, fosse sopravvissuto in Germania anche dopo l’avvento del
film sonoro.
• Vladimiro Proutchichew, Pilsudski, pp.24-29.
351
Biografia del maresciallo polacco Józef Piłsudski.
Anno XV (1935)
n. 3, 1 marzo:
• Balticus, Aspetti della Russia d’oggi. L’amministrazione della
giustizia, pp. 7-13.
L’A. evidenzia come l’introduzione della N.E.P. in Russia nel 1921 e il
consolidarsi dell’edificio statale comunista resero necessario un nuovo ordinamento
chiaro e definito per il diritto penale.
n. 5, 1 maggio:
•
Jwan Wassilieff, Il teatro russo d’oggi, pp. 43-45.
Nel contributo vengono descritte le forme del teatro russo contemporaneo nei vari
repertori, classico, ottocentesco e moderno, e il ruolo centrale nella vita del popolo.
Anno XVI (1936)
n. 7 e 8, 1 luglio-1 agosto:
• Massimo Gorki, Platone Bagrow, pp. 46-55 (continua).
n. 9 e n. 10, 1 settembre- 1 ottobre:
• Massimo Gorki, Platone Bagrow, pp. 24-29, continuazione e fine.
Anno XVII (1937)
n. 3, 1 marzo:
• Waldemar Jollos, Puskin e la Russia d’ oggi, pp. 3-11.
In occasione del centenario della morte di Puškin del 10 febbraio scorso, l’A.
associa la gratitudine e l’ammirazione degli emigrati russi nei confronti del poeta
all’entusiasmo con cui la Russia bolscevica proclama il poeta “massimo precursore
spirituale per sé e per la propria idea”.
n. 7e 8, 1 luglio e 1 agosto:
• Mario Maria Martini, Santa Russia (novella), pp. 29-50.
n. 9 e 10, 1 settembre - 1 ottobre:
352
• Taulero Zulberti, Il dramma di Pusckin alla luce di documenti inediti,
pp. 60-63.
In occasione del centenario della morte di Puškin l’articolo riporcorre le vicende
biografiche del poeta alla luce di documenti inediti sulla vita e sulle opere.
Anno XVIII (1938)
n. 2, 1 febbraio:
• Polifilo, Ritorni dalla Russia di Stalin, pp. 3-6.
L’articolo descrive il pensiero comunista e filobolscevico del romanziere francese
Louis Ferdinand Céline di ritorno dal suo viaggio nella Russia dei Soviet.
353
“Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti”.
Direttore: Maggiorino Ferraris (1917-1926)
Anno 53°
Fasc. 1104, 16 gennaio:
• Anonimo, I negoziati di pace fra la Russia e la Germania, in
‘Problemi di guerra’, p. 206:
Breve contributo sui negoziati di pace in corso fra Russia e Germania subito dopo lo
scoppio della rivoluzione in Russia.
Fasc. 1105, 1 febbraio:
• Giovanni Perosio, Le origini della rivoluzione in Russia, pp. 298-303.
S’indagano le cause che condussero alla rivoluzione del 1917 e si evidenziano
episodi e aneddoti che possono considerarsi simbolici di un profondo cambiamento
politico e del crollo definitivo della burocrazia zarista. L’A. rievoca l’invito a colloquio
che il conte Witte, Primo Ministro dello zar Nicola II, rivolse ai delegati del “Comitato
operaio”, guidati dal tribuno popolare Chrustalev-Nosar’, per l’elezione di una
rappresentanza nazionale.
• «Gli Slavi» di A. Mickiewicz.- Milano, Libreria Editrice Milanese, pp.
180. L. 3, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 336.
• La Serbie Agricole et sa démocratie, par Miliorade Zébitch, préface de
Yves Guyot. – Paris, Berger-Levrault, pp. 84. Fr. 3, in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 336.
Fasc. 1108, 16 marzo:
• Benedetto De Luca, Le risorse granarie dell’Ukraina, in ‘Problemi di
guerra’, pp. 233-235.
Bilancio della produzione agraria in Ucraìna, considerata insieme alla Podolia e
alla Bessarabia il “granaio d’Europa”, subito dopo la Rivoluzione e la seconda guerra
mondiale. Negli ultimi vent’anni, grazie alle nuove tecnologie introdotte nella regione
che si estende dalle rive del Volga, presso Kazan’, alla Moldavia attraverso i bacini del
Don, Dnepr’ e Dnestr’, la produzione di frumento era aumentata ma con l’avvento
della guerra subentrarono difficoltà di varia natura.
• La nazione czecoslovacca nella guerra mondiale – I volontri
czecoslovacchi negli eserciti dell’Intesa . –Roma, «Ausonia», in ‘Libri e
recenti pubblicazioni’, p. 236.
Fasc. 1109, 1 aprile:
354
• Perdons-nous la Russie? Par Marcel Sembat. – Paris, Grasset, pp. 64.
Fr. 0.50, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 340.
Fasc. 1112, 16 maggio:
• Wladimiro Korolenko, Le ombre. Novella, traduzione di Luigi Orsini e
Gregorio Bomstein, pp.121-138.
Fasc. 1113, 1 giugno:
• Rasputin – La fine di un regime, di J. W. Bienstock. – Milano, Treves,
pp. 288. L. 4, IN ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 312.
Fasc. 1114, 16 giugno:
• Paix avec l’Ukraine – Podlachie et Chelm, par Léon Wasilewski. –
Genève, Edition Atar, pp. 48, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 414.
Fasc. 1118, 16 agosto:
• Bruno Brunelli, Il teatro nazionale czeco, pp. 377-383.
In ricordo del cinquantenario del “Teatro Nazionale Ceco”, celebrato a
maggio con festeggiamenti ufficiali, l’A. ripercorre la storia del teatro dalla prima
rappresentazione in ceco al “Teatro degli Stati curiali” (Stavovské divadlo) di Praga
Bretislaw e Jitka di Vaclav Tham, avuta luogo nel 1786, alla nascita del “Teatro
Nazionale” (Narodni divadlo) nel 1868.
• Gli Czeco-slovacchi al fronte italiano, di Arnaldo Agnelli. – Milano,
Treves, pp. 64, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 412.
Fasc. 1124, 16 novembre:
• I bolsceviki, di M. Perwoukhine, con prefazione di E. Schmurlo. –
Bologna, Zanichelli, pp. 172. L. 3, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p.
208.
Fasc. 1125, 1 dicembre:
• La rivolta degli Strelitzi, del generale Filareti. – Bologna, Zanichelli,
pp. 100. L. 2.50; Il Montenegro nel conflitto mondiale, di Roberto
Albino. – Roma, De Agazio, pp. 20. L. 2; Gli uomini che crearono la
nazione czeco-slovacca, di R. Albino. – Roma, De Agazio, pp. 16; La
rivoluzione russa e gli alleati di C. Veidemmiller. – Roma, Poligrafica
Italiana, pp. 24; Il compito della Polonia nell’assetto dell’Europa
orientale, di Giovanni Zamorski. – Roma, pp. 16, in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 328.
355
Fasc. 1126, 16 dicembre:
• Enrico San Martino (senatore), Una visita allo Tsar, pp. 351-360:
Si tratta del resoconto di viaggio del senatore San Martino, recatosi in Russia
allo scopo di organizzare la partecipazione della nazione all’esposizione romana del
1911. Il senatore ricorda il numero di teatri prestigiosi esistenti a Mosca, il Coro del
Santo Sinodo, l’eccellente orchestra sinfonica e un gruppo di pittori attivi nella capitale
russa.
Anno 54°
Fasc. 1127, 1 gennaio 1919:
• Principe Alessanandro Wolkonsky, Le origini della Russia moderna e
la propaganda ucrainofila, pp. 61-72.
Lungo e dettagliato articolo fortemente polemico nei confronti della recente
campagna separatista ucrainofila e del “principio di autodecisione” della nazione
Ucraina affermatosi nel dopoguerra. L’A. si prefigge di confutare tale principio, basato
sull’idea (considerata “fantastica”) dell’esistenza di un popolo ucraino, distinto da
quello russo, di una regione chiamata ‘Rutenia’ con capitale Kiev e di uno stato
autonomo cosacco affermatosi nel XVII secolo.
Fasc. 1129, 1 febbraio:
• Giacomo Boni, Spalato e la Dalmazia, pp. 237-255.
L’A. illustra il contenuto dell’opera dell’architetto Th. G. Jackson Dalmatia,
the Quarnero and Istria, Oxford, 1887, 3 voll., sulle bellezze architettonice della costa
dalmata, tradotta da lui stesso per l’Ateneo di Venezia.
• Princ. Alessandro Wolkonsky, A chi appartengono le steppe del Mar
Nero, pp. 310-324.
Breve storia dei territori meridionali della Russia e del loro rapporto col resto
dell’Asia, dall’invasione tatara del khan Batyj nel 1239-41 ai cosacchi “Zaporožcy”.
Fasc. 1131, 1 marzo:
• La Pologne inconnue, par K. Waliszewski. – Paris, Colin. Fr. 3.50;
Montenegro: in history, politics, and war, by A. Devine. – London,
Unwin., in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 124.
Fasc. 1134, 16 aprile:
• Les luttes politiques des Bulgares Macédoniens, par Georges Strézoff
– Géneve, Edition Atar, pp. 154, Fr. 3.50 ; La Macédonie indivisible
devant le futur Congrès de la paix, par Ghélo Lépide – Lausanne, F.
Beudi, pp. 66 ; Conseil National de la Dobrudja – Mémoire des
représentants de la Dobrudja, 1917-1918. Pp. 34 ; Réquisitoire contre la
Bulgarie, par R. A. Reiss et Bonassieux, pp. 64. Fr. 1 ; La Serbie et la
356
Bulgarie devant l’opinion publique – A propos des protestations
publiques de Géneve et de Lausanne, par D. Micheff, pp. 132. Fr. 3 ;
Pour le peuple bulgare, par A. Forel, pp. 16 ; La vérité sur la
Macédoine, par D. Micheff, pp. 42. Fr. 1; Bulgare et Grecs devant
l’opinion publique suisse, par J. Ivanoff, pp. 24 ; Bulgaria’s Historical
Rights to Dobrudja, by M. G. Markoff, pp. 106 ; Le nom de Bulgare –
Eclaircissemént d’hostoire et d’etnographie, par A. Ischirkoff, pp. 68 ;
La Macédonie et la constitution de l’Exarchat bulgare (1830 à 1837),
par A. Ischirkoff, pp. 34 ; Les rapports bulgaro-serbes et la question
macédonienne, par N. S. Derjavine, pp. 162. Fr. 3 ; La Serbie et le
mouvement national bulgare, par Mich. Mintschew, pp. 104. Fr. 2; Un
peuple calomnié – Appel adressé a Sa Sainteté le Pape, par B. Vélianoff,
pp. 40 ; Quelques mots de réponse aux calomniateurs des Macédoniens,
par S. Kitintcheff, pp. 24. Fr. 0.50; Les liens moraux de l’Amérique et de
la Bulgarie, par D. Micheff, pp. 16. Fr. 0.50; The political lot of the
Dobrudja after the Berliner Congress, pp. 30. Fr. 1, in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 477-478.
Fasc. 1135, 1 maggio:
• Ernesto Nathan, L’insidioso contagio delle parole. Il bolscevismo, pp.
76-80.
Breve riflessione sull’etimologia della parola ‘bolscevismo’ e sul suo significato
storico.
Fasc. 1136, 16 maggio:
• Les Bulgares devant le Congrés de la paix – Documents historiques
ethnographiques et diplomatiques, par J. Ivanoff, avec quatre cartes en
couleures, 2° édition augmentée. – Berne, Librairie Académique, pp.
304. Fr. 10, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 220.
Fasc. 1138, 16 giugno:
• V. Totomianz, La cooperazione in Russia, pp. 25-27.
Si evidenzia come in Russia lo spirito cooperativistico e il senso di solidarietà,
presente soprattutto nei villaggi fra i contadini, siano sopravvissuti alla guerra e alla
rivoluzione.
Fasc. 1139, 1 luglio:
• Luigi Luzzatti, La cooperazione russa, pp. 76-78.
L’A. introduce il volume di prossima pubblicazione a cura del prof. V.
Totomianz, economista e sociologo di origine armena esperto in relazioni fra i popoli e
mutuo soccorso. Nel saggio vengono descritte le naturali attitudini del popoli che
abitano la Russia alla mutua collaborazione, dalla cooperazione agraria, di cui è centro
la Siberia, al considerevole numero di Istituti di credito e banche popolari esistenti a
Mosca.
357
Fasc. 1140, 16 luglio –16 settembre:
• C. A. di Gerbaie di Sonnaz, I soldati italiani in Bulgaria, pp. 195-198.
Breve contributo sui rapporti di amicizia e collaborazione tra i soldati italiani e la
popolazione bulgara durante l’occupazione della colonia italiana in Bulgaria nei primi
anni del Principato di Alessandro di Battemberg dal 1878 al 1890, quando, nel 1886, in
occasione della rivoluzione di Filippopoli, la colonia italiana venne in soccorso ai
bulgari durante la guerra bulgaro-serba;
• Giacomo Boni, Maxim Gorkij, 199-213.
Partendo da cenni di satira politica nel mondo greco e romano l’articolo descrive
l’attività di Gor’kij come “Commissario per le belle arti” a Pietrogrado, nomina
ricevuta dal Ministro dell’Istruzione Anatolij Lunačarskij.
Fasc. 1141, 1 ottobre:
• Le droit et la paix dans les Balkans, par D. Mikof. – Géneve, Atar
Editions, pp. 55 ; La génese de la guerre mondiale, par I. E. Guéchoff. –
Berne, Lib. Académique, pp. 165. L. 4.50; Les Bulgares devant le
Congrés de la paix, par J. Ivanof. – Berne, Libreria Ed., pp. 304, L. 10 ;
La Serbie et l’Europe (1914-1918), par Lazare Marchovitch. – Bâle, Lib.
Ed., pp. 334. L. 8; Les atricités serbes, par M. D. Skopiansky. –
Lausanne, Librerie Centrale des Nationalités, pp. 213. L. 5, in ‘Libri e
recenti pubblicazioni’, p. 344.
Anno 55°
Fasc. 1152, 16 marzo:
• Vladimir, L’ intesa e il governo dei Soviet, pp. 193-203:
Bilancio del Governo bolscevico e dei suoi rapporti con le potenze dell’Intesa,
Francia e Regno Unito, alla fine del conflitto mondiale, in cui l’A. cerca di dimostrare
la ‘necessità storica’ delle sue scelte.
Fasc. 1155, 1 maggio:
• Alfredo Galletti, La Russia e la civiltà occidentale, pp. 3-18.
Dopo un’analisi del pensiero e dello spirito del popolo russo attraverso fatti storici
e scrittori, l’A. sottolinea la ‘necessità storica’ per la Russia di trovare la propria
identità tra Asia ed Europa, tra “fatalismo contemplativo” e “concezione energica e
militante dell’esistenza”, questione identica a quella aperta in passato da Vissarion
Belinskij.
Fasc. 1165, 1 ottobre:
• Ossip Félyne, Uccelli senz’ali, , trad. dal russo di Federico Verdinois,
pp. 229-246.
358
Fasc. 1171, 1 gennaio 1921:
• M. Saltykov (Tchedrin), Fiabe, trad. dal russo di Olga Luntz, pp. 3443.
Fasc. 1173, 1 febbraio:
• F. M. Dostojewsky, Il ladro onesto, pp. 241-252.
Fasc. 1176, 16 marzo:
• La Dalmazia e l’Italia, di Niccolò Tommaseo, a cura di Nunzio
Vaccalluzzo – Città di Castello, «Il Solco», pp. 163. L. 3, p. 192.
Fasc. 1188, 16 settembre:
• Federigo Verdinois, traduzione: Lia Neanova, Quando i bolscevichi
entrarono in città. Novella, pp. 134-148.
Fasc. 1190, 16 ottobre:
• I problemi della letteratura russa, di Ettore Lo Gatto. Pp. 132 . L. 5, in
‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 382.
Anno 57° (1922)
Fasc. 1198, 16 febbraio:
• Federigo Verdinois, traduzione: Ossip Félyne, Il programma, pp. 337344.
Fasc. 1202, 16 aprile:
Umberto Benigni, Dopo l’attentato
controrivoluzionarie, pp. 376-381.
•
a
Miliukow.
Note
Sulle cause, che in Russia hanno indotto la borghesia ‘democratico-liberale’ alla
“controrivoluzione”. Se ne distinguono due tipologie: “immediate e particolari” come il
‘rasputinismo’ e gli errori politico-strategici della guerra, “mediate e generali” in
riferimento alla crisi agraria causata dall’obščina durante l’emancipazione della servitù
della gleba sotto lo zar Alessandro II.
Fasc. 1203, 1 maggio:
• Napoleone Colajanni, La rivoluzione russa. Appunti e giudizi, pp. 5473.
Parte di uno studio inedito dell’illustre collaboratore della rivista da poco
359
scomparso. Nell’articolo si evidenziano i cambiamenti dell’opinione pubblica
internazionale riguardo al bolscevismo sulla base di testimonianze dirette di chi aveva
conosciuto da vicino il regime e ne indagava la ‘verità’ storica.
Fasc. 1204, 16 maggio:
Napoleone Colajanni, Nella Russia del bolscevismo. Il fallimento di
una rivoluzione, pp. 161-174.
•
Bilancio negativo della rivoluzione bolscevica in Russia e delle sue conseguenze:
deficit dello Stato, inflazione cartacea, che ridusse il rublo-carta a zero facendo
ripiombare la Russia all’economia degli scambi, calo della produzione, precarie
condizioni di lavoro, non ricompensato secondo la produttività, e una politica
‘antiborghese’.
Fasc. 1208, 16 luglio:
• N. Tchileff, Vasoff e la letteratura bulgara, pp. 154-159.
Rassegna delle principali opere sulla storia e la civiltà letteraria bulgara a partire
dalla monumentale Storia dei Bulgari (Jstorija slavĕno-bolgarskaja), terminata nel
1762 dal frate Paìsij di Hilendar, solitario monaco del monte Athos, e ispirata alle
cronache di Mauro Orbini. L’A. distingue tre periodi: il primo regno bulgaro dal VII
sec. fino alla caduta sotto Bisanzio nel 1014, il secondo regno dalla fine dal 1185 alla
fine del XIV sec. e il terzo regno dal 1787 al 1922, soffermandosi sul periodo
rinascimentale, rappresentato da Ivan Vasov e compreso tra il 1762 e il 1870.
Anno 58° (1923)
Fasc. 1222, 16 febbraio:
• Le condizioni economiche della Russia. Da un rapporto alla Società
delle Nazioni – Riassunto del dott. F. Bruno, pp. 364-369.
Si tratta di una sintesi del rapporto pubblicato a Ginevra nel 1922 in cui vengono
indagate le cause della terribile carestia che colpì negli anni 1921 e1922 la Russia, già
provata dalla guerra mondiale e dalle rivoluzioni. Il settore maggiormente colpito fu
l’agricoltura per una serie di cause fra le quali: mancanza di infrastrutture per la
coltivazione dei campi, blocco degli scambi con altre nazioni, mutamento del regime
fondiario col ritorno a vecchi metodi di lavoro.
Fasc. 1125, 1 aprile:
• Bureau International du Travail. Bibliographie des questions ouvriéres
et sociales dans la Russie des Soviets. – Genève. Fr. 5; ID., Le service
obligatoire du travail en Bulgarie par M. Lazard – Genève. Fr. 5 , in
‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 288.
Fasc. 1126, 16 aprile:
• Achille Loria, Problemi contemporanei secondo scrittori russi, pp.
318-327.
360
L’A. espone il contenuto di un recente volume pubblicato da un gruppo di
intellettuali russi esuli a Parigi sui problemi che affliggono le democrazie
contemporanee. Gli argomenti sono vari fra cui l’origine della democrazia (J.
Delevskij), il diritto di rappresentanza politica delle minoranze (M. W. Višnjak), la
rappresentanza nazionale in Parlamento (B. E. Noliad), democrazia e socialismo (St.
Ivanovič).
Fasc. 1235, 1 settembre:
• Giulio Borghi, Il lavoro obbligatorio in Bulgaria, Roma, I.p.E.O., pp.
15, L. 3, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 96.
Fasc. 1237, 1 ottobre:
• Manfredi Gravina, La Russia e la sua pesante situazione politica,
economica e militare in Europa, pp. 234-243.
L’articolo indaga le cause dell’assenza della Russia dal mercato mondiale dal
dopoguerra in poi, conseguenza della politica adottata del regime bolscevico, di precise
scelte strategiche degli alleati, in particolare dell’Inghilterra, finalizzate a indebolire le
potenzialità economiche del paese, e della nascita di nuovi Stati baltici, Lettonia,
Estonia e Lituania, vero ostacolo per l’accesso al mare e al commercio sulla costa.
Anno 59° (1924)
Fasc. 1244, 16 gennaio:
• Manfredi Gravina, L’impresa contro Pietrogrado del 1919, pp. 186195.
L’A. descrive nei dettagli l’offensiva controrivoluzionaria antibolscevica di
Pietrogrado dell’8 ottobre 1919, preparata dalle forze miltari coalizzate contro il
governo leniniano e dai generali francesi e inglesi in un momento delicato per la
Russia, il cui regime era stato da poco abbattuto e che aveva interrotto ogni rapporto
diplomatico con le altre potenze della Triplice Intesa.
Fasc. 1245, 1 febbraio:
• Victor, Italia e Jugoslavia, pp. 315-316.
Oggetto del contributo sono la nuova “Convenzione tra Italia e Jugoslavia”, che
regola la questione di Fiume ,e il “Patto di amicizia” tra i due Stati. Nel primo caso, il
documento firmato a Roma tra l’on. Mussolini per l’Italia e gli on. Pasič e Nincič per
Serbia, Croazia e Slovenia, riconosce la sovranità dell’Italia su Fiume e della
Jugoslavia su Porto Baross; nel secondo, si tratta di un accordo di collaborazione
diplomatica e militare che apre nuovi rapporti dell’Italia coi paesi balcanici e
dell’Europa Centro-Orientale.
Fasc. 1246, 16 febbraio:
• Francesco Sapori, La seconda biennale d’arte a Roma, pp. 389-405.
L’A. passa in rassegna le opere di autori italiani e stranieri esposte alla biennale
361
d’arte di Roma, citando, nella sezione dedicata agli stranieri, i bozzetti “a carbone”
provenienti da Parigi realizzati da Boris Grigorev, disegnatore d’eccezione e già autore
di un gruppo di disegni esposti alla XII Mostra Internazionale di Venezia.
• Gina Giannini Alessandri, Nicola Pachitch e l’unità jugoslava, pp.
410-413.
Si traggono alcune conclusioni dopo l’accordo italio-jugoslavo; il patto ha
favorito la politica jugoslava e filoserba del patriota Pasič, che riacquista libertà
d’azione sia contro il separatista Radič che contro gli autonomisti della Slovenia. Il
contributo si apre con una descrizione della ‘nazione jugoslava’ così come viene
concepita dalle tre diverse etnie della regione: ‘centralista’ per i sebi, ‘federalista’ per i
croati e ‘autonomista’ per gli sloveni.
Fasc. 1249, 1 aprile:
• Valentina Dolgin, Diario di Leone Tolstoj. – Milano, Treves, L. 10 in
‘Libri e recenti pubblicazioni’.
Fasc. 1250, 16 aprile:
• Armando Michieli, Pagine d’album d’un prigioniero in Russia
(memorie), pp. 359-372.
Si tratta di memorie di un italiano, prigioniero di guerra in Ucraina e in Siberia,
che ritraggono la quotidianità degli abitanti di Poltava e Tomsk e che si concludono
con un breve saggio sul bolscevismo partendo da un’esperienza di vita in Russia. Nel
saggio il bolscevismo viene visto come naturale e necessaria reazione all’assolutismo
delle classi dirigenti e al disprezzo e all’abbandono morale cui erano condannati
lavoratori e operai.
Fasc. 1253, 1 giugno:
• Michail Ossorghin. Rondinella Natascia. – Milano, Morreale. L. 6 in
‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 320.
Fasc. 1254, 16 giugno:
• T. A. Kouzminskaia, La mia vita, di Leone Tolstoi.-Milano, Treves. L.
6, in ‘Lbri e recenti pubblicazioni’, p. 414.
Fasc. 1256, 16 luglio:
• E. Lo Gatto, Massimo Gorkij, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 192.
Fasc. 1258, 16 agosto:
• Manfredi Gravina, L’eredità di Lenin, pp. 322-332.
L’A. cerca di esporre la situazione del governo di Mosca dopo la pesante eredità
lasciata da Lenin con l’avvio della NEP, ossia: la presenza di un governo ufficiale
dell’Unione delle Repubbliche sovietiche, un ufficio politico del partito comunista, il
362
Politbureau, gestito in gran parte dal triumvirato Sinovev, Stalin, Kamenev, e la Terza
Internazionale.
Fasc. 1259, 1 settembre:
• Nanni T., Bolscevismo e Fascismo al lume della critica marxista.
Benito Mussolini – Bologna,Cappelli, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’,
L. 12, p 96.
• T. A. Kouzminskaia. La mia vita. Riveduto e corretto da Leone Tolstoi
in ‘Libri e recenti pubblicazioni – L. 6, p. 96.
Anno 60° (1925)
Fasc. 1267, 1 gennaio 1925:
• Vlastimil Kibal, La Cecoslovacchia e l’Italia. – Roma, Istituto per
l’Europa Orientale, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 112.
Fasc. 1273, 1 aprile:
• Georges Popoff. Sous l’étoile des soviets, «Plon», Paris, in ‘Libri e
recenti pubblicazioni’, p. 336.
Fasc. 1275, 1 maggio:
• Di San Martino Valperga, Paderewsky, pp. 17-22.
L’A. ricorda qui la visita del musicista polacco Paderewsky a Roma dopo
ventiquattro anni di assenza, in particolare il suo concerto presso l’Accademia e il
discorso tenuto al banchetto in suo onore con cui faceva un parallelo tra Italia e
Polonia, accennando alla fortuna dell’Italia che, rispetto alla Polonia, ha raggiunto
l’unità nazionale.
Fasc. 1278, 16 giugno:
• Vico Mantegazza, Dalla Bulgaria di ieri a quella d’oggi, pp. 363-370:
Breve storia diplomatica della Bulgaria a partire dalla costituzione del Principato
di Battemberg dopo la guerra del 1877-78.
Fasc. 1279, 1 luglio:
• N. Brian-Chaninov. Le Tragédie moscovite (Essai de psychologie
collective). – Paris, «Editions Spes». Fr. 6,50 in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 96.
Fasc. 1280, 16 luglio:
363
• Otto Cuzzer, Dostoїevsky .-Roma, Stock, L. 10; V. S. Reymont, E’
giusto! Romanzo, Stock, L. 10 in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 190.
Fasc. 1282, 16 agosto:
• Anton Cecof, Il Monaco Nero ed altri racconti, Morreale, Milano;
Ivan Turgeniew, Demetrio Rudin. Romanzo, Morreale, Milano; Fiodor
Dostoievski. Les Possedes suivis de la Confession de Stavroguine. –
Volume I, II, III. Edition Bossard, Parigi in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 382.
Fasc. 1283, 1 settembre:
• Leonardo Kociemski, L. S. Reymont – A. F. Formiggini, Edit. In
Roma, in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 96.
Fasc. 1284, 16 settembre:
• Th. Dostoїevscky. Le Joueur. Les nuits blanches. – Paris, Bibli. Plon.
Fr. 3 in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 192.
Fasc. 1286, 16 ottobre:
• Callsya R. (Traduzione dallo spagnolo di E. De Zuani). Russia,
specchio salutare per i ricchi e per i poveri. Ed. F. Campitelli, Foligno
in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 382.
Fasc. 1287, 1 novembre:
• Massimo Gorky, La Vita Azzurra, traduz. Dal russo di Ettore Lo Gatto.
– L. 12.50; Nicola S. Lyeskov, L’Angelo suggellato. Traduz. Dal russo
di Ettore Lo Gatto. – L. 9.50 in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 96.
Fasc. 1289, 1dicembre:
• Serge Voronoff. Etude sur la vieillesse et le rejeunissement par la
Greffe. – Gaston Doin, Editeur, Paris. France 15, in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 288.
Anno 61° (1926)
Fasc. 1292, 16 gennaio:
• Alessandro Puskin. Eugenio Onjéghin. Trad., introduzione e note di
Ettore Lo Gatto. – G. C. Sansoni ed., Firenze. L. 10 in ‘Libri e recenti
364
pubblicazioni’, p. 192.
Fasc. 1293, 1 febbraio:
• Massimo Gorki, Noterelle. – Casa Editrice Morreale, Milano. L. 8 in
‘Libri e recenti pubblicazioni’, p. 288.
Fasc. 1295, 1 marzo:
• P. Kropotkin, Il mutuo appoggio in ‘Libri e recenti pubblicazioni’, p.
104.
Fasc. 1302, 16 giugno:
• Francesco Tommasini, La marcia su Varsavia, pp. 419-432.
Sullo sfondo della grave crisi politica e istituzionale che in quel periodo
attraversava la Polonia l’A. descrive i fatti che condussero il Maresciallo Jozef
Piłsudski all’elezione a Presidente della Repubblica Polacca, nonostante l’opposizione
della sinistra e di certi gruppi del partito di destra.
Fasc. 1303, 1 luglio:
• Georges Lakhowsky L’origine de la vie. La radiation et les êtres
vivants – Editions Nilsson, Paris, Frs. 15 in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 120.
Fasc. 1305, 1 agosto:
• Manfredi Gravina, Il libro arancione russo e la questione degli stretti
alla luce di nuovi documenti, pp. 312-325:
Storia della lunga “Questione degli Stretti” dall’occupazione del Mar Nero da
parte dei turchi nel 1453 alla “Convenzione degli Stretti”, annessa al trattato di pace
con la Turchia firmato a Losanna nel 1923.
• Leonardo Kociemski, La Polonia economica e gli ultimi avvenimenti.
– Ediz. De “La Rassegna dell’Est”, Roma, L. 2, in ‘Libri e recenti
pubblicazioni’, p. 376.
“Occidente” (Armando Ghelardini, 1932-1935)
I 1932
01 – Ottobre-dicembre:
365
• Giulio Santangelo, Lenin mito e uomo – recensione, pp. 106-109:
L’A. presenta il nuovo libro di Curzio Malaparte sulla biografia di Lenin, Le
bonhomme Lenin. Scritto con grande pazienza e di piacevole lettura, il libro ripercorre
fasi della vita del grande rivoluzionario russo, rubate alle cronache ufficiali e non,
cercando di dimostrare che la sua indole non era quella del tiranno.
II 1933
02 – gennaio/marzo:
• Feodor Dostoievschi, Personalità di Rascolnicof, da Appunti inediti di
Feodor Dostoevschi, pp. 7-12.
Si tratta di acuni brani della lettera, che Dostoevskij indirizzò al redattore del
Messaggero russo Kacov, in cui lo scrittore spiega l’argomento del romanzo, che
dovrebbe essere pubblicato dal giornale. (v. “Fiera letteraria”, ultmo numero);
• Maria Ferst, Libri di Stansislaw Baczynski, pag. 136.
03 – apriole/giugno:
• Stanislaw Baczyski, Sangue su Parnaso, pag. 27.
04 – luglio/settembre:
• Panteleimon Romanof, Le stelle, pp. 102-115.
• Giulio Santangelo, La Russia: questione di civiltà, pag. 141-143.
L’articolo trae spunto da un saggio di P.M. Bardi sul “rapporto fascista”
durante un soggiorno nella Russia dei Soviet. La cronaca, realizzata dal punto di vista
del professionista e non del giornalista occasionale, dà all’A. il giusto pretesto per
analizzare il Bolscevismo oggettivamente in un confronto col Fascismo.
III 1934
06 – gennaio/marzo:
• Anonimo, I primi membri dell’ Accademia polacca [foto].
• Anonimo, Vsevolod Pudovchine e i collaboratori del suo ultimo
fonofilm “Il disertore” [foto].
07 – aprile/giugno:
• Lev Tolstoj, Inediti, trad. dal russo e nota introduttiva di T. Landolfi,
pp. 7-20.
Si tratta di una serie di scritti inediti di Lev Tolstoj tratti dal volume L. N. Tolstoj,
Neizdannye Teksty, Redazione e commentari di N. R. Gudzie e N. N. Gusev, pref. di I.
366
M. Nusinov (Ediz. Academia-Gihl, M.-L. Lavori del Museo tolstojano di Stato, 1933,
pp. xxiv-437).
• Anonimo. Un autografo inedito di Leone Tolstoi: la prima pagina
della seconda redazione del romanzo “Resurrezione” [foto].
• Anonimo, L. N. Tolstoi nello studio della casa di Mosca [foto] – L. N.
Tolstoi a passeggio nel giardino dei meli di Iasna Poliana [foto]).
08 –luglio/settembre:
• Umberto Barbaro, Congressi: il primo Congresso degli scrittori dell’
U.R.S.S., pp. 59-61.
Si tratta di una nota informativa sul I Congresso degli scrittori dell’ U.R.S.S.
avvenuto a Mosca nel mese di agosto 1934, che riporta alcuni passi del discorso
inaugurale di Stalin e di una lettera, che gli operai della fabbrica di carta di Balachnino
inviarono ai congressisti, annunziando il dono di 20 tonnellate di carta.
• Boris Pil’njak, Il vento che sa di dimora umana, trad. dal russo di Olga
Resnevic, pp. 72-78.
• Umberto Barbaro, Boris Pilniac con due sermoni, pp. 118-121.
L’A. una biografica di Pil’njak evidenziando i tratti della sua produzione
letteraria, che la distinguono nettamente da quella di altri scrittori contemporanei.
Scorrendo i titoli delle opere, fra cui Golyj god, Čërnyj chleb e Volga vpadaet v
Kaspijskoe more, Barbaro sottolinea il ‘nazionalismo retorico’ più volte condannato
dalla critica comunista in epoca rivoluzionaria.
• Francesco Orlando, Note: su Kafka e su Rèpaci, pag. 130.
• Tommasio Landolfi, Scrittori sovietici. Recensione a: A. Lebedenko,
Tjazelyi divizion (La divisione pesante). II ediz. (Casa editrice degli
scrittori a Leningrado, 1934) – Boris Pasternak, Izbrannye Stihotvorenija
(Poesie scelte). Gihl., Mosca 1934, pp. 136-138.
Nel suo primo intervento l’A. evidenzia alcune mende stilistiche nel volume di
Lebedenko, che confluiscono in una “grigia e cocciuta petulanza” e che si nascondono
dietro una “falsa vena documentaria”. Il critico elogia, però, l’ampio respiro culturale
del volume. Nel secondo intervento, dopo un’introduzione sulla doppia natura artistica
di Pasternak, l’A. analizza la scelta di poesie fatta dallo scrittore russo, considerando la
prefazione di A. Tarašenko “tendenziosa”.
• Anonimo, Scrittori d’ Occidente: Boris Pilniac [foto].
09 – ottobre/dicembre:
• Tommasi Landolfi, Brjusov e Remizov. Recensione a: Valerij Brjusov,
Izbrannye Stihi (Versi scelti). Red., introduz. e note di Igor’
Postupal’skij. Accademia, Mosca-Leningrado, 1934 – A. Remizov,
Tourgueniev, poète du rêve. Hippocrate, Parigi 1934, pp. 118-120.
Nel primo intervento l’A., dopo aver introdotto la figura di Brjusov definendolo
“il padre del simbolismo russo”, elogia la raccolta di versi sia per il ricco apparato
367
critico-introduttivo, sia per la curata veste grafica. Nel secondo caso si tratta di brevi
osservazioni sul volume in lingua francese, considerato dall’A. “uno studio psicologico
di Remizov su Turgenev piuttosto che un saggio critico sulla sua arte”.
IV 1935
10/11 gennaio/aprile:
• Tommaso Landolfi, Nota su Ilf e Petrof, pp. 59-63.
L’A. presenta i due scrittori resi celebri negli anni Venti dai romanzi 12
seggiole e Un Milionario al paese dei Sovieti. Ilf e Petrov erano accomunati da
interessi comuni e i loro scritti, intrisi di umorismo e velata malinconia, possono
considerarsi a metà tra satira e romanzo picaresco.
• Jordan Jovcov, Balkan, pp. 105-115.
12 – maggio/giugno:
• Giuseppe Bukàcek, L’ Europa letteraria. La poesia Céca, pp. 17-22.
• Simone Cucia, Memorie di Sravinsky, pp. 148-150.
• Anonimo, Scrittori d’ “Occidente”: Otokar Brezina [foto].
368
INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI
ADAMI G., “Bilychnis”, XI (1)
ALLIER Raoul, “Bilychnis”, XII (1)
ALMEDINGER M.E., “Bilychnis”, XXIV (1)
AMENDOLA Eva, “Bilychnis”, IX (3), XI (1)
AMOR Bava, “Critica fascista”, XIV (1)
ANAGNIN Eugenio, “Critica fascista”, V (2)
ANDRIULLI Giuseppe A., “L’Italia che scrive”, XII (1)
ANGIOLETTI G, B., “Fiera letteraria”, IV (1)
ANTONINI Giacomo, “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, V
(1), VI (1)
APOLLONIO Mario, “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, VII
(1)
BACCHELLI Riccardo, “Fiera letteraria”, II (7), “La Ronda”, I (1), II
(1)
BALLA Ignazio, “Fiera letteraria”, III (1)
BANDI P.M., “Critica fascista”, X (1)
BANDINI Gino, XXI (2)
BARBADORO Bernardino, “Il Marzocco”, XXIII (1)
BARBARO Umberto, “Occidente”, III (2)
BARILE Angelo, “Solaria”, VII (1)
BARILLI Bruno, “La Ronda”, II (1)
BEGEY BERSANO Maria, “Bilychnis”, XVII (1)
BEM Alfred, “La Cultura”, X (1)
BENEDETTI Giulio, I (1), III (1)
BENIGNI Umberto, “Nuova Antologia”, 57° (1)
BIANCHI Renzo, “Le Opere e i Giorni”, I (2), II (2)
BIANCO Merlo, “Il Selvaggio”, VII (1)
BISCOTTINI Giuseppe, “Critica fascista”, X (1)
BO Carlo, “Frontespizio”, IV (1)
BONI Giacomo, “Nuova Antologia”, 54° (1)
BORGHI Giulio, “Nuova Antologia”, 58° (1)
BOTTI Cesare, “L’Italia che scrive”, VII (1)
BRAGAGLIA Anton Giulio, “Fiera letteraria”, V (1)
BRONZINI Giuseppe, “L’Italia che scrive”, XXIII (1)
BRUNELLI Bruno, “Nuova Antologia”, 53° (1)
BRUNETTA Ernesto, “Critica fascista”, IX (1)
CAJUMI Arrigo, “Fiera letteraria”, IV (1)
CALVINI Luigi, “Frontespizio”, IX (1)
CAMPIGLI M., “Scenario”, XIX (2)
CANTALUPO R., “Critica fascista”, I (1)
CANTIMORI Delio, “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, IV
(1)
CAPASSO Aldo, “Solaria”, V (1), “La Nuova Italia”, II (1)
CAPRILE Enrico, “L’Italia che scrive”, XV (1)
369
CARENA Annibale, “I libri del giorno”, XII (3)
CASALINO Mario,”Fiera letteraria”, IV (1)
CAZZAMINI Francesco, “L’Italia che scrive”, IV (1)
CECCHI Emilio, “La Ronda”, I (1), II (1)
CECCHINI G.F., “I libri del giorno”, XI (1)
CHIERICO Didimo, “Il Selvaggio”, II (1)
CHIESA Francesco, “Almanacco letterario”, II (1)
CHIMINELLI Piero, “Bilychnis”, XXIII (1), XXV (1)
COLAJANNI Napoleone, “Nuova Antologia”, 57° (2)
COLOMBINI Dionisio, “I lIbri del giorno”, XI (1)
COMISSO Giovanni, “Fiera letteraria”, III (4)
CORA Marcello, “La Ronda”, I (2)
CORSO Raffaele, “Bilychnis”, XXIV (1)
COSTA Giovanni, “L’Italia che scrive”, XVII (1)
CRONIA Arturo, “La Cultura”, IV-1924 (2), V-1925 (4), VI 1926-1927
(1); “La Nuova Italia”, III (1); “Lo Spettatore italiano” (1)
CUZZER Otto, “La Cultura”, III (1)
D’AGOSTINI N., “La Lettura”, XXIX (1)
DAL FABBRO Beniamino, “Campo di Marte”, I (1)
DAMIANI Enrico, “Leonardo. Rassegna mensile della cultura italiana”,
II (1), IV (11), VII (10); “La Cultura”, V (2), VI (2), X (1); “Leonardo.
Rassegna bibliografica mensile”, I (2)
D’AMICO Silvio, “La Lettura”, XXVIII (1)
DE’FRANCESCHI, Fiera letteraria”, II (1)
DE LUCA Benedetto, “Nuova antologia”, 53° (1)
DE MARSANICH Augusto, “Critica fascista”, III (1)
DE SILVA Mario, “Critica fascista”,
DE STEFANO Antonio, “Bilychnis”, XI (1)
DELICH Silvio, “Critica fascista”, II (1), III (1)
DI SAN MARTINO VALPERGA, “Nuova antologia”, 60° (1)
DI SARRA Dante, “La Nuova Italia”, IX (1). XI (1)
EMANUELLI Enrico, “Quadrivio”, III (1)
ENGELY Giovanni, “Critica fascista”, XIV (1)
ERRERA Carlo, “La Lettura”, XVIII (1)
FAGGI A., “Il Marzocco”, XXIII (1), XXIV (2), XXVI (2), XXVII (2),
XXVIII (1), XXIX (1), XXXIII (1), XXXIV (2), XXXV (1)
FALCO Giorgio, “L’Italia che scrive”, III (2)
FALCONE Pompeo, IV (1)
FALQUI Enrico, “Fiera letteraria”, V (3)
FELYNE Iris, “Fiera letteraria!, II (2)
FERRATA Giansiro, “Solaria”, III (2), IV (1)
FERRERO Leo, “Solaria”, VII (1)
FERRETTI Giovanni, “Bilychnis”, XXI (1)
FESTA MONTESI Hilda, “L’Italia che scrive”, IX (1)
FESTA Nicola, “La Cultura”, I (1)
370
FORMIGGINI SANTAMARIA Emilia, “L’Italia che scrive”, X (1), XV
(1), XVIII (1)
FRACCHIA Umberto, “Fiera letteraria”, II (1), III (2)
FRANCINI Alberto, “La Lettura”, XXXVI (1)
FRATEILI Arnaldo, “Fiera letteraria”, II (2)
MUÑOZ GASPARINI Lina, “Il Marzocco”, XXVIII (1)
GABRIELLI Aldo, “L’Italia che scrive”,VIII (2), X (1)
GALATI V.G., “Bilychnis”, XXXIII (1)
GALLETTI Alfredo, “Nuova Antologia”, 55° (1)
GARGIULO Alfredo, “Fiera letteraria”, IV (1)
GATTI G. Maria, “Pan”, II (1), III (1)
GERBAIE DE SONNEZ, “Nuova Antologia”, 54° (1)
GIANNINI ALESSANDRI Gina, “Nuova Antologia”, 59° (1)
GIARDINI Cesarino, “I libri del giorno”, VI (2)
GIGLI Lorenzo, “I libri del giorno”, IV (2), V (2)
GINZBURG Leone, “La Cultura”, VIII (5), IX (11), X (12), XI (7), XII
(3); “Fiera letteraria”, V (1); ”La Nuova Italia”, I (5), II (3); “Pègaso”,
III (2), IV (3)
GIOVANNETTI Eugenio, “Pegaso”, IV(1)
GIUSTI Wolfango, “La Cultura”, X (1); Fiera letteraria”, V (1);
“Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, II (2)
GRABHER Carlo, “Fiera letteraria”, II (1); “Leonardo. Rassegna
mensile della cultura italiana”, I (3), II (1)
GRAVINA Manfredo, “Nuova Antologia”, 58° (1), 59° (2)
GRAZIANOVA V.M., “Critica fascista”, III (2)
GROMSKA Janina, “Fiera letteraria”, II (1)
GUSTARELLI Andrea, “I libri del giorno”, I (1)
INGIANNI Luciano, “Critica fascista”, IX (1)
IVANOV Vjačeslav, “Frontespizio”, II (1)
JACOVENCO Boris, “Fiera letteraria”, II (1)
JOLLOS Waldemaro, “Le Opere e i Giorni”, I (1), XVI (1)
KALINOWSKA Stefania, “I libri del giorno”, VII (1), IX (2), X (2), XI
(1)
KARA-MURZIA Sergio, I (1), II (1)
KOCIEMSKI Leonardo, “L’Italia che scrive”, X (4), XI (19), XII (14),
XIII (12), XIV (20), XV (7), XVI (1)
KOLTONSKI Alessandro, “La Lettura”, XXVI (1)
KÜFFERLE Rinaldo, “Fiera letteraria”, II (11), III (1), IV (3)
LANDI Stefano, “Lo Spettatore italiano” (2)
LANDOLFI Tommaso, “Quadrivio”, V (2), “Occidente”, III (2)
LIABOOKA Ivan, “Bilychnis”, VIII (1)
LIEBE Hans, “Fiera letteraria”, II (2)
LO GATTO Ettore, “L’Italia che scrive”, IV (7), V (16), VI (13), XVII
(1); “I libri del giorno”, IV (2), V (9), VI (8), VII (13), VIII (13), IX (9),
X (8), XI (1), XII (4); “Leonardo. Rassegna mensile della cultura
italiana”, I (3); “Lo Spettatore italiano” (5); “Quadrivio”, II (1);
371
“Scenario”, I (4), V (1); “Bilychnis”, XVII (1), XIX (1), XX (2), XXIII
(2), XXIV (2), XXV (1), XXVII (1), XXIX (3), XXX (2), XXXI (3),
XXXIII (1), XXXV (1); “Almanacco letterario”, III (7)
LONGO G.A., “Critica fascista”, XIV (1)
LORIA Achille, “Nuova Antologia”, 58° (1)
LOVER John, “Bilychnis”, I (1)
LOZZI Carlo, “Critica fascista”, IX (1); “Le Opere e i Giorni”, XI (1)
LUCHINI Alberto, “Critica fascista”, IX (1)
LUZZATTI Luigi, “Nuova Antologia”, 54° (1)
MACALUSO-ALEO G., “Critica fascista”, X (1)
MALAVASI ARPSHOFEN Olga, “Le Opere e i Giorni”, VIII (1)
MARIANI Erminio, “Critica fascista”, III (3)
MARTINI Mario Maria, “Le Opere e i Giorni”, XVII (1)
MARTINI Vito Augusto, “Le Opere e i Giorni”, XIV (1)
MARUSSIG Giuseppe, “Quadrivio”, II (2)
MASSIS Enrico, “Critica fascista”, IV (1)
MAVER Giovanni, “I libri del giorno”, VIII (3), IX (1), X (3), XI (2),
XII (5); “La Cultura”, II (1)
MEANO Cesare, “Fiera letteraria”, V (1)
MELEGARI Giulio, “Le Opere e i Giorni”, VI (1)
MEMMOLI Gubello, “Le Opere e i Giorni”, I (1)
MEREZKOVSKIJ Dmitrij, “Fiera letteraria”, IV (1)
MICHIELI Armando, “Nuov Antologia”, 59° (1)
MICLAVIO Antonio, “Quadrivio”, IV (2); “Il Selvaggio”, VII (3), XI
(1)
MIGLIORE Benedetto, “L’Italia che scrive”, XX (1)
MIOTTO Antonio, “Frontespizio”, VI (1)
MIRSKY D.S., “La Cultura”, X (1)
MISSIROLI Mario, “La Lettura”, XXXVII (1)
MOCIULSKI, “Lo Spettatore italiano” (1)
MONGAULT Henri, “Fiera letteraria”, II (1)
MORANDI Carlo, “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, III (1),
IV (1)
MORMINO Giuseppe, “L’Italia che scrive”, XX (1)
MOSCA Rodolfo, “Le Opere e i Giorni”, XI (1)
MUÑOZ Antonio, “Il Marzocco”, XXIII (2)
NANI Umberto, “Critica fascista”, VII (1), IX (1), X (1)
NAPOLITANO Tommaso, “Critica fascista”, IX (2), X (6), XI (4), XII
(2), XIII (2), XV (2), XVI (1), XVII (2), XVIII (1); “Quadrivio”, II (1)
NASALLI ROCCA Saverio, “La Lettura”, XIX (1)
NASTI Agostino, “Critica fascista”, XIV (2)
NATHON Ernesto, “Nuova Antologia”, 54° (1)
NEPPI Alberto, “L’Italia che scrive”, VIII (1), IX (1)
OJETTI Ugo, “Pègaso”, III (1)
OLIVETTI O., “Critica fascista”, V (1)
ORTOLANI Giuseppe, “Il Marzocco”, XXXIII (1)
372
PACINI SAVOJ Leone, “La Nuova Italia”, I (1), II (2), III (3), IV (3),
XI (1); “Frontespizio”, III (1), XII (1)
PADOVANI Cesare, “Fiera letteraria”, II (1)
PALADINI Vinicio, “Quadrivio”, II (1)
PALMIERI Aurelio, “L’Italia che scrive”, V (1), “Fiera letteraria”, II
(1); “Lo Spettatore italiano” (3); “Critica fascista”, II (1)
PALMIERI Enzo, “L’Italia che scrive”, XIV (1)
PALUMBO Pier Fausto, “Critica fascista”, XVI (1), XIX (1)
PAOLI Rodolfo, “Frontespizio”, VII (1), VIII (1), IX (1), XII (1)
PAPINI Giovanni, “Fiera letteraria”, IV (1); “Frontespizio”, V (1), VIII
(1)
PARODI Mario, “I libri del giorno“, XI (1)
PAVLOVA Tat’jana, “Fiera letteraria”, II (1); “Scenario”, V (1)
PAVOLINI Corrado, “L’Italia che scrive”, IV (2), VI (1)
PAVOLINI Paolo Emilio, “L’Italia che scrive”, III (1), IV (2), V (1), VI
(2), VII (1), VIII (4), IX (7), XI (3), XII (1), XIII (3), XX (4);
“Bilychnis”, XIII (1)
PEROSIO Giovanni, “Nuova Antologia”, 53° (1)
PINCHERLE A., “La Cultura”, V (1)
PINO DI VALMERANA, “Fiera letteraria”, II (1)
PIOLI Giovanni, “Bilychnis”, VII (2), XI (3), XIX (2), XXI (1)
PIOVENE Guido, “Pan”, II (1)
PIRONE Michele, “Critica fascista”, V (2)
PISTOLENZA Domenico, “Il Selvaggio”, V (1)
POGGIOLI Renato, “Solaria”, V (1), VI (2), VII (1), VIII (1);
“Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, II (1), III (1); “Scenario”, I
(2), VI (6), VII (4); “Campo di Marte”, II (1); “Frontespizio”, VII (1)
POLLAK Roman, “La Cultura”, IV (1), VI (1)
POLLEDRO Alfredo, “La Cultura”, X (1)
POZNER Vladimir, “La Cultura”, X (1)
PRAMPOLINI Giacomo, “Fiera letteraria”, I (1), II (5), III (12), V (4)
RAIMONDI Giuseppe, “Fiera letteraria”, IV (1); “Solaria”, VI (1)
RANDI Oscar, “Critica fascista”, III (1), IV (1), V (6), IX (1), X (1)
RAVEGNANI Giuseppe, “Fiera letteraria”, II (1)
REŠETAR M., “La Cultura”, VII-1927-1928 (1)
RICCI STOCCARDA Berto, “Critica fascista”, XIV (1)
RIVOIRE Mario,”Critica fascista”, IX (1)
ROBERTI G., “Bilychnis”, XX (1)
RODOLICO Niccolò, “Il Marzocco”, XXIII (1)
ROMANOWSKI Nina, “La Lettura”, XXV (1)
ROSSI Mario, “Bilychnis”, XII (1)
RUSKAJA Ja, “Fiera letteraria”, III (1)
SAFFI Aurelio Emilio, “La Ronda”, I (1), II (1)
SALVINI Guido, “La Lettura”, XXXV (1)
SALVINI Luigi, “L’Italia che scrive”, XXII (1), XXIII (1)
SANGIORGI G.M., “Le Opere e i Giorni”, IX (1)
373
SANTANGELO Giulio, “Occidente”, I (2)
SAPORI Francesco, “Nuova Antologia”, 59° (1)
SAROV Peter, “Scenario”, II (1)
SETTANNI Ettore, “Quadrivio”, II (1)
SIGNORELLI Olga Resnevič, “Fiera letteraria”, IV (1); “Scenario”, I
(2)
SKARBEK TLUCOWSKI O., “Fiera letteraria”, II (1)
SLONIM Marco, “Fiera letteraria”, IV (2), V (1)
SOFFICI Ardegno, “La Ronda”, III (1)
SOFIA Corrado, “Quadrivio”, II (1), IV (1); “Scenario”, VII (1)
SOLARI-BOZZI G., “Critica fascista”, XIV (2)
SOLMI Sergio, “Fiera letteraria”, IV (1)
SPAINI Alberto, “Fiera letteraria”, V (1)
SPAMPANATO Bruno, “Critica fascista”, IX (1)
SPELLANZON Cesare, “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, II
(1); “Le opere e i giorni”, III (2), X (1)
STRAKCSZ P.A.,”L’Italia che scrive”, VI (1)
SUCHOTINA TOLSTAJA Tat’jana, ”Quadrivio”, II (3), III (2)
SUCKERT C.E., “La Ronda”, III (1)
TAGLIATELA Eduardo, “Bilychnis”, IV (1)
TILGHER Adriano, “L’Italia che scrive”, VIII (3)
TITTA ROSA G., „Fiera letteraria”, IV (1)
TOFFANIN Giuseppe,”La Cultura”, I (1)
TONELLI Luigi, “Bilychnis”, XXIV (1)
TOSTI Armando, “Critica fascista”, IX (1)
TOTAMIANZ V., “Nuova Antologia”, 54° (1)
UNGARETTI Giuseppe, “La Ronda”, III (1)
URBANEZ-URBANI, “Lo Spettatore italiano” (1)
VALITUTTI Salvatore, “Quadrivio”, II (1)
VASILEV Ivan, “Le Opere e i Giorni”, I (1), III (2), V (2), VII (4), IX
(1), XIV (1)
VICINELLI Augusto, “I libri del giorno”, XI (1)
VICO MANTEGAZZA, “Nuova Antologia”, 60° (1)
VINCIGUERRA Mario, “Le Opere e i Giorni”, III (1)
VIOLA Cesare Giulio, “Le Opere e i Giorni”, IX (1)
VITA FINZI Paolo, “L’Italia che scrive”, X (3), XII (1), XIII (1)
VITALI Giulio, “Bilychnis”, III (1)
VITTORINI Elio, “Pan”, III (1)
VLCEK Bartos, “L’Italia che scrive”, VII (1)
WEIDLE’ Wladimir, “Pan”, III (1)
WEISS Roberto, “Frontespizio”, II (1)
WITTINGHILL D.G.. “Bilychnis”, XV (1)
WOLFANGO Sigfrido, “Quadrivio”, III (1)
WOLKONSKY Alessandro, “Nuova Antologia”, 54° (2)
ZAMBONI Giuseppe, “Leonardo. Rassegna bibliografica mensile”, VI
(1)
374
ZAMJATIN Evgenij, I (1)
ZIELIŃSKI Taddeusz, “Il Selvaggio”, XIII (1)
ZINI Zino, “La Cultura”, X (1)
ZULBERTI Taulero, “Le Opere e i Giorni”, XVII (1)
375
376
Scarica