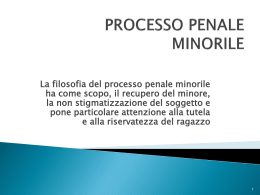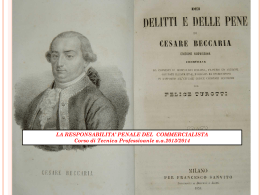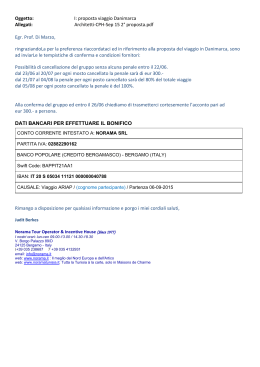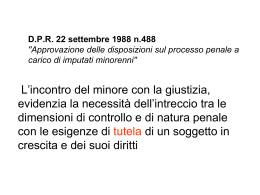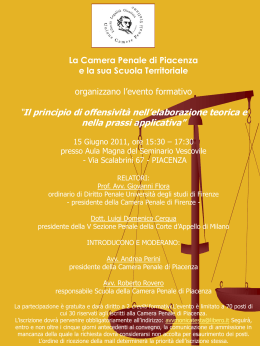Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Corso di Diritto Penale Il principio di colpevolezza Dispense ad uso degli specializzandi per fini esclusivamente didattici ANNO ACCADEMICO 2004/2005 Indice: 1. Principio di colpevolezza e delitto preterintenzionale Sent. Cass. pen., sez. V, 13/2/2002, n. 13114 Sent. Cass. pen., sez. IV, 9/3/2001, n. 28132 2. Responsabilità del concorrente nel reato, ex art. 116 c.p., e principio di colpevolezza Sent. Corte cost., 13/05/1965, n. 42 Sent. Cass. pen., sez. I, 9/11/1995, n. 21740 Sent. Cass. pen., sez. I, 2/2/2001 n. 4399 3. Fattispecie di delitti aggravati dall’evento e principio di colpevolezza: l’ipotesi della morte quale conseguenza non voluta del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, comma 2) Sent. Cass. pen., sez. II, 5 aprile 1990, Bernasconi Sent. Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2002 n. 34068 Sent. Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1991, n. 11407 4. Aberratio ictus e aberratio delicti. Sent. Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 1986, n. 1673 5. Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) e principio di colpevolezza. Sent. Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 1991, Greco Sent. Tribunale Roma 12 febbraio 1985, Trombetti e altro 6. Teoria dell’inesigibilità e principio di colpevolezza Sent. Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 1991, Bracco Sent. Tribunale di Bologna, 29 aprile 2002, n. 193 7. Appendice Sent. Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364 Sent. Corte cost., 13 dicembre 1988, n. 1085 - Materiali Articolato e Relazione Progetto Grosso in tema di colpevolezza - Suggerimenti bibliografici CANESTRARI S., La responsabilità colpevole nell’articolato della parte generale del progetto Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 885. DOLCINI E., Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 863. 2 1. Principio di colpevolezza e delitto preterintenzionale ****** Cassazione penale, sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114 Responsabilità oggettiva è concetto ben distinto da quello di responsabilità per fatto di terzi. Orbene, poiché il delitto è preterintenzionale “quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto” (art. 43 cp), deve necessariamente giungersi alla conclusione che esso è caratterizzato dal verificarsi di un evento che, benché non sia perseguito dall'agente, è comunque conseguenza della sua condotta e, per questo, ne aggrava il trattamento sanzionatorio. In altre parole, l'agente risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto. La stessa Corte costituzionale ha affermato, in più di un'occasione (sent. 152/84 e 364/88) che il comma I dell'art. 27 della Carta fondamentale non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, dal momento che esso si limita a postulare la colpevolezza dell'agente in ordine agli elementi più significativi della fattispecie. Detti elementi vanno individuati di volta in volta. SINTESI SENTENZA CASO: Nel corso di una lite un soggetto, dal carattere particolarmente iracondo, viene aggredito, subendo, a causa delle lesioni patite e per la paura e il dolore connesso, un trauma psichico tale da determinare (anche per le particolari condizioni di salute del soggetto passivo) una crisi “adrenergica” che causa la sua morte. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte sconfessa un orientamento tanto dottrinale quanto giurisprudenziale sufficientemente consolidato in forza del quale, in caso di omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p., si avrebbe un concorso di dolo (con riferimento alle lesioni e percosse) e colpa (con riguardo all’evento morte). Tale concezione discende direttamente da una lettura garantista dell’art. 27, comma 1, Cost. in materia di responsabilità penale "personale", secondo la quale il principio costituzionale, oltre che a sancire il divieto di responsabilità per fatto altrui, varrebbe da ultimo a formalizzare il divieto di responsabilità per fatto proprio ogni qualvolta gli elementi di disvalore del fatto di reato non risultino tutti, in qualche modo, soggettivamente riconducibili al relativo autore (colpevolezza). Secondo la Cassazione, in realtà, tanto l’art. 584 c.p. in materia di omicidio preterintenzionale, quanto la fattispecie di cui al successivo art. 586 c.p. (morte come conseguenza di altro delitto, diverso dalle percosse o lesioni) non richiedono una negligenza o imprudenza o imperizia nell’agente e, con particolare riferimento all’omicidio preterintenzionale, dell’aggressore. In realtà il fatto più grave è attribuito all’agente proprio a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza della scelta discrezionale a livello legislativo di punire più gravemente, e di tutelare maggiormente sotto il profilo penale, taluni beni costituzionalmente rilevanti. Del resto per la Suprema Corte sarebbe assurdo pretendere una cautela (quanto alle conseguenze) da parte di chi, comunque, mette in atto un’aggressione fisica nei confronti di un terzo. Sempre secondo la Cassazione, la stessa Corte costituzionale in passato (nel 1984 n. 152 e nel 1988 n. 364) in alcune sue sentenze non avrebbe del tutto escluso la possibilità che nel nostro sistema siano configurabili fattispecie di responsabilità oggettiva, richiedendo solo che gli elementi più significativi della fattispecie (e non già tutti gli elementi di essa) siano imputabili soggettivamente all’agente. (In senso contrario Corte cost. 1988 n. 1085, secondo cui ai fini dell’imputazione del fatto è “indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il 3 disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente – siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa – ed è altresì indispensabile che tutti e ciascun dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati”). A conferma della bontà del proprio orientamento, inteso ad escludere nel caso di omicidio preterintenzionale la sussistenza di un dolo misto a colpa, la Corte invoca anche argomenti di ordine letterale e sistematico, facendo riferimento agli articoli 589 e 590 c.p. che, in materia di lesioni o omicidio colposi, puniscono l’autore assai meno gravemente di quanto accade con riferimento all’omicidio preterintenzionale, dimostrando ancora una volta che la colpa non entrerebbe affatto nell’orbita dell’ipotesi punita dall’art. 584 c.p.. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE quinta sezione penale Composta dagli ill.mi sigg: - dott. Bruno Foscarini - dott. Giuliana Ferrua - dott. Alfonso Amato - dott. Gennaro Marasca - dott. Maurizio Fumo ha pronunziato la seguente - presidente - consigliere - consigliere - consigliere - consigliere - estensore SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nel proc. pen. a carico di <I. A.>, nato a Poggiomarino 25.11.1942, avverso la sentenza del 19.4.2001 della Corte di assise di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza della Corte di assise di Napoli del 22.12.1999, appellata dal PM, con la quale l'<I.> era stato assolto perché il fatto non costituisce reato dal delitto di omicidio preterintenzionale in danno di <C. A.>. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Maurizio Fumo, Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dott. F. M. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, Udito il difensore dell'imputato avv.to Andrea Mario Aprea, che ha chiesto il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corte: con il ricorso il PG deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Poiché pacificamente l'omicidio preterintenzionale si connota, sotto il profilo soggettivo, tanto di un dato positivo, quanto di uno negativo (da un lato, la volontà di offendere con percosse e lesioni, dall'altro, la mancanza della intenzione di uccidere) e poiché dunque la morte non è voluta, neanche sub specie di dolo eventuale, nel caso in esame, l'attenzione deve essere posta sulla sussistenza del nesso eziologico. Ebbene, non possono nutrirsi dubbi - come viceversa fa il giudice di merito - in proposito, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che rimane integrato l'omicidio preterintenzionale, anche se dalle percosse sia derivato un trauma psichico, vale a dire uno stato emotivo tale da determinare (anche per le particolari condizioni di salute del soggetto passivo) la morte dell'aggredito. La sentenza di appello, tuttavia, ritiene che non sia stato adeguatamente provato il nesso causale tra l'azione dell'imputato e la morte della vittima e che comunque la colpa dell'<I.> - in relazione al più 4 grave evento non voluto - non sia rimasta provata, permanendo, al proposito, insuperati elementi di dubbio; questo perché i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il carattere iracondo del <C.> (la vittima) possa essere stata la causa di quella crisi "adrenergica" che lo condusse a morte. Ma, in realtà, afferma il ricorrente, il carattere del <C.> non può essere ritenuto concausa dell'evento, atteso che esso non gli aveva impedito di vivere serenamente, sino ad una età avanzata, in condizioni di buon equilibrio psicofisico. Dunque, si deve necessariamente giungere alla conclusione che solo nelle lesioni patite (ed emerse chiaramente della relazione autoptica) debba essere individuata la causa mortis, atteso che entrambi i CCTT hanno attribuito una spiccata valenza efficiente alla riduzione del flusso sanguigno dell'aorta, riduzione determinata dal tentativo di strangolamento, nonché dalla paura e dal dolore conseguenti a tale aggressione. Sul corpo della vittima, inoltre, vi è traccia di almeno quindici colpi. La pronunzia censurata affronta inoltre il problema di chi abbia dato inizio alla lite, giungendo (arbitrariamente, sostiene l'impugnante) ad addossare la principale responsabilità proprio al <C.>, senza comunque tener presente che la reazione dell'<I.> deve essere considerata del tutto sproporzionata, atteso che il <C.> fu immobilizzato dal suo avversario, che, così operando, non voleva bloccare una ipotetica aggressione, quanto piuttosto mettersi in condizioni di continuare nella sua violenta azione offensiva. In realtà, emerge dagli atti che la lite fu fomentata dall'<I.>, creditore del <C.>, mentre le stesse ferite riportate dall'imputato sono evidentemente da ascrivere alla seconda parte della lite e sono riconducibili ad un estremo tentativo di difesa posto in essere dal <C.>. Il ricorrente PM pertanto chiede l'annullamento con rinvio. Il ricorso ha fondamento: i dedotti vizi, infatti, sussistono. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di assise di appello, per nuovo esame. Dalla lettura della sentenza di secondo grado si evince che il giudicante ha percorso il seguente iter logico: a) l'omicidio preterintenzionale è caratterizzato, quanto all'elemento psicologico, da dolo misto a colpa, b) <C.> ed <I.> si scambiarono reciprocamente percosse, c) non esiste prova del fatto che sia stato l'<I.> a dare inizio alla zuffa, anzi, poiché il <C.> aveva, probabilmente, un carattere iracondo, è ipotizzabile che l'iniziativa sia stato sua, d) non esiste - dunque - prova della colpa dell'<I.>, e) egli, comunque, avendo semplicemente reagito alla aggressione del <C.>, era tenuto ad agire con una cautela minore di quella che gli sarebbe stata richiesta se fosse stato il responsabile della aggressione, f) non è certo che sussista nesso eziologico tra la condotta dell'<I.> e la morte del <C.>, atteso che l'opinione del CT, il quale probabilmente non era a conoscenza di tutti i dati di fatto, non può essere assunto acriticamente, g) non è impossibile che la crisi che condusse a morte il <C.> sia stata causata, non dal dolore o dalla paura, ma dal suo carattere iracondo. Orbene, è subito da dire che una siffatta consecutio argomentativa (cui anche il difensore in udienza ha aderito, sostenendo che l'<I.> si era semplicemente limitato a difendersi da un'azione offensiva del <C.>) appare profondamente errata, come errata è l'interpretazione e la applicazione della norma incriminatrice ex art. 584 cp.. Innanzitutto, infatti, non può essere condivisa l'opinione - pur presente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ASN 199302634 - RV 194325 + ASN 198504836 - RV 161038 + ASN 1981110994 - RV 151265, ma contra ASN 198210134 - RV 155865) - che configura la preterintenzione come dolo misto a colpa. Da tempo ormai la dottrina ha abbandonato tale impostazione, rilevando, da un lato, che il legislatore, nell'art. 584 cp, non esige affatto che l'evento più grave sia dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza (atteso che la norma in questione prevede semplicemente che, con atti diretti a percuotere o ledere un soggetto, se ne causi la morte); osservando, dall'altro, che sarebbe assurdo pretendere cautela (quanto alle conseguenze) da parte di chi, comunque, mette in atto un'aggressione fisica nei confronti di un terzo. È stato poi fatto notare che la concezione che vede nell'omicidio preterintenzionale una condotta sostenuta da dolo misto a colpa porterebbe e conseguenze irragionevoli anche sul piano sanzionatorio. Per la sussistenza della colpa, infatti, è 5 necessaria la prevedibilità dell'evento, elemento che il legislatore non esige per l'omicidio preterintenzionale; ma, mentre il reato ex art. 584 cp è punito con la reclusione da 10 a 18 anni, l'omicidio colposo - nel quale, si ripete, l'evento deve essere quantomeno prevedibile - è punito molto meno gravemente (da 6 mesi e 5 anni). Peraltro, seppure si volesse esigere, anche nell'omicidio preterintenzionale, la prevedibilità dell'evento-morte, l'omicidio colposo, commesso con colpa cosciente (art. 61 n. 3 cp) rimane comunque punito meno gravemente. Considerazioni, dunque, di ordine letterale e logico impongono di abbandonare la concezione che vuole l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale come caratterizzato da dolo misto a colpa, atteso che, peraltro, non è neanche esatto quanto si afferma nella impugnata sentenza circa la incompatibilità costituzionale di qualsiasi altra concezione. Invero la Corte costituzionale ha affermato, in più di un'occasione (sent. 152/84 e 364/88) che il comma I dell'art. 27 della Carta fondamentale non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, dal momento che esso si limita a postulare la colpevolezza dell'agente in ordine agli elementi più significativi della fattispecie. Detti elementi vanno individuati di volta in volta. Insomma, responsabilità oggettiva è concetto ben distinto da quello di responsabilità per fatto di terzi. Orbene, poiché il delitto è preterintenzionale "quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto" (art. 43 cp), deve necessariamente giungersi alla conclusione che esso è caratterizzato dal verificarsi di un evento che, benché non sia perseguito dall'agente, è comunque conseguenza della sua condotta e, per questo, ne aggrava il trattamento sanzionatorio. In altre parole, l'agente risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto. Appare allora evidente che, per approntare una completa tutela contro l'aggressione volontaria al bene della integrità fisica, il legislatore, accanto alle lesioni lievi, gravi, gravissime, ha voluto prevedere, da un lato, l'ipotesi in cui dalle lesioni (o percosse), dolosamente inferte, sia derivata la morte (non voluta) della vittima (art. 584), dall'altro, quella in cui la morte sia stata conseguenza, parimenti non voluta, di altro delitto doloso, diverso dalle lesioni o percosse (art. 586). Tanto premesso, non ha evidentemente significato porsi il problema se sia stato il <C.> o l'<I.> a dare inizio alla lite; parimenti non è utile interrogarsi circa la "proporzione" della risposta dell'imputato alla (presunta) aggressione del <C.>. Peraltro, tale ultimo quesito avrebbe un senso, ai fini di una eventuale applicazione del dettato degli artt. 52-55 cp, solo se diversa fosse stata la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito. Nel caso in esame, viceversa, ciò che deve essere innanzitutto accertato è se la morte del <C.>, cronologicamente successiva alla colluttazione tra costui e l'<I.>, sia causalmente legata alla condotta dell'imputato, come accertata nella fase di merito (colpì al capo, pressione alla gola, ecc.). Sul punto, la motivazione appare gravemente insufficiente, nonché congetturale e contraddittoria, atteso che essa è incerta circa la valutazione delle conclusioni del CT, dubitativa per quel che riguarda la causa mortis (attribuita alternativamente alla crisi "adrenergica" o ad un preteso substrato iracondo del carattere del <C.>, desunto per altro per tabulas, sulla base di un unico precedente penale) e, in fine, poco chiara (quando afferma che il <C.> aveva vissuto in maniera accettabile, nonostante le sue patologie, sino ad età avanzata, patologie che, tuttavia, potrebbero averlo autonomamente condotto e morte). Al proposito, non può farsi a meno di osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (ASN 199609197 - RV 205943) che sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento (art. 41 comma II cp), quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato. Non può dunque essere considerata causa sopravvenuta (o, il che dal punto di vista eziologico, è lo stesso: causa preesistente) quella che abbia cagionato il suo evento in sinergia con la condotta dell'imputato. Infatti, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe realizzato. Ora, nel caso in esame, pur ammettendo che le condizioni di salute del <C.> fossero state non buone, il giudice del merito, per escludere la responsabilità dell'<I.>, avrebbe dovuto accertare che la morte si era determinata a prescindere dalla condotta aggressiva di quest'ultimo. 6 Viceversa, una volta accertato, in ipotesi, che la condotta dell'imputato sia stata causa (o concausa) del decesso del <C.>, il giudice di merito avrebbe dovuto (ed il giudice del rinvio dovrà) passare alla valutazione dell'elemento psicologico che sottese tale condotta, facendo evidentemente applicazione dei principi elaborati (e recentemente ribaditi) da questa Corte, in base ai quali "il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'"animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta." (cfr. ASN 200100711, sez. I, ric. <M.> ed altri, 21.6.2001 + ASN 199602553 - RV 204069). La (diversa sezione della) Corte di assise si appello di Napoli, pertanto, facendo applicazione dei principi sopra enunziati, dovrà nuovamente pronunziarsi circa la sussistenza e la volontarietà delle lesioni che l'<I.> è accusato aver provocato al <C.>, nonché circa la esistenza di nesso causale tra dette lesioni e la morte di quest'ultimo. Va da sé che, seppure fosse escluso il nesso causale tra lesioni e morte, alle prime, se ritenute effettivamente sussistenti, andrà comunque ricollegato il relativo trattamento sanzionatorio, cosa che, viceversa, i primi giudici di appello hanno omesso di fare. P. Q. M. la Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 06 APR. 2002. **** Cassazione penale sez. V, 11 dicembre 1992 E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p., in quanto previsione normativa di un'ipotesi di responsabilità obiettiva, in contrasto con l'art. 3 cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a fattispecie che presenterebbero identica connotazione (evento non voluto posto a carico dell'agente: art. 83, 116, 586 c.p.) e con l'art. 27 comma 1 cost., in forza del quale l'imputazione dell'illecito penale si concreta nella rapportabilità (o riferibilità) psichica del fatto all'agente sotto il profilo minimale della prevedibilità, intesa quale capacità di prevedere le conseguenze della propria condotta e di esercitare su questa il dovuto controllo finalistico. Da un lato, infatti, non e' invocabile il principio di eguaglianza, quando si pongono a raffronto situazioni come quelle richiamate dagli art. 584, 83, 116 e 586 c.p., che sono sostanzialmente dissimili tra loro, al di là del dato formale comune dell'imputazione di un evento non voluto o non avuto di mira direttamente dall'agente. Dall'altro, poi, va considerato che la giurisprudenza configura la preterintenzione come dolo misto a colpa, i cui profili non confliggono, ma sono in linea con le pronunce n, 364 e 1085/88 della Corte costituzionale, in tema di personalizzazione dell'illecito penale. **** Sentenza Cassazione penale, sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132 7 Si avrà l'elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie in tutti i casi in cui il chirurgo, o il medico, pur animato da intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell'integrità fisica o psichica del paziente. E poiché l'omicidio preterintenzionale si configura anche se la condotta è diretta a commettere il delitto di percosse non può escludersi, in astratto, anche se appare difficile immaginare il concreto verificarsi di queste ipotesi, che l'evento morte non voluto sia conseguente ad una condotta diretta non a provocare una malattia nel corpo o nella mente ma ad una condotta qualificabile come percossa (il che rende inutile, tra l'altro, affrontare il problema, dibattuto soprattutto in dottrina, sulla nozione di malattia con particolare riferimento alla necessità che, all'alterazione anatomica, si accompagni anche una riduzione apprezzabile della funzionalità). SINTESI SENTENZA Con la sentenza in esame, la Suprema Corte si pronuncia in ordine alla possibilità di configurare l’omicidio preterintenzionale per la morte del paziente nel corso di un intervento, ove il chirurgo abbia agito in modo ulteriore e non programmato rispetto a quanto concordato dietro consenso con il paziente. Secondo la Cassazione per aversi omicidio preterintenzionale occorre il dolo diretto o intenzionale quanto all’evento voluto, non essendo sufficiente il mero dolo eventuale: sicché il medico, con l’intervento ulteriore (non coperto da consenso), dovrà essere conscio che esso produrrà una non necessaria menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente, non essendo sufficiente che egli accetti il rischio che tale menomazione si produca. Il consenso del paziente ha valore scriminante ex art. 50 c.p., purché espresso nei limiti di cui all’art. 5 c.c.. Soltanto in ipotesi di urgenza terapeutica, o in quelle comunque previste dalla legge, il medico può prescindere dal consenso del paziente. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mauro Domenico LOSAPIO 1. Dott. Renato OLIVIERI 2. " Vincenzo COLARUSSO 3. " Carlo BRUSCO 4. " Vincenzo ROMIS ha pronunciato la seguente: Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) BARESE GIUSEPPE nato a Napoli il 20 luglio 1937; 2) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro; avverso la sentenza pronunziata in data 12 luglio 2000 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi; udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Brusco; udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. Dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi, per la parte civile, gli avv.ti Italo Reale e Angelo Grandinetti che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi dell'imputato; 8 udito il difensore dell'imputato avv. Carlo Bevilacqua che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi dell'imputato e per il rigetto del ricorso del Procuratore generale di Catanzaro. Svolgimento del processo La Corte di assise d'appello di Catanzaro, con sentenza 12 luglio 2000, giudicando sugli appelli proposti (dal <P. G.>, dalle parti civili e dall'imputato <B.>) contro la sentenza 24 settembre 1999 della Corte di assise di Catanzaro, ha riaffermato la responsabilità penale di <B. G.> in ordine al reato di omicidio colposo in danno di <G. R. A.> rideterminando in anni due di reclusione la pena inflitta dal primo giudice (che l'aveva condannato ad anni due e mesi sei di reclusione) ed ha confermato l'assoluzione di <P. P.> e <B. P.>, già affermata in primo grado, respingendo quindi gli appelli di pubblico ministero e parti civili volti per un verso a far ritenere l'esistenza del delitto di omicidio preterintenzionale e, per altro verso (solo quelli delle parti civili), a ritenere responsabili anche i due imputati assolti. La Corte d'assise d'appello, nella sentenza impugnata, ha così ricostruito i fatti oggetto del presente processo. <G. R. A.>, di anni 43, era stata ricoverata presso l'ospedale di Lamezia Terme dove, il 17 settembre 1993, era stata sottoposta ad intervento chirurgico per l'asportazione di una diagnosticata cisti ovarica. A seguito di complicanze verificatesi dopo l'intervento (ischemia acuta dell'arto inferiore destro) la paziente era stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Catanzaro dove aveva subito, alle ore 23 del medesimo giorno, un altro intervento chirurgico, finalizzato alla rivascolarizzazione dell'arto, che non aveva però impedito un ulteriore peggioramento delle sue condizioni e il conseguente decesso verificatosi il successivo 18 settembre 1993. I tre imputati svolgevano la propria attività presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Lamezia Terme in qualità di primario (<B.>), aiuto (<P.>) e assistente (<B.>) ed avevano tutti partecipato, sotto la direzione del primo, all'intervento chirurgico di cui si è detto. Nel corso di questo intervento - programmato e disposto esclusivamente per l'asportazione della cisti ovarica per la quale soltanto era stato espresso il consenso della paziente - veniva accertata la presenza di una grossa massa tumorale in zona sottoperitoneale e si procedeva quindi all'asportazione della massa nonché dell'utero e annessi (asportazione sulla quale la paziente non aveva espresso alcun consenso e che non rivestiva, secondo la sentenza impugnata.carattere di urgenza). Durante l'esecuzione dell'intervento, sempre secondo la ricostruzione dei giudici di merito effettuata in base alle risultanze di una perizia disposta d'ufficio - erano stati sezionati completamente i vasi iliaci esterni (arteria e vena) ed erano stati lesi i vasi ipogastrici con conseguente trombosi per interruzione del flusso ematico dell'arto inferiore destro che aveva condotto al decesso per "gravissime alterazioni emodinamiche, ematochimiche ed emocoagulative indotte da shock chirurgico, tipico da sindrome di rivascolarizzazione". I giudici di merito, sempre sulla scorta degli accertamenti svolti e dei pareri tecnici acquisiti, hanno ritenuto che il comportamento del dott. <B.> fosse gravemente colposo sotto diversi profili che risultano così riassunti nella sentenza impugnata che evidenzia la “scorrettezza della tecnica prescelta per la visualizzazione e preparazione dei vasi, prodromica alla (altrettanto erronea) asportazione dei tessuti in una regione appunto interessata da grossi vasi iliaci e, peraltro, nella clamorosa negligenza dell'operatore medesimo, per avere egli ignorato la possibilità che, nella fase della asportazione della massa, si fosse determinata una lesione dei vasi iliaci”. In buona sostanza la Corte, nella sentenza impugnata, ha ritenuto inutile e improvvida la decisione di un intervento demolitorio (oltre tutto finalizzato all'asportazione di un tumore - linfoma - per il quale l'intervento chirurgico è sconsigliato) e gravemente imperita la sua esecuzione perché risoltasi nell'interruzione dei vasi iliaci esterni inglobati nella massa tumorale asportata con le gravissime conseguenze descritte in quanto eseguita con tecniche scorrette che vengono analiticamente descritte nella sentenza (così come quelle che avrebbero dovuto essere correttamente adottate). Alle ipotesi di colpa indicate la sentenza impugnata ha poi addebitato al chirurgo, quale ulteriore elemento di colpa, anche il comportamento successivo dell'imputato che ha sottovalutato i primi 9 segnali di complicanze affidando la paziente alla gestione ordinaria del reparto e ritardando colposamente il trasferimento nell'ospedale di Catanzaro dove era stata poi tentata, inutilmente, la rivascolarizzazione dell'arto e dei tessuti interessati dal primo intervento chirurgico. La sentenza ha poi escluso la responsabilità dei medici <P.> e <B.> avendo ritenuto che il dott. <B.> si fosse assunto “ogni determinazione circa la programmazione e l'espletamennto del trattamento chirurgico in questione” e che il medesimo sanitario avesse “sostanzialmente gestito in condizione di esclusività l'intervento medesimo”. Infine, sul complesso problema della qualificazione giuridica del fatto accertato, le due Corti hanno concordemente e motivatamente escluso (con argomentazioni che saranno più avanti esaminate) che potesse ravvisarsi l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale prevista dall'art. 584 cod. pen. formulata dal pubblico ministero e fondata essenzialmente sull'inesistenza del consenso informato della paziente e sulla circostanza che, in mancanza di tale consenso, la condotta del medico chirurgo fosse intenzionalmente diretta, in una situazione caratterizzata dall'assenza di ragioni di urgenza rinconducibili ad uno stato di necessità, a ledere l'integrità fisica della <G.>. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso il <P. G. della R.> presso la Corte d'Appello di Catanzaro e l'imputato <B.> i cui difensori hanno separatamente impugnato la sentenza. Il Procuratore generale deduce erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte d'assise d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la fattispecie accertata dai giudici di merito fosse configurabile come omicidio colposo, e non come omicidio preterintenzionale, in base a considerazioni metagiuridiche fondate su valutazioni finalistiche della condotta senza tener conto che il fine deve essere ritenuto non rilevante essendo invece sufficiente che la lesività della condotta sia coscientemente rappresentata in presenza di intervento chirurgico illecito perché non consentito. Con il primo ricorso l'imputato deduce: 1) violazione dell'art. 41 cpv in relazione all'art. 606, comma 1^, lett. b e c del codice di rito; in sintesi il motivo si fonda su un'erronea valutazione dei fatti di causa da parte dei giudici di merito che non avrebbero tenuto alcun conto di fondamentali circostanze (quali il fatto che la <G.> era giunta all'ospedale di Catanzaro in buone condizioni; che la ricostruzione dell'evoluzione della situazione patologica della persona offesa era stata condotta sulla base di descrizioni interessate dai soggetti che avevano partecipato al secondo intervento; il sospetto di falsità ideologica nella cartella clinica redatta presso l'ospedale di Catanzaro) che avrebbero dovuto condurre alla conclusione che la tragica conclusione della vicenda era dovuta ad errori intervenuti nel secondo intervento; 2) violazione dell'art. 495 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1^, lett. d del c.p.p. per omessa riapertura dell'istruzione dibattimentale su circostanza decisiva (audizione del perito d'ufficio per verificare la individuazione del vaso reciso nel corso del primo intervento) peraltro già posta in dubbio dal perito d'ufficio; 3) violazione dell'art. 444, in relazione all'art. 606, comma 1^, lett. c del c.p.p. in quanto la derubricazione da omicidio preterintenzionale a colposo avrebbe dovuto comportare la possibilità per l'imputato di chiedere l'applicazione della pena. Con il secondo ricorso vengono proposte le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. c del c.p.p. per avere, la Corte di merito, omesso di dichiarare, malgrado l'eccezione formulata con i motivi di appello, la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notifica del medesimo atto ai difensori dell'imputato non presenti all'udienza preliminare; 2) lo stesso vizio per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputato sulla base di prove inutilizzabili; in particolare la cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di Catanzaro, redatta dal dott. <C. D. L.>, indagato in procedimento connesso (e avvalsosi, in tale veste, della, facoltà di non rispondere in dibattimento); in buona sostanza, secondo l'impostazione del ricorrente, con la utilizzazione dibattimentale delle annotazioni effettuate dal dott. <D. L.>, si sarebbe eluso il divieto di utilizzazione di dichiarazioni non confermate in dibattimento; con ciò violando, altresì, i principi stabiliti nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione sia sotto il profilo indicato che sotto 10 quella della formazione della prova in contradditorio; il vizio si estenderebbe, secondo il ricorrente, alla perizia d'ufficio fondata, per la massima parte, sul contenuto della cartella clinica in questione; 3) violazione dell'art. 606. comma 1^, lett. b, c ed e del c.p.p. per avere, la Corte di merito, omesso di prendere in considerazione dati rilevanti ai fini della decisione e per non aver tenuto nel minimo conto le osservazioni svolte dai consulenti del ricorrente con particolare riferimento: alla inconciliabilità tra le annotazioni contenute nella cartella clinica redatta dal dott. <D. L.>, la situazione clinica della paziente al momento del ricovero a Catanzaro e i risultati dell'autopsia; alla circostanza che le dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero e dal perito d'ufficio non consentivano di riferire all'uno o all'altro intervento la resezione dei vasi; alla mancata considerazione che tutti i dati e pareri acquisiti portavano alla conclusione che i vasi recisi dal ricorrente, unitamente alla massa tumorale, erano quelli corrispondenti alla vena e arteria ipogastrica la cui resezione non avrebbe potuto avere le conseguenze letali poi verificatesi; alla mancata considerazione che gli interventi praticati successivamente a quello del dott. <B.> erano stati da soli sufficienti a determinare l'evento. Con riferimento, poi, alla decisione di asportare utero e annessi e di intervenire sulla massa tumorale (peraltro rimossa solo in parte) con il medesimo motivo si fa rilevare che questa decisione fu resa obbligata dalla necessità di avere un accesso facilitato al campo operatorio, di evitare un processo di infiltrazione dell'utero e degli altri organi genitali, di attenuare l'effetto compressivo in atto sulla vena e sull'arteria iliaca già risultante dagli esami "doppler" in precedenza effettuati; 4) violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b c.p.p. per avere comminato una pena eccessiva senza tener conto dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. e senza motivare il proprio convincimento. Alla pubblica udienza del 9 marzo 2001 il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi; i difensori della parte civile hanno chiesto il rigetto dei ricorsi dell'imputato mentre il difensore del ricorrente ne ha chiesto l'accoglimento Motivi della decisione (omissis) VII) Va ora esaminato il motivo di ricorso proposto dal <P. G.> presso la Corte d'Appello di Catanzaro che insiste, come ha fatto l'accusa nei due precedenti gradi di giudizio, perché i fatti accertati dai giudici di merito vengano qualificati idonei a realizzare il reato di omicidio preterintenzionale e non quello di omicidio colposo ritenuto nella sentenza impugnata e in quella di primo grado. Questa richiesta trova il suo fondamento nella circostanza, ormai indiscutibilmente accertata, che la persona offesa - informata soltanto dell'esigenza di asportazione di una cisti ovarica - non aveva espresso alcun consenso all'intervento effettuato sia per quanto riguarda l'asportazione della massa tumorale sia per quanto riguarda, in particolare, l'asportazione degli organi genitali. Interventi demolitivi eseguiti, anche questo è un dato pacificamente accertato, in assenza di ogni ragione di urgenza che li giustificasse. A fondamento del ricorso viene richiamato un precedente di questa Corte (sez. V, sentenza 13 maggio 1992 n. 5639, Massimo) che, in un caso per alcuni aspetti analogo, ritenne di ravvisare l'esistenza dell'omicidio preterintenzionale. Anche in quel caso il chirurgo, nell'eseguire il programmato intervento di asportazione trans anale di un adenoma rettale benigno, aveva, in mancanza di consenso (la paziente aveva consentito esclusivamente ad un intervento per via endoscopica) e in assenza di ragioni di urgenza, proceduto ad un intervento chirurgico demolitivo di amputazione totale addominoperineale del retto cagionando poi la morte della paziente a causa di complicazioni sopravvenute. Sottolineò la Corte, in quell'occasione, che per il reato di lesioni volontarie (cui l'atto deve essere diretto perché possa, in caso di morte quale evento sopravvenuto non voluto, configurarsi il delitto di omicidio preterintenzionale) è richiesto il dolo generico e che l'esecuzione di un intervento chirurgico non consentito, in assenza di ragioni di urgenza che lo giustifichino, non fa venir meno 11 l'indicato elemento psicologico essendo irrilevante la circostanza che il soggetto abbia agito per il perseguimento di uno scopo lecito o illecito o per un motivo lecito o illecito. Quanto all'elemento materiale esso sarebbe, secondo quel precedente, insito nel trattamento chirurgico anche se la condotta, nella quasi totalità dei casi, è normalmente scriminata ai sensi degli artt. 50 e 51 cod. pen. La decisione citata richiamava in proposito, condividendolo, l'orientamento della Corte di merito che aveva definito la condotta del chirurgo, nel caso esaminato, “un atto solo formalmente terapeutico e sostanzialmente illecito”. Sono note le divergenze sulla ricostruzione teorica del reato preterintenzionale ed in particolare quelle che riguardano la struttura del reato nell'aspetto soggettivo. Pacifico essendo che l'evento voluto debba essere addebitato a titolo di dolo è invece controverso se quello non voluto sia addebitabile a titolo di responsabilità oggettiva, sulla base del semplice rapporto di causalità materiale, ovvero se sia necessaria la colpa. Divergenze che si sono ulteriormente acuite a seguito della sentenza 24 marzo 1988 n. 364, sull'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale (art. 5 cod. pen.) nel caso di ignoranza incolpevole, per l'inevitabile rafforzamento conseguitone del principio di colpevolezza. Ancora: sulla natura della colpa (generica o specifica), su quali elementi debba cadere, se possa configurarsi nella sola violazione dei precetti base, se possa sostituirsi il criterio della colpa con quello della prevedibilità dell'evento più grave le divergenze di opinione sono altrettanto significative. Nel caso in esame non appare però necessario affrontare questi problemi in quanto, per le ragioni esposte in precedenza, la colpa dell'imputato, nella causazione dell'evento più grave, è stata ormai incontestabilmente accertata. Del resto, nel caso della responsabilità professionale medica, ha minor rilievo il problema, già accennato, se l'evento non voluto sia addebitato a titolo di colpa o di responsabilità oggettiva posto che generalmente il problema della ricostruzione del fatto si pone in relazione alle conseguenze dannose non volute cagionate da colpa. Il problema posto oggi all'attenzione della Corte appare di non facile soluzione perché se è vero che la connotazione finalistica della condotta (la finalità terapeutica) è irrilevante - non essendo richiesto il dolo specifico per i reati di lesioni volontarie e percosse - è altrettanto vero che la formulazione dell'art. 584 cod. pen. (“atti diretti a”) fa propendere per la tesi, non da tutti condivisa (anche perché, secondo alcuni orientamenti, la caratteristica prevista dalla legge, riprendendo la formulazione dalla legge usata per il tentativo, riguarderebbe solo la condotta e non l'elemento soggettivo), che l'elemento soggettivo richiesto per l'omicidio preterintenzionale, quanto all'evento voluto, sia costituito dal dolo diretto o intenzionale con esclusione quindi del dolo eventuale. Il che non esclude che la locuzione riferita possa riferirsi anche (ma non esclusivamente) alla condotta. É vero che l'intenzionalità del dolo è elemento estraneo alla descrizione del delitto preterintenzionale data dall'art. 43 cod. pen. ma è stato più volte sottolineato come la struttura del delitto previsto dall'art. 584 cod. pen. (così come quella dell'unica altra ipotesi di delitto preterintenzionale prevista dal nostro ordinamento: l'aborto previsto dall'art. 18, comma 2^ l. 194/1978) non coincida con lo schema normativo previsto dall'art. 43. D'altro canto, se così interpretata (nel senso che per l'omicidio preterintenzionale il dolo debba essere diretto o intenzionale), non sembra irragionevole la scelta del legislatore di addebitare le conseguenze non volute solo quando l'agente abbia almeno direttamente voluto l'evento attribuito a titolo di dolo. Nel caso invece di dolo indiretto o eventuale verrà meno, come è stato sottolineato in dottrina, il reato preterintenzionale ma non quello doloso di lesioni o percosse (sulla necessità che, nell'omicidio preterintenzionale, il dolo sia intenzionale si vedano, nella giurisprudenza di legittimità, le non recenti Cass., sez. V, 20 ottobre 1988, Lupiddi; sez. I, 20 gennaio 1986, Barletta). E allora: quando è possibile affermare che, pur essendo animato da intento terapeutico, il medico ha coscientemente e volontariamente posto in essere una condotta intenzionalmente diretta a ledere o percuotere? Numerosi commentatori della sentenza Massimo hanno infatti evidenziato la differenza tra chi si pone, fin dall'inizio e consapevolmente, in contrasto con il precetto penale e il medico per 12 il quale non è agevole individuare una analoga volontà. D'altro canto affermare che l'intento terapeutico esclude questa volontà significa reintrodurre il non richiesto dolo specifico; per converso affermare l'intenzionalità della condotta, ogni volta che non vi sia il consenso del paziente, significa, in realtà, confondere il problema della natura del dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame con l'esistenza della scriminante costituita dal consenso dell'avente diritto. A parere di questo collegio il problema - fermi restando i presupposti della non necessità del dolo specifico e delle non discusse caratteristiche dell'elemento materiale del reato (ricavabile dal concetto di malattia fatto proprio dall'art. 582 cod. pen.) - va invece riportato all'accertamento dei presupposti per ritenere l'esistenza del dolo intenzionale. L'agente deve anticipatamente (sia pure nel corso dell'intervento chirurgico) rappresentarsi l'esito (voluto) della sua condotta e non agire “a costo” di provocare quell'evento. Non va infatti dimenticato che, nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, l'agente pone in essere una condotta che sa, e vuole, diretta a provocare un'alterazione dell'integrità fisica della persona offesa; egli si pone consapevolmente in una situazione di illiceità ponendo coscientemente in pericolo l'incolumità fisica o la salute del paziente. Non è necessario, come da taluni è stato osservato, che l'agente sia animato da una “malvagia volontà” nei confronti della persona offesa ma è comunque necessario che egli si rappresenti, come conseguenza della sua condotta voluta, la lesione dell'integrità fisica del paziente. E non. va sottaciuta la differenza - proprio per l'incidenza che ne può derivare sulla natura intenzionale dell'elemento psicologico richiesto - tra i casi nei quali l'intervento sia deciso nel corso dell'intervento per sopraggiunte e imprevedibili (ovvero prevedibili ma non previste) circostanze e il caso in cui l'intervento sia stato programmato con quelle caratteristiche fin dall'inizio. La soluzione indicata, tesa alla valorizzazione dell'elemento soggettivo richiesto nella forma del dolo intenzionale, viene incontro anche all'esigenza, sottolineata da alcuni commentatori, che non venga obliterata, nella ricostruzione in esame, la necessità che venga osservato il principio di offensività, anche nell'individuazione dell'elemento soggettivo del reato, proprio richiedendosi la necessità che l'agente debba raffigurarsi anticipatamente le conseguenze dannose della sua condotta. Non compete al giudice di legittimità individuare i casi in cui sia presente l'elemento soggettivo del reato nella forma diretta o intenzionale di cui si è detto trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ma ben può farai astratto riferimento, a titolo di esempio, ai casi in cui la menomazione del corpo o della mente venga provocata, intenzionalmente, per scopi scientifici, di ricerca o per scopi esclusivamente estetici (in questi casi non viene surrettiziamente reintrodotto un dolo specifico: lo scopo è estraneo al reato ma vale a qualificare l'elemento soggettivo come intenzionale), ai casi di interventi demolitivi coscientemente inutili, ai casi in cui il medico proceda ad un'amputazione per curare una patologia che sa poter essere affrontata agevolmente con diversi mezzi terapeutici o a quelli in cui produca un'inutile e consapevole mutilazione all'integrità fisica del paziente. In definitiva si tratta di casi nei quali, già nella rappresentazione dell'agente, il normale rapporto tra costi (certi) dell'intervento e benefici (eventuali) di esso è ampiamente e preventivamente conosciuto e rappresentato dall'agente come assolutamente squilibrato verso i primi. Insomma si avrà l'elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie in tutti i casi in cui il chirurgo, o il medico, pur animato da intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell'integrità fisica o psichica del paziente. E poiché l'omicidio preterintenzionale si configura anche se la condotta è diretta a commettere il delitto di percosse non può escludersi, in astratto, anche se appare difficile immaginare il concreto verificarsi di queste ipotesi, che l'evento morte non voluto sia conseguente ad una condotta diretta non a provocare una malattia nel corpo o nella mente ma ad una condotta qualificabile come percossa (il che rende inutile, tra l'altro, affrontare il problema, dibattuto soprattutto in dottrina, sulla nozione di malattia con particolare riferimento alla necessità che, all'alterazione anatomica, si accompagni anche una riduzione apprezzabile della funzionalità). 13 Così ricondotto l'elemento soggettivo del reato entro i suoi limiti naturali va detto che il discorso sul consenso del paziente trova un suo ridimensionamento dovendo ricondursi la sua efficacia a quella delle scriminanti che, secondo l'opinione maggiormente condivisa, escludono l'antigiuridicità della condotta. Sul consenso del paziente la Corte condivide la preoccupazione, espressa dal <P. G.> nella memoria presentata in udienza, per una eccessiva enfatizzazione di tale elemento le cui finalità sono in realtà diverse rispetto a quella di legittimare interventi lesivi dell'integrità del paziente e la cui rilevanza non ha un ambito di applicazione generalizzato ove si tenga conto dei limiti posti dalla legge (art. 5 cod. civ.: ma anche in questo caso vi sono opinioni che ne escludono l'applicabilità al campo penale) agli atti di disposizione del proprio corpo - che potrebbero fare rientrare nell'ambito del delitto di lesioni volontarie menomazioni consentite in violazione dell'indicata norma civilistica - e delle ipotesi, pure previste dalla legge, di trattamenti sanitari obbligatori nonché dei casi di trattamenti nei contronti di persone non consenzienti (per es. colui che ha tentato il suicidio o che effettua lo “sciopero della fame” o “della sete”) o non in grado di esprimere il consenso. Può quindi affermarsi che il consenso del paziente per un verso precluda la possibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, ma solo nel caso di consenso validamente espresso nei limiti dell'art. 5 cod. civ., per l'efficacia scriminante attribuita dall'art. 50 cod. pen. al consenso della persona che può validamente disporre del diritto; per altro verso che, in presenza di ragioni di urgenza terapeutica, o nelle ipotesi previste dalla legge, il consenso non sia necessario. Diversamente influisce il dissenso del paziente la cui volontà, nel senso della sua libera autodeterminazione, ha trovato un rafforzamento a livello costituzionale (art. 32): a fronte di una manifestazione di volontà esplicitamente contraria all'intervento terapeutico il pericolo grave ed attuale per la vita o per la salute del paziente configura lo stato di necessità di cui si parlerà oltre e, per rimanere al tema in esame, vale certamente ad escludere il dolo diretto di lesioni in quanto ciò che si rappresenta il medico, nell'intervenire malgrado il dissenso del paziente, è la salvaguardia della sua vita e della sua salute poste in pericolo. Al di fuori di queste situazioni di pericolo l'esplicito dissenso del paziente rende l'atto, asseritamente terapeutico, un'indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente ma anche della sua integrità con conseguente applicazione delle ordinarie regole penali. Analoghe considerazioni devono farsi in relazione alle altre cause di giustificazione astrattamente ipotizzabili. Ci si riferisce, in particolare, alle situazioni di urgenza terapeutica che concretizzano lo stato di necessità o l'adempimento di un dovere (secondo altre opinioni sarebbero ipotizzabili anche l'esercizio di un diritto e anche cause di giustificazione non codificate) qualora siano in gioco non solo la vita del paziente ma anche la sua integrità fisica. In questi casi mai potrà affermarsi che il medico abbia intenzionalmente provocato la lesione della salute del paziente; non perché esista la (irrilevante, per quanto si è detto) finalità terapeutica ma perché, nelle ipotesi in esame, la condotta è intenzionalmente diretta a tutelare la salute del paziente e non a provocare una menomazione della sua integrità fisica o psichica. Ciò consente, analogamente, di escludere l'intenzionalità della condotta nei casi, non infrequenti, nei quali il medico, nel corso dell'intervento chirurgico, rilevi la presenza di una situazione che, pur non essendo connotata da aspetti di urgenza terapeutica, potendo essere affrontata in tempi diversi, venga invece affrontata immediatamente senza il consenso del paziente; per es. per evitargli un altro intervento e altri successivi disagi o anche soltanto per prevenire pericoli futuri. Per completare il discorso sulle cause di giustificazione occorre ancora precisare che è naturalmente applicabile, ai casi in esame, la disciplina prevista dall'art. 59 u.c. cod. pen. nella parte relativa all'erronea supposizione di una causa di giustificazione. È quindi necessario, nelle situazioni ipotizzabili, che il chirurgo non si sia erroneamente rappresentato la situazione patologica in modo tale da ritenere che essa richiedesse l'intervento non consentito, ovvio essendo, anche in questo caso, il venir meno dell'intenzionalità della condotta. E ferma restando la sua responsabilità per il reato colposo quando si accerti l'esistenza di questo elemento soggettivo del reato. 14 Secondo un orientamento, affermatosi soprattutto in dottrina, nelle condizioni descritte perché possa ravvisarsi l'omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo del reato consisterebbe non nella rappresentazione di una menomazione qualificabile come malattia del corpo o della mente, nel senso fatto proprio dall'art. 582 cod. pen. (sia o meno richiesta, perché possa configurarsi la malattia, anche l'alterazione funzionale: il problema, già accennato, non è rilevante nel nostro caso), ma nella sola rappresentazione di compiere un atto contro la volontà del paziente (oltre che non necessitato e non urgente). Il bene giuridico protetto di cui si lamenta la lesione sarebbe dunque non l'integrità fisica del paziente ma la sua libertà di autodeterminazione per cui il reato astrattamente configurabile sarebbe quello previsto dall'art. 610 cod. pen. (violenza privata) e l'eventuale evento lesivo o mortale che ne fosse derivato diverrebbe punibile secondo la previsione dell'art. 586 cod. pen. Questa costruzione, a parere della Corte, trova un ostacolo difficilmente superabile nella previsione della necessità che la condotta dell'agente consista in violenza o minaccia. Quest'ultima sembra proprio da escludere, mentre la violenza potrebbe forse ipotizzarsi nei soli casi di dissenso espresso del paziente al trattamento chirurgico. (omissis) Tutti i ricorsi devono pertanto essere rigettati. Al rigetto dei ricorsi del ricorrente conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. P. Q. M. la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta tutti i ricorsi e condanna il ricorrente <B. G.> al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione e rappresentanza in questo grado che liquida in complessiva lire 4.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 LUG. 2001. ******************************************************************************** 2. Responsabilità del concorrente nel reato, ex art. 116 c.p., e principio di colpevolezza ****** Corte costituzionale, 13 maggio 1965, n. 42 La responsabilità ex art. 116 c.p. si fonda sulla sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica, concepita nel senso che il reato diverso più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi dei fatto umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza. 15 Cassazione penale, sez. I, 9 novembre 1995, n. 21740 In tema di concorso di persone nel reato la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 c.p. può essere esclusa soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Detto rapporto di causalità, non meramente materiale, bensì di natura psichica, va inteso nel senso che il reato diverso commesso dal concorrente deve potersi rapportare alla psiche dell’agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e concretamente prevedibile di quello voluto, in tal modo - configurandosi l'elemento necessario della colpevolezza, sotto le forme del dolo per il reato concordato e della colpa per l'evento realizzatosi - si risponde a titolo doloso di un atteggiamento colposo (responsabilità anomala). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Torquato GEMELLI 1. Dott. Piero MOCALI 2. " Natale CAPITANIO 3. " Anna MABELLINI 4. " Stefano CAMPO ha pronunciato la seguente - Presidente Consigliere " " " SENTENZA sul ricorso proposto da 1) <F. P.>, n. Foggia il 29.6.1971 2) <F. G. F.>, n. Foggia il 5.4.1974 avverso la sentenza della Corte d assise d' appello di Bari in data 20.3.1995 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Stefano Campo Udito, per la parte civile l'avv. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Vacca che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori avv.ti G. Aricò e L. Panzano, che concludono per l'accoglimento del ricorso; Svolgimento del processo e motivi della decisione OSSERVA: 1. Il giorno 24 marzo 1993 verso le ore 9,30 la guardia giurata <R. A.>, mentre era in servizio presso la scuola elementare “Vittorino Feltre” in Foggia, veniva uccisa da sei colpi di pistola esplosi da un giovane, poi identificato nel minore <DI V. R.>, nel corso di una rapina in danno della vittima diretta alla sottrazione della pistola in suo possesso. 16 L'arma usata per l'omicidio apparteneva al padre del <DI V.>, cui era stata sottratta dal minore, mentre alla rapina, concordata da tutti i partecipi, e all'azione omicidiaria prendevano parte altro minore - <N. G.> - ed i maggiorenni <F. P.> e <F. G. F.>. Risultava dagli atti che il <DI V.> aveva sparato in quanto ritenuto offeso dall'atteggiamento della vittima che, sorridendo incredula per quanto stava avvenendo, rifiutò di consegnare l'arma in suo possesso. Procedutosi separatamente per gli imputati minorenni, i due <F.> (insieme ad un quinto soggetto, poi assolto in secondo grado) con sentenza in data 28 maggio 1994 dalla Corte d'Assise di <F.> erano ritenuti colpevoli dei reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 112, 575 - 576, 61 n~2 c. p. (omicidio volontario pluriaggravato), 110, 628 co. 1° e 3° n~ 1 c.p. (rapina aggravata) e 112, 81 c.p., 10 - 12 - 14 legge 497/1974 e 23 legge 110/1975 (porto e detenzione illegali di due pistole, delle quali una con matricola abrasa, e del relativo munizionamento) e condannati, con applicazione di attenuanti generiche prevalenti, alla pena anni ventuno di reclusione ciascuno, oltre a quelle accessorie di legge e alla rifusione dei danni in favore della costituita parte civile. <F. G. F.>, inoltre era condannato all'ulteriore pena di anni di furto aggravato (artt. 110, 624, 625 nn.2 e 7 c.p.) e tentata estorsione (artt. 110, 56 e 629 c.p.), peraltro non interessanti il presente processo per non essere stati oggetto di gravame in sede d'appello. A seguito d' impugnazione del P.G. e degli imputati la Corte d'asise d'appello di Bari con sentenza in data 20 marzo 1995 dichiarava i <F.> colpevoli del reato di omicidio ai sensi degli artt. 116 cpv. e 575 c.p. con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n~ 2 c.p. e, ritenuta la continuazione tra i soli reati di rapina e porto e detenzione illegali di armi, li condannava ciascuno alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per il primo reato e a quella di anni quattro di reclusione e lire tre milioni di multa per glia ltri due, applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni tre - pretermessa in primo grado ed oggetto dell'appello del P.G. - e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, i quali, per il tramite del loro difensore, deducono: a) erronea applicazaione di legge e contraddizione e illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) c.p.p.) per avere ritenuto la sussistenza del c.d. concorso anomalo di persone nell'omicidio, atteso che inattesa, repentina ed imprevedibile era stata la reazione del <DI V.> al comportamento della vittima e che tale ricostruzione emergeva dal testo medesimo della sentenza gravata che, peraltro, ne aveva tratto conclusione non conseguente; b) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1° lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 116 c.p.) per avere la corte nella specie, ritenuto la sufficienza della prevedibilità in astratto, e non in concreto, ai fini della sussistenza del c.d. concorso anomalo; c) erronea applicazione di legge mancanza di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 81 c.p.) per non avere ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di omicidio e rapina, pur avendo affermato la esistenza di nesso psichico tra le due violazioni, e per carenza assoluta di motivazione in ordine all'esclusione della stessa applicata in primo grado; d) erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 co. 1° lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 442 medesimo codice) per non avere applicato lo speciale rito abbreviato e la correlata diminuzione di pena, ritualmente richiesti in termine dagli imputati, e non avere in alcun modo motivato sul punto, dopo che era stata esclusa l'aggravante del c.d. nesso teleologico, la cui presenza aveva costituito il motivo di rigetto da parte del g.i.p della richiesta di applicazione dello speciale rito di cui all'art. 442 c.p.p.. 3) Il ricorso è meritevole d'accoglimento nei limiti che si diranno. Il primo ed il secondo motivo di gravame vanno congiuntamente trattati, riguardando la medesima questione di diritto, pur se formulata sotto profili diversi. Questa Corte ha dato modo di affermare costantemente che in tema di concorso di persone nel reato la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 c.p. può essere esclusa soltanto quando il 17 reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Detto rapporto di causalità, non meramente materiale - in quanto in tale ipotesi diventerebbe un caso di responsabilità oggettiva contrario alla Costituzione come ha avuto modo di rilevare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 31 maggio 1965 - bensì di natura psichica, va inteso nel senso che il reato diverso commesso dal concorrente deve potersi rapportare alla psiche dell’agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e concretamente prevedibile di quello voluto, in tal modo configurandosi l'elemento necessario della colpevolezza - sotto le forme del dolo per il reato concordato e della colpa per l'evento realizzatosi si risponde a titolo doloso di un atteggiamento colposo (responsabilità anomala). A detti fini non deve farsi confusione tra la concreta verificabilità, in relazione alle modalità di commissione del reato voluto e concordato dai partecipi ed al contesto - soggettivo ed oggettivo del suo svolgimento, dell'evento non voluto e la specifica occasione che ha determinato il concorrente a realizzarlo, rimanendo al di fuori dell'oggetto della prevedibilità in concreto detta modalità esecutiva ma non potendosi la stessa equiparare ad evento eccezionale e del tutto imprevedibile idoneo ad escludere il nesso di causalità psichica. Infatti il mero motivo che ha determinato il concorrente a realizzare l'evento non voluto, in presenza di tutti gli elementi fattuali connotanti il suddetto rapporto psichico, non assume alcun rilievo in ordine alla prevedibilità in concreto da parte dell'agente, atteso che non ha incidenza alcuna sull'oggetto del suo atteggiamento psicologico per essere rimaste immutate le circostanze di svolgimento del reato voluto. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi di diritto, dal momento che era concretamente prevedibile che la concordata rapina a mano armata potesse sfociare in un evento omicidiario del soggetto passivo della stessa. Infatti si trattava di sottrarne con la minaccia di una pistola l'arma in dotazione di una guardia giurata nell'esercizio delle sue mansioni, sicché rientrava nella normalità degli accadimenti umani che un'azione di tal fatta poteva avere esiti cruenti, stanti il contesto soggettivo ed oggettivo presenti per la commissione del reato voluto. Il motivo, pertanto, che ebbe a determinare il materiale autore dell'omicidio (la reazione di incredulità della vittima a quanto stava avvenendo interpretata come schermo alla sua persona) non è stato di tale natura da modificare il contesto dato e, quindi, da potere essere qualificato com'é circostanza eccezionale ed imprevedibile idonea a troncare il rapporto di causalità psichica tra il reato concordato e l'evento diverso realizzatosi, di guisa che esattamente è stata affermata la sussistenza del concorso ex art. 116 c.p. da parte degli odierni ricorrenti nel reato di omicidio volontario realizzato dal coimputato <DI V.>. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non soltanto risulta aderente alle norme di legge applicate, ma anche è adeguatamente motivata con conseguente infondatezza dei motivi di ricorso esaminati. In merito al terzo motivo di ricorso, premesso che l'istituto della continuazione - che, a seguito della modifica dell'art. 81 cp. a mezzo dell'art. 8 D.L. 11.4.1974 n~ 99 convertito con legge 7.6.1974 n~ 220, richiede come presupposto soltanto la identità del disegno criminoso tra i vari reati unificabili a tale titolo - è compatibile con la presenza, tra le violazioni sottoponibili al regime della continuazione, di quelle previste dagli artt. 82 (c.d. aberratio ictus), 83 (aberratio delicti), 116 (c.d. concorso anomalo) e 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) del codice penale, le quali tutte non escludono l'applicabilità dell'istituto in questione sol perché possono verificarsi talune deviazioni nel corso dell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, ed è finalizzato a mitigare la rigidezza del sistemza del cumulo materiale delle pene così costituendo misura favorevole al reo, la Corte rileva che, stante la detta natura mitigatrice della sanzione penale, il giudice d'appello, in conformità del divieto di "reformatio in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p., non può escludere la continuazione tra i 18 reati, per i quali l'imputato è stato condannato in primo grado, applicata con la sentenza di prime cure in mancanza di specifica impugnazione sul punto. Ciò anche nella ipotesi - come accaduto nella fattispecie in esame - di mutamento della qualificazione giuridica del più grave dei reati giudicati e delle diminuzione della pena complessivamente irrogata all'imputato, in quanto il venire meno del vincolo della continuazione importa sempre un calcolo di pena svantaggioso per costui. E tale errore di diritto che inficia la sentenza impugnata risalta ancora dippiù, in quanto s'accompagna alla totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la corte barese ad escludere la continuazione tra il reato di concorso anomalo in omicidio e quelli di rapina e porto e detenzione illegali di armi, sicché s'impone l'annullamento sul punto della sentenza in esame. Parimenti va annullata la pronuncia gravata relativamente alla totale carenza motivazionale relativa all'applicabilità o meno del rito abbreviato - ritualmente richiesto dagli imputati - a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 576 e 61 n~ 2 c.p. contestata per il reato di omicidio, così come evidenziato nell'ultimo motivo di ricorso. Sul punto il giudice del merito dovrà accertare, con giudizio “ex ante”, se il reato punibile - per l'originaria contestazione - con la pena dell'ergastolo era definibile o meno allo stato degli atti dal giudice delle indagini preliminari, per essere risultata la medesima errata (per l'aggravante contestata o per la qualificazione giuridica del fatto) sì da prevedere una pena temporanea e non perpetua, motivando, di conseguenza, per l'applicabilità o meno della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. agli odierni ricorrenti. In accoglimento dei sopra indicati motivi di gravamela sentenza va annullata "in parte qua" e gli atti rimessi al competente giudice di rinvio, meglio indicato in dispositivo, che nel procedere a nuovo giudizio sui due punti oggetto dell'annullamento si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. P. Q. M. letti ed applicati gli artt. 615 e 623 c.p.p., ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione in ordine all'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e della continuazione. Così deciso in Roma il 9 novembre 1995 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 DIC. 1995 *** 19 Cassazione penale, sez. I, 2 febbraio 2001, n. 4399 In tema di concorso di persone nel reato, l'attribuzione della responsabilità per il reato più grave rispetto a quello deliberato deve essere risolta caso per caso, accertando se l'evento ulteriore e più grave sia stato previsto e voluto, anche nella forma del dolo eventuale, oppure sia stato solo prevedibile, ma senza l'accettazione del relativo rischio. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva partecipato a una rapina essendo consapevole che i due complici erano muniti di armi automatiche pronte all'impiego in caso di resistenza delle vittime, condannato dalla Corte d'Assise d'Appello per il delitto di omicidio, addebitato a titolo di dolo eventuale, escludendo nella specie la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen.). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6/3/2000, la Corte di Assise di Appello di Salerno confermava la decisione emessa il 28/10/1998 con cui la locale Corte di Assise aveva condannato A.A. alla pena di ventisei anni e venti giorni di reclusione e R.R. alla pena di ventisei anni di reclusione perché ritenuti colpevoli di rapina aggravata, dell'omicidio aggravato di A.C., di lesioni volontarie aggravate in danno di C.S., di porto e detenzione di armi clandestine, nonché, il solo A.A., di distruzione di carte d'identità, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Dopo avere rilevato che l'omicidio era stato commesso nel corso di una rapina compiuta da un gruppo di quattro persone in casa dell'A.C., ucciso per il fatto di avere reagito e di essere riuscito a disarmare uno degli aggressori, e che nell'episodio era rimasto ucciso anche un rapinatore ed erano rimasti feriti un altro rapinatore e la moglie dell'A.C., la Corte di secondo grado rilevava che i due imputati avevano ammesso di avere partecipato alla rapina e avevano indicato R.A., morto successivamente in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, come l'esecutore dell'omicidio dell'A.C.: la Corte riteneva, quindi, insussistenti le condizioni perché al R.R. e all'A.A. potesse applicarsi la disposizione di cui all'art. 116 c.p., non potendo configurarsi l'ipotesi del concorso anomalo rispetto ad una situazione concreta in cui era riscontrabile il dolo omicidiario, nella forma eventuale, da parte degli imputati partecipanti, con altri due complici, ad una rapina compiuta con armi automatiche con il colpo in canna. Nella sentenza impugnata veniva altresi ritenuto che il dolo eventuale è compatibile con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., che nel caso di specie era stata esattamente applicata l'aggravante della crudeltà riguardo al delitto di rapina e che erano condivisibili le statuizioni relative all'equivalenza delle attenuanti con le aggravanti e alla determinazione della pena. Infine, la Corte distrettuale negava l'applicazione della diminuente del giudizio abbreviato, considerando inapplicabile la disposizione introdotta dall'art. 30 lett. b) della L. n. 479/99 che ha ammesso il rito speciale anche per i reati puniti con la pena edittale dell'ergastolo. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Nell'interesse del R.R. venivano denunciate erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la Corte di merito aveva considerato inapplicabile la figura del concorso anomalo, pur essendo stato accertato che il R.R. doveva identificarsi per il rapinatore non armato e non travisato che prese parte solo alla fase iniziale della rapina in casa dell'A.C., allontanandosene prima che iniziasse la sparatoria. Il ricorrente deduceva che la ritenuta esistenza del dolo eventuale era stata basata su una incompleta e illogica valutazione delle risultanze probatorie, da cui era scaturita una ricostruzione dei fatti non attendibile nel punto in cui aveva fatto discendere dal possesso delle armi la volontà di uccidere. Censurava altresi l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 4 c.p., giacché la condotta non era finalizzata a procurare inutili sofferenze alle vittime della rapina: lamentava altresi l'illegittimità della mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 30 lett. b) della L. n. 479/99 per l'omessa riduzione di pena giustificata dalla richiesta di giudizio abbreviato disattesa in sede di udienza preliminare. 20 Anche nell'interesse dell'A.A. venivano denunciate violazione di legge e mancanza e illogicità manifesta della motivazione in ordine all'omessa applicazione della disposizione di cui all'art. 116 c.p. per la ragione che il convincimento della Corte di merito era derivato da un ragionamento cosparso di lacune logiche e di incongruenze argomentative, onde doveva considerarsi priva di base logica e giuridica l'opinione che aveva condotto all'affermazione del dolo eventuale. Il ricorrente censurava, infine, la mancata riduzione di pena per il giudizio abbreviato denunciando l'erroneità dell'analisi interpretativa che aveva fatto escludere la natura sostanziale della nuova disciplina e aveva fatto negare che essa potesse trovare applicazione anche nei processi in corso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'ordine logico, devono essere esaminate, anzitutto, le censure formulate dai ricorrenti per contestare la correttezza delle linee argomentative poste a base dell'interpretazione delle risultanze probatorie e delle enunciazioni in punto di diritto alla stregua delle quali è stato escluso che nel caso in esame possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 116 c.p., che regola la figura del concorso anomalo. La giurisprudenza di questa Corte si è, da tempo, adeguata ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 c.p., ha escluso che tale disposizione configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la fattispecie da essa delineata esige anche un rapporto di causalità psicologica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave debba potere rappresentarsi alla psiche del concorrente nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani - come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza (Corte cost., 31 maggio 1965, n. 42). Nel solco di tale linea interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la configurazione del concorso anomalo sono necessari tre elementi, e cioè l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave e, infine, l'esistenza di un nesso causale, materiale e psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve porsi come il prevedibile sviluppo di quello concordato (Cass., Sez. I, 10 aprile 1996, Angeloni ed altro; Cass., Sez.I, 9 novembre 1995, Fortebracio ed altro). Ditalché l'esclusione della responsabilità ex art. 116 c.p. postula che il reato più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, mentre allorquando la condotta dell'imputato sia connotata non dalla sola prevedibilità, ma dalla effettiva previsione dell'evento diverso e dalla conseguente accettazione del rischio dell'avveramento, non potrà più parlarsi di responsabilità a titolo di concorso anomalo ma di piena responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. sotto il profilo del dolo eventuale (Cass., Sez. I, 28 giugno 1995, Cocuzza ed altro; Cass., Sez. I, 2 luglio 1993, Frandina; Cass., Sez. I, 22 giugno 1993, Rho). Per tali ragioni, il limite della sfera di operatività della disposizione di cui all'art. 116 c.p. è segnato dal dolo eventuale: questo si distingue dalle altre figure di dolo per il fatto che mentre nel dolo intenzionale la volontà persegue l'evento come scopo finale della condotta o come mezzo ritenuto necessario per conseguire un ulteriore risultato e nel dolo diretto l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta ma è accettato dall'agente come certo o altamente probabile, il dolo eventuale è caratterizzato, invece, dal rischio di verificazione e dall'accettazione dell'evento, che nella rappresentazione psichica appare soltanto probabile (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, Mele; Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Cassata; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Cutruzzolà; Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Casu). In questa stessa prospettiva ricostruttiva della normativa è stato precisato che l'omicidio non può considerarsi quale evento eccezionale e imprevedibile rispetto alla concordata rapina a mano armata, in quanto - come più volte riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte - il più grave reato di omicidio risulta collegato al reato di rapina con l'uso di armi da 21 un rapporto di regolarità causale, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass., Sez. I, 25 marzo 1994, Giugni ed altro; Cass., Sez. V, 17 dicembre 1991, Vizzini). Dai precedenti rilievi deve inferirsi che, nell'ipotesi di omicidio commesso durante una rapina con uso di armi, la questione relativa alla responsabilità per l'omicidio da parte di chi non abbia fatto uso delle armi) a titolo di concorso anomalo o pieno, deve essere risolta caso per caso, senza aprioristiche opzioni concettuali, accertando - in riferimento alle specifiche e peculiari circostanze concrete - se l'evento mortale fosse solo prevedibile oppure se esso sia stato realmente previsto e voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale. La Corte territoriale ha dato esatta applicazione ai principi dianzi illustrati, escludendo che nella specie i due imputati possano rispondere dell'omicidio ai sensi dell'art. 116 c.p. per la ragione che le risultanze probatorie sono state reputate inequivocamente comprovanti che l'uccisione dell'A.C. è addebitabile ad entrambi a titolo di dolo eventuale. Infatti, la Corte di merito ha accertato che l'A.A. era armato e che i due imputati hanno partecipato alla rapina nella consapevolezza che gli altri due complici erano muniti di armi automatiche e che, all'occorrenza, erano pronti ad usarle in caso di resistenza delle vittime: in tal senso sono state considerate univocamente conducenti le circostanze che le armi avevano il colpo in canna, che tale fatto era conosciuto dagli imputati, in quanto mentre erano ancora sull'auto avevano sentito il rumore caratteristico dello "scarellamento" dell'arma, e che lo stesso R.R. aveva riferito che il M. la sera precedente aveva commesso una rapina, con le medesime modalità, nel corso della quale si era registrata la reazione armata della vittima. Tali puntuali elementi fattuali sono stati valutati con prudente apprezzamento dalla Corte distrettuale, che, con argomentazioni del tutto coerenti e legate da piena coordinazione logica, ha accolto la conclusione che l'A.A., il quale era munito di un'arma, e il R.R. avevano concretamente previsto la probabilità dell'uso delle armi per superare la resistenza delle vittime della rapina, accettando il rischio dell'uccisione e del ferimento di una di esse. Ne consegue, che l'ineccepibilità logica e giuridica della motivazione rende non censurabili nel giudizio di legittimità sia l'affermata sussistenza del dolo eventuale nei due imputati sia la dichiarazione della loro responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 e 575 c.p., dovendosi escludere la correttezza del riferimento fatto dai ricorrenti alla figura del concorso anomalo. (omissis) PQM La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che si liquidano in complessive lire 4.500.000, delle quali lire 4.000.000 per onorari. ******************************************************************************** 22 3. Fattispecie di reati aggravati dall’evento e principio di colpevolezza: l’ipotesi della morte quale conseguenza non voluta del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, comma 2) *** Cassazione penale sez. II, 5 aprile 1990, Bernasconi maggiormente compatibile con il principio di colpevolezza) (orientamento Nella ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione posto in essere da più soggetti, ove taluni di essi uccidano volontariamente il sequestrato, gli altri, a seguito della entrata in vigore della l. 7 febbraio 1990, n. 19 (che ha disciplinato la materia in termini più favorevoli per il reo), rispondono del delitto aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 630 c.p. solo dove abbiano avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato, malgrado la loro volontà contraria, o abbiano ignorato o ritenuto inesistente il pericolo per colpa. *** Cassazione penale, Sez. II, 10 ottobre 2002 n. 34068 (orientamento intermedio) Nel sequestro di persona a scopo di estorsione, la morte della vittima rientra nel campo della normale prevedibilità dell’evento, conseguendone che l’accettazione da parte del correo del programma criminoso importa anche accettazione dei rischi a esso connessi. Quindi, il correo, per non andare incontro alla responsabilità per la morte della vittima, non basta che adduca di «non avere voluto » un tale evento, ma occorre dimostri di avere posto in essere un’attività impeditiva di esso. *** Cassazione penale, sez. V, 14 novembre 1991, n. 11407 (orientamento più rigoroso) Il disposto del secondo comma dell'art. 630 cod. pen. trova applicazione tutte le volte in cui la morte non sia voluta né conosciuta dall'agente, ma sia comunque derivata dal sequestro e ciò perché l'ulteriore evento è pur sempre ricollegabile alla condotta criminosa tipica del sequestro di persona a scopo di estorsione. Invero nel momento in cui il legislatore ha recepito un dato sociale quale la frequenza, nei sequestri, della morte del sequestrato - ha anche ritenuto di considerare la morte di costui come conseguenza possibile del sequestro, sicché questa, alla stregua degli attuali normali accadimenti, è legata al sequestro sotto il profilo del nesso causale e, per tale ragione, va sempre imputata al reo, anche se non voluta, essendo irrilevante ogni atteggiamento psichico di inerzia (o di comodo agnosticismo) al cospetto di una realtà, normativa sì ma desunta da un'esperienza condotta su elementi effettuali, che conferisce al fatto iniziale (sequestro) la potenziale produttività dell'ulteriore evento; una forza cioè che rientra nella normale prevedibilità da parte dell'agente, quale elemento soggettivo sufficiente ad integrare in concreto la fattispecie in discorso. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, stante la congiunzione "comunque" che figura nel suddetto comma, la rilevanza della morte può essere esclusa solo se l'evento sia totalmente al di fuori del nesso causale col sequestro, come quando ad es. il rapito venga ucciso da persone e per ragioni totalmente estranee al sequestro e senza che i sequestratori abbiano potuto evitarla pur avendo posto in essere tutte le difese a loro disposizione). 4. Aberratio ictus e aberractio delicti. 23 Art. 83 Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 1986, n. 1673 L'art. 83 cod. pen., nel disciplinare l'ipotesi di "evento diverso da quello voluto dall'agente", stabilisce che qualunque sia in concreto nelle singole fattispecie il determinismo causale che dà luogo all'"aberratio", l'evento non voluto può esser posto a carico dell'agente solo se dal comportamento di questi sia stato cagionato per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per qualsiasi altra causa. L'esistenza di una causalità materiale comunque verificatasi tra l'azione o l'omissione e l'evento diverso è sufficiente per giustificare l'addebitabilità di questo senza che sia necessaria la colpa, non potendosi identificare come ipotesi di colpa l'errore e le altre cause menzionate dall'art. 83 cod. pen. Elemento psicologico necessario per l'affermazione di responsabilità è il dolo del reato voluto, anche se la punibilità per il reato verificatosi è a titolo di colpa. 5. Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) e principio di colpevolezza. **** Cassazione penale, sez. IV, 28 giugno 1991, Greco Lo spacciatore di droga risponde del reato di cui all'art. 586 c.p. nel caso di morte dell'acquirente derivata dall'assunzione della sostanza stupefacente. Il rapporto tra il fatto del delitto doloso (spaccio di stupefacenti e vendita della dose) e l'evento non voluto (morte del tossicodipendente) e' stabilito dalla mera causalità materiale, sicché l'imputato, come autore del delitto doloso, deve rispondere a titolo di colpa dell'evento (morte) non voluto, indipendentemente o anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o accidentale. Per il vigente sistema penale, l'azione od omissione dell'agente e' giuridicamente considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, anche se altre circostanze, a lui estranee, di qualsiasi genere (preesistente, concomitanti o successive), concorrono alla sua produzione, perché il comportamento dell'agente costituisce sempre una delle condizioni dell'evento. Non spiegano, pertanto, alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità ne' l'essere quelle concause dipendenti od indipendenti dal comportamento del colpevole e nemmeno l'avere le stesse una maggiore prossimità all'evento oppure una preminente efficienza causale. (Nella fattispecie e' stato ritenuto inidoneo ad escludere il nesso di causalità il fatto che la dose venduta ed assunta fosse stata in quantità non eccessiva, cosicché la morte non fu dovuta ad overdose, ma ad una previa assunzione di alcool, ignota all'imputato, che aveva accentuato l'effetto del narcotico). **** Tribunale Roma 12 febbraio 1985, Trombetti e altro 24 Nel caso di morte derivante da assunzione di sostanza stupefacente di per sè non letale, gli spacciatori non rispondono di omicidio colposo, per inesistenza del nesso causale ex art. 40 c.p. tra la semplice cessione della sostanza e l'evento-morte, ove il tossicodipendente, al momento di iniettarsi la droga, sia capace di autocontrollo e pienamente consapevole dei rischi cui volontariamente si espone (nella specie, si è ritenuto che il tentativo di porre in relazione l'azione di spaccio con l'evento causato autonomamente dall'azione della vittima condurrebbe ad una affermazione di responsabilità penale per fatto altrui in contrasto con l'art. 27, comma 1 cost.). 6. Teoria dell’inesigibilità e principio di colpevolezza ***** Cassazione penale, sez. I, 17 aprile 1991, n. 4342 In tema di elemento soggettivo del reato, non può trovare applicazione la cosiddetta teoria dell'inesigibilità, secondo la quale verrebbe meno la colpevolezza, quando sia impossibile pretendere dal soggetto una condotta conforme al precetto. Il vigente ordinamento giuridico penale è fondato sul principio di legalità ed al giudice non è lasciato alcun margine per l'individuazione della condotta punibile. Ne deriva che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento i ritardi della P.A. nell'attivazione di un impianto centralizzato di depurazione non determinano l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di superamento dei limiti di accettabilità dello scarico. ****** Tribunale di Bologna, 29 aprile 2002, n. 193 Deve essere assolto per non aver commesso il fatto ex art. 530, cpv., del c.p.p., con connessa affermazione di responsabilità penale del padre, per mancanza del dolo specifico della frode fiscale di cui all'art. 4, lett. f), della L. 7 agosto 1982, n. 516, a causa della sua particolare personalità, un contribuente-imputato, ritenuto inconsapevole degli aspetti amministrativi della sua attività sportiva, allorché si possa ritenere che il medesimo non abbia avuto consapevolezza, non solo del disvalore degli atti compiuti, ma anche del loro significato. TRIBUNALE di BOLOGNA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (Omissis) FATTO E DIRITTO In data 8.4.1997 perveniva alla Procura della Repubblica di Bologna e, per conoscenza, al Comandante del Nucleo Regionale di Polizia tributaria, una lettera anonima che sottoponeva alla "cortese attenzione" dei destinatari "la situazione di Paolo Comellini". Segnalava e lamentava l'anonimo la palese incongruenza tra la proclamata nullatenenza di quest'ultimo, nei cui confronti vantava un credito, ed un tenore di vita lussuoso, del quale forniva dettagliatissime manifestazioni (cinque auto di prestigio, lunghe vacanze in località esclusive, etc.). E, poiché nessun altro nella famiglia lavorava, si domandava retoricamente se non potessero essere vere notizie da lui raccolte circa una illecita attività di esportazione di capitali all'estero a mezzo di 25 società di comodo e si firmava (con ironico riferimento alla inesigibilità del suo credito) "un nullatenente vero" La missiva conteneva un riferimento ad un atleta innominato che "godeva dei suoi servigi" e ad un ricatto che il Comellini stava ponendo in essere nei suoi confronti. La notorietà dei suoi rapporti e dei recenti disaccordi con Alberto Tomba conferiva carattere esplosivo alla denuncia, che usciva dalla sua genericità solo con la indicazione esemplificativa di una società che procurava false fatturazioni al Comellini: la Padana Pubblicità di Biondini Luciano, della quale venivano forniti indirizzo, telefono e partita IVA. Le indagini, affidate dalla Procura al Nucleo Regionale di Polizia tributaria, conducevano, in data 27.5.1997, alla perquisizione e al sequestro di documentazione contabile nella sede della Padana Pubblicità. Il 29 maggio un ufficiale della G.D.F., il colonnello Moscuzza, contatto' tale Malena il quale si presentò nel suo ufficio il giorno successivo con Andrea Vidotti. Il Moscuzza intratteneva da tempo un rapporto di amicizia con il Malena, che conduceva una attività di organizzazione di avvenimenti dello sport e dello spettacolo ed era stato da lui presentato alla famiglia Tomba, conoscendo anche il Vidotti, un tempo collaboratore del Comellini, che attualmente si occupava della società New Events, costituita dai familiari di Tomba dopo la rottura dei rapporti con il Comellini. Sullo scopo e sulla natura del colloquio accusa e difesa danno interpretazioni diverse ma è comunque certo che il Moscuzza consentì al Vidotti di prendere visione della denuncia anonima. Tale comportamento e la conseguente sensazione che in quel modo si volesse far sapere alla famiglia Tomba delle indagini in corso per consentire di correre, per quanto possibile, ai ripari ha condotto alle imputazioni di rivelazione di segreto di ufficio e di tentativo di abuso di ufficio. La Sezione di Polizia giudiziaria della G.D.F. procedeva successivamente agli accertamenti sulla correttezza di quella che veniva chiamata la "gestione dell'immagine" di Alberto Tomba. Che l'immagine non corrisponda sempre alla realtà è predicato da sempre dalla saggezza popolare, senza poter reprimere la istintiva tentazione di credere alla immagine. Tale constatazione muove intenti speculativi. L'immagine di Alberto Tomba era quella di un giovane dotato di uno straordinario talento e di una eccezionale vigoria fisica che aveva deciso di impiegarli in uno sport dilettantistico, praticandolo come milite dell'Arma dei carabinieri. Quanto di più accattivante si possa proporre. Gli straordinari e meritati successi gli avevano fatto conseguire una notorietà ed una ammirazione addirittura superiore a quella di campioni di altri sport più popolari, riconosciuti e remunerati come professionisti. E' come scoprire una miniera d'oro in un parco naturale. E così come i divieti, le sanzioni, i rischi non fermavano i cercatori del Klondike invasati dalla febbre, anche qui l'entità del filone e la consapevolezza della sua effimera consistenza non poteva non indurre la tentazione di incursioni extralegali. La giovane età di Tomba e la tendenza equilibrante della natura non potevano far si che a tale dovizie di doti fisiche si associasse altrettanta capacità imprenditoriale: di qui la necessità di "gestione". Va premesso che il giusto riconoscimento del valore delle prestazioni agonistiche da un lato, e il pericolo di evidenti tentazioni dall'altro, avevano condotto la federazione dilettantistica di appartenenza a concedere "l'utilizzo promo-pubblicitario" della immagine degli atleti stipulando contratti con le aziende interessate. 26 Degli importi incassati (e parzialmente trattenuti dalla F.I.S.I.) una quota veniva corrisposta agli atleti in varie forme, parte immediatamente, parte mediante polizze-vita per la fine della carriera. E della eccezionale rilevanza delle prestazioni di Tomba si era tenuto conto creando per lui un vero e proprio (ben remunerato) jus singularis. La ipotesi accusatoria emersa dalle indagini è la stipulazione di contratti paralleli con le medesime aziende per importi notevolmente superiori, con la finalità di ottenere la disponibilità immediata di tali ingenti somme in elusione del fisco, figurando i relativi introiti in capo a società italiane o estere fittiziamente interposte. L'originario affidamento della gestione a Paolo Comellini ha subito nel tempo vicende che hanno condotto ad una modifica e poi ad una cessazione dei rapporti con la famiglia Tomba e alla assunzione diretta del ruolo da parte del padre dell'atleta. In precedenza il Comellini avrebbe assunto la gestione della immagine come "collaboratore" della International Management Group Team Italia (collegata alla I.M.G. U.K. inglese), nonché come "amministratore di fatto" della Group Italia srl . Franco Tomba, procuratore speciale del figlio Alberto fin dal 1989, nel giugno 1996 divenne amministratore della appositamente costituita New Events s.r.l., una società associata in partecipazione con Alberto Tomba, di fatto gestita da Vidotti e Sgorlon (già collaboratori di Comellini) e seguita professionalmente dai commercialisti Poggi e Corinaldesi. La depenalizzazione della ipotesi di reato a questi ultimi contestata e la richiesta di applicazione di pena da parte del Biondini hanno limitato la istruttoria dibattimentale ai fatti e agli imputati indicati in rubrica, dei quali unicamente in questa sede ci si occupa (essendo venute meno anche alcune contestazioni a carico del Comellini e di Franco Tomba). La maggior parte della attività difensiva, nel quadro del rito abbreviato prescelto e variamente condizionato da tutti, è stata svolta sul piano "tecnico", volta a lucrare, legittimamente, le incongruenze legislative conseguite alla successione delle norme senza una regolamentazione delle situazioni di diritto transitorio, promessa e intravista, ma malauguratamente abbandonata. Ma da parte della difesa dei Tomba è stato compiuto uno sforzo rilevante anche in fatto per sottrarre Alberto ai perversi automatismi della nemesi biblica delle colpe dei padri. Una perfetta consapevolezza del maggior interesse difensivo, per motivi agevolmente intuibili, nei confronti di Alberto non esime dal valutare coscienziosamente i fatti posti a fondamento della richiesta di differenziazione tra le condotte dei due familiari imputati. Sono stati chiamati testi, tra cui una curiosa figura di allenatore- convivente - confidente di Alberto (una sorta di Mentore appenninico), che hanno ritratto una mitica figura di atleta, completamente avulsa dalle complicazioni di una società che vive anche di aspetti diversi dall'agonismo e dai festeggiamenti pre e post-agonistici. Talmente tutelato da ogni turbativa da indurre una sorta di atrofizzazione in fieri di ogni capacità pratica a condurre una vita di relazione, che comporta anche lo scambio di danaro con modalità universalmente conosciute. Dicono l'allenatore e la sorella Alessia che Alberto non possedeva nemmeno un libretto di assegni, perché dovunque andasse era ospite o c'era chi pagava per lui. Atteggiamento che viene dipinto non come regale disinteresse ma proprio come fanciullesca inconsapevolezza; una alienante robotizzazione dell'atleta nella quale parrebbe mortificante identificarsi, ma che appare accettabile, od addirittura utile, in un dibattimento. I non obliterabili aspetti formali (le sue firme sui contratti paralleli) possono in questo quadro essere ricondotti alla descritta sconoscenza sesquipedale di aspetti fondamentali della vita di relazione e fondare un dubbio concreto sulla sussistenza dell'elemento psicologico, non solo sul disvalore degli atti compiuti, ma sul loro stesso significato. 27 Non essendo appositamente prevista una formula assolutoria adeguata alle ipotizzate circostanze di fatto, Alberto va assolto, in accoglimento della tesi difensiva, per non aver commesso il fatto. (Per gli anni 1993-94-95 si è addivenuto ad accertamento con adesione). L'accoglimento, nei limiti segnati dall'art. 530 cpv. c.p.p., di tale tesi riverbera però effetti opposti per quanto riguarda la consapevolezza piena dell'effetto degli atti che andava compiendo Franco Tomba, unitamente ai suoi diversi incaricati, nel corso degli anni. Per cui, di necessità, la posizione di questo imputato è stata difesa in puro diritto, "in punta di fioretto", come ha detto un valentissimo difensore, di seguito sciorinando raffinate considerazioni giuridiche. La tesi accusatoria punta il dito sull'occultamento dei redditi costituiti dai proventi pubblicitari ottenuti in violazione del regolamento F.I.S.I. mediante la stipulazione di contratti paralleli, con la interposizione fittizia da parte di I.M.G. U.K. e di altre società,e sulla realizzazione di una cosiddetta frode esterna, commessa cioè con artifici diversi rispetto alla più banale e ricorrente formazione di documenti materialmente o ideologicamente falsi. Obbietta la difesa che la interposizione della società inglese non era fittizia ma reale, sulla inconfutata considerazione che tale società non solo era realmente esistente, ma aveva prestigio internazionale e dimensioni "planetarie"; tanto che per i suoi ambiti servigi tratteneva una più che consistente percentuale sugli introiti del 25%. Quindi si deve parlare di contratti esistenti e leciti, di interposizione reale, con un rapporto instaurato direttamente tra interponente e interposto (così come, tra l'altro, riconosciuto dai giudici tributari che hanno affrontato la questione per quanto di loro spettanza). Si riconosce che, per le sue modalità, tale genere di contratto consente di occultare il sorgere del presupposto della imposta (che per I.M.G. si colloca al momento dell' incasso del danaro fornito dallo sponsor e per Tomba al momento della retrocessione del suo 75%). Ma per la difesa "da quel momento sono fatti e scelte del contribuente se assumere un comportamento ortodosso o no, ma quello che precede non ha rilievo, essendo censurabili penalmente soltanto le dichiarazioni fiscali", tanto che nessuno degli interposti ha mai ricevuto imputazioni. Si tratta quindi di "un comportamento illecito il cui disvalore non supera mai la soglia della contravvenzione" della dichiarazione infedele. Con argomenti non dissimili si cercò di dimostrare che Achille non avrebbe mai potuto raggiungere la tartaruga. Non si può concettualmente segmentare quella che appare come una linea concepita e realizzata come un percorso ininterrotto verso una destinazione prestabilita. C'è una volontà di sfruttare economicamente la immagine di un atleta al di là dei modi e dei limiti consentiti dalla legge, si affida ad una società l'incarico di stipulare contratti paralleli non realizzabili lecitamente in Italia e di dirottare i proventi su conti esteri che sfuggono alla nostra imposizione fiscale. La dichiarazione infedele, omissiva di tali cospicui cespiti, sarebbe inconcepibile e temeraria se non fosse stato posto in essere quel meccanismo contrattuale che artificiosamente dissimula la esistenza dei redditi e che non può quindi non essere definito fraudolento. Il consilium fraudis precede e accompagna l'intero iter, rallegrandosi infine della evasione che ha consentito. Sostenere, dopo che si è creato questo complicato (e costoso) castello, che vi era una sola possibilità (che avrebbe reso tutto giuridicamente lecito), che Franco Tomba potesse inserire tali proventi nella dichiarazione fiscale, condurrebbe ad una sua improponibile assimilazione alla insipienza finanziaria del figlio o ad una improbabile proliferazione delle vie di Damasco. 28 Non si pagano percentuali del 25% su contratti-fotocopia di quelli già conclusi con gli sponsores in Italia se il servizio non prevede una capacità di occultamento dei redditi. Ma si è eccepita anche la discontinuità normativa tra il delitto di frode fiscale previsto dall'art. 4 lett. F della legge 5 16/82 originariamente contestato ed il vigente art. 4 del D.vo 74/2000, sia per la fissazione in quest'ultimo di soglie di punibilità della quantità di imposta evasa, sia per la introduzione di una nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta espressamente punita sub art. 3 e riservata ai soggetti tenuti alle scritture contabili. Questo jus superveniens attizza sensazioni e tentazioni di impunità al di là delle già ampie concessioni, conseguenti a criteri di opportunità che hanno condotto ad una politica fiscale meno rigida, intesa a selezionare e facilitare le indagini, sospingendo la punibilità sull'evento anziché sulla condotta, rendendo penalmente irrilevante il tentativo e limitando le sanzioni ai casi di più rilevante offensività per l'Erario. Le nuove indicazioni legislative riservano la punibilità della dichiarazione fraudolenta (art. 3) ai soggetti tenuti alle scritture contabili, continuando a tenerla separata dalla dichiarazione infedele (art. 4) che prevede sanzioni erga omnes, ponendo per entrambe soglie di punibilità ignote alla legislazione precedente, che sanzionava la mera condotta fraudolenta o omissiva qualunque fosse il livello di evasione. Soprattutto la indicazione di tali soglie, considerato elemento costitutivo del reato, segnerebbe la disomogeneità strutturale tra le vecchie e le nuove norme, determinando nel caso di specie di contestazione originaria dell'art. 4 lett. F una abolitio criminis e quindi la impossibilità di una contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p. E' lecito infatti pretendere che la fattispecie contestata lo sia in tutti quegli elementi che incidono sulla certezza della imputazione e sul diritto di difesa. Elementi, evento ovviamente compreso, che debbono essere inclusi nella volizione dolosa. Su questi punti appaiono da seguire le considerazioni del P.M., supportate da Giurisprudenza e dottrina qualificate, che evidenziano da un lato come le soglie introdotte costituiscono "la semplice misurazione e constatazione della entità della evasione, ampiamente compresa nell'oggetto della rappresentazione e della volizione dolosa degli imputati" e dall'altro come la nuova norma si ponga come generale aspetto alla specialità del vecchio art. 4 lett. F e del nuovo art. 3 che, oltre al dolo specifico di evasione e alla condotta di infedele dichiarazione, contengono anche gli estremi della fraudolenza; mantenendo il primo una sopravvivenza significativamente sconosciuta dal D.L. 25.9.2001 n. 350 (c.d. scudo fiscale) che gli fa esplicito riferimento come a norma tuttora operante. Di qui la insostenibilità della tesi della difesa che condurrebbe ad una radicale depenalizzazione delle frodi fiscali consumate nella vigenza della legge 516/82. Nella sentenza n. 36 del 15.1.2001 delle Sezioni Penali Unite della Corte di Cassazione è stata dalla difesa limita chiaramente la esclusione della continuità normativa al caso della contravvenzione di omessa dichiarazione (art. 1 comma 1 legge 516/82) e del delitto attuale (art. 5 D.vo 74/2000) che prevede per la sua punibilità un dolo specifico di evasione dell'imposta nell'ammontare stabilito dalla legge e impone di ciò specifica contestazione. Tale interpretazione, oltre ad essere largamente condivisa, è l'unica che consente di identificare una funzione repressiva nella norma, che si presume in qualche modo essere stata nelle intenzioni del legislatore e che sarebbe completamente vanificata da interpretazioni come quelle proposte dalla difesa. ------------------------------------------- Quanto invece al capo B), la imputazione nei confronti di Franco Tomba, conseguita alla mancata denuncia di analoghi redditi relativi all'anno 1966 da parte della società New Events deve cadere, come ha ritenuto anche il P.M., a fronte del versamento 29 all'Erario da parte dei soggetti fisici che avevano costituito la società di un importo triplo rispetto al tributo dovuto. Eccessivi formalismi sui soggetti tenuti condurrebbero a conseguenze incomprensibilmente inique. E a nulla ovviamente rileva che tale eccessiva riparazione abbia trovato causa nella trepidazione e nella precipitazione sulle notizie delle indagini in corso, dovendosi avere esclusivo riguardo alla tempestività di un versamento che, pur necessitato, vi è stato nei modi e nei tempi dovuti. Le considerazioni sopra esposte sulla ritenuta continuità normativa tra il reato contestato al capo A) e le nuove disposizioni non possono condurre sic et simpliciter alla affermazione di responsabilità anche per il Comellini, il cui concorso appare testualmente configurato per un suo ruolo di "collaboratore" della I.M.G. s.r.l. e di "amministratore di fatto" della Group Italia. Rileva il suo difensore che la accertata, intensa e riconosciuta attività di procacciatore di affari e la sua conseguente incidenza nella formazione dei redditi non denunciati, non può ex se considerarsi concorso nel reato contestato, pena una analoga, mai ritenuta, possibilità di coinvolgimento di qualsiasi venditore "porta a porta" nei reati fiscali imputabili all'imprenditore per cui presta la sua opera. Discorso apparentemente paradossale e provocatorio, vista la centralità della figura del Comellini in questa vicenda, ricavabile da fatti dalla opinione pubblica ritenuti notori e dalla stessa iniziale direzione delle indagini, avviate in primo luogo nei suoi confronti con il sequestro delle fatture compiacenti del Biondini. Tuttavia il dato formale è preclusivo ad interpretazioni di apriorismo logico non supportato da prove. E se la stessa accusa, al termine delle indagini, qualifica il Comellini semplicemente come collaboratore della I.M.G. occorre solo prendere atto della inidoneità di tale qualifica a fargli rivestire il ruolo di concorrente. Diversa sorte seguirebbe ad un effettivo accertamento della sua qualifica di amministratore di fatto della Group Italia; ma tale risultato non pare conseguito. Questa società aveva un suo amministratore di diritto, nominato ben prima dell'ingresso del Comellini, che aveva le qualità imprenditoriali per esercitare quella funzione, che l'aveva fin ad allora esercitata e che quindi non poteva essere retrocesso ad "uomo di paglia", con le conseguenze giuridiche relative, solo a seguito dell'intervento propulsivo del Comellini e per la maggiore notorietà e visibilità da questi conseguita. Anche nella nostra storia recente situazioni di prospettata ineleggibilità derivanti dalla titolarità di concessioni pubbliche hanno dovuto segnare il passo di fronte alla insuperabilità di dati formali che escludevano la incompatibilità con cariche governative. Nessun potere più poteva avere, nessun coinvolgimento concreto, nessun interesse infine il Comellini sul corretto comportamento fiscale di Alberto Tomba, affidato per questo e per altro al padre, da sempre suo procuratore speciale. Per i redditi poi relativi all'anno 1995 nessuna prova è emersa circa una loro produzione a seguito di atti da lui compiuti. Da ultimo conviene trattare della posizione processuale del colonnello Moscuzza, gravato da ben due contestazioni per un suo comportamento, che non ha influito sulle indagini, dettato da una improvvida (e, si deve ritenere, improduttiva) captatio benevolentiae di un personaggio ricco e famoso. Sussiste il primo reato (rivelazione di segreto di ufficio), per giurisprudenza costante compatibile con lo stato delle indagini, ancora nella fase di valutazione dell'anonimo, e con la assenza di danno per la P.A. 30 Il mostrare al Vidotti, consulente della famiglia Tomba, il testo dell'anonimo e il consentire diffuse annotazioni dello stesso integra certamente il reato di cui all'art. 316 c.p., non essendo in alcun modo atto necessario o utile per la richiesta di informazioni sul Comellini che l'ufficiale dichiara essere stato il motivo reale e unico della sua convocazione. Non appare invece provato l'abuso di ufficio, nella infrequente forma tentata, per avere cercato di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai Tomba assicurando un rallentamento delle indagini o consentendo l'occultamento delle prove. Non è dato vedere infatti, al di là del tempestivo intervento del P.M., quale utile attività per celare illeciti risultanti documentalmente avrebbe potuto porre in essere il Moscuzza. Oltre alla violazione dei propri doveri è richiesta anche la esistenza di propri poteri; una impotente disposizione al favoreggiamento non integra il reato. La non rilevante gravità del fatto e le altre valutazioni ex art. 133 c.p. consentono di contenere nel minimo la pena, irrogata in mesi tre di reclusione, in concorso di attenuanti generiche, da concedersi (unitamente ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna) in relazione alla incensuratezza (pena base mesi sei, ridotta di mesi uno e giorni quindici ex art. 62 bis c.p. e di un ulteriore terzo per il rito). La evidenziata responsabilità di Franco Tomba in ordine ai fatti contestati al capo A) rende congrua la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (pena base anni tre, ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p. e di u n ulteriore terzo per il rito). P.Q.M. IL GIUDICE Visti gli artt.438 e sgg. C.p.p. DICHIARA TOMBA FRANCO responsabile del reato ascrittogli al capo A) e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo CONDANNA alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000 applica per pari periodo le pene accessorie ivi stabilite. DICHIARA MOSCUZZA GIUSEPPE responsabile del reato contestato al capo H) e, concesse le attenuanti generiche, lo CONDANNA Alla pena di mesi tre di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Visto l'art. 31 c.p. applica la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per pari periodo. Visto l'art. 6531 c.p.p. DICHIARA N.D.P. nei confronti di Tomba Alberto in ordine alla imputazione sub A), limitatamente agli anni 1993-1994 1995 per essere il reato estinto a seguito di accertamento con adesione. 31 Visto l'art. 530 cpv. c.p.p. ASSOLVE TOMBA ALBERTO dalle rimanenti imputazioni sub A) per non aver commesso il fatto. ASSOLVE COMELL1NI PAOLO dalla imputazione sub A), relativamente all'anno 1995, perché il fatto non sussiste, per le altre annualìtà perché il fatto non costituisce reato ASSOLVE MOSCUZZA GIUSEPPE dalla imputazione ascrittagli al capo I) perché il fatto non sussiste. Motivazione in 90 giorni. Bologna, 31.1.2002 Il Giudice Norberto Lenzi ******************************************************************************** APPENDICE SENTENZA N. 364 32 ANNO 1988 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Prof. Francesco SAJA, Giudici Prof. Giovanni CONSO Prof. Ettore GALLO Dott. Aldo CORASANITI Prof. Giuseppe BORZELLINO Prof. Renato DELL'ANDRO Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Prof. Antonio BALDASSARRE Prof. Vincenzo CAIANIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, 42, 43 e 47 del codice penale e dell'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 luglio 1980 dal Pretore di Cingoli nel procedimento penale a carico di Marchegiani Mario ed altri, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1980; 2) ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Marin Giacinto, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 dell'anno 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto l.- Le ordinanze in epigrafe propongono analoghe questioni: riuniti i giudizi, le stesse questioni possono, pertanto, esser decise con unica sentenza. 2. - L'ordinanza di rimessione del Pretore di Cingoli riferisce che agli imputati e stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l'ordinanza di rimessione del Pretore di Padova riferisce che l'imputato é stato chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 666 c.p.: mentre le predette ordinanze risultano sufficientemente motivate in ordine alla rilevanza non si può qui far riferimento al notissimo indirizzo giurisprudenziale relativo alla <buona fede> nelle contravvenzioni senza impostare e risolvere il generale problema della legittimità dell'art. 5 c.p.: a parte la sua non uniformità, il predetto indirizzo giurisprudenziale, come in seguito si motiverà, non trova fondamento nella vigente legislazione a causa della norma di <sbarramento>, di cui all'art. 5 c.p., che impedisce ogni rilievo, comunque, all'ignoranza della legge penale, sia essa qualificata o meno. Come é stato esattamente rilevato, disciplinando un elemento negativo (l'ignoranza) lo stesso articolo non offre possibilità d'operare distinzioni di disciplina tra le diverse cause dell'ignoranza o tra le varie modalità concrete nelle quali la medesima si manifesta. 3. - Prima d'esaminare se ed in quali limiti l'art. 5 c.p. deve ritenersi illegittimo, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, vanno qui brevemente sottolineate alcune premesse ideologiche, di metodo, storiche e dommatiche. La mancata considerazione delle relazioni tra soggetto e legge penale, l'idea che nessun rilievo giuridico va dato all'ignoranza della legge penale, e, fra l'altro, il risultato di tre ben caratterizzate impostazioni ideologiche. La prima, in radicale critica alla concezione normativa del diritto, contesta che l'obbedienza o la trasgressione della legge abbia attinenza con la conoscenza od ignoranza della medesima. La seconda sottolinea che, essendo l'ordinamento giuridico sorretto da una <coscienza comune> che lo legittima e costituendo, pertanto, la trasgressione della legge <episodio> particolare, incoerente e perciò ingiustificato (attuato da chi, conoscendo e contribuendo a realizzare i valori essenziali che sono alla base dello stesso ordinamento, appunto arbitrariamente ed incoerentemente si pone in contrasto con uno 33 dei predetti valori) non può lo stesso ordinamento condizionare l'effettiva applicazione della sanzione penale alla prova della conoscenza, da parte dell'agente, per ogni illecito, del particolare precetto violato. La terza impostazione ideologica, comunemente ritenuta soltanto politica, attiene all'illuministica <maestà> della legge, la cui obbligatorietà, si sostiene, non va condizionata dalle mutevoli <psicologie> individuali nonchè dall'alea della prova, in giudizio, della conoscenza della stessa legge. Senonchè, contro la prima tesi, va osservato che, supposta l'esistenza di leggi giuridiche statali, nessun dubbio può fondatamente sorgere in ordine al principio che spetta all'ordinamento dello Stato stabilire le condizioni in presenza delle quali esso entra in funzione (e, tra queste, ben può essere prevista la conoscenza della legge che si viola). Alla seconda tesi va obiettato che, in tempi in cui le norme penali erano circoscritte a ben precisi illeciti, ridotti nel numero e, per lo più, costituenti violazione anche di norme sociali universalmente riconosciute, era dato sostenere la regolare conoscenza, da parte dei cittadini, dell'illiceità dei fatti violatori delle leggi penali; ma, oggi, tenuto conto del notevole aumento delle sanzioni penali, sarebbe quasi impossibile dimostrare che lo Stato sia effettivamente sorretto da una <coscienza comune> tutte le volte che <aggiunge> sanzioni a violazioni di particolari, spesso <imprevedibili>, valori relativi a campi, come quelli previdenziale, edilizio, fiscale ecc., che nulla hanno a che vedere con i delitti, c.d. naturali, di comune <riconoscimento> sociale. Alla terza impostazione ideologico-politica va obiettato che, certamente, e pericoloso, per la tutela dei valori fondamentali sui quali si fonda lo Stato, condizionare, di volta in volta, alla prova in giudizio della conoscenza della legge penale, da parte dell'agente, l'effettiva applicabilità delle sanzioni penali ma che, tuttavia, il principio dell'irrilevanza assoluta dell'ignoranza della legge penale non discende dal l'obbligatorietà della stessa legge; tant'é vero che, come é stato sottolineato di recente dalla dottrina, nei sistemi nei quali si attribuisce rilevanza all'ignoranza della legge penale non per questo la legge diviene <meno obbligatoria>. Vero é che gli opposti principi dell'assoluta irrilevanza o dell'assoluta rilevanza dell'ignoranza della legge penale non trovano valido fondamento: ove, infatti, s'accettasse il principio dell'assoluta irrilevanza dell'ignoranza della legge penale si darebbe incondizionata prevalenza alla tutela dei beni giuridici a scapito della libertà e dignità della persona umana, costretta a subire la pena (la più grave delle sanzioni giuridiche) anche per comportamenti (allorchè l'ignoranza della legge sia inevitabile) non implicanti consapevole ribellione o trascuratezza nei confronti dell'ordinamento; ove, invece, si sostenesse l'opposto principio dell'assoluta scusabilità della predetta ignoranza, l'indubbio rispetto della persona umana condurrebbe purtroppo (a parte la questione della possibilità che esistano soggetti che volutamente si tengano all'oscuro dei doveri giuridici) a rimettere alla variabile <psicologia> dei singoli la tutela di beni che, per essere tutelati penalmente, si suppone siano fondamentali per la società e per l'ordinamento giuridico statale. 4. - Sul piano metodologico va osservato che non é prospettiva producente ed esaustiva quella che esamini il tema dell'ignoranza della legge penale considerando il solo <istante> nel quale il soggetto oggettivamente viola la legge penale nell'ignoranza della medesima. E indispensabile, infatti, non trascurare le <cause>, remote e prossime, della predetta ignoranza e, pertanto, estendere l'indagine al preliminare stato della relazioni tra ordinamento giuridico e soggetti ed in particolare ai rapporti tra l'ordinamento, quale soggetto attivo dei processi di socializzazione di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. ed autore del fatto illecito. Se non si mancherà d'accennare a tale indagine, va, peraltro, sottolineato che la medesima non potrà, ovviamente, esser sufficientemente approfondita in questa sede. 5. - Dal punto di vista storico e di diritto comparato va sottolineato che il principio dell'irrilevanza dell'ignoranza di diritto non é mai stato positivamente affermato nella sua assolutezza. Si può, anzi, affermare che la storia del principio in esame coincida con la storia delle sue eccezioni: dal diritto romano-classico, per il quale era consentito alle donne ed ai minori di 25 anni <ignorare il diritto>, attraverso i <glossa tori> ed il diritto canonico, fino alle attuali normative di diritto comparato (codici penali tedesco-occidentale, austriaco, svizzero, greco, polacco, iugoslavo, giapponese ecc.) si evidenziano tali e tante <eccezioni> all'assolutezza del principio in discussione che il codice Rocco si può sostenere sia rimasto, in materia, isolato, neppure più seguito dal codice penale portoghese. Quest'ultimo, infatti, mutando recentemente la precedente normativa, ha previsto il c.d. <errore intellettuale>, nel quale rientra l'errore sul divieto la cui conoscenza appare ragionevolmente indispensabile perchè possa aversi coscienza dell'illiceità del fatto. 6. -Va, infine, ricordato che, come rilevato da recente dottrina, il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, concepito nella sua assolutezza, non trova neppure convincente sistemazione dommatica. Escluso che possa prospettarsi l'esistenza d'un <dovere autonomo di conoscenza> della legge penale (ne mancherebbe, fra l'altro, la relativa sanzione) anche le tesi della presunzione iuris et de iure e della <finzione> di conoscenza della legge penale (a parte la considerazione che le medesime, mentre ritengono essenziale al reato la coscienza dell'antigiuridicità del comportamento criminoso, <presumono>, in fatto, ciò che assumono essenziale in teoria) s'inseriscono in un contesto che parte dall'opposto principio dell'essenzialità al reato della coscienza dell'illiceità e, pertanto, della <scusabilità> dell'ignoranza della legge penale. 7. - Prima d'iniziare il confronto tra l'art. 5 c.p. e la Carta fondamentale, va, ancora, ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore di quest'ultima, lo stesso articolo e stato oggetto di numerose, pesanti critiche. Partendo da ben note premesse sistematiche (l'imperatività della norma penale); ricordata la strumentalizzazione che lo Stato autoritario aveva operato del principio dell'assoluta irrilevanza dell'ignoranza della legge penale (già nel 1930 tal principio, trasferito dal capitolo dell'imputabilità, nel quale era inserito dal codice del 1879, a quello dell'obbligatorietà della legge penale, era divenuto <cardine> del sistema); ed affermata la necessità, per la punibilità del reato, dell'effettiva coscienza, nell'agente, dell'antigiuridicità del fatto; é stata con forza sottolineata la stridente incompatibilità dell'art. 5 c.p., qualificato come <incivile>, con la Costituzione. 34 E' stato, tuttavia, agevole, sul versante delle premesse sistematiche, contrapporre alla tesi dell'effettiva imperatività della norma penale, la formula dell'idoneità della stessa norma a funzionare come comando e, sul versante dell'illegittimità dell'art. 5 c.p., contrapporre alla richiesta di totale abrogazione o di dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'intero articolo l'inesistenza, nella Costituzione, d'un vincolo, per il legislatore ordinario, di non sanzionare penalmente fatti carenti d'effettiva coscienza dell'antigiuridicità. Le risposte, indubbiamente corrette, da una parte hanno, tuttavia, finito col <chiudere> ogni indagine sulla relazione tra ordinamento giuridico e soggetti, viventi in una determinata concretezza storica, in una particolare situazione sociale e d'altra parte hanno precluso, tranne lodevolissime eccezioni, ogni ulteriore esame della Costituzione, allo scopo di verificare se, in mancanza del precitato <vincolo> dell'effettiva presenza della coscienza dell'antigiuridicità, non esistessero altri vincoli, per il legislatore ordinario, mirati ad escludere l'incriminazione di fatti commessi in carenza di altre, anche se meno penetranti, relazioni tra soggetto e legge penale. Sorge, invero, spontanea la domanda: a che vale richiedere come essenziale requisito subiettivo (minimo) d'imputazione uno specifico rapporto tra soggetto ed evento, tra soggetto e fatto, quando ogni <preliminare> esame delle relazioni tra soggetto e legge e, conseguentemente, tra soggetto e fatto considerato nel suo <integrale> disvalore antigiuridico viene eluso? E come é possibile risolvere i quesiti attinenti alla c.d. costituzionalizzazione (salve le osservazioni che, in proposito, saranno prospettate in seguito) del principio di colpevolezza, intesa quest'ultima come relazione tra soggetto e fatto, quando, non <rimuovendo> il principio d'assoluta irrilevanza dell'ignoranza della legge penale, sancito dall'art. 5 c.p., vengono <stroncate>, in radice, le indagini sulle metodiche d'incriminazione dei fatti e quelle sulla chiarezza e riconoscibilità dei contenuti delle norme penali nonchè sulle <certezze> che le norme penali dovrebbero assicurare e, pertanto, sulle garanzie che, in materia, di libertà d'azione, il soggetto attende dallo Stato? 8. - Allo scopo d'un attento approccio all'esegesi dell'art. 27, primo comma, Cost., occorre preliminarmente accennare al valore ed alla funzione che il momento subiettivo dell'antigiuridicità penale, il personale contrasto con la norma penale, assume nel sistema della vigente Costituzione. Si noti: una parte della dottrina richiede anche un mutamento terminologico, valido a distinguere la concezione della colpevolezza quale fondamento etico della responsabilità penale dalla concezione che ne accentua la sua funzione di limite al potere coercitivo dello Stato. A parte ogni questione sull'ammissibilità d'un'idea di colpevolezza che limiti senza fondare la potestà punitiva dello Stato, i richiesti mutamenti terminologici appaiono necessari ed anche urgenti; e, tuttavia, in questa sede, é preferibile mantenersi fermi alla tradizionale etichetta <colpevolezza> sia per ovvii motivi di chiarezza sia per sottolineare, pur nel variare, storicamente condizionato, delle nozioni dommatiche, la continuità dell'esigenza costituzionale del rispetto e tutela della persona alla quale viene attribuito il reato. Va, a questo proposito, sottolineato che non e stato sufficientemente posto l'accento sulla diversità di due accezioni del termine colpevolezza. La prima, tradizionale, fa riferimento ai requisiti subiettivi della fattispecie penalmente rilevante (ed eventualmente anche alla valutazione di tali requisiti ed alla rimproverabilità del soggetto agente); la seconda, fuori dalla sistematica degli elementi del reato, denota il principio costituzionale, garantista (relativo alla personalità dell'illecito penale, ai presupposti della responsabilità penale personale ecc.) in base al quale si pone un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell'incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati i necessari requisiti subiettivi minimi d'imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena. Qui si userà il termine colpevolezza soprattutto in quest'ultima accezione mentre lo stesso termine, all'infuori della prospettiva costituzionale (nell'impossibilità di ritenere <costituzionalizzata>, come si preciserà fra breve, una delle tante concezioni della colpevolezza proposte dalla dottrina) verrà riferito al vigente sistema ordinario di cui agli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p.: questo sistema verrà, infatti, posto in raffronto con l'art. 27, primo e terzo comma e con i fondamentali principi dell'intera Costituzione, al fine di chiarire come l'art. 5 c.p., incidendo negativamente sul sistema ordinario della colpevolezza (attraverso l'esclusione d'ogni rilievo della conoscenza della legge penale) fa si che lo stesso sistema non si riveli adeguato alle direttive costituzionali in tema di requisiti subiettivi minimi d'imputazione. Va, a questo punto, precisato, per quanto, forse, superfluo, che la colpevolezza costituzionalmente richiesta, come avvertito dalla più recente dottrina penalistica, non costituisce elemento tale da poter esser, a discrezione del legislatore, condizionato, scambiato, sostituito con altri o paradossalmente eliminato. Limpidamente testimonia ciò la stessa recente, particolare accentuazione della funzione di garanzia (limite al potere statale di punire) che le moderne concezioni sulla pena attribuiscono alla colpevolezza. Sia nella concezione che considera quest'ultima <fondamento>, titolo giustificativo dell'intervento punitivo dello Stato sia nella concezione che ne accentua particolarmente la sua funzione di limite allo stesso intervento (garanzia del singolo e del funzionamento del sistema) inalterato permane il <valore> della colpevolezza, la sua insostituibilità. Per precisare ancor meglio l'indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la funzione di garanzia assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su <congrui> elementi subiettivi. La strutturale <ambiguità> della tecnica penalistica conduce il diritto penale ad essere insieme titolo idoneo d'intervento contro la criminalità e garanzia dei c.d. destinatari della legge penale. Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli é lecito e cosa gli é vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza e, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioé, che sarà chiamato a rispondere penalmente 35 solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella <non colpevole> e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto. A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non e in grado, senza la benchè minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto. 9.-Le premesse precisazioni indicano la <chiave di lettura>, il quadro garantistico entro il quale inserire l'esegesi dell'art. 27, primo comma, Cost. Va, intanto, notato che l'art. 27 Cost. non può esser adeguatamente compreso ove lo si legga in maniera, per così dire, spezzettata, senza collegamenti <interni>. I commi primo e terzo vanno letti in stretto collegamento: essi, infatti, pur enunciando distinti principi, costituiscono un'unitaria presa di posizione in relazione ai requisiti subiettivi minimi che il reato deve possedere perchè abbiano significato gli scopi di politica criminale enunciati, particolarmente, nel terzo comma. Delle due l'una: o il primo é in palese contraddizione con il terzo comma dell'art. 27 Cost. oppure é, appunto, quest'ultimo comma che svela, ove ve ne fosse bisogno, l'esatto significato e la precisa portata che il principio della responsabilità penale personale assume nella Costituzione. Sicchè, quand'anche la lettera del primo comma dell'art. 27 desse luogo a dubbi interpretativi, essi sarebbero certamente fugati da un'attenta considerazione delle finalità della pena, di cui al terzo comma dello stesso articolo. 10. - Nell'esame del merito dell'interpretazione dell'art. 27, primo comma, Cost., vanno approfonditi i dibattiti svoltisi durante i lavori preparatori. E' anzitutto da sottolineare che la motivazione politica della norma in esame non risulta essere stata l'unico argomento dei dibattiti svoltisi, nella seduta del 18 settembre 1946, presso la 1a sottocommissione (della <Commissione per la Costituzione>) anzi, tale motivazione venne introdotta, come opinione personale del presidente della stessa sottocommissione, quasi alla fine della seduta ed allo scopo di <mantenere> la norma (che costituiva il capoverso dell'art. 5 del Progetto di Costituzione) contro le richieste della sua soppressione. Gli argomenti trattati in precedenza risultano essere stati vari, tutti, comunque, tendenti ad escludere che da una, sia pur erronea, interpretazione della formula normativa potesse desumersi la legittimità di responsabilità penali senza partecipazione subiettiva. Alcuni Costituenti mostrarono, con felice intuizione, davvero premonitrice, forti preoccupazioni sulla possibilità di equivoci nell'interpretazione della formula <La responsabilità penale é personale> e ne chiesero la soppressione, temendo si potesse ritenere <configurabile> una responsabilità penale senza elemento subiettivo. La terminologia é spesso imprecisa ma la volontà certa. Si inizio, da parte di alcuni Costituenti, rilevando che vi sono casi in cui e <discutibile se si tratti di responsabilità personale o non si tratti di responsabilità penale anche per fatto altrui>. Si prosegui sottolineando che non si devono creare equivoci, anche <avuto riguardo agli artt. 1151, 1152 e 1153 del vecchio Codice civile, articoli che non trovano la loro corrispondenza nel codice fascista>. Si sostenne, da altro Costituente, che la formula <La responsabilità penale é personale> fosse da mantenersi, essendo essa affermazione di libertà e civiltà, limpidamente aggiungendo: <Si risponde per fatto proprio e si risponde attraverso ogni partecipazione personale al fatto proprio. Questo e il principio del diritto moderno, che trova la sua espressione nel principio della consapevolezza che deve accompagnare il fatto materiale. Parlare di responsabilità personale significa richiamarsi ad un principio che domina nell'odierno pensiero della scienza giuridica>. Intorno ai <dubbi> (ripetiamo, non sulla necessita dell'elemento subiettivo per la responsabilità penale ma sulla possibilità che, interpretando erroneamente la formula, si potesse ritenere ammissibile una responsabilità senza elemento subiettivo) si chiesero <chiarimenti> sui <fatti penali commessi per ordine altrui> e, dando all'espressione <fatto altrui> un significato che includeva nel termine <fatto> anche l'elemento subiettivo, si osservò che quest'ultimo manca, talvolta, in chi pur consuma materialmente il reato e che, appunto per tale mancanza, non può esser chiamato a rispondere penalmente. Se chi opera materialmente, s'affermo esplicitamente, agisce per fatto altrui, per esempio per l'esecuzione d'un ordine, la responsabilità non é più dell'esecutore dell'ordine, il quale ha consumato il reato ma di chi ha dato l'ordine. Non é, dunque, responsabile <chi ha eseguito un ordine legittimo dell'autorità> perchè manca di elemento subiettivo ed é responsabile chi ha commesso il fatto (altrui rispetto all'esecutore) perchè nel fatto é incluso il predetto elemento. Si replicò, puntualmente, da parte di autorevoli Costituenti, affermando che <colui che ha commesso un atto delittuoso risponde di persona propria se si trovava nella condizione di poter disobbedire>: <altrimenti risponderà colui che ha dato l'ordine e risponderà in persona propria per aver prodotto il fatto delittuoso stesso>. E si aggiunse che colui che esegue l'ordine <non risponde penalmente perchè da lui non si poteva pretendere che agisse diversamente>. Vi fu, poi, chi osservo che la responsabilità personale non é un principio moderno ma un principio che, già nel 1500 o 1600, il diritto canonico, riportando il delitto ad un peccato dell'anima, aveva reso effettivo; e chiese la soppressione della formula in esame da un canto perchè scontata e dall'altro perchè, ritornando sul principio, si potevano provocare confusioni in tema di soggetti che sono in colpa (e per questo devono penalmente rispondere) ma le cui azioni non sono causa diretta o prossima dell'evento (<non sono direttamente colpevoli>). Tutti i Costituenti, dunque, almeno fino a questo momento del dibattito, sostennero che la responsabilità penale personale implicava necessariamente, oltre all'elemento materiale, un requisito subiettivo e, per alcuni Costituenti, 36 l'esistenza, in particolare, della possibilità di muovere rimprovero all'agente, potendo da lui pretendersi un comportamento diverso. Esaminando gli ulteriori interventi ci s'accorge che, soltanto quasi alla fine della discussione, mirandosi a respingere le richieste di soppressione della norma in esame, si sposto il dibattito sulle motivazioni politiche della stessa norma sostenendo che non si doveva dimenticare che, in occasione di attentati alla vita di Mussolini, si erano perseguiti i familiari dell'attentatore od i componenti dei circoli politici a cui era affiliata la persona che aveva consumato l'attentato e che, pertanto, la norma andava mantenuta. Da ciò si desume da un canto che il termine fatto (altrui) venne usato, da chi sosteneva la motivazione politica dell'attuale primo comma dell'art. 27 Cost., come comprensivo dell'elemento subiettivo (attentare alla vita di Mussolini e agire colpevolmente) e dall'altro che tale motivazione tendeva (di chiarata per l'avvenire l'illegittimità costituzionale di sanzioni collettive) a non far ricadere su innocenti <colpe> altrui. L'intervento successivo a quello del presidente della prima sottocommissione é oltremodo eloquente in proposito: <...Proprio in questi ultimi tempi si sono viste delle persone pagare con la vita colpe che non avevano assolutamente commesso>. La motivazione politica della norma é, dunque, quella d'impedire che <colpe altrui> ricadano su chi é estraneo alle medesime. Nè va dimenticato che, nella seduta successiva (19 settembre 1946) della stessa prima sottocommissione, allorchè si tratto di sostituire il termine <colpevole> con quello di <reo>, dapprima si suggerì d'usare la parola <condannato> ma, successivamente, di fronte alla contestazione sull'inusualità del termine <condannato> fuori dalla sede processuale, si torno, per un momento, alla parola <colpevole>, dichiarandosi espressamente: <Questa parola é più chiara, specialmente quando si parla di rieducazione del colpevole, perchè il termine di rieducazione presuppone una colpa>. Ma la conferma definitiva per la quale i Costituenti mirarono, con la norma di cui al primo comma dell'art. 27 Cost., ad escludere la responsabilità penale senza elemento subiettivo si ha ricordando che alcuni Costituenti presentarono, questa volta in Assemblea (seduta antimeridiana del 15 aprile 1947) un emendamento alla norma in esame, sostitutivo della parola <personale> con l'espressione <solo per fatto personale> e che, nella seduta del 26 marzo 1947 dell'Assemblea costituente, si motivo l'emendamento, fra l'altro, affermando che si doveva armonizzare la responsabilità penale per fatto proprio con la responsabilità del direttore di giornali per reati di stampa, <cosi che la presunzione assoluta di colpa iuris et de iure si trasformi in presunzione iuris tantum>. E nella seduta pomeridiana del 27 marzo 1947 della stessa Assemblea, si motivò ancora una volta, da parte d'altro autorevole presentatore, il citato emendamento, dichiarandosi: <... E qui conviene stabilire che la responsabilità penale é sempre per fatto proprio mai per fatto altrui; così delimitandosi quell'arbitraria inaccettabile configurazione di responsabilità presuntiva in materia giornalistica>. La responsabilità penale sorge, dunque, solo nell'effettiva presenza dell'elemento subiettivo: non si può mai dare per presunta la colpa. Se si tien presente che il caso della responsabilità penale del direttore di giornali per reati commessi a mezzo stampa era considerato, nel 1946-47, dall'assoluta maggioranza della dottrina, classico caso di responsabilità penale senza elemento subiettivo di collegamento con l'evento, non si può non dare il giusto rilievo all'<assicurazione> che il Presidente della prima sottocommissione, nella seduta antimeridiana del 15 aprile 1947 dell'Assemblea, diede ai presentatori del citato emendamento, nel pregarli di ritirarlo, sull'inesistenza delle preoccupazioni affacciate, data la formulazione proposta dalla Commissione. In conclusione, va confermato che, per quanto si usino le espressioni fatto proprio e fatto altrui, che possono indurre in errore, in realtà, in tutti i lavori preparatori relativi al primo comma dell'art. 27 Cost., i Costituenti mirarono, sul piano dei requisiti d'imputazione del reato, ad escludere che si considerassero costituzionalmente legittime ipotesi carenti di elementi subiettivi di collegamento con l'evento e, sul piano politico, a non far ricadere su <estranei> <colpe altrui>. E mai, in ogni caso, venne usato il termine fatto come comprensivo del solo elemento materiale, dell'azione cosciente e volontaria seguita dal solo nesso oggettivo di causalità: anzi, sempre venne usato lo stesso termine come comprensivo anche d'un minimo di requisiti subiettivi, oltre a quelli relativi alla coscienza e volontà dell'azione. 11. - Ma il significato del primo comma dell'art. 27 Cost. va chiarito, anche a parte i citati lavori preparatori, nei suoi particolari rapporti con il terzo comma dello stesso articolo e con gli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 73, terzo comma, Cost. Anzitutto, é significativa la <lettera> del primo comma dell'art. 27 Cost. Non si legge, infatti, in esso: la responsabilità penale é <per fatto proprio> ma la responsabilità penale é <personale>. Sicchè, chi tendesse ad esaminare lo stesso comma sotto il profilo, per quanto, in sede penale, superato, della distinzione tra fatto proprio ed altrui (salvo a precisare l'esatta accezione, in materia, del termine <fatto>) dovrebbe almeno leggere la norma in esame come equivalente a: <La responsabilità penale é per personale fatto proprio>. Ma é l'interpretazione sistematica del primo comma dell'art. 27 Cost. che ne svela l'ampia portata. Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi piu significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la <rieducazione> di chi, non essendo almeno <in colpa> (rispetto al fatto) non ha, certo, <bisogno> di essere <rieducato>. Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò é sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili (oltre a quanto si dirà in tema d'ignoranza inevitabile della legge penale) alla predetta colpa dell'agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento. 37 12. - Non é dato qui scendere ad ulteriori precisazioni: va soltanto chiarito che quanto sostenuto é in pieno accordo con la tendenza mostrata dalle decisioni assunte da questa Corte allorchè é stata chiamata a decidere sulla costituzionalità di ipotesi criminose che si assumeva non contenessero requisiti subiettivi sufficienti a realizzare il dettato dell'art. 27 Cost. Qui quella tendenza si completa e conclude. A parte un momento le affermazioni <di principio> contenute nelle citate decisioni, nessuno può disconoscere che, sempre, le sentenze, in materia, hanno cercato di ravvisare, nelle ipotesi concrete sottoposte all'esame della Corte, un qualche <requisito psichico> idoneo a renderle immuni da censure d'illegittimità costituzionale ex art. 27 Cost. Le stesse decisioni, pur muovendosi nell'ambito dell'alternativa tra fatto proprio ed altrui, non hanno mancato di ricercare spesso un qualche coefficiente soggettivo (anche se limitato) sul presupposto che il <fatto proprio> debba includere anche simile coefficiente per divenire <compiutamente proprio> dell'agente: cosi, ad esempio, nella sentenza n. 54 del 1964, nella quale si afferma che il reato in esame <presuppone nell'agente la volontà di svolgere quell'attività che va sotto il nome di ricerca archeologica e che la legge interdice ai soggetti non legittimati dal necessario provvedimento amministrativo. Il fatto punito é perciò sicuramente un fatto proprio del soggetto cui la sanzione penale viene comminata>: si noti che l'attività indicata, in mancanza d'evento naturalistico, integra l'intero fatto, oggettivo che, in conseguenza del riferimento ad esso della volontà dell'autore, <perciò sicuramente> costituisce <fatto proprio> dell'agente; così nella sentenza 17 febbraio 1971, n. 20 ove, a proposito dell'art. 539 c.p., si rileva come, pur in presenza dell'errore sull'età dell'offeso, <la condotta del delitto di violenza carnale, essendo posta in essere volontariamente (e si badi: non esistendo, nell'ipotesi esaminata, evento naturalistico, tal condotta esaurisce il fatto, oggettivamente considerato, al quale va riferita la volontarietà) é con certezza riferibile all'autore come <fatto suo proprio>; e così ancora, a tacere di altre decisioni, in quella del 17 febbraio 1971, n. 2l. Ed anche a proposito delle dichiarazioni <di principio> contenute nelle citate sentenze va sottolineato che, se si deve qui confermare che il primo comma dell'art. 27 Cost. contiene un tassativo divieto della responsabilità <per fatto altrui, va comunque precisato che ciò deriva dall'altro, ben più <civile> principio, di non far ricadere su di un soggetto, appunto estraneo al <fatto altrui>, conseguenze penali di <colpe> a lui non ascrivibili. Come e da confermare che si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, purchè si precisi che per <fatto proprio> non s'intende il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale (da notare che, anzi, nella fattispecie plurisoggettiva il fatto comune diviene anche <proprio> del singolo compartecipe in base al solo <favorire> l'impresa comune) ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla <colpa> in senso stretto. Ed anche a proposito dell'esclusione, nel primo comma dell'art. 27 Cost., del tassativo divieto di responsabilità oggettiva va precisato che (ricordata l'incertezza dottrinale in ordine alle accezioni da attribuire alla predetta espressione) se nelle ipotesi di responsabilità oggettiva vengono comprese tutte quelle nelle quali anche un solo, magari accidentale, elemento del fatto, a differenza di altri elementi, non e coperto dal dolo o dalla colpa dell'agente (c.d. responsabilità oggettiva spuria od impropria) si deve anche qui ribadire che il primo comma dell'art. 27 Cost. non contiene un tassativo divieto di <responsabilità oggettiva>. Diversamente va posto il problema, a seguito di quanto ora sostenuto, per la c.d. responsabilità oggettiva pura o propria. Si noti che, quasi sempre e in relazione al complessivo, ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole <preventive> che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato. Ma, ove non si ritenga di restringere la c.d. responsabilità oggettiva <pura> alle sole ipotesi nelle quali il risultato ultimo vietato dal legislatore non é sorretto da alcun coefficiente subiettivo, va, di volta in volta, a proposito delle diverse ipotesi criminose, stabilito quali sono gli elementi più significativi della fattispecie che non possono non essere <coperti> almeno dalla colpa dell'agente perchè sia rispettato da parte del disposto di cui all'art. 27, primo comma, Cost. relativa al rapporto psichico tra soggetto e fatto. E non va, infine, dimenticata la sentenza n. 3 del 1956, nella quale limpidamente si afferma: <Ma appunto il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perchè tra la sua omissione e l'evento c'é un nesso di causalità materiale, al quale s'accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente, come é opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della personalità>. A parte ogni rilievo, peraltro già sottolineato, in ordine all'alternativa tra fatto proprio ed altrui, é altamente indicativa l'affermazione per la quale al nesso di causalità materiale s'accompagna <sempre> un certo nesso psichico. 13. - La verità é che non va <continuata> la polemica sulla costituzionalizzazione, o meno, del principio di colpevolezza, di cui agli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p., quasi che, malgrado l'evidente inversione metodologica, sia consentito interpretare le norme costituzionali alla luce delle norme ordinarie (qual é, peraltro, tra le tante concettualizzazioni scientifiche, la nozione di colpevolezza che dovrebbe essere costituzionalizzata?) ma, chiariti i contenuti delle norme costituzionali che determinano i requisiti subiettivi <minimi> d'imputazione, a prescindere un momento dal sistema ordinario, desunto dagli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p., occorre verificare, di volta in volta, se le singole ipotesi criminose di parte speciale (collegate con le disposizioni di parte generale) siano o meno conformi, quanto ad elementi subiettivi, ai requisiti minimi richiesti dalle autonomamente interpretate norme costituzionali. La stessa possibilità (che si chiarirà, fra poco, essere essenziale per il giudizio di responsabilità penale) di muovere al l'autore un <rimprovero> per la commissione dell'illecito non equivale ad accoglimento da parte della Costituzione (a costituzionalizzazione) d'una delle molteplici concezioni <normative> della colpevolezza prospettate in dottrina bensì costituisce autonomo risultato, svincolato da ogni premessa concettualistica, dell'interpretazione dei commi primo e 38 terzo dell'art. 27 Cost., anche se, per accidens, tale <rimprovero> venga a coincidere con una delle nozioni di colpevolezza (normativa) prospettate in dottrina o desunte da un determinato sistema ordinario. A conclusione del primo approccio interpretativo del disposto di cui al primo comma dell'art. 27 Cost., deve, pertanto, affermarsi che il fatto imputato, perchè sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Il fatto (punibile, <proprio> dell'agente) va, dunque, nella materia che si sta trattando, costituzionalmente inteso in una larga, anche subiettivamente caratterizzata accezione e non in quella, riduttiva, d'insieme di elementi oggettivi. La <tipicità> (oggettiva e soggettiva) del fatto (ovviamente, di regola, vengono richiesti nelle diverse ipotesi criminose, ulteriori elementi subiettivi, come il dolo ecc.) costituisce, cosi, primo, necessario <presupposto> della punibilità ed é distinta dalla valutazione e rimproverabilità del fatto stesso. 14. - Dal collegamento tra il primo e terzo comma dell'art. 27 Cost. risulta, altresì, insieme con la necessaria < rimproverabilità> della personale violazione normativa, l'illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle norme penali. La piena, particolare compenetrazione tra fatto e persona implica che siano sottoposti a pena soltanto quegli episodi che, appunto personalmente, esprimano il predetto, riprovevole contrasto od indifferenza. Il ristabilimento dei valori sociali <dispregiati> e l'opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata <soggettiva antigiuridicità> del fatto. Discende che, anche quando non si ritenesse la <possibilità di conoscenza della legge penale> requisito autonomo d'imputazione costituzionalmente richiesto, ugualmente si dovrebbe giungere alla conclusione che, tutte le volte in cui entra in gioco il dovere d'osservare le leggi penali (che, per i cittadini, e specificazione di quello d'osservare le leggi della Repubblica, sancito dal primo comma dell'art. 54 Cost.) la violazione di tal dovere, implicita nella commissione del fatto di reato, non può certamente divenire rilevante, e dar luogo alla pena, in una pura dimensione obiettiva od in una <subiettiva>, limitata alla colpa del fatto. Trattandosi, appunto, dell'applicazione d'una pena, da qualunque teoria s'intenda muovere (eccezion fatta per quella della prevenzione generale in chiave di pura deterrenza, che, peraltro, come s'é già avvertito, non può considerarsi legittimamente utilizzabile per ascrivere una responsabilità penale) e dovendo la violazione del precitato dovere essere <rimproverabile>, l'impossibilita di conoscenza del precetto (e, pertanto, dell'illiceità del fatto) non ascrivibile alla volontà dell'interessato deve necessariamente escludere la punibilità. Il vigente sistema costituzionale non consente che l'obbligo di non ledere i valori penalmente garantiti sorga e si violi (attraverso la commissione del fatto di reato) senza alcun riferimento, se non all'effettiva conoscenza del contenuto dell'obbligo stesso, almeno alla <possibilità> della sua conoscenza. Se l'obbligo giuridico si distingue dalla <soggezione> perchè, a differenza di quest'ultima, richiama la partecipazione volitiva del singolo alla sua realizzazione, far sorgere l'obbligo d'osservanza delle leggi (delle <singole>, particolari leggi) penali, in testa ad un determinato soggetto, senza la benchè minima possibilità, da parte del soggetto stesso, di conoscerne il contenuto e subordinare la sua violazione soltanto ai requisiti <subiettivi> attinenti al fatto di reato, equivale da una parte a ridurre notevolmente valore e significato di questi ultimi e, d'altra parte, a strumentalizzare la persona umana a fini di pura deterrenza. Quanto ora precisato già basterebbe a far ritenere l'art. 5 c.p. incostituzionale nella parte in cui impedisce ogni esame della rimproverabilità e, pertanto, scusabilità dell'ignoranza della (od errore sulla) legge penale. Anche quando non si sia dell'avviso che l'art. 5 c.p. operi nell'ambito della colpevolezza e lo si agganci, come nel codice Rocco, all'obbligatorietà della legge penale, ugualmente lo stesso articolo, per le ragioni innanzi indicate, si dovrebbe ritenere contrastante con l'art. 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude ogni rilevanza all'ignoranza od errore sul precetto dovute all'impossibilità (non rimproverabile) di conoscerlo. 15. -Ma il modo più appagante per convalidare tutto ciò é quello intrapreso, in tempi recenti, dalla dottrina che ritiene la <possibilità di conoscere la norma penale> autonomo presupposto necessario d'ogni forma d'imputazione e che estende la sfera d'operatività di tale <presupposto> a tutte le fattispecie penalmente rilevanti, comprese le dolose. Considerando il combinato disposto del primo e terzo comma dell'art. 27 Cost. nel quadro delle fondamentali direttive del sistema costituzionale desunte soprattutto dagli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 73, terzo comma Cost. ecc., alla <possibilità di conoscere la norma penale> va, infatti, attribuito un autonomo ruolo nella determinazione dei requisiti subiettivi d'imputazione costituzionalmente richiesti: tale <possibilità> é, infatti, presupposto della rimproverabilità del fatto, inteso quest'ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato. 16. - Basilari norme costituzionali relative alla materia penale, mentre tendono a garantire al cittadino, ed in genere ai c.d. destinatari delle norme penali, la sicurezza giuridica di non esser puniti ove vengano realizzati comportamenti penalmente irrilevanti, svelano la funzione d'orientamento culturale e di determinazione psicologica operata dalle leggi penali. Non é, infatti, senza significato che il principio di legalità, inteso come <riserva di legge statale> sia espressamente costituzionalizzato, in sede penale, dall'art. 25, secondo comma, Cost.: trattandosi dell'applicazione delle più gravi sanzioni giuridiche, la Costituzione intende particolarmente garantire i soggetti attraverso la praevia lex scripta. I principi di tassatività e d'irretroattività delle norme penali incriminatrici, nel l'aggiungere altri contenuti al sistema delle fonti delle norme penali, evidenziano che il legislatore costituzionale intende garantire i cittadini, attraverso la <possibilità> di conoscenza delle stesse norme, la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione. E tutto ciò si chiarisce ancor più (come é stato sottolineato in dottrina) ove si ricordi che, nel quadro dello <Stato di diritto>, anche il principio di riserva di legge penale e gli altri precedentemente indicati, sono espressione della contropartita (d'origine contrattualistica) che lo Stato offre in cambio, appunto, dell'obbligatorietà della legge penale: lo 39 Stato assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che é vietato o comandato ma richiede dai singoli l'adempimento di particolari doveri (sui quali ci si soffermerà fra breve) mirati alla realizzazione dei precetti <principali> relativi ai fatti penalmente rilevanti. 17. - Va qui, subito, precisato che le garanzie di cui agli artt. 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., per loro natura formali, vanno svelate nelle loro implicazioni: queste comportano il contemporaneo adempimento da parte dello Stato di altri doveri costituzionali: ed in prima, di quelli attinenti alla formulazione, struttura e contenuti delle norme penali. Queste ultime possono essere conosciute solo allorchè si rendano <riconoscibili>. Il principio di <riconoscibilità> dei contenuti delle norme penali, implicato dagli artt. 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., rinvia, ad es., alla necessita che il diritto penale costituisca davvero la extrema ratio di tutela della società, sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di <rilievo costituzionale> e tali da esser percepite anche in funzione di norme <extrapenali>, di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare. L'osservazione dell' <istante> in cui si viola la legge penale nell'ignoranza della medesima non può far dimenticare, come s'é avvertito all'inizio, che, <prima> del rapporto tra soggetto e <singola> legge penale, esiste un ben definito rapporto tra ordinamento e soggetto <obbligato> a non violare le norme, dal quale ultimo rapporto il primo e necessariamente condizionato. E stato osservato e ribadito, esattamente, che un precetto penale ha valore, come regolatore della condotta, non per quello che e ma per quel che appare ai consociati. E la conformità dell'apparenza all'effettivo contenuto della norma penale dev'essere assicurata dallo Stato che é tenuto a favorire, al massimo, la riconoscibilità sociale dell'effettivo contenuto precettivo delle norme. Oltre alle condizioni relative al rapporto soggetto-fatto, esiste, pertanto, un altro <presupposto> della responsabilità penale, costituito, appunto, dalla <riconoscibilità> dell'effettivo contenuto precettivo della norma. L'oggettiva impossibilita di conoscenza del precetto, nella quale venga a trovarsi <chiunque> (non soltanto il singolo soggetto, particolarmente considerato) non può gravare sul cittadino e costituisce, dunque, un altro limite della personale responsabilità penale. 18.-Ma il problema centrale, per il nostro tema, attiene ai doveri <strumentali> di conoscenza delle leggi, incombenti sui c.d. destinatari dei precetti penali e, conseguentemente, ai limiti dei predetti doveri. Il passaggio dall'oggettiva possibilità di conoscenza delle leggi penali, assicurata dallo Stato all'effettiva, concreta conoscenza delle leggi stesse avviene attraverso la <mediazione>, ovviamente insostituibile, dell'attività conoscitiva dei singoli soggetti. Supposta esistente, in fatto, l'oggettiva possibilità di conoscenza d'una particolare legge penale, i soggetti privati, divenendo diretti destinatari dell'obbligo (principale) d'adempimento del precetto oggettivamente conoscibile, devono operare la predetta, insostituibile mediazione. A questo fine incombono sul privato, preliminarmente, strumentali, specifici doveri d'informazione e conoscenza: ed é a causa del non adempimento di tali doveri che é costituzionalmente consentito chiamare a rispondere anche chi ignora la legge penale. Gli indicati doveri d'informazione, di conoscenza ecc. costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale, di cui all 'art. 2 Cost. La Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima, costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'<altrui>) persona umana: ed e per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica. Posto, dunque, che lo Stato adempia ai suoi doveri, che esista, cioé, per l'agente l'oggettiva <possibilità> di conoscere le leggi penali, residuano, tuttavia, ulteriori problemi. L'assoluta, <illuministica> certezza della legge sempre più si dimostra assai vicina al mito: la più certa delle leggi ha bisogno di <letture> ed interpretazioni sistematiche che (dato il rapidissimo succedersi di <entrate in vigore> di nuove leggi e di abrogazioni, espresse o tacite, di antiche disposizioni) rinviano, attraverso la mediazione dei c.d. destinatari della legge, ad ulteriori <seconde> mediazioni. La completa, in tutte le sue forme, sicura interpretazione delle leggi penali ha, oggi, spesso bisogno di seconde, ulteriori mediazioni: quelle ad es. di tecnici, quanto più possibile qualificati, di organi dello Stato (soprattutto di quelli istituzionalmente destinati ad applicare le sanzioni per le violazioni delle norme, ecc.). Specifici, particolari doveri, nei destinatari delle leggi penali (di richiesta e controllo delle informazioni ricevute, ecc.) discendono da un sistema di norme .strumentali>, la violazione delle quali già denota quanto meno una <trascuratezza> nei confronti dei diritti altrui, delle persone umane e, conclusivamente, dell'ordinamento tutto. D'altra parte, chi, invece, attenendosi scrupolosamente alle <richieste> preventive dell'ordinamento, agli obblighi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., adempia a tutti i predetti doveri, strumentali, nella specie prevedibili e ciò nonostante venga a trovarsi in stato d'ignoranza della legge penale, non può esser trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri. Come é stato rilevato, discende dall'ideologia contrattualistica l'assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini su che cosa é vietato o comandato ma da tale ideologia discende anche la richiesta, in contropartita, che i singoli s'informino sulle leggi, si rendano attivi per conoscerle, prima d'agire. La violazione del divieto di commettere reati, avvenuta nell'ignoranza delle legge penale, può, pertanto, dimostrare che l'agente non ha prestato alle leggi dello Stato tutta l'attenzione <dovuta>. Ma se non v'é stata alcuna violazione di quest'ultima, se il cittadino, nei limiti possibili, si e dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, primo comma Cost.) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua ignoranza é <inevitabile> e, pertanto, scusabile. Non esiste, é vero, un <autonomo> obbligo di conoscenza delle singole leggi penali; non può disconoscersi, tuttavia, l'esistenza in testa ai c.d. destinatari dei precetti <principali>, nei confronti di tutto l'ordinamento, di doveri 40 <strumentali>, d'attenzione, prudenza ecc. (simili a quelli che caratterizzano le fattispecie colpose) nel muoversi in campi prevedibilmente lesivi di <interessi altrui>; doveri già incombenti prima della violazione delle singole norme penali, mirati, attraverso il loro adempimento e, conseguentemente, attraverso la raggiunta conoscenza delle leggi, a prevenire (appunto inconsapevoli) violazioni delle medesime. Inadempiuti tali doveri, l'ignoranza della legge risulta inescusabile, evitabile. Adempiuti ai medesimi la stessa ignoranza, divenuta inevitabile e, pertanto, scusabile, esclude, la rimproverabilità e, pertanto, la responsabilità penale. 19. -L'effettiva possibilità di conoscere la legge penale é, dunque, ulteriore requisito subiettivo minimo d'imputazione, che si ricava dall'intero sistema costituzionale ed in particolare dagli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost. Tale requisito viene ad integrare e completare quelli attinenti alle relazioni psichiche tra soggetto e fatto e consente la valutazione e, pertanto, la rimproverabilità del fatto complessivamente considerato. Non si creda, peraltro, che, ricavandosi il requisito della <possibilità> di conoscere la legge penale> dall'intero sistema costituzionale (ed in particolare dai precitati articoli) esso sia estraneo all'art. 27, primo comma, Cost., quasi che quest'ultimo comma si riferisca soltanto alle relazioni psichiche tra soggetto e fatto, e, in particolare, alla violazione, nelle ipotesi di colpa in senso stretto, delle norme preventive che caratterizzano la colpa oltre, se mai, alla <rimproverabilità> dell'autore del reato. Vero é che l'art. 27, primo comma, Cost., dichiarando che la responsabilità penale e personale, non soltanto presuppone la <personalità> dell'illecito penale (la pena, appunto <in virtù> della <personalità> della responsabilità penale, va subita dallo stesso soggetto al quale é personalmente imputato il reato) ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione. Il comma in discussione, interpretato in relazione al terzo comma dello stesso articolo ed in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., svela non soltanto l'essenzialità della colpa dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica ma anche l'indispensabilità del requisito minimo d'imputazione costituito dall'effettiva <possibilità di conoscere la legge penale>, essendo anch'esso necessario presupposto della <rimproverabilità> dell'agente. Il principio della <personalità dell'illecito penale> é <totalmente> implicato dal principio della <responsabilità penale personale> espresso, appunto, dal primo comma dell'art. 27 Cost.: che l'integrale contenuto di questo comma debba esser svelato anche in base alla sua interpretazione sistematica nulla toglie od aggiunge al contenuto stesso. 20. - A questo punto va precisata l'interpretazione da dare all'art. 5 c.p. nel momento in cui lo si <confronta> con gli articoli della Costituzione innanzi richiamati e con l'intero sistema, in materia penale, della Carta fondamentale. Per quanto occorra allontanare le tentazioni di sopravvalutazione dell'art. 5 c.p. (e quasi impensabile, infatti, che un soggetto <imputabile>) commetta i c.d. delitti naturali nell'ignoranza della loro <illiceità> mentre l'ignoranza delle norme incriminatrici dei c.d. reati di pura creazione legislativa, tenuto conto del loro sempre crescente numero e del relativo <più intenso> dovere di conoscenza da parte dei soggetti che operano nei settori ai quali tali norme appartengono, si rivela, di regola, inescusabile) lo stesso articolo costituisce, tuttavia, norma fondamentale nel vigente sistema delle leggi penali ordinarie. Le interpretazioni che dottrina e giurisprudenza offrono dell'art. 5 c.p., soprattutto allo scopo di distinguere l'irrilevante errore sul precetto dal rilevante errore sulla legge extrapenale di cui all'art. 47, terzo comma, c.p., sono tanto varie e così diverse tra loro che é impossibile tentarne una sia pur sommaria esposizione. Qui occorre prendere le mosse dalla <rigorosa> interpretazione che dello stesso articolo danno una parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità (esclusa la <parentesi> della rilevanza della buona fede nelle contravvenzioni). Non é questa, infatti, la sede per procedere ad un'interpretazione <esaustiva> della norma impugnata: non, essendo invero, possibile qui chiarire, con precisione, neppure l'oggetto sul quale cade il <vizio>, che l'art. 5 c.p. sottende ed in base al quale, ove lo stesso articolo non esistesse, l'agente sarebbe scusato, vale qui riportarsi, in materia, alle dottrine che risultano in accordo con la citata <rigorosa> interpretazione dell'articolo in discussione: tali dottrine sottolineano che, incidendo l'art. 5 c.p. sul momento subiettivo dell'antigiuridicita, l'errore che, ai sensi dello stesso articolo, non scusa é quello che cade sul precetto, sull'aspetto determinativo del precetto, tenuto conto, peraltro, che valutazione e determinazione sono inscindibili nella norma penale. Per nessuno degli aspetti dai quali viene considerato l'art. 5 c.p. si può, infatti, qui partire dalle riduttive interpretazioni che dello stesso articolo alcuni Autori offrono, pur nel lodevole tentativo di <mitigarne> il rigore: non foss'altro perchè tali interpretazioni non sono condivise dal diritto vivente. Vero é che il problema dei rapporti tra soggetto e legge penale, tra soggetto e norma penale, vanno impostati, come impone la Costituzione, nell'ambito dell'autonomo requisito <possibilità di conoscenza della legge penale> sulla quale ci si e soffermati innanzi: allorchè s'ignori la legge penale e l'ignoranza sia inevitabile la mancata relazione tra soggetto e legge, tra soggetto e norma penale, diviene, ai sensi dell'art. 27, primo comma, Cost., rilevante (risultando esclusa la personalità dell'illecito e non essendo legittima la punizione in carenza del requisito della colpevolezza costituzionalmente richiesta) mentre, ove l'ignoranza della legge penale sia evitabile, rimproverabile, la stessa mancata relazione tra soggetto e legge, tra soggetto e norma penale, non esclude la punizione dell'agente che versa in errore di diritto (sempre che si realizzino tutti gli altri requisiti subiettivi ed obiettivi d'imputazione) giacchè, in quest'ultima ipotesi, tale mancata relazione già rivela quanto meno un'<indifferenza> dell'agente nei confronti delle norme, dei valori tutelati e dell'ordinamento tutto. Richiamato l'art. 5 c.p. alla logica dell'elemento subiettivo, della colpevolezza, che lo stesso articolo arbitrariamente mutila; rilevato il contrasto tra l'articolo in discussione e l'art. 27, primo comma, Cost. (espressivo quest'ultimo, come 41 s'é innanzi chiarito, dell'intero sistema costituzionale in materia di elemento subiettivo del reato); la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 5 c.p. esclude, in ogni caso, che siano chiamati a rispondere penalmente coloro che versano in stato d'inevitabile (scusabile) ignoranza della legge penale. 2l.-Allo stesso modo non é, in questa sede, consentito riferirsi all'interpretazione dell'art. 5 c.p., secondo la quale quest'ultimo, mentre dichiarerebbe irrilevante la conoscenza effettiva della legge penale, nulla disporrebbe in ordine alla possibilità di tale conoscenza. Questa tesi e degna di particolare considerazione in quanto riconosce rilievo autonomo alla possibilità di conoscere la legge penale e fa derivare tale rilievo dall'art. 27, primo e terzo comma, c.p.: questo articolo, statuendo la necessita di considerazione d'una qualche relazione psicologica del soggetto con il disvalore giuridico del fatto, si riconnette, infatti, ai principi di fondo della convivenza democratica a termini dei quali, si ribadisce, così come il cittadino é tenuto a rispettare l'ordinamento democratico, quest'ultimo é tale in quanto sappia porre i privati in grado di comprenderlo senza comprimere la loro sfera giuridica con divieti non riconoscibili ed interventi sanzionatori non prevedibili. Senonchè, alla predetta interpretazione riduttiva dell'art. 5 c.p. e stato esattamente osservato che quest'ultimo, escludendo ogni efficacia scusante dell'ignoranza della legge penale, non consente alcuna distinzione attinente alla causa dell'ignoranza, in modo da ritenere l'ignoranza scusabile, a differenza di quella inescusabile, suscettibile di diverso trattamento. D'altra parte, la proposta interpretazione <adeguatrice>, ex art. 27, primo e terzo comma, Cost., sarebbe in stridente contrasto con l'interpretazione che il diritto vivente da all'art. 5 c.p.: non solo non s'interpreta questo articolo, soprattutto da parte della giurisprudenza di legittimità (tranne l'<eccezione> della buona fede nelle contravvenzioni) in maniera rigida ma, nel dare all'art. 5 c.p. la massima <espansione> , si é, da parte della stessa giurisprudenza, finito, praticamente, con l'addivenire ad una interpretatio abrogans dell'art. 47, terzo comma, c.p. 22.-E poichè anche il rilievo attribuito dalla giurisprudenza alla <positiva> buona fede nelle contravvenzioni non trova fondamento nell'attuale sistema del Codice Rocco (l'art. 5 c.p., statuendo, in ogni caso, l'irrilevanza dell'ignoranza della legge penale, non consente di distinguere la disciplina giuridica delle ipotesi che danno luogo all'ignoranza <inqualificata> da quelle che la <qualificano> per esser fondate sulla <positiva> buona fede del soggetto; e poichè anche le diverse interpretazioni <evolutive> dell'art. 5 c.p., secondo le quali lo stesso articolo statuirebbe soltanto una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure d'irrilevanza dell'ignoranza della legge penale (tutte, peraltro, degne di considerazione, in quanto mirate ad attenuare l'incostituzionale rigore della statuizione in esame) contrastano con l'interpretazione che dell'articolo in discussione da il diritto vivente; non resta, dunque, che partire qui da quest'ultima interpretazione. 23. -Non può tacersi, a questo punto, che l'art. 5 c.p. ha natura <bifronte>: da un canto nega efficacia scusante all'ignoranza della legge penale e dall'altro esclude ogni rilevanza all'errore sull'illiceità del fatto e, pertanto, alla consapevolezza della stessa illiceità. E' stato, invero, in dottrina, precisato che l'art. 5 c.p. non disciplina l'ignoranza della legge penale in astratto ma l'ignoranza (od errore) <essenziale>, anche incolpevole, sull'illiceità d'un concreto comportamento. Si possono, é vero, attenuare gli inconvenienti che si producono a seguito del disposto di cui all'art. 5 c.p., in sede di dolo, sostenendo essenziale al medesimo, ex art. 43 c.p., la coscienza della violazione dell'interesse tutelato ed assumendo che l'art. 5 c.p. renda irrilevante soltanto la coscienza dell'illiceità penale (= punibilità) del fatto. Ma per le ipotesi colpose il soggetto agente verrebbe ad esser punito senza nemmeno la più lontana possibilità (carenza incolpevole) di conoscere la <giuridicità> delle regole di diligenza, prudenza ecc. in base alla violazione delle quali lo stesso soggetto vien punito. Va aggiunto che l'esistenza d'una norma, quale quella dell'art. 5 c.p., diretta ad escludere ogni giuridico rilievo all'ignoranza (od errore) sulla legge penale, presuppone la contrapposta possibilità, almeno teorica, che il reo, in assenza di tale norma, pretenda scusarsi: ed il reo, in tal caso, si scuserebbe adducendo il <turbamento>, prodotto dall'ignoranza della legge penale sul processo formativo della volontà del fatto. Nell'ipotesi prospettata, tuttavia, da un canto si dimostrerebbe assurda una <pretesa> d'essere scusati (nell'inesistenza dell'art. 5 c.p.) sol in base all'ignoranza , anche inescusabile, della sola punibilità del fatto (pur essendo coscienti di ledere il bene tutelato) e d'altro canto sarebbe sempre l'errore nella formazione della concreta volontà dell'illecito, al quale consegue la carenza di coscienza dell'illiceità penale del fatto, anche se dovuta all'ignoranza (od errore) sulla legge penale, a costituire la ragione della <scusa>, che appunto, lo stesso articolo esclude. Senonchè, a seguito della predetta osservazione, si ha la riprova che l'art. 5 c.p., nell'attuale vigore, non soltanto determina un uguale trattamento di chi agisce con la coscienza dell'illiceità (totale o soltanto penale) del fatto e di chi opera senza tale coscienza ma esclude ogni possibilità di valutazione della <causa> della mancata coscienza (della sola punibilità o dell'<intera> antiprecettività del fatto) trattando allo stesso modo errore scusabile, inevitabile ed errore inescusabile, evita bile, sull'illiceità. Punendo, in ogni caso, l'agente che versa in errore di diritto l'art. 5 c.p. presume, iuris et de iure, comunque si delimiti l'oggetto di tale errore, la <rimproverabilità> del medesimo. Vero é che l'art. 5 c.p. rende incostituzionale tutto il sistema ordinario in materia di colpevolezza, in quanto sottrae a questa l'importantissima materia del rapporto tra soggetto e legge penale e, conseguentemente, tra soggetto e coscienza del significato illecito del fatto. Ma l'art. 5 c.p. <snatura>, togliendone fondamento, anche la residua materia che non sottrae alla colpevolezza (dolo, colpa del fatto ecc.). Allorchè l'agente ignora, del tutto incolpevolmente, la legge penale e, pertanto, incolpevolmente ignora l'illiceità del fatto, non mostra alcuna opposizione ai valori tutelati dall'ordinamento: può il suo dolo costituire 42 oggetto di rimprovero ex art. 27, primo e terzo comma, Cost.? Certo, includendo nel dolo la coscienza dell'offesa (a parte ogni discussione sulla conseguente riduttiva interpretazione dell'art. 5 c.p.) si attenuano gli effetti che, invece, discendono dalla rigorosa interpretazione dello stesso articolo. Senonchè, pur ammettendo che l'art. 5 c.p. sottragga alla colpevolezza soltanto il rapporto tra soggetto e coscienza del significato illecito <penale> del fatto e non dell'intero disvalore antiprecettivo del fatto stesso (e sempre a prescindere dalla pratica <inoperatività>, in tal caso, dell'art. 5 c.p.) rimarrebbero del tutto <scoperte> le ipotesi colpose (contravvenzionali ad es.). Per assumere il soggetto agente <in colpa> dovrebbe, invece, almeno essergli offerta la <possibilità> di conoscere le norme penali che <trasformano> in doverose le regole di diligenza, prudenza ecc. in base alla violazione delle quali, nella prevedibilità ed evitabilità concreta dell'evento, si viene chiamati a rispondere: se l'agente, del tutto incolpevolmente, ignorasse le predette norme penali, la sua <colpa> (del fatto) non dovrebbe potersi ritenere rimproverabile ex art. 27, primo e terzo comma, Cost. La colpevolezza prevista dagli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p. va, pertanto, arricchita, in attuazione dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost., fino ad investire, prima ancora del momento della violazione della legge penale nell'ignoranza di quest'ultima, l'atteggiamento psicologico del reo di fronte ai doveri d'informazione o d'attenzione sulle norme penali, doveri che sono alla base della convivenza civile. Nè si tema che le conclusioni qui raggiunte delineino una forma di <colpa per la condotta della vita>: risalire alle <cause> dell'ignoranza della legge penale, per verificarne l'evitabilità, costituisce verifica dell'esistenza, in concreto, almeno d'un atteggiamento d'indifferenza, da parte dell'agente, nei confronti della doverosa informazione giuridica. Tale verifica non solo non viola il principio della responsabilità penale <per il singolo fatto> ma mira a cogliere il completo disvalore soggettivo del particolare episodio criminoso e può, condurre, come più volte ribadito, all'esclusione della colpevolezza per il singolo fatto, nell'ipotesi d'inevitabilità dell'ignoranza. 24. - L'art. 5 c.p. viola, infine, anche l'art. 3, primo e secondo comma, Cost. In ordine alla violazione del primo comma dell'art. 3 Cost. va anzitutto ricordato (a conferma di quanto innanzi osservato in ordine all'uguale trattamento che, ai sensi dell'art. 5 c.p., riceve chi agisce con la coscienza dell'illiceità del fatto e chi invece con tale coscienza non opera) che, come ha avuto modo di rilevare recente, attenta dottrina, colui che commette un reato nell'ignoranza della legge penale dovuta ad impossibilita di prenderne conoscenza vien punito con una pena che, rispetto a quella cui soggiace chi commette lo stesso reato conoscendone l'illiceità, può esser diminuita soltanto entro i limiti edittali ex art. 133 c.p. o, se mai, ex art. 62 bis c.p. La diversità tra le predette situazioni (conoscenza effettiva ed impossibilita incolpevole di conoscenza della legge penale) é, invece, notevole sia sotto il profilo del disvalore sia sotto quello della <sintomaticità>. L'art. 5 c.p. viola, dunque, anche il primo comma dell'art. 3 Cost. Per quanto attiene alla violazione del secondo comma dell'articolo ora citato va ribadito che il non poter addurre a scusa dell'ignoranza della legge penale l'obiettiva o la subiettiva (nei limiti anzidetti) impossibilita di conoscere la stessa legge equivale a far ricadere sul singolo tutte le colpe della predetta ignoranza. Ben é, invece, almeno possibile, come s'é già sottolineato, che lo Stato non abbia reso obiettivamente riconoscibili (o <prevedibili>) alcune leggi; oppure che, malgrado ogni positiva predisposizione di determinanti soggetti all'adempimento dei predetti doveri strumentali d'informazione ecc., l'ignoranza della legge penale sia dovuta alla mancata rimozione degli <ostacoli> di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost. 25. - In conclusione: oltre agli specifici articoli della Costituzione indicati in precedenza, l'art. 5 c.p., nell'interpretazione che del medesimo danno una parte della dottrina e soprattutto la giurisprudenza, viola, come s'é sottolineato più volte, lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale ed i suoi essenziali principi ispiratori. Far sorgere l'obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza dell'agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla conoscenza od ignoranza della legge penale e dell'illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati. 26. - Non resta che accennare ai criteri, ai parametri in base ai quali va stabilita l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale. E, invero, di gran rilievo impedire che, in fase applicativa, vengano a prodursi, insieme alla <vanificazione> delle risultanze qui acquisite, altre violazioni della Carta fondamentale. E' doveroso, per prima, chiarire che, ove una particolare conoscenza, da parte del soggetto agente, consenta al medesimo la possibilità di conoscere la legge penale, non e legittimo che lo stesso soggetto si giovi d'un (eventuale) errore generale, comune, sul divieto. Ciò va rilevato non perchè si disconoscano i tentativi, per tanti aspetti meritevoli di considerazione, della dottrina mirati, attraverso l'oggettivazione, per quanto possibile, dei criteri di misura della colpevolezza, a sottolinearne l'aspetto, peraltro fondamentale, di garanzia delle libere scelte d'azione ma perchè non é desumibile dalla Costituzione la legittimità d'una concezione della colpevolezza che consenta di non rimproverare il soggetto per il fatto commesso (ovviamente, in presenza dei prescritti elementi subiettivi) quando esista, in concreto, la possibilità, sia pur eccezionale (di fronte ad un generale, comune errore sul divieto) per il singolo agente di conoscere la legge penale e, pertanto, l'illiceità del fatto. Ammettere, allo stato attuale della normativa costituzionale ed ordinaria, il soggetto agente (che e in errore sull'illiceità del fatto per ignoranza della legge penale, pur essendo in grado di conoscere quest'ultima e di non errare sulla predetta illiceità) a giovarsi del comune errore sul divieto, determinato dall'altrui, generale, inevitabile ignoranza della legge penale, val quanto riconoscere all'errore comune sul divieto penale il valore di consuetudine abrogatrice di incriminazioni penali. 43 27.-Da quanto innanzi osservato discende, in via generale, che l'inevitabilità dell'errore sul divieto (e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l'errore sul precetto e inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravita va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari ecc. La spersonalizzazione che un giudizio formulato alla stregua di criteri oggettivi puri necessariamente comportava, tuttavia, compensata, secondo quanto innanzi avvertito, dall'esame di eventuali, particolari conoscenze ed <abilità> possedute dal singolo agente: queste ultime, consentendo all'autore del reato di cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge penale escludono che l'ignoranza della legge penale vada qualificata come inevitabile. Ed anche quando, sempre allo scopo di stabilire l'inevitabilità dell'errore sul divieto, ci si valga di <altri> criteri (c.d. <misti>) secondo i quali la predetta inevitabilità può esser determinata, fra l'altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s'é formata la deliberazione criminosa (es. <assicurazioni erronee> di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare; precedenti, varie assoluzioni dell'agente per lo stesso fatto ecc.) occorre tener conto della <generalizzazione> dell'errore nel senso che qualunque consociato, in via di massima (salvo quanto aggiungiamo subito) sarebbe caduto nell'errore sul divieto ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell'agente; ma, ancora una volta, la spersonalizzazione del giudizio va compensata dall'indagine attinente alla particolare posizione del singolo agente che, in generale, ma soprattutto quando eventualmente possegga specifiche <cognizioni> (ad es. conosca o sia in grado di conoscere l'origine lassistica o compiacente di assicurazioni di organi anche ufficiali ecc.) é tenuto a <controllare> le informazioni ricevute. Il fondamento costituzionale della <scusa> dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità e non può certo esser strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze, ecc., di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali. 28. - La casistica relativa all'<inevitabilità> dell'errore sul divieto va conclusa con alcune precisazioni. E' stato, in dottrina, osservato che, realisticamente, l'ipotesi d'un soggetto, sano e maturo di mente, che commetta un fatto criminoso ignorandone l'antigiuridicità é concepibile soltanto quando si tratti di reati che, pur presentando un generico disvalore sociale, non sono sempre e dovunque previsti come illeciti penali ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale (es. violazione di alcune norme fiscali ecc.). E, in relazione a queste categorie di reati, sono state opportunamente prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto effettivamente si rappresenti la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui l'agente neppure si rappresenti tale possibilità. Or qui occorre precisare che, mentre nella prima ipotesi, esistendo, in concreto (ben più della possibilità di conoscenza dell'illiceità del fatto) l'effettiva previsione di tale possibilità, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (essendo il soggetto obbligato a risolvere l'eventuale dubbio attraverso l'esatta e completa conoscenza della (singola) legge penale o, nel caso di soggettiva invincibilità del dubbio, ad astenersi dall'azione (il dubbio oggettivamente irrisolvibile, che esclude la rimproverabilità sia dell'azione sia dell'astensione e soltanto quello in cui, agendo o non agendo, s'incorre, ugualmente, nella sanzione penale); la seconda ipotesi comporta, da parte del giudice, un'attenta valutazione delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non s'é neppure prospettato un dubbio sull'illiceità del fatto. Or se l'assenza di tale dubbio discende, principalmente, dalla personale non colpevole carenza di socializzazione dell'agente, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile. Inevitabile si palesa anche l'errore sul divieto nell'ipotesi in cui, in relazione a reati sforniti di disvalore sociale e, per l'agente, socializzato oppur no, oggettivamente imprevedibile l'illiceità del fatto. Tuttavia, ove (a parte i casi di carente socializzazione dell'agente) la mancata previsione dell'illiceità del fatto derivi dalla violazione degli obblighi d'informazione giuridica, che sono, come s'é avvertito, alla base d'ogni convivenza civile deve ritenersi che l'agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale. Come inevitabile, rimproverabile ignoranza della legge penale versa chi, professionalmente inserito in un determinato campo d'attività, non s'informa sulle leggi penali disciplinanti lo stesso campo. La casistica non può esser qui approfondita: basta aver indicato che (alla luce del fondamento costituzionale della scusa dell'inevitabile ignoranza della legge penale) allo scopo di verificare, in concreto, tale inevitabilità, da un canto e necessario (per garantire la certezza della libertà d'azione del cittadino) far riferimento a criteri oggettivi c.d. <puri> e <misti> e dall'altro canto é doveroso recuperare la spersonalizzazione, causata dall'uso preponderante di tali criteri, con l'esame delle particolari situazioni in cui eventualmente versi il singolo soggetto agente. La giurisprudenza va, infine, rinviata, nell'interpretazione ed applicazione del nuovo testo dell'art. 5 c.p. ai criteri generali che, in tema di responsabilità a titolo di colpa e di buona fede nelle contravvenzioni, la stessa giurisprudenza é andata via via adottando. Il nuovo testo dell'art. 5 c.p., derivante dalla parziale incostituzionalità dello stesso articolo che qui si va a dichiarare, risulta cosi formulato: <L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile>. 29.-Non resta che sottolineare che spetta al legislatore (oltre all'eventuale emanazione di norme <di raccordo>) stabilire se l'ignoranza evitabile della legge penale meriti un'attenuazione di pena, come per gli ordinamenti tedesco occidentale 44 ed austriaco, oppure se il sistema dell'ignoranza della legge penale debba restare quello risultante a seguito della qui dichiarata parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. Ogni altra questione sollevata dalle ordinanze di rimessione rimane assorbita dalla predetta illegittimità costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88. Francesco SAJA, PRESIDENTE Renato DELL'ANDRO, REDATTORE Depositata in cancelleria il 24/03/88. *** SENTENZA N. 1085 ANNO 1988 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Prof. Giovanni CONSO, Giudici Prof. Ettore GALLO Dott. Aldo CORASANITI Prof. Giuseppe BORZELLINO Dott. Francesco GRECO Prof. Renato DELL'ANDRO Prof. Gabriele PESCATORE Avv. Ugo SPAGNOLI Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Prof. Antonio BALDASSARRE Prof. Vincenzo CAIANIELLO Avv. Mauro FERRI Prof. Luigi MENGONI Prof. Enzo CHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., in relazione agli artt. 624, 625, 56 e 83 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Ferracuti Tiziano, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a ss. dell'anno 1988; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro. Considerato in diritto 1. -Va anzitutto disattesa l'eccezione, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, d'inammissibilità dell'ordinanza di rimessione. 45 E' ben vero che il giudice <a quo> parte da una configurazione del tentativo di furto d'uso che, come si chiarirà, non sembra condividibile: ciò, peraltro, non rileva ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'ordinanza di rimessione. Né può condividersi l'assunto dell'Avvocatura generale dello Stato secondo il quale, allorché esista contrasto interpretativo tra il giudice rimettente ed il diritto vivente, il primo è tenuto ad applicare alla fattispecie la disciplina che ritiene preferibile anziché sollevare questione di legittimità costituzionale. Nella specie, in sostanza, il giudice <a quo>, a parte la complessità del suo argomentare e la non condividibile configurazione del tentativo di furto d'uso, dubita della costituzionalità della norma di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p.: escludendo ogni rilevanza al caso fortuito ed alla forza maggiore nella mancata restituzione della cosa sottratta, la norma .de qua>, a parere del Pretore di Fermo, rende applicabile la disciplina normativa prevista per il furto comune anche a chi ha voluto soltanto il furto d'uso. 2.-L'ordinanza di rimessione non può essere condivisa nella parte in cui censura l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in mancanza d'effettiva restituzione della cosa sottratta, non è configurabile il tentativo di furto d'uso, ex artt. 56 e 626, primo comma, n. 1, c.p.; la stessa ordinanza e, invece, da condividere nella parte in cui ritiene costituzionalmente illegittima l'applicazione, all'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, dell'art. 624 c.p. A tale ipotesi va, invero, applicato l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., che incrimina e disciplina il c.d. furto d'uso consumato. Alcune chiarificazioni di fondo vanno premesse ai fini dell'esatto inquadramento sistematico della fattispecie tipica di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., in relazione al tipo previsto nell'art. 624 c.p. Vero è che l'6immediata restituzione> della cosa sottratta, dopo l'uso momentaneo della cosa stessa, rileva nella fattispecie di c.d. furto d'uso, prima ancora che quale elemento obiettivo, quale momento del contenuto intenzionale del soggetto attivo del fatto, <accanto ed oltre> lo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta. Ed è appunto l'intero contenuto volitivo del reo che, almeno inizialmente, nettamente distingue, nel sistema del vigente codice penale, l'ipotesi di c.d. furto d'uso dal tipo di cui all'art. 624 c.p., che qui si denominerà, per esigenze di chiarezza espositiva, furto semplice, ordinario o comune. Deve, preliminarmente, esser precisato che il furto d'uso non va configurato quale furto semplice (soltanto) ulteriormente caratterizzato ed attenuato dal momentaneo uso e dalla restituzione, immediatamente dopo l'uso, della cosa sottratta. Quand'anche non s'accolga la peraltro convincente tesi, autorevolmente proposta, della sostanziale e strutturale autonomia, rispetto al furto comune, della fattispecie tipica di furto d'uso, certo e che, dall'interpretazione sistematica dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., s'evince che o già al momento della sottrazione della cosa mobile altrui esiste, nel reo, oltre allo scopo di far (soltanto) uso momentaneo della cosa che si sta sottraendo, anche l'intenzione di restituire la cosa stessa immediatamente dopo l'uso, ed in tal caso e applicabile (a parte, un attimo, i problemi relativi all'effettiva restituzione della cosa, dei quali ci si occuperà oltre) la disciplina prevista per il furto d'uso; oppure tale intenzione specificamente relativa alla restituzione della cosa (si ribadisce: già nel momento dell'impossessamento) non esiste, ed in questo secondo caso è applicabile la disciplina prevista per il furto comune. E, infatti, la presenza nel reo della specifica intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l'uso momentaneo (oltre, s'intende agli altri requisiti essenziali) che caratterizza, in relazione al furto comune, e sin dall'origine, il furto d'uso. Quest'ultimo non nasce come furto semplice, solo successivamente <trasformato>, a seguito dell'uso momentaneo e della restituzione della cosa sottratta, in furto d'uso, bensì, e sin dall'origine, si manifesta per il particolare, caratteristico contenuto intenzionale del reo, consistente nello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta ed insieme nell'intenzione di restituire quest'ultima immediatamente dopo l'uso. Alla tesi secondo la quale, nello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta, sarebbe necessariamente implicita l'intenzione di restituire la medesima, e stato giustamente obiettato che non sempre (così, ad es., nell'ipotesi di esistenza, nel reo, di tale scopo e dell'intenzione di abbandonare, poi, la cosa) e necessariamente implicita, nello scopo dell'uso momentaneo, anche l'intenzione d'immediatamente restituire la cosa sottratta. Senonché, appunto l'esempio proposto (presenza nel reo, al momento della sottrazione, dello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta ed insieme dell'intenzione d'abbandonare la cosa stessa dopo l'uso) rende evidente la volontà del soggetto attivo del fatto, fin dall'inizio, d'appropriarsi della cosa sottratta, ossia d'agire con animus domini. Insomma: se al momento della sottrazione c'è, nel soggetto attivo, oltre allo scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta, anche l'intenzione di restituire la cosa stessa immediatamente dopo l'uso, si realizza, almeno inizialmente (salve le successive vicende relative a mutamenti volitivi) l'ipotesi del furto d'uso; se, invece, l'intenzione, nel reo, d'immediata restituzione della cosa non c'è, si realizza, sempre ab initio, l'ipotesi del furto comune. Il furto d'uso e alternativo al furto semplice: o si verifica, in concreto, almeno ab initio, un'ipotesi di furto d'uso (in presenza dell'intenzione di restituire, dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta) oppure, in alternativa, con l'ovvia conseguente esclusione di detta ipotesi, si attua (in mancanza di tale intenzione ed in presenza, s'intende, di tutti gli altri requisiti di cui agli artt. 624, 42 e segg. c.p.) un'ipotesi di furto semplice. Ad avviso della Corte, è appunto dall'inserimento, nel sistema, della fattispecie di furto d'uso (che non esisteva nel codice penale Zanardelli) che risulta particolarmente caratterizzato anche il dolo specifico del furto semplice, se di dolo specifico si tratta: se l'intenzione d'immediatamente restituire dopo l'uso momentaneo la cosa sottratta caratterizza il furto d'uso, l'intenzione di non restituire la stessa cosa (anche dopo un eventuale uso momentaneo) ossia di spossessare definitivamente gli aventi diritto, caratterizza il furto ordinario. Ma, anche quando, con una parte della giurisprudenza, queste, peraltro sicure, conclusioni, desunte dall'interpretazione sistematica degli artt. 624 e segg. c.p., non venissero 46 condivise, non si potrebbe disconoscere, almeno in ordine al furto d'uso, la necessita dell'<ulteriore> positiva intenzione (al momento della sottrazione) d'immediatamente restituire, dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta. A conferma vale ricordare, in materia, i lavori preparatori; ed in particolare la Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto (Lavori preparatori del codice penale, vol. V, parte II, n. 741) ove espressamente si legge: <... si risponderà di furto semplice... sia quando siasi sottratta la cosa allo scopo di usarla e poi di restituirla, ed in effetti non siasi restituita sia quando, pur di fronte ad una avverata restituzione, non sia provato che la sottrazione fu commessa con lo scopo di restituire. Potrà in quest'ultima ipotesi concedersi la diminuente di pena per la circostanza della restituzione del tolto>. Non c'e dubbio, dunque, che la sottrazione e l'impossessamento, perché si abbia furto d'uso, devono avvenire con l'intenzione d'immediatamente restituire, subito dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta. Da quanto osservato s'evince non soltanto che, prima ancora che sul piano obiettivo, la restituzione opera quale iniziale, <ulteriore> contenuto intenzionale caratterizzante il furto d'uso ma anche che soltanto un mutamento, intervenuto successivamente alla sottrazione, del predetto contenuto intenzionale può porre problemi relativi all'applicabilità della disciplina prevista per il furto ordinario; a meno che, come si preciserà in seguito, non s'intenda illegittimamente escludere dalla comprensione dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., l'ipotesi della mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta. 3.-Le osservazioni che precedono, desunte soltanto dal l'interpretazione sistematica degli artt. 624 e 626, primo comma, n. 1, c.p., valgono, <a fortiori>, per quelle legislazioni nelle quali, non essendo attribuito, sul piano oggettivo, alcun rilievo all'effettiva restituzione della cosa sottratta, fondano il furto d'uso unicamente su elementi subiettivi tipici e, in particolare, sull'intenzione di restituire la cosa sottratta. Il 248 b,1 del codice penale della Repubblica federale tedesca, infatti, prevede, in mancanza d'una disposizione generale sul furto d'uso, la fattispecie d'uso di veicoli a motore o di biciclette contro la volontà del proprietario: e la dottrina tedesca non dubita della necessita, per l'applicabilità del precitato paragrafo, dell'intenzione nel reo, al momento dell'impossessamento, di restituire all'avente diritto la cosa sottratta; e così anche per la non punibilità dell'uso di cose altrui diverse dagli autoveicoli e biciclette. La dottrina tedesca, dopo aver sottolineato che il soggetto attivo del fatto deve calcolare, con un certo grado di sicurezza, la possibilità di restituire la cosa sottratta, sostiene, peraltro, che già il dubbio in ordine alla predetta restituzione comporta l'applicabilità della norma sul furto comune. Interessante è, fra le altre, anche la normativa dei Paesi di lingua inglese, a cominciare dalla stessa Inghilterra: descrivendosi (nella section 1 (1) del Theft Act del 1968, modificato nel 1978) il furto comune come <l'appropriarsi disonestamente di una cosa altrui con l'intenzione di privare l'altro permanentemente di tale cosa>, e agevole da un canto sottolineare che, se e provata tale intenzione specifica, al momento della sottrazione, si applicano senz'altro le norme sul furto comune (anche se il soggetto attivo del reato di li a poco, per qualsiasi motivo, restituisca la cosa sottratta) e d'altro canto concludere che a colui che s'impossessa temporaneamente d'una cosa con l'intenzione di restituirla, ove diventi impossibile l'effettiva restituzione (salvo che l'impossibilita di quest'ultima derivi da un comportamento doloso del reo) non è applicabile la disciplina del furto comune, mancando, appunto, nell'autore del fatto, l'intenzione specifica di privare permanentemente della cosa sottratta l'avente diritto. Né va dimenticato che negli Stati Uniti d'America si son verificati <casi> giurisprudenziali nei quali e stato espressamente negata l'applicabilità della norma sul furto comune allorché, come nell'ipotesi che ci occupa, viene sottratta un'auto per restituirla, dopo breve uso, all'avente diritto e successivamente diviene impossibile la restituzione per un guasto alla macchina. 4. - La restituzione assume un particolare rilievo, sul piano obiettivo, nella legislazione italiana: questa, infatti, a differenza di altre legislazioni, non soltanto prevede una fatti specie tipica generale (ossia applicabile alla sottrazione di qualunque genere di cose mobili) di furto d'uso ma richiede, per l'integrazione della medesima, l'effettiva restituzione della cosa sottratta. Non interessano, in questo momento, le motivazioni delle scelte operate dall'art. 626, primo comma, n. 1, c.p.: potrà anche esser stata la necessita d'individuare un elemento valido a provare, in maniera inconfutabile, l'iniziale intenzione, nel reo, di restituire la cosa sottratta (contro gli artifici difensivi in ordine alla prova di tale intenzione) ad indurre il legislatore a richiedere, per l'integrazione del furto d'uso, l'effettiva restituzione della cosa sottratta. Certo è che, come risulta anche dal citato passo della Relazione ministeriale al vigente codice penale, si risponde di furto comune (e non di furto d'uso) anche quando, pur essendosi sottratta la cosa altrui con lo scopo di momentaneamente usarla e, subito dopo, di restituirla al legittimo detentore, la stessa cosa non sia stata (salvo quanto si osserverà di qui a poco) effettivamente restituita. Difficile è l'inquadramento, nel sistema, del requisito obiettivo del quale si sta discutendo, e tenace e la tentazione, nella quale cade anche il giudice <a quo>, d'allargare, <in avanti>, il fatto di furto d'uso, ritenendolo perfezionato soltanto nel momento dell'avverata restituzione della cosa sottratta e, così, di ravvisare, nell'ipotesi di sottrazione ed uso momentaneo della cosa, con conseguenti atti diretti a restituirla interrotti in itinere, tentativo di furto d'uso e non furto d'uso consumato: sembra, infatti, a prima vista, agevole argomentare che, se la pena prevista per il furto d'uso scatta nel momento dell'avvenuta restituzione, questa ultima (rappresentando, peraltro, la realizzazione <finale> della volontà del reo) costituisce l'evento della fattispecie di furto d'uso e, pertanto, come nella specie all'esame del giudice <a quo>, gli atti idonei, realizzati dopo la sottrazione e l'uso momentaneo della cosa sottratta, diretti a restituire la medesima interrotti <in itinere> integrano tentativo di furto d'uso. Senonché, va intanto preliminarmente ribadito che, in caso di volontaria mancata restituzione della cosa sottratta, non può che esservi stato, nel soggetto attivo del fatto, un mutamento volitivo, se e vero che, nel momento della sottrazione, 47 lo stesso soggetto ha nutrito l'intenzione di restituire la cosa e che solo successivamente, <mutando d'avviso>, ha deciso di spossessare definitivamente l'avente diritto. Ma, quel che più conta, la restituzione non può costituire l'evento del delitto di furto d'uso, giacche essa, a differenza della sottrazione (ed eventualmente dell'uso momentaneo) non e <negativamente valutata> dal legislatore. L'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. si dirige al privato, in questi termini: <Non impossessarti, sottraendola a chi la detiene, della cosa mobile altrui, neppure con lo scopo d'un uso momentaneo della cosa stessa; ove ti fossi impossessato della medesima con l'intenzione di restituirla e l'avessi momentaneamente usata, restituiscila immediatamente>. Nel furto d'uso, la restituzione non soltanto non viola alcun divieto normativo ma realizza una condotta positivamente valutata dal legislatore. La restituzione non può, dunque, costituire evento del delitto di furto d'uso: è, invece, la mancata restituzione, negativamente valutata dal legislatore, a far divenire applicabili le più gravi sanzioni previste per il furto ordinario. Tale mancata restituzione, esaminata, come si osserverà fra poco, alla stregua dei principi generali, costituisce un dato esclusivamente obiettivo, che necessita, secondo la vigente Costituzione, d'essere integrata dai correlativi requisiti subiettivi: in carenza di questi ultimi, la mancata restituzione della cosa non può esser addebitata al soggetto agente. La distinzione tra fatto e fattispecie vale ad inquadrare il tema: il fatto di furto d'uso comprende tutti gli estremi che integrano l'oggetto del divieto normativo e s'estende fino al momento della restituzione, compreso, pertanto, anche il divieto d'uso momentaneo (ed inclusi anche gli estremi subiettivi). Poiché non può denominarsi dolo l'intenzione di realizzare una condotta positivamente valutata dal legislatore (la restituzione della cosa sottratta) non può includersi nel dolo specifico anche l'intenzione di tale restituzione: la stessa intenzione - si ripete - deve, peraltro, esistere (ed esser rigorosamente provata) insieme al dolo generico ed allo scopo d'uso momentaneo della cosa perché siano, in concreto, integrati, nel momento dell'impossessamento, tutti gli estremi subiettivi del furto d'uso. La restituzione della cosa sottratta costituisce, dunque, condotta susseguente, che fa parte della fattispecie di furto d'uso in senso ampio, fattispecie che include il fatto (integrato, come si e detto, da tutti gli estremi violativi del divieto normativo) e la predetta condotta susseguente: caratteristica peculiare della fattispecie di furto d'uso e che, mentre solitamente la condotta susseguente costituisce realizzazione d'un mutamento di volontà del soggetto attivo del fatto ed ha come effetto, di regola, l'estinzione del reato, la restituzione della cosa sottratta realizza, invece, l'iniziale intenzione del reo ed ha, insieme agli altri elementi del furto d'uso, l'effetto d'attenuare la pena e di condizionare la perseguibilità (a querela) del reato. Da ciò discende che, pur essendo configurabile il tentativo di furto d'uso, la sottrazione e l'impossessamento segnano il momento oltre il quale tale tentativo non può più esser integrato. E l'impossessamento della cosa l'evento consumativo del furto d'uso. Anche l'uso momentaneo (che si potrebbe inquadrare, quale condotta di mantenimento, in un sia pur breve stato di perdurante consumazione, inclusa, sempre, tale condotta, in quanto normativamente vietata, nel fatto di furto d'uso) perde i caratteri dell'essenzialità: ove il reo, impossessatosi della cosa altrui con lo scopo d'usarla momentaneamente, rinunciasse ad usarla e, subito dopo la sottrazione, la restituisse all'avente diritto, ugualmente si configurerebbe un'ipotesi di furto d'uso consumato: in tal caso lo stato di <perdurante> consumazione si ridurrebbe a brevissimo tempo. Le precedenti considerazioni conducono a non condividere l'ordinanza di rimessione, nella parte in cui ritiene che, nell'ipotesi all'esame del giudice <a quo>, sia ravvisabile un tentativo di furto d'uso: poiché gli imputati s'erano già impossessati del veicolo, e l'avevano anche momentaneamente usato, non e costituzionalmente illegittimo escludere, nella stessa ipotesi, il tentativo di furto d'uso e ravvisare, invece, il furto d'uso consumato. 5. - La norma di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. viola, invece, l'art. 27, primo comma, Cost., in quanto esclude che, nella specie all'esame del giudice <a quo>, sia applicabile la disciplina dettata per il furto d'uso. La mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta non può esser legittimamente addebitata al soggetto attivo del fatto, con la conseguente sottoposizione dello stesso soggetto alle più gravi sanzioni del furto comune. Non dovrebbe residuare dubbio alcuno, dopo quanto e stato osservato, sul rilievo per il quale la restituzione della cosa sottratta costituisce elemento essenziale e particolarmente significativo della fattispecie di furto d'uso. Ma, altrettanto essenziale e significativa e la mancata restituzione della cosa sottratta, tenuto conto dell'eventuale esclusione dell'applicabilità delle ridotte sanzioni previste per il furto d'uso e della conseguente applicazione delle più gravi sanzioni previste per il furto ordinario. II comando legislativo, diretto al soggetto attivo del reato, si configura in questi termini: <se hai sottratto la cosa mobile altrui allo scopo di momentaneamente usarla, restituiscila immediatamente>; in altre parole: <opera, attivati a restituirla (nel qual caso otterrai una notevole riduzione di pena ed il delitto sarà perseguito soltanto a querela di parte); se, invece, non la restituirai, immediatamente dopo l'uso, si applicheranno le gravi sanzioni determinate dalla legge per il furto ordinario e non saranno invocabili restrizioni alla perseguibilità del delitto>. Nella sistematica dei rapporti tra furto comune e furto d'uso, allo stesso modo per il quale l'effettiva restituzione della cosa sottratta (in quanto realizzazione dell'iniziale intenzione del reo) esclude l'ipotesi, e le ridotte sanzioni, del furto comune, la (volontaria) mancata restituzione della predetta cosa-salvo quanto si preciserà fra poco-esclude il disposto relativo al furto d'uso e, conseguentemente, rende applicabili le gravi sanzioni previste per il furto comune. Non resta che stabilire i criteri in base ai quali valutare, nel furto d'uso, la mancata restituzione della cosa sottratta. 48 Poiché tale mancata restituzione, nel furto d'uso, risulta essere positivamente valutata dal legislatore, essa va trattata in maniera analoga alle omissioni: la mancata restituzione va considerata, come per l'omissione, soltanto estremo oggettivo. L'analisi deve, pertanto, incentrarsi sull'esistenza del correlativo elemento subiettivo: l'elemento oggettivo della condotta negativa, per esser imputato, va integrato dai corrispondenti requisiti subiettivi e cioè dalla volontà di non restituire la cosa sottratta. Or nella specie all'esame del giudice <a quo> non soltanto non e stata dimostrata, nel soggetto attivo del fatto, la volontà di <non restituire> ma risulta provata, secondo l'assunto dello stesso giudice, l'esistenza nel reo, già al momento della sottrazione e dell'impossessamento della cosa, della contraria volontà, mai mutata, d'immediatamente restituire, dopo l'uso momentaneo, la cosa sottratta. La giurisprudenza e la dottrina che sono dell'avviso che sia applicabile la normativa del furto comune anche all'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta interpretano l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. alla luce del sistema del vigente codice penale, nel quale non soltanto e prevista la responsabilità oggettiva ma vige il principio: <qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu>. Ed infatti, la dottrina esplicitamente afferma che, in caso di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, risponde di furto comune anche chi ha sottratto la cosa allo scopo di farne uso momentaneo e con l'intenzione d'immediatamente restituirla, a cagione della vigenza, nel codice penale del 1930, del principio ora ricordato. Senonché, tale principio contrasta con l'art. 27, primo comma, Cost. La sentenza di questa Corte n. 364 del 1988, nell'interpretare, alla luce dell'intero sistema costituzionale, il parametro ora richiamato, ha sancito che dal medesimo risulta richiesto, quale essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato. Ed innanzi si è sottolineato che, se l'intenzione di restituire la cosa e l'effettiva sua restituzione sono altamente significativi e caratterizzanti la fattispecie tipica di furto d'uso, anche la mancata restituzione della cosa sottratta non può che essere particolarmente significativa ai fini d'escludere l'applicabilità delle ridotte sanzioni di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. e di rendere conseguentemente applicabili le gravi sanzioni previste per il furto ordinario. Non può tacersi che ben a ragione, quasi unanimemente, dottrina e giurisprudenza concludono nel senso che, per l'applicazione del disposto relativo al furto d'uso, l'effettiva restituzione della cosa sottratta deve, in concreto, costituire realizzazione della particolare intenzione di restituire, già presente al momento dell'impossessamento, nell'autore del reato e non <oggettivo> evento dovuto al caso: or non si comprende perché mai la restituzione della cosa sottratta non operata, direttamente od indirettamente, dallo stesso reo non si ritiene integrare l'estremo dell'effettiva restituzione richiesto dall'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. ed invece la mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore, del tutto estranea alla volontà del reo, debba aver rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni relative al furto d'uso; con l'assurda conseguenza che il soggetto agente, che fortunatamente fosse riuscito a restituire la cosa sottratta, verrebbe perseguito soltanto a querela di parte e sanzionato con le pene ridotte di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. mentre altro soggetto, con la stessa intenzione del primo in ordine alla restituzione della cosa, sol perché impedito sfortunatamente a riconsegnare la cosa sottratta, dovrebbe essere più gravemente punito per furto ordinario. E' ben vero che la massima: <qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu> implica già, almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) senza del qual collegamento non si avrebbe il <versari in re illicita>: così, nella specie all'esame del giudice <a quo>, il dolo della sottrazione e dell'impossessamento della cosa mobile altrui. Ma non per tal ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi (nella specie, mancata restituzione della cosa per caso fortuito o forza maggiore) nella produzione dei quali la volontà del reo e rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo. Dal primo comma dell'art . 27 Cost., come e stato chiarito nella citata sentenza n. 364 del 1988, non soltanto risulta indispensabile, ai fini dell'incriminabilità, il collegamento (almeno nella forma della colpa) tra soggetto agente e fatto (o, nella specie, tra soggetto ed elemento significativo della fattispecie) ma risulta altresì necessaria la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento. E' ben vero che la fattispecie di furto d'uso è unitaria ed unitariamente valutata dal legislatore: in essa, oltre all'effettiva restituzione della cosa sottratta, il dolo dell'impossessamento per lo scopo di momentaneamente usare della cosa altrui e l'intenzione di restituirla immediatamente dopo l'uso sono elementi costitutivi della tipica, attenuata illiceità del furto d'uso, prima ancora di divenire, in sede di colpevolezza, elementi indispensabili per il rimprovero da muovere all'autore del delitto. L'unitarietà e la valutazione unitaria, in sede d'illiceità, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie tipica di furto d'uso, non esclude, tuttavia, che, in sede di colpevolezza, si analizzino i diversi dati, i singoli elementi che contribuiscono a contrassegnare il disvalore oggettivo del tipo: ed è in relazione a ciascuno di tali elementi che va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del fatto per che possa concludersi per la sua personale responsabilità penale. Soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi) si sottraggono alla regola della rimproverabilità ex art. 27, primo comma, Cost. 49 Si è già notato che le due condotte della fattispecie tipica di furto d'uso (sottrarre e restituire) sono diversamente (l'una negativamente e l'altra positivamente) valutate dal legislatore. L'ipotesi della sottrazione e della mancata restituzione della cosa sottratta prospetta, pertanto, due condotte, entrambe negativamente valutate e fra loro strutturalmente distinte. Poiché entrambe contribuiscono ad integrare quella illiceità che, nel l'escludere il furto d'uso, riconduce la medesima a quella del furto comune, per determinare se questo ultimo effetto debba prodursi e indispensabile ravvisare, in relazione a ciascuna delle due condotte (sottrazione e mancata restituzione) gli elementi subiettivi idonei a generare il rimprovero di cui all'art. 27, primo comma, Cost. L'elemento subiettivo attinente alla sottrazione od all'impossessamento della cosa altrui, ed il conseguente rimprovero relativo ai medesimi, non può estendersi alla condotta di mancata restituzione della cosa: il dolo della sottrazione e dell'impossessamento non e estensibile alla mancata restituzione, così come il rimprovero, la disapprovazione eticosociale attinente alla sottrazione ed all'impossessamento non può esser arbitrariamente esteso alla mancata restituzione della cosa sottratta. Detta mancata restituzione, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non e addebitabile al soggetto agente: il caso fortuito e la forza maggiore-non consentendo il rimprovero di colpevolezza, attinente all'oggettiva mancata restituzione della cosa sottratta, non consentendo, cioè, l'addebitabilità d'uno degli elementi che contribuiscono ad integrare la singolare illiceità (che caratterizza l'ipotesi in esame)-impediscono, di conseguenza, il rimprovero, a titolo di furto comune, dell'unitaria predetta ipotesi. Rimanendo, peraltro, dolosi e addebitabili gli altri elementi della fattispecie concreta, va applicato l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. Perché l'art. 27, primo comma, Cost, sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, e indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed e altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati. 6.-Dalla illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., consegue che soltanto un mutamento di volontà del soggetto attivo del fatto in ordine alla restituzione della cosa sottratta può rendere applicabile la disciplina del furto ordinario. Se il reo, sottratta la cosa con lo scopo di momentaneo uso e con l'intenzione, dopo l'uso, d'immediatamente restituirla, successivamente decidesse di non restituirla, all'iniziale contenuto volitivo caratterizzatore del furto d'uso si sostituirebbe altra intenzione, almeno parzialmente contrastante con la prima. Solo in tal caso, tenuto conto della progressione criminosa (da una fattispecie meno grave, peraltro ancora non compiutamente attuata, si passerebbe, in un unico contesto d'azione, alla realizzazione d'una fattispecie più grave) determinata dal mutamento dell'iniziale intenzione del reo, risulterebbero applicabili le sanzioni previste per il furto ordinario. Valutando, da un diverso punto di vista, unitariamente, dato l'unico contesto d'azione, l'ipotesi della mancata restituzione della cosa sottratta dovuta al mutamento dell'iniziale intenzione del soggetto attivo del fatto, dovrebbe osservarsi che-avendo il reo, successivamente al realizzato impossessamento della cosa mobile altrui con il dolo generico del furto ordinario (che coincide con il dolo generico del furto d'uso) integrato il dolo specifico (se di dolo specifico si tratta) del furto ordinario - sarebbe stata completata la realizzazione di quest'ultimo e che, pertanto, l'iniziale intenzione del furto d'uso (scopo di momentaneo uso della cosa sottratta ed intenzione di restituire la medesima immediatamente dopo l'uso) verrebbe assorbito dalla contraria intenzione, successivamente insorta, di non restituire la cosa. E', invece, di certo costituzionalmente illegittimo, nell'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, chiamare a rispondere di furto ordinario il reo del quale e rimasto intatto il dolo, generico e specifico, del furto d'uso, senza che si siano aggiunti diversi, rilevanti contenuti intenzionali. Una volta verificato che l'art. 626, primo comma, n. 1, c.p., nel sistema delle leggi ordinarie e nel diritto vivente, contrasta con il primo comma dell'art. 27 Cost., si rende superflua l'indagine sull'eventuale contrasto della norma impugnata con gli altri parametri indicati nell'ordinanza di rimessione; tanto più che, come si e avuto modo di rilevare, la violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. già di per se comporta disparità di trattamento di soggetti in identica posizione. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88. Francesco SAJA, PRESIDENTE Renato DELL'ANDRO, REDATTORE Depositata in cancelleria il 13/12/88. PROGETTO PRELIMINARE Parte Generale DI *** RIFORMA DEL CODICE PENALE 50 ARTICOLATO approvato dalla Commissione Ministeriale per la Riforma del codice penale nella seduta del 26 maggio 2001 (Omissis) Capo IV. Colpevolezza. Art. 25. Responsabilità colpevole. 1. La colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presupposto indefettibile della responsabilità penale. 2. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non lo ha realizzato con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente previsti dalla legge. 3. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come contravvenzione se non lo ha realizzato con dolo o con colpa. Art. 26. Ignoranza ed errore sulla legge penale. 1. La colpevolezza è esclusa nel caso di errore sull'illiceità del fatto commesso, derivante da ignoranza o errore scusabile sulla legge penale. Art. 27. Dolo. 1. Risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato: a) se agisce con la intenzione di realizzare il fatto, b) se agisce rappresentandosi la realizzazione del fatto come certa, c) se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile. Art. 28. Colpa. 1. Risponde a titolo di colpa chi, con una condotta che viola regole di diligenza, o di prudenza, o di perizia, ovvero regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, realizza un fatto costitutivo di reato che è conseguenza prevedibile ed evitabile dell'inosservanza della regola cautelare. 2. Il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al comma precedente esclude la colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette regole, salvo che il progresso scientifico o tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate. 3. Relativamente agli aspetti non considerati da regole cautelari specifiche, l'adozione di misure di generale applicazione, salvo che esse siano palesemente inidonee, esclude la colpa. 51 Art. 29. Errore sul fatto e sulle cause di giustificazione. 1. Esclude il dolo e, se scusabile, anche la colpa, l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza di elementi del fatto costitutivo del reato, nonché la supposizione erronea della presenza di cause di giustificazione. 2. Costituisce errore rilevante ai sensi del comma precedente anche l'ignoranza o l'errore su qualificazioni giuridiche di elementi del fatto costitutivo di reato, derivante da errore su leggi diverse dalla legge penale violata. 3. L'erronea rappresentazione di un elemento differenziale fra più reati comporta la responsabilità per il reato che l'agente si è rappresentato, se meno grave. Art. 30. Imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti. 1. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa. Art. 31. Delitti aggravati dall'evento. 1. Se la legge ricollega una pena più grave ad una conseguenza non voluta di un delitto doloso, di tale conseguenza si risponde solo se essa è ascrivibile a colpa. Art. 32. Reato contro persona diversa da quella cui esso era diretto. Errore sulla persona dell'offeso. 1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella cui essa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. 2. Nel caso di cui al comma 1, ed in caso di errore sulla persona dell'offeso, sono valutate a favore del colpevole le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole, tranne che si tratti di circostanze che riguardino l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa. 3. Qualora, oltre che l'offesa voluta, il colpevole realizza l'offesa a danno di persona diversa, si applicano le norme sul concorso di reati. Art. 33. Condizioni oggettive di punibilità. 1.Condizioni oggettive di punibilità possono essere previste con disposizione espressa di legge, che utilizzi tale definizione. 2. Al verificarsi di una condizione oggettiva di punibilità non possono essere collegati aumenti di pena. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE ISTITUITA CON D. M. 1 OTTOBRE 1998 (omissis) 52 III. REALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA. 1. Principi generali. L'individuazione del principio di colpevolezza quale uno dei principi fondamentali ed inderogabili del diritto penale costituisce opinione comune in dottrina. La rilevanza costituzionale del principio è stata affermata dalla Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza n. 364/88. L'adeguamento completo al principio di colpevolezza appare obbiettivo fondamentale d'una riforma del codice penale. Per quanto concerne la struttura dell'imputazione soggettiva si ritiene valida la struttura di fondo del sistema vigente, con le modifiche finalizzate alla piena attuazione del principio di colpevolezza, e con una semplificazione tendente ad eliminare disposizioni ridondanti. In questa prospettiva si ritiene di confermare: a) la previsione del dolo e della colpa come forme base dell'imputazione soggettiva; b) l'esclusione della responsabilità penale nel caso di errore o ignoranza di fatto e nel caso di errore o ignoranza incolpevole sull'illiceità del fatto secondo l'indirizzo dettato dalla Corte Costituzionale; c) nell'ambito dei delitti, responsabilità per dolo, salvo l'espressa previsione di figure di delitto colposo; d) nell'ambito delle contravvenzioni (se confermate: v. retro punto II), responsabilità indifferentemente per dolo o per colpa. 2. Dolo e colpa. Le definizioni del codice Rocco hanno contribuito più a far sorgere problemi che ad additare soluzioni. La scelta che si pone in sede di riforma è fra la loro sostituzione con definizioni nuove e più idonee ad orientare la prassi, ovvero la rinuncia a qualsiasi definizione legale, lasciando l'elaborazione degli istituti alla razionalità interna della cultura giuridica. L'opzione a favore di definizioni legislative è ritenuta preferibile per esigenze di certezza del diritto. 2.1. Questioni relative al dolo. Relativamente al dolo (forma più grave di colpevolezza e criterio normale di imputazione soggettiva dei delitti) v'è sostanziale concordia sui tratti fondamentali: dolo significa volontà consapevole di realizzazione del fatto illecito; la consapevolezza deve abbracciare tutti gli aspetti da cui dipende la tipicità penale del fatto commesso. L'ambito problematico, nella teoria e nella prassi, è il c.d. dolo eventuale. Lo schema Pagliaro, con il richiedere (art. 12) una definizione di dolo "univocamente comprensiva del dolo eventuale", si limita ad esprimere l'esigenza che l'imputazione per dolo sia estesa a fatti che l'agente si è rappresentato non in termini di certezza, come conseguenza della propria condotta. In realtà l'esigenza di fondo, in sede di riforma, non è quella di consolidare il già incontroverso ancoraggio normativo della figura del dolo eventuale, ma, al contrario, quella di precisare i limiti di tale forma di dolo: la formula corrente della 'accettazione del rischio' ha carattere essenzialmente retorico, e la prassi applicativa evidenzia il pericolo di slabbramenti della figura del dolo, sia sotto il profilo definitorio, sia sotto il profilo probatorio e applicativo. Si tratta allora di determinare le condizioni minime in presenza delle quali resti fondato il rimprovero di volontaria realizzazione del fatto illecito, ancorchè la previsione dell'evento o (più in generale) la rappresentazione del fatto non siano in termini di certezza. Alla luce dell'esperienza, il legislatore potrebbe utilmente stabilire: a) che occorre comunque, per l'imputazione per dolo, una rappresentazione della realizzazione del fatto tipico in termini di alta probabilità, e non di generica possibilità; b) che l'oggetto della rappresentazione, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, deve essere il fatto realizzato in concreto, e non una generica rappresentazione di qualcosa d'illecito. 2.2. Questioni relative alla colpa. Relativamente alla colpa lo schema di base resta quello della attribuzione di responsabilità per avere realizzato il fatto con inosservanza di regole di comportamento aventi funzione cautelare. Rispetto alla formula del codice Rocco, ed alla prassi che su di essa si è formata, si pongono diversi problemi: 53 a) Individuazione delle regole cautelari pertinenti al giudizio di colpa. Resta valido il modello vigente, nel quale hanno rilievo sia regole 'non formalizzate' (di diligenza prudenza perizia), ricostruibili secondo i criteri della prevedibilità e prevenibilità, sia regole tipizzate a livello normativo (inosservanza di leggi ecc.). b) Questione della prevedibilità: la prevedibilità dell'evento (o meglio, di un fatto del tipo di quello in concreto realizzato) deve o non deve essere considerata un autonomo elemento caratterizzante della fattispecie colposa, non necessariamente assorbito nella violazione della regola cautelare? La rilevanza del tema è bene evidenziata da vicende giudiziarie come quella dei processi relativi a tumori per esposizione ad amianto in anni remoti: l'imputazione per omicidio colposo è sufficientemente fondata sulla violazione di regole cautelari generiche, relative alla esposizione a polveri, o richiede la prevedibilità di eventi di morte da tumore, alla luce delle conoscenze disponibili al momento del fatto? c) Questione della prevenibilità: si può affermare la responsabilità per colpa quando risulti che l'evento non si sarebbe evitato nemmeno tenendo una condotta conforme alla regola di diligenza? d) Metro della colpa. Lo schema Pagliaro propone (art. 12) di formulare la definizione della colpa "in modo che in tutte le forme di imputazione si fondino su di un criterio strettamente personale". L'indicazione, pur poco chiara, sottende l'esigenza di ancorare la colpa ad un criterio non meramente oggettivo. A tal fine è sufficiente il criterio dell'agente modello, diversificato per tipi di attività, o si può (si deve) riconoscere rilevanza a condizioni personali di incapacità? e) Metro della colpa relativamente alle attività professionali: il limite della colpa grave, previsto dal codice civile per le prestazioni professionali di speciale difficoltà, vale anche in materia penale? Con motivazioni apparentemente contrastanti, la prassi recepisce l'esigenza di una delimitazione della colpa per imperizia, che tenga conto delle peculiari difficoltà di certe prestazioni. A livello normativo potrebbe essere espressamente sancito il principio che eventuali limitazioni di responsabilità, previste in altri settori dell'ordinamento, valgono anche per il diritto penale. f) Rischio consentito. Relativamente allo svolgimento di attività pericolose è affermazione comune che i confini del rischio permesso dipendono da un bilanciamento d'interessi: da un lato l'interesse allo svolgimento dell'attività, dall'altro la misura del rischio ad essa connesso (in funzione della natura e della probabilità di eventi lesivi). La concretizzazione di tale bilanciamento rappresenta un punto critico (di incertezza) nella disciplina delle attività pericolose. Rispetto alla colpa, vengono in rilievo sistemi più o meno complessi di regole cautelari formalizzate da leggi, regolamenti ecc.: vi è spazio, ove tali sistemi esistano, per ulteriori riferimenti ai criteri della colpa generica? In via di principio sembra ragionevole tenere ferma la corrente risposta affermativa, con l'avvertenza che il riferimento alla colpa generica non può essere adoperato per spostare le soglie del rischio accettabile che fossero riconoscibilmente individuate dal legislatore con la determinazione di valori soglia o di altri parametri definiti. La criticità del rapporto fra esigenze inderogabili di tassatività del precetto ed esigenze di tutela 'a tutto campo' è bene esemplificata dal tipo di questioni esaminato dalla Corte Cost. 312/96 (rinvio della legge a 'misure tecniche, organizzative e procedurali' necessarie per la riduzione al minimo del rischio rumore) . La soluzione interpretativa proposta dalla Corte (riferimento agli standard generalmente adottati nei diversi settori), volta a salvare la determinatezza del precetto, rischia di disperdere la dimensione 'normativa' propria delle regole cautelari, la cui funzione è di controllo (non dunque di mera convalida) delle prassi. Si pone qui l'interrogativo radicale, se clausole generali come quella della 'riduzione al minimo' di dati rischi possano trovare diretta applicazione in sede penale, senza la mediazione di più puntuali specificazioni da parte di fonti autorizzate, che traducano la direttiva generale in precetti sufficientemente determinati. 3. La disciplina dell'errore. 3.1. L'errore sul precetto. La disciplina dell'errore sul precetto, rimodellata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/88, rappresenta un ragionevole punto d'equilibrio. L'errore (o ignoranza) sull'illiceità del 54 fatto commesso esclude (per vincolo costituzionale) la colpevolezza, se si tratta di errore o ignoranza incolpevole. La questione (su cui v'è contrasto sia in dottrina che in giurisprudenza) se occorra avere riguardo alla consapevolezza dell'illiceità penale o della generica illiceità giuridica, dovrebbe essere risolta nel senso di ritenere sufficiente, per affermare la colpevolezza dell'agente, la possibilità di conoscere l'illiceità giuridica del fatto commesso Andare oltre, verso una più ampia rilevanza scusante dell'errore (anche 'evitabile') sul precetto, rischierebbe di indebolire le condizioni d'efficacia generalpreventiva dell'ordinamento penale, senza che ciò trovi giustificazione in serie esigenze di garanzia dell'individuo da interventi arbitrari della potestà punitiva. L'attribuzione di responsabilità per dolo (cioè secondo la forma più grave di colpevolezza, e con conseguenze sanzionatorie consistenti) appare sufficientemente fondata sulla volontaria realizzazione del fatto, sempre che l'illiceità di questo fosse riconoscibile dall'agente. Resta ovviamente prioritaria l'esigenza di ridurre al minimo lo spazio di credibili errori sull'illiceità mediante una adeguata selezione e formulazione delle fattispecie di reato. 3.2. L'errore sul fatto. La rilevanza dell'errore 'essenziale' sul fatto costitutivo di reato è il riflesso logico dei principi sul dolo e sulla colpa, ed è destinata ad essere riconosciuta anche indipendentemente da una sua eventuale espressa riaffermazione. L'errore sul fatto esclude il dolo, non esclude la colpa se dovuto a colpa, la esclude se incolpevole. Un problema particolare si pone peraltro per l'errore su legge extrapenale, trattandosi di questione controversa, con una contrapposizione fra giurisprudenza e dottrina. In una prospettiva di riforma non interessa tanto prendere posizione su quale sia l'interpretazione corretta del vigente art. 47 u.c., quanto individuare la soluzione preferibile, avendo riguardo innanzi tutto ai vincoli posti dal principio di colpevolezza, e trovare una formulazione normativa capace di trasmettere un messaggio chiaro, superando le attuali incertezze interpretative. Anche se, teoricamente, una norma espressa potrebbe apparire a qualcuno non necessaria, una disciplina specifica sembrerebbe opportuna nella prospettiva della necessità di una correzione della prassi, con un messaggio puntuale in grado di correggere i principi giuridici affermati in materia dalla giurisprudenza, probabilmente per ragioni di semplificazione probatoria. L'obiettivo è di evitare che, in sede applicativa, vengano sottratti alla applicazione dei principi generali tipi di errore che incidono sulla comprensione del fatto, ricadendo su profili giuridici o comunque 'valutativi' da cui dipende la tipicità penale dello stesso. 3.3. Errore sugli elementi differenziali tra più reati ed errore sulle cause di giustificazione. In tema di errore "sugli elementi differenziali tra più reati" la soluzione concordemente ritenuta preferibile (e già leggibile, però non senza incertezze, nel vigente art. 47, 2° comma) è quella della punibilità per il reato meno grave (schema Pagliaro, art. 15). I criteri generali di disciplina dell'errore vanno tenuti fermi anche in materia di errore sulle cause di giustificazione, come già nel sistema vigente (art. 59) e come propone lo schema Pagliaro (art. 15). 4. Eliminazione delle residue ipotesi di responsabilità oggettiva o anomala. 4.1. Linee generali e specifiche della riforma. L'indirizzo di "escludere qualsiasi forma di responsabilità incolpevole" (schema Pagliaro, art. 12) esprime una posizione comune della dottrina, e costituisce la doverosa attuazione di un principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 364/88 e 1085/88). Come è noto, in proposito la Corte ha affermato, in un importante obiter dictum della sentenza n. 364/88, che pur non essendo posto dall'art. 27 Cost. un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, "va, di volta in volta, stabilito quali sono gli elementi più significativi della fattispecie che non possono non essere 'coperti' almeno dalla colpa dell'agente perchè sia rispettata la parte del disposto di cui all'art. 27, primo comma, Cost., relativa al rapporto psichico tra soggetto e fatto". Nel modello delineato dalla Corte, l'inserzione fra i presupposti della punibilità di elementi meramente obiettivi, non toccati dalla colpevolezza dell'agente, potrebbe mantenere un ambito residuale ed eccezionale, all'interno di un sistema nel quale siano comunque assicurate le condizioni dell'imputazione per un fatto illecito colpevolmente realizzato. 55 Dalla funzione garantista del principio di colpevolezza deriva dunque - per vincolo costituzionalel'inaccettabilità dell'imputazione meramente oggettiva di elementi i quali siano a) significativi rispetto all'offesa, nel senso che (anche) da essi dipenda la realizzazione dell'offesa o messa in pericolo dell'interesse protetto, e quindi la riconoscibilità dell'illecito; b) oppure significativi rispetto alla pena, nel senso che da essi venga fatta dipendere la misura della sanzione: in un ordinamento conforme al principio di colpevolezza, condizioni obiettive di maggiore punibilità non possono avere spazio, come del resto il legislatore ha (parzialmente) riconosciuto superando il criterio della rilevanza meramente obiettiva delle circostanze aggravanti. L'unica categoria ammissibile di presupposti 'meramente oggettivi' della responsabilità è ravvisabile in condizioni di punibilità che, accedendo ad un fatto illecito già riconoscibile come tale indipendentemente dalla condizione, delimitino ulteriormente la risposta penale per ragioni 'estrinseche' d'opportunità. Una riforma ispirata ai criteri sopra enunciati dovrebbe comportare: a) la eliminazione di disposizioni (tipo art. 42, 3° comma, del vigente codice) legittimanti forme d'imputazione dell'illecito 'altrimenti' che per dolo o per colpa. b) la modifica della disciplina delle condizioni obiettive di punibilità. La disposizione vigente (art. 44) è una formula tautologica, che equivale ad una sorta di riconoscimento dell'esistenza di condizioni oggettive di punibilità, ma non pone limiti contenutistici espliciti alla possibilità del legislatore di prevedere condizioni 'operanti oggettivamente', e nemmeno indica all'interprete delle disposizioni di parte speciale criteri idonei a far riconoscere le condizioni oggettive, distinguendole da altri presupposti della punibilità. A livello di parte generale, una disposizione sulle condizioni obiettive di punibilità può avere un concreto significato normativo in quanto indichi un criterio di identificazione degli elementi riconducibili a tale categoria. c) l'abrogazione della figura generale della preterintenzione e (anche mediante una clausola abrogativa di carattere generale) delle singole figure di delitti preterintenzionali e di delitti aggravati dall'evento, nelle quali l'imputazione dell'evento aggravante non sia conseguenza prevedibile (colposa) della commissione del reato-base doloso, ma sia fondata sul mero criterio del versari in re illicita. Realizzata questa operazione, si tratta di disciplinare in sede di parte speciale ipotesi di eventi di morte, di lesione o di 'disastro' cagionati involontariamente mediante condotte dolosamente aggressive o pericolose per l'incolumità delle persone o di beni collettivi, previsti espressamente sotto il profilo della responsabilità per colpa, e muniti di un trattamento sanzionatorio adeguato alla peculiare forma di colpevolezza: più grave rispetto alle altre ipotesi di colpa, ma in misura comunque agganciata al carattere colposo dell'evento realizzato. d) l'abrogazione della attuale disciplina (art. 83) della aberratio delicti, con conseguente riconduzione ai principi generali sulla responsabilità per colpa. e) nella parte speciale e nella legislazione penale speciale: a) radicale eliminazione di ogni ipotesi di condizioni obbiettive di maggiore punibilità; b) abrogazione di disposizioni che escludano l'esigenza della colpevolezza con riguardo ad elementi del fatto costitutivo di reato (dai quali dipenda l'offesa o messa in pericolo dell'interesse protetto); c) riforma delle figure di reato (in particolare, dei reati fallimentari) in cui attualmente sia attribuito un ruolo centrale a condizioni obiettive di punibilità o di maggiore punibilità. f) in materia di aberratio ictus: sono stati prospettati argomenti sia per l'eliminazione dell'istituto, con conseguente applicabilità dei criteri generali, sia per il mantenimento della disciplina attuale. 4.2. In particolare sul reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti e sul concorso dell'estraneo nel reato proprio. Sia l'attuale disciplina della responsabilità per reato diverso da quello voluto (art. 116) interpretata secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 42 del 1965), sia la proposta di modifica dello schema Pagliaro (agevolazione colposa del reato realizzato da altri), presentano i medesimi scarti dal modello normale dell'imputazione soggettiva: una responsabilità che strutturalmente è per colpa viene imputata a titolo di dolo, comporta una pena la cui misura è agganciata (sia pure con il correttivo di 56 una forte diminuzione) alla pena prevista per il reato doloso realizzato, e l'ambito della responsabilità strutturalmente colposa copre anche delitti non previsti fra le figure di reato colposo. Tali modelli di disciplina, poco conciliabili con il principio di colpevolezza, non sono nemmeno giustificati da esigenze di politica criminale. L'estensione dell'ambito della responsabilità sulla base della colpa in relazione a fatti non previsti come reati colposi, appare incoerente con la selezione delle figure di delitto colposo operata dal legislatore 'di parte speciale'. La mancata punizione di eventuali contributi colposi alla realizzazione di eventi dolosi, come tali ascritti a responsabilità degli autori, non aprirebbe alcuna lacuna rispetto alle esigenze di tutela generalpreventiva, così come valutate dal legislatore della parte speciale. Con riguardo ad eventi previsti anche come delitti colposi, realizzati dolosamente da altri, è conforme al sistema l'attribuzione di responsabilità a titolo di colpa al partecipe che abbia dato un contributo colposo, con applicazione della pena prevista per il delitto colposo. Un aggravamento di pena, comunque agganciato alla pena base per il delitto colposo, potrebbe essere giustificato (soltanto) quando la condotta di concorso nel reato voluto costituisca una consapevole violazione di una regola cautelare volta a prevenire l'evento realizzato, e siano in gioco interessi di particolare importanza. In concreto, il problema si rivela essere 'di parte speciale': come dimostra la casistica applicativa dell'art. 116 cod. pen., si tratta essenzialmente di assicurare adeguata tutela all'integrità o alla libertà della persona, in relazione a prevedibili sviluppi di azioni esecutive di determinati delitti. Meglio, allora, rinunciare a clausole generali di estensione della punibilità secondo modelli 'anomali', e riportare il problema alla parte speciale. Individuate le situazioni tipiche per le quali si ritenga opportuno intervenire (delitti contro la persona, rapina, eventuali altre ipotesi 'nominate') si potrà provvedere o con la previsione 'mirata' di eventuali figure specifiche di agevolazione colposa, o con circostanze aggravanti speciali, evitando in ogni caso di agganciare le pene per la realizzazione colposa a quelle previste per la realizzazione dolosa. Mentre, se proprio si volesse mantenere una (sostanzialmente inutile) disciplina di carattere generale, essa non potrebbe che riflettere nella fattispecie i principi generali sulla responsabilità soggettiva (ciascuno dei concorrenti risponde nei limiti della sua colpevolezza; se è commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde quando nel suo comportamento sia ravvisabile almeno la colpa, ed il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo). Analogamente, in materia di concorso dell'estraneo nel reato proprio la Commissione, superato il testo proposto dallo schema di legge-delega Pagliaro (non risultando chiaro come si concili la persistente vigenza della fattispecie speciale con il collegamento al principio di colpevolezza), ritiene che l'unico modo di realizzare senza ambiguità il principio di colpevolezza sia di procedere alla abrogazione pura e semplice dell'art. 117 c.p., sottoponendo la disciplina di tale tipo di concorso di persone ai principi generali sulla responsabilità soggettiva. 4.3. Reati a mezzo stampa o radiotelevisione. La vigente disciplina dei reati a mezzo stampa (artt. 57 s.) presenta gli stessi caratteri strutturali dell'art. 116: anche qui un meccanismo 'di parte generale' estende l'ambito della responsabilità sulla base della colpa in relazione ad eventi non previsti come reati colposi nella parte speciale, ed aggancia la pena per un fatto strutturalmente colposo a quella prevista per delitti dolosi. Lo schema Pagliaro (art. 31) si muove nel solco della disciplina vigente, con importanti innovazioni: la considerazione congiunta della stampa e della radiotelevisione; la previsione - quali destinatari della norma penale accanto al direttore o vicedirettore responsabile - di soggetti 'delegati' a svolgere la funzione di controllo; una accentuata riduzione di pena per il caso di omesso impedimento colposo. Il problema concerne sostanzialmente un gruppo delimitato di reati d'opinione previsti nella parte speciale come reati dolosi. Per ciascuno di essi può essere posta autonomamente la questione se sia opportuno estendere la responsabilità penale a soggetti 'garanti', incriminando condotte di mancato impedimento colposo. Un meccanismo 'di parte generale' sottende una risposta globalmente affermativa, e prefigura un modello tendenzialmente accentrato di impresa giornalistica o radiotelevisiva, caratterizzato dalla presenza obbligatoria di poteri di controllo gerarchico. 57 Appare preferibile lasciare la soluzione alla disciplina di singole figure di reato, o ad una organica riconsiderazione della legislazione sui mezzi di comunicazione. Se proprio si ritiene di mantenere un meccanismo unitario nel codice penale, occorre: rendere effettivo l'aggancio al criterio della colpa, prevedere per il mancato impedimento colposo una pena svincolata da quella prevista per il fatto doloso, ed evitare di bloccare, con l'imposizione di un modello di responsabilità necessariamente accentrata al vertice, le opzioni relative alla disciplina dell'impresa giornalistica o radiotelevisiva. 4.4. Le circostanze del reato. Lo schema Pagliaro mantiene il criterio della colpa per l'imputazione delle aggravanti, e lo estende alle attenuanti nel senso di attribuire rilevanza alle attenuanti "supposte per errore non dovuto a colpa". Si tratta d'un adeguamento a esigenze imposte dal principio di colpevolezza, da considerare positivamente. Una compiuta valutazione delle soluzioni prospettabili non può essere tuttavia fatta se non nell'ambito di una revisione complessiva della disciplina delle circostanze, anche con riguardo al profilo sanzionatorio. **** D RELAZIONE ALL’ARTICOLATO DATATO 12 SETTEMBRE 2000 (stralcio) 2. 3. Colpevolezza. 1. Che il principio di colpevolezza costituisca uno dei principi fondamentali ed inderogabili di garanzia del diritto penale costituisce opinione assolutamente pacifica in dottrina. La Commissione ha considerato la realizzazione piena di tale principio fra gli obbiettivi primari della riforma. Realizzare fino in fondo il principio di colpevolezza significa eliminare non soltanto le ipotesi di responsabilità oggettiva, ma altresì le ipotesi di responsabilità anomala, nelle quali la sanzione è commisurata ad un grado di colpevolezza diverso da quello rinvenibile nel soggetto chiamato a rispondere penalmente (es., art. 116 c.p. Rocco, in forza del quale chi ha voluto un reato diverso da quello realizzato da taluno dei concorrente risponde con una pena, sia pure ridotta, prevista per un reato doloso, nonostante che la sua responsabilità si fondi sulla colpa), e bandire per quanto possibile dall'area del diritto penale ipotesi di responsabilità per rischio. In questa prospettiva la Commissione, recependo l'orientamento già imboccato dai progetti Pagliaro e Riz, ma andando oltre le loro indicazioni, nel perseguire l'obbiettivo di salvaguardare sempre la correlazione fra grado di colpevolezza e specifica responsabilità penale cui il colpevole è chiamato a soggiacere ha eliminato la responsabilità oggettiva (art. 42 comma 3 c.p. Rocco) e la preterintenzione (art. 43 comma 2 c.p. Rocco); ha previsto di eliminare i delitti aggravati dall'evento; ha dettato una disciplina diversa delle condizioni oggettive di punibilità; pur non riuscendo ad abolirla del tutto, ha preveduto in una dimensione residuale ridotta la responsabilità penale colposa per omesso od inadeguato controllo sulla stampa e la radiotelevisione (retro, n. 2. 2. 3); ha eliminato l'aberratio delicti, ritenendo sufficiente la disciplina del concorso formale di reati, e cioè la responsabilità per il reato doloso se realizzato, e la responsabilità per il reato diverso a titolo di colpa nei soli casi in cui esso sia previsto come reato colposo; in tema di aberratio ictus ha stabilito che qualora oltre la offesa voluta il colpevole realizza l'offesa a danno di persona diversa si applicano le norme sul concorso di reati, con conseguente responsabilità per la seconda offesa soltanto nel caso in cui essa sia prevista come delitto colposo; ha disciplinato il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti in modo assolutamente coerente alla necessità di una completa correlazione fra colpevolezza e responsabilità; ha abolito la disposizione contenuta nell'art. 117 c.p. Rocco, ritenendo che sia giusto che chi non possiede la qualifica richiesta per la commissione di un reato a soggettività specifica, per risponderne debba rappresentarsi di concorrere con persona che possiede tale qualifica. In coerenza a quanto indicato, la parte concernente l'elemento soggettivo del reato inizia con la enunciazione secondo cui "la colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presupposto indefettibile della responsabilità penale" (art. 28 comma 1). Indicazione netta, che dovrebbe troncare ogni perplessità in ordine ai limiti soggettivi della responsabilità penale. Enunciato nei termini menzionati il presupposto soggettivo indefettibile della responsabilità penale, alla Commissione è d'altronde sembrato che fosse inutile continuare a prevedere la coscienza e volontà della condotta di cui all'art. 42 comma 1 c.p Rocco, ed il caso fortuito, la forza maggiore ed il costringimento fisico di cui, rispettivamente, agli artt. 45 e 46 c.p. Rocco. Esigere la coscienza e volontà della condotta come presupposto indispensabile di ogni forma di responsabilità penale aveva senso in un sistema che prevedeva la responsabilità oggettiva, una forma di responsabilità che, pur essendo 'altro' rispetto al dolo e alla colpa, 58 presupponeva pur sempre la realizzazione di una condotta cosciente e volontaria; enunciato il principio di colpevolezza, e cioè una responsabilità necessariamente ancorata alla presenza del dolo o della colpa, è implicito che la condotta dovrà essere cosciente e volontaria, secondo i contenuti propri dell'uno o dell'altra. Ugualmente inutile è prevedere il caso fortuito, la forza maggiore ed il costringimento fisico. Il primo non significa infatti altro se non mancanza di colpa; il mancato insorgere della responsabilità penale in caso di forza maggiore e di costringimento fisico è a sua volta implicito nella enunciazione del principio di colpevolezza. L'art. 28 commi 2 e 3 enuncia i due corollari del principio di colpevolezza in materia, rispettivamente, di delitti e di contravvenzioni. Con riferimento ai delitti stabilisce che "nessuno può essere punito per tale tipo di reato se non lo ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente preveduti dalla legge"; con riferimento alle contravvenzioni che "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come contravvenzione se non lo ha realizzato con dolo o con colpa". In materia di contravvenzioni non si è ritenuto di prevedere che la realizzazione colposa può dare luogo a diminuzione di pena (così invece il progetto Pagliaro), ritenendosi sufficiente ad adeguare la responsabilità al grado della colpevolezza un impiego corretto dei criteri di commisurazione in concreto della pena. 2. L'art. 29, recependo il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88 in tema di errore sulla legge penale, dispone che "la colpevolezza è esclusa nel caso di errore sulla illiceità del fatto commesso, derivante da ignoranza o errore scusabile sulla legge penale". La Corte Costituzionale aveva parlato di errore 'inevitabile'; coerentemente il progetto Riz parla di errore che non può essere evitato, il progetto Pagliaro parla di errore 'invincibile'. La espressione 'scusabile', con la sua lieve sfumatura di diversità, sottende che l'errore sul precetto penale deve essere valutato secondo lo stesso metro che, in materia di errore sul fatto, corrisponde ai principi sulla colpa, e non secondo un metro più severo. Si tratta dunque di una indicazione tendenzialmente 'ampliativa', coerente con quanto enunciato in linea generale in tema di realizzazione del principio di colpevolezza. E' quasi inutile osservare che, fuori dai casi considerati, l'errore sul precetto penale non esclude la colpevolezza. 3. La Commissione, coerente con la impostazione del documento di base 15 luglio 1999, e considerato il consenso emerso nei confronti di tale orientamento, ha definito le nozioni di dolo e di colpa. La definizione del dolo 'risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato: a) se agisce con la intenzione di realizzare il fatto, b) se agisce rappresentandosi la realizzazione del fatto come certa ovvero come altamente probabile' (art. 30), risponde alla esigenza di procedere ad una formulazione in grado di identificare le diverse possibili gradazioni del dolo. Il dolo intenzionale, interamente coperto dalla volontà dell'agente (che vuole la condotta e agisce con la intenzione di realizzare il reato); il dolo diretto, che si verifica quando l'agente vuole la condotta, rappresentandosi come certa (e quindi implicitamente volendo) la realizzazione del reato; il dolo eventuale, in cui l'agente vuole la condotta ma non si rappresenta come certa la realizzazione del reato. Il punto più delicato della disciplina enunciata riguarda la configurazione del dolo eventuale (che il progetto Pagliaro aveva giustamente indicato come oggetto necessario di esplicita considerazione, ma non aveva specificamente definito) data la varietà di opinioni esistenti in dottrina e le oscillazioni rinvenibili nella prassi giudiziaria. La Commissione, escluso di utilizzare formule inutilmente complicatorie talvolta affiorate in dottrina, ha ritenuto di confermare l'orientamento già enunciato nel documento di base 15 luglio 1999, e cioè che agli effetti della realizzazione della ipotesi marginale di dolo occorre una rappresentazione della realizzazione del fatto (ovviamente il fatto realizzato in concreto, e non una generica rappresentazione di qualcosa di illecito) in termini di probabilità. La indicazione della probabilità come 'alta', scelta dopo ampia discussione, tende a qualificare il dolo in termini restrittivi, opponendosi alle tendenze, non estranee alla giurisprudenza, a dilatare l'area del dolo eventuale sulla base di una generica previsione dell'evento come possibile. La aggiunta 'accettandone il rischio', pur nella consapevolezza della sostanziale superfluità della specificazione, è stata inserita, dietro suggerimento di taluni commissari, da un lato per sottolineare ulteriormente, con una formula retorica comunque ricorrente nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, la necessità che la rappresentazione in termini di probabilità deve essere davvero qualificata; dall'altro per sottolineare che il dolo eventuale è comunque cosa diversa dal dolo diretto, dove non ci si accontenta di una accettazione di rischio, ma si esige la prova della certezza del verificarsi dell'evento. La Commissione auspica che con queste specificazioni risultino superate le obbiezioni di perdurante incertezza da un lato, e di rischio (parlando di 'alta' probabilità) di confondere dolo eventuale e 59 dolo diretto dall'altro, prospettate dalle Commissioni della Cassazione e della Procura Generale nei loro pareri al documento di base 15 luglio 1999. La Commissione non ha ritenuto di dare spazio alla indicazione del progetto Pagliaro secondo cui la definizione di dolo doveva 'esprimere in ogni caso la necessità del significato del fatto'. A prescindere dalla difficoltà di interpretare espressioni quali 'significato' del fatto, si è osservato che la circostanza secondo cui la legge penale non è applicabile a fatti che non determinano una offesa del bene giuridico (art. 3 comma 2) implica che il soggetto, per rispondere a titolo di dolo, deve volere e/o rappresentarsi comunque un fatto concreto dotato di offensività, e che questa volontà e/o rappresentazione è sufficiente ad esprimere la volontà dolosa penalmente rilevante. La Commissione si è posta infine il problema se fosse necessario enunciare regole particolari in materia di dolo dei reati commissivi mediante omissione. Essa ha escluso che con riferimento a tale categoria di reati abbia senso negare rilevanza al dolo eventuale (come sembrerebbe suggerire la Commissione della Procura Generale nel suo parere), perché esso bene si concilia con numerosi casi di reati causalmente orientati (si pensi, fra i tanti prospettabili, a quello della infermiera cui sia stato affidato un paziente, che omette di somministrargli medicine prescritte rappresentandosi come altamente probabile che ne potrà scaturire una lesione personale). E si è piuttosto domandata se fosse opportuno richiedere esplicitamente il dovere di rappresentarsi la situazione di obbligo giuridico di impedire l'evento che costituisce presupposto perché la omissione acquisti efficacia causale. Dopo avere in un primo tempo prospettato una norma di questo tipo, ha valutato che essa sarebbe stata inutile, in quanto la soluzione è comunque desumibile dalla disciplina generale del dolo e dell'errore. 4. In tema di colpa il documento di base poneva una serie di interrogativi: scontato che la colpa consiste nella inosservanza di regole cautelari codificate o non codificate, si può ritenere esistente colpa, sulla base di un normale concetto di diligenza, imprudenza, imperizia (prevedibilità), anche in ipotesi di osservanza delle regole cautelari scritte? E' sufficiente, per valutare la colpa, il riferimento al criterio oggettivo dell'agente modello, diversificato per tipi di attività, o si può (o deve) riconoscere rilevanza a condizioni personali di incapacità? In materia di colpa professionale è opportuno introdurre il limite della colpa grave previsto dal codice civile? Quid iuris in materia di colpa nelle attività pericolose, dove la evidente insufficienza del criterio della prevedibilità ha indotto la prassi a cercare un difficile bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse allo svolgimento della attività e la misura del rischio consentito in funzione della natura e probabilità del verificarsi di eventi lesivi? Nello stendere l'articolato si è dovuto ovviamente rispondere a questi interrogativi. La formula proposta è la seguente (art. 31 comma 1): "risponde a titolo di colpa chi, con una condotta che viola regole di diligenza, o di prudenza, o di perizia, ovvero regole cautelari stabilite da leggi regolamenti, ordini o discipline, realizza un fatto costitutivo di reato che è conseguenza prevedibile ed evitabile dell'inosservanza della regola cautelare". La norma riecheggia elementi presenti nella definizione di cui all'art. 43 comma 3 c.p. Rocco. Si discosta tuttavia da tale definizione in più punti significativi: - innanzitutto la colpa generica e la c.d. colpa specifica vengono unificate dal riferimento, in entrambi i casi, al concetto della 'violazione di regole'; - si parla specificamente di regole 'cautelari', allo scopo di evitare (sempre possibili) allargamenti arbitrari delle regole la cui inosservanza può fondare la colpa (l'aggettivo 'cautelare' è stato formulato con riferimento alla sola colpa specifica, in quanto è implicito che la violazione in cui si sostanzia un comportamento negligente, imprudente o imperito sia violazione di una regola sociale di doverosa cautela); - si fa specifico riferimento alla realizzazione di un fatto costitutivo di reato che è conseguenza 'prevedibile ed evitabile dell'inosservanza della regola cautelare'. In questo modo si sottolinea da un lato espressamente che a fondare la colpa non è sufficiente la prevedibilità, ma occorre anche la evitabilità del reato; si chiarisce dall'altro che il fatto, per risultare colposo, deve essere conseguenza della inosservanza della regola cautelare. I commi 2 e 3 dell'art. 31 cercano di dare risposta ad alcuni problemi inerenti alla disciplina di attività pericolose: tema cruciale nell'ambito della colpa, su cui la Commissione ha discusso approfonditamente, concludendo per l'inutilità di formule generiche, che sostanzialmente sarebbero di mero (superfluo) rinvio al criterio del bilanciamento d'interessi su cui fanno leva la dottrina e la giurisprudenza. Indicazioni concrete sono invece state ritenute possibili ed opportune con riguardo a questioni specifiche connesse alla previsione - o alla assenza di previsione - di regole cautelari specifiche. L'art. 31 comma 2 affronta il problema se il rispetto delle regole cautelari scritte, dove esistenti, sia sufficiente ad escludere la colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette regole. Recependo considerazioni sviluppate dal parere espresso dalla Commissione della Cassazione sul documento di base 15 60 luglio 1999, il progetto accoglie il punto di vista secondo cui la regola cautelare scritta è comunque cristallizzazione normativa di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo, per cui normalmente la prevedibilità non può non ritenersi necessariamente assorbita nella violazione delle regole cautelari scritte, e il rispetto di queste costituisce, in via di principio, adempimento idoneo del dovere di diligenza nello svolgimento dell'attività regolata. Questa statuizione, che molti (ma non tutti) ritengono desumibile già dal diritto vigente, dovrebbe ridurre le incertezze nello svolgimento - e nella valutazione - di attività pericolose che siano state opportunamente fatte oggetto di una disciplina specifica di settore. E' parso peraltro necessario prevedere una limitata eccezione alla regola, per il caso, teoricamente non impossibile, che a causa del progresso scientifico e tecnologico le regole enunciate siano divenute obsolete. Si è perciò previsto che "il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al comma precedente esclude la colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette regole, salvo che il progresso scientifico e tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate". L'art. 31 comma 3 concerne il problema della disciplina di attività che richiedono l'adozione di cautele, nell'ipotesi di inesistenza di regole cautelari formalizzate. Tali lacune di disciplina dovrebbero essere evitate, o comunque ridotte al minimo da un buon legislatore; d'altra parte, non appare ragionevole equiparare la eventuale mancanza di regole specifiche ad indifferenza rispetto alla tutela dei beni giuridici in gioco. Con tutti i rischi di insufficiente determinatezza che ciò comporta, è giocoforza trovare soluzioni sul terreno della colpa generica. Secondo la soluzione prospettata, "relativamente agli aspetti non considerati da regole cautelari specifiche, non può essere ascritta a colpa l'adozione di misure di generale applicazione, salvo che esse siano riconoscibilmente inidonee". Questa soluzione, con il dare rilievo agli standard in concreto adottati nei diversi settori in un determinato momento storico, si muove nel solco delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 312/96, senza peraltro disperdere la dimensione normativa (non riducibile a mero dato della prassi) delle regole cautelari: la rilevanza delle prassi restando infatti condizionata ad una valutazione di non inidoneità. Quanto al problema se il limite della colpa grave stabilito dal codice civile per le prestazioni professionali, che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la Commissione, dopo ampia discussione, ha ritenuto opportuno non riprodurre una disposizione analoga a quella dettata dall'art. 2236 cod. civi., contrariamente a quanto previsto nel disegno di legge Riz, nel quale è contenuta una esplicita limitazione della responsabilità penale alla imperizia grave. Sarà compito della dottrina e della giurisprudenza specificare i limiti del grado di colpa per le ipotesi di prestazioni professionali, assumendo come necessari punti di orientamento il principio di unitarietà dell'ordinamento e le esigenze di coerenza interna del sistema, nella consapevolezza che, in mancanza di tali parametri di riferimento, le scelte interpretative risulterebbero contraddittorie e non ragionevoli, dato che si ammetterebbe l'illiceità penale di condotte colpose, qualificate da imperizia lieve, che, non costituendo illecito civile, non possono rappresentare titolo per i risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile nel processo penale. Peraltro, affidabili e convincenti indicazioni interpretative - seguite da talune decisioni, anche recenti, della Corte di cassazione - sono state offerte, nella materia in esame, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 28 novembre 1973, con cui la coerenza del sistema è stata assicurata precisando che il limite della colpa grave ex art. 2236 cod. civ. concerne unicamente l'imperizia e non anche l'imprudenza e la negligenza. Il problema del metro di valutazione della colpa è stato oggetto di discussione particolarmente ampia. - Una parte della Commissione ha insistito nel rilevare la correttezza della posizione espressa (genericamente) dal progetto Pagliaro, secondo il quale occorrerebbe "formulare la definizione della colpa in modo che in tutte le forme di essa l'imputazione si fondi su di un criterio strettamente personale". - Pur condividendo in linea di principio tale enunciato, la Commissione ha incontrato difficoltà ad enunciare una regola scritta che fosse in grado di individuare una linea di equilibrio di tipo generale fra la esigenza di configurare comunque un modello ideale cui ancorare il giudizio di riprovevolezza soggettiva, ed il grado di concretezza 'personalistica' del modello stesso. In particolare, è stata respinta la proposta di introdurre un'ipotesi di inesigibilità in concreto del seguente tipo: 'la colpa è esclusa, nonostante l'oggettiva inosservanza della regola cautelare, quando l'agente si è trovato costretto ad agire, senza sua colpa, in una situazione eccezionale di panico o di fortissimo stress emotivo, tale da rendere inesigibile l'osservanza della regola'. Alla maggioranza della Commissione una simile formulazione è sembrata introdurre profili di incertezza e discrezionalità applicativa incompatibili con il principio di stretta legalità. 61 5. In tema di errore che esclude il dolo e, se scusabile, anche la colpa, si è confermata la linea di fondo della disciplina del c.p. Rocco, introducendo tuttavia alcune significative modifiche formali tendenti a rendere più esplicito, e conseguentemente più chiaro, il contenuto dell'articolato. In questa prospettiva: - sono stati trattati congiuntamente l'errore sul fatto e l'erronea supposizione di cause di giustificazione, così da evidenziare l'assoluta identità della disciplina delle due ipotesi; - si è precisato che 'esclude il dolo, e se scusabile anche la colpa, l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza di elementi del fatto costituivo del reato, nonché la supposizione erronea della presenza di cause di giustificazione" (art. 32 comma 1), allo scopo di evidenziare esplicitamente l'efficacia specifica dell'errore di fatto; - in materia di errore sulla legge extrapenale si propone una modifica del testo normativo, allo scopo di rendere evidente che è applicabile a tale tipo di errore l'intera disciplina dell'errore di fatto (e pertanto anche la sua possibile fonte di responsabilità per colpa, se inescusabile), e soprattutto di cercare di superare finalmente la tenace interpretazione giurisprudenziale che attraverso il principio della incorporazione della norma extrapenale in quella penale ha abrogato di fatto l'art. 47 ult. cpv. c.p. Rocco. In questo senso, dovrebbe ritenersi inequivoca la formula adottata nell'art. 32 comma 2; essa chiarisce che "costituisce errore rilevante ai sensi del comma precedente l'ignoranza o l'errore su qualificazioni giuridiche di elementi del fatto costitutivo di reato, derivanti da errore su leggi diverse dalla legge penale violata". Si confida in questo modo di avere esplicitato in maniera sufficientemente univoca la volontà di dare rilievo ad ogni ipotesi di errore sulla legge extrapenale che determini un errore sul fatto (più specificamente, sulle qualificazioni giuridiche che caratterizzano i c.d. elementi normativi). La specificazione "leggi diverse dalla legge penale violata" serve altresì a chiarire che nel concetto di legge extrapenale rientrano anche le leggi penali richiamate da quella penale incriminatrice del reato del cui dolo si discute. In conformità a quanto già indicato dal progetto Pagliaro, l'art. 32 comma 3 chiarisce che l'erronea rappresentazione di un elemento differenziale fra più reati comporta la responsabilità per il reato rappresentato soltanto se esso è meno grave, poiché non è consentito addebitare ad un soggetto fattori di maggiore gravità ai quali non corrisponde una loro reale realizzazione. 6. L'art. 33 prevede una disciplina della imputazione soggettiva delle circostanze diretta a salvaguardare anche nei confronti di tali elementi la applicazione del principio di colpevolezza. Riproducendo quanto già oggi disposto dall'art. 59 comma 2 c.p. (come modificato dalla legge n. 19/90), prevede che "le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa". La Commissione in un primo tempo aveva pensato di distinguere la disciplina dell'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti ad effetto ordinario e di quelle ad effetto speciale. Rilevata l'eccessiva complicazione di tale normativa, ha preferito ribadire la disciplina unitaria, auspicando tuttavia nel contempo che in sede di redazione della parte speciale si proceda ad una drastica riduzione delle circostanze ad effetto speciale, optando per quanto possibile per la configurazione di titoli autonomi di reato. 7. Nonostante il diverso avviso di qualche commissario, la Commissione ha deciso di mantenere la previsione della aberratio ictus soprattutto per ragioni di chiarezza: evitare che, in assenza di una disciplina dell'istituto, in caso di realizzazione del reato in danno di persona diversa da quella cui l'offesa era diretta dottrina e giurisprudenza rischiassero di invischiarsi in complesse questioni interpretative in ordine allo specifico tipo di responsabilità cui tale situazione avrebbe dovuto dare luogo. Poiché deve essere chiaro che in caso di offesa diretta contro una persona, e che si realizza invece nei confronti di persona diversa a causa di errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, il soggetto deve rispondere, e soltanto, per il reato che ha voluto e di fatto ha realizzato sia pure a danno di persona diversa (voleva cagionare la morte di una persona, e la ha comunque cagionata: responsabilità penale per omicidio volontario), si è appunto ritenuto opportuno riproporre la norma prevista nel comma 1 dell'art. 82 c.p. Rocco (art. 34 comma 1). Il comma 2 dell'art. 34 si richiama, per i casi di aberratio ictus e di errore sulla persona dell'offeso, alla disciplina prevista dall' art. 60 c.p. Rocco. Il comma 3 dell'art. 34 prevede una rilevante novità dispetto alla disciplina di cui all'art. 82 comma 2 c.p. Rocco. Allo scopo di eliminare ogni scarto tra responsabilità penale e colpevolezza dispone che "qualora oltre che l'offesa voluta, il colpevole realizza l'offesa anche a danno di persona diversa, si applicano le norme sul concorso di reati". Il che significa che della offesa a persona diversa il colpevole risponderà soltanto se il fatto è preveduto come reato colposo, e con la pena prevista per tale reato, calcolata secondo i principi del cumulo giuridico previsti in materia di concorso formale di reati. 62 8. Eliminato l'art. 44 c.p. Rocco, tautologico in quanto è ovvio che una condizione, se 'oggettiva', si applica indipendentemente dalla eventuale volontà e rappresentazione da parte dell'agente, la Commissione si è preoccupata di circondare di cautele formali l'eventuale ricorso a un tale istituto, che per sua natura pone problemi di compatibilità con il principio di colpevolezza. Ad esigenze, ad un tempo, di certezza applicativa e di delimitazione garantista guarda la formula dell'art. 35 comma 1, secondo cui "condizioni oggettive di punibilità possono essere previste con disposizione espressa di legge, che utilizzi tale definizione". Alla luce di questa disposizione generale, se mancano le menzionate indicazioni l'elemento dovrebbe essere, interpretativamente, considerato costitutivo essenziale del reato. La Commissione non ha ritenuto di specificare che la condizione oggettiva deve consistere in elemento estraneo all'oggetto della tutela penale (come aveva invece previsto il progetto Pagliaro), facendo affidamento sui vincoli costituzionali posti al legislatore dalla rilevanza costituzionale del principio di colpevolezza. E' ovvio, infatti, che tale principio risulterebbe violato, ove mai il legislatore prevedesse condizioni oggettive di punibilità che interferissero significativamente con il bene giuridico tutelato. L'art. 35 comma 2 risponde all'esigenza di evitare che attraverso una sorta di scambio delle etichette si sottraggano i presupposti di aumenti di pena ai principi di imputazione soggettiva. Non essendo prevista la categoria delle 'condizioni di maggior punibilità', si stabilisce che se alla sussistenza di un determinato elemento di fattispecie dovesse risultare collegato un aumento di pena, in via interpretativa esso dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante, ed essere di conseguenza soggetto alla disciplina di cui all'art. 33. erapeutica e degli interventi chirurgici, che era stata invece prevista dal progetto Pagliaro. RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DI RIFORMA DEL CODICE PENALE Parte Generale, nel testo riveduto tenendo conto del dibattito novembre 2000-maggio 2001 sul testo originario del progetto preliminare (Omissis) 4. Recependo le osservazioni critiche enunciate nei confronti della formulazione del dolo eventuale, centrate soprattutto sulla utilizzazione del concetto di "accettazione del rischio" a fianco della indicazione del livello della rappresentazione del fatto in termini di "alta" probabilità, si è definito il dolo eventuale come il dolo di chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato "se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile" (art. 27 lettera c, sostitutivo dell'originario art. 30 lettera b seconda parte). Anche se pure questa formulazione potrà dare adito a critiche, essa presenta comunque il vantaggio di centrare il concetto del dolo eventuale sulla accettazione del fatto rappresentato in termini di mera probabilità. 5. In tema di colpa la Commissione, pur concordando con le osservazioni di chi ha sostenuto che non si sono adeguatamente affrontati a livello legislativo nodi fondamentali come quello della personalizzazione del concetto di colpa, e soprattutto della colpa nelle attività pericolose, non è stata in grado, anche nella assenza di convincenti proposte concrete di disciplina legislativa alternative a quella configurata, di colmare le lacune denunciate, preferendo affidarsi, come già si era rilevato nella Relazione all'articolato originario, alla elaborazione giurisprudenziale. Essa si è pertanto limitata a prevedere, nel comma 3 dell'art. 28 (art.31 nel testo originario dell'articolato), una formulazione orientata a maggiore chiarezza. 6. Rilevato che sarà inevitabile prevedere nella parte speciale sia pure limitate ipotesi in cui il legislatore ricollega una pena più grave ad una conseguenza non voluta di un delitto doloso, si è introdotto un articolo (delitti aggravati dall'evento) nel quale, in conformità al principio di colpevolezza, si è espressamente previsto che "di tale conseguenza si risponde solo se essa è ascrivibile a colpa" (art. 31 nuovo articolato). 63
Scaricare