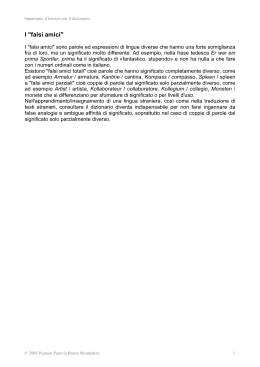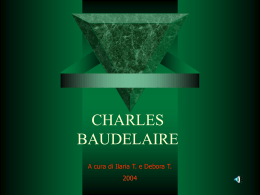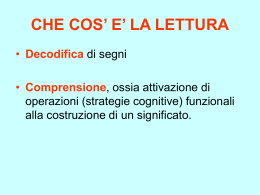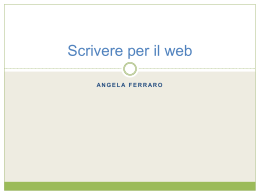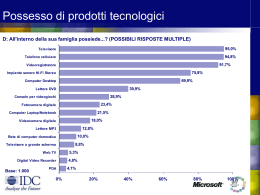OPERA PRIMA, POESIA, VIVIANA FRASCHI Vincenzo di Maro presenta l’opera prima di Viviana Faschi LO SPLEEN DI MILANO SUPERMARKET OCCIDENTE, SEMPRE APERTO Viviana Faschi, un’opera prima Capita che il titolo di un libro suggerisca qualche suo illustre precedente. Perciò si può pensare che le ragioni che hanno indotto Viviana Faschi, autrice di “Lo spleen di Milano”, a scegliere un titolo tanto allusivo, siano quelle di un’accorta propaganda. Sfogliando questo scarno libretto di prose poetiche si cambia però idea quasi subito. Qui non si tratta dell’egotismo di uno scrittore alla sua opera prima: lo spirito guida di “Lo spleen di Milano” non è tanto, il Baudelaire dello “Spleen di Parigi”, quanto, per toni e stile, attraverso il poeta francese, quello del suo esegeta più eterodosso e acuto, Walter Benjamin. Citazione non scontata, quindi, come a prima vista sembrerebbe: vanno ascritte anzi alla Faschi una spiccata capacità autoanalitica e una chiara riflessione sulle proprie ragioni compositive. Come già il suo mitico antenato parigino, Lo spleen di Milano induce a cauti rilievi. Ad esempio, l’umbratile sequela di scene sospese tra l’intimistico e l’urbano che compongono il libro: perché per esse scegliere un tipo così raro di lettore, quel baudelairiano hipocrite lecteur che, appunto, Benjamin nel suo saggio teorizzava e che sanciva, per sua propria esistenza, la marginalità della poesia moderna? In fondo, nel nostro Paese il genere evoca la più elegante tradizione novecentesca, il rondismodi Cecchi e Cardarelli. E’ lo stesso libro della Faschi, proprio attraverso Benjamin, a rispondere. Ciò che infatti caratterizza l’esperienza di Lo spleen di Milano è il modus che la lirica contemporanea nella sua fase inaugurale coglie: la reiterazione, cioè, dello choc negli spazi urbani. Proprio choc e nuovo urbanesimo industriale sono la condicio sine qua non dell’uomo contemporaneo e del suo modo di percepire lo spazio. (…) Fammi perdere dove non avrò più nome. Nelle periferie di multisala, Ikea, centri commerciali strapieni di nulla. (…)[i] E’ che, come il pensatore berlinese insegna, nella vita dell’uomo moderno, l’accadimento non diviene mai esperienza se non al prezzo di una simulazione: un volontario obnubilamento dello sguardo e, con esso, la rinuncia alla verità dei fatti. Allo stesso Baudelaire la città appariva un fondale appena abbozzato, inadeguato alla magnitudo dei sentimenti e delle riflessioni dell’uomo pre moderno. Pare che i contemporanei non reggessero lo sguardo di Baudelaire. Nei suoi occhi si apriva loro un abisso di vacuità: tollerarla è sempre stata faccenda da pochi eletti. Hanno qui buon gioco alcuni passi esemplari del libro della Faschi: “San Satiro mi ha ingannato, anche se conoscevo l’inganno, mi ha portato nel profondo delle due dimensioni, mi ha fatto credere di sprofondare restando alla superficie.”, ammette il narratore. “Non è forse la migliore delle fantasmagorie, la più adrenalinica delle giostre, la profondità illusoria? Non è (…), la critica temuta solo per gioco?”[ii] Attraverso Benjamin, altri numi tutelari: Debord, ma anche Lacan. La deriva debordiana e la filosofia di matrice greca (buoni studi e privata fascinazione dell’autrice) sono qui tutt’uno, in un modo che potremmo definire eccentrico. Nella prima si sperimenta, infatti, l’anacronismo della seconda: l’uomo tragico diviene qui farsesco; non può che consentire un ripetuto straniamento, un costante perdersi al largo della città. E in fondo, poi, la figura del flaneur parigino non anticipava le derive di Debord? Così la La jouissance lacaniana: declinata sul piano urbano, essa diventa l’unica possibile opportunità di fruizione dello spazio cittadino, ma al costo di una strana permuta allegorica, laddove al sesso e alle sue proibizioni si sostituiscono storia e tradizione. Solo infrangendo il tabù della Storia, in specie quella che ha determinato la nascita della città moderna, infatti, si può rendere duttili al desiderio, quasi ectoplasmatiche le quinte della città, in questo caso quella meneghina. Quinte che divengono perciò nuovamente ospitali, disposte ai privati voleri dell’individuo. La città diventa allora pura concrezione del piacere e dell’immaginario: ma in una forma di continua delusione, poiché in essa agiscono potenti ma evasivi fantasmi di storia urbana antica e recente; così come le architetture diventano fluide, anche se dense di rimandi: sagome di un carosello crepuscolare, vertiginoso e talvolta solenne. “L’ho visto snodarsi dal cielo e pareva dotato di coerenza, con grazia ordinata si infittiva, si complicava.(…) Però Lui, il labirinto, dal canto della sua etimologia non così semplice, era tutt’altro: molto di meglio e molto di peggio. E io camminavo sempre più velocemente, in automatico(…). Ma non trovavo. Erano corridoi d’albergo antico ad Assisi, era un centro commerciale la domenica da bambina, era una rete metropolitana straniera.”[iii] Ecco che l’io sperimenta la definitiva perdita dell’aura, la decadenza del poetico alla condizione di prodotto. Così ogni “esperienza vissuta” si pavoneggia nelle vesti dell’esperienza (per dirla con Benjamin)[iv], ma senza mai riuscire a raggiungerla. Essa è destituita di qualunque senso stabile, impalpabile e bardata, com’è, delle viete vesti della tradizione. Perché, direbbe ancora il Berlinese, “Con spavento il malinconico vede la terra ricaduta nel nudo stato di natura”[v]. Ma in essa simulacri e templi del consumo non sono soltanto adombrati: diventano essi stessi oggetto di sparizione, una scenografia deperibile e presto consunta. “McDonalds di Piazza Cordusio, quando esisteva, (…)”[vi] Come non pensare ancora allo spaesato Baudelaire che si aggira tra le Tuileries, alla nostalgia per una Parigi che non esiste più, alla forma di ogni città, che cambia, [vii]“plus vite, hélas! que le coeur d’un mortel”. Come l’esperienza, anche la memoria, perciò, nella sua chiave moderna, è imprevista e del tutto involontaria: ma diventa (nei tipici cortocircuiti di questo breve e facondo libriccino per Milano), stranamente consapevole; poco padroneggiata, eppure riconoscibile ogni volta che accade. La Faschi sa scegliere con accortezza i suoi riferimenti. L’io narrante non solo indirizza il lettore verso la poetica dello straniamento e dello choc (che nascono, lo ripetiamo, dall’urbanesimo industriale di metà ottocento), ma si interroga sulla materiale possibilità di una lettura di sé: lo fa nei noti e reiterati schemi della contemporanea vulnerabilità. Il viaggiatore urbano, come già Poe insegnava, è alla deriva, quasi privo di pelle, esposto com’è ai colpi della strada. “Ma chi sono, dimmi, le figure del Duomo, tutte germinate, radicate a Mariae Nascenti (…) brulicante, tumorale, una colonia umana.” [viii] Una folla da cui emergono talvolta, in una sorta di resistenza all’oblio, alcuni esemplari figuranti, (cos’altro, il venditore di braccialetti africano, se non l’ironico residuo del baudelairiano esotismo a buon mercato…); figuranti che prendono tutta la scena, ma che, a ben vedere, hanno il rilievo di labilissime immagini psichiche, che costituiscono un passeggero orgoglio dell’io estetizzante: il quale, peraltro, cerca di attrezzarsi e difendersi come può, mediante un collaudato meccanismo di subitanea disillusione. Orgoglio intellettuale, quindi, ma anche disincanto e rinuncia. Qui l’autrice, però, con imprevedibile scarto sembra confidare in un coinvolgimento del lettore quia absurdum: la sua sicura assenza si muta, per il narratore, in un rovesciamento sostanziale. Rispetto al Baudelaire poeta della modernità, la fiducia di “Lo spleen di Milano” sta in questo: in una specie di lettore–cittadino, che abiti all’occasione il libro o la città, ma con somma attenzione; che abbia a cuore (ed è già un controsenso) la città consumista e reificata; un lettore che anteponga, ai piaceri sensibili, quelli dell’intelletto; un lettore, infine, che sappia cos’è lo spleen e, ciò malgrado, sia ricettivo e vigile. Perché la scommessa è questa: forse non è più il tempo dei lettori “ipocriti”, ma dei lettori. Strana parola, spleen: inattuale e nuovissima, il decisivo ostacolo che tocca superare. Chissà non si rivolga a questo potenziale ricevente, la Faschi, quando scrive: “Non ho mai avuto paura di perderMi. Ho sempre avuto paura di trovare, trovare qualcuno che non eri tu, al tuo posto.” [ix] Scommettere in un simile lettore basta e avanza a fare dello Spleen di Milano un libro coraggioso.
Scaricare