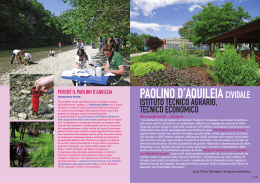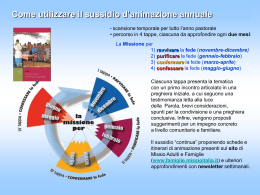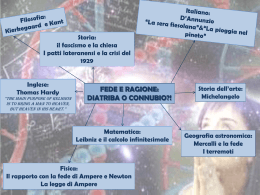IMPEGNO E DIALOGO / 14 1 2 BIBLIOTECA DIOCESANA S. PAOLINO SEMINARIO - NOLA IMPEGNO E DIALOGO 14 INCONTRI CULTURALI 2000-2002 Contributi di: Gianfranco Ravasi, Franco Pastore, Carlo Greco, Piero Casillo, Bruno Forte, Pino M. De Stefano, Antonino F. Lanza, Rachele Sibilla, Ciro Riccio, Giuseppe Mollo, Antonia Solpietro, AntonioV. Nazzaro, Giovanni Santaniello Edizioni LER 3 © - Proprietà riservata Libreria Editrice Redenzione direzione e vendita: MARIGLIANO (NA) Corso Umberto I, 70 Tel. 081.885.42.06 E-mail: [email protected] - Sito Web: www.netgroup.it/ler 2003 Stampato nella Scuola Tipo-Litografica «Istituto Anselmi» di Marigliano (Napoli) - Tel. 081.841.11.76 4 E-mail: [email protected] INTRODUZIONE Questo XVI Volume degli Atti, frutto del diuturno impegno dei suoi nove settori, costituisce la testimonianza concreta dell’attività culturale che la nostra Biblioteca continua a svolgere a sostegno dell’azione pastorale della nostra chiesa locale. E per meglio contribuire all’opera di evangelizzazione della cultura del nostro popolo, dopo venticinque anni di attività, su richiesta del nostro Vescovo Beniamino Depalma, siamo usciti dalle vetuste mura del nostro Seminario: intendiamo avvicinarci di più, anzi “farci prossimi” alle tante associazioni e realtà culturali presenti ed operanti sul nostro territorio. E come primo approccio ci siamo portati a Pomigliano d’Arco, ospiti dell’associazione culturale “Giorgio La Pira”; quindi ci siamo trasferiti a S. Giuseppe Vesuviano, presso le Suore di Cristo Re, per presentarvi il Volume XIII degli Atti della Biblioteca. Un esperimento, questa sortita, che è risultato del tutto interessante e positivo e che intendiamo senz’altro continuare. Il presente Volume contiene numerosi interventi – non tutti, in verità – che i coordinatori dei diversi settori della Biblioteca hanno promosso in questo biennio 2000-2002. E così come sempre, anche adesso la nostra attività ha prestato particolare attenzione agli eventi della Grande e della Piccola Storia, cercando di sintonizzarsi il più possibile con essi. Pertanto, saldamente radicati nel nostro passato, noi ci siamo protesi verso il futuro. Ed anche in questo frammento di tempo, che ha attraversato la nostra esistenza, noi abbiamo tenuto un occhio ancora rivolto al grande evento del Giubileo di purificazione e di rinnovamento spirituale appena trascorso, mentre con l’altro ci siamo immersi nel futuro ormai fatto presente del Terzo Millennio. Con un siffatto atteggiamento interiore abbiamo potuto affrontare e seguire da vicino le tappe del percorso dell’uomo da sempre “pellegrino dell’Assoluto”. 5 In questo arduo cammino di individuazione e di chiarimento delle linee direttrici e delle coordinate della nostra storia, da una parte, abbiamo considerato ed osservato con crescente perplessità l’evolversi e la maturazione della convulsa situazione politica dell’Italia, alle prese con partiti di ispirazione cattolica militanti in ordine sparso e completamente disorientati. Dall’altra parte, invece, sono state di notevole rilievo la riflessione del gesuita Carlo Greco sulla “credibilità della Rivelazione” e quella di Pino De Stefano sulla possibilità della “comunicazione, voce plurale della democrazia, in un mondo globalizzato”. Ma soprattutto la rivisitazione e la “lettura” di due grandi poeti del Novecento, Clemente Rebora e Mario Luzi, hanno dato respiro e messo ali alla nostra attività. In modo particolare nell’intervento di alto profilo, compiuto dal teologo e poeta napoletano Bruno Forte su “la poesia metafora della verità in Mario Luzi”: un incontro, quest’ultimo, di palpitante e profondo significato storicoletterario, che ha entusiasmato l’uditorio presente nell’antica aula settecentesca della Biblioteca. Ma a questo punto ci corre l’obbligo di sottolineare per i nostri lettori che, come sempre, tanta parte del lavoro svolto non risulta presente in questi Atti: non sempre, infatti, è stato possibile ottenere i testi delle Relazioni svolte. Soprattutto manca qui la registrazione degli echi, a volte davvero interessanti, dei vivaci dibattiti che per lo più si sono sviluppati a conclusione dei singoli incontri. Infine non possiamo passare sotto silenzio un avvenimento che ha riscosso notevole risonanza nella comunità degli studiosi di storia locale e nell’ambito di tutta la Chiesa diocesana. Infatti per iniziativa del Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola, diretto dal Preside Prof. Antonio V. Nazzaro, e in collaborazione col settore di Storiapatria della stessa Biblioteca, il 19 Maggio 2001, è stato promosso e si è svolto un pubblico Convegno, presieduto del Prof. Emerito Boris Ulianich, dell’Università Federico II di Napoli, sulla figura e l’opera dello storico ecclesiastico Gianstefano Remondini, di cui ricorreva il III Centenario della nascita (17002000). Con questa iniziativa scientifica la nostra Biblioteca ha inte6 so contribuire alla celebrazione non solo dell’Autore Della Nolana Ecclesiastica Storia, ma soprattutto dell’appassionato Studioso e del dotto e solerte Traduttore dell’Opera Omnia del santo Vescovo di Nola. Fu, quella del Remondini, la prima traduzione integrale “in italiana favella”, che nella metà del Settecento, il secolo dei Lumi, diede impulso e vigore agli studi paoliniani. Orbene gli Atti di quel Convegno sono in corso di pubblicazione a parte, nella Collana “Strenae Nolanae”. In attesa del lieto evento, affidiamo all’attenzione benevola dei nostri lettori questo quattordicesimo Volume degli Atti della nostra Biblioteca. GIOVANNI SANTANIELLO PAOLO SCAFURO 7 8 L’UOMO PELLEGRINO DELL’ASSOLUTO GIANFRANCO RAVASI * La vastità del tema comporta una fatica piuttosto notevole per metterlo a fuoco. Io vorrei, perciò, in maniera molto semplice, quasi didascalica, proporre un itinerario in due momenti. Suggerirei una specie di percorso, che comprende una prima tappa che potrei intitolare: “Lontano dall’Assoluto”, vale a dire l’uomo che fa un pellegrinaggio all’inverso rispetto all’Assoluto. Naturalmente questo Assoluto per noi porta già il nome, e questo nome è Dio. Noi, cioè, cammineremo come se ci trovassimo idealmente su un crinale con due versanti: l’uno, illuminato e l’altro, in penombra. Il versante oscuro sarà la prima tappa del nostro itinerario. Naturalmente camminare nell’interno della oscurità richiede particolari accorgimenti. Vorrei perciò proporvi, in questo primo momento, l’analisi quasi di un antipellegrinaggio, cioè dell’allontanamento dall’Assoluto, dal mistero, dal trascendente, da Dio. Una regione in ombra Vorrei indicare due aree. La prima la rappresentiamo - sempre per stare all’immagine parabolica - come un’area in penombra o in ombra, una regione un po’ oscura, nella quale individueremo due componenti che naturalmente tengono conto soprattutto della prospettiva del nostro sguardo, tendenzialmente di tipo spirituale, religioso, credente. Comincio subito con una considerazione che definisca un primo aspetto di questo orizzonte che ho definito intenzionalmente in penombra e ombra (ma non necessariamente nell’oscurità assoluta). Parto da un punto di riferimento capitale: il concetto e la presenza di Dio nell’interno di questa regione. Il Dio che troviamo qui, nell’area dell’oscurità, è un Dio che può essere definito moribondo o anche morto. Faccio riferimento, usando queste metafore, a un’esperienza culturale che ormai sta estinguendosi, che però ha ancora qualche notevole riflusso. * Conferenza tenuta il 27 Gennaio 2001. 9 Ci sono stati dei periodi storici in cui il senso profondo della morte di Dio costituiva persino una componente stimolante dal punto di vista teologico stesso. Vorrei, comunque ricordare alcune dichiarazioni che poi sono diventate celebri. Penso a una frase poetica di Heine che riguarda un Dio al quale si sta praticando una specie di dolce eutanasia: “Non sentite la campanella? In ginocchio, si portino i sacramenti a un Dio che muore”. Su questa frase Nietzsche costruirà poi quella sua ben nota architettura di pensiero che avrà risultati anche a livello popolare. In reazione a questo Dio moribondo, accanto al suo capezzale, si sono accaniti i rianimatori, cioè una certa apologetica, qualche volta particolarmente feconda, altre volte con le caratteristiche, molto meccaniche, di un accanimento terapeutico. Andando un po’ oltre, ci si è sempre più accorti che questo Dio lentamente stava spegnendosi, si riduceva a cadavere. Basti qui soltanto ricordare quella famosa dichiarazione di Nietzsche sul “lezzo della divina putrefazione” che egli considerava sicuramente come una caratteristica della nuova èra che stava aprendosi. Questo tema della morte di Dio è oggi, a mio avviso, non particolarmente significativo, né incisivo. Ritengo che questo sia per certi versi un male. Sempre più i grandi atei stanno spegnendosi: ciò che si presenta è un’altra modalità di negazione, come vedremo subito dopo. Ebbene, la “morte di Dio”, se è vissuta in forma autentica, genuina, cioè veramente sperimentata, codificata, quasi toccata con mano, può avere effetti che io ritengo pure positivi. Anche se per noi credenti Dio non muore, la convinzione che siamo di fronte al “lezzo della divina putrefazione” può dare risultati paradossalmente fecondi sia per il mondo che sta al di là dello steccato sia per il credente stesso. Infatti è una morte, questa, che genera lutto, paura, solitudine. Tutto ciò alla fine segnala che l’uomo non può così facilmente liberarsi da quella ingombrante presenza che era Dio. Pensiamo a che cosa abbia significato la costatazione di questo fatto da parte di un Freud, da parte di Sartre, ma prima, già nell’Ottocento, da parte di un credente quale Dostoevskij; pensiamo a cosa abbia significato anche in Leopardi, in Camus, in Bloch e così via. La lista potrebbe allungarsi. Si tratta di pensatori che io ritengo molto fecondi e preziosi anche per noi credenti e non soltanto significativi per il pensiero umano che di fronte a questa esperienza della morte di Dio si è dovuto inesorabilmente interrogare. 10 L’uomo di fronte al Dio “moribondo” I “senza Dio” sono persone sicuramente inquietate, tormentate, se sono autenticamente tali. E da questo punto di vista dobbiamo dire che forse le nostre stesse matrici cristiane ci inviterebbero qualche volta di più a studiare questo fenomeno del Dio debole, del Dio che sta quasi nascondendosi e riducendosi nell’orizzonte della storia. Gli stimoli ci vengono proprio da ambiti teologici importanti. Il primo lo desumo dal mondo delle Scritture, ove abbiamo a più riprese la percezione di un Dio che sembra lentamente essere assente e come tale scomparire dall’orizzonte, ed essere eventualmente oggetto di un’interrogazione che tante volte sembra ripiegarsi e serpeggiare per terra, senza mai trasformarsi nell’esclamativo di una fede o di una lode. Pensiamo al Libro di Giobbe, tutto centrato - come ormai gli studiosi asseriscono - non tanto sul problema del male quanto piuttosto sul problema del vero concetto di Dio. E’ il fatto che noi incrociamo spesso anche sulle nostre strade ove le immagini di Dio – ivi comprese alcune presentate dalla teologia - sembrano essere quelle degli dèi morti, degli idoli. Non dimentichiamo mai che i tre (più uno) amici di Giobbe rappresentano, attraverso la loro parola, nient’altro che le discipline teologiche fondamentali di allora e sono coloro che alla fine si rivelano quali portatori di una vera e propria forma di ateismo, un ateismo paradossalmente religioso. Pensiamo a Qoèlet, una figura che chiama Dio prevalentemente con la formula ha-Elohim, “il Dio”, cioè “la divinità”, neppure col nome suo specifico. Ebbene, la frase riassuntiva della sua ricerca di Dio è in quell’espressione per molti versi gelida e terribile: “Dio è nei cieli, tu sei sulla terra; perciò poche parole” (5,1). Questo Dio è un Dio assente: sembrerebbe essere il Dio di coloro che lo negano, anche se naturalmente Qoèlet non è definibile come un ateo. Nell’interno delle Scritture, quindi, Dio stesso ci invita a cercare un Dio che parla attraverso la sua assenza, un Dio che si manifesta attraverso il suo silenzio. Per questo motivo io non potrò mai dire che l’ateo tormentato e autentico è del tutto irrilevante ai fini della mia ricerca di credente, perché persino in lui potrebbe annidarsi il linguaggio di Dio, la declinazione della sua Parola. Un altro esempio che vorrei citare è quella frase, a me particolarmente cara, del Primo Libro dei Re (19,12), in cui Elia, dopo aver ripetutamente conclamato la necessità di un Dio teofanico, cioè di un Dio clamoroso, solare, di un Dio rivelatore esplicito, scopre che il Dio che si presenta a lui e che è il vero Dio, non è quello della folgo- 11 re, non è quello del vento o del terremoto. L’originale ebraico è di straordinaria fragranza poetica, ma soprattutto di straordinaria grandezza teologica. Abbiamo infatti nel testo soltanto tre parole: qol demamah daqqah. Qol è “voce”, demamah è “silenzio”, daqqah, “sottile”: “una voce di silenzio sottile”. Nell’interno del silenzio di Dio c’è indubbiamente un suo misterioso svelarsi e rivelarsi. Non è il silenzio “nero” della nostra società, convinta che Dio non parli, bensì quello “bianco” che riassume in sé tutte le voci ma attraverso una via ardua. Vi sono due conseguenze riguardo al tema del Dio moribondo e del Dio morto. La prima l’abbiamo appena vista proprio nella Bibbia. Dio può parlare attraverso la sua morte, può essere vivo attraverso il suo apparente spegnersi. Ma vorrei anche fare riferimento ad un altro aspetto che è curiosamente e paradossalmente ripreso proprio dalla letteratura mistica: il Dio ferito dal male. Qui entriamo in un territorio dal punto di vista filosofico molto delicato, che ha sollecitato ripetutamente pensatori di grande rilievo fino ai nostri giorni. Pensiamo a Pareyson, che ha riflettuto sul tema del rapporto tra Dio e la creazione e tra Dio e il male. Questo tema affonda le sue radici soprattutto all’interno dell’esperienza mistica. Cito qui tre figure: Meister Eckhart, Giovanni della Croce e Angelus Silesius. Questi tre personaggi, diversissimi tra loro, si avviano sulla strada del male e della tenebra come via quasi privilegiata per poter incontrare Dio, per contemplare il vero volto di Dio, il Dio ferito dal nulla. Vi sono delle frasi veramente sorprendenti di Eckhart e di Silesius. Dio crea e, per essere coerente con se stesso e lasciare spazio e consistenza alla creazione e soprattutto all’uomo libero, deve in qualche modo ritrarsi. Troviamo questa idea nella famosa teoria dello zimzum, propria della teologia medievale giudaica cabbalistica: il termine significa letteralmente “il ritrarsi” di Dio. Hölderlin ha scritto che Dio creando si comporta come fanno gli oceani: essi si ritirano per lasciar spazio ai continenti. Questo ritrarsi è in qualche modo un ferirsi, è in qualche modo - e sempre parliamo per paradossi - un po’ morire. Entrare nella figura di Cristo è forse la dimostrazione più visibile di questo dramma, della tragedia suprema del divino: il Logos eterno e infinito si contrae nell’interno dell’umanità dell’uomo-sarx. Questa esperienza di Dio che sembrerebbe a prima vista così negativa viene considerata dalla stessa tradizione mistica e poi da altre tradizioni come la grande via per riuscire a scoprire Dio. Quindi anche nell’interno di un orizzonte come quello che è definito in penombra 12 e in ombra, caratterizzato da un Dio trafitto dal male o trafitto dalla morte stessa, noi siamo invitati a essere in un atteggiamento di ascolto e contemplazione. Si tratta di un percorso in cui non soltanto noi credenti ci troviamo a camminare, ma in cui Dio stesso - se è vero quello che abbiamo detto a proposito delle Scritture - sta camminando e manifestandosi, soprattutto in Cristo. L’ateismo della indifferenza Propongo qui una seconda considerazione, sempre a proposito di questo orizzonte della penombra. C’è effettivamente un morire di Dio, all’interno del cuore dell’uomo. C’è un ateismo che ai nostri giorni è negativo, non è produttivo e fecondo come quello che ho descritto prima. Questo nuovo modo di vedere la tenebra fine a se stessa è in un ambito che a prima vista sembrerebbe essere meno offensivo, meno tragico, meno drammatico dell’ateismo classico. Lo rappresento con un verso del poeta che ho appena citato e che ritengo anche un grande pensatore: non a caso ha entusiasmato anche molti filosofi, tra i quali Heidegger. Mi riferisco a Hölderlin, che nella sua celebre poesia Pane e vino - che tutti i tedeschi sanno quasi a memoria perché la imparano nelle scuole elementari - recita: Wozu Dichter…, “Perché i poeti nel tempo della povertà?”. Questa domanda è stata così sviluppata da Heidegger nella sua opera Sentieri interrotti: “Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà perché diviene sempre più povero; è già diventato tanto povero da non poter riconoscere la mancanza di Dio come mancanza”. Questa frase mi sembra particolarmente adatta a rappresentare lo status di un mondo ateo nel senso che stiamo considerando adesso, non nel senso tragico di prima. In tempo di povertà Dio continua a darci poeti, quindi ci salva: la poesia è anche il simbolo della fede. L’assenza dei poeti diventa, allora, segno di giudizio. Ora noi siamo in un tempo in cui i poeti non ci sono più, ma noi non ne sentiamo più la mancanza. Questo tempo è già diventato tanto povero da non poter riconoscere la mancanza di Dio come mancanza. È questo ciò che sperimentiamo quando incontriamo un orizzonte culturale, ma che è anche quello comune, di solito definito con il termine “indifferenza”, oppure con “superficialità”, “banalità”, “volgarità”, “vuoto”, “inconsistenza”. In questo mondo, che è dominante ai nostri giorni, noi vediamo che Dio non è combattuto, non è più oggetto di una contestazione, non c’è bisogno di trafiggerlo, Dio può essere anche presente, ma è del tutto irrilevante. 13 È del tutto irrilevante perciò anche la poesia, come pure l’arte nella sua forma più alta. Mi colpisce, ad esempio, nella rivista Flash art, che tratta di arte contemporanea, la continua celebrazione dello sfaldamento, della morte dei colori, della figura, dell’itinerario stesso di ricerca. Si continua sempre di più a celebrare la corruzione, lo stemperarsi della realtà, il suo dissolversi. In questa luce naturalmente l’artista entra e si abbandona, trovandosi come nel suo grembo quieto. Kierkegaard scrive nel suo Diario: “La nave ormai è in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani”. In questa frase c’è la rappresentazione di questo mondo che non sente più la mancanza di Dio. Noi abbiamo quel mezzo egemone della comunicazione che è la televisione che si accende nelle nostre case e che ci dice tutto su come dobbiamo mangiare, come dobbiamo vestire, sulle mode e sui modi, ma non ci dice nulla sulla rotta da seguire. Indicare la rotta è divenuto del tutto irrilevante. Noi viviamo in un orizzonte oscuro, nel quale è necessario sicuramente riuscire a reagire, a non lasciarci lentamente contaminare noi stessi. Questo mondo non è autenticamente tenebroso: è grigio. E il grigiore è nebbioso, e la nebbia è sicuramente più pericolosa della tenebra, perché questa almeno ti inquieta. Ho presentato due percorsi che costituiscono una specie di impasto del profilo in ombra rivelato dalla prima regione che abbiamo individuato al di là dello steccato. Tuttavia, sappiamo bene quanto le frontiere siano ai nostri giorni mobili, se non proprio del tutto cancellate. La regione della luce Gettiamo ora uno sguardo sul secondo territorio, quello in luce. Vi sono, però, diversi tipi di luce: una luce prealbare, oppure una luce solare, squillante, sontuosa, o anche una luce crepuscolare. Vorrei ora presentare solo due tipologie di luce, come prima ho fatto cenno solo a due tipi di oscurità. La prima è una luce “crepuscolare”, o “prealbare”. Ai nostri giorni Dio è risorto, è presente, non è così negativamente lontano e remoto: anche nell’ambito dell’indifferenza può essere un testimone marginale ma presente. Il vero problema in molti ambiti di questo territorio in luce è la domanda su “quale Dio” scegliere. La religione non è del tutto accantonata in questa situazione di luce incerta. Nel 1799 Schleiermacher nel Discorso sulla 14 religione - in pieno Illuminismo - scriveva: “Alle grida di aiuto dei più sulla fine della religione io non unisco la mia voce perché non mi risulta che alcuna epoca l’abbia trattata meglio di adesso”. Per certi versi, se noi guardiamo un po’ la nostra società, potremmo anche dire che la religione apparentemente sembra essere considerata come una componente che non è da espellere, anzi che potrebbe essere assunta. Ma qui scatta la domanda: quale Dio? Mi sembrano significativi due esempi antitetici. Il primo Dio che emerge nella nostra società svela una luce crepuscolare: non siamo di fronte alla vera luce del Dio vivente. Pensiamo alle forme di sincretismo, di magia, di devozionalismo, alla New Age e Next Age. Pensiamo a questa religiosità un po’ impalpabile, di un’inconsistenza assoluta, che è una specie di fitness dell’anima celebrato in templi che sono più simili a grandi e solenni saune. È una miscela tra messaggio e massaggio, tra yoga e yogurt, in modo tale che la pace del corpo viene intrecciata con una spiritualità molto evanescente. Queste forme sincretistiche costituiscono una religiosità liofilizzata; ma certamente evidenziano il bisogno di Dio. La società tecnologica, dopo aver fatto a meno di Dio, dopo essere stata nella regione oscura prima descritta, alla fine sente ancora un bisogno autentico di Dio. Ma ha ormai il palato guasto e ha bisogno di omogeneizzati spirituali. Le grandi religioni tradizionali hanno un cibo solido molto impegnativo, difficile da offrire a questi palati incapaci. Alcune Chiese hanno tentato allora di edulcorare il più possibile, di annacquare la verità del Dio vivente, per cercare di far sì che questo uomo, passato attraverso la totale incapacità di assumere Dio, potesse assumerlo almeno in questa forma più semplice e adattata. L’altro esempio che vorrei fare a proposito del Dio culturalmente rilevante ma in una forma non del tutto autentica - anche se ci sono degli elementi di verità che possono essere accolti - è proprio l’antipodo. Lo definirei il Dio del vessillo apocalittico, il Dio fondamentalista. Siamo di fronte ad una cultura che se prima (nel sincretismo) era la cultura del duetto, è qui piuttosto quella del duello. Il vessillo del drago rosso è piantato nell’interno della società, delle nostre piazze. Perciò, c’è un tipo di credente che se ne sta remoto nel suo mondo, integralisticamente chiuso nel suo tempio. Vi è in Racine una battuta veramente emblematica di tutte le visioni rinchiuse in se stesse. In un’opera di quello scrittore francese, un sacerdote - non per nulla un sacerdote – dice: Ce temple est mon pays: je n’en connais point d’autre, “Questo tempio è la mia nazione, io non ne conosco altri”. Trono e altare sono in sé uniti, e se c’è 15 qualcosa che è profano, bisogna in tutti i modi cercare di cancellarlo. Pensiamo a un movimento come i Testimoni di Geova che considerano sotto il segno del Maligno tutta la cultura che non sia nell’interno del loro perimetro e così pure la società stessa. Questo Dio ha una luce che non è autentica. Ci possono essere in questa concezione indubbiamente anche dei valori. Ci può essere da un lato, come nel primo esempio, il richiamo al fatto che, benché con il gusto ormai deformato, l’uomo d’oggi sente sempre la nostalgia del divino, sente sempre il bisogno di abbeverarsi a quella sorgente. Egli però va, per usare l’immagine di Geremia (2, 13), alle cisterne screpolate che non possono contenere l’acqua. Nell’altro esempio abbiamo il bisogno di una identità, di ritrovare la propria matrice, impedendo che essa si stemperi in una genericità. Entrambe queste forme di loro natura hanno, però, in sé una debolezza di fondo perché non hanno il coraggio di guardare Dio e l’uomo in maniera compiuta e completa. Hume ha una battuta che ha il suo fondo di verità: “Gli errori della filosofia sono sempre ridicoli, gli errori della religione sono sempre pericolosi”. Dobbiamo quindi essere molto attenti perché sono errori che hanno un significato, hanno un’anima di verità, come tutte le eresie. Sappiamo anzi che possono essere l’esasperazione di una verità che non è più capace di essere sinfonica. Ma d’altra parte dobbiamo ricordare che sono anche degli ordigni capaci di deformare le culture e le società. Fede e religione Nel secondo territorio, quello illuminato, vorrei ancora presentare due altri esempi più luminosi volti a illustrare la fede che si intreccia autenticamente con la cultura, una fede capace di presentarsi come tale senza morire, senza amputarsi, però al tempo stesso capace anche di entrare in un connubio, in un dialogo. Il primo esempio si riferisce a quella delicata e persino criticabile distinzione di Barth tra fede e religione. È una distinzione ormai superata dalla teologia, ma può essere uno strumento utile per la nostra riflessione. A Barth fu rivolta una domanda quando, dopo essere stato a lungo professore e aver scritto quel monumento che è la Dogmatica ecclesiale, ritornò al paese in cui era stato pastore da giovane, un villaggio di boscaioli, di taglialegna, di gente semplice, vicino a Berna. I giornalisti gli chiesero: “Se lei deve insegnare tutto quello che ha scritto a questa gente, che cosa può dire loro?”. Rispose: “Ripeterei 16 una preghiera che recito ogni giorno: O Signore, liberami dalla religione e dammi la fede”. Naturalmente noi qui intendiamo la “religione” non come manifestazione necessaria della fede esistenziale, altrimenti la fede resta intimismo, solitudine, solipsismo; ma come una spiritualità che è semplicemente quella coloritura spalmata su tutto l’Occidente, il quale non può non dirsi cristiano, come affermava Croce. Ora noi abbiamo, invece, la necessità di riconoscere certamente il valore della religione come capacità di essere struttura, ma soprattutto dobbiamo ritrovare il fermento, il lievito della fede. Nel 1999 è uscito da Giunti un libretto che raccoglieva un dialogo tra l’Arcivescovo di Firenze, il cardinale Piovanelli, e Vannino Chiti, presidente della Regione Toscana. Il cardinale Piovanelli diceva: “È molto meglio un piccolo gregge di credenti che non una massa di appartenenti”. È necessario indubbiamente anche avere cura della massa, è necessario anche riconoscere che la cultura prosegue attraverso i grandi fenomeni di base, e che quindi la religione è una componente da considerare positivamente. Guai però se alla fine noi non fossimo capaci di far balenare davanti alla cultura che ci circonda la straordinaria potenza e grandezza del credere. Pensiamo soltanto a ciò che ci potrebbero dire a questo riguardo, se ci dovessero parlare ora, un Agostino o un Pascal. Verità penultima e ultima La seconda considerazione che vorrei fare a proposito di questo ambito luminoso concerne una distinzione parallela a quella di Barth tra fede e religione. Si tratta della distinzione - anch’essa discutibile, ma con un suo contenuto valido - tra le verità “penultime” e le verità “ultime”, elaborata da un altro teologo del Novecento: Dietrich Bonhoeffer. La presenza cristiana è indubbiamente quella che dovrebbe ininterrottamente unire in un nodo d’oro queste due tipologie di verità, perché il nodo d’oro fondamentale del cristianesimo è l’Incarnazione. Ora l’Incarnazione è Logos sarx eghéneto. Logos e sarx: proprio questo fa sì che, da un lato, ci debba essere un Dio legato (e quindi un credente) a tutta la polvere della storia, a tutto l’impegno continuo e quotidiano, a tutta la realtà, alle coordinate storico-spaziali nelle quali noi siamo immersi; ma, dall’altra parte, è assolutamente necessario che le verità penultime abbiano continuamente come loro approdo le verità ultime, il divino, perché altrimenti avremmo una forma di storicismo perfino materialistico. 17 Devo dire che la cultura contemporanea laica sente profondamente il bisogno - dopo averci visto camminare con essa nell’ambito delle verità penultime e sperimentare che cosa vuol dire il Dio debole e impotente - che alla fine ci siano quelle parole che sono le parole estreme, definitive. È necessario che più spesso noi andiamo a riproporre nel nostro annunzio vita e morte, anche se, come dicevo prima, il palato e le orecchie di chi ci ascolta, non sono in grado di captare appieno questo tipo di discorso. Dobbiamo riproporre ancora bene e male, verità e falsità, menzogna, giustizia e ingiustizia nel senso alto, l’amore nelle dimensioni più alte, dobbiamo riproporre ancora la Parola divina. Mai ho visto l’orizzonte anche più refrattario alla cultura di matrice religiosa uscire indenne dalla lettura di un testo biblico, sia pure quando la Bibbia venga considerata in partenza soltanto come la grande testimonianza della cultura dell’Occidente, il grande alfabeto colorato in cui tanti artisti hanno intinto il pennello. Per questo motivo sono le grandi verità ultime e la Parola, in tutta la loro forza e grandezza, ciò che i cristiani dovrebbero più spesso presentare all’umanità che sta al di là degli steccati. Questo tipo di presenza riuscirebbe a creare nell’interno del mondo che ci circonda almeno una reazione che io ritengo particolarmente significativa e che non si riesce più a trovare purtroppo ai nostri giorni. Ed è la reazione che io chiamerei della inquietudine: riuscire a stimolare ancora “un timore e tremore acuito dal trovarsi in un mondo perverso che crocifigge l’amore” (Kierkegaard). Questa inquietudine deve essere prima di tutto nostra, trovandoci in un mondo che crocifigge l’amore. Questa inquietudine, che è ricerca, noi dovremmo riuscire a trasmetterla e alla fine essa permetterebbe forse all’uomo di oggi di tendere verso quello che potremmo chiamare il nudo Essere, con la E maiuscola, un ultimo punto d’approdo decisivo e fondamentale. Ho citato il “nudo Essere” perché vorrei terminare con le parole di un poeta, che mi è stato amico negli ultimi anni della sua vita e che voi tutti avete conosciuto e che sul problema del rapporto col mondo della non credenza ha investito anche un po’ della sua libera, creativa, qualche volta anche discutibile, testimonianza. Intendo riferirmi a padre David Maria Turoldo. Una poesia contenuta nei Canti Ultimi, la sua collezione poetica migliore, è indirizzata al “fratello ateo nobilmente pensoso”, espressione ripresa da Paolo VI. Con questa poesia vorrei riassumere il mio discorso. Essa invita a entrare in un pellegrinaggio nell’interno del mondo, di quel 18 territorio nel quale – dice Turoldo - ci sono le foreste lussureggianti delle fedi, delle religioni. Eppure esse non sono il punto d’approdo ultimo: noi dobbiamo andare oltre, noi siamo per la visione e la comunione con Dio, come dicono Paolo (1Corinzi 13, 12) e Giovanni (1Giovanni 3, 2). Dall’altra parte ci sono anche i deserti, quei deserti che abbiamo rappresentato sotto l’immagine dell’indifferenza, del grigio e della nebbia. Alla fine, quando anche morirà la parola, ci sarà il “nudo Essere”, che è ovviamente l’esperienza del divino e che altri diranno del trascendente, o più semplicemente del desiderio di un oltre che va al di là della pelle, cioè della debolezza e della miseria del quotidiano entro cui ci intristiamo e ci isteriliamo. Scrive il poeta: “Fratello ateo/ nobilmente pensoso,/ alla ricerca di un Dio/ che io non so darti,/ attraversiamo insieme il deserto,/ di deserto in deserto/ andiamo oltre/ la foresta delle fedi,/ liberi e nudi,/ verso il nudo Essere./ E là dove/ la Parola muore/ abbia fine il nostro cammino”. 19 20 IL POTERE NELLA POLITICA: RISORSA O TENTAZIONE? FRANCO PASTORE * Non ho una particolare competenza per parlare dell’argomento. Non sono un politico e non ho l’esperienza di chi si è misurato sul campo con questa tematica, né sono uno studioso di politica o di etica. Quindi le considerazioni che farò non hanno alcuna pretesa di completezza o sistematicità. Possiamo considerarle semplicemente come l’introduzione alla discussione che certamente sarà più ricca e significativa. Il tema, al di là delle specificazioni che assume in riferimento alla politica, pone interrogativi di natura etica sul rapporto con il potere di quanti, e sono tanti, occupano e gestiscono posizioni di potere. Io stesso che faccio il magistrato, chiamato ad esercitare nel mio lavoro quotidiano il potere giurisdizionale, dovrei chiedermi: il potere per me è risorsa o tentazione? è strumento per affermare la giustizia nel caso concreto o è strumento di prevaricazione e mortificazione di chi è chiamato a subire il mio giudizio? o ancora è un trampolino di lancio per acquisire posizioni di prestigio e notorietà al di fuori dell’ambito professionale? Ma il problema del rapporto con il potere riguarda tante altre persone che pure non sono investite di pubbliche funzioni. Pensiamo al rapporto medico-paziente. Nell’ambito di una relazione che non ha alcun connotato pubblicistico, che vede i due soggetti in un rapporto di assoluta parità formale, uno dei due – il medico – si trova in una posizione di potere che gli deriva da due fattori: 1) dal fatto di avere nelle proprie mani uno dei beni più importanti dell’altra persona: la salute; 2) dal fatto che l’altro, normalmente a digiuno di cognizioni di scienza medica, non ha alcun potere di controllo sul suo operato: si deve fidare! E pensiamo al rapporto tra il maestro e l’alunno nel quale il secondo, in situazione di assoluta dipendenza, pone non solo la propria * Relazione tenuta il 15 Dicembre 2000. 21 istruzione ma la sua stessa personalità in formazione nelle mani del primo. Venendo più specificamente al tema della riflessione, mi sembra di poter innanzitutto affermare che la prima caratteristica del potere è che esso si presenta come un dato necessario ed ineliminabile dell’agire politico: «la convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un’autorità legittima che assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del bene comune in grado sufficiente» (Pacem in terris, 46). La seconda caratteristica del potere politico è quella di potersi imporre, in casi estremi, anche con l’uso o la minaccia della forza. Questo tratto differenzia profondamente il potere politico dalle forme di potere a cui ho fatto cenno prima. Si tratta perciò di un potere invasivo e potenzialmente in grado di interferire ed incidere profondamente sui diritti di libertà della persona. L’interrogativo se il potere sia risorsa o tentazione si pone allora non solo sul piano soggettivo dell’agire politico individuale ma anche sul piano oggettivo dell’organizzazione del potere. A questo primo livello, credo che il potere sia risorsa quando la politica è orientata al bene comune inteso come «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente» (GS 26). In sostanza, il bene comune implica tre elementi essenziali: il rispetto della persona umana, il benessere sociale e la pace. Innanzitutto il rispetto della persona in quanto tale. In nome del bene comune, i pubblici poteri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana. Ogni persona, in quanto tale, indipendemente dal sesso, dalla razza, dall’età, dalla religione, dalla condizione sociale, ecc..., è titolare di alcuni diritti innati che non gli possono essere negati. Nel nostro ordinamento, questa esigenza trova espresso riconoscimento nell’articolo 2 della Costituzione che afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». L’espressione “riconosce” sta a significare che lo Stato prende atto del fatto che la persona ha un nucleo fondamentale di diritti che le derivano dal solo fatto di essere persona. Diritti che lo Stato può solo proteggere e promuovere ma non eliminare. In secondo luogo, il bene comune richiede il benessere sociale e lo sviluppo del gruppo stesso. La politica, pur nella necessaria opera 22 di selezione e mediazione tra interessi particolari, deve rendere accessibile a tutti e a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana: vitto, alloggio, vestito, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a fondare una famiglia. Anche questa esigenza trova eco nella Carta costituzionale che, non solo riconosce espressamente il diritto al lavoro e ad una retribuzione che sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, il diritto alla salute, all’istruzione, alla famiglia, al mantenimento e all’assistenza sociale, ma che impegna la Repubblica (quindi, non solo lo Stato, ma tutte le istituzioni anche locali) «a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3/2 Cost.), indicando un programma di promozione umana che dovrebbe costituire la cornice entro cui inserire le scelte politiche contingenti. Il bene comune, infine, implica la pace, cioè la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto. Suppone che l’autorità garantisca, con mezzi onesti, la sicurezza della società e quella dei suoi membri. Implica inoltre rapporti di pacifica convivenza con gli altri popoli e nazioni. Infatti, quando il benessere materiale e spirituale di un Paese è fondato sul bene comune, non tollera lo sfruttamento di popoli di altri Paesi. Il bene comune è naturalmente inclusivo e tende a farsi carico dei problemi dello sviluppo di aree del mondo più povere. In questo ambito si situano tutte le questioni legate al tema della remissione del debito internazionale da parte dei Paesi ricchi o dello sfruttamento del lavoro minorile ed in generale delle condizioni di miseria di gran parte della nostra umanità. In definitiva si può dire che il potere è risorsa quando è strumentalmente orientato al perseguimento del bene comune. Ma affinché il potere sia orientato al bene comune, è necessario che non sia un potere tirannico e totalitario. Occorre invece che sia limitato, cioè regolamentato, controllato e controllabile. Che sia cioè un potere democratico. In questa prospettiva, la democrazia appare come una forma di governo fondata non sulla negazione del potere ma sulla sua circoscrizione, limitazione e diffusione, mediante un delicato sistema di pesi e contrappesi nel quale il potere politico, per un verso, si articola in una pluralità di sedi e istituzioni, per altro verso, accetta esso 23 stesso di assoggettarsi alla legge che ne ragolamenta le modalità di esercizio e prevede gli strumenti di controllo: è il principio dello Stato di diritto e della separazione dei poteri su cui si fondano le moderne democrazie che, al di là delle specifiche differenze, sono caratterizzate dal fatto che la sovranità appartiene al popolo e che i poteri che tradizionalmente esprimono la sovranità stessa (esecutivo, legislativo e giudiziario) mettono capo a organi tra loro indipendenti. Altri profili del potere democratico sono costituiti dalla temporaneità delle cariche elettive, dalla partecipazione del popolo non solo mediante libere elezioni ma anche attraverso istituti di democrazia diretta quali i referendum, dalla istituzione di un particolare organo giudiziario, quale la Corte Costituzionale, chiamato a dirimere i conflitti tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le altre comunità locali dotate di larga sfera di autonomia rispetto allo Stato stesso (in Italia le Regioni), nonché a effettuare il controllo di legalità costituzionale sulle leggi, al fine di salvaguardare l’inviolabilità dei diritti fondamentali della persona dalla possibile tirannia della maggioranza parlamentare. Di questa esigenza tennero conto i Padri costituenti allorché, dopo aver fissato i principi fondamentali della Costituzione, passarono ad occuparsi, nella sua seconda parte, dell’assetto istituzionale da dare al Paese. Si disse che «è la struttura stessa dello Stato democratico che, con il riconoscimento della sovranità popolare, con la divisione dei poteri, con il primato del legislativo, la stabilità dell’esecutivo, l’indipendenza del giudiziario, nonché con il decentramento amministrativo, le autonomie locali ed il regionalismo, deve contribuire a garantirci l’esercizio sicuro e permanente delle libertà» (Gonella). Si osservò anche «che la struttura organizzativa di uno Stato orientato in senso liberistico non può, nella sua sostanza, non essere sostanzialmente diversa da quella propria di uno Stato che si proponga fini di intervento più o meno penetranti nella sfera dei rapporti sociali, onde correggere o attenuare gli effetti del gioco spontaneo dei medesimi» (Mortati). Come è noto il recente dibattito sulle riforme istituzionali ha rimesso in gran parte in discussione l’assetto dei poteri delineato nella seconda parte della Costituzione. Senza addentrarmi in questioni particolari, vorrei segnalare che le vicende degli ultimi anni hanno messo in rilievo due profili problematici che andrebbero affrontati e risolti per garantire quella precondizione di ordine sociale necessaria all’equilibrio della vita politica e che riguardano rispettivamente il rapporto tra politica ed economia e politica ed informazione. 24 Con riferimento al rapporto tra politica ed economia sembra avvertirsi la malcelata pretesa dell’economia di emanciparsi da ogni regola giuridica. La politica dovrebbe astenersi dall’interferire con i meccanismi del mercato e della concorrenza. Mentre il potere politico resta circoscritto all’ambito del territorio dello Stato, il potere economico si atteggia a potere sopranazionale che sfugge alla regolamentazione dei singoli Stati. La possibilità di spostare in poche ore ingenti capitali dalla Borsa di una nazione all’altra (con ciò influenzando pesantemente la ricchezza di grandi e piccoli investitori), di allocare la produzione là dove il costo del lavoro è più basso (senza alcuna considerazione per i diritti fondamentali dei lavoratori, spesso poco più che bambini), di influenzare le stesse politiche economiche dei governi nazionali (attraverso le pressioni più o meno occulte delle varie lobbies) ecc..., rivelano tutta la potenza del potere economico tanto che c’è chi individua il tratto qualificante della globalizzazione, non nella intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza, ma in un travaso di poteri dagli Stati verso le istituzioni economiche. Occorre invece che la politica riaffermi il proprio primato sul potere economico perché, se è vero che il fondamento ed il fine della politica è il bene comune, non è possibile sottrarre al suo governo un settore, come quello dell’economia, capace di incidere così profondamente sulle condizioni di vita delle persone. Di qui l’esigenza di assicurare, sul piano degli ordinamenti nazionali, l’indipendenza della politica dall’economia (c’è qui il tema del cd. conflitto di interessi di chi aspira a governare un Paese), e di creare, sul piano degli ordinamenti sopranazionali, delle istituzioni in grado di dettare regole vincolanti per il maggior numero possibile di Stati (c’è qui il tema delle costituzioni sopranazionali, del ruolo e del potere dell’ONU, della Comunità Europea e delle altre organizzazioni internazionali). In relazione al rapporto tra politica ed informazione, si è messo in evidenza il ruolo condizionante che i mass-media hanno nella formazione (anche) del consenso politico. Di qui l’esigenza di assicurare l’accesso ai mezzi di informazione in modo paritario ai vari contendenti politici, nonché l’esigenza di evitare che chi abbia posizioni di potere nel campo dell’informazione possa avvantaggiarsene quando scende nel campo della politica. E questa esigenza, ancorché sembri riferita ad un ben individuato personaggio politico, in realtà è un’esigenza di carattere più generale che attiene alla fondamentale neces- 25 sità di evitare che una persona possa esercitare impropriamente, nella politica, il potere acquisito in un diverso ambito, oppure che si eserciti in modo strumentale un certo potere, per poter poi “scendere” in politica. Pensiamo, ad es., al magistrato che esercita in modo strumentale il potere giurisdizionale come trampolino di lancio per la futura carriera politica. Oppure all’ex magistrato che, sceso in politica, si avvale in questo ambito del potere giurisdizionale esercitato in precedenza (ad es. mediante l’uso di conoscenze acquisite proprio in ambito professionale). In questi casi tutto il sistema corre seriamente il rischio di essere delegittimato e non credibile agli occhi dei cittadini. Per chiudere sul punto, vorrei fare un cenno anche sul tormentato rapporto tra politica e magistratura che si arricchisce quasi quotidianamente di nuove occasioni di polemica (da ultimo le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati sulla legittimità a governare di un noto personaggio politico). Senza entrare nei dettagli, la vicenda mi pare sintomatica di una condizione di crisi che andrebbe superata al più presto, perché, delle due l’una: se fossimo effettivamente di fronte al disegno politico di una parte della magistratura di impedire che una certa parte politica giunga al governo del Paese, saremmo in presenza di una grave, indebita e strumentale interferenza di un potere nel libero dispiegarsi della competizione politica. Se, invece, fossimo in presenza del disegno politico di ridimensionare i poteri della magistratura come ritorsione alle vicende giudiziarie che hanno svelato il malaffare politico-amministrativo, saremmo in presenza di un altrettanto inaccettabile tentativo della politica di sottrarsi al controllo di legalità. Ho indugiato su questi profili, per sottolineare come la questione delle riforme istituzionali non sia una questione tecnica o di mera ingegneria costituzionale, perché l’assetto organizzativo del potere non è neutrale rispetto al suo essere funzionale al bene comune. Ma, per quanto sofisticato possa essere un sistema democratico nel quale il potere sia organizzato in termini di funzionalità al bene comune, resta decisiva la coscienza e la responsabilità dell’individuo che agisce in politica e che può usare in modo improprio e distorto il potere connesso alla politica, in dispregio di ogni buona norma giuridica. In definitiva, la realizzazione del bene comune passa attraverso l’azione concreta delle persone che fanno politica. In tal modo l’interrogativo si sposta al livello individuale: per me consigliere comunale, sindaco, ministro, parlamentare, ecc..., il potere è risorsa o tentazione? 26 Abbiamo tanti esempi di politici che hanno testimoniato, anche a caro prezzo, come il potere possa essere risorsa e non tentazione. C’è chi è morto per mano dei brigatisti e chi per mano dei mafiosi. Ci sono tantissimi politici sconosciuti all’opinione pubblica che, ad ogni livello (consiglieri comunali, sindaci, parlamentari...), dedicano all’attività politica con generosità il loro tempo, la loro intelligenza, la loro tenacia, la loro professionalità, sacrificando affetti, famiglia, soldi ecc... lontano dalla notorietà di cui godono i (tutto sommato) pochi politici che hanno ruoli di preminenza nel governo e nei partiti. Ma ci sono stati e ci sono anche numerosi esempi di politici che hanno ceduto alla tentazione di potere lasciandosi corrompere, utilizzando in modo strumentale la funzione esercitata, favorendo amici e parenti e clienti quando c’era da distribuire risorse, posti di lavoro, denaro pubblico ecc... In molti casi, la degenerazione ha assunto addirittura le caratteristiche del sistema. Di conseguenza, anche sul piano dell’agire politico individuale c’è da chiedersi a quali condizioni il potere è risorsa e non tentazione. Senza pretesa di dare lezioni, credo che il politico debba innanzitutto conoscere ed essere competente. È necessaria una competenza che nasce da preparazione professionale qualificata, aggiornata, capace di invenzione continua e che sappia coniugarsi proficuamente anche con altre garanzie di moralità, di chiarezza di collaborazione. Non ci si può inserire adeguatamente nelle istituzioni tipiche della nostra vita sociale e non si può operare efficacemente in esse se non si è scientificamente competenti, tecnicamente capaci, professionalmente esperti. La politica non può essere mera testimonianza o declamazione di principi e valori senza capacità di attuare le mediazioni necessarie per tradurli in leggi, riforme, provvedimenti. Tante volte abbiamo avuto la sensazione che chi ha fatto una legge o un provvedimento non conoscesse ciò di cui si è occupato. La mancanza di conoscenza o, peggio, la decisione assunta sulla base di un pregiudizio ideologico o religioso o del condizionamento di interessi corporativi sta alla base del fallimento di tante riforme e dello scollamento tra paese legale e paese reale e della disaffezione della gente dalla politica che non appare capace di risolvere i problemi. Il politico poi deve scegliere. Spesso per non perdere consenso dice sì a tutti e non sceglie. Io non credo che il consenso è lo strumento attraverso cui il politico afferma le sue idee e i suoi programmi. Il politico non può dire: datemi il voto e farò tutto ciò che volete. Deve dire cosa farà e cosa non farà, indicando le priorità del suo agire. 27 Ogni scelta comporta un progetto e un coinvolgimento personale: chi sceglie si compromette, non è al di fuori. Dunque ogni scelta richiede saggezza e coraggio. In politica la scelta, il saper decidere, comporta anche riconoscere una scala di valori e puntare ai più elevati di essi. Lo scegliere va evidentemente contro una delle caratteristiche più negative di un certo modo di fare politica: il trasformismo! Uomini buoni per ogni politica e per ogni stagione della politica. Ma l’abito virtuoso dello scegliere va anche contro un altro elemento negativo della politica: il corporativismo degli interessi. Scegliere significa andare contro qualcuno, o meglio optare per il bene che è superiore, che è comune, con sacrificio di qualcuno, di qualche bene particolare che è egoistico, settoriale, corporativo. Scegliere è un valore altamente morale ed umano ed è il modo tipico di essere e di agire di chi è capace di mediare tra l’analisi della realtà e il progetto per il futuro, tenendo conto della gente che ha di fronte. Può sembrare poi banale richiamare l’esigenza che il politico sia uomo d’azione eppure spesso la politica si riduce a mere dichiarazioni di intento non seguite dai fatti concreti. Alle decisioni devono seguire i fatti. Pensiamo a tutto ciò che si è detto sulla necessità delle riforme istituzionali o di una nuova legge elettorale e alla situazione di impasse in cui ci troviamo. La incapacità di far seguire i fatti alle promesse è una delle cause più importanti della sfiducia della gente nella politica e fomenta un senso di rassegnazione e di impotenza nella possibilità di risolvere i problemi. Infine, la politica va fatta con rigore morale, spirito di servizio e stile di gratuità. Il politico deve essere persona onesta, disinteressata, non legata alla carica e al potere. Deve essere rispettoso dell’altro e delle idee diverse dalle sue. Deve essere persona interiormente libera e aperta ad accogliere ogni contributo che concorre a realizzare il bene comune, nella consapevolezza che anche l’avversario politico può essere portatore di un pezzettino più o meno grande di verità. Ma deve anche saper essere intransigente quando vengono in gioco i diritti fondamentali degli ultimi e dei deboli perché tradirebbe la ragione stessa della politica se disponesse dei diritti degli ultimi a vantaggio degli interessi forti. Egli non deve porsi alcun fine di tornaconto personale nell’agire politico. E non dovrà mai pretendere una ricompensa per ciò che fa. Intendiamoci: non metto in discussione il diritto a percepire stipendi e/o indennità per l’attività svolta. Voglio però dire che il politico deve mettere in conto una sproporzione tra ciò 28 che dà con il suo servizio e ciò che riceve, sia in termini economici che in termini di gratificazione umana. Anzi dovrà mettere nel conto anche l’offesa, la maldicenza, l’ingratitudine di quanti vorranno colpirlo e screditarlo, magari, proprio a ragione della sua onestà e del suo rigore morale. Se spesso nel concreto dell’agire politico gli atteggiamenti che ho descritto sono sembrati perdenti è perché in tanti ci siamo limitati a denunciare che la politica è una “cosa sporca” e, per non sporcarci le mani, abbiamo lasciato il campo libero a chi vive il potere della politica come tentazione. Ma questo atteggiamento non è più consentito. Di fronte alle grandi e piccole ingiustizie che ogni giorno si commettono nei nostri paesi, così come nel mondo intero, di fronte alle violenze, alle guerre, alle discriminazioni... nessuno di noi può dire: io non sapevo, io non immaginavo, perché i giornali, la TV, internet portano nelle nostre case tutte le miserie del mondo contemporaneo. L’assenza è oggettivamente una complicità con chi cede alle tentazioni del potere e trasforma la politica da strumento di promozione umana a strumento di oppressione. E, se per tutti l’assenza è complicità, per il cristiano l’assenza è anche peccato di omissione: «Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite benedetti dal Padre mio, prendete possesso del Regno preparato per voi sin dall’origine del mondo. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero pellegrino e mi ospitaste, nudo e mi copriste, infermo e mi visitaste, ero in carcere e veniste a trovarmi. Allora i giusti diranno: Signore quando ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da bere? Quando ti vedemmo pellegrino e ti ospitammo? Nudo e ricoprimmo? Quando ti vedemmo infermo o in carcere e venimmo a trovarti? E il Re risponderà loro: in verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete fatto a me» (Mt. 25, 34-40). A me piace pensare al potere come a una risorsa della politica per scrivere questa pagina di Vangelo nella storia degli uomini di oggi. 29 30 LE FATICHE DI SISIFO DEI CATTOLICI IN POLITICA PIERO CASILLO* Premessa Voglio preliminarmente evidenziare il solco in cui mi muovo con le riflessioni che vengo a proporvi, anche per segnarne il limite. Quando si parla di politica, infatti, si pensa subito ai partiti e alle istituzioni, al governo e al potere. E dico subito che è alla politica in tale accezione comune che si intendono riferire le presenti riflessioni. Non bisogna dimenticare, però, che vi sono due concetti diversi, distinti di politica. Il primo attiene alla politica nel suo significato più ampio (la politica c.d. con la P maiuscola) nel senso cioè di cultura politica: “Ad essa, in effetti, spetta precisare i valori fondamentali di ogni comunità, conciliando l’uguaglianza con la libertà, l’autorità pubblica con la legittima autonomia e partecipazione delle persone e dei gruppi, la sovranità nazionale con la convivenza e la solidarietà internazionale. Essa definisce anche i mezzi e l’etica dei rapporti sociali” 1 . Dunque, nel contesto di questa prima più ampia accezione, rientrano nel concetto di Politica pure le attività sociali, quelle assistenziali, di volontariato, di ispirazione religiosa e culturale, non elaborate direttamente dai partiti e dalle istituzioni dello Stato,ma nate spontaneamente dall’impegno sociale dei mondi vitali. Naturalmente, in tale senso ampio la politica interessa anche la chiesa e pertanto i suoi pastori, ministri dell’unità. La chiesa, in questo senso, fa politica contribuendo a promuovere i valori che devono ispirare la prassi politica. La seconda accezione di politica, come accennavo, è quella usata più comunemente: ci si riferisce, cioè, alla prassi dei partiti, dei sindacati, del governo, delle istituzioni, al loro programma di cose da fare, alla traduzione tecnica dei valori, dei bisogni e delle aspirazioni della società civile, da coordinare in vista del bene comune. * Conferenza tenuta il 30 Aprile 2002. 1 Puebla Comunione e partecipazione AVE, Roma, 1979, n. 521 (documento finale della terza Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano). 31 E’ la politica con la p minuscola. E’ la prassi politica che viene dopo la cultura politica, nel senso che la suppone e la traduce in pratica operativa. Questa politica partitica è il campo proprio dei laici. Quindi, Politica (con la P maiuscola) e politica (con la p minuscola) sono due aspetti distinti ma tra di loro inseparabili della stessa realtà. A tal punto che la rottura tra cultura politica e prassi politica porta alla crisi della politica in sé. Di conseguenza, quando i protagonisti della politica (i partiti in particolare) perdono il collegamento con il proprio retroterra sociale e culturale, sono destinati a morire. Tali precisazioni aiutano a “comprendere che cosa si deve precisamente intendere quando i documenti della chiesa parlano dei diversi modi della presenza sociale (e politica) dei fedeli laici e della comunità cristiana; quando parlano cioè di scelta sociopolitica dei primi e di scelta religiosa della seconda; oppure quando parlano di possibile o anche di necessaria supplenza politica da parte della chiesa in determinate situazioni di emergenza; quando parlano, infine, dell’urgenza d’investire uomini e mezzi nell’opera di formazione dei fedeli laici sia all’impegno sociale e politico, sia allo stile cristiano di fare politica, istituendo luoghi d’incontro e di dialogo per quanti desiderano confrontarsi e prepararsi a divenire costruttori e protagonisti della civiltà dell’amore” 2 . 1. BREVE EXCURSUS STORICO DELLA PRESENZA DEI CATTOLICI NELLA POLITICA ITALIANA Riprendo da un libro del 1991 di Bartolomeo Sorge3 il profilo storico sino agli inizi degli anni ottanta. La nascita nel 1944 della DC di De Gasperi si lega strettamente all’esperienza del PPI (soppresso da Mussolini nel 1926). Secondo l’intuizione di Sturzo il primo elemento essenziale di una presenza politica dei cattolici doveva essere quello di una chiara ispirazione cristiana. Il punto VIII del Programma del Partito Popolare afferma inequivocabilmente che “la coscienza cristiana va considerata come fondamento e presidio della vita della nazione, delle libertà popolari e delle ascendenti conquiste della civiltà nel mondo”4 . Tale fedeltà 2 B. Sorge, Per una civiltà dell’amore: La proposta sociale della Chiesa. Queriniana, Brescia, 1966, pag. 190. 3 Cattolici e politica, Armando editore, Roma 4 cfr. Civiltà Cattolica, 1919 I 250-254 32 all’ispirazione cristiana va però vissuta, secondo Sturzo, nel pieno rispetto dell’aconfessionalità del partito. Nella relazione al primo congresso del Ppi, tenuto a Bologna il 14 giugno 1919, Sturzo afferma che “Non possiamo trasformarci da partito politico in ordinamento di Chiesa, né abbiamo diritto di parlare in nome della Chiesa, né possiamo essere dipendenza ed emanazione di organismi ecclesiastici, né possiamo avvalorare della forza della Chiesa la nostra organizzazione politica… nelle diverse attività e nelle forti battaglie, che solo in nome nostro dobbiamo e possiamo combattere, sul medesimo terreno degli altri partiti con noi in contrasto”. Ulteriore elemento dell’identità del partito, secondo Sturzo, era la sua dimensione popolare, l’interclassismo vissuto non in modo statico bensì dinamico, al fine della promozione dei ceti più deboli ed emarginati. Il quarto elemento identificativo era la democrazia, dovendo il partito d’ispirazione popolare mantenere il suo collegamento con tutte le masse popolari, a differenza dei partiti liberali, espressione dei dominanti ceti borghesi. Tale concezione di partito non era ben vista da tanti nella stessa Chiesa. Anche De Gasperi si trovò, con la DC, a fronteggiare, all’esterno, i problemi posti dalla ricostruzione postbellica e da un mondo diviso in blocchi; e, all’interno, un laicato cattolico che, durante il ventennio fascista, pur riuscendo a sopravvivere, non era riuscito comunque a sviluppare una visione politica autonoma. I cattolici, infatti, durante il ventennio, dovettero astenersi da ogni impegno politico, per dedicarsi esclusivamente alla formazione religiosa; i laici, secondo la visione che allora si aveva dell’Azione Cattolica (la massima organizzazione del laicato), erano collaboratori della gerarchia nell’apostolato, dipendendo totalmente dal clero. 1.1. Primo periodo (1946-1958). L’iniziativa della Gerarchia. E’ caratterizzato dalla ricostruzione post-bellica e dal centrismo. La Chiesa, che era rimasta l’unica grande forza morale e sociale sopravvissuta al fascismo, era punto di riferimento di una nazione sbandata, per cui esercitava una funzione di supplenza anche politica, tra l’altro in un contesto internazionale dominato dal conflitto tra la democrazia occidentale e il comunismo sovietico. Nacque così il blocco cattolico apertamente sostenuto da Pio XII. Questo pose un’ipoteca pesante sulla presenza dei cattolici in politica che si tradusse in una gestione (per conto della gerarchia) di un progetto in funzione essenzialmente anticomunista. Così la DC degasperiana, 33 che ebbe senz’altro il merito di acquisire alla democrazia larghe masse di cattolici, non riuscì però ad attuare larghi tratti del progetto politico sturziano, specie con riguardo allo sviluppo della laicità dell’impegno politico dei cattolici. 1.2. Secondo periodo (1958-1963). L’iniziativa del partito. Prima con Fanfani e poi in particolare con Moro l’iniziativa fu assunta sempre più dalla DC, anche per la concomitante presa di distanza da parte della Gerarchia (cf. il papato di Giovanni XXIII). Anche a seguito dell’evoluzione del PSI (col congresso di Venezia del 1957) si aprivano possibilità nuove di schieramenti politici ed il centrismo entrò in crisi. Moro intuì il nuovo momento politico e al congresso di Napoli del 1962 ripropose il ritorno (seppure aggiornato alla luce delle vicende storiche intervenute) all’ispirazione sturziana del popolarismo. In particolare, con tale illuminante discorso (non ancora digeribile da parte del mondo cattolico) Moro affrontò il discorso dell’ispirazione cristiana del partito e ribadì che i dati della coscienza morale e religiosa dovevano essere mediati nelle scelte politiche, le quali sono di natura contingente ed hanno regole loro proprie. 1.3. Terzo periodo (1963-1976). La grande crisi. Col Concilio si afferma in maniera inequivocabile l’autonomo valore delle realtà storiche e si getta un germoglio non più arrestabile circa la fine del collateralismo cattolico con il partito della democrazia cristiana. D’altro canto, il miracolo economico segna un brusco arresto (si pensi alla crisi petrolifera dei primi anni settanta) ed esplode nel ’68 la contestazione studentesca ed operaia. Anche l’associazionismo cattolico (in forte crisi d’identità e di numeri) è attraversato da fermenti che si ispirano al Concilio. L’Azione Cattolica (passata da 3 milioni a 600 mila iscritti) compie la scelta religiosa con Bachelet, che è di fondamentale importanza per capire la successiva evoluzione dei rapporti della Chiesa con la DC, che vede sempre più franare i ponti che la tenevano collegata al suo tradizionale retroterra culturale. Di conseguenza, la politica di partito, priva di ispirazione culturale, diviene fine a se stessa, si traduce in mera gestione e lottizzazione di potere tra le correnti e con gli altri centri di potere. In tale momento oscuro il vero salto di qualità lo compì la Chiesa con la scelta religiosa: si tratta di una scelta che restituisce credibilità pastorale alla gerarchia e che offre ai cattolici la possibilità di attuare 34 pienamente l’ideale di don Sturzo oltre che di muoversi in maniera più viva in ambito sociale e culturale. 1.4. Quarto periodo (1976-1983). L’iniziativa del mondo cattolico. Vi è una vigorosa ripresa del mondo cattolico organizzato, a partire dal convegno nazionale del 1976 su “Evangelizzazione e promozione umana”. Riprende vigore il discorso sulla necessità di ritornare alle intuizioni sturziane. Questo però in un momento storico certamente più difficile di quello in cui ha operato Sturzo. Infatti, l’ispirazione cristiana della politica occorre tradurla in un contesto socio-culturale non più omogeneo e cristianizzato, bensì in un ambito secolarizzato e pluralista. 1.5. Quinto periodo (1984-1992). Il ritrovato vigore del mondo cattolico e la crisi del partito cattolico Secondo Pasquino5 tre elementi costituivano l’asse portante della strategia democristiana per il mantenimento del consenso: - il clientelismo, - la rappresentanza politica dei cattolici, - l’anticomunismo. A provocare il loro crollo furono: - con la sempre più forte integrazione europea, l’impossibilità di continuare a finanziare il clientelismo con il disavanzo di bilancio, - con la caduta del muro di Berlino nel 1989, l’anticomunismo perde gran parte della sua spendibilità in termini d’identità elettorale (anche se occorre dire che essa non è persa integralmente, anche per la presenza ancora oggi di partiti che si richiamano nel nome a tale esperienza. Dal che l’astuto uso propagandistico che ancora ne fa Berlusconi), - col Concilio, come innanzi detto, era cominciato il lungo processo di fine dell’esperienza della rappresentanza unitaria dei cattolici in politica, che trova il suo epilogo proprio in questi anni, anche a causa di una sempre più diffusa e radicata coscienza in ambito ecclesiale della scelta religiosa che deve contraddistinguere l’associa5 cf. G.Pasquino, Recenti trasformazioni nel sistema di potere della Democrazia cristiana in Graziano-Tarrow (edd.) “La crisi italiana, vol.II, Sistema politico e istituzioni, Einaudi, Torino, 1979, p.627. 35 zionismo cattolico e, d’altro canto, della sempre più forte laicizzazione del partito democristiano (che viene percepito sempre meno come partito cattolico e sempre più come contenitore di correnti impegnate nella spartizione del potere e nell’occupazione dello Stato). D’altro canto, il pontificato di Giovanni Paolo II (si noti: un Papa non italiano dopo molti secoli) rivolge la sua attenzione alle problematiche socio-politiche di valore “globale”. Come afferma padre Sorge6 : “E’ sensibile, nelle encicliche sociali del Papa, lo spostamento dell’attenzione della chiesa dai sistemi politici ed economici all’uomo in sé, dall’aspetto quantitativo dei problemi a quello qualitativo.. la chiesa vive.. una fase profetica. Il suo discorso sociale, in risposta alle sfide etiche fondamentali del nostro tempo, è essenzialmente l’annuncio profetico del Vangelo della vita, del vangelo del lavoro e del vangelo della carità”. La DC, d’altro canto, è sempre più irretita in una mera e cinica gestione del potere, in competizione col PSI al cui segretario Craxi cede la guida del governo, prodromica alla sua crisi esiziale che avrà poi il suo compimento (non certo la sua causa) con tangentopoli. 1.6. Sesto periodo (1992-2001). La questione morale con tangentopoli, la fine della DC, la nascita del Partito popolare e degli altri partiti di ispirazione cristiana. Con tangentopoli si ha l’epilogo della democrazia cristiana, i cui prodromi, come fatto cenno, si ritrovano, da un lato, sul versante religioso sin dal Concilio Vaticano e, dall’altro, sul versante sociopolitico con la contestazione operaio-studentesca del’68-’69 che fa esplodere la società civile: Questa, infatti, non riesce più ad essere gestita dal contenitore-Stato, col quale di fatto si identificava il partito-mamma della DC. Il 22 gennaio 1994 viene costituito il nuovo Partito Popolare che, nel preambolo dello Statuto, si dichiara quale Partito di ispirazione cristiana. E’ chiara, sin dal nome, l’intenzione di ridare vigore all’intuizione di Sturzo che, negli anni venti, aveva fondato il Partito Popolare, volutamente laico ed espressione dei fermenti del mondo cattolico (particolarmente vivo a livello sociale, anche per il non expedit del 1874 di Pio IX e dopo la Rerum Novarum di Leone XIII del 6 36 Per una civiltà dell’amore, op. cit., p.66 1891). Ma non tutti i democristiani confluiscono nel nuovo soggetto politico. Una parte degli ex DC, guidata da Casini e Mastella, fonda il Centro cristiano democratico. Anche per tale partito, nello Statuto si afferma che esso si ispira ai principi cristiani. Nel 1995 il PPI si divide: i popolari di Buttiglione siglano un accordo elettorale con il centro-destra, mentre i popolari guidati da Gerardo Bianco aderiscono alla coalizione di centro-sinistra.. Buttiglione poi fonda nel luglio del 1995 il CDU (Cristiani democratici uniti): nel preambolo dello Statuto si afferma che esso è ancorato all’insegnamento sociale della Chiesa. Accanto a tali neonati partiti, i discendenti della vecchia DC sono molteplici: Patto Segni, Cristiano Sociali, La rete, Unione Democratica, Italia Federale, Rinascita della Democrazia Cristiana7 . Il processo di disgregazione si accentua ulteriormente nel luglio del 1998 con la nascita dell’UDR (Unione democratica per la repubblica) di Francesco Cossiga. “Le scelte politiche derivanti dalla condivisione del progetto di Cossiga che si propone di coalizzare le forze di centro in alternativa alla sinistra e in posizione distinta e distante dalla destra, porteranno infatti alla scissione del CCD, con una sua parte che rimarrà fedele alle alleanze sedimentate nel Polo delle libertà e una parte che aderirà all’UDR. Questa seconda parte, guidata da Mastella, darà vita a un nuovo partito: il CDR (Cristiano democratici per la repubblica). Anche il CDU aderisce all’UDR, ma questa decisione non è unanime.Una componente minoritaria del partito, raccolta attorno a Formigoni, rigetta l’accordo con Cossiga ed esce dal partito fondandone un altro: il CDL (Cristiano democratici per la libertà)”8 . Continua ancora il Bova, commentando tale molteplicità di iniziative partitiche fiorite sulle ceneri della DC che “La balena bianca, che per quasi un cinquantennio era stata capace di contenere al suo interno posizioni ideologiche ed esperienze apparentemente inconciliabili, sembra trasformarsi in un disorientato banco di variegati pesciolini” .9 Più recentemente, alla vigilia delle elezioni politiche del 13 maggio, una nuova formazione politica voluta da Andreotti, D’Antoni e Zecchino rilancia la sfida di una presenza politica che vuole adottare, in forma autonoma dai poli di centro-destra e di centro sinistra, 7 cf. V. Bova, Cattolici e politica. Evoluzione nell’ultimo cinquantennio. In “Aggiornamenti Sociali” n. 7-8/2001, pagg. 565-576, p.565. 8 Ibidem, pp.565-566 9 Ibidem, p.566 37 gli stessi valori e principi che stanno all’origine della costruzione europea e che hanno ispirato l’azione dei suoi padri fondatori: nasce così Democrazia Europea. Il confronto tra conservatori e progressisti tende a radicalizzarsi, confermando che il Paese è avviato irreversibilmente (almeno per il medio periodo) sulla via del bipolarismo. Tuttavia siamo ancora lontani da una democrazia dell’alternanza; il nostro bipolarismo è ancora più a livello di coalizione elettorale che di effettiva omogeneità culturale e programmatica. D’altra parte non si può non rilevare che l’elettorato continua a bocciare ogni tentativo di creare un terzo polo: nel 1995 non vi riuscirono né Rifondazione comunista, né la Lega Nord; il 16 aprile 2000 furono bocciati i Radicali della Lista Bonino; così come è fallito ogni tentativo di tentare l’avventura del grande Centro, alternativo alla sinistra e distante dalla destra. Tale ipotesi si è dimostrata improponibile “almeno per due ragioni. In primo luogo, perché in Italia non esiste una sola cultura omogenea di centro (come, per esempio, in Germania); da noi, il centro stesso è diviso: la cultura neoliberista è di centro (centro-destra), ma è diversa dalla cultura sociale che pure è di centro (centro-sinistra). In secondo luogo, perché - in un sistema bipolare - un eventuale polo moderato di centro si contrapporrebbe di fatto al polo progressista, diverrebbe per ciò stesso un polo conservatore, nel quale i cattolici democratici non potrebbero mai ritrovarsi.”10 2. PROSPETTIVE DELLA PRESENZA DEI CATTOLICI IN POLITICA Come accennato al punto precedente, vi è una condizione di evidente instabilità del mosaico dei partiti che si richiamano alla tradizione politica dei cattolici. Si moltiplicano i contenitori (a volte sedicenti) dell’agire politico cristianamente ispirato e si accentua nel contempo la disponibilità dell’elettorato cattolico a esprimere diversificate esperienze politiche11 . Di tale situazione vi è, del resto, chiara eco sin dal Convegno ecclesiale svoltosi a Palermo nel 1995, laddove si è affermato che “La fine dell’unità partitica dei cattolici e la conseguente frammentazione che non ha ancora trovato assetti adeguati e maturi au10 B. Sorge, L’area popolare democratica in “Aggiornamenti sociali” n. 910/2000 pag. 629. 11 Cf. Bova, articolo cit., p. 567 38 mentano nelle comunità ecclesiali il rischio delle divisioni e dell’indifferentismo verso la politica”.12 Negli ultimi giorni si stanno, però, avviando processi di aggregazione che tendono a semplificare il panorama politico italiano e, per quanto in questa sede interessa, le formazioni che si rifanno alla tradizione del cattolicesimo politico. Ci si riferisce, come è noto, ai nuovi soggetti politici della Margherita (neonato col congresso costitutivo del mese di marzo) e dei Democratici cristiani- Biancofiore (che nascerà ufficialmente col congresso previsto per il prossimo mese di luglio). Come è noto, nello scorso mese di marzo il Partito Popolare, unitamente ai Democratici e a Rinnovamento Italiano, è confluito nella neonata Margherita, a capo della quale vi è Francesco Rutelli. Le ragioni di tale scelta da parte dei popolari sono state esplicitate da Castagnetti nella relazione introduttiva dell’ultimo congresso del Partito Popolare, della quale ci sembra utile riportare alcuni stralci. “Diamo corpo” dice PierLuigi Castagnetti “a una svolta che insieme avevamo individuato come necessaria sin dal congresso di Rimini quando avvertimmo la necessità di riunire in un soggetto unico e nuovo tutte le formazioni del centro sinistra che si ispiravano alle culture cattolico-democratica e liberal-democratica. Adesso abbiamo anche il nome “Margherita - Democrazia è Libertà”, ma l’idea nacque allora. Avremmo potuto accontentarci di amministrare un lento e incolpevole declino del partito che i nostri padri fondarono in altri tempi, rassegnandoci alla logica inesorabile della storia che cammina con i suoi ritmi e lungo i suoi percorsi, e invece abbiamo scelto di rifiutare un destino che molti amici, che ci hanno nel frattempo abbandonato, consideravano ineluttabile. E’ sicuramente non facile lasciare ciò che si ha e ciò che si è, ma se lo si fa per una prospettiva più grande, per un’opportunità più grande, è anche edificante. E’ questo lo spirito con cui facciamo questo passo, senza superficialità ma anche senza timidezza. Noi vogliamo dar vita nel centro sinistra a una forma più matura, più al passo con la storia, più ricca, di presenza in politica dei cattolici, “non in nome della fede, ma a causa della fede” come diceva Zaccagnini”13 . 12 G.Rumi, Impegno sociale e politico in “Atti del III Convegno ecclesiale su Il Vangelo della carità per una nuova società italiana, Palermo 20-24 novembre 1995, Edizioni Paoline, Milano, 1995, p.51. 13 P.L. Castagnetti Relazione introduttiva al Congresso del PPI di Roma nei giorni 8,9 e 10 marzo 2002 in Internet 39 Ulteriori osservazioni di ordine più generale fatte da Castagnetti ci sembra utile riportare: “Dobbiamo chiederci perché i vecchi partiti a ispirazione cristiana non sono sopravvissuti in tutti i Paesi in cui si è passati al bipolarismo o si sono trasformati in partiti meramente conservatori. E, purtroppo, con l’avanzamento del processo di secolarizzazione stanno fortemente riducendosi anche in America Latina. Dobbiamo, per tornare in Italia, indagare nel profondo il risultato negativo del centro sinistra il 13 maggio, per capire come e dove è cambiato il nostro Paese, in quali aree, in quali ceti e accettare che i cambiamenti abbiano riguardato in particolare aree elettorali di riferimento cosiddetto centrista. Dobbiamo capire come e/o perché è diminuito l’appeal elettorale di partiti come il nostro, soprattutto nell’elettorato nuovo, cioè non ex, non legato esclusivamente a ciò che noi siamo stati in passato. Dobbiamo capire perché negli ultimi dieci anni la toponomastica dei partiti italiani ha subito un cambiamento pressochè totale. Recentemente uno studioso, Alessandro Corneli, ha analizzato la condizione dei partiti italiani sino a non molti anni fa “socialmente omogenei”, divenuti in seguito, con la progressiva frammentazione delle classi indotta dal superamento della società industriale, sempre più eterogenei. Il consenso che essi ricercano, prima dipendeva da una ideologia organica, poi dalla aggregazione intorno a obiettivi programmatici che a loro volta si coagulano e si esprimono in leader tendenzialmente carismatici anche per effetto della diffusione di nuovi media che diventano la nuova piazza della politica. Il partito-tutto fortemente ideologizzato diventa partito-obiettivo per realizzare un programma a ideologia debole che viene accettato da una coalizione di interessi e quindi un partito-gestore, senza quasi più riferimenti ideologici e con un confronto che si riduce a comparare i consuntivi delle proposte elettorali.”14 E ancora: “Non voglio aprire parentesi perché sono convinto che “tangentopoli” ha influito sulla “crisi dei partiti” ma non sulla crisi della politica: il vuoto politico ha altre ragioni. Il mutamento, che a dire il vero non è stato improvviso, ma che si è avvertito con l’irrompere dell’egemonia dell’alta, diffusa, tecnologia, ha eliminato le ideologie politiche, ridotto ai margini le culture 14 40 Ibidem dello spirito, in un certo senso sovvertito, se non cancellato, le gerarchie dei valori. Non è questo un riferimento alla “secolarizzazione” dei Cox, dei Robinson, della “morte di Dio” e alla sua decisiva influenza sulla “desacralizzazione” delle “chiese politiche”; voglio riferirmi al fatto che l’uomo liberato da Dio vuol liberarsi da sé stesso e al fatto che “l’umanità” non vuole essere gregge ubbidiente e asservito, e cerca un modello nuovo di produrre, di sanare, di concorrere alla ricchezza, di comunicare, di essere presenti in ogni luogo, di essere abitanti di ogni luogo: è la rivoluzione del tempo e dello spazio. La politica, come la religione, come la cultura vengono “declassate”, impoverite di ideali e di idee: aggrappate a coraggiose testimonianze, ad “eroiche solitudini”, a “missionarietà” presso le sofferenze, i disagi, le povertà; a “compromessi obbligati”; non ultimo ad espressioni di alto magistero, insistente e nuovo ma anche in gran parte inascoltato. I confini si sono allentati, anche superati: i muri delle civiltà che dividono, delle religioni che si “contestano”, che reciprocamente diffidano, delle culture che si ignorano, delle etnie che si chiudono, sono destinati a crollare perché il processo è inevitabile. Verso “l’umanità una”, “la terra una”, il prossimo sempre meno straniero e sempre più conoscibile, le “patrie gelose” sempre meno gelose e più aperte. Non siamo nel regno dell’utopia, siamo invece “nell’obbligata necessità” della creazione, apprendimento, esperienza di una nuova politica, di “nuovi valori”, di “nuove culture”. Anche su questo fronte la politica è sopravanzata. La scelta che sembra oggi vincente della “non-politica” o “dell’antipolitica” o della “politica dei privilegi del governo” non è neppure da considerarsi come un tentativo di “uscire dalla crisi” ma, nel breve termine, essendo la scelta più facile, è risultata quella vincente. Per quanto tempo non si sa, per ora è così. Non si può per questo restare fermi e paralizzati. Non si può attendere che il cambiamento accada da solo, occorre, invece, determinarlo. L’unica cosa che non si può fare è “stare, abitare, convivere” nella “crisi della politica” che, ripeto, ha molte cause, anche quella della frammentazione, della “ricerca-diritto” di visibilità di ogni gruppo e frammento che rallenta la “sintesi”, la capacità progettuale. Di’ qualcosa di “sinistra” urlava Nanni Moretti a Massimo D’Alema già qualche tempo prima di Piazza Navona. Altri potrebbero aggiun- 41 gere: “dite qualcosa di centro-sinistra”. Altri ancora: “dite qualcosa di centro. E, recentemente, “dite qualcosa di cristiano”. Non sono richieste prive di fondamento: liberate dall’accento, dal tono di sfogo angosciato, stanno a significare: portateci fuori dalla crisi politica, non vi accorgete che la società è “senza politica”? E’ vero che i problemi sono più “forti” di chi è chiamato a risolverli ma non si può ricorrere all’alibi che i problemi sono difficili, ricchi di incognite, imponenti. La politica non è l’arte dell’ovvio, di ciò che è facile: è l’arte di promuovere, ordinare, regolare i rapporti, i processi di sviluppo sociale, culturale, economico per un “bene comune”: deve produrre le condizioni di “libertà e di giustizia” soprattutto per chi è povero di libertà e di giustizia. Abbiamo dimenticato cose che sapevamo e stiamo imparando cose che non sapevamo: per quelle del passato avevamo una storia che ci aveva maturato, delle esperienze cui riferirci, delle sedi di riflessione: ora siamo un po’ soli e non abbiamo una “riserva” in cui pescare il pensiero, le suggestioni, le ispirazioni, le culture. Allora c’era uno stretto rapporto tra cultura e politica. Un rapporto dialettico, necessario, non perché gli intellettuali fossero o dovessero essere impegnati ma perché c’erano piccole e grandi capitali della cultura. Ora non c’è alcuna cultura che anticipi ciò che accade o può accadere, cioè che, in un certo senso, cammina davanti a noi. E’ una trasformazione epocale della società umana. Ha scritto Khaled Fouad Allam: «… la cultura non sa più interpretare il mondo e non è più in grado di farlo, non può chiedere alla politica, ai partiti di farlo». Allora quell’urlo “dite qualcosa” è l’urlo dello smarrimento, della paura di essere ingoiati dalla “non-politica”. E noi dobbiamo avere l’umiltà, l’abnegazione, il coraggio di non essere smarriti, di non affogare nella crisi della politica. Per questo abbiamo superato o, per meglio dire, abbiamo dovuto superare, il cespuglio per far crescere qualcosa di maggiore forza e di maggiore consenso. Per questo facciamo la Margherita.”15 In questi giorni si sta dando vita all’UDC (Unione democristiana di centro) dato dalla confluenza del CCD di Casini, del CDU di Bottiglione e di Democrazia Europea di D’Antoni. Siamo ancora in un’ottica bipolare, apparendo non ancora vicino il (da alcuni auspicato) bipartitismo. Sembra infatti condivisibile 15 42 Ibidem quanto ha scritto Sorge: “Per molto tempo ancora in Italia, i due poli saranno costituiti ognuno da soggetti politici diversi, ciascuno con la propria identità e con la propria storia, uniti da un leader e da un programma comuni, ma non potranno trasformarsi in due grandi partiti. Infatti, dopo cinquant’anni di dura contrapposizione ideologica, ci vorranno ancora molti anni prima che gli epigoni di tradizioni tanto diverse raggiungano tra loro una totale omogeneità, culturale e politica, da consentirne la fusione in un unico partito”.16 Il movimento dei girotondi, di chiara marca di sinistra, animato da intellettuali legati ai partiti della sinistra, ha indotto anche alcuni intellettuali cattolici a esternare la loro frustrazione circa la mancanza di effervescenza del mondo cattolico. In particolare Giorgio Campanini ha lamentato la mancanza di luoghi di dialogo, denunciando i ritmi a dir poco lenti (decennali) dei convegni ecclesiali e l’intermittenza delle settimane sociali. Per superare tale impasse egli auspica un salutare scossone (sul modello di quello dato da Nanni Moretti alla sinistra) per comunità cristiane pigre e “tutte prese dai loro problemi interni, preoccupate soprattutto di tenere in piedi strutture istituzionali fattesi ormai scricchiolanti per il progressivo venir meno dell’abbondante personale ecclesiastico di un tempo”17 . Al convegno del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) tenuto a Roma lo scorso mese di ottobre Francesco Casavola ha riflettuto sulla necessità di ripensare il posto dei cattolici nella politica italiana di oggi: cattolici divisi tra il disorientamento e la voglia di contare. Le conseguenze della fine della DC e del crollo delle ideologie non può essere vista solo come una diaspora disordinata dei cattolici nei diversi schieramenti politici. Ha affermato l’ex presidente della Corte costituzionale che “La diaspora dei cattolici in più partiti non si legittima solo a partire dall’insegnamento conciliare. Ma soprattutto a partire dal mutamento della concezione della democrazia. E’ tramontata la democrazia dei partiti dove gli elettori non erano altro che degli eserciti permanenti legati ai partiti da opinioni confessionali, di classe, di ideologia. Ed è stata inaugurata l’era del pluralismo che rende più acuta la preoccupazione della coerenza con i valori che devono illuminare le scelte ma, allo stesso tempo, apre nuovi orizzonti”. 16 17 L’area popolare... cit., pag.630 Avvenire del 28-2-2002. 43 Secondo Lorenzo Ornaghi, prorettore dell’Università Cattolica Sacro Cuore, occorre investire molto sulla formazione dei cattolici, cominciando dal progetto culturale lanciato dai vescovi italiani che va portato avanti nei vari contesti dove operano i cattolici, perché non resti sterile esercizio intellettuale. 3. I FONDAMENTI TEOLOGICI DELLA PRESENZA DEI CATTOLICI IN POLITICA Seppure per brevi cenni, in presenza di tale delineato panorama storico-politico, ci preme esplicitare la fondazione teologico-morale dell’impegno del cristiano nella città dell’uomo – come si usava dire sino a qualche tempo fa –. E questo anche per capire la ragione prima della passione della chiesa e del cattolico per la politica. Il nostro vescovo, nell’intervento fatto l’11 giugno 2001 ai parlamentari e ai sindaci della diocesi nel salone dell’episcopio, ha richiamato l’orizzonte dei rapporti chiesa-mondo, fede-politica delineato nel quarto capitolo dello costituzione conciliare Gaudium et Spes. “La missione della chiesa è rivolta” ha detto il vescovo “alla salvezza di tutto l’uomo e perciò non può rimanere estranea e indifferente a nessuna situazione umana; anzi è sollecitata a non essere disincarnata, a non staccare la fede dalla vita quotidiana, ad evidenziare la rilevanza sociale della fede”… Al n. 76 della Gaudium et Spes è magistralmente delineato tale rapporto nel quale si evidenziano la distinzione dei compiti, l’autonomia legittima di tutte le realtà umane e il diritto di insegnare la fede e la sua dottrina sociale e da parte della chiesa dare il giudizio morale anche su cose che riguardano l’ordine politico… Diventa prioritaria una rifondazione culturale della politica, urgenza delle urgenze non solo per rispondere a sfide storiche ma per recuperare una sapienza ordinatrice dell’agire politico. Di fronte al carattere pervasivo di un economicismo tecnocratico che ha fagocitato gli spazi della politica, gli spazi cioè di una riflessione e di una progettualità capaci di mediare e di individuare soluzioni concrete alle nuove domande emergenti da ogni ambito di vita, occorre riflettere sul tipo di società, di umanesimo che si vuole costruire… La pluralità degli approcci, la varietà delle appartenenze e dei modi di essere spesso finiscono col ridurre le questioni essenziali dell’uomo ad una formula privata su cui si esercita l’osanna della platea e il crucifige delle masse. La prospettiva economica vincente ha modellato comportamenti, valori, relazioni, stili di vita strutturati 44 solo in vista del successo, del potere, del benessere.. Anche il sapere è coinvolto nella frammentazione e nel disorientamento, è sempre più fruito come bene di consumo, funzionale ad un agire politico che frutta e dà vantaggi.” A fronte di tale “finanziarizzazione della vita quotidiana”18 il cristiano è chiamato profeticamente a promuovere la civiltà dell’amore di cui parlava spesso Paolo VI 19 e che “compendia tutta l’eredità etico-culturale del vangelo”20 . L’Istruzione della Congregazione vaticana, allo stesso n. 81, così continua: “Questo compito richiede una nuova riflessione su ciò che costituisce il rapporto del comandamento supremo dell’amore con l’ordine sociale considerato in tutta la sua complessità. La conclusione diretta di questa profonda riflessione è la elaborazione e l’attuazione di audaci programmi d’azione in vista della liberazione sociale ed economica di milioni di uomini e donne, la cui condizione di oppressione economica, sociale e politica è intollerabile. Questa azione deve cominciare con uno sforzo assai grande dell’educazione: educazione alla civiltà del lavoro, educazione alla solidarietà, accesso di tutti alla cultura”. Ciò che i vescovi latino-americani hanno detto più di 30 anni fa 21 è quanto mai attuale anche per noi italiani: “La mancanza di una coscienza politica nei nostri Paesi rende indispensabile l’azione educatrice della chiesa per far sì che i cristiani considerino la loro partecipazione alla vita politica della nazione come un dovere di coscienza e come esercizio della carità, nel suo significato più nobile ed efficace per la vita della comunità”. Così ancora la Lumen Gentium al n.36 indica mirabilmente come i laici debbono sanare le istituzioni e le situazioni del mondo così che tutto prenda giusta forma e sia di promozione per l’esercizio 18 cf. G.Bianchi, Nel paese degli atei devoti. I Cattolici oltre il partito unico. Roma, Editori Riuniti, pagg. 52 ss.. E’ significativo che il sottotitolo del paragrafo citi la seguente frase di David Maria Turoldo: “E la rinuncia è più ricca della preda imperiale”. 19 Cf. l’enciclica di Giovanni Paolo II Sollicitudo rei socialis del 30-12-1987 n.33, che così riassume tale civiltà dell’amore: “Il cristiano.. chiamato alla partecipazione della verità e del bene, che è Dio stesso, non comprende l’impegno per lo sviluppo e la sua attuazione fuori dell’osservanza e del rispetto della dignità unica di questa immagine. In altre parole, il vero sviluppo deve fondarsi sull’amore di Dio e del prossimo, e contribuire a favorire i rapporti tra individui e società”. 20 Istruzione Libertatis Conscientia della Congregazione per la dottrina della fede, 22-3-1986, n.81. 21 Presencia de la Iglesia, documento della II Assemblea Generale dell’Episcopato latino-americano a Medellin (Colombia), 6-9-1968, n.16 45 delle virtù: “in ogni cosa temporale (i fedeli) devono lasciarsi guidare dalla coscienza cristiana, perché nessuna attività umana, nemmeno temporale, può sottrarsi al dominio di Dio. Nel nostro tempo è molto importante che questa distinzione e, insieme, quest’armonia risplendano chiaramente nel modo di agire dei fedeli, perché la missione della chiesa possa rispondere più pienamente alle condizioni particolari del mondo moderno. Come infatti bisogna riconoscere che la città terrena, dedita giustamente alle occupazioni temporali, è retta da propri principi, così va rigettata a ragione la funesta dottrina che pretende di costruire la società senza tenere in alcun conto la religione, combattendo e sopprimendo la libertà religiosa dei cittadini”. Ovvero, riducendola a mero esercizio privato. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Pur avendo precisato il piano, storico-politico, nel quale si è dipanato il presente intervento, non posso esimermi, dopo aver delineato i fondamenti dell’impegno del cattolico in politica, da una conclusiva considerazione che si muove ad un livello distinto (ma ovviamente non separato rispetto alla prassi politica) che è quello etico e religioso. “Dopo la seconda guerra mondiale, caduti i regimi totalitari, di fronte alle nuove esigenze di un regime democratico ormai universalmente affermato e di fronte al pericolo comunista, con Pio XII il movimentismo cattolico assume le caratteristiche di un vero e proprio mondo cattolico: si stringono i ranghi, si mobilitano i laici cattolici nelle più diverse associazioni, e tutte le associazioni affiancano il partito democristiano; nasce il collateralismo tra la chiesa, i movimenti cattolici e il partito cattolico. Si crea così una situazione che sarebbe durata sino al Concilio, e sarebbe stata superata definitivamente soltanto dalla caduta del muro di Berlino e dopo il fallimento storico del comunismo (1989). Giungiamo così agli anni novanta e all’Area culturale di ispirazione cristiana. Tramontato il mondo cattolico, s’impone la necessità di trovare un modo nuovo di presenza sociale della chiesa e dei cattolici adeguata al momento di transizione che vive nel delicato passaggio al terzo millennio. Ora, data la natura essenzialmente culturale, morale e spirituale della crisi, il bisogno più urgente che si avverte è quello di risolverla proprio a partire da queste sue radici, 46 cioè dalla riaffermazione dei valori etici e culturali.… Essa dovrebbe essere un’area intermedia: cioè autonoma sia nei confronti dell’area ecclesiale propriamente detta, sia dell’area politica. … l’iniziativa dovrebbe essere gestita dai laici, ai quali spetta per vocazione nativa la competenza specifica di animare cristianamente le realtà temporali.” 22 L’attuale Papa, in un discorso tenuto al Convegno della Chiesa italiana per il 90° della Rerum Novarum23 aveva affermato che dopo il livello dell’unità soprannaturale vi è un secondo livello, collegato col primo: il livello dell’unità sui valori. Questa unità si realizza sul piano etico e culturale e “consiste nella fedeltà alla verità intera sull’uomo, con le esigenze morali incondizionate e assolute che ne scaturiscono” 24 . E’ una unità che nasce dalla coerenza con la fede e con il Magistero della Chiesa e che induce spontaneamente i cristiani ad agire uniti ogni volta che sono in gioco i valori fondamentali dell’uomo e della convivenza sociale. Proprio questa “unità fondamentale sui valori è prima di ogni pluralismo e sola consente al pluralismo di essere non solo legittimo, ma auspicabile e fruttuoso”.25 Tale unità morale e culturale si può definire politica con la P maiuscola e di per sé orienta verso la medesima direzione la prassi politica. In questo senso – come ha ribadito Giovanni Paolo II al terzo convegno nazionale della Chiesa italiana – il legittimo pluralismo politico “nulla ha a che fare con una diaspora culturale dei cattolici, infatti il cristiano non può ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con la fede, né può dare una facile adesione a forze politiche o sociali che si oppongono o non prestano sufficiente attenzione ai principi della dottrina sociale della chiesa sulla persona e sul rispetto della vita umana, sulla famiglia, sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione della giustizia e della pace”26 “I cristiani, cioè, sono tenuti a offrire al mondo il servizio e la testimonianza anche comunitaria della loro fede. Quindi l’unità culturale e morale è un bene da perseguire tra i cristiani. L’unità culturale si dovrà allora trasformare in unità partitica…? Giovanni Paolo II 22 Sorge, B. Per una civiltà dell’amore.La proposta sociale della Chiesa. Queriniana, Brescia,1996 pagg. 186-187 23 Si veda il testo integrale in “Dalla Rerum novarum a oggi. Atti del Convegno ecclesiale (Roma, 28-31 ottobre 1981), AVE, Roma 1982, 11-15 24 Ivi, n. 3,13 25 Ivi, n.14 26 ID., Discorso al III Convegno ecclesiale di Palermo (23 novembre 1995), n.10, in Osservatore Romano, 24 novembre 1995. 47 non evita di affrontare il tema della possibile unità politica dei cattolici, ma non parla più di unità partitica; si limita soltanto a sottolineare la utilità di una eventuale concordia nell’azione. La concordia o convergenza dei cattolici nella azione politica è sempre auspicabile, perché è condizione del servizio cristiano al mondo… pertanto, la concordia nell’azione è desiderabile, nonostante la piena legittimità del pluralismo delle scelte”27 Come hanno precisato anche i vescovi italiani, l’identità cristiana “a scanso di equivoci, non coincide con i programmi di azione culturale, sociale o politica che i cristiani, singoli o associati, perseguono. Si fonda invece sulla fede e sulla morale cristiana, con il loro preciso richiamo all’insegnamento della chiesa in campo sociale, si vive nella comunione ecclesiale e si confronta fedelmente con la Parola di Dio letta nella chiesa. E’ una identità da incarnare (senza rivendicarla solo per sé) nel pluralismo delle situazioni, giorno per giorno”28 “La fine del mondo cattolico e la crisi di identità.. hanno messo in crisi ineluttabilmente pure l’esistenza dei partiti d’ispirazione cristiana… (ma) pur nel mutato contesto socioculturale, è giusto ribadire tuttora la piena legittimità teorica e pratica della presenza di partiti d’ispirazione cristiana .. (e questo perché) in regime democratico e nella società pluralistica, una qualche forma di aggregazione si rende necessaria, se si vuole che i valori in cui si crede possano essere affermati e di fatto contribuiscano in modo efficace alla edificazione della Città dell’uomo. La sola testimonianza personale e privata, sebbene sia in ogni caso necessaria ed efficace, tuttavia non basta a incidere sulla formazione di quel consenso, che si richiede per influire in modo determinante sulle scelte pubbliche e, in particolare, su quelle legislative… La storia di tante nazioni contemporanee dimostra in modo eloquente quanto sia stato efficace e determinante il contributo dei partiti d’ispirazione cristiana alla costruzione, alla difesa e alla crescita della moderna democrazia. Se contro queste affermazioni non vi possono essere obiezioni serie in linea teorica, tuttavia l’opportunità o meno di dar vita oggi effettivamente a un partito d’ispirazione cristiana va valutata più attentamente, tenendo presenti le mutate situazioni storiche di tempo e di luogo, nonché i nuovi orientamenti pastorali, a seguito delle acquisizioni dottrinali del Concilio. 27 28 48 Ivi, pag.241. Cei, La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, 23 ottobre 1981, n.25 In ogni caso, dev’essere ben chiaro che una cosa è riconoscere la legittimità dell’esistenza di un partito d’ispirazione cristiana, e un’altra cosa (del tutto improponibile) sarebbe pretendere di dedurre dalla fede un partito cattolico. Già don Luigi Sturzo – fondatore del primo partito d’ispirazione cristiana in Italia – spiegava (all’inizio del ‘900”!) che i due termini (partito e cattolico) sono antitetici; infatti il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito invece è politica, è divisione” . 29 Va anche detto che non sembra condivisibile la prospettiva politica di chi vorrebbe che i cattolici partecipassero alla costituzione della gamba moderata all’interno dei due poli. In effetti, la vocazione dei cattolici moderati non può essere quella di rappresentare l’ala moderata dello schieramento politico. Certo – come ha ben spiegato il Cardinale Martini30 - vi è uno stile cristiano di fare politica, che rifugge dagli estremismi oggi in voga, comporta invece il rispetto dell’avversario e rifiuta di fare della politica un assoluto; ma questo tipo di moderazione non ha nulla a che vedere con il moderatismo, tipico della politica conservatrice. Anzi, le encicliche sociali vedono il cristiano come depositario di iniziative coraggiose e di avanguardia, anche se questa socialità avanzata ha caratteri diversi da quella, attualmente in auge, di tipo radical-individualistico e libertario – fautore dei soli diritti individuali – nella quale per lo più viene fatto risiedere il progressismo. Dopo il Convegno ecclesiale di Palermo del 1995 è prevalsa nella chiesa italiana la linea indicata dallo stesso Papa, per cui la chiesa non si schiera per nessun partito e per nessuna coalizione. Ciò le è imposto non solo dalla sua missione essenzialmente religiosa, ma anche dalle condizioni storiche che attualmente sono diverse da quelle del dopoguerra, che indussero la chiesa a svolgere una funzione di supplenza. Sarebbe tuttavia sbagliato confondere la giusta equidistanza con una impossibile neutralità. Qualcuno potrebbe essere indotto a credere che per la coscienza cristiana un programma politico valga l’altro, cosicchè, dopo la fine delle ideologie, i cattolici potrebbero tranquillamente aderire all’uno o all’altro partito, con l’unica condizione di non scendere mai a com- 29 B. Sorge, op.cit., pagg. 242-244. C.M. Martini, “Coraggio sono io, non abbiate paura”. Discorso per la Vigilia di Sant’Ambrogio, Milano, 6 dicembre 1999, Centro Ambrosiano 30 49 promessi con la propria coscienza o con la propria fede. Ora, non vi è dubbio che, dopo la fine delle ideologie, i partiti in Italia non pongono più alcuni problemi di coscienza. Tuttavia, ciò non vuol dire che tutti i programmi politici si equivalgano e che per il cristiano sia del tutto indifferente scegliere l’uno o l’altro partito. Infatti, la coerenza soggettiva con i valori cristiani è necessaria, ma non basta. Vi è pure una coerenza oggettiva dei programmi con il magistero sociale della chiesa, che non può essere disattesa. Dunque, equidistanza sì, neutralità no. Non vi può essere neutralità nei confronti di un atteggiamento che contesta la funzione dello stato nella difesa dei più deboli, di una logica decisionistica che cerca di estorcere il consenso per via plebiscitaria, di un neoliberismo utilitaristico che fa del profitto, della efficienza e della competitività un fine a cui subordinare le ragioni della solidarietà, di una politica che chiede deleghe del potere sulla base di promesse o prospettive generiche, più che sulla base di programmi coerenti. Vi è il giudizio critico su una leadership populista che incarni la semplificazione dei problemi, sul cortocircuito antipolitico formato dalla televisione, dalla personalizzazione, dall’assolutismo del comando, santificati dal giudizio sommario e preventivo dei sondaggi, moderna traduzione del consenso. D’altro canto c’è la necessità, come aveva detto Carlo Levi 50 anni fa, di suscitare forze nuove trovando quella parola che butti all’aria la scacchiera e trasformi il gioco in cosa viva. Verrebbe da dire che noi cattolici questa parola già l’abbiamo, dovendo solo ritrovare il coraggio di dirla all’uomo d’oggi: essa è il vangelo della carità. Come ci hanno ricordato recentemente i Vescovi: “.. ci sembra importante che la comunità sia coraggiosamente aiutata a maturare una fede adulta, pensata, capace di tenere insieme i vari aspetti della vita facendo unità di tutto in Cristo. Solo così i cristiani saranno capaci di vivere nel quotidiano, nel feriale.. la sequela del Signore, fino a rendere conto della speranza che li abita… I cristiani possono fecondare il tempo in cui vivono solo se sono continuamente attenti a cogliere le sfide che provengono loro dalla storia, e si esercitano a rispondervi alla luce del Vangelo. La comunità cristiana deve costituire il grembo in cui avviene il discernimento comunitario, indicato nel convengo ecclesiale di Palermo del 1995 come scuola di comunione ecclesiale e metodo fondamentale per il rapporto Chiesa-mondo. Oggi più che mai i cristiani sono chiamati a essere partecipi della vita della città, senza esenzio50 ni, portando in essa una testimonianza ispirata al Vangelo e costruendo con gli altri uomini un mondo più abitabile”31 Il titolo di queste brevi riflessioni è volutamente provocatorio. Non è venato però di pessimismo senza speranza, anche se non si può non applicare all’attuale momento politico quanto ha affermato David Maria Turoldo in Il sapore del pane (edito dalle Paoline): “Quando un popolo è indifferente, allora sorgono le dittature e l’umanità diventa un gregge solo, appena una turba senza volto; allora il bene è uguale al male, il sacro al profano; e l’amore è unicamente piacere, un male il sacrificio, un peso la libertà e la ricerca”. Vi è piena consapevolezza delle difficoltà che noi cattolici incontriamo a vivere il vangelo e ad incarnarlo. Tanto più in uno scenario politico (anche internazionale: vedi Le Pen in Francia) che sembra muoversi in un orizzonte lontano anni luce dai valori di solidarietà scritti nel patrimonio genetico dei cristiani. Così come non sfugge la considerazione storica di una quasi irrilevante presenza dei cristiani nella vita politica dei Paesi occidentali (e questo senza trascurare la specificità del nostro Paese per la presenza della cattedra di Pietro). Guai, però, a pensare e ad agire senza speranza. Come ammoniva S.Agostino: “Cerchiamo sempre con il desiderio di trovare e troviamo con il desiderio di cercare ancora”. 31 Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del 2000. 29 giugno 2001. 51 52 LE COMUNICAZIONI GLOBALI: LA VOCE PLURALE DELLA DEMOCRAZIA PINO MARIO DE STEFANO * UNA SVOLTA EPOCALE “Comunicazione” è la parola chiave degli ultimi cinquant’anni: l’orizzonte di pensiero intorno a cui sono ripensati i termini di fondo che definiscono la modernità. Si tratta di un vero e proprio terminecostellazione 1 , che abbraccia altri concetti contigui, tra cui, ovviamente, informazione, conoscenza, informatica, linguaggio ecc. Anche se l’ambiguità del termine, che si colloca appunto nei movimenti di trasformazione più profondi della società contemporanea, rende difficile definire il concetto, è fuori di dubbio che il processo di digitalizzazione della società2 , avviatosi con l’inizio degli anni settanta, pone la questione su tutt’altro piano. Se, infatti, la comunicazione media, per definizione, tutti i rapporti umani tra sistemi differenti, oggi appare evidente quanto la dinamica di digitalizzazione tenda a inglobare in sé anche questa definizione. Non è un mistero per nessuno oggi che fra qualche anno il Web sarà veramente tutt’altra cosa da quello che è attualmente: e cioè un potentissimo strumento multimediale, commerciale, di trasmissione di comando produttivo, intercreativo e assolutamente ipertestuale. Una vera e propria “noosfera digitale” per dirla con Teilhard de Chardin, “un’entità che ha in sé le possibilità di trasformarsi veramente in una sorta di intellettuale-mente collettiva, in grado di dar voce anche alle emozioni primarie del pianeta”3 . All’inizio del nuovo millennio stiamo vivendo, quindi, una svolta epocale che ha pochi precedenti nella storia della nostra specie, forse una vera e propria mutazione antropologica, come ha scritto * Rielaborazione della conferenza tenuta il 15.01.2002 al Centro “La Pira” di Pomigliano D’Arco (Na) 1 Vedi R. Scelsi, Comunicazione, in Lessico post-fordista, Feltrinelli, Milano 2001, p. 56 2 Cfr. F. Ciotti - G. Roncaglia, Il mondo digitale, Laterza, Bari, 2000 3 R. Scelsi, cit., p. 60 53 qualcuno4 . Addirittura una trasformazione dello stesso modo di “essere uomini”, se essere uomini significa porsi in relazione con gli altri. Forse i nostri posteri chiameranno questa rivoluzione “il periodo della informatizzazione globale”. Eppure, nonostante la velocità con cui questa mutazione sta sopravvenendo, e anche la diffusa consapevolezza di alcuni dei fenomeni più evidenti (almeno tra gli uomini di cultura, una parte degli industriali, una piccola parte dei politici), il più delle volte ci si ferma a considerazioni parziali, suggerite da questo o quel tassello del processo in corso. Mentre difficilmente ci si avvicina a una riflessione e a una visione panoramica del significato e delle implicazioni sociali, culturali e economiche e politiche del fenomeno in atto. Il processo in corso è quello, appunto, della trasformazione del nostro mondo da “società delle merci”, figlia della rivoluzione industriale iniziata col telaio a vapore alla fine del Settecento, in una società dell’informazione. Un mondo cioè in cui gli oggetti divengono sempre più virtuali e vengono rappresentati non più dalla loro tangibile concretezza, ma da simboli che viaggiano alla velocità della luce attraverso un tessuto che tende a ricoprire tutto il globo e raggiungere chiunque, qualsiasi sia la sua attesa. E’ il completamento della simbolizzazione del mondo, un processo che si è aperto con l’inizio della civilizzazione umana. Ma forse più importante ancora è il fatto che questa tecnica comprende e plasma sempre più proprio le attese; in altre parole innesca una potente retroazione che modifica (e modificherà sempre più) il modo stesso di essere e sentirsi uomini, modella a propria somiglianza il mondo dell’immaginario umano. NATURA UMANA, LINGUAGGIO E CULTURA L’uomo non è infatti soltanto un produttore e consumatore di oggetti legati alla sua sopravvivenza biologica. Se fosse solo questo, la sua differenza rispetto a altre specie animali complesse sarebbe modesta. La caratteristica che rende l’uomo unico nel panorama della vita sul nostro pianeta, è quella di essere uno story teller, un narra- 4 F. Pratico, La rete globale, necessità e destino, su Telèma 1/1996. Cfr. J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul comportamento sociale, Baskerville, Bologna 1993; A. Toffler, La Terza ondata, Cde, Milano 1987; ma vedi anche D. Lyon, La società dell’informazione, Il Mulino, Bologna 1991 54 tore; e ovviamente, e in misura ancor maggiore, un consumatore di storie. Noi organizziamo la nostra esperienza e la nostra memoria degli eventi umani principalmente sotto forma di narrazioni: storie, spiegazioni, miti, motivi per fare e non fare. Larry Gross5 , professore di comunicazione presso l’Università della Pennsylvania, scrive: «La cultura che è costituita dalle narrazioni non è sovraimposta sul substrato biologico che è la nostra vera natura. La unicità della specie umana non consiste (solo) nel fatto che siamo esseri sociali. Centinaia di specie, prima di quella umana, si organizzano in società. L’esistenza sociale ha creato l’umanità, non il contrario. Ciò che ci rende unici è che la cultura è la nostra natura. Ci evolviamo come animali che creano significati, e le storie che ci raccontiamo rappresentano il modo primario con cui costruiamo e conserviamo significati e li condividiamo al di là dei confini di spazio e di tempo». La nostra specie è relativamente giovane. Secondo gli studi di antropologia contemporanea, ancora centomila anni fa, in quel periodo che viene definito medio paleolitico, i nostri antenati (ossia i primi uomini moderni) si affacciavano al di là dei confini africani, condividendo ancora la cultura materiale, e probabilmente anche l’immagine del mondo, dei loro parenti che da più di un milione di anni si erano sparsi in Africa, in Asia, in Medio Oriente e in Europa. E’ possibile ipotizzare pochissimo sui processi che hanno dato ai nostri antenati una prevalenza schiacciante sugli altri discendenti del ceppo originario del genere Homo già insediati da millenni nel mondo, e che erano divenuti, per parere concorde dei paleoantropologi, sapiens, sia pure arcaici. Ma certamente tra gli elementi di superiorità che hanno consegnato il mondo ai nostri antenati, e fatto sparire gli altri concorrenti, un ruolo decisivo deve essere stato svolto dal possesso di un linguaggio articolato più evoluto rispetto a quello degli altri, di una capacità di comunicazione che appariva per la prima volta in modo così completo. E’ il linguaggio che ha consentito ai nostri antenati di vivere efficacemente non solo in modo immediato il presente, ma di proiettarsi anche nel futuro e nel passato; cioè di raccogliere, conservare e tramandare la memoria individuale e di gruppo, e renderla attuale (appunto, ricordare) nel momento dell’emergenza. E al tempo stesso di proiettarsi nel futuro, progettare, costruire strategie e soluzioni per eventi di là da venire6 . 5 L. Gross, Mass Media and their impact on society, relazione all’International multidisciplinary workshop on the evolution, 1992, citato in F. Prattico, cit. 6 Cfr. E. A. Havelock, Dike, la nascita della coscienza, Laterza, Bari 1990 55 Attraverso il linguaggio, infatti, la parola codifica le norme di comportamento, descrive il mondo e lo ipotizza, propone le regole per affrontare le sue trappole, costruisce e conserva conoscenze e interpretazioni, alle origini sotto forma di favole e miti dal fortissimo contenuto simbolico e normativo. «Tutte le società umane - osserva ancora Gross - hanno risposto alle fondamentali questioni dell’esistenza sotto forma di storie. Facciamo ancora questo raccontando storie ai giovani (il processo di socializzazione e acculturazione attraverso cui ogni generazione diviene parte di una cultura) e ripetendo alcune di queste storie abbastanza spesso per ricordare agli adulti le credenze fondamentali della società». E’ un processo di rappresentazione e diffusione della cultura che utilizza favole, miti, credenze religiose per fondare e distribuire interpretazioni del mondo e veicolare attraverso essi i modelli a cui, in modo consapevole o meno, ogni membro di una data società storica fa riferimento (che li accetti o cerchi di sfidarli) e a cui deve attenersi. Un compito al quale, nella nostra epoca, assolve ad esempio massicciamente (e forse con efficacia maggiore di altri mezzi) la televisione. Per millenni, quindi, la nostra specie ha trasmesso il sapere accumulato, di cultura e di regole, attraverso la parola (il discorso, il canto, l’attività educativa, ecc.). Il mondo della civilizzazione orale ha dominato la maggior parte della vicenda umana, travalicando anche quel momento di crisi che è stata l’invenzione della scrittura (che si fa risalire ai Sumeri nel sesto millennio avanti Cristo), perché questa, fino a Gutemberg, è rimasta circoscritta a cerchie privilegiate, ai detentori del sapere (sacerdoti, legislatori, capi politici e militari, letterati e filosofi). Il libro, scritto pazientemente a mano in esemplari unici, rappresentava certo una fonte carica di potere magico ed esoterico (si pensi ad esempio al valore che la Cabala attribuiva alle lettere dell’alfabeto ebraico, considerato allora il più antico), una sorta di certificazione del sapere: ma la circolazione delle conoscenze e la capacità di modellare le menti e prescrivere i comportamenti era affidata prevalentemente alla diffusione orale di quei contenuti.7 7 Cfr. per queste analisi Pietro Rossi (cur.) La memoria del sapere, Laterza, Bari 1988 56 LIBRO E MODERNITÀ La società umana esce quindi dal regno dell’oralità solo tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento con l’invenzione dei caratteri mobili e del torchio da stampa, che segnano la nascita del libro nel senso in cui l’intendiamo oggi, ossia come un oggetto materiale riproducibile a volontà. Non più misterioso deposito cristallizzato del sapere, la parola scritta entra in circolazione, perde il suo carattere sacrale ed elitario, impone una trasformazione profonda: masse crescenti di uomini, e non i soli ceti privilegiati, imparano a leggere e scrivere. La cultura, da privilegio, diviene bene accessibile quasi a chiunque. Non senza resistenze da parte dei più tradizionali detentori del sapere. Ai primi del Cinquecento, appena mezzo secolo dopo l’invenzione della stampa, si calcola che fossero in circolazione in Europa otto milioni di libri stampati. Tuttavia, intellettuali raffinati li respingono con disprezzo: il manoscritto, per loro, è l’unica forma accettabile del libro, l’unica adatta a un oggetto che è portatore di idee. Quando il tedesco Fust, socio e poi rivale di Gutemberg, porta a Parigi i primi libri stampati da lui stesso, viene espulso per stregoneria, per ordine degli intellettuali della Sorbona; mentre gli Orleans e Federico da Montefeltro vietano l’ingresso nelle loro preziose biblioteche a volumi che non siano manoscritti. E ancora, quasi due secoli dopo, il filosofo Leibniz arriccia il naso davanti alla marea di libri che si stampano ormai in tutta Europa: «Temo - scrive - che la gente si stanchi delle scienze e, spinta da un fatalistico sconforto, ripiombi in costumi barbarici. E a questo risultato forse contribuirà non poco quella orribile massa di libri che cresce continuamente...». Ma la “esplosione” del libro e successivamente delle gazzette, dei giornali, dei manifesti, insomma dei supporti fisici della cultura, segna di fatto l’ingresso nel mondo moderno, industriale. Da misterioso ricettacolo del sapere il libro si trasforma in merce, incide profondamente sui costumi, sui modelli di vita, sulle norme sociali che vanno così incontro a una prodigiosa trasformazione: «Con la stampa - scrive Marshall McLuhan - l’Europa sperimenta la sua prima fase di consumo, non soltanto perché la stampa è un mezzo di comunicazione per il consumatore, oltre che una merce, ma in quanto essa insegnò agli uomini come organizzare ogni altra attività su una base lineare e sistematica. Mostrò come creare gli eserciti e i mercati». La Riforma luterana non sarebbe stata possibile se la Bibbia, tradotta nei volgari e stampata in migliaia di copie, non avesse 57 scavalcato la intermediazione orale fino allora detenuta dalla Chiesa; la rivoluzione francese, che segna la fine di una visione gerarchica e sacrale dell’organizzazione sociale, la vittoria della società borghese, capitalistica e industriale, non sarebbe pensabile senza l’Enciclopedia e l’Illuminismo, che attraverso la stampa diffondono una immagine esaltante della grande potenza manipolatrice dell’intelletto umano8 . LA COMUNICAZIONE ELETTRONICA E L’INTERATTIVITÀ Oggi è proprio quel mondo che volge al tramonto. Di fronte al mondo simbolico della cultura scritta torna ad ergersi la prospettiva dell’oralità. E’ un processo iniziato esattamente un secolo fa, il 1895, con gli esperimenti di Guglielmo Marconi, quando un segnale partito da un apparecchio emittente viaggia sulle onde elettromagnetiche per raggiungere una stazione ricevente. Il supporto della parola non è più solo la carta. Da allora la trasmissione elettromagnetica è andata via via conquistando nuovi spazi, dilatando la possibilità di comunicazione e la sua velocità, creando nuove attese e nuove potenzialità. Può aiutare a comprenderne le potenzialità implicite nell’attuale processo mediatico fare un passo indietro, ed esaminare il concetto di attesa, una categoria che investe sia l’economia sia la psicologia umana. Una delle nostre caratteristiche come specie è la costruzione di bisogni (che non hanno rapporto diretto con la esigenze biologiche di fondo). Il bisogno è, nel mondo culturale che è il mondo umano, indotto proprio dalla presenza del mezzo che può appagarlo, e provoca un feed-back, un avvitamento che viaggia continuamente dal mezzo al fruitore e ritorno. Ad esempio, l’invenzione della stampa ha moltiplicato, cinque secoli fa, il numero di coloro che erano in grado (e desideravano) di fruire di questo tipo di comunicazione, allargando quindi la base a cui la parola scritta e stampata faceva riferimento. L’allargamento della base potenziale di utenti della parola scritta stimolava la produzione di messaggi ad essa indirizzati, e questi a loro volta raggiungevano (venivano richiesti da) un pubblico sempre più ampio. 8 Cfr per queste analisi M. McLuhan, La Galassia Gutemberg, Armando, Roma 1991; G. Giovannini, Dalla selce al silicio, Gutemberg, Torino 1994 58 Il salto di qualità e quantità è oggi rappresentato dai media elettromagnetici, che a differenza di libri e giornali non richiedono la intermediazione della lettura (diminuiscono cioè la quantità di lavoro necessario alla decifrazione dei messaggi, abbreviando il passaggio attraverso categorie simboliche da decrittare). E ciò naturalmente moltiplica la platea a cui il mezzo si riferisce. Anche se permane comunque la unidirezionalità della comunicazione, la suddivisione tra un centro produttore di informazione e un pubblico sempre più affamato – passivamente?- di questi messaggi. Forse anche questa evoluzione è oggi agli sgoccioli. La trasformazione entro cui stiamo entrando propone altro ancora: tende a spostare l’accento dal ruolo di ascoltatore, fruitore passivo del messaggio, a quello di co-narratore. E’ l’interattività. La natura dei mezzi elettronici rende oggi possibile trasformare ognuno di noi in centrale che non solo riceve una serie di input, ma contribuisce direttamente a formarli, almeno in parte, e quindi rimetterli in circolo. E’ con essa che dovremo fare i conti, nel millennio che sta cominciando. Alle soglie del terzo millennio, l’interazione globale che unifica tutti i sistemi di relazione si profila non solo come una possibilità, ma addirittura come una necessità, una evoluzione “naturale”. Era iniziata col telefono e il telegrafo senza fili, si era affermata con la radio e successivamente con la televisione, aveva raggiunto e interconnesso Università e laboratori, dilagata per case e uffici attraverso i computer, guadagnato lo spazio con i satelliti da comunicazione. Oggi telefono, fax, modem, computer, televisione, CD-Rom, dischi ottici, banche dati, comunicazione via cavo, via etere, via fibra ottica confluiscono per formare un intreccio di autostrade informatiche che collegano o collegheranno tutto a tutti, fasciando l’intero pianeta, senza tralasciare nessun settore della vita e dell’esperienza umana9 . Prendendo in prestito immagini dalla fantascienza senza, con ciò, assumere atteggiamenti acriticamente entusiasti, si potrebbe dire che la rete globale cresce e si modifica come se fosse un organismo vivente, autonomo, le cui determinazioni sfuggono anche alla volontà dei suoi creatori e i cui terminali raggiungono ognuno di noi 9 Fondamentale su questi sviluppi mi sembra il lavoro di Manuel Castells, La nascita della società in rete, pubblicata delle Edizioni dell’Università Bocconi, Milano 2002 59 in mille modi, consapevoli o meno. Si realizza nel concreto una intuizione di Popper: il complesso di strumenti e di operazioni che si riferiscono all’informazione, alla sua formulazione e trasmissione, acquistano autonomia, nella complessità della sua struttura si configura un quarto mondo che incide e modella i destini e le volontà degli uomini che pure lo usano. A questo punto, il mezzo, nel suo potente espandersi, tende ad avvicinarsi sempre più al suo pubblico: globalizzarsi, quotidianizzarsi. Infatti, come si è detto, si coniuga col telefono, col computer, col modem, col fax, per scavalcare le distanze grazie alla rete satellitare e insieme si miniaturizza per raggiungere qualsiasi combinazione di interazioni possibile. E insieme perde, in parte, il carattere di fiction (salvo laddove la fiction è espressamente richiesta) e assume il volto della realtà: o meglio, sostituisce la propria realtà a quella fisica e storica del fruitore. Per ottenere ciò deve coinvolgerlo, renderlo attore dell’operazione stessa. L’interattività per ora ha la sua manifestazione più nota con internet - prototipo delle autostrade informatiche su cui ognuno può viaggiare in qualsiasi direzione - e con le macchine per la realtà virtuale - che si rivolgono direttamente al nostro sistema percettivo e sensoriale. Ma sembra già iniziato il tempo in cui l’interattività assumerà forme e dimensioni ben più vaste: a partire dal telelavoro, dalla telespesa, dalla telescuola, dal televoto, dalla gestione elettronica del traffico e così via10 . In breve il terzo millennio sembra promettere la più assoluta libertà di comunicare, all’insegna del motto “anywhere, anytime”. Diventeremo veramente “cittadini del mondo” perché potremo comunicare “dovunque e in ogni momento”. Ci sposteremo, senza portare con noi né cellulare, né personal computer, né altri tipi di terminali, e non dovremo avvisare alcuno dei nostri spostamenti. Avremo, insieme con noi, esclusivamente una “scheda intelligente”, passepartout per qualsiasi tipo di comunicazioni in tutto il pianeta, nonché mezzo per essere virtualmente “sempre a casa” per i nostri corrispondenti, maneggevole e tanto piccola che bisognerà soltanto fare attenzione a non perderla. 10 60 Ivi, cap. IV IL “VILLAGGIO GLOBALE”: CONOSCERE PER COESISTERE MEGLIO Possiamo a questo punto comprendere meglio il senso di un’immagine oggi molto utilizzata: quella di “villaggio globale”. Il “villaggio globale” è il fortunato ossimoro inventato da Marshall McLuhan11 per descrivere la situazione contraddittoria in cui viviamo. Così come in festina lente, ovvero “affrettati lentamente”, i due termini dell’enunciato si contraddicono a vicenda, il “villaggio” esprime qualcosa di piccolo, mentre “globale” sta a significare l’intero pianeta. Non è possibile affrettarsi lentamente, così come non è possibile un villaggio grande quanto l’intero pianeta. Il significato è ovviamente simbolico. McLuhan ha forzato il linguaggio per meglio esprimere una situazione inedita e difficilmente rappresentabile. Da questa angolazione si ha un’idea più completa del fenomeno della globalizzazione contemporanea come una caratteristica fondamentale dell’epoca presente e una delle conseguenze più visibili della modernità12 . Essa può essere descritta come un insieme di processi collegati in cui si verifica una crescente integrazione su scala mondiale non solo delle transazioni di beni, servizi, capitali, forza lavoro e materie prime, ma anche dei centri decisionali e delle comunicazioni materiali (trasporti, infrastrutture) e simboliche (conoscenze, informazioni, simboli, immagini). È ovvio che senza l’interattività della rete globale non sarebbe pensabile il fenomeno della globalizzazione nelle sue dimensioni attuali. La globalizzazione agisce a molti livelli che interagiscono e si “rinforzano” reciprocamente. Si pensi ad esempio alla possibilità di vedere in televisione, praticamente in tempo reale, i fatti e i misfatti che accadono in tutto il mondo. Riceviamo queste immagini contemporaneamente alle notizie di ciò che succede “sotto casa”. Soprattutto Internet però può essere considerata la principale metafora della globalizzazione, la sua “incarnazione” più significativa. Più rivoluzionaria di quanto lo fu, a suo tempo, la televisione. La sua caratteristica più eclatante è proprio quella di azzerare il fattore spazio-temporale e collegare qualsiasi parte del globo (lo spazio) istantaneamente (il tempo). È evidente che i problemi giuridici, etici, sociali, culturali ed economici che la “rete” pone sono paragonabili a quelli aperti dalla sco11 Cfr. M. McLuhan e B. Powers, Il villaggio globale, SugarCo, Carnago, 1992. Vedi R. Robertson, Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale, Asterios, Trieste, 1999 12 61 perta di un nuovo continente. Basta pensare, per esempio, che Internet - tendenzialmente - non ha centro, né padroni. Al vertice della rete mondiale infatti non c’è alcun vero proprietario, non c’è un’effettiva autorità di controllo centrale. Questo fatto non è privo di conseguenze. In un’epoca in cui i giganteschi imperi dell’informazione si spartiscono tutto, Internet è anarchica, ma anche democratica. È vero che un problema relativo alla rete telematica globale e ad internet consiste nell’ancora ridotta diffusione e disponibilità per tutti, ma è altrettanto vero che al suo interno possono trovare ampio spazio idee sperimentali e non dogmatiche che si contrappongono al potere centralizzato e alle opinioni ufficiali. La rete è un vasto fenomeno scarsamente regolamentato e tenuto in esercizio dai suoi utenti, che potrebbe diventare il sistema di comunicazione più potente della storia. Non è ovviamente il caso di attribuire alla rete poteri salvifici, ma è pur vero che la vecchia mentalità per cui ci si preoccupa di un fenomeno solo quando colpisce direttamente la nostra esistenza può ricevere un vero scacco dalla rete non lasciandoci vie di scampo perché ora tutto ci colpisce direttamente: la farfalla che muove le ali nella foresta amazzonica può produrre effetti macroscopici fin all’altro capo del mondo. Un altro aspetto, in un certo senso, positivamente inquietante di questa visione “forzatamente” ecologica è che l’Occidente non potrà ignorare ancora per molto, ad esempio, il fatto che i due terzi della popolazione mondiale muoiono di fame, e comunque non potrà più fingere che se il resto del mondo ha fame non vi si può porre rimedio. Cosa ciò possa produrre non lo sappiamo ancora ma senz’altro qualcosa potrà succedere nei rapporti tra gruppi e tra popoli, e non necessariamente qualcosa di negativo. Siamo quasi costretti ad assumere un’ottica e una responsabilità anche “politica” di fronte a un mondo che è diventato, sotto certi aspetti, il nostro cortile di casa. Un effetto della globalizzazione della comunicazione consiste, dunque, nel fatto che non si potrà più continuare a coltivare il proprio orticello ignorando ciò che succede nel resto del mondo proprio perché il resto del mondo ha invaso il nostro piccolo orto, contaminandolo o fertilizzandolo a seconda dei casi. “Stare tutti nello stesso orto” significa essere a stretto contatto con popoli di razze e culture diverse. La globalizzazione telematica perciò ci vieta di chiuderci nei nostri piccoli e fragili gusci, imponendoci di spalancare gli occhi su tutto ciò che è “Altro”, vicino a noi sebbene molto lontano. E questo forse è un segno di speranza per i destini dell’umanità. 62 CYBERSPAZIO E CYBERCULTURA La necessità di sottolineare la radicale novità di Internet e in genere della comunicazione telematica e globalizzata spiega la tendenza attuale, nella saggistica sociologica e anche filosofica, a sostituire l’immagine del “villaggio globale” con metafore legate alla fantascienza come quella di cyberspazio e quella analoga di cybercultura13 . Ma cos’è il ciberspazio? È l’interconnessione fra tutti i computer del mondo. L’interconnessione fisica tra le macchine implica, virtualmente, la messa in comune delle informazioni immagazzinate nelle loro memorie e il contatto fra tutti gli individui e i gruppi che si trovano davanti ai loro schermi. Per questo il ciberspazio lungi dall’essere soltanto una prodezza tecnica, è uno spazio di comunicazione dotato di caratteristiche radicalmente nuove. Questa rete di reti, tendenzialmente, non appartiene a nessuno, non ha un bilancio centrale né un direttore in carica. La sua organizzazione poggia sulla collaborazione fra macchine e reti disparate. Possiamo chiarire meglio il significato di cyberspazio e cybercultura con tre concetti. In primo luogo, cybercultura significa che tutti i testi, tutte le immagini, tutti i suoni registrati fanno parte ormai virtualmente di un unico iperdocumento planetario, accessibile da qualsiasi punto della rete. Questo immenso iperdocumento (possiamo chiamarlo il primo, imperfetto, abbozzo di una “cultura” mondiale?) viene continuamente letto, consultato, guardato, commentato, ma anche alimentato, accresciuto e modificato dagli “internauti”. Ciascuno, a un costo minimo, può - o potrà - avere una pagina web e contribuire così alla tessitura di questa grande “tela” mondiale, sfuggendo alla selezione a priori imposta dagli intermediari tradizionali, cioè editori, produttori, addetti stampa, istituzioni scolastiche e altri. In secondo luogo il cyberspazio è un mezzo di comunicazione interattiva e collettiva del tutto diverso da quello unidirezionale e isolante cui ci hanno abituato i media classici e in particolare la televisione. Inoltre l’internauta non deve essere immaginato e rappresentato come un individuo solitario, sperduto in una grande e labirintica banca dati. Al contrario egli è, spesso, accompagnato e guidato da servizi di assistenza disponibili su internet. È invitato a 13 Cfr. per questi concetti H. Rheingold, Comunità virtuali: Parlare, incontrarsi, vivere nel ciberspazio, Sperling e Kupfer, Milano 1994 63 comunicare con altre persone interessate agli stessi argomenti, a pubblicare, a scambiare, a partecipare in un modo o nell’altro a diversi processi di intelligenza collettiva. Il terzo punto è che Internet non è solo un medium ma un metamedium che sta assorbendo, trasformando e rinnovando non soltanto i media già esistenti ma anche un gran numero di istituzioni tradizionali, in particolar modo il mercato e la scuola. Ovviamente, questo non significa che tutto passerà per Internet ma che il peso crescente di Internet è destinato a cambiare tutto. Comunque occorre guardare soprattutto alla linea di tendenza più che all’attuale stato di sviluppo della rete: e la linea di tendenza è quella di un’estensione rapida, più rapida di qualsiasi sistema di comunicazione esistente. Il che significa che vi saranno sempre meno “esclusi” dalla rete. In un certo senso, oggi, il genere umano – nonostante le evidenti resistenze - sembra tendere alla costituzione di un’unica società (anche se tale concetto andrebbe inteso in un senso più fluido, dinamico e “virtuale” di quello a cui siamo abituati dalla sociologia positivistica): di fronte a un tale fenomeno gran parte dei nostri concetti, delle nostre forme culturali e delle nostre istituzioni politiche, ereditate dai secoli precedenti, appare inadeguata. Ma c’è dell’altro: gli esseri umani allargano tanto più velocemente e potentemente il proprio campo d’interazione quanto più sono interconnessi tra loro. I grandi progressi della storia dell’umanità, a partire dal Neolitico, si sono sempre verificati in stretta relazione con un processo di concentrazione fisica (nelle città e nelle terre coltivate) e di collegamento nel tempo e nello spazio (sistemi di scrittura e di comunicazione). Più è aumentata e aumenta la quota di popolazione addetta alle connessioni interne – interne al “cervello” e al “cuore” dell’umanità – più cresce il potere dell’umanità sull’ambiente. Con l’accrescimento delle connessioni, non è tanto lo spazio a restringersi quanto l’essere umano a espandersi. Ma allora possiamo forse immaginare una sorta di “intelligenza collettiva” nel futuro dell’evoluzione umana anche se essa è solo agli inizi della sua crescita, come sostiene il filosofo P. Levy 14 , con un esplicito riferimento alla noosfera di Teilhard de Chardin? 14 Cfr. Pierre Levy, C’è una “intelligenza collettiva” nel futuro dell’evoluzione umana, in Teléma, n. 17/18, 1999; inoltre Lévy P., L’intelligenza collettiva, Feltrinelli, Milano, 1996; Id. Cybercultura, Feltrinelli, Milano 1999. 64 Se si volesse tradurre queste riflessioni in un’ottica più “politica”, si potrebbe, forse, dire che la visione di una «comunità illimitata di comunicazione»15 – e Internet dilata tale comunità al mondo intero – è un’utopia che, nella società della comunicazione globale, per la prima volta, sembra avere qualche chance di essere realizzata. Anche se qui la precisazione che si tratta di una «just in time community», come scrive Habermas, ovvero di una comunità che si forma e si riforma continuamente – perché ciascun partecipante all’interazione virtuale può non solo unirsi ma anche disimpegnarsi in qualsiasi momento –, ci rende avvertiti della precarietà di questa grandiosa utopia. I RISCHI, LE PAURE E LE ANGOSCE Ma proprio considerando la rete globale in una prospettiva anche “politica” emergono - e spesso si traducono, oggi, anche in fenomeni e movimenti sociali collettivi - sentimenti di sospetto, pericolo, paura e talora anche angoscia, associati all’era dei computer, della rete telematica, di Internet e della globalizzazione. Perciò, tralasciando le espressioni più rozze e banali di tale disagio, non si può omettere di riflettere soprattutto su qualche questione che anche tra i più avvertiti e attenti analisti torna spesso in primo piano. Un dilemma che riempie le riflessioni sull’avvenire culturale del pianeta, sotto la spinta degli universi simbolici dei consumi di massa e delle comunicazioni in tempo reale è soprattutto: “mcMondo” o “jihad”? Si tratta di un interrogativo che ha dato origine anche ad agguerrite teorie contrapposte16 . In altre parole, le prospettive che si confrontano e che hanno una loro ricaduta anche nell’immaginario collettivo, annunciano, da un lato, la monocultura e la omogeneizzazione del pianeta, dall’altro paventano – proprio per questo – fratture ad ogni livello, sociale, culturale, economico, religioso ecc. e quindi la jiahd come possibilità reale del pianeta della comunicazione globalizzata17 . 15 Cfr. soprattutto J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986; poi anche Id., Il discorso filosofico della modernità, Laterza, RomaBari 1987; e Id., Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari 1998 16 Cfr. per queste teorie K. Kumar, Le nuove teorie del mondo contemporaneo, Einaudi, Torino 2000 17 Vedi per esempio le tesi molto discusse di S. Huntington in The Clash of Civilizations, Cambridge 1996; anche G. Ritzer, Il mondo alla McDonald, Il Mulino, Bologna 1997 65 Occorre proprio rassegnarsi a queste prospettive entrambi pessimistiche? O forse è il caso di considerare che fin dall’inizio della storia degli scambi nel mondo, anche i modelli culturali e istituzionali diffusi dalle potenze egemoni hanno sempre incontrato popoli e culture che hanno opposto resistenza all’annessione, che sono stati contaminati, che si sono assimilati e che, spesso, è vero, sono anche scomparsi. In questi crogioli culturali, però, si sono prodotti anche i sincretismi o, meglio, le contaminazioni reciproche. Si è verificato spesso una specie di riappropriazione degli elementi delle culture egemoni da parte di altri popoli e culture fino a dare origine a realtà nuove e creative. Questa riappropriazione è un elemento centrale di ciò che viene chiamato “meticciato”, una dimensione, oggi, considerata una reale possibilità, e, spesso, fatta oggetto di analisi a proposito della globalizzazione culturale18 . Da tale punto di vista, molti analisti insistono spesso sui rapporti complessi che si intrecciano tra “globale” e “locale”, ponendosi in modo dissonante sia con l’idea, spesso proposta, della fatalità della monocultura, sia con l’altra, opposta ma altrettanto angosciante, dell’inevitabile scontro delle civiltà. In altre parole, la frammentazione e la globalizzazione andrebbero viste non in modo statico ma piuttosto come una coppia in tensione, all’interno della quale si gioca continuamente la scomposizione- ricomposizione delle identità sociali e culturali.19 Secondo molti antropologi l’intensificazione dei flussi culturali senza frontiere e la innegabile realtà di una tendenza alla globalizzazione della cultura, non portano necessariamente all’omogeneizzazione culturale del pianeta, ma certamente verso un mondo sempre più “meticciato”. Le nozioni di ibridazione e di “meticciato” rappresentano bene le ricombinazioni e i riciclaggi dei flussi culturali transnazionali presso le culture locali (anche da qui l’uso del termine “glo-cale”20 per rappresentare questo asse dialettico). In breve le culture locali non spariscono necessariamente dalla carta del mondo, ma possono rielaborarsi integrando il moderno con 18 Per questo concetto e con riferimento anche alla questione religiosa cfr. il libro di J. Audinet, Il tempo del meticciato, Queriniana, Brescia 2001 19 Vedi A. Mattelart, La comunicazione globale, Editori Riuniti, Roma 1998, p.123 20 Cfr. U. Beck, Che cos’è la globalizzazione, Carocci, Roma 2001 66 la tradizione, e stabilire nuove basi anche per le proprie industrie culturali e per la propria capacità di creazione.21 È sempre più vero, in fin dei conti, che ogni individuo, nel mondo della comunicazione globalizzata, prende coscienza di appartenere al mondo. Tutti si sentono contemporanei con tutti, ma in un quadro di pluralità. Per questo oggi occorre piuttosto allenarsi a pensare contemporaneamente l’unicità del pianeta e la diversità dei mondi che lo costituiscono.22 Può essere utile, per questo, l’utilizzo di una categoria, introdotta dall’antropologo M. Augé, e idonea a rappresentare una dimensione peculiare della nostra esperienza contemporanea, cioè quella dei “non-luoghi”, spazi esclusivamente di passaggio (autostrade, rotte aeree), di consumo (ipermercati) e di comunicazione (telefoni, fax, televisione, reti telematiche). In questi “non-luoghi” si coesiste, si coabita senza vivere insieme. Questi non-luoghi dell’esperienza, contribuendo a far ripensare anche l’appartenenza senza annullarla, fanno nascere atteggiamenti psicologici e forme diverse di rapporti tra la gente, per cui la grande metropoli virtuale odierna può essere vista come “punto centrale, nodo di relazioni, di emissione e di assorbimento nel vasto intreccio che oggi è il pianeta”. È vero, però, che una prospettiva del genere, pur interessante ed efficace, non dovrebbe comportare, in modo acritico, la rinuncia a una lettura attenta dei rapporti tra le culture, che spesso sono di subordinazione di alcune ad altre, né dovrebbe, semplicisticamente, annunciare l’avvento del consumatore sovrano, che naviga nell’universo della cultura globale senza altro limite che la propria libera scelta. In realtà, se si eliminano dal campo dell’analisi dei fenomeni della comunicazione contemporanea i rapporti di forza e le dinamiche socio-economiche, si perde la possibilità di comprensione realistica del mondo globalizzato e rimane spazio solo per una lettura superficiale e/o un super relativismo culturale che alla fine si rivelerebbe anche rischioso per la stessa crescita della convivenza e della comunicazione umana. Qui si comprende come le questioni relative alle comunicazioni, in un mondo globalizzato, siano anche, necessariamente, una questione politica. 21 Interessante sottolineare fenomeni come l’affermazione dell’industria televisiva e della fiction brasiliana o indiana. 22 Vedi M. Augé, Non luoghi. Introduzione a un’antropologia della sur-modernità, Milano, Eleuthera, 1996 67 Tuttavia, sembra che, al di là di rituali o logori episodi di dialettica tra partiti o gruppi di potere, la maggioranza delle organizzazioni politiche e sociali esiti ancora a farsi carico in modo organico ed efficace dei problemi dei media e dell’informazione oggi. Basta pensare, tralasciando dolenti esempi relativi alla situazione italiana attuale, al fatto che anche gli organizzatori del primo vertice del G7, dedicato all’informazione planetaria, quello del 1995, non vollero inserire nell’ordine del giorno il tema dei “contenuti” cioè delle diversità culturali, perché ritenuto “troppo polemico”! Su questo versante, bisogna dire che sono soprattutto le cosiddette organizzazioni non governative quelle più attente, efficaci e capaci di trasformare la loro battaglia in evento pubblico. E forse è a questo livello che occorre anche immaginare un ruolo più attivo di individui, organizzazioni, Chiese ecc. È vero che non è facile farsi carico della effettiva rilevanza politica del problema delle comunicazioni oggi, ma è senz’altro evidente che le modalità della comunicazione attuale modificano i termini e il contesto della vita politica e democratica. Per cui senza una lucida e diffusa consapevolezza delle dinamiche radicalmente nuove della comunicazione globale difficilmente si arriverà a porre correttamente le questioni in campo. E allora forse si potrebbe favorire la nuova consapevolezza cominciando, da un lato, con l’approntare condizioni che aiutino i cittadini a riconciliarsi con il mondo della tecnica, per molti ancora in gran parte estraneo (e questo in tutti gli ambienti da quello politico a quello produttivo, da quello della cultura a quello delle Chiese), dall’altro, inventando un “nuovo insieme di riferimenti per aprire la strada a una riappropriazione e riclassificazione simbolica degli strumenti di comunicazione e di informazione, al di fuori delle logiche martellanti del marketing”, come auspicava F. Guattari23 alcuni anni fa. Non è meno urgente, infine, orientare la presa di coscienza del cittadino, al di là anche della padronanza individuale degli strumenti multimediali, perché egli sia capace di arrivare al livello dove si decide l’architettura dei sistemi di comunicazione. Infatti è a quel livello che si pongono i problemi più seri e le possibilità più reali per una ridefinizione della libertà e della democrazia. Poiché, se è vero che non possiamo chiedere alla tecnica di salvare il mondo, non 23 Citato in A. Mattelart, La comunicazione globale, cit., p. 136; vedi anche F. Guattari, Caosmosi, Costa & Nolan, Genova 1996 68 è meno vero che, oggi, le tecnologie della comunicazione e il loro controllo rappresentano elementi decisivi anche per la ridefinizione del contratto sociale e delle istituzioni, tanto sul piano locale che su scala mondiale. COMUNICAZIONE GLOBALE E PROBLEMI DELLA DEMOCRAZIA Ma quali opportunità vengono dalla società della comunicazione globalizzata per affrontare i nuovi problemi della convivenza civile e della democrazia? Sicuramente alcune questioni possono ricevere nuova luce in un contesto di rete globale anche se molte questioni relative alle modalità della democrazia e all’esercizio dei diritti all’autogoverno hanno sicuramente ancora bisogno di analisi, proposte e soluzioni, in un contesto postnazionale e globalizzato. Ma, anche senza pretendere di proporre compiute analisi di filosofia o scienza politica, proviamo a evidenziare alcuni dei problemi aperti della convivenza democratica sui quali spesso gli studiosi ritornano. Lo faremo seguendo le indicazioni soprattutto di C. Castoriadis24 e R. Dahl. 25 Secondo questi autori è fondamentale, oggi, ripensare e chiarire, prima di tutto, cosa bisogna intendere per democrazia, se si vogliono affrontare i problemi che nella società dell’ informazione vengono in primo piano. Se la democrazia è, soprattutto, come scrive Castoriadis, un regime dell’autonomia e dell’autolimitazione, un potere che non accetta di essere limitato dall’esterno (al di la dei limiti naturali); se è un potere autoistituente: cioè un regime che si autoistituisce esplicitamente in modo permanente, o, come ritiene R. Dahl, se la democrazia è, prima di tutto, il diritto all’autogoverno, allora è anche vero che in una società siffatta nessuno può volere l’autonomia per se stesso senza volerla per tutti. Ma, poiché si parla di una collettività e una collettività non può vivere senza leggi, nessuno è effettivamente autonomo, cioè libero, se non ha l’effettiva possibilità di partecipare alla determinazio24 C. Castoriadis, La rivoluzione democratica, Elèuthera, Milano 2001 Vedi R. Dahl, Democrazia o tecnocrazia?, Il Mulino, Bologna1987; Id., Politica e virtù. La teoria democratica nel nuovo secolo, Laterza, Roma-Bari, 2001 25 69 ne di quelle leggi. Soprattutto in questo sta il significato dell’uguaglianza in una società democratica. Libertà e uguaglianza si reclamano l’un l’altra. A rigore di termini, uguaglianza significa quindi: uguale possibilità per tutti, possibilità effettiva e non teorica, di partecipare al potere. Non si tratta soltanto di entrare nella cabina elettorale, si tratta anche, per esempio, di essere informato, e informato come chiunque altro, su ciò che deve essere deciso, e contribuire a deciderlo. È da qui che occorre partire se si vuole onestamente e concretamente tentare di coniugare mondo della comunicazione globale con le libertà e la democrazia. Oggi non basta più richiamarsi al voto e al consenso elettorale per legittimare democraticamente il proprio potere! E non credo debba essere necessario, a tale proposito, richiamare la lezione di Tocqueville! La democrazia può infatti essere, anche, definita come il “divenire realmente pubblica della sfera, cosiddetta, pubblica/pubblica”, il luogo cioè in cui si delibera e si decide degli affari comuni, sfera che negli altri regimi è di fatto più o meno privata. E proprio qui nasce una delle questioni aperte della democrazia d’oggi che, in un contesto di rete globale, potrebbe ricevere qualche contributo alla soluzione. Infatti, non è solo nel cosiddetto “antico regime” o sotto il totalitarismo dell’apparato del Partito che il “pubblico” politico è affare privato del monarca; in realtà, una delle ragioni per cui diventa sempre più problematico parlare di democrazia nella nostra società attuale è proprio il fatto che, oggi, sempre più spesso, la sfera “pubblica” sembra diventare, in realtà, “privata”. Lo è, prima di tutto, nel senso che le vere decisioni sono prese a porte chiuse, nei corridoi o nei luoghi di incontro dei “governanti” di turno. È diventato, infatti, quasi un luogo comune ritenere che le decisioni che contano non sono prese nei luoghi ufficiali in cui si presume che vengano prese; quando arrivano davanti ai Consigli dei ministri o alle Camere dei Deputati, i giochi sono già fatti. Inoltre anche le motivazioni ( le vere motivazioni) sono spesso segrete, e, nella maggioranza dei casi, accedervi è vietato legalmente. Nei vari paesi europei per esempio, il termine temporale per accedere agli archivi pubblici è di venti, trenta o cinquanta anni. Ma anche un mese, in ogni caso, sarebbe sufficiente per quello che qui si vuol dimostrare. Aspettate cinquanta o trent’anni e saprete perché 70 vostro fratello o vostro figlio sono stati ammazzati in guerra. Sarebbe questa la democrazia? O bisognerebbe parlare di oligarchia politica? Sembra questo il “tallone d’Achille” delle democrazie in una società sempre più complessa e globalizzata come quella attuale. Che la sfera pubblica/pubblica diventi veramente tale implica, ovviamente, che la collettività e i poteri pubblici siano tenuti a informare realmente i cittadini su tutto ciò che riguarda le decisioni da prendere, e che è loro necessario per poterle prendere con cognizione di causa. Si capisce bene come non si insista mai a sufficienza sia sulla necessità, oggi, di una reale molteplicità delle fonti di informazione, sia sul ruolo fondamentale della diffusione delle informazioni pertinenti, affinché le decisioni siano prese con cognizione di causa, sia sul carattere essenzialmente politico (e quindi di servizio pubblico e quindi implicante responsabilità e obbligo di rendere conto – non soltanto attraverso il momento elettorale) delle funzioni di raccolta e diffusione delle informazioni. È altrettanto ovvio come la soluzione di questi problemi non solo richieda la possibilità per tutti di accesso all’informazione ma implichi altre due condizioni e cioè, da un lato, la capacità effettiva, per tutti, di giudicare (si pone perciò anche la questione dell’educazione e della scuola), dall’altro, il tempo necessario per l’informazione e la riflessione (e quindi la questione del lavoro, della produzione e dell’economia). Come si vede, nel mondo globalizzato, anche le varie questioni della convivenza democratica sono molto più interdipendenti di quanto, di solito, si pensi. Ma forse, affrontare una buona volta queste questioni, può essere anche la strada per contribuire a ridurre quei sentimenti di ansia, paura e angoscia, di cui si è detto sopra, e che si accompagnano spesso, anche con fenomeni, che si potrebbero considerare di nevrosi collettiva, quali l’emergere di movimenti integralistici, xenofobi e populistici, ai processi della globalizzazione. La realtà effettiva dell’informazione e delle comunicazioni, però, è molto distante da quella ideale: basta considerare, infatti, che la maggior parte delle informazioni offerte dalle parti in causa, per esempio durante le competizioni elettorali, è fortemente influenzata e manipolata, soprattutto nei contesti, come quello italiano, in cui, in sostanza, l’informazione vive in assenza di vero pluralismo e in regime di quasi monopolio. È vero che la gente istruita può giungere con una ricerca ostinata a una conoscenza che si avvicina alla migliore possibile. Molte 71 persone istruite però non fanno così, mentre i cittadini con minor istruzione si basano spesso su informazioni del tutto inadeguate. Come è possibile allora dar vita a un corpo di cittadini capaci di produrre giudizi adeguatamente illuminati sugli stessi problemi pubblici o sui termini in cui poter delegare ad altri senza preoccupazione l’autorità di prendere le decisioni?. È possibile utilizzare la tecnologia per incrementare il numero di cittadini politicamente competenti? Sembra che il mondo delle comunicazioni globali renda possibile quello che, finora, sarebbe stato difficilmente attuabile. Sembra cioè che nel contesto delle comunicazione globali sia possibile porre in termini nuovi e più possibilistici la questione della democrazia. Secondo R. Dahl è possibile, nel contesto della rete globale, proporsi almeno tre fondamentali obiettivi per ogni democrazia e cioè: • fare in modo che le informazioni relative ai problemi politici all’ordine del giorno siano anche facilmente e completamente accessibili a tutti i cittadini • creare per tutti i cittadini delle opportunità facilmente realizzabili e totalmente accessibili per influenzare le informazioni per la compilazione dell’ordine del giorno, di ciò che talora si chiama “agenda politica” e per prendere parte in modo adeguato alle discussioni politiche • fare in modo di avere un corpo di opinione pubblica molto ben informato che sia rappresentativo dell’intero corpo cittadino26 . Rendere possibile ai cittadini una influenza più diretta non su finte questioni ma sull’ordine del giorno della politica potrebbe essere consentito proprio dal carattere interattivo della tecnologia dell’informazione. Anche se ci sarebbero, è vero, dei problemi pratici, non sarebbero, però, insuperabili. “Il problema oggi, scrive Dahl, è come rivitalizzare la speranza che l’antica visione, ormai vecchia di 25 secoli, del popolo che si autogoverna mediante il processo democratico e che possiede tutte le risorse e le istituzioni necessarie per reggersi con saggezza, possa essere riadattata ancora una volta, come è già successo in passato, ad un mondo sempre più diverso da quello in cui una tale visione delle cose venne messa in pratica per la prima volta”27 . 26 27 72 Cfr R. Dahl, Democrazia o tecnocrazia?, Il Mulino, Bologna1987, p. 107 Ibid., p. 123 Ma a partire da quali caratteri della comunicazione telematica è possibile pensare a condizioni per una nuova esperienza della democrazia? VERSO UNA NUOVA CITTADINANZA? Da anni, lo abbiamo già sottolineato, ai termini elettronica, informatica, telematica è stato strettamente associato quello di rivoluzione. Ma questa rivoluzione non si è fermata alle sfere della vita privata o della produzione: ha investito anche la sfera pubblica, le istituzioni, la politica e i suoi processi. Ogni ambito della vita associata è stato invaso e viene dominato dalla potenza dell’informazione e della comunicazione. È una situazione questa che costringe a prendere atto dell’inadeguatezza della tradizione del pensiero politico occidentale. Sembra, infatti, che il consenso non si crei più attraverso la mediazione delle forme rappresentative e la discussione pubblica, ma attraverso la tentata “cattura” di un’enorme platea mediatica: tecniche di marketing aziendale si fanno tecnica politica. Anche attraverso tali modalità si manifesta la tendenza, sopra richiamata, per cui la sfera pubblica sembra diventare privata, quasi una questione di poteri di mercato. In tal modo, la società dell’informazione fornisce di sé una rappresentazione virtuale, che la fa ritenere libera, o liberata, dal sistema politico, dalla coazione alla forma della rappresentanza sovrana che la politica moderna aveva pensato28 . Anzi a qualcuno sembra che alla volontà generale, costruzione mediata dell’uno attraverso i singoli secondo il processo della sovranità rappresentativa, si possa addirittura contrapporre, nel contesto della società mediatica, un “general intellect” come sfera pubblica non statuale”29 . Anche se gli strumenti concettuali di cui disponiamo sono ancora inadeguati per una compiuta e organica riflessione su queste questioni (e del resto non è questa la sede per questa analisi), ce n’è abbastanza per pensare che ciò che oggi sta avvenendo riguarda comunque anche il modo in cui ciascuno può essere cittadino. È a partire da qui che occorre cercare delle linee che diano un senso alla nostra esperienza di cittadini nel contesto della rivoluzione telematica. 28 Cfr. M. L. Lanzillo, Rappresentanza, in Lessico post-fordista, cit., p. 238 Vedi P. Virno, Mondanità. L’idea di “mondo” tra esperienza sensibile e sfera pubblica, manifestolibri, Roma 1994 29 73 Per comprendere, almeno in parte, il modo in cui la sfera pubblica sta cambiando, è indispensabile considerare un insieme di mezzi, che sinteticamente si possono indicare con il termine tecnopolitica e che operano in forme sempre più intrecciate: la televisione (via etere, cavo, satellite), le reti telematiche, i personal computer, il telefono, i sondaggi, il marketing politico, la consultazione di gruppi appositamente selezionati. Ora, nel momento in cui la politica e la democrazia si presentano con le forme della tecnopolitica, diventa necessario esaminare un nuovo concetto di cittadinanza: la cittadinanza elettronica 30 . Il concetto di cittadinanza elettronica, in questa prospettiva, non riguarda soltanto le nuove modalità d’azione dei cittadini, e la necessità di realizzarle pienamente e per tutti. Deve essere riferito, come si è detto, anche a una realtà completamente nuova, che riguarda la possibilità di far nascere sulle reti veri e propri soggetti collettivi elettronici, profondamente diversi per natura, organizzazione e modalità di funzionamento dai soggetti collettivi che abbiamo finora conosciuto, perché liberi da ogni vincolo spaziale e temporale. In un certo senso, siamo in presenza di vere e proprie comunità virtuali. In una situazione di crisi dei tradizionali soggetti politici (partiti, sindacati) non può essere trascurata questa nuova frontiera dell’organizzazione sociale, anche se non può essere ignorato il rischio di un conflitto tra comunità virtuale, che utilizza il tempo mondiale delle telecomunicazioni, e comunità reale, che utilizza il tempo locale delle attività immediate. Il costante riferimento al problema delle reti, quindi, consente di identificare più analiticamente una delle caratteristiche della comunicazione elettronica, destinata ad influenzare direttamente le modalità della cittadinanza. Finora, lo abbiamo già sottolineato, ci siamo trovati quasi esclusivamente in presenza di forme di comunicazione verticale (o unidirezionale), legate al modello della televisione via etere, e, sostanzialmente questo modello unidirezionale è stato prevalente anche nella comunicazione politica. In un modello del genere, la dimensione del cittadino è cancellata dalla figura dello spettatore. Un’ autorità lontana e incontrollabile sceglie momenti, modalità e linguaggi della comunicazione. Lontani e tra loro separati, i cittadini assistono passivamente. Questo non significa necessariamente che il loro assistere sia privo di capacità critica o di possibilità di reazione: vuol dire che non sono in condizione di intervenire attivamen30 74 Cfr., S. Rodotà, Verso una nuova cittadinanza, in Telèma 1/1995 te nel processo comunicativo che, per questo suo connotato, si presenta come intimamente autoritario31 . Diversa sarebbe la condizione del cittadino che ha la possibilità di servirsi di una rete, dunque di una forma di comunicazione che è non solo orizzontale (o bidirezionale) ma reticolare (o circolare). In questo caso “esistono molti mittenti e molti destinatari, che possono scambiarsi di ruolo. Ma ciascun agente comunicativo è in grado di comunicare con molti altri. Nella comunicazione reticolare infatti si realizza una interazione collettiva”32 . Qui non esistono posizioni di supremazia, agende prestabilite, tempi di parola imposti. Una volta riconosciute le modalità di accesso nelle forme prima ricordate, tutti i cittadini si trovano in posizioni paritarie, possono diventare protagonisti attivi della comunicazione, e questa assume inequivocabili tratti democratici. Anche senza voler apparire prigionieri della retorica delle reti, che indica in Internet il modello che ci riscatterà da tutti i mali del mondo, contrapponendo schematicamente la televisione via etere e le reti telematiche, qui si intende solo mostrare come nell’ambito delle tecnologie elettroniche siano presenti forme diverse di comunicazione, tra loro profondamente diverse per protagonisti e effetti. Tra l’altro, riflettendo sul problema delle reti e sul ruolo che in esse possono assumere i cittadini, si può anche chiarire un altro tema oggi assai enfatizzato riguardo alle tecnologie interattive. Considerata nella dimensione della cittadinanza, l’interattività viene assai spesso presentata come la possibilità di continui referendum elettronici, di una democrazia rattrappita in un eterno gioco di domande e risposte che, in realtà, non modificherebbe la possibilità di partecipazione al potere del cittadino. La suggestione populista, versione volgarizzata dell’attenzione alle nuove tecnologie, che oggi sembra esercitare molto fascino, non può nascondere l’impoverimento della democrazia che tutto questo comporterebbe. La logica vera della rete è invece assai lontana dallo schema del sì e del no, da un uso dell’elettronica che si limita a dilatare smisuratamente la dimensione del sondaggio. L’interattività, infatti, si pone all’origine di nuovi e diversi processi comunicativi. In generale, si può dire che, all’interno del più vasto campo dei new media, ossia dei mezzi di comunicazione fecondati dall’infor31 Per questi problemi, D. McQuail, I media in democrazia. Comunicazioni di massa e interesse pubblico, Il Mulino, Bologna 1995 32 F. Ciotti – G. Roncaglia, cit., p.300 75 matica, le reti occupano un posto privilegiato proprio perché mettono in questione le forme tradizionali della cittadinanza33 , aprendo nuove e impensate opportunità. Perciò, contrariamente a quanto spesso si pensa, i rapporti fra i comportamenti dei singoli e la esplosiva crescita delle tecnologie dell’informazione non vanno necessariamente nella direzione di fare di noi singoli cittadini, progressivamente, dei prigionieri dei processi e degli apparati di un più o meno esplicito “grande fratello” informatico e telematico. Sembra anzi che la molecolarità dei soggetti e dei comportamenti debba vincere sul totalitarismo invasivo degli strumenti: basta pensare a quanto sia personalizzato l’uso delle carte di credito, il consumismo dei cellulari telefonici, la navigazione un po’ solipsistica in Internet. E’ il singolo che riduce alla propria dimensione la grande tecnologia, e non il contrario. Quali effetti ciò potrà avere per le dinamiche della democrazia e del potere? DAL CONFRONTO MEDIATICO ALLA CYBERDEMOCRAZIA Secondo Pierre Levy la rete globale, la cosiddetta onnivisione, o la trasparenza digitale, diventerà la base di una cyberdemocrazia ancora difficilmente immaginabile34 . Infatti, anche se in teoria esiste il rischio ( pensiamo per esempio al caso di Echelon un sistema ultrasegreto che però ora attraverso internet è conosciuto nei minimi dettagli dal grande pubblico35 ), non è il caso tuttavia di temere una nuova forma di totalitarismo perché la trasparenza generalizzata, verso la quale ci stiamo dirigendo, ha la tendenza a divenire simmetrica. In altre parole, la logica della rete globale tende a far sì che la libertà di espressione e l’accesso all’informazione aumentino per tutti e non soltanto per gli Stati e per le grandi imprese. Questa, probabilmente, è una considerazione che ci può far guardare con meno sospetto e timore alla globalizzazione telematica. 33 Vedi per queste questioni, G. Bettetini e F. Colombo, Le nuove tecnologie della comunicazione, Bompiani, Milano 1994 34 Pierre Levy, Dal confronto mediatico alla cyberdemocrazia, in Problemi dell’informazione/ a. XXVI, n. 2-3, 2001, p.244 35 Vedi sito http://www. Wdnet.co.uk.news/specials/2000/06/echelon e inoltre http://www.aclu.org/echelonwatch/ 76 In realtà, in termini di comunicazione, il potere autoritario si definisce attraverso l’asimmetria della visibilità: in altre parole coloro che sono dominati sono trasparenti mentre il centro del potere resta opaco. Inoltre il totalitarismo si contraddistingue anche per il carattere verticale e unidirezionale del flusso di informazioni. Le informazioni salgono dalla popolazione, gli ordini e la propaganda scendono dal potere. Il tipo di comunicazione, invece, reso possibile dal cyberspazio, è all’esatto opposto della configurazione totalitaria. Possiamo comprendere meglio ciò che qui si vuol dire riflettendo sulle considerazioni seguenti. Gli scandali finanziari o sessuali che colpiscono il mondo politico da molti anni in tutti i Paesi democratici, l’accanimento dei giudici, dei giornalisti e degli oppositori a caccia dei minimi errori, delle gaffes e goffaggini dei dirigenti, probabilmente, non sono prevalentemente il segno di una maggiore debolezza morale delle élites politiche, quanto piuttosto la spia dell’ascesa della volontà e della pratica della trasparenza democratica, resa possibile, in una modalità nuova, dalla rete globale. Certo è che questa trasparenza non potrà essere dissociabile – nonostante qualunque volontà contraria, dalla libertà di stampa e dalla autonomia della giustizia36 . In effetti, gli uomini politici sono probabilmente meno corrotti oggi rispetto a quanto lo erano in passato, solo che questa corruzione oggi è più visibile e lo sarà sempre di più, come qualunque altro aspetto dell’esercizio del potere. Dato che la libertà è protetta meglio dalla luce che dall’ombra, l’aumentata trasparenza permessa dagli strumenti del cyberspazio sembra, a molti analisti, uno dei fattori determinanti non solo della transizione dalla democrazia moderna alla cyberdemocrazia, ma anche della caduta delle dittature alla vecchia maniera. Questo, beninteso, a condizione che la trasparenza rimanga simmetrica e che, quindi, la rete si capillarizzi e rimanga globale. Quale dittatura potrebbe resistere in un Paese in cui il 25% della popolazione ha accesso a internet? 36 Il che in altri Paesi, per esempio gli USA, è considerato ovvio anche da parte di uomini politici potenti (vedi il caso dei Presidenti come Clinton); mentre dirigenti politici del nostro Paese, pur considerati esperti di comunicazione, sembrano, a quanto pare, non rendersene conto, agendo, in queste questioni, con una logica di potere di altri tempi; che sia anche questo un segno dell’ arretratezza della nostra classe dirigente? 77 Nicholas Negroponte, il guru del Media Lab del MIT, ha sostenuto un’idea simile quando ha detto: “un sistema di comunicazione come Internet, con le sue possibilità di scambio estese e costanti, non può non avere effetti sui nostri rapporti sociali. Immaginate, per esempio, la convivenza di una dittatura con la rete”.37 Internet, in altre parole, metterà sempre più in discussione le situazioni di monopolio del potere di parola nei vecchi Paesi dell’Europa occidentale e nell’America del Nord. Ma offrirà, senz’altro, anche una boccata d’aria e presto probabilmente una capacità di gridare e di esprimersi ai popoli che soffocano sotto il potere delle cricche dittatoriali, in vari paesi del mondo. Nella prospettiva della cyberdemocrazia, l’effetto principale di internet è contribuire a indebolire le dittature di ogni genere, che sono sempre essenzialmente mafiose, che esse si presentino sotto una luce nazionalista, xenofoba, populista, militare, “comunista”, integralista o altro. Come spiegare infatti l’opposizione a internet o il tentativo di controllarlo da parte di regimi come quello cinese o quelli integralisti musulmani? Internet, con la sua apertura sul mondo e la libertà di espressione che le è propria, pone i grandi e i piccoli dittatori in una situazione difficile. Da una parte, infatti, essi sono costretti a promuovere internet e il commercio elettronico, pena l’accusa di produrre deliberatamente arretratezza e povertà. Dall’altra parte, essi pretendono di resistere con tutte le loro forze alla libertà di espressione che si accompagna naturalmente con il nuovo medium. Ma come sarebbe possibile fabbricare un internet “puramente cinese” o “puramente tunisino” dove poter esercitare la censura? In sostanza, tutte le dittature sono destinate a cadere inesorabilmente al ritmo dell’espansione della cybercultura, come ha scritto P. Levy. Certo, l’idea di dare reale cittadinanza a chiunque, di parlare a molti e divenire, in qualche modo, partner di molti ai quali tante altre persone, singole o in gruppo, si possono rivolgere, è affascinante ed è un potente strumento di democrazia possibile, perché non c’è nessun monopolio dell’ informazione che alla fine non possa essere aggirato. Sta pure qui la novità della rete globale! Ed è anche questo aspetto che rende possibile ripensare i temi della libertà, della democrazia e della cittadinanza oggi. 37 Intervista con Negroponte in Cambiamento culturale e fede cristiana, (a cura del Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI), ELLEDICI Leumann (Torino), 2000, p.16 78 Infine, poiché la libertà e la pluralità delle voci, rese possibili dalla comunicazione globale, si nutrono anche della capacità, propria della rete, di educare alla ricerca, di insegnare un paziente processo di prova ed errore, di spingere alla condivisione e all’appartenenza collettiva dei percorsi fatti in comune, di creare nuove forme di relazione, enfatizzando l’importanza del comunicarsi ed ascoltarsi, non è un caso che si parli di “intelligenza collettiva” a proposito della modalità peculiare di crescita culturale nella rete. Forse non è utopistico pensare che - come ha scritto P. Levy - questa effettiva pluralità delle voci, resa possibile dalla comunicazione telematica globalizzata, pluralità che si incontra e si esprime attraverso una sorta di iperdocumento planetario, possa veramente dare origine a una forma di nuova “cultura mondiale”, da intendersi non come una monocultura che neghi o emargini le diversità, ma piuttosto come una “tela” che viene continuamente tessuta insieme, consultata, guardata, commentata, ma anche alimentata, accresciuta e modificata, in altre parole, come “una voce plurale”. La metafora continuamente incombente, oggi, del grande fratello, che domina e manipola l’informazione da un unico centro potrebbe, dunque, essere sostituita dalla frantumazione - non dispersione dei luoghi della comunicazione, dando vita a una realtà senz’altro più democratica, anche sul piano della comunicazione culturale. Tutto questo non sembri solo utopia o aspirazione perché qualunque tentativo di negare l’abbondanza ininterrotta della conversazione plurale non resisterebbe - già oggi - al semplice esame della reale situazione come appare sul Web. Si tratta di uno scenario che occorre imparare ad abitare, uno scenario che costringe a ripensare forme di partecipazione e modi di fare comunicazione, uno scenario che forse renderà obsoleti tanti nostri modi di essere presenti sul piano pubblico. Uno scenario che offre maggiori possibilità di partecipazione e creatività, ma che moltiplica anche le responsabilità, depositandole su ciascun nodo della rete. 79 80 LA CREDIBILITA’ DELLA RIVELAZIONE CARLO GRECO S.I. * 1. LA RELIGIONE CRISTIANA COME RELIGIONE DI RIVELAZIONE La religione cristiana si definisce come religione rivelata, al fine di indicare in tal modo la propria origine, l’istanza su cui si fonda, il contenuto di ciò che annunzia, le ragioni della sua specificità. Naturalmente la rivelazione, come termine storico-religioso, non è esclusivo della religione cristiana. “La scienza delle religioni parla di religioni di rivelazione quando il centro vitale di una religione è determinato in maniera essenziale dall’azione esplicita di una divinità, azione volta alla salvezza dell’uomo e del suo mondo”1 . La caratterizzazione del cristianesimo come religione rivelata si afferma soprattutto nell’età moderna contro l’illuminismo, allo scopo di sottolinearne l’origine trascendente e la superiorità rispetto ad una religione fondata sulla semplice ragione naturale. Tuttavia, la convinzione dell’origine e del fondamento trascendente del cristianesimo fa già parte fin dall’inizio dalla confessione e dall’autocoscienza cristiana. Questa esiste solo perché è avvenuta la rivelazione di Dio nella storia d’lsraele e in Gesù Cristo. Già nel Nuovo Testamento il termine ‘rivelazione’ viene usato per delimitare e qualificare il messaggio cristiano in base alla sua origine e al suo contenuto. Paolo, per esempio, scrive di “non aver ricevuto né imparato il vangelo da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo”(Gal 1,12), e che il contenuto del suo messaggio non è una “sapienza di questo mondo”, ma una “sapienza divina” (1Cor 2,6 s.). Nel corso dell’epoca moderna il termine ‘rivelazione’ diviene una categoria teologica universale e trascendentale2: il concetto centrale dell’autocomprensione cristiana, con cui s’intende indicarne il fondamento ontologico, gnoseologico e legittimante. Sono stati soprattutto i due Concili, Vaticano I e Vaticano II, ad assegnare alla nozione di rivelazione una posizione teologica centrale e, in partico* Relazione tenuta il 27 Marzo 2001. 1 J.SCHMITZ “Il cristianesimo come religione di rivelazione nella confessione della Chiesa” in Corso di Teologia Fondamentale, II, cit., 13-14. 2 H. FRIES, Teologia Fondamentale, Queriniana, Brescia 1987, 206. 81 lare il Vat.II, dedicando ad essa un’intera costituzione, a promuovere tale categoria a concetto-base del cristianesimo. “La rivelazione o Parola di Dio all’umanità è la prima realtà cristiana, il primo fatto, il primo mistero, la prima categoria”3 . Ogni economia di salvezza, nell’ordine della conoscenza, si basa su questo mistero dell’autocomunicazione di Dio in una confidenza d’amore. E’ il mistero primordiale, quello che ci comunica tutti gli altri, perché è la manifestazione del disegno di salvezza pensato da Dio da tutta l’eternità e realizzato in Gesù Cristo (Ef 1,9-10; Rom 16, 25-27). Essa è fondamento dell’esistenza cristiana come fede, speranza e carità e della riflessione teologica in senso proprio. 2. LA NECESSITÀ DELLA LEGITTIMAZIONE DELLA FEDE DERIVANTE DALLA RIVELAZIONE Questa pretesa del cristianesimo di essere una religione rivelata non è più capita dall’uomo moderno. Dall’epoca dell’illuminismo in poi l’uomo si è imposto come fondamento, centro e norma della propria condotta di vita, la ragione. Richiamarsi invece ad una rivelazione significa che almeno alcune nozioni importanti per l’orientamento e la condotta della vita non possono essere conosciute dall’uomo mediante la ragione umana. Un tale richiamo a conoscenze non accessibili a tutti e comunicate in maniera straordinaria solo a pochi eletti, eppure rivendicanti un carattere vincolante universale, sembra limitare indebitamente la competenza della ragione nello stabilire quale sia una condotta umana responsabile, disturba la comunicazione tra esseri uguali e rende più difficile la convivenza umana. Per queste e altre ragioni l’uomo moderno avverte disagio e rifiuta l’idea di una rivelazione4. La teologia, in particolare la teologia fondamentale, deve aiutare non solo i credenti ad accertare, comprendere e approfondire il fatto che la fede cristiana poggia sulla rivelazione e di là attinge la propria essenza e verità, ma deve legittimare la fede anche verso l’esterno: cioè non solo davanti alla ragione illuminata dalla fede, ma davanti alla ragione in generale. Tale legittimazione, che manifesta la credibilità della rivelazione davanti a se stessi e agli altri, è inscindibilmente congiunta alla fede, fa parte della sua essenza. La fede, infatti, non è solo dono di Dio all’uomo, ma anche un atto libero dell’uomo, che 3 4 82 R. LATOURELLE, Teologia della rivelazione, Cittadella, Assisi 1967, 5–6 Cf. J. SCHMITZ, La rivelazione, Queriniana, Brescia 1991, 8-9. egli deve giustificare di fronte alla propria coscienza e che presuppone sempre la consapevolezza e la libertà tipica dell’essere razionale. Essa non diventa un atto umano libero fintanto che è solo un prodotto derivante dalla casualità delle circostanze storiche della vita. Chi è stato educato alla fede fin dall’infanzia deve a un certo punto decidersi a credere in base ad una propria decisione. Se tale atto di fede non deve essere una decisione arbitraria, allora l’uomo deve avere motivi per prendere tale decisione e deve poterla anche legittimare5. La giustificazione della fede, inoltre, è necessaria a motivo della pretesa della stessa fede di essere assolutamente necessaria alla salvezza di ogni uomo e per tutti i tempi. Solo mediante una continua disponibilità a dare ragione della fede e farlo in maniera intelletualmente onesta, affrontando senza riserve tutte le domande e tutte le critiche, la fede che pretende di essere così universale potrà evitare il fanatismo e l’intolleranza. Occore, per prima cosa, che venga confutata l’impressione e la convinzione che la fede sia qualcosa di irrazionale. “Se anche un non credente deve poter distinguere la fede nella rivelazione da una irrazionalità superstiziosa, allora deve essere perlomeno possibile mostrare che essa né afferma quanto la ragione giustamente contesta, né contesta quanto la ragione giustamente afferma ed esige”6. Tutto ciò significa che non è sufficiente la testimonianza della vita e della parola. Una semplice affermazione della certezza della propria fede può, in un primo momento, suscitare interesse e curiosità, ma poi occorre anche renderne conto e motivarla, se non si vuole rischiare di apparire strani e di non essere più ascoltati. “Oggi l’intelligenza della fede non può più essere semplice e ingenua, benchè la fede di un ‘povero’ sia sempre benedetta da Dio, ma dev’essere per quanto possibile ‘critica’, passata al vaglio delle esigenze più rigorose della ragione”7. C’è, infatti, una semplicità che è dono; c’è , però, una semplicità che è fideismo e ignoranza. C’è un voler sapere che è presunzione e arroganza, ma c’è anche una scienza che è sapienza, che è la maturità della fede. Nel Nuovo Testamento la magna charta di qualsiasi giustificazione della fede è offerta dalla prima lettera di Pietro: “E se anche dovete soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri 5 6 7 Cf. ivi, 201-202. Ivi, 204. «L’uomo di oggi di fronte al cristianesimo», in Civ. Cattolica 137(1986),325. 83 cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domadi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza” (1Pt 3,14-16). La traduzione letterale suona meglio così: “Siate sempre pronti all’apologia verso chiunque v’interroghi sul logos (sulla ragione) della speranza che è in voi”. Viene richiesta, dunque, una permanente disponibilità alla legittimazione del logos, cioè del senso (della ragione) della speranza cristiana. Questo logos non è un prodotto della capacità argomentativa del credente, perché gli è già dato con la speranza, ma deve essere lasciato apparire e mostrato all’interpellante. Non si tratta di dare una risposta ad un bisogno di informazione a colui che chiede tale ragione, perché il contesto della lettera di Pietro è un contesto di persecuzione; né di una discussione accademica; ma di quel motivo profondo della speranza cristiana, per la quale ciascuno è pronto a dare anche la vita. Applichiamo questo criterio alla riflessione teologica. La giustificazione della fede che risponde ad una esigenza della fede matura e alla sua possibilità di comunicazione, consisterà allora nel passaggio fondamentale dalla certezza della coscienza credente, che accoglie la rivelazione, alla conoscenza riflessa e argomentata di fronte alla ragione critica di questa stessa certezza per mezzo dell’esercizio della ragione teologica. La cura della giustificazione critica della fede è una questione di fedeltà verso noi stessi (per non cedere alla tentazione della incredulità), di rispetto verso il dono della fede (per consentirle di esprimere la destinazione universale della sua verità), e di sollecitudine verso coloro che sono cercatori della verità. Nel corso recente della sua storia la teologia fondamentale ha conosciuto tre opposte modalità di giustificazione della fede e della verità della rivelazione, a cui qui vogliamo accennare per meglio delineare infine quella che ci sembra teologicamente più adeguata. 3. IL MODELLO APOLOGETICO NEOSCOLASTICO DI GIUSTIFICAZIONE DELLA FEDE Sorto nel periodo dell’illuminismo razionalista, questo modello apologetico si sforzava di collocarsi sullo stesso piano, e usando gli stessi strumenti concettuali, del suo interlocutore razionalista, che negava la possibilità di ogni intervento divino soprannaturale. Esso, aveva la pretesa di fornire, appoggiandosi unicamente ad argomentazioni metafisiche, fisiche e storico-apodittiche, una prova vera e propria (demonstratio) della verità della religione cristiana e della 84 chiesa cattolica. In questa prospettiva, lo scopo della ragione teologica era quello di fondare una credibilità “naturale” della fede ( in linea di principio possibile senza la cooperazione della grazia), puramente razionale ( dimostrabile mediante la sola ragione) e oggettiva (motivabile unicamente in base a criteri esterni) della verità di fede. Di conseguenza, i criteri di credibilità dovevano essere oggettivi, universalmente validi, in permanente rapporto con la rivelazione, e dovevano offrire una certezza filosofica e storica della rivelazione di Dio.Tali erano per es. i miracoli, intesi in senso puramente fisico come eventi che si pongono al di fuori delle leggi naturali, le profezie (e la presenza testimoniante della chiesa nel mondo). L’adempimento di queste condizioni consentiva di giustificare la fede di fronte alle esigenze della ragione critica e di sottrarla all’isolamento fideistico. Per ovviare, poi, all’accusa di razionalismo si sottolineava che la conoscenza della credibilità era soltanto la condizione esterna o il presupposto della decisione di fede, mentre quest’ultima si fondava sull’autorità di Dio rivelante 8. Si affermò, così, soprattutto negli ultimi tre secoli, una apologetica “oggettiva” del cristianesimo e del cattolicesimo basata su tale credibilità naturale, razionale, oggettiva, possibile - si riteneva in linea di principio - anche senza l’aiuto della grazia divina. Nelle sue forme più esasperate, questo modo di pensare portò addirittura alla teoria della doppia fede: una fede naturale, motivata esclusivamente da argomenti naturali, e una fede soprannaturale, motivata dalla volontà di rendere omaggio a Dio rivelante ed emessa sotto l’impulso della grazia. La critica al razionalismo da parte della fenomenologia e dell’esistenzialismo, il conseguente superamento di un concetto di ragione esclusivamente modellato sulle scienze esatte, il mutamento della comprensione della rivelazione e del miracolo, hanno determinato la trasformazione radicale del problema della credibilità. 4. L’AUTOFONDAZIONE DELLA FEDE Reagendo al precedente modello di giustificazione della fede, si elaborò agli inizi del Novecento un modo, autenticamente teologico, di fondare la fede che comportava di riportare la fede alla sua origine, alla sua essenza, che è la rivelazione, mettendone in luce il suo caratte8 Cf. H.J. POTTMEYER, “Segni e criteri della credibilità del cristianesimo” in Corso di Teologia Fondamentale/ 4., Queriniana, Brescia 1990, 449-470. 85 re di assoluta novità rispetto ad ogni altro evento o fatto umano. Il teologo, che più di ogni altro ha affermato la totale alterità di Dio e l’irriducibilità della fede ad ogni prospettiva umana, è stato senz’altro K. Barth nel periodo dialettico (anni Venti). “Non vi è nessuna presupposizione umana (pedagogica, intellettuale, economica, psicologica ecc.) che debba essere compiuta come preliminare della fede. Non vi è nessuna introduzione umana, nessun itinerario di salvezza, nessuna scala graduata verso la fede che debba essere in qualche modo percorsa: la fede è sempre l’inizio, la presupposizione, il fondamento”9. Dio non si può dimostrare, né a partire dal cosmo, né dalle profondità dell’esistenza umana. Egli si dimostra da se stesso. “La rivelazione di conseguenza non è una sorgente di luce che illumina la realtà .... bensì è in primo luogo l’autorivelazione di Dio, in cui Dio rivela se stesso tramite se stesso. La sua rivelazione deve essere allora accettata quale dimostrazione di Dio data da lui stesso, e la dimostrazione di Dio non può essere presupposta ulteriormente nei preambula ad articulos fidei ... La luce in cui la rivelazione di Dio diviene comprensibile non è perciò la luce della ‘teologia naturale’, bensì la luce dello Spirito Santo”10 . Dio che si rivela, crea egli stesso la possibilità di comprendere la realtà della sua rivelazione in forza di una pneumatologia trinitaria, che conserva la sovranità di Dio anche nel processo della comprensione e della conoscenza della rivelazione. “La rivelazione divina, nella quale avviene che l’uomo giunge alla vera conoscenza di Dio, è la decisione di Dio - dello stesso Dio trinitario che egli è anche in se medesimo - di operare con noi in modo tale che, pur essendo noi uomini e non Dio, siamo resi partecipi della verità della conoscenza che egli ha di se stesso”11. E’ nella forza dello Spirito Santo che è possibile intendere la rivelazione di Dio. In quanto Dio si fa comprendere, crea pure le condizioni che rendono possibile il professarlo nella fede ed il conoscerlo, l’ascoltarlo e l’ubbidirgli. In questa prospettiva, la fede è fondata (oggettivamente) dalla rivelazione (intervento gratuito e radicalmente nuovo di Dio), ma a sua volta la rivelazione è fondata (soggettivamente) dalla fede stes9 10 K. BARTH, L’epistola ai Romani, trad. Miegge, Milano 1962, 74 Cf. J.MOLTMANN, Prospettive della teologia, Queriniana, Brescia 1973, p. 23. 11 K. BARTH, Dogmatica ecclesiale, Antologia italiana a cura di H.Gollwitzer, Bologna 1968, p. 31. 86 sa. La garanzia dell’evento della rivelazione che fonda la fede è la fede stessa. Essa è contemporaneamente fondante la rivelazione e da essa fondata. La fondazione della fede è in realtà un’autofondazione. Anche se il modello teologico dell’autofondazione sembra garantire meglio l’assoluta libertà dell’atto di fede e rappresenta il rifiuto di misurare il divino con l’umano, riducendelo a semplice compimento dei bisogni e delle attese dell’uomo, tuttavia, la sua struttura argomentativa appare quella di un circolo vizioso. Si può rispondere a tale critica rilevando che la gratuità stessa della rivelazione e la sua provenienza divina escludono la possibilità di una fondazione estrinseca alla rivelazione. Non c’è, infatti, alcun criterio esterno alla fede con cui misurare la stessa fede e la rivelazione. Infatti, è proprio di Dio e solo di Dio non poter fare riferimento ad altri se non a se stesso per farsi conoscere e per convincere. D’altra parte, se Dio è pensato come il fondamento ultimo della realtà, non si può dare altro criterio più grande, a cui la fede possa riferirsi per fondare la propria certezza. Già il Concilio Vaticano I aveva dichiarato, contro il razionalismo, che il fondamento ultimo della certezza della fede non è l’evidenza della ragione, ma Dio stesso nella sua rivelazione: “noi crediamo vere le cose da lui rivelate, non già per la intrinseca verità delle medesime conosciuta con la luce naturale della ragione, ma per l’autorità dello stesso Dio rivelante, che non può ingannarsi né ingannare” (DS 3008). La ragione del credere - osserva in proposito W. Kasper - non è qui l’autorità del comando di Dio (auctoritas Dei imperantis) ma quella stessa della rivelazione (auctoritas Dei revelantis), che attira e convince. La fede che ne scaturisce è una luce nuova sulla realtà, un nuovo modo di percezione dotato di una sua intrinseca evidenza. Per cui, egli conclude, richiamandosi ad analoga argomentazione di H.U. von Balthasar: “E questa illuminazione non cala quasi ‘perpendicolarmente’ sull’uomo, ma promana dalla figura storica della rivelazione. In ultima analisi si tratta di un’autoevidenza dell’amore di Dio, che non possiamo dimostrare dall’esterno ma che è esso stesso a rendersi convincente. Infatti solo l’amore è credibile”.12 Tuttavia, se non si vuole restare prigionieri di un circolo vizioso, in cui la fede risulta essere il fondamento di se stessa, è necessario mostrare come si arriva a conoscere la verità di Dio. «Se è vero, infatti, che la certezza della fede in quanto certezza non può essere 12 W. KASPER, IL Dio di Gesù Cnsto, Queriniana, Brescia 1984, 172. 87 dedotta da una certezza ancora più grande, e se è vero perciò che Dio quale verità e fondamento della fede può divenire evidente soltanto attraverso se stesso, allora sorge ancora una volta la domanda circa il modo con cui comprendiamo questa luce illuminante ed evidente della verità. In che modo il credente coglie la verità di Dio come ultimo fondamento della sua fede?»13. Rimane aperto, cioè, il problema del raggiungimento della rivelazione nel suo darsi oggettivo. Ora, l’evento della rivelazione è irraggiungibile nella sua oggettività assoluta. Esso è raggiungibile solo mediatamente, attraverso un processo ermeneutico, che include inevitabilmente la mediazione dell’interlocutore umano. Ciò, del resto appare evidente nella stessa Sacra Scrittura, che è insieme parola di Dio in parole umane. D’altra parte, chi garantisce che la fede sia suscitata dallo Spirito come risposta all’evento della rivelazione? Come sfuggire al pericolo di identificare la fede con una scelta arbitraria della nostra volontà, con una proiezione dei nostri desideri? L’autofondazione della fede, sottraendo la fede ad ogni controllo ad essa esterno, non conduce ad un fideismo e soggettivismo inaccettabili per la stessa decisione del credere, che rendono di fatto incomunicabile la stessa rivelazione? 5. LA GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE ESTRINSECA: LA CATEGORIA DEL RELIGIOSO, DELL’ETICO E DEL METAFISICO. Pur riconoscendo la necessità di ricondurre la fede ai suoi fondamenti intrinseci, cioè alla rivelazione e alla tradizione biblica che la contiene, il terzo modello di giustificazione della fede si chiede se la rivelazione non sia a sua volta fondabile, grazie ad una razionalità non esclusivamente teologica, cioè con elementi estrinseci alla fede stessa. E’ possibile, ad es., una fondazione-giustificazione della fede attraverso il ricorso alla categoria del “religioso” (cf Schleiermacher), interpretando l’esperienza cristiana come un momento particolare dell’esperienza religiosa, comune a gran parte dell’umanità. In questo caso il fenomeno religioso, come fenomeno umano universale, diventa il fondamento, ciò a cui può essere ricondotto il fenomeno cristiano ( rapporto di genere a specie). A questo punto ci si può fermare, riconoscendo a tale categoria un’assoluta originarietà, in questo caso l’autofondazione riguarde13 W. KASPER, Was alles erkennen ubersteigt. Besinnung auf den christlichen Glauben, Herder, Freildurg-Basel-Wien 1987, 63. 88 rebbe il “religioso” in quanto tale e non più la rivelazione cristiana: il “religioso” sarebbe una forma della coscienza assolutamente autonoma rispetto alla morale e alla metafisica (Schleiermacher). Tuttavia, l’esigenza della razionalità di veder chiaro potrebbe richiedere un ulteriore fondazione del “religioso” e questo può avvenire attraverso due vie : quella etica, per cui la verità del religioso verrebbe ad identificarsi con la sua capacità di realizzare quei valori etici che appaiono dotati del carattere di universalità. La religione è tanto più vera quanto più contribuisce a realizzare un compiuto umanesimo. Qui non è più la fede a fondare l’etica, ma l’etica a fondare la fede (Kant). Oppure attraverso la via metafisica, che ponendo il problema radicale della verità della religione, in quanto fondata sulla rivelazione di Dio, procede attraverso la dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio e dei suoi attributi. La rivelazione trova così la sua fondazione ultima sulla base di una solida dimostrazione metafisica. Al termine di questo processo si è operata certamente una fondazione della religione- rivelazione con la ragione critica, in grado di garantirne la significatività e la intelligibilità, ma essa viene raggiunta attraverso una serie di riduzioni che hanno portato dal particolare della fede cristiana all’universale: dal cristiano al religioso, dal religioso all’etico, dall’etico al metafisico. In tale impostazione il cristianesimo risulterebbe giustificato nella sua essenza e nella sua rivendicazione di assolutezza e superiorità, ma questa non gli deriverebbe più dalla verità della rivelazione, bensì dal fatto che appare razionalmente come la religione più razionale, più vera, più buona. Bisogna chiedersi, però, se una siffatta giustificazione razionale della fede permetta ancora di salvare la specificità del cristianeismo o se invece non ne segni la sua definitiva dissoluzione nell’etica o nella filosofia14. 6. LA GIUSTIFICAZIONE CRITICA DELLA FEDE 6.1 Ragione teologica e ragione critica Oggi non manca chi ritiene impossibile o almeno teologicamente ingiustificato il tentativo di una giustificazione della fede, depotenziando in tal modo la teologia al livello di un discorso puramente Cf. V. BORTOLIN, “La teologia fondamentale nei suoi rapporti con la filosofia” in Studia Patavina XLII (1995), 1, 43-66, di cui seguiamo le argomentazioni qui sintetizzate. 14 89 narrativo, autobiografico e autoespressivo. Sostituendo in tal modo alla certezza del sapere la certezza della coscienza, si finisce col presupporre la verità della fede senza offrire alcun argomento per essa. Le ragioni della credibilità non vengono più percepite. Per evitare questo rischio non si può fare riferimento soltanto alla certezza soggettiva della fede, ma occorre anche indagare sulle sue ragioni e i suoi contenuti. La riflessione teologica attuale ha maturato una rinnovata consapevolezza del proprio compito e del rapporto con le altre forme del sapere. Essa riconosce di non avere potere sulla verità che le viene offerta nella forma della rivelazione. Lo statuto scientifico della teologia non può essere quello di una scienza apodittica e dimostrativa, ma di una scienza ermeneutica, cioè di una intelligenza recuperatrice di un senso donato e di una verità rivelata. “Fare teologia significa rifare criticamente il processo di comprensione che si produsse all’interno della storia della rivelazione e della interpretazione di essa da parte della tradizione ecclesiale. Pertanto, la teologia è essenzialmente re-interpretazione d’un processo interpretativo previamente dato”15. L’esercizio della ratio theologica, perciò, non ha un compito di fondazione, ma di verifica e di articolazione critica del sapere della fede e di mediazione della sua verità. Precisamente per questo aspetto la teologia fondamentale odierna ha fatto registrare i più significativi mutamenti rispetto alla tradizionale impostazione dell’apologetica neoscolastica. La teologia è chiamata innanzi tutto a individuare il fondamento della fede. Esso non è un prodotto dalla riflessione teologica, ma un’offerta storica. Si tratta del libero e gratuito rivelarsi di Dio, a cui corrisponde da parte dell’uomo l’accoglienza (l’obbedienza) della fede. La teologia, in quanto sapere critico, dovrà giustificare la scelta della rivelazione come concetto fondamentale ed essenziale della fede cristiana; in secondo luogo, dovrà mostrare l’umana pensabilità del rivelarsi di Dio nella sua propria possibilità, necessità e verità per la fede medesima, esplicitandone al tempo stesso le ragioni di credibilità incluse nell’assenso di fede. La consapevolezza critica così raggiunta consisterà nel passaggio fondamentale dalla certezza vissuta della coscienza credente, che accoglie la rivelazione, alla conoscen- 15 A. GESCHE’, «Teologia dogmatica» in Aa.Vv. Iniziazione alla pratica della teologia. Introduzione, Queriniana, Brescia 1986, 291-292). 90 za riflessa e argomentata di questa stessa certezza per mezzo dell’ esercizio dell’ intellectus fidei. Questa modalità argomentativa deriva anche dalla peculiare problematica epistemologica della rivelazione e dalla dialettica ad essa intrinseca. Vediamola. La TF, infatti, in quanto intellectus fidei si propone come una riflessione condotta all’interno dell’ orizzonte di senso costituito dalla rivelazione, allo scopo di esplicitarlo, rendendolo intelligibile e credibile a partire dai contenuti stessi della fede. La gratuità della rivelazione e la sua provenienza divina escludono la possibilità di una fondazione estrinseca della fede e costituiscono la garanzia ultima e definitiva della sua verità. A partire da tale presunzione la teologia, in quanto riflessione razionale, si costituisce e porta le sue argomentazioni come forma di razionalità autonoma e specifica. Tuttavia, la presunzione di verità ad essa intrinseca è immediatamente evidente soltanto per la fede, ma non lo è altrettanto e immediatamente per la ragione critica. Per es. non è evidente che la negazione dei contenuti della fede comporti contraddizione. “Ciò significa che quanto alla sua forma epistemologica, la fede e quindi la presunzione di verità che le è implicita, non può avere il carattere dell’ universalità”16. Per tale motivo la verità della fede è totalizzante e assoluta, in quanto orizzonte di senso ultimo e definitivo della realtà e proposta di salvezza radicale, ma nello stesso tempo appare come particolare e possibile di fronte alle sollecitazioni della razionalità critica, soprattutto se quest’ultima intenda porre il criterio della propria verità nell’assoluta incontrovertibilità. “Le affermazioni della teologia, pur esprimendo un sapere, non esprimono il sapere, non essendo evidenti al logos di una ragione autonoma dalla fede, e perciò non hanno immediatamente il carattere della universalità”17. L’evidenza della fede non può venire fondata sull’ evidenza della ragione autonoma; la fede non può che trovare in se stessa le radici ultime della propria evidenza. A conclusioni analoghe si arriva anche muovendo dal riconoscimento della natura della rivelazione come autocomunicazione di Dio e dalla fede che l’accoglie. E’ la fede che qui riconosce come dovuta all’autoapertura divina la conoscenza di Dio che essa possiede. La fede funge da categoria ermeneutica: è un’opera d’interpreta16 Cf. V. BORTOLIN, “La teologia fondamentale nei suoi rapporti con la filosofia” in Studia Patavina XLII (1995),1,59. 17 Ivi, 64. 91 zione del soggetto credente, in base alla quale egli ritiene appunto che la conoscenza di Dio posseduta è derivata dalla stessa autocomunicazione divina. Da qui il suo carattere ambivalente sul piano epistemico. L’interpretazione credente di una conoscenza di Dio derivata da una rivelazione, riconosciuta come tale nella fede, non conferisce a quest’ultima alcuna certezza indubitabile sul piano del sapere in generale. Si possono dare altre interpretazioni. Dio non si rivela in modo da non ammettere più alcun dubbio razionale a riguardo della realtà di tale evento. Sta in ciò il carattere di libertà, che la teologia ha rivendicato sempre all’assenso di fede18. Questa situazione epistemologica comporta forse che la fede derivante dalla rivelazione sia un’interpretazione arbitraria, puramente illusoria e irrazionale? Intanto è da dire che la fede ha tramite la rivelazione storica un riferimento realistico costituito dall’esperienza religiosa da essa stessa determinata. La ragione teologica non può dimostrare che questa interpretazione dell’esperienza della rivelazione è razionalmente vincolante. Ma essa può e deve mostrare che è giustificata razionalmente, cioé che l’esperienza di fede è fondamentalmente affidabile, rimuovendo per quanto possibile le obiezioni sollevate contro tale affidabilità e in positivo esplicitandone le ragioni e lo specifico logos. E’ sufficiente, tale percorso per soddisfare le esigenze della ragione critica? E qui occorre riflettere sulla figura di questa razionalità critica e tentare di definirla. Tale razionalità per essere veramente critica non può partire dalla presunzione di verità che è propria della fede, perché è appunto tale presunzione che deve essere sottoposta a critica. Ma analogamente, non deve partire nemmeno dalla presunzione della non verità della fede. Deve essere in grado di argomentare, almeno inizialmente in maniera autonoma, partendo unicamente da se stessa e dal criterio che essa accetta: l’evidenza razionale, che ha il carattere della incontrovertibilità e quindi della necessità: il vero è solo il necessariamente vero, vale a dire ciò che è necessariamente, non potendo essere altrimenti da come é. Tuttavia, questo tipo di razionalità è solo ideale. La razionalità non è mai assoluta, incondizionata, ma sempre storica, situata e incarnata in una determinata cultura. Essa si esercita sempre all’interno di un contesto ed è orientata da una precomprensione: in questo senso l’esercizio della razionalità critico-riflessiva è sempre seconda 18 Cf. P. SCHMIDT-LEUKEL, “Sulla credibilità dell’annuncio cristiano” in La Scuola Cattolica CXXV ( 1997), 3-4, pp.469-477. 92 all’esperienza e al suo vissuto. Una delle conquiste della filosofia contemporanea è stata la scoperta della storicità, come costitutiva dell’uomo e della sua razionalità, anche se la ragione è in grado di trascendere o di “sospendere” tali presupposti, prendendo le distanze e sottoponendo a critica l’esperienza. Inoltre, grazie agli studi di K. Popper e della sua scuola il concetto moderno di razionalità ha subito profonde revisioni. L’ideale di una dimostrabilità indubitabile come presupposto del consenso razionale è stato decisamente abbandonato come non realizzabile, in quanto resta prigioniero di un infinito regresso dimostrativo relativo alle premesse su cui si fonda ogni dimostrazione. Se non è possibile una dimostrazione certa della verità, sono pensabili due alternative, che rimagono dipendenti da questa idea-guida: o la ricerca della più alta verosimiglianza o, almeno, il tentativo della limitazione dell’errore. La prima via è quella percorsa dalle diverse forme dell’induttivismo e del probabilismo; la seconda via è quella del razionalismo critico e del fallibilismo. In entrambi i casi viene abbandonata non solo la connessione della razionalità e del sapere certo, ma nel contempo anche una comprensione sostanzialistica della ragione in favore di una sua comprensione disposizionale. La razionalità secondo i recenti orientamenti epistemologici non dipende dal possesso della verità, ma dalla tensione ad essa, seria e adeguata. In un senso disposizionale la razionalità contrassegna in un certo qual modo l’etica delle nostre persuasioni intellettuali, cioè la domanda normativa circa l’esercizio corretto delle nostre capacità intellettuali, del nostro potere di conoscenza. In altri termini il passaggio da una comprensione sostanzialistica della religione ad una disposizionale comporta che la ragione non è più una fonte primaria di conoscenza, ma una sorta d’istanza di controllo, una disposizione appunto ad una verifica critica delle nostre persuasioni circa il loro contenuto veritativo, che come tale solo secondariamente possiede una funzione mediatrice di conoscenza.19 In questa prospettiva, come ragione critica che interroga la fede, la ragione potrebbe avere una funzione unicamente negativa: ricorderebbe alla fede che il suo sapere non è mai assoluto e incondizionato, fondato sull’evidenza razionale. D’altra parte, non riconoscendosi in grado di poter determinare tutto l’ambito del vero, manterrebbe aperto e fonderebbe lo spazio della fede, offrendone le condizioni di pensabilità e di possibilità. 19 Cf. ivi, 465 93 6.2 Il metodo della giustificazione critica della fede Vediamo a questo punto come argomentare la credibilità della rivelazione. Contestando l’estrinsecismo e il razionalismo dell’apologetica neoscolastica, la teologia contemporanea ricerca nello stesso evento rivelativo le ragioni dell’assenso di fede e della sua certezza. E ciò per un duplice motivo. Il primo per il carattere assolutamente gratuito della rivelazione di Dio: l’uomo non può né esigerla né dedurla dai dati generali del mondo. Il secondo motivo sta nella constatazione che è proprio di Dio e solo di Dio non poter fare riferimento ad altri se non a se stesso per farsi conoscere e convincere. D’altra parte, se Dio è pensato come il fondamento ultimo della realtà, non si può dare altro criterio più grande, a cui la fede possa riferirsi per la propria certezza. Tuttavia, questa tesi teologica non risolve, ma pone con maggiore forza il problema teologico-fondamentale. Se non si vuole restare prigionieri di un circolo vizioso, in cui la fede risulta essere il fondamento di se stessa, è necessario mostrare gli elementi e le condizioni per la formulazione di un giudizio di credibilità, tenendo conto della differenza tra la certezza incondizionata della fede (certitudo fidei) e la certezza limitata della conoscenza razionale della sua credibilità (certitudo credibilitatis) a causa della fallibilità della ragione umana. Per fondare la credibilità della fede non si può far ricorso agli abituali metodi di tipo induttivo e deduttivo. È necessario, invece, argomentare mostrando la coerenza interna dell’avvenimento della rivelazione e la sua capacità d’interpretazione autentica dell’esperienza della realtà. A siffatta esigenza sembra ben corrispondere, a giudizio di H.J. Pottmeyer, il modello basato su una «struttura cumulativa di fondazione» (‘kumulative’ Begrundungsstruttur)20. Sul piano formale esso risulta costituito da una serie di argomenti veri, strettamente connessi tra loro e capaci di sostenersi e di illuminarsi a vicenda. Inoltre, deve possedere i requisiti della comprensibilità, della correttezza e coerenza, e della intelligibilità dei suoi rapporti essenziali, senza far ricorso a presupposti di fede. L’insieme di questi elementi produce un contesto fondativo che consente un giudizio razionale responsabile e adeguato21. Applicando questo modello alla riveCf. H.I.POTTMEJER, cit., 470-472. Questo tipo di argomentazione sembra avere una certa somiglianza strutturale con la posizione di J. H. NEWMAN (Grammatica dell’assenso, Jaca Book, 20 21 94 lazione si può coglierne la corrispondenza e l’efficacia. La rivelazione, infatti, è un avvenimento complesso in cui i diversi aspetti s’integrano e si sostengono a vicenda. L’articolazione metodologica di questo itinerario consta di vari momenti. Poiché la rivelazione è offerta in una storia ed è custodita in una tradizione religiosa e di essa occorre accertarne il senso, il primo momento del metodo sarà fenomenologico-ermeneutico. D’altra parte, poiché di questa stessa rivelazione s’intende dare ragione in quanto rivelazione di Dio per la salvezza dell’uomo, il secondo momento sarà critico-veritativo. Accenniamo brevemente ai due momenti: a) il momento fenomenologico-ermeneutico. Se la rivelazione ha necessariamente in Dio il suo principio e il suo fondamento in quanto è la sua autocomunicazione salvifica, il compito primo della ragione teologica è quello di rilevare tale essenza nelle stesse testimonianze della esperienza di tale evento, cioè nella Scrittura e nella Tradizione. Il momento fenomenologico ha come scopo di raccogliere in un’unità intelligibile le diverse esperienze della rivelazione, registrate dalla testimonianza biblica dell’AT e NT, per individuarne una struttura in base alla quale poter determinare l’essenza della rivelazione stessa. Ma poiché l’eidos cercato è sedimentato nei testi religiosi che costituiscono la Sacra Scrittura, esso si presenta come un dato nella forma di un significato, che perciò va accertato per via ermeneutica. In altri termini si tratta di sviluppare un’ermeneutica delle origini, che risalendo alla fase costitutiva della stessa rivelazione indaghi le modalità e le ragioni della sua accoglienza nella fede da parte dell’uomo. Milano 1980), per il quale i singoli motivi di credibilità non riescono a provare con certezza logica la fede, né con la loro accumulazione, né con la loro convergenza. Essi, però, garantiscono una probabilità e una sicurezza spirituale, grazie alle quali la decisione per la fede diviene umanamente possibile, intellettualmente responsabile e moralmente vincolante. La certezza si raggiunge soltanto quando la convergenza del singoli elementi viene considerata alla luce della grazia della fede. Tuttavia, c’è una fondamentale differenza tra i due tipi di argomentazione: mentre in quella di Newman si tratta di una convergenza di probabilità nella struttura cumulativa di fondazione, invece, è l’accumulazione di singoli argomenti veri (e non soltanto probabili) che nella loro reciproca connessione e interrelazione, consentono un gludizio motivato di credibilità. 95 Elaborare una ermeneutica delle origini non è sufficiente per la TF, occorrerebbe anche sviluppare il potenziale apologetico inerente alla rivelazione, mostrandone la relazione all’uomo e al suo bisogno di salvezza (mediazione antropologica) e l’adeguatezza a interpretare l’esperienza della realtà. Ciò comporta l’elaborazione di un’ermeneutica della rilevanza, che ponga in rapporto il carattere intrinseco di universalità della rivelazione storica con l’autocomprensione dell’uomo di oggi, con le sue domande e le sue attese. Ma una siffatta ermeneutica, per quanto pastoralmete utile e necessaria, resta condizionata dal destinatario a cui è rivolta, dalla sua cultura, e dalla situazione storica in cui vive, e risulta perciò geograficamente molto differenziata: una TF elaborata in America Latina appare differente da una costruita in Occidente. Allo scopo di ovviare alla difficoltà derivante da una marcata contestualizzazione storico-culturale del discorso teologico è in ogni caso possibile e ineludibile per la fondazione della credibilità della rivelazione il confronto con le esigenze della ragione critica. E’ questo propriamente il momento critico-veritativo del metodo della TF, orientato per un aspetto alla fondazione della credibilità e quindi della ragionevolezza dell’assenso di fede e per l’altro al rapporto della rivelazione con la verità. b) il momento critico-veritativo Presupposta la fattualità storica della rivelazione secondo la testimonianza della fede, si tratta di renderne ragione, investigandone a posteriori le condizioni di possibilità e le modalità di attuazione. Si tratta di un momento sistematico-dottrinale e al tempo stesso criticoveritativo, dove la ragione teologica, riprendendo riflessivamente il dato fenomenologico, argomenta la mediazione della universalitàverità della rivelazione. La necessità di questa legittimazione critica è necessaria perché la fede si radica nella rivelazione storica di Dio, cioé nella particolarità e singolarità, ma al tempo stesso avanza la pretesa di essere verità e salvezza per tutti gli uomini di tutti i tempi, cioè di avere un valore e una destinazione universali. Ciò richiede un’intelligenza critica della sua complessa singolarità e della pretesa di assolutezza ad essa intrinseca. Ma la credibilità della rivelazione come autocomunicazione di Dio, che nella sua indisponibile libertà ha la propria esclusiva origine, non è in primo luogo il frutto di un’argomentazione della ragione 96 teologica, ma è il modo costitutivo, l’effettualità, di quella fede che è accoglienza della rivelazione di Dio22. La teologia fondamentale ha il compito di riprendere e di esplicitare criticamente nella dimensione del pensare, ad essa propria, la rivelazione offerta nella forma della fede testimoniale e la sua intrinseca credibilità in stretta relazione alla verità rivelata. Ciò richiederà in primo luogo, l’elaborazione dello statuto ontologico ed epistemologico della rivelazione con il compito previo di risolvere due aporie. La prima, inerente alla stessa pensabilità della rivelazione, può essere formulata nel seguente interrogativo: come può il trascendente, il totalmente altro, rivelarsi senza cessare di essere tale, perdendo nell’immanenza alterità e trascendenza? Il concetto specifico di trascendenza, espresso dalla realtà trinitaria del Dio cristiano, indicherà la soluzione di questa aporia. La seconda, inerente alla conoscibilità della rivelazione da parte dell’uomo, può essere formulata nel seguente interrogativo: In che modo una realtà trascendente ogni umana esperienza può essere percepita e conosciuta dall’uomo? Come può l’autocomunicazione del Dio infinito essere accolta e fatta propria dall’uomo finito, senza che perda il suo carattere di comunicazione di Dio? L’inevitabile mediazione simbolica della rivelazione e la specifica modalità della conoscenza simbolica indicheranno la soluzione di questa seconda aporia. Sulla base di questi presupposti, si dovranno vagliare criticamente le mediazioni della rivelazione di Dio: la creazione, la parola e gli eventi (in particolare i miracoli e la risurrezione), saggiandone non solo la loro concreta capacità e modalità mediativa, ma contestando argomentativamente le eventuali obiezioni della ragione critica. In particolare, per la persona di Cristo, occorrerà giustificare attraverso un preciso itinerario ermeneutico e ontologico-veritativo la pretesa di mediazione unica e universale del Cristo sul piano rivelativo e salvifico, a fronte dell’obiezione illuministica perdurante nella nostra cultura che non riconosce ad un concreto uomo storico la possibilità di essere portatore di valori assoluti e universali, e di quella più attuale derivante dal pluralismo delle religioni. 22 Essa è “la forma dell’evidenza in cui la fede identifica la verità di Dio degna di essere riconosciuta come tale…L’evidenza della credibilità non è una possibilità della fede: è semplicemente la sua effettualità… La rivelazione di Dio in Gesù, la verità che istituisce la fede cristiana, consiste nella credibilità di Gesù, è semplicemente il modo costitutivo di quella fede.”, P.A. SEQUERI, “Ragione teologica e analysis fidei.Idee per una teologia fondamentale pura”, in La Scuola cattolica, CXXV (1997), n. 3-4, 496. 97 Questo itinerario riflessivo- lo ribadiamo- non intende sostituire il credere con prove razionali, ma far emergere dalle testimonianze la credibilità della fede come inerente alla sua stessa effettualità23. In tal modo apparirà “l’intima compatibilità tra la fede e la sua esigenza essenziale di esplicarsi mediante una ragione in grado di dare in libertà il proprio assenso” (Fides et ratio, n.67). Ovviamente il fondamento della certezza incondizionata della fede è solo la rivelazione storica di Dio, che resta l’unico motivo dell’assenso di fede. Essa viene riconosciuta e affermata come fondamento della fede, solo nell’atto soprannaturale di fede. L’assenso che ne scaturisce è quindi essenzialmente un’opera dello Spirito Santo (1 Cor 2,10-16). Tuttavia, possiamo assentire in maniera responsabile alla rivelazione di Dio, perché essa è un evento che comunica da se stesso in maniera convincente al credente la propria verità. La verità della rivelazione, poi, può essere conosciuta dal credente e criticamente verificata dalla ragione. Perciò, può anche essere esposta al non credente in maniera tale che egli possa presagirne la sensatezza, anche se l’assenso alla verità della rivelazione non è un puro atto della ragione. “In tal modo la fede, dono di Dio, pur non fondandosi sulla ragione, non può certamente fare a meno di essa; al tempo stesso, appare la necessità per la ragione di farsi forte della fede, per scoprire gli orizzonti ai quali da sola non potrebbe giungere” (Fides et ratio, n.67). 23 Per lo sviluppo di questo itinerario, come anche per la giustificazioni delle argomentazioni suesposte, mi permetto di rinviare al mio trattato: C. GRECO, La rivelazione. Fenomdenologia, dottrina e credibilità, ed. S.Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2000. 98 L’«IMPETO FECONDO». LA POESIA DI CLEMENTE REBORA CIRO RICCIO * Il compito che devo assolvere questa sera è parlare della poesia di Clemente Rebora. Compito abbastanza insidioso, visto che Rebora è davvero un poeta diverso. Voglio dire che parlare della poesia di Clemente Rebora costringe a rifiutare l’offerta prospettica entro la quale, almeno usualmente, viene, o veniva, organizzato il discorso critico intorno alla poesia italiana del Novecento. E questo perché la poesia di Rebora fonda, per di più in anticipo, come vedremo dopo, un modello contrastante con quello che diverrà lo schema profondo, programmatico, endoletterario, che orienta una parte cospicua dei versi novecenteschi. Parafrasando il celebre formalista russo Jacobson, si potrebbe dire che la poesia di Rebora è una violenza organizzata ai danni della poesia tradizionale (tradizionale per il ‘900). E ciò vale in riferimento sia alla lingua che Rebora usa sia all’ideologia naturalmente incorporata in quella stessa lingua. Dico «naturalmente incorporata» poiché Rebora, come più avanti spiegherò, è un poeta senza poetica. E tale deficienza riveste un enorme significato a fronte dei comportamenti letterari dominanti nel ‘900. Rebora è, insomma, un degno rappresentante dell’«antinovecento», di quel novecento sotterraneo, umbratile, defilato, di cui già riferiva Baldacci a proposito della poesia di Carlo Betocchi. E non è un caso che Betocchi rimanga tra i più fervidi ammiratori della poesia reboriana, anche se egli fu attratto soprattutto dai Canti anonimi di Rebora, mentre a noi preme ora di rivolgere l’attenzione ai Frammenti lirici, per individuare l’impeto fecondo che li nutre. I Frammenti lirici furono pubblicati nel 1913. È stupefacente che a quell’altezza cronologica del secolo, Rebora, eludendo non solo le grandi suggestioni crepuscolari e futuriste, ma anche i richiami eterogenei amalgamati da quella cosiddetta “cultura vociana” che pure favorì l’apparizione dei Frammenti lirici, offrì con i suoi versi il magistrale e precoce documento di fondazione di una poesia controcor* Relazione tenuta il 24 Aprile 2001. 99 rente, di una poesia diversa. È una diversità anzitutto stilistica: penso alla “martellatura potente” di cui già parlava Serra, alle violente impennate verbali, a procedimenti come lo stilismo verbale già individuato da Contini, e che si può spiegare come l’applicazione di un verbo fisicamente concreto a nozioni astratte, un verbo che deroga dal normale contesto in cui di solito è usato (alcuni esempi: «sdraiare passi d’argilla», «lo spazio zonzando scintilla», «sguscia fulminea la vita», «Il sol schioccando si spàmpana»). E allo stilismo verbale si lega un altro procedimento frequentissimo nei Frammenti, e cioè la trasformazione dei verbi intransitivi in transitivi (esempi: «ma ragionarono il mondo», «ciascun apra suo gorgo e lo fluisca/ruscello all’acqua altrui», ecc). Penso poi all’applicazione analogica del verbo (esempi: «rumina l’ozio e aduna i suoi cocci», «il minuto… s’ingorga», «ciel che… contro la noia sguinzaglia l’eterno»,ecc), all’utilizzo di verbi parasintetici sul modello di quelli danteschi (esempi: infognare, infoscare, incielarsi, inspeloncarsi). E si badi che tutto ciò non è il risultato di una studiata volontà di rottura con la tradizione, ma, secondo tutt’altra prospettiva, il prodotto di chi ebbe sempre un rapporto di edificante scontrosità con la lingua, di chi sempre cercò di “spremere” la lingua fino al fondo, per ricavarne il massimo di energia. Rebora non fu mai un cultore raffinato della parola splendida ed esatta, non condivise mai la dichiarazione dannunziana che «(…) divina è la parola/e il verso è tutto», ma non per questo professò la sua fede in una parola dimessa - e in realtà altrettanto orgogliosa – come ad esempio quella crepuscolare. Né, d’altra parte, caricò la parola di un significato avanguardistico che, in terra nostrana, palesava allora l’adesione ai programmi futuristi. Eppure, la parola poetica reboriana riesce egualmente rivoluzionaria, e rivoluzionaria senza alcun bersaglio da indicare, senza alcuna autorità da deporre: basti pensare a quale polare distanza dalla tradizione poetica essa si situi, nonostante Rebora abbia ricuperato e reinventato alcuni stilemi e sintagmi della poesia tradizionale1 . È perciò anche, necessariamente, una diversità tematica, ideologica. Rebora è una sorta di poeta duplex, poeta che con i Frammenti lirici, riflettendo sulla serie di 1 È un discorso, questo, che vale sia per la metrica che per il linguaggio. Rebora infatti ha sí utilizzato il verso libero ma ha pure adottato alcuni metri della tradizione. Inoltre è stato uno degli ultimi poeti italiani a comporre sonetti. Per quanto riguarda il linguaggio si pensi ad alcuni calchi carducciani o dannunziani od anche, come si vedrà poi, alla ripresa di alcune espressioni leopardiane (come di derivazione leopardiana è l’unione di endecasillabo e settenario). Una riflessione a parte meriterebbe poi la presenza dantesca in Rebora (Orelli, Cicala, etc). 100 antinomie che impacciano l’esistenza, ha innegabilmente concorso a plasmare il volto della modernità poetica e, di contro, poeta che non rinuncia a cantare il presente, che non abdica all’idea di magnificarne le sorti. Dovendo ricorrere a una formula, mi verrebbe da dire «nuova poesia del desiderio». Il desiderio è lo stato che ne propizia la venuta, e con tutte le conseguenze di una stretta aderenza alla necessità etimologica del nome: desiderio, che è de-siderium (suffisso sottrattivo de + sîd?s, eris), ovvero in assenza di stelle. La condizione di chi desidera è quella di chi è in assenza di un riferimento astrale, cioè orfano di Dio. In questo senso il de-siderium è il denominatore comune a ogni visione poetica del mondo. Rebora ha però interrotto, relativamente alle sorti novecentesche in Italia della poesia della crisi, il modo di traduzione letteraria del de-siderium, che, se continua a essere versificato, non esaurisce il destino della sua poesia. Rebora, cioè, realizza una formidabile acrobazia tenendo coesi il fulcro della modernità, ovvero il pensiero poetante che smette di credere nell’unitarietà dell’io, nel sapere oggettivo, nella gnoseologia romantica, nella “scrittura transitiva” riflettente un opus perfectum, con l’antica aspirazione alla totalità, con l’aspirazione a chiedere quella che Rebora ancora chiama «la verità della vita», a riscoprire l’integrazione dell’uomo a tutto l’universo, secondo quella lex continui che dominava nella concezione romantica. Ma è forse meglio passare alla lettura di alcuni dei Frammenti lirici, per intenderne direttamente il valore. Nei fogli a vostra disposizione la numerazione in numeri romani rispetta quella presente nella raccolta; è però disatteso il normale avanzamento numerico, poiché ho cercato di disporre, attraverso la lettura, un certo tipo di ragionamento. Devo anche dire che, per ragioni di tempo, non potrò fermarmi su tutti quanti i frammenti che voi troverete sui fogli. Obbligato a fare perciò una cernita, essendo l’impeto fecondo rintracciabile e per via linguistica e per via contenutistica, seguirò la seconda traccia, anche perché vorrei dopo saldare l’analisi poetica con una breve riflessione su Rebora e il Novecento. Pertanto mi riferirò ai fr. 1, 39, 62, 63, 60, di nuovo 39, e poi 28, 50, e 71. Possiamo cominciare dal primo frammento, che è già rappresentativo di un organismo poetico che non assumerà in seguito una conformazione molto dissimile da quella mostrata all’avvio. L’egual vita diversa urge intorno; Cerco e non trovo e m’avvio Nell’incessante suo moto: A secondarlo par uso o ventura 101 Ma dentro fa paura. Perde, chi scruta, L’irrevocabil presente; Né i melliflui abbandoni Né l’oblioso incanto Dell’ora il ferreo battito concede. E quando per cingerti io balzo - Sirena del tempo – Un morso appena e una ciocca ho di te: O non ghermita fuggi, e senza grido Nel pensiero ti uccido E nell’atto mi annego. Se a me fusto è l’eterno, Fronda la storia e patria il fiore, Pur vorrei maturar da radice La mia linfa nel vivido tutto E con alterno vigore felice Suggere il sole e prodigar il frutto; Vorrei palesasse il mio cuore Nel suo ritmo l’umano destino, E che voi diveniste – veggente Passïone del mondo, Bella gagliarda bontà – L’aria di chi respira Mentre rinchiuso in sua fatica va. Qui nasce, qui muore il mio canto: E parrà forse vano Accordo solitario; Ma tu che ascolti, rècalo Al tuo bene e al tuo male: E non ti sarà oscuro Siamo davanti a un attacco quasi epico, almeno in senso tecnico, un attacco in medias res, che denuncia l’ingovernabilità del flusso vitale; non a caso, il primo verbo che s’incontra, urge, restituisce integra l’ansietà dell’individuo travolto dal magma del divenire, nel quale è così arduo destreggiarsi che: «Cerco e non trovo e m’avvio/ Nell’incessante suo moto». L’appercezione reboriana fa immediatamente i conti con la corrosiva nozione di tempo, che è un inarginabile scorrere di attimi internamente pauroso: «a secondarlo par uso o ventura/Ma dentro fa paura». Ma il presente essendo “irrevocabil” e la “sirena del tempo” fuggente poiché non ghermita, non rimane che tuffarsi nel precipizio dell’atto («e nell’atto mi annego»). Il verbo urge, forse non per nulla primo verbo del verso primo, è fortemente denotativo della sollecitudine che accompagna il poeta 102 nella sua esperienza del reale. Esso anticipa altri verbi cari a Rebora, e in abbandonza disseminati nella raccolta, che ugualmente dicono dell’energia rovente sprigionata dalle disarmonie dell’attuale (i vari preme, attanaglia, freme, pulsa, palpita, tumultua). Viene poi fronteggiata la spinosa questione del tempo, la cui metafisica prepotenza più volte sarà oggetto di meditazione. Proprio la cognizione di quanto deciduo e transeunte sia il possesso del tempus che, orazianamente, è un frammento di aetas, induce a esaltare il presente come arena dell’azione di riscatto. Perciò, se da una parte l’atto, termine che spesso ricorre nei Frammenti, e che tradisce la memoria di una giovanile adesione alla filosofia di Bergson, è l’escamotage necessario per una salvifica incoscienza delle distonie del reale («e nell’atto mi annego»), dall’altra esso è fonte di impeto battagliero: «(…) e rivivi/Nell’atto la fede», come dirà nel fr. II. Fin qui il negativum dell’indagine poetica. Ma, lo accennavo prima, quando ricordavo la grande acrobazia di questa poesia, il pensiero reboriano non si accontenta di ratificare gli immobilistici corollari di lamenti tanto sofisticati - e i suoi, peraltro, non sono mai tali – quanto in sé conclusi. C’è sempre un fine che esige di essere realizzato e le cui basi progettuali sono, credo, già rintracciabili nella seconda parte del primo frammento. I versi 19-20 professano la volontà di integrarsi attivamente – a un livello sia biologico che spirituale – nel meccanismo della vita universale. Una volta descritte le metafore di provenienza botanica, Rebora dice «(…) vorrei maturar da radice/La mia linfa nel vivido tutto», ovvero esprime l’intenzione di proiettarsi ed espandersi in un tutto che, pur riecheggiando quello leopardiano, non è poeticamente e malinconicamente infinito, bensì vivido, cioè brillante e rigoglioso. Questa aspirazione è premessa alla seconda dichiarazione d’intenti, con la quale si tocca uno dei nervi centrali della poesia non solo dei Frammenti ma reboriana in genere: «Vorrei palesasse il mio cuore/Nel suo ritmo l’umano destino,/E che voi diveniste – veggente/Passïone del mondo,/Bella gagliarda bontà - /L’aria di chi respira/Mentre rinchiuso in sua fatica va». C’è quindi in Rebora l’ambizione, per dirla con Saba, di «aderire alla calda vita di tutti». In più egli invoca un nome, bontà, la cui ricerca non finirà mai di accendere la sua passione (e voglio ricordare l’emistichio «e sol bontà è vita» del Curriculum vitae, la biografia in versi ancora di là da venire): la comprensione dei mali altrui, che sono anche i propri, è il commovente risultato di una dote morale dinanzi alla quale la poesia stessa si deve inchinare. Illuminante a tale proposito un passo del fr. XXXIX, che è riportato di seguito: 103 XXXIX Ma qui c’è amore e vorrebbe Altro amore infiammare; Mentre rapace artiglia Nel cervello e nel senso La fame e la sciagura La voglia e l’ansietà, Vien qua tu, poesia maledetta, A veder la bellezza A provar la bontà: Ma qui c’è aiuto e vorrebbe Altro aiuto invocare. (vv. 13-23) Ecco, così come è la poesia a doversi redarguire, a doversi recriminare per la sua ritrosia a scoprire bellezza e bontà, allo stesso modo, sostiene Rebora contro ogni forma di disinganno post-umanistico, è all’uomo che spetta di correggere la disarmonia tra se stesso e la natura, tra io e mondo. Alcuni versi del fr. 62 denunciano proprio l’inadeguatezza dell’uomo moderno ad integrarsi ai ritmi naturali: LXII Stella in baglior di nebulosa avvinta, Notte succhiata dal cuor dei tramonti, Goccia indistinta nel grido del mare, Rupe sommersa nel clivo dei monti, Pianta dispersa mentre inseni fonda, Forza agli ordigni nascosta e feconda, Anonima rozza che il carro trascini, Dite dite l’arcana maniera Dell’invisibile amore A noi, che meschini Coniamo dei nostri suggelli Il lavoro di Dio Gridando: Io, io ,io! (vv. 14-26) È quindi compito dell’uomo rintracciare la via arcana dell’amore, la via che rende partecipi del divino; e il divino è coscienza della vita che è l’essere tra cose che sono, terrestre operosità illuminata dalla logica celeste, futura memoria di un ribattezzato essere da sempre che non fa neppure per un attimo balenare l’idiozia, avrebbe detto Cioran, di “lanciarsi nell’apprendistato dell’altrove”. Il fr. LXIII è ancor più paradigmatico della volontà di integrarsi naturalmente al ritmo della vita: 104 LXIII Il mio passo è la traccia dell’erba, Il mio cuor è la specie del luogo, E tutto si palesa e nulla è vano Nel grande andar del mondo. Vil trastullo di sé, Orrenda solitudine di sé, Sulla mia forza piena Breve conquista vi resta: Siete un batter di ciglio Sul perenne guardare. Tu, divin senso palpitante e intriso Del sangue quotidiano; Tu, divin senso che irraggi La vita e più la doni e più n’accresci: Se nelle prove oscure m’incoraggi E sull’arduo cammino che mi piacque La mia forza costrinsi all’altrui forza, Tu nella tregua m’accalori i polsi E per te spazia il consenso che nacque Innavvertito agli uomini e alle cose (vv. 25-44) E inutilmente tu, gravoso spazio, Dall’infeconda nuvolaglia premi L’indicibile fervore: La bigia terra inerte Dai tronchi ai rami ascende; La bigia anima inerte Nell’amore e nell’atto più s’intende, E sugge dal tormento Le sue gioie più certe. (vv. 75-83) La fatica di captare il divino, la maledizione di rincorrerlo ad infinitum nel nostro finito, sono ricompensate dalla gioia di essere dal divino irradiati, come per una sorta di stilnovistica teoria di metafisica della luce: Il divino si alimenta del proprio donarsi, e cresce per quanto il dono di sé è ricevuto senza conoscerlo. Il divino è questa pienezza di vita che ci apparterrebbe se fossimo nella potenza di pensarla con sapiente naturalezza: LX Divino è l’esser tra cose che sono E il pensarlo, e con pace Accogliere ignorando La misterïosa armonia, Mentre in un fluido eguale Spazia ineffabile il tempo. (vv. 16-21) 105 Va da sé che il dolore è tuttavia presente; è presente, per esempio, nelle imprecazioni di Rebora contro la città vorace, le quali, superando l’adesione a un maledettismo urbano allora di moda per alcuni, traducono un disagio dell’esistenza corrotta dai ritmi antinaturali. È poi anche il dolore prodotto dall’ansia del, dice Rebora, «divenir tremendo che non cura l’opporsi/e si fa natura e storia». Ma il dolore è una questione troppo seria e non può, non potrebbe, non dovrebbe, sfociare nella grandiosa tragedia di un’intelligenza individuale che, non riuscendo a tollerare il peso della vita – la sua variegata ricchezza – tenta di soffocarlo, di eliminare il mondo. Il dolore per Rebora c’è, è denso, fitto, esteso, implacabile, e che serva a qualche cosa perlomeno: XXXIX Il dolor plachi come la stanchezza Che reca sonno a riprodur la veglia, Il dolor snodi come la giornata Che rovinando crea l’indomani, Il dolor viva come buona madre Che trae dal penar la sua speranza, Il dolor fiammi come la lanterna Che dal nostro il cammin svela degli altri. Ciascun apra suo gorgo e lo fluisca Ruscello all’acqua altrui. (vv. 27-36) Se solo si pensa a ciò che la cognizione del dolore implica nella poesia di ogni tempo (in genere), già spicca la disarmante e schietta propositività di un tal modo d’intendere il fare poetico. Quella che per alcuni è stata la sterzata in limine che ha scongiurato l’incidente nichilistico è in Rebora nozione preliminare al fatto stesso di non pensare mai l’essere come pena di essere. Rebora è nutrito dal senso di una vita sana che in nessun momento si lascia catturare dal piacere elegiaco della querimonia. Lo testimonia senza tregua questa poesia così straordinariamente antiletteraria, che conosce basse durezze, che fa lo sberleffo ai dotti avvolgimenti di un pensiero aristocratico, perché ne sospetta l’inganno: XXVIII A me, che siete, o spregi insofferenti Del comun senso, o dotti avvolgimenti, O smanie ben pasciute, Se nel cuore le forme conosciute Degli uomini e del mondo Mi rivelano il prodigio? (vv. 14-19) 106 A che possono valere le trappole di un pensiero ricercato, che esiste anzitutto per testimoniare il proprio inarrivabile splendore. Non è forse meglio, come dice Rebora nel fr. L: L Esistere e pensare, Cinger di sé l’ignoto Universo e amare, Per ridiscender domani Umanamente pronti Al terribile giorno. (vv. 103-108) E si può concludere questa lacunosa lettura con alcuni versi del fr. LXXI, che ribadiscono, con sintetica e asciutta irruenza, la volontà di non rassegnarsi mai: LXXI Al nostro polmon sano Anche poc’aria basta Per respirar profondo, Se turbini con Dio La volontà nutrita Di ricrear nel mondo Questa angoscia gioita, Quest’impeto fecondo, Questo veggente oblio: Questa vita che è vita. (vv. 75-84) Così i Frammenti lirici. Vorrei a questo punto esprimere alcune considerazioni riguardo la figura di Rebora nel nostro Novecento. Mi sembra che Rebora sia giunto a comunicare un’angoscia tipicamente novecentesca pur non essendo uomo di pena, o meglio, essendolo in un altro modo: restando ancorato alla storia grazie a una sua “rozzezza” che gli ha sempre impedito di scovare nella parola un baluardo contro la violenza del reale. La parola è sempre in lui fastidiosamente ingombrante, impregnata di scorie repellenti, incapace di raffinare il dolore per mezzo di una sua forma preziosa. Dev’essere una sensazione alquanto diffusa, provata da molti, quella di un incomodo, di un irritante disagio avvertito al primo contatto con la poesia reboriana. Il lettore non è abituato, non è allenato a ricevere un’energia che è difficile gestire. Secondo una bella meta- 107 fora un poeta, in realtà, non si legge. Un poeta si accosta, si avvicina, con una serie di manovre avvedute che servono a propiziare il momento dell’incontro. Ebbene, questo tipo di operazione difficilmente vale nel caso di Rebora. È stato forse Giovanni Raboni a spiegare nella maniera più chiara la causa dell’incidente comunicativo che guasta il primo appuntamento con il poeta: è vero, come egli nota, che le parole usate da Rebora sono “impure”, sono parole che nella poesia continuano a significare qualcosa che hanno già significato prima, parole crudemente segnate da un uso anteriore, così come, di contro, sono “pure” le parole usate da Montale, Ungaretti, Quasimodo, parole drammaticamente isolate nello sforzo di essere solo se stesse e la propria apparizione e non già anche il proprio significato e la propria storia. È forse in questo modo d’intendere il mestiere poetico che matura quella grandezza tempestivamente intuita da Boine, precoce difensore dei Frammenti. Di certo Rebora si è applicato con lungo sacrificio alla composizione dei versi; è naturale – come lo è per chiunque scriva qualcosa che sarà letto da altri, e perciò più ancora lo è per il poeta, che intuisce nella responsabilità della parola il suo vincolo – che egli abbia assiduamente rivisitato le sue poesie, fino alla convinzione che nulla più andava aggiunto o sottratto. Meno ovvio è che Rebora abbia rinunciato a una qualsivoglia “presentazione” della sua opera. Nessuna introductio ad auctorem, nemmeno in separata sede. Voglio dire: in un periodo storico in cui il prodotto letterario e artistico assume importanza soprattutto per il valore programmatico che ne favorisce la genesi, per il progetto di una risposta alla modernità che esso contiene (e si pensi alle avanguardie, ma poi anche al vocianesimo, al rondismo, all’ermetismo, ecc., insomma, al tentativo, variamente declinato, di ricercare una forma d’arte che testimoni lo scandalo della storia), Rebora non avverte la necessità di giustificare la sua poesia, di inscriverla in una cornice intellettuale che le dia un senso per la storia del tempo. Va da sé che la poesia non ha necessità alcuna di essere introdotta, giustificata, chiarita. È un prodotto dello spirito. La poesia è. E basta. Altri s’impegnerà a divulgarla o a chiosarla. Ma il punto, accennato sopra, è questo: nel corso del ‘900, e specificamente nella prima metà del secolo, i poeti, più di tutti, recepiscono con acutezza il bisogno di attribuire alla propria parola un carattere di “sperimen tazione”. I drammatici eventi contemporanei, le guerre, e poi, soprattutto, il riconoscimento integrale della frattura procurata dalla modernità, esortano a intravedere e ad edificare nella poesia uno scher108 mo che protegga dal gratuito esibirsi della storia. In casi di forte entusiasmo la risposta della poesia non sarà un riparo ma, di contro, una reazione. Ad ogni modo, più che la poesia in sé acquista rilievo, per così dire, la poetica che ne legittima l’esistenza. Perfino Saba, appartato almeno quanto Rebora, scriverà nel 1948 una Storia e cronistoria del Canzoniere, vero e proprio saggio critico sulla sua opera in versi, la sua «tesi di laurea» come si disse. Ma poi, si pensi alle Ragioni d’una poesia di Ungaretti, all’Intervista immaginaria di Montale, ai discorsi sulla poesia di Quasimodo. Una specie di amara autoesegesi completa a distanza il senso dei versi poetici, rendendoli così, se possibile, ancor più disperati e autentici. Diversamente, Rebora, senza bisogno di escogitare un modus poetandi rispecchiante il disastro storico, si direbbe che giunga con spontaneità a pensare una poesia che, a parte l’indiscussa originalità linguistica, si pone come tipicamente novecentesca per via dell’inquietudine che la sostenta, e sia pure così operosamente governata nei modi che prima abbiamo visto. Ma l’idea che Rebora sia un poeta orfano di poetica, insensibile ai richiami teorici di una qualunque ars poetandi, è poi rinfrancata da un’altra osservazione: in lui intercorre una differenza quasi impercettibile tra l’uso della lingua in poesia e in prosa, e per impellenze che nulla hanno a che vedere con l’adesione a un frammmentismo lirico di derivazione vociana. La parola in prosa gode della stessa impervia consistenza che governa quella poetica. La scrittura in versi non si oppone a tutto ciò che prosaicamente è altro da sé; i sostantivi, gli avverbi, gli aggettivi impiegati nelle composizioni poetiche sono i medesimi che Rebora utilizza in altri momenti della comunicazione. Il modo di torcere la lingua, di disporla a un uso quanto più materiale possibile, non cambia nel passaggio tra registri espressivi differenti. La poesia di Clemente Rebora non cresce in un laboratorio linguistico separato, costruito ad hoc. Essa abita quasi sempre nello stesso spazio grammaticale, sintattico, verbale destinato ad altri usi linguistici. Lo si può acclarare leggendo il suo epistolario, leggendo le sue prose, come ad esempio quelle che ho riportato sui vostri fogli. Io non ho ora il tempo di commentarle, ma vorrei almeno soffermarmi sull’ultimo scritto, perché, trattandosi di un articolo, si sottrae anche all’ipotesi di una consonanza con il linguaggio poetico in quanto documento di una prosa d’arte. È un articolo del 1910, la cronaca di una serata tipo in un teatro milanese dell’epoca: 109 Gli spettatotori dell’ultimo piano (1910) (…) Poi la folla aumenta. Allora si arrischia qualche passettino in avanti, e adagio adagio ci si stipa, quasi inavvertitamente. (…). Talvolta si ammorza subito; ma spesso circola, si trasforma, si drappeggia di rimedi e consigli. Poi si consultano orologi, quando si possa giungere fino al panciotto nella pressura che si è fatta più gagliarda (…). E giunge il gran momento: la calca fluttua dentro i primi che spruzzano dentro la porta spalancatasi. (…). Quando l’uscio s’apre, l’assalto si fa rabbioso e brutale; le povere donne gridano in un tramestìo di braccia e petti stringenti (…). Quando infine comincia lo spettacolo, chi può vedere bene s’accovaccia nella propria attenzione (…). Calato il sipario, dopo l’ansietà della rappresentazione, la gola pizzica e si sente bisogno di bere e mangiucchiare qualcosellina. Poi, alla fine dell’atto, scattan su gli applauditori e fischiatori arrabiati, e s’affaticano quasi per missione; e rigurgitano i commenti. Ci sono i cani da fiuto del plagio, che assordano: «questo c’è nel tal punto della tale opera; si ricorda? – Ma che! – (…). Basta considerare il folto numero di analogie preposizionali («tramestìo di braccia», «i cani da fiuto del plagio», ecc.), l’alterazione delle forme verbali consuetudinarie, la conversione di verbi transitivi in intransitivi-assoluti («spruzzano dentro la porta»), una formula a metà tra una voce parasintetica e un’analogia preposizionale come «si drappeggia di rimedi», un hapax come «qualcosellina»: è evidente allora come le parole poetiche non siano sottoposte a nessuna azione detergente che le ripulisca delle incrostazioni quotidiane. Un’identica e innata concezione linguistica presiede agli interventi in prosa e in poesia. Guardare allora a Rebora come a un poeta senza poetica, accertare in lui l’assenza di una poetica, nei termini in cui ho prima inteso quest’ultima, e cioè come momento fondativo d’una poesia agglutinata a una sorta di apparato critico che ne commenta la forma esclusiva assunta di fronte all’irragionevole corso della storia, induce ad apprezzare maggiormente la considerevolezza del risultato ottenuto dai Frammenti lirici. È cioè sbalorditivo che da una concezione così “artigianale” del lavoro poetico, così genuina e schietta, voglio dire così poco “aristocratica”, letteraria, derivi una poesia che non solo condivide le più grandi controversie impegnanti l’ontologia novecentesca, ma che anche, in qualche modo, ne anticipa l’avvento. 110 Quanto ho detto non sembrerà forse inclinare verso un’incauta apologia se si ricordano le parole di Mario Luzi: «i Frammenti lirici restano la più alta investitura spirituale che la poesia del Novecento potesse chiedere e augurare». Dev’essere un motivo profondo, assai consistente, quello che ha indotto Luzi a esprimere un pensiero tanto netto, inequivocabile, perentorio. Un motivo sul quale conviene soffermarsi poiché il poeta fiorentino si può considerare un po’ come la coscienza poetica del secolo, l’ultimo rappresentante delle generazioni passate (soprattutto per il fatto che egli è ancora vivo). Il motivo, spiega Luzi, è che i Frammenti lirici, come i Canti orfici di Campana, consumano ancora un’esperienza totale, evadono cioè da quella che si può definire l’«episteme leopardiana», ovvero la grande eredità del pensiero leopardiano nel ‘900, che si riflette nella poesia modellata unicamente sulla propria coscienza, cui è chiaro che il derelitto apparato post-umanistico è stato per sempre abbandonato dall’umanesimo. Se il reale è antinomico rispetto alla coscienza soggettiva, alla coscienza soggettiva non resta che ridurlo al suo proprio limite, anziché aprirsi alla inesauribile trasformazione del reale stesso. Esattamente l’opposto di quello che a ogni passo i Frammenti lirici dicono ed esaltano. 111 112 SULLE TRACCE DELLA POESIA DI MARIO LUZI RACHELE SIBILLA * 1. PELLEGRINO DELL’ASSOLUTO NEL CONTATTO COL FIUME VIVENTE DELLA VITA. E’ nel nome dell’uomo, nel volerci pienamente umani, lucidamente attenti alla concretezza dei suoi bisogni e capaci di intercettare domande radicali di valore e di senso della vita e della storia che non si esauriscono nella sfera privata ma investono atteggiamenti culturali e sociali di rilevanza pubblica, che proponiamo quest’incontro con la poesia di Mario Luzi. Non è una riflessione accademica, ma uno spazio di largo respiro umanistico, aperto al dialogo tra poesia e teologia, o meglio, tra il poeta e il teologo. Sui sentieri della Parola entrambi s’incontrano, ascoltatori e mediatori di una parola che ciascuno spezza agli uomini, con la specificità del suo linguaggio: il poeta fiducioso nella parola poetica con cui scava nei meandri sotterranei ed esplora frammenti e grumi di vita; il teologo, fedele alla Parola che illumina di senso le parole della vita, accende il dinamismo dell’interpretazione, del discernimento, della ricerca che restituisce all’uomo la sua verità. In un contesto di frantumazione del sapere e di omologazione, in cui si fa fatica ad osare domande e ad attraversare i guadi dell’esistenza, senza fughe dalla responsabilità, è significativo e, sotto certi aspetti, provocatorio, l’incontro con la poesia di Luzi. Questa, infatti, è cifra della problematicità esistenziale, testimonianza di una fede costante nel valore della scrittura poetica, itinerario cognitivo, etico, filosofico, tensione veritativa che l’unisce al filo rosso che si dipana da Agostino a Dante, a Pascal, a Leopardi, a Montale, per quella ricerca densa di interrogativi, non dissimile da poeti e pensatori pur diversissimi da lui. Luzi è una stella di prima grandezza nell’universo della lirica contemporanea, che non si finisce mai di esplorare: la sua produzione poetica è un contatto con il fiume della vita vivente, con le sue * Relazione tenuta il 16 Aprile 2002. 113 sfide, le sue provocazioni e sfugge ad ogni rigida interpretazione, ad ogni storicizzazione, ad ogni “etichetta”. Ora energica ed occulta nel suo preziosismo stilistico, ora profetica, nella sua apparente semplicità, lungi da ogni “sistemazione”, s’impone per la sua voce e per la sua testimonianza di una condizione umana affacciata sul Mistero, sul senso ultimo del proprio consistere che resta inesplorato e costantemente sollecita l’intelligenza indagante ad aprirsi all’avvento dell’altro e alla novità della storia, senza cedere alla tentazione di ridurre le differenze o di catturarle negli schemi delle proprie proiezioni. Il poeta scava nel paradosso, nelle contraddizioni della vita, nelle trasformazioni della storia, con l’umiltà di chi non presume di possedere risposte ma si sforza di ascoltare e di comprendere, di passare dalla contingenza del fenomeno al fondamento, capace di imprimervi un senso, in un perenne atto d’amore per l’uomo. Non troveremo, nei suoi testi, soluzioni o sovrapposizioni interpretative, l’intento di comunicare messaggi, ma uno spessore esistenziale ed una compromissione con la storia guardata da una prospettiva sapienziale che non è rifugio consolatorio e tranquillizzante, ma tensione che continuamente spinge al largo, per una ricognizione più vasta in cui supera, per evoluzione, senza tuttavia rinnegarli, i presupposti di partenza. Lo stesso atteggiamento si traduce in una ricerca formale che, pur attraversando i fermenti culturali del suo tempo approda ad esiti nuovi, a svolte radicali in cui si va precisando la sua vocazione poetica: le tappe esistenziali sono un’occasione per mettere a fuoco un’immagine del mondo e trovare un centro unitario, un filo di luce che la rischiari, quella sua “integrale vocazione metastorica”1 e quella religiosa ricerca della verità che non si arresta di fronte a nessun fallimento e dinamicamente la proietta verso nuove soluzioni stilistiche ed una coerente ricerca poetica. 2. LA POESIA DI LUZI: CARMEN FLORENTINUM L’approccio alla poesia di Luzi è come il primo contatto con la città di Firenze, con il suo paesaggio che penetra negli occhi e nel cuore con la forza perentoria della sua antica bellezza: è come trovarsi in un cantiere a cielo aperto in cui confluisce l’opera e l’inge1 Mengaldo – Poeti italiani del Novecento – Mondadori, pag. 653 114 gno di artefici e di artisti; nell’intreccio poderoso e armonico di linee e di disegni svettano monumenti, quasi ponti gettati verso l’alto, in cui vibra e si riconosce l’anima antica e sempre nuova di una città così raccolta e così aperta al mondo, così discreta e così maestosa. Di volta in volta, la luce radente o un velo di nebbia te la fa scoprire nella sua semplicità intrigante e misteriosa, nella profondità spirituale delle sue voci che sembrano venire da lontano ma sono cariche dell’oggi, di tutto l’umano, della leggerezza pensosa delle cose concrete, delle infinite possibilità di una comunicazione continuamente adeguata alla molteplicità delle esperienze e ad una pluralità che è garanzia di una verità non parziale e di una ricchezza inventiva inesauribile. Si avvia, così, un colloquio sommesso che entra nel sangue e parla all’anima coinvolgendola in quella che il poeta chiama “vicissitudine sospesa”. Proprio nella Firenze degli anni Trenta, insieme ad un folto gruppo di intellettuali, per lo più di estrazione cattolica, ed intorno al alcune riviste come “Frontespizio”, “Campo di Marte”, “Letteratura” inizia l’avventura poetica di Luzi. Intellettuale di punta, con Bigongiari, Parronchii, Gatto, Macrì, Contini, Bo e tanti altri, fa parte di quella generazione che, nel solco del rinnovamento avviato dagli ermetici della prima e della seconda generazione e sollecitato dalle esperienze simboliste, surrealiste ed esistenzialistiche, apre un dibattito culturale che, per la vivacità dell’elaborazione e l’intensità dell’invenzione fa maturare una nuova sensibilità sulla funzione della letteratura e dell’esercizio poetico ed apre prospettive a percorsi poetici originali. Nel 1958, Carlo Bo, su “Frontespizio” pubblica una saggio significativo del nuovo indirizzo: “Letteratura come vita” che, rovesciando l’estetismo e la retorica dannunziana, già denunciata dai movimenti di avanguardia, e andando oltre gli esiti di quel linguaggio assoluto, avulso da contenuti sociali e culturali e rivolto non a comunicare messaggi ma solo a tradurre l’illuminazione lirica ed una concezione individuale del mondo, identifica vita e letteratura. E’ evidenziata una tensione conoscitiva ed autoconoscitiva che non è tanto un processo intellettuale, analitico ed introspettivo di progressiva acquisizione di conoscenze, ma domanda di verità, disponibilità ad accogliere una rivelazione ed ascoltare il reale, nell’attesa di ciò che possa dare senso al vivere. La letteratura, afferma il critico, “è forse la strada più completa per la conoscenza di noi stessi ….. per la vita della nostra coscienza 115 …..; per noi in egual misura letteratura e vita sono strumenti di ricerca e quindi di verità: mezzi per raggiungere l’assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio di continuare ad attendere con dignità, con coscienza, una notizia che ci superi e ci soddisfi ….. un golfo di attesa metafisica”.2 Molto acutamente un fine studioso dell’ermetismo come Silvio Ramat osserva: “è la concezione stessa di vita che va approfondita: vediamo che nell’ordine intellettuale dell’ermetismo essa contempla una verità come primum, intuita in interiore homine, di densa e ardua esprimibilità proprio per il suo stare confitta all’interno della coscienza personale; è una verità che teme di disintegrarsi al contatto con i fenomeni così come essi brutalmente appaiono, e, pertanto, li evita proponendo l’assenza; ma anche spesso li sussume in una sintesi mentale, li dialettizza, cioè, verso la nozione. L’assenza mantiene desto il senso dell’attesa che s’incarna variamente nei singoli poeti del movimento, ivi compreso Montale che viveva a Firenze, in familiare rapporto coi giovani i quali vedevano già in lui un maestro anche sotto il rispetto etico, sentivano la sua lezione di docenza quotidiana”3 . La poesia dell’assenza e dell’attesa non è, pertanto, disimpegno e chiusura nella torre d’avorio delle lettere, è piuttosto esplicita volontà di non compromissione col fascismo, difesa dell’autonomia degli artisti e di un’attiva ricerca della verità, una scelta che si colloca in una prospettiva diversa da quella di Bargellini e di quei tradizionalisti che si pongono nella linea avviata dal Concordato. In questo contesto Luzi s’impegna a creare una nuova parola poetica, mai disgiunta dall’intelligenza del reale, dalla chiarificazione delle ragioni dell’arte e della poesia che non s’identifica con nessuna cultura, con nessuna ideologia ed è, tuttavia, portatrice di una speranza, spinta trepida ed insieme fiduciosa verso un bene ed un bello a cui tendere. E’ una speranza aperta alla ricerca del fondamento, ponte tra la precarietà e la crisi del presente e la possibilità di una pienezza che spinge verso un oltre. E’ una fiducia non tanto nell’assoluto della parola e delle sue possibilità conoscitive, quanto, piuttosto, nel valore della vita e della 2 Carlo Bo – Letteratura come vita – in “Frontespizio” Silvio Ramat – Ermetismo – in Dizionario critico della letteratura italiana – UTET, pag. 41 3 116 storia che la poesia può cogliere, nella certezza di un senso e di una verità profonda da scandagliare. E’ qui la novità e l’originalità di Luzi, la forza della sua testimonianza poetica, capace di esprimere il significato della vita e del mondo, di attraversarlo con lo spirito del viandante, dell’apri – pista che, a confronto con le trasformazioni e le brucianti contraddizioni della contemporaneità, rimette continuamente in discussione le antiche certezze, con un’interrogazione metodica, profondamente religiosa, poeticamente feconda per gli esiti a cui approda. Già la poesia giovanile rivela una maturità che è sorprendente: nella raccolta “La barca” (1955) si delinea una visione di sintesi, rara in un giovane. La figura della barca lascia intuire quella prospettiva di distanza da cui il poeta osserva la realtà: c’è il tempo della storia e dei fatti contingenti che si dipanano tra presente, passato e futuro, c’è il tempo della cultura che, ormai priva di quadri di riferimento si sfalda nei mille rivoli di interpretazioni soggettive in cui la poesia ricerca ciò che è stabile, il fulcro unitario e rende possibile la proiezione delle esperienze in un presente acronico, in una dimensione spazio – temporale che è fuori dal tempo. La poesia diventa, in tal modo, esperienza totalizzante. Sotto tale profilo diventa emblematico il testo “L’immensità dell’attimo”: “quando tra estreme ombre profonde/ in aperti paesi l’estate/ rapisce il canto degli armenti/ è la memoria dei pastori e ovunque tace/ la segreta alacrità della specie/ i nascituri avvallano nella dolce volontà delle madri/ e preme i rami dei colli e le pianure/ arido il progressivo essere dei frutti. Sulla terra accadono senza luogo,/ senza perché le indelebili/ verità, in quel soffio ove affondan/ leggero il peso le fronde/ le navi inchinano il fianco/ e l’ansia dei naviganti a strane coste,/ il suono d’ogni voce/ perde sé nel suo grembo, al mare, al vento”. Quell’accadimento “senza luogo e senza perché” delle indelebili verità è contemplato a distanza, in una sorta di conoscenza che tende a capire e a ritrovare una realtà attraverso barlumi ed una tensione spirituale con cui il poeta fa rapide incursioni in un passato più o meno lontano. L’impressine che si riceve è quella di un’atemporalità di una vicenda quotidiana attraverso cui il poeta ritrova realtà fuggite o cancellate: nonostante l’immobilismo delle immagini la vita non cessa di propagarsi perpetuando il suo ciclo universale e indecifrabile. Nel tessuto analogico del linguaggio è di straordinaria suggestività l’analogia tra il piegarsi dei rami sotto il peso dei giorni e il vigore delle navi dei marinai desiderosi di esplorare nuove terre, dispersi al 117 mare e al vento, all’infinito e all’indefinito. E’ comunicata una sorta di ritualità in un linguaggio raffinato ma lontano da esternazioni, cifra di quella stessa tensione euristica e stilistica dell’autore. La disponibilità a scandagliare una condizione umana difficile da decifrare, il contrasto fra tempo ed eternità, tra la vita del soggetto e il tutto, il tema della presenza/ assenza, il sentimento di un vuoto, di una notte della conoscenza che può essere vissuta solo dall’immaginazione poetica danno vita alla raccolta di “Avvento notturno” (1940) che è l’espressione più alta dell’ermetismo. Nelle immagini poetiche, nel paesaggio popolato di cipressi (“parla il cipresso equinoziale”4 ), di “oscuri e montuosi caprioli”5 , di rose di “esistenti città” e di “giardini tormentosi”6 , di “rispecchio degli opali”7 di cristalli e “di occhi di mica”, di “pallide arene” e di “ortiche” che comunicano freddezza e immobilità, si scorge sempre una traccia della storia, una visione cupa della vita, investita da un senso di angoscia e di precarietà. Ogni immagine è il corrispettivo di una verità esistenziale, di un’esperienza sofferta, sicché il suo linguaggio anche quando è così raffinato e ricercato attraverso l’intarsio di termini colti, tecnici o esotici non si risolve nella pura ricerca tecnica, nell’assoluto della parola, ma è cifra di una problematica esistenziale affrontata attraverso l’aspirazione costante al suo valore universale. Il simbolo, allora, nella poesia di Luzi, va oltre quel lirismo totalizzante, quell’assoluto della parola che si carica di significati ulteriori, va oltre gli esiti montaliani caratterizzati da istanze esistenziali e dalla sfiducia nella sua possibilità di stabilire un’apertura verso l’Altro, in una linea che è lontana dal simbolismo e ne evidenzia la crisi. L’originalità dell’ermetismo luziano è, dunque, tutta nella fiducia e nella consapevolezza che il valore dell’atto poetico non è nella parola in sé, nella sua autoreferenzialità, ma nella possibilità di comunicare il senso e la verità profonda dell’uomo e della storia. Immagini, suggestioni, oggetti, presenze umane diventano perciò occasione per una meditazione metastorica, per una spiritualizzazione delle esperienze quotidiane. “Quaderno gotico”, la raccolta del 1947, è, appunto, un documento rappresentativo della tendenza a comunicare un mondo sensibile ed insieme impalpabile, molto 4 Cfr. Avvento notturno – Avorio – Poeti italiani del Novecento a cura di Mongaldo, pag. 654 5 Ibidem 6 Ibidem 7 Cfr. Avvento notturno – Città lombarda 118 vicino a movenze stilnovistiche, ad una maniera gotica, ben evidenziata dal titolo. Centrale è, qui, il tema dell’apparizione della donna, di una epifania che richiama alla mente la Beatrice di Dante e la donna – angelo, la Clizia di Montale. Il poeta genovese recupera il modello stilnuovistico della donna – angelo, portatrice di una salvezza: Clizia è la nuova Beatrice, dal carattere sociale, personificazione di salvezza e occasione di esperienza del divino, di riscatto per tutti gli uomini, non solo per il poeta e per pochi eletti. In lei si condensano, come per la Beatrice dantesca, sentimenti privati e valori ideologici oggettivi di carattere religioso, anche se di una religiosità laica, assunta come campo di valori, come momento di attesa e di speranza, da incarnare nella storia. Clizia, infatti, è per il poeta l’allegoria di una vicenda spirituale: è Clizia che il poeta ha conosciuto in un lontano passato e poi ha perduto, ma da lei riceve messaggi, parole e segnali quasi incomprensibili per la distanza; è lei l’intrepida messaggera tra il poeta e un Dio invisibile, nella cui assenza o muta presenza si svolge il dramma della storia. Di fronte al male del mondo la donna – angelo assume una funzione sacrificale, come quella di Cristo, diventa “Cristofora”: il sacrificio di Cristo si trasforma e si perpetua nel sacrificio dell’uomo. E’ un’apertura di Montale all’oltre, al Mistero che esclude un’adesione esplicita ed ogni risposta positiva. L’epifania della donna, come “presenza che s’aggira” come evento salvifico che apre alla speranza è centrale anche nella poesia di Luzi, ma la forza evocativa con cui ogni riferimento concreto è smateriallizato, fino a farne una presenza misteriosa, quasi un’ombra evanescente, è assolutamente nuova. L’atmosfera rarefatta squisitamente petrarchesca fa da sfondo al vagheggiamento della donna e al senso dell’attesa, attraverso immagini lievi che rendono la dimensione psicologica e introspettiva dell’amore. In un testo che è tra le realizzazioni più alte della poesia ermetica8 , in una cornice che ha i tratti emblematici della pittura gotica, un cielo proteso verso l’apparire della luna, una brezza leggera che scompiglia l’erba del prato, appare una donna, una “vaga essenza”. La sua presenza, invisibile appare vibrante, è simile ad un vento sottile che rigenera un arbusto appassito e varca la “Siepe dell’infinito”, la barriera tra sogno e realtà, tra presente e passato: come il vento va oltre la siepe, così la donna dischiude la porta alla speranza, ad un futuro diverso come “lucciola 8 “Oscillano le fronde” da “Quaderno gotico” – in M. Luzi: Tutte le poesie – ed. Garzanti, Milano, 1988 119 che vola rapida ad accendersi e a sparire” che sfiora il pergolato in un contrasto di luce e di ombre, di fugace mobilità ed incisiva presenza, simbolo di quel segreto desiderio di vita e di gioia, così fragile, così provvisorio, che rimane inappagato, non colto e “lascia intatta la tenebra”; per un attimo si accende un barlume, si percepisce un’intensa emozione ma subito sparisce, quasi una perenne metamorfosi del divenire di ogni cosa. Le immagini stilizzate della cornice e dei suoi luoghi emblematici, il portico, il prato, la siepe, i significati metaforici di cui sono caricate le immagini, la perizia tecnica e lo scarto del linguaggio ermetico traducono, oltre quell’epifania, il sentimento religioso del poeta proteso tra coscienza del limite e tensione verso l’Assoluto, nella certezza di una speranza, nella possibilità di un futuro nuovo che va oltre la montaliana allegoria umanistica e sociale di Clizia. La poesia supera il limite del reale e giunge alla salvezza attraverso il sublime. 3. LA SVOLTA DECISIVA Finora Luzi affronta senza miti consolatori e con una religiosità che lo rende più sensibile al dramma esistenziale, il tema del rischio e delle lacerazioni che tormentano la coscienza: un dramma antico quanto l’uomo, ricorrente nei Greci, eccitato dal Cristianesimo, complicato dalle filosofie moderne. Senza mai ripudiare la precedente esperienza di fronte agli avvenimenti della guerra e al travaglio della storia collettiva, proprio per le premesse implicite nel suo percorso, Luzi abbandona i toni più astratti e metafisici per una nuova attenzione alla realtà, sente di dover rivolgere la sua indagine e la sua lucidità critica e poetica a ciò che sconvolge e smarrisce l’uomo. La produzione degli anni cinquanta è densa di riferimenti agli eventi della guerra, agli interrogativi e alle incertezze che suscita. Anche questa tragedia, questa “bufera” che provoca un’irruzione sconvolgente del reale nel mondo della poesia, come simbolo di un male più vasto che sconvolge la stessa civiltà umana di un dolore e di una violenza ineliminabili e dà voce alla sfiducia, ad una visione cupa in un poeta come Montale, lascia sempre uno spazio all’abbandono fiducioso nella visione di Luzi. Quella “notte del mondo” nella quale “gli dei sono fuggiti e la stessa poesia, ultima divinità per Montale, rischia di soccombere, può essere ancora” aperta alla luce di un’alba nuova. 120 In un testo che chiude la raccolta di “Brindisi”9 il poeta dà un messaggio di speranza di un’alba nuova che lascia intravedere un “monte che ride illuminandosi”, “barlumi dall’acqua” mentre si riflette “negli specchi un sorriso, sui vetri aperto un brivido”. Una giovane, lasciata nell’indeterminatezza per rendere più suggestivo il suo valore simbolico di giovinezza, “contraddice in un tratto la morte”. Allo stesso modo da una porta aperta – la porta della fede e della speranza – irrompono “felici i colori”, le tenebre si dissolvono ed un nuovo soffio di vita e di luce sospinge verso l’alto. Nella contemplazione del creato il poeta ritrova, dopo i segni di morte, quelli della vita che rinasce e lo comunica con quella raffinatezza stilistica e con quelle cifre simboliche che connotano ormai, la sua scrittura, meno rarefatta, meno intellettualistica, più attraversata dal brivido dell’esperienza storica. E’ abbandonata, infatti, la poesia oscura, densa di trame analogiche per una comunicazione meno cifrata e più attenta ai temi del rinnovamento, dell’attesa e delle trasformazioni del mondo, alle domande sul ruolo del poeta, sul suo andare incontro agli uomini, ad un’alterità che si svela, che provoca ed interpella. Attraverso un tema profondamente religioso come quello dell’Epifania10 , il poeta coglie quei segni di turbamento e di speranza di sfascio e di rinnovamento che sono nella realtà. La notte dell’Epifania è descritta come “notte d’ansia e di vertigine” quando il tempo “sgrana i germi del nuovo” nel vento della mutazione e del cambiamento radicale che immerge la realtà in un processo costante di metamorfosi, tra passato e futuro, vita e morte, luce e tenebre, in un intreccio di contrari: “in una notte come questa l’anima mia ….. fiutò la notte tumida/ di semi che morivano, di grani/ che scoppiavano, ravvisò stupita/ i fuochi in lontananza dei bivacchi/ più vividi che astri”. Sono questi contrari che rinviano alla ricerca dell’unità e segnano, anche per gli stilemi nuovi, più scarni ed essenziali, una via altra dai moduli ermetici, ma sempre aperta al mistero e densa di valenze metafisiche. Il recupero della dimensione realistica non significa, tuttavia, immediata adesione ai problemi socio – politici ma a quella verità che è nelle cose più semplici della vita quotidiana, nei gesti meno clamorosi e lo stesso superamento dei precedenti moduli poetici av9 Diana, Risveglio – cfr.Tutte le poesie di M. Luzi, ed. Garzanti, Milano, 1988 Epifania: Tutte le poesie, Garzanti 10 121 viene, non per elaborazione di una nuova poetica, ma all’interno di quella stessa ragione del poetare, inteso come investigazione sulle ragioni più profonde e sulla dimensione più autentica della vita, segnata da una condizione di sospensione, di attesa: la meditazione sull’effimero del tempo della storia e sul non senso della vita postula una riflessione più alta e partecipata sulla sorte dell’uomo, uno sguardo non ripiegato intimisticamente, ma proteso verso l’eterno. 4. NEL MAGMA DELLA STORIA Fin dagli anni sessanta il poeta avverte di trovarsi ad una svolta della civiltà: la società sta cambiando; la volontà di ripresa e di ricostruzione nella direzione di un benessere economico evidenzia un impoverimento di valori e di quadri di riferimento. La massificazione della cultura determina il declino della civiltà occidentale e mette in crisi la funzione degli intellettuali, emarginati dalla mercificazione e dalla reificazione dei processi in atto. E’ significativo a tale riguardo, la polemica sorta tra Pasolini e Montale, il primo sostenitore di un’omologazione culturale che, assunta passivamente dal popolo porta ad un imborghesimento e ad una perdita dei valori popolari; il secondo sostenitore di una massificazione che, mercificando tutto, stabilisce e degrada la cultura borghese; nel magma informe che costituisce lo squallido mondo della vita non c’è posto per la poesia e l’unica scelta possibile è quella del silenzio. Luzi si confronta più direttamente con quanto sta avvenendo, coglie la falsità dei miti illusori del consumismo e del benessere della società industrializzata e tecnologica ed assume il magma informe e caotico della vita per rappresentarlo nel magma formale di un nuovo linguaggio poetico che infrange ogni separazione tra vita e poesia. La sua ricerca poetica si rivolge ai temi dell’esistenza e ai problemi sociali, tenendo sempre distinti i due piani della riflessione ideologica e dell’attività poetica, senza chiusure e senza distanze, tipiche della prima stagione. In un raffinato poemetto della raccolta “Nel magma” (1966), intitolato “Presso il Bisanzio”, un affluente dell’Arno, Luzi affronta una tematica scottante in quegli anni, quella delle lotte sindacali, da una prospettiva che non è solo ideologica e riconduce al senso vero della storia. In un paesaggio urbano, avvolto dalla nebbia, deserto, fangoso, con pali e antenne dove sorge una conceria un uomo, lasciato 122 nell’anonimato, incontra quattro compagni “pigri nell’andatura, pigri anche nel fermarsi” che si portano dentro la rabbia delle rivendicazioni e lo rimproverano di non aver condiviso la loro battaglia, fissandolo con occhi furenti ed ironici, di non aver compreso il significato di riscatto di scelte ideali e morali. L’uomo tace e poi spiega al compagno più giovane ed incerto: “E’ difficile spiegarti. Ma sappi che per me il cammino/ era più lungo che per voi/ e passava da altre parti”. Il suo non è disimpegno, è una scelta più alta, è una scelta metafisica il cui giudizio è riservato ai poveri: “Mentre pensi/ e accordi le sfere d’orologio della mente/ sul moto dei pianeti per un presente eterno/ che non è il nostro, che non è divenuto/ poni mente a che cosa questo tempo ti richiede,/ non la profondità, né l’ardimento,/ ma la ripetizione di parole/ la mimesi senza perché né come,/ dei gesti in cui si sfrena la nostra moltitudine/ morsa dalla tarantola della vita, e basta”. Mentre Montale è convinto che non c’è più spazio per la poesia, Luzi è convinto che il poeta ha la possibilità o di limitarsi a ripetere parole, ad invitare i gesti delle masse, integrandosi nella corrente, oppure può conservare una fedeltà assoluta alla poesia, l’unica che salva, non riducibile alla logica del mercato perché atto d’amore gratuito, espressione altissima di umanità. La poesia non può schierarsi da una parte o dall’altra e, perciò, “le sfere dell’orologio della mente” sono in sintonia non con il “qui ed ora” della storia, ma con il “movimento dei pianeti”, con una prospettiva più ampia. Il poeta, dunque, lavora anche per chi lotta, per amore loro. Per questo nessuno dei compagni potrà “giudicare a cuore duro di questi anni vissuti….. potranno farlo altri, in un tempo diverso” con libertà interiore e con una “pietà più perfetta”. Il poeta legge la storia da una prospettiva sapienziale in cui si riafferma la sua vocazione metastorica attraverso un linguaggio che tende sempre più alla prosa e si fa più oscuro, non più per la concentrazione analogica e l’evocazione mallarmeana, ma per un adeguamento alle figure, agli oggetti, alle presenze del reale; è un brulicare di vita, di forme che rivelano ancora una volta una sete di conoscenza e di ulteriorità. I temi relativi a problematiche civili, come quelle del “terrorismo” e “degli anni di piombo” rinviano sempre ad una visione di fede e ad una verifica storica; il problema della violenza, del male, del dolore del mondo rimane senza risposta, ma in ogni frammento senza senso si rivela una Presenza, l’incarnazione di Cristo che riscatta e trasfigura: “e lui forse è là” fermo nel nocciolo dei tempi/ là 123 nel suo esercito di poveri/ acquartierato nel protervo campo in variabili uniformi”11 . Nessuna rassegnazione ma una fede incarnata, problematica e provocata da quella presenza è garanzia di un’armonia del mondo che libera dallo scetticismo e dall’indifferenza. La conoscenza della realtà, l’essenza di sé non è frutto di chissà quali ragionamenti; questa conoscenza solo in parte può essere enunciata nelle forme ufficiali della cultura; l’arte stessa cerca di esprimerla, ma le tracce si perdono nella complessità dell’elaborazione artistica: “non le tracce nei libri/ nulle o quasi le impronte,/ e se mai troppo nascoste, nella materia dell’arte”12 . Tale conoscenza può solo essere intuita come nello sguardo sfuggente che la madre rivolge al figlio o nel sorriso di una donna, ma è un’intuizione fragile di cui facilmente si smarrisce il senso. Alla storia come certezza collettiva, alla possibilità di fondarla solo negativamente subentra in Luzi la consapevolezza di un fondamento invisibile per cui il mistero della vita coincide con la vita stessa e le sue contraddizioni: la vita non può essere compresa né spiegata, ma solo vissuta (“vita fedele alla vita/ tutto questo che le è cresciuto in seno/ dove va, mi chiedo, discende o sale a sbalzi verso il suo principio,/ ….. sebbene non importi, sebbene sia la nostra vita e basta”13 . Lo stesso desiderio di felicità che nasce da una assenza, da una mancanza si rivela impossibile e non si sa da dove venga e a chi si volga, ma proprio quando è risospinto nei meandri dell’io si apre un varco (che richiama “l’anello che tiene” di Montale), un’apparizione miracolosa. L’acqua, presenza casta e purificatrice, viene a ristorare da ogni arsura, è il sorso di felicità atteso e raccolto nelle mani congiunte, quasi a conservarlo come un tesoro. Forse si tratta di un’illusione, di una resa al fascino di quell’incanto: “e vedo di lì a poco, mentre un po’ dormo e un po’ penso,/ un’acqua meravigliosa raccogliersi in due mani fini e trepide, serrate/ nella loro giumella un po’ infantile, un’acqua azzurra mi sembra,/ giù dalle fenditure di un’antica roccia dolorosa stillando./ A meno non sia parte dell’inganno/ …..14 11 “A che pagina della storia” da “Al fuoco della Controversia” “Detto? Non taciuto appena. Duro” da “Al fuoco della Controversia 13 “Vita fedele alla vita” da “Su fondamenti invisibili” 14 “Dammi il mio sorso di felicità prima che sia tardi” da “Su fondamenti invisibili” 12 124 Non è difficile notare la novità di un linguaggio poetico che senza indulgere al lirismo, appare spezzato e contratto nel suo impianto ritmico e sintetico, più duro o attraversato da una dolente tensione. Sul piano formale ora il discorso poetico si frantuma: è ricorrente la mancanza di punteggiatura la struttura a “scalino” dei versi per isolare le varie espressioni linguistiche e renderle più incisive. Come la vita sembra pacificarsi nell’attesa, che immerge nel flusso della storia e dilata l’orizzonte così la poesia si fa ricerca di un significato possibile che rimane aperto e rifiuta ogni definizione conclusiva. 5. IL FASCINO ORIENTALE Col passare del tempo la poesia di Luzi sembra dilatarsi in intensità ed estensione, acquistare sempre più spessore a vantaggio di un adeguamento ai toni del dialogo e del monologo con cui cerca di cogliere le tracce dell’eterno nel “grembo dell’oscurità che ci fascia”. Tra i numerosi viaggi fatti in America, in Cina, in Georgia ha un particolare rilievo quello in India. La conoscenza del mondo e della cultura indiana ha certamente influito sui poemetti dei “Fondamenti invisibili”, in particolare “Nel corpo oscuro delle Metamorfosi” e nel “Gorgo di salute e malattia”. Dagli appunti del Diario, in cui l’autore ha annotato quell’esperienza, pubblicato a cura di Roberto Cardini si può rilevare la svolta, la conversione maturata nel poeta. Il poeta ammette di essere arrivato a Bombay con una serie di pregiudizi con quell’atteggiamento tipico dell’uomo occidentale, chiuso nei suoi schemi mentali. Avverte l’enorme contraddizione tra lo splendore dei templi, la magnificenza e lo sforzo dei palazzi del Maharajah e la miseria di infinite moltitudini. E’ proprio nel contatto con i poveri, con i questuanti ricoperti di stracci lungo la strada che portava a Benares, in quel pellegrinaggio che egli fa l’esperienza evangelica, comprende la situazione in cui si trova il Signore nella Galilea, quando incontra le folle bisognose, gli straccioni che attendono il Messia e il riscatto della loro povertà. Quei poveri meritano attenzione, rispetto e soprattutto uno sguardo d’amore che spinge ad assumerli, a condividerne l’ansia di salvezza e di liberazione. Il contatto con i poveri lo cambia, lo apre alla totalità dell’umano all’accettazione del mondo e della diversità, alla scoperta di una cultura ricca di fascino e di spontaneità, non intellettualistica ed aprioristica, come quella occidentale. 125 Il contatto con quella povertà e quella diversità di riti, di cultura lo converte: dal pregiudizio e dalla chiusura passa alla disponibilità della mente e del cuore ad aderire a quella realtà umana e naturale, alla contemplazione di una verità da cogliere non solo dentro di sé ma nelle trasformazioni del mondo e nella creazione continua dell’universo. Con un felice ossimoro si potrebbe dire che l’esperienza indiana lo fa “restare pellegrino” nell’umanità per un desiderio di compagnia con gli uomini di oggi con la consapevolezza che ogni itinerario è illuminato da un “topografo” di eccezione, lo Spirito, ed è iscritto nell’imprevedibilità che dischiude nuovi sentieri e pagine inedite di storia. Negli scritti del poeta vibra il cuore di uno che cerca sempre: la sua ricerca è un andare verso, mai casa in cui prendere fissa dimora, mai assicurata, ma sempre rinnovata ed ogni volta conquistata. La visione del credente non emerge come questione privata, ma come prospettiva da cui leggere ed interpretare il mondo, come testimonianza, come identità credente che non si chiude mai in un colloquio che esclude l’altro e sempre si risolve in un vincolo di agape, di caritas che va oltre i “pragmata”, il puro profitto utilitaristico ed è capace di assoluta gratuità. 6. OPUS FLORENTINUM Una radicale visione di fede e un grande amore per la sua città danno voce a quel canto sacro che è uno degli ultimi testi “Opus florentinum”15 . Qui il poeta, dopo aver immaginato un dialogo tra gli operai e gli artisti che hanno costruito la cattedrale di santa Maria del Fiore, un’opera a cui ha posto mano cielo e terra, fino a farne il simbolo più alto del patrimonio artistico, culturale e spirituale non solo di Firenze, ma del mondo intero, fa parlare la cattedrale stessa, il “Fiore della fede”. Artisti sommi come Arnolfo, Giotto, ser Filippo e un popolo di artisti ha reso possibile quel miracolo di un’opera in cui si esprime l’anima più autentica di Firenze e della fede cristiana. In occasione dell’anno giubilare la Chiesa, madre di tutte le altre, fa una sorta di esame di coscienza: “officina delle anime fui per molti secoli ….. chi si introduce nel mio ventre/ esce/ lavorato dal sapere 15 Mario Luzi: Opus florentinum, ed. Passigli, 2000. 126 cristiano e dalla preghiera/ di molte e molte generazioni: si ricoverano qui gli sperduti, si ritemprano in questa penombra./ Ma anche si raccolgono i relitti/, si raggiustano i rottami,/ si fabbricano ali per volo in questa officina./ Hanno qui trovato asilo e lavorato la parola/ che oggi vi offro i santi di Firenze./ Ma quanto è necessario/ che sia sempre infuocato questo laboratorio, delle anime/ e io giustificata dalla mia attiva opera!/ Vorrei, figli miei presenti nella città e nel tempo,/ e voi figli defunti nelle epoche recenti/ e in quelle più remote/ formassimo tutti insieme un corpo unico/ che si offre all’avvenire/ il quale si approssima sotto specie misteriosa di millennio/ e già sta per entrarmi dalla porta./ Viene con volto imperscrutabile/ ad avere il mio battesimo/ ed insieme il forte viatico/ per il suo dubbio cammino. Viene anche/ a portare nuove angosce ed ansie,/ nuova preghiera, nuove beatitudini al mio antico magistero. E forse ne rinnova in me/ la ragione prima e l’anima….. Vorrei essere forte/ di tutti i miei slanci e di tutti i miei peccati/ di tutte le mie miserevoli omissioni/ e delle mie tribolate penitenze/ per accogliere con fede e con esperienza/ questo advena, questo sopravvenuto tempo./ viene forse duro ed impietoso a chiedere ragione/ del grande patrimonio che abbiamo dissipato, viene/ forse smarrito a mendicare un po’ di quella povera sostanza./ Vorrei fossimo uniti tutti insieme, figli miei, per essere una roccia/ su cui posso posare il piede/ chi arriva/ e prendere slancio per il volo…../ Abbiamo noi, chiesa cristiana,/ trasmesso/ integro il Vangelo,/ ma non siamo qui soltanto per commemorare/ bensì per attuare…../ sia il millennio un allarme temporale/ all’intemporalità che noi viviamo/ da poveri, umilmente giorno per giorno,/ sia esso un incremento/ senza fine del Verbo e del suo senso./ Figli miei voglio essere il luogo per la crescita degli uomini,/ tutti, di ogni provenienza e origine…./ O secolo che vieni/ su un secolo nostro/ nell’ordine della cristiana previsione/ di fede e di certezza…../ Quella che si dispone al rito festoso del riconoscimento,/ figli è una chiesa penitenziale. Molti hanno operato in me/ e in nome mio non onesta/ ma anzi perfida e maliziosa gente./ In molti hanno abusato del mio limpido sigillo,/ e io chiesa materna mi affliggo di tutte le magagne./ Perdono, chiediamo a mani giunte”. Da tutto il monologo promana un profondo senso ecclesiale ed una passione per la comunione che rivelano la sensibilità di un credente proteso alla radicalità della fede e all’unitarietà non solo come tensione al superamento di separatezze, frammentazioni ma alla ricerca di una comune umanità che ci rende fratelli in una dimensione universale, aperta, cordiale. E’ una fede che cresce attraverso l’inter- 127 rogazione e si illumina attraverso un pensiero che lo dilata ed una testimonianza provata. E’ una fede che si fa coltivazione dell’uomo che cresce nella ricerca intelligente e libera della verità, nella comprensione del mondo e della storia dove non si stanca di scorgere i germi di speranza, pur nelle sue contraddizioni ed incoerenze. E’ la fede nel Mistero della chiesa, della sua maternità, della sua forza di redenzione e di trasfigurazione destinata a farsi incessantemente, sotto l’azione di Dio, nonostante i limiti e le omissioni. E’ espressione di fede l’esercizio faticoso di una continua assunzione del vissuto, del suo dolore, delle sue contraddizioni, dei suoi enigmi, per lasciarlo avvolgere dalla luce di quel Mistero, della luce della Pasqua del Signore, per scoprire la vita come luogo dove Cristo e la Sua Croce sono presenti perché la resurrezione e la vita nuova s’inscrivono nella cronaca e nell’esperienza di ogni giorno. Il segno inequivocabile del rinnovamento è, pertanto, nella conversione – riconciliazione: è una svolta radicale, mai definitiva e capace di mostrare ad ogni uomo il volto della compassione e della misericordia. In una realtà segnata da divisioni e conflitti, da odio e da violenza la profezia della Chiesa che è, insieme, annuncio e sfida da accogliere, provocazione e responsabilità è la riconciliazione: solo un’umanità riconciliata non più divisa e lacerata in se stessa, può celebrare la vita, riscoprire il dono della fraternità, può integrarsi armonicamente nel tutto nel quadro di una nuova cittadinanza universale in cui ciascuno è accolto, riconosciuto, tutelato, aiutato a crescere. Chiedere perdono a mani giunte è la via per nuove relazioni come fondamento di una nuova soggettività non autoreferenziale, ma aperta al dialogo, al confronto, alla responsabilità verso l’altro, è il tramite di accesso ad una nuova umanità, e quell’homo humanus trasfigurato dalla luce trinitaria. Il testo si configura, pertanto, non solo come scritto ispirato da un evento significativo come quello giubilare, ma come una tappa ulteriore di un itinerario umano e poetico coerente che rimette al centro l’uomo, il suo sforzo di autocomprensione, in un atteggiamento costruttivo di fronte ai disagi e ai cambiamenti in corso per convertirli con fiducia e realismo, col magistero di una voce autorevole perché densa di vita e distante dai toni perentori del predicatore o del moralista, carico di esperienza in una visione dolorosa. Colpisce soprattutto il senso e il valore dello sperare che il poeta trasmette nella sua comunicazione lirica, quell’apertura su un orizzonte infinito in cui si rivela la sua visione di credente che non imprigiona negli 128 assoluti, alla fine deludenti, delle piccole speranze quotidiane e costituisce un’ala di riserva per il progetto di una società nuova, capace di tenere desto l’appello profetico e di tradurlo in scelte storico – politiche e restituisce l’uomo alla sua umanità più profonda. La lettura stimola sempre, attraverso la commozione e il coinvolgimento che provoca, una riflessione sul senso della storia e sul fondamento del vivere, suscita nuovi interrogativi sul futuro della convivenza e sui valori che possono orientarla e rimuoverla. 7. IN MEMORIA DI VALENTINA: QUASI UN COMPENDIO Tutta la poesia di Luzi è una costante comunicazione di quel rapporto profondo con la problematicità e la complessità della condizione umana: la suggestione di ogni occasione è strumento fenomenologico per una meditazione storica, per una conoscenza non intellettualistica, ma per “cifre e per barlumi” dell’essenza trascendente del mondo e dell’uomo e riafferma l’integrale vocazione metastorica della sua poesia. Alle contraddizioni, agli enigmi, al dolore e al male del mondo non si possono dare soluzioni, interpretazioni elaborate secondo schemi razionali, ideologici, moralistici. Essi possono solo essere attraversati, condivisi nel coinvolgimento di ogni esperienza di vita, dando voce autentica alle cose. E’ per questo che la poesia luziana è espressione irripetibile ed incisiva della crisi e della speranza, “tenta il diagramma della turbata avventura spirituale dell’uomo contemporaneo, ne descrive la storia attraverso i segni dello smarrimento dell’invocazione, della speranza ….. e la sua religiosità si presenta come nozione di una sofferenza che non ha conforto qui, ora, che ha fiducia assoluta nella storia e conseguente scetticismo verso tentativi di soluzione storica”16 . Il senso e il fondamento di ogni problema e di ogni sofferenza è oltre la soglia dei ricorrenti messianismi ideologici e utopici, è in quella zona di Mistero e di Paradosso dove l’umano si scopre nella sua dimensione più autentica, nella sua debolezza e nella sua forza, nel suo limite ontologico, creaturale, nella sua essenzialità e nella sua condizione di esodo, di eternità, entrata nel tempo. In questa prospettiva possono essere considerati una poderosa sintesi i versi inediti che Luzi ha scritti per Valentina, vittima della 16 Cfr. Barberi Squarotti in Giacalone: storia della letteratura italiana e critica letteraria “Da Svevo ai nostri giorni” ed. Signorelli, pag. 409 129 recente tragedia di Linate17 : “Bruciarono con quelle del velivolo/ Valentina, le tue ali. Si erano/ teneramente aperte al primo vento/ oscillavano felici/ volavano con te i pensieri dei tuoi cari,/ le ansie, le attese, i desideri./ Tutto fu crudelmente preparato/ per le vampe di quel rogo/ d’amore e di dolore. Addio, Vale. Valentina è una giovanissima di ventisei anni che studiava a Pisa ingegneria elettronica, doveva discutere solo la tesi di laurea e, poiché aveva vinto una borsa di studio ad Aalberg in Danimarca era su quell’aereo maledetto che avrebbe spezzato la sua vita, come “flos succisus aratro”. Con delicatissima sensibilità che richiama alla mente accenti virgiliani, densi di tenerezza e di lacrime, il poeta porta alla luce la verità di un paradosso, razionalmente indecifrabile ma che si dice attraverso la “tenebra luminosa” del Mistero e della Croce, scandalo per gli intelligenti e sapienza per chi impara l’umiltà dell’abbandono. Quel rogo “d’amore e di dolore” in cui bruciano le ali che oscillano felici, è cifra dell’infinito dolore del mondo, attraverso il quale s’impara a stare nel mondo con amore, ad aprirsi ad una relazionalità – reciprocità che dicano il nostro essere costitutivamente trascendente. I nostri occhi si fissano su quelle ali: le ali dell’aereo protese al grande volo nello spazio, le ali della giovinezza spiegate verso un radioso futuro ricco di progetti e di promesse. Attraverso le sue immagini il poeta spinge il nostro sguardo oltre la fiamma di quel rogo, dove la linea dell’orizzonte risplende nella serena distesa di un cielo terso. Il miracolo della poesia luziana è in questa capacità di coinvolgere, di introdurre nell’evento e di condurre al largo ed oltre, di suscitare passione e “pietas” per ogni uomo, di sollecitare a procedere, a fare quel passo oltre che per il credente è l’atto di fede, della fede pagata a caro prezzo, quasi a ribadire che l’essere credente è un caso serio. E’ per questo che abbiamo chiesto ad un teologo della statura e della sensibilità di don Bruno Forte di introdurci nel mondo poetico di Luzi al quale il nostro teologo è legato da affinità elettive e da vincoli di profonda amicizia. E’ per noi un dono questa testimonianza e alla mensa della sua parola ci disponiamo ad accogliere tutta la ricchezza di indicazioni e 17 Cfr. Corriere della Sera del 13.08.02 130 suggestioni che possono far luce sull’itinerario umano e poetico dell’autore. Fin da ora gli diciamo un grazie vivissimo per il suo essere tra noi, per la sua testimonianza e per quello che saprà suscitare ed, in particolare, per quella nostalgia del bello, per quei frammenti di luce che saprà far guizzare nel cuore e nell’intelligenza di noi tutti. 131 BIBLIOGRAFIA • M. Luzi: Tutte le poesie, ed. Garzanti, 1988. • Frasi ed incisi di un canto salutare, Garzanti, Milano, 1990. • Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, Garzanti, Milano , 1992. • Luzi – Dante – Leopardi e le modernità, ed. Riuniti, Roma, 1992 • Opus florentinum, Passigli Poesia, 2000. Su Luzi • G. De Benedetti: Poesia italiana del ‘900, Garzanti, Milano, 1974, pp. 107 – 124. • Pasolini: Le poesie di Luzi in laboratorio in “Passione e ideologia”, Milano, Garzanti, 1960 pp. 453 – 457. • Fortini – Luzi in “Saggi italiani” Bari, De Donato, 1975 pp. 37- 68. • Pautasso – Luzi: Storia di una poesia, Milano, Rizzoli, 1981. • G. Mariani: Il lungo viaggio verso la notte – Itinerario poetico di M. Luzi, Padova – Livorno, 1982. • M. Luzi: Atti del Convegno di studi, Siena 9 e 10 maggio a cura di Serrao, ed. dell’Ateneo, Roma, 1983. • G. Quiriconi: Il fuoco e la metamorfosi, Cappelli, Bologna, 1980. • L. Rizzoli – G. Morelli: Mario Luzi, Mursia, Milano, 1992. • Philippe Renard: Mario Luzi Framenti e totalità. Saggio su “Per il battesimo dei nostri frammenti” Bulzoni, Roma, 1995. • Fabiano d’Avigo: Gozzano e Luzi - il Viaggio in Oriente in Nuova secondaria, La scuola del 15 dicembre 1999. 132 LA VERITA’ NELLA POESIA DI MARIO LUZI BRUNO FORTE * Ringrazio il Signore, innanzitutto, di questa possibilità di pensare con voi, ringrazio il Vescovo, per la cui parola e il cui invito sono qui, grazie naturalmente alla signora Sibilla, coordinatrice della sezione letteraria della biblioteca, al direttore della biblioteca e a tutti voi. In realtà, io non ho titoli particolari per poter parlare di Mario Luzi, poeta, se non il titolo di una ormai antica amicizia e di un dialogo ricco e profondo con lui, che si è espresso, da parte sua, nei due testi che lui ha scritto sui due miei volumi di poesia, “Di te ricordo quando” e “Il silenzio di Tommaso”, e, da parte mia, nella relazione che tenni al Congresso “Gli intellettuali italiani e la poesia di Mario Luzi”, che si tenne a Montepulciano e che doveva essere il momento celebrativo con cui, a fine secolo, in qualche modo, si cercava di riconoscere la straordinaria incidenza e testimonianza che la poesia di Mario Luzi rappresenta per la cultura italiana. Le cose che stasera vi dirò sono anche quelle che, in qualche modo, ho cercato di presentare quella sera, nel contesto di molti altri interventi, da quello di Massimo Cacciari a quelli di letterati e critici come Bo e di tanti altri, che, devo dire, trovarono in Mario Luzi un profondo consenso. In qualche modo, vorrei dire che l’interpretazione che vi propongo è autentica, perché è l’Autore stesso che, avendola prima ascoltata e poi letta, mi ha più volte confermato di ritrovarsi in questo tentativo di lettura della sua opera. E’ dato di fatto, direi, evidente, che la poesia di Mario Luzi attraversa per intero il secolo breve, il secolo che si è appena concluso, e ne è, in qualche modo, nella nostra società italiana e per la nostra cultura, una sorta di controcanto, di coscienza riflessa, di voce critica al tempo stesso espressiva e inquietante; dall’altra parte, bisogna anche riconoscere che la ricerca religiosa di Mario Luzi e anche la sua esplicita confessione di Fede sono elementi che rendono questa poesia particolarmente intrigante per la sensibilità del teologo e in generale del credente. * Relazione tenuta il 16 Aprile 2002. Testo trascritto dalla registrazione non rivisto dall’Autore. 133 Mario Luzi è un credente, non ne fa mistero, ed, anzi, molti dei suoi testi sono esplicitamente attraversati non solo dalla tematica della ricerca di Dio, ma anche da quella della esplicita confessione di Dio. Pensiamo, per esempio, ai testi, certamente singolari, della Via Crucis che lui ha scritto per la celebrazione al Colosseo presieduta dal Papa e che sono, certamente, anche una voce poetica assolutamente singolare in questo caso. Procederò, dunque, anzitutto dalla domanda che pongo alla poesia di Mario Luzi, e poi dalla rivisitazione di cinque metafore che, in qualche modo, mi sembra ci aiutino a trovare la risposta alla domanda. La domanda è quella del procuratore di Galilea al prigioniero: “Che cos’è la verità?”. Io parto da questo interrogativo di Giovanni (18,38), perché mi sembra che in questo interrogativo sia compendiata la ricerca umana nella sua valenza più profonda. In realtà, conoscere la verità è conoscere il senso, è orientarsi nella notte del mondo. Voi sapete che nella redazione del racconto di Giovanni a questa domanda Gesù non dà nessuna risposta. Il suo silenzio, davanti al Procuratore romano, è la sua risposta quasi a dire che il medesimo, quale si esprime nel linguaggio, non è capace di contenere l’altro. La verità non si dice nella parola, la verità si testimonia nella presenza. E questa interpretazione del silenzio è talmente, vorrei dire, forte, auto-evidente, che, come sapete, i Medievali avevano anagrammato l’interrogativo di Pilato. E la domanda “Quid est veritas?” era diventata “Est vir qui adest”, “Che cos’è la verità?” “E’ l’uomo che ti sta davanti”. Io vorrei avvicinarmi a questa domanda e vorrei anche misurare la poesia di Mario Luzi non solo sulla domanda stessa, ma sulla risposta che l’anagramma dei Medievali ci fa intuire. In altre parole, vorrei misurare la poesia di Mario Luzi non solo sulla verità greca, che certamente è presente in tutta la sua opera e in tutto il suo pensiero, figlio della cultura occidentale, della nostra cultura, e come tale segnato nel profondo dall’anima greca, ma al tempo stesso vorrei cogliere in lui quell’altra voce della verità, che ci viene dall’Oriente e che ci raggiunge e diventa linfa della nostra cultura, nell’incontro con la novità cristiana e con l’avvento del Vangelo. Dunque, rintraccio nella poesia di Mario Luzi - abbraccio, in qualche modo, l’intera sua produzione poetica fino alle ultimissime cose, anche “Sottospecie umana”, che è l’ultimo testo più rilevante di Mario Luzi - cinque metafore fondamentali: la metafora della luce, la metafora della donna, la metafora del viaggio, la metafora del silenzio, e la metafora della soglia. Ecco, mi sembra che, attraverso queste cinque metafore, sia possibile tracciare un percorso di rispo134 sta alla grande domanda “Che cos’è la verità?”, cogliendovi, di volta in volta, l’eco diversa, differente, che Mario Luzi, poeta e testimone della coscienza del nostro Paese, nell’intera sua evoluzione in questo fatidico secolo che si è compiuto, ha saputo esprimere. I. LA METAFORA DELLA LUCE Parto, dunque, dalla prima metafora: la metafora della luce. La metafora della luce è per eccellenza la metafora della verità nella tradizione occidentale. Come sapete, il termine greco per dire “verità” è “alétheia”, e “alétheia” deriva da “lanthàno”, la parola del nascondimento, della latenza. Anche in latino noi abbiamo la stessa etimologia nel verbo “lateo” di “latère”, essere latente, nascondersi. La parola “alétheia”, con quella alfa privativa strappa alla latenza ciò che è originariamente nascosto e lo esibisce. Ma, attenzione, lo esibisce a che cosa? Lo esibisce alla visione. La verità per il greco è soprattutto visione, cioè è soprattutto luce. La conferma straordinaria di questo, l’abbiamo nel predominio greco dell’idea. “Idea” viene dal tema “id” del verbo “orào”, vedere. L’idea è propriamente la visione. Allora che cos’è la verità per il greco? La verità è l’oggetto della visione e, dunque, la verità è il totalmente baciato dalla luce ed è il totalmente uscito, sortito dalla latenza, per offrirsi alla visione e allo sguardo. Lo straordinario è che per il greco, in questo concetto della verità, si ritrova anche totalmente il concetto di bellezza. Sapete che in greco “bello” è “kalòs” e “kalòs” ha la stessa etimologia di “kaleìn”, cioè di chiamare, richiamare. Che cos’è, allora, la bellezza per il greco? E’ l’esibirsi dell’oggetto nella sua potenza di richiamo della visione. Quando l’oggetto si offre e si impone alla visione, quando la sua forma, la sua “morphè”, in qualche modo, riesce ad attrarre la sua visione su di esso in modo che, nel frammento che è l’oggetto, si riconosca la forma, la proporzione del tutto, quello è la “bellezza”. Se dovessimo definire la bellezza con il concetto greco, che è poi il concetto pitagorico che domina tutto l’Occidente (pensate che ancora Agostino nel “De pulchro”, l’opera perduta, ma poi nel “De musica”, definirà così la bellezza: la bellezza è “convenientia, proportio, forma”). I numeri del cielo si riproducono nel piccolo del frammento, per cui c’è un’esatta corrispondenza fra il frammento dell’oggetto bello e il tutto dei numeri del cielo grazie alla corrispondenza proporzionata della forma. Tant’è vero, osserverà Agostino, che bello si dice “formosus”, bello è ciò che ha forma. 135 Questa è la concezione greca della verità e della bellezza. Ecco perché la tradizione greca e Plotino - questo è soltanto la sintesi di una tradizione secolare - parlerà del bello come splendore del vero, “Veritatis splendor” in realtà è la bellezza. La bellezza è lo splendore. Ora tutta questa tradizione è una tradizione che inonda, in qualche modo, la nostalgia dell’Occidente. In un certo senso noi siamo assetati di luce. L’Occidente, plasmato dall’anima greca, porta in sé questa sete di visione, questa sete di luce. Il trionfo di questo processo è nella modernità illuminata. L’Illuminismo, come dice la stessa parola, non è che il compimento di questa nostalgia della visione e della luce, che l’anima greca ha immesso nella nostra cultura sin dalle sue origini. La parola magica, la parola dominante della stagione dei lumi è appunto la “luce”, “siècle des lumières”, “Illuminismo”, “Enlightement”, “Aufklärung”, “Illustration”; in tutte le lingue europee è il tema della luce quello che domina e la metafora di tutto questo ce la dà il grandissimo poeta Goethe quando sul letto di morte pronuncia quelle parole che sono, in qualche modo, la “pointe”, l’espressione di un’epoca, “Licht mehr Licht”, luce più luce: la sete di luce della ragione moderna è l’estremo compimento di questa ansia. Bene, questo tema della luce come verità, della luce come comprensione totale, è un tema che troviamo sin dall’inizio nell’opera di Mario Luzi. Vorrei dire che, in questo senso, lui è totalmente figlio della modernità occidentale. Egli stesso, in una bellissima conversazione pubblicata alcuni anni fa in un libro intitolato “La porta del cielo: Conversazione sul Cristianesimo” a cura di Mario Luzi, confessa: “La luce mi ha occupato molto di più negli ultimi anni rispetto agli inizi, dove la luce associata ai colori dà sostanza ai colori, poi mi sono reso conto che la luce è un mondo a sé, autonomo, che crea l’altro, cioè una specie di radiosità o fulgore avvertito come tale, avvertito come mistero”. Con queste parole, in realtà, Luzi non ci dice semplicemente che la luce è apparsa ad un certo punto nella sua opera, ci dice che lui ha preso coscienza di questo predominio della luce presente, tuttavia sin dall’inizio, una specie di radiosità o fulgore, avvertito come tale, avvertito come mistero. Dunque, che cos’è la luce nell’opera di Luzi? E’ la sete di verità, di comprensione, è la sete di lettura di questa realtà ferita, frammentata, per cogliere in essa, in qualche modo, l’orizzonte di un senso. Per darvene, quindi, una testimonianza citerò alcuni brani di Luzi. Mi sembra di poter prendere come altissima testimonianza, proprio la conclusione di questo libro “Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini” che è anche una straordinaria opera di teologia poetica. 136 Noi siamo di fronte alla grandissima metafora della ricerca del cielo; e questa ricerca del cielo è la ricerca della luce. Il grande pittore toscano diventa, in qualche modo, la figura del cercatore della luce e non è un caso che Simone, morente, alla conclusione del lungo itinerario, che è una sorta di pellegrinaggio, dice così - sono le parole conclusive dell’opera - : “Tutto, senza ombra, placa. E’ essenza, avvento, apparenza; tutto trasparentissima sostanza. E’ forse il Paradiso questo? Oppure luminosa insidia, un nostro, oscuro ab origine, mai vinto sorriso?”. Ecco la grande domanda del poeta. La ricerca di tutta la sua vita, la ricerca della luce, la sete della luce, che è poi, l’abbiamo detto, sete della bellezza. Pensate alla definizione che la teologia orientale dava dell’uomo: “L’uomo è sete del bene”; e per il greco la sete della bellezza è la sete della luce. Ebbene tutto questo Mario Luzi lo confessa nelle parole conclusive di Simone Martini. Tuttavia, con un dubbio, notate: “E’ forse il Paradiso questo? Oppure luminosa insidia, un nostro, oscuro ab origine, mai vinto sorriso?” Strano, paradossale. Questo poeta della luce che riconosce la luce, Leit-motiv di tutta la sua ricerca, conclude con un dubbio la sua opera, tra le più alte, e certamente l’opera della sua più alta maturità. Oserei dire che “Sottospecie umana” è una sorta di decadenza rispetto a questo vertice costituito da “Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini”. Voi direte che è proprio dei grandi ed è proprio dei vecchi il dubbio. Noi sappiamo come anche i più grandi testimoni della Fede hanno conosciuto, nell’età più avanzata della loro vita, la notte della domanda oscura: la Fede trovata è la Fede che è stata segnata dal cammino della vita? Dunque, potremmo dire che è anche molto naturale che la domanda sorga a conclusione del cammino. Qui c’è qualcosa di più profondo, secondo me, ed è che il dubbio, è che la luce sia tutto; il dubbio che la luce solare, in comprensiva sia veramente il Paradiso; è un dubbio che ha preso Luzi ben prima della sua esistenza. Ed è il grande dubbio della crisi della modernità. Che cosa ha prodotto questa sete di luce della ragione moderna, questo voler comprendere tutto, spiegare tutto? Pensate ai vari campi in cui questa sete di luce si è applicata: il campo dell’ideologia, la sfera della rivoluzione, della politica, le ideologie di destra e di sinistra, luminose perfino nelle loro metafore, il sole dell’avvenire, metafora del socialismo, la svastica che è il sole, la metafora dell’ideologia di destra; queste ideologie hanno, in realtà, inseguito la luce. Ma che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto uno straordinario cumulo di violenza. Che cosa non funziona, allora, in questa sete di 137 luce. Ecco, potremmo dire che la luce, quando è sete di totalità, diventa totalitarismo e violenza. Ma pensate a quello che avviene, per fare soltanto un altro esempio, nel campo della psiche umana. La sete di luce spinge la ricerca su questo campo, alla straordinaria scoperta di Freud, la scoperta dell’inconscio. La grande operazione, che la psicanalisi avalla, è quella di far emergere alla luce gli abissi dell’inconscio. Questo è il grande progetto che Freud avanza, ed è un progetto certamente geniale perché fa conoscere quello che, con intuizione letteraria straordinaria, Dostoevskij aveva chiamato “i doppi pensieri”, cioè il sottofondo dell’anima. Ma qual è il risultato finale di questa operazione di sete di luce applicata agli abissi, alle memorie del sottosuolo, per usare la metafora di Dostoevskij. E’, lo sappiamo, una ancor più travagliata e complessa condizione umana. Oggi, siamo tutti d’accordo, anche i più convinti sostenitori, che la psicanalisi, così come proposta da Freud, è una forma di ideologia; cioè è una forma della presunzione di comprendere totalmente il mondo anche negli abissi delle caverne dell’inconscio. Ora, è questo che altre forme di lettura della psiche umana cercheranno di superare, di temperare. Faccio solo l’esempio di Jung come valorizzazione della componente religiosa, come componente che lascia nel rispetto dell’insondabile gli abissi, alcuni abissi della coscienza. Ma tutto questo per dire che cosa? Che il dubbio con cui Mario Luzi conclude l’itinerario di Simone Martini “E’ Paradiso questo o è luminosa insidia, un nostro, oscuro ab origine, mai vinto sorriso?” ci porta veramente alla bellezza ultima e senza tramonto, o è qualcosa di nostro, oscuro, una sorta di ferita dell’anima che, in realtà, non sarà mai saziata e dimostra soltanto la nostra fragilità e caducità? Bene, è in questa domanda che io colgo il passaggio ad un altro mondo, che opera nell’anima di Luzi. Luzi è stato il testimone del Novecento, il secolo tragico, “il secolo breve”, lo definisce Eric Hobsbawm nella sua opera “The short twenty century”, breve, perché sta tra il 1914 e il 1989, fra lo scoppio della prima guerra mondiale e il crollo del muro di Berlino; ma proprio nella sua brevità è un secolo tragico, un secolo violento, lo stesso Hobsbawm ci dice che, alla fine del Novecento, un terzo dell’umanità, degli abitanti del pianeta degli inizi del Novecento, era stato sterminato da guerre, genocidi e violenze. Questo è stato il Novecento: un secolo tragico, un secolo di straordinaria violenza, il secolo dei grandi racconti ideologici. Allora il dubbio che Luzi avanza sulla luce non è forse il dubbio di un’intera epoca, che mette in discussione se stessa? Questa è la mia domanda. Luzi è stato il testimone di quest’epo138 ca. E proprio perché l’ha vissuta tutta, partecipando attivamente, anche in maniera critica, alla coscienza, alla cultura del suo tempo, egli ha saputo esprimere, non in forma di saggio e analisi, come dire, concettuale, ma in forma poetica, come è del genere della poesia, la crisi di questo sogno della luce che era stato il sogno dell’epoca moderna. E questo io lo colgo in una poesia, “Il pensiero fluttuante della felicità”, che vi leggo e che poi cerco di interpretare con voi. E’ una poesia che è tratta da “Sui fondamenti invisibili”, dunque scritta negli anni ‘60, quando cominciano già ad avviarsi alcuni processi di denuncia critica della ideologia nelle sue varie realizzazioni storiche. Che cosa Luzi ci dice? Ascoltiamo: “I morti male” - i morti male, vedete già questa è formula potente: ci sono i morti bene, cioè quelli che corrispondono a come bisogna vivere e morire secondo l’ideologia, ma ci sono anche i morti male cioè quelli la cui morte sembra semplicemente perdita alla luce dell’ideologia. “I morti male, coloro che cadono quando non ci sono più lacrime, se non i lucciconi del piccolo, dopo Hiroshima, dopo Mathausen” - Capite chi sono i morti male: sono gli sterminati dei campi di concentramento della Shoà, sono le vittime della bomba atomica - “ah, vorrei almeno intravederlo il Dio accecante che avanza da crimine a crimine e penetra l’umano di una chiarità dell’Empireo ” . Qui la luce è la luce del Dio della violenza. Terribile questo, no? Lui che prende luce dalle sue vittime e cresce tanto fermo da cicala a cicala dell’estate nella maturità dei tempi, nella pienezza della storia, dicono. Guardate che questo è un testo poetico di bellezza straordinaria, perché in esso Luzi ci dice, in poche parole, quella che è stata la grande tragedia del Novecento. Il Novecento ha creduto ai grandi miti ideologici di destra e di sinistra, dallo stalinismo al fascismo, al nazismo; ha inseguito questi miti, ha inseguito il Dio accecante che penetra l’umano di una chiarità di Empireo e ha preteso che questo fosse la maturità dei tempi. Capite? Non dimenticate che tutte le follie ideologiche hanno sognato di essere il compimento della storia, fino alla futilità, direi anche provinciale, di iniziare una nuova datazione degli anni a partire, per esempio, nel caso della nostra provincia, dall’avvento dell’era fascista. Questa è stata la tipica tentazione di tutte le ideologie, per il nazismo era addirittura il “Terzo Reich”, che è, in realtà, una categoria prestata dalla storia della teologia. Chi è che aveva inventato il terzo Reich? Era Gioacchino da Fiore, era il terzo Stato che veniva con l’era dello spirito, e il nazismo ha secolarizzato questa dottrina che, attraverso gli Spirituali francescani, era passata attraverso le ideologie moderne, fino a farla 139 diventare la terribile categoria dell’avvento di un nuovo mondo che la violenza totalitaria avrebbe dovuto imporre. Allora quando Luzi dice: “nella maturità dei tempi, nella pienezza della storia, dicono, c’è una finissima ironia di questa presunzione dei mondi ideologici di aver potuto con la loro luce, non solo interpretare il mondo, ma anche trasformarlo”. Undicesima tesi marxiana, no? non basta interpretare il mondo, bisogna trasformarlo. Così lo abbiamo trasformato, con la violenza di una luce che ha voluto imporsi a tutte le cose e in tal modo ha forzato le cose. Allora è in questa crisi, che non è più la crisi soltanto di un uomo o di un poeta, ma è la crisi di un’epoca perciò visitare la poesia di Mario Luzi significa ripercorrere il nostro Novecento - che si affaccia un’altra metafora. Ecco la seconda delle mie metafore. II. LA METAFORA DELLA DONNA La seconda metafora è la metafora della donna. Che cosa significa propriamente la metafora della donna? Ascoltiamola. Ve la leggo nella stessa poesia, cioè nella stessa raccolta di poesie di cui fa parte “Il pensiero fluttuante della felicità”. Anzi, devo dirvi, è addirittura lo stesso componimento; quindi, a distanza di pochi versi da quello che abbiamo ascoltato, da questa finissima ironia della presunzione moderna di una luce onnicomprensiva, Luzi dice: “Finché una luce senza margini d’ombra illumini l’oscurità del tempo, risale ad uno ad uno i suoi tornanti e m’accorgo di te, entrata nella mia vita, neppure mi chiedo da che parte e quando e se lo sei o se invece non sei sorta su dalla sua profondità di notte in notte, affiorando”. Allora qual è l’elemento nuovo, dunque, che entra in questa luce che va tramontando? E’ l’elemento della donna. “Di te entrata nella mia vita”. Perché? Che cosa rappresenta la donna? La donna rappresenta l’altro. Fuor di metafora, l’ideologia moderna è il trionfo della identità, è l’io della ragione che presume di comprendere tutto e di trasformare tutto. La grande alternativa all’ideologia è la riscoperta della alterità: l’io non è tutto, l’altro; l’altro che ti guarda con il suo volto, direbbe Levinas, è la misura dei limiti del tuo io; dunque l’altro è la metafora di un’altra verità, che non è più la verità ideologica, la verità violenta, ma è la verità, oserei dire duale, la verità relazionale, la verità del rapporto, la verità dell’amore. Ecco la metafora della donna intesa come metafora di questo altro che entra nella tua vita e ti strappa alla solitudine gonfia del tuo io, che ha prodotto violenza e morte. Ebbene, qual è la concezione della verità che si esprime in questa metafo140 ra della donna? Io non esito a dire che è la concezione biblica, la concezione ebraica e cristiana. L’ebraico vero, non l’ebraico artificiale oggi parlato in Israele, l’ebraico biblico è una lingua povera di vocaboli; ci sono solo 6750 vocaboli, eppure con questi pochissimi vocaboli - confrontateli al milione di vocaboli dell’arabo o ai centomila- centoventimila vocaboli in media di tutte le lingue moderne europee, a cominciare dall’italiano - l’ebraico riesce ad esprimere, in maniera straordinaria, tutti i grandi sentimenti umani: basta leggere i Salmi, basta leggere l’Antico Testamento. Ora l’ebraico biblico non ha una parola per dire verità, o meglio ha una parola, ma questa, in realtà, significa un’altra cosa. Questa parola è “emet”, che propriamente significa “fedeltà”. Allora –attenzione! - per il greco la verità è ciò che è latente, che viene esibito alla visione tanto che tu lo possiedi con lo sguardo e lo domini; la verità è la “adaequatio rei et intellectus”, cioè è l’intelletto che domina la cosa, la comprende, come noi diciamo anche comprende, lo stesso termine in tedesco “enthalten”, concepire, prendere in sé. Nel mondo biblico, invece, la verità è “emet”, che è rapporto, relazione, la verità è pattizia, duale, non è una verità monastica, totalitaria, violenta. Quando la verità comprende l’altro come elemento costitutivo, allora è una verità “debole”, aggettivo che va colto nella sua giusta accezione: non è una verità che giustifica la violenza, ma è una verità che fonda patti di relazione, patti di pace. Le citazioni potremmo prenderle non solo dall’Antico Testamento, dove il termine “emet” è ovviamente quello della lingua in cui esso si esprime, ma anche, e questo è straordinario, dalla testimonianza del Nuovo Testamento, perché dietro la parola greca “alètheia”, che vuol dire verità, nel Nuovo Testamento c’è però il concetto ebraico di “emet”, di “fedeltà”. Ve ne dò un esempio: “Chi opera la verità viene alla luce” (Gv 3, 21). La verità non è qualcosa che si concepisce, è qualcosa che si fa, che si pone nella relazione, cioè, tu operi quando ti relazioni all’altro, al fuori di te, in un esodo da te senza ritorno, oppure (Gv 8, 31) : “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La via che ci apre la verità è la fedeltà”. Perfino la Vulgata traduce spesso “veritas” con “fidelitas”. “Fidelitas domini manet in aeternum”. “La verità del Signore rimane in eterno”, e il culmine di questo processo noi lo troviamo nel testo di Giovanni 14,6, dove dice Lui, Cristo: “Io sono la via, la verità e la vita”; è chiarissimo qui che la verità non è qualcosa che tu puoi possedere, la verità è qualcuno, e qualcuno non è mai un oggetto da possedere, è l’altro cui relazionarsi, cui corrispondere. 141 La grande differenza fra l’alètheia e l’emet, verità in senso di fedeltà, è che mentre l’alètheia sbocca nel possesso e quindi nella violenza, come ha dimostrato Heidegger, l’emet sbocca nella relazione, nella sequela, nel patto o, per usare la grande categoria biblica, nell’alleanza. Ecco l’altra grande idea di verità. Dunque, se la verità greca trionfa nel suo culmine nell’idea del “cogito, ergo, sum”, io penso, dunque io esisto, dunque io sono, cartesiano, la verità-emet biblica, al limite, potrebbe culminare in quest’altra formulazione “cogitor, ergo, sum”, cioè, io esisto, perché un altro mi pensa, o meglio, dovremmo dire “amor, ergo, sum”, esisto perché sono amato da un altro, cioè è l’altro la condizione della mia esistenza, della mia permanenza. Allora capite che questa verità non è qualcosa che diviene semplicemente in te, ma è qualcosa, o meglio, qualcuno che viene a te, come è esattamente la figura della donna. “M’accorgo di te, entrata nella mia vita, neppure mi chiedo da che parte e quando, se lo sei, se non sei sorta su dalle profondità, di notte in notte, affiorando”. Dalle profondità della vita affiora nella notte questo avvento, questa figura che viene a noi. A me sembra che questa intuizione è un’intuizione di grande importanza, di grande bellezza, che attraversa, peraltro, l’intera opera di Luzi e culmina nel parlare di una donna in particolare. La donna in particolare, di cui lui parla presto, di cui lui parla spesso, è Maria, la madre di Cristo, la madre di Gesù. Pensate, per esempio, a questa poesia del 1938, “Annunciazione”. Il poeta dice così: “La mano al suo tepore abbandonata, nelle lacrime spenti i desideri, forse è questo una donna. Un tempo esangue nell’ombra la bontà opaca di ieri. Poi di luna, un inane fianco rosa, teso al vento gremito del Tuo nome, la sua caducità bianca di chiome, quella povera luce che ci opprime”. Ecco chi è la donna: la donna è l’altro accogliente, è l’altro che non invade, che non opprime, è l’altro che crea spazio di vita, come la Vergine dell’Annunciazione crea in sé, nel suo grembo accogliente, lo spazio per la vita che viene. Allora qui è la crisi di un’epoca che si affaccia, è la fine dei mondi ideologici, è il bisogno di una nuova ricerca di verità, che non si esprima nella verità solare, totalitaria, violenta, dietro cui c’è, come già denunciava Nietsche, la volontà di potenza, ma la verità che sia liberante, relazionale. Ed è a questo punto che emerge una terza metafora, quella del viaggio. III. LA METAFORA DEL VIAGGIO Se la verità non è possesso, qualcosa che si possiede, ma è qualcuno a cui rapportarsi, in una relazione sempre nuova d’amore, allora nella verità non si è mai arrivati. Ecco perché la grande metafora 142 che esprime tutto questo è la metafora del viaggio. Qui ci sarebbe da dire tantissimo, poiché la metafora del viaggio attraversa tutta la Bibbia, l’Esodo, “il viaggio di Gesù, che indurì la sua faccia”, per andare a Gerusalemme (Lc 9,51). E’ la grande metafora anche della letteratura greca, quella del viaggio di Ulisse, con una differenza fondamentale, però, che il viaggio del greco è circolare, è la metafora dell’eterno ritorno (Ulisse ritorna all’inizio), il viaggio dell’ebreo, invece, è lineare, senza ritorno, verso l’infinito, è “Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini”. Sin dal titolo, quest’opera della piena maturità del poeta, questa metafora della ricerca umana di Dio, è la metafora del viaggio. Siamo tutti dei “viatores”, siamo tutti dei pellegrini. Un altro testo è un testo del ’47, in cui la metafora della donna e la metafora del viaggio si intrecciano. Egli, dopo aver attraversato la desolazione della guerra e aver sperimentato i fragili ottimismi delle ideologie, scrive versi che si illuminano con le parole rilasciate dall’Autore stesso nell’intervista citata: “Io ho sempre inteso il nostro destino di viventi sotto la specie del viaggio; di un viaggio che va fatto a partire dal nostro percorso vitale e terreno, e credo possa avere un fine e un senso”. Ma ecco come questo diventa commento alla storia del nostro Novecento. “E’ questa”, scrive nel ’47 - la poesia si intitola “Ne il tempo”- “è questa la nostra regione senza limiti, cogline i fiori tristi, le erbe opache, messe che oscilla intentate, riposa. E quel grano non so che sia, pallido, nel campo abbandonato dove niente rimane da sperare. Ora falcia le reste grigie, il triste velo a perdita d’occhio delle spighe, inoltrati nel folto senza fine. Riconosco la nostra patria, desolata, della nascita nostra senza origine, della nostra morte senza fine. E questa l’avevo chiamata il caso, l’avevo chiamata l’avventura, o la sorte o la notte o con quei noi inquieti che mi dettava l’angoscia, non la pietà che penetra, che vede”. E’ la descrizione della nostra patria desolata, dell’Italia del dopoguerra, dell’Italia distrutta, dove la follia delle ideologie ha prodotto il dramma della guerra e della distruzione. Ma anche qui la metafora del viaggio ritorna come una metafora di possibile novità, di possibile speranza. Allora la verità non è semplicemente l’altro, ma è l’altro verso cui tu ti muovi, in una incessante ricerca, è l’altro che entra nella vita, al di là di tutti gli esiti, di tutti i naufragi, di tutte le solitudini, di tutte le stanchezze. Così, questo cammino verso la verità è espresso nella figura dell’ “éstudiant”, del giovane studente che accompagna Simone Martini e parla la langue d’oc (“éstudiant” è il suo nome, in 143 quella lingua). Scrive così: “Chi è? Improvvisamente non conosce costui che, invece, sua e sotto sua parvenza subentra nel Creato. Lui non fu mai rigidamente lui, ma un ceppo brulicante di ogni vita, immaginata, vissuta, futura, passata”. Chi è questo lui di cui l’éstudiant sta parlando? E’ Cristo, Cristo che è colui che ha fatto il viaggio verso di noi, ha fatto suo questo viaggio. E dove porta questo viaggio? “Inchiodami alla croce della mia identità, così come fu fatto per te e per la tua, da cui prende colore e senso ogni crocifissione, ciascuno ai bracci della sua persona”. Cristo diventa la rivelazione dell’uomo, e diventa la rivelazione dell’uomo perché facendosi uomo, entrando nel nostro viaggio, Lui ha aperto il nostro viaggio ad un’altra sponda, ad un’altra patria. Qui, Luzi è l’erede di una straordinaria tradizione teologica che è la tradizione delle trasgressioni di Dio. Il più grande testimone di questo è Tommaso d’Aquino. Tutta l’opera di Tommaso si raccoglie nelle due grandi trasgressioni: l’”exitus a deo”, trasgressione in senso etimologico, varcare la soglia, Dio che esce da sé, crea il mondo, si fa uomo; e il “reditus ad deum”, il Crocifisso che risorge alla vita e riporta al Padre l’universo intero, che con sè ha portato nell’abisso della morte. Ecco allora, il viaggio non è più solo metafora della nostra solitudine, della nostra ricerca al di là di tutti i naufragi, di tutti i frammenti da battezzare (cfr. “Per il battesimo dei nostri frammenti”), ma è il viaggio di Dio, che, facendosi uomo, ha assunto il nostro viaggio e lo ha aperto alle sue sponde, alla sua patria, alle sue promesse. IV. LA METAFORA DEL SILENZIO E questo ci porta ad una quarta potente metafora, che è la metafora del silenzio. Sì, proprio quella del silenzio, perché la Bibbia non è soltanto il libro della parola di Dio - come mostra André Neher, in quel bellissimo libro “Esilio della parola”, e come mostra un’intera schiera di autori ebrei francesi, per esempio Claude Viget, fra gli altri - la Bibbia è anche il libro del silenzio di Dio. Perché? Ve lo dico in maniera rapida con le parole di Neher, perché nella Bibbia ci sono almeno due concezioni di Dio: c’è il Dio dei ponti sospesi, cioè il Dio che sull’abisso che ci separa da lui lancia il ponte della sua parola, che ci rassicura, che ci conforta; e poi c’è il Dio dell’arcata spezzata, cioè il Dio che lascia che il tuo tentativo di varcare l’abisso resti interrotto, è il Dio che tace davanti alla prova di Abramo, è il Dio che nasconde la sua faccia quando tu lo invochi, è il Dio che quando tu 144 sei sulla croce e gridi “Perché mi hai abbandonato?”, resta nel silenzio, è il Dio che ad Elia che sale sul monte per fare la sua esperienza, si rivela non nel fuoco, non nel vento, ma in una brezza, in un vento sottile: il termine ebraico è “koldamannà”, che significa “voce del silenzio”. Dio si rivela nella voce del silenzio. Questo significa che se Dio, così commenta Neher, fosse solo parole, la Fede sarebbe nient’altro che una certezza, un’ideologia, una comoda e tranquillante rassicurazione. Solo il Dio, che si rivela nascondendosi, lascia l’uomo libero, gli lascia il rischio della libertà. Ora, commentando il silenzio di Dio, Neher – e tutta una serie di pensatori ebraici come Levinas - dice la stessa cosa in “Difficile liberté”: il silenzio di Dio non è che lo spazio della libertà dell’uomo. Ecco, questo motivo ritorna anche nell’opera di Luzi. Al pellegrino, al cercatore in viaggio, che cerca la verità, non la verità monastica, violenta, ma la verità duale, pattizia, a cui corrispondere, Dio si manifesta anzitutto come silenzio. Vi leggo un altro dei suoi testi, del 1945: “Tu non resti inerte nel tuo cielo, e la via si ripopola d’allarmi, poiché la tua imminenza respira contenuta, dal silenzio di lucide pareti, dai vetri che fissano l’inverno. Camminare e venirti incontro, vivere e progredire a te, tutto è fuoco e sgomento. E quante volte, prossimo a svelarti, ho tremato di un viso repentino dietro i battenti di un’antica porta, nella penombra o a capo delle scale”. La rivelazione di Dio, qui, non è una esibizione, una “Offenbarung”, come si dice in tedesco, cioè una manifestazione totale; la rivelazione di Dio, qui, è quella di un Dio che parla nel silenzio, di un Dio, cioè, che lascia l’uomo esposto al rischio della sua libertà, e tuttavia di un Dio che parla, che parla. Ancora una volta, ecco, ascoltiamo questo testo dove silenzio, parola, donna, le varie metafore si intrecciano: “Non più lunghi poemi, suppongo, l’anima brucia rapidamente la sua scorza, la mente divora la metafora, il significato è fulmineo, maturo, forse al suo apice, perciò credo in disarmo, mentre lei, catturata dal bosco non gli risponde, non gli volge uno sguardo di antica complicità, sorride ad altro, tra le torce di luce e i molti pozzi di oscurità, nel folto, nel folto”. Questo è un testo - “Al fuoco della controversia” - degli anni ’70, che riassume in un’unica potente immagine la metafora del viaggio, la metafora della luce, dell’oscurità, la metafora della donna, e ci fa capire che l’uomo pellegrino nel folto, cioè nell’oscurità, sente il bisogno non solo di una parola che dica, ma anche di un silenzio eloquente. E qual è la forma di un silenzio eloquente? E’ l’amore; di cui, per Luzi, l’espressione più alta è la carità, ed è la carità, che lui 145 riannoda alla figura, ancora una volta, della donna, di Maria e anche della madre. Pensate a questa poesia dedicata alla madre: “Ed eccolo da un punto perduto del cuore, risale in lui quel timore antico, e quella povera, umbilicale carità, per ogni vita creata e per le nasciture”. Questa è la verità, è la verità di un amore materno, proprio per questo, silenzioso; l’amore materno non è quello che si esprime nelle parole vuote, bensì quello che si esprime nella umbilicale carità, cioè in quella carità viscerale, in quel darsi che non chiede ragioni. E poi l’espressione richiama l’ebraico “rahamim”, per dire l’amore di Dio: Dio non ci ama, diceva San Bernardo, perché siamo buoni e belli; Dio ci rende buoni e belli, perché ci ama; il suo amore è un amore gratuito.Questa è la verità silenziosa, cioè la verità la cui eloquenza non è la parola ma è il gesto dell’amore, della compassione, della pura gratuità. V. LA METAFORA DELLA SOGLIA La quinta metafora è quella della soglia. Qualunque approdo è sempre uno stare sulla soglia: la verità non è mai un possesso scontato e tranquillo, ma uno stare sulla soglia. Anche il credente, voglio dire, lo dico spesso, è come un ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere; perché la verità della Fede non è un possesso scontato e tranquillo, ma è la verità del pellegrino che deve ogni giorno cominciare ad arrendersi al Dio vivente, perciò ogni giorno abbiamo bisogno di parlare e tacere con Dio, di pregare e di affacciarci a lui. Ecco, questo è molto presente nell’opera di Luzi e nella sua poesia. I nostri frammenti, cioè le nostre solitudini, le nostre notti, hanno bisogno di un sempre nuovo battesimo, così si intitola una delle sue raccolte: “Per il battesimo dei nostri frammenti”; e tutta la poesia di Luzi è un continuo cercare questa verità, questa luce, altro, esodo, viaggio, silenzio, senza mai pretendere di averla catturata e posseduta. Qui, in un certo senso, la poesia di Luzi si offre come una sorta di educazione alla discrezione e al pudore davanti alla verità. Se la verità non è qualcosa che tu possiedi, ma qualcuno da cui senti di dover lasciarti possedere, allora la verità esige di essere accostata, in punta di piedi, sulla soglia. Davanti alla verità, se è la verità, tutti siamo chiamati ad essere umili. Non dimenticatelo mai quello che diceva il Cardinale Bea: “La verità non ha bisogno di essere difesa, la verità si difende da sé stessa”. Questo è un principio straordinario, perché ci fa capire che, se la verità avesse bisogno di essere difesa, sarebbe un nostro possesso, una nostra ideologia, ma se la verità è la 146 verità, essa va servita, essa va amata, essa va testimoniata, ma mai dovremmo presumere di possederla come qualcosa di nostro. Noi siamo soltanto i servi della verità; e la poesia, più che ogni altro discorso umano, è consapevole di questa umiltà: la poesia dice la verità tacendo, la poesia la rivela nascondendo, la poesia è quella parola ferita che sa che ogni detto è evocazione dell’aldilà del detto, e solo così è veramente poesia, solo così è disciplina e discorso che schiude verso gli abissi della verità. VI. A MO’ DI CONCLUSIONE Tutto quello che ho cercato di esprimere con le cinque metafore non è che si trovi in Mario Luzi come in un trattato: esso si trova in Luzi nell’evoluzione di una vita e con tutte le involuzioni della vita. Amici, non dimenticatelo mai: Se un autore è grande, se è veramente grande, è pieno di contraddizioni: solo i minori, solo i mediocri sono assolutamente coerenti con il loro pensiero, perché dicono poche idee e quindi è facile incollarle insieme. Ma i grandi, tutti i grandi, sono percorsi dall’inquietudine, dalla ricerca, dal dubbio. Pensate Agostino, pensate Paolo, gli anacoluti Paolini, per fare un esempio biblico, cioè questa potenza, il magma che vuole esprimere, ma che non riesce ad esprimere. Pensate Tommaso d’Aquino nella tensione fra l’anima apofatica di Dionigi l’Areopagita, da cui lui è enormemente influenzato, e la filosofia aristotelica, e così via. Dunque, anche Luzi è vivo; il suo è un percorso fatto di tensioni e contraddizioni; un testo, ne prendo uno a caso, che ho appena aperto adesso, di questo libro “Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini”, ve lo leggo, ma questo testo certamente, Luzi non lo avrebbe scritto: “Durissimo silenzio tra noi uomini e il cielo, arido per aridità di mente o scomparsa degli angeli rientrati nel verde, muti alla sorgente…anche morte dei profeti, ma colmato da nuvole, da pietre, da alberi, da animali, da quel loro ininterrotto afflato tutto creaturalmente, o anima del mondo da tutto ferita, da tutto risarcita, non piangere, non piangere mai, dice nel sonno la sua amorosa lungimiranza”. Che cos’è quest’esperienza? E’ un’esperienza che si fa nella maturità della vita, quando quel Dio a cui tu ti rivolgi ti appare un durissimo silenzio, e quando ciononostante, la sua presenza che, a volte, ti sembra un rientrare gli angeli muti nel verde alla sorgente, ti parla attraverso tanti altri segni silenziosi, per cui è paradossalmente ancora più eloquente che la sua parola del tempo dell’entusiasmo. 147 Questa è la condizione del credente pellegrino, e qui Luzi è la metafora non solo della vita umana in ricerca, ma anche della Fede, perché, a parte la sua vicenda personale, lui è stato sempre credente, ma certamente c’è stato un cammino progressivo della scoperta della Fede: lui mi ha sempre detto che, per lui, due riferimenti sono stati fondamentali: sua madre, perché era una donna di una Fede profonda, ma che si esprimeva nella carità, nell’amore, soprattutto ai più poveri, ai più deboli; e un vecchio prete, alla cui Messa lui andava sempre, a Pienza, che è una città che Luzi ha scelto un po’ come patria d’elezione, che con la sua Fede campagnola, genuina, dura, lo ha aiutato a capire che Dio non è una verità comoda, tranquillizzante, ideologica, ma esattamente quel Dio sempre più grande, che anche quando è venuto a visitarti, in Cristo, e ha parlato in Cristo, ti chiama ad una soglia oltre la quale l’abisso del suo silenzio è ancora più grande. Perciò ecco, una tesi come quella che io credo di dover sostenere, e che sostengo da ormai molti anni, anche nei miei libri, in teologia della storia, cioè che la rivelazione cristiana non è assolutamente “Offenbarung”, come spesso dico quando mi capita di fare conferenze in Paesi di lingua tedesca, vale a dire che la grande tragedia della teologia cristiana degli ultimi due secoli, è stata di essere pensata in tedesco. E poi spiego: noi abbiamo pensato il Cristianesimo come una religione da “Offenbarung”, “Rivelazione”, che Lutero sceglie e che diventa epocale. Allora quando Hegel interpreta questa parola dice: “La religione Cristiana è la religione della Offenbarung”: traduzione italiana della “Rivelazione”, dove tutto è manifesto, ma questo è impreciso. Noi sappiamo non solo che Dio è, ma anche chi Dio è, la Offenbarung è la rivelazione totale. Questo non è il Cristianesimo. Il Cristianesimo è la religione dell’ “Apokalypse” Revelatio. Prendiamo la parola latina “revelare”, significa due cose: togliere il velo, ma anche revelare, cioè nuovamente mettere il velo. Voglio dire che la rivelazione non è mai una rivelazione totale di Dio, ma è l’apertura che consente l’accesso agli abissi del mistero, cioè Cristo ci introduce nel seno del Padre. Ecco perché la primitiva teologia Cristiana, il Padre, in rapporto al Figlio, che chiamiamo Logòs, lo chiamava “sighè”, cioè “silenzio”, così Ignazio d’Antiochia. Poi questo linguaggio è stato abbandonato, perché sembrava avesse un sapore agnostico; era, invece, un linguaggio bellissimo, perché ci faceva capire che Gesù è la porta delle pecore, a cui non potremo mai rinunciare, che ci introduce negli abissi della vita, del silenzio divino, imprendibili dalla parola. Ora, in una concezione del genere, 148 teologia e poesia si scoprono sorelle, perché si trovano nella condizione che dice il famoso “Inno” di Tommaso: “Adoro te devote, latens deitas, quae sub his figuris vere latitas”, cioè la divinità sarà sempre presente sotto figure, le figure del linguaggio, le figure dei sacramenti: per noi pellegrini in questo mondo la verità non sarà mai di Dio, non sarà mai un possesso tranquillizzante e comodo, perché se fosse tale sarebbe ideologia, non sarebbe più la verità di Dio; Dio è più grande del nostro cuore. Allora, dove se ne va, che ne sarà della singolarità di Gesù Cristo? E’ chiaro che la singolarità di Cristo è fuori discussione, ma la sua singolarità non sta nel fatto che lui esibisce tutta la verità, ma nel fatto che lui è la porta, la via irrinunciabile per entrare negli abissi della verità. Ringrazio di nuovo il Vescovo e tutti voi. Avendo percorso questa sera un comune cammino, chiediamo a Dio di aiutarci a cercare sempre la verità, a vivere nella verità e a fare la verità. 149 150 ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL’UNIVERSO: GLI ULTIMI SVILUPPI ANTONINO F. LANZA * 1. INTRODUZIONE La cosmologia, intesa come la scienza che si occupa dello studio delle caratteristiche dell’universo fisico nel suo insieme, ha conosciuto nel XX secolo un notevole sviluppo. Nell’ultimo decennio, l’incremento delle conoscenze è stato senza precedenti e ulteriori risultati di grande rilievo sono attesi per il prossimo decennio, grazie al lancio di missioni spaziali dedicate. Non è possibile illustrare gli ultimi sviluppi in Cosmologia senza ripercorrere almeno brevemente le tappe fondamentali che hanno condotto ai risultati osservativi più importanti nel corso del XX secolo. Nel secondo decennio del XX secolo divenne chiaro che le nebulose a spirale che si osservavano tramite i grandi telescopi erano sistemi stellari esterni alla nostra Galassia, posti a distanze dell’ordine dei milioni o delle decine di milioni di anni luce. Edwin Hubble alla fine degli anni ‘20 si rese conto che le galassie si allontanano le une dalle altre con una velocità che cresce proporzionalmente alla distanza che le separa (espansione dell’Universo). Intorno alla metà degli anni ‘40 George Gamow e i suoi collaboratori formularono il modello cosmologico detto del Big Bang, che spiega l’espansione dell’universo come il risultato di un’esplosione primordiale. L’Universo, secondo tale modello, iniziò la sua evoluzione a partire da una condizione di altissima temperatura (>10 9 K) e densità, cui fece seguito una fase di espansione che dura tuttora, caratterizzata da un progressivo raffreddamento e da una sempre maggiore rarefazione su grande scala (ovvero per distanze maggiori delle centinaia di milioni di anni luce). Il modello di Gamow e collaboratori conteneva due notevoli predizioni: a) l’esistenza di un fondo cosmico di radiazione, dovuto alla radiazione termica presente all’inizio, diluita dalla espansione cosmica fino a livelli molto bassi; b) una precisa abbondanza degli elementi chimici di basso numero atomico e dei loro isotopi nelle stelle (in particolare deuterio e elio). * Relazione tenuta il 20 Febbraio 2001. 151 Tali previsioni furono verificate rispettivamente negli anni ‘50 e ‘60. In particolare la scoperta della radiazione di fondo avvenne in modo del tutto inatteso nel 1965 da parte di due scienziati che lavoravano allo sviluppo di nuovi ricevitori radio. L’espansione dell’Universo, infatti, è stata tale da portare il fondo di radiazione a una temperatura di circa 3 K (solo tre gradi sopra lo zero assoluto), e a tale temperatura l’emissione è rivelabile praticamente solo nel campo radio. Possiamo quindi dire che il modello del Big Bang, proposto da Gamow e perfezionato da altri scienziati, già alla fine degli anni ‘70 risultava essere condiviso dalla maggioranza dei cosmologi poiché spiegava: a) l’espansione dell’Universo; b) l’esistenza del fondo cosmico a 3 K; c) l’abbondanza degli elementi leggeri (in particolare deuterio ed elio); d) le osservazioni sull’evoluzione delle galassie, che indicano una modificazione delle loro proprietà nel corso del tempo. A partire dalla seconda metà degli anni ‘70 inizia la storia più recente della cosmologia moderna, di cui intendo delineare brevemente gli aspetti principali. 2. GLI SVILUPPI PIÙ RECENTI 2.1 La materia oscura Nella seconda metà degli anni ‘70 ci si rese conto che la maggior parte della materia dell’Universo non emette luce visibile né altre forme di radiazione elettromagnetica. Essa fa sentire la sua presenza soltanto tramite gli effetti gravitazionali. Le misure sempre più accurate condotte negli anni ‘80 e negli anni ‘90 hanno condotto a stabilire che tale materia oscura è almeno 5-10 volte più abbondante della materia luminosa che forma le stelle e le nebulose osservabili. Secondo i modelli cosmologici più recenti, tale materia sarebbe composta solo in piccola parte da oggetti astronomici privi di sorgenti di energia (pianeti, nane bianche, stelle di neutroni, buchi neri); essa consisterebbe per la maggior parte di particelle subatomiche che interagiscono molto debolmente con la materia e la radiazione ordinaria, al punto da non risultare rilevabili. Esse sarebbero state prodotte durante le primissime fasi di vita dell’Universo quando esso aveva meno di un milionesimo di secondo di età. 152 Qualunque sia la sua natura, resta comunque il fatto che la maggior parte della materia dell’Universo sfugge alla nostra capacità di rilevazione. Quella che possiamo osservare è solo una piccola frazione (10% - 15%) della massa totale. 2.2 Le fluttuazioni del fondo cosmico Una fondamentale caratteristica del fondo cosmico è l’altissimo livello di isotropia che riflette la quasi perfetta uniformità della temperatura e della densità della materia cosmica quando l’universo aveva un’età di circa trecentomila anni, nel momento in cui esso divenne trasparente alla radiazione. Le misure più recenti hanno mostrato che le deviazioni dalla isotropia, cioè le fluttuazioni del fondo cosmico, sono dell’ordine di una parte su 30.000. Nel corso degli ultimi anni sono state dedicate molte ricerche alle misure di tali fluttuazioni. Lo scopo fondamentale è quello di verificare le proprietà previste dai modelli teorici proposti all’inizio degli anni ‘80 e che vanno sotto il nome di inflationary cosmological models, infelicemente tradotto in Italiano con “modelli cosmologici inflazionari”. Secondo tali modelli, originariamente proposti da Alan Guth, l’Universo primordiale attraversò una fase di espansione accelerata durante i suoi primissimi istanti (circa 10-35 s dopo l’inizio). Tale espansione accelerata, denominata tecnicamente inflation (dall’Inglese “to inflate”, cioè gonfiare) ridusse enormemente le differenze di temperatura e densità presenti nell’Universo primordiale, conferendogli il carattere di altissima uniformità e isotropia rispecchiato nel fondo cosmico. In realtà il modello inflazionario prevede che le fluttuazioni non si riducano esattamente a zero. Quelle rimaste, sebbene estremamente piccole (circa una parte su centomila), mostrano delle proprietà caratteristiche nella loro intensità e distribuzione spaziale che possono essere utilizzate per sottoporre a verifica il modello stesso. Queste misure sono estremamente delicate e solo negli ultimi due o tre anni si sono ottenuti alcuni risultati preliminari. In particolare, l’esperimento denominato Boomerang ha fornito i primi dati a sostegno del modello inflazionario. I modelli teorici prevedono ulteriori interessanti proprietà delle fluttuazioni. In particolare, esse contengono informazioni sulle condizioni iniziali dell’Universo e su alcune delle sue proprietà globali, come la velocità di espansione iniziale, la geometria dello spaziotempo e l’abbondanza di materia ordinaria. 153 Si può quindi affermare che lo studio delle fluttuazioni del fondo cosmico è lo strumento privilegiato per la comprensione dell’origine e delle proprietà dell’Universo. Per questa ragione nei prossimi anni due importanti missioni spaziali saranno specificamente dedicate a queste ricerche: MAP della NASA e Planck dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, in cui l’Italia gioca un ruolo fondamentale. Quando queste missioni avranno completato le loro misure e i dati saranno analizzati, ovvero intorno al 2012-2015, avremo un quadro molto più preciso dell’Universo e delle sue caratteristiche globali. 2.3 L’accelerazione dell’espansione Le misure effettuate negli ultimi anni sulla velocità di espansione delle galassie più lontane hanno condotto al risultato sorprendente che l’espansione cosmica, accelera nel tempo, ovvero l’Universo si espande tanto più velocemente quanto più invecchia. La probabilità che tale risultato sia dovuto a errori sistematici non ancora evidenziati è abbastanza piccola. Questa scoperta è in disaccordo con i modelli cosmologici classici i quali prevedono che l’espansione debba rallentare nel tempo per effetto della forza di attrazione gravitazionale che agisce tra le masse dell’Universo. La presenza di un’espansione accelerata implica che vi sia una sorgente di energia ignota che incrementa la velocità di espansione. Sulla natura di tale energia oscura si possono solo proporre delle speculazioni sulla base della proprietà che la Fisica teorica prevede per i campi di forze. In ogni caso la sua densità di energia è molto più piccola delle forme di energia ordinaria che si manifestano nei nostri esperimenti di laboratorio, per cui la sua diretta rilevazione sperimentale è al di là delle attuali possibilità. 2.4 Le proprietà antropiche L’esistenza della vita intelligente risulta strettamente legata alle proprietà globali dell’Universo, determinate dalle costanti fondamentali della Fisica (costanti di natura) e dalle condizioni iniziali a partire dalle quali l’Universo stesso si è evoluto. Ad esempio, se le costanti che regolano l’intensità relativa delle forze nucleari e delle forze elettriche nei nuclei atomici fossero diverse solo dell’1-2% dal valore osservato, non sarebbe possibile l’esistenza di stelle stabili in grado di emettere energia per miliardi di anni e quindi l’evoluzione 154 della vita sui pianeti fino alle forme più avanzate. Inoltre l’esistenza del Carbonio, l’elemento fondamentale per la biochimica, è connessa con una serie di delicate coincidenze tra i valori delle costanti che regolano le energie dei livelli dei nuclei atomici coinvolti nel suo processo di formazione all’interno delle stelle. Le condizioni iniziali hanno un ruolo altrettanto importante. Se la velocità di espansione del cosmo fosse stata diversa dal valore attuale di circa una parte su dieci milioni, il destino del cosmo sarebbe stato quello di ricollassare prima che la vita potesse sorgere sulla Terra, ovvero la materia si sarebbe dispersa troppo velocemente per potersi aggregare in galassie ed in stelle. Anche la quantità di energia oscura presente all’inizio è fondamentale perché se questa fosse stata troppo elevata avrebbe condotto ad una accelerazione dell’espansione troppo rapida perché potessero formarsi galassie e stelle. Un’analisi dettagliata del profondo legame tra proprietà cosmiche ed esistenza della vita intelligente è stata condotta dai cosmologi Barrow e Tipler nel loro trattato “The Anthropic Cosmological Principle”, che ha segnato l’inizio del dibattito moderno su questa interessantissima questione, il cui impatto trascende l’ambito strettamente tecnico della cosmologia per acquistare una rilevanza culturale generale. 3. UN’IPOTESI INTERPRETATIVA UNITARIA E I SUOI ATTUALI LIMITI I risultati osservativi che ho brevemente descritto sollecitano lo sviluppo di un quadro interpretativo unitario che possa renderne ragione. Come osservava recentemente James Peebles, uno dei padri della cosmologia contemporanea, sebbene i risultati osservativi siano ormai generalmente consolidati, le interpretazioni teoriche sono ancora in uno stadio iniziale. Purtroppo accade sempre più spesso di vedere, veicolate dai mass media, volgarizzazioni delle speculazioni avanzate da questo o quel cosmologo che vengono spacciate come nuove, sicure acquisizioni della scienza moderna. Peebles ricorda che le caratteristiche di una seria divulgazione devono essere almeno: a) rispecchiare le idee di una comunità scientifica competente e qualificata e non le ipotesi o le opinioni di un singolo, per quanto influente egli possa essere; b) presentare adeguatamente i metodi con cui sono stati ottenuti i risultati descritti, i loro limiti e le questioni ancora aperte. Possiamo con ragionevole certezza affermare che l’Universo si è evoluto da una situazione di altissima temperatura e densità espandendosi alle dimensioni attuali in circa 15 miliardi di anni, ma sui 155 processi accaduti prima del primo minuto possiamo solo fare delle ipotesi. In questo senso possiamo affermare che i risultati più recenti pongono con forza tre questioni fondamentali: a) perché l’Universo mostra un altissimo grado di omogeneità a grande scala? b) qual è la natura della materia oscura e della energia oscura? c) perché l’Universo è così adatto allo sviluppo della vita intelligente? Le ipotesi su cui sono basati gli inflationary cosmological models forniscono un tentativo di risposta alla domanda a), ma dipendono da notevoli estrapolazioni delle leggi della fisica non ancora confermate da esperimenti di laboratorio. Si tratta comunque di un tentativo serio che potrebbe essere sottoposto a verifica in futuro, sia tramite le misure della radiazione di fondo che con esperimenti di laboratorio di nuova concezione. Per quanto riguarda la questione b), le nostre conoscenze sono ancora più limitate e si può solo sperare che i progressi nelle teorie e nuovi esperimenti di fisica delle particelle, che utilizzano l’Universo stesso come laboratorio, ci forniscano un giorno qualche elemento per tentare una soluzione del problema. La questione c) è forse quella più importante perché coinvolge il significato del nostro essere qui ed ora e costringe la ragione umana a recuperare quell’ambito di problemi, fondamentali che una visione ideologica della vita tende a considerare come privi di senso e indegni di un’intelligenza evoluta ed adulta. La scienza non può dare risposta alla fondamentale domanda di conoscenza e di senso che sorge nell’impatto della ragione umana con la realtà perché il suo oggetto e il suo metodo sono troppo specifici e limitati. Tuttavia, come ogni serio tentativo di rapporto con la realtà, essa pone questioni che trascendono il suo ambito specifico e chiamano in causa altre discipline e altri metodi della conoscenza. La serietà dell’impresa scientifica e il rispetto del valore della ragione esigono che non si sospenda l’indagine prima di avere tenuto conto di tutti i fattori del problema e che si eviti accuratamente ogni argomentazione che muova da ipotesi pregiudiziali ed ideologiche, ovvero non fondate sull’esperienza o senza possibilità di verifica sperimentale. In questo senso è particolarmente istruttivo considerare brevemente la soluzione proposta alla questione c) a partire dai modelli cosmologici recentemente sviluppati dal cosmologo Andrei Linde e dai suoi collaboratori. 156 4. TENTATIVI IDEOLOGICI Il modello proposto da Linde e collaboratori va sotto il nome di chaotic inflation ed assume una particolare estrapolazione delle leggi fisiche secondo la quale il nostro Universo sarebbe una bolla in espansione in un insieme infinito ed eterno di bolle che differiscono per le condizioni iniziali e le costanti fisiche fondamentali. La maggior parte di tali universi-bolla evolvono senza raggiungere le condizioni necessarie allo sviluppo della vita cosciente, per cui in essi non vi sarà mai alcuno che possa porsi la domanda su come mai le condizioni iniziali e le costanti fisiche abbiano proprio quei precisi valori. Solo in un numero piccolissimo di tali universi-bolla si realizzano casualmente le condizioni opportune per lo sviluppo di esseri coscienti i quali, a un certo punto della loro storia, cominceranno a porsi la domanda su come mai il loro universo appaia così sorprendentemente ben calibrato per lo sviluppo della vita intelligente. Il modello della chaotic inflation ha avuto notevole fortuna nelle volgarizzazioni dei mass-media perché viene presentato come una grande scoperta della scienza moderna, la quale avrebbe così finalmente dimostrato che il nostro essere qui ed ora è frutto di un cieco caso. Questa operazione culturale è sostenuta da coloro che ritengono che la domanda sulla ultima natura e struttura di ciò che esiste e sulla sua relazione con noi sia una questione priva di senso. Tale posizione filosofica è ben nota nella storia del pensiero occidentale e si può far risalire ad Epicuro. Le sue conseguenze negative sullo sviluppo della scienza, e della cultura in generale, sono ben note. In effetti, alla vasta diffusione della idea dei molti universi nelle pubblicazioni divulgative, corrisponde, per contro, una puntuale critica della comunità scientifica sulle riviste specialistiche, essendo state riconosciute gravi limitazioni metodologiche a questo tipo di approccio ai problemi della cosmologia. Esse si possono così brevemente riassumere: a) i modelli a molti universi sono basati su estrapolazioni estreme delle leggi fisiche, in particolare delle proprietà quantistiche dei campi, non ancora verificabili sperimentalmente; b) gli altri universi non possono essere sperimentalmente osservati (è impossibile quindi il fondamentale paragone con i risultati osservativi e sperimentali); c) metodologicamente si pone una indebita barriera all’indagine scientifica poiché, se le proprietà del nostro universo sono frutto del caso, allora non ha senso investigarle ulteriormente per comprenderne l’origine. 157 Esiste nella storia della cosmologia moderna un interessante precedente che dimostra come l’introduzione di una spiegazione basata su un evento casuale sia limitativa e si ritorca contro il progresso della conoscenza. Si tratta dell’osservazione, già nota a partire dagli anni ‘50, che la velocità di espansione dell’universo è calibrata in modo molto preciso per consentire lo sviluppo di strutture complesse come le galassie, le stelle, i pianeti e i viventi (v. § 2.4). Alcuni ricercatori proposero che tale fatto fosse di natura casuale, poiché se non si fosse verificato noi non saremmo qui a porre la domanda, e molti scienziati aderirono a tale posizione ritenendola ragionevole. Fu solo agli inizi degli anni ‘80 che Alan Guth e collaboratori svilupparono i primi inflationary cosmological models che permettevano di spiegare tale proprietà senza far ricorso al caso, ma a partire da leggi fisiche deterministiche, anche se ancora in attesa di una completa verifica sperimentale. In conseguenza di questo fatto, l’opinione della maggioranza dei cosmologi cambiò, e si riconobbe che era stato un grave errore l’avere introdotto una spiegazione basata sulla casualità poiché essa aveva precluso per decenni l’investigazione su una questione fondamentale. Allo stesso modo nella cosmologia moderna è di fondamentale importanza mantenere vive le questioni ancora aperte cui ho prima fatto cenno. Le nuove teorie fisiche che puntano alla unificazione delle forze fondamentali della natura potrebbero aprire una nuova prospettiva, consentendo di dedurre il valore delle costanti di natura e delle condizioni iniziali a partire da principi più generali. Occorre comunque tenere presente il carattere specifico e contingente delle leggi fisiche e i limiti intrinseci dell’approccio ipotetico-deduttivo su cui si basano le nostre teorie, riconosciuto dai matematici e dai fisici teorici proprio nel corso del XX secolo. Ciò implica che le teorie e i modelli che la scienza può sviluppare non potranno mai esaurire la comprensione della realtà fisica. 5. CONCLUSIONI: LA CATEGORIA DELLE POSSIBILITÀ E LA RICERCA SCIENTIFICA La riflessione sul metodo scientifico e la storia della scienza moderna ci rivelano come la ricerca scientifica deve sempre essere dominata dalla categoria della possibilità e dalla concezione della ragione come energia conoscitiva che non può ritenersi soddisfatta finché non ha tenuto conto di tutti i fattori della realtà. Nel considerare quindi le acquisizioni della cosmologia moderna, bisogna sempre ricordare che la realtà dell’Universo è più grande di ciò che noi 158 conosciamo. Tutte le volte che l’uomo ha preteso di affermare che il confine del cosmo era stato raggiunto, si è trovato di lì a poco smentito da nuove scoperte. In questo senso, al di là degli errori metodologici commessi da alcuni cosmologi nelle loro speculazioni, la possibilità che l’Universo sia infinito o che esistano altri universi non può essere esclusa a priori. In effetti il grande storico della scienza Pierre Duhem ha posto come inizio della scienza moderna proprio l’affermazione di tale possibilità da parte del vescovo di Parigi, Étienne Tempier, nel 1277. Contro la concezione aristotelica che vedeva nella ragione la misura del reale e che pretendeva di dedurre e imporre l’unicità dell’universo, il vescovo ribadiva la fondamentale importanza della categoria della possibilità nella ricerca della verità e la libertà ultima della sorgente misteriosa della realtà, non sottoposta alle limitazioni che pretendeva di imporle la filosofia umana. La questione del significato ultimo dell’esistenza e della struttura dell’Universo non può dunque essere affrontata solo con mezzi scientifici, e tuttavia l’importanza della questione è tale da non poter essere elusa. Un’ipotesi di risposta deve dunque partire da una valorizzazione di altri metodi conoscitivi e di ogni aspetto della realtà, di tutti i dati così come ci si presentano. Su questa posizione è il grande cosmologo John Wheeler, che nella prefazione al trattato di Barrow e Tipler, così esordiva: «Consideriamo un Universo per sempre privo di vita?» – «Naturalmente no!», avrebbe risposto un antico filosofo, aggiungendo, mentre si allontanava, declinando di considerare una tale questione: «Non ha senso parlare di un Universo, a meno che non ci sia qualcuno in esso a parlarne». Un tale rifiuto dell’idea di un Universo privo di vita non risulta così semplice dopo Copernico. Egli detronizzò l’uomo dal suo posto centrale nell’ordine delle cose. Il suo modello del moto dei pianeti e della Terra ci ha insegnato a guardare il mondo alla stregua di una macchina. Da quell’inizio è scaturita una scienza che sembra non avere alcun posto particolare da assegnare all’uomo, alla mente e alla domanda sul significato. L’uomo? Pura biochimica! La mente? una memoria riproducibile mediante circuiti elettronici! Il significato? Perché chiedersi qualcosa di così intangibile e complicato! «Sire» – qualcuno oggi potrebbe dire parafrasando la famosa risposta di Laplace a Napoleone – «Io non ho alcun bisogno di tale concetto». Che cosa è l’uomo perché l’Universo si debba curare di lui? I telescopi raccolgono la luce di lontanissime sorgenti quasi-stellari 159 che sono esistite miliardi di anni prima della comparsa della vita sulla Terra, addirittura ancor prima che ci fosse la Terra [...]. Un termometro e l’abbondanza relativa degli elementi più leggeri che oggi misuriamo ci danno informazioni sulla correlazione fra la densità e la temperatura dell’Universo durante i suoi primi tre minuti. Condizioni ancora più violente ed estreme apprendiamo dallo studio della fisica delle particelle elementari. Nella prospettiva di tali violenze della materia e dei campi di forze, di questi valori estremi di temperatura e di pressione, di queste estensioni di spazio e di tempo, non è l’uomo una trascurabile particella di polvere su un pianeta insignificante, in una insignificante galassia, in una insignificante regione perduta nell’immensità dello spazio? No! L’antico filosofo aveva ragione! La questione del significato è importante, è addirittura centrale. Non è che l’uomo si sia appena adattato all’Universo. L’Universo è adatto alla vita dell’uomo. Immaginiamo un Universo in cui l’una o l’altra delle costanti fondamentali della fisica sia modificata in più o meno di pochi punti percentuali. L’uomo non sarebbe mai potuto apparire in un Universo siffatto. Questo è il punto centrale del Principio antropico. Secondo tale principio, un fattore che produce la vita sta al centro dell’intera macchina e dello schema del mondo. Qual è l’attuale condizione ed il ruolo del Principio antropico? Si tratta di un teorema? No. Si tratta di una mera tautologia, equivalente all’affermazione banale «L’Universo deve essere tale da permettere lo sviluppo della vita, da qualche parte, in una qualche fase della sua evoluzione, perché noi siamo qui»? No. È una proposizione che possa essere sottoposta a verifica sperimentale? Forse. [...]. Nel processo di sviluppo di un nuovo settore di ricerca fino al punto in cui esso diviene una parte ben stabilita e definita della scienza, è spesso più difficile porre le domande giuste piuttosto che trovare le risposte giuste, e in nessun altro caso questo risulta così cruciale come nel trattare del Principio antropico. Soprattutto risulta necessario un retto modo di giudicare, giudicare nel senso in cui lo intendeva George Graves: «Una consapevolezza di tutti i fattori in gioco nella situazione e una corretta valutazione della loro importanza relativa». Ripercorrendo la storia della ricerca recente in cosmologia e in astronomia, rimaniamo umanamente stupiti nel constatare come l’Universo intero cooperi alla nostra esistenza: le stelle che vediamo in una notte serena stanno lavorando per noi, sintetizzando gli elementi chimici che serviranno alla formazione di nuovi pianeti ed allo sviluppo dell’attività biologica su di essi. Contemplando anche solo 160 quel poco che conosciamo dell’Universo intorno a noi, credo non si possa evitare la riflessione del fisico teorico Freeman Dyson: Quando osserviamo l’Universo e identifichiamo le tante coincidenze fisiche ed astronomiche che hanno lavorato a nostro beneficio, sembra quasi che l’Universo avesse saputo che noi stavamo per arrivare. 6. NOTA BIBLIOGRAFICA In quest’ultima sezione sono indicati alcuni riferimenti che permettono di approfondire i concetti e i temi prima accennati. Si tratta per la maggior parte di opere a livello divulgativo. Non sempre si tratta di testi in Italiano, dato che ormai la maggior parte della divulgazione scientifica si pubblica in Inglese. Si tratta comunque di testi che ogni biblioteca specialistica dovrebbe avere o poter reperire. 1. Una descrizione dei fondamentali risultati osservati su cui si basa la cosmologia del XX secolo si può trovare in ogni buon testo generale di introduzione all’Astronomia (vedi, per es., H. L. Shipman, 1984, Introduzione all’Astronomia, Zanichelli, Bologna; J. Hermann, 1992, Atlante di Astronomia, Sperling & Kupfer, Milano). Si veda anche: D. W. Sciama, 1973, Cosmologia moderna, E.S.T. Mondadori, Milano. Questi testi sono accessibili anche a chi non ha conoscenze specifiche di Fisica e di Matematica. D’altra parte, un testo recente che introduce gli aspetti tecnici della Cosmologia per chi ha approfondite conoscenze di Fisica a livello universitario, è: A. Braccesi, 2000, Dalle stelle all’Universo, Zanichelli, Bologna. 2. Informazioni sugli ultimi sviluppi in Cosmologia si possono trovare in testi divulgativi recentemente pubblicati come: B. Green, 2000, L’Universo elegante, Einaudi, Torino; L. Amendola, 2000, Il cielo infinito, Sperling & Kupfer, Milano. Un aggiornamento sulle ricerche correnti a livello divulgativo si può trovare anche nei seguenti articoli: a) C. Lamberti, 1998, Universo: un’esplosione senza fine, L’Astronomia n. 191, p. 6. b) C. J. Hogan, R.P. Kirshner, N.B. Suntzeff, 1999, Il mistero delle supernovae lontane, Le Scienze, marzo 1999, n. 367, p. 40. c) L.M. Krauss, 1999, L’antigravità cosmologica, Le Scienze, marzo 1999, n. 367, p. 47. d) M.A. Bucher, D.N. Spergel, 1999, Inflazione in un Universo a bassa densità, Le Scienze, marzo 1999, n. 367, p. 55. 161 e) C. Lamberti, 2000, Il Boomerang conferma il Big Bang con Inflazione, L’Astronomia, n. 210, p. 4. f) R.R. Caldwell, M. Kamionkowski, 2001, Echoes from the Big Bang, Scientific American, January 2001, p. 28. g) J.P. Ostriker, P.J. Steinhardt, 2001, The Quintessential Universe, Scientific American, January 2001, p. 37. Esistono anche siti Internet con notizie ed aggiornamenti sulla Cosmologia. Uno dei più interessanti è all’indirizzo: http://www.atro.ucla.edu/%7Ewright/cosmolog.htm Esso contiene anche una interessante introduzione alla Cosmologia di cui esiste una versione italiana (sebbene meno ricca ed aggiornata dell’originale) all’indirizzo: http://www.vialattea.net/cosmo/ Per quanto riguarda la radiazione cosmica di fondo e le sue fondamentali proprietà si veda anche il sito Internet: http:// background.uchicago.edu/ Le missioni Planck e MAP (Microware Anisotropy Probe) hanno i loro rispettivi siti Internet agli indirizzi: http://astro.estec.esa.nl/SA-general/Projects/Planck http://map.gsfc.nasa.gov Il testo di riferimento per gli aspetti relativi alle proprietà antropiche dell’Universo è: J.D. Barrow, F.J. Tipler, 1986, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press, Oxford. Vedasi anche: F. Bertola, U. Curi (a cura di), 1993, The Anthropic Principle, Cambridge University Press, Cambridge, dove sono trattati anche alcuni aspetti che interessano la riflessione filosofica e teologica. 3. Una breve e autorevole discussione critica dei più recenti modelli cosmologici si può trovare in: P.J.E. Peebles, 2001, Making Sense of Modern Cosmology, Scientific American, January 2001, p. 44. È anche interessante leggere le considerazioni di Sir Martin Rees, uno dei maggiori astronomi contemporanei, pubblicate in: M. Rees, 1999, Esplorare il nostro e altri universi, Le Scienze, dicembre 1999, n. 376, p. 58. 4. Una introduzione divulgativa ai modelli proposti da Linde è stata recentemente pubblicata dall’autore stesso: A. Linde, 1995, Un Universo inflazionario che si autoriproduce, Le Scienze, gennaio 1995, n. 317, p. 26. 5. Una presentazione delle basi metodologiche e delle linee principali di sviluppo delle scienze fisiche moderne si può trovare in: F.T. Arecchi, I. Arecchi, 1990, I simboli e la realtà, Jaca Book, Milano. 162 Sono anche di notevole interesse le considerazioni di Feyerabend sul ruolo della scienza nella cultura moderna, in P.K. Feyerabend, 1987, Galileo e la tirannia della verità, L’Astronomia, n. 71, p. 28. Una discussione elementare delle limitazioni dell’approccio basato sul metodo scientifico nella cosmologia moderna si può trovare nell’intervento di J.D. Barrow in L’uomo, i limiti, le speranze, a cura di G. Giorello e E. Sindoni, Piemme, 1998, p. 105; si noti la prospettiva neo-empirista, che caratterizza la posizione di Barrow, e la sottolineatura dei limiti intrinseci del metodo ipotetico-deduttivo su cui si basano le teorie fisiche. Questi ultimi costituiscono un campo di ricerca estremamente interessante, e sono discussi, tra l’altro, nel saggio: D.J. Barrow, 1988, The World within the World, Oxford University Press, Oxford. Un’introduzione alla figura di Gödel e al ruolo del suo teorema nell’ambito della matematica si può trovare in: J.W. Dawson, Jr., 1999, Gödel e i limiti della logica, Le Scienze, ottobre 1999, n. 374, p. 88. Il pronunciamento del vescovo di Parigi sulla pluralità dei mondi possibili è presentato e discusso, tra gli altri, da: E. Grant, 1974, A Source Book in Medieval Science, Harvard University Press, Harvard, p. 45. Si veda anche: M.J. Crowe, 1986, The Extraterrestrial Life Debate 1750-1900, Cambridge University Press, Cambridge, Ch. 1. Le considerazioni di Wheeler compaiono nella prefazione del trattato di Barrow e Tipler, The Anthropic Cosmological Principle. La citazione di Dyson è tratta da: R. Breuer, 1991, The Anthropic Principle, Birkhäuser, Boston, p. VI. Ringraziamenti: Sono grato al Dr. Vincenzo Antonuccio De Logu dell’Osservatorio Astrofisico di Catania per l’aiuto a reperire le più recenti immagini che ho presentato nel corso di questa conferenza e per le interessanti discussioni su alcuni aspetti della cosmologia moderna. 163 164 LA VALORIZZAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI DELLA CHIESA NELLA DIOCESI DI NOLA BILANCI E PROSPETTIVE GIUSEPPE MOLLO E ANTONIA SOLPIETRO * O Dei proles genitrixque rerum, Vinculum mundi,stabilisque nexus, gemma terrenis, speculum caducis, Lucifer orbis. Pax, amor,virtus,regimen,potestas, ordo,lex,finis,via,dux,origo, vita, lux, splendor, species, figura, Regula mundi. (Alanus ab Insulis (1128c.-1202), De Planctu naturae, ed. N. Häring, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo,1978, p. 831.) E’ una piacevole novità assistere ormai da qualche anno ad una particolare premura per i problemi inerenti la conservazione dei beni culturali ecclesiastici. Basti qui ricordare i quattro Corsi per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali della Chiesa attivati dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di questo Seminario e il III Convegno Regionale di Liturgia promosso dalla Conferenza Episcopale Campana su “Gli spazi della celebrazione liturgica” che nel 1995 vide protagonista la nostra diocesi favorendo il dibattito sugli innumerevoli problemi connessi con questo tema, e coinvolgendo quanti hanno responsabilità di committenza, di progettazione, di esecuzione e di fruizione degli edifici di culto. A tal proposito giova ricordare quanto disse S. E. Mons. Garlato al Convegno di Milano (4-7 maggio 1987) imperniato sul tema “La Chiesa Italiana per i beni culturali”: “I beni culturali ai quali la Chiesa ha dato origine nel suo bimillenario cammino per le finalità che le sono proprie non possono né devono essere valutati secondo una lettura esclusivamente storicistica o estetica: in essi convergono * Relazione tenuta il 12 Febbraio 2002. 165 inseparabilmente componenti storiche, teologiche, iconografiche, ecclesiologiche, liturgiche e pastorali prescindendo dalle quali si finirebbe per penalizzare non solo la testimonianza religiosa in quanto tale, ma anche la storia e la civiltà stessa di un paese, di una regione, di una città, di un territorio insomma in cui tale testimonianza si è potuta realizzare”. Di contro corre l’obbligo di richiamare anche l’esortazione della Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium del 4 dicembre 1963: “I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e lo sviluppo dell’Arte Sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere d’Arte Sacra, in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e offrire opportuni consigli agli artisti nella realizzazione delle loro opere”. Riportiamo altresì quanto affermava, nel 1990, nell’introduzione al lavoro Domine Servavi Decorem Domus Tuae, Mons. Franco Strazzullo responsabile per l’Arte Sacra della Diocesi napoletana : “Se in tutti i Seminari d’Italia,…, si fosse insegnato anche Arte Sacra, non staremmo a lamentare tanti scempi perpetrati ai danni delle antiche chiese e la mediocre produzione artistica di chiese nuove costruite e decorate in questo ultimo quarto di secolo”. Perché si chiedeva, e ci chiediamo, tanta insensibilità, eppure nelle Norme per la tutela del patrimonio storico artistico della chiesa in Italia, deliberate dalla X Assemblea generale della CEI il 14 giugno 1974 e ribadite nelle intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 (articolo 19 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352.) sono messi in evidenza “i valori storici e teologici delle opere d’arte” e opportunamente si esalta l’aspetto teologico-pastorale dell’Arte Sacra: “La storia dell’Arte Sacra, in ogni tempo, testimonia la teologia della fede, il rapporto tra vita e religione, l’adesione dell’umano al divino, sempre con riferimento a Dio, mediante il Cristo vivente nella Chiesa”. A seguito dell’Intesa del 13 settembre 1996 tra il Presidente della C.E.I. card. Camillo Ruini ed il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, On. Walter Veltroni, si è rafforzata l’opera di tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali ecclesiastici. La stessa Intesa disciplina, altresì, i rapporti intercorrenti tra le Diocesi e gli Enti pubblici: Comuni, Province, Regioni e Soprintendenze. 166 Ancora oggi, purtroppo, l’antico si vende arbitrariamente, e il più becero artigianato è messo al servizio del culto. Anche il Santo Padre nel Discorso rivolto agli artisti nell’aprile del 1999, ha sottolineato l’importanza di conservare gelosamente il patrimonio artistico. Prima di rimuovere un altare, una balaustra, un tabernacolo, un fonte battesimale, un antico pavimento maiolicato, magari consunto dal tempo, non è forse opportuno consultare i competenti uffici diocesani? Nell’attuale fase di decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni, le Consulte costituite dai delegati delle singole diocesi e da autorevoli giuristi, tuteleranno gli interessi della Chiesa nella difesa, gestione e protezione dei suoi beni culturali, promuoveranno e coordineranno convegni di studio, l’organizzazione di un catalogo del patrimonio storico-artistico degli Enti Ecclesiastici ed il restauro delle opere d’arte. Ammessa l’urgenza di salvare un patrimonio culturale nel quale le Comunità ecclesiali riconoscono gli elementi più originali delle loro identità storiche, è già stato avviato un discorso puntuale e scientifico nel più aperto spirito di collaborazione con le Soprintendenze e la Regione affinché si salvaguardino, non solo l’entità, ma lo stesso valore spirituale, oltre che artistico, dei beni culturali ecclesiastici. Presenza e impegno nel rispetto del diritto di proprietà che da secoli vanta la Chiesa cattolica sul suo patrimonio di beni culturali, che rappresentano tanta parte della storia e della civiltà delle nostre comunità locali. LA TUTELA: UNA RIFLESSIONE SUI PROBLEMI L’esame che abbiamo tentato di fare per quanto parziale e superficiale, vuole dare l’idea della eccezionale varietà e ricchezza di questo patrimonio culturale. Esso però, non sarebbe completo se non accennassimo ai problemi enormi della conservazione e tutela che comporta una così vasta ed eterogenea quantità di beni. I motivi della conservazione dei beni culturali della chiesa sono ben comprensibili. Le gravi distruzioni e dispersioni degli ultimi decenni sono conseguenza della tumultuosa e, spesso, disordinata crescita delle nostre città: si pensi agli effetti legati alla smobilitazione della struttura parrocchiale più periferica, ai furti nei luoghi incustoditi, alle alienazioni abusive, ai guasti dell’antiquariato di rapina, che sono riuscite ad 167 intaccare la consistenza di questo immenso patrimonio. Il patrimonio storico della chiesa è, soprattutto, insidiato dai grandi mutamenti socio-economici e culturali che hanno investito e investono costantemente il nostro territorio e le nostre città. Il declino numerico del clero, soprattutto regolare, costringe alla chiusura totale o parziale di imponenti edifici, mentre, il mutare del costume religioso ha decretato già da tempo la morte di quella rete fittissima di cappelle private, di oratori pubblici, di confraternite laicali, che, se sopravvivono ancora, come struttura edilizia nel territorio ed in ogni strada dei centri storici, sono ormai ridotti, tranne poche eccezioni, a gusci vuoti, privi di officiatura, costantemente chiusi, con la suppellettile in rovina, quando non alienata o dispersa. Se si considera poi, che la riforma liturgica (Concilio Vaticano II, 1962-1965), non di rado interpretata e applicata in maniera radicale e frettolosa, ha provocato il disuso e quindi il rapido degrado di molti arredi sacri, insieme a modifiche strutturali spesso rovinose all’interno di chiese e complessi ecclesiastici Ma in concreto che cosa è possibile fare per impedire o almeno attenuare gli effetti più gravi dei fenomeni prima individuati? Pur consapevoli che fra i costi della civiltà moderna c’è quello di una inevitabile dispersione delle testimonianze del nostro passato, anche religioso, possiamo indicare che le strade che si stanno percorrendo, ancora, con insufficiente disponibilità di uomini e mezzi, ma con convinzione e sempre crescente armonia di metodi e intenti fra autorità ecclesiastiche e uffici della tutela, sono sostanzialmente due. Innanzi tutto il catalogo scientifico dei beni, e non sarà inutile ricordare che gli arredi storici delle chiese sono sottoposti alla vigente Legge di tutela (Decreto Legislativo N. 490 del 1999 - Testo Unico). In secondo luogo la musealizzazione di quella parte, ed è vastissima, del patrimonio che non può essere più conservato “in situ” per comprensibili ragioni di tutela e di sicurezza dei luoghi di origine. Le recenti Carte del Restauro propongono che i metodi di intervento siano quelli del moderno restauro scientifico a fondamento storico-critico, che garantisce insieme alla difesa del bene culturale, il suo inserimento nella vita attuale, senza che si adottino pericolose scorciatoie o semplificazioni operative, celate alle volte sotto l’equivoca dizione di recupero. Accanto ad un intervento filologicamente rigoroso, che richiede perizia e competenza tecnica dei progettisti, bisogna leggere quelle matrici storico-religiose, che hanno determinato la nascita di “un’architettura sacra”. 168 Ci pare che, in questo settore, sia necessario un grosso sforzo culturale e che la strada da percorrere sia ancora lunga. Infatti se ci mettiamo nel giusto punto di vista dobbiamo riconoscere validità a una sorta di mutamento deontologico: dal restauro come teoria estetica e scienza storica, alla conservazione come scienza e tecnica della prevenzione e della manutenzione. LA NECESSITÀ DELLA CATALOGAZIONE La sbalorditiva capacità di ogni cellula religiosa di trascinare davanti ai nostri occhi oggetti e memorie di ogni materia, giustifica, ancora oggi, il fervore delle accuse rivolte ai naturali amministratori del patrimonio delle chiese, così come ad un governo politico e amministrativo che a più di cento anni dall’unità nazionale, non ha condotto quell’opera di ricognizione del patrimonio che oggi ci appare, nonostante sporadici episodi, come una lontana chimera. Affreschi, stucchi, sculture, metalli, vetri, legni, tarsie, intagli, decorazioni, dipinti d’ogni forma e misura,incorporati nello spazio sacro, sono elementi di lettura delle vicende storico – culturali e religiose di un edificio di culto. Una volta che una corretta anagrafe del patrimonio ecclesiastico fosse solidamente costituita, certamente, sarebbero anche minori, le preoccupazioni nei riguardi del trasferimento di oggetti dal loro luogo di origine, nei depositi. Non si deve mai dimenticare, che un filo soltanto, assicura l’opera alla sua origine culturale, e cioè, la persistenza locale dell’oggetto attraverso la trama contestuale del patrimonio artistico circostante. In questo senso una sollecita carta delle aree culturali è obbligo irrinunciabile e prioritario. La catalogazione consentirebbe, anche, alle comunità una più attenta considerazione verso la stessa entità estetica, oltre che quella più intima di natura sacra e liturgica, a difesa della sua conservazione. Ciò contribuirebbe a porre un riparo all’abuso e alla dilagante scorreria dei ladri. A promuovere la tutela e la conservazione del patrimonio mobile delle nostre chiese, vi è la citata Intesa del 1996, che ha previsto l’inventario informatizzato, secondo precisi parametri, in accordo con l’I.C.C.D. (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione). 169 LA CONSERVAZIONE COME DISCIPLINA GLOBALE Da tempo, le metodologie, l’azione conservativa hanno abbandonato ogni criterio monoliticamente qualitativo, per abbracciare, invece, un criterio più largamente integrativo, nella certezza che una selezione forzata del patrimonio, qual è quella, che discende dall’uso del giudizio di qualità formale, danneggi irreparabilmente la mirabile complessità del patrimonio stesso. Anche un oggetto minore, infatti, specie se preservato nel contesto che l’ha visto nascere, detiene una capacità di informazione generale e specifica assolutamente insostituibile, e non soltanto ai fini della storia dell’arte, ma pure e soprattutto ai fini di un corretto processo ricostruttivo dell’importanza dell’azione della Chiesa presso le popolazioni che ebbero ad esprimerlo e crearlo. La conservazione come disciplina globale porta, naturalmente, in primo piano, anche, il problema della conservazione degli edifici di culto. Di questa constatazione sono o dovrebbero esserlo interpreti gli ingegneri, gli architetti e gli urbanisti che specie in questi ultimi anni, si sono applicati ad opportune ricerche in ambito di pianificazione territoriale. Essi, ben conoscono, infatti, l’importanza che nella vicenda tanto dei centri storici, quanto del rapporto tra città e territorio assumono le strutture architettoniche di culto, il reticolo parrocchiale, gli spazi sacri, il secolare taglio territoriale della diocesi. Non si sbaglia nel ritenere la parrocchia come l’ultima trincea di un antico assetto territoriale di eccezionale equilibrio sociale, economico e culturale. L’adozione di una “griglia diocesana” nel vasto disegno comprensoriale, potrebbe consentire l’acquisizione di elementi preziosi sotto il profilo della storia delle arti. Sarà dunque, auspicabile che opportuni studi determinino, per tempo, le reali necessità e le virtuali possibilità di nuovi musei: conducendo, in tal modo, alla definizione di un vero standard museografico, verificando la possibilità di numerose vocazioni museografiche che domani potrebbero rivelarsi come un nuovo contributo alla depauperazione delle zone più emarginate. Non deve sfuggire, infatti, come negli ultimi anni si stia toccando il punto più basso di una involuzione che vede degrado, furti e abusi, circondare l’intero nostro patrimonio territoriale, che è per eccellenza patrimonio ecclesiastico. Può dunque, sembrare spontaneo, il ricorso a musei diocesani come istituti di tutela e raccolta. Un edificio può domani ritornare a nuova vita: l’azione congiunta della 170 Chiesa, dello Stato e degli enti locali, può consentire alla comunità una più sicura conservazione del patrimonio. Infatti, ogni moderna disciplina conservativa, non intende fare dell’oggetto conservato una vitrea ostentazione di feticismo storicistico, quanto piuttosto, inserire l’oggetto stesso in una realtà più legata e complessa, completa, dunque, come esperienza storica e quindi vitale. IL PROBLEMA DEL PATRIMONIO CULTURALE ECCLESIASTICO: CONOSCENZA REALE PER UNA PROGRAMMAZIONE DIFFICILE Mentre, in gran parte, degli edifici laici, pubblici e privati, gli oggetti di decorazione e d’uso sono stati sostituiti o distrutti, alienati e dispersi, con ritmo continuo e per le occasioni più varie (esigenze del gusto e della moda, mutamenti economici e politici, vicende patrimoniali, divisioni ereditarie, continua evoluzione dei sistemi abitativi, delle tecniche e dei metodi di produzione, ecc.), nei luoghi di culto, per l’assenza o la minore incidenza di queste motivazioni, tale fenomeno è stato più lento e le sue conseguenze assai meno radicali. Non c’è, si può dire, chiesa, per quanto rinnovata, che non abbia trasmesso fino ai giorni nostri qualche documento del suo primitivo stato, sia esso una scultura o un’oreficeria, una lastra tombale o una lapide; oggetti giunti sino a noi per esigenze devote, per scrupolo documentario o, semplicemente, per pura inerzia conservativa. All’eccezionale sopravvivenza quantitativa della suppellettile sacra corrisponde, poi, una altrettanto eccezionale funzione culturale. C’è da dire, infine, che l’arredo sacro delle nostre chiese è espressione dell’arte religiosa dell’Occidente cattolico e consente una straordinaria pluralità di conoscenze della storia politica, sociale, economica, religiosa e culturale del territorio di pertinenza diocesana. Di fronte alle necessità di possedere maggiori informazioni, circa il problema reale delle chiese e delle loro condizioni, sarebbe di grande utilità spedire a tutti i parroci un questionario contenente una nutrita serie di domande. Le risposte costituirebbero una prima base per una sommaria valutazione del problema, al fine di identificare modelli di comportamento per una futura programmazione degli interventi. E’ fondamentale la pubblicazione sul Bollettino Diocesano dei documenti riguardanti i beni culturali ecclesiastici, per far conoscere e divulgare ai religiosi, quali sono le indicazioni, gli uffici e le persone competenti ad agire su tali beni. 171 LE COMPETENZE Il problema delle competenze e del rispetto di esse, non è la parola vana della lingua burocratica, ma l’esatta constatazione della profondità dei livelli, della necessaria preparazione tecnica e scientifica. Il lavoro conservativo, di questi tempi e di fronte a simili impegni, esige un confronto tanto di metodo quanto di prassi. Ogni chiesa progettata, costruita, ornata, è un frutto molto complesso della nostra cultura e, non soltanto, di quella più larga e vasta cultura, che si annoda attorno ai grandi centri ecumenici del potere, ma anche, dell’infinita cultura dei luoghi che rende tanto nobile l’arte italiana, variabili e mutevoli le sue espressioni. La scelta di questo incontro che vorrebbe costruire un progetto di comportamento, è quella che si indirizza a cercare di recuperare la chiesa, il suo corpo intriso di contenuti diversi, le sue opere di cultura e arte, entro un più generale e comprensivo recupero urbanistico e territoriale, così che esse possano ritrovare la dimensione più giusta e più originaria in quella nozione di contesto e di rapporto che per secoli le ha sorrette. Per dirla con Emiliani “ Le chiese (…) sono fuochi di frequenza immensamente presente, di dignità altissima; apparizioni molteplici per materia, forma e finalità, accumuli giganteschi di lavoro e di storia del lavoro, coaguli di pietà individua e collettiva, segnali di devozione ma anche di elevatissima norma estetica. (…). In queste navate, sotto queste volte, fu figurata e narrata la nuova terra promessa, consolazione per i deboli, illustrazione per i potenti, messaggio sempre di altissima dignità culturale ed artistica. Occorre ripercorrere questo lungo, lunghissimo viaggio.” [A. EMILIANI (a cura di), Chiesa città campagna. Il patrimonio artistico e storico della Chiesa e l’organizzazione del territorio, Bologna 1981, pp. 11-14]. UN ESEMPIO: IL MUSEO DIOCESANO DI NOLA Il Museo Diocesano di Nola inaugurato l’11 marzo 2000 da mons. Beniamino Depalma è concepito come realtà integrata e diffusa sul territorio. La finalità del progetto di allestimento e di organizzazione degli spazi museali è ispirata ad una nuova forma di accostamento 172 alle opere d’arte, non più raccolte in un unico contenitore, snaturate dal loro contesto di origine, ma visibili nei propri luoghi di culto che si caratterizzano come strutture museali organizzate e decentrate sul territorio diocesano. Il percorso si articola in due itinerari: il primo si svolge intorno all’insula del duomo e raggiunge i maggiori monumenti sacri del centro cittadino; il secondo percorso ruota intorno all’erigendo Museo del Seminario, toccando gli antichi conventi siti sulle colline circostanti la città. Il nucleo espositivo del Museo Diocesano è ospitato negli spazi adiacenti alla cattedrale: le strutture della trecentesca chiesa di S. Giovanni Battista, la cinquecentesca cappella dell’Immacolata e gli antichi ambienti dell’Episcopio concorrono con le collezioni di diversa natura a rappresentare la millenaria storia della Diocesi nolana. Le sale sono dedicate all’esposizione di preziosi argenti, di eleganti paramenti, di opere scultoree in marmo e legno, nonché di dipinti dal XV al XVIII secolo. Interessante la sezione documentaria e libraria, parte del patrimonio dell’attiguo Archivio Storico Diocesano. Il Museo ospita periodicamente mostre tematiche allestite nella sala dei Medaglioni, così denominata per i ritratti dei vescovi nolani dipinti nei tondi delle pareti. 173 DOCUMENTI Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione su la sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 4 dec. 1963 Discorso agli artisti di Martini C.M., Voi artisti siete un tramite attraverso cui il divino parla, in “Rivista Diocesana Milanese” Milano, 3, (1983) Conferenza Episcopale Italiana, Commissione episcopale per la Liturgia, La Progettazione di Nuove Chiese. Nota pastorale, Quaderni “ La vita in Cristo e nella Chiesa” Documenti 1, Roma 1993. Conferenza Episcopale Italiana, Orientamenti: I beni culturali della chiesa in Italia, n.25, Edizioni Dehoniane, Bologna 1993. Commissione Episcopale per la Liturgia della CEI, Nota pastorale: L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, n.57, Edizioni Dehoniane, Bologna 1996. Conferenza Episcopale Campana, Commissione per la Liturgia, Gli Spazi della celebrazione liturgica, III° Convegno regionale di Liturgia, Nola 13-14 ottobre 1995, Napoli 1997. Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Necessità ed urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei Beni Culturali della Chiesa, Città del Vaticano, 8 dicembre 1999. Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, da “L’Osservatore Romano” sabato 24 aprile 1999, stampato da L.E.R. Napoli – Roma 1999. Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, La funzione pastorale dei Musei Ecclesiastici, Città del Vaticano, 15 agosto 2001. Quaderni della Segreteria Generale CEI, Notiziario dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali, Anno II, n.3, Gennaio 1998 Quaderni della Segreteria Generale CEI, Notiziario dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali, Anno III, n.4, Aprile 1999 Quaderni della Segreteria Generale CEI, Notiziario dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali, Anno III, n.9, Aprile 1999 Quaderni della Segreteria Generale CEI, Notiziario dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali, Anno IV, n.5, Gennaio 2000 Quaderni della Segreteria Generale CEI, Notiziario dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali, Anno IV, n.6, Dicembre 2000 Intesa Programmatica tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, Napoli 13 maggio 2002. 174 BIBLIOGRAFIA AA.VV., L’architettura sacra oggi, Atti del congresso internazionale di Perugia, 1989. AA.VV., Arte e Liturgia. L’arte sacra a trent’anni dal Concilio, Edizioni San Paolo, Torino 1993. AA.VV., Architettura e spazio sacro nella modernità, Catalogo della mostra, Biennale di Venezia 1992, Editrice Abitare Segesta, Milano 1992. AA.VV., Concorsi per nuovi complessi parrocchiali nelle diocesi di Milano, Perugia e Lecce. 1998-1999, 22 Progetti per Nuove Chiese commissionati dalla Conferenza Episcopale Italiana, Electa, Milano 1999. AA.VV., Concorsi per nuovi complessi parrocchiali nelle diocesi di Modena - Nonantola, Foligno e Catanzaro - Squillace, 2000-2001, 24 Progetti per Nuove Chiese commissionati dalla Conferenza Episcopale Italiana, Electa, Milano 2001. AA.VV., Segni del Novecento. Architettura e arti per la liturgia in Italia, Catalogo della mostra fotografica itinerante, Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna (VR) 2001. AMARI G., GATTI G., CENI G., FABBRETTI N., GRESLERI G., NONNIS P.G., PIAZZI A., RUGGERI C., Progettare lo spazio del sacro (le giornate dell’arte sacra 1988-1989 - Marmocchine S. Ambrogio di Volpicelli Verona). Percorso iconografico Glauco Gresleri, Ente Fiere di Verona, Verona. Beni Culturali nelle Chiese. Suggerimenti per la buona conservazione (a cura di Maria Teresa Binaghi Olivari), vol. I, Beni artistici e storici, Curia Arcivescovile di Milano, Milano 1992. BOUYER L., Architettura e Liturgia, Edizioni Qiqajon Comunità di Bose, Magnano (VC) 1994. CHENIS C., Fondamenti teorici dell’arte sacra. Magistero post-conciliare, Las, Roma 1991. GRASSO G., Tra teologia e architettura, Edizioni Borla, Roma 1988. GRASSO G.,Chiesa e Arte. Documenti della Chiesa testi canonici e commenti, Edizioni San Paolo, Torino 2001. Luce e Chiese, (a cura della Reggiani S.p.a. Illuminazione), Sovico (MI) 1998. JOHNSON C., JOHNSON S., Progetto Liturgico, Guida pratica liturgica al riadattamento delle chiese, CLV Edizioni Liturgiche, Roma 1992. KIDDER SMITH G. E., Nuove chiese in Europa, Edizioni Comunità, Milano 1964. 175 MIARI E.G., MARIANI P., I musei religiosi in Italia, R. Viola Editore, Roma 2001. NAPOLITANO E., L’arte sacra immagine dell’invisibile, in “Teologia e Vita”, N. 5. Quaderni dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Duns Scoto”, Nola, LER, Marigliano 1999. PONTI G., Amate l’architettura, Editore Vitali e Ghianda, Genova 1957 SANTI G., Il luogo della celebrazione del sacramento della penitenza, in “ Rivista di pastorale liturgica”, 5, (1979). SANTI G., I Beni Culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana, in “Arte Cristiana”, 69, (1980), 205. SCHMIDT H., La vita sacramentale nello spazio interno dell’edificio per il culto, in “Architettura e Liturgia” , (a cura di) P. Ciampani, Pro Civitate Christiana, Assisi 1965. SODI M., Gli spazi della celebrazione rituale, (a cura di) Facoltà Teologica di Sicilia, OR, Milano 1984. VALENZIANO D., Sei tesi per l’arte cristiana, in “Rivista Liturgica”, 1, (1996). VARALDO G., Arte sacra e sacra suppellettile, in AA.VV. “La Costituzione sulla sacra liturgia”, Torino, L.D.C., 1967. Vicariato di Roma, Concorso europeo 50 chiese per Roma 2000, Edizione l’Arca, 2000. 176 APPENDICE 1 L’INTESA C.E.I. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Il 13 settembre 1996 il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Camillo Ruini, e il Ministro per i beni culturali e ambientali, Onorevole Walter Veltroni, hanno firmato l’Intesa per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, prima attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 12 dell’Accordo 18 febbraio 1984. CONSULTA NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI CIRCOLARE N. 1 L’INTESA PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 13 settembre 1996 1. Contenuti 2. Primi adempimenti 3. Suggerimenti per facilitare l’avvio delle nuove procedure Allegati: 1) Suggerimenti per la costituzione dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali 2) Schema di statuto della Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali 3) Schema di statuto della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici Premessa Come è noto, il 13 settembre 1996 il Ministro per i beni Culturali e Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana hanno sottoscritto l’Intesa per la tutela dei beni culturali ecclesiastici (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 9, 20 novembre 1996, pp. 336347). Con la stipula dell’Intesa, come ebbe a dire il Cardinale Camillo Ruini in occasione della firma, «si consolida la già viva collaborazione tra Stato e Chiesa in questa materia, di grandissima importanza nel nostro paese, e 177 vengono poste le premesse perché tale collaborazione si sviluppi e si precisi ulteriormente in futuro». L’Intesa, frutto di una trattativa avviata nel 1987, costituisce il primo atto del processo normativo che dà attuazione all’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede. Essa, infatti, riguarda soltanto i primi due commi del n. 1 del citato articolo 12; si prevede che saranno stupulate altre intese, in particolare, in materia di archivi e di biblioteche ecclesiastiche. 1. I contenuti dell’Intesa Vengono illustrate, in sintesi, le disposizioni contenute nell’Intesa firmata il 13 settembre 1996 che precisa quali sono i soggetti chiamati a collaborare (art. 1), quali le forme e gli strumenti per attuare la collaborazione tra Chiesa e Stato (artt. 2-7), quali prospettive si aprono in vista di eventuali intese da stipulare tra gli enti ecclesiastici, le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali (art. 8). a) Quanto ai soggetti chiamati a collaborare, l’art. 1, n. 1 precisa che essi sono: a livello centrale, per parte statale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i Direttori generali degli Uffici centrali del Ministero da lui designati e, per parte ecclesiastica, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e le persone da lui eventualmente delegate. A livello locale, i Soprintendenti e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi. In relazione al patrimonio culturale di rispettiva competenza anche gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica concorrono con i soggetti ecclesiastici nella collaborazione con gli organi statali indicati a determinate condizioni (che, cioè, siano civilmente riconosciuti e si tratti di articolazioni a livello non iinferiore alla provincia religiosa) e secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede. Tali disposizioni sono attualmente in corso di definizione. b) L’Intesa prevede numerose forme e strumenti di collaborazione. * Nell’art. 2 si prevedono apposite riunioni tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici individuati dall’art. 1, sia a livello centrale, sia a livello locale. Tali riunioni sono indette dagli organi del Ministero e hanno come oggetto i programmi statali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa. Lo scopo delle riunioni è molteplice: – consentire agli organi ministeriali di informare gli organi ecclesiastici in merito agli interventi che si intendono intraprendere a favore dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche; – mettere gli organi del Ministero nella condizione di acquisire dagli organi ecclesiastici eventuali proposte di interventi; – consentire agli organi del Ministero di acquisire da quelli ecclesiastici valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso comunque connesse alle iniziative statali. 178 In occasione di tali riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere. * Nell’art. 3 è prevista la possibilità che gli organi ministeriali e gli organi ecclesiastici stipulino accordi allo scopo di «realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti». * Nell’art. 4 è prevista la più ampia informazione tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici in merito ai programmi statali di intervento pluriennali e annuali e i relativi piani di spesa di cui all’art. 2, oltre che in merito agli interventi e alle iniziative oggetto degli accordi tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici, di cui all’art. 3. * Per favorire la collaborazione tra Chiesa e Stato, gli artt. 5 e 6 dell’Intesa prevedono nuove procedure. In particolare è stata definita una nuova procedura per regolare nel loro complesso i rapporti tra enti ecclesiastici e Soprintendenze (art. 5) in base alla quale il Vescovo diocesano assume un ruolo centrale ed esclusivo. Gli enti ecclesiastici, d’ora in poi, potranno presentare le loro richieste ai Soprintendenti solo per il tramite del Vescovo diocesano (o suo delegato), che è tenuto a valutarne congruità e priorità. Il Vescovo diocesano territorialmente competente presenta ai Soprintendenti anche le richieste degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica: in questo caso, però, senza valutarne congruità e priorità. A loro volta le Soprintendenze si rivolgeranno agli enti ecclesiastici solo per il tramite del Vescovo diocesano. Con l’art. 6, l’Intesa introduce anche una nuova e specifica procedura in relazione ai problemi relativi alle esigenze di culto (come ad esempio i progetti di adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica) che sono tradizionalmente motivo di tensioni e di conflitti: si precisa che i provvedimenti amministrativi previsti dall’art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 sono assunti dal competenti organo ministeriale “previa intesa” con l’Ordinario diocesano competente. * Infine, l’art. 7 dell’Intesa istituisce l’«Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica» allo scopo di verificare con continuità l’attuazione delle forme di collaborazione previste dall’Intesa, esaminare i problemi di comune interesse e suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti. c) Quanto ad eventuali intese, che le Regioni e gli enti autonomi territoriali (come le Province e i Comuni) da una parte e gli enti ecclesiastici dall’altra, intendessero stipulare, nell’ambito delle rispettive competenze, l’art. 8 dell’Intesa si limita a un cenno, senza entrare nel merito. In relazione ai contenuti di tali eventuali intese, le disposizioni contenute nell’Intesa 13 settembre 1996 vengono proposte semplicemente come possibile “base di riferimento”. 179 2. Adempimenti previsti dall’Intesa Dopo avere brevemente presentato l’intesa sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici è opportuno fornire qualche informazione in merito agli adempimenti da essa previsti. In particolare, in attuazione all’art. 7, n. 2 dell’Intesa, il Ministro per i beni Culturali e Ambientali e il Presidente della C.E.I. hanno nominato i rispettivi rappresentanti nell’«Osservatorio». L’Osservatorio si è insediato in data 28 maggio 1997. In accordo con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 dell’Intesa entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 1997. Dal momento che tali disposizioni interessano direttamente i Vescovi e sono destinate a innovare fortemente la prassi e la mentalità ecclesiale, i Vescovi stessi sono tenuti a due adempimenti di notevole importanza di loro stretta competenza: nominare un delegato che Li rappresenti nei rapporti con i Soprintendenti e avviare le diverse forme di collaborazione previste dall’Intesa. a) Secondo l’art. 1 dell’Intesa, a livello locale sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione «i Soprintendenti e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi»; i successivi artt. 5 e 6 prevedono che i rapporti tra enti ecclesiastici e Soprintendenti avvengano secondo una nuova procedura, in base alla quale il Vescovo assume un ruolo centrale. È urgente perciò che ogni vescovo provveda a individuare una persona dotata di particolare competenza in materia di beni culturali e a nominarla. Suo delegato a tenere i rapporti con i Soprintendenti (a questo riguardo, sembra da escludere che, in ragione delle specificità della materia, il delegato sia dotato solo di competenze amministrative). Tale delegato, di norma, dovrebbe essere la stessa persona che in diocesi ha la responsabilità dell’Ufficio per i beni culturali e l’arte sacra (cfr. allegato n. 1). In situazioni particolari il delegato potrebbe rappresentare anche più di una diocesi. Poiché i progetti da presentare ai Soprintendenti dovranno essere preventivamente valutati quanto a congruità e priorità, è necessario che, laddove essa non esista già, venga istituita o rinnovata la Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali (cfr. allegato n. 2). Tale Organismo, che può essere anche a livello interdiocesano, dovrà preventivamente valutare le richieste presentate dagli enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione del Vescovo e, successivamente, presentare al Vescovo stesso una relazione dalla quale risultino congruità e priorità degli interventi. b) Quanto alle diverse forme di collaborazione previste dagli artt. 2, 3 e 4 dell’Intesa è necessario che, con la gradualità richiesta dalla situazione, fin da ora venga colta ogni possibilità perché tra gli Organismi competenti della diocesi e i rispettivi uffici delle Soprintendenze competenti per territorio vengano avviati contatti e scambi di informazione. In questo modo si 180 potrà favorire la graduale messa a regime dei meccanismi di collaborazione previsti dall’Intesa, in particolare per quanto riguarda gli incontri indetti dai Soprintendenti allo scopo di formulare i piani annuali e pluriennali di interventi a favore dei beni culturali. 3. Alcuni suggerimenti Per consentire l’avvio delle nuove procedure previste dagli artt. 5 e 6 dell’Intesa, oltre alla nomina del delegato e all’istituzione dell’Ufficio e della Commissione per l’arte sacra e i beni culturali, è opportuno informare tempestivamente gli amministratori degli enti ecclesiastici e i responsabili delle comunità religiose maschili e femminili del fatto che, a partire del 1° luglio 1997, le richieste di qualunque natura da sottoporre alle Soprintendenze dovranno essere inviate al competente Ufficio di Curia – l’unico soggetto abilitato a trasmettere ai Soprintendenti – e che, a loro volta, i Soprintendenti comunicheranno le loro determinazioni al competente Ufficio di Curia, il quale provvederà a trasmetterle al responsabile dell’ente ecclesiastico interessato. In conclusione sembra utile suggerire alcune iniziative da attuare nella fase di avvio dell’Intesa e comunque prima del 1° luglio 1997. È molto opportuno che dell’Intesa per i beni culturali si parli nell’ambito della Conferenza episcopale regionale; che i delegati dei Vescovi si incontrino a livello regionale nell’ambito della Consulta regionale per i beni culturali (cfr. allegato n. 3) per coordinare le loro attività; che i delegati dei Vescovi il cui territorio ricade nella competenza della medesima Soprintendenza mantengano costanti contatti tra di loro; che il Vescovo incontri i Soprintendenti competenti per territorio e, in quella occasione, presenti loro il Suo delegato. Sarà il caso, inoltre, che la graduale attuazione dell’Intesa sia seguita con grande attenzione sia in ambito diocesano mediante l’apposito Ufficio e Commissione, sia in ambito regionale mediante la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici. La prima Intesa sui beni culturali, stipulata per facilitare la collaborazione tra Chiesa e Stato, richiede alle diocesi italiane un rinnovato impegno anche di natura organizzativa a favore dei beni culturali eccllesiastici; sarebbe molto positivo che questo impegno venisse assunto quale parte qualificante del progetto culturale che le Chiese che sono in Italia stanno promuovendo in modo unitario. Dal momento che in questa fase qualche disagio sarà inevitabile, l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici rimane a disposizione per eventuali consulenze e chiarimenti. 181 ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE 18 febbraio 1984 Art. 12 1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 182 APPENDICE 2 INTESA PROGRAMMATICA TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI APPARTENENTI AD ENTI ED ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE Napoli, 13 maggio 2002 183 L’anno duemiladue, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 16.00, presso la Sede della Giunta Regionale della Campania in via S. Lucia, 81 Napoli; La Regione Campania, nella persona del Presidente On.le Antonio Bassolino; La Conferenza Episcopale Campana, nella persona di S. E. Card. Michele Giordano, in conformità agli indirizzi della Giunta Regionale della Campania ed all’autorizzazione, espressa all’unanimità nella sessione dell’8 aprile 2002, da parte della Conferenza Episcopale Campana, costituita dagli Ordinari diocesani di: Acerra, Alife-Caiazzo, Amalfi-Cava de’ Tirreni, Ariano Irpino-Lacedonia, Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Nocera Inferiore-Sarno, Nola, Pompei, Pozzuoli, Salerno, Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco-Conza-Bisaccia, Santissima Trinità di Cava, Sessa Aurunca, Sorrento-Castellammare di Stabia, Teano-Calvi, TeggianoPolicastro, Vallo della Lucania, al fine di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa e di assumere espressamente l’impegno di adempiere a quanto di propria competenza. PREMESSO che: – tra i fini istituzionali della Regione Campania (di seguito denomin a t a Regione) c’è la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di interesse regionale (art. 5 - Statuto Regione Campania); – il patrimonio culturale di proprietà degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e operanti nel territorio regionale campano, riveste un considerevole interesse nell’ambito dell’esercizio delle succitate competenze regionali statutarie; – la Conferenza Episcopale Campana (di seguito denominata C.E.C.), è l’organo di governo della Regione Ecclesiastica Campana, Ente civilmente riconosciuto, cui compete mantenere i rapporti con le istituzioni politiche della Regione Campania in rappresentanza degli interessi religiosi cattolici, secondo l’art. 2 del suo Regolamento. Essa promuove, presso gli Enti ecclesiastici proprietari dei beni di interesse culturale presenti sul territorio regionale, l’impegno per la conservazione e la valorizzazione degli stessi, testimonianza della storia, della cultura e della tradizione della popolazione campana; – le disposizioni dell’art. 12 dell’accordo sottoscritto in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, comportante modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, prevedono rapporti di reciproca collaborazione fra la Pubblica Amministrazione e l’Autorità ecclesiastica per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche; 184 – il discorso dell’art. 8 del D.P.R. n. 571 del 26-9-1996 relativo all’intesa tra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana prevede che le disposizioni in essa contenuta “possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate nell’esercizio delle rispettive competenze tra le Regioni e gli Enti autonomi territoriali ecclesiastici”. VALUTATO che si rende necessario un intervento coordinato tra Autorità ecclesiastica e Governo regionale al fine di armonizzare ed ottimizzare gli interventi tesi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali di interesse regionale e locale di proprietà ecclesiastica. VISTO: – l’art. 12, n. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 121 (Modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929); – il D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571 (Intesa fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottoscritta in data 13 settembre 1996, relativa ai beni culturali ecclesiastici); – il Tit. I del D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali); – la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 4571 del 9 novembre 2000 (Criteri e indirizzi per gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali), che determina, in analogia con quanto stabilito a livello statale e in altre regioni italiane, per quanto riguarda gli interventi relativi ai beni culturali di proprietà ecclesiastica, che vada stabilita la forma di consultazione regolata con protocollo d’intesa tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale della Campania, sul modello della sopraccitata intesa tra Stato e Chiesa del 13/9/96, autorizzando l’assessore con delega per i beni culturali a definire e firmare protocolli d’intesa con la Conferenza Episcopale Campana. PRESO ATTO del documento della Conferenza Episcopale Italiana «I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti», approvato dalla XXXVI Assemblea Generale dei Vescovi italiani (26-29 ottobre 1992) ed in conformità agli indirizzi dell’Autorità ecclesiastica. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono sull’opportunità di definire un accordo, atto a coordinare gli interventi rientranti nelle rispettive competenze e tesi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, al fine di ottimizzare il perseguimento dei comuni obiettivi. Tale accordo viene definito sulla base dei princìpi dell’intesa sottoscritta fra il Ministero per i beni culturali e 185 ambientali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 13 settembre 1996 e portata ad esecuzione con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571, per le finalità di cui all’art. 12, n. 1, comma 1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense. Quanto sopra costituisce parte integrante della presente Intesa. Si conviene quanto segue: Articolo 1 Finalità Scopo della presente Intesa è l’attivazione di reciproche forme di collaborazione permanente fra la Regione e la Conferenza Episcopale, al fine di concordare opportune disposizioni per armonizzare ed ottimizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed istituzioni ecclesiastiche. Articolo 2 Soggetti sottoscrittori Sono competenti, per l’attuazione delle presenti disposizioni: a) il Presidente della Giunta Regionale della Campania, o persona da lui delegata; b) il Presidente della Conferenza Episcopale della Campania o persona da lui delegata. Gli Ordinari diocesani territorialmente competenti, ciascuno nell’ambito della propria giurisdizione ecclesiastica e secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, fungono da tramite tra il Presidente della Conferenza Episcopale Campana o persona da lui delegata, con gli Istituti di vita consacrata, le Società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciute. Articolo 3 Accordi Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui all’art. 1, la Regione e la Conferenza Episcopale Campana promuovono, altresì, accordi e programmi congiunti con gli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali, nonché con Comuni e Province. Detti accordi potranno definire anche la realizzazione di interventi ed iniziative che richiedono una partecipazione organizzativa e finanziaria congiunta, individuando le forme, i modi, i tempi e le risorse finanziarie attivabili da ciascuna delle Parti interessate. 186 Articolo 4 Reciprocità di informazione Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il perseguimento dei compiti prioritari di cui all’art. 1. In particolare, fra i soggetti competenti ai sensi dell’art. 2, è assicurata la più ampia informazione in ordine alla pianificazione annuale e pluriennale, ai piani di spesa e alle determinazioni finali, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli artt. 1 e 3. Articolo 5 Osservatorio regionale per i beni culturali di proprietà ecclesiastica Al fine di favorire lo scambio di informazioni, di suggerire orientamenti per sviluppare forme di collaborazione, di esaminare problematiche di comune interesse, di verificare con continuità l’attuazione delle presenti disposizioni e di contribuire in tal modo alla concreta attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Intesa, un organismo paritetico denominato “Osservatorio regionale per i beni culturali ecclesiastici”. Attraverso tale organismo, la Regione e la Conferenza Episcopale Campana, oltre a scambiarsi reciproche informazioni in ordine ai piani e programmi disciplinati dalla normativa vigente e/o a quelli predisposti dall’Autorità ecclesiastica, alle iniziative sostenute mediante l’erogazione di contributi europei, nazionali, regionali o della Conferenza Episcopale Italiana, provvederanno a relazionare, con cadenza almeno trimestrale, sul loro stato di attuazione. L’Osservatorio è composto dall’Assessore alla Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali o suo delegato, dal Dirigente del Settore Tutela Beni Paesaggistici, Ambientali e Culturali e da un funzionario designato dalla Giunta Regionale della Campania, dal Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale della Campania, dall’Incaricato Regionale della Conferenza Episcopale Campana per i Beni Culturali e da un componente designato dalla Conferenza Episcopale Campana. Articolo 6 Procedure Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa prevista dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanzia- 187 rie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo d’Intesa. Le Parti concordano, altresì, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di interesse regionale afferenti i beni culturali saranno presentati alla Regione Campania per il tramite del Presidente della Conferenza Episcopale Campana o persona da lui incaricata. Articolo 7 Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro di beni culturali nella disponibilità di Enti ed Istituzioni soggetti alla loro giurisdizione, gli Ordinari diocesani territorialmente competenti presenteranno un piano annuale, evidenziando le priorità e l’eventuale partecipazione finanziaria all’intervento di altri Enti pubblici e/o privati. Tali priorità, se corredate dalla documentazione prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4571 del 9/11/2000 citata in Premessa e nel rispetto dei criteri e degli indirizzi in essa contenuti, avranno valore di richiesta di finanziamento ai sensi della Legge Regionale 9 novembre 1974, n. 58. Articolo 8 Fruizione e accessibilità al pubblico. Recupero funzionale di immobili in disuso La Regione e la Conferenza Episcopale Campana si impegnano ad individuare, di comune accordo, modalità ed ambiti operativi al fine di assicurare le più idonee condizioni di fruizione pubblica e valorizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, nel rispetto delle esigenze di culto. La Conferenza Episcopale Campana si impegna a favorire la stipula di Convenzioni con gli Enti proprietari per l’utilizzo di beni immobili ecclesiastici attualmente in disuso. Per le destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica ed in disuso, si esigerà che la loro sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Soprintendenze, corrisponda al titolo della dignità originaria. Articolo 9 Modalità di attuazione L’attuazione della presente Intesa, nel rispetto degli indirizzi e dei suggerimenti che saranno forniti dall’Osservatorio di cui al precedente art. 5, è rispettivamente demandata alle strutture e organi regionali e agli organismi ecclesiastici competenti per la materia e sarà, di volta in volta, regolamentata da apposite Convenzioni. 188 Articolo 10 Decorrenza La presente Intesa entrerà in vigore dalla data di pubblicazione ed avrà durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente di legislatura in legislatura, salvo diverso intendimento di una delle parti espresso con formale comunicazione. Durante il periodo di validità la presente intesa potrà comunque essere oggetto di verifica periodica e modificata di comune accordo. PER LA REGIONE CAMPANIA On.le Antonio Bassolino PER LA CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA S. E. Card. Michele Giordano 189 190 LUCA 1, 39-56 NELLE PARAFRASI DI GIOVENCO (1, 80-104) E PAOLINO (carm. 6, 139-78) ANTONIO V. NAZZARO * 1. Luca è l’evangelista che fornisce la maggiore quantità di notizie su Giovanni Battista nelle tre grandi sezioni in cui possiamo dividere i suoi scritti: e cioè, il Vangelo dell’infanzia (Lc 1-2: il primo capitolo dedicato a Giovanni, il secondo a Gesù); il Vangelo della vita pubblica di Gesù (Lc 3-24) e gli Atti (Act 1, 5; 1, 22; 10, 37; 11, 16; 13, 24; 19, 4). Luca è l’evangelista che spinge forse più avanti il suo progetto di assimilazione di Giovanni con Gesù. Il Battista non solo è sin dall’inizio perfettamente inserito nel piano di Dio, ma risulta addirittura per via di madre, parente di Gesù (1, 36). Luca, pur riducendone il significato rispetto a Marco, conserva il ricordo del battesimo ricevuto da Gesù. Con la scena della visitazione è Gesù stesso l’origine prima e significativa di quel battesimo. Perciò al momento del battesimo di Gesù, la presenza del Battista è secondaria nel racconto, tanto che il «battezzarsi» di Gesù è stato inteso da alcuni esegeti come una sorta di autobattesimo. Il gioco di parallelismi fra Giovanni e Gesù risponde al doppio scopo di “cristianizzare” il Battista e di subordinarlo in modo definitivo a Gesù. La scena dell’incontro dei nascituri è architettata per cancellare ogni sospetto che Gesù, in quanto destinato a essere battezzato da Giovanni, gli sia in qualche modo inferiore, ovvero che abbia bisogno del battesimo per ricevere lo Spirito. Luca è attento alla Visitazione, per rendere accettabile il dato, che gli crea un problema teologico, del battesimo di Gesù. E’ Gesù che, generato dallo Spirito-potenza di Dio, comunica lo Spirito a Giovanni al sesto mese dal di lui concepimento (straordinario, ma pur sempre naturale). Da tale comunicazione di Spirito trae efficacia il battesimo di Giovanni, che anche per Luca toglie i peccati (3, 3; 1, 77), ma esso non serve a Gesù. Perciò, probabilmente, la scena del battesimo di Gesù è evitata da Luca, e la discesa dello Spirito non avviene in concomitanza * Conferenza tenuta il 28 Maggio 2002. 191 con esso, ma dopo, mentre Gesù prega (3, 21). Il Cristo nasce però da una vergine, per opera dello Spirito santo (Lc 1, 26-38) e il divario fra i due personaggi lucani è incolmabile . A Giovanni Battista, “precursore del Signore”, “porta sacra del Vangelo” e “punto d’arrivo della Legge”, uno dei più significativi personaggi di confine tra Antico e Nuovo Testamento 1 , Paolino di Nola ha dedicato il carme VI, in 330 esametri. In esso è cantata la storia del Battista, dall’apparizione angelica e promessa della nascita, fatta a Zaccaria, fino alla vita penitente nel deserto e alla sua attività di battezzatore presso le rive del Giordano. Il fatto che il carme s’interrompa bruscamente sulla soglia dell’incontro di Giovanni con il Messia e trascuri il suo glorioso martirio è stato spiegato o con la perdita della parte finale o con l’ipotesi che il componimento sia incompiuto. Entrambe le ipotesi si scontrano contro l’ovvia considerazione che il carme è sostanzialmente una parafrasi di Lc 1, 5-80. Il tema di Giovanni, precursore di Cristo, è da considerarsi concluso con la sua attività di battezzatore presso le rive del Giordano, che costituisce la sua vera missione anche rispetto alla precedente vita penitente nel deserto. Il carme VI fu composto tra gli anni 389-394, o, se vogliamo essere più precisi, nel 389/90 in Gallia, nell’imminenza del battesimo per mano di Delfino o, più verosimilmente, in Spagna, poco dopo il battesimo . È in questo contesto di esperienza personale che il carme s’inquadra ed è dalla teologia battesimale che esso riceve luce. Ben presto - sempre che il Carme VI sia anteriore - Paolino si cimenta con la parafrasi del Salterio, a sua volta retractatio poetica dei precedenti libri biblici. Del disegno di versificazione del Salterio, che è il libro biblico più utilizzato da Paolino, ci resta la parafrasi dei soli Salmi 1 (carme VII in trimetri giambici), 2 (carme VIII in esametri) e 136 (carme IX in esametri). Non essendo verisimile che questi siano tre pezzi isolati, quasi massi erratici, nella produzione poetica paoliniana, si può ragionevolmente ipotizzare sia la perdita degli altri Salmi, sia la rinuncia del parafraste a proseguire nella versificazione del Salterio, e non necessariamente perché s’accorse che l’assunto era superiore alle sue forze. Quanto poi alla successione cronologica dei tre Carmi, o Paolino, dopo aver parafrasato i primi due Salmi, ha fatto un ultimo tentativo con il famoso Salmo 136, 1 Paolino, accennando alle reliquie conservate nel tempio di Felice, così definisce Giovanni: Hic et praecursor domini et baptista Iohannes / idem euangelii sacra ianua metaque legis (carm. XXVII 411s.). 192 oppure proprio dalla parafrasi di quest’ultimo Salmo gli è nata l’idea di estenderla a tutto il Salterio e ha abbandonato il progetto dopo i primi due Salmi. La parafrasi salmica di Paolino è il primo esempio di poesia parafrastica veterotestamentaria in Occidente e l’unica retractatio - sia pure assai limitata - del Salterio. Quanto al genere (o ai generi letterari), è innegabile che il carme VI appartenga alla parafrasi esametrica biblica, un genere poetico sul quale Paolino riflette nella praefatio. Il parafraste cristiano segue, infatti, come ipotesto fondamentale del suo carme il primo capitolo del vangelo dell’infanzia di Luca (in particolare, i versetti 5-45 e 57-80), integrandolo con Lc 3, 2-5, Mt 3, 4 ; 11, 7-11 e Mc 1, 2-6. Altrettanto innegabile è la sua appartenenza all’agiografia, genere letterario che Paolino non mancherà di trattare anche in versi 2 . A questo genere rimandano, infatti, sia gli sviluppi parafrastici del testo evangelico, riguardanti soprattutto il Battista fanciullo, la sua eccezionale docilità e serietas, che preannuncia il futuro penitente (vv. 205ss.); sia l’impiego di topoi agiografici, quali sono, a esempio, la voce celeste che invita il Battista a compiere la sua missione sulle rive del Giordano (vv. 255-69) e l’apparizione a Zaccaria dell’Angelo, che lascia dietro di sé l’aria impregnata di profumi; sia, infine, la descrizione della vita nel deserto con una spiccata accentuazione dei tratti ascetici della figura di Giovanni, considerato dalla tradizione monastica princeps degli anacoreti e modello della vita perfetta, che si realizza nel monachesimo.3 Nel descrivere la vita ascetica del Battista Paolino utilizza lo stesso lessico, con il quale definirà più tardi la sua vita di monaco. Il carme VI si ricollega, infine, al genere poetico del panegirico cristiano, discendente dalla laus o encomio: il cod. Paris. Lat. 7558, del sec. IX., reca come titolo Laus sancti Iohannis, che, anche se non è originale, conferma tuttavia il carattere di encomio, con cui manifestamente si chiude il carme (vv. 315-330). Certamente Paolino 2 Su Paolino agiografo vd. G. LUONGO, Lo specchio dell’agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di Paolino di Nola, Napoli 1992. 3 Cfr. Hier. epist. 22, 6 Iohanes princeps nostri dogmatis, ipse monachus . Sulla presenza del Battista nella letteratura cristiana antica e medievale si vedano G. PENCO, S. Giovanni Battista nel ricordo del monachesimo medievale , « Studia Monastica» 3 , 1961, pp. 9ss., ed. E. LUPIERI, Felices sunt qui imitantur Iohannem (Hier. Hom. in Io.), «Augustinianum» 24, 1984, pp. 33-71. Dello stesso autore sono due fondamentali saggi sul Battista apparsi nel 1988 presso la Paideia Editrice di Brescia (Giovanni Battista nelle tradizioni sinottiche e Giovanni Battista fra storia e leggenda ). 193 sperimenta in questo carme una laudatio in versi di un uir Dei, non dimenticando i moduli delle laudationes funebres e dei panegirici imperiali.4 2. Con la presente relazione proseguo l’analisi della riscrittura metrica del carme 6 di Paolino comparato con la corripondente riscrittura metrica di Giovenco (autore degli Euangeliorum libri IV, composti nel 330 ca), che segue - come vedremo - ad uerbum l’ipotesto lucano. E passo alla pericope lucana, che è l’ oggetto di questa relazione: la visita di Maria a Elisabetta e l’incontro - prima della loro nascita - di Giovanni e Gesù. Maria fa visita a Elisabetta, accogliendo con pronta generosità le parole con cui l’angelo le ha rivelato il progetto di Dio. Essa corre là dove questo progetto comincia a realizzarsi, per riconoscere, adorare e cantare. Luca concentra il tutto intorno a due discorsi: quello di Elisabetta che proclama la beatitudine di Maria (vv. 41-45) e quello di Maria, che magnifica la potenza del Signore (vv. 46-55). 2. 1. Le notizie storiche sono precise ed essenziali: in quei giorni Maria si reca in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda; entra nella casa di Zaccaria e saluta Elisabetta; il figlio non ancora nato si muove nel seno di Elisabetta, che è ricolma di Spirito Santo. Il dono dello Spirito la rende capace di comprendere e di interpretare il significato profondo di quanto sta avvenendo: Lc 1, 39 Exsurgens autem Maria in diebus illis abiit in montana cum festinatione in ciuitatem Iuda. (40) Et intrauit in domum Zachariae et salutauit Elisabeth. (41) Et factum est ut audiuit salutationem Mariae Elisabeth,/exsultauit infans in utero eius /et repleta est Spiritu sancto Elisabeth 5 . 4 È appena il caso di ricordare che Paolino è autore di un panegirico perduto a Teodosio; su questo scritto informa compiutamente Y.-M. DUVAL, Le panégyrique de Théodose par Paulin de Nole. Sa date, son sens, son influence, in G. LUONGO (ed.), Anchora uitae. Atti del II Convegno Paoliniano nel XVI centenario del ritiro di Paolino a Nola (Nola-Cimitile 18-20 maggio 1995), Napoli-Roma, LER, 1998, pp. 137-58 . Per R. P. H. GREEN (The Poetry of Paulinus of Nola. A Study of his Latinity , Bruxelles 1971, p. 22): « The opening prayer and the frequent speechs are paralleled in the contemporary panegyrics of Claudian». 5 Lc 1, 39-41: « In quei giorni Maria, messasi in viaggio, si recò in fretta verso la regione montagnosa, in una città di Giuda. Ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E accadde che appena Elisabetta ebbe ascoltato il saluto di Maria, le balzò in seno il bambino ed Elisabetta fu ripiena di Spirito santo». 194 I versetti 39-41 sono parafrasati quasi alla lettera da Giovenco: Illa dehinc rapidis Iudaeam passibus urbem Zachariaeque domum penetrat grauidamque salutat Elisabet, clausae cum protinus anxia prolis membra uteri gremio motu maiore resultant. Et simul exiluit mater concussa tremore, diuinae uocis conpleta est flamine sancto6 . Il presbitero spagnolo segue paene ad uerbum l’ipotesto lucano, trascurando il solo dettaglio in montana: rende cum festinatione con rapidis passibus 7 ; muta ciuitatem Iuda in Iudaeam urbem; aggiunge grauidam a Elisabeth; e al sussulto del figlio nel grembo della madre fa seguire quello della stessa madre, che dalla voce di Maria riceve lo Spirito. A differenza di Giovenco, che come s’è visto si attiene strettamente all’ipotesto lucano, Paolino lo sviluppa con maggiore libertà, apportando a esso variazioni e trasposizioni interessanti: Interea grauidam soboles quamquam edita necdum instigat Mariam sanctam, ut progressa reuisat Elisabeth, longo quae iam uenerabilis aeuo dilectum domino puerum paritura gerebat. Auscultat nato genitrix ( uis tanta fidei!) et quo iussa uenit; mouit materna Iohannes uiscera et inpleuit diuino pectora sensu. Iam uates necdum genitus conclusus in aluo iamque propheta prius gesta et uentura uidebat 8 . 6 Iuuenc. 1, 80-85 (CSEL 24, 7) : « Ella poi con rapidi passi entra nella città di Giuda e nella casa di Zaccaria e saluta Elisabetta incinta, mentre le membra ansiose del figlio racchiuso nel grembo dell’utero rimbalzano con un più intenso movimento. E nel contempo balzò la madre scossa dalla paura ed è riempita dal santo soffio della voce divina» 7 Il nesso ricorre in Verg. Aen. 7, 156 festinant iussi rapidisque feruntur/passibus (sono i cento oratori inviati in ambasceria da Enea a re latino) e, nella stessa sede metrica, in Val. Fl. Arg. 6, 489 e Stat. Theb. 3, 410. 8 Paul. Nol. carm. 6, 139-47 : « Frattanto il figlio, sebbene non ancora venuto alla luce, sprona la santa Maria in stato di gravidanza a mettersi in viaggio e a far di nuovo visita a Elisabetta, che, ormai venerabile per l’età avanzata portava nel grembo ed era prossima a partorire il fanciullo caro al Signore. La madre dà ascolto al figlio (tanta è la forza della fede !) e venne là dove le era stato comandato; Giovanni mosse le viscere della madre e le riempì il cuore di ispirazione divina. Già il profeta, non ancora nato e ancora racchiuso nel ventre, e già il profeta vedeva le cose passate e future». 195 Paolino, a cui poco interessano le coordinate temporali e spaziali della narratio lucana, sottolinea il ruolo attivo che i due figli non ancora nati svolgono in essa: Gesù, non ancora nato, svolge una funzione di stimolo (instigare è però comunemente impiegato in accezione negativa!) nei riguardi della madre incinta a mettersi in viaggio per far visita (progressa reuisat) 9 a Elisabetta prossima a partorire, non ostante l’età avanzata, il fanciullo caro al Signore e Maria si mette in viaggio, non per sciogliere un dubbio o verificare la verità delle parole dell’angelo (v. 36), ma per obbedienza al figlio appena concepito (v. 143). Giovanni, il profeta (si noti la repetitio anaforica di iam e la uariatio sinonimica uates /propheta), non ancora nato, mosse le viscere della madre e le riempì il cuore della divina ispirazione. In Luca (1, 41 e, nella sua scia, Giovenco) al saluto di Maria Giovanni sussulta nel grembo di Elisabetta e questa è nel contempo ripiena dello Spirito santo; in Paolino, invece, è Giovanni, che all’ascolto del saluto di Maria, muove le viscere della madre e a essa trasmette lo Spirito. Lo scarto paoliniano dall’ipotesto lucano si spiega alla luce di un’interessante pagina del Commento a Luca di Ambrogio: Vocem prior Elisabet audiuit, sed Iohannes prior gratiam sensit: illa naturae ordine audiuit, iste exultauit ratione mysterii, illa Mariae, iste domini sensit aduentum, femina mulieris et pignus pignoris [… ] Exsultauit infans, repleta mater est. Non prius mater repleta quam filius, sed cum filius esset repletus spiritu sancto, repleuit et matrem […] Exsultante Iohanne repletur Elisabet»10 . 2. 2. Elisabetta risponde al saluto proclamando a gran voce Maria benedetta fra le donne a motivo della presenza nel suo seno di un frutto benedetto. Considera, poi, gli effetti che la visita, di cui si sente indegna, provoca in lei. Il bambino le sussulta in seno: è un pic- 9 Il verbo reuisere sottolinea una consuetudine nello scambio di visite di cortesia tra le due parenti. 10 Ambr. in Luc. 2, 23 (SAEMO 11, 164-66) : «Elisabetta per prima sentì la voce, ma Giovanni per primo sperimentò la grazia: quella sentì secondo l’ordine della natura, questo esultò per effetto del mistero, quella avvertì la venuta di Maria, questi avvertì la venuta del Signore, la donna avvertì la venuta dell’altra donna, il figlio quella dell’altro figlio[…] Esultò il bambino, fu ripiena la madre. Né la madre fu ripiena prima del figlio, ma, essendo il figlio ripieno dello Spirito Santo, ne ricolmò anche la madre […] Mentre Giovanni esulta, Elisabetta è ripiena.» 196 colo segno che le fa intuire chi è che le sta davanti. Lo Spirito Santo, poi, le fa conoscere e confessare il mistero: Maria è madre del Messia, nel suo seno porta il santo, colui che è fonte di ogni benedizione e sorgente della gioia messianica. Elisabetta conclude proclamandola beata per la fede con la quale ha reagito alla proposta divina: è beata, perché fedele, perché uditrice della parola del Signore: Lc 1, 42. et exclamauit uoce magna et dixit:/Benedicta tu inter mulieres et benedictus fructus uentris tui. (43) Et unde hoc mihi ut ueniat mater Domini mei ad me? (44) Ecce enim ut facta est uox salutationis tuae in auribus meis,/exsultauit in gaudio infans in utero meo (45) et beata quae credidisti/quoniam perficientur ea quae dicta sunt tibi a Domino11 . I quattro versetti di Luca sono metricamente ritrascritti da Giovenco: et magnum clamans: ‘Felix o femina, salue, felicem gestans uteri sinuamine fetum. Unde meam tanto uoluit Deus aequus honore illustrare domum, quam mater numinis alti 90. uiseret? Ecce meo gaudens in uiscere proles exultat, Mariae cum prima adfamina sensit. Felix, qui credit finem mox adfore uerbis, quae Deus ad famulos magnum dignando loquetur 12 . È appena il caso di far notare come Giovenco segua pedissequamente la narratio lucana, sia nella ripresa degli incipit dei singoli versetti (1, 42 et exclamauit uoce magna ~ v. 86 et magnum clamans; 43 Et unde ~ v. 88 Vnde; 44 Ecce ~ v. 90 Ecce; 45 et beata quae credidit ~ v. 92 Felix, qui credit), sia nella rielaborazione accurata del lessico. Nei vv. 86-87 il presbitero spagnolo esplicita a livello sintattico l’evidente rapporto di subordinazione esistente tra i due stichi paral11 Lc 1, 42-45: «Ed escamò a gran voce e disse: “Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo ventre. E perché mi accade ciò, che venga a me la madre del Signore mio? Ecco, infatti, che appena il suono del tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino m’è balzato in seno per la gioia. E benedetta colei che ha creduto che si realizzeranno le cose che ti sono state dette dal Signore». 12 Iuuenc. 1, 86-93 : «E ad alta voce dice: O donna benedetta, salve, tu che porti un frutto benedetto nella sinuosa cavità dell’utero. Perché il giusto Dio volle illustrare con tanto onore la mia casa, che la madre dell’alto Nume venisse a visitarla? Ecco per la gioia esulta il figlio nelle mie viscere, appena ha sentito le prime parole rivolte da Maria. Beato colui che crede che avranno presto compimento le parole che Dio con grande degnazione dirà ai suoi servi» 197 leli del versetto 42 Benedicta tu inter mulieres /et benedictus fructus uentris tui (Maria è benedetta, perché porta nel suo seno un frutto benedetto). Con sinuamine il poeta spagnolo sottolinea la nozione di cavità (gr. koiliva), che inerisce a uterus, così detto «quod duplex sit et ab utraque in duas se diuidat partes, quae in diuersum diffusae ac replexae circumplicantur in modum cornu arietis; uel quod interius impleatur foetu» (Isid. or. 11, 1, 135). Nei vv. 88-89 la riscrittura esametrica dell’interrogatio del versetto 43 sottolinea l’onore che la visita della madre del sommo Dio arreca alla casa di Elisabetta. Il nesso Deus aequus rinvia a Verg. Aen. 6, 129 s. pauci quos aequus amauit/Iuppiter; in entrambi i testi aequus è da intendere nell’accezione di propitius: la giustizia spinge Giove e Dio a essere propizi rispettivamente ai pochi eroi destinati dalla divinità a risalire dagli inferi e alla casa, pur essa prediletta, di Elisabetta. Quanto alla clausola, dal sapore pagano, numinis alti , essa ricorre in Ilario, De euangelio 2, 19 e in Cipriano poeta, Gen. 798. 1086 e Deut. 31. Nei vv. 90-91 è sottolineato il rapporto tra le parole (adfamina è un hapax giovenchiano) pronunciate da Maria e il sussulto per la gioia del bambino (versetto 44); nei vv. 45-46 passando dal femminile dell’ipotesto (versetto 45) (et beata quae credit) al maschile (Felix qui) il poeta spagnolo conferisce al makarismòs un’intonazione di carattere universale e introduce il concetto della dignatio divina nei riguardi dell’uomo. Nella parafrasi dei versetti lucani, Paolino procede con grande libertà, spiegando il testo e realizzandolo con additiones interessanti: Illa ubi concepto fulgentem lumine longe conspexit Mariam, celeri procul incita gressu obuia progreditur uenerataque brachia tendens: salue, o mater, ait, domini, salue, pia uirgo, inmunis thalami coitusque ignara uirilis, sed paritura deum; tanti fuit esse pudicam, intacta 13 ut ferres titulos et praemia nuptae. Cur mihi non meritae nec tanto munere dignae officii defertur honos? Cur gloria caeli in nostros delata Lares et uilia tecta 13 Accolgo l’emendazione intacta proposta da D. R. Shakleton Bailey (Critical Notes on the Poems of Paulinus Nolanus , «Am. Journ. Philol.» 1976p. 4 s.) sulla base della considerazione che lo stato di nupta intacta non è in sé stesso miracoloso e non comporta alcun titolo o premio. Il senso è: Maria, pur rimanendo vergine, aveva diritto al nome e ai privilegi della donna sposata e madre. 198 obscuris tantum lumen penetralibus infert? Sed mitis placidusque suis cultoribus adsit, praestet et hunc genitus quem praestitit ante fauorem. Dixit et amplexus ulnis circumdata iunxit iamque deum uenerata pio dedit oscula uentri 14 . Nella scena inondata dalla luce irradiata da Maria il Nolano colloca Elisabetta, che, non appena la vede da lontano, le va subito incontro e le tende le braccia in atto di venerazione (brachia tendens ). La lontananza tra le due donne, esclusa da Luca (v. 40) e sottolineata invece da Paolino attraverso l’impiego di longe al v. 148 e procul al v. 149, è un motivo epico, probabilmente mutuato da Virgilio15 e dal suo predecessore Giovenco.16 Il saluto di Elisabetta (secondo stico del versetto 42) è sviluppato nei vv. 151-54 da Paolino, che, riprendendo da Giovenco il termine classico salue e impiegandolo due volte nello stesso verso, saluta Maria, come madre di Dio e pia vergine.17 L’interrogatio lucana (versetto 43) si sdoppia in Paolino in due interrogationes, che sottolineano l’omaggio di Elisabetta, che nella prima si dichiara indegna della visita della congiunta e nella seconda (nella scia di Giovenco) si stupisce che il Signore abbia voluto con la sua presenza illuminare la sua oscura dimora. Il motivo della luce riprende e sviluppa l’accenno contenuto nel v. 148 e ha indubbi punti di contatto con il luogo parallelo di Giovenco 1, 88s. Unde meam tanto uoluit deus aequus honore /illustrare domum . 14 Paul. Nol. carm. 6, 148-62: «Ella appena vide da lontano Maria fulgente della luce che aveva concepito, le va incontro da lontano muovendosi con passo veloce e, tendendo le braccia in atto di venerazione, dice : “Salve, o madre di Dio, salve, o pia vergine, libera da nozze e ignara di rapporti con uomo, ma destinata a partorire dio; fu tanto importante per te l’essere pudica, che da vergine portavi i titoli e i privilegi della donna sposata. Perché a me che non lo merito e non sono degna di un dono così grande viene offerto l’onore della tua visita? Perché la gloria del cielo portata nella nostra famiglia e nella nostra umile casa introduce negli oscuri penetrali una luce così intensa? Ma il figlio assista mite e placido i suoi devoti e garantisca il favore che già prima aveva concesso”. Disse e circondata dalle sue braccia ricambiò gli abbracci e, già venerando Dio, dette baci al santo seno». 15 Cf. Verg. Aen. 6, 684s. Isque ubi tendentem aduersum per gramina uidit / Aenean, alacris palmas utrasque tetendit . 16 Cf. Iuuenc. 2, 110 illum ubi tendentem longe respexit Iesus . 17 Cf. P. Flury, Das sechste Gedicht des Paulinus von Nola, «Vig. Chr.» 27, 1973, p. 138. 199 Segue l’invocazione al redentore dell’umanità, che con l’incarnazione ha già manifestato il suo favore, ad assistere i suoi devoti . La preghiera è modellata su quella dei fanciulli ad Apollo nel Carmen saeculare di Orazio (33s Condito mitis placidusque telo / supplices audi pueros) più che su quella di Enea a Mercurio (Verg. Aen. 4, 578 Adsis o placidusque iuues). Paolino conclude la parafrasi dei versetti lucani con l’inedito particolare del mutuo abbraccio delle due donne (Maria per prima abbraccia Elisabetta, che risponde con un abbraccio e con il bacio al santo grembo di Maria).18 2. 3. La pericope della visita di Maria a Elisabetta si conclude con il Magnificat, che, con abbondanti riferimenti alle profezie veterotestamentarie, celebra le gesta misericordiose di Dio lungo l’arco della storia della salvezza, che trovano nella pienezza dei tempi la loro definitiva realizzazione. Nel cantico, che si ispira a quello di Anna (1 Samuele 2, 1-10), Maria, a differenza di Elisabetta, si rivolge direttamente a Dio e lo saluta come salvatore. Maria esprime la sua gioiosa gratitudine per il favore ricevuto (46-48), canta la misericordia di Dio verso tutti quelli che lo temono (49-50) e il suo speciale amore per gli umili (51-53) e per Israele (54-55): Lc 1, 46. Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum (47) et exsultauit spiritus meus in Deo salutari meo. (48) Quia respexit humilitatem ancillae suae; ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 49. Quia fecit mihi magna qui potens est; et sanctum nomen eius.50. Et midericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. 51. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui. 52. Deposuit potentes de sede et exaltauit humiles. 53. Esurientes impleuit bonis et diuites dimisit inanes. 54. Suscepit Israhel puerum suum, recordatus misericordiae suae, 55. sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. 56. Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus, et reuersa est in domum suam19 . 18 Il primo emistichio del v. 161 è mutuato da Verg. Aen. 8, 615 Dixit et amplexus nati Cytherea petiuit . 19 Lc 1, 46-56: «E Maria dice: L’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esultò in Dio, mio Salvatore. Perché ha considerato l’umiltà della sua ancella; ecco infatti da questo momento tutte le generazioni mi chiameranno beata.Perché grandi cose mi ha fatto il Potente; e santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione va a quelli che lo temono. Ha messo in opera la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi con i disegni da loro concepiti. Ha rovesciato i potenti dal trono e innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato i 200 Il Magnificat è stato parafrasato da Giovenco in undici versi: Illa trahens animum per gaudia mixta pudore subpressae uocis pauitantia dicta uolutat: “Magnificas laudes animus gratesque rependit inmensi Domino mundi. Vix gaudia tanta spiritus iste capit, quod me dignatus in altum erigit ex humili celsam cunctisque beatam gentibus et saeclis uoluit Deus aequus haberi. Sustulit ecce thronum saeuis fregit superbos, largifluis humiles opibus ditauit egentes”. Tunc illic mansit trinos ex ordine menses ad propriamque domum repedat iam certa futuri20 . Nei versi 94-95, costruiti con materiali poetici21 , il presbitero spagnolo dà voce alla contenuta gioia di Maria, che si esprime attraverso la voce rotta dall’emozione. La parafrasi procede, quindi, nella scia dell’ipotesto, di cui riprende concetti e lessico. Giovenco sviluppa nei vv. 96-97 il versetto 47, aggiungendo il motivo della gratitudine al Signore dell’immenso mondo (inmensi mundi)22 ; accentua nella riscrittura del versetto 47 l’umana incontenibilità dell’esultanza di Maria (97-98 uix ... /... capit ); unisce in un rapporto di subordinazione sintattica i due stichi paratattici del versetto 48 trasformando la considerazione di Dio dell’umiltà della sua ancella in degnazione per il suo stato (vv. 98-99) e accentuando il ruolo di Dio (anche qui definito aequus) nella proclamazione della ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri a favore di Abramo e della sua discendenza, per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi ritornò a casa sua.». 20 Iuuenc. 1, 94-104: «Ella respirando con gioia mista a pudore emette parole con la voce smorzata dal timore: “L’animo rende magnifiche lodi e ringraziamenti al Signore dell’immenso mondo. A stento questo spirito contiene una gioia sì grande, perché il Dio giusto si è degnato di innalzare in alto me che stavo in basso e ha voluto che fossi ritenuta beata da tutti i popoli nei secoli. Ecco ha tolto il trono ai malvagi, ha abbattuto i superbi, ha arricchito con abbondanti ricchezze gli umili bisognosi”. Allora rimase lì tre mesi di seguito e ritorna alla propria casa ormai certa del futuro» 21 Nel v. 94 il poeta spagnolo riusa il primo emistichio di Varrone, Arg. 8, 400 Ille trahens spiritum e le clausole di Ovidio met. 9, 527 e Stat. silu. 5, 1, 65 mixta pudori e nel v. 95 rielabora le immagini di Ovidio met. 5, 192s. pars ultima uocis / in medio suppressa sono est e trist. 3, 3, 21 suppressaque lingua palato . 22 Il nesso è mutuato da Ou. met. 2, 35 o lux immensi publica mundi: è Fetonte che così appella il padre Febo. 201 sua beatitudine da parte di tutte le genti (vv. 99-100); dei versetti 4952 ritiene al v. 101 - accostandole asindeticamente - solo le due immagini contenute dai versetti 521 e 512; ricrea poeticamente nel v. 102 il primo stico del versetto 53 23 ; omette i versetti 54 e 55; e parafrasa quasi ad uerbum il versetto 56 nei vv. 103-04 con due non insignificanti additiones: i circa tre mesi diventano tre mesi senza interruzione (la clausola ex ordine menses è mutuata da Verg. georg. 4, 507) e Maria ritorna con la certezza di ciò che le avverrà (la clausola iam certa futuri sembra richiamare la clausola in litote di Verg. Aen. 4, 508 haud ignara futuri). Omessa la riscrittura del Magnificat di Maria (Lc 1, 46-56), il Nolano rivolge ex abrupto un’apostrofe alla Giudea, rea di non aver creduto alle profezie scritturistiche (vv. 163-72) e inserisce nei vv. 173-78 dichiarazioni che valgono a integrare il quadro del programma poetico, quale emerge dalla praefatio. Riporto il primo brano: Dic age nunc, Iudaea nocens et sanguine regis conmaculata tui, uerbis si nulla priorum est adhibenda fides, sacros si fallere uates creditis et Moysen ipsum, si fallere Dauid inpia peruersae putat inclementia gentis, credite non genitis; materna clausus in aluo quid uideat, sancto matris docet ore Iohannes. Quis, precor, hunc docuit quem casto uiscere uirgo contineat, quantus maneat noua saecula partus? Sed sanctis abstrusa patent nec uisa profanis 24 . Cf. Lc 1, 531 Esurientes impleuit bonis ~ v. 102 largifluis humiles opibus ditauit egentes ; questo verso - impreziosito da un aggettivo poetico (cf. Lucr. 5, 598 largifluum fontem) - è armonioso grazie alla prevalenza dei dattili, alla triplice scansione delle cesure, e alla corrispondenza delle due coppie di aggettivi e sostantivi. 24 Paul. Nol. carm. 6, 163-72: « Orsù rispondi, o Giudea funesta e macchiata del sangue del tuo re, se non bisogna prestar fede alle parole degli antenati, se credete che i sacri profeti e lo stesso Mosè siano ingannatori, se l’empia inclemenza del tuo popolo perverso ritiene che Davide sia un ingannatore, prestate allora fede a coloro che non sono ancora nati; Giovanni ci comunica attraverso la santa bocca della madre ciò che vede mentre è racchiuso nel ventre materno. Chi, ti prego, gli mostrò chi sia colui che la santa vergine contiene nelle caste visceri e quanto grande sia il figlio riservato alla nuova età. Ma le cose segrete sono manifeste ai santi, mentre quelle viste non lo sono ai profani». 23 202 Nell’improvvisa apostrofe alla Giudea, definita funesta e regicida,25 Paolino invita con un ragionamento sillogistico, che ha del paradossale, i Giudei che si rifiutano di credere ai sacri profeti, a Mosè e a Davide 26 , a credere a Giovanni che dal seno materno comunica ciò che vede. E da chi è informato Giovanni, se non da colui che è destinato ai noua saecula? 27 . Il brano si chiude con un’antitesi, marcata dal chiasmo, tra i santi che vedono le cose segrete, e i profani che non vedono neppure quelle palesi. Riporto il secondo brano: Verum egressa modum latos petit orbita campos atque oblita mei procurrere longius audet. Spero, erit ut possim firmato robore quondam hoc quoque per spatium fortes agitare quadrigas. Nunc coeptum repetamus iter; mortalia dicat pagina mortalis, dominum diuina loquantur 28 . La quadriga di Paolino, oltrepassando i suoi limiti, tende verso campi spaziosi, e, dimentica delle capacità dell’auriga, osa spingersi troppo lontano. L’auriga non rinuncia, però, alla speranza di poter un giorno, quando avrà raggiunto una maggiore sicurezza nelle sue capacità, cimentarsi su questo più ampio terreno. Già in Tacito il campo nel quale gli oratori debbono muoversi con piena libertà è assimilato agli ampi campi che mettono alla prova la bravura e la classe dei cavalli 29 . 25 I vv. 163-64, nei quali è possibile scorgere l’eco di Giovenco 3, 419s. si fratrem proprium delicto commaculatum/ cernis, sono tenuti presente da Aratore 1, 1 Vt sceleris Iudaea sui polluta cruore e 2, 958 O Iudaea nocens . 26 Il v. 164s. è modellato sull’incipit di Auson. epist. 2 (ed. Mondin, Venezia 1995, p. 6 ) Si qua fides falsis umquam est adhibenda poetis (si questa inuitatio vd. Mondin , p. 66s.). Per Paolino, insomma, i giudei porrebbero sullo stesso piano i sacri uates e i falsi poetae . 27 Questo nesso è, a mio avviso, l’eco dell’interpretazione cristiana di Verg. buc. 4, 4-7. Cf., anche, Prud. cath. 11, 57-60 O quanta rerum gaudia/aluus pudica continet, /ex qua nouellum saeculum/ procedit et lux aurea! 28 Paul. Nol. carm. 6, 173-78 : «Ma la mia quadriga, superando i suoi limiti, si dirige verso campi spaziosi e dimentica di me osa spingersi più lontano. Verrà il tempo - lo spero- in cui potrò, consolidate le mie forze, lanciare le forti quadrighe anche su questo terreno. Riprendiamo ora il cammino intrapreso; la pagina scritta da un mortale parli di cose mortali, gli scritti divini parlino del Signore». 29 Cf. Tac. dialogus de oratoribus 39 Nam quo modo nobiles equos cursus et spatia probant, sic est aliquis oratorum campus, per quem nisi liberi et soluti ferantur, debilitatur ac frangitur eloquentia. 203 Fuor di metafora, il poeta, preso atto della sua inadeguatezza a cantare temi teologicamente più elevati, ne rimanda la trattazione a quando avrà irrobustito le sue competenze teologiche (a queste mi pare che sia da riferire il sintagma firmato robore più che alla capacità poetica, di cui aveva chiara coscienza). Per il momento è meglio proseguire il cammino intrapreso, lasciando che lo scritto di un uomo canti avvenimenti mortali e gli scritti sacri parlino del Signore. Il che significa che Paolino, pur continuando a lavorare alla pagina mortalis, coltiva la segreta (ma non tanto!) aspirazione a un carme teologicamente più impegnato che lo trasformi in poeta diuinus . In quest’ottica la Laus sancti Iohannis può ben essere considerata come la premessa di una «storia evangelica» in versi, che avrebbe dovuto avere inizio con il Vangelo della nascita e infanzia di Cristo. 3. Al termine dell’esame comparativo delle due riscritture metriche di Lc 1, 39-56 è opportuno formulare qualche sia pur provvisoria conclusione: 1. Alla pericope lucana Giovenco ha dedicato 25 esametri, vale a dire il 62,5% di quelli dedicati da Paolino (40); alla diversa ampiezza corrispondono un diverso approccio e una diversa prospettiva. 2. Le coincidenze verbali tra i due testi, non riconducibili all’ipotesto lucano, depongono a favore della dipendenza di Paolino da Giovenco. 3. Virgilio è utilizzato more centonario da Giovenco e in maniera più significativa da Paolino. 4. A differenza di Paolino o di Sedulio, più proclivi alle ekphraseis, alle amplificazioni retoriche e patetiche, nonché agli sviluppi esegetici e meditativi, Giovenco si matiene più aderente alla narratio evangelica, che egli ‘traduce’ hexametris uersibus paene ad uerbum (Hier. uir. ill. 84). La sua parafrasi può essere qualificata come letterale o grammaticale, a condizione che con tale definizione si voglia sottolineare solo la pronunciata fedeltà degli Euangeliorum libri all’ipotesto sacro e non invece presentarli come il frutto di una versificazione pedissequa priva di ogni pregio poetico. 204 IL DRAMMA DELLA CONVERSIONE NEL DIBATTITO TRA AUSONIO E PAOLINO GIOVANNI SANTANIELLO 1 PREMESSA Negli anni della sua biografia, compresi tra la fine del suo governatorato campano (381) e il definitivo ritiro a Nola (395), Paolino maturò gradualmente la radicale “conversione” alla fede cristiana. Negli scritti di questo periodo egli ci fornisce puntuali e precisi riscontri. Ed anche in seguito egli farà ricorso alla sua “memoria” per “rileggere” la sua esperienza ascetica.2 Infatti nello sketch autobiografico abbozzato nel carme XXI Paolino passa in rassegna gli avvenimenti più importanti della sua vita.3 Ma più puntuale, per la cronologia, era stato già nella lettera 5 a Severo.4 Questi tre lustri della vita di Paolino sono nettamente distinti in due fasi: la prima, quella aquitana (381-389), che Paolino, rientrato in patria da Roma, trascorre per lo più nel suo podere di Ebromago presso Bordeaux; la seconda, quella spagnola (389-395), segna il ritiro di Paolino in Spagna, nei suoi possedimenti presso Barcellona. Infatti Paolino, ricevuto il battesimo, nel 389, si ritira con la moglie Terasia in Spagna. Qui assapora la gioia della paternità con la nascita del figlio Celso, morto dopo appena otto giorni e sepolto a Complutum (Alcalà de Henares); matura insieme con la moglie la decisione di una vita ascetica, che comporta la vendita dell’immenso patrimonio per darne il ricavato ai poveri; diventa sacerdote su pressante richiesta del popolo di Barcellona, nel Natale del 394. Il ritiro spagnolo di Paolino è documentato soprattutto dalla corrispondenza col suo maestro Ausonio.5 1 Relazione tenuta al Convegno svoltosi al Centro “Resurrexit” di Pompei (22 Giugno 2002) sul tema “Mondo classico e mondo cristiano: Contnuità e discontinuità. 2 Così, per esempio, nella lettera 5 a Severo, del 395, e nel carme XXI, del 407. 3 Cf. PAVL. NOL. c. XXI, nat. 13, 344-450. 4 Cf. ID. epist. 5, 4-6 a Severo. 5 A questo periodo spagnolo appartengono anche altri scritti di Paolino, come 205 I - DUE PROTAGONISTI Ausonio e Paolino, due personaggi di primo piano sull’orizzonte occidentale dell’impero romano alla fine del IV secolo. La loro corrispondenza costituisce “un episodio della fine del paganesimo”.6 Il maestro e l’alunno, vissuti per decenni in piena sintonia e concordia di vita e di arte, dimostrandosi stima ed affetto reciproci, immersi nel mondo aristocratico e letterario dei grandi proprietari terrieri della Gallia imperiale, ad un certo momento si ritrovano a dover constatare che le loro esistenze hanno imboccato decisamente strade diverse e che, anzi, adesso le loro vite procedono in direzione opposta. Da una parte, Ausonio, il maestro, il retore più illustre ed il poeta più raffinato del suo tempo, il cantore convinto di un mondo mitologico e divino, mondo che ora appare svuotato del suo significato religioso. Egli è di certo uno dei rappresentanti più in vista, stimato ed onorato, della società aristocratica dell’impero, i cui ricchi proprietari terrieri trascorrevano il tempo nelle loro villae di campagna tra gli svaghi e gli ozi letterari, e che, una volta battezzati, consideravano e vivevano anche la loro fede come motivo e occasione di intrattenimento e di svago, senza che la nuova religione coinvolgesse e permeasse in profondità la loro vita: era la classe dei demichrétiens, di cui parlava già il Guignebert.7 Ausonio, chiamato a corte dall’imperatore Valentiniano I, è impegnato per diversi anni nella formazione umana e intellettuale dell’erede al trono Graziano: il poeta, da quella posizione di prestigio e di potere, dispensa favori le epistt. 35 e 36 a Delfino e ad Amando per la morte di un suo fratello, il carme XXXI per il piccolo Celso, i carmi VI-IX con la Laus Sancti Iohannis e la parafrasi di tre salmi, oltre al Panegirico di Teodosio (perduto) e alle lettere (perdute) a Girolamo e ai Vescovi Africani. 6 Cf. A. PUECH, De Paulini Nolani Ausoniique epistolarum commercio et communibus studiis, Paris 1887; P. DE LABRIOLLE, La correspondance d’Ausone et de Paulin de Nole: Un épisode de la fin du paganisme, Paris 1910; R. P. H. GREEN, The Correspondence of Ausonius, in L’Antiquité classique 49 (1980), pp. 191211, e G. GUTTILLA, Ausonio e Paolino: rapporti letterari ed umani,in Impegno e dialogo 10 (1992-94), pp. 177-189. 7 CH. GUIGNEBERT, Les demi-chrétiens et leur place dans l’Église antique, in Revue de l’hist. des religions 88 (1923), pp. 65-102. Sul cristianesimo di Ausonio, cf. C. RIGGI, Il cristianesimo di Ausonio, in Salesianum 30 (1968), pp. 642-695; P. LANGLOIS, Les poèmes chrétiens et le christianisme d’Ausone, in Revue de philologie 43 (1969), pp. 39-58, e R. P. H. GREEN, The Christianity of Ausonius, in Studia Patristica 28 (1993), pp. 39-48. 206 a parenti e amici ed anche al suo pupillo Paolino. Egli, alla morte di Graziano, ritorna in patria e trascorre gli ultimi anni della vita nei diletti ozi letterari e poetici nel suo podere aquitano di Lucaniacum o di Pagus Novarus, presso Bordeaux, in corrispondenza epistolare con gli amici di sempre e con il suo discepolo prediletto.8 Dall’altra parte, Paolino, l’alunno, giovane speranza dell’impero romano, nobile e straordinariamente ricco, davanti al quale brillano grandi progetti futuri. Il giovane discepolo, diligente e precoce, suscita l’ammirazione del maestro, perché assetato di sapere ed appassionato nella ricerca della verità: nella sua formazione intellettuale ed umana egli si è letteralmente immerso ed impregnato di quello stesso mondo mitico ed eroico incarnato e trasmesso a lui dal suo maestro, divenuto amico fedele e compagno di vita. Paolino, membro del senato romano, ha percorso una brillante carriera politica, il suo cursus honorum, in seno all’impero, fino a raggiungere il consolato e il governatorato della Campania (380/381).9 Orbene, in seguito all’assassinio dell’imperatore Graziano, Paolino con tutta la sua famiglia viene fatto segno di gravi calunnie da parte dell’usurpatore Massimo, per cui anche lui è costretto a ritornare in Aquitania. Qui vive ritirato nel suo podere di Ebromago, presso Bordeaux, rimanendo anche lui in corrispondenza epistolare con gli amici e con il maestro. Nel frattempo il giovane senatore sposa la nobildonna spagnola Terasia e si pone seriamente il problema della fede, lui che ancora non è battezzato. Sono gli anni in cui Paolino, affascinato da Cristo, si orienta decisamente verso la nuova religione: chiede il battesimo al vescovo di Bordeaux Delfino, che lo affida al suo presbitero Amando per farlo istruire nella fede. Alla fine viene battezzato e subito dopo con la moglie Terasia si ritira in Spagna presso Barcellona. Siamo nel 389. Da questo momento per più di tre anni Paolino non riceve notizie del suo maestro.10 Quindi il dialogo riprende e si intreccia in un autentico “dibattito” sulla scelta di fede, nel quale però i due amici stentano a capirsi, perché espressione ormai di due mondi diversi, incarnando Ausonio, 8 Cf. AVSON. Epistt. 5, 36 a Teone; 22, r. 11 e v. 43 a Paolino; Epigr. 30, 7. Sul sito di Lucaniacus, cf. R. ETIENNE, Bordeaux antique, Bordeaux 1962, pp. 354357. Cf., inoltre, AVSON. Epist. 25, 95 a Paolino per il Pagus Novarus. Cf. A.PASTORINO, Opere di Decimo Magno Ausonio, Torino 1971, pp. 24-25, nota 36. 9 Cf. D. E. TROUT, Paulinus of Nola: Life, Letters and Poems, Berkeley-Los Angeles-London 1999, pp.23-52. 10 Ibid. pp. 53-77. 207 la vecchia generazione, quella pagana o cristiana solo in superficie, e Paolino, la nuova, quella cristiana, che fa del Vangelo la legge fondamentale della propria vita. I due amici, che hanno camminato concordi e felici per lungo tratto di strada, ad un certo punto si ritrovano su posizioni radicalmente opposte, quasi costretti a separarsi, a rompere l’antica amicizia, soprattutto perché il maestro non riesce a capire né a condividere le scelte di fede del discepolo, che intende dare una svolta decisiva alla sua vita e alla sua attività poetica, dedicandosi anima e corpo all’ideale ascetico. Ausonio, invece, della sua fede in Cristo e dei risvolti nella propria vita mostra di avere una concezione tutt’altro che autentica e seria. I due amici parlano ormai linguaggi diversi. Si delinea ormai nella loro corrispondenza e nella loro vita una frattura insanabile, che riproduce quella tra il mondo classico delle Muse, e il mondo cristiano, dominato da Cristo, unico magister virtutum.11 Un’opposizione, questa, che apparirà ancora più decisa e drammatica nella prima lettera di Paolino a Sulpicio Severo, l’amico di sempre, del 395. E solo in seguito questa posizione così rigida andrà mitigandosi in Paolino, che riuscirà a conciliare il vecchio e il nuovo, “rivitalizzando” e “riconcettualizzando” l’ormai anemico mondo del mito e della poesia classica con i nuovi contenuti teologici e morali, quelli della religione cristiana. Resteranno sempre in vigore e operanti le antiche forme classiche della poesia e dell’arte, che però verranno “rivitalizzate” dalle verità di fede e dalla nuova morale instaurata dal Vangelo. 12 II - PAOLINO IN SPAGNA TRA OTIUM RURIS E CONVERSIONE All’indomani dell’eliminazione dell’usurpatore Massimo da parte dell’imperatore Teodosio (388), Paolino insieme con la moglie Terasia si ritira presso Barcellona in Spagna ed interrompe drasticamente ogni contatto con il mondo e la consuetudine epistolare con gli amici di un tempo. Anche col suo maestro Ausonio. Si ha l’impressione che siasi trattato di vera e propria “fuga” dal suo podere di Ebromago presso Bordeaux, dove aveva compiuto la iniziazione cristiana e maturato l’antico sogno ascetico balenatogli nella mente presso la tomba di S. Felice fin dalla sua prima giovinezza. Non sap- 11 12 ID. c. X, 52: magister hic virtutum. Cf. D. E. TROUT, Paulinus of Nola… cit., pp. 78 e 89. 208 piamo se sia stato proprio il suo “padre” spirituale Delfino oppure qualche altro cui stava a cuore la sua vita, a consigliargli il ritiro in incognito e lontano dalla patria diletta. Forse nella città di Bordeaux continuava a spirare aria e voci di persecuzione nei confronti suoi e della famiglia: calunnie e maldicenze infondate porteranno all’uccisione di un suo fratello. Anche la morte precoce del figlio Celso avrà contribuito a mettere i suoi giovani genitori di fronte alla scelta vitale della loro esistenza: consacrare il proprio cuore a Cristo mediante la perfezione evangelica. II.1 - Le due lettere superstiti di Ausonio Della corrispondenza intercorsa tra Ausonio e Paolino nel ritiro spagnolo dal 389 al 394 ci sono giunte tre lettere di Ausonio (23.24.25 Schenkl) e due di Paolino (carmi X e XI). Le tre epistole superstiti di Ausonio facevano parte di un gruppo di almeno cinque, spedite dal maestro al discepolo nel periodo 389-393/ 394: delle cinque missive, tre giunsero a Paolino nel 393 in un unico plico: delle tre ce ne rimane una sola, la 23 Schenkl, a cui se ne aggiunse una quarta, la 24 Schenkl, spedita da Ausonio, ancora nel 393, ma prima di ricevere alcun riscontro da parte di Paolino. Quest’ultimo subito dopo, col carme X, risponde direttamente a queste due lettere di Ausonio, che, a sua volta, ribadisce poi le sue posizioni critiche con l’epistola 25 Schenkl, a cui Paolino farà seguito con il carme XI. A questo punto il carteggio tra i due si interrompe e nel contempo si spezzano definitivamente i vincoli della loro antica amicizia. Come già si può intuire, si tratta di uno scambio epistolare di notevole importanza per comprendere il cammino di conversione di Paolino. Ma nello stesso tempo esso evidenzia anche l’incapacità del maestro ad entrare ed accettare la radicale metànoia dell’allievo. Perciò la rottura dell’amicizia tra l’ottuagenario uomo di lettere e l’ancora giovane suo discepolo diventa come il “tipo”, il simbolo, delle tante fratture che certamente Paolino dovette operare con gli amici di un tempo, fratture che rispecchiavano la lotta finale tra l’antico mondo e le nuove forze spirituali ed intellettuali, che alla fine del IV secolo andavano trasformando la società occidentale. Nel ritiro spagnolo (389-395) Paolino ha continuato, almeno all’inizio, a condurre la vita del grande proprietario terriero nella sua villa di campagna. Ma nel contempo egli è impegnato a riflettere sulle conseguenze del battesimo, appena ricevuto, sulle sue scelte religiose e sulla nuova condotta di vita. 209 Nelle prime tre lettere, giunte a Paolino in Spagna in un unico plico, Ausonio, tra aspre critiche e amari rimproveri, si lamentava in modo particolare del lungo silenzio del suo discepolo. E non avendo ricevuto alcuna risposta, ne scrisse una quarta, più lunga e fremente di sdegno e di delusione: il suo discepolo non lo ha degnato nemmeno di un saluto nel lungo periodo dei tre anni trascorsi. Perché? Chi gli impedisce di comunicare con l’amico? Sarà quella Tanaquilla di sua moglie Terasia, sempre gelosa e piena di sospetti, oppure Paolino si è imposto da sé la lex tacendi, dimenticando i doveri dell’antica amicizia e mettendo da parte la buone abitudini di un tempo, allorquando con regolarità e stima reciproca i due si scambiavano doni e graziose lettere di accompagnamento, composte secondo i canoni classici della retorica e dell’arte poetica, e nel contempo ricche di sentimenti di amicizia schietti e profondi? Oppure il suo discepolo ha deciso di allontanarsi dalla patria e dagli amici per vivere in luoghi deserti un sereno otium ruris lontano dallo strepito del foro e dalle preoccupazioni per i beni del mondo, sull’esempio di filosofi e poeti impegnati a vivere in solitudine per meglio dedicarsi alle attività dello spirito e della poesia? Oppure Paolino si è ritirato in luoghi selvaggi in odio al genere umano, ad imitazione del mitico cavaliere di Pegaso, Bellerofonte, o per seguire le orme del rigorismo ascetico del vescovo di Avila Priscilliano? Tutti questi interrogativi e questi dubbi affollavano la mente e le epistole di Ausonio, che evidentemente non conosceva i nuovi progetti di Paolino e della moglie Terasia. Infatti dal giorno in cui i due giovani sposi avevano lasciato l’Aquitania per la Spagna, la corrispondenza tra i due amici si era interrotta. Ed Ausonio aveva diffusamente esposto i suoi dubbi e gridato la sua amara delusione nelle sue epistole, dando corpo alle malevole dicerie (rumores) che pur erano trapelate sull’improvvisa “fuga” di Paolino da Bordeaux. Nell’epistola 23 Schenkl, infatti, Ausonio ripete i rimproveri rivolti al suo pupillo nella lettera precedente (perduta) per il suo silenzio e nello stesso tempo gli suggerisce stratagemmi, tratti dal mito e dalla storia, per poter eludere la vigilanza di un eventuale “traditore” o indiscreto testimone della loro corrispondenza. Quindi punta i suoi strali direttamente contro Terasia individuando in lei l’imperiosa e scaltra Tanaquilla, in quanto forse condannava il crimen amicitiae del suo sposo. Quest’accusa contro la moglie aveva ferito profondamente il cuore di Paolino. Nella parte finale del carme Ausonio richiama Paolino ai suoi doveri affettivi, che ancora lo legano al suo maestro, cui deve peren210 ne gratitudine ed affetto per la formazione umana e intellettuale ricevuta: “Lascia perdere gli altri, ma non avere a disdegno il dialogo con tuo padre. Sono io che ti ho allevato, che ti ho istruito, io che per primo ti ho fatto beneficiare degli antichi onori, per primo ti ho condotto nell’assemblea delle Muse”.13 E nell’epistola 24 Schenkl, sempre in riferimento all’ostinato silenzio del discepolo, Ausonio sottolinea la “tendenza naturale di tutti gli esseri a far sentire la loro voce”.14 Tutti, tranne il suo diletto Paolino, che caparbiamente si ostina nel suo silenzio.15 Orbene, “anche una breve risposta, annota il Maestro, è di certo migliore del silenzio, dal momento che egli “non chiede che una pagina intessa lunghi versi e nemmeno che riempia le tavolette di prosa copiosa… V’è infatti un certo piacere nella brevità… E mai nessuno è piaciuto per il silenzio, molti invece per la brevità di eloquio (nemo silens placuit, multi brevitate loquendi)”.16 Nella parte centrale dell’epistola, poi, Ausonio chiede al suo destinatario: “Hai dunque cambiato carattere (mores), mio dolcissimo Paolino?”, avendo Paolino preferito le selvagge regioni della Guascogna alle civili e colte contrade dell’Aquitania e al tranquillo otium ruris di Ebromago.17 Perciò il vecchio poeta maledice la Spagna per aver allontanato Paolino dal cielo della sua patria per spingerlo in regioni impervie dei Pirenei. In questo modo Paolino ha seguito l’esempio del mitico Bellerofonte, la cui figura di demente rende più individuabili e concreti gli stessii sospetti di Ausonio: colui che ha consigliato al suo alunno il ritiro in luoghi selvaggi e il silenzio prolungato è un empio, un violatore della pietas: “triste, povero, egli frequenti i deserti, percorra muto i luoghi alpestri, che si incurvano, così come un tempo Bellerofonte – dicono – andò vagando per luoghi impervi, privo di ragione, evitando il contatto e le tracce degli uomini”.18 13 AVS. epist. 23 Schenkl, vv..32-35: Tu contemne alios nec dedignare parentem / adfari verbis. Ego sum tuus altor et ille / praeceptor primus, veterum largitor honorum, / primus in Aonidum qui te collegia duxi. 14 ID. epist. 24Schenkl, 17: Nil mutum natura dedit. 15 ID. epist. 24, 26-28. 16 Ibid. 34-44: Non ego longinquos ut texat pagina versus / postulo multiplicique oneret sermone tabellas /… Est etenim comis brevitas… O certa loquendi / regula… Nemo silens placuit, multi brevitate loquendi. 17 Ibid. 50: Vertisti, Pauline, tuos dulcissime mores? / Vasconis hoc saltus et ninguida Pyrenaei / hospitia et nostri facit hoc oblivio caeli? 18 Ibid. 69-72. 211 Ausonio conclude il suo carme con la preghiera alle Muse della Beozia, affinché riportino il giovane poeta alle Camene del Lazio: “Muse della Beozia, vi prego: accogliete questa preghiera, questo grido e richiamate il vostro vate alle Camene del Lazio”.19 II.2 - Tanaquilla e Bellerofonte Tra mito e realtà Due figure della leggenda, quasi due icone fontali del testo, dominano nell’una e nell’altra lettera di Ausonio come metafore della condotta di Paolino e della moglie Terasia, individuati rispettivamente nell’eroe Bellerofonte di Corinto (= Efira di Omero) e nella donna di Tarquinia (città fondata da coloni corinzi), Tanaquilla, moglie del leggendario re di Roma Tarquinio Prisco ed esperta di riti magici etruschi. Sia l’uno che l’altro personaggio risultano familiari al vecchio poeta e presenti anche altrove nella sua opera. a). La storia di Tanaquilla, moglie del re Tarquinio Prisco, è presentata con dovizia di particolari dallo storico Tito Livio nel lungo capitolo 34 del I libro della sua opera Ab Urbe condita: Lucumone, “uomo ambizioso e potente per le sue ricchezze”, figlio di Demarato di Corinto, “bandito dalla patria in seguito ad una rivoluzione”, era venuto a vivere a Tarquinia, città etrusca, dove aveva preso moglie. Gli erano nati due figli, Lucumone ed Arunte. Arunte muore prima del padre, lasciando la moglie incinta. Lucumone invece gli sopravvive, ereditando l’immenso patrominio paterno. Ma il giovane Lucumone diviene ancora più ricco sposando appunto l’etrusca Tanaquilla, donna di nobile stirpe ed oltremodo ambiziosa. Costei induce il marito ad emigrare da Tarquinia a Roma, al fine di impossessarsi del regno. Lucumone, avido anche lui di onori e di gloria, asseconda i desideri della moglie: abbandona Tarquinia e, giunto alle porte di Roma, riceve un buon auspicio da parte degli dei: un’aquila, uccello sacro a Giove, sorvolando sul capo del giovane sposo, seduto accanto alla moglie sul carro, gli porta via il copricapo: per Tanaquilla, esperta nell’interpretazione degli auspici (perita, ut vulgo Etrusci, caelestium prodigiorum mulier), è il segno dell’ineludibile volere degli dei in loro favore. Frattanto Lucumone e la moglie, sta- 19 Ibid. 73-74: Haec praecor, hanc vocem, Boeotia numina Musae, / accipite et Latiis vatem revocate Camenis. 212 bilitisi nella città di Roma, si conquistano ben presto le grazie ed i favori del re Anco Marzio. E alla morte del re, Lucumone, preso il nome di Lucio Tarquinio Prisco, con la sua facondia riesce a convincere il popolo ad eleggerlo re dei Romani. E fu il quinto re nella serie dei re di Roma.20 La storia-leggenda dell’imperiosa Tanaquilla, narrata dallo storico romano, trova ampio riscontro nella tradizione poetica latina. Accenniamo soltanto a qualche esempio. Così nei Fasti di Ovidio, Tanaquilla, come regina e moglie di Tarquinio Prisco, presiede alla celebrazione dei riti sacri indetti dal re in seguito all’incendio del tempio della dea Fortuna. La regina è assistita dalla sua ancella Ocresia, oriunda da Cornicoli, antica località del Lazio: la bellissima Ocresia, in questa occasione, rovistando tra le macerie ancora fumanti, si unisce al dio Vulcano e concepisce Servio Tullio, che sarà appunto il successore di Tarquinio Prisco. 21 Anche in questo testo ovidiano risalta la peculiare attività di Tanaquilla come donna esperta dell’arte mantica, in cui erano maestri gli antichi Etruschi. Né poteva mancare Tanaquilla nella famosa diatriba della sesta Satira di Giovenale contro le donne. Qui, però, la moglie di Tarquinio Prisco appare nelle vesti di una donna malefica che consulta un famoso astrologo, relegato in un’isoletta delle Cicladi, nel mare Egeo: Tanaquilla vuole essere informata “sulla morte troppo lenta della madre itterica... e vuol sapere quando potrà accompagnare al cimitero la sorella e gli zii e se sopravvivrà l’amante: quali grazie maggiori potrebbero elargire gli dei?...”.22 Negli scritti di Ausonio Tanaquilla compare almeno due volte e nella sua duplice immagine di donna di grandi virtù (ingenitis pollens virtutibus), accanto alla figura di donna sospettosa ed intrigante. Innanzi tutto la incontriamo nell’ultimo componimento dei Parentalia (...Urbica, Censoris nobilitata toro, / ingenitis pollens virtutibus auctaque et illis /... / quas habuit Tanaquil...). In questo carme, dedicato a Pomponia Urbica, suocera di una figlia di Ausonio e sposa di Giuliano Censore, Tanaquilla, celebre per prudenza e perizia negli auspici, Ausonio la presenta come modello di virtù egregie, accanto a Teano, figlia o discepola di Pitagora, e all’eroina Alcesti, che ri- 20 LIV. I, 34. OVID. Fast. VI, 629-636. 22 IVV. Sat. VI, 565-571. 21 213 scattò dal destino fatale, con la propria vita, la vita del marito Admeto.23 Nel secondo passaggio ausoniano, invece, appare l’altra faccia, quella negativa, del personaggio Tanaquilla. Ed è proprio nella lettera 23 di Ausonio a Paolino. Si tratta appunto del luogo in cui la moglie di Paolino Terasia è presentata da Ausonio nelle vesti di Tanaquilla, donna bisbetica e ambiziosa, gelosa e indiscreta sulle scelte del suo marito. b). Quanto alla figura di Bellerofonte, presente nell’epistola 24 di Ausonio a Paolino, essa appare nella leggenda narrata per la prima volta da Omero nel VI libro dell’Iliade: figlio di Glauco, a sua volta discendente di Sisifo e di Eolo, Bellerofonte, eroe di Efira (Corinto), avendo ucciso Bellero, tiranno di Corinto, fu costretto ad abbandonare la città. Esule, fu accolto dal re di Tirinto Preto. Qui la moglie del re, Stenebea (Omero la chiama Antea), si invaghì dell’eroe, che respinse sdegnosamente il suo amore. Bellerofonte, perciò, accusato dalla donna di aver tentato di sedurla, venne dal re esiliato presso il suocero Iobate, re di Licia, in Asia Minore. Qui Bellerofonte, sempre protetto e guidato dagli dei, fu impegnato dal re in una serie di imprese, alle quali difficilmente sarebbe sopravvissuto, se con l’aiuto di Atena non fosse riuscito a domare il cavallo alato Pegaso: uccise così la Chimera, vinse i Solimi, le Amazzoni e i più valorosi guerrieri degli stessi Lici, finché il re Iobate, ammirato, gli concesse il diritto a succedergli sul trono, sposando sua figlia Filonoe. Da costei Bellerofonte ebbe tre figli: Isandro, Ippoloco e Laodamia, tutti ben poco fortunati nella loro vita. D’altra parte, lo stesso Bellerofonte, insuperbitosi per i suoi successi, in groppa al cavallo Pegaso, volle salire sull’Olimpo. Ma, disarcionato da Giove, precipitò nella pianura di Alea, in Licia, dove, fuori di sé e nella più squallida solitudine, andò errando per il resto della sua vita.24 Quest’ultimo aspetto della vita dell’eroe, aspetto che sarà sottolineato nella tradizione latina, viene così descritto da Omero: “Ma quando anch’egli fu in odio a tutti i numi, allora errava, solo, per la pianura Alea, consumandosi il cuore, fuggendo orma d’uomini”.25 Al di fuo23 AVSON. Parent. 32, 1-6: Ut generis clari, veterum sic femina morum, / Urbica, Censoris nobilitata toro, / ingenitis pollens virtutibus auctaque et illis, / quas docuit coniunx, quas pater et genetrix:/ quas habuit Tanaquil, quas Pythagorea Theano, / quaeque sine exemplo pro nece functa viri. 24 HOM. Il. VI, 152-211. 25 Ibid. 200-202. 214 ri del racconto omerico, la vicenda di Bellerofonte è strettamente legata al cavallo Pegaso, con l’aiuto del quale l’eroe compie le gloriose imprese, ed anche l’ultimo tentativo che, però, lo porterà alla rovina. Ad ogni modo soprattutto due elementi sono posti in risalto nella tradizione del mito: da una parte, la casta integrità dell’eroe, che lo rende grato agli dei e glorioso fra gli uomini e che accomuna la sua vicenda a quella di altri eroi mitici, come Ippolito e Peleo, e a quella del biblico Giuseppe, figlio di Giacobbe, e, dall’altra parte, l’empia demenza, che alla fine lo perderà.26 Presso gli autori latini, poi, la figura di Bellerofonte esercitò un grande fascino,27 e la sua complessa e tragica vicenda umana ebbe il suo tramite in Cicerone, che nelle Tusculanae Disputationes, richiamandosi ad Omero, sottolineava la tragica fine dell’eroe di Corinto.28 Certamente l’opera di Cicerone costituisce la fonte diretta, a cui attinse anche Ausonio nella sua lettera metrica a Paolino, dove il vecchio poeta ribadiva il vagare in solitudine dell’eroe caduto in disgrazia degli dei per la sua superbia (coetus hominum et vestigia vitans).29 In molti altri luoghi ausoniani, poi, la figura dell’eroe corinzio ritorna legata al cavallo alato Pegaso, che lo accompagna nella realizzazione delle sue gloriose imprese.30 Anche Rutilio Namaziano, circa 25 anni dopo Ausonio, utilizzerà la figura di Bellerofonte per accusare gli asceti cristiani e scagliarsi contro i monachi che, in fuga dal mondo e dalla luce, vivevano sull’isola di Capraia, al largo della costa settentrionale italiana.31 26 Quanto alla tradizione greca, anche ESIODO, nella Teogonia (v. 325), ricorda l’eroe di Corinto. Ma è soprattutto L UCIANO che nei Dialoghi continua la tradizione omerica (33, 42; 36, 13; 58, 18; 59, 26; 80, 254). 27 Cf. HOR. Cc. III, 12, 8; III, 7, 15; IV, 11, 28; IVV. Sat. X, 324-328. 28 CIC. Disp. III, 26, 63: ut ait Homerus de Bellerophonte: Qui miser in campis maerens errabat Aleis, / ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans. 29 AVSON. Epist. 24, 69-72: Tristis, egens deserta colat tacitusque pererret / alpini convexa iugi, ceu dicitur olim / mentis inops coetus hominum et vestigia vitans / avia perlustrasse vagus loca Bellerophontes. 30 ID. epist. 4, 9 a Teone; epistt. 21, 8-10 e 19-22; Epitaph. 32, 9; Grat. Actio 18, 15-16. 31 NAMAT. De reditu suo I, 448-452. Sulla figura di Bellerofonte nella tradizione cristiana, cf. Y.-M. DUVAL, Recherches sur la langue et la litterature latines: Bellérophon et les ascètes chrétien:” Melancholia” ou “otium”?, in Caesarodunum 3 (1968), 183-190; M. SIMON, Bellérophon chrétien, in Mélanges d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire offerts à Jérome Carcopino, Paris 1966, pp. 889-904. 215 II.3 - La prima risposta di Paolino: carme X Allorquando, nel 393, Paolino riceve, il plico inatteso e legge le lettere del suo vecchio maestro, rimane molto sconcertato e profondamente amareggiato per il forte risentimento, per le accuse e le insinuazioni emergenti dai versi del diletto “padre”: un’amarezza ed una critica che certamente tormentano e preoccupano l’ormai ottuagenario precettore, ma che pungono nell’intimo soprattutto la sensibilità del discepolo. Pertanto la risposta di Paolino è immediata e decisa. In essa il giovane neofita ribadisce con forza che egli, insieme con la moglie Terasia, nel 393, stavano maturando seriamente la decisione di cambiare vita per seguire Cristo, in attuazione del nuovo progetto di perfezione evangelica. Consideriamo brevemente i passaggi più significativi della risposta di Paolino nel carme X, di 331 versi, composto appunto nel 393, che si articola in tre parti, distinte da ritmi poetici diversi: - vv. 1-18, la propositio o argumentum, in distici elegiaci, in cui Paolino accusa ricevuta delle tre lettere dell’amico e presenta il piano letterario della sua epistola; - vv. 19-102, l’expositio, in distici giambici (senario seguito da quaternario), in cui il poeta espone il suo progetto di vita spirituale e ascetica, che parte e si incentra nella sequela di Cristo; - vv. 103-331, la confutatio, in esametri dattilici, in cui Paolino confuta e ribatte, l’una dopo l’altra, le accuse e le insinuazioni del maestro. Di primo acchito colpisce la struttura e la varietà polimetrica del carme. Ma la scelta formale compiuta da Paolino doveva servire non solo a compiacere il vecchio Maestro, ma soprattutto a dimostrargli concretamente che nell’allievo di un tempo non era affatto venuto meno il poeta, e che anzi questo era più vivo ed operoso che mai, pronto a spingere la sua quadriga ad arare nuovi campi e ad esplorare più vasti orizzonti, a cantare, cioè, nelle antiche forme poetiche i nuovi argomenti della sua fede.32 Questa viva “contraddizione” o, meglio, “opposizione” tra rifiuto della poesia pagana e composizioni cristiane in metri classici è di 32 Cf. PAVL. NOL. Carm.. VI, 173-176: “Il mio cammino, oltrepassando il giusto limite, percorre vasti campi e, dimentico delle mie forze, osa spingersi troppo lontano. Lo spero: verrà il tempo in cui potrò ccn forza sicura guidare le forti quadrighe anche su questo terreno”. 216 certo uno degli elementi più costanti di continuità tra mondo pagano e mondo cristiano: questo dissidio interiore accompagnerà tutta la vita e l’opera di Paolino convertito al cristianesimo. Paolino, dopo l’introduzione, nella sezione giambica del carme X (19-102), prende l’avvio per il suo canto proprio dalla preghiera alle Muse con cui Ausonio aveva concluso l’epistola 24: invocare le Muse, per Paolino, andava bene in altri tempi, allorquando il maestro e il discepolo, in piena sintonia di vita e di arte e con uguale ardore “chiamavano fuori dalla sua caverna di Delfi il sordo Apollo, invocavano le Muse come esseri divini, chiedevano alle foreste ed ai gioghi montani il dono dell’eloquio, conferito solo dalla munificenza divina”.33 Ma chiedere alle Muse il suo ritorno all’antico mondo di favole, ora che, battezzato, egli ha dedicato a Cristo il suo cuore, risulta del tutto vano, perché le Muse, così come tutti gli dei dell’Olimpo, non sono che nomina sine numine, e le preghiere a loro rivolte si fermano sulle nubi, vengono disperse dal vento e non giungono nella reggia stellata del Dio del cielo.34 Questo Dio, unico, noi dobbiamo pregare, perché Lui solo è l’Onnipotente in grado di intervenire nelle vicende dell’uomo, così come di fatto è intervenuto con somma efficacia a cambiare la vita di Paolino.35 E’ il Dio, sostegno e sorgente del vero e del bene, Dio che nessuno vede se non in Cristo (…veri bonique fomitem et fontem deum, quem nemo nisi in Christo videt), che è luce di verità, via di vita, forza mente mano e potenza del Padre, sole di giustizia, nato da Dio e creatore del mondo. E’ un Dio esclusivo e geloso che reclama tutto per sé, noi stessi e tutti i nostri beni.36 Pertanto non può essere considerato empio e perverso - così come ha fatto il suo maestro - chi, come Paolino, si è offerto a Dio con amore e dedizione ed in Lui ha riposto ogni sua cosa. Proprio per questo nel vero cristiano non può mai venir meno la “pietà”, che è la disponibilità piena nei confronti di Dio e soprattutto dei i fratelli.37 33 ID. Carm. X, 23-28: Fuit ista quondam non ope, sed studio pari / tecum mihi concordia / ciere surdum Delphica Phoebum specu, / vocare Musas numina / fandique munus munere indultum dei / petere e nemoribus aut iugis. 34 Cf. ibid. 109-118. 35 Ibid. 128-130: Quid me accusas? Si displicet actus / quem gero agente deo, prius est, si fas, reus auctor, / cui placet aut formare meos aut vertere sensus. 36 Ibid. 45-66: Questi versi che si presentano come un vero e proprio inno cristologico, altamente poetico e profondamente connotato in senso teologico, mostrano già ad evidenza il notevole cristocentrismo che caratterizzerà poi tutto il pensiero e l’opera di Paolino. 37 Cf. Ibid. 83-85. 217 Subito dopo Paolino proclama la sua conversione, confessa cioè di avere ormai aderito anima e corpo all’invito di Cristo e di essere orientato e deciso ad abbracciare il nuovo ideale di vita: “Ora una forza diversa soggioga la mia anima, un dio più potente che pretende altri costumi di vita, reclamando per sé dall’uomo il dono che gli concesse, di vivere cioè per il padre della vita”.38 Adesso bisogna dunque vivere solo per Dio: le ricchezze e tutto il resto, filosofia, retorica e la stessa poesia, tutto è vanità, futilità, menzogna che non porta alla salvezza ed oscura la sola Verità (… qui corda falsis atque vanis imbuunt / tantumque linguas instruunt, / nihil ferentes, ut salutem conferant, / quod veritatem detegat),39 Verità che è Cristo che vi conduce, Cristo che adesso reclama tutto di noi, ma che ci ripagherà con usura gli interessi di tutto ciò che gli avremo riconsegnato nutrendo i suoi poveri.40 D’altronde, l’intervento di Dio nell’esistenza e nell’esperienza di Paolino ha trasformato radicalmente il suo modo di essere, il suo modo di pensare e di vivere. Lo stesso Paolino dichiara espressamente di non essere più quello di un tempo: Dio ha suscitato in lui, rigenerato o cambiato nel profondo i suoi sentimenti: “Infatti se tu pensi che la mia condotta sia quella di prima, che tu conosci, spontaneamente ti confesserò che io non sono quello che sono stato in quel tempo, allorquando non ero ritenuto perverso, ma ero perverso tuttavia, poiché non vedevo che attraverso la caligine dell’errore, possedendo quella saggezza che per Dio è follia, e vivendo nei pascoli della morte”.41 La sua “rigenerazione”, dunque, iniziata col battesimo, è da attribuire al Sommo Padre, che ha suscitato in lui una “volontà nuova, una volontà non mia, non mia una volta (quondam), ma mia ora (nunc) per ispirazione divina (auctore deo)”.42 38 Ibid. 29-32: Nunc alia mentem vis agit, maior deus, / aliosque mores postulat, / sibi reposcens ab homine munus suum, / vivamus ut vitae patri. 39 Cf. Ibid. 33-42. 40 Ibid. 70-80: Si evidenzia già da questo testo del 393 l’atteggiamento di Paolino nei confronti dei beni del mondo, che la fede “non rigetta come profani o di nessun valore, ma ci insegna a riporli nel cielo, come più preziosi, dopo averli affidati a Cristo Dio, il quale promise una ricompensa maggiore di ciò che doniamo, in modo da restituire con grande interesse mediante la sua presenza ciò che è stato disprezzato o meglio rimesso nelle sue mani. Custode fedele, da buon debitore, restituirà accresciute le ricchezze a chi ha avuto fiducia in lui, e come Dio, nella sua grande munificenza, renderà con molto frutto il denaro disprezzato (… multaque spretam largior pecuniam / restituet usura deus)”. 41 Ibid. 131-135. 42 Ibid. 137-143: … agnosci datur a summo genitore novari / quod non more 218 Tra il “quondam” ed il “nunc”, opposizione che caratterizza il dipanarsi del testo paoliniano, che si dibatte tra il vecchio mondo della mitologia e della favola, ispiratore della poesia classicheggiante di Ausonio, ed il nuovo mondo della vita e della esperienza del Dio incarnato in Cristo, nuovo Apollo, ispiratore del canto di Paolino, c’è ancora una volta una chiara e netta contrapposizione, che Paolino, tuttavia, considera in una continuità di fondo e saldamente radicata nella sua formazione umanistica, una continuità evidente non solo nella variegata polimetria formale dei suoi versi, ma soprattutto allorquando egli afferma senza mezzi termini che “di tutto il bene che Dio ha tratto ed operato in lui, trovando nella sua anima qualcosa di degno per i suoi doni, la gratitudine e la gloria vanno attribuite soprattutto ad Ausonio, perché dai suoi alti insegnamenti ha avuto origine ciò che Cristo avrebbe amato”.43 Il cristianesimo, con la nuova fede e la sua morale, anche per il nostro Paolino, presuppone la natura umana e si innesta vitalmente sulla formazione spirituale dell’uomo, insieme sublimandole. E il grande merito del maestro Ausonio è appunto quello di aver preparato un terreno fertile e ben disposto all’azione della grazia di Dio nel cuore del suo prediletto discepolo. Un merito, questo, che il vecchio poeta adesso non può e non deve assolutamente sciupare. Paolino, da parte sua, si mostra infinitamente riconoscente al suo amico e maestro: “Perciò tu devi piuttosto rallegrarti che lamentarti - gli dice - perché io, il tuo Paolino, formato dai tuoi insegnamenti e dalle tue virtù (tuis studiis et moribus ortus), al quale tu non devi negare di essere padre, neppure adesso che lo credi traviato, ho così cambiato i miei pensieri da meritare di appartenere a Cristo pur rimanendo di Ausonio. Egli renderà la sua ricompensa alla tua gloria, e a te offrirà il primo frutto della tua pianta. Perciò, ti prego, abbi opinione migliore e non perdere il più grande premio, detestando i beni scaturiti dalle tue sorgenti”.44 meo geritur; non, arbitror, istic / confessus dicar mutatae in prava notandum / errorem mentis, quoniam sim sponte professus / me non mente mea vitam mutasse priorem. / Mens nova mi, fateor, mens non mea, non mea quondam,, / sed mea nunc auctore deo,… 43 Ibid. 143-146: …[deus], qui si quid in actu / ingeniove meo sua dignum ad munia vidit, / gratia prima tibi, tibi gloria debita cedit, / cuius praeceptis partum est quod Christus amaret. 44 Ibid. 147-155. 219 D’altra parte, Paolino non è ancora fuggito lontano dagli uomini, sull’esempio dei filosofi e poeti antichi, in ritiro dal mondo per dedicarsi alla meditazione e alle Muse, ma soprattutto non vive ancora l’esperienza dei grandi asceti cristiani appartati in luoghi deserti e silenziosi per “meditare Cristo con mente pura” (castis /… animis: 160s.). Anche se egli nutre vivo nel suo cuore il desiderio di imitare quegli illustri amatores Christi. Paolino perciò non si considera affatto un Bellerofonte, che mens demens vive in solitudine e nega con forza di essere fuor di senno, dal momento che egli non abita nei luoghi selvaggi della Guascogna né sulle vette innevate dei Pirenei, bensì in città illustri e civili della Spagna, che Ausonio mostra di non conoscere affatto. D’altra parte Paolino non ha dimenticato il cielo della patria, ora che lo contempla nel Dio del cielo. Tanto meno egli ha per moglie una imperiosa Tanaquilla, bensì una virtuosa Lucrezia.45 Orbene - osserva Paolino - un padre vigile e buono riprende e corregge il figlio, che è “passato dalla rettitudine alla cattiveria, dalla religiosità ad una vita profana, dall’onestà alla turpitudine”: è giusto che l’ira spinga il padre benigno a riportare l’amico caduto ai retti costumi (…blandum licet ira parentem / excitet, ut lapsum rectis instauret amicum / moribus et monitu reparet meliora severo)”. “Ma se il figlio - continua il Poeta - ha scelto e segue Cristo, ha consacrato cioè il suo cuore al Dio della bontà seguendo il venerabile comando di Cristo con docile fede e persuaso dagli insegnamenti divini che all’uomo mortale sono preparati doni eterni acquistati attraverso le sofferenze presenti, non penso che ciò costituisca motivo di dolore per un padre buono fino al punto da ritenere colpa il vivere per Cristo, come Cristo ha stabilito” (ut errorem credat sic vivere Cristo, / ut Christus sanxit).46 Il giovane Paolino è giunto ormai alla piena convinzione che l’uomo e tutto ciò che gli appartiene è fugace e di breve durata e che l’uomo senza Cristo è polvere ed ombra (homo… sine Christo pulvis et umbra). Perciò la cosa più importante per lui adesso è quella di vivere secondo il precetto di Cristo Signore (At nisi, dum tempus 45 Ibid. 156-195: In questa parte centrale del carme, sezione che si prolunga fino al verso 259, Paolino, attraverso la rigorosa confutazione e il netto rifiuto delle gravi accuse mossegli da Ausonio, chiarisce e mette a fuoco con lucidità il suo propositum ascetico-monastico da vivere e realizzare sulle orme dei grandi discepoli di Cristo. 46 Cf. ibid. 278-285. 220 praesens datur, anxia nobis / cura sit ad domini praeceptum vivere Christi, / sera erit…), senza prestare ascolto alle accuse e alle sollecitazioni di tutti quelli che vivono lontani da questo suo ideale, fosse pure l’antico maestro e padre.47 Il nuovo Poeta cristiano chiude il suo canto con la scena grandiosa del Giudizio finale, quando il Cristo glorioso tornerà in tutta la sua maestà divina per giudicare con equo giudizio tutte le genti e concedere le ricompense dovute alle diverse opere (…regem… / venturum, ut cunctas aequato examine gentes / iudicet et variis referat sua praemia gestis).48 In attesa dell’avvento finale di Cristo, il cuore di Paolino è in ansia e “trema nelle trepide fibre temendo fin d’ora che, legato alle dolorose cure del corpo e gravato dal peso delle cose terrene, quando nel cielo aperto risuonerà la tromba potente, non possa levarsi nell’etere su agili ali incontro al Re, volando tra le schiere gloriose dei santi nel cielo”. Timore e preoccupazione di Paolino, dunque, è che “l’ultimo giorno lo sorprenda inattivo oppure immerso nelle tenebre del mondo intento a compiere azioni inutili e dannose”. Orbene, soprattutto per evitare questa tragica sventura, Paolino “ha deciso di prevenire gli eventi colla scelta ascetica (propositum) e nella vita che gli resta porre termine alle agitazioni e, affidate a Dio tutte le sue cose, per il tempo futuro aspettare col cuore tranquillo la morte crudele (trucem mortem)”.49 Questa prospettiva escatologica, in cui Paolino ha già collocato la sua vita con le sue scelte religiose, questa nuova visione del mondo e della propria esperienza di vita, considerata ormai sub specie aeternitatis, non poteva di certo allettare il vecchio Ausonio. Costui invece di congratularsi con il discepolo, ormai avviato su altre strade e ad altre vette, avverte la profonda frattura che si è generata in loro due nei confronti della loro tradizionale concezione dell’amicizia e della pietà. Una frattura, questa, che di fatto viene sancita da Paolino come da un epitaffio e scandita dai due esametri conclusivi del suo carme, che hanno tutto il sapore di un ultimatum irrevocabile: Si placet hoc, gratare tui spe divite amici: / si contra est, Christo tantum me linque probari: “Se ti è gradito ciò, rallegrati della ricca speranza del tuo amico; se invece no, lascia che io sia approvato da Cristo”.50 47 Cf. ibid. 288-295. Ibid. 299-301. 49 Cf. ibid. 304-329. 50 Ibid. 330-331. 48 221 Come cristiano io sto e vivo con Cristo e con gli uomini, ma non con gli uomini senza Cristo, sembra ripetere Paolino a se stesso e al diletto maestro, a conclusione del suo articolato discorso, in questa fase così importante della sua ricerca e del suo ritiro spagnolo. III - LA FINE DI UNA CORRISPONDENZA III.1 - La risposta di Ausonio: Il giogo e l’amante respinto Ausonio accusa ricevuta del carme X di Paolino, e ne avverte subito il drammatico messaggio di chiarimento, che egli legge e rilegge in chiave di una frattura definitiva della loro antica amicizia: voci e dicerie popolari, insinuazioni malvagie, che pur erano giunte al suo orecchio, ormai non hanno più motivo di esistere, data l’inequivocabile chiarezza e decisione del discorso del discepolo. Egli perciò risponde con l’epistola metrica 25, l’ultima indirizzata a Paolino, nella quale fra l’altro accusa con viva amarezza l’amico come l’unico colpevole e responsabile del loro vincolo di amicizia infranto. Un giogo leggero, quello che li ha tenuti uniti in dolce concordia per lunghi anni, un giogo che i loro stessi genitori avevano portato con gioia per tutta la vita, trasmettendolo poi ai loro figli ed eredi prediletti, Paolino e Ausonio: “Ecco, noi scuotiamo il giogo, Paolino, quel giogo che la nota moderazione rendeva facile… guidato da una dolce concordia (concordia mitis), mai scosso da falsa diceria, da lamentela o rimprovero, questo giogo dolce (mite iugum) che hanno portato i nostri due padri dalla loro infanzia fino alla sera della loro vita; essi l’hanno trasmesso ai loro eredi nella speranza che persistesse sino al giorno lontano della fine della loro esistenza… Ed ecco che noi lo scuotiamo, ma la colpa non è reciproca, ma soltanto tua, o Paolino”.51 La metafora del “giogo”, da cui prende l’avvio l’epistola di Ausonio, richiama la nota espressione del Vangelo (Mt 11, 30: “Il mio giogo infatti è dolce (suave) e il mio carico leggero (leve)”, afferma Cristo, invitando i suoi discepoli a prenderlo su di sé e a portarlo con 51 AVSON. Epist. 25, 1-21:Discutimus, Pauline, iugum… / … leve quod positu et venerabile iunctis / tractabat paribus concordia mitis habenis; / … tam placidum, tam mite iugum,, quod utrique parentes / ad senium nostri traxere ab origine vitae / inpositumque piis heredibus usque manere / optarunt, dum longa dies dissolveret aevum. /… Discutitur, Pauline, tamen: non culpa duorum / ista, sed unius tantum tua. 222 gioia). E l’immagine evangelica domina la prima parte dell’epistola e risulta quanto mai appropriata ed efficace anche sulle labbra di un cristiano superficiale come Ausonio: all’inizio il giogo è leggero (leve), perché guidato con briglie uguali da una concordia, che è dolce (mitis) (vv. 1-3); ma poco dopo il giogo appare così tranquillo (placidum) e dolce (mite) (vv. 9 e 16), che sarebbe stato sopportato facilmente e con docile collo (docili cervice) anche dai destrieri più focosi e bizzarri della tradizione mitica.52 D’altra parte sembra che Ausonio abbia accolto l’invito di Paolino a rivolgere le sue preghiere non agli dei falsi e bugiardi, bensì all’unico e vero Dio dei cristiani, per ottenere concretamente il ritorno in “patria” e alle Muse del suo discepolo.53 Ed invece anche questa sua ultima epistola è tutta tramata di richiami al mondo del mito e della favola, quasi a sottolineare ancora una volta che i due corrispondenti si muovono ormai su piani profondamente diversi ed opposti tra loro e parlano linguaggi che non possono incontrarsi. Pertanto l’elogio dell’amicizia che segue, con la rassegna di personaggi diventati famosi, nella leggenda e nella storia, per il loro legame di amicizia - un mondo questo, in cui anche Ausonio e Paolino nell’opinione dei contemporanei erano destinati ad entrare, per esservi immortalati alla stregua del grande Scipione e del vecchio Lelio - lascia intravedere, attraverso il richiamo alla tradizione letteraria, la sofferenza del poeta deluso ed amareggiato, che non riesce a capire e a recepire le nuove istanze religiose del discepolo, né tantomeno a sintonizzarsi col lucido e nuovo discorso di Paolino, per cui egli si limita a prendere atto e a registrare l’ormai avvenuta rottura dell’amicizia col suo ex-alunno.54 A conclusione del suo epillio, Ausonio si libra sulla fantasia, contempla e segue, con la sua immaginazione, il discepolo che ritorna in patria nei suoi possedimenti presso Bordeaux e conclude riportando il penultimo verso dell’VIII Bucolica di Virgilio: è realtà oppure sogno di innamorati? 52 Ibid. 16-19: Hoc tam mite iugum docili cervice subirent / Martis equi stabuloque feri Diomedis abacti / et qui mutatis ignoti Solis habenis / fulmineum Phaethonta Pado mersere iugales. Cf. OVID. Met. II, 19-300. 53 Cf. PAVL NOL. Carm. X, 109-128 con AVSON. Epist. 25, 112-114: Certa est fiducia nobis, / si genitor natusque dei pia verba volentum / accipiat, nostro reddi te posse precatu,… 54 Cf., in modo particolare, AVSON. Epist. 25, 34-57. 223 III. 2 - Il carme XI di Paolino: dulcis amicitia aeterno mihi foedere tecum Con la risposta del carme XI di Paolino cala definitivamente il sipario sulla figura di Ausonio e sul saldo rapporto di amicizia che fin dai più teneri anni ha tenuto legato il giovane proprietario terriero col maestro e padre della sua formazione intellettuale. E Paolino, col carme XI, di appena 68 versi complessivi, composto alla fine del 393 o agli inizi del 394, risponde all’ultima epistola metrica di Ausonio, e, pur lasciando aperto il dialogo col vecchio maestro, non può fare a meno di ribadire la sua decisione ascetica, che ormai lo impegna totalmente alla sequela di Cristo. Anche quest’ultimo carme di Paolino ad Ausonio si svolge in versi polimetrici: 1-48 esametri e 49-68 distici giambici (trimetri e dimetri giambici). Nella prima sezione il Poeta, dopo aver accennato di nuovo alle accuse lanciategli dal maestro nelle lettere precedenti, accuse che “lacerano” il suo cuore e “offendono” la sua coscienza di amico fedele, sottolinea con forza che i suoi profondi sentimenti di stima e di affetto nei confronti dell’amico non sono venuti mai meno. Anzi essi ora sono più vivi che mai perché fondati e messi sullo stesso piano dell’amore a Cristo: “Lascia, ti prego, di tormentare chi ti appartiene, e non mescolare parole amare con espressioni paterne, come assenzio con il miele. Fu sempre mia cura, e ancora rimane, di onorarti con tutti i riguardi e rispettarti con amore fedele”.55 Egli pertanto non ha scosso affatto il giogo dei “dotti studi”, che - al dire di Ausonio - lo teneva unito al “santo genitore”. Questo giogo letterario in realtà egli non l’ha mai portato, perché del tutto inferiore al suo maestro, col quale a stento un Cicerone e un Virgilio avrebbero potuto stare alla pari sotto il medesimo giogo. Invece da sempre Paolino è sotto il dolce giogo di un’amicizia sincera e fedele, lui e tutti quelli della sua casa, con il suo maestro di un tempo. Un giogo, quest’ultimo, che non è stato mai scosso, e che anzi adesso potrà e dovrà essere rinsaldato dallo stesso amore di Cristo.56 Questa nuova amicizia, che è l’amicizia cristiana, “fondata sull’eterna alleanza con te ed uguale sempre per la reciproca legge della corrispondenza dell’affetto, pone insieme il piccolo con il grande 55 PAVL. NOL. Carm. XI, 6-9: Parce, precor, lacerare tuum nec amara paternis / admiscere velis ceu melli absinthia verbis. 56 Ibid. 17-19: Hoc mea te domus exemplo coluitque colitque, / inque tuum tantus nobis consensus amorem, / quantus et in Christum conexa mente colendum. 224 con redini appaiate”57 e tende all’”amore di unità” 58 , perché proiettata e tutta protesa verso orizzonti celesti, fuori dei confini del tempo e dello spazio. In questa dolce visione del nuovo vincolo di carità che ci unisce al fratello nel tempo e per l’eternità, la cara immagine paterna del vecchio maestro rimarrà impressa indelebilmente nel cuore del suo discepolo. E’ questa la vera “novità” e il senso profondo dell’autentica amicizia, sottolineato da Paolino nella sezione giambica del suo carme: finché e dovunque vivrà “e quando, liberato dal carcere del corpo e dalla terra, volerà via, in qualunque parte del cielo lo collocherà il Padre comune”, Paolino conserverà nell’intimo del cuore l’immagine dell’antico maestro e lo abbraccerà a lui presente con affettuoso pensiero (mente complectar pia / ubique praesentem mihi)”.59 Proiettando ormai il suo “nuovo” amore sullo sfondo escatologico, Paolino proclama solennemente la sua fede incrollabile nella immortalità dell’anima umana, “che, essendo di origine celeste, sopravvive alla corruzione del corpo, necessariamente conserva insieme i suoi sentimenti ed affetti, come la sua propria vita, e non ammette né morte né oblio, eternamente viva e memore”.60 Tutto questo è proclamato da Paolino forse in sottile polemica proprio col suo maestro, che, non molti anni prima, aveva concluso l’elogio del professore di Bordeaux, Tiberio Vittore Minervio, amato e pianto come un padre, insinuando appunto il dubbio sulla sopravvivenza dell’anima umana.61 57 Ibid. 39-43: Si iungar amore, / hoc tantum tibi me iactare audebo iugalem, / quo modicum sociis magno contendit habenis / dulcis amicitia aeterno mihi foedere tecum / et paribus semper redamandi legibus aequa. 58 D. SORRENTINO, L’amore di unità: Amicizia spirituale ed ecclesiologia in Paolino di Nola, in Impegno e dialogo 9 (1991-1992), pp. 149-169. 59 PAVL. NOL. Carm. XI, 49-62: Ego te per omne quod datum mortalibus / et destinatum saeculum est, / claudente donec continebor corpore, / discernar orbe quolibet, / nec ab orbe longe nec remotum lumine / tenebo fibris insitum, / videbo corde, mente conplectar pia / ubique praesentem mihi. / Et cum solutus corporali carcere / terraque provolavero, / quo me locarit axe communis pater / illic quoque animo te geram. / Neque finis idem qui meo me corpore / et amore laxabit tuo : Paolino, sguardo e cuore protesi verso il futuro immortale, ribadisce che nel tempo che vivrà e per tutta l’eternità, dovunque il Padre comune vorrà collocarlo nel suo regno infinito, conserverà per sempre il suo amore per Ausonio. 60 Ibid. 63-68. 61 Cf. AVSON. Prof. I, 39-42: Et nunc, sive aliquid post fata extrema superfit, / vivis adhuc, aevi, quod periit, meminens; / sive nihil superest nec habent longa otia sensus, / tu tibi vixisti: non tua fama iuvat. 225 La risposta di Paolino segna pertanto la fine di un’amicizia umana e di un rapporto di “pietà”, che non sono riusciti a sublimarsi nella carità di Cristo né a proiettarsi sull’orizzonte dell’eternità, per vivere un’esperienza di vita nuova.62 IV - ALL’OMBRA DEL “VASTO FAGGIO”: TITYRUS CHRISTIANUS 63 Ausonio e Paolino in questa loro corrispondenza finale, che anima il vivace dibattito sulla conversione ascetica del discepolo, si muovono ambedue costantemente sullo sfondo virgiliano: il Mantovano domina ancora l’immaginario e l’espressione poetica dei due autori. Soprattutto con le vicende dei protagonisti di due delle Bucoliche, la prima e l’ottava, che costituiscono le icone germinali dell’epistola metrica 25 di Ausonio e del carme XI di Paolino. Ausonio, a sancire la presa d’atto della frattura del vincolo d’affetto col discepolo, che, da solo, ha rotto la loro antica amicizia, conclude l’epistola 25 con la descrizione del suo sogno fantastico di rivedere e riabbracciare il suo Paolino. A questo punto egli riporta il penultimo verso dell’VIII Bucolica di Virgilio: Credimus? an qui amant, ipsi sibi somnia fingunt?= “Devo crederci? Oppure questi sono sogni che coloro che amano s’inventano per loro consolazione?”.64 Orbene, l’ottava egloga virgiliana, in 109 esametri, tratta il tema dell’amore respinto, in una gara di canto tra due pastori, Damone e Alfesibeo, e svolge due opposti drammi amorosi: nel canto di Damone (1-62) è un giovane pastore, che, respinto e tradito dall’amatissima Nisa, chiude col suicidio la propria vita infelice; in quello di Alfesibeo (62-109), invece, è una giovane donna, che, abbandonata dall’amante Dafni, ricorre a molteplici scongiuri ed incantesimi, per ottenere il ritorno del suo uomo. E alla fine ci riesce. Perciò il Poeta mantovano al vecchio ritornello “Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim”, che ha scandito il dipanarsi del canto di Alfesibeo, sostituisce in ultima sede, a suggello del suo carme, il nuovo esametro 62 Anche se l’opera poetica di Ausonio continua ad essere presente e molto attiva negli scritti del suo discepolo: cf. G. GUTTILLA, La presenza di Ausonio nella poesia dell’ultimo Paolino, in Orpheus 14 (1993), pp. 275-297. 63 W. SCHMID, Tityrus Christianus: Probleme religiöser Hirtendichtung an der Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert, in Rheinisches Museum für Philologie 96 (1953), pp. 101-165. 64 VERG. Ecl.. VIII, 108. 226 “Parcite, ab urbe venit, iam parcite, carmina, Daphnis” (109), che presenta appunto il compimento favorevole dell’evento. Pertanto Ausonio, che intende presentarsi nelle vesti dell’amante tradito, trascura che nell’ultimo verso virgiliano l’Incantatrice mostra di aver ormai avvertito i segni dell’avvenuto ritorno dell’amante che era fuggito in città. Ma ad Ausonio premeva soprattutto sottolineare la sua amara delusione e turbare i “sogni” del suo discepolo. Paolino, da parte sua, risponde per le rime all’epistola 25 del suo maestro. Accoglie la sfida del precettore, ma non accetta la sua immagine di amante respinto. E nel suo carme XI si richiama anche lui al mondo pastorale virgiliano, ma spazia in modo speciale nell’ambito e sullo sfondo della prima Bucolica del Mantovano. In realtà non mancano richiami espliciti di questo testo virgiliano nei versi di Paolino.65 Ma in modo particolare il Nolano si rifà alla “situazione” dei due pastori, protagonisti della prima egloga, Titiro e Melibeo, la cui diversa condizione esistenziale è stata sancita dall’intervento del giovane Ottaviano, venerato come un dio da Titiro, che, sdraiato all’ombra del vasto faggio, si gode tranquillamente la pace e il possesso dei suoi campi, insieme con i suoi greggi. Anche Paolino, come Titiro a Melibeo, potrebbe dichiarare ad Ausonio: “deus nobis haec otia fecit” (I, 6): un dio, quello che Titiro ha avuto modo di contemplare e venerare nel suo viaggio a Roma e che gli ha conservato l’otium nel suo podere, e un Dio, quello che Paolino ha accolto nel suo cuore e nella sua vita e che ha trasformato il suo otium ruris in ritiro ascetico, un Dio, il cui volto rimarrà impresso indelebilmente e per sempre nel cuore e del giovane pastore e del neofita cristiano. Paolino, da parte sua, riconosce nella diversa condizione dei due pastori virgiliani l’immagine diretta della situazione che si è creata tra lui e il suo maestro, nel momento in cui il Signore Dio è intervenuto nella sua vita cambiandola radicalmente e spezzando tutti i legami col mondo ed anche i vincoli delle antiche amicizie: come l’otium concesso a Titiro dal suo dio romano ha spezzato il suo consortium con l’amico Melibeo, costretto dagli eventi bellici ad abbandonare la patria e i suoi campi, così la decisione di vivere in ritiro cristiano (otium), ispirata da Dio a Paolino, ha comportato la necessità di rompere ed abbandonare le vecchie amicizie, nate e rimaste sul piano puramente umano. Orbene, un poeta cristiano e di 65 ID. Ecl. I, 25. 63. 227 fede ardente come Paolino non poteva non proiettare sul vasto orizzonte celeste della vita immortale anche l’antica amicizia col suo patrono, maestro e padre. Sarebbe bastato che quest’ultimo avesse disposto il suo cuore a seguire il discepolo sulla nuova via del Vangelo, perché la loro unione e corrispondenza di amorosi affetti assumesse i caratteri perenni dell’immortalità. E’ evidente che la poesia e il mondo fantastico di Virgilio costituiscono ancora “un ponte vitale” tra i due mondi che si trovano a confronto ed in netta opposizione: quello, vecchio, di Ausonio e quello, nuovo, di Paolino. Ausonio in realtà rappresenta la cultura e la società letteraria dell’aristocrazia del tardo Impero, immersa nel mondo della mitologia e della favola, ma del tutto incapace di procurare all’uomo la salvezza e la felicità. Ma, nello stesso tempo, la corrispondenza, intercorsa in questo periodo spagnolo tra il maestro e il discepolo, evidenzia che i due elementi essenziali alla sopravvivenza dei loro rapporti umani, vale a dire un’amicizia nata e costruita in modo tradizionale ed una letteratura puramente secolare e fantastica, appaiono al nostro Paolino, già in questa fase della sua vita, del tutto insufficienti ed inadeguate ad esprimere il nuovo mondo della fede e della morale del Vangelo. Per Paolino, convertito ormai all’ideale della perfezione evangelica, occorrono adesso ben altre fonti e ben altri personaggi per rivitalizzare e riconcettualizzare la cultura classica, che si avvia a diventare cristiana ed a produrre i suoi frutti maturi: sarà la Bibbia ed il suo ricco e complesso mondo religioso a fornire materia nuova alla vita e al canto in prosa ed in versi di Paolino. Questo nuovo orientamento di vita e di arte, Paolino lo sta già realizzando nel suo ritiro spagnolo con la composizione di poesie di contenuto religioso, databili appunto agli anni 389-394.66 V - NOVITA’ E CONTINUITÀ: UN PERCORSO TUTTO IN SALITA L’atteggiamento leale e nello stesso tempo deciso, tenuto da Paolino nei confronti del suo maestro ed amico, diventa ancora più rigoroso dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta nel Natale del 394. Subito dopo infatti egli scrive l’epist. 1 a Severo, appena convertito all’ideale ascetico, e lo esorta a fuggire lontano dagli amici di un tempo, che, opponendosi alle scelte dei due amici, devono essere 66 Si tratta dei Carmi VI-IX, del Carme XXXI, delle Epistole 35 e 36 a Delfino e ad Amando e del Panegirico di Teodosio. 228 recisi dalla comunità cristiana.67 E qualche anno dopo egli rivolgerà gli stessi consigli ad un altro amico di gioventù, Apro, che, insieme con la moglie ha deciso di seguire l’esempio di Paolino (epistt. 38.39.44 ad Apro e Amanda).68 A proposito dei carmi X e XI abbiamo sottolineato l’opposizione netta che nel pensiero di Paolino si era ormai consolidata, già nella prima fase del suo ritiro spagnolo, tra mondo classico e mondo cristiano. Ma in essi egli sottolinea con forza anche gli elementi e i segni di continuità tra le due visioni del mondo. Infatti, oltre alle diverse forme poetiche classiche, di cui egli continua a servirsi per esprimere i nuovi contenuti spirituali e morali, illustrati e narrati attraverso l’assidua utilizzazione della Sacra Scrittura, Paolino sostiene con convinzione che il Signore Dio ha innestato la nuova realtà ed esperienza della sua vita cristiana e della sua arte sull’antica formazione classica ricevuta appunto ad opera di Ausonio. Egli non ha ancora messo in atto il suo profondo desiderio, oggetto della sua preghiera, di seguire l’esempio dei grandi filosofi e asceti in ritiro dal mondo per meditare Cristo, ma è questa la meta che ormai brilla davanti alla sua mente e lo alletta in modo particolare. In Spagna ora Paolino sta vivendo ancora in città famose e ricche, ma già il suo pensiero è fisso a S. Felice e alla sua Coemeterium. Sotto l’apparentemente logico e sereno itinerario di maturazione cristiana di Paolino, si intuisce la drammatica tensione delle sue scelte, il tormento e le difficoltà che insieme con la moglie Terasia deve affrontare e superare per tradurle in pratica. Paolino poi è profondamente convinto che il battesimo costituisce l’atto di santificazione fondamentale, rigenerativo, fondante della vita cristiana, vissuta in sintonia con la legge del Vangelo: consacrata a Dio ed innestata in Cristo, la vita spirituale col sacramento del battesimo compie ap67 PAVL. NOL. epist. 1, 5: “Sia pur esso un tuo fratello ed un amico a te unito più della tua destra e più caro dei tuoi occhi, se però è a te estraneo e nemico in Cristo, sia per te un pagano e un pubblicano. Sia reciso dal tuo corpo come inutile destra chi non è unito a te nel corpo di Cristo; sia cavato come occhio dannoso, chi con la sua immondezza o cecità ottenebra tutto il tuo corpo. Infatti è preferibile che un solo membro perisca per la salvezza di tutto il corpo, piuttosto che tutto il corpo, come dice il Signore, vada nella Geenna per amore di un solo membro difettoso”. 68 Soltanto in un secondo momento, Paolino mitigherà alquanto il suo atteggiamento di fronte agli amici che di fatto si sono rifiutati di seguirlo e di abbracciare l’ideale ascetico. Così nell’epist.16 e nel carme XXII indirizzati a Giovio, suo parente, oppure nelle lettere 40 e 41 a Santo, amico d’altri tempi. 229 punto il suo primo passo, quello di ingresso nel circuito ad alta tensione della comunità cristiana. Una volta entrato a far parte della Chiesa, il cristiano è chiamato a compiere comunque le sue scelte personali di “conversione”: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15), è il messaggio che Cristo rivolge a tutti i suoi seguaci, all’inizio del suo ministero salvifico. Ebbene, il suo discepolo può senz’altro fermarsi all’esperienza “ordinaria”, che si realizza in una sequela di Cristo che potremmo indicare di primo grado, limitata cioè all’osservanza scrupolosa dei comandamenti, che di certo non contraddice né si oppone ad una completa e perfetta esperienza umana in tutte le sue legittime possibilità offerte dal mondo. Ma il cristiano può anche consacrare anima e corpo al Maestro ed abbracciare con decisione l’invito alla perfezione evangelica proposta da Cristo al giovane ricco: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quanto possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi” (Mt 19, 21). Questa strada di totale consacrazione a Cristo è quella scelta da Paolino: rifiuto dei beni del mondo riconsegnandoli a Cristo nei suoi poveri; rifiuto dei propri beni interni, vale a dire l’intelletto con la sua ricca formazione culturale e la volontà con i suoi sentimenti più profondamente umani e vitali come l’amore coniugale, l’amicizia e la grande passione per la cultura umanistica. “Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”, sottolinea Gesù nel Vangelo (Mc 8, 34). Paolino dunque, già in questi anni spagnoli, si è impegnato seriamente in una “conversione” piena, in un completo quanto radicale cambiamento della propria vita materiale, culturale e spirituale, un cambiamento, questo, che è frutto di una “mentalità” nuova, un nuovo modo di sentire e di vivere, che è proprio di chi ha abbracciato l’ideale ascetico-monastico: contemptus mundi e sequela Christi, come egli stesso sottolineerà poi all’amico Sulpicio Severo.69 Il percorso è lungo e difficile, soprattutto nella fase di spogliamento e purificazione interiori, e Paolino lo proclama a chiare lettere negli intimi colloqui epistolari con i suoi numerosi corrispondenti. E’ un percorso duro che il suo antico maestro e sempre caro padre Ausonio non riuscirà mai a comprendere in pieno. Perciò anche quan69 PAVL. NOL. epist. 5, 4 a Severo: “Allontanato a poco a poco il mio animo dai torbidi del mondo ed applicatolo ai precetti del Signore, lottai con più facilità per il disprezzo del mondo e per la sequela di Cristo, come se provenissi da una strada già molto vicina a questo nuovo progetto di vita”. 230 do finalmente riceve notizie del discepolo in ritiro ai piedi dei Pirenei, la sua reazione rimane alla superficie, così come alla superficie era sempre stata la sua scelta cristiana. Tutti questi elementi sono già presenti nei due carmi diretti ad Ausonio: Paolino non ha scosso il giogo dell’antica amicizia col maestro, patrono e padre che l’ha nutrito ed allevato fin dai più teneri anni; egli non vive ancora in luoghi deserti, prediletti da asceti e da anime nobili dedite alla poesia e alla filosofia; non è un Bellerofonte fuor di senno, né è alla mercé della moglie, che non è una Tanaquilla, bensì una Lucrezia. Ancora non si è liberato dei beni terreni, ma ha capito benissimo che essi devono essere rimessi nelle mani di Cristo per farne usufruire con interesse centuplicato i poveri. Paolino ha davvero dato una svolta decisiva alla sua esistenza. Egli non è più quello di una volta. Non intende più seguire le Muse e le vuote favole dei poeti, ma neppure i sofismi dei filosofi e gli artifici degli oratori. Ispiratore del suo canto d’ora in poi sarà solo Cristo. 231 232 INDICE G. SANTANIELLO - P. SCAFURO, Introduzione . . . . . . . Pag. 5 G. RAVASI, L’uomo pellegrino dell’assoluto . . . . » 09 F. PASTORE, Il potere nella politica: risorsa o tentazione? . . » 21 P. CASILLO, Le fatiche di Sisifo dei cattolici in politica . . . » 31 P.M. DE STEFANO, Le comunicazioni globali: la voce plurale della democrazia. . . . . . . . . . . . . . . . . » 53 C. GRECO S.I., La credibilità della rivelazione . . . . . . » 81 C. RICCIO, L’«impeto fecondo». La poesia di Clemente Rebora » 99 R. SIBILLA, Sulle tracce della poesia di Mario Luzi . . . . » 113 B. FORTE, La verità nella poesia di Mario Luzi . . . . . . » 133 A. F. LANZA, Origine ed evoluzione dell’universo: gli ultimi sviluppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 151 G. MOLLO, A. SOLPIETRO, La valorizzazione ed il restauro dei beni culturali della Chiesa nella Diocesi di Nola. Bilanci e prospettive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 165 Appendice 1 L’Intesa C.E.I. - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali » 177 Appendice 2 Intesa Programmatica tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana . . . . . . . . . . . . » 183 A.V. NAZZARO, Luca 1, 39-56 nelle parafrasi di Giovenco (1, 80-104) e Paolino (Carm. 6, 139-78) . . . . . . . . . » 191 G. SANTANIELLO, Il dramma della conversione nel dibattito tra Ausonio e Paolino . . . . . . . . . . . . . . . . » 205 233 PUBBLICAZIONI CENTRO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SU PAOLINO DI NOLA Collana «Strenae Nolanae» diretta da Antonio V. Nazzaro S. PRETE, Motivi ascetici e letterari in Paolino di Nola (Strenae Nolanae 1), LER, Napoli/Roma 1987, L. 20.000. T. PISCITELLI CARPINO, Paolino di Nola. Epistole ad Agostino (Strenae Nolanae 2), LER, Napoli/Roma 1989, L. 30.000. A. RUGGIERO (a cura di), Il ritorno di Paolino. 80° dalla traslazione a Nola. Atti, documenti, testimonianze letterarie (Strenae Nolanae 3), LER, Napoli/Roma 1990, L. 30.000. G. SANTANIELLO, Paolino di Nola. Le Lettere, 2 voll. (Strenae Nolanae 4-5), LER, Napoli/Roma 1992, L. 90.000. A. RUGGIERO, Paolino di Nola. I Carmi, 2 voll. (Strenae Nolanae 67), LER, Napoli/Roma 1996, L. 90.000. AA.VV, Atti del II Conveno. XVI Centenario del ritiro di Paolino a Nola (395-1995), Nola 18-20 maggio 1995, a cura di G. Luongo (Strenae Nolanae 8), LER, Napoli/Roma 1998, L. 60.000. SAVERIO DE RINALDIS, Paolineide, a cura di Andrea Ruggiero (Strenae Nolanae 9), LER, Napoli 2002, Euro 12,00. AA.VV., Gianstefano Remondini, Atti del Convegno nel III Centenario della nascita, Nola, 19 maggio 2001, a cura di Carlo Ebanista e Tobia R. Toscano (Strenae Nolanae 10), LER, Napoli 2003, Euro 26,00. 234 VOLUMI PUBBLICATI DALLA BIBLIOTECA S. PAOLINO IMPEGNO E DIALOGO / 1 Atti Sommari 1981-82 G. SANTANIELLO, Aspetti religiosi e socio-culturali dell’età di Paolino; G. M. RUGGIERO, Paolino in Nola Pelagiana; A. V. NAZZARO, Il Carme IX di Paolino di Nola; A. RUGGIERO, Carme XXI, Nola Crocevia dello spirito; A. RUGGIERO, Carme XVII, Il Canto dell’Amicizia cristiana; G. GRIMALDI, Paolino di Nola: una proposta spirituale per il nostro tempo; V. DE FALCO, L’uomo in Erich Fromm; B. SCHETTINO, L’uomo in E. Mounier; L. SIMONETTI, L’uomo in Antonio Gramsci; P. LA MARCA, L’uomo in Rudolf Carnap; M. F ABBROCINI, L’uomo in Teilhard de Chardin; L. VASSALLO, Il contesto storico-sociale dell’Enciclopedia; D. S ORRENTINO, L’Encyclopedie; G. MERCOGLIANO, La filosofia dell’illuminismo; D. SORRENTINO, Gli illuministi e il problema di Dio; C. ROBERTO, Interpretazione e rappresentazione della natura; S. DE FALCO, La chimica all’epoca degli illuministi; W. SORRENTINO - V. CONFETTO, Gli strumenti chirurgici del ‘700; F. MANGANELLI, L’economia dell’Enciclopedia; L. MUCERINO, L’illuminismo oggi; E. IORIO, «Premi Letterari»: Il Campiello ‘81: «Diceria dell’untore» di G. Bufalino; E. CAPPA, Il Bancarella ‘81, Socialista di Dio, di Sergio Zavoli; E. CAPPA, «Narrativa flash»: «La sopravvivenza» di Dante Troisi; E. CAPPA, «Severina» di Ignazio Silone; E. IORIO, Leonardo Sciascia: La letteratura come verità; T. TOSCANO, Rilettura della narrativa di Mario Pomilio; R. SIBILIA, Vita e morte nell’itinerario umano e artistico di G. Testori; E. IORIO, Dolore e speranza nell’opera di Giorgio Saviane; G. MINIERI (a cura di), Nola Millenaria; C. NAPOLITANO, Casamarciano nei secoli; M. ACIERNO, Nella realtà delle cose. IMPEGNO E DIALOGO / 2 Incontri Culturali 1983-85 A. MONTICONE, L’impegno culturale del cristiano; M. POMILIO, Il dolore nel Manzoni; S. PRETE, La povertà in Paolino: estetismo letterario o sincerità di convertito?; T. PISCITELLI CARPINO, Tra Classicismo e Cristianesimo: Le Epistole di Paolino di Nola ad Agostino; A. RUGGIERO, Nola e San Paolino nei Carmi di Gennaro Aspreno Galante; G. COSTANZO - S. IOVINO, Tavola Rotonda su: Alle radici culturali e sociali della camorra; C. PETRELLA - A. M. DI GENIO, Droga: problemi, prospettive, esperienze; E. SANTUCCI - G. DEVASTATO, L’esperienza 235 della comunità «Il pioppo» di Somma Vesuviana; A. DI CARO, LeviStrauss: i segni e il potere; M. PRISCO, La provincia addormentata: 1949-1984; R. SIBILLA - S. LUMINELLI, Radici crisitane nell’opera di Rocco Scotellaro; E. CAPPA, Eugenio Corti e il Cavallo Rosso; E. IORIO, Per un ripensamento delle unità aristoteliche: Il teatro di T. Wilder; R. SIBILLA, La poesia di Giuseppe Centore; E. CAPPA, Umano e divino nella narrativa di L. Santucci; C. MASUCCI, Ecologia. fondamenti e prospettive; G. MASCIO, Ecologia e salute: aspetti generali e situazione dell’area nolana; F. MANGANELLI, Inquinamento e disinquinamento; G. COSTANZO, Alle radici del male, a cura di A. MONSURRÒ; G. GIUSTI, Nazareno, una storia del Sud, a cura di C. TESONE; E. CAPPA, Le rime del silenzio, a cura dell’Autrice; L. AMMIRATI, Ambrogio Leone nolano, a cura di TOBIA R. TOSCANO; D. CAPOLONGO, Momenti di storia dell’Agro Nolano; G. FULCO - T. TOSCANO - D. CAMPANELLI, Studi in onore di Pietro Manzi, a cura degli Autori. IMPEGNO E DIALOGO / 3 Incontri Culturali 1985-86 G.COSTANZO, La Biblioteca Diocesana «San Paolino»; Statuto della Biblioteca; Statuto del Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola; A. CORTESE ARDIAS, Biblioteca e territorio: per una politica della cultura in Campania; M. G. MALATESTA PASQUALITTI, La Biblioteca: da luogo di consultazione a centro di animazione culturale; D. SORRENTINO, Biblioteca S. Paolino: dieci anni di attività; M. G. MARA, Ricchezza e povertà nel cristianesimo primitivo; G. SANTANIELLO, L’opera missionaria della Chiesa tra il IV e il V secolo: La lettera 18 di Paolino a Vittricio di Rouen ed il Carme 17 a Niceta di Remesiana; trad. di G. SANTANIELLO, Le due lettere di Paolino a Vittricio; D. SORRENTINO, La «democrazia» di Luigi Sturzo; L. SIMONETTI, La democrazia in Karl Marx e Antonio Gramsci; M. FABBROCINI, Karl Raimund Popper e la società aperta; G. DE RITA, La complessità sociale e le nuove povertà; R. SIBILLA, Incontro con Domenico Rea; E. CAPPA, Attualità di Carlo Levi; R. SIBILLA, Calvino: una biografia intellettuale; F. MANGANELLI, Incontro con i poeti del Gambrinus; R. DE LUCA, Libroforum su V. Quindici, Nola antica; A. DRAGO, Quale alternativa alla difesa nucleare?; G. RAGOZZINO, Il Cardinale Bartolomeo D’Avanzo nell’inedito «Chronicon» di Gennaro Aspreno Galante. IMPEGNO E DIALOGO / 4 Incontri Culturali 1986-87 F. BELLA, Una scienza per l’uomo; S. D’ELIA, Sullo sfondo storicoculturale dell’opera di S. Paolino di Nola; A. RUGGIERO, Paolino cantore di Cristo; E. IORIO, Leonardo Sciascia; P. DI SOMMA, Clemente Rebora: Tormento e poesia; M. CONDORELLI, Eutanasia: approccio eti- 236 co-medico-giuridico; G. GIULIANO, L’Eutanasia: approccio teologicomorale; A. NEGRO, L’omeopatia: una medicina per tutto l’uomo; Medicina omeopatica Hahnemanniana: un’esperienza della dr.ssa Alma Rodriguez; R. RAIMONDI, Premesse metodologiche per le ricerche di Storia locale; D. CAPOLONGO, Brevi considerazioni sull’attuale situazione storiografica del nolano; F. R. DE LUCA, L’archivio storico diocesano di Nola; F. MIANO, Etica ed esistenza nella filosofia di Karl Jaspers; M. MALATESTA, La logica e il problema di Dio; P. CASILLO, Che cosa pensano i giovani della vocazione sacerdotale e religiosa?; A. RUGGIERO, Libroforum su: M. Piciocchi, Quattro conversazioni su Giordano Bruno; S. GAETA, Libroforum su: D. Sorrentino, Giuseppe Toniolo. Una Chiesa nella storia. IMPEGNO E DIALOGO / 5 Incontri Culturali 1987-88 B. SORGE, Cattolici e politica oggi in Italia; D. SORRENTINO, Chiesa, cattolici e politica in Italia tra la caduta del fascismo e il referendum istituzionale nel diario inedito di Egilberto Martire; F. MANGANELLI, Alla ricerca del senso della cultura popolare; G. ZARONE, Su essere e verità in Heidegger; E. SGRECCIA, Ingegneria genetica umana: problemi etici; P. DE STEFANO, Leopardi tra linguistica e semiotica; E. CAPPA, La sfida ne «L’ultima valle» di Carlo Sgorlon; Incontro con l’autore: Dante Troisi. IMPEGNO E DIALOGO / 6 Incontri Culturali 1988-89 G. C AMPANINI , Il contributo dei cattolici alla Costituzione; D. SORRENTINO, La rivoluzione francese e la cultura politica dei cattolici italiani; V. DINI, La società post-industriale e la crisi dei linguaggi; A. D’ACUNTO, L’emergenza “ambiente” in Campania; G. SAVERESE, La filosofia del Leopardi; M. T. SCALA - P- D. SOMMA, La poesia: il potere di immaginare nella società tecnologica; L. FERRAGINA - A. MASULLO, La situazione documentaria concernente S. Felice Vescovo di Nola; V. CIMMELLI, La chiesa arcipretale nullius di S. Pietro a Scafati; P. LUCIANO, Il Vallo di Lauro nei documenti di una Commenda del S.M.O. di Malta. IMPEGNO E DIALOGO / 7 Incontri Culturali 1989-90 F. CASAVOLA, Democrazia: da potere del popolo a bene comune; E. MAZZARELLA, La crisi del socialismo reale e i nodi della democrazia occidentale: quali prospettive? Tavola rotonda: Per un nuovo sviluppo del Mezzogiorno: la sfida della solidarietà. interventi di: Giuseppe 237 Costanzo, Antonio Auriemma, Gennaro Ferrara, Carlo Biffi; D. SORRENTINO, Moralità e prassi politico-amministrativa; P. G. DONINI, Islam e Occidente; M. ABRAH, Nuovi aspetti del crescente fermento religioso sciita; O. MARRA, Sul rapporto tra scienza arabo-islamica e scienza occidentale; L. D’ONOFRIO, Dall’utopia alla speranza. L’esperienza teologico-poetica di Charles Péguy; M. T. SCALA - S. M. MARTINI - E. MICCINI, La poesia visiva: parole ed altro...; G. NAPPI, Il concetto di stress nello sviluppo delle neuroscienze; D. CAPOLONGO - B. MORALDO - V. CAPUTO, Il parco del Partenio: una valenza ecologica della Campania; P. MOSCHIANO, Il brigantaggio nel nolano e nel Vallo di Lauro; A. RUGGIERO, Il culto dei santi e delle loro reliquie nei carmi di Paolino di Nola; A. FRANCHI DE BELLIS, Intorno al cippo abellano. IMPEGNO E DIALOGO / 8 Incontri Culturali 1990-91 S. ZAVOLI, Mass media e impegno per la democrazia. Una testimonianza; Tavola rotonda: Rinnovamento della politica e «questione morale». Interventi di Raffaele Cananzi e Ennio Pintacuda; D. SORRENTINO, Dalla Rerum Novarum alla Centisimus Annus. Profilo storico del magistero sociale; A. TORTORA, Diocesi di Nola e mondo del lavoro. Situazione e prospettive; P. DE STEFANO, Il linguaggio della politica; P. PIFANO, L’uomo nella cultura mitteleuropea; E. CAPPA, Cesare Pavese: Un approccio esistenziale; M. T. SCALA - A. IZZO , Dadaismo per iniziare; M. DE MARIA; I trapianti d’organo; G. GIULIANO, Trapianti d’organo: approccio etico; G. MOLLO, Il convento di S. Angelo in Palco a Nola; M. NUNZIATA, Ferdinando Fuga e la caserma Principe Amedeo; A. RUGGIERO, Agostino, Paolino di Nola e l’epigrafe per Cinegio, C. IANNICELLI, Note al lessico paoliniano. Indagine su alcuni appellativi riferiti a S. Felice. IMPEGNO E DIALOGO / 9 Incontri Culturali 1991-92 B. FORTE, Cristianesimo ed Europa: oltre la modernità, i fondamenti della speranza; R. GATTI, La crisi della democrazia e le prospettive dell’umanesimo politico; G. SALVINI, Rapporti Nord-Sud del mondo: una sfida per il 2000; G. ACONE, Le nuove frontiere dell’educazione; L. CUCCURULLO, Scienze-Scientismo e valori dell’uomo; V. DE LUCA, Il caso di Primo Levi: un particolare rapporto tra Ebraismo e letteratura; M. T. SCALA, Lo specchio trasparente. Introduzione al surrealismo; M. FRANCO, Dada e surrealismo al cinema; A. RUGGIERO, Nola e il Beato Giovanni Duns Scoto; F. R. DE LUCA, I documenti relativi a Giovanni Duns Scoto conservati nell’Archivio Storico Diocesano di Nola; A. CACCAVALE, La Compagnia di Gesù a Nola; G. D’ERRICO, 238 Dottrina e poesia nelle Lettere di Paolino di Nola. Note critiche; R. MARANDINO, I dolci colloqui di Paolino nell’Epistolario; D. SORRENTINO, L’amore di unità - Amicizia spirituale ed ecclesiologica in Paolino di Nola; C. IANNICELLI, Il miracolo in Paolino di Nola. Saggio di sintesi; T. PISCITELLI CARPINO, La figura di Maria nell’opera di Paolino di Nola. IMPEGNO E DIALOGO/10 Incontri Culturali 1992-94 P. GIUNTELLA, Il «muro italiano» Nord-Sud: crisi sociale e prospettive del Paese; S. CECCANTI, Crisi dei partiti e riforme istituzionali; A. RIGOBELLO, Libertà e verità nell’odierno orizzonte culturale; A. ABIGNENTE, Democrazia e partecipazione: spunti per una riflessione; B. ULIANICH, La Chiesa nel mutamento della politica italiana; S. VASSALLO, Dinamismo elettorale e nuovi soggetti politici; G. V. COYNE, Il punto sulle teorie cosmologiche; G. MELANDRI, La difesa dell’ambiente dopo la conferenza di Rio de Janeiro; G. NERI, All’origine della vita umana, scenza ed etica a confronto; E. CAPPA, La poesia religiosa nel Novecento; G. AGNISOLA, Disperazione e speranza di Padre Turoldo; A. SERRA, Invito alla lettura di Pasquale Maffeo; P. MAFFEO, Il mio lavoro di scrittore; R. SIBILLA, Ritratti di donne nella letteratura e nella cultura contemporanea; A. SENA, La mosca e la bottiglia; R. LA CAPRIA, Il ruolo dell’intellettuale nel Sud, oggi nel laboratorio di «Ferito a Morte»; G. GUTTILLA, Ausonio e Paolino: rapporti letterari ed umani; A. SALVATORE, Riflessioni sulla poetica di Paolino di Nola; G. SANTANIELLO. La spiritualità di Paolino di Nola: Il cammino ascetico e mistico del convertito; A. NAZZARO, Orazio e Paolino; B. ULIANICH, Eucherio di Lione e il «De contemptu mundi»; C. IANNICELLI, Deus operatus est. Sull’autore del miracolo in Paolino di Nola e in alcuni scritti agiografici greco-latini; C. RUBINO, La poesia di Luigi Tansillo; D. NATALE, Angelo Mozzillo ed i suoi rapporti con Nola; R. PINTO, Considerazioni critiche sull’opera pittorica di Angelo Mozzillo; G. MOLLO, Metodologia per un restauro. La Chiesa di S. Chiara in Nola; F. MILO, Nola, la rinascita di una città nel secolo dei lumi; F. TRIFUOGGI, Giovanni Rinaldi, S. Maria delle Grazie, Insigne Collegiata in Marigliano. Cinquecento anni di storia ed arte. IMPEGNO E DIALOGO / 11 Incontri Culturali 1994-96 D. SORRENTINO - G. SANTANIELLO, Introduzione; P. SCOPPOLA, Presente e futuro della democrazia in Italia; A. MONTICONE, Il ruolo della cultura nell’attuale momento storico; D. M ONGILLO , Etica e fede; D. SORRENTINO, Cattolici e politica: che fare?; A. MARZANO, Politica ed economia; F. MANGANELLI, La disoccupazione giovanile; G. IORIO, Di- 239 soccupazione giovanile a Nola: Un’indagine con metodi qualitativi; C. R. MASUCCI - A. CICCONE - M. FUSCO, La diffusione delle patologie nel territorio nolano; F. FABBROCINI, Intelligenza artificiale, sistemi esperti e apprendimento automatico: tecniche, problemi, prospettive; A. DRAGO, Scienza ed etica in fisica e biologia; A. CARANDENTE, La letteratura: Quale futuro?; M. T. SCALA, I diritti del lettore; R. SIBILLA, Da donne... verso il terzo millennio; G. VITOLO, Federico II: Imperatore medievale o sovrano moderno?; G. LORIZIO, Il duplice volto della morte nel pensiero post-moderno; T. R. TOSCANO - F. TRIFUOGGI, La Stampa periodica a Napoli dalla rivoluzione del 1799 al nonimestre del 1820-21, nella ricerca di G. Addeo; V. D. IASEVOLI, Significativa presenza fiamminga a Pomigliano nel XVI secolo. Ripercussioni della strage di San Bartolomeo nell’arte del ‘500 a Napoli; G. SANTANIELLO, Momenti del percorso teologico di Paolino nel dialogo epistolare con Agostino; C. IANNICELLI, Rassegna di studi paoliniani (1980-1997). IMPEGNO E DIALOGO / 12 Incontri Culturali 1996-98 D. SORRENTINO - G. SANTANIELLO, Introduzione; B. SORGE, Quale speranza per la politica; S. ZAMAGNI, Lavoro, occupazione, economia civile; L. CORRADINI, Presenza Cristiana nella scuola che cambia; E. SGRECCIA, Dalla procreazione artificiale alla clonazione. Considerazioni etiche; Sulla clonazione a scopi “terapeutici”. Documento del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; P. CASILLO, Pluralismo delle scelte politiche e unità dei valori; F. MANGANELLI, Una esperienza: dalla Società civile al Parlamento; F. CASTELLI, Gesù nella letteratura contemporanea; M. MIELE, Gli anni di Giordano Bruno a Napoli. L’ambiente conventuale e i maestri; S. RIONERO, Il ruolo della matematica nella scienza moderna; G. SANTO, Il Seminario Vescovile di Nola dopo il Remondini; G. SANTO, Angelo Mozzillo e il Seminario Vescovile di Nola; M. C. CAMPONE, La lastra tombale di Monsignor Gallo: un’ipotesi ricostruttiva sulla Cripta di S. Felice nel Duomo di Nola; G. ADDEO, Il territorio nolano e la Repubblica Napoletana del 1799; A. D’AVANZO, L’associazionismo Nolano nell’ultimo ventennio dell’800; B. D’ANIELLO - C. R. MASUCCI, Aspetti naturalistici ed impatto antropico nel territorio Nolano; A. FUSCO, Le colline di Cicala; G. SANTANIELLO, Il presbitero Uranio testimone oculare della morte di Paolino; G. SANTANIELLO (a cura di), Lettera del presbitero Uranio a Pacato sulla morte di Paolino; D. SORRENTINO, L’immagine ideale del Vescovo nell’Epistola De obitu Sancti Paulini di Uranio; T. LEHMANN, Alarico in Campania: un nuovo Carme di Paolino di Nola; A. RUGGIERO, La teologia dell’arte sacra negli scritti di Paolino di Nola. 240 IMPEGNO E DIALOGO / 13 Incontri Culturali 1998/2000 G. SANTANIELLO, Introduzione; A. RIGOBELLO, I nuovi saperi del contesto culturale ed educativo di oggi; G. DE RITA, La società italiana di fine Millennio; G. BREGANTINI, Quale chiesa per il sud; F. MANGANELLI, Capitalismo e “capitalità”: la Laborem exercens e il conflitto capitale-lavoro; R. SIBILLA, La narrativa italiana dagli anni settanta agli anni novanta; V. PLACELLA, Giubileo e pellegrinaggio in Dante; M. T. SCALA, Il viaggio nel mondo femminile; F. MANGANELLI, Ridistribuzione della ricchezza: generosità o giustizia?; P. POUPARD, Purificazione della memoria e cultura della persona nel Terzo Millennio; G. ROMEO, La condanna di Giordano Bruno alla luce dei più recenti studi sull’inquisizione romana; G. CIOFFARI, Giordano Bruno e la tradizione teologica domenicana; B. DEPALMA, La nostra chiesa locale s’interroga; L. MUCERINO, Giordano Bruno, quale misticismo; G. SANTANIELLO, La figura ideale del Vescovo nell’opera di Paolino di Nola; G. GUTTILA, Spunti di “teologia politica” nei Carmi di Paolino di Nola; M. C. CAMPONE, Testimonianze iconografiche di Paolino di Nola. Inediti aspetti della fortuna del Santo: l’Inventio della vera croce; A. V. NAZZARO, La Laus Sancti Iohannis di Paolino di Nola: tra parafrasi ed esegesi; G. GUTTILLA, L’esordio di Paolino come poeta “dotto” cristiano. Il propempticon a Niceta (Carm. 17). 241
Scaricare