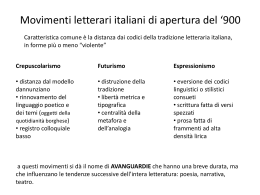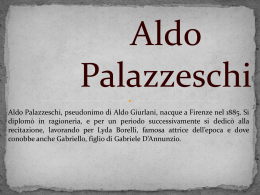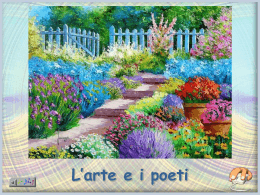1 2 « Lezione seconda » Quaderni del Centro Scolastico Diocesano –1– I Mercoledì letterari 2010-2011 INCONTRI CON LA LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO - II - a cura di Giannino Balbis Redemptoris Mater Albenga 2011 3 4 Il Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater, da lungo tempo operante sul nostro territorio, è una delle ricchezze della Città. Al pari delle altre scuole albenganesi, con una preziosa opera di formazione, istruzione, educazione, l'Istituto contribuisce in maniera determinante a crescere i nostri ragazzi e plasmare le future generazioni. In questo contesto, si inserisce perfettamente anche la pregevole iniziativa dei “Mercoledì letterari”, sapientemente organizzati dal prof. Giannino Balbis che, con l'ausilio di docenti e alunni, ogni anno confeziona un prodotto di grande valore. La letteratura, come scriveva lo studioso britannico C.S. Lewis, aggiunge alla realtà e non si limita a descrivere, arricchisce le competenze necessarie che la vita quotidiana richiede e, in questo senso, irriga i deserti delle nostre vite. Ecco perché i “Mercoledì letterari” rappresentano un approfondimento di eccellenza, che contribuisce ad arricchire la cultura e la conoscenza delle classi dirigenti del domani ingauno. Rosy Guarnieri Sindaco di Albenga 5 6 È con rinnovata soddisfazione che, per il secondo anno, da Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione del Comune di Albenga, saluto la presentazione degli atti dei “Mercoledì letterari 2010-2011” del Centro Scolastico Diocesano di Albenga, nel quadro degli “Incontri con la letteratura italiana del '900” curati dal prof. Giannino Balbis. L’impegno che tale pubblicazione comporta per la sua redazione e, per gli Insegnanti, la profusione di energie impegnate nell’educazione dei giovani e più in generale nella divulgazione della disciplina letteraria sono azioni meritorie del più ampio riconoscimento e del più sentito ringraziamento da parte di chi, come il sottoscritto, è impegnato a realizzare le migliori condizioni possibili per la formazione dei nostri giovani. In un mondo che, purtroppo, è contagiato sempre più da qualunquismo, dalla ricerca del piacere immediato e gratuito, dalla scarsa o nulla considerazione delle libertà e della personalità altrui, dal lassismo morale, ogni sforzo teso all’educazione ai valori morali tipici di una civiltà costruita a misura d’uomo è meritevole della considerazione, dell’approvazione e del sostegno di tutti coloro che hanno a cuore la formazione di “cittadini“ degni di tale nome. È quindi con sentito ringraziamento per il lavoro fin qui svolto che invito tutti i partecipanti ed i sostenitori di tale iniziativa a continuare nell’impegno in futuro coinvolgendo soprattutto, oltre a professori di ottima preparazione e conoscenza del mondo dei giovani, i giovani stessi in modo che siano consapevoli e attori del proprio futuro (quisque fortunae suae faber est). Ancora, come già in precedenza, consapevole del notevole impegno profuso da docenti ed alunni nel confezionare un prodotto dalla così grande valenza didattica, colgo con piacere l’occasione per augurare ogni successo e fortuna a chi vorrà consultare e seguire con profitto gli insegnamenti derivanti da questa pregevole pubblicazione. Nicola J. Podio Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione 7 8 Prefazione Con la fondazione nel 1990 del Centro Scolastico Diocesano “Redemptoris Mater”, la Chiesa locale di Albenga-Imperia si è munita di uno strumento essenziale per porsi in dialogo attivo con il mondo dell’educazione del nostro territorio. Da scuola media e ginnasiale, principalmente maschile e attiva nella accogliente e prestigiosa sede del Seminario Vescovile, dove prese avvio, sul finire degli anni '60 del secolo scorso, per felice intuizione e profusa dedizione pastorale del suo iniziatore, il Rettore Mons. Mario Ruffino, la scuola cattolica ingauna fu da lui trasformata in quella articolata realtà educativa che S.E. Mons. Alessandro Piazza e S.E. Mons. Mario Oliveri, Vescovi di Albenga-Imperia nella transizione tra gli ultimi decenni del Novecento e il primo scorcio del terzo millennio, hanno voluto sostenere e fortemente sviluppare integrandovi l’istituto magistrale e, in tempi più recenti, la scuola primaria. Attualmente il Centro Scolastico Diocesano accoglie alunni dai sei ai diciannove anni e, nel corso del tempo, ha saputo progressivamente radicarsi nel bacino urbano del ponente savonese e del levante imperiese, ponendosi come qualificato riferimento educativo e culturale per molte famiglie, alle quali ha saputo offrire un servizio di istruzione di ampio spettro per i propri figli, dalla scuola primaria alla maturità liceale. L’attenzione alla formazione integrale della persona, soggetto di sintesi di valori umani e spirituali, culturali e morali, ha caratterizzato da sempre l’offerta del Centro Scolastico Diocesano, che aspira sempre più ad identificarsi quale preziosa risorsa per l’arricchimento del nostro tessuto formativo attraverso una piena collaborazione con le istituzioni pubbliche e mantenendo ben saldi i tratti distintivi della propria originalità educativa di scuola di ispirazione cristiana. 9 Nel 2010 il Centro Scolastico Diocesano ha pubblicato il volume di lancio dei “Quaderni” della nuova collana “Lezione seconda”, avendo cura di mettere a disposizione dei giovani di tutte le scuole superiori del comprensorio ingauno la serie di lezioni tenute da docenti delle Università di Genova e Torino all’interno del ciclo di conferenze dei “Mercoledì letterari” curato dal prof. Giannino Balbis. Dalla sua qualificata collaborazione didattica e scientifica, infatti, ha preso spunto nel 2009 l’iniziativa di organizzare conferenze per approfondire ed indirizzare la preparazione degli studenti maturandi. Una gradita sponsorizzazione e la preziosa rete organizzativa dell’assessorato ingauno all’istruzione hanno consentito la distribuzione gratuita di 500 copie del volume agli alunni delle classi terminali di tutto il distretto. Nel presente volume 1 dei “Quaderni”, la collana “Lezione seconda” è arricchita dai sei interventi dei prestigiosi accademici che Giannino Balbis ha saputo coordinare in un delicato viaggio nella letteratura italiana del Novecento, potendo, così, offrire un originale profilo tematico capace di guidare anche gli studiosi più attenti attraverso il vasto materiale presentato. Auspichiamo che questa raccolta possa offrire al lettore una interessante ed autorevole prospettiva sui rapporti sempre più stretti che il Nuovo Polo Educativo Diocesano di prossima inaugurazione (2012) vuole promuovere tra il mondo della ricerca (letteraria, artistica, musicale, scientifica) e la scuola, tra la scuola e la società, tra la società e l’uomo. Un uomo che la Chiesa interpella con il suo pressante invito alla ricerca del bene. Il Centro Scolastico Diocesano, tramite le proprie attività, si augura di poter rappresentare un affidabile e fiducioso riferimento per i giovani che desiderano condividere una parte di quel cammino cui guardano con trepidazione per le molte sfide che prefigurano gli anni a venire. Giorgio Airaldi Preside Centro Scolastico Diocesano 10 Conferenza stampa di presentazione della collana “Lezione seconda” e della terza edizione dei Mercoledì letterari (Comune di Albenga, Sala degli stucchi, 15 ottobre 2010) 11 12 La terza edizione dei Mercoledì letterari Col conforto delle adesioni e dei consensi ottenuti, del patrocinio del Comune di Albenga e del sostegno della Provincia di Savona, i nostri Mercoledì letterari hanno confermato per il 2010-2011 la formula delle prime due edizioni, snodandosi in due cicli (ottobredicembre, gennaio-marzo), per un totale di sei conferenze-lezioni, nelle quali altrettanti docenti dell’Università di Genova hanno illustrato autori, opere, generi e temi del Novecento letterario italiano. In dettaglio: Vittorio Coletti, Il romanzo in Italia negli ultimi decenni; Giangiacomo Amoretti, La poesia di Ungaretti; Elio Gioanola, La poesia di Montale; Luigi Surdich, La poesia di Gozzano; Francesco De Nicola, Gli scrittori liguri e l’unità d’Italia; Franco Vazzoler, La letteratura secondo Pasolini, Fortini, Sanguineti. Nella conferenza stampa di presentazione della collana “Lezione seconda” e della terza edizione dei Mercoledì letterari – il 15 ottobre 2010, nella splendida Sala degli stucchi del Comune di Albenga – ho avuto l’opportunità di accennare al duplice orizzonte, scolastico ed extrascolastico, del nostro progetto. Da un lato, le lezioni dei Mercoledì letterari valgono come integrazione, approfondimento e completamento delle conoscenze e competenze degli allievi in vista dell’Esame finale di Stato (non a caso, figurano nei piani formativi e, a tutti gli effetti, nei programmi d’esame); per questo, seppur tenute da autorevoli docenti universitari, sono pensate per la scuola secondaria e tarate sui suoi livelli di interesse e fruibilità. Dall’altro, proprio in virtù della disponibilità comunicativa e divulgativa dei relatori, le lezioni sono aperte al pubblico, costituendo importanti occasioni di formazione permanente per l’intera comunità cittadina. I Mercoledì letterari, per altro, rappresentano il primo traguardo di un ampio progetto culturale rivolto alla città e al territorio, di cui il nostro Istituto vuole essere promotore e fulcro. Il prossimo traguardo 13 sarà l’organizzazione, a partire dalla primavera del 2012, di convegni annuali sulla letteratura italiana del Novecento, in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes (titolare, fra l’altro, del nuovo premio Grinzane), che in parallelo organizza i Convegni liguri-piemontesi (ogni anno, a settembre, a Monforte d’Alba). A tal fine, in data 2 aprile 2011, è stato ufficialmente costituito un apposito comitato scientifico, presieduto da Giorgio Bárberi Squarotti e composto, fra gli altri, da Giangiacomo Amoretti, Alberto Beniscelli e Valter Boggione, docenti delle Università di Genova e di Torino (che patrocinano i convegni monfortesi e patrocineranno anche i convegni albenganesi), già preziosi collaboratori e protagonisti dei nostri Mercoledì letterari. Giannino Balbis 14 Prima riunione del Comitato scientifico per i Convegni letterari (Aula magna del Redemptoris Mater, 2 aprile 2011) 15 16 VITTORIO COLETTI Il romanzo in Italia negli ultimi decenni Mentre la poesia italiana del Novecento è inquadrabile in categorie critiche (Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo ecc.) che ne distinguono momenti, contenuti, caratteri, non altrettanto si può dire per la narrativa, con la sola eccezione del Neorealismo. Si possono tuttavia riscontrare alcuni caratteri ricorrenti, il primo dei quali è l’attenzione ai fatti storici e politici: si pensi a Lussu (Un anno sull’altipiano), Calvino (Il sentiero dei nidi di ragno), Primo Levi (Se questo è un uomo), Rigoni Stern (Il sergente nella neve). Il romanzo italiano ha una forte connotazione nazionale e regionale, già con Manzoni, Nievo, Verga e ancora, per esempio, con Carlo Levi (Cristo si è fermato a Eboli) e Luigi Meneghello (Libera nos a malo), per non parlare di Camilleri e del suo singolare dialetto. Fra i principali caratteri del romanzo negli ultimi decenni (a partire dalla cesura dei primi anni ’70) si segnalano: a) l’accostarsi della tecnica del racconto e del montaggio al linguaggio televisivo-cinematografico; b) il perdurare della connotazione regionale (Calvino, Biamonti, Orengo, Maggiani in Liguria); c) il grande successo del giallo-noir (talora con intento di analisi sociale e denuncia) e, dunque, la forte preminenza della trama; d) il rilancio del romanzo-saggio (dai romanzi a tesi di Sciascia a Danubio di Magris); e) l’attenzione alla scienza (es. Il sistema periodico di Primo Levi, Le cosmicomiche di Calvino, Staccando l’ombra da terra di Daniele Del Giudice); f) l’abbassamento della qualità della scrittura; g) i primi casi di romanzi italiani scritti da non italiani (fra i migliori, Caduta libera di Nicolai Lilin). *** Mentre per la poesia italiana del Novecento esistono categorie critiche (Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo ecc.) che ne distinguono e fissano diversi momenti, contenuti, caratteri formali, non altrettanto si può dire per la narrativa, con la sola eccezione del Neorealismo (per altro, negli ultimi tempi, molto discusso e ridimensionato in ambito letterario). Non ci sono in Italia consuetudini di scrittura e di stile paragonabili, ad esempio, al 17 nouveau roman francese. Tuttavia si possono riscontrare alcuni caratteri ricorrenti (pur in romanzi e in autori fra loro diversi). Il primo di questi caratteri è l’attenzione ai fatti storici e politici. Il romanzo, genere già di per sé più vicino alla realtà, meno mediato e filtrato della poesia e del teatro, è in Italia – più che all’estero – particolarmente aperto ai grandi e spesso drammatici eventi storici, sociali, politici (la guerra, i lager, la resistenza ecc.): basti pensare a Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Se questo è un uomo di Primo Levi, Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern; addirittura, con Metello di Vasco Pratolini, il romanzo diventa luogo di discussione politica. La storia italiana offre da sempre molti spunti al romanzo (dai Promessi sposi alle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, ai Malavoglia di Verga): molto forte, perciò, è la connotazione nazionale ed anche quella regionale (diversamente da quel che accade, per esempio, in Inghilterra, dove si prediligono le storie individuali, le realtà psicologiche). Fra Otto e Novecento, in tal senso, non c’è quasi soluzione di continuità. Si pensi agli spaccati sociali di Moravia o ai romanzi a tesi di Sciascia; si pensi alla diversificazione regionale, anche in chiave linguistica, di romanzi come Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, Libera nos a malo di Luigi Meneghello, fino al recentissimo Accabadora di Michela Murgia, per non parlare dei fortunatissimi romanzi di Camilleri (con il loro singolare uso del dialetto). Nessun altro paese europeo può permettersi una narrativa altrettanto variegata, altrettanta varietà di ambientazioni e di linguaggi. Minore attenzione il romanzo italiano riserva ai problemi dell’io (nonostante La coscienza di Zeno di Svevo) e al genere fantastico (anche le Cosmicomiche di Calvino non sono narrativa di pura fantasia). Per entrare più direttamente nel tema della lezione, nella narrativa degli ultimi decenni – a partire dalla cesura che si determina all’inizio degli anni ’70 – si notano i seguenti principali atteggiamenti. a) Cambiano la tecnica del racconto e il montaggio: l’incipit è in medias res; il narratore tende a nascondersi e a coinvolgere il lettore nella narrazione; la costruzione della narrazione si avvicina al linguaggio televisivo e cinematografico (non a caso diversi romanzi 18 si prestano a trasposizioni cinematografiche – vedi Il nome della rosa di Eco – e talora sono scritti già in forma di sceneggiatura). b) Perdura la connotazione regionale: per limitarci alla Liguria, si pensi a Calvino, Biamonti, Orengo (per il Ponente), Maggiani (per lo spezzino). Tendono però a ridursi il mistilinguismo e la mescolanza degli stili. c) Si fanno più importanti le trame. Negli anni ’60 la descrizione prevale ancora sulla narrazione, mentre dagli anni ’70 le parti si rovesciano, anche grazie all’esplosione, in tutta Europa, del genere noir-giallo (Millennium di Stieg Larsson e Montalbano di Camilleri): il giallo è tutto fondato sulla forza della trama. Nei casi migliori (ad esempio nei romanzi del veneto Massimo Carlotto) il giallo è attento alla realtà sociale e può avere anche intento di denuncia politica e morale; può diventare anche romanzo-reportage, con particolare forza di denuncia, come nel caso di Gomorra di Roberto Saviano. Esempio di costruzione narrativa molto ben congegnata sono anche i romanzi di Niccolò Ammaniti. d) Si assiste ad un rilancio del romanzo-saggio, mai del tutto tramontato dai Promessi sposi in poi. Fra i migliori, in quest’ambito, i romanzi a tesi di Sciascia e Danubio di Claudio Magris. Da segnalare anche i recenti romanzi di Eugenio Scalfari. e) Si presta maggiore attenzione alla scienza: si pensi, ad esempio, a Il sistema periodico di Primo Levi, alle Cosmicomiche e a Ti con zero di Calvino, a Staccando l’ombra da terra di Daniele Del Giudice (La solitudine dei numeri primi, invece, allude al mondo scientifico soltanto nel titolo). f) Al romanzo arrivano tutti: non soltanto scrittori di professione, ma attori, cantautori, celebrità varie ed anche autori occasionali, dilettanti, persone della più varia estrazione sociale. Anche – ma non solo – per questa ragione, la qualità della scrittura si è molto abbassata: dai livelli di perfezionismo di un Calvino e di un Levi o di eleganza forbita e di esibizione di ricchezza di D’Arrigo, Consolo, Bufalino (per non parlare di Gadda), negli ultimi tempi si è passati ad una certa trascuratezza, per non dire sciatteria. C’è anche da mettere in conto che non esistono più gli editori di un tempo, attenti e scrupolosi nel leggere, selezionare, interloquire l’autore. g) Si registrano i primi casi di romanzi italiani scritti da non italiani (cosa normale per la narrativa in inglese o in spagnolo, ma 19 fino ad ora sconosciuta all’Italia, dove la lingua coincide sostanzialmente con il territorio nazionale). Il migliore tra questi – e fra i migliori in assoluto – è Caduta libera di Nicolai Lilin, moldavo siberiano dal 2003 residente in Italia; il romanzo, edito da Einaudi, racconta la vicenda autobiografica di un soldato dell’armata russa in Cecenia. La lezione di Vittorio Coletti (20 ottobre 2010) 20 GIAN GIACOMO AMORETTI Giuseppe Ungaretti Un grande poeta innovatore Dopo aver ricordato i momenti salienti della biografia e della formazione di Ungaretti (dall’Egitto alla Francia e all’Italia), il relatore ne illustra le due prime raccolte poetiche, L’Allegria (1919; titolo originale Allegria di naufragi, mutato ne L’Allegria nel 1931) e Sentimento del Tempo (1933), accennando anche a Il porto sepolto, prima raccolta in ordine cronologico (Udine, 1916), confluita poi ne L’Allegria. Allegria di naufragi (i naufragi alludono ai momenti dolorosi dell’esistenza, in primo luogo quelli prodotti dalla guerra, mentre l’allegria è la carica vitale dei sopravvissuti alla tragedia, l’amore per la vita, tanto più forte, per reazione, quanto più orrida è la guerra) è il primo libro poetico italiano davvero novecentesco. Ungaretti proviene da Alessandria d’Egitto, dal deserto, da un altro mondo: è estraneo alla tradizione letteraria italiana e può esimersi, dunque, dal confronto con Carducci, Pascoli, d’Annunzio (Gozzano invece, per fare un esempio, è in qualche modo costretto ad “attraversare” d’Annunzio per allontanarsene); la sua formazione passa per Nietzsche e Baudelaire (letti ad Alessandria) e per le avanguardie frequentate a Parigi (Marinetti e il futurismo, in particolare); è nella condizione ideale, dunque, per fondare una nuova poesia, estranea ai canoni metrici, stilistici, retorici della tradizione poetica italiana. Dal futurismo prende alcune istanze, come il rifiuto dei segni di interpunzione, che, tuttavia, per i futuristi obbedisce ad un’istanza “rivoluzionaria”, mentre per Ungaretti è il segno di una poesia nuova, fondata soltanto sulla parola. Nell’Allegria, infatti, la parola è isolata nel verso, dotata di rilevanza assoluta, nuda portatrice di significati radicali, “scrostata” dei ritmi poetici tradizionali. Si confrontino La pioggia nel pineto di d’Annunzio (dove le parole sono fuse in un ritmo fluido, musicale, nel quale perdono i propri contorni, come accade agli oggetti nella pittura impressionistica) e Casa mia, dove le parole isolate, gli a-capo, le paroleverso obbligano il lettore a disabituarsi al ritmo tradizionale (i vv. 1-3 sono frutto di un endecasillabo diviso in tre; il v. 2 è un endecasillabo acefalo; nei vv. 2-3 è nascosto un altro endecasillabo: di averlo sparpagliato / per il mondo) e a misurarsi appunto con le parole singole e con i relativi significati. 21 Questa poetica della parola è dichiarata nelle liriche Il porto sepolto e Commiato, che rispettivamente aprono e chiudono la sezione Il porto sepolto, centrale nell’Allegria. La prima si rifà alla leggenda di un antico porto sepolto sotto il mare di Alessandria, immagine metaforica della ricchezza nascosta nel fondo dell’anima, nell’inconscio, dove il poeta, come un palombaro, deve scendere per cogliere e portare in superficie il tesoro nascosto di profonda verità, quel nulla / d’inesauribile segreto che soltanto la parola poetica è in grado di esprimere. La seconda ribadisce che non è la parola a fiorire dalla vita, ma, al contrario, sono la vita e il mondo a fiorire dalla parola: è la parola poetica a creare il mondo (Ungaretti richiama la lezione del simbolismo e di Mallarmé). La poesia compie dunque un viaggio verticale che ha per meta l’abisso, le radici profonde dell’essere e della condizione esistenziale dell’uomo. La parola rivela e salva, la non-parola conduce all’angoscia, all’annullamento, al suicidio. Così è nella lirica In memoria (cronologicamente uno degli ultimi testi del Porto sepolto, ma significativamente spostato all’inizio della raccolta). Moammed Sceab è un apolide, un nomade, come il giovane Ungaretti, ma, a differenza del poeta, non sa salvarsi attraverso la parola, non riesce a sciogliere in canto il proprio dramma. L’esistenza volge verso la solitudine, l’oblio, il non-essere, da cui soltanto può salvare la parola poetica: io solo / so ancora / che visse. La salvezza offerta dalla parola è, dunque, da un lato rivelazione dell’abisso, dall’altro sostanza di memoria. Tutta L’Allegria è incentrata sull’opposizione presente-passato, tra l’ora-e-qui della guerra (si veda anche la puntuale indicazione dei luoghi e delle date di composizione delle poesie) e il richiamo all’interiorità, alla memoria. Basti rileggere I fiumi, dove il poeta, rievocando i fiumi della propria vita – il Serchio degli antenati lucchesi, il Nilo dell’infanzia, la Senna degli anni parigini, l’Isonzo della guerra presente – restituisce un ordine, un senso complessivo alla propria esistenza, in termini (quasi hegeliani) di progresso di coscienza: dal tempo sacro prenatale (simboleggiato dal Serchio) a quello dell’inconsapevolezza (l’infanzia in Egitto), fino alla scoperta di sé (a Parigi) e alla piena autocoscienza (il bagno lustrale nell’Isonzo). Se la memoria dei Fiumi è volontaria, quindi razionale e ordinatrice, quella di In dormiveglia è involontaria (in senso proustiano). Le schioppettate che si alzano dalle trincee e crivellano l’aria richiamano, alla mente in dormiveglia del poeta, i colpi, uditi nell’infanzia, degli scalpellini sui lastricati di Alessandria. Il rapporto con la guerra è sempre mediato, compensato da un’attenzione all’interiorità. Ungaretti è lontano dalla celebrazione della guerra dei futuristi, come dagli entusiasmi nazionalistici, come dall’odio per 22 il nemico; vive la guerra come un dovere, la subisce come una malattia sociale; non vuole banalmente dire che la guerra è brutta: ne descrive l’orrore soprattutto per contrapporlo alla propria interiorità, al proprio attaccamento alla vita (l’allegria contro il naufragio). Questa opposizione è portata alle estreme conseguenze in Veglia, dove l’immagine fortemente realistica del compagno / massacrato con la bocca digrignata penetra nel silenzio del poeta, cioè nello spazio dell’anima in cui germoglia la parola poetica, capace di esprimere lettere piene d’amore per la vita. In Sentimento del Tempo, finita la guerra, il registro poetico ungarettiano muta sensibilmente. È riaffermato il principio del rilievo assoluto della parola, ma di una parola che è ora del tutto slegata dalla realtà contingente: è davvero parola assoluta, che vale in quanto tale, senza condizionamenti esterni. Si veda, ad esempio, O notte. Il poeta non si rapporta a nulla di reale, non più ad un qui-e-ora (qual era la guerra nell’Allegria); le parole fluiscono senza referenti: alba, risvegli, foglie, autunni ecc. non rimandano a momenti o oggetti reali, non descrivono ma stimolano alla suggestione, hanno significato non denotativo ma connotativo, non sono legate in maniera logico-razionale ma per associazioni (si vedano le “libere associazioni” della psicanalisi), per vaghe connessioni analogiche. Questo vale per l’intera raccolta, che apre la stagione dell’ermetismo, di cui Ungaretti è capostipite e maestro. Dopo i versi spezzati e i sistematici enjambements dell’Allegria, nel Sentimento del Tempo si tende a recuperare l’unità sintattica e l’unità metrica: tornano i versi tradizionali (l’endecasillabo in particolare) e si distribuiscono in strofette dotate di unità logica (le pause non sono più tra una parola e l’altra, ma tra una strofa e l’altra). Domina l’analogia, come in Lago luna alba notte, dove, già nel titolo, i richiami vaghi e suggestivi producono una forma liquida in cui tutto si scioglie e si compenetra. Anche i testi che sembrano avere un andamento narrativo, come L’isola, in realtà non raccontano alcuna vicenda reale, ma danno vita a catene di immagini analogiche assimilabili, semmai, ad una narrazione di tipo onirico. Fine di Crono e Memoria d’Ofelia d’Alba sono due significativi esempi di poesia religiosa ungarettiana. Nella prima lirica Zeus che vince su Crono è, in chiave cristiana, Dio che vince il tempo e torna a prendere possesso dell’universo, come Ulisse con Itaca (gli astri sono Penelopi innumeri). La seconda richiama, già nel titolo, la lirica per Moammed Sceab; anche Ofelia, come Moammaed, si è tolta la vita, ma mentre lui è sprofondato nel nulla dell’oblio, lei ha ottenuto l’immortalità e, nei suoi occhi… immortali, trovano pace e immortalità anche le cose mutevoli del mondo. 23 A completamento e approfondimento della sua lezione, il prof. Amoretti ci ha lasciato il testo scritto che di seguito pubblichiamo. *** Giuseppe Ungaretti nasce nel 1888 alla periferia di Alessandria d’Egitto, ai confini col deserto egiziano. È inevitabile attribuire un senso quasi simbolico a questa nascita, come del resto lo stesso poeta si compiacerà più volte di fare. Egli “viene” infatti da un luogo remoto, fuori dall’Italia e – verrebbe da dire – dalla civiltà e dalla storia europea. Se per un verso l’Egitto appare come un mondo “altro”, emblema di un’antichità assoluta e fuori dal tempo, per altro verso il deserto richiama l’idea di uno spazio infinito e vuoto – una sorta quasi di non luogo. È come se la voce di Ungaretti non provenisse dall’Italia e dalla sua tradizione culturale e dalla sua concreta realtà letteraria fra fine ‘800 e inizio ‘900, ma da un punto assoluto di là dalla storia, da un “fuori” indeterminato e indeterminabile. Solo nel 1912, all’età di 24 anni, Ungaretti lascia l’Africa e insieme ad un amico egiziano, Moammed Sceab, va a vivere a Parigi, dove ha modo di conoscere i nuovi movimenti d’avanguardia che animano la scena letteraria e artistica francese. Con questo passaggio repentino dalla periferica Alessandria a quello che era allora il centro forse più vivo della cultura europea, il poeta si trova immerso quasi di colpo dentro una fervida e confusa atmosfera artistico-letteraria, segnata da un’ansia febbrile di rinnovamento. Si trova collocato, cioè, nel pieno manifestarsi della crisi di un’intera tradizione letteraria, senza aver mai davvero partecipato (se non a distanza e astrattamente) a questa tradizione, senza averla mai sentita davvero propria. La sua coscienza poetica inizia dentro questa crisi, dentro questo vuoto. Altri poeti della sua generazione avevano dovuto faticosamente prendere le distanze da una tradizione letteraria appresa in Italia fin dai banchi di scuola ed anche “attraversare” – come dice Montale a proposito di Gozzano – le forme più “aggiornate” di tale tradizione, come la poesia di Pascoli, ad esempio, o quella di d’Annunzio. Ungaretti invece ha la ventura di non dover “attraversare” né 24 d’Annunzio né Pascoli né Carducci, ma di trovarsi collocato di colpo e subito nel “vuoto” creato dalla crisi di ogni tradizione – potremmo dire fra le macerie di tutta una cultura. Da questo punto di vista la prima guerra mondiale – a cui egli parteciperà come soldato semplice dal 1915 al 1918 – non farà che “collocarlo” concretamente e drammaticamente nella dimensione, che già gli era propria, di solitario testimone del vuoto e del silenzio. Sarà di fatto quella occasione eccezionale che gli permetterà di comprendere di primo acchito le ragioni della propria poesia. Posto di fronte, giorno dopo giorno, alla minaccia concreta della morte, il giovane Ungaretti vive un’esperienza estrema, al confine fra l’esistenza e la non esistenza: un’esperienza – oggi si direbbe – border-line. La guerra, quindi, si risolve per lui nella scoperta della condizione esistenziale dell’uomo, “gettato” nel qui ed ora della vita e ad ogni istante confrontato tragicamente con la possibilità della morte. Alieno da qualunque retorica nazionalistica e guerrafondaia, Ungaretti riesce a fare dell’esperienza in trincea uno strumento, accuratamente elaborato e tenacemente difeso, di riscoperta di sé. In un processo che lo porta a svuotare la parola poetica da ogni ingombro allotrio, letterario o retorico, e a sfrondare l’espressione da ogni eccesso e da ogni superfluo, i primi a cadere saranno proprio i termini politici e ideologici. La guerra, in tal modo, è vissuta da lui non come un evento storico dai significati precisi e con un senso comprensibile, ma come una realtà “naturale”, emblematica, pur nella sua radicalità, della condizione umana in generale, fatta in profondo di dolore, di angoscia e di speranza. L’Allegria Questa esperienza è descritta con straordinaria intensità nel primo grande libro di Ungaretti, Allegria di Naufragi, pubblicato a Firenze nel 1919, in cui, insieme a nuove poesie, vengono riprese le liriche che erano già apparse in un libretto stampato ad Udine nel 1916, Il Porto sepolto. A partire dall’edizione del 1931 l’opera sarà intitolata semplicemente L’Allegria. Il titolo originale allude all’esperienza di chi ritrova la forza di vivere dopo essere scampato ad un evento tragico, paragonabile ad “un superstite / lupo di mare” 25 che si lascia alle spalle il terribile “naufragio” della propria nave (naufragio come simbolo di morte ma anche, in quanto discesa nelle acque vivificanti del mare, di rinascita interiore) per iniziare caparbiamente un nuovo “viaggio”. Il libro appare subito nuovissimo e sconvolgente nel panorama letterario italiano del tempo (ancora dominato sostanzialmente dai grandi modelli dannunziani e pascoliani), soprattutto per la radicalità delle scelte espressive e metriche. In effetti Ungaretti è il primo grande poeta italiano a servirsi con originalità e coerenza del verso libero, uno strumento che – insieme ad altre drastiche innovazioni formali proposte dall’avanguardia – egli aveva trovato per così dire già “pronto all’uso”, ormai largamente teorizzato e praticato, nel momento in cui aveva fatto ritorno in Europa nel 1912. Dai futuristi, che ne erano stati fra i più decisi assertori, egli tuttavia prende subito le distanze, in quanto non gli interessa distruggere in toto la lingua poetica tradizionale (fra le tante soluzioni rivoluzionarie dei marinettiani il primo Ungaretti nell’Allegria accoglierà, oltre al verso libero, soltanto il rifiuto dei segni di interpunzione). Più che un rivoluzionario, in effetti, vuole essere un riformatore: non mira cioè a rifondare alla radice la parola poetica, ma a renderla più viva, più intensa, più “vera” (e questo – almeno a partire dal Sentimento del tempo – sempre in “dialogo” con la tradizione). A tal fine non sfrutta neppure alcune interpretazioni del verso libero che si stavano tentando soprattutto in ambito crepuscolare: da una parte la tendenza a costruire versi caratterizzati non più dall’isosillabismo ma dalla successione di “piedi”, cioè di nuclei ritmici uguali e ripetuti, con esiti di scansioni ritmiche anche (volutamente) facili e monotone (Palazzeschi); dall’altra parte lo scioglimento del discorso poetico in una misura prosaica, con versi lunghi e senza “ossatura” ritmica (Corazzini). Proprio per rifiutare queste soluzioni, che per lui sono artificiose, false e quindi impoetiche, Ungaretti spezza il verso “lungo” (tradizionale e/o prosaico), rinunciando nel contempo a qualunque costante ritmica, al fine di isolare il più possibile ogni singola parola, ogni singola unità del discorso. Lo scopo è di “obbligare” il lettore a fare continue pause, impedendogli così di lasciarsi andare alle cadenze ritmiche famigliari, togliendogli la possibilità di “gustare” il 26 ritmo astratto del verso più delle singole parole che lo compongono. Si pensi ad una lirica come Casa mia, fra le prime che troviamo aprendo il libro. Sorpresa dopo tanto d’un amore Credevo di averlo sparpagliato per il mondo Si può subito osservare come i primi tre versi, di fatto la prima strofetta, dissimulino un endecasillabo regolare, che così spezzato non è immediatamente riconoscibile (o meglio: il lettore è obbligato a non leggere i tre versi come fossero un endecasillabo, ma come un trisillabo + un quadrisillabo + un altro quadrisillabo). Il quarto verso è invece un endecasillabo ipometro o acefalo: basterebbe cioè aggiungere una sillaba all’inizio – ad esempio un “io” – per trasformarlo in un endecasillabo regolare. Infine un ultimo endecasillabo si nasconde a cavallo fra il quarto e il quinto verso: “di averlo sparpagliato / per il mondo”, dove di nuovo però il lettore è obbligato a spezzare l’unità famigliare dell’endecasillabo e quindi a far emergere, così isolata dal flusso ritmico precedente, tutta la carica semantica implicita nel quadrisillabo finale “per il mondo”. Si pensi anche alla famosissima Soldati – “Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie” –, dove la possibilità di leggere la lirica come se fosse costituita da due settenari regolari – o addirittura da un unico alessandrino, o doppio settenario – è impedita dalla strutturazione in quattro versicoli (e si noti che nella prima versione su rivista del 1918 i due primi versi erano costruiti diversamente: “Si sta / come d’autunno”, con la presenza cioè di un quinario – “come d’autunno” –, che è pur sempre, insieme al settenario e all’endecasillabo, un verso imparisillabo tradizionale della metrica italiana e come tale sarebbe suonato troppo “ovvio” all’orecchio del lettore). La pausa a fine verso, che è propria di ogni poesia, viene insomma fittamente sfruttata dal primo Ungaretti sia in funzione semantica, allo scopo di far sprigionare dalle singole parole tutta la loro intensità di significazione, sia anche in funzione anti-ritmica, per impedire che nella lettura (in quella particolare interpretazione della 27 poesia che è la lettura) ci si lasci andare ad un’onda musicale troppo facile. La lirica deve essere scabra, dura, non musicale (ma anche, sempre e rigorosamente, non prosastica). A tal fine possono essere isolate e forzate a costituire un verso anche espressioni semanticamente neutre, come ad esempio gli articoli, non allo scopo ovviamente di “produrre” significato, ma allo scopo opposto di non produrre significato, cioè ad esempio connessioni eufoniche o musicali, e quindi di rompere il ritmo, di creare effetti di disarmonia, di una cadenza tutta sincopata e franta. In una lirica come Natale, ad esempio, la terza strofa contiene ben due versicoli del tutto asemantici (“come una” e “in un”) ed un versicolo limitato ad un termine semanticamente quasi neutro (“cosa”): lo scopo è evidentemente quello di “stoppare” la musica endecasillabica troppo facile cui tendono i primi tre versicoli (“Lasciatemi così come una cosa”) e obbligare il lettore a trasformare un ritmo “noto all’orecchio” in un altro fittamente pausato, e quindi franto e disarmonico. La sezione centrale dell’Allegria è Il Porto sepolto. Composto fra il ’15 e il ’16 e pubblicato ad Udine nel 1916, Il Porto sepolto è di fatto la prima raccolta poetica di Ungaretti e il cuore dell’Allegria, che apparirà soltanto tre anni dopo. Come poi sarà tipico dell’intera Allegria, qui ogni lirica è datata, quasi a dare l’impressione che i versi si susseguano come pagine di un diario essenziale, trascrizioni rapide e concise degli eventi giornalieri (ma l’ordine delle liriche non segue esattamente la cronologia: la prima poesia, in effetti, è proprio una delle ultime – 30 settembre 1916 – mentre la seconda è del giugno 1916 e solo a partire dalla terza – 22 dicembre del ’15 – si inizia a seguire con apparente esattezza l’ordine cronologico). Il titolo è di fatto una esplicita dichiarazione di poetica: rifacendosi alla leggendaria immagine di un favoloso porto di epoca pretolemaica sepolto nel mare davanti ad Alessandria, Ungaretti paragona il poeta ad una sorta di palombaro, capace di scendere nelle “acque” dell’anima alla ricerca di un tesoro nascosto. Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde 28 Di questa poesia mi resta quel nulla d’inesauribile segreto Ciò che il poeta trova nel fondo di sé è un “nulla”, cioè “qualcosa” che non appartiene alla realtà consueta di tutti i giorni, che non è un oggetto definibile e razionalmente comprensibile: egli trova, a rigore, un non-essere, un ni-ente, appunto un “nulla”. Ma questo oggetto-non oggetto, questo essere-nulla è talmente vero e talmente vivo da essere “inesauribile”. È – dice il poeta – un “segreto”, cioè una realtà “altra”, misteriosa e nascosta: quell’assoluto arcano e quasi divino che si cela nelle profondità della nostra anima. Questa esigenza di “scendere” negli abissi di noi stessi per scoprire la poesia, la vera poesia (un’esigenza in cui si rivela l’influenza su Ungaretti della lirica simbolista francese, e in particolare del grande poeta Stéphane Mallarmé), è ribadita in un altro breve testo, che sembra voler dichiarare in modo esplicito i principi di una poetica fondata sulla parola (ed è significativo che queste due poesie, di fatto delle sintetiche dichiarazioni di poetica, siano collocate strategicamente l’una all’inizio e l’altra alla fine della sezione Il Porto sepolto). Gentile Ettore Serra poesia è il mondo l’umanità la propria vita fioriti dalla parola la limpida meraviglia di un delirante fermento Quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata è nella mia vita come un abisso 29 Nella forma di un frammento di dialogo con l’amico Ettore Serra, Ungaretti parla, in termini più genericamente esistenziali rispetto a Il porto sepolto, di un “abisso” scavato nella propria vita. Sono – se vogliamo – le due facce della poesia ungarettiana: da una parte l’aspetto simbolico-ermetico, “orfico”, mallarméano, legato all’idea che la poesia debba assurgere a rivelazione e conoscenza dell’“altro”, dell’assoluto, dell’“inesauribile segreto” (il tesoro obliato al fondo del mare); dall’altra parte l’aspetto esistenziale, con la poesia che si esprime immergendosi dentro il dolore della vita (l’abisso “scavato” di Commiato sembra esprimere non tanto l’entusiasmo dello scopritore di tesori nascosti, quanto il dolore di chi si raccoglie in sé, di chi scruta tormentosamente nel fondo della propria anima). Ma in entrambe le dichiarazioni emerge la primarietà della parola, al punto che in Commiato viene detto che il mondo, l’umanità e la propria stessa vita “fioriscono” dalla parola. È la parola e solo la parola, cioè, a “creare” quella realtà esistenziale, quel “mio silenzio”, che nel contempo esprime: una parola legata all’esistere individuale, che nel contempo “crea” e dà realtà a questo esistere. Lo scavo negli abissi dell’anima porta alla coscienza in primo luogo le immagini del proprio passato. Il tema della memoria, di fatto, è centrale in tutta l’Allegria, che non è riducibile al solo motivo della guerra, in quanto gli episodi bellici vengono sempre filtrati da una soggettività lirica che ha radice nelle esperienze passate e si definisce quindi inevitabilmente nella loro continua rievocazione. È certo molto significativo che proprio la prima lirica del Porto sepolto sia intitolata In memoria. Si chiamava Moammed Sceab Discendente di emiri di nomadi suicida perché non aveva più Patria Amò la Francia e mutò nome 30 Fu Marcel ma non era Francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi dove si ascolta la cantilena del Corano gustando un caffè E non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono L’ho accompagnato insieme alla padrona dell’albergo dove abitavamo a Parigi dal numero 5 della rue des Carmes appassito vicolo in discesa Riposa nel camposanto d’Ivry sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera E forse io solo so ancora che visse La lirica rievoca, con un andamento “narrativo” del tutto inusuale nell’Allegria, l’amicizia del poeta con l’egiziano Moammed Sceab, che insieme a lui aveva lasciato nel 1912 l’Africa per Parigi ma poi, incapace di adattarsi alla vita europea, si era tolto la vita. Il tema acquista particolare risalto a causa della collocazione proemiale del testo (e che non sia un caso è dimostrato dalla sua stesura relativamente tarda: Ungaretti, cioè, ha davvero voluto collocarlo in questa posizione di assoluto rilievo, forzando l’ordine cronologico 31 che struttura la raccolta). Il poeta apre Il Porto sepolto “raccontando”, cioè richiamando alla memoria, un’esperienza fondamentale dell’immediato passato prima di dare inizio al “diario” del presente, così da collocare tale diario sullo sfondo del ricordo, come se il sentimento del presente, del qui ed ora, non potesse che trovare radici nella memoria del passato. Per altro verso la poesia si connette in certo modo con quella successiva, cioè Il Porto sepolto, nel senso che la seconda costituisce una sorta di risposta alla prima, proponendo una “soluzione” al dramma di Sceab. Il giovane arabo, infatti, si è ucciso perché “non sapeva / sciogliere / il canto / del suo abbandono”, non sapeva sublimare la propria pena nella parola, mentre il poeta del Porto sepolto – come abbiamo visto – “torna alla luce con i suoi canti”, emerge cioè e si salva dall’oscurità del male grazie alla parola. Le due poesie esprimono così il nesso oppositivo di silenzio / parola, esistenza muta / esistenza trasfigurata nel canto, che costituisce uno degli assi tematici fondamentali della raccolta e insieme il cardine stesso della poetica ungarettiana. In una delle liriche più note di tutta l’Allegria – I fiumi – la memoria diventa strumento per una rimeditazione, per un riepilogo o consuntivo complessivo sul senso della propria vita. Mi tengo a quest’albero mutilato abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna Stamani mi sono disteso in un’urna d’acqua e come una reliquia ho riposato L’Isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso 32 Ho tirato su le mie quattr’ossa e me ne sono andato come un acrobata sull’acqua Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole Questo è l’Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell’universo Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia Ma quelle occulte mani che m’intridono mi regalano la rara felicità Ho ripassato le epoche della mia vita Questi sono i miei fiumi Questo è il Serchio al quale hanno attinto duemil’anni forse 33 di gente mia campagnola e mio padre e mia madre Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d’inconsapevolezza nelle estese pianure Questa è la Senna e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto Questi sono i miei fiumi contati nell’Isonzo Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora ch’è notte che la mia vita mi pare una corolla di tenebre La biografia del poeta acquista un significato attraverso la successione dei quattro fiumi che lo hanno in qualche modo formato: i tre che ha conosciuto direttamente – cioè il Nilo (durante l’infanzia e l’adolescenza ad Alessandria), la Senna (nei due anni trascorsi a Parigi fra il ’12 e il ’14) e l’Isonzo (sulle rive del quale il poeta sta combattendo) – e quello che precede la sua nascita, presso il quale hanno abitato i suoi avi toscani (il Serchio). Per un verso i fiumi rappresentano simbolicamente la fugacità del tempo e della vita, secondo un’immagine che risale ai presocratici greci e al “panta rei”. Per altro verso la loro disposizione secondo un ordine non solo cronologico ma soprattutto significativo per il poeta, un ordine inscritto per così dire nella sua storia personale di maturazione umana, in qualche modo li “ferma”, li fissa in uno schema sincronico che sfugge alla diacronia. È la memoria, insomma, che in qualche modo, proustianamente, restituisce un ordine e un senso al passato, 34 fermando il movimento altrimenti inarrestabile del tempo. Questa opposizione fra fugacità del tempo e ordine metatemporale corrisponde ad una più astratta opposizione fra la linea retta (il fiume) e il cerchio. In effetti questa poesia, che parla di fiumi, si apre da una parte e si chiude dall’altra con due immagini di circolarità: quella della dolina simile a “un circo / prima o dopo lo spettacolo” (cioè a qualcosa di circolare e di solitario) all’inizio, e quella della “corolla / di tenebre” alla fine. Questa ricerca di un tempo assoluto e metastorico si oppone fortemente al tragico incombere di un presente fatto di orrore e di morte; e si fa sentire, sia pure su un piano di minore tensione conoscitiva rispetto ad un testo come I fiumi, in altre liriche dove il tema è piuttosto quello dell’inerzia, della sonnolenza, del lasciarsi andare ad una immobilità al limite vegetale o minerale. Il poeta si sente “docile / all’inclinazione / dell’universo sereno”: vi si lascia andare in una sorta di felice passività, di lucido panismo, quasi perdendo i sensi (l’aria “era uno svenimento”), come scivolando in un sonno che è simile al preludio di una morte serena: “In una gita che se ne va in fumo / col sonno/ e se incontra la morte / è il dormire più vero” (Malinconia). Spesso uno stato di sonnolenza è associato al riemergere di immagini memoriali. Si veda, come esempio, questa lirica (In dormiveglia): L’aria è crivellata come una trina dalle schioppettate degli uomini ritratti nelle trincee come le lumache nel loro guscio Mi pare che un affannato nugolo di scalpellini batta il lastricato di pietra di lava delle mie strade ed io l’ascolti 35 non vedendo in dormiveglia Qui nettissimo è il contrasto fra il presente, con la “notte violentata” e le continue “schioppettate”, e il passato alessandrino, con il suono provocato dagli scalpellini che battono sul lastricato: e l’effetto sull’io di questa ennesima emergenza della memoria è come un senso di infinita spossatezza: mi pare – dice il poeta – che “io l’ascolti / non vedendo / in dormiveglia”. Ma è una memoria ben diversa da quella dei Fiumi: là – per usare una famosa distinzione proustiana – si trattava di una memoria volontaria, mediante la quale il poeta ricostruiva lucidamente e consapevolmente il proprio passato; qui invece la memoria è involontaria: emerge da sola, senza alcuna sollecitazione attiva da parte dell’io lirico. Dal nucleo tematico di questo lasciarsi andare alla memoria di un passato fatto di incoscienza è già possibile individuare un motivo che sarà fondamentale nella poesia religiosa di Ungaretti, cioè la nostalgia di un eden perduto, l’ansia confusa di rinascere in qualcosa di prima – e non di dopo – la storia: l’eternità, cioè, concepita come qualcosa che ci sta alle spalle, che è dietro, in qualche eden perduto di prima della nascita. Vediamo in ogni caso strutturarsi tutta una serie di opposizioni omologhe: realtà / sogno; veglia / sonno; presente / passato; prossimità / lontananza; coscienza / perdita di coscienza; dolore / serenità; maturità / infanzia o adolescenza; storia / eden perduto dell’infanzia; guerra / pace; morte / vita. E si potrebbe proseguire. Ciò che è significativo è che la salvezza si configura qui in un recupero del passato e, parallelamente, nell’abbandono dei controlli razionali, nel “sacrificio” della coscienza. Da questo punto di vista il giovane poeta si rivela in perfetta sintonia con la grande letteratura “della crisi” di primo Novecento: una sintonia tanto più sorprendente se si pensa che l’interpretazione vulgata del primo Ungaretti ha sempre teso a privilegiare invece gli aspetti “realistici” legati al tema della guerra, alla lucidità ferma della rappresentazione, piuttosto che questi aspetti “liquidi”, morbidi, di un abbandono irrazionale alla non-azione, al sogno e alla memoria. Resta il fatto che il tema della guerra è centrale nel Porto sepolto e in genere nell’Allegria, benché non sia dominante: se si pensa in 36 effetti che queste liriche vennero quasi tutte scritte in trincea, nel mezzo dei combattimenti e sotto una costante minaccia di morte, ci si stupisce della tutto sommato scarsa presenza di immagini belliche. Già questo fa capire come l’intento del poeta non fosse quello di documentare realisticamente il dramma della guerra (e basterebbe tale osservazione per distaccare l’Allegria da tanti altri libridocumento sul primo conflitto mondiale), ma piuttosto quello di esprimere i propri stati d’animo, le proprie sensazioni, il proprio personale vissuto esistenziale, al di qua, per così dire, della guerra. In ogni caso le immagini belliche sono sempre legate strettamente alle vicissitudini dell’io lirico, alla sua solitaria e individuale problematica esistenziale. Talvolta addirittura la guerra sembra funzionare da mero termine di paragone in un discorso tutto sull’io. Si veda la penultima strofa di Perché?, dove “il mio cuore” è paragonato a “un proiettile / nella pianura”. Qui la metafora o analogia procede dall’interiorità dell’io al mondo di fuori, dal soggetto all’oggetto (il cuore è come un proiettile); nel caso invece che abbiamo visto di In dormiveglia il movimento è inverso e la metafora-analogia procede dall’aria “crivellata […] dalle schioppettate” al ricordo del “nugolo di scalpellini”. Un caso analogo, con un “movimento” dal “fuori” al “dentro”, si ha nella famosissima San Martino del Carso, dove alle macerie causate dalla guerra vengono fatte corrispondere le macerie del cuore. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto Ma nel cuore nessuna croce manca 37 È il mio cuore il paese più straziato La lirica è costruita in modo rigorosamente simmetrico: due quartine, la prima “oggettiva” e la seconda “soggettiva”, sono seguite da due distici, in ognuno dei quali l’ordine delle quartine viene per così dire ribaltato: si passa cioè in entrambi da un piano soggettivo ad uno oggettivo, in quanto il primo verso si riferisce al “cuore” (versi 9 e 11) e il secondo, per analogia, ad un oggetto reale, ad una sorta di “correlato oggettivo” (la “croce”, v.10, e “il paese più straziato”, v.12). Ancora più forte e più intensamente drammatica è l’opposizione fra “fuori” e “dentro”, fra oggetto e soggetto, in una lirica come Veglia. Un’intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d’amore Non sono mai stato tanto attaccato alla vita È forse il testo più emblematico di quel nucleo di algido “realismo” descrittivo che secondo una certa vulgata caratterizzerebbe la rappresentazione ungarettiana della guerra (e basta considerare il titolo, che si oppone nettamente e programmaticamente a quello di In dormiveglia). Eppure non si può non osservare che proprio il giorno prima della stesura di Veglia Ungaretti scriveva Lindoro di deserto, uno degli esempi più radicali 38 di analogismo simbolisteggiante di tutta l’Allegria. Ciò dimostra come l’attenzione lucida alla terribile realtà presente fosse soltanto una fra le componenti della poetica ungarettiana, che comprendeva anche – lo abbiamo visto – la discesa nella memoria e nel contempo la ricerca mallarméana dell’assoluto attraverso la parola. In ogni caso qui ritroviamo con nitidissima evidenza, portati all’estremo limite della contraddizione, i due termini dell’opposizione ‘oggetto / soggetto’ di cui parlavamo. Nella prima parte della poesia c’è una descrizione “ravvicinata” dell’orrore della guerra che non ha uguali, per l’evidenza e l’atrocità dei particolari, in tutta l’Allegria, mentre già alla fine della prima strofa c’è il passaggio, contraddittorio e perciò inatteso, alle “lettere piene d’amore”, con una opposizione fortissima fra vicino e lontano, fra realtà e sogno, fra realismo e lirismo, fra prevalere dell’oggetto e prevalere del soggetto. L’intera poesia poi si regge sull’opposizione, altrettanto forte e radicale, fra morte – i primi nove versi – e vita – la seconda e ultima strofa. Il Sentimento del tempo Tutt’altro clima è nella seconda raccolta di Ungaretti, Sentimento del tempo, che esce a Roma nel 1933. Nel 1936 l’opera verrà ristampata con alcune correzioni e con l’aggiunta di pochi testi scritti fra il 1932 e il 1935. Soprattutto nella prima parte di Sentimento del tempo, cioè quella composta grosso modo nel corso degli anni ’20, il poeta ricorre ad una utilizzazione massiccia delle tecniche analogiche e simbolistiche, rinunciando del tutto ad ogni realismo descrittivo, mentre nella seconda parte il discorso si farà più largo e più lucidamente argomentato. Come esempio di analogismo è possibile considerare la lirica proemiale dell’intera raccolta, O notte. Dall’ampia ansia dell’alba Svelata alberatura. Dolorosi risvegli. Foglie, sorelle foglie, Vi ascolto nel lamento. 39 Autunni, Moribonde dolcezze. O gioventù, Passata è appena l’ora del distacco. Cieli alti della gioventù, Libero slancio. E già sono deserto. Preso in questa curva malinconia. Ma la notte sperde le lontananze. Oceanici silenzi, Astrali nidi d’illusione, O notte. La poesia riprende e radicalizza una tecnica già sperimentata nell’Allegria, quella cioè di frantumare il discorso lirico in una serie fitta di minitesti, ognuno brevissimo e costituente una strofetta (qui non più di due versi ognuna). Ogni minitesto ha una sua autonomia, in quanto non è collegato, se non da vaghissimi rapporti analogici, agli altri che lo precedono o lo seguono; ma sono questi rapporti analogici a segnare un filo che lega i successivi minitesti nei loro temi: alba, risveglio, foglie (qui la connessione è semplicemente assente), autunno, gioventù trascorsa, deserto, malinconia, notte, silenzi. È come una catena di libere associazioni, che può ricordare quella che il paziente è invitato a formare, senza alcun controllo cosciente, in una seduta psicanalitica. Non c’è qui in effetti un discorso razionale e quindi riassumibile, ma una successione di vaghissimi stati d’animo, a mala pena collegati da questo filo associativo: un risveglio in un’alba autunnale, il senso della fine della giovinezza, la solitudine, la discesa ancora nella notte, appena addolcita da “astrali nidi d’illusione”. Come si è detto, però, all’interno di questo fluire di associazioni ogni strofa conserva una sua forte autonomia: può quasi valere, al limite, come una lirica distinta. Lo spazio fra una strofa e l’altra è come un invito al lettore ad una pausa di silenzio. Mentre nell’Allegria in genere le pause e gli spazi bianchi separavano le 40 singole parole, obbligando ad una pronuncia lentissima e sillabata di ogni termine, qui il poeta comincia a lavorare sulla strofa piuttosto che sulla singola parola. Grazie a questo più fluido ricomporsi del discorso poetico in unità strofiche e musicali più ampie, possono anche più facilmente riapparire versi della tradizione. Si veda la prima strofa, che esibisce due settenari. Al centro della poesia, poi, in posizione calcolata di rilievo, spicca un bell’endecasillabo: “Passata è appena l’ora del distacco” (dopo un endecasillabo “ricostruibile”: “moribonde dolcezze. O gioventù”), mentre in chiusa è facile ricomporre di nuovo una serie di endecasillabi: “sperde le lontananze. Oceanici” (con dialefe centrale), “lontananze. Oceanici silenzi”, “silenzi, astrali nidi d’illusione” e infine il più evidente: “astrali nidi d’illusione, o notte”. Il Sentimento del tempo insomma esibisce fin dall’incipit una poesia nuova, dove acquista rilievo anche il ritmo e la musicalità dei versi, assai spesso in accordo con la prosodia tradizionale e le cadenze endecasillabiche. Un altro esempio emblematico è Lago luna alba notte: Gracili arbusti, ciglia Di celato bisbiglio… Impallidito livore rovina… Un uomo, solo, passa Col suo sgomento muto… Conca lucente, Trasporti alla foce del sole! Torni ricolma di riflessi, anima, E ritrovi ridente L’oscuro… Tempo, fuggitivo tremito… Già il titolo rimanda ad una indistinzione tematica, ad una “liquidità” semantica che la lirica non farà nulla per “coagulare” e 41 determinare. Nel contempo questo titolo “plurale” allude alla significazione delle parole del testo, che non vogliono descrivere ma evocare vagamente. Il significato denotativo è sostituito qui da quello connotativo; il senso unico e precisamente determinato, quello cioè fornito – diciamo così – dal vocabolario, si apre ad una raggiera semantica tanto molteplice quanto in ultimo ambigua. È pur vero che la lirica parla di un “movimento” – benché forse minimo (un “fuggitivo tremito”) – e non di una situazione statica, ma non è ben chiaro se ci si muova dall’alba verso la notte o dalla notte verso l’alba. Un’interpretazione potrebbe individuare un passaggio dall’alba (le prime due strofette) al mezzogiorno (“conca lucente”); e infine dalla sera (la “foce del sole”) alla notte (“l’oscuro”). Ma questo filo è talmente esile che certo non può valere come verosimile schema strutturante del discorso lirico. Già la prima strofetta mescola e fonde in una sola indistinta unità semantica elementi appartenenti a piani concettuali diversi: da una parte naturali e dall’altra umani ed esistenziali. I “gracili arbusti” sono fusi per via analogica con le “ciglia”, mentre il “celato bisbiglio” può essere contemporaneamente umano e naturale. Così il successivo “livore rovina” può alludere sì ad una realtà naturale, ma può anche connotare stati d’animo o sentimenti umani. L’immagine centrale, nella terza strofetta, dell’“uomo solo”, ribadisce con nettezza pittorica la valenza umana ed esistenziale del paesaggio naturale. Anche la “conca lucente” della quarta strofetta lega la natura all’uomo per mezzo di quel “trasporti”, che fa della “conca”, cioè forse del lago, una sorta di veicolo che “reca” verso la sera, e quindi analogicamente verso la morte. Ma sarebbe una violenza interpretativa pretendere di chiudere la poesia in un significato preciso. La fusione fra elementi naturali ed elementi esistenziali fa oscillare i significati in modo ambiguo, fra l’allusione ad un paesaggio – gli arbusti, il lago-conca – e la dolente espressione di uno “sgomento”. Nulla qui è chiaramente definito, e nulla deve esserlo. Il paesaggio naturale sfuma nell’indefinito, e le ragioni dello sgomento non sono affatto chiarite. Sul piano dei contenuti la poesia si presenta come un intreccio ambiguo e volutamente non decifrabile: non è possibile, in altre parole, una parafrasi, un “riassunto” della lirica. Sul piano del significante, in particolare su quello fònico, cioè 42 dei suoni, abbiamo tutta una serie calcolatissima di riprese e di echi, che contribuiscono a dare come un senso di immobilità al lettore, imprimendo una sorta di continuo “ritorno all’indietro” al procedere del discorso. Si vedano questi fenomeni: 1) la consonanza “ciglia / bisbiglio” (vv.1-2); 2) le allitterazione al v.3, che legano, mediante la ripresa del suono della liquida, “impallidito” con “livore” e poi, con il ritorno della -v- e della -r-, “livore” con “rovina”; 3) un’altra consonanza fra “sgomento” e “lucente” (vv.5-6); 4) l’assonanza “conca” / “ricolma”, sottolineata nel mezzo da tutta una serie di accenti in –ò (“traspòrti”, “fòce”, “sòle”); 5) un’altra assonanza, benché a distanza, fra “muto” (v.5) e “oscuro” (v.10), entrambi a fine verso; 6) la rima fra “lucente” (v.6) e “ridente” (v.9) 7) e infine, nell’ultimo verso, la delicata allitterazione della -t-. Sul piano ritmico – come già osservavamo a proposito di O notte – le parole non vengono isolate come nell’Allegria, ma sono disposte in modo che si leghino l’una all’altra. Benché il discorso proceda secondo un ordine sintattico elementare – una sorta di grado sintattico zero – non vi sono enjambements che lo spezzino per far risaltare, in opposizione ad esso, le singole parole. In tal modo le parole si aggregano anche sul piano ritmico, formando dei versi spesso riconoscibili come tradizionali. Sono espliciti endecasillabi regolari il v.3 e il v.8, mentre endecasillabi impliciti sono “estraibili” a cavallo fra il v.2 e il v.3 (“di celato bisbiglio impallidito”) e fra il penultimo e l’ultimo verso, che insieme formano un endecasillabo (“l’oscuro tempo fuggitivo tremito”). In tal modo alla liquidità dei significati – cioè alla loro indeterminatezza e indefinibilità, al loro divagare a raggiera, al loro trascendere i confini denotativi – corrisponde un’accentuata presenza dei “significati” fònici e ritmici, che per un verso integrano l’indeterminatezza dei contenuti, colmandone per così dire i vuoti, ma per un altro verso si affiancano ad essa, aggiungendo a un piano semantico vago un secondo piano altrettanto vago e indeterminato. Sia pur raramente, càpita nel Sentimento del tempo che la catena delle immagini analogiche si disponga secondo una cadenza apparentemente “narrativa”, creando l’effetto allora non certo di una narrazione realistica o anche soltanto plausibile, ma di una sorta di 43 racconto onirico. I nessi fra le immagini, cioè, non acquistano alcuna verosimiglianza “logica”, restano vaghi e indeterminati, ma grazie ad una serie di connettivi narrativi (ad esempio avverbi di tempo: ‘prima’, ‘dopo’, ‘quindi’, ‘poi’) si dispongono “come se” fossero i momenti successivi di una storia. Le corrispondenze analogiche, in altre parole, si succedono in modo tale da dare l’impressione dello sviluppo di una narrazione. L’esempio più significativo e anche più famoso è L’isola. A una proda ove sera era perenne di anziane selve assorte, scese, e s’inoltrò e lo richiamò rumore di penne ch’erasi sciolto dallo stridulo batticuore dell’acqua torrida, e una larva (languiva e rifioriva) vide; ritornato a salire vide ch’era una ninfa e dormiva ritta abbracciata a un olmo. In sé da simulacro a fiamma vera Errando, giunse a un prato ove l’ombra negli occhi s’addensava delle vergini come sera appiè degli ulivi; distillavano i rami una pioggia pigra di dardi, qua pecore s’erano appisolate sotto il liscio tepore, altre brucavano la coltre luminosa; le mani del pastore erano un vetro levigato da fioca febbre. È una lirica tanto più sconcertante in quanto “racconta”, o sembra raccontare, una vicenda che, nel momento stesso in cui è raccontata, si sottrae alla comprensione, sfumando nella nebbia dell’ambiguità: una vera e propria narrazione “liquida”. Gli stessi elementi che sembrerebbero poter garantire al testo una sia pur 44 minima e vaghissima plausibilità narrativa, ovvero una successione diacronica di “eventi”, da un prima a un poi (“a una proda scese”, “s’inoltrò”, “ritornato a salire vide”, “errando, giunse” ecc.), valgono in negativo per confermare la non-narrabilità di ciò che viene presentato immagine dopo immagine, in quanto non si appoggiano ad alcuna determinazione concreta e, per così dire, galleggiano nel vuoto. Hanno la funzione di brandelli figurativi irrelati fra loro in un quadro astratto, che con la loro figuratività frantumata ne confermano il non-realismo, l’astrattezza. Una delle caratteristiche della raccolta è il recupero di immagini mitologiche, che è indizio e spia di una ricerca di valori classici anche sul piano dei contenuti. La funzione principale di queste immagini è di sollevare il discorso ad una misura assoluta e metastorica, accentuando e accompagnando altri strumenti espressivi aventi già la funzione di dematerializzare e di rendere indeterminato il discorso (ad esempio l’uso di termini astratti, di paesaggi “assoluti” ecc.). Altre volte l’immagine mitica è segno esplicito di paganità. Il poeta per suo tramite esprime una sorta di pagano ritorno alla natura, che può forse confondersi con la sua ricerca di una primitiva ed edenica innocenza. Del tutto diversa è l’immagine di Crono in Fine di Crono, che dà il titolo all’intera seconda sezione della raccolta. L’ora impaurita In grembo al firmamento Erra strana. Una fuligine Lilla corona i monti, Fu l’ultimo grido a smarrirsi. Penelopi innumeri, astri Vi riabbraccia il Signore! (Ah, cecità! Frana delle notti…) E riporge l’Olimpo, Fiore eterno di sonno. 45 Qui il personaggio mitologico, peraltro relegato nel titolo, ha un mero valore segnico più che simbolico: Crono, cioè, come sinonimo di tempo. Ma anche così il riferimento mitico permette l’acquisto di un di più di vaghezza, che sembra accompagnarsi all’affermazione di una verità alta e assoluta. Il titolo aiuta – come spesso accade nelle liriche ungarettiane, dove sempre il titolo fa corpo con il testo, non è quasi mai un’aggiunta esteriore e superflua – a decifrare il senso del discorso, che muove da un sentimento di paura (l’“ora impaurita” del primo verso) per giungere, attraverso appunto la “morte” del tempo-Crono, ad un ritorno (“riporge”, e non “porge”, nel penultimo verso) di un divino oltre-tempo, legato anche alla perdita di coscienza che è propria del “sonno”. Dalla paura, cioè, al sonno (secondo un tragitto, qui però in chiave tutta metafisica e assoluta, già sperimentato – come si ricorderà – nell’Allegria). Il tema della poesia è quello del ritorno: se prestiamo fede all’immagine centrale degli astri-Penelopi, è il tema, più precisamente, dell’uomo-Ulisse che , dopo una lunga erranza (“erra strana”, cioè “straniera”, e poi al 6° verso “smarrirsi”: un erramento che è smarrimento), ritorna a Dio – ma anche, inversamente, del DioUlisse che ritorna agli astri-Penelopi, cioè alla natura che era stata abbandonata nelle mani di Crono. Si noti come il mito pagano della vittoria di Zeus su Crono sia reinterpretato in termini cristiani come vittoria di Dio sul tempo. Una svolta nell’esperienza umana e poetica di Ungaretti si ha nel 1928, quando il poeta, dopo una sofferta crisi religiosa, ritorna con piena convinzione alla fede cristiana che gli era stata trasmessa nell’infanzia dalla madre (una fede, peraltro, che di fatto non aveva mai del tutto abbandonato). Di conseguenza la sua poesia acquista una più esplicita ispirazione religiosa – particolarmente evidente nella sezione Inni, che risale proprio al 1928 – abbandonando nel contempo i modi analogico-ermetici più radicali. È come se la liquidità analogica tendesse per la prima volta a “coagularsi” in nuclei narrativi o in squarci di confessione, che certo non ne modificano la sostanza ma danno comunque l’impressione di un rinnovamento della poesia ungarettiana. Basti considerare una lirica assai nota, La madre. 46 E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all’Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: Mio Dio, eccomi. E solo quando m’avrà perdonato, ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d’avermi atteso tanto, e avrai negli occhi un rapido sospiro. La poesia non è certo in linea con i modi analogici e “liquidi” prevalenti nella prima parte del Sentimento del tempo. C’è di nuovo un personaggio reale, di nuovo il poeta che dice io e di nuovo una “narrazione” (questa volta non “finta”, non analogica), segnata con forza e intensità drammatica dalla temporale iniziale che dà il via – il “prima” cui segue il “poi” – alle proposizioni successive. La lirica si apre con una forte anastrofe (la figura retorica con la quale si invertono rispetto all’ordine consueto alcuni elementi della frase: “e il cuore quando” invece di “e quando il cuore”): una tecnica ricorrente nell’Ungaretti post-Allegria, che recupera sì a poco a poco una sintassi sempre più complessa e sinuosa, ma operandovi distorsioni anche forti, allo scopo di evitare il rischio di una “prosaicizzazione” eccessiva del discorso e soprattutto al fine di isolare una singola parola – qui, nella Madre, “il cuore” – dal tessuto sintattico in cui tale parola rischierebbe invece di “perdersi”, di passare inavvertita. È insomma la stessa funzione che nell’Allegria veniva delegata alla frantumazione del verso e all’estrema semplificazione del discorso e qui invece proprio alla sua estrema complessità sintattica. Si veda anche, da questo punto di vista, una lirica come Memoria d’Ofelia d’Alba. 47 Da voi, pensosi innanzi tempo, Troppo presto Tutta la luce vana fu bevuta, Begli occhi sazi nelle chiuse palpebre Ormai prive di peso, E in voi immortali Le cose che tra dubbi prematuri Seguiste ardendo del loro mutare, Cercano pace, E a fondo in breve del vostro silenzio Si fermeranno, Cose consumate: Emblemi eterni, nomi, Evocazioni pure… La poesia è tutta costruita su un unico, lungo periodo, distorto da frequenti anastrofi che ne rendono non facilissima la lettura. Ad esempio: “Da voi la luce fu bevuta” invece che “la luce fu bevuta da voi”; oppure: “a fondo del vostro silenzio si fermeranno” invece che “si fermeranno a[l] fondo del vostro silenzio”. La lirica è la “memoria”, la rievocazione commossa di una suicida: la giovanissima Ofelia d’Alba (1914-1932), figlia del poeta Auro d’Alba (1888-1965), coetaneo di Ungaretti. Come tale non può non ricordare, anche nel titolo, In memoria, la lirica che apriva Il Porto sepolto. Tuttavia la comunanza tematica e la similarità dei titoli non può che mettere in evidenza la distanza che separa i due testi. Di Moammed Sceab venivano ricordati frammenti della vita proprio perché dopo la sua morte non era rimasto più nulla di lui: solo a malapena il ricordo del poeta (“E forse io solo / so ancora / che visse”). Qui al contrario non viene detto nulla della vita di Ofelia e tanto meno dei motivi che possono averla spinta al suicidio: mediante una prolungata metonimia o sineddoche (pars pro toto), la figura della giovane donna è interamente sostituita dai suoi occhi, mentre la realtà mondana viene condensata genericamente dapprima nella “luce vana” (v.3) e poi nelle “cose”, che sono “consumate” (terzultimo verso) in opposizione agli occhi che sono “immortali” (v.6). Mentre dunque di Moammed Sceab non resta nulla, Ofelia, una volta spogliata del corpo, divenuta puro sguardo, pura essenza, è immortale; e le cose stesse solo nel suo sguardo acquistano una loro 48 immortalità, anch’esse spogliate della loro materia “consumata”, transeunte, e sublimate – si direbbe – in pure idee platoniche: “emblemi eterni, nomi, / evocazioni pure…”. Nella sezione Inni, che risale al 1928, cioè l’anno della “conversione” del poeta, sono contenuti i testi più complessi ed ardui della tematica religiosa ungarettiana del Sentimento del tempo. Perché le apparenze non durano? Se ti tocco, leggiadra, geli orrenda, Nudi l’idea e, molto più crudele, Nello stesso momento Mi leghi non deluso ad altra pena. Perché crei, mente, corrompendo? Perché t’ascolto? Quale segreto eterno Mi farà sempre gola in te? T’inseguo, ti ricerco, Rinnovo la salita, non riposo, E ancora, non mai stanca, in tempesta O a illanguidire scogli, Danni con fantasia. Silenzi trepidi, infiniti slanci, Corsa, gelose arsure, titubanze, E strazi, risa, inquiete labbra, fremito, E delirio clamante E abbandono schiumante E gloria intollerante E numerosa solitudine, La vostra, lo so, non è vera luce, Ma avremmo vita senza il tuo variare, Felice colpa? Già la fitta successione di domande che costituiscono l’ossatura di questa lirica (Danni con fantasia) allude ad una inquietudine esistenziale, ad un vuoto che non riesce ad essere colmato, cioè il vuoto dell’immanenza, aperto ad una invisibile trascendenza. Sarà 49 questo il tema centrale della sezione: la rappresentazione di una dualità radicale, da una parte il mondo profano, la vita umana priva di senso, la colpa, il peccato, dall’altra parte la “vera luce” (qui il terz’ultimo verso), Dio (come vedremo in La pietà), la “primavera eterna” (Caino). Qui il discorso è ancora, per così dire, “interno” all’immanenza – e il dialogo si svolge diretto ad un tu che è forse la “mente” del v.6 oppure la “felice colpa” dell’ultimo verso (o ad entrambe, quasi che la mente, cioè il pensare, il sentire stesso, fosse già di per sé una colpa) – mentre nella successiva Pietà si fonderà sul rapporto fra l’io lirico e lo stesso Dio. Qui la tecnica della frantumazione del discorso poetico in una serie di frammenti non porta ad eliminare un forte legame di continuità, che garantisce al testo una sua saldissima unità tematica, dal primo fino all’ultimo verso. Il tema è l’opposizione ossimorica fra la bella e “leggiadra” molteplicità delle apparenze illusorie create dalla mente e la loro precarietà, la loro negatività ontologica (poiché non durano, si corrompono), che quindi fa di loro un male, un oggettivo peccato. A garantire, come si diceva, una salda unità alla lirica, il tema è dichiarato con sùbita efficacia già nel primo verso (le apparenze che “non durano”: tutte le parole successive non saranno che una chiosa a questa netta affermazione-domanda iniziale) e poi ridefinito, questa volta in termini etico-religiosi (oltre che nel titolo, dove sono unite ossimoricamente l’idea della dannazione e quella della fantasia), nell’ultimo verso: “felice colpa”. E si noti che non si tratta qui di una colpa particolare, ma per così dire della colpa originale che grava sul creato: una colpa che fa tutt’uno con la vita, con il variare delle illusioni che sono la vita. La pietà è forse la poesia più tipica della sezione. È il testo più lungo dell’intera raccolta, a conferma dell’esigenza di un discorso più articolato e complesso che caratterizza la seconda parte di Sentimento del tempo. 1 Sono un uomo ferito. E me ne vorrei andare E finalmente giungere, Pietà, dove si ascolta 50 L’uomo che è solo con sé. Non ho che superbia e bontà. E mi sento esiliato in mezzo agli uomini. Ma per essi sto in pena. Non sarei degno di tornare in me? Ho popolato di nomi il silenzio. Ho fatto a pezzi cuore e mente Per cadere in servitù di parole? Regno sopra fantasmi. O foglie secche, Anima portata qua e là… No, odio il vento e la sua voce Di bestia immemorabile. Dio, coloro che t’implorano Non ti conoscono più che di nome? M’hai discacciato dalla vita. Mi discaccerai dalla morte? Forse l’uomo è anche indegno di sperare. Anche la fonte del rimorso è secca? Il peccato che importa, Se alla purezza non conduce più. La carne si ricorda appena Che una volta fu forte. È folle e usata, l’anima. 51 Dio, guarda la nostra debolezza. Di noi nemmeno più ridi? E compiangici dunque, crudeltà. Non ne posso più di stare murato Nel desiderio senza amore. Una traccia mostraci di giustizia. La tua legge qual è? Fulmina le mie povere emozioni, Liberami dall’inquietudine. Sono stanco di urlare senza voce. 2 Malinconiosa carne Dove una volta pullulò la gioia, Occhi socchiusi del risveglio stanco, Tu vedi, anima troppo matura, Quel che sarò, caduto nella terra? È nei vivi la strada dei defunti, Siamo noi la fiumana d’ombre, Sono esse il grano che ci scoppia in sogno, Loro è la lontananza che ci resta, E loro è l’ombra che dà peso ai nomi. La speranza d’un mucchio d’ombra E null’altro è la nostra sorte? E tu non saresti che un sogno, Dio? Almeno un sogno, temerari, 52 Vogliamo ti somigli. È parto della demenza più chiara. Non trema in nuvole di rami Come passeri di mattina Al filo delle palpebre. In noi sta e langue, piaga misteriosa. 3 La luce che ci punge È un filo sempre più sottile. Più non abbagli tu, se non uccidi? Dammi questa gioia suprema. 4 L’uomo, monotono universo, Crede allargarsi i beni E delle sue mani febbrili Non escono senza fine che limiti. Attaccato sul vuoto Al suo filo di ragno, Non teme e non seduce Se non il proprio grido. Ripara il logorio alzando tombe, E per pensarti, Eterno, Non ha che le bestemmie. Il testo è suddiviso in 4 parti, le prime due assai più lunghe delle ultime due, come a significare che la brevità dell’effusione lirica non può darsi da sé, come nell’Allegria, ma deve poggiare su un’elaborata e complessa “argomentazione” preliminare. Ma questa lunghissima “argomentazione” è più frantumata – si potrebbe dire sminuzzata, sbriciolata – ancora di quanto non avvenisse in altre liriche. È come se i frantumi sparsi della prima raccolta qui fossero ripresi e raggruppati all’interno di un “discorso” più ampio, ma nel 53 contempo lasciati nella loro forma frammentaria, sbriciolata. Questo discorso funziona quindi come uno “schema”, che fissa una cornice per ogni minimo frammento lirico, la “casella” dove esso trova la propria esatta collocazione. Volendo, si potrebbe leggere il componimento come una serie o quasi una raccolta di miniliriche: si pensi, a mo’ di esempio, al primo verso, che sembra tratto pari pari, così netto e lapidario, dall’Allegria (dove però avrebbe costituito una lirica a sé stante, mentre qui vale soltanto come la nota d’avvio dell’intero componimento). Ma quasi ogni frammento o strofetta, soprattutto delle prime due parti, potrebbe essere letto, senza tutto sommato perdere la propria intensità evocativa e religiosa, come un’autonoma unità lirica, come una poesia a sé. Qui il “discorso” che struttura la poesia è un lungo dialogo o preghiera con Dio: non siamo più cioè, come nel testo precedente, all’interno dell’orizzonte dell’immanenza, ma entro un campo di forte tensione fra l’immanenza da una parte e la trascendenza dall’altra. Ma è una trascendenza che si sottrae e che si nega: un Dio che non risponde, che di noi neppure ride (“Di noi nemmeno più ridi?”). L’urlo dell’uomo rimane “senza voce”. Nella seconda parte entrano in scena i “defunti” (una sorta di “citazione” pascoliana), l’unica “lontananza che ci resta”; ma se “null’altro è la nostra sorte” che finire nel loro “mucchio d’ombra”, allora davvero Dio non è che “un sogno”. Ci resta soltanto nel cuore una “piaga misteriosa”, una ferita, una mancanza che allude arcanamente a Dio, inteso dunque come assenza, come non esserci e, insomma, come indicibilità. Le ultime due parti ribadiscono l’infinita, incolmabile distanza fra Dio e l’uomo. Da una parte Dio non abbaglia senza uccidere (“Più non abbagli tu, se non uccidi?”), cioè non dà una luce che possa essere guardata rimanendo vivi, dentro la nostra immanenza: conoscere Dio significa non solo rimanere abbagliati, cioè acciecati – significa, più radicalmente, essere strappati dalla nostra immanenza, e quindi morire (terza parte). D’altronde l’uomo, per quanto possa creare ed operare, non fa altro che tracciare i propri limiti, cioè non esce comunque da uno spazio chiuso di pura immanenza; così che non può ascoltare che la propria voce, “il proprio grido”; e in tal modo, se parla di Dio, non può che dire delle bestemmie, cioè delle parole negative (la bestemmia è tale perché nega, dice negando): delle parole, insomma, che restano umane e non “dicono” né possono 54 “dire” davvero Dio. Sul piano metrico è da segnalare l’uso ormai intensivo dell’endecasillabo, con la tendenza a concentrare un’intera strofetta o mini-lirica in un solo, lapidario endecasillabo, con esiti spesso di straordinaria intensità lirica o drammatica. In ogni caso, soprattutto nella prima parte, è frequente la tendenza a limitare la strofetta ad un solo verso, a farne cioè un monostico. Le pause che nell’Allegria separavano le singole parole qui separano, con uguale effetto “rallentante” e quindi con uguale funzione, i versi-strofa. Se queste due poesie non sembrano offrire alcuna soluzione all’impasse – da una parte una realtà illusoria che “danna” se ad essa ci si abbandona; dall’altra parte un Dio invisibile e indicibile, che si può nominare solo in termini negativi, solo “bestemmiandolo” – la terza lirica della sezione, Caino formula una preghiera che apre forse uno spiraglio: se non di una speranza, di un “vorrei che”, di uno struggente “ottativo”. Qui l’opposizione è fra il fascino oscuro di questa vita, dominata dall’istinto e dal desiderio (prima parte), e l’ansia di una liberazione che porti ad una ritrovata innocenza, ad una “primavera eterna” (seconda parte). Corre sopra le sabbie favolose E il suo piede è leggero. O pastore di lupi, Hai i denti della luce breve Che punge i nostri giorni. Terrori, slanci, Rantolo di foreste, quella mano Che spezza come nulla vecchie querci, Sei fatto a immagine del cuore. E quando è l’ora molto buia, Il corpo allegro Sei tu fra gli alberi incantati? E mentre scoppio di brama, Cambia il tempo, t’aggiri ombroso, Col mio passo mi fuggi. 55 Come una fonte nell’ombra, dormire! Quando la mattina è ancora segreta, Saresti accolta, anima, Da un’onda riposata. Anima, non saprò mai calmarti? Mai non vedrò nella notte del sangue? Figlia indiscreta della noia, Memoria, memoria incessante, Le nuvole della tua polvere, Non c’è vento che se le porti via? Gli occhi mi tornerebbero innocenti, Vedrei la primavera eterna E finalmente nuova, O memoria, saresti onesta. Nella prima parte si mescolano sapientemente diversi campi semantici: i principali sono quelli relativi ad un mondo selvaggio e primitivo (“lupi”, “terrori”, “foreste”), alla leggenda o alla favola (“sabbie favolose”, “alberi incantati”) e all’oscurità (“luce breve”, “ora molto buia”, “ombroso”, “ombra”). A fare da centro della poesia, e quasi da perno fra la prima e la seconda parte, è il v.16 – “Come una fonte nell’ombra, dormire!” –, un endecasillabo di quarta e settima dal lento e scandito ritmo dattilico, cui segue una invocazione prima all’anima e poi alla memoria – o, se si vuole, all’anima-memoria, all’anima che è memoria – con la disperata evocazione di una innocenza-primavera eterna. Qui la liquidità delle prime poesie della raccolta è del tutto superata: la lirica è costruita su un discorso sostanzialmente decifrabile, benché complesso e articolato su più piani e secondo una serie di opposizioni che si richiamano a vicenda oppure si differenziano nettamente l’una dall’altra: l’antico Caino e l’Eden futuro, la violenza ferina e la favola incantata, la noia e la memoria e così via. È insomma un discorso sui generis, affidato ad un intreccio di immagini raggruppate – come si è visto – in campi semantici 56 anche in apparenza contraddittori. Pertanto il riassunto che della poesia si potrebbe tentare dovrebbe muoversi su più linee interpretative, intersecantisi l’una con l’altra; ad esempio potrebbe essere svolto più o meno così: “Il passato remoto ci appare favoloso, tendiamo a vagheggiarlo con la memoria, ma in realtà è fatto di violenza bestiale – ne è simbolo il biblico Caino –, di terrori e di oscurità. Si vorrebbe dormire; e conquistare una memoria nuova, buona, e non legata alla noia, cioè ad una vita priva di senso”; dove dovrebbero intrecciarsi un discorso sul passato mitico e favoloso dell’uomo (dagli echi in certo modo “vichiani”), uno sulle radici bibliche del peccato, uno sul desiderio di quiete e di sonno, uno sulla noia, uno sulla memoria e infine uno sull’ansiosa speranza di una rigenerazione futura, di un ritorno liberatorio ad una innocenza edenica. La poesia di Ungaretti non si conclude certo con queste liriche di alta e complessa religiosità, ma continua ben oltre i confini del Sentimento del tempo, con esiti spesso non meno intensi. Ma per ovvi motivi di tempo ho preferito limitare qui la mia presentazione alle due grandi raccolte iniziali, che costituiscono molto probabilmente i vertici assoluti dell’intera poesia ungarettiana. Basti in ogni caso ricordare, anche solo a mo’ di informazione, che una terza raccolta, Il Dolore, apparirà nel 1947, cui seguiranno altre opere di complessa ed elaboratissima frattura, come La Terra promessa nel 1950, Un Grido e Paesaggi nel 1952 e Il Taccuino del Vecchio nel 1960. Ungaretti morirà a Milano nel 1970. 57 La lezione di Giangiacomo Amoretti (24 novembre 2010) 58 LUIGI SURDICH Gozzano, l’Oriente, l’Occidente Secondo Sanguineti, fra i poeti che inaugurano il Novecento vanno tenuti in particolare considerazione Lucini e Gozzano: il primo introduce il verso libero, il secondo rivisita la tradizione in chiave ironico-parodica. Nel gruppo dei “crepuscolari” – l’originaria definizione di G. A. Borgese ne sottolinea la distanza dalla solarità dannunziana – si possono distinguere almeno tre “scuole”: a) quella romana di Sergio Corazzini, che alla laus vitae di d’Annunzio oppone una laus mortis, in chiave lacrimevole e di autocommiserazione; b) quella romagnola di Marino Moretti (di Cesenatico), che al bel mondo e all’enfasi del poeta vate oppone una poesia sentimentale dimessa, votata alla grigia quotidianità; c) quella torinese di Gozzano, caratterizzata da un raffronto ironico con la realtà; la produzione poetica gozzaniana, a parte i testi sparsi (pubblicati su periodici o manoscritti), è concentrata in due raccolte: La via del rifugio (1907) e I colloqui (1911). La poesia di apertura ed eponima della prima raccolta (in origine però intitolata Convalescente) – composta a Pegli – pone subito in evidenza un tema centrale: la rinuncia al desiderio. Gozzano è il poeta della rinuncia. Alla vivacità delle nipotine oppone la propria inerzia estrema (Un desiderio? Sto / supino nel trifoglio / e vedo un quadrifoglio / che non raccoglierò), ai loro nomi in bella mostra (Sandra, Simona, Pina) il proprio minuscolizzato e il proprio io quasi reificato (questa cosa vivente / detta guidogozzano). C’è l’eco del poemetto La leggenda del principe Siddharta dell’amico Carlo Ballini: Gozzano è affascinato dalla filosofia orientale, in particolare dall’idea della rimozione del dolore attraverso l’annullamento del desiderio. Fra il male ontologico leopardiano e la divina Indifferenza montaliana, l’inconsapevolezza gozzaniana (…Non agogno / che la virtù del sogno: / l’inconsapevolezza) è una sorta di tappa intermedia. La rinuncia non è, comunque, la strategia esclusiva. Gozzano elabora anche diverse forme di partecipazione alla vita, di mediazione con la realtà. Ne L’amica di nonna Speranza, ad esempio, c’è un vitalismo proiettato nel passato, verso quella data del 28 giugno 1850 della fotografia con dedica che fa da spunto al poemetto. Il poeta ricrea nei dettagli – le buone cose di pessimo gusto – la casa della nonna diciassettenne, per regredire in quel mondo (… rinasco, rinasco del mille ottocento cinquanta) e, infine, 59 ritrovarvi il senso di una possibile scelta di vita e di amore (… amica di Nonna! Ove sei / o sola che, forse, potrei amare, amare d’amore?). Gozzano è un poeta che non coincide col proprio presente. Non vi si sottrae, ma lo elabora, lo esorcizza attraverso la letteratura e l’ironia. Nello stesso 1907 in cui esce La via del rifugio, inizia il rapporto con la poetessa Amalia Guglielminetti, che si risolve in un amore strozzato, in una relazione quasi esclusivamente epistolare, mediata dalla letteratura. E sempre nel 1907 ha la conferma dell’irreparabilità della propria malattia (la tisi), sulla quale è tuttavia capace di esercitare (come nella poesia Alle soglie) una drammatica ironia. Le figure femminili create da Gozzano sono sempre sul crinale tra desiderio e frustrazione. Si veda, per tutte, la Signorina Felicita che dà il titolo ad uno dei suoi testi più noti, quasi una novella in versi, in cui il poeta, giocando tra vita e letteratura, verità (i limiti estetici e culturali della ragazza) e menzogna (la propria finta disponibilità all’amore con lei), approda ad un’importante dichiarazione di poetica, riconoscendo che il buono / sentimentale giovine romantico è ciò che finge d’essere e non è, e addirittura arrivando a dire …Io mi vergogno, / sì, mi vergogno d’essere un poeta! È l’esautorazione, la detronizzazione del poeta-vate (Carducci, d’Annunzio e, in qualche misura, lo stesso Pascoli). Lo stesso fanno Corazzini (Io non sono un poeta. / Io non sono che un piccolo fanciullo che piange), Palazzeschi (Son forse un poeta? / No, certo. / […] / Chi sono? / Il saltimbanco dell’anima mia) ed altri, fino al Montale di Non chiederci la parola. In Ketty, invece, composta al tempo del viaggio in India (1912), Gozzano rilancia la dignità del poeta, il valore della gratuità dell’arte ed anche il senso della storia e della cultura che caratterizza l’Italia e l’Europa, contro il vuoto culturale, la grossolana modernità, il “tanto spazio e poca storia” dell’America (per dirla col Don DeLillo di Underworld), impersonati – nella poesia – dalla mascolina, emancipata e rozzamente ironica ragazza di Baltimora. A completamento e approfondimento della sua lezione, il prof. Surdich ci ha lasciato il testo scritto che di seguito pubblichiamo. *** Un aspetto nei confronti del quale Gozzano non si rivela affatto insensibile è quello che diremmo della mentalità indiana, con la sua «poesia del superfluo» e la sua «scienza delle cose inutili», come si 60 legge in Giaipur: la città rosea, una delle prose del libro postumo Verso la cuna del mondo (1917): Città di sogno e popolo adorabile, che ha la poesia del superfluo e la scienza delle cose inutili. Nessuna cosa più inutile di questa grande città color di rosa. Certo mi ricorderò di Giaipur, se un giorno dovrò scegliere una patria alla mia pigrizia contemplativa. Il dolce far niente italiano è, al confronto, un vortice di attività spaventosa. A questa terra, a questa mentalità, a questa civiltà che, ad esempio, ha prodotto il minareto di Ktub, «la più leggiadra delle cose inutili» (L’impero del Gran Mogol), a questo popolo come è descritto in Golconda: la città morta, va la simpatia di Gozzano: La vita quotidiana è fatta di necessità. Ora questa gente non fa nulla di necessario. Tutti i negozi, sotto le arcate, ostentano le più deliziose cose inutili: gioielli, sete, velluti, vasi d’argento e di bronzo, babbucce ricurve, scimitarre cesellate e gemmate, veli tinti pur ora e tesi ad asciugare al vento, leggeri come la nube che si sfalda, vivi di tutte le tinte più delicate; profumi, essenze contenute in alti vasi suggellati o in barattoli dalla forma singolare, segnati di lettere cabalistiche. I fiori, fiori in abbondanza, piramidi di magnolie, di ibischi, di rose decapitate che i mercanti vendono a peso, come i frutti, e che la folla infilza per via, improvvisando la ghirlanda quotidiana più necessaria del pane; strana folla che vive di colori, di profumi, di sogno, d’apparenza! Come siamo lontano da Bombay, da Calcutta, dalle grandi città della costa, dove già si sovrappone ed impera la nostra pratica attività occidentale! Ma questo richiamo all’occidente e alla sua etica della produttività, in contrasto col senso dell’inutilità e col gusto della pigrizia contemplativa dell’Oriente, ci rinvia a un testo estraneo alle prose indiane di Gozzano, ma interamente dentro, in ogni senso (prima di tutto cronologico), all’esperienza indiana: una poesia. L’indolenza indiana, che prontamente contagia Gozzano, il quale rilutta dal redigere le proprie corrispondenze e le lettere dall’India, come già si era accennato, le scriverà in Piemonte («Io sarò a Torino il 6-7 maggio – scrive alla sorella Erina da Ceylon in data 3 aprile. – 61 Che cosa si fa? Andremo direttamente ad Agliè. È meglio, anche per sottrarmi agli amici e ai giornali ai quali avevo promesso corrispondenze di tutti i generi – per avere le tessere – e non ho mandato una sola parola»), è condizione non del tutto negativa per quanto riguarda l’ispirazione poetica, anche se il riscontro oggettivo è esiguo. Due, infatti, sono le poesie scritte in India da Gozzano: il Risveglio sul Picco d’Adamo e un altro componimento vulgato col titolo non d’autore di Ketty, componimento che, alla luce delle testimonianze che si hanno in merito, costituisce il solo superstite di un gruppo di poesie «erotico-pornografiche» composte durante il soggiorno in India e buttate nel cestino. In una lettera inviata all’amico Emilio Zanzi e dallo Zanzi stesso ritrascritta in occasione di una commemorazione del poeta, Gozzano aveva scritto: Tranne il poemetto di Ketty, l’agile ragazza americana ( ... ) tutto il resto è per il cestino: la pornografia di raro diventa arte, forse. Io poi non sono tagliato per le spirituali sconcezze letterarie. Ho letto il poemetto di Ketty a Chiaves e a mia madre. Ne sono entusiasti ... ho fatto qualche correzione: sto limandolo. Vorrei pubblicarlo sulla «Lettura». E Francesco Pastonchi, che sul filo della memoria ricostruisce i suoi incontri con Gozzano, così riferisce di un dialogo col poeta in un albergo di Genova, dopo il suo ritorno dall’India: Di sé, del suo lavoro fu come sempre ritroso a parlare. Dopo molto chiedergli ammise di avere scritto qualche versicolo, su cose indiane: e dopo altre insistenze trasse di tasca pochi foglietti, ché io leggessi. Erano versi di una ardita sensualità, versi maestrevolmente fatti con questo di nuovo nella materia che ponevano un contrasto tra le nudità femminili dell’oriente e le donne occidentali vestite, rimpiangendo queste davanti a quelle. Ma l’arte ne era più scaltrita che profonda: vi ritornavano e stanchi i soliti atteggiamenti, con forzature d’echi non favorevoli al soggetto, come nei «Colloqui», anzi ingombranti (. .. ). Le poesie dell’India non dovevano mai vedere la luce. Gozzano le distrusse prima di morirsi. Per uno scrupolo religioso, fu detto e non ne dubito, ma certo anche perché egli s’accorse che non avrebbero aggiunto nulla alla sua poesia e non 62 avrebbero neppure pareggiato i componimenti minori dei «Colloqui». Ma, prescindendo da giudizi di valore in cui le componenti d’ordine morale risultavano predominanti, il fatto è che almeno uno dei poemetti indiani c’è, è rimasto, e che la sua sopravvivenza non appare del tutto casuale e immotivata, poiché a salvarlo dal cestino sembra essere stata non tanto la misura estremamente ridotta dell’audacia “pornografica” (addirittura assente, si direbbe), quanto piuttosto l’importanza del suo significato profondo, che annoda l’opzione “orientale” per l’inutilità con l’interrogazione sul senso del “fare poesia”: quanto di occasionale è nell’incontro tra il poeta con la giovane americana si allarga proiettandosi in responsabilità ideologica sul piano della composizione poetica. Demi-vierge perfettamente disegnata nella fisionomia che le compete e involgarita nei tratti “maschi” dei suoi atti e dei suoi contegni: Sputa. Nell’arco della sua saliva m’irroro di freschezza: ha puri i denti, pura la bocca, pura la genciva. Cerulo-bionda, le mammelle assenti, ma forte come un giovinetto forte, vergine folle da gli error prudenti (vv. 8-16), Ketty esercita una fascinazione nei confronti del poeta, per il prospettarsi, a livello di rapporti interpersonali, di uno strepitoso contrasto fra la «virile/ franchezza», «l’inurbana tracotanza» (vv. 21-2) di lei che «zufola e fuma» (v. 21) e il «latin sangue gentile» (v. 23) di lui (con tanto di sottolineatura ed enfatizzazione, risolta in chiave ironica, del divario che la maliziosa tessera petrarchesca viene a scandire). La messinscena del canovaccio di un mediocre gioco di seduzione, imperniato sulle attese avances di lui: mordicchio il braccio, con martirio lento dal polso percorrendolo all’ascella a tratti brevi, come uno stromento (vv. 67-9); 63 L’attiro a me (l’audacia superando per cui va celebrato un cantarino napolitano, dagli Stati in bando ... ) (vv. 79-81), e sulle altrettanto attese resistenze di lei, disponibile solo ad «Error prudenti e senza rimembranza» (v. 20): ma sui confini ben contesi ancora ben si difende con le mani tozze, al pugilato esperte ... (vv. 85-7), incornicia la contrapposizione reale e ideologicamente significativa di due orizzonti di civiltà. Miss Ketty, «Bel fiore del carbone e dell’acciaio» (v. 5), che è incapace di pensare che vi possa essere alloro senza oro e che nell’esprimersi impiega un lessico “economico”: [ ... ] « ... or come vivete, se non ricco, al tempo nostro? È quotato in Italia il vostro nome? Da noi procaccia dollari l’inchiostro» (vv. 27-30); che è «la figlia della cifra e del clamore» (v. 54); che ha un progetto di vita già delineato («sola giunse a Ceylon da Baltimora/ dove un cugino le sarà consorte», vv. 15-6; «In Baltimora/ il cugino l’attende a giuste nozze», vv. 88) e che subordina alla calcolata convenienza i propri comportamenti (1’amore che non può attingere più alla sublimazione non tocca neppure le sponde opposte dell’eros naturale e istintuale); che profana la storia e la cultura e l’arte trasformandole in hobby di basso collezionismo (in merce di scambio, in definitiva): - «O yes! Ricerco, aduno senza posa capelli illustri in ordinate carte: l’Illustriuous lòchs collection più famosa. Ciocche illustri in scienza in guerra in arte corredate di firma o documento, dalla Patti, a Marconi, a Buonaparte .... 64 … «Manca D’Annunzio tra le mie primizie; vane l’offerte furono e gl’inviti per tre capelli della sua calvizie ... » (vv. 61-6; 73-5) è figura rappresentativa della civiltà occidentale, è creatura poetica che riflette i guasti intellettuali e, soprattutto, spirituali che può produrre una società, come quella americana, fondata sul produttivismo: è immagine, insomma, di un futuro che pare ormai essere presente. E allora, di fronte a lei che incarna l’«estremo occidente», in questo incontro in oriente il pur occidentale Gozzano si riscopre in un certo senso orientale, condividendo dell’etica indiana il rifiuto della praticità e dell’efficienza e consapevolmente assumendo a valore il senso dell’inutilità dell’arte e del “gratuito” della poesia: l’arte è paga di sé, preclusa ai molti, a quegli è data che di lei si muore ... (vv. 51-2). Con queste parole Gozzano conclude l’apologia della poesia e dei poeti («una casta felice d’infelici», v.43), a replica del momento di sanzione dell’irrapportabilità tra sé stesso e Ketty, allorché irriverentemente storpia («… la bocca stridula ripete/ in italobritanno il grido immenso», vv. 33-4) e non giunge a dire per intero «il più bel verso» (v. 32) della poesia italiana: «Due cose belle ha il mon ... » (v. 35). Il binomio della cultura romantica (ed europea) su cui si è formato Gozzano, vivendone, scontandone, conoscendone e anche svelandone i limiti e le contraddizioni, impossibili da tenere occultate per chi come lui è di un’epoca in cui il romanticismo può costituire “finzione” e non più “essere” («ed io fui l’uomo d’altri tempi, un buono/ sentimentale giovine romantico…// Quello che fingo d’essere e non sono!», così si conclude La signorina Felicita), non può essere pronunciato da Ketty, perché estraneo alla sua logica del calcolo (estraneo al disinteresse assoluto delle “passioni”). La reazione di Gozzano è come sdoppiata, in un duplice registro di “serietà” ed “ironia”. La replica di lui che non ride («Non rido. Oimè! Non rido…», v.36) e che approda all’autenticazione dell’arte «paga di 65 sé» va a scontrarsi col muro d’incomprensione della «figlia della cifra e del clamore», per cui le parole di Gozzano sfumano nell’accertamento di una resa personale, istituita dal rilevatissimo accostamento tra l’eco del primo emistichio del più vulgato e famoso dei versi stilnovistici (della poesia come sublimazione, dunque): «Ma intender non mi può ...», v. 53 e il riconoscimento della sordità impenetrabile di Ketty («benché m’ascolti», v. 53). La polarizzazione tra le due personae del componimento è dunque radicale. Nel suo intervento (ascoltato, ma non capito) Gozzano ha come ribaltato, rimuovendone l’allusività dell’elocuzione antifrastica, i termini dei versi di Felicita: Oh! questa vita sterile, di sogno! Meglio la vita ruvida concreta del buon mercante inteso alla moneta, meglio andar sferzati dal bisogno, ma vivere di vita! lo mi vergogno, sì, mi vergogno d’essere un poeta! In presenza di Ketty la vergogna si rovescia in orgoglio, a riscontro di un complesso itinerario della coscienza in cui Gozzano ha totalmente messo in causa se stesso: perché è vero che egli non può disconoscere né rinnegare la sua appartenenza al mondo borghese, alla sua inautenticità, alla sua ipocrisia; ma questo suo essere in tale mondo significa concretamente, nella sua stessa coscienza, essere, in virtù della sua natura di poeta, due volte ipocrita, essere “peggiore” e non “migliore” dei borghesi che gli stanno attorno, e in questo essere “peggiore” c’è pure la radice della “superiorità”: almeno quella particolare specie di superiorità che ogni peggiore sente nei confronti della limitatezza del migliore. Parametri di valutazione, questi ora accennati, che funzionano bene se applicati a Ketty: nel rapportarsi con quella perfetta alto-borghese che è Ketty, il piccolo borghese che è Gozzano rivendica (come dire?) la superiorità della sua inferiorità, al cospetto dell’ottusità di lei. Ciò che scava un solco non colmabile tra i due è essenzialmente il divaricatissimo senso della memoria. Da una parte, infatti, abbiamo Gozzano che, come è ben noto, vive il tempo come fuga dal presente e come profondità («Adoro le date. Le date: incanto che non so dire,/ 66 ma pur che da molto passate o molto di là da venire», L’ipotesi, vv. 21-2) e che soggiace al dominio della memoria fino in fondo: il che significa, quale estrema conseguenza, che egli viene a trovare la sua esatta collocazione solo nel ruolo di “poeta postumo”, di poeta cioè che si situa entro un punto di vista “postumo” rispetto alla realtà e che dunque non solo proietta la vitalità all’indietro, nel passato, ma anche risolve il suo rapporto col “moderno”, che si stava ponendo, negli anni della sua attività letteraria, come rapporto con l’ “avanguardia”, nei termini non tanto di semplice e naturale rifiuto dell’avanguardia stessa, quanto piuttosto, proprio per il fatto che egli scrivesse in presenza dell’ avanguardia, in quelli di attivazione d’un gusto postmoderno. Dall’altra parte sta Ketty, che è creatura senza memoria e che sembra dunque farsi portatrice simbolica del senso di colpa americano dell’essere senza passato e senza storia; il suo essere senza memoria fa sì che la sua personalità declini verso quelle forme di reificazione su cui Gozzano insiste ad apertura della terza e ultima parte del poemetto: Gelido è il braccio ch’ella m’abbandona come cosa non sua. Come una cosa non sua concede l’agile persona… (vv. 58-60); ma, al tempo stesso, l’impossibilità di una sua collocazione, da parte del poeta, entro gli archetipi di un immaginario amoroso (un Don Giovanni alla maniera del Convito, oppure, in altra direzione, una cocotte della poesia omonima) determina la ragione per cui il prototipo di “modernità” rappresentato da Ketty sia destinato a rimanere un unicum, e al di là del testo che parla di lei «non è difficile prevedere la scelta del silenzio da parte di Gozzano», come ha scritto Marziano Guglielminetti. E l’accostamento al silenzio prende le mosse da quel processo di rimozione di tale inusitata presenza femminile che è la terza parte del poemetto ad avviare, allorché si accentua il pedale dell’ironia, nel momento in cui i ruoli sono stabiliti e Gozzano finge di stare al gioco, accompagnando di pari passo il rituale di una seduzione destinata all’inappagamento e la simulazione di accettazione del presente e di immersione nell’ «attualità», nel divertito modo in cui mostra di voler assecondare la nozione di poesia-collezionismo di Ketty: 67 - «Dischiomerò per voi l’Italia bella!» [ ... ] - «Vi prometto sin d’ora i peli ambiti; completeremo il codice ammirando: a maggior gloria degli Stati Uniti ... » (v. 72 e vv. 76-8) Vero è che, di fronte alla minaccia dell’occidente futuro (ma già operante), l’esperienza indiana consegna a Gozzano il riparo del senso “orientale” dell’esistere, governato non da efficientismo, produttività, denaro, ma dall’ “inutilità” assunta a valore. Con la consapevolezza tutta gozzaniana, peraltro (quasi una cifra e una formula per leggere e inquadrare la sua poesia) che, come l’esotismo orientale sopravvive perché ormai cosa morta, anche la poesia ha una sua sopravvivenza, caduta ormai l’ «aura», solo nella misura in cui la si accetti come portatrice di verità esprimibile unicamente attraverso la menzogna e la si riproponga quale reperto archeologico che riedifìchi l’«aura» caduta, facendone però avvertire tutta l’irrecuperabilità: che testimoni della sua morte, insomma. La lezione di Luigi Surdich (26 gennaio 2011) 68 FRANCESCO DE NICOLA Gli scrittori italiani e il Risorgimento La Liguria è protagonista del Risorgimento grazie a personaggi come Mazzini e Garibaldi, ma anche grazie a scrittori come De Amicis, Ruffini, Abba, Barrili. Cuore di Edmondo De Amicis è un libro patriottico. A venticinque anni dall’unità (il romanzo è pubblicato nel 1886), vuole contribuire alla formazione della coscienza nazionale (basti notare come i racconti mensili abbiano per protagonisti ragazzi delle varie regioni d’Italia) attraverso lo strumento principe dell’educazione scolastica (non a caso il racconto è strutturato come diario di un anno di scuola). Fra le pagine più esemplari, quella dell’arrivo del nuovo alunno di Reggio Calabria (Il ragazzo calabrese). Da non dimenticare, in chiave scolastica, anche la Storia dei Mille narrata ai giovinetti di Abba e Garibaldi ricordato ai ragazzi di Angiolo Silvio Novaro. Lorenzo Benoni e Il dottor Antonio di Giovanni Ruffini sono, rispettivamente, un romanzo di formazione autobiografico e un romanzo di amore e patria. Il primo racconta gli anni di sodalizio dell’autore con Mazzini, la fondazione della Giovane Italia, il fallito tentativo di sollevazione di Genova nel 1833, la fuga all’estero, con uno stile leggero e ironico che deve molto a Dickens. Il secondo, ambientato nella prima parte a Bordighera, narra il contrastato amore fra un giovane dottore e patriota siciliano e una nobile ragazza inglese, Lucy, sullo sfondo delle vicende storiche fra 1840 e 1848. Scritti entrambi in inglese, contribuiscono a far conoscere il Risorgimento italiano in Europa. In Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille Giuseppe Cesare Abba racconta (a distanza di anni: l’edizione definitiva è del 1891) l’impresa dei Mille, a cui ha preso parte: dal reclutamento al raggruppamento a Genova, dai primi dubbi sulla meta alla decisione di puntare sulla Sicilia, dallo sbarco a Marsala alla conquista di Palermo. A questo punto il libro si trasforma in diario di viaggio: Abba documenta il suo itinerario attraverso la Sicilia, alla scoperta di una terra sconosciuta e delle persone che vi abitano. Ma si chiude ancora nel segno di Garibaldi, con il resoconto dell’incontro di Teano e della conseguente delusione del Generale. Nel segno della delusione si conclude anche Con Garibaldi alle porte di Roma di Anton Giulio Barrili, che racconta l’impresa culminata con la battaglia di Mentana (1867). Come quello di Abba, è anche un libro di 69 viaggio e, a tratti, una guida turistica (ad esempio quando Barrili parla delle visite a Firenze o alle cascate delle Marmore). Alla fine, però, è soprattutto il libro della sconfitta di Garibaldi. A completamento e approfondimento della sua lezione, il prof. De Nicola ci ha lasciato il testo scritto che di seguito pubblichiamo. *** Un importante contributo alla diffusione degli ideali risorgimentali e alla conoscenza dei protagonisti delle vicende che nel 1861 portarono all’ (ancora incompiuta) Unità nazionale è stato dato certamente dai nostri scrittori, anche se in misura minore di quanto abbiano fatto la musica popolare, le arti figurative e le gazzette. Occorre infatti tener presente che nel 1861 in Italia i lettori di libri in prosa erano assai pochi, come dimostra il fatto che in quell’anno ne furono stampati solo 88, quando il 75% della popolazione era costituito da analfabeti: dunque sui 30 milioni di sudditi del re d’Italia solo il 10% era formato da potenziali lettori, più orientati semmai a leggere i sempre più numerosi giornali e periodici che non i libri, anche per il livello culturale piuttosto basso: solo 150.000 italiani avevano compiuto studi superiori e solo 40.000 erano laureati. Insomma all’indomani dell’Unità nazionale il popolo italiano doveva essere per grandissima parte scolarizzato e questo spiega i grandi sforzi affrontati dai governi e dai ministri dell’Istruzione, il primo dei quali fu Francesco De Sanctis, per realizzare una politica scolastica che migliorasse questa iniziale situazione di sottosviluppo culturale. La scuola fu dunque al centro dell’attenzione (anche se solo nel 1877 con la legge Coppino si rese obbligatoria la frequenza di almeno due anni di scuola elementare con pene severe per i trasgressori) non solo per la formazione di maestri che conoscessero e fossero capaci di insegnare l’italiano, poi disposti per pochi soldi a trasferirsi nei paesi più sperduti, ma anche per la preparazione di testi che servissero allo scopo di “fare gli italiani”. Ciò spiega lo sviluppo ragguardevole della produzione di libri per gli scolari che dai 190 pubblicati nel 1878, all’indomani della citata legge Coppino, salirono a ben 633 nel 1886, quando uscì 70 quello che sarebbe stato a lungo il libro fondamentale per l’educazione laica di generazioni di giovani italiani: Cuore di Edmondo De Amicis. E allora proprio da questo libro partirà il nostro discorso perché esso, diffuso in centinaia di migliaia di copie, è stato il veicolo maggiore di conoscenza del Risorgimento che in pratica è lo sfondo costante delle vicende che accadono nella scuola elementare torinese frequentata dal piccolo Enrico nell’anno scolastico 1881-82. E infatti alcune occasioni esterne offrono l’occasione perché di volta in volta si parli di Cavour (per l’inaugurazione di un monumento a lui dedicato il 29 marzo 1882), di Mazzini (il 29 aprile per una lezione sugli ideali e gli affetti familiari) e di Garibaldi (il 3 giugno, all’indomani della sua morte); ma oltre a diffondere la conoscenza di questi personaggi, De Amicis si preoccupa forse ancor più di creare una coscienza nazionale e di definire un’identità ancora difficile da realizzare 25 anni dopo l’Unità quando il libro esce per la prima volta. Ecco allora che i racconti mensili hanno per protagonisti ragazzi che rappresentano le diverse regioni d’Italia: Il piccolo scrivano fiorentino, Il tamburino sardo, Il piccolo patriota padovano, La piccola vedetta lombarda così come genovese è il protagonista del famosissimo Dagli Appennini alle Ande; ma è in un episodio accaduto in uno dei primi giorni di scuola, il 22 ottobre, che De Amicis offre una lezione esemplare (e ancora attualissima) di negazione di ogni forma di razzismo e di coscienza nazionale: Il ragazzo calabrese Ieri sera entrò il Direttore con un nuovo iscritto, un ragazzo di viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte, tutto vestito di scuro, con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il Direttore, dopo aver parlato nell'orecchio al maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo, che guardava noi con quegli occhioni neri, come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano, e disse alla classe: “Voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di cinquecento miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. Egli è nato in una terra gloriosa, che diede all'Italia degli uomini illustri, e le dà dei 71 forti lavoratori e dei bravi soldati; in una delle più belle terre della nostra patria, dove son grandi foreste e grandi montagne, abitate da un popolo pieno d'ingegno, di coraggio. Vogliategli bene, in maniera che non s'accorga di esser lontano dalla città dove è nato; fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana metta il piede, ci trova dei fratelli”. Detto questo s'alzò e segnò sulla carta murale d'Italia il punto dov'è Reggio di Calabria. Poi chiamò forte: “Ernesto Derossi!” - quello che ha sempre il primo premio. Derossi s'alzò. “Vieni qua”, disse il maestro. Derossi uscì dal banco e s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia al calabrese. “Come primo della scuola - gli disse il maestro, - dà l'abbraccio del benvenuto, in nome di tutta la classe, al nuovo compagno; l'abbraccio dei figliuoli del Piemonte al figliuolo della Calabria”. Derossi abbracciò il calabrese, dicendo con la sua voce chiara: “Benvenuto!” e questi baciò lui sulle due guance, con impeto. Tutti batterono le mani. “Silenzio! - gridò il maestro, - non si batton le mani in iscuola!”. Ma si vedeva che era contento. Anche il calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco. Poi disse ancora: “Ricordatevi bene di quello che vi dico. Perché questo fatto potesse accadere, che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio di Calabria, il nostro paese lottò per cinquant'anni e trentamila italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi; ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia, si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore”. Con Cuore De Amicis aprì la strada ad altri libri per ragazzi sul Risorgimento che quasi andarono a costituire una sorta di genere, centrato soprattutto sugli episodi fondanti della storia patria e sul suo eroe per antonomasia: in questa serie rientrarono, tra gli altri, la Storia dei Mille narrata ai giovinetti (1904) di Giuseppe Cesare Abba e Garibaldi ricordato ai ragazzi (1910) di Angiolo Silvio Novaro, allora uno dei più popolari poeti sui banchi di scuola, dove la sua lirica La pioggerellina di marzo era uno dei testi in versi più studiati. Ma neppure i maggiori poeti italiani tra Otto e Novecento mancarono di celebrare il Risorgimento nei loro versi: Giosue 72 Carducci già sul finire degli anni Cinquanta scrisse su Vittorio Emanuele II e su Garibaldi, sulle battaglie di Palestro, Magenta, Montebello e San Martino e sulla Croce di Savoia, e poi sulla sollevazione siciliana e sul plebiscito; nei Levia gravia (1861-1871) celebrò la proclamazione del regno d’Italia e ricordò le vicende militari di Curtatone e Montanara per tornare in Giambi ed epodi (1867-1879) a celebrare Mazzini e Garibaldi e altri patrioti esemplari come Giovanni Cairoli e i romani Monti e Tognetti; Giovanni Pascoli in Odi e inni (1906) incluse l’ode Manlio dedicata al figlio di Garibaldi morto prematuramente e aveva poi progettato un intero ciclo lirico, dal titolo Canti del Risorgimento, rimasto inconcluso e pubblicato postumo nel 1913, mentre Gabriele D’Annunzio in Elettra comprese il poemetto Notte di Caprera (1903) che presenta un Garibaldi domestico e quasi crepuscolare, certo inatteso per uno scrittore abituato a celebrare superuomini. Ma non furono solo i grandi poeti a ricordare l’eroe dei due mondi, più volte presente nei versi di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, autore nei primi anni del nuovo secolo dell’accorata lirica Per un bimbo garibaldino e dell’angosciata ode Quando tornerà Garibaldi?; a questa preoccupata domanda darà una tanto inconsapevole quanto involontaria risposta verso la fine del ‘900 il complesso musicale “Gli Statuto”, autore di un pezzo dal titolo rassicurante E’ tornato Garibaldi, caso peraltro non unico nella musica leggera italiana della presenza del Generale a tener conto di Garibaldi blues di Bruno Lauzi e di Garibaldi innamorato di Sergio Caputo. Ma dall’ultimo Novecento canzonettistico torniamo invece alle origini del Risorgimento e dunque al libro che per primo, scritto da un protagonista dei moti del 1820-21, rese testimonianza degli ideali carbonari e delle prime cospirazioni e cioè Le mie prigioni di Silvio Pellico; questi, piemontese di nascita, si trasferì a Torino dove frequentò il Foscolo che gli trasmise i suoi ideali patriottici ed entrò in contatto con il conte Federico Confalonieri che lo fece entrare nella Carboneria, dove assunse un ruolo di responsabilità che lo condusse all’arresto nel 1821 e quindi alla condanna a morte da parte del tribunale austriaco di Venezia; questa sentenza venne trasformata in condanna al carcere duro che egli scontò nella fortezza dello Spielberg in Moravia, dalla quale venne liberato nel 1830. Già attivo 73 in ambito letterario – era stato autore nel 1815 dell’apprezzata tragedia Francesca da Rimini ed era il redattore capo del periodico “Il Conciliatore” – decise di raccontare in un libro la sua esperienza di carcerato e nel 1832 pubblicò Le mie prigioni, nel 1843 tradotto in francese e arricchito di dodici nuovi capitoli. Con il resoconto della cattura, del processo e della detenzione Pellico volle testimoniare la sua disumana esperienza maturata nel clima di repressione austriaco e segnata da vivaci scorci narrativi e descrittivi ai quali aggiunse le riflessioni intime suggeritegli dalla crisi spirituale attraversata in quegli anni dolorosi, con la sua riconciliazione con la religione cattolica che un po’ alla volta lo allontana dalle questioni politiche e civili; il libro, osteggiato ovviamente dagli austriaci che – secondo una loro ripetuta affermazione – lo consideravano più negativo per loro di una battaglia perduta, non piacque troppo però neppure ai liberali per lo spirito rinunciatario che nelle pagine finali dominava lo stato d’animo del protagonista il quale peraltro, dopo essere tornato libero, visse nell’ambiente reazionario dei duchi di Barolo, dove lavorò come bibliotecario e scrisse il trattato morale I doveri degli uomini (1834), che solo nel titolo richiama il mazziniano Dei doveri dell’uomo (1861). E un Mazzini giovane e ancora ben lontano dalla cupezza tenebrosa che lo caratterizzerà nei suoi anni più maturi, troviamo in uno dei primi romanzi risorgimentali italiani, il Lorenzo Benoni o scene della vita di un italiano (1853) di Giovanni Ruffini. Questi era stato tra i primi promotori con Mazzini della “Giovine Italia” e come lui e con lui, dopo la mancata sollevazione di Genova del 1833, costretto all’esilio, prima a Marsiglia, poi in Svizzera e quindi a Londra; giunto infine a Parigi si guadagnò da vivere facendo il librettista (tra gli altri compositori anche per Donizetti) e scrivendo dapprima racconti e quindi il racconto dei suoi anni giovanili in un ampio romanzo nel quale si attribuì lo pseudonimo di Lorenzo Benoni, mentre Mazzini vi era chiamato Fantasio. Con grande senso dell’umorismo, il romanziere inglese Charles Dickens era il suo modello, Ruffini raccontò gli anni della sua formazione e dei suoi studi fino all’università per passare poi al periodo della cospirazione, vissuto con la spinta di grandi ideali patriottici ma ancor più civili, con l’insopprimibile volontà di conquistar per sé e per la propria città la libertà dall’oppressione dei Savoia. Per aver un numero non 74 irrilevante di lettori, tenendo conto di quanto si è detto circa la scarsa popolarità in Italia del romanzo, Ruffini scrisse il Benoni in inglese e lo pubblicò a Glasgow, con ciò anche diffondendo presso i lettori anglosassoni le ragioni di quanti in Italia lottavano per l’unità nazionale e per la liberazione dall’oppressione straniera. Il Benoni ebbe un buon successo, tanto che l’editore chiese a Ruffini di scrivere la continuazione della sua biografia e cioè gli anni dell’esilio vissuti a Londra con Mazzini, che in Inghilterra era molto popolare; i rapporti tra i due si erano però nel frattempo guastati e Ruffini si allontanò dalla traccia autobiografica sicché il suo secondo romanzo, Il dottor Antonio, uscito nel 1855 e ancora scritto in inglese, segue un intreccio d’invenzione senza però abbandonare il tema risorgimentale. Protagonista infatti è un patriota siciliano, il dottor Antonio, che ha dovuto lasciare l’isola, dove la sua attività cospirativa lo ha reso sospetto alle autorità borboniche, e si è trasferito in Liguria per fare il medico condotto a Bordighera dove soccorre un’inglesina, Lucy, vittima di un infortunio; destinata a rimanere irrealizzata la vicenda amorosa che nasce tra loro, Antonio partecipa ai moti del 1848 in Sicilia e viene poi invitato dal Re Ferdinando II a Napoli per far da mediatore tra i patrioti e i Borboni; ma il cambiamento della situazione politica lo porta alla cattura, al processo, alla condanna e alla carcerazione nell’isola di Ischia, da dove Lucy, che si è messa avventurosamente sulle sue tracce, si adopera per farlo scappare: Eccoci ora giunti al mese di maggio, quel fatal mese di maggio! La notte è scura quanto amanti e contrabbandieri potrebbero desiderare e i neri contorni del torreggiante castello si distinguono appena nel tetro fondo di un cielo nuvoloso. Un battello, nel quale stanno il Diplomatico e Battista, si avanza cautamente, con remi ravvolti di panno, fino al piede del massiccio edifizio, e prende posizione proprio dove lo scoglio cade perpendicolarmente nel mare. A un breve miglio dal piccolo porto d’Ischia sta ancora il Perseverante. Nella cabina sul ponte stanno lady Cleverton e Speranza, mute come ombre. La loro ansietà è troppo grande per esprimerla con parole. Speranza, in ginocchio a lato della sua amata padrona, le bagna con acqua le tempie. La vita di Lucy pende dall’esito di quest’ora. Ogni orologio della città suona mezzanotte – le 75 due donne nello yacht fissano gli occhi nella direzione della fortezza –; i due uomini nel battello tengono i loro occhi fissi in alto: non un movimento, non un suono. Anche un’altr’ora, un secolo, è passata e regna pure la stessa quiete di morte. Che vuol dir mai questo ritardo? Mezzanotte era l’ora convenuta; la limatura delle catene del prigioniero e delle sbarre di ferro della finestra, dalla quale deve tentare la fuga, doveva occupare solo venti minuti. Possibile che tutto sia stato scoperto? Ma se ciò fosse, si sarebbe udito qualche allarme, qualche colpo di fucile, qualche suono di voce – almeno si sarebbero veduti dei lumi – eppure tutto rimane scuro e quieto come la morte. O fosse mai che al momento decisivo, a faccia a faccia col sottoposto abisso, sia venuto meno il coraggio al prigioniero? Tre anni di tortura, quale si pratica sul fisico e sul morale nelle prigioni di Napoli, si sapeva che avevano indebolito altri cuori nobili e intrepidi come quello di Antonio. Mentre a bordo dello yacht e del battello queste congetture si discutevano con tremulo bisbiglio, la vasta massa del castello diveniva ogni momento più distinta per il progressivo albeggiare dell’orizzonte. Altri dieci minuti e sarebbe troppo tardi per il battello il ritirarsi senza destar sospetti; però il Diplomatico e Battista ripresero di nuovo i remi e, lasciando cautamente la loro pericolosa situazione, navigarono verso lo yacht e dopo poco più di un’ora una portantina depose lady Cleverton nella sala della sua villa. Battista volò alla villa e fu dall’atterrita Speranza introdotto immediatamente alla presenza di lady Cleverton. “Egli non vuol uscire!” gemette il poverino stracciandosi i capelli e battendosi le mani. “Egli non vuole uscire”. Questo era il fatto. Antonio aveva ricusato di fuggire e il negativo esito della notte passata era stato opera sua. “Questa è decisa pazzia!” esclama il Diplomatico. Lo sguardo a queste parole scambiato tra Lucy e Speranza fu pieno di nuovo terrore. In quell’istante Battista stende a lady Cleverton un sudicio pezzo di carta. O gioia! Era suo, benché potesse dirsi appena di sua mano. Le lettere erano formate di piccoli forellini nella carta. Queste poche parole, tracciate interamente all’oscuro, erano costate allo scrittore un’intera notte di lavoro. Eccone il senso: Sono qui con me cinque altre nobili persone, la minima delle quali vale dieci volte me. Non posso abbandonarle. Voi non potete salvarci tutti, lasciatemi dunque al mio fato. La 76 Provvidenza mi ha assegnato il posto fra quelli che soffrono. Forse le nostre pene saranno contate a salvezza del nostro paese. Pregate che sia così. Pregate per l’Italia! Dio vi benedica! Il vostro A. Se il Dottor Antonio sarà il romanzo risorgimentale più letto dagli italiani per oltre un secolo, tanto che da esso sarà tratto il primo sceneggiato agli albori delle trasmissioni televisive italiane nel 1954, l’altro grande romanzo ambientato in quel periodo, e anch’esso portato sui piccoli schermi con grande successo, è Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo; ma di questo scrittore vorrei qui ricordare altre due opere: il quaderno di appunti Impressioni di Sicilia, da lui scritto nei primi mesi della spedizione dei Mille alla quale egli partecipò in prima persona e che ritraggono con essenzialità ciò che accadde nell’isola nel 1860, e la raccolta di poesie Amori garibaldini composta nel 1859 quando egli si era arruolato tra i Cacciatori delle Alpi di Garibaldi per partecipare alla campagna per la conquista del lombardo-veneto da parte dei Piemontesi e dei Francesi, campagna che si concluderà con la deludente pace di Villafranca (con l’umiliante cessione della Lombardia dagli Austriaci ai Francesi che a loro volta la cederanno ai Piemontesi in cambio di Nizza e della Savoia). Questa esperienza aveva suggerito a Nievo una settantina di poesie che sono una sorta di diario poetico, l’unico di notevole qualità all’interno del Risorgimento, che segue giorno per giorno le vicende militari, con il pensiero che però torna costante all’amata abbandonata, amata peraltro non nominata né nominabile perché già moglie (di un cugino) e madre. E se dunque non mancano da queste pagine gli echi delle battaglie né ovviamente la figura del protagonista militare Garibaldi, neppure sono assenti i momenti di ripensamento e di riflessioni esistenziali, espressi senza cadute retoriche e con misura: A un buon cigarro1 Ier ti deposi all’ora dei sospiri2 All’ora dei sospiri or ti riprendo. 1 2 Sigaro. Al tramonto, tradizionalmente il momento della giornata più incline alla malinconia. 77 Ieri il tuo fumo in indolenti giri All’aer mesto si venìa mescendo, Né m’accorgea di loro, Né di te che dicevi: Io moro, moro. Oggi le labbra han sete di conforto Né mi consente il cor che ingrato3 io sia. E ti favello, e sento ch’ebbi torto Di sprezzar la tua muta compagnia, Povera foglia ardente, Che il cor m’incalorisci arcanamente. Ella4 mi è tolta e tu per poco resti Povera foglia; e bruci e ti consumi. Così passano i dì sereni o mesti, Come passan per l’aria i tuoi profumi; E ne riman soltanto Cenere amara, la memoria e il pianto. Il Generale Ha un non so che nell’occhio5 Che splende dalla mente E a mettersi in ginocchio Sembra inchinar la gente, Pur nelle folte6 piazze Girar cortese, umano, E porgere la mano Lo vidi alle ragazze. Sia per fiorito calle7 In mezzo a canti e a suoni Che tra fischianti palle E scoppio de’ cannoni, Ei nacque sorridendo 3 Per il conforto ricevuto dal sigaro. La donna amata clandestinamente perché moglie del cugino. 5 Un qualcosa d’indefinibile nello sguardo che esprime il suo carisma. 6 Affollate. 7 Piccola strada di paese ornata di fiori in suo onore. 4 78 Né sa mutar di stile Solo al nemico e al vile E’ l’occhio suo tremendo. Stanchi, disordinati Lo attorniano talora Lo stringono i soldati. D’un motto ei li ristora8, Divide9 i molti guaj, Gli scarsi lor riposi Né si fu accorto mai Che fossero cenciosi10. Conscio forse il cavallo Di chi gli siede in groppa, Per ogni via galoppa Né mette piede in fallo. Talor bianco di spume S’arresta, e ad ambi i lati Fan plauso al loro nume11 La folla dei soldati. Chi nol’ vide tal fiata12 Sulle inchinate teste Passar con un’occhiata Che infinita direste? È allor che nelle intense Luci13 avvampa il desio Delle Pampas immense14 E del bel mar natio15! 8 Li incoraggia con una parola. Condivide la sorte con i suoi soldati. 10 Male in arnese perché senza le divise che invece sono proprie dei soldati negli eserciti regolari. 11 Ai suoi soldati Garibaldi appare dotato di poteri quasi divini. 12 Talvolta. 13 Occhi. 14 Dal 1835 al 1848 Garibaldi era vissuto nell’America latina. 15 Era nato nel 1807 a Nizza, allora italiana, e sin da bambino aveva cominciato ad andar per mare. 9 79 Fors’anco altre memorie Ingombran l’orizzonte16 Di quell’altera fronte E il sogno d’altre glorie! Ma nel sospeso ciglio La vision s’oscura, E quasi ei la spaura Con subito cipiglio. Oh numi d’altri tempi, Idoli d’altri altari, Tolti di braccio agli empi, Salvi di là dei mari, Ditemi, che chiedete Al vostro vecchio amico? Ombre e non altro siete, Ombre d’un sogno antico. Garibaldi vuol dire soprattutto impresa dei Mille, spallata decisiva per la liberazione dai Borboni della Sicilia e del Mezzogiorno e dunque passo fondamentale per quella proclamazione del regno d’Italia che avverrà solo pochi mesi dopo la spedizione delle camicie rosse. Non furono poche le pagine scritte dagli stessi garibaldini su quelle vicende: da quelle essenziali ma incisive di Nievo che abbiamo già ricordato, all’ampio volume di memorie I Mille da Quarto a Capua di Giovanni Bandi, da I garibaldini di Alexandre Dumas a quello che è forse il libro più alto su questo tema: Noterelle d’uno dei Mille. Da Quarto al Volturno di Giuseppe Cesare Abba. Egli era un giovane dell’entroterra ligure di poco più di vent’anni quando s’imbarcò da Quarto con i volontari di Garibaldi, combatté con loro in Sicilia e sul Volturno e, terminate le operazioni, dopo qualche tempo tornò al suo paese, dove fu sindaco e, mettendo a frutto i suoi studi umanistici, scrisse un romanzo storico ambientato in epoca napoleonica - Le rive della Bormida nel 1794 – e non sarebbe più tornato sul suo passato garibaldino se Carducci non gli avesse chiesto in lettura gli appunti che aveva preso durante la 16 Ricordi dolorosi, come la morte della moglie Anita, avvenuta dieci anni prima, nel 1849. 80 spedizione avendo progettato di scrivere una biografia di Garibaldi. Ma a parere del poeta toscano quelli non erano semplici appunti, sicché lo esortò a dargli una forma organica e a farli diventare un libro; Abba, nel frattempo diventato professore di Lettere a Faenza (e poi a Brescia dove visse fino alla morte avvenuta nel 1910), pubblicò nel 1880 una prima versione del libro che si concludeva con il racconto della vittoriosa battaglia di Palermo, nel 1882 vi aggiunse gli avvenimenti compresi sino all’abbandono della Sicilia e solo nel 1891, nel trentennale dell’Unità, pubblicò la redazione definitiva che comprende l’intero arco degli eventi compresi, come indica il sottotitolo, tra la partenza da Quarto e la battaglia conclusiva del Volturno. Nel suo libro Abba racconta gli avvenimenti militari, il coraggio dei giovani e meno giovani, per lo più borghesi e per lo più lombardi, partiti da Quarto e la successiva adesione popolare dei picciotti siculi; certo, ritrae anche Garibaldi, ma in poche occasioni e se certo il suo ruolo carismatico è fuori discussione in realtà non minori attenzioni sono di volta in volta attribuite ad altri personaggi anonimi incontrati. E questa è la seconda, e più interessante, dimensione del libro di Abba, che può anche essere letto come un libro di viaggio per le descrizioni ampie del paesaggio e dei suoi abitanti, un’ autentica scoperta della Sicilia e del sud , dei siciliani e dei napoletani ma anche al contrario l’incontro con i settentrionali da parte di meridionali che ben poco sapevano dei loro prossimi connazionali. Marsala, 11 maggio. Ora la città è nostra. Dal porto alle mura corremmo bersagliati di fianco. Nessun male. Il popolo applaudiva per le vie; frati d’ogni colore si squarciavano la gola gridando; donne e fanciulle dai balconi ammiravano. “Beddi!Beddi!” si sentiva dire da tutte le parti. Io ho bevuto all’anfora d’una giovanetta popolana che tornava dalla fonte. Rebecca! E quell’arco della porta per la quale entrammo in città, come l’ho innanzi agli occhi! Mi parve l’ingresso d’una città araba; e un po’ mi parve anche di essere alle porte del mio villaggio, che hanno un arco come questo. Mi fermai a dare un’occhiata verso il porto. Venivano su correndo gli ultimi manipoli dei nostri: due navi 81 borboniche balenavano avvolte nel fumo; e quel nostro Lombardo , adagiato su d’un fianco, mi fece pietà. 13 maggio. Salemi. Da un balcone di convento, in faccia alla gloria del sole. Ho fatto un giro per la città. L’hanno piantata quassù che una casa si regge sull’altra, e tutte paiono incamminate per discendere giù da oggi a domani. Avessero pur voglia di sbarcare i Saraceni, Salemi sarebbe al sicuro! Vasta, popolosa, sudicia, le sue vie somigliano a colatoi. Si pena a tenersi ritti; si cerca un’osteria e si trova una tana. Ma i frati, oh!, i frati gli avevano belli i conventi, e questo dov’è la mia compagnia è anche netto17. Essi se ne sono andati. Gli abitanti, non scortesi, sembrano impacciati se facciamo loro qualche domanda. Non sanno nulla, si stringono nelle spalle, o rispondono a cenni, a smorfie, chi capisce è bravo. […] Il Generale ha percorsa la città a cavallo. Il popolo vede lui e piglia fuoco: magia dell’aspetto o del nome, non si conosce che lui. Il Generale ha assunta la Dittatura in nome d’Italia e Vittorio Emanuele. Se ne parla, e non tutti sono contenti. Ma questo sarà il nostro grido. Alle cantonate si legge un proclama del Dittatore. Egli si rivolge ai buoni preti di Sicilia. Un retore ha notato che preti buoni sarebbe stato detto meglio. Alcamo, 17 maggio. Sulla soglia d’una chiesetta, quasi in riva al mare. Da Calatafimi a qui18 fu una camminata allegra, per campagne fiorenti. Ma dappertutto vi era traccia della sconfitta che facemmo toccare ai regi: zaini, berretti, bende insanguinate buttate lungo la via. All’alba partendo si cantava; poi, tra per quella vista e per il sole che si alzò a schiacciarci, si tacque e si tirò innanzi come ombre. Verso le dieci, ci imbattemmo in certe belle carrozze, mandate ad incontrarci come gran signori. Alcamo era vicina. Nelle carrozze v’erano gentiluomini lindi e lucenti, che fecero le accoglienze al Generale; mentre allo sbocco dei sentieri, si affollavano dai campi molte donne campagnole, confidenti e senza paura di noi. Alcune si segnavano devotamente; una la vidi con due bambini sulle braccia inginocchiarsi quando il Generale passò; e uno dei 17 18 Pulito. Il 16 maggio è stata combattuta e vinta la durissima battaglia di Calatafimi. 82 nostri ricordò le Trasteverine d’undici anni or sono, che lo chiamavano il Nazzareno. Entrammo in Alcamo alle undici. È bella questa città, sebbene mesta; e all’ombra delle sue vie par di sentirsi investiti da un’aria moresca. Le palme ispiratrici si spandono dalle mura dei suoi giardini; ogni casa pare un monastero; un paio d’occhi balenano dagli alti balconi; ti fermi, guardi, la visione è sparita. Fummo in cinque da un signore che ci volle a forza a casa sua, e vi desinammo. Che gentilezza d’uomo, in quest’isola solitaria: ma che ingenua ignoranza delle cose d’Italia! Egli non ci tenne nascoste le sue figliuole, che ci guardavano ansiose e ci parlavano come a conoscenti antichi. «Di dove siete?» chiedeva il loro babbo a Delucchi. «Genovese». «E voi?» volgendosi a Castellani. «Da Milano». «Ed io da Como», rispondeva senza aspettare di essere interrogato Rienti. «Che bei paesi devono essere i vostri! Ma perché siete vestiti così da paesani19? Via, dite la verità, voi siete soldati piemontesi. No? E allora come avete fatto a vincere tanti Napoletani? Passarono di qui che era una pietà vederli. Non arriveranno a Palermo la metà». Poi il discorso cadde sulla guerra dell’anno scorso20. Quel signore pareva nato ieri. Credeva appena che Vittorio Emanuele fosse davvero al mondo […]. Se l’impresa dei Mille era stata ampiamente raccontata per i suoi esiti vittoriosi, lo stesso non accadde per la più bruciante delle sconfitte, quella toccata sette anni più tardi, quando per l’ennesima volta Garibaldi tentò di conquistare Roma, ma dovette arrestarsi a Mentana davanti alla supremazia francese. Tuttavia anche questa impresa ha dato vita ad un libro importante, Con Garibaldi alle porte di Roma, scritto da Anton Giulio Barrili. Questi, garibaldino tra i più fedeli, era stato direttore dal 1860 del giornale “Il Movimento” che 19 I volontari avevano coperte al posto di cappotti: da qui il loro aspetto dimesso e lo stupore dei siciliani. 20 La seconda guerra d’indipendenza, conclusasi con la vittoria franco-piemontese sugli Austriaci, grazie alla quale al Piemonte furono annessi la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Toscana, Modena e Parma, ma non il Veneto per volontà dei Francesi. 83 rappresentava l’organo ufficiale del garibaldinismo, ma ciò non di meno aveva combattuto al fianco del Generale a Bezzecca e appunto a Mentana. Da giornalista a scrittore di romanzi d’appendice il passo era breve e Barrili, guidato dal suo undicesimo comandamento: “Non annoiare”, si era conquistato un vasto pubblico di fedeli lettori che fecero di lui negli anni Settanta uno dei romanzieri più letti in Italia. Anche per lui, come per Abba, l’esperienza garibaldina sarebbe rimasta alle spalle se per il xxv anniversario della presa di Roma egli non fosse stato sollecitato a scrivere un libro sulle vicende del 1867; e lo fece con un’ottica non diversa dall’Abba delle Noterelle e anzi, se possibile, ancor più orientato verso il racconto di viaggio, tanto da non nascondere che, preparandosi a partire per combattere, si era procurato una guida turistica per avere notizie dei luoghi e dei monumenti che avrebbe incontrati lungo il percorso. E infatti racconta con piacere la sua visita agli Uffizi a Firenze e alla cascata delle Marmore, soffermandosi volentieri sulla qualità dei vini consumati, sull’ospitalità ricevuta nelle diverse locande e sulle qualità estetiche delle donne incontrate e proprio questo tipo scanzonato di racconto motiva il titolo di Scampagnata epica che inizialmente Barrili avrebbe voluto attribuire al suo libro. Ma poi, opportunamente, cambiò idea perché quando cominciano i combattimenti la narrazione diventa drammatica, tanto più che appare evidente che i settemila volontari iniziali un po’ alla volta, mettendosi male le cose, si assottigliano sempre più e l’esito della contesa, tanto più quando i Francesi si rivelano dotati di più moderno armamento, appare segnato negativamente per Garibaldi. Eppure egli non smette mai di incitare i suoi e, sessantenne pieno di vigore, sprona il suo cavallo in prima linea incurante del pericolo che sta correndo e senza tener conto che il suo sacrificio non servirebbe a nulla, anche perché, indipendentemente dall’esito di una battaglia, la vita tuttavia sembra destinata a scorrere come prima: Garibaldi è di buon umore, confida ancora21. Tre giorni prima aveva settemila uomini; non ne ha più che cinquemila, oggi; ma saranno tutti buoni? È il dubbio di parecchi, nella 21 È il 1° novembre 1867, Garibaldi e i suoi volontari sono a Monterotondo, nell’Agro Romano: l’impresa per la liberazione di Roma sta per concludersi infruttuosamente. 84 comitiva: il modo tumultuario22 con cui sono stati accettati e avviati dalle diverse città, la poca o nessuna conoscenza che hanno gli ufficiali di tanta gente nuova, raccolta a Terni e avviata in fretta al confine, ritorna spesso e volentieri sul tappeto, anzi sulla tovaglia. “Si squaglieranno a poco a poco” dice un pessimista. “Ebbene” conchiuse Garibaldi “quando saremo in trecento, faremo come Leonìda”. Egli pronunziava Leonìda, con l’accento sulla penultima. Aggiungo ora, per confessione alla nostra miseria, che se egli era capace di fare come Leonida, ci sarebbero voluti trecento Spartani, e risoluti al sacrificio, per fargli compagnia. Ma la storia non si ripete. Del resto, quarantott’ore dopo, su poco più di duemila combattenti, furono cinquecento che gli caddero intorno a Mentana. Come lezione all’Italia di allora non fu poi tanto male […]. Seguitiamo a ritirarci23, con le quadriglie francesi a cinquanta passi da noi, al fragore dei loro chassepots che fanno veramente prodigi. Guai se quella gente dilaga, giungendo prima di noi a Monterotondo, che è in vista oramai! Ma no, ecco Garibaldi ancora, Garibaldi con un centinaio di uomini, alla riscossa. È gente nuova, o avanzo della vecchia, ch’egli è riuscito a rianimare pur ora? Chiunque siano, ben vengano. Si avanzano con le baionette spianate; un po’ balenanti, mi pare, e Garibaldi non vuole trepidazioni in quel momento supremo. Lo vedo ancora, fiammeggiante cavaliere, nella luce sanguigna del tramonto; ritto in sella, battendo a colpi ripetuti il fianco del suo cavallo alto e bianco, con una striscia di cuoio, all’americana; risoluto di arrestare ad ogni costo un nemico che la fortuna aveva fatto insolente. E percuotendo il cavallo, scendeva dalla spianata, gridando con voce vibrata: “Venite a morire con me! Venite a morire con me! Avete paura di venire a morire con me?”. L’occhio vigile di Stefano Canzio ha precorso il pericolo. L’animoso ufficiale coglie il momento opportuno del nemico arrestato, si gitta alla testa del cavallo e 22 23 Cioè in fretta e alla rinfusa. Proprio quando pensavano di essere vittoriose, perché avevano conquistato Mentana e ripreso la località di Vigna Santucci, le truppe garibaldine furono attaccate dalle truppe imperiali francesi e, mentre le prime schiere cercavano di resistere al nemico, il grosso degli uomini del Generale fuggì disordinatamente. 85 ne afferra le redini, gridando con voce di amoroso rimprovero, ma donde trapelano tutte le collere addensate da un’ora: “Per chi vuol farsi ammazzare, Generale? Per chi?” Ho veduto, ho sentito: il ripetuto “per chi?” fu quello che vinse l’animo di Garibaldi, serbando il suo cuore, il suo braccio, il suo nome, alla gloria di una sublime vendetta. Non facilmente s’era piegato l’eroe. Aveva data in giro un’occhiata leonina; aveva abbassate le ciglia, forse mormorando quel maraviglioso “Avete ragione” in cui soleva sfolgorare la sua bella modestia, chiudendo molte discussioni e mostrando il lavoro interiore che si faceva rapidamente nel suo nobile spirito; poi aveva dato ancora uno sguardo lungo e profondo in quella penombra della strada contornata di siepi, onde balenavano i lampi della moschetteria contro lui invulnerabile. Né, ritiratosi lentamente di là, avrebbe voluto cedere il campo. Non erano ancora di là da Mentana, sulla strada di Tivoli, i tre battaglioni mandati la sera innanzi ad occupare Sant’Angelo? Perché non si erano mossi? Perché non erano accorsi al cannone? E perché, finalmente, non avrebbero potuto attaccare nella notte, aiutando così a ripigliar l’offensiva? […] Ci sarebbero volute ore ed ore, a raccogliere quella gente; e neanche, dopo tanti esempi dolorosi, era da sperare che si potesse venirne a capo. La sera intanto è venuta; segue la notte, scura per il cielo nuvoloso, e dei tre battaglioni invocati non si ha nuova né canzone. Ad ora tarda, dopo aver inutilmente specolato dalla torre del castello Piombino, Garibaldi si arrende all’evidenza delle cose, ai consigli di tutti i suoi ufficiali, e comanda la ritirata. […] A quella stazione24 erano accorsi anche due amici artisti, che mi strapparono dal treno e mi condussero in città. D’uno tra essi indossai gli abiti, lasciando per una sera le mie spoglie soldatesche; e poco dopo, vedete stranezza! in una poltrona, a teatro, assistevo alla rappresentazione di un’opera in musica. Mai l’arte dei suoni mi parve più bella; mai ebbi dalle sette note una commozione più viva. In Francia, lo ha detto un francese, tout finit par des chansons25. Io, in Italia, finivo la mia piccola odissea con una orecchiata di musica eccellente. 24 25 La stazione di Terni, dove Barrili era giunto in treno dopo la disfatta. Tutto finisce in canzonette. 86 La vita è piena di tali contrasti. Ed io vedevo tanta gente allegra, a teatro! tante belle dame sorridenti nella mezza luce dei palchetti ai cavalieri galanti, dai guanti grigi perlati e dai candidi petti di porcellana! Niente di nuovo, niente di grave era accaduto in Italia. Per chi volevate farvi ammazzare, Generale? Per chi? Come abbiamo sottolineato i due importanti libri di Abba sull’impresa dei Mille e di Barrili sulla sconfitta di Mentana furono scritti e pubblicati a considerevole distanza di tempo dai fatti: il primo dopo 31 e il secondo dopo 28 anni: perché? Una prima risposta potrebbe essere che i due autori avevano inteso raccontare a freddo, e dunque con le opportune riflessioni a posteriori, l’andamento delle vicende militari dando anche spazio a quelle pregevoli descrizioni di ambiente certo improbabili in una cronaca militare scritta contemporaneamente o subito dopo gli eventi: insomma, dal materiale documentario i due scrittori, ormai ex garibaldini, avevano tratto spunto per comporre due libri molto più ricchi e stilisticamente più apprezzabili. Ma non è tutto: nei quasi trent’anni trascorsi tra le imprese dei Mille e di Mentana e il presente che cosa era successo che potesse rendere accettabile il sacrificio di tanti giovani garibaldini? Evidentemente assai poco, perché quei princìpi umanitari e sociali che, ancor più di quelli politici, avevano guidato le azioni di Garibaldi non erano stati realizzati nell’Italia post-unitaria, nella quale i poveri continuavano a essere poveri e gli sfruttati a essere sfruttati, tanto che, proprio a partire dagli anni Ottanta e quindi nel tempo della pubblicazione dei libri di Abba e Barrili, era cominciato quel fenomeno sconvolgente che era l’emigrazione di massa, nata dalla miseria e dal coraggio della disperazione. Insomma quanti avevano combattuto generosamente con Garibaldi si rendevano conto dell’inutilità del loro sacrificio e allora si può intendere che con le loro opere i nostri due scrittori abbiano compiuto un estremo tentativo per richiamare alla memoria vicende che erano state troppo presto dimenticate da chi doveva adoperarsi per “fare gli italiani”, ma beninteso italiani non affamati e vessati. Ed è proprio una pagina di De Amicis, tratta dal suo intenso romanzo sull’ emigrazione Sull’oceano (1889), che ben fa 87 comprendere la delusione dei reduci garibaldini in un suo dialogo con uno di loro costretto all’emigrazione: Era un uomo sui quarant’anni, dell’aspetto di un antico soldato, di corpo poderoso, ma che s’indovinava svelto ancora, già grigio. La fronte ardita e gli occhi iniettati di sangue mi rammentarono Nino Bixio, ma la parte inferiore del viso era più mite, benché triste e come contratta da un’espressione di disprezzo, che faceva violenza alla bontà della bocca. Non so bene per quale associazione di idee, pensai a una di quelle nobili figure di Garibaldini del 60, che avevo conosciuto nelle pagine indimenticabili di Cesare Abba26 e mi fissai nel capo ch’egli avesse fatto quella campagna e che dovesse essere lombardo. S’avvicinava il garibaldino, che veniva da prua27. Quando mi passò accanto, mi scappò di domandargli: “E’ stato fra gli emigranti?” così per simpatia. Egli parve stupito che gli rivolgessi la parola e accennò di sì, soffermandosi, ma di fianco, come chi vuol fare un discorso corto. Ridomandai: “Ha visto quei poveri contadini?.”. “I contadini” rispose lentamente, guardando il mare “sono embrioni di borghesi”. Non afferrai subito il concetto. “Hanno il solo merito” continuò senza guardarmi “di non mascherarsi con la retorica patriottica e umanitaria. Del resto… lo stesso egoismo di belve addomesticate. Il ventre, la borsa. Nemmeno l’ideale della redenzione della loro classe. Ciascuno vorrebbe veder più miserabili tutti, pur di campar lui meglio di prima. Tornino gli Austriaci, ma ad arricchirli, saran con loro”. E soggiunse dopo una pausa: “Facciano buon viaggio”. “Eppure” osservai “quando sono in America, ricordano e amano la patria”. Egli si appoggiò al parapetto, rivolto al mare. Poi rispose: “La terra, non la patria”. “Non credo” risposi. Egli scrollò le spalle. Poi, senza preamboli, col tono di chi parla per liberarsi una volta per sempre da un importuno, più che per un bisogno di confidarsi a lui, aperse l’animo suo con poche parole rapide e secche. Nemmeno lui rimpiangeva la 26 Evidentemente De Amicis si riferisce alle prime due edizioni delle Noterelle uscite nel 1880 e nel 1882, essendo invece del 1891 la terza e definitiva edizione. 27 Il 10 marzo 1884 De Amicis s’imbarcò a Genova sul piroscafo Nord America diretto a Buenos Aires; con lui viaggiavano circa 1600 emigranti, uno dei quali era il garibaldino protagonista di queste pagine. 88 patria, infine. Essa era riuscita troppo al di sotto dell’ideale per cui s’era battuto. Un’ Italia di declamatori e d’intriganti, appestata ancora di tutta la cortigianeria antica, idropica28 di vanità, priva di ogni grande ideale, non amata né temuta da alcuno, accarezzata e schiaffeggiata ora dall’uno or dall’altro, come una donna pubblica, non forte d’altro che della pazienza del giumento. Dall’alto al basso non vedeva che una putrefazione universale. Una politica disposta sempre a leccar la mano al più potente, chiunque fosse; uno scetticismo tormentato dal terrore segreto del prete; una filantropia non ispirata da sentimenti generosi degli individui, ma da interessi paurosi di classe. E nessuna salda fede, nemmeno monarchica. Dei milioni di monarchici, incapaci di difendere prodemente, a un bisogno, la loro bandiera, pronti a mettersi a pancia a terra davanti al berretto frigio, appena lo vedessero in alto. Una passione furiosa in tutti di arrivare non alla gloria, ma alla fortuna; l’educazione della gioventù non rivolta ad altro; ciascuna famiglia mutata in una ditta senza scrupoli, che batterebbe moneta falsa per far strada ai figliuoli. E le sorelle incamminate per la via dei fratelli, perdendosi di giorno in giorno nell’educazione e nella vita della donna ogni spirito di poesia e di gentilezza. E mentre l’istruzione popolare, una pura apparenza, non faceva che seminare orgoglio e invidia, cresceva la miseria e fioriva il delitto. Metà degli uomini che avevan dato la vita per la redenzione dell’Italia, se fossero resuscitati, si sarebbero fatti saltare le cervella”. Al Risorgimento continueranno a guardare anche alcuni scrittori del Novecento e proprio uno dei più importanti romanzi del dopoguerra, nonché primo best seller italiano, avrà come sfondo le vicende successive all’impresa di Garibaldi: Il Gattopardo (1958) di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In questo romanzo, tutto giocato tra l’immobilismo conservatore del vecchio principe di Salina e l’entusiasmo innovatore del giovane e spregiudicato Tancredi, si afferma infine il principio dell’accettazione dei cambiamenti come unica condizione perché di fatto nulla cambi, tanto che viene da domandarsi quanto cammino sia stato fatto nella realtà in questi centocinquant’anni per creare quella effettiva coscienza nazionale e 28 Gonfia. 89 quell’identità di popolo per il cui raggiungimento abbiamo letto quanto già si fosse impegnato De Amicis nelle pagine di quel Cuore, che si può legittimamente considerare il battistrada dei libri italiani risorgimentali. La lezione di Francesco De Nicola (23 febbraio 2011) 90 FRANCO VAZZOLER Letteratura e poesia in Fortini, Pasolini e Sanguineti fra anni Cinquanta e Sessanta La lezione ruota su due domande di fondo: che cosa unisce i tre autori? che cosa resta della loro opera (in particolare presso i giovani di oggi)? Tutti e tre sono innanzi tutto poeti, ma dediti anche alla narrativa, alla saggistica, alla pubblicistica, alla traduzione (Fortini e Sanguineti sono anche docenti universitari, Pasolini è anche regista). Tutti e tre, pur con diverse sfumature, si riconoscono nell’idea della letteratura come “impegno” (matrice Vittorini); Pasolini, in particolare, è tutto interno al problema del rapporto tra cattolicesimo e marxismo (da Le ceneri di Gramsci e L’usignolo della Chiesa Cattolica ad Accattone e La ricotta ecc.). Sono accomunati, soprattutto, da una visione critica – da diverse posizioni ideologiche – della realtà italiana dal primo dopoguerra agli anni ’60-’70. In conclusione sono letti e commentati tre testi: La gioia avvenire di Fortini (del ’46), Il pianto della scavatrice di Pasolini (poemetto del ’56, compreso ne Le ceneri di Gramsci) e A domanda rispondo… di Sanguineti (da Cataletto del 1982). A completamento e approfondimento della sua lezione, il prof. Vazzoler ci ha lasciato il testo scritto che di seguito pubblichiamo. *** I I tre autori che ho scelto – e non li ho scelti a caso – sono tutti e tre poeti, hanno scritto opere di narrativa, di saggistica letteraria (due su tre sono stati professori universitari di letteratura italiana), di interventi su giornali e settimanali, di teatro (in proprio e/o come traduttori), uno (Pasolini) è stato un importante regista cinematografico. Nessuno di loro può essere definito un letterato “puro”. Tutti e tre hanno svolto un ruolo importante come “intellettuali”, cioè come scrittori che, attraverso la scrittura (cioè la letteratura) prendevano posizione, cercavano di interpretare 91 criticamente la realtà: scrittori (intellettuali) “impegnati”, come si diceva una volta, stavo per dire ai miei tempi, che erano quelli del secolo scorso, scorso da dieci anni; dieci anni che sono quasi la metà della vostra vita, immagino, di voi che mi state davanti; e certamente la vostra vita intellettuale si è svolta tutta in questo nuovo secolo. Per cominciare, può aiutarci ricordare gli estremi della loro biografia. Franco Fortini era nato nel 1917, a Firenze. Fortini è il nome della madre, nome che assunse, quando in Italia furono applicate le leggi razziali, nel 1940, perché il padre era ebreo (si chiamava Lattes); è morto nel 1994. Pier Paolo Pasolini nasce nel 1922 (a Bologna) e muore tragicamente nel 1975. Edoardo Sanguineti era nato a Genova nel 1930 ed è morto l’anno scorso: l’unico ad aver scavalcato il secolo. Se solo otto anni dividevano Pasolini da Sanguineti (e solo cinque Fortini da Pasolini) i tredici anni in meno di Sanguineti rispetto a Fortini, se non rappresentano un salto generazionale, certo segnano una differenza significativa nella loro biografia (l’esperienza della resistenza) e nella loro formazione, di cui possiamo renderci conto pensando alle date in cui hanno pubblicato i loro primi libri. Fortini esordisce nel 1946 con la raccolta di poesie Foglio di via e altri versi e l’anno dopo con il romanzo Agonia di Natale (entrambi pubblicati da Einaudi, che è la casa editrice per cui lavorano Pavese e Vittorini). Pasolini a quell’epoca aveva già pubblicato, a vent’anni, nel 1942, la raccolta Poesie a Casarza, in dialetto friulano (subito notate da un critico letterario e filologo importante come Gianfranco Contini) e poi nel 1957 Le ceneri di Gramsci. Nel 1955 aveva fondato la rivista “Officina” e pubblicato il romanzo Ragazzi di vita; le poesie scritte in precedenza, negli anni fra il 1943 e il 1949, usciranno nel 1958, con il titolo L’usignolo della Chiesa cattolica. La prima raccolta poetica di Sanguineti, Laborintus, esce nel 1956, ed ha anch’essa un padrino importante, Luciano Anceschi, studioso di estetica, che proprio nel 1955 aveva fondato la rivista milanese “il verri”. Questa, che può sembrare una piccola selva di date, ci dà però l’idea di come, quella che poi diventerà una contemporaneità 92 sostanziale fra i tre scrittori, sia comunque segnata da differenze e sfasature che possono aver determinato un diverso approccio alla letteratura e possono aiutare a dare una ragione anche del loro muoversi lungo assi culturali ben individuati. Fortini si forma nel clima dei Guf e poi delle persecuzioni razziali, dell’esilio in Svizzera e della Resistenza in Valdossola; Pasolini in Friuli, oltre alla scoperta dell’eros omosessuale, vive drammaticamente l’esperienza della Resistenza attraverso la tragedia famigliare dell’uccisione del fratello da parte delle formazioni titine. Sanguineti, più giovane, si forma nel clima intellettuale della Torino antifascista, attraverso lo zio che aveva frequentato Gobetti e immediatamente dopo la guerra, negli anni del liceo, subisce il fascino dell’insegnamento di Albino Galvano (pittore, critico d’arte, conoscitore della teoria freudiana e interessato alle avanguardie), attraverso Guido Seborga ha una precoce conoscenza di Artaud. Pasolini parte dal dialetto (quello della madre e della periferia friulana dove vive gli anni della giovinezza) per approdare nelle poesie in lingua ad una poesia pluristilistica. Fortini (su cui esercita una grande influenza un intellettuale eccentrico come Noventa), mentre nella prosa dirige il neorealismo verso esiti espressionistici, in poesia, pur collocandosi inizialmente nel segno dell’ermetismo fiorentino, ha ben presente anche Saba, ma con lo sguardo rivolto ai tempi nuovi, dopo l’esperienza della guerra: Prevert e Eluard, quasi subito Brecht. Sanguineti aggredisce anarchicamente le convenzioni liriche con un poemetto narrativo, plurilingue (Laborintus), in cui si rifà alla grande poesia europea (Eliott), ma pure alla tradizione antica di Dante, rivisto anche con l’occhio sperimentale di Pound nella rappresentazione infernale di una labirintica palus putredinis; al materialismo marxiano, ma anche al simbolismo psicoanalitico (Joung oltre a Freud); fin dall’inizio la sua poesia decreta la fine del lirismo e sceglie la prosasticità quotidiana. Tre testi, scelti fra quelli degli anni Cinquanta, tutti e tre sul tema del “rinnovamento”, possono darcene un’idea. Fortini, La gioia avvenire Scritta nel 1945, ma non accolta nella prima edizione di Foglio di via (non è compresa ancora neppure in Poesia ed errore del 1959), 93 sarà pubblicata per la prima volta nella seconda edizione, riveduta, della raccolta (1967) per figurare, infine in Una volta per sempre (1978), stampata in corsivo, come a raccordare, in posizione rilevata, ma isolata – nel disegno poetico-autobiografico di questo libro complessivo ed autorialmente definitivo – le due raccolte, Foglio di via e Poesia ed errore. [Andrebbe aperta qui una parentesi su come vengano ad organizzarsi, per fasi successive, non solo quelle di Fortini, ma quasi tutte le raccolte poetiche del Novecento (cito a mo’ di esempio i casi di Palazzeschi, Ungaretti, Saba e Montale), ma mi limito a segnalare il problema, che è di grande rilevanza, ma esce dai confini e dagli scopi di questo intervento] La gioia avvenire Potrebbe essere un fiume grandissimo Una cavalcata di scalpiti un tumulto un furore Una rabbia strappata uno stelo sbranato Un urlo altissimo Ma anche una minuscola erba per i ritorni Il crollo d'una pigna bruciata nella fiamma Una mano che sfiora al passaggio O l'indecisione fissando senza vedere Qualcosa comunque che non possiamo perdere Anche se ogni altra cosa è perduta E che perpetuamente celebreremo Perché ogni cosa nasce da quella soltanto Ma prima di giungervi Prima la miseria profonda come la lebbra E le maledizioni imbrogliate e la vera morte Tu che credi dimenticare vanitoso O mascherato di rivoluzione La scuola della gioia è piena di pianto e sangue Ma anche di eternità E dalle bocche sparite dei santi Come le siepi del marzo brillano le verità. 94 È una poesia semplice, di una semplicità che può richiamare, oltre che l’ermetismo (evidente nell’uso metaforico delle immagini naturali), Saba per il dipanarsi piano discorsivo e colloquiale degli incipit delle prime quattro strofe («Potrebbe essere...», «Ma anche...», «Qualcosa comunque...»). Una discorsività che nella formulazione ipotetica e nel gioco delle avversative (si notino i tre «Ma...», e i due «O...»), vuole proporre non l’inconoscibilità del reale, ma la dialettica della sua possibile interpretazione. Nasce infatti da un’istanza palingenetica, di trasformazione e rinascita che punta tutto sul verso finale, come risoluzione di un atteggiamento lirico che fonde quello personale (anche autoironico) ad un discorso più generale, per legare il destino del soggetto non tanto (ungarettianamente) alla Natura, ma piuttosto alla Storia. Pasolini. Il pianto della scavatrice, sezione VI Compresa nella raccolta Le ceneri di Gramsci (1957), fa parte di un lungo poemetto, che appartiene a tutt’altro genere rispetto alla poesia di Fortini letta prima. Ho dovuto stralciare una sezione, l’ultima, di un poemetto molto più lungo. VI Nella vampa abbandonata del sole mattutino - che riarde, ormai, radendo i cantieri, sugli infissi riscaldati - disperate vibrazioni raschiano il silenzio che perdutamente sa di vecchio latte, di piazzette vuote, d'innocenza. Già almeno dalle sette, quel vibrare cresce col sole. Povera presenza d'una dozzina d'anziani operai, con gli stracci e le canottiere arsi dal sudore, le cui voci rare, le cui lotte contro gli sparsi blocchi di fango, le colate di terra, 95 sembrano in quel tremito disfarsi. Ma tra gli scoppi testardi della benna, che cieca sembra, cieca sgretola, cieca afferra, quasi non avesse meta, un urlo improvviso, umano, nasce, e a tratti si ripete, così pazzo di dolore, che, umano, subito non sembra più, e ridiventa morto stridore. Poi, piano, rinasce, nella luce violenta, tra i palazzi accecati, nuovo, uguale, urlo che solo chi è morente, nell'ultimo istante, può gettare in questo sole che crudele ancora splende già addolcito da un po' d'aria di mare... A gridare è, straziata da mesi e anni di mattutini sudori - accompagnata dal muto stuolo dei suoi scalpellini, la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco sterro sconvolto, o, nel breve confine dell'orizzonte novecentesco, tutto il quartiere... È la città, sprofondata in un chiarore di festa, - è il mondo. Piange ciò che ha fine e ricomincia. Ciò che era area erbosa, aperto spiazzo, e si fa cortile, bianco come cera, chiuso in un decoro ch'è rancore; ciò che era quasi una vecchia fiera 96 di freschi intonachi sghembi al sole, e si fa nuovo isolato, brulicante in un ordine ch'è spento dolore. Piange ciò che muta, anche per farsi migliore. La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci: è qui, che brucia in ogni nostro atto quotidiano, angoscia anche nella fiducia che ci dà vita, nell'impeto gobettiano verso questi operai, che muti innalzano, nel rione dell'altro fronte umano, il loro rosso straccio di speranza. Si noti innanzitutto la scelta del metro: la terzina dantesca, sottoposta ad adattamenti: la misura dei versi non tutti endecasillabi naturali, le rime che sono legate in assonanze o attraverso analogie fonico-grafiche (rime imperfette), che denuncia la scelta di una poesia narrativa. Questa della poesia narrativa è una linea sperimentale che ha già avuto un esempio in Lavorare stanca di Pavese e che si ritrova anche in Volponi e in Pagliarani. In questo senso siamo in una fase storica della società italiana in cui la “speranza avvenire” ha lasciato il posto alla disillusione. Pasolini cerca di oggettivare la propria poesia non evidenziando l’io lirico, ma collocando il lirismo nell’oggettività della narrazione. Un aspetto importante del poemetto di Pasolini sta nel fatto che il tema è affrontato non da un punto di vista individuale, ma collettivo, storico. Per questo ha molta importanza il paesaggio urbano: Roma è la città-metropoli-capitale a cui approda lo scrittore provinciale. É una città in trasformazione. Pasolini la rappresenta tra realtà e mito. Ma la figura mitica qui non è una figura dell’antichità classica, ma una moderna scavatrice, lo strumento della 97 trasformazione edilizia e urbanistica di Roma, il cui “pianto” contiene (miticamente, appunto) tutto il dolore della trasformazione. Sanguineti, Laborintus, sezione 1 Nella raccolta di esordio di Sanguineti (Laborintus, 1956) l’anti-ermetismo e lo sperimentalismo assumono un carattere del tutto diverso rispetto alle più caute prese di distanza di Fortini e Pasolini. 1. composte terre in strutturali complessi sono Palus Putredinis riposa tenue Ellie e tu mio corpo tu infatti tenue Ellie eri il mio corpo immaginoso quasi conclusione di una estatica dialettica spirituale noi che riceviamo la qualità dai tempi tu e tu mio spazioso corpo di flogisto che ti alzi e ti materializzi nell'idea del nuoto sistematica costruzione in ferro filamentoso lamentoso lacuna lievitata in compagnia di una tenace tematica composta terra delle distensioni dialogiche insistenze intemperanti le condizioni esterne è evidente esistono realmente queste condizioni esistevano prima di noi ed esisteranno dopo di noi qui è il dibattimento liberazioni frequenza e forza e agitazione potenziata e altro aliquot lineae desiderantur dove dormi cuore ritagliato e incollato e illustrato con documentazioni viscerali dove soprattutto vedete igienicamente nell'acqua antifermentativa ma fissati adesso quelli i nani extratemporali i nani insomma o Ellie nell'aria inquinata in un costante cratere anatomico ellittico perché ulteriormente diremo che non possono crescere tu sempre la mia natura e rasserenata tu canzone metodologica periferica introspezione dell'introversione forza centrifuga delimitata Ellie tenue corpo di peccaminose escrescenze che possiamo roteare e rivolgere e odorare e adorare nel tempo desiderantur (essi) analizzatori e analizzatrici desiderantur (essi) personaggi anche ed erotici e sofisticati desiderantur desiderantur 98 Quello di Sanguineti è un testo che, ad una prima lettura, può apparire di difficile decifrazione. La raccolta-racconto di Laborintus, qui colta nel suo incipit, nel suo momento iniziale, è la storia di un soggetto che si trasforma in una sorta di uomo nuovo (in realtà simbolo dell’umanità) gettato nella realtà. Questa fondazione del nuovo ha, dal punto di vista stilistico, il corrispondente nella fondazione di una nuova realtà linguistica e letteraria, basata sul montaggio di materiali eterogenei. Nel testo c’è una selva di citazioni, di prelievi da altri autori, che sono stati minuziosamente indicati e commentati da Erminio Risso (Manni, 2006). La poesia non è creazione dell’io, è occasione, diario. «Canzone metodologica» (v. 21): l’auto-definizione indica la peculiarità prosastico-ragionativa del’esperienza lirica che il poeta sta intraprendendo. Al tempo stesso riflesso della realtà e riaffiorare del già detto, attraverso la citazione: qui, ad esempio, in posizione centrale Foscolo («noi che riceviamo la qualità dai tempi») Stalin («le condizioni esterne à evidente esistono realmente»). Il tessuto linguistico è variegato: dal linguaggio tecnicofilologico («aliquot lineae desiderantur») al verso 13 (in traduzione: «si sente la mancanza di alcun righe»: per segnalare una probabile lacuna del testo), al linguaggio alchemico («flogisto», «palus putredinis », «composte terre», «acqua antifermentativa», «nani extratemporali [...] nell’aria inquinata» e a quello dell’astronomia, della medicina e della fisica («cratere anatomico ellittico», «forze centrifughe»). Ma al di là del ricorso di puntuali citazioni nascoste (e alla necessità della loro decifrazione), è il montaggio delle immagini (di derivazione surrealista) a dare il senso del paesaggio lunare postatomico, attraversato dalla figura onirica di Ellie: figura femminile, immagine dell’anima, personificazione dell’inconscio: è in virtù di questa che il percorso di crisi potrà concludersi, alla fine del poemetto, con l’uscita dalla palude labirintica (che è la realtà capitalistica nell’era atomica), attraverso l’esperienza dell’amore, materialisticamente inteso come necessità dell’io (e il ricorrente «desiderantur» ha, così, il doppio significato di desiderio e mancanza). 99 In questo modo viene sottolineata anche l’esigenza di interpretazione dell’irrazionale, considerato esso stesso come una esperienza reale. II Ho fatto tre esempi di poesie, ma per nessuno dei tre poeti la poesia (intesa nello stretto senso di lirica) esaurisce le possibilità della letteratura, dello strumento letterario. Ho accennato alle più o meno contemporanee esperienze romanzesche che accompagnano, o seguono di poco, l’esordio poetico, e ad essi si devono aggiungere gli interventi teorico-critici, per completare il quadro di una letteratura intesa come intervento sulla realtà Fortini è uno stretto collaboratore del “Politecnico”, settimanale culturale fondato da Vittorini nel 1945, subito dopo la liberazione, inizialmente appoggiato dal Pci, ma fatto chiudere nel 1947 e poi collaboratore anch’egli di “Officina”, la rivista bolognese di cui Pasolini è redattore e su cui si aprirà la polemica con Sanguineti (il cui punto di riferimento è la rivista “il verri” di Luciano Anceschi, più attento alle ragioni estetiche delle avanguardie) sul tema dello sperimentalismo letterario. Nel clima del dopoguerra “Il politecnico” di Vittorini aveva impostato il tema del rapporto fra letteratura e realtà, fra letteratura e storia, tema cruciale per tutti e tre i nostri autori. E ad esso è legata l’idea di una letteratura in continua trasformazione. Di qui l’attenzione che “il menabò” (la rivista diretta da Vittorini e Calvino ed edita da Einaudi) che è l’ideale continuazione del “Politecnico” riserverà al tema dei rapporti fra letteratura e industria, nel tempo dell’industrializzazione, delle trasformazioni del capitalismo. [Un’altra parentesi da aprire ora sarebbe quella della rinnovata importanza delle riviste di letteratura, per meglio dire di cultura. Qui si svolge il dibattito fra gli intellettuali, qui sono presentati, in anteprima, i nuovi testi: dopo “Il politecnico”, “Officina”, “il verri”, “il menabò”, “Rendiconti”, “Quartiere”,”Comunità”, “Quaderni piacentini”, più tardi “Quindici”. E ognuna rappresenta 100 sia una precisa idea di letteratura, sia l’esigenza di uscire da un discorso soltanto letterario.] Nell’intenso dibattito culturale del dopoguerra, se Fortini è, e sarà, l’irrequieto critico dei luoghi comuni della sinistra, e Pasolini, in procinto di aprirsi all’esperienza del cinema (Accattone è del 1961), cercherà di fondare il proprio realismo sulla conciliazione delle ragioni rivoluzionarie e del populismo cattolico, Sanguineti rappresenterà il richiamo costante dell’ideologia. Gli scritti di Fortini fra il 1947 e il 1957 e poi quelli dei successivi anni sessanta (in cui ebbe la funzione, ancor più di Pasolini e Sanguineti, di maître à penser delle nuove generazioni che militavano culturalmente e politicamente a sinistra) sono raccolti in due volumi: uno dal titolo evocativo Dieci inverni (1957), l’altro dal titolo arcigno, neutralmente tecnico-giuridico di Verifica dei poteri (1965), che egli stesso spiegava così: «Si tratta di registrare gli strumenti critici, di verificarne i poteri, di decidere a quale livello del mare cominciano i nostri calcoli, entro quale arco di meridiani e di paralleli consideriamo validi i nostri discorsi». I saggi di Pasolini si possono leggere in una raccolta (Passione e ideologia) del 1960. Del 1965, invece, è la prima edizione di Ideologia e linguaggio di Sanguineti, che raccoglie saggi pubblicati precedentemente su “il verri” a partire dal 1962, tutti dedicati a Montale e all’avanguardia, tranne il primo sui Poemetti pascoliani che era uscito sulla rivista accademica “Lettere italiane” . Mi sembra giusto fare una precisazione, solo in apparenza un po’ pedantesca: Ideologia e linguaggio avrà poi una seconda edizione ampliata nel 1970 e, infine, una terza, ancora notevolmente ampliata, nel 2001, a cura di Erminio Risso (che è quella che si trova oggi in libreria). Questo incessante impegno di raccogliere la propria produzione sotto lo stesso titolo di un unico libro incessantemente in progress indica la continuità e la coerenza di un discorso sviluppato negli anni. Se confrontiamo i due titoli (Passione e ideologia e Ideologia e linguaggio), non sfugge il fatto che il titolo di Sanguineti (1965) è una replica a quello di Pasolini (1960), su quello che appare il tema cruciale nel rapporto fra i due autori: la divaricazione concettuale, oltre che pratico-letteraria, fra passione e linguaggio: per Pasolini 101 l’ideologia è in conflitto con i contenuti sentimentali della letteratura, per Sanguineti l’ideologia è programmaticamente all’interno del linguaggio. Ma le divaricazioni (che avranno accenti personali anche crudelmente polemici) si faranno negli anni sempre più forti, fino all’incomprensione, soprattutto a proposito del movimento del Sessantotto; ma anche oltre. Basti confrontare il diverso atteggiamento tenuto da Sanguineti alla loro morte: la commossa rievocazione che Sanguineti farà di Pasolni, e la continuazione della polemica con Fortini, accusato, anche in quell’occasione, di essere andato ad insegnare in una università del Sud-Africa razzista. Da quel momento, ognuno con caratteristiche diverse e da diversi “punti di fuoco”, Sanguineti, Pasolini e Fortini animano il dibattito culturale, con reciproca attenzione e elementi di chiara polemica. Se Fortini è l’irrequieto critico dei luoghi comuni della sinistra, Pasolini sviluppa il discorso dell’omologazione (il Pasolini luterano e corsaro), mentre Sanguineti rappresenta il richiamo costante dell’ideologia, dell’unità della sinistra. Fra Sanguineti e Fortini, ci fu una radicale contrapposizione sui temi della neoavanguardia (con Avanguardia, società e impegno del 1966, relazione al convegno Avanguardia e neoavanguardia, cui faceva da pendant polemico e contrapposto il saggio di Fortini Le due avanguardie): se Sanguineti ne é il personaggio di maggior spicco, Fortini accusava la neo-avanguardia di essere semplicemente un prodotto dell’ammodernamento del mercato culturale. Ma soprattutto Sanguineti non perdonerà l’idea “alta” dello stile, il profetismo e il moralismo. Quando più tardi, questa volta dalle pagine della stampa quotidiana a più larga diffusione (è il primo a comprendere l’importanza di questa “tribuna”) Pasolini svilupperà il discorso dell’omologazione (il Pasolini “luterano” e “corsaro”), Sanguineti non coglierà l’importanza di questo discorso pasoliniano e non gli perdonerà il rimpianto per il mondo agricolo pre-borghese e l’utopia regressiva di una purezza sotto-proletaria. Per altro verso, Pasolini ebbe una celebre polemica con Fortini nel Sessantotto (quando Pasolini scrisse una difesa dei poliziotti, in 102 cui identificava gli sfruttati sottoproletari e li contrapponeva agli studenti figli della borghesia). III Un ultimo terreno di confronto è quello delle posizioni critiche nei confronti della letteratura (in particolare della poesia) del Novecento. Qui si tratta di valutare contributi di natura diversa, ma ciò non impedisce di proporre alcune considerazioni. Pasolini, negli anni Cinquanta aveva pubblicato due antologie dedicate, invece, alle forme della poesia dialettale (Poesia dialettale del Novecento, 1952) e popolare (Canzoniere italiano, 1959): due orizzonti completamente diversi. Ma sono fondamentali i suoi interventi su “Officina”, poi ripubblicati in Passione e ideologia nella sezione intitolata Da Pascoli ai neo-sperimentali. Per Fortini bisognerà ricordare soprattutto il saggio La poesia italiana di questi anni, apparso sul secondo numero di “il menabò” nel 1959 (che verrà a far parte dei Saggi italiani , 1974), dove la linea della nuova poesia indicata da Fortini è quella della prosasticità, con una particolare attenzione a Sereni, Volponi, Roversi, Pagliarani e, naturalmente, a Pasolini (più tardi il capitolo I poeti del Novecento, nella Letteratura italiana Laterza del 1977). Nelle sue scelte e nel saggio introduttivo dell’antologia della Poesia italiana del Novecento (Einaudi, 1970) Sanguineti, prende le mosse, in un sontuoso prologo fin de siècle, da D’Annunzio e Pascoli, dando poi grande rilievo agli autori della prima metà del secolo: Gozzano, Palazzeschi, Lucini, l’avanguardia futurista. Una scelta che corrisponde agli interessi del Sanguineti studioso, ma soprattutto alla sua visione del Novecento poetico italiano. Fra gli autori più recenti, c’è Pasolini, ma non c’è Fortini. È un’esclusione la cui motivazione esplicita Sanguineti darà alla morte di Fortni, quando esplicitamente dirà di salvare, eventualmente, solo gli epigrammi di L’ospite ingrato. Tutte diverse erano state le antologie di Pasolini degli anni Cinquanta: Poesia dialettale del Novecento (1952) e Canzoniere italiano (1959) dedicato alla poesia popolare. E le introduzioni 103 delineavano un orizzonte completamente diverso. Sanguineti considera il dialetto un inutile residuo di un passato regionale (polemicamente, in tempi più recenti, gli capiterà di vedervi addirittura un antecedente ideologico, il terreno di cultura del leghismo, persino in Zanzotto). Diverso è il caso della poesia popolare: a Pasolini interessa quella che nasce attraverso la quotidianità sociale, a Sanguineti interessano altre forme “popolari”: il melodramma, il teatro di varietà, eventualmente la canzonetta, cioè quelle legate allo svilupparsi della cultura di massa: non quello che resta, del passato, ma ciò che si trasforma nella modernità. Ma a parte la vistosa eccentricità di Pasolini, il saggio di Fortini del 1959 e l’antologia di Sanguineti del 1977 possono essere considerati come due capitoli fondamentali della cultura letteraria, della riflessione sulla poesia nei primi venticinque anni del dopoguerra (e, forse, l’antologia di Sanguineti volta pagina rispetto alla cultura post-bellica). Ma fra il 1959 e il 1977 sono davvero successe tante cose, che hanno ridisegnato il quadro della poesia italiana. Sanguineti ha assunto il ruolo di leader dell’avanguardia “impegnata”. Esaurita, con la morte di Vittorini, l’esperienza di “il menabò” (1959-1967), c’è stata e si è appena conclusa quella di “quindici” (1967-1969) – l’unica rivista che ha avuto una continuità è “il verri” dal 1956 che dura tutt’ora, alla cui ombra c’era stato l’esordio sanguinetiano di Laborintus – che è l’ultima rivista su cui si anima il discorso sull’impegno. Il profilo di Sanguineti si è definito insieme a quello del gruppo ’63 (e soprattutto dentro il gruppo ’63), con l’aggiunta dei romanzi (1963 e 1968), di Passaggio e dell’Orlando Furioso. Il tragico poeta di Laborintus ha già “comicizzato” la sua poesia (Erotopegna) verso forme di colloquialità antilirica e con una sperimentazione che non solo tocca tutte le forme espressive, ma soprattutto si pone programmaticamente il problema del pubblico. Pasolini nel frattempo ha esordito nel cinema ed ha già avanzato la sua proposta teatrale (tutto puntualmente registrato nella nota biografica, brevissima, dell’antologia sanguinetiana). Fortini è l’indiscusso protagonista delle proposte intellettuali che precedono e preparano i movimenti del Sessantotto (è uno degli 104 scrittori di punta di “quaderni piacentini” e di altre riviste in cui escono i saggi che saranno raccolti nel 1965 in Verifica dei poteri). Basti guardare le ultime raccolte presenti nella antologia di Sanguineti e uscite dopo il saggio fortiniano del 59: Gli strumenti umani di Sereni, il Congedo del viaggiatore cerimonioso di Caproni, Nel magma di Luzi, Satura di Montale: oltre naturalmente I novissimi. Tutte raccolte su cui Fortini è intervenuto nel frattempo come recensore (recensioni che vengono a completare, nel disegno dei Saggi italiani, il saggio del 1958. Protagonisti e testimoni critici di quel periodo, tutti e te hanno sperimentato e messo in evidenza, pur da prospettive diverse, a volte addirittura polemicamente opposte, il carattere “impuro” della poesia e il suo imprescindibile, inevitabile rapporto con la storia. 105 La lezione di Franco Vazzoler (30 marzo 2011) 106 ELIO GIOANOLA La poesia di Montale: Le occasioni Il prof. Gioanola non è potuto essere presente ai nostri Mercoledì letterari, ma ci ha inviato il testo della sua lezione, che di seguito pubblichiamo. È un’anticipazione di un capitolo del volume su Montale che ha in corso di stampa: una magistrale analisi della seconda raccolta montaliana, Le occasioni. *** Nel novembre del ’38, quando Montale ancora spera di raggiungere Irma in America e pensa a quale tipo d’esistenza potrebbe andare incontro se il sogno si avverasse, scrive: «Quanto a me è un’incognita cosa, potrei scrivere in una nuova situazione, in una nuova luce. Ma sono prima un uomo, poi, poi un letterato. Non penso che la letteratura possa essere presa come un lavoro, uno sport, una carriera. Non penso si sia obbligati a scrivere. La felicità è un dovere non un’altra forma di vita». Alla donna aveva detto che avrebbe dovuto uccidere il lui il poeta se avesse voluto incontrare l’uomo: sapeva fin troppo bene, come più volte ha ripetuto, che l’arte è la forma di vita di chi veramente non vive e che quindi l’esercizio della poesia contrasta frontalmente con quella felicità che, per qualche attimo, ha potuto gustare con lei («Divento mezzo matto quando ricordo il bagno di Genova», leggiamo nella stessa lettera). L’essere veramente uomo, e quindi avere diritto alla propria razione di felicità, significa mettere a debita distanza l’attività del letterato, ammesso che possa sopravvivere a quest’altra forma di vita. Eppure il ‘38, o meglio la parte finale di quest’anno, vede un forte riafflusso di scrittura poetica: otto mottetti recano questa data, alla quale sono riconducibili Verso Capua, A Liuba che parte, probabilmente Tempi di Bellosguardo e certamente Notizie dall’Amiata (anche Costa San Giorgio conosce l’ultima mano in questi mesi). È come se la partenza di Irma, dopo il riaccendersi dell’amore, seguita dalla fitta corrispondenza all’insegna della speranza, a volte persino della 107 certezza, di un prossimo ricongiungimento, fosse già aduggiata dall’ ombra di una perdita. Sembra ripetersi la situazione espressa nel primo mottetto, «Lo sai: debbo riperderti e non posso». Nella scarsissima produzione degli anni dal ’35 al ’37, un vuoto che comprende anche un biennio di mancata corrispondenza con Irma, c’è il famoso mottetto dei due sciacalli al guinzaglio: «Un poeriggio d’estate Mirco si trovava a Modena e passeggiava sotto i portici. Angosciato com’era e sempre assorto nel suo ‘pensiero dominante’, stupiva che la vita gli presentasse come dipinte o riflesse su uno schermo tante distrazioni. Era un giorno troppo gaio per un uomo non gaio. Ed ecco apparire a Mirco un vecchio in divisa gallonata che trascinava con una catenella due riluttanti cuccioli color sciampagna, due cagnuoli che a una prima occhiata parevano né lupetti né bassotti né volpini. Mirco si avvicinò al vecchio e gli chiese: «Che cani sono questi?». E il vecchio, secco e orgoglioso: «Non sono cani, sono siacalli». (Così pronunciò da buon settentrionale incolto; e scantonò poi con la sua pariglia). Clizia amava gli animali buffi. Come si sarebbe divertita a vederli! Pensò Mirco. E da quel giorno non lesse il nome di Modena senza associare quella città all’idea di Clizia e dei due sciacalli. Strana, persistente idea. Che le due bestiole fossero inviate da lei, quasi per emanazione? O forse erano solo un’allucinazione, i segni premonitori della sua decadenza, della sua fine?» È già il modo con cui la donna apparirà prima e dopo essere diventata Clizia, attraverso segni che dicono di un’assenza e di una distanza solo recuperabile per istanti rivelativi in mezzo alle distrazioni della scena mondana: «La speranza di pure rivederti / m’abbandonava; / / e mi chiesi se questo che mi chiude / ogni senso di te, schermo d’immagini, / ha i segni della morte o del passato / è in esso, ma distorto e fatto labile, / un tuo barbaglio». Pure del ’37 è il mottetto forse ispirato dall’avere visto un giardiniere che, con un colpo di scure, taglia la cima di un’acacia e, sul fango di novembre, cade un guscio di cicala: la paura è che un simile colpo, come quello di una forbice su una fotografia, cancelli il volto della donna: «non far del grande suo viso in ascolto / la mia nebbia di sempre». Assenza e distanza investono Irma del crisma dell’alterità, significata anche dalla non appartenenza alle dimensioni del tempo: il ramarro che sbuca improvviso, la vela che di colpo s’inabissa, il cannone del mezzogiorno sono deboli figure dell’istantaneità e «Luce di lampo / 108 invano può mutarvi in alcunché / di ricco e strano. Altro era il tuo stampo» (anche questo mottetto è del ’37). Poi Irma ricompare, con tutte le conseguenze che conosciamo sul piano dell’esistenza del poeta, ma la poesia che riaffluisce non registra segnali di un’attiva presenza di lei: già Verso Capua, con l’apparizione quasi fiabesca della carrozza e del postiglione, con il fiume Volturno come confine con un altrove introduce una scena di addio: un improvviso raggio di sole incendia «di colpo il sughereto / scotennato» e, in questo barbaglio, ecco la donna che agita la sua sciarpa tempestata di pallini bianchi come le bacche del vischio, un chiaro richiamo alla bandiera stellata del paese al quale ritornerà. Così 1’andare e venire delle rondini, che ripete nel breve spazio presente il loro destino di migranti, allude ad una partenza che però non contempla un ritorno: «Il saliscendi bianco e nero dei / balestrucci dal palo / del telegrafo al mare / non conforta i tuoi crucci su lo scalo / né ti riporta dove più non sei». Insomma, la scomparsa reale di Irma è la condizione rigorosa del suo riapparire come presenza poetica, così che quanto è intuito, malgrado tutto, come perduto sul piano del vissuto si trasforma in acquisto sul piano alternativo dell’invenzione trasfiguratrice. Occorre non viverle le cose se si vuole che prendano vita in altra forma, fissandosi nell’espressione che le salva dal tempo. Irma riapparirà nei lampi e barbagli che la fanno creatura sottratta all’entropia del reale: «Nulla finisce, o tutto, se tu folgore / lasci la nube». «Ecco il segno; s’innerva / sul muro che s’indora: / un frastaglio di palma bruciato dai barbagli dell’aurora»: anche i passi felpati nella serra, di cui si dice in questo mottetto, non sono quelli della realtà ma della memoria e se sono «ancora / tua vita, sangue tuo nelle mie vene», questo non riporta tanto all’attuaità di una passione vissuta ma alla trasfusione di questa nelle vene di chi ritorna poeta nel nome di lei. Così la lontana si fa presente se una musica popolare ne riporta la voce: «La tua voce è quest’ anima diffusa. / Su fili, su ali, al vento, a caso, col / favore della musa o d’un ordegno, / ritorna lieta o triste. Parlo d’altro, / ad altri che t’ignora e il suo disegno / è là che insiste do re la sol sol ... » (Luciano Rebay ha interpretato le note come quelle di una canzonetta sentita in un ballo popolare a cui i due innamorati hanno assistito all’inizio della loro relazione, «Amore amor portami tante rose»). Nel mottetto in cui si ricorda l’infuriare di 109 una grandinata, che devasta i fiori del giardino, il suono da questa prodotto riporta alla memoria musica da lei suonata al pianoforte, come il gelo della tempesta corrisponde al brillare della donna, «quando fingevi col tuo trillo d’aria / Lakmé nell’Aria delle Campanelle» («Certo lei suonava. La pianola degli inferi mantiene la poesia nel clima di un inferno anche meccanico. L’aria della Lakmé [di Delibes] fu realmente cantata ed è una grandine di suoni vocali»). Insomma, il rifiorire della poesia in questo scorcio del ’38 coincide con il progressivo accostamento della donna ai domini del non immanente, dell’intemporale, di cui tende a farsi annunciatrice, simbolo, messaggera. È ancora di quest’anno uno dei grandi testi terminali delle Occasioni, messo dal poeta proprio a sigillo della sua seconda raccolta, Notizie dall’Amiata, di cui già si è detto qualcosa. C’è stato un soggiorno in uno dei paesini di questo monte vulcanico, che ha suscitato impressioni quasi infere di degrado e di morte, di un mondo invivibile, di un tempo chiuso e remoto, in contrapposizione col manifestarsi di una presenza luminosa, sola capace di offrire un possibile riscatto ad una realtà tanto deietta. Commenta lo stesso Montale: «Notizie dall’Amiata. Uno qualsiasi dei 3 o 4 paesi di là. Paesi di un sapore cristiano romanico, non rinascimentale. Perciò immagini di bestiario (porcospino) o di religiosità antica (l’icona)». Il clima generale di opposizione tra questo reale e il miracolo di un’apparizione è tanto più accentuato dalla «rissa cristiana» che nel commento il poeta dice di essere quella «dell’anima e del corpo, la rixa di cui esistono saggi nelle lett. popolari. Condizione più o meno perpetua». Come sarà nell’altro grande testo parallelo, Elegia di Pico Farnese, il religioso gioca un ruolo di primaria importanza perché si presta ad accentuare lo scarto tra forme arcaiche o paganeggianti di devozione e attese di un più autentico segno di trascendenza, affidato ad un’assente, vera portatrice del divino. Come viene detto nell’accennato commento l’Amiata è stata testimone dell’avventura religiosa di David Lazzaretti, visionario fondatore di un movimento mistico a base comunistica, riconducibile ad antiche forme devozionali preumanistiche. La prima strofa ricostruisce un interno che configura, pur nelle umili misure di una specie di soffitta, una separatezza positiva rispetto agli esterni che raccolgono tutte le figure del negativo, inaugurate dal perentorio «Fuori piove» che chiude questa strofa. La povera stanza odora di meloni, i lampi e tuoni del temporale stanno 110 diventando «murmure d’arnie», i vetri sono appannati dalla nebbia che risale la valle, il camino è acceso; «e ti scrivo di qui, da questo tavolo / remoto, dalla cellula di miele / di una sfera lanciata nello spazio – / e le gabbie coperte, il focolare / dove i marroni esplodono, le vene / di salnitro e di muffa sono il quadro / dove tra poco romperai. La vita / che t’affàbula è ancora troppo breve / se ti contiene! Schiude la tua icona / il fondo luminoso. Fuori piove.» Tutto è preparazione all’apparire di lei, i marroni che esplodono sono il segnale più prossimo dell’evento (‘marroni’ anagramma Irma e lo scoppio ricorda quello delle pigne verdi in un falò a cui i due hanno assistito), la vita «che ti fa materia di favola» (Montale) è troppo breve per quanto puoi ancora dare, l’icona apre di scatto il suo fondo luminoso nel quale tu appari («schiude l’icona lo pensavo quasi come l’aprirsi a scatto di uno sportello»; e infatti spesso le icone sono chiuse da antine che nascondono il fondo dorato). Così, dice Isella, «l’umile stanza-deposito, tarlata e umida, si trasforma nell’abbagliante luogo della Visitazione» e la strofa «è colma dell’epifania dell’Assente». Davvero ormai soltanto l’assenza reale può propiziare una presenza epifanica, Irma sta diventando compiutamente Clizia, la sua divinizzazione si sta compiendo e a lei è delegata una salvezza che non riguarda più la reale esistenza dell’amato ma la sua invincibile natura di poeta, rinato nel momento in cui la perdita è diventata ormai sicura. Nella strofa successiva l’auspicio che lei possa accompagnare il solitario visitatore nell’esplorazione del paese notturno («E tu seguissi le fragili architetture / annerite dal tempo e dal carbone, [...] il volo infagottato degli uccelli / notturni»), nel tentativo di dare un senso a quel paesaggio alieno, cade nel vuoto. Il visitatore rimane solo in quell’ «ascesa / di tenebre» in cui anche il profumo dei fiori «duole amaro». E allora c’è l’invocazione al vento gelido del nord che, nell’impossibilità di un riscatto, (il gelo, come il fuoco – Brandeis contiene entrambi i termini – è pur sempre un segno cliziano) blocchi almeno la disperazione nella prigione dell’atonia, fino a rendere care le catene e a chiudere anche «le spore del possibile» (Montale: «Il vento rende care le catene perché valorizza (!) lo star fermi, immobili, la stasi al posto del divenire, 1’essere al posto del dover essere»). Ma il vento non viene e la realtà esterna si mostra in tutto il suo terribile degrado: «Oh il gocciolìo che scende a rilento / dalle casipole buie, il tempo fatto acqua, / il lungo colloquio 111 coi poveri morti, la cenere, il vento, / il vento che tarda la morte, la morte che vive!» La strofa finale, di interpretazione tanto difficile, è aperta dalla «rissa cristiana» (forse allude anche al contrasto interiore tra il dovere di assistere la compagna di vita e il desiderio di seguire Irma) e aggiunge altri elementi di quel paesaggio avverso («Una ruota di mola, un vecchio tronco, / confini ultimi al mondo», il «cumulo di strame»), ma introduce anche un estremo cenno di speranza, simboleggiato in quei porcospini, animali cari alla donna e anche al poeta, che escono ad abbeverarsi a «un filo di pietà», unendo la veglia di lui insonne al sonno di lei lontana. Ma conviene rifarsi alla spiegazione che dà Montale a Bazlen dei versi più controversi della strofa: «Tanto (così) poco di me può portarti ciò che sta accadendo qui, quanto poco (o anche meno) di te può portarmi (averti rapito) la gora, il ruscello, il rigagnolo che scorre nel suo alveo, nel suo cunicolo di cemento. Tout se tient, tutto è in tutto, ma tali ‘corrispondenze’ sono poca cosa per la mia fame di identità. Se non che i porcospini qui presenti e che lei sogna (li riceve) tengono ancora i contatti ecc.» (I have got informations about porcupines. Maggots and milk is their menu [ ... ] I am the porcupine and hope God will pour milk in the piattino»). In fondo la partenza e la perdita data come definitiva di Irma agisce nella mente del poeta allo stesso modo della (supposta) morte di Arletta: il sacrificio dell’amore come rapporto attuale ha funzione di attualizzatore della nostalgia per la Cosa materna, per ciò che è dato come perduto senza mai essere stato davvero posseduto, per quell’altrove fuori del tempo e del reale di cui si nutre in sostanza la grande lirica, che fa della donna il termine di un desiderio assoluto. Irma nella fitta e alta produzione poetica che coincide con il suo dileguarsi diventa davvero l’only begetter, secondo l’espressione che il poeta adotta traendola dalla famosa dedica di Shakespeare ai Sonetti. George Steiner, sostenendo il potere creativo della poesia («esiste la creazione estetica perché esiste la creazione [. .. ] un moto creatore, che viene sempre dopo il moto creatore primario»), suggerisce di tradurre l’espressione shakespeariana non con il banale «mio solo ispiratore» ma, secondo il significato proprio del termine «mio solo generatore». Nel Montale degli ultimi grandi testi delle Occasioni siamo di fronte davvero ad un processo generativo di intensa forza di cui la donna è movente e soggetto. Nel marzo del ’39 112 Montale è ospite di Tommaso Landolfì nella sua vecchia dimora di Pico Farnese, il paesino della Ciociaria affidato ai ritmi delle sue antiche tradizioni: il locale santuario è meta di pellegrinaggi e il poeta, nell’atmosfera disfatta dalla pioggia e dall’umidità primaverili, ascolta i canti dei pellegrini che al mattino ritornano da dove sono venuti. Tutto il rituale è sentito come carico di un’arcaica religiosità pagana, intrisa di risentimenti sensuali, in un paesaggio sprofondato nel tempo assimilabile a quello di Notizie dall’Amiata: «Strade e scale che salgono a piramide, fitte / d’intagli, ragnateli di sasso dove s’aprono / oscurità animate dagli occhi confidenti / dei maiali, archivolti tinti di verderame, / si svolge a stento il canto dalle ombrelle dei pini, / e indugia affievolito nell’indaco che stilla / su anfratti, tagli, spicchi di muraglie». In contrasto con queste forme di impurità e desolazione è invocata una Presenza, annunciata al suo fedele dai balenii luminosi del ferro incandescente, dal prillare dei piattelli del tirassegno, dal lampo di una veste: «Oh la pigra illusione. Perché attardarsi qui / a questo amore di donne barbute, a un vano farnetico / che il ferraio picano quando batte l’incudine / curvo sul calar bianco da sé scaccia? Ben altro / è 1’Amore – e tra gli alberi balena col tuo cruccio / e la tua frangia d’ali, messaggera accigliata! / Se urgi fino al midollo i diòsperi e nell’acque / specchi il piumaggio della tua fronte senza errore / o distruggi le nere cantafavole e vegli / al trapasso dei pochi tra orde d’uomini-capre, / [ ... ] il tuo splendore è aperto». Su questa Elegia, che ha dato molto da fare ai critici per le difficoltà interpretative, Montale ha avuto una fitta corrispondenza con 1’amico Bazlen, a cui l’ha inviata in una prima stesura, per un parere e in vista di una possibile traduzione in tedesco: «Tra l’ingestione e la digestione di un piatto di tortellini inaffiati di Chianti ho scritto rapidissimamente [il poeta è di lunga gestazione e rapido parto] l’Elegia di Pico che ti accludo. Falla leggere a Tom [Landolfì]. Scrivimi subito che ti pare dell’Elegia. Forse a un pubblico tedesco è più adatta delle Notizie [dall’Amiata]». Bazlen deve avere sollevato parecchie obiezioni e chiesto chiarimenti e il poeta risponde: «Grazie, temevo di peggio. Ma al solito, quando si va nei dettagli, mi sfugge (specie con te) il valore obiettivo dei medesimi. Non so fino a che punto la diversa percezione di certe nuances sia dovuta ai miei difetti obiettivi e a un tuo fisiologicamente diverso orecchio. Mi spiego? Non so fino a che punto noi sentiamo allo stesso modo 113 1’attuale valore del mio impasto verbale, non so fino a che punto tu senta quello che c’è di necessario e quello che ci può essere di arbitrario. Ciò a parte altre difficoltà nelle quali il torto (?) può essere tutto mio, e delle quali ti dò un esempio: nel distico ‘è 1’Amore ... messaggera imperiosa’ [diventerà ‘accigliata’] (che per me sarebbe il centro delle poesia, la massima elevazione di tono) ci sono elementi che per me , soggettivamente, erano vitalissimi e non suscettibili di interpretazione neo classica: la frangia che tu hai visto nella fotografia di..., qui frangia d’ali, ma insomma anticipazione dell’incredibile ‘piumaggio’ attribuito alla fronte senza errore, cioè la vera frangetta. ‘Imperiosa’ mi pare insostituibile, ‘messaggera’ idem.». In realtà Montale accetta di apportare ritocchi («hanno giovato all’insieme della poesia») e dall’amico si aspetta, dopo la revisione di cui si mostra soddisfatto, soltanto l’ «exequatur», aggiungendo di avere molta fretta. È significativo che per dare un esempio delle difficoltà il poeta scelga i versi della manifestazione della donna, portatrice di un Amore che, come sottolinea la maiuscola, travalica ormai i confini di un eros sia pure sublimato per diventare religiosa charitas, contro il «vano farnetico» delle «nere cantafavole». Non per nulla questo è per lui il centro della poesia, il punto della «massima elevazione di tono», per cui è restio ad eseguire quei ritocchi che toglierebbero intensità al dettato: appare la «frangia d’ali», appare il «piumaggio della tua fronte senza errore», la frangetta che segna nel modo più caratteristico il viso di Irma assume le forme di una dotazione angelica, e non importa se ciò può indurre difficoltà interpretative. Nel terzo degli incisi che si alternano in versicoli ai versi lunghi, appare il «seme del girasole», che disperde le «parole di cera» delle preghiere dei pellegrini: la donna è già affidata all’insegna del girasole, è già diventata, effettualmente se non ancora nominalmente, Clizia, «quella ch’a veder lo sol si gira». Quanto alla fretta che il poeta mostra di avere, è l’indizio della decisione ormai presa di arrivare alla pubblicazione della sua seconda raccolta. Fino a pochi mesi prima non era affatto sicuro di poter mettere assieme un nuovo libro poetico, per 1’esigua messe di testi a disposizione: dopo la pubblicazione degli Ossi, per molti anni Montale si è creduto autore di un solo libro, anche solo per disperazione di vita. È stato il dileguarsi di Irma, possiamo ripetere, con l’imporsi di un nuovo, decisivo personaggio 114 poetico, a permettere un ritorno generoso ai versi, con la fitta produzione dei mottetti e le grandi liriche del ’38-’39. È in seguito a questa accelerazione che si fa strada e si consolida l’idea di un secondo libro e si arriva alla rapida pubblicazione delle Occasioni. Tutte cliziane sono le Nuove stanze, quattro ottave che riportano all’ultima presenza fiorentina di Irma, nell’imminenza del suo dileguarsi anche a fronte dei drammatici eventi storici che stanno per abbattersi sul mondo, di cui in qualche modo lei si fa annunciatrice e oppositrice. «Caduto in stato di trance», scrive il poeta a Contini, suo vigile consulente, «(ciò che mi avviene di rado, perché di solito scrivo in condizioni di cinico autocontrollo) ho dato seguito alle vecchie STANZE che tanto piacquero a Gargiulo. Sèguito per modo di dire. Queste, che potrebbero intitolarsi ‘Amore, scacchi e vigilia di guerra’, ma porteranno invece un 2 e basta, sono un po’ diverse. Sono più fiorentine, più intarsiate, più dure; ma mi sembrano buone e spero che tali ti sembrino, soprattutto a una ri-rilettura. La Martinella, come sai, è la campana di Palazzo Vecchio; suona solo, secondo Palazzeschi, per indicare ‘vituperio’. Inter nos l’ho sentita anche in certe circostanze che comprendi ... » [il riferimento è alla vicende con la Mosca]. In un interno cittadino la donna ha schiacciato nel portacenere il mozzicone di sigaretta, salgono al soffitto spirali di fumo, davanti alle pedine degli scacchi fermi sulla scacchiera. È la preparazione ad una specie di rito divinatorio, di cui la donna è sacerdotessa, per cui quel fumo diventa un incenso. Si apre una finestra, l’aria agita il fumo e insieme fa sparire le torri e i ponti della città, mentre irrompe il soffio della bufera («altro stormo», dice Montale, «è la guerra che matura»), come se nella vita privata, rappresentata da questa stanza di città, entrassero minacciosi gli eventi che si preparano. La scacchiera è diventata quella dei fatti storici, della «follia di morte», e il poeta dubita che il lampo dello sguardo della donna possa fare fronte alla minaccia. Però «Oggi so ciò che vuoi; batte il suo fioco / tocco la Martinella ed impaura / le sagome d’avorio in una luce / spettrale di nevaio. Ma resiste / e vince il premio della solitaria / veglia chi può con te allo specchio ustorio / che accieca le pedine opporre / i tuoi occhi d’acciaio». Commenta Contini: «Lei sola lo conosce [ciò che sta per abbattersi sul mondo]; soli i suoi ‘occhi d’acciaio’ sapranno resistere all’acciecamento, e vincere». Insomma. Clizia sta assumendo il ruolo di portatrice di 115 salvezza per l’umanità in pericolo, ormai oltre la semplice funzione di mira amorosa per la possibile salvezza personale di chi in lei confida. Così in Palio la scomparsa reale di Clizia è diventata occasione del suo profilarsi come figura che si alza al di sopra delle superstizioni, quelle religiose come questa sportiva del palio di Siena: «Il lancio dei vessilli non ti muta / nel volto; troppa vampa ha consumati / gl’indizi che scorgesti». L’impassibilità del suo sguardo è indizio di chi scorge l’essenziale al di là delle apparenze, pur concitate, che la realtà propone, per una chiaroveggenza che fa giustizia di ogni vana agitazione: «È strano: tu / che guardi la sommossa vastità, / i mattoni incupiti, la malcerta / mongolfiera di carta che si spicca / dai fantasmi animati sul quadrante / dell’immenso orologio, l’arpeggiante / volteggio degli sciami e lo stupore / che invade la conchiglia / del Campo, tu ritieni / tra le dita il sigillo imperioso / ch’io credevo smarrito / e la luce di prima si diffonde sulle teste e le sbianca dei suoi gigli». Lo sguardo d’acciaio trova rinforzo nella figura del rubino che la donna porta al dito, secondo una simbologia che fa dei gioielli di lei (le pietre preziose, gli anelli, gli orecchini) i corrispettivi della sua dura determinazione, del suo contrapporsi al volgare mondano, qui rappresentato da tutto lo scomposto spettacolo della gara dei cavalli e del suo apparato di contorno. Il «sigillo imperioso» del gioiello non è andato smarrito con la partenza della donna e diffonde la sua luce di prima su quell’accolta tumultuame. Al ricordo dell’anello «Torna un’eco di là», cioè dal buio della «cantina» (del W.C.), da quel1uogo da dove una mattina lontana giunse a lei una preghiera in forma di fiaba, non quella di un re – come recitano i versicoli che interrompono il testo – ma di chi si era sentito leggero al punto da sfiorare appena la terra. Ora sotto la volta dell’ipogeo «grava un sonno di sasso», le sbarre delle finestre non dividono più la luce per chi si è smarrito e per chi si sente morto non c’è altra voce di quella «che spande la vita». Qui, sulla piazza del palio, l’urlo unanime degli spettatori che seguono la gara in una atmosfera infernale: «E tu dimentica! / Dimentica la morte / toto coelo raggiunta e l’ergotante / balbuzie dei dannati!» Per virtù della donna «Il presente s’allontana / ed il traguardo è là: fuor della selva / dei gonfaloni, su lo scampanìo / del cielo irrefrenato, oltre lo sguardo / dell’uomo – e tu lo fissi». Il testo si chiude con la metafora della trottola che 116 l’aveva aperto, a indicazione del moto circolare della corsa ma soprattutto a quello, opposto, della vita della donna: «La tua fuga non s’è dunque perduta / in un giro di trottola / al margine della strada». Questa è la conclusione: «Così alzati, / finché spunti la trottola il suo perno / ma il solco resti inciso. Poi, nient’altro». La vita di lei, anche nell’ assenza, non si è perduta e ora può adergersi al di sopra di quel mondo di tifosi-dannati, finché la giostra della trottola si arresti, ma resti inciso nella vita e nella memoria questo giorno, quest’ultimo ricordo di lei. La trattativa con Einaudi per la pubblicazione delle Occasioni parte dall’inizio del ’39 ed è dovuta ad un caso abbastanza fortuito. L’editore, infatti, su consiglio di Leone Ginzburg, aveva chiesto al poeta un libro sulla poesia contemporanea per la collana dei ‘Saggi’ («Volevamo da Montale un saggio polemico, al limite partigiano»), ma la risposta era stata negativa, nessuna possibilità e voglia di applicarsi ad un lavoro così impegnativo in condizioni di salute malferma e con tutti i guai personali che conosciamo. Montale suggerisce, in cambio, la pubblicazione di una quarantina di poesie, sufficienti a comporre un libro vero e proprio, il suo secondo libro di poesie, non semplicemente un opuscolo. È l’accrescersi recente del numero dei testi che si trova tra le mani (da quaranta diventeranno alla fine cinquanta) a persuadere l’autore che è arrivato il momento di dare alle stampe una seconda raccolta. Quanto alla pubblicazione di una plaquette, già nel ’31 aveva fatto una proposta in tal senso a Scheiwiller, non accolta, e così ancora nel ’36 allo stesso editore, con lo stesso esito: a questa data i testi non erano più di una ventina, insufficienti per dare vita ad un’opera veramente organica e compiutamente organizzata. È abbastanza evidente che è stata l’irruzione della only begetter a rendere possibile il costituirsi di un vero e proprio canzoniere, il canzoniere d’amore di cui parla Contini. Rispondendo alla proposta di Einaudi il poeta scrive: «Un libro come quello che lei mi propone presupporrebbe una chiarezza critica ch’io, per ora, non ho in materia. Siccome non ho cessato di far versi (pochi), ho bisogno piuttosto di oscurità interiore che di autocontrollo. Non sarà così per tutti, ma è così per me. Ma arrischio una controproposta, destinata a fallire nel caso Lei pubblichi solo organiche ‘collezioni’ (perché mai Le consiglierei una collezione di poeti oggi!). Pubblicherebbe entro il ’39 la collana delle mie poesie 117 posteriori a Ossi di seppia? Saranno quaranta, non lunghe. Con titanici sforzi tipografici, spazi sapienti e carta di un certo spessore si può farne un libro di mole normale (non vorrei la solita plaquette) da vendere a 10 lire o più. L’esito di 1000 copie sarebbe, credo, sicuro». Einaudi non ha e non prevede una collana di poesia, ma si mostra immediatamente interessato alla pubblicazione, certo perché la fama dell’autore degli Ossi di seppia è ormai consolidata e anche perché l’estraneità di Montale al fascismo non dispiace davvero né a lui né a Ginzburg, che sarà l’impeccabile editor del libro: «Accetto con gioia di diventar Suo editore. Mi sorriderebbe però l’idea di dare subito un’edizione di Ossi di seppia arricchita delle quaranta poesie nuove». Ma è proprio ciò che il poeta non vuole perché sa di avere fatto opera nuova, diversa dalla prima raccolta, e pubblicare tutto insieme significherebbe appiattire questo secondo tempo sul primo, troppo noto per non risultare prevaricante. «Grazie della Sua accettazione di massima.», è la risposta a Einaudi, «Ho l’impressione che per due o tre anni non ci sia bisogno del mio vecchio libro, che ha un po’ saturato il ‘mercato’. In tre fortunate edizioni. Domani le cose muteranno perché i varii GUF eruttano annualmente legioni di aspiranti poeti, pseudo intellettuali ecc. Inoltre le mie ultime cose sono effettivamente un libro nuovo che pubblicato come coda del libro vecchio rischierebbe di non essere considerato di per sé e di avere poca ‘stampa’ e poco successo. Questo sarebbe un rischio anche per l’editore, e occorre evitarlo. Last and least, ho bisogno di non sentirmi più un autore unius libri e di aumentare di un ‘numero’ la mia scarsa bibliografia. A fine Marzo le mando il mio manoscritto: Le occasioni (1928-1938), quarantadue liriche nuove, che Lei può pubblicare in Giugno o in Settembre, a suo piacimento». Fine marzo diventa, malgrado i solleciti dell’editore, fine maggio, perché il libro è veramente in progress e conosce nuove e cospicue aggiunte: «Caro dott. Einaudi non si spaventi vedendo i 10 foglietti qui acclusi (avevo già avvisato l’amico Leone che minacciavo, in una sola volta, alcune aggiunte; ma da oggi il ms. è definitivo). […] Siamo così a 50 poesie – e veramente stop». La richiesta di essere pubblicato entro settembre-ottobre è motivata da Montale con la necessità di poter partecipare, nei tempi previsti, ad un premio letterario, a cui tiene parecchio soltanto per l’apprezzabile dotazione, in un periodo per lui di ristrettezze 118 finanziarie dovute alle circostanze che ci sono note: «Il 28 ottobre si assegna un premio ‘Savini’ per il quale avrei (data la composizione del giurì) molte probabilità. A me interesserebbe (per la prima volta in vita mia) unicamente per il lato finanziario». Ma nel contempo il poeta teme che la relativa fretta possa pregiudicare 1’esito perfetto della pubblicazione e, nella fitta corrispondenza che corre tra lui e l’editore durante l’estate, ci sono allarmi e preoccupazioni per i tempi e la qualità delle bozze, fino a quando il 25 settembre riceve l’impaginato definitivo, in cui riscontra ancora un congruo numero di refusi, segnalando anche la necessità di non pochi allineamenti, spaziature, interpunzioni. Con molti dubbi che il libro possa comparire davvero entro metà ottobre, tanto più che a fine mese non ha ancora fra le mani le terze bozze. Malgrado tutto – e grazie all’ efficienza delle poste del tempo – il libro esce davvero alla data ultimativa indicata dall’autore: «lo ho bisogno urgente, assoluto, che al massimo per il 18 cm. siano spediti i 10 omaggi che vi ho indicato [...]. Mi occorre insomma che il libro sia citabile, nominabile come uscito prima del 20 – e per far ciò occorre che quegli omaggi siano spediti e che qualche librario di Milano e Roma ne abbia copia». Il 19 una copia viene spedita al poeta, che risponde a giro di posta: «Vi ringrazio; l’attesa è stata ripagata dal resultato. Sono molto contento e Vi prego esprimere all’amico Menzio la mia gratitudine. Lo farei io stesso se ne avessi l’indirizzo. Sono soddisfatto di non aver ceduto alla tentazione di Mondadori, che non m’avrebbe fatto un’edizione così». Menzio è il pittore torinese che ha disegnato la copertina della raccolta. Quanto al premio, niente da fare, come lascia intendere la lettera dell’editore del 23 ottobre: «Vigorelli ci accenna a un ‘retroscena’ del premio Savini: si tratterebbe d’impedire che il premio andasse alle Occasioni. Ne sa niente Lei? Noi, com’è giusto, siamo all’oscuro di tutto; ma abbiamo creduto opportuno comunicarLe la voce, nella forma in cui ci è pervenuta». Il retroscena è l’imposizione venuta dall’alto di non attribuire il premio a un poeta contrario al regime. La prima edizione si esaurisce in pochi mesi e segue immediatamente una seconda: saranno cinque fino al ’45. La dedica «a I. B.» compare nella prima edizione Mondadori (1949). La struttura delle Occasioni mostra un’attenta cura organizzativa: mentre il poeta si preoccupa di costruire un libro del tutto diverso dal primo, per un 119 altro verso ne ricalca le modalità compositive, a cominciare dal testo che fa da prologo, Pareva facile giuoco, che è molto tardo e appartiene alla serie dei mottetti, come era tardo e apparteneva agli ‘ossi brevi’ Godi se il vento ch’ entra nel pomario («IL BALCONE: fa parte dei MOTTE’ITI. È stampato in limine per il suo valore di dedica»). La raccolta è distinta in quattro parti, non date in ordine cronologico se, per esempio, la prima parte accoglie quell’ addio a Irma che è Verso Capua, del ’38 come altri testi contigui, e la terza La casa dei doganieri del ’30 o Stanze, addirittura del ’27; nel complesso però la linea cronologica è sufficientemente rispettata. Altri elementi di simmetria rispetto alla prima raccolta sono dati dai 21 mottetti che, per composizione metrica, corrispondono ai 22 ossi brevi, e da Tempi di Bellosguardo, che, dice lo stesso poeta, «doveva essere il pendant di Mediterraneo». Il primo invio del manoscritto a Einaudi non comprendeva Tempi di Bellosguardo, già composto, perché i tempi della composizione avrebbero dovuto nell’intenzione essere nove come quelli di Mediterraneo. Quanto al titolo proposto all’editore senza la minima esitazione, Le occasioni, segna di per sé la distanza dagli Ossi di seppia per il suo alludere a circostanze, incontri e conoscenze dovute alla rottura dell’incantamento oggettuale del primo libro, in un’apertura spazio-temporale che si oppone, in termini di cultura, alla stasi di un soggetto messo di fronte all’immobile natura. Come dice Contini, la cui «attiva complicità» (Isella) accompagna la composizione della seconda raccolta, «In questa conversione dal nulla-inerzia verso il motivo-attesa sono Le occasioni: non più libro, per dir così, senza contenuto, ma canzoniere d’amore». Si sa che Contini ha sostenuto con vigore la distanza, anche di valore poetico, della seconda raccolta rispetto alla prima, anche se Montale non era poi tanto d’accordo su questa opinione, che gli sembrava screditasse indebitamente gli Ossi. Nel saggio che ora si intitola Dagli «Ossi» alle «Occasioni», ma che aveva in origine altro titolo perché scritto nel ’38, prima dell’uscita della raccolta, a partire dai testi pubblicati sparsamente su giornali e riviste o letti direttamente sui manoscritti che il poeta gli sottoponeva via via, Contini sostiene che «È un po’ dopo gli Ossi, che comincia veramente l’arte di Montale, come autoidentificazione perfetta dei suoi motivi: ogni sua lirica consisterà, da allora, nella definizione di un fantasma che abbia la possibilità di liberare il mondo nascosto» 120 (ricevendo copia della raccolta dirà: «La quarta parte del tuo libro è la cosa più europea che si sia scritta in Italia in questo secolo»). Per il grande critico «la vera salute (nell’ordine del concreto, e perciò della lirica) della poesia montaliana è, sempre fuori di questo mondo, presente e distrutto, nel sospetto di un altro mondo, autentico e interno, o magari ‘anteriore’ e ‘passato’»: Irma, della cui presenza e importanza Contini era informato, è stato il personaggio che ha sancito in maniera somma e definitiva la tensione al «fuori di questo mondo», in una ‘diversità’ che trovava il suo punto di partenza nel fatto di essere ebrea e straniera, e poi definitivamente assente. È lei che, nel farsi compiutamente «fantasma», sancisce l’ «aspra ma decisiva vittoria della forma sulla psicologia». Proprio a proposito di questo saggio, subito fatto pervenire a Irma, Montale dice del suo autore: «Diventerà senza dubbio un grande critico, anzi forse lo è già»; e anche «He is a sort of genius». Quando, nell’imminenza dell’uscita a stampa, il poeta manda all’editore Tempi di Bellosguardo, le parti della suite sono soltanto tre, invece delle nove preventivate, ma sono sufficienti a comporre un poemetto che, sostituendo la cultura alla natura, ribadisce in altra forma la «legge severa» che in Mediterraneo era rappresentata dal mare. Non è un testo cliziano, anche se si respira come in Nuove stanze l’imminenza della bufera, avendo le caratteristiche di «una tesa meditazione poetica sulla condizione della vita umana» (Isella). Per la sua natura abbastanza estravagante rispetto al «canzoniere d’amore», occupa una sezione a sé della raccolta, la terza. La stessa collocazione a Bellosguardo richiama memorie foscoliane e classicistiche che tanto più accentuano la dominanza degli elementi culturali già di per sé esaltati dal paesaggio fiorentino e toscano. In proposito dice il poeta stesso che, come in Mediterraneo, «doveva essere una mareggiata, ma stavolta ‘umanistica’. Il moto sospeso come segreta immobilità. [...] Negli Ossi di seppia tutto era attratto e assorbito dal mare fermentante, più tardi vidi che il mare era dovunque, per me, e che persino le classiche architetture dei colli toscani erano anch’esse movimento e fuga». Nel primo ‘tempo’ la vista da Bellosguardo, nella «luce di zàffiro» della sera, posata sulla fuga dei colli addomesticati dalla cura umana con il decoro dei viali, delle ville, delle vasche colme d’acqua realizza un attimo sospeso di pace. Subito però lo sguardo volto dall’alto sulla città e agli «uomini 121 / che vivono laggiù» dissolve l’incanto e ripropone la desolazione di sempre: «è troppo triste / che tanta pace illumini a spiragli / e tutto ruoti poi con rari guizzi / su l’anse vaporanti, con incroci / di camini, con grida dai giardini / pensili, con sgomenti e lunghe risa / sui tetti ritagliati». L’incanto subito svanito induce, nel secondo ‘tempo’, la desolazione anche sulle cose della natura, come su quelle umane: «Derelitte sul poggio / fronde della magnolia [...] e più ancora / derelitte le fronde / dei vivi che si smarriscono / nel prisma del minuto». La vita umana è preda del tempo che si ripete, «fugace altalena tra vita / che passa e vita che sta», per cui a dominare è la morte, sia per chi è consapevole del suo incombere, sia per chi è tanto occupato a vivere da ignorarla. Scendendo verso la città, ecco la fitta presenza delle statue e delle lapidi che rinviano a grandi figure e ai valori che hanno incarnato, e forse qualcosa rimane, una passione di vita vissuta da persone irripetibili, che forse può forzare il buio presente «con l’esile / sua punta di grimaldello». Il terzo ‘tempo’, di ardua interpretazione nei dettagli, oppone ai simboli della bufera che rompe tegole e scuote il grande pioppo quelli di una vita di alta civiltà, rappresentata da quel luogo privilegiato che è Bellosguardo. È sparito dunque il segno di una vita umanamente regolata, capace di assecondare la natura come una scala che sale gradino per gradino, al modo dell’edera che cresce piano e diffida dell’altezza dei ponti, è sparito il segno «d’una clessidra che non sabbia / ma opere / misuri e volti umani, piante umane; / d’acque composte sotto padiglioni / e non più irose a ritentar fondali / di pomice»? Ma prevalgono le figure del negativo: le terrecotte risuonano alla grandinata, i pali non reggono i convolvoli, piovono sui libri dalle pergole le locuste che hanno interrotto il loro lavoro di tessitrici. «E domani. .. » è la conclusione interrotta: domani altra peggiore bufera si abbatterà sulle opere dell’uomo. Tempi di Bellosguardo chiude il decennio fiorentino che ha determinato il passaggio dai modi poetici della prima raccolta a quelli della seconda. La mareggiata umanistica ha sostituito quella tutta naturale di Mediterraneo, Firenze ha permesso l’evasione da un mondo immobile, reliquiario e prigione per un io accidioso in attesa di un miracolo, offrendo possibilità di ricchi incontri umani e i tesori della sua cultura secolare, ma nulla è veramente cambiato nel profondo di un soggetto originariamente mal disposto alla vita. È quasi 122 obbligatorio citare quanto dice il poeta a proposito del passaggio dalla prima alla seconda raccolta in rapporto al passaggio da una residenza all’ altra: «Mutato ambiente e vita, fatti alcuni viaggi all’estero, non osai mai rileggermi seriamente e sentii il bisogno di andare più a fondo. Fino a trent’anni non avevo conosciuto quasi nessuno, ora vedevo anche troppa gente, ma la mia solitudine non era minore di quella del tempo di Ossi di seppia. Cercai di vivere a Firenze col distacco di uno straniero, di un Browning: ma non avevo fatto i conti con i lanzi della podesteria feudale da cui dipendevo. Del resto, la campana di vetro persisteva intorno a me, ed ora sapevo ch’essa non si sarebbe mai infranta. [...] In sostanza non mi pare che il nuovo libro contraddicesse ai risultati del primo: ne eliminava alcune impurità e tentava di abbattere quella barriera tra interno ed esterno che mi pareva insussistente anche dal punto di vista gnoseologico. […] Il nuovo libro non era meno romanzesco del primo, tuttavia il senso di una poesia che si delinea, il vederla fisicamente formarsi, dava agli Ossi di seppia un sapore che qualcuno ha rimpianto. Se mi fossi fermato là e mi fossi ripetuto avrei avuto torto, ma alcuni sarebbero più soddisfatti». Il viaggio, nelle nuove condizioni, ha sostituito la fissazione quasi allucinata di un luogo unico, Le occasioni presentano fin dall’inizio una pluralità di riferimenti a luoghi visitati, come suggeriscono già i titoli, Buffa/o, Lindau, Bagni di Lucca, Verso Vienna e poi, a seguire, Verso Capua, Nel parco di Caserta, Eastbourne, Barche sulla Marna, ma non muta per questo il senso di una condizione invivibile (la «campana di vetro» che distacca dalla realtà), le cose incontrate nelle diverse visite assumono spesso tonalità infernali. Nella settima sezione di Mediterraneo il soggetto poetico si è definito come «uomo che tarda / all’atto», cogliendo la propria natura più profonda nell’incapacità di decidere: «Seguìto il solco d’un sentiero m’ebbi / l’opposto in cuore, col suo invito; e forse / m’occorreva il coltello che recide, / la mente che decide e si determina». L’accidia, il taedium vitae, l’inerzia malinconica, o come si voglia definire l’esclusione dalla sintonia vitale, si caratterizzano appunto per l’abulia che impedisce di prendere decisioni. Per il Montale degli anni fiorentini si è presentata l’occasione per eccellenza, con la necessità di decidere su un fatto capitale per la sua esistenza: lasciare la Mosca per unirsi a Irma, la donna di cui si era 123 innamorato nel modo estremo di chi getta nell’amore tutta la propria disperazione, una donna che per di più aveva mostrato di corrispondere a quella passione. Ebbene, non c’è stata alcuna decisione, e non soltanto per il ricatto messo in opera da chi minacciava il suicidio se fosse stata abbandonata, ma proprio per incapacità del poeta di superare le intime carenze interiori («non mi tocco per non sentire il vuoto che è in me»). Malgrado i fermi propositi di «agire» non passerà mai davvero all’azione, perché sostanzialmente non ne è capace. Abitando nei recessi dell’io profondo l’ostacolo non è superabile, come ammette lui stesso nei brani di lettere già citati: «Ho un terribile nemico da combattere in me, in questo senso di autodistruzione che mi colpisce, che mi uccide». Per decidere, come abbiamo visto, sarebbe stato necessario uccidere il poeta, cosa su cui l’interessato sarebbe stato anche d’accordo, ma si trattava di un’operazione impossibile perché la poesia è semplicemente il corrispettivo creativo dell’incapacità di decidere, di un’abulia senza rimedio. In fondo la Mosca è stata un alibi e, fornendo al compagno di vita una formidabile scusa per arrendersi, ha favorito il rifiorire della poesia: facendogli perdere la possibilità di ricongiungersi alla donna amata ha contribuito a fare di lei la meta del desiderio assoluto, senza possibile esaudimento e perciò destinato alla trascendenza. Per la grande lirica occorre che l’oggetto amato non abiti più le dimore degli uomini se davvero il suo destino è quello dell’only begetter. Dunque sul piano del vissuto interiore, se non su quello dell’esistenza pratica, nulla è cambiato nei tempi fiorentini rispetto a quelli liguri, nessuna delle ‘occasioni’ occorse o cercate nel nuovo ambiente è riuscita a rendere meno insopportabile l’originario manque à être. È sembrato che un grande evento, come quello dell’apparizione della donna straniera, potesse davvero cambiare le cose, ma niente nella sostanza è cambiato, semmai c’è stata una conferma decisiva dell’insuperabilità del male di vivere. Ciò che davvero cambia sono le modalità dell’esercizio poetico e, soprattutto, se vogliamo accogliere le indicazioni di Contini, la sua qualità: c’è stata la costituzione di un vero e proprio canzoniere in virtù dell’affermarsi di un personaggio capace di rappresentare al meglio le caratteristiche del fantasma salvifico, concedendo la salvezza della poesia a chi «veramente non vive». Già i testi aggiunti alla seconda edizione degli Ossi, con 124 l’apparizione del personaggio (Arsenio, Arletta) presentavano un notevole salto di qualità rispetto al resto della raccolta, proprio perché si creava così una possibilità ‘romanzesca’, con il coagularsi attorno a una figura dei motivi di meditazione esistenziale, fuori dalla fissazione sugli oggetti. Ed è la donna ad assumere il ruolo di personaggio dominante, con cui il oggetto può identificarsi, mettersi a paragone, compiere riti memoriali, costruire progetti di altrove. Il mottetto che il poeta ha voluto in limine alle Occasioni porta la data del 1933, e la critica è d’accordo nell’individuare in Arletta la donna adombrata dai versi. «La vita che dà barlumi». la «finestra che non s’illumina» sono segnali tipici della donna morta giovane, che riappare soltanto in qualche barbaglio di luce ma non può più riaffacciarsi alla vita. Ma perché un testo arlettiano in apertura di un canzoniere dominato dalla figura di Clizia, se non perché in esso si possono anche scorgere tracce della sua scomparsa, con le conseguenze che ha prodotto? Non è un facile gioco annullare nel tedio il «certo fuoco» dell’amore perduto; al vuoto di quella scomparsa «ho congiunto / ogni mio tardo motivo», cioè ogni ragione di vita e di poesia, su quel nulla «si spunta / l’ansia di attenderti vivo». Il ciclo dei mottetti, cronologicamente aperto da questo introduttivo, si chiude con il più alto e famoso di essi, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, che risale al 1940 e compare solo nella seconda edizione delle Occasioni. La trasmutazione di Clizia da presenza reale a creatura appartenente ad una sfera superiore, non abitabile dagli umani, è ormai perfettamente compiuta. Il segno del gelo che lei porta nel suo stesso nome predica questa appartenenza ad un oltrecielo, un gelo che ha raccolto attraversando le «alte / nebulose» per portare al suo fedele il suo messaggio salvifico. Il volo periglioso ha lacerato le sue penne d’angelo, ma lei è qui per lui, mentre nelle dimensioni ristrette del vivere quotidiano (il «riquadro» d’ombra del nespolo, il «vicolo») nessuna tra le «altre ombre che scantonano» può sapere della sua presenza. La distanza da lei, resa incolmabile dalla bufera che sta scatenandosi sull’Europa, ha portato a perfezione la metamorfosi della donna in angelo visitatore, a cui il fedele ha delegato un compito di salvezza non solo personale, ma il primo principio di salute per un poeta è pur sempre la poesia e questo in definitiva è il dono che lei reca con il suo volo periglioso. 125 Elio Gioanola 126 Indice Saluto del Sindaco di Albenga……………………… p. 5 Saluto del Consigliere delegato alla P.I. ..………….. p. 7 Giorgio Airaldi, Prefazione………………………... p. 9 Giannino Balbis, La terza edizione dei Mercoledì letterari…………………. p. 13 Vittorio Coletti, Il romanzo in Italia negli ultimi decenni……………………. p. 17 Giangiacomo Amoretti, Giuseppe Ungaretti. Un grande poeta innovatore…………… p. 21 Luigi Surdich, Gozzano, l’Oriente, l’Occidente……. p. 59 Francesco De Nicola, Gli scrittori italiani e il Risorgimento…………………..…… p. 69 Franco Vazzoler, Letteratura e poesia in Fortini,Pasolini e Sanguineti fra anni Cinquanta e Sessanta................. p. 91 Elio Gioanola, La poesia di Montale: le Occasioni…………………………….. p. 107 127 128
Scarica