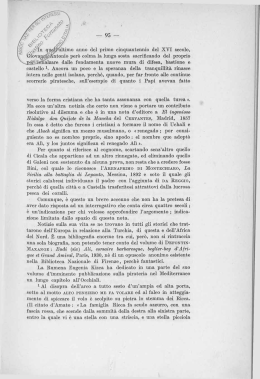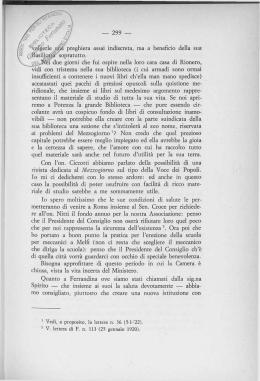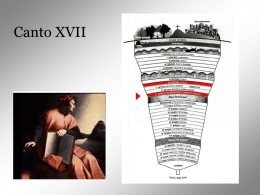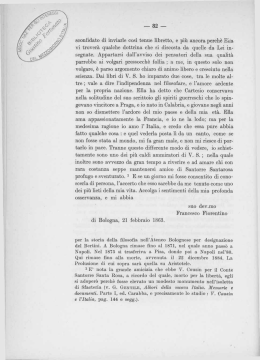Antologia per il corso di Istituzioni di Letteratura italiana (A-L) La prosa italiana 2012-2013 Antologia per il corso di Istituzioni di Letteratura italiana (A-L) La prosa italiana (12 cfu, I semestre) Il Novellino Dante Alighieri, Vita Nuova Convivio Domenico Cavalca, Vite de’ Santi padri Francesco Petrarca, Familiarium rerum libri De remediis utriusque fortune Giovanni Boccaccio, Elegia di Madonna Fiammetta Decameron (proemio) Anonimo romano, Cronica Leon Battista Alberti, Libri della famiglia (prologo) Marsilio Ficino, El libro dell’amore Iacopo Sannazaro, Arcadia Pietro Bembo, Asolani Nicolò Machiavelli, De principatibus Francesco Guicciardini, Storia d’Italia Benvenuto Cellini, Vita Pietro Aretino Ragionamenti Torquato Tasso, Discorsi del poema eroico Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi Daniello Bartoli, La ricreazione del savio Francesco Algarotti, Saggio sopra la necessità di scrivere nella propria lingua Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene Vittorio Alfieri, Vita scritta da esso. Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Iacopo Ortis Alessandro Verri, Le avventure di Saffo Pietro Giordani, A un giovane italiano. Istruzione per l’arte di scrivere Lettera semiseria di Grisostomo Giacomo Leopardi, Operette morali Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana 2 Il Novellino (XIII sec. ex.) [Il Novellino, a cura di G. Favati, rist., Genova, Bozzi, 1970] Prologo Questo libro tratta d'alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di be' risposi e di belle valentie e doni, secondo che per lo tempo passato hanno fatto molti valenti uomini. Quando lo Nostro Signore Gesù Cristo parlava umanamente con noi, in fra l'altre sue parole ne disse che dell'abondanza del cuore parla la lingua. Voi c'avete i cuori gentili e nobili in fra li altri, acconciate le vostre menti e le vostre parole nel piacere di Dio, parlando, onorando e temendo e laudando quel Signore Nostro, che n'amò prima che Elli ne criasse e prima che noi medesimi ci amassimo. E se in alcuna parte, non dispiacendo a lui, si può parlare per rallegrare il corpo e sovenire e sostentare, facciasi con più onestade e con più cortesia che fare si puote. Et acciò che li nobili e ' gentili sono nel parlare e nell'opere molte volte quasi com'uno specchio appo i minori — acciò che il loro parlare è più gradito però che esce di più dilicato stormento —, facciamo qui memoria d'alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di belli risposi e di belle valentie, di belli donari e di belli amori, secondo che per lo tempo passato hanno fatto già molti. E chi avrà cuore nobile et intelligenzia sottile, si li potrà simigliare per lo tempo che verrà per innanzi et argomentare e dire e raccontare (in quelle parti dove avranno luogo), a prode et a piacere di coloro che non sanno e disiderano di sapere. E se i fiori che proporremo fossero mischiati intra molte altre parole, non vi dispiaccia: ché 'l nero è ornamento dell'oro, e per un frutto nobile e dilicato piace talora tutto un orto, e per pochi belli fiori tutto un giardino. Non gravi a' leggitori che sono stati molti che sono vivuti grande lunghezza di tempo et in vita loro hanno appena tanto: un bel parlare, overo una cosa, da mettere in conto fra i buoni. I. Della ricca ambasceria la quale fece lo Presto Giovanni al nobile imperadore Federigo Presto Giovanni, nobilissimo signore indiano, mandoe ricca e nobile ambasceria al nobile e potente imperadore Federigo, a colui che veramente fu specchio del mondo in parlare et in costumi et amò molto dilicato parlare et istudiò in dare savi risponsi. La forma e la intenzione di quella ambasceria fu solo in due cose, per volere al postutto provare se lo 'mperadore fosse savio in parlare et in opere. Mandolli per li detti ambasciadori tre pietre nobilissime e disse loro: «Donatele allo 'mperadore e diteli dalla parte mia che vi dica qual'è la migliore cosa del mondo; e le sue parole e risposte serberete, et aviserete la corte sua e ' costumi di quella, e quello che inverrete raccontarete a me, sanza niuna mancanza». Fuoro allo 'mperadore, dove erano mandati per lo loro signore, salutarlo sì come si convenia per la parte della sua maestade e per la parte dello loro soprascritto signore. Donarli le sopra dette pietre. Quelli le prese e non domandò di loro virtude: fecele riporre, e lodolle molto di grande bellezza. Li ambasciadori fecero la dimanda loro, e videro li costumi e la corte; poi, dopo pochi giorni, adomandaro commiato. Lo 'mperadore diede loro risposta e disse: «Ditemi al signore vostro che la migliore cosa di questo mondo si è misura». Andar li ambasciadori e rinunziaro e raccontaro ciò ch'aveano veduto et udito, lodando molto la corte dello 'mperadore ornata di bellissimi costumi, e 'l modo de' suoi cavalieri. Il Presto Giovanni, udendo ciò che raccontaro li suoi ambasciadori, lodò lo 'mperadore e disse ch'era molto savio in parole, ma non in fatti, acciò che non avea domandato della virtù di cosìe care pietre. Rimandolli ambasciadori et offerseli, se li piacesse, che 'l farebbe siniscalco della sua corte: e feceli contare le sue ricchezze e le diverse generazioni de' sudditi suoi et il modo del suo paese. Dopo non gran tempo, pensando il Presto Giovanni che le pietre c'avea donate allo 'mperadore avevano perduta loro virtude da poi che non erano per lo 'mperadore conosciute, tolse uno suo carissimo lapidaro e mandollo celatamente nella corte dello 'mperadore e disse: «Al postutto metti lo 'ngegno tuo che tu quelle pietre mi rechi. Per niuno tesoro rimanga». Lo lapidaro si mosse, guernito di molte pietre di gran bellezza, e cominciò, presso alla corte, a legare sue pietre. Li baroni veniano, e li cavalieri, e vedevano di suo mistiero. L'uomo era molto savio: quando vedeva alcuno c'avesse luogo in corte, non vendeva, ma donava: e donò anella molte, tanto che la lode di lui andò dinanzi allo 'mperadore: lo quale mandò per lui e mostrogli sue pietre. Lodolle, ma non di gran vertude. Domandò se avesse più care pietre. Allora lo 'mperadore fece venire le tre pietre preziose ch'elli disiderava di vedere. Allora il lapidaro si rallegrò e prese l'una pietra e miselasi in mano e disse così: «Questa pietra, messere, vale la migliore città che voi avete». E poi prese l'altra e disse: «Questa, messere, vale la migliore provincia che voi avete». E poi prese la terza e disse: 1 «Messere, questa vale più che tutto lo 'mperio»: e strinse il pugno con le soprascritte pietre. La vertude dell'una il celò che no 'l potero vedere; e' discese giù per le gradora, e tornò al suo signore Presto Giovanni, e presentolli le pietre con grande allegrezza. XIX. Come tre maestri di nigromanzia vennero alla corte dello 'mperadore Federigo Lo 'mperadore Federigo fue nobilissimo signore; e·lla gente ch'avea bontade venia a·llui di tutte parti, però che l'uomo donava volentieri e mostrava belli sembianti a chi avesse alcuna speziale bontà. A·llui veniano sonatori, trovatori e belli favellatori, uomini d'arti, giostratori, schermitori, e d'ogni maniera gente. Stando lo 'mperadore Federigo — e facea dare l'acqua alle mani, le tavole coverte: e non era ch'entrare a tavola —, sì giunsero a·llui tre maestri di negromanzia con tre schiavine. Salutarlo così di subito, et elli domandò: «Qual'è il maestro, di voi tre?». L'uno si fece avanti e disse: «Messere, io sono»; e lo 'mperadore il pregò che giucasse. Cortesemente quelli gittaro loro incantamenti e fecero loro arti. Il tempo incominciò a turbare: ecco una pioggia repente e spessa, li tuoni, li folgóri e ' baleni, che 'l mondo parea che fondesse; una gragnuola, che parea çopelli d'acciaio. I cavalieri fuggiano per le camere, chi in una parte, chi in un'altra. Rischiarossi il tempo. Li maestri chiesero commiato e chiesero guiderdone. Lo 'mperadore disse: «Domandate». Que' domandaro il conte di San Bonifazio, ched era più presso allo 'mperadore, e dissero: «Messere, comandate a costui che vegna in nostro soccorso contra li nostri nemici». Lo 'mperadore lile comandò teneramente. Misesi il conte in via co·lloro: menarlo in una bella cittade, cavalieri li mostrò di gran paraggio, bel destriere e bell'arme li aprestaro, e dissero al conte: «Questi sono a·tte ubbidire». E mostrarogli li nimici. Vennero a la battaglia: il conte li sconfisse e francò lo paese. E poi ne fece tre, delle battaglie ordinate in campo. Vinse la terra. Diederli moglie. Ebbe figliuoli. Dopo, molto tempo tenne la Signoria. Lasciarlo grandissimo tempo, poi ritornaro. Il figliuolo del conte avea già bene quaranta anni; il conte era vecchio. I maestri dissono: «Riconoscici tu? Vuo' tu ritornare a vedere lo 'mperadore e la corte?» E 'l conte rispuose: «Lo 'mperio fi aora più volte mutato; le genti fier ora tutte nuove: dove ritornerai?». E ' maestri dissero: «Noi vi ti volemo al postutto menare». Misersi in via; camminaro gran tempo; giunsero in corte; trovaro lo 'mperadore e 'suoi baroni, ch'ancor si dava l'acqua la qual si dava quando il conte n'andò co' maestri. Lo 'mperadore li facea contare la novella; que' la contava: «I' ho poi moglie, e figliuolo c'ha quaranta anni; tre battaglie di campo ho poi fatte. Il mondo è tutto rivolto! Come va questo fatto?» Lo 'mperadore lile fa raccontare con grandissima festa, e i baroni e ' cavalieri. XXXV. Qui conta del maestro Taddeo di Bologna Maestro Taddeo, leggendo a' suoi scolari in medicina, trovò che, chi continuo mangiasse nove dì di petronciani, che diverebbe matto; e provavalo secondo fisica. Un suo scolaro, udendo quel capitolo, propuosesi di volerlo provare: prese a mangiare de' petronciani, et in capo de' nove dì venne dinanzi al maestro e disse: «Maestro, il cotale capitolo che leggeste non è vero, però ch'io l'hoe provato, e non sono matto»: e pure alzasi e mostrolli il culo. «Iscrivete» disse il maestro «che provato è; e facciasene nuova chiosa». LXXVIII. Qui conta d'uno filosofo il qual era molto cortese di volgarizzare la scienzia Fue uno filosofo, lo quale era molto cortese di volgarizzare la scienzia a' signori, per cortesia, e ad altre genti. Una notte li venne in visione che li parea vedere le dee della scienzia a guisa di belle donne: e stavano al bordello e davansi a chi le volea. Et elli vedendo questo si maravigliò molto e disse: «Che è questo? Non siete voi le dee della scienzia?» Et elle rispuosero: «Certo sì». «Com'è ciò? Voi siete al bordello?» Et elle rispuosero: «Ben è vero: perché tu se' quelli che vi ci fai stare!» Isvegliossi, e pensossi che volgarizzare la scienzia si era menomare la deitade. Ritràsesine e pentési fortemente. E sappiate che tutte le cose non sono licite a ogni persona. 2 XCIV. Qui conta della volpe e del mulo La volpe andando per un bosco sì trovò un mulo: e mai non n'avea più veduti. Ebbe grande paura e fuggì; e, così fuggendo, trovoe il lupo e disse come avea trovata una novissima bestia e non sapea suo nome. Il lupo disse: «Andianvi». Furono giunti a lui. Al lupo parve vie più nuova. La volpe il domandò di suo nome. Il mulo rispuose: «Certo io non l'ho bene a mente; ma, se tu sai leggere, io l'ho iscritto nel piè diritto di dietro». La volpe rispose: «Lassa, ch'io non so leggere! Ché molto lo saprei volentieri». Rispuose il lupo: «Lascia fare a me, che molto lo so ben fare». Il mulo sì li mostrò il piede dritto, sì che li chiovi pareano lettere. Disse il lupo: «Io non le veggio bene». Rispose il mulo: «Fatti più presso, però che sono minute». Il lupo si fece sotto e guardava fiso. Il mulo trasse e dielli un calcio tale, che l'uccise. Allora la volpe se n'andò e disse: «Ogne uomo che sa lettera non è savio». XCIX. Qui conta una bella novella d'amore Un giovane di Firenze sì amava d'amore una gentile pulzella, la quale non amava neente lui, ma amava a dismisura un altro giovane, lo quale amava anche lei, ma non tanto ad assai quanto costui. E ciò si parea: ché costui n'avea lasciato ogni altra cosa, e consumavasi come smemorato, e spezialmente il giorno ch'elli non la vedea. A un suo compagno ne 'ncrebbe: fece tanto, che lo menò a un suo bellissimo luogo, e là tranquillaro quindeci dì. In quel mezzo, la fanciulla si crucciò con la madre: mandò la fante e fece parlare a colui cui amava, che ne voleva andar con lui. Quelli fu molto lieto. La fante disse: «Ella vuole che voi vegniate a cavallo già quando fia notte ferma. Ella farà vista di scendere nella cella; aparecchiato sarete all'uscio, e gitteravisi in groppa: ell'è leggiera e sa ben cavalcare». Elli rispuose: «Ben mi piace». Quand'ebbero così ordinato, fece grandemente apparecchiare a un suo luogo: et ebbevi suoi compagni a cavallo e feceli stare alla porta perché non fosse serrata, e mossesi con un fine ronzone e passò dalla casa. Ella non era ancora potuta venire, perché la madre la guardava troppo. Questi andò oltre per tornare a' compagni. Ma quelli che consumato era in villa, non trovava luogo: era salito a cavallo, e 'l compagno suo no 'l seppe tanto pregare, che 'l potesse ritenere; e non volle la sua compagnia. Giunse quella sera alle mura. Le porte erano tutte serrate, ma tanto acerchiò, che s'abatté a quella porta dov'erano coloro. Entrò dentro. Andonne inverso la magione di colei, non per intendimento di trovarla né di vederla, ma solo per vedere la contrada. Essendo ristato di rimpetto alla casa (di poco era passato l'altro), la fanciulla diserrò l'uscio e chiamollo sottoboce e disse che acostasse il cavallo. Questi non fu lento: accostossi, et ella li si gittò vistamente in groppa, et andarono via. Quando furo alla porta, li compagni dell'altro non li diedero briga, ché no 'l conobbero: però che se fosse stato colui cui elli aspettavano sarebbe ristato co·lloro. Questi cavalcaro ben diece miglia, tanto che furono in un bello prato intorniato di grandissimi abeti. Smontaro e legaro il cavallo a un albero: e' prese a basciarla; quella il conobbe: accorsesi della disaventura. Cominciò a piangere duramente. Ma questi la prese a confortare lagrimando et a renderle tanto onore, ch'ella lasciò il piagnere e preseli a volere bene, veggendo che·lla ventura era pur di costui; et abbracciollo. Quell'altro cavalcò poi più volte, tanto che udì il padre e la madre fare romore nell'agio, e intese dalla fante com'ella n'era andata in cotal modo. Questi sbigottì: tornò a' compagni e disselo loro. E que' rispuosero: «Ben lo vedemmo passar co·llei, ma no 'l conoscemmo: et è tanto, che puote essere bene alungato; et andarne per cotale strada». Misersi incontanente a tenere loro dietro: cavalcaro tanto, che·lli trovaro dormire così abbracciati: e miravagli per lo lume della luna ch'era apparito. Allora ne 'ncrebbe loro disturbarli e dissero: «Aspettiamo tanto ch'elli si sveglieranno, e poi faremo quello ch'avemo a fare». E così stettero tanto che 'l sonno giunse e furo tutti adormentati. Coloro si svegliaro in questo mezzo, e trovaro ciò ch'era. Maravigliarsi; e disse il giovane: «Costoro ci hanno fatta tanta cortesia, che non piaccia a Dio che noi li ofendiamo»: ma salìo questi a cavallo, et ella si gittò in su un altro de' migliori che v'erano, e poscia tutti i freni degli altri cavalli tagliaro et andarsi via. Quelli si destaro e fecero gran corrotto, perché più non li potevano ire cercando. 3 Dante Alighieri, Vita Nuova [Vita Nuova in Le Opere di Dante, a cura di M. Barbi, Firenze, Società Dantesca Italiana, 1960] I. In quella parte del libro de la mia memoria, dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice:Incipit vita nova. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d'asemplare in questo libello; e se non tutte, almeno la loro sentenzia. II.1. Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare. [2] Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente de le dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono. [3] Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si convenia. [4] In quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia ne li menimi polsi orribilmente; e tremando disse queste parole: "Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur michi". [5] In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora ne l'alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spezialmente a li spiriti del viso, sì disse queste parole: "Apparuit iam beatitudo vestra". [6] In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: "Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!". [7] D'allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. [8] Elli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte volte l'andai cercando, e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero: "Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di deo". [9] E avvegna che la sua imagine, la quale continuatamente meco stava, fosse baldanza d'Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima vertù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire. [10] E però che soprastare a le passioni e atti di tanta gioventudine para alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse; e trapassando molte cose le quali si potrebbero trarre de l'essemplo onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi. III.1. Poi che fuoro passati tanti die, che appunto erano compiuti li nove anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, ne l'ultimo di questi die avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga etade; e passando per una via, volse li occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutoe molto virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine. [2] L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quello giorno; e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire a li miei orecchi, presi tanta dolcezza, che come inebriato mi partio da le genti, e ricorsi a lo solingo luogo d'una mia camera, e puosimi a pensare di questa cortesissima. [3] E pensando di lei, mi sopragiunse uno soave sonno, ne lo quale m'apparve una maravigliosa visione: che me parea vedere ne la mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro a la quale io discernea una figura d'uno segnore di pauroso aspetto a chi la guardasse; e pareami con tanta letizia, quanto a sé, che mirabile cosa era; e ne le sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non poche; tra le quali intendea queste: "Ego dominus tuus". [4] Ne le sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente; la quale io riguardando molto intentivamente, conobbi ch'era la donna de la salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. [5] E ne l'una de le mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e pareami che mi dicesse queste parole: "Vide cor tuum". [6] E quando elli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia; e tanto si sforzava per suo ingegno, che le facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. [7] Appresso ciò poco dimorava che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto; e così piangendo, si ricogliea questa donna ne le sue braccia, e con essa mi parea che si ne gisse verso lo cielo; onde io sostenea sì grande angoscia, che lo mio deboletto sonno non poteo sostenere, anzi si ruppe e fui disvegliato. [8] E mantenente cominciai a pensare, e trovai che l'ora ne la quale m'era questa visione apparita, era la quarta de la notte stata; sì che appare manifestamente ch'ella fue la prima ora de le nove ultime ore de la notte. [9] Pensando io a ciò che m'era apparuto, propuosi di farlo sentire a molti li quali erano famosi trovatori in quello tempo: e con ciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, propuosi di fare uno sonetto, ne lo quale io salutasse tutti li fedeli d'Amore; e pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a loro ciò che io avea nel mio sonno veduto. E cominciai allora questo sonetto, lo quale comincia: A ciascun'alma presa. 4 A ciascun'alma presa, e gentil core, nel cui cospetto ven lo dir presente, in ciò che mi rescrivan suo parvente salute in lor segnor, cioè Amore. Già eran quasi che atterzate l'ore del tempo che onne stella n'è lucente, quando m'apparve Amor subitamente cui essenza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava Amor tenendo meo core in mano, e ne le braccia avea madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava, e d'esto core ardendo lei paventosa umilmente pascea: appresso gir lo ne vedea piangendo. [13] Questo sonetto si divide in due parti; che la prima parte saluto e domando risponsione, ne la seconda significo a che si dee rispondere. La seconda parte comincia quivi: Già eran. [14] A questo sonetto fue risposto da molti e di diverse sentenzie; tra li quali fue risponditore quelli cui io chiamo primo de li miei amici, e disse allora uno sonetto, lo quale comincia: Vedesti al mio parere onne valore. E questo fue quasi lo principio de l'amistà tra lui e me, quando elli seppe che io era quelli che li avea ciò mandato. [15] Lo verace giudicio del detto sogno non fue veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo a li più semplici. IV. Da questa visione innanzi cominciò lo mio spirito naturale ad essere impedito ne la sua operazione, però che l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima; onde io divenni in picciolo tempo poi di sì fràile e debole condizione, che a molti amici pesava de la mia vista; e molti pieni d'invidia già si procacciavano di sapere di me quello che io volea del tutto celare ad altrui. [2] Ed io, accorgendomi del malvagio domandare che mi faceano, per la volontade d'Amore, lo quale mi comandava secondo lo consiglio de la ragione, rispondea loro che Amore era quelli che così m'avea governato. Dicea d'Amore, però che io portava nel viso tante de le sue insegne, che questo non si potea ricovrire. [3] E quando mi domandavano: «Per cui t'ha così distrutto questo Amore?», ed io sorridendo li guardava, e nulla dicea loro. V.1 Uno giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove s'udiano parole de la regina de la gloria, ed io era in luogo dal quale vedea la mia beatitudine: e nel mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio sguardare, che parea che sopra lei terminasse. [2] Onde molti s'accorsero de lo suo mirare; ed in tanto vi fue posto mente, che, partendomi da questo luogo, mi sentio dicere appresso di me: «Vedi come cotale donna distrugge la persona di costui»; e nominandola, eo intesi che dicea di colei che mezzo era stata ne la linea retta che movea da la gentilissima Beatrice e terminava ne li occhi miei. [3] Allora mi confortai molto, assicurandomi che lo mio secreto non era comunicato lo giorno altrui per mia vista. E mantenente pensai di fare di questa gentile donna schermo de la veritade; e tanto ne mostrai in poco tempo, che lo mio secreto fue creduto sapere da le più persone che di me ragionavano. Con questa donna mi celai alquanti anni e mesi; e per più fare credente altrui, feci per lei certe cosette per rima, le quali non è mio intendimento di scrivere qui, se non in quanto facesse a trattare di quella gentilissima Beatrice; e però le lascerò tutte, salvo che alcuna cosa ne scriverò che pare che sia loda di lei. VI.1. Dico che in questo tempo che questa donna era schermo di tanto amore, quanto da la mia parte, sì mi venne una volontade di volere ricordare lo nome di quella gentilissima ed acompagnarlo di molti nomi di donne, e spezialmente del nome di questa gentile donna. [2] E presi li nomi di sessanta le più belle donne de la cittade ove la mia donna fue posta da l'altissimo sire, e compuosi una pìstola sotto forma di serventese, la quale io non scriverò: e non n'avrei fatto menzione, se non per dire quello che, componendola, maravigliosamente addivenne, cioè che in alcuno altro numero non sofferse lo nome de la mia donna stare, se non in su lo nove, tra li nomi di queste donne. VII.1. La donna co la quale io avea tanto tempo celata la mia volontade, convenne che si partisse de la sopradetta cittade e andasse in paese molto lontano: per che io quasi sbigottito de la bella difesa che m'era venuta meno, assai me ne disconfortai, più che io medesimo non avrei creduto dinanzi. [2] E pensando che se de la sua partita io non parlasse alquanto dolorosamente, le persone sarebbero accorte più tosto de lo mio nascondere, propuosi di farne alcuna 5 lamentanza in uno sonetto; lo quale io scriverò, acciò che la mia donna fue immediata cagione di certe parole che ne lo sonetto sono, sì come appare a chi lo intende. E allora dissi questo sonetto, che comincia: O voi che per la via. […] XVIII.1. Con ciò sia cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso lo secreto del mio cuore, certe donne, le quali adunate s'erano dilettandosi l'una ne la compagnia de l'altra, sapeano bene lo mio cuore, però che ciascuna di loro era stata a molte mie sconfitte; e io passando appresso di loro, sì come da la fortuna menato, fui chiamato da una di queste gentili donne. [2] La donna che m'avea chiamato era donna di molto leggiadro parlare; sì che quand'io fui giunto dinanzi da loro, e vidi bene che la mia gentilissima donna non era con esse, rassicurandomi le salutai, e domandai che piacesse loro. [3] Le donne erano molte, tra le quali n'avea certe che si rideano tra loro. Altre v'erano che mi guardavano, aspettando che io dovessi dire. Altre v'erano che parlavano tra loro. De le quali una, volgendo li suoi occhi verso me e chiamandomi per nome, disse queste parole: "A che fine ami tu questa tua donna, poi che tu non puoi sostenere la sua presenza? Dilloci, ché certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo". E poi che m'ebbe dette queste parole, non solamente ella, ma tutte l'altre cominciaro ad attendere in vista la mia risponsione. [4] Allora dissi queste parole loro: "Madonne, lo fine del mio amore fue già lo saluto di questa donna, forse di cui voi intendete, e in quello dimorava la beatitudine, ché era fine di tutti li miei desiderii. Ma poi che le piacque di negarlo a me, lo mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno". [5] Allora queste donne cominciaro a parlare tra loro; e sì come talora vedemo cadere l'acqua mischiata di bella neve, così mi parea udire le loro parole uscire mischiate di sospiri. [6] E poi che alquanto ebbero parlato tra loro, anche mi disse questa donna che m'avea prima parlato, queste parole: "Noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sta questa tua beatitudine". Ed io, rispondendo lei, dissi cotanto: "In quelle parole che lodano la donna mia". [7] Allora mi rispuose questa che mi parlava: "Se tu ne dicessi vero, quelle parole che tu n'hai dette in notificando la tua condizione, avrestù operate con altro intendimento". [8] Onde io, pensando a queste parole, quasi vergognoso mi partio da loro, e venia dicendo fra me medesimo: "Poi che è tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna, perché altro parlare è stato lo mio?". [9] E però propuosi di prendere per matera de lo mio parlare sempre mai quello che fosse loda di questa gentilissima; e pensando molto a ciò, pareami avere impresa troppo alta matera quanto a me, sì che non ardia di cominciare; e così dimorai alquanti dì con disiderio di dire e con paura di cominciare. XIX.1. Avvenne poi che passando per uno cammino lungo lo quale sen gia uno rivo chiaro molto, a me giunse tanta volontade di dire, che io cominciai a pensare lo modo ch'io tenesse; e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona, e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine. [2] Allora dico che la mia lingua parlò quasi come per se stessa mossa, e disse: Donne ch'avete intelletto d'amore. [3] Queste parole io ripuosi ne la mente con grande letizia, pensando di prenderle per mio cominciamento; onde poi, ritornato a la sopradetta cittade, pensando alquanti die, cominciai una canzone con questo cominciamento, ordinata nel modo che si vedrà di sotto ne la sua divisione. La canzone comincia: Donne ch'avete. Donne ch'avete intelletto d'amore, i' vo' con voi de la mia donna dire, non perch'io creda sua laude finire, ma ragionar per isfogar la mente. Io dico che pensando il suo valore, Amor sì dolce mi si fa sentire, che s'io allora non perdessi ardire, farei parlando innamorar la gente: E io non vo' parlar sì altamente, ch'io divenisse per temenza vile; ma tratterò del suo stato gentile a respetto di lei leggeramente, donne e donzelle amorose, con vui, ché non è cosa da parlarne altrui. Angelo clama in divino intelletto e dice: «Sire, nel mondo si vede maraviglia ne l'atto che procede d'un'anima che 'nfin quassù risplende». Lo cielo, che non have altro difetto che d'aver lei, al suo segnor la chiede, e ciascun santo ne grida merzede. Sola Pietà nostra parte difende, ché parla Dio, che di madonna intende: 6 «Diletti miei, or sofferite in pace che vostra spene sia quanto me piace là ov' è alcun che perder lei s'attende, e che dirà ne lo inferno: «O malnati, io vidi la speranza de' beati». Madonna è disiata in sommo cielo: or vòi di sua virtù farvi savere. Dico, qual vuol gentil donna parere vada con lei, chè quando va per via, gitta nei cor villani Amore un gelo, per che onne lor pensero agghiaccia e père; e qual soffrisse di starla a vedere diverria nobil cosa, o si morria; E quando trova alcun che degno sia di veder lei, quei prova sua vertute, ché li avvien ciò che li dona salute, e sì l'umilia ch'ogni offesa oblia. Ancor l'ha Dio per maggior grazia dato che non pò mal finir chi l'ha parlato. Dice di lei Amor: «Cosa mortale come esser pò sì adorna e sì pura?» Poi la reguarda, e fra se stesso giura che Dio ne 'ntenda di far cosa nova. Color di perle ha quasi in forma, quale convene a donna aver, non for misura; ella è quanto de ben pò far natura; per esemplo di lei bieltà si prova. De li occhi suoi, come ch'ella li mova, escono spirti d'amore inflammati, che fèron li occhi a qual che allor la guati, e passan sì che 'l cor ciascun retrova: voi le vedete Amor pinto nel viso, là 've non pote alcun mirarla fiso. Canzone, io so che tu girai parlando a donne assai, quand'io t'avrò avanzata. Or t'ammonisco, perch'io t'ho allevata per figliuola d'Amor giovane e piana, che là ove giugni tu dichi pregando: «Insegnàtemi gir, ch'io son mandata a quella di cui laude so' adornata». E se non vuoli andar sì come vana, non restare ove sia gente villana; ingègnati, se puoi, d'esser palese solo con donne o con omo cortese, che ti merranno là per via tostana. Tu troverai Amor con esso lei; raccomàndami a lui come tu dei. […] XXIII.1 Appresso ciò per pochi dì avvenne che in alcuna parte de la mia persona mi giunse una dolorosa infermitade, onde io continuamente soffersi per nove dì amarissima pena; la quale mi condusse a tanta debolezza, che me convenia stare come coloro li quali non si possono muovere. [2] Io dico che ne lo nono giorno, sentendome dolere quasi intollerabilemente, a me giunse uno pensero lo quale era de la mia donna. [3] E quando ei pensato alquanto di lei, ed io ritornai pensando a la mia debilitata vita; e veggendo come leggiero era lo suo durare, ancora che sana fosse, sì cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria. Onde, sospirando forte, dicea fra me medesimo: "Di necessitade convene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia". [4] E però mi giunse uno sì forte smarrimento, che chiusi li 7 occhi e cominciai a travagliare sì come farnetica persona ed a imaginare in questo modo: che ne lo incominciamento de lo errare che fece la mia fantasia, apparvero a me certi visi di donne scapigliate, che mi diceano: "Tu pur morrai". E poi, dopo queste donne, m'apparvero certi visi diversi e orribili a vedere, li quali mi diceano: "Tu se' morto". [5] Così cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello ch'io non sapea ove io mi fosse; e vedere mi parea donne andare scapigliate piangendo per via, maravigliosamente triste; e pareami vedere lo sole oscurare, sì che le stelle si mostravano di colore ch'elle mi faceano giudicare che piangessero; e pareami che li uccelli volando per l'aria cadessero morti, e che fossero grandissimi terremuoti. [6] E maravigliandomi in cotale fantasia, e paventando assai, imaginai alcuno amico che mi venisse a dire: "Or non sai? la tua mirabile donna è partita di questo secolo". Allora cominciai a piangere molto pietosamente; e non solamente piangea ne la imaginazione, ma piangea con li occhi, bagnandoli di vere lagrime. [7] Io imaginava di guardare verso lo cielo, e pareami vedere moltitudine d'angeli li quali tornassero in suso, ed aveano dinanzi da loro una nebuletta bianchissima. A me parea che questi angeli cantassero gloriosamente, e le parole del loro canto mi parea udire che fossero queste: Osanna in excelsis; e altro non mi parea udire. [8] Allora mi parea che lo cuore, ove era tanto amore, mi dicesse: "Vero è che morta giace la nostra donna". E per questo mi parea andare per vedere lo corpo ne lo quale era stata quella nobilissima e beata anima; e fue sì forte la erronea fantasia, che mi mostrò questa donna morta: e pareami che donne la covrissero, cioè la sua testa, con uno bianco velo; e pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umilitade, che parea che dicesse: "Io sono a vedere lo principio de la pace". [9] In questa imaginazione mi giunse tanta umilitade per vedere lei, che io chiamava la Morte, e dicea: "Dolcissima Morte, vieni a me, e non m'essere villana, però che tu dei essere gentile, in tal parte se' stata! Or vieni a me, ché molto ti disidero; e tu lo vedi, ché io porto già lo tuo colore". [10] E quando io avea veduto compiere tutti li dolorosi mestieri che a le corpora de li morti s'usano di fare, mi parea tornare ne la mia camera, e quivi mi parea guardare verso lo cielo; e sì forte era la mia imaginazione, che piangendo incominciai a dire con verace voce: "Oi anima bellissima, come è beato colui che ti vede!". [11] E dicendo io queste parole con doloroso singulto di pianto, e chiamando la Morte che venisse a me, una donna giovane e gentile, la quale era lungo lo mio letto, credendo che lo mio piangere e le mie parole fossero solamente per lo dolore de la mia infermitade, con grande paura cominciò a piangere. [12] Onde altre donne che per la camera erano s'accorsero di me, che io piangea, per lo pianto che vedeano fare a questa; onde faccendo lei partire da me, la quale era meco di propinquissima sanguinitade congiunta, elle si trassero verso me per isvegliarmi, credendo che io sognasse, e diceanmi: "Non dormire più", e "Non ti sconfortare". [13] E parlandomi così, sì mi cessò la forte fantasia entro in quello punto ch'io volea dicere: "O Beatrice, benedetta sie tu"; e già detto avea "O Beatrice", quando riscotendomi apersi li occhi, e vidi che io era ingannato. E con tutto che io chiamasse questo nome, la mia voce era sì rotta dal singulto del piangere, che queste donne non mi pottero intendere, secondo il mio parere; e avvegna che io vergognasse molto, tuttavia per alcuno ammonimento d'Amore mi rivolsi a loro. [14] E quando mi videro, cominciaro a dire: "Questi pare morto", e a dire tra loro: "Proccuriamo di confortarlo"; onde molte parole mi diceano da confortarmi, e talora mi domandavano di che io avesse avuto paura. [15] Onde io, essendo alquanto riconfortato, e conosciuto lo fallace imaginare, rispuosi a loro: "Io vi diroe quello ch'i' hoe avuto". Allora, cominciandomi dal principio infino a la fine, dissi loro quello che veduto avea, tacendo lo nome di questa gentilissima. [16] Onde poi, sanato di questa infermitade, propuosi di dire parole di questo che m'era addivenuto, però che mi parea che fosse amorosa cosa da udire; e però ne dissi questa canzone: Donna pietosa e di novella etate, ordinata sì come manifesta la infrascritta divisione. […] XXV. 1. Potrebbe qui dubitare persona degna da dichiararle onne dubitazione, e dubitare potrebbe di ciò, che io dico d'Amore come se fosse una cosa per sé, e non solamente sustanzia intelligente, ma sì come fosse sustanzia corporale: la quale cosa, secondo la veritate, è falsa; ché Amore non è per sé sì come sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia. [2] E che io dica di lui come se fosse corpo, ancora sì come se fosse uomo, appare per tre cose che dico di lui. Dico che lo vidi venire; onde, con ciò sia cosa che venire dica moto locale, e localmente mobile per sé, secondo lo Filosofo, sia solamente corpo, appare che io ponga Amore essere corpo. Dico anche di lui che ridea, e anche che parlava; le quali cose paiono essere proprie de l'uomo, e spezialmente essere risibile; e però appare ch'io ponga lui essere uomo. [3] A cotale cosa dichiarare, secondo che è buono a presente, prima è da intendere che anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare, anzi erano dicitori d'amore certi poete in lingua latina; tra noi, dico, avvegna forse che tra altra gente addivenisse, e addivegna ancora, sì come in Grecia, non volgari ma litterati poete queste cose trattavano. [4] E non è molto numero d'anni passati, che appariro prima questi poete volgari; ché dire per rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino, secondo alcuna proporzione. E segno che sia picciolo tempo, è che se volemo cercare in lingua d'oco e in quella di sì, noi non troviamo cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta anni. [5] E la cagione per che alquanti grossi ebbero fama di sapere dire, è che quasi fuoro li primi che dissero in lingua di sì. [6] E lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare, si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna, a la quale era malagevole d'intendere li versi latini. E questo è contra coloro che rimano sopra altra matera che amorosa, con ciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore. [7] Onde, con ciò sia cosa che a li poete sia conceduta maggiore licenza di parlare che a li prosaici dittatori, e questi dicitori per rima non siano altro che poete volgari, degno e ragionevole è che a loro sia maggiore licenzia largita di parlare che a li altri parlatori volgari: onde, se alcuna figura o colore rettorico è conceduto a li poete, conceduto è a li rimatori. [8] Dunque, se noi vedemo che li poete hanno parlato a le cose inanimate, sì come se avessero senso e ragione, e fattele parlare 8 insieme; e non solamente cose vere, ma cose non vere, cioè che detto hanno, di cose le quali non sono, che parlano, e detto che molti accidenti parlano, sì come se fossero sustanzie e uomini; degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante, ma non sanza ragione alcuna, ma con ragione la quale poi sia possibile d'aprire per prosa. [9] Che li poete abbiano così parlato come detto è, appare per Virgilio; lo quale dice che Iuno, cioè una dea nemica de li Troiani, parloe ad Eolo, segnore de li venti, quivi nel primo de lo Eneida: Eole, nanque tibi, e che questo segnore le rispuose, quivi: Tuus, o regina, quid optes explorare labor; michi iussa capessere fas est. Per questo medesimo poeta parla la cosa che non è animata a le cose animate, nel terzo de lo Eneida, quivi: Dardanide duri. Per Lucano parla la cosa animata a la cosa inanimata, quivi: Multum, Roma, tamen debes civilibus armis. Per Orazio parla l'uomo a la scienzia medesima sì come ad altra persona; e non solamente sono parole d'Orazio, ma dicele quasi recitando lo modo del buono Omero, quivi ne la sua Poetria: Dic michi, Musa, virum. Per Ovidio parla Amore, sì come se fosse persona umana, ne lo principio de lo libro c'ha nome Libro di Remedio d'Amore, quivi: Bella michi, video, bella parantur, ait. E per questo puote essere manifesto a chi dubita in alcuna parte di questo mio libello. [10] E acciò che non ne pigli alcuna baldanza persona grossa, dico che né li poete parlavano così sanza ragione, né quelli che rimano deono parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono; però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto vesta di figura o di colore rettorico, e poscia, domandato, non sapesse denudare le sue parole da cotale vesta, in guisa che avessero verace intendimento. E questo mio primo amico e io ne sapemo bene di quelli che così rimano stoltamente. […] XXVIII.1, Quomodo sedet sola civitas plena populo! facta est quasi vidua domina gentium. Io era nel proponimento ancora di questa canzone, e compiuta n'avea questa soprascritta stanzia, quando lo segnore de la giustizia chiamoe questa gentilissima a gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta virgo Maria, lo cui nome fue in grandissima reverenzia ne le parole di questa Beatrice beata. [2] E avvegna che forse piacerebbe a presente trattare alquanto de la sua partita da noi, non è lo mio intendimento di trattarne qui per tre ragioni: la prima è che ciò non è del presente proposito, se volemo guardare nel proemio che precede questo libello; la seconda si è che, posto che fosse del presente proposito, ancora non sarebbe sufficiente la mia lingua a trattare come si converrebbe di ciò; la terza si è che, posto che fosse l'uno e l'altro, non è convenevole a me trattare di ciò, per quello che, trattando, converrebbe essere me laudatore di me medesimo, la quale cosa è al postutto biasimevole a chi lo fae; e però lascio cotale trattato ad altro chiosatore. [3] Tuttavia, però che molte volte lo numero del nove ha preso luogo tra le parole dinanzi, onde pare che sia non sanza ragione, e ne la sua partita cotale numero pare che avesse molto luogo, convenesi di dire quindi alcuna cosa, acciò che pare al proposito convenirsi. Onde prima dicerò come ebbe luogo ne la sua partita, e poi n'assegnerò alcuna ragione, per che questo numero fue a lei cotanto amico. […] XLII.1 Appresso questo sonetto, apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei.[2] E di venire a ciò io studio quanto posso, sì com'ella sae veracemente. Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d'alcuna. [3] E poi piaccia a colui che è sire de la cortesia, che la mia anima se ne possa gire a vedere la gloria de la sua donna: cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira ne la faccia di colui qui est per omnia secula benedictus. 9 Dante Alighieri, Convivio [ed. a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1995] I i, 1. Sì come dice lo Filosofo nel principio della Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere. La ragione di che puote essere [ed] è che ciascuna cosa, da providenza di prima natura impinta, è inclinabile alla sua propia perfezione; onde, acciò che la scienza è ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicitade, tutti naturalmente al suo desiderio semo subietti. 2. Veramente da questa nobilissima perfezione molti sono privati per diverse cagioni, che dentro all'uomo e di fuori da esso lui rimovono dall'abito di scienza. 3. Dentro dall'uomo possono essere due difetti e impedi[men]ti: l'uno dalla parte del corpo, l'altro dalla parte dell'anima. Dalla parte del corpo è quando le parti sono indebitamente disposte, sì che nulla ricevere può, sì come sono sordi e muti e loro simili. Dalla parte dell'anima è quando la malizia vince in essa, sì che si fa seguitatrice di viziose dilettazioni, nelle quali riceve tanto inganno che per quelle ogni cosa tiene a vile. 4. Di fuori dall'uomo possono essere similemente due cagioni intese, l'una delle quali è induttrice di necessitade, l'altra di pigrizia. La prima è la cura familiare e civile, la quale convenevolemente a sé tiene delli uomini lo maggior numero, sì che in ozio di speculazione essere non possono. L'altra è lo difetto del luogo dove la persona è nata e nutrita, che tal ora sarà da ogni studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontano. 5. Le due di queste cagioni, cioè la prima dalla parte [di dentro e la prima dalla parte] di fuori, non sono da vituperare, ma da escusare e di perdono degne; le due altre, avegna che l'una più, sono degne di biasimo e d'abominazione. 6. Manifestamente adunque può vedere chi bene considera, che pochi rimangono quelli che all'abito da tutti desiderato possano pervenire, e innumerabili quasi sono li 'mpediti che di questo cibo sempre vivono affamati. 7. Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane delli angeli si manuca! e miseri quelli che colle pecore hanno comune cibo! 8. Ma però che ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è amico, e ciascuno amico si duole del difetto di colui ch'elli ama, coloro che a così alta mensa sono cibati non sanza misericordia sono inver di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande se[n] gire mangiando. 9. E acciò che misericordia è madre di beneficio, sempre liberalmente coloro che sanno porgono della loro buona ricchezza alli veri poveri, e sono quasi fonte vivo, della cui acqua si refrigera la naturale sete che di sopra è nominata. 10. E io adunque, che non seggio alla beata mensa, ma, fuggito della pastura del vulgo, a' piedi di coloro che seggiono ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in quello che a poco a poco ricolgo, misericordievolemente mosso, non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale alli occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata; e in ciò li ho fatti maggiormente vogliosi. 11. Per che ora volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale convivio di ciò ch'i' ho loro mostrato, e di quello pane ch'è mestiere a così fatta vivanda, sanza lo quale da loro non potrebbe essere mangiata. Ed ha questo convivio di quello pane degno, co[n] tale vivanda qual io intendo indarno [non] essere ministrata. 12. E però ad esso non s'assetti alcuno male de' suoi organi disposto, però che né denti né lingua ha né palato; né alcuno assettatore de' vizii, perché lo stomaco suo è pieno d'omori venenosi contrarii, sì che mai vivanda non terrebbe. 13. Ma vegna qua qualunque è [per cura] familiare o civile nella umana fame rimaso, e ad una mensa colli altri simili impediti s'assetti; e alli loro piedi si pongano tutti quelli che per pigrizia si sono stati, ché non sono degni di più alto sedere: e quelli e questi prendano la mia vivanda col pane che la farà loro e gustare e patire. 14. La vivanda di questo convivio saràe di quattordici maniere ordinata, cioè [di] quattordici canzoni sì d'amor come di vertù materiate, le quali sanza lo presente pane aveano d'alcuna oscuritade ombra, sì che a molti loro bellezza più che loro bontade era in grado. 15. Ma questo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce la quale ogni colore di loro sentenza farà parvente. 16. E se nella presente opera, la quale è Convivio nominata e vo' che sia, più virilmente si trattasse che nella Vita Nova, non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo sì come ragionevolemente quella fervida e passionata, questa temperata e virile essere conviene. 17. Ché altro si conviene e dire e operare ad una etade che ad altra; per che certi costumi sono idonei e laudabili ad una etade che sono sconci e biasimevoli ad altra, sì come di sotto, nel quarto trattato di questo libro, sarà propia ragione mostrata. E io in quella dinanzi, all'entrata della mia gioventute parlai, e in questa dipoi, quella già trapassata. 18. E con ciò sia cosa che la vera intenzione mia fosse altra che quella che di fuori mostrano le canzoni predette, per allegorica esposizione quelle intendo mostrare, appresso la litterale istoria ragionata; sì che l'una ragione e l'altra darà sapore a coloro che a questa cena sono convitati. 19. Li quali priego tutti che se lo convivio non fosse tanto splendido quanto conviene alla sua grida, che non al mio volere ma alla mia facultade imputino ogni difetto: però che la mia voglia di compita e cara liberalitate è qui seguace. […] I iii, 1 Degna di molta riprensione è quella cosa che, ordinata a tòrre alcuno difetto, per se medesima quello induce: sì come quelli che fosse mandato a partire una rissa, e prima che partisse quella neiniziasse un'altra. 2 E però che lo mio pane è purgato da una parte, convienlomi purgare dall'altra, per fuggire questa riprensione; ché lo mio scritto, che quasi comento dir si può, è ordinato a levare lo difetto delle canzoni sopra dette, ed esso per sé fia forse in parte alcuna un poco duro. La qual durezza, per fuggire maggiore difetto, non per ignoranza, è qui pensata. 3 Ahi, piaciuto fosse al dispensatore dell'universo che la cagione della mia scusa mai non fosse stata! ché né altri contra me avria fallato, né io sofferto avria pena ingiustamente, pena, dico, d'essilio e di povertate. 4 Poi che fu piacere delli cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno - nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo 10 della vita mia, e nel quale, con buona pace di quella, desidero con tutto lo core di riposare l'animo stancato e terminare lo tempo che m'è dato -, per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contra mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. 5 Veramente io sono stato legno sanza vela e sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertade; e sono apparito alli occhi a molti che forse che per alcuna fama in altra forma m'aveano imaginato: nel conspetto de' quali non solamente mia persona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opera, sì già fatta come quella che fosse a fare. 6 La ragione per che ciò incontra - non pur in me, ma in tutti - brievemente or qui piace toccare: e prima, perché la fama oltre la veritade si sciampia; e poi, perché la presenza oltre la veritade stringe. 7 La fama buona, principalmente [è] generata dalla buona operazione nella mente dell'amico e da quella è prima partorita; ché la mente del nimico, avegna che riceva lo seme, non concepe. 8 Quella mente che prima la partorisce, sì per far più ornato lo suo presente, sì per la caritade dell'amico che lo riceve, non si tiene alli termini del vero ma passa quelli. E quando per ornare ciò che dice li passa, contra conscienza parla; quando inganno di caritade li fa passare, non parla contra essa. 9 La seconda mente che ciò riceve, non solamente alla dilatazione della prima sta contenta, ma 'l suo riportamento, sì come qu[as]i suo effetto, procura d'adornare; e sì, che per questo fare e per lo 'nganno che riceve della caritate in lei generata, quella più ampia fa che a lei non vène, e [con] concordia e con discordia di conscienza come la prima. E questo fa la terza ricevitrice e la quarta, e così in infinito si dilata. 10 E così, volgendo le cagioni sopra dette nelle contrarie, si può vedere la ragione della infamia, che simigliantemente si fa grande. Per che Virgilio dice nel quarto dello Eneida che la Fama vive per essere mobile e acquista grandezza per andare. 11 Apertamente adunque veder può chi vuole che la imagine per sola fama generata sempre è più ampia, quale che essa sia, che non è la cosa imaginata nel vero stato. 11 Domenico Cavalca, Vite de’ Santi padri Vita di S. Eulogio Alessandrino Di Eulogio, lo quale prese a servire un lebbroso molto orribile, e d'una visione di S. Antonio. Un buon uomo d'Alessandria, lo quale avea nome Eulogio, ed era molto savio di Scrittura, acceso di desiderio della vita immortale, dispregiò questa vita mortale e misera, e ritenne alcuna pecunia per avere onde vivere, perocchè non sapeva lavorare, nè fare altro onde vivesse; e dopo alcun tempo, considerando egli ch'e' non era sì perfetto che fosse per lui istare solitario, nè anche era acconcio a stare a obbedienza, sì per la lunga usanza di stare in sua libertà e sì perchè era già antico e non sapeva, nè credeva potere imparare alcun'arte, incominciò molto ad immalinconire, e non sapeva egli stesso quel che si fare. E stando così, avvenne che, passando un giorno per Alessandria, trovò nella piazza giacere un lebbroso sì pieno di lebbra elefantina, che avea già quasi perdute le mani e i piedi, e non gli era rimaso sano altro che la lingua, acciocchè potesse dimandare aiuto da chi passava. Lo quale Eulogio considerando e avendogli compassione, immaginossi di menarlosi a casa e d'averne cura, acciocchè, poichè nè solitario, nè in congregazione gli diceva il cuore di patire, almeno per questo modo servisse a Dio. E incontanente fece quasi un patto con Dio e orò e disse: "Signor mio Iddio, per lo tuo nome voglio ricevere questo così grave e orribile infermo e servirgli insino al dì della sua morte, acciocchè per lui i' truovi misericordia appo te. Piacciati dunque, Messere, di darmi forza e pazienzia in questo servigio". E fatta questa orazione sì s'accostò a quel lebbroso e dissegli: "Vuoi, fratel mio, che io te ne meni a casa mia e servirotti com'io potrò?". La qual cosa egli ricevendo per gran grazia, andò Eulogio per un asino e puoselvi suso e menol losi a casa, e con gran sollecitudine lo serviva procurandogli medici e medicine e bagni e cibi utili, e servendogli con le sue mani; e quegli con gran pazienzia si confortava e Dio e Eulogio ringraziava. Ma dopo quindici anni lo predetto infermo per operazione di demonio incominciò a diventare molto impaziente, e quasi non si ricordasse di tanti servigi e benefici li quali aveva ricevuti da Eulogio, incominciossi a lamentare di lui e dire che si voleva partire e dirgli molta villania; ed Eulogio ad ogni cosa gli rispondeva dolcemente e dicevagli: "Non dire così, fratel mio, ma dimmi, in che io ti ho contristato o fatto difetto, e ammenderommi e farò meglio". Al quale lo lebbroso rispondeva: "Va via, non voglio queste tue lusinghe; riponmi quivi, dove tu mi trovasti; non voglio più tuo servigio". Al quale Eulogio pur rispondendo mansuetamente e lusingandolo si profferiva a farli ciò che addimandasse, purchè egli non si partisse; e quei gli rispuose: "Non posso più patire queste tue lusinghe e questa vita aspra e arida; io voglio della carne". Ed Eulogio con grande umiltà gli apparecchiò della carne e diegliene. E avuta che ebbe la carne, anche incominciò a gridare in furia e dirli: "Per tutto questo non mi puoi satisfare; non mi contento di stare qui solo con teco, ma voglio star fra la gente". E rispondendo Eulogio, che gli menerebbe molti frati che 'l visiterebbero spesso, incominciò quegli più a turbarsi e a dire: "Oimè misero, io non posso patire di vedere la tua faccia, e tu mi vuoi menare alquanti altri simili a te ghiottoni"; e percotendosi come poteva, gridava: "Non voglio, non voglio; io voglio pur uscir fuori e andare fra la gente"; e diceva: "Oimè, che violenzia è questa che tu mi fai? or vuo'mi tenere per forza? va, ponmi ove tu mi trovasti". 12 E, brievemente, sì l'occupò lo nemico, e in tanta impazienzia venne, che si sarebbe impiccato egli stesso, se avesse potuto. La qual cosa vedendo Eulogio e non sapendo che si fare, andò per consiglio a certi santi frati suoi dimestichi e compagni; e consigliandolo quegli che, poichè Santo Antonio era vivo, lo quale aveva lume e spirito di Dio, gliel dovesse menare e dirli per ordine tutto il fatto. Eulogio ricevette il consiglio e mise questo lebbroso in una barchetta, e andossene con lui al diserto; e giunto al luogo dove stavano li discepoli di Santo Antonio, aspettava che Antonio venisse, secondochè era sua usata di venire alcun dì della settimana. E venendo Antonio ai suoi discepoli e trovandovi molti forestieri, fece consolazione con loro e chiamò ciascuno per sè, e a ciascuno rispondeva secondo il suo dimando. E avvegnachè da nullo avesse udito chi fosse Eulogio e non vedendolo, perchè era di notte, conoscendo per ispirito la sua venuta, chiamollo tre volte per nome; al quale Eulogio non rispondendo, immaginandosi che alcuno di quelli suoi discepoli avesse così nome e che lui non chiamasse, Antonio disse: "Te chiamo, Eulogio, lo quale se' venuto d'Alessandria". Al quale Eulogio andando, Santo Antonio lo dimandò perchè era venuto; ed Eulogio rispuose: "Quegli che ti ha revelato il nome mio, credo che ti abbia revelata la cagione della mia venuta". E Antonio disse: "Ben so perchè se' venuto; ma tuttavia voglio che 'l dichi qui innanzi a questi frati". Allora Eulogio disse innanzi a tutti per ordine tutto lo fatto, come s'avea menato a casa quel lebbroso e servitogli, e come egli ora per operazione del nimico era venuto in tanta impazienzia che tutto dì gli diceva villania e volevasi pur partire; onde egli, non sapendo che si fare, aveasi proposto di gittarlo via com'egli voleva, ma dall'altro lato temendo di farlo, era venuto per consiglio a lui e pregavalo che gli piacesse di consigliarlo. Al quale Antonio mostrandosi molto turbato rispuose: "Di', che hai pensato? di gittarlo via? sappi che colui che 'l fece non l'abbandonerà, e se tu il getti, Iddio lo farà ricevere ad uno che fia migliore di te". Dalle quali parole Eulogio impaurito taceva e non sapeva più che si dire. E allora Antonio si rivolse contr'a quello in fermo e mostrandosi molto turbato, con gran voce gridando gli disse: "Lebbroso vilissimo e orribile, che non se' degno nè del cielo, nè della terra, come non fai se non lamentarti in ingiuria di Dio? Or non sai tu che questi che ti serve è in luogo di Cristo? Come se' stato ardito contra Cristo tanto mormorare e dire tanta villania a costui, lo quale per Cristo è diventato tuo servo?". E poi volgendosi agli altri frati che vi erano venuti, a ciascuno rispuose secondochè avea bisogno, e a quello per che venuti erano; e poi anche volgendosi ad Eulogio e a quell'infermo, ammonígli che non si partissero l'uno dall'altro e tornassero a casa e con gran pazienzia e umiltade sì portassero insieme, dicendo loro come erano presso alla morte, e però Iddio aveva permesso che venisse loro quella tentazione per provargli e dare loro la corona; onde disse: "Fate dunque come io v'ho detto e perseverate in pace, acciocchè non perdiate la corona che v'è apparecchiata". E tornati che furono a casa in pace, Eulogio lo quadragesimo dì passò di questa vita in santa pace, e da ivi a tre giorni morì lo predetto infermo con gran pazienzia. Alla morte de' quali trovandosi Cronio prete di Nitria, lo quale era stato alle predette parole che avea loro dette Antonio, maravigliandosi molto, e dinanzi a molti frati ci disse tutto questo fatto e come Santo Antonio avea predetta la loro morte. Disse anche, che in quella medesima notte che Antoniò parlò ad Eulogio, e mandolne a casa con quell'infermo, fra l'altre cose disse, che tutto quell'anno avea pregato Iddio che gli rivelasse i luoghi de' giusti e de' peccatori; e dicea ch'avea veduto per visione un gigante grande da terra infino alle nuvole molto laido e orribile e tenea le mani istese verso il cielo, e ai piedi avea un lago orribile e grande molto, e parvegli che molte anime volassero verso il cielo a modo di uccelli, e quel gigante istendea le mani e prendeane molte e gittava in quel lago. E udì una voce che gli disse: che tutte quell'anime che campavano delle mani di quel gigante, erano giuste che andavansene al cielo; ma quelle ch'egli prendea e gittava in quel lago, erano dannate, com'erano lussuriosi e iracondi che non perdonano mai, e altri peccatori. 13 Francesco Petrarca, Familiarium rerum libri Ed. a cura di V. Rossi - U. Bosco, 4 voll.. Sansoni, Firenze 1933-1942 (rist. 1968). I 1, Ad Socratem suum. [1] Quid vero nunc agimus, frater? Ecce, iam fere omnia tentavimus, et nusquam requies. Quando illam expectamus? ubi eam querimus? Tempora, ut aiunt, inter digitos effluxerunt; spes nostre veteres cum amicis sepulte sunt. [2] Millesimus trecentesimus quadragesimus octavus annus est, qui nos solos atque inopes fecit; neque enim ea nobis abstulit, que Indo aut Caspio Carpathio ve mari restaurari queant: irreparabiles sunt ultime iacture; et quodcunque mors intulit, immedicabile vulnus est. Unum est solamen: sequemur et ipsi quos premisimus. Que quidem expectatio quam brevis futura sit, nescio; hoc scio, quod longa esse non potest. Quantulacunque sane est, non potest esse non molesta. [3] Sed a querelis saltem in principio temperandum est. Tibi, frater, quenam tui cura sit, quid de te ipso cogites, ignoro; ego iam sarcinulas compono, et quod migraturi solent, quid mecum deferam, quid inter amicos partiar, quid ignibus mandem, circumspicio. Nichil enim venale michi est. Sum sane ditior seu, verius, impeditior quam putabam: multa michi scriptorum diversi generis supellex domi est, sparsa quidem et neglecta. Perquisivi situ iam squalentes arculas, et scripturas carie semesas pulverulentus explicui. Importunus michi mus nocuit atque edacissimum tinee vulgus; et palladias res agentem inimica Palladis turbavit aranea. [4] Sed nichil est quod non frangat durus et iugis labor. Confusis itaque circumventus literarum cumulis et informi papiro obsitus, primum quidem cepi impetum cunta flammis exurere et laborem inglorium vitare; deinde, ut cogitationes e cogitationibus erumpunt, ‘Et quid’ inquam, ‘prohibet, velut e specula fessum longo itinere viatorem, in terga respicere et gradatim adolescentie tue curas metientem recognoscere?’ Vicit hec sententia; sicut enim non magnificus, sic non inamenus labor visus est, quid quo tempore cogitassem recordari. [5] Sed temere congesta nullo ordine versanti, mirum dictu quam discolor et quam turbida rerum facies occurreret; ut quedam, non tam specie illorum quam intellectus mei acie mutata, vix ipse cognoscerem; alia vero non sine voluptate quadam retroacti temporis memoriam excitarent. [6] Et erat pars soluto gressu libera, pars frenis homericis astricta, quoniam ysocraticis habenis raro utimur; pars autem, mulcendis vulgi auribus intenta, suis et ipsa legibus utebatur. Quod genus, apud Siculos, ut fama est, non multis ante seculis renatum, brevi per omnem Italiam ac longius manavit, apud Grecorum olim ac Latinorum vetustissimos celebratum; siquidem et Athicos et Romanos vulgares rithmico tantum carmine uti solitos accepimus. [7] Hec itaque variarum rerum tanta colluvio aliquot me diebus occupatum habuit; et licet dulcedine non parva atque amore ad proprias inventiones insito retraherer, vicit tamen caritas maiorum operum, que iam diutius interrupta, non sine expectatione multorum de manibus meis pendent; vicit recordatio vite brevis. Timui, fateor, insidias; quid enim, queso, fugacius vita est, quid morte sequacius? [8] Subiit animum que iecissem fundamenta, quid michi laborum vigiliarumque restaret: temeritas, imo vero insania visa est in tam brevi et incerto tempore tot longos certosque labores amplecti, et vix ad singula suffecturum ingenium in diversa distrahere; presertim cum, ut nosti, labor alius me maneat, tanto preclarior quanto plus solide laudis est in actionibus quam in verbis. [9] Quid multa? incredibilem forte rem audies, veram tamen: mille, vel eo amplius, seu omnis generis sparsa poemata seu familiares epystolas — non quia nichil in eis placuisset, sed quia plus negotii quam voluptatis inerat — Vulcano corrigendas tradidi. Non sine suspirio quidem — quid enim mollitiem fateri pudeat? —; sed occupato animo quamvis acri remedio succurrendum erat, et tanquam in alto pregravata navis, relevanda preciosarum etiam iactu rerum. [10] Ceterum, illis ardentibus, pauca quidem animadverti in angulo iacentia, que vel casu magis quam consilio servata vel pridem a familiaribus transcripta, cunta vincenti senio restiterant. Pauca, dixi; vereor ne lectori multa, scriptori autem longe nimia videantur. His ego indulgentior fui: vivere passus sum, non illorum dignitati, sed labori meo consulens; nichil enim negotii preferebant. [11] Ea vero duorum amicorum libranti ingenia hac lance partiri visum est, ut prosa tibi, carmen Barbato nostro cederet; sic enim et vos olim optare solitos et me pollicitum esse memineram. Itaque cunta passim occursantia uno impetu vastanti et ne his quidem — ut tunc erat animus — parsuro, vestrum alter ad levam, alter ad dextram adesse visus, et apprehensa manu, ne fidem meam et spes vestras uno igne consumerem, familiariter admonere. Hec illis evadendi precipua causa fuit; alioquin, crede michi, cum reliquis arsissent. [12] Hec ergo, que nunc tibi de virili reliquiarum illarum parte obveniunt, qualicunque sunt, non solum equo, quin etiam avido animo perleges. Non audeo illud Apuleii Madaurensis in comune iactare: «Lector, intende: letaberis»; unde enim michi id fidutie, ut lectori delectationem letitiam ve pollicear? [13] Leges tamen ista, mi Socrates, et ut es amantissimus tuorum, fortasse letabere, cuiusque animum probas, delectaberis stilo. Quid enim refert quanta sit forma nonnisi amantis subitura iudicium? supervacuo comitur que iam placet. Siquid hic sane meum placet, non id meum fateor, sed tuum: hoc est, non ingenii mei sed amicitie tue laus est. [14] Nulla hic equidem magna vis dicendi; quippe que nec michi adest, et quam, si plane afforet, stilus iste non recipit; ut quam nec Cicero ipse, in ea facultate prestantissimus, epystolis suis inseruit certe, nec libris in quibus est «equabile» quoddam, ut ipse ait, «et temperatum orationis genus»; eximiam illam vim lucidumque et rapidum et exundans flumen eloquentie in orationibus suis exercuit. Quo genere infinities pro amicis, sepe adversus reipublice suosque hostes usus est Cicero; quo pro aliis sepe, pro se “quater et quadragies” Cato; quod quidem genus inexpertum michi est; [15] nam et a reipublice muneribus abfui et fama mea, tenui murmure forsan interdum et sibilis lacessita clandestinis, nullum hactenus quod ulciscerer vel vitarem, iudiciarium vulnus excepit; et verbalem ferre opem alienis vulneribus non est nostre professionis. Neque enim aut tribunal ambire aut locare linguam didici, adversante penitus et reluctante natura, que me silentii ac solitudinis amatorem fecit, fori hostem, pecunie 14 contemptorem; sed bene habet, quando me eius rei non egentem fecit, cuius forte inopem fecerat si egerem. [16] Omissa illa igitur oratoria dicendi vi, qua nec egeo nec abundo et quam, si exuberet, ubi exerceam non habeo, hoc mediocre domesticum et familiare dicendi genus amice leges, ut reliqua, et boni consules, his quibus in comuni sermone utimur, aptum accomodatumque sententiis. Sed non omnes tales iudices habebo; neque enim aut idem omnes sentiunt aut similiter amant omnes. Quomodo autem omnibus placerem, cui placere paucis semper studium fuit? [17] Triplex est profecto veri iudicii venenum: amor, odium, invidia. Illud autem vide, ne nimium nos amando, vulgare coegeris que melius latuissent; ut enim tibi amor, sic aliis forte aliud officiet. Inter amoris autem et invidie cecitatem, causa quidem plurimum, effectu nichil interest. Odium, quod medio loco numeraveram, nec mereor certe nec metuo. [18] Sed fieri potest ut nugas meas tibi habere, tibi legere nilque in eis aliud quam nostros ac nostrorum casus meminisse cogites; in quo rem michi pergratam feceris; sic enim et petitio tua non neglecta videbitur et fama mea tuta erit. [19] Alioquin, nisi supervacuo nosmet ipsos favore decipimus, quonam modo amicum licet, nisi sit idem alter ego, lecturum hec sine fastidio arbitremur, diversa invicem et adversa, in quibus non idem stilus, non una scribentis intentio, quippe cum pro varietate rerum varie affectus animus illa dictaverit, raro quidem letus, mestus sepe? [20] Epycurus, philosophus vulgo infamis sed maiorum iudicio magnus, epystolas suas duobus aut tribus inscripsit: Ydomeneo, Polieno et Metrodoro; totidem pene suas Cicero: Bruto, Athico et Ciceronibus suis, fratri scilicet ac filio; Seneca perpaucas preterquam Lucilio suo scribit. Promptum opus et felicissimi successus nosse collocutoris sui animum, unius assuevisse ingenio, scire quid illum audire iuvet, quid te loqui deceat. [21] Michi autem sors longe alia; nempe cui usque ad hoc tempus vita pene omnis in peregrinatione transacta est. Ulixeos errores erroribus meis confer: profecto, si nominis et rerum claritas una foret, nec diutius erravit ille nec latius. [22] Ille patrios fines iam senior excessit; cum nichil in ulla etate longum sit, omnia sunt in senectute brevissima. Ego, in exilio genitus, in exilio natus sum, tanto matris labore tantoque discrimine, ut non obstetricum modo sed medicorum iudicio diu exanimis haberetur; ita periclitari cepi antequam nascerer et ad ipsum vite limen auspicio mortis accessi. [23] Meminit haud ignobilis Italie civitas, Aretium, quo pulsus patria pater magna cum bonorum acie confugerat. Inde mense septimo sublatus sum totaque Tuscia circumlatus prevalidi cuiusdam adolescentis dextera; qui — quoniam iuvat laborum discriminumque meorum tecum primitias recordari — linteo obvolutum, nec aliter quam Metabus Camillam, nodoso de stipite pendentem, ne contactu tenerum corpus offenderet, gestabat. Is, in transitu Arni fluminis, lapsu equi effusus, dum honus sibi creditum servare nititur, violento gurgite prope ipse periit. Finis tusci erroris, [24] Pise; unde rursus etatis anno septimo divulsus ac maritimo itinere transvectus in Gallias, hibernis aquilonibus haud procul Massilia naufragium passus, parum abfui quin ab ipso rursus nove vite vestibulo revocarer. [25] Sed quo rapior, oblitus propositi? Inde nimirum usque ad hanc etatem aut nulla prorsus aut rarissima subsistendi respirandique facultas fuit; et quot inter errandum periculorum timorum vespecies pertulerim, preter me unum nemo te melius novit. Que idcirco memorare nunc libuit, ut memineris me inter pericula natum, inter pericula senuisse; si modo iam senui, et non graviora michi in senio reservantur. [26] Hec autem, etsi comunia sint omnibus intrantibus in hanc vitam — neque enim “militia” solum, sed pugna “est vita hominis super terram” — sunt tamen alia alii et longe diversum pugne genus; et quamvis quenque sua pregravent, tamen revera inter eas quibus premimur sarcinas, multum refert. [27] In his ergo vite tempestatibus, ut ad rem redeam, nullo portu anchoram longum in tempus iaciens, quot veros amicos nescio, quorum et iudicium anceps et penuria ingens est, notos autem innumerabiles quesivi. Multis itaque multumque animo et conditione distantibus scribere contigit; tam varie ut ea nunc relegens, interdum pugnantia locutus ipse michi videar. Quod propemodum coactum me fecisse fatebitur quisquis in se simile aliquid expertus est. [28] Prima quidem scribentis cura est, cui scribat attendere; una enim et quid et qualiter ceterasque circumstantias intelliget. Aliter virum fortem, aliter ignavum decet alloqui; aliter iuvenem inexpertum, aliter vite muneribus functum senem; aliter prosperitate tumidum, aliter adversitate contractum; aliter denique studiosum literisque et ingenio clarum, aliter vero non intellecturum siquid altius loquaris. [29] Infinite sunt varietates hominum, nec maior mentium similitudo quam frontium; et sicut non diversorum modo, sed unius stomacum non idem cibus omni tempore delectat, sic idem animus non uno semper nutriendus stilo est; ut geminus sit labor: cogitare quisnam ille sit cui scribere propositum est, qualiter ve tunc affectus, cum ea que scribere instituis lecturus est. [30] Quibus ego difficultatibus multum a me ipso differre compulsus sum; quod ne michi ab iniquis iudicibus vitio verteretur, partim beneficio ignis obtinui, partim tu michi prestiteris, si clanculum suppressoque nomine ista possederis. Que si inter paucos superstites amicos occultare non potes, quoniam linceos oculos habet amicitia nilque amicorum visui impervium est, admone ut siquid horum apud eos substiterit, quamprimum abiciant, nequa in eis rerum aut verborum mutatione turbentur. [31] Ita enim accidit ut qui hec in unam congeriem redigi nunquam aut tibi ut peteres aut michi ut assentirer, venturum in animum suspicabar, laborem fugiens, passim in una dictum epystola in altera repeterem meisque, ut ait Terrentius, pro meis uterer. Novissime, cum multis annis edita et ad diversas mundi plagas ire iussa unum in tempus locumque convenissent, facile deformitas uniti corporis apparuit, que per membra tegebatur, et verbum quod semel in una epystola positum delectabat, in toto opere sepius repetitum fastidio esse cepit: uni itaque relinquendum, de reliquis eradendum fuit.[32] Multa quoque de familiaribus curis, tunc forte dum scriberentur cognitu non indigna, nunc quamvis cupido lectori gravia, detraxi, memor in hoc irrisum a Seneca Ciceronem; quanquam in his epystolis magna ex parte Ciceronis potius quam Senece morem sequar. Seneca enim, quicquid moralitatis in omnibus fere libris suis erat, in epystolis congessit; Cicero autem philosophica in libris agit, familiaria et res novas ac varios illius seculi rumores in epystolis includit. De quibus quid Seneca sentiat, ipse viderit; michi, fateor, peramena lectio est; relaxat enim ab 15 intentione illa rerum difficilium, que perpetua quidem frangit animum, intermissa delectat. [33] Multa igitur hic familiariter ad amicos, inter quos et ad te ipsum, scripta comperies, nunc de publicis privatisque negotiis, nunc de doloribus nostris, que nimis crebra materia est, aut aliis de rebus quas casus obvias fecit. Nichil quasi aliud egi nisi ut animi mei status, vel siquid aliud nossem, notum fieret amicis; probabatur enim michi quod prima ad fratrem epystola Cicero idem ait, esse «epystole proprium, ut is ad quem scribitur de his rebus quas ignorat certior fiat». [34] Atque ea michi tituli fuit occasio; de quo aliquando cogitanti, quamvis epystolarum nomen consentaneum rebus esset, quia tamen et multi veterum eo usi erant et ipse ego varium carmen ad amicos, de quo paulo supra mentio incidit, eodem prenotabam, bis eo uti piguit, novumque ideo placuit nomen, ut Familiarium Rerum Liber diceretur. [35] In quo pauca scilicet admodum exquisite, multa familiariter deque rebus familiaribus scripta erant; etsi interdum, exigente materia, simplex et inelaborata narratio quibusdam interiectis moralibus condiatur; quod et ab ipso Cicerone servatum est. [36] Et hec tam multa quidem de tam parva re loqui, censorum premordacium iubet metus; qui, nichil scribentes quod iudicari queat, de aliorum iudicant ingeniis. Impudentissima temeritas, que solo silentio tuta est: complosis in litore manibus sedenti, facile est ferre quam velit de gubernatoris arte sententiam. [37] Adversus hanc proterviam latebris saltem tuis horridula hec atque improvide nobis elapsa defendito. Illam vero non Phidie Minervam, ut ait Cicero, sed qualemcunque animi mei effigiem atque ingenii simulacrum multo michi studio dedolatum, si unquam supremam illi manum imposuero, cum ad te venerit, secure qualibet in arce constituito. [38] Hec hactenus. Illud libentius, si liceret, silentio tegerem; sed ingens morbus non facile occultatur; erumpit enim et indicio suo proditur. Pudet vite in mollitiem dilapse: ecce enim, quod epystolarum ordo ipse testabitur, primo michi tempore sermo fortis ac sobrius, bene valentis index animi, fuerat, adeo ut non me solum sed sepe alios consolarer; sequentia in dies fragiliora atque humiliora sunt, neque sat virilibus referta querimoniis. Illa precipue ut occultare studeas, precor. [39] Quid enim alii dicerent, cum ipse relegens erubescam? ergo ego in adolescentia vir fuero, ut in senectute puer essem? Infelix et execranda perversitas: fuit animus vel mutare ordinem vel subtrahere tibi penitus ista que damno! Neutro circumveniri posse visus eras, qui et flebilium exempla et omnium cum consule diem tenes. [40] Ad excusationum igitur arma confugio. Lassavit me longo et gravi prelio fortuna. Dum spiritus dumque animus fuit, et ipse restiti et ad resistendum alios cohortatus sum. Ubi hostis viribus atque impetu labare michi pes atque animus cepit, excidit confestim sermo ille magnificus et ad hec que modo displicent, lamenta descendi. [41] Qua in re excuset me forsitan amicorum pietas, quibus salvis ad nullum fortune vulnus ingemui; eisdem mox una pene omnibus ruina obrutis, et mundo insuper moriente, inhumani potius quam fortis visum est non moveri. Ante hoc tempus quis me unquam de exilio, de morbo, de iudicio, de comitiis, de ullis fori turbinibus; quis me de paterna domo, de fortunis perditis, de gloria imminuta, de pecunia dilata, de absentia amicorum, flebiliter agentem audivit? [42] Quibus quidem in molestiis tam molliter agit Cicero, ut quantum stilo delector tantum sepe sententia offendar. Adde litigiosas epystolas et adversus clarissimos atque ab eodem paulo ante laudatissimos viros iurgia ac probra, mira cum animi levitate; quibus legendis delinitus pariter et offensus, temperare michi non potui quominus, ira dictante, sibi tanquam coetaneo amico, familiaritate que michi cum illius ingenio est, quasi temporum oblitus, scriberem et quibus in eo dictis offenderer admonerem. [43] Que michi cogitatio principium fuit ut et Senece tragediam que inscribitur Octavia, post annos relegens parili impetu eidem quoque, ac deinde, varia occurrente materia, Varroni Virgilioque atque aliis scriberem; e quibus aliquas in extrema parte huius operis inserui, que, nisi premonitum, lectorem subita possent admiratione perfundere; quedam in illo publico incendio periere. [44] Talis ille vir tantus in doloribus suis fuit; talis ego in meis fueram. Hodie, ut scias presentem animi mei habitum — neque enim invidiosum fuerit id michi tribuere, quod imperitis evenire ait Seneca —, factus sum ex ipsa desperatione securior. Quid enim metuat, qui totiens cum morte luctatus sit? Una salus victis, nullam sperare salutem. Animosius in dies agere videbis, animosius loqui; et siquid forte stilo dignum se obtulerit, erit stilus ipse nervosior. Multa sane se offerent: scribendi enim michi vivendique unus, ut auguror, finis erit. [45] Sed cum cetera suos fines aut habeant aut sperent, huius operis, quod sparsim sub primum adolescentie tempus inceptum iam etate provectior recolligo et in libri formam redigo, nullum finem amicorum caritas spondet, quibus assidue respondere compellor; neque me unquam hoc tributo multiplex occupationum excusatio liberat. Tum demum et michi immunitatem huius muneris quesitam et huic operi positum finem scito, cum me defunctum et cuntis vite laboribus absolutum noveris. Interea iter inceptum sequar, non prius vie quam lucis exitum operiens; et quietis michi loco fuerit dulcis labor. [46] Ceterum, quod et rethores et bellorum duces solent, infirmioribus in medium coniectis, dabo operam ut sicut prima libri frons, sic extrema acies virilibus sententiis firma sit; velo eo amplius quo vivendo magis ac magis induruisse videor contra impetus atque iniurias fortune. Denique quis inter experimenta rerum sim futurus, profiteri minime ausim; sed hoc animo sum, ut nulli amplius rei succumbam: Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruine. Ita me Maronis Flaccique sententiis armatum scito, quas olim lectas et sepe laudatas, nunc tandem in extremis casibus meas facere ipsa inevitabilis fati necessitate didici. [47] Dulce michi colloquium tecum fuit, cupideque et quasi de industria protractum; vultum enim tuum retulit per tot terras et maria teque michi presentem fecit usque ad vesperam, cum matutino tempore calamum cepissem. Diei iam et epystole finis adest. [48] Hec igitur tibi, frater, diversicoloribus, ut sic dicam, liciis texta dicaverim; ceterum, si stabilis 16 sedes et frustra semper quesitum otium contigerit, quod iam hinc ostendere se incipit, nobiliorem et certe uniformem telam tuo nomine meditor ordiri. Vellem ex his paucis esse, qui famam promittere possunt et prestare; sed ipse vi propria in lucem venies, alis ingenii subvectus nichilque auxilii mei egens. Profecto tamen, si inter tot difficultates assurgere potuero, tu olim Ydomeneus, tu Athicus, tu Lucilius meus eris. Vale. IV 1, Ad Dyonisium de Burgo Sancti Sepulcri ordinis sancti Augustini et sacre pagine professorem, de curis propriis. [1] Altissimum regionis huius montem, quem non immerito Ventosum vocant, hodierno die, sola videndi insignem loci altitudinem cupiditate ductus, ascendi. Multis iter hoc annis in animo fuerat; ab infantia enim his in locis, ut nosti, fato res hominum versante, versatus sum; mons autem hic late undique conspectus, fere semper in oculis est. [2] Cepit impetus tandem aliquando facere quod quotidie faciebam, precipue postquam relegenti pridie res romanas apud Livium forte ille michi locus occurrerat, ubi Philippus Macedonum rex — is qui cum populo Romano bellum gessit — Hemum montem thesalicum conscendit, e cuius vertice duo maria videri, Adriaticum et Euxinum, fame crediderat, vere ne an falso satis comperti nichil habeo, quod et mons a nostro orbe semotus et scriptorum dissensio dubiam rem facit. Ne enim cuntos evolvam, Pomponius Mela cosmographus sic esse nichil hesitans refert; Titus Livius falsam famam opinatur; michi si tam prompta montis illius experientia esset quam huius fuit, diu dubium esse non sinerem. [3] Ceterum, ut illo omisso, ad hunc montem veniam, excusabile visum est in iuvene privato quod in rege sene non carpitur. Sed de sotio cogitanti, mirum dictu, vix amicorum quisquam omni ex parte ydoneus videbatur: adeo etiam inter caros exactissima illa voluntatum omnium morumque concordia rara est. [4] Hic segnior, ille vigilantior; hic tardior, ille celerior; hic mestior, ille letior; denique hic stultior, prudentior ille quam vellem; huius silentium, illius procacitas; huius pondus ac pinguedo, illius macies atque imbecillitas terrebat; huius frigida incuriositas, illius ardens occupatio dehortabatur; que, quanquam gravia, tolerantur domi — “omnia” enim “suffert caritas” et nullum pondus recusat amicitia —; verum hec eadem fiunt in itinere graviora. [5] Itaque delicatus animus honesteque delectationis appetens circumspiciensque librabat singula sine ulla quidem amicitie lesione, tacitusque quicquid proposito itineri previdebat molestum fieri posse, damnabat. Quid putas? tandem ad domestica vertor auxilia, germanoque meo unico, minori natu, quem probe nosti, rem aperio. Nil poterat letius audire, gratulatus quod apud me amici simul ac fratris teneat locum. [6] Statuta die digressi domo, Malausanam venimus ad vesperam; locus est in radicibus montis, versus in boream. Illic unum diem morati, hodie tandem cum singulis famulis montem ascendimus non sine multa difficultate: est enim prerupta et pene inaccessibilis saxose telluris moles; sed bene a poeta dictum est: labor omnia vincit Improbus. Dies longa, blandus aer, animorum vigor, corporum robur ac dexteritas et siqua sunt eiusmodi, euntibus aderant; sola nobis obstabat natura loci. [7] Pastorem exacte etatis inter convexa montis invenimus, qui nos ab ascensu retrahere multis verbis enisus est, dicens se ante annos quinquaginta eodem iuvenilis ardoris impetu supremum in verticem ascendisse, nichilque inde retulisse preter penitentiam et laborem, corpusque et amictum lacerum saxis ac vepribus, nec unquam aut ante illud tempus aut postea auditum apud eos quenquam ausum esse similia. [8] Hec illo vociferante, nobis, ut sunt animi iuvenum monitoribus increduli, crescebat ex prohibitione cupiditas. Itaque senex, ubi animadvertit se nequicquam niti, aliquantulum progressus inter rupes, arduum callem digito nobis ostendit, multa monens multaque iam digressis a tergo ingeminans. Dimisso penes illum siquid vestium aut rei cuiuspiam impedimento esset, soli duntaxat ascensui accingimur alacresque conscendimus. [9] Sed, ut fere fit, ingentem conatum velox fatigatio subsequitur; non procul inde igitur quadam in rupe subsistimus. Inde iterum digressi provehimur, sed lentius: et presertim ego montanum iter gressu iam modestiore carpebam, et frater compendiaria quidem via per ipsius iuga montis ad altiora tendebat; ego mollior ad ima vergebam, revocantique et iter rectius designanti respondebam sperare me alterius lateris faciliorem aditum, nec horrere longiorem viam per quam planius incederem. [10] Hanc excusationem ignavie pretendebam, aliisque iam excelsa tenentibus, per valles errabam, cum nichilo mitior aliunde pateret accessus, sed et via cresceret et inutilis labor ingravesceret. Interea, cum iam tedio confectum perplexi pigeret erroris, penitus alta petere disposui, cumque operientem fratrem et longo refectum accubitu fessus et anxius attigissem, aliquandiu equis passibus incessimus. [11] Vixdum collem illum reliqueramus, et ecce prioris anfractus oblitus, iterum ad inferiora deicior, atque iterum peragratis vallibus dum viarum facilem longitudinem sector, in longam difficultatem incido. Differebam nempe ascendendi molestiam, sed ingenio humano rerum natura non tollitur, nec fieri potest ut corporeum aliquid ad alta descendendo perveniat. Quid multa? non sine fratris risu, hoc indignanti michi ter aut amplius intra paucas horas contigit. [12] Sic sepe delusus quadam in valle consedi. Illic a corporeis ad incorporea volucri cogitatione transiliens, his aut talibus me ipsum compellabam verbis: ‘Quod totiens hodie in ascensu montis huius expertus es, id scito et tibi accidere et multis, accedentibus ad beatam vitam; sed idcirco tam facile ab hominibus non perpendi, quod corporis motus in aperto sunt, animorum vero invisibiles et occulti. [13] Equidem vita, quam beatam dicimus, celso loco sita est; “arcta”, ut aiunt, ad illam ducit “via”. Multi quoque colles intereminent et de virtute in virtutem preclaris gradibus ambulandum est; in summo finis est omnium et vie terminus ad quem peregrinatio nostra disponitur. Eo pervenire volunt omnes, sed, ut ait Naso, Velle parum est; cupias, ut re potiaris, oportet. 17 [14] Tu certe — nisi, ut in multis, in hoc quoque te fallis — non solum vis sed etiam cupis. Quid ergo te retinet? nimirum nichil aliud, nisi per terrenas et infimas voluptates planior et ut prima fronte videtur, expeditior via; veruntamen, ubi multum erraveris, aut sub pondere male dilati laboris ad ipsius te beate vite culmen oportet ascendere aut in convallibus peccatorum tuorum segnem procumbere; et si — quod ominari horreo — ibi te “tenebre et umbra mortis” invenerint, eternam noctem in perpetuis cruciatibus agere’. [15] Hec michi cogitatio incredibile dictu est quantum ad ea que restabant et animum et corpus erexerit. Atque utinam vel sic animo peragam iter illud, cui diebus et noctibus suspiro, sicut, superatis tandem difficultatibus, hodiernum iter corporeis pedibus peregi! Ac nescio annon longe facilius esse debeat quod per ipsum animum agilem et immortalem sine ullo locali motu in ictu trepidantis oculi fieri potest, quam quod successu temporis per moribundi et caduci corporis obsequium ac sub gravi membrorum fasce gerendum est. [16] Collis est omnium supremus, quem silvestres ‘Filiolum’ vocant; cur, ignoro; nisi quod per antifrasim, ut quedam alia, dici suspicor: videtur enim vere pater omnium vicinorum montium. Illius in vertice planities parva est; illic demum fessi conquievimus. Et quoniam audiisti quenam ascendentis in pectus ascenderint cure, audi, pater, et reliqua; et unam, precor, horam tuam relegendis unius diei mei actibus tribue. [17] Primum omnium spiritu quodam aeris insolito et spectaculo liberiore permotus, stupendi similis steti. Respicio: nubes erant sub pedibus; iamque michi minus incredibiles facti sunt Athos et Olimpus, dum quod de illis audieram et legeram, in minoris fame monte conspicio. [18] Dirigo dehinc oculorum radios ad partes italicas, quo magis inclinat animus; Alpes ipse rigentes ac nivose, per quas ferus ille quondam hostis romani nominis transivit, aceto, si fame credimus, saxa perrumpens, iuxta michi vise sunt, cum tamen magno distent intervallo. Suspiravi, fateor, ad italicum aerem animo potius quam oculis apparentem, atque inextimabilis me ardor invasit et amicum et patriam revidendi, ita tamen ut interim in utroque nondum virilis affectus mollitiem increparem, quamvis excusatio utrobique non deforet magnorum testium fulta presidio. [19] Occupavit inde animum nova cogitatio atque a locis traduxit ad tempora. Dicebam enim ad me ipsum: ‘Hodie decimus annus completur, ex quo, puerilibus studiis dimissis, Bononia excessisti; et, o Deus immortalis, o immutabilis Sapientia, quot et quantas morum tuorum mutationes hoc medium tempus vidit! Infinita pretereo; nondum enim in portu sum, ut securus preteritarum meminerim procellarum. [20] Tempus forsan veniet, quando eodem quo gesta sunt ordine universa percurram, prefatus illud Augustini tui: «Recordari volo transactas feditates meas et carnales corruptiones anime mee, non quod eas amem, sed ut amem te, Deus meus». [21] Michi quidem multum adhuc ambigui molestique negotii superest. Quod amare solebam, iam non amo; mentior: amo, sed parcius; iterum ecce mentitus sum: amo, sed verecundius, sed tristius; iantandem verum dixi. Sic est enim; amo, sed quod non amare amem, quod odisse cupiam; amo tamen, sed invitus, sed coactus, sed mestus et lugens. Et in me ipso versiculi illius famosissimi sententiam miser experior: Odero, si potero; si non, invitus amabo. [22] Nondum michi tertius annus effluxit, ex quo voluntas illa perversa et nequam, que me totum habebat et in aula cordis mei sola sine contradictore regnabat, cepit aliam habere rebellem et reluctantem sibi, inter quas iandudum in campis cogitationum mearum de utriusque hominis imperio laboriosissima et anceps etiam nunc pugna conseritur’. Sic per exactum decennium cogitatione volvebar. [23] Hinc iam curas meas in anteriora mittebam, et querebam ex me ipse: ‘Si tibi forte contingeret per alia duo lustra volatilem hanc vitam producere, tantumque pro rata temporis ad virtutem accedere quantum hoc biennio, per congressum nove contra veterem voluntatis, ab obstinatione pristina recessisti, nonne tunc posses, etsi non certus at saltem sperans, quadragesimo etatis anno mortem oppetere et illud residuum vite in senium abeuntis equa mente negligere?’. [24] Hec atque his similes cogitationes in pectore meo recursabant, pater. De provectu meo gaudebam, imperfectum meum flebam et mutabilitatem comunem humanorum actuum miserabar; et quem in locum, quam ob causam venissem, quodammodo videbar oblitus, donec, ut omissis curis, quibus alter locus esset oportunior, respicerem et viderem que visurus adveneram — instare enim tempus abeundi, quod inclinaret iam sol et umbra montis excresceret, admonitus et velut expergefactus —, verto me in tergum, ad occidentem respiciens. [25] Limes ille Galliarum et Hispanie, Pireneus vertex, inde non cernitur, nullius quem sciam obicis interventu, sed sola fragilitate mortalis visus; Lugdunensis autem provincie montes ad dexteram, ad levam vero Massilie fretum et quod Aquas Mortuas verberat, aliquot dierum spatio distantia, preclarissime videbantur; Rodanus ipse sub oculis nostris erat. [26] Que dum mirarer singula et nunc terrenum aliquid saperem, nunc exemplo corporis animum ad altiora subveherem, visum est michi Confessionum Augustini librum, caritatis tue munus, inspicere; quem et conditoris et donatoris in memoriam servo habeoque semper in manibus: pugillare opusculum, perexigui voluminis sed infinite dulcedinis. Aperio, lecturus quicquid occurreret; quid enim nisi pium et devotum posset occurrere? [27] Forte autem decimus illius operis liber oblatus est. Frater expectans per os meum ab Augustino aliquid audire, intentis auribus stabat. Deum testor ipsumque qui aderat, quod ubi primum defixi oculos, scriptum erat: «Et eunt homines admirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus fluminum et occeani ambitum et giros siderum, et relinquunt se ipsos». [28] Obstupui, fateor; audiendique avidum fratrem rogans ne michi molestus esset, librum clausi, iratus michimet quod nunc etiam terrestria mirarer, qui iampridem ab ipsis gentium philosophis discere debuissem «nichil preter animum esse mirabile, cui magno nichil est magnum». [29] Tunc vero montem satis vidisse contentus, in me ipsum interiores oculos reflexi, et ex illa hora non fuit qui me loquentem audiret donec ad ima pervenimus; satis michi taciti negotii verbum illud attulerat. [30] Nec opinari poteram id fortuito contigisse, sed quicquid ibi legeram, michi et non alteri dictum rebar; recolens quod idem de se ipso suspicatus olim esset Augustinus, quando in lectione codicis Apostolici, ut ipse refert, primum sibi illud occurrit: «Non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in contentione 18 et emulatione; sed induite Dominum Iesum Cristum, et carnis providentia ne feceritis in concupiscentiis vestris». [31] Quod iam ante Antonio acciderat, quando audito Evangelio ubi scriptum est: «Si vis perfectus esse, vade et vende omnia tua quecunque habes et da pauperibus, et veni et sequere me et habebis thesaurum in celis», veluti propter se hec esset scriptura recitata, ut scriptor rerum eius Athanasius ait, ad se dominicum traxit imperium. [32] Et sicut Antonius, his auditis, aliud non quesivit, et sicut Augustinus, his lectis, ulterius non processit, sic et michi in paucis verbis que premisi, totius lectionis terminus fuit, in silentio cogitanti quanta mortalibus consilii esset inopia, qui, nobilissima sui parte neglecta, diffundantur in plurima et inanibus spectaculis evanescant, quod intus inveniri poterat, querentes extrinsecus; admirantique nobilitatem animi nostri, nisi sponte degenerans ab originis sue primordiis aberrasset, et que sibi dederat in honorem Deus, ipse in opprobrium convertisset. [33] Quotiens, putas, illo die, rediens et in tergum versus, cacumen montis aspexi! et vix unius cubiti altitudo visa est pre altitudine contemplationis humane, siquis eam non in lutum terrene feditatis immergeret. Illud quoque per singulos passus occurrebat: si tantum sudoris ac laboris, ut corpus celo paululum proximius fieret, subire non piguit, que crux, quis carcer, quis equuleus deberet terrere animum appropinquantem Deo, turgidumque cacumen insolentie et mortalia fata calcantem? [34] et hoc: quotocuique accidet, ut ab hac semita, vel durarum metu rerum vel mollium cupidine, non divertat? O nimium felix! siquis usquam est, de illo sensisse arbitrer poetam: Felix qui potuit rerum cognoscere causas Atque metus omnes et inexorabile fatum Subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari! O quanto studio laborandum esset, non ut altiorem terram, sed ut elatos terrenis impulsibus appetitus sub pedibus haberemus! [35] Hos inter undosi pectoris motus, sine sensu scrupulosi tramitis, ad illud hospitiolum rusticum unde ante lucem moveram, profunda nocte remeavi, et luna pernox gratum obsequium prestabat euntibus. Interim ergo, dum famulos apparande cene studium exercet, solus ego in partem domus abditam perrexi, hec tibi, raptim et ex tempore, scripturus; ne, si distulissem, pro varietate locorum mutatis forsan affectibus, scribendi propositum deferveret. [36] Vide itaque, pater amantissime, quam nichil in me oculis tuis occultum velim, qui tibi nedum universam vitam meam sed cogitatus singulos tam diligenter aperio; pro quibus ora, queso, ut tandiu vagi et instabiles aliquando subsistant, et inutiliter per multa iactati, ad unum, bonum, verum, certum, stabile se convertant. Vale. VI Kal. Maias , Malausane. 19 De remediis utriusque fortune [PETRARQUE, Le remèdes aux deux fortunes, (1354-1366), I. Texte et traduction, texte établi et traduit par C. Carraud; II. Commentaires, notes et index, Préface de G. Tognon, Introduction, notes et index par C. Carraud, Grenoble, Jerôme Millon, 2002] II. Prefatio Ex omnibus que vel michi lecta placuerint vel audita, nichil pene vel insedit altius, vel tenacius inhesit, vel crebrius ad memoriam rediit, quam illud Heracliti: "Omnia secundum litem fieri". Sic est enim, et sic esse propemodum universa testantur. Rapido stelle obviant firmamento; contraria invicem elementa confligunt; terre tremunt; maria fluctuant; aer quatitur; crepant flamme; bellum immortale gerunt venti; tempora temporibus concertant, secum singula, nobiscum omnia: ver humidum, estas arida, mollis autumnus, hiems hispida, et que vicissitudo dicitur, pugna est. Hec ipsa igitur quibus insistimus, quibus circumfovemur et vivimus, que tot illecebris blandiuntur, quanque, si irasci ceperint, sint horrenda, indicant terremotus et concitatissimi turbines, indicant naufragia atque incendia seu celo seu terris sevientia. Quis insultus grandinis, quenam illi vis imbrium, qui fremitus tonitruum, qui fulminis impetus, que rabies procellarum, qui fervor, qui mugitus pelagi, qui torrentium fragor, qui fluminum excursus, qui nubium cursus et recursus et concursus? Mare ipsum, preter apertam ac rapidam vim ventorum atque abditos fluctuum tumores incertis vicibus alternantes, certos statutosque fluxus ac refluxus habet, cum multis in locis, tum conspectius in occasu, que res, dum manifesti motus latens causa queritur, non minorem Philosophorum in scholis, quam fluctuum ipso in pelago, litem movit. Quid, quod nullum animal bellis vacat? Pisces, fere, volucres, serpentes, homines: una species aliam exagitat, nulli omnium quies data. Leo lupum, lupus canem, canis leporem insequitur. Est et canum stirps audentior, non lupis modo resistere, sed leones, pardos, apros, ursos insectari solita atque aggredi. Quorundam vero tam generosa ferocia, et tam nobilis fertur elatio, ut ursos aprosque fastidiant, inque solos elephantes aut leones dignentur irruere; qualem unum Alexandro regi missum, contemptuque tali mali cognito, contemptum occidique iussum legimus, missumque inde alterum probatumque qua decuit, dilectumque regi unice atque in delitiis habitum. Nam ipsius canis erga hominem cui fertur amicissimus quanta sit caritas, nisi quam conciliat spes cibi, preter morsus et latratus implacabiles, non tantum Acteonis fabula, sed discerptus vere probat Euripides. Vulpina fallacia una quidem ex multis audita est: piscatores cum ad urbem pisces deferent, quod estate libenter noctu faciunt, aliquando vulpeculam ceu exanimem calle medio transversam habuisse, quam arreptam decoriaturi ex commodo, cum supra sarcinam proiecissent illam ubi se piscibus affatim implesset subito prosiluisse, mirantibusque illis atque indignantibus effugisse. Iam qui, oro, alii vulpium doli? qui luporum ululatus? quod murmur ad caulas? que corvorum milvorumque circa columbrarum domos ac pullorum nidos vigilantia? quod inter se, ut perhibent naturale atque eternum odium? Alter alterius invadit nidum, effractisque ovis spem prolis interimit: nam cucullo non unus quidem alterque est hostis: omnes fere avicule illi insultant, profugo semper et querulo. Quenam preterea et quales mustellarum contra aspides insidie? quod circa divitum thalamos acumen furum? Quenam, ex diverso, cuiusque pro se suo in genere excubie, quantaque quanque vigil repugnantia est? quis venatorum, quisve aucupum artes ac laqueos, quis piscatorum hamos ac retia, horumque omnium labores vigiliasque explicet? aut hec contra, ferarum, avium, piscium ingenia? que cuncta quid sunt aliud, quam litium instrumenta? Age, quinam asilorum aculei vesparumque, hisque cum pestibus que boum prelia, qui sudores? nec maior canum equorumque aut reliquorum quadrupedum pax quiesve. Que muscarum estiva tedia, que nivium, quas muscas albas ludo dicunt, hiberne molestie? Que soricum perennis inquietudo? que pulicum pernox obsidio? que culicum lis diurna? que anguium ranarumque cum ciconiis? que Pygmeorum bella cum gruibus? quas inter Arimaspos et gryphes pugnas excitat auri sitis? ut quorum maior improbitas haud facile iudicem, nisi quod illi rapinam, hi custodiam moliuntur, illos avaritia stimulat, hos natura. Idem et custodie studium, et prede, distantissimo mundi tractu apud Indos invenio, illic quoque suum aurum, contra parem gentis avaritiam, formicis quibusdam incredibili mole et mira feritate tuentibus. Basiliscus angues reliquos sibilo territat, adventu fugat, visu perimit. Elephantem draco spiris implicat seu perosus (est enim incertum unde nonnullis animantibus inter se naturale odium), seu estate algidum sitiens cruorem, quod et quidam tradidere, et pugne exitus facit ut credi possit, si verum est alterum exanguem exiccatumque emori, alterum vero fusi hostis hausto sanguine, ceu bello victorem, victumque delitiis et nimio potu ruptum commortuumque procumbere. Multa preterea genus hoc, atque in primis acerrimus epote dolor hirundinis et visi vel auditi muris, fastidia offendunt; mirum dictu, tantum animal et tantarum virium, tam pusilli hostis horrere conspectum. Sed sic, sine lite atque offensione nil genuit natura parens. Leo ipse, generosum ac securum animal, pro defensione fetuum ferrum spernens, neu forte visum terreat, nec aspiciens quidem rotarum strepitum vacuos currus agentium, et gallinaceorum cristas (quis non stupeat, si vera fama est), magisque etiam cantus, super omnia vero flammas metuere crepitantes traditur? Ea ergo huic generi lis propria est, preter illam communem feris omnibus venationem. Est et sua lis tigribus rapte prolis, et profugi hostis ludificantis instantem atque ingenio retardantis. Lupo una semper cum fame perpetua rusticisque ac pastoribus lis manet. Venenosa loquor et ferocia. Quenam vero mansuetis gregibus est quies? Quantis nisibus quantisque odiis dentati confligunt sues? Quantis armentorum duces? Quenam inter illos certamina? Quenam fuge? Que victoris insolentia? Qui victi dolor? Que iniuriarum recordatio? qui reditus ad vindictam? Quis non, legendo, perpendit ut poetarum ingenia, et bellaces exercent tauri, et inter se adversis luctantes cornibus hedi? 20 Quid de aliis? lis omnibus una est, nichilque non secundum litem fit. Quando novum ad presepe hospes equus, quando pullus advena quietum cibum inter pares sumpsit? Quis non illud advertit gallinis fetantibus pro imbecilli familia, quantus ardor, impatientia quanta sit, quanquam est id quidem commune omnium? Nullum tam mite animal, quod non amor sobolis ac metus exasperet. Galli se calcaribus impetunt et natura, et cruore rutilas cristas inter vulnera detinent, totis corporibus obnixi; tantum invidie tantumque superbie parvo regnat in pectore, tanta vincendi cupiditas, tantus cedendi pudor est. Anatum atque anserum pertinaciam quis non vidit, ut pectoribus se perurgent, clangoribus increpitant, alis diverberant, rostris herent? Et quidem in ferocibus minus miri usitatum enim et commune est, ut animalia maiora minorum pernicies ac sepulcrum sint. Fera feram, avis avem, piscis piscem, vermem vermis rodit. Quin et litoree volucres, aquaticeque quadrupedes, equor, stagna, lacus et flumina rimantur, exhauriunt, et infestant, ut michi omnium inquietissima pars rerum aqua videatur, et suis motibus et incolarum perpetuis acta tumultibus, quippe que novorum animantium ac monstrorum feracissima esse non ambigitur, usque adeo, ut vulgi opinionem, ne docti quidem respuant omnes prope, quas terra vel aer animantium formas habet, esse in aquis, cum innumerabiles ibi sint, quas et aer et terra non habet; et in his quidem ferme omnibus, preda vel odium litem parit. Quid, quod his cessantibus lis non cessat? Age enim in amore quantus zelus, quanta in coniugio dissonantia, quot querele, quante suspitiones amantium, que suspiria, qui dolores! Quanta non dicam dominorum ac servorum, qui non ideo minus infesti, quia domestici hostes sunt, cum quibus nulla unquam pax speranda, nisi quam vel mors fecerit, vel paupertas; non dicam fratrum, quorum gratiam raram ipsam veritas ore Nasonis testata est; non filiorum in parentes, quod eiusdem poete carmen canit; sed parentum, quorum opinatissimus est amor, quanta indignatio in filios, quos dum bonos cupiunt, malos lugent! Atque ita quodammodo, dum valde diligunt, oderunt, et fraternum quidem paternumque vincli nomen arctissimi, sepe sine amore, interdumque cum odio videmus. Veniam ad amicitie sanctum nomen, quod ab amando dictum, absque amore nec esse certe nec intelligi potest: quanta vero in amicis, quamvis finium concordia, vie tamen actuumque discordia, quanta opinionum atque consiliorum conflictatio est? ut vix Ciceroniana diffinitio stare queat. Sit enim licet inter amicos benivolentia et caritas, deest tamen illa "omnium divinarum humanarumque rerum consensio", ex qua ille diffinitionem conficit: quid in odio speres igitur? Est et in amore odium, et in pace bellum, et in consensione dissensio. Ostendam tibi sic esse, ex his ipsis que assidue in oculis sunt. Feras aspice, quas ferro indomitas, omnipotens amor domat; intende animum: leene, tigres, urse, quanto cum murmure veniunt, ad id quod cupidissime faciunt? non cupidas, sed coactas putes. Ferarum alie, dum coeunt, magnis stridoribus, alie rapidis unguibus inquiete sunt; iam si credimus quod de natura viperea magni scribunt viri, quanta rerum contrarietas, quantumque litigium! Maris caput sua quadam naturali, sed effrenata dulcedine, in os vipere insertum, illa precipiti fervore libidinis amputat; inde, iam pregnans vidua, cum pariendi tempus advenerit, fetu multiplici pregravante, et velut in ultionem patris uno quoque quamprimum erumpere festinante, discerpitur. Ita duo animantium prima vota, proles et coitus, huic generi infausta penitusque mortifera deprehenduntur, dum marem coitus, matrem partus interimit. Apum alvearia contemplare: que illa concursatio, qui strepitus, quenam non modo bella cum proximis, sed civiles, ut ita dixerim, discordie, ac bella domestica! Columbarum nidos intuere: simplicissimum animal, et, ut memorant, felle carens, quantis, queso, cum preliis quantisque clamoribus vitam ducit? Indisciplinatis in castris ac barbaris esse videare, adeo nec luce pacati aliquid, nec nocte quidem videas; mitto autem insultus in alterutrum, ipsum in se vinculo mutue voluptatis astrictum par, eamque ob causam Veneri sacrum, quantis querimoniis ad optatum fertur, ut sepe columbam circumit, sepe alis rostroque persequitur suus amans? Ad minutissima te remittam, que non ut minor, sic et minus spectabilis minusve laboriosa materia est: quenam ergo aranearum insidie et quam vigil intentio? Que captandis infirmioribus telarum scena, qui retium obtentus fallaciis ac rapinis? Quid pannis tinee, quid caries tignis, nocturnique vermiculi non sine tedio, et, obtuso quodam sub strepitu, trabium viscera fodientes, illarum maxime quibus cedendis lune ac mensium observatio diligens sit neglecta? Que latens pestis ut fumosis tectis agrestium, sic auratis regum laquearibus insultat, templis quoque sacratis et altaribus, sacrisque opibus philosophantium non parcit; quin et librorum postes et membranas et literas addam; quod nisi pice liquida, levique incendio sit occursum, nonnunquam periculi vel naufragii etiam causa est, et maria ingredi, et carinas navium terebrare ausa, sepe bellum grave nescientibus intulit. Preterea quid bruchus oleribus, quid segetibus locusta, quid messibus seu anser advena, seu passer indigena, seu grus domicilii translatrix, volucresque alie importunum genus? Unde illud Georgicum Virgilii, quod mirari soleo, iam non miror, ut aves sonitu terreantur. Rure enim nunc Italico habitanti unum hoc ex multis estivis tediis esse cepit, sic michi ad vesperam et insultus volucrum, et lapidum collisio, et villici clamor durat. Ad hec quid ericius vindemie, quid erugo herbis, eruca frondibus, talpa radicibus? quid postremo areis horreisque curculio atque inopi metuens formica senecte ut ait ille? Quis fervor et perexigui animantis inquietudo, ut dum brume sue consulit, nostram turbat estatem? Tardus essem ad credendum aliis; expertus scio, quanto non solum tedio sed et damno sit pulverulentum illud, ac trepida semper expeditione festinum agmen, ut non tantum agros, sed arcas et thalamos et promptuaria populentur. Iam credere incipiam, Pisanis in finibus, castrum quod haud longe a mari navigantibus ostenditur, formicarum scatebris ac diluvio desertum; tale aliquid Vicentinis quoque memorant in finibus, et ego vel utrobique, vel ubique fieri posse crediderim. Sic me nuper non agresti quidem, sed urbana paulominus pepulerunt domo, ut ignis et calcis, ad extremum fuge rerum remedio opus esset; Apuleioque fidem habeam, consumptum ab his hominem, et si desit mel, mirarique me non negem. Quid est, quod quidam sollicitudinis exemplum proposuere formicam, alii de hac longos texuere sermones, parsimoniam atque industriam predicantes? Bene hercle, si omnis sollicitudo laudabilis esset; exemplum fortasse igitur predonibus ydoneum, non his quibus de suo vivere, sine 21 cuiusquam iniuria mens est. At sollicitum animal (quis nescit?), sed improbum, sed iniustum, rapto vivens, nullius industrie, nisi in malum, nullius usus, ac incommodi tediique multiplicis. Cur igitur hoc exemplum dederint, cur hoc animal laudaverint, dico iterum, miror, precipue cum adesset apis industrium providentissimumque animal, nulli noxium, multis utile, sibique et aliis arte quadam naturaliter insita et suo illo nobili labore subveniens. Quid nunc ego damnosam eloquar ubertatem et excrescentium luxuriem foliorum, contra quam pervigil excubat, et pre duris unguibus armatus agricola, et ultrici succinctus falce frondator? quid lappas et tribulos, atque annuam tempestatem renascentium stirpium ac radicum, litium ac laborum materiam immortalem? Quid imbrium bella furentium, et moles nivium, et uredinem pruinarum, et asperitatem et violentiam glaciei, et torrentium repentinos impetus, et vaga fluminum incrementa, totas sepe regiones et magnos populos, sed in primis rusticorum septa quassantium, quorum in tot malis vix terrestris, et in terra, semper acclivis agitur vita? Atque ut delicatorum ac divitum de tediis aliquid dicam, quis nocturna aurium bella non pertulit: bubones strigesque et oblatrantium lune canum supervacuas excubias, et catas in tegulis nundinantes ac tranquilla silentia horrendis occentibus et clamore tartareo infestantes, et mesti soricum occentus, et quicquid inter tenebras importunum strepit? His accedunt et nocturna ranarum coaxatio, et matutini plantus hirundinum ac mine. adesse Itym putes ac Tereum. Nam diurnam aurium quietem et cicade stridule, et procaces corvi, et rudentes impediunt aselli, et balatus pecudum, et mugitus boum, et magno pretio parva ova vendentium gallinarum concentus inconditus fine carens. Super omnia vero vel suillus grunnitus, vel vulgaris clamor, et stultorum risus, quo inepto res ineptior nulla est, ut Catullus ait; et ebriorum cantus ac gaudia, quibus nichil est tristius, et litigantium querele et anile convicium seu garritus; et puerorum nunc prelia, nunc lamenta; et nuptiarum vel convivia turbida, vel choree; et uxorum viros arte lugentium leti fletus, et parentum veri natorum in mortibus eiulatus. Adde his fori turbas ac strepitum, altercationesque mercantium, et ementium hinc contemptus, hinc vendentium iuramenta. Adde hinc artificum laborem voce mulcentium mestos cantus, hinc fidibus lanas ac vellera conglobata pulsantium iniucundam musicam, et telas pectinis pererrantis, hinc follium fabrilium raucos flatus, et acutos sonitus malleorum, quibus scissa equis partibus hiberna nox additur, ut nullum vel quieti datum tempus, litibus sit immune. Ut vero insensibilium rerum genus attingam, quid vel cum ferro magnes habet, vel cum magnete adamas? quorum etsi causa litis occultior, lis aperta est. Magnes si quidem ferrum trahit; adhibe adamantem: trahere desinet remittetque si traxerit; utrobique vis mirabilis, seu quod pigro et informi lapidi natura quasi manus atque uncos dederit adversus rigidum ac prevalidum metallum, seu quod illos, sibi de lapide altero astante, subripuerit; que non prime litis finis, sed nova lis est, etsi hoc ultimum multi negent. Michi enim experiendi hactenus vel occasio defuit vel voluntas, itaque nichil affirmo: primum vero notum adeo, ut ne affirmari quidem sit necesse. Verum ego, brevi nimis in tempore et angusto in spatio opus ingens magno impetu aggressus, iam hinc video, ad hanc rem plus michi animi esse, quam virium: nec michi nec cuiquam sane, unum hoc agenti ex commodo, facile futurum singula prosequi, ex quibus appareat "omnia secundum litem fieri"; que seu magna, seu parva, magno miraculo fiant licet, nondum tamen illud maximum stupendumque inter summa et extrema nature prodigia numeratum attigi; sed attingam paucis. Echinus, semipedalis pisciculus, navim quamvis immensam ventis, undis, remis, velis actam, retinet solus, elementorum atque hominum vim retundens, nullo quidem actu alio, quam navigii postibus adherendo, nullo demum conamine, sed natura ipsa; quod etsi scriptis illustribus insitum, e numero tamen incredibilium haberetur, si de occeano Indico fortassis aut Scythico scriptum esset, et non potius in nostro mari monstrum hoc Romanis imperatoribus accidisset: Animadversa enim more causa, quod, tota classe prodeunte, navis una velut in anchoris staret, neque prorsus loco moveretur, dimissis pelagi expertis, manu, ut dicitur, comperta veritas et, limacis instar, piscis clavo insidens inventus atque ostensus est principi indignanti, tantum in se potuisse tantillum animal, idque unum precipuum admiranti, quod in navigium receptus, tantam illam exterius inherendi efficaciam amisisset. Nam illud alterum monstri genus, non siluisse equidem quam affirmasse maluerim, cuius apud nos nescio quam verax, sed nova utique et ob id ipsum suspecta michi est fama. Esse circa mare Indicum inaudite magnitudinis avem quandam, quam "rochum" nostri vocant, que non modo singulos homines, sed tota insuper rostro prehensa navigia secum tollat in nubila, et pendentes in aere miseros navigantes, advolatu ipso terribilem mortem ferat. Quanta vero vis avaritie est, que neque aliis multis, neque hoc uno tam immani periculo a navigatione deterritos, sequaces suos prede avidos predam facit? Iam vero ut de invisibilibus aliquid ad inceptum traham, quanta commixtione contrariorum fit votiva temperies? inter quas contrarietates adversantium extremorum ad medium virtutis; per quas differentias quantamque discordiam vocum ad musicam concordiam pervenitur? denique quecunque sunt excute, et percurre animo celum, terras, maria: eque in summo ethere et in fundo pelagi, inque imis terre certatur hiatibus, eque in silvis et in agris, eque in desertis arenarum et in plateis urbium lis eterna est. Ne enim varietate rerum ab incepto deviem, taceo quod iam inde, ab ipso mundi primordio, inter ethereos spiritus, in ipsa celi arce pugnatum est, hodieque in hoc tractu caliginosi aeris pugnari creditur. Taceo quod, in illo celesti congressu, victi angeli, victoribusque iam suis facti impares, dum in nos mortales terre accolas ulcisci student, immortale nobis bellum tentationum variarum durumque negotium atque ambiguum peperere. Taceo quod, ut omnia (et que sensu carent, et que sentiunt) in unum cogam, a supremo celi vertice, ut dixi, usque ad infimum terre centrum, et a principe angelo, usque ad minimum et extremum vermem, iugis et implacabilis pugna est. Homo ipse, terrestrium dux et rector animantium, qui rationis gubernaculo solus hoc iter vite et hoc mare tumidum turbidumque tranquille agere posse videretur, quam continua lite agitur, non modo cum aliis, sed secum! De quo mox dicam. Nunc de primo agendum, si quidem nichil mali est quod non homo in hominem machinetur, ut cetera hominum mala undecunque venientia seu a natura, seu a fortuna, huic una collata, levia quedam 22 incommoda videantur; id enim vero, si ad plenum aperire voluero, id quod nolim, quodque a proposito longe est, et omnis humanorum actuum scena retegenda, et omnis evi historia retexenda erit. Hoc unum dixisse satis sit, quia si nulla unquam alia quam Romanorum bella toto fuissent orbe terrarum, abunde bellorum esset et litium. Adde sententiarum dissonantiam, et inenodabiles rerum nodos. Quis sectarum varietates, aut philosophorum bella dinumeret? Populorum et regum prelia quievere, Philosophi non quiescunt; et pugnant illi de eo, quod cum huius esse ceperit, esse desinit illius; hi de veritate litigant, que una simul omnium esse potest, neque hanc litem aut quesite veritatis splendor, aut Academicus unquam valuit finire Carneades, philosophice sequester pacis anxius sed irritus, ut non ineleganter michi quidem lusisse videatur Anneus Seneca, ubi horologia Philosophis confert, quod scilicet par utrisque discordia est. Idque quam verum sit, quisquis et Philosophis animum et horologiis aurem dedit, intelligere potuit. Nec vero aliorum doctrina tranquillior: que grammaticorum adhuc sub iudice lis existens? qui conflictos rethorum, que dialecticorum altercationes? Que denique artium omnium discordie? qui clamores? Inter Causidicos quam bene conveniat ipsarum causarum immortalitas probat! De concordia medicorum testimonium sit egrorum: vitam certe quam brevem dixere, sepe suis litibus fecere brevissimam. Quanta est preterea de sacris et de religione difformitas animorum, non tam literatorum verbis hominum, quam populorum armis, et campo sepius commissa quam schole; ita cum una sit veritas, unumque sit in rebus verum, cui, ut ait Aristoteles, omnia consonant, de hoc ipso tam dissone pugnantesque sententie, ipsos veri agitant professores. Quid de communi vita deque actibus mortalium loquar? Vix duos in magna urbe concordes, cum multa, tum maxima edificiorum habituumque varietas arguit. Nam quis unquam tam locupletis delicatique patris familias nactus est domum, ut non ibi multa mutaverit, ut quod uni studium fuit extruere, alteri sit voluptas evertere? Testantur mutate sepius fenestre, obstrusa ostia, passimque vetustis in parietibus nove indicant cicatrices. Neque in alienis id tantum, sed in nostris patimur, sua dum cuiusque sententia secum pugnans; quod ait Flaccus: diruit, edificat, mutat quadrata rotundis, quo luce clarius fiat quis nostrum quisque cum aliis, quisve secum sit. Iam qui vestium modus, quive habitus triduum totum nostris durat in urbibus? Que municipiorum scita non, ut longeva essent, cum suis latoribus desierunt? Ad hec, quenam ducum in ordinanda acie, quenam magistratuum in ferendis legibus, quenam nautarum in capiendo consilio disparitas, queve discordia est? Didici hoc ego ultimum magnis sepe periculis meis, dum, mari celoque mortem minantibus, nocte simul ac nubibus cuncta terrarum ac stellarum signa tegentibus, puppe iam fatiscente et semioppleta fluctibus, naute de summa rerum, media in morte, contrariis studiis atque opinionibus obstinatissime litigarent! Adde in quibus sine adversario lis est. Que scriptorum prelia cum membranis, cum atramento, cum calamis, cum papyro? Que fabrorum cum malleis, cum forcipibus, cum incude? Que aratorum cum stiva, cum vomere, ipsisque cum glebis et cum bobus? Que militum, non dico cum hoste, sed cum equis atque armis propriis, dum et illi rebellant, et hec pregravant aut comprimunt? Quid dictantibus scribentibusque negotii est, dum hos in expletum loqui multa cogit intentio, illos vel expleta percipere vetat, hinc inscitia, hinc volatilis et inconstans animus, semperque aliud cogitans quam quod agit? Sed quid singillatim ago? Nulla mechanicarum difficultatibus suis vacat. Relique vero, ut quiddam note dulcedinis, sic latentis amaritudinis multum habent, nilque eorum etiam que delectant sine lite agitur. Iam que infantium bella cum lapsibus? Que puerorum rixa cum literis, amarissime serentium, quod predulciter metant? Quenam insuper adolescentium lis cum voluptatibus, dicam verius, immo quanta secum lis affectuumque collisio? cum voluptatibus enim nulla lis penitus, sed consensus est, omni lite funestior. Credo, expertus, nulli hominum generi, nulli etati plus litigii esse, plus inextricabilis laboriosique negotii, nullos hominum tam letos videri, nullos esse tam miseros aut tam mestos. Postremo quenam feminis puerperii difficultas, quantumque discrimen? Quenam viris cum paupertate atque ambitione luctamina? Quanta vite plura quam expedit satagentis anxietas? Quod denique illud senum cum etate ac morbis propinquante morte? Quod omnium ipsa cum morte, quodque est morte molestius, cum perpetuo mortis terrore certamen? Possem hunc sermonem mille rerum argumentis extendere; sed si ut libro superiore voluisti, sic epystolam quoque hanc, prologi locum obtinere et libri huius partem esse volueris, iam hinc video, quantum hec ipsa prefatio libri modum excedat, itaque frenanda curiositas, et cohibendus est stilus. Ad summam ergo, omnia, sed in primis omnis hominum vita, lis quedam est. Verum hac externa lite interim omissa, de qua paulo ante diximus (et que minor utinam, et ob id minus omnibus nota esset), lis interior quanta est? Neque enim solum contra aliam, sed contra suam, ut dixi, speciem, neque contra aliud individuum, sed contra semetipsum. Idque et in superficie ista corporea, que nostri pars vilissima atque ultima est, et in intimis anime penetrabilibus: quisque secum assidue bellum habet. Nam et corpus hoc, quam contrariis estuet ac turbetur humoribus, ab his quos Physicos dicunt, quere! Animus quam diversis quanque adversis secum pugnet affectibus, unusquisque non alium quam sese interroget, sibique respondeat, quam vario quanque reciproco mentis impulsu, modo huc rapitur, modo illuc, nusquam totus, nusquam unus, secum ipse dissentiens, se discerpens. Nam ut sileam reliquos motus, velle, nolle, amare, odisse, blandiri, minari, irridere, fallere, fingere, iocari, flere, misereri, parcere, irasci, placari, labi, deici, attolli, titubare, subsistere, progredi, retroverti, inchoari, desinere, dubitare, errare, falli, nescire, discere, oblivisci, meminisse, invidere, contemnere, mirari, fastidire, despicere simulque suspicere et que sunt eiusmodi, quibus utique nichil incertius fingi potest, quibusve sine ulla requie ab ingressu usque ad exitum fluctuat vita mortalis. Quenam tandem, illa passionum quattuor tempestas ac rabies, Sperare seu Cupere et Gaudere, Metuere et Dolere, que rerum inter scopulos, procul a portu miserum alternis flatibus animum 23 exagitant? Quas alii fortasse, immo certe, aliter sub uno ne integro quidem versiculo et, ut Augustino placet, notissima veritate Virgilius strinxit, de quibus ad utranque partem, et plura quidem et pauciora dici posse scio. Verum ego nec brevitati admodum studui, nec copie, sed que de communi vita hominum, quo se obtulerunt ordine, scriptis inserui, ne legentem vel inopia vel fastidio fatigarem. Neque vero te moveat fortune nomen, non tantum in ipsis inscriptionibus sed opere repetitum: sepe quidem ex me quid de fortuna sentiam audisti, sed cum his maxime qui doctrina minus fulti essent hec necessaria previderem, noto illis et communi vocabulo usus sum, non inscius, quid de hac re late alii, brevissimeque Hieronymus ubi ait: "Nec fatum nec fortuna". Communis ergo acies suum hic loquendi morem recognoscet. Docti autem, qui perrari sunt, quid intendam scient, nec vulgari cognomine turbabuntur. Bipartiti sane operis passionum ac fortune, de parte altera que visa sunt diximus, de altera que dehinc visa fuerint, dicemus. [...] II 67, de exilio D. Exilio pellor iniusto. R. Quid tu igitur? Iusto pelli malles exilio? Nempe quod ad iniurie cumulum, animum in diversum trahit? Habes enim iniusti exilii solatium, comitem iustitiam, que, iniustos cives destituens, te secuta, tecum exulat. D. Iniusto exilio pulsus sum. R. An te rex expulit, an tyrannus, an populus, an hostis, an tu ipse? Nam si rex, aut iniustum exilium non erit, aut ipse non iustus, atque ita nec rex quidem. Si tyrannus, ab illo te pulsum gaude, sub quo boni exulant, fures imperant. Si populus, moribus ille suis utitur: bonos odit; et is quoque multiceps tyrannus nunquam sui similem pepulisset. Non te igitur patria, sed malorum cetibus arceri, neque in exilium, sed in partem bonorum civium cogi putes. At si hostis, agnosce iniurie levitatem, non hostiliter sevit, qui omnia cum posset, patriam abstulit, spem reliquit. Sin tu ipse, mores populi perosus aut Tyranni habitum, elegisti, non modo ne doleas, sed etiam gloriare virtutem patrie pretulisse, non tu flebilem sed honestam et prorsus invidiosam bonis atque optabilem, non iam exilii, sed absentie causam habes. Sponte Pythagoras Samon liquit, Athenas Solon, Lycurgus Lacedemona, Romam Scipio. D. Exilio damnatus sum. R. Multos exilium honestavit, multos acrior aliqua fortune vis atque iniuria notos reddidit et illustres. Quid te vetat illis inseri, qui, quasi ignem de silice, claram famam collisionibus quesiere? D. In exilium agor. R. Habes in historiis magnos rei huius socios, quorum speciosissimus comitatus, non sensum modo doloris imminuat, sed oblivionem afferat. Non minor in exilio Camillus fuit, quam fuisset domi: quantus civis, quantus exul, qui victorias ac triumphos, non iustitia minus quam prosperitate conspicuos, in Capitolium duxit! Mox, hinc pulsus, pro accepta iniuria, ingrate salutem patrie rependit. Non facile aliud tam clari exulis exemplo fateor: sed Rutilius et Metellus tam nil exilium fracti sunt, ut Rutilius revocatus ab illo, cuius nutu non parere capitale erat, exilium amplexus, reditum contempserit, seu ne ulla in parte Senatui iniustisque licet legibus patrie obstaret, seu ne forte exul iterum fieri posset? At Metellus eodem quo in exilio profectus erat vultu atque animo remearet. His Marcellus accedat: hic ultimus, qui in belli civilis tempus incidit, pulsus nempe, non solitam modo constantiam honestarumque artium studium non omisit, sed strinxit arctius, et publicis liber curis, uni excolendo animo tam ardenter incubuit, ut ad scholas missus honestissimas, non ad exilium videretur. Quod quidem, in Cicerone, conspectius operum splendor et literarum copia maior facit, non exilii modo sed carceris dulce solatium. D. Exilium patior. R. Exilium breve cito te patrie tue reddet, longum vero aliam tibi patriam dabit, unde exulent qui te exulem voluere, dedissetque nunc, si ad naturam rerum non ad opiniones hominum aspiceres: valde enim angustus est animus, qui sic ad unum terre angulum se applicat, ut, quicquid extra sit, exilium putet. Multum abest exilii deplorator ab illa animi magnitudine, cui totus orbis carcer exiguus videtur. Interrogatus Socrates cuias esset, "Mundanus, inquit, sum". Vere Socraticum responsum; Atheniensem se alius respondisset: Socrati autem patria omnium mundus erat, non hic solum, quem vulgo mundum dicitis, cum pars ultima mundi sit, sed celum ipsum, quod hac rectius appellatione comprehenditur. Illi patrie destinati estis, ad quam sin suspirat animus, qualibet in parte terrarum peregrinum atque exulem se noverit. Nam quis patriam vocet, ubi non habitet nisi ad breve tempus? Illa vere cuiusque patria dicenda est, ubi quisque perpetuo securus ac tranquillus deget. Quere hanc? in terris, puto, irrita erit inquisitio. Ut nature autem lex est data mortalibus ac prescripti fines, dum hic vivitur, terra omnis patria vestra est; intra quam, qui se exulem facit, non tam rei, quam animi vitio laborat. "Non habemus hic manentem civitatem", dixit Paulus. Inquit Naso: Omne solum forti patria est. Ait Statius: Omni homini natale solum. His te vocibus armatum velim, quibus ubique unus, et vel numquam vel semper in patria tua sis. D. Ire in exilium iubeor. R. I sponte: peregrinatio erit non exilium. Et memento quibusdam exitum, quibusdam vero reditum pro exilio fore. Sunt quibus nusquam peius quam in patria sua sit. D. In exilium cogor. 24 R. Cupiendo quod cogeris, efficies ne cogaris. Omne violentum patientia vincitur, et desinet esse violentum quod volenti fit. D. Ire in exilium est necesse. R. Tu fac volens, quod vel nolens faceres; fac letus omnia, ne quid mestus patiaris: ita omnem vim necessitatis, omnes clavos quos adamantinos illi tribuunt, catenasque, omne tedium molestiamque discusseris. Sed vos impossibilia cupitis, necessaria fugitis, utrunque nequicquam. D. In exilium eo. R. Immo forsan in requiem: sub obtentu false miserie vera felicitas. Iam saltem ab invidia tutus eris: propera, mixtamque cum gloria securitatem arripe. Tutis et honestis latebris nil est dulcius: nulle his conferri possunt urbium platee. D. Pellor e patria. R. Pulsum te pessimis, optimis insere, neque te patria, sed patriam te indignam rebus proba. Sentiat illa quid perdidit, tu nil perdidisse te sentias. Mali cives tui tedio simulque presentis odio ac suspitione careant, boni autem amore absentis ac desiderio teneantur, sequanturque oculis atque animis abeuntem. Illi se solos linqui doleant, tu te comitatum gaudeas proficisci, neque te in tergum respicias, neque reditum cogites, neque cum illis esse cupias, qui te cupiunt abesse: neque demum quod a te fieri debuit, ab alio factum egre feras. Debuisti cedere civium invidie, utque illam fugeres, ultro in exilium ire. Huius ero consilii dux eram. Nec exempli duces deerant clarissimi: nam in primis tres magnos Scipiadas id fecisse noveras, tamque perseveranter, ut patriam sua presentia, qua nil clarius habebat, spoliatam indignam quoque cineribus defunctorum, quidam insuper, famoso dignam epigrammate iudicarent. Nomina sunt immortali memoria, que tibi per famam perque omnis historie fidem ignota esse non poterant: Africanus, Nasica, Lentulus. D. Mittor in exilium. R. Immo in experimentum tui: videris quem tu in exilio prebeas; si succumbis exul verus, si consistis exilio clarus, ut multi olim qui invicti et fulgidi per asperitates incesserunt, ut sequentibus rectum iter ostenderent. Sine tyrannos sevire, sine populum furere, sine hostes ac fortunam fremere: pelli potes, capi, cedi, perimi, vinci autem, nisi manum extuleris, non potes, neque ornamentis tuis spoliari, cum quibus, quocunque ieris, et civis et patrie principum unus eris. D. Exulatum pergo. R. Perge alacer, i securus: nescis quam longa sint brachia tui regis. Nil illi longe est, ubique te proteget qui protexit in patria. 25 Giovanni Boccaccio, Elegia di Madonna Fiammetta [Ed. a cura di C. Delcorno, in Tutte le opere, a cura di V. Branca, Milano, Mondadori, 1994] Prologo Suole a' miseri crescere di dolersi vaghezza, quando di sé discernono o sentono compassione in alcuno. Adunque, acciò che in me, volonterosa più che altra a dolermi, di ciò per lunga usanza non menomi la cagione, ma s'avanzi, mi piace, o nobili donne, ne' cuori delle quali amore più che nel mio forse felicemente dimora, narrando i casi miei, di farvi, s'io posso, pietose. Né m'è cura perché il mio parlare agli uomini non pervenga; anzi, in quanto io posso, del tutto il niego loro, però che sì miseramente in me l'acerbità d'alcuno si discopre, che gli altri simili imaginando, più tosto schernevole riso che pietosa lagrima ne vedrei. Voi sole, le quali io per me medesima conosco pieghevoli e agl'infortunii pie, priego che leggiate: voi, leggendo, non troverrete favole greche ornate di molte bugie né troiane battaglie sozze per molto sangue, ma amorose, stimolate da molti disiri; nelle quali davanti agli occhi vostri appariranno le misere lagrime, gl'impetuosi sospiri, le dolenti voci e i tempestosi pensieri, li quali, con istimolo continuo molestandomi, insieme il cibo, il sonno, i lieti tempi e l'amata bellezza hanno da me tolta via. Le quali cose, se con quel cuore che sogliono essere le donne vedrete, ciascuna per sé e tutte insieme adunate, son certa che i dilicati visi con lagrime bagnerete, le quali a me, che altro non cerco, di dolore perpetuo fieno cagione. Priegovi che d'averle non rifiutiate, pensando che, sì come i miei, così poco sono stabili i vostri casi, li quali se a' miei simili ritornassero, il che cessilo Iddio, care vi sarebbono rendendolevi. E acciò che il tempo più nel parlare che nel piagnere non trascorra, brievemente allo impromesso mi sforzerò di venire, da' miei amori più felici che stabili cominciando, acciò che da quella felicità allo stato presente argomento prendendo, me più ch'altra conosciate infelice; e quindi a' casi infelici, ond'io con ragione piango, con lagrimevole stilo seguirò com'io posso. Ma primieramente, se de' miseri sono i prieghi ascoltati, aflitta sì come io sono, bagnata dalle mie lagrime, priego, se alcuna deità è nel cielo, la cui santa mente per me sia da pietà tocca, che la dolente memoria aiuti, e sostenga la tremante mano alla presente opera; e così le facciano possenti, che quali nella mente io ho sentite e sento l'angoscie, cotali l'una proferi le parole, l'altra, più a tale oficio volonterosa che forte, le scriva. Capitolo secondo nel quale madonna Fiammetta discrive la cagione del dipartire del suo amante da lei, e la partita di lui, e il dolore a lei seguìtone nel partire. [1] Mentre che io, o carissime donne, in così lieta e graziosa vita, come di sopra è discritta, menava i giorni miei, poco alle cose future pensando, la nemica Fortuna a me di nascoso temperava i suoi veleni, e me con animosità continua, non conoscendolo io, seguitava. Né bastandole d'avermi, di donna di me medesima, fatta serva d'Amore, veggendo che dilettevole già m'era cotale servire, con più pugnente ortica s'ingegnò d'afliggere l'anima mia. E venuto il tempo da lei aspettato, m'apparecchiò, sì come appresso vedrete, i suoi assenzii, i quali a me, mal mio grado, convenuti gustare, la mia allegrezza in tristizia, e il dolce riso in amaro pianto mutarono. Le quali cose, non che sostenendole, ma pure pensando il doverle altrui scrivendo mostrare, tanta di me stessa compassione m'assalisce che, quasi ogni forza togliendomi, e infinite lagrime agli occhi recandomi, appena il mio proposito lascia ad effetto perducere; il quale, quantunque male io possa, pure m'ingegnerò di fornire. [2] Noi, egli e io, come caso venne, essendo il tempo per piove e per freddo noioso, nella mia camera, menando la tacita notte le sue più lunghe dimore, riposando nel ricchissimo letto insieme dimoravamo; e già Venere, molto da noi faticata, quasi vinta ci dava luogo, e uno lume grandissimo, in una parte della camera acceso, gli occhi suoi della mia bellezza faceva lieti, e i miei similemente faceva della sua. Li quali, mentre che di quella, parlando io cose varie, essi soperchia beveano, quasi d'essa inebriata la luce loro, non so come per piccolo spazio da ingannevole sonno vinti, toltemi le parole, stettero chiusi. Il quale così soave da me passando com'era entrato, del caro amante ramarichevoli mormorii sentirono i miei orecchi; e sùbito della sua sanità in varii pensieri messa, volli dire: “Che ti senti? ”. Ma vinta da nuovo consiglio mi tacqui, e con occhio acutissimo, e con orecchia sottile, lui nell'altra parte del nostro letto rivolto, cautamente mirandolo, per alcuno spazio l'ascoltai. Ma nulla delle sue voci presero gli orecchi miei, bene che lui, in singhiozzi di gravissimo pianto affannato, e il viso parimente e il petto bagnato di lagrime conoscessi. Oimè! quali voci mi sarieno sofficienti ad espriemere quale in tale aspetto, la cagione ignorando, l'anima mia divenisse mirandolo? E' mi corsero mille pensieri per la mente in un momento, e quasi tutti terminavano in uno: cioè che egli, amando altra donna, contra voglia dimorasse in tal modo. Le mie parole furono più volte infino alle labbra per dimandarlo qual fosse la sua noia; ma dubitando che vergogna non gli porgesse l'essere da me trovato piagnendo, si ritraevano indietro; e similemente trassi gli occhi più volte da riguardarlo, acciò che le calde lagrime cadenti da quelli, venendo sopra di lui, non gli dessero materia di sentire che egli fosse da me veduto. Oh quanti modi, impaziente, pensai da operare acciò che egli desta mi sentisse non averlo sentito, e a niuno m'accordava! Ma ultimamente, vinta dal disio di sapere la cagione del suo pianto, acciò che egli a me si volgesse, quali coloro che ne' sogni, o da caduta o da bestia crudele o da altro spaventati, subitamente pavidi si riscuotono, il sogno e il sonno ad una ora rompendo, cotale sùbita con voce pavida mi riscossi, l'uno de' miei bracci gittando sopra i suoi omeri. E certo lo 'nganno ebbe luogo, però che egli, lasciando le lagrime, con infinta letizia sùbito a me si volse, e disse con voce pietosa: — O anima mia bella che temesti? — Al quale io, sanza intervallo risposi: 26 — Parevami ch'io ti perdessi. — Oimè! che le mie parole, non so da che spirito pinte fuori, furono del futuro e agurio e verissime anunziatrici, come ora veggo. Ma egli rispose: — O carissima giovane, morte, non altri, potrà che tu mi perda operare. — E queste parole seguì sanza mezzo un gran sospiro, del quale non fu sì tosto da me, che de' primi pianti disiderava sapere, la cagione dimandata, che l'abondanti lagrime da' suoi occhi, come da due fontane, cominciarono a scaturire, e il male rasciutto petto di lui a bagnare con maggiore abondanza; e me in grave doglia e già lagrimante tenne per lungo spazio sospesa, sì lo 'mpediva il singhiozzo del pianto, anzi che alle mie molte dimande potesse rispondere. Ma poi che libero alquanto dall'impeto si sentio, con voce spesso rotta dal pianto così mi rispose: [3] — O a me carissima donna, e da me amata sopra tutte le cose, sì come gli effetti aperto ti possono mostrare, se i miei pianti meritano fede alcuna, credere puoi non sanza cagione amara con tanta abondanza spandono lagrime gli occhi miei, qualora nella memoria mi torna quello che ora, in tanta gioia con teco stando, mi vi tornò: e cioè solamente il pensare che di me due fare non posso, com'io vorrei, acciò che ad Amore e alla debita pietà ad una ora satisfare potessi, qui dimorando e là, dove necessità strettissima mi tira per forza, andando. Dunque non potendosi, in afflizione gravissima il mio cuore misero ne dimora, sì come colui che, da una parte traendo pietà, è fuori delle tue braccia tirato, e dall'altra in quelle con somma forza da Amore ritenuto. — Queste parole m'entrarono nel misero cuore con amaritudine mai non sentita, e ancora che bene non fossero prese dallo 'ntelletto, nondimeno quante più di quelle riceveano gli orecchi attenti a' danni loro, tante più, in lagrime convertendosi, n'uscivano per gli occhi, lasciando nel cuore il loro effetto nemico. Questa fu la prima ora, che io sentii dolori al mio piacere più nimichevoli; questa fu quell'ora, che sanza modo lagrime mi fe' spandere, mai prima da me simili non sparte; le quali niuna sua parola né conforto, di che assai era fornito, poteva ristrignere. Ma poi che per lungo spazio ebbi pianto amaramente, quanto potei il pregai ancora che più chiara qual pietà il traeva delle mie braccia mi dimostrasse; ond'egli, non ristando però di piagnere, così mi disse: […] Se alcuna di voi fu mai, o donne, a cui io parlo, alla quale, ferventemente amando, tale caso adivenisse, colei sola spero che possa conoscere quale allora fosse la mia tristizia; a l'altre non curo di dimostrarlo, però che così come ogni altro essemplo che il detto, così ogni parlare ci sarebbe scarso. Io dico sommariamente che, udendo io queste parole, l'anima mia cercò di fuggire da me, e sanza dubbio credo fuggita sariesi, se non che sé di colui nelle braccia, cui più amava, si sentia stare; ma nondimeno paurosa rimasa, e occupata da grave doglia, lungamente mi tolse il potere dire alcuna cosa. […] [14] Poi che egli così ebbe parlato, io, misera, vinta dall'angoscioso pianto, appena li pote' rispondere alcuna cosa; ma pure, sforzandomi, tremanti parole pinsi fuori della trista bocca in cotale forma: — La fede ai mie orecchi promessa, e data alla mia destra mano dalla tua, fermi Giove in cielo con quello effetto che Inache fece i prieghi di Teletusa, e in terra, come io disidero, e come tu chiedi, la faccia intera —. — E accompagnato lui infino alla porta del nostro palagio, volendo dire “Adio! ”, sùbito fu la parola tolta alla mia lingua, e il cielo agli occhi miei. E quale succisa rosa negli aperti campi, infra le verdi frondi, sentendo i solar raggi, cade perdendo il suo colore, cotale semiviva caddi nelle braccia della mia serva; e dopo non picciolo spazio, aiutata da lei fedelissima, con freddi liquori rivocata al tristo mondo, mi risentii. E sperando ancora d'essere alla mia porta, quale il furioso toro, ricevuto il mortal colpo, furibundo si leva saltando; cotale io stordita levandomi, appena ancora vedendo, corsi, e con le braccia aperte la mia serva abracciai, credendo prendere il mio signore; e con fioca voce, rotta da pianto in mille parti, dissi: — O anima mia, addio! — La serva tacque, conoscendo il mio errore; ma io poi, ricevuta veduta più libera, il mio avere fallito sentendo, appena un'altra volta in simile smarrimento non caddi. [15] Il giorno era già chiaro per ogni parte; ond'io nella mia camera sanza il mio Panfilo vedendomi, e intorno mirandomi per ispazio lunghissimo, come ciò avvenuto si fosse ignorando, la serva domandai che di lui fosse; a cui ella piagnendo rispose: — Già è gran pezza che egli qui nelle sue braccia recatavi, da voi il sopravegnente giorno con lagrime infinite a forza il divise. — A cui io dissi: — Dunque si pure è egli partito? — — Sì — rispose la serva. Cui io ancora seguendo adomandai: — Or con che aspetto si partì. Con grave? — A cui ella rispose: — Niuno mai più dolente ne vidi. — Poi seguitai: — Quali furono gli atti suoi? E che parole disse nella partenza? — E ella rispose: — Voi quasi morta nelle mie braccia rimasa, vagando la vostra anima non so dove, egli vi si recò, tosto che tale vi vide, nelle sue teneramente; e con la sua mano nel vostro petto cercato se con voi fosse la paurosa anima, e trovatala forte battendo, piagnendo, cento volte e più agli ultimi baci credo vi richiamasse; ma poi che voi immobile non altramente che marmo vide, qui vi recò, e dubitando di peggio, lagrimando più volte bagnò il vostro viso, dicendo: ‘O 27 sommi idii, se nella mia partenza peccato alcuno si contiene, venga sopra me il giudicio, non sopra la non colpevole donna. Rendete ai luoghi suoi la smarrita anima, sicché di questo ultimo bene, cioè di vedermi nella mia partita, e di darmi gli ultimi baci dicendo adio, e ella e io siamo consolati’. Ma poi che vide voi non risentirvi, quasi sanza consiglio, ignorando che farsi, pianamente in su il letto posatavi, quali le marine onde, da' venti e dalla piaggia sospinte, ora inanzi vengono, e quando adietro si tornano, cotale da voi partendosi infino in sul limitare dell'uscio della camera pigramente andando, mirava per le finestre il minacciante cielo, nemico alla sua dimora; e quindi subitamente verso voi ritornava, da capo chiamandovi, aggiugnendo lagrime e baci al vostro viso. Ma poi che così ebbe fatto più volte, vedendo che più lunga non potea essere con voi la sua dimora, abracciandovi disse: ‘O dolcissima donna, unica speranza del tristo cuore, la quale io, a forza partendomi, lascio in dubbia vita, Iddio ti renda il perduto conforto, e te a me tanto servi, che insieme felici ancora ci possiamo rivedere, sì come sconsolati ne divide l'amara partenza’. E così come le parole diceva, così continuamente piagneva forte, tanto che i singhiozzi del pianto suo più volte mi fecer paura che, non che dai nostri di casa, ma che da' vicini sentiti non fossero. Ma poi, più non potendo dimorare per la nemica chiarezza sopravegnente, con maggiore abondanza di lagrime disse: ‘Addio!’ E quasi a forza tirato, percotendo forte il piede nel limitare, uscì delle nostre case. Onde uscito, appena si saria detto che egli potesse andare, anzi ad ogni passo volgendosi, quasi pareva sperasse che, voi risentita, io il dovessi chiamare a rivedervi. — Tacque allora quella; e io, o donne, quale voi potete pensare, cotale, dolendomi della partita del caro amante, isconsolata rimasi piagnendo. […] Capitolo nono e ultimo nel quale madonna Fiammetta parla al libro suo imponendogli in che abito e quando e a cui egli debba andare, e da cui guardarsi, e fa fine. [1] O picciolo mio libretto, tratto quasi della sepoltura della tua donna, ecco, sì come a me piace, la tua fine è venuta con più sollecito piede che quella de' nostri danni; adunque tale quale tu se' dalle mie mani scritto, e in più parti delle mie lagrime offeso, dinanzi dalle inamorate donne ti presenta. Esse, pietà guidandoti, sì come io fermissimamente spero, ti vedranno volentieri, se Amore non ha mutate leggi poi che noi misera divenimmo. Né ti sia, in questo abito così vile come io ti mando, vergogna d'andare a ciascheduna, quantunque ella sia grande, pure che essa te avere non recusi. A te non si richiede altramenti fatto, posto che io pure dare te 'l volessi. Tu déi essere contento di mostrarti simigliante al tempo mio; il quale essendo infelicissimo, te di miseria veste come fa me; e però non ti sia cura d'alcuno ornamento, sì come li altri sogliono avere: cioè di nobili coverte di colori varii tinte e ornate, o di pulita tonditura, o di leggiadri minii, o di gran titoli: queste cose non si convengono alli gravi pianti li quali tu porti: lascia e queste e li larghi spazii e li lieti inchiostri, e le impomiciate carte alli libri felici; a te si conviene d'andare rabbuffato, con isparte chiome e macchiato e di squalore pieno, là dove io ti mando, e con li miei infortunii nelli animi di quelle che te leggeranno destare la santa pietà. La quale se avviene che per te di sé ne' bellissimi visi mostri segnali, incontanente di ciò rendi merito qual tu puoi; e io né tu non siamo sì dalla Fortuna avallati, che essi non sieno grandissimi in noi da potere dare. Né questi sono però altri se non quelli, li quali essa a niuno misero può tòrre: cioè essemplo di sé donare a quelli che sono felici, acciò che essi pongano modo alli loro beni, e fuggano di divenire simili a noi. Il quale, sì come tu puoi, sì fatto dimostra di me, che, se savie sono, nelli loro amori savissime ad ovviare alli occulti inganni de' giovani diventino per paura de' nostri mali. Va' adunque; io non so qual passo si convenga a te più tosto, o sollecito o quieto; né so quali parti prima da te sieno da essere cercate, né so come tu sarai né da cui ricevuto. Così come la Fortuna ti pigne, così procedi: il tuo corso non puote essere guari ordinato. A te occulta il nuvoloso tempo ogni stella. Le quali se pure tutte paressono, niuno argomento t'ha la 'mpetuosa Fortuna lasciato a tua salute e perciò in qua in là ributtato, come nave sanza timone e sanza vela da l'onde gittata, così t'abandona, e come li luoghi richieggiono, così usa varii li consigli. Se tu forse alle mani d'alcuna pervieni, la quale sì felici usi li suoi amori, che le nostre angoscie schernisca, e per folle forse riprendane, umile sostieni li gabbi fatti, li quali menomissima parte sono de' nostri mali, e a lei la fortuna essere mobile torna a mente, per la qual cosa noi lieta, e lei come noi potrebbe rendere in brieve, e risa e beffe per beffe le renderemmo. E se tu alcuna troverrai che, leggendoti, li suoi occhi asciutti non tenga, ma dolente e pietosa de' nostri mali con le sue lagrime multiplichi le tue macchie, quelle in te sì come santissime con le mie raccogli, e più pietoso e aflitto mostrandoti, umile priega che per me prieghi colui, il quale con le dorate piume in uno momento visita tutto il mondo; sì che egli, forse da più degna bocca che la nostra pregato, e più ad altrui pieghevole che a noi, allevii le nostre angoscie. E io, chiunque ella fia, priego da ora con quella voce che alli miseri più essaudevole è data, che ella mai a tali miserie non pervenga, e che sempre le sieno l'iddii placabili e benigni, e li suoi amori secondo li suoi disii felici produca per lunghi tempi. Ma se per aventura tra l'amorosa turba delle vaghe donne, delle mani d'una in altra cambiandoti, pervieni a quelle della inimica donna, usurpatrice de' nostri beni, come di luogo iniquo, fuggi incontanente, né parte di te non mostrare agli occhi ladri, acciò che ella la seconda volta, sentendo le nostre pene, non si rallegri d'averci nociuto. Ma se pure avviene che essa per forza ti tenga, e pure ti voglia vedere, per modo ti mostra che non risa, ma lagrime le venga de' nostri danni, e a coscienza tornando, ci renda il nostro amante. Oh quanto felice pietà sarebbe questa, e come fruttuosa la tua fatica! Gli occhi degli uomini fuggi, da' quali se pure se' veduto, di': “O generazione ingrata e detrattrice delle semplici donne, non si convengono a voi di vedere le cose pie”. Ma se a colui che de' nostri mali è radice pervieni, sgridalo dalla lungi, e di': “O tu, più rigido che alcuna quercia, fuggi di qui, e noi con le tue mani non violare: la tua rotta fede è di tutto ciò ch'io porto cagione; ma se con umana mente leggere mi vuoli, forse riconoscendo il fallo commesso 28 contro a colei che, tornando tu ad essa, di perdonarti disidera, vedimi; ma se ciò fare non vuoli, non si conviene a te di vedere le lagrime che date hai, e spezialmente se d'acrescerle dimori nel volere primo”. E se forse alcuna donna delle tue parole rozzamente composte si maraviglia, di' che quella ne mandi via, però che gli ornati parlari richieggiono li animi chiari, e li tempi sereni e tranquilli. E però più tosto dirai che prenda ammirazione come a quel poco che narri disordinato bastò lo 'ntelletto e la mano, considerando che dall'una parte amore, e da l'altra gelosia con varie trafitte in continua battaglia tengono il dolente animo e in nubiloso tempo, favoreggiandoli la contraria fortuna. Tu puoi da ogni aguato andare sicuro, sì come io credo, però che nulla invidia te morderà con aguto dente, ma se pure più misero di te si trovasse, che nol credo, il quale quasi a te, come a più beato di sé la portasse, làsciati mordere. Io non so bene qual parte di te nuova offesa possa ricevere, sì per tutto dalle percosse della Fortuna ti veggio essere lacerato. Egli non ti può guari offendere, né farti d'alto tornare in basso luogo, sì è infimo quello ove dimori. E posto ancora che non bastasse alla Fortuna d'averci con la superficie della terra congiunti, e ancora sotto quella cercasse di sotterrarci, sì siamo nelle avversità anticati, che con quelle spalle con le quali le maggiori cose abbiamo sostenute e sostegnamo, sosterremo le minori; e perciò entra dove ella vuole. Vivi adunque: nullo ti può di questo privare, e essemplo etterno alli felici e a' miseri dimora delle angoscie della tua donna. 29 Giovanni Boccaccio, Decameron [Ed. a cura di V. Branca, Milano, Mondadori, 1976] COMINCIA IL LIBRO CHIAMATO DECAMERON, COGNOMINATO PRENCIPE GALEOTTO, NEL QUALE SI CONTENGONO CENTO NOVELLE IN DIECE DÌ DETTE DA SETTE DONNE E DA TRE GIOVANI UOMINI. [Proemio] Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente richesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hannol trovato in alcuni; fra' quali, se alcuno mai n'ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Per ciò che, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato d'altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo, si richiedesse, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne io ne fossi lodato e da molto più reputato, nondimeno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire, certo non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito: il quale, per ciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non m'era spesse volte sentir mi facea. Nella qual noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d'alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avenuto che io non sia morto. Ma sì come a Colui piacque il quale, essendo Egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine, il mio amore, oltre a ogn'altro fervente e il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né piegare, per se medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé nella mente m'ha al presente lasciato quel piacere che egli è usato di porgere a chi troppo non si mette ne' suoi più cupi pelaghi navigando; per che, dove faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser rimaso. Ma quantunque cessata sia la pena, non per ciò è la memoria fuggita de' benifici già ricevuti, datimi da coloro a' quali per benivolenza da loro a me portata erano gravi le mie fatiche; né passerà mai, sì come io credo, se non per morte. E per ciò che la gratitudine, secondo che io credo, trall'altre virtù è sommamente da commendare e il contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero dir mi posso, e se non a coloro che me atarono, alli quali per avventura per lo lor senno o per la loro buona ventura non abisogna, a quegli almeno a' quali fa luogo, alcuno alleggiamento prestare. E quantunque il mio sostentamento, o conforto che vogliam dire, possa essere e sia a' bisognosi assai poco, nondimeno parmi quello doversi più tosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto. E chi negherà questo, quantunque egli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare? Esse dentro a' dilicati petti, temendo e vergognando, tengono l'amorose fiamme nascose, le quali quanto più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che l'hanno provate: e oltre a ciò, ristrette da' voleri, da' piaceri, da' comandamenti de' padri, delle madri, de' fratelli e de' mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, seco rivolgendo diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre sieno allegri. E se per quegli alcuna malinconia, mossa da focoso disio, sopraviene nelle lor menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa: senza che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere; il che degli innamorati uomini non avviene, sì come noi possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleggiare o da passar quello, per ciò che a loro, volendo essi, non manca l'andare a torno, udire e veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giucare o mercatare: de' quali modi ciascuno ha forza di trarre, o in tutto o in parte, l'animo a sé e dal noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o con altro, o consolazion sopraviene o diventa la noia minore. Adunque, acciò che in parte per me s'amendi il peccato della fortuna, la quale dove meno era di forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, per ciò che all'altre è assai l'ago e 'l fuso e l'arcolaio, intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e di tre giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità fatta, e alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto. Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d'amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno così ne' moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già dette donne, che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare: le quali cose senza passamento di noia non credo che possano intervenire. Il che se avviene, che voglia Idio che così sia, a Amore ne rendano grazie, il quale liberandomi da' suoi legami m'ha conceduto il potere attendere a' lor piaceri. I, Introduzione Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose, tante conosco che la presente opera al vostro iudicio avrà grave e noioso principio, sì come è la dolorosa ricordazione della 30 pestifera mortalità trapassata, universalmente a ciascuno che quella vide o altramenti conobbe dannosa, la quale essa porta nella sua fronte. Ma non voglio per ciò che questo di più avanti leggere vi spaventi, quasi sempre tra' sospiri e tralle lagrime leggendo dobbiate trapassare. Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a' camminanti una montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto più viene lor piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza. E sì come la estremità della allegrezza il dolore occupa, così le miserie da sopravegnente letizia sono terminate. A questa brieve noia (dico brieve in quanto in poche lettere si contiene) seguita prestamente la dolcezza e il piacere il quale io v'ho davanti promesso e che forse non sarebbe da così fatto inizio, se non si dicesse, aspettato. E nel vero, se io potuto avessi onestamente per altra parte menarvi a quello che io desidero che per così aspro sentiero come fia questo, io l'avrei volentier fatto: ma per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva senza questa ramemorazion dimostrare, quasi da necessità constretto a scriverle mi conduco. Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn'altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de' corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'inumerabile quantità de' viventi avendo private, senza ristare d'un luogo in uno altro continuandosi, verso l'Occidente miserabilmente s'era ampliata. E in quella non valendo alcuno senno né umano provedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da officiali sopra ciò ordinati e vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell'anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera, a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte: ma nascevano nel cominciamento d'essa a' maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun'altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s'incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno. A cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto: anzi, o che natura del malore nol patisse o che la ignoranza de' medicanti (de' quali, oltre al numero degli scienziati, così di femine come d'uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che si movesse e per consequente debito argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra 'l terzo giorno dalla apparizione de' sopra detti segni, chi più tosto e chi meno e i più senza alcuna febbre o altro accidente morivano. E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme s'avventava a' sani, non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché non solamente il parlare e l'usare cogli infermi dava a' sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator transportare. Maravigliosa cosa è a udire quello che io debbo dire: il che, se dagli occhi di molti e da' miei non fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fededegna udito l'avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenzia narrata nello appiccarsi da uno a altro, che non solamente l'uomo all'uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell'uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell'uomo, non solamente della infermità il contaminasse ma quello infra brevissimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei, sì come poco davanti è detto, presero tra l'altre volte un dì così fatta esperienza: che, essendo gli stracci d'un povero uomo da tale infermità morto gittati nella via publica e avvenendosi a essi due porci, e quegli secondo il lor costume prima molto col grifo e poi co' denti presigli e scossiglisi alle guance, in piccola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, come se veleno avesser preso, amenduni sopra li mal tirati stracci morti caddero in terra. Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti o maggiori nacquero diverse paure e imaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fine tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di fuggire gl'infermi e le lor cose; e così faccendo, si credeva ciascuno a se medesimo salute acquistare. E erano alcuni, li quali avvisavano che il viver moderatamente e il guardarsi da ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere: e fatta lor brigata, da ogni altro separati viveano, e in quelle case ricogliendosi e racchiudendosi, dove niuno infermo fosse e da viver meglio, dilicatissimi cibi e ottimi vini temperatissimamente usando e ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare a alcuno o volere di fuori, di morte o d'infermi, alcuna novella sentire, con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano. Altri, in contraria opinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l'andar cantando a torno e sollazzando e il sodisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male: e così come il dicevano il mettevano in opera a lor potere, il giorno e la notte ora a quella taverna ora a quella altra andando, bevendo senza modo e senza misura, e molto più ciò per l'altrui case faccendo, 31 solamente che cose vi sentissero che lor venissero a grado o in piacere. E ciò potevan far di leggiere, per ciò che ciascun, quasi non più viver dovesse, aveva, sì come sé, le sue cose messe in abandono: di che le più delle case erano divenute comuni, e così l'usava lo straniere, pure che a esse s'avvenisse, come l'avrebbe il propio signore usate; e con tutto questo proponimento bestiale sempre gl'infermi fuggivano a lor potere. E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda auttorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta per li ministri e essecutori di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi o sì di famiglie rimasi stremi, che uficio alcuno non potean fare; per la qual cosa era a ciascun licito quanto a grado gli era d'adoperare. Molti altri servavano, tra questi due di sopra detti, una mezzana via, non strignendosi nelle vivande quanto i primi né nel bere e nell'altre dissoluzioni allargandosi quanto i secondi, ma a sofficienza secondo gli appetiti le cose usavano e senza rinchiudersi andavano a torno, portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere e chi diverse maniere di spezierie, quelle al naso ponendosi spesso, estimando essere ottima cosa il cerebro con cotali odori confortare, con ciò fosse cosa che l'aere tutto paresse dal puzzo de' morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso e puzzolente. Alcuni erano di più crudel sentimento, come che per avventura più fosse sicuro, dicendo niuna altra medicina essere contro alle pistilenze migliore né così buona come il fuggir loro davanti: e da questo argomento mossi, non curando d'alcuna cosa se non di sé, assai e uomini e donne abbandonarono la propia città, le proprie case, i lor luoghi e i lor parenti e le lor cose, e cercarono l'altrui o almeno il lor contado, quasi l'ira di Dio a punire le iniquità degli uomini con quella pistolenza non dove fossero procedesse, ma solamente a coloro opprimere li quali dentro alle mura della lor città si trovassero, commossa intendesse, o quasi avvisando niuna persona in quella dover rimanere e la sua ultima ora esser venuta. E come che questi così variamente oppinanti non morissero tutti, non per ciò tutti campavano: anzi, infermandone di ciascuna molti e in ogni luogo, avendo essi stessi, quando sani erano, essemplo dato a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto languieno. E lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne' petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. Per la qual cosa a coloro, de' quali era la moltitudine inestimabile, e maschi e femine, che infermavano, niuno altro subsidio rimase che o la carità degli amici (e di questi fur pochi) o l'avarizia de' serventi, li quali da grossi salari e sconvenevoli tratti servieno, quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti: e quegli cotanti erano uomini o femine di grosso ingegno, e i più di tali servigi non usati, li quali quasi di niuna altra cosa servieno che di porgere alcune cose dagl'infermi adomandate o di riguardare quando morieno; e servendo in tal servigio sé molte volte col guadagno perdeano. E da questo essere abbandonati gl'infermi da' vicini, da' parenti e dagli amici e avere scarsità di serventi, discorse uno uso quasi davanti mai non udito: che niuna, quantunque leggiadra o bella o gentil donna fosse, infermando non curava d'avere a' suoi servigi uomo, qual che egli si fosse o giovane o altro, e a lui senza alcuna vergogna ogni parte del corpo aprire non altramenti che a una femina avrebbe fatto, solo che la necessità della sua infermità il richiedesse; il che in quelle che ne guerirono fu forse di minore onestà, nel tempo che succedette, cagione. E oltre a questo ne seguio la morte di molti che per avventura, se stati fossero atati, campati sarieno; di che, tra per lo difetto degli oportuni servigi, li quali gl'infermi aver non poteano, e per la forza della pistolenza, era tanta nella città la moltitudine di quegli che di dì e di notte morieno, che uno stupore era a udir dire, non che a riguardarlo. Per che, quasi di necessità, cose contrarie a' primi costumi de' cittadini nacquero tra coloro li quali rimanean vivi. Era usanza, sì come ancora oggi veggiamo usare, che le donne parenti e vicine nella casa del morto si ragunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano piagnevano; e d'altra parte dinanzi la casa del morto co' suoi prossimi si ragunavano i suoi vicini e altri cittadini assai, e secondo la qualità del morto vi veniva il chericato; e egli sopra gli omeri de' suoi pari, con funeral pompa di cera e di canti, alla chiesa da lui prima eletta anzi la morte n'era portato. Le quali cose, poi che a montar cominciò la ferocità della pistolenza, o in tutto o in maggior parte quasi cessarono e altre nuove in lor luogo ne sopravennero. Per ciò che, non solamente senza aver molte donne da torno morivan le genti, ma assai n'eran di quegli che di questa vita senza testimonio trapassavano: e pochissimi erano coloro a' quali i pietosi pianti e l'amare lagrime de' suoi congiunti fossero concedute, anzi in luogo di quelle s'usavano per li più risa e motti e festeggiar compagnevole; la quale usanza le donne, in gran parte postposta la donnesca pietà, per salute di loro avevano ottimamente appresa. E erano radi coloro i corpi de' quali fosser più che da un diece o dodici de' suoi vicini alla chiesa acompagnato; de' quali non gli orrevoli e cari cittadini ma una maniera di beccamorti sopravenuti di minuta gente (che chiamar si facevan becchini, la quale questi servigi prezzolata faceva) sotto entravano alla bara; e quella con frettolosi passi, non a quella chiesa che esso aveva anzi la morte disposto ma alla più vicina le più volte il portavano, dietro a quatro o a sei cherici con poco lume e tal fiata senza alcuno; li quali con l'aiuto de' detti becchini, senza faticarsi in troppo lungo oficio o solenne, in qualunque sepoltura disoccupata trovavano più tosto il mettevano. Della minuta gente, e forse in gran parte della mezzana, era il raguardamento di molto maggior miseria pieno: per ciò che essi, il più o da speranza o da povertà ritenuti nelle lor case, nelle lor vicinanze standosi a migliaia per giorno infermavano, e non essendo né serviti né atati d'alcuna cosa, quasi senza alcuna redenzione, tutti morivano. E assai n'erano che nella strada publica o di dì o di notte finivano, e molti, ancora che nelle case finissero, prima col puzzo de' lor corpi corrotti che altramenti facevano a' vicini sentire sé esser morti: e di questi e degli altri che per tutto morivano, 32 tutto pieno. Era il più da' vicini una medesima maniera servata, mossi non meno da tema che la corruzione de' morti non gli offendesse, che da carità la quale avessero a' trapassati. Essi, e per se medesimi e con l'aiuto d'alcuni portatori, quando aver ne potevano, traevano delle lor case li corpi de' già passati, e quegli davanti alli loro usci ponevano, dove, la mattina spezialmente, n'avrebbe potuti veder senza numero chi fosse attorno andato: e quindi fatte venir bare, e tali furono che per difetto di quelle sopra alcuna tavola, ne ponieno. Né fu una bara sola quella che due o tre ne portò insiememente, né avvenne pure una volta, ma se ne sarieno assai potute annoverare di quelle che la moglie e 'l marito, di due o tre fratelli, o il padre e il figliuolo, o così fattamente ne contenieno. E infinite volte avvenne che, andando due preti con una croce per alcuno, si misero tre o quatro bare, da' portatori portate, di dietro a quella: e, dove un morto credevano avere i preti a sepellire, n'avevano sei o otto e tal fiata più. Né erano per ciò questi da alcuna lagrima o lume o compagnia onorati, anzi era la cosa pervenuta a tanto, che non altramenti si curava degli uomini che morivano, che ora si curerebbe di capre: per che assai manifestamente apparve che quello che il naturale corso delle cose non avea potuto con piccoli e radi danni a' savi mostrare doversi con pazienza passare, la grandezza de' mali eziandio i semplici far di ciò scorti e non curanti. Alla gran moltitudine de' corpi mostrata, che a ogni chiesa ogni dì e quasi ogn'ora concorreva portata, non bastando la terra sacra alle sepolture, e massimamente volendo dare a ciascun luogo proprio secondo l'antico costume, si facevano per gli cimiterii delle chiese, poi che ogni parte era piena, fosse grandissime nelle quali a centinaia si mettevano i sopravegnenti: e in quelle stivati, come si mettono le mercatantie nelle navi a suolo a suolo, con poca terra si ricoprieno infino a tanto che della fossa al sommo si pervenia. E acciò che dietro a ogni particularità le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando non vada, dico che così inimico tempo correndo per quella, non per ciò meno d'alcuna cosa risparmiò il circustante contado. Nel quale, lasciando star le castella, che simili erano nella loro piccolezza alla città, per le sparte ville e per li campi i lavoratori miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di medico o aiuto di servidore, per le vie e per li loro colti e per le case, di dì e di notte indifferentemente, non come uomini ma quasi come bestie morieno; per la qual cosa essi, così nelli loro costumi come i cittadini divenuti lascivi, di niuna lor cosa o faccenda curavano: anzi tutti, quasi quel giorno nel quale si vedevano esser venuti la morte aspettassero, non d'aiutare i futuri frutti delle bestie e delle terre e delle loro passate fatiche ma di consumare quegli che si trovavano presenti si sforzavano con ogni ingegno. Per che adivenne i buoi, gli asini, le pecore, le capre, i porci, i polli e i cani medesimi fedelissimi agli uomini, fuori delle proprie case cacciati, per li campi, dove ancora le biade abbandonate erano, senza essere non che raccolte ma pur segate, come meglio piaceva loro se n'andavano; e molti, quasi come razionali, poi che pasciuti erano bene il giorno, la notte alle lor case senza alcuno correggimento di pastore si tornavano satolli. Che più si può dire, lasciando stare il contado e alla città ritornando, se non che tanta e tal fu la crudeltà del cielo, e forse in parte quella degli uomini, che infra 'l marzo e il prossimo luglio vegnente, tra per la forza della pestifera infermità e per l'esser molti infermi mal serviti o abbandonati ne' lor bisogni per la paura ch'aveono i sani, oltre a centomilia creature umane si crede per certo dentro alle mura della città di Firenze essere stati di vita tolti, che forse, anzi l'accidente mortifero, non si saria estimato tanti avervene dentro avuti? O quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili abituri per adietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al menomo fante rimaser voti! O quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza successor debito rimanere! Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno, Ipocrate o Esculapio avrieno giudicati sanissimi, la mattina desinarono co' lor parenti, compagni e amici, che poi la sera vegnente appresso nell'altro mondo cenaron con li lor passati! A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravolgendo: per che, volendo omai lasciare star quella parte di quelle che io acconciamente posso schifare, dico che, stando in questi termini la nostra città, d'abitatori quasi vota, addivenne, sì come io poi da persona degna di fede sentii, che nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina, non essendovi quasi alcuna altra persona, uditi li divini ufici in abito lugubre quale a sì fatta stagione si richiedea, si ritrovarono sette giovani donne tutte l'una all'altra o per amistà o per vicinanza o per parentado congiunte, delle quali niuna il venti e ottesimo anno passato avea né era minor di diciotto, savia ciascuna e di sangue nobile e bella di forma e ornata di costumi e di leggiadra onestà. Li nomi delle quali io in propria forma racconterei, se giusta cagione da dirlo non mi togliesse, la quale è questa: che io non voglio che per le raccontate cose da loro, che seguono, e per l'ascoltate nel tempo avvenire alcuna di loro possa prender vergogna, essendo oggi alquanto ristrette le leggi al piacere che allora, per le cagioni di sopra mostrate, erano non che alla loro età ma a troppo più matura larghissime; né ancora dar materia agl'invidiosi, presti a mordere ogni laudevole vita, di diminuire in niuno atto l'onestà delle valorose donne con isconci parlari. E però, acciò che quello che ciascuna dicesse senza confusione si possa comprendere appresso, per nomi alle qualità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte intendo di nominarle: delle quali la prima, e quella che di più età era, Pampinea chiameremo e la seconda Fiammetta, Filomena la terza e la quarta Emilia, e appresso Lauretta diremo alla quinta e alla sesta Neifile, e l'ultima Elissa non senza cagion nomeremo. Le quali, non già da alcuno proponimento tirate ma per caso in una delle parti della chiesa adunatesi, quasi in cerchio a seder postesi, dopo più sospiri lasciato stare il dir de' paternostri, seco della qualità del tempo molte e varie cose cominciarono a ragionare. IV, Introduzione 33 Carissime donne, sì per le parole de' savi uomini udite e sì per le cose da me molte volte e vedute e lette, estimava io che lo 'mpetuoso vento e ardente della 'nvidia non dovesse percuotere se non l'alte torri o le più levate cime degli alberi: ma io mi truovo della mia estimazione ingannato. Per ciò che, fuggendo io e sempre essendomi di fuggire ingegnato il fiero impeto di questo rabbioso spirito, non solamente pe' piani ma ancora per le profondissime valli mi sono ingegnato d'andare; il che assai manifesto può apparire a chi le presenti novellette riguarda, le quali non solamente in fiorentin volgare e in prosa scritte per me sono e senza titolo, ma ancora in istilo umilissimo e rimesso quanto il più si possono. Né per tutto ciò l'essere da cotal vento fieramente scrollato, anzi pressoché diradicato e tutto da' morsi della 'nvidia esser lacerato, non ho potuto cessare; per che assai manifestamente posso comprendere quello esser vero che sogliono i savi dire, che sola la miseria è senza invidia nelle cose presenti. Sono adunque, discrete donne, stati alcuni che, queste novellette leggendo, hanno detto che voi mi piacete troppo e che onesta cosa non è che io tanto diletto prenda di piacervi e di consolarvi e, alcuni han detto peggio, di commendarvi, come io fo. Altri, più maturamente mostrando di voler dire, hanno detto che alla mia età non sta bene l'andare omai dietro a queste cose, cioè a ragionar di donne o a compiacer loro. E molti, molto teneri della mia fama mostrandosi, dicono che io farei più saviamente a starmi con le Muse in Parnaso che con queste ciance mescolarmi tra voi. E son di quegli ancora che, più dispettosamente che saviamente parlando, hanno detto che io farei più discretamente a pensare donde io dovessi aver del pane che dietro a queste frasche andarmi pascendo di vento. E certi altri in altra guisa essere state le cose da me raccontatevi che come io le vi porgo s'ingegnano in detrimento della mia fatica di dimostrare. Adunque da cotanti e da così fatti soffiamenti, da così atroci denti, da così aguti, valorose donne, mentre io ne' vostri servigi milito, sono sospinto, molestato e infino nel vivo trafitto. Le quali cose io con piacevole animo, sallo Idio, ascolto e intendo: e quantunque a voi in ciò tutta appartenga la mia difesa, nondimeno io non intendo di risparmiar le mie forze, anzi, senza rispondere quanto si converrebbe, con alcuna leggiera risposta tormegli dagli orecchi, e questo far senza indugio. Per ciò che, se già, non essendo io ancora al terzo della mia fatica venuto, essi son molti e molto presummono, io avviso che avanti che io pervenissi alla fine essi potrebbono in guisa esser multiplicati, non avendo prima avuta alcuna repulsa, che con ogni piccola lor fatica mi metterebbono in fondo; né a ciò, quantunque elle sien grandi, resistere varrebbero le forze vostre. Ma avanti che io venga a far la risposta a alcuno, mi piace in favor di me raccontare, non una novella intera, acciò che non paia che io voglia le mie novelle con quelle di così laudevole compagnia, quale fu quella che dimostrata v'ho, mescolare, ma parte d'una, acciò che il suo difetto stesso sé mostri non esser di quelle; e a' miei assalitori favelando dico Che nella nostra città, già è buon tempo passato, fu un cittadino il quale fu nominato Filippo Balducci, uomo di condizione assai leggiere, ma ricco e bene inviato e esperto nelle cose quanto lo stato suo richiedea; e aveva una sua donna moglie, la quale egli sommamente amava, e ella lui, e insieme in riposata vita si stavano, a niuna altra cosa tanto studio ponendo quanto in piacere interamente l'uno all'altro. Ora avvenne, sì come di tutti avviene, che la buona donna passò di questa vita, né altro di sé a Filippo lasciò che un solo figliuolo di lui conceputo, il quale forse d'età di due anni era. Costui per la morte della sua donna tanto sconsolato rimase, quanto mai alcuno altro amata cosa perdendo rimanesse; e veggendosi di quella compagnia, la quale egli più amava, rimaso solo, del tutto si dispose di non volere più essere al mondo ma di darsi al servigio di Dio e il simigliante fare del suo piccol figliuolo. Per che, data ogni sua cosa per Dio, senza indugio se n'andò sopra Monte Asinaio, e quivi in una piccola celletta se mise col suo figliuolo, col quale di limosine in digiuni e in orazioni vivendo, sommamente si guardava di non ragionare, là dove egli fosse, d'alcuna temporal cosa né di lasciarnegli alcuna vedere acciò che esse da così fatto servigio nol traessero, ma sempre della gloria di vita eterna e di Dio e de' santi gli ragionava, nulla altro che sante orazioni insegnandogli. E in questa vita molti anni il tenne, mai della cella non lasciandolo uscire né alcuna altra cosa che sé dimostrandogli. Era usato il valente uomo di venire alcuna volta a Firenze: e quivi secondo le sue oportunità dagli amici di Dio sovenuto, alla sua cella tornava. Ora avvenne che, essendo già il garzone d'età di diciotto anni e Filippo vecchio, un dì il domandò ov'egli andava. Filippo gliele disse; al quale il garzon disse: “Padre mio, voi siete oggimai vecchio e potete male durar fatica; perché non mi menate voi una volta a Firenze, acciò che, faccendomi cognoscere gli amici e divoti di Dio e vostri, io, che son giovane e posso meglio faticar di voi, possa poscia pe' nostri bisogni a Firenze andare quando vi piacerà, e voi rimanervi qui?” Il valente uomo, pensando che già questo suo figliuolo era grande e era sì abituato al servigio di Dio, che malagevolmente le cose del mondo a sé il dovrebbono omai poter trarre, seco stesso disse: “Costui dice bene”; per che, avendovi a andare, seco il menò. Quivi il giovane veggendo i palagi, le case, le chiese e tutte l'altre cose delle quali tutta la città piena si vede, sì come colui che mai più per ricordanza vedute no' n'avea, si cominciò forte a maravigliare e di molte domandava il padre che fossero e come si chiamassero. Il padre gliele diceva; e egli, avendolo udito, rimaneva contento e domandava d'un'altra. E così domandando il figliuolo e il padre rispondendo, per avventura si scontrarono in una brigata di belle giovani donne e ornate, che da un paio di nozze venieno: le quali come il giovane vide, così domandò il padre che cosa quelle fossero. A cui il padre disse: “Figliuol mio, bassa gli occhi in terra, non le guatare, ch'elle son mala cosa.” Disse allora il figliuolo: “O come si chiamano?” 34 Il padre, per non destare nel concupiscibile appetito del giovane alcuno inchinevole disiderio men che utile, non le volle nominare per lo proprio nome, cioè femine, ma disse: “Elle si chiamano papere.” Maravigliosa cosa a udire! Colui che mai più alcuna veduta non avea, non curatosi de' palagi, non del bue, non del cavallo, non dell'asino, non de' denari né d'altra cosa che veduta avesse, subitamente disse: “Padre mio, io vi priego che voi facciate che io abbia una di quelle papere.” “Oimè, figliuol mio, “ disse il padre “taci: elle son mala cosa.” A cui il giovane domandando disse: “O son così fatte le male cose?” “Sì” disse il padre. E egli allora disse: “Io non so che voi vi dite, né perché queste sieno mala cosa: quanto è, a me non è ancora paruta vedere alcuna così bella né così piacevole come queste sono. Elle son più belle che gli agnoli dipinti che voi m'avete più volte mostrati. Deh! se vi cal di me, fate che noi ce ne meniamo una colà sù di queste papere, e io le darò beccare.” Disse il padre: “Io non voglio; tu non sai donde elle s'imbeccano!” e senti incontanente più aver di forza la natura che il suo ingegno; e pentessi d'averlo menato a Firenze. Ma avere infino a qui detto della presente novella voglio che mi basti e a coloro rivolgermi alli quali l'ho raccontata. Dicono adunque alquanti de' miei riprensori che io fo male, o giovani donne, troppo ingegnandomi di piacervi, e che voi troppo piacete a me. Le quali cose io apertissimamente confesso, cioè che voi mi piacete e che io m'ingegno di piacere a voi: e domandogli se di questo essi si maravigliano, riguardando, lasciamo stare gli aver conosciuti gli amorosi basciari e i piacevoli abbracciari e i congiugnimenti dilettevoli che di voi, dolcissime donne, sovente si prendono, ma solamente a aver veduto e veder continuamente gli ornati costumi e la vaga bellezza e l'ornata leggiadria e oltre a ciò la vostra donnesca onestà; quando colui che nudrito, allevato, accresciuto sopra un monte salvatico e solitario, infra li termini d'una piccola cella, senza altra compagnia che del padre, come vi vide, sole da lui disiderate foste, sole adomandate, sole con l'affezion seguitate. Riprenderannomi, morderannomi, lacererannomi costoro se io, il corpo del quale il cielo produsse tutto atto a amarvi e io dalla mia puerizia l'anima vi disposi sentendo la vertù della luce degli occhi vostri, la soavità delle parole melliflue e la fiamma accesa da' pietosi sospiri, se voi mi piacete o se io di piacervi m'ingegno, e spezialmente guardando che voi prima che altro piaceste a un romitello, a un giovinetto senza sentimento, anzi a uno animal salvatico? Per certo chi non v'ama e da voi non disidera d'essere amato, sì come persona che i piaceri né la vertù della naturale affezione né sente né conosce, così mi ripiglia: e io poco me ne curo. E quegli che contro alla mia età parlando vanno, mostra mal che conoscano che, perché il porro abbia il capo bianco, che la coda sia verde: a' quali, lasciando il motteggiar da l'un de' lati, rispondo che io mai a me vergogna non reputerò infino nello stremo della mia vita di dover compiacere a quelle cose alle quali Guido Cavalcanti e Dante Alighieri già vecchi e messer Cino da Pistoia vecchissimo onor si tennero, e fu lor caro il piacer loro. E se non fosse che uscir serebbe del modo usato del ragionare, io producerei le istorie in mezzo, e quelle tutte piene mostrerei d'antichi uomini e valorosi, ne' loro più maturi anni sommamente avere studiato di compiacere alle donne: il che se essi non fanno, vadano e sì l'apparino. Che io con le Muse in Parnaso mi debbia stare, affermo che è buon consiglio, ma tuttavia né noi possiamo dimorar con le Muse né esse con essonoi. Se quando avviene che l'uomo da lor si parte, dilettarsi di veder cosa che le somigli, questo non è cosa da biasimare: le Muse son donne, e benché le donne quel che le Muse vagliono non vagliano, pure esse hanno nel primo aspetto simiglianza di quelle, sì che, quando per altro non mi piacessero, per quello mi dovrebber piacere; senza che le donne già mi fur cagione di comporre mille versi, dove le Muse mai non mi furono di farne alcun cagione. Aiutaronmi elle bene e mostraronmi comporre que' mille; e forse a queste cose scrivere, quantunque sieno umilissime, si sono elle venute parecchie volte a starsi meco, in servigio forse e in onore della simiglianza che le donne hanno a esse; per che, queste cose tessendo, né dal monte Parnaso né dalle Muse non mi allontano quanto molti per avventura s'avisano. Ma che direm noi a coloro che della mia fame hanno tanta compassione che mi consigliano che io procuri del pane? Certo io non so, se non che, volendo meco pensare quale sarebbe la loro risposta se io per bisogno loro ne dimandassi, m'aviso che direbbono: “Va cercane tralle favole.” E già più ne trovarono tralle loro favole i poeti, che molti ricchi tra' loro tesori, e assai già, dietro alle loro favole andando, fecero la loro età fiorire, dove in contrario molti nel cercar d'aver più pane, che bisogno non era loro, perirono acerbi. Che più? Caccinmi via questi cotali qualora io ne domando loro, non che la Dio mercé ancora non mi bisogna; e, quando pur sopravenisse il bisogno, io so, secondo l'Appostolo, abbondare e necessità sofferire; e per ciò a niun caglia più di me che a me. Quegli che queste cose così non essere state dicono, avrei molto caro che essi recassero gli originali: li quali se a quel che io scrivo discordanti fossero, giusta direi la lor riprensione e d'amendar me stesso m'ingegnerei; ma infino che altro che parole non apparisce, io gli lascerò con la loro oppinione, seguitando la mia, di loro dicendo quello che essi di me dicono. E volendo per questa volta assai aver risposto, dico che dall'aiuto di Dio e dal vostro, gentilissime donne, nel quale io spero, armato, e di buona pazienza, con esso procederò avanti, dando le spalle a questo vento e lasciandol soffiar: per ciò che io non veggo che di me altro possa avvenire che quello che della minuta polvere avviene, la quale, spirante turbo, o egli di terra non la muove, o se la muove la porta in alto e spesse volte sopra le teste degli uomini, sopra le corone dei 35 re e degl'imperadori, e talvolta sopra gli alti palagi e sopra le eccelse torri la lascia; delle quali se ella cade, più giù andar non può che il luogo onde levata fu. E se mai con tutta la mia forza a dovervi in cosa alcuna compiacere mi disposi, ora più che mai mi vi disporrò, per ciò che io conosco che altra cosa dir non potrà alcuno con ragione, se non che gli altri e io, che v'amiamo, naturalmente operiamo; alle cui leggi, cioè della natura, voler contrastare troppo gran forze bisognano, e spesse volte non solamente invano ma con grandissimo danno del faticante s'adoperano. Le quali forze io confesso che io non l'ho né d'averle disidero in questo; e se io l'avessi, più tosto a altrui le presterei che io per me l'adoperassi. Per che tacciansi i morditori, e se essi riscaldar non si possono, assiderati si vivano: e ne' lor diletti, anzi appetiti corrotti standosi, me nel mio, questa brieve vita che posta n'è, lascino stare. Ma da ritornare è, per ciò che assai vagati siamo, o belle donne, là onde ci dipartimmo e l'ordine cominciato seguire. Cacciata aveva il sole del cielo già ogni stella e dalla terra l'umida ombra della notte, quando Filostrato levatosi tutta la sua brigata fece levare, e nel bel giardino andatisene quivi s'incominciarono a diportare: e l'ora del mangiar venuta, quivi desinarono dove la passata sera cenato aveano. E da dormire, essendo il sole nella sua maggior sommità, levati, nella maniera usata vicini alla bella fonte si posero a sedere, là dove Filostrato alla Fiammetta comandò che principio desse alle novelle: la quale, senza più aspettare che detto le fosse, donnescamente così cominciò. 36 Cronica di Anonimo romano Anonimo Romano, Cronica, a cura di G. Porta, Milano, Adelphi, 1979 XVIII. Delli granni fatti li quali fece Cola de Rienzi, lo quale fu tribuno de Roma augusto. Cola de Rienzi fu de vasso lenaio. Lo patre fu tavernaro, abbe nome Rienzi. La matre abbe nome Matalena, la quale visse de lavare panni e acqua portare. Fu nato nello rione della Regola. Sio avitazio fu canto fiume, fra li mulinari, nella strada che vao alla Regola, dereto a Santo Tomao, sotto lo tempio delli Iudei. Fu da soa ioventutine nutricato de latte de eloquenzia, buono gramatico, megliore rettorico, autorista buono. Deh, como e quanto era veloce leitore! Moito usava Tito Livio, Seneca e Tulio e Valerio Massimo. Moito li delettava le magnificenzie de Iulio Cesari raccontare. Tutta dìe se speculava nelli intagli de marmo li quali iaccio intorno a Roma. Non era aitri che esso, che sapessi leiere li antiqui pataffii. Tutte scritture antiche vulgarizzava. Queste figure de marmo iustamente interpretava. Deh, como spesso diceva: «Dove soco questi buoni Romani? Dove ène loro summa iustizia? Pòterame trovare in tiempo che questi fussino!» Era bello omo e in soa vocca sempre riso appareva in qualche muodo fantastico. Questo fu notaro. Accadde che un sio frate fu occiso e non fu fatta vennetta de sia morte. Non lo potéo aiutare. Penzao longamano vennicare lo sangue de sio frate. Penzao longamano derizzare la citate de Roma male guidata. Per sio procaccio gìo in Avignone per imbasciatore a papa Chimento de parte delli tredici Buoni Uomini de Roma. La soa diceria fu sì avanzarana e bella che sùbito abbe 'namorato papa Chimento. Moito mira papa Chimento lo bello stile della lengua de Cola. Ciasche dìe vedere lo vole. Allora se destenne Cola e dice ca·lli baroni de Roma so' derobatori de strade: essi consiento li omicidii, le robbarie, li adulterii, onne male; essi voco che la loro citate iaccia desolata. Moito concipéo lo papa contra li potienti. Puoi, a petizione de missore Ianni della Colonna cardinale, venne in tanta desgrazia, in tanta povertate, in tanta infirmitate, che poca defferenzia era de ire allo spidale. Con sio iuppariello aduosso stava allo sole como biscia. Chi lo puse in basso, quello lo aizao: missore Ianni della Colonna lo remise denanti allo papa. Tornao in grazia, fu fatto notaro della Cammora de Roma, abbe grazia e beneficia assai. A Roma tornao moito alegro; fra li dienti menacciava. Puoi che fu tornato de corte, comenzao a usare sio offizio cortesemente; e bene vedeva e conosceva le robbarie delli cani de Campituoglio, la crudelitate e la iniustizia delli potienti. Vedeva pericolare tanto Communo e non se trovava uno buono citatino che·llo volessi aiutare. Imperciò se levao in pede una fiata nello assettamento de Roma, dove staievano tutti li consiglieri, e disse: «Non site buoni citatini voi, li quali ve rodete lo sangue della povera iente e non la volete aiutare». Puoi ammonìo li officiali e·lli rettori che devessino provedere allo buono stato della loro romana citate. Quanno la luculenta diceria fu fornita, levaose uno de Colonna, lo quale avea nome Antreuozzo de Normanno, allora cammorlengo, e deoli una sonante gotata. Puoi se levao uno lo quale era scrivisenato — Tomao de Fortifiocca avea nome — e feceli la coda. Questo fine abbe soa diceria. Anco secunnario lo preditto Cola ammonìo li rettori e·llo puopolo allo bene fare per una similitudine la quale fece pegnere nello palazzo de Campituoglio 'nanti lo mercato. Nello parete fòra sopra la Cammora penze una similitudine in questa forma. Era pento uno grannissimo mare, le onne orribile, forte turvato. In mieso de questo mare stava una nave poco meno che soffocata, senza tomone, senza vela. In questa nave, la quale per pericolare stava, stava una femina vedova vestuta de nero, centa de cengolo de tristezze, sfessa la gonnella da pietto, sciliati li capelli, como volessi piagnere. Stava inninocchiata, incrociava le mano piecate allo pietto per pietate, in forma de precare che sio pericolo non fussi. Lo soprascritto diceva: «Questa ène Roma». Atorno a questa nave, dalla parte de sotto, nell'acqua stavano quattro nave affonnate, loro vele cadute, rotti li arbori, perduti li tomoni. In ciascheuna stava una femina affocata e morta. La prima avea nome Babillonia, la secunna Cartaine, la terza Troia, la quarta Ierusalem. Lo soprascritto diceva: «Queste citati per la iniustizia pericolaro e vennero meno». Una lettera iessiva fra queste morte femine e diceva così: «Sopra onne signoria fosti in aitura. Ora aspettamo qui la toa rottura». Dallo lato manco stavano doi isole. In una isoletta stava una femina che sedeva vergognosa, e diceva la lettera: «Questa ène Italia». Favellava questa e diceva così: «Tollesti la balìa ad onne terra e sola me tenesti per sorella». Nella aitra isola staievano quattro femine colle mano alle gote e alli inuocchi con atto de moita tristezze, e dicevano così: «D'onne virtute fosti accompagnata. Ora per mare vai abannonata». Queste erano quattro virtù cardinale, cioène Temperanza, Iustizia, Prudenza e Fortezze. Dalla parte ritta stava una isoletta. In questa isoletta stava una femina inninocchiata. Le mano destenneva a cielo como orassi. Vestuta era de bianco. Nome avea Fede Cristiana. Lo sio vierzo diceva così: «O summo patre, duca e signor mio, se Roma pere, dove starraio io?» Nello lato ritto della parte de sopra staievano quattro ordini de diverzi animali colle scelle, e tenevano cuorni alla vocca, e soffiavano como fussino vienti li quali facessino tempestate allo mare, e davano aiutorio alla nave che pericolassi. Lo primo ordine erano lioni, lopi e orzi. La lettera diceva: «Questi so' li potienti baroni, riei rettori». Lo 37 secunno ordine erano cani, puorci e caprioli. La lettera diceva: «Questi soco li mali consiglieri, sequaci delli nuobili». Lo terzo ordine stavano pecoroni, dragoni e golpi. La lettera diceva: «Questi soco li faizi officiali, iudici e notari». Lo quarto ordine stavano liepori, gatti e crape e scigne. La lettera diceva: «Questi soco li populari, latroni, micidiari, adulteratori e spogliatori». Nella parte de sopra staieva lo cielo. In mieso stava la maiestate divina como venissi allo iudicio. Doi spade li iessivano dalla vocca, de là e de cà. Dall'uno lato stava santo Pietro, dall'aitro santo Pavolo ad orazione. Quanno la iente vidde questa similitudine de tale figura, onne perzona se maravigliava. Quanno Cola de Rienzi scriveva, non usava penna de oca; anco soa penna era de fino ariento. Diceva che tanta era la nobilitate de sio officio, che la penna devea essere d'ariento. Non moito tiempo passao che ammonìo lo puopolo per uno bello sermone vulgare lo quale fece in Santo Ianni de Laterani. Dereto dallo coro, nello muro, fece ficcare una granne e mannifica tavola de metallo con lettere antique scritta, la quale nullo sapeva leiere né interpretare, se non solo esso. Intorno a quella tavola fece pegnere figure, como lo senato romano concedeva la autoritate a Vespasiano imperatore. Là, in mieso della chiesia, fece fare uno parlatorio de tavole e fece fare gradi de lename assai aiti per sedere. E fece ponere ornamenta de tappiti e de celoni. E congregao moiti potienti de Roma, fra li quali fu Stefano della Colonna e Ianni Colonna sio figlio, lo quale era delli più scaitriti e mannifichi de Roma. Anche ce fuoro moiti uomini savii, iudici e decretalisti, moita aitra iente de autoritate. Sallìo in sio pulpito Cola de Rienzi fra tanta bona iente. Vestuto era con una guarnaccia e cappa alamanna e cappuccio alle gote de fino panno bianco. In capo aveva uno capelletto bianco. Nella rota dello capelletto stavano corone de aoro, fra le quale ne stava denanti una la quale era partuta per mieso. Dalla parte de sopra dello capelletto veniva una spada d'ariento nuda, e la sia ponta feriva in quella corona e sì·lla partiva per mieso. Audacemente sallìo. Fatto silenzio, fece sio bello sermone, bella diceria, e disse ca Roma iaceva abattuta in terra e non poteva vedere dove iacessi, ca li erano cavati li uocchi fòra dello capo. L'uocchi erano lo papa e lo imperatore, li quali aveva Roma perduti per la iniquitate de loro citatini. Puoi disse: «Vedete quanta era la mannificenzia dello senato, ca la autoritate dava allo imperio». Puoi fece leiere una carta nella quale erano scritti li capitoli colla autoritate che·llo puopolo de Roma concedeva a Vespasiano imperatore. In prima, che Vespasiano potessi fare a sio benepiacito leie e confederazione con quale iente o puopolo volessi; anche che potessi mancare e accrescere lo ogliardino de Roma, cioène Italia; potessi dare contado più e meno, como volessi; anche potessi promovere uomini a stato de duca e de regi e deponere e degradare; anco potessi disfare citate e refare; anco potessi guastare lietti de fiumi e trasmutarli aitrove; anche potessi imponere gravezze e deponere allo benepiacito. Tutte queste cose consentìo lo puopolo de Roma a Vespasiano imperatore in quella fermezza che avea consentuto a Tiberio Cesari. Lessa questa carta, questi capitoli, disse: «Signori, tanta era la maiestate dello puopolo de Roma, che allo imperatore dava la autoritate. Ora l'avemo perduta». Puoi se stese più innanti e disse: «Romani, voi non avete pace. Le vostre terre non se arano. Per bona fede che·llo iubileo se approssima. Voi non site proveduti della annona e delle vettuaglie; ca se la iente che verrao allo iubileo ve trova desforniti, le prete ne portaraco de Roma per raia de fame. Le prete a tanta moititudine non bastaraco». Puoi concluse e disse: «Pregove che la pace con voi aiate». Po' queste paravole disse: «Signori, saccio ca moita iente me teo in vocca per questo che dico e faccio, e questo perché? Per la invidia. Ma rengrazio Dio che tre cose consumano li medesimi. La prima ène la lussuria, la secunna lo fuoco, la terza ène la invidia». Fatto lo sermone e desceso, da tutta iente fu pienamente laodato. In questi dìi usanno alli magnari colli signori de Roma, con Ianni Colonna, li baroni ne prennevano festa de sio favellare. Facevanollo sallire in pede e sì·llo facevano sermonare. E diceva: «Io serraio granne signore o imperatore. Tutti questi baroni persequitaraio. Quello appenneraio, quello decollaraio». Tutti li iudicava. De ciò li baroni crepavano delle risa. Po' queste cose 'nanti disse la salluta soa e·llo stato della citate e·llo ieneroso reimento per questo muodo. Fece pegnere nello muro de Santo Agnilo Pescivennolo, lo quale è luoco famoso a tutto lo munno, una figura così fatta. Nello cantone della parte manca stava uno fuoco moito ardente, lo fume e·lla fiamma dello quale se stennevano fi' allo cielo. In questo fuoco staievano moiti populari e regi, delli quali alcuni parevano miesi vivi, alcuni muorti. Anco in quella medesima fiamma staieva una donna moito veterana, e per la granne caliditate le doi parte de questa veglia erano annerite, la terza parte remasa era illesa. Da la parte ritta, nello aitro cantone, era una chiesia con uno campanile aitissimo, dalla quale chiesia iessiva uno agnilo armato, vestuto de bianco. La soa cappa era de scarlatto vermiglio. In mano portava una spada nuda. Colla mano manca prenneva questa donna veglia per la mano, perché la voleva liberare da pericolo. Nella aitezza dello campanile staievano santo Pietro e santo Pavolo como venissino da cielo, e dicevano così: «Agnilo, agnilo, succurri alla albergatrice nostra». Puoi staieva pento como de cielo cadevano moiti falconi e cadevano muorti in mieso de quella ardentissima fiamma. Anco era nella aitezza dello cielo una bella palomma bianca, la quale teneva nello sio pizzo una corona de mortella, e donavala ad uno minimo celletto como passaro, e puoi cacciava quelli falconi da cielo. Quello piccolo celletto portava quella corona e ponevala in capo della veglia donna. De sotto a queste figure staieva scritto così: «Veo lo tiempo della granne iustizia e ià taci fi' allo tiempo». La iente che conflueva in Santo Agnilo resguardava queste figure. Moiti dicevano ca era vanitate e ridevano. Alcuni dicevano: «Con aitro se vòlzera rettificare lo stato de Roma, che con figure». Alcuno diceva: «Granne cosa ène questa e granne significazione hao». Anche 'nanti disse la salluta soa per questa via. Scrisse una cetola e ficcaola nella porta de Santo Iuorio della Chiavica. La cetola diceva così: «In breve tiempo li Romani tornaraco allo loro antico buono stato». Questa scritta fu posta la prima dìe de quaraiesima nella porta de Santo Iuorio della Chiavica. Puo' questo adunao moiti Romani populari, discreti e buoni uomini. Anco fra essi fuoro cavalerotti e de buono lenaio, moiti descreti e ricchi mercatanti. Abbe con essi consiglio e rascionao dello stato della citate. Uitimamente adunao questa bona iente e matura nello Monte de Aventino e in uno luoco secreto. Là fu deliverato de 38 intennere allo buono stato. Fra li quali esso fu levato in piedi e recitao piagnenno la miseria, la servitute e·llo pericolo nello quale iaceva la citate de Roma. Anco recitao lo stato pacifico, signorile, lo quale Romani solevano avere. Recitao la fidele subiezzione delle terre circustante perduta. Queste cose dicenno piagneva e piagnere faceva cordogliosamente la iente. Puoi concluse e disse ca se conveniva servare pace e iustizia, comenzanno con sollanieri. Puoi disse «Della moneta non dubitete, ca la Cammora de Roma hao moite riennite inestimabile. In prima, per lo focatico pacano per fumante quattro , comenzanno dallo ponte Ceperano fi' allo ponte della Paglia. Montava ciento milia fiorini. Item de sale ciento milia fiorini. Anche li puorti de Roma e·lle rocche de Roma ciento milia fiorini. Anche per lo passo delle vestie e per connannazioni ciento milia fiorini». Puoi disse: «Allo presente comenzaremo con quattro milia fiorini, li quali hao mannati missore lo papa, e ciò sao lo vicario sio». Puoi disse: «Signori, non crediate che questo non sia de licenzia e voluntate dello papa, ca moiti tiranni faco violenzia nelli bieni della Chiesia». Per queste paravole accese li animi delli congregati. Anco moite cose recitao, donne piagnevano. Puoi deliverao de intennere allo buono stato, e de ciò ad onneuno deo sacramento nelle lettere. Fatto questo, la citate de Roma stava in grannissima travaglia. Rettori non avea. Onne dìe se commatteva. Da onne parte se derobava. Dove era luoco, le vergine se detoperavano. Non ce era reparo. Le piccole zitelle se furavano e menavanose a desonore. La moglie era toita allo marito nello proprio lietto. Li lavoratori, quanno ivano fòra a lavorare, erano derobati, dove? su nella porta de Roma. Li pellegrini, li quali viengo per merito delle loro anime alle sante chiesie, non erano defesi, ma erano scannati e derobati. Li prieiti staievano per male fare. Onne lascivia, onne male, nulla iustizia, nullo freno. Non ce era più remedio. Onne perzona periva. Quello più avea rascione, lo quale più poteva colla spada. Non ce era aitra salvezza se non che ciascheuno se defenneva con parienti e con amici. Onne dìe se faceva adunanza de armati. Li nuobili e li baroni in Roma non staievano. Missore Stefano della Colonna era ito colla milizia in Corneto per grano. Era in fine dello mese de abrile. Allora Cola de Rienzi la prima dìe mannao lo vanno a suono de tromma che ciasche omo senza arme venisse allo buono stato allo suono della campana. Lo sequente dìe là, da mesa notte, odìo trenta messe dello Spirito Santo nella chiesia de Santo Agnilo Pescivennolo. Là, su l'ora de mesa terza iessìo fòra della preditta chiesia, armato de tutte arme, ma solo lo capo era descopierto. Iesse fòra bene e palese. Moititudine de guarzoni lo sequitavano tutti gridanti. Denanti da sé faceva portare da tre buoni uomini della ditta coniurazione tre confalloni. Lo primo confallone fu grannissimo, roscio, con lettere de aoro, nello quale staieva Roma e sedeva in doi lioni, in mano teneva lo munno e la palma. Questo era lo confallone della libertate. Cola Guallato, lo buono dicitore, lo portava. Lo secunno era bianco, nello quale staieva santo Pavolo colla spada in mano, colla corona della iustizia. Questo portava Stefanello, ditto Magnacuccia, notaro. Nello terzo staieva santo Pietro colli chiavi della concordia e della pace. Anco portava un aitro lo confallone lo quale fu de santo Iuorio cavalieri. Perché era veterano fu portato in una cassetta su in una asta. Ora prenne audacia Cola de Rienzi, benché non senza paura, e vaone una collo vicario dello papa, e sallìo lo palazzo de Campituoglio anno Domini MCCCXLVI[[I]]. Aveva in sio sussidio forza da ciento uomini armati. Adunata grannissima moititudine de iente, sallìo in parlatorio, e sì parlao e fece una bellissima diceria della miseria e della servitute dello puopolo de Roma. Puoi disse ca esso per amore dello papa e per salvezza dello puopolo de Roma esponeva soa perzona in pericolo. Puoi fece leiere una carta nella quale erano li ordinamenti dello buono stato. […] XXVII. Como missore Nicola de Rienzi tornao in Roma e reassonse lo dominio con moite alegrezze e como fu occiso per lo puopolo de Roma crudamente. Currevano anni Domini MCCCLIII[[I]], lo primo dìe de agosto, quanno Cola de Rienzi tornao a Roma e fu receputo solennissimamente. Alla fine a voce de puopolo fu occiso. La novella fu per questa via. Puoi che Cola de Rienzi cadde dallo sio dominio, deliverao de partirese e ire denanti allo papa. 'Nanti la soa partita fece pegnere nello muro de Santa Maria Matalena, in piazza de Castiello, uno agnilo armato coll'arme de Roma, lo quale teneva in mano una croce. Su la croce staieva una palommella. Li piedi teneva questo agnilo sopra lo aspido e lo vasalischio, sopra lo lione e sopra lo dragone. Pento che fu, li valordi de Roma li iettaro sopra lo loto per destrazio. Una sera venne Cola de Rienzi secretamente desconosciuto per vedere la figura 'nanti soa partenza. Viddela e conubbe che poco l'avevano onorata li valordi. Allora ordinao che una lampana li ardessi denanti uno anno. De notte se partìo e gìo luongo tiempo venale. Anni fuoro sette. Iva forte devisato per paura delli potienti de Roma. Gìo como fraticiello iacenno per le montagne de Maiella con romiti e perzone de penitenza. Alla fine se abiao in Boemia allo imperatore Carlo, della cui venuta se dicerao, e trovaolo in una citate la quale se appella Praga. Là, denanti alla maiestate imperiale, inninocchiato parlao prontamente. Queste fuoro soie paravole e sio loculento sermone denanti a Carlo re de Boemia, nepote de Enrico imperatore, novellamente elietto imperatore per lo papa: «Serenissimo principe, allo quale è conceduta la gloria de tutto lo munno, io so' quello Cola allo quale Dio deo grazia de potere governare in pace, iustizia, libertate Roma e·llo destretto. Abbi la obedienzia della Toscana, Campagna e Maretima. Refrenai le arroganzie delli potienti e purgai moite cose inique. Verme so', omo fraile, pianta como l'aitri. Portava in mano lo vastone de fierro, lo quale per mea umilitate convertiei in vastone de leno, imperciò Dio me hao voluto castigare. Li potienti me persequitano, cercano l'anima mea. Per la invidia, per la supervia me haco cacciato de mio dominio. Non voco essere puniti. De vostro lenaio so', figlio 39 vastardo de Enrico imperatore lo prode. A voi confugo. Alle ale vostre recurro, sotto alla cui ombra e scudo omo deo essere salvo. Credome essere salvato. Credo che me defennerete. Non me lassarete perire in mano de tiranni, non me lassarete affocare nello laco della iniustizia. E ciò è verisimile, ca imperatore site. Vostra spada deo limare li tiranni. Vedi la profezia de frate Agnilo de Mente de Cielo nelle montagne de Maiella. Disse che l'aquila occiderao li cornacchioni». Puoi che abbe parlato, Carlo destese la mano e recipéolo graziosamente, disse che non dubitassi de alcuno. Quanno ionze in Praga fu lo primo dìe de agosto. Demorao per lo spazio de tiempo alcuno. Desputava con mastri in teologia. Diceva assai. Favellava cose maravigliose. Lengua deserta faceva stordire quelli Todeschi, quelli Boemi e Schiavoni. Abafava onne perzona. In presone non stette, ma con compagnia assai onorata sotto qualche guardia. Assai vino, assai vivanna li era data. Po' alcuno tiempo domannao in grazia allo imperatore de ire in Avignone e comparere denanti allo papa e mostrare como non era eretico né patarino. Moito li contrastao lo imperatore che non isse. Alla fine condescese alla voluntate soa. Diceva Cola de Rienzi: «Serenissimo principe, io voluntario vaio denanti allo santo patre. Dunque, se voi non me mannete per forza, site innocente dello sacramento». Nello ire che faceva per tutte le terre se levavano puopoli e, fatto grege con romore, li venivano denanti. Prennevanollo, dicevano ca lo volevano salvare de mano dello papa. Non volevano che issi. A tutti responneva, diceva: «Io voluntario vaio, non costretto». Rengraziavali e così passava de citate in citate. Per tutta la via li fuoro fatti solienni onori. Quanno li puopoli vedevano esso, maraviglianno l'accompagnavano. E per tale via ionze in Avignone lo primo dìe de agosto. Ionto in Avignone parla denanti allo papa. Scusavase ca non era patarino, né incurreva la sentenzia dello cardinale don Bruno. Voleva stare alla esaminazione. A queste paravole lo papa stette queto. Fu renchiuso in una torre grossa e larga. Una iusta catena teneva in gamma. La catena era legata su alla voita della torre. Là staieva Cola vestuto de panni mezzani. Aveva livri assai, sio Tito Livio, soie storie de Roma, Abibia e aitri livri assai. Non finava de studiare. Vita assai sufficiente della scudella dello papa, che per Dio se daieva. Fuoro esaminati suoi fatti e fu trovato fidele cristiano. Allora fu revocato lo prociesso e·lla sentenzia de don Bruno e dello cardinale de Ceccano, e fu assoluto. E venne in grazia dello papa e fu scapulato. Quanno iessìo de presone fu lo primo dìe de agosto. Deveva venire in Italia uno legato, don Gilio Conchese, cardinale de Spagna. Apparecchiavase e scriveva sia famiglia. Cola de Rienzi con questo legato iessìo de Avignone purgato, benedetto e assoluto. E collo legato passao la Provenza e venne a Montefiascone per recuperare lo Patrimonio, como ditto ène. Delle prime terre che se renniero alla Chiesia fu Toscanella, e·llo cassaro fu vennuto per moneta. Cola de Rienzi se retrovao a prennere la terra per la Chiesia. Puoi se retrovao nello assedio de Vitervo, e retrovaose a tutti quelli fatti de arme da cavalieri. Avea vestimenta assai iuste e oneste, buono cavallo. Non solamente in l'oste, anco in Montefiascone aveva tamanta rechiesa de Romani, che stupore era a dicere. Onne Romano ad esso fao capo. Forte ène visitato. Granne coda de populari se strascinava dereto. Onne iente faceva maravigliare, persi' lo legato, tanto l'appresciava la rechiesa delli citatini de Roma. Per maraviglia lo vedevano. Forte li pareva che campata avessi la vita infra tanti potienti. Alla sopraditta depopulazione de Vitervo, como sopra narrato ène, fuoro Romani. Tornata l'oste, granne partita de Romani trasse a vedere Cola de Rienzi: uomini populari, granne lengue e core; maiure proferte, poche attese. Dicevano: «Torna alla toa Roma. Curala de tanta infirmitate. Sinne signore. Noa te darremo sobalimento, favore e forza. Non dubitare. Mai non fusti tanto demannato né amato quanto allo presente». Queste vessiche li populari de Roma li daievano: non li daievano denaro uno. Per queste paravole mosso Cola de Rienzi, anco per la gloria, la quale naturalemente affettava, penzava de fare alcuno fonnamento donne potessi avere iente e sussidio per Roma entrare. Dissene collo legato. Non li deo denaro uno. Aveva tame ordinato che dallo Communo de Peroscia avessi alcuna provisione, donne poteva iustamente vivere con onore. Questa soa provisione non li vastava a fare sollati. Allora cavalcao e venne a Peroscia, e per presure voite fu nello Consiglio. Bene parlava, bene diceva, meglio prometteva. Assai avevano quelli consiglieri le recchie attente ad odire per la doicezza delle paravole che se lassavano ascoitare. Così se facevano leccare como lo mele. Ma perché li consiglieri staco a scinnicato, convenne fare bona custodia delle cose de sio Communo. Da Communo de Peroscia non potéo ottenere uno cortonese. Retrovarose allora in Peroscia doi iovini provenzali, missore Arimbaldo, dottore de leie, e missore Bettrone, cavalieri de Narba in Provenza, frati carnali. Questi erano frati carnali dello prodo fra Monreale. Fra Monreale fu a fare la guerra dello re de Ongaria. Puoi fu capo della Granne Compagnia. Guastao moite terre in Puglia, arze e refocao moite, assai communanze mise a roba e portaone le femine. In Toscana revennéo Siena, Fiorenza, Arezzo e moite terre. La pecunia partiva fra suoi compagni. Puoi ne passao nella Marca e consumao li Malatesti. Prese per forza Montefilaterano e Filino, dove moriero più de setteciento villani. Arze le terre e derobaole. Revennéo li uomini e portaone le donne, quelle che apparenza avevano. Era feriero de Santo Ianni, omo sollicito e prodo, della cui prodezza se dicerao. Questo avea acquistata de moita pecunia per le robbarie, per le prede. Avea tanta moneta, che poteva sufficientemente vivere ad onore senza ire più sollato. Connusse questi doi suoi fratelli in Peroscia e feceli dare provisione dallo Communo. La soa moneta deo alli mercatanti e commannao alli frati che avessino fra loro pace, non fecessino contenzione; ché, puoi che·lli aveva allocati, intenneva de servire allo abito sio. Gìo fra Monreale aitrove per aitri suoi mestieri fare. Puoi che Cola de Rienzi sentìo demorare in Peroscia missore Arimbaldo de Narba, omo iovine, perzona letterata, abiaose allo sio ostieri e voize con esso pranzare. Sumpto cibo, mette mano Cola de Rienzi a favellare della potenzia de Romani. Mistica soie storie de Tito Livio. Dice soie cose de Bibia. Opere la fonte de sio sapere. Deh, como bene parlava! Tutta soa virtute opere in lo rascionare. E sì de ponto dice, che onne omo abafa soa bella diceria, leva de piedi onne omo. Teo la mano alla gota e ascoita con silenzio Missore Arimbaldo. Maravigliaose dello bello parlare. Ammira la magnitudine delli virtuosi Romani. Incalescente 40 vino, monta lo animo in aitezze. Lo fantastico piace allo fantastico. Missore Arimbaldo senza Cola de Rienzi non sao demorare: con esso stao, con esso vao. Uno civo prienno, in uno lietto posano. Penzano de fare cose magne, derizzare Roma e farla tornare in pristino sio. A ciò fare bisognava moneta. Senza sollati non se pò fare. A tre milia fiorini sallìo la mastice. Fecese promettere tre milia fiorini, e esso promise de rennerelli, e per merito promise farlo citatino de Roma e granne capitanio onorato, a despietto dello frate, missore Bettrone. Anco dello mercatante toize dello puosto quattro milia fiorini e deoli a Cola de Rienzi. 'Nanti tame che missore Arimbaldo assenassi questa moneta a Cola de Rienzi, voizene avere licenzia de sio maiure frate, frate Monreale. Mannaoli una lettera. La sentenzia era questa: «Onorato fratello, più aio guadagnato io in uno dìe che voi in tutto tiempo de vostra vita. Io aio acquistato la signoria de Roma, la quale me promette missore Nicola de Rienzi cavalieri, tribuno, visitato da Romani, chiamato dallo puopolo. Credo che lo penzieri non verrao fallato. Vego ca collo aiutorio dello ignegno vuostro lo mio stato non serrao rotto. Bisogna in ciò moneta per incomenzare. Quanno piacerao alla vostra fraternitate, io tollo quattro milia fiorini dello puosto e con potenzia armata me camino a Roma». Fra Monreale, lessa la lettera de sio frate, rescrisse. Lo tenore de soa scrittura era questo: «Granne ora me aio penzato sopra la opera la quale intienni. Granne e importavile peso ène quello che vòi fornire. Nello animo mio bene non cape che te venga fatto. La mente non ce vao. La rascione me·llo contradice. Nientemeno fate voi e facciate bene. Imprimamente hai guardia che·lli quattro milia fiorini non se perdano. Se ve scontrasse alcuna cosa sinistra, scrivateme. Verraio con succurzo, con milli, doi milia perzone, quante bisognaraco, e farraio le cose magnifiche. Non dubitete. Tu e tio frate ameteve e onoreteve, non fate romore». Missore Arimbaldo, receputa la lettera, fu lieto assai. Mise in ordine collo tribuno dello caminare. Puoi che Cola de Rienzi abbe li quattro milia fiorini, vestìose riccamente de più robbe, adobaose a senno dello savio sio ornatamente: gonnella, guarnaccia e cappa de scarlatto forrata de varo, infresata de aoro fino, pistiglioni de aoro, spada ornata in centa, cavallo ornato, speroni de aoro, famiglia vestuta nova. Così adorno ne tornao a Montefiascone denanti allo legato. Menava per compagnia missore Bettrone e missore Arimbaldo de Narba fratelli, con famiglie e cose. Quanno fu denanti allo legato, faceva dell'altiero. Mustravase gruosso con sio cappuccio in canna de scarlatto, con cappa de scarlatto, forrati de panze de vari. Stava supervo. Capezziava. Menava lo capo 'nanti e reto, como dicessi: «Chi so' io? Io chi so'?» Puoi se rizzava nelle ponte delli piedi; ora se aizava, ora se abassava. Maravigliase lo legato e deo alquanto fede alle soie paravole. Puro non li deo denaro uno. Allora parlao Cola e disse: «Legato, famme senatore de Roma. Io vaio e parote la via». Lo legato lo fece senatore e mannaolo via. A potere venire a Roma bisognava iente. De noviello missore Malatesta de Arimino aveva cassati li sollati suoi, da sedici banniere, bona iente, doiciento cinquanta varvute. Demoravano in Peroscia per trovare suollo. Per questa iente avere mannao Cola de Rienzi sio messaio. Lo messaio trovao li conestavili e disse così: «Prennete suollo per doi mesi. Recepate per uno la paca. Averete suollo in perpetuo. Connucerete missore Nicola de Rienzi a Roma, senatore per lo papa». A queste paravole li conestavili fuoro in consiglio. La sentenzia delli Todeschi fu de non ire. Assenavano tre cascioni. La prima: «Romani soco mala iente, supervi, arroganti, non haco paro». La secunna: «Questo ène omo popularo, povero, de vile connizione. Non averao da pacare. Dunqua a chi serviremo noa?» La terza: «Li potienti de Roma non voco lo stato de questo omo. Tutti ne serraco nimici, ca·lli despiace mo'. Dunqua questo suollo non prennamo. La annata a Roma non fao per noa». Da vero questa fu la resposta delli Todeschi, e fu vera. Soco Todeschi como descengo dalla Alamagna semplici, puri, senza fraude. Como se allocano fra Italiani deventano mastri coduti, viziosi, che siento onne malizia. Alli Todeschi respuse uno conestavile borgognone e disse: «Prennamo questi denari novielli sollacciati per uno mese. Tornaremo lo buono omo in soa casa. Scorgamolo in Roma. Guadagnaremo la perdonanza. Chi vorrao tornare tornarao, chi vorrao remanere remanerao». Questa sentenzia venze. Le sedici banniere presero suollo da Cola de Rienzi. Questa iente da cavallo abbe. Abbe anco alquanti Peroscini, figli de buoni uomini. Abbe anco da ciento fanti toscani masnadieri con corazzine da suollo, nobile e bella brigata. Con questa iente descenne per Toscana, passa valli e monti e locora pericolose. Senza reparo ionze ad Orte. Allora la soa venuta fu sentuta a Roma. Romani se apparecchiavano a receperelo con letizia. Li potienti staievano alla guattata. Da Orte se mosse e ionze a Roma, anno Domini MCCCLIII[[I]]. La cavallaria de Roma li iessìo denanti fi' a Monte Malo colle frasche delle olive in mano in segno de vettoria e pace. Iessìoli lo puopolo con granne letizia, como fussi Scipione Africano. Fuoro fatti archi triomfali. Entrao la porta de Castiello. Per tutta piazza de Castiello, per lo ponte, per la strada fuoro fatte arcora de drappi de donne, de ornamento de aoro e de ariento. Pareva che per la letizia tutta Roma se operissi. Granne ène la alegrezza e·llo favore dello puopolo. Con questo onore fu menato fi' allo palazzo de Campituoglio. Là fece sio bello e luculento parlare e disse ca sette anni era ito spierzo fòra de soa casa, como gìo Nabuccodonosor, ma per la potenzia dello virtuoso Dio era tornato in soa sede senatore per la vocca de papa. Non che esso fussi sufficiente; la soa vocca lo poteva sufficiente fare. Aionze che intenneva rettificare e relevare lo stato de Roma. Allora fece capitanii de guerra missore Bettrone e missore Arimbaldo de Narba e donaoli lo confallone de Roma. Fece cavalieri uno Cecco de Peroscia sio consigliero e vestìolo de aoro. Granne festa li Romani li fecero, como fecero li Iudiei a Cristo, quanno entrao in Ierusalem a cavallo nella asina. Quelli lo onoraro destennennoli 'nanti panni e frasche de oliva, cantanno 'Benedictus qui venis!' Alla fine tornaro a casa e lassarolo solo colli discipuli nella piazza. Non fu chi li proferissi uno povero magnare. Lo sequente dìe Cola de Rienzi abbe alcuno ammasciatore delle vicinanze intorno. Deh, como bene responneva! Dava resposte e promissioni. Apparecchiavase de ferventemente guidare. Li baroni staievano alla guattata, a que reiessiva. Lo stormo dello triomfo era granne. Moite banniere. Mai non [fu] tanta pompa. Fanti con duridaine de·llà e de cà. Per bene pare che voglia per tirannia guidare. Delle soie cose che perdìo le moite li fuoro rassenate. Mannao commannamenti e 41 lettere per le terre e·llo destretto de soa felice tornata. Vole che ciascuno se apparecchi a buono stato. Era questo omo fortemente mutato dalli primi suoi muodi. Soleva essere sobrio, temperato, astinente. Ora deventato destemperatissimo vevitore, summamente usava lo vino. Ad onne ora confettava e veveva. Non ce servava ordine né tiempo. Temperava lo grieco collo fiaiano, la malvascia colla rebola. Ad onne ora era dello vevere più fiesco. Orribile cosa era potere patere de vederlo. Troppo veveva. Diceva che nella presone era stato accalmato. Anco era deventato gruosso sterminatamente. Aveva una ventresca tonna, triomfale a muodo de uno abbate asiano. Tutto era pieno de carni lucienti como pagone, roscio, varva longa. Sùbito se mutava nella faccia, sùbito suoi uocchi se·lli infiammavano. Mutavase de opinione. Così se mutava sio intellietto como fuoco. Aveva li uocchi bianchi: tratto tratto se·lli arrosciavano como sangue. Stato che fu nello palazzo de Campituoglio, lo più aito, dìi quattro, mannao per la obedienzia a tutti li baroni. Fra li aitri rechiese Stefano della Colonna in Pellestrina. Questo Stefanello remase piccolo guarzone po' la morte dello patre Stefano e de Ianni Colonna sio frate, como ditto ène. Redutto s'è ora in Pellestrina allo forte. A questo Stefanello mannao doi citatini de Roma, Buccio de Iubileo e Ianni Cafariello, per ammasciatori, che devessi obedire li commannamenti dello santo senato, sotto pena de soa ira. Questi ammasciatori Stefanello retenne e alcuni de essi mise in oscuritate. Anco li trasse uno dente e connannaoli in quattrociento fiorini. Lo sequente dìe curze li campi de Roma con suoi arcieri e briganti. Tutto lo vestiame ne menava. Lo romore se levao per Roma. La mormoranza ne venne allo tribuno della preda de Romani che se ne iva. Allora lo tribuno cavalcao con suoi pochi famigli. Solo iessìo la porta. Li sollati lo sequitaro, tale armato, tale no, secunno che lo tiempo pateva. Curzero da porta Maiure, via de Pellestrina, per avia, per locora salvatiche, deserte. La tratta fu vana, inutile. Non trovaro né omo né vestia né arcieri. Li arcieri e·lli fanti de Pellestrina dotti de guerra per moite fiate descretamente avevano connutta la preda e nascostala in una selva, la quale se chiama Pantano, che iace fra Tivoli e Pellestrina. Là se tennero queti. La notte saviamente quella preda trassero da Pantano e salvarola in Pellestrina. Cercato che abbe moito la iente dello tribuno, non trovanno cosa alcuna, perché la notte era, venne alla citate de Tivoli. Là posao. Fatta la dimane, la novella ionze che le vestie de Romani erano tratte da Pantano e connutte in Pellestrina. Allora lo tribuno irato disse: «Que iova de ire de là e de cà per locora senza vie? Non voglio più scelmire cosa della Colonna. Alle mano voglio essere». Quattro dìi in Tivoli stette. Mannao suoi editti. Espeditamente fece venire da Roma la romana cavallaria, tutti li sollati da cavallo e·lli fanti masnadieri. Era vivace de scrivere. Staieva sio stennardo in Tivoli con soa arme de azule a sole de aoro e stelle de ariento e coll'arma de Roma. Forte cosa! Quello stennardo non era lucente como era prima; staieva miserabile, fiacco, non daieva le code allo viento regoglioso. Venuto lo stuolo de suoi sollati, le moite banniere, cornamuse e trommette assai, venuti missore Bettrone e missore Arimbaldo, li quali li aveva fatti capitanii de guerra generali, li sollati se mormoravano, ca volevano la paca. Li conestavili todeschi demannavano moneta, ché loro arme staievano in pegno. Moite scuse trovao. Non valeva più la fuga. Vedi bella lerciaria che fece alli suoi capitanii. Abbe missore Bettrone e missore Arimbaldo e disseli: «Trovo scritto nelle storie romane che non era moneta in Communo de Roma per sollati. Lo consolo adunao li baroni de Roma, disse: 'Noa che avemo li offizii e·lle dignitate siamo li primi a dunare quello che ciascheuno pò de bona voluntate'. Per quello duno fu adunata tanta moneta, che iustamente la milizia fu pacata. Così voi doi comenzete a dunare. La bona iente de Roma vederao che voi forestieri dunate. Serrao pronta a dunare. Averemo denari a furore». Li capitanii allora li dunaro milli fiorini, cinqueciento per uno, in doi vorze. Quella pecunia lo tribuno compartio alli sollati. Alla fantaria deo mesa paca de moneta de tevertini. Puoi adunao puopolo nella piazza de Santo Lorienzo de Tivoli e fece soa bella diceria. Disse como era ito venale anni sette, como fu in grazia de Carlo imperatore, lo cui aiutorio de prossimo aspettava. Disse como fu in grazia dello papa a despietto de Colonnesi suoi nemici. Mo' era per lo papa senatore de Roma, non lassato guidare per la tirannia de Colonnesi, per Stefanello serpente venenoso, ionco vallico. Dunque intenneva de desertare casa della Colonna e farli peio che quello che prima li fece aitra voita. Casa maladetta, ché per la loro supervia terra de Roma vive in povertate. Le aitre contrade vivo in ricchezza. Puoi aionze e disse: «Voglio fare l'oste sopra Pellestrina e farli lo guasto generale. Dunqua prego voi Tevertini che de buono core ce accompagnete, in tanta necessitate ce sovengate, non ce abannonete». Questa diceria fu fatta nello parapietto delli Palloni. Fatta questa diceria, lo sequente dìe mosse la fantaria forestiera, mosse tutta soa cavallaria e·llo puopolo de Tivoli con grascia e con arnese ad oste, e gìone a Castiglione de Santa Perzeta. Là posao dìi doi. Là se adunao la iente tutta. Puoi se mosse lo sequente dìe e fu sopra Pellestrina con tutto sio sfuorzo, anno Domini MCCCLIII[[I]], de mese , dìe Assediao Pellestrina e allocao lo tribuno l'oste a Santa Maria della Villa, doi miglia da longa dalla citate. Là fuoro milli cavalieri fra Romani e sollati, fu lo puopolo de Tivoli e de Velletri, e·lle masnate delle communanze intorno e della badia de Farfa, e de Campagna e della Montagna. Puosto lo assedio, ciasche perzona cobelle faceva. Solo esso Cola de Rienzi de continuo aveva l'uocchi sopra Pellestrina. Aizava la testa e resguardava lo aito colle, lo forte castiello, e considerava per quale muodo potessi confonnere e derovinare quelle edificia. Non levava lo sguardo de·llà. Diceva: «Questo è quello monte lo quale me conveo appianare». Spesso anco, continuo guardanno e non movenno lo penzieri sio da Pellestrina, vedeva che per la parte de sopra vestiame veniva da pascere e entrava la porta de sopra per abbeverare, puoi tornava alli pascoli. Anco vedeva da l'aitra porta de sopra entrare uomini con salmarie, con some. Vedeva la traccia longa delli vetturali che venivano con fodere in Pellestrina. Allora domannava quelli li quali staievano seco e diceva: «Quelli somarieri que voco dicere?» Responnevano quelli che con esso staievano: «Senatore, quello vestiame veo da pascere e torna in Pellestrina a l'acqua per vevere. Quelli uomini portano farina e grascia per infoderare la terra che non affamassi». Allora responneva e diceva: «Diceteme, non se pòterano pigliare li passi, che questo vestiame sì liberamente non issi a pastura e quelli non portassino fodere?» 42 Responnevano li meno liali Romani e dicevano: «Tanta è la fortura delli monti de Pellestrina, che quelle entrate de sopra e quelle iessite non se·lli puoco vetare. Tanta è la salvatichezza de questo luoco, che nulla oste là pòtera demorare». Ma non era così. Anco era la cruditate delli baroni de Roma, li quali staievano a vedere que ne iessiva, non ce volevano operare. Allora lo tribuno disse queste paravole: «Mai non te lento fi' che non te consumo, Pellestrina. E se io po' la sconfitta de Colonnesi a porta de Santo Lorienzo avessi cavalcato collo puopolo de Roma, in questa terra liberamente entrava senza contradizzione. Ià fora deruvinata. Io non sostènnera allo presente questo affanno. Lo puopolo de Roma vìssera in pace reposato». Allo secunno dìe che l'oste posta fu, fu comenzato lo guasto e fu depopulato tutto lo ogliardino de Pellestrina, tutto lo piano fi' alla citate. Non remase aitro che la parte de sopra, meno che·llo terzo. Quello poco non fu depopulato, perché alli dìi otto l'oste se partìo. E questa partenza fu per doi cascioni. La prima, che Velletrani erano odiosi con Tevertini. Subitamente se mettevano dentro in Pellestrina. Per tale via fuoro auti sospietti che·lla baratta non se levassi nell'oste. La secunna cascione fu che·lla fante de missore «Sostenga qui uno o doi de noi, lassi ire mi. Io li farraio venire dieci milia, vinti milia fiorini e moneta e iente quanta li piace. Deh, faccialo per Dio!» A queste paravole non trovava tutore alcuno. Fatta la notte, preso da primo suonno fra Monreale fu menato allo tormento. Quanno vidde la corda, desdegnato con mormorazione disse: «Ià ve aio bene ditto che voi rustichi villani site. Voleteme ponere allo tormento. Non vedete che io so' cavalieri? Como è in voi tanta villania?» Puro un poco fu aizato. Allora disse: «Io so' stato capo della Gran Compagnia. E perché so' cavalieri, so' voluto vivere ad onore. Aio revennute le citati de Toscana, messali la taglia, derupate terre e presa la iente». Allora fu tornato nello luoco delli suoi fratelli, intro li ceppi, redutto in restretto fra suoi fratelli. Conubbe che morire li conveniva. Domannao penitenza, e per tutta notte abbe con seco uno frate lo quale lo confessava. E così ordinao tutti suoi fatti. Odenno lo mormuorito de suoi fratelli, ad ora se voitava ad essi, parlava. Queste paravole diceva: «Doici frati, non dubitete. Voi site zitielli iovini, non avete provate le onne della ventura. Voi non morerete. Io moro e de mea morte non dubito. La vita mea sempre fu con trivulazioni. Fastidio me era lo vivere. De morire non dubitava. So' contento, ca moro in quella terra dove morìo lo biato santo Pietro e santo Pavolo, benché nostra desaventura sia per toa colpa, missore Arimbaldo, che me hai connutto qui in questo laberinto. Non perciò questo lasso. Non ve mormorete, non ve dogliate de me, ché io moro volentieri. Omo so', como ciello fui ingannato, como l'aitri uomini so' traduto. Dio me averao misericordia. Fui buono allo munno, serraio buono denanti a Dio, e specialemente non dubito perché venni con intenzione de bene fare. Voi iovini site: temete, ca non avete conosciuto que ène la fortuna. Pregove che ve amete e siate valorosi allo munno, como fui io che me feci fare obedienzia alla Puglia, Toscana e alla Marca». Spesse voite così dicenno, lo dìe se fece. La matina voize odire la messa, e odìola staienno scaizo a nude gamme. All'ora de mesa terza fu sonata la campana e fu adunato lo puopolo. Connutto fra Monreale nelle scale allo lione, staieva inninocchiato denanti a madonna santa Maria. Alle gote teneva uno cappuccio de scuro con uno freso de aoro. Aduosso teneva uno iuppariello de velluto bruno, cosito de fila de auro. Descento era senza alcuno cegnimento. Le caize in gamma de scuro. Le mano legate larghe. Teneva la croce in mano. Tre fraticielli con esso staievano. Mentre che odiva la sentenzia, parlava e diceva: «Ahi Romani, como consentite mea morte? Mai non ve feci offesa, ma la vostra povertate e·lle mee ricchezze me faco morire». Puoi diceva: «Dove so' io cuoito? Per bona fe' diece tanta iente me aio veduta denanti e più che questa non è». Puoi diceva: «So' alegro de morire là dove morìo Pietro e Pavolo. La mea vita senza trivolazione non è stata». Puoi diceva: «Tristo questo male traditore po' la mea morte!» Nella sentenzia fuoro mentovate le forche. Allora stordìo forte e levaose sùbito in piedi como perzona smarrita. Allora quelli che stavano intorno lo confortaro che non dubitassi. Fecero fede che connannato era alla testa. De ciò fu contento, stette queto. Abiato allo piano, per tutta la strada non finava volverse de là e de cà. Parlava e diceva: «Romani, iniustamente moro. Moro per la vostra povertate e per le mie ricchezze. Questa citate intenneva de relevare». Moite cose diceva. A peta a peta la croce basava. Forte se maniava de quello che poteva. Omo operativo, triomfatore, sottile guerrieri. Da Cesari in cà mai non fu alcuno megliore. Questo ène quello lo quale, con fortuna arrivato, ruppe in piaia romana, como ditto ène de sopra della galea sorrenata. Puoi che fu nello piano, là dove fuoro le fonnamenta della torre, fatta la rota intorno, inninocchiase in terra. Puoi se levao e disse: «Io non staio bene». Voitaose invierzo oriente e raccommannaose a Dio. Puoi se inninocchiao in terra, basao lo ceppo e disse: «Dio te salvi, santa iustizia». Fece colla mano una croce sopra lo ceppo e basaola. Trasse lo cappuccio e iettaolo. Posta che li fu la mannara in cuollo, favellao e disse: «Non stao bene». Allora era seco moita bona iente, fra quali era lo sio miedico de piaghe. Questo li trovao la ionta. Puosto lo fierro, allo primo colpo stoizao in là. Pochi peli della varva remasero nello ceppo. Frati minori tuoizero sio cuorpo in una cassa, ionto lo capo collo vusto. Pareva che atorno allo cuollo avessi una zaganella de seta roscia. Fu tumulato in Santa Maria de l'Arucielo lo escellente omo fra Monreale, la cui fama sonao per tutta Italia de virtute e de gloria. In la citate de Tivoli staieva uno domestico sio de sio lenaio, lo quale, odita la morte de sio signore, lo sequente dìe de dolore morìo senza remedio. Muorto questo valente omo, li Romani ne staievano forte afferrati. Allora lo tribuno adunao lo puopolo, favellao e disse: «Signori, non staiate turbati della morte de questo omo, ché ène stato lo peiore omo dello munno. Hao derobato citate e castella, muorti e presi uomini e donne, doi milia femine manna cattive. Allo presente era venuto per turbare nuostro stato e non relevarelo. Cercava de essere libero signore. Esso voleva le grazie fare. Voleva depopulare Campagna e terra de Roma, lo residuo de Italia. Nostra briga bene connuceremo a buono fine colla grazia de Dio. Ma allo presente farremo como fao lo trescatore dello grano: la spulla e·lle scorze voite manna allo viento, le vaca nette se serva per si. Così noi avemo dannato questo faizo omo. La moneta soa, li cavalli, le arme terremo per fare nostra briga». Per queste paravole Romani fuoro alquanto acquetati. Fra 43 tanto una espressa lettera e commannamento venne dallo legato che missore Arimbaldo li fussi mannato sano e salvo. Così fu fatto. Remase sio frate, missore Bettrone, in le catene. Della moneta de fra Monreale abbe lo tribuno gran parte; tutta no, perché missore Ianni de Castiello ne abbe la maiure parte. Allora li nuobili de Roma se guardavano da esso como da traditore, perché non servava fede a sio amico. Allora Cola de Rienzi pacao li sollati espeditamente, da pede e da cavallo, quelli che remanere voizero. L'aitri liberamente lassao tornare. Recoize arcieri in granne quantitate. Da treciento uomini da cavallo aveva. Fece capitanio dello puopolo lo savio e saputo guerrieri Liccardo Imprennente delli Aniballi, signore de Monte delli Compatri. Mise le masnate intorno alle terre de Pellestrina. In Frascati teneva masnata de fanti e de arcieri. In la Colonna teneva masnata de fanti e de arcieri. In Castiglione de Santa Perzeta mise masnata de fanti. In Tivoli teneva lo menescalco. Se reservao in Roma, in Campituoglio, per provedere, per vedere que era da fare. Granne penzieri aveva de procacciare moneta per sollati. Restretto se era a povera spesa; onne denaro voleva per pache. Mai non fu veduto tale omo. Solo esso portava lo penzieri de Romani. Più vedeva esso stanno in Campituoglio che suoi officiali nelle locora puosti. Sempre bussava, sempre scriveva alli officiali. Daieva lo muodo, l'ordine da fare cose e·lli fatti prestamente, de chiudere li passi donne se facevano le offese, de prennere uomini e spie. Mai non finava. Mai suoi officiali staievano lienti, freddi; non facevano cosa notabile, salvo lo prode guerrieri Liccardo, lo quale non se infegneva. Notte e dìe faceva predare Colonnesi, per tutta Campagna li persequitava. Non li lassava cogliere cielo. Consumava Stefanello e Colonnesi e Pellestrinesi. La guerra menava a buono fine, omo mastro che sapeva li passi e·lle locora, conosceva li tiempi. Sapevase fare amare da sollati. Era obedito de voglia. Dicevano l'Ongari: «Mai non fu veduto tale capitanio sì valoroso». Desarmato voitava la mano, dicenno: «Quello vestiame venga cà». Como lo diceva così veniva. A buono fine la guerra veniva. Ora voglio contare la morte dello tribuno. Aveva lo tribuno fatta una gabella de vino e de aitre cose. Puseli nome 'sussidio'. Coize sei denari per soma de vino. Coglievase la moita moneta. Romani se·llo comportavano per avere stato. Anco stregneva lo sale per più moneta avere. Anco stregneva soa vita e soa famiglia in le spese. Onne cosa penza per sollati. Repente prese uno citatino de Roma nobile assai, perzona sufficiente, saputa: nome avea Pannalfuccio de Guido. Omo virtuoso, assai desiderava la signoria dello puopolo. E sì·lli troncao la testa senza misericordia e cascione alcuna. Della cui morte tutta Roma fu turbata. Staievano Romani como pecorella. Queti non osavano favellare. Così temevano questo tribuno como demonio. In loco consilii obtinebat omnem suam voluntatem, nullo consiliatore contradicente. Ipso instanti ridens plangebat et emittens lacrimas et suspiria ridebat, tanta inerat ei varietas et mobilitas voluntatis. Ora lacrimava, ora sgavazzava. Puoi se deo a prennere la iente. Prenneva questo e quello, revennevali. Lo mormuorito quetamente per Roma sonava. Perciò a fortezza de si sollao cinquanta pedoni romani per ciasche rione, priesti ad onne stormo. Le pache non li dava. Prometteva onne dìe. Tenevali in spene. Promettevali abunnanzia de grano e cose assai. Novissime cassao Liccardo della capitania e fece aitri capitanii. Questa fu la soa sconfittura. Allora lassao Liccardo lo predare e·llo sollicito guerriare, mormorannose debitamente de sì ingrato omo. Era dello mese de settiembro, a dìi otto. Staieva Cola de Rienzi la dimane in sio lietto. Avease lavata la faccia de grieco. Subitamente veo voce gridanno: «Viva lo puopolo, viva lo puopolo». A questa voce la iente traie per le strade de·llà e de cà. La voce ingrossava, la iente cresceva. Nelle capocroce de mercato accapitao iente armata che veniva da Santo Agnilo e da Ripa e iente che veniva da Colonna e da Treio. Como se ionzero insiemmori, così mutata voce dissero: «Mora lo traditore Cola de Rienzi, mora!» Ora se fionga la ioventute senza rascione, quelli proprio che scritti aveva in sio sussidio. Non fuoro tutti li rioni, salvo quelli li quali ditti soco. Curzero allo palazzo de Campituoglio. Allora se aionze lo moito puopolo, uomini e femine e zitielli. Iettavano prete; faco strepito e romore; intorniano lo palazzo da onne lato, dereto e denanti, dicenno: «Mora lo traditore che hao fatta la gabella, mora!» Terribile ène loro furore. A queste cose lo tribuno reparo non fece. Non sonao la campana, non se guarnìo de iente. Anco da prima diceva: «Essi dico: 'Viva lo puopolo', e anco noi lo dicemo. Noi per aizare lo puopolo qui simo. Miei scritti sollati so'. La lettera dello papa della mea confirmazione venuta ène. Non resta se non piubicarla in Consiglio». Quanno a l'uitimo vidde che·lla voce terminava a male, dubitao forte; specialemente ché esso fu abannonato da onne perzona vivente che in Campituoglio staieva. Iudici, notari, fanti e onne perzona aveva procacciato de campare la pelle. Solo esso con tre perzone remase, fra li quali fu Locciolo Pellicciaro, sio parente. Quanno vidde lo tribuno puro lo tumuito dello puopolo crescere, viddese abannonato e non proveduto, forte se dubitava. Demannava alli tre que era da fare. Volenno remediare, fecese voglia e disse: «Non irao così, per la fede mea». Allora se armao guarnitamente de tutte arme a muodo de cavalieri, la varvuta in testa, corazza e falle e gammiere. Prese lo confallone dello puopolo e solo se affece alli balconi della sala de sopra maiure. Destenneva la mano, faceva semmiante che tacessino, ca voleva favellare. Sine dubio che se lo avessino scoitato li àbbera rotti e mutati de opinione, l'opera era svaragliata. Ma Romani non lo volevano odire. Facevano como li puorci. Iettavano prete, valestravano. Curro con fuoco per ardere la porta. Tante fuoro le valestrate e·lli verruti, che alli balconi non potéo durare. Uno verruto li coize la mano. Allora prese questo confallone e stenneva lo sannato da ambedoi le mano. Mostrava le lettere dello auro, l'arme delli citatini de Roma, quasi venissi a dicere: «Parlare non me lassate. Ecco che io so' citatino e popularo como voi. Amo voi, e se occidete me, occidete voi che romani site». Non vaize questi muodi tenere. Peio fao la iente senza intellietto. «Mora lo traditore!» chiama. Non potenno più sostenere, penzao per aitra via campare. Dubitavase de remanere su nella sala de sopra, perché anco stava presone missore Bettrone de Narba, a chi fatta aveva tanta iniuria. Dubitava che non lo occidessi con soie mano. Conosceva e vedeva che responneva allo puopolo. Penzao partirse dalla sala de sopra e delongarese da missore Bettrone per cascione de più securitate. Allora abbe tovaglie de tavola e legaose in centa e fecese despozzare ioso nello scopierto denanti alla presone. Nella presone 44 erano li presonieri; vedevano tutto. Tolle li chiavi e tenneli a sé. Delli presonieri dubitava. De sopra nella sala remase Locciolo Pellicciaro, lo quale a quanno a quanno se affaceva alli balconi e faceva atti con mano, con vocca allo puopolo e diceva: «Essolo che vene ioso dereto», e issino dereto allo palazzo, ca dereto veniva. Puoi se volvea allo tribuno, confortavalo e diceva che non dubitassi. Puoi tornava allo puopolo facenno li simili cenni: «Essolo dereto, essolo ioso dereto». Davali la via e l'ordine. Locciolo lo occise. Locciolo Pellicciaro confuse la libertate dello puopolo, lo quale mai non trovao capo. Solo per quello omo poteva trovare libertate. Solo Locciolo se·llo avessi confortato, de fermo non moriva; ché fu arza la sala, lo ponte della scala cadde a poca d'ora. Ad esso non poteva alcuno venire. Lo dìe cresceva. Li rioni della Regola e li aitri forano venuti, lo puopolo cresciuto, le voluntate mutate per la diverzitate. Onne omo fora tornato a casa, overo granne vattaglia stata fora. Ma Locciolo li tolle la speranza. Lo tribuno desperato se mise a pericolo della fortuna. Staienno allo scopierto lo tribuno denanti alla cancellaria, ora se traieva la varvuta, ora se·lla metteva. Questo era che abbe da vero doi opinioni. La prima opinione soa, de volere morire ad onore armato colle arme, colla spada in mano fra lo puopolo a muodo de perzona magnifica e de imperio. E ciò demostrava quanno se metteva la varvuta e tenevase armato. La secunna opinione fu de volere campare la perzona e non morire. E questo demostrava quanno se cavava la varvuta. Queste doi voluntate commattevano nella mente soa. Venze la voluntate de volere campare e vivere. Omo era como tutti li aitri, temeva dello morire. Puoi che deliverao per meglio de volere vivere per qualunche via potéo, cercao e trovao lo muodo e·lla via, muodo vituperoso e de poco animo. Ià li Romani aveano iettato fuoco nella prima porta, lena, uoglio e pece. La porta ardeva. Lo solaro della loia fiariava. La secunna porta ardeva e cadeva lo solaro e·llo lename a piezzo a piezzo. Orribile era lo strillare. Penzao lo tribuno devisato passare per quello fuoco, misticarese colli aitri e campare. Questa fu l'uitima soa opinione. Aitra via non trovava. Dunque se spogliao le insegne della baronia, l'arme puse io' in tutto. Dolore ène de recordare. Forficaose la varva e tenzese la faccia de tenta nera. Era là da priesso una caselluccia dove dormiva lo portanaro. Entrato là, tolle uno tabarro de vile panno, fatto allo muodo pastorale campanino. Quello vile tabarro vestìo. Puoi se mise in capo una coitra de lietto e così devisato ne veo ioso. Passa la porta la quale fiariava, passa le scale e·llo terrore dello solaro che cascava, passa l'uitima porta liberamente. Fuoco non lo toccao. Misticaose colli aitri. Desformato desformava la favella. Favellava campanino e diceva: «Suso, suso a gliu tradetore!» Se le uitime scale passava era campato. La iente aveva l'animo suso allo palazzo. Passava la uitima porta, uno se·lli affece denanti e sì·llo reaffigurao, deoli de mano e disse: «Non ire. Dove vai tu?» Levaoli quello piumaccio de capo, e massimamente che se pareva allo splennore che daieva li vraccialetti che teneva. Erano 'naorati: non pareva opera de riballo. Allora, como fu scopierto, parzese lo tribuno manifestamente: mostrao ca esso era. Non poteva dare più la voita. Nullo remedio era se non de stare alla misericordia, allo volere altruio. Preso per le vraccia, liberamente fu addutto per tutte le scale senza offesa fi' allo luoco dello lione, dove li aitri la sentenzia vodo, dove esso sentenziato aitri aveva. Là addutto, fu fatto uno silenzio. Nullo omo era ardito toccarelo. Là stette per meno de ora, la varva tonnita, lo voito nero como fornaro, in iuppariello de seta verde, scento, colli musacchini inaorati, colle caize de biada a muodo de barone. Le vraccia teneva piecate. In esso silenzio mosse la faccia, guardao de·llà e de cà. Allora Cecco dello Viecchio impuinao mano a uno stuocco e deoli nello ventre. Questo fu lo primo. Immediate puo' esso secunnao lo ventre [?] de Treio notaro e deoli la spada in capo. Allora l'uno, l'aitro e li aitri lo percuoto. Chi li dao, chi li promette. Nullo motto faceva. Alla prima morìo, pena non sentìo. Venne uno con una fune e annodaoli tutti doi li piedi. Dierolo in terra, strascinavanollo, scortellavanollo. Così lo passavano como fussi criviello. Onneuno ne·sse iocava. Alla perdonanza li pareva de stare. Per questa via fu strascinato fi' a Santo Marciello. Là fu appeso per li piedi a uno mignaniello. Capo non aveva. Erano remase le cocce per la via donne era strascinato. Tante ferute aveva, pareva criviello. Non era luoco senza feruta. Le mazza de fòra grasse. Grasso era orribilemente, bianco como latte insanguinato. Tanta era la soa grassezza, che pareva uno esmesurato bufalo overo vacca a maciello. Là pennéo dìi doi, notte una. Li zitielli li iettavano le prete. Lo terzo dìe de commannamento de Iugurta e de Sciarretta della Colonna fu strascinato allo campo dell'Austa. Là se adunaro tutti Iudiei in granne moititudine: non ne remase uno. Là fu fatto uno fuoco de cardi secchi. In quello fuoco delli cardi fu messo. Era grasso. Per la moita grassezza da sé ardeva volentieri. Staievano là li Iudiei forte affaccennati, afforosi, affociti. Attizzavano li cardi perché ardessi. Così quello cuorpo fu arzo e fu redutto in polve: non ne remase cica. Questa fine abbe Cola de Rienzi, lo quale se fece tribuno augusto de Roma, lo quale voize essere campione de Romani. In cammora soa fu trovato uno spiecchio de acciaro moito polito con carattere e figure assai. In quello spiecchio costregneva lo spirito de Fiorone. Anco li fuoro trovati pugillari dove aveva scritti Romani, la coita che voleva mettere. Lo primo ordine, ciento perzone da cinqueciento fiorini; lo secunno ordine, ciento perzone da quattrociento fiorini; lo terzo, da ciento fiorini; lo quarto, da cinquanta fiorini; lo quinto, da dieci fiorini. Quanno questo omo fu occiso currevano anni Domini MCCCLIII[[I]], alli otto dìi de settiembro in ora della terza. Non solamente questo fu muorto in furore de puopolo, ma tutta soa forestaria fu derobata de tutto arnese. Perdiero cavalli e arme. Fuoro lassati nudi sì quelli che se trovaro a Roma, sì quelli che staievano de fore per le fortezze a guerriare. Vogliome stennere sopra questa materia. Franceschi entraro in Roma e assediaro Tarpeia, lo monte de Campituoglio. Per la paura Romani se erano redutti là. Puoi che viddero che in Tarpeia non era sufficienzia de fodero, deliveraro de mannare fòra li veterani, como perzone inutile, per avere più fodero, per salvare la ioventute. Così fu. Li veterani, 'nanti che issiro fòra de Tarpeia, fuoro in consiglio. Dissero così: «Noi gimo alle case nostre. Fra li Franceschi per carnario muorti serremo senza dubio. Meglio ène che moramo in abito de virtute che de miseria. Onneuno se vesta le ornamenta soie». Così fu. Li veterani ne iro alle case. Ciascheuno se adobao con quelli ornamenti li 45 quali avevano auti nelle onoranze delli offizii. Tale se vestìo a muodo de pontefice, tale a muodo de senatore, chi de consolo. Allocarose nelli facistuori adornati, colle bacchette in mano, adorni de prete preziose e de aoro. Fra li aitri uno aveva nome Papirio. Forte adorno staieva denanti la soa casa, cum pretexta, cum trabea indutus. La matina li Franceschi se maravigliaro de tale novitate, curzero a vedere como cosa nova. Uno Francesco prese la varva a questo Papirio e disse: «Ahi vegliardo, vegliardo!» Allora Papirio se desdegnao, perché lo Francesco non li favellava con reverenzia, como l'abito sio mustrava. Destese la bacchetta e ferìo lo Francesco nello capo, e non teméo de morire per salvare la onoranza della maiestate soa. Lo buono Romano dunqua non voize morire colla coitra in capo como Cola de Rienzi morìo. 46 Leon Battista Alberti, I Libri della famiglia [Ed. a cura di R. Romano. A. Tenenti, F. Furlan, Torino, Einaudi, 1994] Prologo Repetendo a memoria quanto per le antique istorie e per ricordanza de' nostri vecchi insieme, e quanto potemmo a' nostri giorni come altrove cosí in Italia vedere non poche famiglie solere felicissime essere e gloriosissime, le quali ora sono mancate e spente, solea spesso fra me maravigliarmi e dolermi se tanto valesse contro agli uomini la fortuna essere iniqua e maligna, e se cosí a lei fosse con volubilità e temerità sua licito famiglie ben copiose d'uomini virtuosissimi, abundante delle preziose e care cose e desiderate da' mortali, ornate di molta dignità, fama, laude, autoritate e grazia, dismetterle d'ogni felicità, porle in povertà, solitudine e miseria, e da molto numero de' padri ridurle a pochissimi nepoti, e da ismisurate ricchezze in summa necessità, e da chiarissimo splendore di gloria somergerle in tanta calamità, averle abiette, gittate in tenebre e tempestose avversità. Ah! quante si veggono oggi famiglie cadute e ruinate! Né sarebbe da annumerare o racontare quali e quante siano simili a' Fabii, Decii, Drusii, Gracchi e Marcelli, e agli altri nobilissimi apo gli antichi, cosí nella nostra terra assai state per lo ben publico a mantener la libertà, a conservare l'autorità e dignità della patria in pace e in guerra, modestissime, prudentissime, fortissime famiglie, e tali che dagl'inimici erano temute, e dagli amici sentiano sé essere amate e reverite. Delle quali tutte famiglie non solo la magnificenza e amplitudine, ma gli uomini, né solo gli uomini sono scemati e disminuiti, ma piú el nome stesso, la memoria di loro, ogni ricordo quasi in tutto si truova casso e anullato. Onde non sanza cagione a me sempre parse da voler conoscere se mai tanto nelle cose umane possa la fortuna, e se a lei sia questa superchia licenza concessa, con sua instabilità e inconstanza porre in ruina le grandissime e prestantissime famiglie. Alla qual cosa ove io sanza pendere in alcuna altra affezione, sciolto e libero d'ogni passion d'animo penso, e ove fra me stessi, o giovani Alberti, rimiro la nostra famiglia Alberta a quante avversità già tanto tempo con fortissimo animo abbia ostato, e con quanta interissima ragione e consiglio abbino e' nostri Alberti saputo discacciare e con ferma constanza sostenere i nostri acerbi casi e' furiosi impeti de' nostri iniqui fati, da molti veggo la fortuna piú volte essere sanza vera cagione inculpata, e scorgo molti per loro stultizia scorsi ne' casi sinistri, biasimarsi della fortuna e dolersi d'essere agitati da quelle fluttuosissime sue unde, nelle quali stolti sé stessi precipitorono. E cosí molti inetti de' suoi errati dicono altrui forza furne cagione. Ma se alcuno con diligenza qui vorrà investigare qual cosa molto estolla e accresca le famiglie, qual anche le mantenga in sublime grado d'onore e di felicità, costui apertamente vederà gli uomini le piú volte aversi d'ogni suo bene cagione e d'ogni suo male, né certo ad alcuna cosa tanto attribuirà imperio, che mai giudichi ad acquistare laude, amplitudine e fama non piú valere la virtú che la fortuna. Vero, e cerchisi le republice, ponghisi mente a tutti e' passati principati: troverassi che ad acquistare e multiplicare, mantenere e conservare la maiestate e gloria già conseguita, in alcuna mai piú valse la fortuna che le buone e sante discipline del vivere. E chi dubita? Le giuste leggi, e' virtuosi princípi, e' prudenti consigli, e' forti e constanti fatti, l'amore verso la patria, la fede, la diligenza, le gastigatissime e lodatissime osservanze de' cittadini sempre poterono o senza fortuna guadagnare e apprendere fama, o colla fortuna molto estendersi e propagarsi a gloria, e sé stessi molto commendarsi alla posterità e alla immortalità. Co' Macedoni fu seconda la fortuna e prospera quanto tempo in loro stette l'uso dell'armi coniunto con amor di virtú e studio di laude. Vero, doppo la morte d'Allessandro Grande, subito ch'e' príncipi macedoni cominciarono ciascuno a procurare e' suoi propri beni, e aversi solliciti non al publico imperio, ma curiosi a' privati regni, fra loro subito nacquero discordie, e fra essi cuocentissime fiamme d'odio s'incesoro, e arsero e' loro animi di face di cupiditate e furore, ora d'ingiuriare, mo di vendicarsi: e quelle medesime armi e mani trionfali, le quali aveano occupato e suggette la libertà e forze d'innumerabili populi, le quali aveano compreso tanto imperio, colle quali già era il nome e fama de' Macedoni per tutto el mondo celebratissima, queste armi medesime invittissime, sottoposte a' privati appetiti di pochi rimasi ereditarii tiranni, furono quelle le quali discissero e disperderono ogni loro legge, ogni loro equità e bontà, e persegorono ogni nervo delle sue prima temute forze. Cosí adunque finirono non la fortuna, ma loro stultizia e' Macedoni la conseguita sua felicità, e trovoronsi in poco tempo senza imperio e senza gloria. Ebbe ancora seco la Grecia vittoria, gloria e imperio, mentre ch'ella fu affezionata e officiosa non meno a reggere, regolare e contenere gli animi de' suoi cittadini, che in adornar sé con delizie e sopra dell'altre con pompa nobilitarsi. E della nostra Italia non è egli manifesto el simile? Mentre che da noi furono le ottime e santissime nostre vetustissime discipline osservate, mentre che noi fummo studiosi porgere noi simili a' nostri maggiori e con virtú demmo opera di vincere le lode de' passati, e mentre ch'e' nostri essistimorono ogni loro opera, industria e arte, e al tutto ogni sua cosa essere debita e obligata alla patria, al ben publico, allo emolumento e utilità di tutti e' cittadini, mentre che si esponeva l'avere, il sangue, la vita, per mantenere l'autorità, maiestate e gloria del nome latino, trovoss'egli alcun popolo, fu egli nazione alcuna barbara ferocissima, la quale non temesse e ubidisse nostri editti e legge? Quello imperio maraviglioso sanza termini, quel dominio di tutte le genti con nostre latine forze acquistato, con nostra industria ottenuto, con nostre armi latine amplificato, dirass'egli ci fusse largito dalla fortuna? Quel che a noi vendicò la nostra virtú, confesseremo noi esserne alla fortuna obligati? La prudenza e moderanza di Fabio, quello uno uomo, el quale indugiando e supersedendo restituí la quasi caduta latina libertà, la giustizia di Torquato qual per osservare la militare disciplina non perdonò al suo figliuolo, la continenza di quello, el quale contento nella agricultura, piú stimò la onestà che ogni copia d'auro, la severità di Fabrizio, la parsimonia di Catone, la fermezza di Orazio Cocles, la sofferenza 47 di Muzio, la fede e religione di Regolo, la affezione inverso la patria di Curzio, e l'altre essimie, prestantissime e incredibili virtú, le quali tutte furono celebratissime e illustrissime apo gli antichi, e colle quali virtú non meno che col ferro e colla forza delle battaglie, e' nostri ottimi passati Itali debellorono e sottoaverono tutte le genti in qualunque regione barbare, superbe, contumace e nimiche alla libertà, fama e nome latino, quelle tutte divine virtú ascriverelle noi alla fortuna? La giudicaremo noi tutrice de' costumi, moderatrice delle osservanze e santissime patrie nostre consuetudini? Statuiremo noi in la temerità della fortuna l'imperio, quale e' maggiori nostri piú con virtú che con ventura edificorono? Stimeremo noi suggetto alla volubilità e alla volontà della fortuna quel che gli uomini con maturissimo consiglio, con fortissime e strenuissime opere a sé prescrivono? E come diremo noi la fortuna con sue ambiguità e inconstanze potere disperdere e dissipare quel che noi vorremo sia piú sotto nostra cura e ragione che sotto altrui temerità? Come confesseremo noi non essere piú nostro che della fortuna quel che noi con sollicitudine e diligenza delibereremo mantenere e conservare? Non è potere della fortuna, non è, come alcuni sciocchi credono, cosí facile vincere chi non voglia essere vinto. Tiene gioco la fortuna solo a chi se gli sottomette. E in quanti modi si vide con ogni sua possa e malizia a Canne, a Trebia, a Trasimene, fra le Gallie, nelle Ispanie e in altri luoghi, non con minor odio e ira ch'e' crudelissimi e immanissimi inimici, la fortuna contro gli esserciti latini travagliarsi e combattere e in molti modi affaticarsi per opprimere e abbattere l'imperio e la gloria nostra e tutta Italia, la qual con assidui e innumerabili triunfi di dí in dí maravigliosa cresceva! E chi mai racontasse come spesso e in che modi contro a noi, a que' tempi e poi, la fortuna istessa ci fusse iniqua e infesta, sollevando ad invidia populi, príncipi, nazioni, e a tutto il mondo perseminando avverso di noi odio e malivolenza? Né lei pur valse mai con alcuna sua furia o bestiale alcuno impeto frangere gli animi di que' buoni patrizii senatori latini, e' quali, vincendo e soperchiando ogni avversità, domorono e oppressorono tutte le genti superbe, e tutto in provincie el mondo ridussero, e persino fuori delli ambiti e circuiti della terra affissero e' termini dello incredibile nostro latino imperio. Poterono adunque gli avoli nostri latini ivi opporsi e sostenere ogni inimico impeto, ove per niuna sinistra fortuna quelli animi virilissimi, quelle menti divine, restorono di volere, come volendo poterono e potendo saperono, grandirsi e augumentarsi trionfando. Si fu la loro immensa gloria spesso dalla invidiosa fortuna interrutta, non però fu denegata alla virtú; né mentre che giudicorono l'opere virtuose insieme colle buone patrie discipline essere ornamento ed eterna fortezza dello imperio, all'ultimo mai con loro sequí la fortuna se non facile e seconda. E quanto tempo in loro quegli animi elevati e divini, que' consigli gravi e maturissimi, quella fede interissima e fermissima verso la patria fioriva, e quanto tempo ancora in loro piú valse l'amore delle publice cose che delle private, piú la volontà della patria che le proprie cupiditati, tanto sempre con loro fu imperio, gloria e anche fortuna. Ma subito che la libidine del tiranneggiare e i singulari commodi, le ingiuste voglie in Italia piú poterono che le buone legge e santissime consuete discipline, subito cominciò lo imperio latino a debilitarsi e inanire, a perdere la grazia, decore e tutte le sue pristine forze, e videsi offuscata e occecata la divina gloria latina, quale persino fuori dello Occeano prima risplendea per tutto e collustrava. E tu, Italia nobilissima, capo e arce di tutto l'universo mondo, mentre che tu fusti unita, unanime e concorde a mantenere virtú, a conseguir laude, ad ampliarti gloria, mentre che tuo studio e arte fu debellar e' superbi ed essere umanissima e iustissima co' tuoi sudditi, e mentre che tu sapesti con animo rilevato e dritto sostenere qualunque impetuosa avversità, e riputasti non minor lode in ogni ardua e laboriosa cosa vincere sofferendo che evitarla schifando, e quanto tempo gl'inimici virtú, gli amici fede, e' vinti misericordia in te essere conobbero, tanto tempo allora potesti contro alla fortuna e sopra di tutti e' mortali, e potesti in tutte l'universe nazioni immettere tue santissime leggi e magistrati, e persino al termine degli Indii a te fu permesso constituire fulgentissimi insigni della tua inestimabile e divina meritata gloria, e per le tue prestantissime virtú, pe' tuoi magnificentissimi, validissimi e fortissimi animi fusti pari agli dii riverita, amata e temuta. Ora poi con tue discordie e civili dissensioni subito incominciasti a cadere di tua antica maiestà subito le are, e' templi e teatri tuoi latini, quali soleano di giuochi, feste e letizia vedersi pieni, e coperte e carche di ostili essuvie e vittoriosi voti e lauree trionfali, subito queste cominciorono essere piene di calamità e miseria, asperse di lacrime, celebrati con merore e lamenti. E le barbare nazioni, le serve remotissime genti, quali soleano al tuo venerando nome, Italia, rimettere ogni superbia, ogni ira, e tremare, subito queste tutte presero audacia di irrumpere in mezzo el tuo seno santissimo, Italia, sino ad incendere el nido e la propria antica sedia dello imperio de tutti li imperii. E ora, poiché o l'altre nazioni se l'hanno per nostra negligenza e desidia usurpato, o poiché noi Latini abbiamo tanta a noi devuta gloria abandonata e derelitta, chi è che speri piú mai recuperare el perduto nostro imperial scettro, o che giudichi piú mai riavere o rivedere la purpura e diadema nel suo qui in Italia primevo sacratissimo e felicissimo domicilio e sedia, la qual già tanto tempo, nostro difetto, n'è rimasa spogliata e nuda? E chi adunque stimasse tanta incomparabile e maravigliosa nostra amplitudine e gloria latina per altri che per noi medesimi essere dal suo vero recettaculo e nido esterminata e perduta? Qual multitudine di genti mai arebbe potuto contro a chi tutto el mondo ubidiva? E chi avessi potuto, non volendo né lo permettendo noi, non obbedirci? Cosí adunque si può statuire la fortuna essere invalida e debolissima a rapirci qualunque nostra minima virtú, e dobbiamo giudicare la virtú sufficiente a conscendere e occupare ogni sublime ed eccelsa cosa, amplissimi principati, suppreme laude, eterna fama e immortal gloria. E conviensi non dubitare che cosa qual si sia, ove tu la cerchi e ami, non t'è piú facile ad averla e ottenerla che la virtú. Solo è sanza virtú chi nolla vuole. E se cosí si conosce la virtú, costumi e opere virili, le quali tanto sono de' mortali quanto e' le vogliono, i consigli ottimi, la prudenza, i forti, constanti e perseveranti animi, la ragione, ordine e 48 modo, le buone arti e discipline, l'equità, la iustizia, la diligenza e cura delle cose adempieno e abracciano tanto imperio, e contro l'insidiosa fortuna salgono in ultimo suppremo grado e fastigio di gloria; o giovani Alberti, chi di voi, per questa quale spesso si vede volubilità e inconstanza delle cose caduce e fragili, mai stimasse facile persuadermi che quello, el quale non può a' mortali essere vetato in modo che a loro arbitrio e volontà essi nollo apprendino e rendanselo suo, questo già in possessione degli uomini ridutto, possa non sanza grandissima difficultà a' diligenti e vigilanti possessori essere suttratto, o a' virili e forti defensori rapito? Saremo adunque sempre di questa opinione, nella quale credo siate ancora voi, e' quali tutti siete prudenti e savi, che nelle cose civili e nel vivere degli uomini piú di certo stimeremo vaglia la ragion che la fortuna, piú la prudenza che alcuno caso. Né chi locasse nella virtú speranza manco che nelle cose fortuite, mai parrebbe a me iudicarlo savio né prudente. E chi conoscerà l'industria, le buone arti, le constanti opere, e' maturi consigli, le oneste essercitazioni, le iuste volontà, le ragionevoli espettazioni prostendere e agrandire, ornare, mantenere e difendere le republice e príncipi, e con questo ogni imperio surgere glorioso, e senza queste rimanere privato di tutta sua maiestate e onore; e chi noterà la desidia, inerzia, lascivia, perfidia, cupidità, iniquità, libidine e crudezze d'animi e isfrenate affezioni degli uomini contaminare, dirupare e profondare quantunque ben alta, ben ferma e stabilita cosa, costui credo stimerà questo medesimo come a' principati, cosí alle famiglie convenirsi, e confesserà le famiglie rarissime cadere in infelicità per altro che per solo sua poca prudenza e diligenza. Onde, perché conosco questo cosí essere, o per non sapere nelle cose prospere frenarsi e contenersi, o per ancora non essere prudente e forte nelle avverse tempestati a sostenersi e reggersi, la fortuna con suoi immanissimi flutti, ove sé stessi abandonano, infrange e somerge le famiglie; e perché non dubito el buon governo, e' solleciti e diligenti padri delle famiglie, le buone osservanze, gli onestissimi costumi, l'umanità, facilità, civilità rendono le famiglie amplissime e felicissime, però mi parse da investigare con ogni studio e diligenza quali ammonimenti siano al ben ordinare e amaestrare e' padri e tutta la famiglia utili per divenire all'ultima e supprema felicità, e non avere per tempo alcuno a succumbere alla fortuna iniqua e strana. E quanto m'è stato licito dall'altre mie faccende usurpare ocio, tutto mi diletta averlo conferito a ricercare apresso gli antichi scrittori quali precetti essi abbino lasciati atti e commodi al bene, onore e amplitudine delle famiglie; quali trovandogli essere molti e perfettissimi erudimenti, arbitra' lo nostro officio volerveli radunare e tutti insieme congregarvegli, acciò che avendogli noi qui in uno luogo racolti, voi con manco fatica abbiate da conoscerli, e conoscendogli seguitarli. E credo io, poiché voi arete meco riveduto e' ditti e le autorità di que' buoni antiqui, e notati gli ottimi costumi de' nostri passati Alberti, sarete in questa medesima sentenza, e giudicarete in voi stessi come la virtú cosí stare ogni vostra fortuna. Né manco vi piacerà leggendomi vedere l'antiche maniere buone del vivere e costumi di casa nostra Alberta, che riconoscendo consigli e ricordi degli avoli nostri Alberti tutti essere necessarii e perfettissimi, crederli e satisfarli. Voi vederete da loro in che modo si multiplichi la famiglia, con che arti diventi fortunata e beata, con che ragioni s'acquisti grazia, benivolenza e amistà, con che discipline alla famiglia s'accresca e diffunda onore, fama e gloria, e in che modi si commendi el nome delle famiglie a sempiterna laude e immortalità. Né però sia chi reputi me sí arrogante ch'io vi proferisca tante singularissime cose, come se voi per vostro intelletto e prudenza da voi nolle ben conoscessi; ché a me sempre fu chiaro e notissimo, e per ingegno e per erudizione e per molto conoscimento d'infinite e lodatissime cose, di voi ciascuno m'è molto superiore. Ma non forse però questa mia volontà sarà indarno, colla quale già piú e piú giorni mi sono affaticato in questo modo essere utile piú a que' piú giovani che verranno che a voi, a' quali potrei poco insegnare e meno ricordare cosa la quale non vi sappiate e meglio di me tutto conosciate. Ma pure stimo l'avermi affaticato apresso di voi non poco mi gioverà, imperoché dove, secondo ch'io cerco, alla nostra Alberta famiglia questa nostra opera non fusse come sarà utile, pure a me fia gran premio una e un'altra volta essere da voi letto; anzi me lo riputerò a grandissima remunerazione, massime ove voi piglierete da me quello ch'io sopratutto desidero, tutte le mia volontà, ogni mia espettazione non altro cercare se non di rendermivi oveunque io possa, piú grato molto piú e accetto. E cosí m'ho indutto a me stessi nell'animo non potervi Battista se non piacere, poiché in quel poco a me sia possibile, in questo tutto m'ingegno e sforzo darmivi di dí in dí migliore, a voi piú utile e viepiú caro. E sarammi veementissima cagione ad incitarmi con assai piú ardentissimo studio, con molte piú lunghe vigilie, con viepiú assidua cura in qualche altra piú culta e piú elimata opera satisfare a' giudicii ed espettazioni vostre. E questo, vero, se io vedrò che voi pregiate, come stimo assai quanto dovete pregiarete, gli amonimenti de' nostri passati Alberti, e' quali vederete essere ottimi e degni di memoria, e se me qui stimarete qual sono cupidissimo della vera laude e ferma essaltazione della nostra famiglia Alberta, la quale sempre meritò essere pregiata e onorata, e per cui ogni mio studio, ogni mia industria, ogni pensiero, animo e volontà ebbi sempre e arò a suo nome dedicato. Né mai quanto sia arte in me e forza, mai, né a fatica, né a sudore, né a me stessi perdonerò per fare qualunque cosa resulti in bene e utile della famiglia Alberta, e tanto con maggior volontà, con piú lieto animo, con piú assidua diligenza, quando vederò l'opere mie sieno a voi grate. E cosí prego anche voi giovani Alberti meco, come fate, facciate; proccurate el bene, accrescete lo onore, amplificate la fama di casa nostra, e ascoltate a quello e' passati nostri Alberti, uomini studiosissimi, litteratissimi, civilissimi, giudicavano verso la famiglia doversi, e ramentavano si facesse. Leggetemi e amatemi. 49 Marsilio Ficino, El libro dell’amore [Marsilio Ficino, El libro dell'amore, a cura di Sandra Niccoli, ed. Olschki, Firenze 1987] Proemio di Marsilio Fecino fiorentino sopra El libro dell'Amore, a Bernardo del Nero e Antonio di Tuccio Manetti, prudenti ciptadini fiorentini, amici suoi carissimi. Sogliono e mortali quelle cose che generalmente e spesso fanno dopo lungo uso farle bene, e quanto più le frequentano, tanto farle meglio. Questa regola per la nostra stoltitia e ad nostra miseria falla nello amore. Tutti continuamente amiamo in qualche modo, tutti quasi amiamo male e quanto più amiamo tanto peggio amiamo, e se uno in centomila ama rectamente, perché questa non è comune usanza, non si crede. Questo monstruoso errore, guai ad noi, ci adviene perché temerariamente entriamo prima in questo faticoso viaggio d'amore che impariamo el termine suo, e modo di camminare, e e pericolosi passi del cammino. E però quanto più andiamo tanto più, omè miseri, ad nostro gran danno erriamo. Tanto più importa lo sviarsi per questa selva obscura che per gli altri viaggi, quanto più numero e più spesso ci cammina. El sommo amore della providentia divina, per ridurci alla diritta via da noi smarrita, anticamente spirò in Grecia una castissima donna chiamata Diotima, sacerdote, la quale da Dio spirata, trovando Socrate philosopho dato sopra tutti allo amore, gli dichiarò che cosa fussi questo ardente desiderio e per che via ne possiamo cadere al sommo male, e per che via ne possiamo salire al sommo bene. Socrate rivelò questo sacro mysterio al nostro Platone, Platone, philosopho sopra gli altri pio, subito uno libro per rimedio de' Greci ne compose. Io per rimedio de' Latini el libro di Platone di greca lingua in latino tradussi e, confortato dal nostro magnifico Lorenzo de' Medici, e mysterii che in decto libro erano più difficili comentai, e acciò che quella salutifera manna a Diotima dal cielo mandata a più persone sia comune e facile, ho tradocto di latina lingua in toscana e decti platonici mysterii insieme col comento mio. El qual volume dirizzo principalmente ad voi Bernardo del Nero e Antonio Manetti, dilectissimi miei, perché son certo che l'amore el quale vi manda el vostro Marsilio Fecino con amore riceverete, e darete ad intendere a qualunque persona presumessi leggere questo libro con negligentia o con hodio, che non ne sarà capace in sempiterno; imperò che la diligentia dello amore non si comprende colla negligentia, e esso amore non si piglia con l'odio. El Santo Spirito, Amore Divino, el quale spirò Diotima, ci allumini la mente e accenda la volontà in modo che amiamo Lui in tutte le sue opere belle, e poi amiamo l'opere sue in Lui, e infinitamente godiamo la infinita sua bellezza. I. CAPITOLO I Dell'ordine del libro. Platone padre de' philosophi, adempiuti gli anni ottantuno della sua età, el septimo dì di novembre nel quale egli era nato sedendo a mensa, levate le vivande, finì sua vita. Questo convito, nel quale parimente la natività e fine d'esso Platone si contiene, tutti gli antichi platonici infino a' tempi di Plotino e Porfirio ciascuno anno celebravano. Ma dopo Porfirio anni MCC si pretermissono queste solenne vivande. Finalmente ne' nostri tempi el clarissimo viro Lorenzo de' Medici, volendo el platonico convivio rinnovare, la cura d'esso a Francesco Bandino commisse. Con ciò sie cosa adunque che el Bandino avessi ordinato honorare el septimo dì di novembre, invitati nove platonici, con regale apparato nella villa di Careggi gli ricevette. Questi furono: messere Antonio degli Agli vescovo di Fiesole; maestro Fecino medico; Cristofano Landini poeta; Bernardo Nuti retorico; Tommaso Benci; Giovanni Cavalcanti nostro familiare; dua de' Marsupini, Cristofano e Carlo, figliuoli di Carlo poeta. Finalmente el Bandino volle che io fussi el nono, acciò che per Marsilio Fecino, a quegli di sopra aggiunto, el numero delle Muse si raguagliassi. E quando le vivande furono levate Bernardo Nuti prese el libro di Platone, el quale è Convivio d'Amore intitolato, e di decto Convivio lesse tutte le orationi; le quali lecte, pregò gli altri convitati che ciascuno una ne dovessi exporre. La qual cosa tutti acconsentirono; e per sorte quella prima oratione di Phedro toccò a Giovanni Cavalcanti a sporre, la oratione di Pausania a Antonio theologo, quella di Erisimaco medico a Fecino medico, e similmente d'Aristophane poeta a Cristofano poeta, e così del giovanetto Agatone a Carlo Marsupino; a Tommaso Benci fu data la disputatione di Socrate; l'ultima d'Alcibiade a Cristofano Marsupino. Questa tale sorte tutti approvorono, ma el vescovo e il medico, l'uno alla cura dell'anime, l'altro a quella de' corpi obligati andare, a Giovanni Cavalcanti loro disputationi commissono; gli altri, ad costui voltati, con attentione stettono a udire. Allora in tal modo cominciò a parlare. CAPITOLO II Della regola di lodare l'amore e della sua dignità e grandezza. 50 Gratissima sorte, optimi convitati, oggi a me tocca, per la quale è accaduto che io Phedro Mirrinusio rapresenti. Io dico quel Phedro, la familiarità del quale tanto stimò Lisia tebano, sommo oratore, che con oratione diligentissimamente composta renderselo benivolo si sforzò. La cui apparentia fu a Socrate di tanta admiratione, che già appresso al fiume Ilisso, dallo splendore d'essa commosso e più altamente elevato, cantò mysterii divini; il quale innanzi non solamente delle cose celesti, ma ancora delle terrene diceva sé essere ignorantissimo. Dello ingegno del quale tanto dilecto pigliava Platone, che e primi fructi degli studii suoi a Phedro mandò; a questo gli epigrammi, ad costui l'elegie di Platone, ad questo el primo libro di Platone che tractò della bellezza, el quale Phedro si chiama. Con ciò sia adunque che io simile a Phedro sia suto giudicato, non certamente da me, perché tanto non mi attribuisco, ma dal caso della sorte, la qual cosa da voi è suta approvata, con questi felici auguri la sua oratione volentieri imprima interpreterò, dipoi quello che al vescovo e al medico toccava, secondo la facultà dello ingegno, metterò ad executione. Tre parti in ogni cosa considera qualunque platonico philosopho: di che natura sono quelle cose che gli vanno innanzi, di che quelle che l'accompagnano, e così quelle che seguitano dipoi. E se queste parti essere buone appruova, essa cosa loda, e così per contrario. Quella adunque è laude perfecta la quale l'antica origine della cosa racconta, narra la forma presente e dimostra e fructi futuri. Dalle prime parti ciascuna cosa di nobiltà si loda, dalle seconde di grandezza, dalle terze di utilità. Il perché per quelle tre parti nelle lode queste tre cose si concludono: nobiltà, grandezza e utilità. Per la qual cosa el nostro Phedro, principalmente contemplato la presente excellentia d'Amore, grande iddio lo chiamò. Sobgiunse: agli huomini e gli dii degno d'ammiratione. E non sanza ragione, con ciò sia che noi propriamente delle cose grandi pigliamo admiratione. Colui veramente è grande allo imperio del quale tutti gli huomini e tutti gli dii, secondo che si dice, si sottomettono; imperò che apresso agli antichi, così gli dii come gli huomini s'innamorano. La qual cosa Orpheo e Esiodo insegnano quando dicono le menti degli huomini e degli dii da Amore essere domate. Dicesi ancora essere degno d'admiratione, perché ciascuno quella cosa ama, per la bellezza della quale si maraviglia. Certamente gl'iddii, o vero angeli come vogliono e nostri theologi, maravigliandosi della bellezza divina, quella amano, e similmente adviene agli huomini di quella de' corpi. Questa certamente è laude d'amore, che si trahe dalla sua presente excellentia che esso accompagna. Dipoi dalle parte che gli vanno innanzi Phedro lo loda, quando afferma Amore essere antiquissimo di tutti gl'iddii, dove risplende la nobiltà d'Amore, quando la sua prima origine si narra. Terzo, lo loderà dalle cose che seguitano, dove apparirà la sua maravigliosa utilità. Ma imprima dell'antica e nobile sua origine, appresso della sua futura utilità disputereno. CAPITOLO III Della origine dell'Amore. Orfeo nell'Argonautica, imitando la teologia di Mercurio Trismegisto, quando cantò de' principii delle cose alla presentia di Chirone e degli Heroi, cioè huomini angelici, pose el chaos innanzi al mondo e dinanzi a Saturno, Giove e gli altri iddii. Nel seno d'esso chaos collocò l'Amore, dicendo Amore essere antiquissimo, per sé medesimo perfecto, di gran consiglio. Hesiodo nella sua Theologia, e Parmenide pictagoreo nel libro Della natura, e Acusileo poeta, con Horfeo e Mercurio s'accordano. Platone nel Thimeo similmente descrive el chaos e in quello pone l'Amore, e questo medesimo nel Convivio racconta Phedro. E platonici chiamano el caos el mondo sanza forme, e dicono el mondo essere caos di forme dipinto. Tre mondi pongono, tre ancora saranno e caossi. Prima che tutte le cose è Iddio Auctore di tutte, el quale noi esso Bene chiamiamo. Iddio imprima crea la mente angelica, dipoi l'anima del mondo come vuole Platone, ultimamente el corpo dello universo. Esso sommo Iddio non si chiama mondo, perché el mondo significa ornamento di molte cose composto, e lui al tutto semplice intendere si debbe. Ma esso Iddio affermiamo essere di tutti e mondi principio e fine. La mente angelica è il primo mondo facto da Dio, el secondo è l'anima dell'universo, el terzo è tutto questo edificio el quale noi veggiamo. Certamente in questi tre mondi ancora tre caos si considerano. In principio Iddio crea la substantia della mente angelica, la quale noi ancora essentia nominiamo. Questa nel primo momento della sua creatione è sanza forme e tenebrosa, ma perché ella è nata da·Ddio per uno certo appetito innato a Dio suo principio si volge; voltandosi a·Ddio dal suo razzo è illustrata, e per lo splendore di quel razzo s'accende l'appetito suo; acceso tutto a·Ddio s'accosta; accostandosi piglia le forme, imperò che Iddio, che tutto può, nella mente che a·Llui s'accosta scolpisce le nature di tutte le cose che si creano. In quella adunque spiritualmente si dipingono tutte le cose che in questo mondo sono. Quivi le spere de' cieli e degli elementi, quivi le stelle, quivi le nature de' vapori, le forme delle pietre, de' metalli, delle piante e degli animali si generano. Queste spetie di tutte le cose, da divino aiuto in quella superna mente concepute, essere le idee non dubitiamo; e quella forma e idea de' cieli spesse volte iddio Cielo chiamiamo, e la forma del primo pianeta Saturno, e del secondo Giove, e similmente si procede ne' pianeti che seguitano. Ancora quella idea di questo elemento del fuoco si chiama iddio Vulcano, quella dell'aria Giunone, dell'acqua Nettunno, e della terra Plutone. Per la qual cosa tutti gl'iddii assegnati a certe parti del mondo inferiore sono le idee di queste parti in quella mente superna adunate. Ma innanzi che la mente angelica da Dio perfettamente ricevessi le idee a·Llui s'accostò; e prima che a·Llui s'accostassi era già d'accostarsi acceso l'appetito suo; e prima che il suo appetito s'accendessi aveva il divino razzo ricevuto; e prima che di tale splendore fussi capace, l'appetito suo naturale a Dio suo principio già s'era rivolto; e innanzi che a Lui si rivolgessi era la sua essentia sanza forme e tenebrosa, la quale essentia, per ancora di forme privata, 51 vogliamo che caos certamente sia. E' l suo primo voltamento a·Ddio è el nascimento d'Amore, la infusione del razzo è cibo d'Amore, lo incendio che ne seguita crescimento d'Amore si chiama, l'accostarsi a·Ddio è l'impeto d'Amore; la sua formatione è perfectione d'Amore, e lo adunamento di tutte le forme e idee e Latini chiamano mondo, e' Greci cosmon, che ornamento significa. La gratia di questo mondo e di questo ornamento è la bellezza, alla quale subitamente che quello Amore fu nato tirò e condussevi la mente angelica, la quale essendo brutta per suo mezzo bella divenne. Però tale è la conditione d'Amore, ch'egli rapisce le cose alla bellezza e le brutte alle belle congiugne. Chi dubiterà adunque che l'Amore non seguiti subitamente el chaos, e prima sia che il mondo e che tutti gl' iddei che sono alle parti del mondo distribuiti, considerato che quello appetito della mente sia innanzi alla sua formatione, e nella mente formata naschino gl'iddei e il mondo? Meritamente adunque fu costui da Orfeo «antiquissimo» chiamato. Oltre a questo «per sé medesimo perfecto», quasi voglia dire che a sé medesimo dia perfectione. Imperò che pare che quel primo instinto della mente per sua natura la sua perfectione attinga da Dio, e quella dia alla mente che di quivi piglia sue forme, e similmente faccia agl'iddii che di quivi si generano. Ancora lo chiamò «di gran consiglio», e ragionevolmente, con ciò sia che la sapientia onde propriamente deriva ogni consiglio alla angelica mente è attribuita, perché quella per amore inverso Iddio voltatasi per lo ineffabile suo razzo risplendette. Non altrimenti si dirizza la mente inverso Iddio che inverso el lume del sole l'occhio si faccia. L'occhio prima guarda, dipoi non altro che lume del sole è quello che vede, terzo nel lume del sole e colori e le figure delle cose comprende. Il perché l'occhio, primamente obscuro e informe, ad similitudine di caos ama el lume mentre che ei guarda, e guardando piglia e razzi del sole, e quegli ricevendo de' colori e delle figure delle cose si forma. E sì come quella mente subito ch'ell'è sanza le forme nata, si volge a Dio, e quivi si forma, similmente l'anima del mondo inverso la mente e Iddio, di quivi generata, si rivolta; e benché imprima ella sia caos e nuda di forme, nondimeno inverso l'angelica mente per amore dirizzatasi, pigliando le forme mondo diventa. Né altrimenti la materia di questo mondo per lo innato amore difacto inverso l'anima si dirizzò, e a lei tractabile si dispose. E benché ella nel suo principio sanza ornamento di forme fussi caos non formato, nondimeno per mezzo di tale amore ricevette dalla anima l'ornamento di tutte le forme che in questo mondo si veggono, il perché di caos mondo è divenuta. Tre adunqu' e mondi, tre e caos si considerano. Finalmente in tutti l'amore accompagna el chaos e va innanzi al mondo; desta le cose che dormono, le tenebrose illumina, dà vita alle cose morte, forma le non formate, e dà perfectione alle imperfecte. Delle quali laude quasi nessuna maggiore si può dire o pensare. CAPITOLO IV Della utilità d'amore. Abbiamo insino a hora della sua origine e nobiltà parlato; della sua utilità stimo già sia da disputare. Certamente superfluo sarebbe narrare tutti e beneficii che l'amore arreca alla humana generatione, maxime potendo in somma tutti ridurgli. Perché l'uficio della vita humana consiste in questo: che ci scostiamo dal male e accostiànci al bene. El male dell'uomo è quello che è inonesto, e quello che è il suo bene è l'onesto. Sanza dubio tutte le leggi e discipline non d'altro si sforzano che dare agli huomini tali instituti di vita che dalle cose brutte si guardino, e le honeste mandino ad executione. La qual cosa finalmente appena con grande spatio di tempo, legge e scientie quasi innumerabili possono conseguire, e esso semplice amore in brieve mette ad effecto. Perché la vergogna delle cose turpe, cioè brutte, rimuove, e il desiderio dell'essere excellente alle honeste gli huomini tira. Queste due cose non per alcuno altro modo che per amore possono gli huomini con più facilità o prestezza conseguire. Quando noi diciamo amore, intendete desiderio di bellezza, perché così apresso di tutti e philosaphi è la diffinitione d'amore; e la bellezza è una certa gratia la qual maximamente el più delle volte nasce dalla conrispondentia di più cose; la qual conrispondentia è di tre ragioni. Il perché la gratia che è negli animi è per la conrispondentia di più virtù; quella che è ne' corpi nasce per la concordia di più colori e linee. Ancora gratia grandissima ne' suoni per la consonantia di più voci apparisce. Adunque di tre ragioni è la bellezza: cioè degli animi, de' corpi e delle voci. Quella dell'animo con la mente solo si conosce; quella de' corpi con gli occhi; quella delle voci non con altro che con gli orecchi si comprende. Considerato adunque che la mente, el vedere e l'udire sono quelle cose con le quali sole noi possiamo fruire essa bellezza, e l'amore di fruire la bellezza desiderio sia, l'amore sempre della mente, occhi e orecchi è contento. Or che gli fa bisogno d'odorare, di gustare o di toccare, con ciò sia che questi sensi non altro che odori, sapori, caldo e freddo, molle e duro o simil cose comprendino? Nessuna di queste cose adunque, da poi ch'elle sono semplice forme, è la bellezza humana; maxime considerato che la pulcritudine del corpo humano richiegga concordia di varii membri, e l'amore riguardi la fruitione della bellezza come suo fine. Questa solo alla mente e al vedere e allo udire s'apartiene. Lo amore adunque in queste tre cose si termina. E lo appetito che gli altri sensi seguita non amore, ma piuttosto libidine o rabbia si chiama. Oltre ad questo, se lo amore inverso lo huomo desidera essa bellezza humana, e la bellezza del corpo humano in una certa conrispondentia consiste, e la conrispondentia è certa temperantia, seguita che non altro appetisca amore se non quelle cose le quali sono temperate, modeste e onorevoli. Sì che e piaceri del gusto e tacto che sono voluptà, cioè piaceri tanto vehementi e furiosi che la mente del proprio stato rimuovono, e l'uomo perturbano, non solo non le desidera amore anzi l'ha in abbominatione, e quelle fugge come cose che per la loro intemperanza sono contrarie alla bellezza. La rabbia venerea, 52 cioè luxuria, tira gli huomini alla intemperanza, e per conseguente alla inconrispondentia; il perché similmente pare che alla deformità, cioè bruttezza, gli huomini tiri, e amore alla bellezza: la deformità e la pulchritudine sono contrarii. Questi movimenti adunque che alla deformità e pulchritudine ci rapiscono, medesimamente appariscono intra loro essere contrarii. Per la qual cosa l'appetito del coito e lo amore non solamente non sono e medesimi moti, ma essere contrarii si mostrano. E questo testificano gli antichi theologi e quali a Dio el nome d'Amore hanno attribuito. La qual cosa ancora e cristiani theologi sommamente confermano, e nessuno nome comune con le cose disoneste è conveniente a Dio. E però ciascuno che è d'intellecto sano si debba guardare che l'amore, certamente nome divino, alle stolte perturbationi scioccamente non transferisca. Vergognisi adunque Dicearco e qualunque altro ha ardire di riprendere la maestà di Platone, che abbi troppo allo amore attribuito. Imperò che agli affecti onesti, onorevoli e divini, non solamente troppo, ma abastanza mai attendere non possiamo. Di qui nasce che ogni amore è onesto e ogni amatore è giusto, perché ogni vero amore è bello e condecente, e propriamente le cose a sé simili ama. Ma lo sfrenato incendio dal quale agli acti lascivi siamo tirati, con ciò sia che egli tragga alla deformità, giudicasi alla bellezza essere contrario. Acciò che adunque noi ritorniamo qualche volta alla utilità d'amore, el timore della infamia che dalle cose inoneste ci discosta, e el desiderio della gloria che alle honorevoli imprese ci fa caldi, agevolmente e presto da amore procedono. E prima perché amore appetisce le cose belle, sempre le laudabili e magnifiche desidera; e chi ha in odio le deforme, necessario è che le disoneste e spurche sempre fugga. Ancora se due insieme s'amano, l'uno all'altro con diligentia attendono, e doversi piacere scambievolmente desiderano: in quanto l'uno dall'altro è atteso, come quegli che mai non mancano di testimonianza, sempre si guardano dalle disoneste cose; in quanto ciascuno di piacere all'altro s'ingegna, sempre con ogni sollecitudine e diligentia alle magnifiche si mettono, acciò che e' non sieno a disprezzo alla persona amata, ma d'essere degni di reciproco amore si stimino. Ma questa ragione copiosissimamente la dimostra Phedro, e pone tre exempli d'amore: uno di femmina di maschio innamorata, dove parla d'Alceste moglie di Admeto, la qual fu contenta morire pe' l suo marito; l'altro di maschio innamorato di femmina, come fu Orfeo di Euridice; terzo di maschio a maschio come fu Patroclo d'Achille, dove dimostra nessuna cosa quanto amore rendere gli huomini forti. Ma l'allegoria d'Alceste o d'Orfeo al presente non ricercheremo; imperò che queste cose, narrandole come storie, molto più mostrano la forza e lo 'mperio d'amore che volendo a quelle sensi allegorici dare. Adunque confessiamo al tutto che Amore sia iddio grande e mirabile; ancora nobile e utilissimo, e in tal modo allo amore opera diamo che del suo fine, che è essa bellezza, rimaniamo contenti. Questa bellezza con quella parte solo con la quale è conosciuta si fruisce, con la mente e col vedere e con l'udire la conosciamo. Adunque con questi tre la possiamo fruire; con gli altri sensi non la bellezza, la quale desidera amore, ma più tosto qualche altra cosa che fa bisogno al corpo possediamo. Con questi tre adunque la bellezza cercheremo, e per quella che si mostra ne' corpi o nelle voci, come per certi vestigi, cioè mezzo conveniente, quella dell'animo investighereno. Lodereno la corporale e quella approvereno, e sempre ci sforzereno d'observare che tanto sia l'amore quanto sia essa bellezza; e dove non l'animo ma solo el corpo fussi bello, quello come ombra e caduca imagine della bellezza appena e leggermente amiamo; dove solamente fussi l'animo bello, questo perpetuo ornamento dell'animo ardentemente amiamo; e dove l'una e l'altra bellezza concorre, vehementissimamente piglieremo admiratione. E così procedendo dimostreremo che noi siamo in verità famiglia platonica, la qual certamente non altro pensa che cose liete, celeste e divine. E questo basti quanto alla oratione di Phedro. Adunque vegnamo a Pausania. QUI FINISCE LA I ORATIONE E COMINCIA LA II 53 Iacobo Sannazaro, Arcadia Iacopo Sannazaro, Opere volgari, a cura di Alfredo Mauro, Bari, Laterza, 1961. Prologo Sogliono il più de le volte gli alti e spaziosi alberi negli orridi monti da la natura produtti, più che le coltivate piante, da dotte mani espurgate, negli adorni giardini a' riguardanti aggradare; e molto più per i soli boschi i selvatichi ucelli sovra i verdi rami cantando, a chi gli ascolta piacere, che per le piene cittadi, dentro le vezzose et ornate gabbie non piacciono gli ammaestrati. Per la qual cosa ancora, sì come io stimo, addiviene, che le silvestre canzoni vergate ne li ruvidi cortecci de' faggi dilettino non meno a chi le legge, che li colti versi scritti ne le rase carte degli indorati libri; e le incerate canne de' pastori porgano per le fiorite valli forse più piacevole suono, che li tersi e pregiati bossi de' musici per le pompose camere non fanno. E chi dubita che più non sia a le umane menti aggradevole una fontana che naturalmente esca da le vive pietre, attorniata di verdi erbette, che tutte le altre ad arte fatte di bianchissimi marmi, risplendenti per molto oro? Certo che io creda niuno. Dunque in ciò fidandomi, potrò ben io fra queste deserte piagge, agli ascoltanti alberi, et a quei pochi pastori che vi saranno, racontare le rozze ecloghe, da naturale vena uscite; così di ornamento ignude esprimendole, come sotto le dilettevoli ombre, al mormorio de' liquidissimi fonti, da' pastori di Arcadia le udii cantare; a le quali non una volta ma mille i montani Idii da dolcezza vinti prestarono intente orecchie, e le tenere Ninfe, dimenticate di perseguire i vaghi animali, lasciarono le faretre e gli archi appiè degli alti pini di Menalo e di Liceo. Onde io, se licito mi fusse, più mi terrei a gloria di porre la mia bocca a la umile fistula di Coridone, datagli per adietro da Dameta in caro duono, che a la sonora tibia di Pallade, per la quale il male insuperbito Satiro provocò Apollo a li suoi danni. Che certo egli è migliore il poco terreno ben coltivare, che 'l molto lasciare per mal governo miseramente imboschire. I Giace nella sommità di Partenio, non umile monte de la pastorale Arcadia, un dilettevole piano, di ampiezza non molto spazioso però che il sito del luogo nol consente, ma di minuta e verdissima erbetta sì ripieno, che se le lascive pecorelle con gli avidi morsi non vi pascesseno, vi si potrebbe di ogni tempo ritrovare verdura. Ove, se io non mi inganno, son forse dodici o quindici alberi, di tanto strana et eccessiva bellezza, che chiunque li vedesse, giudicarebbe che la maestra natura vi si fusse con sommo diletto studiata in formarli. Li quali alquanto distanti, et in ordine non artificioso disposti, con la loro rarità la naturale bellezza del luogo oltra misura annobiliscono. Quivi senza nodo veruno si vede il drittissimo abete, nato a sustinere i pericoli del mare; e con più aperti rami la robusta quercia e l'alto frassino e lo amenissimo platano vi si distendono, con le loro ombre non picciola parte del bello e copioso prato occupando. Et èvi con più breve fronda l'albero, di che Ercule coronar si solea, nel cui pedale le misere figliuole di Climene furono transformate. Et in un de' lati si scerne il noderoso castagno, il fronzuto bosso e con puntate foglie lo eccelso pino carico di durissimi frutti; ne l'altro lo ombroso faggio, la incorruttibile tiglia e 'l fragile tamarisco, insieme con la orientale palma, dolce et onorato premio de' vincitori. Ma fra tutti nel mezzo presso un chiaro fonte sorge verso il cielo un dritto cipresso, veracissimo imitatore de le alte mete, nel quale non che Ciparisso, ma, se dir conviensi, esso Apollo non si sdegnarebbe essere transfigurato. Né sono le dette piante sì discortesi, che del tutto con le lor ombre vieteno i raggi del sole entrare nel dilettoso boschetto; anzi per diverse parti sì graziosamente gli riceveno, che rara è quella erbetta che da quelli non prenda grandissima recreazione. E come che di ogni tempo piacevole stanza vi sia, ne la fiorita primavera più che in tutto il restante anno piacevolissima vi si ritruova. In questo così fatto luogo sogliono sovente i pastori con li loro greggi dagli vicini monti convenire, e quivi in diverse e non leggiere pruove esercitarse; sì come in lanciare il grave palo, in trare con gli archi al versaglio, et in addestrarse nei lievi salti e ne le forti lotte, piene di rusticane insidie; e 'l più de le volte in cantare et in sonare le sampogne a pruova l'un de l'altro, non senza pregio e lode del vincitore. Ma essendo una fiata tra l'altre quasi tutti i convicini pastori con le loro mandre quivi ragunati, e ciascuno, varie maniere cercando di sollacciare, si dava maravigliosa festa, Ergasto solo, senza alcuna cosa dire o fare, appiè di un albero, dimenticato di sé e de' suoi greggi giaceva, non altrimente che se una pietra o un tronco stato fusse, quantunque per adietro solesse oltra gli altri pastori essere dilettevole e grazioso. Del cui misero stato Selvaggio mosso a compassione, per dargli alcun conforto, così amichevolmente ad alta voce cantando gli incominciò a parlare. […] X Le selve che al cantare de' duo pastori, mentre quello durato era, aveano dolcissimamente rimbombato, si tacevano già, quasi contente, acquetandosi a la sentenzia di Montano; il quale ad Apollo, sì come ad aguzzatore de' peregrini ingegni, donando lo onore e la ghirlanda de la vittoria, avea ad ambiduo i suoi pegni renduti. Per la qual cosa noi, lasciando l'erbosa riva, lieti cominciammo per la falda del monte a poggiare, tuttavia ridendo e ragionando de le contenzioni udite. E senza essere oltra a duo tratti di fronda andati, cominciammo appoco appoco da lunge a scoprire il reverendo e sacro bosco, nel quale mai né con ferro né con scure alcuna si osava entrare; ma con religione grandissima, 54 per paura de' vendicatori Dii, fra' paesani populi si conservava inviolato per molti anni. E, se degno è di credersi, un tempo, quando il mondo non era sì colmo di vizii, tutti i pini che vi erano, parlavano, con argute note rispondendo a le amorose canzoni de' pastori. Al quale con lenti passi dal santo sacerdote guidati, sì come lui volse, in un picciolo fonticello di viva acqua, che ne la entrata di quello sorgea, ne lavammo le mani; con ciò sia cosa che con peccati andare in cotal luogo non era da religione concesso. Indi adorato prima il santo Pan, dopo li non conosciuti Dii, se alcuno ve ne era, che per non mostrarsi agli occhi nostri nel latebroso bosco si nascondesse, passammo col destro piede avanti in segno di felice augurio; ciascuno tacitamente in sé pregandoli, li fusseno sempre propizii, così in quel punto, come ne le occorrenti necessità future. Et entrati nel santo pineto, trovammo sotto una pendente ripa, fra ruinati sassi una spelunca vecchissima e grande, non so se naturalmente o se da manuale artificio cavata nel duro monte; e dentro di quella, del medesmo sasso un bello altare, formato da rustiche mani di pastori. Sovra al quale si vedeva di legno la grande effigie del selvatico Idio, appoggiata ad un lungo bastone di una intiera oliva, e sovra la testa avea due corna drittissime et elevate verso il cielo; con la faccia rubiconda come matura fragola, le gambe e i piedi irsuti, né d'altra forma che sono quelli de le capre. Il suo manto era di una pelle grandissima, stellata di bianche macchie. Da l'un lato e da l'altro del vecchio altare pendevano due grandi tavole di faggio, scritte di rusticane lettere; le quali successivamente di tempo in tempo per molti anni conservate dai passati pastori, continevano in sé le antiche leggi e gli ammaestramenti de la pastorale vita; da le quali tutto quello che fra le selve oggi si adopra, ebbe prima origine. Nell'una eran notati tutti i dì de l'anno e i varii mutamenti de le stagioni, e la inequalità de la notte e del giorno, inseme con la osservazione de le ore, non poco necessaria a' viventi, e li non falsi pronostici de le tempestati; e quando il sole col suo nascimento denunzia serenità e quando pioggia, e quando vènti e quando grandini; e quali giorni son de la luna fortunati e quali infelici a le opre de' mortali; e che ciascuno in ciascuna ora dovesse fuggire o seguitare, per non offendere le osservabili voluntà degli Dii. Ne l'altra si leggeva quale dovesse essere la bella forma de la vacca e del toro; e le età idonee al generare et al parturire; e le stagioni e i tempi atti a castrare i vitelli, per poterli poi nel giogo usare a le robuste opre de la agricultura. Similmente come la ferocità de' montoni, forandoli il corno presso l'orecchia, si possa mitigare; e come legandoli il destro testicolo, genera femine, e 'l sinestro mascoli; et in che modo gli agnelli vegnano bianchi o di altri colori variati; e qual rimedio sia a le solitarie pecore, che per lo spavento de' tuoni non si abortiscano. Et oltra a questo che governo si convegna a le barbute capre, e quali e di che forma e di che etade, et in che tempo de l'anno et in che paese quelle siano più fruttifere; e come i loro anni si possano ai segni de le noderose corna chiaramente conoscere. Appresso vi erano scritte tutte le medicine appertinenti a' morbi, tanto de' greggi, quanto de' cani e de' pastori. Dinanzi a la spelunca porgeva ombra un pino altissimo e spazioso, ad un ramo del quale una grande e bella sampogna pendeva, fatta di sette voci, egualmente di sotto e di sopra congiunta con bianca cera; la cui simile forse mai non fu veduta a pastore in alcuna selva. De la quale dimandando noi qual fusse stato lo auttore, perché da divine mani composta et incerata la giudicavamo, il savio sacerdote così ne respuse: — Questa canna fu quella che 'l santo Idio, che voi ora vedete, si trovò ne le mani, quando per queste selve da amore spronato seguitò la bella Siringa. Ove, poi che per la sùbita transformazione di lei si vide schernito, sospirando egli sovente per rimembranza de le antiche fiamme, i sospiri si convertirono in dolce suono. E così, solo, in questa sola grotta, assiso presso a le pascenti capre, cominciò a congiungere con nova cera sette canne, lo ordine de le quali veniva successivamente mancando, in guisa che stanno i diti ne le nostre mani, sì come ora in essa medesma vedere potete; con la qual poi gran tempo pianse in questi monti le sue sventure. Indi pervenne, e non so come, ne le mani d'un pastore siracusano; il quale prima che alcuno altro ebbe ardire di sonarla senza paura di Pan o d'altro Idio, sovra le chiare onde de la compatriota Aretusa. Et è fama che mentre costui cantava, i circonstanti pini movendo le loro sommità li rispondeano; e le forestiere querce, dimenticate de la propria selvatichezza, abandonavano i nativi monti per udirlo, porgendo sovente piacevoli ombre a le ascoltanti pecorelle; né era Ninfa alcuna né Fauno in quelle selve, che di attrecciare ghirlande non si affatigasse, per ornarli di freschi fiori i giovenili capelli. Il quale poi da invidiosa morte sovragiunto, fe' di quella lo ultimo dono al mantuano Titiro, e così col mancante spirto, porgendogliela, li disse: «Tu sarai ora di questa il secondo signore; con la quale potrai a tua posta riconciliare li discordevoli tauri, rendendo graziosissimo suono a li selvatichi Idii». Per la qual cosa Titiro lieto di tanto onore, con questa medesma sampogna dilettandosi, insegnò primeramente le selve di risonare il nome de la formosa Amarillida; e poi, appresso, lo ardere del rustico Coridone per Alessi; e la emula contenzione di Dameta e di Menalca; e la dolcissima musa di Damone e di Alfesibeo, facendo sovente per maraviglia dimenticare le vacche di pascere, e le stupefatte fiere fermare fra' pastori, e i velocissimi fiumi arrestare dai corsi loro, poco curando di rendere al mare il solito tributo; aggiungendo a questo la morte di Dafni, la canzone di Sileno e 'l fiero amore di Gallo, con altre cose di che le selve credo ancora si ricordino e ricorderanno mentre nel mondo saranno pastori. Ma avendo costui da la natura lo ingegno a più alte cose disposto, e non contentandosi di sì umile suono, vi cangiò quella canna che voi ora vi vedete più grossa e più che le altre nova, per poter meglio cantare le cose maggiori, e fare le selve degne degli altissimi consuli di Roma. «Il quale poi che abandonate le capre si diede ad ammaestrare i rustichi coltivatori de la terra, forse con isperanza di cantare appresso con più sonora tromba le arme del troiano Enea, la appiccò quivi, ove ora la vedete, in onore di questo Idio, che nel cantare li avea prestato favore. Appresso al quale non venne mai alcuno in queste selve, che quella sonare potuto avesse compitamente; posto che molti, da volenteroso ardire spronati, tentato lo abbiano più volte e tentino tuttavia. 55 Ma perché il giorno tutto fra questi ragionamenti non trapassi, tornando omai a quello per che venuti siete, dico, l'opra e 'l saper mio così a tutt'i vostri bisogni, come a questo un solo, essere sempre non men disposto che apparecchiato. E con ciò sia cosa che ora per lo scemo de la cornuta luna il tempo molto atto non sia, udrete non di meno del luogo e del modo che a tenere avremo alquanto ragionare. E tu principalmente, inamorato pastore, a chi il fatto più tocca, porgi intentivamente le orecchie a le mie parole. Non molto lunge di qui, fra deserti monti giace una profondissima valle, cinta d'ogn'intorno di solinghe selve e risonanti di non udita selvatichezza; sì bella, sì maravigliosa e strana, che di primo aspetto spaventa con inusitato terrore gli animi di coloro che vi entrano; i quali poi che in quella per alquanto spazio rassicurati si sono, non si possono saziare di contemplarla. Ove per un solo luogo, e quello strettissimo et aspro, si conviene passare; e quanto più basso si scende, tanto vi si trova la via più ampia e la luce diventa minore, con ciò sia cosa che da la sua sommità insino a la più infima parte è da opache ombre di gioveni alberi quasi tutta occupata. Ma poi che al fondo di quella si perviene, una grotta oscurissima e grande vi si vede incontanente aprire di sotto ai piedi; ne la quale arrivando, si sentono sùbito strepiti orribilissimi, fatti divinamente in quel luogo da non veduti spirti, come se mille milia naccari vi si sonassono. E quivi dentro in quella oscurità nasce un terribilissimo fiume, e per breve spazio contrastando ne la gran voragine, e non possendo di fuora uscire, si mostra solamente al mondo et in quel medesmo luogo si sommerge; e così nascoso per occolta via corre nel mare, né di lui più si sa novella alcuna sovra de la terra. Luogo veramente sacro, e degno, sì come è, di essere sempre abitato dagli Dii. Niuna cosa non venerabile o santa vi si può giudicare; con tanta maiestà e riverenza si offre agli occhi de' riguardanti. Or quivi, come la candida luna con ritonda faccia apparirà a' mortali sovra l'universa terra, ti menerò io primeramente a purgarti, se di venirvi ti darà il core; e bagnato che ti avrò nove volte in quelle acque, farò di terra e di erbe un novo altare, et in quello, circondato di tre veli di diversi colori, raccenderò la casta verbena e maschi incensi, con altre erbe non divelte da le radici, ma secate con acuta falce al lume de la nova luna. Dopo spargerò per tutto quel luogo acque tolte da tre fontane, e farotti poi, discinto e scalzo d'un piede, sette volte attorniare il santo altare, dinanzi al quale io con la manca mano tenendo per le corna una nera agna, e con la destra lo acuto coltello, chiamarò ad alta voce trecento nomi di non conosciuti Dii; e con quelli la riverenda Notte accompagnata da le sue tenebre, e le tacite Stelle consapevoli de le occolte cose, e la moltiforme Luna potente nel cielo e negli oscuri abissi, e la chiara faccia del Sole circondata di ardenti raggi; la quale continuamente discorrendo intorno al mondo, vede senza impedimento veruno tutte le opere de' mortali. Appresso convocarò quanti Dii abitano ne l'alto cielo, ne la ampia terra e ne lo undoso mare; e 'l grandissimo Oceano padre universale di tutte le cose, e le vergini Ninfe generate da lui: cento che ne vanno per le selve, e cento che guardano i liquidi fiumi; et oltra a questi, Fauni, Lari, Silvani e Satiri, con tutta la frondosa schiera de' semidei, e 'l sommo Aere, e 'l durissimo aspetto de la bruta Terra, i stanti Laghi, i correnti Fiumi e i sorgenti Fonti. Né lascerò li oscuri regni de li sutterranei Dii; ma convocando la tergemina Ecate, vi aggiungerò il profondo Caos, il grandissimo Erebo e le infernali Eumenidi abitatrici de le stigie acque; e alcuna altra deità è là giù, che con degno supplicio punisca le scelerate colpe degli uomini, che siano tutte presenti al mio sacrificio. E così dicendo, prenderò un vaso di generoso vino e versarollo ne la fronte de la dannata pecora, e disvellendoli da mezzo le corna la fosca lana, la gitterò nel fuoco per primi libamenti; dopo, aprendoli la gola col destinato coltello, riceverò in una patera il caldo sangue, e quello con gli estremi labri gustato, versarò tutto in una fossa fatta dinanzi a l'altare, con oglio e latte inseme, acciò che ne goda la madre terra. E preparato che ti avrò in cotal modo, sovra la pelle di quella ti farò distendere; e di sangue di nottola ti ungerò gli occhi con tutto il viso, che le tenebre de la notte al vedere non ti offendano, ma come chiaro giorno ti manifestino tutte le cose. Et acciò che le strane e diversissime figure de' convocati Dii non ti spaventino, ti porrò indosso una lingua, uno occhio et una spoglia di libiano serpente, con la destra parte del core d'un leone inveterato e secco all'ombra solamente de la piena luna. Appresso a questo comanderò ai pesci, a le serpi, a le fiere et agli ucelli (dai quali, quando mi piace, intendo e proprietà de le cose e gli occolti secreti degli Dii) che vegnano tutti a me di presente, senza fare dimora alcuna. Per la qual cosa quelli solamente retinendo meco che mistiero mi faranno, gli altri rimanderò via ne le loro magioni. Et aperta la mia tasca, ne trarrò veleni potentissimi, coi quali a mia posta soglio io transformarmi in lupo, e lasciando i panni appiccati ad alcuna quercia, mescolarmi fra gli altri ne le deserte selve; non già per predare come molti fanno, ma per intendere i loro secreti, e gl'inganni che si apparecchiano a' pastori di fare; i quali potranno ancora al tuo bisogno commodamente servire. E se uscire da amore totalmente vorrai, con acqua lustrale e benedetta ti inaffiarò tutto, soffumigandoti con vergine solfo, con issopo e con la casta ruta. Da poi ti spargerò sovra al capo de la polvere, ove mula o altro sterile animale involutrato si sia; e sciogliendoti un per uno tutti i nodi che indosso avrai ti farò prendere la cenere dal sacro altare, et a due mani per sovra 'l capo gettarlati dopo le spalle nel corrente lume, senza voltare più gli occhi indietro. Il quale subitamente con le sue acque ne porterà il tuo amore ne l'alto mare, lasciandolo ai delfini et a le notanti balene. Ma se più tosto la tua nemica ad amarti di constringere tieni in desio, farò venire erbe da tutta Arcadia, e sugo di nero aconito, e la picciola carne rapita dal fronte del nascente cavallo prima che la madre di inghiottirla si apparecchiasse. E fra queste cose, sì come io ti insegnarò, legarai una imagine di cera in tre nodi con tre lacci di tre colori; e tre volte con quella in mano attorniando lo altare, altre tante li pungerai il core con punta di omicida spada, tacitamente dicendo queste parole: 56 Colei pungo et astringo, Che nel mio cor depingo. Appresso avrai alcuna parte del lembo de la sua gonna, e piegandola appoco appoco, e così piegata sotterrandola ne la cavata terra, dirai: Tutte mie pene e doglie Richiudo in queste spoglie. Da poi ardendo un ramo di verde lauro, soggiungerai: Così strida nel foco Chi il mio mal prende in gioco. Indi prendendo io una bianca colomba, e tu tirandoli una per una le penne e gittandole ne le fiamme, seguiterai: Di chi il mio bene ha in possa Spargo le carni e l'ossa. Al fine, poi che la avrai tutta spogliata, lasciandola sola andare, farai così l'ultimo incanto: Rimanti, iniqua e cruda, D'ogni speranza ignuda. Et ogni fiata che le dette cose farai, sputerai tre volte, però che de l'impari numero godono i magichi Dii. Né dubito punto che saranno di tanta efficacia queste parole, che, senza repugnanza alcuna fare, la vedrai a te venire, non altrimente che le furiose cavalle ne le ripe de lo estremo occidente sogliano i genitabili frati di zefiro aspettare. E questo ti affermo per la deità di questa selva e per la potenzia di quello Idio, il quale ora presente standone, ascolta il mio ragionare. — E così detto, puse silenzio a le sue parole; le quali quanto diletto porgesseno a ciascuno, non è da dimandare. Ma parendone finalmente ora di ritornare a le lasciate mandre, benché il sole fusse ancora molto alto, dopo molte grazie con parole renduteli, ne licenziammo da lui; e per una via più breve postine a scendere il monte, andavamo con non poca ammirazione comendando lo udito pastore; tanto che quasi al piano discesi, essendo il caldo grande e veggendone un boschetto fresco davanti, deliberammo di volere udire alcuno de la brigata cantare. Per la qual cosa Opico a Selvaggio il carco ne impuse, dandogli per soggetto che lodasse il nobile secolo, il quale di tanti e tali pastori si vedeva copiosamente dotato; con ciò fusse cosa che in nostra età ne era concesso vedere et udire pastori cantare fra gli armenti, che dopo mille anni sarebbono desiati fra le selve. E stando costui già per cominciare rivolse, non so come, gli occhi in un picciolo colle che da man destra gli stava, e vide l'alto sepolcro ove le riverende ossa di Massilia si riposano con eterna quiete; Massilia, madre di Ergasto, la quale fu, mentre visse, da' pastori quasi divina Sibilla riputata. Onde drizzatosi in piedi disse: — Andiamo colà, pastori; ché se dopo le esequie le felici anime curano de le mondane cose, la nostra Massilia ne avrà grazia nel cielo del nostro cantare; la quale sì dolcemente soleva un tempo tra noi le contenzioni decidere, dando modestamente ai vinti animo, e comendando con maravigliose lode i vincitori. — A tutti parve ragionevole quello che Selvaggio disse, e con espediti passi, l'un dopo l'altro, molto con parole raconsolando il piangente Ergasto, vi andammo. Ove giunti, avemmo tanto da contemplare e da pascere gli occhi, quanto da' pastori in alcuna selva si avesse giamai; et udite come. Era la bella piramide in picciolo piano sovra una bassa montagnetta posta, fra due fontane di acque chiarissime e dolci, con la punta elevata verso il cielo in forma d'un dritto e folto cipresso; per le cui latora, le quali quattro erano, si potevano vedere molte istorie di figure bellissime, le quali lei medesma, essendo già viva, aveva in onore de' suoi antichi avoli fatte dipingere, e quanti pastori ne la sua prosapia erano in alcun tempo stati famosi e chiari per li boschi, con tutto il numero de' posseduti armenti. E dintorno a quella porgevano con suoi rami ombra alberi giovenissimi e freschi, non ancora cresciuti a pare altezza de la bianca cima, però che di poco tempo avanti vi erano dal pietoso Ergasto stati piantati. Per compassione del quale molti pastori ancora avevano il luogo circondato di alte sepi, non di pruni o di rubi, ma di genebri, di rose e di gelsomini; e formatovi con le zappe un seggio pastorale, e di passo in passo alquante torri di rosmarino e di mirti, intessute con mirabilissimo artificio. Incontro a le quali con gonfiate vele veniva una nave, fatta solamente di vimini e di fronde di viva edera, sì naturalmente che avresti detto: «Questa solca il tranquillo mare»; per le sarte de la quale, ora nel temone et ora ne la alta gabbia, andavano cantanti ucelli vagandosi, in similitudine di esperti e destrissimi naviganti. Così ancora per mezzo degli alberi e de le sepi si vedevano fiere bellissime e snelle allegramente saltare e scherzare con varii giochi, bagnandosi per le fredde acque; credo forse per dare diletto a le piacevoli Ninfe guardiane del luogo e de le sepolte ceneri. A queste bellezze se ne aggiungeva una non meno da comendare che qualsivoglia de le altre; con ciò sia cosa che tutta la terra si potea vedere coverta di fiori, anzi di terrene stelle, e di tanti colori dipinta, quanti ne la pomposa coda del superbo pavone o nel celestiale arco, quando a' mortali denunzia pioggia, se ne vedeno variare. Quivi gigli, quivi ligustri, quivi viole tinte di amorosa pallidezza, et in gran copia i sonnacchiosi papaveri con le inchinate teste, e le rubiconde spighe de l'immortale amaranto, graziosissime corone ne l'orrido verno. Finalmente quanti fanciulli e magnanimi re furono nel primo tempo pianti dagli antichi pastori, tutti si vedevano quivi transformati fiorire, servando ancora gli avuti nomi: Adone, Iacinto, Aiace e 'l giovene Croco con la amata donzella; e fra questi il vano Narcisso si poteva ancora comprendere che contemplasse sopra quelle acque la dannosa bellezza che di farlo partire dai vivi gli fu cagione. 57 Le quali cose poi che di una in una avemmo fra noi maravigliosamente comendate, e letto ne la bella sepoltura il degno epitafio, e sovra a quella offerte di molte corone, ne ponemmo inseme con Ergasto in letti di alti lentischi distesi a giacere. Ove molti olmi, molte querce e molti allori sibilando con le tremule frondi, ne si moveano per sovra al capo; ai quali aggiungendosi ancora il mormorare de le roche onde, le quali fuggendo velocissime per le verdi erbe andavano a cercare il piano, rendevano inseme piacevolissimo suono ad udire. E per li ombrosi rami le argute cicale cantando si affatigavano sotto al gran caldo; la mesta Filomena da lunge tra folti spineti si lamentava; cantavano le merole, le upupe e le calandre; piangeva la solitaria tortora per le alte ripe; le sollecite api con suave susurro volavano intorno ai fonti. Ogni cosa redoliva de la fertile estate: redolivano i pomi per terra sparsi, de' quali tutto il suolo dinanzi ai piedi e per ogni lato ne vedevamo in abondanza coverto; sovra ai quali i bassi alberi coi gravosi rami stavano sì inchinati, che quasi vinti dal maturo peso parea che spezzare si volessono. Onde Selvaggio, a cui sovra la imposta materia il cantare toccava, facendo con gli occhi segnale a Fronimo che gli rispondesse, ruppe finalmente il silenzio in queste voci: […] XI Se le lunghe rime di Fronimo e di Selvaggio porsono universalmente diletto a ciascuno de la nostra brigata, non è da dimandare. A me veramente, oltra al piacere grandissimo, commossono per forza le lacrime, udendo sì ben ragionare de l'amenissimo sito del mio paese. Che già mentre quelli versi durarono, mi parea fermamente essere nel bello e lieto piano che colui dicea; e vedere il placidissimo Sebeto, anzi il mio napolitano Tevere, in diversi canali discorrere per la erbosa campagna, e poi tutto inseme raccolto passare soavemente sotto le volte d'un picciolo ponticello, e senza strepito alcuno congiungersi col mare. Né mi fu picciola cagione di focosi sospiri lo intender nominare Baie e Vesuvio, ricordandomi de' diletti presi in cotali luoghi. Coi quali ancora mi tornaro a la memoria i soavissimi bagni, i maravigliosi e grandi edificii, i piacevoli laghi, le dilettose e belle isolette, i sulfurei monti, e con la cavata grotta la felice costiera di Pausilipo, abitata di ville amenissime e soavemente percossa da le salate onde. Et appresso a questo, il fruttifero monte sovraposto a la città, et a me non poco grazioso, per memoria degli odoriferi roseti de la bella Antiniana, celebratissima Ninfa del mio gran Pontano. A questa cogitazione ancora si aggiunse il ricordarmi de le magnificenzie de la mia nobile e generosissima patria. La quale di tesori abondevole, e di ricco et onorato populo copiosa, oltra al grande circuito de le belle mura, contiene in sé il mirabilissimo porto, universale albergo di tutto il mondo; e con questo le alte torri, i ricchi templi, i superbi palazzi, i grandi et onorati seggi de' nostri patrizii, e le strade piene di donne bellissime e di leggiadri e riguardevoli gioveni. Che dirò io de' giochi, de le feste, del sovente armeggiare, di tante arti, di tanti studii, di tanti laudevoli esercizii? che veramente non che una città, ma qualsivoglia provincia, qualsivoglia opulentissimo regno ne sarebbe assai convenevolmente adornato. E sopra tutto mi piacque udirla comendare de' studii de la eloquenzia e de la divina altezza de la poesia; e tra le altre cose, de le merite lode del mio virtuosissimo Caracciolo, non picciola gloria de le volgari Muse; la canzone del quale, e se per lo coverto parlare fu poco da noi intesa, non rimase però che con attenzione grandissima non fusse da ciascuno ascoltata. Altro che se forse da Ergasto, il quale, mentre quel cantare durò, in una fissa e lunga cogitazione vidi profondamente occupato, con gli occhi sempre fermati in quel sepolcro, senza moverli punto né battere palpebra mai, a modo di persona alienata; et a le volte mandando fuori alcune rare lacrime, e con le labra non so che fra se stesso tacitamente submormorando. Ma finito il cantare, e da diversi in diversi modi interpretato, perché la notte si appressava e le stelle cominciavano ad apparere nel cielo, Ergasto, quasi da lungo sonno svegliato, si drizzò in piedi, e con pietoso aspetto vèr noi volgendosi disse: — Cari pastori, sì come io stimo, non senza voluntà degli Dii la fortuna a questo tempo ne ha qui guidati; con ciò sia cosa che 'l giorno, il quale per me sarà sempre acerbo e sempre con debite lacrime onorato, è finalmente a noi con opportuno passo venuto; e compiesi dimane lo infelice anno, che con vostro commune lutto e dolore universale di tutte le circonstanti selve, le ossa de la vostra Massilia furono consecrate a la terra. Per la qual cosa, sì tosto come il sole, fornita questa notte, averà con la sua luce cacciate le tenebre, e gli animali usciranno a pascere per le selve, voi similmente convocando gli altri pastori, verrete qui a celebrar meco i debiti officii e i solenni giochi in memoria di lei, secondo la nostra usanza. Ove ciascuno de la sua vittoria averà da me quel dono, che da le mie facultà si puote espettare. — E così detto, volendo Opico con lui rimanere, perché vecchio era, non gli fu permesso; ma datigli alquanti gioveni in sua compagna, la maggior parte di noi quella notte si restò con Ergasto a veghiare. Per la qual cosa, essendo per tutto oscurato, accendemmo di molte fiaccole intorno a la sepoltura, e sovra la cima di quella ne ponemmo una grandissima, la quale forse da lunge a' riguardanti si dimostrava quasi una chiara luna in mezzo di molte stelle. Così tutta quella notte tra fochi, senza dormire, con suavi e lamentevoli suoni si passò; ne la quale gli ucelli ancora, quasi studiosi di superarne, si sforzavano per tutti gli alberi di quel luogo a cantare; e i silvestri animali, deposta la solita paura, come se demesticati fusseno, intorno a la tomba giacendo, parea che con piacere maraviglioso ne ascoltasseno. E già in questo la vermiglia Aurora alzandosi sovra la terra, significava a' mortali la venuta del sole, quando di lontano a suon di sampogna sentimmo la brigata venire, e dopo alquanto spazio, rischiarandosi tuttavia il cielo, gli cominciammo a scoprire nel piano; li quali tutti in schiera venendo vestiti e coverti di frondi, con rami lunghissimi in mano, parevano da lungi a vedere non uomini che venisseno, ma una verde selva che tutta inseme con gli alberi si 58 movesse vèr noi. A la fine giunti sovra al colle ove noi dimoravamo, Ergasto ponendosi in testa una corona di biancheggianti ulivi, adorò prima il sorgente sole: dopo a la bella sepoltura voltatosi, con pietosa voce, ascoltando ciascuno, così disse: — Materne ceneri, e voi castissime e reverende ossa, se la inimica Fortuna il potere mi ha tolto di farve qui un sepolcro eguale a questi monti, e circondarlo tutto di ombrose selve con cento altari dintorno, e sovra a quelli ciascun matino cento vittime offrirvi, non mi potrà ella togliere che con sincera voluntà et inviolabile amore questi pochi sacrificii non vi renda e con la memoria e con le opre, quanto le forze si stendono, non vi onore. — E così dicendo, fe' le sante oblazioni, basciando religiosamente la sepoltura. Intorno a la quale i pastori ancora collocarono i grandi rami che in mano teneano, e chiamando tutti ad alta voce la divina anima, ferono similmente i loro doni: chi uno agnello, chi uno favo di mèle, chi latte, chi vino, e molti vi offersono incenso con mirra et altre erbe odorifere. Allora Ergasto, fornito questo, propose i premii a coloro che correre volesseno; e facendosi venire un bello e grande ariete, le cui lane eran bianchissime e lunghe tanto che quasi i piedi gli toccavano, disse: — Questo sarà di colui, a cui nel correre la sua velocità e la Fortuna concederanno il primo onore. Al secondo è apparecchiata una nova e bella fiscina, convenevole instrumento al sordido Bacco; e 'l terzo rimarrà contento di questo dardo di genebro, il quale ornato di sì bel ferro, potrà e per dardo servire e per pastorale bastone. — A queste parole si ferono avanti Ofelia e Carino, gioveni leggerissimi et usati di giungere i cervii per le selve; e dopo questi, Logisto e Galicio, e 'l figliuolo di Opico chiamato Partenopeo, con Elpino e Serrano, et altri lor compagni più gioveni e di minore estima. E ciascuno postosi al dovuto ordine, non fu sì tosto dato il segno, che ad un tempo tutti cominciarono a stendere i passi per la verde campagna con tanto impeto, che veramente saette o fólgori avresti detto che stati fusseno; e tenendo sempre gli occhi fermi ove arrivare intendeano, si sforzava ciascuno di avanzare i compagni. Ma Carino con maravigliosa leggerezza era già avanti a tutti. Appresso al quale ma di bona pezza seguiva Logisto, e dopo Ofelia; a le cui spalle era sì vicino Galicio, che quasi col fiato il collo gli riscaldava e i piedi in quelle medesme pedate poneva, e se più lungo spazio a correre avuto avessono, lo si avrebbe senza dubbio lasciato dopo le spalle. E già vincitore Carino poco avea a correre, che la disegnata meta toccata avrebbe, quando, non so come, gli venne fallito un piede, o sterpo o petra o altro che se ne fusse cagione; e senza potere punto aitarsi, cadde subitamente col petto e col volto in terra. Il quale, o per invidia non volendo che Logisto la palma guadagnasse, o che da vero levar si volesse, non so in che modo ne l'alzarsi gli oppose davanti una gamba, e con la furia medesma che colui portava, il fe' parimente a sé vicino cadere. Caduto Logisto, cominciò Ofelia con maggiore studio a sforzare i passi per lo libero campo, vedendosi già esser primo; a cui il gridare de' pastori e 'l plauso grandissimo aggiungevano animo a la vittoria. Tal che arrivando finalmente al destinato luogo, ottenne, sì come desiderava, la prima palma. E Galicio, che più che gli altri appreso gli era, ebbe il secondo pregio, e 'l terzo Partenopeo. Qui con gridi e rumori cominciò Logisto a lamentarsi de la frode di Carino, il quale opponendogli il piede, gli avea tolto il primo onore, e con instanzia grandissima il dimandava. Ofelia in contrario diceva esser suo, e con ambe le mani si tenea per le corna il guadagnato ariete. Le voluntà de' pastori in diverse parti inclinavano, quando Partenopeo, figliuolo di Opico, sorridendo disse: — E se a Logisto date il primo dono, a me, che sono ora il terzo, quale darete?— A cui Ergasto con lieto volto rispose: — Piacevolissimi gioveni, i premii che già avuti avete, vostri saranno; a me fia licito aver pietà de l'amico. — E così dicendo, donò a Logisto una bella pecora con duo agnelli. Il che vedendo Carino, ad Ergasto voltosi, disse: — Se tanta pietà hai degli amici caduti, chi più di me merita esser premiato? che senza dubbio sarei stato il primo, se la medesma sòrte che nocque a Logisto, non fusse a me stata contraria. — E dicendo queste parole, mostrava il petto, la faccia e la bocca tutta piena di polvere; per modo che movendo riso a' pastori, Ergasto fe' venire un bel cane bianco, e tenendolo per le orecchie, disse: — Prendi questo cane, il cui nome è Asterion, nato d'un medesmo padre con quel mio antico Petulco, il quale sovra tutti i cani fedelissimo et amorevole, meritò per la sua immatura morte essere da me pianto, e sempre con sospiro ardentissimo nominato. — Acquetato era il rumore e 'l dire de' pastori, quando Ergasto cacciò fuori un bel palo grande e lungo e ponderoso per molto ferro, e disse: — Per duo anni non arà mistiero di andare a la città né per zappe né per pale né per vomeri colui che in trar questo sarà vincitore; ché 'l medesmo palo gli sarà e fatica e premio. — A queste parole Montano et Elenco con Eugenio et Ursacchio si levarono in piedi; e passando avanti e postisi ad ordine, cominciò Elenco ad alzare di terra il palo; e poi che fra sé molto bene esaminato ebbe il peso di quello, con tutte sue forze si mise a trarlo, né però molto da sé il poteo dilungare. Il qual colpo fu sùbito segnato da Ursacchio; ma credendosi forse che in ciò solo le forze bastare gli dovesseno, benché molto vi si sforzasse, il trasse per forma che fe' tutti ridere i pastori, e quasi davanti ai piedi sel fe' cadere. Il terzo che 'l tirò fu Eugenio, il quale di bono spazio passò i duo precedenti. Ma Montano, a cui l'ultimo tratto toccava, fattosi un poco avanti, si bassò in terra, e prima che il palo prendesse, due o tre volte dimenò la mano per quella polvere; dopo, presolo, et aggiungendo alquanto di destrezza a la 59 forza, avanzò di tanto tutti gli altri, quanto due volte quello era lungo. A cui tutti i pastori applausono, con ammirazione lodando il bel tratto che fatto avea. Per la qual cosa Montano, presosi il palo, si ritornò a sedere. Et Ergasto fe' cominciare il terzo gioco, il quale fu di tal sòrte. Egli di sua mano con un de' nostri bastoni fe' in terra una fossa, picciola tanto, quanto solamente con un piè vi si potesse fermare un pastore, e l'altro tenere alzato, come vedemo spesse volte fare a le grue. Incontro al quale un per uno similmente con un piè solo aveano da venire gli altri pastori, e far prova di levarlo da quella fossa e porvisi lui. Il perdere, tanto de l'una parte quanto de l'altra, era toccare con quel piè che suspeso tenevano, per qualsivoglia accidente, in terra. Ove si videro di molti belli e ridiculi tratti, ora essendone cacciato uno et ora un altro. Finalmente toccando ad Ursacchio di guardare il luogo, e venendoli un pastore molto lungo davanti, sentendosi lui ancora scornato del ridere de' pastori, e cercando di emendare quel fallo che nel trare del palo commesso avea cominciò a servirse de le astuzie, e bassando in un punto il capo, con grandissima prestezza il puse tra le cosce di colui che per attaccarsi con lui gli si era appressato; e senza fargli pigliar fiato, sel gettò con le gambe in aere per dietro le spalle, e sì lungo come era, il distese in quella polvere. La maraviglia, le risa e i gridi de' pastori furono grandi. Di che Ursacchio prendendo animo, disse: — Non possono tutti gli uomini tutte le cose sapere. Se in una ho fallato, ne l'altra mi basta avere ricoprato lo onore. — A cui Ergasto ridendo affermò che dicea bene; e cavandosi dal lato una falce delicatissima col manico di bosso, non ancora adoprata in alcuno esercizio, gliela diede. E sùbito ordinò i premii a coloro che lottare volessono, offrendo di dare al vincitore un bel vaso di legno di acero, ove per mano del padoano Mantegna, artefice sovra tutti gli altri accorto et ingegnosissimo, eran dipinte molte cose; ma tra l'altre una Ninfa ignuda, con tutti i membri bellissimi, dai piedi in fuori, che erano come quegli de le capre. La quale sovra un gonfiato otre sedendo, lattava un picciolo Satirello, e con tanta tenerezza il mirava, che parea che di amore e di carità tutta si struggesse; e 'l fanciullo ne l'una mammella poppava, ne l'altra tenea distesa la tenera mano, e con l'occhio la si guardava, quasi temendo che tolta non gli fosse. Poco discosto da costoro si vedean duo fanciulli pur nudi, i quali avendosi posti duo volti orribili di mascare, cacciavano per le bocche di quelli le picciole mani, per porre spavento a duo altri che davanti gli stavano; de' quali l'uno fuggendo si volgea indietro e per paura gridava, l'altro caduto già in terra piangeva, e non possendosi altrimente aitare, stendeva la mano per graffiarli. Ma di fuori del vaso correva a torno a torno una vite carica di mature uve; e ne l'un de' capi di quella un serpe si avolgeva con la coda, e con la bocca aperta venendo a trovare il labro del vaso, formava un bellissimo e strano manico da tenerlo. Incitò molto gli animi de' circonstanti a dovere lottare la bellezza di questo vaso; ma pure stettono a vedere quello che i maggiori e più reputati facessono. Per la qual cosa Uranio, veggendo che nessuno ancora si movea, si levò sùbito in piedi e spogliatosi il manto, cominciò a mostrare le late spalle. Incontro al quale animosamente uscì Selvaggio, pastore notissimo e molto stimato fra le selve. La espettazione de' circonstanti era grande, vedendo duo tali pastori uscire nel campo. Finalmente l'un verso l'altro approssimatosi, poi che per bono spazio riguardati si ebbero dal capo insino ai piedi, in un impeto furiosamente si ristrinsero con le forti braccia; e ciascuno deliberato di non cedere, parevano a vedere duo rabbiosi orsi o duo forti tori, che in quel piano combattessono. E già per ogni membro ad ambiduo correva il sudore, e le vene de le braccia e de le gambe si mostravano maggiori e rubiconde per molto sangue; tanto ciascuno per la vittoria si affaticava. Ma non possendosi in ultimo né gittare né dal luogo movere, e dubitando Uranio che a coloro, i quali intorno stavano, non rincrescesse lo aspettare, disse: — Fortissimo et animosissimo Selvaggio, il tardare, come tu vedi, è noioso: o tu alza me di terra, o io alzarò te; e del resto lassiamo la cura agli Dii —; e così dicendo il sospese da terra. Ma Selvaggio, non dimenticato de le sue astuzie, gli diede col talone dietro a la giuntura de le ginocchia una gran botta, per modo che facendoli per forza piegare le gambe il fe' cadere sopino, e lui senza potere aitarsi gli cadde di sopra. Allora tutti i pastori maravigliati gridarono. Dopo questo, toccando la sua vicenda a Selvaggio di dovere alzare Uranio, il prese con ambedue le braccia per mezzo; ma per lo gran peso e per la fatica avuta non possendolo sustinere, fu bisogno, quantunque molto vi si sforzasse, che ambiduo così giunti cadessono in quella polvere. A l'ultimo alzatisi, con malo animo si apparecchiavano a la terza lotta. Ma Ergasto non volse che le ire più avanti procedessono, et amichevolmente chiamatili, gli disse: — Le vostre forze non son ora da consumarsi qui per sì picciolo guidardone. Eguale è di ambiduo la vittoria, et eguali doni prenderete. — E così dicendo, a l'uno diede il bel vaso, a l'altro una cetara nova, parimente di sotto e di sopra lavorata e di dolcissimo sòno; la quale egli molto cara tenea per mitigamento e conforto del suo dolore. Avevano per aventura la precedente notte i compagni di Ergasto dentro la mandra preso un lupo; e per una festa il tenean così vivo legato ad un di quegli alberi. Di questo pensò Ergasto dover fare in quel giorno lo ultimo gioco; et a Clonico voltandosi, il quale per niuna cosa ancora levato si era da sedere, gli disse: — E tu lasserai oggi così inonorata la tua Massilia, che in sua memoria non abbii di te a mostrare prova alcuna? Prendi, animoso giovene, la tua fronda, e fa conoscere agli altri che tu ancora ami Ergasto. — E questo dicendo, a lui et agli altri mostrò il legato lupo, e disse: — Chi per difendersi da le piogge del guazzoso verno desidera un cucullo o tabarro di pelle di lupo, adesso con la sua fionda in quel versaglio sel può guadagnare. — 60 Allora Clonico e Partenopeo e Montano, poco avanti vincitore nel palo, con Fronimo cominciarono a scingersi le fionde et a scoppiare fortissimamente con quelle; e poi gittate fra loro le sòrti, uscì prima quella di Montano, l'altra appresso fu di Fronimo, la terza di Clonico, la quarta di Partenopeo. Montano adunque lieto ponendo una viva selce ne la rete de la sua fronda, e con tutta sua forza rotandolasi intorno al capo, la lasciò andare. La quale furiosamente stridendo pervenne a dirittura ove mandata era; e forse a Montano avrebbe sovra al palo portata la seconda vittoria, se non che il lupo impaurito per lo romore, tirandosi indietro, si mosse dal luogo ove stava, e la pietra passò via. Appresso a costui tirò Fronimo, e benché indrizzasse bene il colpo verso la testa del lupo, non ebbe ventura in toccarla, ma vicinissimo andandoli, diede in quel albero e levògli un pezzo de la scorza; e 'l lupo tutto atterrito fe' movendosi grandissimo strepito. In questo parve a Clonico di dovere aspettare che 'l lupo si fermasse, e poi sì tosto come quieto il vide, liberò la pietra; la quale drittissima verso quello andando, diede in la corda con che a l'albero legato stava, e fu cagione che il lupo, facendo maggiore sforzo, quella rumpesse. E i pastori tutti gridarono, credendo che al lupo dato avesse: ma quello sentendosi sciolto, sùbito incominciò a fuggire. Per la qual cosa Partenopeo, che tenea già la fionda in posta per tirare, vedendolo traversare per salvarsi in un bosco che da la man sinestra gli stava, invocò in sua aita i pastorali Dii; e fortissimamente lasciando andare il sasso, volse la sua sòrte che al lupo, il quale con ogni sua forza intendeva a correre, ferì ne la tempia sotto la manca orecchia, e senza farlo punto movere, il fe' sùbito morto cadere. Onde ciascuno di maraviglia rimase attonito, et ad una voce tutto lo spettacolo chiamò vincitore Partenopeo; et ad Opico volgendosi, che già per la nova allegrezza piangea, si congratulavano, facendo maravigliosa festa. Et Ergasto allora lieto fattosi incontro a Partenopeo, lo abbracciò, e poi coronandolo d'una bella ghirlanda di fronde di baccari, gli diede per pregio un bel cavriuolo, cresciuto in mezzo de le pecore et usato di scherzare tra i cani e di urtare coi montoni, mansuetissimo e caro a tutti i pastori. Appresso a Partenopeo, Clonico che rotto avea il legame del lupo, ebbe il secondo dono; il quale fu una gabbia nova e bella, fatta in forma di torre, con una pica loquacissima dentro, ammaestrata di chiamare per nome e di salutare i pastori; per modo che chi veduta non la avesse, udendola solamente parlare, si avrebbe per fermo tenuto che quella uomo fusse. Il terzo premio fu dato a Fronimo, che con la pietra ferì ne l'albero presso a la testa del lupo; il quale fu una tasca da tenere il pane, lavorata di lana mollissima e di diversi colori. Dopo dei quali toccava a Montano l'ultimo pregio, quantunque al tirare stato fosse il primo. A cui Ergasto piacevolmente e quasi mezzo sorridendo disse: — Troppo sarebbe oggi stata grande la tua ventura, Montano, se così ne la fionda fossi stato felice, come nel palo fosti —; e così dicendo, si levò dal collo una bella sampogna di canna fatta solamente di due voci, ma di grandissima armonia nel sonare, e gliela diede; il quale lietamente prendendola ringraziò. Ma forniti i doni, rimase ad Ergasto un delicatissimo bastone di pero selvatico, tutto pieno di intagli e di varii colori di cera per mezzo, e ne la sua sommità investito d'un nero corno di bufalo, sì lucente che veramente avresti detto che di vetro stato fusse. Or questo bastone Ergasto il donò ad Opico, dicendogli: — E tu ancora ti ricorderai di Massilia, e per suo amore prenderai questo dono, per lo quale non ti sarà mistiero lottare, né correre, né fare altra prova. Assai per te ha oggi fatto il tuo Partenopeo, il quale nel correre fu de' primi, e nel trare de la fionda, senza controversia, è stato il primo. — A cui Opico allegro rendendo le debite grazie, così rispose: — I privilegii de la vecchiezza, figliuol mio, son sì grandi, che, o vogliamo, o non vogliamo, semo costretti di obedirli. Oh quanto ben fra gli altri mi avresti in questo giorno veduto adoperare, se io fusse di quella età e forza che io era, quando nel sepolcro di quel gran pastore Panormita furono posti i premii, sì come tu oggi facesti, ove nessuno, né paesano né forastiero si possette a me agguagliare. Ivi vinsi Crisaldo, figliuolo di Tirreno, ne le lotte; e nel saltare passai di gran lunga il famoso Silvio; così ancora nel correre mi lasciai dietro Idalogo et Ameto, i quali eran fratelli e di velocità e scioltezza di piedi avanzavano tutti gli altri pastori. Solamente nel saettare fui superato da un pastore che avea nome Tirsi; e questo fu per cagione che colui, avendo uno arco fortissimo con le punte guarnite di corno di capra, possea con più securtà tirarlo che non facea io, il quale di semplice tasso avendolo, dubitava di spezzarlo; e così mi vinse. Allora era io fra' pastori, allora era io fra' gioveni conosciuto; ora sovra di me il tempo usa le sue ragioni. Voi dunque a cui la età il permette, vi esercitate ne le prove giovenili; a me e gli anni e la natura impongono altre leggi. Ma tu, acciò che questa festa da ogni parte compita sia, prendi la sonora sampogna, figliuol mio, e fa che colei che si allegrò d'averti dato al mondo, si rallegri oggi di udirti cantare: e dal cielo con lieta fronte mire et ascolte il suo sacerdote celebrare per le selve la sua memoria. — Parve ad Ergasto sì giusto quello che Opico dicea, che senza farli altra risposta, prese di man di Montano la sampogna che poco avanti donata li avea; e quella per bono spazio con pietoso modo sonata, vedendo ciascuno con attenzione e silenzio aspettare, non senza alcun sospiro mandò fuora queste parole: […] A la Sampogna Ecco che qui si compieno le tue fatiche, o rustica e boscareccia sampogna, degna per la tua bassezza di non da più colto, ma da più fortunato pastore che io non sono, esser sonata. Tu a la mia bocca et a le mie mani sei non molto tempo stata piacevole esercizio, et ora, poi che così i fati vogliono, imporrai a quelle con lungo silenzio forse eterna quiete. Con ciò sia cosa che a me conviene, prima che con esperte dite sappia misuratamente la tua armonia esprimere, per malvagio accidente da le mie labra disgiungerti, e, quali che elle si siano, palesare le indòtte note, atte più ad 61 appagare semplici pecorelle per le selve, che studiosi popoli per le cittadi; facendo sì come colui che offeso da notturni furti nei suoi giardini, coglie con isdegnosa mano i non maturi frutti dai carichi rami; o come il duro aratore, il quale dagli alti alberi inanzi tempo con tutti i nidi si affretta a prendere i non pennuti ucelli, per tema che da serpi o da pastori non gli siano preoccupati. Per la qual cosa io ti prego, e quanto posso ti ammonisco, che de la tua selvatichezza contentandoti, tra queste solitudini ti rimanghi. A te non si appertiene andar cercando gli alti palagi de préncipi, né le superbe piazze de le populose cittadi, per avere i sonanti plausi, gli adombrati favuri, o le ventose glorie, vanissime lusinghe, falsi allettamenti, stolte et aperte adulazioni de l'infido volgo. Il tuo umile suono mal si sentirebbe tra quello de le spaventevoli buccine o de le reali trombe. Assai ti fia qui tra questi monti essere da qualunque bocca di pastori gonfiata, insegnando le rispondenti selve di risonare il nome de la tua donna, e di piagnere amaramente con teco il duro et inopinato caso de la sua immatura morte, cagione efficacissima de le mie eterne lacrime e de la dolorosa et inconsolabile vita ch'io sostegno; se pur si può dir che viva, chi nel profondo de le miserie è sepelito. Dunque, sventurata, piagni; piagni, che ne hai ben ragione. Piagni, misera vedova; piagni, infelice e denigrata sampogna, priva di quella cosa che più cara dal cielo tenevi. Né restar mai di piagnere e di lagnarti de le tue crudelissime disventure, mentre di te rimanga calamo in queste selve; mandando sempre di fuori quelle voci, che al tuo misero e lacrimevole stato son più conformi. E se mai pastore alcuno per sòrte in cose liete adoprar ti volesse, fagli prima intendere che tu non sai se non piagnere e lamentarti, e poi con esperienzia e veracissimi effetti esser così gli dimostra, rendendo continuamente al suo soffiare mesto e lamentevole suono; per forma che temendo egli di contristare le sue feste, sia costretto allontanartesi da la bocca, e lasciarti con la tua pace stare appiccata in questo albero, ove io ora con sospiri e lacrime abondantissime ti consacro in memoria di quella, che di avere infin qui scritto mi è stata potente cagione; per la cui repentina morte la materia or in tutto è mancata a me di scrivere, et a te di sonare. Le nostre Muse sono estinte; secchi sono i nostri lauri; ruinato è il nostro Parnaso; le selve son tutte mutole; le valli e i monti per doglia son divenuti sordi. Non si trovano più Ninfe o Satiri per li boschi; i pastori han perduto il cantare; i greggi e gli armenti appena pascono per li prati, e coi lutulenti piedi per isdegno conturbano i liquidi fonti, né si degnano, vedendosi mancare il latte, di nudrire più i parti loro. Le fiere similmente abandonano le usate caverne; gli ucelli fuggono dai dolci nidi; i duri et insensati alberi inanzi a la debita maturezza gettano i lor frutti per terra; e i teneri fiori per le meste campagne tutti communemente ammarciscono. Le misere api dentro ai loro favi lasciano imperfetto perire lo incominciato mèle. Ogni cosa si perde, ogni speranza è mancata, ogni consolazione è morta. Non ti rimane altro omai, sampogna mia, se non dolerti, e notte e giorno con ostinata perseveranza attristarti. Attrìstati adunque, dolorosissima; e quanto più puoi, de la avara morte, del sordo cielo, de le crude stelle, e de' tuoi fati iniquissimi ti lamenta. E se tra questi rami il vento per aventura movendoti ti donasse spirito, non far mai altro che gridare, mentre quel fiato ti basta. Né ti curare, se alcuno usato forse di udire più esquisiti suoni, con ischifo gusto schernisse la tua bassezza o ti chiamasse rozza; ché veramente, se ben pensi, questa è la tua propria e principalissima lode, pur che da' boschi e da' luoghi a te convenienti non ti diparta. Ove ancora so che non mancheran di quegli, che con acuto giudicio esaminando le tue parole, dicano te in qualche luogo non bene aver servate le leggi de' pastori, né convenirsi ad alcuno passar più avanti che a lui si appertiene. A questi, confessando ingenuamente la tua colpa, voglio che rispondi, niuno aratore trovarsi mai sì esperto nel far de' solchi, che sempre prometter si possa, senza deviare, di menarli tutti dritti. Benché a te non picciola scusa fia, lo essere in questo secolo stata prima a risvegliare le adormentate selve, et a mostrare a' pastori di cantare le già dimenticate canzoni. Tanto più che colui il quale ti compose di queste canne, quando in Arcadia venne, non come rustico pastore ma come coltissimo giovene, benché sconosciuto e peregrino di amore, vi si condusse. Senza che in altri tempi sono già stati pastori sì audaci, che insino a le orecchie de' romani consuli han sospinto il loro stile; sotto l'ombra de' quali potrai tu, sampogna mia, molto ben coprirti e difendere animosamente la tua ragione. Ma se forse per sòrte alcun altro ti verrà avanti di più benigna natura, il quale con pietà ascoltandoti mandi fuori qualche amica lacrimetta, porgi subitamente per lui efficaci preghi a Dio, che ne la sua felicità conservandolo, da queste nostre miserie lo allontane. Ché veramente chi de le altrui avversità si dole, di se medesmo si ricorda. Ma questi io dubito saranno rari e quasi bianche cornici; trovandosi in assai maggior numero copiosa la turba de' detrattori. Incontra ai quali io non so pensare quali altre arme dar mi ti possa, se non pregarti caramente, che quanto più puoi rendendoti umile, a sustinere con pazienzia le lor percosse ti disponghi. Benché mi pare esser certo, che tal fatica a te non fia necessaria, se tu tra le selve, sì come io ti impongo, secretamente e senza pompe star ti vorrai. Con ciò sia cosa che chi non sale, non teme di cadere; e chi cade nel piano, il che rare volte adiviene, con picciolo agiuto de la propria mano, senza danno si rileva. Onde per cosa vera et indubitata tener ti puoi, che chi più di nascoso e più lontano da la moltitudine vive, miglior vive; e colui tra' mortali si può con più verità chiamar beato, che senza invidia de le altrui grandezze, con modesto animo de la sua fortuna si contenta. 62 Pietro Bembo, Gli Asolani [P. Bembo, Prose della volgar lingua, Gli Asolani, Rime, a cura di Carlo Dionisotti, Milano, TEA, 1997] [1.I.] Suole a' faticosi navicanti esser caro, quando la notte, da oscuro e tempestoso nembo assaliti e sospinti, né stella scorgono, né cosa alcuna appar loro che regga la lor via, col segno della indiana pietra ritrovare la tramontana, in guisa che, quale vento soffi e percuota conoscendo, non sia lor tolto il potere e vela e governo là, dove essi di giugnere procacciano o almeno dove più la loro salute veggono, dirizzare; e piace a quelli che per contrada non usata caminano, qualora essi, a parte venuti dove molte vie faccian capo, in qual più tosto sia da mettersi non scorgendo, stanno in sul piè dubitosi e sospesi, incontrare chi loro la diritta insegni, sì che essi possano all'albergo senza errore, o forse prima che la notte gli sopragiunga, pervenire. Per la qual cosa avisando io, da quello che si vede avenire tutto dì, pochissimi essere quegli uomini, a' quali nel peregrinaggio di questa nostra vita mortale, ora dalla turba delle passioni soffiato e ora dalle tante e così al vero somiglianti apparenze d'openioni fatto incerto, quasi per lo continuo e di calamita e di scorta non faccia mestiero, ho sempre giudicato grazioso ufficio per coloro adoperarsi, i quali, delle cose o ad essi avenute o da altri apparate o per se medesimi ritrovate trattando, a gli altri uomini dimostrano come si possa in qualche parte di questo periglioso corso e di questa strada, a smarrire così agevole, non errare. Perciò che quale più graziosa cosa può essere che il giovare altrui? O pure che si può qua giù fare, che ad uom più si convenga, che essere a molti uomini di lor bene cagione? E poi, se è lodevole per sé, che è in ogni maniera lodevolissimo, un uom solo senza fallimento saper vivere non inteso e non veduto da persona, quanto più è da credere che lodar si debba un altro, il quale e sa esso la sua vita senza fallo scorgere e oltre a ciò insegna e dona modo ad infiniti altri uomini, che ci vivono, di non fallire? Ma perciò che tra le molte cagioni, le quali il nostro tranquillo navicar ci turbano e il sentiero del buon vivere ci rendono sospetto e dubbioso, suole con le primiere essere il non saper noi le più volte quale amore buono sia e qual reo, il che non saputo fa che noi, le cose che fuggire si devrebbono amando e quelle che sono da seguire non amando, e tal volta o meno o più del convenevole ora schifandole e ora cercandole, travagliati e smarriti viviamo, ho voluto alcuni ragionamenti raccogliere, che in una brigata di tre nostre valorose donne e in parte di madonna la Reina di Cipri, pochi dì sono, tre nostri aveduti e intendenti giovani fecero d'Amore, assai diversamente questionandone in tre giornate, affine che il giovamento e pro che essi hanno a me renduto, da loro che fatti gli hanno sentendogli, che nel vero non è stato poco, possano eziandio rendere a qualunque altro, così ora da me raccolti, piacesse di sentirgli. Alla qual cosa fare, come che in ciascuna età stia bene l'udire e leggere le giovevoli cose e spezialmente questa, perciò che non amare come che sia in niuna stagione non si può, quando si vede che da natura insieme col vivere a tutti gli uomini è dato che ciascuno alcuna cosa sempre ami, pure io, che giovane sono, i giovani uomini e le giovani donne conforto e invito maggiormente. Perciò che a molti e a molte di loro per aventura agevolmente averrà che, udito quello che io mi profero di scriverne, essi prima d'Amore potranno far giudicio che egli di loro s'abbia fatto pruova. Il che, quanto esser debba lor caro, né io ora dirò, e essi meglio potranno ne gli altri loro più maturi anni giudicare. Ma di vero, sì come nel più delle cose l'uso è ottimo e certissimo maestro, così in alcune, e in quelle massimamente che possono non meno di noia essere che di diletto cagione, sì come mostra che questa sia, l'ascoltarle o leggerle in altrui, prima che a pruova di loro si venga, senza fallo molte volte a molti uomini di molto giovamento è stato. Per la qual cosa bellissimo ritrovamento delle genti è da dir che sieno le lettere e la scrittura, nella qual noi molte cose passate, che non potrebbono altramente essere alla nostra notizia pervenute, tutte quasi in uno specchio riguardando e quello di loro che faccia per noi raccogliendo, da gli altrui essempi ammaestrati ad entrare nelli non prima o solcati pelaghi o caminati sentieri della vita, quasi provati e nocchieri e viandanti, più sicuramente ci mettiamo. Senza che infinito piacere ci porgono le diverse lezioni, delle quali gli animi d'alquanti uomini, non altramente che faccia di cibo il corpo, si pascono assai sovente e prendono insieme da esse dilettevolissimo nodrimento. Ma lasciando questo da parte stare e alle ragionate cose d'Amore, che io dissi, venendo, acciò che meglio si possa ogni lor parte scorgere tale, quale appunto ciascuna fu ragionata, stimo che ben fatto sia che, prima che io passi di loro più avanti, come il ragionare avesse luogo si faccia chiaro. [1.II.] Asolo adunque, vago e piacevole castello posto ne gli stremi gioghi delle nostre alpi sopra il Trivigiano, è, sì come ogniuno dee sapere, di madonna la Reina di Cipri, con la cui famiglia, la quale è detta Cornelia, molto nella nostra città onorata e illustre, è la mia non solamente d'amistà e di dimestichezza congiunta, ma ancora di parentado. Dove essendo ella questo settembre passato a' suoi diporti andata, avenne che ella quivi maritò una delle sue damigielle, la quale, perciò che bella e costumata e gentile era molto e perciò che da bambina cresciuta se l'avea, assai teneramente era da lei amata e avuta cara. Per che vi fece l'apparecchio delle nozze ordinare bello e grande, e, invitatovi delle vicine contrade qualunque più onorato uomo v'era con le lor donne, e da Vinegia similmente, in suoni e canti e balli e solennissimi conviti l'un giorno appresso all'altro ne menava festeggiando con sommo piacer di ciascuno. Erano quivi tra gli altri, che invitati dalla Reina vennero a quelle feste, tre gentili uomini della nostra città, giovani e d'alto cuore, i quali, da' loro primi anni ne gli studi delle lettere usati e in essi tuttavia dimoranti per lo più tempo, oltre a ciò il pregio d'ogni bel costume aveano, che a nobili cavalieri s'appartenesse d'avere. Costor per aventura, come che a tutte le donne che in que' conviti si trovarono, sì per la chiarezza del sangue loro e sì ancora molto più per la viva fama de' loro studi e del lor valore fosser cari, essi nondimeno pure con tre di loro belle e vaghe giovani e di gentili costumi ornate, perciò che prossimani eran loro per sangue e lunga dimestichezza con esse e co' lor mariti aveano, i quali tutti e tre di que' dì a Vinegia tornati erano per loro bisogne, più spesso e più sicuramente si davano che con altre, volentieri sempre in sollazzevoli ragionamenti dolci e oneste dimore traendo. Quantunque Perottino, che così nominare un di loro m'è 63 piaciuto in questi sermoni, poco e rado parlasse, né fosse chi riso in bocca gli avesse solamente una volta in tutte quelle feste veduto. Il quale eziandio molto da ogniuno spesse volte si furava, sì come colui che l'animo sempre avea in tristo pensiero; né quivi venuto sarebbe, se da' suoi compagni, che questo studiosamente fecero, acciò che egli tra gli allegri dimorando si rallegrasse, astretto e sospinto al venirvi non fosse stato. Né pure solamente Perottino ho io con infinta voce in questa guisa nomato, ma le tre donne e gli altri giovani ancora; non per altro rispetto, se non per tôrre alle vane menti de' volgari occasione, i loro veri nomi non palesando, di pensar cosa in parte alcuna meno che convenevole alla loro onestissima vita. Con ciò sia cosa che questi parlari, d'uno in altro passando, a brieve andare possono in contezza de gli uomini pervenire, de' quali non pochi sogliono esser coloro che le cose sane le più volte rimirano con occhio non sano. [1.III.] Ma alle nozze della Reina tornando, mentre che elle così andavano come io dissi, un giorno tra gli altri nella fine del desinare, che sempre era splendido e da diversi giuochi d'uomini che ci soglion far ridere e da suoni di vari strumenti e da canti ora d'una maniera e quando d'altra rallegrato, due vaghe fanciulle per mano tenendosi, con lieto sembiante al capo delle tavole, là dove la Reina sedea, venute, riverentemente la salutarono; e poi che l'ebbero salutata, amendue levatesi, la maggiore, un bellissimo liuto che nell'una mano teneva al petto recandosi e assai maestrevolmente toccandolo, dopo alquanto spazio col piacevole suono di quello la soave voce di lei accordando e dolcissimamente cantando, così disse: Io vissi pargoletta in festa e 'n gioco, De' miei pensier, di mia sorte contenta: Or sì m'afflige Amor e mi tormenta, Ch'omai da tormentar gli avanza poco. Credetti, lassa, aver gioiosa vita Da prima entrando, Amor, a la tua corte; E già n'aspetto dolorosa morte: O mia credenza, come m'hai fallita. Mentre ad Amor non si commise ancora, Vide Colco Medea lieta e secura; Poi ch'arse per Iason, acerba e dura Fu la sua vita infin a l'ultim'ora. Detta dalla giovane cantatrice questa canzone, la minore, dopo un brieve corso di suono della sua compagna che nelle prime note già ritornava, al tenor di quelle altresì come ella la lingua dolcemente isnodando, in questa guisa le rispose: Io vissi pargoletta in doglia e 'n pianto, De le mie scorte e di me stessa in ira: Or sì dolci pensieri Amor mi spira, Ch'altro meco non è che riso e canto. Arei giurato, Amor, ch'a te gir dietro Fosse proprio un andar con nave a scoglio; Così là 'nd'io temea danno e cordoglio, Utile scampo a le mie pene impetro. Infin quel dì, che pria la punse Amore, Andromeda ebbe sempre affanno e noia; Poi ch'a Perseo si diè, diletto e gioia Seguilla viva, e morta eterno onore. Poi che le due fanciulle ebber fornite di cantare le lor canzoni, alle quali udire ciascuno chetissimo e attentissimo era stato, volendo esse partire per dar forse a gli altri sollazzi luogo, la Reina, fatta chiamare una sua damigiella, la quale, bellissima sopra modo e per giudicio d'ogniun che la vide più d'assai che altra che in quelle nozze v'avesse, sempre quando ella separatamente mangiava di darle bere la serviva, le impose che alle canzoni delle fanciulle alcuna n'aggiugnesse delle sue. Per che ella, presa una sua vivola di maraviglioso suono, tuttavia non senza rossore veggendosi in così palese luogo dover cantare, il che fare non era usata, questa canzonetta cantò con tanta piacevolezza e con maniere così nuove di melodia, che alla dolce fiamma, che le sue note ne' cuori degli ascoltanti lasciarono, quelle delle due fanciulle furono spenti e freddi carboni: Amor, la tua virtute Non è dal mondo e da la gente intesa, Che, da viltate offesa, Segue suo danno e fugge sua salute. Ma se fosser tra noi ben conosciute L'opre tue, come là dove risplende Più del tuo raggio puro, Camin dritto e securo 64 Prenderia nostra vita, che no 'l prende, E tornerian con la prima beltade Gli anni de l'oro e la felice etade. [1.IV.] Ora soleva la Reina per lo continuo, fornito che s'era di desinare e di vedere e udire le piacevoli cose, con le sue damigielle ritrarsi nelle sue camere, e quivi o dormire o, ciò che più le piacea di fare facendo, la parte più calda del giorno separatamente passarsi, e così concedere chell'altre donne di sé facessero a lor modo, infino a tanto che venuto là dal vespro tempo fosse da festeggiare; nel qual tempo tutte le donne e gentili uomini e suoi cortigiani si raunavano nelle ampie sale del palagio, dove si danzava gaiamente e tutte quelle cose si facevano che a festa di reina si conveniva di fare. Cantate adunque dalla damigiella e dalle due fanciulle queste canzoni e a tutti gli altri sollazzi di quella ora posto fine, levatasi dall'altre donne la Reina, come solea, e nelle sue camere raccoltasi, e ciascuno similmente partendo, rimase per aventura ultime, le tre donne, che io dissi, co' loro giovani per le sale si spaziavano ragionando, e quindi, da' piedi e dalle parole portate, ad un verone pervennero, il quale da una parte delle sale più rimota sopra ad un bellissimo giardino del palagio riguardava. Dove come giunsero, maravigliatesi della bellezza di questo giardino, poi che di mirare in esso alquanto al primo disiderio sodisfatto ebbero, ora a questa parte ora a quella gli occhi mandando dal disopra, Gismondo, che il più festevole era de' suoi compagni e volentieri sempre le donne in festa e onesto giuoco teneva, a loro rivoltosi così disse: - Care giovani, il dormire dopo 'l cibo a questa ora del dì, quantunque in niuna stagion dell'anno non sia buono, pure la state, perciò che lunghissimi sono i giorni, come quello che cosa piacevole è, da gli occhi nostri volentieri ricevuto, alquanto meno senza fallo ci nuoce. Ma questo mese si incomincia egli a perder molto della sua dolcezza passata e a farsi di dì in dì più dannoso e più grave. Per che, dove voi questa volta il mio consiglio voleste pigliare, le quali stimo che per dormire nelle vostre camere a quest'ora vi rinchiudiate, io direi che fosse ben fatto, lasciando il sonno dietro le cortine de' nostri letti giacere, che noi passassimo nel giardino, e quivi al rezzo, nel fresco dell'erbe ripostici, o novellando o di cose dilettevoli ragionando, ingannassimo questa incresciosa parte del giorno, infin che l'ora del festeggiare venuta nelle sale ci richiamasse con gli altri ad onorare la nostra novella sposa -. Alle donne, le quali molto più le ombre de gli alberi e gli accorti ragionamenti de' giovani che il sonno delle coltre regali e le favole dell'altre donne dilettavano, piacque il consiglio di Gismondo. Per che, scese le scale, tutte liete e festose insieme con lui e cogli altri due giovani n'andarono nel giardino. […] [1.XVII.] E così detto seguitò: - Parti, Lisa, che a questi miracoli si convenga che il loro facitore sia Idio chiamato? Parti che non senza cagione que' primi uomini gli abbiano imposto cotal nome? Perciò che tutte le cose che fuori dell'uso naturale avengono, le quali per questo si chiamano miracoli, che maraviglia a gli uomini recano o intese o vedute, non posson procedere da cosa che sopranaturale non sia, e tale sopra tutte l'altre è Dio. Questo nome adunque diedero ad Amore, sì come a colui la cui potenza sopra quella della natura ad essi parea che si distendesse. Ma io a dimostrarloti, più vago de' miei mali che de gli altrui, non ho quasi adoperato altro, sì come tu hai veduto, che la memoria d'una menomissima parte de' miei infiniti e dolorosi martiri; i quali però insieme tutti, avenga che essi di soverchia miseria fare essempio mi potessero a tutto il mondo in fede della potenza di questo Idio, se bene in maggior numero non si stendessero che questi sono, de' quali tu hai udito, pure, a comperazione di quelli di tutti gli altri uomini, per nulla senza fallo riputar si possono o per poco. Che se io t'avessi voluto dipignere ragionando le historie di centomila amanti che si leggono, sì come nelle chiese si suole fare, nelle quali dinanzi ad uno Idio non la fede d'un uom solo, ma d'infiniti, si vede in mille tavolette dipinta e raccontata, certo non altramente maravigliata te ne saresti che sogliano i pastori, quando essi primieramente nella città d'alcuna bisogna portati, a una ora mille cose veggono che son loro d'infinita maraviglia cagione. Né perché io mi creda che le mie miserie sien gravi, come senza fallo sono, è egli perciò da dire che lievi sieno l'altrui, o che Amore ne' cuori di mille uomini per aventura non s'aventi con tanto impeto, con quanto egli ha fatto nel mio, e che egli cotante e così strane maraviglie non ne generi, quante e quali son quelle che egli nel mio ha generate. Anzi io mi credo per certo d'avere di molti compagni a questa pruova per grazia del mio signore, quantunque essi non così tutti vedere si possano da ciascuno e conoscere, come io me stesso conosco. Ma è appresso le altre questa, una delle sciocchezze de gli amanti, che ciascuno si crede essere il più misero e di ciò s'invaghisce, come se di questa vittoria ne gli venisse corona, né vuole per niente che alcuno altro viva, il quale amando possa tanto al sommo d'ogni male pervenire, quanto egli è pervenuto. Amava Argia sanza fallo oltre modo, se alle cose molto antiche si può dar fede, la quale chi avesse udita, quando ella sopra le ferite del suo morto marito gittatasi piagneva, sì come si dee pensare che ella facesse, averebbe inteso che ella il suo dolore sopra quello d'ogni altra dolente riponeva. E pure leggiamo d'Evadna, la quale in quella medesima sorte di miseria e in un tempo con lei pervenuta, sdegnando alteramente la propria vita, il suo morto marito non pianse solamente, ma ancora seguìo. Fece il somigliante Laodomia nella morte del suo, fece la bella asiana Pantea, fece in quella del suo amante la infelice giovane di Sesto questa medesima pruova, fecero altresì di molt'altre. Per che comprender si può ogni stato d'infelicità potersi in ogni tempo con molti altri rassomigliare; ma non di leggier si veggono, perciò che la miseria ama sovente di star nascosa. Tu dunque, Lisa, dando alle mie angoscie quella compagnia che ti parrà poter dare, senza che io vada tutte le historie ravolgendo, potrai agevolmente argomentare la potenza del tuo Idio tante volte più distendersi di quello che io t'ho co' miei essempi dimostrato, quanti possono esser quelli che amino come fo io, i quali possono senza fallo essere 65 infiniti. Perciò che ad Amore è per niente, che può essere, solo che esso voglia, ad un tempo parimente in ogni luogo, di cotali prodezze, a rischio della vita de gli amanti, in mille di loro insieme insieme far pruova. Egli così giuoca e, quello che a noi è d'infinite lagrime e d'infiniti tormenti cagione, suoi scherzi sono e suoi risi non altramente che nostri dolori. E già in modo ha sé avezzo nel nostro sangue e delle nostre ferite invaghito il crudele, che di tutti i suoi miracoli quello è il più maraviglioso, quando egli alcuno ne fa amare, il qual senta poco dolore. E perciò pochissimi sono quegli amanti, se pure alcuno ve n'è, che io no 'l so, che possano nelle lor fiamme servar modo; dove in contrario si vede tutto 'l giorno, lasciamo stare che di riposati, di riguardosi, di studiosi, di filosofanti, molte volte rischievoli andatori di notte, portatori d'arme, salitori di mura, feritori d'uomini diveniamo, ma tutto dì veggiamo mille uomini, e quelli per aventura che per più costanti sono e per più saggi riputati, quando ad amar si conducono, palesemente impazzare. [1.XVIII.] Ma perciò che, fatto Idio da gli uomini Amore per queste cagioni che tu vedi, Lisa, parve ad essi convenevole dovergli alcuna forma dare, acciò che esso più interamente conosciuto fosse, ignudo il dipinsero, per dimostrarci in quel modo non solamente che gli amanti niente hanno di suo, con ciò sia cosa che essi stessi sieno d'altrui, ma questo ancora, che essi d'ogni loro arbitrio si spogliano, d'ogni ragione rimangono ignudi; fanciullo, non perché egli si sia garzone, che nacque insieme co' primi uomini, ma perciò che garzoni fa divenire di conoscimento quei che 'l seguono e, quasi una nuova Medea, con istrani veneni alcuna volta gli attempati e canuti ribambire; alato, non per altro rispetto se non perciò che gli amanti, dalle penne de' loro stolti disideri sostentati, volan per l'aere della loro speranza, sì come essi si fanno a credere, leggiermente infino al cielo. Oltre a.cciò una face gli posero in mano accesa, perciò che, sì come del fuoco piace lo splendore ma l'ardore è dolorosissimo, così la prima apparenza d'Amore, in quanto sembra cosa piacevole, ci diletta, di cui poscia l'uso e la sperienza ci tormentano fuor di misura. Il che se da noi conosciuto fosse prima che vi si ardesse, o quanto meno ampia sarebbe oggi la signoria di questo tiranno e il numero de gli amanti minore che essi non sono. Ma noi stessi, del nostro mal vaghi, sì come farfalle ad essa n'andiam per diletto; anzi pure noi medesimi spesse volte ce l'accendiamo, onde poi, quasi Perilli nel proprio toro, così noi nel nostro incendio ci veggiamo manifestamente perire. Ma per dar fine alla imagine di questo Idio, male per gli uomini di sì diversi colori della loro miseria pennellata, a tutte queste cose, Lisa, che io t'ho dette, l'arco v'aggiunsero e gli strali, per darci ad intendere che tali sono le ferite che Amore ci dà, quali potrebbono essere quelle d'un buono arciere che ci saettasse; le quali però in tanto sono più mortali, che egli tutte le dà nel cuore, e questo ancora più avanti hanno di male, che egli mai non si stanca od a pietà si muove, perché ci vegga venir meno, anzi egli tanto più s'affretta nel ferirci, quanto ci sente più deboli e più mancare. Ora io mi credo assai apertamente averti, Lisa, dimostrato quali fossero le cagioni che mosser gli uomini a chiamare Idio costui, che noi Amore chiamiamo, e perché essi così il dipinsero, come tu hai veduto; il quale, se con diritto occhio si mira, non che egli nel vero non sia Idio, il che essere sarebbe sceleratezza pure a pensare non che mancamento a crederlo, anzi egli non è altro se non quello che noi medesimi vogliamo. Perciò che conviene di necessità che Amore nasca nel campo de' nostri voleri, senza il quale, sì come pianta senza terreno, egli aver luogo non può giamai. È il vero che, comunque noi, ricevendolo, nell'animo gli lasciamo aver piè e nella nostra volontà far radici, egli tanto prende di vigore da se stesso, che poi nostro mal grado le più volte vi rimane, con tante e così pungenti spine il cuore affligendoci e così nuove maraviglie generandone, come ben chiaro conosce chi lo pruova. […] SECONDO LIBRO [2.I.] A me pare, quando io vi penso, nuovo, onde ciò sia che, avendo la natura noi uomini di spirito e di membra formati, queste mortali e deboli, quello durevole e sempiterno, di piacere al corpo ci fatichiamo quanto per noi si può generalmente ciascuno, all'animo non così molti risguardano e, per dir meglio, pochissimi hanno cura o pensiero. Perciò che niuno è così vile, che la sua persona d'alcun vestimento non ricuopra, e molti sono coloro che, nelle lucide porpore e nelle dilicate sete e nell'oro stesso cotanto pregiato fasciandola e delle più rare gemme illustrandola, così la portano, per più di grazia e più d'ornamento le dare; dove si veggono senza fine tutto il giorno di quegli uomini, i quali la lor mente non solo delle vere e sode virtù non hanno vestita, ma pure d'alcun velo o filo di buon costume ricoperta né adombrata si tengono. Oltre a ciò sì aviene egli ancora che, per vaghezza di questo peso e fascio terreno, il quale pochi anni disciogliono e fanno in polve tornare, dove a sostenimento di lui le cose agevoli e in ogni luogo proposteci dalla natura ci bastavano, noi pure i campi, le selve, i fiumi, il mare medesimo sollecitando, con molto studio i cibi più preziosi cerchiamo, e per acconcio e agio di lui, potendo ad esso una capannuccia dalle nevi e dal sole difendendolo sodisfare, i più lontani marmi da diverse parti del mondo raunando, in più contrade palagi ampissimi gli fondiamo; e la celeste parte di noi molte volte, di che ella si pasca o dove abiti non curiamo, ponendole pure innanzi più tosto le foglie amare del vizio che i frutti dolcissimi della virtù, nello oscuro e basso uso di quello più spesso rinchiusa tenendola, che nelle chiare e alte operazioni di questa invitandola a soggiornare. Senza che, qualora aviene che noi alcuna parte del corpo indebolita e inferma sentiamo, con mille argomenti la smarrita sanità in lui procuriamo di rivocare; a gli animi nostri non sani poco curiamo di dare ricovero e medicina alcuna. Sarebbe egli ciò forse per questo che, perciò che il corpo più appare che l'animo non fa, più altresì crediamo che egli abbia di questi provedimenti mestiero? Il che tuttavia è poco sanamente considerato. Perciò che non che il corpo nel vero più che l'animo de gli uomini non appaia, ma egli è di gran lunga in questo da.llui evidentemente superato. Con ciò sia cosa che l'animo tante faccie ha, quante le sue operazioni sono, dove del corpo altro che una forma non si mostra giamai. E questa in molti anni molti uomini appena 66 non vedono, dove quelle possono in brieve tempo essere da tutto 'l mondo conosciute. E questo stesso corpo altro che pochi giorni non dura, là dove l'animo sempiterno sempiternamente rimane, e può seco lunghi secoli ritener quello di che noi, mentre egli nel corpo dimora, l'avezziamo. Alle quali cose e ad infinite altre, che a queste aggiugner si potrebbono, se gli uomini avessero quella considerazione che loro s'apparterrebbe d'avere, vie più bello sarebbe oggi il viver nel mondo e più dolce che egli non è, e noi, con bastevole cura del corpo avere, molto più l'animo e le menti nostre ornando e meglio pascendole e più onorata dimora dando loro, saremmo di loro più degni che noi non siamo, e molta cura porremmo nel conservarle sane e, se pure alcuna volta infermassero, con maggiore studio ci faticheremmo di riparare a' lor morbi che noi non facciamo. Tra' quali quanto sembri grave quello che Amore addosso ci reca, assai si può dalle parole di Perottino nel precedente libro aver conosciuto. Quantunque Gismondo, forte da lui discordando, molto da questa openione lontano sia. Perciò che venute il dì seguente le belle donne, sì come ordinato aveano, appresso 'l mangiare co' loro giovani nel giardino, e nel vago praticello accoste la chiara fonte e sotto gli ombrosi allori sedutesi, dopo alquanti festevoli motti sopra i sermoni di Perottino da' due compagni e dalle donne sollazzevolmente gittati, aspettando già ciascuno che Gismondo parlasse, egli così incominciò a dire: [2.II.] - Assai vezzosamente fece hieri, sagge e belle donne, Perottino; il quale nella fine della sua lunga querimonia ci lasciò piangendo, acciò che quello, che aver non gli parea con le parole potuto guadagnare, le lagrime gli acquistassero, ciò è la vostra fede alle cose che egli intendea di mostrarvi. Le quai lagrime tuttavia, quello che in voi operassero, io non cerco: me veramente mossero elle a tanta pietà de' suoi mali, che io, come poteste vedere, non ritenni le mie. E questa pietà in me non pure hieri solamente ebbe luogo; anzi ogni volta che io alle sue molte sciagure considero, duolmene più che mezzanamente, e sonomi sempre gravi le sue fatiche, sì come di carissimo amico che egli m'è, forse non guari meno che elle si sieno a lui. Ma queste medesime lagrime, che in me esser possono meritevolmente lodate, come quelle che vengono da tenero e fratellevole animo, veda bene Perottino che in lui non sieno per aventura vergognose. Perciò che ad uomo nelle lettere infin da fanciullo assai profittevolmente essercitato, sì come egli è, più si conviene calpestando valorosamente la nimica fortuna ridersi e beffarsi de' suoi giuochi, che, lasciandosi sottoporre a.llei, per viltà piagnere e ramaricarsi a guisa di fanciullo ben battuto. E se pure egli ancora non ha da gli antichi maestri tanto di sano avedimento appreso, o seco d'animo dalle culle recato, che egli incontro a' colpi d'una femina si possa o si sappia schermire, ché femina pare che sia la fortuna se noi alla sua voce medesima crediamo, assai avrebbe fatto men male e cosa ad uom libero più convenevole Perottino, se, confessando la sua debolezza, egli di se stesso doluto si fosse, che non è stato, dolendosi d'uno strano, avere in altrui la propria colpa recata. Ma che? Egli pure così ha voluto e, per meglio colorire la sua menzogna e il suo difetto, lamentandosi d'Amore, accusandolo, dannandolo, rimproverandolo, ogni fallo, ogni colpa volgendo in lui, s'è sforzato di farlovi in poco d'ora di liberalissimo donatore di riposo, di dolcissimo apportator di gioia, di santissimo conservatore delle genti, che egli sempre è stato, rapacissimo rubator di quiete, acerbissimo recator d'affanno, sceleratissimo micidiale de gli uomini divenire; e come se egli la sentina del mondo fosse, in lui ha ogni bruttura della nostra vita versata, con sì alte voci e così diverse sgridandolo, che a me giova di credere oggimai che egli, più aveduto di quello che noi stimiamo, non tanto per nasconderci le sue colpe, quanto per dimostrarci la sua eloquenza, abbia tra noi di questa materia in così fatta guisa parlato. Perciò che dura cosa pare a me che sia il pensare che egli ad alcun di noi, che pure il pesco dalla mela conosciamo, abbia voluto fare a credere che Amore, senza il quale niun bene può ne gli uomini aver luogo, sia a noi d'ogni nostro male cagione. E certamente, riguardevoli donne, egli ha in uno canale derivate cotante bugie, e quelle così bene col corso d'apparente verità inviate dove gli bisognava, che senza dubbio assai acqua m'arebbe egli addosso fatta venire, sì come le sue prime minaccie sonarono, se io ora dinanzi a così intendenti ascoltatrici non parlassi, come voi sete, le quali ad ogni raviluppatissima quistione sciogliere, non che alle sciolte giudicare, come questa di qui a poco sarà, sete bastanti. La qual cosa, acciò che senza più oltra tenervi incominci ad aver luogo, io a gli effetti me ne verrò, solo che voi alcuna attenzion mi prestiate. Né vi sia grave, o donne, il prestarlami, ché più a me si conviene ella oggi che a Perottino hieri non fece. Perciò che oltre che lo snodare gli altrui groppi più malagevole cosa è che l'annodargli non è stato, io, la verità dinanzi a gli occhi ponendovi, conoscere vi farò quello che è sommamente dicevole alla vostra giovane etade e senza il che tutto il nostro vivere morte più tosto chiamar si può che vita; dove egli, la menzogna in bocca recando, vi dimostrò cosa, la quale posto che fosse vera, non che a gli anni vostri non convenevole, ma ella sarebbe vie più a' morti che ad alcuna qualità di vivi conforme. [2.III.] Avea così detto Gismondo e tacevasi, quando Lisa verso madonna Berenice baldanzosamente riguardando: - Madonna, - disse - egli si vuole che noi Gismondo attentamente ascoltiamo, poscia che di tanto giovamento ci hanno a dovere essere i suoi sermoni; la qual cosa se egli così pienamente ci atterrà, come pare che animosamente ci prometta, certa sono che Perottino abbia oggi non men fiero difenditore ad avere, che egli hieri gagliardo assalitore si fosse. - Rispose madonna Berenice a queste parole di Lisa non so che, e rispostole, tutta lieta e aspettante d'udire si taceva; là onde Gismondo così prese a dire: - Una cosa sola, leggiadre donne, e molto semplice oggi ho io a dimostrarvi, e non solamente da me e dalla maggior parte delle nostre fanciulle, che a questi ragionamenti argomento hanno dato, ma da quanti ci vivono, che io mi creda, almeno in qualche parte, solo che da Perottino, conosciuta, se egli pure così conosce come ci ragiona; e questa è la bontà d'Amore, nella quale tanto di rio pose hieri Perottino, quanto allora voi vedeste e, sì come ora vederete, a gran torto. Ma perciò che a me conviene, per la folta selva delle sue menzogne passando, all'aperto campo delle mie verità far via, prima che ad altra parte io venga, a' suoi ragionamenti rispondendo, 67 in essi porrem mano. E lasciando da parte stare il nascimento che egli ad Amore diè, di cui io ragionar non intendo, questi due fondamenti gittò hieri Perottino nel principio delle sue molte voci e, sopra essi edificando le sue ragioni, tutta la sua querela assai acconciamente compose: ciò sono che amare senza amaro non si possa, e che da altro non venga niuno amaro e non proceda che da solo Amore. E perciò che egli di questo secondo primieramente argomentò, a voi, madonna Berenice, ravolgendosi, la quale assai tosto v'accorgeste quanto egli, già nell'entrar de' suoi ragionamenti andava tentone, sì come quegli che nel buio era, di quinci a me piace d'incominciare, con poche parole rispondendogli, perciò che di molte a così scoperta menzogna non fa mestiero. Dico adunque così, che folle cosa è a dire che ogni amaro da altro non proceda che d'Amore. Perciò che se questo vero fosse, per certo ogni dolcezza da altro che da odio non verrebbe e non procederebbe giamai, con ciò sia cosa che tanto contrario è l'odio all'amore, quanto è dall'amaro la dolcezza lontana. Ma perciò che da odio dolcezza niuna procedere non può, ché ogni odio, in quanto è odio, attrista sempre ogni cuore e addolora, pare altresì che di necessità si conchiuda che da amore amaro alcuno procedere non possa in niun modo giamai. Vedi tu, Perottino, sì come io già truovo armi con le quali ti vinco? Ma vadasi più avanti, e a più strette lotte con le tue ragioni passiamo. Perciò che dove tu, alle tre maniere de' mali appigliandoti, argomenti che ogni doglia da qualche amore, sì come ogni fiume da qualche fonte, si diriva, vanamente argomentando, ad assai fievole e falsa parte t'appigli con fievoli e false ragioni sostentata. Perciò che se vuoi dire che, se noi prima non amassimo alcuna cosa, niun dolore ci toccherebbe giamai, è adunque amore d'ogni nostra doglia fonte e fondamento, e che per ciò ne segua che ogni dolore altro che d'amore non sia; deh perché non ci di' tu ancora così, che, se gli uomini non nascessero, essi non morrebbono giamai, è adunque il nascere d'ogni nostra morte fondamento, e perciò si possa dire che la cagion della morte di Cesare o di Nerone altro che il loro nascimento stata non sia? Quasi che le navi che affondano nel mare, de' venti che loro dal porto aspirarono secondi e favorevoli, non di quelli che l'hanno vinte nimici e contrari, si debbano con le balene ramaricare, perciò che, se del porto non uscivano, elle dal mare non sarebbono state ingozzate. E posto che il cadere in basso stato a coloro solamente sia noioso i quali dell'alto son vaghi, non perciò l'amore che alle ricchezze o a gli onori portiamo, sì come tu dicesti, ma la fortuna, che di loro ci spoglia, ci fa dolere. Perciò che se l'amarle parte alcuna di doglia ci recasse nell'animo, con l'amor di loro, possedendole noi o non possedendole, verrebbe il dolore in noi. Ma non si vede che noi ci dogliamo, se non perdendole; anzi manifesta cosa è egli assai che in noi nulla altro il loro amore adopera, se non che quelle cose, che la fortuna ci dà, esso dolci e soavi ce le fa essere: il che se non fosse, il perderle, che se ne facesse, e il mancar di loro, non ci potrebbe dolere. Se adunque nell'amar questi beni di fortuna doglia alcuna non si sente, se non in quanto essa fortuna, nel cui governo sono, gli permuta, con ciò sia cosa che Amore più a grado solamente ce gli faccia essere, e la fortuna, come ad essa piace, e ce gli rubi e ce gli dia, perché giova egli a te di dire che del dolore, il quale le loro mutazioni recano a gli uomini, Amore ne sia più tosto che la fortuna cagione? Certo se mangiando tu a queste nozze, sì come tutti facciamo, il tuo servente contro tua voglia ti levasse dinanzi il tuo piatello pieno di buone e di soavi cose, il quale egli medesimo t'avesse recato, e tu del cuoco ti ramaricassi, e dicessi che egli ne fosse stato cagione, che il condimento dilicato sopra quella cotal vivanda fece, per che ella ti fu recata e tu a mangiarne ti mettesti, pazzo senza fallo saresti tenuto da ciascuno. Ora se la fortuna nostro mal grado si ritoglie que' beni che ella prima ci ha donati, de' quali ella è sola recatrice e rapitrice, tu Amore n'encolperai, che il conditor di loro è, e non ti parrà d'impazzare? Certo non vorrei dir così, ma io pure dubito, Perottino, che oggimai non t'abbiano in cotali giudicii gran parte del debito conoscimento tolto le ingorde maninconie. Questo medesimamente, senza che io mi distenda nel parlare, delle ricchezze dell'animo e di quelle del corpo ti si può rispondere, quali unque sieno di loro i ministratori. E se le tue fiere alcun de' loro poppanti figliuoli perdendo si dogliono, il caso tristo che le punge, non l'amore che la natura insegna loro, le fa dolere. D'intorno alle quali tutte cose, oggimai che ne posso io altro dire, che di soverchio non sia, se non che mentre tu con queste nuvole ti vai ombreggiando la tua bugia, niuna soda forma ci hai ritratta del vero? Se per aventura più forte argomento non volessimo già dire che fosse dell'amaritudine d'Amore quello dove tu di' che Amore da questa voce Amaro assai acconciamente fu così da prima detto, affine che egli bene nella sua medesima fronte dimostrasse ciò che egli era. Il che io già non sapea, e credea che non le somiglianze de' sermoni, ma le sustanze delle operagioni fossero da dovere essere ponderate e riguardate. Che se pure le somiglianze sono delle sustanze argomento, di voi, donne, sicuramente m'incresce, le quali non dubito che Perottino non dica che di danno siate alla vita de gli uomini, con ciò sia cosa che così sono inverso di sé queste due voci, Donne e Danno conformi, come sono quest'altre due, Amore e Amaro, somiglianti. [2.IV.] Aveano a piacevole sorriso mosse le ascoltanti donne queste ultime parole di Gismondo, e madonna Berenice tuttavia sorridendo, all'altre due rivoltasi così disse: - Male abbiam procacciato, compagne mie care, poi che sopra di noi cadono le costoro quistioni. A cui Sabinetta, della quale la giovanetta età e la vaga bellezza facevano le parole più saporose e più care, tutta lieta e piacevole rispose: - Madonna, non vi date noia di ciò: elle non ci toccano pure. Perciò che dimmi tu, Gismondo, qua' donne volete voi che sien di danno alla vostra vita: le giovani o le vecchie? Certo delle giovani secondo il tuo argomentare non potrai dire, se non che elle vi giovino; con ciò sia cosa che Giovani e Giovano quella medesima somiglianza hanno in verso di sé che tu delle Donne e del Danno dicesti. Il che se tu mi doni, a noi basta egli cotesto assai: le vecchie poi sien tue. 68 - Sieno pure di Perottino, - rispose tutto ridente Gismondo - la cui tiepidezza e le piagnevoli querele, poi che le somiglianze hanno a valere, assai sono alla fredda e ramarichevole vecchiezza conformi. A me rimangano le giovani, co' cuori delle quali, lieti e festevoli e di calde speranze pieni, s'avenne sempre il mio, e ora s'aviene più che giamai, e certo sono che elle mi giovino, sì come tu di'. - A queste così fatte parole molte altre dalle donne e da' giovani dette ne furono, l'uno all'altro scherzevolmente ritornando le vaghe rimesse de' vezzosi parlari. E di giuoco in giuoco per aventura garreggiando più oltre andata sarebbe la vaga compagnia, nella quale solo Perottino si tacea, se non che Gismondo in questa maniera parlando alla loro piacevolezza pose modo: [2.V.] - Assai ci hanno, mottegiose giovani, dal diritto camino de' nostri ragionamenti traviati le somiglianze di Perottino, le quali, perciò che a noi di più giovamento non sono che elle state sieno utili a lui, oggimai a dietro lasciando, più avanti ancora de' suoi ramarichi passiamo. E perché avete assai chiaro veduto quanto falsa l'una delle sue proposte sia, dove egli dice che ogni amaro altro che d'Amore non viene, veggasi ora quanto quell'altra sia vera, dove egli afferma che amare senza amaro non si puote. Nella quale una egli ha cotante guise d'amari portate e raunate, che assai utile lavorator di campi egli per certo sarebbe, se così bene il loglio, la felce, i vepri, le lappole, la carda, i pruneggiuoli e le altre erbe inutili e nocive della sua possessione sciegliesse e in un luogo gittasse, come egli ha i sospiri, le lagrime, i tormenti, le angoscie, le pene, i dolor tutti e tutti i mali della nostra vita sciegliendo, quegli solamente sopra le spalle de gl'innocenti amanti gittati e ammassati. Alla qual cosa fare, acciò che egli d'alcuno apparente principio incominciasse, egli prese argomento da gli scrittori, e disse che quanti d'Amor parlano, quello ora fuoco e ora furor nominando e gli amanti sempre miseri e sempre infelici chiamando, in ogni lor libro, in ogni lor foglio si dolgono, si lamentano di lui, né pure di sospiri o di lagrime, ma di ferite e di morti de gli amanti tutti i loro volumi son macchiati. Il che è da.llui con assai più sonanti parole detto che con alcuna ragionevole pruova confermato, sì come quello che non sente del vero. Perciò che chi non legge medesimamente in ogni scrittura gli amorosi piaceri? Chi non truova in ogni libro alcuno amante che, non dico le sue venture, ma pure le sue beatitudini non racconti? Delle quali se io vi volessi ora recitare quanto potrei senza molto studio ramentarmi, certo pure in questa parte sola tutto questo giorno logorerei, e temerei che prima la voce che la materia mi venisse mancata. Ma perciò che egli con le sue canzoni i gravi ramarichi de gli amanti e la ferezza d'Amore vi volle dimostrare, e fece bene, perciò che egli non arebbe di leggiero potuto altrove così nuovi argomenti ritrovare, come che a' proprii testimoni non si creda, pure, se a voi, donne, non ispiacerà, io altresì con alcuna delle mie quanto d'Amore si lodino gli uomini e quanto abbiano da lodarsi di lui non mi ritrarrò di farvi chiaro. […] [2.XIV.] Di poco avea così detto Gismondo, quando Lavinello, il quale lungamente s'era taciuto, con queste parole gli si fe' incontro: - Cattivi testimoni aresti trovati, Gismondo, se questi allori parlassero, a quello che tu intendi di provarci. Perciò che se essi ritratto fanno al primo loro pedale, sì come è natura delle piante, essi non amarono giamai. Perciò che non amò altresì quella donna che primieramente diè al tronco forma, del quale questi tutti sono rampolli, se quello vero è che se ne scrive. - Male stimi, Lavinello, e male congiugni le cose da natura separate - rispose incontanente Gismondo. - Perciò che questi allori bene fanno ritratto al primo loro pedale, sì come tu di', ma non alla donna, la quale se stessa lasciò, quando ella primieramente la buccia di lui prese. Questi, come anco quello fece, amano e sono amati altresì, essi la terra e la terra loro, e di tale amor pregni partoriscono al lor tempo ora talli, ora orbache, ora frondi, secondo che esso, da cui tutti nacquero, partoriva, né mai ha fine il loro amore, se non insieme con la lor vita. Il che volesse Idio che fosse ne gli uomini, che Perottino non arebbe forse ora cagion di piagnere così amaramente, come egli fa vie più spesso che io non vorrei. Ma la donna non amò già essendo amata, sì come tu ragioni; la qual cosa perciò che fu contro natura, forse meritò ella di divenir tronco, come si scrive. E certo che altro è, lasciando le membra umane, albero e legno farsi, che, gli affetti naturali abandonando molli e dolcissimi, prendere i non naturali, che sono così asperi e così duri? che se questi allori parlassero e le nostre parole avessero intese, a me giova di credere che noi ora udiremmo che essi non vorrebbono tornare uomini, poi che noi contro la natura medesima operiamo, la qual cosa non aviene in loro; non che essi buoni testimoni non fossero, Lavinello, a quello che io ti ragiono. [2.XV.] È adunque, né bisogna che io ne quistioni, o donne, naturale affetto de gli animi nostri Amore, e per questo di necessità e buono e ragionevole e temperato. Onde quante volte aviene che l'affetto de' nostri animi non è temperato, tante volte non solamente ragionevole né buono è più, ma egli di necessità ancora non è Amore. Udite voi ciò che io dico? Vedete voi a che parte la pura e semplice verità m'ha portato? Che dunque è, potrestemi voi dire, se egli non è Amore? ha egli nome alcuno?. Sì bene che egli n'ha, e molti, e per aventura quelli stessi che Perottino quasi nel principio de' suoi sermoni gli diè, pure di questo medesimo ragionando quello, che egli d'Amor si credea favellare: fuoco, furore, miseria, infelicità e, oltre a questi, se io porre ne gli posso uno, egli si può più acconciamente che altro chiamare ogni male, perciò che in Amore, sì come poco appresso vi fie manifesto, ogni bene si rinchiude. Che vi posso io dire più avanti? Né v'ingannino queste semplici voci, o donne, che senza fatica escono di bocca altrui, d'amore, d'amante, d'innamorato, che voi crediate che incontanente Amor sia tutto quello che è detto Amore, e tutti sieno amanti quelli che per amanti sono tenuti e per innamorati. Questi nomi piglia ciascuno per lo più co' primi disii, i quali esser 69 possono non meno temperati che altramente e, così presi, comunque poi vada l'opera, esso pure se gli ritiene, aiutato dalla sciocca e bamba oppenione de gli uomini che, senza discrezion fare alcuna con diverse appellazioni alle diverse operazion loro, così chiamano amanti quelli che male hanno disposti gli affetti dell'animo loro nelle disiderate cose e cercate, come quelli che gli han bene. Ahi come agevolmente s'ingannano le anime cattivelle de gli uomini, e quanto è leggiera e folle la falsa e misera credenza de' mortali. Perottino, tu non ami; non è amore, Perottino, il tuo; ombra sei d'amante, più tosto che amante, Perottino. Perciò che se tu amassi, temperato sarebbe il tuo amore, e essendo egli temperato, né di cosa che avenuta ne sia ti dorresti, né quello che per te avere non si può disidereresti tu o cercheresti giamai. Perciò che, oltre che soverchio e vano è sempre il dolore per sé, stoltissima cosa è e fuori d'ogni misura stemperata, quello che avere non si possa, pur come se egli aver si potesse, andare tuttavia disiderando e cercando. La qual follia volendo significarci i poeti, fecero i Giganti che s'argomentassero di pigliare il cielo, guerreggianti con gl'Idii, a cui essi non erano bastanti. Che se la fortuna t'ha della tua cara donna spogliato, dove tu amante di lei voglia essere, poscia che altro fare non se ne può, non la disiderare, e quello che perduto vedi essere, tieni altresì per perduto. Amala semplice e puramente, sì come amare si possono molte cose, come che d'averle niuna speranza ne sia. Ama le sue bellezze, delle quali tanto ti maravigliasti già e lodastile volentieri; e dove il vederle con gli occhi ti sia tolto, contentati di rimirarle col pensiero, il che niuno ti può vietare. E in fine ama di lei quello che oggi poco s'ama nel mondo, mercé del vizio che ogni buon costume ha discacciato, l'onestà dico, sommo e spezialissimo tesoro di ciascuna savia, la qual sempre ci dee esser cara, e tanto più ancora maggiormente, quanto più care ci sono le donne amate da noi; sì come io m'ingegnai di fare già, che ella fosse a me cara nella persona della mia donna, non men di quello che la sua bellezza m'era graziosa, quantunque ne' primi miei disii, sì come veggiamo tutto dì a' cavalli non usati essere la sella e il freno, ella dura e gravetta mi fosse alquanto nell'animo a sopportare. Di che io allora ne feci in testimonio questa canzone; la quale tanto più volentieri vi sporrò, graziose giovani, quanto a voi, che non meno oneste sete che belle, ella più che alcuna dell'altre già dette s'acconviene. Sì rubella d'Amor, né sì fugace Non presse erba col piede, Né mosse fronda mai Ninfa con mano, Né trezza di fin oro aperse al vento, Né 'n drappo schietto care membra accolse Donna sì vaga e bella, come questa Dolce nemica mia. Quel che nel mondo, e più ch'altro mi spiace, Rade volte si vede, Fanno in costei, pur sovra 'l corso umano, Bellezza e castità dolce concento. L'una mi prese il cor come Amor volse, L'altra l'impiaga, sì leggiera e presta, Ch'ei la sua doglia oblia. Sola in disparte, ov'ogni oltraggio ha pace, Rosa o giglio non siede, Che l'alma non gli assembri a mano a mano, Avezza nel desio ch'i' serro drento, Quel vago fior, cui par uom mai non colse. Così l'appaga e parte la molesta Secura leggiadria. Caro armellin, ch'innocente si giace, Vedendo, al cor mi riede Quella del suo penser gentile e strano Bianchezza, in cui mirar mai non mi pento: Sì novamente me da me disciolse La vera maga mia che, di rubesta, Cangia ogni voglia in pia. Bel fiume, alor ch'ogni ghiaccio si sface, Tanta falda non diede, Quanta spande dal ciglio altero e piano Dolcezza, che pò far altrui contento; E sé dal dritto corso unqua non tolse. Né mai s'inlaga mar senza tempesta, Che sì tranquillo sia. Come si spegne poco accesa face, Se gran vento la fiede, 70 Similemente ogni piacer men sano Vaghezza in lei sol d'onestate ha spento. O fortunato il velo, in cui s'avolse L'anima saga e lei, ch'ogni altra vesta Men le si convenia. Questa vita per altro a me non piace, Che per lei, sua mercede, Per cui sola dal vulgo m'allontano; Ch'avezza l'alma a gir là 'v'io la sento, Sì ch'ella altrove mai orma non volse; E più s'invaga, quanto men s'arresta Per la solinga via. Dolce destin, che così gir la face, Dolci del mio cor prede, Ch'altrui sì presso, a me 'l fan sì lontano; Asprezza dolce e mio dolce tormento, Dolce miracol, che veder non suolse, Dolce ogni piaga, che per voi mi resta Beata compagnia. Quanto Amor vaga, par beltate onesta Né fu giamai, né fia. [2.XVII.] Ora, perciò che da ritornare è là, onde ci dipartimmo, quinci comprender potete, donne, e quale sia l'errore di Perottino e dove egli l'ha preso. Perciò che dovendo egli mettersi per quella via dell'animo che ad Amor lo scorgesse nel favellare, egli, entrando per l'altro sentiero, alla contraria regione è pervenuto, per lo quale caminando, in quelle tante noie si venne incontrato, in quelle pene, in que' giorni tristi, in quelle notti così dolorose, in quelli scorni, in quelle gelosie, in coloro che uccidono altrui e talora per aventura se stessi, in que' Mezii, in que' Tizii, in que' Tantali, in quelli Isioni, tra' quali ultimamente, quasi come se egli nell'acqua chiara guatato avesse, egli vide se stesso: ma non si riconobbe bene, ché altramente si sarebbe doluto e vie più vere lagrime arebbe mandate per gli occhi fuora che egli non fece. Perciò che credendo sé essere amante e innamorato, mentre egli pure nella sua forma s'incontra imaginando, egli è un solitario cervo divenuto, che poi, a guisa d'Atteone, i suoi pensieri medesimi, quasi suoi veltri, vanno sciaguratamente lacerando; i quali egli più tosto cerca di pascere che di fuggire, vago di terminare innanzi tempo la sua vita, poco mostrando di conoscer quanto sia meglio il vivere, comunque altri viva, che il morire, quasi come se esso oggimai sazio del mondo niuno altro frutto aspettasse più di cogliere per lo innanzi de gli anni suoi, i quali non hanno appena incominciato a mandar fuora i lor fiori. Che quantunque così smaghino la costui giovanezza, donne, e così guastino le lagrime, come voi vedete, non perciò venne egli prima di me nel mondo, il quale pure oltre a tanti anni non ho varcati, quanti sarebbero i giorni del minor mese, se egli di due ancora fosse minore che egli non è. E cotestui, come se egli al centinaio s'appressasse, a guisa de gl'infermi perduti, chiama sovente chi di queste contrade levandolo in altri paesi ne 'l rechi, forse avisandosi, per mutare aria, di risanare. O sciagurato Perottino, e veramente sciagurato poi che tu stesso ti vai la tua disaventura procacciando e, non contento della tua, cerchi di teco far miseri insiememente tutti gli uomini. Perciò che tutti gli uomini amano, e necessariamente ciascuno. Che se gli amanti sempre accompagnano quegli appetiti così trabocchevoli, quelle allegrezze così dolorose, quelle così triste forme di paura, quelle cotante angoscie che tu di', senza fallo non solamente tutti gli uomini fai miseri, ma la miseria medesima costrigni ad essere per se stesso ciascun uomo. Taccio le pene di quelle maraviglie così fiere del tuo Idio, che tu ci raccontasti, le quali non che a.ffar la vita de gli uomini bastassero trista e cattiva, ma, di meno assai, gl'inferni tutti n'averebbono e tutti gli abissi di soverchio. O istolto, quanto sarebbe meglio por fine oggimai alla non profittevole maninconia, che ogni giorno andare meno giovevole ramarichio rincominciando; e alla tua salvezza dar riparo, mentre ella sostiene di riceverlo, che ostinatamente alla tua perdezza trovar via; e pensare che la natura non ti diè al mondo, perché tu stesso ti venissi cagion di tortene, che, tra queste lamentanze favolose vaneggiando e quasi al vento cozzando, dal vero sentimento e dalla tua salute medesima farti lontano. Ma lasciamo oggimai da canto con le sue menzogne Perottino, il quale hieri dal molto dolor sospinto e molto d'Amor lamentandosi, alquanto più lunga m'ha oggi fatta tenere questa parte della risposta, che io voluto non arei. Né siamo noi così stolti, donne, che crediamo il dolore altro che da Amore non essere, che pure parte alcuna non ha con lui, o che pensiamo che amare non si possa senza amaro, il qual sapore per niente ne gli amorosi condimenti non può aver luogo. E poscia che l'arme di Perottino, le quali egli contro ad Amore con sì fellone animo impalmate s'avea, nell'altrui scudo, sì come quelle che di piombo erano, si sono rintuzzate agevolmente, veggiamo ora quali sono quelle che Amore porge a chiunque si mette in campo per lui; come che Perottino si credesse hieri che a me non rimanesse che pigliare. Quantunque io né tutte le mi creda poter prendere, ché di troppo mi terrei da più che io non sono, né, se io pure il potessi, mi basterebbe egli il dì tutto intero a ciò fare, non che questo poco d'ora meriggiana che m'è data. Tuttavia dove egli non fosse, dilettose giovani, che voi voleste che io alcun'altra cosa ancora ne sopraragionassi alle raccontate. 71 […] TERZO LIBRO [3.XII.] Stette nel mio saluto alquanto sopra sé il santo uomo e poi, verso me con miglior passo facendosi, disse: "Dunque sei tu pure qui ora, il mio Lavinello". E questo detto, ravicinatomisi e di me amendue le gote soavemente prendendo, mi basciò la fronte. Nuova cosa mi fu senza fallo alcuno l'essere quivi così amichevolmente ricevuto e per nome chiamato da colui, del quale io alcuna contezza non avea, né sapea in che modo egli avere di me la si potesse. Per che da subita maraviglia soprapreso, e mirando cotal mezzo con vergogna il santo uomo pure per vedere se io racconoscere ne 'l potessi, e non racconoscendolo, sì come quello che io altra volta veduto non avea, stetti per buono spazio senza nulla dire, infino a tanto che egli, con un dolce sorriso, del mio maravigliare mostrò che s'accorgesse. Là onde io, preso ardire, così risposi: - Qui è ora, Padre, Lavinello per certo, sì come voi dite, non so se a caso venutoci o pure per volere del cielo. Ma voi il fate sopra modo maravigliare, né sa pensare come ciò sia, che voi lui conosciate, il quale né in questo luogo fu altra volta più, né vi vide, che egli sappia, giamai -. Allora il buon vecchio, che già per mano preso m'avea, movendo verso la capanna il passo, con lieto e tranquillo sembiante disse: - Io non voglio, Lavinello, che tu di cosa che ad alto possa piacere ti maravigli. Ma perciò che tu, come io veggo, a piè qui dal castello venuto, salendo il colle puoi avere alcuna fatica sostenuta più tosto che no, sì come dilicato che mi pare che tu sii, andiamci colà, e sì sederai e io ti terrò volentieri compagnia, che non sono perciò il più gagliardo uom del mondo, e quello che io so di te, sedendo e riposando, ti farò chiaro -. Indi con pochi valchi sotto alcune ginestre guidatomi, che dinanzi la picciola casa erano, sopra il piano d'un tronco d'albero, il quale, lungo le ginestre posto, a lui e a' suoi osti semplice e bastevole seggio facea, si pose a sedere e volle che io sedessi; e poi che m'ebbe alquanto lasciato riposare, incominciò: -Tanto è largo e cupo il pelago della divina providenza, o figliuolo, che la nostra umanità, in esso mettendosi, né termine alcuno vi truova, né in mezzo può fermarsi; perciò che vela di mortale ingegno tanto oltre non porta e fune di nostro giudicio, per molto che ella vi si stenda, non basta a pigliar fondo; in maniera che bene si veggono molte cose tutto dì avenire, volute e ordinate da lei, ma come elle avengano o a che fine, noi non sappiamo, sì come ora in questo mio conoscerti, di che ti maravigli, è avenuto -. E così seguendo mi raccontò che, dormendo egli questa notte prossimanamente passata, gli era nel sonno paruto vedermi a sé venire tale quale io venni, e dettogli chi io era e tutti gli accidenti di questi due passati giorni e le nostre dispute e il mio dover dire d'oggi alla presenza di Vostra Maestà e quello che io in parte pensava di dirne, che è quanto testé udito avete, raccontatogli, dimandarlo di ciò che ne gli paresse e che esso d'intorno a questo fatto dicesse, se a lui convenisse ragionarne, come a me conveniva. Là onde egli con questa imaginazione destatosi e levatosi, buona pezza v'avea pensato e tuttavia, quando io il sopragiunsi, vi pensava. Di che egli a guisa di conosciuto mi ricevette e a sé già per la contezza della notte fatto dimestico e famigliare. Crebbe in cento doppi la mia dianzi presa maraviglia, udendo il santo uomo, e la credenza, che io vi recai, della sua santità, divenne senza fine maggiore. E così tutto d'orrore e di riverenza pieno, come esso tacque: - Ben veggo io, - dissi - Padre, che io non senza volere de gl'Idii qui sono, a' quali voi cotanto siete, quanto si vede, caro. Ora, perciò che si dee credere che essi con l'avuta visione v'abbiano dimostrato essere di piacer loro che voi a questo mio maggiore uopo aiuto e consiglio mi prestiate, credo io acciò che la nostra Reina, dolce cura della loro maestà, non come io posso ma come essi vogliono, s'onori, piacciavi al voler loro di sodisfare, ché al mio oggimai non debbo io dir più -. - Anzi pure a Colui piaccia al quale ogni ben piace, che io al tuo disiderio possa con la sua volontà sodisfare - rispose il santo uomo. E così risposto e gli occhi verso il cielo alzati e per picciolo spazio con fiso sguardo tenutovegli, a me rivolto in questa guisa riprese a dire: [3.XIII.] - Grande fascio avete tu e i tuoi compagni abbracciato, Lavinello, a me oggimai non meno di figliuol caro, a dir d'Amore e della sua qualità prendendo: sì perché infinita è la moltitudine delle cose che dire vi si posson sopra, e sì ancora maggiormente perciò che tutto il giorno tutte le genti ne quistionano, quelle parti ad esso dando, che meno gli si converrebbe dare, e quelle che sono sue certissime, propriissime, necessariissime tacendo e da parte lasciando per non sue; la qual cosa ci fa poi più malagevole il ritrovarne la verità contro le openioni de gli altri uomini, quasi allo 'ndietro caminando. Non pertanto non dee alcuno di cercarne spaventarsi e, perché faticoso sia il poter giugnere a questo segno, ritrarsi da farne pruova. Perciò che di poche altre cose può avenire, o forse di non niuna, che lo intendere ciò che elle sono più ci debba esser caro, che il sapere che cosa è Amore. Il che quanto a voi sia ora nelle dispute de' tuoi compagni e in quello che tu stimi di poterne dire avenuto, e chi più oltre si sia fatto di questo intendimento e chi meno, ne rimetto io a madonna la Reina il giudicio. Ma dello avere avuto ardire di cercarne, bella loda dare vi se ne conviene. Tuttavolta se a te giova che io ancora alcuna cosa ne rechi sopra e più avanti se ne cerchi, facciasi a tuo sodisfaccimento, pure che non istimi che la verità sotto queste ginestre più che altrove si stia nascosa. E a.ffine che tu in errore non istii di ciò che detto hai, che Amore e disidero sono quello stesso, io ti dico che egli nel vero non è così. Ma veggasi prima che cosa in noi o pure che parte di noi è Amore; dapoi, che egli non sia disidero, ti farò chiaro. È adunque da sapere che, sì come nella nostra intellettiva parte dell'animo sono pure tre parti o qualità o spezie, ciascuna di loro differente dall'altre e separata (perciò che v'è primieramente l'intelletto, che è la parte di lei acconcia e presta allo 'ntendere e può nondimeno ingannarsi; v'è per secondo lo intendere, che io dico, il quale non sempre ha luogo, ché non sempre s'intendono le intelligibili cose, anzi non ha egli se non tanto, quanto esso intelletto si muove e volge con profitto d'intorno a quello che a lui è proposto per intendersi e per sapersi; èvvi dopo queste ultimamente e di loro nasce quella cosa o luce o 72 imagine o verità, che dire la vogliamo, che a noi bene intesa si dimostra, frutto e parto delle due primiere, la qual tuttavia, se è male intesa, né verità né imagine né luce dire si può, ma caligine e abbagliamento e menzogna), così, né più né meno, sono nella nostra vogliosa parte del medesimo animo pure tre spezie, per gli loro ufficii propria e dall'altre due partita ciascuna. Con ciò sia cosa che v'è di prima la volontà, la qual può e volere parimente e disvolere, fonte e capo delle due seguenti; e che v'è dopo questa il volere, di cui parlo, e ciò è il disporsi a mettere in opera essa volontà o molto o poco, o ancora contrariamente, che è disvolendo; e che v'è per ultimo quello, che di queste due si genera: il che, se piace, amore è detto, se dispiace, odio per lo suo contrario necessariamente si convien dire. Nasce adunque amore, Lavinello, e creasi nella guisa che tu hai veduto, e è in noi o di noi quella parte, che tu intendi. Ora che egli non sia disiderio in questo modo potrai vedere. Perciò che bene è vero che disiderar cosa per noi non si può, che non s'ami, ma non perciò ne viene che non s'ami cosa, che non si disideri altresì; perciò che se n'amano molte e non si disiderano, e ciò sono tutte quelle che si posseggono; ché, tosto che noi alcuna cosa possediamo, a noi manca di lei il disiderio in quella parte che noi la possediamo, e in luogo di lui sorge e sottentra il piacere. Ché altri non disidera quello che egli ha, ma egli se ne diletta godendone; e tuttavia egli l'ama e hallo caro vie più che prima: sì come fai tu, il quale, mentre ancor bene l'arte del verseggiare e del rimare non sapevi, sì l'amavi tu assai, sì come cosa bella e leggiadra che ella è, e insieme la disideravi; ma ora che l'hai e usar la sai, tu più non la disideri, ma solamente a te giova e ètti caro di saperla e amila molto ancor più, che tu prima che la sapessi e possedessila non facevi. La qual cosa meglio ti verrà parendo vera, se tu a quello che odio e timor siano parimente risguarderai. Perciò che quantunque temere di niuna cosa non si possa, che non s'abbia in odio, pure egli non è che alle volte non s'odii alcuna cosa senza temerla. Ché tu puoi avere in odio i violatori delle mogli altrui, e di loro tuttavia non temi, perciò che tu moglie non hai, che essere ti possa violata. E io in odio ho i rubatori dell'altrui ricchezze, né perciò di lor temo, ché io non ho ricchezza da temerne, come tu vedi. Per la qual cosa ne segue che, sì come odio può in noi essere senza timore, così vi può amore essere senza disio. Non è adunque disio Amore, ma è altro. [3.XIV.] Tuttavia io non voglio, Lavinello, ragionar teco e disputare così sottilmente come per aventura farei tra filosofi e nelle scuole. E sia per me, se così a te piace, amore e disidero quello stesso. Ma io sapere da te vorrei, poscia che tu questa notte detto m'hai che amore può essere e buono e reo, secondo la qualità de gli obbietti e il fine che gli è dato, perché è che gli amanti alle volte s'appigliano ad obbietti malvagi e cattivi. Non è egli per ciò, che essi nello amare più il senso seguono che la ragione? -. - Non per altro, che io mi creda, - risposi - Padre, che per cotesto -. - Ora se io ti dimanderò allo 'ncontro - seguitò il santo uomo - perché aviene che gli amanti eziandio s'invogliano de gli obbietti convenevoli e sani, non mi risponderai tu ciò avenire per questo, che essi, amando, quello che la ragione detta loro più seguono, che quello che il senso pon loro innanzi? -. - Così vi risponderò, - dissi io - e non altramente -. - È adunque - diss'egli - ne gli uomini il seguir la ragione più che il senso, buono, e allo 'ncontro il seguire il senso più che la ragione, reo -. - È - dissi io - senza fallo alcuno -. - Ora mi di', - riprese egli - che cagione fa che ne gli uomini seguire il senso più che la ragione sia reo? -. - Fallo - risposi - ciò, che essi la cosa migliore abandonano, che è la ragione, e essa lasciano, che appunto è la loro, là dove alla men buona s'appigliano, che è il senso, e esso seguono, che non è il loro -. - Che la ragione miglior cosa non sia che il senso, io - diss'egli - non ti niego, ma come di' tu che il senso non è il loro? non è egli de gli uomini il sentire? -. - A quello che io avedere me ne possa, Padre, voi ora mi tentate, - risposi - ma io nondimeno v'ubidirò -; e dissi: - Sì come nelle scale sono gradi, de' quali il primiero e più basso niuno n'ha sotto sé, ma il secondo ha il primo e il terzo ha l'uno e l'altro e il quarto tutti e tre, così nelle cose che Dio create ha infino alla spezie de gli uomini, dalla più vile incominciando, essere si vede avenuto. Perciò che sono alcune che altro che l'essere semplice non hanno, sì come sono le pietre e questo morto legno, che noi ora sedendo premiamo. Altre hanno l'essere e il vivere, sì come sono tutte le erbe, tutte le piante. Altre hanno l'essere e la vita e il senso, sì come hanno le fiere. Altre poi sono, che hanno l'essere e la vita e il senso e la ragione, e questi siam noi. Ma perciò che quella cosa più si dice esser di ciascuno, che altri meno ha, come che l'essere e il vivere sieno parimente delle piante, non si dice tuttavia se non che il vivere è il loro, perciò che l'essere delle pietre è e di molte altre cose parimente, delle quali non è poi la vita. E quantunque l'essere e il vivere e il sentire sieno delle fiere, come io dissi, medesimamente ciascuno, non pertanto il sentire solamente si dice essere il loro, perciò che il vivere esse hanno in comune con le piante e l'essere hanno in comune con le piante e con le pietre, delle quali non è il sentire. Simigliantemente perché l'essere e il vivere e il senso e la ragione sieno in noi, dire per questo non si può che l'essere sia il nostro o il vivere o il sentire, che sono dalle tre maniere, che io dico, avute medesimamente e non pur da noi, ma dicesi che è la ragione, di cui le tre guise delle create cose sotto noi non hanno parte -. - Se così è, - disse allora il santo uomo - che la ragione sia de gli uomini e il senso delle fiere, perciò che dubbio non è che la ragione più perfetta cosa non sia che il senso, quelli che amando la ragione seguono, ne' loro amori la cosa più perfetta seguendo, fanno in tanto come uomini, e quelli che seguono il senso, dietro alla meno perfetta mettendosi, fanno come fiere -. - Così non fosse egli da questo canto, - risposi io - Padre, vero cotesto che voi dite, come egli è -. 73 - Adunque possiamo noi la miglior parte nello amare abandonando, - diss'egli - che è la nostra, alla men buona appigliarci, che è l'altrui? -. - Possiamo - rispos'io - per certo -. - Ma perché è - diss'egli - che noi questo possiamo? -. - Perciò che la nostra volontà, - risposi - con la quale ciò si fa o non fa, è libera e di nostro arbitrio, come io dissi, e non stretta o, più a questo che a quello seguire, necessitata -. - Ora le fiere - seguitò egli - possono elleno ciò altresì fare, che la miglior parte e quella che è la loro abandonino e a dietro lascino giamai? -. - Io direi che esse abandonare non la possono, - risposi - se non sono da istrano accidente violentate. Perciò che ad esse volontà libera non è data, ma solo appetito, il quale, dalla forma delle cose istrane con lo strumento delle sentimenta invitato, sempre dietro al senso si gira. Perciò che il cavallo, quandunque volta a bere ne lo 'nvita il gusto, veduta l'acqua, egli vi va e a bere si china, dove, la briglia ritraendo, non gliele vieti colui che gli è sopra -. [3.XV.] - Quanto vorrei che tu altramente m'avessi potuto rispondere, Lavinello - disse il santo uomo. - Perciò che, se noi possiamo ne' nostri amori, alla men buona parte appigliandoci, la migliore abandonare, e le fiere non possono, esse non operando come piante e noi operando come fiere, piggior condizione pare che sia in questo la nostra, figliuolo, a quello che ne segue, che non pare la loro; e questa nostra volontà libera, che tu di', a nostro male ci sarà suta data, se questo è vero. E potrassi credere che la natura, quasi pentita d'avere tanti gradi posti nella scala delle spezie, che tu di', poscia che ella ci ebbe creati col vantaggio della ragione, più ritorre non la ne potendo, questa libertà ci abbia data dell'arbitrio, affine che in questa maniera noi medesimi la ci togliessimo, del nostro scaglione volontariamente a quello delle fiere scendendo; a guisa di Phebo, il quale, poscia che ebbe alla troiana Cassandra l'arte dell'indovinare donata, pentitosi e quello che fatto era frastornare non si possendo, le diede che ella non fosse creduta. Ma tu per aventura che ne stimi? parti egli che così sia? -. - Io, Padre, quello che me ne paia o non paia, non so dire, - risposi - se io non dico che tanto a me ne pare, quanto pare a voi. Ma pure volete voi che io creda che la natura si possa pentere, che non può errare? -. - Mai no, che io non voglio che tu il creda - disse il santo uomo. - Ben voglio che tu consideri, figliuolo, che la natura, la quale nel vero errar non può, non avrebbe alla nostra volontà dato il potere, dietro al senso sviandoci, farci scendere alla spezie che sotto noi è, se ella dato medesimamente non l'avesse il potere, dietro alla ragione inviandoci, a quella farci salire che c'è sopra. Perciò che ella sarebbe stata ingiusta, avendo nelle cose, da sé in uso e in sostentamento di noi create, posta necessità di sempre in quelli privilegi servarsi, che ella concessi ha loro; a noi, che signori ne siamo e a' quali esse tutte servono, avere dato arbitrio d'arrischiare il capitale da lei donatoci sempre in perdita, ma in guadagno non mai. Né è da credere che alle tante e così possenti maniere d'allettevoli vaghezze, che le nostre sentimenta porgono all'animo in ogni stato in ogni tempo in ogni luogo, perché noi dietro all'appetito avallandoci sozze fiere diveniamo, ella ci abbia concesso libero e agevole inchinamento; e a quelle che lo 'ntelletto ci mette innanzi, affine che noi con la ragione inalzandoci diveniamo Idii, ella il poter poggiare ci abbia tolto e negato. Perciò che, o Lavinello, che pensi tu che sia questo eterno specchio dimostrantesi a gli occhi nostri, così uno sempre, così certo, così infaticabile, così luminoso, del sole, che tu miri? e quell'altro della sorella, che uno medesimo non è mai? e gli tanti splendori che da ogni parte si veggono di questa circonferenza che intorno ci si gira, ora queste sue bellezze ora quelle altre scoprendoci, santissima, capacissima, maravigliosa? Elle non sono altro, figliuolo, che vaghezze di Colui che è di loro e d'ogni altra cosa dispensatore e maestro, le quali egli ci manda incontro a guisa di messaggi, invitantici ad amar lui. Perciò che dicono i savi uomini che, perciò che noi di corpo e d'animo constiamo, il corpo, sì come quello che d'acqua e di fuoco e di terra e d'aria è mescolato, discordante e caduco da' nostri genitori prendiamo, ma l'animo esso ci dà purissimo e immortale e di ritornare a lui vago, che ce l'ha dato. Ma perciò che egli in questa prigione delle membra rinchiuso più anni sta, che egli lume non vede alcuno, mentre che noi fanciulli dimoriamo, e poscia, dalla turba delle giovenili voglie ingombrato, ne' terrestri amori perdendosi può del divino dimenticarsi, esso in questa guisa il richiama, il sole ogni giorno, le stelle ogni notte, la luna vicendevolmente dimostrandoci. Il quale dimostramento che altro è, se non una eterna voce che ci sgrida: "O stolti, che vaneggiate? Voi ciechi, d'intorno a quelle vostre false bellezze occupati, a guisa di Narciso vi pascete di vano disio, e non v'accorgete che elle sono ombre della vera, che voi abandonate. I vostri animi sono eterni: perché di fuggevole vaghezza gl'innebbriate? Mirate noi, come belle creature ci siamo, e pensate quanto dee esser bello Colui, di cui noi siam ministre". [3.XVI.] E senza dubbio, figliuolo, se tu, il velo della mondana caliggine dinanzi a gli occhi levandoti, vorrai la verità sanamente considerare, vedrai alla fine altro che stolto vaneggiamento non essere tutti i vostri più lodati disii. Che per tacere di quegli amori, i quali di quanta miseria sien pieni li perottiniani amanti e Perottino medesimo essere ce ne possono abondevole essempio, che fermezza, che interezza, che sodisfazione hanno perciò quegli altri ancora, che essi cotanto cercar si debbano e pregiare, quanto Gismondo ne ha ragionato? Senza fallo tutte queste vaghezze mortali che pascono i nostri animi, vedendo, ascoltando e per l'altre sentimenta valicando e mille volte col pensiero entrando e rientrando per loro, né come esse giovino so io vedere, quando elle a poco a poco in maniera di noi s'indonnano, co' loro piaceri pigliandoci, che poi ad altro non pensiamo, e gli occhi alle vili cose inchinati, con noi medesimi non ci raffrontiamo giamai, e infine, sì come se il beveraggio della maliosa Circe preso avessimo, d'uomini ci cangiamo in fiere; né in che guisa esse così pienamente dilettino so io considerare: pogniamo ancora che falso diletto non sia il loro, 74 quando elle sì compiute essere in suggietto alcuno non si vedono, né vedranno mai, che esse da ogni parte sodisfacciano chi le riceve, e pochissime sono le più che comportevolmente non peccanti. Senza che esse tutte ad ogni brieve caldicciuolo s'ascondono di picciola febbre che ci assaglia, o almeno gli anni vegnenti le portan via, seco le giovanezza, la bellezza, la piacevolezza, i vaghi portamenti, i dolci ragionamenti, i canti, i suoni, le danze, i conviti, i giuochi e gli altri piaceri amorosi traendo. Il che non può non essere di tormento a coloro che ne son vaghi, e tanto ancor più, quanto più essi a que' diletti si sono lasciati prendere e incapestrare. A' quali se la vecchiezza non toglie questi disii, quale più misera disconvenevolezza può essere che la vecchia età di fanciulle voglie contaminare, e nelle membra tremanti e deboli affettare i giovenili pensieri? Se gli toglie, quale sciocchezza è amar giovani così accesamente cose, che poi amare quelli medesimi non possono attempati? e credere che sopra tutto e giovevole e dilettevole sia quello, che nella miglior parte della vita né diletta né giova? Ché miglior parte della vita nostra è per certo quella, figliuolo, in cui la parte di noi migliore, che è l'animo, dal servaggio de gli appetiti liberata, regge la men buona temperatamente, che è il corpo, e la ragione guida il senso, il quale dal caldo della giovanezza portato non l'ascolta, qua e là dove esso vuole scapestratamente traboccando. Di che io ti posso ampissima testimonianza dare, che giovane sono stato altresì, come tu ora sei; e quando alle cose, che io in quegli anni più lodar solea e disiderare, torno con l'animo ripensando, quello ora di tutte me ne pare, che ad un bene risanato infermo soglia parere delle voglie che esso nel mezzo delle febbri avea, che schernendosene conosce di quanto egli era dal convenevole conoscimento e gusto lontano. Per la qual cosa dire si può che sanità della nostra vita sia la vecchiezza e la giovanezza infermità; il che tu, quando a quegli anni giugnerai, vederai così esser vero, se forse ora veder no 'l puoi. Ma tornando al tuo compagno, che ha le molte feste de' suoi amanti cotanto sopra 'l cielo tolte ne' suoi ragionamenti, lasciamo stare che le minori di loro asseguire non si possano senza mille noie tuttavia, ma quando è che egli, nel mezzo delle sue più compiute gioie, non sospiri alcun'altra cosa più che prima disiderando? o quando aviene che quella conformità delle voglie, quella comunanza de' pensieri, della fortuna, quella concordia di tutta una vita in due amanti si trovi, quando si vede niuno essere che ogni giorno seco stesso alle volte non si discordi, e talora in maniera che, se uno lasciare se medesimo potesse, come due possono l'uno l'altro, molti sono che si lascierebbono e un altro animo si piglierebbono e un altro corpo? E per venire, Lavinello, eziandio a' tuoi amori, io di certo gli loderei e passerei nella tua openione in parte, se essi a disiderio di più giovevole obbietto t'invitassero, che quello non è, che essi ti mettono innanzi, e non tanto per sé soli ti piacessero, quanto perciò che essi ci possono a miglior segno fare e meno fallibile intesi. Perciò che non è il buono amore disio solamente di bellezza, come tu stimi, ma è della vera bellezza disio; e la vera bellezza non è umana e mortale, che mancar possa, ma è divina e immortale, alla qual per aventura ci possono queste bellezze inalzare, che tu lodi, dove elle da noi sieno in quella maniera, che esser debbono, riguardate. Ora che si può dire in loro loda per ciò, che pure sopra il convenevole non sia? con ciò sia cosa che, del loro allettamento presi, si lascia il vivere in questa umana vita come Idii. Perciò che Idii sono quegli uomini, figliuolo, che le cose mortali sprezzano come divini e alle divine aspirano come mortali, che consigliano, che discorrono, che prevedono, che hanno alla sempiternità pensamento, che muovono e reggono e temprano il corpo, che è loro in governo dato, come de gli dati nel loro fanno e dispongono gli altri Idii. O pure che bellezza può tra noi questa tua essere, così piacevole e così piena, che proporzion di parti, che in umano ricevimento si trovino, che convenenza, che armonia, che ella empiere giamai possa e compiere alla nostra vera sodisfazione e appagamento? O Lavinello, Lavinello, non sei tu quello che cotesta forma ti dimostra, né sono gli altri uomini ciò che di fuori appare di loro altresì. Ma è l'animo di ciascuno quello che egli è, e non la figura, che col dito si può mostrare. Né sono i nostri animi di qualità, che essi con alcuna bellezza, che qua giù sia, conformare si possano e di lei appagarsi giamai. Che quando bene tu al tuo animo quante ne sono potessi por davanti e la scielta concedergli di tutte loro e riformare a tuo modo quelle, che in alcuna parte ti paressero mancanti, non lo appagheresti perciò, né men tristo ti partiresti da' piaceri che avessi di tutte presi, che da quegli ti soglia partire che prendi ora. Essi, perciò che sono immortali, di cosa che mortal sia non si possono contentare. Ma perciò che sì come dal sole prendono tutte le stelle luce, così quanto è di bello oltra lei dalla divina eterna bellezza prende qualità e stato, quando di queste alcuna ne vien loro innanzi, bene piacciono esse loro e volentieri le mirano, in quanto di quella sono imagini e lumicini, ma non se ne contentano né se ne sodisfanno tuttavia, pure della eterna e divina, di cui esse sovengono loro e che a cercar di se medesima sempre con occulto pungimento gli stimola, disiderosi e vaghi. Per che sì come quando alcuno, in voglia di mangiare preso dal sonno e di mangiar sognandosi, non si satolla, perciò che non è dal senso, che cerca di pascersi, la imagine del cibo voluta, ma il cibo, così noi, mentre la vera bellezza e il vero piacere cerchiamo, che qui non sono, le loro ombre, che in queste bellezze corporali terrene e in questi piaceri ci si dimostrano, aggogniando, non pasciamo l'animo, ma lo inganniamo. La qual cosa è da vedere che per noi non si faccia, acciò che con noi il nostro buon guardiano non s'adiri e in balìa ci lasci del malvagio, veggendo che per noi più amore ad una poca buccia d'un volto si porta e a queste misere e manchevoli e bugiarde vaghezze, che a quello immenso splendore, del quale questo sole è raggio, e alle sue vere e felici e sempiterne bellezze non portiamo. E se pure questo nostro vivere è un dormire, sì come coloro i quali a gran notte addormentati con pensiero di levarsi la dimane per tempo e dal sonno sopratenuti si sognano di destarsi e di levarsi, per che tuttavia dormendo si levano e presa la guarnaccia s'incomiciano a vestire, così noi, non delle imagini e sembianze del cibo e di questi aombrati diletti e vani, ma del cibo istesso e di quella ferma e soda e pura contentezza nel sonno medesimo procacciamo e a pascere incominciancene così sogniando, acciò che poi, risvegliati, alla Reina delle Fortunate isole piacciamo. Ma tu forse di questa Reina altra volta non hai udito -. 75 - Non, Padre, - diss'io - che me ne paia ricordare, né intendo di qual piacimento vi parliate -. - Dunque l'udirai tu ora - disse il santo uomo, e seguitò: [3.XVIII.] - Hanno tra le loro più secrete memorie gli antichi maestri delle sante cose, essere una Reina in quelle isole, che io dico, Fortunate, bellissima e di maraviglioso aspetto e ornata di cari e preziosi vestiri e sempre giovane. La qual marito non vuole già e servasi vergine tutto tempo, ma bene d'essere amata e vagheggiata si contenta. E a quegli che più l'amano ella maggior guiderdone dà de' loro amori, e convenevole, secondo la loro affezione, a gli altri. Ma ella di tutti in questa guisa ne fa pruova. Perciò che venuto che ciascuno l'è davanti, che è secondo che essi sono da lei fatti chiamare or uno or altro, essa, con una verghetta toccatigli, ne gli manda via. E questi, incontanente che del palagio della Reina sono usciti, s'addormentano, e così dormono infino a tanto che essa gli fa risvegliare. Ritornano adunque costoro davanti la Reina un'altra volta risvegliati, e i sogni che hanno fatti dormendo porta ciascuno scritti nella fronte tali, quali fatti gli hanno, né più né meno, i quali essa legge prestamente. E coloro i cui sogni ella vede essere stati solamente di cacciagioni, di pescagioni, di cavagli, di selve, di fiere, essa da sé gli scaccia e mandagli a stare così vegghiando tra quelle fiere, con le quali essi dormendo si sono di star sognati, perciò che dice che, se essi amata l'avessero, essi almeno di lei si sarebbono sognati qualche volta, il che poscia che essi non hanno fatto giamai, vuole che vadano e sì si vivano con le lor fiere. Quegli altri poi a' quali è paruto ne' loro sogni di mercatantare o di governare le famiglie e le comunanze o di fare somiglianti cose, tuttavvia poco della Reina ricordandosi, essa gli fa essere altresì quale mercatante, quale cittadino, quale anziano nelle sue città, di cure e di pensieri gravandogli e poco di loro curandosi parimente. Ma quelli che si sono sognati con lei, essa gli tiene nella sua corte a stare e a ragionar seco tra suoni e canti e sollazzi d'infinito contento, chi più presso di sé e chi meno, secondo che essi con lei sognando più o meno si sono dimorati ciascuno. Ma io per aventura, Lavinello, oggimai troppo lungamente ti dimoro, il quale più voglia dei avere o forse mestiero di ritornarti alla tua compagnia, che di più udirmi. Senza che oltre a ciò a te gravoso potrà essere lo indugiare a più alto sole la partita, che oggimai tutto il cielo ha riscaldato e vassi tuttavia rinforzando -. - A me voglia né mestiero fa punto che sia, Padre, - diss'io - ancora di ritornarmi, e dove a voi noioso non sia il ragionare, sicuramente niuna cosa mi ricorda che io facessi giamai così volentieri, come ora volentieri v'ascolto. Né di sole che sormonti vi pigliate pensiero, poscia che io altro che a scendere non ho, il che ad ogni ora far si può agevolmente -. - Noioso a gli antichi uomini non suole già essere il ragionare, - disse il buon vecchio - che è più tosto un diporto della vecchiezza che altro. Né a me può noiosa esser cosa che di piacere ti sia. Per che seguasi -. E così seguendo, disse: [3.XIX.] - Dirai adunque a Perottino e Gismondo, figliuolo, che se essi non vogliono essere tra le fiere mandati a vegghiare, quando essi si risveglieranno, essi miglior sogno si procaccino di fare, che quello non è, che essi ora fanno. E tu, Lavinello, credi che non sarai perciò caro alla Reina, che io dico, poscia che tu poco di lei sognandoti, tra questi tuoi vaneggiamenti consumi più tosto senza pro, che tu in alcuna vera utilità di te usi e spenda, il dormire che t'è dato. E infine sappi che buono amore non è il tuo. Il quale, posto che non sia malvagio in ciò, che con le bestievoli voglie non si mescola, sì è egli non buono in questo, che egli ad immortale obbietto non ti tira, ma tienti nel mezzo dell'una e dell'altra qualità di disio, dove il dimorare tuttavia non è sano, con ciò sia cosa che nel pendente delle rive stando, più agevolmente nel fondo si sdrucciola, che alla vetta non si sale. E chi è colui che a' piaceri d'alcun senso dando fede, per molto che egli si proponga di non inchinare alle ree cose, egli non sia almeno alle volte per inganno preso, considerando che pieno d'inganni è il senso, il quale una medesima cosa quando ci fa parer buona, quando malvagia, quando bella, quando sozza, quando piacevole, quando dispettosa? Senza che come può essere alcun disio buono, che ponga ne' diletti delle sentimenta quasi nell'acqua il suo fondamento, quando si vede che essi avuti inviliscono, e tormentano non avuti, e tutti sono brevissimi e di fugitivo momento? Né fanno le belle e segnate parole, che da cotali amanti sopra ciò si dicono, che pure così non sia. I qua' diletti tuttavolta, se il pensiero fa continui, quanto sarebbe men male che noi la mente non avessimo celeste e immortale, che non è, avendola, di terreno pensiero ingombrarla e quasi sepellirla? Ella data non ci fu, perché noi l'andassimo di mortal veleno pascendo, ma di quella salutevole ambrosia, il cui sapore mai non tormenta, mai non invilisce, sempre è piacevole, sempre caro. E questo altramente non si fa, che a quello dio i nostri animi rivolgendo, che ce gli ha dati. Il che farai tu, figliuolo, se me udirai; e penserai che esso tutto questo sacro tempio, che noi mondo chiamiamo, di sé empiendolo, ha fabricato con maraviglioso consiglio ritondo e in se stesso ritornante e di se medesimo bisognoso e ripieno; e cinselo di molti cieli di purissima sustanza sempre in giro moventisi e allo 'ncontro del maggiore tutti gli altri, ad uno de' quali diede le molte stelle, che da ogni parte lucessero, e a quelli, di cui esso è contenitore, una n'assegnò per ciascuno, e tutte volle che il loro lume da quello splendore pigliassero, che è reggitore de' loro corsi, facitore del dì e della notte, apportatore del tempo, generatore e moderatore di tutte le nascenti cose. E questi lumi fece che s'andassero per li loro cerchi ravolgendo con certo e ordinato giro, e il loro assegnato camino fornissero e fornito rincominciassero, quale in più brieve tempo e quale in meno. E sotto questi tutti diede al più puro elemento luogo e appresso empié d'aria tutto ciò che è infino a noi. E nel mezzo, sì come nella più infima parte, fermò la terra, quasi aiuola di questo tempio; e d'intorno a.llei sparse le acque, elemento assai men grave che essa non è, ma vie più grave dell'aria, di cui è poscia il fuoco più leggiero. Quivi diletto ti sarà estimare in che maniera per queste quattro parti le quattro guise della loro qualità si vadano mescolando, e come esse in un tempo e accordanti sieno e discordanti tra loro; mirare gli aspetti della mutabile luna; riguardare alle fatiche del sole; scorgere gli altri giri dell'erranti stelle e di quelle che non sono così erranti e, di tutti le cagioni, le operagioni considerando, portar l'animo 76 per lo cielo e, quasi con la natura parlando, conoscere quanto brieve e poco è quello che noi qui amiamo, quando il più lungo spazio di questa nostra vita mortale due giorni appena non sono d'uno de' veri anni di questi cieli e quando la minore delle conosciute stelle di quel tanto e così infinito numero è di tutta questa soda e ritonda circunferenza, che terra è detta, maggiore, per cui noi cotanto c'insuperbiamo, della quale ancora quello che noi abitiamo è, a rispetto dell'altro, stretta e menomissima particiuola. Senza che qua ogni cosa v'è debole e inferma: venti, piogge, ghiacci, nevi, freddi, caldi vi sono, e febbri e fianchi e stomachi e gli altri cotanti morbi, i quali nel votamento del buon vaso, male per noi dall'antica Pandora scoperchiato, ci assalirono; dove là ogni cosa v'è sana e stabile e di convenevole perfezion piena, ché né morte v'è né aggiugne, né vecchiezza vi perviene, né difetto alcuno v'ha luogo. [3.XX.] Ma vie maggior diletto ti sarà e più senza fine maraviglioso, se tu da questi cieli che si veggono a quelli che non si veggono passerai, e le vere cose che ivi sono contempierai, d'uno ad altro sormontando, e in questo modo a quella bellezza, che sopra essi e sopra ogni bellezza è, inalzerai, Lavinello, i tuoi disii. Perciò che certa cosa è tra coloro, che usati sono di mirare non meno con gli occhi dell'animo che del corpo, oltra questo sensibile e material mondo, di cui e io ora t'ho ragionato e ciascuno ne ragiona più spesso, perciò che si mira, essere un altro mondo ancora né materiale né sensibile, ma fuori d'ogni maniera di questo separato e puro, che intorno il sopragira e che è da lui cercato sempre e sempre ritrovato parimente, diviso da esso tutto, e tutto in ciascuna sua parte dimorante, divinissimo, intendentissimo, illuminatissimo e esso stesso di se stesso e migliore e maggiore tanto più, quanto egli più si fa alla sua cagione ultima prossimano; nel qual cielo bene ha eziandio tutto quello che ha in questo, ma tanto sono quelle cose di più eccellente stato, che non son queste, quanto tra queste sono le celesti a miglior condizione, che le terrene. Perciò che ha esso la sua terra, come si vede questo avere, che verdeggia, che manda fuori sue piante, che sostiene suoi animali; ha il mare, che per lei si mescola; ha l'aria, che li cigne; ha il fuoco; ha la luna; ha il sole; ha le stelle; ha gli altri cieli. Ma quivi né seccano le erbe, né invecchiano le piante, né muoiono gli animali, né si turba il mare, né s'oscura l'aere, né riarde il fuoco, né sono a continui rivolgimenti i suoi lumi necessitati o i suoi cieli. Non ha quel mondo d'alcun mutamento mestiero, perciò che né state, né verno, né hieri, né dimane, né vicinanza, né lontananza, né ampiezza, né strettezza lo circonscrive, ma del suo stato si contenta, sì come quello che è della somma e per se stessa bastevole felicità pieno; della quale gravido egli partorisce, e il suo parto è questo mondo medesimo che tu miri. Fuori del quale, se per aventura non ci pare che altro possa essere, a noi adivien quello che adiverrebbe ad uno, il quale, ne' cupi fondi del mare nato e cresciuto, quivi sempre dimorato si fosse, perciò che egli non potrebbe da sé istimare che sopra l'acque v'avesse altre cose, né crederebbe che frondi più belle che alga, o campi più vaghi che di rena, o fiere più gaie che pesci, o abitazioni d'altra maniera che di cavernose pietre, o altre elementa che terra e acqua fossero e vedessersi in alcun luogo. Ma se esso a noi passasse e al nostro cielo, veduto de' prati e delle selve e de' colli la dipintissima verdura e la varietà de gli animali, quali per nodrirci e quali per agevolarci nati, veduto le città, le case, i templi che vi sono, le molte arti, la maniera del vivere, la purità dell'aria, la chiarezza del sole, che spargendo la sua luce per lo cielo fa il giorno, e gli splendori della notte, che nella sua oscura ombra e dipinta la rendono e meravigliosa, e le altre così diverse vaghezze del mondo e così infinite, esso s'avedrebbe quanto egli falsamente credea e non vorrebbe per niente alla sua primiera vita ritornare. Così noi miseri, d'intorno a questa bassa e fecciosa palla di terra mandati a vivere, bene miriamo l'aere e gli uccelli che 'l volano con quella maraviglia medesima, con la quale colui farebbe il mare e i pesci che lo natano parimente, e per le bellezze eziandio discorriamo di questi cieli che in parte vediamo; ma che oltre a questi altre cose sieno vie più da dovere a noi essere, che le nostre a quel marino uomo non sarebbono, e maravigliose e care, o in che modo ciò sia, nella nostra povera stimativa non cape. Ma se alcuno Idio vi.cci portasse, Lavinello, e mostrasseleci, quelle cose solamente vere cose ci parrebbono, e la vita, che ivi si vivesse, vera vita, e tutto ciò che qui è, ombra e imagine di loro essere e non altro; e giù in queste tenebre riguardando da quel sereno, gli altri uomini, che qui fossero, chiameremmo noi miseri e di loro ci prenderebbe pietà, non che noi più a così fatto vivere tornassimo di nostra volontà giamai. [3.XXI.] Ma che ti posso io, Lavinello, qui dire? Tu sei giovane e, non so come, quasi per lo continuo pare che nella giovanezza non appiglino questi pensieri o, se appigliano, sì come pianta in aduggiato terreno essi poco allignano le più volte. Ma se pure nel tuo giovane animo utilmente andassero innanzi, dove tu al fosco lume di due occhi, pieni già di morte, qua giù t'invaghi, che si può istimare che tu a gli splendori di quelle eterne bellezze facessi, così vere, così pure, così gentili? E se la voce d'una lingua, la quale poco avanti non sapea fare altro che piagnere e di qui a poco starà muta sempre, ti suole essere dilettevole e cara, quanto si dee credere che ti sarebbe caro il ragionare e l'armonia che fanno i cori delle divine cose tra loro? E quando, a gli atti d'una semplice donnicciuola, che qui empie il numero dell'altre, ripensando, prendi e ricevi sodisfaccimento, quale sodisfaccimento pensi tu che riceverebbe il tuo animo, se egli da queste caliggini col pensiero levandosi e puro e innocente a quelli candori passando, le grandi opere del Signore, che là su regge, mirasse e rimirasse intentamente e ad esso con casto affetto offeresse i suoi disii? O figliuolo, questo piacere è tanto, quanto comprendere non si può da chi no 'l pruova, e provar non si può, mentre di quest'altri si fa caso. Perciò che con occhi di talpa, sì come i nostri animi sono di queste voglie fasciati, non si può sofferire il sole. Quantunque ancora con purissimo animo compiutamente non vi s'aggiugne. Ma, sì come quando alcuno strano passando dinanzi al palagio d'un re, come che egli no 'l veda, né altramente sappia che egli re sia, pensa fra se stesso quello dovere essere grande uomo che quivi sta, veggendo pieno di sergenti ciò che v'è, e tanto maggiore ancora lo stima, quanto egli vede essere quegli medesimi sergenti più orrevoli e più ornati, così tutto che noi quel gran Signore con veruno occhio non 77 vediamo, pure possiam dire che egli gran Signore dee essere, poscia che ad esso gli elementi tutti e tutti i cieli servono e sono della sua maestà fanti. Per che gran senno faranno i tuoi compagni, se essi questo Prence corteggieranno per lo innanzi, sì come essi fatto hanno le loro donne per lo adietro, e ricordandosi che essi sono in un tempio, ad adorare oggimai si disporranno, ché vaneggiato hanno eglino assai, e, il falso e terrestre e mortale amore spogliandosi, si vestiranno il vero e celeste e immortale: e tu, se ciò farai, altresì. Perciò che ogni bene sta con questo disio e da lui ogni male è lontano. Quivi non sono emulazioni, quivi non sono sospetti, quivi non sono gielosie, con ciò sia cosa che quello che s'ama, per molti che lo amino, non si toglie che altri molti non lo possano amare e insieme goderne, non altramente che se un solo amandolo ne godesse. Perciò che quella infinita deità tutti ci può di sé contentare, e essa tuttavia quella medesima riman sempre. Quivi a niuno si cerca inganno, a niuno si fa ingiuria, a niuno si rompe fede. Nulla fuori del convenevole né si procaccia, né si conciede, né si disidera. E al corpo quello che è bastevole si dà, quasi un'offa a Cerbero, perché non latri, e all'animo quello che più è lui richiesto si mette innanzi. Né ad alcuno s'interdice il cercar di quello che egli ama, né ad alcun si toglie il potere a quel diletto aggiugnere, a cui egli amando s'invia. Né per acqua, né per terra vi si va; né muro, né tetto si sale. Né d'armati fa bisogno, né di scorta, né di messaggiero. Idio è tutto quello, che ciascun vede, che il disidera. Non ire, non scorni, non pentimenti, non mutazioni, non false allegrezze, non vane speranze, non dolori, non paure v'hanno luogo. Né la fortuna v'ha potere, né il caso. Tutto di sicurezza, tutto di contentezza, tutto di tranquillità, tutto di felicità v'è pieno. [3.XXII.] E queste cose di qua giù, che gli altri uomini cotanto amano, per lo asseguimento delle quali si vede andare così spesso tutto 'l mondo sottosopra e i fiumi stessi correre rossi d'umano sangue e il mare medesimo alcuna fiata, il che questo nostro misero secolo ha veduto molte volte e ora vede tuttavia, gl'imperii dico e le corone e le signorie, esse non si cercano per chi là su ama più di quello che si cerchi, da chi può in gran sete l'acqua d'un puro fonte avere, quella d'un torbido e paludoso rigagno. Là dove allo 'ncontro la povertà, gli esilii, le presure se sopravengono, il che tutto dì vede avenire chi ci vive, esso con ridente volto riceve, ricordandosi che, quale panno cuopra o quale terra sostenga o qual muro chiuda questo corpo, non è da curare, pure che all'animo la sua ricchezza, la sua patria, la sua libertà, per poco amore che egli loro porti, non sia negata. E in brieve, né esso ai dolci stati con soverchio diletto si fa incontro, né dispettosamente rifiuta il vivere ne gli amari; ma sta nell'una e nell'altra maniera temperato tanto tempo, quanto al Signor, che l'ha qui mandato, piace che egli ci stia. E dove gli altri amanti e vivendo sempre temono del morire, sì come di cosa di tutte le feste loro discipatrice, e, poscia che a quel varco giunti sono, il passano sforzatamente e maninconosi, egli, quando v'è chiamato, lieto e volentieri vi va e pargli uscire d'un misero e lamentoso albergo alla sua lieta e festevole casa. E di vero che altro si può dire questa vita, la quale più tosto morte è, che noi qui peregrinando viviamo, a tante noie, che ci assalgono da ogni parte così spesso, a tante dipartenze, che si fanno ogni giorno dalle cose che più amiamo, a tante morti, che si vedono di coloro dì per dì che ci sono per aventura più cari, a tante altre cose, che ad ogni ora nuova cagione ci recano di dolerci, e quelle più molte volte, che noi più di festa e più di sollazzo doverci essere riputavamo? Il che quanto in te si faccia vero, tu il sai. A me certo pare mill'anni che io, dallo invoglio delle membra sviluppandomi e di questo carcere volando fuora, possa, da così fallace albergo partendomi, là onde io mi mossi ritornare e, aperti quegli occhi che in questo camino si chiudono, mirar con essi quella ineffabile bellezza, di cui sono amante, sua dolce mercé, già buon tempo; e ora, perché io vecchio sia, come tu mi vedi, ella non m'ha perciò meno che in altra età caro, né mi rifiuterà perché io di così grosso panno vestito le vada innanzi. Quantunque né io con questo panno v'andrò, né tu con quello v'andrai, né altro di questi luoghi si porta alcun seco dipartendosi che i suoi amori. I quali se sono di queste bellezze stati, che qua giù sono, perciò che elle colà su non salgono, ma rimangono alla terra di cui elle sono figliuole, elle ci tormentano, sì come ora ci sogliono quelli disii tormentare, de' quali godere non si può né molto né poco. Se sono di quelle di là su stati, essi maravigliosamente ci trastullano, poscia che ad esse pervenuti pienamente ne godiamo. Ma perciò che quella dimora è sempiterna, si dee credere, Lavinello, che buono amore sia quello, del quale goder si può eternamente, e reo quell'altro, che eternamente ci condanna a dolere -. - Queste cose ragionatemi dal santo uomo, perciò che tempo era che io mi dipartissi, egli a me rimise il venirmene -. Il che poscia che ebbe detto Lavinello, a' suoi ragionamenti pose fine. 78 N. Machiavelli, De principatibus [Il principe, a cura di G. Inglese, Torino, Einaudi, 1995] I. QUOT SINT GENERA PRINCIPATUUM ET QUIBUS MODIS ACQUIRANTUR. Tutti gli stati, tutti e' dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o republiche o principati. E' principati sono o ereditari, de' quali el sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o sono nuovi. E' nuovi, o e' sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che gli acquista, come è el regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi dominii così acquistati o consueti a vivere sotto uno principe o usi a essere liberi; e acquistonsi o con l'arme d'altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù II. DE PRINCIPATIBUS HEREDITARIIS. Io lascerò indreto il ragionare delle republiche, perché altra volta ne ragionai a lungo. Volterommi solo al principato e andrò ritessendo gli orditi soprascritti, e disputerò come questi principati si possino governare e mantenere. Dico adunque che, nelli stati ereditari e assuefatti al sangue del loro principe, sono assai minore difficultà a mantenergli che ne' nuovi, perché basta solo non preterire gli ordini de' sua antinati e di poi temporeggiare con gli accidenti; in modo che, se tale principe è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato, se non è una estraordinaria ed eccessiva forza che ne lo privi: e privato che ne fia, quantunque di sinistro abbi l'occupatore, lo riacquista. Noi abbiamo in Italia, in exemplis, el duca di Ferrara, il quale non ha retto alli assalti de' viniziani nell'ottantaquattro, né a quelli di papa Iulio nel dieci, per altre cagioni che per essere antiquato in quello dominio. Perché el principe naturale ha minori cagioni e minori necessità di offendere, donde conviene che sia più amato; e se estraordinari vizi non lo fanno odiare, è ragionevole che naturalmente sia benevoluto da' sua. E nella antiquità e continuazione del dominio sono spente le memorie e le cagioni delle innovazioni: perché sempre una mutazione lascia lo addentellato per la edificazione dell'altra. […] XVIII QUOMODO FIDES A PRINCIPIBUS SIT SERVANDA. Quanto sia laudabile in uno principe il mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende; nondimanco si vede per esperienza ne' nostri tempi quelli principi avere fatto gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto e che hanno saputo con l'astuzia aggirare e' cervelli delli uomini: e alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in su la realtà. Dovete adunque sapere come e' sono dua generazioni di combattere: l'uno, con le leggi; l'altro, con la forza. Quel primo è proprio dello uomo; quel secondo, delle bestie. Ma perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo: pertanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. Questa parte è suta insegnata alli principi copertamente da li antichi scrittori, e' quali scrivono come Achille e molti altri di quelli principi antichi furno dati a nutrire a Chirone centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi. Il che non vuole dire altro, avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe sapere usare l'una e l'altra natura: e l'una sanza l'altra non è durabile. Sendo dunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione: perché el lione non si difende da' lacci, la golpe non si difende da' lupi; bisogna adunque essere golpe a conoscere e' lacci, e lione a sbigottire e' lupi: coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendono. Non può pertanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede quando tale osservanzia gli torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E se li uomini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono: ma perché e' sono tristi e non la osserverebbono a te, tu etiam non l'hai a osservare a loro; né mai a uno principe mancorno cagioni legittime di colorire la inosservanzia. Di questo se ne potrebbe dare infiniti esempli moderni e mostrare quante pace, quante promisse sono state fatte irrite e vane per la infidelità de' principi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire ed essere gran simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare. Io non voglio delli esempli freschi tacerne uno. Alessandro sesto non fece mai altro, non pensò mai ad altro che a ingannare uomini, e sempre trovò subietto da poterlo fare: e non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia in asseverare, e con maggiori iuramenti affermassi una cosa, che la osservassi meno; nondimeno sempre gli succederno gl'inganni ad votum, perché conosceva bene questa parte del mondo. A uno principe adunque non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle; anzi ardirò di dire questo: che, avendole e osservandole sempre, sono dannose, e, parendo di averle, sono utili; come parere piatoso, fedele, umano, intero, religioso, ed essere: ma stare in modo edificato con lo animo che, bisognando non essere, tu possa e sappia diventare il contrario. E hassi a intendere questo, che uno principe e massime uno principe nuovo non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono chiamati buoni, sendo spesso 79 necessitato, per mantenere lo stato, operare contro alla fede, contro alla carità, contro alla umanità, contro alla religione. E però bisogna che egli abbia uno animo disposto a volgersi secondo che e' venti della fortuna e la variazione delle cose gli comandano; e, come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere entrare nel male, necessitato. Debbe adunque uno principe avere gran cura che non gli esca mai di bocca cosa che non sia piena delle soprascritte cinque qualità; e paia, a udirlo e vederlo, tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto umanità, tutto religione: e non è cosa più necessaria a parere di avere, che questa ultima qualità. E li uomini in universali iudicano più alli occhi che alle mani; perché tocca a vedere a ognuno, a sentire a pochi: ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se'; e quelli pochi non ardiscono opporsi alla opinione di molti che abbino la maestà dello stato che gli difenda; e nelle azioni di tutti li uomini, e massime de' principi, dove non è iudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e' mezzi sempre fieno iudicati onorevoli e da ciascuno saranno laudati; perché el vulgo ne va preso con quello che pare e con lo evento della cosa: e nel mondo non è se non vulgo, e' pochi non ci hanno luogo quando gli assai hanno dove appoggiarsi. Alcuno principe de' presenti tempi, il quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e dell'una e dell'altra è inimicissimo: e l'una e l'altra, quando e' l'avessi osservata, gli arebbe più volte tolto e la riputazione e lo stato. XIX DE CONTEMPTU ET ODIO FUGIENDO. Ma perché, circa le qualità di che di sopra si fa menzione, io ho parlato delle più importanti, l'altre voglio discorrere brevemente sotto queste generalità: che el principe pensi, come in parte di sopra è detto, di fuggire quelle cose che lo faccino odioso o contennendo; e qualunque volta e' fuggirà questo, arà adempiuto le parti sua e non troverrà nelle altre infamie periculo alcuno. Odioso soprattutto lo fa, come io dissi, essere rapace e usurpatore della roba e delle donne de' sudditi: da che si debbe astenere. E qualunque volta alle universalità delli uomini non si toglie né onore né roba, vivono contenti: e solo si ha a combattere con la ambizione de' pochi, la quale in molti modi e con facilità si raffrena. Contennendo lo fa essere tenuto vario, leggieri, effeminato, pusillanime, irresoluto: da che uno principe si debbe guardare come da uno scoglio, e ingegnarsi che nelle azioni sua si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza; e circa a' maneggi privati tra ' sudditi volere che la sua sentenza sia irrevocabile; e si mantenga in tale opinione che alcuno non pensi né a ingannarlo né ad aggirarlo. Quel principe che dà di sé questa opinione è reputato assai, e contro a chi è reputato con difficultà si congiura, con difficultà è assaltato, purché s'intenda che sia eccellente e che sia reverito da' sua. Perché uno principe debbe avere dua paure: una dentro, per conto de' sudditi; l'altra di fuori, per conto de' potentati esterni. Da questa si difende con le buone arme e con e' buoni amici: e sempre, se arà buone arme, arà buoni amici. E sempre staranno ferme le cose di dentro, quando stieno ferme quelle di fuora, se già le non fussino perturbate da una congiura: e quando pure quelle di fuora movessino, s'egli è ordinato e vissuto come ho detto, quando e' non si abbandoni, sosterrà sempre ogni impeto, come io dissi che fece Nabide spartano. Ma circa ' sudditi, quando le cose di fuora non muovino, si ha a temere che non coniurino secretamente; di che el principe si assicura assai fuggendo lo essere odiato o disprezzato, e tenendosi el populo satisfatto di lui: il che è necessario conseguire, come di sopra a lungo si disse. E uno de' più potenti remedi che abbia uno principe contro alle congiure, è non essere odiato da lo universale: perché sempre chi coniura crede con la morte del principe satisfare al populo, ma quando creda offenderlo non piglia animo a prendere simile partito. Perché le difficultà che sono da la parte de' congiuranti sono infinite, e per esperienza si vede molte essere state le congiure e poche avere avuto buono fine. Perché chi congiura non può essere solo, né può prendere compagnia se non di quelli che creda essere malcontenti: e subito che a uno malcontento tu hai scoperto lo animo tuo, gli dai materia a contentarsi, perché manifestandoti lui ne può sperare ogni commodità; talmente che, veggendo il guadagno sicuro da questa parte, e da l'altra veggendolo dubbio e pieno di periculo, conviene bene o ch'e' sia raro amico o ch'e' sia al tutto ostinato inimico del principe, a osservarti la fede. E per ridurre la cosa in brevi termini, dico che da la parte del coniurante non è se non paura, gelosia e sospetto di pena che lo sbigottisce: ma da la parte del principe è la maestà del principato, le leggi, le difese delli amici e dello stato che lo difendono. Talmente che, aggiunto a tutte queste cose la benivolenzia populare, è impossibile che alcuno sia sì temerario che congiuri: perché dove, per l'ordinario, uno coniurante ha a temere innanzi alla esecuzione del male, in questo caso debbe temere ancora poi, avendo per nimico el populo, seguìto lo eccesso, né potendo per questo sperare refugio alcuno. Di questa materia se ne potrebbe dare infiniti esempli, ma voglio solo essere contento di uno seguìto a' tempi de' padri nostri. Messere Annibale Bentivogli, avolo del presente messer Annibale, che era principe di Bologna, sendo da' Canneschi, che gli coniurorno contro, ammazzato né rimanendo di lui altri che messere Giovanni, quale era in fasce, subito dopo tale omicidio si levò il populo e ammazzò tutti e' Canneschi. Il che nacque da la benivolenzia populare che la casa de' Bentivogli aveva in quelli tempi: la quale fu tanta che, non restando di quella alcuno, in Bologna, che potessi, morto Annibale, reggere lo stato, e avendo indizio come in Firenze era uno nato de' Bentivogli, che si teneva fino allora figliuolo di uno fabbro, vennono e' bolognesi per quello in Firenze e gli dettono il governo di quella città; la quale fu governata da lui fino a tanto che messer Giovanni pervenissi in età conveniente al governo. Concludo pertanto che uno principe debbe tenere delle congiure poco conto, quando il populo gli sia benivolo: ma quando gli sia nimico e abbilo in odio, debbe temere d'ogni cosa e di ognuno. E gli stati bene ordinati ed e' principi savi 80 hanno con ogni diligenzia pensato di non disperare e' grandi e satisfare al populo e tenerlo contento: perché questa è una delle più importanti materie che abbi uno principe. In tra e' regni bene ordinati e governati a' tempi nostri è quello di Francia, e in esso si truovono infinite constituzioni buone donde depende la libertà e la sicurtà del re: delle quali la prima è il parlamento e la sua autorità. Perché quello che ordinò quello regno, conoscendo l'ambizione de' potenti e la insolenzia loro, e iudicando essere loro necessario uno freno in bocca che gli correggessi, — e da l'altra parte conoscendo l'odio dello universale contro a' grandi fondato in su la paura, e volendo assicurargli, — non volle che questa fussi particulare cura del re, per torgli quello carico che potessi avere co' grandi favorendo e' populari, e co' populari favorendo e' grandi. E però constituì uno iudice terzo, che fussi quello che sanza carico del re battessi e' grandi e favorissi e' minori: né poté essere questo ordine migliore né più prudente, né che sia maggiore cagione della sicurtà del re e del regno. Di che si può trarre un altro notabile: che e' principi le cose di carico debbono fare sumministrare ad altri, quelle di grazia loro medesimi. E di nuovo concludo che uno principe debbe stimare e' grandi, ma non si fare odiare dal populo. Parrebbe forse a molti, considerato la vita e morte di alcuno imperadore romano, ch'e' fussino esempli contrari a questa mia opinione, trovando alcuno essere vissuto sempre egregiamente e mostro gran virtù d'animo: nondimeno aver perso lo imperio, o vero essere stato morto da' sua che gli hanno congiurato contro. Volendo pertanto rispondere a queste obiezioni, discorrerò le qualità di alcuni imperadori, mostrando le cagioni della loro ruina non disforme da quello che da me si è addutto; e parte metterò in considerazione quelle cose che sono notabili a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio mi basti pigliare tutti quelli imperadori che succederno allo imperio da Marco filosofo a Massimino, e' quali furno: Marco, Commodo suo figliuolo, Pertinace, Iuliano, Severo, Antonino Caracalla suo figliuolo, Macrino, Eliogabal, Alessandro e Massimino. Ed è prima da notare che, dove nelli altri principati si ha solo a contendere con la ambizione de' grandi e insolenzia de' populi, gl'imperadori romani avevano una terza difficultà, di avere a sopportare la crudeltà e avarizia de' soldati. La quale cosa era sì difficile che la fu cagione della ruina di molti, sendo difficile satisfare a' soldati e a' populi; perché e' populi amavano la quiete, e per questo e' principi modesti erano loro grati, ed e' soldati amavano el principe di animo militare e che fussi crudele, insolente e rapace: le quali cose volevano che lui esercitassi ne' populi, per potere avere duplicato stipendio e sfogare la loro avarizia e crudeltà. Le quali cose feciono che quelli imperadori che per natura o per arte non avevano una gran reputazione, tale che con quella e' tenessino l'uno e l'altro in freno, sempre ruinavano. Ed e' più di loro, massime di quegli che come uomini nuovi venivono al principato, conosciuta la difficultà di questi dua diversi umori, si volgevano a satisfare a' soldati, stimando poco lo iniuriare el populo. Il quale partito era necessario: perché, non potendo e' principi mancare di non essere odiati da qualcuno, si debbono sforzare prima di non essere odiati da le università, e quando non possono conseguire questo, debbono fuggire con ogni industria l'odio di quelle università che sono più potenti. E però quelli imperadori che per novità avevano bisogno di favori estraordinari, si aderivano a' soldati più tosto che a' populi: il che tornava nondimeno loro utile, o no, secondo che quel principe si sapeva mantenere reputato con esso loro. Da queste cagioni sopraddette nacque che Marco, Pertinace e Alessandro, sendo tutti di modesta vita, amatori della iustizia, inimici della crudeltà, umani, benigni, ebbono tutti, da Marco in fuora, tristo fine. Marco solo visse e morì onoratissimo, perché lui successe allo imperio iure hereditario e non aveva a riconoscere quello né da' soldati né da' populi; di poi, essendo accompagnato da molte virtù che lo facevano venerando, tenne sempre, mentre che visse, l'uno e l'altro ordine in tra e' termini suoi, e non fu mai odiato né disprezzato. Ma Pertinace, creato imperadore contro alla voglia de' soldati, — e' quali essendo usi a vivere licenziosamente sotto Commodo non poterno sopportare quella vita onesta alla quale Pertinace gli voleva ridurre, — onde avendosi creato odio e a questo odio aggiunto el disprezzo sendo vecchio, ruinò ne' primi principii della sua amministrazione. E qui si debbe notare che l'odio si acquista così mediante le buone opere, come le triste: e però, come io dissi di sopra, uno principe volendo mantenere lo stato è spesso sforzato a non essere buono. Perché, quando quella università, o populi o soldati o grandi che si sieno, della quale tu iudichi avere, per mantenerti, più bisogno è corrotta, ti conviene seguire l'umore suo per satisfarle: e allora le buone opere ti sono nimiche. Ma vegnamo ad Alessandro, il quale fu di tanta bontà che, in tra le altre laude che gli sono attribuite, è questa: che in quattordici anni che tenne lo 'mperio non fu mai morto da lui alcuno iniudicato; nondimanco, essendo tenuto effeminato e uomo che si lasciassi governare alla madre, e per questo venuto in disprezzo, conspirò in lui l'esercito e ammazzollo. Discorrendo ora per opposito le qualità di Commodo, di Severo, di Antonino Caracalla e Massimino, gli troverrete crudelissimi e rapacissimi: e' quali, per satisfare a' soldati, non perdonorno ad alcuna qualità d'iniuria che ne' populi si potessi commettere. E tutti eccetto Severo ebbono tristo fine; perché in Severo fu tanta virtù che, mantenendosi e' soldati amici, ancora che e' populi fussino da lui gravati, possé sempre regnare felicemente: perché quelle sua virtù lo facevano nel conspetto de' soldati e de' populi sì mirabile che questi rimanevano quodammodo stupidi e attoniti, e quelli altri reverenti e satisfatti. E perché le azioni di costui furno grandi e notabili in uno principe nuovo, io voglio brevemente mostrare quanto e' seppe bene usare la persona del lione e della golpe, le quali nature io dico di sopra essere necessarie imitare a uno principe. Conosciuto Severo la ignavia di Iuliano imperadore, persuase al suo esercito, del quale era in Stiavonia capitano, che e' gli era bene andare a Roma a vendicare la morte di Pertinace, il quale da' soldati pretoriani era suto morto. E sotto 81 questo colore, sanza mostrare di aspirare allo imperio, mosse lo esercito contro a Roma e fu prima in Italia che si sapessi la sua partita. Arrivato a Roma, fu dal senato per timore eletto imperadore e morto Iuliano. Restava dopo questo principio a Severo dua difficultà, volendosi insignorire di tutto lo stato: l'una in Asia, dove Nigro, capo delli eserciti asiatici, si era fatto chiamare imperadore; e l'altra in Ponente, dove era Albino quale ancora lui aspirava allo imperio. E perché iudicava periculoso scoprirsi inimico a tutti a dua, deliberò di assaltare Nigro e ingannare Albino: al quale scrisse come, sendo stato dal senato eletto imperadore, voleva participare quella dignità con lui; e mandogli il titulo di Cesare e per deliberazione del senato se lo aggiunse collega: le quali cose furno da Albino accettate per vere. Ma poi che Severo ebbe vinto e morto Nigro e pacate le cose orientali, ritornatosi a Roma, si querelò in senato come Albino, poco conoscente de' benifizi ricevuti da lui, aveva dolosamente cerco di ammazzarlo: e per questo era necessitato di andare a punire la sua ingratitudine; di poi lo andò a trovare in Francia e gli tolse lo stato e la vita. E chi esaminerà tritamente le azioni di costui, lo troverrà uno ferocissimo lione e una astutissima golpe, e vedrà quello temuto e reverito da ciascuno e da li eserciti non odiato; e non si maraviglierà se lui, uomo nuovo, arà potuto tenere tanto imperio, perché la sua grandissima reputazione lo difese sempre da quello odio che ' populi per le sue rapine avevano potuto concipere. Ma Antonino suo figliuolo fu ancora lui uomo che aveva parte eccellentissime e che lo facevano maraviglioso nel conspetto de' populi e grato a' soldati, perché lui era uomo militare, sopportantissimo d'ogni fatica, disprezzatore d'ogni cibo dilicato e di ogni altra mollizie: la qual cosa lo faceva amare da tutti li eserciti. Nondimanco la sua ferocia e crudeltà fu tanta e sì inaudita, per avere dopo infinite occisioni particulari morto gran parte del populo di Roma e tutto quello di Alessandria, che diventò odiosissimo a tutto il mondo e cominciò a essere temuto etiam da quelli che lui aveva d'intorno: in modo che fu ammazzato da uno centurione in mezzo del suo esercito. Dove è da notare che queste simili morte, le quali seguano per deliberazione di uno animo ostinato, sono da' principi inevitabili, perché ciascuno che non si curi di morire lo può offendere: ma debbe bene el principe temerne meno, perché le sono rarissime. Debbe solo guardarsi di non fare grave ingiuria ad alcuno di coloro di chi si serve e che egli ha d'intorno a' servizi del suo principato; come aveva fatto Antonino, il quale aveva morto contumeliosamente uno fratello di quello centurione e lui ogni giorno minacciava, tamen lo teneva a guardia del corpo suo: il che era partito temerario e da ruinarvi, come gl'intervenne. Ma vegnamo a Commodo, al quale era facilità grande tenere l'imperio per averlo iure hereditario, sendo figliuolo di Marco: e solo gli bastava seguire le vestigie del padre, e a' soldati e a' populi arebbe satisfatto. Ma essendo di animo crudele e bestiale, per potere usare la sua rapacità ne' populi, si volse a intrattenere li eserciti e fargli licenziosi: da l'altra parte, non tenendo la sua dignità, discendendo spesso ne' teatri a combattere co' gladiatori e faccendo altre cose vilissime e poco degne della maestà imperiale, diventò contennendo nel conspetto de' soldati. Ed essendo odiato da l'una parte e disprezzato da l'altra, fu conspirato in lui e morto. Restaci a narrare le qualità di Massimino. Costui fu uomo bellicosissimo, ed essendo gli eserciti infastiditi della mollizie di Alessandro, del quale ho di sopra discorso, morto lui lo elessono allo imperio: il quale non molto tempo possedé, perché due cose lo feciono odioso e contennendo. L'una, essere vilissimo per avere già guardate le pecore in Tracia: la qual cosa era per tutto notissima, il che li faceva una grande dedignazione nel conspetto di qualunque. L'altra, perché, avendo nello ingresso del suo principato differito lo andare a Roma e intrare nella possessione della sedia imperiale, aveva dato di sé opinione di crudelissimo, avendo per li suoi prefetti in Roma e in qualunque luogo dello imperio esercitato molte crudeltà. Talmente che, commosso tutto il mondo da lo sdegno per la viltà del suo sangue e da l'odio per la paura della sua ferocia, si ribellò prima Africa, di poi el senato, con tutto il populo di Roma e tutta Italia, gli conspirò contro; a che si aggiunse el suo proprio esercito, quale, campeggiando Aquileia e trovando difficultà nella espugnazione, infastidito da la crudeltà sua e, per vedergli tanti nimici, temendolo meno, lo ammazzò. Io non voglio ragionare né di Eliogabalo né di Macrino né di Iuliano, e' quali per essere al tutto contennendi si spensono subito, ma verrò alla conclusione di questo discorso; e dico che ' principi de' nostri tempi hanno meno questa difficultà di satisfare estraordinariamente a' soldati ne' governi loro: perché, non ostante che si abbia ad avere a quegli qualche considerazione, tamen si resolve presto per non avere alcuno di questi principi eserciti insieme che sieno inveterati con e' governi e amministrazione delle provincie, come erano gli eserciti dello imperio romano. E però se allora era necessario satisfare più alli soldati che a' populi, perché e' soldati potevano più che e' populi, ora è più necessario a tutti e' principi, eccetto che al Turco e al Soldano, satisfare a' populi che a' soldati, perché e' populi possono più di quelli. Di che io ne eccettuo el Turco, tenendo quello continuamente insieme intorno a sé dodicimila fanti e quindicimila cavagli, da' quali depende la securtà e fortezza del suo regno: ed è necessario che, posposto ogni altro respetto, quel signore se li mantenga amici. Similmente el regno del Soldano sendo tutto in nelle mani de' soldati, conviene che ancora lui sanza respetto de' populi se li mantenga amici. E avete a notare che questo stato del Soldano è disforme a tutti li altri principati, perché e' gli è simile al pontificato cristiano, il quale non si può chiamare né principato ereditario né principato nuovo: perché non e' figliuoli del principe vecchio sono eredi e rimangono signori, ma colui che è eletto a quello grado da quegli che ne hanno autorità; ed essendo questo ordine antiquato non si può chiamare principato nuovo, per che in quello non sono alcune di quelle difficultà che sono ne' nuovi: perché, se bene el principe è nuovo, gli ordini di quello stato sono vecchi e ordinati a riceverlo come se fussi loro signore ereditario. Ma torniamo alla materia nostra. Dico che qualunque considerrà el soprascritto discorso, vedrà o l'odio o il disprezzo essere suti cagione della ruina di quelli imperadori prenominati; e conoscerà ancora donde nacque che, parte di loro procedendo in uno modo e parte al contrario, in qualunque di quegli uno di loro ebbe felice e gli altri infelice 82 fine. Perché a Pertinace e Alessandro, per essere principi nuovi, fu inutile e dannoso volere imitare Marco, che era nel principato iure hereditario; e similmente a Caracalla, Commodo e Massimino essere stata cosa perniziosa imitare Severo, per non avere aùta tanta virtù che bastassi a seguitare le vestigie sua. Pertanto uno principe nuovo in uno principato nuovo non può imitare le azioni di Marco, né ancora è necessario seguitare quelle di Severo: ma debbe pigliare da Severo quelle parti che per fondare el suo stato sono necessarie, e da Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno stato che sia già stabilito e fermo. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia [Storia d'Italia, a cura di Silvana Seidel Menchi, Felix Gilbert, Torino, Einaudi, 1971] LIBRO PRIMO CAPITOLO I Proposito e fine dell’opera. Prosperità d’Italia intorno al 1490. La politica di Lorenzo de’ Medici ed il desiderio di pace de’ prìncipi italiani. La confederazione de’ prìncipi e l’ambizione de’ veneziani. Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, dappoi che l’armi de’ franzesi, chiamate da’ nostri prìncipi medesimi, cominciorono con grandissimo movimento a perturbarla: materia, per la varietà e grandezza loro, molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti; avendo patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, ora per l’ira giusta d’Iddio ora dalla empietà e sceleratezze degli altri uomini, essere vessati. Dalla cognizione de’ quali casi, tanto vari e tanto gravi, potrà ciascuno, e per sé proprio e per bene publico, prendere molti salutiferi documenti onde per innumerabili esempli evidentemente apparirà a quanta instabilità, né altrimenti che uno mare concitato da’ venti, siano sottoposte le cose umane; quanto siano perniciosi, quasi sempre a se stessi ma sempre a’ popoli, i consigli male misurati di coloro che dominano, quando, avendo solamente innanzi agli occhi o errori vani o le cupidità presenti, non si ricordando delle spesse variazioni della fortuna, e convertendo in detrimento altrui la potestà conceduta loro per la salute comune, si fanno, poca prudenza o per troppa ambizione, autori di nuove turbazioni. Ma le calamità d’Italia (acciocché io faccia noto quale fusse allora lo stato suo, e insieme le cagioni dalle quali ebbeno l’origine tanti mali) cominciorono con tanto maggiore dispiacere e spavento negli animi degli uomini quanto le cose universali erano allora più liete e più felici. Perché manifesto è che, dappoi che lo imperio romano, indebolito principalmente per la mutazione degli antichi costumi, cominciò, già sono più di mille anni, di quella grandezza a declinare alla quale con maravigliosa virtù e fortuna era salito, non aveva giammai sentito Italia tanta prosperità, né provato stato tanto desiderabile quanto era quello nel quale sicuramente si riposava l’anno della salute cristiana mille quattrocento novanta, e gli anni che a quello e prima e poi furono congiunti. Perché, ridotta tutta in somma pace e tranquillità, coltivata non meno ne’ luoghi più montuosi e più sterili che nelle pianure e regioni sue più fertili, né sottoposta a altro imperio che de’ suoi medesimi, non solo era abbondantissima d’abitatori, di mercatanzie e di ricchezze; ma illustrata sommamente dalla magnificenza di molti prìncipi, dallo splendore di molte nobilissime e bellissime città, dalla sedia e maestà della religione, fioriva d’uomini prestantissimi nella amministrazione delle cose publiche, e di ingegni molto nobili in tutte le dottrine e in qualunque arte preclara e industriosa; né priva secondo l’uso di quella età di gloria militare e ornatissima di tante doti, meritamente appresso a tutte le nazioni nome e fama chiarissima riteneva. Nella quale felicità, acquistata con varie occasioni, la conservavano molte cagioni: ma trall’altre, di consentimento comune, si attribuiva laude non piccola alla industria e virtù di Lorenzo de’ Medici, cittadino tanto eminente sopra ’l grado privato nella città di Firenze che per consiglio suo si reggevano le cose di quella republica, potente più per l’opportunità del sito, per gli ingegni degli uomini e per la prontezza de’ danari, che per grandezza di dominio. E avendosi egli nuovamente congiunto con parentado, e ridotto a prestare fede non mediocre a’ consigli suoi Innocenzo ottavo pontefice romano, era per tutta Italia grande il suo nome, grande nelle deliberazioni delle cose comuni l’autorità. E conoscendo che alla republica fiorentina e a sé proprio sarebbe molto pericoloso se alcuno de’ maggiori potentati ampliasse più la sua potenza, procurava con ogni studio che le cose d’Italia in modo bilanciate si mantenessino che più in una che in un’altra parte non pendessino: il che, senza la conservazione della pace e senza vegghiare con somma diligenza ogni accidente benché minimo, succedere non poteva. Concorreva nella medesima inclinazione della quiete comune Ferdinando di Aragona re di Napoli, principe certamente prudentissimo e di grandissima estimazione; con tutto che molte volte per l’addietro avesse dimostrato pensieri ambiziosi e alieni da’ consigli della pace, e in questo tempo fusse molto stimolato da Alfonso duca di Calavria suo primogenito, il quale malvolentieri tollerava che Giovan Galeazzo Sforza duca di Milano, suo genero, maggiore già di venti anni, benché di intelletto incapacissimo, ritenendo solamente il nome ducale fusse depresso e soffocato da Lodovico Sforza suo zio: il quale, avendo più di dieci anni prima, per la imprudenza e impudichi costumi della madre madonna Bona, presa la tutela di lui e con questa occasione ridotte a poco a poco in potestà propria le fortezze, le genti d’arme, il tesoro e tutti i fondamenti dello stato, perseverava nel governo; né come tutore o governatore, ma, dal titolo di duca di Milano in fuora, con tutte le dimostrazioni e azioni da principe. E nondimeno Ferdinando, avendo più innanzi agli occhi l’utilità presente che l’antica inclinazione o la indegnazione del figliuolo, benché giusta, desiderava che Italia non si alterasse; o perché, avendo provato pochi anni prima, con gravissimo pericolo, l’odio contro a sé de’ baroni e de’ popoli suoi, e sapendo l’affezione 83 che per la memoria delle cose passate molti de’ sudditi avevano al nome della casa di Francia, dubitasse che le discordie italiane non dessino occasione a’ franzesi di assaltare il reame di Napoli; o perché, per fare contrapeso alla potenza de’ viniziani, formidabile allora a tutta Italia, conoscesse essere necessaria l’unione sua con gli altri, e specialmente con gli stati di Milano e di Firenze. Né a Lodovico Sforza, benché di spirito inquieto e ambizioso, poteva piacere altra deliberazione, soprastando non manco a quegli che dominavano a Milano che agli altri il pericolo dal senato viniziano, e perché gli era più facile conservare nella tranquillità della pace che nelle molestie della guerra l’autorità usurpata. E se bene gli fussino sospetti sempre i pensieri di Ferdinando e di Alfonso d’Aragona, nondimeno, essendogli nota la disposizione di Lorenzo de’ Medici alla pace e insieme il timore che egli medesimamente aveva della grandezza loro, e persuadendosi che, per la diversità degli animi e antichi odii tra Ferdinando e i viniziani, fusse vano il temere che tra loro si facesse fondata congiunzione, si riputava assai sicuro che gli Aragonesi non sarebbono accompagnati da altri a tentare contro a lui quello che soli non erano bastanti a ottenere. Essendo adunque in Ferdinando, Lodovico e Lorenzo, parte per i medesimi parte per diversi rispetti, la medesima intenzione alla pace, si continuava facilmente una confederazione contratta in nome di Ferdinando re di Napoli, di Giovan Galeazzo duca di Milano e della republica fiorentina, per difensione de’ loro stati; la quale, cominciata molti anni innanzi e dipoi interrotta per vari accidenti, era stata nell’anno mille quattrocento ottanta, aderendovi quasi tutti i minori potentati d’Italia, rinnovata per venticinque anni: avendo per fine principalmente di non lasciare diventare più potenti i viniziani; i quali, maggiori senza dubbio di ciascuno de’ confederati ma molto minori di tutti insieme, procedevano con consigli separati da’ consigli comuni, e aspettando di crescere della altrui disunione e travagli, stavano attenti e preparati a valersi di ogni accidente che potesse aprire loro la via allo imperio di tutta Italia: al quale che aspirassino si era in diversi tempi conosciuto molto chiaramente; e specialmente quando, presa occasione dalla morte di Filippo Maria Visconte duca di Milano, tentorono, sotto colore di difendere la libertà del popolo milanese, di farsi signori di quello stato; e più frescamente quando, con guerra manifesta, di occupare il ducato di Ferrara si sforzorono. Raffrenava facilmente questa confederazione la cupidità del senato viniziano, ma non congiugneva già i collegati in amicizia sincera e fedele: conciossiacosaché, pieni tra se medesimi di emulazione e di gelosia, non cessavano di osservare assiduamente gli andamenti l’uno dell’altro, sconciandosi scambievolmente tutti i disegni per i quali a qualunque di essi accrescere si potesse o imperio o riputazione: il che non rendeva manco stabile la pace, anzi destava in tutti maggiore prontezza a procurare di spegnere sollecitamente tutte quelle faville che origine di nuovo incendio essere potessino. CAPITOLO II Morte di Lorenzo de’ Medici. Morte di papa innocenzo VIII ed elezione di Alessandro VI. La politica amichevole di Piero de’ Medici verso Ferdinando d’Aragona ed i primi timori di Lodovico Sforza. Tale era lo stato delle cose, tali erano i fondamenti della tranquillità d’Italia, disposti e contrapesati in modo che non solo di alterazione presente non si temeva ma né si poteva facilmente congetturare da quali consigli o per quali casi o con quali armi s’avesse a muovere tanta quiete. Quando, nel mese di aprile dell’anno mille quattrocento novantadue, sopravenne la morte di Lorenzo de’ Medici; morte acerba a lui per l’età, perché morì non finiti ancora quarantaquattro anni; acerba alla patria, la quale, per la riputazione e prudenza sua e per lo ingegno attissimo a tutte le cose onorate e eccellenti, fioriva maravigliosamente di ricchezze e di tutti quegli beni e ornamenti da’ quali suole essere nelle cose umane la lunga pace accompagnata. Ma e fu morte incomodissima al resto d’Italia, così per l’altre operazioni le quali da lui, per la sicurtà comune, continuamente si facevano, come perché era mezzo a moderare e quasi uno freno ne’ dispareri e ne’ sospetti i quali, per diverse cagioni, tra Ferdinando e Lodovico Sforza, prìncipi di ambizione e di potenza quasi pari, spesse volte nascevano. La morte di Lorenzo, preparandosi già ogni dì più le cose alle future calamità, seguitò, pochi mesi poi, la morte del pontefice; la vita del quale, inutile al publico bene per altro, era almeno utile per questo, che avendo deposte presto l’armi mosse infelicemente, per gli stimoli di molti baroni del regno di Napoli, nel principio del suo pontificato, contro a Ferdinando, e voltato poi totalmente l’animo a oziosi diletti, non aveva più, né per sé né per i suoi, pensieri accesi a cose che la felicità d’Italia turbare potessino. A Innocenzio succedette Roderigo Borgia, di patria valenziano, una delle città regie di Spagna, antico cardinale, e de’ maggiori della corte di Roma, ma assunto al pontificato per le discordie che erano tra i cardinali Ascanio Sforza e Giuliano di san Piero a Vincola, ma molto più perché, con esempio nuovo in quella età, comperò palesemente, parte con danari parte con promesse degli uffici e benefici suoi, che erano amplissimi, molti voti di cardinali: i quali, disprezzatori dell’evangelico ammaestramento, non si vergognorono di vendere la facoltà di trafficare col nome della autorità celeste i sacri tesori, nella più eccelsa parte del tempio. Indusse a contrattazione tanto abominevole molti di loro il cardinale Ascanio, ma non già più con le persuasioni e co’ prieghi che con lo esempio; perché corrotto dall’appetito infinito delle ricchezze, pattuì da lui per sé, per prezzo di tanta sceleratezza, la vicecancelleria, ufficio principale della corte romana, chiese, castella e il palagio suo di Roma, pieno di mobili di grandissima valuta. Ma non fuggì, per ciò, né poi il giudicio divino né allora l’infamia e odio giusto degli uomini, ripieni per questa elezione di spavento e di orrore, per essere stata celebrata con arti sì brutte; e non meno perché la natura e le condizioni della persona eletta erano conosciute in gran parte da molti: e, tra gli altri, è manifesto che il re di Napoli, benché in publico il dolore conceputo dissimulasse, significò alla reina sua moglie con lacrime, dalle quali era solito astenersi eziandio nella morte de’ figliuoli, essere creato uno pontefice che sarebbe perniciosissimo a Italia e a tutta la 84 republica cristiana: pronostico veramente non indegno della prudenza di Ferdinando. Perché in Alessandro sesto (così volle essere chiamato il nuovo pontefice) fu solerzia e sagacità singolare, consiglio eccellente, efficacia a persuadere maravigliosa, e a tutte le faccende gravi sollecitudine e destrezza incredibile; ma erano queste virtù avanzate di grande intervallo da’ vizi: costumi oscenissimi, non sincerità non vergogna non verità non fede non religione, avarizia insaziabile, ambizione immoderata, crudeltà più che barbara e ardentissima cupidità di esaltare in qualunque modo i figliuoli i quali erano molti; e tra questi qualcuno, acciocché a eseguire i pravi consigli non mancassino pravi instrumenti, non meno detestabile in parte alcuna del padre. Tanta variazione feciono per la morte di Innocenzio ottavo le cose della chiesa. Ma variazione di importanza non minore aveano fatta, per la morte di Lorenzo de’ Medici, le cose di Firenze; ove senza contradizione alcuna era succeduto, nella grandezza del padre, Piero maggiore di tre figliuoli, ancora molto giovane, ma né per l’età né per l’altre sue qualità atto a reggere peso sì grave, né capace di procedere con quella moderazione con la quale procedendo, e dentro e fuori, il padre, e sapendosi prudentemente temporeggiare tra’ prìncipi collegati, aveva, vivendo, le publiche e le private condizioni amplificate, e, morendo, lasciata in ciascuno costante opinione che per opera sua principalmente si fusse la pace d’Italia conservata. Perché non prima entrato Piero nella amministrazione della republica che, con consiglio direttamente contrario a’ consigli paterni né comunicato co’ cittadini principali, senza i quali le cose gravi deliberare non si solevano, mosso dalle persuasioni di Verginio Orsino parente suo (erano la madre e la moglie di Piero nate della famiglia Orsina), si ristrinse talmente con Ferdinando e con Alfonso, da’ quali Verginio dependeva, che ebbe Lodovico Sforza causa giusta di temere che qualunque volta gli Aragonesi volessino nuocergli arebbono per l’autorità di Piero de’ Medici congiunte seco le forze della republica fiorentina. Questa intelligenza, seme e origine di tutti i mali, se bene da principio fusse trattata e stabilita molto segretamente, cominciò quasi incontinente, benché per oscure congetture, a essere sospetta a Lodovico, principe vigilantissimo e di ingegno molto acuto. Perché dovendosi, secondo la consuetudine inveterata di tutta la cristianità, mandare imbasciadori a adorare, come vicario di Cristo in terra, e a offerire di ubbidire il nuovo pontefice, aveva Lodovico Sforza, del quale fu proprio ingegnarsi di parere, con invenzioni non pensate da altri, superiore di prudenza a ciascuno, consigliato che tutti gli imbasciadori de’ collegati entrassino in uno dì medesimo insieme in Roma, presentassinsi tutti insieme nel concistorio publico innanzi al pontefice, e che uno di essi orasse in nome comune, perché da questo, con grandissimo accrescimento della riputazione di tutti, a tutta Italia si dimostrerebbe essere tra loro non solo benivolenza e confederazione, ma più tosto tanta congiunzione che e’ paressino quasi un principe e un corpo medesimo. Manifestarsi, non solamente col discorso delle ragioni ma non meno con fresco esempio, l’utilità di questo consiglio; perché, secondo che si era creduto, il pontefice ultimamente morto, preso argomento della disunione de’ collegati dall’avergli con separati consigli e in tempi diversi prestato l’ubbidienza, era stato più pronto ad assaltare il regno di Napoli. Approvò facilmente Ferdinando il parere di Lodovico; approvoronlo per l’autorità dell’uno e dell’altro i fiorentini, non contradicendo ne’ consigli publici Piero de’ Medici, benché privatamente gli fusse molestissimo, perché, essendo uno degli oratori eletti in nome della republica e avendo deliberato di fare illustre la sua legazione con apparato molto superbo e quasi regio, si accorgeva che, entrando in Roma e presentandosi al pontefice insieme con gli altri imbasciadori de’ collegati, non poteva in tanta moltitudine apparire agli occhi degli uomini lo splendore della pompa sua: la quale vanità giovenile fu confermata dagli ambiziosi conforti di Gentile vescovo aretino, uno medesimamente degli eletti imbasciadori; perché aspettandosi a lui, per la degnità episcopale e per la professione la quale negli studi che si chiamano d’umanità fatta avea, l’orare in nome de’ fiorentini, si doleva incredibilmente di perdere, per questo modo insolito e inaspettato, l’occasione di ostentare la sua eloquenza in cospetto sì onorato e sì solenne. E però Piero, stimolato parte dalla leggierezza propria parte dall’ambizione di altri, ma non volendo che a notizia di Lodovico Sforza pervenisse che da sé si contradicesse al consiglio proposto da lui, richiese il re che, dimostrando d’avere dappoi considerato che senza molta confusione non si potrebbeno eseguire questi atti comunemente, confortasse che ciascuno, seguitando gli esempli passati, procedesse da se medesimo: nella quale domanda il re, desideroso di compiacergli, ma non tanto che totalmente ne dispiacesse a Lodovico, gli sodisfece più dell’effetto che del modo; conciossiacosaché e’ non celò che non per altra cagione si partiva da quel che prima avea consentito che per l’instanza fatta da Piero de’ Medici. Dimostrò di questa subita variazione maggiore molestia Lodovico che per se stessa non meritava l’importanza della cosa, lamentandosi gravemente che, essendo già nota al pontefice e a tutta la corte di Roma la prima deliberazione e chi ne fusse stato autore, ora studiosamente si ritrattasse, per diminuire la sua reputazione. Ma gli dispiacque molto più che, per questo minimo e quasi non considerabile accidente, cominciò a comprendere che Piero de’ Medici avesse occultamente intelligenza con Ferdinando: il che, per le cose che seguitorono, venne a luce ogni dì più chiaramente. 85 Benvenuto Cellini, Vita [La vita, a cura di Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 1982] XXXIV. Era di già tutto il mondo in arme. Avendo papa Clemente mandato a chiedere al signor Giovanni de' Medici certe bande di soldati, i quali vennono, questi facevano tante gran cose in Roma, che gli era male stare alle botteghe pubbliche. Fu causa che io mi ritirai in una buona casotta drieto a Banchi; e quivi lavoravo a' tutti quelli guadagnati mia amici. I mia lavori in questo tempo non furno cose di molta importanza; però non mi occorre ragionar di essi. Mi dilittai in questo tempo molto della musica e di tai piaceri simili a quella. Avendo papa Clemente, per consiglio di misser Iacopo Salviati, licenziato quelle cinque bande che gli aveva mandato il signor Giovanni, il quale di già era morto in Lombardia, Borbone, saputo che a Roma non era soldati, sollecitissimamente spinse l'esercito suo alla volta di Roma. Per questa occasione tutta Roma prese l'arme; il perché, essendo io molto amico di Alessandro, figliuol di Piero del Bene, e perché a tempo che i Colonnesi vennono in Roma mi richiese che io gli guardassi la casa sua: dove che a questa maggior occasione mi pregò, che io facessi cinquanta compagni per guardia di detta casa, e che io fussi lor guida, sì come avevo fatto a tempo de' Colonnesi; onde io feci cinquanta valorosissimi giovani, e intrammo in casa sua ben pagati e ben trattati. Comparso di già l'esercito di Borbone alle mura di Roma, il detto Alessandro del Bene mi pregò che io andassi seco a farli compagnia: così andammo un di quelli miglior compagni e io; e per la via con esso noi si accompagnò un giovanetto addomandato Cechino della Casa. Giugnemmo alle mura di Campo Santo, e quivi vedemmo quel maraviglioso esercito, che di già faceva ogni suo sforzo per entrare. A quel luogo delle mura, dove noi ci accostammo, v'era molti giovani morti da quei di fuora: quivi si combatteva a più potere: era una nebbia folta quanto immaginar si possa. Io mi vuolsi a Lessandro e li dissi: – Ritiriamoci a casa il più presto che sia possibile, perché qui non è un rimedio al mondo; voi vedete, quelli montano e questi fuggono –. Il ditto Lessandro spaventato, disse: – Così volessi Idio che venuti noi non ci fussimo! – e così voltosi con grandissima furia per andarsene, il quale io ripresi, dicendogli: – Da poi che voi mi avete menato qui, gli è forza fare qualche atto da uomo –. E vòlto il mio archibuso, dove io vedevo un gruppo di battaglia più folta e più serrata, posi la mira innel mezzo apunto a uno che io vedevo sollevato dagli altri; per la qual cosa la nebbia non mi lasciava discernere se questo era a cavallo o a piè. Voltomi subito a Lessandro e a Cechino, dissi loro che sparassino i loro archibusi, e insegnai loro il modo, acciocché e' non toccassino una archibusata da que' di fuora. Così fatto dua volte per uno, io mi affacciai alle mura destramente, e veduto in fra di loro un tumulto istrasordinario, fu che da questi nostri colpi si ammazzò Borbone; e fu quel primo che io vedevo rilevato da gli altri, per quanto da poi s'intese. Levatici di quivi, ce ne andammo per Campo Santo, ed entrammo per San Piero; e usciti là drieto alla chiesa di Santo Agnolo, arrivammo al portone di Castello con grandissime difficultà, perché il signor Renzo da Ceri e il signor Orazio Baglioni davano delle ferite e ammazzavono tutti quelli che si spiccavano dal combattere alle mura. Giunti al detto portone, di già erano entrati una parte de' nimici in Roma, e gli avevamo alle spalle. Volendo il Castello far cadere la saracinesca del portone, si fece un poco di spazio, di modo che noi quattro entrammo drento. Subito che io fui entrato, mi prese il capitan Pallone de' Medici, perché, essendo io della famiglia del Castello, mi forzò che io lasciassi Lessandro; la qual cosa molto contra mia voglia feci. Così salitomi su al mastio, innel medesimo tempo era entrato papa Clemente per i corridori innel Castello; perché non s'era voluto partire prima del palazzo di San Piero, non possendo credere che coloro entrassino. Da poi che io mi ritrovai drento a quel modo, accosta'mi a certe artiglierie, le quali aveva a guardia un bonbardiere chiamato Giuliano fiorentino. Questo Giuliano affacciatosi lì al merlo del castello, vedeva la sua povera casa saccheggiare, e straziare la moglie e' figliuoli; in modo che, per non dare ai suoi, non ardiva sparare le sue artiglierie; e gittato la miccia da dar fuoco per terra, con grandissimo pianto si stracciava il viso; e 'l simile facevano certi altri bonbardieri. Per la qual cosa io presi una di quelle miccie, faccendomi aiutare da certi ch'erano quivi, li quali non avevano cotai passione: volsi certi pezzi di sacri e falconetti dove io vedevo il bisogno, e con essi ammazzai di molti uomini de' nemici; che se questo non era, quella parte che era intrata in Roma quella mattina, se ne veniva diritta al Castello; ed era possibile che facilmente ella entrassi, perché l'artiglierie non davano lor noia. Io seguitavo di tirare; per la qual cosa alcun cardinali e signori mi benedivano e davonmi grandissimo animo. Il che io baldanzoso, mi sforzavo di fare quello che io non potevo; basta che io fu' causa di campare la mattina il Castello, e che quelli altri bonbardieri si rimessono a fare i loro uffizii. Io seguitai tutto quel giorno: venuto la sera, in mentre che l'esercito entrò in Roma per la parte di Tresteveri, avendo papa Clemente fatto capo di tutti e' bonbardieri un gran gentiluomo romano, il quale si domandava misser Antonio Santa Croce, questo gran gentiluomo la prima cosa se ne venne a me, faccendomi carezze: mi pose con cinque mirabili pezzi di artiglieria innel più eminente luogo del Castello, che si domanda da l'Agnolo a punto: questo luogo circunda il Castello atorno atorno e vede inverso Prati e in verso Roma: così mi dette tanti sotto a di me a chi io potessi comandare, per aiutarmi voltare le mie artiglierie; e fattomi dare una paga innanzi, mi consegnò del pane e un po' di vino, e poi mi pregò, che in quel modo che io avevo cominciato seguitassi. Io, che tal volta più era inclinato a questa professione che a quella che io tenevo per mia, la facevo tanto volentieri, che la mi veniva fatta meglio che la ditta. Venuto la notte, e i nimici entrati in Roma, noi che eramo nel Castello, massimamente io, che sempre mi son dilettato veder cose nuove, istavo considerando questa inestimabile novità e 'ncendio; la qual cosa quelli che erano in ogni altro luogo che in Castello, nolla possettono né vedere né 86 inmaginare. Per tanto io non mi voglio mettere a descrivere tal cosa; solo seguiterò descrivere questa mia vita che io ho cominciato, e le cose che in essa a punto si appartengono. XXXV. Seguitando di esercitar le mie artiglierie continuamente, per mezzo di esse in un mese intero che noi stemmo nel Castello assediati, mi occorse molti grandissimi accidenti degni di raccontargli tutti; ma per non voler essere tanto lungo, né volermi dimostrare troppo fuor della mia professione, ne lascierò la maggior parte, dicendone solo quelli che mi sforzano, li quali saranno i manco e i più notabili. E questo è il primo: che avendomi fatto quel ditto misser Antonio Santa Croce discender giù de l'Agnolo, perché io tirassi a certe case vicino al Castello, dove si erano veduti entrare certi dell'inimici di fuora, in mentre che io tiravo, a me venne un colpo di artiglieria, il qual dette in un canton di un merlo, e presene tanto, che fu causa di non mi far male: perché quella maggior quantità tutta insieme mi percosse il petto; e, fermatomi l'anelito, istavo in terra prostrato come morto, e sentivo tutto quello che i circustanti dicevano; in fra i quali si doleva molto quel misser Antonio Santa Croce, dicendo: – Oimè, che noi abiàn perso il migliore aiuto che noi ci avessimo –. Sopragiunto a questo rumore un certo mio compagno, che si domandava Gianfrancesco, piffero, questo uomo era più inclinato alla medicina che al piffero, e subito piangendo corse per una caraffina di bonissimo vin greco: avendo fatto rovente una tegola, in su la quale e' messe su una buona menata di assenzio, di poi vi spruzzò su di quel buon vin greco; essendo inbeuto bene il ditto assenzio, subito me lo messe in sul petto, dove evidente si vedeva la percossa. Fu tanto la virtù di quello assenzio, che resemi subito quelle ismarrite virtù. Volendo cominciare a parlare, non potevo, perché certi sciocchi soldatelli mi avevano pieno la bocca di terra, parendo loro con quella di avermi dato la comunione, con la quale loro più presto mi avevano scomunicato, perché non mi potevo riavere, dandomi questa terra più noia assai che la percossa. Pur di questa scampato, tornai a que' furori delle artiglierie, seguitandoli con tutta quella virtù e sollecitudine migliore che inmaginar potevo. E perché papa Clemente aveva mandato a chiedere soccorso al duca di Urbino, il quale era con lo esercito de' Veniziani, dicendo all'imbasciadore, che dicessi a Sua Eccellenzia, che tanto quanto il detto Castello durava a fare ogni sera tre fuochi in cima di detto Castello, accompagnati con tre colpi di artiglieria rinterzati, che insino che durava questo segno, dimostrava che il Castello non saria areso; io ebbi questa carica di far questi fuochi e tirare queste artiglierie: avvenga che sempre di giorno io le dirizzava in quei luoghi dove le potevan fare qualche gran male; la qual cosa il Papa me ne voleva di meglio assai, perché vedeva che io facevo l'arte con quella avvertenza che a tal cose si promette. Il soccorso de il detto duca mai non venne; per la qual cosa io, che non son qui per questo, altro non descrivo. XXXVI. In mentre che io mi stavo su a quel mio diabolico esercizio, mi veniva a vedere alcuni di quelli cardinali che erano in Castello, ma più ispesso il cardinale Ravenna e il cardinal de' Gaddi, ai quali io più volte dissi ch'ei non mi capitassino innanzi, perché quelle lor berrettuccie rosse si scorgevano discosto; il che da que' palazzi vicini, com'era la Torre de' Bini, loro e io portavomo pericolo grandissimo; di modo che per utimo io gli feci serrare, e ne acquistai con loro assai nimicizia. Ancora mi capitava spesso intorno il signor Orazio Baglioni, il quale mi voleva molto bene. Essendo un giorno in fra gli altri ragionando meco, lui vidde certa dimostrazione in una certa osteria, la quale era fuor della porta di Castello, luogo chiamato Baccanello. Questa osteria aveva per insegna un sole dipinto immezzo dua finestre, di color rosso. Essendo chiuse le finestre, giudicò il detto signor Orazio, che al dirimpetto drento di quel sole in fra quelle due finestre fussi una tavolata di soldati a far gozzoviglia; il perché mi disse: – Benvenuto, s'e' ti dessi il cuore di dar vicino a quel sole un braccio con questo tuo mezzo cannone, io credo che tu faresti una buona opera, perché colà si sente un gran romore, dove debb'essere uomini di molta importanza –. Al qual signor io dissi: – A me basta la vista di dare in mezzo a quel sole – ma sì bene una botte piena di sassi, ch'era quivi vicina alla bocca di detto cannone, el furore del fuoco e di quel vento che faceva il cannone, l'arebbe mandata atterra. Alla qual cosa il detto signore mi rispose: – Non mettere tempo in mezzo, Benvenuto: imprima non è possibile che, innel modo che la sta, il vento de il cannone la faccia cadere; ma se pure ella cadessi e vi fussi sotto il Papa, saria manco male che tu non pensi, sicché tira, tira –. Io, non pensando più là, detti in mezzo al sole, come io avevo promesso a punto. Cascò la botte, come io dissi, la qual dette a punto in mezzo in fra il cardinal Farnese e misser Iacopo Salviati, che bene gli arebbe stiacciati tutti a dui: che di questo fu causa che il ditto cardinal Farnese a punto aveva rimproverato, che il ditto misser Iacopo era causa del sacco di Roma; dove dicendosi ingiuria l'un l'altro, per dar campo alle ingiuriose parole, fu la causa che la mia botte non gli stiacciò tutt'a dua. Sentito il gran rimore che in quella bassa corte si faceva, il buon signor Orazio con gran prestezza se ne andò giù; onde io fattomi fuora, dove era caduta la botte, senti' alcuni che dicevano: – E' sarebbe bene ammazzare quel bonbardieri –; per la qual cosa io volsi dua falconetti alla scala che montava su, con animo risoluto, che il primo che montava, dar fuoco a un de' falconetti. Dovetton que servitori del cardinal Farnese aver commessione dal cardinale di venirmi a fare dispiacere; per la qual cosa io mi feci innanzi, e avevo il fuoco in mano. Conosciuto certi di loro, dissi: – O scannapane, se voi non vi levate di costì, e se gli è nessuno che ardisca entrar drento a queste scale, io ho qui dua falconetti parati, con e' quali io farò polvere di voi; e andate a dire al cardinale, che io ho fatto quello che dai mia maggiori mi è stato commesso, le qual cose si sono fatte e fannosi per difension di lor preti, e non per offenderli –. Levatisi e' detti, veniva su correndo il ditto signor Orazio Baglioni, al quale io dissi che stessi indrieto, se non che io l'ammazzerei, perché io sapevo benissimo chi egli era. Questo signore non sanza paura si fermò alquanto, e mi disse: – Benvenuto, io son tuo amico –. Al quale io dissi: – Signore, montate pur solo, e venite poi in tutti i modi che voi volete 87 –. Questo signore, ch'era superbissimo, si fermò alquanto, e con istizza mi disse: – Io ho voglia di non venire più su e di far tutto il contrario che io avevo pensato di far per te –. A questo io gli risposi, che sì bene come io ero messo in quello uffizio per difendere altrui, che così ero atto a difendere ancora me medesimo. Mi disse che veniva solo; e montato ch'e' fu, essendo lui cambiato più che 'l dovere nel viso, fu causa che io tenevo la mana in su la spada, e stavo in cagnesco seco. A questo lui cominciò a ridere, e ritornatogli il colore nel viso, piacevolissimamente mi disse: – Benvenuto mio, io ti voglio quanto bene io ho, e quando sarà tempo che a Dio piaccia, io te lo mostrerrò. Volessi Idio che tu gli avessi ammazzati que' dua ribaldi, ché uno è causa di sì gran male, e l'altro talvolta è per esser causa di peggio –. Così mi disse, che se io fussi domandato, che io non dicessi che lui fussi quivi da me quando io detti fuoco a tale artiglieria; e del restante che io non dubitassi. I romori furno grandissimi, e la cosa durò un gran pezzo. In questo io non mi voglio allungare più inanzi: basta che io fu' per fare le vendette di mio padre con misser Iacopo Salviati, il quale gli aveva fatto mille assassinamenti (secondo che detto mio padre se ne doleva). Pure disavedutamente gli feci una gran paura. Del Farnese non vo' dir nulla, perché si sentirà al suo luogo quanto gli era bene che io l'avessi ammazzato. XXXVII. Io mi attendevo a tirare le mie artiglierie, e con esse facevo ognindì qualche cosa notabilissima; di modo che io avevo acquistato un credito e una grazia col papa inistimabile. Non passava mai giorno, che io non ammazzassi qualcun degli inimici di fuora. Essendo un giorno in fra gli altri, il Papa passeggiava per il mastio ritondo, e vedeva in Prati un colonello spagnuolo, il quale lui lo conosceva per alcuni contrassegni, inteso che questo era stato già al suo servizio; e in mentre che lo guardava, ragionava di lui. Io che ero di sopra a l'Agnolo, e non sapevo nulla di questo, ma vedevo uno uomo che stava là a fare aconciare trincee con una zagaglietta in mano, vestito tutto di rosato, disegnando quel che io potessi fare contra di lui, presi un mio gerifalco che io avevo quivi, il qual pezzo si è maggiore e più lungo di un sacro, quasi come una mezza colubrina: questo pezzo io lo votai, di poi lo caricai con una buona parte di polvere fine mescolata con la grossa; di poi lo dirizzai benissimo a questo uomo rosso, dandogli un'arcata maravigliosa, perché era tanto discosto, che l'arte non prometteva tirare così lontano artiglierie di quella sorta. Dèttigli fuoco e presi apunto nel mezzo quel uomo rosso, il quali s'aveva messo la spada per saccenteria dinanzi, in un certo suo modo spagnolesco: che giunta la mia palla della artiglieria, percosso in quella spada, si vidde il ditto uomo diviso in dua pezzi. Il Papa, che tal cosa non aspettava, ne prese assai piacere e maraviglia, sì perché gli pareva inpossibile che una artiglieria potessi giugnere tanto lunge di mira, e perché quello uomo esser diviso in dua pezzi, non si poteva accomodare come questo caso star potessi; e mandatomi a chiamare, mi domandò. Per la qual cosa io gli dissi tutta la diligenza che io avevo usato al modo del tirare; ma per esser l'uomo in dua pezzi, né lui né io non sapevamo la causa. Inginocchiatomi, lo pregai che mi ribenedissi dell'omicidio, e d'altri che io ne avevo fatti in quel Castello in servizio della Chiesa. Alla qual cosa il Papa, alzato le mane e fattomi un patente crocione sopra la mia figura, mi disse che mi benediva, e che mi perdonava tutti gli omicidii che io avevo mai fatti e tutti quelli che mai io farei in servizio della Chiesa appostolica. Partitomi, me ne andai su, e sollecitando non restavo mai di tirare; e quasi mai andava colpo vano. Il mio disegnare e i mia begli studii e la mia bellezza di sonare di musica, tutte erano in sonar di quelle artiglierie, e s'i' avessi a dire particularmente le belle cose che in quella infernalità crudele io feci, farei maravigliare il mondo; ma per non essere troppo lungo me le passo. Solo ne dirò qualcuna di quelle più notabile, le quale mi sono di necessità; e questo si è, che pensando io giorno e notte quel che io potevo fare per la parte mia in defensione della Chiesa, considerato che i nimici cambiavano le guardie e passavano per il portone di Santo Spirito, il quale era tiro ragionevole, ma, perché il tiro mi veniva in traverso, non mi veniva fatto quel gran male che io desiderava di fare; pure ogni giorno se ne ammazzava assai bene: in modo che, vedutosi e' nimici impedito cotesto passo, messono più di trenta botti una notte in su una cima di un tetto, le quali mi impedivano cotesta veduta. Io, che pensai un po' meglio a cotesto caso che non avevo fatto prima, volsi tutti a cinque i mia pezzi di artiglieria dirizzandogli alle ditte botti; e aspettato le ventidua ore in sul bel di rimetter le guardie; e perché loro, pensandosi esser sicuri, venivano più adagio e più folti che 'l solito assai, il che, dato fuoco ai mia soffioni, non tanto gittai quelle botti per terra che m'inpedivano, ma in quella soffiata sola ammazzai più di trenta uomini. Il perché, seguitando poi così dua altre volte, si misse i soldati in tanto disordine che, infra che gli eran pieni del latrocinio del gran sacco, desiderosi alcuni di quelli godersi le lor fatiche, più volte si volsono abottinare per andarsene. Pure, trattenuti da quel lor valoroso capitano, il quale si domandava Gian di Urbino, con grandissimo lor disagio furno forzati pigliare un altro passo per il rimettere delle lor guardie; il qual disagio importava più di tre miglia, dove quel primo non era un mezzo. Fatto questa impresa, tutti quei signori ch'erano in Castello mi facevano favori maravigliosi. Questo caso tale, per esser di tanta importanza seguito, lo ho voluto contare per far fine a questo, perché non sono nella professione che mi muove a scrivere; che se di queste cose tale io volessi far bello la vita mia, troppe me ne avanzeria da dirle. Eccene sola un'altra che al suo luogo io la dirò. 88 Pietro Aretino Ragionamenti [Pietro Aretino, Ragionamento, a cura di Nino Borsellino e Paolo Procaccioli, Milano, Garzanti, 1984] NANNA Ora odi questa. Sei giorni inanzi a me, dai suoi fratelli era stata misa dove io fui posta una non–vo'–dir donzella, e una robba–che–dio–tel–dica; e per gelosia d'uno dei primi della terra innamorato d'essa (secondo che mi fu detto), la badessa la tenea in una camera sola; e la notte, riserratala, ne portava seco la chiave. E il giovane amante, accortosi che una finestra serrata della camera sua rispondea nello orto, aggrappandosi su per il muro di quella finestra come un picchio, al meglio che potea dava da beccare alla papera; e a punto in questa notte che io ti conto venne a lei: e acconciatosi alla ferrata, abeverava il bracco alla tazza che si gli sporgeva in fuore, tenendo però le braccia intrecciate con i ferri traditori. E venendo il mèle sul fiadone, la dolcitudine gli tornò più amara che non è una medecina. ANTONIA A che modo? NANNA Lo sventurato venne in tanto sfinimento in sul fà–che–io–fo, che, abbandonate le braccia, cadde dal balcone sopra un tetto, e del tetto in un pollaio, e del pollaio in terra, di maniera che si ruppe una coscia. ANTONIA Oh le avesse rotte tutte due la strega badessa, poiché volea che ella osservasse castità in bordello! NANNA Ella lo facea per paura dei fratelli che aveano giurato di abbrusciarla con tutto il monestero udendone biasimo. E per tornare a dirti, il giovane che ebbe il lavorar dei cani, misse a romore tutto il mondo: e corsero ciascuna per le finestrette alzando le impannate, scorgendo per il lume della luna il ruinato e fracassato meschino. Fecero scovare duo seculari del letto con le posticce mogli loro, e mandatogli nell'orto, lo ricolsero su le braccia e lo portaro di fuora: e ti so dire che ci fu che dir per la terra di cotal caso. Dopo questo scandolo, ritornandoci in cella per paura che il dì non ci giungesse a spiare i fatti d'altri, udimmo un frate buonissimo brigante, bisuntone, che contava una fola a non so quante suore e preti e secolari che aveano giocato a dadi e a carte tutta notte: finito di sbevazzare, erano entrati a chiacchiarare, scongiurando il frate che dicesse una novella; ed egli, dicendo “Io vi vo' contare una istoria che cominciò in riso e finì in pianto per un cagnaccio stallone”, impetrò udienza e cominciò: “Dui dì fa, passando per piazza, mi fermai a vedere una cagnoletta in frega che avea due dozzine di cagnoletti tratti allo odore della fregna sua, tutta enfiata e sì rossa, che parea di corallo che ardesse: e tuttavia fiutandola or questo e ora quello, cotal gioco avea ragunati una gran frotta di fanciulli a vedere ora salir suso questo e dar due menatine, e or questo altro e darne due altre. Io a tale spasso facea viso proprio fratesco, ed ecco che comparisce un cane da pagliaio, che parea il luogotenente delle beccarie di tutto il mondo: e afferratone uno, lo trasse in terra rabbiosamente; e lasciatolo, ne prese un altro, né gli rimasse a dosso il cuoio intero; in questo, chi fugge di qua e chi di là; e il cagnone, fatto arco della schiena, arricciando il pelo come il porco le setole, con occhi guerci, digrignendo i denti, rignendo, con la schiuma alla bocca, guardava la cagnola male arrivata; e fiutatole un tratto la bella bellina, le diede due spinte che la fecero abbaiare da cagna grande: ma sguizzatagli di sotto, si diede a correre. E i cagnoletti, che stavano alla vedetta, le trottàr dietro; il cagnaccio, in collera, la seguitava: e così la cagna, veduta la fessura d'una porta chiusa, di subito ci saltò dentro, e i cagnuoli seco. Il cane poltrone si rimase fuoruscito, imperò che egli era cotanto sconcio che non capiva dove gir gli altri; onde rimaso di fuora, mordeva la porta, zappava in terra, urlava che parea un leone che avesse la febbre. E stato così gran pezzo, sbuca fuora un dei poverini: e il can traditore, ciuffatolo, gli staccò tutta una orecchia; e apparendo il secondo, gli fece peggio, e di mano in mano gli castigò tutti nello uscire; e gli fece disgombrare il paese come sgombrano i villani per la venuta dei soldati. Alla fine la sposa venne fuora, ed egli presola nella gola, le ficcò le zanne nella canna e strozzolla, mandandone i fanciulli, con il popolo raccolto alla festa canina, i gridi al cielo...”; onde noi, non ci curando di vedere né di udire più altro, entrati in camera nostra e caminato un miglio per il letto, ci adormentammo. ANTONIA Perdonimi il Centonovelle: egli si può andare a riporre. NANNA Questo non dico io; ma voglio che egli confessi almeno che le mie son cose vive, e le sue dipinte. Ma non ti ho io da dire? ANTONIA Che? NANNA Levatami a nona, sendosi non so come partito a buona otta il gallo della mia parrocchia, e andando a desinare, non potea contener i ghigni vedendo quelle che erano la notte gite in carnafau: e domesticata in pochi dì con tutte, fui chiarita che sì come i' vidi altri, altri vide me: cioè in tresca col baccelliere. E disnato che avemmo, salì in pergamo un fra luteriano che avea una voce da far guardie, e sì penetrativa e tonante, che si saria udita da Campidoglio a Testaccio; e fece una essortazione alle suore, di così fatta maniera che arìa convertito la stella Diana. ANTONIA 89 Che cose diceva egli? NANNA Egli diceva che non era cosa più in odio alla natura che vedere perdere il tempo alla gente, però che ella ce lo ha dato perché lo spendiamo in consolazione d'essa; e che gode del vedere le sue creature crescere e multiplicare, e sopra ogni altra cosa si rallegra quando scorge una donna che, giunta nella vecchiezza, può dir “Mondo, fatti con Dio”; e che oltre le altre, la natura tiene per gioie care le monicelle le quali fanno i zuccherini allo dio Cupido: onde i piaceri che ci dona son più dolci che mille che ne dia alle mondane; affermando ad alta voce che i figliuoli che nascono di frate e di suora sono parenti del Disitte e del Verbumcaro. Ed entrato poi nello amore fino delle mosche e delle formiche, era forte riscaldato nel volere che fosse di bocca della verità tutto quello che usciva della sua. Non è ascoltato sì attentamente un canta–in–panca dagli scioperati, come ascoltavano le buone massaie il cicalone; e data la benedizione con uno di quelli, tu mi intendi, di vetro lungo tre spanne, scese giuso; e infrescandosi facea del vino quello che fanno i cavalli della acqua, divorando le confezioni con la ingordigia che divora un asinaccio i sermenti; e gli fu donato più cose che non dona il parentado a chi canta la messa novella, o vero una madre alla figlia che va a marito; e partitosi, chi si diede a fare una bagattella e chi un'altra. E io, tornata in camera, non stei molto che odo percuotermi la porta; onde apro, ed ecco a me il fanciullo del baccelliere che con uno inchino cortigiano mi porge una cosa inguluppata e una lettera piegata nel modo che sono quelle penne con tre cantoni, o spicchi che si gli debba dire, che stanno in cima alle frecce. La soprascritta dicea..., io non so se mi ricorderò delle parole...; aspetta, sì, sì, così dicevano: Queste mie poche e semplici parole, sciutte co' miei sospir, scritte col pianto, sien date in paradiso in man del Sole. ANTONIA O buono! NANNA Dentro ci era una diceria lunga lunga; e cominciava da quei capegli che mi fur tagliati in chiesa, dicendo che gli avea ricolti e fattosene un laccio intorno al collo; e che la mia fronte era più serena che il cielo, assimigliandomi le ciglia a quel legno nero di che si fanno i pettini; e che le mie guance faceano aschio al latte e al cremisi; a una filza di perle mi agguagliò i denti, e le labbra a' fiori delle melagrane; facendo un gran proemio su le mie mani: e fino le unghie lodò; e che la mia voce era simile al canto del gloria in eccelsis; e venendo al petto, disse mirabilia, e che tenea duo pomi candidi come la neve calda. Alla fine si lasciò sdrucciolare alla fonte, dicendo averci bevuto indegnamente, e che ella stillava manuscristi e manna, e che di seta erano i peluzzi suoi. Del rovescio della medaglia tacque, scusandosi che bisogneria che rinascesse il Burchiello a dirne una minima particella; e venne a finirla col rendermi grazie per infinito seculo della liberalità che io gli avea fatto del mio tesoro, e giurando che verria tosto a me; e con uno “addio coricino mio”, si sottoscrisse a punto così: Quel[lo] che nel bel petto vostro vive, spinto da troppo amor, questa vi scrive. ANTONIA E chi non si arìa alzato i panni a sì bella canzona? NANNA Letta la novella, ripiego la carta e, prima che io me la ponga in seno, la bascio; e tratta la cosa dello invoglio, veggio che egli è uno ufficiuolo molto vago che lo amico mi manda, cioè lo ufficiuolo che io credea che mi mandasse: egli era coperto di velluto verde, che significava amore, con i suoi nastri di seta. E lo piglio sorridendo e di fuora lo vagheggio, tuttavia basciandolo e lodandolo per il più bello che avesse mai visto. E licenciato il messo con dirgli che in vece mia basciasse il suo maestro, rimasa sola apro il libricciuolo per leggere la magnificat: e apertolo, veggiolo pieno di dipinture che si trastullano nella foggia che fanno le savie moniche; e scoppiai in tanto riso nel vedere una che, spingendo le sue cose fuora di una cesta sanza fondo, per una fune si calava su la fava di uno sterminato baccello, che ci corse una sorella che più di alcuna altra si era domesticata meco; e dicendomi “Che significano coteste tua risa?”, sanza corda le dico il tutto; e mostratole il libretto, ce ne demmo insieme uno spasso che ci mise in tanta voglia di provare i modi dipinti, che ci fu forza a consigliarcene col manico di vetro: il quale acconciossi fra le cosce la mia compagnetta sì bene, che parea il cotale di uno uomo drizzato inverso la sua tentazione; onde io gittatami là come una di quelle di ponte Santa Maria, le pongo le gambe in su le spalle; ed ella ficcandomelo ora a buon modo e ora a tristo, mi fece far tosto quello che io avea a fare; e arrecatasi ella alla foggia che mi recai io, le fu renduto da me migliaccio per torta. ANTONIA Sai tu, Nanna, quello che interviene a me udendoti ragionare? NANNA No. ANTONIA Quello che interviene a uno che odora una medicina: che sanza prenderla altrimenti, va due e tre volte del corpo. NANNA Ah! ah! ah! 90 ANTONIA Dico che mi paiono tanto veri i tuoi ragionamenti, che mi hai fatto pisciare sanza che io abbia gustato né tartufo né cardo. NANNA Tu mi riprendi del parlare a fette, e poi usi anche tu la favella di chi narra le novelluzze alle bambine dicendo: “Io ho una mia cosa che è bianca come una oca: oca non è, or dimmi ciò ch'ella è”. ANTONIA Io favello per compiacerti, perciò uso le oscurità. NANNA Ti ringrazio. Ora seguiamo la antifana. Dopo gli scherzi che ci facemmo l'una a l'altra, ci venne voglia di farci vedere alla grata e alla ruota: dove non potemmo aver luogo, perché tutte erano corse ivi come corrono le lucertole al sole; e la chiesa parea San Piero e San Paolo il dì della stazzone, e fino a monaci e a soldati si dava udienza; e se me lo vuoi credere credimelo, io vidi Iacob ebreo che con una gran securtà cianciava con la badessa. ANTONIA Il mondo è corrotto. NANNA Io lo dirò, escane che vuole: ci vidi anco uno di quei Turchi disgraziati che si lasciò dare nella ragna in Ungaria. ANTONIA Egli dovea esser fatto cristiano. NANNA Basta che vi lo vidi, né ti saprei dire se col battesimo o sanza. Ma sono stata una bestia a prometterti di raccontare in un dì la vita delle suore, perciò che elle in una ora fanno cose che non si narrerebero in uno anno. Il sole si mette in ordine per tramontare, onde io abbreviando farò conto di essere uno che ha fretta di cavalcare: che, benché abbia appitito grande, appena assaggia quattro bocconi bevendo un tratto, e via al suo camino. ANTONIA Lasciami dire un poco. Tu mi dicesti da principio che il mondo non è più quello ch'egli era al tuo tempo: io pensava che tu mi avessi a contare delle suore di allora di quelle cose che sono in sul libro dei santi Padri. NANNA Ho errato io, se ti ho detto cotesto: io volli forse dire che non son più come erano al tempo antico. ANTONIA Errò adunque la lingua, non il core. NANNA Sia come vuole, io ora non l'ho in mente: attendiamo a questo, che importa più. Dico che tentandomi il demonio, mi lasciai porre il basto da un frate che era venuto da Studio, guardandomi però dal baccelliere: e come la fortuna volse, egli mi menava spesso a cena fuora del monestero, non sapendo che io fossi maritata al baccelliere. E fra le altre, venne per me una sera dopo le avemarie allo improviso e disse: “Cara la mia putta, fammi grazia di venir meco in questo punto, che ti vo menare in un luogo che averai grandissimo piacere: e udirai non pure musiche angeliche, ma recitare una comedietta molto gentile”. Io che avea il capo pieno di grilli, sanza indugiarmi mi spoglio, aitandomi lui; e trattimi i panni sacrati, mi vesto i profumati, cioè i panni da garzone, i quali mi fece fare il primo amante; e postomi in capo un cappelletto di seta verde con una pennetta rossa e un fermaglio d'oro, con la cappa indosso men vado seco. E caminato un tirar di sasso, egli entra in una stradetta lunga e larga mezzo passo, sanza uscita; e fischiando soave soave, udimmo ratto scendere una scala e poi aprire uno uscio, sul quale posto che avemmo il piede, apparse un paggio con un torchio di cera bianca acceso; e salita la scala al lume, comparimmo in una sala ornatissima, tenendomi il mio studiante per mano; e alzando il paggio dal torchio la portiera della camera con dirci “Entrino le Signorie vostre: , entrammo; e tosto che io giunsi, vedesti levarsi suso le persone con la berretta in mano, come fanno le brigate nel dar la benedizione del predicatore. Ivi era il ricetto di tutti i fottisteri sacrati, alla similitudine di una baratteria; e ivi si riducea ogni sorte di suore e di frati, come alla noce di Benevento ogni generazione di streghe e di stregoni. E ripostosi ciascuno a sedere, non si udiva altro che bisbigliare del visetto mio: che, ancora che non stia bene a dirlo a me, sappi Antonia che egli fu bello. ANTONIA È da credere, sendo tu bellissima vecchia, che tu sia stata bellissima giovane. NANNA E stando in sui vezzi, arrivò la virtù della musica che mi fece risentire fino alla anima: erano quattro che guardavano sopra un libro; e uno, con un liuto argentino accordato con le voci loro, cantava “Divini occhi sereni...”. Dopo questo venne una ferrarese che ballò sì gentilmente, che fece maravigliare ognuno: ella facea cavriole che non le avria fatte un cavriuolo; con una destrezza, Dio, con una grazia, Antonia, che non avresti voluto vedere altro. Che miracolo era, raccogliendosi la gamba mancina a usanza della grue, e fermatasi tutta nella dritta, vederla girare come un torno: di modo che la sua veste gonfiata per il presto rivolgimento, spiegatasi in un bel tondo, tanto si vedea, quanto le girelle 91 mosse dal vento sopra d'una capanna, o vogliamo dire quelle di carta poste dai fanciulli in cima ad una canna, che, distesa la mano dandosi a correre, godono di vederle girare sì che appena si scorgono. ANTONIA Dio la benedica. NANNA Ah! ah! ah! Io mi rido di uno che lo dimandavano “il fio di Giampolo”, secondo me veneziano, che, tiratosi dentro a una porta, contrafece una brigata di voci. Egli facea un facchino che ogni bergamasco gliene avrebbe data vinta; e il facchino, dimandando a una vecchia della madonna, in persona della vecchia dicea: “E che vuoi tu da madonna?”; ed egli a lei: “Le vorria parlare”; e da cattivo le dicea: “Madonna, o madonna, io moro, io sento il polmon che mi bolle come un laveggio di trippe”; egli facea un lamento alla facchina il più dolce del mondo; e cominciando a toccarla, ridea con alcuni detti proprio atti a farle guastar la quaresima o a rompere il digiuno. E in questa ciancia, eccoti il suo marito vecchio rimbambito che, visto il facchino, levò un romore che parve un villano che vedesse mettere a sacco il suo ciriegio; e il facchino gli dicea: “Messere, o messere, ah! ah! ah!”; e ridendo e facendo cenni e atti da balordo, “Và con Dio” gli disse il vecchio, “imbriaco, asino”. E fattosi scalzare dalla fante, contava alla moglie non so che del sofì e del Turco; e facea scompisciare delle risa ognuno quando, tirando alcuna di quelle con le quali egli si affibbiava, facea sagramento di non mangiare più cibi ventosi; e lasciatosi colcare, e addorméntosi ronfando, ritornò il predetto nella forma del facchino: e con la madonna tanto pianse e tanto rise, che si mise a scuoterle il pelliccione. ANTONIA Ah! ah! ah! NANNA Riso averesti tu udendo il dibattimento del rimenarsi loro, mescolato con alcuni ladri detti del facchino, che campeggiavano troppo bene con quelli di madonna fàmmelo. Finito il vespro delle voci, ci riducemmo in sala, dove era uno apparato per coloro che aveano a recitare la comedia: e già la tenda si dovea scoprire, quando uno percosse fortemente la porta, perché il romore del favellare non lo averia lasciato udire percotendola piano; e restando di mandar giù la tenda, fu aperto al baccelliere. Ché il baccelliere era quello che, a caso passando, batté allo uscio, non sapendo che io gli fossi traditrice; e venuto suso e vistami fare gli amori con lo studiante, mosso da quel maladetto martello che accieca altrui, con quella furia che si avventò il cagnaccio che uccise la cagnuola (come raccontò la novella del frate), mi prese per i ciuffi: e trascinandomi per la sala e poi giù per la scala, non dando cura ai preghi che per me facea ognuno, salvo lo studiante che, tosto che vide il baccelliere, sparve come un raggio dalla girandola, mi condusse sempre percotendomi al monistero; e in presenza di tutte le suore mi diede un cavallo con quella discrizione che dimostrano i frati nel punire un frate da meno di loro se avviene che egli abbia sputato in chiesa; e fur tali e tante le scorreggiate che con la correggia del leggio mi diede, che mi s'alzò la carne per le natiche una spanna: e quello che più mi dolse fu che la badessa tenea la ragione del baccelliere. Onde io, stata otto giorni ungendomi spesso e bagnandomi con acqua rosa, feci intendere a mia madre che, se mi volea veder viva, venisse tosto: e trovandomi che non parea più dessa, credendosi che io fussi caduta inferma per le astinenze e per i mattutini, a tutti i patti del mondo volse che allora allora io fossi portata a casa; né valse ciance di suora né di monica a farmici rimanere pure un dì. E sendo a casa mia, mio padre, che temea più mia madre che non temo io non so che, di subito volea correre per il medico: e non fu lasciato per buon rispetto. E non potendo io celare il male da basso, dove lo staffile si era maneggiato come si maneggiano le mazze dei fanciulli la sera della settimana santa per le predelle degli altari e per le porte delle chiese dopo gli uffici, dissi che per macerare la carne, sedendo sopra un pettine dalla stoppa, ciò mi era avvenuto: ghignò mia madre alla scusa magra, perché i denti del pettine mi avrieno passato il core, non pure il culo (sano il tuo sia); e per lo meglio si tacque. ANTONIA Io comincio a credere che sia il vero che tu abbia dei guai per la Pippa in quanto al farla monica; e ora mi ricorda che quella benedetta anima di mia madre solea dire che una suora di un monestero, acciò che tutti i medici le mettessero lo orinale nella vesta, fingea ogni terzo dì di avere tutti i mali. NANNA Io so ben chi ella fu, e non la ho conta per lunghezza. Ora, da che io ti ho tenuta tuttodì oggi con le ciance, vo' che ne venga istasera meco. ANTONIA Ciò che ti piace. NANNA E mi aiterai a sbrigar di alcune cosette; e poi domane dopo disinare, in questa mia vigna, sotto a questa proprio ficaia, entreremo alla vita delle maritate. ANTONIA Eccomi per servirti. E così detto, sanza ingombrarsi di veruna cosa della vigna, avviaro a casa di Nanna che stava alla Scrofa: dove giunte in su lo annottarsi, la Pippa fece alla Antonia molte carezze; e così venuta la ora di cena, cenaro; e state così un poco, giro a dormire. FINE DE LA PRIMA GIORNATA 92 Torquato Tasso, Discorsi del poema eroico [Ed. in Prose, a cura di Ettore Mazzali e Francesco Flora, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959] Libro secondo […] Ecco, illustrissimo signore, le condizioni che giudizioso poeta dee ne la materia ricercare: le quali, riepilogando in breve giro di parole quanto s'è detto, sono queste: l'autorità de l'istoria, la verità de la religione, la licenza del fingere, la qualità de' tempi accomodati e la grandezza de gli avenimenti. Ma questa, prima che sia caduta sotto l'artificio de l'epico, materia si chiama: dopo ch'è stata dal poeta disposta e trattata e con l'elocuzione è vestita, se ne forma la favola, la qual non è più materia, ma è forma ed anima del poema; e tale è da Aristotele giudicata. Ma il poema non è forma semplice, perché egli è composto di materia e di forma. Ma avendo nel principio di questo Discorso assomigliata quella materia che fu detta nuda a quella che chiamano i naturali materia prima, giudico che, sì come ne la materia prima, benché priva d'ogni forma, nondimeno vi si considera da' filosofi la quantità, la quale è perpetua ed eterna compagna di lei, ed innanzi il nascimento de la forma vi si ritrova, e dopo la sua corruzione vi rimane; così anco il poeta debba in questa nostra materia, innanzi ad ogn'altra cosa, la quantità considerare: però che è necessario che, togliendo egli a trattare alcuna materia, la toglia accompagnata d'alcuna quantità. Avertisca dunque che la quantità ch'egli prende non sia tanta che, volend'egli poi, nel formare la testura de la favola, interserirvi molti episodi, e adornare ed illustrare le cose che semplici sono in sua natura, il poema cresca in tanta grandezza che disconvenevol paia e dismisurato: però che non dee il poema eccedere una certa determinata grandezza, come nel suo luogo si tratterà: ché s'egli vorrà pure schivare questa dismisura e questo eccesso, sarà necessitato lasciare le digressioni e gli altri ornamenti che sono necessari al poema, e quasi rimanersi ne' puri e semplici termini de l'istoria. Il che a Lucano ed a Silio Italico si vede in qualche parte avvenuto, l'una e l'altro de' quali troppo ampia e copiosa materia abbracciò: perché quegli non solamente la giornata di Farsaglia, come dinota il titolo, ma tutta la guerra civile fra Cesare e Pompeo, questi tutta la seconda guerra africana prese a trattare: le quali materie, sendo in se stesse ampissime, erano atte ad occupare tutto quello spazio ch'è conceduto a la grandezza de l'epopeia, non lasciando luogo alcuno a l'invenzione ed a l'ingegno del poeta; ed alcune volte paragonando le medesime cose trattate da Silio poeta e da Livio istorico, molto più asciuttamente e con minor ornamento mi par di vederle nel poeta che ne l'istorico, al contrario apunto di quello che la natura de le cose richiederebbe. Di questa riprensione non è afatto sicuro Stazio, benché abbia l'invenzione poetica; nondimeno, cominciando da i primi principii de la guerra, disprezza l'ammaestramento d'Orazio e spende molti libri prima c'abbia condotti i Greci sotto Tebe; e la venuta di Teseo nel fine e la battaglia che si fa per dar sepoltura a i morti pare quasi soggetto d'un altro poema. A questa medesima è soggetto il Trissino. Ciascuno in somma che materia troppo ampia si propone, è costretto d'allungare il poema oltre il convenevol termine (la qual soverchia lunghezza sarebbe forse nel'Innamorato e nel Furioso, chi questi due libri, distinti di titolo e d'autore, quasi un sol poema considerasse, come in effetto sono); o almeno è sforzato di lasciare gli episodi e gli altri ornamenti, i quali sono necessari al poeta. Maraviglioso fu in questa parte il giudizio d'Omero, il quale, avendo propostasi materia assai breve, quella accresciuta d'episodi e ricca d'ogn'altra maniera d'ornamento a lodevole e conveniente grandezza ridusse. Più ampia alquanto la si propose Virgilio, come colui che tanto in un sol poema raccoglie quanto in due poemi d'Omero si contiene; ma non però di tanta ampiezza la scelse che 'n alcuno di que' duo vizi sia costretto di cadere. Con tutto ciò se ne va a le volte così ristretto che sebben quella gravità e brevità sua è maravigliosa e inimitabile, non ha peraventura tanto del poetico quanto la faconda copia d'Omero. E mi ricordo in questo proposito aver udito dire da lo Sperone (uomo eccelentissimo, la cui privata camera, mentre io in Padova studiava, era solito di frequentare non meno spesso e volentieri che le publiche scuole, parendomi che mi rappresentasse la sembianza di quella Accademia e di quel Liceo in cui Socrate e Platone aveano in uso di disputare), mi ricordo d'aver udito da lui che 'l nostro poeta latino è più simile al greco oratore ch'al greco poeta, e 'l nostro latino oratore ha maggior conformità co 'l poeta greco che con l'orator greco; ma che l'oratore e 'l poeta greco aveano ciascuno per sì conseguita quella virtù ch'era propria de l'arte sua, ove l'uno e l'altro latino avea più tosto usurpata quell'eccelenza che a l'arte altrui era conveniente. Ed in vero chi vorrà sottilmente esaminare la maniera di ciascun di loro, vedrà che quella copiosa eloquenza di Cicerone è molto conforme con la larga facondia d'Omero, sì come ne l'acume e ne la pienezza e nel nervo d'una illustre brevità sono molto somiglianti Demostene e Virgilio. Raccogliendo dunque quanto s'è detto, dee la quantità de la materia nuda esser tanta e non più che possa da l'artificio del poeta ricever molto accrescimento, senza passare i termini de la convenevole grandezza. Ma poiché s'è ragionato del giudizio che dee mostrare il poeta intorno a la scelta de lo argomento, l'ordine richiede che nel seguente Discorso si tratti de l'arte con la quale deve esser disposto e formato. LIBRO TERZO Credono molti, illustrissimo signore, che de le scienze e de l'arti più nobili sia avvenuto come de' popoli, e de le province, e de le terre, e de' mari, molti de' quali non erano ben conosciuti da gli antichi, ma di nuovo son ritrovati oltre le Colonne d'Ercole verso Occidente, overo di là da gli altari che pose Alessandro ne l'Oriente: e rassimigliano costoro gli ammaestramenti de l'arte poetica e de la retorica a le mete ed a' segni i quali son posti per termini a' timidi naviganti. Ma sì come io non biasimo l'ardire guidato da la ragione, così non lodo l'audacia senza consiglio, parendomi pazzia ch'altri voglia fare arte del caso, virtù del vizio e prudenza de la temerità, e tutto concedere a la fortuna, la qual ha minor 93 parte ne l'operazioni de l'ingegno che ne le fatiche del corpo: tuttavolta in quelle medesime che si fanno con la parte men nobile, cerchiamo di moderare i fortunosi avvenimenti e di restringerli quasi sotto alcuna legge. Laonde molto più debbiamo considerare l'operazioni de l'intelletto, a cui sempre è proposto a guisa di segno un obietto medesimo nel quale ei rimira: e questo è il vero, il quale non si muta già mai, né sparisce a gli occhi de la mente. Ma l'Orse si celano a coloro ch'avendo passato Abila e Calpe, navigano ne l'ampissimo oceano: nondimeno altre stelle sono in quello emispero, con le quali essi deono reggere il corso; altrimente non avrebbono arte alcuna del navigare; e possono in qualche modo schifare l'incostanza de le maritime cose con la costanza de le celesti. Ma quanto sono più stabili, quanto più vere, quanto più certe le cose intellettuali, a le quali drizziamo l'intelletto? e se pur talvolta consideriamo le cose verisimili, non possiamo aver altra notizia di loro, se non quella che ci dà la cognizione del vero. Però andiamo formando l'idee de le cose artificiali: ne la quale operazione ci pare d'esser quasi divini e d'imitare il primo artefice. Ma qualunque sia questo nostro artificio, da niuno altro può esser meglio estimato. Legga dunque V. S. illustrissima quel ch'io discorro con lei quasi in un ragionamento: perché s'egli è gran difficoltà il ritrovare il vero fra le cose verisimili, il giudicarlo non è minor lode, o a la filosofia men conveniente. Scelta ch'averà il poeta materia per se stessa capace d'ogni perfezione, gli rimane l'altra assai più difficile fatica, che è di darle forma e disposizion poetica; intorno al quale officio, come intorno a proprio soggetto, quasi tutta la virtù de l'arte si manifesta. Ma però che quello che principalmente constituisce e determina la natura de la poesia, e la fa da l'istoria differente, non è il verso, come dice Aristotele (perché facendosi in versi l'istoria d'Erodoto, non sarebbe meno istoria), ma è il considerare le cose non come sono state, ma in quella guisa che dovrebbono essere state, avendo riguardo più tosto a l'universale che a la verità de' particolari, prima d'ogni altra cosa dee il poeta avvertire se ne la materia ch'egli prende a trattare sia avvenimento alcuno, il quale, altrimente essendo succeduto, fosse più meraviglioso e verisimile o per qualsivoglia altra cagione portasse maggior diletto; e tutti i successi che sì fatti troverà, cioè che meglio in un altro modo potessero essere avvenuti, senza rispetto alcuno di vero o d'istoria a sua voglia muti e rimuti, ordini e riordini, e riduca gli accidenti de le cose a quel modo ch'egli giudica migliore, mescolando il vero co 'l finto, ma in guisa che 'l vero sia fondamento de la favola, come insegna Aristotele ne la Retorica ed Alessandro Piccolomini nel suo libro De le stelle. Questo esempio ci diede Omero, il quale ci ammaestra con la favola e con l'istoria (come disse Dione Crisostomo, e prima di lui Strabone scrisse) che i poeti interpongono la falsità ne le cose vere e le favole ne le vere contemplazioni, come fa colui che fonde l'oro intorno a l'argento. Ebbe opinione il medesimo autore che la licenza de' poeti abbia queste tre parti: l'istoria, la favola e la disposizione; e che 'l fine de l'istoria sia la verità, de la disposizione l'espressione, de la favola il piacere; ma che 'l fingere tutte le cose non convenga, né paresse ad Omero conveniente. Virgilio ancora ne gli errori d'Enea e ne la guerra fatta fra lui e Latino non scrisse solamente le cose che vere estimò, ma quelle che giudicò migliori e più eccelenti: perché non solo è falso l'amore e la morte di Didone, e favoloso quello che scrive di Polifemo e de lo scender d'Enea a l'inferno; ma le battaglie fra lui e i popoli del Lazio descrive altrimente di quello ch'avvennero secondo la verità, come si conosce chiaramente paragonando il suo poema con l'istoria di Dionigio Alicarnasseo e d'altri greci e latini c'hanno scritto davanti e dopo lui. Egli in Didone confuse di tanto spazio l'ordine de' tempi con quella figura che da' Greci è detto anakhronismos o più tosto con quella licenza che fu prima di Platone e de' poeti greci ch'introdussero insieme a ragionare persone vissute in secoli differenti, come nota Ateneo nel Convito de' Dinosofisti. Questa licenza fu parimente d'Ovidio ne le sue Trasformazioni, nel fine de le quali Pitagora, italiano filosofo, ammaestra Numa re de' Romani, quantunque sia più certa opinione che Pitagora nascesse dopo qualche centinaio di anni. La medesima dottrina o 'l medesimo artificio del mescolare il vero co 'l falso o co 'l finto si può raccogliere da Orazio e da Plutarco nel principio de la Vita di Teseo, da Macrobio nel Sogno di Scipione e da Servio sopra Virgilio, e molto prima da' platonici scrittori, e da Platone medesimo, e da Xenofonte nel suo Ciro; e quantunque egli non fosse poeta, ma filosofo ed istorico, nondimeno, nell'avere risguardo a l'universale ed a l'idea, fu più somigliante a' poeti ch'a gli istorici; ma di questa mescolanza non fu lodato «Erodoto di greca istoria padre», e ne gli oratori fu biasimata. Laonde Isocrate riprende Policrate de l'errore e de la confusione de' tempi, ne la quale, seguendo la favolosa licenza de' poeti, finge che fussero in un medesimo tempo Ercole e Busiride, avenga che molto prima nascesse Busiride, sì come colui che fu anteriore a Perseo di anni più di ducento, e Perseo nacque avanti ad Ercole quattro secoli intieri: talché tra il primo e l'ultimo furono interposte sei età. Con queste autorità e de' nuovi e de' vecchi scrittori può esser difeso Virgilio; ma egli forse cercò occasione di mescolare tra la severità de l'altre materie i piacevoli ragionamenti d'amore, quantunque seguisse la morte di Didone, fiero ed infelice avvenimento; o più tosto volle assignare un'alta ed ereditaria cagione de le inimicizie tra' Romani e Cartaginesi: ne la quale fu poi imitato da Silio Italico ch'introduce Annibale giovanetto, anzi fanciullo, a giurare perpetua inimicizia contra i Romani, così persuaso da Amilcare suo padre. Ma con l'artificiosa narrazione de la rovina e de l'incendio di Troia rimosse Virgilio da gli animi quella suspizione che s'ebbe d'Enea: perché egli fu sospetto di tradimento, come dice Servio; e con le parole dette da Diomede a gli ambasciatori de' Latini l'onorò più che non avea fatto Omero ne la sua Iliade; e v'aggiunse la favola di Polifemo, de la Sibilla, e la conversione de le navi in ninfe, per accoppiare il maraviglioso col verisimile; e raccontò diversamente la morte di Turno; non volle far menzione di quella d'Enea, se non accennando ch'egli al fine accrescerebbe il numero de gl'iddii; v'aggiunse quella d'Amata; mutò gli avvenimenti e l'ordine de le battaglie per accrescer la gloria d'Enea e terminar con un fine più perfetto il suo nobilissimo poema. A queste finzioni fu molto favorevole l'antichità de' tempi; ma non dee peraventura la licenza de' poeti stendersi tanto oltre ch'ardisca di mutar l'ultimo fine de l'imprese ch'egli 94 prende a trattare, o pur narrare al contrario di quello che sono avvenuti alcuni de gli avvenimenti principali e più noti che già sono ricevuti per veri ne la notizia del mondo. Simile audacia mostrarebbe colui che descrivesse Roma vinta e Cartagine vincitrice, o Annibale vincitore in campo aperto di Fabio Massimo, non con arte tenuto a bada; quantunque si legga ne' Paralleli di Plutarco che Fabio ne la guerra africana fosse mandato da' Romani con cinquecento soldati contra Annibale e che, spronando furiosamente il cavallo, gli cavasse il diadema e poi gli morisse appresso, avendo prima ricevuta una mortalissima ferita. 95 Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi [ed. a cura di Libero Sosio, Torino, Einaudi, 1970] AL DISCRETO LETTORE Si promulgò a gli anni passati in Roma un salutifero editto, che, per ovviare a' pericolosi scandoli dell'età presente imponeva opportuno silenzio all'opinione Pittagorica della mobilità della Terra. Non mancò chi temerariamente asserì, quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata, e si udirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina tarpar l'ale a gl'intelletti speculativi. Non poté tacer il mio zelo in udir la temerità di sì fatti lamenti. Giudicai, come pienamente instrutto di quella prudentissima determinazione, comparir publicamente nel teatro del mondo, come testimonio di sincera verità. Mi trovai allora presente in Roma; ebbi non solo udienze, ma ancora applausi de i più eminenti prelati di quella Corte; né senza qualche mia antecedente informazione seguì poi la publicazione di quel decreto. Per tanto è mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere, che di questa materia se ne sa tanto in Italia, e particolarmente in Roma, quanto possa mai averne imaginato la diligenza oltramontana; e raccogliendo insieme tutte le speculazioni proprie intorno al sistema Copernicano, far sapere che precedette la notizia di tutte alla censura romana, e che escono da questo clima non solo i dogmi per la salute dell'anima, ma ancora gl'ingegnosi trovati per delizie degl'ingegni. A questo fine ho presa nel discorso la parte Copernicana, procedendo in pura ipotesi matematica, cercando per ogni strada artifiziosa di rappresentarla superiore, non a quella della fermezza della Terra assolutamente, ma secondo che si difende da alcuni che, di professione Peripatetici, ne ritengono solo il nome, contenti, senza passeggio, di adorar l'ombre, non filosofando con l'avvertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principii mal intesi. Tre capi principali si tratteranno. Prima cercherò di mostrare, tutte l'esperienze fattibili nella Terra essere mezi insufficienti a concluder la sua mobilità, ma indifferentemente potersi adattare così alla Terra mobile, come anco quiescente; e spero che in questo caso si paleseranno molte osservazioni ignote all'antichità. Secondariamente si esamineranno li fenomeni celesti, rinforzando l'ipotesi copernicana come se assolutamente dovesse rimaner vittoriosa, aggiungendo nuove speculazioni, le quali però servano per facilità d'astronomia, non per necessità di natura. Nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa. Mi trovavo aver detto, molti anni sono, che l'ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricever qualche luce, ammesso il moto terrestre. Questo mio detto, volando per le bocche degli uomini, aveva trovato padri caritativi che se l'adottavano per prole di proprio ingegno. Ora, perché non possa mai comparire alcuno straniero che, fortificandosi con l'armi nostre, ci rinfacci la poca avvertenza in uno accidente così principale, ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile, dato che la Terra si movesse. Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà, che se altre nazioni hanno navigato più, noi non abbiamo speculato meno, e che il rimettersi ad asserir la fermezza della Terra, e prender il contrario solamente per capriccio matematico, non nasce da non aver contezza di quant'altri ci abbia pensato, ma, quando altro non fusse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza, e la coscienza della debolezza dell'ingegno umano, ci somministrano. Ho poi pensato tornare molto a proposito lo spiegare questi concetti in forma di dialogo, che, per non esser ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche, porge campo ancora a digressioni, tal ora non meno curiose del principale argomento. Mi trovai, molt'anni sono, più volte nella maravigliosa città di Venezia in conversazione col signor Giovan Francesco Sagredo, illustrissimo di nascita, acutissimo d'ingegno. Venne là di Firenze il signor Filippo Salviati, nel quale il minore splendore era la chiarezza del sangue e la magnificenza delle ricchezze; sublime intelletto, che di niuna delizia più avidamente si nutriva, che di specolazioni esquisite. Con questi due mi trovai spesso a discorrer di queste materie, con l'intervento di un filosofo peripatetico, al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per l'intelligenza del vero, che la fama acquistata nell'interpretazioni Aristoteliche. Ora, poiché morte acerbissima ha, nel più bel sereno de gli anni loro, privato di quei due gran lumi Venezia e Firenze, ho risoluto prolungar, per quanto vagliono le mie debili forze, la vita alla fama loro sopra queste mie carte, introducendoli per interlocutori della presente controversia. Né mancherà il suo luogo al buon Peripatetico, al quale, pel soverchio affetto verso i comenti di Simplicio, è parso decente, senza esprimerne il nome, lasciarli quello del reverito scrittore. Gradiscano quelle due grand'anime, al cuor mio sempre venerabili, questo publico monumento del mio non mai morto amore, e con la memoria della loro eloquenza mi aiutino a spiegare alla posterità le promesse speculazioni. Erano casualmente occorsi (come interviene) varii discorsi alla spezzata tra questi signori, i quali avevano più tosto ne i loro ingegni accesa, che consolata, la sete dell'imparare: però fecero saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme, nelle quali, bandito ogni altro negozio, si attendesse a vagheggiare con più ordinate speculazioni le maraviglie di Dio nel cielo e nella terra. Fatta la radunanza nel palazzo dell'illustrissimo Sagredo, dopo i debiti, ma però brevi, complimenti, il signor Salviati in questa maniera incominciò. GIORNATA PRIMA INTERLOCUTORI: Salviati, Sagredo e Simplicio SALV. 96 Fu la conclusione e l'appuntamento di ieri, che noi dovessimo in questo giorno discorrere, quanto più distintamente e particolarmente per noi si potesse, intorno alle ragioni naturali e loro efficacia, che per l'una parte e per l'altra sin qui sono state prodotte da i fautori della posizione Aristotelica e Tolemaica e da i seguaci del sistema Copernicano. E perché, collocando il Copernico la Terra tra i corpi mobili del cielo, viene a farla essa ancora un globo simile a un pianeta, sarà bene che il principio delle nostre considerazioni sia l'andare esaminando quale e quanta sia la forza e l'energia de i progressi peripatetici nel dimostrare come tale assunto sia del tutto impossibile; attesoché sia necessario introdurre in natura sustanze diverse tra di loro, cioè la celeste e la elementare, quella impassibile ed immortale, questa alterabile e caduca. Il quale argomento tratta egli ne i libri del Cielo, insinuandolo prima con discorsi dependenti da alcuni assunti generali, e confermandolo poi con esperienze e con dimostrazioni particolari. Io, seguendo l'istesso ordine, proporrò, e poi liberamente dirò il mio parere; esponendomi alla censura di voi, ed in particolare del signor Simplicio, tanto strenuo campione e mantenitore della dottrina Aristotelica. È il primo passo del progresso peripatetico quello dove Aristotile prova la integrità e perfezione del mondo coll'additarci com'ei non è una semplice linea né una superficie pura, ma un corpo adornato di lunghezza, di larghezza e di profondità e perché le dimensioni non son più che queste tre, avendole egli, le ha tutte ed avendo il tutto, è perfetto. Che poi, venendo dalla semplice lunghezza costituita quella magnitudine che si chiama linea, aggiunta la larghezza si costituisca la superficie, e sopragiunta l'altezza o profondità ne risulti il corpo, e che doppo queste tre dimensioni non si dia passaggio ad altra, sì che in queste tre sole si termini l'integrità e per così dire la totalità, averei ben desiderato che da Aristotile mi fusse stato dimostrato con necessità, e massime potendosi ciò esequire assai chiaro e speditamente. SIMP. Mancano le dimostrazioni bellissime nel 2o, 3o e 4o testo, doppo la definizione del continuo? Non avete, primieramente, che oltre alle tre dimensioni non ve n'è altra, perché il tre è ogni cosa, e 'l tre è per tutte le bande? e ciò non vien egli confermato con l'autorità e dottrina de i Pittagorici, che dicono che tutte le cose son determinate da tre, principio mezo e fine, che è il numero del tutto? E dove lasciate voi l'altra ragione, cioè che, quasi per legge naturale, cotal numero si usa ne' sacrifizii degli Dei? e che, dettante pur così la natura, alle cose che son tre, e non a meno, attribuiscono il titolo di tutte? perché di due si dice amendue, e non si dice tutte; ma di tre, sì bene. E tutta questa dottrina l'avete nel testo 2o. Nel 3o poi, ad pleniorem scientiam, si legge che l'ogni cosa, il tutto, e 'l perfetto, formalmente son l'istesso; e che però solo il corpo tra le grandezze è perfetto, perché esso solo è determinato da 3, che è il tutto, ed essendo divisibile in tre modi, è divisibile per tutti i versi: ma dell'altre chi è divisibile in un modo, e chi in dua, perché secondo il numero che gli è toccato, così hanno la divisione e la continuità; e così quella è continua per un verso, questa per due, ma quello, cioè il corpo, per tutti. Di più nel testo 4o, doppo alcune altre dottrine, non prov'egli l'istesso con un'altra dimostrazione, cioè che non si facendo trapasso se non secondo qualche mancamento (e così dalla linea si passa alla superficie, perché la linea è manchevole di larghezza), ed essendo impossibile che il perfetto manchi, essendo egli per tutte le bande, però non si può passare dal corpo ad altra magnitudine? Or da tutti questi luoghi non vi par egli a sufficienza provato, com'oltre alle tre dimensioni lunghezza, larghezza e profondità, non si dà transito ad altra, e che però il corpo, che le ha tutte, è perfetto? SALV. Io, per dire il vero, in tutti questi discorsi non mi son sentito strignere a concedere altro se non che quello che ha principio, mezo e fine, possa e deva dirsi perfetto: ma che poi, perché principio, mezo e fine son 3, il numero 3 sia numero perfetto, ed abbia ad aver facultà di conferir perfezione a chi l'averà, non sento io cosa che mi muova a concederlo; e non intendo e non credo che, verbigrazia, per le gambe il numero 3 sia più perfetto che 'l 4 o il 2, né so che 'l numero 4 sia d'imperfezione a gli elementi e che più perfetto fusse ch'e' fusser 3. Meglio dunque era lasciar queste vaghezze a i retori e provar il suo intento con dimostrazione necessaria, che così convien fare nelle scienze dimostrative. SIMP. Par che voi pigliate per ischerzo queste ragioni: e pure è tutta dottrina de i Pittagorici, i quali tanto attribuivano a i numeri; e voi, che sete matematico, e, credo anco in molte opinioni filosofo Pittagorico, pare che ora disprezziate i lor misteri. SALV. Che i Pittagorici avessero in somma stima la scienza de i numeri, e che Platone stesso ammirasse l'intelletto umano e lo stimasse partecipe di divinità solo per l'intender egli la natura de' numeri, io benissimo lo so, né sarei lontano dal farne l'istesso giudizio; ma che i misteri per i quali Pittagora e la sua setta avevano in tanta venerazione la scienza de' numeri sieno le sciocchezze che vanno per le bocche e per le carte del volgo, non credo io in veruna maniera; anzi perché so che essi, acciò le cose mirabili non fussero esposte alle contumelie e al dispregio della plebe, dannavano come sacrilegio il publicar le più recondite proprietà de' numeri e delle quantità incommensurabili ed irrazionali da loro investigate, e predicavano che quello che le avesse manifestate era tormentato nell'altro mondo, penso che tal uno di loro, per dar pasto alla plebe e liberarsi dalle sue domande, gli dicesse, i misterii loro numerali esser quelle leggerezze che poi si sparsero tra il vulgo; e questo con astuzia ed accorgimento simile a quello del sagace giovane che, per torsi dattorno l'importunità non so se della madre o della curiosa moglie, che l'assediava acciò le conferisse i segreti del senato, compose quella favola onde essa con molte altre donne rimasero dipoi, con gran risa del medesimo senato, schernite. 97 SIMP. Io non voglio esser nel numero de' troppo curiosi de' misterii de' Pittagorici; ma stando nel proposito nostro, replico che le ragioni prodotte da Aristotile per provare, le dimensioni non esser, né poter esser, più di tre, mi paiono concludenti; e credo che quando ci fusse stata dimostrazione più necessaria, Aristotile non l'avrebbe lasciata in dietro. SAGR. Aggiugnetevi almanco, se l'avesse saputa, o se la gli fusse sovvenuta. Ma voi, signor Salviati, mi farete ben gran piacere di arrecarmene qualche evidente ragione, se alcuna ne avete così chiara, che possa esser compresa da me. […] Libro terzo SALV. Dichiarate queste cose, è tempo che venghiamo a esaminare i particolari accidenti, e loro diversità, che ne' flussi e reflussi dell'acque per esperienza si osservano. E prima, non dovremo aver difficultà nell'intendere, onde accaggia che ne i laghi, stagni, ed anco ne i mari piccoli, non sia notabil flusso e reflusso: il che ha due concludentissime ragioni. L'una è, che, per la brevità del vaso, nell'acquistare egli in diverse ore del giorno diversi gradi di velocità, con poca differenza vengano acquistati da tutte le sue parti; ma tanto le precedenti quanto le susseguenti, cioè l'orientali e l'occidentali, quasi nell'istesso modo si accelerano e si ritardano; facendosi, di più, tale alterazione a poco a poco, e non con l'opporre un repentino intoppo e ritardamento o una subitanea e grande accelerazione al movimento del vaso contenente, ed esso e tutte le sue parti vengon lentamente ed egualmente impressionandosi de i medesimi gradi di velocità: dalla quale uniformità ne séguita che anco l'acqua contenuta, con poca contumacia e renitenza riceva le medesime impressioni, e per conseguenza molto oscuramente dia segno d'alzarsi o abbassarsi, scorrendo verso questa o verso l'altra estremità; il quale effetto si vede ancora manifestamente ne' piccoli vasi artifiziali, ne i quali l'acqua contenuta si va impressionando de gl'istessi gradi di velocità, tuttavoltaché l'accelerazione o ritardamento si faccia con lenta ed uniforme proporzione. Ma ne i seni de i mari che per grande spazio si distendono da levante a ponente, assai più notabile e difforme è l'accelerazione o 'l ritardamento, mentre una delle sue estremità si troverà in un moto assai ritardato, e l'altra sarà ancora di moto velocissimo. La seconda causa è la reciproca librazion dell'acqua, proveniente dall'impeto che ella pure avesse concepito dal moto del suo continente, la qual librazione ha, come si è notato, le sue vibrazioni molto frequenti ne i vasi piccoli: dal che ne risulta, che risedendo ne i movimenti terrestri cagione di contribuire all'acque movimento solo di dodici in dodici ore, poi che una volta sola il giorno sommamente si ritarda e sommamente si accelera il movimento de i vasi contenenti, nientedimeno l'altra seconda cagione, dependente dalla gravità dell'acqua, che cerca ridursi all'equilibrio e, secondo la brevità del vaso, ha le sue reciprocazioni o di un'ora o di due o di tre etc., questa mescolandosi con la prima, che anco per sé ne i vasi piccoli resta piccolissima, la vien del tutto a render insensibile; imperocché, non si essendo ancora finita di imprimer la commozione procedente dalla cagion primaria, che ha i periodi di 12 ore, sopravvien, contrariando, l'altra secondaria, dependente dal proprio peso dell'acqua, la quale, secondo la cortezza e profondità del vaso, ha il tempo delle sue vibrazioni di 1, 2, 3 o 4 ore, etc., e, contrariando alla prima, la perturba e rimuove, senza lasciarla giugnere al sommo né al mezo del suo movimento. E da tal contrapposizione resta annichilata in tutto, o molto oscurata, l'evidenza del flusso e reflusso. Lascio stare l'alterazion continua dell'aria, la quale, inquietando l'acqua, non ci lascerebbe venire in certezza d'un piccolissimo ricrescimento o abbassamento di mezo dito o di minor quantità, che potesse realmente risedere ne i seni e ricetti di acque non più lunghi di un grado o due. Vengo, nel secondo luogo, a sciorre il dubbio, come, non risedendo nel primario principio cagione di commuover l'acque se non di 12 in 12 ore, cioè una volta per la somma velocità di moto e l'altra per la massima tardità, nulladimeno apparisce comunemente il periodo de i flussi e reflussi esser di sei in sei ore. Al che si risponde che tale determinazione non si può in verun modo avere dalla cagion primaria solamente, ma vi bisogna inserire le secondarie, cioè la lunghezza maggiore o minore de i vasi, e la maggiore o minor profondità dell'acque in essi contenute: le quali cagioni, se ben non hanno azione veruna ne i movimenti dell'acque, essendo tale azione della sola cagion primaria, senza la quale nulla seguirebbe de' flussi e reflussi, tuttavia l'hanno principalissima nel terminar i tempi delle reciprocazioni, e così potente, che la cagion primaria convien che gli resti soggetta. Non è dunque il periodo delle 6 ore più proprio o naturale di quelli d'altri intervalli di tempi, ma ben forse il più osservato, per esser quello che compete al nostro Mediterraneo, che solo per lunghi secoli fu praticabile; ancor che né tal periodo si osserva in tutte le sue parti, atteso che in alcuni luoghi più ristretti, qual è l'Ellesponto e l'Egeo, i periodi son assai più brevi, ed anco tra di loro molto differenti, per la qual varietà e sue cagioni, incomprensibili ad Aristotile, dicono alcuni che, dopo l'averla egli lungamente osservata sopra alcuni scogli di Negroponte, tratto dalla disperazione si precipitasse in mare e spontaneamente s'annegasse. Avremo, nel terzo luogo, molto spedita la ragione, onde avvenga che alcun mare, benché lunghissimo, qual è il Mar Rosso, nulladimeno è quasi del tutto esente da i flussi e reflussi. La qual cosa accade, perché la sua lunghezza non si distende dall'oriente verso l'occidente, anzi traversa da sirocco verso maestro: ma essendo i movimenti della Terra da occidente in oriente, gli impulsi dell'acque vanno sempre a ferire ne i meridiani, e non si muovono di parallelo in parallelo; onde ne i mari che traversalmente si distendono verso i poli, e che per l'altro verso sono angusti, non resta cagione di flussi e reflussi se non per la participazione di altro mare co 'l quale comunicassero, che fusse soggetto a movimenti grandi. 98 Intenderemo, nel quarto luogo, molto facilmente la ragione, perché i flussi e reflussi siano massimi, quanto all'alzarsi ed abbassarsi le acque, ne gli estremi de' golfi, e minimi nelle parti di mezo: come la quotidiana esperienza ne mostra qui in Venezia, posta nell'estremità dell'Adriatico, dove comunemente tal diversità importa 5 o 6 piedi; ma ne i luoghi del Mediterraneo distanti da gli estremi tal mutazione è piccolissima, come nell'isole di Corsica e Sardigna e nelle spiaggie di Roma e di Livorno, dove non passa mezo piede. Intenderemo anco come, all'incontro, dove gli alzamenti ed abbassamenti son piccoli, i corsi ed i ricorsi son grandi. Agevol cosa, dico, è l'intender la cagion di questi accidenti, poiché di essi ne aviamo riscontri manifesti in ogni sorte di vasi artifizialmente da noi fabbricati, ne i quali i medesimi effetti si veggono naturalmente seguire dal muovergli noi con movimento difforme, cioè ora accelerato ed ora ritardato. In oltre, considerando, nel quinto luogo, come la medesima quantità d'acqua, mossa, benché lentamente, per un alveo spazioso, nel dover poi passare per luogo ristretto, per necessità scorre con impeto grande, non avremo difficultà d'intendere la causa delle gran correnti che si fanno nello stretto canale che separa la Calabria dalla Sicilia, poiché tutta l'acqua che dall'ampiezza dell'isola e dal golfo Jonico vien sostenuta nella parte del mare orientale, benché in quello per la sua ampiezza lentamente descenda verso occidente, tuttavia nel ristrignersi nel bosforo tra Scilla e Cariddi rapidamente cala e fa grandissima agitazione: simile alla quale, e molto maggiore, s'intende esser tra l'Affrica e la grand'isola di S. Lorenzo, mentre le acque de i due vasti mari Indico ed Etiopico, che la mettono in mezo, devono, scorrendo, ristrignersi in minor canale, tra essa e la costa d'Etiopia. Grandissime conviene che sieno le correnti nello Stretto di Magalianes, che comunica gli oceani vastissimi Etiopico e del Sur. Séguita adesso, nel 6o luogo, che per render ragion di alcuni più reconditi ed inopinabili accidenti che in questa materia si osservano, andiamo facendo un'altra importante considerazione sopra le due principali cagioni de i flussi e reflussi, componendole poi e mescolandole insieme. La prima e più semplice delle quali è (come più volte si è detto) la determinata accelerazione e ritardamento delle parti della Terra, dalla quale arebbon l'acque un determinato periodo di scorrere verso levante e ritornar verso ponente dentro al tempo di ventiquattr'ore. L'altra è quella che depende dalla propria gravità dell'acqua, che, commossa una volta dalla causa primaria, cerca poi di ridursi all'equilibrio con iterate reciprocazioni, le quali non sono determinate da un tempo solo e prefisso, ma hanno tante diversità di tempi quante sono le diverse lunghezze e profondità de i ricetti e seni de i mari; e per quanto depende da questo secondo principio, scorrerebbero e ritornerebbero altre in un'ora, altre in 2, in 4, in 6, in 8, in 10 etc. Ora, se noi cominceremo a congiugner la cagion primaria, che ha stabilmente il suo periodo di 12 in 12 ore, con alcuna delle secondarie che avesse il suo periodo, verbigrazia, di 5 in 5, accaderà che in alcuni tempi la cagion primaria e la secondaria si accordino a far gli impulsi amendue verso la medesima parte, ed in questo congiugnimento, e per così dire unanime cospirazione, i flussi saranno grandi: in altri tempi accadendo che l'impulso primario venga in un certo modo a contrariare a quello che porterebbe il periodo secondario, ed in cotal raffronto togliendo l'uno de' principii quello che l'altro ne darebbe, si debiliteranno i moti dell'acque, e ridurrassi il mare in uno stato assai quieto e quasi immobile: ed altre volte, secondo che i due medesimi principii né del tutto si contrarieranno né del tutto andranno uniformi, si faranno altre mutazioni circa l'accrescimento e diminuzion de' flussi e reflussi. Può anco accadere che due mari assai grandi e comunicanti per qualche angusto canale s'incontrino ad aver, mediante la mistione de i due principii di moto, l'uno causa di flusso nel tempo che l'altro abbia causa di movimento contrario; nel qual caso nel canale dove essi mari comunicano si fanno agitazioni straordinarie, con movimenti opposti e vortici e bollimenti pericolosissimi, de i quali se ne hanno continue relazioni ed esperienze in fatto. Da tali discordi movimenti, dependenti non solamente dalle diverse positure e lunghezze, ma grandemente ancora dalle diverse profondità de i mari comunicanti, nasceranno in alcuni tempi varie commozioni nell'acque, sregolate ed inosservabili, le ragioni delle quali hanno assai perturbato e tuttavia perturbano i marinari, mentre le incontrano senza vedere che né impeto di venti o altra grave alterazion dell'aria ne possa esser cagione. Della qual perturbazion d'aria debbiamo in altri accidenti far gran conto, e prenderla come terza cagione ed accidentaria, potente a grandemente alterare l'osservazione de gli effetti dependenti dalle primarie e più essenziali cagioni. E non è dubbio che continuando a soffiar venti impetuosi, per esempio, da levante, sosterranno l'acque proibendoli il reflusso, onde, sopraggiugnendo all'ore determinate la seconda replica, e poi la terza, del flusso, rigonfieranno molto; e così, sostenute per alcuni giorni dalla forza del vento, si alzano più del solito, facendo straordinarie inondazioni. Dobbiamo ancora (e sarà come il settimo problema) avere avvertenza d'un'altra cagione di movimento, dependente dalla copia grande dell'acque de i fiumi che vanno a scaricarsi ne' mari non molto vasti: dove ne i canali o bosfori che con tali mari comunicano, l'acqua si vede scorrer sempre per l'istesso verso, come accade nel Bosforo Tracio sotto Costantinopoli, dove l'acqua scorre sempre dal Mar Negro verso la Propontide. Imperocché in esso Mar Negro per la sua brevità, di poca efficacia sono le cause principali del flusso e reflusso; ma all'incontro, scaricandosi in esso grandissimi fiumi, nel dover passare e sgorgar tanto profluvio d'acque per lo stretto, quivi il corso è assai notabile e sempre verso mezo giorno. Dove, di più, deviamo avvertire che tale stretto e canale, benché assai angusto, non è sottoposto alle perturbazioni come lo stretto di Scilla e Cariddi: imperocché quello ha il Mar Negro sopra verso tramontana, e la Propontide e l'Egeo co 'l Mediterraneo postogli, benché per lungo tratto, verso mezogiorno; ma già, come abbiamo notato, i mari quanto si voglino lunghi da tramontana verso mezogiorno non soggiacciono a i flussi e reflussi: ma perché lo stretto di Sicilia è traposto tra le parti del Mediterraneo distese per gran distanze da ponente a levante, cioè secondo la corrente de' flussi e reflussi, però in questo le agitazioni son molto grandi: e maggiori sarebbero 99 tra le Colonne quando lo stretto di Gibilterra s'aprisse meno; e grandissime riferiscono esser quelle dello stretto di Magalianes. Questo è quanto per ora mi sovviene di poter dirvi intorno alle cause di questo primo periodo diurno del flusso e reflusso e suoi varii accidenti, dove se hanno da propor cosa alcuna, potranno farlo, per passar poi a gli altri due periodi, mestruo ed annuo. SIMP. Non mi par che si possa negare che il discorso fatto da voi proceda molto probabilmente, argumentando, come noi dichiamo, ex suppositione, cioè posto che la Terra si muova de i due movimenti attribuitigli dal Copernico: ma quando si escludano tali movimenti, il tutto resta vano ed invalido; l'esclusion poi di tale ipotesi ci viene dall'istesso vostro discorso assai manifestamente additata. Voi con la supposizion de i due movimenti terrestri rendete ragione del flusso e reflusso, ed all'incontro, circolarmente discorrendo, dal flusso e reflusso traete l'indizio e la confermazione di quei medesimi movimenti: e passando a più specifico discorso, dite che l'acqua per esser corpo fluido, e non tenacemente annesso alla Terra, non è costretta ad ubbidir puntualmente ad ogni suo movimento, dal che inducete poi il suo flusso e reflusso. Io su le vostre stesse pedate arguisco in contrario, e dico: L'aria è assai più tenue e fluida dell'acqua, e meno annessa alla superficie terrena, alla quale l'acqua, se non per altro per la sua gravità, co 'l premergli sopra assai più che l'aria leggierissima, aderisce; adunque molto meno dovrebbe l'aria secondar i movimenti della Terra; e però quando la Terra si movesse in quella maniera, noi, abitatori di quella e da lei con simile velocità portati, dovremmo perpetuamente sentir un vento da levante, che con intollerabil forza ci ferisse: e del così dover seguire l'esperienza ci fa cotidianamente avvertiti; ché se nel correr la posta solamente con velocità di 8 o 10 miglia per ora, nell'aria tranquilla, l'incontrarla noi con la faccia ci rassembra un vento che non leggiermente ci percuota, che dovrebbe fare il nostro rapido corso di 800 o 1000 miglia per ora, contro l'aria libera da tal moto? tuttavia nulla di tale accidente sentiamo noi. SALV. A questa instanza, che ha assai dell'apparente, rispondo che è vero che l'aria è più tenue e più leggiera, e per la sua leggerezza meno aderente alla Terra, che l'acqua, tanto più grave e corpulenta; ma è poi falsa la conseguenza che voi deducete da queste condizioni, cioè che per tal sua leggerezza tenuità e minore aderenza alla Terra ella dovesse esentarsi più dell'acqua dal secondare i movimenti terrestri, onde a noi, che totalmente gli partecipiamo, tal sua inobbedienza si facesse sensibile e manifesta: anzi accade tutto l'opposito. Imperocché, se voi ben vi ricordate, la causa del flusso e reflusso dell'acqua, assegnata da noi, consiste nel non secondar l'acqua la disegualità del moto del suo vaso, ma ritener l'impeto concepito per avanti, senza diminuirlo o crescerlo con quella precisa misura che si accresce o diminuisce nel suo vaso: perché dunque nella conservazione e mantenimento dell'impeto concepito prima consiste l'inobbedienza ad un nuovo agumento o diminuzion di moto, quel mobile che sarà più atto a tal conservazione, sarà anco più accomodato a dimostrar l'effetto che a tal conservazione viene in conseguenza. Ora, quanto sia l'acqua disposta a mantenere una concepita agitazione, benché cessi la causa che l'impresse, l'esperienza de i mari altamente commossi da venti impetuosi ce lo dimostra, l'onde de i quali, benché tranquillata l'aria e cessato il vento, per lungo tempo restano in moto, come leggiadramente cantò il Poeta sacro: «Qual l'alto Egeo» etc.: ed il continuar in tal guisa nella commozione depende dalla gravità dell'acqua; imperocché come altra volta s'è detto, i corpi leggieri son ben più facili ad esser mossi che i più gravi, ma son ben tanto meno atti a conservar il moto impressoli, cessante la causa movente; onde l'aria, come in se stessa tenuissima e leggierissima, è agevolissimamente mobile da qualsivoglia minima forza, ma è anco inettissima a conservare il moto, cessante il motore. Però quanto all'aria che circonda il globo terrestre, direi che, per la sua aderenza, non meno che l'acqua venga portata in giro, e massime quella parte che è contenuta da i vasi, i quali vasi sono le pianure circondate da i monti; e questa tal porzione possiamo noi molto più ragionevolmente affermare che sia portata in volta, rapita dall'asprezza della Terra, che la superiore, rapita dal moto celeste, come asserite voi Peripatetici. Quanto sin qui ho detto mi pare assai competente risposta all'instanza del signor Simplicio; tuttavia voglio con nuova obbiezione e con nuova risposta, fondata sopra una mirabile esperienza, soprabbondantemente dar sodisfazione ad esso, e confermare al signor Sagredo la mobilità del globo terrestre. Ho detto, l'aria, ed in particolare quella parte di lei che non si eleva sopra la sommità delle più alte montagne, esser dall'asprezza della terrestre superficie portata in giro; dal che pare che in conseguenza ne venga, che quando la superficie della Terra non fusse ineguale, ma tersa e pulita, non resterebbe cagione per tirarsi in compagnia l'aria, o almeno per condurla con tanta uniformità. Ora, la superficie di questo nostro globo non è tutta scabrosa ed aspera, ma vi sono grandissime piazze ben lisce, cioè le superficie di mari amplissimi, le quali, sendo anco lontanissime da i gioghi de i monti che le circondino, non par che possano aver facultà di condur seco l'aria sopreminente; e non la conducendo, si dovrebbe in quei luoghi sentir quello che in conseguenza ne viene. SIMP. Questa medesima difficultà volevo io ancora promuovere, la qual mi pare esser di grand'efficacia. SALV. Voi parlate benissimo: di maniera che, signor Simplicio, dal non si sentir nell'aria quello che in conseguenza accaderebbe quando questo nostro globo andasse in volta, voi argumentate la sua immobilità. Ma quando questo, che vi par che per necessaria conseguenza sentir si dovesse, in fatto e per esperienza si sentisse, l'accettereste voi per indizio ed argomento assai gagliardo per la mobilità del medesimo globo? 100 SIMP. In questo caso non bisogna parlar con me solo perché quando ciò accadesse, e che a me ne fusse occulta la causa, forse ad altri potrebbe esser nota. SALV. Talché con esso voi non si può mai guadagnare, ma sempre si sta su 'l perdere, e però sarebbe meglio non giocare; tuttavia, per non piantare il terzo, seguirò avanti. Dicevamo pur ora, e con qualche aggiunta replico, che l'aria, come corpo tenue e fluido e non saldamente congiunto alla Terra, pareva che non avesse necessità d'obbedire al suo moto, se non in quanto l'asprezza della superficie terrestre ne rapisce e seco porta una parte a sé contigua, che di non molto intervallo sopravanza le maggiori altezze delle montagne: la qual porzion d'aria tanto meno dovrà esser renitente alla conversion terrestre, quanto che ella è ripiena di vapori fumi ed esalazioni, materie tutte participanti delle qualità terrene, e per conseguenza atte nate per lor natura a i medesimi movimenti. Ma dove mancassero le cause del moto, cioè dove la superficie del globo avesse grandi spazii piani e meno vi fusse della mistione de i vapori terreni, quivi cesserebbe in parte la causa per la quale l'aria ambiente dovesse totalmente obbedire al rapimento della conversion terrestre; sì che in tali luoghi, mentre che la Terra si volge verso oriente, si devrebbe sentir continuamente un vento che ci ferisse spirando da levante verso ponente, e tale spiramento devrebbe farsi più sensibile dove la vertigine del globo fusse più veloce; il che sarebbe ne i luoghi più remoti da i poli e vicini al cerchio massimo della diurna conversione. Ma già de facto l'esperienza applaude molto a questo filosofico discorso: poiché ne gli ampi mari e nelle lor parti lontane da terra e sottoposte alla zona torrida, cioè comprese da i tropici, dove anco l'evaporazioni terrestri mancano, si sente una perpetua aura muovere da oriente, con tenor tanto costante, che le navi mercé di quella prosperamente se ne vanno all'Indie Occidentali, e dalle medesime, sciogliendo da i lidi messicani, solcano con'l medesimo favor il Mar Pacifico verso l'Indie, orientali a noi, ma occidentali a loro; dove che, per l'opposito, le navigazioni di là verso oriente son difficili ed incerte, né si possono in maniera alcuna far per le medesime strade, ma bisogna costeggiar più verso terra, per trovare altri venti, per così dire, accidentarii e tumultuarii, cagionati da altri principii, sì come noi abitanti tra terra ferma continuamente sentiamo per prova: delle quali generazioni di venti molte e diverse son le cagioni, che al presente non accade produrre; e questi venti accidentarii son quelli che indifferentemente spirano da tutte le parti della Terra, e che perturbano i mari remoti dall'equinoziale e circondati dalla superficie aspra della Terra, che tanto è quanto a dire sottoposti a quelle perturbazioni d'aria che confondono quella primaria espirazione, la quale, quando mancassero questi impedimenti accidentarii, si devrebbe perpetuamente sentire, e massime sopra mare. Or vedete, come gli effetti dell'acqua e dell'aria par che maravigliosamente s'accordino con l'osservazioni celesti a confermar la mobilità nel nostro globo terrestre. 101 Daniello Bartoli, La ricreazione del savio [Ed. a cura di Bice Mortara Garavelli, Milano-Parma, Fondazione Bembo/Guanda, 1992] Libro I, capo II Iddio nascoso e palese sotto il trasparente velo delle creature che il cuoprono e tutto insieme il rivelano. Osservazione certissima è che di qualunque forma sia uno spiraglio o forame per cui il Sole tramandi alcun raggio della sua luce, dilungato che si è alquanto quel raggio, egli già più non rappresenta, colà dove batte, la figura dello spiraglio per cui trapassa, ma si trasforma in circolo e con esso descrive l'imagine del suo principio, ch'è il Sole, dal cui corpo deriva. E ciò, com'io diceva, è infallibile ad avvenire, comunque sia l'apertura dov'entra il raggio, o triangolare o quadrata o di qualunque altra figura eziandio se stranissima: ché egli sempre al medesimo modo s'incerchia e ritonda, spianando a poco a poco gli angoli e regolando le obliquità fin che a una cotal proporzionata distanza egli è girato tutto in sé stesso e divenuto circolo ben contornato. E vi sarà più volte avvenuto, non solo di porvi mente, ma come a novità peregrina maravigliarvene e, cercandone fra voi medesimo la cagione, trovarla, più che a prima vista non sembra, difficile a rinvenire. Qui non è luogo di renderla; e già l'hanno espressa in dimostrazione valentissimi matematici, avvegnaché non tutti fra loro pienamente in accordo. A me dunque non fa mestieri altro che riscontrare in questo maraviglioso lavoro del Sole quel che Iddio fa in tutte l'opere della sua mano, in quanto, per mezzo loro, di qualunque natura elle siano, ci rappresenta sé stesso, solis radio scriptum, per usar questa forma di Tertulliano in vece di chiaramente. Tutte le creature, e le sensibili e le pure spirituali e le miste, sono come spiragli per cui quello a noi invisibil sole Iddio, con imagine proporzionata alla piccolezza del nostro intendere, la grandezza del divino suo essere rappresenta. E come il teologo san Giovan Damasceno, mirando colà su le cime del monte Tabor uscir del volto a Cristo una sì eccessiva bellezza, che rassembrava il Sole, disse che la viva e mistica pietra di quella divina umanità perexiguam quandam rimam suae carnis aperuit, e di è licenza d'uscirne e mostrarsi a gli occhi de' suoi tre più cari discepoli un pochissimo di quell'infinito bello che dentro si nascondeva; similmente Iddio, a mostrarci di sé quanto eravam capevoli di vederne, tanti, per così dire, spiragli ha aperti, quante son le fatture dell'onnipotente sua mano. Ben sono elle, non niego, quanto alla virtù del rappresentare, cifere, non imagini; non effigie, ma ombre; e quanto alla grandezza, un nonnulla a paragon dell'immenso; ma pur così a noi bastano: nella maniera, disse il vescovo san Cirillo Alessandrino, che descrivendo in un piccol foglio i gran circoli delle sfere celesti, intendiamo che quel che ivi è figura d'un palmo, colasù è spazio, che a misurarlo co' milioni delle miglia quante ve ne ha bisogno, il pensier nostro, quantunque infaticabile, vi si stanca. Sono adunque le creature imagini espressive di Dio, in quanto tutto il lor bello è una copia visibile di quella invisibil bellezza, tutto il lor buono è una partecipazione finita di quella infinita bontà ch'è in lui. Così, mentre in tal modo cel rappresentano com'è loro possibile, ancor che non dican vero elle non sono bugiarde: peroché a dimandarle di sé e di cui sono imagine, chiaramente rispondono, protestando, secondo il pontefice S. Gregorio, d'esserlo come l'orma del piè, che stampata nella polvere è figura e indicio di chi ve la impresse. Ma oh quanto è da lungi a ravvisarsi e a conoscere nel vestigio d'un piede segnato in terra la bellezza del volto, l'amenità del colore, la proporzion delle membra, la grazia del portamento, la buona attitudine, la snellezza, il garbo, e molto più le interne doti dell'anima di chi ve l'impresse! E tali, è vero, sono da dir che siano, quantunque bellissime e ottime e tutte insieme oltre numero, le creature: conciosiaché di quel quanto Dominator earum speciosior est chi può definire il vantaggio o mettere in proporzione la differenza? Come d'una stilla all'oceano, d'una scintilla al Sole, d'un atomo a tutto il mondo: se tutto il mondo in comparazione di Dio non è quanto un invisibile atomo, e gli sparisce d'avanti come lungi da lui quanto il tempo all'eterno, la misura all'immenso, il termine all'infinito. E nondimeno, coll'esser le creature a paragon di Dio un niente, pur elle sono assai, mentre coll'essere vestigia Creatoris, per haec, quae ab ipso sunt, sequendo, imus ad ipsum. Così egli in esse si truova, perché noi, sopra esse, che sono orme di lui e a lui portano, incaminandoci il troviamo: anzi esse medesime, come specchi in riflesso, lontano cel rappresentano e, per così dire, invisibile cel fan vedere. Non enim, disse S. Atanagi, invisibili sua natura abusus est Deus, ut illum homines ignorarent, sed ita rerum naturam instruxit, ut ipse, quamquam natura invisibilis, ex operibus suis agnosceretur. E ne reca in esempio quel Fidia scultore nominatissimo, le cui figure in marmo nella proporzione delle membra, nelle attitudini delle vite, nell'arie de' volti e in ciò che altro si può foggiare con lo scarpello ed esprimere col disegno, erano un miracolo a vedere; e fra le opere sue e quelle degli altri scultori v'avea quella differenza ch'è fra uomini vivi e statue morte: e se quegli non incidevano i propri nomi a piè delle loro statue, non si sapeva di cui mano elle fosser lavoro; dove quelle di Fidia, in solamente vederle, erano, all'eccellenza, riconosciute per sue ed egli in esse; onde anche Tertulliano, prima di S. Atanagi, avea detto che nel famoso Giove Olimpico, fattura di Fidia, Phidiae manus adorabantur. Ma che le opere di Dio sian suoi vestigi, non solamente in quanto elle cel danno a conoscere come effetti la lor cagione o come fonti l'original principio ond'elle derivano, ma in maniera anche più espressiva a chi ne sa alquanto più de' volgari intendere il magistero: per dimostrarlo, raccordivi di quell'Aristippo, celebratissimo, tra' filosofi del suo tempo, a cui, sorta nell'Arcipelago una insuperabil tempesta che 'l gittò a rompere alle spiagge di Rodi, infranta la nave ed egli a gran pena campatosi dall'affogare, come prima mise il piè in sul lito, gli vennero osservate certe figure 102 geometriche disegnate quivi nella rena da chi che si fosse. Ravvisolle, come intendente che n'era, e tutto in espressione di giubilo esclamò: "Vestigia hominum video"; indi, rivoltosi a' compagni del commune naufragio, ignudi, addolorati e piangenti, li confortò a sperar bene, già che la rea fortuna del mare gli avea gittati non a perdersi, ma a prender porto in un'isola fortunata, sì come d'uomini colti e savi, quali egli in quelle ingegnose figure, vestigie della lor mente ivi lasciate, li ravvisava; né l'ingannò il suo pensiero: sì splendidamente e com'era degno di tal ospite vi fu accolto, e per lui ben veduti e rimessi in miglior fortuna anche i compagni. Or chi ha in capo occhi da non veder solamente le superficie visibili anco a gli animali per dilettarsene il senso, ma da intendere l'artificio del lavoro così di tutto insieme il mondo come d'ogni particolare avvegnaché minima e poco in apparenza pregevole sua fattura, e la collocazion delle parti, non possibili a disporsi né con più bell'ordine per la vaghezza, né con più aggiustata situazione per l'utile; e in esse l'armonia delle superiori con le mezzane e di queste coll'infime; e le sempre mobili o sempre quiete, e le or mobili or quiete, quelle per l'intrinseca proprietà delle lor forme, queste per l'estrinseca impression degli agenti; e le smisurate e le piccolissime, quelle più riguardevoli per la gran mole, queste per lo più fin lavoro; e le perpetue vicende del succedersi le une cose alle altre, dando luogo il finir di queste al cominciar di quelle, e in tal guisa continuando sempre il medesimo, ma il medesimo sempre nuovo; e l'insolubile legamento e concordia fra nature non solamente dissimili, ma nemiche; e la concatenazione de' fini, a ciascuna specie il suo proprio, ma tutti a un sol commun termine rispondenti; e 'l ripartimento de' beni sì ben inteso che il bisogno non è punto men utile che l'abbondanza, facendosi necessaria la communicazion de' lontani, per dar gli uni quel che loro soverchia e cercar gli altri quel che lor manca; e finalmente, in tutto la varietà, l'unione, la grazia, la consonanza, l'ordine, l'efficacia, il decoro, la stabilità, la maestà, l'utile, la bellezza: chi così vede il mondo, chi così ne intende l'armonia del tutto e l'ufficio delle parti, ah, non può altrimenti che, come in mezzo a innumerabili maraviglie, anzi, a dir meglio con S. Giovanni Crisostomo, a tanti miracoli quanti individui non che nature, dovunque si volge non senta rapirsi coll'animo in giubilo per diletto e in estasi per istupore. E non può essere che tutto insieme con la mente non salga in Dio, a riconoscervi il dominio di quell'onnipotente volere che un sì gran mondo fe' uscir del nulla con solamente chiamarnelo fuori e, conservandolo, quasi continuo il riproduce, altrimenti nel suo primiero non essere ricadrebbe; e la bellezza di quelle invisibili idee onde sì belle copie si ritrassero e renderon visibili nella materia la maestria di quella sapientissima mano che tante e sì varie e sì artificiose e utili opere lavorò; e 'l rettissimo intendimento di quella non mai fallibile providenza che con sì aggiustato ordine le dispose; e l'immensità di quell'essere che tutto il mondo empie di sé, né il luogo il circoscrive né lo spazio il distende né il termine il misura; e la capacità di quella mente così tutta assistente al governo del tutto, che insieme tutta a qualunque sia menoma particella è intesa. Così vedute le opere di Dio, elle son linee e figure, per così dir, teometriche, delle quali il men ch'elle abbian di bello è quel che mostrano a gli occhi: l'incomparabile è per la mente, cioè la forza del dimostrar ch'elle fanno Iddio e quell'infinito ammirabile ch'è in lui. Non ch'elle cel diano a comprendere; ché più può una favilla chiudersi in seno il Sole, che mente creata adeguar coll'intendere tutto l'intelligibile ch'è in Dio. Neanco cel danno a vedere in lui stesso, ma come chi di su la punta a uno scoglio mira l'oceano, ancorché non ne vegga né il termine né il fondo, ma solo una superficie di quanto è l'orizzonte della sua corta veduta, nondimeno e assai ne vede, e vede in certo modo ancora quel che non vede, in quanto il conosce incomparabilmente maggiore di quel ch'egli può abbracciare con la veduta. Per un simil modo anche noi in questa superficie delle creature, che sono cosa di Dio, veggiamo ancor l'invisibil di lui, e ne arriviamo al profondo non coll'intelligenza, ma collo stupore, ch'è la sola giusta misura delle cose ch'eccedono ogni misura; e ciò fassi argomentando così: se la sensibile e grossa materia, al lavorarla egli, riceve dalle sue mani forme, miracoli di bellezza, qual bellezza debbe essere in lui, di perfezione infinitamente maggiore, e quella delle immateriali e nobilissime Idee della sua mente! Vennero una volta, a miglior lume che mai per avanti, vedute a Michelangelo Bonaruoti le porte di San Giovan di Firenze, nelle quali il men che sia di pregevole è il pregio della materia, bronzo finissimo, ma per miracolo d'arte condotto sì morbido nelle figure di che elle sono istoriate e ne' fregi che l'ornano, che più non si potrebbe volere arrendevole e ubbidiente a figurarsi la cera. Quanto poi al lor disegno e al modello, basti dire mano di Giotto e d'Andrea Pisani. Ma le più da lui attentamente considerate furon quelle di Lorenzo Ghiberto, veramente degne della spesa, che quel valente maestro fe' loro intorno, di quaranta anni di studio e di fatica; ma ben ancor pagate, non dico solo in danaro da' Fiorentini, che largamente nel premiarono, ma in quel che avanza ogni prezzo: la lode che Michelagnolo glie ne diede e lo stupirne che fece, dicendo che quelle porte starebbono ottimamente al Paradiso; e fu assai che non aggiungesse che in entrarvi le anime de' beati si fermerebbono, come lui, a riguardarle con pari maraviglia e diletto. Questo ho io riferito in grazia d'un detto del Platon degli Ebrei, Filone dottissimo, che delle creature filosofa appunto come io diceva, mostrando il lor bello metterci dentro a Dio e darcene a conghietturare il bellissimo delle forme esemplari della sua sapienza. Cum intelligibilis mundi cognitio, dice egli, contingat nobis per sensibilem, hic illius porta dicitur. Or vada a piangere non l'altrui, com'egli era uso di fare, ma la sua propria stoltizia Eraclito, a cui parve che Iddio, per gelosia di maestà e non si render vile col farsi noto, cercasse abissi dove nascondersi e tenebre con che ammantarsi, nulla di sé mostrando nella superficie per non dar segno con che poter giungere a trovarlo nel fondo. Solo, diceva egli, a gli acutissimi ingegni, e perciò rarissimi, a gli uomini che specolando si fan tutto spirito e tutto mente dopo un continuo struggersi l'anima in pensieri e la vita su' libri filosofando, Iddio s'approssima, e a gli occhi loro, vegghianti le lunghe e 103 fredde notti, un po' poco si manifesta. Misero: a che stancarsi in vano, aggrappandosi a mani e piedi e struggendosi in sudore al salir su le cime all'erta inaccessibile d'un'altissima rupe, per niun altro effetto che di poter vedere il Sole, come altronde non fosse visibile che d'in su le punte de' monti, s'egli da sé presentandosi a ogni luogo discende fin giù in fondo alle valli e quivi, con quanti raggi di luce ha in volto, a noi e a sé fa lume perché il veggiamo? Èvvi per avventura luogo ove Iddio non si manifesti e ci si dia a conoscere, se non v'è luogo dove non si truovi stampato un carattere della sua sapienza, che il prèdica, impresso un vestigio della sua grandezza, che il rappresenta, tirata una linea dell'infinito suo essere, che il dimostra? Certe – disse ben Vittorino – totum hoc quod mundus est regnum est veritatis et lucis: e tante son le lumiere che ne mettono in chiaro la verità, quante le creature, in cui tutte risplende Iddio; e se ne prenda, non dico solo alcuna d'isquisitissimo lavorio, ma la più semplice e alla nostra apparenza meno artificiosa: anco in lei, se ben si consideri, troverassi onde vedere Iddio e ammirarlo. Come degli specchi, così i finissimi e che hanno intorno cornici intarsiate di gemme e messe a fregi d'oro, come gli schietti e di niuna ornatura, al far veder di riflesso ciò che lor si presenta servono ugualmente. Qual più lieve opera, di quante ne lavora il Sole, che l'iride ch'egli tutto insieme disegna e dipinge su una nuvola rugiadosa? Bene in ciò dimostrandosi alla pruova quale il Bonaruoti dicea dover essere un perfetto maestro nell'arte del disegno, cioè avente il compasso negli occhi: e ve l'ha il Sole sì fattamente che senza altro che guardare una nuvola vi contorna e dipinge con più colori quel perfettissimo circolo e al vederlo sì vago e al considerarlo sì prodigioso, che mille volte più per lo stupor della mente che per lo piacer degli occhi gli si confà il nome appropriatogli dalla maraviglia. Fallo il Sole: ma chi glie ne infuse l'arte? Chi gli di è i pennelli de' raggi? Chi gli stempera que' bei colori che han su le punte, e come sa condurli ugualissimi e sfumarli e unirli? Chi gli appunta il centro per tirarvi intorno que' circoli sempre ugualmente distanti un semidiametro di quarantacinque gradi? Chi gli spiana e pulisce e mette in postura acconcia d'avanti il quadro di quella nuvola in cui lavora? Protesta Iddio ch'egli è desso il maestro del Sole: egli in lui, che vogliam dire, o per lui, il facitor di quell'opera, tal che in vederla vuol che vi si riconosca dentro e la giustamente dovuta lode si dia all'invisibil sua mano. Così il valentissimo dipintor Giotto, che fu l'Apelle de' suoi tempi, richiesto di dare alcun saggio del suo sapere in quell'arte, onde veggendolo il pontefice Benedetto nono il condurrebbe ad alcuna grand'opera in san Pietro di Roma, egli, preso il pennello e fermando il gomito su la tavola, tirò sopra un semplice foglio bianco null'altro che una linea in cerchio, ma senza centro, sì perfettamente ritondo che altri con le seste in mano più a misura nol girerebbe: e tanto fu di vantaggio a far conoscere di che perizia egli fosse. Quanto più poi dell'opere che il lavorarle non è che di maestro consumato nell'arte? E di queste, quantunque a Dio ogni cosa possibile ad essere è ugualmente agevole a lavorare (nella maniera che il Sole niente più fatica intorno alle miniere de' metalli e delle gioie durissime che ad un tenero e semplice fiorellino) quante in numero ve ne ha in questo grande universo e, quanto al considerarne l'artificio, le proprietà e gli effetti, maravigliose? Il sanno i nostri ingegni che in tanti secoli che vi studiano intorno così poco ne han finalmente compreso. A quel tanto di più che ci rimane ad intenderne, a dir vero, ne abbiamo inteso poco più di niente. E se v'ha di quegli (e troppi ve ne ha; ché de' pazzi n'è fertile così ben la terra de' savi come ogni altra) a cui, per qualche lampo di verità che ha lor dimostrato il perché o il come di alcun effetto particolare, sembra aver veduto e compreso quanto ha d'ammirabile la natura, egli son da mettere tra' forsennati, a una stessa catena che quel vanissimo Serse, quando, tirato un ponte di barche non più che da Abido a Sesto per passar sopra esso d'Asia in Europa, gittò un paio di ceppi d'oro in mare, come in quel pochissimo spazio di men d'un miglio già tutto l'avesse soggiogato e rendutolo schiavo. Non così chi veramente è savio: ma sicut tenebrae eius ita et lumen eius, in quanto egli utilmente si vale non meno dell'ignoranza che del sapere a conoscer Dio, delle cui opere, che non sono sforzi del suo braccio ma scherzi delle sue dita, se l'intenderne il maraviglioso e 'l bello sopravanza di tanto l'umana capacità, quale e quanto de' essere quell'ammirabile e quel bello ch'è in lui? Egli per farcisi ora vedere convien che si ricuopra il volto, come Mosè troppo eccessivamente luminosoex consortio sermonis Domini, e mostrarcisi per tal modo che, pur veggendolo, nol veggiamo: e ciò fa sotto il velo delle creature, che col medesimo ricoprirlo e cel nascondono e cel rivelano. Così l'imperador della Cina certe pochissime volte che s'affaccia in publico e dà a vedersi, tante e sì dense e lunghe son le fila di perle e di preziosissime gioie che dal sommo della fronte gli cadono in su 'l volto, che null'altro di lui appare: e pur se ne adora da' popoli la presenza, e quel maestoso muoversi e quel vivo scintillar delle gemme si ha per altrettanto che sue guardature e suoi cenni. E di Dio ben disse il pontefice san Gregorio che dum facturae suae decus foris proponit,quasi quibusdam se nutibus nobis innuit. Vero è che come l'occhio sensibile non è atto a vedere altro che il velo delle sensibili creature che sotto si nascondono Iddio, conviene adoperar quello della mente; e non basta aprirlo, se non gli vien di sopra un lume che gli assottigli la vista, tal che penetri dentro il sensibile e il velo opaco gli renda trasparente e apparente Iddio sotto esso. Così anche il Trismegisto ne avvisa il suo discepolo Tazio e l'esorta a chieder per ciò lume da Dio, già che a vedere il Sole pur ci bisogna il lume del Sole. Sic enim Deum tantum percipere poteris, si vel unus dumtaxat illius radius, intelligentiae tuae benigne refulserit. Sola siquidem intellectio latens latentia perspicit. Itaque si mentis oculis inspexeris, ille tibi, crede mihi, patebit Deus, sane totius expers invidiae, per singulas mundi particulas ubique splendens. Atque adeo se notum praestat, ut non intelligere modo, sed manibus etiam ipsis, ut ita dixerim, liceat attrectare. Nam undique nostris oculis eius obversatur seseque obicit et inculcat imago. Quando beati in cielo avrem l'anima fuor del loto di questa carne mortale, e l'occhio della mente, libero e netto dalle terrene imagini per cui sole ella ora vede secondo quel che i materiali e grossi canali de' sensi gl'inviano, sarà rischiarato e pieno, quanto glie ne cape, d'un cotal lume, che basta dirne che questo per cui ora veggiamo non è degno di paragonarglisi pur come ombra, allora, revelata facie gloriam Domini speculantes, videbimus eum sicuti est. 104 Francesco Algarotti, Saggio sopra la necessità di scrivere nella propria lingua. Di non pochi vantaggi, parte fisici parte morali, vogliono i più dei dotti che, per quanto si spetta alle umane lettere e singolarmente alla eloquenza e alla poesia, godessero gli antichi sopra di noi. Donde si rende in buona parte ragione della eccellenza a cui da essi recate furono quelle facoltà. Tra i quali vantaggi forse non è il meno considerabile quello, che dissipati non venivano, come noi, in vari studi di differente natura, e sopra tutto che dietro ad altre lingue oltre alla propria non ispendevano l'opera ed il tempo. Appresso a' Greci una cosa era la lingua volgare e la dotta; non sapevano che dir si volesse una morta favella che da fanciulli, quasi prima della materna si dovesse apprendere; e il dispregio in cui tenevano tutte le nazioni che altra lingua usavano dalla greca era effetto, non è dubbio, del loro orgoglio, ma era forse anche una delle principali cagioni del loro sapere. Invitati a legger poco potevano considerar molto; e quel tempo che non erano obbligati a consumar dietro alle parole poteano collocarlo nelle cose, o almeno darlo tutto a ben conoscere, a coltivare, ad abbellire la propria lingua, che è il fondamento primo degli studi della eloquenza e della poesia. Ai Romani convenne, egli è vero, se e' vollero sentire avanti nelle scienze e in ogni maniera di lettere, apprendere la lingua dei Greci, i quali nel tempo che divennero soggetti di Roma ne divennero anche i maestri. Ma per quanto avessero per le mani gli esemplari di quelli, e in quelli ponessero ogni loro studio, di comporre in lingua greca non si piccavano punto, sdegnando di scrivere in altra lingua fuorché nella propria; in quella lingua trionfale e sovrana che dal Campidoglio dettava leggi all'universo. I moderni, all'incontro, si trovano costretti di apprendere le varie lingue in cui parlano e scrivono nazioni che hanno tra loro comunione di trattati, di letteratura, di traffici, che non la cedono l'una all'altra né per ingegno, né per imperio; ed hanno da studiare inoltre la lingua latina e la greca, le quali sono come l'erario di ogni nostro sapere. Tanto da noi esige una certa necessità letteraria, dirò così, e politica, che risulta dalla presente constituzione del mondo. Molte varietà hanno quindi da nascere, per quanto alle lettere si appartiene, tra gli antichi e noi; e tra le altre che, dove quelli scrivevano soltanto nella propria lingua, alcuni de' nostri debbano preferire di comporre in qualche forestiero linguaggio, come pur fanno, perché da esso loro riputato più gentile o perché è più generalmente inteso del proprio. E coloro che si danno veramente agli studi ed hanno tra noi il titolo di letterati, non degnano depositare i loro pensamenti che dentro al sacrario delle lingue morte, le quali hanno il vanto, dicono essi, di essere intese in tutti i paesi, si trovano fissate dall'autorità degli scrittori, non vanno più soggette a verun cambiamento, e sono in certo modo divenute il linguaggio dell'universo e della eternità. Per quanto speciose parer possano tali ragioni alla turba dei letterati, i quali si persuadono agevolmente, scrivendo nelle lingue dotte, di salire in fama a paro degli antichi maestri e di levare nel mondo una più gran vampa di ammirazione del proprio ingegno, sono pure in effetto i mal consigliati coloro che si mettono a scrivere in altra lingua fuorché nella lor propria e nativa. Diversi sono appresso nazioni diverse i pensamenti, i concetti, le fantasie; diversi i modi di apprendere le cose, di ordinarle, di esprimerle. Onde il genio, o vogliam dire la forma di ciascun linguaggio, riesce specificamente diversa da tutti gli altri, come quella che è il risultato della natura del clima, della qualità degli studi, della religione, del governo, della estensione dei traffici, della grandezza dell'imperio, di ciò che constituisce il genio e l'indole di una nazione. A segno che una dissimilitudine grandissima conviene che da tutto ciò ne ridondi tra popolo e popolo, tra lingua e lingua; e i politici tengono per naturalmente nemici quei popoli che parlano lingue diverse. Gli orientali hanno un metaforeggiare, starei per dire, così caldo quanto è il cielo che sotto al quale son nati. La lingua latina, ch'era nelle bocche d'un popolo di soldati, non è lingua così rotonda e soave come la greca, ma è più ardimentosa e concisa. Orazio paragonò l'una al Falerno, vino gagliardo ed austero; l'altra al vino di Scio, generoso insieme ed amabile. La nostra favella è maneggevole, immaginosa, armonica; disinvolta e gentile la francese; così questa come quella prende quasi l'impronta delle nazioni che in esse si esprimono. Gli Spagnuoli, signori di tanto mondo, parlano un linguaggio tutto sostenutezza e gravità. Gl'inglesi hanno moltissime forme di dire tolte dal commercio, dal bel mezzo delle scienze, e singolarmente dalla nautica tanto da essi coltivata. E quella loro lingua egualmente libera, che coloro che in essa parlamentano, soffre meno che qualunque altra la briglia dei fastidiosi grammatici. Ora perché altri fosse atto a scrivere acconciamente in uno idioma non suo, converrebbe egli fosse un altro Proteo, atto a vestire qualunque più strana forma dipendente da un governo, da un clima, da un sistema di cose, nel quale non è altrimenti nato, e a svestire del tutto la propria sua e natural forma, che vuol pur vincere ad ogni istante, per quanto un faccia, e mostrarsi al di fuori. Come di cosa oltremodo singolare e mirabile si parla tuttavia di quel Greco il quale poteva cogli Ateniesi gareggiare di finezza d'ingegno, di austerità di maniere cogli Spartani, e quasi scordarsi tra gli Asiatici di esser nato in Europa, che sapeva divenir cittadino di ogni paese. Ennio per possedere tre lingue diceva di avere tre cuori. Diis geniti potuere. Non pochi belli ingegni francesi tentarono nel passato secolo di comporre nella nostra lingua, quando le cose italiane erano di là da' monti in tanta riputazione, che non era tenuto gentile chi non sapeva delle nostre maniere, non dotto chi non avea gran dimestichezza co' nostri autori. Venne fatto a quel tempo ad alcuni Francesi di raccozzare a forza d'imitazione un qualche componimento che aveva assai di sembianza e anche di genio italiano. Tali sono tra parecchi altri esempi che addurre se ne potrebbono, le vite di Lionardo da Vinci e di Leonbatista Alberti scritte da Raffaello Dufresne, e alcune cose singolarmente del Menagio. Pochi de' nostri uomini furono nella nostra lingua più dotti di lui. Ma a niun Francese meglio riuscì di scrivere in italiano quanto all'abate Regnier, il quale all'Accademia della 105 Crusca seppe ordire quell'illustre suo inganno contrafacendo una canzone come se fosse del Petrarca, ed arricchì la Toscana di una versione di Anacreonte, che sopra quelle medesimamente de' Toscani meritò palma e corona. Se non che, a parlar giustamente, fu il Regnier nella poesia come il Pussino nella pittura, uomo francese e autore italiano: tanto è lo studio ch'egli pose ne' nostri scrittori, oltre a quel molto ch'egli poté apprendere nella dimora ch'e' fece tra noi. E in ogni modo egli è molto meno difficile a scrivere come si conviene in una lingua non sua ma vivente, che in una che si rimane solamente dipinta in sulle morte carte de' libri. Perché in fine né i principi del pensare, né gli studi sono tra le varie nazioni di Europa così differenti, né sono così diseguali gl'imperi, che tra esse non vi abbia molta proporzione ed analogia. Oltreché di un grandissimo aiuto ti può essere la viva voce di coloro che pur parlano quella lingua in cui tu ti proponi di scrivere. Dove altrimenti va la faccenda in una lingua morta. E pigliando in esempio la latina, in cui si suole dai dotti più comunemente scrivere, la educazione dei Romani avea per fondamento principi di religione, instituzioni, studi, costumanze e modi in tutto diversi da' nostri. Donde nascevano espressioni ad essi modi corrispondenti e per niente adattabili alle nostre istituzioni ed usanze. Litare Diis manibus, come disse il Bembo, per celebrare la messa dei morti, interdicere aqua et igni per fulminar la scomunica, Collegium augurum per il Concistoro dei cardinali, sono sconvenevolezze tali, che maggior non sarebbe il mettere indosso a uno de' nostri dottori la toga romana, il voler porre su' nostri altari la statua di Venere anadiomene o di Marte vendicatore. Non mihi mille placent, non sum desultor Amoris spectatum satis et donatum iam rude quaeris, Maecenas, iterum antiquo me includere ludo erano immagini vivissime appresso ai Romani per dire che uno non fa il zerbino in amore, che l'altro dopo un lungo servigio domanda il riposo. Appresso di noi, che non siamo soliti assistere allo spettacolo de' gladiatori e abbiam perduto l'arte dell'antica cavallerizza, non sono intese che per via di comento; sarebbono immagini disconvenienti, se da un moderno poeta si usassero, da fare almeno sulla nostra fantasia così poca impressione, che farieno a un Samoiedo o a un Lappone quei versi del nostro poeta: E quale annunziatrice degli albori l'aura di maggio movesi ed olezza tutta impregnata dall'erba e da' fiori. Dalla grandezza similmente del romano imperio, di tanto superiore in potenza agli imperi del tempo presente, nascevano maniere di esprimersi elevate e grandiose, che male si confanno con le cose di oggidì. Doveano quelle maniere corrispondere a' concetti di una gente che vedea i loro propri concittadini avere per clienti dei re, che gli vedeva far costruire dodici mila sale per banchettare il popolo, trionfare ad un tempo delle tre parti del mondo; intantoché fu detto da un bello ingegno che quando leggeva le cose de' Romani, gli era avviso che un passerotto leggesse la storia delle aquile. Qual nuova disconvenevolezza adunque il vedere i fatti de' Pieri, de' Giovanni e de' Mattei descritti con le frasi di Tito Livio e di Giulio Cesare, udire un pedante arringare i suoi ragazzi con quella gravità che un consolo parlava in Senato, voler suggellare le moderne imprese col Regna adsignata, coll'Orbis Restitutori, col Pace terra marique parta Ianum clusit, e con altre simili antiche leggende, adattare alla picciolezza delle cose nostre la maestà del linguaggio di quel popolo re? Ma diamo che tale e tanta sia la discrezione di giudizio in chi compone, ch'egli venga a schivare lo inconveniente della magniloquenza, che è quasi connaturale ai latini scrittori, dov'è colui che possa sedere a scranna e farsi a decidere della Crusca latina? Sicché non ci rimanga scrupolo alcuno di aver usato il termine naturale e proprio; che è pur nello scrivere la importantissima cosa di tutte, onde nella mente dell'uditore si viene ad eccitare quella precisa idea che conviene, e non altra, ed equivale alla intonazione perfetta, al toccar giusto nella musica. A ciò fare ci vogliono altri maestri che i semplici libri. E il più delle volte la moltitudine è una miglior guida, che esser nol possono gli scrittori. Il Satirico francese, volendo dimostrare e mordere a un tratto la presunzione di coloro che si piccavano in Francia di scrivere latinamente, introduce in certo suo dialogo Orazio a parlare la lingua francese, da esso lui appresa nell'ozio degli Elisi per via della lettura degli scrittori e de' migliori libri che ne dieno le regole. Con tutto il suo ingegno e il suo studio commette in parlando di non piccioli errori; per esempio si serve della parola cité, dicendo la cité de Rome, dove conviene dire la ville de Rome; dice le pont nouveau, e va detto le pont neuf; e cade in simili altri barbarismi, dando di che ridere a un Francese col quale s'intrattiene. Si mette costui a correggerlo; Orazio a difendersi. Replica il Francese, e a tutte le autorità addotte in suo favore dal poeta latino egli va contrapponendo le leggi sovrane dell'uso corrente, che è il vero padron delle lingue, quem penes arbitrium est, et ius, et norma loquendi. 106 E Orazio, sconfitto dalle sue proprie armi, ammutolisce, e colle trombe nel sacco se ne torna a raggiungere i suoi compagni nella beatitudine dell'Eliso. Ma senza andar dietro agli apologhi e alle finzioni, di tale verità ne siamo testimoni noi medesimi in Italia. E non si vede egli bene spesso le scritture di quei nostri italiani i quali, senza voler badare a quella favella che è nelle bocche degli uomini, hanno volti unicamente i loro studi a imitare gli antichi autori di nostra lingua, sono piene di affettazione, di parole insolite e diciamo anche d'improprietà, sono alle persone di gusto uno isfinimento di cuore? E già credettero dover fare, per bene scrivere in italiano, qualche dimora in Firenze l'Ariosto, il Caro, il Chiabrera, il Guarino, il Castiglione e il Bembo, tuttoché nati e cresciuti nel bel mezzo d'Italia. Al pericolo di non usare scrivendo per latino le voci proprie, si aggiunge anche quello non punto minore, che nello stile che nasce dall'insieme di esse non vi abbia naturalezza, né unità. Dal dover noi raccogliere le parole di pochi e morti scrittori quasi gocciole dalle grondaie, dice il Davanzati, tutti differenti di genere e di stile, e non potere attingere al perenne fonte della città, ne viene in conseguenza che si va riducendo insieme un componimento di frasi latine bensì, ma che non è per niente latino. Unus et alter assuitur pannus; e il risultato non può essere altro che uno stile rotto, stentato e non di vena. Onde de' latinanti della età sua ebbe a dire ne' giudiziosi suoi capricci quel bell'umore del Gelli: «Facciano quanto fanno; e' non si vede mai ne' loro scritti quel candore, né quello stile che è ne' Latini propri». Nello stato presente della lingua latina ristretta, come abbiam detto, in picciol numero di autori, non basterebbe già ella a' Romani stessi per esprimere tutti i loro concetti: e molto meno dovrà bastare a noi, i quali dovremmo in essa esprimere tante nuove cose apparite nel mondo, per quanto si spetta alle arti, alle scienze, ai traffici, ai governi, alle religioni, dopo che è spenta quella lingua. Né lecito è a noi, essendo ella pur morta, il pensare di potervi aggiugnere nulla di nuovo. Le lingue nascono povere, dice Bernardo Tasso; e siccome i principi fanno agli uomini le donazioni e i privilegi degli onori e degli stati, così la liberalità degli ingegni di alto sapere forniti e di purgato giudizio fanno le donazioni e i privilegi alle lingue delle parole, delle locuzioni, delle figure e degli altri ornamenti del dire; e con la loro autorità li confermano per tutti i secoli. In tal maniera quel chiaro ingegno incoraggisce il Caro a voler ampliare, arricchire la nostra lingua, ad aggiugnervi nuovi modi di dire e nuove bellezze. La qual cosa non avrebbe già egli fatto, se trattato si fosse della lingua latina. Noi non abbiamo sopra di essa, che punto a noi non si appartiene, ragione alcuna né diritto. In essa, come in ogni altra lingua morta, conviene esaminare quali sieno le donazioni e i privilegi, che già le furono conceduti dalla munificenza degli antichi: a quelle donazioni e a quei privilegi unicamente bisogna stare, senza che vi sia luogo alla liberalità dei moderni. E qualunque cosa vorremmo noi aggiugnere alle vecchie pergamene, sarebbe rigettato a ragione come interpolato, falso ed apocrifo. Finalmente, per quanto grandi sieno le difficoltà che incontrano coloro i quali si danno a scrivere in prosa latina, maggiori ancora sono quelle che s'incontrano nei versi. E ciò perché ivi si ricercano modi di dire di somma gagliardia o di somma dilicatezza, e in ogni cosa il fiore ultimo della espressione. Il che non si può ottenere se non hai come schierata dinanzi alla mente la suppellettile tutta e il tesoro delle parole, delle locuzioni e delle metafore della lingua in cui tu scrivi. Anzi non basta quello che dagli altri fu detto: è necessario formarsi talvolta come una nuova lingua; perché la espressione penetrando addentro nell'animo non sia, come altri disse, superficiale, perché si dia sfogo a quell'estro che ha invaso ed agita il poeta. Le quali cose pur sappiamo aver fatte i poeti latini non già in tempo che povera esser trovavasi la romana favella, ma quando sotto al dominio di Augusto pervenuta era al colmo della ricchezza. Per vie maggiormente animare i loro concetti hanno inventato di nuove parole, per dare alla espressione più vivacità e più mossa sonosi serviti di ellenismi come di più pronti atteggiamenti, e brillano a ogni verso metafore da esso loro formate quasi nuovi lampi d'ingegno. Ma qual cosa potranno fare coloro che si danno a poetare in una lingua ristretta dentro a' confini che vi han posto gli antichi scrittori, che maneggiare non posson a lor talento, dove non è loro permesso niuno ardire, anzi hanno da temere del continuo di non mettere piede in fallo e si trovano esser sempre tra il Calepino e la grammatica, quasi direi tra l'ancudine e il martello? Sarà pur loro forza rintuzzare il proprio entusiasmo, porre i piedi nelle pedate altrui, accrescere la greggia degl'imitatori. La moderna schiera in effetto de' poeti latini, quelli eziandio che hanno il maggior grido tra noi, non meritano forse altro titolo che quello di centonisti, facendo soltanto bella comparsa quando si mostrano rivestiti delle spoglie o delle divise altrui. Assai facilmente le riconosce chiunque è versato nella latina poesia. Anzi bene spesso si può accorgere come le espressioni che negli antichi autori trovansi belle e fatte, guidano esse e formano il sentimento del poeta, in luogo che i pensamenti si tirino dietro le espressioni. E tale autore che in lingua italiana è poeta casto e platonico, diviene licenzioso ed epicureo in lingua latina, trattovi come a forza dalle frasi di Catullo e di Ovidio, suoi maestri e suoi duci. Che se pure vogliono alcuni esprimere le particolari loro impressioni, rappresentar nettamente le modificazioni del loro animo, troppo male ne riescono. Assecondare il proprio naturale, trovare modi di dire che sieno il nostro caso in una lingua da tanti secoli morta, è impossibile. Perché avendo, come si è detto, per tante cause variato le cose, non vi possono più rispondere le espressioni. E così, dovendo noi accomodare le immagini ai colori e non i colori alle immagini, ogni cosa riesce languido e fosco. Guai al divino Ariosto se dava orecchio al Bembo, il quale lo consigliava di lasciar da banda le muse italiane e darsi tutto in braccio a quelle del Lazio. Né già lo stile di Dante sarebbe così vivo, che si trasforma nelle cose medesime, s'egli avesse disteso il suo poema in latino. E ben si potrebbe dire di lui 107 che la dritta via era smarrita, quando egli avesse proseguito giusta quel suo principio: Infera regna canam supero contermina mundo. Che se a cagione del poema latino dell'Affrica fu coronato il Petrarca in Campidoglio, conviene considerare che ciò avvenne in tempi che il raccozzare pochi versi in quella lingua era tenuto a miracolo; e la verità si è che il Petrarca non per altro è famoso, letto e studiato, che per le sue rime volgari. Degna adunque di somma lode, per quanto in favore della lingua latina vadano predicando gli Aldi, i Romoli Amasei ed altri simili invasati nell'antichità, è la usanza che si va di dì in dì facendo più comune, che ogni scrittore, là dove specialmente gioca la fantasia, scriva nel materno suo linguaggio. In esso solamente gli è conceduto di esercitare tutte le sue forze, di spiegarle con franchezza e disinvoltura; come a quel soldato che non si serve della corazza e de' braccialetti altrui, ma ha l'armatura fatta al suo dosso. In tal modo solamente potrà nutrire fondata speranza di emulare quei Greci e quei Latini che scrissero essi pure nel proprio loro linguaggio, in quello cioè che si affaceva unicamente a' loro modi di sentire, di apprendere, di pensare; e potrà con ragione appropriarsi di quelle memorabili parole di Dante, ... I' mi son un che quando Natura spira, noto et a quel modo che detta dentro, vo significando; che è il solo mezzo di giugnere alle altezze più sublimi dell'arte. 108 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene [Dei delitti e delle pene ; Consulte criminali, a cura di Giuseppe Armani, Milano, Garzanti, 1987 I. Origine delle pene Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall´incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de´ motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell´antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl´infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perché la sperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell´universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né l´eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti. II. Diritto di punire Ogni pena che non derivi dall´assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall´assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell´uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo. Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne´ romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo. La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s´incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall´individuo alle nazioni. Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L´aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto. Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl´interessi particolari, che senz´esso si scioglierebbono nell´antico stato d´insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l´idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell´altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire. III. Conseguenze La prima conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest´autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta più un´altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino. La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l´anarchia. Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l´altra dall´accusato, che la nega. Egli è dunque 109 necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere assersioni o negative di fatti particolari. La terza conseguenza è che quando si provasse che l´atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d´impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l´effetto d´una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo. IV. Interpretazione delle leggi Quarta conseguenza. Nemmeno l´autorità d´interpetrare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d´ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell´attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d´un antico giuramento, nullo, perché legava volontà non esistenti, iniquo, perché riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l´intestino fermento degl´interessi particolari. Quest´è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo l´esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un´azione contraria alle leggi? In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev´essere la legge generale, la minore l´azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all´incertezza. Non v´è cosa più pericolosa di quell´assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un piccol disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll´offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell´animo fluttuante dell´uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de´ miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell´attuale fermento degli umori d´un giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l´errante instabilità delle interpetrazioni. Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell´incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de´ cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell´ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire, più fatali che quelle di un solo, perché il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di esattamente calcolare gl´inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d´indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante a´ supremi magistrati, bensì a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di trasmettere agl´inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura. V. Oscurità delle leggi Se l´interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l´oscurità che strascina seco necessariamente l´interpetrazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l´esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l´inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v´ha dubbio che l´ignoranza e l´incertezza delle pene aiutino l´eloquenza delle passioni. 110 Una conseguenza di quest´ultime riflessioni è che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl´interessi privati. L´esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni? Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d´intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l´atrocità de´ delitti che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l´umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede: l´umanità gemente sotto l´implacabile superstizione, l´avarizia, l´ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell´oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l´opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto. 111 Vittorio Alfieri, Vita scritta da esso [Vita, a cura di G. Dossena, Torino, Einaudi, 1967] Epoca seconda. Adolescenza. Capitolo decimo CAPITOLO DECIMO Primo amoruccio. Primo viaggetto. Ingresso nelle truppe. In una villeggiatura ch'io feci di circa un mese colla famiglia di due fratelli, che erano dei principali miei amici, e compagni di cavalcate, provai per la prima volta sotto aspetto non dubbio la forza d'amore per una loro cognata, moglie del loro fratello maggiore. Era questa signorina, una brunetta piena di brio, e di una certa protervia che mi facea grandissima forza. I sintomi di quella passione, di cui ho provato dappoi per altri oggetti così lungamente tutte le vicende, si manifestarono in me allora nel seguente modo. Una malinconia profonda e ostinata; un ricercar sempre l'oggetto amato, e trovatolo appena, sfuggirlo; un non saper che le dire, se a caso mi ritrovava alcuni pochi momenti (non solo mai, che ciò non mi veniva fatto mai, essendo ella assai strettamente custodita dai suoceri) ma alquanto in disparte con essa; un correre poi dei giorni interi (dopo che si ritornò di villa) in ogni angolo della città, per vederla passare in tale o tal via, nelle passeggiate pubbliche del Valentino e Cittadella; un non poterla neppure udir nominare, non che parlar mai di essa; ed in somma tutti, ed alcuni più, quegli effetti sì dottamente e affettuosamente scolpiti dal nostro divino maestro di questa divina passione, il Petrarca. Effetti, che poche persone intendono, e pochissime provano; ma a quei soli pochissimi è concesso l'uscir dalla folla volgare in tutte le umane arti. Questa prima mia fiamma, che non ebbe mai conclusione nessuna, mi restò poi lungamente semiaccesa nel cuore, ed in tutti i miei lunghi viaggi fatti poi negli anni consecutivi, io sempre senza volerlo, e quasi senza avvedermene l'avea tacitamente per norma intima d'ogni mio operare; come se una voce mi fosse andata gridando nel più segreto di esso: “Se tu acquisti tale, o tal pregio, tu potrai al ritorno tuo piacer maggiormente a costei; e cangiate le circostanze, potrai forse dar corpo a quest'ombra”. Nell'autunno dell'anno 1765 feci un viaggietto di dieci giorni a Genova col mio curatore; e fu la mia prima uscita dal paese. La vista del mare mi rapì veramente l'anima, e non mi poteva mai saziare di contemplarlo. Così pure la posizione magnifica e pittoresca di quella superba città, mi riscaldò molto la fantasia. E se io allora avessi saputa una qualche lingua, ed avessi avuti dei poeti per le mani, avrei certamente fatto dei versi; ma da quasi due anni io non apriva più nessun libro, eccettuati di radissimo alcuni romanzi francesi, e qualcuna delle prose di Voltaire, che mi dilettavano assai. Nel mio andare a Genova ebbi un sommo piacere di rivedere la madre e la città mia, di dove mancava già da sette anni, che in quell'età paiono secoli. Tornato poi di Genova, mi pareva di aver fatta una gran cosa, e d'aver visto molto. Ma quanto io mi teneva di questo mio viaggio cogli amici di fuori dell'Accademia (benché non lo dimostrassi loro, per non mortificarli), altrettanto poi mi arrabbiava e rimpiccioliva in faccia ai compagni di dentro, che tutti venivano di paesi lontani, come Inglesi, Tedeschi, Polacchi, Russi, etc.; ed a cui il mio viaggio di Genova pareva, com'era in fatti, una babbuinata. E questo mi dava una frenetica voglia di viaggiare, e di vedere da me i paesi di tutti costoro. In quest'ozio e dissipazione continua, presto mi passarono gli ultimi diciotto mesi ch'io stetti nel Primo Appartamento. Ed essendomi io fatto inscrivere nella lista dei postulanti impiego nelle truppe sin dal prim'anno ch'io v'era entrato, dopo esservi stato tre anni, in quel maggio del 1766, finalmente fui compreso in una promozione generale di forse centocinquanta altri giovanotti. E benché io da più d'un anno mi fossi intiepidito moltissimo in questa vocazione militare, pure non avendo io ritrattata la mia petizione, mi convenne accettare; ed uscii porta-insegna nel Reggimento Provinciale d'Asti. Da prima io aveva chiesto d'entrare nella cavalleria, per l'amore innato dei cavalli; poi di lì a qualche tempo, aveva cambiata la domanda, bastandomi di entrare in uno di quei Reggimenti Provinciali, i quali in tempo di pace non si radunando all'insegne se non se due volte l'anno, e per pochi giorni, lasciavano così una grandissima libertà di non far nulla, che era appunto la sola cosa ch'io mi fossi determinato di voler fare. Con tutto ciò, anche questa milizia di pochi giorni mi spiacque moltissimo; e tanto più, perché l'aver avuto quell'impiego mi costringeva di uscire dall'Accademia, dove io mi trovava assai bene, e ci stava altrettanto volentieri allora, quanto ci era stato male e a contragenio nei due altri Appartamenti, e i primi diciotto mesi del Primo. Bisognò pure ch'io m'adattassi, e nel corrente di quel maggio lasciai l'Accademia, dopo esservi stato quasi ott'anni. E nel settembre mi presentai alla prima rassegna del mio reggimento in Asti, dove compiei esattissimamente ogni dovere del mio impieguccio, abborrendolo; e non mi potendo assolutamente adattare a quella catena di dipendenze gradate, che si chiama subordinazione; ed è veramente l'anima della disciplina militare; ma non poteva esser l'anima mai d'un futuro poeta tragico. All'uscire dell'Accademia, aveva appigionato un piccolo ma grazioso quartiere nella casa stessa di mia sorella; e là attendeva a spendere il più che potessi, in cavalli, superfluità d'ogni genere, e pranzi che andava facendo ai miei amici, ed ai passati compagni dell'Accademia. La smania di viaggiare, accresciutasi in me smisuratamente col conversare moltissimo con codesti forestieri, m'indusse contro la mia indole naturale ad intelaiare un raggiretto per vedere di strappare una licenza di viaggiare a Roma e a Napoli almeno per un anno. E siccome era troppo certa cosa, che in età di anni diciassette e mesi ch'io allora mi aveva, non mi avrebbero mai lasciato andar solo, m'ingegnai con un aio inglese cattolico, che guidava un Fiammingo, ed un Olandese a far questo giro, e coi quali era stato già più d'un anno nell'Accademia, a vedere s'egli voleva anche incaricarsi di me, e così fare il sudetto viaggio noi quattro. Tanto feci insomma, che invogliai anche questi di avermi per compagno, e servitomi poi del mio cognato per ottenermi dal re la 112 licenza di partire sotto la condotta del sudetto aio inglese, uomo più che maturo, e di ottimo grido, finalmente restò fissata la partenza per i primi di ottobre di quell'anno. E questo fu il primo, e in seguito poi l'uno dei pochi raggiri ch'io abbia intrapresi con sottigliezza, e ostinazione di maneggio, per persuadere quell'aio, e il cognato, e più di tutti lo stitichissimo curatore. La cosa riuscì, ma in me mi vergognava e irritava moltissimo di tutte le pieghevolezze, e simulazioni, e dissimulazioni che mi conveniva porre in opera per ispuntarla. Il re, che nel nostro piccolo paese di ogni piccolissima cosa s'ingerisce, non si trovava essere niente propenso ai viaggi de' suoi nobili; e molto meno poi di un ragazzo uscito allora del guscio, e che indicava un certo carattere. Bisognò insomma ch'io mi piegassi moltissimo. Ma grazie alla mia buona sorte, questo non mi tolse poi di rialzarmi in appresso interissimo. E qui darò fine a questa seconda parte; nella quale m'avvedo benissimo che avendovi io intromesso con più minutezza cose forse anco più insipide che nella prima, consiglierò anche il lettore di non attestarvisi molto, o anche di saltarla a piè pari; poiché, a tutto ristringere in due parole, questi otto anni della mia adolescenza altro non sono che infermità, ed ozio, e ignoranza. Epoca terza GIOVINEZZA Abbraccia circa dieci anni di viaggi, e dissolutezze. CAPITOLO PRIMO Primo viaggio. Milano, Firenze, Roma. La mattina del dì 4 ottobre 1766, con mio indicibile trasporto, dopo aver tutta notte farneticato in pazzi pensieri senza mai chiuder occhio, partii per quel tanto sospirato viaggio. Eramo una carrozzata dei quattro padroni, ch'io individuai, un calesse con due servitori, du' altri a cassetta della nostra carrozza, ed il mio cameriere a cavallo da corriere. Ma questi non era già quel vecchiotto datomi a guisa di aio tre anni prima, ché quello lo lasciai a Torino. Era questo mio nuovo cameriere, un Francesco Elia, stato già quasi vent'anni col mio zio, e dopo la di lui morte in Sardegna, passato con me. Egli aveva già viaggiato col suddetto mio zio, due volte in Sardegna, ed in Francia, Inghilterra, ed Olanda. Uomo di sagacissimo ingegno, di un'attività non comune, e che valendo egli solo più che tutti i nostri altri quattro servitori presi a fascio, sarà d'ora in poi l'eroe protagonista della commedia di questi miei viaggi; di cui egli si trovò immediatamente essere il solo e vero nocchiero, stante la nostra totale incapacità di tutti noi altri otto, o bambini, o vecchi rimbambiti. La prima stazione fu di circa quindici giorni in Milano. Avendo io già visto Genova due anni prima, ed essendo abituato al bellissimo locale di Torino, la topografia milanese non mi dovea, né potea piacer niente. Alcune cose che vi sarebbero pur da vedersi, io o non vidi, o male ed in fretta, e da quell'ignorantissimo e svogliato ch'io era d'ogni utile o dilettevole arte. E mi ricordo, tra l'altre, che nella Biblioteca Ambrosiana, datomi in mano dal bibliotecario non so più quale manoscritto autografo del Petrarca, da vero barbaro Allobrogo, lo buttai là, dicendo che non me n'importava nulla. Anzi, in fondo del cuore, io ci aveva un certo rancore con codesto Petrarca; perché alcuni anni prima, quando io era filosofo, essendomi capitato un Petrarca alle mani, l'aveva aperto a' caso da capo, da mezzo, e da piedi, e per tutto lettine, o compitati alcuni pochi versi, in nessun luogo aveva inteso nulla, né mai raccapezzato il senso; onde l'avea sentenziato, facendo coro coi Francesi e con tutti gli altri ignoranti presuntuosi; e tenendolo per un seccatore, dicitor di arguzie e freddure, aveva poi così ben accolto i suoi preziosissimi manoscritti. Del resto, essendo io partito per quel viaggio d'un anno, senza pigliar meco altri libri che alcuni Viaggi d'Italia, e questi tutti in lingua francese, io mi avviava sempre più alla total perfezione della mia già tanto inoltrata barbarie. Coi compagni di viaggio si conversava sempre in francese, e così in alcune case milanesi dove io andava con essi, si parlava pur sempre francese; onde quel pochin pochino ch'io andava pur pensando e combinando nel mio povero capino, era pure vestito di cenci francesi; e alcune letteruzze ch'io andava scrivendo, erano in francese; ed alcune memoriette ridicole ch'io andava schiccherando su questi miei viaggi, eran pure in francese; e il tutto alla peggio, non sapendo io questa linguaccia se non se a caso; non mi ricordando più di nessuna regola ove pur mai l'avessi saputa da prima; e molto meno ancora sapendo l'italiano, raccoglieva così il frutto dovuto della disgrazia primitiva del nascere in un paese anfibio, e della valente educazione ricevutavi. Dopo un soggiorno di due settimane in circa, si partì di Milano. Ma siccome quelle mie sciocche Memorie sul viaggio furono ben presto poi da me stesso corrette con le debite fiamme, non le rinnoverò io qui certamente, col particolarizzare oltre il dovere questi miei viaggi puerili, trattandosi di paesi tanto noti; onde, o nulla o pochissimo dicendo delle diverse città, ch'io, digiuno di ogni bell'arte, visitai come un Vandalo, anderò parlando di me stesso, poiché pure questo infelice tema, è quello che ho assunto in quest'opera. Per la via di Piacenza, Parma, e Modena, si giunse in pochi giorni a Bologna; né ci arrestammo in Parma che un sol giorno, ed in Modena poche ore, al solito senza veder nulla, o prestissimo e male quello che ci era da vedersi. Ed il mio maggiore, anzi il solo piacere ch'io ricavassi dal viaggio, era di ritrovarmi correndo la posta su le strade maestre, e di farne alcune, e il più che poteva, a cavallo da corriere. Bologna, e i suoi portici e frati, non mi piacque gran cosa; dei suoi quadri non ne seppi nulla; e sempre incalzato da una certa impazienza di luogo, io era lo sprone perpetuo del nostro aio antico, che sempre lo instigava a partire. Arrivammo a Firenze in fin d'ottobre; e quella fu la prima città, che a luoghi mi piacque, dopo la partenza di Torino; ma mi piacque pur meno di Genova, che aveva vista due anni prima. 113 Vi si fece soggiorno per un mese; e là pure, sforzato dalla fama del luogo, cominciai a visitare alla peggio la Galleria, e il Palazzo Pitti, e varie chiese; ma il tutto con molta nausea, senza nessun senso del bello; massime in pittura; gli occhi miei essendo molto ottusi ai colori; se nulla nulla gustava un po' più era la scoltura, e l'architettura anche più; forse era in me una reminiscenza del mio ottimo zio, l'architetto. La tomba di Michelangelo in Santa Croce fu una delle poche cose che mi fermassero; e su la memoria di quell'uomo di tanta fama feci una qualche riflessione; e fin da quel punto sentii fortemente, che non riuscivano veramente grandi fra gli uomini, che quei pochissimi che aveano lasciata alcuna cosa stabile fatta da loro. Ma una tal riflessione isolata in mezzo a quell'immensa dissipazione di mente nella quale io viveva continuamente, veniva ad essere per l'appunto come si suol dire, una goccia di acqua nel mare. Fra le tante mie giovenili storture, di cui mi toccherà di arrossire in eterno, non annovererò certamente come l'ultima quella di essermi messo in Firenze ad imparare la lingua inglese, nel breve soggiorno di un mese ch'io vi feci, da un maestruccio inglese che vi era capitato; in vece di imparare dal vivo esempio dei beati Toscani a spiegarmi almeno senza barbarie nella loro divina lingua, ch'io balbettante stroppiava, ogni qual volta me ne doveva prevalere. E perciò sfuggiva di parlarla, il più che poteva; stante che la vergogna di non saperla potea pur qualche cosa in me; ma vi potea pure assai meno che la infingardaggine del non volerla imparare. Con tutto ciò, io mi ero subito ripurgata la pronunzia di quel nostro orribile u lombardo, o francese, che sempre mi era spiaciuto moltissimo per quella sua magra articolazione, e per quella boccuccia che fanno le labbra di chi lo pronunzia, somiglianti in quell'atto moltissimo a quella risibile smorfia che fanno le scimmie, allorché favellano. E ancora adesso, benché di codesto u, da cinque e più anni ch'io sto in Francia ne abbia pieni e foderati gli orecchi, pure egli mi fa ridere ogni volta che ci bado; e massime nella recita teatrale, o camerale (che qui la recita è perpetua), dove sempre fra questi labbrucci contratti che paiono sempre soffiare su la minestra bollente, campeggia principalmente la parola nature. In tal guisa io in Firenze, perdendo il mio tempo, poco vedendo, e nulla imparando, presto tediandomivi, rispronai l'antico nostro mentore, e si partì il dì primo decembre alla volta di Lucca per Prato e Pistoia. Un giorno in Lucca mi parve un secolo; e subito si ripartì per Pisa. E un giorno in Pisa, benché molto mi piacesse il Camposanto, mi parve anche lungo. E subito, a Livorno. Questa città mi piacque assai e perché somigliava alquanto a Torino, e per via del mare, elemento del quale io non mi saziava mai. Il soggiorno nostro vi fu di otto o dieci giorni; ed io sempre barbaramente andava balbettando l'inglese, ed avea chiusi e sordi gli orecchi al toscano. Esaminando poi la ragione di una sì stolta preferenza, ci trovai un falso amor proprio individuale, che a ciò mi spingeva senza ch'io pure me ne avvedessi. Avendo per più di due anni vissuto con Inglesi; sentendo per tutto magnificare la loro potenza e ricchezza; vedendone la grande influenza politica: e per l'altra parte vedendo l'Italia tutta esser morta; gl'Italiani, divisi, deboli, avviliti e servi; io grandemente mi vergognava d'essere, e di parere Italiano, e nulla delle cose loro non voleva né praticar, né sapere. Si partì di Livorno per Siena; e in quest'ultima città, benché il locale non me ne piacesse gran fatto, pure, tanta è la forza del bello e del vero, ch'io mi sentii quasiché un vivo raggio che mi rischiarava ad un tratto la mente, e una dolcissima lusinga agli orecchi e al cuore, nell'udire le più infime persone così soavemente e con tanta eleganza proprietà e brevità favellare. Con tutto ciò non vi stetti che un giorno; e il tempo della mia conversione letteraria e politica era ancora lontano assai; mi bisognava uscire lungamente d'Italia per conoscere ed apprezzar gli Italiani. Partii dunque per Roma, con una palpitazione di cuore quasiché continua, pochissimo dormendo la notte, e tutto il dì ruminando in me stesso e il San Pietro, e il Coliseo, ed il Panteon; cose che io aveva tanto udite esaltare; ed anche farneticava non poco su alcune località della storia romana, la quale (benché senza ordine e senza esattezza) così presa in grande mi era bastantemente nota ed in mente, essendo stata la sola istoria ch'io avessi voluto alquanto imparare nella mia prima gioventù. Finalmente, ai tanti di decembre dell'anno 1766 vidi la sospirata Porta del Popolo; e benché l'orridezza e miseria del paese da Viterbo in poi mi avesse fortemente indisposto, pure quella superba entrata mi racconsolò, ed appagommi l'occhio moltissimo. Appena eramo discesi alla piazza di Spagna dove si albergò, subito noi tre giovanotti, lasciato l'aio riposarsi, cominciammo a correre quel rimanente di giorno, e si visitò alla sfuggita, tra l'altre cose, il Panteon. I miei compagni si mostravano sul totale più maravigliati di queste cose, di quel che lo fossi io. Quando poi alcuni anni dopo ebbi veduti i loro paesi, mi son potuto dare facilmente ragione di quel loro stupore assai maggiore del mio. Vi si stette allora otto giorni soli, in cui non si fece altro che correre per disbramare quella prima impaziente curiosità. Io preferiva però molto di tornare fin due volte il giorno a San Pietro, al veder cose nuove. E noterò, che quell'ammirabile riunione di cose sublimi non mi colpì alla prima quanto avrei desiderato e creduto, ma successivamente poi la maraviglia mia andò sempre crescendo; e ciò, a tal segno, ch'io non ne conobbi ed apprezzai veramente il valore se non se molti anni dopo, allorché stanco della misera magnificenza oltramontana, mi venne fatto di dovermi trattenere in Roma degli anni. CAPITOLO SECONDO Continuazione dei viaggi, liberatomi anche dell'aio. Incalzavaci frattanto l'imminente inverno; e più ancora incalzava io il tardissimo aio, perché si partisse per Napoli, dove s'era fatto disegno di soggiornare per tutto il carnevale. Partimmo dunque coi vetturini, sì perché allora le strade di Roma a Napoli non erano quasi praticabili, sì per via del mio cameriere Elia, che a Radicofani essendo caduto sotto il cavallo di posta si era rotto un braccio, e ricoverato poi nella nostra carrozza avea moltissimo patito negli strabalzi di essa, venendo così fino a Roma. Molto coraggio e presenza di spirito e vera fortezza d'animo aveva mostrato costui in 114 codesto accidente; poiché rialzatosi da sé, ripreso il ronzino per le redini, si avviò soletto a piedi sino a Radicofani distante ancora più d'un miglio. Quivi, fatto cercare un chirurgo, mentre lo stava aspettando si fece sparare la manica dell'abito, e visitandosi il braccio da sé, trovatolo rotto, si fece tenere ben saldamente la mano di esso stendendolo quanto più poteva, e coll'altra, che era la mandritta, se lo riattò sì perfettamente, che il chirurgo, giunto quasi nel tempo stesso che noi sopraggiungevamo con la carrozza, lo trovò rassettato a guisa d'arte in maniera che, senza più altrimenti toccarlo, subito lo fasciò, e in meno d'un'ora noi ripartimmo, collocando il ferito in carrozza, il quale pure con viso baldo e fortissimo pativa non poco. Giunti ad Acquapendente, si trovò rotto il timone della carrozza; del che trovandoci noi tutti impicciatissimi, cioè noi tre ragazzi, il vecchio aio, e gli altri quattro stolidi servitori, quel solo Elia col braccio al collo, tre ore dopo la rottura, era più in moto, e più efficacemente di noi tutti adoperavasi per risarcire il timone; e così bene diresse quella provvisoria rappezzatura, che in meno di du' altre ore si ripartì, e l'infermo timone ci strascinò senz'altro accidente poi sino a Roma. Io mi son compiaciuto d'individuare questo fatto episodico, come tratto caratteristico di un uomo di molto coraggio e gran presenza di spirito, molto più che al suo umile stato non parea convenirsi. Ed in nessuna cosa mi compiaccio maggiormente, che nel lodare ed ammirare quelle semplici virtù di temperamento, che ci debbono pur tanto far piangere sovra i pessimi governi, che le trascurano, o le temono e le soffocano. Si arrivò dunque a Napoli la seconda festa del Natale, con un tempo quasi di primavera. L'entrata da Capo di China per gli Studi e Toledo, mi presentò quella città in aspetto della più lieta e popolosa ch'io avessi veduta mai fin allora, e mi rimarrà sempre presente. Non fu poi lo stesso, quando mi toccò di albergare in una bettolaccia posta nel più buio e sozzo chiassuolo della città: il che fu di necessità perché ogni pulito albergo ritrovavasi pieno zeppo di forestieri. Ma questa contrarietà mi amareggiò assai quel soggiorno, stante che in me la località lieta o no della casa, ha sempre avuto una irresistibile influenza sul mio puerilissimo cervello, sino alla più inoltrata età. In pochi giorni per mezzo del nostro ministro fui introdotto in parecchie case; e il carnovale, sì per gli spettacoli pubblici, che per le molte private feste e varietà d'oziosi divertimenti, mi riusciva brillante e piacevole più ch'altro mai ch'io avessi veduto in Torino. Con tutto ciò in mezzo a quei nuovi e continui tumulti, libero interamente di me, con bastanti danari, d'età diciott'anni, ed una figura avvenente, io ritrovava per tutto la sazietà, la noia, il dolore. Il mio più vivo piacere era la musica burletta del Teatro Nuovo; ma sempre pure quei suoni, ancorché dilettevoli, lasciavano nell'animo mio una lunghissima romba di malinconia; e mi si venivano destando a centinaia le idee le più funeste e lugubri, nelle quali mi compiaceva non poco, e me le andava poi ruminando soletto alle sonanti spiagge di Chiaia e di Portici. Con parecchi giovani signori napoletani avea fatto conoscenza, amicizia con niuno: la mia natura ritrosa anzi che no mi inibiva di ricercare; e portandone la viva impronta sul viso, ella inibiva agli altri di ricercar me. Così delle donne, alle quali per natura era moltissimo inclinato, non mi piacendo se non le modeste, io non piaceva pure che alle sole sfacciate; il che mi facea rimaner sempre col cuor vuoto. Oltre ciò, l'ardentissima voglia ch'io sempre nutriva in me di viaggiare oltre i monti, mi facea sfuggire di allacciarmi in nessuna catena d'amore; e così in quel primo viaggio uscii salvo da ogni rete. Tutto il giorno io correva in quei divertentissimi calessetti a veder le cose più lontane; e non per vederle, che di nulla avea curiosità e di nessuna intendeva, ma per fare la strada, che dell'andare non mi saziava mai, ma immediatamente mi addolorava lo stare. Introdotto a corte, benché quel re, Ferdinando IV, fosse allora in età di quindici, o sedici anni, gli trovai pure una total somiglianza di contegno con i tre altri sovrani ch'io avea veduti fin allora; ed erano il mio ottimo re Carlo Emanuele, vecchione; il duca di Modena, governatore in Milano; e il granduca di Toscana Leopoldo, giovanissimo anch'egli. Onde intesi benissimo fin da quel punto, che i principi tutti non aveano fra loro che un solo viso, e che le corti tutte non erano che una sola anticamera. In codesto mio soggiorno di Napoli intavolai il mio secondo raggiro per mezzo del nostro ministro di Sardegna, per ottenere dalla corte di Torino la permissione di lasciare il mio aio, e di continuare il mio viaggio da me. Benché noi giovanotti vivessimo in perfetta armonia, e che l'aio non più a me che ad essi cagionasse il minimo fastidio, tuttavia siccome per le gite da una all'altra città bisognava pure combinarci per muovere insieme, e siccome quel vecchio era sempre irresoluto, mutabile, e indugiatore, quella dipendenza mi urtava. Convenne dunque ch'io mi piegassi a pregare il ministro di scrivere in mio favore a Torino, e di testimoniare della mia buona condotta e della intera capacità mia di regolarmi da me stesso, e di viaggiar solo. La cosa mi riuscì con mia somma soddisfazione, e ne contrassi molta gratitudine col ministro, il quale avendomi preso anche a ben volere, fu il primo che mi mettesse in capo ch'io dovrei tirarmi innanzi a studiar la politica per entrare nell'aringo diplomatico. La cosa mi piacque assai; e mi parve allora, che quella fosse di tutte le servitù la men serva; e ci rivolsi il pensiero, senza però studiar nulla mai. Limitando il mio desiderio in me stesso, non l'esternai con chicchessia, e mi contentai di tenere frattanto una condotta regolare e decente per tutto, superiore forse alla mia età. Ma in questo mi serviva la natura mia assai più ancora che il volere; essendo io stato sempre grave di costumi e di modi (senza impostura però), ed ordinato, direi, nello stesso disordine; ed avendo quasi sempre errato sapendolo. Io viveva frattanto in tutto e per tutto ignoto a me stesso; non mi credendo vera capacità per nessuna cosa al mondo; non avendo nessunissimo impulso deciso, altro che alla continua malinconia; non ritrovando mai pace né requie, e non sapendo pur mai quello che io mi desiderassi. Obbedendo ciecamente alla natura mia, con tutto ciò io non la conosceva né studiava per niente; e soltanto molti anni dopo mi avvidi, che la mia infelicità proveniva soltanto dal bisogno, anzi necessità ch'era in me di avere ad un tempo stesso il cuore occupato da un degno amore, e la mente da un qualche 115 nobile lavoro; e ogniqualvolta l'una delle due cose mi mancò, io rimasi incapace dell'altra, e sazio e infastidito e oltre ogni dire angustiato. Frattanto, per mettere in uso la mia nuova indipendenza totale, appena finito il carnovale volli assolutamente partirmene solo per Roma, atteso che il vecchio, dicendo di aspettar lettere di Fiandra, non fissava nessun tempo per la partenza dei suoi pupilli. Io, impaziente di lasciar Napoli, di rivedere Roma; o, per dir vero, impazientissimo di ritrovarmi solo e signore di me in una strada maestra, lontano trecento e più miglia dalla mia prigione natia; non volli differire altrimenti, e abbandonai i compagni; ed in ciò feci bene, perché in fatti poi essi stettero tutto l'aprile in Napoli, e non furono per ciò più in tempo per ritrovarsi all'Ascensione in Venezia, cosa che a me premeva allora moltissimo. CAPITOLO TERZO Proseguimento dei viaggi. Prima mia avarizia. Giunto a Roma, previo il mio fidato Elia, azzeccai a piè delle scalere della Trinità de' Monti un grazioso quartierino molto gaio e pulito, che mi racconsolò della sudiceria di Napoli. Stessa dissipazione, stessa noia, stessa malinconia, stessa smania di rimettermi in viaggio. E il peggio era, stessissima ignoranza delle cose le più svergognanti chi le ignora; e maggiore ogni giorno l'insensibilità per le tante belle e grandiose cose di cui Roma ridonda; limitandomi a quattro e cinque delle principali che sempre ritornava a vedere. Ogni giorno poi capitando dal conte di Rivera ministro di Sardegna, degnissimo vecchio, il quale ancorché sordo non mi veniva per punto a noia, e mi dava degli ottimi e luminosi consigli; mi accadde un giorno che si trovò da lui su una tavola un bellissimo Virgilio in folio, aperto spalancato al sesto dell'Eneide. Quel buon vecchio vedendomi entrare, accennatomi d'accostarmi, cominciò ad intuonare con entusiasmo quei bellissimi versi per Marcello così rinomati e saputi da tutti. Ma io, che quasi più punto non li intendeva, benché li avessi e spiegati e tradotti e saputi a memoria circa sei anni prima, mi vergognai sommamente e me ne accorai per tal modo, che per più giorni mi ruminai il mio obbrobrio in me stesso, e non capitai più dal conte. Con tutto ciò la ruggine sovra il mio intelletto si andava incrostando sì densa, e tale di giorno in giorno sempre più diveniva, che assai più tagliente scalpello ci volea che un passeggiere rincrescimento, a volernela estirpare. Onde passò quella sacrosanta vergogna senza lasciare in me orma nessuna per allora, e non lessi altrimenti né Virgilio, né alcun altro buon libro in nessuna lingua, per degli anni parecchi. In questa mia seconda dimora in Roma fui introdotto al papa, che era allora Clemente XIII, bel vecchio, e di una veneranda maestà; la quale, aggiunta alla magnificenza locale del palazzo di Montecavallo, fece sì che non mi cagionò punto ribrezzo la solita prosternazione e il bacio del piede, benché io avessi letta la storia ecclesiastica, e sapessi il giusto valore di quel piede. Per mezzo poi del predetto conte di Rivera, io intavolai e riuscii il mio terzo raggiro presso la corte paterna di Torino, per ottenere la permissione di un secondo anno di viaggi in cui destinava di vedere la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda; nomi che mi suonavano maraviglia e diletto nella mia giovinezza inesperta. E anche questo terzo raggiretto mi riuscì, onde, ottenuto quell'anno più, per tutto il 1768 in circa io mi trovava in piena libertà e certezza di poter correre il mondo. Ma nacque allora una piccola difficoltà, la quale mi contristò lungamente. Il mio curatore, col quale non si era mai entrato in conti, e che non mi avea mai fatto vedere in chiaro con esattezza quello ch'io m'avessi d'entrata; dandomi parole diverse ed ambigue, ed ora accordandomi danari, ora no; mi scrisse in quell'occasione dell'ottenuta permissione, che pel second'anno mi avrebbe somministrata una credenziale di millecinquecento zecchini, non me ne avendo dati che soli milleduecento pel primo viaggio. Questa sua intimazione mi sbigottì assai, senza però scoraggirmi. Udendo io sempre mentovare la gran carezza dei paesi oltramontani, mi riusciva assai dura cosa di dovermi trovare sprovvisto, e di esservi costretto a far delle triste figure. Per altra parte poi, io non mi arrischiava di scrivere di buon inchiostro allo stitico curatore, perché a quel modo l'avrei subito avuto contrario; e m'avrebbe intuonato la parola re, la quale in Torino nei più interni affari domestici si suole sempre intrudere, fra il ceto dei nobili; e gli sarebbe stato facilissimo di divolgarmi per discolo e scialacquatore, e di farmi come tale richiamar subito in patria. Non feci dunque nessuna querela col curatore, ma presi in me la risoluzione di risparmiare quanti più danari potrei in quel primo viaggio dai milleduecento zecchini già assegnatimi, per così accrescere quanto più potrei ai millecinquecento da esigersi, e che mi pareano scarsissimi per un anno di viaggi oltramontani. In questo modo io per la prima volta, da un giusto e piuttosto largo spendere, ristrettomi alla meschinità, provai un doloroso accesso di sordida avarizia. Ed andò questa tant'oltre che non solo non andava più a visitare nessuna delle curiosità di Roma per non dare le mancie, ma anche al mio fidato e diletto Elia, procrastinandolo d'un giorno in un altro, io venni a negargli i danari del suo salario e vitto, a segno ch'egli mi si protestò ch'io lo sforzerei a rubarmeli per campare. Allora, di mal animo, glie li diedi. Rimpicciolito così di mente e di cuore, partii verso i primi di maggio alla volta di Venezia; e la mia meschinità mi fece prendere il vetturino, ancorché io abborrissi quel passo mulare: ma pure il divario tra la posta e la vettura essendo sì grande, io mi vi sottoposi, e mi avviai bestemmiando. Io lasciava nel calesse Elia col servitore, e me n'andava cavalcando un umile ronzino, che ad ogni terzo passo inciampava; onde io faceva quasi tutta la strada a piedi, conteggiando così sotto voce e su le dita della mano quanto mi costerebbero quei dieci o dodici giorni di viaggio; quanto, un mese di soggiorno in Venezia; quanto sarebbe il risparmio all'uscir d'Italia, e quanto questa cosa, e quanto quell'altra; e mi logorava il cuore e il cervello in cotali sudicerie. Il vetturino era patteggiato da me sino a Bologna per la via di Loreto; ma giunto con tanta noia e strettezza d'animo in Loreto, non potei più star saldo all'avarizia e alla mula, e non volli più continuare di quel mortifero passo. E qui la 116 nascente gelata avarizia rimase vinta e sbeffata dalla bollente indole e dalla giovanile insofferenza. Onde, fatto a dirittura un grosso sbilancio, sborsai al vetturino quasi che tutto il pattuito importare di tutto il viaggio di Roma a Bologna, e piantatolo in Loreto, me ne partii per le poste tutto riavutomi; e l'avarizia diventò d'allora in poi un giusto ordine, ma senza spilorceria. Bologna non mi piacque nulla più, anzi meno al ritorno che non mi fosse piaciuta all'andare; Loreto non mi compunse di divozione nessuna; e non sospirando altro che Venezia, della quale avea udito tante maraviglie già fin da ragazzo, dopo un solo giorno di stazione in Bologna, proseguii per Ferrara. Passai anche questa città senza pur ricordarmi, ch'ella era la patria e la tomba di quel divino Ariosto di cui pure avea letto in parte il poema con infinito piacere, e i di cui versi erano stati i primi primissimi che mi fossero capitati alle mani. Ma il mio povero intelletto dormiva allora di un sordidissimo sonno, e ogni giorno più s'irruginiva quanto alle lettere. Vero è però, che quanto alla scienza del mondo e degli uomini, io andava acquistando non poco ogni giorno senza avvedermene, stante la gran quantità di continui e diversi quadri morali che mi venivan visti e osservati giornalmente. Al ponte di Lagoscuro m'imbarcai su la barca corriera di Venezia; e mi vi trovai in compagnia d'alcune ballerine di teatro, di cui una era bellissima; ma questo non mi alleggerì punto la noia di quell'imbarcazione, che durò due giorni e una notte, sino a Chiozza, atteso che codeste ninfe faceano le Susanne, e che io non ho mai tollerato la simulata virtù. Ed eccomi finalmente in Venezia. Nei primi giorni l'inusitata località mi riempì di maraviglia e diletto; e me ne piacque perfino il gergo, forse perché dalle commedie del Goldoni ne avea sin da ragazzo contratta una certa assuefazione d'orecchio; ed in fatti quel dialetto è grazioso, e manca soltanto di maestà. La folla dei forestieri, la quantità dei teatri, ed i molti divertimenti e feste che, oltre le solite farsi per ogni fiera dell'Ascensa, si davano in quell'anno a contemplazione del duca di Wirtemberg, e tra l'altre la sontuosa regata, mi fecero trattenere in Venezia sino a mezzo giugno, ma non mi tennero perciò divertito. La solita malinconia, la noia, e l'insofferenza dello stare, ricominciavano a darmi i loro aspri morsi tosto che la novità degli oggetti trovavasi ammorzata. Passai più giorni in Venezia solissimo senza uscir di casa; e senza pure far nulla che stare alla finestra, di dove andava facendo dei segnuzzi, e qualche breve dialoghetto con una signorina che mi abitava di faccia; e il rimanente del giorno lunghissimo, me lo passava o dormicchiando, o ruminando non saprei che, o il più spesso anche piangendo, né so di che; senza mai trovar pace, né investigare né dubitarmi pure della cagione che me la intorbidava o toglieva. Molti anni dopo, osservandomi un poco meglio, mi convinsi poi che questo era in me un accesso periodico d'ogni anno nella primavera, alle volte in aprile, alle volte anche sino a tutto giugno; e più o meno durevole e da me sentito, secondo che il cuore e la mente si combinavano essere allora più o meno vuoti ed oziosi. Nell'istesso modo ho osservato poi, paragonando il mio intelletto ad un eccellente barometro, che io mi trovava avere ingegno e capacità al comporre più o meno, secondo il più o men peso dell'aria; ed una totale stupidità nei gran venti solstiziali ed equinoziali; e una infinitamente minore perspicacità la sera che la mattina; e assai più fantasia, entusiasmo, e attitudine all'inventare nel sommo inverno e nella somma state che non nelle stagioni di mezzo. Questa mia materialità, che credo pure in gran parte essere comune un po' più un po' meno a tutti gli uomini di fibra sottile, mi ha poi col tempo scemato e annullato ogni orgoglio del poco bene ch'io forse andava alle volte operando, come anche mi ha in gran parte diminuito la vergogna del tanto più male che avrò certamente fatto, e massime nell'arte mia; essendomi pienamente convinto che non era quasi in me il potere in quei dati tempi fare altrimenti. CAPITOLO QUARTO Fine del viaggio d'Italia, e mio primo arrivo a Parigi. Riuscitomi dunque il soggiorno in Venezia sul totale anzi noioso che no; ed essendo perpetuamente incalzato dalla smania del futuro viaggio d'oltramonti, non ne cavai neppure il minimo frutto. Non visitai neppure la decima parte delle tante maraviglie, sì di pittura che d'architettura e scoltura, riunite tutte in Venezia; basti dire con mio infinito rossore, che né pure l'Arsenale. Non presi nessunissima notizia, anco delle più alla grossa, su quel governo che in ogni cosa differisce da ogni altro; e che, se non buono, dee riputarsi almen raro, poiché pure per tanti secoli ha sussistito con tanto lustro, prosperità, e quiete. Ma io, digiuno sempre d'ogni bell'arte, turpemente vegetava, e non altro. Finalmente partii di Venezia al solito con mille volte assai maggior gusto che non c'era arrivato. Giunto a Padova, ella mi spiacque molto; non vi conobbi nessuno dei tanti professori di vaglia, i quali desiderai poi di conoscere molti anni dopo; anzi, allora al solo nome di professori, di studio, e di Università, io mi sentiva rabbrividire. Non mi ricordai (anzi neppur lo sapeva) che poche miglia distante da Padova giacessero le ossa del nostro gran luminare secondo, il Petrarca; e che m'importava egli di lui, io che mai non l'avea né letto, né inteso, né sentito, ma appena appena preso fra le mani talvolta, e non v'intendendo nulla buttatolo? Perpetuamente così spronato e incalzato dalla noia e dall'ozio, passai Vicenza, Verona, Mantova, Milano, e in fretta in furia mi ridussi in Genova, città che da me veduta alla sfuggita qualch'anni prima, mi avea lasciato un certo desiderio di sé. Io avea delle lettere di raccomandazione in quasi tutte le suddette città, ma per lo più non le ricapitava, o se pur lo faceva, il mio solito era di non mi lasciar più vedere; fuorché quelle persone non mi venissero insistentemente a cercare; il che non accadea quasi mai, e non doveva in fatti accadere. Questa sì fatta selvatichezza era in me occasionata in parte da fierezza e inflessibilità d'ineducato carattere, in parte da una renitenza naturale e quasi invincibile al veder visi nuovi. Ed era pur cosa impossibile davvero di andar sempre cangiando paese senza che mi si cangiassero le persone. Avrei voluto per la parte del cuore convivere sempre con la stessa gente; ma sempre in luogo diverso. 117 In Genova dunque, non vi essendo allora il ministro di Sardegna, e non conoscendovi altri che il mio banchiere, non tardai anche molto a tediarmi; e già aveva fissato di partirne verso il fine di giugno, allorché un giorno quel banchiere, uomo di mondo e di garbo, venutomi a visitare, e trovatomi così solitario, selvatico, e malinconico, volle sapere come io passassi il mio tempo; e vedendomi senza libri, senza conoscenze, senza occupazione altra che di stare al balcone, e correre tutto il giorno per le vie di Genova, o di passeggiare pel lido in barchetta, gli prese forse una certa compassione di me e della mia giovinezza, e volle assolutamente portarmi da un cavaliere suo amico. Questi era il signor Carlo Negroni, che avea passata gran parte della sua vita in Parigi, e che vedendomi cotanto invogliato di andarvi, me ne disse quel vero e schietto, al quale non prestai fede se non se alcuni mesi dopo, tosto che vi fui arrivato. Frattanto quel garbato signore mi introdusse in parecchie case delle primarie; e all'occasione del famoso banchetto che si suol dare dal doge nuovo, egli mi servì d'introduttore e compagno. E là fui quasi quasi sul punto d'innamorarmi d'una gentil signora, la quale mi si mostrava bastantemente benigna. Ma per altra parte smaniando io di correre il mondo e di abbandonar l'Italia, Amore non poté per quella volta afferrarmi, ma me la serbò per non molto tempo. Partito finalmente per mare in una feluchetta alla volta di Antibo, pareva a me d'andare all'Indie. Non mi era mai scostato da terra più che poche miglia nelle mie passeggiate marittime; ma allora, alzatosi un venticello favorevole, si prese il largo; successivamente poi rinforzò tanto il vento, che fattosi pericoloso fummo costretti di pigliar porto in Savona; e soggiornarvi due dì per aspettare buon tempo. Questo ritardo mi noiò ed afflisse moltissimo; e non uscii mai di casa, neppure per visitare quella famosissima Madonna di Savona. Io non voleva più assolutamente vedere né sentir nulla dell'Italia; onde ogni istante di più che mi ci dovea trattenere, mi pareva una dura difalcazione dai tanti diletti che mi aspettavano in Francia. Frutto in me di una sregolata fantasia, che tutti i beni e tutti i mali m'ingrandiva sempre oltremodo, prima di provarli; talché poi gli uni e gli altri, e principalmente i beni, all'atto pratico poi non mi parevano nulla. Giunto pure una volta in Antibo, e sbarcatovi, parea che tutto mi racconsolasse l'udire altra lingua, il vedere altri usi, altro fabbricato, altre faccie; e benché tutto fosse piuttosto diverso in peggio che in meglio, pure mi dilettava quella piccola varietà. Tosto ripartii per Tolone; e appena in Tolone, volli ripartir per Marsiglia, non avendo visto nulla in Tolone, città la cui faccia mi dispiacque moltissimo. Non così di Marsiglia, il cui ridente aspetto, le nuove, ben diritte e pulite vie, il bel corso, il bel porto, e le leggiadre e proterve donzelle, mi piacquero sommamente alla prima; e subito mi determinai di starvi un mesetto, per lasciare sfogare anche gli eccessivi calori del luglio, poco opportuni al viaggiare. Nel mio albergo v'era giornalmente tavola rotonda, onde io trovandomi aver compagnia a pranzo e cena, senza essere costretto di parlare (cosa che sempre mi costò qualche sforzo, sendo di taciturna natura), io passava con soddisfazione le altre ore del giorno da me. E la mia taciturnità, di cui era anche in parte cagione una certa timidità che non ho mai vinta del tutto in appresso, si andava anche raddoppiando a quella tavola, attesa la costante garrulità dei Francesi, i quali vi si trovavano di ogni specie; ma i più erano ufficiali, o negozianti. Con nessuno però di essi né amicizia contrassi né famigliarità, non essendo io in ciò mai stato di natura liberale né facile. Io li stava bensì ascoltando volentieri, benché non v'imparassi nulla; ma lo ascoltare è una cosa che non mi ha costato mai pena, anche i più sciocchi discorsi, dai quali si apprende tutto quello che non va detto. Una delle ragioni che mi aveano fatto desiderare maggiormente la Francia, si era di poterne seguitatamente godere il teatro. Io aveva veduto due anni prima in Torino una compagnia di comici francesi, e per tutta un'estate l'aveva assiduamente praticata; onde molte delle principali tragedie, e quasi tutte le più celebri commedie, mi erano note. Io debbo però dire pel vero, che sì in Torino che in Francia; sì in quel primo viaggio, come nel secondo fattovi due anni e più dopo; non mi cadde mai nell'animo, né in pensiero pure, ch'io volessi o potessi mai scrivere delle composizioni teatrali. Onde io ascoltava le altrui con attenzione sì, ma senza intenzione nessuna; e, ch'è più, senza sentirmi nessunissimo impulso al creare; anzi sul totale mi divertiva assai più la commedia, di quello che mi toccasse la tragedia, ancorché per natura mia fossi tanto più inclinato al pianto che al riso. Riflettendovi poi in appresso, mi parve che l'una delle principali ragioni di questa mia indifferenza per la tragedia, nascesse dall'esservi in quasi tutte le tragedie francesi delle scene intere, e spesso anche degli atti, che dando luogo a personaggi secondari mi raffreddavano la mente ed il cuore assaissimo, allungando senza bisogno l'azione, o per meglio dire interrompendola. Vi si aggiungeva poi, che l'orecchio mio, ancorché io non volessi essere Italiano, pur mi serviva ottimamente malgrado mio, e mi avvertiva della noiosa e insulsa uniformità di quel verseggiare a pariglia a pariglia di rime, e i versi a mezzi a mezzi, con tanta trivialità di modi, e sì spiacevole nasalità di suoni; onde, senza ch'io sapessi pur dire il perché, essendo quegli attori eccellenti rispetto ai nostri iniquissimi; essendo le cose da essi recitate per lo più ottime quanto all'affetto, alla condotta, e ai pensieri; io con tutto ciò vi andava provando una freddezza di tempo in tempo, che mi lasciava mal soddisfatto. Le tragedie che mi andavano più a genio, erano la Fedra, l'Alzira, il Maometto, e poche altre. Oltre il teatro, era anche uno de' miei divertimenti in Marsiglia il bagnarmi quasi ogni sera nel mare. Mi era venuto trovato un luoghetto graziosissimo ad una certa punta di terra posta a man dritta fuori del porto, dove sedendomi su la rena con le spalle addossate a uno scoglio ben altetto che mi toglieva ogni vista della terra da tergo, innanzi ed intorno a me non vedeva altro che mare e cielo; e così fra quelle due immensità abbellite anche molto dai raggi del sole che si tuffava nell'onde, io mi passava un'ora di delizie fantasticando; e quivi avrei composte molte poesie, se io avessi saputo scrivere o in rima o in prosa in una lingua qual che si fosse. 118 Ma tediatomi pure anche del soggiorno di Marsiglia, perché ogni cosa presto tedia gli oziosi; ed incalzato ferocemente dalla frenesia di Parigi; partii verso il 10 d'agosto, e più come fuggitivo che come viaggiatore, andai notte e giorno senza posarmi sino a Lione. Non Aia col suo magnifico e ridente passeggio; non Avignone, già sede papale, e tomba della celebre Laura; non Valchiusa, stanza già sì gran tempo del nostro divino Petrarca; nulla mi potea distornare dall'andar dritto a guisa di saetta in verso Parigi. In Lione la stanchezza mi fece trattenere due notti e un giorno; e ripartitone con lo stesso furore, in meno di tre giorni per la via della Borgogna mi condussi in Parigi. CAPITOLO QUINTO Primo soggiorno in Parigi. Era, non ben mi ricordo il dì quanti di agosto, ma fra il 15, e il 20, una mattinata nubilosa fredda e piovosa; io lasciava quel bellissimo cielo di Provenza e d'Italia, e non era mai capitato fra sì fatte sudicie nebbie, massimamente in agosto; onde l'entrare in Parigi pel sobborgo miserrimo di San Marcello, e il progredire poi quasi in un fetido fangoso sepolcro nel sobborgo di San Germano, dove andava ad albergo, mi serrò sì fortemente il cuore, ch'io non mi ricordo di aver provato in vita mia per cagione sì piccola una più dolorosa impressione. Tanto affrettarmi, tanto anelare, tante pazze illusioni di accesa fantasia, per poi inabissarmi in quella fetente cloaca. Nello scendere all'albergo, già mi trovava pienamente disingannato; e se non era la stanchezza somma, e la non picciola vergogna che me ne sarebbe ridondata, io immediatamente sarei ripartito. Nell'andar poi successivamente dattorno per tutto Parigi, sempre più mi andai confermando nel mio disinganno. L'umiltà e barbarie del fabbricato; la risibile pompa meschina delle poche case che pretendono a palazzi; il sudiciume e goticismo delle chiese; la vandalica struttura dei teatri d'allora; e i tanti e tanti e tanti oggetti spiacevoli che tutto dì mi cadeano sott'occhio, oltre il più amaro di tutti, le pessimamente architettate faccie impiastrate delle bruttissime donne; queste cose tutte non mi venivano poi abbastanza rattemperate dalla bellezza dei tanti giardini, dall'eleganza e frequenza degli stupendi passeggi pubblici, dal buon gusto e numero infinito di bei cocchi, dalla sublime facciata del Louvre, dagli innumerabili e quasi tutti buoni spettacoli, e da altre sì fatte cose. Continuava intanto con incredibile ostinazione il mal tempo, a segno che da quindici e più giorni d'agosto ch'io aveva passati in Parigi, non ne aveva ancora salutato il sole. Ed i miei giudizi morali, più assai poetici che filosofici, si risentivano sempre non poco dell'influenza dell'atmosfera. Quella prima impressione di Parigi mi si scolpì sì fortemente nel capo, che ancora adesso (cioè ventitré anni dopo) ella mi dura negli occhi e nella fantasia, ancorché in molte parti la ragione in me la combatta e condanni. La corte stava in Compiegne, e ci si dovea trattenere per tutto il settembre; onde non essendo allora in Parigi l'ambasciatore di Sardegna per cui aveva delle lettere, io non vi conosceva anima al mondo, altri che alcuni forestieri già da me incontrati e trattati in diverse città d'Italia. E questi neppure conosceano nessuna onesta persona in Parigi. Dunque così passava io il mio tempo fra i passeggi, i teatri, le ragazze di mondo, e il dolore quasi che continuo: e così durai sino al fin di novembre, tempo in cui da Fontainebleau si restituì l'ambasciatore a dimora in Parigi. Introdotto io allora da esso in varie case, principalmente degli altri ministri esteri, dall'ambasciatore di Spagna dove c'era un faraoncino, mi posi per la prima volta a giuocare. Ma senza notabile perdita né vincita mai, ben presto mi tediai anche del giuoco, come d'ogni altro mio passatempo in Parigi; onde mi determinai di partirne in gennaio per Londra; stufo di Parigi, di cui non conoscea pure altro che le strade; e sul totale già molto raffreddato nella smania di veder cose nuove; tutte sempre trovandole di gran lunga inferiori, non che agli enti immaginari ch'io mi era andati creando nella fantasia, ma agli stessi oggetti reali già da me veduti nei diversi luoghi d'Italia; talché in Londra poi terminai d'imparare a ben conoscere e prezzare e Napoli, e Roma, e Venezia, e Firenze. Prima ch'io partissi per Londra, avendomi proposto l'ambasciatore di presentarmi a corte in Versailles, io accettai per una certa curiosità di vedere una corte maggiore delle già vedute da me sin allora, benché fossi pienamente disingannato su tutte. Ci fui pel capo d'anno del 1768, giorno anche più curioso attese le varie funzioni che vi si praticano. Ancorché io fossi prevenuto che il re non parlava ai forestieri comuni, e che certo poco m'importasse di una tal privazione, con tutto ciò non potei inghiottire il contegno giovesco di quel regnante, Luigi XV, il quale squadrando l'uomo presentatogli da capo a piedi, non dava segno di riceverne impressione nessuna; mentre se ad un gigante si dicesse: “Ecco ch'io gli presento una formica”: egli pure guardandola, o sorriderebbe, o direbbe forse: “Oh che piccolo animaluzzo!”; o se anche il tacesse, lo direbbe il di lui viso per esso. Ma quella negativa di sprezzo non mi afflisse poi più allorquando, pochi momenti dopo, vidi che il re andava spendendo la stessa moneta delle sue occhiate sopra degli oggetti tanto più importanti che non m'era io. Fatta una breve preghiera fra due suoi prelati, di cui l'uno, se ben mi ricordo, era cardinale, il re si avviò per andare alla cappella, e fra due porte gli si fece incontro il preposto della Mercanzia, primo uffiziale della Municipalità di Parigi, e gli balbettò un complimentuccio d'uso pel capo d'anno. Il taciturno sire gli rispose con un'alzata di testa: e rivoltosi ad uno de' suoi cortigiani che lo seguivano, domandò dove fossero rimasti les echevins, che sono i consueti accoliti del suddetto preposto. Allora una voce cortigianesca uscita così a mezzo dalla turba di essi, facetamente disse: Ils sont restés embourbés. Rise tutta la corte, e lo stesso monarca sorrise, e passò oltre verso la messa che lo aspettava. La incostante fortuna poi volle, che in poco più di vent'anni io vedessi in Parigi nel Palazzo della Città un altro Luigi re ricevere assai più benignamente un altro assai diverso complimento fattogli da altro preposto sotto il titolo di maire, il dì 17 luglio 1789: ed erano allora rimasti embourbés i cortigiani nel venir di Versailles a Parigi, benché fosse di fitta estate; ma il fango su quella strada era fino a quel punto fatto perenne. E di 119 aver visto tal cosa ne loderei forse Dio, se non temessi, e credessi pur troppo, che gli effetti e influenza di questi re plebei siano per essere ancor più funesti alla Francia ed al mondo, che quelli dei re capetini. 120 Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Iacopo Ortis [a cura di G. Gambarin, Firenze, Le Monnier, 1970. AL LETTORE Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta; e di consecrare alla memoria del solo amico mio quelle lagrime, che ora mi si vieta di spargere su la sua sepoltura. E tu, o Lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri quell'eroismo di cui non sono eglino stessi capaci, darai, spero, la tua compassione al giovine infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. LORENZO ALDERANI 2. PARTE I 1 Da' colli Euganei, 11 ottobre 1797. Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch'io per salvarmi da chi m'opprime mi commetta a chi mi ha tradito? consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti sono dunque gli sventurati? E noi, pur troppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl'italiani. Per me segua che può. Poichè ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da' pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de' miei padri. 2 13 Ottobre. Ti scongiuro, Lorenzo; non ribattere più. Ho deliberato di non allontanarmi da questi colli. È vero ch'io aveva promesso a mia madre di rifuggirmi in qualche altro paese; ma non mi è bastato il cuore: e mi perdonerà, spero. Merita poi questa vita di essere conservata con la viltà, e con l'esilio? Oh quanti de' nostri concittadini gemeranno pentiti, lontani dalle loro case! perchè, e che potremmo aspettarci noi se non se indigenza e disprezzo; o al più, breve e sterile compassione, solo conforto che le nazioni incivilite offrono al profugo straniero? Ma dove cercherò asilo? in Italia? terra prostituita premio sempre della vittoria. Potrò io vedermi dinanzi agli occhi coloro che ci hanno spogliati, derisi, venduti, e non piangere d'ira? Devastatori de' popoli, si servono della libertà come i Papi si servivano delle crociate. Ahi! sovente disperando di vendicarmi mi caccerei un coltello nel cuore per versare tutto il mio sangue fra le ultime strida della mia patria. E questi altri? — hanno comperato la nostra schiavitù, racquistando con l'oro quello che stolidamente e vilmente hanno perduto con le armi. — Davvero ch'io somiglio un di que' malavventurati che spacciati morti furono sepolti vivi, e che poi rinvenuti, si sono trovati nel sepolcro fra le tenebre e gli scheletri, certi [di] vivere, ma disperati del dolce lume della vita, e costretti a morire fra le bestemmie e la fame. E perchè farci vedere e sentire la libertà, e poi ritorcela per sempre? e infamemente! 3 16 Ottobre. Or via, non se ne parli più: la burrasca pare abbonacciata; se tornerà il pericolo, rassicurati, tenterò ogni via di scamparne. Del resto io vivo tranquillo; per quanto si può tranquillo. Non vedo persona del mondo: vo sempre vagando per la campagna; ma a dirti il vero penso, e mi rodo. Mandami qualche libro. Che fa Lauretta? povera fanciulla! io l'ho lasciata fuori di sè. Bella e giovine ancora, ha pur inferma la ragione; e il cuore infelice infelicissimo. Io non l'ho amata; ma fosse compassione o riconoscenza per avere ella scelto me solo consolatore del suo stato, versandomi nel petto tutta la sua anima e i suoi errori e i suoi martirj — davvero ch'io l'avrei fatta volentieri compagna di tutta la mia vita. La sorte non ha voluto; meglio così, forse. Ella amava Eugenio, e l'è morto fra le braccia. Suo padre e i suoi fratelli hanno dovuto fuggire la loro patria, e quella povera famiglia destituta di ogni umano soccorso è restata a vivere, chi sa come! di pianto. Eccoti, o Libertà, un'altra vittima. Sai ch'io ti scrivo, o Lorenzo, piangendo come un ragazzo? — pur troppo! ho avuto sempre a che fare con de' tristi; e se alle volte ho incontrato una persona dabbene ho dovuto sempre compiangerla. Addio, addio. 4 18 Ottobre. Michele mi ha recato il Plutarco, e te ne ringrazio. Mi disse che con altra occasione m'invierai qualche altro libro; per ora basta. Col divino Plutarco potrò consolarmi de' delitti e delle sciagure dell'umanità volgendo gli occhi ai pochi 121 illustri che quasi primati dell'umano genere sovrastano a tanti secoli e a tante genti. Temo per altro che spogliandoli della magnificenza storica e della riverenza per l'antichità, non avrò assai da lodarmi e nè degli antichi, nè de' moderni, nè di me stesso — umana razza! 5 23 Ottobre. Se m'è dato lo sperare mai pace, l'ho trovata, o Lorenzo. Il parroco, il medico, e tutti gli oscuri mortali di questo cantuccio della terra mi conoscono sin da fanciullo e mi amano. Quantunque io viva fuggiasco, mi vengono tutti d'intorno quasi volessero mansuefare una fiera generosa e selvatica. Per ora io lascio correre. Veramente non ho avuto tanto bene dagli uomini da fidarmene così alle prime: ma quel menare la vita del tiranno che freme e trema d'essere scannato a ogni minuto, mi pare un agonizzare in una morte lenta, obbrobriosa. Io seggo con essi a mezzodì sotto il platano della chiesa leggendo loro le vite di Licurgo e di Timoleone. Domenica mi s'erano affollati intorno tutti i contadini, che, quantunque non comprendessero affatto, stavano ascoltandomi a bocca aperta. Credo che il desiderio di sapere e ridire la storia de' tempi andati sia figlio del nostro amor proprio che vorrebbe illudersi e prolungare la vita unendoci agli uomini ed alle cose che non sono più, e facendole, sto per dire, di nostra proprietà. Ama la immaginazione di spaziare fra i secoli e di possedere un altro universo. Con che passione un vecchio lavoratore mi narrava stamattina la vita de' parrochi della villa viventi nella sua fanciullezza, e mi descriveva i danni della tempesta di trentasett'anni addietro, e i tempi dell'abbondanza, e quei della fame, rompendo il filo ogni tanto, ripigliandolo, e scusandosi dell'infedeltà! Così mi riesce di dimenticarmi ch'io vivo. È venuto a visitarmi il signore T. che tu conoscesti a Padova. Mi disse che spesso gli parlavi di me, e che jer l'altro glien'hai scritto. Anche egli s'è ridotto in campagna per evitare i primi furori del volgo, quantunque a dir vero non siasi molto ingerito ne' pubblici affari. Io n'aveva inteso parlare come d'uomo di colto ingegno e di somma onestà: doti temute in passato, ma adesso non possedute impunemente. Ha tratto cortese, fisonomia liberale, e parla col cuore. V'era con lui un tale; credo, lo sposo promesso di sua figlia. Sarà forse un bravo e buono giovine; ma la sua faccia non dice nulla. Buona notte. 6 24 Ottobre. L'ho pur una volta afferrato nel collo quel ribaldo contadinello che dava il guasto al nostro orto, tagliando e rompendo tutto quello che non poteva rubare. Egli era sopra un pesco, io sotto una pergola: scavezzava allegramente i rami ancora verdi perchè di frutta non ve ne erano più: appena l'ebbi fra le ugne, cominciò a gridare: Misericordia! Mi confessò che da più settimane facea quello sciagurato mestiere perchè il fratello dell'ortolano aveva qualche mese addietro rubato un sacco di fave a suo padre. — E tuo padre t'insegna a rubare? — In fede mia, signor mio, fanno tutti così. — L'ho lasciato andare, e scavalcando una siepe io gridava: Ecco la società in miniatura; tutti così. 7 26 Ottobre. La ho veduta, o Lorenzo, la divina fanciulla; e te ne ringrazio. La trovai seduta miniando il proprio ritratto. Si rizzò salutandomi come s'ella mi conoscesse, e ordinò a un servitore che andasse a cercar di suo padre. Egli non si sperava, mi diss'ella, che voi sareste venuto; sarà per la campagna; nè starà molto a tornare. Una ragazzina le corse fra le ginocchia dicendole non so che all'orecchio. È un amico di Lorenzo, le rispose Teresa, è quello che il babbo andò a trovare l'altr'jeri. Tornò frattanto il signore T.: m'accoglieva famigliarmente, ringraziandomi che io mi fossi sovvenuto di lui. Teresa intanto, prendendo per mano la sua sorellina, partiva. Vedete, mi diss'egli, additandomi le sue figliuole che uscivano dalla stanza; eccoci tutti. Proferì, parmi, queste parole come se volesse farmi sentire che gli mancava sua moglie. Non la nominò. Si ciarlò lunga pezza. Mentr'io stava per congedarmi, tornò Teresa: Non siamo tanto lontani, mi disse; venite qualche sera a veglia con noi. Io tornava a casa col cuore in festa. — Che? lo spettacolo della bellezza basta forse ad addormentare in noi tristi mortali e tutti i dolori? vedi per me una sorgente di vita: unica certo, e chi sa! fatale. Ma se io sono predestinato ad avere l'anima perpetuamente in tempesta, non è tutt'uno? […] 3. PARTE II 10 Milano, 4 Dicembre. Siati questa l'unica risposta a' tuoi consiglj. In tutti i paesi ho veduto gli uomini sempre di tre sorta: i pochi che comandano; l'universalità che serve; e i molti che brigano. Noi non possiam comandare, nè forse siam tanto scaltri; noi non siam ciechi, nè vogliamo ubbidire; noi non ci degniamo di brigare. E il meglio è vivere come que' cani senza 122 padrone a' quali non toccano nè tozzi nè percosse. — Che vuoi tu ch'io accatti protezioni ed impieghi in uno Stato ov'io sono reputato straniero, e donde il capriccio di ogni spia può farmi sfrattare? Tu mi esalti sempre il mio ingegno; sai tu quanto io vaglio? nè più nè meno di ciò che vale la mia entrata: se per altro io non facessi il letterato di corte, rintuzzando quel nobile ardire che irrita i potenti, e dissimulando la virtù e la scienza, per non rimproverarli della loro ignoranza, e delle loro scelleraggini. Letterati! — O! tu dirai, così da per tutto. — E sia così: lascio il mondo com'è; ma s'io dovessi impacciarmene vorrei o che gli uomini mutassero modo, o che mi facessero mozzare il capo sul palco; e questo mi pare più facile. Non che i tirannetti non si avveggano delle brighe; ma gli uomini balzati da' trivj al trono hanno d'uopo di faziosi che poi non possono contenere. Gonfj del presente, spensierati dell'avvenire, poveri di fama, di coraggio e d'ingegno, si armano di adulatori e di satelliti, da' quali, quantunque spesso traditi e derisi, non sanno più svilupparsi: perpetua ruota di servitù, di licenza e di tirannia. Per essere padroni e ladri del popolo conviene prima lasciarsi opprimere, depredare, e conviene leccare la spada grondante del tuo sangue. Così potrei forse procacciarmi una carica, qualche migliajo di scudi ogni anno di più, rimorsi, ed infamia. Odilo un'altra volta: Non reciterò mai la parte del piccolo briccone. Tanto e tanto so di essere calpestato; ma almen fra la turba immensa de' miei conservi, simile a quegli insetti che sono sbadatamente schiacciati da chi passeggia. Non mi glorio come tanti altri della servitù; nè i miei tiranni si pasceranno del mio avvilimento. Serbino ad altri le loro ingiurie e i lor beneficj; e' vi son tanti che pur vi agognano! Io fuggirò il vituperio morendo ignoto. E quando io fossi costretto ad uscire dalla mia oscurità — anzichè mostrarmi fortunato stromento della licenza o della tirannide, torrei d'essere vittima deplorata. Che se mi mancasse il pane e il fuoco, e questa che tu mi additi fosse l'unica sorgente di vita — cessi il cielo ch'io insulti alla necessità di tanti altri che non potrebbero imitarmi — davvero, Lorenzo, io me n'andrei alla patria di tutti, dove non vi sono nè delatori, nè conquistatori, nè letterati di corte, nè principi; dove le ricchezze non coronano il delitto; dove il misero non è giustiziato non per altro se non perchè è misero; dove un dì o l'altro verranno tutti ad abitare con me e a rimescolarsi nella materia, sotterra. Aggrappandomi sul dirupo della vita, sieguo alle volte un lume ch'io scorgo da lontano e che non posso raggiungere mai. Anzi mi pare che s'io fossi con tutto il corpo dentro la fossa, e che rimanessi sopra terra solamente col capo, mi vedrei sempre quel lume sfolgorare sugli occhi. O Gloria! tu mi corri sempre dinanzi, e così mi lusinghi a un viaggio a cui le mie piante non reggono più. Ma dal giorno che tu più non sei la mia sola e prima passione, il tuo risplendente fantasma comincia a spegnersi e a barcollare — cade e si risolve in un mucchio d'ossa e di ceneri fra le quali io veggio sfavillar tratto tratto alcuni languidi raggi; ma ben presto io passerò camminando sopra il tuo scheletro, sorridendo della mia delusa ambizione. — Quante volte vergognando di morire ignoto al mio secolo ho accarezzato io medesimo le mie angosce mentre mi sentiva tutto il bisogno e il coraggio di terminarle! Nè avrei forse sopravvissuto alla mia patria, se non mi avesse rattenuto il folle timore, che la pietra posta sopra il mio cadavere non seppellisse ad un tempo il mio nome. Lo confesso; sovente ho guardato con una specie di compiacenza le miserie d'Italia, poichè mi parea che la fortuna e il mio ardire riserbassero forse anche a me il merito di liberarla. Io lo diceva jer sera al Parini — addio: ecco il messo del banchiere che viene a pigliar questa lettera; e il foglio tutto pieno mi dice di finire. — Pur ho a dirti ancora assai cose: protrarrò di spedirtela sino a sabbato; e continuerò a scriverti. Dopo tanti anni di sì affettuosa e leale amicizia, eccoci, e forse eternamente, disgiunti. A me non resta altro conforto che di gemere teco scrivendoti; e così mi libero alquanto da' miei pensieri; e la mia solitudine diventa assai meno spaventosa. Sai quante notti io mi risveglio, e m'alzo, e aggirandomi lentamente per le stanze t'invoco! siedo e ti scrivo; e quelle carte sono tutte macchiate di pianto e piene de' miei pietosi delirj e de' miei feroci proponimenti. Ma non mi dà il cuore d'inviartele. Ne serbo taluna, e molte ne brucio. Quando poi il Cielo mi manda questi momenti di calma, io ti scrivo con quanto più di fermezza mi è possibile per non contristarti del mio immenso dolore. Nè mi stancherò di scriverti; tutt'altro conforto è perduto; nè tu, mio Lorenzo, ti stancherai di leggere queste carte ch'io senza vanità, senza studio e senza rossore ti ho sempre scritto ne' sommi piaceri e ne' sommi dolori dell'anima mia. Serbale. Presento che un dì ti saranno necessarie per vivere, almeno come potrai, col tuo Jacopo. Jer sera dunque io passeggiava con quel vecchio venerando nel sobborgo orientale della città sotto un boschetto di tigli. Egli si sosteneva da una parte sul mio braccio, dall'altra sul suo bastone: e talora guardava gli storpj suoi piedi, e poi senza dire parola volgevasi a me, quasi si dolesse di quella sua infermità, e mi ringraziasse della pazienza con la quale io lo accompagnava. S'assise sopra uno di que' sedili ed io con lui: il suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente ch'io m'abbia mai conosciuto; e d'altronde un profondo, generoso, meditato dolore a chi non dà somma eloquenza? Mi parlò a lungo della sua patria, e fremeva e per le antiche tirannidi e per la nuova licenza. Le lettere prostituite; tutte le passioni languenti e degenerate in una indolente vilissima corruzione: non più la sacra ospitalità, non la benevolenza, non più l'amore figliale — e poi mi tesseva gli annali recenti, e i delitti di tanti uomicciattoli ch'io degnerei di nominare, se le loro scelleraggini mostrassero il vigore d'animo, non dirò di Silla e di Catilina, ma di quegli animosi masnadieri che affrontano il misfatto quantunque e' si vedano presso il patibolo — ma ladroncelli, tremanti, saccenti — più onesto insomma è tacerne. — A quelle parole io m'infiammava di un sovrumano furore, e sorgeva gridando: Chè non si tenta? morremo? ma frutterà dal nostro sangue il vendicatore. — Egli mi guardò attonito: gli occhi miei in quel dubbio chiarore scintillavano spaventosi, e il mio dimesso e pallido aspetto si rialzò con aria minaccevole — io taceva, ma si sentiva ancora un fremito rumoreggiare cupamente dentro il mio petto. E ripresi: 123 Non avremo salute mai? ah se gli uomini si conducessero sempre al fianco la morte, non servirebbero sì vilmente. — Il Parini non apria bocca; ma stringendomi il braccio, mi guardava ogni ora più fisso. Poi mi trasse, come accennandomi perch'io tornassi a sedermi: E pensi tu, proruppe, che s'io discernessi un barlume di libertà, mi perderei ad onta della mia inferma vecchiaja in questi vani lamenti? o giovine degno di patria più grata! se non puoi spegnere quel tuo ardore fatale, chè non lo volgi ad altre passioni? Allora io guardai nel passato — allora io mi voltava avidamente al futuro, ma io errava sempre nel vano e le mie braccia tornavano deluse senza pur mai stringere nulla; e conobbi tutta tutta la disperazione del mio stato. Narrai a quel generoso Italiano la storia delle mie passioni, e gli dipinsi Teresa come uno di que' genj celesti i quali par che discendano a illuminare la stanza tenebrosa di questa vita. E alle mie parole e al mio pianto, il vecchio pietoso più volte sospirò dal cuore profondo. — No, io gli dissi, non veggo più che il sepolcro: sono figlio di madre affettuosa e benefica; spesse volte mi sembrò di vederla calcare tremando le mie pedate e seguirmi fino a sommo il monte, donde io stava per diruparmi, e mentre era quasi con tutto il corpo abbandonato nell'aria — essa afferravami per la falda delle vesti, e mi ritraeva, ed io volgendomi non udiva più che il suo pianto. Pure s'ella — spiasse tutti gli occulti miei guai, implorerebbe ella stessa dal Cielo il termine degli ansiosi miei giorni. Ma l'unica fiamma vitale che anima ancora questo travagliato mio corpo, è la speranza di tentare la libertà della patria. — Egli sorrise mestamente; e poichè s'accorse che la mia voce infiochiva, e i miei sguardi si abbassavano immoti sul suolo, ricominciò: — Forse questo tuo furore di gloria potrebbe trarti a difficili imprese; ma — credimi; la fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia; due quarti alla sorte; e l'altro quarto a' loro delitti. Pur se ti reputi bastevolmente fortunato e crudele per aspirare a questa gloria, pensi tu che i tempi te ne porgano i mezzi? I gemiti di tutte le età, e questo giogo della nostra patria non ti hanno per anco insegnato che non si dee aspettare libertà dallo straniero? Chiunque s'intrica nelle faccende di un paese conquistato non ritrae che il pubblico danno, e la propria infamia. Quando e doveri e diritti stanno su la punta della spada, il forte scrive le leggi col sangue e pretende il sacrificio della virtù. E allora? avrai tu la fama e il valore di Annibale che profugo cercava per l'universo un nemico al popolo Romano? — Nè ti sarà dato di essere giusto impunemente. Un giovine dritto e bollente di cuore, ma povero di ricchezze, ed incauto d'ingegno quale sei tu, sarà sempre o l'ordigno del fazioso, o la vittima del potente. E dove tu nelle pubbliche cose possa preservarti incontaminato dalla comune bruttura, oh! tu sarai altamente laudato; ma spento poscia dal pugnale notturno della calunnia; la tua prigione sarà abbandonata da' tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto sospiro. — Ma poniamo che tu superando e la prepotenza degli stranieri e la malignità de' tuoi concittadini e la corruzione de' tempi, potessi aspirare al tuo intento; di'? spargerai tutto il sangue col quale conviene nutrire una nascente repubblica? arderai le tue case con le faci della guerra civile? unirai col terrore i partiti? spegnerai con la morte le opinioni? adeguerai con le stragi le fortune? ma se tu cadi tra via, vediti esecrato dagli uni come demagogo, dagli altri come tiranno. Gli amori della moltitudine sono brevi ed infausti; giudica, più che dall'intento, dalla fortuna; chiama virtù il delitto utile, e scelleraggine l'onestà che le pare dannosa; e per avere i suoi plausi, conviene o atterrirla, o ingrassarla, e ingannarla sempre. E ciò sia. Potrai tu allora inorgoglito dalla sterminata fortuna reprimere in te la libidine del supremo potere che ti sarà fomentata e dal sentimento della tua superiorità, e della conoscenza del comune avvilimento? I mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi. Intento tu allora a puntellare il tuo trono, di filosofo saresti fatto tiranno; e per pochi anni di possanza e di tremore, avresti perduta la tua pace, e confuso il tuo nome fra la immensa turba dei despoti. — Ti avanza ancora un seggio fra' capitani; il quale si afferra per mezzo di un ardire feroce, di una avidità che rapisce per profondere, e spesso di una viltà per cui si lambe la mano che t'aita a salire. Ma — o figliuolo! l'umanità geme al nascere di un conquistatore; e non ha per conforto se non la speranza di sorridere su la sua bara. — Tacque — ed io dopo lunghissimo silenzio esclamai: O Cocceo Nerva! tu almeno sapevi morire incontaminato. — Il vecchio mi guardò — Se tu nè speri, nè temi fuori di questo mondo — e mi stringeva la mano — ma io! — Alzò gli occhi al Cielo, e quella severa sua fisonomia si raddolciva di soave conforto, come s'ei lassù contemplasse tutte le sue speranze. — Intesi un calpestio che s'avanzava verso di noi; e poi travidi gente fra' tiglj; ci rizzammo; e l'accompagnai sino alle sue stanze. Ah s'io non mi sentissi oramai spento quel fuoco celeste che nel tempo della fresca mia gioventù spargeva raggi su tutte le cose che mi stavano intorno, mentre oggi vo brancolando in una vota oscurità! s'io potessi avere un tetto ove dormire sicuro; se non mi fosse conteso di rinselvarmi fra le ombre del mio romitorio; se un amore disperato che la mia ragione combatte sempre, e che non può vincere mai — questo amore ch'io celo a me stesso, ma che riarde ogni giorno e che s'è fatto onnipotente, immortale — ahi! la Natura ci ha dotati di questa passione che è indomabile in noi forse più dell'istinto fatale della vita — se io potessi insomma impetrare un anno solo di calma, il tuo povero amico vorrebbe sciogliere ancora un voto e poi morire. Io odo la mia patria che grida: — SCRIVI CIÒ CHE VEDESTI. MANDERÒ LA MIA VOCE DALLE ROVINE, E TI DETTERÒ LA MIA STORIA. PIANGERANNO I SECOLI SU LA MIA SOLITUDINE; E LE GENTI SI AMMAESTRERANNO NELLE MIE DISAVVENTURE. IL TEMPO ABBATTE IL FORTE: E I DELITTI DI SANGUE SONO LAVATI NEL SANGUE. — E tu lo sai, Lorenzo, avrei coraggio di scrivere; ma l'ingegno va morendo con le mie forze, e vedo che fra pochi mesi avrò fornito questo mio angoscioso pellegrinaggio. Ma voi pochi sublimi animi che solitarj o perseguitati, su le antiche sciagure della nostra patria fremete, se i cieli vi contendono di lottare contro la forza, perchè almeno non raccontate alla posterità i nostri mali? Alzate la voce in nome 124 di tutti, e dite al mondo: Che siamo sfortunati, ma nè ciechi nè vili; che non ci manca il coraggio, ma la possanza. — Se avete braccia in catene, perchè inceppate da voi stessi anche il vostro intelletto di cui nè i tiranni nè la fortuna, arbitri d'ogni cosa, possono essere arbitri mai? Scrivete. Abbiate bensì compassione a' vostri concittadini, e non istigate vanamente le loro passioni politiche; ma sprezzate l'universalità de' vostri contemporanei: il genere umano d'oggi ha le frenesie e la debolezza della decrepitezza; ma l'umano genere, appunto quand'è prossimo a morte, rinasce vigorosissimo. Scrivete a quei che verranno, e che soli saranno degni d'udirvi, e forti da vendicarvi. Perseguitate con la verità i vostri persecutori. E poi che non potete opprimerli, mentre vivono, co' pugnali, opprimeteli almeno con l'obbrobrio per tutti i secoli futuri. Se ad alcuni di voi è rapita la patria, la tranquillità, e le sostanze; se niuno osa divenire marito; se tutti paventano il dolce nome di padre, per non procreare nell'esilio e nel dolore nuovi schiavi e nuovi infelici, perchè mai accarezzate così vilmente la vita ignuda di tutti i piaceri? Perchè non la consecrate all'unico fantasma ch'è duce degli uomini generosi, la gloria? Giudicherete l'Europa vivente, e la vostra sentenza illuminerà le genti avvenire. L'umana viltà vi mostra terrori e pericoli; ma voi siete forse immortali? fra l'avvilimento delle carceri e de' supplicj v'innalzerete sovra il potente, e il suo furore contro di voi accrescerà il suo vituperio e la vostra fama. […] 19 Ventimiglia, 19 e 20 Febbraro. Tu sei disperatamente infelice; tu vivi fra le agonie della morte, e non hai la sua tranquillità: ma tu dèi tollerarle per gli altri. — Così la Filosofia domanda agli uomini un eroismo da cui la Natura rifugge. Chi odia la propria vita può egli amare il minimo bene che è incerto di recare alla Società e sacrificare a questa lusinga molti anni di pianto? e come potrà sperare per gli altri colui che non ha desiderj, nè speranze per sè; e che abbandonato da tutto, abbandona se stesso? — Non sei misero tu solo. — Pur troppo! ma questa consolazione non è anzi argomento dell'invidia secreta che ogni uomo cova dell'altrui prosperità? La miseria degli altri non iscema la mia. Chi è tanto generoso da addossarsi le mie infermità? e chi anco volendo, il potrebbe? avrebbe forse più coraggio da comportarle; ma cos'è il coraggio voto di forza? Non è vile quell'uomo che è travolto dal corso irresistibile di una fiumana; bensì chi ha forze da salvarsi e non le adopra. Ora dov'è il sapiente che possa costituirsi giudice delle nostre intime forze? chi può dare norma agli effetti delle passioni nelle varie tempre degli uomini e delle incalcolabili circostanze onde decidere: Questi è un vile, perchè soggiace; quegli che sopporta, è un eroe? mentre l'amore della vita è così imperioso che più battaglia avrà fatto il primo per non cedere, che il secondo per sopportare. Ma i debiti i quali tu hai verso la Società? — Debiti? forse perchè mi ha tratto dal libero grembo della Natura, quand'io non aveva nè la ragione, nè l'arbitrio di acconsentirvi, nè la forza di oppormivi, e mi educò fra' suoi bisogni e fra' suoi pregiudizj? — Lorenzo, perdona s'io calco troppo su questo discorso tanto da noi disputato. Non voglio smoverti dalla tua opinione sì avversa alla mia; vo' bensì dileguare ogni dubbio da me. Saresti convinto al pari di me, se ti sentissi le piaghe mie; il Cielo te le risparmi! — Ho io contratto questi debiti spontaneamente? e la mia vita dovrà pagare, come uno schiavo, i mali che la Società mi procaccia, solo perchè gli intitola beneficj? e sieno beneficj: ne godo e li ricompenso fino che vivo; e se nel sepolcro non le sono io di vantaggio, qual bene ritraggo io da lei nel sepolcro? O amico mio! ciascun individuo è nemico nato della Società, perchè la Società è necessaria nemica degli individui. Poni che tutti i mortali avessero interesse di abbandonare la vita, credi tu che la sosterrebbero per me solo? e s'io commetto un'azione dannosa a' più, io sono punito; mentre non mi verrà fatto mai di vendicarmi delle loro azioni, quantunque ridondino in sommo mio danno. Possono ben essi pretendere ch'io sia figliuolo della grande famiglia; ma io rinunziando e a' beni e a' doveri comuni posso dire: Io sono un mondo in me stesso: e intendo d'emanciparmi perchè mi manca la felicità che mi avete promesso. Che s'io dividendomi non trovo la mia porzione di libertà; se gli uomini me l'hanno invasa perchè sono più forti; se mi puniscono perchè la ridomando — non gli sciolgo io dalle loro bugiarde promesse e dalle mie impotenti querele cercando scampo sotterra? Ah! que' filosofi che hanno evangelizzato le umane virtù, la probità naturale, la reciproca benevolenza — sono inavvedutamente apostoli degli astuti, ed adescano quelle poche anime ingenue e bollenti le quali amando schiettamente gli uomini per l'ardore di essere riamate, saranno sempre vittime tardi pentite della loro leale credulità. — Eppur quante volte tutti questi argomenti della ragione hanno trovato chiusa la porta del mio cuore, perch'io tuttavia mi sperava di consecrare i miei tormenti all'altrui felicità! Ma! — per il nome d'Iddio, ascolta e rispondimi. A che vivo? di che pro ti son io, io fuggitivo fra queste cavernose montagne? di che onore a me stesso, alla mia patria, a' miei cari? V'ha egli diversità da queste solitudini alla tomba? La mia morte sarebbe per me la meta de' guai, e per voi tutti la fine delle vostre ansietà sul mio stato. Invece di tante ambasce continue, io vi darei un solo dolore — tremendo, ma ultimo: e sareste certi della eterna mia pace. I mali non ricomprano la vita. E penso ogni giorno al dispendio di cui da più mesi sono causa a mia madre; nè so come ella possa far tanto. S'io mi tornassi, troverei casa nostra vedova del suo splendore. E incominciava già ad oscurarsi, molto innanzi ch'io mi partissi, per le pubbliche e private estorsioni le quali non restano di percuoterci. Nè però quella madre benefattrice cessa dalle sue cure: trovai dell'altro denaro a Milano; ma queste affettuose liberalità le scemeranno certamente quegli agi fra' quali nacque. Pur troppo fu moglie mal avventurata! le sue sostanze sostengono la mia casa che rovinava per le prodigalità di 125 mio padre; e l'età di lei mi fa ancora più amari questi pensieri. — Se sapesse! tutto è vano per lo sfortunato suo figliuolo. E s'ella vedesse qui dentro — se vedesse le tenebre e la consunzione dell'anima mia! deh! non gliene parlare, o Lorenzo: ma vita è questa? — Ah sì! io vivo ancora; e l'unico spirito de' miei giorni è una sorda speranza che li rianima sempre, e che pure tento di non ascoltare: non posso — e s'io voglio disingannarla, la si converte in disperazione infernale. — Il tuo giuramento, o Teresa, proferirà ad un tempo la mia sentenza — ma finchè tu se' libera; — e il nostro amore è tuttavia nell'arbitrio delle circostanze — dell'incerto avvenire — e della morte, tu sarai sempre mia. Io ti parlo, e ti guardo, e ti abbraccio: e mi pare che così da lontano tu senta l'impressione de' miei baci e delle mie lagrime. Ma quando tu sarai offerita dal padre tuo come olocausto di riconciliazione su l'altare di Dio — quando il tuo pianto avrà ridata la pace alla tua famiglia — allora — non io — ma la disperazione sola, e da sè, annienterà l'uomo e le sue passioni. E come può spegnersi, mentre vivo, il mio amore? e come non ti sedurranno sempre nel tuo secreto le sue dolci lusinghe? ma allora più non saranno sante e innocenti. Io non amerò, quando sarà d'altri, la donna che fu mia — amo immensamente Teresa; ma non la moglie d'Odoardo — ohimè! tu forse mentre scrivo sei nel suo letto! — Lorenzo! — Ahi Lorenzo! eccolo quel demonio mio persecutore; torna a incalzarmi, a premermi, a investirmi, e m'accieca l'intelletto, e mi ferma perfino le palpitazioni del cuore, e mi fa tutto ferocia, e vorrebbe il mondo finito con me. — Piangete tutti — e perchè mi caccia fra le mani un pugnale, e mi precede, e si volge guardando se io lo sieguo, e mi addita dov'io devo ferire? Vieni tu dall'altissima vendetta del Cielo? — E così nel mio furore e nelle mie superstizioni io mi prostendo su la polvere a scongiurare orrendamente un Dio che non conosco, che altre volte ho candidamente adorato, ch'io non offesi, di cui dubito sempre — e poi tremo, e l'adoro. Dov'io cerco ajuto? non in me, non negli uomini: la Terra io la ho insanguinata, e il Sole è negro. Alfine eccomi in pace! — Che pace? stanchezza, sopore di sepoltura. Ho vagato per queste montagne. Non v'è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua e là molte croci che segnano il sito de' viandanti assassinati. — Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V'è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell'Alpi altre Alpi di neve che s'immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde — da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi. I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d'ogni parte dalla pertinace avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita infelice per te: ma che può fare il solo mio braccio e la nuda mia voce? — Ov'è l'antico terrore della tua gloria? Miseri! noi andiamo ogni dì memorando la libertà e la gloria degli avi, le quali quanto più splendono tanto più scoprono la nostra abbietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre magnanime, i nostri nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà forse giorno che noi perdendo e le sostanze, e l'intelletto, e la voce, sarem fatti simili agli schiavi domestici degli antichi, o trafficati come i miseri Negri, e vedremo i nostri padroni schiudere le tombe e disseppellire, e disperdere al vento le ceneri di que' Grandi per annientarne le ignude memorie: poichè oggi i nostri fasti ci sono cagione di superbia, ma non eccitamento dall'antico letargo. Così grido quand'io mi sento insuperbire nel petto il nome Italiano, e rivolgendomi intorno io cerco, nè trovo più la mia patria. — Ma poi dico: Pare che gli uomini sieno fabbri delle proprie sciagure; ma le sciagure derivano dall'ordine universale, e il genere umano serve orgogliosamente e ciecamente a' destini. Noi argomentiamo su gli eventi di pochi secoli: che sono eglino nell'immenso spazio del tempo? Pari alle stagioni della nostra vita mortale, pajono talvolta gravi di straordinarie vicende, le quali pur sono comuni e necessarj effetti del tutto. L'universo si controbilancia. Le nazioni si divorano perchè una non potrebbe sussistere senza i cadaveri dell'altra. Io guardando da queste Alpi l'Italia piango e fremo, e invoco contro agl'invasori vendetta; ma la mia voce si perde tra il fremito ancora vivo di tanti popoli trapassati, quando i Romani rapivano il mondo, cercavano oltre a' mari e a' deserti nuovi imperi da devastare, manomettevano gl'Iddii de' vinti, incatenevano principi e popoli liberissimi, finchè non trovando più dove insanguinare i lor ferri, li ritorceano contro le proprie viscere. Così gli Israeliti trucidavano i pacifici abitatori di Canaan, e i Babilonesi poi strascinarono nella schiavitù i sacerdoti, le madri, e i figliuoli del popolo di Giuda. Così Alessandro rovesciò l'impero di Babilonia, e dopo avere passando arsa gran parte della terra, si corrucciava che non vi fosse un altro universo. Così gli Spartani tre volte smantellarono Messene e tre volte cacciarono dalla Grecia i Messeni che pur Greci erano e della stessa religione e nipoti de' medesimi antenati. Così sbranavansi gli antichi Italiani finchè furono ingojati dalla fortuna di Roma. Ma in pochissimi secoli la regina del mondo divenne preda de' Cesari, de' Neroni, de' Costantini, de' Vandali, e de' Papi. Oh quanto fumo di umani roghi ingombrò il Cielo della America, oh quanto sangue d'innumerabili popoli che nè timore nè invidia recavano agli Europei, fu dall'Oceano portato a contaminare d'infamia le nostre spiagge! ma quel sangue sarà un dì vendicato e si rovescierà su i figli degli Europei! Tutte le nazioni hanno le loro età. Oggi sono tiranne, per maturare la propria schiavitù di domani: e quei che pagavano dianzi vilmente il tributo, lo imporranno un giorno col ferro e col fuoco. La Terra è una foresta di belve. La fame, i diluvj, e la peste sono ne' provedimenti della Natura come la sterilità di un campo che prepara l'abbondanza per l'anno vegnente: e chi sa? fors'anche le sciagure di questo globo apparecchiano la prosperità di un altro. 126 Frattanto noi chiamiamo pomposamente virtù tutte quelle azioni che giovano alla sicurezza di chi comanda, e alla paura di chi serve. I governi impongono giustizia: ma potrebbero eglino imporla se per regnare non l'avessero prima violata? Chi ha derubato per ambizione le intere province, manda solennemente alle forche chi per fame invola del pane. Onde quando la forza ha rotti tutti gli altrui diritti, per serbarli poscia a sè stessa inganna i mortali con le apparenze del giusto, finchè un'altra forza non la distrugga. Eccoti il mondo, e gli uomini. Sorgono frattanto d'ora in ora alcuni più arditi mortali; prima derisi come frenetici, e sovente come malfattori, decapitati: che se poi vengono patrocinati dalla fortuna ch'essi credono lor propria, ma che in somma non è che il moto prepotente delle cose, allora sono obbediti e temuti, e dopo morte deificati. Questa è la razza degli eroi, de' capisette, e de' fondatori delle nazioni i quali dal loro orgoglio e dalla stupidità de' volghi si stimano saliti tant'alto per proprio valore; e sono cieche ruote dell'oriuolo. Quando una rivoluzione nel globo è matura, necessariamente vi sono gli uomini che la incominciano, e chè fanno de' loro teschj sgabello al trono di chi la compie. E perchè l'umana schiatta non trova nè felicità nè giustizia sopra la terra, crea gli Dei protettori della debolezza e cerca premj futuri del pianto presente. Ma gli Dei si vestirono in tutti i secoli delle armi de' conquistatori: e opprimono le genti con le passioni, i furori, e le astuzie di chi vuole regnare. Lorenzo, sai tu dove vive ancora la vera virtù? in noi pochi deboli o sventurati; in noi, che dopo avere sperimentati tutti gli errori, e sentiti tutti i guai della vita, sappiamo compiangerli e soccorrerli. Tu, o Compassione, sei la sola virtù! tutte le altre sono virtù usuraje. Ma mentre io guardo dall'alto le follie e le fatali sciagure della umanità, non mi sento forse tutte le passioni e la debolezza ed il pianto, soli elementi dell'uomo? Non sospiro ogni dì la mia patria? Non dico a me lagrimando: Tu hai una madre e un amico — tu ami — te aspetta una turba di miseri, a cui se' caro, e che forse sperano in te — dove fuggi? anche nelle terre straniere ti perseguiranno la perfidia degli uomini e i dolori e la morte: qui cadrai forse, e niuno avrà compassione di te; e tu senti pure nel tuo misero petto il piacere di essere compianto. Abbandonato da tutti, non chiedi tu ajuto dal Cielo? non t'ascolta; eppure nelle tue afflizioni il tuo cuore torna involontario a lui — va, prostrati; ma all'are domestiche. O Natura! hai tu forse bisogno di noi sciagurati, e ci consideri come i vermi e gl'insetti che vediamo brulicare e moltiplicarsi senza sapere a che vivano? Ma se tu ci hai dotati del funesto istinto della vita sì che il mortale non cada sotto la soma della sue infermità ed ubbidisca irrepugnabilmente a tutte le tue leggi, perchè poi darci questo dono ancor più funesto della ragione? Noi tocchiamo con mano tutte le nostre calamità ignorando sempre il modo di ristorarle. Perchè dunque io fuggo? e in quali lontane contrade io vado a perdermi? dove mai troverò gli uomini diversi dagli uomini? O non presento io forse i disastri, le infermità, e la indigenza che fuori della mia patria mi aspettano? — Ah no! Io tornerò a voi, o sacre terre, che prime udiste i miei vagiti, dove tante volte ho riposato queste mie membra affaticate, dove ho trovato nella oscurità e nella pace i miei pochi diletti, dove nel dolore ho confidato i miei pianti. Poichè tutto è vestito di tristezza per me, se null'altro posso ancora sperare che il sonno eterno della morte — voi sole, o mie selve, udirete il mio ultimo lamento, e voi sole coprirete con le vostre ombre pacifiche il mio freddo cadavere. Mi piangeranno quegli infelici che sono compagni delle mie disgrazie — e se le passioni vivono dopo il sepolcro, il mio spirito doloroso sarà confortato da' sospiri di quella celeste fanciulla ch'io credeva nata per me, ma che gl'interessi degli uomini e il mio destino feroce mi hanno strappata dal petto. 127 Alessandro Verri, Le avventure di Saffo [Ed. in I romanzi, a cura di L. Martinelli, Ravenna, Longo, 1975] III - CAPITOLO IX. Il salto di Leucate. Giunse così la fanciulla al promontorio, e quando vi fu sopra, mirò l'ampiezza delle onde, che fremevano sotto entro gli scogli, rimanendo alquanto immota nella considerazione dello spaventevole slancio. Girò quindi gli occhi atterriti d'ogni intorno, e poi li rivolse alle memorie, ivi scolpite, di quelli che prima di lei eransi felicemente gettati dall'alta rupe. Di poi accostandosi cautamente al margine estremo di quell'abisso, stese in fuori, con seno palpitante, la pallida fronte e vide con ribrezzo che l'antico impeto delle acque aveva corrose le radici del monte. Sporgeva il curvo sasso, quasi cadente, nel mare, e il flutto romoreggiava nella profonda pendice. Si restrinse per orrore la misera fanciulla, ritraendo il passo tremante, e ricoprì gli occhi col velo, per non rimirare scena così spaventevole. Giunse intanto Rodope, non consapevole per qual fine ivi fosse la smaniosa donzella; ma però dubitando di qualche disperata risoluzione, poiché la vide accostarsi al lembo di quella profondità, abbracciolla affettuosamente, appunto quand'ella retrocedeva per orrore del veduto precipizio. Saffo da lei si disciolse inquieta, sgridandola, perché la turbasse; ma non lasciando l'ancella di trattenerla e d'esortarla: “Io ti prego (disse a lei Saffo) per la tua fedeltà antica, la quale t'induce ad errare meco infelice compagna de' miei deliri, di non impedirmi l'esercizio de' sacri riti, siccome da me vuole il Dio dominatore di queste contrade, la di cui volontà or ora mi ha rivelata il sacerdote nel tempio. Io qui debbo invocare il Nume come in luogo a lui specialmente dedicato, e dove troverò, per quanto spero, alcun refrigerio al mio insoffribile ardore. Scostati adunque alquanto, io te ne prego per la tua benevolenza e per la mia miseria, ond'io possa liberamente invocare gli Dei ed ubbidirli”. Così dicendo, tenera insieme ed imperiosa respinse l'ancella, la quale sommessa eseguì il comando, credendo alle di lei parole; e Clito seco lei tacendo si ritrasse in remota parte. Mentre eglino si allontanavano, la infelice amante rivolta al cielo ed al mare, così dall'alta rupe sollevando le braccia e gli occhi lagrimosi pregò: “Propizi Numi, se da voi ottengono pietà le amorose nostre pene, per certo non la potrete negare alle mie, di quante mai furono le più acerbe e le più tormentose. Ecco che io sommessa alle vendette del cielo seguo la voce degli oracoli divini; e se fu involontaria la mia colpa, mi offro spontaneamente alla pena. Che se mai queste acque saranno la mia tomba, io spero che la morte mia trarrà da quel seno, spietato come questo dirupo, alcun sospiro; o se, come imploro, io tornerò a questo lido sanata da' miei deliri, non avverrà mai ch'entri nel mio cuore disingannato altra fiamma insidiosa; ma vo' dedicarmi al culto della casta Diana con la speranza di godere nel sacro silenzio del tempio gioia più tranquilla che nei fallaci contenti d'Amore. O Teti, accogli chi si getta nel tuo grembo”. Disse correndo verso l'estremità della rupe, deliberata di gittarvisi; ma giunta a rivedere quella spaventosa profondità, si trattenne involontariamente. Rodope intanto, che nell'allontanarsi, appoggiata a Clito, volgea spesso a lei sospettosamente gli occhi, quando vide quell'atto, indizio manifesto della sua misera determinazione, gridò con quant'alito le rimanea dopo gli stenti del disastroso sentiero, e subitamente mosse Clito a trattenerla. Saffo adunque veggendo scoperto il suo pensiero, e che già accorrevano per impedirlo gli affettuosi seguaci, prevenne il loro arrivo. Ma forse avrebbe nel di lei animo la timidità del sesso superati gl'impulsi della Religione, se Venere implacabile persecutrice, tormentandola con la sua invisibile presenza, non si fosse tratta dalle bionde trecce un ago d'oro, con cui le tratteneva leggiadramente, e col quale pungeva il cuore della misera in quell'atto, compiacendosi con maligno sorriso delle di lei smanie. E però la dolente fanciulla agitata da quello stimolo irritante, qual giumenta punta dall'aculeo dell'ape, rivolse gli omeri al mare, gittò in capo il manto, strinse le palpebre, e sospirando si abbandonò per l'indietro a capitombolo. Accorse Clito, e mirando giù nell'ampio mare, nulla vide, perché la caduta impetuosa dall'alto avea tuffata nell'acque la misera, che poi in breve riapparve agonizzante e che invano luttava con l'onde prepotenti. Clito è fama che a vista così luttuosa si gittasse in mare, spintovi dal desiderio di soccorrere lei, che sì fedelmente avea seguitata; ma vi perì l'infelice, urtando nel cadere in uno scoglio insidioso mal coperto dalle acque. Rodope accorsa più tardi e vacillante, vide appunto risorgere dal flutto la sventurata signora e poi richiudersi su di lei l'estrema onda crudele. Alla qual vista dolorosa, priva de' sensi ella cadde su la sterile rocca; e Saffo intanto sommersa nel fondo avverò l'infausto oracolo, che avrebbe estinto il suo tristo amore nelle acque di Leucate. Che se per altri fu quel salto più avventuroso (siccome ne facevano testimonianza le memorie ivi incise), per questa fu estremo, perché a lei non sembrava miglior conforto la implacabile vendetta di Venere. Se pure non v'ebbe anche parte qualche funesta incredulità nell'animo della fanciulla, che si trattenne al primo slancio, dovendosi considerare che il sacerdote le avea chiaramente espresso che il maggior pericolo dello spaventevole esperimento proveniva dalla dubitazione. Ma forse qualche ingegno più audace, esaminando le dubbiose parole di Stratonica, scoprirebbe in quelle una fallacia insidiosa, per cui dovevansi in ogni evento verificare. Perché morendo nella prova (com'era quasi certo dover accadere a fanciulla inesperta del nuoto), ella pur troppo estingueva nelle acque la face d'Amore; e resistendo, per incredibile evento, all'impeto loro, il ribrezzo dell'immersione e l'orrore dell'evitato pericolo avrebbero richiamata la mente a più sani pensieri. Comunque siasi, te misera o Saffo fra gli amanti, la quale vivendo non ottenesti alcuna utile pietà dal tuo barbaro tiranno, e solo fosti compianta in morte con tarda ed infruttuosa commiserazione! Che se alcuno giammai versò lagrime sincere sul tuo misero fato, io son quegli, il quale per la prima volta avendo svelate a' posteri tutte le tue infelicità, le ho non meno prima di tutti, che più di tutti, comprese. Raccolsero il giorno seguente i servi del tempio l'estinta spoglia, gettata sul lido dal fluttuante mare, e l'onorarono di sepoltura. Quindi i Mitilenesi alzarono ivi per pubblico decreto magnifica tomba con l'inscrizione del caso, ed eressero 128 nella patria quella di lei statua, che tuttora si vede. La crudele nuova della quale avventura abbreviò i già provetti giorni de' genitori e rattristò quelli di Eutichio, quantunque per benignità del cielo e per di lui natura così tranquilli e sereni. 129 Pietro Giordani, A un giovane italiano. Istruzione per l’arte di scrivere 15 agosto 1821. Eugenio, che io non conosco ed amo, vuoi darti all'arte di scrivere? Il tuo desiderio è buono; perché in quest'arte troverai piacere quanto in nessun' altra; e dilettevolissima è la stessa fatica d' impararla. Con quest'arte potrai giovare agli uomini, quanto con verun'altra: da questa potrai quanto o più che da ogni altra acquistar gloria che si diffonda e duri. Gli antichi la chiamavano arte di parlare (Artem dicendi), perché in quei governi migliori si poteva al popolo radunato parlare de' suoi interessi da chi meglio l’intendeva. In questi tempi si concede solo ai preti e ai ciarlatani di parlare in pubblico: ma si può scrivendo parlare a molti separati di luogo e di tempo, e passare alla posterità. E lo scrivere, che non si fa improvviso, permette di dare ai pensieri e alla espression loro migliore ordine, e più efficacia. Tieni che l’arte di scrivere è l’arte di ben pensare, e ben esprimere i nostri pensieri; talché divengano altrui niente meno che nostri. Tieni che a conseguir questo si vuole arte e studio. Molti in ciò s'ingannano, e non comprendono che arte e studio sia necessario: perché la materia e lo strumento di ciò (i pensieri e la lingua) non sono in potere di pochi uomini, come i colori e la creta o i marmi sono adoperati solamente da certi artefici; e i pensieri e le parole sono comuni a tutti gli uomini. Ma il fatto è che il pensar bene non è di molti; e il far pensare altrui è di pochi, i quali ciò abbiano acquistato con buono ingegno, e molto artificio, e lungo esercizio. Tu hai venti anni; e sei maturo a cominciare questa fatica: ma non persuaditi di dovervi durare meno di dieci anni; a volervi riuscire non mediocre. E qual altra delle belle arti potresti conseguire in minor tempo? Né la perfezione di questa è più facile di nessun' altra. Né si trova grande utilità gloria dal mediocre. Anche, per molte ragioni, non è bene che l’uomo prima de' trent' anni pubblichi i suoi studi immaturi. Tu dall’uso della vita, dalla conversazione degli uomini, dalle letture, dalie tue meditazioni, sei già pieno di molti pensieri: e molti ancora più ne andrai acquistando. Già conosci le opere della natura; e l’uso che può farne l’uomo. Conosci in gran parte quel che sono gli uomini, e quello che in diversi tempi e paesi hanno fatto. Cominci ad intendere quel che potrebbero e dovrebbero fare. Le scienze ti han dato l’abito di ordinare e dedurre le tue idee: la storia ti ha mostrato le cagioni e gli effetti delle umane passioni. Spero che avrai letto i quattro volumi dell'Etica di Giacomo Stellini; che racchiudono il meglio dell’antica e della moderna sapienza: e gì' Italiani hanno gran torto di trascurare un tal maestro. Ti credo preparato allo studio di quest'arte nobilissima, bellissima, trionfatrice delle tirannidi e dell’obblio. E se pur accadesse che poi la fortuna o il tuo consiglio ti distogliessero dall’esercitarla; non perciò andrà perduto lo studio in essa collocato: perché tale studio avrà perfezionato d' assai le tue facoltà intellettuali e morali: e potrai cavare e fruito e diletto molto maggiore dalle opere altrui; che non possono quelli che non conoscono l’arte. Due popoli furono in essa eccellenti; de' quali uno superò tutti di potenza, l’altro di gentilezza: e tuttavia rimangono maestri dell’arte, non agguagliati mai di lunga dagli altri popoli, che sono costretti impararla da' greci e da' romani. Tu intendi quelle due lingue: le intenderai più addentro, rileggendo quegli scrittori per imparare da essi a potere ottimamente scrivere italiano. Tutto lo scrivere sta nella lingua, e nello stile; due cose diversissime, egualmente necessarie. La lingua sono i vocaboli e le frasi: segni delle idee. Lo stile è la distribuzione delle idee, la collocazione dei segni; con tale arte che producano il maggiore e migliore effetto; cioè di essere il più facilmente, il più profondamente, e il più volentieri accolte nell’animo di chi legge. I vocaboli e le frasi sono i colori di questa pittura; lo stile è il colorito. Ora persuaditi, caro Eugenio, che l’acquisto de' colori sia fatica della memoria: l’uso del colorito sia esercizio d' ingegno, disciplina di buoni esempi, di pochi precetti, di moltissima osservazione, di molla pratica. Dagli Scrittori Italiani devi necessariamente prendere la lingua: solo nei latini, e meglio ne' greci troverai lo stile. Gl'Italiani hanno una bellissima lingua (e tutte le nazioni se durano qualche secolo civili, formano di necessità una lingua sufficiente): ma in Italia lo stile resta quasi del tutto a crearsi. E potrei dirti da quali cagioni ciò sia avvenuto. Ma sarebbe cosa lunga, e che supera le mie presenti forze. Verrà tempo che tu lo intenda per te stesso; e meglio di me. Oh che bello e divino e beato scrittore sarà l’Italiano, che saprà mostrarci in effetto una bellezza di lineamenti greci, e di colori italiani; voglio dire la lingua del trecento, e lo stile dei migliori Greci, che furono da Erodoto a Demostene! Nel cinquecento fu comunemente saputa la lingua greca: ma quelli che vollero formare l’eloquenza italiana non pensarono punto ai greci, e vollero prender tutto dai latini. Dai quali se volessimo prendere un poco di maestà e di vigore, potrebbe riuscirci, ed apparir bene. Del resto non potremo ricopiar bene coloro dai quali siam troppo dissomiglianti: e noi abbiamo coi greci una somiglianza maravigliosa; sebben vedo che pochissimi se ne accorgono. I greci furono un popolo pittore, come gl’italiani. Milioni di frasi greche farebbero graditissimo effetto nella nostra lingua, e vi parrebbero native (il che tu a prova intenderai benissimo a suo tempo); dove il latinismo nell’italiano è duro e pedantesco. Il sì diverso valore de' nomi, o accompagnati o scompagnati dall’articolo; l’adoperare i verbi all’uso de' nomi; e tante altre cose abbiam noi comuni co' greci, che non ebbero i latini. Poco adunque di vocaboli, e meno di frasi possiamo con bel, profitto prendere dai latini. I latini impararono dai greci; e non lutto. Sarebbe grossa pedanteria, o goffa ciarlataneria (com' è de' medici)grecizzare ne' vocaboli: ma sarà gentilissimo e fortunatissimo artificio trasportare in Italia quanti più si potranno de' bei modi greci. I quali vedrai se risplendono come gioie anche negli scrittori latini; come in Orazio, in Virgilio, in Lucrezio, in Livio, in Tacito. Ritieni dunque che siccome perfetto scultore è colui che sappia osservare la natura, e in lei scegliere, e lei bene scelta rappresentare; e dell’osservare, e dello scegliere, e del rappresentare si faccia guida i greci, che furono felicissimi di avere una bella natura, 130 e abilissimi tanto nel saperla vedere come nel poterla esprimere: cosi il perfetto e ottimo scrittore d' Italia sarà quegli che figurerà ne' bei modi greci il buono e vero naturale italiano della lingua de' trecentisti. Tu imaginerai che se nello scrivere, la lingua è fatto di memoria, e lo siile è uso di artificio; di questo artificio debbono essere trovati molti precetti, e composti molti insegnamenti d'arie. Ho letto molti antichi e moderni che vollero esserne maestri: ho perduto tempo, e acquistato noia, senza profitto. Veri maestri ho trovato gli esempi de' grandi scrittori. Leggerai Quintiliano, per conoscere istoricamente qual fosse la disciplina di quest' arte ne' suoi tempi. Nel padre dei Seneca troverai i più sicuri mezzi per corromperla. De' moderni puoi vedere il breve trattato di Condillac, Art d’écrire. Di tutto quel libro, abbastanza buono, m'è rimasto in mente questo solo principio, molto raccomandato da lui «de la plus grande liaison des idées». Ma in verità sono persuasissimo che in ciò consista più che due terzi della bontà dello stile: dalla mancata osservanza di quel fecondissimo principio derivo tutti i difetti de' moderni: da lui deduco in grandissima parte le tante ammirabili perfezioni degli antichi. Vero è che quel legame delle idee non deve sempre esser logico; ma secondo la materia che si tratta dev' esser pittorico o affettuoso: di che i moderni intendon pochissimo: gli antichi vi furono meravigliosi. Ma persuaditi che se vuoi penetrare ai fondo l’arte di scrivere, ed esercitarla con quella perfezione che glorifica tanto gli antichi; ti bisogna intendere non mediocremente la pittura, e conversar molto con artisti che siano filosofi in quest' arte. Allora ti farai da te stesso le regole migliori e più sicure di scriver hene. Ciò affermo di mia esperienza. Se non sono riuscito scrittore è colpa della fortuna più che mia: ma non cominciai ad intendere qualche cosa di quest' arte, e tentar dì farmene maestro a me stesso, e forse trovarne la vera e sicura via; se non quando ebbi aperti gli occhi, e il cuore, e l’intelletto alla pittura. Posto adunque che un vero insegnamento dell’arte di scrivere non l’abbiamo (ch'io sappia ), abbiamo però molte osservazioni che ci possono giovare. I volumi della Enciclopedia Metodica ne' quali è trattata la grammatica e l’eloquenza ti possono esser utili. Gli articoli rettorici di Marmontel non mi paiono più che mediocri; quelli di Jaucourt assai meno che mediocri. Ma bellissimi i grammatici di Dumarsais, e di La-Beauzée. E il conoscere e adoperare filosoficamente la lingua è gran virtù di eccellente scrittore. E prontamente si applica alla nostra quel che è notato della francese. Cominciando adunque il tuo studio in questa cara arte di scrivere, ti consiglio di cominciare, e proseguir sino al fine, quella lettura; tornando poi a tuo grado a rivedere quegli articoli che più ti saranno piaciuti. Non istimo profittevole quello studio che sia più di otto ore al giorno, meno di sei. Di queste consiglierei che desti due o tre ogni giorno alla lettura di quegli articoli enciclopedici; interrompendo con essa lo studio che devi fare della lingua, e preparandoti a quello che poi farai dello stile. Perché io giudico che quello della lingua debba precedere. Non si dee prima sapere qual sia la materia de' colori; poi imparare ad impastarli e mescolarli; poi esercitarsi a collocarli, e accordarli? Affermo che la lingua italiana, cioè i vocaboli e i modi meramente nostri e bellissimi, sono negli scrittori del trecento; e là si devono cercare. Mi bisogna qui dirti due cose, a premunirti da molte opinioni false. Molti si fanno ridicoli per adoperare vocaboli disusati e morti. Sciocca e misera ambizione di voler parere dottissimi per sapere qualche paroluzza ignota ai viventi. Ma ingiustamente da questa vanità si argomenta contro la lingua del secolo che fu il più facondo e il meglio parlante in Italia. Tu ritieni per giusta questa considerazione, che tre sorti di parole si presentano allo scrittore. Molte sono anche oggidì adoperate non che intese da tutti: e queste lo scrittore piglia liberamente; né altro accorgimento gli bisogna che di bene sceglierle, e bene collocarle. Altre parole sono comunemente intese, ma non comunemente adoperate. E il numero di queste era diventato infinito nel secolo passato: che il non leggere altro che libri francesi, aveva riempito di voci e di frasi straniere l’Italia, e cacciate d' uso le nazionali: e se quell’usanza durava, la lingua italiana avrebbe cessato non solo di scriversi ma d'intendersi in Italia: perché eravamo venuti a tale che tutti i vocaboli e tutti i modi che esprimessero operazioni deli' animo, (oltre ì nomi significanti le delizie della vita, e le usanze della civiltà) erano francesi. In questo secolo prevale una contraria volontà: ma a ripigliare un uso lungamente interrotto si richiede assai tempo e fatica. Bisogna che alcuni pochi imparino con fatica dai libri antichi, e oggi dismessi, a scriver libri che i moderni possano legger volentieri; e cosi lentamente si rimetta in vigore il legittimo linguaggio italiano. Ma del parlare che tuttavia è inteso, benché non comunemente sia usato, può lo scrittore servirsi a suo arbitrio. Rimangono i vocaboli e i modi che ninno adopera e ninno intende: e da questi dee lo scrittore guardarsi; se pure non è stretto da vera necessità; che la cosa ch’ei vuole esprimere manchi di segno. Allora perché non ravviveremo quel segno che già fu cittadino tra i nostri antichi; piuttostoché lasciar senza segno la cosa, o introdurlo forestiero? Ma sia vera la necessità; e la senta lo stesso lettore: che non senza cagione dee lo scrittore obbligar me italiano, di ricorrere al vocabolario, per ravvisare la faccia d* un vocabolo della mia lingua. Se nel vocabolario acquisterò sotto un nuovo segno una idea nuova; ringrazierò lo scrittore, che ad una mia ignoranza ha soccorso. Ma s'egli non mi avrà fatta acquistar altro che un morto, e inutil, sinonimo d’un segno già da me conosciuto, d'una idea che già avevo; odierò l’incivile e importuna pedanteria dello scrittore, stoltamente ambizioso. Questa sorta di vocaboli non può mai esser di materie comuni, ma di scienze, di arti, o di mestieri. Un'altra opinione è ripetuta molto da gente che si credono saputi: che le lingue vanno aumentando col tempo; e perciò i secoli che più sanno, più sono di lingua copiosi: e cosi il trecento dev'essere più infacondo che i più dotti secoli a lui succeduti. Ma qui è un equivoco. Le scienze e le arti portando nuove cose han recato nuovi segni. Ma ciò quanta parte è della lingua universale? Guarda allo esprimere i pensieri e gli affetti; che sono la più abbondante e la più generale materia della lingua: e vedrai (e l’esperienza di quegli scrittori (e ne farà certissimo)che i trecentisti furono di ciò ricchissimi; e poveri i successori. Cominciò il 131 cinquecento ad abbandonare l’uso di più d' una metà di quella felice lingua: quindi il non saper più esprimere tante e tante proprietà e differenze delicate: quindi il bisogno di ripetere (con sazietà molesta)frequentemente le stesse parole e maniere: dove tanto rapisce la beata varietà e abbondanza e finezza de' trecentisti. Vedrai come sono teneri e amorosi quegli scrittori; e spesso ancora, nella sua amabile semplicità, dignitosi e forti , e magnifici ! Come freddi e scoloriti gli altri dopo loro ! Io dunque ti consiglio d'incominciare il tuo istudio dalla lingua; e la lingua impararla da quelli che la seppero buona e copiosa, i trecentisti. — Debbo io leggerli tutti ? — Non dirò tutti; ma quanti più potrai: e dare ad essi tre o quattro di quei dieci anni, che sei disposto di spendere nello studio deir arte. Né contristarti perciò; pensando che sterile, e in acquisto di nude parole ti debba passare questa lunga lettura. Distinguerò in due classi le scritture di quel secolo: originali e traduzioni. Il primo pregio di utilità tra le originali darò alle istorie, o cronache, o racconti. Gran profitto faresti se avessi cuore di prendere nella gran raccolta degli scrittori Rerum Italicarum fatta dal Muratori tutto ciò che vi è di scritto Italiano; cominciando dal IX volume, e seguitando fino ai tre che in Firenze e in Faenza vi furono aggiunti. Niuno artificio di eloquenza hanno quegli scrittori: ma è pura e schietta la favella: e con molta persuasione rappresentano le cose che videro. In fine di quella lettura ti troveresti acquistata una vera conoscenza dello stato d'Italia, quando ella fu potente, e ricca, e la più civile delle moderne nazioni. Uno scrittore dee aver per fine di contribuire, per quanto può l'ingegno, al miglioramento della sua nazione: e a far questo bisogna conoscer bene ciò eh' ella fu nel tempo della sua maggiore attività. Dunque, se ti cale di conoscere le origini della nostra lingua (e certo è meglio saperle che ignorarle)leggi quel non molto che fu scritto prima di Dante: almeno il libretto de' poeti antichi, Il Novellino, e il Tesoro di Brunetto Latini. Questo è la vera enciclopedia del suo secolo: benché la traduzione del suo originale francese, è di parecchi anni posteriore alla sua morte. Ma dopo il Novellino, che é la più antica prosa italiana, e dopo i poeti antichi, e la traduzione di Albertano Giudice, e la guerra di Troia tradotta da Guido delle Colonne Messinese (per conoscere gli agresti principii della lingua) e prima del Tesoro di Brunetto, leggi secondo l’ordine Muratoriano i Cronisti. Il primo, che ò Dino Compagni, coetaneo di Dante, vedrai se manca di molto ad essere un Sallustio Italiano. Vero è che gli altri seguenti gli sono molto inferiori d' ingegno. Prima del Compagni leggerai Ricordano Malespini; e dopo il Compagni l’anonimo delle Storie Pistoiesi: e i due fratelli Giovanni, e Matteo Villani; ricchi di notizie, ricchissimi di lingua. La lettura del primo Villani, e de' suoi antecessori, ti avrà talmente istruito delle condizioni e de' fatti e delle persone di quel secolo, che poco ti bisogneranno altri Commenti a bene intender Dante. Ma prima del sacro poema (pel quale o non cede ad Omero, o cede a lui solo), leggi le sue rime, la sua vita Nuova, il suo Convivio. Così meglio entrerai nelle sue cantiche; le quali sono libro da rileggere per tutta la vita. Dopo i Villani, e prima dì Dante avrai letta l’opera del suo maestro Latini, il Tesoro. Letto Dante, ripiglierai i Cronisti sino al fine. E a questa lettura andrai, se ti piace, inframettendo le opere letterarie: le quali, come dissi, sono in gran parte traduzioni. E non ti maraviglierai; pensando che la letteratura di tutte le nazioni è cominciata dal tradurre. Senza eredità non può essere gran ricchezza. Solo dei greci non si sa da chi traducessero: ma è credibile che anch' essi tradussero. Rimane l’opera di Horapollo egiziano dei geroglifici tradotta in greco; sebbene in tempi assai bassi per la Grecia. I nostri buoni Italiani non tradussero originalmente dal greco; ma italianizzarono le traduzioni di altri popoli. Il più tradussero immediatamente dal francese e dal latino. Le opere francesi furono la maggior parte devote; e però di materia gradita a quel secolo, intollerabile al nostro. Io non esigerò che per imparare la lingua ti annoi nelle divozioni troppo semplici e goffe di quel secolo. Di tante opere ti raccomanderò una sola: i quattro volumi delle Vite de' Santi Padri, volgarizzate da Domenico Cavalca: le quali per me sono la più perfetta prosa del trecento: e dove non solamente è aurea la lingua; ma prezioso lo stile; puro, dolce, armonioso, nobile, affettuoso. Anche l'operetta de' Fioretti di San Francesco, ha mirabili grazie di stile. Molti autori latini, di prosa e di verso, furono volgarizzati in prosa in quel secolo. E queste traduzioni mi paiono da studiare, confrontandole cogli originali. È vero che spesso i traduttori, per debolezza, più spesso per avere cattivi testi (e non ancora corretti dalla diligenza erudita del quattrocento e del cinquecento ), sbagliarono nel senso: ma anche spesso fanno stupire per la grande proprietà ed efficacia colla quale la loro semplicità esprime cose che a noi darebbero non poco da pensare. Le due più voluminose opere tradotte in quella età, sono due pessime e insopportabili opere. La Città di Dio, tradotta da un Anonimo; e i Morali di Gregorio Papa, tradotti da Zanobio da Strada, insigne letterato di quei dì; la cui fatica interrottagli dalla morte, fu continuata da un altro. Se l’opera di San Gregorio non fosse veramente uno dei limiti della demenza umana, quanto volentieri si leggerebbe quella traduzione; che è. della bellissima prosa italiana. La Città di Dio manca quasi sempre di senso in italiano: e pare impossibile che uno scrittore duri tanto a scrivere senza sapere quello che si dica. non sapea il latino; o ebbe un testo corrottissimo. Nondimeno dell'una e dell'altra opera assaggerai un poco; almeno per sapere che cosa sono. Devi leggere le Novelle di Francesco Sacchetti, e del Pecorone: queste son molte volte esempio graziosissimo di pura e amabile narrazione: quelle in più negletto stile fanno viva pittura de' costumi pubblici e privati di quel secolo. In somma de' trecentisti quanti ne leggerai, tanto guadagnerai di buonissima lingua: il profitto sarà doppio in quelli che o traducono dal latino, o raccontano fatti. I due volumi del Catalogo di Gaetano Poggiali ti daranno indizio di tutti cotesti scrittori. Guardati però dal credere opera di quell'aureo tempo La guerra di Semifonte; che è una impostura (e mal eseguita, e con affettazione pessima) nel fine del seicento, o nel principio del settecento. Non mi dilungherò qui a dimostrarlo; il che ho fatto in altra scrittura: ma dopo lunga lettura de' puri e schietti trecentisti avrai tu stesso acquistato bastante giudizio per discernere da te. 132 Le “Annotazioni dei Deputati al Decamerone”, scritte da quel purgatissimo e finissimo giudizio di Vincenzo Borghini, ti daranno abilità e uso di notare e scorgere il fino dell’antica e genuina lingua negli scrittori di quella ottima età. Devi certamente leggere tanto le poesie quanto le prose del Boccaccio; che sono tutte ricchissime di squisita lingua: ma persuaditi che è viziosissimo, e non da imitarsi il .suo stile; di che tra poco ti discorrerò: e vedrai quanto è lontano dalla semplicità naturale e scorrevole di tutti gli altri suoi contemporanei: i quali tutti nelle Vite de' Padri vince il Cavalca; il quale scrivendo come gli altri con abbondanza di cuore, e senza niuno stento, né anche apparenza di studio; ha una condotta, una dignità, un suono; che beato chi oggidì potesse imitarlo. Tre quattro anni di lettura de' trecentisti ti avran fatto un assai buon capitale di lingua, cioè di vocaboli e di frasi, genuinamente e graziosamente Italiane. Ora conviene imparare a metterlo in opera. Conviene con questi cosi belli e morbidi abiti imparare a vestire i pensieri. E a tale studio nel quale la tua memoria ben provveduta dee servire al tuo giudizio, che si andrà con esercizio formando e purgando e raffinando, devi donare altri tre o quattro anni. Né devono essere tuoi i pensieri che ti proverai a colorire: ma già disegnati, e con altro colore dipinti da migliori teste. Sai che s' impara a dipingere prima copiando quadri di eccellenti pittori; poi colorando disegni di maestri ottimi: infine si prende sicurtà di colorire le proprie invenzioni. Perciò ti consiglio che traducendo dagli ottimi impari a scrivere. E credimi che quest’ordine è necessario. Se un uomo deve ad un tratto stare intento nel trovare i concetti, e maturarli; e comporli insieme, e distribuirli, ed esprimerli, e pennelleggiarli; non può tante cose condurre insieme con egual cura e perfezione. Conviene dunque ch'egli prenda una tela di pensieri già benissimo disposti; e scarico di questa gravissima cura, attenda solo a vedere come un ottimo scrittore nella propria lingua li colorò, e cerchi nel suo idioma i colori rispondenti; e nel collocarli segua l’esempio dell’originale. Inoltre se nel principio di esercitar l’arte scrivi del proprio, è facilissimo che tu renda un vizio difficile poi a correggere; che non venendoti facile il dire quello che propriamente vorresti, ti pieghi a dire quello che puoi: vizio che troverai frequentissimo ne' mediocri scrittori; cioè nel maggior numero: poiché solamente dei grandi e vigorosi è poter dire quello che vogliono, e come vogliono. Ma trasportando tu nella tua lingua ciò che fu detto da un eccellente scrittore, se mai dici di più di meno; hai l’originale incorruttibile che ti avverte e ti riprende; e ti tiene in riga, e ti avvezza a non declinar punto nel parlare dall’intima e primitiva intenzione: cosa necessarissima a scriver in modo che faccia impressione distinta e durevole nell’animo del lettore. Tutto ciò che esce obbliquo, e però debole, striscia sul lettore; noi penetra, né anche lo colpisce. Avrai osservato in Dante un maraviglioso e singolare esempio di efficacia. Vedi che ritratti egli fa con poche linee; come scolpisce; che faville suscita. Vedrai come in ciò valsero gli antichi. Tu per imparare la lingua greca, cioè per intendere quegli scrittori, ne hai già letti molti. Ora con altra intenzione ti conviene rileggerli, per imparare da essi l’arte nella quale furono essi soli perfettissimi, del dipingere i più alti e gentili pensieri. Rileggerai dunque Omero, Erodoto, Tucidide, Senofonte, Eschine, Lisia, Iseo, Demostene, Platone, Aristotele. Da quel seccatore d' Isocrate, comunque tanto lodato, ti dispenso. Ora che sai bene la vera lingua italiana (della quale tanti parlano, e per dio non la sanno) potrai intendere quel che ti dissi della mirabile corrispondenza che è tra lei e la greca; e quanto da un valente uomo si potrebbe arricchir la nostra coi tesori di quella. Da Omero a Demostene son lutti modelli di scrivere: diversi, ma tutti belli. I posteriori, Polibio, Diodoro, Arriano, Dionigi, Plutarco, Luciano, sono degnissimi e utilissimi di esser letti; lontani però da quella perfezione. In que' primi osserverai la distribuzione delle idee e i vincoli; la scelta de' colori, la semplicità graziosissima, l’efficacia e la forza. Di tratto in tratto l’invoglierai di provarti a fare italiano ora questo pezzo, ora quello. Cedi a queir impulso; e non ti risparmiare in questa bella fatica. Sai che Cicerone v'impiegò la gioventù, e si formò quell’eloquentissimo ed elegantissimo, traducendo Platone, Eschine, Demostene. Ma è lavoro da giovane, se vuol farsi utilmente. 11 povero Alfieri molto inutilmente vi si affaticò, perché vi si pose da vecchio. Tutti i pittori cominciano dal copiare; ma questo è principio, non fine degli studi. Troverai Erodoto narratore unico nel suo genere: e il solo di tutti gli scrittori (secondo me) impossibile ad esser bene tradotto: e molto meno difficile ad essere superata la tanto decantata arduità di Tucidide; sommo raccontatore, in altro genere; e il primo degli uomini di Stato. Se bai imparato a pronunziare il greco, non alla maniera corrottissima de’ moderni, ma all'antica; sentirai leggendo il buon Erodoto un' armonia somigliantissima a quella del Cavalca, nelle vite de' Padri. Non temo d' ingannarmi in ciò; essendo stato costretto di acconsentirmi il primo poliglotte del nostro secolo, anzi di tutti i secoli, Giuseppe Mezzofanti: il quale non voleva rimuoversi da quella pronuncia moderna del greco, né soffrire che altri leggesse a lui diversamente: ma pur cedendo a me, e sopportando che gli leggessi a mio modo l’Erodoto, sentì e confessò anch' egli questa rassomiglianza di armonia tra lo Ionico, e lo scrittore Pisano. Tradurrai molto di Tucidide; il quale fu otto volte copiato da Demostene, per impossessarsi di quello stile stretto e robusto. Faticherai di più ad esprimere la semplicità di Senofonte. La pompa e magnificenza di Platone, la pienissima e profonda brevità e precisione di Aristotele, il calore e l’impeto di Demostene, devi imbeverli, e studiarti di esprimerli: sopratutti studierai in quest' ultimo. Vedrai, vedrai come a tradurre costoro si presti la ricca e pieghevole lingua del trecento: al paragone della quale è si povera e stentata quella che ritenne il cinquecento. Come con si poveri colori si potrebbe ricopiare una pittura tanto variala di lumi ? Nel tradurre dai greci l’uso ti mostrerà quanto di frase possa comodamente e graziosamente passare da quella lingua nella nostra. E se tu vi riuscirai bene, potrai compiacerti e gloriarti d'essere autore di novissimo e bellissimo stile all’Italia. Leggendo e traducendo i greci imparerai che cosa sia semplicità, abbondanza, grazia, varietà, precisione, chiarezza, eleganza, vigore, armonia di stile: e non ti bisognerà imparare nient'altro da altri. Però se avrai tradotto molto dai greci, non occorrerà che volgarizzi dai latini. 133 Bensì bisognerà rileggere attentamente alcuni migliori; e perché hanno certe bellezze loro proprie, degnissime di attenzione; e per conoscer meglio i nostri Italiani: i quali nulla si avvisarono di prendere dai greci; e non molto, e male pigliarono, dai latini. Di questi devi particolarmente rileggere Cicerone, Livio, Tacito. L’abbondanza elegante di Cicerone, e l’armonia ch'egli solo ha saputo creare e donare a una lingua cosi dura e aspra, sono degnissime di considerazione. L’eloquente, l'affettuoso, il gran pittore, il drammatico Livio prendo il cuore, benché agli orecchi non porti quella dolcezza del Tulliano concento. La gravità e la forza e il sentenzioso di Tacito ti piaceranno e gioveranno. Leggilo tre volte: prima solo nel suo latino; poi a parte a parte confrontandolo col suo traduttore Davanzali: e infine leggi segnatamente e da sé il Davanzali. Vedrai come costui abbia studiato nel Novellino e nel Compagni per farsi quel suo stile, tutto suo, e dotato di rari pregi. Di tutti i poeti Italiani credo che il solo Dante possa giovare a un prosatore, per la gran copia e proprietà di vocaboli, in che vince tutti insieme gli altri scrittori; e per la vaghezza ed efficacia dei modi; e per la spontaneità dello stile; dalla quale rare volte, o per durezza della intrattabile materia, o per falsa ambizione si diparte. Ma in alcuni poeti latini puoi trovare di bei lumi da collocar felicemente nel tuo stile. Da Virgilio imparerai un gran decoro di frase sempre nobile, e spesso affettuosa: dignità e grazia in Orazio; copia amabile in Ovidio; sdegni magnanimi in Lucano e Giovenale. Leggi Cornelio Celso, come esempio somigliante ai greci nella semplicità di uno stile insegnativo. Leggi i due Plinii; de' quali il giovane ti farà conoscere il suo secolo; e il vecchio in uno stile un po' forzato ha raccolte molte notizie importanti. Curzio in un secolo degenerato si formò uno stile cogliendolo dalle migliori età che lo precedettero: è come i Caracci nella pittura. Sono autori da conoscere, non da studiarvi. Se leggi Tacito attentamente, vedrai quanto egli avesse studiato Cicerone, e Livio, e Sallustio. Se vuoi vedere come un grande scrittore imita uno scrittor sommo, paragona il fine dell’Agricola di Tacito (Finis vitae eius nobis luctuosus, ec.) colla morte di Crasso compianta da Cicerone nell’Oratore. Se vuoi vedere come l’arte perfezionata da un sommo scrittore aggrandisce e nobilita i timidi abbozzi d' uno scrittore più antico e povero; paragona il fatto di Manlio Torquato descritto da Livio, colla narrazione di Claudio Quadrigario riportata da Gellio. Aulo Gellio è autore che devi leggere; e per le molte notizie; e perché spesso vi s'incontrano buoni esempi di stile. Nelle Pandette anco troverai del buono: e specialmente ne' responsi o consulti dei legisti antichi, imparerai la gravità e precision dello stile conveniente agli affari. Vedrai con quanta chiarezza e brevità espongono un fatto; quanto dirittamente e sobriamente discutono le ragioni: con quanta sicurezza conchiudono e sostengono il giudizio. Ti sarebbe utile se questa parte (la sola buona)della giurisprudenza romana la leggessi tutta. Cicerone, Livio, e Tacito, meritano frequente e ripetuta lettura. Di tutti i latinisti moderni, alle guerre Italiche di Castruccio Bonamici, e alle satire del Sergardi, o Settano, fa l’onore di leggerli; come i soli veramente romani de' tempi moderni. Leggi l’opera del Morcelli sulle iscrizioni latine; e per la sua bella latinità; e per la molta e scelta erudizione antica; e per impararvi molte buone regole da comporre belle iscrizioni Italiane. Pochissimi tra i latini, come Cesare, Celso, i giureconsulti si tennero scrivendo alla semplicità greca: gli altri amarono una certa pompa e maestà: della quale sarà forse bene derivare alquanto allo stile italiano; ma con buon garbo; e piuttosto coir innalzare qualche volta (modestamente) la frase: non mai col girare violentemente la clausula, contro l’indole e il potere di nostra lingua; come tentò infelicissimamente il Boccaccio, ed inescusabilmente il pedantissimo Bembo. Se mai t' invogliassi di tradurre qualche cosa dai latini; potrai paragonare il tuo lavoro con quello de' cinquecentisti: ma credo che tu arricchito della lingua del trecento, ed istruito nello stile de’ greci; avrai sempre fatto meglio de' cinquecentisti; che mal non espressero la forza de' latini. Solo il Frangipane nelle due orazioni che tradusse a Cicerone, conservò abbastanza la dignità e il suono dell’originale. Finito di leggere i latini come esempi di buono stile; bisognerà che tu passi a conoscere gì' Italiani del cinquecento e del seicento. Bisogna conoscerli, per molte ragioni. Ma niente v' imparerai di lingua: perché essi abbandonarono una grandissima parte di quella beata favella del trecento; e di quei tanti vocaboli si espressivi, e di quei tanti modi si graziosi e varii e pieni, si privarono. Sicché la strettezza e povertà della lingua del cinquecento è una vera miseria e compassione: e bene te ne avvederai tu stesso. Poco potrai da loro cavare di stile: s' invogliarono di quest' arte, ma non la intesero; ed errarono fino da' principi i buoni trecentisti (eccetto il Boccaccio)senza niuna presunzione scrissero come il cuor dettava; disordinatamente un poco; senza legami, senza condotta: ma con grande chiarezza, e con grandissimo affetto. I cinquecentisti vollero comporsi. Non pensarono ai modelli greci: si proposero i latini; ma non riuscirono a prenderli in quella poca parte dove sono imitabili. Si ostinarono a tutti i vizi del Boccaccio; guidandoli in ciò con fatale autorità il Bembo. Quindi la prolissità, i giri intricati e interminabili, le trasposizioni dure, e generatrici di oscurità in una lingua che non varia le desinenze de' nomi; le confusioni ora pesanti e ora ridicole in una lingua che scarseggiando nelle coniugazioni de' verbi è costretta si spesso all’aiuto grossolano e lento degli ausiliarii. Il primo effetto del buono stile è la buona distribuzione delle idee subalterne; il far campeggiare le principali; il separare e unire a tempo gli accessorii: quello che nella pittura è l’ombreggiare, o come dicono (malamente) i moderni, il chiaroscuro: quello che si bene senti Orazio: Haec amai obscurum; volet haecsub luce videri. Il povero Boccaccio imbroglia tutto. Si scorda il gran precetto «semper ad eventum festinat»: squarta e affoga l’idea principale con accessorii per lo più inutilissimi; sospende e affatica per una trasposizione ingratissima, e stentata. Lo scrivere non dovrebbe esser altro che uno scelto e perfetto parlare. 134 Secondo questa regola è ben cattivo il Boccaccio; e molto difettosi i cinquecentisti. Bisogna leggerli nondimeno: e da molti di loro si può prendere qua e là qualche cosa di buono; benché tutti rimangano lontani dall’ottimo. Comincierai peraltro da quello che più vi sì accosta, dalla Storia d' Europa del Giambullari, la miglior prosa del cinquecento; la quale sola fra gl'Italiani, dopo il Cavalca nelle vite de' Padri (e dico dopo, in tempo e in merito) fa ricordare quell'unica e beatissima vena di Erodoto. Questo Giambullari è veramente caro prosatore, e da leggere attentamente. Leggerai dipoi il Macchiavello, troppo rettorico nelle Storie, troppo negletto ne' Discorsi, neglettissimo nelle Legazioni, migliore nel Principe, saviamente colto nell'Arte della Guerra. Gli succederà il Guicciardino; la prima testa politica degl’italiani (superiore non poco al Macchiavello, checché si creda in contrario dai più); il più fornito di eloquenza, il più mancante di stile; perché spesso pedantesco ne' latinismi, e privo affatto di economia nella distribuzione delle idee. Conosce gli affetti sufficientemente; è ricco di concetti: nel resto insopportabile. Non vizioso é lo stile del Cortigiano: e giova conoscere come s' intendesse la eleganza de' costumi nel principiare del secolo sedicesimo. Ricca di lingua, noiosa d' imbrogliato stile é la Storia del Varchi: ma utilmente minuta nel rappresentare i costumi del suo tempo. Migliore di stile é Bernardo Segni. Si distingue fra tutti per la disinvoltura il Caro: egli vedeva il mondo da uomo di mondo. Un carissimo matto è Benvenuto Cellini: il solo fra tutti che scrivendo sembra parlare. È da porre attenzione in lui, per rubargli, se si può, quello scrivere che sembra un parlare: e che deve essere il più frequente; salvo che in alcune occasioni solenni: laddove il gran difetto degl'Italiani é di scostarsi troppo da questa naturalezza. Non se ne allontanano il Gelli, e il Firenzuola (ma questi solamente nei discorsi degli animali; nelle altre opere ha l’affettazione de' suoi contemporanei): e questi due scrittori sono unici tra i cinquecentisti a rappresentare in gran parte la cara ingenuità del trecento. Il Vasari si mostra studiato ne' proemii; ch'ei si faceva fare da amici più dotti: ma nel corso delle Vite scrive alla buona. Una disinvoltura di stile in quel secolo non la troverai se non in questi nominati Caro, Cellini, Gelli, Vasari. Lavoratissimo e battuto a martello è lo stile del Casa, ma il più esatto di tutti: e nelle Orazioni ha dell’eloquente. Tieni però che la sola cosa veramente eloquentissima di nostra lingua sono le poche pagine dell’Apologia di Lorenzo de' Medici, scritte senza cura, con impeto di animo eguale agli antichi eroi della libertà. Lo Speroni mi pare gran modello di stile filosofico per la gran precisione. Le orazioni son fredde e morte: ma quella in morte di Giulia Varana mi pare la più dolce e affettuosa armonia che mai suonasse in prosa italiana. Il Bembo mi pare insopportabile in tutto, fuori che nelle lettere. I Discorsi di Vincenzo Borghini, utili per la materia, mi sembrano bell’esempio di stile esatto (benché alquanto affaticato) nel trattar materie erudite. La storia di Paolo Paruta è da leggere; ma eccellenti nel suo genere di stile, e per la materia nobili sono i suoi Discorsi. Le Storie e i Discorsi dell'Ammirato poco perderai se le trascuri: dico lo stesso delle opere del Salviati, e delle lettere del Tasso Padre e del Tolomei. Ma le lettere di Torquato Tasso le credo stupende; e bellissime non poche delle sue Prose: e se non fosse la noiosa filosofia peripatetica, direi tutte. Egli fu poeta con fatica, e da natura fatto alla più nobile prosa. Ha una dignità spontanea, che nessun altro scrittore italiano ha potuta conseguire collo studio. La malinconia che tanto lo travagliò, gli ha nobilitato lo stile. Ti raccomando un prezioso libretto, La Congiura de' Baroni Napoletani descritta da Camillo Porzio. Vero modello di stile insegnativo è Andrea Palladio nell'Architettura. Leggi quell'opera veramente classica e per lo stile e per la materia. Peccato fu che non seguisse ragionando dei secentisti. Benché di quel secolo, e degli scrittori che lo vituperarono (poeti e oratori), non che di quelli che lo glorificarono (istorici, filosofi e scienziati), discorre a lungo in altre scritture, date e a darsi. 135 Sul «Cacciatore feroce» e sulla «Eleonora» di Goffredo Augusto Bürger. Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo [ed. in Opere di Giovanni Berchet, a cura di Egidio Bellorini, vol. 2, Scritti critici e letterari, Bari, Laterza, 1912] Figliuolo carissimo, M'ha fatto maraviglia davvero che tu, convittore di un collegio, ti dessi a cercarmi con desiderio cosí vivo una traduzione italiana di due componimenti poetici del Bürger. Che posso io negare al figliuolo mio? Povero vecchio inesercitato, ho penato assai a tradurli; ma pur finalmente ne sono venuto a capo. In tanta condiscendenza non altro mi stava a cuore che di farti conoscere il Bürger: però non mi resse l'animo di alterare con colori troppo italiani i lineamenti di quel tedesco; e la traduzione è in prosa. Tu vedi che anche col fatto io sto saldo alle opinioni mie; e la veritá è che gli esempi altrui mi ribadiscono ogni dí piú questo chiodo. Non è per altro ch'io intenda dire che tutto tuttoquanto di poetico manda una lingua ad un'altra s'abbia da questa a tradurre in prosa. Nemico giurato di qualunque sistema esclusivo, riderei di chi proponesse una legge siffatta, come mi rido di Voltaire che voleva che i versi fossero da tradursi sempre in versi. Le ragioni che devono muovere il traduttore ad appigliarsi piú all'uno che all'altro partito stanno nel testo, e variano a seconda della diversa indole e della diversa provenienza di quello. Tutti i popoli, che piú o meno hanno lettere, hanno poesia. Ma non tutti i popoli posseggono un linguaggio poetico separato dal linguaggio prosaico. I termini convenzionali per l'espressione del bello non sono da per tutto i medesimi. Come la squisitezza nel modo di sentire, cosí anche l'ardimento nel modo di dichiarare poeticamente le sensazioni è determinato presso di ciaschedun popolo da accidenti dissimili. E quella spiegazione armoniosa di un concetto poetico, che sará sublime a Londra od a Berlino, riescirá non di rado ridicola se ricantata in Toscana. Ché se tu mi lasci il concetto straniero ma, per servire alle inclinazioni della poesia della tua patria, me lo vesti di tutti panni italiani e troppo diversi da' suoi nativi, chi potrá in coscienza salutarti come autore, chi ringraziarti come traduttore? Colla prosa la faccenda è tutt'altra; da che allora il lettore non si dimentica un momento mai che il libro ch'ei legge è una traduzione, e tutto perdona in grazia del gusto ch'egli ha nel fare amicizia con genti ignote e nello squadrarle da capo a piedi tal quali sono. Il lettore, quand'ha per le mani una traduzione in verso, non sempre può conseguire intera una tale soddisfazione. La mente di lui, divisa in due, ora si rivolge a raffigurare l'originalitá del testo, ora a pesare quanta sia l'abilitá poetica del traduttore. Queste due attenzioni non tirano innanzi molto cosí insieme; e la seconda per lo piú vince, perché l'altra, come quella che è la meno direttamente adescata e la meno contentata, illanguidisce. Ed è allora che chi legge si fa schizzinoso di piú; e come se esaminasse versi originali italiani, ti crivella le frasi fino allo scrupolo. Chi porrá mente alle circostanze differenti che rendono differente il modo di concepire le idee e verrá investigando le origini delle varie lingue e letterature, troverá che i popoli, anche per questo lato, hanno tra di loro de' gradi maggiori o minori di parentela. Da ciò deriverá al traduttore tanto lume che basti per metter lui sulla buona via, ov'egli abbia intenzione conforme all'obbligo che gli corre, quella cioè di darci a conoscere il testo, non di regalarcene egli uno del suo. Il signor Bellotti imprese a tradurre Sofocle; e prima ancora che comparisse in luce quell'esimio lavoro, chi sognò mai che egli si fosse ingannato nella scelta del mezzo, per avere pigliato a condurre in versi la sua traduzione? Per lo contrario vedi ora, figliuolo mio, se io ti abbia vaticinato il falso quando ti parlai tempo fa d'una traduzione del teatro di Shakespeare, prossima allora ad uscire in Firenze. Il signor Leoni ha ingegno, anima, erudizione, acutezza di critica, disinvoltura di lingua italiana, cognizione molta di lingua inglese, tutti insomma i requisiti per essere un valente traduttore di Shakespeare. Ma il signor Leoni l'ha sbagliata. I suoi versi sono buoni versi italiani. Ma che vuoi? Shakespeare è svisato; e noi siamo tuttavia costretti ad invidiare ai francesi il loro Letourneur. E sí che il signor Leoni bastava a smorzarcela affatto questa invidia! Di quanti altri puntelli potrebbesi rinfiancare questo argomento, lo sa Dio. Ma perché sbracciarmi a dimostrare che il fuoco scotta? Chi s'ostina a negarlo, buon pro per lui! E non occorre dire che la lingua nostra non si pieghi ad una prosa robusta, elegante, snella, tenera quanto la francese. La lingua italiana non la sapremo maneggiare con bella maniera né io né tu, perché tu sei un ragazzotto ed io un vecchio dabbene e nulla piú; ma fa' ch'ella trovi un artefice destro, ed è materia da cavarne ogni costrutto. Ma questa materia non istá tutta negli scaffali delle biblioteche. Ma non lá solamente la vanno spolverando que' pochi cervelli acuti che non aspirano alla fama di messer lo Sonnifero. In Italia qualunque libro non triviale esca in pubblico incontra bensí qua e lá qualche drappelletto minuto di scrutinapensieri, che pure non lo spaventano mai con brutto viso, perché genti di lor natura savie e discrete. Ma poveretto! eccolo poi dar nel mezzo ad un esercito di scrutinaparole, infinito, inevitabile e sempre all'erta e prodigo sempre d'anatemi. Però io, non avuto riguardo per ora alla fatica che costano i bei versi a tesserli, confesso che qui, tra noi, per rispetto solamente alla lingua, chiunque si sgomenta de' latrati dei pedanti piglia impresa meno scabra d'assai se scrive in versi e non in prosa. Confesso che per rispetto solamente alla lingua e non ad altro, tanto nel tradurre come nel comporre di getto originale, il montar su' trampoli e verseggiare costa meno pericoli. Confesso che allo scrittore di prose bisogna studiare e libri e uomini e usanze; perocché altro è lo stare ristretto a' confini determinati di un linguaggio 136 poetico, altro è lo spaziarsi per l'immenso mare di una lingua tanto lussuriante ne' modi, e viva e parlata ed alla quale non si può chiudere il vocabolario, se prima non le si fanno le esequie. Ma lo specifico vero per salire in grido letterario è forse l'impigrire colle mani in mano, e l'inchiodar se stessi sul vocabolario della Crusca, come il giudeo inchioda sul travicello i suoi paperi perché ingrassino? No no, figliuolo mio, la penuria che oggidí noi abbiamo di belle prose non proviene, grazie a Dio, da questo che la lingua nostra non sia lingua che da sonetti. Fa' che il tuo padre spirituale ti legga la parabola dei talenti nell'evangelista; e la santa parola con quel "serve male et piger" ti snebbierá questo fenomeno morale. Ora, per dire di ciò che importa a te, sappi, o carissimo, che i lirici tedeschi piú rinomati, parlo della scuola moderna, sono tre: il Goethe, lo Schiller e il Bürger. Quest'ultimo, dotato di un sentire dilicato ma d'un'immaginazione altresí arditissima, si piacque spesso di trattare il terribile. Egli scrisse altre poesie sull'andare del Cacciatore feroce e della Eleonora; ma queste due sono le piú famose. lo credo di doverle chiamare "romanzi"; e se il vocabolo spiacerá ai dotti d'Italia, non farò per questo a scappellotti colle Signorie Loro. Poesie di simil genere avevano i provenzali; bellissime piú di tutti e molte ne hanno gli inglesi; ne hanno gli spagnuoli; altre e d'altri autori i tedeschi; i francesi le coltivavano un tempo; gli italiani, ch'io sappia, non mai: se pure non si ha a tener conto di leggende in versi congegnate non da' poeti letterati, ma dal volgo, e cantate da lui; fra le quali quella della Samaritana meriterebbe forse il primato per la fortuna di qualche strofetta. Non pretendo con ciò di menomare d'un pelo la reputazione di alcuni "romanzi" in dialetti municipali; perché, parlando di letteratura italiana, non posso aver la mira che alla universale d'Italia. Il Bürger portava opinione "che la sola vera poesia fosse la popolare". Quindi egli studiò di derivare i suoi poemi quasi sempre da fonti conosciute e di proporzionarli poi sempre con tutti i mezzi dell'arte alla concezione del popolo. Anche delle composizioni che ti mando oggi tradotte, l'argomento della prima è ricavato da una tradizione volgare, quello della seconda è inventato, imitando le tradizioni comuni in Germania; il che vedremo in séguito piú distesamente. Anche in entrambi questi componimenti v'ha una certa semplicitá di narrazione, che manifesta nel poeta il proponimento di gradire alla moltitudine. Forse il Bürger, com'è destino talvolta degli uomini d'alto ingegno, trascorreva in quella sua teoria agli estremi. Ma perché i soli uomini d'alto ingegno sanno poi di per se stessi ritenersene giudiziosamente nella pratica, noi, leggendo i versi del Bürger, confessiamo che neppure il dotto vi scapita, né ha ragione di dolersi del poeta. L'opinione nondimeno che la poesia debba essere popolare non albergò solamente presso del Bürger, ma a lei s'accostarono pur molto anche gli altri poeti sommi d'una parte della Germania. Né io credo d'ingannarmi dicendo ch'ella pende assai nel vero. E se, applicandola alla storia dell'arte e pigliandola per codice nel far giudizio delle opere dei poeti che furono, ella può sembrare troppo avventata (giacché al Petrarca, a modo d'esempio, ed al Parini, benché rade volte popolari, bisogna pur fare di cappello), parmi che, considerandola come consiglio a' poeti che sono ed ammettendola con discrezione, ella sia santissima. E dico cosí, non per riverenza servile a' tedeschi ed agli inglesi, ma per libero amore dell'arte e per desiderio che tu, nascente poeta d'Italia, non abbia a dare nelle solite secche che da qualche tempo in qua impediscono il corso agli intelletti e trasmutano la poesia in matrona degli sbadigli. Questa è la precipua cagione per la quale ho determinato che tu smetta i libri del Blair, del Villa e de' loro consorti, tosto che la barba sul mento dará indizio di senno in te piú maturo. Allora avrai da me danaro per comperartene altri, come a dire del Vico, del Burke, del Lessing, del Bouterweck, dello Schiller, del Beccaria, di madama de Staël, dello Schlegel e d'altri che fin qui hanno pensate e scritte cose appartenenti alla estetica: né il Platone in Italia del consigliere Cuoco sará l'ultimo dei doni ch'io ti farò. Ma per ora non dir nulla di questo co' maestri tuoi, che giá non t'intenderebbono. Tuttavolta, perché la massima della popolaritá della poesia mi preme troppo che la si faccia carne e sangue in te, contentati ch'io m'ingegni fin d'ora di dimostrartene la convenienza cosí appena di volo, e come meglio può un vecchiarello che non fu mai in vita sua né poeta né filologo né filosofo. Tutti gli uomini, da Adamo in giú fino al calzolaio che ti fa i begli stivali, hanno nel fondo dell'anima una tendenza alla poesia. Questa tendenza, che in pochissimi è attiva, negli altri non è che passiva, non è che una corda che risponde con simpatiche oscillazioni al tocco della prima. La natura, versando a piene mani i suoi doni nell'animo di que' rari individui ai quali ella concede la tendenza poetica attiva, pare che si compiaccia di crearli differenti affatto dagli altri uomini in mezzo a cui li fa nascere. Di qui le antiche favole sulla quasi divina origine de' poeti, e gli antichi pregiudizi sui miracoli loro, e l'"est deus in nobis". Di qui il piú vero dettato di tutti i filosofi: che i poeti fanno classe a parte, e non sono cittadini di una sola societá ma dell'intero universo. E per veritá chi misurasse la sapienza delle nazioni dalla eccellenza de' loro poeti, parmi che non iscandaglierebbe da savio. Né savio terrei chi nelle dispute letterarie introducesse i rancori e le rivalitá nazionali. Omero, Shakespeare, il Calderon, il Camoens, il Racine, lo Schiller per me sono italiani di patria tanto quanto Dante, l'Ariostoe l'Alfieri. La repubblica delle lettere non è che una, e i poeti ne sono concittadini tutti indistintamente. La predilezione con cui ciascheduno di essi guarda quel tratto di terra ove nacque, quella lingua che da fanciullo imparò, non nuoce mai alla energia dell'amore che il vero poeta consacra per instituto dell'arte sua a tutta insieme la umana razza, né alla intensa volontá per la quale egli studia colle opere sue di provvedere al diletto ed alla educazione di tutta insieme l'umana razza. Però questo amore universale, che governa l'intenzione de' poeti, mette universalmente nella coscienza degli uomini 137 l'obbligo della gratitudine e del rispetto; e nessuna occasione politica può sciogliere noi da questo sacro dovere. Finanche l'ira della guerra rispetta la tomba d'Omero e la casa di Pindaro. Il poeta dunque sbalza fuori delle mani della natura in ogni tempo, in ogni luogo. Ma per quanto esimio egli sia, non arriverá mai a scuotere fortemente l'animo de' lettori suoi, né mai potrá ritrarre alto e sentito applauso, se questi non sono ricchi anch'essi della tendenza poetica passiva. Ora siffatta disposizione degli animi umani, quantunque universale, non è in tutti gli uomini ugualmente squisita. Lo stupido ottentoto, sdraiato sulla soglia della sua capanna, guarda i campi di sabbia che la circondano, e s'addormenta. Esce de' suoi sonni, guarda in alto, vede un cielo uniforme stendersegli sopra del capo, e s'addormenta. Avvolto perpetuamente tra 'l fumo del suo tugurio e il fetore delle sue capre, egli non ha altri oggetti dei quali domandare alla propria memoria l'immagine, pe' quali il cuore gli batta di desiderio. Però alla inerzia della fantasia e del cuore in lui tiene dietro di necessitá quella della tendenza poetica. Per lo contrario un parigino agiato ed ingentilito da tutto il lusso di quella gran capitale, onde pervenire a tanta civilizzazione, è passato attraverso una folta immensa di oggetti, attraverso mille e mille combinazioni di accidenti. Quindi la fantasia di lui è stracca, il cuore allentato per troppo esercizio. Le apparenze esterne delle cose non lo lusingano (per cosí dire); gli effetti di esse non lo commovono piú, perché ripetuti le tante volte. E per togliersi di dosso la noia, bisogna a lui investigare le cagioni, giovandosi della mente. Questa sua mente inquisitiva cresce di necessitá in vigoria, da che l'anima a pro di lei spende anche gran parte di quelle forze che in altri destina alla fantasia ed al cuore; cresce in arguzia per gli sforzi frequenti a' quali la meditazione la costringe. E il parigino di cui io parlo, anche senza avvedersene, viene assuefacendosi a perpetui raziocini o, per dirla a modo del Vico, diventa filosofo. Se la stupiditá dell'ottentoto è nimica alla poesia, non è certo favorevole molto a lei la somma civilizzazione del parigino. Nel primo la tendenza poetica è sopita; nel secondo è sciupata in gran parte. I canti del poeta non penetrano nell'anima del primo, perché non trovano la via d'entrarvi. Nell'anima del secondo appena appena discendono accompagnati da paragoni e da raziocini: la fantasia ed il cuore non rispondono loro che come a reminiscenze lontane. E siffatti canti, che sono l'espressione arditissima di tutto ciò che v'ha di piú fervido nell'umano pensiero, potranno essi trovar fortuna fra tanto gelo? E che maraviglia se, presso del parigino ingentilito, quel poeta sará piú bene accolto che piú penderá all'epigrammatico? Ma la stupiditá dell'ottentoto è separata dalla leziosaggine del parigino fin ora descritto per mezzo di gradi moltissimi di civilizzazione, che piú o meno dispongono l'uomo alla poesia. E s'io dovessi indicare uomini che piú si trovino oggidí in questa disposizione poetica, parmi che andrei a cercarli in una parte della Germania. A consolazione non pertanto de' poeti, in ogni terra, ovunque è coltura intellettuale, vi hanno uomini capaci di sentire poesia. Ve n'ha bensí in copia ora maggiore, ora minore; ma tuttavia sufficiente sempre. Ma fa d'uopo conoscerli e ravvisarli ben bene, e tenerne conto. Ma il poeta non si accorgerá mai della loro esistenza, se per rinvenirli visita le ultime casipole della plebe affamata, e di lá salta a dirittura nelle botteghe da caffé, ne' gabinetti delle Aspasie, nelle corti de' principi, e nulla piú. Ad ogni tratto egli rischierá di cogliere in iscambio la sua patria, ora credendola il capo di Buona speranza, ora il cortile del Palais-royal. E dell'indole dei suoi concittadini egli non saprá mai un ette. Ché s'egli considera che la sua nazione non la compongono que' dugento che gli stanno intorno nelle veglie e ne' conviti; se egli ha mente a questo: che mille e mille famiglie pensano, leggono, scrivono, piangono, fremono e sentono le passioni tutte, senza pure avere un nome ne' teatri; può essere che a lui si schiarisca innanzi un altro orizzonte, può essere che egli venga accostumandosi ad altri pensieri ed a piú vaste intenzioni. L'annoverare qui gli accidenti fisici propizi o avversi alla tendenza poetica; il dire minutamente come questa, del pari che la virtù morale, possa essere aumentata o ristretta in una nazione dalla natura delle instituzioni civili, delle leggi religiose e di altre circostanze politiche; non fa all'intendimento mio. Te ne discorreranno, o carissimo, a tempo opportuno, i libri ch'io ti presterò. Basti a te per ora il sapere che tutte le presenti nazioni d'Europa - l'italiana anch'essa né piú né meno - sono formate da tre classi d'individui: l'una di ottentoti, l'una di parigini e l'una, per ultimo, che comprende tutti gli altri individui leggenti ed ascoltanti, non eccettuati quelli che, avendo anche studiato ed esperimentato quant'altri, pur tuttavia ritengono attitudine alle emozioni. A questi tutti io do nome di "popolo". Della prima classe, che è quella dei balordi calzati e scalzi, non occorre far parole. La seconda, che racchiude in sé quei pochi i quali escono dalla comune in modo da perdere ogni impronta nazionale, vuole bensí essere rispettata dal poeta, ma non idolatrata, ma non temuta. Il giudizio, che i membri di questa classe fanno delle moderne opere poetiche, non suole derivare dal suffragio immediato delle sensazioni, ma da' confronti. Negli anni del fervore eglino hanno trovato il bello presso tale e tal altro poeta; e ciò che non somiglia al bello sentito un tempo, pare loro di doverlo ora ricusare. Le opinioni scolastiche, i precetti bevuti pigramente un tempo come infallibili, reggono tuttavia il loro intelletto, che non li mise mai ad esame, perché d'altro curante. Però l'orgoglio umano, a cui è duro il dover discendere a discredere ciò che per molti anni s'è creduto, il piú delle volte li fa tenaci delle massime inveterate. E il piú delle volte eglino combattono per esse come per l'antemurale della loro riputazione. Allora ogni arme, ogni scudo giova. E perché una serie di secoli non si brigò piú che tanto di discutere l'importanza di quelle massime, eccoti in campo un bello argomento di difesa nel silenzio delle generazioni. "Chi tace non parla", diciamo noi. Ma "chi tace approva", dicono essi, e il sopore dei secoli lo vanno predicando come consenso assoluto di tuttaquanta la ragione umana alla necessitá di 138 certe regole chiamate, Dio sa perché, di "buon gusto"; e però via via d'ugual passo sgozzano ad esse ogni tratto qualche vittima illustre. La lode, che al poeta viene da questa minima parte della sua nazione, non può davvero farlo andare superbo; quindi anche il biasimo ch'ella sentenzia non ha a mettergli grande spavento. La gente ch'egli cerca, i suoi veri lettori stanno a milioni nella terza classe. E questa, cred'io, deve il poeta moderno aver di mira, da questa deve farsi intendere, a questa deve studiar di piacere, s'egli bada al proprio interesse ed all'interesse vero dell'arte. Ed ecco come la sola vera poesia sia la popolare: salve le eccezioni sempre, come ho giá detto; e salva sempre la discrezione ragionevole, con cui questa regola vuole essere interpretata. Se i poeti moderni d'una parte della Germania menano tanto romore di sé e in casa loro e in tutte le contrade d'Europa, ciò è da ascriversi alla popolaritá della poesia loro. E questa salutare direzione ch'eglino diedero all'arte fu suggerita loro dagli studi profondi fatti sul cuore umano, sullo scopo dell'arte, sulla storia di lei e sulle opere ch'ella in ogni secolo produsse: fu suggerita loro dalla divisione in "classica" e "romantica" ch'eglino immaginarono nella poesia. Però sappi, tra parentesi, che tale divisione non è un capriccio di bizzarri intelletti, come piace di borbottare a certi giudici che senza processare sentenziano; non è sotterfugio per sottrarsi alle regole che ad ogni genere di poesia convengono; da che uno de' poeti chiamati "romantici" è il Tasso. E fra le accuse che si portano alla Gerusalemme, chi udí mai messa in campo quella di trasgressione delle regole? Qual altro poema piú si conforma alle speculazioni algebraiche degli aristotelici? Né ti dare a credere, figliuolo mio, che con quella divisione i tedeschi di cui parlo pretendessero che d'un'arte, la quale è unica, indivisibile, si avesse a farne due; perocché stolti non erano. Ma se le produzioni di quest'arte, seguendo l'indole diversa dei secoli e delle civilizzazioni, hanno assunte facce differenti, perché non potrò io distribuirle in tribú differenti? e se quelle della seconda tribú hanno in sé qualche cosa che piú intimamente esprime l'indole della presente civilizzazione europea, dovrò io rigettarle per questo solo che non hanno volto simile al volto della prima tribú? Di mano in mano che le nazioni europee si riscuotevano dal sonno e dall'avvilimento, di che le aveva tutte ingombrate la irruzione de' barbari dopo la caduta dell'impero romano, poeti qua e lá emergevano a ringentilirle. Compagna volontaria del pensiero e figlia ardente delle passioni, l'arte della poesia, come la fenice, era risuscitata di per sé in Europa, e di per sé anche sarebbe giunta al colmo della perfezione. I miracoli di Dio, le angosce e le fortune dell'amore, la gioia de' conviti, le acerbe ire, gli splendidi fatti de' cavalieri muovevano la potenza poetica nell'anima de' trovatori. E i trovatori, né da Pindaro instruiti né da Orazio, correndo all'arpa prorompevano in canti spontanei ed intimavano all'anima del popolo il sentimento del bello, gran tempo ancora innanzi che l'invenzione della stampa e i fuggitivi di Costantinopoli profondessero da per tutto i poemi de' greci e de' latini. Avviata cosí nelle nazioni d'Europa la tendenza poetica, crebbe ne' poeti il desiderio di lusingarla piú degnamente. Però industriaronsi per mille maniere di trovare soccorsi; e giovandosi della occasione, si volsero anche allo studio delle poesie antiche, in prima come ad un santuario misterioso accessibile ad essi soli, poi come ad una sorgente pubblica di fantasie, a cui tutti i lettori potevano attignere. Ma ad onta degli studi e della erudizione, i poeti, che dal risorgimento delle lettere giú fino a' dí nostri illustrarono l'Europa e che portano il nome comune di "moderni", tennero strade diverse. Alcuni, sperando di riprodurre le bellezze ammirate ne' greci e ne' romani, ripeterono, e piú spesso imitarono modificandoli, i costumi, le opinioni, le passioni, la mitologia de' popoli antichi. Altri interrogarono direttamente la natura: e la natura non dettò loro né pensieri né affetti antichi, ma sentimenti e massime moderne. Interrogarono la credenza del popolo: e n'ebbero in risposta i misteri della religione cristiana, la storia di un Dio rigeneratore, la certezza di una vita avvenire, il timore di una eternitá di pene. Interrogarono l'animo umano vivente: e quello non disse loro che cose sentite da loro stessi e da' loro contemporanei; cose risultanti dalle usanze ora cavalleresche, ora religiose, ora feroci, ma o praticate e presenti o conosciute generalmente; cose risultanti dal complesso della civiltá del secolo in cui vivevano. La poesia de' primi è "classica", quella de' secondi è "romantica". Cosí le chiamarono i dotti d'una parte della Germania, che dinanzi agli altri riconobbero la diversitá delle vie battute dai poeti moderni. Chi trovasse a ridire a questi vocaboli può cambiarli a posta sua. Però io stimo di poter nominare con tutta ragione "poesia de' morti" la prima, e "poesia de' vivi" la seconda. Né temo di ingannarmi dicendo che Omero, Pindaro, Sofocle, Euripide ecc. ecc., al tempo loro, furono in certo modo romantici, perché non cantarono le cose degli egizi o de' caldei, ma quelle dei loro greci; siccome il Milton non cantò le superstizioni omeriche, ma le tradizioni cristiane. Chi volesse poi soggiungere che, anche fra i poeti moderni seguaci del genere classico, quelli sono i migliori che ritengono molta mescolanza del romantico e che giusto giusto allo spirito romantico essi devono saper grado se le opere loro vanno salve dall'obblio, parmi che non meriterebbe lo staffile. E la ragione non viene ella forse in sussidio di siffatte sentenze, allorché gridando c'insegna che la poesia vuole essere specchio di ciò che commuove maggiormente l'anima? Ora l'anima è commossa al vivo dalle cose nostre che ci circondano tuttodí, non dalle antiche altrui che a noi sono notificate per mezzo soltanto de' libri e della storia. Allorché tu vedrai addentro in queste dottrine, e ciò non sará per via delle gazzette, imparerai come i confini del bello poetico siano ampi del pari che quelli della natura, e che la pietra di paragone, con cui giudicare di questo bello, è la natura medesima e non un fascio di pergamene; imparerai come va rispettata davvero la letteratura de' greci e de' latini, imparerai come davvero giovartene. Ma sentirai altresí come la divisione proposta contribuisca possentemente a sgabellarti del predominio sempre nocivo della autoritá. Non giurerai piú nella parola di nessuno, quando trattasi di cose 139 a cui basta il tuo intelletto. Farai della poesia tua una imitazione della natura, non una imitazione di imitazione. A dispetto de' tuoi maestri, la tua coscienza ti libererá dall'obbligo di venerare ciecamente gli oracoli di un codice vecchio e tarlato, per sottoporti a quello della ragione, perpetuo e lucidissimo. E riderai de' tuoi maestri che colle lenti sul naso continueranno a frugare nel codice vecchio e tarlato, e vi leggeranno fin quello che non v'è scritto. Materia di lungo discorso sarebbe il voler parlare all'Italia della divisione suaccennata; ed importerebbe una anatomia lunghissima delle qualitá costituenti il genere classico e di quelle che determinano il romantico. A me non concede la fortuna né tempo né forze sufficienti per tentare una siffatta dissertazione, perocché il ripetere quanto hanno detto in ciò i tedeschi non basterebbe. Avvezzi a vedere ogni cosa complessivamente, eglino non di rado trascurano di segnare i precisi confini de' loro sistemi; e la fiaccola, con cui illuminano i passi altrui, manda talvolta una luce confusa. Ma poiché in Italia, a giudicare da qualche cenno giá apparso, non v'ha difetto intero di buona filosofia, io prego che un libro sia composto finalmente qui tra noi, il quale non tratti d'altro che di questo argomento, e trovi modo di appianar tutto, di confermare nel proposito i giá iniziati, di rincorare i timidi e di spuntare con cristiana caritá le corna ai pedanti. Ben è vero che a que' pochi del mestiere, a' quali può giovare per le opere loro una idea distinta del genere romantico, questa, io spero, sará giá entrata nel cervello loro, mercé l'acume della propria lor mente. Ma perché voi altri giovinetti siete esposti alla furia di tante contrarie sentenze, e la veritá non siete in caso di snudarla da per voi, è bene che qualcuno metta in mano vostra ed in mano del pubblico un libro che vi scampi dal peccato, pur sí frequente in Italia, di bestemmiare ciò che s'ignora. Intanto che il voto mio va ricercando chi lo accolga e lo secondi; intanto che, irritati dalla novitá del vocabolo "romantico", da Dan fino a Bersabea si levano a fracasso i pedanti nostri, e fanno a rabbuffarsi l'un l'altro e a contumeliarsi e a sagramentare e a non intendersi tra di loro, come a Babilonia; intanto che la divisione per cui si arrovellano è per loro piú mistica della piú mistica dottrina del Talmud; vediamo, figliuolo mio, quali effetti ottenessero i poeti che la immaginarono. Posti frammezzo a un popolo non barbaro, non civilissimo, se se ne riguarda tutta la massa degli abitanti e non la sola schiera degli studiosi, i poeti recenti d'una parte della Germania dovevano superare in grido i loro confratelli contemporanei sparsi nel restante d'Europa. Ma della fortuna della poesia loro tutto il merito non è da darsi alla fortuna del loro nascimento. L'essersi avveduti di questa propizia circostanza e l'aver saputo trarne partito, è merito personale. E a ciò contribuí, del pari che l'arguzia dell'ingegno, la santitá del cuore. Sentirono essi che la verissima delle muse è la filantropia, e che l'arte loro aveva un fine ben piú sublime che il diletto momentaneo di pochi oziosi. Però, avidi di richiamare l'arte a' di lei principi, indirizzandola al perfezionamento morale del maggior numero de' loro compatrioti, eglino non gridarono, come Orazio: Satis est equitem nobis plaudere; non mirarono a piaggiare un Mecenate, a gratificarsi un Augusto, a procurarsi un seggio al banchetto dei grandi; non ambirono i soli battimani d'un branco di scioperati raccolti nell'anticamera del principe. Oltrediché non è da tacersi come insieme a questo pio sentimento congiurasse anche nelle anime di que' poeti la sete della gloria, ardentissima sempre ne' sovrani ingegni e sprone inevitabile al far bene. Eglino avevano letto che in Grecia la corona del lauro non l'accordavano né principi né accademie, ma cento e cento mila persone convenute d'ogni parte in Tebe e in Olimpia. Avevano letto che i canti di Omero, di Pindaro, di Tirteo non erano misteri di letterati, ma canzoni di popolo. Avevano letto che Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane non si facevano belli della lode de' loro compagni di mestiere, ma anelavano al plauso di trentamila spettatori e l'ottenevano. Quindi, agitati da castissima invidia, vollero anch'essi quel plauso e quella corona. Ma e in che modo conseguirla? Posero mente alle opere che ci rimangono de' poeti greci; e quantunque s'innamorassero sulle prime della leggiadria di quei versi, dello splendore di quella elocuzione, dell'artificio mirabile con cui le immagini erano accoppiate e spiegate, pure non si diedero a credere che in ciò fosse riposto tutto il talismano. E come crederlo, se in casa loro e fuori di casa vedevano condannati all'untume del pizzicagnolo versi, a cui né sceltezza di frasi mancava né armonia? Lambiccarono allora essi con piú fina critica quelle opere, onde scoprire di che malie profittavansi in Grecia i poeti per guadagnarsi tanto suffragio dai loro contemporanei. Videro che quelle malie erano i loro dèi, la loro religione, le loro superstizioni, le loro leggi, i loro riti, i loro costumi, la storia loro, le loro tradizioni volgari, la geografia loro, le loro opinioni, i loro pregiudizi, le fogge loro, ecc. ecc. ecc. - E noi - dissero eglino, - noi abbiamo altro Dio, altro culto; abbiamo anche noi le nostre superstizioni; abbiamo altre leggi, altri costumi, altre inclinazioni piú ossequiose e piú cortesi verso la beltá femminina. Caviamo di qui anche noi le malie nostre, e il popolo c'intenderá. E i versi nostri non saranno per lui reminiscenze d'una fredda erudizione scolastica, ma cose proprie e interessanti e sentite nell'anima. A rinforzarli nella determinazione soccorse loro l'esempio altresí de' poeti che dal risorgimento delle lettere in Europa fino a' dí nostri sono i piú famosi. E chi negherá questi essere tanto piú venerati e cari, quanto di queste nuove malie piú sparsero ne' loro versi? Cosí i poeti d'una parte della Germania, co' medesimi auspici, con l'arte medesima né piú né meno, col medesimo intendimento de' greci, scesero nell'aringo, desiderarono la palma e chiesero al popolo che la desse loro. E il popolo, non obbliato, non vilipeso da' suoi poeti, ma carezzato, ma dilettato, ma istruito, non ricusò d'accordarla. 140 A che miri la parola mia, tu lo sai: però fanne senno, figliuolo mio, e non permettere che la paterna caritá si sfoghi al vento. So che agli uomini piace talvolta di onestare la loro inerzia con bei paroloni. Ma io non darò retta mai né a te né a chiunque mi ritesserá le solite canzoni: e che l'Italia è un armento di venti popoli divisi l'uno dall'altro, e ch'ella non ha una gran cittá capitale dove ridursi a gareggiare gli ingegni, e che tutto vien meno ove non è una patria. Lo sappiamo, lo sappiamo. Ma l'avevano questa unitá di patria e questo tumulto d'una capitale unica i poeti dei quali ho parlato? E se noi non possediamo una comune patria politica, come neppure essi la possedevano, chi ci vieta di crearci intanto, com'essi, a conforto delle umane sciagure, una patria letteraria comune? Forse che Dante, il Petrarca, l'Ariosto per fiorire aspettarono che l'Italia fosse una? Forse che la latina è la piú splendida delle letterature? e nondimeno qual piú vasta metropoli di Roma sotto Ottaviano e sotto i Cesari? - Voi - gridava l'altro dí nella voce dell'ira sua il curato di Monte Atino, l'amico mio dall'anima ardente, - voi, se siete caldi di vero amore per la vostra bella Italia, levate l'orecchio, o generosi italiani. Udite come tuttaquanta l'Europa ne rinfaccia d'ogni parte il presente decadimento delle nostre lettere. È egli da credersi che tanta universalitá di disprezzo sia tutta opera della malignitá? Ponetevi, in nome di Dio, ponetevi una mano al petto; interrogate la coscienza vostra. E non la sentite anch'essa tremar di vergogna? Però perdonate gli insulti villani, con che ne strapazzano oggi que' popoli stessi che un tempo o ne lodavano o taciturni rodevansi d'invidia pe' nostri trionfi letterari: alle calunnie, ché calunnie pur anche piovono addosso all'Italia, non istate ad opporre altro che la dignitá del silenzio; e cadranno di per sé. Ma de' consigli giovatevi: e la gloria della vostra terra ricuperatela col far voi, non col citare le opere degli avi vostri. "Gloria nostra sit testimonium conscientiae nostrae", diceva san Paolo a que' di Corinto. Vincete l'avversitá collo studio, smettete una volta la boria di reputarvi i soli europei che abbiano occhi in testa, smettete la petulanza con cui vi sputate l'un l'altro in viso e per inezie da fanciulli, unitevi l'un l'altro coi vincoli di amorosa concordia fraterna, senza della quale voi sarete nulli in tutto e per tutto. E poiché perspicacia d'intelletto non ve ne manca, solo che vogliate rifarvi delle male abitudini, lavorate, ve ne scongiuro, e lavorate da senno. Ma prima di tutto spogliatevi della stolida divozione per un solo idolo letterario. Leggete Omero, leggete Virgilio, che Dio ve ne benedica! Ma tributate e vigilie e incenso anche a tutti gli altri begli altari che i poeti in ogni tempo e in ogni luogo innalzarono alla natura. E quantunque a rischio di lasciare qualche dí nella dimenticanza e i volumi dell'antichitá e i volumi de' moderni, traetevi ad esaminare da vicino voi stessi la natura, e lei imitate, lei sola davvero e niente altro. Rendetevi coevi al secolo vostro e non ai secoli seppelliti; spacciatevi dalla nebbia che oggidí invocate sulla vostra dizione; spacciatevi dagli arcani sibillini, dalle vetuste liturgie, da tutte le Veneri e da tutte le loro turpitudini, cavoli giá putridi; non rifriggeteli. Fate di piacere al popolo vostro; investigate l'animo di lui; pascetelo di pensieri e non di vento. Credete voi forse che i lettori italiani non gustino altro che il sapore dell'idioma e il lusso della verbositá? Badate che leggono libri stranieri, che s'accostumano a pensare e che dalle fatuitá vanno ogni dí piú divezzandosi. Badate che i progressi intellettuali d'una parte di Europa finiranno col tirar dietro a sé anche il restante. E voi con tutta la vostra albagia rimarrete lí soli soli, a far voi da autori insieme e da lettori. Insomma siate uomini e non cicale; e i vostri paesani vi benediranno, e lo straniero ripiglierá modestia e parlerá di voi coll'antico rispetto. - Nessuno de' ricchi tra' tuoi terrazzani venga a morte fuori della tua giurisdizione parrocchiale, o buon curato di Monte Atino, o anima italiana davvero! Chi non ti perdonerebbe la declamazione in grazia dello zelo e del patriottismo che spirano le tue ammonizioni? Ora, figliuolo mio, ti sia palese che tutto il discorso fatto sin qui, sebbene paresse sviarsi dal soggetto, pure era necessario. Cosí mi sono preparata la via alla soluzione de' due quesiti che tu mi hai fatti, ed ai quali posso ora rispondere con maggiore brevitá. Eccoli entrambi, e in termini piú precisi de' tuoi: 1. "La moderna Italia ammetterebbe ella poesie di questo genere (i romanzi)?". 2. "Il Cacciatore feroce e l'Eleonora piaceranno in Italia?". Non fa mestieri, cred'io, di molte lucubrazioni per trovare che alla prima interrogazione vuolsi rispondere con un "sí" netto e stentoreo. Da quanto ho detto sulla opportunitá di indirizzare la poesia non all'intelligenza di pochi eruditi ma a quella del popolo, affine di propiziarselo e di guadagnarne l'attenzione, tu avrai di per te stesso inferita questa sentenza: che i poeti italiani possono del pari che gli stranieri dedurre materia pe' loro canti dalle tradizioni e dalle opinioni volgari, e che anzi gioverebbe di presente ch'eglino preferissero queste a tutto intero il libro di Natale de' Conti. Però non voglio sprecar tempo in dimostrarti che, per tale rispetto, questo genere di romanzi si conviene anche all'Italia; e per veritá non farei che ridire le parole mie. Che poi questo modo di narrare liricamente una avventura offenderá gli italiani, non credo. La poesia d'Italia non è arte diversa dalla poesia degli altri popoli. I princípi e lo scopo di lei sono perpetui ed universali. Ella, come vedemmo, è diretta a migliorare i costumi degli uomini, a farne gentili gli animi, a contentarne i bisogni della fantasia e del cuore; poiché la tendenza alla poesia, simigliante ad ogni altro desiderio, suscita in noi veri bisogni morali. Per arrivare all'intento suo la poesia si vale di quattro forme elementari: la lirica, la didascalica, l'epica e la drammatica. Ma perché ella di sua natura abborre i sistemi costrettivi e perché i bisogni che ella prende ad appagare possono essere modificati in infinito, ha diritto anche ella di adoperare mezzi modificati in infinito. Quindi a sua posta ella unisce e confonde insieme in mille modi le quattro forme elementari, derivandone mille temperamenti. Se la poesia è l'espressione della natura viva, ella deve essere viva come l'oggetto ch'ella esprime, libera come il pensiero che le dá moto, ardita come lo scopo a cui è indirizzata. Le forme ch'ella assume non costituiscono la di lei essenza, ma solo contribuiscono occasionalmente a dare effetto alle di lei intenzioni. Però fino a tanto ch'ella non esce 141 dell'instituto suo, non v'ha muso d'uomo che di propria facoltá le abbia a dettare restrizioni su questo punto del tramischiare le forme elementari. Che i due romanzi del Bürger spiaceranno agli italiani per l'argomento loro e per lo stile, forse sará. Ma che l'Italia non patirebbe che i suoi poeti scrivessero romanzi del genere di questi, perché forse schifa della mescolanza dell'epico col lirico, non credo. Siffatte obbiezioni non suggeriscono che al cervello de' pedanti, i quali parlano della poesia senza conoscerne la proprietá. Ma se il presagio non mi falla, la tirannide dei pedanti sta per cadere in Italia. E il popolo e i poeti si consiglieranno a vicenda senza paura delle Signorie Loro, ed a vicenda si educheranno; e non andrá molto, spero. La meditazione della filosofia riuscirá bensì a determinare, a un di presso, di quali materiali debbano i poeti giovarsi nell'esercizio dell'arte, di quali no, e fin dove possano estendere l'ardimento della imitazione. E l'esperienza dimostra che in questo l'arte della poesia soffre confini come tutte le di lei sorelle. Ma quale filosofia potrá dire in coscienza al poeta: "Le modificazioni delle forme sono queste, non altre"? So che i pedanti si stilleranno l'intelletto per rinvenire, a modo d'esempio, la bandiera sotto cui far trottare le terzine del signor Torti sulla Passione del Salvatore. So che, nel repertorio de' titoli disceso loro da padre in figlio, non ne troveranno forse uno che torni a capello per quelle terzine. Carme no, ode no, idillio no: eroide forse?... Ma intanto quella squisita poesia, con buona pace delle Signorie Loro, è giá per le bocche di tutti. E l'Italia, non badando a' frontispizi, scongiura il signor Torti a non lasciarla lungamente desiderosa d'altri regali consimili. Lo stesso avverrá d'ogni altra poesia futura, quando le modificazioni delle forme siano corrispondenti all'argomento ed alla intenzione del poeta, e quando siffatta intenzione sia conforme allo scopo dell'arte ed a' bisogni dell'uomo. Il sentimento della convenienza, che induce il poeta alla scelta di un metro piuttosto che di un altro, è contemporaneo nella mente di lui alla concezione delle idee ch'egli ha in animo di spiegare nel suo componimento ed al disegno che lo muove a poetare. Le regole generali degli scrittori di Poetiche non montano gran fatto, da che ogni caso vorrebbe regola a parte. Laonde è opinione mia che un uomo dell'arte possa bensí assisterti ogni volta con un buon consiglio; ma che se tu aspetti che te lo diano i trattatisti, non ne faremo nulla, figliuolo mio. E a questo proposito mi piace di rallegrarti con un'altra scappata declamatoria, in cui diede, non ha guari, il buon curato di Monte Atino, l'amico mio dall'anima ardente. Una persona, che aveva aria d'uomo non dozzinale e non l'era davvero, parlava della poesia "romantica" con Sua Reverenza. E Sua Reverenza l'udiva con volto pacato e con segni d'approvazione, perché erano lodi alla poesia "romantica", la prediletta dell'anima sua. Quando tutt'ad un tratto il panegirista uscí fuori con un voto, perché alcuno in Italia pigliasse a scrivere una Poetica romantica. - Che Poetiche di Dio! - gridò allora il buon curato di Monte Atino, dimenandosi sul suo seggiolone come un energumeno, - che Poetiche di Dio! Se ai giorni nostri vivesse Omero, vivesse Pindaro, vivesse Sofocle, dovrebbono essi cambiare arte forse? No, in nome del cielo, no. Ma la differenza dei secoli renderebbe differenti le cose che que' poeti imprenderebbono ora a trattare. E la differenza delle cose indurrebbe di necessitá differenza nella mescolanza delle forme e nell'accoppiamento delle immagini. E Omero, Pindaro, Sofocle sarebbero poeti "romantici", volere o non volere. Ma l'arte loro sarebbe tuttavia quella stessa de' classici antichi. Che importa a me se il Cellini oggi mi cesella un vezzo per madama d'Étampes e domani un calice pel santo padre? Egli è pur sempre Benvenuto, l'orefice fiorentino. Ma questo Proteo irrequieto come l'amore, quest'arte della poesia, questa perpetua inventrice del bello, chi l'insegna? Le Poetiche forse? Sono forse le Poetiche che hanno sviluppate le menti a que' tre miracoli della Grecia? sono forse le Poetiche che dissero come tener la penna in mano a Dante, all'Ariosto, a Shakespeare? Al diavolo queste corbellerie! Mostratemi una Poetica anteriore alla esistenza di un poeta. Mostratemi un vero poeta educato e formato dalle Poetiche. Dov'è, dov'è? Io vi mostrerò de' poeti che colle opere loro hanno prestata materia di che rimpinzare di regoluzze un libruzzo a trenta maestruzzi. Io vi mostrerò trentamila pedanti, e tutti figli delle Poetiche, e tutti misuratori di sillabe, e tutti sputasentenze, e tutti teste di legno. Al diavolo colle Poetiche! Perché non t'incarni un'altra volta, o bella anima di Omar, tanto appena che ti basti tempo per discendere in Italia a metter fuoco a tutte le Poetiche, da quella di Aristotile fino a quella del Menzini? E qui Sua Reverenza mandò un lungo sospiro di desiderio. Poi tosto ammutí, guardò in alto per un poco, e si fece tutto rosso in viso, vergognando, cred'io, d'avere unito il nome d'Aristotile a quello di un guastamestiere. Poi, ripreso fiato, stese la mano all'ospite e col sorriso della cortesia lo pregò perché proseguisse il panegirico che tanto gli andava a sangue. Terminato il dire, l'ospite pigliò licenza. Il povero curato lo accompagnò fino all'uscio; e lasciata scappare una lagrima, gli strinse la mano e gli disse: - Domando mille scuse; ho gridato fuori d'ogni creanza: ma sappia Vossignoria ch'io non l'aveva con lei. A lei io ho data la mia stima. Capperi! Vossignoria ha detto pel primo in Italia cose che non tutti sanno dire o che tutti qui s'ostinano a non voler dire. Da bravo! Stia fermo, e non si lasci atterrire da chi senza entrare in ragionamenti le abbaia dietro de' mali motteggi e delle insipide satire. Siamo cristiani e sacerdoti entrambi; perdoniamo adunque di buona volontá agli insolenti. Dio n'abbia anch'egli misericordia! Sono montato in furia contro le Poetiche, perché la sento cosí e perché questo mio maledetto naturale è tutto stizza e non lo so mai frenare. Ma i filosofi estetici io non li confondo cogli scrittori di Poetiche. No, no, quelli li rispetto, e glielo giuro sull'onor mio. E le giuro che qualche volta leggo con vera aviditá le cose del Burke e del Lessing, come se fossero squarci della Cittá di Dio del mio sant'Agostino. Ma Ella compatisca se in questo punto delle Poetiche io sono di parere contrario a quello manifestato da lei: compatisca e mi voglia bene. - 142 Interrogazione seconda. "Il Cacciatore feroce e l'Eleonora piaceranno in Italia?". Questo è quesito di non cosí facile scioglimento come il primo. Madama de Staël, nell'ingegnosa ed arguta sua opera sull'Alemagna, ha analizzati entrambi questi romanzi. E come è solito dei fervidi ed alti intelletti, che hanno sortita fantasia vasta, l'aggiungere senza avvedersene qualche cosa sempre del loro alle opere altrui delle quali s'innamorano, ella vi trovò bellezze forse piú che non hanno e gli ammirò forse troppo. Nondimeno ella è di parere che difficile e quasi impossibile sarebbe il far gustare que' romanzi in Francia; e che ciò provenga dalla difficoltá del tradurli in versi, e da questo: che in Francia "rien de bizarre n'est naturel". In quanto alla bizzarria ed alla difficoltá di tradurre in versi, sta a' francesi ed a madama de Staël il decidere. In quanto al poterne tentare una versione in prosa francese, io credo di non errare pensando che, se madama de Staël avesse voluto piegarsi ella stessa all'ufficio di traduttore, i francesi avrebbero accolta come eccellente la traduzione di lei. E se mai il giudizio, che ella portò sulla incompatibilitá del gusto francese colla bizzarria de' pensieri, fosse meno esatto, la tanta poesia che vive in tutte le prose di madama si sarebbe trasfusa di certo anche in questa, per modo che la mancanza del metro non sarebbe stata sciagura deplorabile. L'armonia non è di cosí essenziale importanza da dover dipendere totalmente da essa la fortuna di un componimento. Per riguardo all'Italia, io non saprei temere di un ostacolo dal semplice lato della bizzarria, da che l'Ariosto è l'idolo delle fantasie italiane. Però, lasciato stare il danno che a questi romanzi può venire dall'andar vestiti di una poco bella traduzione per le contrade d'Italia, dico che a me sembra di ravvisare in essi una cagione piú intrinseca, per la quale non saranno forse comunemente gustati tra di noi. Entrambi questi romanzi sono fondati sul maraviglioso e sul terribile, due potentissime occasioni di movimento per l'animo umano. Ma l'uomo che, per uscire del letargo che gli è incomportabile, invoca anche scosse violenti all'anima sua e anela sempre di afferrare siffatte occasioni, pure non se ne lascia vincere mai, se non per via della credenza. E il terribile e il maraviglioso, quando non sono creduti, riescono inoperosi e ridicoli, come la verga di Mosé in mano a un misero levita. L'effetto dunque, che produrranno i due romanzi del Bürger, sará proporzionato sempre alla fede che il lettore presterá agli argomenti di maraviglia e di terrore de' quali essi riboccano. Ora, dipendendo da ciò principalmente l'esito della loro emigrazione presso gli italiani, a me non dá il cuore di pronosticarla fortunata. Cominciamo dal primo. Ecco la traduzione del Cacciatore feroce. 143 Giacomo Leopardi, Operette morali DIALOGO DI TORQUATO TASSO E DEL SUO GENIO FAMILIARE Ebbe Torquato Tasso, nel tempo dell'infermità della sua mente, un' opinione simile a quella famosa di Socrate; cioè credette vedere di tratto in tratto uno spirito buono ed amico, e avere con esso lui molti e lunghi ragionamenti. Così leggiamo nella vita del Tasso descritta dal Manso: il quale si trovò presente a uno di questi o colloqui o soliloqui che noi li vogliamo chiamare. GENIO. Come stai, Torquato? TASSO. Ben sai come si può stare in una prigione, e dentro ai guai fino al collo. GENIO. Via, ma dopo cenato non è tempo da dolersene. Fa buon animo, e ridiamone insieme. TASSO. Ci son poco atto. Ma la tua presenza e le tue parole sempre mi consolano. Siedimi qui accanto. GENIO. Che io segga? La non è già cosa facile a uno spirito. Ma ecco: fa conto ch'io sto seduto. TASSO. Oh potess'io rivedere la mia Leonora. Ogni volta che ella mi torna alla mente, mi nasce un brivido di gioia, che dalla cima del capo mi si stende fino all'ultima punta de' piedi; e non resta in me nervo nè vena che non sia scossa. Talora, pensando a lei, mi si ravvivano nell'animo certe immagini e certi affetti, tali, che per quel poco tempo, mi pare di essere ancora quello stesso Torquato che fui prima di aver fatto esperienza delle sciagure e degli uomini, e che ora io piango tante volte per morto. In vero, io direi che l'uso del mondo, e l'esercizio de' patimenti, sogliono come profondare e sopire dentro a ciascuno di noi quel primo uomo che egli era: il quale di tratto in tratto si desta per poco spazio, ma tanto più di rado quanto è il progresso degli anni; sempre più poi si ritira verso il nostro intimo, e ricade in maggior sonno di prima; finchè durando ancora la nostra vita, esso muore. In fine, io mi maraviglio come il pensiero di una donna abbia tanta forza, da rinnovarmi, per così dire, l'anima, e farmi dimenticare tante calamità. E se non fosse che io non ho più speranza di rivederla, crederei non avere ancora perduta la facoltà di essere felice. GENIO. Quale delle due cose stimi che sia più dolce: vedere la donna amata, o pensarne? TASSO. Non so. Certo che quando mi era presente, ella mi pareva una donna; lontana, mi pareva e mi pare una dea. GENIO. Coteste dee sono così benigne, che quando alcuno vi si accosta, in un tratto ripiegano la loro divinità, si spiccano i raggi d'attorno, e se li pongono in tasca, per non abbagliare il mortale che si fa innanzi. TASSO. Tu dici il vero pur troppo. Ma non ti pare egli cotesto un gran peccato delle donne; che alla prova, elle ci riescano così diverse da quelle che noi le immaginavamo? GENIO. Io non so vedere che colpa s'abbiano in questo, d'esser fatte di carne e sangue, piuttosto che di ambrosia e nettare. Qual cosa del mondo ha pure un'ombra o una millesima parte della perfezione che voi pensate che abbia a essere nelle donne? E anche mi pare strano, che non facendovi maraviglia che gli uomini sieno uomini, cioè creature poco lodevoli e poco amabili; non sappiate poi comprendere come accada, che le donne in fatti non sieno angeli. TASSO. Con tutto questo, io mi muoio dal desiderio di rivederla, e di riparlarle. GENIO. Via, questa notte in sogno io te la condurrò davanti; bella come la gioventù; e cortese in modo, che tu prenderai cuore di favellarle molto più franco e spedito che non ti venne fatto mai per l'addietro: anzi all'ultimo le stringerai la mano; ed ella guardandoti fisso, ti metterà nell'animo una dolcezza tale, che tu ne sarai sopraffatto; e per tutto domani, qualunque volta ti sovverrà di questo sogno, ti sentirai balzare il cuore dalla tenerezza. TASSO. Gran conforto: un sogno in cambio del vero. GENIO. Che cosa è il vero? TASSO. Pilato non lo seppe meno di quello che lo so io. GENIO. Bene, io risponderò per te. Sappi che dal vero al sognato, non corre altra differenza, se non che questo può qualche volta essere molto più bello e più dolce, che quello non può mai. 144 TASSO. Dunque tanto vale un diletto sognato, quanto un diletto vero? GENIO. Io credo. Anzi ho notizia di uno che quando la donna che egli ama, se gli rappresenta dinanzi in alcun sogno gentile, esso per tutto il giorno seguente, fugge di ritrovarsi con quella e di rivederla; sapendo che ella non potrebbe reggere al paragone dell'immagine che il sonno gliene ha lasciata impressa, e che il vero, cancellandogli dalla mente il falso, priverebbe lui del diletto straordinario che ne ritrae. Però non sono da condannare gli antichi, molto più solleciti, accorti e industriosi di voi, circa a ogni sorta di godimento possibile alla natura umana, se ebbero per costume di procurare in vari modi la dolcezza e la giocondità dei sogni; nè Pitagora è da riprendere per avere interdetto il mangiare delle fave, creduto contrario alla tranquillità dei medesimi sogni, ed atto a intorbidarli Apollonio, Hist. commentit. cap. 46. Cicerone, de Divinat. lib. 1, cap. 30; lib. 2, cap. 58. Plinio, lib. 18, cap. 12. Plutarco, Convival. Quaestion. lib. 8, quaest. 10, opp. tom. 2, p. 734. Dioscoride,de Materia Medica lib. 2, cap. 127. , e sono da scusare i superstiziosi che avanti di coricarsi solevano orare e far libazione a Mercurio conduttore dei sogni, acciò ne menasse loro di quei lieti; l'immagine del quale tenevano a quest'effetto intagliata in su' piedi delle lettiere Meursio, Exercitat. critic. par. 2, lib. 2, cap. 19, opp. vol. 5, col. 662. . Così, non trovando mai la felicità nel tempo della vigilia, si studiavano di essere felici dormendo: e credo che in parte, e in qualche modo, l'ottenessero; e che da Mercurio fossero esauditi meglio che dagli altri Dei. TASSO. Per tanto, poichè gli uomini nascono e vivono al solo piacere, o del corpo o dell'animo; se da altra parte il piacere è solamente o massimamente nei sogni, converrà ci determiniamo a vivere per sognare: alla qual cosa, in verità, io non mi posso ridurre. GENIO. Già vi sei ridotto e determinato, poichè tu vivi e che tu consenti di vivere. Che cosa è il piacere? TASSO. Non ne ho tanta pratica da poterlo conoscere che cosa sia. GENIO. Nessuno lo conosce per pratica, ma solo per ispeculazione: perchè il piacere è un subbietto speculativo, e non reale; un desiderio, non un fatto; un sentimento che l'uomo concepisce col pensiero, e non prova; o per dir meglio, un concetto, e non un sentimento. Non vi accorgete voi che nel tempo stesso di qualunque vostro diletto, ancorchè desiderato infinitamente, e procacciato con fatiche e molestie indicibili; non potendovi contentare il goder che fate in ciascuno di quei momenti, state sempre aspettando un goder maggiore e più vero, nel quale consista insomma quel tal piacere; e andate quasi riportandovi di continuo agl'istanti futuri di quel medesimo diletto? Il quale finisce sempre innanzi al giungere dell'istante che vi soddisfaccia; e non vi lascia altro bene che la speranza cieca di goder meglio e più veramente in altra occasione, e il conforto di fingere e narrare a voi medesimi di aver goduto, con raccontarlo anche agli altri, non per sola ambizione, ma per aiutarvi al persuaderlo che vorreste pur fare a voi stessi. Però chiunque consente di vivere, nol fa in sostanza ad altro effetto nè con altra utilità che di sognare; cioè credere di avere a godere, o di aver goduto; cose ambedue false e fantastiche. TASSO. Non possono gli uomini credere mai di godere presentemente? GENIO. Sempre che credessero cotesto, godrebbero in fatti. Ma narrami tu se in alcun istante della tua vita, ti ricordi aver detto con piena sincerità ed opinione: io godo. Ben tutto giorno dicesti e dici sinceramente: io godrò; e parecchie volte, ma con sincerità minore: ho goduto. Di modo che il piacere è sempre o passato o futuro, e non mai presente. TASSO. Che è quanto dire è sempre nulla. GENIO. Così pare. TASSO. Anche nei sogni. GENIO. Propriamente parlando. TASSO. E tuttavia l'obbietto e l'intento della vita nostra, non pure essenziale ma unico, è il piacere stesso; intendendo per piacere la felicità, che debbe in effetto esser piacere; da qualunque cosa ella abbia a procedere. GENIO. Certissimo. TASSO. Laonde la nostra vita, mancando sempre del suo fine, è continuamente imperfetta: e quindi il vivere è di sua propria natura uno stato violento. 145 GENIO. Forse. TASSO. Io non ci veggo forse. Ma dunque perchè viviamo noi? voglio dire, perchè consentiamo di vivere? GENIO. Che so io di cotesto? Meglio lo saprete voi, che siete uomini. TASSO. Io per me ti giuro che non lo so. GENIO. Domandane altri de' più savi, e forse troverai qualcuno che ti risolva cotesto dubbio. TASSO. Così farò. Ma certo questa vita che io meno, è tutta uno stato violento: perchè lasciando anche da parte i dolori, la noia sola mi uccide. GENIO. Che cosa è la noia? TASSO. Qui l'esperienza non mi manca, da soddisfare alla tua domanda. A me pare che la noia sia della natura dell'aria: la quale riempie tutti gli spazi interposti alle altre cose materiali, e tutti i vani contenuti in ciascuna di loro; e donde un corpo si parte, e altro non gli sottentra, quivi ella succede immediatamente. Così tutti gl'intervalli della vita umana frapposti ai piaceri e ai dispiaceri, sono occupati dalla noia. E però, come nel mondo materiale, secondo i Peripatetici, non si dà vòto alcuno; così nella vita nostra non si dà vòto; se non quando la mente per qualsivoglia causa intermette l'uso del pensiero. Per tutto il resto del tempo, l'animo, considerato anche in se proprio e come disgiunto dal corpo, si trova contenere qualche passione; come quello a cui l'essere vacuo da ogni piacere e dispiacere, importa essere pieno di noia; la quale anco è passione, non altrimenti che il dolore e il diletto. GENIO. E da poi che tutti i vostri diletti sono di materia simile ai ragnateli; tenuissima, radissima e trasparente; perciò come l'aria in questi, così la noia penetra in quelli da ogni parte, e li riempie. Veramente per la noia non credo si debba intendere altro che il desiderio puro della felicità; non soddisfatto dal piacere, e non offeso apertamente dal dispiacere. Il buon desiderio, come dicevamo poco innanzi, non è mai soddisfatto; e il piacere propriamente non si trova. Sicchè la vita umana, per modo di dire, è composta e intessuta, parte di dolore, parte di noia; dall'una delle quali passioni non ha riposo se non cadendo nell'altra. E questo non è tuo destino particolare, ma comune di tutti gli uomini. TASSO. Che rimedio potrebbe giovare contro la noia? GENIO. Il sonno, l'oppio, e il dolore. E questo è il più potente di tutti: perchè l'uomo mentre patisce, non si annoia per niuna maniera. TASSO. In cambio di cotesta medicina, io mi contento di annoiarmi tutta la vita. Ma pure la varietà delle azioni, (!) delle occupazioni e dei sentimenti, se bene non ci libera dalla noia, perchè non ci crea diletto vero, contuttociò la solleva ed alleggerisce. Laddove in questa prigionia, separato dal commercio umano, toltomi eziandio lo scrivere, ridotto a notare per passatempo i tocchi dell'oriuolo, annoverare i correnti, le fessure e i tarli del palco, considerare il mattonato del pavimento, trastullarmi colle farfalle e coi moscherini che vanno attorno alla stanza, condurre quasi tutte le ore a un modo; io non ho cosa che mi scemi in alcuna parte il carico della noia. GENIO. Dimmi: quanto tempo ha che tu sei ridotto a cotesta forma di vita? TASSO. Più settimane, come tu sai. GENIO. Non conosci tu dal primo giorno al presente, alcuna diversità nel fastidio che ella ti reca? TASSO. Certo che io lo provava maggiore a principio: perchè di mano in mano la mente, non occupata da altro e non isvagata, mi si viene accostumando a conversare seco medesima assai più e con maggior sollazzo di prima, e acquistando un abito e una virtù di favellare in se stessa, anzi di cicalare, tale, che parecchie volte mi pare quasi avere una compagnia di persone in capo che stieno ragionando, e ogni menomo soggetto che mi si appresenti al pensiero, mi basta a farne tra me e me una gran diceria. GENIO. Cotesto abito te lo vedrai confermare e accrescere di giorno in giorno per modo, che quando poi ti si renda la facoltà di usare cogli altri uomini, ti parrà essere più disoccupato stando in compagnia loro, che in solitudine. E quest'assuefazione in sì fatto tenore di vita, non credere che intervenga solo a' tuoi simili, già consueti a meditare; ma 146 ella interviene in più o men tempo a chicchessia. Di più, l'essere diviso dagli uomini e, per dir così, dalla vita stessa, porta seco questa utilità; che l'uomo, eziandio sazio, chiarito e disamorato delle cose umane per l'esperienza; a poco a poco assuefacendosi di nuovo a mirarle da lungi, donde elle paiono molto più belle e più degne che da vicino, si dimentica della loro vanità e miseria; torna a formarsi e quasi crearsi il mondo a suo modo; apprezzare, amare e desiderare la vita; delle cui speranze, se non gli è tolto o il potere o il confidare di restituirsi alla società degli uomini, si va nutrendo e dilettando, come egli soleva a' suoi primi anni. Di modo che la solitudine fa quasi l'ufficio della gioventù, o certo ringiovanisce l'animo, ravvalora e rimette in opera l'immaginazione, e rinnuova nell'uomo esperimentato i beneficii di quella prima inesperienza che tu sospiri. Io ti lascio; che veggo che il sonno ti viene entrando; e me ne vo ad apparecchiare il bel sogno che ti ho promesso. Così, tra sognare e fantasticare, andrai consumando la vita; non con altra utilità che di consumarla; che questo è l'unico frutto che al mondo se ne può avere, e l'unico intento che voi vi dovete proporre ogni mattina in sullo svegliarvi. Spessissimo ve la conviene strascinare co' denti: beato quel dì che potete o trarvela dietro colle mani, o portarla in sul dosso. Ma, in fine, il tuo tempo non è più lento a correre in questa carcere, che sia nelle sale e negli orti quello di chi ti opprime. Addio. TASSO. Addio. Ma senti. La tua conversazione mi riconforta pure assai. Non che ella interrompa la mia tristezza: ma questa per la più parte del tempo è come una notte oscurissima, senza luna nè stelle; mentre son teco, somiglia al bruno dei crepuscoli, piuttosto grato che molesto. Acciò da ora innanzi io ti possa chiamare o trovare quando mi bisogni, dimmi dove sei solito di abitare. GENIO. Ancora non l'hai conosciuto? In qualche liquore generoso. XII DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre; andando una volta per l'interiore dell'Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove acque Camoens, Lusiad. canto 5. . Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell'isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse. NATURA. Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? ISLANDESE. Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa. NATURA. Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finchè gli cade in gola da se medesimo. Io sono quella che tu fuggi. ISLANDESE. La Natura? NATURA. Non altri. ISLANDESE. Me ne dispiace fino all'anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di questa non mi potesse sopraggiungere. NATURA. Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi? ISLANDESE. Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e chiaro della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo continuamente gli uni cogli altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, che affannano e nocciono in effetto, tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando molestia a chicchessia, non procurando in modo 147 alcuno di avanzare il mio stato, non contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche corporali: che ben sai che differenza è dalla fatica al disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova come egli è vano a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo sempre spontaneamente, e contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia luogo, e che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: cosa che nell'isola mia nativa si può recare ad effetto senza difficoltà. Fatto questo, e vivendo senza quasi verun'immagine di piacere, io non poteva mantenermi però senza patimento: perchè la lunghezza del verno, l'intensità del freddo, e l'ardore estremo della state, che sono qualità di quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il fuoco, presso al quale mi conveniva passare una gran parte del tempo, m'inaridiva le carni, e straziava gli occhi col fumo; di modo che, nè in casa nè a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo disagio. Nè anche potea conservare quella tranquillità della vita, alla quale principalmente erano rivolti i miei pensieri: perchè le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce del monte Ecla, il sospetto degl'incendi, frequentissimi negli alberghi, come sono i nostri, fatti di legno, non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme a se medesima, e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza, e quasi di ogni altra cura, che d'esser quieta; riescono di non poco momento, e molto più gravi che elle non sogliono apparire quando la maggior parte dell'animo nostro è occupata dai pensieri della vita civile, e dalle avversità che provengono dagli uomini. Per tanto veduto che più che io mi restringeva e quasi mi contraeva in me stesso, a fine d'impedire che l'esser mio non desse noia nè danno a cosa alcuna del mondo; meno mi veniva fatto che le altre cose non m'inquietassero e tribolassero; mi posi a cangiar luoghi e climi, per vedere se in alcuna parte della terra potessi non offendendo non essere offeso, e non godendo non patire. E a questa deliberazione fui mosso anche da un pensiero che mi nacque, che forse tu non avessi destinato al genere umano se non solo un clima della terra (come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli animali, e di quei delle piante), e certi tali luoghi; fuori dei quali gli uomini non potessero prosperare nè vivere senza difficoltà e miseria; da dover essere imputate, non a te, ma solo a essi medesimi, quando eglino avessero disprezzati e trapassati i termini che fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre osservando il mio proposito, di non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall'incostanza dell'aria, infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia formata a quegli abitanti, non rei verso te di nessun'ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori dell'aria. Tal volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal altra, per l'abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai piedi; alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi, che m'inseguivano, come fossi colpevole verso loro di qualche ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me con una menoma offesa, mi hanno voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è mancato poco che gl'insetti volanti non mi abbiano consumato infino alle ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all'uomo, e infiniti di numero; tanto che un filosofo antico Seneca, Natural. Quaestion. lib. 6, cap. 2. non trova contro al timore, altro rimedio più valevole della considerazione che ogni cosa è da temere. Nè le infermità mi hanno perdonato; con tutto che io fossi, come sono ancora, non dico temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio prendere non piccola ammirazione considerando come tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del piacere; disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l'uso di esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita. Ma in qualunque modo, astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho potuto fare di non incorrere in molte e diverse malattie: delle quali alcune mi hanno posto in pericolo della morte; altre di perdere l'uso di qualche membro, o di condurre perpetuamente una vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il corpo e l'animo con mille stenti e mille dolori. È certo, benchè ciascuno di noi sperimenti nel tempo delle infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore che egli non suole (come se la vita umana non fosse bastevolmente misera per l'ordinario); tu non hai dato all'uomo, per compensarnelo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, la quale gli sia cagione di qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza. Ne' paesi coperti per lo più di nevi, io sono stato per accecare: come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria. Dal sole e dall'aria, cose vitali, anzi necessarie alla nostra vita, e però da non potersi fuggire, siamo ingiuriati di continuo: da questa colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni; da quello col calore, e colla stessa luce: tanto che l'uomo non può mai senza qualche maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all'una o all'altro di loro. In fine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena; laddove io non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento: mi avveggo che tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il 148 non godere; tanto impossibile il viver quieto in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere che tu sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c'insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia, de' tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto rimango privo di ogni speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione, non lasci mai d'incalzarci, finchè ci opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e questo tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de' viventi, preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro in là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo della vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, tutto il rimanente allo scadere, e agl'incomodi che ne seguono. NATURA. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro, che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. ISLANDESE. Ponghiamo caso che uno m'invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande instanza, e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d'intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e battere da' suoi figliuoli e dall'altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali trattamenti, mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de' tuoi sollazzi, e di farti le buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poichè spontaneamente hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l'avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: t'ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo nè ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che l'abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura. NATURA. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra se di maniera, che ciascheduna serve continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l'una o l'altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento. ISLANDESE. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poichè quel che è distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall'inedia, che appena ebbero la forza di mangiarsi quell'Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui disseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di Europa. FRAMMENTO APOCRIFO DI STRATONE DI LAMPSACO PREAMBOLO Questo Frammento, che io per passatempo ho recato dal greco in volgare, è tratto da un codice a penna che trovavasi alcuni anni sono, e forse ancora si trova, nella libreria dei monaci del monte Athos. Lo intitolo Frammento apocrifo perchè, come ognuno può vedere, le cose che si leggono nel capitolo della fine del mondo, non possono essere state 149 scritte se non poco tempo addietro; laddove Stratone da Lampsaco, filosofo peripatetico, detto il fisico, visse da trecento anni avanti l'era cristiana. È ben vero che il capitolo della origine del mondo concorda a un di presso con quel poco che abbiamo delle opinioni di quel filosofo negli scrittori antichi. E però si potrebbe credere che il primo capitolo, anzi forse ancora il principio dell'altro, sieno veramente di Stratone; il resto vi sia stato aggiunto da qualche dotto Greco non prima del secolo passato. Giudichino gli eruditi lettori. DELLA ORIGINE DEL MONDO Le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così tutte ebbero incominciamento. Ma la materia stessa niuno incominciamento ebbe, cioè a dire che ella è per sua propria forza abeterno. Imperocchè se dal vedere che le cose materiali crescono e diminuiscono e all'ultimo si dissolvono, conchiudesi che elle non sono per se nè ab eterno, ma incominciate e prodotte, per lo contrario quello che mai non cresce nè scema e mai non perisce, si dovrà giudicare che mai non cominciasse e che non provenga da causa alcuna. E certamente in niun modo si potrebbe provare che delle due argomentazioni, se questa fosse falsa, quella fosse pur vera. Ma poichè noi siamo certi quella esser vera il medesimo abbiamo a concedere anco dell'altra. Ora noi veggiamo che la materia non si accresce mai di una eziandio menoma quantità, niuna anco menoma parte della materia si perde, in guisa che essa materia non è sottoposta a perire. Per tanto i diversi modi di essere della materia, i quali si veggono in quelle che noi chiamiamo creature materiali, sono caduchi e passeggeri; ma niun segno di caducità nè di mortalità si scuopre nella materia universalmente, e però niun segno che ella sia cominciata, nè che ad essere le bisognasse o pur le bisogni alcuna causa o forza fuori di se. Il mondo, cioè l'essere della materia in un cotal modo, è cosa incominciata e caduca. Ora diremo della origine del mondo. La materia in universale, siccome in particolare le piante e le creature animate, ha in se per natura una o più forze sue proprie, che l'agitano e muovono in diversissime guise continuamente. Le quali forze noi possiamo congetturare ed anco denominare dai loro effetti, ma non conoscere in se, nè scoprir la natura loro. Nè anche possiamo sapere se quegli effetti che da noi si riferiscono a una stessa forza, procedano veramente da una o da più, e se per contrario quelle forze che noi significhiamo con diversi nomi, sieno veramente diverse forze, o pure una stessa. Siccome tutto dì nell'uomo con diversi vocaboli si dinota una sola passione o forza: per modo di esempio, l'ambizione, l'amor del piacere e simili, da ciascuna delle quali fonti derivano effetti talora semplicemente diversi, talora eziandio contrari a quei delle altre, sono in fatti una medesima passione, cioè l'amor di se stesso, il quale opera in diversi casi diversamente. Queste forze adunque o si debba dire questa forza della materia, muovendola, come abbiamo detto, ed agitandola di continuo, forma di essa materia innumerabili creature, cioè la modifica in variatissime guise. Le quali creature, comprendendole tutte insieme, e considerandole siccome distribuite in certi generi e certe specie, e congiunte tra se con certi tali ordini e certe tali relazioni che provengono dalla loro natura, si chiamano mondo. Ma imperciocchè la detta forza non resta mai di operare e di modificar la materia, però quelle creature che essa continuamente forma, essa altresì le distrugge, formando della materia loro nuove creature. Insino a tanto che distruggendosi le creature individue, i generi nondimeno e le specie delle medesime si mantengono, o tutte o le più, e che gli ordini e le relazioni naturali delle cose non si cangiano o in tutto o nella più parte, si dice durare ancora quel cotal mondo. Ma infiniti mondi nello spazio infinito della eternità, essendo durati più o men tempo, finalmente sono venuti meno, perdutisi per li continui rivolgimenti della materia, cagionati dalla predetta forza, quei generi e quelle specie onde essi mondi si componevano, e mancate quelle relazioni e quegli ordini che li governavano. Nè perciò la materia è venuta meno in qual si sia particella, ma solo sono mancati que' suoi tali modi di essere, succedendo immantinente a ciascuno di loro un altro modo, cioè un altro mondo, di mano in mano. DELLA FINE DEL MONDO Questo mondo presente del quale gli uomini sono parte, cioè a dir l'una delle specie delle quali esso è composto, quanto tempo sia durato fin qui, non si può facilmente dire, come nè anche si può conoscere quanto tempo esso sia per durare da questo innanzi. Gli ordini che lo reggono paiono immutabili, e tali sono creduti, perciocchè essi non si mutano se non che a poco a poco e con lunghezza incomprensibile di tempo, per modo che le mutazioni loro non cadono appena sotto il conoscimento, non che sotto i sensi dell'uomo. La quale lunghezza di tempo, quanta che ella si sia, è ciò non ostante menoma per rispetto alla durazione eterna della materia. Vedesi in questo presente mondo un continuo perire degl'individui ed un continuo trasformarsi delle cose da una in altra; ma perciocchè la distruzione è compensata continuamente dalla produzione, e i generi si conservano, stimasi che esso mondo non abbia nè sia per avere in se alcuna causa per la quale debba nè possa perire, e che non dimostri alcun segno di caducità. Nondimeno si può pur conoscere il contrario, e ciò da più d'uno indizio, ma tra gli altri da questo. Sappiamo che la terra, a cagione del suo perpetuo rivolgersi intorno al proprio asse, fuggendo dal centro le parti dintorno all'equatore, e però spingendosi verso il centro quelle dintorno ai poli, è cangiata di figura e continuamente cangiasi, divenendo intorno all'equatore ogni dì più ricolma, e per lo contrario intorno ai poli sempre più deprimendosi. Or dunque da ciò debbe avvenire che in capo di certo tempo, la quantità del quale, avvengachè sia misurabile in se, non può essere conosciuta dagli uomini, la terra si appiani di qua e di là dall'equatore per modo, che perduta al tutto la figura globosa, si riduca in forma di una tavola sottile ritonda. Questa ruota aggirandosi pur di continuo dattorno al suo centro, attenuata tuttavia più e dilatata, a lungo andare, fuggendo dal centro tutte le sue parti, riuscirà traforata nel mezzo. Il qual foro ampliandosi a cerchio di giorno in giorno, la terra ridotta per cotal modo a figura di uno anello, ultimamente 150 andrà in pezzi; i quali usciti della presente orbita della terra, e perduto il movimento circolare, precipiteranno nel sole o forse in qualche pianeta. Potrebbesi per avventura in confermazione di questo discorso addurre un esempio, io voglio dire dell'anello di Saturno, della natura del quale non si accordano tra loro i fisici. E quantunque nuova e inaudita, forse non sarebbe perciò inverisimile congettura il presumere che il detto anello fosse da principio uno dei pianeti minori destinati alla sequela di Saturno; indi appianato e poscia traforato nel mezzo per cagioni conformi a quelle che abbiamo dette della terra, ma più presto assai, per essere di materia forse più rara e più molle, cadesse dalla sua orbita nel pianeta di Saturno, dal quale colla virtù attrattiva della sua massa e del suo centro, sia ritenuto, siccome lo veggiamo essere veramente, dintorno a esso centro. E si potrebbe credere che questo anello, continuando ancora a rivolgersi, come pur fa, intorno al suo mezzo, che è medesimamente quello del globo di Saturno, sempre più si assottigli e dilati, e sempre si accresca quello intervallo che è tra esso e il predetto globo, quantunque ciò accada troppo più lentamente di quello che si richiederebbe a voler che tali mutazioni fossero potute notare e conoscere dagli uomini, massime così distanti. Queste cose, o seriamente o da scherzo, sieno dette circa all'anello di Saturno. Ora quel cangiamento che noi sappiamo essere intervenuto e intervenire ogni giorno alla figura della terra, non è dubbio alcuno che per le medesime cause non intervenga somigliantemente a quella di ciascun pianeta, comechè negli altri pianeti esso non ci sia così manifesto agli occhi come egli ci è pure in quello di Giove. Nè solo a quelli che a similitudine della terra si aggirano intorno al sole, ma il medesimo senza alcun fallo interviene ancora a quei pianeti che ogni ragion vuole che si credano essere intorno a ciascuna stella. Per tanto in quel modo che si è divisato della terra, tutti i pianeti in capo di certo tempo, ridotti per se medesimi in pezzi, hanno a precipitare gli uni nel sole, gli altri nelle stelle loro. Nelle quali fiamme manifesto è che non pure alquanti o molti individui, ma universalmente quei generi e quelle specie che ora si contengono nella terra e nei pianeti, saranno distrutte insino, per dir così, dalla stirpe. E questo per avventura, o alcuna cosa a ciò somigliante, ebbero nell'animo quei filosofi, così greci come barbari, i quali affermarono dovere alla fine questo presente mondo perire di fuoco. Ma perciocchè noi veggiano che anco il sole si ruota dintorno al proprio asse, e quindi il medesimo si dee credere delle stelle, segue che l'uno e le altre in corso di tempo debbano non meno che i pianeti venire in dissoluzione, e le loro fiamme dispergersi nello spazio. In tal guisa adunque il moto circolare delle sfere mondane, il quale è principalissima parte dei presenti ordini naturali, e quasi principio e fonte della conservazione di questo universo, sarà causa altresì della distruzione di esso universo e dei detti ordini. Venuti meno i pianeti, la terra, il sole e le stelle, ma non la materia loro, si formeranno di questa nuove creature, distinte in nuovi generi e nuove specie, e nasceranno per le forze eterne della materia nuovi ordini delle cose ed un nuovo mondo. Ma le qualità di questo e di quelli, siccome eziandio degl'innumerevoli che già furono e degli altri infiniti che poi saranno, non possiamo noi nè pur solamente congetturare 151 Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana XV Ci è un piccolo libro del Machiavelli, tradotto in tutte le lingue, il Principe, che ha gittato nell'ombra le altre sue opere. L'autore è stato giudicato da questo libro, e questo libro è stato giudicato non nel suo valore logico e scientifico, ma nel suo valore morale. E hanno trovato che questo libro è un codice della tirannia, fondato sulla turpe massima che il fine giustifica i mezzi, e il successo loda l'opera. E hanno chiamato machiavellismo questa dottrina. Molte difese sonosi fatte di questo libro ingegnosissime, attribuendosi all'autore questa o quella intenzione più o meno lodevole. Così n'è uscita una discussione limitata e un Machiavelli rimpiccinito. Questa critica non è che una pedanteria. Ed è anche una meschinità porre la grandezza di quell'uomo nella sua utopia italica, oggi cosa reale. Noi vogliamo costruire tutta intera l'immagine, e cercare ivi i fondamenti della sua grandezza. Niccolò Machiavelli è innanzi tutto la coscienza chiara e seria di tutto quel movimento, che nella sua spontaneità dal Petrarca e dal Boccaccio si stende sino alla seconda metà del Cinquecento. In lui comincia veramente la prosa, cioè a dire la coscienza e la riflessione della vita. Anche lui è in mezzo a quel movimento, e vi piglia parte, ne ha le passioni e le tendenze. Ma, passato il momento dell'azione, ridotto in solitudine, pensoso sopra i volumi di Livio e di Tacito, ha la forza di staccarsi dalla sua società, e interrogarla: — Cosa sei? dove vai? L'Italia aveva ancora il suo orgoglio tradizionale, e guardava l'Europa con l'occhio di Dante e del Petrarca, giudicando barbare tutte le nazioni oltre le Alpi. Il suo modello era il mondo greco e romano, che si studiava di assimilarsi. Soprastava per coltura, per industrie, per ricchezze, per opere d'arti e d'ingegno: teneva senza contrasto il primato intellettivo in Europa. Grave fu lo sgomento negl'italiani, quando ebbero gli stranieri in casa; ma vi si ausarono, e trescarono con quelli, confidando di cacciarli via tutti con la superiorità dell'ingegno. Spettacolo pieno di ammaestramento è vedere tra lanzi, svizzeri, tedeschi, francesi e spagnuoli l'alto e spensierato riso di letterati, artisti, latinisti, novellieri e buffoni nelle eleganti corti italiane. Fino ne' campi i sonettisti assediavano i principi: Giovanni de' Medici cadeva tra' lazzi di Pietro Aretino. Gli stranieri guardavano attoniti le maraviglie di Firenze, di Venezia, di Roma e tanti miracoli dell'ingegno; e i loro principi regalavano e corteggiavano i letterati, che con la stessa indifferenza celebravano Francesco I e Carlo V. L'Italia era inchinata e studiata da' suoi devastatori, come la Grecia fu da' romani. Fra tanto fiore di civiltà e in tanta apparenza di forza e di grandezza mise lo sguardo acuto Niccolò Machiavelli, e vide la malattia, dove altri vedevano la più prospera salute. Quello che oggi diciamo decadenza egli disse: "corruttela", e base di tutte le sue speculazioni fu questo fatto, la corruttela della razza italiana, anzi latina, e la sanità della germanica. [4.] La forma più grossolana di questa corruttela era la licenza de' costumi e del linguaggio, massime nel clero: corruttela che già destò l'ira di Dante e di Caterina, ed ora messa in mostra ne' dipinti e negli scritti, penetrata in tutte le classi della società e in tutte le forme della letteratura, divenuta come una salsa piccante che dava sapore alla vita. La licenza accompagnata con l'empietà e l'incredulità avea a suo principal centro la corte romana, protagonisti Alessandro VI e Leone X. Fu la vista di quella corte che infiammò le ire di Savonarola e stimolò alla separazione Lutero e i suoi concittadini. Nondimeno il clero per abito tradizionale tuonava dal pergamo contro quella licenza. Il Vangelo rimaneva sempre un ideale non contrastato, salvo a non tenerne alcun conto nella vita pratica: il pensiero non era più la parola, e la parola non era più l'azione, non ci era armonia nella vita. In questa disarmonia era il principale motivo comico del Boccaccio e degli altri scrittori di commedie, di novelle e di capitoli. Nessun italiano, parlando in astratto, poteva trovar lodevole quella licenza, a' cui allettamenti pur non sapeva resistere. Altra era la teoria, altra la pratica. E nessuno poteva non desiderare una riforma de' costumi, una restaurazione della coscienza. Sentimenti e desideri vani, affogati nel rumore di quei baccanali. Non ci era il tempo di piegarsi in sé, di considerare la vita seriamente. Pure erano sentimenti e desideri che più tardi fruttificarono e agevolarono l'opera del Concilio di Trento e la reazione cattolica. Rifare il medio evo, e ottenere la riforma de' costumi e delle coscienze con una ristaurazione religiosa e morale era stato già il concetto di Geronimo Savonarola, ripreso poi e purgato nel Concilio di Trento. Era il concetto più accessibile alle moltitudini e più facile a presentarsi. I volghi cercano la medicina a' loro mali nel passato. Machiavelli, pensoso e inquieto in mezzo a quel carnevale italiano, giudicava quella corruttela da un punto di vista più alto. Essa era non altro che lo stesso medio evo in putrefazione, morto già nella coscienza, vivo ancora nelle forme e nelle istituzioni. E perciò, non che pensasse di ricondurre indietro l'Italia e di ristaurare il medio evo, concorse alla sua demolizione. L'altro mondo, la cavalleria, l'amore platonico sono i tre concetti fondamentali, intorno a' quali si aggira la letteratura nel medio evo, de' quali la nuova letteratura è la parodia più o meno consapevole. Anche nella faccia del Machiavelli sorprendi un movimento, ironico quando parla del medio evo, soprattutto allora che affetta maggior serietà. La misura del linguaggio rende più terribili i suoi colpi. Nella sua opera demolitiva è visibile la sua parentela col Boccaccio e col Magnifico. Il suo Belfegor è della stessa razza, dalla quale era uscito Astarotte. 152 Ma la sua negazione non è pura buffoneria, puro effetto comico, uscito da coscienza vuota. In quella negazione ci è un'affermazione, un altro mondo sorto nella sua coscienza. E perciò la sua negazione è seria ed eloquente. Papato e impero, guelfismo e ghibellinismo, ordini feudali e comunali, tutte queste istituzioni sono demolite nel suo spirito. E sono demolite, perché nel suo spirito è sorto un nuovo edificio sociale e politico. Le idee che generarono quelle istituzioni sono morte, non hanno più efficacia di sorta sulla coscienza, rimasta vuota. E in quest'ozio interno è la radice della corruttela italiana. Questo popolo non si può rinnovare, se non rifacendosi una coscienza. Ed è a questo che attende Machiavelli. Con l'una mano distrugge, con l'altra edifica. Da lui comincia in mezzo alla negazione universale e vuota la ricostruzione. Non è possibile seguire la sua dottrina nel particolare. Basti qui accennare la idea fondamentale. Il medio evo riposa sopra questa base: che il peccato è attaccarsi a questa vita, come cosa sostanziale, e la virtù è negazione della vita terrena e contemplazione dell'altra; che questa vita non è la realtà o la verità, ma ombra e apparenza; e che la realtà è non quello che è, ma quello che dee essere, e perciò il suo vero contenuto è l'altro mondo, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, il mondo conforme alla verità e alla giustizia. Da questo concetto della vita teologico–etico uscì la Divina Commedia e tutta la letteratura del Dugento e del Trecento. Il simbolismo e lo scolasticismo sono le forme naturali di questo concetto. La realtà terrena è simbolica; Beatrice è un simbolo: l'amore è un simbolo. E l'uomo e la natura hanno la loro spiegazione e la loro radice negli enti o negli universali, forze estramondane, che sono la maggiore del sillogismo, l'universale da cui esce il particolare. Tutto questo, forma e concetto, era già dal Boccaccio in qua negato, caricato, parodiato, materia di sollazzo e di passatempo: pura negazione nella sua forma cinica e licenziosa, che aveva a base la glorificazione della carne o del peccato, la voluttà, l'epicureismo, reazione all'ascetismo. Andavano insieme teologi e astrologi e poeti, tutti visionari: conclusione geniale della Maccaronea, ispirata al Folengo dal mondo della Luna ariostesco. In teoria ci era una piena indifferenza, e in pratica una piena licenza. Machiavelli vive in questo mondo e vi partecipa. La stessa licenza nella vita, e la stessa indifferenza nella teoria. La sua coltura non è straordinaria: molti a quel tempo avanzavano lui e l'Ariosto di dottrina e di erudizione. Di speculazioni filosofiche sembra così digiuno come di enunciazioni scolastiche e teologiche. E a ogni modo non se ne cura. Il suo spirito è tutto nella vita pratica. Nelle scienze naturali non sembra sia molto innanzi, quando vediamo che in alcuni casi accenna all'influsso delle stelle. Battista Alberti avea certo una coltura più vasta e più compiuta. Niccolò non è filosofo della natura, è filosofo dell'uomo. Ma il suo ingegno oltrepassa l'argomento e prepara Galileo. L'uomo, come Machiavelli lo concepisce, non ha la faccia estatica e contemplativa del medio evo, e non la faccia tranquilla e idillica del Risorgimento. Ha la faccia moderna dell'uomo che opera e lavora intorno ad uno scopo. Ciascun uomo ha la sua missione su questa terra, secondo le sue attitudini. La vita non è un giuoco d'immaginazione, e non è contemplazione. Non è teologia, e non è neppure arte. Essa ha in terra la sua serietà, il suo scopo e i suoi mezzi. Riabilitare la vita terrena, darle uno scopo, rifare la coscienza, ricreare le forze interiori, restituire l'uomo nella sua serietà e nella sua attività, questo è lo spirito che aleggia in tutte le opere del Machiavelli. È negazione del medio evo, e insieme negazione del Risorgimento. La contemplazione divina lo soddisfa così poco, come la contemplazione artistica. La coltura e l'arte gli paiono cose belle, non tali però che debbano e possano costituire lo scopo della vita. Combatte l'immaginazione come il nemico più pericoloso, e quel veder le cose in immaginazione e non in realtà gli par proprio esser la malattia che si ha a curare. Ripete ad ogni tratto che bisogna giudicar le cose come sono, e non come debbono essere. Quel "dover essere", a cui tende il contenuto nel medio evo e la forma nel Risorgimento, dee far luogo all'essere, o com'egli dice, alla verità "effettuale". Subordinare il mondo dell'immaginazione, come religione e come arte, al mondo reale, quale ci è posto dall'esperienza e dall'osservazione, questa è la base del Machiavelli. [5.] Risecati tutti gli elementi sopraumani e soprannaturali, pone a fondamento della vita la patria. La missione dell'uomo su questa terra, il suo primo dovere è il patriottismo, la gloria, la grandezza, la libertà della patria. Nel medio evo non ci era il concetto di patria. Ci era il concetto di fedeltà e di sudditanza. Gli uomini nascevano tutti sudditi del papa e dell'imperatore, rappresentanti di Dio, l'uno era lo spirito, l'altro il corpo della società. Intorno a questi due Soli stavano gli astri minori, re, principi, duchi, baroni, a cui stavano di contro in antagonismo naturale i comuni liberi. Ma la libertà era privilegio papale e imperiale, e i comuni esistevano anch'essi per la grazia di Dio, e perciò del papa o dell'imperatore, e spesso imploravano legati apostolici o imperiali a tutela e pacificazione. Savonarola proclamò re di Firenze Gesù Cristo, ben inteso lasciando a sé il dritto di rappresentarlo e interpretarlo. È un tratto che illumina tutte le idee di quel tempo. Ci era ancora il papa e ci era l'imperatore. Ma l'opinione, sulla quale si fondava la loro potenza, non ci era più nelle classi colte d'Italia. Il papa stesso e l'imperatore avevano smesso l'antico linguaggio, il papa, ingrandito di territorio, diminuito di autorità, l'imperatore debole e impacciato a casa. Di papato e d'impero, di guelfi e ghibellini non si parlava in Italia, che per riderne, a quel modo che della cavalleria e di tutte le altre istituzioni. Di quel mondo rimanevano avanzi in Italia il papa, i gentiluomini e gli avventurieri o 153 mercenari. Il Machiavelli vede nel papato temporale non solo un sistema di governo assurdo e ignobile, ma il principale pericolo dell'Italia. Democratico, combatte il concetto di un governo stretto, e tratta assai aspramente i gentiluomini, reminiscenze feudali. E vede ne' mercenari o avventurieri la prima cagione della debolezza italiana incontro allo straniero, e propone e svolge largamente il concetto di una milizia nazionale. Nel papato temporale, nei gentiluomini, negli avventurieri combatte gli ultimi vestigi del medio evo. La patria del Machiavelli è naturalmente il comune libero, libero per sua virtù e non per grazia del papa e dell'imperatore, governo di tutti nell'interesse di tutti. Ma, osservatore sagace, non gli può sfuggire il fenomeno storico de' grandi stati che si erano formati in Europa, e come il comune era destinato anch'esso a sparire con tutte le altre istituzioni del medio evo. Il suo comune gli par cosa troppo piccola e non possibile a durare dirimpetto a quelle potenti agglomerazioni delle stirpi, che si chiamavano stati o nazioni. Già Lorenzo, mosso dallo stesso pensiero, avea tentato una grande lega italica, che assicurasse l'"equilibrio" tra' vari stati e la mutua difesa, e che pure non riuscì ad impedire l'invasione di Carlo VIII. Niccolò propone addirittura la costituzione di un grande stato italiano, che sia baluardo d'Italia contro lo straniero. Il concetto di patria gli si allarga. Patria non è solo il piccolo comune, ma è tutta la nazione. L'Italia nell'utopia dantesca è il giardino dell'impero; nell'utopia del Machiavelli è la patria, nazione autonoma e indipendente. La patria del Machiavelli è una divinità, superiore anche alla moralità e alla legge. A quel modo che il Dio degli ascetici assorbiva in sé l'individuo, e in nome di Dio gl'inquisitori bruciavano gli eretici, per la patria tutto era lecito, e le azioni, che nella vita privata sono delitti, diventavano magnanime nella vita pubblica. "Ragion di stato" e "salute pubblica" erano le formole volgari, nelle quali si esprimeva questo dritto della patria, superiore ad ogni dritto. La divinità era scesa di cielo in terra e si chiamava la patria, ed era non meno terribile. La sua volontà e il suo interesse era suprema lex. Era sempre l'individuo assorbito nell'essere collettivo. E quando questo essere collettivo era assorbito a sua volta nella volontà di un solo o di pochi, avevi la servitù. Libertà era la partecipazione più o meno larga de' cittadini alla cosa pubblica. I dritti dell'uomo non entravano ancora nel codice della libertà. L'uomo non era un essere autonomo, e di fine a sé stesso: era l'istrumento della patria, o ciò che è peggio, dello stato, parola generica, sotto la quale si comprendeva ogni specie di governo, anche il dispotico, fondato sull'arbitrio di un solo. Patria era, dove tutti concorrevano più o meno al governo, e se tutti ubbidivano, tutti comandavano: ciò che dicevasi repubblica. E dicevasi principato, dove uno comandava e tutti ubbidivano. Ma, repubblica o principato, patria o stato, il concetto era sempre l'individuo assorbito nella società, o, come fu detto poi, l'onnipotenza dello stato. Queste idee sono enunciate dal Machiavelli, non come da lui trovate e analizzate, ma come già per lunga tradizione ammesse, e fortificate dalla coltura classica. Ci è lì dentro lo spirito dell'antica Roma, che con la sua immagine di gloria e di libertà attirava tutte le immaginazioni, e si porgeva alle menti modello non solo nell'arte e nella letteratura, ma ancora nello stato. La patria assorbisce anche la religione. Uno stato non può vivere senza religione. E se il Machiavelli si duole della corte romana, non è solo perché a difesa del suo dominio temporale è costretta a chiamar gli stranieri, ma ancora perché co' suoi costumi disordinati e licenziosi ha diminuita nel popolo l'autorità della religione. Ma egli vuole una religione di stato, che sia in mano del principe un mezzo di governo. Della religione si era perduto il senso, ed era arte presso i letterati e istrumento politico negli statisti. Anche la moralità gli piace, e loda la generosità, la clemenza, l'osservanza della fede, la sincerità e le altre virtù, ma a patto che ne venga bene alla patria; e se le incontra sulla sua via non istrumenti, ma ostacoli, gli spezza. Leggi spesso lodi magnifiche della religione e delle altre virtù de' buoni principi; ma ci odori un po' di rettorica, che spicca più in quel fondo ignudo della sua prosa. Non è in lui e non è in nessuno de' suoi contemporanei un sentimento religioso e morale schietto e semplice. Noi che vediamo le cose di lontano, troviamo in queste dottrine lo stato laico, che si emancipa dalla teocrazia, e diviene a sua volta invadente. Ma allora la lotta era ancor viva, e l'una esagerazione portava l'altra. Togliendo le esagerazioni, ciò che esce dalla lotta, è l'autonomia e l'indipendenza del potere civile, che ha la sua legittimità in sé stesso, sciolto ogni vincolo di vassallaggio e di subordinazione a Roma. Nel Machiavelli non ci è alcun vestigio di diritto divino. Il fondamento delle repubbliche è vox populi, il consenso di tutti. E il fondamento de' principati è la forza, o la conquista legittimata e assicurata dal buon governo. Un po' di cielo e un po' di papa ci entra pure, ma come forze atte a mantenere i popoli nell'ubbidienza e nell'osservanza delle leggi. Stabilito il centro della vita in terra e attorno alla patria, al Machiavelli non possono piacere le virtù monacali dell'umiltà e della pazienza, che hanno "disarmato il cielo e effeminato il mondo" e che rendono l'uomo più atto a "sopportare le ingiurie che a vendicarle". Agere et pati fortia romanum est. Il cattolicismo male interpretato rende l'uomo più atto a patire che a fare. Il Machiavelli attribuisce a questa educazione ascetica e contemplativa la fiacchezza del corpo e dell'animo, che rende gl'italiani inetti a cacciar via gli stranieri e a fondare la libertà e l'indipendenza della patria. La virtù è da lui intesa nel senso romano, e significa forza, energia, che renda gli uomini atti a' grandi sacrifici e alle grandi imprese. Non è che agl'italiani manchi il valore; anzi ne' singolari incontri riescono spesso vittoriosi: manca l'educazione o la disciplina o, come egli dice, "i buoni ordini e le buone armi", che fanno gagliardi e liberi i popoli. Alla virtù premio è la gloria. Patria, virtù, gloria, sono le tre parole sacre, la triplice base di questo mondo. [6.] Come gl'individui hanno la loro missione in terra, così anche le nazioni. Gl'individui senza patria, senza virtù, senza gloria sono atomi perduti, "numerus fruges consumere nati". E parimente ci sono nazioni oziose e vuote, che non lasciano 154 alcun vestigio di sé nel mondo. Nazioni storiche sono quelle che hanno adempiuto un ufficio nell'umanità, o, come dicevasi allora, nel genere umano, come Assiria, Persia, Grecia e Roma. Ciò che rende grandi le nazioni è la virtù o la tempra, gagliardia intellettuale e corporale, che forma il carattere o la forza morale. Ma come gl'individui, così le nazioni hanno la loro vecchiezza, quando le idee che le hanno costituite s'indeboliscono nella coscienza e la tempra si fiacca. E l'indirizzo del mondo fugge loro dalle mani e passa ad altre nazioni. Il mondo non è regolato da forze soprannaturali o casuali, ma dallo spirito umano, che procede secondo le sue leggi organiche e perciò fatali. Il fato storico non è la provvidenza, e non la fortuna, ma la "forza delle cose", determinata dalle leggi dello spirito e della natura. Lo spirito è immutabile nelle sue facoltà ed immortale nella sua produzione. Perciò la storia non è accozzamento di fatti fortuiti o provvidenziali, ma concatenazione necessaria di cause e di effetti, il risultato delle forze messe in moto dalle opinioni, dalle passioni e dagl'interessi degli uomini. La politica o l'arte del governare ha per suo campo non un mondo etico, determinato dalle leggi ideali della moralità, ma il mondo reale, come si trova nel tal luogo e nel tal tempo. Governare è intendere e regolare le forze che muovono il mondo. Uomo di stato è colui che sa calcolare e maneggiare queste forze e volgerle a' suoi fini. La grandezza e la caduta delle nazioni non sono dunque accidenti o miracoli, ma sono effetti necessari, che hanno le loro cause nella qualità delle forze che le movono. E quando queste forze sono in tutto logore, esse muoiono. E a governare, quelli che stanno solo in sul lione, non se ne intendono. Ci vuole anche la volpe, o la prudenza, cioè l'intelligenza, il calcolo e il maneggio delle forze che muovono gli stati. Come gl'individui, così le nazioni hanno legami tra loro, dritti e doveri. E come ci è un dritto privato, così ci è un dritto pubblico, o dritto delle genti, o, come dicesi oggi, dritto internazionale. Anche la guerra ha le sue leggi. Le nazioni muoiono. Ma lo spirito umano non muore mai. Eternamente giovane, passa di una nazione in un'altra, e continua secondo le sue leggi organiche la storia del genere umano. C'è dunque non solo la storia di questa o quella nazione, ma la storia del mondo, anch'essa fatale e logica, determinata nel suo corso dalle leggi organiche dello spirito. La storia del genere umano non è che la storia dello spirito o del pensiero. Di qui esce ciò che poi fu detto filosofia della storia. Di questa filosofia della storia e di un dritto delle genti non ci è nel Machiavelli che la semplice base scientifica, un punto di partenza segnato con chiarezza e indicato a' suoi successori. Il suo campo chiuso è la politica e la storia. Questi concetti non sono nuovi. I concetti filosofici, come i poetici, suppongono una lunga elaborazione. Ci si vede qui dentro le conseguenze naturali di quel grande movimento, sotto forme classiche realista, ch'era in fondo l'emancipazione dell'uomo dagli elementi soprannaturali e fantastici, e la conoscenza e il possesso di sé stesso. E a' contemporanei non parvero nuovi, né audaci, veggendo ivi formulato quello che in tutti era sentimento vago. [7.] L'influenza del mondo pagano è visibile anche nel medio evo, anche in Dante Roma è presente allo spirito. Ma lì è Roma provvidenziale e imperiale, la Roma di Cesare, e qui è Roma repubblicana, e Cesare vi è severamente giudicato. Dante chiama le gloriose imprese della repubblica miracoli della provvidenza, come preparazione all'impero: dove pel Machiavelli non ci sono miracoli, o i miracoli sono i buoni ordini; e se alcuna parte dà alla fortuna, la dà principalissima alla virtù. Di lui è questo motto profondo: "I buoni ordini fanno buona fortuna, e dalla buona fortuna nacquero i felici successi delle imprese". Il classicismo adunque era la semplice scorza, sotto alla quale le due età inviluppavano le loro tendenze. Sotto al classicismo di Dante ci è il misticismo e il ghibellinismo: la corteccia è classica, il nocciolo è medievale. E sotto al classicismo del Machiavelli ci è lo spirito moderno che ivi cerca e trova sé stesso. Ammira Roma, quanto biasima i tempi suoi, dove "non è cosa alcuna che gli ricomperi di ogni estrema miseria, infamia e vituperio, e non vi è osservanza di religione, non di leggi e non di milizia, ma sono maculati di ogni ragione bruttura". Crede con gli ordini e i costumi di Roma antica di poter rifare quella grandezza e ritemprare i suoi tempi, e in molte proposte e in molte sentenze senti i vestigi di quell'antica sapienza. Da Roma gli viene anche la nobiltà dell'ispirazione e una certa elevatezza morale. Talora ti pare un romano avvolto nel pallio in quella sua gravità, ma guardalo bene, e ci troverai il borghese del Risorgimento, con quel suo risolino equivoco. Savonarola è una reminiscenza del medio evo, profeta e apostolo a modo dantesco; Machiavelli in quella sua veste romana è vero borghese moderno, sceso dal piedistallo, uguale tra uguali, che ti parla alla buona e alla naturale. È in lui lo spirito ironico del Risorgimento con lineamenti molto precisi de' tempi moderni. Il medio evo qui crolla in tutte le sue basi, religiosa, morale, politica, intellettuale. E non è solo negazione vuota. È affermazione, è il Verbo. Di contro a ciascuna negazione sorge un'affermazione. Non è la caduta del mondo, è il suo rinnovamento. Dirimpetto alla teocrazia sorge l'autonomia e l'indipendenza dello stato. Tra l'impero e la città o il feudo, le due unità politiche del medio evo, sorge un nuovo ente, la Nazione, alla quale il Machiavelli assegna i suoi caratteri distintivi, la razza, la lingua, la storia, i confini. Tra le repubbliche e i principati spunta già una specie di governo medio o misto, che riunisca i vantaggi delle une e degli altri, e assicuri a un tempo la libertà e la stabilità, governo che è un presentimento de' nostri ordini costituzionali, e di cui il Machiavelli dà i primi lineamenti nel suo progetto per la riforma degli ordini politici in Firenze. È tutto un nuovo mondo politico che appare. Si vegga, fra l'altro, dove il Machiavelli tocca della formazione de' grandi stati, e soprattutto della Francia. Anche la base religiosa è mutata. Il Machiavelli vuole recisa dalla religione ogni temporalità, e, come Dante, combatte la confusione de' due reggimenti, e fa una descrizione de' principati ecclesiastici, notabile per la profondità 155 dell'ironia. La religione ricondotta nella sua sfera spirituale è da lui considerata, non meno che l'educazione e l'istruzione, come istrumento di grandezza nazionale. È in fondo l'idea di una Chiesa nazionale, dipendente dallo stato, e accomodata a' fini e agl'interessi della nazione. Altra è pure la base morale. Il fine etico del medio evo è la santificazione dell'anima, e il mezzo è la mortificazione della carne. Il Machiavelli, se biasima la licenza de' costumi invalsa al suo tempo, non è meno severo verso l'educazione ascetica. La sua dea non è Rachele, ma è Lia, non è la vita contemplativa, ma la vita attiva. E perciò la virtù è per lui la vita attiva, vita di azione, e in servigio della patria. I suoi santi sono più simili agli eroi dell'antica Roma, che agl'iscritti nel calendario romano. O per dir meglio, il nuovo tipo morale non è il santo, ma è il patriota. [8.] E si rinnova pure la base intellettuale. Secondo il gergo di allora, il Machiavelli non combatte la verità della fede, ma la lascia da parte, non se ne occupa, e quando vi s'incontra, ne parla con un'aria equivoca di rispetto. Risecata dal suo mondo ogni causa soprannaturale e provvidenziale, vi mette a base l'immutabilità e l'immortalità del pensiero o dello spirito umano, fattore della storia. Questo è già tutta una rivoluzione. È il famoso cogito, nel quale s'inizia la scienza moderna. È l'uomo emancipato dal mondo soprannaturale e sopraumano, che, come lo stato, proclama la sua autonomia e la sua indipendenza e prende possesso del mondo. E si rinnova il metodo. Il Machiavelli non riconosce verità a priori, e principî astratti, e non riconosce autorità di nessuno, come criterio del vero. Di teologia e di filosofia e di etica fa stima uguale, mondi d'immaginazione, fuori della realtà. La verità è la cosa effettuale, e perciò il modo di cercarla è l'esperienza accompagnata con l'osservazione, lo studio intelligente de' fatti. Tutto il formolario scolastico va giù. A quel vuoto meccanismo fondato sulle combinazioni astratte dell'intelletto incardinate nella pretesa esistenza degli universali sostituisce la forma ordinaria del parlare diritta e naturale. Le proposizioni generali, le "maggiori" del sillogismo, sono capovolte e compariscono in ultimo come risultati di una esperienza illuminata dalla riflessione. In luogo del sillogismo hai la "serie", cioè a dire concatenazione di fatti, che sono insieme causa ed effetto, come si vede in questo esempio:Avendo la città di Firenze perduta parte dell'imperio suo, fu necessitata a fare guerra a coloro che lo occupavano, e perché chi l'occupava era potente, ne seguiva che si spendeva assai nella guerra senza alcun frutto: dallo spendere assai ne risultava assai gravezze, dalle gravezze infinite querele del popolo; e perché questa guerra era amministrata da un magistrato di dieci cittadini, l'universale cominciò a recarselo in dispetto, come quello che fosse cagione e della guerra e delle spese di essa.Qui i fatti sono schierati in modo che si appoggiano e si spiegano a vicenda: sono una doppia serie, l'una complicata, che ti dà le cause vere, visibile solo all'uomo intelligente; l'altra semplicissima, che ti dà la causa apparente e superficiale, e che pure è quella che trascina ad opere inconsulte l'universale, con una serietà ed una sicurezza, che rende profondamente ironica la conclusione. I fatti saltan fuori a quel modo stesso che si sviluppano nella natura e nell'uomo, non vi senti alcuno artificio. Ma è un'apparenza. Essi sono legati, subordinati, coordinati dalla riflessione, sì che ciascuno ha il suo posto, ha il suo valore di causa o di effetto, ha il suo ufficio in tutta la catena: il fatto non è solo fatto, o accidente, ma è ragione, considerazione, sotto la narrazione si cela l'argomentazione. Così l'autore ha potuto in poche pagine condensare tutta la storia del medio evo e farne magnifico vestibulo alla sua storia di Firenze. I suoi ragionamenti sono anch'essi fatti intellettuali, e perciò l'autore si contenta di enunciare e non dimostra. Sono fatti cavati dalla storia, dall'esperienza del mondo, da un'acuta osservazione, e presentati con semplicità pari all'energia. Molti di questi fatti intellettuali sono rimasti anche oggi popolari nella bocca di tutti, com'è quel "ritirare le cose a' loro principii", o quell'ironia de' "profeti disarmati", o "gli uomini si stuccano del bene, e del male si affliggono", o "gli uomini bisogna carezzarli o spegnerli". Di queste sentenze o pensieri ce ne sono raccolte. E sono un intero arsenale, dove hanno attinto gli scrittori, vestiti delle sue spoglie. Come esempio di questi fatti intellettuali usciti da una mente elevata e peregrina, ricordo la famosa dedica de' suoi Discorsi. [9.] Con la forma scolastica rovina la forma letteraria, fondata sul periodo. Ne' lavori didascalici il periodo era una forma sillogistica dissimulata, una proposizione corteggiata dalla sua maggiore e dalle sue idee medie, ciò che dicevasi dimostrazione, se la materia era intellettuale, o descrizione, se la materia era di puri fatti. Machiavelli ti dà semplici proposizioni, ripudiato ogni corteggio; non descrive e non dimostra, narra o enuncia, e perciò non ha artificio di periodo. Non solo uccide la forma letteraria, ma uccide la forma stessa come forma, e fa questo nel secolo della forma, la sola divinità riconosciuta. Appunto perché ha piena la coscienza di un nuovo contenuto, per lui il contenuto è tutto e la forma è nulla. O, per dire più corretto, la forma è essa medesima la cosa nella sua verità effettuale, cioè nella sua esistenza intellettuale o materiale. Ciò che a lui importa, non è che la cosa sia ragionevole, o morale, o bella, ma che la sia. Il mondo è così e così; e si vuol pigliarlo com'è, ed è inutile cercare se possa o debba essere altrimenti. La base della vita, e perciò del sapere, è il Nosce te ipsum, la conoscenza del mondo nella sua realtà. Il fantasticare, il dimostrare, il descrivere, il moralizzare sono frutto d'intelletti collocati fuori della vita e abbandonati all'immaginazione. Perciò il Machiavelli purga la sua prosa di ogni elemento astratto, etico e poetico. Guardando il mondo con uno sguardo superiore, il suo motto è: Nil admirari. Non si maraviglia e non si appassiona, perché comprende, come non dimostra e non descrive, perché vede e tocca. Investe la cosa direttamente, e fugge le perifrasi, le circonlocuzioni, le amplificazioni, le argomentazioni, le frasi e le figure, i periodi e gli ornamenti, come ostacoli e indugi alla visione. Sceglie la via più breve, e perciò la diritta: non si distrae e non distrae. Ti dà una serie stretta e rapida di proposizioni e di fatti, soppresse 156 tutte le idee medie, tutti gli accidenti, e tutti gli episodi. Ha l'aria del pretore, che non curat de minimis, di un uomo occupato in cose gravi, che non ha tempo, né voglia di guardarsi attorno. Quella sua rapidità, quel suo condensare non è un artificio, come talora è in Tacito e sempre è nel Davanzati, ma è naturale chiarezza di visione, che gli rende inutili tutte quelle idee medie, di cui gli spiriti mediocri hanno bisogno per giungere faticosamente ad una conseguenza, ed è insieme pienezza di cose, che non gli fa sentire necessità di riempiere gli spazi vuoti con belletti e impolpature, che tanto piacciono a' cervelli oziosi. La sua semplicità talora è negligenza; la sua sobrietà talora è magrezza: difetti delle sue qualità. E sono pedanti quelli che cercano il pel nell'uovo, e gonfiano le gote in aria di pedagoghi, quando in quella divina prosa trovino latinismi, slegature, scorrezioni e simili negligenze. La prosa del Trecento manca di organismo, e perciò non ha ossatura, non interna coesione: vi abbonda l'affetto e l'immaginativa, vi scarseggia l'intelletto. Nella prosa del Cinquecento hai l'apparenza, anzi l'affettazione dell'ossatura, la cui espressione è il periodo. Ma l'ossatura non è che esteriore, e quel lusso di congiunzioni e di membri e d'incisi mal dissimula il vuoto e la dissoluzione interna. Il vuoto non è nell'intelletto, ma nella coscienza, indifferente e scettica. Perciò il lavoro intellettivo è tutto al di fuori, frasche e fiori. Gli argomenti più frivoli sono trattati con la stessa serietà degli argomenti gravi, perché la coscienza è indifferente ad ogni specie di argomento, grave o frivolo. Ma la serietà è apparente, è tutta formale e perciò rettorica: l'animo vi rimane profondamente indifferente. Monsignor della Casa scrive l'orazione a Carlo V con lo stesso animo che scrive il capitolo sul forno, salvo che qui è nella sua natura, e ti riesce cinico, lì è fuori della sua natura e ti riesce falso. Il Galateo e il Cortigiano sono le due migliori prose di quel tempo, come rappresentazione di una società pulita ed elegante, tutta al di fuori, in mezzo alla quale vivevano il Casa e il Castiglione, e che poneva la principale importanza della vita ne' costumi e ne' modi. Anche l'intelletto, in quella sua virilità ozioso, poneva la principale importanza della composizione ne' costumi e ne' modi, ovvero nell'abito. Quell'abbigliamento boccaccevole e ciceroniano divenne in breve convenzionale, un meccanismo tutto d'imitazione, a cui l'intelletto stesso rimaneva estraneo. I filosofi non avevano ancora smesse le loro forme scolastiche, i poeti petrarcheggiavano, i prosatori usavano un genere bastardo, poetico e rettorico, con l'imitazione esteriore del Boccaccio: la malattia era una, la passività o indifferenza dell'intelletto, del cuore, dell'immaginazione, cioè a dire di tutta l'anima. Ci era lo scrittore, non ci era l'uomo. E fin d'allora fu considerato lo scrivere come un mestiere, consistente in un meccanismo che dicevasi forma letteraria, nella piena indifferenza dell'animo: divorzio compiuto tra l'uomo e lo scrittore. Fra tanto infuriare di prose rettoriche e poetiche comparve la prosa del Machiavelli, presentimento della prosa moderna. Qui l'uomo è tutto, e non ci è lo scrittore, o ci è solo in quanto uomo. Il Machiavelli sembra quasi ignori che ci sia un'arte dello scrivere, ammessa generalmente e divenuta moda o convenzione. Talora ci si prova, e ci riesce maestro; ed è, quando vuol fare il letterato anche lui. L'uomo è in lui tutto. Quello che scrive, è una produzione immediata del suo cervello, esce caldo caldo dal di dentro, cose e impressioni spesso condensate in una parola. Perché è un uomo che pensa e sente, distrugge e crea, osserva e riflette, con lo spirito sempre attivo e presente. Cerca la cosa, non il suo colore: pure la cosa vien fuori insieme con le impressioni fatte nel suo cervello, perciò naturalmente colorita, traversata d'ironia, di malinconia, d'indignazione, di dignità, ma principalmente lei nella sua chiarezza plastica. Quella prosa è chiara e piena come un marmo, ma un marmo qua e là venato. È la grande maniera di Dante che vive là dentro. Parlando dei mutamenti introdotti al medio evo ne' nomi delle cose e degli uomini, finisce così: "e i Cesari e i Pompei Pietri, Mattei e Giovanni diventarono". Qui non ci è che il marmo, la cosa ignuda; ma quante vene in questo marmo! Ci senti tutte le impressioni fatte da quell'immagine nel suo cervello, l'ammirazione per quei Cesari e Pompei, il disprezzo per quei Pietri e Mattei, lo sdegno di quel mutamento; e lo vedi alla scelta caratteristica de' nomi, al loro collocamento in contrasto come nemici, e a quell'ultimo ed energico "diventarono", che accenna a mutamenti non solo di nomi, ma di animi. Questa prosa asciutta, precisa e concisa, tutta pensiero e tutta cose, annunzia l'intelletto già adulto emancipato da elementi mistici, etici e poetici, e divenuto il supremo regolatore del mondo, la logica o la forza delle cose, il fato moderno. Questo è in effetti il senso intimo del mondo, come il Machiavelli lo concepisce. Lasciando da parte le sue origini, il mondo è quello che è, un attrito di forze umane e naturali, dotate di leggi proprie. Ciò che dicesi fato, non è altro che la logica, il risultato necessario di queste forze, appetiti, istinti, passioni, opinioni, fantasie, interessi, mosse e regolate da una forza superiore, lo spirito umano, il pensiero, l'intelletto. Il Dio di Dante è l'amore, forza unitiva dell'intelletto e dell'atto: il risultato era sapienza. Il Dio di Machiavelli è l'intelletto, l'intelligenza e la regola delle forze mondane: il risultato è scienza. — Bisogna amare, — dice Dante. — Bisogna intendere, — dice Machiavelli. L'anima del mondo dantesco è il cuore; l'anima del mondo machiavellico è il cervello. Quel mondo è essenzialmente mistico ed etico; questo è essenzialmente umano e logico. La virtù muta il suo significato. Non è sentimento morale, ma è semplicemente forza o energia, la tempra dell'animo, e Cesare Borgia è virtuoso perché avea la forza di operare secondo logica, cioè di accettare i mezzi, quando aveva accettato lo scopo. Se l'anima del mondo è il cervello, hai una prosa che è tutta e sola cervello. [10.] Ora possiamo comprendere il Machiavelli nelle sue applicazioni. La storia di Firenze sotto forma narrativa è una logica degli avvenimenti. Dino scrive col cuore commosso, con l'immaginazione colpita: tutto gli par nuovo, tutto offende il suo senso morale. Vi domina il sentimento etico, come in Dante, nel Mussato, in tutt'i trecentisti. Ma ciò che interessa il Machiavelli, è la spiegazione de' fatti nelle forze motrici degli uomini, e narra calmo e meditativo, a modo di 157 filosofo che ti dia l'interpretazione del mondo. I personaggi non sono colti nel caldo dell'affetto e nel tumulto dell'azione: non è una storia drammatica. L'autore non è sulla scena, né dietro la scena; ma è nella sua camera, e, mentre i fatti gli sfilano avanti, cerca afferrarne i motivi. La sua apatia non è che preoccupazione di filosofo, inteso a spiegare e tutto raccolto in questo lavoro intellettivo, non distratto da emozioni e impressioni. È l'apatia dell'ingegno superiore, che guarda con compassione a' moti convulsi e nervosi delle passioni. […] [16.] Di ogni scrittore muore una parte. E anche del Machiavelli una parte è morta, quella per la quale è venuto a trista celebrità. È la sua parte più grossolana, è la sua scoria quella che ordinariamente è tenuta parte sua vitale, così vitale che è stata detta il machiavellismo. Anche oggi, quando uno straniero vuol dire un complimento all'Italia, la chiama patria di Dante e di Savonarola, e tace di Machiavelli. Noi stessi non osiamo chiamarci figli di Machiavelli. Tra il grande uomo e noi ci è il machiavellismo. È una parola, ma una parola consacrata dal tempo, che parla all'immaginazione e ti spaventa come fosse l'orco. Del Machiavelli è avvenuto quello che del Petrarca. Si è chiamato petrarchismo quello che in lui è un incidente ed è il tutto ne' suoi imitatori. E si è chiamato machiavellismo quello che nella sua dottrina è accessorio e relativo, e si è dimenticato quello che vi è di assoluto e di permanente. Così è nato un Machiavelli di convenzione, veduto da un lato solo e dal meno interessante. È tempo di rintegrare l'immagine. Ci è nel Machiavelli una logica formale e c'è un contenuto. La sua logica ha per base la serietà dello scopo, ciò ch'egli chiama virtù. Proporti uno scopo, quando non puoi o non vuoi conseguirlo, è da femmina. Essere uomo significa "marciare allo scopo". Ma nella loro marcia gli uomini errano spesso, perché hanno l'intelletto e la volontà intorbidata da fantasmi e da sentimenti, e giudicano secondo le apparenze. Sono spiriti fiacchi e deboli quelli che stimano le cose, come le paiono e non come le sono: a quel modo che fa la plebe. Cacciar via dunque tutte le vane apparenze, e andare allo scopo con lucidità di mente e fermezza di volontà, questo è essere un uomo, aver la stoffa d'uomo. Quest'uomo può essere un tiranno o un cittadino, un uomo buono o un tristo. Ciò è fuori dell'argomento, è un altro aspetto dell'uomo. Ciò a che guarda Machiavelli è di vedere se è un uomo; ciò a che mira è rifare le radici alla pianta uomo in declinazione. In questa sua logica la virtù è il carattere o la tempra, e il vizio è l'incoerenza, la paura, l'oscillazione. Si comprende che in questa generalità ci è lezioni per tutti, pe' buoni e pe' birbanti, e che lo stesso libro sembra agli uni il codice de' tiranni, e agli altri il codice degli uomini liberi. Ciò che vi s'impara è di essere un uomo, come base di tutto il resto. Vi s'impara che la storia, come la natura, non è regolata dal caso, ma da forze intelligenti e calcolabili, fondate sulla concordanza dello scopo e de' mezzi; e che l'uomo, come essere collettivo o individuo, non è degno di questo nome, se non sia anch'esso una forza intelligente, coerenza di scopo e di mezzi. Da questa base esce l'età virile del mondo, sottratta possibilmente all'influsso dell'immaginazione e delle passioni, con uno scopo chiaro e serio e con mezzi precisi. Questo è il concetto fondamentale, l'obbiettivo del Machiavelli. Ma non è principio astratto e ozioso: ci è un contenuto, che abbiamo già delineato ne' tratti essenziali. La serietà della vita terrestre, col suo istrumento, il lavoro, col suo obbiettivo, la patria, col suo principio, l'eguaglianza e la libertà, col suo vincolo morale, la nazione, col suo fattore, lo spirito o il pensiero umano, immutabile ed immortale, col suo organismo, lo stato, autonomo e indipendente, con la disciplina delle forze, con l'equilibrio degl'interessi, ecco ciò che vi è di assoluto e di permanente nel mondo del Machiavelli, a cui è di corona la gloria, cioè l'approvazione del genere umano, ed è di base la virtù o il carattere, agere et pati fortia. Il fondamento scientifico di questo mondo è la cosa effettuale, come te la porge l'esperienza e l'osservazione. L'immaginazione, il sentimento, l'astrazione sono così perniciosi nella scienza, come nella vita. Muore la scolastica, nasce la scienza. Questo è il vero machiavellismo, vivo, anzi giovane ancora. È il programma del mondo moderno, sviluppato, corretto, ampliato, più o meno realizzato. E sono grandi le nazioni che più vi si avvicinano. Siamo dunque alteri del nostro Machiavelli. Gloria a lui, quando crolla alcuna parte dell'antico edificio. E gloria a lui, quando si fabbrica alcuna parte del nuovo. In questo momento che scrivo, le campane suonano a distesa, e annunziano l'entrata degl'italiani a Roma. Il potere temporale crolla. E si grida il viva all'unità d'Italia. Sia gloria al Machiavelli. Scrittore, non solo profondo, ma simpatico. Perché nelle sue transazioni politiche discerni sempre le sue vere inclinazioni. Antipapale, antimperiale, antifeudale, civile, moderno e democratico. E quando, stretto dal suo scopo, propone certi mezzi, non di rado s'interrompe, protesta, ha quasi aria di chiederti scusa e di dirti: — Guarda che siamo in tempi corrotti; e se i mezzi son questi, e il mondo è fatto così, la colpa non è mia. Ciò che è morto del Machiavelli non è il sistema, è la sua esagerazione. La sua patria mi rassomiglia troppo l'antica divinità, e assorbe in sé religione, moralità, individualità. Il suo stato non è contento di essere autonomo esso, ma toglie l'autonomia a tutto il rimanente. Ci sono i dritti dello stato: mancano i dritti dell'uomo. La ragione di stato ebbe le sue forche, come l'Inquisizione ebbe i suoi roghi, e la salute pubblica le sue mannaie. Fu stato di guerra, e in quel furore di 158 lotte religiose e politiche ebbe la sua culla sanguinosa il mondo moderno. Dalla forza uscì la giustizia. Da quelle lotte uscì la libertà di coscienza, l'indipendenza del potere civile e più tardi la libertà e la nazionalità. E se chiamate machiavellismo quei mezzi, vogliate chiamare anche machiavellismo quei fini. Ma i mezzi sono relativi e si trasformano, sono la parte che muore: i fini rimangono eterni. Gloria del Machiavelli è il suo programma, e non è sua colpa, che l'intelletto gli abbia indicati de' mezzi, i quali la storia posteriore dimostrò conformi alla logica del mondo. Fu più facile il biasimarli, che sceglierne altri. Dura lex, sed ita lex. Certo, oggi il mondo è migliorato in questo aspetto. Certi mezzi non sarebbero più tollerati, e produrrebbero un effetto opposto a quello che se ne attendeva Machiavelli, allontanerebbero dallo scopo. L'assassinio politico, il tradimento, la frode, le sètte, le congiure sono mezzi che tendono a scomparire. Presentiamo già tempi più umani e civili, dove non sieno più possibili la guerra, il duello, le rivoluzioni, le reazioni, la ragion di stato e la salute pubblica. Sarà l'età dell'oro. Le nazioni saranno confederate, e non ci sarà altra gara che d'industrie, di commerci e di studi. È un bel programma. E quantunque sembri un'utopia, non dispero. Ciò che lo spirito concepisce, presto o tardi viene a maturità. Ho fede nel progresso e nell'avvenire. Ma siamo ben lontani dal Machiavelli. E anche da' nostri tempi. E non è co' criteri di un mondo nascosto ancora nelle ombre dell'avvenire che possiamo giudicare e condannare Machiavelli. Anche oggi siamo costretti a dire: — Crudele è la logica della storia; ma quella è. Nel machiavellismo ci è una parte variabile nella qualità e nella quantità, relativa al tempo, al luogo, allo stato della coltura, alle condizioni morali de' popoli. Questa parte, che riguarda i mezzi, è molto mutata, e muterà in tutto, quando la società sia radicalmente rinnovata. Ma la teoria de' mezzi è assoluta ed eterna, perché fondata sulle qualità immutabili della natura umana. Il principio dal quale si sviluppa quella teoria, è questo, che i mezzi debbono avere per base l'intelligenza e il calcolo delle forze che movono gli uomini. È chiaro che in queste forze c'è l'assoluto e il relativo, e il torto del Machiavelli, comunissimo a tutt'i grandi pensatori, è di avere espresso in modo assoluto tutto, anche ciò che è essenzialmente relativo e variabile. Il machiavellismo, in ciò che ha di assoluto o di sostanziale, è l'uomo considerato come un essere autonomo e bastante a sé stesso, che ha nella sua natura i suoi fini e i suoi mezzi, le leggi del suo sviluppo, della sua grandezza e della sua decadenza, come uomo e come società. Su questa base sorgono la storia, la politica, e tutte le scienze sociali. Gl'inizi della scienza sono ritratti, discorsi, osservazioni di uomo che alla coltura classica unisca esperienza grande, e un intelletto chiaro e libero. Questo è il machiavellismo, come scienza e come metodo. Ivi il pensiero moderno trova la sua base e il suo linguaggio. Come contenuto, il machiavellismo su' rottami del medio evo abbozza un mondo intenzionale, visibile tra le transazioni e i vacillamenti dell'uomo politico, un mondo fondato sulla patria, sulla nazionalità, sulla libertà, sull'uguaglianza, sul lavoro, sulla virilità e serietà dell'uomo. 159
Scaricare