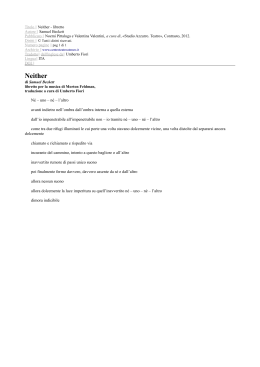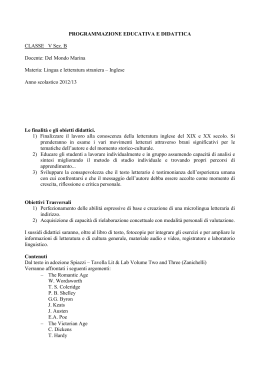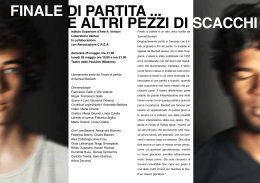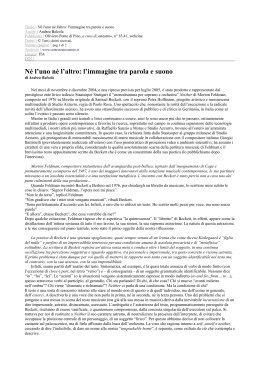44 C ORRIERE DELLA S ERA U D OMENICA 4 F EBBRAIO 2007 # TEATRO, MUSICA E DVD Alla Tosse di Genova Come era «normale» Adolfino A dolfino era un bambino con i capelli pettinati a banana, un ragazzino che scriveva invano lettere d’amore alle compagne, un giovane con i suoi bei calzoncini alla zuava e i calzettoni a scacchi che amava tanto l’ordine. Adolfino era un ragazzo come milioni di ragazzi, ma per fortuna milioni di ragazzi non furono come Adolfino che cresciuto diventò il Führer Adolf Hitler. L’infanzia e la prima giovinezza del dittatore è evocata da Emanuele Conte in Caro piccolo Adolf, spettacolo ambientato in un cabaret anni Trenta, su testimonianze di amici e conoscenti del giovane Hitler, dalla madre al padre ubriacone e assente, dalla vecchia maestra alla vicina di casa, al compagno di putsch. Figure che ricompongono un’immagine del dittatore da bambino che non riesce a non essere inquietante nella sua «normalità». Nella ronda di personaggi, cui danno vita tra gli altri l’ottima Claudia Lawrence con la sua ammiccante ironia e la sua straniata comicità, spiccano l’Adolfino bambino, interpretato dal bravissimo undicenne Alessandro Bandini, e Adolfo giovinetto, Paolo Maria Polosio, che si confrontano e si affrontano. Idea suggestiva che dà la sensazione cupa di un «io» diviso, di un bimbo mai bimbo, di un ragazzo mai ragazzo. La materia è scivolosa ed è difficile, anche per l’attento e bravo regista-drammaturgo, evitare che si giunga a facili semplificazioni e cioè che Hitler sia divenuto Hitler perché aveva un difficile rapporto con le donne o perché era un pittore fallito mai accettato all’Accademia, o perché il padre ubriacone lo trascurava. Ironia e leggerezza restano comunque le armi vincenti di questo curioso spettacolo. Magda Poli CARO PICCOLO ADOLF di Emanuele Conte Teatro della Tosse di Genova Paolo Graziosi mette in scena e interpreta «Catastrofe» e «L’ultimo nastro di Krapp» Home video Gli uomini estremi di Samuel Beckett 007 stupisce ancora In dvd i primi venti titoli della saga di FRANCO CORDELLI I n un festival intitolato «101 Beckett», torna a dar segni di vita lo Stabile delle Marche con due atti unici, Catastrofe e L’ultimo nastro di Krapp, interpretati e diretti da Paolo Graziosi. Catastrofe andò in scena nel 1986, alla Versiliana, nell’ambito della kermesse di Giancarlo Sepe «Buon compleanno Samuel Beckett». Tre anni dopo Carlo Quartucci lo ripropose all’Ateneo di Roma, con un protagonista d’eccezione, Franco Citti. In tutte e due le occasioni il testo di Beckett fu valutato con riserva, a qualcuno parve ridotto a mero sketch. Il che tuttavia dipendeva da un fattore esterno e piuttosto inevitabile: Catastrofe è brevissimo e non può che finire in un collage, perdendo di forza. Nello spettacolo di Graziosi la situazione è diversa, i testi di Beckett sono solo due, uniti, senza soluzione di continuità, dall’Allegretto della Settima di Beethoven: li si può apprezzare, ciascuno nella sua pienezza e completezza. Per Catastrofe vi è un dissenso interpretativo: questo breve atto unico, che nel dittico dello stabile marchigiano dura 15 minuti, è dedicato a Vaclav Havel. Beckett lo scrisse quando Havel era un non troppo noto drammaturgo cecoslovacco incarcerato dal suo governo in quanto dissidente. Beckett e Arthur Miller presentarono un proprio contributo al Festival di Avignone del 1982, una data che ora impressiona in due sensi: sia in quanto relativamente vicina, benché appaia d’un altro mon- SUL PALCO Una scena de «L’ultimo nastro di Krapp» al Teatro Comunale di Cagli do e d’un altro tempo, sia in relazione alla storia personale di Beckett. Per noi, Beckett è un autore degli anni Quaranta e Cinquanta, scoprirlo attivo negli Ottanta è sempre una sorpresa (di fatto l’ultimo suo testo, Cosa dove, è del 1983). Dicevo del dissenso interpretativo. Alcuni critici leggono Catastrofe come una metafora politica. Altri come una pièce metateatrale. Vi è un personaggio R, cioè un regista, molto vanitoso (almeno così lo rende, con un pizzico di felicità, Paolo Graziosi); vi è un personaggio A, cioè un’assistente, che è la disciplinata benché impaziente Elisabetta Arosio; e vi è un P, cioè un protagonista-prigioniero, l’immobile e muto Francesco Macedonio. Costui sta dritto su un piedistallo, stretto in un impermeabile, come fosse un gangster in un film di Howard Hawks o una spia nazista in un film di Fritz Lang. Avvolto in una pelliccia, più o meno sfarzosa, alla Orson Welles, e con un colbacco (così mi immagino) alla Sergej Bondar- ciuk, tanto per cominciare a spostarci verso Est, il regista dà puntigliosi, maniacali, ottusi ordini: o, almeno, ordini che ci paiono ottusi perché non conosciamo l’intero progetto. Ma, sembra suggerire Beckett, anche lo conoscessimo la nostra percezione non muterebbe: ciò che conta è come quel regista si muove, come parla e, infine, che cosa dice. Dice un mucchio di piccole, esiziali sciocchezze, che pochi minuti dopo risultano vere e proprie vessazioni: egli dice ad A che deve far abbassare a P la testa, che deve sbiancargli le mani, che deve ottenere una piena visibilità dei suoi piedi, o che deve oscurare il palcoscenico. Per noi spettatori, il quadro non cambia. Prima di arrivare alla desolazione, ben altrimenti conosciuta, di Krapp, il quadro è questo. Paolo Graziosi, con rapida e incredibile trasformazione fisica, diventerà un Krapp dagli occhi cerchiati di rosso, o viola, o blu, occhi pesti e gonfi di vecchie lacrime, e i capelli dritti in testa, come spiritati. Ma prima era, lo ripeto, quel dispotico R, una caricatura d’uomo, terribilmente reale, o realistica. Che importanza ha stabilire se sia un regista vero e proprio o la metafora di un poliziotto sadico? Ciò che conta è il suo coatto, demente dispotismo: vale per l’uno e per l’altro e per tutti quelli, lo sappiano o meno, che gli somigliano. CATASTROFE e L’ULTIMO NASTRO DI KRAPP di Beckett/Graziosi Teatro Comunale di Cagli La showgirl tv debutta con «Cabaret» al Teatro della Luna Hunziker, dimenticare Liza? S olo negli applausi finali Sally Bowles, dopo aver cantato un po' brilla sul grande scalone del varietà che la Vita è un cabaret, oh yeah, torna Michelle Hunziker: si toglie la parrucca nera del Kit Kat club della Berlino 1930, diventa bionda. Lo sapevamo tutti ma un po' di stupore resta perché la diva di «Zelig» e ora di Sanremo si è buttata coraggiosa nella mission impossible di far dimenticare Liza Minnelli. Marconi regista le ha predisposto un bello spettacolo fuori da ogni cliché: niente fumi, calze a rete, nè gambe sulla sedia stile Dietrich, «Mein herr» la fa fra due marcantoni e «Non dirlo a mamma» sul cavallino a dondolo. Sul versante storico il capolavoro musical-brechtian-espressionista di Masteroff, Kander ed Ebb un po' soffre a favore del messaggio evergreen sull’indifferenza: «Che c'entriamo con la politica?» ripete Sally nel finale. Ed ecco spiegato e servito non solo il nazismo. La personalità adolescenziale di Sally è resa dalla Hunziker con volontà ed entusiasmo anche nella parte canora che presenta il conto di vocalità difficili in pezzi mitici («Soldi, soldi», «Questa volta», «Cabaret») anche se dovrà diventare meno graziosa, più cattiva, più consapevole di ciò che urge spiegare in sala: i vip plaudenti della prima non sembravano saperla lunga. Dopo i revival a Londra e Broadway anche Marconi, regista di un magnifico «Cabaret» già nel '94, ci ragiona su e dopo aver metaforizzato la storia, alla fine, nel gioco a specchi della scenografia, ci mostra i bombardamenti: è il cabaret. Ma la sorpresa, l'applauditissima scoperta, è il maestro di cerimonie Christian Ginepro, che dà il Willkommen ai tavoli e ricava dal personaggio l'anima dello spettacolo, spesso restando in scena da osservatore-entertainer, come i comici della commedia stanno a guar- BRUNA Michelle Hunziker in «Cabaret» ispirato al film con Liza Minnelli: solo negli applausi finali si toglie la parrucca nera dare Arlecchino. I suoi momenti e quel finale senza orchestra sono da pelle d'oca: evitando ogni ambiguità, spiega la follia con un salto, un'occhiata, cantando tre fantastici pezzi: sull'altalena quello dei soldi, poi quello razzista con scimmia e il trasgressivo «Two ladies». Privo del ménage a tre inventato da Fosse, «Cabaret» è specchio di umane ro- vine che ci tocca da vicino. Il cast esegue con entusiasmo, bravura, sintonia: Gianluca Ferrato, Michele Radice, Silvana de Santis, la dotatissima Silvia di Stefano. Maurizio Porro CABARET regia di Saverio Marconi Teatro della Luna di Milano (grazie agli extra) C on i suoi ventun film in quarantatrè anni (finora), James Bond è probabilmente il personaggio cinematografico più longevo. E anche uno di quelli che sono passati attraverso più volti — sei, da Connery a Craig — senza mai perdere i favori del pubblico (se si esclude la parentesi di Lazenby e Al servizio segreto di sua maestà). Inevitabile che Fox e Mgm, proprietarie dei diritti di sfruttamento dei film, decidessero di investire su questo loro «tesoro» rieditando e restaurando tutti i primi venti film. Ne è uscita The Best Edition, dove ogni titolo, acquistabile separatamente, è corredato da un dischetto di extra. E per una volta cominciamo proprio da questi complementi perché il lavoro di John Cork, a cui si deve sostanzialmente la selezione e l’organizzazione del materiale extra, è stato davvero eccellente. Ci sono curiosità giornalistiche, come i filmati delle prime di gala dei vari film, oppure «imperdibili» chicche, come l’intervista (allegata al dvd di Licenza di uccidere) a un esperto di pistole, Geoffrey Boothroyd, che spiegò a Fleming perché Bond doveva lasciare la Beretta per la Walther Pkk. Ma la vera novità è nella sezione Terence Young «007 controllo missione» do007 LICENZA DI ve il film viene dissezionato UCCIDERE (Fox-Mgm) in tutte le sue componenti — donne, alleati, cattivi, combattimenti, gadget, paesaggi esotici — e offerto in pillole al fan, che in questo modo ha sottomano tutte le scene che si riferiscono a questo o a quel personaggio. Inutile sottolineare, poi, l’ampiezza dei commenti e dei dietro le quinte, che crescono in maniera quasi espoGuy Hamilton nenziale con la vicinanza cro007 VIVI E LASCIA nologica delle produzioni, olMORIRE (Fox-Mgm) tre alla ricchezza di trailer originali, spot televisivi e radiofonici, materiali fotografici vari e alle notizie contenute in un libretto allegato a ciascun film: tutti elementi che, insieme a un restauro digitale di ottimo livello (e a una traccia DTS Digital Surround per tutti e venti i titoli), consigliano «caldamente» l’acquisto della serie indipendentemente dal fascino che esercita il mito di Bond. Che naturalmente finisce per uscirne ancora una volta ingigantito e attualizzato. Resterebbero da spiegare le ragioni del successo di questo mito, nato nella fantasia di Fleming come risposta britannica alla supremazia tecnologica americana ma ben presto diventato molto altro: una specie di archetipo ideale del maschio occidentale, elegante e colto quanto virile e muscolare, impeccabile nel gusto (i suoi modi, i suoi vestiti, le sue «ricette») e imbattibile nell’azione, ultima — per ora — incarnazione di quel tipo d’uomo con cui in molti (di entrambi i sessi) vorrebbero almeno una volta intrecciare il destino. Paolo Mereghetti Dischi JAZZ SONNY, PLEASE COLONNE SONORE DREAMGIRLS Sonny Rollins, 75 anni e un sax ancora turbolento Dalla vera storia di Diana Ross Quasi un festival a Lugano: Bloc Party alla controprova anche tre canzoni da Oscar nomi noti e giovani promesse dentro il caos metropolitano Avevamo lasciato «saxophone colossus» all’indomani del tragico attentato alle Torri Gemelle: Without a Song, uscito poco più di un anno fa, riprendeva un pensoso concerto di pochi giorni successivo. Sonny, Please, registrato in tre diverse date a cavallo fra 2005 e 2006, è piuttosto diverso. A 75 anni suonati Sonny Rollins ha ancora voglia di creare con il suo sassofono tenore ritmi turbolenti, linee melodiche danzanti, sonorità brumose di gran fascino. Affiancato dai soliti accompagnatori un po’ routinieri, fra i quali Clifton Anderson al trombone e Bobby Broom alla chitarra, il gran vecchio torna su un paio di cavalli di battaglia (Someday I’ll Find You e Stairway to the Stars), ripesca addirittura la «Serenata» dai Milioni d’Arlecchino dell’ottocentesco Riccardo Drigo e dà il meglio di sé nell’incalzante brano che intitola l’album e nel solare, Sonny Rollins pacificato calypso Park Palace Parade. SONNY, PLEASE Claudio Sessa (Doxy) Dreamgirls è la trasposizione cinematografica dell’omonimo musical di Broadway che racconta, tra anni ’60 e fine ’70, storia, vita e carriera del gruppo musicale «The Dreamettes» composto da 3 giovani cantanti di colore. In realtà ricalca la vera storia di Diana Ross e The Supremes. Tre canzoni di questo album-colonna sonora sono in nomination per l’Oscar: Listen (cantata da una travolgente Beyonce), Love You I Do (Jennifer Hudson), Patience (Eddie Murphy, Keith Robinson & Anika Noni Rose) nella categoria miglior brano originale di colonna sonora. Curiosamente in un contesto in cui la disco music fa la parte del leone sono in nomination canzoni romantico-melodiche nelle quali la ritmica ha un ruolo secondario. Questa è, evidentemente, musica che piace a quelli del cinema e non a quelli della musica: tant’è che canzoni e artisti di DreamgirAutori Vari ls sono ignorati nelle nomination dei Grammy l’11 febbraio. DREAMGIRLS Mario Luzzatto Fegiz (Sony BMG) PROGETTI MARTHA ARGERICH Da qualche anno a questa parte Martha Argerich riunisce attorno a sé, d’estate a Lugano, amici musicisti e una nidiata di sicuri talenti di domani. Lo scopo è di far musica insieme ma in uno spirito audace e festoso che se da un lato non si sottrae al giudizio del pubblico, dall’altro conserva tratti d’estemporaneità e improvvisazione. In ciò consiste il «Progetto Argerich», dell’ultima edizione del quale reca traccia il presente, prezioso cofanetto di 5 cd, relativi ad altrettante serate, con un dvd in omaggio che mostra sessioni di prova e il bel clima che le attraversa. Nei programmi c’è di tutto: gli immancabili Mozart e Sciostakovic (era giugno 2006) ma anche rarità di Gulda, Schnittke e Taneev in formato sia cameristico sia sinfonico. Con la geniale padrona di casa, l’elenco degli interpreti annovera tra gli altri i fratelli Capuçon, Vedernikov, Maisky, Zilberstein e Autori Vari giovani sulla rampa di lancio coPROGETTO MARTHA ARGERICH me Tiempo, Montero e Vallina. E. Gir. LUGANO FESTIVAL 2006 (Emi) ROCK A WEEKEND IN THE CITY Pro e contro di un debutto straordinario: il successo e il plotone di invidiosi pronti a impallinare il secondo lavoro. Per evitare il lato negativo c’è chi cambia strada e spiazza critica e pubblico chiedendogli uno sforzo in più per entrare nelle canzoni. Pro e contro, questa volta, coincidono. E facciamolo questo sforzo. Senza fermarci a un primo ascolto perché «non sono più i Bloc Party di Silent Alarm». No che non lo sono. A Kele Okereke e soci è venuta meno quell’urgenza che aveva reso immediato il debutto. Ma in questi 51 minuti il loro indie rock ballerino si arricchisce di chitarre alla Muse (Song for Clay), sintetizzatori new wave o alla Killers per stare ai giorni nostri (Hunting for Witches), batterie campionata fra hip hop (The Prayer) e Radiohead (On). Attenzione ai testi. Che fotografano lucidamente il qui e adesso: la paura del diverso (Kele ha i genitori nigeriani), la droga che gira come acqua, il vuoto edonismo, i teenager omologati, l’amore gay. Con la consapevolezza, cantaBloc Party no in Uniform, che «il pop non cambia i governi». A WEEKEND IN THE CITY Andrea Laffranchi (Wichita/V2)
Scaricare