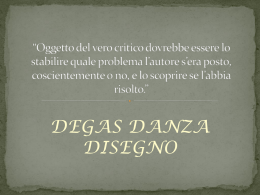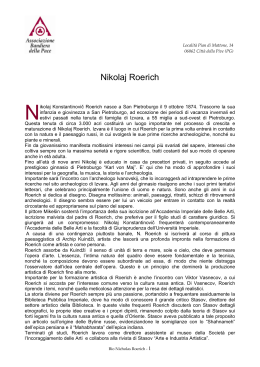S. Carandini, E. Vaccarino La generazione danzante L’arte del movimento in Europa nel primo Novecento Roma, Di Giacomo 1997 Loie Fuller di Silvia Carandini (pp. 61-69) Nel marzo 1892, a Parigi, sul palcoscenico delle Folies Bergère. l’esibizione di una giovane americana in alcuni spettacoli di danza, suscita un insolito interesse e clamore. Tutta l’intellighenzia parigina accorre per ammirare evanescenti figure - spirali, vortici, onde, fiamme, gigli - e gli straordinari effetti di luce, ritmo e colore, che la danzatrice viene producendo nel buio con ampi movimenti, un sapiente ondeggiamento di stoffe e un accurato gioco di riflettori. Loie Fuller (1861-1928) (18), proveniva dagli Stati Uniti e non aveva tradizionalmente studiato da ballerina. Sui palcoscenici del suo paese prima di approdare in Europa, si era lungamente esibita in modesti spettacoli di operette e vaudevilles. Anche nel corso di una prima tournée londinese ai Royal Theatre aveva vanamente tentato la fortuna come attrice. L’insuccesso l’aveva spinta a unirsi alla Gaiety Theater Company, a darsi una rapida formazione da ballerina, a cimentarsi nei passi della skirt dance, un ibrido Ira flamenco e can-can, molto di moda in quegli anni. Dalle movenze seduttive di un’ampia gonna che sollevandosi disvela il corpo, alla scoperta e messa a punto (di ritorno a New York) di un nuovo originale linguaggio di danza, il passaggio è notevole e fulmineo (19). Quello che nel 1891, forse casualmente - come romanzescamente racconta nella sua autobiografia - la Fuller sperimentava, era lo straordinario impatto sul pubblico di una scena in cui, quasi in ipnosi, la danzatrice su una musica particolare eseguiva un movimento a spirale. Del tutto scomparsa la sua figura, si sviluppava l’immagine fantastica di un vortice formato dai lembi sollevati di un’ ampia gonna multicolore illuminata da luce intensa. Grazie al movimento ritmico, la veste prendeva vita, dava forma visibile al ritmo, trattenendo la luce. Nasceva così la Danse Serpentine. Nasceva forse la prima scultura cinetica luminosa. La Fuller perfezionava da quel momento un primo “vocabolario” di gesti :e movimenti, metteva a punto l’impianto e la collocazione di luci colorate provenienti da diverse angolazioni, l’allestimento di uno spazio scenico drappeggiato di nero, l’abito di stoffe leggerissime trattenute alla vita o all’altezza del collo. Ordinava gli schemi di altri tre numeri di danza, La Violette, Le Papillon, XXX (una sorta di evocazione spiritica). Sempre ancora a New York. con spirito pratico e per salvaguardarsi dalle imitatrici che subito la perseguitano, pensa a brevettare la sua creazione, con minuzia fissa la partitura di tre quadri coreografici completi di indicazioni sulla musica, la scena, le luci colorate, i movimenti, le pause, le figure e le forme che nello spazio dovevano svilupparsi. Era la prima volta che per una coreografia veniva chiesto il copyright, soprattutto per una coreografia “astratta”, priva di narrazione. Quando poco dopo Loie Fuller tenterà di fare riconoscere i suoi diritti in una causa contro una imitatrice, sarà proprio l‘astrattezza del soggetto. la 18 19 La dizione Loïe con la dieresi è adottata nel francese per motivi di pronuncia, non è necessaria nella lingua inglese e italiana. Lo studio più documentato e recente su di lei è di G. LISTA. Loïe Fuller, Danseuse de la Belle Ėpoque. Paris, Stock. 1995. Importanti anche gli studi di F. KERMODE. Loie Fuller and the dance before Diaghilev, in «Theatre Arts», sept., 1962; S. R. SOMMER, Loie Fuller in «The Drama Review», 19, 1 mar. 1975; G. BRANDSTETTER, B. M. OCHAIM, Loïe Fuller. Tanz. Licht-Spiel. Art Nouveau, Freiburg, Rombach Verlag , 1989. mancanza di narratività, la fugacità delle forme presentate al pubblico a determinare un giudizio a lei contrario che peserà nel diritto americano fino addirittura al 1978, quando finalmente verrà riconosciuto lo statuto di prodotto artistico e quindi il diritto alla proprietà intellettuale per l’autore di una coreografia astratta (20). Nella educazione della giovane americana erano certo confluiti elementi vari della eterogenea cultura sviluppatasi nella seconda metà dell’Ottocento oltreoceano, motivi spiritualisti, neoplatonici, suggestioni dalla mistica orientale, dall’occultismo, temi tutti di quella “via” americana alla natura, alla rivalutazione del corpo, teorizzati dalla scuola trascendentalista di Emerson e di Thoreau, coltivati dai pittori luministi dell’Hudson River School. È possibile, anche se non documentato, un rapporto della Fuller con la fortunata filiazione americana della scuola di Delsarte, il teosofo francese che intorno alla metà dell’Ottocento aveva studiato i valori dell’espressività e della gestualità nell’uomo, aveva predicato il rapporto assoluto di anima e di corpo e proprio negli Stati Uniti, tramite l’opera di Steele MacKaye (1842-1894) e Genevieve Stebbins aveva visto divulgato il suo pensiero, applicato alle tecniche del corpo e della danza. In particolare la Stebbins, che proponeva i suoi esercizi di “ginnastica estetica” nel corso di matinées delsartiane a New York intorno al 1890, sembra anticipare la Fuller nel creare «i movimenti sulla base di quanto considerava essere il movimento fondamentale in natura, la curva a spirale o il moto ondoso a spirale, e sviluppare ciò che possiamo chiamare movimento spiraliforme di successione» (21) Quando nel 1892 approda nella capitale francese. Loie Fuller è alla ricerca di quel riconoscimento che solo la cultura europea a quel punto può tributarle. Si deve accontentare del palcoscenico delle Folies-Bergère, solo lì riesce a convincere il direttore del teatro, dove una sua imitatrice già l’aveva preceduta, a sottoporre al pubblico e alla critica l’arte originale della Danse Serpentine. il successo è immediato, strepitoso, tutta l’intellighenzia parigina si precipita a vedere lo spettacolo. Dalle tavole di un popolare teatro di varietà, la meraviglia poetica e tecnologica di quel corpo di donna - corpo grassottello e non particolarmente aggraziato - trasfigurato e mutato in puro movimento di luce sapientemente schermata dai veli e misteriosamente colorata dai riflettori, sembra traboccare da allora e moltiplicarsi nei più diversi linguaggi della letteratura e dell’arte. Poeti, letterati, pittori, disegnatori, scultori, architetti, fanno di lei e della sua danza l’emblema di una ricerca artistica tesa a esplorare inedite soluzioni formali e modalità percettive, a prefigurare nuove coordinate dell’esperienza artistica nel tempo e nello spazio: uno spazio privato di riferimenti geometrici e indicatori materiali, un tempo interiorizzato, percepibile al limite come bergsoniana “durata”. Il momento della percezione si fa centrale nel processo creativo e nell’esperienza intima di chi guarda e ascolta. Il modello è quello della fruizione musicale e della libera associazione di immagini osservabile in una réverie fantastica. I primi manifesti di Bac, di Choubrac, di Cheret, di Pal, con efficacissima tecnica grafica e pubblicitaria, iniziano a diffondere l’immagine dinamica della danzatrice col velo, della donnafiore, farfalla, vortice, onda, fiamma. Apice di questa vera e propria operazione critica è il celebre manifesto di Toulouse-Lautrec del 1893. Lo spazio scenico nell’incisione tirata con diverse prove di colore, spruzzate con polvere d’oro e d’argento risulta indefinito, una buca fonda e oscura è trasversalmente tagliata da un pulviscolo di luce, il primo piano ancora più in ombra accenna a uno strumento dell’orchestra, a mezz’aria si libra la silhouette fantastica della danzatrice, un puro segno di luce colorata, solo la testa e i piedi riconoscibili, abbandonati nell’attimo supremo della sospensione, della visione estatica. Numerosi altri artisti si dedicheranno in seguito a fermare sulla carta, nella creta, nel bronzo, nel marmo, in ceramica, su lastra fotografica, in oggetti di arredo, l’essenza inafferrabile della danza di Loie Fuller. - 20 21 - G. LISTA, Loïe Fuller…, cit., pp. 94-96. N. L. RUYTER, Genevieve Stebbins teorica, educatrice, artista della scena, in E. RANDL a cura di, François Delvarte… cit., p. 96. Era stata la Stebbins a pubblicare The Dl/sarte System of Expression, 6ª ed. New York 1902. Diverse imitatrici aggiungono le loro performances e le loro immagini a questa vera e propria inondazione di figurine aeree e danzanti. Alcune di loro furono anche riprese su pellicola, mentre non si conoscono immagini fumate di Loie Fuller (22) Ecco allora farfalle, gigli, viole, fiamme, onde, ragnatele, conchiglie, figure evocate dalla danzatrice, ma molto più “alla lettera” assunte dai suoi esegeti e “interpreti” quali metafore atte a fissare l’ineffabile magia delle forme in movimento. Ecco soprattutto vortici, grandi calici, arabeschi e geroglifici di linee e di colori, parvenze fantasmatiche, segni luminosi, ritmicamente apparire e sparire in uno spazio nero e indefinito: forme primigenie e astratte, volumi pura- menti virtuali che la danzatrice sprigiona, con «matematica precisione» (sono parole di Mallarmé) manovrando stoffe, proiettori, gelatine colorate. Spettatore d’eccezione alle Folies-Bergère è proprio Stéphane Mallarmé. Il balletto era già stato, come abbiamo visto, uno dei generi preferiti del nume tutelare del movimento simbolista, anche prima di assistere alla Danse Serpentine della Fuller. Le intuizioni sulla natura impersonale della ballerina, sul potenziale emotivo delle forme essenziali che la danza disegna nello spazio, tali da aderire «alla nostra nudità spirituale», trovano piena attuazione nello spettacolo offerto dalla danzatrice americana nel 1892. La prosa densa, criptica, evocativa del poeta sembra allora pienamente cogliere per intima adesione della scrittura - una scrittura analogica, appunto, che danza i procedimenti artistici della Fuller: - Quando all’alzarsi del sipario, in una serata di gaia a locale esaurito la danzatrice appare con furia come fiocco di neve, venuto da dove? L’impiantito schivato per salti o duro alle punte, acquista una verginità di sito non sognato, che isola, edificando, fiorendo, la figura. La scena giace, latente nell’orchestra, tesoro di immaginazioni; per venir fuori, a lampi, secondo la visione che la rappresentante dell’idea qua e là dispensa alla ribalta. Ora questo trapasso di sonorità ai tessuti (cosa più di una garza somigliante alla Musica), unicamente, è il sortilegio che opera la Loie Fuller, per istinto tramite l’esagerazione... L’incantatrice crea l’ambiente, lo estrae da sé e lo rientra in un silenzio che palpita di carta crespa [...] (23) Con acutezza inoltre, Mallarmé il quale resterà ovviamente del tutto deluso dall’incontro personale con la Fuller coglie nella esibizione di lei alle Folies Bergère l’effetto spirituale che risiede tutto in quella «effusione delle vesti» e nella danza «tanto ampia e possente da sostenerle all’infinito, quali sue espansioni». Il segreto del fascino, sembra di capire, consiste in fin dei conti in quella presenza-assenza della persona e quindi nella universalizzazione dell’«anima» dello spettatore, grazie alla negazione del corpo dell’interprete. La danzatrice diventa allora il paradigma della vagheggiata confusione di soggetto e oggetto, i suoi movimenti, privi di logica e di coerenza, paiono ritmici e mobili, generatori di immagini e di idee, in tutto simili alle produzioni interiori della mente (24). Intuisce inoltre il poeta, la modernità di un fare artistico che su un procedimento tecnico-riproduttivo fonda l’interpretazione del reale, dato che l’«esercizio» di Loie Fuller comporta ai suoi occhi «un’ebrezza d’arte e simultaneamente, una compiutezza industriale». «Ebrezza d’arte» unita .a «compiutezza industriale», la formula sembra oggi una efficace definizione delle novità che la Fuller introduce nella danza (ne specifica i legami con l’Art Nouveau). A Parigi Loie Fuller, dopo i primi successi, instancabilmente prosegue nella ricerca artistica e nella sperimentazione tecnica, sceglie temi nuovi e inedite suggestioni per le sue danze, cerca ancora di perfezionare l’uso di dispositivi e materiali sulla scena, sempre tentando di sfruttare i ritrovati nuovi della scienza e dell’industria («ebrezza d’arte» appunto e «compiutezza industriale»). Nuovi titoli delle sue danze: La Danse Bianche, La Danse de l’Archange, Le Firmament, La Danse des Nuages, La Danse du Lys, La Danse du Feu, La Danse du Miroir, La Danse Phosphorescente, La Danse Ultraviolette. La scelta delle immagini-guida, anche nei titoli, appare dettata da un’esigenza progressiva di smaterializzazione e astrazione, sembra liberarsi dei riferimenti - - 22 Si veda per tutta questa produzione il ricchissimo apparato illustrativo nello studio di G. LISTA, Loie Fuller..., cit. S. MALLARME, Autre étude de danse. Lesfonds dans le ballet (1893, in S. CARANDINI, La melagrana..., cit., p. 27). 24 Si veda in proposito lo studio di E. GOULD, Virtual theatre, from Diderot to Mallarmé, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1989, pp. 141-177 23 iconografici Art Nouveau privilegiando gli effetti luministici, cromatici e cinetici, spesso riferibili a fenomeni della natura. Nelle prime realizzazioni gli stimoli percettivi sollecitati rimandano all’esperienza diffusa della lanterna magica, delle vedute ottiche, dei diorami, dei panorami, di tutti quegli spettacoli fondati su fenomeni di proiezione e decomposizione della luce su uno schermo, in uno spazio oscuro (25). Nel movimento di danza però lo schermo costituito dai veli diventa mobile, mentre la luce viene opportunamente diretta e regolata. La componente cinetica rinvia inoltre ovviamente alle precorritrici sperimentazioni di Muybridge e di Marey, agli studi su uomini e animali in moto del primo e alle cronofotografie del secondo. I volumi virtuali che la Fuller magicamente crea con il concorso dei veli e della luce nel buio della scena sono illusioni ottiche, prodotte da un movimento ritmico e continuo che sfrutta le modalità percettive dell’occhio umano, il tempo mentale di integrazione visiva delle immagini. Il cinematografo è alle porte, è del 1895 il primo film dei fratelli Lumière. Altri procedimenti, altre invenzioni brevetta quindi la Fuller: un dispositivo di illuminazione dal basso sotto il palcoscenico con una lastra di vetro sul pavimento, una piattaforma rialzata per librarsi a mezz’aria. Inventa quinte e fondali di specchio per moltiplicare la sua immagine, vetri sfaccettati sui fondali per rifrangere con maggiore efficacia la luce, pertiche sempre più lunghe per muovere i veli, tinture fosforescenti per gli abiti, gelatine colorate e “trasparenti” figurati sovrapposti ai potenti riflettori (26). Interpella anche i Curie pensando di sfruttare la radioattività! È in contatto con scienziati, astronomi, teosofi, e ovviamente sempre artisti e uomini di lettere. Suo sogno irrealizzato è farsi ritrarre da Rodin mentre danza…(27) Con la consacrazione all’Exposition Universelle parigina del 1900, e il teatro-museo a lei dedicato sormontato da una statua-ritratto di Pierre Roche, colta la Fuller nello slancio dei veli (tutta la facciata dell’edificio è un velo-sipario palpitante), inizia per la danzatrice anche l’attività di organizzatrice teatrale e di impresario. Presenta al pubblico parigino l’attrice giapponese Sada Yacco con la sua troupe, adatta per lei un testo (La Geisha et le chevalier) e inserisce l’esotica rappresentazione nel suo spettacolo creando effetti suggestivi di contrappunto (28). Convince Isadora Duncan a seguirla in una poco fortunata tournée in Germania. Quindi apre una scuola per giovani allieve, realizza spettacoli con loro sempre servendosi della luce, della danza, dei veli e introducendo forti contrasti di ombre proiettate. Gira un fallimentare ma interessante film d’arte (Le Lys de la vie, protagonista il futuro regista René Clair). Fra le sue più tarde realizzazioni, divenuta principalmente coreografa e scenografa di luci, significativi due spettacoli: nel 1914 al Théâtre du Châtelet i tre balletti Acier (musica di Florent Schmitt), Promethée (musica di Skrjabin) e Feu d’artifice (musica di Stravinskij). Fra gli spettatori più attenti, Sergej Djagilev, si ricorderà di quest’ultimo brano quando nel 1917 a Roma affiderà a Giacomo Balla la realizzazione scenica della stessa partitura. Nel 1924 per le Soirées de Paris del Conte di Beaumont, sono opera della Fuller le proiezioni luminose per Mouchoir de nuages di Tristan Tzara, nel corso dello spettacolo coreografico comprendente Mercure (di Mjasin, Satie, Picasso). Si tratta di una tragedia in 15 atti, ognuno dominato da una tonalità di colore, il luogo dell’azione di volta in volta indicato da ingrandimenti di cartoline illustrate. Il velo-schermo della Fuller, nell’invenzione dadaista di Tzara, si muta nell’atto finale in poetico “mouchoir de nuages”, fazzoletto di nubi, sipario poetico dell’oblio (29) In Italia Loie Fuller si reca in tournée nel 1902, ma molti artisti già l’avevano vista a Parigi. È amica del conte Primoli che la fotografa, conosce D’Annunzio, è ammirata da Gian Piero Lucini, 25 S. BORDINI, Storia del panorama. La visione totale nella pittura del IX secolo, Roma, 1984. Vedi G. LISTA, Loie Fuller..., cit., p.152-168 27 H. PINET, Rodin e le danzatrici, in E. CASINI ROPA, a cura di, Alle origini..., cit., pp. 255-267 28 . In anni successivi presenta anche la danzatrice giapponese Hanako particolarmente ammirata da Rodin. Si veda O. LISTA, Loie Fuller..., cit, pp. 36 1-380; C. GOLDSCHEIDER, Rodin et la danse, in «Art de France», 1963; N. SAVARESE, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Bari, Laterza, 1992, pp.30l-332. 29 Scrive Tzara riguardo alla collaborazione della Fuller: «Non voglio nascondere agli spettatori che ciò che vedono è teatro. Per questo gli elettricisti di Miss Fuller stanno in scena con i loro riflettori e il macchinista srotola la scena davanti a tutti», in T. TZARA, Oeuvres complètes, a cura di H. BÉHAR, I, Paris, Flammarion, 1975, pp.303-35l, 689. Tralascio qui, ovviamente per questioni di spazio, i numerosi prestiti dall’esperienza della Fuller alle avanguardie soprattutto francesi e tedesche 26 Orio Vergani, suggestiona Mariano Fortuny, Achille Ricciardi che tenterà con poco successo nel 1920 di realizzare un Teatro del Colore a Roma con Prampolini. Troppo note le ricerche e le realizzazioni di futuristi che all’esperienza della Fuller si possono ricollegare. Pensiamo all’ammirazione di Marinetti proclamata nel Manifesto della danza futurista (1917), ricordiamo opere di Balia e di Boccioni su dinamismi di luce e di colore che a lei si ricollegano, la sintesi Colori (1916) di Depero, il manifesto Scenografia e coreografia futurista (1915) di Prampolini che poi colloca la Fuller fra le «annunziatrici del nuovo verbo danzante» (30) Ricordiamo le fotodinamiche di Anton Giulio Bragaglia, l’esperimento di “musica dei colori” progettato (19101912) per “pianoforte cromatico” da Arnaldo Ginna e Bruno Corra, considerato la genesi del cinema astratto. Più recentemente, ancora artisti e danzatori hanno ripreso la direzione indicata dalla danzatrice americana (31). Nel 1908 la Fuller pubblica a Parigi presso la Librairie Félix Juven la sua autobiografia Quinze ans de ma vie (32) con prefazione di Anatole France. Nel racconto di Loie i momenti cruciali della sua vita artistica assumono aspetti fiabeschi e avventurosi, il grande impegno e la faticosa ricerca sembrano annullarsi dietro intuizioni improvvise, felici aneddoti, episodi rivelatori. Qui riportiamo parte dei capitoli quinto e sesto. Nel primo è descritto l’arrivo a Parigi e la suggestiva conquista del successo. Nel secondo invece la danzatrice tenta con discorso più teorico di analizzare le componenti innovative dell’esperienza condotta. Nel mettere a fuoco le sue concezioni sull’essenza della danza, sulle funzioni del colore, del movimento, della musica, della visione, giunge a definire un interessante concetto di “tranche de vie” emotiva manifestabile tramite la danza. Quanto alla sua opera più creativa, Loie Fuller conia la definizione di: «un aggregato di luce, di colore, di musica e di danza». Nel suo lungo percorso, la traiettoria della Fuller anticipa e attraversa le più avanzate ricerche artistiche del suo tempo. Con ingenuità e competenza, la danzatrice raccoglie parole d’ordine, dà corpo a ideali e intuizioni, sperimenta un’ardita commistione di tecniche e linguaggi artistici. Bibliografia Essenziale AA.VV., Debussy e il simbolismo, catalogo della mostra, Accademia di Francia, Roma, Palombi, 1984 G. BRANDSTETTER, B. M. OCHAIM, Loie Fuller Tanz. Licht-Spiel. Art Nouveau, Freiburg, Verlag Rombach, 1989 S. CARANDINI, La danzatrice è una metafora. Poesia del corpo e composizione dello spazio nella danza di Loie Fuller in L’astrazione danzata. Le arti del primo Novecento e lo spettacolo di danza, «Ricerche di Storia dell’Arte», n. 58, 1996 H. HAILE, Loie Fuller: Magician of light, Richmond, Editions Virginia Museum, 1979 F. KERMODE, Loie Fuller and the dance before Diaghilev, in «Theatre Arts», september 1962 E LE COZ, Le Mouvement: Loie Fuller in «Photographies», n. 7, maggio 1985 G. LISTA, Loïe Fuller Danseuse de la Belle Époque, Paris, Stock, 1995 P. PACINI, Gino Severini, l’unanimismo di Jules Romains e le danze cromatiche di Loie Fuller, in «Antichità viva», Firenze, Cantini, 1990 S. R. SOMMER, Loie Fuller in «The Drama Review», marzo1975 S. R. SOMMER, Loie Fuller’s Art of Music and Light, in «Dance Chronicles» IV, marzo 1982 30 Si veda più avanti, nello stesso volume, pp. 417-424 e inoltre: G. P. LUCINI, La Danse sacrée (Loie Fu11er, in «Poesia», 3, 1908; E. PRAMPOLINI, L’arte del gesto e del movimento, in «2000», I, 2; A. G. BRAGAGLIA, Loie Fuller, in Jazz Band, Milano, Corbaccio, 1929. 31 Riconoscendo il suo influsso, a partire dagli anni cinquanta, in particolare Alwin Nikolais, Meredith Monk, Bob Wilson, gli artisti Bruce Nauman e di recente Brygida Maria Ochaim, una danzatrice impegnata nella ricostruzione degli spettacoli della Fuller. 32 Una prima traduzione inglese esce a Londra nel 1913, Ftfteen Years of a Dancer’s Lfe, Editions Herbert Jenkins, la più recente è edita a New York da Dance Horizons. Isadora Duncan di Silvia Carandini (pp. 77-83) Dopo Loie Fuller, ancora una americana approda a Parigi agli inizi del secolo. Parigi è anche per Isadora Duncan (1878-1927), giovane danzatrice californiana, la meta ambìta da raggiungere, il crocevia delle arti, la scena più rappresentativa su cui esibire le primizie di un’arte nuova faticosamente maturata oltreoceano, la platea più qualificata da cui ottenere un riconoscimento. A differenza però di Loie Fuller che sceglie Parigi come base e che, pur con numerosi spostamenti, vi si stabilisce, la vita artistica di Isadora Duncan sarà molto più movimentata e inquieta, si svolgerà come un percorso erratico fra diversi paesi europei, compresa la Russia, compresa la Grecia, di volta in volta stabilendosi dove i suoi progetti sembrano potersi realizzare. I suoi stessi ripetuti viaggi negli Stati Uniti saranno in genere molto più che semplici tournées. Sempre comunque la Francia sarà per lei una seconda patria e Parigi costituirà il punto di riferimento fondamentale, un luogo dove tornare, dove raccogliere nuovi trionfi, dove tentare di impiantare il suo progetto più tenace, quello che costituirà per la danzatrice il vero scopo della sua carriera e della sua arte: far vivere stabilmente una scuola, portare avanti con costanza un preciso progetto pedagogico, un sogno, un’utopia sociale. Allevare generazioni di bambine e bambini con la speranza che fra essi possa un giorno sorgere la Danzatrice del Futuro, possano crescere uomini e donne di una nuova società. Isadora Duncan era nata a San Francisco. Cresciuta con i tre fratelli in un clima di grande libertà e di fervore artistico-musicale, si era fin da piccola nutrita dei principi di una religione naturale e di uno spirito rivoluzionario di frontiera tipici della giovane America cantata da Walt Whitman, nel solco di quella “via” americana alla natura e alla rivalutazione del corpo già citata a proposito di Loie Fuller. Racconterà nella sua biografia My life, pubblicata nel 1927 (33), di aver danzato da sempre, come un modo istintivo di esprimersi, di pregare e di comunicare; insieme alla sorella e alla madre di aver fin da piccola organizzato corsi di danza elaborando un iniziale “sistema” basato sulla spontaneità e libertà dei movimenti. Si era quindi spostata verso la costa orientale, aveva cercato fortuna a Chicago e New York. Aveva lavorato senza entusiasmo per modesti impresari, era venuta elaborando per sé un modello di esibizione artistica in forma di “concerto” che propone nei salotti newyorkesi, con movimenti di danza, musica e letture di poesia, un genere assai vicino alle performance della scuola delsartiana di Genevieve Stebbins di cui abbiamo parlato anche a proposito della formazione di Loie Fuller. Un miscuglio di ingenuità e verginità culturale, di aspirazioni panteistiche, di apertura verso altre tradizioni, di disinvolto approccio alle poetiche e teoriche artistiche europee, una disponibilità a recepire le nuove conquiste della scienza e della tecnica, costituiscono certo il fascino che in questi anni a cavallo del secolo queste giovani americane importano in Europa. Specialiste del corpo in movimento e coreografe di se stesse, si esibiscono in performance soliste, teorizzano una nuova “filosofia della danza” destinata a influenzare l’intero sistema europeo delle arti. Ricevono in questi anni una prima elaborazione alcuni temi principali dell’arte della Duncan: il culto per la natura, la passione per l’antica Grecia, l’attrazione per l’universo filosofico di Platone e il pensiero di Schopenhauer, l’interesse per l’ideale pedagogico tracciato nell’Emile di Rousseau. Si precisano le caratteristiche della sua danza: rifiutati gli stilemi ballettistici, passi semplici a piedi nudi, il corpo libero, una leggera tunica come veste, una musica capace di stimolare il ritmico fluire dei movimenti, uno spazio naturale privo di riferimenti illusivi, il corpo danzante in grado di evocare immagini pittoriche o scultoree. L’avventura europea della famiglia Duncan (la seguono con esaltazione la madre, il fratello e una sorella) inizia a Londra nel 1898, poi, come si è detto a Parigi, proprio a cavallo del secolo. Prosegue Isadora al seguito di Loie Fuller, sua prima protettrice, a Berlino e a Vienna, quindi, ormai 33 I. DUNCAN, My Life, trad it. La mia vita, Milano, Savelli, 1980; V. SEROFF, Isadora Duncan, Milano, Dall’Oglio, 1974. artista autonoma, in Ungheria, a Monaco, a Firenze, in Grecia, a Mosca... Raccoglie nelle città che attraversa i primi trionfi esibendo le sue insolite performance, sempre danzando a piedi nudi, sempre con la sua tunica leggera, sempre la scena allestita con quei semplici tendaggi blu che tanto piaceranno a Craig. Negli spostamenti della danzatrice, i grandi musei sono le mete più frequentate dove abbeverarsi al grande repertorio di immagini e di forme della civiltà europea, prima di tutte quelle dell’antica Grecia, ma anche Botticelli (la Primavera a Firenze) e la pittura rinascimentale, anche la recente produzione preraffaellita. A teatro, sono i grandi attori del tempo che colpiscono la giovane americana, Ellen Terry, la madre di Gordon Craig, Eleonora Duse, Mounet-Sully, acclamato interprete tragico nella parte di Edipo. La musica di Wagner, le teorie di Nietzsche - «il filosofo che danza» - sembrano più di tutto avvincere la giovane americana. Nel 1904 la Duncan compie con i fratelli il lungo pellegrinaggio in Grecia, poi danza il Baccanale del Tannhauser a Bayreuth per Cosima Wagner, nel 1905 è per la prima volta a Mosca dove conosce Mamontov, Djagilev, la Paviova e la Karsavina (danzatrici che sinceramente ammira malgrado la «deformazione» professionale che segna il loro corpo e la loro arte). Incontra Craig a Berlino e inizia con il grande uomo di teatro un’importante relazione di vita e d’arte, conosce con lui la Duse. Craig serberà un ricordo incancellabile del primo incontro, ne scriverà anni dopo una testimonianza ancora piena di emozione, che qui riportiamo. Nel 1908 Isadora torna in America e danza a Broadway. Nel 1909 con l’organizzazione di Lugné-Poe ottiene nuovi trionfi a Parigi. Incontra Gabriele D’Annunzio, compie un altro viaggio a Mosca. I primi gravi lutti giungono a colpirla con la morte dei suoi bambini in un incidente automobilistico. Incontra Rudolf Laban a Monte Verità... Da questa profonda, un po’ invasata immersione nella cultura occidentale più antica e moderna, dalla continua pratica e sperimentazione, Isadora trae linfa abbondante per perfezionare, più che il suo modello di danza che sostanzialmente non muta, le idee che intende sostenere e propagandare, in particolare il progetto pedagogico che diventa parte imprescindibile del suo credo artistico. Numerosi scritti, brevi saggi per riviste, testi per conferenze o discorsi che spesso accompagnano le sue esibizioni, frammenti manoscritti, appunti su quaderni di studio testimoniano del suo pensiero e della sua idea di danza in questo periodo. Mai in modo sistematico, spesso ripresi ed elaborati, alcuni temi emergono insistentemente, vere parole d’ordine che creano un sottofondo efficace di immagini e di metafore alla riflessione della danzatrice e alla sua arte. Spesso comunque cosciente, la grande Isadora, che «per spiegare la danza è molto meglio danzare che pubblicare saggi e trattati» (34). Predominante, come abbiamo visto, quasi un’ossessione nel pensiero della giovane americana, diventa l’armonioso modello greco di bellezza, le linee fluenti dei corpi danzanti riprodotti sulle concave superfici dei vasi, lo spazio evocatore degli antichi teatri dell’Ellade religiosamente visitati e praticati nel corso del 1904, quando trascorre un anno in quel paese. La bellezza del corpo nudo e naturale, il corpo umano inteso come suprema opera d’arte vivente, la funzione religiosa e drammatica della danza nel teatro greco, sono questi gli stimoli principali che Isadora viene elaborando negli anni più maturi. Il coro tragico nella drammaturgia ateniese, le sue funzioni espressive, l’empito dionisiaco, la musica che lo accompagna, i movimenti che compie nell’orchestra, sono per lei l’idea guida, l’inarrivabile modello da far rivivere, superando i travisamenti e le impasses in cui, a suo giudizio, a partire da Monteverdi fino a Wagner la drammaturgia musicale europea si era dibattuta. Il tempio-scuola che tenta di costruire a Kopanòs, vicino ad Atene, il coro di ragazzi greci che su musiche bizantine fa danzare e cantare nelle Supplici dì Eschilo, ad Atene prima, poi in una difficile tournée a Vienna, Berlino e Monaco, sono il tentativo (in parte fallito) di avvicinarsi a questo ideale. Il movimento tipico del coreuta con la testa 34 La grande sorgente, 1911, in I. DUNCAN, Lettere dalla danza, Firenze, La Casa Usher, 1980, titolo orig. The art of dance, New York, Theatre Arts Books, 1969. rovesciata indietro in un moto di frenesia dionisiaca è uno degli atteggiamenti che predilige, più volte riprodotto in disegni e fotografie. Il tema della natura, quindi, tema congeniale alle sue matrici culturali in patria, è l’altra grande fonte di ispirazione, un fecondo serbatoio di immagini per i “discorsi” che la Duncan viene maturando sull’arte. Le forme mobili del mare, delle onde, del vento, il moto ritmico e ininterrotto degli elementi terrestri, armoniosamente regolato dalla forza di gravità, costituiscono il principio che fonda la sua riflessione sul movimento: il movimento di tutta la natura mostrato nel corpo mobile che danza. In questa direzione si precisa il tema della bellezza del corpo umano, di quello femminile in particolare, liberato dalle costrizioni e gli eccessi della civilizzazione; nel caso della danzatrice, liberato dalle imposizioni deformanti di una tecnica ormai fine a se stessa. «Danzare il corpo che risorge dopo secoli di oblio civilizzato» proclama Isadora, danzare in forma di donna: «dateci di nuovo la gioia di vedere il corpo semplice, inconsapevole e puro della donna...» (35) I movimenti della danza diventano quindi il segno e lo strumento di una liberazione che da fisica e prevalentemente estetica diventerà anche sociale. Tenderanno, tali movimenti, a mimare la natura nella sua attività creatrice e vitale, a esprimere la bellezza della forma umana, a valorizzare le componenti “spirituali” del corpo liberato. Tenderanno a sgorgare quale spontanea effusione di forze interiori, a riconquistare il linguaggio primigenio del corpo in grado di esprimere quel sostrato emozionale della psiche, dalla Duncan paragonato alla forza gravitazionale che in natura regola gli elementi. Il centro motore ditale espressività è individuato nella metà superiore del corpo, nel plesso solare. Da qui, in quasi religiosa concentrazione, parte la ricerca interiore che porta il corpo a ritrovare i movimenti fondamentali in grado di esprimere le esperienze spirituali ed emotive e a trasmetterle al pubblico, a renderlo partecipe della straordinaria esperienza di «veder muovere un’anima». Un tale processo si attua, nella visione della Duncan, non tramite un metodo (diffida di tutti i metodi, quello di Dalcroze in particolare), si sviluppa per istinto naturale, tramite concentrazione. Usa curiosamente in proposito una metafora modernista che paradossalmente sarebbe piaciuta a Marinetti: «l’emozione agisce come un motore, deve esser riscaldata per poter funzionare bene e il calore non si sviluppa subito ma gradualmente. Anche la danza segue questa legge di sviluppo e di gradualità» (36) Il fine di questa operazione, di ordine non certo meccanico, piuttosto alchemico, è trasmutare il corpo del danzatore in un «fluido luminoso». Nulla di più lontano dalla riflessione della danzatrice americana del culto della macchina. La ricerca del “bello” e del “naturale” costituiscono, negli ideali che esprime, motivi di decisa opposizione ai cammini per- corsi da coeve avanguardie. Opposizione alle tendenze dell’arte del primo Novecento centrate sulla mitologia della tecnica e dell’artificiale, sull’interesse per il primitivo, il mostruoso e il grottesco. Il culto per l’Ellade costituisce per Isadora un sicuro antidoto contro i nuovi apporti della civiltà industriale, in netta opposizione ai più barbarici miti primitivisti coltivati dal suo tempo sotto il segno del grande interesse per la cultura africana tributato da artisti e letterati, di una estetica “modernista” fondata sui principi della disarmonia e della difformità. Altro tema costante nella riflessione della Duncan riguarda lo statuto della danza, arte di pari dignità delle altre. Uno statuto da riconquistare dopo la lunga decadenza e mercificazione, un confronto da ristabilire con la pittura, la scultura, la musica in un rinverdito progetto di opera d’arte totale («io vorrei che musica, danza e dramma si unissero»). Vede le arti tutte congiunte intorno al coro in una nuova creazione realizzabile in un futuro prossimo, ma in un mondo nuovo ancora da edificare. Nella concezione della Duncan la musica sembra assumere la funzione di unificare le diverse forme artistiche, ma non tutti i generi musicali sono in grado di assolvere tale compito. Categoricamente escluso il genere più tipicamente ballettistico, la danzatrice privilegia la grande musica, da Gluck, a Beethoven, a Chopin, a Wagner, si interessa alle più recenti teorie di Skrjabin. Ma esclude gran parte della musica contemporanea, in parti colare quella di matrice africana, il jazz responsabile della degenerazione, a suo avviso, dei balli contemporanei come il charleston, accusati 35 36 I. DUNCAN, Lettere…, cit. p. 84. I. DUNCAN, Lettere..., cit, p. 96. di produrre effetti disarmonici e di risultare profondamente amorali. La scultura è vista invece come l’arte più affine alla danza, più vicina alla ricerca che vi si conduce per unificare in un tutto espressivo forma e movimento, per guardare alla danzatrice come a una scultura in carne ed ossa. Come tante utopie primonovecentesche, l’idea di una danza “vera” da creare e contrapporre al modello “falso” del presente, l’accento posto sull’Avvenire, su un “Danzatore del Futuro” in grado di padroneggiare il nuovo linguaggio del movimento, dell’emozione, del corpo trasformato in opera d’arte vivente, contiene una forte componente ideologica e pedagogica: «io intendo lavorare per questa danza del futuro» proclama già nel 1903 (37). Il progetto prevede di partire dall’educazione del fanciullo, dalle radici ancora incontaminate della gestualità umana, partire dal respiro stesso, per educare alla vita libera e naturale, a una più trasparente espressione dei sentimenti, a una vera e propria religione della danza. Idee tutte che malgrado i diversi e generosi tentativi di realizzazione, le numerose allieve cresciute nelle scuole che viene aprendo, restano nella Duncan piuttosto a livello di intuizioni, non saranno mai coerentemente sviluppate e codificate. Ricordiamo fra i tentativi avviati, nel 1905 la scuola di Grunewald vicino a Berlino, nel 1909 la scuola parigina di Beaulieu, un’altra scuola in Svizzera, fino, nel 1921, alla scuola impiantata a Mosca su invito del governo sovietico. Come per tanti artisti, la rivoluzione sovietica sembra per brevi anni aprire le porte dell’utopia, fornire un insperato campo di applicazione per teorie innovative. Le prime lettere di Isadora da Mosca nel ‘21 inneggiano al drago capita- lista vìnto dal forte eroe rivoluzionario, alla bellezza delle strade affollate come nell’Open Road di Walt Whitman, ai teatri gratuiti per tutti. Danza al Bol’oj sulle note dell’Internazionale, pare mandando in visibilio Lenin e provocando però la reazione parodica di Nikolaj Foregger, l’anno seguente nel corso di una delle sue parate-buffonate (38). Giungono dalla danzatrice americana a Mosca resoconti entusiasti di grandi raduni con centinaia di bambini danzanti nel campo sportivo, giovani guerrieri e amazzoni pronti a combattere per gli ideali del Nuovo Mondo. L’entusiasmo per i corpi all’unisono di giovani proletari educati alla ginnastica di parata appare sinistramente speculare alle motivazioni che di lì a poco indurranno un’altra danzatrice, Mary Wigman, a sovrintendere alle esibizioni giovanili promosse dalla dittatura nazista. Segue presto, dopo il 1923, per la Duncan la delusione, il taglio dei finanziamenti, i teatri che tornano a rispondere a criteri commerciali. Resta indomita la volontà e la speranza: «verrà il giorno in cui una grande scuola internazionale di fanciulli.., aprirà le porte del futuro ad una nuova umanità» (39). Un’automobile in corsa, nel 1927, una sciarpa avvolta al collo che si impiglia nelle ruote, troncheranno tanta instancabile attività, tanta carica progettuale, l’anelito innovatore di questa apostola della natura e del corpo libero che aveva attraversato tutte le controversie artistiche in perenne conflitto con i “tecnicismi” e le “disarmonie” della cultura industriale. Paradossale simbolo del suo tempo, Isadora Duncan doveva conoscere il fallimento dell’ideologia ugualitaristica e restare vittima della potenza distruttrice di una macchina. Biblio grafia Essenziale N. ADLER, Reconstructing the Dances of Isadora Duncan in the United States, in «The Drama Review», 28, 3, 1984 37 La danza del futuro, conferenza tenuta a Berlino nel 1903 e pubblicata lo stesso anno a Lipsia (Eugen Diederichs editore). Testo poi più volte rimaneggiato e ripubblicato. I. DUNCAN, Lettere ..., cit., pp.l8-29 38 Si veda più avanti, in questo volume, pp. 187-206. 39 I. DUNCAN, Mi chiedete di raccontarvi…, lettera del periodo 1921-27 inerente al progetto fallito di cuola in Unione Sovietica, scritta in francese, tradotta in Lettere…, cit., pp. 152-156. N. L. CHALFA RUYTER, Reformers and Visionaries: The Americanization of the Art of Dance, New York, Dance Horizons, 1979 (antologizzato in E. CASINI ROPA, a cura di, Alle origini della danza moderna, Bologna, il Mulino, 1990 A. DALY, Done into Dance, Isadora Duncan in America, Indiana Univerity Press, 1995 Irma DUNCAN, The Technique of Isadora Duncan, New York, Dance Horizons, 1970 I. DUNCAN, Lettere dalla danza, Firenze, La Casa Usher, 1980, titolo orig. The art of dance, New York, Theatre Arts Books, 1969 I. DUNCAN, My Life, trad it. La mia vita, Milano, Savelli, 1980 D. DUNCAN, C. PRATL, C. SPLATT, a cura di, Life into Art. Isadora Duncan and Her World, New York-London, W.W. Norton & Company, 1993 M. LEVER, Isadora, roman d’une vie, Paris, Editions Les Presses de la Renaissance, 1987 V. SEROFF, Isadora Duncan, Milano, Dall’Oglio, 1974 A. SWANSON, Isadora Duncan: à propos de son enseignement et de safihiation, in «La recherche en danse», 2, 1983 Le Sacre du Printemps di Nijinskij e Mjasin di Ada D’Adamo (pp. 101-113) Nella storia della danza del Novecento Le Sacre du Printemps costituisce un autentico “caso” (40) L’impatto che suscitò nel pubblico il giorno della prima (Parigi, Théatre des ChampsElysées, 29 maggio 1913) è stato paragonato allo scandalo dell’Hernani di Victor Hugo: se quest’ultimo nel 1830 apriva simbolicamente la via al romanticismo, quasi un secolo dopo il Sacre decretava l’ingresso della danza nella nuova epoca moderna. Vi confluivano la carica rivoluzionaria della musica composta da Igor Stravinskij e il genio di Vaclav Nijinskij (1889-1950), già danzatore leggendario dei Ballets Russes che, appena ventiquattrenne, ne concepiva la coreografia (la terza, in ordine di tempo, dopo L’Après-midi d’un Faune e Jeux e prima della sua ultima prova, Till Eulenspiegel). Ciò che preme qui evidenziare è l’assoluta modernità del lavoro di Nijinskij: una modernità a suo tempo incompresa ed oggi indubbia tanto da motivare la scelta di concentrare la nostra attenzione - nell’ampio e diversificato repertorio dei Ballets Russes - esclusivamente su questo titolo. Lungi dal voler mettere in discussione la ricchezza di stimoli che la fitta produzione legata ai Balletti Russi e ai suoi numerosi collaboratori tuttora suscita, molti sono i motivi che giustificano la scelta del Sacre come opera degna di studio approfondito e di analisi, a cominciare dalla sua storia singolare di balletto “perduto” (sparì dal repertorio della troupe dopo le sole nove rappresentazioni del 1913) e poi “ritrovato” dopo oltre settant’anni (grazie al lavoro decennale di due studiosi che nel 1987 ne hanno restituito una interessante ricostruzione) (41). Se la follia che portò Nijinskij ad abbandonare le scene ne consacrò definitivamente il mito, il primitivismo, il sacrificio e la morte, temi intorno a cui ruota il balletto, hanno fatto del Sacre un’opera la cui modernità continua a rinnovarsi nelle decine di versioni coreografiche esistenti, alcune delle quali dovute alle personalità più importanti della storia della danza internazionale: da Mary Wigman a Pina Bausch, da Martha Graharn a Maurice Béjart, da Leonid Mjasin ad Aurelio Milloss a Mats Ek e Paul Taylor. Il primo nucleo del balletto (il cui libretto reca la firma del compositore Stravinskij e del pittore Nicholas Roerich, autore anche delle scene e dei costumi) risale, secondo quanto racconta Stravinskij nella sua autobiografia, almeno al 1910, cioè all’epoca in cui egli stava ultimando la partitura dell’Oiseau de Feu a Pietroburgo: [...] un giorno intravvidi nella mia immaginazione lo spettacolo di un grande rito sacro pagano: i vecchi saggi seduti in cerchio che osservano la danza fino alla morte di una giovinetta che essi sacrificano per rendersi propizio il dio della primavera (42). Di quest’idea Stravinskij dice dì aver messo subito al corrente Nicholas Roerich, suo amico nonché pittore e specialista nell’evocazione del paganesimo. Anche Djagilev venne informato del progetto: in una lettera a lui indirizzata, Roerich così descrive il soggetto: Nel balletto così come lo abbiamo concepito io e Stravinskij, il mio scopo è presentare un certo numero di scene che manifestano gioia terrena e trionfo celestiale secondo la sensibilità degli slavi... La prima scena deve trasportarci ai piedi di una collina sacra, in una pianura rigogliosa, dove le tribù slave sono riunite per celebrare i riti di primavera. In questa scena c’è una vecchia strega che predice il futuro, un 40 Ad alcune delle numerosissime versioni coreografiche di questo capolavoro è dedicato un mio studio più ampio e circostanziato, di prossima pubblicazione: Le Sacre du Printemps balletto del Novecento: alcune versioni i confronto dal 1913 ai giorni nostri. 41 Cfr. di seguito in questo volume il paragrafo sulla ricostruzione del Sacre di Nijinskij a p. 121 42 I. STRAVINSKIJ, Chroniques de ma vie (1935), trad. it. Cronache della mia vita, Milano, Feltrinelli, 1981, pp. 32-33. matrimonio dopo un ratto, danze in tondo. Poi viene il momento più solenne. Il vecchio saggio è condotto dal villaggio per imprimere il suo sacro bacio sulla terra che ricomincia a fiorire. Durante questo rito la folla è in preda ad un terrore mistico [...] Dopo questo sfogo di gioia terrestre, la seconda scena suscita intorno a noi un mistero celestiale. Giovani vergini danzano in circolo sulla collina sacra, fra rocce incantate; poi scelgono la vittima che vogliono onorare. Immediatamente ella danzerà davanti ai vecchi vestiti di pelli d’orso per mostrare che l’orso era l’antenato dell’uomo. Poi i vecchioni dedicano la vittima al dio Jarilo (43). Tuttavia gli studi più recenti hanno ricostruito con maggiore precisione l’origine della collaborazione di Stravinskij con Roerich, avvalorando l’ipotesi che il balletto nascesse in realtà da un’idea del pittore proposta a Stravinskij e in seguito elaborata da entrambi (44). Il balletto - che si compone di due parti: “l’Adorazione della Terra” (atto primo) e “il Sacrificio della Vergine Eletta” (atto secondo) - si apre, al levarsi del sipario, con le danze degli adolescenti intorno ad una vecchia che svela loro i segreti della natura e il mistero del rinnovarsi della primavera. Alle danze dei giovani fa seguito l’ingresso del Saggio che adora con lente evoluzioni la terra. Subito dopo si scatena la danza della terra alla quale partecipano, con movimenti orgiastici, tutti i presenti. Nella seconda parte le fanciulle danzano misteriosamente in cerchio. Fra esse dovrà essere scelta la vittima da sacrificare alla terra. È l’Eletta che si ritrova immobile al centro del cerchio mentre gli altri giovani danzano intorno a lei sempre più freneticamente. Tocca infine alla vergine prescelta eseguire la sua danza rituale. Ella si abbandona a un delirio estatico fino a che non cade morta: il sacrificio è compiuto, gli uomini raccolgono la vittima e la sollevano verso il cielo. Il sottotitolo del balletto, scene della Russia pagana, allude alle violente primavere russe, fenomeno naturale fonte di superstizioni e di riti. In questo senso è da interpretare il titolo dove il termine Sacre sta ad indicare appunto un rituale pagano, il Rite inglese tradotto con l’italiano Sagra, dalla cui etimologia (femminile di “sagro”=”sacro”) proviene il significato di “consacrazione”. Nell’accezione corrente, il termine “sagra” indica la «festa popolare nell’anniversario della consacrazione di una chiesa». Tale aspetto rituale può essere assunto come punto di partenza per valutare quale fu l’effettivo apporto delle tradizioni slave nella creazione dell’opera e, soprattutto, in che modo si concretizzò tale apporto nella composizione della partitura musicale, nell’invenzione coreografica e nell’elaborazione dello spazio visuale. Dalle lettere di Stravinskij, Roerich e Niinskij si delinea un procedimento creativo fondato sulla reciproca collaborazione ma originato dalle profonde conoscenze di Roerich in materia etnografica. Come diversi studiosi hanno messo in evidenza (45), in questo ruolo di consigliere esperto Roerich doveva fornire non solo fatti e idee, ma anche ricreare per Stravinskij l’atmosfera del periodo arcaico che il compositore cercava di evocare attraverso la sua musica. Il fatto che Stravinskij abbia dedicato la partitura dell’opera a Roerich sottolinea, probabilmente, la sua riconoscenza nei confronti di chi aveva rivestito un ruolo fondamentale nella nascita di quel progetto, la cui paternità non fu mai riconosciuta pienamente. D’altra parte, anche se Stravinskij lo ha sempre negato, i canti popolari russi furono il materiale di partenza di cui si servì per elaborare la sua partitura. A questo proposito gli studi sul rapporto di Stravinskij con la musica popolare, condotti in particolare dal musicologo Richard Taruskin (46) hanno messo in evidenza come tutta la musica del Sacre sia stata composta attingendo ad un’antologia di canzoni popolari lituane, ad una collezione di canti popolari russi pubblicata alla fine dell’Ottocento e a canti ascoltati direttamente da Stravinskij in Ucraina. Grazie allo studio degli sketchbooks di Stravinskij, Taruskin ha dimostrato il procedimento di assorbimento e di astrazione 43 Citato in E. W. WHITE, Srravinsky (1966), trad. it. Milano, 1983. Si vedano in particolare gli studi condotti da Kenneth Archer sulla base delle dichiarazioni di Svetoslav Roerich, figlio 1el pittore, riportate in AA.VV., Le Sacre du Printemps de Nijinsky, Paris, Cicero, 1990, pp. 75-95 e 97-101. 45 In particolare Lynn Garafola, Millicent Hodson, Kenneth Archer. 46 R. TARUSKIN, From Firebird to the Rite: folk elements in Stravinsky ‘s scores, in «Ballet Review», n. 2, estate 1982. 44 degli elementi stilistici mutuati dalla musica popolare: un lavoro di trasformazione profondo che, senza l’analisi di simili documenti, non sarebbe stato possibile immaginare. L’asimmetria ritmica, la politonalità, la ricchezza timbrica costituiscono i tratti essenziali di un’opera che, da un punto di vista metrico-ritmico, sembra non concedere più nulla alla regolarità della scansione. La prova più eclatante di ciò è nella danza finale dell’Eletta, dove quasi ogni battuta apporta un cambiamento di tempo e l’alternanza continua 3-2 è pressoché costante. L’impiego di una imponente massa orchestrale (un organico di cento strumenti) è di tipo radicalmente antiromantico e antimpressionista: per la funzione melodica vengono preferiti legni e ottoni agli archi e questi ultimi vengono impiegati spesso in modo percussivo. Una simile massa sonora produsse nel pubblico uno shock pari almeno a quello suscitato dalla coreografia di Nijinskij. Anche nei confronti di quest’ultimo Roerich fece da consigliere in materia di paganesimo e la sua collaborazione con Nijinskij trova eco nei molteplici influssi pittorici riscontrabili nella coreografia. Bronislava Niinskaja ricorda le parole del fratello: Ora che lavoro al Sacre, l’arte di Roerich mi ispira quanto la musica potente di Stravinskij. I suoi quadri, Gli idoli dell’antica Russia, Le fanciulle della terra e in particolare quello intitolato, credo, Il richiamo del sole. Te Io ricordi, Bronia? (47). Ma, oltre ai quadri, anche i costumi disegnati da Roerich furono per Nijinskij fonte di ispirazione. Dalle lettere dell’epoca, infatti, si apprende che Nijinskij non voleva iniziare le prove con i danzatori prima di aver visto i costumi disegnati dallo scenografo (48). Evidentemente era sua intenzione trarre ispirazione dai disegni di Roerich per disporre i differenti gruppi sulla scena tenendo conto dei colori dei costumi. E infatti nell’idearli Roerich aveva utilizzato motivi ispirati dalla geometria rituale legata al luogo di culto ed è probabile che avesse poi spiegato a Nijinskij questi concetti illustrandoli attraverso i suoi quadri. Egli, dunque, doveva essere in grado di identificare tali schemi rituali presenti nei costumi e di ripeterli nella sua coreografia. I disegni a forma di cerchi presenti sulle casacche dei giovani nel primo atto ripetono lo schema geometrico del luogo di culto raffigurato nel quadro Les idoles e nelle sue varianti. Tale configurazione si ritrova alla fine del primo atto del balletto con il Saggio al centro e, intorno a lui, dei gruppi che girano in cerchi concentrici. Corrispondenze analoghe si riscontrano numerosissime nel paragonare la coreografia ai quadri di Roerich e ai suoi disegni per i costumi (49). Per l’elaborazione delle due scenografie (una per le cerimonie diurne dell’atto primo, una per i rituali notturni dell’atto secondo), Roerich utilizzò una vasta gamma di verdi. La prima scena rappresentava un paesaggio collinare e un lago sotto un cielo attraversato dalle nuvole. Quello sferico è il motivo conduttore di tutto il quadro: esso si ripete nel profilo delle colline, nella forma degli alberi e nel contorno del lago e trova un corrispettivo nei disegni circolari della coreografia. Il secondo fondale raffigurava con toni magici e misteriosi la montagna sacra e le rocce, luogo del sacrificio della vergine. Per entrambe le scene, quindi, Roerich si attenne ai canoni del figurativismo decorativo creando un’atmosfera di serenità e di pace in pieno contrasto sia con la partitura sia con la coreografia. Per i danzatori egli disegnò costumi e accessori dipinti a mano con motivi geometrici in colori vivi: rosso, blu, magenta, viola. L’elemento geometrico ritornava nei cappelli a punta degli uomini, nelle calzature con nastri incrociati fino al ginocchio, così come nel trucco del volto e negli amuleti che rivelano quanto Roerich conoscesse la simbologia rituale slava. Nijinskij iniziò a lavorare sul Sacre insieme alla sorella Bronislava. Con lei impostò la posizione di base del corpo con i piedi rivolti in dentro, le ginocchia piegate, la testa inclinata 47 B NIJINSKA, Early memoirs, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1981, p. 449. V STRAVINSKIJ, R. CRAFT, Stravinskij in Pictures and Docurnents, Simon and Schuster, New York, 1978 49 Cfr. nota 44. 48 lateralmente, le mani chiuse a pugno. Una posizione che già di per sé negava ogni regola accademica forzando il danzatore in un atteggiamento opposto a quello accademico. Con Bronislava (alla quale l’interpretazione dell’Eletta era destinata e che invece non la eseguì perché incinta), Nijinskìj elaborò i sussulti, i tremolii, l’incalzare dei salti fino alla morte della danza sacrificale, il momento culminante in cui la fanciulla si dibatte per liberarsi dal cerchio dentro il quale è stata imprigionata. Il movimento circolare - elemento costante dell’intera coreografia - trova qui il suo compimento negli sfibranti saltì finali: una serie dì coupés-jetés en tournant intervallati dai sussulti spasmodici della vittima. Con questo assolo si conclude una coreografia costruita - come evidenzia Millicent Hodson sul concetto di democratizzazione inteso a vari livelli: la centralità del corpo di ballo rispetto al solista, figura che non compare se non nel finale; l’uguale evidenza attribuita al movimento di tutte le parti del corpo (testa, torace, braccia, gambe e non solo a queste ultime); l’analoga importanza della caduta rispetto al salto, che generalmente nella tecnica accademica viene enfatizzato come emblema del virtuosismo; la distribuzione delle azioni nello spazio indipendentemente dalla loro importanza (una scena significativa non deve necessariamente svolgersi al centro del palcoscenico). In una lettera datata 2 gennaio 1912, Nijinskij così scrive a Stravinskij a proposito del Sacre: Se il lavoro prosegue su questa via, Igor, il risultato possiede qualcosa di grande. So che cosa può essere Le Sacre du Printemps quando tutto sarà come noi lo abbiamo concepito (...). Tutto sarà diverso, nuovo, bello (50). Se la collaborazione con Roerich per la concezione generale della coreografia e per il disegno geometrico dei gruppi si rivelò preziosa, è ormai accertato che sull’elaborazione dei movimenti influì notevolmente la ritmica di Emile Jaques-Dalcroze per il tramite - in qualità di assistente chiamata da Djagilev - di Marie Rambert, la danzatrice, insegnante e coreografa polacca (Varsavia 1888-Londra 1982: Cyvia Rambam era il suo vero nome, poi mutato in Miriam Ramberg e, infine, in Rambert) che aveva studiato con Dalcroze e ne era diventata assistente. Fu probabilmente nel febbraio 1912 che Djagilev e Nijinskij fecero la loro prima visita ad Hellerau (51). In seguito la Rambert accettò l’invito di Djagilev ad unirsi ai Ballets Russes per dare alcune lezioni speciali di ritmica dalcroziana alla compagnia, per aiutare Nijinskij ad utilizzare tale metodo nel Sacre e per danzare i ruoli per i quali sarebbe stata ritenuta adatta (52). In realtà, a causa del fitto calendario di impegni della compagnia, la Rambert non assolse mai al suo ruolo di insegnante di ritmica. In compenso, data la difficoltà della partitura stravinskiana, dovette lavorare sui ritmi del Sacre con ciascun danzatore, compito che ben presto le valse il nomignolo di “Rithmichka”: il suo ruolo, infatti, era quello di aiutare i ballerini a muoversi su una musica priva di melodie cui appigliarsi e l’unico modo per riuscire a farlo era saper contare alla perfezione le battute. A questo si aggiungeva la difficoltà di mantenere, nel movimento, la “scomoda” posizionebase imposta da Nijinskij. I salti a piedi uniti, con le ginocchia tese e con le spalle curve, i tremolii, le cadute, provocarono violente reazioni da parte della compagnia che accusava mal di testa, contusioni, talloniti causate dalle discese non ammortizzate. Inoltre - e in questo consiste il maggior influsso dell’euritmica dalcroziana - Nijinskij non solo assegnava a ciascun gruppo un movimento differente ma, all’interno di uno stesso gruppo, variava i movimenti assegnando alla testa, alle braccia e alle gambe un andamento ritmico diverso, costringendo i danzatori a contare contemporaneamente tempi differenti per la parte inferiore e superiore del corpo. 50 La lettera è citata nel numero speciale di «L’Avant-scène Ballet/Danse» dedicato a Le Sacre du Printemps, Paris, août-octobre 1980, p. 44 51 Cfr. in proposito il saggio di S. LANDEN ODOM Nijinsky a Hellerau, in AA. VV., Ecrits sur Nijinski, La Recberche en danse, Paris, 1992 52 Cfr. M. RAMBERT, Quicksi1ver an autobiography, London, Macmillan, 1972, p. 54. Il malcontento dei danzatori rese le prove più difficili e accrebbe il nervosismo di Nijinskij che, d’altra parte, non godeva neppure del sostegno morale di Stravinskij e dell’entourage di Djagilev, tutti poco fiduciosi nei confronti delle sue conoscenze musicali e della sua coreografia (53) Oltre alla sorella e a pochi altri ballerini tra cui Maria Piltz (che era subentrata a Bronislava nel ruolo dell’Eletta), l’unico sostenitore di Niinskij era, ancora una volta, Roerich. In questo clima di tensione, giunse il 29 maggio, giorno della prima. Dalle numerose recensioni dell’epoca (54) e dal racconto di quanti assistettero all’evento, è possibile farsi un’idea del clamore che quest’opera suscitò nei presenti. Le reazioni degli spettatori furono così violente da impedire ai ballerini di udire l’orchestra. Djagilev e Nijinskij cercarono di rimediare come potevano alle proteste del pubblico che si sentiva vittima di una vera e propria presa in giro. L’uno dava continui ordini ai tecnici di sollevare e abbassare il sipario o di accendere e spegnere le luci in sala, l’altro, nascosto dietro le quinte, contava ad alta voce le battute per farsi sentire dai ballerini. Sulle pagine dei maggiori quotidiani il balletto venne ben presto ribattezzato «Massacre du printemps» (55) e la maggior parte dei recensori definì i movimenti «convulsioni epilettiche» (56) e bollò l’intera danza come ridicola (57). Era «l’opposto, la negazione, la distruzione dell’arte e dello stile nella danza» (58). Quasi sempre veniva riconosciuta all’opera una assoluta originalità, anche laddove questa non era considerata un motivo di merito: i termini «originale» e «nuovo» sono i più ricorrenti sia nella stampa parigina sia in quella londinese, che si espresse tuttavia nei confronti del balletto con toni più moderati. Nel mese di novembre sulla «Nouvelle Revue Française» comparve un lungo saggio di Jacques Rivière, una delle poche voci lungimiranti che non solo si levò in difesa del Sacre di Nijinskij, ma ne comprese tutta la carica di novità e di rottura con grande lucidità (59). Individuando in Stravinskij la via per liberarsi dal debussismo, Rivière ne elogia la scrittura «in prosa», «diretta» e «priva di allusioni», mentre nella coreografia di Nijinskij riconosce un ritorno al corpo: lo sforzo di aderire il più possibile ai movimenti naturali superando l’eccessiva importanza attribuita da Fokin all’espressione del volto. Le rappresentazioni del 1913 a Parigi e Londra rimasero le sole repliche della coreografia di Nijinskij che - inizialmente a causa dell’accoglienza sfavorevole da parte della critica, poi per l’allontanamento del coreografo dalla compagnia in seguito al suo matrimonio - venne esclusa dal repertorio dei Ballets Russes. Solo diversi anni dopo - nel 1920 - non avendo i mezzi economici per finanziare nuove produzioni, Djagilev decise di riallestire Le Sacre du Printemps, del quale erano stati conservati i costumi e le scenografie. Della coreografia, però, non erano rimaste tracce: in quel momento, infatti, solo cinque danzatori che avevano ballato la versione di Nijinskij si trovavano ancora in compagnia ed essi non erano in grado (li ricordarla per intero. Djagilev decise allora di affidare una nuova versione del balletto a Leonid Mjasin. Questo “secondo Sacre” andò in scena al Théâtre des Champs-Elysées il 15 dicembre 1920 e fu accolto da un vivo successo che ne decretò la definitiva acquisizione nel repertorio della troupe (60). 53 Sui rapporti tra Nijinskij e Stravinskij confronta le memorie del compositore (I. STRAVINSKIJ, Cronache..., cit.) e quelle di Bronislava (B. NIJINSKA, Early..., cit.). 54 Cfr. F. LESURE, Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, dossier de presse, Genève, Editions Minkoff, 1980. 55 Vedi, tra gli altri, G. DE PAWLOWSKI in «Comoedia», 31 maggio 1913 e L. VALLAS in «Revue Française de musique», giugno-luglio 1913. 56 L. VALLAS, ibidem 57 «È impossibile non mettersi a ridere» scrisse Adolphe Boschot su «L’Echo de Paris» del 30 maggio. 58 Pierre Lalo in «Le temps» del 5 agosto. 59 J RIVIERE, Le Sacre du Printemps (1 novembre 1913), trad. it. in E. CASINI ROPA, a cura di, Alle origini..., cit., pp. 269-280. Rivière aveva già dedicato all’argomento un articolo comparso sulla medesima rivista il 1 agosto 1913. La lucidità con cui analizza il balletto scaturiva certamente anche dalla distanza temporale che lo separava da quel “tumultuoso” 29 maggio. 60 Questa versione fu danzata dai Ballets Russes fino al 1929 con la Sokolova e la Niinskaja che si alternavano nel ruolo dell’Eletta. Mjasin (1895-1979) si era unito alla compagnia dei Ballets Russes nel 1914, destinato a divenire ben presto il vero successore di Nijinskij, dapprima come interprete elegante e vitale nelle produzioni firmate da Fokin durante la stagione 1914, poi come artefice di numerosi balletti. Nell’estate del 1920 Mjasin si recò da Stravinskij, che si trovava allora in Svizzera, per parlare con lui della partitura del Sacre e per mostrargli alcune sue nuove idee sul modo di mettere in scena il balletto. Stravinskij gli rivelò che non era rimasto soddisfatto della versione di Nijinskij il quale, secondo lui, aveva commesso l’errore di attenersi troppo rigidamente ai ritmi della partitura. «Dopo aver studiato la musica per molte settimane - racconta il coreografo - giunsi alla conclusione che forse avrei potuto evitare l’errore di Niinskij tentando un contrappunto in enfasi tra musica e coreografia» (61) Djagilev, a sua volta, lo incoraggiò raccomandandogli di non ripetere l’errore di Nijinskij, il quale aveva fallito perché aveva cercato di fare troppe cose insieme, senza rendersi conto che «gli occhi e le orecchie non possono assorbire simultaneamente tanto quanto possono fare le orecchie da sole» (62) L’operazione voluta da Stravinskij e Mjasin si orientava verso un astrattismo dichiarato fin dalla presentazione della nuova versione: sul programma di sala infatti non figurava più la scansione dei singoli “episodi” musicali (giochi delle tribù rivali, danza della terra, corteo del saggio, etc.) ma la sola divisione in due quadri preceduta da una dichiarazione d’intenti: «Le Sacre du Printemps è uno spettacolo della Russia pagana. L’opera è in due parti e non prevede alcun soggetto. È coreografia costruita liberamente sulla musica». Inoltre per l’intero balletto venne utilizzato solo il fondale dell’atto secondo e cambiamenti sostanziali avvennero anche per l’uso dei costumi, in particolare per quello dell’Eletta nel secondo atto che venne sostituito da un nuovo costume più leggero, in seta bianca (63). È possibile che tali modifiche siano state favorite dall’assenza di Roerich che in quel periodo si trovava a New York e non poté seguire da vicino il riallestimento del balletto. Nel creare la sua coreografia, Mjasin iniziò, come aveva fatto Nijinskij, dalla danza dell’Eletta, scegliendo come interprete la danzatrice Lidija Sokolova che nel 1913 aveva partecipato alla prima produzione del Sacre. Ella aveva già sostenuto diversi ruoli principali nelle precedenti coreografie di Mjasin del quale conosceva bene lo stile. Nella sua autobiografia, la Sokolova racconta i primi giorni di prova della danza dell’Eletta. Nonostante le difficoltà della partitura, che costringeva lei e Mjasin a servirsi del metronomo e ad appuntare su un taccuino i conteggi della musica, la danzatrice sottolinea che questo Sacre era chiaro e sistematico e che nulla, nella sua coreografia, era lasciato al caso; al contrario ella ricorda che il Sacre di Nijinskij era un lavoro vago, meno complesso ed accurato di quest’ultimo (64) Quanto alla danza sacrale, la Sokolova la definisce «forse la danza più straordinaria che sia mai stata inventata», culminante in una serie di grand jetés en tournant assai faticosi che, alla fine del balletto, la lasciavano stremata al suolo. Analoga opinione espresse in seguito Luciana Novaro, interprete dell’Eletta nella riedizione scaligera del balletto del 1948 (65) Quando, nel 1914, Mjasin era entrato a far parte della troupe, tutti i ballerini che avevano danzato il Sacre facevano ancora parte della compagnia. È molto probabile che egli abbia domandato loro di mostrargli alcuni passi e di raccontargli qualcosa sui ruoli che avevano interpretato. Tuttavia, pur essendoci diverse analogie con il “primo Sacre” dovute alla comune 61 L. MASSINE, My Life in Ballet (1968), trad. it. La mia vita nel balletto, Napoli, Fondazione Léonide Massine, 1995. A conclusione di un’intervista non firmata, pubblicata sul quotidiano londinese «The Observer» il 3 luglio 1921, Stravinskij, dopo aver parlato del concetto di «musica pura», si riferisce alle due diverse coreografie del Sacre in questi termini: «La costruzione coreografica di Nijinskij, pur essendo di grande bellezza plastica, era tuttavia soggetta alla tirannia della battuta musicale; quella di Mjasin è basata su frasi costituite ciascuna di numerose battute. Questo è ciò che si intende per libera connessione della costruzione coreografica con la costruzione musicale». 62 citato in S. BERG, Le Sacre du Printemps, 7 productions from Nijinsky to Martha Graham, New York, UMI Research Press, 1988. 63 cfr. L. SOKOLOVA, Dancingfor Diaghilev, London, John Murray, 1960. 64 Ibidem. 65 cfr. A. AGOSTINI, Le Sacre de Massine, in «L’Avant-scène Ballet/Danse», cit., p. 56. matrice russa, i danzatori di Mjasin assomigliavano ad una tribù universale piuttosto che ad una particolare tribù primitiva russa. Se nel Sacre di Nijinskij i due sessi venivano isolati in gruppi ben differenziati e non si stabiliva quasi mai un contatto fisico tra loro, nella versione di Mjasin esisteva una interdipendenza molto più stretta tra uomini e donne che, secondo l’interpretazione di Kenneth Archer e di Millicent Hodson (66) suggerirebbe un mondo più “evoluto” rispetto a quello di Nijinskij e inaugurerebbe la serie di versioni del Sacre incentrate sul desiderio sessuale primordiale (vedi, ad esempio, la versione di Béjart). Numerosi critici che avevano visto entrambi i Sacre, non esitarono a paragonare le due produzioni, con opinioni discordanti tra loro. La maggior parte apprezzò il Sacre ragionato e intellettuale di Mjasin, spogliato della carica rivoluzionaria e primitiva che aveva caratterizzato la produzione del 1913 (la posizione en dedans dei piedi, ad esempio, venne sostituita da una più “naturale” posizione parallela) e ricondotto negli ambiti di un rigore formale che, pur essendo moderno, era strutturato secondo canoni classici, I fautori di Mjasin ne apprezzarono anche le doti musicali, riconoscendogli una maggiore professionalità ed esperienza in fatto di musica, rispetto al suo predecessore Nijinskij. Ci furono però anche critici che videro nella coreografia di Mjasin solo una pallida immagine del lavoro di Nijinskij e che ne difesero strenuamente la memoria, soprattutto contro l’ingratitudine di Stravinskij. I testi qui riportati in traduzione italiana mostrano come, in più di un’intervista rilasciata alla stampa (67) il compositore (che prima del debutto del balletto nel 1913 si era dichiarato soddisfatto del lavoro di Nijinskij (68), insistesse ora sull’idea di astrattismo, affermando di aver finalmente trovato in Mjasin chi aveva compreso il vero spirito della sua musica, chi aveva saputo eliminare ogni carattere aneddotico e descrittivo restituendo alla musica il puro valore di «costruzione architettonica». In realtà a questa dichiarazione di intenti non corrispondeva di fatto una danza “astratta”: specie nel primo atto i movimenti dei ballerini, seppur stilizzati, conservavano un intimo legame con la quotidianità dei lavori domestici (le donne) e dei campi (gli uomini). In seguito, nel corso della sua carriera, Mjasin rimise in scena più volte il suo Sacre. Nel 1930, a dieci anni di distanza da quella prima produzione, venne invitato a riallestire il balletto in America per un gruppo costituito per la maggior parte da danzatrici della compagnia di Martha Graham. Fu proprio quest’ultima ad interpretare il ruolo dell’Eletta, sottomettendosi ad uno stile che non le apparteneva e al quale, giunta alla soglia dei 90 anni, volle rispondere misurandosi lei stessa con la partitura di Stravinskij e dando vita ad una propria versione del Sacre (69), Una sfida a cui non hanno saputo sottrarsi tutti i coreografi che dal 1913 ad oggi hanno raccontato, ciascuno con il loro Sacre, il mistero di una Primavera - la vita, l’amore, l’arte - che continuamente rinasce. Bibliografia Essenziale AA. VV., Le Sacre du Printemps de Nijinsky, Paris, Cicero, 1990 AA. VV., Le Sacre du Printemps, numero monografico di «l’Avant-Scène Ballet/danse», Paris, aoùt-octobre 1980 J. ACOCELLA, L. GARAFOLA, J. GREENE, Rites of Spring, in «Ballet Review», 66 cfr. Hommage a Massine, programma di sala. Balletto dell’Opera di Nizza, 1994. cfr, il testo a p. 117. 68 cfr. il testo a p. 114. 69 Sul Sacre del 1930 cfr. L. MASSINE, La mia vita..., cit. e M. GRAHAM, Blood Memory (1991), trad. it. Memoria di sangue, Milano, Garzanti, 1992. In Italia, tra le grandi interpreti dell’Eletta nella “versione Mjasin” ricordiamo Luciana Novaro nell’edizione scaligera del 1948 e Marga Nativo in quella del 1973 al Teatro Comunale di Firenze. Su alcune delle numerosissime versioni del Sacre cfr. inoltre il mio studio: Le Sacre du Printemps balletto del Novecento..., cit., di prossima pubblicazione. 67 Summer 1992 S. C. BERG, Le Sacre du Printemps, 7 productions from Nijinsky to Martha Graham, New York, UMI Research Press, 1988 R. BUCKLE, Diaghilev, London, Weidenfeld & Nicolson, 1993 E. CASINI ROPA, Alle origini della danza moderna, Bologna, Il Mulino, 1990 L. GARAFOLA, Diaghilev’s Ballets Russes, New York, Oxford University Press, 1989 M. KAHANE, N. WILD, Les Ballets Russes à 1 ‘Opfta, Paris, Hazan/Bibliothèque Nationale, 1992 L. MASSINE, My Life in Ballet (1968), trad. it. La mia vita nel balletto, Napoli, Fondazione Léonide Massine, 1995 C. MIGLIACCIO, i balletti di Igor Stravinskij, Milano, Mursia, 1992 R. NIJINSKY, a cura di, The diary of Vaslav Nijinsky (1963), trad. it. Il diario di Nijinsky, Milano, Adelphi, 1979 J. SASPORTES, Pensare la danza, Bologna, Il Mulino, 1989 L. SOKOLOVA, Dancing for Diaghilev, London, John Murray, 1960 I. STRAVINSKY, Chroniques de ma vie (1935), trad. it. Cronache della mia vita, Milano, Feltrinelli, 1981 A. TESTA. Diagilev e l’italia, in «La danza italiana», n. 2, 1985 P. VEROLI, Le compagnie di Djagilev e di Bòrlin, in Musica in scena, storia dello spettacolo musicale, vol. V, Torino, Utet, 1995
Scaricare