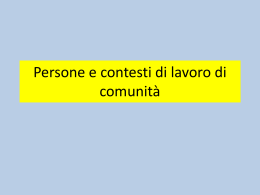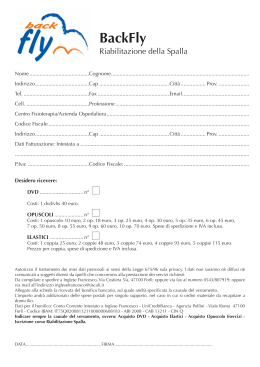Conoscere X Cambiare NONDISOLOLAVORO Luoghi, identità ed esistenze in mutazione nella società multiculturale Quaderni di Télos n. 3 Il presente volume raccoglie gli atti di “Nondisololavoro. Seminario conclusivo del progetto penisolaDONNE”, organizzato dalla Comunità Oasi2 San Francesco il 16 Maggio 2008 a Trani (Ba). Questo materiale può essere liberamente riprodotto, parzialmente o integralmente e modificato purché non a scopo di lucro e nel rispetto del Copyleft. La citazione della fonte è sempre obbligatoria. 2009 © Copyleft Comunità Oasi2 S.Francesco Onlus via Pedaggio Santa Chiara, 57bis 70059 Trani (Ba) t. +39.0883.580546 fx +39.0883.502146 web : www.oasi2.it email : [email protected] Indice 1. Prefazione Felice Di Lernia p.5 2. Trasformazioni urbane: comunità e metropoli tra accoglienza e identità Francesco indovina p.11 3. Amori possibili. La via della mixité sentimentale alla comunicazione tra culture Gaia Peruzzi p.53 4. Identità e mercato del lavoro. Due dispositivi di una stessa trappola mortale Augusto Ponzio p.83 Nondisololavoro Luoghi, identità ed esistenze in mutazione nella società multiculturale Prefazione Felice Di Lernia Felice Di Lernia, antropologo, da oltre venti anni si occupa di pratiche di cura in ambito medico, socio-sanitario, psico-pedagogico e scolastico. Formatore senior, supervisore e consulente, coordina il Centro Studi Télos della Comunità Oasi2 che ha fondato nel 1986 e della quale è direttore scientifico. E' Presidente di Nova Onlus - Consorzio Nazionale per l'Innovazione Sociale. E’ autore del libro “Ho perso le parole. Potere e dominio nelle pratiche di cura”, Ed. la meridiana, 2008. 5 6 Prefazione L’approccio culturale più diffuso ai fenomeni migratori riproduce colpevolmente lo stereotipo stigmatizzante e invalidante dell’immigrato come forza lavoro e, di conseguenza, produce, altrettanto colpevolmente, impianti legislativi che vincolano al posto di lavoro il diritto di abitare i luoghi. In un certo senso potrebbe non essere una vera e propria novità: le culture liberiste, colonialiste e capitaliste hanno in realtà sempre considerato “l’altro” (lo straniero immigrato è “altro” per eccellenza, ma è “altro” in questo senso anche il proletario, il povero, il non garantito, il non appartenente alla casta degli imprenditori) come mero fattore della produzione. Ma in un altro senso la novità c’è: le culture “neo” (liberiste, colonialiste, capitaliste) hanno reificato un nuovo diritto di cittadinanza che si aggiunge a quelli di sangue e di suolo e, in qualche modo, li supera perché ancora un po’ di tempo e non sarà più sufficiente essere nati in un luogo o avere lo stesso sangue di chi vi è nato (regola tuttora in vigore per i nati all’estero da italiani nati in Italia, ma emigrati), ma per abitare legittimamente una terra bisognerà disporre di un lavoro (che, detto in altri termini, significa che bisognerà servire a qualcuno e a qualcosa, non a se stessi). In questa visione padronale del diritto alla vita il rapporto tra cittadino e lavoro si inverte incredibilmente e il diritto al lavoro si trasforma in dovere del lavoro quale condizione per poter esercitare il diritto ad esistere. Ma per gli addetti ai lavori, per coloro che si occupano di migrazioni, che le studiano, che le incontrano, che se ne fanno 7 carico, la vera novità (da un punto di vista concettuale più che fattuale) sta nella necessità di mettere ufficialmente a discussione il fatto che anche le politiche sociali comunitarie e statali, in campo migratorio, assumono come propria la suddetta visione e investono, in maniera asfittica e compulsava, sull’occupazione quale unico indicatore di esito, in ossequio al paradigma dello sviluppo economico inteso come unica possibile via dell’esistenza. Questo approccio diffuso (per definire il quale si rende necessario riutilizzare la categoria pasoliniana di “borghese” forse fuori moda, ma sicuramente efficace e centrata) è un approccio che scotomizza le diverse morfologie delle esistenze reali delle persone ed anche le loro diverse espansioni culturali e riduce l’immigrato e l’extracomunitario (in quanto tali, come soggetti specifici, non lo straniero in genere) a nuda vita, come direbbe Slavoy Zizek per indicare l’esistenza senza titolarità o a nuda forza come sarebbe forse più giusto dire. Questo approccio istituzional-borghese esclude la possibilità di una vita non-lavorativa o extra-lavorativa, trascende l’idea stessa di esistenza nella sua necessaria immaterialità, reifica una forma di permanenza in vita come sola permanenza materiale e temporanea in un luogo e pone questioni che vanno ben al di là delle ovvie valutazioni di natura bio-politica. Pone ad esempio, ed è ciò che qui ci interessa approfondire, questioni legate al delicato e sfumato problema della conoscenza: all’interno di questo approccio, di questa visione del mondo dall’alto verso il basso, l’altro (l’immigrato e/o l’extracomunitario, in questo caso) è sconosciuto e sconoscibile in quanto esistenza reale; è non interloquibile, non rela8 zionabile, non assumibile in quanto elemento che compone e trasforma la realtà. Né possono essere considerate sufficienti, alla conoscenza, le pur numerose iniziative di scambio socio-culturale che, al di là delle intenzioni frequentemente lodevoli, in realtà si collocano in un’area più orientata politicamente (Bauman direbbe mixofilica) che centrata scientificamente, in un ambito mosso più dal gusto dell’esotico che dalla urgenza antropologica. La conoscenza è invece una necessità metodologica. Una conoscenza scientificamente centrata risponde alla necessità ermeneutica di nuovi significati per i nuovi significanti del nostro tempo ibrido, alla necessità ermeneutica di completezza e di completamento del nostro reale socio-storico strutturalmente determinato dalla contaminazione culturale: in questa direzione può e deve collocarsi una riflessione sulle diverse matrici identitarie come quella di Nondisololavoro. Nondisololavoro è un tentativo, non solo per chi si occupa di immigrazione, per dire delle forme e dei luoghi dell’esistenza e delle identità ad essa connesse. A tre intellettuali, ricercatori, “conoscitori” - appunto – italiani abbiamo chiesto di mettere insieme le loro visioni, i loro tasselli. L’idea è assemblare, con sguardi dall’interno, un mosaico della mutazione, una sorta di ritratto della nostra ontologica e salutare impermanenza. 9 10 Trasformazioni urbane: comunità e metropoli tra accoglienza e identità Francesco Indovina Francesco Indovina insegna analisi territoriale e pianificazione presso l'Università IUAV di Venezia e alla Facoltà di Architettura di Alghero. Direttore della collana Studi Urbani e Regionali della Franco Angeli, cofondatore della rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali (ASUR). Si occupa delle relazioni tra processi economici sociali e trasformazioni del territorio. La "città diffusa" e la "metropolizzazione del territorio" sono i suoi più recenti contributi. Tra le pubblicazioni recenti: Governare la città con l'urbanistica (Maggioli ed.); L'esplosione urbana (a cura insieme a L. Fregolent e M. Savino) (Compositori Ed.); Il territorio derivato (F. Angeli ed.). 11 12 1. Come ogni specie anche quella umana ha necessità di una propria e appropriata “nicchia ecologica”. La città è, appunto, il “luogo” in cui la specie umana è “progredita”; si assume, cioè, la città come elemento (luogo, organizzazione, tipologia di rapporti, stile di vita, ecc.) che è stato, ed è, essenziale per lo sviluppo e la trasformazione della specie umana. Si intende sostenere che lo sviluppo e l’evoluzione dell’umanità sia stato, storicamente, legato strettamente alla "vita urbana": scienza, arte, tecnica, conoscenza, modalità di organizzazione, arricchimento delle relazioni, liberazione dal dominio della “natura”, elaborazione di forme di governo, ecc. sono tutti effetti e, allo stesso tempo, causa della condizione urbana. La città non costituisce prodotto esogeno alla specie, ma piuttosto il risultato di una “invenzione” sociale: l’umanità, infatti,a differenza delle altre specie si è creata la propria nicchia. La creazione, prima, e lo sviluppo, poi, della condizione urbana corrispondono ad una necessità e ad un’opportunità assieme creando un circolo virtuoso evolutivo. Il termine città non individua una realtà immutabile, ma piuttosto una “condizione” in continua trasformazione (la città non è come il cavolo che il bruco trova più o meno sempre immutato). L’organizzazione urbana, la sua forma, le possibilità e la qualità della convivenza si sono modificate in relazione ai modi con i quali l’umanità ha organizzato la produzione, ha articolato gli strumenti di potere e di governo, ha utilizzato la tecnologia, ha accresciuto le conoscenze. È proprio questa relazione che fa le città diverse ma insieme simili; le singole culture danno luogo a specifiche forme urbane in re 13 lazione anche al rapporto che esse hanno con l’organizzazione dello spazio. Oggi le città, nel mondo occidentale, appaiono come avviate alla decadenza e, ad uno sguardo superficiale, potrebbero sembrare avviate verso l’“evaporazione”, tuttavia occorre resistere ad una tale semplificazione: al contrario infatti, uno sguardo attento, osserva che, con più forza che nel passato, oggi la condizione e l’esperienza urbana e metropolitana si afferma e diventa comune. È proprio su questa esperienza umana allargata, per così dire, che converrebbe riflettere, tendendo conto delle nuove tipologie di organizzazione dei territori e della creazione di nuove forme urbane. Le città moderne sono figlie della rivoluzione industriale, dello sviluppo della scienza e della tecnologia, della diversa declinazione della politica e dello sviluppo culturale, ma, insieme, ricompongono continuamente i tratti delle loro origini: sono tra di loro diverse ma con una sostanza comune. Le caratteristiche peculiari di ogni singola città variano, transitano da una forma a un’altra, crescono o decadono nel tempo, ma solido resta il connotato comune che possiamo individuare nella condizione urbana: una modalità di vita che attrae e che, una volta conosciuta e sperimentata, è difficile abbandonare, anche quando, come nel presente, sembra essere messa in discussione. 14 Essa esprime ancora quella necessità e opportunità di cui si è detto. Contemporaneamente, anche in riferimento ai temi di questo seminario, appare assolutamente necessario considerare le dinamiche di trasformazione che hanno investito la città. Una riflessione non solo sul come e sul perché si sia in presenza di nuove forme urbane, ma anche se sia lecito riferire a queste nuove conformazioni il concetto di condizione urbana e metropolitana 1 . 2. I “nuovi territori” si caratterizzano per la dispersione: famiglie, funzioni, attività economiche, abitazioni, servizi, ecc., prima erano concentrati nella città compatta, nella città tradizionale; ora, al contrario, si presentano, sempre più, dispersi in ampi territori: si tratta di una tendenza generale che, ovviamente, assume forme proprie in ragione delle specifiche situazioni locali. Qualche studioso suggerisce di guardare a tale fenomeno con l’ottica del “frammento”: la dispersione come una sommatoria di parti sconnesse, senza nessun reciproco legame; lo sfaldamento della città, la vanificazione della condizione urbana e la realizzazione di territori privi di senso. Un riferimento più adeguato sarebbe stato quello alla frammentazione in senso biologico o botanico, cioè alla modalità di riproduzione di un corpo che, a partire da una sua parte, si riproduce nella forma intera o forse, ancora più opportunamente, si potrebbe fare riferimento alle cellule staminali. 1 Per una trattazione più estesa di questa trasformazione si rinvia a Indovina 2003 15 La dispersione, infatti, non costituisce la disseminazione nel territorio di schegge sconnesse, ma, piuttosto, una “nuova” modalità di organizzare gli insediamenti con la ricostruzione di relazioni e connessioni che hanno a che fare con la condizione urbana. Le singole parti, apparentemente sconnesse, perché così si intende leggerle, in realtà si relazionano tra di loro, non solo in termini “funzionali”, ma anche dal punto di vista sociale, culturale e di “vita”, riproducendo relazioni di tipo urbano in una situazione fisica-morfologica non urbana. In specifici contesti, per esempio il Veneto centrale o la via Emilia, si può, infatti, cogliere l’esistenza di una nuova realtà urbana, quella definita città diffusa (Indovina,1990), che, come si accennava precedentemente, non fa riferimento alla struttura fisica della città tradizionale (quella compatta), ma piuttosto alla condizione urbana (funzionamento, ruolo sociale, occasione di incontri, sviluppo culturale, imprevedibilità, ecc.). Le cause che hanno determinato la dispersione, dette in modo sintetico, sono individuabili: nel “costo” della città (la città più ha “successo”, più si valorizza, più costa); nelle innovazione tecnologiche e nei relativi effetti sulla produzione, sui servizi e sulla stessa vita quotidiana; nell’affermarsi di nuovi stili di vita; nella dirompente carica dell’informazione di massa. Ma, mentre nel passato i processi di trasformazione (di natura uguale a quelli prima citati), determinavano la tendenza all’agglomerazione (tutti volevano stare vicino a tutti e a tutto) perché questa produceva vantaggi per ciascuno, oggi, da una parte, l’agglomerazione produce svantaggi 16 (costi della congestione, inquinamento, lunghe attese, ecc.) e, dall’altra parte, i precedenti vantaggi possono ottenersi nella dispersione grazie alle nuove tecnologie. Due richiami di attenzione. Non si afferma che l’agglomerazione ha perso tutta la sua forza, ma soltanto che essa è fortemente diminuita. Non si afferma che i territori della città diffusa si presentano privi di elementi negativi, al contrario: più alto risulta il consumo di suolo, più alto il consumo energetico (trasporti, soprattutto); minore l’attenzione all’inquinamento, maggiore il costo per la Pubblica Amministrazione di fornire servizi, ecc. Preme anzi sottolineare che gli esiti negativi sono derivanti dal fatto che si tratta di un risultato frutto di autoorganizzazione e non governato. 3. La dispersione è sembrata mettere in crisi la città, la sua esistenza: quello che non avevano potuto, in più di due secoli, le concezioni e le politiche antiurbane, si realizzava “spontaneamente” (questo termine – “spontaneamente” – contiene anche la determinazione del “mercato”). Ma qui riemerge il binomio necessità-opportunità con il quale si è connotata la nascita e lo sviluppo della città: il bisogno di città non si cancella, esso emerge con forza dando luogo ad una condizione urbana in un tessuto territoriale morfologicamente non urbano. I territori definiti come città diffusa lo sono in quanto funzionano come se fossero una città compatta. 17 Un esercizio mentale utile alla comprensione del fenomeno è il seguente: dilatando tutti gli spazi di interconnessione di una città compatta si arriva alla città diffusa, dove tutti gli elementi caratterizzanti la città compatta si trovano dispersi in quella; o, al contrario, compattando tutti gli spazi di una città diffusa si otterrà una città compatta, ricca di tutti i propri elementi. Nel territorio disperso, infatti, oltre alle abitazioni e alle attività produttive, si trovano quelli che è possibile chiamare “servizi banali”: centri e aree commerciali, ipermercati, grandi magazzini specializzati (tutto legno, tutto luce….), negozi collegati alla grande produzione); concentrazioni specializzate per il divertimento (multisale, booling, pizzerie, sale di biliardo….); grandi aree per lo sport, e così via. Ciascuna “servizio banale” tende a proporsi come un “episodio” urbano in un tessuto dilatato e serve la popolazione dell’intero territorio (da qui la scelta localizzativa che premia non la “vicinanza” all’utente o cliente, ma piuttosto l’accessibilità). Ma la trasformazione non si ferma, produce dell’altro. La dispersione che ha generato campagne urbanizzate fino a città diffuse, procede presentando nuove fenomenologie. In una nuova situazione si ripropone il passaggio dalla città alla metropoli. In una prima fase di questa trasformazione (nella fase di formazione della città diffusa), infatti, nelle città tradizionali, quelle grandi, permanevano, oltre le famiglie e le attività che potevano sostenere i cresciuti costi della città, oltre alle 18 attività marginali che potevano sfruttare le situazioni interstiziali (generando un processo di “polarizzazione” sociale ed economico), anche le “funzioni di governo” (economiche, scientifiche, culturali, delle comunicazioni, della ricerca, della politica, ecc.). Queste funzioni hanno mostrato, per un certo periodo, una forte resistenza alla dispersione continuando a privilegiare la città compatta (la più grande). Una resistenza alla fine vinta, da una parte, dai problemi di costo e, dall’altra parte, dal riferimento al proprio “mercato”, sempre più disperso. Alcune di queste funzioni di “governo” hanno ritenuto conveniente abbandonare la città centrale e rilocalizzarsi nel territorio, contemporaneamente alla crescita di nuove funzioni di tipo metropolitano richiamate dall’utenza allargata (la popolazione dei territori urbanizzati), dando luogo ad una nuova fenomenologia spaziale. La cosa da rilevare, tuttavia, è una differenza di tono, di immagine e soprattutto di effetti rispetto ai servizi che sono stati definiti banali. Mentre questi nei loro insediamenti, nell’architettura proposta e nell’articolazione degli spazi interni, hanno teso a “creare” una sorta di immagine urbana (ciascuno era come un “pezzo di città”) proprio per contrastare la loro dislocazione nella “campagna”, le “funzioni di governo” hanno continuato, in generale, a privilegiare la città tradizionale, scegliendo però come loro localizzazione le piccole e medie città esistenti nel territorio. In queste ultime hanno così finito per localizzarsi le funzioni “superiori” (o di “eccellenza”), prima esclusivo appannaggio della grande città, che sono risultate al servizio non del solo 19 ambito urbano, dove localizzate, ma di tutto l’ampio territorio. Sovrapponendo la dispersione di famiglie e attività produttive, la costituzione di poli di servizi banali, la dislocazione nelle medie città di “funzioni di governo”, si ricava un’immagine del territorio che è possibile identificare con quello che è stato chiamato un arcipelago metropolitano (Indovina, 2005). Una situazione nella quale i poli di eccellenza non si trovano più concentrati in un’unica città, ma anch’essi, per una parte significativa, risultano dispersi nel territorio preferendo le medie e piccole città. Si riproduce così, in una forma inedita, lo storico passaggio che ha investito alcune città facendole diventare metropoli e, per questa strada, gerarchizzando fortemente il territorio. Nella nuova situazione va posto l’accento non solo al fatto che le gerarchie territoriali appaiono molto più soft e che emerge una situazione reticolare, ma, soprattutto, alla possibilità che la condizione metropolitana non sia esclusiva di alcune poche città ma, piuttosto, comune a molti territori. Come si è già avuto occasione di scrivere: “non si tratta di un territorio senza gerarchie, ma sicuramente esso risulta caratterizzato da gerarchie più deboli di quelle di una città metropolitana; non si tratta di un territorio all’interno del quale sono scomparse le differenze sociali, ma queste appaiono mitigate dalla dispersione; non si tratta di un territorio omogeneo socialmente e culturalmente, ma che vive proprio di “differenze” e che, in prospettiva, potrebbe permettere forme di organizzazione insediative rispettose delle differenze culturali, senza per questo determinare ghetti; non si trat 20 ta di un territorio caratterizzato in funzione esclusiva del consumo, ma, piuttosto, appaiono sempre più integrate funzioni di produzione, di consumo, di loisir, culturali, ecc.”. Dal punto di vista morfologico il territorio dell’arcipelago metropolitano si caratterizza per l’esistenza: di attività pro duttive, in parte diffuse in modo disordinato, 2 in parte aggregate in aree produttive attrezzate; di poli commerciali e di “punti di vendita” (outlet) diffusi; di poli per il divertimento; di piccoli centri storici; di insediamenti residenziali nuovi, sia concentrati che diffusi; di medie città; di una fitta maglia di collegamenti stradali (che ricalca i collegamenti agricoli del passato ai quali è aggiunta una rete anche autostradale) e, talvolta, ferroviari. Un territorio attraversato da una fitta mobilità di persone, di informazioni e di merci. Ci si trova di fronte, contrariamente a quello che molti pensano, non tanto alla vanificazione della città, ma, piuttosto, ad una sua riproduzione alle nuove condizioni: sono preservati gli scambi non solo economici, si organizza uno spazio dove si creano e ricreano continuamente i “meticciati” culturali e si moltiplicano le relazioni sociali; un luogo dove si manifestano contraddizioni e conflitti, ma, contemporaneamente, si innova la vita economica, sociale e culturale. Che tale dinamica territoriale sia, in larga parte, frutto di processi di autorganizzazione, pone problemi di comprensione e soprattut2 “Se cerchi di seguire il nome di una ditta al terzo incrocio sei finito. (…) Non resta che chiedere aiuto con il cellulare ad una premurosa segretaria d’azienda multilingue: Guardi you ciappa da Conelliano verso Sacile, aòl semaforo di Pianzano gira a destra e non sbaglia. El va ‘vanti sette chilometri, s’el trova il passaggio a livello, vuol dire ch’el ga sbaglia strada, non lo passa, torna indietro, el vede una strada a destra , non la ciappa. Quella dopo a sinistra, oltre il sottopassaggio e non sbaglia. Trova un rotatoria non la prima, non la seconda… la quarta. Bravo! Va ‘vanti, prosegue e non sbaglia. Se arriva a San Fior è andato troppo avanti, torna indietro, sulla destra c’è zona artigianale, là el domanda ancora ma … el se rivà” (Paolini, 1999). 21 to di “governo pubblico” finalizzato, anche, a limitare gli aspetti negativi del fenomeno già citati. Ma tutto questo sarebbe argomento di un diverso seminario. 4. Oggi l’immagine della città si complica e, soprattutto, si moltiplica. La tradizione iconica (pittorica, fotografica e cinematografica) non è più quella “tradizionale” del secolo scorso; alle immagini di Manatthan, Roma, Venezia, Parigi, Londra, Firenze, ecc., che hanno formato una variegata cultura figurativa della singola città e, in generale, della condizione urbana (“moderna”), si sovrappongono ulteriori immagini che arricchiscono il vocabolario. Alla città descritta dai grandi romanzi che, a partire dal Settecento e, soprattutto, dall’Ottocento, hanno aiutato a riconoscere e conoscere la città moderna, oggi si affiancano descrizioni di nuove e diverse situazioni umane e urbane, quasi da romanzo di fantascienza, mentre si tratta di una estremizzazione della condizione data 3 . Non si sostiene che “prima” le città fossero tutte identiche tra di loro, ma, piuttosto, che era facile riconoscere i tratti comuni, la loro identica essenza. Oggi questa identificazione può appare più difficile ma, contemporaneamente, bisogna riflettere che, con più forza che nel passato, come si è già sottolineato, si afferma e diventa comune la condizione e l’esperienza urbana e metropolitana. Non solo bisogna riflettere sulle nuove forme della città e della metropoli, ma anche sulle esperienze che l’abitante di 3 Si può fare riferimento, perché molto apprezzati, ai molti romanzi di J.G. Ballard. 22 questi nuovi territori fa o è costretto a fare. Forse si è in presenza di un nuovo “soggetto”: non più soltanto l’immigrato (prevalente in ogni città dinamica), non più soltanto il forzato del pendolarismo (lavoratore o studente che sia), ma, anche e soprattutto, un soggetto “libero” e anche costretto a muoversi, in grado di vivere lo spazio nella sua completezza, di attraversare, quotidianamente, forme di organizzazione urbane diverse. Nei nuovi territori metropolitani, non sono eliminate né le differenze tra centro e periferia, né, ovviamente, le gerarchie spaziali, anche se “centro” e “periferia” hanno connotati diversi da quelli tradizionali. Le differenze tra i diversi punti del territorio continuano ad essere la conseguenza sia della differenziazione della rendita, sia della diversa dotazione di beni posizionali e dei servizi e si manifestano attraverso la divisione sociale dello spazio: ogni famiglia è “messa al proprio posto” che è determinato dalla collocazione sociale della famiglia stessa. La periferia, com’è noto, non è né fenomeno territoriale, né urbanistico, né edilizio, ma soprattutto sociale, esito del meccanismo economico-sociale. Si deve sottolineare, tuttavia, che le nuove forme di organizzazione metropolitana, per effetto della minore concentrazione, non esasperano tali differenze, che permangono, ma le mitigano. Vale la pena di affermare che fenomeni quali quelli schematicamente descritti possono leggersi in casi concreti: sia, e questo appare importante, in situazioni di consolidata tradi- 23 zione metropolitana (di area o di città metropolitana) – è il caso, per fare pochissimi esempi, di Barcellona in Spagna o di Milano – , sia in situazioni segnate dalla diffusione con scarse o nulle tradizioni metropolitane, come è il caso del Veneto centrale o della via Emilia. In questi esempi emerge la tendenza dei territori ad organizzarsi nella forma di arcipelago metropolitano o di città di città, dove il dato negativo del gigantismo urbano è rimediato da quella che appare come la povertà organizzativa dei territori dispersi, e dove i dati negativi (sociali, politici, amministrativi, culturali e gestionali) dei territori dispersi sono corretti da un “effetto metropoli” che garantisce accessibilità a funzioni superiori e produce forme di integrazione non tradizionali. 5. Le caratteristiche personali sicuramente sono importanti nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni sociali, ma deve essere sottolineato che un insediamento residenziale diffuso, per lo più a bassa densità (casa isolata), contribuisce notevolmente alla riduzione delle relazioni sociali, ad un rinchiudersi dentro una dimensione di socializzazione molto costrittiva e all’isolamento. Il processo di metropolizzazione del territorio contribuisce alla rottura di tale isolamento, non viene ricostruita la maglia delle possibili relazioni tipiche della città compatta, ma si moltiplicano le occasioni di socializzazione e di incontri, magari generati dalla necessità alla mobilità che una struttura territoriale diffusa genera. 24 L’offerta di sempre più numerosi servizi e l’abitudine alla loro utilizzazione genera una crescente mobilità e moltiplica le occasioni di incontro e di socializzazione. Ci si trova di fronte, da una parte, all’esperienza “comunitaria” e, dall’altra, a quella metropolitana. Sotto l’aspetto analitico fondamentale appare la questione della dimensione. L’esperienza “comunitaria” (piccola città o nuclei dispersi) si presenta come fortemente coinvolgete e, per così dire, omniassorbente. Una situazione che coinvolge tutti gli abitanti che fanno la medesima esperienza territoriale e che sono implicati e partecipi di un’unica realtà sociale e simbolica. Una dimensione territoriale ristretta, una popolazione non numerosa, un’esperienza comune e coinvolgente. La situazione nella metropoli si presenta diversa: non solo la dimensione territoriale è molto più ampia e la popolazione molto numerosa, ma l’esperienza metropolitana, da una parte, parcellizza l’esperienza di vita ma, dall’altra parte, moltiplica le occasioni di socializzazione ed esalta la libertà. Le caratteristiche dei due tipi di insediamento, con un rischio di un eccessivo schematismo, possono essere in qualche modo descritte. Nella comunità si hanno relazioni di tipo affettivo e personalizzate, alta solidarietà tra i suoi membri, una solidarietà che si esprime anche nel massimo del controllo sociale. L’esperienza quotidiana si presenta come ripetitiva, mentre modeste sono le occasioni culturali, le relazioni sociali esterne ridotte al minimo e segnate da una tratto negativo (quasi un tradimento). Molto alta l’identità comune. Nella metropoli la libertà individuale è molto alta anche per l’assenza di un 25 controllo sociale generalizzato. Le relazioni e le scelte sono di tipo razionale, mentre l’esperienza quotidiana è segnata dall’imprevedibilità. Le opportunità culturali e sociali sono molto numerose, ma è anche alto il senso di solitudine e di anonimato; la segmentazione sociale esprime tutte le sue valenze negative ed è scarso il senso di appartenenza e di identità. Così segni e simboli della metropoli sono parti consistenti dell’essere metropoli, ma essi non sono costitutivi (per intensità, per qualità e per percezione) dell’esperienza di tutti gli abitanti della metropoli. Così limiti e vincoli della condizione comunitaria sono comuni a tutti gli abitanti della comunità anche se alcuni suoi membri li lacerano (magari nascostamente) effettuando esperienze esterne alla comunità. Cogliere tali differenze, notare la forzatura di un esperienza in una caso e il vincolo limitativo nell’altro caso, costituisce un tratto importante. Questa semplificazione non dà conto della complessità e contraddittorietà della realtà, ma premeva mettere in evidenza il dato che tende a prevalere nelle diverse situazioni, con l’avvertenza, tuttavia, che va rifiutata ogni interpretazione di monodimensionalità; individuando le caratteristiche delle due situazioni è necessario tener conto che al loro interno sono presenti articolazioni soggettive diverse. L’insediamento della popolazione nell’arcipelago metropolitano, come già detto, risulta articolato: accanto ad insediamenti tradizionalmente urbani di grande dimensione, si trovano piccoli nuclei, città di piccola dimensione (la tendenza delle grandi e medie città a perdere popolazione è costante e 26 non si inverte), città medie, case sparse, aggregati di edilizia economica e popolare, ecc. Si notano, cioè, situazioni che potrebbero essere definite di “comunità”: anche la parte di popolazione insediata nel disperso in senso stretto, tende ad aggregarsi funzionalmente, culturalmente e socialmente alla “comunità” più vicina. Mettendo insieme l’uso metropolitano del territorio e l’insediamento residenziale in comunità viene fuori un’esperienza in qualche modo nuova, che fa propri gli elementi positivi dell’uno e dell’altro, i quali, insieme, annullano gli aspetti negativi dell’uno e dell’altro. Un esito, che va giudicato in modo molto favorevole, è l’indebolirsi di una identità legata al luogo. La tendenza a rinsecchirsi in una “identità locale”, tipica dell’esperienza di piccola comunità, viene “corretta” da una parte, dalla contemporanea esperienza metropolitana e, dall’altra parte, dal fatto che la comunità locale non risulta, il più delle volte, tutta autoctona, ma è costituita da persone di diversa provenienza (compresa quote più o meno ampie di immigrati stranieri). In sostanza si è in presenza di una diversa tipologia di esperienze che tende ad esaltare gli elementi positivi dei due modelli. In questo contesto è chiaro che le letture dei simboli territoriali si arricchiscono e che, contemporaneamente, le interpretazioni tradizionali di tali segni (metropolitani e di comunità) vanno aggiornate nell’ottica di una nuova dimensione urbana. Una particolare attenzione va posta all’analisi dello spazio pubblico. L’arcipelago metropolitano ha bisogno di una nuova 27 concezione dello spazio pubblico. Nella nuova dimensione, infatti, convivono sia spazi pubblici tradizionali, magari usati in modo non tradizionale, che spazi pubblici nuovi e tendono a diffondersi in maniera crescente “spazi privati di uso pubblico”. La ripetizione, fuori contesto e con significati impropri, di formule come “non luoghi” non aiutano certo ad analizzare con acume la nuova situazione. Non solo, quindi, diventa rilevante esercitare attenzione a classificare, tipizzare e costruire inventari di spazi pubblici e di uso pubblico, mettendo insieme tradizione e novità, ma pare altrettanto rilevante analizzare le modalità con le quali questi spazi vengono utilizzati, non sempre uguali nel tempo, da chi vengono utilizzati, e per quali scopi. Questa analisi, in realtà, dice molto della nuova condizione urbana, modifica pregiudizi e permette di dare corpo sociale alle nuove forme del vivere insieme. La nuova dimensione urbana è comunque figlia della crescita di “ricchezza” delle famiglie, sia ricchezza in termini monetari che di tempo. Non si sta sostenendo che si è tutti diventati ricchi, ma soltanto che le famiglie, pur nelle grandi differenze sociali, hanno maggiori disponibilità. Non si sta sostenendo che è scomparsa la povertà, ma piuttosto che, pur con le variazioni di tempo e di spazio, essa trova elementi di mitigazione. Non si sta sostenendo che nell’arcipelago metropolitano le differenze sociali sono scomparse, ma che esse si riproducono in qualche modo mediate sia nella forma comunitaria, sia nella polarizzazione sociale tipica dei centri di maggior dimensione. Per quanto riguarda il costo della vita, nell’arcipelago metropolitano si possono realizzare consisten28 ti risparmi, ma, per la loro realizzazione, sarà necessaria una notevole capacità organizzativa delle famiglie, disponibilità di tempo e capacità di mobilità. Qualsiasi sia l’organizzazione territoriale essa non riesce ad annullare differenze e contraddizioni create dalla struttura socio-economica; l’arcipelago metropolitano non sfugge a questa regola. Esso, tuttavia, pare presentare un sorta di diluizione delle situazioni problematiche. Inoltre, sembra di potere affermare che si tratta di una condizione territoriale che, spontaneamente, proprio perché partecipe delle due diverse esperienze (di comunità e metropolitane), realizza, come già detto, una “identità debole” che costituisce fattore che può aiutare la convivenza. Non quindi un territorio pacificato, privo di contraddizioni, di crisi e, anche, di conflitti, ma una forma di organizzazione che meglio può costituire un meccanismo di “risarcimento sociale” per quanti risultino penalizzati dall’organizzazione economico-sociale. 6. Come si colloca l’immigrato nella sua interezza, come persona integra, in questo nuovo contesto territoriale? Per tentare di dare qualche indicazione in proposito si rende necessario precisare alcuni aspetti senza i quali ogni risposta potrebbe risultare inconsistente e dettata da “buona volontà”. È possibile convenire che si sta attraversando un periodo nel quale al moltiplicarsi dei mezzi non corrisponda, come sarebbe lecito aspettarsi, un’aumentata diffusione della "cultura"e del "sapere". Fa da traino a questa situazione la "critica" della 29 ragione; il populistico rifiuto dell'illuminismo (origine di tutti i mali!) rappresenta il dato più evidente di tale fenomeno. In tale clima culturale i risultati più recenti e più avanzati della ricerca scientifica, proprio per i problemi che pongono al "sapere precedente" (che avanzamento sarebbe, altrimenti?), sia sul piano scientifico vero e proprio, che su quello etico, sono spesso risolti con la critica radicale delle procedure scientifiche e della loro lecità (in questo campo imperversano le diverse chiese). L'evidenza di relazioni sempre più complesse tra i diversi fenomeni che insistono sulla realtà (la divulgazione della nozione di "complessità") finisce per essere assunta come un ostacolo invalicabile alla “conoscibilità” della realtà stessa. L'evidente "disattenzione" che si è posta in passato all'entropia finisce per dettare una regola di vita “immobile”. Irrompe l'irrazionale e il mistico, si modifica, così, la cifra dell'atteggiamento con la quale si guarda al mondo, ai fatti della nostra vita quotidiana, agli stessi nostri interessi. Non più la "ragione" (il ragionare su, il ragionare perché, il ragionare come) governa i nostri passi 4 , ma il pathos. Siamo sempre più una società patetica. Sono l'istinto e il sentimento che dettano gli atteggiamenti (sia nel “bene” che nel “male”); si manda a quel paese il processo di civilizzazione che si fonda sul “governo” dell'istinto e si sfugge alla banale considerazione che la nostra istintività non è più "naturale" ma condizionata storicamente 4 Si potrebbe dubitare di un passato governato dalla “ragione”, d’accordo, ma forse non è possibile negare una riduzione della sua influenza sulle nostre vite. 30 e che l'assenza di un controllo consapevole libera scelte non dettate dalla convinzione. Funzionale a questo atteggiamento risulta la perdita della memoria (storica e sociale). Sbarazzarsi di ogni strumento che potrebbe permettere di interpretare il presente e quindi "condizionarci" è fondamentale per il prevalere del pathos. Non si tratta di un atteggiamento che influenza la vita intellettuale, esso dà frutti consistenti sul piano sociale e sull’operatività quotidiana. Un caso esemplare è quello che riguarda la “sicurezza” o, per meglio dire, il generalizzato senso di insicurezza: non si percepisce il costrutto politico della questione (Indovina, 2001) così si producono fenomeni pericolosissimi di razzismo, di caccia all’uomo, di tentativi di linciaggi (episodi proprio di questi giorni nel napoletano, ma non solo). Non si riflette, perché la ragione non conta e, appunto, prevale il sentimento che mettere in discussione il “monopolio della violenza” dello stato e apre la porta ad una società di violenza inaudita: tutti armati, tutti contro tutti. L’identificazione di tale costrutto collettivo (governato dal pathos) pare molto utile per comprendere gli atteggiamenti rispetto al problema che interessa questo seminario: il rapporto con le altre culture. Possiamo osservare come, indifferentemente, gli atteggiamenti “soggettivi” si caratterizzino per il rifiuto (razzista) o l'entusiastica accettazione (buonista). Nessun fondamento di “ragione” governa questa soggettività se non una risposta “istintiva” e di “sentimento” rispetto al problema del rapporto con la diversità. La sua scarsa fondatezza, nell'uno e nell'altro caso, dà luogo sia a manifestazioni possenti che ad un’instabilità di atteggiamento (per31 sone che hanno fatto chiara manifestazione di intolleranza razzista si possono, all'improvviso, commuovere per la disgrazia di un famiglia "diversa" e, a suo favore, mobilitarsi “sinceramente”). La "sincerità" dei sentimenti è data per acquisita e i sentimenti sono il dettato dell'istinto (come l'amore di madre, si dice). Storia, cultura, esperienza, tutto è apparentemente cancellato. La convivenza non può essere fondata sul pathos, ma deve essere razionalmente critica, proprio perché essa possa essere stabile, possa costituire una costante nel modo d’essere della società, non messa in discussione sulla base di emozioni di segno diverso. Con questo non si intende sostenere la cancellazione dei sentimenti nelle relazioni sociali, ma piuttosto tentare di costruire una modalità dove i sentimenti non travalichino investendo territori impropri. Affrontando il tema in discussione si cercherà di argomentare come una possibile "città della convivenza" rischi di essere una pretesa se non inquadrata nel contesto generale della "condizione urbana", quale quella che ha caratterizzato il formarsi del "cittadino". 7. La città moderna è il punto più intenso della contraddizione della nostra organizzazione sociale; da una parte è il concentrato delle differenze sociali che la nostra società produce (di reddito, di cultura, di consumo, ecc.), ma, dall'altra parte è il luogo canonico per il "risarcimento sociale" delle classi e dei ceti meno fortunati. Il sistema di sicurezza sociale che ha 32 carattere ridistributivo, è sostanzialmente urbano; la "cultura urbana" è, in senso generale, aperta e accessibile; il sistema degli spazi pubblici dovrebbe compensare le ristrettezze di quelli privati; ecc. La città è un luogo "duro", fatto di contrasti e anche di concorrenza, di conflitti sociali e politici nei quali l'appropriazione dello spazio è momento di tensione. Spesso descritta come il luogo della "solitudine", dove più drammatica può essere l'emarginazione, è, tuttavia, anche il luogo dove più intensa è la percezione e l'esercizio dei "diritti di cittadinanza", dove il processo di istituzionalizzazione può essere burocraticamente pesante ma, almeno in parte, permette di sfuggire alla dipendenza delle relazioni di potere. Certo è anche discriminante, soprattutto con i più deboli, con quelli che avrebbero più bisogno di sostegno, quale riflesso di una discriminazione costitutiva, di fatto, della nostra organizzazione sociale. La città dovrebbe essere idealmente (ideologicamente, più correttamente si dovrebbe dire) l'espressione delle esigenze di una comunità, la concreta realizzazione della giustizia sociale conquistata con lotte e sangue, il regno dell'affermazione delle libertà individuali, conquista, essa stessa, "politica". Nella realtà è molto meno di questo, vive nella contraddizione tra quello che dovrebbe e avremmo voluto che fosse e quello che le forze economiche e sociali (e politiche) realizzano. Non è né il frutto perverso di una volontà negativa, né l'errore di una classe politica, né l'espressione dell’incapacità collettiva, ma l'esito di una logica sociale che, pur nei contrasti, nelle contraddizioni e nei conflitti, si afferma. 33 La città, nella sua aspirazione, è il luogo dove si affermano i diritti di cittadinanza (qualsiasi sia il livello da loro raggiunto nello specifico contesto storico), frutto di lotte, i quali ampliano le possibilità e migliorano le condizioni di vita di tutti e, soprattutto, dei più deboli, ma, nella sua concreta materialità, risulta di fatto discriminante. Oggi, sempre più, piuttosto che parlare di "diritti" si invoca la "solidarietà", non si tratta di un semplice scivolamento linguistico: è la rappresentazione di una modifica di atteggiamento (e di cultura). Si passa, cioè, da diritti generalizzati e universalisti, garantiti dalla "collettività", affermati e gestiti, alla necessità di un coinvolgimento personale (volontario e, forse, "dovuto") quale mezzo per "rispondere meglio" ai bisogni dei singoli. Oggi è consuetudine criticare i "diritti", e la loro concreta realizzazione, perché asettici, impersonali o addirittura burocratici (quanto di conquista c'è in questa "impersonalità" viene spesso dimenticato) e, soprattutto, perché inefficaci e inefficienti (quando, addirittura, non vengono individuati come la causa del fiaccare della volontà individuale). La nuova frontiera è, appunto, la solidarietà, il “non profit” del servizio alle persone, ecc. Usando questa nuova terminologia si può affermare che la città è, nella sua idealità, solidale, ma, nella sua concretezza, non solidale. Assumendo, cosa non data, che per solidale si intenda l'esercizio in altra forma dei diritti di cittadinanza. Preme sottolineare come al convegno biennale del Gruppo Abele, don Ciotti abbia affermato “basta con la solidarietà, vogliamo diritti”, ove, evidentemente, non esecrava la solidarietà, ma portava in evidenza, da chi la solidarietà la prati34 ca quotidianamente, come questa può finire per esser uno strumento per limitare i diritti. Pare necessario, a questo punto, osservare che il "futuro" della città appare sempre meno favorevole. La società, infatti, per effetto di sue trasformazioni economiche, per l'affermarsi del principio delle "opportunità" contro quello dei diritti di cittadinanza, proietterà sulla città un indirizzo ancor meno solidale (detto in modo brutale, si stringono i cordoni per la spesa sociale). Se così fosse, tuttavia, non si potrebbe non affrontare la questione della "logica" che caratterizza l’organizzazione sociale. E' solo il mutamento di questa logica (che invece pare incancrenirsi) che può garantire una città della convivenza dove si affermi il principio di non discriminazione e di giustizia ed equità sociale per tutti.. Sono molto rari i periodi nei quali la città è cresciuta consistentemente per via "naturale", il suo accrescimento o declino è segnato dai flussi migratori. Tra città e migrazione, in un certo senso, esiste un rapporto molto stretto (Vidal Bendito, 1997). La città "accoglie", ma ogni volta, ogni nuovo immigrato è uno "straniero" che si deve integrare nella realtà della città. La città "accoglie", è banale dirlo, ma accoglie attraverso il filtro della propria scala di "valori sociali". Ogni immigrato ricco, per quanto sia di cultura diversa e di diversa etnia, troverà facile insediarsi (ad eccezione di momenti particolarmente tesi di ondata razzista esplicita e politica), potrà essere guardato con curiosità per la sua esoticità, ma non costituirà un problema. Al contrario, un immigrato povero, anche se della stessa cultura e dell’etnia prevalente nella 35 città, avrà dei problemi. Nel primo caso la città non ha da esprimere una solidarietà materiale, nel secondo caso la città è chiamata a moltiplicare la sua solidarietà 5 . Questo fa problema. Ciascun immigrato, con più o meno problemi, si insedierà (o sarà insediato dal meccanismo di “mercato”), secondo il proprio statuto sociale. La città, cioè, lo "accoglierà" ma lo metterà al suo posto. Lo collocherà nel contesto urbano (zona, accessibilità ai servizi, ecc.) secondo il suo status sociale in corrispondenza, nel migliore dei casi alla collocazione dei già residenti dello stesso strato sociale. La città, in sostanza, nel migliore dei casi, sarà solidale con il "nuovo arrivato" come lo è con il resto dei suoi abitanti (detti indigeni, anche se frutto di immigrazione del passato). Si manifesta, cioè, una sorta di automatismo urbano nell’assegnazione dello spazio e nella distribuzione nello spazio. 8. L’esistenza di una consistente quota di immigrati appartenenti ad altre culture e ad altre etnie, non può non modificare il nostro sistema di “accoglienza” 6 . La, così detta, immigrazione extracomunitaria, termine che esprime una grossa dose di "ipocrisia" (il riferimento, infatti, non è tanto ai giap5 C’è da riflettere sul fatto che, mentre si prospetta una società multietnica, si fa sempre più pressante un’opzione di “sangue”, la paura di perdita di identità per la vicinanza, fino al meticciato, del diverso esaspera il nazionalismo e la rivendicazioni di fattori di identità di basso profilo (Boatti, 1992; Di Nola, 1992; Rossanda, 1992). 6 Vale la pena ricordare che, nel periodo di più ampi flussi migratori dal sud del paese al nord, in alcune città (segnatamente a Torino) erano apparsi dei cartelli che dicevano “non si affitta a meridionali”. Questo richiamo serve per far riflettere come non possa considerarsi scontato un atteggiamento di “accoglienza” neanche nei casi all’interno dello stesso paese. 36 ponesi ricchi, ma agli africani o asiatici "poveri"), secondo alcuni, pone sostanzialmente due questioni: come modificare il nostro “stile” di accoglienza; quali conseguenze sull’organizzazione urbana. In realtà le questioni appaiono più complesse e si può sintetizzare nel modo seguente: la necessità di costruire un atteggiamento comprensivo della diversità culturale e la possibilità-necessità che tale diversità abbia dignità di cittadinanza nella città 7 . In sostanza, detto in modo molto semplificato, per questa popolazione si vorrebbero diritti di cittadinanza completi e, al tempo stesso, speciali. Diritti completi – e, su questo, l’accordo non potrebbe che essere totale – relativamente ai rapporti di lavoro ed economici, all'istruzione, alla salute, all’abitazione, ecc., fino a quelli politici (locali o nazionali); la necessità e l’opportunità che questa quota di popolazione acquisisca diritti di cittadinanza completi. Qui sta il massimo di arretratezza della situazione: è questa carenza che crea situazioni di forte disagio agli immigrati e alimenta una cultura del rifiuto nei residenti. Non solo la conquista piena di questi diritti di cittadinanza migliorerebbe molto la situazione degli immigrati, non solo farebbe di loro dei cittadini a pieno titolo, ma alimenterebbe, anche, una cultura della tolleranza (reciproca) 8 . 7 Non si affronta, perché esula dal ragionamento, la questione della legislazione che regola l'immigrazione dai paesi extracomunitari (poveri) nel nostro paese. Si rileva, soltanto, che si tratta di una legislazione controversa e fonte di nequizie e strumento per la costruzione di una cultura del "rifiuto". Essa, inoltre, è sempre in revisione costruendo una “incertezza” del diritto, funzionale allo sfruttamento dell’immigrato. 8 Andrebbe maggiormente argomentato come la "concessione" della cittadinanza (il diritto romano, insegna) non possa costituire un privilegio (che qualcuno detiene e che a qualcuno viene concesso), ma, in una società "democratica", una condizione dell'esistenza (della società democratica, prima che dell’individuo). 37 Solo in questo modo l’immigrato potrebbe non costituire l’esercito di lavoro di riserva di cui si serve il capitale per abbassare i salari e ricattare i lavoratori indigeni che, a questo punto, vedono nell’immigrato il nemico sociale, il concorrente, l’antagonista. Diritti speciali perché si aspirerebbe all’accettazione delle "culture" diverse e delle relative espressioni in ogni campo, compreso quello dell'organizzazione dello spazio. Qualcosa di più e forse di diverso di un'ampia tolleranza. Questione meritevole di attenta riflessione. La giusta critica ad ogni atteggiamento eurocentrico non può, infatti, costituire un vincolo per affrontare una questione così rilevante. Anche qui tende a prevalere il pathos. Nel caso di una cultura conservatrice, quello che emerge è il "rifiuto" (gli immigrati poveri, di altro colore e di altra cultura sono, così, tutti ladri, spacciatori, sporchi, puttane, fannulloni, ecc., "spediamoli a casa loro!"); nel caso di una cultura progressista il pathos suggerisce l'accettazione acritica (quando non esaltata) dei contenuti di tale cultura 9 . La cultura, in senso antropologico, costituisce sicuramente un potente strumento di identità: riti, abitudini alimentari, modi di fare, credenze, relazioni con lo spazio, costumi, ecc., tutto questo permette la costruzione di un’identità dell'individuo nel gruppo, del gruppo rispetto agli altri. Tutto ovvio, così come è altrettanto ovvio che, in una realtà "diversa", una 9 Ovviamente non si fa riferimento al manifestarsi di azioni illegali (spaccio di droga, controllo della prostituzione, ecc.) che, si conviene, devono essere repressi con gli stessi mezzi (non maggiori né minori) a prescindere da razza, cultura e religione; ci si riferisce a manifestazioni "lecite" delle culture diverse, o a quelle che diventano lecite perché, appunto, "espressione" di culture diverse. 38 minoranza che non volesse perdere la propria cultura finirebbe per accentuare, in un certo senso, gli elementi evidenti di questa (in una sorta di estremismo espressivo) 10 . Per il ragionamento che si intende sviluppare, si vorrebbero mettere in luce alcune altre caratteristiche delle "culture" (in generale e al plurale, comprendendo anche la “nostra”). Esse costituiscono l'espressione “autonoma” (ma non indipendente) della materialità sociale; rappresentano il come, in uno specifico contesto di relazioni sociali, di mezzi e tec niche di produzione, di rapporti economici, attraverso i quali una data società organizza il suo modo di essere. In particolare i mezzi e gli strumenti adoperati e le modalità seguite per produrre le cose di cui si ha necessità (e che determinano le stesse necessità) costituiscono un fattore molto potente (anche se non esclusivo) nel determinarne i connotati. È per questo che le culture non risultano stabili, esse variano nel tempo, una variazione che è determinata da fattori materiali, ma anche da fattori “culturali” veri e propri (che vanno dall'avanzamento delle conoscenze, alla "critica" dell'esistente in qualsiasi forma esercitata). Infine, ed è un aspetto rilevante, la cultura, oltre che potente fattore di identità, è anche un altrettanto potente fattore di dominio. Essa è finalizzata (endogamicamente, si potrebbe dire) alla riproduzione di quella determinata società e delle relazioni di potere e di discriminazione esistenti in tale società. 10 “Viviamo in una società i cui problemi della cultura e dell’identità sono diventati centrali (...). Diciamolo diversamente: la questione del razzismo e dell’antirazzismo è divenuta di rilievo nella nostra vita collettiva, non soltanto per ragioni etiche e morali, ma anche perché essa si iscrive nel cuore dei processi attraverso i quali la cultura si impone come oggetto centrale dei dibattiti e dei conflitti” (Wieviorka, 1995). 39 Mi sembrerebbe ovvio che la cultura come strumento di potere dovrebbe essere "criticata" nelle sue concrete manifestazioni. Così, ma è un esempio tra tanti, non è possibile accettare che le culture "altre" si costituiscono come strumento di una sottomissione (per altro estrema) delle donne rispetto agli uomini, perché è possibile assumere che l'eguaglianza tra i sessi non sia una valore relativo, ma un strumento del processo di liberazione dalle barbarie dell'umanità (non è come la diversa abitudine all'uso di determinate spezie). E questo vale anche se la singola donna accettasse la sua condizione, non solo perché tale accettazione è l'effetto, appunto, del potere della "cultura", ma perché anche dal la critica può emergere un rinnovamento. Una critica che non può escludere, ma anzi deve comprendere, come appunto battaglia culturale, anche le manifestazioni esteriori di questo potere imposto. Anche il principio dell'integrità del corpo, esito di una lotta multisecolare contro la manipolazione che il potere faceva dei corpi, non può che essere affermato. Se è ineccepibile premere perché si abolisca la pena di morte, ove ancora sussiste, che nella sua essenza non è che l'espressione di una cultura che privilegia il valore scoraggiante della pena estrema o il diritto di una società ad eliminare il "peccatore" (l'inquisizione non è mai dimenticata), così sembrerebbe assolutamente ovvio il rifiuto e la contestazione delle culture che presumono la necessità della manipolazione del corpo (anche qui come strumento di potere). Detto brutalmente non solo 40 l’infibulazione non va accettata, ma va combattuta 11 , così come non vanno rispettate le "fedi", come accade per i testimoni di Geova, che rifiutano determinate cure. Potrebbero essere portati altri esempi, ma non importa. Insomma, una cultura dominante non è mai uno strumento di di emancipazione bensì di potere e come tale va combattuta12. 9. Come già detto la cultura è anche il dettato dei rapporti sociali materiali, il riflesso delle relazioni interne ad una società per la realizzazione delle cose di cui ha bisogno, ma, se così fosse, allora sarebbe necessario chiedersi cosa avviene di queste culture "altre" quando i suoi “portatori” entrano, come soggetti attivi, nel rapporto sociale di produzione di tipo capitalista. E' facile dire che si modificherà il rapporto con il lavoro, con il tempo, con lo spazio, con lo scambio e con la "moneta". Insomma tutto il modo interiore si modifica. Questo, cioè, non può non avere effetti, non incidere sui valori, sui presupposti, sulle radici stesse; il dato di fatto è che la cultura viene terremotata (la stessa cosa è avvenuta per i contadini meridionali quando sono andati alla catena di montaggio in Fiat). 11 Su questo terreno anche la cultura progressista presenta le sue contraddizioni; per esempio l'infibulazione è da tutti (quasi) negata, mentre la circoncisione non ha un altrettanto rifiuto. Per non parlare delle manipolazioni così dette estetiche (piercing, tatuaggi, ecc.), tutte da criticare non per ragioni estetiche, ma etiche. Più complessa e la questione della "body art" dove l'elemento "scandaloso" costituisce forse una prevaricazione del principio generale. 12 E' il caso di ricordare le grandi battaglie "culturali" combattute dalle forze progressiste in Italia. Non soltanto per il divorzio e l’aborto, ma, per esempio, alle lotte condotte contro un certo costume prevalente nel mezzogiorno di prevaricazione della condizione della donna; le battagli per l'affermazione di un atteggiamento laico dello stato nei riguardi dell'insegnamento; contro il "delitto d'onore" (costume prevalente, anche se non esclusivamente, nel mezzogiorno), ecc. Certo, le battaglie non sono mai vinte del tutto (e in questi giorni se ne ha evidenza). 41 Ma se così fosse, è lecito chiedere se quella che appare cultura "diversa", da difendere e salvare, non sarebbe altro che esteriorità, "manifestazione folcloristica", cioè "tradizione" trasformata in merce (del resto, di tale trasformazione si hanno, nella città, moltissimi e diversi esempi). Può darsi che di questo fatto non ci sia piena consapevolezza, ma accettare questo stato comporta alimentare un equivoco e anche una specie di schizofrenia sociale e individuale. Non solo, ma la "cultura" salvata, per così dire, al di fuori delle sue proprie radici materiali, finirebbe per essere, sempre di più, puro strumento di potere, perdendo la caratura “originaria” identificativa e partecipata. Si ha consapevolezza che il terreno affrontato è un terreno minato, ma se si assumesse – né potrebbe essere diversamente un dinamismo interno alle culture, sarebbe utile svelare questi aspetti, criticare gli elementi negativi, aiutare il dinamismo trasformativo. Tra "culture" diverse e intensamente vissute, gli elementi di "confronto" (scontro) non sono pochi; ipotizzare un'accettazione "pacifica" è possibile solo nella presunzione di un atteggiamento di indifferenza, sia verso la propria che l'altrui cultura. Un atteggiamento di indifferenza non fonda una buona convivenza, ma piuttosto uno stare insieme quanto mai precario e instabile. La convivenza partecipata, quindi, non potrà che produrre un continuo confronto, presupposto e base per un dinamismo interno alle singole culture (dinamiche che 42 possibile definire in linea generale evolutive, ma su questo la discussione, come è noto, risulta molto aperta). Le formule sono sempre semplificatrici di una realtà molto complessa, ma, per sintesi, si può sostenere che l'atteggiamento più corretto e condivisibile non potrebbe che essere quello sintetizzabile nella formula "massima convivenza con le persone, ma critica serrata alle culture" (che pare il contrario di quello che sembra prevalere). Ma in che direzione? Non certo verso una semplice integrazione, ma piuttosto verso quello che sempre più spesso si chiama un progetto di meticciato. Sembra un’opzione quanto mai corretta sul piano culturale, sociale e politico, né sembra utile, in questa sede, dilungarsi sulle valenze positive di un trasfusione reciproca di valori (non solo di ricette culinarie). Tuttavia il meticciato è facile a dirsi, ma molto difficile a realizzarsi. Non solo per le resistenze diffuse verso la diversità, ma anche perché tali diversità appaiono spesso molto meno flessibili e "meticciabili". 10. Si cercherà di mettere in luce un possibile indirizzo di "governo urbano" che non sia discriminante verso le culture "diverse" e sia rispettoso dell’individuo, senza distinzione di razza e religione, sesso, ecc. La città moderna fonda la sua natura sull'accettazione della diversità, se fosse vero che parte consistente del suo dinamismo sembrerebbe fondato sull'immigrazione. Tale accettazione, tuttavia, avviene in un ambito ben delineato, quello della 43 "società di maggioranza", di una collettività che, pur nell'ambito di accentuati e forti conflitti di interesse, si riconosce come unità, nella quale tutti sono partecipi di un comune sentire civico. Non si fa riferimento ad una presunta omogeneità, né ad omologazioni, né all'assenza di differenze (soprattutto sociali) o di conflitti, ma a qualcosa di più sottile e insieme più importante: alla percezione individuale e collettiva di appartenere ad una comune organizzazione sociale (che magari alcuni vogliono trasformare – rivoluzionare – e altri conservare, ma di cui tutti sono parte). Una percezione, questa, che fonda l'interesse generale (costitutivo della stessa cittadinanza), valore oggi quanto mai negletto e il cui "tramonto" colpisce i settori della comunità più deboli con possibili effetti deleteri sulla stessa organizzazione urbana. E' solo in questo contesto che l'individualità esprime il massimo della sua potenzialità, in un ambito di "garanzie" riconosciute. Appropriata pare la formulazione di individualismo ben temperato, di un individualismo che si connette agli altri e che, da questa connessione, subisce, insieme, una limitazione, ma anche un potenziamento. Tutto il contrario dell’individualismo assoluto al quale oggi si fa sempre più riferimento sia come espressione delle “potenzialità” individuali che come “affermazione” di identità che, di fatto, finiscono per negare l’uno e l’altro. Alla società di maggioranza si oppone una società di minoranze nella quale configurazioni sociali e culturali (e anche etniche) diverse, convivono in modo accostato. Una configurazione (anche in termini spaziali) ideologicamente giustificata da buoni sentimenti, come il rispetto della diversità e il ricono44 scimento che tale diversità possa esercitarsi in ogni ambito (compreso quello spaziale), ma, in concreto, dettata da reciproca diffidenza e dove ciascuno, nella propria "cittadella", trova il massimo di identità e sicurezza nei riguardi delle altre diversità. Non tanto un buon diritto, ma una pericolosa paura. Del resto il XX secolo, fino al suo tramonto, narra degli esiti tragici ai quali sono giunte le società di minoranza. Ma non si vorrebbe sfuggire a qualche considerazione "pratica" su come la città possa accogliere i flussi di immigrati di diversa cultura ed etnia i quali quasi sempre, invece, sono costretti a vivere in situazioni "inospitali" e di emarginazione. Un "governo urbano" che non voglia essere segregazionista, ma voglia costruire e alimentare una società di maggioranza, come prevenzione di mali maggiori, non potrebbe che partire dal riconoscere a questi nuovi "cittadini" il complesso dei diritti di cittadinanza già attivi: alla salute, all’istruzione, all’abitazione, politici, compreso quello all'esercizio di attività economiche autonome. Non si tratta di azioni integrazioniste, ma soltanto di fornire i mezzi (compresa la capacità di comprensione) per una migliore conduzione della vita quotidiana e fornire, concretamente, l’idea di una “parità” di tutti con tutti. In concreto significa che, insieme al riconoscimento della “residenza” 13 , il nuovo cittadino debba ricevere il libretto sa- 13 Qui c'è il problema delle "quote" e dell'immigrazione clandestina. E' certo che le quote costituiscono un fattore "odioso" di esclusione, è certo che sulla numerosità dell'immigrazione si è molto giocato per assecondare le posizioni più conservatrici (e spesso razziste), ma, contemporaneamente, le quote andrebbero definite sulla base di criteri di equilibrio sociale reale. Il pericolo di un "rigetto" collettivo è sempre possibile, ovviamente esso è tanto più rilevante quanto questi immigrati sono lasciati senza diritti e in condizione di emarginazione, esso va combattuto politicamente e culturalmente, ma anche, in un certo senso, sulla base di un equilibrio sociale. 45 nitario, il diritto a partecipare all'assegnazione di abitazioni pubbliche e, dopo un certo minimo tempo, il certificato elettorale con i connessi diritti attivi e passivi, il diritto per bambini e giovani di frequentare la scuola, il riconoscimento e la parificazione del titolo di studio di provenienza, ecc. In sostanza, la "gestione" dell'immigrazione è questione "sociale" non di "polizia" (come invece spesso avviene). Si potrebbe dire “in parte questo già avviene”, ma, intanto, quell’“in parte” non tranquillizza (e gli altri?), senza contare che poi queste opportunità appaiono, da una parte, una “concessione” e, dall’altra, uno “strappo”. Così come, anche se in astratto, ogni nascituro indigeno riceve, oltre il nome, il carico di “diritti di cittadinanza” esistenti a quel tempo, così ogni immigrato dovrebbe essere dotato degli stessi diritti. Le modalità della loro concessione non sono solo forma, ma costituiscono sostanza sia per l’immigrato, ma anche per i cittadini indigeni che finiscono per viverli, proprio perché si presentano come eccezione, come una sottrazione dei loro diritti, senza avere consapevolezza che sarebbe proprio l’assenza di tali diritti agli immigrati a mette in discussione non solo la convivenza, ma anche lo stesso esercizio degli stessi diritti per gli indigeni (per esempio nei rapporti di lavoro). Solo in questo modo l'immigrato evita di essere mera "carne da lavoro" (magari in nero; magari senza il rispetto di norme di salario, di orario e di salvaguardia della salute, ecc.; magari impegnato in attività criminali, non solo il traffico di droga e la prostituzione, ma anche il trattamento dei rifiuti tossici, il contrabbando, ecc.). 46 Una gestione urbana conseguente mentre dovrebbe evitare, per quanto possibile e certo non con l'uso repressivo, il formarsi di zone omogenee per etnia e cultura (la formazione di ghetti non aiuta la convivenza), al contempo dovrebbe garantire la realizzazione di edifici di culto che, per dimensione e numerosità, siano corrispondenti alla relativa popolazione (non sto parlando di una proporzione matematica, ma di una gestione attenta della cosa) e di ambienti propri di riunione, incontro e socializzazione, separati e distanti da quelli di culto. Edifici "religiosi" e "civili" propri per ogni cultura ove facilitare l’associazionismo, non solo la comunità religiosa. Non basta, una gestione della città attenta dovrebbe contribuire a realizzare iniziative adatte a valorizzare gli apporti positivi che le singole culture possono fornire: espressioni artistiche, tradizioni, esposizioni di prodotti, manifestazioni culinarie, ecc. Così come andrebbe garantita e facilitata l'attività commerciale specializzata e, al contempo, integrata alle altre. E' proprio in quest'ambito che un "buon" governo urbano dovrebbe occuparsi degli spazi pubblici (una tradizione che in Italia si è persa), come luoghi non solo al servizio del "commercio", ma, soprattutto, alla socializzazione. In una città multiculturale quello dello spazio pubblico diventa un esigenza rinnovata proprio per le finalità di "convivenza" pacifica: una convivenza pacifica è frutto, anche se non esclusivo, di una pratica quotidiana di contatti, di confronti, di un "mischiarsi" e "scontrarsi" continuo. Creare queste opportunità non significa soltanto moltiplicare gli spazi pubblici, ma, ad essi, dare un senso civile e sociale, di colloquialità urbana. 47 Il governo urbano della città multiculturale pretende più attenzione, più iniziativa, più cura. Sarebbe compito "istituzionale", oltre che politico e sociale, promuovere (con attenzione e senza supponenza) la critica di tutte le manifestazioni, abitudini, riti che ledono diritti universali (come prima indicato). E' da qui che può iniziare una "critica interna" delle singole culture, unico ed efficace strumento di trasformazione. Ovviamente, nello stesso tempo, l'immigrato deve farsi carico dei doveri relativi alla cittadinanza: il rispetto generale delle leggi. E' solo in questo modo che l'immigrato può sentirsi accolto, vedere difesa (anche se criticamente) la propria cultura, la cui espressione non costituisce elemento di esibizione antagonistica, ma necessità individuale di identità (ed è così che si sfugge alla "manifestazione folcloristica”); è in questo modo che riesce a recepire "del mondo che trova" – verso il quale è stato spinto sicuramente dal bisogno, ma che costituisce anche una condizione ambita – la complessità e la contraddittorietà. Ed è solo così che l'indigeno può accogliere la diversità, vedendo nell'immigrato non il "ruba lavoro" (o peggio), ma il portatore di una cultura e di saperi diversi, magari curiosi, ma che sicuramente arricchiscono la realtà urbana. Si è solo nell'ambito dei propositi? In parte, infatti, alcune amministrazioni si sono mosse (con lentezza e non completamente) in questa direzione, anche se nell’ultimo periodo si colgono molti passi indietro. È importante, tuttavia, avere la consapevolezza che solo con percorsi di questo tipo si può fondare una società multiculturale che sommi alle contraddi48 zioni della nostra società quelle del multiculturalismo, ma che faccia degli abitanti tutti della città o della metropoli, i soggetti attivi della costruzione della convivenza. La “convivenza” con la diversità costituisce un valore che si accumula; se si accetta la convivenza con le altre culture si riesce ad essere convivente con ogni diversità; in caso contrario, si avvia un processo di esclusione che finisce per esaltare la discriminazione (gli stranieri siano i ben venuti, ma…; gli omosessuali mi sono indifferenti, ma…; le coppie di fatto sono fatti loro, ma…; le altre religioni sono importanti, ma…). È noto che, negli insediamenti di piccole dimensioni, quote relativamente modeste di immigrati trovano situazioni di favorevole accoglienza (vale ripetere che la frequentazione aiuta al riconoscimento reciproco). A partire da questa osservazione vale la pena di rilevare come le considerazioni fatte all’inizio circa la costruzione di metropoli territoriali o di arcipelaghi metropolitani, possono costituire la forma (nuova) della metropoli che meglio si presta alla convivenza. In questi nuovi territori, infatti, gli immigrati da una parte trovano soluzione alla vita quotidiana (e anche alla loro accettazione) negli aggregati minori, e dall’altra, nella dimensione metropolitana trovano l’ambito privilegiato per la ricerca di occupazione. Inoltre, la costruzione di “comunità proprie” non necessariamente dev’essere spaziale, con la costruzione di ghetti, ma può realizzarsi a livello metropolitano. Non si sostiene che i problemi della convivenza sono risolti, ma piuttosto che forme di organizzazione spaziali di “comunità” cos- 49 tituiscono ambiti favorevoli all’accettazione e che la loro “oppressione”, anche amorevole, sia nel caso degli indigeni che degli immigrati, trova limitazione e compensazione nella dimensione metropolitana. Il clima politico e la costruzione, attraverso questa strada, di una cultura dell’accoglienza e del riconoscimento, appare fondamentale, tuttavia se la politica costruisce, al contrario, un atteggiamento di rifiuto e di diffidenza, giustificandolo con costruzioni dette “oggettive”, allora la reazione dell’opinione pubblica non potrà che essere quella del rifiuto e magari della persecuzione. La storia, come è noto, difficilmente è maestra, ma certo essa ci offre scenari già realizzati che non possono che spaventare e che esigono una reazione politica e culturale. 50 Bibliografia di riferimento e citata G. Boatti, (1992), “La sindrome di Krasnow”, in AAVV, Radici e nazioni, ed. Il Manifesto A.M. di Nola, (1992), “L’incubo del meticciato”, in AAVV, Radici e nazioni, ed. Il Manifesto F. Indovina, (1990), La città diffusa, (a cura di), D.a.e.s.t, Quaderno n.1 F. Indovina, (1997), “Città solidale versus città dei diritti” relazione presentata ad un convegno sulla “solidarietà” Politecnico di Milano (non pubblicata) F. Indovina, (2001), “Post-fazione. Una città sicura, come?”, in Archivio di studi urbani e regionali, n.68, pp. 149-201, ora anche in E. Milanesi, A. Naldi (a cura di), Cantando sotto la pioggia. Sicurezza ed insicurezza urbana, Franco Angeli, Milano F. Indovina, (2003) “La metropolizzazione del territorio. Nuove gerarchie territoriali”, in Economia e società regionale – Oltre il ponte, nn. 3-4 (traduzione spagnola e inglese in L’explosiò de la ciutat, catalogo della mostra stesso titolo; anche in L’esplosione della città, catalogo della mostra stesso titolo, Compositori, 2005) 51 M. Marcelloni (a cura di), (2005), “La nuova dimensione urbana. L’arcipelago metropolitano”, Questioni della città contemporanea, F. Angeli; M. Paolini (1999), Bestiario veneto, Edizione Biblioteca dell’Immagine (Avverte l’autore che il testo è tratto liberamente da P. Rumiz, “La secessione leggera”) R. Rossanda, (1992), “L’io senza radici”, in AAVV, Radici e nazioni, ed. Il Manifesto T. Vidal Bendito, (1997), “Ciutat i immigraciò: dos fets inseparable” in Manuel Delgato (ed.), Ciutat i immigraciò, Centro de Cultura Contemporània de Barcellona, Barcellona M. Wieviorka, (1995), “I paradossi dell’antirazzismo”, in Confronto, n. 1 52 Amori possibili. La via della mixité sentimentale alla comunicazione tra culture Gaia Peruzzi Gaia Peruzzi è docente di Comunicazione Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Sassari. Sul tema dell’immigrazione ha scritto: Le coppie miste in Toscana. Antiche vie e nuove strade di comunicazione tra culture, Pisa, Felici editore, 2006; I quotidiani locali raccontano l’immigrazione. Luoghi e storie di un’altra Sardegna, in Sociologia Urbana e Rurale, a. XXVIII, n. 83, 2007; Amori possibili. Le coppie miste nella provincia italiana, di prossima pubblicazione. 53 54 Premessa Due sono state le richieste espresse dagli organizzatori del convegno ad ispirare e vincolare la preparazione di questo intervento. La prima era che, essendo l’occasione un seminario conoscitivo, l’obiettivo principale fosse far conoscere aspetti nuovi, poco noti del fenomeno immigrazione. La seconda era che si trattasse di aspetti dell’immigrazione che si spingessero oltre il lavoro, come suggerisce appunto il titolo stesso di questa giornata. Il mio tema, le coppie miste, risponde ad entrambi i requisiti: le coppie miste sono un fenomeno emergente, oggi, in Italia e sono anche un oggetto di studio ancora poco indagato; inoltre, la via della mixité sentimentale mira alla comunicazione tra culture, attraversando campi diversi da quelli del lavoro, ovvero la sfera sentimentale e la vita intima e familiare. Ancora, un’altra breve premessa sul titolo. Utilizzo una parola straniera perché non ho trovato un sostantivo italiano che mi convinca più di mixité. E preferisco spesso comunicazione a integrazione perché la comunicazione è un luogo, un processo, un tentativo in cui si cerca di mettere in comune, di condividere qualcosa, per costruire un clima, un’identità, una relazione che risulteranno sempre nuovi. 55 Le coppie miste in 8 punti Questo intervento è un percorso scandito in 8 tappe, individuate da altrettante domande-chiave. 1. Perché le coppie miste sono interessanti? Perché il fenomeno oggi interessa, oltre agli operatori e agli esperti dell’immigrazione, anche i sociologi della cultura e della comunicazione? 2. Che cos’è oggi una coppia mista? La letteratura, che per decenni ha parlato di matrimoni misti, ormai parla spesso di coppie miste: perché? 3. Qual è lo stato attuale della ricerca sulle coppie miste in Italia? 4. Quante e quali sono le coppie miste in Italia oggi? 5. Dove nascono e come si formano oggi le coppie miste in Italia? 6. Come reagisce la società italiana al formarsi delle coppie miste? 7. Quali sono le diversità che fanno problema, oggi, nella vita privata delle coppie miste che abitano nel nostro paese? I dati e le informazioni per queste risposte provengono da una serie di ricerche che chi parla ha condotto negli anni, integrando analisi quantitative e interviste a partner ed expartner di coppie miste e che saranno a breve oggetto di una pubblicazione (Peruzzi 2008). Questa relazione ne costituisce in pratica un’anteprima. La natura sintetica di alcune parti dell’esposizione è dovuta, ovviamente, ai limiti di tempo previsti per questo intervento. 56 “Non c’è integrazione senza inter-matrimoni” (Braudel 1986).“I matrimoni misti sono l’indicatore ultimo di assimilazione o di segregazione che può opporre la propria verità a quella degli indicatori politici o ideologici” (Todd 1994). “I matrimoni misti sono l’indice della volontà degli stranieri di radicarsi nella società ospite e della capacità della società ospite di accettarli totalmente”(Streiff-Fenart 1989). I matrimoni misti – ma anche le coppie miste non sancite da unione matrimoniale, come vedremo tra poco – sono un indicatore classico dell’integrazione tra autoctoni e stranieri su un territorio perché, parlando con parole semplici, se uno straniero e un autoctono arrivano a sposarsi significa che si è avviato un processo, un progetto serio e profondo di avvicinamento e di integrazione. Un’interazione, appunto, non di solo lavoro. Le frasi emblematiche dei tre autori appena citati spiegano perché i matrimoni misti sono considerati un osservatorio privilegiato dell’incontro tra differenze: essi sono uno di quei luoghi in cui si possono vedere immigrati e autoctoni che comunicano, che cercano cioè di costruire insieme un progetto di convivenza non conflittuale, condiviso. In letteratura si chiamano unioni endogamiche i legami sentimentali fra un uomo e una donna che appartengono al medesimo gruppo (e dunque simili) ed esogamiche le unioni con un partner che proviene da un’altra cerchia, differente. Poi, ci sono le coppie miste. La coppia mista è un matrimonio o un’unione con uno straniero o con una straniera: con qualcuno, 57 1. Perché le coppie miste sono interessanti? cioè, che non solo è diverso da me – diverso perché non fa parte della cerchia dei miei conoscenti o di coloro che sono simili a me per censo, per livello di istruzione, per abitudini – , ma che, invece, è lontano da me, molto diverso. La coppia mista è qualcosa che va al di là, oltre l’esogamia, perché è il matrimonio con lo straniero, con colui che è non solo diverso, ma anche sconosciuto. Il matrimonio misto è l’annuncio di un cambiamento per la società, l’annuncio che la società, il mio gruppo, la mia comunità, in qualche modo, si sta contaminando con lo straniero, con una diversità altra, forte, sconosciuta. In questo annuncio di cambiamento consistono la forza e il valore di queste coppie. Le unioni miste “spaventano” anche per un secondo motivo: non solo introducono lo straniero nella comunità, ma, spesso, queste relazioni si presentano anche, allo sguardo, un po’ “anomale”, eccessive. Spesso infatti esse si caratterizzano per delle asimmetrie molto forti, vistose, tra i partner: differenze di età, dislivelli di istruzione o di censo che non si trovano facilmente nelle coppie “normali” e che, invece, qui appaiono così forti da attirare l’attenzione e, talvolta, pure il fastidio della gente che le circonda. Vedremo più avanti a cosa sono da attribuirsi queste asimmetrie. Riassumendo il primo punto, le coppie miste interessano gli operatori e gli scienziati sociali perché sono un sintomo forte, un indicatore non solo dello stato di accettazione dello straniero da parte della società ospite, ma anche dello stato di mescolamento fra indigeni e nuovi arrivati. 58 In una società culturalmente chiusa e più omogenea di quelle attuali era abbastanza intuitivo immaginare un’unione mista: l’unione con uno straniero, ovvero unione con una persona che, venendo da fuori, “automaticamente” parlava un’altra lingua e aveva, quasi sempre, una religione, costumi, stili di vita e abitudini completamente diversi. Ma oggi, nelle nostre società complesse e frammentate, chi è lo straniero e, dunque, qual è l’unione mista? Che cosa vuol dire essere una coppia mista oggi? Viviamo in società aperte nelle quali le nuove tecnologie, i media, le leggi e un’educazione più democratica ci hanno abituato alla compresenza di nazionalità diverse, al movimento incessante e alla contaminazione di mentalità, forme e tendenze culturali. Quali sono, in questa nuova realtà, i confini problematici, quelli che fanno mixité sentimentale? Proviamo a tracciare delle linee partendo dai due termini del concetto: il sostantivo unione e l’aggettivo misto. Le unioni sentimentali comprendono da sempre i matrimoni, oggi, tuttavia, una ricerca su questo tema non può permettersi di tralasciare le convivenze tra due partner anche nel caso in cui non siano sancite dal massimo vincolo ufficiale. Sarebbe inoltre interessante includere in un campione di unioni misteanche le convivenze omosessuali miste, anche se, in una fase ancora esplorativa della ricerca, forse è ancora prematuro. 59 2. Che cos’è oggi una coppia mista? Passiamo al secondo vocabolo, l’aggettivo misto. La letteratura quando parla di matrimoni e coppie misti fa riferimento a differenze fra i partner di provenienza (regione o paese), religione, lingua, cultura o etnia (quest’ultimo in corsivo perché è un termine comunemente usato, ma scientificamente poco affidabile). Mi sono domandata, fin dall’inizio delle mie ricerche, quali di questi elementi oggi danno veramente fastidio, provocano problemi all’interno e intorno alla coppia e, dunque, creano mixité. Lo sforzo delle mie indagini era quello di attualizzare, passandoli in rassegna nelle testimonianze degli intervistati, i criteri fondanti la mixité tramandati dalla letteratura. Ho scelto come perno della mixité la differenza di nazionalità. Ovvero, ho scelto come miste le coppie bi-nazionali. Sapendo bene che anche questo criterio presenta dei lati ambigui perché è chiaro che un italiano sposato con una francese o con un’americana fa meno “scandalo”, meno mixité dello stesso italiano coniugato con una giapponese, una polacca o una marocchina. Inoltre, poiché all’inizio di questo viaggio non potevo sapere quali fra le altre differenze storicamente candidate a “sostanziare” la mixité sarebbero risultate poi davvero problematiche nei contesti contemporanei, ho scelto, un po’ come guida del mio percorso, questa definizione che hanno dato due studiose francesi del fenomeno: “sono miste tutte quelle unioni concluse tra religione, etnie, razze differenti quando queste differenze provocano una reazione da parte dell’ambiente circostante” (Bensimond e Lautman 1977). 60 Mi sono inoltrata, dunque, in un terreno inizialmente molto vago, “fangoso”, mettendo i piedi in criteri che, talvolta, si rivelavano effettivamente solidi, talvolta, invece, non reggevano all’esperienza; via via ho cercato di capire quali di questi provocassero reazioni all’esterno della coppia e quali, invece, conflitti interni ad essa. Le coppie miste in Italia sono un fenomeno emergente, ma ancora poco conosciuto. Poco conosciuto perché poco indagato. Rispondere alla domanda: “quante sono le coppie miste oggi in Italia?” non è facile, per diversi motivi che accennerò brevemente. Intanto in Italia si possono rilevare solo i matrimoni perché le convivenze, che sarebbero interessanti da studiare, non sono registrate. Già questa, evidentemente, è una restrizione molto forte. Anche limitandosi ai matrimoni, la situazione rimane complicata. Quali sono le fonti che registrano i matrimoni misti? Dovrebbero esserci i dati del Censimento, ma, a parte il fatto che quelli del 2001 sui matrimoni misti non sono stati pubblicati, le rilevazioni avvengo solo ogni dieci anni. Ci sono poi le Anagrafi comunali. Considerate però che occorre recarsi in ogni comune, chiedere i dati, ripulirli per l’occasione.Il lavoro è fattibile (personalmente l’ho fatto per tre comuni capoluogo della Toscana), ma occorrono risorse ed energie non indifferenti e, in ogni caso, la disponibilità della singola amministrazione rimane una discriminante fondamentale. Poi ci sono 61 3. Qual è lo stato attuale della ricerca sulle coppie miste in Italia? le Schede matrimoniali dell’Istat che, ogni anno, rileva i matrimoni celebrati in tutto il paese. I dati sono dunque aggiornati ma, si badi bene, i matrimoni di cui si parla sono solo quelli celebrati nell’arco dell’anno sul territorio nazionale e non tutti quelli in vita su questo territorio. Quindi l’informazione fornita è senza dubbio interessante, ma ci dà la misura di una tendenza, non la dimensione del fenomeno. Tra l’altro, entrambe le due ultimi fonti presentano un difetto, una distorsione grave: spesso gli immigrati si sposano perché, oppure anche perché, questo è uno dei modi per ottenere la cittadinanza. Se ottengono la cittadinanza diventano italiani. Ora, se la fonte presso la quale è registrato non consente di mantenere la prima cittadinanza, è chiaro che lo straniero, diventato italiano, dopo due, tre anni, comparirà nelle registrazioni esclusivamente come cittadino italiano. Cioè, nella misura in cui costui si sposa, io, come ricercatore, perdo del tutto le sue tracce presso le fonti. Questo meccanismo è quello dei cosiddetti matrimoni invisibili e, capite bene, si tratta di una distorsione grave. L’ultimo Censimento ha previsto la richiesta del dato relativo alla doppia cittadinanza – quella del paese di provenienza e la cittadinanza che si è acquisita – per cui sarebbe tecnicamente possibile quantificare con precisione i matrimoni misti… purtroppo, però, anche questi dati non sono mai stati pubblicati. Quindi, riassumendo, ad oggi la risposta alla domanda quante sono le coppie miste è fatta di dati parziali, incerti. Di fatto, si hanno solo stime. Tutto questo sul versante quantitativo della ricerca. Dal punto di vista, invece, delle indagini qualitative, per problemi diversi, la situazione è ugualmente arretrata. 62 In Italia, ad oggi, si può citare, almeno dal punto di vista sociologico, solo un libro importante sulle coppie miste, purtroppo ormai un po’ datato ed è il lavoro di una studiosa che una decina di anni fa ha raccolto una serie di contributi sul tema, Mara Tognetti Bordogna. Basta solo questo, capite bene, per illustrare la situazione. Quante sono le coppie miste oggi in Italia? Ricerche diverse ci dicono che c’è una tendenza a una forte crescita. I dati pubblicati dall’Istat nel 2007, ma facenti riferimento al 2004 e al 2005, ci dicono che quasi il 9% dei matrimoni celebrati in quegli anni avevano almeno un coniuge straniero. Almeno un coniuge straniero vuol dire che potevano essere anche tutti e due stranieri: quindi l’8,8% non identifica il numero reale dei matrimoni misti che equivarranno, in realtà, ad un numero inferiore. Il dato, tuttavia, è destinato a crescere. In media su 4 matrimoni misti celebrati, 3 sono del tipo donna straniera–uomo italiano, 1 del tipo marito straniero–donna italiana; ricerche effettuate dalla sottoscritta nel 2002 a Pistoia, Prato e Firenze (Peruzzi 2008) rilevavano tendenze analoghe e anche altre ricerche pubblicano percentuali che sembrano mantenersi, per ora, su questo ordine di grandezze. Come sono distribuiti i matrimoni misti in Italia? La maggior parte vengono celebrati nel Nord e nel Centro Italia, dove di63 4. Quante e quali sono le coppie miste in Italia oggi? verse regioni sfiorano, fra le nuove unioni celebrate, il 1314% di matrimoni misti. Questo significa che gli immigrati sono una risorsa notevole del mercato matrimoniale in Italia oggi, almeno in alcune regioni. Nel Sud e nelle isole le percentuali rimangono molto più basse, sfiorando in media il 5%. Ho isolato per l’occasione i dati della Puglia che, ad ora, è la regione con la percentuale di matrimoni misti più bassa in Italia, avendo celebrato nel 2004-05 solo un 3% di unioni bi-nazionali. Anche qui la percentuale più alta vede una donna straniera con un marito italiano e solo pochissimi casi del tipo uomo straniero–donna italiana. Chi si sposa con chi? Nei matrimoni del tipo donna stranierauomo italiano le mogli provengono nel 49% dei casi dall’Est Europa, nel 20% circa, invece, sono donne sud-americane, del Brasile o dell’area cubana. Questo è un dato interessante perché ci dice che le comunità nazionali partecipano in maniera diversa a questo fenomeno. La via della mixité sentimentale alla comunicazione tra culture è una strada selettiva che solo alcune nazionalità percorrono. I gruppi asiatici, filippini, cinesi, che pure sono comunità storiche sul nostro territorio, magari arrivate molto prima di altre, hanno dei tassi di mescolamento con gli italiani via matrimonio bassissimi. Quando si ribalta invece il punto di vista e si guardano le coppie in cui uomini stranieri sono sposati con donne italiane, vediamo che i nord-africani sono i primi della lista, seguiti da albanesi e rumeni. La mia impressione è che sia sempre più in crescita la tendenza degli uomini dell’Est a sposare donne italiane. 64 Le coppie miste, comunque, sono uno di quei luoghi in cui le donne straniere hanno un ruolo forte: ovvero, nel mescolamento sentimentale con gli autoctoni, le immigrate fanno spesso da “apripista” della propria comunità straniera. Che età hanno i partner delle coppie miste? Noi sappiamo che la tendenza degli italiani, oggi, è a sposarsi prevalentemente fra coetanei dove, per demografi e sociologi, essere coetanei equivale ad una differenza di al massimo tre anni d’età. Dunque, i dati ci dicono che le coppie miste re-immettono nel mercato italiano matrimoniale squilibri che noi stavamo dimenticando. Infatti, se nel passato si era abituati anche a coppie con differenze di età maggiori, queste tornano ad essere di nuovo attuali con i matrimoni misti. Tradotto in parole semplici: nei matrimoni misti la differenza di età fra i 5 e i 10 anni è una differenza molto frequente e, addirittura, troviamo molti casi nei quali la differenza di età fra i partner è superiore ai 10 anni. La differenza di età di 20 o più anni, cioè coppie in cui uno dei due partner è più vecchio di 20 o più anni dell’altro – cosa che fra gli italiani è rarissima – si trova abbastanza frequente fra le coppie in cui uno dei due è immigrato; anzi, si può dire che questa differenza sia abbastanza frequente quando la donna è straniera e l’uomo italiano, ma può darsi anche all’inverso (ossia casi di donne italiane sposate con uomini molto più giovani). Idem, troviamo degli scompensi forti per quanto riguarda il livello di istruzione. Quando i coniugi sono entrambi italiani, nel 75% dei casi o hanno lo stesso livello di istruzione o quello del marito è leggermente maggiore. L’Istat mostra, invece, che per le unioni miste i valori sono diversi. Solo nel 67% dei casi lui ha 65 un livello di istruzione uguale o un po’ più alto della consorte: nelle coppie miste le donne sono mediamente più istruite di quanto non avvenga in quelle “normali”. Queste asimmetrie anomale che stiamo vedendo – differenze ulteriori a quella di nazionalità e comunque non usuali tra connazionali italiani – rivelano dei meccanismi compensatori in atto nelle coppie miste. Detto in parole povere: io, donna straniera, che arrivo in Italia con una condizione svantaggiata, con uno status sociale più basso, nel mercato matrimoniale compenso questo elemento negativo – negativo perché percepito come socialmente svantaggiato – offrendo magari al mio partner un’età molto più giovane o un grado di istruzione nettamente più alto. A livello di percezione sociale questa ulteriore differenza aggrava ancora di più l’anomalia percepita rispetto alla coppia, per cui, quando abbiamo una coppia mista, ci troviamo di fronte a quelli che io chiamo dei concentrati di differenze anomale. Ancora, sempre secondo l’Istat (2007), i matrimoni misti sono spesso secondi matrimoni, cioè matrimoni in cui uno dei due coniugi – se non entrambi i partner – sono alle seconde nozze. Quasi tutti sono celebrati quindi in comune. 5. Dove nascono e come si formano oggi le coppie miste in Italia? Ho diviso questa quinta domanda in 3 brevi sotto-domande: 1. Dove avviene il primo incontro fra i partner di una coppia mista? 66 2. Come si arriva dalla conoscenza alla convivenza? 3. Che cosa si può dire dell’evento matrimonio misto? Le risposte a queste domande, e a quelle dei due punti successivi, provengono, come anticipato a inizio relazione, dai risultati di una ricerca in corso di pubblicazione (Peruzzi 2008). È chiaro che il numero limitato di interviste che ho condotto, essendo in fase di ricerca ancora esplorativa, mi permette di proporre degli elementi da sottoporre all’interesse della comunità scientifica; si tratta di ipotesi che sto tirando fuori e che meriterebbero di essere ulteriormente approfondite, discusse, confrontate. Allora, torniamo al nostro primo interrogativo. Dove avviene il primo incontro fra i partner di una coppia mista? Dalle interviste emergono una serie di luoghi molto eterogenei: il bar, la strada, Internet – prevalentemente le chat – e, ancora, associazioni e reti interculturali, agenzie di mediazione interculturale e case private in cui le donne straniere esercitano come assistenti familiari, o, più comunemente, badanti. Anche se questa piccola geografia è molto eterogenea, difficile da ricondurre a una tipologia ben precisa, ho notato che questi citati sono tutti luoghi che, in un qualche modo, presuppongono una certa permeabilità, una disponibilità all’incontro tra stranieri e autoctoni. La strada e il bar sono i primi luoghi frequentati da immigrati, luoghi aperti all’incontro e alla frequentazione mista. Le associazioni e le reti interculturali nascono apposta perché ci si possa frequentare tra culture diverse. In casa la badante 67 chiamata spesso proprio in quanto straniera. Le agenzie matrimoniali nascono per far incontrare persone lontane. Inoltre notavo che tutte le persone intervistate inizialmente dichiaravano di essersi incontrate per caso; poi, però, inoltrandoci nei racconti della vita di queste coppie, veniva fuori che gli incontri non erano stati mai, o quasi mai, casuali. Ho ipotizzato che questo ricorrere del caso “coprisse” qualcosa: a mio avviso era un tentativo di coprire qualcosa che casuale proprio non era stato. Gli spunti principali che ho “tirato fuori” da questa prima parte delle testimonianze: 1. Gli spazi dove comincia a formarsi la mixité sono spazi in qualche modo già aperti alla frequentazione fra indigeni e stranieri. In particolare, lavorare nel sociale, essere operatori nel sociale è sicuramente una condizione che espone all’incontro con gli immigrati, anche per relazioni sentimentali. 2. La conoscenza dell’italiano è un presupposto fondamentale per la nascita di una relazione mista. Tutti i partner stranieri, uomini e donne che ho intervistato, parlavano bene la nostra lingua già prima di conoscere il partner italiano. 3. Una certa passione per l’esotismo sembra costituire un ingrediente favorevole alla mixité sentimentale. Alcune donne italiane fidanzate o sposate hanno raccontato di essere state in Africa o di essersi interessate alla cultura africana già prima di conoscere il partner. Qualcuna aveva frequentato corsi di lingua o di cucina araba. In qualche modo, sembrava che lo straniero lo avessero un po’, come dire, “cercato”. 68 4. Il protagonismo femminile. L’espressione non è mia, me l’ha suggerita uno studioso delle migrazioni molto importante, Maurizio Ambrosini (2005), parlando dei percorsi di vita e di inserimento, anche fuori dall’ambito sentimentale, delle donne migranti. Le donne straniere risultano straordinariamente attive, protagoniste delle proprie vite, dei processi di integrazione e delle reti transnazionali. Così come, d’altra parte, anche da parte delle donne straniere mi è parso quasi, in qualche modo, “cercato” l’incontro con un uomo italiano. Questo è un aspetto sul quale sto ancora lavorando, ma credo di poter affermare che nelle donne la propensione alla mixité è più forte o sicuramente dichiarata in maniera più esplicita che negli uomini. Come si arriva dalla conoscenza alla convivenza? Affronterò, su questo punto, due soli aspetti, che mi paiono particolarmente interessanti. Il primo è quello che ho definito il timing anomalo della mixité. Le coppie intervistate sono arrivate dalla conoscenza alla convivenza in maniera rapidissima, nel giro di qualche mese se non di qualche settimana. Stessi tempi ugualmente rapidi per il matrimonio. C’è un’urgenza, in queste unioni, evidente, dovuta al bisogno di sistemazione, di un alloggio, di documenti, che le spinge a metter su casa insieme celermente. Sulla base di cosa affermo questo? I giovani italiani, sui 35-40 anni, escono di casa tardi, si sposano o vanno a convivere tardi. E’ un dato evidente e lo confermano le statistiche e i giornali. Le coppie miste, invece, una volta che i due partner si sono conosciuti, arrivano a convivenze rapidissime spesso perché uno 69 dei due, per rimanere in Italia, ha bisogno di una sistemazione e di documenti. Ho chiamato le relazioni miste delle scorciatoie perché, come accade per le strade secondarie, spesso non è facile trovare l’imbocco, l’inizio. Così, se per un uomo o una donna straniera che desidera avviare una relazione con un partner italiano, non sempre si offrono occasioni e luoghi di incontro, “una volta trovata la strada”, il più delle volte, la relazione procede rapidissima verso la meta della convivenza. Il secondo punto su cui voglio soffermarmi è il fattore d, d come donne. In parte l’ho già anticipato: in queste relazioni le donne appaiono protagoniste molto più degli uomini. Può darsi che esse abbiano anche una capacità diversa di esprimersi nelle interviste, ma, oltre a questo, a me sembra, dai loro racconti, di dedurre che abbiano avuto un ruolo molto più determinato, se non determinante, rispetto ai partner maschili. Che cosa si può dire dell’evento matrimonio misto? Il matrimonio è una tappa importante nella vita di una coppia mista, più forte, secondo la mia percezione, del matrimonio fra connazionali perché qui sposarsi significa anche mostrare, esibire la propria diversità. Alcune di queste coppie si erano frequentate per un po’ anche in sordina, diciamo così; arrivare a sposarsi equivale, invece, a rendere pubblica, ad affermare la relazione. È il momento dell’esposizione indifferibile. Il matrimonio misto è spesso un luogo di tensione, perché si sa che ci si apre al confronto esplicito con i connazionali 70 stranieri e con i parenti italiani. Per cui le nozze per una coppia mista sono sempre una questione delicata. La festa è importante in quanto diventa essa stessa il rito, la celebrazione dell’evento. Abbiamo visto che queste coppie spesso non si sposano in chiesa. Per dei giovani italiani sposarsi in comune è talvolta anche la voglia di una celebrazione più moderna, meno tradizionale. Nelle unioni miste non è così: anche se non ci si può sposare in chiesa è probabile che i festeggiamenti saranno comunque importanti. Racconto spesso, perché è emblematico, il caso del matrimonio fra una donna cinese e un coetaneo italiano, entrambi sui 50, entrambi in seconde nozze. Quando mi hanno mostrato le foto del matrimonio la donna era in bianco, in bianco lungo, come nei nostri matrimoni in chiesa tradizionali. Lì per lì mi sorpresi: perché l’abito bianco se non siete neppure in chiesa, con un matrimonio anche deciso rapidamente? Mi hanno spiegato che ci vuole l’abito bianco, comunque occidentale, ci vuole il fotografo, ci vuole il pranzo ufficiale, se possibile anche il passaggio nella nuova casa perché bisogna mandare le foto ai parenti lontani, in patria: per mostrare il marito italiano e, dunque, il successo del percorso di immigrazione. Ci sono poi anche i matrimoni interreligiosi e anche quelli sono un aspetto difficile e importante della mixité. Purtroppo non abbiamo tempo per trattarli in questa sede. Quello che mi interessa sottolineare è che il matrimonio è comunque una tappa per la coppia e soprattutto per il partner straniero. 71 6. Come reagisce la società italiana al formarsi delle coppie miste? E Come reagiscono gli amici e i connazionali stranieri? Le risposte dei miei intervistati sono state molto variegate. La risposta più frequente è stata: “Avevamo imbarazzo, paura a presentarci alla famiglia italiana”; tutti i testimoni e le testimoni italiane che ho incontrato avvertivano la presentazione ai genitori in qualche modo come un momento problematico. La maggior parte delle coppie ha denunciato una tensione iniziale, seguita da una progressiva accettazione da parte della famiglia. Rari i casi – però qualcuno c’è stato – in cui l’ostilità immaginata da parte della famiglia ha impedito che ci fosse un contatto tra questa e il partner straniero. Le strategie con cui si tengono nascosti il fidanzato o la fidanzata straniera in qualche racconto rasentavano il comico. Ricordo una donna di 45 anni che conviveva in un capoluogo toscano con un professore marocchino di 48 e non lo ha mai presentato ai genitori, benestanti e ben istruiti perché “…non si può presentare a casa un marocchino!” Devo dire, però, che i casi come questo sono stati pochissimi. Pochi anche quelli, d’altra parte, nei quali si sapeva che l’accoglienza sarebbe stata del tutto priva di problemi. Il caso più frequente, ribadisco, è stato quello in cui la soglia difficile era la presentazione in famiglia; poi però questi casi si sono risolti tutti in una sostanziale accettazione. Sintetizzando, i fattori che 72 ho riscontrato agevolare l’accettazione in famiglia sono i seguenti: 1. l’accettazione è più facile se la famiglia ha già conosciuto il partner/la partner stranieri, ovviamente in una condizione diversa da quella di partner del proprio figlio/della propria figlia. Magari perché era la badante di casa, magari perché lo si era portato prima a casa come un amico. 2. uno stile di vita molto aperto, “anticonformista” della famiglia italiana: genitori definiti “di sinistra” e “progressisti” dai propri figli perché “mi hanno sempre educato alla conoscenza dell’altro, frequentavamo sempre i partiti, le associazioni”, sono risultati molto tolleranti di fronte al fidanzato o alla fidanzata stranieri dei propri ragazzi. 3. l’età avanzata dei partner: può sorprendere, ma i partner che avevano superato entrambi la cinquantina hanno denunciato meno problemi degli altri ad essere accettati. Quasi che la famiglia percepisse il nuovo partner o la nuova partner straniero/a come la soluzione a situazioni di solitudine del congiunto. 4. il colore della pelle: le nostre società sono aperte quanto si vuole, ma il problema rimane: la pelle nera è ancora un ostacolo serio nell’interazione tra culture. Pensate che ci sono coppie in cui persino un partner mi ha detto esplicitamente: “beh, se la mia ragazza avesse avuto una pelle più scura… insomma, non staremmo insieme”. 5. l’età avanzata di parenti e familiari: se i genitori, con il tempo, appaiono disponibili ad atteggiamenti più tolleranti, nonni, zii e parenti più anziani, in molti casi, non hanno voluto sentir parlare di stranieri o di straniere in famiglia o hanno rea- 73 gito comunque male. Si hanno casi di immigrati presentati ai genitori, ma non alla famiglia allargata, che quindi possono andare a cena dai genitori italiani di lui o di lei, ma non ai pranzi “allargati” di Pasqua e Natale. Questo, in pillole, per quanto riguarda la famiglia. Passando ora alle reazione di amici e conoscenti dei due partner avremo altre sorprese. Un meccanismo che ho registrato in più di una coppia e che mi ha colpito, purtroppo negativamente, è il seguente: se i due partner sono entrambi giovani, per giovani intendo fino ai 35-40 anni, mirano a costruirsi un progetto di vita interamente insieme, vogliono cioè passare insieme il tempo libero e vorrebbero che il partner o la partner frequentassero i propri amici. Ebbene, tutte le coppie di questo tipo che ho intervistato (badate bene: tutti universitari e diplomati) hanno raccontato di aver dovuto cambiare la cerchia di amici perché tutti avevano registrato una freddezza più o meno forte, un’ostilità da parte del gruppo. A distanza di qualche anno dall’inizio della relazione mista, tutte le coppie giovani che ho intervistato frequentavano nel tempo libero altre coppie miste o altri luoghi misti come associazioni interculturali e avevano rotto i rapporti con i vecchi amici. Non si è registrato, invece, nessun caso simile tra le coppie più anziane, con partner sopra i 40-45 anni dove pare che sia messa in conto, sin dall’inizio, una certa separazione di stili di vita e frequentazioni. Mi sono sentita raccontare: “Ok, ci siamo sposati, ma io voglio mantenere le mie abitudini, voglio continuare a uscire con i miei amici, voglio continuare ad andare alle partite di calcio, voglio uscire la sera a giocare a 74 carte come facevo prima; lei, ovviamente, è altrettanto libera di mantenere le sue amicizie… Poi, ovvio, alcune volte usciamo insieme, molte cose le facciamo insieme e allora lì decidiamo insieme”. Le aspettative nei confronti del gruppo amicale in questi casi sono ovviamente molto ridimensionate e, in genere, si sono registrati molti meno conflitti con l’ambiente esterno. È come se queste coppie, aspettandosi dai propri amici molto meno di quanto non si attendano le coppie giovani, rinunciando alla pretesa di essere subito accettati con la propria mixité, si risparmiassero molte ansi e, in alcuni casi, riuscissero ad integrarsi quasi meglio. La cosa che mi ha stupito in tutto questo è ovviamente l’ostilità verso queste coppie di ragazzi e ragazze, giovani uomini e giovani donne, soprattutto considerando che in molti casi si trattava di studenti universitari, cioè proprio di quella parte della popolazione che ci aspetteremmo più aperta e disponibile verso la diversità. Le reazioni dei connazionali stranieri non erano invece un oggetto specifico della mia indagine. Da varie testimonianze raccolte, però, posso ipotizzare l’esistenza di conflitti anche pesanti tra le donne italiane e gli amici e i parenti del compagno, soprattutto africani. Le “mie” donne italiane hanno tentato di inserirsi nelle comunità marocchina o tunisina, ma quasi sempre senza successo. In genere il problema pare fosse la moglie di lui lasciata in patria o l’ostilità del gruppo di fronte alla prospettiva di un’ufficializzazione della relazione mista. Al contrario, ho riscontrato più di un caso in cui il partner italiano è stato esibito come un trofeo davanti ai propri connazionali da donne cinesi e filippine, quasi a testimoniare che il loro 75 percorso di integrazione era stato sancito dal massimo dei traguardi. 7. Quali sono le diversità che fanno problema oggi nella vita privata delle coppie miste? In questa parte del lavoro ho passato in rassegna le differenze che la letteratura ci tramanda come problematiche nella vita delle coppie miste o bi-nazionali per capire quali di queste fossero ancora attuali nei territori complessi della postmodernità e ho cercato di portare alla luce eventuali nuove tensioni all’interno di queste relazioni. Ho fatto, in sostanza, uno sforzo di attualizzazione dei criteri caratterizzanti la mixité. Le differenze quasi innocue: la lingue e la cucina Per prime tratterò le differenze classiche della mixité che, nelle mie testimonianze, sono risultate quasi innocue: sono la differenza di lingua e quella di abitudini alimentari. 1. Riguardo alle incomprensioni linguistiche non ho trovato nessuna coppia che abbia riconosciuto questa una differenza effettivamente problematica. Anzi, le donne straniere sono risultate spesso interessate ad apprendere la lingua italiana per trovare lavoro e per integrarsi, mentre le italiane sposate con africani erano curiose di imparare la lingua del marito. Gli uomini sono apparsi decisamente meno volenterosi 76 nell’apprendimento di una nuova lingua, in particolare gli uomini fidanzati o sposati con immigrate. Di nuovo, troviamo le donne più attive dei compagni nei processi di comunicazione e di mescolamento. 2. Le abitudini alimentari non costituiscono mai problema. Qualche volta può essere un po’ complicato per le giovani straniere adattarsi agli orari e ai ritmi delle famiglie italiane, ma le tensioni sono parse davvero di poco conto. Si sono rilevati invece diversi esperimenti di cucina fusion. Una differenza ambigua: la religione La differenza di segno più ambigua è risultata la religione. La religione è una delle diversità più citate e più temute nella letteratura sulle coppie miste. Addirittura è usata come un criterio distintivo della mixité. Io l’ho riscontrata come un fattore di segno ambiguo: in molti casi non era affatto un problema – “abbiamo due religioni diverse? ognuno si gestisce individualmente le sue pratiche” – in altri si rivelava un grosso fattore di tensione. I partner italiani, in più casi, si sono dichiarati non credenti, non praticanti o indifferenti rispetto alla questione religiosa: in queste convivenze ovviamente il problema della differenza di religione non esisteva. I problemi scoppiano invece quando entrambi i partner sono credenti e si trovano di fronte a delle scelte importanti: con quale cerimonia celebrare il matrimonio, che religione dare ai figli, etc. Un particolare che vorrei segnalare è quello del prodursi di curiosi fenomeni di mixité nelle pratiche religiose di alcune partner di coppie miste. Alcune donne straniere non 77 cattoliche hanno raccontato di essersi avvicinate alla Madonna, ritenuta vicina perché donna e di aver accostato, nel tempo, il culto di Maria a quello della propria divinità. Non è possibile in questa sede addentrarsi nei dettagli, ma credo opportuno segnalarli come un esempio originale di trasformazione dell’identità e di creazione della mixité nell’incontro tra abitudini e stili di vita indigeni e stranieri. Le nuove diversità Quelle che seguono sono le differenze principali fra quelle che, almeno stando ai racconti della nostra ricerca, possono produrre tensioni e fratture serie fra i due partner all’interno di una coppia mista. 1. Il ruolo della donna e le sue libertà. La ripartizione dei compiti casalinghi è stata dichiarata un problema da quasi tutte le coppie intervistate. Alcuni mariti hanno ricondotto le tensioni scoppiate intorno a questo tema alla mentalità e agli stili di vita del paese di origine della moglie. Più di un marito ha confessato di essere rimasto sorpreso dalle rivendicazioni di autonomia e di libertà della nuova compagna, soprattutto quando questa proveniva dall’Europa dell’Est o dalle Filippine: si sarebbero immaginati, infatti, donne meno sicure e intraprendenti. In alcune storie l’incontro tra questa immagine diversa della donna e del suo ruolo ha innescato dei processi di trasformazione importanti: ho raccolto testimonianze preziose di uomini italiani, tutti sulla sessantina, che, non avendo mai toccato in vita propria una pentola o una scopa, dopo il matrimonio con la seconda moglie, magari di 10-20 anni più 78 giovane, sono stati costretti a rimettersi in gioco per non sprecare la seconda occasione e si sono scoperti ottimi casalinghi. La parte più interessante di questa voce sono stati senza dubbio alcuni percorsi di ricostruzione della maschilità. 2. la gestione del denaro. Le donne straniere che ho intervistato ponevano tutte il lavoro e l’indipendenza economica in cima alla lista delle proprie priorità. I conflitti con i partner nascono quando, prive di un lavoro, queste donne pretendono comunque di gestire in autonomia una parte del budget familiare. 3. le rimesse alle famiglie in patria. È frequente che gli stranieri e le straniere immigrati in Italia inviino regolarmente del denaro ai familiari lasciati in patria. Ho trovato mariti e mogli italiani molto comprensivi e tendenzialmente ben disposti verso questa pratica. I problemi sorgono nelle situazioni di crisi, quando per esempio uno dei due perde il lavoro o nei casi di spese impreviste per la coppia: allora il mantenimento di una moglie o di parenti lontani possono divenire un problema. Ho ragione di credere che questo accada spesso nelle famiglie miste. 4. l’incertezza del futuro. In una coppia mista aleggia spesso il timore che se le cose non funzionano lei o lui possano decidere di tornarsene al paese di origine. Questo timore è un fattore di tensione latente nella coppia: difficilmente i partner ti segnalano in maniera diretta ed esplicita questa paura come un problema della coppia, ma analizzando i racconti emerge evidente che l’incertezza e la nostalgia sono elementi che interferiscono nel vissuto di queste coppie e che, in un momento difficile, possono emergere e produrre liti e conflitti. 79 Conclusioni Sinteticamente, quali immagini mi ha suggerito questo viaggio nella mixité sentimentale dei nostri giorni? Al libro che racconta i risultati di questa ricerca ho dato il titolo di Amori possibili (Peruzzi 2008). Ho scelto volutamente la parola amori, perché sui media e nell’immaginario comune, spesso la coppia mista è associata al matrimonio di convenienza, a relazioni di opportunità, alla badante che sposa l’uomo 20 anni più vecchio solo per prenderne l’eredità. E invece, quando ho provato ad affondare nel vissuto di coppie che presentavano differenze di età anomale o altre asimmetrie eccessive che lasciavano, in qualche misura, presagire unioni solo di interesse, spesso mi sono trovata di fronte a convivenze che è difficile non definire “sentimentali”. Vorrei dunque concludere con questa immagine: le coppie miste sono unioni nuove, perché immettono nel mercato matrimoniale e nella società italiana delle contraddizioni forti. Queste contraddizioni sono la compresenza, all’interno di una stessa relazione, di elementi di modernità (l’apertura all’altro, stili di vita e abitudini diversi), insieme con elementi della tradizione (differenze di età o di ceto sociale marcate) a cui non eravamo più abituati. Il punto interessante è che questi elementi di modernità e di tradizione si trovano mischiati nella stessa coppia. Se la domanda iniziale era: “le coppie miste sono dei luoghi di osservazione particolare?”, la risposta dunque è senza dubbio “sì” perché esse sono dei concentrati anomali, interessantissimi, di nuovo e vecchio, di sentimento e opportunità. Sono, soprattutto, un campo ancora in larga parte inesplorato: molte di quelle che vi ho proposto sono ancora ipotesi che attendono conferme, confutazioni, specificazioni. 80 Riferimenti bibliografici Ambrosini M. (2005), Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna. Bensimon D., Lautman F. (1977), Un mariage, deux traditions: chrétiens et juifs, Université de Bruxelles, Bruxelles. Braudel F. (1986), “L’immigration étrangère: un problem récent” in L’identité de la France, vol. 2, Les hommes et les choses, Arthaud-Flammarion, Paris. Istat (2007), Il matrimonio in Italia: un’istituzione in mutamento. Anni 2004-2005, www.demo.istat.it. Peruzzi G. (2008), Amori possibili. Le coppie miste nella provincia italiana, FrancoAngeli, Milano. Streiff-Fenart J. (1989), Les couples franco-maghrebins en France, L’Harmattan, Paris. Todd E. (1994), Le destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales, Seuil, Paris. Tognetti Bordogna M. (2001), Legami familiari e immigrazione. I matrimoni misti, L’Harmattan Italia, Torino. 81 82 Identità e mercato del lavoro. Due dispositivi di una stessa trappola mortale Augusto Ponzio Augusto Ponzio insegna Filosofia del linguaggio e Linguistica generale all’Università di Bari e fa parte del Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi. Dirige, dal 1989, la serie annuale “Athanor. Arte, Letteratura, Semiotica, Filosofia”, edita prima da Longo (Ravenna) e attualmente da Meltemi, di cui l’ultimo volume (2008) si intitola Umano troppo disumano. Ha contribuito come curatore e traduttore alla diffusione in Italia e all’estero del pensiero di Pietro Ispano, Bachtin, Lévinas, Marx, Rossi-Landi, Schaff, Sebeok. Nella sua ricerca sui segni e sul linguaggio, di questi autori, ha ripreso ciò che, malgrado le loro differenze, soprattutto li accomuna, vale a dire l’idea dell’imprescindibilità, qualsiasi sia l’oggetto di studio, e per quanto specializzata ne sia l’analisi, dalla vita di ciascuno, nella concreta singolarità del suo coinvolgimento, senza alibi, nel destino degli altri. Tra le sue pubblicazioni: A mente. Processi cognitivi e formazione linguistica (Guerra, 2008); Fuori luogo. L'esorbitante nella riproduzione dell'identico (Meltemi, 2007); Linguaggio e relazioni sociali (Graphis, 2006); Elogio dell'infunzionale. Critica dell'ideologica della produttività (Mimesis, 2004), e con Susan Petrilli Semioetica (Meltemi 2003) e Il sentire nella comunicazione globale Meltemi 2000). 83 84 Ringrazio molto chi ha organizzato questo incontro – incontro in senso forte, perché, come diceva Felice Di Lernia nel presentarlo, siamo qui insieme per la prima volta e senza che ci siano stati rapporti precedenti, e neppure scambi di idee sulle tematiche di cui qui si tratta. Conoscevo di nome Francesco Indovina e, quando Andrea Catone – di Bari – , che invece lo conosce bene, ha sentito che venivi anche tu [si rivolge a Indovina. NDR], quando gli ho detto di questo seminario, era molto contento che ci saremmo incontrati. Non conoscevo e ho avuto il piacere di conoscere Gaia Peruzzi. Ciò che soprattutto mi piace molto, e che, come vedo dalla partecipazione da parte del pubblico, c’è grande interesse su questi problemi. Chi ha organizzato l’incontro lo ha orientato su questioni di grande importanza nella vita di oggi. Sottoscrivo pienamente il titolo di questo seminario che, come pure la presentazione dell’incontro fatta da Felice Di Lernia, dice in maniera forte e chiara che non si può identificare la vita con l’avere un lavoro. “Non di solo lavoro” è un titolo extra-ordinario: il lavoro-merce sia ben inteso, il “lavoro” nell’accezione astratto-concreta della forma sociale capitalistica, quella delle espressioni, note a tutti e ben realistiche, malgrado l’uso dell’astrazione “lavoro”, come “mercato del lavoro”, “datore di lavoro”, “cerco lavoro”, “certificato di lavoro” (il certificato di lavoro nella Germania nazista – Arbeitsbescheinung esonerava dalla deportazione e dall’internamento come ebreo; oggi, permette all’ “extracomunitario” di non essere espulso). 85 Per cominciare Il lavoro occupa, ma anche pre-occupa. Chi vive in contatto con i giovani, con gli studenti, come nel mio caso, lo vede bene: essi sono seriamente già pre-occupati dal lavoro. Tutta la vita si organizza in funzione della riuscita a vendere il proprio lavoro: “riuscirà il nostro eroe ad avere un posto di lavoro?”. E, naturalmente, fra chi, nella campagna elettorale, promette posti di lavoro – deve farlo se vuole avere successo in questo mondo, il gioco funziona così –, ma che di mestiere fa il politico e chi, invece, si è messo in politica, ma è “datore di lavoro”, uno affermato, uno che è riuscito nella vita (nel mercato del lavoro) e che dà quello che tutti vogliono (è proprio lui, “il datore di lavoro”!), è chiaro che, a parità di offerta, è quest’ultimo che prende più voti. I giovani con cui ho a che fare nell'università oggi si addestrano per il “mercato del lavoro”. Sono sicuri che “il lavoro rende liberi” proprio come era scritto nel campo di sterminio di Dachau. Si abituano, attraverso il sistema universitario del conteggio in "crediti" dello studio e della loro formazione, alla quantificazione in "ore-uomo" anche del "lavoro immateriale" (“risorsa fondamentale” della fase odierna della produzione capitalistica, quella della “comunicazione globale” o “comunicazione-produzione”). Sono predisposti alla sua equiparazione e vendita, se mai – attraverso una "formazione permanente" e accumulando “bollini-del-mulino-bianco”, o “indulgenze” – riusciranno a "inserirsi" nel "mercato del lavoro" e a trovare un posto di lavoro nel paradiso per laici e realisti, per gente con i piedi per terra e senza utopie perchè è “questo mondo l’unico possibile, ragazzo mio!”. 86 Ebbene, “Non di solo lavoro”. Nel titolo che ho dato a questa mia relazione faccio riferimento al rapporto tra identità e mercato del lavoro: due dispositivi di una stessa trappola mortale! Che cosa è più importante? Indubbiamente il lavoro non solo è importante, ma fondamentale, decisivo; lo è a tal punto che la mancanza, la perdita, la fine del lavoro comporta la mancanza, la perdita o per lo meno la messa in crisi dell’identità. Attenzione – vale la pena esplicitarlo – quando dico “lavoro” non sto dicendo né inventiva, né creatività, né capacità di trasformare le cose. “L’uomo è l’animale che lavora” – nel senso che non mangia il crudo, lo elabora, lo trasforma: non gli interessa, se non in situazioni inumane di mera sussistenza, il cibo, ma il “piatto” – “l’uomo è un animale infunzionale”, nel senso che non esiste il più preistorico vaso di creta, di terracotta, che non abbia un fregio, una forma particolare, un dettaglio inutile. Che cosa si conserva, che cosa si protegge, in una teca, in un museo, di un vaso privo del fondo, se non l’inutile, l’eccedente, l’infunzionale? L’infunzionale è il marchio dell’umano (attenzione “umano”, qui, non dall’identità del genere che tutti ci include: homo, ma da Humus, come humilitas). Il lavoro come creatività, invenzione, trasformazione, il mangiare il “cotto”, il mangiare insieme, il piacere di stare insieme (“le maniere di stare a tavola”, ecco, non più il cibo, ma il piatto, l’elaborazione del cibo). Non ci sono forme culturali 87 Ricerca dell’identità e ricerca del lavoro poverissime che non abbiano il piatto. Il piatto significa: c’è un in più al di là del bisogno, un in più al di là della necessità. Certo ci sono culture ridotte alla sopravvivenza, ma esse sono state ridotte alla sopravvivenza, perché nessuna cultura, anche la più – per l’antropologo più gretto – “primitiva”, è tale da limitarsi semplicemente alla soddisfazione del bisogno. L’infunzionale, l’eccedente, il “gioco del fantasticare”, è talmente essenziale per l’individuo umano che il mercato ne fa una merce appetibile al di là della soddisfazione del “bisogno” e della relativa possibilità di saturazione della necessità di acquistare. Il miglior posto di lavoro è quello che maggiormente permette di ampliare la possibilità di procurarsi l’infunzionale, il superfluo. Il lavoro-merce come mezzo per entrare nel regno del propriamente umano, il regno della libertà. Diceva Marx nel libro III del Capitale (p. 933) che il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna: si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria. È al di là di esso che comincia lo sviluppo delle capacità umane, fini a se stesse (Marx 1867-1894, III, p 933). Lo stravolgimento di questa verità l’abbiamo menzionato sopra: “Arbeit macht frei”. La rilevanza del lavoro in generale, del lavoro astratto, indifferente, è tale che anche la progettazione di forme sociali alternative, generalmente, non è riuscita a immaginare altra fonte di ricchezza sociale se non il lavoro come si configura nella sua forma alienata; altra soluzione ottimale che quella del “posto di lavoro per tutti”. 88 Ciò aveva ben presente Walter Benjamin, quando osservava nel testo noto con il titolo “Tesi di filosofia della storia” (1939-40), che la vecchia morale protestante del lavoro risorgeva, in forma laica, tra gli operai tedeschi con Il programma di Gotha. Esso definisce il lavoro come “la fonte di ogni ricchezza e di ogni cultura”. Allarmato, Marx intervenne dicendo che l’uomo che non possiede altra proprietà che la sua forza-lavoro, “non può non essere lo schiavo degli altri uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del lavoro”. Ciononostante, la confusione, dice Banjamin, continua a diffondersi e, a poco a poco, J. Dietzgen proclama che il lavoro è il messia del tempo nuovo e che nell’incremento del lavoro consiste la ricchezza. Questo concetto del lavoro, proprio del marxismo volgare, che vede solo i progressi (e non i danni) del dominio della natura e non i regressi della società, mostra, aggiunge Benjamin, già i tratti tecnocratici che appariranno più tardi nel fascismo (ivi, pp. 214-215). “Il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza”, precisa Marx nella “Critica del programma di Gotha” (1875). E aggiunge: “I borghesi hanno i loro buoni motivi per attribuire al lavoro una forza creatrice soprannaturale” (p. 11). Nel manoscritto del 1844, che è stato intitolato “Proprietà privata e comunismo”, Marx criticando il “comunismo rozzo e materiale” (ed ante litteram, ante factum, anche il “socialismo reale”) – che sopprime la proprietà privata generalizzandola (opponendola a quella privata generale) e che oppone alla proprietà privata la proprietà privata generale, il possesso fisico esteso a tutti – combatte l’equivoco di una ri-progettazione del sociale che continui a fare, come la società capitalistica , del lavoro in generale la fon89 te della ricchezza, sicché “l’attività degli operai non viene soppressa, ma estesa a tutti gli uomini” (ivi, p. 108). Per tale comunismo “rozzo e volgare”, “la comunità, dice Marx – lo cito testualmente (p. 109) – non è altro che una comunità del lavoro e l’eguaglianza del salario, il quale viene pagato dal capitale comune, dalla comunità in veste di capitalista generale. Entrambi i termini del rapporto vengono elevati ad una universalità rappresentata: il lavoro in quanto è la determinazione in cui ciascuno è posto, il capitale in quanto è la generalità riconosciuta e la potenza riconosciuta della comunità“. In contrasto con “comunità”, che generalmente indica una comunità di lavoro identitaria, chiusa (v. il “classico” libro di Tönnies, Gemeinschaft und Geselschaft, 1887, 1935; nel lessico della Germania nazista, Geselschaft, società, fu soppiantato da Gemeinschaft, comunità), il termine comunanza (in mancanza d’altri) può essere impiegato per indicare una forma di socialità non basata sulla compra-vendita del lavoro, aperta all’alterità e libera dall’ossessione dell’identità. All’internazionalismo del lavoro si oppone un internazionalismo altro: quello della irriducibilità di ciascuno a forza lavoro, materiale o immateriale che sia, a risorsa per il profitto – irriducibilità che i due fenomeni incontenibili in questo sistema e che fanno inceppare il circuito della comunicazione globale, la migrazione e la disoccupazione strutturale, ci mettono sotto gli occhi. Così intesa, la società è extracomunitaria a se stessa e ciascuno è extracomunitario; una comunanza per alterità, senza confini, territori, appartenenze, ra- 90 dici; fondata sul lavoro incommensurabile, singolare, unico di ciascuno e nella quale la ricchezza è misurata dal tempo disponibile – disponibile per l’alterità propria e altrui. Marx preconizzava nei Grundrisse (1857-58) la trasformazione, tramite lo sviluppo tecnologico, tramite l’automazione, della riduzione del tempo di lavoro, obiettivo necessario della produzione capitalistica, in condizione di sviluppo della piena ricchezza dei singoli e dell’intera società, ricchezza che consiste nel tempo disponibile per sé e per l’altro, nel poter dare tempo (ciò in cui consiste veramente l’ascolto) all’altro di sé e all’altro da sé. Sicché, egli diceva, risulta il tempo disponibile e non il tempo di lavoro la vera ricchezza sociale. Nell’accezione attuale, nei luoghi comuni del discorso – a questo proposito va ricordata, la tesi di Marx, come dice Arcangelo Leone De Castris in un suo recente scritto (2008), spesso dimenticata dai marxismi, che le idee dominanti sono le idee della classe dominante — il lavoro viene identificato con il lavoromerce, il lavoro che si vende e che si compra: “sono senza lavoro”, “cerco lavoro”, “mercato del lavoro”. “L’università deve essere funzionale al mercato del lavoro”. Stando da diverso tempo nell’università ho assistito a questa trasformazione della formazione universitaria in funzione sempre di più, attualmente, del cosiddetto “mercato del lavoro”: più va riducendosi, per diverse cause strutturali alla forma di produzione odierna, il mercato del lavoro – è il fenomeno dilagante della disoccupazione strutturale –, e più, paradossalmente, esso diventa obiettivo e parametro. Accade: più una cosa ti sfugge di mano e più ti ci accanisci. 91 Così è anche con l’identità: più andiamo perdendo identità – identità di genere (non solo nel senso di “genere sessuale”, ma anche di “genere umano”, data la sempre maggiore sovrapponibilità di umano e disumano, di umano e bestiale), identità etnica, identità di lingua, identità di nazione, identità di colore – e più ci si accanisce all’affermazione dell’identità (ivi compresa la riaffermazione dell’antropocentrismo, direttamente proporzionale alla sempre più deleteria antropizzazione del pianeta): il parossismo dell’identità. Parossismo dell’identità, rivendicazione e affermazione esasperata dell’identità, esaltazione dell’identità come conseguenza della crisi dell’identità. Abbiamo tenuto a Bari quest’anno una serie di seminari, che si sono svolti nella libreria Palomar, dal titolo “Esaltazione e crisi dell’identità” dai quali è emerso che è la crisi dell’identità stessa a produrne l’esaltazione. Questo è detto nella scrittura di Pasolini – la scrittura riesce a dire l’indicibile –, particolarmente in Petrolio (che è davvero il romanzo del nostro tempo). Più entra in crisi la “propria” identità e più ci si aggrappa – ci si appiglia – a qualunque cosa pur di trattenerla, di non lasciarsela sfuggire. Allora dove aggrapparsi per trovare l’identità? Non certo al nuovo. Pensate allo spazio, pensate all’omologazione degli spazi. C’è quel tale antropologo francese che, in maniera impropria per la verità, parla di non luoghi. Usa questa espressione per indicare gli spazi tutti uguali del “nuovo”. Il nuovo è tutto omologato: tutto ciò che è nuovo – dall’aeroporto al supermercato, al luogo dove ti fermi per fare benzina o per 92 rifocillarti sull’autostrada – è tutto uguale. Anche le città, la loro parte nuova: se a uno che viene paracadutato in una città gli si chiede “dove siamo?” egli non lo sa dire, però se trova il tale monumento, la tale chiesa antica, la parte vecchia della città, se gli capita di imbattersi nel “centro storico” intuisce facilmente dove si trova. La città viene finalmente identificata. Quindi ecco l’appiglio: il passato; aggrapparsi al passato e alla memoria. Il passato di cosa è fatto? Dei riti, delle religioni, delle usanze, dei costumi (vestiario compreso), delle tradizioni… Quindi la rivendicazione dell’identità si appella a qualcosa di stantio, di vecchio: le radici. Le radici sono collegate con il passato. Questo abbarbicarsi al passato, anche per dire “io c’ero prima”, rivendicando l’appartenenza del territorio, fermando la propria identificazione col suolo, la “propria terra”, è oggi più che mai un argomento molto valido nel conflitto tra identità nazionali, etniche. Si porta a discussione: chi c’era prima? Chi è arrivato prima? Chi ha originariamente occupato questa terra? “Noi siamo arrivati prima”. Questo appellarsi al passato “Sono arrivato prima”, lo sappiamo, ha molto peso sul piano conflittuale e sappiamo anche quanto sia esiziale la trappola dell’identità quando fa leva sul territorio. Crisi ed esaltazione Più c’è crisi e più c’è il parossismo dell’identità; più c’è pa- dell’identità rossismo dell’identità e più c’è l’insofferenza dell’altro, l’allergia per l’altro. Ma non soltanto per l’altro, per l’altro “da me”, ma anche per l’altro “di me”, cioè anche per quell’extracomunitario di me stesso. 93 Di più: tutti quegli extracomunitari “di me stesso” che io cerco di tenere a bada, di zittire, di controllare, di ridurre al silenzio, ogni volta che dico “io”. Giustamente Kant, acuto filosofo, parlava di “sintesi” a proposito dell’“io”. L’“io penso” è una sintesi. Ogni volta che dico “io” sembra che si parli solo di uno. Di qualcosa di unitario, come quando di una lingua diciamo che è l’italiano, l’inglese… o di un insieme di persone diciamo che è quel popolo, quella nazione. La parola “individuo” contiene il significato di non divisibile, di unitario, di “tutto d’un pezzo” e ciò sia che si tratti dell’individualità di una persona sia che si tratti della individualità di una comunità, di una cultura, di una religione: l’“Occidente”, la “Cristianità”. Sono espedienti pronti e usati inconsapevolmente, che sia nel caso di “io”, sia nel caso di “noi”, sia quando parliamo di “patria”, di “nazione”, di “lingua” (la mia lingua, la lingua materna con lo stesso senso di appartenenza, di proprietà, come se stessimo dicendo la “casa materna”), realizzano una situazione di omologazione e anche di sopraffazione, di cancellazione nei confronti di altre possibilità, di altre differenze, di altri modi di vedere le cose. Però più quest’Io [si riferirsce a Felice Di Lernia che gli siede accanto NDR] – e tu lo descrivi bene perché nel tuo libro, Ho perso le parole, dove ti occupi della “cura” – si irrigidisce, si sclerotizza, è centrato, si aggrappa a qualche identità – e più va soggetto alla possibilità di scindersi, di frantumarsi. La sua arroganza – sicumera, presunzione – è la sua debolezza, fin dall’inizio, prima ancora che “vada in pezzi”. Intermezzo: volere il bene di qualcuno e volere bene a qualcuno. Qui vorrei aggiungere, e credo che sia pertinente con il tema del semi94 nario, come certe parole, certi sostantivi, certi verbi, si carichino di un duplice senso quando sono impiegati nella forma del rapporto tra soggetto e oggetto (in base alla dicotomia attivo-passivo, funzionale alla logica dell’identità e della determinazione dell’essere di qualcosa o di qualcuno; infatti del soggetto si può affermare che è ciò che indica il verbo nella forma del participio presente, e dell’oggetto ciò che è nella forma del participio passato: x cura y: x è curante e y è curato) e quando invece lo sono nella forma che, in analisi logica, chiamiamo dei “casi indiretti” o “obliqui”. Una cosa è curare qualcuno (il malato mentale, il deviante, l’incapace, il disadattato; ma anche il “normale”: tutti noi, in questa fase di medicametalizzazione diffusa e di farmacrazia, ci sottoponiamo a qualche cura), e un’altra è aver cura di qualcuno, prendersi cura di lui; una cosa è pensare qualcuno e un’altra è pensare a qualcuno, come quando diciamo “ti penso” e vogliamo dire “penso a te”, o come quando diciamo di essere in pensiero per qualcuno; una cosa è volere il bene di qualcuno (“voglio il tuo bene”: sembra che chi lo dice voglia appropriarsene, e in effetti spesso è proprio così) e un’altra è voler bene a qualcuno; una cosa è ascoltare qualcuno nel senso di ubbidirgli, e un’altra è ascoltarlo nel senso di mettersi in ascolto nei suoi confronti; una cosa è sentire la paura di qualcuno, dove, malgrado la forma obliqua (come anche in “dare ascolto a qualcuno”), si tratta in effetti pur sempre del rapporto soggetto-oggetto (e infatti l’analisi logi-ca parla di “genitivo oggettivo”, se si intende che si teme qualcuno, oppure di “genitivo oggettivo”se si intende che è quel qualcuno ad avere paura), un’altra è sentire paura per qualcuno, temere per lui. Con questo voglio evidenziare 95 che nel rapporto soggetto-oggetto, che è il rapporto dominante nella logica predicativa, giudicativa, apofantica, quella della frase come unità di senso fatta di soggetto e predicato, è implicito un rapporto di dominio, di controllo, di pretesa, di padronanza. E non è casuale, invece, che nei casi obliqui, indiretti, si esprima un andare verso l’altro, l’apertura all’altro, il rivolgersi a lui, il porsi in una posizione di ascolto, Adesso non si usano più, per quanto riguarda la cura del “malato di mente”, nella terminologia nosografica parole come “isterica” (generalmente appunto al femminile) “schizofrenico”… : c’è solo il depresso perché la farmacrazia ha bisogno di medicinali omologati: allora tu sei più o meno depresso e, in base a ciò, meriti la dose più alta, la dose più bassa, ma è tutto semplificato dal fatto che si tratta pur sempre, in ogni caso, di depressione (anche qui la dicotomia o “bipolartità” come si usa dire, “euforico-depresso). Stabilito che si tratta di un caso di depressione, all’ascolto, di cui avrebbe bisogno chi si trova in difficoltà, si sostituisce il farmaco. È da ridere il fatto che la statistica dica che la depressione è notevolmente aumentata: in realtà è solo aumentato l’uso, l’abuso, di questa parola come passepartout. Io credo che su questi aspetti del sociale odierno ci siano numerosi punti in comune con le tesi del tuo libro [si rivolge a Felice Di Lernia NDR] Ho perso le parole, che ho letto con molto interesse. Comunità e lavoro Torniamo all’uso di “comunità”, concetto estremamente funzionale rispetto a quello di “identità”. A proposito dell’Europa unita si è generalmente parlato, e si parla, in termini di 96 comunità tanto da stabilire la dicotomia comunitario/extracomunitario che, in riferimento al fenomeno inarrestabile della migrazione (in una forma di produzione in cui lo sviluppo e il benessere si realizzano sulla base del sottosviluppo e del malessere di alcuni), va assumendo sempre più connotazioni razziste. Comunità indica l’avere qualcosa in comune. Comporta un “noi” contrapposto a “gli altri”. Questo qualcosa in comune che assicura l’appartenenza a un “noi” può essere la storia, il colore della pelle, il sangue, il suolo, la cultura, la tradizione, la lingua, la religione: a questi fattori fa appello la comunità, (avvalendosi ora maggiormente dell’uno, ora dell’altro, a seconda dell’ampiezza dell’insieme da ritagliare e che serve ad assicurare l’identità). Ho menzionato sopra il sociologo tedesco Ferdinand Tönnies (1855-1936), il cui libro, Gemeinschaft und Gesellschaft (Comunità e società, 1887), ebbe molto successo (fu riedito nella Germania nazista nel 1935). Egli distingueva tra la società come qualcosa di meccanico e di casuale e la comunità che invece indica legami forti e indissolubili. Nella Germania nazista, vi ho accennato sopra, il termine Gesellschaft, società, venne sostituito con Gemeinschaft, comunità. Comunità di che cosa? Di sangue certamente, ma anche comunità di lavoro, comunità del lavoro. “Il lavoro rende liberi”: così era scritto all’ingresso del campo di sterminio di Dachau. Io faccio spesso questo esperimento nell’aula dove faccio lezione: “Il lavoro rende liberi”. Chi di voi non è d’accordo? Chi non accetterebbe questo slogan? Chi ècontrario? Chi si astiene?” Approvato all’unanimità. “Sto qui, studio, prendo crediti, trovo un lavoro e sono libero”. Chi studia, va all’università, si laurea, si specializza, si prepara per il 97 lavoro “immateriale”, proprio ciò che oggi è maggiormente richiesto: investimento e profitto sul “lavoro immateriale, sulle “risorse umane”. L’hanno detto chiaro coloro che fanno parte della Commissione Europea con i loro libri bianchi e verdi ed è di dominio pubblico che la risorsa determinante, oggi, non è quella del lavoro materiale, ma è quella del lavoro immateriale. Pensate che fissazione materialistica e fisicalista hanno costoro per parlare dell’inventiva, della creatività, dell’intel-ligenza, dello studio come “risorsa immateriale” quantificabile e conteggiabile in ore. Materiale sarebbe semplicemente ciò che è fisico, ciò che riguarda il lavoro fisico. Quest’altro, invece, quello che è propriamente lavoro umano (inseparabile, malgrado la divisione del lavoro, imposta storicamente, nelle diverse forme sociali della produzione) è il lavoro nel senso dell’inventare, del creare, dell’immaginare, del cambiare, anche in senso infunzionale come nel caso dell’“opera” dell’artista, ma, in realtà, come in qualsiasi opera umana essendo l’infunzionale il marchio dell’uomo (sin dal più primitivo vaso di terracotta). L’uomo, come “animale semiotico”, è capace di innovazione, è capace di quel “gioco del fantasticare” (Charles S. Peirce, Thomas A. Sebeok) che non sta nell’utile; egli non si limita alla sopravvivenza, alla necessità (a meno che non sia costretto, e, anche in questo caso, è difficile che non tenti qualche “evasione”) ed è proprio tutto questo ciò che viene considerato immateriale, lavoro immateriale. 98 Sul vocabolario della lingua italiana le parole “infunzionale” e “infunzionalità”non sono incluse. E il correttore del word te le segna in rosso quando le scrivi al computer, eppure la vita non è vita (e il diritto alla vita è deprivato dell’essenziale) senza il diritto dell’infunzionalità. La stessa infunzionalità mercificata, quella dei beni superflui del supermercato, si regge su questa esigenza irriducibile. L’infunzionale è considerato un affare privato; nella stragrande maggioranza dei casi (diciamo per l’ottantacinque per cento della popolazione mondiale, ma si tratta di una percentuale sicuramente da aggiornare), “privato” anche nel senso di “deprivato” (privo dell’esenziale). Ciascuno di noi sa che è alla propria infunzionalità che vorrebbe che l’affetto altrui fosse diretto. In un rapporto che ci coinvolge fortemente, nel senso che è un rapporto decisivo per noi – non un rapporto di lavoro –, un rapporto decisivo nel senso affettivo, nel senso del volere bene a qualcuno e del desiderare che anch’egli voglia bene a noi, sappiamo con certezza che il valore di questo rapporto consiste nel suo essere “disinteressato”. Insomma, a nessuno di noi fa piacere accorgersi che chi dice di volerci bene, ci mostra affetto, tiene al nostro rapporto, in realtà lo fa in quanto siamo utili in questo, funzionali in quest’altro, efficienti per quest’altra cosa. In quei rapporti che non sono di scambio e che ormai sono relegati nel “privato” 99 Il diritto all’infunzionalità (quelli pubblici sono basati sullo scambio, sull’interesse, sul dare-avere e, in effetti, non sono rapporti se non sul piano forma-le sicché, sostanzialmente, sono essi i veri rapporti “privati” nel senso di privi del carattere essenziale del rapporto) vorremmo tutti, ciascuno di noi, che l’altro – il fidanzato, il marito, il parente, l’amico… – ci volesse bene “per niente”. Altrimenti si parla, non a caso, di amicizia interessata, di matrimonio d’interesse. Quindi noi sappiamo bene, malgrado i valori di mercato, che ciascuno di noi vale nella sua infunzionalità, nel suo “per niente”, come fine a sé. Questo “per niente”anche in una telefonata fra amici, ve lo dite, ce lo diciamo: “Pronto?”. “Sì. Dimmi”. “No, niente, volevo soltanto sentirti”. “Niente”. “Che mi dici?”. “Niente, e tu? Niente. Sono contento di sentirti”. E si va avanti su questo niente, è un niente molto importante. Questo rapporto fatto di niente è un rapporto che conta; è importante quella telefonata in cui non ti si deve dire niente, ma tu l’hai aspettata tutta la sera. E se invece, poi, scopri che ti si sta chiamando per un motivo preciso, che si voleva qualcosa da te, che insomma ti si voleva utilizzare in qualche modo, che ti si voleva considerare possibilmente funzionale, ecco, la cosa non ti piace, non ti garba. Ecco, il diritto all’infunzionalità. Non è il diritto alla vita l’essenziale. Attenzione: la vita, come ce la stanno conciando, non è vita, non basta il diritto alla vita perché bisogna rivendicare quest’altro diritto: il diritto all’infunzionalità, il diritto all’essere considerato valore come fine a sé stante; “tratta l’altro come fine, non come mezzo”. Questo essere 100 considerato fine, questo essere considerato valore (non “risorsa umana”), questo essere considerato avente un senso di per sé, questo è il punto centrale. Quindi il diritto alla vita non basta, se poi questa vita deve essere una vita di sfruttamento. Le forme sociali sono comunità di lavoro da quando il lavoro si vende e si compra, da quando esiste il lavoro libero. Il lavoro libero è il lavoro che uno può vendere liberamente; si coniò il termine “proletario” (oggi in disuso, ma il rapporto di compravendita del lavoro permane, malgrado la crisi del mercato del lavoro) per indicare chi è libero di vendere il proprio lavoro, non avendo niente altro da vendere che il proprio lavoro. La compravendita del lavoro: se un extraterrestre viene inviato sulla terra per sapere “c’è ancora il capitalismo sulla terra?”, quale criterio deve usare per dare una risposta? Egli dovrà semplicemente vedere se si vende e si compra il lavoro. Una volta che si vende e che si compra il lavoro, cioè si vende la caratteristica più specifica dell’umano, questa possibilità di inventare, di creare, di modificare, di trasformare, di elaborare – il cuocere, per dire l’intervento umano più semplice – se questo è in vendita, allora, non c’è più limite circa che cosa si può vendere. Una volta che il lavoro è in vendita allora c’è – già a livello potenziale, prima di divenire attuale come avviene oggi col mercato globale – la situazione di “mercato universale”. Mercato universale significa che nulla si sottrae all’essere merce e tutto ciò che ci serve è merce. Ormai siamo in questa condizione, una condizione per la quale dobbiamo comprare tutto tranne quei rapporti che sono veramente rapporti e che, paradossalmente, sono considerati, proprio essi, come “privati” (nel duplice senso di estro101 messi, ghettizzati, rispetto al “pubblico” e di “deprivati”, di privi dell’essenziale), cioè i rapporti di amicizia, d’amore, di responsabilità senza alibi per l’altro, che sono i rapporti per eccellenza, dati gratuitamente, sulla base del valore della infunzionalità di cui parlavo prima. Comunità di lavoro: nella Germania nazista – avete visto il film di Spielberg Schindler's List, no? – mostrare di essere stato assunto (vi ho fatto riferimento en passant prima) – in quel caso parliamo dell’industria bellica, nell’industria delle armi, mostrare di avere un posto di lavoro, significava essere riconosciuto come funzionale alla nazione, facente parte della comunità, perfino se si era ebrei. Addirittura, ciò valeva per gli ebrei. Chiudevano un occhio, li chiudevano tutti e due. Beh, la stessa cosa accade oggi, che cos’è cambiato? L’extracomunitario se mostra di avere l’attestato, il certificato di lavoro (cosa non facile), viene accettato nella comunità, perché questa comunità è una comunità di lavoro. E non è una bella cosa. Del resto, “l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”. Stiamo dicendo questo: che siamo una comunità di lavoro? Forse il senso è diverso. Ma emerge ancora quello secondo cui si tratta proprio di una comunità di lavoro, oggi più che mai. Già Hanna Arendt avverte che il lavoro sta finendo, che siamo alla fine del lavoro. E che il rischio è l’addestramento per il mercato del lavoro senza posti di lavoro. Lo stesso problema è esaminato da Adam Schaff, da Eric Weil… E dunque Jeremy Rifkin con il suo “best seller” è arrivato un po’ tardi; l’aveva detto già André Gorz che la cosa più paradossale è che ci troviamo in una so 102 cietà di gente preparata per il lavoro, ammaestrata, istruita per il mercato del lavoro, ma per un lavoro che non c’è. Una società di lavoratori senza lavoro; io direi una società di lavoristi per distinguerli dai lavoratori. I lavoristi senza lavoro sono quelli che sono già pronti, inquadrati, pre-occupati di “inserirsi” al più presto: “datore di lavoro cercasi”. Sono disposti anche a votarlo se si presenta alle elezioni politiche. Ho accennato prima alla faccenda della formazione e dei crediti. Che si possa conteggiare in ore il lavoro “materiale” sembra più facile, sembra fattibile. Ma anche per esso l’equiparazione lavoro-salario non c’è se c’è un profitto. Si è parlato di plusvalore – oggi dire “plusvalore” equivale a dire “Marx” – meglio allora: “valore aggiunto”. In ogni caso una sperequazione c’è. Comunque, la quantificazione, il conteggio in ore, per il lavoro materiale sembra fattibile (se dobbiamo dipingere questa sala, noi possiamo fare un calcolo: quante ore? Ecco, possiamo stabilire quante ore ci vogliono, ti pago a ore e la cosa funziona; sembra funzionare, no?). Pagare in base alle ore, al tempo necessario, è la condizione per quantificare. Il famoso Adam Smith diceva: “la vera ricchezza sociale è il tempo di lavoro”; non l’oro nelle casse dello Stato (buglionismo) e neppure la terra (fisiocrazia), ma il tempo di lavoro. Il paradosso è che questo tempo di lavoro deve essere ridotto sempre di più, per far crescere il profitto e l’automazione tecnologicamente avanzata porta questo processo a tendere all’azzeramento del lavoro: “lavoro zero”, “fine del lavoro”. Più si riduce il tempo di lavoro e più la produzione diventa competitiva. E come si riduce il tempo di 103 lavoro di un operaio? Sostituendolo con la macchina. Dunque la sostituzione del lavoro fisico con la macchina, prima semiautomatica, poi automatica. Ad un certo momento c’è stata pure la possibilità di sostituire l’intelligenza, il lavoro “immateriale” con l’intelligenza artificiale, la macchina intelligente. La macchina automatica espelle, elimina lavoro (una sorta job-killer), rende “esubero” il lavoro intellettuale, oltre che il lavoro materiale. Come dicevo, sembra semplice quantificare il lavoro materiale, cioè stabilire quante ore si è lavorato e pagare in base a questo calcolo. Ma il lavoro immateriale, il lavoro creativo, il lavoro inventivo, come può essere quantificato? Quando noi, nell’università, compiliamo un modulo per chiedere un contributo per la ricerca, c’è una casella che chiede “quante ore-uomo dura la ricerca?”… Quante ore-uomo? C’era un tale – si chiamava Newton – stava sotto un albero, stava pure dormendo, gli cadde la famosa mela sulla testa e inventò la teoria della gravitazione universale. Quanto ci vuole ad inventare una cosa? Per trovare un’idea nuova? Per risolvere un problema? Ci puoi impiegare tre anni, tre mesi, oppure stai guidando una macchina e ti viene un’idea straordinaria. Buona parte delle invenzioni più importanti sono avvenute per serendipity, per serendipità, per caso, anche per errore e distrazione.Dunque, il lavoro “immateriale” non è veramente quantificabile perché si tratta di lavoro inventivo, di lavoro creativo, e questo lavoro deve essere competitivo anche con la macchina automatica e con l’intelligenza artificiale. Ma per essere competitivo con la macchina intelligente, deve essere fortemente creativo, fortemente inventivo. Se ancora si 104 ha bisogno dell’uomo, è perché l’uomo è ancora capace di superare la macchina in invenzione, in fantasia, nel gioco del fantasticare. E come facciamo a valutare, come facciamo a quantificare tutto questo? Beh, non importa sapere se ciò sia possibile o meno; bisogna intanto che abituiamo i giovani sin dall’inizio, fin da quando stanno studiando, fin da quando si stanno formando, a credere che ciò sia fattibile. E come facciamo? Beh, col sistema dei crediti. I crediti: trasformare lo studio, il piacere di leggere un libro, l’ascolto di una lezione, l’interesse per una disciplina, in un punteggio da accumulare. L’altro giorno andai alla presentazione della rivista “Quaderni di comunicazione” – che tu conosci [si rivolge a Felice Di Lernia NDR] – e c’era l’aula piena, ma un’aula che era quattro volte questa ed era pienissima di ragazzi e io ero contento… poi mi venne un sospetto: “Non è che avete stabilito di dare dei crediti a chi partecipa a questo incontro?”, “Sì, due crediti”. E poi mi sono accorto che alcuni, mentre il relatore parlava, muovevano avanti e dietro la testa come se annuissero, ma facevano ciò continuamente e ritmicamente, alcuni in maniera più lenta, altri più veloce e io pensai “ma questi assentono a tutto quello che sentono?” e invece… e invece quelli avevano l’i-pod! [il pubblico ride NDR], insomma, avevano gli auricolari ficcati nelle orecchie, stavano, ciascuno per conto suo, ascoltando musica, portavano il ritmo, stavano lì semplicemente per aspettare che “quella noia” finisse per finalmente poter andare a firmare e prendersi i due crediti. 105 Sotto il governo della libertà e della democrazia alla ricerca del lavoro e dell’identità Comunque, se questa forma sociale è una comunità di lavoro, noi siamo ben fortunati rispetto a quelli che si trovarono nella comunità di lavoro di tipo nazista: noi abbiamo la democrazia! Noi. E gli altri? Ci possiamo vantare di avere la democrazia e la libertà (oggi, in Italia, sono, a chiare lettere, nei nomi dei due partiti al governo) e riteniamo giusto, per senso umanitario, che siano esportate nei paesi che ne sono privi “con tutti i mezzi necessari”. La libertà, come risulta definita nella Costituzione Europea (Treaty establishing a Constitution for Europe) e in The National Security Strategy of the United States of America (settembre 2002; è il testo della Casa Bianca, con introduzione di Bush in cui viene proclamata l’idea della “guerra preventiva”e dove si parla degli “Stati canaglia”), è la libertà dell’ideologia neoliberista che consiste nella possibilità di comprare e di vendere, nella garanzia del ”libero mercato” e delle pari opportunità. Per quanto riguarda la “democrazia” il semiotico americano Charles Morris, in The Open Self, del 1948, osservava che “democrazia” è diventata una parola fortemente apprezzativa, ma poco chiara dal punto di vista designativo. Classificarsi democratici è ora tanto normale e inevitabile, quanto per i politici farsi fotografare con i bambini.E aggiunge: “Quando il fascismo conquisterà l’America lo farà in nome della democrazia. Infatti, qualsiasi cosa si faccia ora in America – o altrove sulla terra – sarà fatto in nome della democrazia”. Se usassimo il termine “democrazia” in senso designativo sareb106 be sinonimo dell’espressione “società aperta di io aperti” (C. Morris1948, pp. 145-146). La società chiusa è quella che usa la democrazia facendola diventare una specie di parola-ombrello. Chi non direbbe che è democratico? Chi non direbbe che è tollerante? Ma poi – come diceva Pier Paolo Pasolini – invece di usare il participio presente “tollerante”, invece di riempirti la bocca di “tollerante”, usa il verbo “tollerare” al participio passato, “tollerato” e poi “applicati” questa parola e vedi se ti piace; a chi piace essere tollerato? Questa è una cosa che fa capire quanta ipocrisia ci sia nella tolleranza. Libertà e democrazia: questi valori vengono sbandierati indifferentemente e unanimemente da “schieramenti” che si considerano opposti, ma “pronti al dialogo” per il mantenimento e la riproduzione di questa forma sociale. Siamo in un periodo di re-incanto (ci sarà di nuovo il disincanto, come c’è stato in passato? Sarebbe pensabile, ma le nuove generazioni non ne sanno niente) nei confronti dei vecchi sani valori: la libertà, l'eguaglianza, la democrazia, il posto di lavoro, il mercato, l’identità ricercata nel lavoro- merce, e, a causa della disoccupazione strutturale, il suo parossismo (che si manifesta nell’identità di sesso, di razza, di nazione, di etnia, di religione, di cultura, insomma relativamente a qualsiasi appartenenza). Allora ecco le due trappole mortali: quella del lavoro e quella dell’identità, ma stanno insieme perché l’identità si realizza attraverso il lavoro. Perdere il lavoro, non trovare lavoro significa perdere d’identità.Identità e lavoro entrano in gioco, insieme, in coppia, nel caso della migrazione, sotto forma di aut-aut: o identità o lavoro, se non puoi esibire l’identità comunitaria, l’identità di appartenente, se sei un immigrato, devi 107 almeno esibire un certificato di lavoro, di assunzione. Il disoccupato non ha il lavoro, ma ha l’identità, la carta di identità, di appartenenza comunitaria. Tu, migrante, privo di appartenenza devi avere lavoro altrimenti sei espulso. Quindi, a parità di disoccupazione, il disoccupato appartenente resta; il disoccupato migrante deve andare via – “smamma” si dice in meridionalese – e viene anche de-tenuto nei CTP fino a quando non è rispedito da dove è venuto. Viene detenuto e sappiamo le condizioni di questa detenzione, nei campi… come li chiamiamo: di lavoro? Lager? No, ecco di detenzione provvisoria o preventiva. Meglio usare una sigla: CTP. Marcuse (1967, p. 112) faceva notare che la sigla “NATO” non dice quel dice, North Arlantic Treaty Organization e cioè che si tratta di un trattato tra le nazioni che si affacciano sull’Atlantico del Nord perché in quel caso uno si potrebbe chiedere perché ne siano membri la Grecia e la Turchia. Ecco come una sigla serve spesso per sanzionare un fatto come fuori discussione. Migrazione e disoccupazione Forse va considerata, a questo punto, la differenza tra migrazione ed emigrazione. Perché c’è una “bella” differenza tra emigrazione e migrazione: l’emigrazione è quella tradizionale, è lo spostamento di forza-lavoro, cioè qualcuno che si sta spostando perché non trova lavoro e lo trova, invece, nel posto dove si sposta ed è un fenomeno assorbibile e che fa comodo a chi “accoglie”. Si può pianificare l’emigrazione, 108 perché si tratta di spostamento di forza-lavoro: “lì è inutile, portatecela da questa parte, fateli venire qua, prego”. La migrazione – attenzione, la parola migrazione si usa per gli uccelli, per gli animali che si spostano – è invece una specie di spostamento non controllabile, non contenibile, non assorbibile. Ecco, questa è la migrazione. Non è spostamento di forzalavoro, perché dove avviene “non c’è lavoro”, nel senso che non si trova il posto di lavoro. La migrazione non è semplicemente la ricerca di lavoro, ma è la ricerca di uno spazio di vita dovuto alla situazione d’invivibilità che il cosiddetto sviluppo ha prodotto sul cosiddetto sottosviluppo. E sappiamo tutti che il sottosviluppo è il risultato dello “sviluppo”, che non ci può essere “sviluppo” – proprio come non ci può essere una collina senza valle – senza “sottosviluppo”, senza sfruttamento. E il sottosviluppo prima era esterno, ora comincia ad essere sempre più interno – ce lo abbiamo dentro insomma, come nel caso del nostro meridione. E cominciano a chiamarci “forestieri” (“terroni” era meglio). Con la complicazione che, benché nel nostro paese al governo ci sia vuoi la Libertà vuoi la Democrazia, in Parlamento non c’è più nessuno che rappresenta “le minoranze” (minoranze ideologiche, ma maggioranze numericamente: la cosiddetta “falsa coscienza” – io la chiamerei diversamente – fa questi brutti scherzi), come invece la Costituzione italiana vorrebbe: in un paese democratico bisognerebbe che fossero rappresentati coloro che stanno peggio, coloro che stanno male, coloro che non ce la fanno più, coloro che non hanno il problema dell’ICI – lo abbassiamo, lo aumentiamo, lo togliamo? – ma non hanno nemmeno la casa! Che importa loro che se devono o non devono pagare l’ICI se non hanno nemmeno la casa? 109 La migrazione è un fenomeno incontenibile che va crescendo e che si connette con quello della disoccupazione. E non si tratta più di una disoccupazione congiunturale, ma di una disoccupazione strutturale perché se diminuire il tempo di lavoro significa incrementare il profitto – non mi soffermo su questo, vi ho fatto accenno prima –, più diminuisce il tempo di lavoro, più si diventa competitivi. Si può dire che oggi ci siano due buoni motivi per essere licenziati: uno perché l’azienda “ha perso”, è stata sconfitta, chiude i battenti, e quindi licenzia; l’altro perché l’azienda scoppia di salute, e quindi può permettersi degli “esuberi” e può dirti: “non mi servi più, mi compro la macchina automatica, la macchina intelligente, che ti sostituisce”. Allora o l’azienda scoppia di salute o fallisce, la risultante è sempre la stessa: licenziamento, disoccupazione. La disoccupazione è strutturale perché questa forma sociale produce tempo liberato dal lavoro, tempo disponibile. Come lo chiamiamo questo tempo liberato dal lavoro? Lo chiamiamo disoccupazione. È una brutta bestia la disoccupazione… Ma di che cosa si tratta in realtà? Facciamo lo sforzo di vedere l’altra faccia di questa cosa. È possibilità di tempo liberato dal lavoro, di tempo disponibile – da non confondere con il “tempo libero” che è tempo dipendente dal lavoro e per il quale esiste tutta “un’industria”, “l’industria del tempo libero”, appunto. Disponibile per che cosa? Disponibile per la mia alterità, per la mia infunzionalità – altro che identità! – per quell’altro di me che devo sacrificare, per quell’altro da me di cui non posso prendermi cura. Dunque liberazione dal lavoro libero, liberazione dal lavoro merce; e questo è il risvolto, l’altra faccia della medaglia. 110 Quel tale che si chiamava Marx non avrebbe mai immaginato che il socialismo avrebbe potuto pretendere di realizzarsi in paesi come la Russia o la Cina, non avrebbe mai puntato su paesi di miseria per la realizzazione del socialismo (e i fatti hanno dimostrato che aveva ragione): guardava invece ai paesi a capitalismo avanzato perché un capitalismo avanzato produce liberazione dal lavoro, tempo liberato dal lavoro merce. Che cosa accomuna l’emigrato e il disoccupato, malgrado l’identità e i rigurgiti razzisti nei confronti di quest’ultimo? Il non-lavoro. Sono due pezzi di umanità che non sono convertibili in merce. Per il disoccupato questa condizione continua a presentarsi con il carattere della provvisorietà, della contingenza – benché sociologi ed economisti parlino di “disoccupazione strutturale”. Nel migrante, invece, ciò risulta in maniera drastica, essenziale. Per lui il paradosso, reale, è che in una situazione che abbiamo definito di mercato “universale”, tutto può essere convertito in merce tranne lui, il migrante. Nel mondo della “comunicazione globale” tutto può essere fatto circolare, tutto può essere comunicato, tranne lui, ma non perché è una “merce proibita”, ma perché non è una merce, non riesce a convertirsi in merce, è un pezzo, notevole, di umanità non mercificabile. Ecco, questo è interessantissimo: ci sono sempre più pezzi di umanità che non sono riducibili in merce, che non possono essere trasformati in merce, non perché qualcuno si è opposto alla mercificazione, all’alienazione – “non vogliamo più essere mercificati” –, no, quelli che sostenevano questo lo 111 facevano in base a una certa ideologia, in base una presa di posizione, di coscienza. Qui la cosa è diversa: malgrado quello che uno vuole o non vuole, la realtà stessa delle cose contrasta, impedisce la mercificazione. Ci sarà una nuova “internazionale del non lavoro”(“non lavoristi di tutto il mondounitevi!), forse non destinata al fallimento come le “internazionali del lavoro”soggette a sfaldarsi tutte le volte che sono entrate in collisione con l’appartenenza nazionale, particolarmente di fronte alla “prova del fuoco” della guerra. Su questi due aspetti bisognerebbe riflettere per immaginare e vedere scenari diversi da quelli della riproduzione di questa forma sociale, la forma sociale capitalistica: 1) Concretamente, oggi c’è, in continuo aumento, una parte notevole (la gran parte) di umanità (migranti e disoccupati) non convertibile in merce, che non può essere comunicata, per la quale il mercato è saturo. 2) La “risorsa” considerata oggi decisiva per l’investimento, per il profitto – il cosiddetto lavoro immateriale – con molta difficoltà si lascia quantificare, conteggiare in ore. L’espediente dei crediti per renderlo credibile (vale a dire: “credici e crediti da un momento all’altro mercificabile!), fin dal periodo della preparazione, dello studio, della formazione, è penoso e risibile, al tempo stesso. Vattene perché a vederti mi fai venire il senso di colpa Termino con un riferimento alla Medea di Pier Paolo Pasolini. Creonte – il re, il potere, il tiranno – ad un certo punto si reca di persona da Medea la straniera, che è stata portata a Corin112 to da Giasone, a cui ha dato due figli e che ora è stata relegata fuori dalle mura. Perché Creonte va da Medea? Va per dire a lei, già confinata ai margini, extra moenia, che deve andarsene definitivamente, con i suoi figli. “Perché?”, chiede Medea. “Perché anche i miei figli?”. Creonte, in un primo tempo, risponde: “Perché mi fai paura. Mi fai paura – te lo dico apertamente – per la mia figliola [che Giasone intende sposare]. È noto a tutti in questa città che, come barbara, venuta da una terra straniera, sei molto esperta nei malefici. Sei diversa da tutti noi, perciò non ti vogliamo tra noi”. Poi, siccome Medea gli risponde in una maniera così garbata, da fargli addirittura dire: “Sono dolci le tue parole, umane”, Creonte rivela come effettivamente stanno le cose. Si realizza allora un rapporto extra-ordinario, cioè un rapporto fuori ruolo: Creonte e la straniera – la strega – faccia a faccia, a volto scoperto, da singolo a singolo, da unico a unico. Sicché Creonte dice: “Voglio dirti la verità: non è per odio contro di te, né per sospetto della tua diversità di barbara, arrivata nella nostra città con segni di un’altra razza, che ho paura… ma per timore di ciò che può fare mia figlia, che si sente colpevole verso di te”; ho paura, non di te, ho paura per mia figlia. Ebbene, l’analisi logica conosce soltanto due sensi di “sentire la paura dell’altro”. Essa (vi ho accennato prima) distingue tra “genitivo soggettivo”, “genitivo oggettivo”; la paura dell’altro può essere o nel senso che l’altro ha paura – ed è genitivo soggettivo – o che si teme l’altro, genitivo oggettivo. “L’altro” o è soggetto o è oggetto della paura. Allora che cosa dice Creonte? Dice: devo esserti sincero, qui non si tratta del fatto che tu fai paura o che io ho paura di te 113 o che non voglio che mia figlia debba temere la tua presenza. È che io ho paura per mia figlia. Avere paura per… non è più né genitivo soggettivo, né genitivo oggettivo. Due digressioni In Dipartimento (il Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi dell’Università di Bari), abbiamo intitolato Umano troppo disumano l’ultimo volume della serie “Athanor”, pubblicato da poco; come sapetele si sono commessi moltissimi crimini sotto la copertura dell’umano: guerre umanitarie, gli interventi umanitari, i bombardamenti umanitari. Emmanuel Lévinas scrisse un saggio intitolato “I diritti umani e i diritti altrui” in cui, fin dal titolo, risulta che i diritti umani non coincidono con i diritti altrui e ciò per il semplice motivo che, da sempre, essi vengono fatti equivalere ai diritti della propria identità. A questo proposito potremmo distinguere tra l’arrogare a sé la qualifica di “umano” (parafrasando la frase di Orwell “siamo tutti eguali, ma noi siamo più eguali degli altri”, “siamo tutti umani, ma noi siamo più umani degli altri”) ossia quell’identità derivante dall’appartenenza alla specie “homo” e dunque l’“humanitas” e, invece, un umanesimo dell’alterità, in cui humanitas non è fatta derivare da homo (infatti non si dice “homanitas”, ma “humanitas”), bensì da humus, dalla stessa parola da cui deriva humilitas. “Umanità” è una prerogativa di specie naturalmente acquisita e di comodo, come i cosiddetti diritti naturali: “libertà, eguaglianza, proprietà” (impiegati per giustificare un mondo in cui la libertà è confusa con l’egoismo, il modo prevalente di essere liberi è la servitù, il modo prevalente di 114 essere eguali è una disuguaglianza imposta dall’alto e il diritto alla proprietà consiste nel garantirla a chi ne è in possesso), rivendicati in base al fatto dell’appartenenza al genere uomo, il genere più ampio in base al quale far valere (sempre contro qualcuno) la propria identità. Si tratta oggi, invece, di recuperare l’humanitas come umanità derivante da humus, che è tutt’altra cosa dell’esaltarsi come per un’appartenenza di genere, di specie, tutt’altra cosa dell’antropocentrismo – appartenenza che, come quella di qualsiasi identità, ha sempre un carattere discriminante, oppositivo, distruttivo, come mostrano i danni dell’antropizzazione del pianeta e le cosiddette guerre umanitarie. Seconda digressione. Anche “razionale” è una prerogativa acquisita per appartenenza alla specie homo e, anch’essa, ha un carattere discriminante. Quanti crimini in nome della ragione! Le espressioni “avere ragione dell’altro”, “dargliele di santa ragione” e l’uso di ratio (che significa anche mezzo – “con tutti i mezzi necessari”), in “estrema ratio” per giustificare il ricorso alla guerra (“giusta e necessaria”) nei conflitti internazionali, evidenziano bene che la “ragione” è sempre la ragione dell’identità, a servizio della sopraffazione dell’altro. È necessario che l’uomo da “animale razionale” velocissimamente, al più presto possibile, pena la scomparsa sua, ma anche di gran parte della vita del pianeta terra, compia la sua trasformazione da animale razionale ad animale ragionevole. Dunque dicevo “aver paura per”. Mi viene in mente quello che scrive un giornalista, Uberto Tommasi (un giornalista che 115 Accusativo e genitivo etico però sembra un romanziere quando scrive) in un libro “Tulipani rossi”, dedicato alla tortura in Turchia, in cui racconta l’incontro con una ragazza che aveva subito torture terribili e che era in grado di fargli conoscere un gruppo di oppositori che denunciavano questi crimini, ma ciò a suo rischio e pericolo, “suo”, “di lui” e “di lei”. Quando lei va via, guardando le sue spalle esili mentre si allontana, dice così: “Sentì paura, ebbi paura per lei”. Sentire la paura dell’altro, come avere paura per lui. Ecco, qui non c’è più né il genitivo soggettivo, né il genitivo oggettivo. Come lo chiamiamo questo sentire la paura dell’altro in quest’altro senso? In analisi logica non c’è, non è previsto: o sei soggetto o sei oggetto, però noi abbiamo espressioni del tipo non “penso te”, ma “penso a te”. C’è nella lingua spagnola un simpatico modo di dire, ma anche nei nostri idiomi meridionali ce l’abbiamo, che tradotto in italiano è “amo a te”. Lucy Irigaray ha intitolato un suo libro edito italiano “Amo a te. Penso a te”, che non è “te” complemento oggetto, accusativo (così si chiama!). Lo sapete, in francese si usa il verbo amare tanto per dire “mi piace il pollo” quanto per dire “ti amo”. Al ristorante, in francese, accade che, mentre gli stanno servendo il pollo arrosto, uno possa dire alla ragazza alla quale poco prima ha dichiarato “Je t’ame”: “J’ame le poulet roti”. Ho fatto riferimento prima, per quanto concerne il rapporto con l’altro, alla differenza, nella parola, tra l’uso dei casi diretti e di quelli indiretti o obliqui. Come chiamiamo allora questo genitivo “sentire la paura dell’altro” nel senso di avere paura per lui, di temere per lui? 116 Io l’ho chiamato genitivo etico, per analogia al “dativo etico” (“stammi bene!”). Quando Creonte dice: “io ho paura per mia figlia”, lo dice perché sa che lei si sente in colpa: è la donna che si è messa con Giasone, per la verità è Giasone che, per fare carriera, si è messo con la figlia del principale. Dunque “ho paura per mia figlia”; perché si sente in colpa. Nei confronti di chi? Di Medea. Si sente così in colpa a tal punto che può fare qualche pazzia. In altri termini Creonte sta dicendo a Medea: “Ecco perché te ne devi andare, perché non ti deve vedere, più ti vede e più si sente in colpa, più ti vede e più aumenta la cattiva coscienza; invece, se te ne vai, se non ti vede è molto facile che recuperi la coscienza in pace, la buona coscienza”. È quello che facciamo con gli immigrati. Diciamo: “Toglieteceli da sotto casa, toglieteceli davanti! Perché li dobbiamo vedere? Perché io mi ritiro e devo incontrare questi?. A parte che puzzano, e puzza anche il cibo che cucinano. Ma, io sono un tipo sensibile e mi fanno venire sensi di colpa, e non dormo tranquillo. Torno a casa dopo una giornata di lavoro, devo cenare, insomma… non va bene, toglietemeli, toglietemeli davanti”. Ecco, questo è interessantissimo, cioè il togliere via l’altro, ghettizzarlo, espungerlo per avere una situazione di buona coscienza, di coscienza in pace. Ecco perché possiamo parlare di due tipi di pacifisti. I pacifisti che cercano di uscire dal mondo della guerra sono quelli che sanno che tutto il mondo è un mondo di guerra: che non c’è un pezzo di territorio, di nazione, un confine che non sia risultato di guerra; non si è vista ancora, non si è vista mai, una pace che non sia pace di 117 guerra, frutto di una guerra. Poi ci sono quei pacifisti che, da ciò, traggono la conseguenza che non ci potrà mai essere una pace che non sia la pace della guerra. Se vuoi la pace, preparati alla guerra. Sicché la pace consiste nel trovarsi sull’orlo della guerra. O, detto orwellianamente, “la pace è la guerra” e “la guerra è la pace”. E poi c’è un terzo tipo di pacifista ed è quello della coscienza in pace, quello del pacificatore della propria coscienza, quello che vorrebbe non sapere, non sentire, non vedere: “vattene così non ti vedo e non mi sento in colpa”. Tutti e tre questi differenti tipi di pacifisti si ritrovano a marciare insieme nella “marcia della pace”. Sono tanti. Sono tutti. Ma solo una “minoranza” (numerica? ideologica? (non è un conteggio da statistica; certamente però una “minoranza non rappresentata” nel governo della libertà e della democrazia) vuole effettivamente uscire da questo mondo di guerra: uscire dalle trincee dell’identità, smetterla con gli alibi dell’identità, guarire dall’allergia all’altro, recuperare la salute della non indifferenza per l’altro, quale condizione della pace preventiva. Una pace “originaria”, potremmo dire, dato l’individuo isolato dall’altro individuo, con il suo diritto alla libertà e i suoi privati interessi (de-privati del rapporto con l’altro) e il conseguente parossismo della paura dell’altro (genitivo oggettivo e soggettivo), l’homo homis lupus, non sono il punto di partenza (la fallacia di Hobbes!). Sono invece il punto d’arrivo di una forma sociale che ha l’identità e il lavoro-merce come sue trappole mortali: 118 - il lavoro-merce con la sua doppia interna competitività: “cercare lavoro”, nel senso, per chi lo vende, di avere la meglio sull’altro che pure lo cerca e di venderlo meglio e nel senso, per chi lo compra, di ridurne quanto più è possibile la necessità di acquisto e il costo, di sfruttarlo al meglio (ai migranti: “tornatevene alle case vostre, veniamo noi da voi ad assumervi, così ci costate poco, prezzi stracciati!”). - l’identità, che, a qualsiasi genere di appartenenza si richiami (di sesso, di razza, di mestiere, di religione, di nazione, di lingua, di cultura) impone l’opposizione e, come tale, è già arruolamento, reclutamento, chiamata alle armi, è già costrizione al conflitto, costrizione alla guerra. L’identità è sempre trincerata. 119 Riferimenti bibliografici «Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», n.s., 7, 2003-04, Lavoro immateriale, a cura di S. Petrilli, Roma, Meltemi. «Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», n.s., 8, 2004, The Gift, a cura di G. Vaughan, Roma, Meltemi. «Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», n.s., 9, 2005, Mondo di guerra, a cura di A. Catone e A. Ponzio, Roma, Meltemi. «Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», n.s. 10, 2006-07, White Matters / Il bianco in questione, a cura di S. Petrilli, Roma, Meltemi. «Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», n.s. 11, 2007-2008, Umano troppo disumano, a cura di F. De Leonardis e A. Ponzio, Roma, Meltemi. Benjamin, Walter, 1931, “Der destruktive Charakter”, in W. Benjamin, Gesammelte Schriften, a cura di .R. Tiedermann e H. Schweppenhäuser, IV, 1, pp. 396-401, Frankfurt/M, 1972; trad it. di P. Segni, “Il carattere distruttivo”, in W. Benjamin et alii 1995, pp. 9-12. 120 Benjamin, Walter, 1939-40, “Über den Begriff der Geschichte”, in W. Benjamin, Gesammelte Schriften, a cura di R. Tiedermann e H. Schweppenhäuser, I, 3, pp. 1223-1266, Frankfurt a. M., 1972; trad it. di R. Solmi, “Tesi di filosofia della storia”, in Franco Rella (a cura), Critica e storia, Venezia, Cluva, 1980, pp. 209-219. Benjamin, Walter, et al., 1995, Il carattere distruttivo, «Millepiani», 4, Milano, Mimesis, pp. 9-12,» Delors, Jaques, 1994, Commissione Comunità Europee Libro bianco, Crescita, competitività, occupazione, Il Saggiatore, Milano. Derrida, Jacques, 2003, Voyous, Paris, Galilée; trad. it. di G. Berto, 2003, Stati canaglia, Milano, Cortina. Di Lernia, Felice, 2008, Ho perso le parole. Piacere e dominio nelle pratiche di cura, Molfetta, La Meridiana. Enzi, Aldo, 1971, Il lessico della violenza nella Germania nazista, Presentazione di L. Heilmann, Bologna, Pàtron. «La Rose de Personne. La rosa di nessuno», 2, 2007, Culture nazie? Cultura nazista?, Milano, Mimesis. Leone de Castris, Arcangelo, 2008, “La rivoluzione eventuale”, postfazione a Fausto Bertinotti, Ottimismi di volontà, postfazione di Arcangelo leone de Castris, Bari, Palomar, 2008, pp. 91-115. 121 Lévinas, Emmanuel, 1934, “Quelques réflexion sur la philosophie de l’hitlerisme”, trad. it. di A. Ponzio, in «Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», n.s. 11, 2007-2008, Umano troppo disumano, pp. 74-60. Lévinas, Emmanuel, 1972, Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata Morgana; trad it. di A. Moscato, 1995, Umanesimo dell’altro uomo, Milano, Il melangolo. Lévinas, Emmanuel, 1987, Hors Sujet, Fata Morgana, Montpellier; trad. it. e pref. di F. P. Ciglia, 1992, Fuori dal Soggetto, Genova, Marietti. Marcuse, Herbert 1964, One-Dimensional Man, Boston, Bacon Press. Trad it. di L. e T. Gallino, 1967, L’uomo a una dimensione, Torino, Einaudi. Marx, Karl, 1844, Ökonomish-philosophische Manuscripte, trad. it. di N. Bobbio, 1978, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Torino, Einaudi. Marx, Karl, 1857-58, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf, trad. it. di E. Grillo, 2 voll. 1968 e 1970, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Firenze, La Nuova Italia. 122 Marx, Karl, 1867-94, Das Kapital; trad. it. Il capitale, di D. Cantimori, I, 1964; R. Ranieri, II, 1965; L. Boggeri, III, 1965, Il Capitale, Roma, Editori Riuniti. Marx. Karl, 1875, Kritik des Gothaer Programms (pubblicata da Engels nel 1891), trad. it. di I. Pasqualoni, 1975, Critica del programma di Gotha, introd. di Augusto Illuminati, Roma, Savelli. Morris, Charles, 1948, The Open Self, New York Prentice Hall; trad. it. e cura di S. Petrilli, 2002, L’io aperto, Bari, Graphis, 2002. Peirce, Charles, S. , Opere, Milano, Bompiani. Ponzio, Augusto, 1999, La comunicazione, Bari, Graphis, nuova ed. 2006. Ponzio, Augusto, 2002 Individuo umano, linguaggio e globalizzazione nel pensiero di Adam Schaff, Milano, Mimesis. Ponzio, Augusto, 2003, I segni tra globalità e infinità. Per la critica della comunicazione globale, Bari, Cacucci. Ponzio, Augusto, 2004, Elogio dell’infunzionale. Critica dell’ideologia della produttività, Milano, Mimesis. Ponzio, Augusto, 2007, Fuori luogo. L’esorbitante nella produzione dell’identico, Roma, Meltemi. 123 Ponzio, Augusto, 2008, Linguaggio, lavoro e mercato globale, rileggendo Rossi-Landi, Milano, Mimesis. Ponzio, Augusto, Petrilli, Susan, 2000, Il sentire della comunicazione globale, Roma, Meltemi. Ponzio, Augusto, Petrilli, Susan, 2001, I segni e la vita. La semiotica globale di Thomas A. Sebeok, Milano, Spirali. Quadretti, Emilio, 2008, Evasioni e rivolte, Migranti cpt resistenze, Milano, Meltemi. The National Security Strategy of the United States of America, 2002, Seal of the President of the United States, Washington, The White House. Treaty Establishing A Constitution For Europe, Conference of the Representatives of the Governments of the Member States, Brussels, 13 October 2004; trad. it., 2005, La costituzione europea, Lecce, Il Raggio Verde. Tommasi, Uberto, Tulipani rossi, Milano, Edizioni Achab, 2007. Tönnies, Ferdinand, 1887 e 1935, Gemeinschaft und Geselschaft, trad. it. di G. Giordano, 1963. 1979, Milano, Edizioni di Comunità 124 125 126
Scaricare