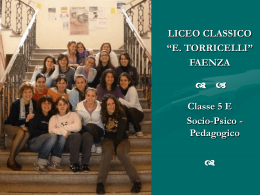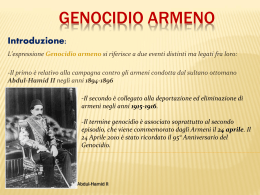piccole conferenze 2 La tragedia degli Armeni Dal genocidio alla rinascita piccola conferenza con Antonia Arslan © ottobre 2010 Scuola Bertolini Portogruaro Area della ricerca metodologico/didattica Trascrizione della conferenza e pubblicazione a cura di Daniele Dazzan Scelta dei materiali di approfondimento: Daniele Dazzan, Lucrezia De Vecchi, Maria Grazia Gelsomini Piccole conferenze per grandi incontri Non un “festival della filosofia” o della matematica in piccolo (e tuttavia non sono estranee le recenti sollecitazioni della Philosophy for children), ma un “festival” della scuola che incontra Grandi Maestri, disponibili a far circolare dentro la scuola stessa le loro idee e capaci di rivolgersi a un pubblico di ragazzi. Una proposta culturale nata dentro la scuola, non preconfezionata all’esterno di essa: gli insegnanti restano i proponenti, i coordinatori, gli artefici dell’iniziativa, e mettono in circolo le loro competenze disciplinari e il loro impegno transdisciplinare per la ricostruzione della rete di relazioni che coinvolge il mondo della conoscenza. La collocazione delle “Piccole conferenze” nel Teatro Comunale Luigi Russolo, reso disponibile dall’Amministrazione di Portogruaro, sottolinea la partecipazione convinta dell’istituzione pubblica a un progetto di rivisitazione critica dei saperi tradizionali e di approfondimento dei nuovi saperi emergenti: il teatro della città si conferma teatro delle idee e luogo di incontro tra scuola e società civile. La compartecipazione di Coop Consumatori Nordest al progetto si configura, infine, come ulteriore presenza significativa nella positiva, sinergica “triangolazione” delle forze vive messe in gioco, tutte interessate alla crescita culturale e alla costruzione del benessere collettivo: il mondo della scuola, l’amministrazione pubblica, il mondo del lavoro e della produzione. 5 Presentazione di Daniela Giovanna Villotta, Dirigente scolastico Do a tutti il benvenuto a questo secondo appuntamento delle “Piccole Conferenze”: ai ragazzi, agli insegnanti, al pubblico, ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di Coop Consumatori Nordest. Ricordo che il progetto delle “Piccole Conferenze”, nato nella nostra scuola con l’intento di sviluppare la ricerca di una metodologia e una didattica sempre più coinvolgenti, intende porre di volta in volta al centro dell’attenzione argomenti e tematiche che per loro natura spingano alla scoperta della complessità e delle interconnessioni tra le cose che si agitano nel mondo. Dopo aver trattato, lo scorso maggio, il tema della musica e del perché agli uomini in generale e agli adolescenti in particolare essa piaccia così tanto, è ora la volta di un argomento molto impegnativo: attraverso il caso emblematico della tragedia armena di inizio Novecento, parleremo delle radici dell’odio, della percezione della diversità come oscura minaccia anziché come fonte di arricchimento, dello sfruttamento delle paure che si annidano nel cuore dell’uomo per dirigerne gli impulsi violenti contro bersagli di comodo... Abbiamo trovato due validi collaboratori per questo progetto, ai quali va il nostro grazie più sentito: l’Amministrazione Comunale di Portogruaro, che è oggi qui rappresentata dall’assessore all’istruzione dott. Ivo Simonella; e la Coop Consumatori Nordest, presente tra noi nella persona del sig. Pietro Borsoi. L’idea sottesa a questa iniziativa è che anche i ragazzi hanno 7 diritto ad avere interlocutori di qualità per potersi abituare da subito a discernere, tra le innumerevoli proposte che nella società attuale ci sottopone il mercato dell’industria culturale, le cose che contano e che hanno significato. L’obiettivo dell’iniziativa, che desidero qui ribadire, è proprio quello di confrontarsi con “modelli alti” per diventare “cittadini dal palato raffinato”. L’ospite di oggi non ha bisogno di presentazioni: sono certa che molti di voi la conoscono. Antonia Arslan è una scrittrice famosa, che interviene nel dibattito culturale contemporaneo non soltanto attraverso i suoi libri, ma anche attraverso le riviste e i giornali con i quali collabora. Con lei affronteremo oggi il tema della diversità attraverso la storia del popolo armeno, il suo popolo. Una storia di grande dolore, quella degli Armeni, che in molti abbiamo già avuto modo di conoscere proprio attraverso il primo romanzo di Antonia Arslan, La masseria delle allodole, e attraverso il film che i fratelli Paolo e Vittorio Taviani hanno ricavato da esso. So che i ragazzi, con i loro insegnanti, hanno parecchio lavorato sull’argomento; so che hanno intenzione di approfondirlo nei prossimi mesi; vedo anche presenti in sala ragazzi di altre scuole e cittadini di Portogruaro: cose che fanno molto piacere. Spero che tutto questo ci permetterà, alla fine, di interloquire con l’illustre ospite, porle domande, chiederle lumi e suggerimenti, ravvivando questa bella giornata di scuola vera. 8 Antonia Arslan Antonia Arslan (Padova, 1938) laureata in archeologia, è stata professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’università di Padova. È autrice di saggi pionieristici sulla narrativa popolare e d’appendice (Dame, droga e galline, Il romanzo popolare italiano fra Ottocento e Novecento) e sulla “galassia sommersa” delle scrittrici italiane (Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900). Attraverso l’opera del grande poeta Daniel Varujan - del quale ha tradotto (con Chiara Haiganush Megighian e Alfred Hemmat Siraky) le raccolte II Canto del Pane e Mari di grano - ha riscoperto la sua profonda e inespressa identità armena. Ha curato un libretto divulgativo sul genocidio (Metz Yeghèrn. Il genocidio degli Armeni, di Claude Mutafian) e una raccolta di testimonianze di sopravvissuti rifugiatisi in Italia (Hushèr. La memoria. Voci italiane di sopravvissuti armeni). Ha scritto il suo primo romanzo, La Masseria delle Allodole, “perché non ha potuto farne meno”. Del 2009 è La strada di Smirne, secondo romanzo dedicato alla storia del genocidio e della sua famiglia. Il 9 marzo 2010, a Roma, è stata celebrata con la medaglia d’oro del Ministero della Cultura dell’Armenia, il 21 marzo a Los Angeles ha ricevuto la medaglia d’oro del premio Narekatsi istituito otto anni fa da Friends of UCLA Armenian Language and Culture Studies, l’associazione che sostiene la cattedra di armenistica all’università californiana di Los Angeles. Ishtar 2. Cronache dal mio risveglio è l’ultimo suo libro: edito da Rizzoli nel novembre 2010, racconta la personale, amgosciante esperienza del coma improvviso e il lento recupero alla vita che si riaccende come per incanto. 9 Avvio a cura di Daniele Dazzan Per incominciare quest’incontro ho pensato di leggere alcune righe di Primo Levi, estratte dal suo romanzo intitolato La Tregua, e di mostrare due brevi scene dal film che i fratelli Taviani hanno ricavato dal primo dei due romanzi di Antonia Arslan, La masseria delle allodole. Il breve brano di Levi potrà forse sembrare, in un primo momento, solo indirettamente collegato al tema di questo appuntamento. In realtà c’entra eccome: e non solo perché questa è una Piccola conferenza sull’umanità dell’uomo e, purtroppo, sulla terribile negazione di questa stessa umanità; ma anche perché, come avremo modo di capire, il rapporto tra il genocidio degli armeni e la Shoah è in realtà strettissimo. Leggerò solo poche righe1, quelle che qui mi sembrano più adatte a introdurre l’intervento di Antonia Arslan e più capaci di esprimere la stima e l’ammirazione per il suo instancabile lavoro al servizio della verità. Hurbinek era un nulla, figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome ... Eppure cerca di comunicare, cerca di dire qualcosa, questo Hurbinek: ma coloro che stanno assieme a lui nel campo 1 Il testo è riportato nella sezione “Materiali”, a pagina 83. 11 Piccole conferenze per grandi incontri di Auschwitz non riescono a capire cosa tenti di dire. Tuttavia, prosegue Primo Levi, ...Hurbinek continuò finché ebbe vita i suoi esperimenti ostinati. Nei giorni seguenti, tutti lo ascoltavamo in silenzio, ansiosi di capire, e c’erano fra noi parlatori di tutte le lingue d’Europa: ma la parola di Hurbinek rimase segreta [...]. Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hurbinek che aveva combattuto come un uomo, fino all’ultimo respiro, per conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole. Ecco: tutti gli Armeni, vittime della follia di questo primo genocidio del ventesimo secolo, hanno potuto testimoniare e testimoniano ancora attraverso le parole di Antonia Arslan. *** Con la storia della sua famiglia, narrata con commossa partecipazione, Antonia Arslan ha fatto rivivere i desideri, le speranze, la cultura di un intero popolo e ne ha raccontato il terribile sconvolgimento nell’orrore di uno sterminio voluto e pianificato. L’amicizia, la riconoscenza, la familiarità vengono travolti improvvisamente da un gelido vento di odio: perché là, in alto, era stato deciso così. Le due brevi scene tratte dal film dei fratelli Taviani ci trasportano proprio nel cuore di questa tragedia: sono la scena in cui gli emissari governativi rendono note le superiori disposizioni al Colonnello Hikmet, il comandante del- 12 La tragedia degli Armeni. Dal genocidio alla rinascita la guarnigione cittadina che pure intesse cordiali rapporti con Sempad Arslanian; e quella finale in cui, davanti alla corte marziale allestita alla fine della guerra mondiale, scorgiamo l’inizio di quell’atteggiamento negazionista che ancora oggi perdura, dopo novantacinque anni dal genocidio del popolo armeno. Una scena tratta da La masseria delle allodole dei fratelli Taviani 13 La tragedia degli Armeni Dal genocidio alla rinascita Sono felice di essere tornata a Portogruaro che - curiosamente ne parlavo prima con il professore - è una delle città che ho sempre amato molto. Sono felice di essere qui con voi e sono felice della lettura di quella pagina di Primo Levi in cui si parla di un bambino: un bambino che ha come unico orizzonte la visione del campo di concentramento, che non ha mai visto un albero... Ci sono tante affinità tra le tante storie dei bambini ebrei come questa e le tragiche storie dei bambini armeni. Che cos’è un genocidio? Perché, vedete, un genocidio è un progetto di distruzione totale. Un progetto senza limiti. Non si tratta di uccidere... un po’ di gente; non si tratta neppure di un massacro, che è già una cosa orribile: è molto, molto peggio... Un genocidio, secondo la definizione di Raphael Lemkin1 del 1944, è un progetto di eliminazione totale, per motivi etnici, religiosi o politici, di una intera minoranza. Detto così, è già agghiacciante. Un giorno, come è capitato a me - che sono armena di origine, ma di madre italiana e nata e vissuta in Italia -, si 1 Cfr. pag. 31 e segg. 15 Piccole conferenze per grandi incontri incomincia a sentire nel cuore e nella mente - quasi come una forma di ossessione - il pensiero di quello che era avvenuto nei deserti della Mesopotamia nel 1915. Ecco che l’orrore non sta più fuori, è dentro di te. Quali sono state, allora, le prime immagini che mi sono venute in mente? Sono state proprio le immagini dei bambini: dei bambini armeni che morivano lungo le strade della deportazione..., delle loro madri costrette ad abbandonarli lungo il cammino... Bambini durante la deportazione Bambini come quei due fratelli che stavano morendo di fame nella lunga marcia sotto il sole del deserto... Il più grande, disperato, ha abbandonato il piccolo di due anni seduto su un muretto, e va avanti seguendo il gruppo, obbligato alla marcia lungo le lande desolate dell’Anatolia interna, in quell’estate terribile del 1915. Il fratellino, mentre il maggiore si sta allontanando, gli grida dietro “Michael, Michael...”. Poi l’angoscia si impadronisce di Michael: dopo due ore, accompagnato da un amico, torna indietro (la carovana si era fermata). Ma non c’è più nessuno seduto ad aspettarlo: Michael non trova più il fratellino. Chi l’aveva portato via? Chi si era impadronito di quella creatura? Cosa poteva essere successo? Michael non lo saprà mai. 16 E dopo tanti anni, sopravvissuto e divenuto medico in Francia, scriverà un libro straziante che si intitola proprio così Il m’appelait Michael, Michael, Mi chiamava Michael, Michael. Non ne ha saputo più niente. Non è una storia a lieto fine: è una testimonianza. Una storia di famiglia Così io per la mia famiglia. Continuamente pensavo a questi quattro bambini sopravvissuti che erano tutto quanto restava della famiglia di mio nonno. Mio nonno era già in Italia nel 1915. Era venuto a tredici anni, a studiare al collegio armeno di Venezia. La sua storia è bellissima... A diciotto anni cominciò a frequentare la facoltà di medicina a Padova (all’epoca la scuola superiore durava un anno in meno rispetto ad ora). Non aveva un soldo: studiò di notte lavorando di giorno come infermiere; e alla fine, quando si laureò, una famiglia di Padova - io l’ho scoperto solo recentemente - gli fece un grande prestito sull’onore perché confidava in lui, era fiduciosa che lui le avrebbe fatto onore. Grazie a tale prestito mio nonno andò a Parigi, e si fece durare per quattro anni i soldi che questa famiglia gli aveva dato. Fece una specializzazione in medicina - allora Parigi era il centro della medicina mondiale -, tornò in Italia e divenne un grande chirurgo. E rimase a Padova: restituì i soldi alla generosa famiglia che aveva confidato in lui e anzi, non appena cominciò a guadagnare - l’ho scoperto recentemente, e ho avuto modo di vederla - fece riconoscente omaggio a questa famiglia di una medaglia d’oro. Mio nonno era dunque in Italia. Tutta la sua famiglia era però ancora nella Piccola Città, nella Piccola Città dell’Ana- 17 Piccole conferenze per grandi incontri tolia che è quella dove si svolge il film, e dove è ambientato il mio libro. In questa Piccola Città il fratello di mio nonno, che si chiamava Sempad, era un mite farmacista. Non credeva alle minacce che si cominciavano a sentire, pensava che non sarebbe successo niente... E pertanto si guardò bene dal fuggire, dall’andarsene, rimase lì: e come lui tutti gli armeni della Piccola città vennero travolti dalla tragedia, da ciò che abbiamo capito guardando la scena del film dove si assiste al colloquio tra il colonnello e gli emissari del governo turco giunti dalla capitale. Ora: questi unici quattro bambini sopravvissuti - come vedete da tutto il libro, che non vi sto naturalmente a raccontare - erano proprio bambini, ragazzini. C’erano tre bambine, una di undici anni, una di dieci, una di due o forse tre, e un maschietto vestito da bambina, che proprio per questo si salvò! Caratteristica del genocidio degli Armeni è infatti il differente destino degli uomini e delle donne: gli uomini vengono uccisi subito; le donne, avviate in deportazione, vengono uccise più lentamente, facendo loro mancare il cibo, rifiutando loro ogni soccorso, lasciandole morire bruciate dal sole lungo le strade polverose e roventi dell’Anatolia. Raccontare per far conoscere Ecco, vedete, io non sono una storica: io sono una cantastorie innamorata delle sue storie... Sono una che racconta: e per raggiungere la gente non si può raccontare se non attraverso dei caratteri, dei personaggi... E io vedevo, tra i miei personaggi, prima di tutto Sempad e sua moglie, la bella Shushanig. (“Shushanig” è molto facile da capire come nome, poichè in realtà vuol dire “Piccola Susanna”, “Shushan” vale “Susanna”). Sempad e Shushanig erano due coniugi e avevano sei figli... Lei, quando Sempad viene decapitato, quando la testa 18 La tragedia degli Armeni. Dal genocidio alla rinascita le viene scagliata addosso, in cuor suo muore a sua volta. Infatti si lascerà andare: e morirà davvero all’inizio del secondo mio libro, La strada di Smirne. Ma i bambini? Ecco: i bambini, incolpevoli, che vivono l’età del gioco, vengono letteralmente travolti da questa immane tragedia... Molto ho riflettuto sulle figure di questi bambini, molto ho pensato. Alcune cose le sapevo, altre man mano sono venute fuori, anche da racconti e lettere familiari. Il bambino più piccolo, che aveva due anni, e che si salvò perchè gli avevano messo addosso, per gioco, dei vestiti femminili, divenne un adulto estremamente simpatico, che io adoravo quando ero bambina: lo zio Nubar. Viveva a Genova, era un chirurgo (come tutti in famiglia... tranne me!). Si era poi sposato con un’armena... Quando veniva da noi a Padova era sempre allegro: lui, essendo così piccolo, non era stato toccato dalla tragedia quanto lo erano state le sue tre sorelle. Bambini durante la deportazione 19 Piccole conferenze per grandi incontri Allora pensate: proprio quest’anno, a marzo, sono stata in California, a Los Angeles. Sono stata molto contenta: la comunità armena di Los Angeles e l’Università della California mi hanno dato una grande medaglia per il lavoro che ho fatto per gli Armeni.. Ma in quell’occasione la cosa più bella è stata che ho conosciuto il destino delle due sorelline maggiori: una divenne sarta delle dive di Hollywood; l’altra si sposò, non più giovane, con un altro sopravvissuto, e coltivava verdure nella cittadina di Fresno... Nessuna delle due ebbe dei figli. All’epoca dei fatti terribili avevano undici e dieci anni. Provate a immedesimarvi in esse. Queste creature avevano attraversato una fame spaventosa, una fame che nasceva dalle viscere, una fame che non poteva essere vinta perchè non avevano niente; e il digiuno durava giorni: senza riposo, senza requie, senza sosta... In più, cosa che ho scoperto, sono state violentate! Ma i soldati, che pure le avevano così maltrattate, non le hanno uccise come spesso succedeva: forse per distrazione, o per puro caso... Comunque queste due creature, piagate nel corpo e nello spirito, dopo essere state salvate - e la fine della Masseria racconta proprio l’episodio romanzesco, ma veramente accaduto, di come i quattro bambini furono tratti in salvo nel doppio fondo di una carrozza - restarono per un anno intero in un sotterraneo di Aleppo. Non potevano uscire alla luce del sole, non potevano tornare in superficie: sarebbero state di nuovo deportate! Immaginate dunque: dopo aver sopportato la deportazione, essere costretti per un intero anno in una cantina, a rimuginare sui propri incubi, sui propri ricordi e sulle proprie terribili emozioni senza poter uscire, senza poter fuggire. Ecco: provate pensare a questi quattro bambini, provate a mettervi nella situazione delle due bambine più grandi..., o di Henriette... Certo, lei era la più piccola, ma era seduta sulle ginocchia della sua mamma quando la testa decapitata di Sempad, suo papà, le fu scagliata in grembo! 20 La tragedia degli Armeni. Dal genocidio alla rinascita Come scrivo nella prima parte del libro, poichè me l’ha raccontato proprio zia Henriette, che viveva con noi e a cui ho dedicato La Masseria delle Allodole, essa rimase sconvolta da questo terribile avvenimento: quasi annegata nel sangue del padre, perse per sempre la sua lingua madre. Zia Enrica non parlava nessuna lingua: non aveva più la sua lingua madre, quella lingua che noi succhiamo con il latte, che tutti parliamo, ma nessuno sa esattamente come la impariamo, che è la nostra lingua, quella in cui ci esprimiamo fin da quando siamo bambini. A lei questa lingua era stata tolta per sempre. Viveva con noi, zia Henriette, ed è rimasta una creatura dimezzata, una creatura che ogni più piccolo turbamento agitava in modo terribile, una persona che noi amavamo, ma che era rimasta infantile, bloccata nel terribile momento del massacro alla masseria. Ecco: i bambini sono effettivamente tra le vittime più terribilmente piagate da un genocidio. Ma anche gli adulti portano nel corpo e nell’anima il segno della violenza gratuita e incomprensibile. Shushanig non riesce a sopravvivere. E come lei molte altre donne, che magari erano state mandate in deportazione nonostante fossero incinte, costrette a partorire per la strada e il giorno dopo obbligate a riprendere il cammino verso un’altra tappa nel cammino della morte... O forzate a scegliere tra i diversi bambini quali portarsi appresso e quali lasciar andare... Di queste donne, piagate nel cuore e nel corpo, di queste “madri coraggio” che riuscirono però alla fine a salvare almeno una parte della nazione armena, di queste donne io sentivo la voce. La loro voce mi risuonava nelle orecchie; vedevo lungo le strade d’Anatolia le centinaia di migliaia di corpi, di cadaveri, che erano stati abbandonati..., gli esseri umani di cui restavano solo le ossa; vedevo le fosse comuni, che ogni tanto ancora oggi vengono alla luce qua e 21 Piccole conferenze per grandi incontri là in Anatolia, e che il governo di Turchia - che ancora nega l’orrore che è accaduto - cerca di occultare, nascondere, affermando per esempio che non si tratta di Armeni. La perfezione del genocidio: negare che sia avvenuto Pensate che due anni fa, presso una città nel centro dell’Anatolia, un contadino costruendo un fienile sfondò quella che sembrava una roccia e portò alla luce una sorta di grotta: era una cavità che ospitava le ossa di almeno un centinaio di persone. Questo contadino in un primo momento chiamò i suoi amici, poi l’informazione arrivò ai giornali, e grazie a quel tam-tam che per fortuna oggi c’è in internet, e che mette in comunicazione molti Armeni, ma anche professori, intellettuali, giornalisti turchi, presto la notizia si diffuse assieme alla relativa documentazione fotografica. Alcune di quelle ossa erano piccole e fragili, ossa di bambini; altre erano ossa inequivocabilmente femminili: voi sapete che oggi è possibile distinguere le ossa maschili da quelle femminili. Dopo dieci giorni - e la cosa uscì anche nei giornali turchi, che sono abbastanza liberi nell’informazione - arrivarono due emissari governativi per affermare che si trattava di resti di ossa di soldati romani. Come si possano far passare ossa di bambino per ossa di militari romani lo lascio alla vostra immaginazione: di fronte alla volontà di negare la verità non c’è buon senso che tenga! Chi sono gli Armeni? Ma dunque, anche per venire al tema della diversità, qual è l’identità degli Armeni, chi sono gli Armeni? Vi dirò solo poche cose. Gli Armeni sono un popolo indoeuropeo. Essi hanno una lingua speciale, una lingua con molte gutturali e con 22 La tragedia degli Armeni. Dal genocidio alla rinascita un proprio e particolare alfabeto. L’alfabeto armeno venne inventato nel V secolo dopo Cristo da un monaco che raccontava di aver sognato un angelo mentre disegnava l’alfabeto su un muro con lettere d’oro: in realtà è un alfabeto derivato in parte dal greco, ma che si usa ancora oggi ed è assolutamente originale. Il popolo armeno possedeva una sua identità e aveva una sua cultura. Una cultura, fra l’altro, antichissima, che si esprimeva prima di tutto in grandissime creazioni architettoniche. Il monastero di Sevanavank (IX sec.). Nell’attuale Armenia, che è quella che stava sotto i Russi e che non venne toccata dal genocidio - ma qualcuna ancora resiste nell’attuale Anatolia turca -, possiamo ammirare ad esempio le splendide chiese armene. Il critico d’arte Cesare Brandi, in un mitico articolo sul Corriere della Sera di più di quarant’anni fa, le chiamò “Le chiese di cristallo” 2 per la loro struttura essenziale, per la loro eleganza e per la capa2 CESARE BRANDI, Le chiese di cristallo, in: Corriere della sera, 5 luglio 1968. 23 Piccole conferenze per grandi incontri cità che hanno di resistere persino ai terremoti. Cancellare la cultura, eliminare un popolo Anche devastanti terremoti non sono riusciti ad abbattere queste chiese: soltanto la volontà degli uomini è riuscita là dove la violenza della natura non aveva provocato danni. In tutta l’Anatolia esistevano circa millecinquecento chiese armene, oltre a palazzi, edifici, case. Ma, parlando delle chiese, nel 1915 gli Armeni erano più di due milioni, e in ogni città, in ogni villaggio, in ogni paesino c’era una chiesa. Oggi, dopo novantacinque anni dai fatti del 1915, le chiese armene in Anatolia sono ridotte a non più di dieci. Sono diventate stalle, sono diventate cave di pietra, sono state rase al suolo: quello che nessun terremoto ha fatto, quello che nessun evento naturale ha prodotto, l’ha prodotto questa volontà di distruggere non solo l’esistenza fisica di un popolo, ma anche il suo retaggio e la sua testimonianza culturale. E quindi le chiese, gli edifici, le scuole... Gli Armeni erano un popolo estremamente accultura- Immagine del genocidio armeno tratta da Ambassador Morgenthau’s Story, scritto da Henry Morgenthau e pubblicato nel 1918. 24 La tragedia degli Armeni. Dal genocidio alla rinascita to. Non c’era una bambina armena, nel 1915, che non sapesse leggere e scrivere: l’Italia era molto meno avanzata a quell’epoca! Si riteneva infatti che tutte le bambine dovessero imparare a leggere e scrivere: non si sa mai cosa potrà succedere, la lettura e la scrittura possono mettere in condizione di difendersi almeno un poco, e di capire gli avvenimenti. Tutto è stato distrutto. Sono state distrutte la diversità culturale e intellettuale, la capacità che avevano gli Armeni in Anatolia di essere maestri in certi mestieri: per esempio in quello di orologiaio, o di fabbro, panettiere, agricoltore... I campi coltivati dagli Armeni, che in certe grandi distese erano chiamati golden plains, “pianure d’oro”, e che permettevano loro di esportare frutta secca, legno, cotone, seta, sono stati abbandonati per decenni e producono ancora oggi molto meno di quanto producessero nel 1915. Ma questa peculiarità, questa bravura, questa tipicità della cultura del popolo armeno erano oggetto di un odio profondo, erano l’oggetto della volontà di distruzione propagandata dal governo dei “Giovani Turchi”, che si concretizzava attraverso le idee dei loro tre capi, dei tre dittatori: Talaat Pasha3, ministro dell’interno, EnTalaat Pasha (Edirne, 1874 - Berlino, 15 marzo 1921) fu uno dei leader dei giovani Turchi insieme a Gemal Pasha e ad Enver Pasha e dal 1913 al 1918 ricoprì il ruolo di ministro dell’interno nell’impero ottomano. Fu uno dei principali sostenitori dell’entrata dell’Impero nella prima guerra mondiale al fianco della Germania nel corso della quale contribuì all’organizzazione del genocidio armeno, venendo perciò poi condannato dal tribunale del sultano alla fine del conflitto insieme agli altri due componenti dei “Tre Pascià”. Fu membro eminente della massoneria turca. Gli armeni lo definiscono l’ “Hitler turco”. La rivoluzione di Atatürk, sovvertendo l’ordine politico della Turchia, ne permise la liberazione, ma durante un viaggio a Berlino fu assassinato da Soghomon Tehlirian, un armeno sopravvissuto al genocidio e membro dell’Operazione Nemesis, il cui gesto è ricordato all’inizio del film di Verneuil, Quella strada chiamata Paradiso. 3 25 Piccole conferenze per grandi incontri ver Pasha, ministro della guerra, e Djemal Pasha, ministro della marina. Dei tre, sono stati i primi due i veri esecutori del genocidio. Talaat Pasha si vantò con l’ambasciatore Morgenthau - che era ebreo, ambasciatore degli Stati Uniti a Costantinopoli dla 1913 al 1916 - di aver fatto in tre mesi quello che i Talaat Pasha Enver Pasha Djemal Pasha 26 La tragedia degli Armeni. Dal genocidio alla rinascita sultani non erano riusciti a fare in cinque secoli: eliminare il popolo armeno4 . Antonia Arslan Portogruaro, 9 ottobre 2010 L’episodio è raccontato nel Diario dell’Ambasciatore Morgenthau (Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano 2010). Le memorie di Morgenthau, ebreo americano nato in Germania, costituiscono un documento di fondamentale importanza sugli eventi tragici del primo grande genocidio del ventesimo secolo. L’ambasciatore americano decise di essere testimone partecipe e non spettatore passivo di fronte a ciò che il governo ottomano definiva come “soluzione del problema armeno”. Morgenthau ricopriva un ruolo istituzionale che gli offriva un punto di osservazione privilegiato per osservare gli eventi e i comportamenti dei potenti di Turchia e degli esponenti della diplomazia internazionale, e che gli consentì anche di intervenire per tentare di salvare gli armeni dall’estinzione totale. Nel suo diario descrive in modo preciso e vivido i personaggi che incontra, le strategie politiche turche, la situazione internazionale sconvolta dal Primo conflitto mondiale e fornisce anche chiavi interpretative acute sulle conseguenze e le ragioni dello sterminio di poco meno di due milioni di armeni turchi. Il testo di Morgenthau costituisce un affresco appassionante della vita nella Costantinopoli di inizio secolo, una cronaca minuziosa degli ultimi terribili anni dell’impero ottomano, una testimonianza preziosa di un protagonista della storia e dei suoi coraggiosi tentativi di fermare la “strage della nazione armena”. Pubblicato per la prima volta nel 1918 negli Stati Uniti, Ambassador Morgenthau’s Story riesce ancora oggi a commuovere e a far riflettere sulla mostruosa capacità umana di compiere le peggiori atrocità ritenendosi comunque nel giusto e sull’assurdità criminale delle ideologie che incitano alla pulizia etnica e alla supremazia razziale. 4 27 DOMANDE Domande Pietro Anche dalla lettura del suo libro, la tragica realtà del genocidio ebreo e quella del genocidio armeno mi sono parse molto simili. Qual è il suo parere al riguardo? Grazie mille! Ottima domanda. Anche perché mi permette di puntualizzare qualcosa cui prima ho appena accennato. Hai visto giusto: infatti il genocidio armeno è esattamente il modello di ciò che poi avverrà con gli ebrei. Sono i due grandi genocidi della prima metà del ventesimo secolo. Ve l’avranno sicuramente già detto i vostri professori, ma in ogni caso ve lo ricordo: il termine, la parola “genocidio”, sembra una parola antica, ma in verità non lo è: fu coniata solo nel 1944 da un professore di legge, ebreo polacco, che si chiamava Raphael Lemkin. Lemkin ancora negli anni trenta, prima della Shoah, prima che il popolo ebreo fosse perseguitato, e prima ancora che Hitler salisse al potere, scrisse esattamente questo: “Io sono convinto che il modo in cui sono stati sterminati gli Armeni sia un orribile modello, e cercherò di fare di tutto, nella mia vita, perché non si ripeta”. L’opera di Lemkin in cui compare ufficialmente il termine “Genocidio”: Axis Rule in Occupied Europe, del 1944. Il termine risulta formato da due basi, una greca e l’altra latina, ed è stato formalmente accolto, grazie al patrocinio di Panama, di Cuba e dell’India, in una risoluzione del 1946 dall’Assemblea generale dell’ONU. 31 Piccole conferenze per grandi incontri Questo straordinario personaggio andò in giro negli anni trenta per tutta l’Europa cercando di parlare ai capi di stato e spiegare loro cosa fosse stato fatto nei confronti degli Armeni: uno sterminio freddamente programmato, pensato a tavolino, di un’intera minoranza. In Polonia, nel 1938-40, assieme alla sua famiglia, Lemkin1 fu poi a sua volta vittima della Shoah. Fuggì dapprima in Svezia, sopravvisse, raggiunse gli Stati Uniti e divenne professore di Legge alla famosa università di Yale. E inventò questo termine, che è costituito da una radice greca e da una latina, “ghenos” e “caedo”, “genocidio”: strage di un intero popolo. Egli l’ha inventata pensando agli Armeni e pensando agli Ebrei. Pensate che due anni fa ero negli Stati Uniti, e ho visto un bellissimo documentario intitolato The Armenian Genocide, Il genocidio degli Armeni, in cui erano riusciti a ritrovare una 1 Lemkin perse circa quarantanove dei suoi familiari più stretti nell’Olocausto: erano tra i più di tre milioni di ebrei polacchi sterminati durante l’occupazione nazista. Alcuni membri della sua famiglia morirono in aree polacche annesse dall’Unione Sovietica. Gli unici familiari europei di Lemkin che furono mandati in un campo di lavoro forzato sovietico e che sopravvissero furono il fratello, Elias, e sua moglie con i due figli. Dopo l’Olocausto, Lemkin promosse la promulgazione di leggi internazionali che definissero e proibissero il genocidio, e raggiunse il suo obiettivo nel 1951, quando, dopo essere stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, entrò in vigore la Convenzione sulla Prevenzione e la Punizione del Crimine di Genocidio. In essa si legge all’articolo II: “Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.” (cfr. RAPHAEL LEMKIN, in: Wikipedia) 32 Domande intervista che Lemkin aveva dato ancora agli albori della televisione, quando si era ancora al bianco e nero... Un’intervista impressionante: Lemkin ha consumato la vita per parlare di questi eventi e promuoverne la conoscenza; essa risale al 1953 o 54, e mostra molto chiaramente il suo pensiero sull’equivalenza e il parallelismo tra i due genocidi. Aggiungerò una cosa, che è importante e che si collega all’ambasciatore Henry Morgenthau, di cui ho citato in precedenza i diari. Morgenthau era ebreo, un ebreo di origine austriaca emigrato con la famiglia negli Stati Uniti all’inizio del ‘900. Divenne un uomo importante, e fu nominato ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Impero Ottomano nel 1913. In questa veste cercò in tutti i modi di salvare qualche vita armena. Un giorno Talaat Pasha gli disse: “Ma, Eccellenza, perché continuate a darvi da fare per gli Armeni? Sono ‘sotto uomini’! E poi, voi siete ebreo: cosa avete da spartire con questi cristiani?”. Morgenthau rispose: “Io mi interesso del fatto che sono esseri umani!”. Quando venne dichiarato persona non gradita e tornò negli Stati Uniti, Henry Morgenthau fondò assieme a degli amici la prima gigantesca operazione di soccorso umanitario del Novecento. Tra il 1917 e il 1925 raccolse più di venti milioni di dollari dell’epoca, per aiutare gli Armeni. E li porto in Oriente. L’associazione si chiamava Near East Relief, Soccorso per il Vicino Oriente. Fu essa che salvò il destino del popolo armeno, perché raccolse in tutte le campagne dell’Anatolia i bambini sopravvissuti, quelli che erano stati presi da famiglie turche, che erano stati convertiti a forza, o che semplicemente venivano usati come piccoli schiavi e servi in casa: li riscattò con danaro sonante, fondò numerosi orfanotrofi e riuscì a salvarli tutti. 33 Piccole conferenze per grandi incontri Bene: mi sono interessata personalmente degli scritti di Morgenthau, e finalmente il suo libro sarà pubblicato anche in traduzione italiana. La scuola potrà certamente acquistarne una copia non appena uscirà. Tra l’altro è un libro di piacevole lettura. Morgenthau scrive semplicemente quello che gli accade: sono le testimonianze dei suoi rapporti con i vertici del governo turco dell’epoca e del suo lavoro di progettazione e realizzazione di quest’operazione di soccorso. Henry Morgenthau, Ambasciatore americano a Costantinopoli tra il 1913 e il 1916. Fonte: Ambassador Motgenthau’s story in: http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/ morgenthau/MorgenTC.htm#TC Ma un’ultima cosa è importante ricordare. Nel 1939 Hitler, mentre programmava la “soluzione finale” - come lui la chiamava - del problema ebraico, disse ai suoi collaboratori questa frase che cito testualmente e che è stata registrata: “Noi - disse - possiamo fare quello che vogliamo. Chi si ricorda più, oggi, dello sterminio degli Armeni?” Ecco, vedete, questo ci porta direttamente proprio al discorso sulla memoria: uno che sta progettando un genocidio sa che l’opposizione maggiore, il maggiore indebolimento del suo sinistro progetto viene proprio dalla gente che ricorda 34 Domande Ferdinando Volevo chiederle: normalmente un essere umano tende a dimenticare le cose brutte. Perchè lei ha voluto scrivere di questa strage? Quanto le è costato intimamente? Mi è costato molto soprattutto cominciare. Perché non avevo voglia..., perché avevo paura... di immergermi in quelle storie. Ma poi ho capito che non era giusto dimenticare, non era giusto cancellare le voci flebili di questi che io ho chiamato “flauti di ossa”. Era come se da tutti i deserti d’Anatolia si levasse una voce che chiedeva di non essere dimenticata. E allora mi sono detta: - Io le so, queste storie! Noi fratelli siamo nati e abbiamo studiato in Italia, abbiamo avuto un’educazione totalmente italiana (io ad esempio ho insegnato per tanti anni letteratura italiana all’università), tuttavia quando ero bambina... c’erano i racconti: per esempio i racconti degli zii che venivano ogni tanto a trovarci dal Libano o dagli Stati Uniti... Le famiglie armene sono famiglie in diaspora, quindi io, come tutti gli Armeni, ho parenti dappertutto, in moltissimi Paesi; parenti più stretti o più lontani, ma disseminati in svariate nazioni. Ho sentito dunque che dovevo raccontare, che non sarei stata in pace con me stessa se non avessi raccontato. Ma siccome io non sono una storica, ho capito anche che dovevo raccontare, attraverso la storia della mia famiglia, la storia un po’ di tutti gli Armeni. E così ho fatto. Devo dire che cominciare è stato difficile: ho fatto fatica a mettermi, ho faticato a costringermi... Era molto più comodo rimanere tranquilla, come stavo. Invece poi, quando ho cominciato a scrivere, ho capito anche che quello che dovevo fare non era un racconto di 35 Piccole conferenze per grandi incontri odio ma un racconto di pietà, un racconto che facesse vedere come l’essere umano possieda abissi di male, ma anche pezzi di bene. Considerate, per esempio, la figura del colonnello (i fratelli Taviani l’hanno resa molto bene, hanno dimostrato di averne colto i tratti e capito bene la psicologia). Anche nel libro (naturalmente un film e un libro sono due realtà diverse, non vanno confuse l’una con l’altra) non appare certo come un personaggio tutto positivo, ma non è nemmeno del tutto negativo: spesso nell’essere umano ci sono sfumature di tutti i tipi. Com’è il colonnello? Certo è anche corrotto, si fa pagare...: ma non è fanatico. La cosa peggiore è il fanatismo, è quello che acceca! Allora io, che sono di terza generazione, non potevo raccontare con odio. Dovevo raccontare come può farlo una persona che è, appunto, di terza generazione. Io non le ho vissute sulla mia pelle queste cose: però il racconto di questi morti, che sono ancora irrequieti perché si continua a negare loro la dignità della morte, e la verità della loro morte, mi ha dato una grande pace. 36 Domande Ilaria Preparandoci a questo incontro abbiamo capito che gli Armeni, durante il genocidio, venivano trattati non come persone, ma come cose, o animali, e veniva loro negata ogni dignità. Ora, come accade nel film che abbiamo visto, Quella strada chiamata Paradiso, lei cosa risponderebbe alla domanda innocente di un bambino, “Che cos’è un Armeno?”. Beh, sono felice che abbiate visto Quella strada chiamata Paradiso, che è un film che io amo molto. Anche Verneuil, il regista, è un armeno. Si chiamava Achod Malakian, ma faceva film con questo pseudonimo francese di Henri Verneuil. Quando morì sua madre, ebbe come una forma di presa di coscienza - un po’ simile alla mia, se vogliamo, o la mia simile alla sua: egli era nato nel 1920, ed è morto nel 2002 - e raccontò la sua storia, la storia della sua infanzia. Che cos’è un armeno? Un armeno è un essere umano come tutti gli altri: questo è naturale! È diverso? Certo che è diverso! Non bisogna negare la diversità: bisogna comprenderla, andarci in fondo... E ciascuno ha l’obbligo, poi, di sapere che non è solo nel vasto mondo, che ci sono tante altre persone con cui deve convivere, e quindi certe nostre caratteristiche le dobbiamo a volte un po’ adattare... “Che cos’è un armeno?” nel film di Verneuil lo chiedono al protagonista i bambini della sua scuola, e lui non sa cosa rispondere: lui si sente uguale agli altri! Però sa anche che nella sua realtà c’è qualcosa di diverso, di peculiare; c’è una diversità, una caratteristica originale che va secondo me salvaguardata. In tutto il mondo, vedete, le comunità armene, che con- 37 Piccole conferenze per grandi incontri tano parecchi milioni di persone, sono benissimo integrate nei Paesi in cui vivono. Non parliamo tanto dell’Italia: in Italia gli Armeni sono pochissimi e sono molto integrati, ma non conta perché appunto sono poche migliaia! Se però pensiamo alla comunità armena di Francia - la Francia di Verneuil - essa conta seicentomila persone: esse conservano la loro lingua, conservano la loro cultura, il loro cibo... Sì, perché il cibo costituisce una delle grandi forme di identità culturale, ed è tra le più persistenti. A volte gli emigranti perdono tutto, perdono la lingua assieme a mille altre cose, ma difficilmente perdono traccia dei loro usi alimentari e culinari. Poi però in Francia, negli Stati Uniti, in Russia - dove ci sono comunità molto consistenti -, o a Los Angeles dove sono stata in marzo e dove gli Armeni, pensate, sono settecentomila, in questi Paesi c’è abbastanza gente da poter pensare anche all’organizzazione di scuole, scuole di lingua per chi lo richiede, istituzioni... Queste conunità armene conservano anche la loro identità religiosa, che è cristiana ma orientale. Non ortodossa: è un errore pensare che la religione degli Armeni sia quella cristiana ortodossa, cosa che a volte si trova scritta anche nei libri. La religione cristiana ortodossa è quella della Grecia, della Russia, ed è diversa. Gli Armeni sono a metà: la loro forma, la loro variante di cristianesimo si chiama “apostolica”, oppure “gregoriana”, da Gregorio Illuminatore, il santo che ha convertito gli Armeni nel 301. 38 Domande Sara Volevo chiederle: qual è la sua posizione nei confronti della proposta di accogliere la Turchia nell’Unione europea? Grazie: altra domanda “utile”. Ti ringrazio. La questione dell’Europa, vedete, è una questione molto delicata e importante. La Turchia attuale ha settantatre milioni di abitanti. Settantatre milioni di abitanti in rapida crescita. Se entrasse nell’Unione Europea, diventerebbe immediatamente la nazione più importante della Comunità! Infatti i numeri contano! I deputati del Parlamento europeo - voi sapete che il Parlamento europeo è altra cosa dalla Commissione di Bruxelles - si riuniscono per la metà delle sedute a Bruxelles e per l’altra metà a Strasburgo. Voi non ci crederete, perché io stessa non lo avevo realizzato finché non sono andata a presentare a Bruxelles il film dei fratelli Taviani, La Masseria delle allodole. Sono stata invitata tre volte al Parlamento europeo, e una in veste ufficiale: lì mi hanno spiegato che i parlamentari europei sono continuamente in movimento, fanno continuamente su e giù, quindici giorni a Bruxelles e quindici giorni a Strasburgo, ogni volta trasportando tutte le loro scartoffie via treno, con delle spese enormi! A me sembrava una cosa da matti... Però effettivamente così avviene! Invece la Commissione europea, che è quella che conta, che governa, sta sempre a Bruxelles. Ora: fare entrare un Paese di settantatre milioni di abitanti - e quando entrasse gli abitanti sarebbero già settantacinque -, significherebbe mettere in discussione tutti gli equilibri tra le Nazioni della Comunità: la Turchia avreb- 39 Piccole conferenze per grandi incontri be un peso enorme, sarebbe più determinante della stessa Germania. Avrebbe infatti il numero di deputati più alto di qualsiasi altro Paese, e gli altri Stati membri diminuirebbero in proporzione la loro rappresentanza, essendo il totale dei deputati prestabilito. Se la Turchia si alleasse con la Germania, poi, dove vivono cinque milioni di Turchi, immediatamente l’Europa diverrebbe una struttura a due velocità: quella di chi determina le scelte e governa, e quella di chi in sostanza rivestirebbe un ruolo di secondaria importanza. Non ci vuole molto a comprendere che far entrare un Paese di un paio di milioni di abitanti... , non so, un Paese come la Slovenia, per esempio, è una cosa diversa: si può fare relativamente a cuor leggero... Ma far entrare un Paese di settantacinque milioni di abitanti è una cosa terribilmente importante, e anche molto difficile! Questo processo è stato affrontato dalla Commissione europea, dai nostri governanti europei, con estrema leggerezza, purtroppo. Io stessa ho incontrato una deputata olandese che, incaricata dalla Commissione, si era recata in Turchia per verificarne personalmente la situazione e lo stato del progresso sociale. Lei era qui, al mio posto, e a me e al gruppo di persone insieme con me - eravamo seduti più o meno dove siete seduti voi - ha riferito senza alcun imbarazzo: “Siamo assolutamente a posto, con la Turchia. Io sono stata quindici giorni in Turchia e mi hanno trattata benissimo, sono stata nei migliori alberghi, il Paese è splendido”. Costei “era stata trattata benissimo”: era stata nei migliori alberghi di Istanbul e di Ankara... Ma non sapeva nulla - le hanno fatto delle domande -, non sapeva nulla della situazione dell’Est dell’Anatolia, delle città che un tempo erano armene, della zona curda... 40 Domande Non sapeva nulla! Era una signora che, semplicemente, si era fatta quindici giorni di vacanza! Non è così che si può affrontare il complesso rapporto di incontro e anche di scontro, di scambio con una Nazione grande, potente e importante come la Turchia. Prescindendo dal problema del riconoscimento del genocidio armeno, che è già stato richiesto dal Parlamento europeo cinque volte e che per il momento la Turchia nega di voler fare, ci sono molte altre questioni non risolte e che persone come questa deputata cercano di far finta che non esistano. Una è il problema di Cipro1. L’esercito turco occupa Cipro nord da trent’anni, e a Cipro nord, come è successo per quelle armene in Turchia, tutte le chiese medievali, bizantine, greche sono state spogliate e distrutte... Gli affreschi di queste chiese sono stati venduti sul mercato dell’arte, gli edifici trasformati in stalle o magazzini per gli attrezzi dei soldati. Poi vi è la questione dei diritti, della libertà di parola. All’interno della Turchia vige ancora l’Articolo 301 del codice penale (gli hanno cambiato il numero, ora: ma la sostanza non cambia) che prevede per chiunque dica cose che non piacciono al governo la possibilità di essere messo sotto accusa e condannato fino a dieci anni di reclusione. A dire il vero hanno ridotto un po’ gli anni di prigione: adesso sono quattro. 1 La Repubblica Turca di Cipro del Nord (in turco Küzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, in sigla KKTC), è una repubblica auto-proclamata nella zona settentrionale dell’isola di Cipro nel 1983, in seguito all’occupazione dall’esercito turco nel 1974. Solamente la Turchia riconosce questa entità statale, la cui dichiarazione di indipendenza è stata dichiarata “non valida dal punto di vista giuridico” dalle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Una parte della dottrina giuridica descrive la RTCN come un esempio di “stato fantoccio”, definizione ribadita di fatto da una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 18 dicembre 1996. (Cfr. Repubblica Turca di Cipro del Nord, in: Wikipedia). 41 Piccole conferenze per grandi incontri Tu puoi andare in prigione per quattro anni semplicemente se dici che c’è stato un genocidio armeno, oppure che gli Armeni sono esistiti, come ha fatto il premio Nobel Orhan Pamuk2, che appunto affermò proprio questo: “Tutti sappiamo, in Turchia, ma nessuno lo dice perché ci viene proibito, che nel 1915 sono morti più di un milione di Armeni” . Ci sono poi tante altre questioni, che purtroppo vengono trattate da parte europea con leggerezza. E questo offende da un lato la stessa Turchia, e dall’altro non porta a risolvere i problemi. Io credo che sia una questione vasta e difficile, e non so se sia opportuno l’ingresso di questa grande Nazione nell’Unione europea. Una partnership - come si dice - economica, certo... Ma un ingresso tout-court è una cosa delicata e controversa. 2 Nato nel 1952 in una famiglia borghese benestante di alterne fortune - il padre fu il primo dirigente della sezione turca dell’Ibm - Pamuk viene educato al liceo americano Robert College di Istanbul. Sotto pressioni della famiglia, si iscrive alla facoltà di architettura del Politecnico di Istanbul, per poi abbandonarla dopo tre anni per dedicarsi alla letteratura. Si laurea in giornalismo all’Università di Istanbul nel 1977. Nel 1982 sposa Aylin Turegen, dalla quale divorzierà nel 2001 dopo la nascita dell’unica figlia, Ruya. È «studioso ospite» alla Columbia University di New York dal 1985 al 1988. Dopo la breve parentesi americana, torna definitivamente a Istanbul, dove rifiuta il titolo di «artista di Stato» del governo turco. Nel 2005 viene incriminato per alcune dichiarazioni sul genocidio degli armeni. Le accuse vennero però ritirate nel gennaio dell’anno successivo. In patria, così come all’estero, Pamuk ha riscosso un ottimo successo, ma è osteggiato da una parte dell’opinione pubblica del suo Paese. Un sottoprefetto di Isparta ha addirittura ordinato la distruzione dei suoi romanzi nelle librerie e nelle biblioteche, mentre una tv locale ha proposto di ritrovare una studentessa che aveva ammesso di possederne uno. (Fonte: Corriere della sera, 12 ottobre 2006) 42 Domande Lucia Quali emozioni ha provato scrivendo questo libro, che riguarda la sua famiglia? Cara Lucia: emozioni fortissime! Era come se fossero lì insieme con me. Pensate: la Masseria delle allodole l'ho cominciata a scrivere dalla prima riga della prima pagina avendo davanti agli occhi i miei zii, le mie zie, i miei cugini lontani; e ho cominciato proprio con lo zio Sempad. Come chiunque vede prendendo in mano il libro, avrete notato anche voi che esso non è diviso in capitoli, ma si presenta in due parti che prendono il titolo da due “personaggi” fondamentali: la prima parte si chiama Lo zio Sempad, la seconda Shushanig (come vi ho già detto, “Shushanig” vuol dire "piccola Susanna, Susannina"). Queste due parti sono dedicate dunque alle due figure principali. E io le sentivo vicine a me, e mi sembrava quasi che mi sussurrassero all'orecchio la loro vera storia e la loro fine. Le sentivo così: vicinissime e intente a suggerirmi non certamente le parole, ma i fatti da ricordare e raccontare. La stessa cosa ho provato con la bella Azniv, la ragazza che si sacrifica affinché i bambini possano salvarsi; Azniv che nell'ultima pagina del libro io saluto mentre, giovane e bella, lascia la vita. Nel film c'è anche la canzone, la canzone che abbiamo ritrovata e che Azniv canta, Ov Sirun Sirun. Io l'ho messa nel libro, era un ricordo d'infanzia: ma non ne conoscevo affatto la musica. Quando i Taviani hanno cominciato a preparare la trasposizione cinematografica, abbiamo cercato e abbiamo trovato la musica della canzone. La si sente nel corso di tutto il film, ed è cantata dalla voce bellissima di una giovane armena che non fa la cantante di professione ma lavora presso l'ambasciata armena di Roma, e che si chiama Valentina Karakhanian. 43 Piccole conferenze per grandi incontri Alessia Perché, secondo lei, ci sono persone che si ostinano a negare la realtà storica? Guarda: il negazionismo è una brutta bestia! Vi sono persino negazionisti della Shoah. Con tutto ciò che esiste, e che tutti conoscono, a testimonianza dell’Olocausto degli Ebrei, ci sono ancora persone che negano che essi siano stati uccisi, durante la seconda guerra mondiale. Questi sono singoli individui che vengono stigmatizzati e, per fortuna, non hanno molto seguito. Ma immaginati cosa vuol dire, per un popolo come quello armeno, avere di fronte uno Stato sovrano che con tutte le sue forze porta avanti una negazione completa, una negazione cieca, ostinata, totale! I professori di storia, in Turchia, non possono scegliere da sé il libro di testo sul quale fare studiare i propri allievi: sono vincolati a utilizzare un testo di storia che viene mandato dallo Stato in ogni scuola all’inizio di ciascun anno scolastico. Essi devono attenersi a questo libro di storia pena il licenziamento. Ottanta professori di liceo, in Turchia, sono stati licenziati: e non per il fatto di aver riconosciuto il genocidio, ma semplicemente per aver proposto di ricordare che queste minoranze armene nel 1915 esistevano, o per aver sottolineato come il Paese, all’epoca, fosse molto più ricco. Ed era proprio la diversità che creava anche una proficua tensione culturale e proficui, reciproci scambi. Nel 1915 in Turchia un quarto della popolazione era cristiana, sommando gli Armeni, gli Assiri o Siriaci e i Greci: tali popoli convivevano da secoli all’interno dell’impero ottomano. Oggi sono totalmente eliminati. 44 Domande Martina Una domanda un po’ personale: ha mai provato un sentimento di vendetta nei confronti dei Turchi? No, vendetta no. Semmai un sentimento di depressione, di delusione... per questa ostinazione cieca nel continuare a negare. Sapete, quando ci si scontra con questo, è dura: perché tu hai centomila argomenti ma l’altro non ascolta, chiude le orecchie, e ti trovi in una situazione di impotenza. Ti vengono a dire le cose più assurde... Io cerco di essere sempre molto paziente, ma naturalmente non cieca, non stupida!Ti trovi anche di fronte a dei discorsi più che assurdi...Ti dicono che era tempo di guerra, che c’erano alcuni Armeni che tenevano per la Russia e che la Russia era in guerra con l’Impero... Ma che cosa vuol dire che era tempo di guerra? Allora tu rispondi: e tutte quelle centinaia e migliaia di donne e bambini che sono stati annegati nel’Eufrate? Ci sono racconti di tutti i tipi: ma non racconti di Armeni, sapete, racconti di testimoni! Tanti tedeschi, che proprio nel 1915 lavoravano nella famosa ferrovia transanatolica, hanno lasciato decine e decine di testimonianze, lettere, racconti, proteste... Essi vedevano quello che succedeva. E molti di questi operai della ferrovia salvarono degli Armeni fingendo che fossero loro parenti tedeschi e nascondendoli nelle baracche. Ciò che fa male è che, nonostante la sovrabbondante quantità di testimonianze e il fatto che il novantotto per cento degli storici oggi lo dia per tranquillamente assodato, ancora il governo di Turchia si dia da fare - e paghi addirittura - per far circolare l’idea che tale genocidio non sia mai avvenuto. Spendono milioni di dollari per negare comunque e dovunque la realtà storica: milioni di dollari che potrebbero utilmente essere utilizzati per aiutare le povere 45 Piccole conferenze per grandi incontri popolazioni dell’est anatolico, le popolazioni curde, o i Turchi stessi che abitano nelle zone più desolate e povere della nazione. Invece queste enormi quantità di danaro vengono impiegate per condurre un’operazione di negazione contro ogni evidenza. Per fortuna la verità si sta facendo strada. Quello che io sogno cos’é? Che crescano di numero, che si moltiplichino, gli intellettuali turchi che due anni fa, nel dicembre del 2008, hanno lanciato un appello che hanno chiamato “l’appello di scuse”. Sono intellettuali, professori universitari. giornalisti, scrittori ma anche persone normali che dicono “Noi chiediamo scusa ai fratelli armeni che hanno subito tanti orrori nel 1915, e vogliamo continuare a vivere assieme a loro...”. C’è infatti ancora una piccola minoranza armena in Turchia: sono circa settantamila persone. Erano due milioni, sono settantamila: una minoranza esigua, ma c’è. Questo appello è un passo molto importante, e io spero che ne seguano altri. 46 Domande Simone Come mai ha scelto di raccontare una cosa così tragica attraverso una storia d’amore? La storia d’amore c’era già! Era la storia, curiosa, e che apparteneva alla mia famiglia, di questa bellissima ragazza armena, sorella di mio nonno, che aveva fatto innamorare di sé un ufficiale turco. A me è parso subito che questa storia rappresentasse tuttavia una parte della vita. Perché, vedete, erano tante le storie che si incrociavano: la storia della ragazza e del suo innamorato turco; la storia d’amore di Sempad e Shushanig, due sposi che dopo diciotto anni di matrimonio si vogliono ancora molto bene, legati così profondamente che quando lui viene ucciso anche lei muore nel suo cuore... Ora dovete sapere che questa storia dell’amore di Sempad e Shushanig, del loro legame così profondo che la morte non è riuscita a spezzare, a me è stata raccontata - me lo ricorderò sempre - da una zia che veniva dall’Etiopia, e che poi emigrò negli Stati Uniti. Lei mi disse: “Forse non te l’hanno raccontata, ma all’epoca della catastrofe è successa una cosa molto bella”. Ed era questa storia d’amore tra Sempad e Shushanig. Io l’ho appresa come un bambino impara le storie che gli raccontano, avevo dieci anni. Mi è piaciuta molto! E ho voluto metterla nel libro, anche perchè alla fine l’amore vince sempre sulla morte: era una storia che mi veniva giusta per il racconto che avevo intenzione di scrivere. Fra l’altro Shushanig, immagino che non abbiate letto La strada di Smirne, muore proprio all’inizio di questo secondo romanzo. E credo che siano pagine che mi sono venute particolarmente bene... Lei muore appena si imbarca sulla nave che la porta verso la salvezza, verso l’Italia di mio nonno, che l’aspetta assieme ai suoi quattro bambini. Imbarcata sulla nave lei sen- 47 Piccole conferenze per grandi incontri te che la sua missione è giunta al termine, non ha più voglia di restare qua e si lascia andare. E Nubar, il piccolo Nubar che nella Masseria, col suo grappolo d’uva, aveva trovato il nonno morto, qui con un altro grappolo d’uva trova morta la sua mamma. Shushanig verrà poi sepolta dal capitano della nave e dai suoi marinai sul lembo orientale dell’isola di Creta, tra le palme. La mia fantasia era particolarmente affascinata da questa immagine, da queste che sono le uniche palme in tutta la Grecia: ho voluto immaginare che per l’eternità queste palme avrebbero oscillato sulla tomba di Shushanig. Questa è la fine di Shushanig, una fine d’amore: e io credo che l’amore, alla fine, in tutte le sue forme, vinca sulla morte. 48 Per concludere... Da parte di tutti, per le parole con cui ci ha saputo affascinare, un sentito ringraziamento ad Antonia Arslan. Ma a commento di questo ringrazimemto, e a testimonianza che mente e cuore sono vicini a lei e a questo suo popolo il quale, dopo aver tanto patito, deve combattere contro le voci che pretendono di negarne le indicibili sofferenze, vorrei leggere qualche riga di un altro Levi, il francese Bernard-Henri Lévy questa volta, tratta da un intervento riportato nel Corriere della sera del 29 gennaio 2007 1. Lévy afferma con estrema lucidità che: “[...] il crimine perfetto è un crimine senza tracce e la cancellazione della traccia, è parte integrante del crimine stesso [...]. Il negazionismo non è il seguito ma un momento del genocidio, gli è consustanziale [...] E ciò vale per tutti i genocidi, e quindi, naturalmente, anche per quello del popolo armeno. Si crede che i negazionisti esprimano un’opinione: essi perpetuano il crimine. E pretendendo d’essere liberi pensatori, apostoli del dubbio e del sospetto, completano l’opera di morte”. Tutto questo con l’augurio che cessi, nei confronti di qualunque essere umano, la perpetuazione di quell’odio che nel corso del ventesimo secolo ha già mietuto milioni di vittime innocenti e che non trova giustificazioni, nè emotive nè razionali. Grazie. 1 Il testo integrale di Bernard-Henri Lévy è a pagina 93. 49 ...voglio dirvi io una cosa per concludere: e cioè che vi ringrazio. La masseria è uscita nel 2004, sei anni fa, e in questi sei anni io ne ho girate tante di scuole. Questa, devo dire, per attenzione, per partecipazione e... emotività è stata veramente una delle mie più belle esperienze. Quindi: grazie a voi! Antonia Arslan 51 MATERIALI di approfondimento testi scelti e proposti da Daniele Dazzan Lucrezia De Vecchi Maria Grazia Gelsomini L’inizio del “Grande Male” di Antonia Arslan La Masseria delle allodole è la saga degli Arslanian, di due fratelli che con le loro scelte differenti hanno forgiato per i loro figli due destini tragicamente opposti, di vita e di morte. Il fratello maggiore, Yerwant, lascia l’Armenia da ragazzo, studiando a Venezia e diventando medico di successo a Padova, dove sposa una nobildonna e ne ha due figli. Il fratello meno avventuroso e più legato alle tradizioni familiari, Sempad, rimane nel villaggio natale in Anatolia, dove riveste uno status preminente, facendo della sua farmacia una finestra sulle novità occidentali. La sua numerosa famiglia incarna i valori e la cultura del popolo armeno, come l’ospitalità festosa, l’intraprendenza mercantile, la religiosità tollerante. Dopo molti anni di lontananza, nel 1915 i due fratelli combinano una rimpatriata: Yerwant con la famiglia si accinge a tornare in Anatolia con due automobili, carico di doni e di nostalgia. Sempad arreda prestigiosamente la “masseria delle allodole”, la villa in campagna, preparando un’accoglienza memorabile. Ma lo scoppio della guerra spezza all’improvviso ogni progetto e consegna l’intero popolo armeno allo sterminio: i turchi, alleati dei tedeschi, attuano il mostruoso piano di eliminazione delle minoranze etniche. Massacrati tutti i maschi, compresi i bambini, le donne armene, fra cui la moglie e le figlie di Sempad, saranno deportate e trasferite ad Aleppo in un esodo atroce e spietato, destinate a un’inesorabile “soluzione finale”. Grazie all’avventuroso intervento di amici fedeli, per le figlie di Sempad si apre in extremis una via di fuga e il romanzo si conclude, in un salto temporale, con la voce della narratrice: “nessuno, caro lettore, è più tornato nella piccola città”. Le pagine che seguono descrivono il massacro alla masseria. 55 Piccole conferenze per grandi incontri In quel preciso momento il drappello di cavalieri si arresta davanti alla Masseria. Il cancello è aperto. Per un attimo luci, suoni, colori li bloccano, e un disagio imprevisto li prende. «Domani, domani» bofonchia uno dei due soldati che hanno denunciato il passaggio delle carrozze, e si strofina le mani sui pantaloni, incerto e intimidito. Ma l’ufficiale sceglie un opportuno furore: «Fanno festa, i cani, sulle nostre sconfitte» esclama. «Aspettano i russi...». E poi, ecco, nel crepuscolo che si sta infittendo, compare la stella della sera. E allora, mentre il profumo delle rose rosse e dei gelsomini rampicanti si diffonde nell’aria con inebriante malinconia, si sente Hrant che accorda il duduk1 sul piccolo palco per i suonatori, sotto i tre grandi platani al bordo del prato, e prova una nota lunga, prolungata, tenerissima. Ma la nota si spegne con un sordo singhiozzo. Silenziosi, gli uomini si sono sparpagliati all’interno, nel giardino: e un coltello ben maneggiato ha tagliato la gola di Hrant da un orecchio all’altro. Levon Yakovlian, l’ispettore-postino, che sta preparando la sua macchina per una foto-ricordo, a giusta distanza dalla tavola, fa la stessa fine, e si accascia senza una parola, con i miti occhi rovesciati, bianchi sull’erba che si inzuppa pian piano di sangue. Come avviene una strage? Quale liquore diventa il sangue, come sale alla testa? Come si diventa assetati di sangue? Chi lo gusta, si dice, non lo dimentica. In pochi istanti, il gruppo si è trasformato in una banda da preda, e con feliIl duduk è uno strumento musicale tradizionale armeno, noto anche come dziranapogh (letteralmente:“flauto albicocca”). Appartiene alla famiglia dei legni. In seguito alla diaspora armena, lo strumento si è diffuso in gran parte dell’Europa orientale e del Medio Oriente (per esempio Turchia, Iran, Georgia, Azerbaijan, Russia, Ucraina, Serbia e Bulgaria). Il nome corrente duduk è una deformazione di dudka, che indica uno strumento simile appartenente alla tradizione russa. Nel 2005 la musica duduk è stata inserita dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità. 1 56 Materiali na scioltezza si è avvicinato a tutte le porte: la porta grande di ingresso, quella della cucina sul retro, le due porte-finestre del salotto, col bovindo e i nuovi vetri a piombo inglesi. La casa si offre all’ospite, senza difese, innocente come Sempad, il suo padrone. La ricostruzione della Masseria delle allodole nel film dei fratelli Taviani Sempad e Shushanig sono ancora in cucina. Lei è seduta, lui in piedi dietro di lei. In quel momento, tutti si accorgono di tutto: i soldati con le lame scintillanti compaiono su tutte le porte come demoni troppo reali; il tenente dietro di loro entra in casa, attraversa il salotto, si fa sulla porta della cucina, guarda in giro con un odio così netto che tutti lo sentono come uno schiaffo, e ordina: «Voi traditori, cani, rinnegati. Avete disubbidito all’ordine del kaymakam, ma io vi ho trovato, e ora sarete puniti». Sempad lo guarda, e non capisce; Shushanig capisce morte, e strage. Tenta di alzarsi, per fare un gesto di ospitalità che disarmi l’ufficiale; non sa ancora che Hrant e il fotografo sono già morti, fuori. 57 Piccole conferenze per grandi incontri Ma Ismail l’ufficiale non la guarda neppure. Secco, riprende, rivolto ai suoi: «Prendete tutti i maschi, e portateli nell’altra stanza». Come pesci nella rete, incapaci di uscirne, Sempad e l’attonito Krikor (che grida invano: «Sono medico, e il dottore qui è farmacista: non potete toccarci...») vengono spinti in salotto, con i gemelli carpentieri, Isacco il prete greco e tutti gli altri. Suren, che era al piano superiore, malinconico, a contemplare il tramonto, sente il baccano e scende, composto, silenzioso. Si mette al fianco del padre e attende. Anche gli altri bambini maschi, Leslie, Garo, James figlio di Vartan il sagrestano, Rupen il fi glio del giardiniere, vengono condotti nel salotto, allineati in piedi sotto la festosa decorazione della tappezzeria a motivi floreali appena completata. Le donne, e le bambine, vengono spinte brutalmente a ridosso della parete di fronte. Shushanig è immobile, e guarda i suoi cari. I suoi occhi dilatati non esprimono niente, le mani sono sprofondate nelle tasche e tengono stretto il piccolo tesoro. Veron e Azniv le stanno a fi anco, stringendo forte le bambine e appoggiandosi a lei in un gruppo apparentemente composto. Niente gesti eccessivi, o lamenti: si direbbe che le donne cercano di scomparire nella tappezzeria. Solo Nevart, accasciata in un angolo, sola, si lamenta sommessamente; e stringe Nubar, vezzoso nella sua vestina rosa. E così si compì il destino di Sempad e dei suoi. Lame balenarono, urla si alzarono, sangue scoppiò dappertutto, un fiore rosso sulla gonna di Shushanig: è la testa del marito, decapitata, che le viene lanciata in grembo. Nella sua gonna, sotto il grembiule da cucina a crocette con motivi pasquali di cui Shushanig è assurdamente orgogliosa, si nasconde Henriette, che solo da qualche mese ha cominciato a parlare veramente, e chiacchiera sempre, raccontandosi storie e nascondendosi dappertutto, come un topolino canoro. Ora un getto di sangue caldo schizzato 58 Materiali fuori dalla testa del padre la bagna tutta, attraverso il grembiule, inondando la calda oscurità del rifugio materno. Un odore fortissimo cancella tutti gli altri, la bocca aperta della piccola si riempie di liquido, più caldo della mamma, come un fiume orrendo che circonda nero il suo piccolo cuore, e lo travolge. Henriette non parlerà mai più la sua lingua materna, e in ogni altra lingua, come in ogni paese del mondo, si sentirà per sempre straniera: qualcuno che ruba il pane, fuori posto dovunque, senza famiglia, invidiando i figli degli altri. Arrotolata su se stessa nel buio, piangerà ogni notte, ogni notte, sopravvivendo: finché si rifugerà in una quieta ebetudine, tronco vivente che attende passivo il ritorno della patria perduta, con la luce di Dio e lo sguardo innocente del padre. Antonia Arslan, La masseria delle allodole, Rizzoli, Milano 2004. 59 La liquidazione di Franz Werfel Monumentale romanzo dello scrittore austriaco di Praga Franz Werfel (1890-1945), pubblicato nel 1933, I quaranta giorni del Mussa Dagh fu abbozzato nel 1929 a Damasco, dopo la pietosa visione di fanciulli profughi armeni che lavoravano in una fabbrica di tappeti, e composto nel 1932-33. Canta epicamente il tragico destino del popolo armeno, minoranza etnica odiata e perseguitata per la sua antichissima civiltà cristiana, intelligente, industre e non bellicosa, in eterno contrasto con la razza guerriera dei Turchi, col grande Impero ottomano detentore del potere. Enver Pascià, ministro turco della Guerra, e Talaat Bey, ministro dell’interno, precursori del razzismo durante il primo conflitto mondiale, decisero di approfittare della guerra per sopprimere definitivamente la questione armena, condannando alla deportazione - ossia al «nulla» - tutta la popolazione. Affiora sotto la questione armena la questione ebraica, di cui lo spirito profetico di Werfel (d’origine ebrea) presenta i futuri tragici sviluppi. In un mirabile capitolo del libro intitolato Intermezzo degli dèi, che rispecchia il gioco degli interessi politici nazionali e internazionali nel conflitto delle razze, delle civiltà e delle religioni (scelto dall’autore per una conferenza da lui tenuta in una città tedesca nel novembre 1932), il pastore tedesco Giovanni Lepsius afferma nello storico colloquio con Enver Pasha: «Se il governo del mio popolo procedesse contro i suoi conterranei di altra razza o di altra opinione in modo ingiusto, illegale, inumano, io mi staccherei all’istante dalla Germania e me ne andrei in America!» L’epopea prende lo spunto dallo storico episodio annunciato alla stampa europea da un comunicato ufficiale francese del 22 settembre 1915: «Perseguitati dai Turchi, circa cinquemila Armeni, fra cui quasi tremila donne, fanciulli e vecchi, si erano rifugiati verso la fine di luglio nel massiccio del Mussa Dagh, a nord della baia di Antiochia, dove erano riusciti fino ai primi di settembre a tenere testa agli aggressori: ma da allora gli approvvigionamenti e le munizio- 61 Piccole conferenze per grandi incontri ni cominciarono a venir meno ed essi erano sul punto di soccombere, quando riuscirono a segnalare a un incrociatore francese la loro grave situazione. Gli incrociatori della squadra francese, che facevano il blocco delle coste della Siria, recarono subito soccorso e poterono assicurare lo sgombero dei cinquemila Armeni, che vennero trasportati a Porto Said, dove ricevettero la migliore accoglienza e furono installati in un accampamento provvisorio». Su quel massiccio dove, in un’improvvisata comunità, vive per quaranta giorni la popolazione di sette villaggi, si ripete in miniatura la storia dell’umanità, con i suoi eroismi e le sue miserie, con le sue vittorie e le sue sconfitte, ma soprattutto con quell’afflato religioso che permea la vita dell’universo e dà a ogni fenomeno terreno un significato divino che giustifica il male con una lungimirante, suprema ragione di bene. Dentro il poema corale si ritrovano tutti i drammi individuali: ogni personaggio ha la sua storia, ogni racconto genera un racconto. Fra scene di deportazioni, battaglie, incendi e morti, ora di una grandiosità impressionante, ora di una tragica sobrietà scultorea, ma sempre di straordinaria potenza rappresentativa, si compone quest’opera fondamentale dell’epica moderna. Tragico documento sulla persecuzione degli armeni da parte dei turchi durante la Prima guerra mondiale, il libro venne pubblicato nel 1933 ed è stato giustamente considerato la più matura creazione di Werfel nel campo della narrativa. All’ora esatta predetta da Alì Nassíf gli zaptié1 giungevano a Yoghonolúk, in numero di cento circa. Che l’autorità pensasse di spiantare il grosso distretto con cosí pochi armati era un segno evidente di disprezzo: i montoni armeni non oppongono resistenza, quando si conducono al macello. I pochi esempi contrari, graditissimi al governo, non dimostrano nulla. Come potrebbe un debole popolo di mercanti misurarsi con un eroico popolo di guerrieri? I cento gendarmi inviati a Yoghonolúk rispondevano a questa domanda. Non erano piú però i bonari assassini dell’epoca di Abdúl 1 Zaptié: gendarmi, poliziotti. 62 Materiali Hamid2. Non visi sfigurati dal vaiolo, le cui strizzate d’occhio feroci e schiette lasciavano capire che per un compenso adeguato si poteva venire a patti. Non c’era più che la semplice crudeltà senza secondi fini. Gli zaptié non portavano più, come un tempo, i rognosi berretti di pelle d’agnello, e neppure quell’uniforme improvvisata del buon tempo antico, che era una combinazione dell’abito d’ordinanza con qualche inesprimibile abito borghese. Il loro corpo era infilato nella comune divisa da campagna giallobruna, confezionata di fresco. Intorno al capo, per il sole e per il sudore, avevano legato, alla guisa dei beduini, dei fazzoletti, che scendevano lunghi sulle spalle, dando loro l’aspetto inesorabile di sfingi egizie. Camminavano in fila, non ancora proprio col passo meccanico dell’Occidente, ma neppur più con l’andatura ondeggiante dell’Oriente. Anche su questi 2 Werfel allude a Abdúl Hamid II (Istanbul, 21 settembre 1842 - Istanbul, 10 febbraio 1918), trentaquattresimo sultano dell’Impero Ottomano dal 31 agosto 1876 al 27 aprile 1909. Succeduto nel 1876 al fratello Murad V deposto da un comitato liberale, seguendo i consigli dell’illuminato Midhat Pasha concesse nello stesso anno una costituzione liberale modellata su quella belga. Ma dopo la dura sconfitta subita a opera della Russia e le conseguenti decisioni del Congresso di Berlino (che deliberava, tra l’altro, la costituzione di nuovi Stati balcanici a spese dell’Impero ottomano) la linea politica del sultano mutò improvvisamente. Sciolto praticamente il Parlamento, esiliato e poi assassinato Midhat Pasha, Abdúl-Hamid abbandonò ogni riforma e innalzò a programma di governo un panislamismo fanatico e intollerante. Il sultano diresse personalmente questa politica, contro la quale le popolazioni soggette (Albanesi, Greci, Armeni, Bulgari, ecc.) reagivano con rivolte e congiure. Particolarmente accanito fu con gli Armeni, perseguitati e spesso massacrati nonostante le proteste delle nazioni europee. Perduta l’amicizia delle potenze occidentali, Abdul-Hamid trovò appoggio nel Kaiser Guglielmo II che volle apparire il protettore del mondo islamico. Nel 1908, in seguito allo sviluppo del movimento detto in Europa dei Giovani Turchi, il sultano si vide costretto a rimettere in vigore la Costituzione del 1876. Tentò allora di fomentare un moto controrivoluzionario, ma fu deposto. 63 Piccole conferenze per grandi incontri zaptié di Antiochia, lontani da Stambul, Ittihàd aveva fatto sentire la sua influenza, convertendo abilmente la breve vampata del fanatismo dell’antico odio religioso nel fuoco lento del freddo fanatismo dell’odio nazionale. Gli uomini erano comandati dal Muafín, o capitano di polizia di Antiochia. Li accompagnava il giovane Müdir3 dagli occhi arrossati e senza ciglia e dalle lentiggini sul volto e sulle mani. Intorno a mezzogiorno il drappello, da un pezzo annunciato dalle spie, entrava nella piazza della chiesa di Yoghonolúk. Gli acuti segnali delle trombe turche squillarono accompagnati dal rullo dei tamburi. Ma nonostante queste imperiose esortazioni gli armeni rimasero nelle loro case. Ter Haigazún aveva fatto vivamente raccomandare a ciascun abitante dei sette villaggi di mostrarsi il meno possibile, di evitare tutti gli assembramenti e di non cadere nella trappola di qualche provocazione. Il Müdir, davanti a un pubblico formato dagli zaptié, dalla poca gente venuta con loro e dalle finestre chiuse della piazza della chiesa, lesse il lungo ordine di bando, che fu contemporaneamente affisso sotto forma di parecchi manifesti al muro della chiesa, nel municipio e alla scuola. Dopo questo atto pubblico gli zaptié, essendo ora di mangiare, si accamparono per terra, fecero fuoco e cominciarono a scaldare la loro pentola di fuhl, fave in grasso di montone. Poi mentre inzuppavano le gallette nella loro porzione di decotto e masticavano accovacciati, si guardavano in giro pigri. « Che belle case! E tutte di pietra, con tetti solidi e verande intagliate in legno! Gente ricca questi armeni, gente ricca dappertutto! A casa, nei nostri villaggi, si è già contenti se le capanne di legno annerite dagli anni non crollano sotto il peso del nido della cicogna. E la chiesa di questi luridi porci è massiccia e presuntuosa come una fortezza, con le sue creste, i suoi angoli, i suoi aggetti. Ma ecco qua Allàh a comprargli un po’ della loro presunzione! Essi avevano le 3 Müdir: governatore locale, funzionario. 64 Materiali mani dappertutto, regnavano a Stambul, facevano fruttare ben bene il loro denaro! E ci si era adattati a tutto, fino a che anche la pazienza più sonnolenta è scattata. » Anche il Müdir e il Muafín ammirarono ancora una volta stupiti la grandiosità di quella piazza di villaggio. Forse per un attimo il capitano di polizia si sentì invaso dall’incertezza di un barbaro di fronte ad una civiltà superiore. Ma poi dovette ribollire in lui con duplicato odio la famosa frase di Talaat Bey, che il Kaimakàm aveva citato il giorno innanzi al momento di spedirli: « O scompaiono loro, o noi ». Il silenzio, che non ostante i molti armati gravava sulla piazza della chiesa, aveva qualcosa di sinistro. E non era per nulla interrotto dalla presenza di alcuni spettatori della deportazione, che si erano uniti agli zaptié. I rigagnoli umani di Antakje e delle maggiori borgate intorno avevano riversato l’eccesso delle loro acque nella valle dei sette villaggi. Quatti quatti, a piedi nudi e sudici, eran venuti da Mengulijé, Hamblas e Bostan, da Tumana, Sciàhsini, Aïn Jeràb e perfino da Beléd es Sceikh. Occhi pieni d’indomata avidità piluccavano già le case. Contadini arabi dei monti El Akrà del sud, accoccolati tranquillamente sui loro calcagni, aspettavano grassi eventi. Perfino un piccolo gruppo di ansarijé si era raccolto là, gli infimi paria del profeta, gentaglia di schiavi semiarabi senza popolo, che sfruttavano la rara possibilità di sentirsi superiori ad altri uomini. Anche alcuni mohagír erano già sul posto, profughi di guerra mandati dal governo nell’interno e cordialmente invitati a compensarsi delle loro perdite coi beni armeni. Accanto a questo popolo schietto c’erano nel gruppo, assai strane da definire, delle donne completamente velate, timide e ardenti. Appartenevano senza dubbio alle classi migliori. Lo si vedeva a prima vista dalla stoffa fine dei mantelli tirati sopra la testa, dai tessuti dei veli, dalle piccole pantofole o scarpette verniciate, in cui si serravano i piedi inanellati. Queste donne erano zelanti clienti di quella liquidazione vantaggiosa, 65 Piccole conferenze per grandi incontri che attendevano con impazienza. Già da alcune settimane nelle stanze delle donne di Suedia e di El Eskèl si bisbigliava: « Ah, non lo sapete? Quei cristiani hanno nelle loro case delle cose magnifiche, che da noi non si conoscono affatto o si possono acquistare solo a caro prezzo ». « Sei mai stata in una casa armena? » « Io no ! Ma la moglie del Mollàh4 mi ha descritto tutto minutamente. Là troverete armadi e cassettoni con sopra torrette, colonnette e ghirlande. Là troverete ben poche stuoie da dormire, quelle che di giorno si chiudono via, ma veri e propri letti di legno scolpito, con fiori e testine di bimbi proibiti da Dio, letti per marito e moglie grandi come l’equipaggiamento del Valí5. Troverete orologi: sopra ci sta un’aquila dorata, oppure dalle loro viscere salta fuori un cuculo che canta. » « Ecco un’altra prova che sono dei traditori, perché altrimenti come avrebbero potuto avere dall’Europa simili suppellettili? » Ma appunto a queste suppellettili aspiravano vivamente le donne, sazie dei bellissimi tappeti, dei piatti d’ottone e dei bracieri di rame. Franz Werfel, I quaranta giorni del Mussa Dagh, Corbaccio, Milano 1997. 4 Mollàh: religioso musulmano. Valí: Prefetto di una circoscrizione amministrativa turca. Nell’impero ottomano: governatore generale di una provincia. 5 66 Materiali Franz Werfel in una foto del 1943 Franz Werfel (Praga, 10 settembre 1890 – Los Angeles, 26 agosto 1945) è stato uno scrittore e drammaturgo austriaco, di origine ebrea, nato nell’epoca dell’impero austro-ungarico. Contemporaneo e collega di altri intellettuali ebrei e autori come Franz Kafka, Max Brod e Martin Buber, si sposò nel 1929 con Alma Schindler, vedova del compositore Gustav Mahler, che per lui divorziò dall’architetto Walter Gropius. La fama letteraria gli venne nel 1933 con la pubblicazione de I quaranta giorni del Mussa Dagh, vero e proprio racconto epico della resistenza armena e del genocidio di quel popolo ad opera dei Turchi. Appartenente alla corrente espressionistica fin dagli anni immediatamente antecedenti la prima guerra mondiale, esordì con dei volumi di liriche, L’amico del mondo (del 1911) e Noi siamo (del 1913). Allo scoppio del conflitto mondiale, nonostante la sua indole votata al pacifismo, si arruolò nell’esercito austriaco per combattere sul fronte russo e servire in mansioni di ufficio stampa. Successivamente, terminata la guerra, si trasferì a Vienna e quindi, con l’Anschluss, in Francia. Nel timore di una espansione del nazismo, scelse - all’inizio della seconda guerra mondiale - di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove vivrà fino alla morte. Fra le opere di Werfel - letterato attratto in particolare dal teatro - si ricordano, oltre ai romanzi Il colpevole non è l’assassino, ma la vittima (1920), I quaranta giorni del Mussa Dagh (1933), Nel crepuscolo di un mondo (1937) e Una scrittura femminile azzurro pallido (1955), i drammi storici Juarez e Massimiliano (del 1924) e Jacobowsky ed il colonnello (scritto poco prima della morte). Il cineasta Henry King trasse nel 1943 dal suo Poema di Bernadette, biografia della santa di Lourdes (scritto due anni prima e nel quale lo scrittore manifesta le sue simpatie verso il Cattolicesimo) un film di grande impatto emotivo e successo popolare. 67 La lettera del dottor Philobosian di Jeffrey Eugenides Middelsex, di Jeffrey Eugenides, è il romanzo di un viaggio che ci proietta nei sogni e nei segreti della saga familiare degli Stephanides, tra furbi imprenditori e ciarlatani, sagge donne di casa e improbabili leader religiosi, in un alternarsi di nascite, matrimoni, scandali e segreti. La storia di Calliope Stephanides, la protagonista del romanzo, parte infatti da molto lontano: dall’entrata dell’esercito turco a Smirne nel 1922 e dall’incendio che devastò gran parte della città vecchia costringendo i nonni greci di Calliope, che condivisero il destino di armeni e bulgari, a fuggire negli USA per stabilirsi a Detroit. Il brano che segue racconta appunto dell’incendio di Smirne, la notte del 13 settembre 1922, dell’eccidio della famiglia armena del dottor Philobosian e del suo imbarco verso la salvezza. Quel pomeriggio anche il dottor Nishan Philobosian era partito per il porto in cerca di una rassicurazione del genere. Aveva salutato con un bacio la moglie Toukhie e le figlie, Rose e Anita; aveva dato una pacca ai figli, Karekin e Stepan, sulla schiena, indicando la scacchiera e dicendo con finta serietà: «Non muovete niente». Chiuso a chiave il portone di casa, e accertatosi con una spallata di averlo fatto davvero, si era avviato lungo la Suyane, passando davanti ai negozi chiusi e alle finestre in frantumi del quartiere armeno. All’altezza della panetteria dei Berberian si era domandato se Charles Berberian avesse portato la famiglia fuori città o se, come i Philobosian, non fossero anche loro nascosti in una stanza ai piani superiori. Era da cinque gior- 69 Piccole conferenze per grandi incontri ni che vivevano segregati, Philobosian e i suoi figli giocando interminabili partite di scacchi, Rose e Anita sfogliando una copia di “Photoplay” che lui aveva preso durante una recente visita nella zona americana di Paradise, e Toukhie cucinando giorno e notte perché mangiare era l’unica cosa che placava l’ansia. Sulla porta della panetteria c’era soltanto un cartello con la scritta “Apertura Imminente” e un ritratto - che gli provocò un certo fastidio - di Kemal, il capo turco, in atteggiamento risoluto con il berretto di astrakan e il colletto di pelliccia, gli occhi di un azzurro pungente sotto le scimitarre incrociate delle sopracciglia. Philobosian distolse lo sguardo da quella faccia e riprese a camminare, ripassando mentalmente tutte le argomentazioni contro la scelta di esporre il ritratto di Kemal. Innanzitutto - come ripeteva alla moglie da una settimana - le potenze europee non avrebbero mai permesso ai turchi di entrare in città. Secondo, qualora lo avessero permesso, la presenza delle navi da guerra in porto avrebbe trattenuto i turchi da atti di vandalismo. Anche durante il massacro del 1915 gli armeni di Smirne erano stati risparmiati. Infine - come ulteriore garanzia per la sua famiglia - c’era la lettera che stava andando a prendere proprio allora nello studio. Così ragionando il dottore scese la collina e arrivò al quartiere europeo. Qui le case avevano un aspetto più prospero, lungo le strade sorgevano ville a due piani con balconi fioriti e alte mura di cinta. Il dottor Philobosian non era mai stato invitato in queste ville per motivi sociali, ma spesso aveva fatto visite a domicilio per curare le levantine che vi abitavano. Erano ragazze di diciotto e diciannove anni che lo attendevano nei “palazzi d’acqua” dei cortili, languidamente sdraiate sulle dormeuse in mezzo a una profusione di alberi da frutta. Il disperato bisogno di trovare un marito europeo le esponeva a una libertà scandalosa, più che sufficiente a giustificare la reputazione di Smirne quale luogo estremamente ospitale nei confronti degli ufficiali stranieri [...]. 70 Materiali Dalle due estremità del porto i soldati greci, esausti, cadaverici, sudici, zoppicavano verso il punto di imbarco di Chesme, a sudovest della città, dove avrebbero aspettato di essere evacuati. Le logore uniformi erano nere della fuliggine dei villaggi bruciati durante la ritirata. Soltanto una settimana prima gli eleganti caffè all’aperto del lungomare erano affollati di ufficiali della marina e diplomatici, adesso il molo era un campo di raccolta profughi. I primi erano arrivati con tappeti e poltrone, radio, lampade, cassettiere, e avevano sistemato tutto sulle banchine a cielo aperto. Gli ultimi si presentavano con un sacco o una valigia. In mezzo a quella confusione i facchini correvano avanti e indietro dalle barche caricando tabacco, fichi, incenso, pezze di seta e mohair. Si svuotavano i magazzini prima dell’arrivo dei turchi. Il dottor Philobosian individuò un profugo che rovistava tra ossi di pollo e bucce di patata in un mucchio di rifiuti. Era un giovanotto con un abito di buon taglio, molto sporco. Perfino da quella distanza l’occhio allenato del dottore notò il taglio sulla mano e il pallore da malnutrizione. Però, quando anche l’altro alzò lo sguardo, vide una faccia inespressiva, impossibile da distinguere nella folla di profughi allo sbando. Ciò nonostante, fissando in quegli occhi vuoti, il dottore domandò: «Ti senti male?». «Non mangio da tre giorni» rispose il giovane. Il dottore sospirò. «Vieni con me.» Lo accompagnò fino al suo studio percorrendo stradine secondarie. Lo fece entrare, prese garza, antisettico e cerotto dall’armadietto e gli esaminò la mano. La ferita era sul pollice, dove mancava l’unghia. «Come è successo?» «Prima c’è stata l’invasione greca» rispose il profugo. «Poi sono tornati i turchi. La mia mano è finita in mezzo.» Mentre puliva la ferita, Philobosian non parlò. «Dovrò 71 Piccole conferenze per grandi incontri pagarla con un assegno, dottore» gli disse il profugo. «Spero che non le dispiaccia. Al momento non dispongo di contanti.» Il dottore si infilò una mano in tasca. «Io ho qualcosa. Tieni, prendi.» Il profugo esitò per un momento. «Grazie, dottore. La ripagherò non appena sarò negli Stati Uniti. Mi dia il suo indirizzo, per favore.» «Sta’ attento a quello che bevi» disse Philobosian ignorando la richiesta. «Fa’ bollire l’acqua, se puoi. Con l’aiuto di Dio potrebbero arrivare delle navi.» Il giovane annuì. «Lei è armeno, dottore?» «Sì.» «E non se ne va?» «Smirne è casa mia.» «Buona fortuna, allora. Che Dio la benedica.» «Benedica anche te.» Ciò detto il dottor Philobosian lo accompagnò fuori e rimase a guardarlo allontanarsi. Non c’è speranza, pensò. Morirà nel giro di una settimana. Se non di tifo, di qualcos’altro. Ma non era questo che lo preoccupava adesso. Infilando una mano nella macchina da scrivere estrasse uno spesso fascio di banconote nascosto sotto il nastro. Rovistò nei cassetti fino a quando, dentro il diploma di laurea, trovò una lettera dattiloscritta ormai sbiadita: “Questa lettera certifica che Nishan Philobosian, medico chirurgo, il 3 aprile del 1919 ha curato Mustafa Kemal Pasha per un caso di diverticolite. Il latore della presente viene rispettosamente raccomandato da Kemal Pasha alla stima, al rispetto e alla protezione di chiunque legga la presente lettera”. La ripiegò e l’infilò in tasca. [...] Cinque vetture ornate di ramoscelli d’ulivo oltrepassano le porte della città. Uomini a cavallo galoppano accanto alle auto che superano il bazar coperto, attraversano le strade del quartiere turco zeppe di folle acclamanti dove un drap- 72 Materiali po rosso ricopre ogni lampione, ogni porta, ogni finestra. La legge ottomana vuole che il suo esercito occupi il punto più alto di ogni città conquistata, perciò è lì che si dirige il convoglio. Le cinque macchine passano per le zone deserte dove la gente ha abbandonato le case o si è nascosta. Dalla finestra chiusa Anita Philobosian osserva la parata di macchine addobbate che si avvicinano, sono bellissime e lo spettacolo è così intenso che sta per aprire gli scuri ma sua madre la allontana bruscamente... e ci sono altre facce premute contro le assicelle di legno delle persiane, occhi armeni, bulgari e greci che spiano da nascondigli e soffitte per guardare i conquistatori e indovinarne le intenzioni; ma le automobili vanno troppo veloci - il sole sulle sciabole sguainate della cavalleria è accecante - e sono già scomparse, hanno raggiunto il molo, dove i cavalli caricano la folla disperdendo i profughi tra le urla. Sul sedile posteriore dell’ultima automobile c’è Mustafa Kemal. È smagrito dalla battaglia, gli occhi azzurri scintillano. Non tocca alcol da due settimane. (La “diverticolite” del pascià curata dal dottor Philobosian era una copertura. Kemal, campione dell’occidentalizzazione e dello stato laico, rimarrà fedele ai suoi principi fino alla fine, morendo a cinquantasette anni di cirrosi epatica.) Mentre passa si volta a guardare la folla e vede una giovane donna che si sta alzando da una valigia. I suoi occhi azzurri perforano i due occhi scuri di lei. Due secondi, nemmeno. Poi Kemal distoglie lo sguardo e il convoglio è lontano. Adesso è soltanto questione di vento. Una di notte, mercoledì 13 settembre 1922. [...] Il profumo dei gelsomini si è trasformato nella puzza del cherosene. Intorno al quartiere armeno sono state erette le barricate. Le truppe turche bloccano tutte le uscite dal molo. Ma il vento continua a soffiare nella direzione sbagliata. Intorno a mezzanotte, tuttavia, gira. Soffia verso sudovest, cioè lontano dalle alture dove si 73 Piccole conferenze per grandi incontri sono stabiliti i turchi, verso il porto. Nell’oscurità si avvicinano le torce, tre soldati turchi nella bottega di un sarto, in piedi. Le torce illuminano le pezze e gli abiti appesi. Poi, quando si alza la fiamma vediamo il sarto. È seduto alla macchina per cucire, la scarpa destra ancora sul pedale. La luce diventa ancora più intensa e rivela la sua faccia, le orbite vuote, la barba strappata in brandelli sanguinanti. I fuochi fioriscono in tutto il quartiere armeno. Come milioni di lucciole le scintille volano sopra la città buia inseminando ovunque germi di un incendio. Nella sua casa di Suyane il dottor Philobosian appende un tappeto bagnato al balcone, corre dentro e chiude gli scuri. Il bagliore delle fiamme penetra nella stanza illuminandone delle strisce: gli occhi pieni di panico di Toukhie, la fronte di Anita, con un nastro d’argento come Clara Bow in “Photoplay”, il collo nudo di Rose, i capelli scuri, le teste chine di Stepan e Karekin. Alla luce del fuoco il dottor Philobosian rilegge per la quinta volta: «“... rispettosamente raccomandato alla stima, al rispetto e alla protezione.” Mi sentite? “Protezione...”». Dall’altra parte della strada la signora Bidzikian canta le prime tre note dell’aria della “Regina della Notte” dal Flauto Magico. Suona così strana quella musica in mezzo ai rumori - porte sfondate, grida, implorazioni di ragazze - che tutti alzano gli occhi. La signora Bidzikian ripete due volte: si bemolle, re, fa, come se stesse studiando il passaggio, poi la sua voce tocca una nota che nessuno ha mai sentito prima e a quel punto è chiaro che non sta cantando. «Rose, dammi la borsa.» «Nishan, no» obietta la moglie. «Se ti vedono uscire capiranno che siamo nascosti.» «Non mi vedrà nessuno.» [...] Ci sono venti macchie arancioni sulla collina. Questi 74 Materiali fuochi hanno una persistenza innaturale. Non appena i pompieri riescono a spegnerne uno, ne scoppia un altro poco lontano. Sui carri di fieno e nei bidoni nell’immondizia, serpeggiano lungo le tracce di cherosene e arrivano in mezzo alle strade, girano gli angoli, entrano dalle porte già sfondate. Un fuoco penetra nella panetteria di Berberian distruggendo in men che non si dica gli scaffali del pane e i carrelli dei dolci. Brucia il negozio e imbocca le scale, dove a metà strada incontra Charles Berberian in persona che cerca di spegnerlo con una coperta. Il fuoco lo scansa e si infila nella casa. Prima attraversa a zigzag un tappeto orientale, raggiunge il portico sul retro, salta agile sul filo della biancheria e cammina come un funambolo fino alla casa confinante. Salta sulla finestra e lì si arresta, come sorpreso dalla sua grande fortuna: in quella casa tutto è fatto per bruciare, il divano damascato con le frange, il tavolo di mogano e i paralumi di chintz. Il calore stacca la tappezzeria dalle pareti, e non soltanto in questo appartamento ma in altri dieci o quindici, in altri venti o venticinque, e ogni casa appicca il fuoco alla casa del vicino fino a quando interi isolati sono in fiamme. L’odore bruciato di quel che non è fatto per bruciare inonda la città: lucido da scarpe, topicida, dentifricio, corde di pianoforte, cinti erniari, culle, clave. Capelli, pelle. [...] Ed ecco che di colpo tutti quei piccoli fuochi sulla collina si uniscono a formare una grande muraglia incandescente che si allunga su tutta la città e - a questo punto è inevitabile - comincia a scendere. [...] Philobosian uscì nella via, guardò a destra, guardò a sinistra, e si infilò di corsa nel portone dall’altra parte della strada. Salì le scale, ed entrando nel salotto vide la testa della signora Bidzikian da dietro, seduta in poltrona. Si precipitò verso di lei dicendole di non preoccuparsi, lui era il dottor Philobosian, abitava di fronte. Sembrò che la signora annuisse, però la testa non ritornò su. Le si inginocchiò ac- 75 Piccole conferenze per grandi incontri canto e toccandole il collo sentì il battito debolissimo. La stava sollevando con delicatezza dalla poltrona per sdraiarla sul pavimento quando udì dei passi sulle scale. Corse a nascondersi dietro le tende proprio mentre entravano i soldati. Per quindici minuti saccheggiarono l’appartamento, prendendo tutto quello che aveva tralasciato la prima banda. Rovesciarono i cassetti e affondarono i coltelli nei divani e negli indumenti in cerca di gioielli e soldi nascosti. Quando se ne furono andati il dottor Philobosian aspettò altri cinque minuti buoni, prima di uscire dal nascondiglio. La signora Bidzikian non respirava più. Le copri il volto con un fazzoletto e tracciò sul suo corpo il segno della croce. Poi prese la valigetta da medico e si precipitò giù dalle scale. Il fuoco è preceduto dal calore. I fichi rimasti ammucchiati sul molo perché non c’è stato il tempo di caricarli cominciano a cuocere e stillano succo. L’odore dolciastro si mescola a quello acre del fumo. [...] Nessuna via di scampo. I soldati turchi non si allontanano dalle barricate. La gente prega, alza le braccia implorando le navi nel porto. I fasci di luce dei riflettori scrutano l’acqua illuminando la gente che nuota, che annega. [...] Il fuoco si avvicina, le porte del consolato francese si spalancano. Il presidio della marina forma due linee che si allungano attraverso il molo, verso il porto. Il tricolore viene ammainato. Dalle porte del consolato emergono uomini in abiti color crema che tengono sottobraccio signore con i cappelli di paglia; si incamminano verso la lancia che li aspetta. [...] Una donna tiene in braccio un barboncino. Un’altra incespica rompendosi un tacco e viene soccorsa dal marito. Quando la lancia a motore è partita, un ufficiale si rivolge alla folla. «Verranno evacuati tutti i cittadini francesi. Comincere- 76 Materiali mo a sbrigare le pratiche dei visti immediatamente.» Quando sentono bussare, sobbalzano. Stepan va alla finestra e guarda giù. «Dev’essere papà.» «Va’. Fallo entrare! Svelto!» dice Toukhie. Karekin scende facendo due gradini alla volta. Davanti alla porta si ferma, si calma, e la spalanca tranquillo. Dapprima non vede niente. Poi sente un sibilo leggero seguito da un suono lacerante. Il rumore non sembra aver niente a che fare con lui, fino a quando all’improvviso un bottone della camicia salta e rimbalza contro la porta. Karekin guarda in basso, ha la bocca piena di un liquido caldo. Viene tirato su dal pavimento e la sensazione lo riporta all’infanzia, a quando suo padre lo lanciava in aria per gioco; fa in tempo a dire: «Papà, il bottone», prima di essere sollevato così in alto da vedere la baionetta di acciaio che gli attraversa lo sterno. Il riflesso del fuoco corre lungo la canna del fucile, il mirino e il cane, arriva all’espressione estatica sulla faccia del soldato. Il fuoco preme sulla folla. L’incendio divampa sul tetto del Consolato americano. Le fiamme si sono arrampicate sul teatro, bruciacchiando l’insegna. La gente indietreggia, un centimetro dopo l’altro, per sfuggire al calore [...] I tetti crollano, la folla grida [...], un uomo salta in acqua cercando di annegarsi, più in là partorisce una donna, nascosta dalla giacca tenuta tesa dal marito. «Kaymaste! Kaymaste!» grida la gente. «Bruciamo! Bruciamo!» [...] Contro un fondale nero la sagoma con il binocolo si muove avanti e indietro osservando i profughi lontani. Gridano in silenzio. Tendono le braccia, supplicano. «Li stanno bruciando vivi, quei poveracci.» «Chiedo il permesso di far salire a bordo un profugo, Signore.» «Permesso rifiutato, Phillips. Se ne prendiamo uno dovremo prenderli tutti.» «E una ragazza, Signore.» 77 Piccole conferenze per grandi incontri «Età?» «Sembra una bambina di dieci o undici anni.» Il maggiore Arthur Maxwell abbassa il binocolo. Nella mascella un nodo triangolare di muscoli si tende e scompare. «Le dia un’occhiata, Signore.» «Non dobbiamo farci prendere dalle emozioni, Phillips. Ci sono in gioco cose più importanti.» «Le dia un’occhiata, Signore.» Le narici del maggiore Maxwell fremono mentre guarda il capitano Phillips. Poi, battendosi la coscia, si allontana. Il cono di luce del riflettore spazza l’acqua: sotto il raggio luminoso, il mare è un brodo incolore sul quale galleggiano gli oggetti più disparati: un’arancia dal colore intenso, un cappello da uomo con l’ala coperta di escrementi, brandelli di carta come lettere strappate. E in mezzo a questa materia inerte lei, aggrappata a una gomena, una ragazzina con un vestito rosa che bagnato sembra rosso, i capelli incollati alla testa. I suoi occhi non chiedono niente, fissa in alto e basta. I piedini battono regolarmente, come pinne. I proiettili sparati dalla riva le finiscono intorno ma lei non pare farci caso. «Spegnete il riflettore.» La luce si spegne e i colpi d’arma da fuoco tacciono. Il maggiore Maxwell guarda l’ora. «Sono le ventuno e quindici. Io vado nella mia cabina, Phillips. Vi rimarrò fino alle sette e zero zero. Se un profugo venisse fatto salire a bordo durante questo periodo io non me ne accorgerei. Mi ha capito?» «Ho capito, Signore.» Al dottor Philobosian non venne neppure in mente che il corpo contorto che scavalcò sulla strada davanti a casa fosse quello del figlio minore. Notò soltanto che la porta era aperta. Nell’ingresso si fermò ad ascoltare: silenzio. Salì le scale lentamente, sempre stringendo la valigetta. Di so- 78 Materiali pra c’erano tutte le lampade accese. Nel salotto illuminato Toukhie lo aspettava sul divano, con la testa piegata all’indietro come in uno scoppio di ilarità, lo squarcio così ampio da lasciar vedere una sezione lucida della trachea. Stepan sedeva accasciato al tavolo da pranzo, la mano destra che stringeva la lettera di protezione, inchiodata al legno con un coltello da arrosto. Il dottor Philobosian fece un passo e scivolò, vide la striscia di sangue che percorreva il corridoio. La seguì fino alla camera da letto dove trovò le due figlie. Erano entrambe nude, supine. Gli avevano tagliato tre seni su quattro. La mano di Rose si protendeva verso la sorella come per sistemarle il nastro d’argento sulla fronte. L’episodio prosegue sul molo. Lefty e Desdemona, gli avi del personaggio principale del romanzo, ottengono di imbarcarsi su una nave fingendosi di origine francese. Incontrano il dottor Philobosian e riescono a farlo partire con loro. La fila era lunga e avanzava lentamente. Lefty aveva tempo per ripetere i vocaboli. Ripassò la grammatica, gettando qualche sbirciatina al frasario. Studiò: «Prima Lezione: Saluti» e quando arrivò al tavolo dell’ufficiale era pronto. «Nome?» «Eleutherios Stephanides.» «Luogo di nascita?» «Parigi.» L’ufficiale lo guardò. «Passaporto.» «È stato tutto distrutto nell’incendio! Ho perso tutti i documenti!» Lefty sporse le labbra sbuffando, come aveva visto fare ai francesi. «Guardi come sono conciato. Ho perso tutti i miei vestiti migliori.» L’ufficiale sorrise sarcastico e timbrò i fogli. «A posto.» «Mia moglie viaggia con me.» «Immagino che sia nata a Parigi anche lei.» «Naturalmente.» «Come si chiama?» 79 Piccole conferenze per grandi incontri «Desdemona.» «Desdemona Stephanides?» «Esatto. Come me.» Quando ritornò con i visti Desdemona non era più sola. Accanto a lei sedeva un uomo. «Ha cercato di buttarsi in acqua. L’ho fermato appena in tempo.» Intontito, insanguinato, con una fasciatura sporca intorno alla mano, l’uomo continuava a ripetere: «Non sapevano leggere. Erano analfabeti!». Lefty controllò che non sanguinasse da altre parti ma non trovò ferite visibili. Svolse la bendatura sulla mano, un nastro d’argento, e lo gettò via. «Non potevano leggere la mia lettera» disse l’uomo. Quando lo guardò in faccia Lefty lo riconobbe. «Ancora tu?» chiese l’ufficiale francese. «È per mio cugino» disse Lefty in un francese terribile. L’uomo timbrò il visto e glielo porse. Una lancia a motore li portò fino alla nave. Lefty tenne a bada Philobosian che continuava a minacciare di annegarsi. Desdemona aprì la scatola con i bachi e il telo bianco per vedere in che stato erano le uova. Molti corpi galleggiavano su quel mare spaventoso. Qualcuno, ancora vivo, gridava. La luce del riflettore illuminò un ragazzo aggrappato a metà della catena dell’ancora di una nave da guerra inglese mentre i marinai gli versavano l’olio addosso per farlo scivolare. Sul ponte della Jean Bart1 i tre nuovi cittadini francesi si voltarono a guardare la città completamente in fiamme. L’incendio continuò a divampare per tre giorni, con fiamme visibili fino a ottanta chilometri di distanza. Dal mare si sarebbe potuto scambiare la nube di fumo per una gigantesca catena montuosa. Nel paese verso cui erano diretti, l’America, l’incendio di Smirne occupò le prime pagine dei giornali per un giorno o due, prima di essere oscurato dal 1 Corazzata della marina francese. 80 Materiali caso Halls-Mills (il corpo di Halls, un ministro protestante, era stato trovato nella camera da letto della signorina Mills, attraente membro del coro) e l’apertura delle finali del campionato di baseball. Il colonnello Mark Bristol della marina statunitense, preoccupato per le relazioni tra America e Turchia, telegrafò il seguente comunicato stampa: “Impossibile stimare il numero di morti causate dal fuoco e dalle esecuzioni. Il totale non dovrebbe superare le duemila unità”. Al console americano George Horton venne riferita una stima molto più alta delle vittime. Dei quattrocentomila cristiani ottomani residenti a Smirne il primo di ottobre ne furono dichiarati dispersi centonovantamila. Horton dimezzò la cifra e stimò i morti intorno alle centomila unità. Furono salpate le ancore. Il ponte vibrò sotto i loro piedi mentre i motori del cacciatorpediniere venivano messi indietro tutta. Desdemona e Lefty guardavano l’Asia Minore allontanarsi. Quando passarono davanti all’Iron Duke2, l’orchestra militare inglese aveva attaccato un valzer. Jeffrey Eugenides, Middlesex, Mondadori, Milano 2003, pagg. 69-76 2 Nave da guerra della marina britannica. Jeffrey Eugenides (Detroit, 18 marzo 1960) è uno scrittore statunitense. Nato da genitori di origine greca, ha frequentato la privata University Liggett School a Grosse Pointe Woods, in Michigan, laureandosi poi alla Stanford University nel 1986, dove ha pure conseguito un master universitario in scrittura creativa. Nel 1986 ha ricevuto l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences “Nicholl Fellowship” per la storia Here Comes Wiston, Full of the Holy Spirit. Il romanzo Le vergini suicide, pubblicato nel 1993, ha ottenuto un successo internazionale in seguito all’adattamento cinematografico realizzato nel 1999 da Sofia Coppola. 81 Piccole conferenze per grandi incontri Eugenides si è mostrato restio alle apparizioni in pubblico o a svelare dettagli della sua vita privata, ad eccezione degli incontri con i lettori nel Michigan durante i quali espone minuziosamente l’influenza delle sue esperienze scolastiche nei sui lavori. Vive a Princeton, in New Jersey, con la moglie - la fotografa e scultrice Karen Yamauchi - e la figlia Georgia. Il suo romanzo Middlesex (2002) ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa 2003. Nell’autunno 2007 ha ottenuto la cattedra di scrittura creativa presso l’Università di Princeton. Figura, inoltre, nell’elenco dei compilatori dei lemmi del Future Dictionary of America (2005). 82 Nei campi di sterminio di Primo Levi Della produzione di memorie e testimonianze relative alla seconda guerra mondiale (nell’insieme più vasta e - sul piano dei risultati letterari - più notevole di quella seguita alla prima) Se questo è un uomo e La tregua sono certamente fra le opere più valide e rappresentative. La pagina che segue è tratta da La tregua. In essa la scrittura precisa e attenta al dettaglio scherma e domina la pietà umana e la commozione. L’ultimo enunciato ha l’austera bellezza di un’epigrafe classica. Hurbinek era un nulla, figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome: quel curioso nome, Hurbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle reni in giù, ed aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi; ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto, saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva: era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. 83 Piccole conferenze per grandi incontri Nessuno, salvo Henek: era il mio vicino di letto, un robusto e florido ragazzo ungherese di quindici anni. Henek passava accanto alla cuccia di Hurbinek metà delle sue giornate. Era materno più che paterno: è assai probabile che, se quella nostra assai precaria convivenza si fosse protratta al di là di un mese, da Henek Hurbinek avrebbe imparato a parlare; certo meglio che dalle ragazze polacche, troppo tenere e troppo vane, che lo ubriacavano di carezze e di baci, ma fuggivano la sua intimità. Henek invece, tranquillo e testardo, sedeva accanto alla piccola sfinge, immune alla potenza triste che ne emanava; gli portava da mangiare, gli rassettava le coperte, lo ripuliva con mani abili, prive di ripugnanza; e gli parlava, naturalmente in ungherese, con voce lenta e paziente. Dopo una settimana, Henek annunziò con serietà, ma senza ombra di presunzione, che Hurbinek “diceva una parola”. Quale parola? non sapeva, una parola difficile, non ungherese; qualcosa come “massklo”, “matisklo”. Nella notte tendemmo l’orecchio: era vero, dall’angolo di Hurbinek veniva ogni tanto un suono, una parola. Non sempre esattamente la stessa, per verità, ma era certamente una parola articolata, o meglio, parole articolate leggermente diverse, variazioni sperimentali attorno a un tema, a una radice, forse a un nome. Hurbinek continuò finché ebbe vita i suoi esperimenti ostinati. Nei giorni seguenti, tutti lo ascoltavamo in silenzio, ansiosi di capire, e c’erano fra noi parlatori di tutte le lingue d’Europa: ma la parola di Hurbinek rimase segreta. No, non era certo un messaggio, non una rivelazione: forse era il suo nome, se pure ne aveva avuto uno in sorte, forse (secondo una delle nostre ipotesi) voleva dire “mangiare”, o “pane”; o forse “carne” in boemo, come sosteneva con buoni argomenti uno di noi, che conosceva questa lingua. Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hurbinek che aveva combattuto come un uomo, fino all’ultimo respiro, 84 Materiali per conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senzanome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole. Primo Levi, La tregua, Einaudi, Torino 1963. Primo Levi, nato a Torino nel 1919, si laureò in chimica nel 1941 e riuscì presto ad affermarsi, nonostante i provvedimenti antisemiti del fascismo. Nel 1943 aderì a Giustizia e Libertà e alla lotta partigiana ma, catturato, venne internato in un campo di sterminio presso Auschwitz. Alla fine del 1945 ritornò a Torino dove è vissuto, ha lavorato come chimico, dedicandosi nel contempo alla letteratura. La sua produzione ha come oggetto sia le terribili esperienze dei campi di sterminio nazisti (Se questo è un uomo, 1956; La tregua, 1963; i saggi de I sommersi e i salvati, 1986) sia il mondo della scienza (Il sistema periodico, 1975) e del lavoro tecnico (La chiave a stella, 1978). È morto suicida a Torino nel 1987. 85 Negazionismo di Primo Levi Da I sommersi e i salvati (Einaudi, 1986) un brano di Levi sulla negazione del genocidio1. È significativo che questo rifiuto fosse stato previsto con ampio anticipo dagli stessi colpevoli; molti sopravvissuti ricordano che le SS si divertivano ad ammonire cinicamente i prigionieri: «In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l’abbiamo vinta noi; nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. Forse ci saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze, perché noi distruggeremo le prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti: dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata, e crederà a noi, che negheremo tutto, e non a voi. La storia dei Lager, saremo noi a dettarla». Curiosamente, questo stesso pensiero («se anche raccontassimo, non saremmo creduti») affiorava in forma di sogno notturno dalla disperazione dei prigionieri. [...] Fortunatamente le cose non sono andate come le vittime temevano e come i nazisti speravano. 1 La pagina è stato ripresa dal Diario di Repubblica del 3 marzo 2009. 87 Notte sull’aia di Daniel Varujan Daniel Varujan, di cui ogni bambino armeno conosce a memoria qualche poesia, è ancora poco conosciuto in Italia, malgrado la traduzione de Il canto del pane uscita nel 1992 presso l’editore milanese Guerini, a cura di Antonia Arslan, che ha anche curato la più recente raccolta Mari di grano (Paoline, 1995), comprendente Il canto del pane ed altre liriche. Tra i grandi rappresentanti del simbolismo europeo,Varujan riuscì a fondere i diversi orizzonti poetici entro cui si formò (la nativa dimensione orientale e quella occidentale) in una sintesi originalissima. Vi si esprimono con vigore e plasticità di immagini – specie nei canti dopo la conversione – sensualità e mistica, corpo e anima, fisicità pagana e spirito cristiano. Nella poesia qui riportata, tratta dal Canto del pane, «Varujan – commenta Antonia Arslan – arriva a una sconcertante visione mistica, approdo di un itinerario della mente che, percorrendo le tappe della vita più elementare, quella del contadino, ha ridato ordine a un mondo sconvolto e, nominandolo, lo ha raccontato in poesia». Dolce notte estiva. La testa abbandonata sull’aratro l’anima sacra del contadino riposa sull’aia. Nuota il grande silenzio tra le stelle divenute un mare. L’infinito con diecimila occhi ammiccanti mi chiama. Cantano di lontano i grilli. Nelle acque del lago questa notte si celebrano le nozze segrete delle naiadi. La brezza agitando il salice sulla sponda del ruscello risveglia dei canti su accordi sconosciuti. 89 Piccole conferenze per grandi incontri Nel profumo del serpillo, disteso in cima a un covone io lascio che ogni raggio tocchi il mio cuore, e m’inebrio del vino della grande botte dell’infinito dove un passo sconosciuto schiaccia le stelle cadenti. È squisito per il mio spirito tuffarsi nell’onda luminosa [di azzurro, naufragare - se è necessario - nei fuochi celesti; conoscere nuove stelle, l’antica patria perduta, da dove la mia anima caduta piange ancora la nostalgia [del cielo. È dolce per me sollevarmi sulle ali del silenzio, ascoltare soltanto il respiro imperturbabile dello spazio, finché i miei occhi si chiudano in un sonno magico, e sotto le mie palpebre rimanga l’infinito con le sue stelle. Così, così si addormenta tutta la gente del villaggio; il pastore sul suo carro, sotto la trapunta che stilla luce, la sposa in cima a un covone, scoperto dallo zefiro il seno dove la Via Lattea svuota il suo latte brocca dopo brocca. E così, avendo dormito un giorno sotto lo sfavillio del [cielo, i miei genitori contadini mi concepirono con tenerezza, mi concepirono fissando lassù i loro occhi buoni sulla più grande stella, sulla fiamma più splendente. I “Khachkar” (Croci di pietra). Scolpiti nelle mura delle chiese, appoggiati nei cortili dei monasteri, conficcati nel terreno circostante con la faccia rivolta a occidente oppure disseminati ai lati delle strade, ai bordi dei campi, ai crocicchi o sulla cima delle colline, sono una caratteristica onnipresente dei siti cristiani armeni. 90 Materiali Daniel Varujan nacque a Perknik, villaggio dell’Anatolia, il 20 aprile 1884. Nel 1886 si recò con la madre a Costantinopoli alla ricerca del padre, scomparso durante le epurazioni volute dal sultano Abdul Hamid: un dramma da cui la sua sensibilità rimase segnata per sempre. Dotato di ingegno eccezionale, dopo i primi studi nella metropoli turca, proseguì la sua educazione a Venezia, dove pubblicò la sua prima raccolta di poesie, Fremiti (1906), e successivamente a Gand. Influenzato dalla crisi religiosa europea di fine Ottocento, attraversò una profonda crisi esistenziale, durante la quale si rifugiò nei miti indoeuropei precristiani della sua tradizione. Di nuovo in Turchia, si sposò e trovò lavoro come precettore nel paese natale. La sua fama di letterato e poeta crebbe dopo la pubblicazione de Il cuore della stirpe (1909) e Canti pagani (1913). Nel 1912 si trasferì a Costantinopoli, dove ottenne un posto di direttore di scuola e si dedicò con tutte le sue energie alla rinascita della cultura e della lingua armena, diventando l’anima del movimento che faceva capo alla rivista Navasart. È di quel periodo il suo ritorno alla fede, purificata e rafforzata dopo il travaglio spirituale. Tre anni dopo, arrestato con altri scrittori, intellettuali e uomini politici armeni,Varujan venne deportato verso l’interno ed ucciso il 28 agosto 1915, nel pieno della sua splendida maturità. 91 Difendo la memoria contro i negazionisti di Bernard-Henri Lévy Si dice: «Non spetta alla legge scrivere la Storia». È assurdo, perché la Storia è già scritta. La Storia di questa storia è stata fatta, cento volte fatta, da tutti i testimoni degni di fede. Che gli armeni siano stati vittime, nel senso stretto, preciso del termine, di un tentativo di genocidio, cioè di un’impresa pianificata di annientamento sistematico, Churchill l’ha detto. Jaurès l’ha gridato fin dal principio, nel 1894. Péguy, nel periodo in cui si schiera dalla parte di Dreyfus, parla di quell’inizio di genocidio come del «più grande massacro del secolo». Anche i turchi lo ammettono. Sì, è una cosa non abbastanza nota e che occorre instancabilmente ricordare: subito dopo la guerra mondiale, dopo il 1918, Mustapha Kemal riconosce le carneficine perpetrate dal governo dei Giovani Turchi; vengono istituite corti marziali, che pronunciano centinaia di sentenze di morte; i peggiori artefici del crimine, individui come Hodja Ilyas Sami, che è un po’ l’Eichmann degli armeni, finiscono con il confessare, chiaramente e distintamente. E non parlo degli storici né dei teorici del genocidio, non parlo dei ricercatori di Yad Vashem, né di Yehuda Bauer, né di Raul Hilberg; non parlo di tutti gli studiosi per i quali, con l’eccezione degna di nota di Bernard Lewis, il problema 93 Piccole conferenze per grandi incontri di sapere se ci sia stato o no genocidio non si è mai posto e non si pone. Quindi, non si tratta di «dire la Storia». La Storia, ripeto, è stata detta, ridetta e arcidetta. Oggi, si tratta d’impedire la sua negazione. Il Senato francese discuterà come complicare, almeno un poco, la vita di chi insulta. Esistono leggi, in Francia, contro l’insulto e contro la diffamazione. Non è forse il minimo che si possa avere, una legge che penalizzi l’insulto assoluto, l’oltraggio che supera tutti gli oltraggi e offende la memoria dei morti? Si dice: «Sì, d’accordo; però darete fastidio agli storici; la legge non deve immischiarsi neppure un poco nell’accertamento della verità, poiché, quando lo fa, la rinchiude in un corsetto che impedisce agli storici di lavorare». È falso. È il contrario. Sono i negazionisti che impediscono agli storici di lavorare. Sono loro che, con falsificazioni e follie, confondono le piste e complicano le cose. È la legge, invece, a proteggere i ricercatori. Prendiamo ad esempio la Legge Gayssot: non troveremo un solo storico al quale essa, penalizzando chi nega la distruzione degli ebrei, abbia ostacolato il lavoro. È una legge che frena le derive di Le Pen o Gollnish, pone qualche limite alle parole di Faurisson e ostacola gli incendiari d’anime come Dieudonné. Una legge che, fra parentesi, ci evita carnevalate come il processo, sette anni fa, del super negazionista David Irving, a Londra, durante il quale, proprio perché non c’era una legge, abbiamo visto giudici, procuratori, avvocati, giornalisti da strapazzo, acrobati di podi televisivi impegnati, per mesi e mesi, a sostituirsi agli storici, a improvvisarsi cacciatori di verità e a seminare davvero il turbamento negli animi. È una legge che, per prendere un esempio completamente diverso e in un altro campo, ha il merito di risparmiarci i presunti dibattiti che impazzano negli Stati Uniti fra sostenitori delle due «tesi» cosiddette «avverse»: il darwinismo e il creazionismo. Ma è 94 Materiali una legge che, ripeto, non ha mai ostacolato il cammino di un solo storico degno di questo nome. E che, contrariamente a quanto tengono a dirci - non riesco a capire perché - certi storici che amano tanto le petizioni, li protegge, sì li protegge dall’inquinamento negazionista. E così accadrà, ne sono profondamente convinto, quando la legge Gayssot sarà estesa alla negazione del genocidio armeno. Si dice: «Dove arriveremo? Perché, visto che ci siamo, non fare leggi sul colonialismo, la Vandea, la notte di San Bartolomeo, le caricature di Maometto, il delitto di bestemmia? Non ci stiamo dirigendo verso il trionfo di un politicamente corretto che vieta l’espressione delle opinioni non conformi? Non ci stiamo orientando verso decine, se non centinaia di leggi della memoria il cui unico risultato sarà di giudiziarizzare lo spazio del discorso e del pensiero?». Altro errore. Altra trappola. Per due ragioni molto semplici. Innanzitutto, non si tratta di «leggi della memoria» ma di genocidi; non si tratta di legiferare su qualsiasi cosa, ma soltanto sui genocidi. E di genocidi, cioè di imprese in cui si pretende di decidere, come diceva Hannah Arendt, chi ha diritto e chi no di abitare su questa Terra, non ce ne sono cento, né dieci: ce ne sono tre, forse quattro, al massimo cinque, con il Ruanda, la Cambogia e il Darfur. È un imbroglio intellettuale quello di agitare lo spauracchio della moltiplicazione di nuove leggi che violano la libertà di pensiero. Ma siamo seri: non si tratta di opinioni non-conformi, scorrette, ma di negazionismo, solo di negazionismo, cioè di una mentalità molto particolare che si esprime soltanto a proposito di genocidi e che non consiste nell’avere una certa opinione sulle ragioni della vittoria di Hitler o su quelle del trionfo dei Giovani Turchi nel 1908 o sui meccanismi che hanno scatenato la soluzione finale di tutsi o armeni. 95 Piccole conferenze per grandi incontri L’oggetto non è tale o tal’altro giudizio, ma una mentalità molto speciale, molto strana, che non ha niente a che vedere con il fatto di enunciare questo o quello e che consiste nel dire che la realtà non ha avuto luogo. Niente ricatti, dunque, alla tirannia della penitenza! Finiamola con la falsa argomentazione del vaso di Pandora che apre la via a un’inquisizione generalizzata! Il fatto che questa legge sia votata, che si punisca il negazionismo antiarmeno, non implica in alcun modo la famosa proliferazione, con metastasi, di leggi politicamente corrette. Si dice ancora: «Tre genocidi, d’accordo; forse quattro, e sia; ma attenzione a non mescolare tutto; non bisogna correre il rischio di banalizzare la Shoah». La mia risposta è chiara. È vero che non è lo stesso. È vero che il numero dei suoi morti, il grado di demenza e l’irrazionalità assoluta raggiunti dagli autori, il tipo di tecnica molto particolare che implica l’invenzione della camera a gas conferiscono alla Shoah un’irriducibile singolarità. Ma, a quest’evidenza, dobbiamo aggiungere che forse non è «lo stesso», ma i crimini come minimo si assomigliano maledettamente. E il primo a saperlo, il primo a prenderne atto fu un certo Adolf Hitler, di cui non diremo mai abbastanza quanto il genocidio antiarmeno l’abbia colpito, l’abbia fatto riflettere e, oso dire, l’abbia ispirato. Conosciamo tutti la famosa frase, pronunciata davanti ai suoi generali, nell’agosto del 1939, appena prima che la Polonia fosse invasa: «Chi parla ancora, oggi, dello sterminio degli armeni?». La verità è che c’è voluto l’esempio armeno per convincerlo, molto presto, della possibilità, nel contesto di una guerra mondiale e totale, di risolvere un problema come quello della «questione ebraica». La verità è che il genocidio armeno, questo primo genocidio, fu il «primo» in tutti i sensi del termine: un genocidio esemplare e quasi fondatore; un genocidio come banco di prova; un laboratorio del 96 Materiali genocidio considerato come tale dai nazisti. Un genocidio a partire dal quale, logicamente, nel memorandum alleato del maggio 1915, è stata formulata per la prima volta la nozione di crimine contro l’umanità; e che fu uno dei due campi di riferimento (il secondo è, beninteso, la Shoah) che, dopo la seconda guerra mondiale, permise al giurista ebreo polacco Rafael Lemkin d’inventare il concetto moderno di genocidio e di far sì che fosse iscritto nella Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del genocidio. La deportazione nell’Anatolia centrale, estate 1915 Da qualche giorno mi sono dovuto immergere, confesso senza piacere, nella letteratura negazionista che riguarda gli armeni. Con sorpresa ho scoperto che è la stessa letteratura, letteralmente la stessa, di quella che mira alla distruzione degli ebrei. Stessa retorica. Stesse argomentazioni. Stesso modo ora di minimizzare (ci sono stati dei morti, d’accordo, ma non tanti quanti ci dicono), ora di razionalizzare (massacri che non furono demenziali né gratuiti ma rientravano in una logica che era quella di una situazione di guerra), ora d’invertire i ruoli (come Céline faceva degli ebrei i veri responsabili della guerra e quindi del loro martirio, così i negazionisti turchi spiegano che sono gli armeni, con il loro doppio gioco, il loro comportamento da 97 Piccole conferenze per grandi incontri traditori, la loro propensione a intendersela con i russi e a colpire le truppe ottomane alle spalle, ad aver suggellato il proprio destino) e ora, infine, di relativizzare (che differenza c’è fra Auschwitz e Hiroshima o Dresda? che differenza fra gli armeni morti di fame nel deserto siriano e le vittime turche del terrorismo delle «bande armate» armene?). Insomma, a coloro che sarebbero tentati di giocare lo sporco gioco della guerra delle memorie e della rivalità tra vittime voglio rispondere difendendo la solidarietà delle vittime di genocidi. È la posizione del filosofo ceco Jan Patocka quando inventa la magnifica formula di «solidarietà dei traumatizzati». Era la posizione, che riguardava specificamente gli armeni, dei pionieri d’Israele, dei primi abitanti dello Yishuv, che sentivano tutti di avere un destino comune con gli armeni naufragati. Non lasciamoci ingannare: la lotta contro il negazionismo non è divisibile; i due meccanismi sono così vicini, il tentativo di negarli è, nei due casi, così incredibilmente simile che lasciare una possibilità all’uno equivarrebbe necessariamente ad aprire una breccia nell’altro. Infine si dice, e questo vuole essere l’argomento definitivo, schiacciante: «Perché non lasciare che la verità si difenda da sola? Non è abbastanza forte per opporsi, per imporsi, per fare mentire i negazionisti?». Ebbene no. Temo proprio di no. Innanzitutto, perché il negazionismo antiarmeno ha una particolarità che non si trova in quello che nega il genocidio degli ebrei: è un negazionismo di Stato, che si appoggia sulle risorse, la forza, la diplomazia, la capacità di ricatto di un grande e potente Stato. Proviamo a immaginare la situazione dei sopravvissuti alla Shoah se lo Stato tedesco fosse stato, dopo la guerra, negazionista! Proviamo a immaginare il loro sconforto ancora più grande se si fossero trovati davanti, invece dei Faurisson e altri Rassinier - i quali, per quanto nocivi siano stati, erano comunque capi di sètte abbastanza strampalati -, una Germania non 98 Materiali pentita che facesse pressione sui suoi partner minacciandoli di ritorsioni qualora avessero qualificato di genocidio la tragedia di uomini, donne e bambini selezionati sulla rampa di Auschwitz! È la situazione attuale degli armeni. È un’avversità che, stavolta, non ha equivalenti e alla quale non sono certo che la verità, nella sua nudità, abbia sufficiente forza per opporsi. E c’è il fatto che qui non si tratta più di «verità» e di «smentita»: poiché, cosa c’è nella testa di un negazionista? Qual è la strana passione che, come dicevamo prima, si manifesta solo per offendere le vittime di genocidi e mai, ad esempio, per negare che la Terra è rotonda o che Mozart è un musicista austriaco? Di cosa si tratta, quando ci si accanisce nel dire a degli uomini: «No, non siete morti; i vostri genitori, i vostri nonni e bisnonni non sono morti come voi sostenete; e il fatto di sostenerlo, di tenere così fortemente a farcelo credere significa che siete grandi imbroglioni, trafficanti della disgrazia matricolati, significa che avete un interesse inconfessabile»? In questo sentiamo che c’è una qualità di odio senza eguali, una volontà di offendere così totale che si può ricondurre soltanto all’odio antisemita o razzista. Contro tale odio, purtroppo, la verità è priva di risorse. In conclusione, ricordiamo Himmler che, nel giugno 1942, crea un commando speciale, il commando 1005, incaricato di dissotterrare i corpi, bruciarli e farne scomparire le ceneri. E ricordiamo l’SS gridare a Primo Levi che non un ebreo resterà per testimoniare e che, se per caso ne rimanesse uno, sarà fatto di tutto perché la sua testimonianza non venga creduta. Conosciamo gli eufemismi utilizzati - evacuazione, trattamento speciale, reinstallazione a Est - per evitare di dire «omicidio di massa» e per cancellare dunque, persino nel discorso, il segno di quello che si stava compiendo. 99 Piccole conferenze per grandi incontri Ebbene, la legge della Shoah, il teorema che io chiamo teorema di Claude Lanzmann, secondo cui il crimine perfetto è un crimine senza tracce e la cancellazione della traccia è parte integrante del crimine stesso; l’evidenza di un negazionismo che non è il seguito ma un momento del genocidio, che gli è consustanziale, valgono per tutti i genocidi e quindi, naturalmente, anche per quello del popolo armeno. Si crede che i negazionisti esprimano un’opinione: essi perpetuano il crimine. E pretendendo d’essere liberi pensatori, apostoli del dubbio e del sospetto, completano l’opera di morte. Occorre una legge contro il negazionismo, perché esso è, nel senso stretto, lo stadio supremo del genocidio. Bernard-Henri Lévy Corriere della sera, 29 gennaio 2007 (traduzione di Daniela Maggio) Bernard-Henri Lévy è nato nel 1948. nel 1968 è entrato alla Scuola Normale Superiore di Parigi, dove ha studiato con Derrida e Althusser. Nel 1971 ha iniziato a insegnare all’università, prima a Strasburgo, poi all’Ecole Normale Supérieure. Dal 1971 al 1973 è stato consigliere di Mitterrand. Nel 1974 ha iniziato a collaborare regolarmente con Le nouvel observateur e Temps modernes, fondando, nel 1990, la rivista Les règles du jeu. Noto come romanziere e saggista, fra i suoi libri più importanti ricordiamo: Les Derniers jours de Charles Baudelaire (1988), Les Aventures de la liberté (1991), Réflexions sur la guerre, le mal et la fin de l’histoire (2001), Chi ha ucciso Daniel Pearl? (Rizzoli, 2003), American Vertigo (Rizzoli, 2008). Nel 1997 ha realizzato, con Jean Pierre Enthoven, il film Jour et la nuit, selezionato al Festival di Berlino. 100 Negazionismo. Gli assassini della memoria che cancellano l’Olocausto di Bernardo Valli I sostenitori del negazionismo cercano di dare basi scientifiche alle loro tesi. Perlomeno lo sostengono. Il loro principale obiettivo è di dimostrare che il genocidio degli ebrei non è mai avvenuto. L’Olocausto sarebbe un mito, creato al fine di favorire gli interessi degli ebrei nel mondo, e giustificare la nascita e la difesa di Israele; sarebbe una colossale invenzione tesa a screditare, a demonizzare, la Germania di Hitler. Oggi le tesi dei negazionisti, dei quali la maggiore espressione è l’Institute for Historical Review, fondato da Dave McCalden (ex membro del National Front) alla fine degli anni Settanta negli Stati Uniti, affermano con argomentazioni variabili secondo i “ricercatori”: 1) che non sono mai esistite camere a gas per uccidere gli ebrei e che se sono esistite servivano, stando ad alcuni, per sterminare i pidocchi di cui Auschwitz era infestato; 2) che i nazisti non si proponevano di uccidere gli ebrei, ma semplicemente di rinchiuderli nei campi; 3) che il numero degli ebrei morti durante la Seconda guerra mondiale è di gran lunga inferiore a quanto si denuncia. Questi, in sintesi, i principi su cui si basa il negazionismo. Ai quali si devono aggiungere molte altre affermazioni più specifiche, o “scientifiche”, contenute in una vasta pubblicistica o 101 Piccole conferenze per grandi incontri espresse durante il congresso (o nel periodico) dell’Institute for Historical Review. Cito, a titolo di esempio, soltanto alcuni degli argomenti usati dai negazionisti in testi presentati come saggi di revisionismo storico. Secondo il Leuchter Report l’inesistenza delle camere a gas sarebbe provata dall’assenza di residui di cianuri negli ambienti di Auschwitz-Birkenau destinati allo sterminio. È inoltre impossibile credere, secondo i negazionisti, che gli inservienti, anche se dotati di maschere, potessero entrare subito, come si racconta, nelle camere a gas dove giacevano fino a millecinquecento cadaveri, senza che essi stessi venissero uccisi a loro volta dai miasmi letali. In quanto al cielo di Auschwitz, dalle fotografie aeree fatte dagli americani, non risulterebbe nascosto da una costante nuvola di fumo nero uscito dai forni crematori, come viene descritto. E le immagini dei prigionieri scarnificati, riprese sempre dagli americani? Lo stato di quei prigionieri sarebbe dovuto all’abbandono, senza cibo e medicine, per giorni e giorni, in seguito allo sfaldamento del fronte tedesco. Insomma Auschwitz sarebbe «una truffa». Non c’è bisogno di sottolineare che, nonostante le pretese, il negazionismo non abbia nulla di scientifico e neppure scalfisca gli studi e le testimonianze dirette sulle tecniche di sterminio nei campi di concentramento nazisti. Il negazionismo è un’ideologia. Meglio ancora, si è di fronte a una setta religiosa, come diceva lo storico francese Pierre Vidal-Naquet, precisando che si trattava di una setta simile a quella che “Weber opponeva con ragione alla Chiesa”. È un’opposizione settaria al culto dominante. VidalNaquet ricorse a quella definizione quando si presentò il caso di Roger Garaudy: un professore di filosofia via via convertito al protestantesimo, poi al comunismo (diventando un dirigente del Pcf), poi al cattolicesimo e infine all’islam. Approdato a quest’ultima religione, Garaudy abbracciò e difese pubblicamente le tesi negazioniste, compiendo un’altra tappa nella sua agitata vita spirituale o ideologica. Fu singolare il sostegno, altrettanto pubblico, che gli dette l’Abbé Pierre, considerato da molti francesi un santo vivente. In seguito l’Abbé Pierre si corresse e si capì che il suo era 102 Materiali stato un eccessivo e irresponsabile slancio d’amicizia. Pierre Vidal-Naquet fu uno dei primi ad affrontare i negazionisti (emersi negli anni Settanta) con una serie di articoli raccolti in un libro: Gli assassini della memoria (Viella, 2008). Egli rifiutò tuttavia di dibattere faccia a faccia con loro. Non erano interlocutori accettabili. Specialista dell’antica Grecia e impegnato con passione nel denunciare la tortura durante la guerra d’Algeria, Vidal-Naquet non aggirava i problemi. Come storico e come ebreo scandiva l’atteggiamento verso la Shoah in tre distinti momenti. Alla Liberazione nessuno si era interessato ai deportati ebrei. Si era poi passati a un interesse esclusivo, specifico, per il genocidio di cui erano state le vittime. E c’è stata a questo punto - ed è il terzo momento - una sacralizzazione della Shoah, a suo parere rischiosa: perché la Shoah non deve essere considerata un culto, suscettibile di creare un anti-culto, ossia un’eresia. Né deve essere uno strumento politico. È un genocidio che, insieme agli altri (quello simultaneo degli zingari, quello precedente degli armeni a opera dei turchi, o quello successivo nel Ruanda), deve impegnare gli storici, cui spetta di tener viva la memoria. Vidal-Naquet era contrario alla legge che condanna chi nega i crimini contro l’umanità, perché può far apparire i negazionisti come dei perseguitati. Si può capire, e condividere, il rigore di Vidal-Naquet, quando sottolinea il rischio implicito nella sacralizzazione o nell’uso politico della Shoah, ma è comprensibile, o addirittura inevitabile, che questo avvenga poco più di mezzo secolo dopo, quando i ricordi sono ancora vivi e sono mantenuti tali, anzi sono arroventati, dalla tragedia mediorientale. I negazionisti vogliono essere considerati dei revisionisti. Una qualifica cui non credo abbiano diritto. Non è revisionista l’intellettuale impegnato a contrastare la realtà, concretamente provata, di un fatto storico, la cui veridicità non richiede supplementi di indagine. Il revisionismo ridefinisce il giudizio su un evento, ne dà un’interpretazione diversa, non ha come fine la sua cancellazione. La storiografia è una continua revisione. Il negazionismo è dettato da un’ideologia. Per evitare che la 103 Piccole conferenze per grandi incontri scomparsa di testimoni viventi favorisca le tesi negazioniste, Claude Lanzmann ha realizzato con anni di lavoro il suo documentario di nove ore sulla Shoah, basato non sulle immagini ma su una straordinaria e sconvolgente serie di testimonianze dirette, destinate a restare quando si passerà definitivamente dalla memoria alla storia. testantesimo Se si scorrono le liste dei partecipanti al congresso dell’Institute for Historical Review si trovano i nomi di Carlo Mattogno, il negazionista italiano più noto, di Bradley Smith, fondatore del CODOH (Comitato per un aperto dibattito sull’Olocausto), di David Irving, autore di Hitler’s War, libro che ha mobilitato tanti tribunali, e di Robert Faurisson, il professore dell’Università di Lione, diventato un autore di riferimento per molti negazionisti. Nel 1992, durante un raduno negazionista in Germania, Irving dichiarò che la camera a gas ricostruita ad Auschwitz era un falso fabbricato dopo la guerra. Nel 2000 il tribunale britannico che trattò la causa per diffamazione intentata da Irving alla storica Deborah Lipstadt, sentenziò che il querelante, ossia Irving, aveva distorto e falsificato l’evidenza storica ed era un antisemita. Il francese Robert Faurisson usufruì del singolare sostegno di Noam Chomsky, illustre linguista, figlio di un professore di ebraico, intellettuale libertario e nemico di tutti gli imperialisti. Chomsky fece infatti la prefazione al libro di Faurisson (Mémoire en defense contre ceux qui m’ accussent del falsifier l’histoire) in cui si immagina, tra l’altro, una dichiarazione di guerra a Hitler da parte della comunità ebraica mondiale, e dove si dice che Hitler, il quale aveva imposto agli ebrei di portare la stella gialla a partire da sei anni, si preoccupava molto di più della sicurezza dei soldati tedeschi che degli ebrei. Chomsky precisava nella prefazione di non avere letto il libro, e, in sostanza, di volere soprattutto difendere la libertà d’opinione, quale che sia. Vidal-Naquet scrisse pubblicamente a Noam Chomsky. Gli disse che poteva sostenere il diritto del peggior nemico alla libertà d’opinione, se non domandava la sua morte e quella dei suoi fratelli. Ma che lui, Chomsky, non aveva il diritto 104 Materiali di prendere un falsario e di ridipingerlo con i colori della verità. A questo equivaleva infatti la sua prefazione. Più tardi Chomsky non sconfessò quanto aveva scritto, ma l’uso che ne era stato fatto. E chiese che la prefazione non fosse pubblicata. Ma era troppo tardi. Era già in libreria. Pochi mesi dopo Robert Faurisson veniva condannato, per la prima volta, per “contestazione di crimine contro l’umanità”. Bernardo Valli, Negazionismo. Gli assassini della memoria che cancellano l’Olocausto, Diario di Repubblica, 3 febbraio 2009. Bernardo Valli (Parma, 1930) è scrittore italiano e giornalista, inviato speciale ed esperto di politica internazionale. Debutta professionalmente nel 1956, scrivendo sulle pagine de Il Giorno di Milano, rimanendovi ininterrottamente fino al 1971, ed occupandosi delle grandi crisi mondiali, come la guerra del Vietnam. Nel 1971 si trasferisce al Corriere della Sera, come inviato in Vietnam, in India, Cina e Cambogia. Nel 1975 rientra in Europa, come corrispondente da Parigi. Diventa poi redattore capo della sede francese de La Repubblica. Nel 1998 ottiene il Premio Saint Vincent per il giornalismo come giornalista che ha dato lustro alla categoria. 105 Lo sterminio senza fine di David Bidussa Che cosa significa negare un fatto storico? E perché, nello specifico, il negazionismo include una forma di antisemitismo? La prima riguarda la dimensione della morte nei campi; la seconda chiama in causa il giudizio sull’identità dei sopravvissuti. Di che si discute quando qualcuno afferma che non sono esistite le camera a gas e che, più in generale, quei morti “non sono morti”? Consideriamo i numeri (un dato che costituisce un’ossessione per i negazionisti). I numeri dello sterminio riferiti ad Auschwitz sono stati riepilogati da Jean-Claude Pressac nel suo libro Le macchine dello sterminio (Feltrinelli 1994). Questi i numeri che Pressac riporta: ebrei gasati non iscritti, da 470 mila a 550 mila (l’oscillazione riguarda il numero complessivo degli ebrei ungheresi gasati): corrispondono ai deportati trasportati ad Auschwitz e selezionati già sulla rampa di arrivo; detenuti iscritti deceduti (ebrei e non ebrei) 126 mila: ovvero quelli sopravvissuti alla prima selezione sulla rampa e poi, gasati per malattia, debilitamento...; prigionieri di guerra sovietici, 15 mila; diversi (di cui soprattutto zingari), 20 mila. Complessivamente dunque stiamo parlando di una quantità di persone gasate tra i 631 mila e i 711 mila. Nes- 107 Piccole conferenze per grandi incontri suno di questi numeri è stato contestato dai negazionisti. Nessuno di loro ha mai risposto a Pressac. Questa cosa non fa pensare? Ma la retorica negazionista non riguarda solo i numeri. La ricostruzione storica di un fatto, non è mai fondata su un solo documento o su un corpo di documenti limitati a un punto. Indagare un fatto implica assumere l’intera filiera all’interno del quale si colloca. La storia non è mai l’astrazione di un particolare. La storia si studia solo assumendola “a parte intera”. E dunque ai dati forniti da Pressac, vanno aggiunti: i deportati sterminati in tutti gli altri campi (di sterminio: Treblinka, Majdanek, Sobibor, per esempio; o di concentramento: Dachau, Mauthausen...); quelli che vengono catturati, rinchiusi nei campi di transito, e che lì muoiono; quelli che sono trasportati in vagone e muoiono nel viaggio; tutti coloro che sono uccisi prima della scena del campo di sterminio: per esempio i fucilati nell’estate 1941, durante l’occupazione militare in Unione sovietica e quelli uccisi dai reparti di polizia speciale (per esempio i 260 mila sterminati in Polonia tra il 1940 e il 1944 dal Battaglione 101 come racconta Christopher Browning nel suo Uomini comuni, Einaudi). Negare le camere a gas, dunque, è funzionale a un obiettivo concreto: dichiarare che quella macchina complessiva di morte non sia mai esistita. Nello sterminio non c’è una parte per il tutto, c’è il tutto. E proprio con quel pacchetto complessivo si tratta di confrontarsi. Il primo atto del negazionismo è preliminare alla sua affermazione sulle camere a gas. Consiste nell’eliminare tutti i particolari e tutte le componenti che renderebbero insostenibile la tesi finale. La macchina dello sterminio nazista non è la camera a gas. Quello è il livello ultimo di un lungo percorso. All’interno di ciascun passaggio si uccidono individui, si sterminano interi gruppi famigliari o intere comunità locali. Lo sterminio preesiste alle camere a gas. Quella retorica tuttavia non si limita a negare un fatto provato. Infatti essa contesta non solo le prove, ma le testimonianze di chi 108 Materiali sostiene l’esistenza nelle forme e nei modi dello sterminio. Anzi il vero obiettivo del rifiuto delle prove è la convinzione che i sopravvissuti non abbiano diritto di parola. Quel diritto non viene riconosciuto ai sopravvissuti perché la loro natura - e non la loro esperienza - li rende incredibili. Secondo i negazionisti, infatti, essi non sono credibili e non devono essere creduti non perché ciò che dicono si sarebbe dimostrato fondatamente falso, ma perché la loro identità ebraica li qualifica come pericolosi sovvertitori dell’ordine e perché la loro natura li rende “perfidi”. Credereste mai ai nemici irriducibili? Alla fine, dunque, per i negazionisti quei testimoni sono non credibili perché sono ebrei e dunque per natura, raccontano il falso e lo raccontano perché il loro obiettivo sarebbe la conquista fraudolenta del potere. Lungi dal non essere mai avvenuto, lo sterminio per i negazionisti non è mai finito. È ideologicamente giustificato perché si basa sull’adesione all’ideologia che l’ha predicato e poi praticato. Alla fine lo si nega, per poter avere l’opportunità di completarlo. David Bidussa, Lo sterminio senza fine, Diario di Repubblica, 3 febbraio 2009. David Bidussa (Livorno 1955), storico sociale delle idee, lavora presso la Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano. Ha pubblicato: Ebrei Moderni (Bollati Boringhieri 1989); Il sionismo politico, (Unicopli 1993); Il mito del bravo italiano (il Saggiatore 1994); La mentalità totalitaria (Morcelliana, 2001); I Have a Dream (BUR 2006); Siamo italiani (Chiarelettere 2007); Dopo l’ultimo testimone (Einaudi 2009) Leo Valiani tra politica e storia (Feltrinelli 2009); L’idea sociale di sviluppo (Ediesse 2009). Ha diretto il volume Ebraismo, dell’opera Le religioni e il mondo moderno, a cura di Giovanni Filoramo (Einaudi 2008). 109 TRE FILM La masseria delle allodole Regia: Paolo e Vittorio Taviani 2007 Trama È il 1915. In una cittadina della Turchia vive la benestante famiglia armena degli Avakian. Alla morte dell’anziano capofamiglia, vengono invitati alle esequie anche alcuni Turchi, tra cui il colonnello Arkan, capo della guarnigione locale, nella speranza che i passati contrasti tra Turchi e Armeni siano ormai superati e che si possa instaurare un rapporto di rispetto reciproco tra le due comunità. I funerali sono così l’occasione per la bella armena Nunik di rivedere il suo amato, l’ufficiale turco Egon. Quest’ultimo, pur appartenendo all’organizzazione dei Giovani Turchi, non ne condivide le posizioni antiarmene, e progetta di fuggire all’estero con Nunik. Intanto Assadur, il figlio maggiore del patriarca, che da molti anni vive a Padova e a cui il padre aveva vietato di tornare in patria, apprende che quest’ultimo ha comunque lasciato 113 Piccole conferenze per grandi incontri a lui la vecchia Masseria delle Allodole. Assadur decide che è venuto il momento di tornare in Anatolia e riunire di nuovo tutta la famiglia. La masseria viene così rimessa a nuovo, e inaugurata con una splendida festa, mentre Assadur inizia i preparativi per il viaggio. Questi momenti di felicità sono però bruscamente interrotti. Le autorità turche contattano il colonnello Arkan, dicendogli senza mezzi termini che è arrivato il momento di sbarazzarsi degli Armeni una volta per tutte: tutti i maschi devono essere uccisi, le donne deportate. Arkan è inorridito, ma deve obbedire agli ordini. Spera tuttavia di salvare la vita perlomeno degli Avakian, ma i suoi ordini non vengono rispettati, e una squadra di soldati turchi si presenta alla masseria e massacra tutti gli uomini. Alla notizia della strage, Assadur vorrebbe affrettare il ritorno per aiutare gli Armeni ma l’ingresso in guerra dell’Italia glielo impedisce. Intanto il tentativo di fuga di Egon e Nunik è scoperto, ed Egon viene spedito al fronte contro i Russi. Sotto la stretta sorveglianza dei soldati turchi, inizia così per le donne armene una lunga e terribile marcia nel deserto: ai continui soprusi e maltrattamenti seguirà quasi per tutte la morte. Durante la sosta sotto le mura di Aleppo Nunik, la nipote del patriarca morto all’inizio del film, tenta di prostituirsi ad un soldato per procurare cibo ai bambini. Il soldato la riveste e le dà del cibo senza chiedere nulla in cambio: egli l’ama. Nunik, terrorizzata dall’idea di poter essere torturata, si fa promettere di essere uccisa da lui prima che ciò possa avvenire. Quando tenterà si scappare e verrà fermata dai sorveglianti, il soldato la decapiterà per evitarle il rogo. Quattro anni dopo la guerra finisce e il soldato testimonia davanti alla corte marziale contro i crimini perpetrati nei confronti degli Armeni, ed egli stesso si autodenuncia per aver ucciso la donna che amava. 114 Materiali Recensioni Come sempre, nel cinema dei fratelli Taviani, il dramma storicopolitico-collettivo viene raccontato attraverso le vicende e i destini di alcuni personaggi, dei componenti di una famiglia, di un nucleo ristretto. Perché la Storia è fatta dalle persone, su cui però troppo spesso si accanisce la disumanità di strategie politico-ideologiche che annullano ogni rispetto etico e umano. La masseria delle allodole, tratto dal romanzo dell’italo-armena Atonia Arslan, non vuole essere - secondo i due registi - un accurato quadro storico. Anche se la denuncia del genocidio armeno nel 1915 da parte del partito dei “Giovani Turchi” è centrale nella narrazione, risulta evidente che i Taviani guardino al massacro del passato come esempio negativo e radice di analoghe intolleranze e tragedie posteriori: dall’Olocausto degli Ebrei ad opera dei nazisti fino alla “pulizia etnica” nell’ex-Jugoslavia e ai conflitti politico-religiosi del presente. La didascalia alla fine del film ricorda che “Il popolo armeno attende ancora giustizia” per ciò che ha subìto durante la Grande Guerra. Il romanzo e il film fanno riemergere questa verità taciuta e rimossa colpevolmente dalla Turchia. Un film necessario, dunque, con pagine dure di forte tensione e macabra crudezza (la strage dei maschi - bambini e adulti - rifugiatisi nella masseria e ancora ignari dell’ordine di sterminarli). [...]. (Cinematografo 2007) “La masseria delle allodole è molto, molto interessante, ricco di meravigliose immagini, recitato da un cast internazionale (i più bravi sono André Dussolier e Mohamed Bakri). E segnato dall’inconfondibile grandioso stile dei Taviani, inasprito dal senso di rivolta verso la persecuzione degli armeni e verso gli assassinii di massa dei giorni nostri.” (Lietta Tornabuoni, La Stampa, 14 febbraio 2007) “Forte, sincero, pietoso: ecco La masseria delle allodole, l’atteso film dei fratelli Taviani sul genocidio degli armeni. (...) Nessuna pressione esterna e, alla fine, solo il silenzio con cui i giornalisti in sala hanno accompagnato lo sguardo su questo film dall’argomento forte, scenograficamente calligrafico e teatralmente interpretato. Una pellicola dagli alti additivi di fiction e di pathos che, pur articolandosi anche lungo microcosmi familiari allargati e storie d’amore ‘miste’, cerca il rimbalzo per arrivare a rappresentare il capitolo tragico di un intero popolo, senza per questo ideologizzarne la memoria, ma senza nemmeno risparmiare qualche crudezza nella messinscena. (...) E allora niente premeditazioni politiche, solo il tentativo di raccontare una verità documentata storicamente per farla riemergere dalla feritoia-tabù in cui era 115 Piccole conferenze per grandi incontri stata inabissata, abbracciando una prospettiva defilata e sentimentale.” (Lorenzo Buccella, L’Unità, 14 febbraio 2007) “Forse non bisognerebbe cercare di rinchiudere tragedie così grandi, come il massacro degli Armeni, in un film, in una storia: si rischia sempre di dire troppo o troppo poco, di banalizzare o di schematizzare. Succede anche con ‘La masseria delle allodole’, che i fratelli Taviani hanno tratto dall’omonimo romanzo di Antonia Arslan. Forse per una scelta di stile che guarda soprattutto a una destinazione televisiva di tipo generalista. E che finisce per evidenziare quella mancanza di originalità e rigore che in passato aveva contraddistinto le letture storiche fatte dai due registi. Adottando per questo film il punto di vista del romanzo, che fa vivere il dramma del genocidio attraverso le peripezie della famiglia Avakian, i Taviani scelgono di ‘spiegare’ per immagini una tragedia epocale, con diverse sfumature di coinvolgimento nelle file turche e contraddittori atteggiamenti in quelle armene, ma finiscono irrimediabilmente per stemperarne la forza emotiva e spettacolare. Solo in una scena la capacità di sintetizzare in un’immagine tanti discorsi torna a farsi ammirare: è quando una madre, che ha partorito un maschio durante la deportazione verso Aleppo, è costretta a chiedere aiuto a un’amica perché le è stato ordinato di uccidere il neonato. Basta quell’inquadratura senza parole per dire l’atrocità del genocidio armeno. Il resto è illustrazione.” (Paolo Mereghetti, Corriere della Sera, 14 febbraio 2007) “Tutti sappiamo o crediamo di sapere molto della Shoah avendo letto al riguardo migliaia di parole e visto montagne di immagini, fisse o in movimento, autentiche o fittizie. Mentre sul massacro degli armeni, ma il discorso vale per molte pagine atroci anche recenti, abbiamo quasi sempre nozioni vaghe. Parole, più che immagini. Dati, più che emozioni. In questo senso il film che i fratelli Taviani hanno tratto dal romanzo omonimo di Antonia Arslan, La masseria delle allodole, dovrebbe fare finalmente da apripista, per così dire, a una maggior conoscenza del genocidio armeno. Impossibile, dopo averlo visto, dire non sapevamo, non immaginavamo. Nella storia (vera) della famiglia Avakian c’è infatti tutto (o quasi) ciò che occorre sapere. [..] .” (Fabio Ferzetti, Il Messaggero, 15 febbraio 2007) 116 Ararat - Il monte dell’Arca Regia: Atom Egoyan 2002 Trama Nato da un’urgenza privata, l’ultimo film di Atom Egoyan si intreccia anche con la necessità cinematografica di illustrare la Storia. Un racconto in cui uomini e donne, cercando di risolvere la difficile ricerca di una identità personale e culturale, tentano altresì di venire a patti con una cultura moderna fortemente influenzata dagli accadimenti della Storia passata. Il regista di origine armena tesse una storia complessa nella quale si intrecciano i destini di due famiglie, una di origine armena e l’altra canadese. Il film è anche l’opportunità di parlare del doloroso passato del popolo armeno, che subì un vero e proprio massacro da parte dei Turchi prima, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. Una drammatica pulizia etnica che Ego- 117 Piccole conferenze per grandi incontri yan preferisce lasciar raccontare ad un alter ego d’eccezione, Charles Aznavour, che per l’occasione lascia il mondo della musica per vestire i panni di un famoso regista, Edward Saroyan, sul set di un suo film incentrato appunto sull’assedio turco di Van, dove si immagina che il pittore espressionista Arshile Gorky viva, ancora adolescente, il terribile evento. Un film nel film che a tratti perde vigore proprio a causa di questa dualità, lasciando molto spazio alle crudeli immagini dell’eccidio e solo abbozzando l’altro elemento portante della storia, il rapporto dei personaggi con la memoria e con il perdono che si sviluppa soprattutto attraverso Raffi, il giovane protagonista. Il suo racconto del viaggio alla ricerca di un paese che fu quello dei suoi antenati si indebolisce confrontandosi continuamente con le scene del genocidio raccontate dal film di Saroyan/Aznavour, senza mai giungere a contrastare la loro forza storica e ‘cinematografica’. Un film nel film dicevamo, pur non nascondendo i compromessi commerciali ai quali il regista deve far fronte (occasione per Egoyan di sottolineare ciò contro cui si è sempre opposto) esplora il più realisticamente possibile i fatti storici rispettando allo stesso tempo l’imperativo morale di ricordare il passato. Un passato che la velocità della tecnologia è riuscita a mettere da parte, lasciando che gli uomini se ne dimentichino con altrettanta rapidità. (Valeria Chiari, FilmUp) Frasi dal film “Ragazzo mio, qual è la causa ancora oggi di tutto questo dolore? Non è aver perso delle persone care, o la nostra terra... È la consapevolezza di poter essere odiati così tanto. Che razza di umanità è che ci odia fino a questo punto e con che coraggio insiste nel negare il suo odio, finendo così per farci ancora più male?” (Edward Saroyan)“Sai cosa disse Hitler ai suoi generali per convincerli che il suo piano non poteva suscitare obiezioni? Qualcuno al mondo si è accorto dello sterminio degli Armeni?” (Raffi) 118 Mayrig - Quella strada chiamata Paradiso Regia: Henri Verneuil 1991-1992 Mayrig - Quella strada chiamata Paradiso è il titolo unico con cui in Italia, nel 2003, è stata programmata la trasmissione televisiva dei due film di Henri Verneuil che recano rispettivamente il titolo di “Mayrig” e “588, rue Paradis”. Il film non è mai stato edito in Italia, nè mai più trasmesso. Trama Mayrig È l’autobiografia di Henri Verneuil, nato Achod Malakian. Il 15 marzo 1921, un diplomatico turco viene assassinato in una strada di Berlino da un giovane armeno, Tehlirian, che in tal modo intende vendicare il genocidio del suo popolo sei anni prima messo in esecuzione da parte dei Turchi. Sei anni: l’età di Azad quando sbarca sulla piattaforma della Joliette a Marsiglia con suo padre Hagop, sua madre Araxi e le ‘altre’ sue mamme, vale a dire le due zie, Anna e Gayane). Questa famiglia sradicata esplode nella gioia, assieme ai 119 Piccole conferenze per grandi incontri numerosi Armeni sbarcati a Marsiglia, quando viene a conoscenza dell’assoluzione di Tehlirian. Ora però deve affrontare le difficoltà della nuova vita: il lungo e precario alloggio (una sola stanza per cinque al 109 di via Paradiso), il razzismo di un vicino che non vuole condividere il fornello comune a tutto il piano, la ricerca di un lavoro... Hagop, armatore nel suo Paese, diventa un operaio in una raffineria di zucchero. Le tre sorelle fortunatamente trovano un lavoro a domicilio come sarte. Tutti lavorano duramente affinché Azad possa ricevere la migliore educazione al prestigioso Collège Saint-Hilaire, dove però, a dispetto dei suoi buoni risultati viene discriminato da studenti e insegnanti, tra cui l’abate Pignon, l’insegnante di catechismo. “E tu Azad di che chiesa sei?” gli chiede un compagno mentre l’abate Pignon spiega che non c’è salvezza se non nella chiesa cattolica. “Io sono di una chiesa che non parla male delle altre chiese”, risponde il ragazzo. Non sarà più ammesso alle lezioni di catechismo. Poi, grazie ad un amico, scopre il cinema e se ne innamora. Torna a casa e lo grida entusiasta ed eccitato. Padre, madre e zie si sentono morire: altre erano le speranze che riponevano su di lui. Azad coglie al volo la delusione dei suoi famigliari e si corregge. Complice il giornale appoggiato sul tavolo che in qualche modo glielo suggerisce, dichiara che in realtà vuole diventare un ingegnere! Sui volti di Mayrig, Hagop, Anna e Gayane ritorna la felicità, e subito fanno progetti e lasciano volare la fantasia. Azad, a ricompensare l’amore di cui la sua famiglia lo circonda e il duro lavoro cui essa si sottopone per permettergli di costruirsi un solido futuro, terrà fede al suo proposito... imprudente e si laureerà in ingegneria. La festa in famiglia per la laurea chiude il primo dei due film: Mayrig, Hagop e le zie regalano al figlio una Chevalier d’oro con impresse le sue iniziali. Per far ciò hanno fatto fondere gli anelli nuziali. Azad, nel pieno della commozione, non sa cosa dire. Non 120 Materiali vuole rovinare quel momento con le parole, tutte incapaci di esprimere la sua profonda felicità e la sua infinita riconoscenza. Allora prende per mano Mayrig, la trascina in strada e balla con lei un valzer alla luce della luna. Quella strada chiamata Paradiso È su questa stessa scena che comincia il secondo film: “Mi ricordo di questo ballo dei miei vent’anni, quando nel tempo di un valzer abbiamo cancellato la guerra. La luna, indifferente alle regole della sicurezza, rischiarava la città priva di illuminazione. Mi ricordo di questo pezzetto d’oro, inciso con le mie iniziali che sul dito pesa ancora tonnellate d’amore.” Azad non è diventato ingegnere di professione ma uno scrittore e regista teatrale famoso: le sue pièce sono celeberrime a Parigi. Lavora con lo pseudonimo di Pierre Zakar. È sposato, ha due bambini e una moglie che però, pianificando il suo successo, lo ha progressivamente allontanato dalla sua famiglia. Hagop, pieno di ammirazione per la posizione conquistata dal figlio, lo raggiunge a Parigi per la prima della pièce teatrale che mette in scena le loro vite in rue Paradis. Ma la moglie di Azad ne ha predisposto l’alloggio in un albergo lussuosissimo: non lo accoglie in casa sua. Comincia, da parte di Pierre Zakar, il riavvicinamento alle sue origini, al suo vero nome, alla sua vera identità, attraverso il conflitto tra le convenienze acquisite e l’intimo imperativo della riconoscenza nei confronti della famiglia. Quarant’anni prima, giunti a Marsiglia senza più patria, sradicati dalla terra in cui avevano una solida e preminente posizione, gli Zacharian trovarono alloggio in una povera casa di rue Paradis infestata dalle cimici. Ora, però, è il tempo della gratitudine; e Azad regala a Mayrig la villa dei suoi sogni più segreti, quella che da sempre ella aveva ammirato esenza osare desiderarla: 588, rue Paradis. Nota su Henri Verneuil Henri Verneuil, vero nome Achod Malakian (Tekirdağ, 15 ottobre 1920 – Parigi, 11 gennaio 2002), è stato un regista, sceneggiatore e produttore 121 Piccole conferenze per grandi incontri cinematografico francese. Nato in Turchia, a quattro anni scappò con la famiglia a Marsiglia, così come molti altri armeni costretti a fuggire negli anni venti e trenta ai massacri pianificati dal governo turco. Dopo aver studiato ingegneria ad Aix-en-Provence, si occupò di giornalismo e radio prima di debuttare nel cinema alla fine degli anni ‘40 quando fu assistente e poi regista di alcuni cortometraggi. Fu Fernandel ad offrirgli la prima possibilità confidando in lui per la realizzazione di La table aux crevés (1951) e poi de Il frutto proibito (1952). Henri Verneuil diresse di nuovo Fernandel nel 1959 ne La vacca e il prigioniero che fu il suo primo grande successo commerciale. Buone affermazioni anche con Gli amanti del Tago e con Appuntamento al chilometro 424, primo di quattro film con Jean Gabin. Il talento di Henri Verneuil si espresse soprattutto in alcune produzioni popolari. Con Quando torna l’inverno del 1962 egli riunì JeanPaul Belmondo e Jean Gabin trasformando il romanzo di Antoine Blondin in una strana epopea dove due individui rivelano le loro qualità di uomo attraverso l’alcol. Verneuil seppe coniugare abilmente due generazioni di commedie, quelle cioè dell’anteguerra con Jean Gabin e quelle degli anni sessanta con Belmondo e Delon. La sua bravura nella regia emerse nel 1969 con Il clan dei Siciliani con Jean Gabin, Alain Delon e Lino Ventura che resta uno dei più grandi successi del cinema francese. Tra gli anni settanta e ottanta Verneuil collaborò a dei film polizieschi che dettero risalto soprattutto alla figura di Jean-Paul Belmondo. Nel 1991, dopo anni di lontananza dalla macchina da presa, Henri Verneuil dette corpo ai suoi ricordi d’infanzia con i suoi ultimi due bellissimi film Mayrig e Quella strada chiamata paradiso interpretati egregiamente da Omar Sharif e Claudia Cardinale. Mayrig, che in armeno significa “madre” è una delicata poesia: un racconto intimo e accorato, una sorta di testamento spirituale che questo grande autore ci ha lasciato in eredità. Quella strada chiamata paradiso, la popolare strada di Marsiglia “Rue Paradis”, è una metafora della vita, del successo cercato e trovato attraverso il sacrificio e il lavoro. Nel suo insieme i due film rappresentano un inno alla famiglia, ispirato ad un senso radicato di appartenenza alla propria terra e alle proprie origini. Con il suo ultimo film Verneuil dimostra un grande attaccamento a tali valori, malgrado le lusinghe del successo, la fama, la popolarità, il denaro. In una sorta di compimento, non solo artistico, in cui l’uomo ritrova se stesso e riesce nell’arduo compito di dare un senso alla propria vita proprio quando questa sta per volgere alla sua fine e ce ne lascia un’indelebile testimonianza mediante la sua arte. Nel 1996 a coronamento di una carriera piena di successi gli venne consegnato un César onorario (premio alla carriera) ed entrò a far parte dell’Accademia delle Belle Arti. Morì a Parigi l’11 gennaio 2002, a 81 anni, per un attacco di cuore. [da: HENRI VERNEUIL, in: Wikipedia] 122 SOMMARIO Sommario Piccole conferenze per grandi incontri Presentazione Antonia Arslan: nota biografica 5 7 9 Avvio 11 La tragedia degli Armeni. Dal genocidio alla rinascita Che cos’è un genocidio? Una storia di famiglia Raccontare per far conoscere La perfezione del genocidio: negare che sia avvenuto Chi sono gli Armeni? Cancellare la cultura, eliminare un popolo 15 15 17 18 22 22 24 Domande Per concludere... 29 49 Materiali di approfondimento 53 L’inizio del “Grande Male” 55 di Antonia Arslan La liquidazione 61 di Franz Werfel La lettera del dottor Philobosian di Jeffrey Eugenides 69 Nei campi di sterminio 83 di Primo Levi Negazionismo 87 di Primo Levi Notte sull’aia 89 di Daniel Varujan Difendo la memoria contro i negazionisti 93 di Bernard-Henri Lévy Negazionismo. Gli assassini della memoria che cancellano l’Olocausto 101 di Bernardo Valli Lo sterminio senza fine 107 di David Bidussa Tre film La masseria delle allodole Ararat - Il monte dell’Arca Mayrig - Quella strada chiamata Paradiso 113 117 119
Scarica