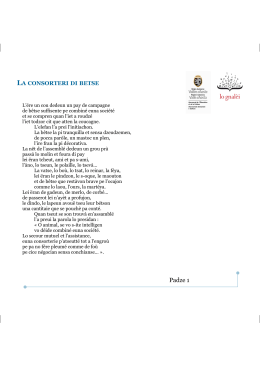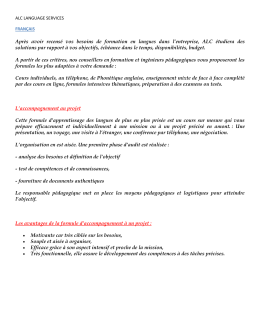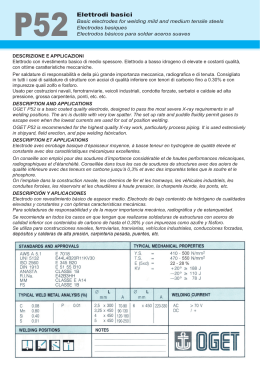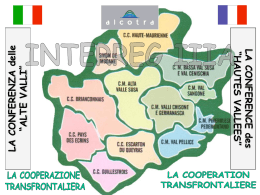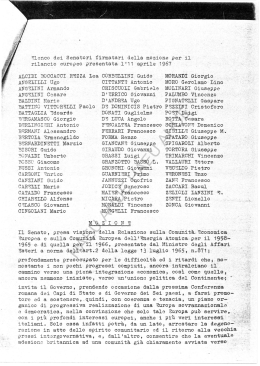Atti del convegno I curricula interculturali. Teoria e pratica per una scuola multietnica Pavia, 23-24 settembre 2010 organizzato da: Cooperativa Sociale ONLUS Progetto Con-Tatto via Porta Calcinara 11, 27100 Pavia (PV) Tel./fax 0382 301183 [email protected] www.progettocontatto.it P.I. 01873030181 con il suo Centro Interculturale La Mongolfiera con la collaborazione dell'Associazione Amici della Mongolfiera per LU.I.S. Col patrocinio di: Ministero dell'Istruzione Fondazione ISMU di Milano Comune di Pavia Provincia di Pavia Università degli studi di Pavia E con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. 1 2 PREMESSA Il concetto di interculturalità è oggi particolarmente attuale in quanto si lega naturalmente a quelli di dialogo, di pace, di convivenza possibile e si contrappone ad altri concetti altrettanto attuali, purtroppo, come scontro di civiltà, integralismo, guerre etniche, razzismo, xenofobia. Nasce di qui la necessità e l’urgenza di porre al centro dell’azione educativa il confronto tra punti di vista differenti, non solo in termini etnoculturali e linguistici, ma anche in termini politici, etici, antropologici, ideologici. Le culture non sono organiche e chiuse, ma passano attraverso processi di trasformazione e di adattamento: i concetti di “cultura” e “identità” sono concetti in divenire, non dati una volta per tutte. La realtà della società globale rende di particolare attualità l’attenzione della scuola alle tematiche connesse all’educazione interculturale. Il compito educativo, in questo tipo di società, assume il carattere specifico di mediazione fra le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli. Riflettere sulla didattica in prospettiva interculturale vuol dire riflettere sulla modalità più idonea alla trasmissione dei principi interculturali. Quindi discipline non come oggetto di studio in se stesse ma come strumenti di conoscenza sempre più raffinati, che esprimono diversi punti di vista per arrivare ad una conoscenza più adeguata e più complessa. Siamo nella fase in cui l´educazione interculturale diventa la normalità dell'educazione nelle società globali e multiculturali come la nostra. Occorre quindi uscire dalla logica italiani/stranieri perché questa logica continua ad ingabbiare i processi formativi entro una 3 falsa pista che distingue tra scuola "normale" e "scuola con alunni non italiani". Ci troviamo di fronte all'urgenza di operare per la costruzione di una nuova cultura in cui ognuno e tutti (italiani e non) possano sentirsi a casa. Una cultura plurale in cui ognuno possa nel contempo integrarsi e differenziarsi, sentirsi a casa ma anche veder rispettata la dimensione irriducibile della propria personale esperienza. Muovendo dal rispetto dell'identità culturale altrui, si passa così alla valorizzazione delle differenze e all'interazione. Anche se lo spazio per l'intercultura non è individuabile in una disciplina specifica, si rende necessario ripensare la collocazione della prospettiva interculturale all’interno dei curricoli, arricchendoli con l’integrazione di fonti, modelli culturali, punti di vista “altri”. La storia, la geografia, la letteratura, la matematica, le scienze, le arti, la musica, i nuovi linguaggi comunicativi e altri campi del sapere costituiscono altrettante occasioni di formazione alla diversità, permettendo di accostarsi non solo a diversi “contenuti”, ma anche a strutture e modi di pensare differenti. Un curriculum interculturale che sia dunque in grado di fornire abilità, conoscenze, atteggiamenti necessari ad affrontare i conflitti, a lavorare in una società plurale, ad analizzare i propri valori culturali promuovendo la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca, l’apertura verso gli altri. In questo senso, l'intercultura non è mai rinuncia, censura, negazione, ma al contrario è arricchimento di conoscenza e di saperi. Questi sono i principi su cui si fonda questo Convegno e del quale vi presentiamo gli atti. Buona lettura. Andrea Cerioli Presidente Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto 4 SALUTI DELLE AUTORITÀ 5 6 Alessandro Cattaneo Sindaco di Pavia Grazie, buongiorno a tutti. È un enorme piacere per me essere qua oggi a salutare e augurare buon lavoro a tutti gli intervenuti per diversi motivi. Innanzitutto perché mi dicono esserci moltissimi studenti, insegnanti, visitatori e persone che vengono da fuori città di Pavia, e quindi questo non può che fare piacere a un sindaco di una città come la nostra perché ancora una volta si conferma come queste occasioni sono importanti sia per i contenuti che si trattano, ma anche divengano occasione, volano per far conoscere la città fuori dai confini territoriali, e questo come amministrazione è davvero un obiettivo su cui stiamo lavorando con grande intensità. È un'iniziativa poi anche nel contenuto, nel titolo, negli argomenti trattati, nei relatori, negli organizzatori, che è stata davvero assemblata con grande attenzione e anche con uno sguardo molto molto moderno, attuale, concreto rispetto a delle tematiche che oggi sono all'ordine del giorno per la nostra società. Ringrazio quindi la Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto e il Centro Interculturale La Mongolfiera, e questa è un'iniziativa che rientra anche nelle attività di Pavia città internazionale dei saperi, per chi non lo sapesse questa è un'associazione che vede insieme il comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte proprio per promuovere una prospettiva internazionale, una prospettiva che possa ampliare gli orizzonti della città di Pavia, e quando sono venuti a chiacchierare con me nello studio di quest'iniziativa davvero l'ho trovata molto pertinente, molto attuale, e quindi per me è stato assolutamente un grande piacere poterla sostenere e poter essere qua stamattina a dare un saluto. 7 I curricula interculturali e le tematiche in generale interculturali sono davvero oggi all'ordine del giorno, soprattutto per le nuove generazioni, e permettetemi, mi metto dentro anch'io nelle nuove generazioni. Credo davvero che oggi il confronto con culture differenti, provenienti da storie, da Paesi lontani, differenti dalle proprie tradizioni, dal proprio sistema di valori sia quasi un obbligo per la nostra generazione, e credo che questo debba essere visto non come a volte capita con delle paure o come un'occasione di scontro: tutt'altro, è un'occasione di grande arricchimento. Questo davvero io lo credo, lo credo da giovane e lo credo da amante profondo dei viaggi e che vede il viaggiare come un'unica occasione di crescita e di apertura mentale, e quindi credo davvero che, ancor di più nei progetti interculturali il confronto con il diverso, il diverso inteso appunto come culture, tradizioni, sistema di valori differenti, sia e debba essere inteso assolutamente come un'occasione di crescita, questo nel rispetto reciproco, questo anche però mi piace dire non nello svilire la propria identità o la propria storia; tutt'altro; la propria identità io credo che debba sempre essere il punto di partenza e la base, ma nel reciproco confronto e dialogo allora davvero l'arricchimento riesce a essere tale, a essere profondo. L'argomento che viene trattato oggi da tanti, da tantissimi, nell'ambito politico naturalmente spesso con polemiche e toni accesi, ma anche penso per esempio a un trattato che è uscito due anni fa del cardinale Tettamanzi che aveva proprio affrontato questo tema, del dialogo e del confronto con l'altro, proprio in questi termini. Io quando mi capita di vedere degli studenti, delle persone delle scuole, di solito dico due cose; una è di vivere sempre con passione, attivamente e intensamente tutto ciò che si fa, perché credo che questo davvero per dei giovani sia un elemento fondamentale, di credere, di avere degli obiettivi, di perseguirli con tenacia, con forza, e facendo anche dei sacrifici, e non lasciarsi vivere, perché poi si perdono delle grandi occasioni, e l'altro consiglio, se posso dare dei consigli, cosa che mi viene magari difficile appunto perché più che altro parlo a coetanei, nell'affrontare i propri studi, le proprie prospettive assolutamente quello del confrontarsi con realtà diverse dalle pro8 prie è un elemento oggi imprescindibile; lo è dal punto di vista professionale, quindi andare all'estero, studiare al di fuori dei propri confini, lo è dal punto di vista personale, viaggiare, aprire la mente, sono assolutamente oggi dei punti essenziali per un giovane che vuole crescere davvero in un contesto nuovo come quello della società moderna, e davvero che sia cosmopolita e che possa essere davvero un'occasione di crescita. Pavia è una città che offre tutto questo, lo offre da tanti punti di vista soprattutto per la presenza della sua Università storica, è un grande patrimonio della nostra città, con Erasmus, corsi in inglese, scambi con studenti dell'estero, penso con la Cina in maniera crescente, tutto questo vuol dire che riusciamo in una città come Pavia che è una città forte e vuol essere sempre più di identità, dei cosiddetti sapere, riusciamo a interpretare le sfide che oggi esistono nel nostro mondo e quindi anche ad offrire occasioni di crescita, occasioni importanti per tutti i giovani della nostra città, del nostro territorio, ma non solo, anche per chi viene da fuori. Quindi, di nuovo i complimenti per il tema, sia nelle modalità con cui si è deciso di affrontarlo sia nei contenuti, che come detto trovo estremamente importanti oltre che entusiasmanti perché davvero per un giovane oggi la lettura della nostra società oggi è estremamente importante, e aver degli strumenti in più, confrontarsi, è assolutamente un elemento positivo. Quindi auguro a voi una buona giornata e certamente sono sicuro che sarà produttiva. Grazie. 9 10 Annita Daglia Assessore alla Solidarietà Sociale e Parità della Provincia di Pavia Con piacere porto i saluti della provincia che rappresento e del suo Presidente Vittorio Poma. Io credo e volevo sinteticamente dirvi quello che è il ruolo della provincia. La Provincia sta lavorando sul mondo della multiculturalità e della multietnicità sostanzialmente su tre fronti, la rilevazione dei dati, quindi avere dei dati precisi di conoscenza di quello che si muove nel territorio per poter poi sostenere o comunque privilegiare il mondo dell'associazionismo che deve dare delle risposte sostenendolo di volta in volta; facilitare e supportare il mondo della scuola , con iniziative, corsi di formazione per insegnanti, perché siano preparati ad affrontare queste tematiche che hanno molti fattori, è un problema, quello dell'immigrazione, della multietnicità, multifattoriale, non dimentichiamo che cambia di mese in mese con tematiche da affrontare che sono totalmente diverse; l'ultimo è quello di valorizzare le associazioni e le esperienze che sul territorio ci sono e si muovono senza doverci inventare nulla. Io credo che abbiamo sul territorio delle esperienze veramente significative, non a caso siamo qui oggi a questo convegno organizzato da una delle associazioni più attive sul territorio pavese; un confronto come questo non è semplice da organizzare, ma soprattutto è la sensibilità che la Cooperativa Progetto Con-Tatto ha inteso oggi dimostrare. Guardate che il titolo del convegno è un titolo apparentemente semplice, ma che ha dietro una complessità straordinaria. Allora io credo che effettivamente la presenza della scuola oggi qui sia fondamentale, fondamentale perché è dalla scuola, dai giovani che si parte davvero, cercando in qualche modo di incuriosire con iniziative i ragazzi; guai al ragazzo che non è curioso, di capi11 re quali sono differenze tra i nostri giovani, giovani che ormai si muovono nel mondo, perché la curiosità è quella che ci fa capire quali sono le differenze, e le differenze se non c'è curiosità non emergono, se non c'è conoscenza delle differenze non si possono mettere sul campo, proprio perché queste differenze diventino patrimonio di tutti, partendo sì dalle lingue, ma dalle lingue arrivare via via a tutte le altre tematiche che sono di livello culturale e artistico ecc. cercare di creare un pool di iniziative che rendono i nostri giovani curiosi di quello che si muove, che sappiano anche, partendo dalla curiosità, valorizzare le differenze, farne un patrimonio continuamente arricchito nel quotidiano, credo che sia veramente il lavoro fondamentale che le istituzioni, insieme alle istituzione scuola, devono essere in grado di portare avanti. L'ultima azione che la provincia sta facendo e la sta portando avanti davvero da anni, prima ancora che il problema della multietnicità davvero fosse così palesato, sono tutti i laboratori su legalità e multietnicità, quindi questo mix straordinario che fa sì che i nostri ragazzi vivano momenti di stage in luoghi protetti con educatori, conduttori di gruppo, dove davvero le differenze vengono valorizzate, quindi nel rispetto reciproco, nella costruzione di una cittadinanza europea, io lo dico sempre molto spesso, è fondamentale capire e conoscere le nostre culture, capire da dove veniamo. Forti di questo fatto noi dobbiamo confrontarci con gli altri. Non posso che auspicarvi che queste due giornate siano davvero di un lavoro intenso, di uno scambio di esperienze e per gli studenti che sono qui veramente di grande curiosità, che è quello che oggi ormai io credo serva al mondo giovanile. Grazie, buon lavoro e buone giornate a tutti. 12 I CURRICULA INTERCULTURALI. TEORIA E PRATICA PER UNA SCUOLA MULTIETNICA 13 14 La revisione dei curricula a prova del futuro Prof.ssa Giovanna Cipollari Ex tecnico Irre Marche e Responsabile Didattica del Settore ESCI del CVM (Centro Volontari del Mondo), Giovanna Cipollari è impegna da più di 20 anni nella Ricerca sull'Educazione Interculturale e sulla Revisione dei Testi in Chiave Interculturale. Grazie di essere qui, anche grazie ai volti che conosco tra il pubblico, perché appunto mi riconfermano che il messaggio che stiamo per dare è un messaggio molto importante oggi per la scuola italiana. La mia relazione si articola in 4 punti, il primo riguarda una riflessione sulle attuali trasformazioni, il secondo il ruolo della scuola, il terzo quali paradigmi per i nuovi curricula scolastici, e infine la ricerca-azione che stiamo portando avanti. I: LE ATTUALI TRASFORMAZIONI Oggi una qualsiasi riflessione sulla scuola non può prescindere dalle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Le innovazioni tecnologiche e scientifiche ci fanno oggi vivere in un mondo completamente diverso da quello di alcuni anni fa. Oggi diciamo venire a Pavia per me ha impiegato molto più tempo che se fossi andata a Londra, partendo da falconara; oggi è il cambiato il concetto di tempo e di spazio, oggi tutto è in profonda trasformazione. Dico questo perché, mentre questo è chiaro a tutti, in realtà la scuola a lungo è restata immobile. Sembrava poter vivere così come sempre, sì qualche ritocco, qualche riforma, ma soprattutto ri15 forme che riguardavano il passaggio da una scuola di élite a una scuola di massa, riforme potremmo dire interne allo stato italiano, mentre tutto il mondo cambiava. Poi, grazie a dio, sono arrivati gli stranieri nelle classi, e questi hanno dato uno scossone alla scuola italiana, quella scuola che oggi mantiene libri di testo, contenuti dei curricula, più o meno quelli di trent'anni fa. Oggi invece la scuola si interroga: cosa insegnare, e come insegnare, in questo scenario profondamente cambiato? L'arrivo degli stranieri rappresenta soltanto la punta di un iceberg di profonde trasformazioni, in realtà oggi è inarrestabile il flusso delle comunicazioni e delle relazioni, mai come in questo momento storico abbiamo avuto la capacità di poter comunicare con l'altra parte del mondo in tempi virtuali nell'attimo reale di un istante, oggi siamo tutti in relazione. Si è parlato prima di identità, ma in realtà oggi tutti, non solo quelli che arrivano, non solo i migranti, tutti abbiamo identità plurime, transconfinarie, perché viviamo in un luogo ma contemporaneamente diciamo siamo in relazione con altri luoghi del mondo. Oggi siamo qui in Italia, lombardi in Italia, ma siamo italiani in Europa, europei nel mondo, terrestri nell'universo. Questa è la nuova configurazione, questa è la nuova riflessione che ci anima, e allora voi capite che con la globalizzazione, al di là dei suoi vizi e delle sue virtù, è nata una nuova società fortemente interrelata, intrecciata, tanto che ciò che io faccio si ripercuote altrove, e tutto ciò che accade altrove si ripercuote qui. E questo ha reato nuove responsabilità, nuove cittadinanze. Oggi parliamo di cittadinanza del mondo proprio in virtù di questa responsabilità. In modo forse molto più autorevole dice questo anche Benjamin Barber, il quale dice: questa è l'era dell'interdipendenza. Nessuno oggi può pensare di risolvere i problemi con le forze si uno stato-nazione, o ancor peggio, con le forze di un leader, perché oggi i problemi sono di portata planetaria, il problema del cambiamento climatico, del riscaldamento della terra, il problema ecologico, il pericolo nucleare, ma al di là di questi grandi temi la stessa disoccupazione giovanile oggi ha una dimensione mondiale; il disagio, la violenza dei giovani, sono proble16 mi che non sono solo italiani, ma sono del mondo, per cui nessuno potrà mai pensare di risolverli in modo unilaterale. Qualcuno si alza e dice: io sono meglio degli altri, io ce la faccio. Oggi o ce la faremo tutti insieme o non ce la farà nessuno. Eppure, se questo è così condivisibile, è un ragionamento di senso, eppure questo sembra non avere abbastanza ascolto; Jeremy Rifkin denuncia il fallimento di Copenaghen e dice che Copenaghen è fallito perché i grandi del mondo che erano in quel vertice hanno ragionato con gli interessi dello stato-nazione, ancora si ragiona con gli schemi antichi mentali dell'illuminismo, legati all'uomo utilitarista, individualista, materialista, ancora si pensa al self-made man, all'uomo che riesce a risolvere da solo le questioni diciamo più difficili, questa è una visione anacronistica, perdente, ma questa visione così non solo la continuiamo a livello internazionale con i fallimenti che stiamo vedendo, ma perfino a livello nazionale. Lo stesso Napolitano cerca di farci capire che non si può più ragionare in termini particolaristici. Io di questo sono sempre più convinta, io problemi sono troppo oggi complessi, non ce la fa né la sinistra contro la destra né la destra contro la sinistra; qui si tratta di uscire da schemi mentali dell'800 e del 900, da schemi campanilistici, di parte, autoreferenziali; gli uni contro gli altri armati perderemo tutti, e questa è una grande responsabilità della scuola, perché dalla scuola escono le generazioni dei politici, di quelli che ci governano, e quindi quale cultura stiamo dado, per avere queste situazioni oggi? II: LA SCUOLA Oggi siamo in un momento di grande trasformazione, oggi siamo in una società complessa, oggi i problemi sono complessi e quindi nessuno può presumere di risolverli in modo autoreferenziale. Chi lo fa ragiona con gli schemi del 700 e dell'800. Si tratta di rigurgiti anacronistici, perdenti, che allungano i tempi della sofferenza. 17 La scuola cosa c'entra in tutto questo? La scuola c'entra molto, perché la scuola può essere a sostegno di una cultura ancora legata a schemi mentali obsoleti e anacronistici, in questo caso è diciamo un rimorchio della società attuale, oppure – ed è per questo che noi siamo qui stamattina, ed è questa la nostra speranza, ed è per questo che io lavoro da tanti anni – oppure può essere traino di una società, elemento di cambiamento, perché una società è violenta se violenta è la cultura, disse Girard. Se noi continuiamo a dare una cultura della violenza, della contrapposizione a scuola, non possiamo che aspettarci quello che sta accadendo, con dei grossi problemi per tutti. Allora, cosa può fare la scuola? Andiamo a vedere in modo diciamo rigoroso qual è la funzione della scuola. La scuola da sempre ha una mission, gli sono assegnati dei ragazzi e il compito della scuole è, attraverso un curriculum che va dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore e prosegue nell'università, dobbiamo dare a questi ragazzi la capacità di vivere in modo autonomo nel futuro; la scuola è sempre proiettata nel futuro, si insegna oggi per ragazzi che usciranno dalle scuole tra dieci anni, questi ragazzi di oggi dovranno sempre più vivere in una società multiculturale, multietnica e sempre più interrelata. E come li prepariamo questi ragazzi? Il veicolo, diciamo, strutturale della scuola sono i saperi. Certo, ci sono le relazioni, ci sono le emozioni ed è vero, ma i saperi non sono in conflitto con i sentimenti, i saperi sono fondamentali per sentire in un modo piuttosto che in un altro, e i saperi non sono neutrali, i saperi sono morali perché i saperi hanno delle finalità, soprattutto a scuola. I saperi da dove li prendiamo? Quelli che prendiamo dall'università sono i saperi alti, i saperi della scienza; altre volte a scuola li prendiamo anche dalle cosiddette pratiche sociali di riferimento, per esempio l'educazione stradale, che non è una scienza, nessuno di noi è laureato in educazione stradale, i saperi secondari della scuola, i saperi alti sono quelli della scienza. Ma quando noi riceviamo questi saperi nella scuola operiamo delle trasformazioni. 18 Un'azione di trasformazione è nella didattica: noi non diamo i saperi che riceviamo dall'università allo stato puro, ma operiamo una mediazione didattica e spezzettiamo il sapere a seconda dell'età dei ragazzi, a seconda delle capacità e delle loro abilità cognitive ecc ecc. e questo è un mestiere che possediamo bene e lo conosciamo. Quello di cui non ci rendiamo spesso conto è che i saperi vengono diciamo trasformati da una finalità etica, quella che chiamiamo un'attività di assolutizzazione, cioè si trasmettono i saperi secondo una finalità educativa. Chi è che in prima battuta fa questa selezione? In prima battuta questa selezione la fanno quelli che fanno i programmi, quindi il ministero, quelli che ci danno i libretti, libretto Moratti, libretto Fioroni, in primis fanno una selezione in base a una finalità etica, poi siamo noi insegnanti i secondi. Perché? Perché noi non insegniamo tutto il programma, insegniamo quello che del programma ci sembra per noi più interessante, diamo più tempo e spazio ad alcuni argomenti piuttosto che ad altri. Un'altra selezione è fatta dagli studenti stessi, i quali grazie a dio apprendono solo quello che per loro è importate. Quindi, non si insegna tutto l'italiano possibile, a scuola. Non si insegna tutta la storia possibile né tutta la matematica possibile, ma si insegna una certa matematica, una certa storia, una certa geografia, e quest'operazione di selezione non è una semplificazione ma è un'opera di trasformazione del patrimonio culturale, che viene appunto declinato dal canone. Il canone è l'unità di misura che stabilisce ciò che deve stare dentro e ciò che deve stare fuori dalla scuola. Il canone diciamo è un elemento antico, e ci fa capire bene la connessione tra antropologia ed epistemologia. L'antropologia focalizza l'attenzione sull'identità che si vuole costruire, quale uomo si vuole costruire. Una volta che si stabilisce quale cittadino, quale uomo si vuole costruire, poi io organizzo i saperi, cioè vado all'epistemologia delle discipline per far sì che quei saperi sostengano quella visione identitaria. Così è sempre stato, lo ha fatto la Chiesa per prima. Pensate cos'ha fatto la Chiesa: ci ha detto all'origine dei tempi, dei suoi tempi, ci ha detto quali vangeli 19 dovevamo leggere, cioè per essere dei buoni cristiani come la chiesa aveva deciso che noi diventassimo dovevamo leggere solo 4 vangeli, il vangelo di Luca, il vangelo di Matteo, Marco e Giovanni. Gli altri, io che vengo da una tradizione familiare religiosa li ho conosciuti da adulta, cioè esistevano i vangeli apocrifi, ma nessuno me ne ha mai parlato, perché non facevano parte della cultura che io dovevo acquisire, come cattolica, perché c'era stato un canone ben preciso, il canone dei 4 vangeli canonici. Ma la stessa cosa l'ha fatta la scuola, da sempre. Da sempre la scuola fa questo lavoro: pensate alla scuola dei gesuiti, una scuola che io comprendo attraverso il curriculum, perché per comprendere dove va una scuola io vado a leggere il curriculum. Nella scuola dei gesuiti non c'era né matematica né francese, la lingua allora parlata. Perché non le facevano? Chi andava a scuola allora? I figli dei mercanti, perché i nobili avevano il precettore, i mercanti invece andavano nei collegi dei gesuiti. E come mai questi committenti, i mercanti, mandavano i loro figli in una scuola dove non si faceva né francese né matematica? Perché allora non interessava che loro imparassero dai gesuiti il francese, che era la lingua allora parlata, quindi non c'era bisogno di andare in collegio, né interessava la matematica, perché secondo loro si apprendeva meglio in bottega, ma volevano che i loro figli studiassero la retorica, studiassero i classici, greci e latini. Perché? Perché dovevano acquistare l'arte della politica, dovevano diventare la classe borghese in grado di strappare il potere ai nobili, e quella scuola ha funzionato, da quella scuola è uscita la classe borghese, che ha tolto il potere alla nobiltà. Visto il successo di quella scuola, anche i nobili poi sono andati a scuola, abbiamo avuto la scuola dello stato assoluto, che ha creato cittadini sudditi, e poi è arrivato lo stato nazionale. E noi nello stato nazionale che cosa abbiamo fatto? Abbiamo risposto a quello che chiedeva D'Azeglio: fatta l'Italia, occorreva fare gli italiani, ed era giusto, e allora è stato affidato a De Sanctis il compito di entrare nella scuola a fare una programmazione per far sì che quelli che frequentavano quella scuola si sentissero cittadini dello stato italiano; la prima legge dello stato italiano è stata la legge Casati. 20 Tutti a scuola per imparare a diventare italiani, e De Sanctis è stato abilissimo a farlo, oggi manca De Sanctis in Italia. Perché De Sanctis ha detto: quali sono i bisogni di questa generazione? Devono diventare italiani? Allora facciamo una letteratura che li faccia diventare italiani. E allora non a caso la prima corona è stata Dante; nato in un 'epoca in cui lui credeva o all'impero o al municipio, e invece è diventato il primo scrittore della letteratura italiana, perché aveva scritto delle cose che importavano molto nell'800, raccordo tra ara ed altare. Secondo, Petrarca, cosmopolita, nato ad Arquà. È utile, ha fatto la canzone all'Italia, e quando andiamo a scegliere il romanzo che cosa facciamo? Prendiamo il romanzo storico, i promessi sposi, perché questi devono imparare ad odiare gli spagnoli per odiare gli austriaci – giustamente De Sanctis ha scelto un romanzo risorgimentale, perché Manzoni l'ha sempre detto, quello era un romanzo di Risorgimento italiano. E allora vedete che anche nella scuola c'è stato sempre un canone che ha selezionato i saperi a seconda dei fini, un rapporto stretto fra antropologia ed epistemologia. A scuola si crea un'identità. Ora, fino a ieri che cosa doveva costruire la scuola italiana? L'identità nazionale, e questo era profondamente giusto, è la scuola dell'800 e del 900, la scuola in cui tutto collimava, perché dovevamo formarci a diventare italiani, c'era l'esaltazione dell'uomo stanziale in quel momento storico – io in tutta la mia carriera scolastica ho sempre sentito parlare male dei nomadi, perché si esaltava sempre la cultura della civiltà stanziale, e a questo hanno piegato anche la storia, tant'è vero che ci hanno fatto credere che prima c'erano i pastori, nomadi, e poi gli agricoltori, stanziali, ma non è così, ma doveva essere piegato al ragionamento che dopo viene il meglio, e il meglio è l'uomo stanziale, è quello appunto della società che ha dei rigidi confini, com'è stata quella dell'800 e del '900, è la società industriale, del taylorismo, la società che ha esaltato il positivismo, la scienza, che è stata importantissima ma è stata slegata dall'etica, una scienza che nella scuola ha portato al pensiero lineare, sequenziale, il pensiero del positivismo, noi siamo stati abituati a ragionare in modo lineare, sequenziale, meccanicistico, secondo uno schema 21 che oggi è estremamente riduttivo per comprendere la complessità. Questo schema non ci aiuta a capire la complessità. Questo è stato il modo di procedere nella scuola ieri. Purtroppo lo è anche oggi. Ma oggi tutti capiscono che la mission della scuola non è quella di formare un cittadino nazionale, quanto piuttosto un cittadino europeo, noi diremo ancora di più, cosmopolita. Allora voi capite che cambia lo scenario, oggi al centro dell'attenzione c'è l'homo migrans, perché migranti ci siamo tutti, migranti non sono solo quelli che stanno arrivando, ma noi siamo migranti, siamo migranti perché i nostri figli studiano all'estero, fanno l'Erasmus, perché noi abbiamo praticamente ormai contatti con tutto il mondo, e anche chi non si muove, va in internet, chatta, e ormai è appunto in relazione con tutti, quindi siamo tutti migranti. Oggi il paradigma di riferimento non è più l'uomo stanziale, ma è l'uomo migrans, e anche qui bisogna stare attenti a scuola, non considerare il migrante come un'espressione patologica, perché qui migranti ci stiamo diventando tutti, la nuova era è dell'uomo migrans, e se continuiamo a presentare la migrazione come una patologia rendiamo infelici tutti, anche i nostri figli, che invece andranno a lavorare nel sud est asiatico molto probabilmente e ci porteranno a casa un bimbo meticcio. È cambiata la società, è cambiato il mondo, e allora anche il pensiero sta cambiando. III – I FERRI DEL MESTIERE A questo punto dobbiamo entrare nei ferri del mestiere. Io parlo agli insegnanti e chiedo: con quali saperi lavorate a scuola? Con quale concetto di cultura, di popolo, di uomo lavorate a scuola? Perché questo è l'interrogativo di fondo. Perché se voi non mettete in crisi il concetto, il sapere che state usando, forse voi siete tra quelli che appunto stanno ancora ragionando con schemi mentali ormai obsoleti. Io vi posso dire che nei libri di testo il concetto di popolo è ancora un concetto legato alla cultura del positivismo, una cultura ormai superata, anacronistica, non in grado di affrontare la complessità. 22 Nei libri di testo il popolo è dato da coloro che hanno la stessa lingua, la stessa cultura, la stessa religione e abitano nello stesso territorio. Ora, tutto questo fa nascere un conflitto tra quelli che hanno queste caratteristiche e quelli che, pur abitando da noi, non hanno queste caratteristiche. Allora bisogna riflettere: questo concetto di popolo è un concetto assoluto, oppure è un concetto relativo? Quand'è nato questo concetto di popolo? È sempre stato così? No, questo concetto di popolo è nato nell'800, Manzoni fa fede, marzo 2821, una d'ara di core d'altare, e così è nato il concetto di popolo, in quel momento storico c'era quel bisogno, e nessuno giudica il passato alla luce del presente, era giusto in quel momento quel concetto, ma era un concetto nato in quel momento storico; nel passato abbiamo avuto altri concetti di popolo. Pensate ai Franchi: sono stati un popolo ma alcuni di loro parlavano lingua todisca e alcuni altri lingua latina, perché loro si sono formati tramite un contratto. Pensate a come ha formato la cittadinanza Caracalla. E allora cos'è più giusto dire ai ragazzi? Che i saperi vanno rivisti, che i saperi non sono dei concetti assoluti, delle certezze, ma vanno rivisti a seconda del momento storico. Oggi questo concetto di popolo fa il cittadino d'Europa fa il cittadino del mondo? Oppure separa e divide? Questo concetto di popolo aiuta a formare una cittadinanza responsabile del bene comune, che è la terra patria, oppure ci divide e ci separa? Su questo dobbiamo meditare: quali concetti stiamo usando? E siccome esiste una stretta connessione fra antropologia ed epistemologia, i saperi sostengono un'identità o un'altra, è chiaro che in questo momento sono in crisi i saperi che fino a ieri erano quelli dei nostri libri di testo – e che purtroppo lo sono ancora oggi – i saperi frammentari, i saperi che ci dividono, in contrapposizione uomo/donna, amico/nemico, cittadino/straniero, sono saperi con i quali non possiamo affrontare la società della complessità. I nuovi saperi devono essere saperi dialogici, saperi dell'empatia, saperi della corresponsabilità, per cui ogni insegnante deve chiedersi: quale sapere sto usando? Quand'è nato questo sapere? Perché di questo 23 noi siamo padroni, gli insegnanti non sono degli esecutivi, sono dei professionisti della scuola, sono degli intellettuali, e hanno un'etica da seguire. Allora su questo filone bisogna interrogarsi: io domani vado a scuola, e quale concetto di popolo do ai miei ragazzi, quale concetto di stato? Ancora nei libri c'è scritto che lo stato è sovrano, ma non ci siamo accorti che le cose sono cambiate? Avevamo la polarità degli ordinamenti nel medioevo, impero e chiesa, poi c'è stato lo stato moderno che praticamente ha portato allo stato assoluto e allo stato nazionale, oggi siamo tornati a una pluralità di ordinamenti, tant'è vero che l'Europa tutte le sere redarguisce l'Italia. Perché lo può fare? Perché l'Italia non è più uno stato sovrano come noi intendiamo, e allora noi continuiamo a dire ai ragazzi che lo stato è sovrano, perché così ci dicono i libri di testo, e purtroppo c'è un problema in cui il serpente si mangia la coda: gli insegnanti sono abituati a questo sapere, e quindi comprano questi libri di testo; quando escono libri nuovi non ci si ritrovano. La colpa non la do agli insegnanti, ma la do a un ministero che non si è fatto carico di un aggiornamento e formazione degli insegnanti in un momento di grande cambiamento. Noi abbiamo bisogno di interrogarci, tutte le discipline vanno storicizzate e riviste alla luce anche dei profondi cambiamenti epocali, com'è sempre stato, quando dal medioevo si è passato all'umanesimo, quando dall'età moderna, come oggi, si sta passando all'età postmoderna, perché questa è un'età postmoderna, non è più l'età di ieri, oggi è il mondo della complessità, questo. Allora, un'analisi dei propri saperi. Tutti devono storicizzare i loro saperi, e capire con quei saperi dove andranno? Se io do quel concetto di stato, se io do quel concetto di popolo, che effetto avrò su quel soggetto? Allora, noi abbiamo bisogno di nuovi paradigmi; Morin, grande maestro, è da anni che dice che bisogna passare dal paradigma della disgiunzione al paradigma della congiunzione ; in quest'età nuova, nel terzo millennio ci salveremo tutti insieme o non si salverà nessuno. La nuova riflessione è sulla relazione, sulla connessione, sull'interdipendenza, sull'interconnessione, sulle reti, questo lo sappiamo 24 perché tutti i gironi ci dicono fate rete, anche a scuola, e allora i nuovi saperi devono sostenere questa nuova mens e formazione mentale. E dunque io insegnante mi devo chiedere: quali saperi sto giocando? Se presento, come avviene oggi in storia, prima un popolo poi l'altro, prima Atene e poi Roma, io sono nel vecchio cliché, nel pensiero lineare, di marca positivista, e con questo posso far capire molto poco ai ragazzi che hanno invece una lettura cronospaziale, io devo far capire che Atene, Roma, Cartagine, sono contemporanee, che non è vero che prima c'è stato l'uomo che si è arrampicato sull'albero e poi c'è stato quello erectus, abilis, uno dietro l'altro, ma hanno vissuto contemporaneamente, mentre i libri di testo continuano a presentare l'evoluzione lineare, poi se continuo ancora a lavorare, come invitano i libri di testo, a focalizzare l'attenzione magari sul Mediterraneo e sull'Europa, non cogliendo le interdipendenze, il Mediterraneo fa parte di un oceano, minimo minimo, e cos'è successo in quest'oceano mentre si operava in un certo modo nel Mediterraneo? A me han fatto studiare l'impero romano, sembrava che fosse Roma caput mundi che ci fosse solo l'impero romano, ma mi sembra che le cose non siano molto variate. Facevamo magari il ciclo dell'acqua ma mai messo in collegamento con l'inquinamento. Anche oggi si studia l'apparato respiratorio staccato da quello circolatorio e da quello digerente. Per cui questi figlioli come faranno a capirci qualcosa? Non si sa, siccome poi quando fanno il viaggio di una caramella vedono che la caramella va in tutti gli apparati. Chiedono le competenze, in Europa, ma cosa vuol dire chiedere le competenze? Appunto uscire da queste visioni settoriali, saper fare gli agganci, le interdipendenze, la relazione, questa che a scuola non si fa perché a scuola abbiamo capitoli separati, addirittura il calcolo prima della geometria, così da non far capire niente a nessuno; perché io calcolo perché devo misurare, e invece comincio col calcolo mnemonico senza far capire e dar motivazioni a questo ragazzo, che mi calcola perché c'è uno spazio. Separiamo aritmetica da geometria... 25 Noi siamo intellettuali e professionisti, se voi ci credete come ci credo io io penso che l'attuale società ha bisogno di un grosso cambiamento, ma questo cambiamento passa solo attraverso la cultura, e noi siamo i responsabili della vera cultura in Italia, questo lo dobbiamo percepire veramente come una qualità deontologica, non siamo esecutivi, siamo intellettuali responsabili. Nuovi paradigmi, quelli della congiunzione, una nuova etica, i saperi li selezioniamo in base a una nuova etica: certo, non posso insegnare tutto lo scibile a scuola, ma quando vado a selezionare devo sapere verso dove vado a selezionare, qual è la linea per cui seleziono. E allora? Allora noi dobbiamo selezionare verso una nuova etica, che è quella della coscienza cosmica. Questi ragazzi devono far fronte a problemi dell'universo, oggi. La coscienza della biosfera, dice sempre Rifkin: oggi dobbiamo sentirci parte dell'universo e sappiamo che esiste una relazione tra l'universo e l'uomo come tra l'uomo e l'universo, ce l'ha detto ce l'hanno detto in tanti, soprattutto viene dalla scienza, dalla fisica, questa nuova visione del mondo, quest'interrelazione, e la coscienza cosmica comprende sia quella planetaria sia quella di specie, spostando la visione autoreferenziale che ancora noi usiamo nelle nostre scuole. Non io e gli altri, ma gli altri e io. Prima il cosmo, e nel cosmo ci sono anch'io: io da solo sono autoreferenziale. Io sono nel cosmo, e se non dico che io sono subito nel cosmo, io rischio di andar dietro a me stessa senza aver capito niente. Cosmo ed io, mondo ed io, natura ed io, gli altri ed io, è un'inversione di ottica, dal NEM dice GNISCI, al MEN, dalla visione nazionale-europea-mondiale a quella mondiale-europea-nazionale intrecciando l'una con l'altra, e non in modo lineare e separato. IV – QUALI PARADIGMI PER I NUOVI CURRICULA? Allora i valori, i saperi, tutti i saperi, matematica, scienze, geografia, devono confrontarsi con i valori della mutualità, della creatività, della corresponsabilità, della coevoluzione, della creolizzazione, 26 della decrescita, problemi importanti per questi ragazzi che hanno tutti i problemi che Copenaghen non ha risolto, e li risolveranno solo se avranno una nuova formazione. Ecco all'ultima parte del mio intervento: le trasformazioni, il ruolo della scuola, quali paradigmi per i nuovi curricula? A questo punto cosa stiamo facendo, noi è da anni che abbiamo messo in piedi nelle Marche una ricerca-azione: abbiamo lavorato tre anni col prof Portera dell'Università di Verona per fare una ricerca e vedere se effettivamente ancora la cultura del positivismo era predominante nei libri di testo, e abbiamo visto che la cultura del positivismo è dominante nei libri di testo della scuola italiana. Poi abbiamo lavorato sulle discipline e sui curricula, in rete con i ricercatori secondo noi più innovativi in Italia – lavoriamo sulla storia col professor Brusa di Bari, per italiano col professor Armando Gnisci di Roma, per diritto col professor Mancini di Macerata e con il professor Pasquino di Bologna, per geografia con la professoressa Katia Brunelli di Urbino, per matematica col professor Favilli di Pisa. Questi sono i ricercatori universitari: non direi le università: le università sono ancora statiche come la scuola, e questo è un grosso problema, perché se quelli che vanno all'università hanno ancora docenti pur sapienti ma che non sono aggiornati a livello di ricerca scientifica mondiale, noi non abbiamo gente preparata che va nelle scuole e quindi il problema vuol dire che si proietta ancora a tempi lunghi. Allora, noi facciamo seminari, andiamo nelle scuole, portiamo il professore universitario che ci dice le innovazioni anche perché gira il mondo – perché a differenza degli insegnanti il ricercatore universitario va anche in altri Paesi, e quindi è in grado di darci i risultati anche di una riflessione mondiale – ai nostri insegnanti e una volta che loro hanno dato questi input, c'è un gruppo di formatori che assiste gli insegnanti nella programmazione, e poi si va in contesto d'aula, cioè si prova la proposta con i ragazzi, in classe, si documenta il tutto e si porta i risultati documentati in un seminario nazionale, quello di Senigallia. Cosa chiediamo ai ricercatori? Noi chiediamo reading, testi antologici, materiali didattici per sostenere l'innovazione. Poi è una ri27 cerca che si è coevoluta: all'inizio eravamo io e il prof Damiano, poi sono andata nelle Marche e l'ho diffusa, poi nel tempo si è allargata e si è approfondita, grazie a un cammino fatto insieme con i professori universitari, quindi è un cammino in itinere, un cammino che si va facendo. Cerchiamo di formare un comitato scientifico di ricercatori, che possa sostenere questa ricerca e diffonderla a livello nazionale, perché le Marche da sole non hanno senso, il nostro gruppo sta lavorando anche in Piemonte, in Lombardia, in Sardegna, diciamo, sta lavorando un po' in tutta Italia, però occorrerà sempre di più ampliare la rete dei formatori, per questo sono molto contenta di essere oggi qui, e vogliamo che la proposta possa avere anche eco a livello europeo e internazionale. 28 Le parole pericolose. I concetti che servono per leggere la storia e costruire l'intercultura Antonio Brusa Antonio Brusa è docente di Didattica della Storia presso il Dipartimento di scienze storiche e sociali dell’Università di Bari, dove svolge la sua attività di Ricercatore (professore aggregato). Collabora con il C.I.D.I. (Centro Iniziativa Democratica Italiana) e il LANDIS (Laboratorio Nazionale Didattica della Storia). Fino al 2009 ha insegnato Didattica della Storia presso la scuola di Specializzazione all'insegnamento di Pavia (Silsis-Lombardia: tutti i cicli). Si occupa dell’organizzazione della sezione didattica nel CRIAT (Bari, 2008). Ha progettato e diretto il corso di Perfezionamento in Didattica del Territorio (Bari), e i corsi di Perfezionamento in Didattica della Storia e di Tecniche di insegnamento della storia (Bari: 1990-2000). Ha insegnato Didattica della storia in diversi cicli, presso la Ssis-Puglia, e tiene annualmente corsi all’Iufms di Ginevra.. Ha coordinato il progetto Comenius2 TEC (Tools of European Citizenship) e ha collabora con diversi progetti Erasmus e Comenius (Sull’integrazione fra storia e geografia, sui nuovi strumenti per l'Insegnamento della storia; sullo studio della storia africana, sulla cittadinanza europea, sull’integrazione di ragazzi emigrati e difficili). Attualmente partecipa al progetto “Eduquer par la diversité” (Parigi 2007, in corso) e la progetto Histoire au présent, coordinato dall’Università di Montpellier e, per l’Italia, ai progetti di ricerca cofinanziati, diretti da Biagio Salvemini. Ha coordinato il settore storico didattico per il Centro PedagogicoDidattico di Berna, fra il 1985 e il 1990. Ha partecipato a numerosissimi convegni di didattica della storia, in Italia e all’estero, e, fra le tantissime, ha svolto la relazione su Storia mondiale e locale al XVIII Convegno Internazionale di Scienze Storiche di Montréal (CISH: 1995). Ha fatto parte delle Commissioni ministeriali Brocca, De Mauro e Ceruti, per la riforma dei programmi di storia per la scuola di base e superiore. Fa parte dell’Osservatorio Nazionale sull’Intercultura. Insieme con Luciana Bresil ha pubblicato Laboratorio con le Edizioni Scolastiche 29 Bruno Mondadori. Presso il suo Istituto si gioca per imparare a insegnare storia. È’ presidente onorario di Historia Ludens, associazione che si occupa di didattica ludica e laboratoriale. Ha tenuto numerosissimi corsi nelle scuole italiane ed estere, sull’insegnamento della storia. Ha fondato e co-diretto “Quaderni Medievali” (1975-1980), per le edizioni Dedalo, Bari; “I Viaggi di Erodoto”, per le edizioni Bruno Mondatori, Milano. Dirige, insieme con Arnaldo Cecchini, la collana “P come Gioco!, della casa editrice La Meridiana, specializzata in Didattica Ludica, e fa parte del comitato scientifico di diverse riviste didattiche, fra le quali “Didactica de las Ciencias sociales y experimentales” (Università di Valencia), “Le cartable de Clio” (Università di Ginevra), “Historiens et Géographes” (Paris). Ha fondato e dirige la rivista di didattica storica “Mundus”, edizioni Palumbo. Le sue pubblicazioni (fra manuali, libri e articoli) di didattica della storia sono in italiano, francese, spagnolo e tedesco. Dirige la collana “III Millennio”, specializzata nella pubblicazione di opere didattiche innovative, presso le edizioni Palumbo (Palermo-Firenze). Nel mio intervento ci occuperemo di un campo specifico: le parole che riguardano la storia. Queste parole hanno un effetto particolare, da una parte sono delle specie di binari mentali per il professore che le ha elaborate, le ha metabolizzate e lo guidano nell'azione, fa delle cose, non sa perché e pensa di saperlo, in realtà sono queste grosse parole che sono state introiettate che gli dicono: domani devi spiegare questo, dopo domani devi spiegare quest'altro ecc ecc. Queste parole sono molto potenti, perché ci fanno vedere il mondo, ce lo trasformano, averle dentro nella propria testa ci fa vedere il mondo in un modo piuttosto che in un altro, e poi hanno un potere straordinario: quando cominci a discutere dei problemi che mi interessano, su cui noi ci accapigliamo a volte fra gente che la pensa in un modo o nell'altro, predeterminano il discorso, è come se dessero sempre in principio ragione a uno piuttosto che a un altro. Questa è la prima di queste parole che ha questo potere: indirizzare il lavoro del docente, farci vedere il mondo in un certo mondo e poi, se l'hai assunta, dare ragione a uno piuttosto che a un altro. Se io adotto questa parola per me tutta la storia è una successione di popoli, tutto il manuale è il popolo a, poi il popolo b, poi il popolo c, il programma che cos'è? È un numero x di popoli, questi popoli ven30 gono per un certo periodo in successione, poi a partire dal '500 li vedo più o meno insieme: la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, però mi danno sia l'organizzazione del tempo sia l'organizzazione dello spazio; il tempo è visto come una successione di popoli, lo spazio è visto come un mosaico di popoli. E sono parole talmente potenti che quando io parlo d'intercultura – e parlo anche d'intercultura con i ragazzi – mi sembra certe volte nella discussione di trovare il ministro degli Esteri di una nazione che parla col ministro degli Esteri di un'altra nazione e non con il ragazzino a che parla con il ragazzino b, tant'è che noi abbiamo reintrodotto involontariamente all'interno della discussione interculturale, che dovrebbe riguardare dei bambini, dei ragazzi che stanno in classe, quindi delle persone vive, il lessico della diplomazia. La negoziazione, i conflitti. Sembrano due cancellerie, due ministeri degli esteri, e invece sono solo dei bambini, dei ragazzi. Ma vediamole, e parliamo di fatti, ragioniamo sui fatti, ragioniamo sulle cose e da queste cose cerchiamo di ricavare alcune considerazioni che non riguardino soltanto il medioevo ma riguardino anche la nostra età. POPOLO Walter Paul, medievista massimo esponente della Scuola di Vienna, dice che noi storici abbiamo una grande responsabilità, abbiamo usato a cuor leggero uno dei concetti che oggi diventa più caldi nella discussione mondiale, 7 miliardi di persone si accapigliano anche perché noi non sappiamo bene cosa voglia dire popolo, o meglio, noi pensiamo che popolo voglia dire “una serie di persone”, un po' come noi, noi parliamo in italiano in questo momento, siamo italiani. Basta però che venga uno da Lugano e dice: io parlo italiano ma non sono italiano, io sono svizzero. Questa cosa però ce la tiriamo appresso, per cui la differenza la misuriamo sul fatto che uno ha una religione diversa, una lingua diversa... 31 Sappiamo che questo concetto nasce nell'800. Attenzione, non è che nasce perché le cose esistevano e quindi finalmente si sono accorti che c'erano i popoli: nasce perché vengono creati i popoli, cioè il modo con il quale le persone stavano insieme prima dell'800 e in altre parti che non fosse l'Europa dell'800 non era il modo di stare insieme definito dagli stati europei, dalle comunità nazione dell'800, cioè la gente stava insieme anche se aveva lingue diverse, se aveva religioni diverse, costumi diversi e cose di questo genere, sono molti i modi che fanno sì che degli uomini e delle donne decidano di passare la vita insieme, di affrontare i pericoli insieme, non solo quel modo che è stato individuato nel'800. Ora, la cosa curiosa è questa: che quando noi andiamo a studiare il passato, a un certo momento troviamo questi popoli. Gli Etruschi: uno prima trovava tante ossa diverse, tanti cocci fatti in un certo modo, a un certo punto trova dei cocci fatti tutti col buco: sono arrivati gli Etruschi. O meglio, siccome compaiono all'improvviso. Se ci riflettete non c'è nessuno nei nostri manuali che stava lì, tutti veniamo da qualche altra parte. Gli indoeuropei stavano da un'altra parte, gli Etruschi stavano in Turchia, i Messapi, i Peuceti, i Piceni, ecc, tutti vengono da qualche parte, arrivano e li troviamo. Sapete perché c'è questa idea? Perché non si ammette che i popoli si creino, si trasformino, e quindi si devono essere formati, già bell'e fatti, da un'altra parte, arrivano qui e siccome – ecco la cosa fondamentale dell'etnoarcheologia dell'800 – i popoli esistono solo perché c'è una certa cultura e si farebbero uccidere in nome di una cultura, alcuni dicevano: quando c'è il cambiamento di un rito di sepoltura, allora è cambiato un popolo, perché uno si fa uccidere piuttosto che rinunciare al modo di seppellire i propri genitori, e invece quelli cambiavano, cambiavano. Quello che sappiamo oggi è che è vero che la gente è venuta, si sono mescolati, ecc, ma gli Etruschi erano quelli di prima che a un certo momento si sono cambiati, e noi li chiamiamo Etruschi, ma non è che prima non fossero un popolo e poi sono diventati un popolo, supponiamo che gli Etruschi compaiano nell'VIII secolo, andia- 32 mo un secolo prima e troviamo della gente che dica: noi saremo Etruschi... non sappiamo che cosa siamo, saremo etruschi. Qualche cosa sono stati, siamo noi che andiamo lì e diciamo: questa facies, dicono gli archeologi, è la facies etrusca, è la facies picena, ecc ecc. Ora, tutti questi ragionamenti di metodologia, di epistemologia, vanno a finire nei racconti che troviamo nei manuali, cioè il fatto che noi troviamo gli Indoeuropei che arrivano nel 2000 e popolano questa parte dell'antico continente, perciò tutti parlano lingue, secondo il famoso schema con mater mother mutter ecc, che dicono che tutti noi veniamo da un'unica origine perché parliamo la stessa lingua di base. Un altro esempio è quello relativo al popolamento dell'Italia: il popolamento dell'Italia è fatto da tante tribù che arrivano; la conquista di Roma. E qui entriamo in una serie di argomenti che parlando di qualche cosa che è avvenuta 3000 anni fa: Roma si impadronisce dei popoli italiani, elimina loro le libertà e costruisce una cosa che si chiama Italia togliendo autonomia e libertà a quelli che erano gli abitanti del posto. Sto parlando di un discorso di 3000 anni fa o di un discorso che si sente oggi? Questo modo di pensare la storia genera un racconto che non è mai esistito. Se noi andiamo a vedere come gli storici ricostruiscono quel periodo, non è vero che il popolo romano si impadronisce dei popoli, nel senso che i popoli si sono costruiti, non è che i Romani attaccano i Piceni: Piceni e Romani si sono formati insieme e spesso si sono formati lottando l'uno contro l'altro, era un insieme di persone. Succede così: le persone si mettono insieme, si costruiscono, si inventano dei nomi, e con i nomi si inventano un'antichità. E lo stesso discorso vale per le cosiddette invasioni barbariche. Cosa dicono Paul e la nutrita schiera che prima lavorava a Vienna e adesso ormai lavora in tutto il mondo, e che quindi ci dà una versione della storia che è quella che noi dobbiamo accettare in questo momento, perché è il livello attuale delle ricerche? Ci dice, attenzione: quando voi trovate “Goto” state attenti, non era il popolo Goto, Goto sì forse sarà stato qualcuno, però a un certo punto il ter33 mine passa da nome proprio a nome comune del “guerriero coraggioso”. Quindi tutti quelli che entravano nell'Impero romano per farsi assumere nell'esercito – pratica molto ambita da quelli che stavano dall'altra parte –, dicevano agli ufficiali dell'esercito romano di essere “un Goto”. E loro li prendevano subito. Faccio un altro esempio: gli Unni. Le fonti ci dicono che gli Unni erano brutti bassi cattivi, e via dicendo. Bene, “Unno” è il termine generico che significa “guerriero piuttosto cattivo”. Immaginiamoci alcuni guerrieri che mettano insieme una banda e che vogliano darsi un nome: noi chi siamo? Quelli cattivi, quelli tosti. Come ci chiamiamo? Unni. Ed è il motivo per cui voi trovate, fra il 429 e il 450, nello spazio di 15 anni, gli Unni contro i Cinesi, contro gli Indiani, e poi fino in Italia contro i Romani. Ma come facevano a spostarsi? La soluzione che noi diamo è che erano tanti, diversi, e si chiamavano tutti Unni. E molti nomi li rubavano. C'era un popolo che si chiamava – un popolo, o meglio, un insieme di tribù – che si chiamavano Magiari. Magiari vuol dire spazi aperti. Come ti chiami? Spazio aperto. Non fai paura a nessuno. Vicino c'era una tribù di Turchi temutissimi da tutti, e allora questi qua che fanno? Gli rubano il nome. E così Franchi, Longobardi, e così via, si inventano nomi, sono gruppi di persone dall'origine etnica a volte misteriosa, vengono da tutte le parti del mondo. Tra i Longobardi ci sono Goti, ci sono Bavari, ci sono Avari, ci sono pure Unni, Mongoli, e poi c'è una quantità enorme di Latini, cioè gente del posto, che quando passa il Longobardo si unisce, e dopo un po' diventa longobardo pure lui. Arrivano centomila persone: come si fa a capire qual è il famoso sangue longobardo se erano tanti, come tanti e diversi erano quelli che stavano lì? RADICI, ORIGINI, IDENTITÀ, APPARTENENZA Ora, questo modo di vedere che tocca gli aspetti etnici costitutivi della nostra nazione e mette in crisi alcune delle parole chiave del nostro discorso storico politico di educazione civile. Radici, origini, 34 identità, appartenenza. Un conto è pensare che noi siamo i discendenti di un popolo determinato e quindi la nostra identità è una e determinata; altra cosa è sapere che non c'è nessuno al mondo che possa dire il mio popolo 20 anni fa era uguale al popolo di oggi, e ancor meno 100 anni fa, o noi siamo i discendenti del popolo X, i cromosomi che abbiamo nel sangue derivano direttamente dal passato. Le radici? Assomigliano a quelle che si ramificano nel passato e arrivano nei posti più impensabili. Le origini, questo mito di arrivare al luogo della purezza da dove nasciamo tutti, poi denaturati, rovinati col corso delle cose... le origini non ci sono. Marc Bloch lo diceva: le origini sono il mito degli storici, assomigliano alla favola della base dell'arcobaleno, con la pignatta d'oro che si cerca invano, perché ogni volta si sposta. Quali sono le origini della gente che stava qui? È sempre un'origine molto composta, lo specchio della complessità di oggi, non c'è mai una semplicità. E poi: identità e appartenenza. A che cosa, a quali dei numerosi cromosomi che compongono la mia base biologica, se vogliamo dire così, a quale dei numerosi cromosomi che compongono la mia base culturale? C'è un racconto fondamentale che si ricava da questa visione sbagliata del mondo, di questa ricerca di un'unica appartenenze e di un'unica origine, ed è il racconto che noi apprendiamo quale che sia la storia che abbiamo studiato. Chi esce da questo sistema di formazione crede che noi siamo i discendenti di un popolo di origini antichissime, perché se no non nobili, se non antichissime, siamo tenuti a difendere le nostre radici, a preservare la purezza della nostra identità: noi esistiamo perché apparteniamo a un popolo. Così pensano quelli che si dicono italiani, padani, pavesi, sardi, lo stesso quelli che si dicono congolesi, americani, e così via. Ma questo discorso è privo di base scientifica. E dirlo a tutti è un dovere dello storico. Dal punto di vista storico c'è il difetto dell'essenzializzazione, che vuol dire semplicemente una cosa: gli storici usano “radici”, usano “popolo”, ma perché devono lavorarci, per 35 praticità, ma quando si dice “la cultura greca” e “la cultura latina”, nessuno di noi storici ha mai immaginato che ci fosse un confine con una barriera fra la cultura greca e la cultura latina: lo facciamo perché uno deve scrivere un libro di greco e un altro deve scrivere un libro di latino. Essenzializzazione vuol dire trasformare in un oggetto reale quello che invece è una fictio, una comodità di studio. “Popolo” è una personificazione: immaginare il popolo come una persona e uno soltanto, ma infine allude a conoscenze erronee, sbagliate. Qui veniamo a toccare uno dei punti fondamentali della deontologia scolastica: non si può insegnare cose sbagliate; si può essere un insegnante di avanguardia oppure un insegnante tradizionale, di destra o di sinistra, ma a nessuno è concesso insegnare cose sbagliate, esattamente come a un medico non è concesso di dare medicine scadute o sbagliate. PATRIMONIO, TRADIZIONE, MEMORIA COLLETTIVA Veniamo a un'altra parola, patrimonio. Un'altra di quelle parole pericolose che voglio portare alla vostra attenzione. Che cos'é il patrimonio? È la nostra ricchezza fondamentale: le arti, le credenze, tutto ciò che noi abbiamo, non solo gli oggetti fisici, ma anche gli oggetti immateriali, per esempio le abitudini, le feste, quello che abbiamo in testa e ci è stato tramandato dagli avi: ecco il nostro patrimonio. Questo patrimonio genera anche questo un racconto fondamentale: il patrimonio è la ricchezza che i nostri antenati ci hanno lasciato, è la nostra proprietà, l'insieme dei beni culturali, ambientali e artistici. Il patrimonio è ciò che ci differenzia dagli altri, noi per quanto ci riguarda siamo i beneficiari di questa ricchezza: un racconto che impariamo noi italiani, ma anche i francesi, gli inglesi, e tutti, quale che sia la storia, la geografia, la storia dell'arte che si apprendono. E a questo patrimonio sono legate tante altre parole che usiamo. “Tradizione”: la tradizione, le tradizioni locali, ecc. “Canone”, “cultu36 ra”, e infine “memoria collettiva”. Concetti che, a differenza di quelli di prima, sono molto legati allo spazio, perché il mio patrimonio è – possiamo dire – il mio paesaggio, il patrimonio si trova nei musei, nelle biblioteche, negli archivi, e infine, il patrimonio è i nostri centri storici. Quindi il patrimonio taglia una parte di spazio e crea un'etica: che devo fare di fronte a questo patrimonio? Lo devo conservare, lo devo difendere, devo impedire che gli altri se lo prendano. Il problema è questo: quando la popolazione di un luogo cambia chi deve gestire questo patrimonio e come ci si deve mettere in rapporto a questo patrimonio? Non è una faccenda di oggi: si è sempre presentato questo tipo di problema. Ora, io vi suggerirei un'immagine, un fatto cui abbiamo assistito a un certo punto della nostra storia recente. Due Buddha enormi, sulla via che portava dall'India alla Cina, che erano stati lì per secoli, eretti dalle popolazioni che si erano convertite a questa religione che veniva dall'india e avevano costruito scavandoli nella roccia, in un complesso con tanti monasteri. Due Buddha enormi rimasti lì anche quando le popolazioni avevano cambiato religione ed erano diventate musulmane, per secoli e secoli. Fino a che, qualche anno fa, sono stati fatti saltare con la dinamite dai cosiddetti Talebani. Ora, io ho parlato con molte persone, e molti non sapevano nemmeno dell'esistenza di questi Buddha, però quando hanno visto qualcuno che li faceva esplodere si sono indignati. Ma qual era la nostra ragione, perché ci dovevamo indignare, a chi apparteneva quel patrimonio? Noi ci siamo indignati proprio perché non è vero che il patrimonio significa il possesso di un oggetto da parte di una comunità, di chi abita un determinato posto. Nel corso dei secoli le comunità hanno distrutto gli oggetti del passato: in Italia San Pietro è stata costruita sulla più grande chiesa della cristianità romanica. In Francia, se si va a vedere Cluny, la più grande abbazia mai costruita al mondo, non si trova l'abbazia, ma dei segni per terra che indicano che un tempo lì c'erano le fondamenta. Per vederla bene, bisogna andare poco oltre, fino a un grande palazzo che è la scuola di equitazione francese, fatta con i mattoni di Cluny stati smontati e rimontati nell'800. 37 E ancora, le nostre chiese sono piene di oggetti che provengono dai templi pagani distrutti, coi cui resti sono state costruite. Il passato ha fatto sempre così, è a partire dall'800 che si comincia ad avere un'idea diversa di patrimonio, quella per cui il passato è la nostra ricchezza, un'idea che viene avanti con la mondializzazione. Mal passato non può essere la ricchezza di uno, perché non si possono mettere i confini nel passato, il passato è la ricchezza degli uomini e delle donne, è la ricchezza dell'umanità. Noi ci indigniamo se qualcuno va ad attentare le piramidi o va ad attentare un monastero egizio senza sapere nulla di queste cose perché quel che sappiamo, e molto bene, è che queste cose sono nostre, esattamente come i nostri grandi monumenti. Il passato appartiene al mondo, all'umanità, e allo stesso modo il patrimonio è sempre patrimonio dell'umanità. Conseguentemente noi siamo civili se capiamo questo e salvaguardiamo qualche cosa che non ci serve, perché lo facciamo in nome del fatto che questo oggetto appartiene all'umanità e anche alle generazioni future. Ma chi è responsabile di un patrimonio? Chi vive dove c'è quel patrimonio. Responsabili del patrimonio di Pavia sono tutti quelli che vivono a Pavia, quale che sia la loro origine, la loro religione, e via dicendo. Il patrimonio è di chi lo cura, in fin dei conti. Ma allora, se ciò che ci tiene insieme non è la cultura, non è il passato, non è l'identità – questi concetti un po' fantastici e mitici, insomma – cos'è che ci tiene insieme, perché si sta insieme? Ci sono altre parole che tengono unite le persone: solidarietà, soccorso, aiuto, ripartizione della ricchezza, redistribuzione, assistenza, difesa, sicurezza, giustizia. Queste parole uniscono concretamente le persone, e ci obbligano all'ultima delle parole chiave che vi voglio sottoporre, e che ha molto a che vedere con l'intercultura, una parola che da un po' di tempo mi sto accorgendo essere centrale in quella che si chiama educazione alla cittadinanza. 38 SCAMBIO, DONO, REDISTRIBUZIONE, TASSE Perché? Ecco un brevissimo e rapido corso di economia: quando pensiamo allo scambio di ricchezza, pensiamo subito al commercio, e ci sembra che il commercio sia l'unica forma attraverso cui passa la ricchezza. Il commercio, ovviamente, è stato studiato in passato. Karl Marx lo definiva come il passaggio di un oggetto da uno all'altro. Un passaggio che concentra l'attenzione di tutti sull'oggetto, che diventa la merce: questo è quel che si chiama “il feticismo della merce”, che e vuole dire esattamente che non ci interessa niente chi vende e chi compra – cristiano, musulmano, ricco, povero, imperatore, ... – : ci interessa la merce. Se ce n'è tanta, prezzo basso; se ce n'è poca, prezzo alto. Il feticismo della merce: il commercio, allora diremo, è lo scambio di ricchezza in cui l'attenzione di tutti viene concentrata sull'oggetto, lo scambio che dà valore a quell'oggetto. Ma c'è un'altra forma di scambio, che è il dono: io do una cosa a un altro ma non mi attendo un ragionamento sul valore o simili, perché io do qualcosa a un altro perché gli voglio bene, lo voglio far sentir bene. So che quando gli regalo una cosa io me ne privo, gliela do, ma lui cosa mi restituisce? Mi restituisce affetto, considerazione, cose che noi nella nostra società abbiamo un po' marginalizzato, mentre ci sono molte società che si basano sul dono, si fondano sul dono, perché il dono è uno scambio che valorizza i soggetti che si scambiano fra di loro l'oggetto e in cui quindi, se io voglio essere importante, devo donare, altrimenti non sono considerato dalla società. E c'è poi un terzo meccanismo di scambio, che si chiama redistribuzione. La redistribuzione non fa crescere il valore dell'oggetto, non fa crescere i contraenti, ma fa crescere la società. Supponiamo di essere un gruppo che caccia in mezzo alla foresta: io, grande cacciatore, ho cacciato un bel cinghiale, e tutti voi altri non avete cacciato. Io che faccio? Ne do un pezzo a te, un pezzo a te, un pezzo a te. Redistribuisco la mia ricchezza. In tutte le società succede che la ricchezza ha questa tendenza a concentrarsi in determinate parti, in certe persone, e queste poi re39 distribuiscono. La forma di redistribuzione di una società complessa è attraverso le tasse, quindi sono le tasse che tengono insieme una società. Facciamo un esempio: l'Impero romano. L'impero romano aveva una forte tassazione – qualcuno oggi si scandalizzerebbe, perché arrivava al 50 per cento della ricchezza prodotta. Questa ricchezza prodotta su un territorio immenso, più di 3 milioni di chilometri quadrati, affluiva verso Roma o verso le capitali dell'impero e poi veniva redistribuita. Redistribuita in varia forma: si pagava l'esercito, che dava sicurezza dei commerci; si costruivano le strade – l'Impero romano aveva 80mila chilometri lineari di strade, tantissimi: basti pensare che l'Impero cinese, l'altro grande impero, più grande, ne aveva 40mila; si costruivano gli acquedotti; serviva a pagare la giustizia; serviva a pagare la produzione artistica; la religione, perché la religione nell'impero romano era di stato; ma serviva anche a fare un'altra cosa. A movimentare su uno spazio enorme i beni di consumo di massa. Nel passato il commercio costava tantissimo, tant'è che conveniva commerciare l'oro, la seta, cioè ciò che è piccolo, pesa poco ma vale tantissimo. Chi commercia il grano? Non vale la pena: ogni 100 chilometri il prezzo del sacco di grano raddoppia. Ora, questo fatto che non si possono commerciare i beni di prima necessità sulla lunga distanza ci interessa moltissimo, nessuno di noi sa in questo momento che avrà fame domani esattamente perché noi possiamo commerciare ovunque: se c'è una carestia o un'inondazione in un certo posto può arrivare tranquillamente grano da ovunque, perché non costa nulla il grano trasferito da una parte all'altra. L'impero romano faceva così, quando c'era una carestia da una parte – mentre fino ad allora chi aveva la carestia moriva di fame, senza altre possibilità – arrivano le navi annonarie dell'impero, e la popolazione aveva di che mangiare. Ne 439 i Vandali si mettono su quello che è l'asse fiscale fondamentale, quello che portava il grano dall'Africa a Roma e di lì poi movimentava tutto, e da questo momento secondo Chris Wickham – quello che noi oggi consideriamo il più grande storico del medioevo vivente – l'Impero romano comincia a crollare. 40 E se l'impero crolla, l'ufficiale imperiale non passa più a riscuotere le tasse. Una vera fortuna per i ricchi. L'unico piccolo problema fu quando si ruppe l'acquedotto che portava l'acqua nella città, faceva alimentare le terme, e così via. Perché si ruppe, poniamo, nel 450 d.C. e venne uno ad aggiustarlo dopo 1.500 anni. Un piccolo problema successe quando si ruppe il ponte. Un altro problema fu quando i contadini cominciarono a prendersi i basolati con cui si facevano le strade, per farci le case. E un altro problema fu quando cominciarono ad arrivare i “cattivi”, Barbari o gente del villaggio vicino, per bruciare, e la cavalleria imperiale non correva più in soccorso. Finito tutto. La differenza fra Occidente e Oriente è che in quella parte nei nostri manuali c'è il fiscale e rapace Impero bizantino. Durò ancora 1.000 anni, dopo che il liberale e senza tasse Impero d'Occidente crollò in nemmeno 30 anni. E a questo punto scegliete voi il vostro racconto fondamentale. C'era una società complessa, nella quale tutti pagavano le tasse, e c'era una società complessa, nella quale tasse era una brutta parola, una pratica ancora più brutta che era bene evitare in tutti i modi: trovate pure voi le vostre conclusioni. Questa è la conclusione di queste parole, che sono parole pericolose perché vanno usate bene. Grazie. 41 42 Dalla multimedialità all'intercultura: una costruzione in cammino Prof. Franco Cambi Franco Cambi, professore ordinario di Pedagogia generale, direttore del Dipartimento di Scienze dell’educazione (poi anche dei Processi culturali e formativi) dal 1994 al 2000 e dal 2003 al 2006. Presidente dell’IRRE-Toscana dal 2002 al 2005, poi Commissario straordinario e rieletto presidente nel 2006. Dirige la rivista «Studi sulla formazione» e collane di studi pedagogici presso Armando, Carocci, Clueb, Unicopli. I suoi campi d’indagine sono stati articolati su molti fronti e ha all’attivo la pubblicazione di circa sessanta volumi, più numerosissimi articoli. Sul fronte della pedagogia generale si è impegnato in una difesa e promozione della filosofia dell’educazione, quale disciplina ‘fondante’ del pedagogico – si veda Manuale di filosofia dell’educazione, 2000, presso Laterza; come pure ha coltivato un’analisi-di-struttura del discorso pedagogico ( Il congegno del discorso pedagogico – Clueb, 1986 – e Metateoria pedagogica – Clueb, 2006) sottolineandone la complessità, categoria alla quale ha dedicato diversi interventi; inoltre ha mantenuto costante uno studio dei classici contemporanei – Gentile, Dewey, il “marxismo pedagogico”, il neopragmatismo – e un’analisi di alcune categorie del pedagogico (la formazione, la differenza, l’intenzionalità), nonché, via via, una sempre maggiore attenzione ai problemi del soggetto e della sua formazione personale (vedi L’autobiografia come metodo formativo – Laterza, 2002 e Abitare il disincanto – UTET, 2006). Sul fronte storicopedagogico, dopo studi su La pedagogia borghese nell’Italia moderna 1915-1970 (La Nuova Italia, 1974), su Antifascismo e pedagogia (Vallecchi, 1980), su La ‘scuola di Firenze’ da Codignola a Laporta (Liguori, 1982), si è impegnato nella ricostruzione della storiografia pedagogica in Italia, dopo il 1945, e nella stesura di una Storia della pedagogia (Laterza, 1995) oltre che di molti saggi su vari autori e argomenti. Ha coltivato anche la letteratura per l’infanzia e gli studi filosofici. Gli studi della prima sono rivolti ai classici (a cominciare da Collodi), ai classici contemporanei (Rodari) e alla fiaba, analizzata sotto vari aspetti. Gli studi filosofici sono stati 43 relativi al razionalismo critico (di Banfi e della sua scuola), all’empirismo critico di Preti e a figure e modelli del neostoricismo. I. LA MULTICULTURALITÀ È UN FATTO La Globalizzazione crea sempre più multi-culturalità. Convivenza di culture diverse, in spazi geo-sociali tra loro differenti: atti più o meno a accogliere e inglobare tali differenti culture. Esemplare ciò che avviene nell’Occidente europeo dove riflessioni avanzate, iniziative di governo e anche tensioni esplicite si manifestano nello stesso tempo e nello stesso spazio. Dove, appunto, una riflessione organica sulla multiculturalità si è sviluppata secondo obiettivi differenziati, ma con la volontà di interpretare e accompagnare questa rivoluzione etnica e culturale, che sta cambiando la fisionomia dell’Europa e del suo già complesso e difficile pluralismo di popoli, nazioni, religioni, tradizioni etc. Dove politiche per governare questo processo si sono rese via via fatte più esplicite e mature, pur oscillando tra emarginazione (si pensi alle condizioni di vita delle banlieux parigine, più volte entrate in sommossa), tolleranza larga (o accoglienza senza progetto e sostegni, con gravi rischi sociali), tolleranza stretta (che pone in primo piano controlli, quote di accoglienza, respingimenti anche), integrazione (lenta e complessa ma da gestire con politiche ad hoc, da parte di stato, enti locali, chiese, associazioni). Dove maturano anche tensioni esplicite, rifiuti, conflitti, de-legittimazione di culture e di etnie, fino ai più dannosi e oscuri rigurgiti di razzismo. La multiculturalità apre, ovunque, un problema: complesso e difficile. Di convivenza. Di riconoscimento di diritti. Di collaborazione anche. Poiché tale condizione sarà, d’ora in poi, permanente e darà vita a società assai diverse da quelle del passato (in genere sì pluriculturali, ma monoetniche), è necessario pre-comprendere, modellizzare, governare il loro reciproco rapporto. Proprio l’Europa (per l’esperienza tragica – e appena di ieri – dei suoi nazionalismi razzisti, delle stragi compiute, ma anche per la sua cultura che dall’Illuminismo in 44 poi ha avuto un suo fronte tollerante, laico, pluralistico, dialogico, ergo democratico e in senso sia etico sia politico) è di fatto ancora il luogo in cui la riflessione e l’azione di interpretazione e gestione della multiculturalità possono esser elaborati, forse, nella forma più avanzata. E lo si sta facendo nella cultura e nella società e nella stessa politica. Se non ovunque, almeno nelle aree e nelle loro frontiere culturali più aperte, più sensibili, più autenticamente democratiche. Come? In primis dando corpo a un modello di accoglienza/integrazione fondato sull’intercultura. Che è cosa diversa dalla multiculturalità: se questa è un fatto, quella è un compito. Ovvero un progetto, una regola, un fine. Da costantemente mettere a fuoco e da tradurre in percorsi d’azione, operando nella società nel suo complesso. II. L’INTER-CULTURA È UN COMPITO Se l’inter-cultura è compito ha bisogno di un progetto. E teorico e operativo. Da calare “in situazione” e quindi capace di aggiustarsi e trascriversi in modi anche diversi, pur sempre coordinati a quel modello ideale: deontologico e regolativo. Tale modello ideale ha al centro tre categorie: la differenza, l’incontro, il dialogo. Attraverso di esse ogni cultura (e ripeto: ogni) deve e può o può e deve aprirsi al confronto. Uscire dal proprio guscio. Disattivare i meccanismi di difesa. E stare nell’avventura del riconoscimento (e reciproco). Costruire anche métissage. Come sempre è accaduto nell’entrare in contatto tra culture diverse. E come è giusto che sia per non far prevalere il conflitto. Che riattiva, sempre, proscrizioni, razzismi, possibili stermini. Come è, in tali casi, sempre accaduto. E la storia sta lì ad insegnarcelo. Allora è al valore della differenza che bisogna dare spazio. Riconoscerla e legittimarla. Ma anche, appunto, valorizzarla come crescita, occasione di arricchimento, momento di affinamento della stessa identità di ogni cultura. La differenza dispone, quindi, allo svi- 45 luppo dell’identità. E senza negarla, poiché è in essa che la stessa differenza riconosciuta e compresa viene a collocarsi. Ma stare nella differenza produce incontro: stare faccia a faccia e come modelli culturali e come soggetti portatori di questi. E starci in modo sensibile, aperto, collaborativo. E anche l’incontro arricchisce: e di ciò che è diverso da noi e di una pratica di collaborazione, che crea convergenza e solidarietà. E apre così una frontiera etica ulteriore nella cultura: di ascolto e di integrazione. Da qui emerge il dialogo: tra soggetti, ancora, e tra modelli culturali. Che li dispone al comprendere (reciproco), che erode gli irrigidimenti, i sospetti, i rifiuti i quali pur sempre emergono nei processi di “acculturazione”. Sul dialogo, poi, cresce, può crescere, il métissage. Ed è questo che, in genere, fa paura: e nella collettività e negli individui. Viene vissuto come “invasione”, “espropriazione”, “perdita”, mentre è – come ben ci ha insegnato l’antropologia culturale (che su questo piano cammina su frontiere più avanzate rispetto anche alla storia e alla filosofia, sempre fatalmente etnocentriche, se non de-costruite in questa identità di base, chiusa e orgogliosa) – è, appunto, una risorsa: rinnova le culture, le ri-problematizza, apre in esse percorsi nuovi e nuovissimi. L’inter-cultura è l’insieme di questi paradigmi. Teoricamente recenti. Storicamente nuovissimi. Anche e soprattutto nel tessuto dell’Occidente, che ha vissuto la sua storia come imperialismo e colonizzazione verso le altre culture. Ma anche in quello dell’Islam, che ancora oggi si dispone secondo principi di fondamentalismo e di integralismo, duri da de-costruire e rimuovere. Ma non impossibile. E ciò è possibile sempre e solo attraverso l’intercultura che proprio davanti a queste resistenze e nel momento che si palesa come compito epocale ci appare come la sfida (una, ma fondamentale: insieme a quella della democrazia, dei diritti umani, del controllo della tecnica, della stessa ecologia) più urgente da vivere nel nostro tempo. 46 III. UNA SFIDA… IN CAMMINO Ma tale sfida è in cammino? Sì, lo è in molti saperi. Che vanno dall’antropologia alla storia, alla politica, alla pedagogia (per citare i più impegnati). E lo è ancora nelle pratiche e sociali e interpersonali con modelli operativi che toccano i conflitti e la loro risoluzione, la gestione di spazi sociali multiculturali secondo procedure di solidarietà e di incontro, le agenzie attive proprio per organizzare e gestire il confronto. A cominciare dalla scuola. Passando all’informazione. Per arrivare all’associazionismo (religioso, caritativo, culturale). Così si è venuta a costruire una rete di occasioni e di agenzie che lavorano secondo l’inter-cultura. Ne dipanano e diffondono i principi. La rendono attiva nella società. La rilanciano come paradigma culturale del presente e del futuro. E ciò avviene e in molti modi nelle agenzie già citate. Fissiamone due. La scuola. Le chiese. Le chiese. La condizione di dialogo interreligioso è un effetto stesso della globalizzazione e della multi-culturalità. Un effetto da guidare e da volere. Da volere come rinnovamento, affinamento, rilancio delle stesse identità religiose. Che nel confronto si ri-comprendono e maturano e crescono. Da guidare nel vissuto delle comunità attraverso azioni comuni, attivazioni di pratiche parallele (e si ricordi l’evento di Assisi del 1986), incontri ravvicinati e ascolti reciproci, di testi, di riti, di tradizioni. Ciò che viene a cadere è l’arroccamento, è la separazione e si va, via via, verso quell’uomo planetario che ormai è in votis e comunque fatalmente in cammino. La scuola. Tratta la cultura. Anzi le culture. E sempre di più. Già per la presenza che esse hanno nel medesimo spazio. Che è di tutti. Lì la multiculturalità si può fare inter-cultura: incontro e dialogo e rispetto e valorizzazione delle differenze, come pure possibile métissage, anche a livelli molto elementari. Di riconoscimento, di legittimazione, di inclusione. E la scuola elementare lavora da tempo e con finezza su questa frontiera. Assai meno la scuola superiore. Ancora più etnocentrica. Ancora dominata dall’Occidente e della sua ideologia di ieri: imperialista e coloniale. Ancora lontana da un’ottica planetaria dei saperi, a cominciare della storia stessa. 47 Poi – e di nuovo – sull’uno e sull’altro fronte si rilanciano e le resistenze e le differenze e poi i conflitti e le esclusioni. Che si legittimano sulla “paura dell’altro”, che è topos arcaico e che fa parte del nostro DNA culturale. La Grecia insegni: già lì l’altro è il nemico, l’estraneo, il portatore di sventure. Come provano Medea o Edipo, se pure in modi diversi. Ma questo DNA va integrato, corretto, trasformato e proprio per rispondere all’evento irreversibile che il Mondo Attuale (e tutto intero) sta vivendo: la Globalizzazione. E deve viverlo come occasione di crescita e non come regressione. Anche se tale effetto negativo è in parte fisiologico. Ma da isolare, curare, oltrepassare. IV. UNA “COSTRUZIONE A PIÙ… PIANI” Il progetto inter-culturale è, allora, una costruzione. Nel senso che è da costruire e che può esser costruito. Ma con impegno, con costanza, con sagacia anche. E sagacia significa, in particolare, articolazione plurale che si sviluppa come una rete dentro d’esperienza sociale, culturale, politica del nostro tempo. Plurale poiché reclama molti fronti d’azione da rendere sinergici. Dalle scuole alle chiese, come già detto. Ma anche dall’informazione all’organizzazione della vita sociale, alle politiche e dei diritti e del sostegno. Sì, anche l’informazione (stampa, TV, internet) deve tener ferma una logica inter-culturale, facendo opera di sensibilizzazione relativa ai problemi e alle loro soluzioni. E anche questo si è fatto e si fa su larga scala. Abbastanza. Le stesse politiche, soprattutto degli enti locali, devono guardare in questa prospettiva. E qui casca l’asino, come suol dirsi. Ci sono politiche opposte. Di esclusione anche clamorosa e perfino ridicola, da un lato. Di accoglienza e di sostegno dall’altro, spesso giocate – però – sul semplice accogliere, piuttosto che sull’integrare e riconoscere e valorizzare. E si pensi alle polemiche sulla costruzione delle moschee, polemiche non solo dettate dalla paura del terrorismo islamico che lì può trovare spazio e diffusione, ma spesso da netta 48 chiusura culturale verso la diversità. E così si opera nettamente contro l’inter-cultura. Politiche anche di diritti che vanno rilanciate e sostenute. Come quelle in difesa della donna e del suo diritto a vivere nella libertà. Ciò contrasta con qualche tradizione? Può accadere. Ma lì è solo lo spazio del confronto interculturale che può sciogliere il problema. Ad esempio costruendo una nuova frontiera comune: quella dei diritti umani. Più propria dell’Occidente? Sia pure. Ma non dobbiamo esserne troppo certi: l’Olocausto insegni. Comunque esportabile. Sempre. Se si parte dai soggetti portatori di cultura e non dalle culture stesse. E soprattutto diritti costruibili insieme. L’intercultura è un edificio complesso, articolato, anche con percorsi “che si perdono nel bosco” o che aprono precipizi e deviazioni, ma che proprio per questo va ben radiografato, fissato nella sua mappa intricata e possibile e poi messa alla prova sul territorio, cercando di farlo corrispondere sempre più a quella mappa. E superando così e via via le disomogeneità di questo rispetto a quella. Il percorso sarà lungo? Forse. Ma probabilmente non troppo. Per l’accelerazione che tutta la vita umana sta subendo in ogni suo ambito. Vinceranno le resistenze? Non è probabile, se l’impegno sarà lucido e forte. E per la lucidità possediamo, appunto, la mappa. E per la forza l’impossibile ritorno al quo ante: la stessa multiculturalità come svolta. E la multiculturalità nelle società democratiche si evolve in interculturalità. Almeno fino a che la democrazia resterà la forma aurea – e in atto e in potenza – del nostro convivere. Che sarà sempre più planetario e quindi intrecciato tra popoli, culture, tradizioni, modelli. In un intreccio da risolvere in incontro e dialogo, sempre. 49 50 Le scuole interculturali: diritti umani e prospettive cosmopolite Dr Hugh Starkey - Institute of Education, University of London Hugh Starkey is Reader of Education at IOE, University of London and co-director of the International Centre for Education for Democratic Citizenship (ICEDC). He chairs the Fellows group of the Centre for Distance Education of University of London. He is responsible for an online master's programme in Citizenship and History Education. He has nine doctoral students all investigating dimensions of citizenship / human rights / democracy and education. My talk is called intercultural schools, human rights and cosmopolitan prospective, and I think you will see many links between what I will say and the previous speeches. The talk is divided in two parts. The first part is the making the argument that teachers need a language to speak about intercultural situations and a new language for their work in school, and I argue that this language already exists in human rights texts. I'll examine human rights texts, a very useful and powerful knowledge for teachers, that gives us a language we can use. The second part of the talk is about some research that I undertook in a very multicultural city, in multicultural schools, about the importance of listening to young people, listening to students, as I think we can see that the language of human rights corresponds to the realities of this young people. So, i begin the talk by saying: schools need a vision. And I was thinking of the slogan for the Olympic games in Bejin in 2008, the slogan was “one world, one dream”. A dream is something that is very powerful in therms of rhetoric. I think everybody knows Martin Luther King's speech “I have a dream”: a dream is a very powerful 51 thing we can use, and in human rights we have some texts that are appropriated for a multicultural society founded on a dream, a vision. In human rights we found standards for a multicultural society and their foundational texts, so let's define what we mean by human rights. The Universal Declaration of Human Rights, from 1948, The european convention, from 1950, and, very important for teachers, the Convention on the Rights of the Child, from 1989. The Universal Declaration of Human Rights in its Preamble provides a cosmopolitan vision: Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world […] I recall your attention to this formulation, “the human family”. We're not talking about a people, or the people is the human people, so that is an identity: we're all member sof the human family, and the Universal Declaration of Human Rights is therefore a cosmopolitan prospective, the human family that is what we call a cosmopolitan prospective, and all the members of the human family are set to have equal rights and equal dignity – that is a very important thing to remember also in schools. And the Universal Declaration, as I said, has a vision: the vision of the Universal Declaration is that respect of the human rights will lead to justice and peace in the world - this is very idealistic, but we need a vision, so this is also very important. Another way of thinking about human rights is in terms of freedoms, and almost all the articles in the Universal Declaration of Human Rights can be identified with one of this for freedoms which were first enunciated by Franklin Roosevelt in 1941: freedom of speech, freedom of belief, freedom from from. We are claiming – along with Aaron Ronald Castan, who was one of the great contributors of the writing of the Universal Declaration of Human Rights –, human rights are principles for everyday life, we need to know these principles, to share these principles, and a school founded on these principles is a better school. 52 Rights are only meaningful when people know about them, so the main thing is to know what human rights are, but although human rights are very often enunciated in the law and there are many laws that protect human rights, in fact on a daily base it's a culture that is important, and it's building a culture of human rights that will protect them, so an intercultural school needs a culture based on cosmopolitan vision of human rights. The UN Convention on the Rights of the Child defines the aims of education: this document is something that teachers need to be aware of, because the authority should be aware of it, the authority's always to take these things very seriously, but we, as teachers, can take them and use them and justify our actions in relation to these principles. The aims of education: these are aims set agreed for every country of the world, every situation, so the aims of educations include generating respect for human rights, teaching about responsible life in a free society based on understanding, peace, tolerance, equality of the sexes, friendship among peoples. SLIDES So, human rights are the center of the school, in order to create a culture of the human rights. I will just spend out one or two concepts from human rights and show the way in which they're applied in school to show that these are very relevant principles for teachers. One principle is security, and security is about the law. In schools we have an own school law, school rules, which should protect the rights of all. So our school culture should be a culture where there is no violence, no racism, no insults: this will be based on the principle of security because we have right to psychological security and physical security, and all the principles, can be applied in school. Other concepts are solidarity and reciprocity. Human rights is not just demanding rights for the individual: obviously, rights are individuals, but everybody else has the same rights, so rights are something that is based in society and everyone is entitled to the same rights. Including the teachers, of course, so when children learn about their rights, they learn about respect, and respect is also re53 spect for the dignity of the teacher and for the rights of the teacher, who has a responsibility for insuring that the class and the school are conducted in a way that is fair to everyone. Reciprocity is the understanding that in defending the rights of others we expect mutuality and that they would do the same for us. Let's see some statistics I created, from an article that was published in 2005 in the «Oxford Review of Education», Violence in schools and representations of young people. We compared England and France and what we found was some interesting researches about racism. It is not recent, but I don't think things are changed. The 17% of teachers in France voted for a party that was racist – you might find that in Italy there are a few teachers who secretly vote for parties that are racist, it's just possible –, and we also find that a quarter of people reported receiving racist abuse in schools, and half in school believed in a racist fashion. Now, although it was from some time ago, I don't think things have got better, i think probably you will recognize this is reality. And in England we have the shocking finding that if you are a black boy in a school you are 5 times more likely to be expelled from school than if you are white. There are maybe reasons for it, but it seems shocking, every way. So, these are the realities that we have to confront with our culture of human rights based on equality of dignity and so. Now I want to talk briefly about some research in Leicester, published in a book from 2005 called Changing Citizenship, Democracy and Inclusion in Education. What we aimed to do was to explore with young people in four inner city schools what they understood by “community” and how they felt about the relationship to the neighborhoods, the city and the wide world, so it was about their identities,. We did this by organizing workshops with the young people (10-14 years old), where first of all we discussed about their own background, the geography and place and culture their experience and the key events in their lives, so, let's say, we discussed about biography. Then, we sent them away with a mission: “to take photographs of me and my community”, and then they came back 54 and they used the photographs, were able to make posters titled “me and my community”. The first thing that they photographed – this is meant to be the most important thing to them – was “my friends” .... PICTURE.... This is the starting point, their friends: it's about community, it's about solidarity. The next thing that they took a photo of was the house: this is my house, isn't it beautiful? And they also took of interesting places in the community, as the local indian radio station, which broadcasts in English and other languages. It was a building that was previously used for something else: it was the church. So, what they are showing us is the transformation of society: different populations came in, some old building are preserved, but they are used for different things. Here is a world in transition, a world that is changing. Another example of an adaptation: it's an Indu temple that before was a municipal sports pavilion. And, again, has been transformed: we have an example of a religious building transformed into a secular building, and of a secular building transformed into a religious building. These are changes in society. Students also took photos of the city center, because it's a place where people meet, so again, what is important in the community? Public spaces where people can interact and where they can meet. Now, I have some quotations, so what how did this young people talk about themselves – and about living in a intercultural society? They define themselves in terms of hybridity, culture and interest in religion. The first one, Nadera said: “I believe in god, I'm Indu, my language is gujarati. I like my religion, I hate people who are racists, I do no have problem with people who have a different culture to me, I mix with other religions”. So, she's living an intercultural life and part of that is the conviction, based on human rights, that racism is something that is against everything that she believes in. She believes in a society where people interact together from different religions and she sees racism as something that totally destroys, or has the pretension to destroy, this vision that she has of a fair world. 55 A second girl describes herself as “Asian” and she says her religion is “Islam”, and she also want to say: “I live in a multicultural area, with Christians, Muslims and Indus”. Her friends come from all these different categories and people she lives with, and she's very proud of that, she's very proud that her city is a place where these people live together. Revenda says: “I'm proud of my religion” – Revenda is a Sick –, “I don't care if my color is different, because we are all equal”. So again, she recognizes the racism that is prevalent in society and feels the need to asset an equality. And these young people that we talked to have an interesting concept of place and of their identities. Again, here are some quotations. “I breathe in Leicester, but my parents are from India and from Africa” – so here's somebody who roots in three different continents, that is very common. Here is another quotation, the second one: “I like living in Leicester because it's multicultural, I like the fact that even if we live in Britain our culture is kept alive, there are many different languages taught in Leicester, including Gujarati and Punjabi, which are Indian languages” – so this girl has an identity with the place where she lives, but that place is a better place because it is multicultural. And these young people have themselves moved about quit a lot, so the first one says: “My father and mother are from Malawi, and my grandmother is from India, and we left Malawi because almost every day people where getting shot in their homes and one of them was my neighbour” – so this is a family that has suffered persecutions: in a sense they are refugees, but we're talking about quite comfortable families who have enough money to live a normal life, but they nonetheless have the background of movement, migration. The second one says: “My mum, dad and grandad are from Africa, and my grandma is from India”, and another one: “My mum was born in Malaysia and my dad in Zimbabwe”. So we have some very complex relationships with places, but actually some wonderful advantages: here are people who are literally connected to the world thought family and themselves represent a 56 cosmopolitan perspective prospective. It's just how they are in their family, they are cosmopolitan, but it doesn't stop them being very proud of being from Leicester, again. And about the feeling of citizenship? What we found is that these young people are exercising what we call cosmopolitan citizenship, so citizenship education should logically follow to be education for cosmopolitan citizenship. We found that they were developing a strong identification with the local neighbourhood, cosmopolitan perspectives, recognition of the common humanity. The sense of solidarity with other people, and an ability to make connections, and that's what education for cosmopolitan citizenship is about. They have those attitudes or values that we would in any case want to promote. They are citizens with multiple identities, and the nation is just one frame of reference among many, the nation is no longer the frame of reference that justifies, explains everything. So, what we have shown here is that people learn for citizenship in schools, yes, but also they learn to be responsible citizens in the family, in the neighbourhood, in churches, in many other groups and forums in civil society. The school has to recognize that what happens in school is only part of this bigger picture, and it's important that what we do is in some sense able to drop on the experience from the bigger picture. I mentioned human rights as a language, and human rights as a language that teachers can use, and that also provides a common agenda for schools. The UN Convention on Rights of the Child says that children have a right to protection, to provision – we provide them with services – and participation. And it's this participation that makes young people citizens, because they have a right to participate, especially to express their views, to receive information, to participate in decisions about their lives and their futures. So this is my conclusion: that education for cosmopolitan citizenship in intercultural school has two important dimensions, that it's a transmission – and it's a transmission of our heritage, in fact a “patrimonio”, and that “patrimonio” is the human heritage of human 57 rights, this is something that human beings have created together as a vision for the future – and it is very important to hold on to that vision and transmit it, to make sure that young people know about their rights –, but it's also in the constructivist paradigm, is about learning together, is building on the experience and understanding of all men, is about living together, and intercultural education is essentially about democracy, developing democracy, justice and peace. I think one of the problems about multiculturalism has been that it has been associated with ethnic minorities. Actually, interculturalism, multiculturalism is about democracy, is about all of us, and that's the important point. 58 Educazione alla cittadinanza: l'inno alla diversità maschera lo scandalo delle ineguaglianze François Audigier Docteur en didactiques des disciplines et titulaire d’un diplôme d’habilitation à diriger des recherches, est professeur ordinaire à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, didactiques des sciences sociales (histoire, géographie, citoyenneté). Après avoir passé l’agrégation de géographie (formation qui, sur la durée complète des études comporte en France environ 40% d’histoire et 60% de géographie), il a commencé sa vie professionnelle comme professeur d’histoire et de géographie dans des lycées et collèges français. Il a très rapidement rejoint les équipes de recherche en éducation de l’Institut National de Recherche Pédagogique à Paris et participé à des recherches-actions portant sur l’élaboration et l’expérimentation de nouveaux curriculums. Après diverses responsabilités à temps partiel, il intègre l’Institut en 1982 et prend la direction des équipes de recherche en didactique des sciences humaines, histoire, géographie et éducation civique. De 1986 à 1995, en collaboration avec une équipe de chercheurs, de formateurs et d’universitaires, il a organisé huit colloques sur les didactiques des sciences sociales. Depuis sa nomination à Genève, ses champs de recherche et de réflexion concernent les pratiques enseignantes et les didactiques dans la formation des maîtres, les conceptions de la vie en société que les élèves construisent à travers les enseignements des trois disciplines, les manières de recentrer ces enseignements autour des modes de pensée spécifiques de chaque discipline tout en travaillant sur les relations qui sont à développer entre ces différentes sciences sociales dont la finalité commune est la formation du citoyen, les conceptions que les élèves ont des disciplines, les curriculums et leurs évolutions actuelles de la forme scolaire en particulier dans une dimension comparative internationale, la contribution des trois disciplines aux ‘éducations à…’ qui sont de plus en plus présentes ou recommandées, principalement sur l’éducation au 59 développement durable, l’éducation à la citoyenneté en incluant la question de valeurs. Il est l’auteur de nombreux articles et chapitres de livres, a dirigé nombreuses publications de recherche et actes de colloque, et publié un ouvrage sur l’éducation à la citoyenneté. Il anime l’équipe de recherche en didactiques et épistémologies des sciences sociales (ERDESS) qui, en collaboration avec d’autres chercheurs de plusieurs institutions tertiaires de Suisse romande, s’interroge notamment sur les significations que les élèves attribuent à ces disciplines de sciences sociales, sur leurs contributions à la construction des identités individuelles et collectives. Cette équipe met en œuvre à la rentrée 2007 une recherche sur l’éducation au développement durable financée par le Fond national de la recherche scientifique en Suisse. Nous avons entendu ce matin beaucoup de prépositions, de réflections qui nous engage très fortement de maniére positive dans le pratiques et le réflections. Mais je vous dix que je vais parler surtout d'inquiétude éducationnelle. Je commence simplement par une image pour poser la question que nous avons déjà rencontrée ce matin, c'est: avec quel concept, avec quelles lectures regardonsnous le monde et apprendons-nous nos élèves a regarder et étudier le monde, et agir. Car il y a, aussi bien dans le mode de penser que dans la formation de les générations futures, la question des concepts, des mots, des interprétations que nous portons a nous e que nous transmettons à travers nos enseignements. Je ne sais pas si certain entre vous reconnaît cette grande ligne sur le mur: si je vous dit que c'est la frontier entre les États-Unis et le Mexique, nous allons a voir tout une série d'images et d'interprétations. Mais, il y a ici [Mexique] des bronzés mexicanes qui parle espanol, y at-il ici [États-Unis] des blondes anglosaxons protestants? Estce ce mure qui separes deux cultures? Est le mure qui separes des riches et de pauvres? La maniere dont nous allons décrire et étudier ce mur, va porter évidemment une interprétation – culturelle – de la réalité. 60 Je ne dis pas que l'interpretatione culturelle est fauxe, mais simplement que elle devient très très prioritaire or unique. Or, que fait l'école? Bien, il y ont chercheurs [p.e. Jacques Leclerce] qui ont fait une très très grande revue sur les effets et les conséquents de l'éducation. Et ce que est intéressant c'est que nous commençons pas par la formation professionelle ou à enseinger à savoir lire, écrire ou compter, mais il commençe bien par cettes idées que l'école entroduit en les élèves: l'école transmet des forms élémentaires de classification, des instruments intellectuelle, des catégories mentalles et le fin de ce apprendrement c'est de se reconnaître entre soi comme les membres d'une même communauté. Évidemment se pose la question de l'échelle de cette communauté, et nous avons entendu ce matin l'importance d'une communauté mondiale, cosmopolite, planetaire. Alors, si d'un point de vue personel, d'un point de vue de “dream” c'est tout un affair interessant, positif, attirant, le spectacle du monde ne me donne pas tout à fait l'impression d'une large communauté humaine. Alors, ce ne veut absolument pas dir qu'il fait nous renoncer à ce mythe, à ce mythe, mais le problème c'est l'articulation avec le réel. Je dis souvent: fait il fair une éducation à la paix or une éducatione à la violence? Non pas parce que le jeunes soient violent, mais pour réfléchir sur la violence. En cette idée des cadres intellectuels et sociaux ce que me semble important ajouter sont les évidences naturelles et les vérités universelles. Un psychologue sociale allemande dit très clairement que la norme pour chacun entre nous est constituée par notre propre expérience du monde, c'est à dire que le jugement par que nous approchons le monde, les autres, les autres experiences est à partire de nous mêmes et à partir de notre propre expérience. C'est qu'il poses évidemment d'un point de vue à la fois étique et pédagogique toute la questionne de la reconnaissance des autres points de vue, des autres manières de construire et de comprendre le monde. 61 Alors je vais très rapidement parcourir quelque millénaire et reprendre quelque chose que nous avons probabilmente rencontré durant nos études et nos formations. Nous connaissons tous la succession des modes de production construit par Marx, et que c'est largement diffusée. Et je me permet de rappeler aussi que cette construction a donnée un sens à l'histoire et au devenir historique. D'autres constructions sont disponibles, par exemple la tripartition des fonctions de George Dumezil, avec donc les sociétés antiques et médiévales organisées par cettes trois fonctionnes, le prêtes, le travailleurs et l'armée, les sociétés d'ordres avec âge moderne, noblesse, clergé, tiers état, puis, avec la révolutionne industrielle les sociétés de classes. Et toutes ça sont des catégories que nous avons plus or moins fortement en tête, mais depuis 20-30 ans toutes cettes catégories ce sont brouillées – je ne vais pais développer cet lieu commun bien connu mais le phénomène de diversification d'une société et un monde et la diversification des échanges ont largement brouillée nos rappelles, nos ripaires. Ce que explique aussi peut être en parti la manière dont le système éducative se réorganise au tour de siècle pour les compétences de base. Donc je fais un petit arrêt dans les années '60 et pour les plus anciens ici qui ont lu ces ouvrages les differences de culture scolaire été suivant passées comme culture de classes. Et s'il y avait les différences de culture c'est parce que il y avait des classes différents. Et dans une démocratie, dans une société dynamique, les classes sont pas fichées. Le destine individuel réponds a certain mobilité, nous savons tout que depuis la fin de la guerre, jusque le 1975, le 30 glorieux, la société le développement des emploi, la modernisation a permis la reproduction sociale et la promotion sociale. Et donc lutter pour l'égalité scolaire c'est aussi lutté contre les inégalités économiques et sociales. Et puis dans les années '80 et après, l'augmentation d'immigration et la visibilité d'émigration, et notamment la visibilité des enfants migrant à l'école, je rappelle aussi pour certain, les deux temps 62 dans les politiques publiques qu'y ont accueilli ou qui on réagi à cette évolution. Au début des années 80 on a introduit dans beaucoup des systèmes éducatives des cours de langue et culture d'origine, pour le retour à le pays d'origine de cettes jeunes. Mais très rapidement nos sociétés occidentales ce sont aperçu que ces émigrants était restées, comme les Visigoths. Mais le problème c'est que avec les grandes migrations de 4 au 19 siècle cettes son durées très long temps, maintenant nous avons à faire a des temporalités extrêmement bref, des situations dans lesquelles les massacres sont interdit et donc il faut trouver des modes pacifiques de réguler les problèmes. Avec toutes les politiques publiques que vous connaissez – faut il intégrer, insérer, reconnaître les différences, et puis, ce que est une réalité, l'augmentation des incivilités, des violences. On a vu fleurir, se développer tout une série d'actions, d'idées, pour pacifier les relations scolaires, et avec évidemment l'idée que s'y on pacifie les relations a la carrière de l'école: s'y on reconnait l'autre, ce là c'est traduit dans le vie sociale. Mais, encore, on y a une évidente tension entre une école qui vas proclamer l'égalité des enfants et une société qui est de plus en plus inégalitaire. Alors, comment parler de “l'autre”? Toujours le problème du vocabulaire, des mots. Faut il parler d'un statut. Statut démographique: immigrées – mais moi que je travallais en suisse quand que je disais que j' étais un travailleur immigré, faisait rire, parce que un cadre, un professor d'université c'est pas un émigre, c'est un expatrié, et dans les écoles où il y a les enfants du professors universitaires, et pour les enfants des cadres la questionne de interculturale et multiculturale ce ne pose pas. C'est naturel; le mélange se fait normalment. Mais in Suisse il y a une courant qui proteste contre le fait que à l'école fédérale et à l'école Polytechnique fédérale de Lausanne il y a trop d'étudiants étrangers. Je me ferme pour une parenthèse. Faut il parler d'étrangers? Au sens strict du terme, beaucoup des enfants migrants sont étrangers.63 Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que il n'ont pas les mêmes droit et notament il n'ont pas des droits politiques. C'est à dire qu'il ne participent à l'elaboration de la loi et à la choix des dirigeants, mais payent les impôts. Faut il distinguer les autres aux classe en la société en fonction des métiers? Faut il parler avec en vocabulaire qui trait de la richesse? Interrogeons la façon dont nous parlons des autres. Mais si je pose le problème problème; Qu'est-ce que est visible dans la vie quotidienne? C'est les différences d'alimentations, du comportament, civiles, les différences d'habiller, les différences du couleur de peau? Alors, comment parler tout ça? Mais voila, c'est évident, c'est la culture. Et il y a un paradoxe: à l'école, nous avons des enfants, des jeunes, qui ne sont généralement pas enserrées dans le marché du travaille, qui sont sans statut politique économique bien précis, et donc le mouvement je dirais prés que naturel de reconnaissance des autres c'est la reconnaissance des habitudes, des croyances, des cultures, des manières d'être, des appartenances. Mais c'est évidemment très difficile parler avec des élèves ou des jeunes de la différence d'appréciation de réalité, dans une classe où j'ai les pauvres dans une côté et le riches dans l'autre. Or demander aux individus de se définir selon leur statut économique. Et donc cettes inégalités économiques et sociales., mais, je dirais, chaque inégalité est négative, c'est mal. Alors, plutôt qu'en faire un objecte de travaille, on la marginalise de plus en plus. Au revers, la reconnaissance de la diversité, la reconnaissance des différences c'est bien, c'est positive, et on va jouir parce que il y a des présentateurs tv qui ont le couleur de la peau diffèrent. Et tout les instances médiatiques, les instances politiques, les experts, vont beaucoup plus d'insister sur les différences de culture et de civilisation que sur le différences économiques et sociales. Et dans les politiques que j'appelle de la reconnaissance – le respect, la tolérance, la reconnaissance de les libertés: c'est évidente que je ne peux qu'adhérer à cette orientation, que je suis bien d'accord – je m'interroge sur ce qu'on peut tolérer qu'est ce qu'il est to64 lérable dans la société? Les différences, oui, mais connote-t-il encore une fois des inégalités? Je fais une petit parenthèse à partir de une proposition de Paul Ricœur, qui distingue en un petit article, Tolérance; intolérance; intolérable, les trois usages de la tolérance – et pour lui la tolérance en la société occidentelle comme valeur positif ou comme principe d'organisation est quelque chose de relativement récent. C'est intéressant parce que nous pouvons retrouver des questionnements sur le fonctionnement de l'école. Le premier moment pour R. est la fin de la guerre des religions, les Traités de Westphalie, 1648; que se postule tout simplement personne ne peut casser la gorge à l'autre, donc on se tolère. chacun chez soi; second temps, qui est un peu contemporain, c'est la reconnaissance de l'autre comme humain, et c'est tout le mouvement de développement des droits naturelles. Je pense que vous connaissez la Controverse de Valladolid; entre Bartolomé de Las Casas et le théologien Juan Ginés de Sepúlveda: «Les Indiens (d'Amérique) ont-ils une âme?» La conclusion de la controverse c'est que les indiens ont une âme, donc on peu pas les réduire en esclavage, mais à la fin de la controverse, voilà quelque chose très intéressante: c'est que si les indiens d'Amérique ont une âme, il existe une Afrique de peuples qui sont tous noirs, et que là on sais pas s'ils ont une âme. Et donc vous connaissez la suite. Ma ce que c'est important dans ce temps c'est reconnaissance de sois droits naturelles et d'une égale humanité sur les textes et les discussions. Le troisième temps de la tolérance? Je reprends la citation de Ricœur: «Le plus court chemin de soi à soi, c'est l'autre». Et le problème là c'est que si les deux premiers points, les deux premières âgespeuvent donner lieu à des décisions politiques, la troisième relève des choix beaucoup plus personnelles. Est attendu aussi que chacun entre nous ait une vie extrêmement limitée, et que donc je rencontre l'autre sur différents faces, formules, occasions, mais c'est toujours un autrui très limité lui aussi. Alors, je reviens à mon point de départ, c'est comment on nomme 65 cettes catégories différentielles? À la fois c'est: qui est moi et qui est le prochain? Et dans la réflection du concept que nous ont utilisé cette matine, voyons comment existent des assembles conceptuelles, des trames conceptuelles: la culture fonctionne avec la religion, l'éthnie, le peuple, la communauté, l'identité – et cette discutable association culture-religion si fréquente. Et de l'autre côté, il y a toute une assemble de vocabulaires qui sont moins utilisées et qui ne fait plus référence ou rapport entre des groups, des individus, des communautés mais qui poses le problème de les classes sociales, de la pauvreté, de la hiérarchie, de la domination. Alors, tout ceci devrait nous pousser à un travaille de fond, comprise la revision des curriculums, la re-articulation des curriculums, de ce que relève de la culture, avec le question, le lecture et le concept et les interprétations politiques et juridiques, sociaux et démographiques, économiques, éthiques. Et la reconnaissance de la diversité des appartenances culturelles qui est nécessitée pour pacifier l'espace social, une nécessité aussi éthique, une responsabilité de nous tous, donnent a transférer sur chaque individu la responsabilité de sa réussite ou sa défaite. Alors, encore, quelles articulation faire entre la culture et les questions justice, légalité? Il va de nouveau falloir faire appel aux autres dimensions de la société. Alors, pour conclure complètement, la culture en toute sa place, la multiculturalité mais aussi le multi-sociale, si je peu dire, la diversité des prises de position politiques de chacun entre nous, s'inscrit pas dans des déterminations culturelles. Ils sont beaucoup plus complexes: voilà alors l'importance de la contextualisation, de-essentialiser les cultures, les dénaturaliser, c'est a dire de l'idée second laquelle les cultures ne sont pas figées et personne a jamais vu ou rencontré une culture, et personne ne représente une culture. Dans les premiers travaux dans les années '80 sur l'enseignement multiculturel ou interculturel, les auteurs insistaient beaucoup sur l'idée que 66 ce sont jamais des cultures qui se rencontre. Ce sont des individus, des personnes, des situations. Deux dernières remarques pour finir. La première c'est de la permanence d'un égard critique; un droit d'examen sur les cultures; les valeurs qui nous avons cité toute à l'heure, sont des points de vue, des valeurs ou des références universelles pour examiner les cultures, mais aussi là il y a un débat lui aussi universel et mondial. Et la deuxième et dernière remarque c'est la non assignation à résidence. Nous sommes tout à insister sur la mobilité des cultures et la mobilité des appartenances: ce la signifie aussi la nécessaire ouverture des toutes le communauté culturelles, de touts les groups, et caetera, et que donc l'affirmation de la liberté va à la fois dans la reconnaissance des différences et dans l'exigence d'affirmation des principes. Et pour terminer sur les inégalités, nous avons bien aussi aujourd'hui une situation mondiale très préoccupante, avec une classe dirigeante mondiale qui d'après à certains docteurs va à faire la sécession, c'est à dire que elle se construit avec ses contradictions et ses conflits à le scène internationale – Zygmunt Bauman dit clairement que pour cette classe l'espace est aboli –; la classe moyen donc je dis que est plutôt en déclin, en crise, on Occident, est en pleine croissance en Orient; avec une fantastique transfert de richesse qui était opéré; et les classes populaires, avec les émigrantes, sont suivant parties, et (je reprend Bauman) cettes classes populaires, elles ont les pieds dans le sol, elles ont les pieds dans le boue; bien sur, elles migrent, elle bourgeonnent, mais avec des intentions et des difficultés de condition qui n'ont rien à voir avec celles classes dirigeantes mondialles que j'ai évoqué. Alors, tout ceci ce sont des grandes paroles, dans les classes, dans les écoles, y il a plein du projets, il y a plein d'initiatives, mais qui sont évidemment limitées, modestes, mais qui sont aussi évidemment indispensables pour la transformation de l'école dans les perspectives que nous avons traité ce matin. 67 68 La didattica dei personaggi ponte. Intercultura e letteratura per l'infanzia Vinicio Ongini Lavora presso l'Ufficio Integrazione alunni stranieri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e fa parte della Direzione Generale per la Formazione e l’Aggiornamento degli insegnanti. Collabora, inoltre, con l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa che ha sede a Firenze e con la Nuova Enciclopedia Treccani per ragazzi. Dal 2000 è impegnato nel gruppo di ricerca dell’indagine nazionale annuale Alunni con cittadinanza non italiana. Esperto di lettura e letteratura per ragazzi, Vinicio Ongini ha ideato diversi progetti di biblioteche multiculturali con enti locali ed istituzioni scolastiche, e ha curato e pubblicato numerosi volumi. Come si può capire dal titolo, il mio intervento è incentrato sulla didattica. Il mio obiettivo è questo: presentarvi attraverso alcuni pochi esempi come anche la letteratura per l'infanzia, quella che conosciamo già e che appartiene alla letteratura italiana, possa essere vista oggi con un occhio interculturale. Comincio da un antefatto, cioè da quando è nata l'idea, l'immagine, dei personaggi-ponte. Con personaggi-ponte intendo dei libri, dei personaggi che sono in comune tra Paesi diversi, che sono conosciuti da più Paesi, da più culture, da più persone, che non sono la tua storia, la mia, ma che sono in comune: personaggi che hanno più appartenenze. L'idea è nata all'inizio degli anni '90 – quindi nel secolo scorso, ma soprattutto in un'Italia giovanissima dal punto di vista interculturale, non abituata alla presenza di gruppi di immigrati, che stava balbettando un po', scegliendo le strategie, gli strumenti. Nell'Italia 69 della famosa “invasione” (da etichetta dei giornali) albanese, che tutti ricordiamo con il fotogramma di una nave sbarcata in Puglia, piena di albanesi aggrappati dappertutto, un'immagine che è andata in giro per il mondo. Anni in cui l'Italia si è svegliata come di soprassalto. Quindi, quando a Roma abbiamo pensato che potevano essere allestiti degli angoli, degli scaffali multiculturali dentro le biblioteche pubbliche, degli scaffali per bambini, per la prima volta nel 1992, abbiamo deciso che il primo, in modo sperimentale, l'avremmo fatto tutto sull'Albania. Una valigia sull'Albania, perché abbiamo messo tutto quello che abbiamo trovato, e da quell'anno è diventata un'idea didattica, la valigia-Paese: dopo è stata fatta la valigia sulla Cina, poi sul Senegal, e così via. La valigia ha una grande qualità, a differenza delle biblioteche: si sposta, e la valigia-scaffale si spostava dalla biblioteca pubblica per bambini del centro di Roma nelle scuole, con gli animatori, i mediatori culturali, gli insegnanti. La prima valigia è stata dedicata all'Albania, dicevo, e abbiamo chiamato perché fosse aperta l'ambasciatore dell'Albania, il quale è venuto, e l'ha inaugurata. L'ha aperta e ha preso due libri, li ha alzati e si è illuminato: questi sono i libri della mia infanzia. E noi siamo rimasti presi in contropiedi, meravigliati, perché ha scelto come libri suoi Pinocchio, Pinoku scritto in albanese, e Cepolini, Cipollino di Gianni Rodari, un vecchio libro degli anni '50 ambientato nel vecchio mondo contadino. Dei libri nostri. Nostri? Ma sono nostri o sono anche albanesi? Per il solo fatto che sono in un'altra lingua, hanno un altro vestito linguistico, possiamo definirli anche un po' albanesi, ma non è solo questo: la molteplicità delle appartenenze di un personaggio, di un libro, è molto di più che non il semplice essere tradotto in un'altra lingua. Ecco, da quel momento è nata l'idea dei personaggi-ponte, di un Pinocchio che non è più solo nostro, è anche albanese, cinese, e così via. Comincio da Pinocchio, con alcuni esempi. Pinocchio potrebbe essere definito un libro glocale, allo stesso tempo globale e locale, secondo la definizione inventata da Edgar Morin. 70 Vi spiego perché: intanto Pinocchio è un perfetto libro dalle molteplici appartenenze, che poi è il tema del nostro tempo, quello diconiugare il locale con il globale, è il tema delle persone, le persone che si spostano tra culture, che devono tenere insieme pezzi diversi, appartenenze diverse: questo è il tema del nostro tempo e il tema dell'educazione oggi. E Pinocchio è un buon esempio perché è un libro locale, localissimo, toscano, toscanissimo, e di una certa Toscana, che è la Toscana di Collodi, paese della mamma dell'autore di Pinocchio, tra Firenze e Pistoia. Pinocchio è nato in un luogo ben preciso, è pieno di toscanismi il libro, di proverbi, di modi di dire, trabocca di una lingua toscana del tempo. È locale, quindi. Nello stesso tempo è nazionale, uno dei pochi libri per bambini che hanno fatto l'Italia e sono riconosciuti come libri dell'Italia. Ed è globale, un libro del mondo, come insegna l'ambasciatore di Albania e come insegnano i tanti esempi degli incontri interculturali fatti da Pinocchio da quando è stato tradotto, cioè portato, in altri Paesi. Igni tanto sento ancora lo slogan di chi contrappone il locale al globale con l'immagine della polenta contro il cous cous, come se fosse una contrapposizione di cibi che ne sottintende una di culture. Ebbene, dentro Pinocchio c'è un soprannome, che è un soprannome che ha Geppetto, che è “polendina”, perché ha dei capelli di un giallo polenta. Come viene tradotto il soprannome di Geppetto in cui non c'è la polenta e non c'è neanche l'idea di polenta? Ad esempio in Iran il soprannome di Geppetto è stato tradotto in “pappa gialla”, che in Iran è un dolce. Un altro esempio: il “grillo parlante”, personaggio famosissimo, è diventato un modo di dire; in un Paese dove non ci sono i grilli come si fa? Ci sono altri insetti, e in Egitto ci sono molti scarafaggi, soprattutto al Cairo, e quindi lo scarafaggio nella traduzione egiziana ha preso il posto del grillo parlante: uno “scarafaggio parlante”. Un altro esempio che è bellissimo è il cappellino di Pinocchio che gli ha fatto Geppetto, un “cappellino fatto di pane”. In India quel cappellino è diventato una via di mezzo tra un copricapo e un foulard come quello che usava Gandhi, e infatti quel cappellino del Pi71 nocchio indiano si chiama “Gandhi tupi”: perfino nel nome c'è il nome di Gandhi. E infine un esempio che la dice lunga sugli incontri, gli scontri che fanno i personaggi che passano i confini, le frontiere – Pinocchio come sapete è un maratoneta, è uno che scappa sempre –: in Cina durante la traduzione di Pinocchio c'è stata una “battaglia” tra linguisti, si sono affrontate due scuole di pensiero intorno ad alcuni termini. Ad esempio c'è una frase di Geppetto a un certo punto, quando racconta che è stato inghiottito dal pescecane, e dice che è stato inghiottito da un pescecane “come un tortellino di Bologna”. Come si traduce in cinese? Sono uscite due traduzioni diversissime, proprio agli antipodi: c'è chi ha tradotto “come un piccolo raviolo al vapore” e chi “come dei piccoli ravioli al vapore di Bologna”. Ha voluto aggiungere di Bologna: la battaglia è stata aver voluto mantenere di Bologna. Ecco, questo ci dà l'idea dei viaggi che anche un personaggio come Pinocchio, che è un personaggio tradizionale, italianissimo, toscanissimo e che è conosciuto dai bambini, come può esser stato un viaggio anche tra somiglianze e differenze con i bambini. Il secondo esempio lo faccio col secondo libro che ha indicato l'ambasciatore albanese quando ha aperto la valigia. Le avventure di Cipollino è un libro scritto nel 1950 dal nostro più importante autore di letteratura per l'infanzia, che è Gianni Rodari, e l'ultima edizione è di pochi mesi fa. La cosa importante, a parte il fatto che in Albania sia conosciuto Cipollino – Gianni Rodari è stato molto tradotto nei Paesi dell'Est – è che il libro si svolge tutto in un orto, i personaggi sono ortaggi, siamo dentro il microcosmo di un orto, ma questo è un libro sulla giustizia, su come si può parlare ai bambini di giustizia e ingiustizia, e democrazia e classi sociali, tutto vissuto attraverso gli ortaggi. Vi leggo l'inizio del libro che vi dà l'idea dell'ambiente sociale: Cipollino è figlio di Cipollone e ha sette fratelli: Cipolletto, Cipollotto, Cipolluccio, e così di seguito. Gente per bene, ma sfortunata. Cosa volete? Quando si nasce cipolle le lacrime sono di casa. 72 E poi Rodari descrive dove abitano, sono dei baraccati in pratica: abitano in una cassetta da ortolano. Tutto il mondo ovviamente è a misura di orto, ma dentro ci sono le classi sociali. C'è un certo Cavalier Pomodoro che è un antagonista, c'è il Principe Limone, e poi ci sono invece gli amici di Cipollino e quelli come lui, che vivono la stessa condizione sociale. Il libro è nato in questo modo: Gianni Rodari si è preso un'aspettativa, faceva il giornalista e andava anche nei mercati in quell'epoca, intervistava le persone, chiedeva come sbarcavano il mese con lo stipendi oche avevano, quanto costavano le cose: proprio un giornalista della cronaca. Ha preso un'aspettativa ed è andato da un contadino in un paese che si chiama Gaggio in piano, vicino a Modena, e si è messo lì a scrivere Le avventure di Cipollino. Infatti dice lui che quando è stato a pagina 100 il contadino, che si chiamava Armando, e la moglie, hanno fatto una festa e hanno mangiato la cascente, che è una specie di gnocco fritto, e hanno stappato il lambrusco. Insomma, siamo proprio immersi nel mondo contadino: gnocco fritto, lambrusco, Modena, campagna modenese, si parla solo di ortaggi. Ma questo è un libro con cui si può parlare di giustizia, di disuguaglianze ai bambini. A parte la traduzione in albanese, qual è il versante nuovo, interculturale? È questo, ed è stata un po' una scoperta anche per me, perché a Modena nei mesi scorsi c'è stato un festival di cultura, alla sua seconda edizione con una sezione dedicata ai libri fatti dalle scuole sul tema dell'orto, ed è successo che gli insegnanti che hanno mandato i loro libri a Modena hanno dato inevitabilmente un taglio multiculturale – e dico inevitabilmente perché in una scuola, come la “Primo Maggio” di Treviso, con più del 50 per cento di alunni stranieri, l'orto di scuola e i discorsi che fanno sull'orto sono inevitabilmente interculturali, perché se chiedono ai genitori se conoscono storie di orti, di ortolani, di personaggi, ecco storie che vengono da altri Paesi. Infatti lì a Modena gli insegnanti della scuola di Treviso hanno “spacciato” una storia secondo loro proveniente dai Paesi dell'Est e che invece si è scoperto essere una storia che conosciamo anche noi, 73 la storia del nonno che va nell'orto, vuole prendere un ortaggio ma non ci riesce, ce la mette tutta ma non esce, fa degli sforzi e chiama via via come aiutanti tutte le persone della famiglia, la nonna, il nipote, il nipote chiama il cane, il cane chiama il gatto, il gatto chiama il topo: tutti che tirano quest'ortaggio che non esce. È stata presentata da una famiglia che veniva dalla Bulgaria, ma la conosciamo anche noi. Ma ecco altre chiavi di lettura che sono state date all'orto. Intanto, la coltivazione di un orto è un'attività intergenerazionale perché tutte le volte che gli insegnanti raccontavano dell'orto che avevano a scuola ecco apparire i genitori e i nonni come aiutanti – e ci sono pochi altri linguaggi, pochi altri luoghi in cui la comunicazione passa tra le generazioni in un linguaggio comune –. Poi, ecco il tema dell'orto come luogo trasversale alle discipline, perché ci hanno spiegato alcune classi e alcune scuole dei molteplici usi cognitivi e didattici, perché intanto un orto è un luogo matematico, un luogo geometrico, poi c'è la questione delle scienze, delle biodiversità, e dietro le sementi c'è la questione storico-geografica, dei viaggi che hanno fatto alcuni ortaggi, e poi c'è la manualità, le applicazioni tecniche, e poi c'è – ma da lì io sono partita – la letteratura. E così abbiamo scoperto un luogo così apparentemente semplice, letto con gli occhi di oggi – perché è lo sguardo che conta, il duplice sguardo alle cose locali, nostre e alle cose nuove, che sono anche il portato di mondi nuovi che sono seduti nelle nostre classi. Vorrei chiudere questa pagina su Cipollino citando le parole secondo me molto belle che ha usato Ermanno Olmi presentando il suo ultimo film documentario, che potremmo definire un documentario interculturale, Terra madre, su comunità, di donne soprattutto, che coltivano la terra in luoghi diversi del mondo. Così Olmi ha detto alla presentazione: la democrazia è fatta di tanti cittadini che la coltivano, come si coltiva un orto. È diventando ortolani di civiltà che si garantisce la democrazia. 74 Il terzo esempio che faccio è soprattutto un esempio legato a un'esperienza che ho seguito e che ho visto, una scuola che fa un'azione interculturale, a Roma, vicino alla stazione Termini: quartiere multietnico e difficile come sono solitamente i quartieri vicini alle stazioni. Ci sono queste due tipologie di quartieri multietnici e a volte di grande difficoltà: quelli vicini alle stazioni, per esempio San Salvario vicino alla stazione di Torino, o i quartieri molto periferici, staccati dalla città, abbandonati. Torno all'esempio: vicino alla stazione Termini c'è un istituto comprensivo, dall'infanzia alle medie, che ha oltre il 50 per cento di bambini con cittadinanza non italiana, molti però nati in Italia (e a proposito, perché chiamarli alunni stranieri se sono nati in Italia e parlano il dialetto romanesco, e sono quasi tutti tifosi della Roma a calcio? Non si può chiamarli stranieri). Questa scuola ha vicino un luogo che è il Museo Nazionale di Arte Orientale, con cui ha organizzato un percorso che ha come protagonista un personaggio-ponte che sono le scarpe. Perché anche gli oggetti, come insegnano le fiabe, sono dei personaggi, come diceva Propp: un bastone, gli stivali, parlano, sono dei personaggi, il sacco... anche gli oggetti possono essere personaggi comuni, personaggi che fanno da ponte tra culture. Il museo ha allestito per alcuni mesi un'esposizione di scarpe – anche sandali, babucce, stivali – provenienti dai Paesi d'Oriente, i Paesi che sono quelli del Museo di Arte Orientale, ovviamente: si va dalla Tunisia all'Afghanistan al Giappone –: hanno tolto le scarpe dalle vetrinette dove erano inaccessibili e hanno fatto un altro percorso, un'altra esposizione, tutta di calzature, intitolata Quattro passi per l'Oriente. La scuola, parallelamente e insieme, ha organizzato un percorso intitolato Nelle scarpe degli altri, e gli alunni da una parte andavano a visitare l'esposizione del Museo, dall'altra a scuola avevano cercato nel loro museo immaginario – che è quello delle storie che si conoscono, quello dei libri, del fantastico – scarpe, stivali, sandali, dentro le fiabe o i romanzi. 75 Poi è stato fatto un laboratorio pratico con gli insegnanti di educazione tecnica e artistica al Museo in cui i bambini e i ragazzi hanno fabbricato delle scarpe alla luce del percorso che avevano fatto dentro i libri, ma anche suggestionati dalle calzature che avevano visto nelle vetrinette. Hanno inventato e costruito manualmente dei loro modelli, con materiali diversi. C'erano delle scarpe incredibili, per esempio delle scarpe fatte con le cravatte vecchie prese al papà che non le usava più, delle scarpe di stoffa, oppure c'erano scarpe di legno, c'erano scarpe col muso di tigre perché siamo nell'anno della tigre e in questa scuola ci sono molti indiani e cinesi, hanno perfino inventato – e secondo me è un'invenzione che andrebbe brevettata – degli stivaletti col navigatore dentro: uno mette le calzature e viene guidato. Ho detto all'inizio che siamo in una scuola che ha il 50-60 per cento di bambini stranieri, molti indiani, pakistani, bengalesi: insieme si è lavorato su un tema comune. E che tema! Le scarpe appartengono a tutte le culture del mondo e nello stesso tempo ci parlano del mondo – perché a volte basta vedere le calzature di una persona e capire forse da che parte viene, perfino di che classe sociale è –, e poi si legano al grande tema delle religioni, di togliersi le scarpe quando si entra in un tempio: noi non lo facciamo nella nostra religione, ma in altre sì, ed è un gesto importantissimo il togliersi le scarpe. Quindi in questo caso le scarpe hanno la valenza di Pinocchio, di personaggio-ponte: naturalmente le scarpe sono un po' dappertutto, pensate a Charlot che cucina gli spaghetti con le stringhe delle scarpe, o ai romanzi, ai racconti, alle fiabe. Chiudo con una notizia e con un proverbio che hanno raccolto i bambini. La notizia è che partirà a ottobre un concorso nazionale proposto da Italia 150 insieme al Ministero dell'Istruzione sul leggere di nuovo oggi le Fiabe italiane di Italo Calvino: quanto sono italiane quelle fiabe? Quanto c'è di locale e quanto c'è del mondo, quanti prestiti, quante influenze? E questo è il momento di andare a cercare le influenze, i prestiti, le contaminazioni che nelle Fiabe italiane ci sono. 76 Il proverbio con cui vi saluto è stato trovato da questa scuola di cui vi ho parlato ed è questo, e contiene forse un po' l'idea dell'intercultura: non giudicare un uomo se non hai camminato per tre lune nelle sue scarpe. Che è un po' la proposta di mettersi nei panni degli altri, e quindi nelle scarpe degli altri. 77 78 Intercultura: qualche suggestione geo-cartografica Maria Teresa di Palma Docente di materie letterarie presso un Istituto Professionale, attualmente sta svolgendo un dottorato di ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità presso l'Università di Bergamo. Si occupa di didattica della geografia e utilizzo delle ITC nella didattica. Su tali tematiche partecipa alle attività del CIM di Pavia. La mia relazione si divide in due parti, la prima più teorica e la seconda invece più pratica. Partiamo da alcune considerazioni. Mezzo secolo fa ude antropologi, Kluckhohn e Kroeber, avevano raccolto in un'antologia [The nature of culture (1952; trad. it. 1976)] più di duecento definizioni del termine “cultura”. Da allora molte cose sono cambiate e il numero delle definizioni è ancora aumentato, e soprattutto è cambiato il significato dato a questo termine. Per questo la parola “cultura” è fonte di incertezza e di fraintendimenti. Oggi ormai tutti sappiamo di vivere in una società multiculturale, e colpisce che nel titolo di questo convegno si sia usato l'aggettivo “multietnico”. A dire il vero, anche la parola “etnia” non dà sicurezze, forse meno ancora di “cultura”, anche se ormai “etnico” è usato per dire che si va a mangiare al libanese sotto casa oppure per indicare la collana comprata dal senegalese nel banchetto sulla spiaggia. Uno dei rischi e dei vantaggi del ragionare per culture è che in tal modo si prende atto del fatto che ci sono gruppi di persone con abitudini diverse: il vantaggio è quello di riconoscerne l'esistenza come gruppi, mentre il rischio è quello di dimenticare che poi all'interno del gruppo ci sono le persone con le proprie specificità: c'è cioè il ri79 schio della generalizzazione, quella stessa generalizzazione che ci fa dire che gli zingari rubano, che i cinesi sono furbi, che gli ebrei sono intelligenti e che noi siamo meglio di tutti gli altri. Quindi ragionare per culture come se fossero categorie fisse non tiene più, o meglio, tiene meno di altre categorizzazioni molto più solide come quelle tra ricchi e poveri. Non dimentichiamoci, come può accadere ragionando troppo per culture, che oggi i poveri sono in aumento e coloro che restano ricchi aumentano le proprie ricchezze. Inoltre, come sostiene Fabietti, da qui può derivare che la tendenza a enfatizzare la dimensione culturale come elemento di distinzione a fini di autovalorizzazione, quello che viene chiamato il culturalismo, unito a qualche forma di rivendicazione di autenticità, cioè di unicità fondata sulla differenza esasperata, può generare mostri come i nazionalismi, gli etnicismi, il nativismo intellettuale, perché la differenza diventa sinonimo di esclusione. Allo stesso modo l'enfasi sulla cultura può essere alla base di progetti egemonici planetari come quelli condotti all'insegna dell'ideologia dello sviluppo che riconduce popoli e nazioni a gradi di una scala di valori basata su criteri di tipo economico o tecnologico. Se il concetto di cultura può ancora implicare un'idea di appartenenza e di identità, tali appartenenze e identità non sono più concettualizzabili in forma tassonomica, la cultura y, la società z, ma in termini di interazioni. Le culture, come dice Hannerz, sono delle strutture di significato supportate da reti sociali che non sono totalmente basate sui singoli territori. Esiste inoltre un secondo rischio nel ragionare per culture, e cioè quello di dimenticare che una cultura, se pure se ne vuole mantenere una compattezza, non è sempre la stessa, e che al contrario ha una storia, in certi momenti è più aperta, è più in movimento, e in certi altri è più chiusa, statica, e che a volte si muove in avanti a volte indietro: come scrive Morin, un momento di un'evoluzione storica. Tutto ciò ha molto a che vedere con la geografia, che dell'antropologia dai tempi di Erodoto è una fedelissima compagna. Se si analizzano molti dei libri di testo di geografia in adozione nelle scuole 80 secondarie di primo grado si noterà che non manca un capitolo relativo se non alle razze – termine ormai tabù sostituito dal più politicamente corretto “etnie” –, alle culture e alle tradizioni legate a un certo territorio, se non addirittura a un certo stato. Che senso ha mantenere la coincidenza di cultura e territorio come entità localizzata in un mondo in cui prevale, come lo chiama Fabietti, il traffico delle culture? Diverso sarebbe spiegarne l'origine in base alle condizioni ambientali, e soprattutto spiegarne le trasformazioni indotte dal mutamento di tali condizioni. Se i mutamenti che hanno investito il mondo hanno portato gli antropologi a mettere in dubbio i fondamenti delle suddivisioni culturali, questi stessi mutamenti hanno portato i geografi, e in particolare i geografi politici, a vagliare attentamente e a mettere in discussione le categorie metageografiche, come le chiama Elena Dell'Agnese, come quella di stato, continente, confine, punti cardinali, nazione ed etnia, concetti che stanno alla base della nostra visione e suddivisione del mondo. Ad esempio, una visione maggiormente storicizzata ha da tempo fornito dinamismo a un concetto come quello di “regione”, che va ben al di là quella questione delle regioni amministrative e degli stati. Nella regionalizzazione di volta in volta si decide quale sia la partizione territoriale più adatta allo studio di un certo fenomeno. Così, rappresentare la propria realtà come centro del mondo a volte può essere corretto, è però altrettanto importante avere la capacità di decentrarsi, di assumere altri punti di vista. Altro concetto quello stato-centrico. L'interpretazione stato-centrica della politica noncurante di quale scala venga considerata appare sempre più limitata e limitante, scriveva nel '94 Adalberto Vallega. La combinazione di fattori quali la globalizzazione, l'emergere delle tecnologie informatiche, il crescente potere delle reti di città mondiali e la fine della guerra fredda, ha eroso la sovranità dello stato, offuscato il confine tra interno ed esterno relativo allo stato e prodotto una società globale comune. 81 Con ciò però non si vuole affermare che la territorialità in quanto tale sia scomparsa, ma piuttosto che lo stato territoriale offre sempre meno monopolio sull'esercizio della violenza, sempre meno controllo sulle transazioni economiche e sempre meno terreno per le identità politiche rispetto al passato, almeno in molte parti del mondo anche se gli eventi si svolgono ancora in luoghi specifici e in un mondo ancora diviso politicamente in unità territoriali di qualche tipo. E d'altro canto la spinta alla globalizzazione porta a un rafforzamento dei particolarismi, costruendo identità che operano contemporaneamente a scale geografiche diverse. Proprio questa compresenza di diverse scale fa della geografia uno strumento indispensabile per analizzare questa complessità, cioè che un fenomeno è contemporaneamente frutto di elementi che insistono, pur a scale diverse, su uno stesso luogo, così come più identità coabitano in ciascuno di noi. Infine, tra le tante questioni geografiche che meriterebbero una trattazione, mi limito ad accennare a come sia cambiato il concetto di “confine”. Certo, c'è il confine di stato, ma non tutti i confini degli stati sono uguali, soprattutto uguali nei due sensi. Un confine può essere invalicabile in una direzione ma non in un'altra, come il confine tra Stati Uniti e Messico, e basta pensare a cosa succede sulle nostre coste dove il confine formale non coincide con quello reale: fermare le emigrazioni eritree – prendo l'esempio più brutale e recente – non è fatto dalla nostra guardia costiera, ma dai nostri accordi con Gheddafi che fa per noi il lavoro sporco di rimandare a casa a piedi nel deserto centinaia di profughi e perseguitati politici: ecco che il nostro confine si è di molto spostato, soprattutto è diventato un confine, per così dire, negoziabile. Per non parlare del problema dei confini per le merci, per i traffici illeciti. Inoltre il confine nei momenti di tensione, si sa, è il luogo dell'esclusione, mentre in momenti di abbondanza è il luogo dello scambio – basta pensare alla nascita di Roma. Quanto, a scuola, questo concetto viene sviluppato in questo modo? La geografia che si limita all'elencazione di stati, prodotti, risorse e confini statici è una geografia mummificata, che insegna che 82 l'ordine del mondo è eterno, non è quella che fornisce una bussola o meglio qualche coordinata per non perdersi nei continui rivolgimenti che ci coinvolgono, eppure è quella generalmente più praticata dagli insegnanti, con la scusa che altrimenti i ragazzi non imparano dove si trovano i luoghi. Il risultato è che i ragazzi continuano a non sapere dove si collocano i luoghi e non hanno nemmeno la più pallida idea di che tipo di relazione esista tra un luogo e un altro. Questa tradizione, questo conservatorismo nell'insegnare ciò che ci è stato insegnato, fa sì che gli editori continuino a fare i libri di testo in questo modo, e quindi l'impostazione dei libri di testo non cambia, perché i libri di geografia fatti per temi e problemi non hanno successo, non vengono adottati; viceversa gli insegnanti trovano raramente dei libri di geografia che li soddisfino, per cui il libro di geografia è uno dei libri più cambiati, si continua a cambiare. Per rompere il circolo vizioso sarebbe importante una serie politica di formazione e un aggiornamento continuo dei docenti, affinché sappiano come adottare un libro di testo, come usarlo senza farsi usare, come cogliere gli spunti per problematizzarlo e affinché soprattutto non ne richiedano uno studio pedissequo, che è quello che più viene fatto in geografia. Rispetto alla questione dell'intercultura, che è l'oggetto di questo convegno, si tende a far ricadere sul singolo insegnante la totale responsabilità di una buona attuazione di una pedagogia interculturale. Quanto spesso gli insegnanti che cercano di mettercela tutta per farlo alla fine dell'anno si sentono falliti perché quei risultati che si erano proposti e per cui hanno lavorato durissimamente tutto l'anno poi sono stati raggiunti solo in parti minime? La responsabilità non va fatta ricadere solo sull'insegnante, forse va condivisa con la struttura della società di cui la scuola è un'articolazione. Ciò detto, non voglio fare del disfattismo, ma cercare di ragionare su come, pur in tale contesto, possono essere trovate delle mediazioni utili e soprattutto come può essere utile la geografia che quanto a trovare le strade dovrebbe abbastanza intendersene. Dire che la nostra società è multiculturale o multietnica significa riferirsi solo alla composizione della popolazione; i rapporti che poi 83 tra le varie componenti vengono a crearsi sono il frutto se va bene di negoziazione oppure più frequentemente di adeguamenti se non di acculturazione. Come può un insegnante, anche un team di insegnanti, fare fronte come spesso viene richiesto, a tante esigenze e a tante tensioni? Per rispondere prenderò spunto da due tra le caratteristiche della pedagogia interculturale delineate da Ezio Compagnoni. La prima è: la scuola non deve essere un'istituzione autoreferente, decontestualizzata, separata dalla cultura e dalla società che agisce su un dato territorio, ma componente principale di un sistema educativo integrato che diventa spazio di socializzazione dei giovani e realizza un'integrazione del sapere scolastico con il mondo del lavoro, con la storia di un territorio, con le grandi problematiche culturali in cui i giovani sono coinvolti attraverso i media. Si può attuare un insegnamento interculturale in una scuola che riesce ad aprirsi al territorio solo in modo formale? Faccio subito l'esempio concreto a cosa mi sto riferendo: con l'autonomia, ogni istituto scolastico ha il diritto-dovere di approntare un piano dell'offerta formativa, che delinei le proprie politiche scolastiche a partire da un'analisi del territorio e delle sinergie che in esso si possono attivare. Questo non solo per capirne la vocazione in senso produttivo, ma anche per meglio individuare i bisogni formativi di chi ci sta vivendo, di chi ne sta vivendo tutte le problematiche. Ora, chi insegna sa benissimo come vengono fatti i POF, soprattutto nella parte di analisi delle caratteristiche territoriali. Già in questo una diffusa preparazione geografica, non quella su mari, monti, fiumi e capitali, aiuterebbe ad aprire la strada a una possibilità concreta di attuare una pedagogia interculturale. La geografia infatti insegna che i luoghi sono spazi vissuti, abitati, frequentati, costituiscono la dimensione spaziale dei legami sociali, hanno la funzione di attrattori perché svolgono una pluralità di funzioni: possono aggregare,rinforzare l'identità e il senso di appartenenza, dare sicurezza, conservare la memoria così come sperimenta84 re soluzioni innovative e nuovi progetti sociali, economici e culturali. In sintesi, possono diventare strumenti di inclusione, quindi di costruzione o di ampliamento della cittadinanza. Ma proprio l'attivarsi di tali funzioni può dare origini a processi opposti, creando confini, marginalità, espulsione, emarginazione, insicurezza e alienazione; possono diventare strumenti di esclusione, di ghettizzazione, di mancanza d'integrazione, d'impedimento all'esercizio della cittadinanza. Quindi capirne e analizzare queste due dimensioni per farne emergere la parte inclusiva rientra nei compiti della politica scolastica, è responsabilità di ciascun istituto scolastico. Un POF in cui vengono solo elencati i dati, spesso approssimativi, sulla composizione e sulla provenienza di chi frequenta, serve solo a giustificare le difficoltà e non a superarle. Ma quanti sono gli istituti scolastici che si fanno carico di analisi più approfondite? Quanti, una volta assolta in modo formale la stesura della prima parte del POF, poi continuano a pensare la scuola come un mondo a parte o, per usare il termine di Compagnoni, coma autoreferenziale, nella quale si vive una specie di “second life” ante litteram in cui tutto funziona in modo astratto e in cui ci si rassegna alle disparità? Una scuola che nel POF sa leggere il territorio su cui insiste per riprogettarlo, per farsi agenzia di trasformazione è una scuola che ha maggiori chances di permettere una pedagogia interculturale e, allo stesso tempo, ha più probabilità di essere una scuola in cui si saprà insegnare una geografia viva che entra nel merito dei problemi. E vengo al secondo aspetto della pedagogia interculturale sempre annunciato da Compagnoni e che vorrei approfondire: non è compito della scuola determinare l'identità dell'allievo, identificarlo per racchiuderlo in seguito in una rete di significati, e nemmeno scegliere per lui un'identità qualsiasi. L'educazione interculturale è fondata sul principio dell'identità del bambino, punto di partenza per ogni vera pedagogia, cioè gli allievi hanno diritto a essere considerati pienamente delle persone, dotati di diritti e di doveri, di una storia personale e familiare, di un'individualità complessa da rispettare. 85 Rispetto a quest'affermazione uno dei problemi è: una scuola che non sia strutturalmente interculturale può permettere di attuare una pedagogia di tale tipo? Allora, il problema strutturale a cui mi voglio riferire non è quello dell'organizzazione degli spazi e dei tempi, perché su questo gli insegnanti si arrampicano sui vetri e riescono a fare dei miracoli; il problema più grande oggi secondo me è quello della valutazione: questo è il vero imbuto che scoraggia dal fare intercultura. Un insegnante si chiede: se poi alla fine di tutto quello che faccio devo ridurre tutto a un voto di una singola materia, come faccio? E soprattutto, vale la pena che lo faccia? L'intercultura non è un sapere, o meglio, non è solo un sapere: è un processo di costruzione continua i cui frutti non sono valutabili in termini numerici. Certo, una valutazione e una didattica per competenze sarebbe più funzionale allo scopo, ma come attuarla oggi quando dietro a tanti discorsi sul ritorno al merito in realtà si nasconde una logica ben diversa che è quella del più meritevole, che quindi presuppone delle graduatorie? Difficile conciliare questo con un progetto interculturale in cui il problema non è fare dei confronti ma trovare delle soluzioni condivise. Al centro dell'intercultura, quindi, al centro della pedagogia interculturale, c'è la persona, intesa come essere unico impigliato in una sua ragnatela di significati frutto di mille fili, dalle più diverse origini ma con pari diritti. Allora forse la nostra funzione di insegnanti in questa società complessa è quella di fornire più filo possibile affinché in questo labirinto i nostri studenti possano avere un gomitolo abbastanza corposo per poter trovare la strada, per poterla rileggere, per potersi soffermare, per riflettere su qual è il senso del proprio cammino passato e anche futuro: Arianna per un insegnante non sarebbe un brutto nome. E allora che cosa abbiamo a disposizione, oltre alla buona volontà e alla nostra insopprimibile vocazione missionaria? La nostra competenza didattica e la nostra competenza disciplinare. Quanto alla prima, essa ci porta a far lavorare insieme i ragazzi o con il peer to peer o con l'organizzazione del lavoro per piccoli gruppi in cui ad ognuno 86 viene assegnato un ruolo diverso e commisurato alle sue forze; si chiama personalizzazione e non è facile da attuare perché porta via un sacco di energie, perché richiede una pratica di osservazione e di ascolto che si guadagna con lo sforzo quotidiano, perché richiede anche un aggiornamento costante sugli strumenti – e mi riferisco alle nuove tecnologie – che permettono e facilitano magari la comunicazione e la collaborazione. È un campo molto delicato d'intervento, in cui è richiesta una sensibilità più sottile di quella di un qualsiasi altro professionista. Mi è capitato spesso di leggere o di sentire consigliare per fare intercultura – espressione orribile secondo me – soprattutto nelle ore di geografia, di fare delle diversità un'opportunità, nel senso di far diventare il ragazzino straniero di turno il riferimento per le conoscenze sul suo Paese d'origine. Altrettanto spesso ciò nel concreto si dimostra non solo inefficace ma deleterio, e non perché sia un'indicazione sbagliata, ma perché c'è qualcosa che deve essere costruito prima. L'insegnante deve tenere presente che a tutti fondamentalmente piace sentirsi uguali agli altri, per tutti gli adolescenti diventare il centro dell'attenzione non avendolo deciso è paragonabile a un'offesa, inoltre non bisognerebbe forzare chi non vuole a parlare di sé. La competenza didattica è quella che sa mettere in atto strategie che facilitino la comunicazione e deve avere molta pazienza. Se il clima che si sarà saputo creare in classe, se le dinamiche di gruppo lo permetteranno, se il reciproco rispetto è diventato davvero un valore condiviso, se tutti si sentono effettivamente parte non di una classe ma di un gruppo vero, allora prima o poi qualcosa verrà fuori, e allora l'insegnante potrà sottolinearne le valenze. Per quanto riguarda l'altra risorsa che gli insegnanti hanno a disposizione per superare la logica missionaria, cioè la competenza disciplinare, sembrerebbe automatico sostenere che la geografia più ancora di altre materie è facilitata nel fornire gli strumenti per il riconoscimento e per la costruzione delle identità multiple a cui ciascuno di noi appartiene. Credo che sia uno stereotipo da sfatare. 87 Non tutta la geografia, e soprattutto non tutta la geografia che viene insegnata a scuola, aiuta a costruire processi interculturali, anzi: nel senso comune la geografia insegna dove sono le cose, ne elenca le caratteristiche, ne quantifica la portata, ne dà una rappresentazione spaziale, ma se la si limita a questo – che è già tantissimo – si rischia di farne un punto di vista chiuso, finalizzato a una conoscenza astratta, eterna, oggettiva, che ha valore di per sé indipendentemente dalle sue possibili ricadute nella vita pratica. Soprattutto, è una concezione della geografia che porta a giustificare l'esistente, a renderlo eterno e immutabile, è un sapere autoreferenziale che va bene per una scuola autoreferenziale. D'altro canto è verissimo che la geografia aiuta a conoscere altre realtà, e inoltre la ricerca sui temi legati alla mobilità della popolazione è in grado di offrire una serie di strumenti molto importanti per capire una serie di dinamiche della società contemporanea. La stessa critica alla meta-categorie geografiche a cui ho accennato all'inizio è basilare per avviare un discorso geografico aperto, basilare ma non ancora sufficiente: come poi trasformare tutto ciò in intercultura? Cioè, basta sapere per essere più aperti? Sarebbe molto bello ma non è così. Sia ben chiaro, conoscere i dati è fondamentale, e questo è compito di una scuola che fa il suo mestiere, badate bene: non una scuola che fa intercultura, una scuola che fa il suo mestiere. Ma questo non basta, lo sappiamo, perché spessissimo insegnando i dati ci siamo trovati di fronte a muri di incredulità, quando dicevamo “i rom sono solo 120.000”, questi muri avevano le proprie fondamenta nella paura di quello che si è, muri tanto più incrollabili quanto più chi li ha eretti è stato a sua volta violato ed escluso. Avviare quindi un processo interculturale richiede un coinvolgimento, un mettersi in gioco, ed è questo ciò che oggi la ricerca geografica sta facendo. Oggi, scrive Cristiano Giorda, a livello epistemologico siamo sempre più consapevoli, noi come geografi, di essere parte in causa rispetto alle trasformazioni future del territorio nell'individuare valori e criticità, visioni e trasformazioni e nel partecipare attivamente alla negoziazione sociale dei suoi cambiamenti. 88 Così il punto di vista del geografo non è un punto di vista sul mondo ma nel mondo che si viene costruendo in itinere, coniugando costantemente le diverse scale possibili, dal globale al locale e viceversa, e soprattutto facendone il più possibile partecipi tutti gli attori coinvolti. Così il sapere geografico diventa un sapere dinamico, in continuo cambiamento perché il gioco tra globale e locale muta lo scenario da un luogo all'altro e anche nello stesso luogo ma in tempi diversi. Anche in classe la geografia nasce nella discussione e nel confronto, nell'invenzione, nella progettazione e nella sperimentazione di soluzioni possibili a piccoli problemi quotidiani che poi spetta – questo sì – all'insegnante, alla sua capacità di tradurre a scale via via crescenti, di riportare quindi al generale. In questo, nel fare della scuola il punto di partenza all'esplorazione della realtà quotidiana di quanto ciascuno sta vivendo per intrecciarne i fili con ciò che succede o è successo altrove e a qualcun altro, sta il plusvalore dell'insegnamento/apprendimento della geografia sul piano della costruzione di un processo interculturale. Scriveva Compagnoni al termine della sua elencazione dei punti di forza della pedagogia interculturale che è fondamentale la questione di come si insegna, del ruolo che deve avere il discente nel rapporto didattico, del tipo di metodologia che viene adottata, perché difficilmente si acquisirà una mentalità aperta partendo da un metodo di insegnamento rigido e poco condiviso. Ebbene, la geografia non si può insegnare e soprattutto apprendere diversamente. La geografia è fatta di ciò che si vede ma anche di ciò che si sente e si odora, di ciò che si vive, le nostre emozioni. L'educazione alla sostenibilità ha qui le sue radici. Così come non basta far studiare le dinamiche della popolazione e gli innegabili vantaggi delle recenti immigrazioni per produrre un clima di rispetto e civile convivenza, allo stesso modo non è sufficiente conoscere le problematiche della sostenibilità ambientale per produrre comportamenti sostenibili. Quando si riduce la geografia a una serie di argomenti da trasmettere, preconfezionati e immodificabili, non solo se ne tradisce lo statuto epistemologico, ma se ne perde la ricchezza che deriva da 89 una partecipazione che consente di fare dei vissuti dei casi di studio da approfondire che allargano i nostri orizzonti e nello stesso tempo aumentano un elemento fondamentale nel processo di apprendimento, che è la motivazione, che viene dal sentirsi effettivamente parte in causa in quanto si va studiando. E nel farlo l'insegnante non può chiamarsi fuori: deve tenere l'occhio aperto anche su di sé, deve esercitare un po' quello che gli antropologi chiamano “lo sguardo strabico”, che guarda sia il dentro sia il fuori, che diventa conscio dei suoi propri stereotipi e che nel confronto anche con i suoi studenti si arricchisce. La scuola del confronto e della partecipazione è una scuola viva anche per l'insegnante, è una scuola sicuramente più viva di quella che cerca solo la conferma, una conferma che non può che essere frustrata. Da sempre, l'alunno più bravo non è l'alunno fotocopia, ma quello che è diventato altro, altro da quanto era all'inizio ma anche altro da quanto è l'insegnante. Certo, bisogna trovare gli strumenti e bisogna trovare dei suggerimenti o delle suggestioni, come le ho chiamate nel titolo della mia comunicazione. La suggestione mi è venuta a partire da un focus group fatto con dei docenti qui a Pavia e organizzato dal CEM, il Centro per l'Educazione alla Multimedialità, su come diffondere maggiore informazione sull'Unione Europea. In tale occasione sono stati proposti e poi esaminati diversi materiali didattici distribuiti nelle scuole dalla Direzione generale affari economici e finanziari della Commissione Europea. Il primo è questo: una carta murale dell'Unione Europea e il secondo è un librettino, Uniti nella diversità, che ritengo possa definirsi come un piccolo atlante degli Stati dell'Unione Europea. Si tratta di carte geografiche? È evidente come siano rappresentazioni approssimativamente basate sulla rilevazione astronomica e su un sistema di proiezione della sfera sul piano: mancano di scale, e quando compaiono queste scale sono decorative. Il rapporto con la realtà è decisamente impreciso. Nonostante ciò forniscono molte informazioni sugli Stati rappresentati. 90 In questo che ho chiamato Atlante, le tavole dei singoli Stati, cioè le varie pagine, si succedono in base all'ordine alfabetico degli Stati e non, come avviene di solito in un atlante, per contiguità territoriale. In alto, sopra il disegno, vicino all'indicazione dello Stato, compaiono la sua estensione, il numero degli abitanti, la bandiera, lo stemma, l'anno di ingresso nell'Unione Europea e, se in uso, la raffigurazione del conio locale dell'euro. Inoltre le uniche parole scritte sono il nome della capitale e il modo di salutare, che informa non solo e non tanto sulla lingua parlata, quanto sui caratteri della scrittura. All'interno del disegno sono presenti prodotti agricoli, animali, piante, località turistiche, monumenti, opere d'arte, musica, danza, sport, prodotti tipici, costumi folkloristici, ritratti di uomini famosi nel presente e nel passato, accomunati dal fatto di esserlo per avere dato in qualche modo lustro alla propria nazione. In esse cioè convivono sullo stesso spazio tempi diversi, personaggi reali e personaggi immaginari. L'unico elemento di unità quindi è quello territoriale: come fare a non chiamarle carte geografiche? Certamente gli aspetti morfologici sono molto approssimativi, quasi assenti, e i toponimi totalmente omessi. Ciò dipende dal fatto che il tema vero e proprio di ciascuna carta è la forte connotazione cultural-identitaria di ogni singolo Paese, e in questo se ne può leggere la funzione. Una carta geografica può porre molte domande, e vedremo quali, ma nasce come una risposta a cui va associata la domanda appropriata. È inutile cercare su una carta stradale le profondità marine, è ovvio, e però potrebbe già essere un ottimo spunto per aprire una discussione in classe, sia nelle scuole medie sia nelle scuole secondarie di secondo grado, sul perché una carta geografica è fatta in un modo piuttosto che in un altro. Una volta stabilito che ci troviamo di fronte a carte geografiche è interessante stabilirne la tipologia. Gli anglosassoni nel loro pragmatismo le chiamano maps for kids, sottovalutandone il potenziale ideologico. Dietro all'ingenuità del tratto, all'infantilismo ammiccante del disegno spiritoso, ci stanno messaggi molto seri sull'identità, sul sentimento di appartenenza, sul senso dei luoghi. 91 Come a volte capita, diamo in mano ai bambini degli oggetti molto più complessi di quanto non vogliano sembrare e anzi, la loro apparente semplicità diventa un mezzo formativo potente di una visione del mondo e delle sue divisioni. Non avendo trovato in italiano un nome secondo me adatto, mi sono inventata il termine b-maps per assonanza con il termine b-movies, che sono i film a basso costo, pieni di stereotipi, apparentemente inaccurati, ma che danno la possibilità di studiare la cultura popolare. Ecco quindi una seconda suggestione: non tutta la cartografia è uguale. Esiste quindi una cartografia diciamo così “di serie a”, quella “scientifica” nel senso che mantiene un rapporto metrico con la realtà; una cartografia razionalista, fredda, che registra ciò che è misurabile e visibile, e una cartografia “di serie b”, non meno scientifica – perché la comunicazione che c'è dietro queste carte è fortemente scientifica, fortemente studiata – ma che della realtà coglie gli aspetti più astratti, ideologici, che si serve di un linguaggio immediatamente comprensibile e fortemente emotivo, che parla al ventre delle persone, mentre l'altra si rivolge alla testa. Diversi modi di rappresentazione compresenti perché rispondenti a bisogni diversi, entrambi però fortemente connotati e ovviamente storicamente determinati. E qui si potrebbe usare la storia della cartografia per far vedere come in altri periodi storici, pur nell'ambito della stessa civiltà, fossero compresenti rappresentazioni diverse e il ridurne la ricchezza porta non solo ad appiattire la complessità presente in ogni epoca, ma anche a formulare giudizi errati: quindi trattare della rappresentazione cartografica come documento storico potrebbe essere d'aiuto nella didattica della geografia soprattutto in questo momento. Con la recente riforma delle superiori, geografia si insegna solo negli istituti tecnici-economici. Nei licei le ore di geografia sono accorpate a quelle di storia, ma sappiamo che le competenze che la geografia può dare restano e sono presenti. Come fare a continuare a insegnarla anche se dal tabellone orario è stata estromessa? Un buon modo per farlo può essere proprio il ricorso alla storia della cartografia, che da discorso marginale può diventare il terreno di 92 aggregazione che permette di tenere insieme diverse discipline. Lavorare all'analisi di un documento cartografico inteso come prodotto di un tempo e di uno spazio determinati, costringe a mettere in campo competenze legate, oltre che alla geografia, alla storia, alla filosofia, alla storia dell'arte, alla matematica e alle tecnologie. Le carte geografiche antiche mostrano non solo dei modelli del mondo che possono essere diversi dal nostro – e quindi già far vedere delle differenze –, ma proprio i modelli su cui coloro che sono venuti prima di noi hanno basato le proprie visioni e le proprie decisioni: in pratica, su cui la stessa storia si è fatta. Certo, viene da chiedere: ma chi è che è in grado di farlo? Di nuovo torna il problema della formazione, e anche qua: il recentissimo decreto sulla formazione ha dato a geografia pochissimi crediti; nelle università verrà studiata sempre meno. Delle discipline necessarie a formare e tenere aggiornati i docenti: è un discorso molto ampio che non voglio sottolineare qui, ma voglio sottolineare che la geografia, anche se non la si insegnerà più – e la storia della cartografia non si è mai insegnata – deve far parte del paniere di discipline che devono essere insegnate a coloro che vanno a insegnare. Ma torno ancora alle carte che ho proposto e a cui si può iniziare a pensare, visto gli spunti che se ne possono trarre, non come maps for kids ma come materiale didattico adatto anche agli studenti delle superiori, cosa di cui peraltro era convinto il gruppo di docenti delle superiori che aveva preso parte al focus group pavese. Infatti, di fronte all'alternativa se utilizzare le carte che abbiamo visto oppure il libretto Il cammino dell'euro, i docenti si sono espressi in modo più favorevole per l'utilizzo del materiale cartografico. Perché questa convergenza nella scelta da parte degli insegnanti delle superiori? Credo sostanzialmente per due motivi. Il primo è di natura più antropologica, cioè può avere a che fare con la storia di quei docenti, per lo più donne, appartenenti a una fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni – l'età non è una questione indifferente quando un gruppo di persone concorda su una scelta di questo tipo –: soprattutto quando ci troviamo di fronte rappresentazioni cartografiche, l'occhio ha le sue abitudini. 93 Orbene, questo aspetto personale ha portato me a ripensare a quali erano le mie, di abitudini, e a quali erano le carte che mi sono rimaste più impresse quando andavo a scuola io. Alcune erano di un disegno più rigido inserite nei volumi dell'enciclopedia Vite meravigliose, oppure come quelle inserite in una collana per ragazzi che ebbe ristampe continue tra il 1956 e il 1986 che si chiama Meravigliosa Italia. È interessante – apro un'altra parentesi – notare di carte che cominciano a circolare nel 1938, in pieno fascismo e in clima di esaltazione delle identità locali. Non mi soffermo su tutte le varie edizioni che si susseguirono di queste carte, con poche variazioni di contenuto, dal 1938 al 1970. Basti sapere che nel 1951 ne venne fatta un'edizione in un Atlante delle Regioni d'Italia pubblicato a cura dell'Economic Recovery Program, il Piano Marshall: si tratta di qualcosa di più di una fortuita coincidenza, e anzi questo potrebbe dare lo spunto per un altro lavoro in classe, per sviluppare un'unità didattica su come un'immagine cartografica venga riutilizzata senza modificazioni prima durante il fascismo, con fini evidenti di esaltazione dell'identità regionale, e poi dagli statunitensi per sottolineare il proprio ruolo di alleati in piena guerra fredda – peraltro, a dicembre di quest'anno l'Assessorato alle culture e identità della Regione Lombardia ha fatto finalmente una mostra con tutte queste carte. Questa digressione mi serve per riprendere il discorso sullo “sguardo strabico” che facevo prima, cioè gli insegnanti dovrebbero ricordarsi e far attenzione a quanto importanti siano nel nostro agire didattico le immagini che ci siamo sorbiti fin da piccoli per non dimenticare la nostra stessa storia, i modelli che ci hanno formato e che per questo facciamo fatica a riconoscere come di parte. Vengo ora al secondo motivo, che poi è quello dichiarato, rispetto alla scelta operata dagli insegnanti rispetto a questo tipo di carte, e che è un motivo più squisitamente didattico. La motivazione che essi avevano dati riguarda gli alunni, perché i ragazzi sono più abituati al linguaggio iconico, come spiegano tutti gli esperti di digital natives. Quindi presentare carte geografiche di questo tipo, un po' spiazzanti per la naiveté dei disegni, sicuramente può accendere 94 l'attenzione e innescare la motivazione di tutti. Inoltre con questo materiale, sempre a detta dei colleghi, si può fare un buon lavoro sugli stereotipi nella visione dell'altro. A questo punto si aprono altri interrogativi: gli stereotipi sono sempre inutili e dannosi? Come evitare di passare dallo stereotipo al pregiudizio? Per rispondere proviamo ad analizzare gli elementi presenti nella carta murale dell'Europa e quelli presenti nelle carte regionali. Nella prima, poche saranno le illustrazioni, e queste non daranno quasi adito a difficoltà se non nei bambini più piccoli; il che porta a una prima considerazione sull'utilità di alcuni stereotipi geografici come punti di riferimento di base. Insomma, non credo che ci sarebbe da ridire sul fatto che si sappia che a Milano c'è il Duomo e che a Roma c'è il Colosseo, oppure che l'Italia è il territorio in cui sono nati Pinocchio e Leonardo da Vinci, mentre è chiaro che raffigurare la Sardegna come un pascolo per pecore che si riparano dietro a un misero sughero è effettivamente qualcosa che, oltre a scontrarsi con l'esperienza diretta che di essa possono avere i ragazzi, facilita la nascita di un pregiudizio, cioè la visione dell'isola come di una regione economicamente e culturalmente arretrata. Quindi dovremo cercare, per usare uno stereotipo, di “non buttare il bambino con l'acqua sporca”: se non ci sono conoscenze di base, anche gli stereotipi possono andare bene, poi il compito della geografia e dell'insegnamento in generale sarà proprio di partire da lì per far scoprire la complessità della realtà – e con questo non intendo farne aumentare le conoscenze, ma la problematizzazione, la problematicità. Quindi ben vengano queste carte se però non sono abbandonate sul muro, ma vengono discusse, usate, integrate, approfondite e modificate. Molti di questi stereotipi poi sono qui usati come simboli nazionali: ecco che il discorso si fa più complesso e decisamente difficile per i bambini delle elementari, mentre diventa molto più interessante per i ragazzi delle superiori. Decostruire questo tipo di simboli è il lavoro da fare. Ma come? Intanto partendo dalla loro conoscenza, dalla conoscenza del loro significato e prima dii tutto da una riflessione sui simboli associati al 95 territorio dello Stato in cui viviamo, da un'indagine se siano ancora sentiti come simboli dai nostri ragazzi, ritenuti validi, e su quanto invece siano sentiti come parziali o limitanti o negativi, andando a scoprire quali poi sono frutto di storia e quali invece sono frutto di leggenda, magari andando a riprendere dei brani del libro di Hobsbawm L'invenzione della tradizione, magari approfondendo la conoscenza del territorio reale, delle sue caratteristiche, delle sue articolazioni, delle sue specificità, ma anche delle interdipendenze con e dagli altri Paesi. Un buon lavoro sarebbe quello di aggiungere nuove illustrazioni che servono a dare una visione più articolata di quella che si ritiene essere la propria identità, cioè che siano i ragazzi a inventare e a dire quali sono i simboli in cui loro si riconoscono; a questo punto poi si può andare a vedere quanto in grado si è di ri conoscere i simboli degli altri. Al di là di questo, quello che emerge lentamente man mano che procediamo nell'analisi di queste carte però è una concezione dell'Unione Europea e direi dell'intercultura – ed è questo che mi interessa –, che merita di essere esplicitata, perché anche questo può dare origine a un buon lavoro in classe e non solo: una concezione che vede questa realtà sovranazionale come la somma delle realtà nazionali prese in toto, però se noi andiamo a vedere nel passaggio di scala tra la carta regionale e la carta europea, che cosa succede? Che siccome ci deve stare più spazio, andiamo a una semplificazione: nella prima abbiamo molti simboli e riferimenti, nella seconda diminuiscono fortissimamente: si è andati a una semplificazione. Questo è un discorso molto importante: cosa vuol dire fare intercultura? Uniti nella diversità. Questa somma che cosa ci fa perdere? È giusta questa domanda? La domanda che viene da porsi è: come fare a costruire intercultura, a costruire ad esempio l'Unione Europea? E su questo ci sarebbe molto da discutere, e non solo per i ragazzi, ma i ragazzi sono gli unici che dalla nascita sono cittadini europei, quindi: come cambiare la carta per arrivare a un risultato diverso? Come fare per non perdere delle cose unendo le diversità? L'operazione che è stata fatta dagli autori di questa carta è stato un pas96 saggio di scala, ma non di transcalarità, che è un concetto fondamentale della geografia, perché transcalarità significa che a ogni cambiamento di scala corrisponde un cambiamento ma non tanto nel numero degli elementi da considerare, ma totalmente dei criteri di scelta e del problema da porsi, così come quando nel cinema si passa da un piano a una panoramica, da un dettaglio a un piano americano. Cambia completamente il messaggio. Quindi, transcalarità significa inoltre tenere conto della scala più piccola, quella mondiale: l'Unione Europea esiste perché esistono altri stati, altri organismi sovranazionali, altre economie. Allora, per fare sì che sulla carta dell'Unione Europea venga mantenuta la ricchezza presente nelle carte dei singoli stati, forse bisogna che la domanda di partenza sia diversa, sia relativa a come ciascuno può contribuire alla costruzione di un territorio comune, con quali stereotipi e con quali simboli e soprattutto con quali valori. La risposta non è facile né scontata, però vale la pena provare a porla ai ragazzi proprio perché loro sono cittadini europei: chi sa che non venga proprio da loro un aiuto per cominciare a ripensare in questa chiave anche i nostri curriculi scolastici. Per concludere, sarà lo scambio e il confronto delle conoscenze e delle informazioni – e soprattutto la volontà di metterle in comune –, in poche parole l'interattività vera, non virtuale, che porterà a costruire una cartografia partecipata, perché dietro ci sono stati competenza, compartecipazione, collaborazione, e non solo nella scelta dei mattoni che costruiscono la conoscenza, ma anche nella modalità di rappresentazione, e questo indipendentemente dai mezzi tecnologici a disposizione e forse proprio perché liberi da questi strumenti. Quello che conta è decidere non solo quale sia il primo passo, ma anche quali siano le scarpe migliori per compierlo. La cartografia non è che un riflesso del cammino percorso. 97 98 Identità e cultura: un autoritratto Kaha Mohamed Aden Nata a Mogadiscio ( Somalia), residente a Pavia. Consegue Laurea in Economia e un Master alla Scuola Europea di Studi Avanzati in Cooperazione e Sviluppo presso l’Università di Pavia. È impegnata su tematiche sociali in particolare quelle attinenti alla mediazione culturale e intercultura. Ha pubblicato I racconti Apriti Sesamo, in «Nuovi Argomenti», 27 (2004); 1982: fuga da casa, in: «El-ghibli», 5 (2004) on line; Autopresentazione, in: Forme della diversità, a cura di C. Barbarulli e L. Borghi, CUEC 2006; Un tè serio bollente, in: Lo sguardo dell'altro, a cura di S. De Marchi, Di Salvo Editore 2008; Eeddo Maryan, in: «Psiche», 1 (2008), Fraintendimenti, ed. Nottetempo, 2010. Tra le performance presentate: The streets of Mogadishu nel giugno 2008 nella settima Conferenza di ISOLA (The International Society for the Oral Literatures of Africa). In occasione del Premio Internazionale Alexander Langer 4-5 luglio 2008 ha messo in scena un racconto/performance dal titolo La Quarta Via, da cui è stato ricavato un video documentario dallo stesso titolo. 99 FRA-INTENDIMENTI Nel 1986, quando suo padre - ministro di Siad Barre - era in carcere già da quattro anni, Kaha Aden ha abbandonato la Somalia per salvarsi dai venti di guerra che avrebbero sconvolto Mogadiscio e tutta la nazione. In Fraintendimenti l'autrice ci racconta due tipi di esperienza del conflitto: la guerra civile fra i clan somali, le riunioni dei saggi sotto le acacie, il profumo di zenzero e cardamomo in una tazza di tè, i soldati bambini in pantaloni kaki. E i pregiudizi che accolgono la sua nuova vita a Pavia, dove ha studiato, e la costringono a un'identità che non sa più nulla dei poeti, dei guerrieri, degli spiriti degli antenati e delle leggende dei clan. Un mondo di colf, collegi di suore, Uffici Immigrazione senza interpreti, un mondo in cui il nero è il colore della prostituzione. Questi racconti danno voce a una Somalia di famiglie allargate, di matriarche, di anziani saggi e di animali parlanti, a cui risponde un'Italia di contraddizioni, burocrazia e ambigua ospitalità. Uno sguardo ironico e spregiudicato per descrivere il difficile passaggio fra due mondi che caratterizza il nostro tempo. 100 UN RITRATTO Mi è stato chiesto di mandare una mia prensentazione. Non è mai facile autopresentarsi. Ho deciso di raccontare in modo molto conciso tre delle mie numerose Nonne. Ho avuto tante nonne; un fatto ordinario in quella che fu la Somalia e straordinario in Italia. Sicome i miei genitori hanno sperato che queste lasciassero un’impronta sul mio carattere o perlomeno nel mio cuore, presentandole spero di presentarmi indirettamente quindi di soddisfare la richiesta che mi è stata fatta. Fine anni quaranta. C’era una casa nel quartiere Skuraran. Alla fine degli anni quaranta c’era una casa dove studiavano le bambine e i bambini che assorbivano il verbo dell’indipendenza. Infatti, alla fine anni quaranta c’era una Lega che lottava per l’indipendenza e i militanti di questa Lega andavano a confabulare i loro intrighi in una casa un po’ matriarcale, piena di mistero e fitta di relazioni. Alla fine degli anni quaranta c’era una speranza ed era nutrita da nonna Xaliima, la padrona di quella casa. Per tutta la mia infanzia, insieme ai miei fratelli, tre mesi all’anno passavo con lei, una generalessa generosa bocca pulita e parole ben composte era il suo motto. Nel suo reggimento bisognava presentarsi con denti e linguaggio brillante tutto qui. Portentosa, regale ed aggressiva, nonna Hawa, quando è stata destinata, da suo padre, come moglie di un suo amico anziano, si è mostrata remissiva e obbediente. Nella sua testa, cornacchie ed aquile si contendevano il posto d’onore. All’alba di quel fatidico giorno, decise di gettare i suoi dadi. Con sorpresa della madre triste, accettò la sua sorte. Si incamminò tutta modesta, dietro il cammello del padrone-marito. 101 Quando il sole arrivò allo zenith e il marito inconsapevole propose uno stop tecnico, lei propose un legden decisivo, una lotta, in genere praticata da maschi, che volevano mettersi in mostra. Incredulo, il neo-marito, cercò di mettere la cosa sullo scherzo: lei invece lo caricò, lo atterrò, prese un’otre d’acqua dalle masserizie deposte, e si avviò verso Galkaio, a circa 120 km. Non si voltò mai più indietro. Nonna Hawa, quella donna ha anche un posto d’onore nell’accesso delle donne al voto politico. Il 19/3/1966 una settimana dopo la mia nascita è stata scelta lei per condurmi fuori dal mio guscio privato. I rumori che ho udito, gli odori, il primo mondo che ho visto e sentito era suggerito da lei. I miei, con tutto quello che comporta, hanno deciso che fosse lei a dirigere la mia prima uscita al mondo, il mio Gardaadis. La mia terza Nonna, Suuban: la Giusta, la corretta. La Madre di mio padre. Lasciava la savana per Mogadiscio solo quando si ammalava. Ad ogni suo arrivo era allegato un otre di carne fine fine essicata, il buonissimo burro profumato e incenso. In camera, dove aveva con sé poche cose, la sua stuoia era il centro di tutto. Quando venivano ospiti in camera sua mi faceva restare e a volte mi chiedeva di partecipare al discorso. Le venivano spesso a trovare le sue con-mogli, le altre giovani spose di suo marito e c’era molto affetto tra di loro e devozione nei suoi confronti. Mi raccontava tante storie sulla Savana dove il leone non era né cattivo né buono ma semplicemente Leone; gli uomini avevano prerogative del genere. L’ultima volta che l’ho vista le chiesi perché non rimanesse a Mogadiscio a vivere con noi e lei mi rispose che non poteva vivere un posto dove era soltanto la madre di Mohamed , mio padre, suo figlio. Attualmente al tavolo delle trattative per la pacificazione dei clan le due famiglie da cui discendono le mie nonne non sono riuscite nemmeno a sedere insieme. Sono tentata di considerare le mie nonne fortunate per non aver assistito all’abbruttimento e al degrado che le loro “famiglie” vivono. La guerra mi ha separato dalla nonna Xaawa. Per fortuna il governo Canadese le ha dato asilo. Una 102 rappresentante, sempre del governo canadese, mi ha impedito di farla visita per paura che anch’io chiedessi asilo. Nella casa delle mie emozioni sono presenti queste donne e, da come ve lo ho presentate, converrete con me che non se ne vanno senza traccia! Sono nata da una famiglia dove le donne direttamente, nonna Xaawa e Suuban, oppure indirettamente, vedi nonna Xaliima, intervenivano su quello che avveniva sotto la quercia, l’albero della discussione. Sono nata da una famiglia dedita per generazioni allo studio del Corano ma il mio nome non si trova fra le pagine del Corano. Il mio nome è un omaggio, una strizzata d’occhio a tanta libertà cercata per l’ indipendenza dell’Africa, agli anni sessanta, quando sono nata. Kaaha: la luce che precede il sole. Il sole forse sono gli Stati indipendenti dell’Africa che dovevano dare vita ad una storia nuova. Per adesso stiamo sguazzando nelle guerre. 103 104 Il cittadino plurilingue: alcune indicazioni curriculari e qualche dubbio Eleonora Salvadori Insegnante di francese nella scuola secondaria di secondo grado, ha svolto attività di ricerca e formazione degli insegnanti, ha insegnato nelle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario dell'Università di Pavia e insegna Francese e Comunicazione presso il corso interfacoltà CIM (Comunicazione Interculturale Multimediale) dell’Università di Pavia. Esperta di progetti europei, è stata comandata presso la DG Affari Internazionali del MPI dove ha coordinato numerosi progetti educativi europei. Ha pubblicato materiali didattici per l'insegnamento della lingua e della letteratura francese. La sua attività si concentra intorno a tematiche connesse con la formazione degli insegnanti di lingua straniera, la progettazione europea, l'interculturalità, l'educazione alla cittadinanza, l'educazione ai media e la promozione del plurilinguismo. Tutto ciò che riguarda l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue è sempre stato per me un interesse profondo perché è un interesse che riguarda il soggetto nella sua complessità e nella sua globalità, e quindi ancora oggi le lingue sono l'elemento su cui continuo a riflettere e sono un oggetto di crescita personale perché attraverso le lingue la mia visione del mondo continua a evolvere, a diventare più ricca, a diventare più libera. Vorrei a questo proposito parlarvi di alcune storie, iniziando così con premesse meno pesanti di quello che poi sarà l'oggetto del mio intervento, che è appunto quello dei curricula linguistici – intervento che ha un aspetto tecnico che cercherò di rendere meno pesante possibile. Vorrei cominciare con una storia che mi sembra una storia interessante anche se banale, perché è una storia che tutti voi avete co105 nosciuto e di cui tutti voi avete già sentito parlare in modo più o meno prossimo o approssimativo. Vi parlo di Giovanna – nome inventato –: Giovanna è una studentessa del terzo anno di Lettere la quale ha fatto un erasmus a Parigi. Al suo ritorno si presenta alla docente e anche a me per chiedere di poter fare una tesi che le permetta di riflettere sull'esperienza che ha vissuto a Parigi, esperienza in cui ha scoperto il piacere di imparare una lingua, ha scoperto quanto, attraverso tutta una serie di esperienze che la mettevano in contatto con interlocutori francesi, tutto il suo modo di vedere se stessa e tutte le strategie che metteva in atto per entrare in contatto con la realtà e in qualche modo per affermare se stessa e non essere troppo succube di questa nuova realtà che la poteva marginalizzare in quanto non possedeva realmente gli strumenti per affermare la propria identità e quindi era oggetto del potere degli altri, attraverso questo sua continua ricerca sulle strategie per sopravvivere e per affermarsi, attraverso questa sua riflessione sui meccanismi e sulle modalità di queste strategie, ha scoperto di esser diventata altra, di aver acquisito un'identità nuova. Così ha voluto poter riflettere su questo processo – un processo duplice: da una parte un processo cognitivo di riflessione sulle strategie messe in atto e d'altra parte un processo identitario, perché la sua identità era intanto profondamente cambiata. E dunque abbiamo fatto una discussione comune, una specie di intervista per creare una sorta di autobiografia linguistica, comprese domande sulle precedenti esperienze – importanti, perché noi siamo plurilingue fin dalla nascita in qualche modo, perché siamo esposti a varietà linguistiche estremamente ricche e plurali. Giovanna ha parlato innanzitutto della sua esperienza scolastica: brillantissima studentessa di un liceo scientifico non pavese che aveva avuto un'ottima votazione in inglese, che aveva studiato per cinque anni mostrandosi una delle allieve più brillanti, era uscita dal suo corso con l'idea di possedere una buona conoscenza dell'inglese, ma soprattutto aveva imparato una materia in un modo molto positivo. 106 Riflettendo però alla luce della come una bellissima materia che permetteva di imparare tante cose, ma una materia come le altre: normalizzata, che aveva assunto una forme scolaire (CIT), e cioè era stata disciplinarizzata ed era diventata una materia di cui venivano imparati in modo fortemente cognitivo i contenuti. Dunque per Giovanna questa materia non era minimamente diversa dalle altre, e quando lei è uscita dalla propria scuola non ha pensato di avere in mano uno strumento concreto con cui porsi in modo nuovo rispetto alla realtà, con cui fare qualcosa di diverso, con cui essere qualcuno di diverso: questo nuovo modo di vedere la lingua – e la funzione, il significato e la ricchezza della lingua – nella sua acquisizione è stato il portato di quest'esperienza fatta a Parigi. Accanto a questo vorrei riportavi una mia traduzione dall'inglese – preciso che io non sono un'anglista, sono una francesista ma ho tradotto questo passaggio che mi sembra estremamente importante e significativo – da Claire Kramsch: una notazione, un passaggio che ci parla proprio del soggetto plurilingue. Prima però faccio una piccola parentesi su questo multi e plurilingue, che Claire Kramsch chiama the multilingual subject, soggetto multilingue noi diremmo. Multilingue e plurilingue sono due parole su cui oggi si riflette molto e che stanno evolvendo nel loro significato, nel senso che in Europa – Claire Kramsch insegna a Berkeley, in California, e assume le terminologie tipiche americane –, noi distinguiamo strettamente tra multilinguismo e plurilinguismo: multilinguismo è in realtà la presenza di più lingue in un unico contesto, plurilinguismo è invece la capacità del soggetto di essere competente in più lingue, naturalmente a livelli diversi. Ma quando Claire Kramsch parla di multilingual subject, parla di quello che per noi è il soggetto plurilingue, cioè del soggetto che è in grado di comunicare in più lingue. Parlare e scrivere in un'altra lingua significa usare una pratica di significazione alternativa che orienta l'intero soggetto nella sua globalità, corpo e mente, verso modi alternativi di percepire, pensare, ricordare il passato, immaginare il futuro. Ognuna delle lingue che parliamo aggiunge la sua dimensione unica alla 107 nostra soggettività significante che, nei suoi sforzi di mantenere la propria autonomia, la propria integrità psicologica e temporale e la propria coerenza, lotta per diventare un soggetto plurilingue. Il potere simbolico che deriva dall'essere capace di usare vari sistemi simbolici non è solo un potere dichiarativo, cioè il potere di rappresentare il mondo con diversi codici linguistici, ma un potere performativo che può creare diverse realtà simboliche con diversi linguaggi e, cambiando le percezioni di altri della realtà sociale, può cambiare questa realtà. È un inno al plurilinguismo, direi: un inno all'apprendimento delle lingue, perché si affida o si attribuisce all'apprendimento delle lingue addirittura la capacità di creare sistemi simbolici diversi e di modificare i sistemi simbolici nei quali noi agiamo e ci muoviamo. E dall'altra parte si parla di un apprendimento delle lingue come di qualcosa che muta completamente e profondamente l'identità della persona nella sua globalità, corpo e mente – dice in inglese Claire Kramsch body in the mind, interessante perché chiaramente è un espressione coniata dalla Kramsch stessa. Ecco, sottolineare questi due aspetti, questi due elementi come premessa a quello che andremo a dire è importante, perché è fondamentale capire che l'esperienza scolastica dovrebbe in qualche modo poter riprodurre e introdurre questa capacità di far vivere l'apprendimento delle lingue come esperienza globale, come la capacità di diventare altri, di acquisire nuove dimensioni, di acquisire un'identità plurale e più sfaccettata. Faccio una breve parentesi sulla mia personale esperienza: quando oggi mi accorgo di poter dire qualcosa in una nuova lingua, la mia sensazione è di un grande piacere. Mi sento di aver acquisito qualche cosa di nuovo, mi sento che in qualche modo sono più libera, più ricca, sono più libera dai vincoli della mia cultura e lingua di origine – cioè ho acquisito un nuovo modo di essere al mondo. Penso che tutti voi, se avete fatto l'esperienza di usare la lingua in contesto, abbiate provato a usare la lingua per ottenere qualcosa: pensate al piacere che si prova quando si ha ottenuto questo qualcosa. 108 Perché questo piacere? Credo che venga proprio dal fatto che si è stati altri, che si è acquisito un nuovo modo per essere in contatto con gli altri. Detto questo ci possiamo chiedere: che cosa la scuola può fare per creare soggetti plurilingue? Tenendo oltretutto presente che la scuola è profondamente cambiata in questi ultimi anni. A mio parere oggi siamo veramente in grado di fare una specie di comparazione tra quello che la scuola era una volta per le lingue, quello che è oggi, e quali sono i nuovi bisogni che emergono. Una volta l'apprendimento delle lingue era confinato dentro la scuola e l'uso stesso della lingua era dentro la scuola: pochissimi erano i privilegiati che si potevano permettere di usarla magari per motivi turistici fuori dalla scuola, e dunque la scuola era il luogo, il contesto in cui la lingua veniva imparata e veniva anche notata, perché il fine di questo apprendimento era quello di ottenere un riconoscimento di tipo formale. Dentro la scuola tutto l'input che veniva offerto agli studenti era un input limitato: era la scuola che l'offriva, non c'erano materiali, documenti, testi, possibilità d'incontro che in qualche modo offrissero materiale linguistico e altri input; oggi invece basta andare su internet o per strada e ascoltare: la pluralità delle fonti d'informazione è tale che le lingue fanno parte della nostra esperienza quotidiana. Imparare le lingue era un processo lineare: si trattava di imparare il francese, lo spagnolo, il tedesco, un repertorio tutto bel definito e limitato, mentre oggi si acquisisce una competenza specifica e parziale in una lingua che poi magari si potrà trasferire a un'altra lingua. La lingua era un patrimonio culturale il cui processo di apprendimento da un punto di vista scolastico era di tipo cognitivo, mentre oggi diciamo piuttosto che è di tipo affettivo emotivo: oggi queste due componenti sono centrali nell'apprendimento delle lingue, il che ci fa capire quanto sia modificato il nostro approccio in quanto docenti e in quanto apprendenti – e, a proposito, se un tempo i nostri apprendenti erano mediamente omogenei, con differenze per lo più di tipo sociale, dalle culture diverse legate alle classi di apparte109 nenza, oggi direi che gli apprendenti da questo punto di vista sono forse più omogenei, ma lo sono meno dal punto di vista dell'appartenenza linguistica, delle origini. La L2 un tempo non doveva interferire con la L1, e bisognava evitare di introdurla troppo precocemente: De Mauro, il nostro grande guru dal punto di vista dell'educazione linguistica – e quindi anche delle lingue, perché l'educazione linguistica è trasversale –, in alcune discussioni tempo fa era convinto, ma forse giustamente, che essendo noi un popolo recentemente alfabetizzato all'italiano per il nostro retaggio di dialetti – all'epoca si parlava di dialetti, adesso credo che l'uso dei dialetti si sia ridotto – bisognava creare prima dei monolingue o dei plurilingue in cui l'italiano in quanto L1 doveva essere preponderante; poi si poteva pensare alla L2, ma prima bisognava passare attraverso una forte alfabetizzazione nella L1. Oggi, e non solo perché i dialetti non sono più presenti, ma perché abbiamo un'altra visione della ricchezza delle lingue e della possibilità di transfert tra una lingua e l'altra per quel che riguarda le competenze, perché abbiamo questa visione delle lingue non come un tutto unico che va a giustapporsi ad altri repertori chiusi, si parla sempre più dell'importanza del plurilinguismo precocissimo, e abbiamo davanti agli occhi esperienze estremamente interessanti e positive di famiglie plurilingue o bilingue, che sono sempre più. La nostra rappresentazione della lingua e dell'apprendimento della lingua sta cambiando, e varrà la pena accennare al tema del diverso: una volta il diverso per noi era fuori, da qualche altra parte, a volte in qualche modo oggetto dei nostri desideri, idealizzato, un altrove da cui pensavamo che il diverso fosse quello che ci portava qualcosa; oggi il diverso è qui, è con noi, non è più questo elemento rispetto al quale ci poniamo tutti in una posizione di apertura e di ricerca di qualcosa di “esotico”: il nostro atteggiamento non è più lo stesso. Allora, perché costruire curriculi plurilingue per formare il soggetto plurilingue? Entriamo negli aspetti più tecnici: cos'è il plurilinguismo? Ecco la definizione tratta dal Quadro comune europeo di riferimento per le 110 lingue. Apprendimento, insegnamento, valutazione , uscito nel 2002 – vorrei sottolineare che nell'ambito delle lingue, del loro insegnamento e apprendimento, la Commissione e il Parlamento europei hanno agito in maniera estremamente positiva: il Quadro con le sue linee generali è ormai conosciuto largamente da tutti i docenti, e non solo di lingue, perché in qualche modo cerca di dare elementi comuni di riferimento per l'analisi delle lingue e per la valutazione anche delle competenze che si acquisiscono nelle lingue stesse. Plurilinguismo: capacità che una persona come soggetto sociale ha di usare le lingue per comunicare, di prendere parte a interazioni interculturali in quanto padroneggia a livelli diversi competenze in più lingue ed esperienze in più culture. Questa competenza non consiste nella sovrapposizione e/o nella giustapposizione di competenze distinte, ma piuttosto nella competenza complessa o addirittura composita su cui il parlante può basarsi. La competenza plurilingue comprende il sapere e il conoscere lingue diverse, il saper agire in più lingue anche con livelli di padronanza diversi, il saper essere in termini di atteggiamenti, di comportamenti e di consapevolezza, e il saper apprendere più lingue, trasferendo conoscenze, abilità e strategie da una lingua già nota a un'altra che si vuole o che si deve imparare. Allora, a partire da questo quello che noi sappiamo è che oggi la scuola deve organizzare il proprio curriculum di educazione linguistica con l'obiettivo di sviluppare capacità di comunicare in modo efficace in contesti sempre più caratterizzati dalla diversità di culture e di linguaggio all'interno di ambiti disciplinari diversi. L'insegnamento e apprendimento dell'L2 si situa dentro questo curricolo trasversale e trans-disciplinare di educazione linguistica. Allora, entriamo nelle proposte concrete e nelle scelte che chi lavora nella scuola e si trova a programmare curricoli, a fare scelte didattiche e in qualche modo a concordare con i propri colleghi quelli che saranno gli elementi trans-disciplinari dentro un curricolo di educazione linguistica, deve fare. 111 Consideriamo la programmazione nella secondaria di primo grado: diversificare obiettivi per la seconda lingua comunitaria rispetto all'inglese, cioè cercare di fare in modo che queste competenze parziali che vengono attribuite all'apprendimento di lingue diverse vengano riconosciute nel curricolo stesso – cioè, che il curricolo sia orientato verso acquisizioni diverse di competenze diverse, proprio per questa capacità di trasferire competenze da una lingua all'altra che ognuno di noi come soggetto plurilingue o come soggetto in genere ha per sua natura. Riuscire a creare una programmazione comune tra gli insegnanti di italiano e di inglese, di seconda lingua, per sviluppare la comprensione multilingue, il plurilinguismo ricettivo. Non possiamo pensare che tutti siano in grado di parlare una lingua, perché parlare vuol dire mettersi in gioco, entrare in una relazione anche di rischio rispetto ai nostri interlocutori: allora occorre ascoltare e capire, e sviluppare la capacità ricettiva dei nostri allievi, che forse sviluppiamo poco perché ci pare che imparare una lingua sia saperla immediatamente produrre. Invece il saperla capire, saper immagazzinare informazioni attraverso questo rapporto di tipo appunto ricettivo è fondamentale, e credo che dentro la scuola su questo si lavori invece poco. Naturalmente, dentro la scuola, ricreare le condizioni per progetti che permettano la presenza e il contatto con altre culture: tutti sanno cosa sono i moduli CLIL, individuare materie o porzioni di materie, contenuti che siano trasmessi, proposti e acquisiti tramite lingue che non siano la lingua madre. Acquisire un contenuto attraverso lingue diverse significa acquisire un contenuto che ha un punto di vista, una prospettiva, un orientamento che non è quello che noi daremmo nella lingua madre, e quindi significa anche riuscire a decentrarci rispetto a quello che è il punto di vista etnocentrico. Poi naturalmente l'uso delle TIC, l'uso del web, la possibilità di gemellaggi e partenariati elettronici che oggi offre, di nuovo, l'Europa; la diffusione tra i genitori di informazioni che riguardano l'importanza del plurilinguismo, perché il plurilinguismo è spesso rifiu- 112 tato dai genitori e visto come un elemento che può far trascurare innanzitutto la lingua madre ma soprattutto l'inglese. E – questa è una mia aggiunta personale – la possibilità di sfruttare la presenza di nuove lingue, di nuove culture nei nostri contesti. Forse non si è abbastanza valorizzato il fatto che nei nostri contesti ci cono persone che stanno vivendo quello che viveva Giovanna a Parigi, in contesto francese: ci sono persone che stanno acquisendo una lingua in contesto naturale attraverso tutta una serie di confronti con la lingua di partenza, con la lingua madre, che stanno riflettendo attraverso strategie di appropriazione e autoriflessione sui propri processi di acquisizione. Utilizzare queste presenze e questa evidente, naturale, necessaria capacità che deve avere il soggetto di padroneggiare e riflettere sui propri processi di apprendimento della lingua è un modo per introdurre anche dentro la scuola questa capacità riflessiva che è fondamentale, questo lavoro sull'imparare a imparare – perché è questo che stanno facendo i nostri giovani di lingua madre diversa: stanno imparando a imparare, e noi dobbiamo aiutare loro nell'imparare a imparare e contemporaneamente aiuteremo i nostri futuri plurilingue o plurilingue in formazione a imparare a imparare le loro nuove competenze linguistiche. Su questo punto che secondo me è importantissimo, della riflessione sui propri processi di apprendimento e su questa competenza che nella scuola spesso abbiamo un po' trascurato dell'imparare ad imparare è interessantissimo quello che dice Muriel Molinié, una docente che studia i processi di apprendimento della L2 e che lavora molto in Francia con gli studenti che si spostano per Erasmus o stages. In particolare, il dubbio è su come fare a trasportare l'esperienza ricchissima di uno studente tedesco che a Parigi stava osservando se stesso nel suo processo di acquisizione della lingua e nella sua necessità di rimettersi in discussione – perché la lingua è potere e perché essendo sempre stato un soggetto molto efficace sul piano della comunicazione si trovava a interagire in situazioni in cui non era in grado di imporre il suo potere performativo, come suol dirsi. 113 Il suo processo è stato quello di fare un diario di bordo in cui scriveva e rifletteva non solo su ciò che in termini affettivi ed emotivi succedeva dentro di sé in questi contatti, ma anche su che cosa lo aiutava a imparare. Il suo diario di bordo è estremamente interessante, perché racconta come lo studente si ponesse il problema di: quali sono le situazioni in cui sentendo una parola nuova riesco a fissarla e poi a riprodurla e poi a dire che fa parte ormai del mio repertorio passivo e attivo? qual è la situazione in cui vedo che utilizzando una certa struttura e una certa strategia comunicativa riesco a essere efficace? Questo diario di bordo è uno strumento di riflessione estremamente utile e importante, un'altra indicazione che possiamo dare a soggetti che stanno riflettendo e che vanno aiutati a riflettere sulle loro acquisizioni linguistiche. A questo punto vorrei vedere qual è la risposta della scuola a questa sfida del soggetto plurilingue e di tutte le competenze che il soggetto plurilingue può acquisire: c'è una risposta istituzionale e una risposta di noi che siamo dentro la scuola. La risposta istituzionale è quella che sappiamo: di fronte a indicazioni europee che puntano sullo sviluppo del soggetto plurilingue, abbiamo un monolinguismo assolutamente definito perché nella secondaria di secondo grado c'è il monolinguismo e salvo alcuni indirizzi specifici si fa solo inglese; per la secondaria di primo grado ci sono le due lingue, con la possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per rafforzare l'inglese – con mia grande sorpresa, le famiglie hanno votato per ora massicciamente la seconda lingua, il problema è che poi i tre anni di due ore alla settimana non troveranno proseguimento negli anni successivi, anche se si dice che ci sia attualmente in corso qualche ravvedimento in base alle direttive comunitarie che dal 1995 indicano che devono essere due le lingue studiate. Ancora due notazioni. Prima di tutto, so che dire che il plurilinguismo porta a questa ricchezza identitaria, a questo soggetto più capace di entrare in relazione con gli altri oggi forse, nella crisi in cui ci troviamo, non ha l'impatto che può avere una volta. E allora vengo all'aspetto pragmatico: perché studiare altro oltre all'inglese? Volendo escludere l'aspetto ideale ed educativo, c'è anche un 114 aspetto utilitaristico e pragmatico: concretamente, oggi, l'occupabilità è molto più garantita dal plurilinguismo. Un ultimo punto. C'è una risoluzione che vi consiglierei di leggere integralmente che è quella del marzo 2009 del Parlamento europeo rivolto alla Commissione europea, estremamente ricca e avanzata in termini di politiche linguistiche. Che cosa dice? Oltre a una serie di cose di cui abbiamo già parlato, dice anche che non possiamo affidare solo alla scuola questo compito: possiamo noi insegnanti attribuirci questa capacità di creare contesti plurilingue tali che favoriscono esperienze? Possiamo contribuire, ma non basta la scuola. È l'insieme della società, dei contesti culturali in cui ci muoviamo, che deve supportare questo tipo di politica, è l'insieme del nostro contesto territoriale, dentro il quale i media in primo luogo devono aiutare a creare un contesto plurilingue e multilingue. Addirittura si parla della possibilità che i programmi tv e i film vengano dati con i sottotitoli, che su internet ci siano tutte le esperienze linguistiche possibili. Non può essere la scuola da sola a risolvere il problema del plurilinguismo, perché il problema del plurilinguismo è questa capacità di aprirsi alle lingue, di mettere in discussione la disciplinarizzazione della lingua dentro la scuola con le modalità per cui la lingua è una pura e semplice acquisizione di tipo cognitivo ed è solo un contesto in cui le lingue diventano esperienza soggettiva, affettiva, emotiva, che ci permetterà di evolvere verso una società plurilingue. Il soggetto plurilingue è colui che è più competente a muoversi nelle società globalizzate, multilinguistiche e multiculturali. L'articolo 42 di questa risoluzione per la prima volta dà questa indicazione: la necessità che i migranti possano utilizzare la loro lingua principale per sviluppare la loro competenza linguistica. Il Parlamento dunque esorta gli Stati membri a incoraggiare l'uso della lingua principale di una persona oltre all'apprendimento della o delle lingue nazionali. 115 116 Prolegomeni a un curriculum vitae di letteratura mondiale del XXI secolo in Italia Armando Gnisci Critico letterario ed ex docente universitario italiano. Ex Professore associato all'università La Sapienza di Roma, è considerato uno dei più importanti studiosi di letteratura comparata in Italia. Ha scritto 40 libri tradotti in 12 lingue. Il titolo del mio intervento è Prolegomeni a un curriculum vitae di letteratura mondiale del XXI secolo in Italia . Dedico questa orazione a due persone che non conosco. La prima si chiama Norman Zarcone: Norman, uomo del nord, normanno. Un giovane palermitano, dottorando in filosofia del linguaggio, prima di discutere la tesi, il 13 settembre, si è buttato dal settimo piano, perché aveva paura, a ventisette anni, di entrare nel mondo dell'università, di non essere accolto, che nessuno lo volesse, di rimanere precario chi sa quanti anni. Norman è morto così. Il padre ha detto ai giornali che si tratta di un omicidio di Stato; io non metto lingua, non dico niente, voglio solo ricordare Norman Zarcone, che non ho mai conosciuto e mai conoscerò. L'altra persona a cui dedico quest'orazione è Kaha Mohammed Aden. Vi propongo, dicevo, dei prolegomeni: non una sapienza consolidata, degli umili prolegomeni, le cose che si dicono prima, prolegomeni a qualcosa che deve e può ancora avvenire e compiersi nel futuro, a un libro che si sta formando e a cui ho dato il titolo La metà delle luci, riprendendo il mio adorato Tito Lucrezio Caro. La parola “prolegomeni” indica i discorsi che dobbiamo fare prima di cominciare ma già avendo cominciato – è questo il punto no117 dale – a conoscere, ma già conoscendo: sono dei segna via, umili ma sempre proficui. Il discorso che intendo dedicare al pensiero di un curriculum vitae della letteratura mondiale può e deve diventare esso stesso una specie di prolegomeno vitalizio a un'educazione letteraria ben temperata nel nostro tempo: lo sento, questo stesso testo prolegomeno, come l'indicazione di una via lunga da camminare – ma da camminare insieme, con colleghi e complici, spero, come voi, anche per favorire una mondializzazione delle nostre menti. I Ecco il primo prolegomeno: il tema del mondializzare la mente, che è il titolo di un libro che pubblicai nel 2006, pretende di far presente la necessità e di rivendicare l'urgenza etica oltre che culturale di decolonizzare le nostre menti europee e italiane, altrimenti con tutto il sapere, le formule e le dottrine che abbiamo e che ci vengono esposte in continuazione non andiamo da nessuna parte. Quindi il primo prolegomeno è mondializzare la mente, e contemporaneamente – perché sono la stessa cosa in due fasi – decolonizzare la mente di noialtri europei e italiani. Decolonizzare da cosa, e a che pro, a quale fine? Decolonizzarci dalla malattia della volontà di potenza tipica dell'eurocentrismo e che ci portiamo addosso, sulla scorza epidermica, e dentro, nella turba psichica, nel “disagio della civiltà”, come lo chiama Freud, e che io chiamo il disagio della nostra civiltà, quella europea, che ci portiamo addosso e indosso da secoli senza nemmeno percepirla e senza nemmeno riconoscerne la ragione, anche nella maggior parte dei cosiddetti sapienti. Jean Paul Sartre, che non è stato mai un filosofo accademico, ha scritto nel 1961 la prefazione al libro base, alla bibbia dell'anticolonialismo, e cioè I dannati della terra di Frantz Fanon, scrittore martinicano poi algerino francofono – cioè ha dovuto pensare, scrivere, sognare, parlare nella lingua del colono, di colui che l'aveva schiavizzato, il francese. Sartre, nella prefazione al libro di Fanon, dice che non sono solo i colonizzati di tutto il mondo, dall'Algeria al Vietnam – parlo di due colonie ferite della Francia: l'Algeria, tutti abbiamo visto La batta118 glia di Algeri di Pontecorvo e ricordiamo, se c'eravamo, la guerra crudele Algeria-Francia e la convocazione a un certo punto di una quinta repubblica dei francesi con l'invocazione al maresciallo De Gaulle; il Vietnam, negli anni '50, fu la prima sconfitta della Francia colonizzatrice del mondo, che dovette andar via dal Vietnam: nel 1955 il generale mitico Giap batté i francesi a Dien Bien Phu, i francesi andarono via e poi i nordamericani si dissero che non poteva rimanere quella falla aperta e aprirono loro la seconda ferita, questa volta degli Stati Uniti, e cioè la guerra in Vietnam. Avevano il diritto di lottare per liberarsi dalla violenza cristallizzata del morso coloniale degli europei, ma anche noialtri europei dovevamo cogliere lo spirito del tempo giusto e imparare a decolonizzarci dal colono che è in noi, dalla volontà di potenza. Lo aveva scritto alla fine dell'Ottocento Friedrich Nietzsche, e la sorella, disgraziata, prese gli ultimi appunti del fratello morto pazzo, di un libro che doveva ancora scrivere, li mise insieme e mise lei il titolo di Wille zur Macht e lo regalò a Hitler. Storie del Novecento poco conosciute – Hitler e il suo ideologo Rosenberg fecero della volontà di potenza di Nietzsche la volontà di potenza del Terzo Reic – che si scoprono leggendo il Discourse on colonialism di Aimé Césaire, professore di Frantz Fanon al liceo in Martinica. Allora, come vedete, la decolonizzazione non è soltanto dei vietnamiti dai francesi e poi dagli americani, degli algerini dai francesi e ancora dai francesi, ma di noi francesi, italiani, tedeschi, …, e poi i grandi imperialisti coloniali atlantici innanzitutto: Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda e Danimarca anche, che mise le mani – e ancora ce le ha – sulla più grande isola del mondo, la cosid detta Groenland. E poi? E poi i russi, che possiedono ancora il più grande impero coloniale della storia, tutta l'Asia coloniale del nord, che si chiama sui mappamondi Russia, non più Unione Sovietica ma Russia, e parte dalle repubbliche baltiche, da Koninsberg, la città di Kant, e finisce alla penisola della Kamchatka, di fronte al Giappone: un impero coloniale che dura tuttora e che nessuno vede, è vestito di Russia e nessuno di noi alza quel vestito. Allora, come vedete noi 119 europei abbiamo ancora da fare molta strada per cominciare a decolonizzarci, sia gli italiani e gli atlantici, sia i continentalissimi russi. Collocando il protocollo e il processo decolonizzante, e quindi la questione del colonialismo, all'inizio del mio discorso per poter pensare bene il curriculum vitae di letteratura mondiale, il mio fine è quello di segnalare e incidere un varco, ma anche una scissura, nella parte più coriacea della corteccia della tradizione della nostra civiltà atavica europea, come la definisce lo scrittore martinicano Édouard Glissant, allievo anche lui come Fanon del grande poeta Césaire, tutti e tre discendenti di schiavi africani deportati nei Caraibi secoli prima dai negrieri europei a morire di lavoro coatto e gratuito nelle piantagioni di canna da zucchero dei padroni nobili francesi di origine bretone che ancora oggi ne sono i padroni – abitano tutti nella stessa zona con i castelli –: sono duchi, marchesi, conti, baroni bretoni, e producono fieramente l'eccellenza del rum del mondo, tenendo schiavi ancora cittadini francesi neri che lavorano nelle piantagioni di canna da zucchero. Dobbiamo fare ancora molta strada per iniziare a decolonizzarci. Mondializzare la mente significa quindi allestire una risposta virtuosa e un contrappunto giustamente ostile all'ingiustizia disumanizzante di quella che oggi chiamiamo globalizzazione, al fine di opporsi a essa da parte di chi non vuol rinunciare a perfezionarsi e ad educarsi alla finezza umana, seguendo nella tenebra le luci della giustizia e della compassione. A che pro tutto questo? Detto in breve, per poter imparare a risanarci e a risanare tutti gli altri di quell'insieme di noi che siamo a disagio nella nostra civiltà; sia i nostri ex colonizzati sia noi che siamo a disagio in questa civiltà e pensiamo che dobbiamo decolonizzarci, e poter arrivare a vivere meglio tutti insieme nel mondo: o c'è giustizia, e conoscenza, e compassione, o tutte le teorie sistemiche e non sistemiche della complessità e della non complessità sono tutte chiacchiere accademiche. Per noi docenti educatori quindi deve diventare assolutamente chiaro, indimenticabile e irrinunciabile che ciò che dobbiamo imparare e insegnare preliminarmente e tuttavia incessantemente agli allievi è la complessità giusta della nostra comune storia moderna; non la com120 plessità in astratto: la complessità degli ultimi cinquecento anni, quando noi abbiamo scoperto il Nuovo Mondo e invaso tutto il mondo – nel 1770 il capitano Cook si prese l'onore di scoprire l'Australia, ma l'aveva già scoperta quasi un secolo prima un olandese che si chiamava Tasman e che si è dovuto accontentare del nome della Tasmania, l'isola piccola che sta sotto l'Australia. Da cosa si riconosce e si valuta la modernità in quanto dimensione storia e vitale della nostra identità europea divenuta da allora mondiale? Sostengo che la costruzione di un curriculum vitae di letteratura mondiale debba salpare da un molo del Cinquecento, un molo di Bordeaux, e il motto epistemologico della modernità, che non è cogito ergo sum, è Montaigne: que sais je? Che cosa so io, sindaco di Bordeaux, uno dei nomi più colti d'Europa della seconda metà del Cinquecento, che cosa so veramente? La domanda, cioè interrogarsi sul sapere che si sa, è quella famosa formula della sapienza giusta della modernità, del sapere di sapere, il fatto per cui noi siamo una specie che si chiama homo sapiens sapiens: due volte, non solo homo sapiens. La modernità creò la prima complessità culturale planetaria della specie sapiens sapiens mediante la civiltà europea: questo è il guaio, e Montaigne lo esprime, lo esibisce. Si interroga, nel saggio che si chiama Delle carrozze: ma come siamo andati noi nel Nuovo Mondo? E come stiamo affrontando l'incontro con queste persone nuove che vivono lì, che non sono antichi, sono imprevisti? Platone e compagnia bella non ne sapevano niente; lo stesso continente è stato intestato a un farabutto, secondo gli inglesi e i nordamericani anglofoni, Amerigo Vespucci, un trafficante – perché italiano, perché noi siamo tutti trafficanti –, lo dice Ralph Waldo Emerson, uno dei grandi filosofi nordamericani: Amerigo Vespucci era un trafficante e un imbroglione fiorentino, e noi tutti in questo continente portiamo il nome di questo disgraziato. Dovremmo cambiare nome. Montaigne risponde: forse sarebbe stato meglio che questo incontro con queste nuove popolazioni sconosciute l'avessero fatto uomini come Alessandro Magno o Giulio Cesare, perché loro possedevano la temperanza, quello che gli antichi greci chiamavano “me121 tis”, la saggezza giusta per affrontare un incontro così importante. Il bravo sindaco di Bordeaux pone la questione e cede le armi, e riconosce che il suo secolo non era quello giusto, che la seconda metà del Cinquecento non era l'epoca giusta, e non erano quelli giusti gli uomini per poter incontrare il Nuovo Mondo e i suoi abitanti. II Passiamo al secondo prolegomeno, che riguarda ancor più da vicino noialtri docenti ed educatori. In questo caso mi rivolgo proprio a chi ha frequentato le università italiane negli anni Ottanta, Novanta e Dieci del nuovo secolo, i tre decenni in cui ho insegnato Letteratura comparata nella facoltà di Lettere e filosofia della Sapienza. Credo che nessuno possa contestare che negli ultimi tre decenni siamo stati tutti noi che abbiamo studiato insieme, io e i miei allievi, anche senza conoscerci, avvinghiati nei vincoli invisibili ma feroci del nuovo mondo abominevole e nel nuovo modo di servitù planetaria – vale a dire che siamo stati comunque e ovunque globalizzati, anche se non ce ne siamo accorti, in quello che io chiamo, senza alcun gusto di pessimismo, il peggiore dei mondi possibile. Esso rappresenta l'opposto, o meglio l'opaco rovescio – opaco è un termine che usa splendidamente Calvino in un suo saggio poco conosciuto, che si chiama Dall'opaco – di ogni possibile, come dice Shakespeare nella Tempesta, di ogni possibile brave new world. Meraviglioso mondo nuovo, vedeva lui. Nulla di meraviglioso ci fu. Montaigne l'aveva capito: era tutto sbagliato quello che stavamo facendo. In più, in Italia, oltre a essere stati globalizzati, noi siamo stati depravati, dispersi e disorientati. Qualcuno di noi si è convenientemente integrato in questa dispersione e depravazione, nella disgrazia di una società nazionale piombata sempre di più, senza che noi ce ne accorgessimo, nell'ignoranza, nella menzogna e nel malaffare – vale a dire, umiliati e offesi, complici e vittime di una implacabile e incurabile mala educazione dall'alto e dal basso, che ha smantellato la coscienza comune e la volontà, ancora acerba in Italia, di saper essere degni e civili cittadini di una repubblica moderna. 122 Quelli tra noi che si sono opposti a tale depravazione sono stati indotti a trasformarsi diventando in questi anni esclusi, resistenti, tristi e arrabbiati; spesso, soli. Credo anche che noi letterati italiani del XX secolo, scrittori, critici, eruditi e insegnanti innanzitutto, ma anche lettori e studenti, che viviamo e operiamo ancora criticamente nel XXI, siamo debitori verso le più giovani generazioni di un'opera di cura e di risanamento delle menti nostre e loro da avviare subito e nella forma della resistenza, perché la ragione e il sentimento non sono al governo, e noi siamo assolutamente minoritari. Questa opera di cura e di risanamento deve essere la prosecuzione di quell'opera interrotta che fu compiuta con dolore ma con qualche soddisfazione dalla generazione dei nostri antenati sotto e contro il fascismo e dopo la sua caduta – ma, come sappiamo, imperfettamente: De Gasperi, Togliatti e Nenni per mettersi d'accordo combinarono un bel pasticcio. Voglio ricordare soltanto un esempio storico rimosso e censurato – mai entrato, dunque, nell'educazione repubblicana di base degli italiani: De Gasperi e Togliatti con la mediazione di Nenni e degli altri partiti liberatori della nazione, e in accordo stretto di sudditanza con le potenze grandi da una parte e dall'altra, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, non processarono i capi fascisti – a Norimberga ci fu un tribunale, in Italia no; il generale Graziani fu addirittura assolto: un massacratore –, ma li inviarono ad amministrare la nostra ex colonia africana della Somalia, dal '50 al '60, in ossequio al mandato di amministrazione fiduciaria AFIS concessoci dall'ONU dopo pellegrinaggi e suppliche, litanie e pianti di De Gasperi e anche di Togliatti, per dire agli alleati vincitori che noi avevamo un nostro passato coloniale civile e bonifico, portatore di bene, esemplare anzi, e che non meritavamo di perdere le nostre amate colonie, perché i somali e gli eritrei e gli etiopi e i libici ci amavano. Senza la lettura di Angelo Del Boca, il grande storico – e l'unico, insieme a dei suoi allievi più giovani – italiano del colonialismo, non sapremmo niente: i nostri manuali di storia, anche quelli più precisi e temperati, hanno sempre omesso e tuttora ignorato queste verità; gli italiani pure. 123 III Il terzo prolegomeno si rivolge ancora alla coscienza e alla saggezza della nostra professione, sempre più umiliata, sottosviluppata, impoverita, tagliata. Introduco questo argomento servendomi della citazione di un passo dello scrittore statunitense ma veramente mondiale del nostro tempo Don De Lillo, da Punto omega. Un personaggio, la figlia del protagonista, dice al coprotagonista, un giovane giornalista andato a intervistare il padre che si è autoesiliato nel deserto: è una vita che parla ai suoi studenti. Questa frase ha innescato dentro di me una sequenza di pensieri successivi e complementari, un flusso di pensieri come sempre deve poter accadere nella lettura tra il libro e il suo lettore – proprio Montaigne, il mio maestro insieme a Shakespeare e Cervantes per capire la modernità, dice che un libro è sempre un'opera doppia, che si mette in opera mediante l'attività della coppia dei suoi due coautori: da una parte chi lo ha scritto, e dall'altra parte chi lo legge. Che cosa ho pensato quando ho letto il testo di De Lillo, sentendo al contempo che quella frase stava parlando con me, a me, e non soltanto tra due figure della fiction narrativa? Ho considerato, subito dopo lo stupore che mi ha provocato, che il discorso che io ho rivolto agli studenti perfezionandolo per quasi quarant'anni, è stato il miglior modo di fare discorso della mia vita, e quello più giusto. Sono arrivato a riconoscere che questo discorso per un docente può e deve essere valutato e vissuto come la parte nobile del nostro destino intellettuale e politico di docenti – e non allora la frase interpretata, come pure potrebbe essere, è una vita che si rivolge a tutti come se fossero i suoi studenti, e cioè in maniera autoritaria e spocchiosa: questa è la prima lettura, banale e volgare, della frase di De Lillo; l'altra lettura è quella nobile che vi ho fatto: vi consiglio di praticarle entrambe, una in maniera autocritica, l'altra in maniera autovalorizzante. Proviamo a pensare positivo, a pensare sapendo e credendo che fare lezione concentra e realizza il valore migliore della nostra missione: ci accorgeremo che l'atto discorsivo del parlare agli studenti produce spirito n ella classe, cioè forma e illumina la nostra stessa 124 persona, perché mette in azione e in opera la vera conversazione pedagogica in una mutua conoscenza veramente rinascimentale: rinasciamo insieme in quella che il filosofo francese Gaston Bachelard ha chiamato co-naissance. Io, come intellettuale – come siamo noi che insegniamo e abbiamo insegnato – ho sempre capito il senso proprio e vivo del mio pensare e operare solo quando lo spiegavo in classe ad altri: io ho capito di essere sapiente quando spiegavo agli studenti – non quando leggevo i libri – e, derivatamente, quando parlavo e parlo in pubblico. D'altra parte sentivo immediatamente l'ascolto assoluto, anche se sempre personale e situato, degli studenti nella classe. Sentivo cioè quello che tanti anni fa chiamai lo spirito nella classe, che non è altro che la partecipazione comunitaria nel fare insieme la lezione, e anzi dirò di più: ho ascoltato gli studenti agli esami reimparando a volte in modi nuovi e imprevedibili e imprevisti la materia stessa del nostro sapere. Una lezione ben fatta produce lo spirito nella classe, e guadagna un grado in più, che io chiamo una specie di survalore ermeneutico, di conoscenza reciproca: io ho imparato meglio e di più, e addirittura pezzi e lampi di una nuova conoscenza in classe e agli esami, paradossalmente. IV Passiamo al quarto prolegomeno. Credo e so che dopo tanti anni di insegnamento questo prolegomeno serve a capire per noi docenti di letteratura come meglio riconoscere e godere la nostra stessa materia professionale. Dobbiamo sapere che la letteratura va riconosciuta innanzitutto come la maestra della finesse umana, come ha scritto il grande poeta russo del secondo Novecento premio Nobel nel 1986 Josiph Brodzky, che è dovuto andare in esilio condannato da un tribunale stalinista. Finesse vuol dire raccontare e spiegare attraverso il racconto, la spiegazione della consistenza stessa della letteratura del mondo. Allora cos'è questa letteratura del mondo? È la complessa e variegata tradizione europea che più o meno dominiamo, ma anche l'A125 frica di Ahmadou Kourouma, un grandissimo scrittore francofono della Costa d'Avorio, morto nel 2003, di Nadir Gordimer, bianca, premio Nobel, a fianco ai sudafricani neri nella battaglia contro l'apartheid, di Chinua Achebe, grande scrittore nigeriano, di Wole Soyinka, altro nigeriano, unico premio Nobel nero dell'Africa, Ngugi wa Thiong'o, Nuruddin Farah, somalo – scrittori spesso nella fuga dell'esilio e della diaspora; delle antiche civiltà che conservano le loro lingue e non le hanno cedute, e cioè il Giappone, la Cina e l'India, dei Caraibi, dove c'è il laboratorio della creolizzazione di cui parla Glissant ma di cui parlano tutti i caraibici, Derek Walcott, premio Nobel anche lui, poeta anglofono dell'Isola di Santa Lucia, discendente di schiavi anche lui neri – che dice in una sua poesia: io, nero con i capelli rossi. C'è del sangue olandese dentro di me – e infine delle migrazioni di moltitudini di persone che scrivono ora in una vita nuova, in un'altra lingua da quella originaria, che sta divenendo sempre più la propria lingua, ma non l'unica, e delle traduzioni da tutte le lingue del mondo verso ogni lingua del mondo: le traduzioni sono la lingua-non-lingua del mondo, la lingua delle lingue. Sostengo insomma che la letteratura diventa mondiale in occidente, in Europa, quando il grande poeta e drammaturgo e narratore tedesco Goethe nel 1827 nei suoi Dialoghi con Eckermann lancia la formula della Weltliterature: da allora gli europei hanno pensato questa categoria e l'hanno esportata, colonialisticamente come al solito, in tutto il mondo. Ora, la letteratura del mondo di Goethe fu riconosciuta subito, nel 1848, dai giovani Marx e Engels trentenni che pubblicano il Manifesto del Partito comunista, esuli anche loro, che scrivono: come esiste una Weltliterature, esiste ormai nel mondo un Weltmarkt. Un mercato mondiale. Eccolo. Ecco i due che hanno inteso il mercato mondiale, la globalizzazione, quando era il momento di cominciare a intenderla, e hanno ripreso il vecchio Goethe che ormai era morto, e hanno messo insieme la Weltliterature e il Weltmarket. La letteratura del nostro tempo infatti è internazionale e traduttiva, e quindi è mondiale, perché la letteratura mondiale, iniziata agli inizi dell'Ottocento, nel Novecento è diventata internazionale e tra126 duttiva. Una volta noi leggevamo i romanzieri del Novecento giapponesi tradotti dal tedesco o dal francese; nella seconda metà del Novecento i nostri nipponisti traduttori sono diventati dei maestri della traduzione, e possiamo leggere direttamente dal giapponese all'italiano Kawabata; Katayama; Yukio Mishima. La letteratura è arrivata a mettere in opera in maniera esemplare nella seconda metà del Novecento la mondialità della finezza, non la globalizzazione delle merci e delle anime: la liberazione, la mondialità della finezza. La letteratura del nostro tempo infatti non riproduce o subisce, non rappresenta o esprime la mondialità come se fosse la realizzazione della globalizzazione in forma letteraria, attenzione: la letteratura va creando dall'inizio dell'Ottocento per merito degli europei, una volta tanto, la mondialità, cioè l'opposto della globalizzazione, e la produce in avanti e oltre la globalizzazione. La mostra e la diffonde nel modo e nello stile suo proprio, anche se dentro la gabbia del blocco dell'impero finanziario e commerciale dell'onnipotente mercato globale. E la letteratura mondiale insegna addirittura la mondialità, perché la mostra: esiste oltre la globalizzazione qualcosa che non è globalizzato, ed è la finesse, la capacità di pensiero creativo, immaginario, critico. Sostengo insomma che nel XX secolo la letteratura abbia conquistato la propria mondialità, e che l'abbia offerta e tradotta immediatamente al mondo delle “nazioni” – sto citando il mio antenato Gian Battista Vico – e di tutti i lettori, contrastando e temperando la ferocia sfrenata dell'ingiustizia planetaria: le nazioni e i lettori del mondo non conoscevano ancora la mondialità come globalizzazione; ma la letteratura sì: abbiamo sempre letto, dall'antichità fino a oggi. La comunicazione di massa continua a chiamare tutto ciò che esiste oggi nel mondo globalizzazione o, se vuole intendere coloro che la contrastano, banalmente usa il termine antiglobalizzazione. Noi non stiamo né nell'uno né nell'altro se ci educhiamo attraverso il pensiero critico della letteratura, il pensiero immaginario, il gusto della finezza. Così facendo la letteratura mondiale va illustrando al mondo dei lettori, ma anche dei non lettori, il potere di contrapporre alla glo127 balizzazione coatta e ingiusta il contrappunto – non la lotta contro, il contrappunto – dell'intelligenza, della ragione e del sentimento. Edward Saïd, il grande studioso palestinese che ha insegnato tanti anni Letteratura comparata alla New York University negli Stati Uniti, parla appunto di contrappunto, di una possibile mondializzazione della finezza contro l'ingiustizia, la volgarità e la menzogna. La finezza del gusto della ragione, della ragione insieme al sentimento, e quindi dell'umanizzazione progressiva, quella che cantò Leopardi nella Ginestra: i valori di giustizia e pietà. La letteratura, quando non è solo prodotto e produzione di mercato, pur apparendo nel mercato globale, mira a stabilire l'equilibrio spirituale della ragione, dell'immaginario, del gusto e di quella che Nietzsche chiamò gaia scienza, le gai savoir, quel composto appunto, ragione e sentimento, di sense and senbility che ci ha insegnato, agli inizi dell'Ottocento, Jane Austen e che qualche anno prima aveva sancito nella fondazione del pensiero critico ultramoderno Immanuel Kant nella Critica del giudizio. Sappiamo che la letteratura traduce nel regno e nel senso di ogni lingua l'immaginario, la diversità e i sensi del mondo e delle vite, mondo e vite che altrimenti sembrano non avere senso, se non quello opaco e abietto imposto dalla comunicazione di massa e dalla menzogna politica, le potenze banali, volgari e spesso criminali che rovinano quotidianamente le nostre menti e la possibilità che possa esserci ancora, come dice il grande romanziere cubano Alejo Carpentier, el reino de este mundo, il regno di questo mondo, il brave new world di Shakespeare, una repubblica mondana di tutti: terre, nazioni, specie viventi, ma anche pietre, nuvole, stelle, bambini e cespugli di more, gazze, cani, gorilla di montagna, delfini. La letteratura continua a coltivare e a nutrire per tutti noi la cosmovisione, il brave new world a cui tutti abbiamo diritto perlomeno di sognare – e nessuna ideologia, religione o politica oggi parla ormai più questa lingua del mondo. La letteratura del mondo traduce la lingua del mondo, che nessuno ancora conosce: tutto sommato direi che la letteratura fa quello che fa la scienza. 128 PICCOLA BIBLIOGRAFIA BARROW J. & TIPLER, Il principio antropico BARROW J., Le immagini della scienza BRODSKIJ J., Dall'esilio CALVINO I., Le Cosmicomiche CELAN P., La verità della poesia CERVANTES, Don Chisciotte COETZEE M. J., La vita degli animali DANTE, De vulgari eloquentia GLISSANT É., Poetica del diverso HOBSBAWM E., Il secolo breve KANT I., Critica della Ragion Pratica LEOPARDI G., Tutte le opere LUCREZIO, De rerum natura MONTAIGNE M., Saggi SASSOON D., La cultura degli europei. Dal 1800 a oggi SHAKESPEARE W., La Tempesta SOYINKA W., Mito e letteratura STEVENS W., Il mondo come meditazione SZIMBORSKA W., Opere VOLUMI ERUDITI MA UTILI GNISCI A., Decolonizzare l'Italia, Bulzoni, Roma 2007 GNISCI A., L'educazione del te, Sinnos, Roma 2009 GNISCI A., SINOPOLI F., MOLL N., La letteratura del mondo nel XXI secolo, Bruno Mondadori, Milano 2010 129 130 Matematica e intercultura: teoria e pratica didattica Franco Favilli Prof. Associato presso il Dipartimento di Matematica "L. Tonelli". Membro della Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Pavia. Direttore del Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa. Parto da dei dati personali che in qualche modo credo riusciranno a far meglio comprendere come mai un matematico si metta a parlare di intercultura – anzi mi spingo più avanti: potrei dire un matematico si occupi di come insegnare matematica in contesti interculturali. Prima ancora di cominciare dirò: io sono nato come matematico puro, come si usa dire in certi casi seguendo una qualche gerarchia che soprattutto in Italia ha avuto un grande seguito, che vedeva il matematico puro in prima fila, in seconda fila il matematico applicato e in terza categoria il didattico della matematica: ecco, io sono passato dalla prima alla terza senza passare tramite la seconda, però arrivando alla seconda – o perlomeno, provando a muovere la situazione soprattutto a livello scolastico dalla terza verso la seconda. Fra il '73 e il '75 sono stato alla Princetown University, negli Stati Uniti; dall''82 all'83 all'Università di Parigi 13, fra l'87 e il 90 due anni a Mogadiscio, Università nazionale somala, fra il 2000 e il 2006 sette mesi a Cuzco in Perù; questa è stata la mia parabola geografica, intervallata da un anno a Cosenza e il resto sempre a Pisa, e questa ha significato però anche una parabola di interessi nell'ambito delle mie ricerche: ho cominciato, come dicevo, come matematico puro – un posto migliore di Princetown credo sia difficile da trovarsi –, a 131 Parigi ho studiato per due anni su un progetto di ricerca finanziato dalla NATO, niente a che fare con le guerre, ma matematica di base, ricerca. Poi nell'87-'90 c'è stata per me la svolta, durante l'insegnamento in Somalia, come si dice a livello tecnico, messo a disposizione del ministero dell'Università dal ministero degli Esteri in qualità di esperto per insegnare. Che cosa? La matematica. Come? Come in Italia. Che cosa? Le stesse cose che in Italia. Avendo davanti chi? Non le stesse persone che avevo davanti in Italia. Non nello stesso contesto chiamiamolo culturale in cui siamo abituati a insegnare quelle cose in quel modo in Italia – nel mondo occidentale, se lo vogliamo chiamare così. Allora il discorso del contesto, dell'educazione matematica in un contesto socioculturale è qualcosa che evidentemente mi colpì in quell'esperienza. Ritornando da Mogadiscio – son partito il 3 giugno 1990 alle ore 9 – la sera è scoppiata la guerra civile. Diciamo che è andata bene. Quando sono arrivato per l'ultimo anno con moglie e figli si viveva col coprifuoco; dopo due mesi il coprifuoco fu tolto, perché aspettavano una rivoluzione annunciata per il 21 ottobre, giorno dell'anniversario dell'insegnamento o della presa del potere di Siad Barre; ovviamente le rivoluzioni annunciate non accadono e quindi tolsero il coprifuoco poco dopo. E così noi siamo arrivati in aeroporto il 3 giugno alle 8 senza particolari problemi, a parte qualche sparatoria che si sentiva, a parte la retata che la sera prima era stata fatta dalla polizia segreta di Barre in occasione del party – non so come chiamarlo – che l'ambasciata italiana aveva organizzato il 2 giugno, appunto, per l'anniversario della repubblica italiana: tra gli invitati c'era la stragrande maggioranza degli oppositori di Siad Barre, e dunque quale occasione migliore per Barre? Parlo di questi fatti per ricordare come questa è stata un'esperienza veramente forte di vita, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista professionale, perché io son tornato, sono andato all'ultimo mio congresso in cui mi presentavo come matematico puro, al Congresso mondiale dei matematici di Kyoto, nell'agosto 1990, con questo grosso fardello dell'esperienza somala. 132 Lì, guardando il programma in maniera diversa rispetto a quello che ero abituato a fare, lessi che un certo D'Ambrosio parlava di una cosa che in quel momento mi incuriosì, che si chiamava etnomatematica: ovviamente fu la conferma dei molti riconvincimenti che mi ero fatto vivendo quest'esperienza. Le esperienze di questo tipo che durano tanto uno all'inizio le fa perché le ha sentite raccontare; qualcuno ci andava anche perché davano tanti soldi, ma io non ci sono andato e soprattutto non ci sono tornato per quello – io ho avuto tre mandati dal ministero degli Esteri: 6 mesi, 6 mesi e poi un anno –: la prima volta sono andato per curiosità, la seconda per capire meglio le cose, la terza volta sono andato avendo nel frattempo seguito un corso di perfezionamento di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, come si diceva all'epoca, organizzato da un collega della facoltà di Scienze politiche. Tutta questa lunga premessa credo possa essere servita a capire come mai un matematico si occupa di queste cose. Di più: immaginate un matematico che – non è il mio caso – sia capace di suonare questo strumento, che noi occidentali, casualmente ma non troppo, chiamiamo flauto di Pan, ma che non è un flauto di Pan per chi lo suona: gli andini lo chiamano sampogna. Quest'oggetto è un oggetto matematico, è un oggetto con cui si può fare tanta, tantissima educazione matematica, ed educazione in senso lato: anche a livello storico, letterario, linguistico. È un prodotto culturale. Se è un prodotto culturale vuol dire che ciascuna delle aree della cultura che entra nelle scuole evidentemente ha una sua possibilità di lettura: quest'oggetto ha avuto l'attenzione di un matematico. A questo punto posso andare avanti e iniziare ufficialmente, con una citazione dell'UNESCO: la matematica e le sue applicazioni hanno importanza centrale nel mondo d'oggi per la scienza, la tecnologia, le comunicazioni, l’economia e numerosi altri campi; la matematica ha profonde radici in molte culture e i più eminenti pensatori, per migliaia d’anni, hanno contribuito in maniera significativa al suo sviluppo; il linguaggio e i valori della matematica sono universali e la rendono perfettamente adatta alla cooperazione internazionale; 133 l’educazione matematica ha un ruolo chiave nella scuola primaria e secondaria, sia per la comprensione di concetti matematici di base, sia per lo sviluppo del pensiero razionale. Mi interessa evidenziare due passaggi: ci si riferisce alla matematica e si dice che ha profonde radici in molte culture. Ma se la matematica ha profonde radici in molte culture mi viene da pensare che debba essere lei stessa vista come un prodotto culturale. Ma perché? Perché l'idea che noi abbiamo è che la matematica sia un unicum, e si dice molto spesso che la matematica è un linguaggio universale. Due più due fa quattro: niente di più falso. 2+2=4, ma dove? Chi conosce qualcosa di matematica, sa che non si conta solo in base 10: si conta anche, per esempio, in base 3, e se in base 3 io faccio 2+2 non ottengo 4, perché la disposizione è 0, 1, 2, 3, e quindi il risultato di 2+2 fa 0. questo non deve turbare le coscienze nostre, ma fa capire come già all'interno della “nostra” matematica ci sono delle affermazioni che tutti riteniamo inoppugnabili, degli stereotipi che di fatto non corrispondono alla realtà. Ma se questo accade all'interno della nostra cultura e della nostra società, immaginate se non possa accadere in realtà, in società, in culture diverse dalla nostra. Dunque non parliamo di matematica, ma di matematiche – io non capisco perché in Italia si continui a parlare di matematica al singolare quando in inglese di parla di mathematics, in francese di mathématiques, in spagnolo di matematicas. L'altro passaggio della citazione dell'UNESCO su cui vorrei soffermarmi è che il linguaggio e i valori della matematica sono universali. Del linguaggio abbiamo fatto cenno, dei valori ancora no, ma se parlo di valori non posso allora che implicitamente riconoscere di nuovo la valenza culturale della matematica, perché i prodotti aculturali – come in qualche modo viene vista e letta la matematica –, indipendenti dalle culture, trasversali a qualunque cultura implicano che i valori non possono che essere universali. Ma se mettiamo in crisi questa visione e alla domanda precedente rispondiamo che bisogna parlare di matematiche al plurale è 134 chiaro che, dando un riferimento culturale al prodotto matematica, inevitabilmente non potrò pensare che esista una matematica unica e universale e dai valori universalmente condivisi. Se dunque se ne riconosce l'essenza di prodotto culturale, non ci si può contraddire dicendo che al di là del linguaggio anche i valori della matematica sono universali. Questo mi porta allora a ripensare a ciò che avevo sentito dire nel 1990 da D'Ambrosio, un brasiliano che aveva studiato a Genova e che nel 1982 era andato per conto dell'UNESCO in Mali e al ritorno era entrato in crisi – come me dopo l'esperienza somala – e nel giro di un paio d'anni ha elaborato questa riflessione sulla matematica che l'ha portato a introdurre il termine “etnomatematica”: siamo nel 1985. Nel 1992 l'ha definito in maniera in qualche modo ancora più larga in un articolo che gli ho fatto pubblicare in versione bilingue in Italia, in inglese con a fianco la traduzione in italiano: l'etnomatematica sono le arti o tecniche sviluppate da culture diverse per spiegare, comprendere e confrontarsi con il proprio ambiente. Diciamo una lettura quasi galileiana; molto più esplicitamente Alan Bishop, un docente dell'università di Cambridge successivamente trasferitosi a Melbourne, in un volume – una cui sintesi è facilmente leggibile in una rivista, «Educational Studies in Mathematics» – afferma in maniera chiara ed esplicita che la matematica è un prodotto culturale, punto e basta. Spiega: la matematica deve essere compresa come un tipo di conoscenza culturale che tutte le culture generano ma che non necessariamente deve sembrare la stessa quando si passa da un gruppo culturale all'altro. Dunque Bishop sancisce l'esistenza delle matematiche: in un blocco monolitico qual è costituito dai matematici, una specie di torre d'avorio, fra il 1985 e il 1992 c'è stato un terremoto, i cui effetti hanno avuto un impatto ovviamente positivo in aree geografiche 135 del mondo in cui era prevedibile che lo avessero – Brasile, America settentrionale, Australia, cioè continenti in cui il tema della multiculturalità era un tema noto e all'ordine del giorno da decenni – Bishop dice dunque che la matematica non è un linguaggio universale, non è culture free. Dice però che tutte le società, tutte le culture hanno una loro matematica che sviluppano facendo ricorso a categorie di attività che possono essere da noi etichettate come attività matematiche che, queste sì, sono sostanzialmente le stesse in qualunque ambito noi ci troviamo. E le sei categorie che lui indica come quelle attorno alle quali qualunque matematica viene sviluppata in qualunque contesto socioculturale sono queste – e mi pare che in qualche modo siano condivisibili: Counting – Locating – Measuring – Designing – Playing – Explaining. Torniamo al discorso dei valori: abbiamo dunque attribuito una valenza culturale anche alla matematica: non un prodotto astratto della testa dell'uomo, ma dell'uomo in quanto essere sociale. Se è un prodotto culturale vuol dire che deve portare con sé dei valori: ma se noi vogliamo essere degli educatori, dal momento che educare vuol dire non solo insegnare ma attribuire dei valori a ciò che comunichiamo, dobbiamo essere consapevoli di chi abbiamo davanti e con chi stiamo parlando, e dunque essere attenti al contesto; se siamo in un'aula al contesto dell'aula – tutto questo anche quando si parla di educazione matematica. Allora in un contesto di aula multiculturale, se vogliamo fare una didattica della matematica che sia interculturale, dobbiamo stare attenti a trovare un modo per bilanciare i valori che noi attribuiamo alle conoscenze matematiche che trasmettiamo. In questo passaggio dalla matematica alle matematiche ci si pone inevitabilmente il problema della lettura di prodotti matematici di culture diverse. Come li leggiamo? La lettura di prodotti non nostri è sempre ardua, sempre problematica e sempre soggetta a critiche. Per quanto riguarda i prodotti matematici di culture diverse sono stati suonati dei campanelli d'allarme molto forti sia da Vithal e Skovmose, una sudafricana e un danese. La Robin Zevenberger che invece è un'australiana, nella sua tesi di dottorato del 1995 gridò 136 allo scandalo, disse che i prodotti matematici di culture diverse non dobbiamo assolutamente permetterci di leggerli, vanno guardati e basta. Sono due atteggiamenti radicali. Vithal e Skovmose evidenziavano soprattutto il fatto che nel dare una lettura e attribuire valori a prodotti culturali diversi, di fatto si rischi di interpretare in maniera errata ciò che viene presentato, col rischio connesso di tornare alla frattura fra etnie. Sempre per quanto riguarda la cultura, cito una lettura, più che una definizione, che fa White nel 1959: identifica le componenti essenziali della cultura: la componente ideologica, sociologica, sentimentale, tecnologica. Secondo White la ciclicità del passaggio dalla prima componente alla seconda alla terza alla quarta è la base dello sviluppo della cultura: io penso qualcosa che sta dentro di me, confronto ciò che penso con l'ambiente circostante, con la società, valuto gli atteggiamenti nei confronti del mio pensiero della società, guardo le reazioni, dopodiché produco. A questo punto sono ritornato al punto iniziale: ho l'oggetto, il prodotto culturale, e ricomincio. Questa ciclicità viene accolta bene da noi matematici, soprattutto da noi – mi metto nella scia di Bishop – che accettiamo questa classificazione per quanto riguarda la cultura matematica e cominciamo ad attribuire dei valori a ciascuna di queste componenti: e così per esempio per la componente ideologica c'è la dualità controllo/progresso, che sembrano antitetici ma non lo sono, sono una forma di conflittualità che alla fine muove il pensiero; per quella sociologica raziocinio/qualcosa di astratto, dopodiché nella pratica comune i matematici trattano gli oggetti astratti come se fossero oggetti veri; per quella sentimentale, apertura/mistero: la matematica è trasparente, una volta fissate le regole, ma è anche qualcosa di cui molti hanno soggezione; la componente tecnologica non ha dei valori, ma se vogliamo è la sintesi dei valori che abbiamo attribuito alle tre componenti precedenti. Allora in questo ambito, etnomatematica o educazione matematica in contesto, ci sono vari filoni di ricerca: uno più attento alla storia, l'altro alla matematica delle culture tradizionali, e quindi all'a137 spetto più antropologico, l'altro che si occupa dei gruppi sociali diversi. Quello che a me evidentemente interessa è quello dell'educazione matematica, che riflette quello che gli altri ambiti di ricerca trovano e hanno trovato. Sempre Vithal e Skovmose evidenziano come la relazione fra etnomatematica o educazione matematica in contesto e l'educazione matematica sia ancora un qualcosa di sottoricercato – eravamo nel 1998, ma la situazione non è molto cambiata. Perché? Perché come spesso succede quando si parla di intercultura – e questo è uno dei motivi che mi ha spinto a prendere iniziative a livello europeo e non solo internazionale: la tematica era di interesse a livello mondiale più che in Europa negli anni '90, e in Italia l'interesse per l'educazione matematica in contesti interculturali è stato dichiarato nel 2005, quando mi è stata affidata la conduzione del seminario nazionale in Ricerca della didattica in matematica – e si inizia a parlare di revisione di curricoli, allora la domanda che io faccio e che credo molto opportuna è: come si fa a fare davvero un cambiamento in direzione interculturale accontentandoci di ciò che ci viene detto e di ciò di cui siamo convinti sulle tematiche dell'intercultura in generale e della didattica interculturale in particolare? Sono stati scritti libri e fatti corsi di formazione e aggiornamento sull'educazione interculturale, ma sempre e quasi esclusivamente a livello generale. Mai che si fosse entrati nel dettaglio delle discipline, se non fino a ieri, nelle Marche col CVM. Il problema è questo: io vado in aula, e poi? Continuo a insegnare matematica, storia, geografia come ho sempre fatto? Finalmente oggi ci si inizia a occupare di che cosa, siamo a un livello più alto, dopo la prima fase “dell'emergenza” che riguardava solo l'italiano L2, l'unica materia per cui è stato fatto qualcosa a livello ministeriale fino al 2005. Ora vorrei tornare un po' indietro: ho cominciato il mio intervento con la sampogna. Quest'oggetto è stato studiato a Pisa da me e dai miei collaboratori insieme a un lavoro in cui è stato studiato come si costruiscono i tappeti, e il terzo soggetto di studio è stata la fabbricazione dei batik. 138 Costruendo una sampogna si fa una serie di attività matematiche incredibili, a cominciare dal fatto che per costruire le canne le devo tagliare, e per tagliarle devo sapere dove le devo tagliare, e quindi ho bisogno di fare la misura; facendo la misura, anche con misure a disposizione, rischio di sbagliare, e quindi devo poi rifare il controllo; per farlo costruire in aula, com'è stato fatto, ho bisogno di educazione tecnica, e per utilizzarlo avrò bisogno di educazione musicale, se quest'oggetto deve essere introdotto in un contesto ho bisogno di un insegnante di lettere per la parte di storia, di geografia, di lingua e anche di letteratura – quindi finora ho tagliato e misurato, ordinato dal più grande al più piccolo e quindi ho fatto matematica, ho visto quale canna individua quale nota, con una relazione che mi fa arrivare ad attribuire un significato a ciascuna di queste canne: una funzione; considerando la variazione del suono in base al volume, e dunque fatti di fisica e fisiologia, riguardo al mio sforzo per far suonare. Questo dunque è un modo di fare attività; un altro è quello tipico dei cantastorie in molte regioni del mondo, anche fra loro lontane, che accompagnano il racconto facendo disegni, di solito sulla sabbia – in Angola, nelle isole Vanuatu, nelle popolazioni Tamil solo per citare le più note. I disegni hanno un significato e veicolano delle conoscenze matematiche impensabili: il discorso è questo – sono essenzialmente tabelle di punti che vengono fatte: il numero di linee che servono per racchiudere tutti i punti della griglia seguendo le regole corrisponde esattamente al massimo comun divisore fra le dimensioni della tabella. E queste persone lo sanno e a seconda della storia hanno bisogno di sovrapporre figure, e dunque di avere tabelle in cui i punti sono racchiudibili utilizzando più di una linea. Loro lo sanno già a priori: fanno matematica e conoscono il concetti di massimo comun divisore, ma nella stragrande maggioranza dei casi non sono mai andati a scuola. Questo oggetto è diventato una proposta didattica, supportata anche da un software che abbiamo creato con una mia giovane collaboratrice, che consente di disegnare questi oggetti al computer e che è diventata ora una delle sette proposte didattiche diffuse in 139 400 scuole italiane nell'ambito di un progetto del ministero PON Fondo Sociale Europeo, e che quest'anno sarà utilizzato in tutta Italia, e su cui mi piace dire: dalla sabbia al silicio – questo il nome del primo articolo che scrivemmo in proposito. 140 Note di intercultura Roberto Aglieri Flautista, compositore e musicoterapeuta. Docente presso l’Istituto Musicale F. Vittadini di Pavia. Direttore del Centro Studi Musica Medicina. Le sue prime sperimentazioni elettroniche iniziano nei primi anni settanta con una chitarra elettrica ed effetti autocostruiti, nastri magnetici e circuiti elettronici di vecchie radio. Poi nel 1979 arriva il primo sintetizzatore, seguito da un registratore multitraccia a cassette, con il quale inizia a fissare le prime composizioni che uniscono i suoni naturali dei flauti ai suoni sintetici dell’elettronica analogica. Nel 1984-85, dopo il diploma di Flauto, frequenta i corsi di Musica elettronica ed Informatica musicale presso l’EMIT di Milano studiando con Alvise Vidolin, Goffredo Haus, Mauro Graziani ed altri. In quel periodo il primo computer, con il quale inizia a comporre con sistemi midi e con software e linguaggi informatici, unendo scrittura ed improvvisazione. Ha composto musica per teatro, cinema, danza, radiofonia pubblicando opere discografiche premiate dalla critica. Oggi, nell’era della riproduzione virtuale predilige il recupero e l’uso di sistemi “vintage”, quasi una sorta di “approccio filologico” alle forme più “antiche” della musica elettronica e dell’informatica musicale. Ringrazio gli organizzatori per l'invito a portare alcune riflessioni e alcune indicazioni sulla musica e su ciò che attiene al campo della pedagogia musicale in un discorso di intercultura. Il professor Favilli ha fatto e si è fatto la stessa domanda riguardo alla matematica e riguardo all'universalità dei linguaggi, e del linguaggio della matematica. Anche io ho la stessa domanda: possiamo parlare di musica, parliamo di musica, in un campo di intercultura, o di musiche? 141 Per fare questo useremo due prospettive, la prima è quella antropologica, degli studi che l'etnomusicologia ha compiuto negli ultimi 100-150 anni – noi sappiamo che forse lo studio della musicologia comparata ha avuto possibilità tecnologiche quando la possibilità di registrare materiali ha dato agli studiosi la possibilità di comparare; la seconda è quella di tipo psicologico, forse più adatta ai nostri tempi: entrambe devono comunque essere presenti negli studi della pedagogia musicale. La domanda è: la musica è realmente un linguaggio universale? E ci facciamo questa domanda su uno dei luoghi comuni più diffusi, quello dell'universalità della musica. Probabilmente non è esattamente così: questo luogo fluttua, e a volte scompare, a seconda delle funzioni della musica. C'è comunque un elemento comune in tutte le civiltà e tra le etnie, che è ciò che Mariusc Schneider nel suo libro La musica primitiva racconta descrivendo una sorta di unitarietà nella concezione della musica come origine e come elemento originario del mondo e del creato: Un gran numero di informazioni sulla natura della musica e sul suo ruolo nel mondo ci viene dai miti della creazione. Tutte le volte che la genesi del mondo è descritta con sufficiente precisione, un elemento acustico interviene nel momento decisivo dell'azione. Nell'istante in cui un dio manifesta la volontà di dare vita a se stesso o a un altro dio, di far apparire il cielo e la terra oppure l'uomo, egli emette un suono. Espira, sospira, parla, canta, grida, urla, tossisce, espettora, singhiozza, vomita, tuona, oppure suona uno strumento musicale. In altri casi, egli si serve di un oggetto materiale che simboleggia la voce creatrice; la fonte dalla quale emana il mondo è sempre una fonte acustica: l'abisso primordiale, la bocca spalancata, la caverna che canta, il singing o supernatural ground degli Eschimesi, la fessura nella roccia delle Upanishad o il tao degli antichi Cinesi da cui il mondo emana come un albero sono immagini dello spazio vuoto e del non essere da cui spira il soffio appena percepibile del creatore. Questo suono nato dal vuoto è il frutto di un pensiero che fa vibrare il nulla e propagandosi crea lo spazio, è un monologo il cui corpo sonoro costituisce la prima 142 manifestazione percepibile dell'invisibile. L'abisso primordiale è dunque un fondo di risonanza, e il suono che ne scaturisce deve essere considerato come la prima forza creatrice, che nella maggior parte delle mitologie è personificata negli dei cantori. Ora, sotto questo aspetto esiste un'universalità della musica. La cosa cambia quando noi esploriamo le musiche e soprattutto analizziamo le musiche, ci avviciniamo alle musiche sulla base delle funzioni: le varie funzioni della musica sono presenti in misura diversa nei vari mondi. Le funzioni che io ho raccolto qui, le più diffuse, sono la funzione rituale, quindi una funzione legata a momenti importanti del gruppo – che sia la tribù, che sia una società, che sia un gruppo più articolato; una funzione religiosa, quindi legata invece ai riti di tipo religioso; una funzione di festa, che forse è quella che noi conosciamo più da vicino e che troviamo con maggior peso nel nostro mondo; una funzione spirituale introspettiva, presente in alcune civiltà musicali, forse assente in altre; infine, una funzione curativa: la musica e la musicoterapia appartengono anche all'antichità. Anzi, forse la coscienza e la convinzione – e anche una scienza – nelle possibilità d'uso della musica nella cura delle malattie è presente fino dalle prime esperienze sonoro-musicali. Pensiamo anche al fenomeno del tarantismo e a tutta la dimensione musicale che è correlata a questa pratica nel Sud Italia – Ernesto De Martino ne ha fatto uno studio molto approfondito; soprattutto in La terra del rimorso, scritto insieme a Diego Carpitella, dove si riportano anche citazioni e temi musicali utilizzati in questa cura. E pensiamo anche ad esempio che nella musica classica indiana tra i 72 ragas che sono qualcosa di più delle scale musicali, per la tradizione indiana, 36 sono considerati ragas curativi, quindi delle vere e proprie musiche e medicine. Ora, noi stiamo parlando della musica della tradizione. Le tradizioni musicali si sono conservate nel mondo in maniera differente, ma io trovo che le tradizioni musicali e la musica si devono confrontare con il tradimento – concetto che è stato lanciato da Luigi Cin143 qui –: le tradizioni subiscono variazioni, cambiamenti, vengono suonate con strumenti differenti. Nel mondo tradizionale irrompono strumenti nuovi: in Africa la chitarra elettrica ha sostituito per buona parte gli strumenti tradizionali a corde; l'influenza degli strumenti porta a modificare le tecniche di esecuzione e, nel complesso, a modificare la musica, il risultato musicale e ciò che si va a fare. Pensiamo al jazz: la musica afroamericana nasce da un processo di tradimento. Lee Roy Jones, ora si chiama Amiri Baraka, musicologo, critico e musicista, nel suo libro Il popolo del blues analizza la nascita della musica jazz come fenomeno della cultura afroamericana, e sostiene che non sarebbe nato il jazz senza la fusione e l'interazione tra due interazioni – e il tradimento di due tradizioni: quella africana nel momento in cui si incontra e trova la cultura e la tradizione musicale dei bianchi americani, a sua volta tradita. Questo fenomeno nato all'inizio del Novecento ha portato poi alla nascita della musica jazz, secondo Lee Roy Jones, intesa proprio come tradizione musicale afroamericana. Cosa caratterizza il jazz? Il jazz è caratterizzato dalle forme di interazione tra i musicisti, e di improvvisazione. L'interazione, che molto spesso diventa una vera e propria sfida tra i musicisti, è il cosiddetto interplay: un buon interplay caratterizza un'ottima esecuzione e un'ottima interazione tra i musicisti; un cattivo pezzo generalmente ha poco interplay, ognuno suona un po' per conto proprio – c'è un sottile fluido magico che nasce nel momento in cui tra i musicisti si stabilisce l'interplay. Però stiamo parlando di una musica che oserei definire anche un po' di nicchia: la nostra cultura eurocentrica in realtà tende ad avvalorare e accreditare la pop musica, quella di tipo commerciale – definiamola così, ma io la direi anche mercantile – come la forma universale di musica. Prendiamo come esempio la canzone di Shakira che è stata l'inno dei mondiali di calcio 2010: una forma musicale unilaterale, in cui gli elementi musicali etnici che sono presenti sono presenti in forma di esotismo, non in una forma strutturale. In realtà quello che passa 144 è un prodotto musicale molto occidentale, che così si contorna di qualche elemento esotico, di qualche suono che ci porta lontano. Forma mercantile, dicevo, perché l'obiettivo fondamentale di questa musica è quello di vendere. Anche nel canto, ci sono esotismi di tipo arabo: l'obiettivo di questa musica era diventare realmente global, cioè piacere un po' a tutti, e quindi toccare le corde, arrivare un po' ai gusti di tutti in giro per il mondo. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'ambito antropologico, e vi lascio solo quest'altra domanda, a cui forse ho già risposto: quest'ultimo esempio musicale può essere considerato una forma di tradimento della tradizione, o invece ha altri caratteri? O meglio, è un tradimento che può dare frutti, che ha un futuro, che porta da qualche parte, oppure non c'è un vero e proprio tradimento, ma c'è, per così dire, un ribattimento di forme musicali già acquisite? Shakira ci serve anche per parlare di un'altra funzione della musica che conosce il nostro mondo occidentale: quella individuale-privata, quella che io definirei la “sindrome da i-pod” – l'avevo chiamata “la sindrome da walkman”, ma ora aggiorno la definizione ai tempi. Le tradizioni musicali non conoscono questo modo di fruizione della musica, quello dell'ascolto privato, personale, con le cuffiette di un singolo. In qualsiasi forma, anche nella funzione spirituale, esistono musicisti che suonano, esistono persone che fanno un percorso spirituale introspettivo meditativo attraverso la musica, in presenza a volte anche di altri e comunque in presenza dei musicisti – e in ogni caso questo percorso è un percorso che ha una proiezione verso l'esterno. La prospettiva psicologica – e io oggi ho portato una prospettiva, che è quella tracciata da Rolando Benenzon, nel suo famoso Manuale di musicoterapia, più che un manuale un libro di principi sulla musicoterapia, che ci dà però la possibilità di estrapolare il suo metodo al di fuori dell'ambito della musicoterapia. La definizione di “iso”, identità sonora, secondo Benenzon, è uno strumento importante anche per analizzare i comportamenti musicali dei nostri giorni, sia individuali che collettivi. 145 Rolando B individua nell'iso quattro livelli differenti: il primo è un iso universale, in qualche modo è un iso che conserva nel patrimonio genetico una memoria ancestrale dei suoni, come l'acqua, l'oceano, il tuono, il vento, suoni che per Benenzon appartengono a tutta l'umanità fin dalle origini e che si sono inscritti nel nostro patrimonio genetico e che muovono in modo universale emozioni e reazioni uniformi. A un livello superiore troviamo un iso culturale: che appartiene a una comunità, a un gruppo, a una società, uno degli elementi fondamentali su cui lavorare nel momento dell'intercultura musicale – le forme musicali sono differenti tra etnia ed etnia, ci sono forme musicale, a volte scale, differenti, di cui dobbiamo tenere conto. Esiste un iso gestaltico, che invece riguarda la persona, l'esperienza psicosonora di un individuo; all'interno dell'iso gestaltico si raccolgono e agiscono in modo dinamico, non statico, le nostre esperienze musicali e sonore. C'è infine un iso gruppale, su cui possiamo lavorare in modo consistente quando lavoriamo con un gruppo: è un iso del gruppo, una sorta di iso segreto del gruppo, attorno a cui il gruppo crea le proprie intese, il proprio interplay – quando si struttura un iso gruppale abbiamo un gruppo che interagisce, che ha messo a punto meccanismi di interazione. Dove realizziamo tutto questo? Il nostro strumento è il gioco, il gioco sonoro-musicale. Quando pensiamo al gioco noi pensiamo a forme di azione che si basano su regole competitive e che generalmente non sono musicali. Nella pedagogia musicale generalmente il termine gioco musicale definisce una modalità d'interazione fatta di regole, a volte; ancora prima, fatta di semplici intese nel gruppo, che utilizza l'improvvisazione, la creatività, l'invenzione; che chiede prestiti all'ambito della narrazione, della letteratura, del racconto, per inventare storie da realizzarsi con i suoni. Il gioco musicale prevede gli strumenti-personaggio, una sorta di gioco delle carte in favola che noi nel nostro lavoro e nel nostro metodo abbiamo definito “suoni in favola”, con crediti verso Propp e il lavoro di Propp sulle favole. Quindi nel gioco sonoro si realizza 146 un'interazione – o, detto in termini musicali jazzistici, un interplay. Il passaggio tra interazione e interplay può essere il passaggio attraverso cui la musica diventa un'altra possibilità di realizzare un'esperienza di intercultura, ovviamente modulata sulla base del gruppo e di tutti gli elementi di esperienza psicosonora che il gruppo porta in sé. Gioco sonoro anche perché la nostra lingua, l'italiano, è l'unica che mostra una certa divergenza, una diffrazione rispetto ai significati che invece presentano le altre lingue: suonare è to play in inglese, jouer in francese, spielen in tedesco e tocar in spagnolo, che non significa propriamente giocare ma indica un'azione psicomotoria che appartiene comunque alla dimensione del gioco, soprattutto per i bambini, toccare è imparare, fare esperienza. Quindi il gioco sonoro diventa l'elemento fondamentale, il laboratorio strumentale grazie a cui operare attraverso la musica in modo creativo nella scuola, per non rischiare di avere direzioni unilaterali: la dimensione creativa è la dimensione prima e fondamentale nell'esperienza musicale – non soltanto per i bambini, per i piccolissimi; il gioco musicale è un'attività che anche gli adulti possono fare: suonare è giocare. 147 148 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DEI RELATORI AUDIGIER, François • Education civique, juridique et sociale, la citoyenneté à l'épreuve des transformations du monde contemporain , Scérén-CRDP-Académie de Nice • L'éducation à la citoyenneté, ENS Editions BRUSA, Antonio • L'alfabeto della storia, Palumbo, Palermo • L'atlante delle storie, Palumbo, Palermo • Terra e tempo. Manuale di geografia, Palumbo, Palermo CAMBI, Franco • La cura di sé come processo formativo, Laterza, Roma-Bari 2010 • Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia culturale , Carocci, Roma 2006 CIPOLLARI, Giovanna • Oltre l'etnocentrismo. I saperi della scuola al di là dell'Occidente, EMI, Bologna 2007 FAVILLI, Franco • Etnomatematica e Didattica della matematica, sul web 149 GNISCI, Armando • La letteratura del mondo nel XXI secolo, con Sinopoli, Moll, Bruno Mondadori, Milano 2010 • Decolonizzare l'Italia, Bulzoni, Roma 2007 • Mondializzare la mente, Cosmo Iannone, Roma 2006 • Creolizzare l'Europa. Letteratura e migrazione, Meltemi, Roma, 2003 • Una storia diversa, Meltemi, Roma, 2001 • Poetiche dei mondi, Meltemi, Roma 1999 • Manuale storico di letteratura comparata (in collaborazione con Franca Sinopoli), Meltemi, Roma 1997 • Ascesi e decolonizzazione, Lithos, Roma 1996 • Appunti per un avviamento allo studio generale e comparato della letteratura, Carocci, Roma 1990 KAHA, Mohamed Aden • Fraintendimenti, Roma, Nottetempo, Roma 2010 • Apriti Sesamo, in «Nuovi Argomenti», 27 (2004) • Autopresentazione, in: Forme della diversità, a cura di C. Barbarulli e L. Borghi, CUEC 2006 • Un tè serio bollente, in: Lo sguardo dell'altro, a cura di S. De Marchi, Di Salvo Editore, 2008 SALVADORI, Eleonora • Per un'educazione interculturale (con Paolo Pulina), Ibis, Pavia 1991 STARKEY, Hugh • The challenge of human rights education , Cassell Council of Europe Series 150 151 LOCANDINA CONVEGNO 152 153 154 155 PREMESSA..........................................................................................................3 SALUTI DELLE AUTORITÀ...............................................................................5 I CURRICULA INTERCULTURALI. TEORIA E PRATICA PER UNA SCUOLA MULTIETNICA................................................................................13 La revisione dei curricula a prova del futuro.......................................15 Le parole pericolose. Leggere la storia e costruire intercultura.....29 Dalla multimedialità all'intercultura.....................................................43 Le scuole interculturali............................................................................51 Educazione alla cittadinanza..................................................................59 La didattica dei personaggi ponte........................................................69 Intercultura: qualche suggestione geo-cartografica........................79 Identità e cultura: un autoritratto.........................................................99 Il cittadino plurilingue...........................................................................105 Prolegomeni a un curriculum vitae di letteratura mondiale del XXI secolo in Italia...................................117 Matematica e intercultura: teoria e pratica didattica....................131 Note di intercultura...............................................................................141 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DEI RELATORI............................................149 LOCANDINA CONVEGNO........................................................................151 INDICE...........................................................................................................155 156 157
Scaricare