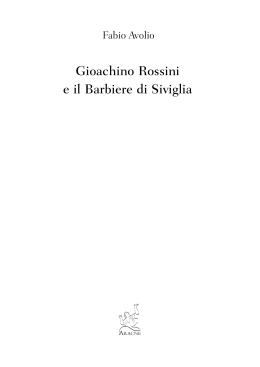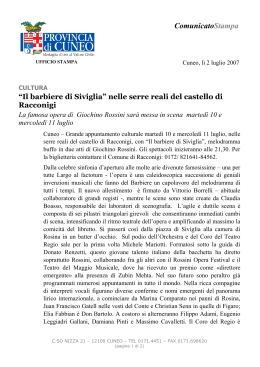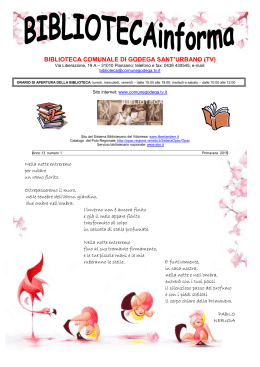Paolo Gallarati Trent’anni all’Opera (1978-2010) Le Lettere INDICE GENERALE Prefazione Lo spettacolo nello specchio della recensione.................................................. p. 7 I. Seicento e Settecento................................................................................... » 19 II.Ottocento.................................................................................................... » 81 III.Novecento................................................................................................... » 229 Indice delle opere............................................................................................... »319 Indice dei nomi................................................................................................... »323 II Ottocento Mi ama per i soldi o per me stesso? Un applauso ha accolto l’altra sera, al Palasport di Pesaro, l’alzarsi del sipario su La pietra del Paragone (1812) che Pier Luigi Pizzi, autore di regia, scene e costumi, ha allestito per il Rossini Opera Festival. La sua trasposizione della vicenda in epoca contemporanea non fa una grinza; anzi, esalta l’attualità di questo spaccato di vita borghese che consacrava la fama di Rossini ventenne al suo debutto alla Scala di Milano con un successo tale da procurargli l’esenzione dal servizio militare. Siamo in una splendida villa, con pareti a riquadri bianchi e rossi, dotata di tennis e piscina all’interno di un parco secolare dove si svolge la vicenda del ricco Conte Asdrubale, desideroso di saggiare la sincerità delle signore che gli ronzano intorno: si traveste, così, da creditore straniero, finge di perdere tutto il suo patrimonio e, attraverso questa “pietra del paragone”, può distinguere tra chi veramente lo ama (la marchesa Clarice) e le semplici aspiranti a un matrimonio da nababbi. Questa storia galante acquista uno straordinario mordente attraverso le tre macchiette che appartengono alla mondana società di cui il Conte si circonda: un giornalista, Macrobio, fiero del suo potere sull’opinione pubblica («Mille vati al suolo io stendo /con un colpo di giornale») e due poeti, uno, Giocondo, più serio e compiaciuto della propria presunta superiorità intellettuale («Vil timore ai versi miei / mai non fece alcun giornale») l’altro, Pacuvio, sciocco, pedante e insistente nel recitare a tutti le sue poesie idiote, tra cui l’esilarante, famosissima «Ombretta sdegnosa del Missipipì» [sic]. Questa vicenda, che va ben oltre la convenzionalità delle trame buffe tradizionali, fece scoppiare dei veri fuochi d’artificio nella fantasia del giovanissimo Rossini. Se nelle quattro farse del 1810-12 il prodigioso ragazzo aveva inventato un nuovo ritmo e una nuova velocità, qui mette a punto la sua inconfondibile personalità melodica: i motivetti che zampillano ovunque sono ormai tutti, inconfondibilmente rossiniani, e attendono solo un libretto meno dispersivo di quello di Romanelli per conquistare, l’anno seguente, con L’Italiana in Algeri, quella compattezza che porterà l’opera comica di Rossini a livelli qualitativamente assoluti nel suo equilibrio tra dramma e gioco. Per metterlo in scena oggi, nel 2002, Pizzi ha fatto una cosa intelligente, spiritosa, elegantissima. Nella villa dell’alta società le signore si bagnano in piscina, gli 82 trent’anni all’opera uomini duettano giocando a tennis sul bilanciarsi ironico delle simmetrie rossiniane, gli innamorati si parlano al telefono, risolvendo così molto bene, col gesto di coprire ogni tanto la cornetta, l’imprudente profluvio degli “a parte” che dilagano nel confuso libretto di Romanelli. I cantanti, sotto la guida di Carlo Rizzi, devono essere stati scelti anche con l’intento di ben figurare in costume da bagno o con gli splendidi vestiti della collezione Torelli di Roma: un seguito inesauribile di Dior, Chanel, Saint Laurent, ecc., uno più bello dell’altro nella fantasia di stoffe, colori, tagli elegantissimi e molto ben portati. Carmen Oprisanu, slanciata come un’indossatrice, era una garbata Marchesa Clarice, Marco Vinco un generoso Conte Asdrubale, Raul Gimenez un poeta Giocondo che supplisce a una voce un poco stimbrata con tecnica sopraffina. Meglio di questi, tuttavia, hanno cantato Pietro Spagnoli, dotato di bella voce e sufficiente personalità nella parte del giornalista Macrobio, che dovrebbe peraltro essere più graffiante, e Bruno De Simone, l’unico assolutamente completo, per voce e presenza scenica, nei panni del goffo poeta che Pizzi veste in pantaloni corti, sandali e calzini neri. L’orchestra del Comunale di Bologna ha suonato abbastanza bene, ma à stata la regia, stavolta, e non l’esecuzione musicale a far scattare quell’incanto che a Pesaro si ripresenta, ogni anno, puntuale: i colori della villa, a linee bianche e rosse, il gruppo di bersaglieri che accompagnano la Marchesa vestita da ufficiale, i movimenti dinoccolati e ostentatamente disinvolti di quella società ultrachic, distesa sotto gli ombrelloni bianchi o sul verdeggiante praticello del bosco secolare, o impegnata a far ginnastica, si sposano alla musica di Rossini con una leggerezza ironica e mostrano, nel lavoro di Pizzi, un’attenzione alla recitazione dei singoli personaggi più evidente qui che in altri suoi spettacoli. Tutti d’accordo, quindi, alla fine nell’applaudire lungamente senza riserve. [11.8.2002] Tancredi eroe al Palasport Con quello che costano gli spettacoli, il Rossini Opera Festival ha deciso di spostarli, almeno in parte, al Palafestival, raddoppiando, così, il numero degli spettatori. L’operazione, abbastanza rischiosa, si può dire sostanzialmente riuscita, anche se un palazzetto dello sport non è un teatro e certe soluzioni sceniche sono precluse in partenza. Nel nuovo allestimento del Tancredi, affidato alle cure di Pier Luigi Pizzi, che ha firmato regia, scene e costumi, tutto funziona assai bene sino all’ultimo quadro, quando Tancredi, disperato per il creduto tradimento di Amenaide, cerca la morte, senza trovarla, nella battaglia contro i saraceni. La scena è prescritta in montagna, luogo sacro alla disperazione romantica, tra burroni scoscesi, torrenti che precipitano, foreste e, in fondo, il selvaggio profilo dell’Etna. Ma qui siamo inchiodati alla scena fissa e tutto avviene dove si è svolta l’azione precedente: davanti al gran palazzo di Siracusa, tra torrioni medievali con lo spazio diviso in due rettangoli di prati verdi e, al centro, uno specchio d’acqua azzurro e navigabile. Pizzi ha voluto sfruttare al massimo la vastità della scena, impegnando interamente il rettangolo del campo sportivo, reso verdeggiante con erba e arbusti: ci sono cavalli veri che portano in scena i protagonisti di questo medioevo avventurosamente letterario, e una vera barca che, scivolando sul canale, rende quanto mai ottocento 83 realistico l’arrivo di Tancredi. Ma, fortunatamente, non ha ceduto alla tentazione di trasformare in grand opéra il primo capolavoro serio di Rossini, l’opera che lanciò il musicista ventunenne e che affascinò Stendhal per il suo «candore verginale»: sarebbe stato un errore marchiano. Al contrario, Pizzi sembra aver fatto tesoro della definizione di Goethe: «favola boschereccia». Così ha conferito a scene e costumi la leggerezza colorata e spiritosa di un fiabesco torneo medievale, scostandosi molto dall’allestimento sontuoso e barocco che aveva proposto nel 1982: costumi a scacchi, a striscie, a pezze di colori squillanti, movimenti roteanti di personaggi, cavalli e comparse, discreto ma pungente impiego dei “tableaux vivants”, come quando, durante la lettura della lettera che accusa Amenaide di tradimento, nella luce soffusa della scena, tredici personaggi si bloccano sugli spalti in pose diverse e assistono, come statue nel silenzio generale, al momento più grave e solenne del primo atto. Un particolare dei costumi non si può tacere: la straordinaria bellezza degli elmi dorati su cui troneggiano teste di cervi e di cani, aquile, cigni, teste di moretti con turbante, i simboli radunati del mondo cavalleresco tra esotismo, caccia e guerresca avventura. Buona l’esecuzione musicale, nella migliore tradizione del Festival pesarese. Lucia Valentini Terrani è semplicemente straordinaria nei panni di Tancredi: spavalda, severa, disperata nella cocciutaggine con cui decide di morire per dimenticare il presunto tradimento dell’amata, con la sua sola presenza riempie il vastissimo palcoscenico del Palafestival. La voce, poi, affronta la coloratura di forza con fiammeggiante bravura, pronunciando le parole in modo da farle capire anche quando sono centrifugate nella girandola dei vocalizzi. Così la Valentini smentisce qualsiasi sospetto circa la “freddezza” del belcanto acrobatico: e mostra come Rossini, ereditando dal Settecento l’arte del gorgheggio, ne facesse l’espressione di una vitalità nuova, sottraendola alla stilizzazione arcadica per adeguarla alla vitalità saettante, all’energia della nuova età napoleonica. Se la Valentini è ormai una veterana in queste che sono tra le imprese più difficili cui è chiamato un cantante d’opera, Mariella Devia si conferma a ogni prova più intensa: la sua Amenaide è semplicemente perfetta per intimità, commozione e splendore vocalistico. La crisi delle voci che si lamentava qualche anno fa sembra ben avviata a risolversi con la comparsa di questi giovani fuoriclasse. L’opera cresce nel secondo atto e, se non fosse per la Valentini che le tiene testa, la figura di Amenaide, interpretata dalla Devia, assumerebbe una preponderanza schiacciante: imprigionata, perseguitata dal destino avverso, canta melodie che nel 1813 irrompevano sulla scena del melodramma italiano con una forza di coinvolgimento emotivo che non ha perduto un grammo del suo potere. Anche lo splendido duetto tra Tancredi e Argirio, nel secondo atto, ha avuto una resa adeguata, grazie alla partecipazione del tenore Raul Gimenez, navigatore esperto tra le insidie del belcanto, mentre Boris Martinovic (Orbazzano), Susanna Anselmi (Isaura) ed Enrico Facini (Roggero) completavano degnamente la compagnia. Buona la prestazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale di Bologna: Daniele Gatti ha diretto con slancio e precisione, mettendo in rilievo il disegno generale dei singoli pezzi e cesellando con amore l’infinita grazia e bellezza dei par- 84 trent’anni all’opera ticolari strumentali: specialmente i legni è come se distendessero sotto le voci continue manciate di fiori, irrorando di screziature colorate anche le parti più “selvagge” e guerresche. Perché questa è, sin dagli inizi, l’essenza del Rossini serio: da un lato fondare il Romanticismo musicale italiano, dall’altro scherzarci su con una agilità, una grazia e uno spirito che solo Mozart nella storia della musica ha posseduto in eguale misura. [12.8.1991] L’opera che visse tre volte Dopo vent’anni il Rossini Opera Festival ha ormai creato un repertorio e ripropone capolavori che erano una volta di rarissimo ascolto. Così, l’altra sera, è andata in scena al teatro Rossini la terza edizione di Tancredi, nuovamente firmata, come le precedenti, da Pier Luigi Pizzi, autore di regia, scene e costumi. Il primo Tancredi pesarese di Pizzi (1982) era un trionfo barocco di capitelli dorati e colonne azzurre di lapislazzulo, e sottolineava l’ascendenza settecentesca dell’opera seria di Rossini; il secondo (1991), dilatato nei grandi spazi del Palasport, puntava invece sul medioevo cavalleresco e favoloso dei tornei, con cavalli sontuosamente addobbati e cavalieri multicolori. Quello visto l’altra sera è forse il più vero e commovente. La Sicilia in cui si svolge l’azione è quella greca dei templi dorici e dei bassorilievi classici: le architetture sono nitide e semplici, tanto massicce quanto flessibili perché sprofondano, si piegano e si rialzano in pochi secondi. Pizzi concepisce il Tancredi, composto dal ventunenne Rossini, come un dramma di ragazzi: liberi nei movimenti, senza armature né abiti sontuosi, amano e si disperano, piangono ed esultano nei loro vestiti leggeri, appassionato Tancredi, dolce e flessuosa Amenaide, nella sua disgrazia di fanciulla perseguitata. Nel progetto, perseguito con un gusto sovrano (quelle figure nere in controluce, il cavallo di marmo, la barca, la gabbia che scende come prigione, i pepli bianchi, neri e grigi, le luci mattutine e sfumate…), Pizzi era favorito dalla compagnia di canto formata da giovani che il Festival ha scoperto e lanciato tra il plauso generale. Il contralto Daniela Barcellona, alta e irruente, canta benissimo nella parte di Tancredi: la sua prima nota, emessa come un sospiro nell’atto di baciare il suolo della patria ritrovata, dapprima piano, poi in crescendo, poi di nuovo pianissimo, è bastata a incatenare il pubblico senza mollare più la presa sino alla fine: colorature splendide, e un tono elegiaco che rovescia l’impeto guerriero di certi modelli precedenti, sino al finale tragico quando Tancredi muore in scena, sostenuto da Amenaide, tra sussurri appena percettibili. Questo esito, che Rossini aggiunse in un secondo momento, rifacendo il convenzionale lieto fine della prima versione, è stato il culmine di uno spettacolo volto a commuovere, più che a stupire: e Gianluigi Gelmetti, dirigendo l’Orchestra della Toscana e lo splendido Coro di Praga, ha sottolineato, oltre alla grazia della musica, alla sua tenerezza ingenua e sorgiva, anche quell’impasto di vivacità e malinconia con cui Rossini rinnovava il teatro musicale europeo, inondandolo attraverso un profluvio di musica nuova. Guai ai cantanti che la riducono a un gelido pizzo di puri gorgheggi: anima ci vuole, oltre alla tecnica, e Darina Takova (Amenaide), Giuseppe Filianoti (Argirio), Simone Alberghini (Orbazzano) ce ne hanno messa molta, determinando, ottocento 85 insieme a tutti gli altri, il trionfo di uno spettacolo che meriterebbe la diffusione televisiva, a dispetto dello strano disinteresse che la Rai ostenta ormai da molti anni nei confronti di questo Festival, tra i primi in Europa. [18.8.1999] Dario Fo più forte di Rossini È un’esplosione di vitalità creativa la regia che Dario Fo ha ideato a Pesaro per L’Italiana in Algeri. Dopo poche note, della sinfonia la macchina scenica gira già a pieno regime: si vede un naufragio che, in un grande agitarsi di onde azzurre, voli di gabbiani, marinai che nuotano, vascelli in tempesta, utilizza l’Ouverture come colonna sonora, spiegandoci che la nave italiana che trasporta Isabella sta avvicinandosi alle coste di Algeri. Poi si apre il sipario e inizia la festa, inesauribile, provocante, audace. Siamo nel palazzo del Bey: dondola un’altalena, ballonzolano mimi, sfilano comparse su trampoli altissimi, una garitta semovente si apre e compare Mustafà. Il palco è pieno come un uovo, che cosa mancherà ancora? Molto, moltissimo, come mostrano, in un parossistico crescendo, le scene seguenti. Scimmioni, cammelli, leoni, struzzi, zebre contrappuntano l’azione che ogni tanto viene riassunta da scritte in italiano e in arabo. Tutto si muove, incessantemente: scende una grata dall’alto su cui si arrampicano i personaggi, Isabella si spoglia in controluce, passano ombre di giocolieri, portantine, baldacchini, attaccapanni pieni di abiti, manichini semoventi e volanti, paraventi, scale a pioli, lunghi pali, di cui uno si trasforma in un missile, palme che si allungano, aiuole che si spostano, vasi di fiori, nastri, enormi coccarde tricolori, trofei di bandiere, macchine fotografiche al lampo di magnesio, cavalletti, la nazionale italiana di calcio, quella di ciclismo, navi, barche, onde, uccelli, pesci. In questa barocca sovrabbondanza di elementi, i personaggi si aggirano come i visitatori di un colorito bazar delle meraviglie: ne restano, perciò, come sperduti, confusi, spaesati, mentre nulla resta di quella rettilinea asciuttezza che caratterizza l’opera comica di Rossini, dove si celebra il razionale e italico trionfo del l’intelligenza, dell’intraprendenza, della capacità di dominare le situazioni e di volgerle a proprio vantaggio, doppiando spiritosamente gli ostacoli della fortuna. Più che interpretata, L’Italiana in Algeri viene così travestita, anche se con scontata bravura, nella forma di un colossale balletto: ma, facendo muovere sempre tutto e tutti, Dario Fo finisce per distruggere la vera comicità rossiniana, quella intrinseca al discorso musicale che gioca sul contrasto tra staticità e moto, bloccando periodicamente i personaggi al proscenio mentre si scatena il delirio del ritmo e del suono, e l’espressione passa i confini del reale. Straordinaria per forza comica è, comunque, la scena finale della cerimonia dei «Pappataci»: qui il carattere grottesco, il movimento roteante di arredi e personaggi, i bellissimi costumi con la cresta di gallo che troneggia in testa a Mustafà sono perfettamente centrati. Ma, dopo tutto il carnevale precedente, chi ci bada più? L’effetto del colpo di scena si affloscia e la fine del frastornante allestimento giunge quasi come una liberazione. Non per il pubblico, però, che ha mostrato di gradire oltremodo la ricchezza e la fantasia dello spettacolo, festeggiando il regista, scenografo e costumista, con sincere ovazioni, e perdonandogli la sua sostanziale impermeabilità ai valori della musica. 86 trent’anni all’opera Quanto all’esecuzione, mi è parsa un po’ al di sotto dei livelli sovente eccelsi cui ci ha abituato il Rossini Opera Festival. Due cantanti spiccano indiscutibilmente: Jennifer Larmore, bravissima e fascinosa Isabella e Bruno Praticò, misurato e spiritoso Taddeo. Facendosi largo nella selva degli elementi scenici, come Tarzan nella foresta equatoriale, sono stati in grado di far intravedere l’individualità dei loro personaggi: cosa che è riuscita meno a Donato di Stefano (Mustafà) e pochissimo a Markus Schäfer (Lindoro), piuttosto sfocato anche sul piano vocale. Pungente, invece, la sortita del giovane e bravo Ildebrando d’Arcangelo nell’aria delle «femmine d’Italia» cantata da Haly, e buona la prestazione dell’Orchestra del Comunale di Bologna e del Coro Filarmonico di Praga (maestro Henryk Wojnarowsky) diretti da David Robertson. Noi che amiamo la satira tagliente, l’esplosiva concentrazione mimica di Dario Fo, il suo gusto essenziale e asciutto ci aspettavamo di tutto, tranne che uno spettacolo spossato dall’eccesso di decorazione: ma la sincerità e l’energia messi dal regista nel correre questo rischio, pur nel dissenso, ci inducono un moto di ammirazione. [14.8.1994] C’è Sigismondo e Rossini finisce in manicomio Dopo più di trent’anni, il Festival di Pesaro continua a riscoprire opere sconosciute. Ora tocca a Sigismondo, presentato da Rossini a Venezia, con scarso successo, nel 1814, un anno dopo la rivelazione del nuovo genio, avvenuta nel 1813 con Tancredi e L’Italiana in Algeri. Siamo nel periodo giovanile dell’opera seria rossiniana, in cui dominano freschezza, leggerezza, spirito e tenerezza nella rappresentazione degli affetti. Poi Rossini, a Napoli, s’impegnerà in opere più severe, drammatiche e cupe. Sigismondo si basa su un libretto assurdo di Giuseppe Foppa: nei suoi versi, la vicenda medievale di Geneviève de Brabant, nota e diffusissima nell’Ottocento romantico (la trattarono, tra gli altri, Schumann, Tieck, Hebbel, Puškin, Rimskij-Korsakov, Offenbach) non offre nessun appiglio al compositore per dar vita a personaggi e situazioni credibili. La musica di Rossini, così, va per va conto suo, e in questa alata indifferenza gira per lo più meravigliosamente a vuoto; e non potrebbe far diversamente, visto l’anguillesca inafferrabilità del dramma. Tipico esempio di “opera concerto”, Sigismondo incanta in molte pagine per la freschezza delle melodie, l’arguzia dei ritmi, la felicità delle combinazioni strumentali, l’elettricità dei crescendo. Molte pagine sono deliziose, altre più convenzionali, ma l’ascolto fila veloce, tanto più se guidato da un direttore come Michele Mariotti che ha condotto l’Orchestra del Comunale di Bologna in modo preciso, energico, raffinato e spiritoso. Eccellenti i cantanti: Daniela Barcellona, contralto strepitoso nella parte en travesti del re Sigismondo, Olga Peretyatko, soprano acrobatico dalla voce un po’ asprigna ma gorgheggiante a dovere in quella di Aldimira, Antonino Siragusa, sempre autorevole nel belcanto di un personaggio serio come Ladislao, Andrea Concetti (basso) e Manuela Bisceglie ottimi comprimari. Tutto il gruppo degli esecutori ha ricevuto applausi entusiastici. Sulla regia di Damiano Michieletto (scenografo Paolo Fantin), accolta tra approvazioni e proteste, bisognerebbe stendere un velo pietoso. Per dovere di crona- ottocento 87 ca segnalerò che l’idea centrale è quella del manicomio: siccome il re Sigismondo è ossessionato da allucinazioni varie, dovute al rimorso per aver fatto uccidere la moglie, che in realtà si è segretamente salvata, tutto il primo atto è ambientato nella corsia di un reparto psichiatrico, con le infermiere, i medici e i poveri matti che si aggirano in camicioni grigi, facendo gesti inconsulti, tra risse, urla, singhiozzi, tremiti, pianti, espettorazioni e conati. Tutto si svolge lì, e la differenza degli ambienti (la reggia, la campagna, il bosco, l’abitazione rustica) è abolita. Nel secondo atto la cura ha fatto evidentemente effetto e Sigismondo, che era sulla sedia a rotelle, appare guarito. Ma in quale sala di riunione si trova ora? Tribunale? Sala lauree universitaria? Grande albergo? Non si capisce. Dovremmo assistere a una guerra, in mezzo a montagne e dirupi: ma qui tutto è risolto con la frenetica estrazione di molti fogli dai cassetti. E tornano i matti, poveri, derelitti, sconvolti. Questa esibizione decorativa della sofferenza umana passa di gran lunga i limiti del buon gusto e, forse, anche della morale. Quindi giù il sipario, per favore. Eppure c’è chi applaude. [11.8.2010] Questo turco frizzante, maestro di dolce vita Una bella edizione del Turco in Italia, forse la più bella tra quelle viste negli ultimi anni, ha aperto la stagione del Teatro Comunale di Bologna. Il regista Antonio Calenda ha allestito una vera commedia, vivace e briosa, leggera e frizzante, senza cupezze né tratti pessimistici. Perché è vero che, come spiega Bruno Cagli nel programma di sala, Il Turco in Italia sostituisce alla visione positiva e ottimistica del l’Italiana in Algeri la vicenda di una umanità mediocre, senza buoni né cattivi, bloccata nel labirinto dell’inganno, della disillusione e dello smarrimento: ma è anche vero che su quel paesaggio di seduzione e frivolezza, di sarcasmo e, talvolta, di sconforto, Rossini, a 22 anni, intreccia una partitura scintillante per grazia e arguzia, con un sorriso che anima tutto, contro la risata travolgente e fragorosa che scrosciava, l’anno prima, nell’Italiana. Sullo sfondo si vedevano i paesaggi del golfo di Napoli, quando era il più bello del mondo, prima della speculazione edilizia: una cascata di verde che cola nell’azzurro del mare. Molto fine, anche nei quadri notturni, questa rielaborazione dei vedutisti napoletani fornita dallo scenografo Nicola Rubertelli e dal costumista Maurizio Millenotti è perfettamente adatta a incorniciare la vicenda del Turco come «manifesto di dolce vita» (Mila): l’aura seduttrice del meridione, la bellezza delle sue donne dagli occhi neri e pieni di luce, il gusto del colore, della mascherata e del mistero, tutte cose che la musica di Rossini fissa in modo chiarissimo, e che l’altra sera sgusciavano fuori dall’esecuzione in piccoli, continui momenti di rivelazione. Ecco, dunque, il caso di uno spettacolo “tradizionale” che, in virtù della sua consonanza con lo spirito dell’opera, sembra nuovo di zecca. Bravo Evelino Pidò, alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale: si è imposto l’ideale della trasparenza e della leggerezza, raggiungendolo a colpo sicuro, con andamenti spiritosi e scattanti e una concertazione molto accurata. Sotto le voci ha disteso un tappeto degno di una compagnia eccezionale per levatura e omogeneità. Trionfatrice della serata è stata Mariella Devia, alla cui Fiorilla manca ancora 88 trent’anni all’opera un poco di vivacità teatrale, abbondantemente compensata dalla qualità unica del canto, capace di seghettature nervose nei vocalizzi ma anche di effusioni nelle frasi melodiche, magari appena sussurrate. Il tenore Rockwell Blake, qui nei panni del cicisbeo Don Narciso, è quel portento che tutti conosciamo: voce brutta ma tecnica onnipotente e stile impeccabile. Ottimo Michele Pertusi, che disegna un Turco galante e dominatore, ma senza prevaricazioni (unica cosa che non mi piace della regia, quel farlo entrare in scena sulla prora altissima di una nave, in atteggiamento eroico, che pare Attilio Regolo di ritorno dalla prima guerra punica). Bravi Susanna Anselmi come Zaida e Bruno Praticò, un «buffo» eccellente per rappresentare la figura del «marito scimunito» che scemo, poi, non è mica tanto, visto che alla fine tira fuori le unghie e sa riconquistare l’affetto della capricciosa Fiorilla. Ma questa è una malignità del poeta Prosdocimo che si aggira sul palco, osservando il carattere da mettere in scena nel suo prossimo dramma: straordinario personaggio rappresentato, in genere, come piuttosto anziano, e qui, invece, affidato al giovane e bravissimo Roberto De Candia, in redingote e bombetta, animato da un’agitazione appassionata che già si addice a un drammaturgo romantico. Tratto certo, molto inatteso, ma determinante per accentuare il trionfale successo dello spettacolo impreziosito dalla coreografia di Aurelio Gatti. [28.11.1994] Fiorilla strega il Turco con malizia Splendido Turco in Italia al Teatro Rossini di Pesaro, quasi deturpato da un recentissimo restauro che ha rovinato il foyer: ma non potevano chiedere un consiglio a Pier Luigi Pizzi, di casa a Pesaro, per rifare un ambiente che è diventato color giallo limone, tra volte basse e lampadari di cristallo, completamente in contrasto con la bellezza della sala neoclassica? Passata quella specie di penitenziale tunnel gialloverde, che porta in sala, si è comunque entrati in un mondo magico: la turchesca vicenda del principe Selim, in viaggio a Napoli dove incontra la bella Fiorilla, «donna capricciosa ma onesta», e se ne innamora, è sbocciata in tutta la sua ironica grazia. Cantanti splendidi, tra veterani e quasi debuttanti. In omaggio all’anzianità di carriera cominciamo da Alessandro Corbelli: il suo Don Geronio, «marito scimunito» dell’incontrollabile Fiorilla, è da manuale. Arriva in frac grigio, cilindro e basettoni, pieno di risentimento represso verso l’invadenza di quel maledetto turco che viene a casa sua a prendere il caffè, e corteggia sua moglie: Corbelli mette a fuoco Geronio con nitidezza fotografica, non trascura una parola del testo di Felice Romani, e canta con stile e voce meravigliosa. Quasi altrettanto pungente è Roberto De Candia nello straordinario personaggio del poeta Prosdocimo che segue tutta la vicenda con l’occhio ironico, divertito, affettuoso e insieme distaccato di chi cerca, nei casi della vita, l’argomento per un dramma buffo, da scrivere per qualche musicista. Rossini ne fa l’autoritratto della propria visione della vita: un gioco aperto a tutte le possibilità, compresa quella di un eventuale esito felice. Questo esistenzialismo latente distacca Il Turco in Italia dalla comicità carnevalesca, fragorosa e tutta positiva dell’Italiana in Algeri e del Barbiere di Siviglia. Qui serpeggiano inquietudini, ombre fugaci si allungano, uno strano senso del mistero chiazza qua e là una musica ottocento 89 straordinariamente frizzante che non scoppia nelle fragorose risate delle grandi opere comiche italiane, ma sembra preannunciare, con quattordici anni di anticipo, le effervescenze maliziose e volatili del francese Comte Ory. Questa leggerezza Patrizia Ciofi l’ha fatta propria ed esaltata con grazia e stile. Come faccia a tirar fuori tanta voce da quel corpicino minuto e asciuttissimo è quasi un mistero: la sua Fiorilla svolazza meravigliosamente in gorgheggi nervosi e pieni di charme. Grande, poi, la sua prestazione nell’aria seria dell’ultimo atto, molto difficile ma non tanto bella, come non lo sono quelle di Geronio e Narciso, perché il Turco non è opera di arie plastiche e scultoree, ma di pittorici pezzi d’assieme, trattati con impressionistica levità. Il giovanissimo e gigantesco basso georgiano Ildar Abdrazakov, nella parte di Selim pascià, è una rivelazione: fisico solenne, portato in modo ironico, voce ben timbrata e forte, sguardo fulminante tra i baffi appuntiti e galanti. Tutti sono stati subissati di applausi, compreso Matthew Polenzani, garbato Narciso. Riccardo Frizza ha diretto con spirito e vivacità l’Orchestra del Festival, bisognosa di una buona cura ricostituente nel settore degli ottoni. Lo spettacolo di Roberto de Monticelli, con i colorati costumi ottocenteschi di Santuzza Calì e le scene funzionali di Paolo Bregni, era molto ben costruito sul gioco degli attori, splendidamente colorato e ben ritmato tra vivacità e stupori. Avesse tolto, al l’inizio, il telo che fluttua nello sfondo, e che non si capisce che cosa sia, nonché il cascamorto deficiente che accompagna occasionalmente Fiorilla, offrendole fiori e rotolandosi per terra, sarebbe stato perfetto. Due piccoli nei, comunque, facilmente asportabili. Per il resto, una festa piena di allegria e capace di caratterizzazione squisita. [13.8.2002] Diavolo di un Rossini: anticipò anche Brecht Successo clamoroso, l’altra sera, all’Auditorium Pedrotti di Pesaro, per l’esecuzione di Elisabetta regina d’Inghilterra, la prima opera composta da Rossini per Napoli, nel 1815. Fulcro di questo successo, la prestazione di Sonia Ganassi nella parte protagonista. Elisabetta è crudele, furibonda, aggressiva: Rossini le affida un campionario di colorature di forza, ossia gorgheggi acrobatici che vanno resi non come aerei e delicati cinguettii, ma con slancio, spessore, volume e vigoroso scatto ritmico. Sono frustate, galoppate veloci dal basso all’acuto e viceversa, arresti improvvisi su una nota da cui spiccare il volo per nuove, scroscianti cascate. La Callas ha insegnato al canto moderno a riscoprire questa vocalità che si era, nel tempo, perduta. La Ganassi è una delle sue numerose eredi: e, anche se la sgranatura delle note nelle colorature potrebbe essere ancora più nitida, nel suo canto vi è concentrata al meglio l’idea fondamentale del teatro rossiniano che è, insieme, immedesimazione nel dramma e straniamento ludico, scultura di gesti musicalmente ralizzati e insieme liberazione del canto nel puro arabesco. Un’idea molto moderna, quasi brechtiana nel suo continuo gioco di specchi che l’ascoltatore moderno deve capire per apprezzare le bellezze e l’originalità dell’opera seria rossiniana. Elisabetta è una partitura aspra, severa. Non possiede le grazie melodiche del Tancredi che ci aveva deliziato la sera prima; molti suoi pezzi hanno invece un anda- 90 trent’anni all’opera mento febbrile, sospinto da un’orchestra che predilige colori cupi, armonie dense, ritmi galoppanti. Ogni tanto Rossini sparge guizzi brillanti, che ricordano l’opera buffa; ma, in quel contesto, perdono il loro valore ironico e appaiono, piuttosto, come scintille sopra un dominante fondo scuro. Il direttore Renato Palumbo ha messo in evidenza con vigore questa forza che stupì, all’epoca, il pubblico napoletano; a differenza di quanto era accaduto la sera prima nel Tancredi, qui l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna ha acquistato il ruolo di un personaggio, in continuo dialogo con i cantanti in scena. Dialogo che potrebbe essere più raffinato, nella stratificazione delle sonorità, ma che appariva, comunque, sempre vitale. Anche lo spettacolo di Daniele Abbado, con le scene e i costumi di Giovanni Carluccio, mirava opportunamente, grazie alle luci di Guido Levi, a suggerire la cupezza di fondo che caratterizza la partitura, per molti versi sperimentale, di Elisabetta: un’incastellatura metallica fatta di colonne d’acciaio, con piani sovrapposti, pedane, corridoi, occupa la scena dall’inizio alla fine, mentre l’argento del metallo lampeggia sul nero. Nel fondo si disegnano tanti riquadri, nei quali i personaggi prendono posto con ieratica fissità: un effetto che piace lì per lì, ma che viene progressivamente a noia, perché la scena è sempre la stessa, ed è movimentata solo da uno scorrere di grate, con una vera e propria ossessione per il motivo quadrettato: troppo poco per alleviare l’ascolto di un’opera che non ha certo l’immediatezza e la tenuta dei grandi capolavori buffi né la continuità inventiva di una Semiramide. Se lo spettacolo non aiuta molto l’ascoltatore, spicca ancor più il merito del l’esecuzione musicale. Accanto alla Ganassi che, oltre alla coloratura di forza, sa cogliere anche i lati umani di Elisabetta e, in particolare, la straordinaria dolcezza dell’ultima aria, molto bene hanno fatto Mariola Cantarero (Matilde), Antonino Siragusa (Norfolc) Bruce Sledge (Leicester): tutti sono apparsi consapevoli delle esigenze stilistiche imposte dal belcanto rossiniano, e accumunati, alla fine, da applausi scroscianti. [9.8.2004] Torvaldo a Pesaro Tra i Festival internazionali quello di Pesaro costituisce un caso unico: nessun’altra manifestazione può vantare, infatti, nel suo cartellone, la presenza di “novità” maggiormente rilevanti per la cultura musicale europea. In più di vent’anni la manifestazione pesarese ha portato avanti la riscoperta delle opere di Rossini, cadute nell’oblio a partire dalla metà dell’Ottocento: il che significa aver messo in luce la maggior parte della produzione di uno tra i massimi dei geni della storia musicale. Quest’anno l’inaugurazione è toccata a Torvaldo e Dorliska, opera semiseria rappresentata a Roma nel dicembre del 1815, un paio di mesi prima del Barbiere di Siviglia. È la vicenda di Dorliska, una ragazza polacca concupita da un tiranno prepotente, che la sottrae a Torvaldo, marito amatissimo, e la tiene prigioniera nel suo castello. Ma, con un colpo di stato organizzato dall’intraprendente Giorgio, custode del feudo, il Duca viene detronizzato, permettendo, così, alla coppia di ritrovare la felicità. ottocento 91 Rispetto alle partiture, tra cui alcune fulgidissime, riscoperte in questi anni, direi che quest’opera semiseria possiede la brillantezza posticcia del similoro, e aggiunge ben poco alla rinnovata immagine di Rossini. L’invenzione è stanca, le melodie sono poco incisive, i giochi di scambio tra orchestra e voci privi di quei guizzi fantasiosi e geniali con cui Rossini aveva colpito, con straordinarie folgorazioni, il pubblico del suo tempo. Ciononostante, è utilissima per documentare ex negativo lo spessore del genio. Torvaldo e Dorliska è “montata”, infatti, facendo ricorso a un formulario musicale, rossiniano al cento per cento: il che significa che nel 1815 Rossini aveva già rivoluzionato il melodramma italiano con uno stile così personale e caratterizzato, da fornire un modello di cui lui stesso si serve. Se l’arte, nelle sue massime espressioni, offre dei modelli assoluti, capaci di generare un repertorio di formule cristallizzate, Torvaldo e Dorliska ci ricorda che il ragazzo, autore del l’Italiana in Algeri e del Tancredi, a ventun anni, aveva già raggiunto quelle vette, e poteva diventare, all’occorrenza, epigono di se stesso. Detto questo, restano da osservare un paio cose. Una è lo straordinario mestiere sfoggiato dal giovanissimo Rossini, anche in un’opera minore. I gorgheggi, qui, non raggiungono l’estasi paradisiaca del “bello ideale” che faceva impazzire Stendhal, ma scorrono e s’intrecciano all’orchestra con una fluidità naturale; gli strumenti stentano a trovare le idee melodiche che, nei grandi capolavori, lampeggiano in una fantasmagoria di trovate geniali, ma giocano tra loro con raffinata leggerezza. Chi soffre meno di questa momentanea fretta, o stanchezza, o distrazione inventiva, è il ritmo, specie nei “crescendo” dei concertati. Il ritmo è l’anima della musica, diceva Rossini, e, grazie all’invenzione ritmica, nel terzetto «Ah qual raggio di speranza» nel primo atto, si accende, improvvisamente, una straordinaria vampata. Questo pezzo si eleva su tutta l’opera come una torre tra graziose casette. È un gigantesco divertimento musicale condotto su tre stati d’animo: Torvaldo gioisce perché sta per rivedere Dorliska, il Duca tiranno crede di poterla finalmente avere per sé, il custode Giorgio si compiace d’aver ingannato a buon fine il suo violento padrone. Giorgio è una parte buffa, portatrice di energia musicale e drammatica: dalla sua voce di baritono, infatti, partono a più riprese, frenetiche raffiche di sillabe che trascinano gli altri due, li risucchiano nei propri mulinelli, mentre la polifonia cresce, cresce, sino alla trascendenza ritmica e sonora. Rossini ha lasciato qui briglia scolta al suo genio, che s’intravede anche nel duetto tra Duca e Giorgio nel secondo atto, per poi rientrare nei limiti di un grande artigianato, vuoi per fretta, vuoi perché il libretto di Cesare Sterbini, per banalità e piattezza, è ben lontano da offrirgli gli stimoli straordinari che, due mesi dopo, scateneranno l’invenzione del musicista nel Barbiere di Siviglia. L’esecuzione, musicale e scenica, è stata ottima e il successo degno della tradizione di Pesaro. L’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano ha suonato assai bene sotto la guida di Victor Pablo Perez. La regia di Mario Martone, con i costumi di Ursula Patzak e le scene di Sergio Tramonti, sostiene la debole partitura con uno spettacolo vivacissimo, che acquista molto mordente anche grazie alla continua discesa dei cantanti in platea. Tra questi spiccano i tre uomini: il basso Michele Pertusi, solenne e impetuoso ma sempre elegantissimo nella parte del Duca, il tenore Francesco Meli, molto gradevole in quella del perseguitato e romantico Torvaldo, e il baritono 92 trent’anni all’opera Bruno Praticò che impersona il custode Giorgio, incarnazione tipicamente rossiniana dell’italica intraprendenza, volta a fini umanitari ma sottilmente compiaciuta di sé e della sua capacità di gabbare gli stupidi, neutralizzare i violenti, affermare il trionfo dei buoni e degli onesti. Il che significa, musicalmente, una sorgente di energia comico-vitale che, a differenza dei grandi capolavori, nel nostro Torvaldo si attiva, qua e là, in modo solo intermittente. [12.8.2006] Un Barbiere giovane, ma che tristezza Il Festival del bicentenario ha dovuto affrontare l’osso durissimo del Barbiere di Siviglia, l’opera più famosa di Rossini, fatta oggetto negli ultimi vent’anni di importanti riletture, registrazioni esemplari, allestimenti memorabili nei primi teatri del mondo. Per far qualcosa di diverso e sottrarsi a imbarazzanti confronti, il Rossini Opera Festival di Pesaro ha quindi pensato a una compagnia di giovani guidata da un direttore ai primi successi e da un regista di provata esperienza come Luigi Squarzina che s’è avvalso delle scene e dei costumi di Giovanni Agostinucci. Dietro le quinte, come sempre, a muovere le fila c’erano il sovrintendente Gianfranco Mariotti che entrerà nella storia come l’inventore del Festival cui dobbiamo la moderna riscoperta dell’opera di Rossini, e il consulente artistico Alberto Zedda, in procinto di lasciare Pesaro per passare alla direzione artistica della Scala. Questo Barbiere era decoroso sul piano dell’esecuzione musicale: Paolo Carignani ha guidato con sicurezza l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, tenendo ritmi brillanti e trattando i tempi con un’elasticità talvolta un po’ libera, ma sostanzialmente accettabile. Sul palcoscenico Roberto Frontali è parso vocalmente e scenicamente brillante nella parte di Figaro e Giovanni Furlanetto ha disegnato un Basilio davvero straordinario per sottigliezza, ambiguità e nitore vocale. Bruce Ford e Lola Casariego hanno fatto del loro meglio nelle parti acrobatiche del Conte di Almaviva e di Rosina, cantando con correttezza di stile e sufficiente esattezza tecnica, mentre Maurizio Picconi e Gabriella Morigi hanno disegnato non senza vivacità le figure di Bartolo e di Berta. Un tipo di vivacità, naturalmente, compatibile con l’interpretazione seriosa di Luigi Squarzina che intende privilegiare la commedia di carattere più che la farsa e, come scrive Zedda, non vuole mai «uscire dai binari del gusto e della misura». Risultato: Bartolo è un vero dottore in medicina che canta la sua comicissima aria, prendendo le misure di un manichino appoggiato su un tavolo anatomico, in uno splendido studio di legno tra statue, colonne tortili, giganteschi portali. Scelta di per sé piuttosto neutra, se non fosse che non s’è mai visto un Bartolo così accigliato, severo, triste, d’una cupezza addirittura tragica nelle movenze e nel trucco. Squarzina, intendiamoci, è un grande maestro e fa recitare i suoi attori con un’eleganza e una scioltezza ammirevoli, lavorando accuratamente i gesti, i movimenti, il gioco sempre mutevole del dialogo mimico. Difficile, ad esempio, realizzare l’aria della calunnia con maggiore sottigliezza: l’ipocrisia di Basilio è folgorata con assoluta precisione. Ma la paura di far ridere, il timore di “cadere nella farsa” gettano su tutta questa regia una cappa soffocante di serietà che mi trova del tutto dissenziente. ottocento 93 Togliere il riso a Rossini sarebbe un po’ come negare il cristianesimo dei Promessi sposi: vuol dire svuotarlo nella sua essenza estetica e morale. Il barbiere di Siviglia è una grande festa del riso, celebrato nella sua capacità di relativizzare il male, annullare la paura, trasformare il negativo – qui la cattiveria di Don Bartolo – in un gioioso spauracchio comico. La commedia realistica c’entra, ma solo nella misura in cui è travolta, e continuamente risucchiata in una risata travolgente quale il teatro d’opera non aveva mai conosciuto e che, in ogni brano, trasforma la realtà, rovesciandola, carnevalescamente, nella “farsa”. Non vedo perché questo nome debba essere impronunciabile, se non in una visione completamente distorta che ignora, o per lo meno nega dignità a un grandissimo filone della cultura occidentale: quello della risata libera e gioiosa che da Aristofane a Plauto alle farse medievali, giunge sino a Rabelais, a Shakespeare, a certo Molière, all’opera buffa: un filone di comicità scrosciante che esprime una precisa visione del mondo e che trova in Rossini la più alta espressione musicale. Negando tutto questo, lo spettacolo di Squarzina diventa imbarazzante quando deve affrontare per forza le situazioni più comiche, come il travolgente quintetto del «Buona sera», mentre Bartolo, il colossale antagonista attorno a cui ruota tutta la comicità della burla, sbiadisce sino ai limiti dell’inconsistenza. Ecco perché il pubblico non ha riso quasi mai, anche se alla fine, riconoscendo la mano tecnicamente magistrale del regista, ha accolto lo spettacolo con applausi un po’ frettolosi ma sostanzialmente unanimi. Da notare che l’opera è stata eseguita in versione integrale e che, nelle riprese delle arie e dei duetti, sono state aggiunte fioriture non scritte, come si faceva all’epoca di Rossini; idea filologicamente apprezzabile, se non fosse che quei ghirigori posticci finiscono quasi sempre per guastare bellissime linee melodiche. Difficile, insomma, riprodurre in vitro quello che i cantanti rossiniani facevano, sorretti da una tradizione allora viva e operante. [2.8.1992] Chailly: Barbiere delle meraviglie, tra soldati, acrobati, mongolfiere Torna Il barbiere di Siviglia alla Scala dopo 15 anni. Riccardo Chailly lo dirige in modo raffinatissimo. L’orchestra è ridotta, forse troppo per colmare la sala con le sonorità dei «crescendo» e dei «fortissimo» rossiniani: ma in compenso suona con meravigliosa leggerezza, e Il barbiere ne esce brillante e veloce. Nel fraseggio sta il segreto di questa esecuzione: anche quando il ticchettìo dei bassi incede implacabile, bastano un respiro, un accenno di rubato, una pausa appena più evidente del solito, per animare la frase musicale con un respiro organico, e toglierle ogni secchezza. Il lavoro fatto da Chailly in tal senso è stato capillare. Anche i cantanti sono eccellenti. Evidentemente, il direttore ha richiesto loro massima leggerezza, e la sgranatura dei vocalizzi è venuta fuori nitida e scorrevole, come se fosse eseguita dai violini o dai flauti. Questo non è solo un pregio musicale. Quando, dall’intonazione ben comprensibile della parola, i personaggi di Rossini spiccano il salto e si lanciano nel delirio dei loro gorgheggi, si stabilisce un gioco tra i più originali dell’intero teatro occidentale: le scultoree figure di Figaro, Rosina, Bartolo, Basilio, Almaviva si immobilizza- 94 trent’anni all’opera no, percorse da un delirio di pura elettricità musicale, immagine di un assoluto che faceva dire a Hegel di amare più il Figaro di Rossini che quello di Mozart. In questi passaggi tutto dev’essere fermo sulla scena, mentre il turbine si avvita nelle voci e in orchestra. Il regista Arias, con lo scenografo Roberto Platé, casca, invece, nel tranello che ha già prodotto vittime illustri (ad esempio Dario Fo, nella regia dell’Italiana in Algeri): far muovere costantemente tutto e tutti. L’azione della commedia è quindi soffocata da una pletora di balzi, piroette, corse, giravolte, saltelli e ruzzoloni che non danno tregua ai cantanti. Inoltre, le più strane comparse passano sulla scena: ballerini in grigio, uomini in frac, cortei di incappucciati, un amorino con le ali, sfilate di soldati ecc. E siccome neanche questo sembra sufficiente, molte immagini contenute nel libretto vengono esplicitate: il «vulcano» cui Figaro paragona la sua mente è una montagnola rossa e fumante, l’«incudine» e il «pesantissimo martello» vengono proiettati sullo sfondo, durante l’aria di Bartolo, Rosina è chiusa in una garitta d’argento, il pettine e le forbici, strumenti del barbiere, compaiono giganteschi sul palcoscenico, e così via. Una platea di bambini dell’asilo avrebbe battuto festosamente le manine nel vedere Figaro scendere da una gigantesca mongolfiera e la scena illuminarsi alla fine come alla festa di Piedigrotta. Il puerile spettacolo di Arias è stato contestato. Grandi ovazioni hanno invece accolto Juan Diego Florez (Almaviva) Alfonso Antoniozzi (Bartolo) Sonia Ganassi (Rosina) Roberto Frontali (Figaro) Giorgio Surian (Don Basilio) e Tiziana Tramonti (Berta) protagonisti di un cast perfetto, nonché Chailly e la splendida orchestra della Scala. [19.06.1999] Soleri rinfresca il Barbiere Da qualche tempo ci preoccupa un poco la messinscena delle opere buffe di Rossini: c’è una tendenza a sovraccaricare, riempire ogni spazio di gesti, figure, comparse, trucchi, movimenti e apparizioni scenotecniche, come nell’ultimo Barbiere visto alla Scala, dove, nell’orgia di balzi, piroette, corse, giravolte, saltelli e ruzzoloni, Figaro s’inventava, tra l’altro, un trionfale atterraggio in mongolfiera. Lo spettacolo di Ferruccio Soleri, il grande Arlecchino di Strehler, allestito dal Teatro Regio di Torino, rimette, invece, le cose a posto. Finalmente un regista “senza idee”, e con l’unica, preoccupazione di capire e mettere in luce quelle di Rossini: fare cioè una commedia basata sul gioco degli attori, un’azione pulita, fresca, vivace, senza distrarci mai dalla straordinaria vicenda musicale che ci viene presentata. Ci avete mai pensato che nei pezzi musicali del Barbiere non succede quasi nulla? Sono arie dichiarative, conversazioni inframmezzate da lunghe e ripetute esclamazioni, intere scene dove l’azione è sospesa in quadri di festa o di stupore. Ma chi s’accorge, all’ascolto, di questa sorprendente staticità? Nessuno. Anzi, la commedia non solo non viene interrotta ma fila veloce e incalzante, talmente è forte la capacità di Rossini di impossessarsi del tempo, stringerlo e dilatarlo a suo piacimento, tenendoci sempre col fiato sospeso. Il barbiere è forse il più clamoroso esempio di come il melodramma possa ricostruire il tempo in una dimensione tutta interiore, e tale da renderlo velocissimo proprio nel momento in cui lo arresta. Di qui la sua strepitosa, fantastica originalità. ottocento 95 Soleri l’ha messa in rilievo perché, evidentemente, capisce e ama la musica. Nulla di speciale avviene in questo spettacolo, ma la naturalezza, il senso del gioco leggero, il palcoscenico quasi vuoto (finalmente!) che mette in evidenza i gesti dei cantanti-attori, discretamente ispirati alla commedia dell’arte, la deliziosa scenografia di Luisa Spinatelli, a piastrelle spagnolesche dipinte di maiolica bianco-azzura con motivi rococò, tutto ciò dà il senso di un’ariosità felice. Anche l’esecuzione è molto vitale, con pregi e limiti capaci di fondersi in una forma armoniosa e divertente, poiché, in teatro, due più due può fare quattro, ma anche di meno, o molto di più. Dipende dal contesto. Qui c’è un cantante perfetto, Bruno Pola, nella parte di Bartolo: arrota il testo rendendolo affilato e tagliente, è buffo ma misurato, e la sua bella voce dà il timbro e lo stile giusto al vivacissimo vecchio, tirannico, borioso, e percorso dalle scosse elettriche che Rossini gli somministra nella sua straripante allegria. Non meno notevole il basso Andrea Papi come Don Basilio: quando entra in scena magnetizza l’attenzione, e la voce, forte e ben timbrata, gli permette di far nascere, di scena in scena, un personaggio sempre più plastico e vivo nella sinistra, ma insieme buffa codardia dell’intrigante. Molto bene canta Anna Caterina Antonacci come Rosina: i gorgheggi sono precisi e leggeri, fluidi e carezzevoli, la voce è morbida e calda, il timbro sempre gradevole. Il suo canto dà costante piacere, mirando alla bellezza, ideale supremo di Rossini: solamente, Rosina mi piacerebbe un po’ più maliziosa e mordente («Sarò una vipera, sarò»). Poco accettabile, invece, la modifica di alcune colorature che la Antonacci introduce nella ripresa delle arie e del duetto con Figaro: Rossini le scriveva stupendamente, aveva combattuto affinché i cantanti le rispettassero, perché dunque cambiarle, rendendole più banali? Cosa che non fa il protagonista, Roberto Servile, un Figaro dal canto elegante, preciso e misurato, ma un po’ al di sotto delle esigenze del personaggio, che deve apparire come il pirotecnico demiurgo e osservatore dell’azione. Per esempio, nell’ultimo terzetto Figaro prende in giro le effusioni dei due amanti per indurli a sbrigarsi e scappar via: ma Servile, al pubblico, non lo fa capire. E siamo giunti all’ultimo degli interpreti principali, il grande tenore Rockwell Blake, croce e delizia dello spettacolo. Croce, perché la voce è ormai usurata; delizia, perché non si può cantare con più stile, spirito, sprezzatura, e anche autoironia. Eseguire il rondò dell’ultimo atto, di solito giustamente tagliato, è diventata da parte sua una sfida temeraria, ma gli serve per dare al Conte d’Almaviva l’ultimo tocco: non solo sentimentale, ma anche un po’ vanesio, e molto divertito nel piacere della burla giocata ai danni del goffo Don Bartolo. L’unico modo per salvare questo pezzo inopportuno, è, infatti, l’ironia, e Blake lo intuisce e lo realizza nei minimi particolari. Bravissima Giovanna Donadini nei panni di Berta, la vecchia, filosofica cameriera. Il direttore Corrado Rovaris, subentrato all’ultimo momento per la malattia del collega Lodovico Zocche, ha preso in pugno la situazione, e ha condotto l’orchestra a esiti ragguardevoli, garantendo la vivacità dei ritmi e la brillantezza dei colori, cose, in Rossini, assolutamente essenziali. Di qui, le accoglienze assai liete che hanno segnato, prevedibilmente, il termine della festa. [2.12.2000] 96 trent’anni all’opera Date un montacarichi a Figaro il barbiere Grande successo al Palasport di Pesaro per l’esecuzione musicale del Barbiere di Siviglia, spettacolo di punta nel cartellone del Festival 2005; la regia di Luca Ronconi ha trovato invece il pubblico diviso tra i contenti e i delusi, applausi e forti proteste. Daniele Gatti ha guidato assai bene l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna: se la nitidezza strumentale, specie negli archi, è ancora perfettibile, il ritmo appare vitale, la dinamica ben contrastata, il fraseggio plastico e sempre propulsivo. La compagnia di canto ha un monarca assoluto nella persona del tenore Juan Diego Florez: voce gorgheggiante con un’agilità e una precisione che, alla fine del grande rondò del secondo atto, musicalmente pregevole ma teatralmente disastroso (tant’è vero che viene di solito, opportunamente tagliato), hanno prevedibilmente scatenato una vera tempesta di applausi e ovazioni. Questa si è ripetuta, alla fine, non solo per il tenore: il contralto Joyce Di Donato è, infatti, una deliziosa Rosina, dalla voce bella e dallo stile impeccabile, Bruno De Simone un bravissimo Don Bartolo, Natale de Carolis un Don Basilio di ottima levatura. Dalibor Jenis è piaciuto nella parte del protagonista, anche se una maggiore autorevolezza scenica e vocale non guasterebbe per rendere appieno la colossale statura del personaggio. Ma non è solo lui che soffre, in questo spettacolo, di un certo appiattimento delle caratteristiche individuali. La grandezza del Barbiere sta, prima di tutto, nella plastica definizione dei personaggi che fa di Rossini il Plauto del teatro moderno: il vitalissimo Figaro, Bartolo, torreggiante trombone, il maligno e untuoso Basilio, la giovane Rosina, con la sua indiavolata furbizia, il Conte, disinvolto e spavaldo, affettuoso e divertito, devono spiccare con evidenza in un gioco di contrapposizioni che fa scoccare, attraverso quella musica immortale, continue scintille teatrali. Qui, questo avviene solo in parte: vestiti tutti di nero, tranne Figaro che è in bianco, quasi si confondono l’uno con l’altro, nonostante la bontà dell’esecuzione musicale. Ma non è solo colpa dei costumi. È che i personaggi, invece di far la commedia, pensano ad altro, preoccupati come sono di giocare senza danni con la scenografia gelida e razionale, in stile Bauhaus, di Gae Aulenti, di una invadenza che sfiora l’ossessione. L’idea centrale sembra essere quella del montacarichi: dal soffitto scendono enormi guardaroba stretti e alti; dal palcoscenico salgono grandi sedie. Seduti su di esse, i personaggi restano appollaiati a mezz’aria, anche a grande altezza, e pazienza se soffrono le vertigini. Una selva di cavi d’acciaio, in scarsa sintonia con la frizzante leggerezza e il senso di libertà che spira dalla musica di Rossini, taglia verticalmente il palcoscenico: dall’alto scende una grancassa perché siamo nell’aria della calunnia e Basilio deve evocare il colpo di cannone; dal basso risale una chitarra; scende un grappolo di monete d’oro mentre Figaro tesse le lodi del denaro; sale un pianoforte a coda; scende un cesso (lavabo e WC) mentre sul palcoscenico scorre un catafalco, e sullo sfondo è parcheggiato un pulmino da cui escono periodicamente i vari personaggi. Ma i marchingegni non sono solo questi. Sul palcoscenico scorrono anche poltrone da barbiere con specchi e luci, un catafalco con quattro ceri, un frigorifero, un confessionale semovente in cui entra Almaviva travestito da prete, quattro letti e ottocento 97 così via, trasformando la scena del Barbiere nel teatro di un perenne trasloco. Gondrand sostituisce Rossini. Peccato. Il gioco, che a Ronconi era riuscito così bene nella Cenerentola, grazie alle scene fantasiose, ironiche e affettuose di Margherita Palli, qui si risolve in un’esposizione di cose vecchie, viste mille volte, da più di vent’anni, negli spettacoli di questo regista; e se all’inizio la regia del Barbiere ci strappa qualche sorriso, a lungo andare simili trovate pesano sempre più sulla partitura più allegra del mondo come una cappa plumbea, di vera noia. Più che interpretata, insomma, l’opera appare semplicemente arredata, anche se un’idea, sotto sotto, sembra esserci: proiettando su di uno schermo un vecchio film del Barbiere di Siviglia degli anni ’40, Ronconi vuole evidentemente sottolineare la differenza tra un allestimento tradizionale, di gusto posticcio, e quello moderno in cui tutto viene ripensato, decostruito, tagliato a fette e messo in vetrina; non ci sarebbe niente di male, se tutto fosse fatto con allegria. Invece, su quel fondale perennemente nero, la lieta vitalità di Rossini irrimediabilmente appassisce. [12.8.2005] Fo “prevarica” Rossini Nella seconda serata del Festival rossiniano di Pesaro è comparso Dario Fo, regista, scenografo e costumista de La Gazzetta, insieme a Francesco Calcagnini e Paola Mariani. Su quest’opera comica, di rarissima esecuzione, rappresentata a Napoli nel 1816 e composta in tutta fretta, con grandi parti prese da lavori precedenti e abilmente rimaneggiate, Fo ha esercitato lo stesso arbitrio prevaricante che aveva guidato anni fa il suo allestimento dell’Italiana in Algeri: solo che qui i danni sono assai più contenuti, e il risultato complessivamente accettabile, perché La Gazzetta è un’operina leggera, disponibile a trattamenti disinvolti, e non costringe l’interprete alla comprensione di una visione del mondo, come fanno L’Italiana, Il barbiere e La Cenerentola. Il libretto di Giuseppe Palomba ricostruisce in chiave d’opera buffa, con parti scritte in napoletano, la trama del Matrimonio per concorso di Goldoni che ruota attorno a un’inserzione pubblicitaria messa da Don Pomponio Storione su di una gazzetta parigina con lo scopo di trovare un marito per accasare la figlia Lisetta. Un gioco di coppie, con equivoci e travestimenti, conduce al lieto fine e alla conseguente delusione di Don Pomponio. La Gazzetta appartiene al filone rossiniano della commedia, culminante nel Turco in Italia (da cui Rossini prende, non a caso, due pezzi lunghi e bellissimi) ma Dario Fo non ne fa una commedia. Nelle sue mani, quest’opera sconosciuta diventa la colona sonora di un frenetico balletto ambientato negli anni venti del Novecento, a tempo di charleston e di tango. Mentre i personaggi cantano, conversando o meditando, si vedono ciechi che passano con i loro bastoni, suore, gente che porta bandiere colorate, un’automobile che emette scoppi di petardi con coriandoli, comparse che spazzano il palcoscenico, ragazzi e ragazze discinte che corrono su pattini a rotelle reggendo cartelli con scritte tratte dal libretto, eccetera. Così la maliziosa Lisetta è una diva inqadrata dalla cinepresa, i disegni musicali degli strumentini che accompagnano l’aria di Doralice sono tradotti nelle mossette di tre galline che si beccano vivacemente, l’aria sentimentale di Alberto è una serie di variazioni sul tema dei glutei femmini- 98 trent’anni all’opera li che nel numero di dodici – scelti indubbiamente con gusto – descrivono, dietro il romantico tenore, le più allusive figurazioni ginniche. Ma non crediate che sia tutto qui. Il madornale errore di credere che la musica di Rossini non sia capace, da sola, di fare teatro, e che vada riempita in ogni modo da elementi estranei, genera in questo spettacolo altre sorprese, talvolta troppo rumorose. Ad esempio, il comico duello in cui è coivolto Don Pomponio s’amplifica in uno scoppiettìo di bombe a mano, e si conclude con le martellate di chi sta inchiodando una cassa da morto; l’aria di Filippo, che evoca la provenienza esotica di possibili pretendenti alla mano di Lisetta, introduce nuovi personaggi: un leone, una zebra, uno struzzo, una giraffa, un cammello, mentre i fogli della gazzetta tappezzano periodicamente lo sfondo del palcoscenico e aeroplanini di carta volano ovunque. Peccato che il pallone, che doveva sollevare alla fine Don Pomponio come una mongolfiera, sia scoppiato prima del tempo. In questo guazzabuglio, delle due l’una: o si esce frastornati prima del tempo, oppure, come ha fatto il pubblico dell’Auditorium Pedrotti, che ha decretato allo spettacolo un successo vivissimo, si sta al gioco, e si passa una serata divertente, accettando che la musica della Gazzetta venga trattata, per una volta, come un arredo tra molti altri, una tappezzeria sonora di valore quasi esclusivamente decorativo. Contro questa ipotesi ha lottato con successo l’eccellente esecuzione musicale, guidata con gusto, vivacità e finezza da Maurizio Barbacini a capo dell’orchestra giovanile del Festival. I cantanti formavano una compagnia ideale: Bruno Praticò (Don Pomponio) Stefania Bonfadelli (Lisetta) Antonino Siragusa (Alberto) Pietro Spagnoli (Filippo) Laura Polverelli (Madama La Rose) hanno cercato di far sì che l’impetuosa corrente figurativa scatenata dal regista non cancellasse completamente i connotati dei loro personaggi, e ci sono riusciti. Inoltre, hanno offerto una prova superba di belcanto rossiniano, mostrando come nella Gazzetta ci siano alcune pagine nuove, non prese da altre opere, in cui Rossini cesella cose preziose per finezza e delicatezza di mezzetinte. Così, pagato il tributo di pazienza alle divertenti ma alla lunga frastornanti esuberanze di Dario Fo, resta vivo il desiderio di riascoltare l’opera in un allestimento che ce la presenti per quello che è. [13.8.2001] Rossini e i mille bagliori Otello Dopo essere stata, ai suoi tempi, l’opera seria più famosa di Rossini, Otello (Napoli 1816), col declinare del belcanto ottocentesco, andò incontro a una strana fortuna critica: chi ne parlò – da Meyerbeer a Hanslick a Fétis – lo descrisse un poco come un pianeta diviso in due emisferi: uno ricoperto da ghiacci, l’altro ardente, pittoresco e avventuroso. Al primo apparterrebbero i due atti iniziali, tacciati di freddezza, dove lo squinternato libretto di Francesco Berio di Salsa ignora quasi completamente Shakespeare e la musica di Rossini dà libero sfogo al furore virtuosistico del belcanto (l’opera fu scritta per la Colbran, Nozzari e il grandissimo David). Senza riserve, invece, si è sempre ammirato il terzo atto, shakespeariano in toto, e stupefacente per l’immediatezza espressiva dell’invenzione musicale. Ora, la riuscita dell’esecuzione che ha aperto l’altra sera, con grande successo, il Rossini Opera Festival sta semplicemente nell’aver sanato questa frattura: il che assume quasi
Scarica