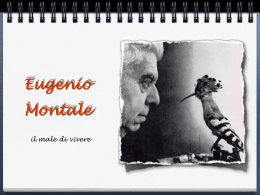Scritture sulla musica. Voci
novecentesche
Moduli di c.d.l. Magistrale:
Lineamenti di letteratura italiana contemporanea [LM45]
Letteratura italiana contemporanea [LM19, LM37, LM64]
Prof. Tommaso Pomilio
A.A. 2014-2015
Fra agonismo, emulazione, trascrizione, “invidia”: riflessi di musica
in autori del '900 italiano.
Oltre alle presenti dispense, gli studenti dovranno leggere:
Bruno Barilli, Il paese del melodramma, con un saggio di Fedele
D'Amico, Milano, Adelphi, 2000
Giorgio Vigolo, Diabolus in musica, a c. di C.Spila, Rovereto,
Zandonai, 2008
Giorgio Manganelli, Una profonda invidia per la musica. Invenzioni
a due voci con Paolo Terni, a c. di A.Cortellessa, Roma, L'Orma, 2014
(n.b.: le letture s'intendono inclusive degli apparati)
L'inquadramento storico-critico è presupposto; si consiglia in ogni
caso di far riferimento al seguente testo:
Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana, vol IV: Il Novecento
e il nuovo millennio, Milano, Mondadori Università, 2012
ALBERTO SAVINIO
Luigi Rognoni
Itinerario musicale di Savinio
L ’avvertimento ad una rilettura dell’opera letteraria di Al
berto Savinio coinvolge la costante presenza della musica o
meglio del linguaggio musicale come sottofondo «psicologi
co» di tutta la sua attività creativa, compresa quella pittorica
che è anch’essa strettamente legata alla vocazione musicale.
Per questo le riflessioni «critiche» sulle musiche ascoltate,
vissute e rivissute nella memoria, che Savinio ci dà negli anni
trenta e quaranta, hanno un fondamentale senso autobiogra
fico, rispecchiano un itinerario percorso, sin dalla gioventù,
alla ricerca di un insondabile segreto che la musica cela in sé,
ma che mai rivela nella sua totalità.
« L ’essenza della musica —scriverà Savinio in tempi recen
ti —sfugge talmente a qualunque possibilità di conoscenza,
che l ’uomo tenta spiegarsela mediante spiegazioni immagina
rie... A che voler spiegare l ’inesplicabile? la sola definizione
che si addica alla musica è laJM.on Mai Conoscibile. E non
senza ragione. La non conoscibilità della musica è la ragione
della sua forza, il segreto del suo fascino... Cedere alla musi
ca è un atto di soggezione a quello che non si conosce, e per
questo attira... Musicista, io mi sono allontanato nel 19 15 ,
all’età di ventiquattro anni, dalla musica, per paura» '.
Vocazione musicale precoce la sua, se si pensa che a dodici
anni ottiene il diploma di pianoforte e di composizione al
Conservatorio di Atene e due anni dopo (1905) scrive un Re
quiem per la morte del padre; a quindici anni un’opera in tre
atti, su libretto proprio, Carmela (1906), nella scia del teatro
musicale verista, talché l’opera interessò Mascagni che la pro1 Musica, estranea cosa, in A ppendice, pp. 7-8.
xvm
Luigi Rognoni
pose a Ricordi per la pubblicazione. Ma non se ne fece nulla.
Savinio stesso, in breve tempo, avvertì che bisognava imboc
care altre strade; e lo avverti nel 1 9 io, quando giunse a Pa
rigi, dopo aver approfondito lo studio dell’armonia e del con
trappunto con Max Reger a Monaco. Vi giunge come compo
sitore e pianista e richiama presto l’attenzione di Djagilev e
Strawinsky, di Max Jacob e Guillaume Apollinaire.
Nel 1 9 1 2 inizia la composizione di un’opera in tre atti, Le
trésor de Rampsénit, su testo di M. D. Calvacoressi, letterato
e critico musicale di punta; e nel 1 9 1 3 , l’anno del Sacre du
printemps di Strawinsky, che suscita un memorabile scanda
lo, a pochi mesi di distanza, Savinio scrive un balletto, Per
sie, su soggetto e coreografia di Michael Fokine, che verrà
"però allestito soltanto nel 1924 a New York.
Il 1 9 1 4 è un anno di intensa attività creativa che segna
una svolta brusca nel linguaggio musicale saviniano; e ciò che
sbalordisce è l’assoluta indipendenza dalle influenze domi
nanti in quel periodo nel crogiolo parigino: non v ’è traccia
né di Debussy, né di Ravel e neppure di Strawinsky, se non
in rari brandelli che vengono assunti come materiali di rot
tura, come risulta da una nutrita serie di pezzi per voce e pia
noforte, tutti su testi propri, emblematici, che già rivelano
quell’ironia invereconda precorrente il dadaismo (1916) e
persino con sorprendenti anticipazioni oniriche che verran
no assunte dal surrealismo (1924).
Alcuni titoli di queste composizioni (Mes poumons argen
tés, La passion des rotules, Matinée alphabétique, Le géné
ral et la Sidonie, Les viscères œuîllées, Je me sens mourir de
néant, Il cuore di Giuseppe Verdi...) possono far pensare a
Erik Satie, che proprio in quegli anni scrive le sue pièces ter
ribles come antidoto ai narcotici del wagnerismo e dell’im
pressionismo.
Ma la musica del giovane Savinio non ha alcun rapporto
con la musique de tapisserie e con l ’intellettualismo formali
stico che da essa scaturirà, nell’immediato primo dopoguer
ra, col Groupe des Six e 1’«estetica» dissacrante di Jean Coc
teau. Avverso all’Art pour l ’Art, il progetto musicale di Savinio mira al teatro, ad un teatro «metafisico» dove il rap
porto tra musica e dramma venga inteso non più come « illu
strazione» del dramma attraverso la musica, ma come rap-
Itinerario musicale d i Savinio
XIX
porto paritetico che garantisca, nello stesso tempo, unità e
autonomia all’«azione drammatica» e all’«azione musicale»;
giacché «la musique est un art exceptionnel qui ne tolère
point la façon, et qui exige d’être employé tel qu’il est...
Ainsi donc, ayant à présenter, dans l’ensemble d’une œuvre,
l’élément musical de concert avec l’élément dramatique... on
ne devra voir dans cette association qu’un rapprochement
complètement désintéressé, car l’élément musical ne dépen
drait guère de l’élément dramatique, ni même celui-ci du
premier» '.
Il progetto si realizza nei Chants de la Mi-Mort, definiti
«scènes dramatiques d’après des épisodes du Risorgimento»
e per i quali Savinio scrive la musica e dipinge i bozzetti dëTle scene e dei costumi, questi ultimi andati perduti. In quello
stesso febbrile 19 14 che vede nascere i Chants de la Mi-Mort,
un altro progetto nasce nel sodalizio con Apollinaire: A quel
le heure un train partira-t-il pour Paris?, «une "pantomime”
de Guillaume Apollinaire - Musique d’Alberto Savinio —Dé
cors et mise en scène de Francis Picabia et Marius de Zayas»,
ideata per essere rappresentata negli Usa, e dove i personaggi
(«Le musicien sans yeux et sans oreilles», « L ’homme sans
bouche», che doveva tuttavia suonare il flauto, ecc.) appaio
no strettamente imparentati con quelli dei Chants de la MiMort («L’homme-chauve», « L ’homme-jaune», «Les hommes-cibles») e mostrano quella tendenza saviniana ad una
spersonalizzazione metafisica che in pittura verrà subito rac
colta dal fratello De Chirico e più tardi, su un altro versante,
dai surrealisti \ La musica per Savinio doveva dunque muo
versi su questo piano, realizzare in sé e per sé questa nuova
visione della realtà: «La musique est l’émanation d’une mé
taphysique réelle», proclamerà nel 19 15 3.
Intanto in un concerto tenuto il 24 maggio 19 14 nei lo
cali della rivista di Apollinaire «Les soirées de Paris», Savi
nio presenta alcuni estratti da suoi lavori teatrali (le danze da
Le trésor de Rampsénit e da tre balletti, Deux amours dans
1 he drame et la m usique, in A ppendice, p. 426.
2 In un articolo sul Poeta assassinato (« L a V oce», 3 1 dicembre 19 16 ), Savinio
ricorda come nelle «canicole del ’ t4 » , durante lunghe serate nel «paccobotto edili
zio» di Apollinaire, dove tutto suggeriva il teatro, nacque e svan i questo progetto
di una pièce newyorkese.
3 Dammi l'anatema, cosa lasciva, in A ppendice, p. 433.
xx
Luigi Rognoni
la nuit, Persée e Niobé) in proprie trascrizioni per pianofor
te; inoltre, fuori programma, una suite di sei pezzi da Les
Chants de la Mi-Mort, che è tutto quanto è rimasto della par
titura musicale di queste «scènes dramatiques». Nelle note
illustrative al programma di sala (scritte dallo stesso compo
sitore) si precisa che nelle opere nate per il teatro (soprattut
to in Niobé) «la musique n’intervient plus dans le drame que
comme un élément parfaitement indépendant»; e quanto al
le caratteristiche del linguaggio musicale, esse sono fondate
sull’« absence complète de toute polyphonie, ainsi que l’in
souciance la plus grande pour toute recherche armonique. La
musique de M. Savinio n’étant point harmonieuse, ni même
harmonisée, est, pour ainsi dire, une musique désharmonisée.
La structure se base essentiellement sur le dessin. Chacun de
ces dessins —pour la plupart tous très corrects —se répète
deux, trois et même quatre fois, selon le besoin naturel de
l’oreille; et, après une pause d’un seul temps, un dessin diffé
rent intervient aussitôt. C ’est ainsi une musique point façon
née et nullement pétrie, mais dessinée et hdrizontale» '.
In queste secche e lucide dichiarazioni non è difficile scor
gere le più avanzate anticipazioni di quelle tendenze ridutti
ve del linguaggio musicale che, attraverso l’atonalità (l’assen
za e la negazione di ogni struttura armonica tonale), sfocieranno nelle nuove proposte strutturali delle neoavanguardie.
Leggendo oggi questa suite per Les Chants de la Mi-Mort, es
senzialmente fondata su rapporti intervallari dissonanti (se
conde minori in posizione stretta e lata, settime, brusche com
mistioni di diatonismo, esatonalismo e cromatismo), spesso
fusi in aggressivi blocchi ritmici, ci si trova sorprendentemen
te in presenza di un modus operandi e di una tecnica pianisti
ca, sia pure ancora allo stato sperimentale e memore di remi
niscenze persino lisztiane, che precorrono analogicamente i
procedimenti dei Klavierstücke di uno Stockhausen o di un
Boulez.
La guerra interrompe l’attività creativa del giovane musi
cista. Nel 19 15 , rientrato in Italia, Savinio viene arruolato
e assegnatcfaFservizio militare a Ferrara, dove incontra Car1 Nota al programma d i un concerto, in A p pendice( p. 428.
Itinerario musicale di Savinio
xxi
rà, De Pisis, Morandi, Soffici; da questo momento i suoi in
teressi si spostano verso la pittura e la letteratura o meglio
vengono assunti come integrazione a quel « manque de tota
lité» della musica che egli aveva lamentato; e questo spiega
la rinuncia di Savinio alla musica puramente strumentale e il
suo crescente interesse per il teatro musicale. Anche se non
compone, la sua attenzione ai destini della musica è sempre
viva e tagliente: «La musique contemporaine n’est qu’un va
gue bourdonnement. Une musique véritable atteint l’éclat
d’une détonation spirituelle. Par l’intermittence rendre à la
musique toute sa vivacité; la liberer de la formule d’égalisa
tion où elle git, retenue par effet de sa moralisation», così
scrive in una serie di «aforismi» che egli invia a Picabia, emi
grato a New Y ork1.
Ma nell’immediato dopoguerra riprende improvvisamen
te l’attività musicale con due balletti che vengono messi in
scena nel 19 25: La morte di Niobe, «tragedia mimica» (Ro
ma, Teatro dell’Arte) e Ballata delle stagioni (Venezia, Tea
tro La Fenice). Poi il decisivo passo verso la pittura nel 19261927, quando ritorna a Parigi ed entra in rapporti con An
dré Breton e i surrealisti, unico tra gli italiani che verrà inclu
so nell 'Anthologie de l ’umour noir ( 19 3 s ) 2.
Forse avverte che col pennello può spaziare in un poli
morfismo più «concreto» che coinvolge direttamente la real
tà fisica e metafisica delle cose e della figura umana; «realtà»
anche come ironia che era già presente e centrale nella sua
ricerca musicale e drammatico-letteraria. Cosi nei Chants de
la Mi-Mort e così in Hermaphrodito (19 18 ), definito «con
certo», dove il carattere stilistico del linguaggio saviniano Ha
le stesse cadenze degli irrompenti pezzi musicali del 19 14 , e
si può in parte ricondurre anche alla «visione interiore» de
gli espressionisti, ma con una sostanziale differenza: che'questa «visiono è sempre sostenuta da una sotterranea ludicità
intellettuale, retta dall’ironia che è una delle forme della ra
tio. Savinio stesso definisce la «tecnica» linguistica di Her
maphrodito come «gusto dell’assurdo, deformazione della
1 Dammi l ’anatema, cosa lasciva, in A ppendice, p. 432.
2 Breton incluse né\\’ Anthologie un brano da Introduzione a una vita d i M ercu
rio (trad. it. A ntologia dello humour nero, a cura di M . Rossetti e I . Simonis, T ori
no 1 9 7 1 2, pp. 303-8).
X X II
Luigi Rognoni
realtà, inversione dei valori, umorismo nero, magismo, sur
realismo, tutto il diabolico gioco che riempie il mondo della
metaphisica naturalis » '.
Cosi la collisione tra fantasma e sofisma, il prolungamen
to dalla coscienza all’inconscio si proiettano anche nelle sue
«riflessioni» sulla musica, dove il retaggio della memoria, la
reminiscenza, la digressione poetica s’innestano, anzi vengo
no sollecitati dal resoconto critico, sempre lucido e puntuale.
Una analoga scrittura «critica» traspare nelle partiture
che nascono di getto nel secondo dopoguerra, dal 1949 al
19 5 1 (Agenzia Fix, Orfeo vedovo, Cristoforo Colombo, Vi
ta dell’uomo). Savinio usa i materiali più eterogenei, rinun
ciando alle tendenze radicali d’un tempo, ma non ai principi
enunciati nel 19 14 : i materiali sonori, talvolta assunti come
collage, vengono strutturati in un sottile procedere di dimen
sioni prospettiche (armoniche ora, oltreché melodiche) nel
rapporto tra percezione auditiva e percezione visiva, dove la
«métaphysique réelle» si realizza come sintesi. L ’opera che
meglio riflette questa sintesi è Orfeo vedovò (1950), un at
to, recentemente riproposto alla Piccola Scala di Milano (di
cembre 1974), dove Orfeo è vedovo, «vedovo momentaneo,
della Poesia. Ed è in questo momentaneo vedovo della Poe
sia, e dunque momentaneamente minorato, che Orfeo cade
momentaneamente nello sciocchismo degli uomini e della vi
ta. Quanto alle pallottole che la sua rivoltella spara, esse non
lui, Orfeo, uccidono, ma, intorno a lui, lo sciocchismo degli
uomini e della vita. A lui anzi, Orfeo, consentono di ritrova
re 1’ " altra” Euridice, la vera Euridice: la Poesia. Più esatta
mente, il complemento di se stesso. Stavo per dire il com
plimento»2.
L ’ironia di Savinio si è fatta amara, emblematica; e la sua
musica la riflette con sferzante spregiudicatezza vocale e stru
mentale: armonie allocche contro dissonanze e boutades tim
briche degli strumenti, uno sciorinare ritmico del tanto con
tro intrusioni di acre belcantismo... Ed è evidente che 1’«al
legoria » mira anche a denunciare la crescente formalizzazio
ne dei linguaggi artistici delle neoavanguardie degli anni cin
1 In Piccola guida alla mia opera prima, M ilano 1947. Hermaphrodito è stato
ristampato di recente (1974) in questa stessa collezione.
2 Parlo d i «O r/eo vedovo », in A ppendice, p. 446.
Itinerario musicale di Savinio
xxm
quanta, che, fatta tabula rasa dell’arte del primo Novecento,
minacciano di insterilire nel gesto puramente materico, nel
suono massa, che rifiuta la comunicazione, aliena il messag
gio, per porsi come rottura e provocazione, ma che finiscono
con l’essere neutralizzate e inglobate nei mass media dell’in
dustria culturale. Questa situazione Savinio la avvertì sino
all’ultimo, anche se non la denunciò apertamente, tuttavia
lasciandola trasparire nelle sue mordaci critiche «d’ascolto»;
e, sino all’ultimo, affermò la musica, romanticamente se si
vuole (ma non aveva parlato, sin dal 1914, di un second ro
mantisme o di romantisme complet?) come linguaggio del
l ’assoluto, messaggio metafisico dì ciò che la parola non può
esprimere, «elemento essenziale dell’educazione. Non può
esservi civiltà senza musica. La musica insegna a stare: a sta
re in compagnia e a stare soli... La musica ci mette in comu
nicazione col moto dell’universo e col nostro proprio movi
mento interno. La musica insegna a vivere, nel senso più pro
fondo e metafisico della parola. E quella sola civiltà sarebbe
perfetta ove tutto quanto, uomini e cose, si movesse a suon
di musica » 1
La sua attività di critico musicale «militante» tra le due
guerre e nel secondo dopoguerra, si esplica soprattutto a
(introduzione
alla seconda
edizione
di "Scatola sonora",
1977) Ogni
Roma e a Milano
dove
egli frequenta
concertiTorino
e opera.
suo resoconto trascende l ’informazione o la pura descrizione
delle musiche ascoltate, e riconduce sempre l ’ascolto ad un
orientamento di scelte che si rapportano alla «crisi» e alla
problematica della musica moderna e contemporanea. Il suo
dichiarato antidealismo, in anni nei quali il crocianesimo si
prolungava con caparbia tenacia negli schemi della critica
musicale italiana, non mancò di richiamare l’attenzione di
Fausto Torrefranca, musicologo «positivista», uno dei pochi
che dall’idealismo dei crociani si era tenuto lontano. E fu
Torrefranca che volle curare la raccolta postuma di Scatola
sonora (Milano 1955) e presentarla, mettendo in rilievo la
singolarità e la concreta validità critica (e non solo letteraria)
degli articoli e saggi che Savinio aveva disseminato su quoti
diani e riviste.
1 C fr. ep ig rafe p . i .
Fausto Torrefranca
POETICA DI SAVINIO CRITICO MUSICALE
Savinio è un uomo tutto esigenze interiori alle quali è necessario
che la sua intelligenza, il suo raziocinio, per primi obbediscano. Ma
non già alla tedesca, tanto ne era aborrente o, per, lo meno, aberrante:
e basta ricordare dove parla di Goethe come primo dilettante del suo
tempo, anzi come il più oppressivo dei dilettanti (p. 2 1 1 ).
È persino banalmente letterario affermare che egli sente il dovere
di costruirsi il suo mondo, un mondo «alla sua misura» perché l ’uo
mo è, alla greca, misura di tutte le cose ed egli, nato in Grecia, lo sen
tiva per primo obbligo. Questo è anzi il suo primo bisogno e obbligo;
e obbligo e bisogno si fondono insieme con tanta pienezza e univocità
da diventare passione, passione di giovane puledro; benché le redini
le tenga sempre nel pugno, che non gli si adombri.
E per questo non vi sono quasi invettive, nelle sue critiche demoli
trici, né tanto meno acredini: il suo è sempre un esercizio dell’intelli
genza : di un giudizio che sa foggiarsi un cuneo dirompi tore e con po
chi colpi ben dati apre le fibre del più duro ciocco o, più facilmente
ancora, sfalda gli scisti delle vecchie rocce che egli vuol demolire. Ta
lora è anche soltanto una insidiosa radice di fico d ’india nella dura
lava, che la dirompe per creare Vhumus futuro; e la sua origine familia
re siciliana glielo insegnava quasi d ’istinto.
Ma in fondo, sentiamo nelle sue critiche come un diario suggerito
giorno per giorno dalle musiche ascoltate; e vogliamo dire, un po’ più
tardi, di che natura sia questo diario.
Ne cogliamo qua e là confessioni molto laterali e, appunto per ciò,
assai intime: dipendono dalla sua complessa natura ed esperienza di
scrittore, musicista e pittore.
Dice, a proposito di Mozart: «per l ’uomo che altra forma di poesia
non ha, non è sola poesia l ’amore?» e benché egli fosse pieno di poe
sia, dell’amore, tra lui e la sua donna, si leggono accenni squisiti, in pa
recchi spunti di confessioni. L ’uomo era in lui il primo motore, prima
ancora del critico: questo è un modo intimo e raro di essere originale,
anzi un modo cattolico. E oltre all’amata, il padre, la madre, i figli sen
tono il diritto di entrare nella sua prosa: come di persone che si sanno
tanto amate e perciò, paghe di affacciarsi sulla soglia e di sorridere,
non passano via: rispettando, e quasi covando, il lavoro che seguono
e caldeggiano.
452
F austo T orrefran ca
Perché, egli musicista — ma di musica vocale o di ballo e non di mu
sica senza gesti o senza parole — notiamolo perché è un dato essenzia
le in lui, letterato - sa pure che il musicista, alla maniera sua, è « il me
no creativo, il più ricettivo, il più femminile degli artisti« (p. 39) e
le figure familiari non gli possono dare noia neppure se dipinge per
ché «in pittura, arte maschile per eccellenza, l ’ispirazione non esiste»
(ibid.).
Perché sorprendersi, dunque, che le sue critiche non siano varia
zioni di temi — antichi o moderni, che essi possano essere - ma rondò,
e di sostanza vocale per eccellenza, i cui temi, anzi le melodie iniziali,
ritornano immutati o quasi: dopo «intermezzi» o piuttosto «diverti
menti», nel significato schietto della parola.
Persino le capestrerie cabalistiche diventano umorosi temi di ron
dò, «ritorni» che bucano la forma o possono bucarla; ma la bucano e,
nello stesso tempo, lo riempiono, come per La sagra della primavera,
con l ’insistente ritorno del 28 (2 + 8 - 1 0 ) che egli si crea nel ricordo
delle due audizioni: la prima a Parigi e l ’altra a Roma perché, tolto al
10 « l’insignificante zero, dà 1, ossia il numero che significa l ’origine»
ossia «un principio nuovo»... « il che del resto si sapeva, anche senza
l ’aiuto della cabala»; sebbene spieghi dopo, intelligente umorista, che
«era un primitivismo da grand hôtel» (p. 178). Ma badava a non sci
volare nel surrealismo critico.
Savinio era un vero critico della musica, vero e vivo. Ma per lui bi
sogna dire che faceva il critico della musica: lo faceva perché gli ser
viva e non come può servire un lavoro che è anche un impegno pratico.
Egli cercava anche di trovare, e di servire, la sua verità e questo gli
riscattava il lavoro come non lo riscatta, può dirsi, quasi a nessun altro
critico quotidiano.
La sua era una verità ciclica e non soltanto perché egli era, oltre
che musicista, anche pittore e scrittore. Ma anche perché non si ritrae
va dall’attività plastica concreta — della scultura e dell’architettura — e
tuttavia non era totale. E, in un piano superiore, correva il rischio di
non riuscire interamente umana per non dire umanistica (basta che ri
pensiamo a Leonardo).
Certo, di fronte a Leonardo, gli manca il senso completo della mec
canica, della scienza, della matematica, proprio quelle che oggi vorreb
bero riempire tutta l ’atmosfera della vita; ed è naturale: perché oggi,
rispetto all’età di Leonardo, le scienze e la tecnica dobbiamo subirle,
più che accettarle con gioia e viverle.
y
Ogni epoca a parametro umano, di'vita vissuta, ha le sue limitazio
ni, mentre la mera vita di Leonardo ebbe, da sola, il valore di un avve
nire vissuto in mente: di una profezia vissuta in potenza e, sino ad un
certo punto, in atto.
Savinio, come pochissimi dei contemporanei, si cercò invece la sua
verità e, artista troppo diretto e troppo concreto, rinunziò a raggiun
gerla per le vie e con i metodi dell’estetica: di quell’estetica che, da
cinquant’anni, tutti si sono industriati a prodigarsi, come necessario
prolegomeno di ogni studio critico e di ogni presentazione storica. E
P oetica di Savin io critico musicale
453
la critica nostrana, in verità, è di scarso fondo — si parla, s’intende,
sempre della musica - e la storia di assai debole conoscenza, proprio
nella sua essenzialità sonora e nella vitalità produttrice.
Egli difatti si cercò i fondamenti critici - quali facevano per lui, ar
tista di più di un’arte - e se li trovò creandosi una poetica della musi
ca: un belvedere che non porta nel cielo empireo (o imperiale?!) del
pensiero, ma ci lascia ancora a contatto con la terra, vista sotto la luce
della poesia; e ce la mostra con l ’aspetto nuovo che l ’artista vuole: an
che e soprattutto quando il critico non è tale per necessità interiore,
ma pratica (ciò che in Savinio non è).
Non poteva essere, il suo, s’intende, lo scolasticismo estetico, né
quello degli altri italiani, né quello degli stranieri - di oggi o di ieri neppure pro tempore o come trampolino per salti in alto: siano fatti
per necessità tecnica o di capriccio. « Io penso, scrive, che i mali che
affliggono l ’umanità vengono in gran parte dalla convivenza di uomini
di generazioni diverse... come mettere assieme un prestissimo ed un
andante, un allegretto e un largo» (vedi il Ritorno di Ulisse in patria,
inedito). « D ’altra parte, - egli confessava {ibid.), di fronte ad una ve
getariana, - io... non riesco ad avere principi, e per chi non può inten
dere da sé avverto che questa è una lode che io mi faccio».
Per questo egli ce l’aveva col «ritorno all’erudizione» con «le pie
riesumazioni» col «devoto dispotismo» che «rivelano un indeboli
mento dell’energia creatoria, una sfiducia nelle proprie facoltà poeti
che e col "reverente amore per l ’antichità” in cui, secondo lui, c ’è in
dubbiamente del dilettantismo»; ma quell’indubbiamente è la scon
trosità di chi ha, in fondo, dei dubbi. Ed io so, per avere più volte con
versato con lui, che egli non sarebbe stato lontano dal mio ideale; e
magari avessimo letto insieme almeno alcuni pacchi di quei quintali di
musica antica che io da decenni conservo per me perché l ’Italia non sa
che farsene, mentre apre il cuore alle musiche straniere di oggi, di ieri
e dell’altro ieri ancor più che ai foresti non dica la nuova Siena musi
cale, con la sua nuova porta parlante.
Saremmo andati d ’accordo.
D ifatti, codesti suoi pensieri sono agitati dal tormento dialettico:
« L ’avviamento dei musicofili, egli dice altrove, verso la musica antica
è un altro aspetto del progredire della civiltà; un liberarsi dal grasso,
dal duro, dal preciso del dramma quotidiano. Passare da Verdi a N i
cola Porpora, da Beethoven agli Scarlatti, è un avviarsi verso la libera
zione dei sensi, una parafrasi del costante desiderio che l ’uomo ha d ’in
diarsi, o almeno di spegnere in sé il "troppo umano” » (p. 43).
Ma più che il critico — e lo storico che era soltanto in potenza, ed
esserlo in potenza era già un prodigio, per un cosi intenso creatore —
era veramente l ’artista che si lasciava sfuggire di bocca: «io questo at
teggiamento di umiltà e ammirazione davanti agli "antichi” non lo ho
mai sentito, non lo ho mai capito, ... mi ha sempre irritato: in tutti:
anche in Francesco Petrarca» (p. 15). Sebbene poi il suo pensiero su
Antonio Vivaldi dimostri sino a qual punto l ’artista sentisse il dura
turo di codesti grandi creatori del passato, in cui partta rei.
454
Fausto T orrefran ca
Egli, del resto, era vicino a stringere nella sua mente una conclu
sione, almeno provvisoria. In linea astratta, meglio che teorica, sapeva
bene che «fiochi uomini... sono destinati a conoscere la verità; perché
un’idea sola può dare la fede, ma a farci intravvedere la verità alme
no due idee sono necessarie — e che (apparentemente) si contraddica
no» (p. 107).
Queste apparenti incertezze egli avrebbe presto risolte perché ave
va fermato il suo pensiero su un’idea che sentiva, se non fondamenta
le, almeno centrale: quella che divideva tutte le musiche in due perio
di: il tolemaico e il copernicano.
Avrebbe sentito presto come un Vivaldi o un Sanmartini - e gli
altri contemporanei italiani che ho studiato 1 — fossero già, come egli
sentiva, dei musicisti copernicani; e, miracolo sorprendente, pur nel
l ’ambito di forme brevi: dove non si agitavano né attiranti soli né im
mense luminose galassie. Dico le forme in iscorcio o sintetiche; e, in
somma, le piti ardue.
Contro i tolemaici egli fu a ragione feroce, ma per dovere e senza
crudeltà né astio «in questo mondo razionalista in cui i musici stessi
hanno acquistato aspetto e comportamento da ragionieri, e si esercita
no a musiche squisitamente tolemaiche, cioè a dire gelide e architet
tate» (p. 4). M a anche i musici di altri tempi erano tolemaici: come
G . S. Bach che «era sordo e dentro e fuori» mentre «Beethoven... in
ternamente era sconvolto dalle voci di una audizione straordinaria»
(P- 2 4 )-
Bach, anzi, «si nascondeva dietro la sua propria musica come die
tro un riparo sicuro» che «il suo tessuto rende altrettanto impermea
bile quanto il fondo oro che circonda le Madonne di Cimabue, quanto
il cielo di Tolom eo» (pp. 25 e 51): «un infinito cristallizzato, un infi
nito "sterile” ai fini nostri e al bisogno d ’infinito della nostra anima»
(p. 51 ). «La sua mente non ha nulla di quel secolo che conobbe gran
di aperture scientifiche e filosofiche» ma rimane ermeticamente tole
maica.
Savinio si accorge di certe difficoltà e dà la colpa non a Bach per
sona ma alla musica che è « arte ritardataria [è un’idea nietzschiana] e
il suo progredire è strettamente legato al progresso meccanico degli
strumenti musicali».
Poco conta che questo sia un pretesto storico: perché quello che
importa a Savinio è che si possa riconoscere e definire, nella musica di
Johann Sebastian Bach, la tolemaicità dell’v t e musicale « fino a Han
del e Haydn inclusi» (p. 32); e «bisogna arrivare a Beethoven, il pri
mo musico copernicano» {ibid) «per trovare anche nella musica lo spi
rito del Rinnovamento cbe spezza la forma teologica, che apre la via
al destino individuale, e libero dell’uomo, e alle nostre avventure soli1 M olti sono gli scopritori di V ivaldi, in Italia e fuori. Basterà che io dica che,
nel 1923-24, ho tenuto a Roma, quale libero (liberissimo, anzi) docente dell’Università, un corso sui Concerti inediti del Prete rosso: rosso di dispetto e di confusione
perché nessuno ne parlava; e in particolare sui Concerti di Dresda che oggi, forse,
io solo posseggo. Ma Vivaldi era l'asintoto della mia iperbole.
Poetica di Savin io critico m usicale
455
tarie, alle nostre disperate conquiste, al nostro infinito senza premio».
E le pagine che seguono (33 e 34), eloquenti e di sofferta poesia («vi
viamo nel sentimento della pietà») ci attraggono ma non ci fanno di
menticare quanto Galuppi, Sanmartini, Giovanni Benedetto Piatti, V i
valdi, Boccherini - e lo stesso Cambini, a gran torto espulso dalle co
siddette Enciclopedie musicali straniere, - hanno arricchito di stelle
cadenti, di nuovi pianetini, di stelle doppie e di intense nebulose il cie
lo: fatto copernicano in una nuova primavera celeste che aveva già pro
dotto, su questa terra, le gemme verdi del madrigalismo (le villote) e,
anche prima, della Ars Nova del Trecento.
Ed è dubbio, secondo me, a questo proposito, che i madrigali di
Claudio Monteverdi « non richiedano il sentimento di un libero desti
no umano». Ma ciò che conta si è che copernicano e tolemaico sono
epiteti bellissimi e convincenti; e delineano due modi di concepire l ’ar
te che possiamo dire superiori — almeno nella musica — a quelli di ro
manticismo e classicismo: sono di sostanza vivente: in realtà, due idee
poetiche che possiamo accogliere quali fondamenti duraturi di una
nuova «poetica della musica»; e questa crea una prospettiva quasi sen
za limiti, quasi senza linea di fondo.
Che l’infinito di Bach sia «un infinito metafisico, un infinito "aral
dico” , un infinito a "uso interno” ... cristallizzato... "sterile” ai fini no
stri e al bisogno d ’infinito della nostra anima» (p. 51) è vero; eppure
un infinito fecondo si ebbe altre volte, ab initio nel jubilus che sant’Agostino — e della stessa idea era san Girolamo — diceva la sola musica
senza parole che si innalzasse sino a Dio.
Altrettanto ricca di essenzialità è la definizione del tolemaico mo
zartiano dove, l ’universo... «decade dalla sua maestà e si riduce ad
una elegante ornamentazione» (p. 52) e la dimostrazione del perché
«Bach... rappresentante dell’universo tolemaico, e Mozart, o come dire
il rappresentante di un mondo neutro, sono i due musici preferiti del
nostro tempo» proprio perché « l’uomo è morto» - l ’uomo, si inten
de, dell’umanesimo - e vengono indicati gli « aspetti di una più vasta
realtà» che «hanno cominciato a riflettersi prima di tutto nelle arti»
{ibid.).
E non possiamo davvero voltar le spalle alle conseguenze surreali
ste e, sino ad un certo punto, politiche che il Savinio ne trae {ibid.).
La sua vista interiore giunge, com’è naturale, più lontano della v i
sta parametrale. Essa vede «l ’uomo-isola» di oggi — e «a questo sto
nante infelice la sola consolazione rimane della donna toccata dall’a
more» — e riconosce che «è merito della donna se il poeta può vivere
nella poesia» (p. 36). Ma dobbiamo tenere anche conto dell’apparente
contraddizione interna del pensiero di Savinio che «il sesso ammazza
la poesia» dove sesso si intenda per sessualità o, tutt’al più, per im
pulso di pubertà: il che, detto di Mozart, è perfettamente ragionevole
(P- 4 3 )La musica che Savinio amava e faceva la sappiamo perché egli stes
so ne parla ben presto, a p. 7: «il ritmo è per noi la "garanzia” della
456
F austo T orrefran ca
musica: la garanzia che la musica è doma e addomesticata e che ormai
possiamo considerarla "cosa nostra” ...» O ancora: «la sola musica che
la mia mente e i miei nervi sopportano è la musica fortemente ritmata,
ossia la musica che ha una qualche organizzazione umana e che in fon
do somiglia a noi. Perché il ritmo è l ’elemento umano della musica, la
garanzia della sua storia quaggiù e del suo ritorno, la confortante ri
sposta a quella idea del ritorno che è la più umana delle idee ».
Non crediate che, con questo, egli voglia addormentare la musica
in quella « narcosi della danza » che ho definito di recente e che pochi
ancora avvertono, o forse nessuno - e che domina, soprattutto, nella
storia e nella spiritualità della musica nordica - perché il suo istinto
vigile l ’avverte che «nella musica... il ritmo è un elemento estraneo,
un elemento imposto, un elemento che la musica sopporta a stento e
dal quale tende a liberarsi; e per questo la musica meno ritmica (De
bussy) è la più "m usicale”, ma anche la più inumana» (p. 7); e gliene
diamo ragione.
E poi, egli stesso ci dà una conferma altrettanto inattesa quanto
umana: che il ritmo è «il galateo della musica» (p. 390).
E bisogna leggere il resto dove egli giunge alla conclusione che «la
sola definizione che si addica alla musica, è la Non Mai Conoscibile».
Soltanto chi è stato preso dalla poetica della musica, che Savinio
vive e ci fa vivere, può leggere e capire, in seguito, i Nostri rapporti
con la pazza (pp. 8-10) dove si conclude che « l’uomo ama sentirsi
schiavo: sottomesso ad una schiavitù fisica e assieme ad una schiavitù
metafisica, quale la musica eccellentemente dà» (p. 9).
Il fascino dei ragionamenti di Savinio è che non sono architettati
secondo logica, sebbene una coerenza interiore ci sia sempre, ma sono
degli intrattenimenti, degli entertenimientos, come egli stesso dichia
ra quale suo metodo di scrittura o piuttosto quale suo stile di pensiero,
in un volume di prose '. Questo stile io lo assimilo, musicalmente, al
ricercare: al ricercare e, insieme, alla fantasia: orditure fluide ma in
trecciate, tutte diverticoli, come un delta. Difatti Savinio dice che il li
bro che intrattiene è un libro discorsivo, ma nel senso che « non è un
libro minore, ma al contrario un libro maggiore: un libro massimo».
Nel suo copernicanismo, in fondo, lo si vede, c ’è del tolemaico e vice
versa: c ’è, dunque, una poesia della musica integrale. E questa è la sua
bellezza.
Io sono giunto ad idee diverse, ma della stessa natura e indipen
dentemente da lui, pur avendo parlato così poco con lui, pur avendolo
letto di rado e dov’era più quotidiano: anche*se quotidiano nel senso
della profonda verità che sta, come sedimento, al fondo della vita
vissuta.
Non cerchiamo, dunque, in Savinio la coerenza filosofica, ma al con
trario l’estrema mobilità del pensiero, anzi della volontà di pensiero,
che sta ancora nella ganga dell’intuizione e, appunto per ciò, vibra in
torno a certi perni oscillanti dai quali non si libererà; ed è bene che
non si liberi.
1 A. s a v in io ,
Ascolto il tuo cuore, città, Milano 19442,
p.
3.
P oetica d i Savin io critico m usicale
457
Così è proprio quando egli ci confida che «spesso, troppo spesso,
il passo della musica di Vivaldi è l ’imitazione del passetto a ricamo
stretto, del passo pettegolo, del passo da sensale e propalatore di pic
cole notizie femminesche di uno che va per Merceria, e si caccia di
sghembo tra la calca delle donnette, e si ferma a spettegolare agli usci
delle botteghe da caffè» (pp. 18-19).
Questo è soltanto, in verità, uno degli aspetti di Vivaldi: quello
che gli si presenta raramente: in ispecie quando si domanda «se V i
valdi pensasse alla morte» o no; ma c ’è un altro Vivaldi, il Vivaldi
copernicano del Concerto doppio per oboe e violino concertanti che
ho, per miracolo, pubblicato e al quale ben pochi musici di oggi si fan
no vicini, talmente è viva la sorpresa di un nuovo mondo - se voglia
mo dirlo con Savinio, copernicano - che il compositore vi ha schizzato
dentro e impastato con l ’impeto e la larghezza di un Tiepolo; e che
veramente può dirsi « tutto un ampio camminare » che possiamo anche
accettare: «al passo solenne del Bucintoro» (p. 19): non soltanto per
mare ma anche, di riflesso, nel cielo.
Certo, si direbbe che la musica che egli preferisce è la vocale e non
sorprende sentirlo dire: «La musica è per sua natura squisitamente
invernale. Vogliamo dire la musica grave e con nobili materiali costrui
ta: la musica che piace a noi: la musica come organizzazione e gioco
mentale, la musica strumentale e polifonica»-, e sentirlo definire «il
contrappunto ciò che la dialettica è in filosofia» e che «solo alla fine
del medioevo... comincia a rivelare la sua organizzazione radicale e ra
mosa» (p. 20). E i due aggettivi danno la più speculare definizione del
contrappunto: vorrei anzi chiamarla l ’impronta geologica, l ’impronta
fossile del contrappunto.
Ma egli corregge presto questa impronta perché non è soltanto ra
dicale e ramosa, dato che «è più profondità, nel senso preciso della
parola... nel canto solitario dello scolio di Sicilo che per tutta la colos
sale opera di Bach» (p. 22). E così arriva al parallelo con Beethoven
del quale abbiamo già fatto cenno (p. 24).
Siamo, con Bach, sullo stesso piano dell’espressionismo dove «quel
lo che piace soprattutto è l ’umiliazione dell’uomo e, sotto a questa, l ’il
lusione che vi si nasconde che in questa libera rappresentazione della
bruttezza umana... si [maschera] la verità»: un avvilimento che ha già
subito nella pittura di Cézanne « attraverso la deformazione, la decor
ticazione degli aspetti e il grigismo» (p. 26). E sebbene queste citazio
ni formino appena un graffito, neppure una sinopia, si capisce che solo
un pittore come Savinio poteva proporre di tradurre lo Stabat Mater,
latino e cattolico, di Rossini in una Deposizione del Domenichino e il
sesto Concerto brandeburghese in una pittura astratta che rappresenti
«il concetto arabogotico del mondo» (p. 27); il che ci convince perfet
tamente.
Sono tutte cose dette « all’infuori del valore in sé d ell’opera d ’arte
di cui non si può parlare, se non quando si è perfettamente sicuri che
si è tra gente abituata a considerare l ’arte di là dalle piccole "verità
passeggere” ».
458
Fausto T orrefran ca
È la forza di Savinio, questa di essere altrettanto pittore quanto
musicista e altrettanto arguto quanto libero.
Q ui non c ’è il solito rivoluzionario e riformatore-distruttore che si
presenta, tanto facilmente, tra gli artisti (e assai ovviamente tra gli ar
tisti che non riescono a creare la loro presunta rivoluzione). Con ardi
tezza, anzi, parla del concetto cattolico della vita che è in Bach e che
può dare «questa calma, questa sicurezza, questa mancanza di dubbi
e d ’inquietudini» la stessa che può dare « l’organismo militare» riba
dendo che «mai mi son sentito cosi "sorretto” nella vita come nel pe
riodo 1915-19 che fui particella dell’Esercito» (p. 30). E possiamo ag
giungere che gli venivano anche dalla vita coniugale, di cui parla con
accenti pudichi e caldi che sono un altro dei più sinceri conformismi di
quest’uomo così singolarmente autodisciplinato e autoconfessato e,
nello stesso tempo, guidato da convinzioni superiori e aperto verso
tutte le strade generose. Egli sa, come si accennò, che «il sesso ammaz
za la poesia» (p. 43): dunque egli sa come difendersi.
In una sola cosa egli segue la tendenza di quasi tutti i compositori
d ’oggi perché l ’infrenabile impeto al movimento e all’azione gli crea e
gli addita una porta che sta troppo oltre: sino a fargli dire che «la mo
da della musica antica è una manifestazione collettiva di codardia».
Ma sono sicuro che intendeva parlare dei trascrittori e degli elaborato
ri: i «ridipintori» della musica storica. Invece riconosceva, come ne
cessità, il parafrasismo (p. 184), ad esempio di Strawinsky.
Ed alcune discussioni che ebbi con lui, appunto perché furono po
che e saltuarie e riposate, mi dimostrarono che egli già era un conver
tito, non verso la moda della musica antica, ma verso l ’esperienza della
musica antica: che vale a creare, nei generosi, una nuova libertà; e mol
ti spunti delle sue critiche bastano a dimostrarlo.
Egli è un romantico e lo sa; anzi non si perita dal confessare: «io
non desidero viaggiare. Sempre più strettamente mi vado implicando
in me; sempre più profondamente mi vado calando nel mio essere; e
il mio anelito di romantico insaziato e insaziabile sempre maggiori sod
disfacimenti trova nei miei orizzonti interni, nelle mie foreste, nelle
mie pianure, nelle mie montagne, nei miei cieli» (p. 44).
Ma egli sa i pericoli che corre il romantico. Quando Brahms lo fa
pensare a Conrad, egli ne trae una semplice ma efficace terapia: « l’ar
te purtroppo e gli artisti sono dei ricettacoli di isterismo, ma se d ’altra
parte si vuole trovare cosa che sia monda di ogni traccia d ’isterismo,
bisogna ascoltare l ’opera di Brahms, leggere l ’opera di Conrad» (p.
133). Mentre poi Verdi gli fa pensare — benché egli lo ammiri — «che
una musica ridotta a far piangere e amare (il motto di D ’Annunzio:
pianse ed amò per tutti) a noi fa la medesima pena di sciupata grandez
za della forza elettrica ridotta a far girare lo spazzolino da denti auto
matico»; e qui si ricorda della scena dei Tempi moderni di Chaplin
(p. 148), ed è un altro aspetto del suo umore risolutivo.
D ’altra parte egli sente che cosa non ci sia sino all’Otello di Verdi:
«fino all’ 0 /e//o le opere di Verdi ci procurano godimenti singolari e
altissimi, ma parziali. Manca quell’elemento morale che ci è stato rive
P oetica di Savin io critico m usicale
459
lato da Socrate, e che tanto presente invece è in Bach, in Beethoven, e,
sebbene più pudico e velato di eleganza greca, in Chopin: quel calore
deH’anima, quel conforto e giustificazione della vita, quel suggerimen
to ineffabile che il nostro destino non è isolato, ma associato al destino
altrui e indissolubilmente legato ai segreti più profondi, più preziosi,
più sacri dell’universo» (p. 154). « E se Verdi ha voluto rappresentarsi
in Otello, poeta della gelosia, è perché la gelosia è il sentimento più
alto e generoso, il grido supremo dell’amore, l ’amore del genio che ama
se stesso in tutti e in tutto. "Anim a mia, ti maledico” , dice Otello a
Desdemona, alla fine del terzo atto; e queste parole sono il patto su
premo che l ’amore propone: vivere o morire» (p. 156).
È interessante che Savinio si serva, ancora una volta, delle sue qua
lità di pittore per fare critica musicale e anche delle sue conoscenze
tecniche di pittura: che gli fanno giuoco, nel raffronto tonale tra il Par
sifal e il Falstaff (p. 158). Ed ecco il sagace confrontare le ultime pen
nellate di Renoir «le più fluide, le più leggere» con gli accenti più cor
diali e più felici del Falstaff.
Ma queste vive delizie sono tuttavia sensuali; e ancor più ci sor
prende che Savinio sia arrivato a sentire, col suo sensibile stetoscopio,
nel cuore di Alice, un segreto «pudico e nostalgico, perché in fondo
non Ford essa ama, ma il grasso Falstaff, ed è per questo che, sedato
il falso riso, essa senza speranza ormai ma con infinito rammarico ri
pete: "E il viso tuo su me risplenderà...” » (p. 160).
Egli va altrettanto addentro nel segreto di Verdi artista dicendoci
tre ragioni della difficoltà di interpretare la sua musica, ad esempio:
«che Verdi esprimeva per mezzo della musica voci del suo cuore, ma
senza quella intima musicalità che ha un Bach per esempio o uno Stra
winsky, la quale rende "naturale” la musica e facile il suo passaggio
dall’autore all’interprete» (p. 163). Questa è una finezza del musicista
e del critico: l ’intima musicalità, non è davvero tutta la musicalità e
neppure fa per intero l ’umanità della musica. (Egli ha una rètina ca
pace di scoprire il più velato e sottile cangiante del colore musicale).
Ma vi sono altre finezze da sottolineare: «Quello che Beethoven
pensa della Pastorale non lo sapremo mai, perché in questa sinfonia
Beethoven, diversamente dal solito, non pensa ma si contenta di guar
dare» (p. 66). Ed egli si serve, di nuovo, della pittura per consigliarci
così: «D el paesaggio sonoramente dipinto nella Pastorale, diremo che
è un paesaggio panoramico, come usavano dipingerne i Breughel, Dü
rer giovinetto all’acquerello, e, più vicino a noi, Hans von Thoma.
Questi anzi poneva nel primo piano dei suoi paesaggi panoramici un
personaggio che contempla il paesaggio e invita lo spettatore a fare
altrettanto...»
«11 suo paesaggio "gira” » e Savinio, nella sua memoria, sa ritro
vare un paesaggio altrettanto girante «al naturale, nelle prealpi vero
nesi»; e appena gli viene in mente, gli serve di esempio (p. 67).
Come si è detto, l ’entertenimiento è sempre il suo modo ideale di
comunicare, di interessare, di aprire la sua fantasia e di aprirla al let
tore. Questa è la grazia più sottile e più leggera di una critica, la prova
460
Fau sto T orrefran ca
più raccolta, più pacata e, nello stesso tempo, più libera della propria
autonomia mentale e della libertà che, senza che appaia, egli offre al
lettore. Si intende che il lettore, in fondo, non è libero del tutto, ma
pur gli sembra di esserlo e gli fa piacere.
C ’è anche una ragione, dirò quasi privata, e Savinio la dice con pa
role sue e partendo dalla domanda: «perché soltanto in musica alligna
no i fanciulli prodigio?» - «Perché, risponde, il musicista è il meno
creativo, il più ricettivo, il più femminile degli artisti». Perché - e que
sta è un’altra delle sue parole poetiche non già dei suoi «paragrafi»
estetici — «nel musicista l ’ispirazione opera più che nelle altre arti (in
pittura, arte maschile per eccellenza, l ’ispirazione non esiste) ossia il
fenomeno di una volontà esteriore che colpisce il musico e lo satura di
sé» (p. 39). E leggetevi il resto, che è, meglio che suggestivo, una ve
rità trovata proprio nell’occhio del musicista: opaco e come velato da
una membrana inutile e che ci fa sentire «una impossibilità di comu
nicare».
Ed è proprio il segreto di Mozart, questo dell’occhio opaco, e, per
questa atonia dello sguardo, di essere rimasto fanciullo; e per quali vie
e con quale tristezza è una delle verità che Savinio ha meglio intuito.
Questo segreto di Mozart è, in uno, il «rivolto» della tristezza e,
secondo me, in questo soltanto - forse, così dobbiamo dire: «soltan
to» - si allontana dalla vera, giocosa e limpida tradizione italiana.
E possiamo anche farlo chiosare da Savinio perché « la musica ita
liana, come la più semplice delle spose italiane, esiste per la sua inno
cenza e cessa di essere non appena fa tanto di buttare un occhio nei se
greti del bene e del male» (p. 206). E bene lo sapeva la prudenza (qua
le prudenza e [di più] quale fiuto! ) dei musicisti italiani del settecen
to: la prudenza del periodo che io chiamo virile: la prudenza della
prima metà del settecento. « Il giorno che i musici italiani vollero dare
ascolto alla voce del male, la musica italiana cominciò a precipitare»
(p. 206).
Forse perché il male è una delle cose essenziali del mondo, Savinio
sa perché mai l ’idea di Petrarca, «questo grandissimo poeta, non gli
riesca... di dissociarla interamente da quella di un grandissimo dilet
tante (... dilettante è colui che si dedica a cose molto importanti, mol
to gravi, molto belle, ma non essenziali)» (p. 15). E in quale rapporto
sia questa idea col problema del male si vede anche dal seguito di pagi
na 15 e dal giudizio che «il nostro tempo sia men vivo e duraturo nella
riesumazione dei musici antichi, che nella ^creazione di qualche melo
dramma verista».
Si vede chiaramente che Savinio non era, non poteva essere, né uno
scolastico esteta, né un filosofo estetico puro, né tanto meno uno sto
rico della musica. Ma un moralista, un uomo religioso, benché a suo
modo, e un poeta.
Ma un musicista, veramente si: perché soltanto chi sa che cosa sia
fare musica sente che «nell’allegro... si capisce se un musicista è intel
ligente o no» (p. 218) (ed io mi sento spinto a dire non soltanto un mu
sicista: anche un poeta e un danzatore; e forse anche più un architetto
Poetica di Savin io critico m usicale
461
[ma non di oggi né di ieri, al modo di Sacconi] o un decoratore a stuc
co come i Bossi). E consento anche nella sua critica che «G luck si sta
chiuso nel grave come in una fortezza sicura» (p. 218). Chiuso nel gra
ve, penso, è il piti incisivo profilo disegnato, in tre parole, da un ascol
tatore di colui che « come tutti gli artisti poco intelligenti, credeva che
l ’arte è solo rappresentazione del sublime» (pp. 217-18).
Ma anche se codesta è una sciabolata, un traversone del pensiero,
e tirato di scatto, a tutta forza, sentiamo che è proprio vero che « l ’in
telligenza è per l ’artista quello che il binario è per il treno» perché
solo il binario gli offre di lasciarsi andare, con fiducia, alla velocità più
continua e, semmai occorra, alla più spinta (p. 240). Per dirla con pa
role mie, G luck di rado sente l ’Anarsi liberatrice: la Catarsi lo avvince
e lo chiude.
E come mot de la fin possiamo anche rifarci alla brutale puntata:
«Credi all’ispirazione, lettore? Ricrediti. L ’ispirazione ogni artista se
la fabbrica da sé giorno per giorno» (p. 239). Ma, vi aggiungiamo - e,
lo sentiamo, col tacito consenso dell’autore - beninteso se egli può, e
soprattutto se l ’Anarsi lo guida, col suo filo.
Anzi, possiamo ribadire questo chiodo con un martello pneumatico
e rapido: «Non ho stima se non dell’intelligenza e dell’ingegno crea
tivo, per meglio dire dell’ingegno creativo associato all’intelligenza,
per dire meglio ancora dell’ingegno creativo "generato” dall’intelligen
za» (p. 238, su Pietro Mascagni); e, in questo punto, il riconoscimento
del «"m oto naturale” dell’ingegno creativo» di Cavalleria e del Rat
cliff apre la visione di un «buco nero» che finirà per divorare «anche
quel tanto di ingegno creativo che aveva brillato in principio» (p. 239).
Certo, è un peccato che l ’autore non abbia potuto rivedere da sé, e
per intero, il manoscritto: avrebbe potuto sopprimere alcuni ritorni di
brevi idee o di curiosità, secondarie e di scarsa prospettiva, piallare,
qua e là, o togliere le poche sprezzature e alcune contraddizioni. Ma
egli, come tutti gli spiriti profondi, lottava sempre col pensiero: ora
facilissimo, ora troppo complesso; e la contraddittorietà è la grande
tentazione del pensiero.
E poi, egli vi era stato trascinato da una tendenza sua intima, che
talvolta idoleggiava più del dovuto: quella che egli esprime con la for
mula arditissima: «anche i valori cosmici si possono superare e arri
vare alla divina frivolezza; ma in quanti siamo ad aver diritto a que
sto supremo gioco? In quanti siamo a poter non essere profondi? »
(p. 123).
Comunque si voglia giudicare l ’opera di pensiero di Savinio, non
si può non riconoscere che essa costituisce un’attività singolare ed
un’esperienza preziosa e degna di essere presa ad esempio. Un fonda
mento di poetica musicale, se anche non appare solido come quello di
una estetica, riesce molto più stimolante e fecondo e chiede che vi si
costruisca sopra, ma non a modo dei giuristi (benché senta di aver so
lide connessioni, a guisa di tessuto: connessioni che valgono, nel pen
siero, talvolta più delle fondamenta).
Tutto questo è molto importante perché se un difetto, una manche
462
Fausto T orrefran ca
volezza, avvertiamo nella critica musicale italiana - e non soltanto nel
la musicale — essa è, salvo qualche rara eccezione, quella della nostra
tradizionale mentalità di giuristi e di applicatori di articoli, di codici
e di regolamenti. E poi naturalmente, come avviene nel giure e appun
to perché .siamo nella «patria del giure», non ci sentiamo, per questo,
sollecitati all’osservanza del diritto tradizionale e conclamato; tutt’altro.
Noi riteniamo, per questo e per molte altre considerazioni facil
mente associabili, che soltanto nelle zone di trasfusione, ossia intuizio
ne e concetto, fra gusto e giudizio, possiamo sperare di radicare qual
che verità utile al nostro avvenire critico.
Quanto alla critica musicale, è anche una necessità essenziale quel
la di crearsi, anzi di vivere, un’idea della musica, un’idea nuova non
soltanto di ordine estetico o poetico, ma anche di ordine storico, solle
vando il proprio mondo alla piena luce della coscienza: appunto per
attingere un «oltre la realtà musicale», un sopramondo, ma che resti
radicato nel mondo.
Un critico, ad esempio, della poesia trova nell’opera d ’arte, volta
per volta, nella sostanza letteraria chiamato a giudicare e valutare, per
lo meno degli appigli e anche un modo di disegnare in iscorci concreti
e di attingere una superiore verità, anche se non segue o non può se
guire una precisa estetica. Il miglior modo di orientarsi, per il critico
musicale, è invece quello di creare, per la musica in genere, ma nei ter
mini più caldi, e insieme piti umani possibili, una poetica della musica
elastica, anzi versatile.
Essa soltanto può condurre il critico a cogliere un’idea personale e nello stesso tempo universale — di una grande opera, o anche soltanto
di un grande autore. Qui i valori di ordine estetico e quelli di ordine
morale si fondono in un valore che appartiene alla sfera che possiamo
chiamare ascensionale; e i soli valori che contano, nell’arte - e nella
critica - sono proprio gli ascensionali.
Savinio l ’ha fatto d ’istinto ed è forse da rimpiangere che egli non
abbia avuto il tempo di allargare, nei particolari, questa geniale «poe
tica della musica» e di fam e, sia pure, una poetica dell’arte tutta, egli
che tanta esperienza aveva di arti musiche e di arti plastiche. Ma ci ha
dato un grande esempio.
E, in realtà, era poi necessario che lavorasse, sino alle ultime conse
guenze, questa poetica?
Sarebbe stato, anzi, pericoloso: come ïutto ciò che spinge a siste
mare qualche cosa di assoluto e di definitivo. Sistemare vuol dire, so
vente, condannare alla decapitazione un pensiero dopo averne fatto
un grande feudatario o, più ancora, un tiranno o, alla moderna, un dit
tatore.
Quando egli ci ha detto che la storia della musica moderna si di
stingue in due periodi, animati da valori e da orientamenti di segno
diverso e quasi opposto, il tolemaico e il copernicano, e il primo può
anche dirlo presocratico (pp. 31-32) e affermare che esclude il senti
mento dell’infinito a quel modo che una casa ben costruita esclude
Poetica di Savin io critico m usicale
463
l ’aria di fuori, può proseguire di chiosa in chiosa, nel suo coerente entertenimiento suggestivo; e cosi ci propone una visione piti alta e piti
costruttiva di quella che potrebbero suggerirci o una valutazione di
ordine ritmico o armonico o una distinzione di sostanze contrappunti
stiche o di,tessiture o anche soltanto di orditure: dove si resta ancora
nel mondo della tecnica e nei limiti, sempre alquanto pedanteschi, dei
modus operandi.
Questo mondo secondo tecnica non potrebbe formare quelle sin
tesi che egli ha costruito a guisa di cale o di baie, di riposo e di medi
tazione, intorno ai nomi, ad esempio, di Chopin - al quale rimandiamo
il lettore - o di Mozart o di G . S. Bach e di Beethoven; ed egli alla tec
nica si è rivolto soltanto per concludere, alla enarmonica - ciò che, per
una cadenza, è doppiamente paradossale — che, «la Messa solenne di
Beethoven è un capolavoro: ma il capolavoro di "un altro” » (p. 76).
Egli ha visto bene, quantunque non l ’abbia detto esplicitamente,
che l ’arte è un espandersi, che essa è costituita di valori per eccellen
za fluidi, appunto perché sono i valori eterni.
Tutta questa istintiva sapienza gli permette di stringere, in pochi
segni, la tragedia di Mozart. «D i quale malattia mori?... Lo sforzo...
la impossibilità di adattarsi, lui fanciullo perenne, alla vita dell’adul
to... un errore della natura... [che] si manifesta nel ritratto che di lui
dipinse il suo cognato Giuseppe Lange» nel quale «appare come un
fanciullo rimasto nelle proporzioni del fanciullo, ma "gonfiato” di vita
adulta, e triste, malato di questa immissione estranea che gli mette in
faccia come un eczema, come una tumefazione di scarlattina... Ed è [il
ritratto] incompiuto. Ma è difetto o eccesso di fedeltà? Mozart stesso
era incompiuto» (pp. 37-28). In lui, lo si vede, l ’espandersi s’era arre
stato; e proprio nel senso più vitale.
Q ui, e più oltre, l ’esperienza del musicista e del pittore si assom
mano a creare la verità, senza contare la genialità sintetica di principi
che vengono dal profondo come questo che « l’infanzia non è una con
dizione naturale: è un’opera d ’arte» (p. 47) (cioè è anch’essa di natura
prettamente espansiva) o l ’altro, di indole musicale, benché avulso
dalla storia e dedotto soltanto dalla mediocre esperienza dei cantanti
d ’oggi (apprendisti di un bel canto che si limita al modesto artigianato
del solfeggio, privo di lume interiore) che «nel trillo, in questo riso
senza gioia, in questo riso senza speranza, è tutta l ’anima di Mozart;
anima senza gioia, anima senza speranza; perché nel trillo è tutto l ’uo
mo Mozart, che ha perduto il Dio esterno seduto sul vertice d ’oro della
piramide, e non ha acquistato ancora il Dio interno. L ’universo di M o
zart è un universo "neutro” » (p. 52).
In questo universo paradossale l ’espansione si è fermata con la gio
vinezza di Mozart.
Ma il nostro Tosi, l ’immenso Tosi, Dio del buon gusto nel sette
cento, ma per il suo secolo e per i secoli seguenti, esigeva il trillo sol
tanto nelle cadenze e Mozart non era tanto italiano da seguirlo, sen
z’altro, in questa massima pacificante. La cadenza infatti è la pace ma,
se vogliamo dirla in termini saviniani, la pace tolemaica (p. 33).
464
F austo T orrefran ca
Per chi vuol capire, come merita, Savinio - ma capirlo non «col
buon senso» col quale «per nostra fortuna, non abbiamo mai avuto
nulla da spartire» (p. 284) - bisogna invece raffigurarselo nella costan
te aspirazione alla « qualità degli dei greci, quella di uomini che hanno
superato la tragedia; che hanno raggiunto quella condizione di "dilet
tantismo” che è la condizione più alta e felice della vita; ... quella con
dizione cui io profondamente aspiro e cui qualunque uomo - credete
a me - può aspirare e raggiungere, basta che lo voglia e sappia render
sene degno» (p. 191).
In questa condizione, finalmente raggiunta, è giusto che egli si ri
belli, domandando: «Chi ha detto che la sola funzione della critica è
di criticare?» e rispondendo: «La critica ha una funzione molto più
importante, che è di inventare» (p. 301). E la sua mente era consa
pevole di una fertilità inventiva, anche - e forse soprattutto - nella
critica.
Ma la sua pittura non era, molte volte, d ’ordine critico-inventivo?
E i suoi libri non erano entertenimientosì
Le aperture sono spesso più importanti, o almeno più anartiche, dei
conseguimenti prossimi.
F A U S T O TO R R EFR AN CA
scritto introduttivo
alla prima edizione di "Scatola sonora" di Savinio
(Milano 1955)
A.S.
i testi sono tratti da:
Scatola sonora
(Milano, Ricordi, 1955;
Torino, Einaudi, 1977)
1. Musica estranea cosa
Ho visto un direttore d’orchestra cadere dal podio. La cosa andò cosi. Stavo
nella sala dell’Adriano, seduto nella mia solita poltrona, fila nove, numero nove. La
mia poltrona è collocata immediatamente dietro quella del mio amico Gabriele. La
testa ai Gabriele è perfettamente aerodinamica e consente a questo eminente
psichiatra dì raggiungere nella corsa a piedi velocità molto alte. La conformazione
cranica del mio amico Gabriele esercita su me un cosi invincibile fascino, che tutte
le domeniche, durante il concerto sinfonico, e per trascinante che sia la musica, la
mia attenzione non cessa di passare con alternanza oscillatoria dalle spalle del
direttore al cranio del mio amico Gabriele, e viceversa. Quella domenica però i poli
d’attrazione non erano due ma uno solo. Il fascino della aerodinamica testa aveva
ceduto a quello ben maggiore del giovane direttore che io vedevo per la prima volta
sul podio dell’Adriano. Costui era alto e magrissimo, di quella magrezza ossuaria e
combusta che fa pensare al monachismo, all’ascetismo, al diabolismo, al magismo
e alla morte. Era stretto in una velada attillata, guaina nera di quel pugnale umano,
chiuso il collo lungo dentro un solino lucido e bianco come un tubo di porcellana.
Medusea la testa nel senso che i capelli nerissimi e lunghi gli brulicavano intorno
al cranio, gli si agitavano come serpi davanti agli occhi. I suoi movimenti erano
spasmodici, e simili a quelli di una rana galvanizzata, di un burattino mosso da
violente strappate dei fili. Soffrivo per simpatia agli squassi di quella testa
anguicrinita, la pensavo in ispecie di uovo nella mano di una massaia enorme e
invisibile che se lo provasse all’orecchio per sentire se è guasto. Temevo che per
effetto di quegli scotimenti il cervello avesse a staccarsi dalle pareti craniche e
cominciare a sbattere come appunto il tuorlo di un uovo guasto. Personaggio
hoffmanniano, un sopravissuto della Kreisleriana sperduto in questo mondo
razionalista in cui i musici stessi hanno acquistato aspetto e comportamento da
ragionieri, e si esercitano a musiche squisitamente tolemaiche, cioè a dire gelide e
architettate. Dirigeva costui senza bacchetta, quasi la bacchetta dovesse essere un
impaccio, un ostacolo, una soluzione di continuità, e le dita nude invece di quelle
mani magrissime e agitate come nel vento due grandi foglie secche svelte dal ramo,
si continuassero in invisibili fili e si attorcessero alle varie famiglie degli strumenti,
come le corde di budello intorno al gambo del bischero. Il primo numero del
programma era un concerto di Vivaldi, ma io arrivai tardi e non potei entrare in
sala. Questo ritardo anzi mi procurò uno strano incidente. Gl’ingressi alla sala
dell’Adriano (la mia macchina aveva scritto «ingrassi»: la sacra freddura parla
dunque anche per bocca delle macchine da scrivere?) sono chiusi da porte a
sventola, dietro le quali è calata una tenda che scorre su anelli di metallo. Arrivato
all’Adriano durante l’esecuzione del concerto di Vivai-di e tirato un battente della
porta con intenzione d’introdurmi di soppiatto nella sala, mi trovai nel buio tra la
porta che si era richiusa dietro a me e la tenda essa pure chiusa, e attraverso la
quale la maschera di guardia alla porta cercava di contrastare la mia avanzata. La
mia situazione era amletica e quella lotta attraverso la tenda mi rammentò
l’uccisione di Polonio. Potevo vincere ma rinunciai alla vittoria, perché la mia
avversaria non avesse a credere che io approfittavo della lotta per palpeggiarla
attraverso la tenda. Il pudore una volta ancora mi fu nemico. Seguiva la Quarta
Sinfonia di Brahms, musico grave e affettuoso insieme, come un padre. Quale
presentimento era in me? Alle spalle del direttore avevano tirato un grosso
cordone fra due enormi birilli di legno verniciato, il che dava al podio un aspetto di
mobile chiesastico, quasi a impedire che il direttore crollasse nell’iposcenio.
Attraverso il primo tempo della sinfonia e ai suoi sviluppi cordialissimi, io pensavo
alla posizione più sicura del direttore d’orchestra di teatro, che solo con la testa
emerge e le spalle dalla fossa mistica, come una testuggine dal carapace; pensavo
ai direttori che dirigevano seduti come professori in cattedra e come io dipingo;
pensavo al tempo che direttore non c’era nel senso che intendiamo noi, ma
l’orchestra era affidata al primo violino che un po’ sonava, un po’ accennava il
tempo con l’archetto, un po’ dava le entrate ai cantanti; pensavo all’orchestra
«senza direttore» che per alcuni anni funzionò in Russia, quale esercito senza
generale.. Pensavo soprattutto a musiche che lasciano dormire i nervi, non
svegliano le passioni, non travolgono con l’onda dei suoni, e poiché dopo la
sinfonia di Brahms il programma annunciava la Morte d'Isotta, il Don Giovanni di
Strauss e altre musiche ardenti e torrentizie, per reazione io immaginavo un
programma bianco composto unicamente di minuetti, rondò, pavane. Perché
esporsi cosi temerariamente all’inferno musicale? Il primo tempo arrivò in porto
senza incidenti, e dalla sala si levò un respiro più di sollievo che di soddisfazione: il
respiro della bestia che dalla tensione passa al rilassamento. Indi a poco il
direttore attaccò il secondo tempo, ma io ero meno in ansia perché il carattere
stesso di quell’«andante moderato» mi dava impressione di minor pericolo. A
quale precisa battuta fu? D’un tratto io non vidi più il direttore, ma un groviglio ai
piedi del podio e udivo l’enorme clamore della sala che di colpo si era levata in
piedi, come un campo di grano venuto su per una miracolosa eruzione vegetale.
Avevo io veduto il direttore cadere? Non ricordo. Ho la vaghissima impressione di
una forma meno di uomo che di una enorme stilografica nera, che si piega e rigida
cade in avanti. Fidando nell’«andante moderato», la mia attenzione si era
rallentata. Lo portarono fuori a braccia, tra i leggii rovesciati e gli strumentisti che
facevano largo, e il clamore continuava come un gran vento nel teatro. Il mio
amico Gabriele si voltò e mi disse: «Forma epilettica non mi pare». Lo sapevo
bene. Dell’epilessia io ho una conoscenza «pratica». Nell’autunno del 1917 fui
ricoverato all’Ospedale Militare 108 di Salonicco, e poiché gli altri reparti erano
pieni, mi misero provvisoriamente nel reparto degli epilettici. Passavo le notti in
una sala illuminata a giorno, sotto lo sguardo vigile di atletici infermieri. Portarono
una sera alcuni militari che al fronte erano stati colpiti da choc nervoso. A uno
dovettero mettergli la camicia di forza; e quegli ripeteva un suo grido a ritmo,
acutissimo, «femminile». Una notte mi svegliai di soprassalto, e nella luce bianca
vidi sul bianco del mio letto il bianco compagno del letto accanto che, lordo la
bocca di bava, si dibatteva come un tonno nella rete. «E allora?» Gabriele rispose:
«Direi piuttosto una lipotimia». Io so abbastanza di greco da sapere che lipotimia
significa semplicemente svenimento, ed è vocabolo del linguaggio segreto dei
medici. Ma non lo dissi. E non dissi neppure quello che io solo sapevo, quello che
io solo avevo veduto, ossia la Musica apparsa sul podio come un’ombra lunga, che
afferra con le mani adunche il giovane direttore al collo e lo butta giù dal podio.
Dopo di che la Vampira se ne andò invisibile in mezzo all’orchestra in tumulto,
tirandosi giù le maniche della vestaglia.
La musica è una straniera nel nostro mondo, un’intrusa. Le sue condizioni
di vita sono cosi diverse dalle nostre, che ogni «naturale» convivenza con la
musica riesce impossibile; meno per una completa rinuncia di noi stessi, per una
resa incondizionata. Pure con la musica noi conviviamo. Sì. Ma è veramente con la
«musica» che conviviamo? E quali le condizioni di vita della musica? Non lo
sappiamo. Troppo diverse dalle nostre, le nostre facoltà intuitive non bastano a
farcele conoscere. L’essenza della musica ci sfugge. E sempre ci sfuggirà. Ci
sfuggirà sempre perché la musica «non è cosa nostra». La musica non fa parte
delle cose che compongono l’assieme degl’«interessi umani». E l’organismo della
conoscenza non funziona se non per le cose che in qualche modo rientrano negli
interessi umani. Ci sono cose che noi conosciamo e altre che non conosciamo.
Tutte le cose che noi conosciamo rientrano negli interessi umani, altrimenti non le
avremmo conosciute. Tra le cose che non conosciamo alcune riguardano
gl’interessi umani, altre no: quelle che riguardano gli interessi umani noi prima o
dopo le conosceremo: è il lento accumularsi della conoscenza, la causa del
progresso; le altre, che non riguardano gli interessi umani, noi «non le
conosceremo mai». Tra queste è la musica. È per questo che l’essenza della musica
rimarrà per noi eternamente ignota. Che è questa misteriosa cosa che vive soltanto
nel tempo? Come possiamo noi stringere rapporti con una cosa che vive soltanto
nel tempo e farne una cosa nostra - un’arte? Noi crediamo possedere la musica, e
invece è la musica che possiede noi. L’uomo, per fare «anche» della musica
un’arte, ossia uno strumento maneggevole, ha dovuto addomesticarla, ridurla,
mutilarla. Ha dovuto rendere terrestre una cosa non terrestre, fermare una cosa
essenziale, sfuggente, formare una cosa per sua natura informe. E l’uomo per
prima cosa ha dovuto dare alla musica — a questa misteriosa cosa che vive
unicamente nel tempo - anche un’apparenza di vita nello spazio; e le ha dato il
ritmo; come si mette il morso a un cavallo selvatico; come si mette il busto a una
donna grassa. Questa l’immensa importanza che il ritmo ha nella musica. Perché il
ritmo colloca o finge di collocare la musica nello spazio, con che le dà carattere
umano e diritto di cittadinanza sulla terra. Il ritmo è per noi la «garanzia» della
musica: la garanzia che la musica è doma e addomesticata e che ormai possiamo
considerarla «cosa nostra». Ma è assoluta questa garanzia? Musica senza ritmo
per me è inaudibile. La sola musica che la mia mente e i miei nervi sopportano è la
musica fortemente ritmata, ossia la musica che ha una qualche organizzazione
umana e che in fondo somiglia a noi. Perché il ritmo è l’elemento «umano» della
musica, la garanzia della sua stasi quaggiù e del suo ritorno, la confortante risposta
a quella idea del ritorno che è la più umana delle idee. Ma nella musica tuttavia il
ritmo è un elemento estraneo, un elemento imposto, un elemento che la musica
sopporta a stento e dal quale tende a liberarsi; e per questo la musica meno ritmica
(Debussy) è la più «musicale», ma anche la più inumana.
L’essenza della musica sfugge talmente a qualunque possibilità di
conoscenza, che l’uomo tenta spiegarsela mediante spiegazioni immaginarie; sia,
come Pitagora, assimilandola ai numeri («toi arithmoi de ta pant’epeoiken»); sia,
come Goethe, presentandola come una «architettura fluida» (ma qui veramente
Goethe parla della musica «artefatta», ossia già chiusa e organizzata come arte);
sia, come Schopenhauer, facendo di lei l’immagine della volontà pura. Ma a che
tentar conoscere l’inconoscibile? A che voler spiegare l’inesplicabile? la sola
definizione che si addica alla musica, è la Non Mai Conoscibile. E non senza
ragione. La non conoscibilità della musica è la ragione della sua forza, il segreto del
fascino; e se l’uomo cede con tanto piacere alla musica, è soprattutto per il
«diverso», per 1’«ignoto» che è in essa, e c’è analogia tra l’uomo che cede alla
musica perché nella musica sente il «contrario» di se stesso, e il meridionale scuro
di pelle e crespo di capelli che cede al fascino della scandinava bianchissima di
carnagione e bionda di capelli, nella quale egli vede quello che egli stesso non è
«ma sogna di essere». Cedere alla musica è un atto di soggezione a quello che non
si conosce, e per questo attira.
Nostri rapporti con la pazza.
Io nego che si possa dare una soluzione filosofica al problema della musica,
salvo a dargli come soluzione la sua stessa insolubilità. Resta a studiare il
problema della musica come «cosa psicologica». Non si combatte contro
un’ombra. I nostri rapporti con la musica vanno regolati da un apposito galateo. In
quanti siamo che sappiamo comportarci nei riguardi della musica? Il pericolo che
la musica costituisce per l’uomo, richiede da parte dell’uomo alcune cognizioni
profilattiche che l’uomo non mostra di possedere. Io ignoro se in sé la musica
obbedisca a una sua ragione, ma in confronto al concetto che noi abbiamo della
ragione, la musica è un’arte pazza, e abbandonarsi alla musica con tanta
imprudenza come le si abbandonano i musici e amatori di musica, è atto da pazzi.
È la pazzia della musica che rende necessaria una cosi complicata e rigorosa
struttura teorica o tecnica, una gabbia enorme per imprigionare la fenice che
tuttavia sfugge. Questo incauto abbandonarsi alla musica genera alcune forme di
pazzia di cui non solo non si tiene il debito conto, ma le si considera ammirevoli
forme di entusiasmo, di rapimento, d’ispirazione. Come abbandonarsi a un’arte
che per prima cosa preclude le idee e vieta di pensare? Musicista, io mi sono
allontanato nel 1915 all’età di ventiquattro anni dalla musica, per «paura». Per non
soggiacere al fascino della musica. Per non cedere totalmente alla volontà della
musica. Perché avevo sperimentato su me stesso gli effetti deprimenti della
musica. Perché da ogni crisi musicale io sorgevo come da un sogno senza sogni.
Perché la musica stupisce e istupidisce. Perché la musica rende l’uomo schiavo; e
la ragione principale del suo grandissimo successo è probabilmente questa, perché
diversamente da quanto credevano gli enciclopedisti che sognarono la libertà per
l’uomo, l’uomo ama sentirsi schiavo: sottomesso a una schiavitù fisica e assieme a
una schiavitù metafisica, quale la musica eccellentemente dà.
Tutto l’uomo può sognare, tutto può «stolidamente» sognare. Come di
fabbricare statue con l’elettricità. Come di comporre poemi sonori imprigionando
il vento entro appositi tubi. Resta a stabilire quello che si può fare e quello che si
deve e quello che non si deve fare, secondo quel «Galateo delle Arti» di cui ancora
io non veggo traccia intorno, ma del quale sento l’urgente bisogno. Domandarono
a Jean Moréas il quale dei Greci vanta la polytechnia, perché i Greci non avessero
inventato anche la macchina da volo, e al che Moréas rispose che «non lo avevano
ritenuto necessario». E invero la macchina da volo accorcia le distanze ma non
allunga l’intelligenza, semmai il contrario. E c’è affinità tra macchina da volo e
musica. Per mascherare la musica come malattia, per mascherarla come peccato,
per mascherarla come cosa estranea a noi e pericolosa alla nostra salute —
intendendo per salute la totale conquista e la totale padronanza di noi stessi, si è
tentato, e si tenta, e sempre si tenterà di scambiare la musica per un’altra cosa.
Che so? Per un «edificio matematico».
Dove va la musica? Dove vanno i suoni che passano su noi come nembi in
tempesta? Non lo domandate ai musici: non ve lo diranno, non ve lo sapranno
dire. E perché non ve lo sapranno dire lo leggerete nei loro torbidi occhi, velati
dalle cateratte che la musica su essi ha calato.
Anche i suoni seguono forse un loro destino, ma diverso dal nostro: dal
nostro che finché siamo in vita, vuol essere rigorosamente circolare e «ritornante»,
cosi da circondare noi e le nostre cose, e alimentare la nostra fiducia nella terrestre
eternità. Perché mischiarci con cose dissimili da noi e con esse giocare? Viene la
volta che la Cosa Estranea si vendica.
Viene la volta che la cosa estranea spezza il morso e ritrova la sua selvaggia
libertà. Illuminiamo di sera le nostre case con la luce elettrica, ma una sera il
fratello di Lorenzo Viani girò l’interruttore per illuminare la sua camera, e cadde a
terra fulminato: era la vendetta dell’Elettricità.
Migliaia e migliaia di uomini «giocano» con la musica sia colandola nelle
varie forme della composizione, sia facendo cantare le sue voci prigioniere, sia
ascoltandola e abbandonandosi al suo canto di bestia doma; e un giorno la Musica
appare simile a un’ombra lunga accanto al giovane direttore, lo afferra per il collo,
lo butta giù dal podio. È la vendetta della Estranea Cosa.
2. Musica telegrafica
Sono stato all’ultimo concerto di «Musica Viva». Trascrivo testualmente il
programma: quindici liriche scritte da Arnold Schonberg su altrettante poesie
tratte dal Libro dei giardini pensili di Stefan George; una lirica di Alfredo Casella,
La sera fiesolana, su poesia di Gabriele D’Annunzio; due liriche di Luigi Cortese
su sonetti di Petrarca; due liriche di Guido Turchi su poesie di Salvatore
Quasimodo, e infine le Histoires naturelles di Ravel. Esecuzione affidata a
Susanna Danco e ad Alfredo Casella, e dunque perfetta. Onde con stupore io mi
domandavo quale potesse mai essere la ragione della noia che a poco a poco
m’intorbidava, me così paziente ascoltatore che mi sono ascoltato una volta senza
batter ciglio l’intera Arte della fuga, e un’altra volta per due sere di seguito I
Troiani di Berlioz. Tanto più che la mia noia non aveva un carattere generico, ma
stranamente somigliava allo speciale torpore che ci viene quando ci troviamo in un
treno accelerato, fermi da lungo tempo in una stazioncella di campagna, nel cuore
dell’estate e nell’ora più calda della giornata, e l’immobilità e il silenzio intorno a
noi sono picchiettati dai colpetti ripetuti, insistenti, infiniti del telegrafo Morse.
A tutta prima imputai la mia noia al soporifico influsso della sala nella quale
eravamo raccolti; perché l’ultimo concerto di «Musica Viva» non si è svolto come i
precedenti in quella ariosa e amena sala all'ultimo piano di Palazzo Barberini,
onde attraverso le ampie finestre si scoprono i tetti, le cupole e gli aggruppamenti
vegetali dei giardini di Roma, ma nella sala dei concerti della Casa Madre dei
Mutilati; e questa sala, romanamente chiamata Auditorium, è la più cupa e
asfissiante sala che io mi conosca, una tomba per uomini non ancora incadaveriti,
cieca di finestre, chiusa lateralmente da alte e pesanti porte carcerarie, coperchiata
da una cupola graticolata che sembra voler vietare anche verticalmente quella
evasione che orizzontalmente vietano le porte di ferro, decorata sulle pareti da
affreschi che illustrano la vita delle quadrate legioni e da elmate e mascellute teste
di guerrieri che trucemente emergono dai muri: una sala insomma che forse con
meditata intenzione di chi la edificò, vuol dare il senso della mutilazione anche a
chi mutilato non è. Ma questa spiegazione non mi convinceva, perché non chiariva
l’analogia tra lo speciale carattere della mia noia, e l’insistente picchiettio del
telegrafo Morse... Finalmente capii: capii che la specialissima noia che io sentivo
nella sala della Casa Madre dei Mutilati durante il concerto di «Musica Viva» non
era ispirata dall’ambiente, sì dalla musica stessa che io ascoltavo. Perché?
La musica è, al pari dell’elettricità, qualcosa d’ineffabile che circola
nell’atmosfera del nostro universo, ma la cui natura nessuno, e non lo stesso
Schopenhauer, è riuscito finora a determinare con esattezza, e probabilmente
nessuno ci riuscirà mai nemmeno in avvenire. Il musico quanto a sé è un uomo
fornito del singolare potere di captare nell’aria questa misteriosa cosa che noi
chiamiamo Musica, che poi in un secondo tempo egli associa al nostro destino
temporale chiudendola dentro la rete del ritmo, e di cui fissa il valore fonico e il
movimento per mezzo delle note variamente disposte nel pentagramma, ossia
della scrittura musicale. Risulta da quanto abbiamo detto che una composizione
musicale è una specie di miracolo, e che l’audizione di una musica sgorgata
direttamente dalle sorgenti genuine della musica, dà la sorpresa dell’inaspettato e
l’impressione che d’improvviso noi siamo trasportati in un mondo diverso. Cosi si
spiega quella «luminosa sorpresa» che si accende all’attacco di certe musiche
direttamente e fortemente ispirate, come l’accordo di quinta minore («enigma del
destino») all’inizio del Crepuscolo degli dèi, o l’accordo di do minore all’inizio
della Patetica, oppure il disegno mi sol, do si che apre l’Apollo musagete come
l’improvvisa apparizione di un raggio di luce. (Del resto elemento fondamentale
dell’Apollo musagete è il raggio di luce (aktin) né io conosco musica più
«raggiante» di questa, quasi Strawinsky in questa che è la sua opera più altamente
ispirata, abbia inteso fare un omaggio di luce al dio stesso della luce).
Ma nel periodo di scolasticismo musicale che stiamo traversando, e che del
resto è pieno di un suo speciale interesse, il «miracolo» non avviene; manca
l’inaspettata «esplosione» musicale, manca quella espressione di repentina
«nascita» della musica che tanto somiglia all’improvvisa apparizione del mare, o di
un lago, o di un fiume, e comunque di un brillare e di un fremere d’acque. Il che
vuol dire che il musico oggi non è colui che secondato da un singolare potere capta
nell’aria la misteriosa cosa, ma scrive: scrive semplicemente: scrive
«orizzontalmente». E la musica diventa grafia. (Anche a me, quasi quarant’anni
sono, il mio professore Max Reger insegnava a «scrivere» musica, e a disprezzare
chi «inventa» musica).
E cosi, sottomessa all’umana volontà, e schiava dell’uomo, da padrona e dea
dell’uomo qual essa era, la musica non «nasce» tra le mani del musico, ma
comincia «come se continuasse», nastro lungo e ininterrotto; e termina perché
l’uomo a un certo punto taglia il nastro sonoro, ma potrebbe anche continuare; e
se ha da metter in suoni le parole di una poesia, segue fedelmente le parole come la
traduzione interlineare segue le parole del testo originale; e a udirla dà meno la
sorpresa e il rapimento della musica «inventata», che il senso di monotono infinito
che dà l’insistente picchiettio del telegrafo Morse, in un afoso pomeriggio d’estate,
nella lunga fermata di un accelerato in una stazioncella di campagna...
3. [da] Condizione della musica
(nota sul contrappunto)
Il contrappunto è nella musica ciò che la dialettica è in filosofia. È la
dimostrazione del principio che «da cosa nasce cosa». E l’analogia in musica dello
sviluppo cellulare nella vita organica. Prima della scoperta del contrappunto, la
musica, al pari della filosofia presocratica, era ristretta ad alcune idee isolate, che
brillavano a grande distanza una dall’altra, come stelle solitarie in un cielo nero.
Nella musica drammatica, si perpetua l’eroica solitudine del pensiero di Eraclito. È
strano a dire, ma alcuni melodrammi di Verdi, i più frusti, i meno «fatti», come II
Trovatore, e la stessa Cavalleria rusticana sono più vicini al pensiero oscuro ed
elementare del filosofo di Efeso, che le composizioni a doppio coro di quel
Giovanni Gabrieli, veneziano, che attraverso l’insegnamento da lui impartito a
Heinrich Schütz, preparò l’avvento delle «cattedrali sonore» di Johann Sebastian
Bach.
Il contrappunto è il moto «interno» della musica. Prima del grande
contrappuntismo la musica sembra mancare di corpo e di vita, più esattamente
sembra mancare di organi interni. All’apparire del contrappunto, comincia la
moltiplicazione cellulare della musica, e la musica, si badi bene, diventa una cosa
facile.
Il contrappunto — questo intenso movimento cellulare della musica, questo
continuo rinnovamento cellulare della musica — non solo dà vita alla musica —
una vita astratta, artefatta (intendi: fatta con arte), aerea — ma le dà anche salute,
perpetua freschezza. La scoperta del contrappunto, questo elemento della musica
più seria, più dotta, più alta, in verità è la scoperta del sistema di conservare la
musica in condizioni di perfetta freschezza.
È per questo che Bach è sempre giovane. È per questo che oggi si va
scoprendo con «borghese» maraviglia, come se si scoprissero balene del Pliocene
sotto i ghiacci della Siberia, la giovinezza dei precursori di Bach, di Frescobaldi, dei
due Gabrieli, ecc. È per questo che quando un musicista (Strawinsky) comincia ad
avvertire i pericoli della marcescenza e della cancrena, chiede consiglio ai
contrappuntisti ed entra egli pure nella grande disinfezione, nella grande cura
preserva trice del contrappunto. È per questo che Bach, e prima di lui il nostro
grande Vivaldi, questo più «camminante» dei musici, e poi gli Scarlatti, possono
scrivere composizioni-monumentali, composizioni-piramidi, composizionicattedrali, composizioni – torri di Babele (la celebrazione scarlattiana avvenuta
l’anno passato a Siena per opera dell’Accademia Chigiana, ci ha rivelato nello
Stabat Mater di Domenico Scarlatti un’opera nella quale come mai prima, e
diversamente da come fanno credere le altre opere di Domenico Scarlatti, la Madre
di Dio è stata esaltata con tanto eroico polifonismo, con tanta «berniniana»
maestà) e farle vive in tutte le loro parti.
Ma è per questo pure che la musica drammatica italiana, preclusa per sua
natura, per suo carattere, per sue esigenze compositive alla grande salute, alla
grande disinfezione, alla grande « sicurezza » del contrappunto, è cosi soggetta al
tempo e alla corruzione che ne deriva, ha tante parti inerti in sé, che ogni poco
bisogna tagliare e buttar via. Ma è forse meno eroica per questo, meno alta, meno
profonda? Guardiamola con attenzione e di là dall’abitudine: malgrado gli
entusiasmi delle platee, malgrado le richieste di bis, malgrado i fiori alla
primadonna, la musica drammatica italiana è meno atta a recare quel piacere
tranquillo, quell’« astratto » piacere, quell’« anaestetico» piacere che dà la musica
dei grandi contrappuntisti, perché essa richiama con ogni sua nota il dramma della
vita, la caducità dell’uomo, e l’idea della morte.
La musica del melodramma italiano è amara e spoglia d’illusioni. Questa la
ragione perché essa affascina il popolo e l’uomo di mente alta, ma respinge d’altra
parte il borghese il quale, ora che del melodramma è stata scoperta la «verità»,
preferisce immergersi nella illusione di una cantata di Alessandro Scarlatti, di una
toccata di Frescobaldi, di una fuga di Bach.
È per questo che Verdi, sentendo la necrosi che minaccia la musica
drammatica e a una sola voce, fa egli pure la sua brava cura di contrappunto e
scrive il Falstaff.
4. Bach e il contrappunto.
L’estate, che libera la natura e scatena l’uomo alla lotta e all’amore, tarpa
per converso le ali alla musica, e la costringe nelle lucide scatolette della radio.
La musica è per sua natura squisitamente invernale. Vogliamo dire la
musica grave e con nobili materiali costruita: la musica che piace a noi: la musica
come organizzazione e gioco mentale: la musica strumentale e polifonica. L’estate
per parte sua è favorevole alle cicale e alla melodia: alla stupida e svariona
melodia. E se il tetto a terrazza invita il tenore a cantare «E lucean le stelle», si
capisce d’altra parte che un uomo come Johann Sebastian Bach, questo Patriarca
dell’Armonia, questo architetto della polifonia e del contrappunto, sia nato sotto
un alto tetto a punta, atto a sopportare un grave peso di neve.
Due violinisti e l’orchestra attaccarono il Concerto in re minore di Bach con
passo gagliardo e spedito, come se volessero sbrigare alla svelta quella faccenda, e
arrivare alla stretta finale prima della cessazione d’orario dei tassi. Ma avevano
fatto i conti senza il contrappunto, i disgraziati.
Il contrappunto è nella musica ciò che la dialettica è in filosofia. È la
dimostrazione del principio che «da cosa nasce cosa». È l’analogia in musica dello
sviluppo cellulare nella vita organica.
Benché vita stessa della musica, il contrappunto rimase ignorato per molto
tempo ai musicisti stessi, come appunto la vita cellulare ai fisiologi, e malgrado
alcuni accenni di contrappunto presso gli antichi, è solo alla fine del medioevo che
il contrappunto comincia a rivelare la sua organizzazione radicale e ramosa, trova
la propria enunciazione in Scoto Eriugena, poi la sua dottrina nell'Ars
contrapuncti di Philippe de Vitry, infine diventa quella complicata architettura di
suoni, che porta cosi in alto le composizioni di Bach.
Prima della scoperta del contrappunto la musica, al pari della filosofia
presocratica, era ristretta ad alcune idee isolate che brillavano a grande distanza
una dall’altra, come stelle solitarie in un cielo nero.
Per chiudere l’analogia tra musica e filosofia diremo che anche la musica è fisica
prima del contrappunto, e metafisica dopo.
Il contrappunto ha qualcosa di miracoloso, di «meccanicamente»
miracoloso. Cade il tema della fuga, ed è come se un magico seme cadesse su una
testa pelata, e la trasformasse di colpo in una foresta di capelli.
Il contrappunto è il moto «interno» della musica, siccome il ritmo è il moto
che muove la musica nel tempo. Prima di Bach – e diciamo prima di Bach per
comodo e convenzione, e per non rifare qui la storia della nascita del
contrappunto, per merito di Schütz prima che per merito di Bach, e per merito di
Frescobaldi e dei grandi polifonisti italiani prima che per merito di Schütz – la
musica sembra non aver corpo e non avere vita: più esattamente, sembra mancare
di organi interni.
All’apparire del contrappunto, s’inizia il fenomeno della moltiplicazione
cellulare della musica. Anche la musica si fa all’immagine della vita, e dà ragione a
Eraclito che panta rei. Annunciato il tema, la composizione – tra contrappunto
doppio, triplo e quadruplo, tra contrappunto legato, contrappunto ostinato e
contrappunto saltato, tra imitazioni, canoni e fughe, tra temi e controtemi, risposte
ed esposizioni, episodi e divertimenti, riprese modulate e strette – la composizione
può crescere, gonfiarsi ed elevarsi all’infinito, e solo i limiti dell’umana fatica e il
senso della misura, consigliano di arrivare alla stretta finale e al pedale.
Il contrappunto – questo intenso movimento cellulare della musica, questo
continuo rinnovamento cellulare della musica – non solo dà vita alla musica, ma le
dà anche salute e perpetua freschezza.
È per questo che Bach è «sempre giovane». È per questo che Bach è la
ginnastica svedese dei musicisti. É per questo che quando un musicista
(Strawinsky) comincia ad avvertire i pericoli della marcescenza e della cancrena,
chiede consiglio a Bach e torna al contrappunto.
È per questo che Bach può scrivere delle composizioni monumentali,
composizioni-piramidi, composizioni-cattedrali, composizioni-torri di Babele e
farle vive in tutte le loro parti.
È per questo che la musica italiana, incline purtroppo al drammatico e
preclusa pertanto alla grande salute, alla grande «disinfezione» del contrappunto,
ha tante parti inerti in sé, che di tanto in tanto bisogna tagliare e buttar via.
È per questo che Verdi, sentendo la necrosi che minaccia la musica
drammatica e a una sola voce, scrive alla fine il Falstaff e fa egli pure la sua brava
cura di contrappunto.
È per questo...
Non bisogna illudersi però. Il contrappunto, e cosi la dialettica, vanno a
scapito della profondità. C’è più profondità, nel senso preciso della parola, in un
pensiero di Eraclito, che in tutta L’evoluzione creatrice di Bergson. C’è più
profondità, nel senso preciso della parola, nel canto solitario dello scolio di Sicilo,
che per tutta la colossale opera di Bach. Ed è appunto questa mancanza di
profondità di Bach, questa sua ingenua serietà, questo suo «non costituire
pericolo», che fanno il suo fascino e giustificano l’attrazione ch’egli esercita ormai
sulla borghesia.
E soprattutto la sua organizzazione da uomo metodico, tranquillo e fedele
alla moglie.
Perché quanto a organizzazione, nelle grandi composizioni di Bach c’è già il
carro armato e la Panzerdivisión.
5. Musica e ritmo
La primavera ha spalancato le finestre delle case. I suoni che altre volte
accompagnavano la gentil stagione in cui natura si rinnova, erano gli stornelli delle
fanciulle innamorate e il gorgheggiare delle gabbie fiorite di lattuga. Ma il regno si
è impiantato della civiltà meccanica e ben altra voce erompe oggi dalle finestre
spalancate: quella imperiosa di mille e mille radio.
Sugli effetti che la musica meccanizzata esercita su quei pochissimi uomini
che vivono più col cervello che con le altre parti del corpo, qui non farò parola. Le
mie recriminazioni in proposito, io le feci altre volte, ma con risultati tali da non
incoraggiarmi a continuare.
Il rumore è elemento necessario alla vita dell’uomo. Parlare a getto continuo
come capita a certe donne che io conosco e anche a molti uomini, e soprattutto
parlare per non dir niente è meno inutile di quanto si crede: è un’attività
fisiologica, è un’attività di vita e per gli animi gentili è un adornarsi di suono; ed è
forse anche un modo di convincersi che si vive, che non si è morti, perché
inconsapevolmente l’uomo frivolo, l’uomo vano, l’uomo stupido è tormentato dal
dubbio di non essere vivo, di essere morto.
Solo una intensa vita interiore consente di sopportare il silenzio, il quale
altrimenti riesce insopportabile e spaventoso. Ma la vita interiore è di una parte
infima dell’umanità. In tutti gli altri casi suoni e rumori intervengono molto
opportunamente a colmare questa lacuna. Che tale sia la ragione metafisica del
gran favore incontrato dalla musica trasmessa, nessuno me lo può negare.
Ben venga dunque il regno della musica trasmessa. Che le nostre gioie e i
nostri dolori, che i nostri amori e i nostri odi, che la nostra vita insomma si debba
svolgere ormai sopra uno sfondo musicale, è una di quelle condizioni fatali sulle
quali nulla può la nostra volontà. Anche l’azione dei film e il loro stesso dialogo si
svolgono su uno sfondo musicale: per la stessa ragione, e all’insaputa dello stesso
regista: per colmare il vuoto del film e soprattutto il vuoto del dialogo.
Ma noi siamo un popolo di propria e alta civiltà. La civiltà italiana ha
caratteri precisi: la linea e il ritmo. Se la vita dunque noi la dobbiamo consumare
d’ora in avanti a suon di musica, sia almeno musica che non contrasta e non
offende, ma sposa lo stile della nostra civiltà: la linea e il ritmo.
Il ritmo è il «galateo» della musica. Musica senza ritmo e musica
screanzata. Il ritmo è la base della musica italiana. Il suo lirismo è un lirismo
ritmico: un lirismo «che cammina». Questa la ragione perché la musica italiana è
di tutte la più viva, la più umana, la più civile.
Queste considerazioni si formano a dir vero alla morte di, Giuseppe Verdi.
Cominciò di poi l’infelice avventura del melodramma verista e linea, ritmo, stile
furono distrutti in nome della verità.
Anche la musica, come le altre attività dello spirito umano, non la si può
considerare unicamente in sé e astraendola dalle necessità fisiologiche della vita.
Bisogna individuare nella musica l’elemento che più di tutti la mette in relazione
diretta con la vita, e dare a questo elemento il posto d’onore.
Questo elemento è il ritmo. Il ritmo della musica è il riflesso sonoro del
ritmo stesso della vita: del palpito del nostro cuore del palpito del nostro cervello
(chi è abituato a pensare sa che anche il pensiero ha un suo ritmo). Una musica
ritmata è una musica vivificante e umana. Una musica senza ritmo è una musica
catalettica e inumana. Non per nulla la sinfonia della Gazza ladra o le Stagioni di
Vivaldi sono musiche ben più vive e attuali che le aritmiche divagazioni sonore di
Claude Debussy.
Se le innumerevoli radio che mi circondano ripetessero all’infinito le
sinfonie della Gazza ladra o altre musiche ugualmente ritmate, la mia vita e il mio
lavoro, e cosi la vita e il lavoro di tutti non ne sarebbero turbati e ostacolati, ma
allietati al contrario e vivificati. In queste musiche cosi fortemente ritmate e
logiche e umane, noi troveremmo un incitamento e una giustificazione. E mentre
ci affatichiamo nella ricerca della ragione e del ritmo ideale della nostra vita, ci
sembrerebbe che questa stessa ragione e questo ritmo si continuano fuori di noi e
si espandono sonoramente per gli spazi infiniti.
Ma ben altre musiche ci sono propinate di solito. E quando non è l’ansimare
delle musiche sincopate, sono i belati caprini, i sentimentalismi bolsi, le
passionalità bestiali, i «rubati», gli «affrettando», i «rallentando», le corone, gli
«ad libitum», i do di petto, gli urli, i singulti, le sghignazzate, tutto lo smanceroso e
idiota condimento di quel melodramma verista che da cinquantanni a questa parte
spande un’ombra sul fulgore della musica italiana.
Pare incredibile, ma Verdi è ancora considerato, e proprio qui, da noi, come
un operista grandissimo, ma un musico da non si dover prendere molto sul serio.
Per capire il profondo valore della musica di Verdi, bisogna considerarla
anzitutto come una musica eccellentemente ritmica. Le sue stesse qualità
sentimentali, drammatiche, poetiche sono costrette e disciplinate dal ritmo. Che
l’ideale supremo di Verdi fosse il ritmo, lo testimonia non il solo Falstaff (che per
certi riguardi costituisce una «diminuzione» di fronte ad altri suoi melodrammi
più corposi e ispirati, ma tuttavia risolve la massima aspirazione del suo autore: il
moto perpetuo), ma lo testimoniano pure i suoi melodrammi più fantasiosi, più
estrosi, più sconvolti dalla melodrammatica foga, come il Rigoletto o Un ballo in
maschera.
Non ho mai trovato ancora una interpretazione delle opere di Verdi che
rispettasse la rigorosa armatura ritmica che le informa. Triste a dire, le òpere di
Verdi servono oggi ancora di sfogo all’arbitrio dei cantanti, alle licenze dei
direttori. La musica di Verdi va eseguita presto e sopprimendo tutte quelle fratture
del ritmo che sono determinate da «stupide» ragioni di patos. (Taluni continuano
a scrivere «pathos», «Pantheon», «Lydia»: esempi di estetismo arcaicizzante).
Che il ritmo sia la base della musica italiana, lo dimostra anche il metodo
dei nostri direttori d’orchestra. Il direttore italiano «batte il tempo» con la
bacchetta: il direttore tedesco «accompagna» con la bacchetta i vari movimenti
della musica. Il metodo italiano (per meglio dire «quello che era» il metodo
italiano) sottintende una ossatura ferma e immutabile, un granito sul quale poggia
la struttura musicale: il metodo tedesco sottintende un’ossatura ritmica che si
adatta allo svolgersi e al mutare dei sentimenti e dunque un’ossatura morbida e
mutabile: un avviamento al dislogamento dell’anatomia musicale e
all’«impressionismo».
La musica italiana è ritmica, la musica settentrionale aritmica. L’ideale della
musica settentrionale è la «Sonata quasi una Fantasia». Sia inteso però che
l’aritmicità della musica settentrionale (riflesso sonoro dell’aritmicità della stessa
mente settentrionale, del suo divagare per i campi della metafisica, dello speciale
carattere della sua «poesia») non ha nulla che vedere con l’aritmicità del non mai
troppo deplorato melodramma verista. Qui non è neppur quistione di aritmicità,
ma di suoni claudicanti, di ruote quadre, di corse sui trampoli.
Una rinascita della musica italiana non può avvenire se non sotto il segno
del ritmo.
In ogni città, dalla torre della casa del Comune, un enorme metronomo,
attivo giorno e notte, dovrebbe regolare il ritmo della nuova musica italiana.
6. Bach e l’estetismo.
Il mio professore di composizione mi faceva analizzare per studio le
musiche di Johann Sebastian Bach. Dovevo indicare nelle fughe l’ingresso delle
varie voci che propongono il tema ora a diritto e ora a rovescio, seguire il tema
attraverso il labirinto del contrappunto, indicare il secondo tema se c’era,
analizzare le modulazioni e arrivare cosi notomizzando alla stretta finale ove le
voci si stringono in un aggruppamento supremo come i superstiti di un naufragio
su uno scoglio, e alla cadenza che chiude la porta sul compiuto edificio sonoro. Ma
il mio professore di composizione, che a sua volta era stato allievo del grande
Reisenauer per il pianoforte e per la composizione del non meno grande Max
Reger soprannominato «il secondo Bach», non si contentava dell’analisi tecnica
delle fughe, voleva soprattutto che mi avventurassi nella loro analisi estetica, e
poiché le mie risposte in questo campo lo lasciavano insoddisfatto, egli finiva per
fare l’analisi da sé, con un entusiasmo e una cosi completa assenza di dubbi che mi
lasciavano perplesso. Il mio professore di composizione era un esteta, perché il
tempo dei miei studi musicali, avvenuti nella prima decade del secolo, coincideva
con l’epoca d’oro dell’estetismo, e dell’esteta egli si era fatto l’acconciatura della
testa, portando barba e chioma alla nazarena, atteggiando l’occhio a un languore di
sogno e il labbro al gusto di sapori squisiti, e vestiva dell’esteta anche l’uniforme,
consistente in ampie giacche di velluto, cravatte svolazzanti punteggiate di
pasticche rosse o verdi, e panciotti fantasia sui quali brillavano due file di bottoni
lucidi come occhi di gatto e altrettanto fascinatori. Ho indicato i primi anni del
secolo come l’epoca d’oro dell’estetismo, ma non bisognerebbe inferire da questo
che oggi l’estetismo non alligni più. L’estetismo purtroppo è un male cronico e che
non dà speranza di guarigione, solo che allora l’estetismo era manifesto e
orgoglioso di sé, oggi è più cauto e silenzioso, ma non meno dannoso per questo né
meno tenace. Tra le varie forme di diabete c’è il diabete cosiddetto «insipido» che,
se non vado errato, è anche il più grave.
Mi domandava il mio professore di composizione quali immagini
m’ispirasse la Fuga n. 1 a quattro voci del primo volume del Clavicembalo ben
temperato, e poiché io rimanevo muto malgrado gli sforzi di volontà che mi
gonfiavano le mascelle e m’incantavano la pupilla destra in un temporaneo
strabismo, egli mi spiegava che la Fuga n. 1 evoca un ameno paesaggio della
Turingia allietato dal gaio scampanio di un armento al pascolo e dal fruscio di un
ruscelletto tra l’erba, e come a documentare il carattere bucolico di questa fuga
aggiungeva che lo stesso nome Bach significa ruscello. Poi mi descriveva il
Preludio e fuga n. 8 dello stesso volume come delle immagini dipinte sulle vetrate
di una cattedrale gotica, e nel Preludio n. 7 mi mostrava un gruppo di vecchierelle
raccolte a chiacchierare davanti al portale di una chiesa, le quali all’andante della
battuta 10 tacciono di colpo perché il portale si è aperto e lascia espandersi gli
accordi dell’organo, poi al primo tempo della battuta 26 riprendono a poco a poco
a chiacchierare sulle note gravi della liturgia.
Chi di noi sfugge all’estetismo? Io stesso, nel dare più sopra una descrizione
sommaria della fuga, mi sono abbandonato a paragonare le voci della fuga raccolte
nella stretta a un gruppo di naufraghi su uno scoglio e la cadenza alla porta di un
edificio, cioè a dire sono incorso in peccato di estetismo. Perché l’estetismo, che è
più o meno acuto e di migliore o peggiore qualità, si esprime attraverso l’immagine
ossia scambia una cosa per un’altra cosa. Nel caso estremo di estetismo l’esteta
arriva alla vergogna della realtà, che è quanto dire la vergogna di se stesso, e si crea
un repertorio di «belle immagini» dietro le quali si nasconde, e l’amore a modo di
esempio diventa una «fiamma purissima», le operazioni più semplici e naturali
diventano dei «riti», la vita intera si ricopre di una pelle scintillante ma falsa.
Chi meno di tutti si presta a questa traduzione per immagini, è Johann
Sebastian Bach. La musica di Bach è perfettamente astratta, negata a qualunque
comparazione, e tanto meno a qualunque approssimazione, del tutto indifferente
alle voci umane o terrestri. Beethoven ricanta il canto cupo dei giganti, ascolta i
sospiri profondi delle montagne, si spinge ai confini estremi della vita, ma della
vita rimane pur sempre implicato dentro il fangoso plasma; mentre Bach non ha
occhi per guardare la vita, non orecchi per ascoltarla. Gli stessi ritratti di Johann
Sebastian confermano questa sua perfetta cecità, questa sua sordità totale. Sordo
dicevano Beethoven, il quale internamente era sconvolto dalle voci di una
audizione straordinaria. Bach invece era sordo e dentro e fuori. Come a meglio
proteggere questa sua immobilità di sentimenti, a meglio custodire questa sua
atarassia di passioni, Bach si nascondeva dietro la sua propria musica come dietro
un riparo sicuro; perché non un desiderio, non una speranza, non l’idea più magra
riesce a traversare la musica di Bach, che il suo tessuto rende altrettanto
impermeabile quanto il fondo oro che circonda le Madonne di Cimabue, quanto il
cielo di Tolomeo.
Al tempo in cui il mio professore di composizione m’insegnava nei preludi
di Bach i ruscelletti che corrono, le vecchierelle che chiacchierano e le immagini
che brillano nelle vetrate delle cattedrali, la borghesia musicale considerava la
musica di Bach una pura esercitazione scolastica e non pensava affatto a farsene
uno strumento di gaudio.
Oggi invece la borghesia musicale ascolta L’arte della fuga come allora
ascoltava La Traviata. Che segno è questo? È segno che gli amici della musica
hanno preso una indigestione di umana passionalità, e oggi hanno bisogno di
questo riposo del cuore, di questo gioco di là dai sentimenti, di questo austero
intorbidimento del cervello che dà la musica di Johann Sebastian Bach.
Del resto tutta la musica naviga verso i mari tranquilli dell’astrazione, ove i
nervi degli ineroici musici d’oggi possono trovare riposo.
7. La «Pastorale» *
La Sesta Sinfonia di Beethoven, detta Pastorale, è un sistema a giostra e a
uso degli amatori di bei paesaggi; un’anticipazione dell’otto volante.
I viaggiatori stanno seduti per benino a coppie nelle vetturette a barca: gli
uomini in gibus peloso, scopettoni a zampa di lepre, cravatta girata più volte
intorno al collo; le signore vestite da copriteiera.
Sotto l’abito a copriteiera, le parti vive della donna risultano infinitamente
più preziose, e quale rischiosa, quale eccitante avventura a ogni uomo sentirsi
Colombo, scoprire un’America di dolcezze!
Le vetturette sono decorate esternamente di angiolini che reggono
ghirlande di fiori, di sirene che vanno in velocipede sulla propria coda, di maialotti
vestiti da onesti cittadini, alcuni che ballano con le loro maialotte, altri che
suonano violini e trombette.
Le signore reggono l’ombrellino a riparo del sole, le frange piangono a salice
sui loro capelli da falconiere.
* S'intende che queste righe, preludio a una considerazione della sesta sinfonia di Beethoven, sono
da leggere alla luce della pagina sull'estetismo (qui da noi anteposta), di cui paiono costituire una
illustrazione nel segno patente del paradosso e dell'eccesso, metafisico-umoristico (e
probabilmente, surreale).
8. Tre note intorno a Strawinsky
«Apollo musagete».
Strawinsky non è creatore. Le corde del suo arco sono la parafrasi,
l’interpretazione, l’imitazione. Ogni sua musica è un «visto da».
Il creatore vive solitario. Non ha relazioni col mondo. È nemico del
prossimo. Se appena una anche minima voce del mondo cade nell’opera del
creatore, nasce uno scandalo. Scandalo il richiamo del cuculo nella Pastorale,
scandalo il tema russo nel finale della Settima.
Per meglio capire questi esempi, il lettore deve uscire dall’abitudine:
dimenticare. Soltanto allora i citati passi della Pastorale e della Settima gli
appariranno nella loro luce vera e «oscena». Lo stesso Beethoven, il grave
Beethoven, gli apparirà in ispecie di vecchio lascivo, che d’un tratto butta via i
panni, si cinge i reni con un tutù, si mette a saltabeccare.
In Strawinsky invece tutto preesiste, tutto è noto, tutto previsto. Diciamo
meglio: previsto ma capovolto. Tutto è «rovescio della medaglia».
Intendiamoci, però: questa imitazione riplasmata non è una forma
«minore», a petto alla originalità, alla primordialità del creatore, di «certi»
creatori.
Il parafrasismo di Strawinsky è meno un male del nostro tempo, che una
«necessità» del nostro tempo. Lo si ritrova eguale in Picasso, il quale parafrasa ora
i disegni di Ingres, ora le pitture pompeiane, ora la statuaria negra.
Spieghiamo questa «necessità del nostro tempo». Creatori del tempo
immediatamente anteriore a questo di Picasso e di Strawinsky, per meglio dire
artisti «atteggiati» a creatori, erano Franz von Stuck, Gabriele D’Annunzio,
Richard Strauss, lo stesso Bistolfi...
È l’ostilità al tipo «creatore», che determina l’antiwagnerismo di
Strawinsky: l’ostilità al demiurgo biblico.
Era necessario reagire all’atteggiamento del creatore. Era necessario
buttarsi alla parafrasi. Parafrasare o morire. Per riallacciare il filo della cultura,
rotto dai sedicenti creatori.
Picasso, Strawinsky, sono due esempi di dichiarata rinascita della cultura.
Nel contorno di Bistolfi, di Strauss, di D’Annunzio, si respira aria d’incoltura,
malgrado i persistenti richiami ai modelli classici; e forse a cagione di questi. È un
buio più che di barbarie: un buio di morte. Peggio: un buio di stupidità. Con
Strawinsky, con Picasso, riappare la luce dorata della rinascita. Che di più
petrarchesco di questo Apollo musagete?
Di là da un’epoca di tenebre, Igor Strawinsky, come a suo tempo Petrarca,
scopre le chiavi della luce; apre le luminose sorgenti e se ne illumina tutto, come ci
si abbevera a una fonte. Nella Rinascita c’è la scoperta della pietà filiale, l’amore a
un padre ritrovato. È il «dolce» sentimento della Rinascita, dopo il lungo tempo
dell’amore nascosto.
La Rinascita si può anche chiamare Risveglio dell’Intelligenza. Al tempo
buio e roccioso dei Creatori, dei demiurghi ottusi, subentra un’epoca rischiarata da
un lungo, un obliquo sguardo divino.
Non fossero state le condizioni storiche qui sopra ricordate, Strawinsky,
Picasso, sarebbero forse stati a loro volta dei creatori, anziché quei parafrasatori,
quei manieristi che sono stati costretti a diventare. Di là da certi limiti, non c’è più
obbligo di obbedire al temperamento: non c’è più temperamento, ma piena libertà
di scelta.
Nell'Apollo musagete, il manierismo di Strawinsky è anche più manifesto
che nelle altre opere, il parafrasismo anche più scoperto. È un risveglio di dolci
ricordi, un ridestarsi di memorie bellissime e fino allora sopite. Ritrovandole, ci si
domanda come, nella lor dimenticanza, vivere fosse possibile.
Nell'Apollo musagete, il «rinascimento» è più accentuato che nelle altre
opere di Strawinsky, più chiaramente determinata la ricostruzione del filo
culturale. E se in questa sua operetta Strawinsky ha ristretto l’orchestra ai soli
archi, è perché, attraverso le lenti da miope, le nere ed enormi pupille del musico
hanno guardato l’Apollo di Raffaello, seduto sulla vetta del Parnaso, la destra
sull’archetto, la ganascia sul violino.
Nell’Apollo musagete, la musica tocca l’imo della dolcezza.
Come illustrare la più alta qualità di questa musica?
È una musica «silenziosa».
Quello che soprattutto si paga negli alberghi di lusso, è il silenzio.
Quello che soprattutto allieta gli dèi, è l’altissimo silenzio dell’Olimpo,
questo «palace des palaces».
Nell'Apollo musagete, Strawinsky ha messo in musica il silenzio
dell’Olimpo.
Grande nel paradiso cattolico, il rumore. Salteri, organi idraulici, tiorbe,
angeli che impallonano le gote sul becco delle trombe, e osanna osanna osanna
senza fine.
Nella sede degli dèi pagani, tutto è silenzio, tatto, decoro.
E malinconia.
Perché consolazione di morte sull’Olimpo non c’è, ma l’infinita tristezza,
invece, di non poter morire. E come sopportare l’immortalità, se non nel chiuso del
silenzio?
L’immensa malinconia dell’Olimpo, Strawinsky la esprime soprattutto alla
fine della partitura, quando Apollo risale verso la sua eccelsa sede, e di lui non
rimane se non il lamento insistente e appena stridulo del violino.
Il punto più sorprendente dell'Apollo musagete, è il tema di Apollo, per
meglio dire il tema che rappresenta Apollo.
Non conosco esempio, che esprima con altrettanta chiarezza, con altrettanta
metafisica precisione, l’apparizione della luce come «apertura». I movimenti di
Apollo sono angolosi e meccanici, come si addice a un dio rappresentato. I raggi si
spiccano da lui, rapidi, diritti, scattanti.
Buttare luce, in Apollo è un tic nervoso. Spade di luce partono dalla testa
metallica del dio, fulminee come la lingua del camaleonte. Non traversano
l’universo, ma trafiggono appena l’ambito del dio, perché la luce di Apollo, la luce
greca non è, al pari dei raggi massicci, dei plumbei raggi di Geova, buona per tutti,
ma solo a una ristretta cerchia di gente, a un petit comité, perché l’olimpicità di
questo Apollo musagete è rigorosamente limitata, nettamente conchiusa, ha
l’intimo di una musica di Chopin, e fa salotto. In ultimo, nell’Apoteosi (apoteosi in
famiglia) Apollo se ne va tirandosi dietro i suoi raggi, come un bimbo un balocco
per un cordino; e i raggi di Apollo, mentre Apollo si allontana, appaiono un po’
zoppicanti, un po’ irranciditi, un po’ malridotti, un po’ stracci.
Confronta il finale dell'Apollo musagete, col finale dell’Orfeo. Orfeo si
allontana a un segnale di tromba: un segnale da caserma. La qualità che cosi
nettamente distingue Strawinsky dagli altri musici, è lo spirito.
Musica dell'Apollo musagete: la più radiante che io conosca. Raggi lancia
questa musica. Ma la parola «raggi» non basta. Bisogna prendere la parola greca:
aktin.
« Oedipus rex».
Questa qualità Strawinsky ha in comune con Jules Verne, di un profondo
fiuto geografico, di conoscere anche i paesi che non ha mai veduto. La Grecia,
Strawinsky forse l’ha visitata da turista. Non so. Ma visitare da turista che
importa? La Grecia Jules Verne non l’aveva visitata mai, e, nell’Arcipelago in
fuoco, egli ha fatto vivere nella maniera più vera, più naturale, la Grecia
palicaresca del primo Ottocento.
Strawinsky, nell’Oedipus rex, fa rivivere in maniera altrettanto vera,
altrettanto naturale, la Grecia; non la Grecia strettamente edipica, né tanto meno
l’edipica Grecia parafrasata dai filologi, ma la Grecia di Edipo e di sempre; cosi
profonda identità è tra la Grecia di Edipo, di Giocasta, di Creonte, e la Grecia del
generale Plastiras.
Solo chi, come me, ha avuto l’onore di nascere in Grecia, può sentire le
qualità «razziali» dell’Edipo di Strawinsky.
Nei primi canti di Edipo (gorgheggi di uccello più che canti d’uomo) c’è
l'insouciance, c’è la leventia degli dèi giovani: Mercurio, Apollo.
Nell’accorato canto di Giocasta, c’è il dolore grasso, contenuto e insieme
sbracato, della magna-, la donna greca tanto del tempo di Edipo, quanto del
tempo di oggi; la donna che ha figliato, che cammina pesante e come legata per
invisibili radici al suolo, che sente tutti gli uomini come suoi propri figli, e la quale
altro modo non ha di opporsi ai grandi dolori che il cielo manda, se non di
afferrarsi con ambo le mani la testa posta in obliquo.
Tra l’ispanismo di Debussy (Iberia), l’ellenismo di Strauss (Elettra) e il
grecismo cosi radicale di Strawinsky (Edipo), fate il raffronto.
Anche per ragioni geografiche, si può essere musicisti migliori.
Quello che resta di Edipo.
Antonio Ghiringhelli, commissario della Scala, e Mario Labroca, direttore
artistico, mi commisero alcuni mesi sono lo scenario, i costumi e la regia
dell’Oedipus rex di Strawinsky; del che io li ringrazio. Lo spettacolo è andato in
scena il 24 aprile scorso [1948].
Lasciate che vi faccia una confessione: io vivo in una perpetua condizione di
felicità. E vivo cosi perché non do presa alla noia. E non do presa alla noia, perché
passo di continuo da poesia a poesia, da arte ad arte, da tecnica a tecnica. E i giorni
mi si svolgono come in un perpetuo viaggio nel paese delle novità. Sono come colui
che non ha mai visto Venezia, e un giorno si affaccia all’improvviso su Piazza San
Marco. Sono come colui che non ha mai veduto il mare, e un giorno da una vetta
della Liguria scopre all’improvviso la distesa azzurra del Tirreno. Sono come colui
che non ha mai veduto l’aurora, e una mattina da una riva d’Abruzzo vede
all’improvviso il sole sorgere dall’orizzonte adriatico e scalare il cielo nella sua
ruota di raggi.
La noia è la nostra peggiore nemica. Ausiliatrice della Morte. La Morte
commette alla Noia di prepararci a lei, facendoci morti in parte mentre siamo
ancora in vita. È la maschera della Morte quella pelle muta e incolore che io vedo
sulla faccia dei passanti in istrada, dei viaggiatori sui treni e sui tramvai, degli
impiegati negli uffici, degli operai nelle fabbriche, dei pittori negli studi, dei
letterati allo scrittoio, dei dirigenti ai posti di comando. In quella riforma
scolastica cosi urgente e alla quale nessuno pensa, i piccoli uomini saranno
addestrati a non vivere la vita se non in istato di freschezza. Ve la immaginate una
alimentazione composta tutta quanta di cibi avanzati? Tale tuttavia è questa vita
composta tutta quanta di vita avanzata... Noia. Fa gli uomini stupidi e malvagi.
Noia. Li porta alla brutalità. È per noia che gli uomini fanno la guerra. È per
timore di un nuovo insabbiamento nella noia, che gli uomini si preparano a nuove
guerre. Se tutti gli uomini fossero tutti distratti come me e divertiti (due participi
passati che hanno entrambi un comune significato di «lontano dal presente»), se
fossero contenti di sé, se fossero «pieni» di sé, puri dell’orrenda e nefasta voglia di
essere diversi da come sono, di possedere cose diverse da quelle che posseggono,
sarebbe possibile la guerra?
Il mio ultimo divertimento è stato questo allestimento scenico dell'Oedipus
rex. (Ma già sono passato ad altri divertimenti). In istato di divertimento, non si
bada a spese. Solo una parte dunque dell’allestimento scenico progettato da me è
andato in attuazione. Lasciate prima che io dimentichi del tutto questo
divertimento, che vi parli delle sue parti inattuate.
La tragedia di Edipo è la tragedia della trasformazione. Edipo, da come egli
sa, è figlio di un pastore. Le cose invece gli vanno come a uomo che vuole e può.
Incontra un tale che gli sbarra la strada: egli lo uccide e passa oltre. S’imbatte nella
Sfinge che gli propone un indovinello mortale: egli scioglie l’indovinello e rende
mortale l’indovinello alla Sfinge stessa. Si presenta a Tebe e Tebe lo proclama re e
gli dà in isposa la regina. Che può desiderare di più? Sono soluzioni da sogno. In
fondo i successi di Edipo sono le soluzioni sognate da tutti noi, e più schiettamente
nel tempo dell’infanzia, a cominciare da quel modo sbrigativo di aprirsi la strada –
e non mi si venga a parlare, qui, di ostacoli morali, queste scappatoie inventate
dall’uomo per giustificare a se stesso i propri insuccessi.
I successi rendon Edipo vano. È perciò che nella prima parte della tragedia,
io lo rappresento in ispecie di uomo piumato, che ricopre di una superficie
iridescente la propria vacuità interiore. Poi, quando Edipo viene a sapere su quali
abissi di orrore i ponti dei suoi facili successi lo hanno fatto passare, il piumaggio
gli crolla di dosso e la sua grande miseria interiore viene allo scoperto.
Edipo non è soltanto il simbolo di quei profondi e oscuri impulsi che Freud
ha raccolto nella denominazione di «complesso di Edipo», è anche il simbolo della
profonda e tragica trasformazione che nel tragico e profondo tempo presente va
compiendo l’uomo, il quale dalla condizione tutta comoda e sicura cui lo aveva
abituato il concetto di corpo e anima, e che la parte vulnerabile e mortale di sé era
compensata da una parte invulnerabile e immortale, ora passa, corpo e psiche, a
una condizione tutta vulnerabile, tutta transito, tutta miseria. Si parla di
esistenzialismo oggi e il volgo ne ride, compresi nel volgo tutti coloro che hanno
occhi e non vedono, hanno cervello e non pensano; ed esistenzialismo non è se non
la condizione dell’uomo che ha perduto il piumaggio di illusione che nulla
giustifica più, e deve rispondere in tutto e per tutto di sé.
Intorno alla trasformazione di Edipo, tutto dovrebbe trasformarsi. Avevo
progettato dunque che anche lo scenario si trasformasse; che i cittadini di Tebe
rappresentati dal Coro passassero dal bianco al nero e viceversa; che le colonne del
tempio e i capitelli girassero su se stessi e diventassero neri da bianchi, bianchi da
neri; ma lo spirito scolastico, che paralizza la vita in generale e in particolare quella
del teatro, non consenti allo scenario di moversi.
C’è anche una ragione più profonda perché lo scenario rompa finalmente la
sua incolore immobilità. Lo scenario rappresenta la natura, e la natura, che per i
naturisti del tempo di Goethe era esemplare immobile, noi, educati da una fisica
molto diversa, abbiamo il dovere di vederla nel suo naturale e continuo
movimento.
Scenario in movimento. Segnalo la mia intenzione di portare, mediante la
personalizzazione e il movimento, anche le varie parti dello scenario alla vita e
dignità del personaggio. Oggi l’attore opera in un ambiente morto: domani opererà
in un ambiente vivo, e la vita dell’ambiente non sarà espressa soltanto dalle luci,
queste troppo fedeli ancelle del pompierismo.
Mobile doveva essere anche l’Occhio dentro il timpano del tempio.
(Parafrasi dell’occhio di Dio nel triangolo). E doveva spiare le tragiche vicende
degli uomini, sotto, e frugarle, e ora tremolare di sorriso, ora spegnersi di noia, ora
fissarsi in una gelida e spietata indifferenza.
Il tempio è la casa degli dèi. Il tempio dunque non è vuoto come sembra, ma
abitato dei suoi inquilini. Nel mio progetto di sceneggiatura, gli uomini vivono
tragicamente, nella città, gli dèi vivono intragicamente nel loro tempio. Il Quale la
precisa qualità degli dèi greci? Quella di uomini che hanno superato la tragedia;
che hanno raggiunto quella condizione di «dilettantismo» che è la condizione più
alta e felice della vita; quella condizione che, se la vita ha un fine, è il fine della
vita; quella condizione cui io profondamente aspiro e cui qualunque uomo –
credete a me – può aspirare e raggiungere, basta che lo voglia e sappia rendersene
degno.
E mentre Edipo, Giocasta, Creonte, il Coro vivono giù la loro tragedia, gli
dèi, in bassa tenuta, vivono lassù la loro vita monda di tragedia; escono dal tempio
e vi rientrano; si appoggiano a riposo alle colonne e siedono sui gradini; guardano
le nuvole e gli uccelli che passano; seguono di tanto in tanto le vicende degli
uomini; si «divertono» ai guai che loro stessi hanno combinato... Finché la grande
pietà degli uomini muove gli stessi dèi a pietà. E allorché Tebe scaccia Edipo,
Giove, Mercurio e Venere scendono dal tempio – scendono dal loro
«dilettantismo»; vogliono seguire Edipo e confortarlo; ma certe manifestazioni,
noblesse oblige, agli dèi non sono consentite; e i tre dèi, l’occhio per la prima volta
appannato dal dolore, guardano Edipo solo e cieco che se ne va.
Nel mio bozzetto di scenario, il blocco intero della città, racchiusa tra il
tempio e la casa del re, è posato su un dado. Questo particolare «greco» vuol
esprimere quel che di oggettivo, di maneggevole, di portatile i Greci davano sia alle
cose che costruivano con le mani, sia alle cose che costruivano col cervello, e che
era un effetto del loro profondo sentimento atomico. Atomisti, i Greci mettevano
ogni loro studio a non lasciarsi sommergere dall’atomismo; da cui l’«oggettiva
immortalità» delle cose greche. Poi viene il cristianesimo che apre l’atomismo
come sentimento, e c’invita tutti a immergerci dentro.
9. Testi per proprie composizioni 1914*
I. Les Chants de la mi-mort, suite pour piano:
7. Abdication (Tempo di marcia – Assai lento – Lento)
Chant (femme)
Chant (homme)
Chant (femme)
Chant (homme)
Chant (femme)
Chant (homme)
Chant (femme)
Chant (femme)
Chant (homme)
Chant (femme)
Il se rua sur la table d'acier,
revolveré à les flacons émaciès.
Ah!... Ah!... Ah!... Ah!...
Je m'appele Julie,
je suis homme et fille.
Il revint après sa morte, ah, ah, ah, ah,
on l'avait livréau sort! Ah, ah, ah, ah.
Oui!
Pauvre roi! Pauvre roi!
Ah... Ah!... Ah!... Ah!...
Dammi questo fucile, per Dio !
Dammi questo fucile, per Dio !
Ah, ah, ah, ah
Ah! Eteignez ce phare,
si vous ne voulez pas me voir mourir,
cet homme, non , qui passe...
Ah, ah, ah, ah.
Ah, ah, ah, ah.
Je lui donnai l'amour gisant, élué.
Ah, ah, ah, ah.
II. Album 1914, pour voix et piano
avec une pièce finale pour voix, basson et célesta
1. Il cuore di Giuseppe Verdi:
Uomo
Donna
Preti! Preti!
Un passo ancor e scopro il suo cuor!
* Guillaume Apollinaire scrive del Savinio musicista ed esecutore: “egli non è affatto come la
maggior parte dei musicisti che, al di là della loro musica, non posseggono più alcun valore
[…] Non possiamo passare sotto silenzio il modo in cui Savinio suona: esecutore di una abilità
e forza incomparabili, questo compositore sta davanti allo strumento in maniche di camicia,
ed è uno spettacolo vederlo agitarsi all'estremo, urlare, fracassare i pedali, descrivere mulinelli
vertiginosi, picchiare pugni nel tumulto di passione, gioia, disperazione. E al termine di ogni
brano, si asciuga il sangue che ha macchiato i tasti". I testi si trascrivono qui dal booklet del cd
di Les chants de la mi-mort – Album 1914, eseguito da B.Canino et al., Stradivarius 1992.
Uomo
Ritagliato in carta rossa,
con le piume palpitanti
gonfio di voce, ah!...
Preti!...
2. Le général et la Sidonie:
Chant (femme)
Ah, ah, ah, ah, ah.
Voici la Sidonie de fer
qui etrangla le général...
Ah, ah, ah, ah.
3. Je me sens mourir de néant:
Basse
Je me sens mourir de néant
le blond est endormi.
Baryton
Ah!...
Donna
Ah! Ah!
Basse
Je m'en vais mourir de néant.
Baryton
Pourquoi ? Pourquoi?
Donna
Ah!..
4. Bellovées fatales n.12 (La passion des rotules):
Chant (femme)
Ah! Il m'a touché de sa jambe
de caout-chou! Mama! Mama! Mama!
Chant (homme)
Tutto sa di rosa, Maria, per te...
Chant (femme)
Mama!
5. Matinée alphabétique:
Chant (femme)
Ah!
Voix
A.. BI... CI... DI...
Chant (femme)
A... BI... CI... DI...
Ah, tu me regardes, pâle nombril...
Rendez moi mes viscères
que je viens de vomir dans l' aiolé!
Ah, tu me regardes, pâle nombril.
6. Le fanal d'épiderme:
Chant (femme)
Danse oiseau, danse oiseau.
Mes poumons argentés.
7. La mort de M. Sacerdote:
Chant (femme)
Voici la maison où est mort
mon professeur Monsieur Sacerdote.
Imbecilli! Imbecilli!
8. Le doux fantôme:
Chant (baryton)
Et si tu crois mourir dans la...
Chant (basse)
Chant (femme)
Chant (basse)
Chant (baryton)
Chant (femme)
Prends ton livre des chants
et la bague d'argent,
car la mort doit revenir...
Vise au front!
Ah ! Ah! Ah! Ah!
Il a mis la collerette de fer blanc, à l'enfant...
Et si tu crois mourir...
Ah! Ah! Ah! Ah!
9. Amitié - Tragédie:
Chant (femme)
Mamma mia! Mamma mia!
10. Mes poumons argentés:
Chant (femme)
Mes poumons argentés!
Mon coeur est captif dans
le filet de mes veines
rouges et bleues.
Mes poumons argentés!
11. Les helmes dorées - Offrande:
Chant (femme)
Ha-hé-hou-ha-hi-a!
Pour toi je meurs, mon roi!
Ha-hé-hou-ha-hi-a!
12. Tirésias est mort
Chant (femme)
Ah...Ah...Ah...Ah...
Chant (homme)
Ah...Ah...Ah...Ah...
Chant (femme)
Tirésias est mort!
Ah...Ah...Ah...Ah...
13. Chant sans paroles
Chant (femme)
Ah...Ah...Ah...Ah...
14. La solitude (Couplet)
Chant (homme)
Pauvre chèvre, on t' atendue... Ah...
Mon navire est un poison d'argent.
Mère et toi mon frère et vous amis,
adieu! adieu!
Voix
In fondo tu sei sempre stato solo...
e allora? che cambiamento c'è?
Chant (homme)
J' avais un petit jou-jou
mais hier je l' ai cassé.
10. Savinio parla di sue opere
Parlo di “Orfeo vedovo” *
La parola del poeta è propriamente la voce della sua anima. Poche volte
questa voce grezza, questa voce-madre, si presenta non accomodata al vivere
civile. Di rado la voce del poeta parla direttamente; quasi sempre attraverso il filtro
del giudizio, della logica, dei principi morali, del pudore. La mia voce, finora, quasi
sempre ha parlato attraverso il filtro del pudore. Esigentissimo filtro.
Esigentissimo in me. Strumento d’igiene, ma anche strumento deformante.
Attraverso il filtro del pudore la voce dell’anima si vela d’ironia. Chi l’ascolta e vuol
capirla, deve guardare dietro il velo. Pochi sanno guardare dietro il velo. Pochi
sanno che, in certi casi, bisogna guardare dietro il velo. E stanno, davanti alle cose
mie, sordi, ciechi.
Mai la voce della mia anima aveva parlato cosi direttamente come in Orfeo
vedovo. Poche volte aveva parlato cosi fuori del filtro. Dico il filtro del pudore,
perché gli altri filtri, a cominciar da quello dei principi morali, io li ignoro. Nuda,
ingenua. Non dico coraggiosa, perché coraggio ignaro di sé, non è coraggio. Se mi
arrischio a questa confessione, è perché voi mi ascoltate ma non mi vedete, io vi
parlo e non vi vedo. Basta a giustificare la radio, questo tranello teso al pudore.
Preciso: direttamente, la voce della mia anima parla nel solo monologo di Orfeo: e
soltanto li.
Perché?
Alle cose che io faccio, non premetto significati. Le faccio «senza pensiero».
Finirò per credere all’assistenza di una musa — di più muse. Ma una grande
soddisfazione mi aspetta. Parlo per esperienza lunga. Nell’opera compiuta, e fatta
cosi alla cieca, io scopro di poi un organismo rigorosamente logico, raccolto
intorno a un significato, a più significati; chiarissimi, imponenti. Pensavo, dunque,
e non sapevo di pensare. Questa la cosiddetta ispirazione? Questo il cosiddetto
stato di grazia?
Cosi è avvenuto anche in questo Orfeo vedovo, composto di getto, parole e
musica, in meno di due mesi, nell’estate scorsa.
Orfeo è l’uomo. L’uomo superiore. L’uomo completo: il poeta. Indovinate?
Orphée c’est moi. E Orfeo non può fingere, non può velarsi.
La sua parola, formulata come parola, ampliata e prolungata nel canto, è
direttamente collegata alla radice. Troppo «pesante di profondità» da tollerare
veli.
Ecco l’argomento. Orfeo, uomo completo, «tutto poeta», viene a trovarsi
implicato suo malgrado nel vario sciocchismo degli uomini, della vita. Implicato
nello sciocchismo di un piazzista che crede di poter restituire a Orfeo, per virtù
meccanica quello che a Orfeo è venuto «momentaneamente» a mancare. Implicato
nello sciocchismo di Euridice, che sa di essere la moglie di Orfeo, ma di esser
anche la sua anima non sa.
Nello stesso aggettivo «vedovo», collocato nel titolo accanto al nome di
Orfeo, ho scoperto, a posteriori, una intenzione precisa. Vedovo Orfeo non è di
* Conversazione tenuta alla RAI, Roma, il 9 novembre 1950.
moglie: di quella Euridice che lo spettatore vede sulla scena; quella Euridice che si
rivolge e parla a un Orfeo che lei sola vede; quella Euridice che flirta col
dattilografo di Orfeo: vedovo è Orfeo, vedovo momentaneo, della Poesia. Ed è in
quanto momentaneo vedovo della Poesia, e dunque momentaneamente minorato,
che Orfeo cade momentaneamente nello sciocchismo degli uomini e della vita.
Quanto alle pallottole che la sua rivoltella spara, esse non lui, Orfeo, uccidono, ma,
intorno a lui, lo sciocchismo degli uomini e della vita. A lui anzi, Orfeo, consentono
di ritrovare l’«altra» Euridice, la vera Euridice: la Poesia. Più esattamente, il
complemento di se stesso. Stavo per dire il complimento.
Nota scenica a “Vita dell’uomo” (1951),
tragicommedia mimata e danzata
Sipario chiuso.
Un sol dei contrabbassi, annuncia che « qualcosa » ha inizio.
Breve introduzione del pianoforte (schumanniana). L’introduzione rimane
sospesa sulla dominante.
Sipario.
Preludietto dell’orchestra.
Meno il Protagonista (l’Uomo) che ancora non è nato, i personaggi sono
tutti in scena. Immobili. Disposti a semicerchio in fondo alla scena. Divisi in tanti
gruppi quanti sono gli episodi della Vita dell’uomo: i Personaggi dell’infanzia, il
Pedagogo, i Personaggi della vita militare, la Donna coniugale, gli Uomini d’affari,
ecc.
Sul fondale, a trofeo, gli oggetti implicati in qualche modo nella vita
dell’Uomo: un vecchio orologio di famiglia, fotografie, una nave che salpa, ecc.
In mezzo alla scena, le sàgome del Padre e della Madre. Più grandi del vero.
In bianco e nero.
I personaggi reali sono colorati: sono il presente. I Genitori sono il passato,
e il passato perde di colore. I genitori fanno corpo con la poltrona nella quale sono
seduti; sono quei personaggi che l’Autore, dipingendoli tante volte o scrivendone,
chiama Poltromamma e Poltrobabbo. Portano in fronte un occhio solo: enorme,
centrato da una pupilla nera. Il basso della gonna della Madre (frangia della
poltrona) è praticabile (termine teatrale).
Terminato il preludietto, ruota la pupilla nell’occhio della Madre.
Accorre, dalla sezione A, la Levatrice-Nutrice. S’inchina alla Madre. Ne
prende gli ordini. Ritorna alla propria sezione. Munita degli strumenti del mestiere
(forbice, asciugamano, ecc.) L-N entra, attraverso la gonna-frangia, nel corpo della
Madre.
Travaglio del parto.
Quantunque immobili, i Personaggi volgono, ciascuno dalla propria sezione,
una commossa attenzione alla Madre.
Su una doppia scala del pianoforte e sullo squittire del tamburo basco, esce
l’Uomo da entro il corpo della madre. Saluto alla voce dei Personaggi immobili.
L’Uomo è chiuso dentro il porte-enfant. Il porte-enfant è ornato di nastri turchini:
colore dei maschietti.
Emergono dal porte-enfant soltanto il capino e i piedini. Danza del
Neonato.
Il Neonato ha male al pancino e frigna. La Nutrice gli fa il clistere. Il
Neonato si calma al suono di un valzerino da giostra.
La Nutrice toglie all'Uomo il porte-enfant, l’Uomo appare vestito da
marinaretto. Finisce il Primo Episodio, comincia il Secondo Episodio: Infanzia.
Si staccano dalla propria sezione i Personaggi del Secondo Episodio: una
vecchia signora, un pensionato, il guardiano del giardino pubblico. Vengono al
proscenio, prendono parte alla vita del ragazzino; ora furiosi, ora giocosi e più
ragazzini di lui.
La Nutrice toglie al ragazzino la casacca da marinaretto, gli fa indossare una
giubba da collegiale. Il ragazzino diventa adolescente.
I Personaggi che hanno preso parte all’Infanzia dell’Uomo, ritornano alla
propria sezione. E cosi, via via, faranno i Personaggi degli episodi seguenti.
Si stacca dalla sezione C il Pedagogo e viene al proscenio.
Il Pedagogo è vestito da alfabeto greco e da simboli algebrici.
Inizia l’Adolescente allo scibile.
L’Adolescente impara la lezione a memoria: un po’ leggendo in quel libro
vivente che è lo stiffelius del Pedagogo, un po’ ripetendo a voce alta e col naso in
aria.
Si stacca dalla stessa sezione C una fanciulla che ha la magrezza e la
scorrevolezza della macchina da cucire. Vederla e innamorarsene, per
l’Adolescente è tutt’uno. Nelle sue giravolte agili e veloci, la Fanciulla se la dice col
Pedagogo, ma dell’Adolescente non s’accorge neppure.
Cala la palpebra sull’occhio dei Genitori: i Genitori sono morti.
Danza funebre, venata di lamenti.
Le sàgome del Padre e della Madre salgono in cielo.
Il dolore matura: l’Adolescente diventa Uomo. Entra nella vita militare. Poi
nella vita borghese.
Prima partenza-sbagliata. Risate. Nei momenti «difficili», l’Uomo ripensa
alla Fanciulla: suo primo amore.
Adulto, incontra la Donna coniugale.
Costei è vistosamente vestita, ha una testa d’oca, ma, davanti alla testa,
manovra abilmente un piccolo schermo a guisa di ventaglio, sul quale è dipinta
una faccia da donna fatale (jipo Greta Garbo). Sotto il fascino della donna fatale,
l’Uomo, che tutto sommato è fatto a pezzi di ricambio, si stacca dal petto il cuore,
si stacca l’anima (in forma di colomba), e li dona alla Donna coniugale. Le dà
anche gli occhi (occhiali da automobilista). Cieco, la sposa.
Vita coniugale, soffice e noiosa. L’Uomo, ora, è come Ercole da Onfale.
La moglie si addormenta.
Si staccano dalla propria sezione gli Uomini d’affari. Uno con testa di volpe,
l’altro con testa di porco. Spogliano l’Uomo e se ne ritornano alla propria sezione.
Si sveglia la Moglie, vede il marito nudo, gli fa una scenata e se ne ritorna
alla propria sezione, sbattendo la porta (immaginaria).
In questo momento difficile, l’Uomo ripensa alla Fanciulla, suo primo
amore.
Lampo.
Muta la luce. Muta «tutto». Mondo ideale. Non più il mondo com’è, ma
come desideriamo che sia. Doglia: neanche nel mondo ideale si entra senza doglie.
I Personaggi, convocati dalla Nutrice, circondano l’Uomo. Diversissimi. La
Donna coniugale non ha più una testa d’oca, ma umana e bellissima.
Disinteressatamente amorosa.
Il Pedagogo è desideroso di «imparare».
Gli Uomini d’affari hanno facce buone, oneste.
Offrono all’Uomo portafogli rigonfi.
La musica perde il ritmo precipitoso, si adagia in movimenti molli.
Ma il mondo ideale è un sogno.
Lampo.
Muta la luce. Ritorna il mondo com’è.
I Personaggi ritrovano la loro vera natura. Si mettono in colonna e, al suono
di un’acida marcetta, escono di scena.
Meno la Nutrice.
Costei veste l’Uomo da vecchio: gli caccia una calvizie in testa, gli lega una
barba bianca sotto il mento, gli mette un bastone in mano.
Solo e vecchio, l’Uomo è smarrito.
Ma ecco ritorna la Fanciulla sospirata.
Il Vecchio e la Fanciulla danzano assieme un valzer con variazioni.
Il Vecchio s’accorge che la Fanciulla è la Morte.
Terrore.
La Morte dice parole dolci e suadenti. Si faranno compagnia.
Il Vecchio si calma.
Andrà assieme con la Fanciulla, ma, prima, vuol salutare la Nutrice che,
sola, l’ha accompagnato per tutta la vita.
Il Vecchio usa alla Nutrice, quelle medesime cure che la Nutrice usò a lui,
bambino. Ritornano in orchestra i temini dell’infanzia.
La Nutrice si addormenta.
Il Vecchio e la Morte s’incamminano.
Si fondono in un personaggio solo.
Scende dal cielo la sagoma della Madre.
L’Uomo traversa la gonna-frangia: rientra nel grembo della Madre.
Tace l’orchestra.
Il pianoforte ripete, leggermente variata, l’introduzione schumanniana, e,
questa volta, si adagia sulla tonica.
Ottavino e contrabbasso conchiudono: questo su un sol basso, quello su un
sol acuto.
Cosi l’Uomo nacque, visse, mori.
Perché?
L’Autore di Vita dell’uomo, da un pezzo ci ha abituati a non domandare il
perché delle cose.
BRUNO BARILLI
Eugenio Montale
«Il paese del melodramma» di Bruno Barilli
(1931)
Vecchio amatore della nostra opera ottocentesca (e tanto meglio se
eseguita in teatri di provincia, da buoni cani nostrani, senza decoro e senza
emicrania, lontani le mille miglia dai golfi mistici e dai matadori
dell’orchestra);vecchio innamorato di questo torrente limaccioso disceso una
volta per sempre ad allagare la nostra storica e civilissima pianura musicale, non
posso che compiacermi di veder segnalato da un premio un libro di Barilli, anzi
il libro che solo Barilii poteva darci: si chiami esso Delirama o Il sorcio nel
violino o Il paese del melodramma.
Con precedenti di questo genere è naturale che il mio primo incontro
letterario con Barilli sia già piuttosto lontano. Ho recensito Delirama sei o sette
anni or sono; e sono poi ritornato sull’argomento a proposito del Sorcio. Che mi
resta a dire del Paese del melodramma? Poco di nuovo; ma quel poco in una
luce più giusta. La sorpresa che i mortaretti e i fuochi di Bengala di Barilli
potevano recarci al tempo della «Ronda», quello ch’essi potevano esprimere per
ragione di contrasto (accanto ai Pesci rossi di Cecchi) in quel paesaggio severo,
nobile, ma non perfettamente geniale, è passato col tempo. La sua polemica
contro i filistei e i mangiatori di ipofosfiti, la sua antipatia per le rarefazioni e i
borborigmi di una musica che non ci riguarda hanno ancora un significato, ma
in questo senso sfondano una porta che s e poi aperta da sé. Quello che resta più
vivo non sono né le girandole né le opinioni di Barilli; è l’arte di Barilli e il
significato di quest’arte.
Musicista per proposito e scrittore per vocazione, Barilli non è uomo che
abbia imbroccata tardi e quasi per caso la propria via. Il suo barocco non è stato,
come press’a poco tutti i secentismi letterari italiani, un’alzata d’ingegno o un
espediente a vuoto; è riuscito uno stato d’animo e perciò uno stile. E nel suo stile
Barilli ha travasato, ha addirittura rovesciato quell’empito musicale che non
aveva trovato strada aperta (dicono) nelle composizioni operistiche della sua
gioventù. Certo nessuno (tra coloro che hanno rispettato le regole dell’arte) è
anelato più avanti di lui nel giuoco delle metafore e delle analogie, nel labirinto
degli accostamenti inaspettati e dei fuochi d’artifizio. Con tutto questo, Barilli
non è riuscito dilettante né secentista. Partito dall’italianismo di Verdi e del
nostro Ottocento musicale, quest’uomo condannato per anni e anni ad
addormentarsi sulle poltrone dell’Augusteo nei pomeriggi dedicati alla musica
seria, ha continuato, su quella spinta, a musicare tra sé e sé il motivo unico che
poteva interessarlo: la sua avventura di italiano, nato sotto un cielo determinato,
tardo invitato a banchetti che parevano consumati da tempo, figlio di un popolo
tipico, visionario e positivo, erede di destini che sembravano esauriti. Attorno a
sé non vedeva che il monumento a Vittorio Emanuele, la pittura delle Biennali e
la musica di Zandonai. Della musica più recente era meglio non occuparsi.
Quella che giungeva d’oltre monte piaceva troppo agli abbonati delle poltrone
vicine: quando piaceva anche a lui doveva esserci un equivoco. Che fare? Dai
primi pretesti musicali doveva prendere la via la poesia di Barilli. Ascoltare le
nostre vecchie opere di repertorio, e più su anche Puccini e Mascagni dove
valgono meglio, con l’anima di un selvaggio che trova esotismo e magia dove
altri non avverte che luoghi comuni e oleografia, è stata la sua fortuna. Così dai
primi profili di direttori d’orchestra e di cantanti, dai primi resoconti veri e
propri, nei quali il filo della critica correva ancora senza troppi intoppi, egli è
passato senza inconvenienti alle trasfigurazioni più arrischiate, alle sarabande
lirico-critiche più imprevedute. Nelle ultime composizioni il pretesto critico è
quasi invisibile; nel Paese del melodramma, che si risolve in un
lungo «omaggio a Verdi» nella forma di una successione di poemetti in prosa, il
cielo e la terra, il campanile e le stagioni, il padreterno e il suggeritore sono
chiamati a tessere una splendida corona intorno al miracolo del Trovatore.
Un’unità, naturalmente, c’è in questa suite; ma è tutta nel temperamento di
Barilli. Se ci divertissimo, con la colla e le forbici, ad alterare l’ordine dei
frammenti credo che non sarebbe gran male e che l’autore stesso non se ne
accorgerebbe. I suoi frammenti si attraggono per virtù propria e trovano la loro
coesione nell’anima stessa del lettore; della musica partecipano ancora in
questo, che appena scatenati vivono per conto proprio e sulla pagina non
lasciano che un fastidioso e fin troppo materiale arruffio di segni neri. Scrittore
di pagine il Barilli non è; scrittore di accordi profondi sì. In questo senso le sue
prose più italiane di spirito e di intenzioni, quelle nelle quali la materia è più in
secco, ridotta quasi solo a una certa idea del «sentimento» italiano, sono ben
diverse da certe pagine del Sole a picco di Cardarelli, affini nella materia, ma
tutte disegnate, tutte scritte, tutte visive nella loro stessa trama musicale. Il
pregio di Barilli è in altra direzione: nella mutevolezza della sua onda, della sua
risonanza; in quel suo caricarsi e scaricarsi come una sveglia a carillon del
vecchio tempo; in quel suo promettere poco e mantenere sempre più di quel
poco; come se a tratti si scoprisse sotto la mezza tuba del saltimbanco l’alloro
sempiterno del giovane Apollo.
Quanto a musicalità di espressione non bisogna chiederne più che tanta a
Barilli, come si chiederebbe, che so, a una prosa di Campana o di un altro poeta
che s’appoggiasse su dati meno visibili; benché la preoccupazione di Barilli non
sia di tradurre in parole, in assonanze, in ritmi, una musica strumentale
preesistente, ma piuttosto di dedurne un complesso di reazioni sentimentali,
giovandosi di ogni sorta di effetti cromatici, di suggestioni visive e auditive. E il
punto d’arrivo non è forse la lirica, nel senso di una esperienza del mondo che
unifichi strettamente un sistema di rapporti intellettuali e morali (per quanto
pochi surrealisti stranieri abbiano le risorse di Barilli), ma l’autobiografia distesa
sul piano dell’intelligenza, il ritratto. Se fosse in giuoco solo l’intelligenza, è
chiaro, arte non si avrebbe ancora. Ma è singolare che il sigillo su questo mondo
caotico, irritabile e indefinibile sia posto chiaramente dall’intelligenza. Bisogna
tener conto di questo fatto per stabilire l’eccellenza di Barilli in un genere che
trattato con minore consapevolezza avrebbe tratto senza scampo lo scrittore nel
limbo senza avvenire di una prosa lirica raziocinante, troppo diffusa e inconscia
dei propri limiti per poter aspirare a un notevole significato nel mondo della
poesia contemporanea. Barilli non ha temuto di andar dritto ad una meta che ad
altri sarebbe parsa modesta o sconveniente; e ci ha dato quei suoi profili di
cantanti nei quali il prosatore gareggia in «corone» e in picchiettati con le gole
più inverosimili. Poi è andato più in là: e abbiamo avuto i ritratti di Cimarosa e
di Bottesini, di Verdi e di Puccini; e in fondo a tutto, su tutto, quello che
c’interessa di più: il ritratto profondamente italiano di Barilli, erede di una
scapigliatura passionale e musicale alla quale non è mancata in ogni tempo
onore e fortuna, e che è suo vanto aver richiamato alla luce con l’autorità di una
vita e di un esempio che ha saputo alzarsi contro il dilagante spleen intellettuale
con la foga e la convinzione di una vecchia cabaletta di repertorio.
(in Il secondo mestiere – Arte musica società, a c. di
G.Zampa, Milano, Mondadori, 1996)
B.B.
da:
Delirama
(1924)
Bottesini
Fu uno dei più geniali fra gli artisti del secolo verdiano, e fra i virtuosi il
più fantastico. Egli riuscì a spiritualizzare la grottesca meccanica del suo
strumento, soffiando su tutti gli ostacoli col fiato di un mistificatore prodigioso.
All’apogeo, questo artista sommo traduceva vivamente Paganini sul
contrabasso.
Figlio d’un’epoca nella quale i padroni della terra non erano degli
ingegneri, ma dei signori magnifici che una gerarchia intellettuale innalzava e
illuminava, incontro a lui si mosse graziosamente il favore di quel tempo
generoso e romantico.
Fino all’ultimo giorno egli mangiò il pane della gloria, poi fu dimenticato.
Con Giovanni Bottesini scomparve l’ultimo esemplare del contrabassista
virtuoso. Non lasciò eredi. La sua superba arte ¡strumentale gli mori a lato come
una sposa che non vuol sopravvivere.
Là dove egli era giunto, per un colpo mancino del genio e con la più
stravagante complicità della natura, nessuno potrà arrivare mai più, né farsi da
presso per capirne e spiegarne il miracolo.
Il suo posto solitario sta distrattamente al di là di ogni limite.
Ai suoi tempi il Gusto aveva una funzione, il Genio un carattere e l’Arte
una tradizione. La politica, questa scienza divenuta flagello, taceva subordinata
e sottomessa. I grossi affari di Stato lasciavano appena un’ombra di fastidio sul
volto dei ministri e qualche granulosa traccia di tabacco sui loro panciotti. Del
resto, le palle di cannone si contavano sulle dita, ed erano cosi pigre che,
contrariate da un vento forte, cambiavano direzione e finivano qualche volta per
tornare indietro.
In quel mondo spiritoso e volubile come la fiamma aggressiva e vacillante del
gaz, l’astrazione esatta non era preveduta: il baratro spettrale della luce elettrica
non s’era ancora spalancato dinanzi agli uomini.
In teatro si leggeva il libretto al fumo di una candela e, sulla scena, la pece
greca poteva rappresentare, senza opposizione, la collera degli elementi.
Anche la matematica soffriva allora l’umidità; e la meccanica, che viveva
in buona lega con il legname, scricchiolava faticosamente e si schiantava ai
primi geli" rimanendo ostruita e ferma sotto le stagioni.
Allora eran permesse soltanto le invenzioni buffe; le burle che facevan
crepare dal ridere eran di moda; c’era per la musica e per la danza del fanatismo
e del furore; l’Italia da Venezia a Napoli era un solo carnevale, del tutto
innocente.
Dunque, non per caso, un bel giorno il nostro pubblico si trovò fra i piedi
anche Giovanni Bottesini con il suo' contrabasso.
Quest’uomo che viaggiò il mondo tutta la vita e lasciò dovunque tracce
profonde di costernazione e di stupore, era grande di statura e aveva un aspetto
lunare e corroso, sciupato e assonnato, insomma un artista dal sangue guasto e
dalle abitudini dissolute.
Entrava in fretta all’ultimo minuto sul palcoscenico fradicio e semibuio
del teatro ducale, sbirciando, col collo torto, di tra le coulisses, il loggione stipato
di gente, mentre il servo di scena gli levava l’immensa pelliccia. Allorquando,
dinoccolato, si presentava tirandosi dietro, bonariamente, quell’enorme topaia,
tutti, del pubblico, ridevano e lui con tutti, a crepapelle.
Faceva volentieri della parodia; cominciavano prima i grugniti del
contrabasso; dopo si passava nel regno dei calabroni e ti pareva che tutta l’aria e
la luce brulicassero di pungiglioni. Allora quasi intontito tra il ronzare, nel
torpore e nell’afa sovraccarica di idrofobia, egli, il suonatore, rotolava, a poco a
poco addormentato, giù per la tastiera attaccandosi per miracolo, alla quarta
corda. Oh, quel russare profondo, voluminoso, inaccessibile, sembrava
confondersi con i trasalimenti assonnati dell’asse terrestre o con il lamentoso e
artritico scricchiolio di una stiva tappata e troppo carica!
Adagio, adagio, pigliava poi via, serpeggiando, con un tramestio obliquo,
cieco e dilungato, come rettile mostruoso che s’inselva.
Fin che si buttava, piegato in due, a suonare con voglia, sferzando
l’istrumento come per rompere una crosta dura. Dal credenzone spiritato
uscivano, allora, i suoni pili volubili, scivolando via stretti in successioni di
accordi e in glissandi veloci, leggeri e lucenti come i raggi che trafiggono le nubi.
Gli arpeggi, le corde doppie e i pizzicati azzeccati saltavano all’aria in una
prodigiosa mescolanza, formando una grandiosa e barocca architettura che
crollava precipitosamente, circondata e distrutta con furia da una sequela di
tonfi mistificatori.
Il suo era un cantare tutto invaghito e pieno di spasimo che somigliava,
sulla prima corda, a quello del violoncello, solo che il suono intonato era reso un
po’ enigmatico quasi da una maschera fosca che non desse di riconoscerlo.
La sua arcata dolce, interminabile, tenace, pacifica e distesa, e il suo stile
nobile, pieno di sentimento e di santità tant’opra facevano da persuadere e
indurre il trappolone puntiglioso e refrattario a parlare con voce ammansita,
soave, incalorita, fremente; e a sciogliere nel velluto d’un pianissimo, una per
una, le note sospirate e perplesse della più adorabile malinconia.
Niente lo accontentava. Istrione, disseppellitore di effetti sempre più rari e
pericolosi, egli si rifaceva sotto, mettendo, di nuovo, tutto a soqquadro per
stanare, scuotere e risvegliare il mostro sedentario.
Superando le difficoltà, cosi, a scalinate; sfasciando piramidi di ottave;
sollevando, in burrasca, il suo lento pachiderma sino alle stelle; con uno
scrollare avventato, astioso e gigantesco egli frullava l’arco tozzo e formidabile,
come una tramontana tempestosa, fra il groviglio dei cordami.
Echeggiava allora, fuggendo, sull’intrico temporalesco, un debole e
lontano scampanio di bronzi, insistente e ferale, e a quello ecco rispondere,
d’acchito, strangolata e vicina, l’anima sprangata e sordida del contrabasso.
Muovente dai silenzi stagionati, una voce gobba e sepolta di ventriloquo
si affacciava domesticamente fra le corde canterellando con una insolenza
ironica delle variazioni grottesche sul motivo del carnevale di Venezia-, la
modulazione oscena s’alzava audacemente di tono, poi ricadeva in mollezze
veneree dondolandosi, al fondo, sull’arco del contrabasso.
Quel che succedeva a questo punto in teatro è indescrivibile. Il pubblico
aristocratico deUa corte si torceva sulle poltrone in preda ad una ilarità stridula.
Gli applausi e le richieste di bis scoppiavano lungo le file scomposte, ad ogni
battuta. Le dame seminude e portentose, che facevan corona nelle logge dei
nobili, tirate in ballo senza preamboli s’ingegnavano di salvare il pudore,
ridendo inorridite dietro i ventagli.
Bottesini, appoggiato al suo carcassone di legno, s’inchinava, intanto, da
trionfatore.
*
Un cantante
Nazzareno De Angelis, la cui voce tempestosa e tonante sembra un afflato
voluminoso che esca dalle fauci di un mascherone greco, col suo primo entrare
non ha più riposo e non può quasi contenere l’ardore del suo superbo e cruento
temperamento: simile a un lussurioso il suo proprio sangue lo tormenta; egli
freme e sussulta repentino, leone che si sferza i fianchi con la coda, e dai suoi
grandi polmoni di bronzo lancia su le platee, con un colpo di spalla, note su
note, roulantes, massiccie e luminose come bolidi incandescenti. Il pubblico
investito da tanta violenza d’arte gli risponde come anticamente la folla
imperiale delle arene romane.
*
Elvira de Hidalgo
Nel quadro spagnolesco del Barbiere di Siviglia (questa opera che
rimescola il sangue giovanilmente, lieta e inebriante come un vino raro,
quest’opera indemoniata da crescendi orchestrali, che fanno una fulminea
propaganda di follia) tutto è imbroccato con una genialità leggera e favolosa.
Questo capolavoro, stravagante e superbuffo, è pieno d’un’ilarità musicale che
turba la ragione e suscita un pandemonio e un delirio parodistico. Rossini ci
appare là, nero, secco, grottesco eppure brillante, luminoso, colorito, tenero,
trasparente, spirituale e ammantato di fantasia e di romanzo come un
personaggio di Goya.
Il genio creativo ha un’incalcolabile forza trascendente. Il limite voluto e
raggiunto viene superato mille volte dall’impeto che ha generato l’atto; un
travaglio ulteriore che opera sempre più profondo e attivo dà all’idea un profilo
soggiogante; il personaggio diventa tipo, e il tipo a sua volta sorge dal simbolo
vivo e scoppia perfetto, come una rosa sbocciata, al sole crudo della realtà.
Allora la creatura nata singolarmente spicca tra la folla che la sfiora e trae seco
dall’origine, nella sua carne e nel suo spirito inconsapevole, i caratteri di uno
straordinario privilegio.
Come il Dio volante di Michelangelo crea, con un gesto lieve che sfiora, il
primo uomo sulla terra, cosi papà Rossini, questo mqptro di pigrizia e di genio,
nell’eccelso e onnipossente attimo della verve, con un soffio amoroso spinto
entro il tessuto impalpabile di una visione, dà lo sguardo, la voce e il sangue
miracoloso a Rosina, oggi, allo stato civile, Elvira de Hidalgo.
Elvira de Hidalgo è pur la figlia del grande pesarese. Lo dice quel
ventaglio che ella muove con destrezza gentile a nascondere il proprio volto,
quel ventaglio tremulo e vivo come l’ala duna farfalla, lo dice quella sua rara
moue d’un comico antico da théatre des bouffes, e la melanconia, lo dice, della
sua voce all’ultima scena notturna, allorquando, deposta li in terra, accesa, la
lanterna delle avventure galanti, splende l’amaranto della sua crinolina di
broccato ed ella esprime in tono di languore l’incantevole sospiro d’esser presa e
protetta nell’ombra calorosa di un epilogo matrimoniale.
Al suono innocente della sua voce che ha un timbro pallido e tenero come
l’argento, ricadono stroncate le mani minaccianti della critica e si spianano i
volti più sconvolti: note umili e ridenti spiccano il volo dalla sua gola e si librano
in giri per la sala come colombe bianche che rechino nel becco il ramo d’ulivo.
Un imbarazzo dolce conquista anche i più burberi controllori. Ella gorgheggia e
smorza il suono nel silenzio con una gemebonda malinconia che pare un’eco
della meraviglia o la fine di un colloquio infantile tenuto con la luna. Il gesto
delle sue dita di zucchero è pieno di candore e di moina e nel suo canto c’è la
mansuetudine, il pudore, il capriccio e l’inquietudine della più casta e volubile
bambina.
Allora le falangi della claque che serpeggiano per le gradinate circolari si
riposano con fiducia e tacciono con galanteria mentre giù scoppiano come
folgori le acclamazioni di mille spasimanti; e dietro le coulisses, simulacri
spezzati di stagioni dipinte, sotto i riverberi crudi e frantumati del gaz, nel
fumoso incantesimo giallo della pece greca che arde, il pompiere di servizio,
guardia assonnata dei lumi, preso di mano in mano nel sortilegio canoro, finisce
per piombare boccheggiando ai piedi della corista, idolo nuziale, bianca di gesso
e tinta di carminio come un confetto da tre soldi l’etto, vomitando a pacchetti
infiammati di Bengala le litanie accese della sua grande passione estemporanea .
.....................................................................
.....................................................................
......
Fra la babilonia sempiterna del cartone dipinto, in una stroppiatura
feroce della realtà, sotto l’azzurro disperato dei cieli, fra i lampi del magnesio
che fanno trasecolare i volti imbiancati e anneriscono gli occhi come olive
ardenti, si desta di soprassalto l’oro rimoto delle attrezzature e risplendono i
laghi nei regni bruciacchiati e secolari di Solimano. Là regna, come un principio,
la Spagnola con la sua vena strana di delirio canoro, intorno a lei nella gran luce
e nel vuoto piove la polvere di un mondo in consunzione.
Dalla fabbriceria degli ori armonici sale un ronzio sonoro di violini
appisolati; uno zufolo flebile e un fiatare roco di legni musicali, i violoncelli
vanno gorgogliando giù fino al fondo delle iridescenze, il fagotto borbotta fra
l’afa smaniando e gli ottoni accaldati sembrano digerire, sopra una nota lunga,
un sonnifero denso, nella gran siesta cocente del fossato orchestrale: la
Spagnola attacca con la voce indolenzita una boutade lunatica appresa al
sillabario puerile d’un usignolo, che sente molto il genere «crepuscolo», e la sua
voce sempre più esitante scompare in un indistinto naufragio di malinconia.
(in: Il sorcio nel violino, a c. di L.Avellini e A.Cristiani,
intr. di M.Lavagetto, Torino, Einaudi, 1982)
Roma sonora
(1932)
La buona acustica non è che il corollario, la limpida conferma della bella
architettura. Sono le stesse leggi di trasmissione, di ritmo, di equilibrio e
d’elasticità: tutto parte, rimbalza, si moltiplica, si accorda, ritorna; così anche il
suono, come l’acqua, corre vivo, come la luce, echeggia sui marmi monumentali.
Per questa ragione Roma è la città più sonora del Mediterraneo. Tutte le
voci del mondo si concentrano là. E una conchiglia. Il suono non muore mai,
non si cheta, scroscia nei suoi meandri: fragore ascoso, perpetuo. Un segreto
detto presto o tardi vien fuori; venature, cavità, orifizi lo riconducono all’aria.
Sotto i tuoi piedi c’è il dedalo: catacombe, cripte, labirinti – canali
evacuati dalla storia – Roma è costruita sul vuoto.
Innocuo e decrepito, laggiù, fra i pilastri di tufo, s’aggira un terremoto
rullando sul suo tamburo con una solerzia commemorativa degna di far paura,
ma non spaventa nessuno.
A mezzodì il colpo di cannone si ripercuote e sfiata nell’azzurro, e i sette
colli si dànno la voce.
Poi tre timbri, tre note fondamentali riprendono il discorso di prima: la
pietra, il bronzo, e l’acqua.
Più tardi il sole picchia sulla cupola delle basiliche come il martello
sull’incudine.
A Roma le ore del giorno sono altrettanti capitoli di un romanzo:
temporali, fontane, tumulti di campane riempiono le piazze d’un’armonia varia,
trasparente e profonda. I palazzi son dei veri « stradivari ». Le arcane facciate
fanno una curva corale intorno agli obelischi. I portoni son tante bocche che
vociano.
Clamorosa città che non dà tregua ai timpani, dove piazza Navona è
l’accordo perfetto.
Acustica fenomenale. Giuochi stupendi e liquidi; la gran piazza agonale è
un serbatoio immenso. Provati a sussurrare contro il muro una parola, se corri
presto puoi raccoglierla nell’orecchio cento metri più in là.
Anche le chiese contro le quali si frange lo strepito stradale sono
distillerie – gli esterni rumori là dentro diventano oro, oro rutilante sotto le
navate. E a piè dei tabernacoli trabocca mormorando, dalla spaccatura
dell’obolo, e cola come il miele, l’«osanna» secolare dei credenti – musica antica
e sommersa che spiccia adagio adagio dal travertino.
D’estate la luce vibra a vampate: fra il crepitare dei lauri e il gemere dei
pini, lontano, il grido strano dei pavoni. Sonnecchiano le fontane nei cortili, poi
d’un tratto nel sogno ride il getto come una sonagliera.
Il cielo di Roma è una cassa armonica. Quando è terso e scottante, se lo
scuoti rimbomba. Ricordate i boati, i petardi, il fragore che lo colmano nei giorni
di feste aviatorie?
La mattinata è bella e senza vento. L’idrovolante ad altissima quota
sembra attaccato al firmamento come una mosca allo specchio; eppure fila,
lavora, incide sul sereno. L’odi stridere lassù come un diamante sul vetro. Ma un
colpo di vento che lo fa ballare mette il cielo e la terra sottosopra – e cominciano
i loopings, le scivolate e le mugghianti riprese del motore. Si strappano i
cortinaggi del cielo; e per la strada la gente volta la testa in su. L’atmosfera
lacerata fa un rumore compatto. L’elica si vede, e sembra spargere il seme
dell’aria intorno a sé. Ma l’aviatore s’abbassa ancora, vien giù, a bella posta,
sulla casa della sua fidanzata: agita il braccio fuori della carlinga per salutare, e
mette in subbuglio la biancheria distesa sulla terrazza.
Nel pomeriggio festivo una vociferazione accaldata e continua trabocca
dalla galleria, dal tunnel, e si lancia a traverso il polverìo lucente e serale della
città.
Il pacifico e sterminato quartiere dei Prati è tutto invaso da quella
invidiabile cittadinanza bonacciona e sportiva che ha l’occhio fatto al
macchinismo pesante dei balli coreografici e ai portentosi giuochi del circo
equestre. Là si vuole il cocomero a grossissime fette, e lo spettacolo lungo,
grandioso, e popolare. Allora gli applausi scrosciano maestosi, alla romana, nel
vasto anfiteatro color sangue di bue. E dopo lo spettacolo, quando si esce
all’aperto, l’occhio spazia più riposato fra le cime dei palazzi sui quali il soffio
caldo del tramonto s’è spento a poco a poco.
Tramonto lungo, sonoro. L’urbe immensa vacilla sulle sue radici eterne,
si dilata, s’irradia come se avesse bevuto tutta la luce del mondo: cantano le
campane. La gente corre in disordine, tentenna incerta sulla via da pigliare,
sotto il terrore delle tenebre che stanno per calare.
E l’ultimo aviatore rimasto nel cielo guarda dall’alto la leggendaria città
impallidire in una lontananza liliale e sfaldarsi come un mucchio di ossa
bruciate.
Gradatamente l’abitato si copre d’ombra e di veli. È il momento degli echi
morenti, e degli spettri fiochi. Fra una conflagrazione di luci crepuscolari ti
sembra di udire, là dietro le millenarie mura, i colpi di spada battere lenti sullo
scudo dei gladiatori. Poi tre note, tre timbri fondamentali riprendono nel buio il
discorso di prima: la pietra, il bronzo e l’acqua.
In questo multanime istrumento solo il Tevere è tardo, silenzioso, torbido
– e scava nella campagna i suoi ghirigori che somigliano all’«esse» di un violino.
(in: Lo stivale, Roma, Casini, 1952)
Mario Lavagetto
Introduzione
a: Bruno Barilli, Il sorcio nel violino,
Torino, Einaudi, 1982
« je suis l ’homme qui ne croit pas à
la mort... d ’Emiral».
« Insonnia, delirio, fame,
Vizio, furore, vecchiaia.
La morte mi tiene alla gola
Io tengo alla gola la morte» (CV, 102) *
«La fine s’avvicina a gran passi, più veloce, più precipitosa
che l’inverno boreale» (CV, 78)
«Sono un pennuto, senza penne — magro sguarnito come
una gabbia — e ora vicino a me si sente in trasparenza un certo
stanco odor di uccelliera» (CV, 80)
«... non posso più vedere la faccia della mia faccia...» (CV,
87)
«Uh... uh... le nefande proposte... fra l’infimo mormorio...
e per di più, i segreti codicilli, di uno spaurito bruno barilli che malamente ancora respira... e sopravvive appena» (US,
310)
« Sangue, sangue, sangue — grida Otello Sono otto anni che questo grido mi scoppia dentro e mi
rompe le vene, i vasi biliari, il cuore, e anche le ossa me le man
da in pezzi e brucia i miei capelli, e mi saltano le unghie, dalla
rabbia, nel furore insorgente...» (T, l x v i i , 140).
La registrazione potrebbe essere protratta e attingere an
cora dai Capricci di vegliardo e dai Taccuini inediti, senza mai
alterare il timbro di una voce profondamente mutata da quan
do — sulle colonne della «Concordia» o del «Tempo», del
* Per le abbreviazioni si rimanda a p. x xx v u .
Nel citare gli inediti di Barilli ho ridotto al minimo i miei interventi
lasciando a errori di grafia e asintattismi il compito di documentare, sia
pure in modo approssimativo, lo stato dei Taccuini e dei dattiloscritti.
Dato il modo in cui lavorava Barilli, molto spesso le singole citazioni
presuppongono fonti plurime: mi sono limitato a un solo rimando per
non appesantire inutilmente questa introduzione.
VI
M ARIO LAVAGETTO
«Tevere» o del «Carlino» - si innalzava in stile fiammeggian
te e vertiginoso accumulando aggettivi, metafore, similitudini,
analogie prevaricanti e afïabulatorie. Quello stile inconfondi
bile e contagioso, che pareva a Cecchi « grandine e spruzzaglia
di rubini e di diamanti» e che induceva il trentenne Debene
detti (proprio nel momento in cui prendeva le distanze in no
me della «critica-critica») a inseguire Barilli sul suo terreno,
a denunciare la fragilità delle sue analogie per mezzo di ana
logie, quello stile - dunque - appare nelle pagine della vec
chiaia solo come una memoria attenuata: è più parca l ’agget
tivazione, più lineare e secca la frase, meno frastornata la lin
gua dal «continuo protendersi verso l’ipotiposi». Tanto che
qualcuno, ancora coinvolto mimeticamente nel gioco-Barilli,
ha parlato di «atmosfera da pianeta spento». La rottura è net
ta. Ma se ignorarla è impossibile e richiederebbe una specie di
sordità premeditata, sarebbe poi fallimentare limitarsi a pren
derne atto e abbandonare la ricerca delle permanenze, dei trat
ti costitutivi di una fisionomia che né gli anni né le metamor
fosi hanno avuto il potere di cancellare: «fra il primo e il se
condo Barilli - ha osservato in un saggio fondamentale Fedele
D ’Amico - la continuità non ha soluzioni, ossia [...] il secondo
non smentisce, ma chiarisce definitivamente la natura del pri
mo [...] La coerenza col suo passato è assoluta; talmente asso
luta che le sue ultime pagine sembrano contenere tutto di lui,
il succo di ogni suo significato». «G li artisti vecchi - scrive
rà lo stesso Barilli - costituiscono très souvent une revelation
retrospective» (T, l x i i i , 33). E altrove: «Non c’è giuoco più
stimolante che l’ultima partita [...] La flamme quand elle s’éteigne prend tous les couleurs» (T, l x v i , 19). Intanto i temi,
che sono gli stessi e vengono riproposti con insistenza, per
quanto su registri fortemente modificati; poi - anche qui, e sia
pure in modo più asciutto e perfino reticente - il bisogno,
quasi fisiologico, di pensare per immagini, di costringere ogni
«idea» a passare attraverso spessori concreti e a comportarsi
secondo il codice che ai poeti aveva prescritto, in anni lontani,
John Keats: razza di camaleonti, diceva, capaci di assumere il
colore delle foglie in mezzo a cui si trovano a passare. Tenia
mocelo per detto.
Sul mimetismo di Barilli bisognerà tornare ancora, ma da
subito vale la pena di sottolineare che l’oggetto primo di quel
mimetismo è una specie di personaggio di se stesso, che Barilli
si è confezionato quasi subito e a cui è rimasto intrepidamente
fedele: «... io, nocchiuto "Ecce Om o” davvero: gli stracci in
INTRODUZIONE
V II
torno, senza bastone, senza cappello, senza denti, senza fissa
dimora, e un fiore all’occhiello. Io terribile vagabondo» (CV,
42). Non mancherà qualcuno per avvertire, e con legittime
motivazioni, nel tratto troppo marcato ed esplicito di questo
ritratto il rischio di slittare nella maschera di maniera e di so
vrapporre all’ironia, pure rimarchevole e scopertamente inten
zionale, quanto è con essa meno conciliabile: e cioè una sorta
di narcisismo in sottotono, da cui può rispuntare quello che a
Gadda appariva «il più impennacchiato dei pronomi di perso
na». Ma quanto conta, di quella controfigura o di quella ma
schera che Barilli ha escogitato, è poi la strategia, è poi il pun
to di vista che essa consente. Se è vero che il romanziere dà
sempre forma, insieme ai suoi personaggi, anche a un suo nar
ratore che pagina dopo pagina, parola dopo parola finisce con
l ’acquistare una identità definita senza che nessuna premedi
tata connotazione lo abbia investito, un critico come Barilli
finisce, anche lui, per crearsi un simile doppio, un delegato
che è la sua voce, il suo stile, il suo stato anagrafico, la sua rico
noscibilità, la sua funzione, il suo contratto con la struttura di
attesa che egli stesso ha contribuito ad edificare. Voglio dire,
a scanso di equivoci, che quel personaggio è la prima, fondamentale e straordinaria invenzione di Barilli da cui conseguo
no, da cui vengono rigorosamente dedotte e a cui sono rigo
rosamente riconducibili tutte le altre: le scelte linguistiche, il
taglio del reportage o della recensione, la particolare struttura
dei motti di spirito, le rime obbligate, il moltiplicarsi degli ag
gettivi che sembrano nascere dalla ripetuta scomposizione di
un organismo monocellulare. «Barilli - ha detto con una for
mula felice Siciliano — scrive Barilli»: lo scrive negli articoli
di viaggio, nelle cronache musicali, nei taccuini. Invecchiato,
quel personaggio «non ha più la stessa voce»: gli si è fatta più
debole, più incrinata, non gli consente acuti e fiorettature;
è - tranne qualche cedimento - un sorvegliatissimo ed emozio
nante falsetto. Il timbro, ha ragione D ’Amico, è rimasto il me
desimo. Se mai, negli ultimi anni, con l’invecchiare di questo
sosia, con il suo progressivo abbandono del teatro e con il con
seguente affievolirsi delle sue funzioni, assistiamo a una specie
di fenomeno di riappropriazione per cui le «parti» tornano ad
avvicinarsi e, almeno parzialmente, a collimare quando, al cen
tro dell’obiettivo, resta - come abbiamo visto - «bruno ba
rilli».
«Come ha potuto succedere una cosa simile: che "n oi” era
vamo qui tutti e due insieme: io, e me stesso, senza il tempo
V ili
M ARIO LAVAGETTO
di fiatare, e non ci siamo quasi nemmeno seduti - e che l’uno di
noi due sia già scomparso? Di chi la colpa? - Il più grande
confusionario del momento: io, o me?
Quale danno incalcolabile! la mirabolante psicologia degli
specchi, su cui noi scivoliamo smarriti e ciechi in due: io, e un
altro me stesso» (US, 308).
Potrà anche sembrare che Barilli - nella vecchiaia - si eman
cipi da quel personaggio e che lo specchio finisca pian piano
col restaurare una identità o, se si preferisce, una confusione,
quando si modificano i rapporti e quando la mano è colta da
quella specie di «admirable tremblement du temps» di cui par
lava Chateaubriand. E tuttavia non si potrà disconoscere l’esi
stenza ancora immediata e suggestiva di quel fantasma funzio
nale, «io e me» che, se a tratti sembra allontanarsi, viene ripe
tuto e commemorato in ogni parola.
Un tempo, fedele all’immagine di una comunità «facinoro
sa» di cui aveva creato (con se stesso) il portavoce, Barilli ave
va dichiarato: « Il vero posto per fare il nostro mestiere sa
rebbe la galleria. A picco sull’orchestra ci vorremmo vedere.
Aggrappati alla coffa dell’albero maestro si può scrutare il ma
re. Non qui dalle poltrone di platea» (Tv, 18 febbraio 1929).
Una simile prospettiva dall’alto, come di un astronomo rove
sciato o di un eroe di Stendhal al declino, sembra essere privi
legiata anche negli scritti della vecchiaia, che investano il pas
sato oppure il presente. «Incastrata lassù, a trenta metri dal
suolo, la mia camera rispondeva su una specie di abisso citta
dino, di canale stradale, sempre immerso nell’ombra» (CV,
19). Difficile non ricordare allora «l’atelier nudo con un gran
de tavolo coperto di appunti» al quale, secondo Gottfried
Benn, l’artista, nella sua vecchiaia, «continua a salire in elicot
teri verdi come il veleno». Quinto piano dell’«enorme palazzo
Burroni» in vicolo San Nicolò da Tolentino, a pochi passi dal
la «luminosa e regale via Venti Settembre» (CV, 19). Barilli
sfrutta 11 suo osservatorio, in modo geniale, per dare corpo e
figura - con uno stile dove l’espressionismo si è fatto più
asciutto e quasi impercettibile - a una serie di folgoranti ve
dute dall’alto, di pozzi, di voragini, di giardini appiattiti, di
tetti comignoli e terrazzini sottostanti, di intrecci stradali,
di cortili dove i corazzieri appaiono come «nani tarchiati»
(CV, 20) e poi, «grama e sontuosa», la «Roma dei Torlonia»
(CV, 29). Le Convertite, la Mercede, le Fratte, i Due Macelli,
il Tritone. «Ma in alto, che respiro! » (CV, 23) «Qui è il mio
teatro, il mio mondo, il mio passato, la mia memoria, in giro
INTRODUZIONE
IX
tondo» (CV, 30). Oppure: « Il breve campanile di Sant’Andrea delle Fratte sorge in una magra rissosa luce di bordelli
medioevali, di viuzze angolose e vecchissime - io lo vedo da
qui, respirare - quasi a portata di mano - loggetta, o guardiola
che spunta in rapimento, non del tutto fuori di eresia» (CV,
30). La finestra è ormai quella dell’Albergo Torlonia, e la fine
stra, che - ha osservato Macchia - «era stata sempre il sim
bolo lucido della sua vita e della sua letteratura», gli offre la
cornice entro cui si delineano alcuni quadri di una «bellezza
nera»:
«Sotto la mia finestra: una voragine di verde, il giardino
chiuso di nobili edere, con l’alta palma, e gli aranci amari del
l’albergo Colonna - e a picco sotto il mio naso: una tettoia di
vetro dell’attigua tipografia, sulla quale saltano e ballano i topi
e le croste di pane, fra qualche straccio e carta di giornali»
(CV, 29).
«Vipere, fogne, canali di scarico - avrebbe commentato
Benn - questo è il preludio alle sere della vita».
« Io ho vissuto non ricordo più dove in compagnia di un’a
vida moltitudine di grossi topi. Io davo loro la caccia e ne ero
assalito sino agli occhi. C ’etait una lotta furiosa senza tregua
ils me grimpaient fra i pantaloni e io sentivo i loro piedi rapidi
e freddi scorrermi sulla pelle; come io li tempestavo di pugni
essi mandavan quelle piccole grida da far rabbrividire ed affon
davano in morsi feroci nella mia carne i loro musi pelosi» (T,
i, 20-21 ). Con queste parole inizia il racconto di un incubo che
si può leggere nel primo dei sessantasette 'Taccuini autografi
custoditi alla Biblioteca Nazionale di Roma: gli anni sono i
primi del secolo e Barilli è a Monaco, dove è «scappato» a po
co più di vent’anni, nel 1902, dopo aver seguito studi irrego
lari a Parma: prima le scuole tecniche e poi il Conservatorio,
cominciando «dallo studio del violoncello» (T, l x i v , 29). A
Monaco, in quella città che - pressappoco negli stessi anni appariva agli occhi di Wassily Kandinsky come «un Regno ad
dormentato reale, non fiabesco», Barilli frequentò i corsi di
«armonia contrappunto fuga e composizione, e la scuola di
direzione d’orchestra dove ebbe maestro Felix Motti» e dove
«a ventiquattro anni ottenne il diploma di maestro» {ibid.).
Le notizie che abbiamo intorno a questo periodo sono pur
troppo scarsissime e affidate a rigalleggiamenti occasionali, re
gistrate in un taccuino o disperse nelle incidentali di un arti
colo. Difficile immaginare, tuttavia, che Bruno Barilli, con la
X
M ARIO LAVAGETTO
sua instancabile voracità e il suo gusto della dissipazione, lui
cosi avventuroso e nobilmente zingaresco potesse presentarsi
con la freddezza velata di Adrian Leverkühn di fronte alla «ba
lorda e innocua atmosfera di vita, alla mentalità artistica sen
sualmente decorativa e carnevalesca di quella Capua sempre
contenta», «in cui una popolazione allegra e baldanzosa ... fe
steggiava i suoi saturnali». Più probabile, viceversa, che «la
bellezza e l’aspetto paesano della città monumentale, attraver
sata dal fiume montano sotto il cielo alpino, azzurro per lo sci
rocco», non si limitassero a blandire i suoi occhi, ma lo faces
sero realmente loro, lo catturassero e lo imprigionassero fino
a lasciare una traccia permanente nella sua esperienza. D ’al
tronde, se ricorriamo ai Taccuini e ne ricaviamo le poche «dia
positive» del periodo, ecco che - rimpicciolite dalla distanza
e dalla rapidità dell’appunto - vediamo apparire, come in fon
do a un binocolo capovolto, le scene del Prinzregententheater
e, in mezzo alle comparse del Don Giovanni, possiamo rico
noscere Bruno Barilli, divertito e nel contempo estasiato dalla
grande direzione di coloro che si succedono sul podio, in par
ticolare di Felix Motti e Bruno Walter (cfr. T , l x i v , 27), men
tre più discutibili gli appaiono le prove di un suo compagno
di studi, Wilhelm Furtwàngler, un direttore che non riuscirà
mai ad amare (cfr. T, x l v i i , 68-69). P °i è lo stesso Bruno Ba
rilli a salire sul podio, per un breve periodo, nelle vesti di so
stituto di Felix Motti, di colui al quale, in anni molto più tar
di, dedicherà uno dei suoi articoli più affettuosi e commossi:
«Fu il mio vero e solo maestro» (Tp.ill., 1939). A Monaco,
continua in quell’occasione Barilli, «cominciai la mia carriera
teatrale, come comparsa nei teatri di Stato, annaspando da un
palcoscenico all’altro, vestito da torero o da brigante» {ibid.).
Questa volta la ricostruzione è appena più insistita, dominata
dal gesto stilistico e tuttavia (nella povertà dei documenti)
non priva di un suo diffuso e suggestivo valore testimoniale.
« A poso a poco i carnevali di Monaco, la birra, i pittori, il
buon mercato, e le modelle, mi fecero dimenticare la musica,
e quando finalmente a ventidue anni entrai nel Conservatorio
di lassù, "Kònigliche Akademie der Tonkunst”, era soltanto
pro forma, per tacitare mio padre. La musica non c’entrava già
più, precipitavo, volavo, che so io; la mia giornata era una frit
tata e l’esistenza un proiettile.
Le mie esperienze non mi stancavano mai, le mie stanchez
ze non mi disgustavano. Allora trascorsi quella vita a rovescio,
piena di dispersioni e di disordine, che non riesco più a rica
INTRODUZIONE
XI
pitolare» {ibid.). Il quadro potrebbe essere lievemente arric
chito attingendo a notizie indirette: consultando il registro di
famiglia tenuto dal padre, Cecrope Barilli, si potrebbe, per
esempio, desumere, grazie allo scrupolo e alla meticolosità di
quel magistrale e a volte poetico pittore d’Accademia, quali
somme venissero mensilmente destinate al mantenimento di
Bruno. Si potrebbe, da lettere e appunti familiari, provare
che Bruno venne raggiunto — per un periodo probabilmente
assai breve - dal fratello Latino, più giovane di tre anni e an
che lui pittore dotatissimo che, dall’esperienza di Monaco, sem
bra essere stato segnato in modo decisivo, se — a partire dal
suo ritorno - comincia a dipingere, accanto a paesaggi dove si
distende la dolcezza del post-macchiaiolismo, anche una serie
di quadri impressionanti e stralunati, che possono apparire co
me l ’equivalente pittorico di certe pagine di Bruno più pros
sime all’espressionismo e all’abbandono fantastico.
Soprattutto, da aggiungere, sarebbe l ’incontro con una al
lieva dei corsi di pianoforte, la principessa serba Danitza Pavlovic che Barilli sposerà nel 1907, da cui avrà una figlia e da
cui si staccherà molto presto, lasciando che nell’assenza il suo
fantasma cresca e si dilati fino ad assediare l’ultimo dei suoi
taccuini, ombra inafferrabile ed enigmatica che può richiama
re alla memoria uno dei più diafani, inesauribili e inquietanti
personaggi femminili di James.
Ma più di tutto preme ora sottolineare quella «vita a rove
scio, piena di dispersione e di disordine», che Barilli non rie
sce più a «ricapitolare»: perché è da quel groviglio, da quel
gomitolo spugnoso e sfuggente di esperienze e di studi che na
sce lo scrittore Bruno Barilli. E nasce quasi di colpo, senza che
alle sue spalle (a parte qualche collaborazione sporadica con
«La lucciola» e la «Gazzetta di Parma») noi riusciamo a rico
struire una qualsiasi preistoria. I suoi anni di apprendistato
restano cosi avvolti nella nebbia e dobbiamo accontentarci
della breve luce che su di essi getta uno squillo di tromba,
insieme spavaldo e commosso, com’è ormai nelle abitudini e
nello stile del personaggio Bruno Barilli, solidamente piantato
sul palcoscenico della critica militante. «Qui a Monaco — ave
va scritto inaugurando il primo dei suoi taccuini - non c’è nul
la di nuovo, se proprio non si vuol considerare che sono arri
vato io» (T, i, 1). E quasi quarant’anni dopo: «quando il mae
stro è Motti, e lo scolaro è imo come me, mi par chiaro che ne
debba venir fuori qualche cosa di buono.
Difatti, quando ritornai in Italia, mi sentivo fortissimo.
XII
M ARIO LAVAGETTO
Ero, dai piedi ai capelli, quel che si dice un pezzo di musica,
e mi buttai a scrivere di musica sui giornali» (Tp.ill., 1939).
La testimonianza è cronologicamente inesatta. Tornato in
Italia Barilli per prima cosa sfoga la sua «forza» scrivendo
un’opera, Medusa, che sarà rappresentata solo molti anni più
tardi. « Il libretto di Schanzer », annoterà nei taccuini della vec
chiaia, «per me valeva un milione. Per me c’era l’illusione sa
pete quel che voglio dire? - L ’illusione, me la dava — voglio
dire che c’era già la mia musica - Esistesse o no questo libret
to — il miraggio c’era - e mi bastava» (T, l x , 79).
La sua prima prova come scrittore (la sua prima prova or
ganica e destinata ad avere un futuro) è del 1912, quando re
dige le sue corrispondenze sulla guerra balcanica a cui segui
ranno, due anni più tardi, quelle sulla guerra austro-serba. A
rileggerle oggi, colpisce subito l’immediata e altissima matu
rità stilistica; colpiscono la precisione e la fermezza con cui
Barilli delinea figure e colline, campi, interni, paesi distrutti
o abbandonati, le stazioni occupate dai feriti, gli ospedali da
campo, gli animali, i fiumi, le strade fangose, la miseria feroce
e implacabile che aggredisce le popolazioni. Chi arriverà a una
simile lettura con l’orecchio assuefatto alle cronache musicali,
avrà la sensazione che qui lo stile — seppure non essenziale
come nella vecchiaia - sia quasi raffreddato, quasi che le «cose
viste» funzionino da valvola omeostatka tra l’energia del linguaggio-Barilli e le pressanti richieste di quelle che Gadda chia
ma le realtà «intangibili», quelle, cioè, che segnano il «limite
inferiore di pertinenza della attività elaboratrice». Cosi potrà
accadere che la consapevolezza, qui molto acuta, dei limiti di
pertinenza, alleandosi con matrici sintattiche più o meno in
tenzionalmente orientate verso l’espressionismo, produca una
specie di grottesco-tragico e possa allora evocare le grandi
acquefprti che alla guerra Otto Dix dedicherà in anni più tar
di. «Un povero zingaro completamente macellato aveva le
labbra asportate nette da un proiettile e tutti i suoi denti era
no scoperti fino alla mandibola» ( W , 141). Ma si tratta di
esiti sporadici: quasi sempre l ’immagine è meno declamata e
aggressiva. E, in ogni caso, Barilli è da subito - come ha visto
molto lucidamente Macchia - uno che «gira il mondo contan
do solo sulle proprie forze». Vale a dire senza difendersi con
«riferimenti culturali» o con «citazioni», senza frapporre tra
sé e le cose nessuno schermo che non sia la sua ricettività pri
INTRODUZIONE
X III
vata e la sintonia con lo strumento linguistico che si è creato
e con il quale ha finito per identificarsi. Allo stesso modo, con
lo stesso tipo di mimetica premeditazione, Barilli si spingerà
attraverso la Danimarca la Svezia e la Norvegia fino al circolo
polare artico, soggiornerà a Parigi e a Londra, attraverserà lo
«Stivale» e la Spagna; oppure, raggiunta Città del Capo, ri
salirà fino alla Somalia e all’Egitto. Sulle sue pagine resteran
no «lo stimolo epidermico, l ’esotico, il pittoresco» che, se
condo Walter Benjamin, «prendono solo lo straniero»: Ba
rilli è, in questo senso, uno straniero di elezione, ma è anche
vero che nelle sue pagine di viaggio la «superficialità» è spesso
illuminata interiormente dal genio di una lingua intemperan
te, e qui controllata. A chi ne voglia conferma, basterà ri
leggere Il sole in trappola, e vedere allora con quanta forza
espressiva e quale smalto, con quale sicurezza lessicale e con
quale fedeltà al «dato» i singoli frammenti siano uno per imo
strutturati e incastrati lungo la «geodetica del racconto». Ba
sterà un solo esempio:
«Un deserto senza dune, senza palme, senza sfingi dal mu
so rotto, senza fogli di giornali inglesi sparsi in terra, senza
piste, né ombra di cammelli, né segni di passaggio umano
- vergine, intatto, fulvo, unico, solo - immerso in una quiete
luminosa.
Tutto uguale, tutto nuovo. La sabbia, pulitissima, di un
colore riposato e potente, non reca traccie di vento. Non è li
sciata né accumulata. Non ci son quelle striscie correnti e cri
stalline, quei veli superficiali, quelle serpentine che anche i
più fugaci squilibrii meteorici lasciano dietro di sé.
L ’aria è limpida e ferma e brucia leggermente senza divam
pare» (ST, 133).
Quella improvvisa sequenza di aggettivi (e non solo quella,
lo vedremo ancora) ha il perentorio potere di identificazione
di una impronta digitale. Ma preme sottolineare che, in que
sta specie di diario, non c’è accumulazione, non metafora né
similitudine, né figura retorica che non funzioni come, in fo
tografia, gli agenti rivelatori quando reagiscono sull’emulsio
ne e portano a galla l’immagine latente. Il dispositivo di cui
si serve Bruno Barilli appare, nello stesso tempo, artigianale
e capace di una precisione millimetrica, tanto che viene da
pensare a quale mirabile sussidio avrebbe potuto ricavarne
una spedizione di ricerca, se è vero che l ’etnologia descrittiva
richiede, accanto alla preparazione paleografica, storica e sta
tistica, anche precise doti di scrittura, le doti di «un roman-
XIV
M ARIO LAVAGETTO
ziere - azzardava Marcel Mauss - capace di evocare la realtà
viva di tutta una società».
Il viaggio in Africa di Barilli comincia nel dicembre 1931.
Pochi mesi prima, il 19 maggio dello stesso anno, è iniziata la
spedizione di Marcel Griault, di cui straordinaria testimonian
za è rimasta nel diario di Michel Leiris, L ’Afrique fantôme.
I due itinerari non si incrociano perché mentre Barilli, sbar
cato a Città del Capo, risale verso nord fino alla costa dei
Somali, Griault e Leiris attraversano l’Africa lungo la linea
dell’equatore, da Dakar a Gibuti. C ’è solo il Mar Rosso in
comune: appena accennato da Leiris (che si sente ormai oltre
la fine del viaggio), e descritto, viceversa, con stupefatta insi
stenza da Barilli. Ciò non toglie che L ’Afrique fantôme possa
- nella sua radicale diversità - consentire una ulteriore e più
sottile definizione del lavoro di Barilli. Leiris è certo un viag
giatore più attrezzato e diffidente, più legato al contratto di
una stenografia quasi quotidiana: «non conta solo sulle pro
prie forze» e sfugge sistematicamente l’esotico e il pittoresco
che, quando lo seducono, vengono poi sterilizzati dalla regi
strazione telegrafica e dalle maglie di una rigidissima paratas
si, a cui si affida una specie di retorica del viaggio. È più at
tento alle forme e alle articolazioni del tessuto sociale e agli
incidenti di un itinerario meno codificato e prevedibile, ma
- soprattutto - il suo diario è, come ha riconosciuto lo stesso
Leiris, in una recentissima prefazione, «à double entrée»:
è il resoconto di una spedizione, ma è anche, in maniera pro
gressivamente più marcata, pagina dopo pagina, il resoconto
di uno sguardo particolare, battezzato, costruito e intorno a
cui si organizza la fisionomia di un occidentale «mal dans sa
peau, qui avait follement ésperé que ce long voyage dans des
contrées alors plus ou moins retirées et, à travers l’observa
tion scientifique, un contact vrai avec leurs habitants ferait
de lui un autre homme, plus ouvert et guéri de ses obses
sions »* di un occidentale che, nel 1934, al tempo della pri
ma pubblicazione, enunciava lucidamente il suo programma:
«décrire ce voyage tel quel je l ’ai vu, moi-même tel que je
suis».
Barilli, al contrario, sembra avere edificato intenzionalmen
te il suo testo con un’unica entrata: le sue immagini e i suoi
frammenti sono pressoché privi di specularità; il suo occhio
resta impercettibile, mentre quello di Leiris occupa man mano
il centro del «fantasma». Probabilmente un etnologo guarde
rebbe con giustificato sospetto un simile occultamento che
INTRODUZIONE
XV
rende in ogni caso più problematico il calcolo degli indici di
deformazione, ma come non riconoscere - in una luce diver
sa - le premesse di un originale partito preso, di una calcolata
e fruttuosa cancellazione di sé? Una cancellazione caratteri
stica di tutto il Barilli viaggiatore e tanto rigorosa - nel ri
spetto di una specifica professionalità - da accantonare le
«ossessioni», che pure vivevano in lui, e da non concedere
mai la parola a chi, in lui, si teneva «mal dans sa peau».
Per riconoscere questo Barilli dobbiamo tornare al 1915,
quando compone la sua seconda, ultima e più amata opera
Emiral, un atto unico di cui lo stesso Barilli scrive il libretto
e che va in scena, con poco successo, nel 1924, dopo essere
stata premiata, l’anno prima, da una giuria presieduta da Gia
como Puccini. «Je ne prouve aucun embarras - griderà nella
vecchiaia - à dire que mon opera Emiral est un chef d’euvre»
(T, L X i ii, 148): «un chef d’euvre nié [...] un petit chef d’eu
vre, nié sans documents, ou pieces d’identité, qui n’a pas
l’anzianità, comprenez-vous, un chef d’euvre petit, encore pe
tit, mais tout de meme sur la route de la immortalité» (T,
LXiii, 135). Una simile profezia è — prima di tutto - patetico
esorcismo e patetico scongiuro: né vale, a smentire una tale
interpretazione, che Barilli dichiari sciolto «ogni vincolo» tra
se stesso «e l ’autore e l’opera» (T, l x i i i , 167-168). D ’altron
de l ’anzianità, che nel frattempo si è accumulata, non sembra
avere giocato molto a favore di una partitura spavaldamente
allineata, in un altro taccuino, con il Fidelio, il Trovatore e il
Don Giovanni (cfr. T , l x v , 31 bis), se — in occasione della sua
ripresa nel decimo anniversario della morte - un ascoltatore
benevolo e intelligente come Fedele D ’Amico, dopo aver po
sto e lasciato in sospeso la domanda «Che vale il compositore
Barilli? », se la cava aggregando, contro le convenzioni, Emiral
alla scuola verista e riconoscendole (ma di sfuggita) «una sem
plicità, freschezza, candore che la tengono piacevolmente lon
tana dagli eccessi, dalle bravate sentimentali cosi frequenti in
quella». Si può essere d’accordo con questo elogio in sordina
e, lasciando ai musicologi il compito di un’eventuale (credo
improbabile) correzione di tiro, varrà la pena di sottolineare
come Barilli, fino all’ultimo, abbia visto in sé, con rabbia e di
sperazione, un compositore, un musicista misconosciuto e for
se anche tradito dal suo stesso talento letterario.
«Enfin, il passa critique». Avesse o no ragione Balzac,
quando vedeva in una simile metamorfosi la prova incontra
XVI
M ARIO LAVAGETTO
stabile dell’impotenza creativa e della fallacia di oroscopi fa
vorevoli ma prematuri, è un fatto che la critica musicale di
Bruno Barilli nasce e assume una fisionomia nei nove anni che
intercorrono tra la composizione di Emiral e la sua prima rap
presentazione. Dal canto suo Barilli cercava di non recidere un
legame, che doveva apparirgli vitale e che gli permetteva di
scommettere sulle sue doti di musicista, e dichiarava, sotto
specie di aforisma, che l’arte e la critica «sono due passioni
in gara - l’una iniziale, l’altra subordinata. Ben di rado la se
conda supera la prima - comunque l’artista le possiede ambe
due» (Fase. i). Era un modo per non credere alla morte di
Emiral e per mantenere aperta - almeno ai propri occhi — la
possibilità di una resurrezione. Come certi animali marini che,
per difendersi dal freddo e dalle acque dolci (dove talvolta si
trovano a vivere), sviluppano capsule chetinose e resistenti,
«gemme» o «uova invernali», al cui riparo l’esistenza risulta
garantita, Barilli trova nella critica - in una particolare, perso
nalissima, molto connotata specie di critica - un guscio che
sembra assicurare una vita, per quanto grama e larvale, al com
positore che è in lui. È un fenomeno ben noto, e che spesso
è documentato da taccuini segreti in cui, lontano dalle pagine
ufficiali, si depositano «veleni» corrosivi, rivalse, epigrammi,
giudizi sferzanti e non coperti da alcuna convenzione.
I Taccuini di Barilli pullulano di atrocità: «Respighi è co
me il pavone, apre la coda e non si vergogna di quel che scopre
dietro di sé» (T, xxx, 33). «La musica del maestro Pizzetti
non esiste, e se mi stuzzicate vi dirò in un orecchio che non
esiste nemmeno il maestro Pizzetti» (T, xx vn , 23). «A d ogni
raffreddore Casella cambia stile e strada musicale. Quando
egli annuncia al pubblico dei concerti "questa è la mia ottava
maniera” vuol dire che la sua testa s’è per l’ottava volta riem
pita d’acqua piovana» (T, xxxv, 78). Mascagni: «Dal giorno
che nacque in poi la sua importanza non fece che diminuire
continuamente» (T, ix, 5).
Ma con la sola eccezione di Mascagni, a cui vengono dedi
cati articoli deferenti e a proposito del quale Barilli, in un al
tro taccuino, dichiara di non dire volentieri quello che pensa
(cfr. T, x x v ii, 107), bisogna riconoscere che anche in pubblico
i riguardi non sono molto pili alti. Così, quando riapre la sta
gione, Barilli estrae dal proprio talento di scrittore una simi
litudine programmatica: «Ecco venuta l’epoca dei più strani
uccelli di passo: esotici, zazzeruti, cerimoniosi emigranti bian
co-neri, dalle ali larghe che s’agitano lentamente come venta
INTRODUZIONE
XVII
gli nel cielo di Novembre. È venuto il momento di drizzar le
orecchie come fa il cane quando il padrone stacca il fucile dal
muro» (RdC, 4 novembre 1927). E allora Boi to non sarà il
«porco» dei Taccuini (T, l x v , 28 bis) o «il primo dei nemici
del teatro italiano» (T, l x , 39), ma «se fa l’atto di trattenere,
di sospendere e di innalzare la musica, gli viene il fiato grosso,
la vista gli si intorbida, e suda, l’autore di "Mefistofele”, come
un Polifemo costretto a scrivere in bella calligrafia» (Cor.it.,
2-3 maggio 1924). «Pizzetti è un musicista tirato su con l’in
cubatrice. Quando lo conobbi stava tra Pinco e Catalani. Poi
Catalani scomparve. Pazienza!» (Tv, 6-7 febbraio 1929). O,
per finire con una pagina più conosciuta, « Alfredo Casella, pia
nista europeo, il più stonato e il più placido dei nostri compo
sitori, l’apostolo, per cosi dire, della nota falsa» (DI, 43).
La moltiplicazione degli esempi non serve solo a docu
mentare la capacità epigrammatica di Barilli o a mettere in
guardia contro un critico che è, e si vuole, rissoso e passiona
le, che a volte è livido, quasi sempre settario, intransigente e,
nello stesso tempo, preso da una specie di frenetico narcisi
smo linguistico. Quelle citazioni, se usate come indizi, posso
no aiutarci a capire la specificità del punto di vista scelto e
privilegiato da Barilli, possono indirettamente illuminare i
suoi interessi fondamentali, le sue idiosincrasie e le sue predilezioni che sono quelle — l’ho detto all’inizio — di un personag
gio critico ritagliato accuratamente come portavoce di un pub
blico facinoroso, di un pubblico di cui sarebbe certo difficile
stabilire la probabilità storico-sociologica, ma che tuttavia
esisteva nella immaginazione di Barilli; di uno che dichiara
va: «J’immagine, laissez-moi dire, sans imagination il n’y a
pas de réalité savez-vous?» (T, xx, 16).
In piena coerenza con simili premesse Barilli, che ha scritto
due opere sfortunate, è soprattutto un critico del melodram
ma, nel senso che li — in quella forma spuria e bastarda, guar
data per lungo tempo con diffidenza dalla cultura letteraria si verifica in tutta la sua pienezza fisica, in tutta la sua inquie
tante alcatorietà il miracolo teatrale: un «fatto», un evento,
una scena drammatica in cui sono coinvolti nello stesso tem
po l’orchestra, i cantanti, gli scenografi, i costumisti, i tecnici
della luce, il pubblico. Quello che preme sopra ogni altra cosa
a Barilli è il teatro, il teatro lirico dove il dramma, disegnato
sommariamente da parole che si consumano, è completamen
te affidato alla musica: il libretto, un buon libretto - non si
stancherà di ripetere — deve essere «schematico e fiero» co
2
XVIII
M ARIO LAVAGETTO
me quello del Trovatore o del Fidelio (T, l x , 33); «stecchito
come un attaccapanni» (T, xxxi, 87), esclude i grandi poeti
perché nell’opera c’è posto per una sola, superba e dispoti
ca personalità, e le parole debbono essere «come i sassi che
non si vedono in fondo al torrente se l’acqua è profonda» (T,
x x v iii, 25). «Le parole nella musica - dirà in un’altra occa
sione - s’adeguano alla misura del fiato, si gonfiano, s’allun
gano e si spappolano come il riso nella minestra. Anzi direi:
le parole si aprono nella musica grandi, immense, e vengono
giù col paracadute. Nel volo si perde il loro senso letterale
- e ne aumenta a dismisura quello sonoro» (T, l x v i , 40).
Manrico, Azucena, Violetta, Don Giovanni, Mimi appaiono
cosi le luminose e drammatiche incarnazioni di ombre lettera
rie dimenticate e irrevocabili. Intorno ad esse il teatro lirico
vive la sua esistenza totale: e per Barilli quel teatro dovrebbe
essere piccolo, raccolto, saturabile - in ogni millimetro cubo
del suo spazio - dal miracolo che si realizza, dalla fiaba che
non conosce più confini di spazio e che occupa, ilare e persua
siva, ogni angolo e ogni anfratto. Tutto quanto appare come
deformazione di quel miracolo, come variante arbitraria di
quel codice fiabesco, che deve conservarsi ereditariamente ed
essere infranto da una musica nel contempo memore e inno
vatrice (cfr. T , xxxv, 47), va combattuto ed estirpato. Barilli
difende la sopravvivenza di una sua idea di teatro, di quel
melodramma italiano che per il pubblico dell’Ottocento era
stato una specie di «Macchina infernale» (Verdi, 33) e in cui,
sopra tutto, lo affascinava il rischio di un’opera d ’arte « tutta
speciale, costruita sul ciglio d’un abisso di ridicolo» e tenuta
a galla, «a forza di genio», in prodigioso equilibrio {ibid.).
E in nome di quella idea Barilli compirà anche gli unici
tentativi di intervento politico. Dopo aver ottenuto (ma per
un breve periodo) «camicie bianchissime» dal fascismo (cfr. T,
x v iii, 9), chiederà anche - ma invano - una riforma dei teatri
liriçi che «sono divenuti dei mattatoi verso i quali le opere
del nostro repertorio si lasciano condurre senza riluttanza»
(«La Stirpe», settembre 1926). Non è il solo, tra gli intellet
tuali, che si illuda di trovare in Mussolini uno strumento per
realizzare i propri progetti di settore, e non è il solo a doversi
accorgere che non è l ’ora dei compositori e dei critici, dei poe
ti e degli scenografi: «è l’ora di Starace» (T, x x vn , 130). Il
teatro lirico resta nella decadenza ed è questa decadenza che
agli occhi di Barilli spiega l ’insuccesso delle sue opere, il trion
fo della musica scolastica e imparaticcia, dei «tecnicismi», del
INTRODUZIONE
XIX
le mode, delle «teorie astratte»: spesso - si dirà - è Barilli
a non capire o a deformare i bersagli, ma se questo può essere
un giudizio sul valore delle sue battaglie (a volte inutili, stre
pitose e donchisciottesche), nulla toglie al suo modo di eserci
tare la critica militante con il piglio aggressivo e spavaldo del
paladino o del livellatore. E quando, nell’ultimo dei suoi tac
cuini, dichiara sornionamente di avere «nel posto del cuore
[...] un teatro» (T, l x v i i , 71), ha certo ragione chi - conoscen
do queste parole - le legge come un «paradosso surrealista»
(si potrebbe perfino pensare a una didascalia per Magritte),
ma sarebbe un errore dimenticare che, oltre il surrealismo,
quelle parole sono anche un rigoroso stemma biografico, il bla
sone di un’esistenza che ha trovato nel teatro, nel profumo
delle quinte e dei praticabili, nei corridoi che circondano la
sala, in platea o in alto, aggrappato « alla coffa dell’albero mae
stro», nelle gallerie, nei vestiboli dove arrivano attraverso «le
porte velate le frasi dei cantanti, e gli scoppi dell’orchestra»
(T, Lx, 6-7), che ha trovato in tutto questo l’alimento della
propria scrittura e della propria immaginazione. E allora biso
gna «essere più feroci d’una volpe legata in un sacco» (T, xiv,
24).
«Ciò che veramente lo affascina - ha scritto Fedele D ’Ami
co - è il rischio di un evento che si propone, per sua natura,
in forme sempre rimesse in questione, e perciò è figura di quel
caduco miracolo al quale soltanto egli riconosce realtà di vita».
L ’irripetibile unicità dello spettacolo teatrale, sempre diverso,
mai chiuso in uno stampo bloccato, funziona insomma per lo
spirito avventuroso di Barilli come un «elisir del diavolo»:
gli dà invenzione, grazia, immagini e sicurezza stilistica, gli dà
ordine e tono, vitalità, leggerezza. G li consente anche di fis
sare la sua pratica di critico e di ascoltatore con ima similitu
dine abbagliante e decisiva: « C ’è chi, a sentire la musica, bal
la: noi scriviamo. È un fatto macchinale; ascoltando con tanto
d’orecchi scriviamo sotto dettatura. Lavoriamo in poltrona,
nel buio del teatro o del concerto, ritiriamo poi la nostra lastra
che non ha bisogno d’esser sviluppata in bagni acidi» (Tv, 20
maggio 1927). La conoscenza dei Taccuini impone, senza om
bra di dubbio, una certa cautela nel prendere alla lettera que
ste parole di Barilli: e tuttavia ne conferma il valore illumi
nante, conferma l’essenza di una critica che si vuole scritta sot
to dettatura, in perfetta sintonia con la musica. Sulle pagine
del taccuino, nel buio, con una grafia disordinata e frettolosa,
finiscono immagini discontinue, registrazioni telegrafiche che
XX
M ARIO LAVAGETTO
avranno poi bisogno di essere « sviluppate e organizzate in un
tutto coerente». Ciò non toglie che sia quasi impossibile im
maginare Barilli al lavoro sulle partiture o nel chiuso di una
stanza di fronte a un fonografo: le sue parole nascono in quel
l ’atmosfera febbrile, vibrante e surriscaldata. Non è certo uno
di quei musicologi che «portano sempre un volume sotto il
braccio» (T, x i i i , 4), non si cura delle teorie, non sa cosa far
sene, si schernisce: «Intellettuale io, per carità» (T, l x v ,
26 bis): «naviga nei suoi succhi originali. Che viaggio d’incli
nazione! Il suo fluido rimane inalterato ed egli ritrova sempre
il suo innocente tornaconto al totale. Natura e umori creano
in lui gli accordi pieni e diversi d’una avventura profonda e
senza fine» (Tv, 20 maggio 1927). Ci sediamo in poltrona per
ascoltare la Tetralogia e partiamo «dal livello dei palombari»,
«siamo sotto le acque del Reno» (T, x l i v , 2); là, sulla scena,
si consuma la tragedia del re Macbeth e «la musica nasce [...]
alle radici stesse del dramma», lo strumentale - «fatto di ven
to, di cigolii e di misterioso abbandono» — sembra appena
uscito «da un barattolo del laboratorio del dottor Mabuse»
(T, x l i v , 67-72).
Lui, Barilli, che vedeva nel lavoro di composizione un viag
gio (cfr. T, LX , 2-3), uno «slancio», che difendeva 1’«ispira
zione» contro la «tecnica», che condannava gli «esperimenti
scientifici» dei compositori moderni (cfr. T, x, 1) tra i quali
era disposto a salvare, senza troppe riserve, il solo Strawinski,
che faceva venir fuori «opere melodrammi tragedie» di Verdi
«dalla noia di questo misantropo immalinconito» durante le
giornate d’autunno a Sant’Agata (T, x l i v , 60), che appariva
dotato di una apparecchiatura molto modesta o che, comun
que, si preoccupava di nascondere la propria apparecchiatura,
non poteva, come critico, esimersi dal guardare con diffidenza
le indicazioni dell’estetica, di ogni estetica, anche di quella cro
ciana davanti a cui molti dei suoi contemporanei (gli pareva)
si fermavano come «davanti a un distributore di benzina»
(T, l x v i , 22). Dal canto suo preferiva affidarsi all’intelligenza,
cioè alla «percezione occasionale» di tutto quanto era nell’a
ria o a mezz’aria all’interno di un teatro (cfr. T, l x v i , 34), la
sciando poi che la ragione, la sua ragione, trovasse il modo di
conciliarsi con verosimiglianza e verità (cfr. T, l x v , 18 bis).
Ma le idee! Dalle idee bisogna guardarsi! Possono certo
procurare un’apertura di credito, una divisa, imporre una coe
renza del tutto esterna e formale, ma finiranno poi con il com
promettere e il guastare la personalità « come l’amido nel latte
INTRODUZIONE
XXI
e il cartone nella suola delle scarpe» (Tv, 20 maggio 1927). Le
idee sono inutili, sono il risultato di codificazioni a posteriori
e destinate, comunque, ad essere deluse dall’irripetibile uni
cità dell’evento: in ogni caso conducono una loro esistenza
separata. Sono «autonome», non ci appartengono. « Il faut les
entretenir comme on entretient une femme. Et ce que nous
leurs donnont sans treves pour les faire vivre, ça est vraiment
a nous - ça est notre creation» (T, xxxi, 178-179). Le idee
vengono dopo le opere d’arte che le hanno nutrite e le seguo
no «come animali». Barilli vuole che lo seguano, non gli im
porta di possederle.
Con questi presupposti sarebbe vano pretendere dalle re
censioni di Barilli qualsiasi struttura dimostrativa: procedono
per definizioni e per immagini, per flash di lunghezza ineguale
e che sono il frutto di successive rapine a mezz’aria, compiute
da un’intelligenza mirabilmente prensile e tesa a scavare, all’in
terno della lingua, i propri cunicoli, ad alimentare una formi
dabile macchina fantastica e sintonizzata sui ritmi discontinui
del singolo evento. Vanno avanti a zig-zag «come gli artisti, le
farfalle, gli ubbriachi» (T, l x i i i , 37), rifuggono da qualsiasi
geometria e da qualsiasi premeditazione, trovano nell’imprevedibilità il proprio codice di onore. A null’altro si attengono.
E se «le opere ispirate e felici hanno un’acustica interna loro
propria che fa funzione di architettura, di luce, di carattere»
(T, xxii, 12), anche gli articoli di Barilli sembrano inseguire
una simile acustica, una specie di necessità biologica e che ga
rantisce, alla fine, l ’emergenza di organismi unitari.
In un «fascio» di appunti, aforismi, note, materiali vari nu
merati irregolarmente dall’i al 335 e ritrovati tra le sue carte,
Barilli ci ha lasciato una specie di parabola, ironicamente pa
radossale e lucidissima, sul suo modo di lavorare. «Non so
ragionare, se vogliono delle spiegazioni butto la testa da un
lato e guardo il mio interlocutore con uno stupido occhio di
gallina - non so come si faccia a dimostrare qualche cosa [...]
Io stesso circolo in un casamento sconosciuto e buio, impene
trabilmente buio, quando ho la penna in mano - le mani in
avanti trovo delle ringhiere che mi salvano, delle rampe che
mi aiutano a salire, e a discendere, delle porte che si aprono
cigolando, traverso sulla sordità dei tappeti degli ambienti in
visibili dove c’è odore di chiuso e di vecchio, mi perdo coi
piedi dentro delle sedie rovesciate e mi aggrappo al lampada
rio trascinandolo giù nella caduta; fuggo sempre più spaven
tato del danno e del chiasso e degli echi, e finisco per precipi
XXII
M ARIO LAVAGETTO
tare da un balcone sulle zolle molli di una aiuola fiorita e là
faccio punto fermo, firmo, saluto chi mi legge, il mio pubblico,
senza voltarmi indietro, senza chiedere una spazzola. E se il
conto non torna, faccia, chi mi legge, l’operazione al rove
scio, rilegga di sotto in su, e vedrà che il risultato è lo stesso»
(Fase. i).
Una simile rappresentazione di sé e delle proprie figurate
peripezie è, da un lato, molto insistita, dall’altro quasi prete
rintenzionale, non inedita, né priva di incrostazioni letterarie:
questa specie di critico-Charlot - al quale, peraltro, Barilli di
chiarerà di assomigliare negli ultimi anni (cfr. T, l x i i i , 122) ha parentele facilmente riconoscibili nella maniera novecente
sca, nei suoi ammiccamenti e nelle sue sommesse infrazioni.
Forse proprio quelle incrostazioni (da cui Barilli dichiarava di
rifuggire e da cui in effetti rifuggiva nei momenti di felicità)
possono averlo indotto, nel Taccuino l u i (66), a cassare il bra
no dopo averlo ricopiato e a scrivere sul margine un vistoso e
perentorio «no». Detto questo la parabola conserva quel tan
to di funzionalità che ci ha indotto a servircene e che ci spinge
ora a osservare più da vicino i passi e gli espedienti e le tecni
che adottate da Barilli durante la sua avventura «in un casa
mento buio », nel buio - per lui antonomastico - dello spazio
teatrale.
In un’occasione Barilli dice che l’esercizio della critica mu
sicale corrisponde a presentare «lo specchio a Narciso» (cfr. T,
xxxi, 32). L ’affermazione di per sé è ambigua: nel caso di Ba
rilli non c’è dubbio, tuttavia, che in quello specchio potrà for
se riflettersi la singola opera, la sinfonia o il quartetto o la
sonata, ma si rifletterà certamente anche lo stile inconfondi
bile, e a suo modo autoritario, del critico. «Il limite inferiore
di pertinenza dell’attività elaboratrice» risulta, negli scritti
musicali, notevolmente più basso che nelle pagine di viaggio:
le fealtà intangibili sono come rattrappite e Barilli non esita
(lo documenta ampiamente l’appendice genetica di questa edi
zione) a compiere i trapianti meno compatibili con il rispetto
del dato, a servirsi - per esempio - di pezzi di Koussevitzky
per costruire, in totale libertà fantastica, il ritratto di Bottesini.
Decisiva, insomma, è la riuscita stilistica che viene insegui
ta sfruttando tutte le risorse del mezzo. «La lingua italiana scrive Barilli in una pagina famosa - quando l’hai tra le brac
cia, e non ti scappa, ti pare, fuor di senno, che palpiti offren
INTRODUZIONE
X X III
doti il fianco, invece si raffredda da capo, si distende e non si
muove più. Ci vuole il potere magnetico, l ’energia d’un Ca
gliostro, perché la lingua italiana si levi, cammini, e ti segua »
(Pa, 52).
Cagliostro dunque, e magari anche «la lingua della Sibilla
che rifiuta di spiegarsi» {ibid.). Ma i maghi - alla cui costella
zione Barilli si aggrega volentieri - hanno tutti un repertorio
di trucchi e di espedienti facilmente inventariabile. L ’inventa
rio dei trucchi di Barilli, almeno dei suoi fondamentali, non
presenta grandi difficoltà proprio perché la sua cifra è molto
netta, perché il suo stile, proteso dichiaratamente verso la va
rietà e la sorpresa, si appoggia poi su alcune soluzioni stan
dard. Quasi tutte le citazioni che ho lasciato alle mie spalle
potrebbero, credo, recarne conferma, ma forse può valere la
pena di aggiungerne qualcuna, in economia, e col solo intento
di illustrare quelle che a me paiono le costanti di maggior ri
lievo in una scrittura cosi concitata e crepitante e tesa al colpo
di scena da rischiare poi - nei momenti di routine - una sor
ta di paralisi o di movimento coatto.
Prima di tutto le figure dell’accumulazione e in particolare
1'evidentia, l’ipotiposi su cui già Debenedetti aveva richiamato
la nostra attenzione:
« Si dimena ferocemente come un olmo squassato dall’ura
gano, ma, cadute che sono, in una pausa del vento, tutte le fo
glie ai suoi piedi, rimane lf pieno di brividi stringendo i denti
e il lungo corpo desolato: vuole ormai un pianissimo, un sus
surro; vuole il ronzio d’un alveare; vuole, da quelle voci smor
te, gli scossoni e la tremarella della febbre terzana, e, ripiglian
do lena, vuole una selva tutta piena di storni, di allocchi, di
gazze e di capinere; il cinguettio vuole, gli sghignazzi e lo schia
mazzare lungo e paradossale di un’uccelliera immensa che il
buio della notte seppellisce man mano e addormenta» (SV,
I7 °). .
Ma in questo passo grondante di immagini e di predicati
che «seppelliscono», accumulandosi gli uni sugli altri, il pri
mo e ormai lontano termine della similitudine (Lhuis Millet
sul podio), emerge - accanto al lusso della accumulazione un’altra delle costanti di Barilli; ed è proprio il ricorso sfre
nato, intemperante all’arsenale delle metafore e delle similitu
dini con il «veicolo» gonfiato ogni volta fino a scoppiare o a
staccarsi dal piano del discorso per galleggiare poi in piena,
aerea e magari felicissima autosufficienza.
«Finalmente, con un zig-zag fulmineo l’arco famoso vien
XXIV
M ARIO LAVAGETTO
giù, tocca la prima corda, e senti una nota che fischia come
una vescica bucata da uno spillo - intorno si sparge tutto il
vapore di una teiera in ebullizione, e in quel vapore lo scor
pione si snoda, ondeggia, prende volume, si solleva fuor di
ogni proporzione, e scrolla dall’istrumento una grandine fitta »
(Tv, 22 novembre 1930).
O ancora:
« Armata di ferro e d’argento, con tutte le sue vele spiega
te, sonante come una nave, quest’opera genovese rientrò son
tuosamente in servizio, dopo cinquantanni di inedia, che non
la distrussero, né la accasciarono.
Non fu necessario tirarla a secco per le riparazioni d’uso.
L ’opera non presentava avarie, o deterioramenti, né di fuori
né di dentro - era intatta.
E più che nuova apparve rafforzata dalla stagionatura.
Con un nuovo equipaggio valoroso e gagliardo, l’altra sera
riprese il mare e passò in bilico perfetto, galleggiando, mae
stosa e chiara, dinanzi agli occhi stupiti del pubblico romano»
(Tv, 5 marzo 1934).
A questo secondo esempio ha dedicato una lettura fin trop
po sottile Gabriele Baldini. Credo che l’essenziale, in questi
casi, non sia tanto una decifrazione (più o meno probabile) del
le intenzioni e dei sensi nascosti; non sia il chiedersi se parlare
di una nave «armata di ferro e d’argento» corrisponda o meno
a un giudizio sottilmente limitativo, perché poi - una decina
d’anni più tardi - Barilli trasferisce la definizione dal Simon
Boccanegra a tutto un gruppo di opere «bussetane e genovesi»
(Verdi, 44). Credo piuttosto che sia opportuno accantonare
alcuni pregiudizi, alcune «idee astratte» (avrebbe detto Ba
rilli). Spesso s’inceppa. E il carico delle iperboli è talvolta esor
bitante, come esorbitante è in genere, a ogni livello, chi di
chiarava ironicamente: «Forse esagero, e lo faccio volentieri»
(Tf LX , 112).
Perché se poi simili rilievi non vengono tradotti in giudizio
sulla base di un codice il più obsoleto e il più accademico, se
il lettore non diventa perciò pregiudizialmente sordo e refrat
tario, sarà quasi impossibile non riconoscere, qui, l’energia
trattenuta e ironica di un Cagliostro che ha fatto «alzare» la
lingua italiana e l’ha indotta a seguirlo docilmente, insieme
alle idee che Barilli dichiarava - lo abbiamo visto - di non vo
ler possedere. Né ci si difenderà allora dall’euforia che si dif
fonde da immagini cosi esplosive, eppure cosi controllate e
INTRODUZIONE
XXV
guidate nei loro effetti lungo binari di senso accuratamente
predisposti: «Forse esagero, e lo faccio volentieri».
« Questo capolavoro, stravagante e superbuffo, è pieno d’un’ilarità musicale che turba la ragione e suscita un pandemo
nio e un delirio parodistico. Rossini ci appare là, nero, secco,
grottesco eppure brillante, luminoso, colorito, tenero, traspa
rente, spirituale e ammantato di fantasia e di romanzo come
un personaggio di Goya» (DI, 31).
Gli antichi precettori di retorica, quelli che avevano elabo
rato e definito la règle des trois adjectifs, avrebbero visto im
pazzire i loro strumenti di controllo, se avessero potuto appli
carli al testo di Barilli, dove l’accumulazione degli epiteti non
si limita a due né a tre né a quattro né a cinque, ma arriva a
sette e a otto e a dieci senza remora alcuna. Non c’è pagina in
cui il fenomeno non sia rilevabile e non si ripeta diverse vol
te: appena Barilli prende la parola gli aggettivi si moltiplicano
come gramigna tra le sue mani, che li dispongono a collane a
festoni, che li organizzano in reticolati e organizzano intorno
ad essi la sintassi. «Quand même - dichiara in un’occasione on trouve toujours des adolescents sensibles a l’adjectiv. Vous
maîtres du substantiv, vous êtes des propriétaires et nous dei
nullatenenti» (Fase. i).
Ma a parte questo piacere autentico e beffardo della nullatenenza (contrapposta alla «proprietà» delle idee), c’è nell’uso
dell’aggettivazione da parte di Barilli un altro particolare che
merita di essere sottolineato, che risulta dagli esempi forniti
in precedenza e che, d’altronde, è consono alla sua più radicale
intenzione stilistica, alla ricerca dello straniamento e alla rot
tura sistematica delia prevedibilità. Lo straniamento Barilli lo
cerca con tutti i mezzi, tanto con quelli evidenziati in più
di un’occasione da Viktor Sklovskij, e cioè con l’invenzione di
una specie di occhio stralunato e intatto come quello di Kholstomer o di Natasa Rostova che porta ad annullare tutte le
convenzioni e a ribattezzare il mondo dalle origini, ma anche
con quelli più sistematicamente previsti dalla retorica classica,
fino a infrangere e a mandare in briciole la struttura di attesa
dei suoi ascoltatori.
C ’è, a questo proposito, una nota dei Taccuini che mi sem
bra del tutto illuminante: «Poesia - on s’y attend à la nais
sance de l ’avorton prodigieuse» (T, x v u , 30). Ogni pagina di
Barilli, ogni sua immagine, ogni sua riga sembra obbedire a
questo principio e adoperarsi con tutte le forze per mettere
alla luce l’aborto prodigioso, per rompere le abitudini, per
XXVI
M ARIO LAVAGETTO
sorprendere l ’intelletto e le emozioni, per costringere il letto
re a interrompere una linea di consuetudini semantiche. Ros
sini «nero, secco, grottesco eppure brillante, luminoso, colo
rito, tenero, trasparente, spirituale e ammantato di fantasia
e di romanzo come un personaggio di Goya»; Verdi: «Allor
ché si presenta la sua faccia ardente e corrugata, e risuona la
sua musica litigiosa e violenta, teatrale e spaziosa ...» (PdM,
31); Debussy con «le sue povere mani fredde, passive, ema
ciate e gialle come due vecchi guanti» (DI, 82). Anche qui gli
esempi potrebbero essere infiniti: determinante sarebbe, in
tutti i casi, l’emergere improvviso di uno o più aggettivi tali
da rompere il campo associativo e da capovolgere compietamente la gerarchia dei rapporti preferenziali che in quel cam
po sembrano imporsi per forza «naturale». Ma oltre che con
Bally - di cui abbiamo chiesto il sussidio come prima avevamo
preso da Lotman la nozione di struttura di attesa - possiamo
tradurre in altre parole la teoria dell’aborto prodigioso. La
bellezza delle frasi - ci suggerirebbe Proust se volessimo pa
rafrasarlo - «è imprevedibile». Chiunque potrebbe dire che
delle mani sono «fredde emaciate e gialle», ma quale legge
poi, o quale «determinismo» potrebbe suggerire il quarto pre
dicato: «passive»? «La vrai varieté est dans cette plénitude
d’éléments réels et inattendus, dans le rameau chargé de fleurs
bleues qui s’élance, contre toute attente, de la haie printa
nière qui semblait déjà comble».
C ’è (e lo vedremo più avanti) una specie di sotterranea ra
gione e di involontaria ironia nel chiedere a Proust - all’auto
re dell’opera più complessa e monumentale della letteratura
moderna - le parole e le indicazioni per definire lo stile di un
autore di pochi, esili e ripetuti libretti. Il primo dei quali ve
de la luce nel 1924, è intitolato Delirama e comprende tre
dici prose, quasi tutte di argomento musicale e le cui origini
(coinè si potrà rilevare dall’appendice genetica di questo vo
lume) derivano in vario modo, e con varie articolazioni, dal
l ’attività pubblicistica che Barilli svolge a partire dal 1916;
quasi tutte, inoltre, hanno trovato una forma pressoché defi
nitiva sulle pagine della «Ronda», di cui Barilli è redattore
con Cardarelli, Cecchi, Baldini, Spadini, Montano, Bacchelli
e Saffi. « Sarebbe stato difficile - riconoscerà in anni più tardi
Emilio Cecchi - trovare e mettere insieme scrittori di tenden
ze più indipendenti». Chiedersi allora quanto Barilli debba
alla «Ronda» è certamente legittimo, a patto di non soprav
INTRODUZIONE
XX VII
valutare il problema: in prima approssimazione si potrebbe
sostenere che nella poetica del rondismo Barilli trovò, non
diversamente da come gli accadde con altri movimenti del No
vecento, una specie di legittimazione a coltivare le sue perso
nali propensioni. E in ogni caso è da sottolineare che anche
le prose comparse sulla «Ronda», per quanto rigorosamente
spogliate da ogni occasionalità giornalistica, conservano tutte
- in maniera più o meno esplicita — memoria dell’evento da
cui sono nate: raccontano un fatto, uno spettacolo, magari
fondendo insieme e rielaborando fatti e spettacoli diversi da
cui Barilli ha ricavato a suo tempo le proprie «lastre». Né
d’altronde, di fronte a simili fotomontaggi e alla ricerca lin
guistica molto elaborata che essi comportano, si può dimen
ticare che Barilli trova in Verdi e nella poetica degli alti e bas
si che lo stesso Verdi viene chiamato ad enunciare nel Paese
del melodramma, la propria stella fissa: quanto di più lontano
insomma dal frammentismo e dalla prosa d’arte sia dato im
maginare, quanto di più alieno dalla ricerca della «sinfonia»
pura degli strumenti e quanto, viceversa, di più impuro, di
più implicato, di più compromesso con gli «ostacoli» che Ba
rilli sia riuscito a escogitare nelle sue ricognizioni. Verdi è per
lui, secondo una pagina dei Taccuini, come «la luce [che] deve
trovare degli ostacoli lungo la sua strada [...] bucare i corpi,
forare le superfici, piegare contro i duri massi che le ostruisco
no il cammino [...] lottare tra la massa del fogliame e rompere
dentro lacerante o stanca velata» (T, x v m , 77). Barilli è tutto
meno che uno scrittore della prudenza, il suo lessico - lo ab
biamo detto - può specchiarsi in se stesso, non è sempre sor
vegliato ed è soggetto a lasciare che il significato cada in tran
sitorie ipnosi davanti alla «musica» dei significanti, tanto che
la sua attendibilità critica non è da misurarsi mai per episodi,
ma sulle sue grandi scoperte, là dove opera, come ha detto
Baldini, «una vera e propria rivoluzione [...] nei miti e nei
feticci della critica verdiana». Se mai alla «Ronda» e al clima
di cui la rivista reca testimonianza, Barilli deve la possibi
lità di pensare ad un libro esile e premeditatamente disconti
nuo come Delirama-, o meglio: di vedere in tredici prose, unite
da sottili legami tematici e da una costante stilistica molto
marcata, un «libro».
Una simile fiducia non sembra avere accompagnato in ma
niera costante Barilli, anche se II sorcio nel violino nel 1926
e la seconda edizione di Delirama nel 1944 paiono basarsi sul
lo stesso criterio genericamente antologico. Ma basta scorrere
XXVIII
M ARIO LAVAGETTO
gli indici di questi libri e poi anche quelli del Paese del melo
dramma e del Verdi (già in bozze nel 1946 e mai pubblicato)
per rendersi conto che il problema è più complesso. Chi vorrà
a questo punto rifarsi alle tabelle, approntate da Luisa Avellini e da Andrea Cristiani e pubblicate alle pp. 7 sg., 49 sg.,
292 sgg., vedrà quanto fitto e intricato sia il passaggio dall’uno
all’altro dei volumi di argomento musicale; e se poi cercherà
di precisare (servendosi delle appendici genetiche) il modo in
cui lavorava Barilli e seguirà l’itinerario compiuto dai singoli
nuclei che si aggregano gli uni con gli altri o si decantano o tor
nano nuovamente a disgregarsi e a produrre — intorno a sé —
«corone» differenziate, potrà avere la sensazione di trovarsi
di fronte a una specie di pioggia di frammenti, che vengono di
volta in volta attratti o respinti da diversi campi magnetici.
Un simile modo di lavorare, una simile spregiudicata riu
tilizzazione di immagini, di frasi, di interi periodi, che ven
gono innestati su qualsiasi altro tronco, può apparire, soprat
tutto per quanto riguarda l’attività giornalistica di Barilli, co
me un espediente di routine: se è vero che un articolo deve
avere la capacità di rotolare su se stesso (cfr. T, l x v i i , 140),
questo non pregiudica la possibilità di costruirlo con materiali
di varia provenienza e di avviare il suo movimento di rota
zione con una o più spinte esterne. Che le cose stiano anche
cosi non ci sono dubbi: Barilli, che teorizza la pigrizia come
forma particolare dell’energia creativa (cfr. T, l x , 140), è pi
gro, specula su se stesso, cerca di estrarre il massimo profitto
da ognuna delle sue invenzioni. Ma una simile interpretazione
appare, nel momento stesso in cui la si enuncia, lacunosa e
riduttiva soprattutto se riportata ai libri: qui i conti diven
gono immediatamente meno semplici. Si può pensare certo
che Barilli utilizzi alcuni frammenti esemplari confidando poi
nella loro potenziale vitalità, nella loro forza di produrre te
sto - ritratto o racconto o libro che sia - ma resta poi da spiegar? quella specie di caparbio e misterioso accanimento ad uti
lizzare ripetutamente alcune carte fisse e, nello stesso tempo,
a servirsi di un «mazzo» relativamente povero, se paragonato
al complesso dell’attività critica di Barilli, tanto che si ha qua
si l ’impressione di assistere ai tentativi ripetuti di risolvere un
gioco di pazienza, di cui non conosciamo le regole e che, pure,
ad alcune regole sotterranee sembra attenersi, dal momento
che le stesse figure vengono giocate e rigiocate e inserite, di
volta in volta, in universi modificati.
Quella impressione si fa anche più netta, quando, leggendo
INTRODUZIONE
XXIX
i Taccuini, vediamo affiorare tutta una serie di indici proget
tuali, di libri ipotetici che Barilli edifica e poi lascia cadere,
mettendo alla prova, nelle varie circostanze, il suo spirito di
calcolo e di combinazione, come se fosse impegnato nella solu
zione di un enigma, nell’abbattimento di un ostacolo che gli si
presenta davanti periodicamente e non si lascia aggirare. E se
talvolta un titolo come Piombo e argento — che riaffiora in di
verse occasioni - può far pensare a una specie di accettazione
pragmatica e astrutturale del doppio binario di scrittura, con
il libro collocato al culmine di un processo lento e laborioso
di raffinazione alchemica, altrove l’intreccio sembra più com
plesso, la soluzione più sfuggente; il calcolo e il successo - più
che a un passaggio stilistico o a una modificazione dei «regi
stri» - paiono allora affidati alla riuscita degli incastri, a un
sofisticato sistema di corrispondenze interne, di simmetrie
cercate o distrutte. Insomma, in una simile prospettiva, se
guendo Barilli tra i libri scritti e quelli soltanto pensati, si
finisce col vedere crescere davanti a sé e prendere forma una
fisionomia inquietante e delusa, quella di uno scrittore che
cerca ripetutamente di scrivere lo stesso libro e che, ripetutamente, se lo vede sfuggire tra le mani perché non riesce a di
segnarne la pianta.
A qualcuno potrà sembrare che in questa luce Barilli finisca
per assomigliare un po’ troppo a un personaggio fittizio, ma
gari a un personaggio di Borges, costruito senza troppi scru
poli e con illecite intenzionalità ermeneutiche. Ma, a parte il
fatto che le nostre letture si svolgono sempre all’ombra di
«fantasmi retroattivi» e che inutilmente cercheremmo di scol
lare quei fantasmi dalle pagine in cui finiscono per infiltrarsi,
non c’è dubbio che a quel personaggio vada riconosciuto il
ruolo di un analogon: costruito appunto, e fittizio, ma di cui
bisognerà poi vedere - come ci ha suggerito Max Black — se
ricade su se stesso o se, viceversa, ci consente di gettare una
nuova luce sui problemi. E allora rimettiamoci alle sue spalle,
alle spalle di questo «autore senza libro» e che pure tenta ri
petutamente di edificarne uno: risulterà subito evidente, con
sultando ancora le appendici genetiche, che «fare il libro» per
Barilli sembra ridursi a una pura e semplice attività di montag
gio e di combinazione. Per il libro — senza lo stimolo dell’oc
casione immediata, dell’evento teatrale o della cosa vista Barilli non riesce materialmente a scrivere; corregge magari,
ma si tratta di correzioni di dettaglio: gli incastri vengono cer
cati a forza facendo ruotare gli stessi pezzi, spostandone la col
XXX
M ARIO LAVAGETTO
locazione, introducendo - al caso - piccoli tasselli. Ma basterà
«rivoltare» il tessuto cosi composto, basterà leggere un indice
diverso per scoprire le cuciture.
Una conferma viene - io credo, e clamorosa - anche dal li
bro più strutturato di Barilli, da quello in cui più intensa e
percettibile si fa la sua volontà architettonica: Il paese del
melodramma. Barilli, quando lo mette insieme, ha un’idea
molto precisa: quella di disegnare una specie di mappa fanta
stica del melodramma italiano nell’Ottocento. Verdi sarà il
perno intorno a cui dovranno disporsi tutte le altre regioni,
anche quelle disegnate oltre i confini italiani; e Verdi ruoterà
a sua volta intorno a quella che, per Barilli, è la sua opera più
esemplare e rappresentativa, più bruciante, più moderna, tan
to da apparirgli in una nota (con il Wozzeck) una possibile
pietra di paragone per il programma surrealista di André Bre
ton: Il Trovatore (cfr. T, l x , 115). E non basta: perché sullo
sfondo, alle spalle di Verdi, potrà disporre Parma e la sua
campagna, alleando cosi al suo mestiere di ascoltatore anche
il suo talento autobiografico e l’occhio che ha esercitato nei
viaggi. Ma «ben altra, e più profonda - continuava Walter
Benjamin quando ho smesso di citarlo - è l’ispirazione che
porta a rappresentare una città nella prospettiva di un nativo.
È l’ispirazione che si sposta nel tempo e non nello spazio. Il
libro di viaggi scritto dal nativo avrà sempre affinità col libro
di memorie: non invano egli ha vissuto in quel luogo la sua
infanzia». E altrove: «smarrirsi in una città, come ci si smar
risce in una foresta, è una cosa tutta da imparare». Chi legge
la prima parte del Paese del melodramma ha nettissimo il sen
so di trovarsi davanti agli esiti e alle circonlocuzioni di un
simile, geniale smarrimento: ci si muove tra ombre, imma
gini leggendarie, si procede senza meta, all’interno di un «la
birinto», che - come ha osservato Szondi commentando Be
njamin - è «nello spazio ciò che nel tempo è il ricordo». Poi,
di cylpo, quella specie di atmosfera incantata si rompe e la
struttura resta al di sotto del progetto: al disordine guidato
e apparente tiene dietro una serie di quadri discontinui, ma
gari splendidi, ma che appaiono, nel loro insieme, come i resi
dui di quel progetto che avevamo intravisto o che è stato som
merso o che non è riuscito ad affiorare. Ma è allora che alle
nostre impressioni di lettura giunge perentoria, e in parte sor
prendente, la garanzia delle fonti reperite (per il secondo vo
lume di questa edizione delle opere) da Luisa Viola: anche la
prima parte del Paese del melodramma è nata sulle colonne dei
INTRODUZIONE
XXXI
giornali ed è stata ottenuta attraverso una serie di collages più
o meno abili e mimetizzati; anche il Commiato, con cui Barilli
cerca di chiudere il libro e di imporgli il sigillo di una struttura
unitaria e risolta, non è che l ’iniziale e identico asterisco di due
articoli comparsi nel 1927 (il primo sul «Tevere» e il secondo
sulla «Nazione»). Il libro sfugge cosi ancora una volta tra le
maglie che la sapienza combinatoria di Barilli ha tentato di in
tessere: resta perpetuamente «a venire», è l’opera incompiuta
iscritta nel destino di uno scrittore che la insegue con accani
mento e che pure, di fronte ad essa, appare paralizzato e come
incapace di produrre scrittura e di ricavare da sé i materiali
necessari alla costruzione.
Quando, nell’immediato dopoguerra, Barilli tenterà la car
ta Verdi, non farà che riproporre II paese del melodramma
con alcune non trascurabili integrazioni. Ma allora sarà dile
guata anche l ’altra segreta possibilità di chiudere il proprio
destino creativo in un organismo esemplare, possibilità che
egli aveva continuato a nutrire dentro di sé e a cui aveva dedi
cato - lo sappiamo - i voti e le attese più fervide: la sua terza
opera in musica.
A più riprese, negli ultimi Taccuini, Barilli indica il 1943
come una data cruciale, come l’inizio della sua parabola di
scendente: il motivo di una simile e ripetuta indicazione re
sta tuttavia enigmatico fino al Taccuino l x v i i , che copre l’ul
timo anno della sua vita. È allora che, rivolgendosi a un ignoto
interlocutore, Barilli racconta: «... nel 1913 ho scritto la mia
seconda opera Emiral - E li mi sono fermato (c’era la guer
ra) - Adesso una pausa di 28 anni.
Nel 1943 decisi di liberarmi del giornalismo e della critica
per dedicarmi esclusivamente alla composizione di una terza
opera. Comprai un pianoforte nuovo, molta carta da partitura
- affittai una stanza a Siena (Anche allora c’era la guerra).
La mia stanza si trovò incastrata fra i due eserciti, gli alleati
e i tedeschi, in più le cascarono addosso i partigiani e i repub
blichini in conclusione scomparvero il pianoforte, la carta da
partitura, e anche la stanza con tutte le mie robe. Cosi scom
parve ancora prima di nascere la mia terza opera. In quei gior
ni ero venuto [a] Roma per liquidare la mia posizione di cri
tico giornalista ecc. - ma prima che lo facessi io, me la fecero
gli altri questa liquidazione a Roma - Degradazione depredato
vilipeso messo al bando - spogliato cestinato e buttato nudo
sulla pubblica strada - Era l’inverno - mi domanderete "Ma
XXXII
M ARIO LAVAGETTO
chi è stato?” Erano in tanti che non ho visto più nessuno.
Quindi niente più composizione e musica nella mia ultima
vita. Dopo la guerra, si spiegò su di me, scoppiando con la
sua spregevole [illeggibile] conflagrazione la guerra civile che
dura sino ad oggi» (T, l x v i i , i o - i i ).
Nella nostra prospettiva di lettori sarebbe senza dubbio un
errore sopravvalutare questa data e drammatizzarla oltre mi
sura: la pubblicazione, anche parziale, dei Taccuini dimostre
rà, oltre ogni dubbio, che esiste, come ci aveva detto D ’Amico,
una linea continua tra il primo e l’ultimo Barilli. Si vedrà allo
ra che 1’«Orfeo in pantofole» è un «costume» di vecchia data
e che appare già negli anni ’25-26; allo stesso modo si tro
veranno aforismi, note, riflessioni, epigrammi che più tardi
verranno ricopiati alla lettera o con piccolissime varianti, tan
to che la fisionomia della vecchiaia potrà sembrare, in alcuni
casi, come il risultato di una previsione «lunga».
Eppure quella data, ripetutamente e ossessivamente sottolineata da Barilli, è davvero fondamentale e apre l’ultima sta
gione, quella che si deposita in forma di nebulosa negli ultimi
otto Taccuini (dal l x al l x v i i ) e che si delinea poi come co
stellazione fermissima nei Capricci di vegliardo.
I quali ultimi, è il caso di dirlo, rappresentano certo un
eccezionale e drammatico esercizio di stile, ma finiscono coll’apparire, a chi conosca l’intero «continente della vecchiaia»,
come un esito dove la misura e l’equilibrio sono stati ottenuti
a scapito dell’intensità e dove è andata smarrita la nota più
tragica e sconvolgente dei Taccuìni, e del loro corso farragi
noso, e cioè il passare del tempo scandito dai successivi com
pleanni e dal restringersi progressivo del campo visuale, dal
fissarsi del diario intorno a pochi punti obbligati, a pochi temi
battenti.
Dunque: 1943. Barilli cerca di spogliarsi di quel guscio
che - lo abbiamo visto - si era costruito subito dopo Emiral.
Vuote scrivere la sua terza opera, riportare alla luce il com
positore. Circostanze esterne — sostiene - glielo impediscono.
Continua a scrivere sui Taccuini che assumono, a partire da
questo momento, un ritmo temporale più definito, che conti
nuano a essere ricettacolo di tutto (appunti, conti della spesa,
inventari della biancheria, giudizi critici, ecc. ecc.) ma che
hanno un tono sempre più privato e accolgono querele, la
mentazioni, invettive, bilanci in rosso, recriminazioni. Orfeo
in pantofole o Giobbe: sono queste le ultime parti di Barilli,
quelle in cui torna più ripetutamente in scena, per parlare
INTRODUZIONE
XXXIII
sommesso e ironico oppure per declamare se stesso e la pro
pria miseria. Non c’è, in quanto dico, ombra di giudizio: è
solo che anche qui, quando sfiora il diario intimo, Barilli ha
bisogno di qualche mediazione tra sé e la sua voce, tra sé e la
sua scrittura. Il ventaglio dei temi, lo dicevo, si chiude pro
gressivamente e tende a restringersi all’osservatorio stesso di
cui parla Barilli.
«La chambre de Giobbe. Ma chambre. La misère. J’y ai
fai les racines. La chambre de Proust - les papiers sur le planchit - les savates le desordre accumulé» (T, l x v i i , 180). In
realtà più che alla camera foderata di sughero, in cui lenta
mente e instancabilmente viene edificata la Recherche, si può
pensare a un rifugio ben più disertato e miserevole. Perché se
Proust è senza dubbio presente all’immaginazione di Barilli
e il suo nome è uno dei pochi a galleggiare in taccuini spogli
di cultura letteraria, è altrettanto indubbio che le famiglie di
appartenenza sono diverse: lontanissima quella di Barilli da
ogni forma di dedizione esclusiva e invece precaria, invece dis
sipatrice e momentanea come quella che trova nel nipote di
Rameau il suo prototipo: c’è in lui la stessa eccedenza di ta
lento e la stessa indisciplina; il suo genio - reale e vorace vive alla giornata ed egli chiude la sua esistenza nella dispera
zione e nell’incuria, in mezzo ai topi e agli scarafaggi, nel feto
re del proprio corpo: «la sudiceria c’est un refuge, la protec
tion de ma pureté, de ma vieillesse refractaire dans mon odeur
de carapace» (T, l x i v , 5). «Non ho più sicurezza, né autono
mia sperduto in un baratro, in una selva, in una gora di nera
incertezza. Tutto il coraggio crolla» (T, l x v i i , 43).
E allora se il diario è, come ha detto Maurice Blanchot, un
mezzo per sfuggire alla solitudine che aggredisce lo scrittore
attraverso la sua opera, in questo diario - scritto oltre ogni
opera possibile — esplode una tremenda e funebre solitudine
esistenziale ed è forse qui, in queste pagine approssimative e
necessariamente incompiute, in cui affiorano progetti, in cui si
sommano i materiali più disparati — che alternano l’indirizzo
o il numero di telefono al grido ossessionante - è qui che Ba
rilli ha depositato la propria immagine più autentica e sinistra.
Una volta pubblicato questo diario della vecchiaia apparirà, io
credo, come una testimonianza conturbante e getterà una luce
nuova, più intensa e più livida non solo sui Capricci, ma su
tutto l’itinerario che ho cercato sommariamente di ricostruire.
La voce di Barilli è, in queste pagine, singolarmente spezzata.
Come è sua consuetudine, nei Taccuini mescola l ’italiano e il
XXXIV
M ARIO LAVAGETTO
francese, due lingue di cui - in anni lontani - aveva definito le
caratteristiche: le mescola nella stessa pagina, ma anche nello
stesso appunto, nella stessa frase dove di colpo lascia rigalleg
giare una parola «altra». E se a volte abbiamo la sensazione di
trovarci di fronte a un ripiego, altre volte l’intenzionalità è
netta e sembra inseguire effetti minimi, ma significativi, di
straniamento. Inoltre, in queste pagine della vecchiaia si as
siste al collaudo di una forma parzialmente inedita di regi
strazione: Barilli procede per istantanee rapidissime, riduce in
briciole il testo e lo frantuma con una serie di lineette molto
ravvicinate e martellanti che mettono la scrittura diaristica al
riparo da ogni «chirurgia grammaticale» e che, in simile con
testo, rappresentano l ’equivalente funzionale dei puntini di so
spensione per la mimesi del linguaggio parlato.
«Vagabondo in se stesso» (T, l x v , 56), Barilli sembra non
preoccuparsi di altro che di lasciare cadere alle proprie spalle
una serie di parole, che costituiscono poi la sua «traccia» e il
cui «disordine» diventa (anche con premeditazione) una spe
cie di contromarca dell’autenticità. E se l’asintattismo, cosi
frequente negli ultimi Taccuini, può derivare dalla stanchezza
della mano, dall’opacità, dalla miseria e forse anche dall’uso
di stupefacenti, è poi vero che Barilli finisce per trovarvi un
sussidio: lo «razionalizza» in qualche modo, e se ne serve co
me di un espediente stilistico, anche se non sempre appare in
grado di difenderne l’efficienza. Certo è che tra frammenti im
possibili, lampi, frasi interrotte, ripetizioni il «tremolio del
tempo» si rappresenta, a volte, in maniera meravigliosa e rap
presenta il passare degli anni e ravvicinarsi della morte, quasi
«dietro la lingua», tra i rumori di fondo che spesso si sovrap
pongono alla registrazione. È allora che il passato (verso cui
Barilli si è rivolto sporadicamente) riemerge sotto forma di
schegge vertiginose e deliranti. « J’ai soif, une soif terrible d’écouter le chant de mon opera» (T, l v i i , 46). Torna la figura
di Danitza, la cui lontananza è ormai insopportabile (T, l x v i i ,
70). «L ’amore - scrive nell’anno della morte - è quello di dare
tutto di sé e della propria vita e del proprio avvenire perdere
tutto - e di cercare per liberarsi di questo impegno del cuore
inutilmente durante quarant’anni, senza fine, fino alla morte
- questo è amore - e odio insieme» (T, l x v i i , 64).
Torna anche, attraverso le ombre di una mente «che è co
me un vetro smerigliato» (T, l x v i , 57), la figura, in preceden
za solo accennata, del padre con cui Barilli si identifica e di cui
(poco prima di morire) descrive la fine, facendone cosi una
INTRODUZIONE
XXXV
specie di Bergotte, il luogo di un oroscopo senza scampo: «Je
suis, sur place, comme mon père jadis a mon age - Et comme
etait-il? Ce n’etait plus lui - c’était un rien de lui même - pres
que sans bouger — presque sans tourner l’œil [...] ne parlait
plus. Il ne dressait pas son regard - pour ne pas voir - une
casquette sur la tête - assis et courbé vers la terre - on aurait
dit qu’il n’ecoutait plus - et ne regardait pas pour manque de
vie [...] Au contraire c’était la luciditée atroce - et la revela
tion impitoiable de la veritée - ultime - splendide, comme
dans l’ipnose - de la veritée vraie - inébranlable - le fond réel
brûlant dans tous les cas de sa vie - le figures - les voix - le
long de son passé - avec une actualitée découverte (scoper
chiata)» ( T , LXVII, i i o - i i i ) .
M ARIO LAVAGETTO
EUGENIO MONTALE
Gilberto Lonardi
MONTALE, LA POESIA E IL MELODRAMMA
in “Chroniques italiennes” n. 57 (1/1999)
1. Assediato dalla musica.
Abitato e assediato dalla musica, anzi più precisamente da arie, storie,
fantasmi del melodramma: Montale lo conosciamo anche cosi, aneddotica
compresa. A Genova studiava canto già da ragazzo, e poi, giovanotto, col mitico
maestro Sivori. Gadda descrive lui e i suoi fratelli che cantano l'Aida su al
pianerottolo ultimo della villa di villeggiatura di Monterosso. Uno di loro dirige,
gli altri sono avvolti in lenzuola, accappatoi e altro da inscenamento domestico
– da baraccone: e il Montale adulto, il recensore di ben altre rappresentazioni
alla Scala, dichiarerà sempre la sua nostalgia per un "fare teatro" più appunto
"da baraccone". Cioè magari meno raffinato, ma più vicino all'aspetto storico
del melodramma ottocentesco: insomma più vicino al suo originario aspetto di
teatro "di tutti". Lo stesso Montale non ne trovava un antecedente comparabile
se non nel grande teatro elisabettiano cinqueseicentesco. Che era come
privilegiarne l'aspetto di glorioso e di unico, in Italia, solido esempio di
interclassismo culturale.
Studiava, dicevo, canto: già prima di fare il soldato nella grande guerra, e
poi, finita la guerra, negli anni '21-'23. Ernesto Sivori gli scoprì allora – racconta
lo stesso Montale – l'assillo: cioè, diremmo noi, un misto di talento, di fervore,
di mania platonica. Di fatto si sa che Montale aveva un vero istinto, perfino
istrionico, per il canto e il personaggio d'opera. E aveva una voce molto
rispettabile. Una voce di basso. Il suo maestro, ex-baritono, voile scovarci e
scavarci una voce di baritono. Cosi lo preparò e lo iniziò a personaggi come il
Lord Enrico della Lucia di Lammermoor. Come Alfonso XI di Castiglia, nella
Favorita, anch'essa, come Lucia, di Donizetti. O come il giovane Valentino,
l'adolescente fratello di Margherita, altro baritono, quest'ultimo nel Faust di
Gounod. Ma nel '23 mori Sivori. E si spense, cosi, anche una comunque
improbabile carriera del cantante Montale. Il quale ritrovò subito la sua voce
"naturale [dice egli stesso] e psicologica" di basso. E restò comunque per sempre
abitato, occupato, assediato dal melodramma.
2. Un esempio di scambio nel sistema, tra il melomane e il poeta.
È tale l'assedio, che a volte tra il Montale melomane e il Montale poeta c'è
in atto uno scambio più o meno perfetto. Faccio un esempio. Tra il '63 e il '65
due ombre, una neanche di un autore di teatro in musica ma semplicemente di
un grande musicista contemporaneo, Poulenc, l'altra della poesia montaliana, la
moglie — la Mosca —, si scambiano tic e gesti in totale collaborazione. Mettiamo
a fronte due "pezzi", il primo in morte del compositore francese Francis Poulenc
— "Corriere d'Informazione", 1963 — il secondo negli Xenia (i madrigali in
morte della moglie, I, 10 [del 1965]):
Non ho mai capito che religion fosse la sua, ma certo Francis era un devoto di
Sant'Antonio, ch'egli invocava per lo smarrimento di un ombrello o per la faticosa
ricerca di un tassi; e sempre col dovuto successo.
"Pregava?" "Sì, pregava Sant'Antonio
perché fa ritrovare
gli ombrelli smarriti e altri oggetti
del guardaroba di Sant' Ermete".
Poi, s'intende, il madrigale per la moglie si completa di una cadenza grave
non concessa qui alla pagina giornalistica («"Per questo solo ?" "Anche per i
suoi morti / e per me". / "È sufficiente, disse il prete"»).
3. Dal primo all'ultimo Montale.
Ma anche quando questo scambio non c'è o non è documentabile, il poeta
Montale, o senza dircelo, o dicendolo — come fa l'ultimo Montale —
direttamente, è "occupato", come pochissimi altri nostri poeti, da quella
particolare "zona" della musica che è il canto melodrammatico.
Bastino come rapida prova per il primo Montale tre "attacchi" dagli Ossi di
seppia:
a) Tentava la vostra mano la tastiera,
i vostri occhi leggevano sul foglio
gl' impossibili segni...
Sembra una romanza. E ancora,
b) Mia vita, a te non chiedo lineamenti
fissi, volti plausibili o possessi.
Nel tuo giro inquieto ormai lo stesso
sapore han miele e assenzio...
E qui allora si pensi a Tosca, di Puccini: «Mia vita — canta il tenore
Mario Cavaradossi a Tosca — mia vita, amante inquieta...». Lo stesso patetico
invocativo (mia vita) spetta al baritono nella parte che ho già nominata conne
un "ruolo di iniziazione" del giovane Montale, il ruolo di Alfonso XI re di
Castiglia: «Per te, mia vita, affronterei l'averno...» — una frase il cui slancio non
finisce qui, nel primo Montale poeta («T'avrei raggiunta anche navigando / per
le chiaviche, a un tuo comando», canta infatti Montale più avanti, nella Bufera).
Terzo e ultimo campione sempre dagli Ossi di seppia: ancora cerchiamoci
un avvio, quello dei Limoni:
c) Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi...
Questo dialogico Ascoltami ha molti padri possibili nel melodramma. Si
tratta insomma di un tòpos. Difficile stabilire una discendenza unica. Credo che
la precedenza debba spettare ai sunnominati "personaggi di formazione", tipo il
Valentino del Faust, tipo l'Enrico della Lucia. Ascoltami, prorompe a un certo
punto quest'ultimo, rivolto al suo nemico Edgardo. E «Or stammi ad ascoltare,
Margherita», cosi avvia (naturalmente nella versione italiana) il suo ultimo
canto il Valentino del Faust rivolto alla sorella, in una scena "testamentaria" —
quella della sua uccisione e morte per mano di Mefistofele — che offre altre
suggestioni al poeta degli Ossi e delle Occasioni. E anche nella Favorita
compare questa specie di poncif o luogo comune del melodramma. Ma è anche
alla Bohème che occorre pensare:
Ascolta, ascolta.
—canta Mimì a Rodolfo —
Le poche robe aduna che lasciai sparse.
Nel mio cassetto
stan chiusi quel cerchietto
d'oro...
Con quel che segue. È forse questa di tutte la scena più pre-montaliana,
con quell'attenzione a minimi oggetti del femminile, intrisi di ricordo e di
suggestione del "privato", che ritroveremo nella borsetta di Dora Markus e
anche dopo, lino almeno al Piccolo testamento.
A sua volta c'era un altro riferimento, fuori-melodramma, per l'Ascoltami
dei Limoni: non veniva dal melodramma, ma era anch'esso molto cantante e
canoro. Veniva, penso, dal D'Annunzio della Pioggia nel pineto. In quella poesia
si nascondeva – non credo che ci badino i critici dannunziani – un omaggio alla
Bohème diventata presto famosa tra fine ‘800 e primissimo ‘900:
Ascolta,
si legge nella Pioggia; e poi,
Ascolta, ascolta.
Proprio il doppio ascolta di Mimi.
In un primo momento lo stesso Montale scrisse “Ascolta”. Poi, Ascoltami:
penso che la memoria assediata gli cantasse dentro qualche esempio di canto
melodrammatico, e che insieme gli si presentasse il ricordo dannunziano; fra
l'altro è certo D'Annunzio, o anzitutto D'Annunzio, il "poeta laureato" che in
questi stessi Limoni preferisce i «bossi ligustri e acanti», cui si oppone
programmaticamente il poeta giovane e polemicamente "povero" e dunque in
cerca di fossi, ciuffi di canne, sparute anguille e alberi appunto di limoni.
Valga quest'ultimo esempio già ad illustrare un aspetto della complessa
memoria dei poeti e di Montale in particolare. Quella di Montale è una memoria
molto stratificata, molto intrecciata, spesso tra alto e basso. Montale contamina,
con lui il basso, il minimo possono caricarsi di valenze massime. È questo il suo
modo – l'unico suo – di fare il rivoluzionario. E cosi nella sua poesia il ricordo
del canto melodrammatico, e di certe sue parole non-illustri, può anche non
presentarsi da solo, ma intrecciato a quello della poesia-poesia, quella illustre,
quella alla e laureata, da Dante a D'Annunzio come minimo.
Ma dunque, il Montale d'esordio è un poeta molto cantante, spesso
intonato sul canto anche pieno. E l'ultimo Montale, tra il Diario (‘71-'72) e Altri
versi ('81), insomma tra primi e ultimi anni ‘70 e primi ‘80? Anche nella poesia
del Vecchio torna il melodramma, vi tornano i suoi fantasmi, ma non più come
canto che si invena nel canto, bensì offrendo figure del melodramma rievocate
espressamente, e oggetto di commossa e insieme ironica autoidentificazione.
Cosi in Annetta, ormai del 1972, può finalmente permettersi di
nominarli, i personaggi del melodramma (già lo aveva fatto negli Xenia, anni
‘60, ma trasversalmente, citando lo «Strana pietà» di Azucena, atto II del
Trovatore). In Annetta ecco dunque chiamato in causa Des Grieux, il giovane
tenore che ama la giovanissima Manon nel Marron di Massenet. Sono queste le
maschere melodrammatiche dell'io poetico giovane e del suo primo amore,
Annetta o Arletta. E la stessa Manon verrà altrettanto espressamente non allusa
ma ricordata («Manon in fuga [...] la voce di Manon») nei Nascondigli II, ormai
dell'ultimo Montale. Intanto, in entrambe queste poesie, si evoca un
riconoscibilissimo emblema della poesia moderna, il passero solitario. E dietro
quell'emblema leopardiano si estende la piana perduta e perenne della
giovinezza, la sua memoria inestinguibile.
4. Ma la tattica è quella del nascondere.
Stiamo però ancora a quello che all'ingrosso chiameremo il primo
Montale, da Ossi di seppia alla Bufera, cioè dal ‘20 circa al ‘56. Questo Montale,
che è poi quello che ricordiamo e amiamo di più, anzitutto nasconde. E per
nascondere cambia contesto, cambia cornice e sposta. Vedi, per esempio,
L'ombra della magnolia, nella Bufera:
Non è più
il tempo dell'unisono vocale,
Clizia, il tempo del nume illimitato [...]
Spendersi era più facile, morire
al primo batter d'ale, al primo incontro
col nemico, un trastullo. Comincia ora
la via più dura...
Guardate come viene rigiocato e decontestualizzato, qui, un ricordo del
canto di Butterfly, l'eroina giapponese di Puccini, che immagina il ritorno
dall'America e dall'oceano del suo marito americano:
Un bel di vedremo
spuntare un fil di fumo...
e poi, dice e anzi canta, io non gli andrò subito incontro, mi nasconderò
per un momento,
un po' per celia
e un po' per non morire
al primo incontro...
Montale conserva in cima di verso sia morire, sia primo incontro. Ma
trasforma profondamente tutto. «Non morire» diventa il contrario, diventa
morire. La scena di attesa e d'amore si trasforma appunto in un'altra cosa:
tornano si alcune memorabili parole della scena pucciniana, ma ora
contrassegnano la giovinezza («il tempo del nume illimitato») che non c'è più, e
che sapeva morire come per gioco, per trastullo. Diciamo di più: niente resta
qui del vero e proprio trauma musicale, dell'intervallo di quarta che investe, nel
canto di Butterfly, quel non morire: e che eclissa anzi nella nostra memoria quel
che subito segue, al primo incontro. Che non si eclissa invece in Montale, ma
per essere spostato a tutt'altro rispetto alla "fonte".
In questo, Montale è ben diverso da un altro grande poeta come Saba. Vi
porto un solo esempio da quest'ultimo: sentite con quale trasparente confidenza
Saba trapianta il ricordo del Rigoletto, del Duca di Mantova che fa la corte a
Maddalena: «bella figlia dell'amore...». E Saba, a Lina, in una poesia intitolata
Carmen:
...amica, austera figlia
d'amore, se la vita oggi n'esiglia,
con la musica ancora vieni a me.
Geloso sono non di don Josè,
non d'Escamillo.
Qui Saba, in questa poesia-canzone molto cantata, non solo "salva"
diversamente dal Montale che si è appena visto la cornice di provenienza – il
canto d'amore resta un canto d'amore – e non solo colloca in cima di verso il
figlia verdiano, ma espone e distende in un sensuale enjambement la «figlia /
d'amore», lei pur cosi austera. E fa anzi di più: chiede alle rime e quasi-rime –
esiglia : Escamillo; me : Josè – di onorare e prolungare quanto c'è di canto
pieno nella tenorile citazione, che cosi è anche più esposta e trionfante che
nell'originale. Il contrario di quanto fa in genere Montale poeta coi suoi ricordi
di canto e di melodramma. Saba cita, Montale vocabolarizza. E questo perché in
Montale prevale sempre o quasi l'aspetto del poeta "riflesso", e tale anche
quando sfida il canto pieno di D'Annunzio – poeta non meno riflesso, s'intende
– o dello stesso ben più diretto e "ingenuo" melodramma. A Saba riesce invece
quella che potrei chiamare una confidenza molto vicina alla naturalezza. O alla
natura stessa: c'è un'implicazione e accoglienza naturale, materna, nel proprio
canto, del canto, cui Saba si accosta con maggiore immediatezza rispetto a
Montale.
5. Montale dunque nasconde: ma non quando c'è di mezzo il calco
ritmico.
Questa immediata confidenza non c'è dunque, di solito, in Montale, che è
un po' più nel segno paterno, e insomma è più borghese e più riflesso rispetto a
Saba. O meglio: non c'è, questa immediatezza, a livello di lessico, di ricordi
verbali. C'è – perché allora è, penso, involontaria, e comunque è a livello
profondo e dunque abbastanza nascosto allo stesso Montale – quando il poeta
giovane, ancora quello degli Ossi, lascia un varco non aile parole, ma al ritmo. A
un calco ritmico-sintattico, e nel ritmo sta force l'essenza stessa del canto come
della poesia.
Ecco il più bell'esempio in proposito: il Montale di Corno inglese, 1923,
canta cosi:
(reami di lassù, d'alti Eldoradi
malchiuse porte)...
E Alfonso XI, proprio al balzante e amoroso avvio del suo canto (un
recitativo) nella Favorita di Donizetti:
Giardini d'Alcazàr, de' mauri regi
care delizie...
Non una sola voce lessicale arriva a questa "ricca" parentesi di Corno
inglese dal primo dispiegarsi del recitativo di Alfonso XI. Cosi Montale bada a
non scoprirsi. Ma lo scopre chi badi al ritmo, al verso, alla sintassi, aile giunture
di questi due passi. Il recipiente ritmico-sintattico è proprio quello. Torna
insomma tale e quale dalla Favorita a Corno inglese. E questo endecasillabo
con forte cesura, dettata dalla tronca in 6a sede – Alcazàr / lassù – rispunterà
poi altrove nel poeta degli Ossi di seppia. Qui basti notare che anche la densità
esoticheggiante e insieme sonora del recitativo di Alfonso è ricalcata da questo
Montale. E allora non solo si risponde con l'Eldorado all'Alcazàr, ma abbondano
le toniche in -à-: da Alcazàr a màuri, a càre in Donizetti, e da reàmi ad àlti a
Eldoràdi appunto nel Corno inglese montaliano.
6. L'uso "metafisico" del messaggio melodrammatico.
Questo peraltro è un esempio-limite. È al limite in quanto Montale,
dicevo, preferisce rielaborare, re-impastare, camuffare. C'è – direi – una
vigilanza del Padre, paterna, in questo: una vigilanza che agisce sul suo modo di
accostarsi alla fisica, corporea maternità del canto.
Da qui deriva non una sottovalutazione della memoria del canto
melodrammatico da parte di Montale (piuttosto la sottovalutazione è da parte di
quasi tutta la critica montaliana). Ne deriva semmai un uso, diciamo, padronale
della parola del melodramma: nel che Montale si comporta proprio come un
Verdi, è anche lui una specie di musicista impaziente e poco rispettoso nei
confronti dei suoi umili "parolieri", dei suoi modesti e incantevoli portatori di
parole (Verdi, si sa, finché non arriva l'illustre Boito, è padre-padrone coi suoi
librettisti; e con loro neanche Puccini era tenero). In questo Montale è
paradossalmente l'ultimo dei grandi "musicisti con parole", se cosi posso dire,
della grande tradizione italiana.
Ma non posso fermarmi solo a questo aspetto. Certo Montale può
adoperare il melodramma anche come una cava di materiali non da citare in
bella vista, ma da elaborare e reimpastare nel suo linguaggio dall'amplissima,
dantesca escursione. Pere,, specialmente nella terza grande raccolta, nella
Bufera, appare l'altro modo, solo in parte conflittuale con quello che ho appena
illustrato – l'aspetto, diciamo, d'uso –: quest'altro aspetto consiste nel "prendere
sul serio" le implicazioni drammatiche e visionarie del melodramma, e anzi
nell'accentuare, nel verticalizzare, questo aspetto, fino a una valenza tragicometafisica.
Ecco due esempi al riguardo, ed entrambi li ho trovati appunto nella
Bufera.
a) Guardiamo ancora alla Tosca di Puccini. Il tenore, Mario Cavaradossi, è
stato apparentemente graziato da Scarpia, il Capo della polizia romana. Questi
ha fatto credere a Tosca (e a Mario) che l' esecuzione sarà una finta esecuzione.
Noi sappiamo che non è cosi. Cavaradossi sarà di fatto ucciso. Anche se non lo
sapessimo, è la musica ad avvertirci che il clima è solo apparentemente "da
commedia", di fatto è tragico. È dentro questa ambiguità a doppio registro che
nell'ultimo atto il Carceriere pronuncia al Condannato una sola parola: L'ora; e
il carcerato Cavaradossi risponde altrettanto brevemente: Son pronto.
Queste due minime cellule verbali sono ben rimaste nella memoria di
Montale. Pensate al mirabile Piccolo testamento: arriverà, dice il poeta alla sua
donna (Clizia? Volpe? o piuttosto un incrocio di entrambe?), un Messo
infernale, un Lucifero, si spegnerà ogni lampada, tu conserva memoria della mia
esigua ma tenace testimonianza e fierezza, «conservane la cipria nello
specchietto» della borsetta,
quando spenta ogni lampada
la sardana si farà infernale
e un ombroso Lucifero scenderà su una prora
del Tamigi, del Hudson, della Senna
scuotendo l'ali di bitume semimozze dalla fatica, a dirti: è l’ora.
E prima, nella Ballata scritta in una clinica, "agiscono" anzi entrambe le
minicellule del breve colloquio tra Carceriere e Carcerato, così:
Attendo un cenno, se è prossima
l'ora del ratto finale:
son pronto...
Il ratto finale non è meno che il ratto di Europa, un mito rivissuto conne
segno di Fine di un mondo, Finis Europae, da un poeta borghese e umanista
come Montale, tra 1944 e ‘45. Dunque sia Piccolo testamento, sia, otto anni
prima, questa Ballata, scavano e sprigionano dal ricordo della Tosca un'oltranza
metafisica, un massimo di energia cupamente, tragicamente visionaria.
7. Col melodramma tra Dante e Shakespeare.
È poco, questa di questo Montale, una poesia italiana, se non si torni a un
Padre altissimo spesso tradito, cioè al Dante della Commedia. E infatti Montale
ci ha pensato, e ha collocato molto melodramma del nostro Ottocento
addirittura tra Dante e Shakespeare. Come già ricordavo, ha scritto negli anni
‘50: «...il nostro Ottocento operistico non ha altro riscontro nella storia della
civiltà europea, che nella grande stagione elisabettiana». E un po' prima, nel ‘46:
specialmente a Verdi «dobbiamo la sorprendente ricomparsa, in pieno
Ottocento, di alcune vampe del fuoco di Dante e di Shakespeare».
Ora, proprio queste vampe e questo fuoco possono, seguendo le
intenzioni stesse di Montale, ricondurci, da Dante a Shakespeare, al
melodramma ottocentesco e all'uso a volte intensamente tragico e visionario che
ne fa il Montale poeta. E cosi vi porto ora il secondo esempio dalla Bufera,
sempre su questa linea tragica, onirica, visionaria, di traduzione e compimento
del messaggio melodrammatico.
b) Guardiamo alla poesia — Anniversario — che chiude di fatto la Bufera,
perché le seguono solo le due Conclusioni provvisorie (Piccolo testamento, già
assaggiato poco fa; e Il sogno del prigioniero). Leggiamo dunque questa poesia,
ultima dei Madrigali privati e dedicata a Volpe:
Dal tempo della tua nascita
sono in ginocchio, mia volpe.
È da quel giorno che sento
vinto il male, espiate le mie colpe.
[…l
Arse a lungo una vampa; sul tuo tetto,
sul mio, vidi l'orrore traboccare.
Resto in ginocchio: il dono che ho sognato
non per me ma per tutti
appartiene a me solo, Dio diviso
dagli uomini, dal sangue raggrumato
sui rami alti, sui frutti.
La vampa. L'ardere, l'orrore, il sangue. Le disillusioni. Solo la giovane
Volpe può vincere tanto male, e può fare dell'io poetico un Dio. Cosi però
Montale rinunciava all'idea che una Donna messaggera del Cristo — Clizia —
potesse apparire in suo nome per salvarli tutti, gli uomini. Ci rinuncia qui
purché cosi — per la via di un amore ben più terrestre, carnale, quello che
riguarda un io e un tu soltanto — si stabilisca una distanza. Una distanza
rispetto a cosa?
La poesia è di qualche anno dopo la seconda guerra mondiale.
Quell'amore divide (e protegge) l'io dal ricordo peraltro tenace che, a lungo, è
stato un incubo, la guerra. Ebbene, per dare immagine a quel lungo incubo di
fuoco — «arse a lungo una vampa» — di orrore — «vidi l'orrore traboccare» —
di sangue — che tuttora è raggrumato «sui rami alti, sui frutti», e dunque
minaccia tuttora lo svolgersi stesso della vita, i suoi frutti — a cosa ricorre
questo Montale?
Ricorre all'opera forse più vermiglia — come diceva Bruno Barilli — del
nostro melodramma. Ricorre al Trovatore di Verdi. Che è come un lungo sogno
notturno, intessuto di pulsioni, di passioni primarie: una lunga notte in cui si
inscenano la guerra e le passioni più elementari nel segno del fuoco e del
sangue. Un dramma onirico, tutto barbaramente percorso dal fantasma della
vampa e insieme dell'orrore e del sangue. E tutti questi segni fanno
"costellazione" in un punto del Trovatore, che è poi quello suo più famoso: nella
cabaletta "della pira", il tenore, Manrico:
Di quella pira l'orrendo foco
tutte le fibre m'arse, avvampò.
Empi spegnetela, o ch'io fra poco
col sangue vostro la spegnerò...
In realtà qui Montale si ricorda del Trovatore "come se" fosse l'ultima
opera di Shakespeare. Di uno Shakespeare arrivato fino all'Ottocento — che
infatti lo riscoperse e lo amò molto — e arrivato a compiersi e a bruciare nel
canto. Il canto come compimento, dunque, della tradizione poetica drammatica
dell'Occidente. E come suo forse ultimo rogo. E infatti Montale lo ricanta, qui,
questo luogo di condensazione massima del Trovatore, tra orrore, arsura,
fuoco, vampa, sangue: e cosi ritrova anche lui, per il tramite del melodramma,
«alcune vampe del fuoco di Dante e di Shakespeare».
Poi, dopo la Bufera, questo fuoco, queste vampe andranno spegnendosi.
Se Montale rievocherà il melodramma sarà in altra prospettiva, in cerca di
Annetta, in cerca del primo aurore – e della sua fine, e della fine della
giovinezza. Allora, come qui non posso dimostrare, accanto alle figure giovani
del melodramma – Manon anzitutto – tornerà a profilarsi Leopardi, il passero
solitario, Silvia. Che già occupavano anche, ma segretamente, tanto orizzonte
del primo Montale.
Ma prima di slacciarsi pian piano dal Sublime, è addirittura nella scia e
nel segno di Dante e di Shakespeare che il Montale della Bufera colloca alcuni
febbrili esemplari melodrammatici: un invito, fra l'altro, a fare con lui il
percorso inverso, a re-incontrare con una maggiore disponibilità e
consapevolezza, partendo dalla poesia montaliana e da Dante e da Shakespeare,
il significato più ricco, più intenso e più "nostro" del melodramma italiano
dell'Ottocento.
in “Chroniques italiennes” n. 57 (1/1999).
Un ampio sviluppo del tema, da parte dell'autore
del presente saggio, è costituito dal volume:
"Il fiore dell'addio: Leonora, Manrico e altri fantasmi
del melodramma nella poesia di Montale",
Bologna, Il Mulino, 2003
E.M.
Le parole e la musica
(1949)
Le parole messe in musica, le parole cantate non piacciono ai più
raffinati cultori dell'arte dei suoni. Fra coloro che ancora le sopportano,
molti preferiscono le forme corali, in cui la parola sparisce, altri amano che
dalla voce giunga solo l'arabesco sonoro, senza che alcuna sillaba si
distingua, altri ancora (i meno) vorrebbero che la parola musicata
giungesse a noi sempre scandita, chiara, intellegibile. Sono i partitanti del
così detto «recitar cantando», italianissimo precetto. Mi unirei volentieri a
questi ultimi se il gioco valesse come suol dirsi la candela, se fossi certo che
la musica può in certi casi far sprizzare dalla poesia, che in se stessa è già
musica, una musica di secondo grado degna, o non indegna, della prima.
So di sfiorare un problema sul quale esiste tutta una letteratura; che
purtroppo conosco solo in minima parte. E musicabile la poesia? E qual
genere di poesia? E fino a che punto? E in quale misura le parole dovranno
conservare la loro autonomia e lasciarsi intendere dall'ascoltatore? In
genere la recente tradizione operistica ha ignorato il problema e ha
considerato la parola come il necessario pretesto a far sì che lo strumento
«voce umana» possa entrare nel gioco degli altri strumenti e farsi valere.
Ma esiste anche una scuola che va dai nostri grandi cinquecentisti fino a
Debussy e magari fino allo Schönberg di Pierrot lunaire, e che pretende di
avere un rispetto assoluto della parola, di creare ad essa il giusto
prolungamento a alone sonoro, senza distruggerne l'individualità. Questi
teorici, più o meno consapevoli, del canto recitato hanno però finito con
l'ammettere che solo una «certa poesia» è musicabile le la scelta dei loro
testi rivela chiaramente ch'essi si sono quasi sempre posti sulla via del
compromesso. Musicavano una volta ballatette, poesiole d'Arcadia,
strofette scritte apposta per la musica; affrontano oggi drammi di scarso
valore poetico (Pelléas et Mélisande) o liriche di una vacuità addirittura
inconcepibile, come la suite del Pierrot lunaire, opera di un Albert Giraud
che deve al musicista viennese il suo insperato repêchage. Il peggior
partito fu quello preso dai musici che scrissero da sé i propri testi o libretti:
incerti fra la doppia vocazione, poetica e musicale, essi si lasciarono
ipnotizzare da parole orrende e solo si salvarono permettendo che le voci
andassero sommerse nella selva del grande golfo mistico. Fa eccezione,
parzialmente, Riccardo Wagner, ma ciò avviene per la superba natura del
suo genio, e non perché in lui non si avverta una soverchiante prepotenza
subìta dalla parola.
Se dal piano delle scuole e delle teorie ci spostiamo all'osservazione
dei fatti, noi vediamo che almeno dall'Ottocento in poi un sapiente
compromesso regola tutte le esecuzioni di musica vocale. Fatta eccezione
per moltissimi Lieder o romanze da camera, o per qualche recitativo
d'opera comica, o per alcuni superbi frammenti del Boris, la soluzione
pratica del difficile problema è sempre la stessa; le parole ci sono e non ci
sono, si sentono e non si sentono, aiutano o danneggiano l'effetto, a
seconda dei casi. Si è formata, anche in questo campo, una tradizione che i
migliori interpreti rispettano quasi d'istinto. E doveroso far sentire le
parole in certi miracolosi «attacchi» che anche poeticamente hanno una
freschezza primaticcia degna del nostro Duecento («Casta Diva che
inargenti...», «Là rivedrà nell'estasi – raggiante di pallore...») o all'inizio
di qualche incalzante proposta tematica («Fuggi fuggi, per l'orrida via –
sento l'orma dei passi spietati...»). In altri casi tutto è affidato all'intuizione
e alle possibilità dell'artista. I ghirigori acrobatici di Rosina non possono
essere pronunciati come le sillabe di un Lied di Schubert; è giusto che
Vasco de Gama liberi dal vago tremolo orchestrale le suggestive parole «O
paradiso dall'onde uscito», ma è altrettanto lecito che il grande navigatore
ci nasconda gli ulteriori sviluppi della sua sorpresa, specie quand'essi
restano affidati alla sola forza di penetrazione del si naturale o del do sopra
le righe. L'invettiva di Rigoletto «Solo per me l'infamia» è un suono di gong
più che un suono di sillabe umane: guai a pronunciare troppo, guai a
turbare la piena rotondità di quel rombo da giorno del Giudizio. Viceversa,
tutte le volte che un tema è annunciato in anticipo da uno o più strumenti,
l'attacco delle prime parole deve riuscire nitidissimo. Quando il vecchio Sir
Giorgio, nei Puritani, incide a gran voce «Il rivale salvar tu puoi...» il
pubblico è felice di sentire incarnarsi in parole un disegno melodico a lui
già noto: ma subito dopo le acque si intorbidano e il tema, ripreso da una
voce troppo uguale, quella di Sir Riccardo, non riesce a far corpo con le
parole come «Fu voler del Parlamento» che fanno veramente cascar
l'asino. Non che sia un verso peggiore di tanti altri; ma le parole troppo
astratte o troppo tecniche o troppo specifiche sopportano male la musica;
ed evidentemente questo quasi carducciano parlamento non fa eccezione.
(E una delle tante meritate disgrazie dell'istituto parlamentare; ma
lasciamo correre...) I problemi della parola in musica, del recitar cantando
o del cantare non recitando affatto restano dunque aperti e insolubili:
Mussorgski, Debussy e alcuni autori di canti negri sembrano, fra i moderni,
coloro che meglio sono riusciti a legare il suono alla parola, ma la loro
personalissima soluzione non può valere per tutti. Sono esistiti, e speriamo
ne sorgano altri in avvenire, grandissimi musicisti del teatro che si servono
della parola scritta come d'un semplice punto d'appoggio: Mozart, Bellini e
Verdi, per esempio. Il loro ideale non era quello di Strawinski, una lingua
morta, un testo latino quasi indecifrabile al gran pubblico, ma un discorso
chiaro e neutro al quale si potesse far violenza. Ciò resta vero anche se
Mozart amò i libretti dell'abate Da Ponte e Bellini quelli di Felice Romani.
E Verdi? Si è un poco esagerato sugli orrori delle parole da lui
musicate. L'orma dei passi spietati, tristamente famosa, non riesce a
muovermi a sdegno. Guai se leggessimo Shakespeare a questa stregua: non
venitemi a dire, per carità!, che l'orma si vede a non si sente. D'altronde
anche i vecchi libretti, fatti apposta per essere musicati, confermano,
quando toccano qualche espressione riuscita, che poesia e musica
camminano per conto proprio e che il loro incontro resta affidato a fortune
occasionali. Peggio quando raggiungono involontariamente il clima del
surreale. Conoscevo un uomo (un uomo in tutto il resto normalissimo) che
provava il bisogno di ripetere da cento a centocinquanta volte al giorno un
verso che era diventato il suo intercalare favorito: «Stolto! ei corre alla
Negroni!». Lo diceva anche al telefono, in conversazioni di carattere
commerciale. Quando gli rivelai che si trattava della Lucrezia Borgia egli
impallidì, geloso del suo segreto, e mi disse che mai avrebbe sentito
quell'opera per non provare la delusione di una musica soprammessa alle
sue «divine parole». Scansato da tutti come un appestato, egli finì per
stringere amicizia con un tale che ripeteva a intermittenza «La nostra
tomba è un'ara» (variante della foscoliana «vostra tomba») e con un terzo
maniaco che aveva scelto il più lungo intercalare ch'io ricordi: «Speriamo
di morire prima che le Pleiadi si colchino.» Doveva essere un classicista a
spasso, un professore in pensione. I tre uomini, vistisi porre al bando per la
loro incorreggibile, benché innocua ed epigrafica, ecolalia, finirono per
incontrarsi clandestinamente in una camera d'affitto dove potevano
emettere a ripetizione il loro verso preferito; e dove poi (il fatto avvenne
una quindicina d'anni fa) furono arrestati, accusati di congiurare contro il
regime e proposti per il confino.
Dopo tale disavventura il trio si sciolse e oggi non saprei dire se
qualcuno dei suoi componenti sopravviva. Inconsapevoli testimoni della
magica autosufficienza della Parola, i tre sventurati sarebbero assai
sorpresi di riconoscersi in uno scritto che sfiora, ma non pretende di
risolvere la vessata questione dei rapporti, coniugali ed extra-coniugali, tra
il Verbo e la Musica.
(in: Il secondo mestiere – Arte Musica Società, cit.)
Paradosso della cattiva musica
(1946)
a Massimo Mila
Il primo teatro in cui io abbia ascoltato a lungo e col dovuto profitto
una sufficiente quantità di cattiva musica non era un teatro ma un
capannone stile liberty provveduto di un piccolo palcoscenico: il caffè
ristorante del Lido d’Albaro, ai tempi della mia prima gioventù. Al tavolino,
succhiando la cannuccia di una bibita, mentre lo sguardo correva sulle
onde giallognole oltre le vetrate e seguiva il fumo dei piroscafi al largo, si
potevano tener d’occhio, s’intende con un occhio solo, gli allegri sberleffi
della Mascotte o della Figlia di Madama Angot, abbandonarsi alla
disperazione di Loris Ipanof o alle prestigiose contraffazioni musicali di
Leopoldo Fregoli. L’ambiente era adatto, il pubblico rozzo, conciliante e
sincero, la natura che spaziava intorno e il grande viale che percorrevo nel
viaggio di andata e ritorno (la passeggiata a mare della Marinetta), tutto
formava la cornice adatta a una buona (o meglio cattiva) educazione
musicale. La cattiva musica, infatti, a differenza della buona, non necessita
di ottimi interpreti ma richiede un concorso di circostanze favorevoli che a
volte solo il caso mette insieme. Un esempio può bastare per tutti. Una
sera, da Radio Amburgo, udii una voce profonda intonare un bellissimo
Lied che mi pareva di conoscere e non sapevo identificare. Ci pensai su a
lungo, poi di colpo scopersi l'incredibile verità. Si trattava nientedimeno
che di Ponchielli, si trattava del canto del «feral marito» Alvise Badoero,
eseguito in tedesco e in un tempo sbagliato, lontanissimo dalle indicazioni
del metronomo. E l’effetto era irresistibile.
Potrei continuare a lungo, potrei insistere su certa musica scritta o
trascritta per banda, o almeno su quella che soltanto in una veste e in una
sede più proprie rivela pienamente la sua efficacia; ma forse i lettori hanno
già capito dove voglio parare. È triste confessarlo, e tuttavia penso che sia
un dovere verso i molti che la pensano come me e che non osano
esprimersi credendosi negati alla sensibilità dei suoni: amo la cattiva
musica, la musica in cui il destino non batte alle porte e in cui i temi
conduttori sono ripetuti trenta o quaranta volte, certo per una immotivata
presunzione della nostra sordità; amo la cattiva musica, o meglio la musica
che la frateria non sempre disinteressata degli specialisti o dei musicanti di
professione proclama pubblicamente tale.
Dico pubblicamente perché per i membri della gilda musicale, come
per i gesuiti e per i grandi politici, esistono due verità: una privata e
strettamente confidenziale e un’altra per il grosso pubblico che si vuole
educare al sublime e al quale soprattutto s’intende propinare sotto
l’etichetta dell’eterno e del classico ogni sorta di esperienze nate in odio alle
Muse. I musicisti intelligenti (ce n’è) sanno benissimo che una parte della
cattiva musica di ieri, di quella ch’è rimasta in giro dopo l’energica
stacciatura del tempo, non è affatto cattiva o trascurabile o priva di
significato; lo sanno, ma si guardano bene dal dirlo nei loro congressi e
tanto meno lo scrivono nelle loro riviste; lo dicono solo agli amici profani,
in rari momenti di sincerità e dopo essersi guardati sospettosamente
intorno, per paura che qualcuno stia ad ascoltarli. Amano anch’essi,
gl’infelici!, la cattiva musica, ma la carriera, la professione, la stessa
resistenza ch’essi trovano in sé, impedisce loro di proclamare questa verità.
E finiscono così per negare l’evidenza che si impone alla felice ignoranza
dei non iniziati: che in nessun’altra arte, come oggi in quella dei suoni, il
dono, la natura, la scintilla che non si acquista con lo studio sono sacrificati
alle ricerche della tecnica, alle trouvailles del mestiere e del laboratorio,
alla parola d’ordine delle conventicole.
La buona musica e la cattiva hanno del resto caratteri assai diversi
che finora non sono stati oggetto di attento studio. La musica buona o
eletta ha bisogno di teatri, di auditori, di golfi mistici o di sale da concerto
in cui i misteri dell’acustica non siano più tali; ha bisogno di interpreti
d’eccezione, possibilmente stranieri, meglio se tedeschi; ha bisogno di
guide tematiche, libretti-programma, prefazioni e introduzioni da
scodellarsi volta per volta; ha bisogno di abbonati, di clienti e di patiti; ha
bisogno insomma di una straordinaria montatura culturale, ed è
naturalmente materia di mercato, merce che dà da vivere a tutto un mondo
che effettivamente non potrebbe vivere in un’altra maniera. Soprattutto
essa ha bisogno di organizzazione e di ritualità. Ci si reca al concerto del
divo o all’operina d’avanguardia o alla salmodia per voce recitante tam-tam
e clarinetto come si va in chiesa, e anzi con costrizioni più rigide, perché in
chiesa, la domenica, le messe si dicono ogni mezz’ora; si va insomma a
sentire la buona musica in condizioni d’animo tali che escludono a priori la
sorpresa, l’imprevisto, il caso, che escludono, cioè, quella condizione di
passività ricettiva e gratuita che meglio permette di cogliere il segreto della
creazione artistica. Un pezzo come la Primavera di Grieg sarebbe forse
intollerabile in una sala da concerto, né io ricordo di avervelo mai sentito
eseguire. Ma fate ch’esso vi giunga dalla casa di faccia una mattina
d’inverno, attraverso gl’incerti annaspamenti di un oscuro dilettante, e vi
sentirete veramente sgelare il cuore, come avviene nel Pan di Hamsun e
come non avviene, oh no, nelle esibizioni dei più illustri concertisti.
Il vantaggio della cattiva musica è infatti ch’essa (piacendo a Dio) ci
soccorre a tutte le ore del giorno e della notte. Si giova anch’essa di un
ambiente adatto e di un pubblico educato (in questo caso ineducato), ma il
suo ambiente non è mai prevedibile né calcolabile, potendo essere il teatro
di provincia, il caffè, il baraccone, la nostra stessa stanza invasa dalle onde
hertziane o dal canto notturno di un ubriaco. Inoltre la cattiva musica non
è soggetta a canoni interpretativi violando i quali si possa passare per
grandi restauratori e scopritori. Accetta, sollecita forse, tutti gli arbìtri, ma
chi commette tali arbìtri non è portato in trionfo come accadde a quel
giovane direttore contemporaneo che «avendo scoperto Verdi» (sic) e
avendolo eseguito assai peggio degli oscuri maestri... omissis omissis, ha
fatto versare fiumi d’inchiostro e ha profondamente commosso i nostri
critici. Povero Verdi, tenuto in quarantena dagl’intellettuali fino a venti
anni fa malgrado l’entusiasmo popolare che lo ha sempre accompagnato,
promosso poi alla schiera dei musicisti tollerabili per l’opera sua più
eclettica, il Falstaff, sopportato anche in qualche spartito che come il
Macbeth ha avuto il battesimo del Festival di Glyndebourne; povero rauco
cigno bussetano messo prudentemente da parte, oggi, come musicista sui
generis, quasi che tale non fosse l’irriducibile situazione dei più grandi
artisti! Mi dicono che il recente astro inglese Benjamin Britten abbia fatto
tanto di cappello alla Traviata; ma chi persuaderà certi amici che so io,
convinti che stile, stilizzazione e noia siano altrettante equivalenze
algebriche? Chi li convincerà che la musica dei concerti contribuisce in
parte minima, quasi infima, all’educazione dell’uomo d’oggi – in confronto
all'«altra musica», alla musica dei boschi e del mare e della vita, alla quale
appartengono di buon diritto anche i più alti vertici di Gluck e Musorgskij,
di Wagner, di Verdi e del migliore Debussy?
Mi accorgo che ho lasciato nella penna le cime maggiori (Bach,
Mozart) e che ho parlato soprattutto di musica teatrale o impura, perché è
quella di cui ho più diretta esperienza, quella che non può morire senza
trascinare con sé la musica pura, a lei legata da molti fili; ma ritengo che
volendo si potrebbe allargare il discorso, si potrebbe postulare l’esistenza di
una musica senza aggettivi che comprenderebbe tanto El relicario e
Stormy Weather quanto certi angosciosi frammenti di Schönberg che
Roman Vlad mi ha fatto sentire recentemente a Roma e che per essere più
poesia che musica sono immediatamente accessibili a chi senza essere
musicista conosca i caratteri e le forme della lirica che va da Rimbaud a
Tralci. E forse non farei che contrapporre la musica geniale alla musica di
applicazione, Padilla a Respighi, la Chovanščina al Faust di Busoni, e di
fronte a questa lapalissiana verità mi si chiuderebbe la bocca, accusandomi
di incompetenza, confusione di «generi», sensibilismo dilettantesco,
antistorico, ecc.; salvo poi riconoscere tra loro, a porte chiuse, i cari
professionisti, che nello scorso secolo pianismo da concerto e sinfonismo
da grande orchestra hanno immiserito e soffocato la musica facendone
un’arte che si può imparare nei conservatori e che più tardi la reazione a
questo andazzo (piccoli complessi orchestrali, ricerche puramente
timbriche, falsarighe di testi letterari ipersquisiti) è stata condotta con
freddezza polemica, da gente che per lo più era nata per seguire la vecchia
strada, sulla quale non si rassegnava all’epigonismo. E a questo punto
l’onesto ignorante, l’amatore della «cattiva» musica, deve concludere che
pura o impura, facile o difficile, la musica viva di domani sempre meno ci
verrà da musicisti di clan, da fanatici; così come non ci verrà la poesia di
domani dai letterati che frequentano le «case della cultura» e i congressi
sulla ricostruzione spirituale dell’Europa.1
Sono convinto che anche Claude Debussy, grande musicista
soprattutto quando scoperse per conto suo il pianoforte, con una
prodigiosa immersione nella civiltà del suo paese, da Rameau-Couperin
fino a Monet e a Renoir, amava quella che io chiamo la cattiva musica, la
musica che alcuni immemori della favola della volpe e dell’uva fingono di
trovare cattiva. Le pagine ch’egli ha dedicate a Massenet nel suo Monsieur
Croche antidilettante sono intonate a ironica condiscendenza, come
qualcuno ha creduto? In realtà Debussy sapeva benissimo che Manon
eseguita come si deve eseguire, da cattivi interpreti francesi dell’Opéra
Comique, era ed è come il Faust di Gounod un’opera di stile; e sapeva che
chi ha scritto la parte di Carlotta nel Werther ha capito il romanticismo
tedesco, e non solo quello musicale, assai meglio di tanti specialisti. A conti
fatti mi si potrà concedere che difficilmente Massenet si potrebbe iscrivere
fra i «cattivi musicisti»; e qualcuno ammetterà con me – come l’ammetteva
Fernando Liuzzi – che persino il povero Mascagni non ha infarcito soltanto
di cose scadenti l’avveniristico (per i suoi tempi) zibaldone dell'Iris. Ma che
vale? In questa materia io non amo convertire i dissenzienti, perché se essi
mi dessero ragione diventerei il più assiduo abbonato della Società del
Quartetto. Amo, e lo dico molto semplicemente, quei musici in cui l'amor
1 Absit iniuria, caro Flora. Se l’invito non mi fosse giunto con un mese di ritardo
sarei venuto ad applaudirti anch’io.
vitae non si fa uccidere dalla superstizione di un nuovo stile; li amo forse
perché indicano la via che avrei voluto seguire nell’arte mia, se ne avessi
una e se la poesia fosse davvero un’arte come le altre: il che non è troppo
facile a dimostrarsi...
E finirò con un aneddoto. Quando Giacomo Puccini (lirico talvolta
ispirato, benché i suoi «pezzi» facciano regolarmente a pugni con la cornice
che li accoglie) rivelò alla prova generale della Fanciulla del West che per
ottenere l’effetto di uno squadrone di cavalleria irrompente dietro le quinte
occorreva «agitare un sacco di noci di cocco», tutti rimasero stupefatti. (A
quel tempo non esistevano grandi registi e il teatro stava in piedi lo stesso.)
Il maestro aveva scoperto il trucco molti anni prima, a Marsiglia,
assistendo a un dramma del Grand Guignol, parlando col direttore della
compagnia, supplicandolo e commovendolo alla rivelazione del suo nome.
E del segreto s’era ricordato al momento opportuno. Anche col sacco delle
noci di cocco la Fanciulla non vivrà in eterno; ma l’episodio mi è rimasto in
mente perché fa luce sulla psicologia di un uomo per cui il mondo esteriore,
nella musica e fuori della musica è veramente esistito. Ho detto il mondo
esteriore e dovevo dire la realtà compatta che ci presenta la vita; quella vita
nella quale non si può distinguere un didentro e un difuori e che troppo
spesso i professionali del sublime mostrano di ignorare nelle loro opere;
quella stessa che attende uno stile dagli artisti e che domanda, ma invano,
di filtrare dai commerciali alambiccamenti di chi, pur facendo bottega
dinanzi a un pubblico guasto e corrotto, osa sovente presentarsi nelle vesti
di bigello del più puro disinteresse.
(in: Il secondo mestiere – Arte Musica Società, cit.)
da: La poesia come arte
(1942)
[…] L'inclusione della poesia nel quadro generale delle arti è un tentativo
abbastanza recente; doveva essere compiuto, apporterà non pochi
vantaggi, ma resta un tentativo che dà luogo a gravi difficoltà teoriche e
pratiche. Abbattendo i vecchi pregiudizi non si è però abbattuta la grande
esigenza (empirica?) che in fondo a quelli viveva. In un certo senso la
poesia è un'arte, non meno libera delle altre e forse più profonda, per
l'estrema imprevedibilità e ricchezza dei suoi risultati; ma d'altra parte essa
si serve di parole, e le parole non possono prescindere da un colore storico
e da una risonanza che mutano con grande rapidità. Perciò la poesia, assai
più delle altre arti, sembra soggetta a invecchiare. Invecchiando sopravvive
se si presta ad essere ricostruita e interpretata in modo diverso, a essere
fonte di altissimi equivoci. Ciò si può dire, beninteso, anche delle
cosiddette arti, ma in senso assai più ristretto. Le arti hanno qualcosa di
più oggettivo, sono in qualche modo più resistenti al tempo. O forse più
docili, si potrà suggerire: in esse il significato non tarda a diventare «
pretesto», occasione; in poesia tale processo è più lento e lascia sempre un
fortissimo residuo. Possiamo spiegarci perciò (restando inteso che in senso
temporale non c'è eternità né per la poesia né per le arti) perché i poeti
antichi, sopravvivendo per noi parzialmente, spogliati del loro senso
originario, ci sembrino tutti un po' più piccoli del vero; mentre gli artisti
antichi ci paiono tutti un po' più grandi del giusto. La poesia, che ha
bisogno di conciliare il « particolarissimo » con l'universale, è a lunga
scadenza insidiata dallo slittamento di uno dei due termini di questo
equilibrio. Il destino alto e oscuro della poesia parrebbe dunque quello di
tendere sempre più alla condizione di arte, all'assoluta purezza che questa
parola postula, restando pur sempre, e con piena coscienza dell'impossibile
assunto, un'arte diversa, un'arte sui generis, alla quale i secoli hanno dato
un altro nome. Rispettarne il nome non rappresenterà certo un vano
scrupolo di pietas storica, quando il mutarlo, com'è nel caso d'oggi, dia
luogo soltanto a una tautologia, o ad un passo indietro.
(in: Il secondo mestiere – Prose 1920-1979, a c. Di
G.Zampa, Milano, Mondadori, 1996)
Alessandro Martini
OCCASIONI M USICALI NELLA POESIA
DEL PRIM O M ONTALE
Riconosci alla musica, in senso tecnico, importanza per la tua
poesia?
Probabilmente sì. Credo che la mia poesia sia stata la più
«musicale» del mio tempo (e di anche prima). Molto più di Pascoli
e di Gabriele. N on pretendo con questo di aver fatto di più e di
meglio. La musica è stata aggiunta, a D ’Annunzio, da Debussy
(S P 603)1.
Così rispondeva M ontale a Giorgio Zam pa nel 1975, con
giusta fermezza nella rivendicazione di un incontestabile pri
m ato nella tradizione del Novecento e con estrema cautela
nell’affrontare rapporti tanto facili da supporre quanto sfug
genti all’analisi, come quelli fra poesia e musica. N on mi pare
che la critica abbia dato un adeguato rilievo all’im portanza
della questione, per cui oso incrementare di qualche pagina la
già sovrabbondante bibliografia m ontaliana con qualche nota
iniziale su dati molto concreti quali i riferimenti alla musica
vera e propria che costellano l’opera in versi del poeta.
Essi implicano, in un primo sommario e rozzo catalogo,
realtà musicali numerose e disparate: strumenti musicali, for
mazioni in cui questi si dispongono, forme e scrittura musicali,
citazioni di poesia per musica e addirittura di frasi musicali,
personaggi del teatro musicale, rumori e silenzi. Per gli stru
menti: non solo i soliti romantici violini, flauti, corni e piano
forti, ma anche più rare celeste e vibrafoni, lungo un arco che
va sintomaticamente dallo struggente canto del corno inglese
che quasi apre gli Ossi all’oboe che stonicchia in versi del 1979
(O V 661). Per le formazioni: mai viene ricordata la grande
orchestra sinfonica, ma più piccoli assiemi che vanno dal trio di
m oderni menestrelli da strada (O V 14) al «quartetto di can
nucce» («la sola musica che sopporto») diretto da una Musa che
106
Alessandro Martini
indossa i panni dello spaventacchio nel Diario del 7 1 (O V 429).
Per le forme: non ci troviamo mai di fronte a generici suoni e
canti (ovvie metafore di una poesia che aspira dannunziana
mente a un sovratono musicale) ma a generi ben individuati:
per esempio un ben preciso lied di Beethoven, cantato e pestic
ciato dal piccolo Eugenio a quattro mani («forse a quattro
piedi») con un barnabita in odore d’eresia, ricordato nel Diario
del 72 (O V 464); oppure si tratta di un’operistica cabaletta del
1975 (O V 565), memore forse di quella coeva di Giorgio
Caproni, l’altro grande genovese che cala spesso la sua teologia
negativa in arguti versicoli arieggiami la poesia per musica.
U na certa preziosità si avverte anche nell’impiego di altra ter
minologia tecnica: dall’intervallo di terza maggiore emesso da
un cucco nella Bufera (O V 230) alla sigla ppp che sta fra gli
ultimi versi a segnare «una fine dolcissima» quanto ironica
(O V 570). A bbondanti devono essere le citazioni di poesia ope
ristica ed operettistica, del grande ma anche del più modesto
repertorio, a giudicare dalle meno occulte, verdiane (O V 287,
471). È questo un territorio tutto da esplorare, tenendo conto
anche delle esplicite dichiarazioni del poeta in Satura:
...Lei che amava solo
Gesualdo Bach e M ozart e io l'orrido
repertorio operistico con qualche preferenza
per il peggiore (O V 391).
M a altrettanto contano le vere e proprie frasi musicali, ben
più difficilmente citabili perché sprovviste di semanticità, peti
tes phrases proprio in senso proustiano, dall’iniziale Debussy di
Minstrels trasposto in poesia, ai mozartiani «angui d’inferno»
nelle Occasioni (O V 178). Le più felici e proustiane interm it
tences du cœ ur sono per altro mediate da un più modesto
Massenet (O V 490 e 684) e da un ancor più modesto Léo
Delibes, nello straordinario m ottetto Infuria sale o grandine, in
cui l’assente è resa presente non tanto da un rintocco debussiano, quanto dalla riproposta poetica del «trillo d’aria» di
«Lakmé nell’Aria delle Campanelle» (O V 146), come ben sotto
lineato da D ante Isella nel suo esemplare com m ento2. N on
trascurabili sono inoltre i personaggi che hanno un’esistenza
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
107
solo musicale come Carmen (O V 427) e tanti altri meno celebri,
come quelli d ’operetta fittamente elencati come occasioni m an
cate in Keepsake (O V 114). E ci sono infine i rumori, estrema
mente insistenti sin dalla prim a poesia degli Ossi: le «gazzarre
degli uccelli», il «susurro dei rami» de I limoni; e sempre nei
Limoni ci sono i silenzi, su cui torneremo: rumori e silenzi che
quando appaiono in relazione al suono (come appunto nei
Limoni) hanno un indubbio valore musicale nell’estetica roman
tica e moderna.
Sul piano biografico ogni profilo del poeta ricorda come a
diciannove anni studiasse canto con il baritono Ernesto Sivori,
realizzando un sogno eminentemente wagneriano e simbolista,
come dichiara l'Intervista immaginaria del 1946: «L’esperienza,
più che l’intuizione, della fondamentale unità delle varie arti
dev’essere entrata in me anche da quella porta» (SP 562). È
dunque con un notevole bagaglio tecnico che negli anni Cin
quanta e Sessanta M ontale esercitò la professione di critico
musicale per il «Corriere d ’informazione», con i risultati che
oggi si possono apprezzare nella raccolta postum a Prime alla
Scala3. È un titolo un po’ riduttivo, poiché sono pagine che
vanno spesso al di là dell’occasionale esercizio giornalistico e
m ondano della prima, e poiché, oltre l’interesse prioritario per
l’opera, vi si scoprono reazioni vivissime anche alla musica stru
mentale, non esclusa quella contemporanea. Anzi forse M on
tale è più attento ai timbri strumentali e ai ritmi che alla melo
dia e al bel canto, non diversamente da quel che succede nella
sua poesia.
Il vario e vasto materiale tematico offerto dalla musica alla
poesia ha dunque, prim a ancora di un’eventuale valenza meta
forica o simbolica, un preciso senso tecnico e cronachistico.
È un materiale di cui l’ultimo M ontale sottolinea la casualità,
l’appartenenza a un privatissimo gusto, volutamente dimesso.
Resta che nel primo M ontale e nel M ontale maggiore, quello
dei primi tre libri, quei materiali assumono il ruolo centrale di
vere e proprie occasioni, nel preciso significato che questo ter
mine ha nella sua poesia: fantasmi che salvano, ritorni di atti
scancellati, maglie rotte nella rete che ci stringe.
108
Alessandro Martini
1. L ’attraversamento di Wagner
Rievocando proprio la genesi del suo primo libro nelYIntervista immaginaria M ontale ci dice di aver ubbidito «a un biso
gno di espressione musicale», e prosegue: «All’eloquenza della
nostra vecchia lingua aulica volevo torcere il collo, magari a
rischio di una controeloquenza» (SP 565). Sono due chiare cita
zioni dell’o r / poétique di Verlaine: «de la musique avant toute
chose»; «prends l’éloquence et tords-lui son cou»: quest’ultima
presa sin troppo sul serio dai critici montaliani. N on così la
prim a che riguarda la musica e che attraverso Verlaine (un
poeta colossale per il giovane M ontale4) rinvia così nettamente
al clima simbolista francese a cavallo del secolo, al di sopra
delle teste dei vociani e dei futuristi che, aggiunge subito M on
tale nell’intervista, quelle esperienze avevano sì apprese, m a
spesso fraintese. Nel primo M ontale non troviamo dunque
rumori futuristi e organetti crepuscolari, e neppure il ritorno
all’antica musica italiana che proprio allora andava propo
nendo D ’Annunzio, ma credo di poter dire che siamo immessi
nel cuore della più alta tradizione musicale del tempo: non uno
Stravinskij probabilm ente ancora ignorato o uno Schònberg che
sarà poi coerentemente rifiutato, ma la premessa di quei due
fenomeni: la più radicale rivoluzione ed evoluzione che va da
W agner a Debussy.
Debussy, che rappresentò per il poeta la scoperta della
nuova musica (SP 563), è poeticamente rifatto, come dice il sot
totitolo, proprio in quei Minstrels già presenti nella prim a edi
zione degli Ossi e poi tolti dalle successive come «cosetta»
velleitaria, m a restaurata per volontà del poeta nella recente
edizione critica di Contini e Bettarini (O V 14, 861 e 866-7).
W agner invece è nominalmente assente dall’opera in versi di
M ontale, ma cercherò di dimostrare come sia sottilmente pre
sente in Corno inglese, che nel testo definitivo precede di poco
Minstrels, quasi a confermare un’indicazione di percorso fonda
mentale non solo per il poeta. È noto il suo perentorio giudizio
su Gozzano, del 1951:
egli fu il primo dei poeti del Novecento che riuscisse (com’era
necessario e come probabilmente lo fu anche dopo di lui) ad attra
versare D ’Annunzio per approdare a un territorio suo, così come, su
scala maggiore, Baudelaire aveva attraversato Hugo per gettare le
basi di una nuova poesia (SP 62).
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
109
È chiaro: M ontale parla qui più di se stesso che di Gozzano, e
come egli stesso abbia attraversato D ’Annunzio ci è stato
ampiamente m ostrato da un memorabile intervento di
M engaldo5. Qui si vuole piuttosto sottolineare che in quel
medesimo intervento su Gozzano precedono altre simili parole,
pure ricordate da Mengaldo, ma che non pretendevano in
quella sede u n ’analoga illustrazione critica:
Ridusse D ’Annunzio come Debussy aveva ridotto Wagner, ma
senza mai giungere a risultati che possano dirsi debussiani (SP 57).
La riserva insinua altrettanto chiaramente che il Debussy della
situazione fu appunto Montale, attraversando Wagner, non
senza dimenticare quanto in Italia la figura di D ’Annunzio
fosse indissolubile da quelle di Wagner, di cui fu il maggiore
corifeo e dei cui intenti musicali tentò una prima gonfia traspo
sizione letteraria. Senza dimenticare inoltre che il Martyre de
saint Sébastien di D ’Annunzio era stato musicato da Debussy
nel non lontano 1911, e che le tragedie dell’imaginifico erano
messe in musica dai compositori italiani più aperti alla nuova
musica europea, come Pizzetti e Malipiero, negli anni in cui
nascono appunto gli Ossi montaliani: il mostro sacro da attra
versare e ridurre, D ’Annunzio, era anche sul piano del nuovo
gusto musicale e della sua divulgazione una personalità ben
viva e operante.
La grande novità del linguaggio musicale wagneriano, deci
siva per le sorti della musica del Novecento, sia per l’impres
sionismo di Debussy che per l’espressionismo di Schònberg,
consiste anzitutto nell’uso del cromatismo, uso che si fa domi
nante e sistematico (lo riconosce lo stesso M ontale in SP 157)
nell’opera sua più ricca di fermenti moderni (quella che per
altro più scosse D ’Annunzio): il Tristano e Isotta. Qui più che
altrove sono continuamente forzati Ì limiti della tonalità clas
sica, attraverso la profusione dei mezzi toni e l’eliminazione
delle cadenze. L’orecchio educato alla musica tradizionale
ritrova difficilmente i suoi punti di riferimento: la stabilità
tonale appunto e le modulazioni che segnalano i passaggi da
una tonalità all’altra. N on si tratta ancora di suoni in libertà,
come nella musica dodecafonica, ma di suoni che tendono a
sottrarsi al loro centro di attrazione, all’ordine gerarchico in cui
110
Alessandro Martini
solitamente si succedevano: se non suoni, frasi in libertà e
soprattutto liberamente accostate, che trascorrono l’una
nell’altra senza le consuete connessioni, nelPintento di ottenere
un flusso musicale ininterrotto.
Beninteso il linguaggio poetico non conosce tonalità e mezzitoni che le definiscono e ne perm ettano la differenziazione.
M a siccome il cromatismo incide proprio sulla sintassi musi
cale, è possibile ravvisare in certe audacie sintattiche e ritmiche
del testo poetico un’analogia con la rivoluzione wagneriana,
soprattutto quando il poeta abbia prestato un’estrema atten
zione a queste analogie. Si rilegga questa ouverture m ontaliana
alla lettura degli Strumenti umani di Sereni (1965):
Per lunghi secoli tributaria della poesia, la musica prende la sua
rivincita nel secondo Ottocento. In Francia, tra i primi fondatori
della «Rivista Wagneriana» appaiono alcuni poeti simbolisti. A
parte coloro che adottano il verso libero, gli altri, i migliori, ten
dono a immettere nelle forme tradizionali la lezione del croma
tismo musicale. Nelle loro poesie le forme architettoniche restano
generalmente «chiuse» ma nell’interno di quegli argini i contenuti
si polverizzano (Mallarmé) o si fanno ambigui (Valéry, considerato
da qualche critico un poeta bergsoniano). Tuttavia resta ancora
possibile versare vino nuovo nei vecchi otri (Yeats). Più tardi appa
riranno poeti che invidiano le conquiste tecniche della nuova
musica. Abolita la dominante, escluso il tematismo (che privilegia
certe note a vantaggio d’altre), ammesso il principio che in ogni
composizione ogni nota sia sempre un principio e una fine e che il
centro debba essere in ogni luogo e in nessuno, i musicisti danno
lezione ai poeti; e questi accettano la lezione (SP 328-9).
2. Un «Corno inglese» wagneriano
Leggiamo ora Corno inglese con orecchio attento a queste
indicazioni, in particolare alla sintassi e alla metrica, cioè agli
elementi che meglio credo perm ettono un’interpretazione cro
matica della poesia.
Il vento che stasera suona attento
- ricorda un forte scotere di lame gli strumenti dei fitti alberi e spazza
l'orizzonte di rame
5 dove strisce di luce si protendono
come aquiloni al cielo che rimbomba
(Nuvole in viaggio, chiari
reami di lassù! D ’alti Eldoradi
malchiuse porte!)
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
111
10 e il mare che scaglia a scaglia,
livido, muta colore,
lancia a terra una tromba
di schiume intorte;
il vento che nasce e muore
15 nell’ora che lenta s ’annera
suonasse te pure stasera
scordato strumento,
cuore.
L’indubbio fascino del testo sta anzitutto nell’essere costi
tuito di un solo periodo ottativo: un unico vocativo sospeso
lungo l’arco estremamente teso di 18 versi. Certo la sintassi è
sempre complessa in Montale, ma qui lo è in modo eccezionale,
tanto da arrischiare l’oscurità6. La coordinazione di orizzonte 4
e mare 10 è interrotta da ben cinque versi, occupati dalla descri
zione del cielo e dai vocativi alle nuvole, ai reami, agli Eldoradi,
per quanto evidenziata dal fortissimo legame fonico dell’ana
gramma fra rame 4 e mare 10. C’è per altro una variante
d’autore assai tarda, del ’78, non accolta a testo nell’edizione
critica, che conferma la volontà di creare un blocco unico, una
assoluta compattezza sintattica, interrotta solo dalla parentesi
metafisica, poiché è variante che elimina anche quello che M on
tale definisce 1’«insopportabile» inciso del secondo verso:
Il vento che stasera ha suonato
con un suo forte scuotere di lame
gli strumenti degli alberi e ha sconvolto
uno sfondo di rame (O V 865).
Oltre la continuità sintattica si noterà la prosaicità del rifaci
mento, e, ciò che più im porta ai fini della mia proposta, l’artifi
ciosa teatralità di quello sfondo per rapporto al primitivo oriz
zonte. Ora, parlando della prim a scaligera dei Maestri cantori di
Wagner nel ’62, Montale ha affermato:
nel passo lento del discorso [...] si trova ancora intatto il carattere
della musica wagneriana, quel procedere per accumulazioni che è il
segreto, imitato ma in realtà inimitabile, del suo stile (PS 369).
È un procedere per accumulazioni che definisce bene sia il cro
matismo del compositore, sia la particolare sintassi di questo
solenne adagio che è Corno inglese.
112
Alessandro Martini
La sintassi credo perm etta di segmentare il testo non in tre
parti, come solitamente fanno i suoi lettori, ma in quattro, che
dai loro temi dom inanti denominerò: 1. del vento che suona lo
strum ento della natura (w . 1^4); 2. del cielo che rimbomba
(w . 5-9); 3. del mare cangiante in tempesta (w . 10-13) e di
nuovo 4. del vento che non può suonare lo scordato strumento
uomo 14-18, con chiara ripresa antitetica del primo tema, evi
denziato dalla riesposizione di ben quattro parole: vento, suo
nare, stasera, strumento. È spazialmente un alternarsi di quattro
blocchi d i 4 - 5 - 4 - 5 versi di varia lunghezza: presi a due a
due nove versi per parte.
Evidente sul piano semantico il disaccordo tra natura
sonora e atonia dell’uomo; ma mi im porta sottolineare come il
titolo musicale della poesia e il suo unico verbo reggente (suo
nasse 16) permettono senz’altro di interpretare questo disac
cordo come una dissonanza musicale: dissonanza che è la prim a
e più sensibile conseguenza, sul piano strettam ente musicale,
del cromatismo wagneriano. Il metaforico strumento è scordato
anzitutto in senso tecnico e concreto: non accordato; e solo in
seconda istanza, per quanto affascinante, scordato assume il
senso di dimenticato, come nei Soleils couchants di Verlaine
{Poèmes saturniens) il «cœur qui s’oublie» con tanta maggior
dolcezza, pure al tramonto:
La mélancolie
berce de doux chants
mon cœur qui s'oublie
aux soleils couchants.
Nella già ricca tessitura tematica del testo quel cuore che chiude
così perentoriam ente la lirica inserisce il tema ben montaliano
della memoria, già preannunciato al v. 2. Altro obbligato rilievo
semantico (altra dissonanza): questo «frammento di natura (in
tempesta) che il cuore cerca invano di interiorizzare»7 è sempre
sdoppiato, ambiguo: il vento suona e spazza (somma di meta
fora musicale e azione propria), il mare muta colore e lancia una
tromba di schiume intorte, il vento nasce e muore (con ben
radicale antitesi).
M a torniamo alle più sottili dissonanze formali, in partico
lare metriche. I primi nove versi, che configurano i primi due
blocchi tematici, sono di tipo tradizionale: endecasillabi inter
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
113
rotti da due settenari (w . 4 e 7) e chiusi da un quinario. Men
galdo ha parlato di una specie di stanza di canzone, dalle rime
spesso difficili e raffinate, come la rim a ipermetra attento 1:
protendono 5, cui si aggiungono i fitti echi interni di vento 1,
strumenti 3, orizzonte 4 8. Gli altri nove invece non sono per lo
più della tradizione lirica. L’aspro mare espone i suoi disaccordi
in due ottonari dagli accenti non canonici (w . 10-11), il vento
canta in due nettissimi novenari pascoliani (w . 15-16), prece
duti e seguiti da altri due versi (14 e 17- 18) che si avviano sullo
stesso ritmo, poi felicemente sincopato, a interrompere lo
«scampanìo addormentante» e la «narcosi» pascoliana9. In
quest’ultima fase di canto spiegato anche le rime si fanno facili
ed esposte nella loro sede tradizionale. Internam ente si risente
invece, e non solo in grazia delle riprese semantiche, l’eco dei
suoni iniziali. È tuttavia un canto spiegato solo per le sue forme
ritmico-timbriche. In realtà è un canto che dichiara l’impossibi
lità di cantare, di «cangiare in inno l’elegia». È un’altra pro
fonda dissonanza, senza dimenticarci di quanto sia anche foni
camente aspro quello scordato strumento. N ei primi nove versi si
può dunque ravvisare la ricchezza timbrica di un pieno orche
strale (gli strumenti 3) e nella ripresa finale il canto di uno stru
mento 17 solista: non quello del cuore, afono, ma la melopea del
corno inglese che campeggia isolato nel titolo. Ovunque
domina, a più livelli, la dissonanza, e quel procedere per accu
mulazioni che così bene possono corrispondere alla tecnica del
cromatismo wagneriano.
3. L'inserimento di «Corno inglese» in due diverse serie:
«Accordi» e «Movimenti»
Corno inglese è stato stam pato la prima volta (e si tratta
della prima pubblicazione in assoluto di Montale) su Primo
Tempo nel 1922, assieme ad altre sei poesie che hanno come
titolo il nome degli strumenti essenziali dell’orchestra tardorom antica e moderna; se non tutti gli strumenti, tutte le loro
famiglie vi sono ordinatam ente rappresentate: Violini, Violon
celli, Contrabbasso; Flauti - Fagotti, Oboe e Corno inglese [oboe
contralto]; Ottoni. Le sette poesie - numero altamente eufo
nico - (ora si vedano in O V 765-72) hanno il titolo comune di
114
Alessandro Martini
Accordi e il sottotitolo Sensi e fantasmi di una adolescente: il
romanticismo della formazione musicale e del programma dei
sensi e fantasmi è subito ironizzato e mascherato dall’invenzione
di un personaggio femminile che parla in prim a persona, per cui
l’io poetico trova uno schermo efficace contro la sentimentalità
dei possibili accordi fra voci strumentali e voci del cuore: che è
già un modo di cantare in falsetto. La didascalia finale accentua
il carattere ludico e teatrale dell’assieme, che non è da dimenti
care nella lettura del nostro Corno inglese: «Unissono fragoroso
d’istrumenti. Comincia lo spettacolo della Vita.» Permettendo
la ristam pa della serie nel ’60 M ontale ha precisato date, intenti
e motivi del parziale rifiuto di questi iuvenilia:
con assoluta precisione non saprei dare una data a quelle poesie:
sono certamente posteriori al primo vero e proprio osso («Merig
giare», del ’16), ma assai anteriori a «Riviere» (marzo 1920)
Il
Corno inglese era l’unica della serie che potesse staccarsi dal ciclo:
del quale mi dispiaceva, e tuttora mi dispiace, il senso generale e
anche l’ingenua pretesa di imitare gli strumenti musicali (a parte
quel po’ di amido che vi si avverte qua e là). Debbo dunque conclu
dere che nel mio giovanile château d’eaux [...] accanto a una vena
più torbida, o addirittura dentro quella vena, si facesse strada assai
per tempo la venatura più magra ma più limpida degli Ossi. Tutta
la sezione iniziale degli Ossi (escluso In limine [...]) [dunque il ciclo
di Movimenti, salvo le aggiunte successive di Altri verri] appartiene
dunque al protomontale: e in questo gruppo vanno inserite - ma
anche entro questi limiti vennero poi da me rifiutate - le poesie di
Accordi (O V 865).
A rovescio è dunque facile sostenere che i Movimenti nascono
dagli Accordi e crescono su quelli, ne sono la versione miglio
rata e corretta. E sarebbe facile mostrare in che senso gli
Accordi sono il serbatoio degli Ossi, ma più sul piano delle
dichiarazioni e dell’effusione sentimentale che dell’espressione,
per cui meglio si capisce il rifiuto del ciclo. Atteniamoci piut
tosto al tema musicale, all’«ingenua pretesa» di imitare gli stru
menti e vediamo come si realizza. I violini (1) sono i più corrivi
e loquaci sulle troppo strade che si aprono alle pupille smarrite
dell’adolescente, che in attesa di un prodigio non sa più ne volere
né disvolere. M a è ben difficile scoprire in che senso il timbro
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
115
dei violini possa adattarsi ai messaggi trasmessi. I violoncelli (2)
(voci suadenti) parlano direttam ente all’adolescente:
Ascolta il nostro canto che ti va nelle vene
e da queste nel cuore ti si accoglie,
[...]
e seguici nel gurge dell’Iddio
che da sé ci disserra,
echi della sua voce, timbri della sua gamma!
Prosperano i punti esclamativi (che in due casi saranno elimi
nati in Corno inglese). Amore, Iddio, Centro, Niente portano la
maiuscola: sono elementi in cui possiamo ravvisare non poco di
quell’amido rifiutato. Il contrabbasso (3) (voce severa) in anti
tesi ai violoncelli ammonisce: «non uscirai tu, viaggiatrice sper
sa, / dai limiti del <Brutto)...» I flauti e fagotti (4) non parlano
direttam ente all’adolescente ma sono evocati da un paesaggio
notturno in cui si ode uno zufolo, un gracchiare di rane, uno
svolìo di uccelli, lo scroscio e rantolo di una fontana un po’
malata: rumori facilmente assunti dai due strumenti del titolo.
L’oboe (5) non parla e non trova facili corrispondenze in
natura, ed è difatti, con il fratello maggiore e minore, il corno
inglese, il pezzo più riuscito della serie. Evoca la fine di un atto,
e sarebbe bello fosse un atto di melodramma, se il successivo
corno inglese (6) può rifare, come dirò, il preludio di un preciso
atto conclusivo:
Ci sono ore rare
che ogni apparenza dintorno vacilla s ’umilia scompare,
come le stinte
quinte
d’un boccascena, ad atto finito, tra il parapiglia.
I sensi sono intorpiditi,
il minuto si piace di sé;
e nasce nei nostri occhi un p o ’ stupiti
un sorriso senza perché.
Anche l’oboe canta un’occasione e finisce per cantarla in nove
nari, solo un p o ’ meno solenni, che sorridono attraverso le rime
tronche. Gli ottoni (7) esprimono in fanfara la letizia breve di
un mattino: quella che ben più intensamente sarà espressa
dall’ultimo movimento: Quasi una fantasia.
116
Alessandro Martini
L’imitazione consiste dunque per lo più nel prestare allo
strum ento una voce um ana un po’ troppo chiacchierina, o vice
versa il timbro di uno strumento ai rumori della natura (fischio
= ottavino, gracchiare di rane — fagotto): tentativi senz’altro
ingenui sul fronte della traduzione del puro significante musi
cale in un significato verbale, e assolutamente scontati nella tra
duzione del suono artificiale in suono naturale.
Nulla di tutto questo in Corno inglese. Lo strum ento (come
nei migliori Accordi) è assente dal corpo della poesia, dove solo
suona il vento, simile soltanto allo scuotere di quelle straordina
rie lamiere. La m etafora si rovescia: non desueto antropom or
fismo dello strumento, ma sottile strumentazione della natura:
il vento suonatore, gli strumenti alberi, il cielo cassa di riso
nanza. Soprattutto all’accordo dichiarato nel titolo della serie
primitiva si oppone il disaccordo fra uomo e natura, moltipli
cato dalle dissonanze formali illustrate. Il periodo unico, con le
sue cromatiche accumulazioni, accentua il carattere dinamico
della poesia: dagli accordi (elementi statici e verticali della par
titura musicale) passiamo ai movimenti prescelti a introdurre gli
Ossi.
I titoli del nuovo ciclo non sono tutti di carattere musicale,
ma tutti i testi, da I limoni a Quasi una fantasia hanno intensi
rapporti con la musica. I limoni ci immettono in umili orti in cui
il «susurro / dei rami amici» propizia «silenzi in cui le cose/
s’abbandonano e sembrano vicine / a tradire il loro ultimo
segreto». Il segreto tuttavia non è scoperto, neppure alle soglie
di altre «malchiuse porte» :
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo del cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
le loro canzoni
le trombe d'oro della solarità.
Su un analogo ritmo sincopato di non del tutto cantabili nove
nari il cuore trova un appagamento musicale (e purtroppo non
gnoseologico) nelle canzoni delle straordinarie trombe solari dei
limoni. Si va dunque dal silenzio di attesa del miracolo a un
trionfale ma alquanto elusivo squillo di tromba: un percorso
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
117
degno del prim o movimento di una sinfonia. Segue l’adagio che
già ben conosciamo, con l’a solo finale del corno inglese. Il
terzo canonico movimento di una sinfonia è lo scherzo, e le
nostre attese non sono deluse: Falsetto indica appunto il
cantare di testa del cantore che fa la parte del contralto o del
soprano, con effetti per lo più caricaturali. E difatti il poeta,
«della razza / di chi rimane a terra» inneggia, con lessico qua e
là parodisticamente neoclassico, alY élan vital di un’Esterina
ventenne che si tuffa in mare, non senza l’accompagnamento di
musiche celestiali. Gli irraggiungibili Eldoradi di Corno inglese
diventano qui più facili campi elisi:
ecco per te rintocca
un presagio nelVelisie sfere.
Un suono non ti renda
qual d ’incrinata brocca
percossa!; io prego sia
per te concerto ineffabile
di sonagliere.
M a con Falsetto si arresta l’analogia sinfonica: ci manca il
conclusivo quarto movimento, che potrebbe essere Quasi una
fantasia, per arrivare alla quale dobbiamo invece ascoltare altri
scherzi. N on sinfonia classica dunque, che sarebbe davvero un
program ma neoclassico nel 1925, ma le sue membra sparse, la
sua wagneriana e debussiana dissoluzione. Cade qui difatti
l’imitazione dei Minstrels di Debussy, non a caso riproposti
dall’edizione critica nell’esatta collocazione che avevano nella
prim a edizione degli Ossi. In Debussy si tratta dell’ultimo pre
ludio del primo libro dei Préludes per pianoforte, del 1910
(musica dunque di attualità): una grottesca parodia di un ritor
nello da music-hall, da suonarsi in modo «nerveux et avec
humeur», un brillante studio di staccato (l’antitesi del legatis
simo corno wagneriano) che anticipa Strawinskij, magistral
m ente reso da M ontale con la sua musica da strada:
Acre groppo di note soffocate,
rìso che non esplode
ma trapunge le ore vuote
e lo suonano tre avanzi di baccanale
vestiti di ritagli di giornali,
con istrumenti mai veduti,
simili a strani imbuti
che si gonfiano a volte e poi s ’afflosciano.
118
Alessandro Martini
Né m anca in chiusa il richiamo al solito scordato cuore e a
un autoironico riferimento al proprio tentativo musicale:
«Bruci / tu pure tra le lastre dell’estate, / cuore che ti smarrisci!
Ed ora incauto / provi le ignote note sul tuo flauto.» La musica
leggera tanto raffinatam ente evocata da Debussy e M ontale si
fa quindi musica infantile in Caffè a Rapallo, fatta di elementari
rumori che incantano «l’animo dubitoso». «Le trombe d’oro
della solarità» dei Limoni e il «forte scotere di lame» di Corno
inglese si riducono qui a «trombe di lama». Finalmente in Quasi
una fantasia, dal titolo ancora una volta musicale (è il sottoti
tolo delle due sonate op. 27 di Beethoven), «Torna l’avveni
mento / del sole» (dunque la solarità che conclude I limoni) «e
le diffuse / voci, i consueti strepiti non porta». Finiti gli scherzi
di Falsetto, Minstrels e Caffè a Rapallo cala il silenzio, di nuovo
propizio all’occasione salvifica, al recupero del tempo, alla tra
sformazione della realtà esterna, siglati dall’occasione del gal
letto di marzo. Il silenzio segnala dunque l’apertura e la chiu
sura dei «movimenti» prettam ente musicali. I successivi sono
infatti movimenti solo in senso fisico: tentativi di uscire
dall’immobilità e dall’atonia. Si ricordi però che in Vento e ban
diere (penultimo e posteriore movimento) il vento marino che
modulò un tempo l’assente è il responsabile di un’intensa ben
ché parziale intermittence du cœur. Al silenzio musicale come
«valico metafisico» accennerà poi il M ontale giornalista nel ’59,
dando relazione di una tavola rotonda sulla musica, con l’iro
nico riserbo di chi quel valico non potè mai superare ma che più
di altri intensamente visitò in poesia:
qui non parve che si fosse raggiunta un’intesa, perché il senso meta
fisico appartiene a chi lo possiede in proprio e tutte le grandi opere
d’arte possono sollecitare questa apertura: Rembrandt non meno
di Beethoven, Baudelaire più di César Franck (PS 20).
Più che nella sede originale degli Accordi, Corno inglese
trova nel nuovo assetto la più vasta spiegazione e risonanza,
date le fittissime connessioni intertestuali che lo legano agli altri
movimenti, e di quel ciclo rappresenta il momento di più
solenne quanto dram m atica musicalità: l’adagio wagneriano su
cui innestare i successivi rapidi schizzi debussiani.
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
119
4. «Como inglese» è una citazione musicale?
Avanzo infine una proposta suggeritami da quella ben
determ inata realtà musicale che è il corno inglese: un corno che
non è un corno, ma un oboe dalla voce più profonda e robusta;
che è detto inglese ma inglese non è, ma ha quell’epiteto per una
misteriosa translitterazione che la filologia non ha ancora del
tutto chiarita: un nome ambiguo per una cosa ambigua, già di
per sé atta ad attirare l’attenzione di un Montale. È parte inte
grale dell’orchestra tardo-rom antica e moderna, ma ha abba
stanza raram ente un ruolo solistico. Lo assume senz’altro alla
fine del preludio del terzo atto del Tristano, l’opera di Wagner
più nota e am m irata da M ontale, che la recensì ben tre volte,
nel ’57, nel ’59 e nel ’64. Nell’ultima occasione vi riconosce una
svolta fondamentale della musica moderna, vi ammira la «stu
penda musica» e, con qualche riserva, le «sterminate lentezze»
(PS 420-3). N ota fra l’altro come fosse già opera di repertorio
«quaranta anni or sono», quindi all’epoca delle sue prime prove
poetiche, all’epoca in cui anche Arturo Onofri firmava una
guida al dramma m usicale10. Né bisogna dimenticare che alle
spalle degli entusiasmi del primo dopoguerra sta, su un piano
diverso, la lunga parafrasi che di questo notturno dramm a di
amore e morte fece D ’Annunzio nel Trionfo della morte (1894).
Il breve e lento preludio del terzo atto (quello della riunifi
cazione nella morte dei due protagonisti) comporta tre motivi
che si incastrano l’uno sull’altro senza pause ma ben distingui
bili. Secondo le tipiche denominazioni wagneriane, che ritro
viamo in ogni guida all’opera, compresa quella di Onofri,
abbiamo: 1. tem a della desolazione, che si alza su cupi e vibrati
accordi degli archi; 2. tema della solitudine, cromatico e ascen
dente, affidato ai violini, che raggiungono note molto acute;
3. tem a della privazione d ’amore, melodico, che si conclude in
ff. A questo punto si alza la tela, l’orchestra tace e udiamo fuori
scena un pastore che, ignaro del dramm a di Tristano, suona la
zampogna (resa dal corno inglese a solo): un motivo desolato,
melodicamente arditissimo, che non porta nome, ma Tristano,
che giace morente sulla spiaggia del mare, sotto un albero, a
questi suoni si riscuote e riconosce in essi la voce del suo
destino tragico, portatogli dal vento, e questo destino consiste
nel desiderio infinito, che fa oltre la morte. Al di qua di ogni
120
Alessandro Martini
interpretazione simbolica e di ogni facile concordanza su quel
piano, credo che la messa in scena sia eloquente, e che il taglio
del preludio orchestrale e del successivo a solo di corno inglese
sia molto vicino a quello della poesia montaliana, se la quadri
partizione proposta regge: al primo tema musicale della desola
zione corrisponderebbe il primo tema della poesia: il vento che
vibra e suona gli alberi; al secondo ascendente ben risponde il
secondo del cielo; al terzo che si chiude in fortissimo il terzo del
mare in tempesta. Infine, se nella musica l’orchestra tace e si
ode fuori scena il corno inglese, nei versi si introduce l’impossi
bile e memorabile a solo, rimanendo fuori testo lo strumento
musicale che lo emette. Il titolo della poesia può dunque avere il
valore di una citazione: indica che di quello strumento non si
tenta un’imitazione, m a che forse di quel preciso corno inglese
wagneriano si offre una trasposizione11.
L’«ingenua pretesa» non muore ma nasce con gli Accordi, e
raggiunge in Corno inglese un primo alto risultato tu tt’altro che
ingenuo. È una pretesa simile a quella che il poeta ha ricono
sciuto nel musicista: «Wagner quasi traduce in realtà la presun
zione di fondere le arti in una sola» (PS 311). A questo sogno,
tradotto in pagine esteriori e magniloquenti da D ’Annunzio,
M ontale non poteva non mettere la sordina e circondarlo di
ogni cautela, ma certamente lo ha rincorso a lungo come un
possibile Eldorado.
Alessandro Martini
Università di Friburgo
in: "Versants - revue suisse des littératures romanes", 11 (1987)
Occasioni musicali nella poesia del primo Montale
121
NOTE
1 Citerò per abbreviazione le seguenti opere di Eugenio Montale: O V :
L ’opera in versi, edizione critica a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco
Contini, Torino, Einaudi, 1980. PS: Prime alla Scala, a cura di Gianfranca
Lavezzi, Milano, Mondadori, 1981. SP: Sulla poesia, a cura di Giorgio Zampa,
Milano, Mondadori, 1976. Ringrazio per gli ottimi suggerimenti l’amico e col
lega Alain Faudemay, e per l’aiuto costante, anche nelle più difficili emergenze,
mia moglie Olivia, alla quale dedico queste mie scarse ma meno fredde pagine.
2 Eugenio Montale, Mottetti, a cura di Dante Isella, Milano, Il Saggiatore,
1980, pp. 63-66. A proposito di questi brevi e concettosi componimenti chia
mati mottetti si insiste molto sul valore letterario del termine, ma si dimentica
spesso l’indicazione di genere musicale sacro e polifonico, da Palestrina a
Poulenc.
3 La raccolta fa splendida luce sui risvolti musicali della poesia montaliana, come documenta Saverio Orlando, «Alla Scala, con Eusebio e con Malvolio», in Paideia, XXXVII, 1982, pp. 45-51. Ma il volume ha anche una sua
intrinseca validità, come mostra l’appassionata e nutrita recensione di Pier
Vincenzo Mengaldo, «Montale critico musicale», in Studi novecenteschi, XI,
n° 28, 1984, pp. 197-239. A p. 204 vi si dice della «sorda resistenza a Wagner
del gusto montaliano», di «antica riluttanza [...] radicalizzata con gli anni», che
sembrerebbe divergere da quanto vado asserendo. Ma appunto di gusto si parla,
non del pieno riconoscimento del ruolo di Wagner nella storia della musica;
della sua accettazione in toto, non del sicuro apprezzamento di singole pagine.
A p. 234 per altro Mengaldo precisa trattarsi soprattutto di avversione ideolo
gica, che si fa più viva con il tempo proprio per l’accresciuta consapevolezza
delle ultime conseguenze espressionistico-dodecafoniche del discorso wagne
riano. Mentre dal Montale esordiente, postillerei, Wagner può essere evocato
anzitutto come l’antesignano di Debussy.
4 Eugenio Montale, Quaderno genovese, a cura di Laura Barile, Milano,
Mondadori, 1983, p. 47 (5 maggio 1917): «L’altro giorno divorai per intero
Sagesse di Verlaine. Il colossale capolavoro! È la terza volta (o la quarta?) che
lo rileggo; e sempre più l’ammiro!» Si veda anche l’attenta nota della Barile a
pp. 156-7.
'
5 Pier Vincenzo Mengaldo, «Da D ’Annunzio a Montale: ricerche sulla for
mazione e la storia del linguaggio poetico montaliano», in AA. W ., Ricerche
sulla lingua poetica contemporanea, Padova, Liviana, 1966, pp. 163-259, poi in
Mengaldo, La tradizione del Novecento, Milano, Feltrinelli, 1975, pp. 13-106.
6 Gian Pietro Biasin, Il vento di Debussy. La poesia di Montale nella cultura
del Novecento, Bologna, il Mulino, 1985, p. 31, preferisce dare a lancia a terra
12 ecc. il soggetto vento 1, piuttosto che il mare 10.
7 Gianfranco Contini, «Su Eugenio Montale. II. Dagli Ossi alle Occasioni»
[1938], in Esercizi di lettura, Torino, Einaudi, 1974, p. 79.
8 Per queste e tante altre osservazioni, che mi permettono qui di tirar
dritto, cfr. Pier Vincenzo Mengaldo, «Per la cultura linguistica di Montale:
qualche restauro. II. Corno inglese e Alcione», in op. cit., pp. 301-313, part,
p. 310.
“
9 Così, con orecchio al solito vigile e acutissimo Giorgio Orelli, Accerta
menti verbali, Milano, Bompiani, 1978, pp. 179-80.
10 Riccardo Wagner, Tristano e Isotta. Guida attraverso il poema e la
musica a cura di Arturo Onofri, Milano, Bottega di Poesia, 1924.
122
Alessandro Martini
11 II rinvio a La mer di Debussy, in particolare alla terza parte del poema
sinfonico, Le dialogue du vent et de la mer (G. P. Biasin, op. cit., p. 27), tematica
mente più ovvio, credo debba cedere a questo wagneriano, tanto più pregnante
a livello di forma del contenuto, senza per questo negare l’evidenza, cioè il peso
ben maggiore di Debussy nella poetica montaliana, rispetto a Wagner. Al di là
del gusto personale, l’altissima competenza musicale del poeta rende ben più
allettante questo refolo wagneriano nel dominante «vento di Debussy», che
spira più fresco altrove e accanto a Corno inglese. Mengaldo ha da par suo riba
dito l’estraneità di fondo della poetica di Montale a quella di Wagner (cfr.
nota 3), ma a chi di Corno inglese ha fatto un bell’esempio di attraversamento
dannunziano (cfr. nota 8) non dovrebbe essere discaro vederlo interpretato
anche come attraversamento wagneriano.
Gian-Paolo Biasin
IL VENTO DI DEBUSSY:
POESIA E MUSICA IN MONTALE*
C'è una decisa affermazione di Eugenio Montale, contenuta nella
famosissima e mai t r o p p o citata "Intervista i m m a g i n a r i a " del
1946, dalla quale conviene prendere le mosse:
Quando cominciai a scrivere le prime poesie degli Ossi di seppia
avevo certo un'idea della musica nuova e della nuova pittura. Avevo
sentito i Minstrels di Debussy, e nella prima edizione del libro c'era
una cosetta che si sforzava di rifarli: Musica sognata. E avevo scorso
gli Impressionisti del troppo diffamato Vittorio Pica.
1
P u r nella cautela, tipicamente montaliana, della sua formulazione
("avevo u n ' i d e a " , " a v e v o s c o r s o " ) , questa affermazione a
posteriori di intenzioni e di consapevolezze determinanti per
l'incipit di tutta u n ' o p e r a di poesia conserva u n ' i m p o r t a n z a
fondamentale, accresciuta poi dalla ripubblicazione recente
nell'edizione critica proprio di quella modesta " c o s e t t a " qui
richiamata. Siamo di fronte in realtà a un'orgogliosa
rivendicazione di apertura culturale e di novità ("la musica
n u o v a " , " l a nuova p i t t u r a " : la posizione e la ripetizione dello
stesso aggettivo non sono certo casuali, ma retoricamente
rivelatrici), per cui le parole di Montale sono da prendere come
*È il testo, ampliato, di una relazione letta al Convegno Internazionale di
Studi, "La poesia di Eugenio Montale", Genova, Aula Magna
dell'Università, 25-28 novembre 1982.
Il tema è stato poi ripreso e sviluppato nel volume "Montale, Debussy,
and Modernism", Princeton U.P.,
- 50 1990.
-
un'informazione preziosa e non come un'indicazione
" d e p i s t a n t e " per il critico che voglia ricostruire le origini della
poesia di Montale e il q u a d r o culturale in cui essa venne a inserirsi
e ad affermarsi.
I n t a n t o , ci sono le tre componenti fondamentali degli
interessi dell giovane (come poi del m a t u r o e del vecchio)
Montale: poesia, musica e pittura; n o n debbo certo richiamare
qui gli elementi, le occasioni, gli aneddoti biografici in cui questi
interessi si articolarono e t r o v a r o n o espressioni diverse, dai
pastelli con le deliziose marine e i sorridenti ritratti agli studi da
baritono presto abbandonati ma mai dimenticati e trasferiti più
tardi nell'attività precisa e puntigliosa di critico musicale esigente
e magari idiosincratico del Corriere della sera. Piuttosto,
l'interazione fra poesia, musica e pittura indica al critico
contemporaneo la complessità della cultura, quale è teorizzata nel
principio " d i a l o g i c o " de Michail Bachtin e che Montale aveva
inteso e indicato da par suo, a u t o n o m a m e n t e , con grande
efficacia. Infatti l'interazione fra diversi generi, modi espressivi,
linguaggi, codici, da sola n o n basta: deve trattarsi di un'interazione attiva, innovativa, che sperimenti nuove possibilità, nuovi
orizzonti, magari traducendo i risultati di un c a m p o in un altro
parallelo, traslando un linguaggio in un altro.
2
3
Occorre d u n q u e chiedersi, preliminarmente, perché Montale
indichi la musica nuova e particolarmente Debussy, e la nuova
pittura e particolarmente gl'impressionisti. Certo, si tratta di
forme espressive congeniali alla poesia per lunga tradizione, da
" u t pictura p o e s i s " fino a " d e la musique avant toute c h o s e "
(basti ricordare le numerose pagine che H u g o Friedrich ha
dedicato a l l ' " u n i t à strutturale" e all'analogia fra poesia, musica e
pittura m o d e r n e ) , e particolarmente congeniali, dati i riferimenti
biografici accennati, al giovane Montale.
4
Ma perché gl'impressionisti, e perché Debussy?
Brevemente, si può dire con Fénéon che gl'impressionisti
furono tra i primi a porre le basi della pittura m o d e r n a , con la
separazione e l'accostamento di colori puri sulla superficie del
dipinto, i quali dovevano poi essere rimescolati e fusi insieme
dalla percezione attiva dell'osservatore, ricreando quell'armonia
visiva — e quindi l'oggetto stesso della visione — che potevano
sembrare persi alla prima impressione: si pensi alla cattedrale di
Rouen, alla stazione di St. Lazare e alle biche di Monet e alla
- 51 -
grande Jatte di Seurat, con le loro sapientissime variazioni
luminose e "l'infinita delicatezza" del modellato. È dunque lo
stile con la sua disgiunzione tra segno e significato che
gl'impressionisti mettono in primo piano a scapito della
rappresentazione e dell'oggettività; ed è una partecipazione attiva
dell'occhio dello spettatore che essi richiedono come parte
integrale del procedimento artistico.
5
Analogamente, Debussy fu tra i primissimi a scardinare il
sistema tonale tradizionale, con dissonanze volute che rompevano
la scala armonica e dovevano essere recepite e accettate
dall'orecchio dell'ascoltatore, che veniva così indirizzato verso la
musicalità intrinseca ed a u t o n o m a dei suoni. Nella nuova poesia,
dissonanza lessicale e parola analogica sono le due categorie
critiche che, d o p o Friedrich, caratterizzano col massimo vigore gli
sviluppi novecenteschi e il loro r a p p o r t o con pittura e musica.
N o n so se Montale avesse chiari fin dall'inizio simili rapporti
e simili analogie in tutte le loro complessità e ramificazioni.
Probabilmente, n o . Certo, Montale aveva capito l'importanza del
libro di Pica, il critico d'arte napoletano davvero " t r o p p o
d i f f a m a t o " , se si pensa che Soffici lo qualificò senza mezzi
termini di " i m b e c i l l e " (mentre Fénéon ne aveva invece messo in
risalto la " c o e r e n z a r a r a " e l ' a p e r t u r a mentale senza
dogmatismi); infatti, il libro di Pica, oltre a presentare un
p a n o r a m a notevole del movimento impressionista, dai precursori
inglesi agli epigoni del divisionismo italiano (Segantini, Morbelli,
Previati, Pellizza da Volpedo ed altri), contiene u n ' i d e a derivata
proprio da Fénéon e fondamentale ancor oggi per la
comprensione degli impressionisti, cioè il loro uso di " m a c c h i e di
colori puri che si fondano a distanza sulla pupilla dello
s p e t t a t o r e " invece che sulla tavolozza. Ma il fatto stesso che
Montale citasse insieme impressionisti e Debussy sembra voler
indicare che considerava sullo stesso piano impressionismo
pittorico e impressionismo musicale, mentre per Debussy
l'etichetta stessa di impressionismo è almeno da rivedere e da
limitare nel t e m p o . Piuttosto, è importante notare, come ha fatto
L a u r a Barile, che " l ' a t t e n z i o n e a ciò che avveniva nel m o n d o
musicale è caratteristica della cultura di quegli a n n i " del primo
Novecento: infatti " a n c h e Serra esplorava la stessa zona, della
musicalità del verso, intesa in termini quantitativi, di arsi e tesi, di
ritmo e non più di m e l o d i a " , e in tale contesto sarà utile ricordare
6
7
- 52 -
La dissonanza, la rivista di breve d u r a t a ma di significative aperture, diretta da G i a n n o t t o Bastianeiii e Ildebrando Pizzetti, dal titolo emblematicamente programmatico e indicativo della 8 " m u s i c a n u o v a " .
In ogni caso, che Montale fosse consapevole ο no di tutte le implicazioni del r a p p o r t o fra le novità espressive nelle tre arti non
è veramente importante: ciò che conta, e m o l t o , è che egli questo
r a p p o r t o lo visse fin dall'inizio con una sensibilità e una
tempestività straordinarie; che di questo r a p p o r t o ο interazione si arricchì tutta la sua prima poesia; e che in particolare
(tralasciando per ora la pittura) la primitiva scelta debussyana
non fu mai rinnegata ma fu ripetutamente e sapientemente usata
dal poeta a fini di poetica e di politica culturale, in modi e contesti
che varrà la pena esplorare.
Il discorso montaliano su Debussy è frammentario,
apparentemente occasionale e discontinuo, ma in realtà
intimamente coerente e rigoroso per chi abbia la pazienza di
avvicinarne i tasselli. Le osservazioni di Montale sono di carattere
teorico, storico, e culturale. A livello teorico, il r a p p o r t o tra
musica e poesia è riconosciuto da Montale lungo tutto l'arco
dell'estetica musicale, dai madrigali ai libretti d ' o p e r a , e la vexata
quaestio della superiorità dell'una sull'altra ο viceversa è risolta
nel senso che " p o e s i a e musica c a m m i n a n o per conto proprio e
che il loro incontro resta affidato a fortune occasionali" (come
per esempio nei casi di Debussy, Mussorski e Schönberg), perché
in realtà, mallarmeanamente, la poesia " i n se stessa è già
m u s i c a " ; posizione ribadita nel 1962: " S o che l'arte della parola è
anch'essa musica, sebbene abbia poco a che fare con le leggi della
a c u s t i c a " . Mi si dirà che simile orgogliosa affermazione
dell'autosufficienza della parola poetica contrasta con quella
iniziale dello sforzo di rifare Minstrels: è vero, ma solo in
superficie, perché anche, anzi proprio " r i f a c e n d o " Debussy
Montale riafferma la superiorità della parola sulla musica, il cui
carattere " a s e m a n t i c o " , " u n a grande conquista della cultura
moderna",
viene d u n q u e t e m a t i z z a t o , c o n c e t t u a l i z z a t o ,
dall'unica forma d'arte capace di compiere u n a tale operazione
esplicitamente, cioè la letteratura, la parola scritta, e in
particolare la parola poetica. Ciò è t a n t o vero che nella stessa
"Intervista i m m a g i n a r i a " Montale aveva richiamato i grandi ismi
filosofici contemporanei (le " p a r o l e g r o s s e " di " M a r f o r i o " :
9
1 0
- 53 -
l'esistenzialismo kierkegaardiano di Scestov, l'immanentismo
assoluto di Gentile, "il grande positivismo idealistico del C r o c e " ,
e soprattutto, per gli anni di Ossi di seppia, il contingentismo di
Boutroux), per poi negarli subito — ma intanto il richiamo, che è
" s e m a n t i c o " , resta:
No, scrivendo il mio primo libro (un libro che si scrisse da sé) non mi
affidai a idee del genere. [...] Ubbidii a un bisogno di espressione
musicale. Volevo che la mia parola fosse più aderente di quella degli
altri poeti che avevo conosciuto. Più aderente a che? Mi pareva di
vivere sotto una campana di vetro, eppure sentivo di essere vicino a
qualcosa di essenziale. Un velo sottile, un filo appena mi separava
dal quid definitivo. L'esperienza assoluta sarebbe stata la rottura di
quel velo, di quel filo: una esplosione, la fine dell'inganno del
mondo come rappresentazione. Ma questo era un limite
irraggiungibile. E la mia volontà di aderenza restava musicale,
istintiva, non programmatica. All'eloquenza della nostra vecchia
lingua aulica volevo torcere il collo, magari a rischio di una
controeloquenza.
11
Niente " i s m i " , dunque; ma questo " b i s o g n o di espressione
m u s i c a l e " , alla luce della a u t o n o m i a e semanticità della poesia, la
dice lunga sulla fede di Montale nella parola scritta, fin
dall'inizio. Occorrerà magari cercare di individuare possibili
omologie (funzionali, strutturale) fra musica e poesia alla luce di
studi recenti, come le appasionanti considerazioni di Leonard
Bernstein in termini chomskiani, in cui le trasformazioni della
grammatica generativa (a livello fonologico, sintattico e
semantico) trovano convincenti applicazioni nelle letture di grandi
testi della musica occidentale; ma lo scetticismo montaliano in
materia resta, e il critico deve prenderne atto, e riconoscere
preliminarmente il fatto evidente che gli sforzi maggiori compiuti
dal poeta per collegare in qualche m o d o poesia e musica
appartengono tutti al suo primissimo periodo, e includono solo:
alcune poesie mai raccolte in volume (mai elevate alla dignità
d e l l ' " o p e r a in versi": Musica silenziosa, Suonatina di pianoforte,
Accordi) e la prima sezione degli Ossi, quei " M o v i m e n t i "
a p p u n t o musicali ed anzi debussyani (Mouvement è u n a delle
Images per piano) ma già metaforici ("Ascoltami, i poeti laureati
/ si muovono..."), che nella ristrutturazione definitiva includ o n o I limoni, Corno inglese, Falsetto e Minstrels; mentre la serie
Mediterraneo è si debitrice di La mer (Pieri), ma direi più come
idea che come esecuzione.
12
13
- 54 -
Negli sviluppi ulteriori della poesia m o n t a l i a n a vi saranno solo echi ο sapienti riferimenti musicali al di fuori di qualsiasi intenzione sistematica, come, per fare solo due esempi, il mottetto Infuria sale ο grandine col richiamo a La cathédrale engloutie
( " m o l t o p r o b a b i l m e n t e " ) , ο La bufera col ricordo di Jardins sous la pluie, sempre di Debussy. I n t a n t o p e r ò , a livello storico, Montale sa bene che musica,
pittura e poesia seguono le proprie strade parallele, che possono
non coincidere nel t e m p o e non corrispondere nello spazio.
Consideriamo con lui " a l c u n e d a t e " relative al decadentismo:
14
Il preraffaellismo [...] era vivo in Inghilterra quando in Italia
dipingevano i Fontanesi e i Cammarano, classici malgrado il loro
romanticismo. Rimbaud e Mallarmé scrivono quando in Italia si è
giunti appena alla scapigliatura; i nostri macchiaioli si svegliano
quando incontrano l'impressionismo francese; Debussy è un
contemporaneo di Puccini e Mascagni. D'Annunzio non si spiega
senza le sue fonti straniere, innumerevoli. Mentre infuria
l'espressionismo viennese, Casella e soci propongono un ritorno al
Settecento.
15
D ' a c c o r d o , " p e r fortuna siamo in r i t a r d o " , come conclude la sua
rassegna Montale con sorridente ma salutare ironia storiografica.
Intanto però Montale ha messo i puntini sugli i, ci ha procurato i
dati di fondo per capire bene la sua operazione culturale, nella
quale Debussy ha una funzione centrale, da vera e propria cartina
di tornasole. Seguiamo il discorso m o n t a l i a n o nel campo
letterario:
[Gozzano] ridusse D'Annunzio come Debussy aveva ridotto
Wagner, ma senza mai giungere a risultati che possano dirsi
debussiani. La poesia di Gozzano resta in quel clima che gli studiosi
dell'ultimo melodramma italiano dell'Ottocento chiamarono
"verista", un clima che sostanzialmente non è di origine decadente.
[ . . . ] Mi par certo che in Gozzano la componente romanticoborghese-verista sia stata la più fruttuosa. Gozzano ridusse al
minimo comun denominatore la poesia italiana del suo tempo, e qui
il raffronto con Puccini torna ancora irresistibile.
16
Si noti l'impeccabile esattezza del ragionamento di Montale, in
cui i riferimenti musicali sono in r a p p o r t o " d i a l o g i c o " coi dati
letterari: sappiamo che Puccini era " i n r i t a r d o " rispetto a
Debussy, e che usando un criterio qualitativo Gozzano non p u ò
- 55 -
essere considerato un innovatore riuscito del tutto ("senza mai
g i u n g e r e a risultati che p o s s a n o dirsi d e b u s s i a n i " ) .
Riconoscendo a Gozzano ciò che gli spetta (fu "il primo che abbia
dato scintille facendo cozzare l'aulico col p r o s a i c o " ) , Montale ci
fa però ricordare anche la propria intenzione, verlainiana, di
"torcere il collo all'eloquenza della nostra vecchia lingua a u l i c a " ,
" m a g a r i a rischio di u n a c o n t r o e l o q u e n z a " : e se Debussy è al
centro del ragionamento, il vero bersaglio che si delinea è in realtà
D ' A n n u n z i o . Come in musica Debussy ha ridotto e quindi in un
certo senso sostituito Wagner, così in letteratura D ' A n n u n z i o sarà
ridotto e superato non da Gozzano, ma da Montale, quel Montale
che avrà " a t t r a v e r s a t o " D ' A n n u n z i o , a cui la musica d o p o t u t t o
era stata aggiunta da Debussy (in Le martyre de Saint Sébastien),
che a sua volta era stato messo in poesia proprio da M o n t a l e !
Converrà dunque dedicare qualche attenzione supplementare
a Claude Debussy e cercare di capire ancor meglio (o più
esplicitamente, più capillarmente) di quanto abbia fatto Montale
la novità e l'importanza della sua opera sia nello svolgimento
della musica contemporanea che in r a p p o r t o alla letteratura, cioè
in un contesto culturale di cui la musica fa parte come sistema
significante " i n cui regnano dei rapporti particolari fra il
significante e il significato, e questo sistema simbolizza a suo
m o d o i grandi temi della Cultura, il r a p p o r t o con l'altro, con la
natura, con la morte, col d e s i d e r i o . "
Nella storiografia musicale, Debussy occupa una
"singolarissima posizione" che viene schematizzata da Salvetti
nei termini seguenti:
1 7
18
19
partecipe dell'impegno intellettuale e morale dei decadentiwagneriani; propenso a un'arte "leggera", fatta di accenni e di
analogie; ricercatore infaticabile (rinnovantesi fino alle morte) di un
linguaggio musicale che esprimesse sia l'evanescenza spirituale delle
esperienze interiori, sia il rigore formale di un fare artistico cosciente
e perfettamente responsabile.
20
Ho scelto queste parole di Salvetti perché mi sembrano assai
efficaci nel tratteggiare gli elementi storico-sostanziali e criticoformali dell'opera di Debussy; del quale vale la pena citare
intanto una dichiarazione fatta a Guiraud già nel 1889:
Non sono tentato di imitare ciò che ammiro in Wagner. Io
concepisco una forma drammatica diversa: la musica comincia là
- 56 -
dove la parola è impotente a esprimere: la musica è scritta per
l'inesprimibile; vorrei che essa sembrasse uscire dall'ombra e che,
qualche istante dopo, vi ritornasse. [...] Sogno dei poemi che non
mi condannino a trascinare avanti atti lunghi, pesanti, [...] dove i
personaggi non discutano, ma subiscano la vita e la sorte.
21
A queste intenzioni giovanili corrispondono i risultati delle opere
maggiori di Debussy, dal Prélude à l'après-midi d'un faune (1894)
a Nocturnes (1900) e fino a Pelléas et Mélisande (1902), le quali
costituiscono quello che è stato chiamato, forse non del tutto
giustamente, "l'impressionismo musicale" del compositore,
basato in ogni caso su un'estetica simbolista e decadente e volto
alla "dissoluzione della solidità, della grandiosità, della
compattezza del linguaggio musicale del tardo romanticismo
tedesco".
Wagner aveva esasperato, nel sistema armonico
tradizionale, la tensione per cui ogni accordo tende verso un altro:
Debussy vuole invece " r o m p e r e questa tensione, spesso
artificiosa, recuperare il valore sonoro di ogni singolo accordo
preso per sé s o l o " , sia accostando "gli uni agli altri accordi
d i s s o n a n t i " , sia passando " d a un accordo consonante ad un altro
appartenente ad altra t o n a l i t à " , sia infine " c o n la minore forza di
attrazione del ' p u n t o di r i p o s o ' , cioè del centro t o n a l e " (scala
pentatonica, scale difettive): il conseguente "allentamento della
tensione a r m o n i c a " produce suoni sempre più p u r i . Analoga
operazione Debussy compie sull'impianto ritmico tradizionale
(con lunghe pause, sospensioni, ripetizioni, variazioni), e
sull'orchestrazione (in cui egli dissolve la massa orchestrale del
sinfonismo tedesco e predilige timbri anch'essi puri e strumenti
solisti, " s o p r a t t u t t o flauto, oboe, corno i n g l e s e " ) . A ulteriore
c o m m e n t o , citerò l'analisi di Prélude à l'après-midi d'un faune,
nella quale Bernstein ha messo in evidenza n o n solo che si tratta di
u n ' o p e r a " a t t e n t a m e n t e costruita e intenzionalmente disegnata"
sul tritono, " l ' a s s o l u t a negazione della t o n a l i t à " , ma che le
implicazioni armoniche basate sul tritono (la scala a toni interi)
p r o d u c o n o "il primo materiale atonico organizzato che sia mai
apparso nella storia della m u s i c a " tonale, per concludere infine
che il Faune è un vero e proprio "saggio sul mi maggiore".
22
23
24
25
Nelle opere posteriori al 1902, sia orchestrali che —
specialmente — pianistiche, Debussy accentua "il rigore nuovo
che collega armonia e m e l o d i a " e, "anziché nascondere la linea
melodica e ritmica nell'alone impressionistico, la mette
nettamente in evidenza" (anche Jacques Rivière fin dal 1910-11
- 57 -
aveva notato che la musica di Debussy era una " m u s i c a della
v o l u t t à " , m a " e s a t t a " , " r i g o r o s a " , " r a r e f a t t a dall'intelligenza",
e ancora, " c o m m o v e n t e per il suo stesso r i g o r e " ) .
26
Il superamento dell'impressionismo, ο se si preferisce l'innovazione del " p e n s i e r o s o n o r i a l e " , avviene anche per mezzo dell'ironia di certi pezzi come il Golliwogg's Cake-walk ο The little shepherd, è notevole nelle Images del 1905-07 e nei 24
Préludes per pianoforte del 1910-13 ed è definitivo nelle ultime
opere, e in particolare nei 12 Études per pianoforte del 1915,
" d o v e , dietro la sollecitazione del fatto meccanico-tecnico,
avviene una totale emancipazione della dissonanza e si esplorano
già chiaramente i luoghi del pianismo del N o v e c e n t o " .
27
Si p u ò , riassumendo, concordare con Jarocinski, il quale
afferma che l'estetica di Debussy " c o r r i s p o n d e " fondamentalmente " a l l a poetica di Mallarmé. Tutti e due agli antipodi del
wagnerismo, essi h a n n o cercato 'l'essenza delle cose', le nude
verità, non deformate da piatte categorie spaziali ο da u n a pom
2 8 posa r e t o r i c a . "
Le brevi notazioni che precedono, oltre a definire la posizione di Debussy nella musica del suo t e m p o , spero indichino abbastanza chiaramente la sua i m p o r t a n z a nel r a p p o r t o dialogico con la letteratura. Opero qui un capovolgimento totale rispetto all'analisi di Wenk, che ha m o s t r a t o con precisissimi riscontri testuali l'influenza di alcuni poeti (specie Banville, Baudelaire, Verlaine, Louÿs e Mallarmé) sulle scelte e sulle soluzioni musicali
di Debussy. Desidero caratterizzare invece l'influenza di Debussy
sul giovane Montale, a p p r o f o n d e n d o l'indicazione lasciata dal
poeta.
L'influenza di Debussy è prima di t u t t o , e non t r o p p o
paradossalmente, letteraria, proprio perché il letteratissimo
musicista ha filtrato e trasmesso la grande lezione del simbolismo
francese, a cui dunque — come ma a differenza di Ungaretti —
anche Montale si richiama, con grande consapevolezza tanto dei
debiti q u a n t o della propria a u t o n o m i a .
29
Ma l'influenza di Debussy è da sottolineare in secondo luogo
per l'anti-grandiosità del suo stile e per l'anti-eroismo dei suoi
personaggi che " n o n d i s c u t o n o " ma " s u b i s c o n o " : modelli
culturali, certo, che si ritrovano non solo nel teatro di Maeterlinck
ma in tanta letteratura del Novecento, e documentabili per
Montale, dalla poetica della diminutio antiaulica di I limoni
- 58 -
all'antieroe per eccellenza Arsenio, p r e p a r a t o fra l'altro da
Minstrels.
C o n uguale decisione va poi sottolineata "l'emancipazione
della d i s s o n a n z a " , che sarà poi ripresa e teorizzata da Igor
Stravinski nella sua Poétique musicale del 1942, citata in apertura
di libro da Friedrich per caratterizzare la lirica m o d e r n a , in
q u a n t o attraverso la dissonanza lessicale si vuole esprimere una
ben più p r o f o n d a dissonanza interiore — e non vi sono dubbi che
Montale è u n a voce assolutamente centrale e genuina in una lirica
così intesa.
A n c o r a , un preciso anche se non d u r a t u r o influsso di
Debussy si p u ò individuare n e l l ' " i m p r e s s i o n i s m o " delle prime
prove poetiche di Montale, al p u n t o che tre dei sette Accordi
p o r t a n o i titoli di tre degli strumenti preferiti dell'orchestrazione
debussyana: flauto, oboe, corno inglese (e si noterà che la
Suonatina di pianoforte, forse proprio perché " a l l a Maurizio
R a v e l " e non alla Claude Debussy, è rimasta nel limbo delle
poesie disperse).
Infine, non t a n t o un'influenza q u a n t o una consonanza ο u n a corrispondenza p r o f o n d a è da riscontrare a livello tematico: il
mare gioca un ruolo notevolissimo nella musica di Debussy come
nella poesia del ligure Montale; a c c o m p a g n a to spesso dal vento,
elemento sonoro che ne completa la figuratività, il m a r e è presente
in n u m e r o s e c o m p o s i z i o n i dei d u e artisti c o m e fonte
d'ispirazione, interlocutore, pretesto descrittivo, narrativo ο discorsivo. Vale la pena citare un c o m m e n t o particolare di Jarocinski: 30
31
Il mare di Monet non è mai terrificante. Si partecipa alla
contemplazione del pittore, lui stesso in un accordo panteista con la
natura. Ma in La mer di Debussy tutto sembra avvenire — come in
Turner — ad un livello cosmico. Nella parte finale di questa sinfonia
poliritmica, Le dialogue du vent et de la mer, il rumore funesto
dell'uragano sembra annunciare la morte e la distruzione; la stessa
impressione promana dal Prélude VII (libro I): Ce qu'a vu le vent de
l'Ouest.
32
Q u a n t o queste osservazioni siano pertinenti anche per la poesia di
M o n t a l e , da Arsenio a La bufera, credo n o n sia necessario
sottolineare.
Ma a p p u n t o , occorre ora verificare sui testi montaliani gli
aspetti dell'influenza e della consonanza debussyane.
- 59 -
N o n è questa la sede per un'analisi approfondita e
sistematica degli Accordi e delle altre poesie " m u s i c a l i " del
giovane Montale, ma mi sarà consentito un brevissimo accenno
ad alcuni aspetti di queste poesie che mi sembrano importanti, a
integrazione di q u a n t o già osservato da critici del valore di Forti,
Sanguineti e R a m a t ,
mentre dedicherò maggior spazio alla
lettura e al c o m m e n t o di Minstrels e di Corno inglese.
33
Testimonianza preziosa di u n a stagione culturale di
un'intensità e di un fervore straordinari, la suite dei sette Accordi
ci consente di verificare testualmente l'incidenza sul fare poetico
di Montale di movimenti non solo contemporanei e italiani (il
dannunzianesimo e il crepuscolarismo, già notati dai critici), ma
anche precedenti e stranieri: in particolare, l'impressionismo ("e a
questa ciarla / s'univano altre, ma più gravi, e come / bolle di
vetro luminose intorno / stellavano la notte che raggiava. / Di
contro al cielo buio erano sagome / di perle, / grandi flore di
fuochi d'artifizio, / cupole di c r i s t a l l o . . . " — in Flauti-Fagotti,
dove si n o t e r a n n o anche la parola analogica e l'allitterazione di
" g r a n d i flore di fuochi d'artifizio"); e il simbolismo, rintracciabile n o n solo nell'uso tipico di maiuscole iniziali per parole chiave
come il " C e n t r o " e il " N i e n t e " in Violoncelli ο il " B r u t t o " in Contrabbasso, ma anche nei numerosi casi di parole analogiche (per esempio: " O c c h i corolle s ' a p r o n o / in me — chissà? — ο nel s u o l o " , con la sua struttura chiasmatica in Violini, o p p u r e il c a n t o che va " n e l l e v e n e " e poi nel " c u o r e " in Violoncelli), e infine nella dissonanza lessicale (si ricordi il bellissimo ossimoro di Flauti-Fagotti: "gli occhi s'abbacinavano / in un gaio s u p p l i z i o ! " ) . 3 4 Inoltre, la suite di Accordi costituisce u n a vera e p r o p r i a " p r o v a d ' o r c h e s t r a " di temi e motivi che si ritroveranno nell'opera poetica di M o n t a l e , dall'attesa del miracolo al grigiore della vita quotidiana, dalla tristezza alla gioia ο felicità fragile,
dalla perplessità ο s m a r r i m e n t o esistenziale all'invenzione d e l l ' i n t e r l o c u t r i c e - " t u " . Ma passiamo i n t a n t o a Minstrels, l'unica poesia derivata esplicitamente "da C. Debussy", pubblicata col titolo Musica sognata nella p r i m a edizione critica. 3 5 Ascoltiamo d u n q u e , p r i m a di t u t t o , il testo musicale da cui deriva quello poetico: è il dodicesimo dei Préludes per p i a n o ,
nell'esecuzione di Walter Gieseking, "il candido Gieseking" come
lo chiama M i l a .
36
- 60 -
Da un p u n t o di vista formale, questo preludio è notevole
p e r c h é illustra q u a n t o a f f e r m a t o i n p r e c e d e n z a nella
presentazione di Debussy: in esso " l e successioni di accordi non
h a n n o alcun carattere funzionale. Un disegno rapido crea
associazioni di suoni, e invano si cercherebbe a questo una
giustificazione nelle regole dell'armonia t r a d i z i o n a l e " . È la
novità del ritmo che si impone, un p o ' come nel Golliwogg's
Cake-walk. Ma forse, per il critico letterario che si occupi dei
rapporti dialogici della cultura, ancor più interessanti degli aspetti
formali possono risultare quelli tematici del b r a n o .
37
Minstrels n o n è l'unico pezzo di Debussy sull'argomento. Va
ricordato che egli musicò poesie di Banville (Pierrot) e di Verlaine
(Fêtes galantes) nelle quali, tramite Watteau, si ritrovano
personaggi della commedia dell'arte italiana: Colombina, Pierrot,
Arlecchino, alcuni dei quali ricompariranno, col Dottor
Balanzone, nel balletto Masques et Bergamasques del 1909 per
Diaghilev. Si p u ò anzi parlare di un vero e proprio topos
musicale in proposito: Petroushka di Stravinski è del 1911, il
Pierrot lunaire di Schönberg del 1912, il Pulcinella di Stravinski
del 1920. Anche nell'iconografia contemporanea la maschera, il
clown, il menestrello, il saltimbanco diventano protagonisti di
u n ' i n t e r a vicenda pittorica, che collega il motivo teatrale e quello
musicale, come si p u ò vedere dai pochi esempi, illustrativi e
interconnessi, che seguono: l'Arlecchino di Paul Cézanne
(1888-90, fig. 1), l'Arlecchino e la sua famiglia di Pablo Picasso
(1905, fig. 2), l'Uomo con la chitarra di Georges Braque (1911,
fig. 3), l'Arlecchino con il violino di Picasso (1918, fig. 4), il
bozzetto di Gino Severini per il balletto Pulcinella di Stravinski
del 1920 (fig. 5), e ancora le Maschere di Picasso (1921, fig. 6), e
di Severini (1922, fig. 7). Analogamente, per il corrispondente
topos letterario, basterà ricordare (magari tramite " L ' i n t e r m e z z o
dell'Arlecchinata" di Lucini del 1898) le movenze chapliniane
dello Zeno di Svevo, le scomposizioni delle " M a s c h e r e n u d e " di
Pirandello, tutto l'atteggiamento dei poeti crepuscolari che si può
far culminare negli emblematici versi di Palazzeschi: " C h i sono?
/ Il saltimbanco dell'anima m i a " (e al Portrait de l'artiste en
saltimbanque è intitolato un ormai classico ed elegante volume di
Jean S t a r o b i n s k i . Si tratta, in una parola, di un luogo deputato
dell'anti-eroismo in arte. Sul cui sfondo possiamo ora leggere il
testo di M o n t a l e :
38
39
40
- 61 -
Ritornello, rimbalzi
tra le vetrate d'afa dell'estate.
Acre groppo di note soffocate,
riso che non esplode
ma trapunge le ore vuote
e lo suonano tre avanzi di baccanale
vestiti di ritagli di giornali,
con istrumenti mai veduti,
simili a strani imbuti
che si gonfiano a volte e poi s'afflosciano.
Musica senza rumore
che nasce dalle strade,
s'innalza a stento e ricade,
e si colora di tinte
ora scarlatte ora biade,
e inumidisce gli occhi, così che il mondo
si vede come socchiudendo gli occhi
nuotar nel biondo.
Scatta ripiomba sfuma,
poi riappare
soffocata e lontana: si consuma.
Non s'ode quasi, si respira.
Bruci
tu pure tra le lastre dell'estate,
cuore che ti smarrisci! Ed ora incauto
provi le ignote note sul tuo flauto.
Montale aderisce al testo di Debussy innanzitutto tematicamente:
l'argomento della sua poesia è la musica suonata dai minstrels del
titolo, i menestrelli ο più specificamente i " s u o n a t o r i a m b u l a n t i "
del vocabolo inglese che diventano i " t r e avanzi di b a c c a n a l e " (o
" u o m i n i paradossali" secondo una variante) "vestiti di ritagli di
g i o r n a l i " nell'interpretazione modernissima del poeta; essi
sembrano davvero " s t r a p p a t i a qualche collage futurista",
oppure "correlativi figurali di gusto fra fauve e cubistico" alla
" e s s e n z a p r i n c i p a l m e n t e fonica e r i t m i c a " del breve
componimento p o e t i c o .
Si noti poi che questa musica è, specificamente, un
" r i t o r n e l l o " , cioè u n a ripetizione-variazione tipicamente
41
- 62 -
musicale, che in Montale è resa con la ripresa del secondo e del
terzultimo verso ( " t r a le vetrate d'afa dell'estate" — " t u pure tra
le lastre dell'estate") e con il paragone fra il ritornello stesso e il
cuore (l'uno e l'altro bruciano nel calore estivo). Infine, la
musica-argomento è anche la forma stessa della poesia, col suo
ritmo ora scattante ora sfumato, con i suoni aspri del suo tessuto
fonico (per esempio " a c r e groppo di note soffocate") e con le
piccole dissonanze di rime imperfette (rimbalzi — avanzi, esplode
— vuote, baccanale — giornali).
Con questa " c o s e t t a " che si sforzava di rifare Debussy,
Montale paga un suo debito culturale e lascia ai suoi lettori una
precisa indicazione in proposito. Indicazione che però è anche
" d e p i s t a n t e " , non per quello che dice, ma per quello che cela:
infatti nella poesia c'è un elemento tipico di Montale, poetico e
metapoetico, quel " c u o r e " qui ancora incerto (si smarrisce come
il cuore di Corno inglese, " s c o r d a t o s t r u m e n t o " ) ma che già
" b r u c i a " al calore estivo; e questo bruciare è non più che un
accenno, ma importantissimo perché verrà poi svolto in momenti
cruciali di Ossi di seppia: "tali i nostri animi arsi // in cui
l'illusione brucia / un fuoco pieno di c e n e r e . . . " (Non rifugiarti
nell'ombra); "il fuoco che non si smorza / per me si chiamò:
l ' i g n o r a n z a " (Ciò che di me sapeste); " N o n sono / che faville
d ' u n tirso. Bene lo so: bruciare / questo, non altro, è il mio
significato" (Dissipa tu se lo vuoi, in Mediterraneo); e " P e n s o
[ . . . ] / al rogo / morente che s'avviva / d ' u n arido paletto, e ferve
trepido"
(Crisalide).
S o n o t u t t i m o m e n t i cruciali per
l'autoconsapevolezza del poeta e del suo fare poetico: egli,
partendo " i n c a u t o " d a l l e ' ' i g n o t e n o t e " suonate sul suo " f l a u t o "
in Minstrels, arriverà agli splendidi risultati del " b r u c i a t o " per
eccellenza, Arsenio.
Ma i n t a n t o , il motivo del cuore, già metonimico della poesia
nascente, viene svolto da Montale anche in u n ' a l t r a poesia coeva
ancor più debussyana di Minstrels, cioè Corno inglese, l'unica
salvata degli Accordi, fin dall'inizio, senza esitazioni e senza
ripensamenti, e il risultato poetico di gran lunga maggiore
raggiunto dal giovane poeta.
Leggiamola.
42
11 vento che stasera suona attento
—ricorda un forte scotere di lame—
gli strumenti dei fitti alberi e spazza
l'orizzonte di rame
- 63 -
dove strisce di luce si protendono
come aquiloni al cielo che rimbomba
(Nuvole in viaggio, chiari
reami di lassù! D'alti Eldoradi
malchiuse porte!)
e il mare che scaglia a scaglia,
livido, muta colore,
lancia a terra una tromba
di schiume intorte;
il vento che nasce e muore
nell'ora che lenta s'annera
suonasse te pure stasera
scordato strumento,
cuore.
È un breve componimento che ha in sé i dati dell'esperienza
debussyana, dal titolo stesso, eco della predilezione del musicista
per lo strumento e p o n i m o ,
ai precisi riferimenti tematici
rintracciabili nei due preludi per piano Le vent sur la plaine e Ce
qu'a vu le vent de l'Ouest e nella terza parte del poema sinfonico
La mer, Le dialogue du vent et de la mer. Ma questi dati sono
come trascesi e fusi in u n a costruzione che è già, interamente e
potentemente, montaliana, a cominciare dalla valenza metaforica
del titolo, confermata appieno da una traduzione posteriore che
Montale fa da Emily Dickinson, " T e m p e s t a " , del 1945: " C o n un
suono di corno / il vento a r r i v ò . . . " ; e la cui importanza
tematica sta tutta nel fatto che quel sostantivo, il vento, su cui è
basata, è il primo in assoluto dell'intera opera in versi: " G o d i se il
vento ch'entra nel p o m a r i o / vi rimena l'ondata della v i t a " ,
esordisce Montale in In limine, definendo emblematicamente non
solo la liminalità della sua poesia, ma il suo duplice spazio
poetico, interno ed esterno, secondo lo schema ormai classico di
L o t m a n , e la funzione dinamica e creativa che in esso ha il
v e n t o . È una costruzione poetica che racchiude un'esperienza
paesaggistica, musicale e affettiva in una unità straordinaria; è un
piccolo concentrato, un microcosmo autosufficiente di temi,
immagini e tecniche di Montale, in una struttura circolare chiusa a
livello fonico, lessicale e sintattico.
43
4 4
45
A livello fonico, Corno inglese è tutta giocata sul contrastocomplemento (dissonanza-armonia) fra i gruppi consonantici
sibilanti e fricativi (onomatopeici ο q u a n t o m e n o suggestivi del vento) S, ST, e ZZ da un lato: STasera, Suona, Scotere, - 64 -
STRumenti, S p a Z Z a , o r i z z o n t e , STRiSce, Scaglia, Schiume,
naSce, S'annera, SuonaSSe, STasera, Scordato, STRumento; e
dall'altro il suono delle nasali, labiali e dentali dei gruppi E N T e
O M B A : v E N T o , a t t E N T o , strumENTi e le varianti orizzoNTE e
p r o t E N D o n o all'inizio della poesia, r i m b O M B A e t r O M B A al
centro, poi ancora v E N T o , l E N T a , s t r u m E N T o : questa
dissonanza-armonia (in cui è possibile forse cogliere anche
suggestioni stravinskiane: sarebbe far torto a Montale limitare
solo a Debussy la " m u s i c a n u o v a " ) si risolve nel distico finale,
con lo scioglimento liquido di " c u o r e " .
È un tessuto fonico compatto nella sua insistita ripetitività,
che fa da base musicale al livello lessicale-semantico della poesia,
dove a lor volta i sememi "il v e n t o " (ripetuto due volte, al primo
e al quattordicesimo verso), "il m a r e " e " l ' o r i z z o n t e " si
riferiscono a u n a situazione semplicissima, definita anche
temporalmente da " s t a s e r a " al primo e terzultimo verso (insieme
col verbo " s u o n a " — " s u o n a s s e " , nonché " s t r u m e n t i " al terzo
verso e " s t r u m e n t o " al penultimo), ma soprattutto riferita al
vocativo finale, fortemente affettivo, " c u o r e " . È a questo livello
che occorre sottolineare la potenza visiva, pittorica, della poesia
di Montale, che completa e s'interseca con l'indubbia musicalità
di frasi quali " u n forte scotere di l a m e " ο "gli strumenti dei fitti a l b e r i " : si pensi alle immagini " o r i z z o n t e di r a m e / dove strisce di luce si p r o t e n d o n o / come a q u i l o n i " , " n u v o l e in viaggio", " i l m a r e che scaglia a scaglia, / livido, m u t a c o l o r e " , " u n a t r o m b a / di schiume i n t o r t e " . Da notare a n c o r a la preziosità delle scelte
lessicali " s c o t e r e " , " s c a g l i a " (riferita a m a r e , come in Meriggiare
pallido e assorto) e " i n t o r t e " ; la vaghezza poetica dei plurali
leopardiani " n u v o l e " , " r e a m i " , " E l d o r a d i " , " p o r t e " ; l a voluta
ambiguità di " s c o r d a t o " , che, nei significati sovrapposti di
" d i s a r m o n i c o " e " d i m e n t i c a t o " riferiti a " s t r u m e n t o " e a
" c u o r e " , costituisce un superamento del crepuscolarismo insito
nel semema finale. L'unità della composizione è ulteriormente
cementata dalle numerose rime, rime interne e rime imperfette:
vento-attento-strumenti-protendono;
lame-rame;
rimbombatromba; porte-intorte; colore-muore-cuore; vento-lentastrumento; s'annera-stasera.
A livello sintattico, siamo di fronte per la prima volta
nell'opera di Montale a una poesia costruita su un unico periodo
dall'ampio respiro, come avverrà più tardi nella famosa
L'anguilla. Esso costituisce indubbiamente una " u n i t à ritmica
m u s i c a l e " , e si potrebbe trascrivere graficamente così:
46
- 65 -
Alla frase principale corrisponde la linea melodica, alle
secondarie i materiali armonici: il r a p p o r t o tra i due elementi
sintattici è sbilanciato a favore dei secondi, per cui si crea un
ritmo nuovo e diverso (percepibile anche visivamente) nella
struttura dela poesia. Si tratta di un unico periodo in cui la sintassi
è retoricamente ripetitiva e sospesa, di grande efficacia: la frase
dichiarativa " I l vento lancia una t r o m b a " diventa ottativa, "il
vento suonasse te p u r e " . Tutte le numerose clausole dipendenti
e incidentali sono rette dall'unico soggetto "il v e n t o " in una
struttura a emboîtement ο a scatole cinesi culminante quasi ossimoricamente nella parentesi centrale. La quale è una frase
nominale, senza verbo, ma chiaramente collegata al soggetto e
all'oggetto della principale: le nuvole sono " i n viaggio", sospinte
a p p u n t o dal vento, come se avessero, per il " c u o r e " , u n a
destinazione verso gli "alti E l d o r a d i " (che ricordano " l e t r o m b e
d ' o r o della solarità" di I limoni, anche per il richiamo "malchiuse
p o r t e " — " m a l c h i u s o p o r t o n e " ) . Questa frase nominale si p u ò
configurare come vera e propria frase musicale in maggiore (si
n o t i n o : " c h i a r i " , " a l t i " , " l a s s ù " , i due esclamativi in dissonanza
ο a contrasto con il resto della poesia in minore (con le connotazioni " d i r a m e " , " l i v i d o " , " i n t o r t e " , e " s ' a n n e r a " ) . Perciò la frase parentetica diventa il centro — sintattico,
visivo, musicale, affettivo — di tutta la poesia, nella quale
produce una dissonanza fondamentale, sottolineata e contenuta
dalle parentesi che prolungano la sospensione già ampia tra il
soggetto e l'oggetto, tra la n a t u r a e il poeta. U n ' a l t r a indicazione
4 7
- 66 -
di questa dissonanza si trova a livello metrico, in cui l'uso assai
libero di versi tradizionali va dall'endecasillabo iniziale al senario
e al binario finali, " s c o r d a t o strumento, / c u o r e " , entrambi
abbastanza inconsueti nel canone della lirica italiana.
Corno inglese esprime per la prima volta la stessa situazione
che verrà svolta completamente ed emblematicamente nel più
t a r d o Arsenio,
configurandola però
in m a n i e r a m e n o
drammatica: nella dialettica fra immobilità e movimento, fra il
poeta e il m o n d o , la frase parentetica centrale supera le
connotazioni potenzialmente tragiche, è un'apertura
all'immaginazione, alla speranza, alla Senhsucht del poeta che
contempla la tempesta, la " t r o m b a di schiume i n t o r t e " : è il varco
che Montale auspica in In limine,
e che forse ha trovato
Esterina, la debussyana " j e u n e fille aux cheveux de l i n " di
Falsetto (lei è " c o m e spiccata da un v e n t o " , il poeta è "della
razza di chi rimane a t e r r a " ) .
In Corno inglese si tratta di un varco immaginario,
concettuale e ipotetico, che tuttavia è li, presente e invitante,
attualizzato dall'invocazione al centro della poesia nata dalla
musica, debussyana e ligure, del v e n t o . Quel vento, che a livello
connotativo-espressivo, il poeta vuole produca una " m u s i c a " che
smuova lo " s c o r d a t o s t r u m e n t o " del cuore. Montale comunque
non descrive un paesaggio e non esprime semplicemente uno stato
d ' a n i m o , ma cerca con i mezzi poetici descritti di squarciare le
apparenze, di rompere il velo, di raggiungere (come Debussy,
come Mallarmé) " q u a l c o s a di essenziale": che il suo sia un
tentativo, e n o n un risultato, è insito nell'espressione ottativa e
parentetica.
Corno inglese è dunque il m o m e n t o di massima fusione tra
poesia e musica in Montale, il m o m e n t o in cui l'occasione-musica
si trasforma veramente, definitivamente, in poesia.
48
49
50
G I A italiani",
N - P A O L O BIASIN
in "Rivista
in di
"Rivista
Studi Italiani",
di studi
University of California,
anno I , n°
2, IDicembre
, n° 2, Dicembre
1983 1983
anno
Berkeley
NOTE
Eugenio Montale, Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1976, p. 563.
Si vedano almeno, in proposito, i tre libri di Montale, Pastelli e
disegni (Milano, Scheiwiller, 1966), Farfalla di Dinard (Milano,
Mondadori, 1960), e Prime alla Scala (Milano, Mondadori, 1982); e la
biografia di Giulio Nascimbeni, Eugenio Montale, Milano, Longanesi,
1969.
1
2
- 67 -
3
Cfr. Michail Bachtin, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979, e
The Dialogical Imagination, Austin, University of Texas Press, 1980; cfr.
inoltre Vittorio Strada, Dialogo con Bachtin, in "Intersezioni" I (1981),
n. 1, pp. 115-24.
Hugo Friedrich, La lirica moderna, tr. it., Milano, Garzanti, 1961.
Félix Fénéon, Au-delà de l'impressionisme, a cura di Françoise
Cachin, Paris, Hermann, 1966, pp. 84-85 (il testo risale al 1887):
"L'innovation de M. Seurat a pour base la division scientifique du ton.
Voici: au lieu de mélanger sur la palette les pâtes dont la résultante,
étendue sur la toile, fournira à peu près la couleur de l'objet à figurer, —
le peintre posera sur la toile des touches séparées correspondant les unes à
la couleur locale de cet objet, les autres à la qualité de la lumière qui y
choit, d'autres aux reflets projetés par les corps voisins, d'autres aux
complémentaires des couleurs ambiantes. [ . . . ]
De cette manière d'operer, voici les avantages:
I. Les couleurs se composent sur la rétine: nous avons donc un
mélange optique. Or l'intensité lumineuse du mélange optique (mélange
de couleurs-lumières) est beaucoup plus considérable que celle du
mélange pigmentaire (mélange des couleurs-matières) [ . . . ] " . Cfr. anche
John Rewald, The History of Impressionism e Post-Impressionism. From
Van Gogh to Gauguin, New York, Museum of Modern Art, 1973 e 1978
rispettivamente: due volumi fondamentali per seguire i complessi rapporti
fra impressionisti, neo-impressionisti, e simbolisti che sono alla base degli
ulteriori sviluppi della pittura moderna, a cominciare da Cézanne.
Si vedano: Ardengo Soffici, Scoperte e massacri. Scritti sull'arte
11908-131, Firenze, Vallecchi, 1929 , p. 235, nonché pp. 290-93; e Fénéon,
pp. 135-37.
Vittorio Pica, Gl'Impressionisti Francesi, Bergamo, Istituto
Italiano d'Arti Grafiche Editore, 1908, p. 55 e passim. Il libro, corredato
di "252 incisioni nel testo e 10 tavole", ha anche un lungo capitolo
dedicato a Monet, "l'iniziatore più convinto e più cosciente ed il
rappresentante più schietto, più fido e più completo dell'impressionismo", p. 51; Renoir è definito "virtuoso delle dissonanze cromatiche",
p. 98; e non manca un dubbio sull'etichetta stessa di impressionismo, un
"nome abbastanza inesatto", p. 14.
Laura Barile in Eugenio Montale, "Tre articoli ritrovati" (a cura di
L. Barile), Inventario, n.s. 4, gennaio-aprile 1982, pp. 11 e 20, n. 18; il
riferimento a Serra rimanda a Gianfranco Contini, Altri esercizi
(1942-1971), Torino, Einaudi, 1978, pp. 77-100, ma anche alle
fondamentali pagine di Ezio Raimondi, Il lettore di provincia: Renato
Serra, Firenze, Le Monnier, 1964.
Eugenio Montale, Auto da fé, Milano, Il Saggiatore, 1966, pp. 113
e 111 (il brano da cui sono tratte le citazioni è del 1949), e p. 244,
rispettivamente.
Montale, Sulla poesia, p. 144.
Ibid,. p. 565.
4
5
6
2
7
8
9
10
11
- 68 -
12
Leonard Bernstein, The Unanswered Question, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1976. 13
Marzio Pieri, Biografia della poesia, Parma, Edizioni della Pilotta, 1980, p. 251 ("Quanto Debussy, nel giovanne Montale"). Interessante anche il tentativo di Silvio Ramat di descrivere la strutturazione degli Ossi di seppia come una'"armonizzazione" tra il "recitativo" degli "Ossi brevi" e il " c a n t a t o " di Mediterraneo: in Storia della poesia italiana del Novecento, Milano, Mursia, 1976, pp. 224-25. 14
Montale, L'opera in versi, p. 913. Cfr. in proposito anche Laura Barile, che ricorda, oltre a Farfalla di Dinard ("tutta percorsa da cavatine, fa diesis sotto le righe, si bemolle e ricami tenorili"), i frequenti espliciti rimandi a determinate forme, ο frasi, musicali, come 'la farandola di fanciulli sul g r e t o . . . ' (farandola: danza di origine greca ma popolare in Provenza, in tempo 6/8 moderato), lo 'scalpicciare del fandango' (danza nazionale spagnola utilizzata da Manuel De Falla nel Cappello a tre punte), la 'fantasia' (brano strumentale di forma assolutamente libera) di Quasi una fantasia (già rilevato da Lonardi), lo
stesso 'mottetto'": in Montale, "Tre articoli ritrovati", p. 10. L'elenco,
naturalmente, si potrebbe allungare.
Montale, Auto da fé, p. 301 ( da "Per fortuna siamo in ritardo"
del 1963).
Montale, Sulla poesia, p. 57.
Ma in Prime alla Scala Puccini viene inteso in una dimensione
moderna, ricca di fermenti e di inquietudini (p. 265); cfr. Mosco Carner,
Puccini. A Critical Biography, New York, Holmes and Meier, 1977 , e
Mario Bortolotto, Consacrazione della casa, Milano, Adelphi, 1982,
pp. 131-51.
Cfr. Sulla poesia, p. 603: "Credo che la mia poesia sia stata la più
'musicale' del mio tempo (e di anche prima). Molto più di Pascoli e di
Gabriele. Non pretendo con questo di aver fatto di più e di meglio. La
musica è stata aggiunta, a D'Annunzio, da Debussy".
Nicholas Ruwet, Langage, musique, poésie, Paris, Seuil, 1972,
p. 44.
Guido Salvetti, Il Novecento I, vol. IX di Storia della Musica, a
cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT, 1977, p. 43. È
opportuno sottolineare una notazione di Montale relativa a quegli anni e
agli sviluppi della musica nuova: "Abolita la dominante, escluso il
tematismo (che privilegia certe note a vantaggio d'altre), ammesso il
principio che in ogni composizione ogni nota sia sempre un principio e
una fine e che il centro debba essere in ogni luogo e in nessuno, i musicisti
danno lezione ai poeti; e questi accettano la lezione": in Sulla poesia, p.
329 (1965). Per un affascinante ritratto della Parigi che fu in parte anche
il milieu di Debussy, si veda Roger Shattuck, The Banquet Years: The
Arts in France, 1885-1918, (il libro tratta di quattro biografie parallele:
Henri Rousseau, Eric Satie, Alfred Jarry e Guillaume Apollinaire).
Citato da Salvetti, p. 45, e da Bartolotto, p. 74.
15
16
17
2
18
19
20
21
- 69 -
22
Salvetti, p. 46. Anche Massimo Mila, Breve storia della musica,
Torino, Einaudi, 1977, p. 358 concorda in tale sistemazione critica;
mentre Stefan Jarocinski rifiuta i termini sia di impressionismo (come
errato) che di simbolismo (come insufficiente) per definire il musicista: in
Debussy. Impressionismo e simbolismo, tr. it., Fiesole, Discanto
Edizioni, 1980. Lo stesso Debussy rifiutava questi termini (si veda per es.
il suo Il Signor Croche, autodilettante, tr. it., Milano, Bompiani, 1945,
p. 26); essi conservano però una loro utilità storica e culturale, se non
critica, da non trascurare (come, d'altronde, il concetto stesso di
"dissonanza").
Salvetti, p. 46. Nella storiografia musicale è proprio il concetto
della purezza del suono che si delinea come caratterizzante per Debussy;
per esempio, ancora Paul Claudel sottolineava impressionisticamente la
"diaprure" nella musica del "Claude national" (in Oeuvres complètes,
XVII, L'oeil écoute, Paris, Gallimard, 1960, p. 150); mentre Jarocinski
insiste più modernamente sul "pensiero sonoriale" tutto volto alla
liberazione della purezza, e non della sfumatura, dei suoni (in Debussy,
passim). Anche Piero Rattalino nota che in Debussy "i timbri non si
fondono, ma semplicemente coesistono, e si perde anche la sensazione
della gerarchia di valori tra melodia e parti di accompagnamento in favore
della compresenza di più eventi sonori indipendenti" (in Storia del
pianoforte, Milano, Il Saggiatore, 1982, pp. 272-73).
Salvetti, pp. 46-47. Cfr. ache Bernstein, pp. 147-89. Sulla melodia,
"forza organizzatrice" di Debussy e "controparte musicale" della linea
sinuosa dell'Art Nouveau, cfr. Arthur Wenk, Claude Debussy and the
Poets, Berkeley, University of California Press, 1976, pp. 180 e 186-87.
Cfr. infine Ruwet, pp. 70-99 ("Note sur les duplications dans l'oeuvre de
Claude Debussy"), e Jarocinski, pp. 157, 164 e 195.
Bernstein, pp. 243-45, 249, 259.
Rispettivamente Salvetti, pp. 51 e 53, e Jacques Rivière, Études,
Paris, Gallimard, 1944 , pp. 131 e 133-34. Per parte sua, Montale ha
osservato che Debussy fu "grande musicista soprattutto quando scoperse
per conto suo il pianoforte, con una prodigiosa immersione nella civiltà
del suo paese, da Rameau-Couperin fino a Monet e a Renoir": in Prime
alla Scala, p. 13.
Salvetti, p. 54: "Ricordiamo i titoli: per le cinque dita, per le terze,
per le quarte, per le seste, per le ottave, per le otto dita; per i gradi
cromatici, per gli abbellimenti, per le note ribattute, per le sonorità
opposte, per gli arpeggi composti, per gli accordi".
Jarocinski, p. 193.
Cfr. in proposito Montale, "Tre articoli ritrovati", in particolare
la recensione al volume di Georges Duhamel e Charles Vildrac Notes sur
la téchnique poétique, pp. 5-6, nella quale Montale si interessava alla
teorica "di quella sottospecie del verso libero che si è chiamata verso
'bianco': un verso, per intenderci, preoccupato di una musicalità più
intrinseca che esteriore, di una maggiore aderenza alle sfumature della
23
24
25
26
19
27
28
29
- 70 -
vita spirituale, e di certa patetica aridità lineare, atta, più che la musica
singhiozzante del ritmo faux exprés dei primi simbolisti, a suggerire echi e
fantasmi dell'intelligenza" (si noteranno espressioni quali "maggiore
aderenza", ripresa nell'"Intervista immaginaria" del 1946 in un contesto
diverso, "aridità" e "intelligenza", che sono vere e proprie autodefinizioni critiche della poesia montaliana; cfr. inoltre il commento di
Laura Barile, pp. 7-8.
Friedrich, p. 12. Si ricorderà che anche per Arnold Schönberg
l'emancipazione della dissonanza come eliminazione della base
dell'armonia è il fondamento della dodecafonia (in Stile e idea, Milano,
Rusconi e Paolazzi, 1960, pp. 109-10; citato anche da Enrico Fubini,
L'estetica musicale dal Settecento a oggi, Torino, Einaudi, 1968, p. 229).
Quello che per Theodor Adorno (in La filosofia della musica moderna) è
un contrasto insanabile fra Stravinski e Schönberg, fra musica tonale e
non tonale, diventa più giustamente per Bernstein (nell'ultima parte di
The Unanswered Question) un rapporto dialettico indispensabile per
capire il pathos e la vitalità della musica del Novecento.
Del "terreno di radicale modernità" su cui è sorta la prima poesia
di Montale ha parlato Sergio Solmi ("La poesia di Montale" in Scrittori
negli anni, Milano, Il Saggiatore, 1963, p. 285), che suggerisce una linea
Heine-Laforgue-Govoni, cui Lanfranco Caretti aggiunge Palazzeschi in
"Un inedito montaliano |Suonatina di pianoforte]", Paragone, 336,
1978, pp. 3-7, p. 5.
30
31
32
Jarocinski, p. 178. L'importanza del mare e il paragone con
Turner sono trattati anche da Wenk, pp. 205-10, che cita pure
un'interessante lettera di Debussy assolutamente contraria al termine
"impressionismo" usato dagli "imbéciles" per definire Turner, "le plus
beau créateur de mystère qui soit en art".
Cfr. Marco Forti, Eugenio Montale, Milano, Mursia, 1973;
Edoardo Sanguineti, Ideologia e linguaggio, Milano, Feltrinelli, 1965; e
Silvio Ramat, Montale, Firenze, Vallecchi, 1965.
Tutte le citazioni si riferiscono a Eugenio Montale, L'opera in
versi, a cura di Gianfranco Contini e Rosanna Bettarini, Torino, Einaudi,
1981, pp. 765-72.
Montale, L'opera in versi, p. 866.
Massimo Mila, L'esperienza musicale e l'estetica, Torino, Einaudi,
1956, p. 180. Cfr. Rattalino, pp. 324-25: fra i grandi pianisti del
Novecento, Gieseking fu tra i primissimi a includere "costantemente e
frequentemente" Debussy nel repertorio.
Jarocinski, p. 168; e a p. 166: "Le prélude XII (che abbonda in
valori sonoriali) mostra come una melodia figurativa ed ornamentale
possa, grazie ad un movimento rapido, trasformare una struttura
orizzontale in una verticale (battute 25-26)".
Cfr. Wenk, pp. 19-23.
Jean Starobinski, Portrait de l'artiste en saltimbanque, Genève,
Skira, 1970.
33
34
35
36
37
38
39
- 71 -
40
L'opera in versi, p. 14.
Silvio Ramat, Protonovecento, Milano, Il Saggiatore, 1978,
p. 486; e Forti, p. 52.
L'opera in versi, p. 11.
Sulla predilezione di Debussy per il corno inglese si veda
Jarocinski, p. 173.
OV, p. 722.
Si veda Jurij Lotman e Boris Uspenskij, Tipologia della cultura, tr.
it., Milano, Bompiani, 1975, pp. 145-81; e per la liminalità, si vedano
l'interpretazione antropologica (turneriana) di Rebecca West, E.M., Poet
on the Edge, Cambridge, Mass., Harvard UP, 1981, e quella
decostruttiva (derridiana) di Stefano Agosti, Cinque analisi. Il testo della
poesia, Milano, Feltrinelli, 1982, specie pp. 83-84.
Ettore Bonora, La poesia di Montale, I, Torino, Tirrenia, 1965,
p. 88. Non sono ovviamente d'accordo con la sua valutazione degli incisi
come "dei momenti in sordina" del componimento (p. 87).
Naturalmente è possibile interpretare la sintassi della poesia, come
fa Giusi Baldissone (Il male di scrivere. L'inconscio e Montale, Torino,
Einaudi, 1979, pp. 1. nota 1, e 123), nel senso che è il mare a lanciare a
terra "una tromba di schiume intorte": in tal caso si avrebbe un'unica
frase principale ottativa col soggetto ripetuto (il vento—)il vento). Ma
simile interpretazione mi pare meno persuasiva di quella che ho scelto,
perché toglie forza (e drammaticità) proprio al vento che è il soggetto
grammaticale, l'occasione della poesia, l'antagonista del poeta; senza
contare che a livello strettamente sintattico la costruzione di due verbi
collegati paratatticamente da una virgola (per di più aggiunta solo
nell'edizione critica: "il mare che [ . . . ] muta colore, lancia a terra una
tromba") è certamente insolita in Montale.
A proposito di questi versi Ramat, Montale, p. 22, parla
erroneamente di "novenario finale", ma osserva con finezza che la
divisione in "due tronconi" sta "quasi a significare la congenita
disarmonia di questo strumento".
Cfr. In limine: "Cerca una maglia rotta nella rete / che ci stringe,
tu balza fuori, fuggi!"; ma l'interrogazione di Montale rimarrà ancora
attraverso gli Ossi (si pensi a Crisalide e a Casa sul mare) e fin nel cuore
delle Ocassioni (La casa dei doganieri: "Il varco è qui?").
Quanto sia intrinsecamente "musicale" Corno inglese si può
verificare anche in un confronto a prima vista secondario ο addirittura improbabile tra il secondo verso "— ricorda un forte scotere di lame —" e un'osservazione di un musicologo contemporaneo: " L a tecnica della costruzione [...] si era evoluta fino a un pianoforte che non era più
esattamente il pianoforte di Chopin e di Liszt. La maggior tensione delle
corde [...] gli aveva sottratto il vecchio suono di corda percossa e,
aggiungiamo noi, gli aveva dato un suono di lamina percossa. È proprio
qui che Debussy sviluppa una concezione nuova non solo del suono, ma
della musica" (Rattalino, p. 271, corsivo aggiunto).
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
- 72 -
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 3
- 73 -
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
- 74 -
Christine Ott
Il problema del “residuo” semantico
[…] Negli scritti critici Montale ritorna più volte su [quella] che egli considera una
tendenza specifica, ma anche una meta irraggiungibile della lirica moderna. Il
problema fondamentale consiste nel fatto che:
la poesia si serve di parole [...] le arti hanno qualcosa di più oggettivo, sono più resistenti
al tempo [...] in esse il significato non tarda a diventare «pretesto», occasione; in poesia
tale processo è più lento e lascia sempre un fortissimo residuo 1.
Le altre arti (musica, pittura) si servono di materiali asemantici 2, e sono quindi
maggiormente in grado di dare alle loro opere un carattere «oggettivo»,
«resistente] al tempo», dietro al quale il «significato» particolare, soggettivo può
celarsi. Il materiale lirico, invece, è necessariamente semantico, storico e
referenziale. L’oggettivazione verbale si presta meno ad assorbire le intenzioni
individuali, e lascia un inevitabile «residuo» soggettivistico. Ciò che Montale, nel
1923, qualificava come «rottame», è definito ora, nel 1942, un residuo semantico.
E interessante notare che nella teoria poststrutturalista il concetto di residuo
indica la particolare eccedenza di senso del linguaggio poetico 3. All’interno di una
teoria lirica postontologica il termine viene a occupare il posto altrimenti riservato
a un “pensiero” che precedesse la parola. È una conferma della (seppure qui
inconsapevole) modernità della poesia montaliana. Il carattere referenziale del suo
mezzo fa sì che la lirica contenga sempre un elemento soggettivo, imponderabile
(attraverso l’irrimediabile eccedenza di senso), “impuro” 4. Ma proprio questo
costituisce per Montale la vitalità della poesia, e insieme la sua singolare
paradossalità:
Il destino alto e oscuro della poesia parrebbe dunque quello di tendere sempre più alla
condizione di arte, all’assoluta purezza che questa parola postula, restando pur sempre, e
con piena coscienza dell’impossibile assunto, un’arte diversa, un’arte sui generis [.,.] (La
poesia come arte).
La particolarità della lirica consisterebbe dunque proprio nel dissidio tra la
necessità di impiegare parole e la tendenza a dissolvere l’elemento semantico
(riflessivo, razionale) nell’assoluta liricità (o purezza) - oppure a trascenderlo:
[...] nessuno scriverebbe versi se il problema della poesia fosse quello di farsi capire. Il
problema è di far capire quel quid al quale le parole da sole non arrivano.
1
2
La poesia come arte (1942).
Naturalmente colori e suoni possono suggerire dei significati emotivi, ma non significano nel senso
proprio del termine.
3 Stefano Agosti definisce il «“residuo” linguistico non simbolizzalo» come «un’eccedenza di linguaggio
impossibilitata ad assidersi (ad assorbirsi) nella trama comunicativa (concettuale) [...] un sovrappiù non
razionalizzabile o non calcolabile di "semanticità”» (Agosti, Discorso, parola analitica, linguaggio
poetico).
4 Cosi nello scritto Parliamo dell’ermetismo del 1940, in cui Montale definisce la «poesia pura» in termini
molti simili a quelli di Intenzioni, per poi concedere: «La poesia lirica, come genere, è una astrazione che
può diventar concreta solo in determinati casi (...) L’obiettivo chiede una giustificazione al subiettivo che
sottintende, all’anima; l’impurità, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra. Per fortuna!».
L’assurdità della lirica è appunto questa: vuole trascendere il linguaggio della
comunicazione, e tuttavia comunicare qualcosa. Impiega parole, ma tenta di
esprimere più di ciò che queste possano dire. Quindi non si tratterà tanto di
armonizzare quest’irriducibile contraddizione quanto piuttosto di sopportarla.
Non a caso Montale ha definito la lirica una «strana convivenza della musica e
della metafisica, del ragionamento e dello sragionamento, del sogno e della
veglia»5. […]
(da: Montale e la parola riflessa, 2003, trad.it. Milano,
Franco Angeli, 2006)
5 «Che cos’è una poesia lirica? Per conto mio non saprei definire quest’araba fenice, questo mostro,
quest’oggetto determinatissimo, concreto, eppure impalpabile perché fatto di parole, questa strana
convivenza della musica e della metafisica, del ragionamento e dello sragionamento, del sogno e
della veglia» (Araba fenice; corsivo mio).
Edoardo Sanguineti
In margine a un paradosso
In un articolo del 1951, che era una recensione al Verdi vivo di Emilio
Radius (Il genio che compì il lavoro di molte vite), Eugenio Montale scriveva, tra
l’altro: “Il problema di Verdi, come del resto quello di Donizetti e di altri operisti
musicali dell’Ottocento, è complicato dal fatto che probabilmente fra
cinquant’anni le sue opere saranno ineseguibili”. Il tempo vola, anzi è scaduto, e il
transito dal cinquantenario al centenario verdiano spinge a ima verifica di quel
prudente vaticinio.
L’ineseguibilità di cui discorreva Montale, occorre ricordare subito, era di
ordine tecnico, esecutivo, essenzialmente vocale. Egli sentiva che si stava
estinguendo una tradizione interpretativa, una modalità di recitazione e di canto, e
anche di messa in scena –di messa in opera, davvero – alla quale si poteva tentare
di porgere forse soccorso, suggeriva con amara ironia, qualora “si allevino e si
formino degli specialisti, tenendoli in gabbia come bestie rare”. Ma se Verdi era
ormai vissuto, o vivibile, come lontano dalle forme concrete delle realizzazioni
teatrali, alla metà del Novecento, non lo era nemmeno abbastanza per essere
sottoposto a quei restauri che già riuscivano necessari, e perfettamente tollerati,
per il Barbiere o per i Puritani. All’orecchio di Montale, insomma, Verdi appariva
come ormai affidato, in grave degrado, a “cantanti di tipo pucciniano”, incapaci di
intendere quel particolarissimo “verismo” verdiano, quella sua rivoluzionaria
vocalità, e prontissimi, anzi, a fraintenderlo.
Ma sotto questo lamento tecnico, si celava poi, più radicale e più
significativa, una diversa preoccupazione. Il timore autentico di Montale era che il
“verdismo” fosse destinato a scomparire come “passione nazionale”. Di una vera
sopravvivenza, scriveva, “francamente, non si vedono i segni”. Del resto, egli si
trovava dinanzi a quella “tenzone” che divideva gli “ammiratori del Verdi centrale”
(cioè del trittico Rigoletto Trovatore Traviata, proverbialmente supremo) dagli
“zelatori del Verdi ultimo” (Otello e Falstaff ovviamente), e dagli amanti del
“primissimo Verdi” (per “quella vena che va dal Nabucco e dai Lombardi fino ai
miracolosi recitativi drammatici del Don Carlos”). Tra questi amanti minoritari
egli iscriveva “modestamente” sé stesso, “pur ammettendo che il Verdi più grande
e più italiano sia quello del Trovatore (melodramma più che dramma)” – e
intendeva dire, appunto, perché più melodramma che dramma.
A mezzo secolo di distanza, questa “tenzone”, credo, può giudicarsi
superata, se non del tutto spenta, ma più per effetto di una distanza la quale
tempera fatalmente molti sbalzi prospettici, che per una concorde risoluzione
critica. E questa distanza è quella che si interpone, di necessità, tra noi che già
siamo affacciati al Duemila e gli “operisti musicali dell’Ottocento” in genere, e
Verdi in prima fila, e che non consiste tanto in un generico blocco d’anni
aritmeticamente sgranati, ma nella grande, e veramente epocale, crisi musicale
novecentesca, che ha segnato, per intanto, la morte, non già del teatro musicale,
ma certamente del melodramma, quale si spegne, precisamente, nel “tipo
pucciniano”. Il problema esecutivo e interpretativo, in ogni caso, era la figura di
una più forte, e non più rimediabile frattura. Montale davvero percepiva che stava
diventando sempre più difficile, e in breve forse impraticabile, vivere il verdismo (e
il puccinismo stesso) come forma, per così dire, culturalmente naturale, e dunque
immediatamente partecipabile, in forza e per grazia di un imprescrittibile
imprinting.
In occasione di un Ernani alla Scala, 1959, rilevava chiaramente, allora:
Non è solo che siano più rare le grandi voci, o almeno le voci adatte; è che il rapporto col
pubblico appare sensibilmente mutato.
E spiegava:
Un telone di cartapesta, un’orchestra discreta ma non sovrabbondante, due o tre artisti capaci
di sentire ed esprimere il canto verdiano erano una volta sufficienti a rivelare Verdi a un
pubblico degno di ascoltarlo; e ciò avveniva spesso in teatri di modeste esigenze.
Alcuni anni prima, nel ‘46, è ben noto, Montale aveva esibito, con dedica a
Massimo Mila, il suo Paradosso della cattiva musica, che avrebbe poi inaugurato,
1981, le sue Prime alla Scala. Non a caso, quel Paradosso recava nel proprio
centro la deprecazione per il cattivo momento che Verdi aveva attraversato,
“tenuto in quarantena dagli intellettuali”, a dispetto dell’“entusiasmo popolare che
lo ha sempre accompagnato”.
Sempre sì, o almeno quasi sempre, in allora, ma non per sempre, dunque.
In giuoco era una maniera di ascolto che era rimasta lungamente attiva presso quel
“pubblico rozzo, conciliante e sincero” che Montale, nella sua prima gioventù,
aveva incontrato al ’’Caffè ristorante del Lido d’Albaro”, con “gli allegri sberleffi
della Mascotte o della Figlia di Madama Angot”, e con affini esemplari da
Keepsake, e con il piacere di “abbandonarsi alla disperazione di Loris Ipanof o alle
prestigiose contraffazioni musicali di Leopoldo Fregoli”. Nel ’56, per una Fedora di
cui Gianandrea Gavazzeni aveva procurato “la versione più vantaggiosa”, infatti,
confessava, maliziosamente nostalgico: “Personalmente, le nostre Fedore le
abbiamo ascoltate in teatri che erano poco più di baracche, con esecutori che
sottolineavano i luoghi più enfatici dello spartito”. Era un’educazione musicale,
oggi del tutto estinta, che aveva avuto modo di degustare ancora, per poco, quello
che Montale definì, nel ’49, Il tempo delle “soubrette”, l’età d’oro dell’operetta,
quando l’“arte umbertina” era riuscita a sopravvivere e continuarsi, “per un paio di
decenni, sotto il successore di Umberto”. È il tempo in cui, “fatte tutte le
sottrazioni possibili, madama Butterfly non canta in modo troppo diverso da Eva”
(quella di Franz Léhar, naturalmente), e “le primedonne dell’opera non
furoreggiano più se non hanno qualità di stelle operettistiche (Lina Cavalieri,
Carmen Melis)”. Era quell’educazione musicale che Montale confessava e vantava
a proposito dei Casi della musica di Fedele D’Amico, dicendosi “partecipe” e
“complice” dell’opera ottocentesca, “poco amante della musica pura ma addirittura
innamorato della musica teatrale e in particolare del melodramma, quasi unica
gloria del nostro romanticismo”. Si capisce che “solo le cattive esecuzioni” avevano
potuto rendergli “del tutto comprensibile l’opera ascoltata”.
Quella paradossale apologia della “cattiva” musica era, insomma,
un’apologià delle “cattive” esecuzioni, e del “cattivo” repertorio. E il paradigma
supremo, per un simile paradosso, era, pur tra molte reticenze e molte ambiguità,
iperparadossalmente, la musica verdiana. Perché “Verdi è stato l’ultimo operista
che abbia fatto cantare i suoi personaggi: quelli che vennero dopo di lui riuscirono
spesso anche a far cantare: ma la differenza resta enorme”. E perché, certo, “le
antiche esecuzioni erano volgarucce, ma rendevano il più e il meglio: l’essenza del
canto di Verdi”. E le “grandi fiammate di entusiasmo” rimasero sempre più
emarginatamente confinate nei “teatri popolari”, in irrimediabile e veloce agonia.
Quella pienezza di “canto” era verificabile nel “colore” operistico verdiano,
perché, per Verdi, “in un’opera, trovato il colore, il gioco è fatto”, dichiaratamente,
come annotava Montale, nel ’56, in margine a un Ballo in maschera. E Verdi
intendeva discorrere “non certo di un colore timbrico, bensì di una colorazione
della melodia”. Quattro anni più tardi, a proposito del Don Carlo (il migliore
esempio della “crisi verdiana”, superiore anche al Boccanegra), Montale osservava
che in quest’opera Verdi “ha trovato un colore nuovo, ha trovato la carie nera e
profonda della Controriforma e le circonvoluzioni e i festoni del grande barocco”.
E, per un Otello del ’59, aveva già notato:
Non sembra che dopo il ventennio ’47-’67 (dal Macbeth al Don Carlo) Verdi potesse in alcun
modo sorpassare le vette che aveva raggiunto. Poteva invece aggiungere nuovi colori alla sua
tavolozza e questo rende importanti Otello e Falstaff se si considera che al colore Verdi dava
un significato strettamente poetico. Trovato il colore di un dramma, diceva, il resto viene da
sé. In tale senso, in cui confluisce anche l’arricchimento tecnico, l’aumentata scienza
dell’orchestratore e dell’armonista, Otello è ancora uno dei capolavori drammatici di Verdi e
porta alle ultime conseguenze il colore che il musicista aveva già intraveduto nel Boccanegra.
E quanto al Boccanegra, nel ’65, dopo aver notato che al libretto “hanno
messo mano tre librettisti: il Verdi che ne abbozzò in prosa la sceneggiatura, il
Piave e da ultimo il Boito” (nel passaggio dalla redazione 1857 a quella 1881),
Montale affermava che alla musica
hanno atteso almeno tre Verdi diversi: quello dei Lombardi e del Macbeth, il Verdi della
maniera nera (quello del Don Carlo e delle parti migliori dell' Otello) e infine il Verdi
“aggiornato” dei coretti ancillari, delle serenate e delle fanfare lontane, il Verdi già accusato
(chissà perché) di ‘wagnerismo; l’ultimo Verdi, insomma, nei suoi aspetti più superficiali.
E tre Verdi, con tre maniere, significa, di fatto, tre coloriture melodiche e
drammatiche. Nel ’57, per altro, per un Falstaff Montale aveva scritto che, nei
primi due atti (nel terzo impera “un sinfonismo da Sogno di una notte di mezza
estate e da Queen Mab”), si scorge “(in parte per merito del libretto, in parte per il
genio di Verdi che in ogni opera trovava un diverso colore), una tinta di vecchio
negozio Old England (o magari Farmacia Roberts) del tardo Ottocento italiano”.
Non è questo il luogo per tentare un abbozzo di diagnosi di un Verdi
secundum Montale. Ma era utile chiedere al poeta genovese, che aveva vissuto, con
la seduzione e il fascino, anche la crisi e il tramonto della gestione dei colori
verdiani “nelle grandi arene, di fronte a un pubblico che vuole commuoversi e non
guarda troppo per il sottile ai mezzi impiegati dall’artista” (sono parole dettate, è
quasi ovvio, per un Trovatore, nel ’62), di testimoniare per noi di un’età che
possiamo, che dobbiamo dire assolutamente conclusa. Proprio in quel ’51 del
cinquantenario, ancora, Montale polemizzava, discorrendo di Gozzano, contro
quegli “intellettuali d’oggi” (dei nostri ieri, cioè, ormai) “che si vergognano di
Puccini e preferiscono il Falstaff al Trovatore (ma in cuor loro amano solo la
musica negra)”. Senza questo rigido moto polemico, non è correttamente
comprensibile il “paradosso” montaliano, e la sua lettura del teatro musicale, e di
Verdi in particolare. Ma la sua non era comunque quella di un poeta prestato alla
critica musicale, nell’ambito del suo secondo mestiere. Era, in qualche modo, e per
questo adesso ci importa, la lettura di una intiera generazione, e può finalmente
valere, infatti, per noi, come documento e come allegoria di una condizione
culturale e di una disposizione storica remota e perduta. Ma, come tale,
precisamente, ci soccorre con una differenza decisiva, ci aiuta a meglio apprestarci
a intendere un altro Verdi, il nostro eventuale contemporaneo, il possibile Verdi
del secolo che si inaugura.
(in: Giuseppe Verdi, genovese, a cura di R.Iovino e
S.Verdino. Celebrazioni Verdiane Genova 2001 – Lim.)
PIER PAOLO PASOLINI
da: Studi sullo stile di Bach
(inedito, 1944-45)
Prefazione ossia confessione
Che non esista una lingua critica per la musica, è una constatazione
scoraggiante per chi si accinga a parlare nientedimeno che dello «stile» di un
musicista. E confesso senz’altro che non solo conosco rozzamente la biografia di
Bach, ma ben poco il suo tempo, cioè i suoi rapporti con la storia. E questo sarebbe
ancora nulla in confronto alla mia quasi assoluta ignoranza di tutta la sua opera
musicale, eccettuate le sei sonate per violino solo, che io conosco limitatamente
alla mia capacità di conoscer musica, cioè alla mia capacità di esprimere
criticamente quel poco che capisco. Ma mi giustifichi il fatto che non esiste una
tradizione di vera critica musicale; e mi consolo pensando che non cadrò nelle
banalità linguistiche della biografia, e, tantomeno, nelle rievocazioni esteticoletterarie di ineffabilità musicali, quali commoventissimo solletico delle proprie
disposizioni immaginative. Ed è certo, poi, che questa mia prova non potrà che
essere inferiore ad alcuni frammenti di critica musicale, apparsi su moderne riviste
letterarie («Letteratura»), in cui però io trovo, da parte mia, il difetto di aver
involato a piene mani il linguaggio critico della letteratura; e di aver involato, poi,
il repertorio più facile di aggettivi, di sintassi, e, infine, di premesse estetiche. Io,
per me, porterò nel criticare la musica la mia possibilità critica di interpretare
certa poesia, pochissimo musicale, come quella di Leopardi, o, alle origini, di
Cavalcanti. E per spiegarmi meglio dovrò indugiare brevissimamente sopra un
uggioso problema, ossia i rapporti storici ed ideali tra musica e poesia. Me la
caverò con due o tre esempi soltanto, riservando se mai per un altro scritto che
non sia una prefazione, la documentazione più varia ed esatta di quanto io credo di
scorgere in tali rapporti. Innanzitutto s’ha da distinguere una musicalità della
poesia da una musicalità della musica. Qui verte l’equivoco. È musicalità della
poesia certo settenario scorrevole, certo cantante quinario, certo lieve
endecasillabo (Metastasio, Belli, Monti etc.); e, se possiamo sempre chiamare tale
poesia «musicale» ciò non significa che abbia qualche rapporto, se non
esteriorissimo, con la musica. Anche la musicalità più scoperta e ricercata di molta
poesia moderna (prendiamo D’Annunzio) non ha nulla a che vedere con la musica;
per es., la musicalità della Pioggia nel pineto potrà ricordare qualche pezzo
musicale di carattere onomatopeico; ma non certo la musica di un Beethoven (dico
Beethoven ricordando un suo luogo che si potrebbe considerare descrittivo, della
Sesta sinfonia); e se di musicalità si può rettamente parlare in D’Annunzio, questa
è musicalità lessicale, poetica. Più giustificato è il paragone tra la musica e la
poesia di un Mallarmé, di un Valéry (ma non di un Verlaine), essendoci nella
musicalità di tale poesia qualcosa di matematico, di riflesso, cioè di concettuale,
molto più vicino alla musicalità della musica che la musicalità ingenuissima delle
parole sdrucciole o tronche. E per di più la musica nelle parole di quei poeti, a cui
possiamo aggiungere Ungaretti, è nel processo con cui vengono scelte; cioè più nel
loro calore o meglio nel loro significato, che nel loro suono. Ma certamente anche
qui l’equivoco permane, per quanto allettante: tuttavia, a sua giustificazione non
c’è, forse, che la musica di un Debussy.
I rapporti tra musica e poesia non sono di un’equivoca musicalità, e
nemmeno rapporti tra note e sillabe; ma, se mai, rapporti tra ritmo e sintassi, se
proprio vogliamo salvare una somiglianza esterna.
[seguono esempi: Beethoven, Sinfonia n. 5; Bach, Sonata n. 6, Preludio]
e «Che fai tu luna in ciel?» (Leopardi, Canto di un pastore etc.), «O del grande
Appennino» (Tasso, Canzone al Metauro).
Prima il silenzio, poi il suono o la parola. Ma un suono e una parola che
siano gli unici, che ci portino subito nel cuore del discorso. Discorso, dico. Se c’è
un rapporto tra musica e poesia questo è nell’analogia, del resto umana, di
tramutare il sentimento in discorso, con quel risparmio, quella misura,
quell’accoratezza che sono semplicemente comuni ad ogni opera d’arte. Basta
rievocarsi il Partenone, un san Pietro di Masaccio, i Sepolcri, la Quinta sinfonia;
da per tutto il medesimo inizio perfetto, cioè passaggio perfetto dal nulla alla realtà
dell’opera; la stessa conclusione perfetta, lo stesso svolgimento perfetto. E, in
fondo a tutto, un sentimento, una passione, un’esperienza umana che divengono
figure concrete. Tali somiglianze si fanno più sensibili tra l’arte musicale e l’arte
poetica.
(in: Saggi sulla letteratura e sull'arte, a c. di W.Siti e S. De
Laude, con un saggio di C.Segre, vol. 1, Mondadori, Milano,
1999)
Lo scritto, nella sua interezza, è reperibile sul seguente link:
www.pasolini.net/saggistica_studistileBach_ppp.htm
Un contributo sulla presenza della musica bachiana nella cinematografia di
Pasolini, ad opera di Alessandro Cadoni, è inoltre leggibile qui:
www.pasolini.net/cinema_bachFilm_cadoni.htm#_ftn2
EDOARDO SANGUINETI
Luigi Pestalozza
Conversazione con Edoardo Sanguineti
In questa conversazione con Edoardo Sanguineti vengono affrontati alcuni temi
generali, che oggi sono importanti, che riguardano anche la storia, ormai, delle
avanguardie musicali e poetiche, letterarie, in Italia, dalla fine della guerra.
Sanguineti parla naturalmente della sua esperienza, di come vede certe cose. Ma
negli anni Sessanta il suo incontro con Luciano Berio, sul quale giustamente si
sofferma, si colloca in un quadro più ampio di problemi. Superare le divisioni fra
le diverse attività culturali, in particolare fra musica e poesia e pittura, tendeva
in realtà a mettere in discussione certe rigidità istituzionali, infine sociali. Non
credo che sia un caso che la contestazione del Sessantotto e il fiorire negli anni
Settanta di tante iniziative il tipo nuovo rispetto alla vita della musica nelle
istituzioni tradizionali, abbia avuto per protagonisti tanti musicisti e non
musicisti (poeti, pittori) che negli anni Sessanta o nei tardi anni Cinquanta
avevano cominciato a mettere in discussione certi schemi. Per esempio avevano
cominciato a lavorare insieme, a intrecciare le ricerche. In diverse e significative
direzioni. Voglio ricordare anche che a metà degli anni Cinquanta, attorno a
Italia Canta e a Cantacronache, si ritrovarono musicisti e letterati come
Manzoni, Fortini, Liberovici, Calvino, Jona ecc. Il problema era una canzone
diversa, antagonista, né soltanto politica-mente impegnata. L’interesse era per la
disponibilità a rompere le competenza, la logica dei generi, perfino delle
specializzazioni (delle gerarchie); e in questo ordine mentale, intellettuale, infine
ideale, teorico, avvennero anche gli incontri sul terreno del teatro musicale. Il
senso vero, fu che venivano rotte le stesse abitudini di collaborazione, poiché
precedenti illustri, certo, ce ne erano stati. Ma ora la ricerca e cioè la critica si
combinava fra musicista e poeta, per esempio, né l’oggetto era una qualche
mitica e sempre mancata (può solo mancare se ha solo sé come oggetto)
interdisciplinarità. L'oggetto fu la critica e la ricerca, appunto, di una nuova
forma di comunicazione o di conoscenza, coi mezzi impiegati. Solo
incidentalmente entrava in causa il teatro, o altro. L’importante era e ridiventa,
come Sanguineti stesso fa capire, il discorso sul come e per che cosa comunicare.
A questi livelli si incontrarono poeti, letterati e musicisti, calandosi nei propri
specifici, la voce, le strutture del discorso di parole e/o di suoni. Ma oggi sono
ancora aperte (riaperte) le questioni di fondo. Probabilmente non è una
coincidenza che a Castelporziano o a Genova o altrove, si siano moltiplicati certi
meeting, di poeti, e di poeti e musicisti. I conti, viene fuori dalla conversazione, li
si fa oggi con la spinta sociale, dominante, alla spettacolarizzazione della vita di
tutti, e di tutto. E musica e poesia sono per definizione, direi, spettacolari: devono
finire nel flusso indistinto di un immaginario collettivo frustrato e rivolto contro
la collettività dall’inconsistenza, in ogni senso, dell’immagine? Non credo che sia
una necessità. Il rischio o il processo già in atto attraverso gli oceani, riguarda
semmai, per dirla franca, le forme in cui si svolge nell’età dei media, la lotta di
classe. Negare l’identità dell’atto musicale o poetico, spettacolarizzandolo
senz’altro scopo, vuol dire usarlo nella società di massa da un punto di vista di
dominio, preciso, sulle masse. Perciò le sorti (anche) della poesia e della musica,
di quelle che hanno le rispettive avanguardie degli anni Cinquanta e Sessanta
alle spalle, sono oggi importanti. Perciò, almeno in campo musicale, il riflusso
neoromantico attorno al quale la nostra stessa rivista dibatte, sembra
appartenere all’affermarsi annichilente della spettacolarizzazione globale dei
fatti, dei comportamenti, delle cose. C’è da chiedersi quanto abbia pesato su
questi sbocchi nel mondo occidentale il dilagare fino a diventare senso comune,
del pensiero negativo. Quanto alla musica, credo parecchio, se solo si pensa al
nesso con i valori viscerali posti ormai come scopo musicale o meglio del consumo
musicale. Un tale consumo puramente fisico viene confuso con tardohegeliani
riferimenti alla verità. Allora, senza allontanarci troppo dalla conversione,
alcune delle notazioni che in esse sì trovano, o dei richiami coraggiosi di
Sanguineti alla critica della spettacolarità, mi sembrano più che un appello,
l’indicazione di una strada che va ripercorsa, in modi nuovi.
L.P.
D. Parto da lontano, dagli anni dei Novissimi, gli anni Cinquanta inoltrati, e i
primi Sessanta. Dei cinque poeti che formavano il gruppo, tre hanno lavorato con
dei musicisti. Pagliarani con Paccagnini, Balestrini con Nono e Henze, tu con Berio
(ripetutamente) e Globokar. D’altra parte Giuliani, fra l’altro molto legato a
Evangelisti, è stato vicino e addentro alle cose musicali di allora. Ti chiedo che
significato ha avuto, secondo te, questo incontro piuttosto sostanzioso dei
Novissimi con la musica e il teatro musicale in particolare, e che cosa ha significato
in particolare per te una tale esperienza.
R. Intanto credo che una ragione di questa collaborazione la si possa ritrovare nel
fatto che uno dei punti di partenza negli anni Cinquanta (perché poi negli anni
Sessanta si venne alla pubblicazione in qualche modo collettiva di lavori che
naturalmente erano stati elaborati nel corso degli anni Cinquanta), era dato dalla
consapevolezza di un certo ritardo della situazione letteraria italiana nei confronti
della situazione pittorica e musicale. Mentre nel campo delle arti figurative, e della
musica, esisteva un tessuto internazionale di lavoro ormai costituito, con
riferimenti molto aperti nei confronti di quello che si veniva facendo in altre
nazioni, e con richiami molto consapevoli alla eredità delle avanguardie storiche,
sul piano letterario la situazione era rimasta molto più chiusa, per ragioni anche
abbastanza spiegabili proprio se consideriamo il tratto differenziale: la
comunicazione linguistica comporta delle difficoltà che non esistono, almeno in
un’area culturale omogenea, sul terreno musicale e su quello pittorico. Non sono,
quello musicale e quello pittorico, linguaggi universali, ma sono anche linguaggi
per i quali il passaggio di frontiera è — naturalmente entro un orizzonte storico
omogeneo, — agevole. Il fatto di accogliere volentieri ogni possibilità di
collaborazione con pittori e con musicisti, nasceva dal desiderio di un contatto
concreto con dimensioni culturali adeguate a quello che noi cercavamo
nell’orizzonte della parola. Per me era molto più facile discutere problemi di
poetica con un pittore o con un musicista, che con un letterato della precedente
generazione, e, nella maggior parte dei casi, anche della mia. Proprio per questa
ricerca di un territorio più avanzato, era possibile allora un incontro con altri
sperimentatori, sia nell’ambito della pittura che della musica, anche sul piano
operativo. Probabilmente intervennero infine anche elementi abbastanza casuali
nel fatto che fu piuttosto l’uno o l’altro di noi a collaborare con dei musicisti.
Occorrevano anche occasioni empiriche di incontro personale oltre che un
interesse e una volontà di uscire dal puro e semplice esperimento della pagina
scritta. Oggi, per quel che mi riguarda personalmente, direi che in fondo i due
personaggi fondamentali furono Baj sul piano della pittura e Berio sul piano della
musica. E una forte simpatia già costituita preventivamente dalla reciproca
conoscenza del nostro lavoro, ci fece trovare poi le occasioni concrete di
collaborazione. Per Berio era impossibile trovare in poeti della tradizione, vuoi
postermetica vuoi neorealistica, una possibilità di incontro che non fosse in
qualche modo sfasata. E se penso al Berio prima del nostro incontro, che lavora
infatti utilizzando Joyce o Cummings, è chiaro che egli, fuori d’Italia, poteva
trovare dei testi, magari relativamente arcaici, ormai, storicamente, ma che
comunque rappresentavano un tipo di ricerca e un tipo di rapporto con il
linguaggio con il quale poteva incontrarsi. Credo dunque che da parte di Berio ci
sia stata una vera soddisfazione nel trovare qualcuno che poteva lavorare sul
terreno del linguaggio in maniera omogenea, armonica rispetto alla sua ricerca
sonora. E voglio subito sottolineare un punto, che cioè, nel caso di Berio, il
rapporto con la voce umana, il rapporto con il materiale verbale, era un rapporto
fondamentale. Berio è un musicista che ha un’importante produzione, è chiaro, di
tipo strumentale, ma c’è tutta una zona di esplorazione vocale, di lavoro sulla voce,
proprio sulle possibilità della voce umana come strumento, che è fondamentale
per i suoi interessi. Da parte mia, non voglio mettere in causa una sorta di
vocazione infantile, rientrata, verso la musica, rientrata in parte accidentalmente,
o forse rientrata indipendentemente dai casi della vita. Ma è certo che un punto di
riferimento, nella mia formazione giovanile, proprio dal punto di vista letterario,
era la ricerca dodecafonica come modello di rigore compositivo, che aspiravo a
trasportare appunto sul terreno della letteratura. Insomma non si è trattato di un
capriccio né di un caso, e nemmeno dello sforzo di trovare una sorta di armonia
prestabilita fra ricerche che si svolgono, prima e poi, di fatto, su terreni
radicalmente differenziati, ma una aspirazione a costruire nuove possibilità
tecniche, di un ordine diverso, al di là di una certa paralisi del linguaggio
convenzionato e pattuito, e della sua cristallizzazione inerte, ecco, anche questo
preesisteva all'incontro con Berio. Quindi, nel momento in cui questo incontro
avvenne, io lo sentii molto come una sorta di realizzazione abbastanza naturale,
come un esito che era in qualche modo interno al mio tipo di ricerca.
D. Parliamo ancora della tua collaborazione con Berio. Una domanda può essere:
che cosa lega, che cosa c’è di continuativo, per te, nelle tre esperienze condotte
assieme, e cioè Passaggio, Laborintus II, A-ronne. Io direi che il filo rosso
potrebbe essere una tua peculiare ricerca sulla parola e sulla lingua, che trova nella
qualità della musica di Berio, in ciò che in essa viene ricercato, soprattutto per
quanto riguarda la voce o l’uso della parola, una corrispondenza ben precisa. Ma
insomma che cosa prosegue, se pur prosegue, in vent’anni di collaborazione e cioè
da Passaggio ad A-ronne che è del ’78.
R. A-ronne fu commissionato dalla radio olandese per il cinquantenario del
manifesto del Surrealismo. Era quella l’occasione, e quindi il suo anno è proprio il
1974. Il mio incontro con Berio, è dell’anno 1960. Passaggio lo elaborammo fra il
1961 e il 1962, e fu eseguito nel 1963. C’è una netta continuità fra quel lavoro e
Laborintus II, perché la prima redazione di Laborintus II fu un balletto
rappresentato per la prima volta, nello stesso 1963, alla Fenice di Venezia, con il
titolo Esposizione. Poi viene il 1965 che è l’anno in cui appunto Esposizione,
fortemente rimanipolata a livello musicale come a livello testuale, raggiunge la
redazione definitiva come Laborintus II, commissionato dalla radio francese,
come omaggio a Dante, in occasione del centenario dantesco. E qui forse non è
inutile spiegare il piccolo enigma del titolo, perché, musicalmente parlando, non
esiste un Laborintus I. Ma Berio volle richiamarsi alla mia prima raccolta di
poesie, il Laborintus stampato nel 1956, alcuni versi del quale, in effetti, sono
passati nel “libretto” di Laborintus II (che è “secondo”, dunque, in relazione a un
testo poetico, soltanto, e non ad una composizione musicale). C’è poi un certo
vuoto, colmato da piccoli episodi. Per esempio, c’è una delle redazioni di Questo
vuol dire che, una redazione radiofonica, che era montata assieme a testi miei che
venivano letti con la mia stessa voce, con quella di Luciano e con quella di Cathy
Berberian sullo sfondo del nastro puro d’origine, elaborato con Leydi. Ma devo
dire che a me riesce probabilmente più difficile, che al lettore e all’ascoltatore,
indicare immediatamente tutti gli elementi di continuità. lo sono tentato,
comunque, di cercarli nella sperimentazione, proprio, sulla voce. O forse quella era
l’ottica intenzionale che mi muoveva. In Passaggio fu molto importante, per me, il
tipo di impostazione drammatica concordato con Berio, con la presenza di uno dei
due cori nel pubblico e di dover risolvere — è un’esperienza che ho vissuto in
qualche modo, benché siano cose molto eterogenee, due volte in vita mia — , il
problema del coinvolgimento. Nel ’63, del coinvolgimento non se ne parlava
ancora, per quanto ricordo. Però di fatto credo che sia stata una delle sole due
volte in cui io sono riuscito, non dico a realizzarlo, ma a vederlo realizzato, perché
di norma è cosa che ho sempre visto attuata, o meglio non attuata, in maniera
molto goffa. Le due sole volte in cui l’ho trovato realizzato autenticamente, fu nello
sgomento vero — ricordo la prima di Passaggio —, provato dal pubblico della
Piccola Scala nel sentirsi insieme investito e rappresentato dal coro sparso nei
palchi, e poi fu, in un tutt'altro tipo di impostazione, anche intenzionale, quando,
con Ronconi si mise in scena L’Orlando Furioso. Erano modi di coinvolgimento
totalmente diversi, ma, a mio parere di eguale efficacia, mentre quelle che
venivano spesso poi celebrate come esperienza di partecipazione del pubblico, le
ho giudicate sempre molto macchinosamente irrealistiche, perché non strutturate,
non richieste e imposte dall’opera nella sua costruzione. Al contrario, in quei due
casi, con Berio e con Ronconi, era la forma organica con cui l’opera veniva
costruita, una volta musicalmente e una volta come teatro di parola, che implicava
quel tipo diretto e totale di partecipazione. E qui, recuperando una cosa che è
implicita nella domanda precedente, si può aggiungere questo: che nelle ricerce
dei Novissimi, e poi del Gruppo ’63, era forte il sentimento di una
drammatizzazione e di una teatralizzazione della parole poetica. La parola, nei
rappresentanti più significativi di quella nuova avanguardia, era sentita molto
come parola detta, come fatto vocale o, come mi piace anche dire, come fatto
corporale, di investimento corposo nel linguaggio, e da questo punto di vista,
almeno nel momento intenzionale, è questo l’elemento di maggiore continuità che
io sentirei presente in quegli esperimenti. In breve, l’energia corporale investita
nella voce. Anche Laborintus II la cui prima esecuzione, come ho già accennato,
prima esecuzione radiofonica, per non parlare di A-ronne, che nacque come testo
radiofonico, e che per me deve rimanere un testo che non ha destinazione scenica
(l’uso scenico sarà semmai un adattamento ulteriore, ma indubbiamente secondo
e secondario), si basano su questo principio della metamorfosi biologica del testo,
del suo calarsi concreto in una voce nella vocalità corporea. Sarei tentato di parlare
di “visceralità della voce umana”. E poi, nel mio stesso lavoro scenico, anche
indipendentemente dalla musica — gli esperimenti teatrali dove per esempio
usavo la sovrapposizione delle voci come altrettanti strumenti —, vale lo stesso
principio. Ma pare abbastanza sintomatico, allora che il primo testo al quale
lavorerà Globokar, che è Traumdeutung — proprio con il titolo freudiano
dell'interpretazione dei sogni, sia estremamente prossimo al tipo di
sperimentazione, di impiego musicale, diciamo, cioè viscerale, della voce, usata
per Passaggio, e venga a sua volta assunto, appunto da parte di Globokar, come
materiale per la musica. Per cui c’è una specie di ricambio circolare di esperienza.
D. Di che anni parli?
R. Globokar incominciò a lavorare con i miei testi, direi, negli anni Sessanta
inoltrati, ora non ricordo esattamente. Traumdeutung, nato per quattro voci (una
voce femminile e tre voci maschili, trattate come un quartetto verbale) diventa, nel
trattamento di Globokar, una composizione per quattro cori. C’è indubbiamente
tutto un momento in cui con Berio prima e con Globokar dopo, la sperimentazione
fonetica del testo diventa per me il momento centrale. Ma ribadirei questo, che, in
fondo, fin dall’inizio, io pensavo sempre ai miei testi poetici come destinati
essenzialmente a una funzione vocale. Mi è capitato molte volte di riflettere
intorno a questo paradosso che è il testo letterario nella condizione
contemporanea, il suo essere situato in bilico tra i due poli della visibilità del testo,
cioè della fruizione ottica che il testo stampato esige, e del suo dissolversi, invece,
in suono. Se vogliamo, la poesia visiva e la poesia fonetica sono i due momenti
polari entro i quali sta un infinito orizzonte di esperienza, e la poesia è in qualche
modo, per me, che non amo né la poesia fonetica né la poesia visiva, questo
difficile equilibrio e gioco tra la fruizione sonora del testo e la sua fruizione visiva.
Una partitura per l’occhio, un disegno per l’orecchio, se vuoi.
D. Quello che dici sollecita un argomento quanto mai attuale. Mi pare che il tuo
incontro con la musica sia un incontro con lo spettacolo, con la stessa voce che
diventa spettacolo di sé. E oggi più che mai sotto le spinte stesse della civiltà
americana, tutto viene sempre più concepito come spettacolo, la politica per
prima. In altre parole, i comportamenti si dissolvono nella loro spettacolarità, e in
essa si dissolve anche la ragione, il suo ruolo. La crisi delle ragioni, o della stessa
razionalità, che sono due cose diverse ma evidentemente intrecciate, sta semmai in
questo: se ne parla tanto quando si parla di dominio della spettacolarità intesa
proprio anche come espressione dell’irrazionale, o della ragione non più candidata
all’egemonia. Se dunque la tua esperienza con la musica privilegia il versante dello
spettacolo, come ti collochi di fronte ai problemi cui ho accennato?
R. Ecco, quello che mi pare importante nei lavori con Berio, e poi darò spazio
anche al lavoro fatto con Globokar non solo perché è il lavoro più recente, ma
perché credo che in esso venga abbastanza alla luce tutta la coerenza di un certo
tipo di rapporto con lo spettacolo, è proprio questo, questo rapporto. L’aspetto
della spettacolarità, infatti, è assunto criticamente, e questo mi pare il tratto
distintivo. E cioè probabile che io e Berio abbiamo, non dice anticipato (mi
parrebbe un po’ buffo immaginarci come dei precursori, non mi piacciono queste
formule), ma indubbiamente messo in causa i problemi di partecipazione e di
coinvolgimento, di spettacolarizzazione nel senso forte della parola, per cui si è
giunti all’opera come antiopera che trascende la chiusura del palcoscenico e
rovescia il vero spettacolo nella sala, tra il pubblico, in platea, senza chiudersi sulla
scena, o non solamente sulla scena. In questo senso il punto capitale è la tematica
del consumo della spettacolarizzazione. In Passaggio episodi come quello della
vendita all’asta della donna, del pubblico che si definisce autocriticamente come
pubblico consumatore, che paga, che è gerarchizzato nelle varie classi sociologiche
ed economiche per cui è situato a livello di platea o di balconata o di palco; in
Laborintus II il tema dantesco dell’usura come tema centrale e insomma del
capitalismo, e della mercificazione (il primo titolo Esposizione alludeva
precisamente proprio a ciò, e in particolare io avevo in mente il Benjamin che
indaga intorno alle esposizioni universali, allo spettacolo delle merci,
derisoriamente risolto poi, nei termini del balletto, in una specie di esibizione di
spazzature, di relitti, di detriti, insomma il consumo e lo spreco). Ecco, in questo
senso io mi distinguerei nettamente da una problematica della
spettacolarizzazione come fine; è anzi, piuttosto, la critica della
spettacolarizzazione, e qui se vogliamo parlare di anticipazione, allora parlerei di
anticipazione di una critica nei confronti di una tendenza che allora era
certamente più che in germe, nella realtà, matura sino al marcio, ma forse
nemmeno in germe nella coscienza critica collettiva. Forse l’immaginario collettivo
cominciava appena a elaborarla, ma l’intenzione certamente di Passaggio e di
Laborintus II è di critica radicale nei confronti di questo tipo di tendenze allora
emergenti. In A-ronne, che in qualche modo può apparire un po’ appartato come
tipo di esperienza, proprio per la sua stessa natura strutturale, la spettacolarità è
di ordine appunto radiofonico, è di ascolto, è lo spettacolo della voce. Ma esiste
una spettacolarizzazione fonetica indipendentemente da ogni gestualità, e non a
caso il giuoco provocatorio sta nel fatto che il breve testo, che poi è un montaggio
citazionale, comincia elaborando il tema del principio, si sviluppa elaborando il
tema della medietà, del mezzo, del centro, si conclude elaborando il tema della
fine, della conclusione, e tematizza quindi la propria pura organizzazione
strutturale, pur orientandola, insieme, sopra il tema della struttura corporea —
dove comincia il corpo umano, quale è il suo centro, quale la sua fine – , e cioè
somatizzando questo tema vocale e formale. Anche qui un tema che mi è
enormemente caro come quello della corporeità, e sul quale appunto insistevo, e di
cui la vocalità in qualche modo è il medio tra quello che è il valore concettuale del
testo, o referenziale, e il valore di fruizione fonetica, viene tematizzato e quindi
portato a un livello di resa consapevole e di critica trasparenza. Ma vengo
finalmente a Carrousel. Carrousel si presenta, e penso alla prima edizione che è
quella di Zagabria in cui collaborai anch’io alla regia, si presenta dunque, nato
come nacque in uno stadio coperto, come spettacolo globale che si apre
ufficialmente con una parodia di discorsi inaugurali, con l’introduzione di bande
che sfilano, di gruppi ginnici e folclorici che vi esibiscono, per utilizzare infine tutti
gli elementi in qualche modo fieristici e di consumo della musicalità,
restringendosi poi a raffinatezze esasperate nell’impiego di mezzi tecnologici, nel
senso delle più ricercate combinazioni di vocalità, e anche delle più perverse
(Globokar utilizza il canto dei fogli di cartavelina sopra la bocca, gli effetti di
circolarità del suono attraverso il cantante che ruota su se stesso e quindi risponde
a diversi punti microfonici che poi a loro volta sono diffusi in rotazione nella sala,
con sovrapposizioni di effetti registrati, e via discorrendo), e termina con una
specie di microspettacolo di pura recitazione, quando tutto pare ormai dissolto:
viene colto cioè il momento giusto di un finale inconcluso (il pubblico sta già
andandosene), per innestare a sorpresa una specie di metacritica del teatro e dello
spettacolo, con una serie di epigrammi gestiti da clown-attori il cui modello è
affetto dal Lustspiel che fa da intermezzo nella Notte di Valpurga di Goethe, e
insomma compare il personaggio storico, quello mitologico, la maschera, il tipo
sociale, il rappresentante di classe, che reagiscono a loro volta allo spettacolo
appunto con gli epigrammi che leggono su cartigli, i quali poi volano nel mezzo
dello stadio, e si spettacolarizzano nel momento stesso in cui lo spettacolo viene in
qualche modo trasceso perché, ecco, è assunto criticamente. Forse questa è l’altra
faccia di quella continuità — in qualche modo vengo a integrare anche qui, con una
risposta ulteriore, la tua domanda precedente —, è dunque l’altra faccia di una
spettacolarità che non è mai goduta per sé stessa, e se vuoi io direi che, in fondo,
l’idea fondamentale del teatro e della spettacolarità rimane per me quella
brechtiana, l’idea di una distanza critica. Se parlavo, prima, di coinvolgimento
riuscito, può apparire contraddittorio ora che io dica che gli unici coinvolgimenti
che ho vissuto davvero, li ho vissuti attraverso le sperienze che ho citato. Ma in
realtà io credo a una sola forma di coinvolgimento, che è il coinvolgimento critico,
in opposizione al coinvolgimento di pura empatia, che si riduce a una
partecipazione psicologica e mistico-emozionale. Che è poi quella che Brecht
definiva aristotelica, e che, infatti, è quella assolutamente tradizionale. D’altra
parte, la formula che è a me cara, e non mi dispiace di dirlo in sede di discorso
musicale, è quella dell’emozione intellettuale. Se io dovessi dire quale è il risultato
che io ricerco, nei confronti dello spettatore o fruitore di un qualunque tipo di mio
testo — che sia la lirica, il romanzo, il teatro, e naturalmente la saggistica, direi che
è un tipo di emozione intellettuale, cioè un tipo di emozione fortemente armata in
senso critico e quindi molto lontana da quello almeno che oggi si intende
comunemente quando parliamo appunto di spettacolarizzazione o peggio di
simulacrizzazione, e finalmente di immaginario collettivo. [...]
Il titolo originale della conversazione (in Musica/Realtà, n.
4, pp. 21-37, Bari 1981), di cui si riproduce la prima parte,
era: Critica spettacolare della spettacolarità
CECILIA BELLO MINCIACCHI
da:da:
«Vociferazione» e «discorso ininterrotto»:
aspetti testuali nelle prime collaborazioni di
Berio e Sanguineti (1961-1965)
Passaggio e Laborintus II
«Il mio sogno era scrivere musica, e scrivo parole
per risarcimento: è un surrogato, un Ersatz1». Questo
confessava Sanguineti in una conversazione del 1988,
sollecito a dire che la sua non era affatto una battuta. Per
lui lavorare con i compositori, e segnatamente con Berio,
ha rappresentato «la realizzazione di un sogno2», la
possibilità di delegare in tutta felicità quello che non
sapeva fare in prima persona. E mai risarcimento deve
essere stato più appagante, per Sanguineti, di quando ha
scritto parole per Berio, cooperando attivamente nel
disegno di un progetto comune: opere
di parole e musica,
[.....................]
1. Edoardo Sanguineti, in Franco VAZZOLER, La scena, il corpo, il
travestimento. Conversazione con Edoardo Sanguineti, in
«L’immagine riflessa», XI, 1988, poi in E.SANGUINETI, Per musica, a
cura di Luigi Pestalozza, Milano-Modena, Ricordi-Mucchi, 1993, pp.
187-211: 189.
2. Idem.
Cecilia Bello Mincicchi
Le modalità compositive del catalogo, del
montaggio e dell’inserto erano condivise da Berio che con
Sanguineti ha sempre dimostrato grande consonanza
ideologica e metodologica. In una lettera del 26 aprile
1965 scrive Sanguineti: «godo che tu possa sviluppare la
tua tendenza all’inserto». Altrove Berio, parlando del
lavoro svolto in collaborazione con Sanguineti, scrive che
il catalogo è l’unica forma, anzi l’unico genere letterario
che «refuses any possible formalistic approach of the type
that made the experience of opera possible64». A questo si
aggiunga quanto Berio scrisse nella nota per il programma
di sala dell’esecuzione del 1968 a Spoleto:
Il principio del catalogo coinvolge anche alcuni aspetti della
struttura musicale infatti Laborintus II è anche un catalogo di
riferimenti (non citazioni) a Monteverdi, Stravinsky e modi di
esecuzione tipici del jazz. Le parti strumentali sono spesso
sviluppate come una estensione delle azioni vocali delle tre
cantanti e dei mimi-attori. Un breve inserto di musica
elettronica [...] è concepito come estensione dell’azione
strumentale. Parte integrante della struttura musicale del lavoro
sono i diversi gradi di intelligibilità del testo: le parole singole
e le frasi talvolta sono percepibili come tali, tal’altra come
“timbri” della struttura sonora globale. Laborintus II si
configura come discorso ininterrotto (la voce umana vi è
64. Questa frase di Berio si può leggere in un manoscritto inedito alla
Paul Sacher Stiftung catalogato come [Laborintus II], 1996 (testo di
una conferenza ad Harvard): «The texture of the elements involved
becomes so rich that at a certain moment the “catalogue” seems to be
the only possible verbal form to order it. [...] The nature of the text is
such that there are certain moments where Dante “sounds” like
Sanguineti and Sang[uineti] like Dante: the litterary form [catalogue]
(if one can use that word) refuses any possible formalistic approach of
the type that made the experience of opera possible». L’estratto mi è
stato segnalato da Angela Ida De Benedictis, che ringrazio.
42
«Vociferazione» e «discorso ininterrotto»: aspetti testuali
nelle prime collaborazioni di Berio e Sanguineti (1961-1965)
sempre presente, in vari modi e con varie funzioni), una sorta
di theatrical speech, una “conferenza” a più livelli, una
eterofania di “arie”..., la cui struttura musicale perfettamente
determinata, suggerisce di volta in volta diversi modi – reali o
virtuali – di drammaturgia.65
Fin dalle prime collaborazioni, i punti di incontro
più forti e significativi tra Berio e Sanguineti sono stati
sostanzialmente tre: il dialogo politico – i soprusi sociali e
culturali in Passaggio, l’esibizione delle merci-feticcio e
della loro volgare tirannia in Esposizione, la condanna
dell’usura in Laborintus II –; il riuso della tradizione
precedente in qualità di riferimento e insieme di materiale
da montare, compresa la derivazione da ambiti storici e
stilistici e da generi tra loro in attrito, e questo vale tanto
per i riferimenti testuali quanto per quelli musicali; il
trattamento della voce e delle voci nella loro
interrelazione, ovvero la vociferazione e la gestualità
vocale. La vociferazione è una delle maniere privilegiate
in cui il testo di Sanguineti, e il testo in genere, è stato
trattato da Berio. All’interno di una più ampia tendenza
alla vociferazione, come si vedrà più avanti, nelle prime
collaborazioni Berio ha lavorato sui testi di Sanguineti
soprattutto in tre modi: lasciando il testo perfettamente
intellegibile, chiarissimo e scandito (parti affidate allo
speaker66 – fig. 3); rendendo il testo non chiarissimo ma
65. Luciano BERIO, Nota per il programma di sala della prima
esecuzione in forma scenica di Laborintus II, Teatro Caio Melisso,
Spoleto, 11 luglio 1968, in E. SANGUINETI, Per musica, op. cit., p. 66.
66. Si veda quanto scrive Sanguineti a Berio nella lettera datata «6
febbraio 1965»: «è anche vero che un recitar cantando, inventato per
uno “speaker”-cantante, sarebbe cosa d’oro (immagina, tanto per dire,
una specie di schönberghismo devastato da Berio)».
43
Cecilia Bello Mincicchi
ancora decifrabile (parti affidate al coro e all’orchestra o
solo al coro con una sovrapposizione non del tutto confusa
perché magari slittante, sfasata, ma almeno in parte
intellegibile – fig. 4); facendo in modo che il testo risulti
non decifrabile nelle sue componenti, ovvero non
intellegibile nei suoi singoli significati verbali (parti di
testo affidate a verticalizzazioni secche, a partenze
simultanee di frasi diverse, fermamente sovrapposte anche
in un insieme di lievi sfasature, così da creare un blocco
fonetico dominante sul nucleo semantico – fig. 5).
Fig. 3: Luciano Berio, Laborintus II, battute 4-8 (pagina 6), per voci
strumenti e registrazioni (1965), Universal Edition 13792, London
1976, p. 1. copyright 1976 by UE SpA Milano assigned to Universal
Edition A.G. Wien (per gentile concessione).
44
«Vociferazione» e «discorso ininterrotto»: aspetti testuali
nelle prime collaborazioni di Berio e Sanguineti (1961-1965)
Fig. 4: Estratto testo parlato (ripoduzione facsimile senza le altre
parti) da pagina 26: Luciano Berio, Laborintus II, per voci strumenti e
registrazioni (1965), Universal Edition 13792, London 1976, p. 1.
copyright 1976 by UE SpA Milano assigned to Universal Edition
A.G. Wien (per gentile concessione).
45
Cecilia Bello Mincicchi
Fig.5 : Estratto testo parlato (ripoduzione facsimile senza le altre
parti) da pagina 2: Luciano Berio, Laborintus II, per voci strumenti e
registrazioni (1965), Universal Edition 13792, London 1976, p. 1.
copyright 1976 by UE SpA Milano assigned to Universal Edition
A.G. Wien (per gentile concessione).
L’asse portante delle opere nate in collaborazione tra
Berio e Sanguineti è un discorso ininterrotto di voci
umane, con tutta la fisicità che la vociferazione può dare
alla parola. In latino vociferare o vociferari (vox + fero)
significa ‘enunciare con forza’, ‘gridare’, ‘vociare’,
‘strillare’, ‘gridare a gran voce, concitatamente’. Molti i
luoghi reperibili in Lucrezio, tra questi: «carmina...
vociferantur» (sono ‘canti’ che ‘risuonano’, ‘echeggiano’,
ma anche ‘canti’ che ‘svelano’, De rerum natura, I, 731732); o «aeraque quae claustris restantia vociferantur» (è il
‘bronzo che resistendo ai catenacci rimbomba’, De rerum
natura, II, 450) o anche «simul ac ratio tua coepit
46
«Vociferazione» e «discorso ininterrotto»: aspetti testuali
nelle prime collaborazioni di Berio e Sanguineti (1961-1965)
vociferari / naturam rerum» (‘non appena la tua dottrina
iniziò a proclamare, a mettere in chiaro, questo sistema
della natura’, De rerum natura, III, 14). Ma vociferare può
indicare anche, in epoca più moderna, una
sovrapposizione continua e mossa, un parlottìo
simultaneo, un raccontare e uno sparlare, anche,
brulicante. Sanguineti, che amava il plurilinguismo, il
montaggio e le contaminazioni; che amava mostrare,
rendere chiare le cose proprio attraverso accostamenti e
contrasti, parlava della musica di Berio come di una
«vociferazione».
In una delle ultime conferenze su Berio, nel 2008,
Sanguineti tracciando un affettuoso ritratto del suo Berio –
«un mio ritratto del mio Berio» – tornerà proprio su questo
punto:
Mi è accaduto di enunciare una volta un paradosso se non
troppo, ma non troppo, uno pseudo-paradosso direi, e lo avrò
anche replicato, come accade negli anni, che potrebbe
esprimersi così: «Se l’uomo non fosse un animale vocale,
Berio non sarebbe mai diventato un musicista». Intendevo dire,
in modo forse più inaccoglibile che stravagante, che Luciano è
in essenza uomo di musica umana, musicista della vox umana.
E dico vox, non canto, è ovvio: dico rumore vocale, rumore
boccale. Insomma, è mia convinzione che il suo lavoro sia
integralmente, anche nelle più rigorose e pure strumentalmente
tra le sue composizioni, tale che gli strumenti vociferano. Berio
è stato un musicista per eccellenza vociferante.67
67. Edoardo SANGUINETI, Quattro passaggi con Luciano, in corso di
stampa, op. cit.
47
Cecilia Bello Mincicchi
A questo brano posso aggiungere che di pochi anni
prima, del 2005, è un racconto di Sanguineti, l’ultimo
edito in vita, intitolato, propriamente, Vociferazioni e che
oggi a me sembra una suggestione memoriale forte, che mi
piace legare, anche rischiando nell’interpretazione, anche
solo in eco, proprio al vociferare di Berio. Del resto
l’incanto del rimando, per quanto assolutamente indiretto,
è pur possibile, se solo pensiamo all’amore che legava
Berio e Sanguineti, come ricorda in modo molto toccante
Talia Pecker Berio68. In questo racconto, Vociferazioni,
cinque voci, cinque protagonisti si presentano in
successione, componendo cinque micro-racconti. Sono
personaggi di un affresco, il ciclo dei mesi nel castello del
Buon Consiglio a Trento, da cui Sanguineti sceglie il mese
di ottobre, che è peraltro il mese in cui è nato Berio. I
cinque personaggi portano, ciascuno, il semplice nome di
una vocale. C’è d’altro canto un interessante passaggio
nella partitura di Laborintus II in cui le voci pronunciano,
a volte sovrapponendosi e a volte sfasandosi, solo le
cinque vocali in un gioco di pura articolazione fonetica
(entrambi gli esempi, voci sovrapposte e sfasate, fig. 6).
68. Per inaugurare i lavori della giornata di studio Il teatro musicale
di Luciano Berio. Passaggio e dintorni, Venezia, Fondazione Cini, 25
settembre 2010, Talia Pecker Berio ha rievocato la corrispondenza e
l’intesa intellettuale tra Sanguineti e Berio in modo tanto bello quanto
fulmineo citando una frase pronunciata da Sanguineti nel convegno di
Siena del 2008 – «io e Luciano eravamo innamorati» –, e
un’affermazione di Luciano Berio – «Ho sempre amato Edoardo
Sanguineti di vero amore, di quel sentimento globale e immanente che
anche i poeti, a dispetto dei loro canzonieri, hanno difficoltà a
descrivere» – riportata nell’Album Sanguineti, a cura di N. Lorenzini
ed E. Risso, Lecce, Manni, 2002, p. 20.
48
«Vociferazione» e «discorso ininterrotto»: aspetti testuali
nelle prime collaborazioni di Berio e Sanguineti (1961-1965)
Fig. 6: Estratti testo parlato (ripoduzione facsimile senza le altre parti)
da pagina 28 (lettera S) et pagina 29 (lettera R): Luciano Berio,
Laborintus II, per voci strumenti e registrazioni (1965), Universal
Edition 13792, London 1976, p. 1. copyright 1976 by UE SpA Milano
assigned to Universal Edition A.G. Wien (per gentile concessione).
Nel testo di Sanguineti le voci si presentano in
successione, si descrivono in modo un po’ frammentario,
parlano del loro lavoro, della loro posizione nell’affresco,
raccontano di se stessi, e degli altri, cose a volte un po’
49
Cecilia Bello Mincicchi
contraddittorie, sono un po’ «tutti confusi».
Rappresentano una pluralità di voci parlanti all’interno
della scena, una sequenza di voci che alla fine esita,
concettualmente, in brulichio, in diversità di prospettive,
di identità (si veda più avanti il nitido e problematico
gioco io/tu). Personaggi esposti in un affresco, immobili,
muti, prendono carne: sono da Sanguineti esposti in voce.
Il testo è tutto, interamente, fatto da voci.
La conclusione, allora, può essere affidata a due
passi da questo racconto, due passi che, oltre ad essere
emblematici della sensibilità di Sanguineti per la
vociferazione, chiudono virtuosamente il circolo e possano
essere letti, per suggestivo fascino, come un omaggio di
Sanguineti a Berio, e nostro ad entrambi:
E non ci sono che storie complicate, ti dico. Perché quando
dico io, io, non dico niente, ancora. Diciamo che vocifero un
mio vociferare, soltanto. Se dico che è ottobre, mettiamo, è che
io dico che è ottobre, appena. Ma non è che è ottobre
veramente, magari. È che io dico che è ottobre appena. È
soltanto che io vocifero, allora. E allora tu puoi metterti lì che
dici che vuoi sapere chi è lì che vocifera. E chi vocifera, quello
può essere tutto, cioè chiunque, cioè tutti. Puoi essere tu,
anche. È chiaro, anzi, che sei tu che dici che io dico che è
ottobre, forse, mettiamo. Anzi, te lo metti tu, lì. E sei tu che
dici che noi mettiamo che sono io che dico, vociferando, che è
ottobre.
[...]
È che ci sono tanti e tanti modi di vociferare, in un io, e cioè in
tanti ii diversi, in tanti ii rimescolati come a caso, come si
rimescola un mazzo di carte, in tutti i tanti ii che siamo, come
capita in te, se ti capita, e come capita in me, in tutti gli ii,
quando gli capita. E adesso ti avverto, io, che io smetto di
vociferare, tra un momento. Io sono un io taciturno, allora,
50
«Vociferazione» e «discorso ininterrotto»: aspetti testuali
nelle prime collaborazioni di Berio e Sanguineti (1961-1965)
tanto per dirti qualche cosa, dicendo ancora, e per farmi una
mia ultima vociferazione, prima di essere un io che non ti
vocifera più, a te, almeno, se non altro. Ma è poco, ma sì, lo so.
Ma un io, se tu ci stai attento, è proprio quasi un niente. No,
che è poco più di niente, piuttosto. Ma volevo poi dire, invece,
che è poco meno, ecco. Fine.69
in "La distruzione da vicino. Forme e figure
delle avanguardie del secondo Novecento"
(Nocera
Oèdipus,
2012) Forme e figure
in LaInferiore,
distruzione
da vicino.
delle avanguardie del secondo Novecento
(Nocera Inferiore, Oèdipus, 2012)
69. Edoardo SANGUINETI, Vociferazioni, in Id., Smorfie. Romanzi e
racconti, Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 409-421: 419-421.
51
E.S.
La messa in scena della parola
(1982)
La musica vocale, ha dichiarato Berio una volta, è una “messa in scena della
parola” . E in altra occasione ha affermato che gli interessa in quanto mima e
descrive “quel prodigioso fenomeno che è l’aspetto centrale del linguaggio: il
suono che diventa significato”.
Incominciamo dalla seconda affermazione, in cui, per così dire, la parola
non è ancora data, e possiamo ancora situarci dinanzi al suono umano informe.
Credo che Berio sia stato affascinato sempre, da sempre, dalla forza espressiva e
impressiva che, nella comunicazione intersoggettiva, possono acquistare i segni
volontari e involontari di cui è portatrice l’emissione vocale preverbale, dal gemito
al colpo di tosse. È questo grado zero (anzi, sottozero) del linguaggio, che si
potrebbe definire puro rumore orale, puro gesto sonoro, questo spazio così
resistente alla notazione scrittoria, e di così basso livello convenzionale, questo
aspetto non articolato della vocalità, quello in cui tuttavia affonda le proprie radici
ogni discorso possibile. L'animale uomo, del resto, ci appare naturalmente capace,
originariamente, di una sterminata gamma di versi istintuali e spontanei, tra i
quali selezionerà, disciplinandosi, il proprio limitato codice fonetico. E sarà tanto
disciplinato, da precludersi infine, a selezione avvenuta, il recupero integrale di
quello strumento sonoro di partenza che è il suo corpo medesimo. E a un tale
strumento, per molte corde, potrà regredire soltanto, e per lo più con fatica, a
partire dalla competenza esecutiva selettivamente raggiunta, con le proprie
determinazioni e i propri limiti. Tutto questo non meriterebbe forse grande
attenzione, se non emergesse subito un tratto capitale in questo aspetto del
processo di umanizzazione dell’uomo. Ed è che la vocalizzazione primaria è
assunta, immediatamente, come significante, e viene così in partenza socializzata.
Al verso umano primitivo si risponde con parole umane, l'enfant sauvage,
nel senso in cui tutti lo siamo, nascendo, è già immesso, a partire dal suo primo
gesto sonoro, entro il tessuto generale del dialogo. Qui non voglio fermarmi,
naturalmente, sopra quella simulazione di dialogo che l’uomo può instaurare, e in
effetti instaura, con gli animali, e con lo stesso “paesaggio sonoro” in genere (il
soundscape di Schafer), e sopra la donazione di senso che egli effettua, al riguardo.
Sono cose che ci condurrebbero troppo lontano, ma che è necessario almeno
evocare. Voglio rivolgermi subito, piuttosto, ai luoghi estremi, e più tipici, di un
esperimento come A-Ronnne, dove il doppio processo, di innalzamento dal suono
al senso, e di abbassamento dal senso al suono, attraverso un perpetuo giuoco di
analisi e di sintesi, di composizione e di scomposizione, di strutturazione e di
destrutturazione della parola, modellizza il decorso generale dell’opera, tra
esercizio fonetico e esercizio fonologico. Sono infatti proprio tali luoghi di confine,
quelli che decidono, al tempo stesso, il paradigma di fruizione corretta della
composizione (di esecuzione e di ascolto), e il processo di articolazione del
discorso sonoro. Da un lato, infatti, è proprio a questa zona indecidibile, tra suono
e significato, che occorre mirare, continuamente, e d’altro lato è il raccontò sonoro,
di accesso àl senso e di uscita dal senso, che fonda la trama, l'intreccio, e
finalmente il significato oggettivo dell’opera. I significanti acquistano senso alla
luce di questo metasignificato dominante, di un tale percorso e di una tale
oscillazione polare. In causa, insomma, è una esplorazione delle zone critiche in
cui il segno verbale si crea e si cancella, ovvero di alcune situazioni, assunte come
moduli esemplari, in cui rumore vocale e carica semantica si convertono e si
scollano, si incrociano e si compattano. A-Ronne fa, della vocalità musicale, anzi
della vocalità umana, il proprio oggetto, problematizzando la dicibilità del senso, e
il senso della dicibilità.
Ho puntato su A-Ronne, non tanto perché, come suo responsabile testuale,
mi sento più autorizzato a discorrerne, ma perché mi pare sia giusto scorgere in
questa composizione il luogo centrale in cui la vocalità beriana si rivela e confessa
in tutti i suoi tratti specifici. Spazio di una laboratorialità privilegiata, non è tanto
un “documentario” sopra un determinato materiale verbale, quanto un
“documento” rivelatore intorno all’idea di voce umana, in Berio. Che l’esclusione
della musicalità strumentale, in una simile prova, renda un tale documento più
puro e più trasparente, è ovvio. La deliberata riduzione di campo permette agli
elementi posti a reagire nell’orizzonte dell’osservazione inventiva un supplemento
di lucidità - e non si deve dimenticare l'originario lavoro di registrazione, affidato
non a cantanti, ma ad attori. Ma questa riduzione è soltanto un aspetto
dell’esperimento. E penso alla fondamentale indiscriminazione, per contro, tra
voce e strumento, nel linguaggio di Berio. Quando Cathy Berberian, narrando della
nascita di Circles, raccontava che “les instrumentistes devaient produire des sons
qui ressemblaient au mot que je disais, et moi je devais rapprocher le son du mot
prononcé du timbre des instruments” , così che “le ‘Sting’ du début, par exemple,
ressemble exactement au son de la harpe”, discorreva giustamente, subito, di
“interaction”, di “une sorte d’échange permanent”, di “reciprocité”, di “challenge”,
evocando l’altra faccia, assolutamente complementare a A-Ronne, della ricerca di
Luciano. Suono “organico” e suono “strumentale” sono invitati a giocare senza
gerarchizzazione determinata, in una sorta di aperta e indefinita concorrenzialità.
Se raccordiamo e integriamo Circles (1960) e A-Ronne (1974), scegliendo due
“points on the curve to find”, non dirò a caso, ma con sufficiente arbitrio
campionativo, non ricostruiamo, propriamente, una linea storica di sviluppo, ma
decidiamo, in ideale sincronia, due momenti che si spiegano e si completano
reciprocamente. E dicono, in sostanza, una cosa, la medesima cosa. Perché si
capisce che la “messa in musica” della parola non potrà che essere concepita, come
da ulteriore dichiarazione d’autore, che come una forma di “trascrizione”, e senza
alcuna cautela immaginosa o metaforica. Mettere in musica significherà dunque
immettere l’espressione verbale entro “una macchina ulteriore che amplifica e
trascrive il senso su un diverso piano della percezione e dell’intelligenza”. Nella
interminabile querelle, rappresentata in re, prima ancora che teoricamente,
dall’infinita vicenda della relazione di parola e musica, la posizione di Berio appare
così, trascendendo la sua stessa vicenda personale, come la posizione
naturalmente paradossale su cui si fonda la possibilità stessa della comunicazione
e dell’espressione musicale. È in causa la fiducia nella semantizzazione del rumore
in figura di suono. E questo postulato, o questa illusione (ma qui non fa differenza)
è quella per cui il suono ha senso, e un senso non meno determinato, anche se
diversamente determinato, di quel senso che riposa semanticamente nel discorso
verbale (tanto che, se illusione esiste, l’illusione sembrerà gravitare
completamente, a questo punto, sopra lo scorporamento indotto dalla scrittura). Si
capisce che, a queste condizioni, la “messa in musica” della parola sia
“trascrizione” donatrice di senso (e che insomma scavalchi, in qualche modo, l’”
iscrizione” scrittoria, gravitando sopra la registrazione notatoria del suono). È
l'immissione della materia verbale entro una “macchina” (ma per una macchina
organica e corporea), quella che riuscirà, non tanto amplificatrice e moltiplicatrice
di significati, ma istitutrice, radicalmente, di senso. La parola del “paroliere” e del
“librettista”, se possiede un senso “linguistico”, possiede pure da sempre, come
ogni parola umana, anzi proprio come ogni umano rumore, un senso “musicale”.
Tutto quello che appartiene alla sfera della connotazione espressiva, tutto il
concreto vissuto linguistico (che la scrittura non può che descrivere mediatamente,
per circuito denotativo), è la notazione musicale che può assumere come il proprio
specifico verbale (e, più latamente, come proprio specifico sonoro). Se la scrittura
letteraria fissa il senso dell’enunciato, in termini riduzionalmente denotativi, la
scrittura musicale ne controlla direttamente la connotazione. E la “trascrizione”
beriana, in sostanza, non significa altro che questo. Di fronte al muto materiale
verbale, la notazione musicale decide e definisce quella misconosciuta dimensione
semantica, acusticamente articolata e declinata, che la civiltà della scrittura ha
depresso, sempre più fortemente, in favore di una logica semantica riduttivamente
concettuale, astratta, scorporata. In ultima istanza, la donazione e la dotazione di
senso, che dipendono dalla “messa in musica”, sono da risolversi,
antropologicamente, in una restituzione di senso. Si salda un debito.
Ma Luciano non parla, propriamente e soltanto, di “messa in musica” della
parola, ma, lo abbiamo visto a principio, di “messa in scena”. Si tratta di vocalità (e
di strumentalità) corporea, e la corporeità vocale è iscritta in un sistema più vasto
di significati corporei, nel lessico generale della gestualità. Nel momento stesso in
cui, con la musica ex machina, a livello generativo come ricettivo, deperisce il
significato dello strumento come strumento di un corpo, come protesi corporea se
osiamo dire, e si rende sintetizzabile la voce stessa, una restituzione di senso non
può che rivolgersi con forza a riportare, con l'esecuzione in genere, l’emissione
vocale in particolare, alla sua dinamica base somatica, alla “scena”. La
riproducibilità sonora, anzi la producibilità, incide negativamente sopra la
contingenza concreta dell’esecuzione, mette in oblio che la musica non è soltanto
una realtà per l’orecchio, ma anche, assolutamente, per lo sguardo. Ora, l'atto di
parola, in situazione, è prima di tutto gesto corporeo. E se la “scena” restituisce,
come spazio del gesto sonoro, l’integrità del messaggio verbale, i suoi sensi plurali,
sarà proprio la codificazione musicale quella che potrà fissare, storicamente, i
parametri della scena verbale.
Come è noto, la teatralità beriana precede di molto, così idealmente come
cronologicamente, l’interesse per il teatro propriamente detto. L’opera in musica,
la destinazione al palcoscenico della composizione, la narrazione drammatica, non
saranno allora che i casi più pronunciati e conclamati di una tensione verso quella
musica come spettacolo che è essenziale al suo vero discorso sonoro, E se questo
può riuscire rilevante, più largamente, per tutto il nostro uso della musica,
soprattutto nell’età della sua producibilità e riproducibilità ex machina, a cui
Berio, non a caso, ha portato un'estrema attenzione pionieristica, e sulle cui
possibilità è tornato più volte, nel tempo, a interrogarsi creativamente, conviene
pure sottolineare che, sul piano della tradizione melodrammatica, è infine questo
atteggiamento di consapevole e calcolata spettacolarità radicale, quella che
determina realmente e irreversibilmente la crisi dell’opera come genere pattuito e
strutturalmente riconoscibile, e così anche, per contro e in parallelo, la sua
possibilità di assunzione allusivamente straniata. Il metaoperismo.di Berio, le
definizioni, precisamente, di “messa in scèna” e di “azione musicale” , non giovano
tanto alla designazione di questa e quella specifica composizione, quanto a
indicare la costellazione centrale in cui, presso Berio, parola e musica vengono a
contatto, vengono in scena.
Quasi come in un’allegoria, nell’opera più citazionalmente impegnata a un
confronto con quello che, per il nostro compositore, è il melodramma per
eccellenza, il Trovatore verdiano, la determinazione del genere diventa, con la
mediazione di Calvino, lo sappiano o no gli autori, un titolo, poiché la “vera storia”
è iscritta nei gesti sonori, vocali e strumentali, che si esibiscono in scena e in
orchestra. Ed è ancora più sintomatico, forse, che i tre atti di Opera valgano,
latinamente, quasi in parodia, come un neutro plurale. Proprio da ultimo, a
proposito di Un re in ascolto, Berio indicava nella impossibilità dell’opera il tema
di questa sua opera estrema, aggiungendo che precisamente e soltanto nella forma
dell’opera questa impossibilità può essere dichiarata e scrutata compiutamente,
può essere “messa in scena”. E tuttavia, l’astuzia di Berio, per cui il melodramma si
converte nella propria negazione (in modi che, per altro, il nostro secolo ha
conosciuto in parallelo, per tutte le forme teatrali, e per il romanzo, e per la poesia,
e per tutti i generi, genericamente), è chiaramente esposta a quella anche più
astuta rivincita del genere, che si conserva, e persino si rafforza, nella propria
negazione medesima. Non è affatto un accidente se, in questa chiave, di una resa o
di una conquista di un'opera vera, di un vero melodramma, Berio ha ottenuto
consensi critici tutt’altro che marginali. È certo, ad ogni modo, che il grande tema
della “scena” straniata, che percorre un po’ tutto il Novecento, sembra ormai
orientarsi, e in ogni modo lo deve, verso modi di impossibile riconversione, di
impraticabile recupero.
Forse è un’indiscrezione, ma so pure che la preoccupazione attuale di Berio,
oggi, trova significativamente il suo centro, sul terreno dell’opera, nel problema
della fossa orchestrale, nello storico emblema del golfo mistico, che è appunto il
segno macroscopico della grande illusione incantatoria, e della separatezza
manifesta e invalicabile tra il visibile e il gestuale della vocalità e l’occulto e il
truccato dello strumentale. Se questo è il nodo presente della “scena” beriana,
ancora una volta non può ridursi a fatto personale, a accidente privato. È un nodo
che le cose stesse hanno imposto, e che, in qualche misura, concerne così noi tutti.
(in: Ideologia e linguaggio, nuova edizione ampliata, a c.
di E.Risso, Milano, Feltrinelli, 2001)
Praticare l’impossibile
(1996)
Volendo tentare di riassumere in una proposizione sola il senso ultimo del
legato culturale di John Cage, trascurando gli sviluppi tutt'altro che semplici e
lineari delle sue posizioni, nel tempo, e cercando di forzarne unitariamente il
decorso, credo che si potrebbe ricorrere con vantaggio a una dichiarazione che egli
stese, in margine al suo A Year from Monday, nel '63 (e che fu tradotta, nel '71, da
Renato Pedio, nell’edizione italiana di Silenzio): “Vorrei che le nostre attività
fossero più sociali, e sociali in modo anarchico” .
Cage era ben convinto, e lo dichiarò molte volte, che i grandi ideali
dell’anarchismo filosofico del secolo scorso, in America, ideali ai quali faceva
specificamente riferimento, erano tramontati senza possibilità di recupero, senza
speranza di ritorno. E tuttavia, si sa, Thoreau fu per lui un punto costante e
irrinunciabile di riferimento, in particolare per l’idea che la migliore forma
auspicabile di governo rimanga la soppressione di ogni governo, la morte dello
stato, e, se non altro per la nozione capitale di disobbedienza civile, il modello
ideologico prediletto. Al di là di ogni anarchismo politico, in ogni caso, manteneva
tutta la sua forza, per Cage, quello spirito anarchico che la cultura e l’arte erano in
grado di conservare e rilanciare e approfondire senza tregua. La missione del
poeta, per Cage, era, in essenza, la riproposta continua del valore
dell’insubordinazione e della rivolta. Se l’anarchismo può apparire, ormai,
politicamente impraticabile, è praticabile artisticamente, e l’esercizio estetico, in
generale, fa corpo con la pratica concreta dell’anarchia, che è il suo esclusivo
contenuto concreto di verità. E non si tratta affatto di una qualche sublimazione
compensatoria, di un risarcimento dimidiato sul terreno intellettuale. Al contrario,
quello che veramente importa è conservare intatto, anzi accrescere di continuo,
nell'arte, il nucleo vivo e insopprimibile di quel messaggio civile,operando sopra la
mente degli uomini attraverso i suoni e le immagini, le parole e i gesti, così da
ricondurli, oltre ogni sospensione e rottura, empirica e provvisoria, alla volontà e
alla capacità di modificare le proprie convinzioni e convenzioni, le idee e le
percezioni, reinstaurando la fedeltà a quella visione del mondo che l’anarchia
propone, e ristrutturando il consenso a quell’utopia, reinducendone la tangibile
praticabilità.
Quando Cage insiste sopra il superamento di qualunque divorzio e distanza
tra l'arte e la vita, non intende per nulla militare in favore di un’estetizzazione
dell’esistenza, come accadrà non poche volte presso non pochi suoi ammiratori e
seguaci, forse soprattutto sul terreno musicale, e forse soprattutto in Europa. Al
contrario, il problema è quello di riversare sopra il vissuto quotidiano, nell'azione
sociale di ognuno, quanto l’arte addita in forma simbolica ma reale, fornendo
modelli sperimentabili di nuove relazioni con gli uomini e con le cose. Non sarebbe
né importante né appassionante sforzarsi di modificare l’arte, di innovare il
linguaggio, se non ci fosse, più che la speranza, la certezza che, modificando l’arte,
si modifica la mente, e si può così avviare una vera e progressiva rivoluzione dei
comportamenti sociali, onde pervenire a mutare il mondo, a cambiare la vita.
L’arte, anzi, nel momento stesso in cui l’immediatezza politica
dell'anarchismo sembra irrealizzabile, non offre un semplice surrogato tattico, ma
addita una strategia superiore. Al miraggio di un sovvertimento frontale si può
contrapporre, se così possiamo dire, una tenace e non violenta guerra di posizione.
Thoreau può incontrarsi con Gandhi come con Mao. E a Mao si richiama volentieri
Cage, puntando preferibilmente, è naturale, sopra il momento della lunga marcia,
assunta come paradigma di una I accorta rinuncia all’urto conflittuale diretto, in
vista di una più controllata arte di rivincita nel ripiegamento, di trionfo nel
temporeggiamento.
Dichiara Cage, infatti: “La cosa decisiva che penso influenzi il mio modo di
agire più di ogni altra è l’interesse sociale, e così cerco di non scrivere un pezzo a
meno che non abbia una sua utilità in quanto esempio di una società”. È ancora
Mao, per altro, che è evocato a testimoniare per una disposizione al bene, nelle
masse, che soltanto una coazione opprimente a contegni forzosamente competitivi
e conflittuali può pervertire e corrompere. In termini di stretta pedagogia, già
l'emulazione scolastica è, nell’orizzonte formativo, l’avvio di quella corruzione di
fondo che una società lacerata e divisa impone fatalmente agli uomini. Si possono
indiziare di utopismo, certo, anche molti tratti delle proposte di Cage, su questo
terreno, ma non si può negare la chiarezza assoluta del principio che regola, ad
ogni passo, il suo progetto artistico: “L’intera struttura sociale deve cambiare, così
come sono cambiate le strutture nelle arti”. Una poetica ha senso se è un progetto
politico, allegoricamente organizzato, sperimentalmente esemplificato e agito.
Per essere più precisi, e più fedeli, intanto, al lessico di Cage, conviene
avvertire che egli dice di non avere interesse, propriamente, per l’impegno politico,
in estetica, ma per l’impegno sociale. Cage tende anzi, ripetutamente, anche in
momenti tra loro diversi e lontani, a opporre alla politica, come pratica violenta, e
perciò compromessa e contaminata alle radici, la socialità, e prima di tutto la
socialità artistica, come pratica ideologica di consenso diffuso e profondo, e si
vorrebbe dire molecolare, che attraverso il messaggio effettuale delle opere
musicali e pittoriche, letterarie e coreografiche, rende egemone, per gradi, un’idea
di comunità altra e migliore, liberata dai conflitti d’interesse e di dominio, dalle
opposizioni di classe. E non si tratta di un’illusione candidamente irenica. Cage è
convinto che la forza della cultura sia più potente di qualunque costrizione, in
ultima istanza, e che, per quanto sia operazione di lungo aggiramento e di tenace
scavo, sia destinata, nel tempo, a riuscire comunque vittoriosa. Per eccellenza,
l’esperienza dell’happening, nell’elaborazione di Cage, così distante da troppi
deformanti tentativi di imitazione malintesa e di replica incomprensiva, assume il
valore esemplare di esperienza collettiva collaborante, di conquista disciplinata di
una superiore armonia di menti associate: è la lunga marcia dell’organizzazione
dell'anarchia liberata.
Anche per questo punto, è necessario prestare attenzione al vocabolario
concettuale di Cage, per evitare qualche facile e non di rado banalizzato equivoco.
Il problema dell’interpretazione, per Cage, è noto, è un problema cruciale. Quando
Cage oppone l'aleatorietà, all’improvvisazione, intende rilevare il fatto, anche
troppo facilmente verificabile, che, improvvisando, in musica come in qualunque
altra forma di azione, estetica e no, si ricorre, in realtà, irresistibilmente,
fatalmente, alla replicazione meccanica dei propri atteggiamenti consolidati, e
quindi a stereotipi rassicuranti e inerti, perdendo ogni pulsione creativa, ogni
stimolo innovativo, e cedendo a una stanca quanto vana ripetizione. Il sogno di un
inventare irriflesso, in nativa spontaneità e in sgorgo sorgivo, si rovescia di
necessità nel calco passivo del passato, nelle risposte precondizionate dalle
consuetudini e dal ricordo. Cage può persino fare appello, a un certo punto, in
materia, allo spirito di competizione, e a una nozione di improvvisazione
competitiva, di cui ritrova esempi nella cultura indiana, avendo in mente un tipo di
competizione collaborante, che si esprime come stimolazione reciproca verso un
impiego intensificato delle diverse capacità personali, e insomma, in maniera
apparentemente paradossale, e persino ossimorica, verso una emulazione solidale,
un conflitto cooperante. E siamo così alla questione centrale del pensiero di Cage,
e da Cage elaborato per lo più secondo le categorie procurategli dal buddismo zen,
che vede nel casuale il superamento dell’egotismo desiderante, la sconfìtta dell’io
che opera per porre in atto soltanto le sue avide intenzioni individuali, e che è
vincolato al carcere della volontà chiusamente soggettiva, della volontà di potenza.
Uscire dai limiti dell’ego, aprirsi al mondo, aderire al caso con assoluto
rigore: sono queste, per Cage, le procedure etiche dell'arte. E aleatorietà è libertà,
proprio in quanto si oppone radicalmente all’arbitrario, al caotico: in quanto è
disciplina. Afferma Cage, discorrendo dei suoi primi lavori indeterminati:
“Quando io dico, ad esempio: ‘Fate un'azione disciplinata’, non sto dicendo: ‘Fate
quello che volete’. Eppure questo è esattamente ciò che ora alcune persone
pensano che dica”. E spiega, allora: “Le libertà che ho concesso non sono state date
per permettere qualsiasi cosa uno voglia fare, ma rappresentano piuttosto degli
inviti, rivolti alla gente, a liberarsi dai propri gusti personali e a disciplinare se
stessi”. Un agire deistituzionalizzato si pone in perfetta antitesi nei confronti delle
sfrenatezze del capriccio e della tirannia di un soggetto che affermi
autoritariamente e licenziosamente le proprie pulsioni irriflesse. È invece la
meticolosa costruzione di un’autodisciplina che scrupolosamente elabora
un’autolegislazione radicalmente socializzata e radicalmente decentrata nei
confronti dell'io. È la linea che conduce, in emblema, dal mozartiano
Musikalisches Würfelspiel alla consultazione archetipica dell’I Ching.
Ma
Cage
non
insiste
soltanto
sopra
l'autoeducazione
e
l’autoregolamentazione che, proposta all’interprete della sua musica, diventa un
programma pedagogico di significato universale. C’è la difficoltà opposta,
incarnata nell’esecutore che, ben lontano dall’abbandonarsi ciecamente
all’arbitrio, che significa, come già si è considerato, un affidarsi inerme e inerte alla
pigrizia rutiniera, rifiuta la responsabilità di cui deve farsi carico, quale gli è
concessa e, in qualche modo, imposta, e esige piuttosto che gli sia indicato
dettagliatamente quello che deve fare, chiudendosi, come in un protetto rifugio
rassicurante, nel ruolo, precisamente, del mero esecutore passivo. Parlando di
Etcetera (1973), in cui l’interprete può sentirsi vincolato o sciolto da prescrizioni,
Cage chiarisce che una siffatta composizione intende rappresentare con empirica
evidenza simbolica, sensibilmente, la presente condizione della società, in cui
emergono, insieme, il desiderio di una responsabile autonomia e il terrore di una
rischiosa libertà. Nel caso, Cage mette alla prova e pone a confronto capacità e
incapacità di fare uso delle proprie occasioni di azione, di gestire la propria
indipendenza e la propria servitù.
Il fare musica, a questo modo, si configura come una sorta di via regia per
modificare sé stessi. Al limite, per Cage, diventare un individuo diverso,
diversamente socializzato, comporta l’acquisizione graduale di un'abilità di
emancipazione progressiva dalla musica stessa: superare la musica, la musica che
si produce come la musica che altri ha prodotto e va producendo, e pervenire a
godere sempre meglio, sempre più liberamente appunto, dei suoni dell’ambiente,
delle voci della natura come dei rumori dell’industria. U sogno, o l’incubo, non
so,.della morte della musica, della morte dell’arte, non designa così una perdita, e
nemmeno, e ancora meno piuttosto, la transizione a una ulteriore condizione
spirituale, ma una costante, illimitata estensione delle capacità sensibili e delle
strumentazioni tecnologiche, del godimento e degli artifici. Non saprei dire se Cage
potesse avere in mente il Lautréamont che propone una poesia fatta da tutti, non
da uno, ma so di certo che Cage aveva in mente, fondamentalmente, una musica
fatta da nessuno, non da tutti, e ancora meno da uno.
È chiaro, allora, perché Cage respingesse, più ancora con sdegno che con
forza, l'idea di un’arte come autoespressione. L’arte è automodificazione:
e ciò che altera è la mente, e la mente è nel mondo e costituisce un fatto sociale [...]. Noi
cambieremo in modo meraviglioso se accetteremo le incertezze del cambiamento: e
questo condizionerà qualsiasi attività di progettazione. Questo è un valore.
L’arte, così concepita, è la forma piena della capacità di mettersi in giuoco, e
a rischio. Non c’è né da manifestare una propria presunta interiorità occulta, né da
conoscere una propria supposta natura profonda. Non c’è né automanifestazione
né autoconoscenza, poiché c’è, tutt’al contrario, autorinnovamento. Importa
rivoluzionare se stessi, e non esibirsi né comprendersi. È utile, dunque, “usare la
parola ‘comprensione’ contrapposta a ‘esperienza’”. E positiva è l' “esperienza”.
Anche a questo riguardo, non so quale ruolo possa avere avuto Dewey, nella
formazione di Cage. Ma per Cage, è sicuro, l’arte è soltanto e sempre “esperienza’’,
e “esperienza” sociale. Essa non ha valore né emotivo né intellettivo, non conduce
a nuovi sentimenti o nuove verità. L'arte arricchisce e approfondisce la prassi.
“Non credo affatto - proclama Cage - che comprendere qualcosa conduca
necessariamente a farne esperienza.” E avere “esperienza” del mondo, di sé e delle
cose, questo importa, perché questo modifica noi e il mondo, e “dobbiamo essere
preparati all’esperienza, non tramite la comprensione di qualcosa, ma piuttosto
aprendo la nostra mente”. A questo punto, e a queste condizioni, Cage potrà
affermare anche che nell’arte c’è mistero: perché c'è mistero nell’esperienza, che è
inesauribile, e che nessuna conoscenza può surrogare, non per altro. E la musica,
finalmente, è da usare. La musica, infatti, non ha un senso, ma ha un significato:
ha significati che si svelano nel praticarla, nell'usurarla. Come diceva Wittgenstein,
e come Cage sottolinea con vigore, “il significato di qualcosa è il suo uso”. La
poetica di Cage, come poetica dell’esperienza, dell'uso, è una poetica della prassi.
Esperienza, uso, prassi d'autore, certamente. È di esecutore. Ma anche, e
massimamente, esperienza, uso, prassi di fruitore. L’estetica di Cage, se così
vogliamo dire, una compiuta estetica della ricezione. Ed essenziale è che il fruitore
usi il lavoro dell’autore e dell'esecutore, perché, anche per questo riguardo, siamo
di fronte a un tratto di valore sociale decisivo. Si delinea, in effetti, un percorso
netto “dalla proprietà all'uso”.
Per tutto questo, se Finnegans Wake è “il libro più importante del
ventesimo secolo” , è perché è un libro “privo di senso”, ma, essendo tale, carico di
un’estrema “molteplicità di significati” . Di fronte a questo testo,
siamo liberi di scegliere il nostro percorso, piuttosto che essere costretti a percorrere
quello di Joyce. Joyce ha un atteggiamento anarchico nei confronti del lettore e così il
lettore può agire in totale autonomia.
Nell’85, commentando l’irritazione provocata in gran parte del pubblico,
che usciva dalla sala, a un'esecuzione di Muoyce, a Francoforte, Cage notava:
Ho quindi motivo di supporre che il lavoro sia ancora irritante. La gente forse non si
accorge di essere irritata, ma prova tuttavia una grande difficoltà nel prestare attenzione a
qualcosa che non capisce. Credo che ci sia una linea di confine tra il “comprendere” e il
“fare esperienza”, e molta gente pensa che l’arte abbia a che fare con la comprensione, ma
non è così. L’arte ha a che fare con l’esperienza [...]. Non è l'esperienza ciò che si vuole.
Non si desidera irritarsi, 'è così la gente esce, dicendo che l’avanguardia non esiste. Ma
l’avanguardia continua, ed è esperienza.
In tempi come questi, tempi di postmodernità, ritorna particolarmente utile
e urgente il richiamo persuaso di Cage alle ragioni irrefutabili della modernità e
dell’avanguardia. Egli dice:
Penso che la gente abbia sempre sperato che sarebbe finita, ma il guaio è che questo non
accadrà mai. Il motivo per cui non finirà è rappresentato dal fatto che avanguardia è
sinonimo di invenzione, scoperta e cambiamento: e queste sono qualità essenziali che
saranno sempre là a irritare la gente.
Ora, avanguardia significa poi, semplicemente, ‘‘una mente flessibile”. E
sorge, e risorge, poiché la storia non è finita, ‘‘come il giorno dalla notte, dal non
dover cadere preda del governo e dell’educazione”.
Qui, adesso, non occorre ridisegnare, poiché è assai nota e assai limpida, la
costellazione cara a Cage, costituita dai suoi sodali e compagni. Se in alto, supremo
correlativo ideologico e artistico, può stare Marcel Duchamp, e con lui, in generale,
lo spirito di Dada, così come sta, indimenticato maestro, Schönberg, e stanno
ovviamente Satie e Varèse, Artaud e Joyce, Busoni e Ives, accanto e intorno si
collocano Cunningham e Tudor, Rauschenberg e Johns, e quanti superbamente e
generosamente sono stati magnificati in Silence e in A Year from Monday. Vorrei
soltanto rilevare una proposizione determinante, almeno storicamente, che è
l’epigrafe indimenticabile delle pagine su Bob Rauschenberg (1961): “A chiunque
possa interessare: I ‘quadri bianchi’ vennero per primi: il mio pezzo silenzioso
venne più tardi” (e si allude, s’intende, a 4’33”, che discende dalla serie di ‘‘white
paintings”). E se non è il luogo opportuno, questo, poiché si punta a un’immagine
globale e unitaria e terminale, per affrontare la questione della genealogia della
poetica di Cage, non sarà inutile, almeno, rammentare la rivelazione recata a Cage
dal giudizio di Stravinskij su Schönberg: “La ragione per cui la musica di
Schònberg non mi è mai piaciuta è perché non è moderna” . (E non si può non
pensare, magari per associazione libera, al famoso, se non famigerato Schönberg è
morto di Boulez, 1952, a condizione di rilevare intanto, al minimo, quel giudizio
severo, se non spietato, su Boulez appunto, dello stesso Cage: “Pierre ha la
mentalità di un connoisseur. Con quel tipo di mente si può solo avere a che fare
con il passato. Non si può essere esperti in ciò che è sconosciuto” – dove si
contiene quella che è forse la più affascinante e la più precisa definizione, presso
Cage, e non soltanto presso Cage probabilmente, del ruolo dell’artista: un esperto
del non ancora mai sperimentato.)
Ma, a comprendere correttamente la posizione di Cage è essenziale
sottolineare l’opposizione che egli instaura e approfondisce, in più circostanze, tra
Dada e Surrealismo. Il principio dell’alea è nettamente posto come alternativo
all’automatismo surrealista, e sappiamo perché, dal momento che “l’arte
automatica costituisce un modo per ripiegarsi su se stessi, soffermandosi sui
propri ricordi e sulle proprie sensazioni”, come avviene, esattamente, con la cattiva
improvvisazione. Dada è una finestra sul mondo, è l’apertura massima alla
sperimentazione della realtà, laddove il Surrealismo appare, complice la
psicoanalisi, introversamente chiuso sull’io, sprofondato nell’inconscio
individuale. E sarà pure sintomatico che al “Surrealismo dell’individuo” si
opponga, per Cage, quel “Surrealismo della società”, di cui può essere considerata
una forma il New Dada della Pop Art. Non meno coerente e chiarificatore è il
rifiuto che Cage porta nei confronti dell’Arte Concettuale, e la denuncia
dell'equivoco per cui egli viene talora ascritto tra i suoi anticipatori e promotori,
laddove importa, al solito, che sopra il progetto concettualmente intenzionato
trionfi la rivelazione luminosa e inquietante dell’esperienza. Quanto a radicalismo,
d’altra parte, si pensi alla distanza che Cage colloca tra la propria ricerca e l’opera
di Schwitters e Picabia, accusati di essere diventati, a un certo punto, puri artisti, e
accettati come artisti, mentre un Duchamp è riuscito a rimanere, sino alla fine,
irriducibile e inaccoglibile ricercatore, inaddomesticabile anarchico.
È dovere dell’artista, finalmente, in questa prospettiva, “nascondere la
bellezza”. La storia dell’arte, per quanto ha di autentico, è una storia della
“liberazione del brutto”, che si tratta di penetrare, di sperimentare, di usare. “Ciò
che stiamo cercando di fare - potrebbe essere la conclusione estrema di Cage, la
morale della sua favola - è aprire le nostre menti in modo tale da non vedere più le
cose come brutte o belle, ma di vederle esattamente come sono.” È così,
precisamente, che Cage apre la strada, per sé, per tutti, al realismo
dell’avanguardia, e insomma al realismo tout court, in questa nostra modernità. E
il realismo è la meta storicamente naturale per qualunque experiencing mind, per
qualunque accepting mind.
Affermare la praticabilità artistica, sociale e etica dell’anarchia significa,
dunque, fornire saggi e sensate esperienze della “praticabilità dell’impossibile”. È
come dire, tornando circolarmente a quella nota di A Year from Monday da cui
siamo partiti, che “il nostro vero lavoro, oggi, se amiamo l’umanità e il mondo in
cui viviamo, è la rivoluzione”.
(in: Ideologia e linguaggio, cit.)
Rap e poesia
(1996)
Nella tipologia dei rapporti di collaborazione fra poesia e musica ci sono due
polarità fondamentali: da un lato c'è il caso di uno scrittore che, senza pensare
assolutamente alla musica, scrive un testo, che un musicista utilizza, perché lo
giudica adoperabile ai suoi fini espressivi, stimolato oltre che dall'aspetto tematico,
dall'aspetto dell'organizzazione linguistica; dall'altro lato esiste invece il caso di
una collaborazione che nasce perché il musicista chiede ad un autore un testo che
sia appositamente scritto; poi ci sono i casi intermedi, in cui l'autore propone dei
materiali che ha già elaborato e che il musicista trasceglie liberamente. Il mio
lavoro sul rap con Andrea Liberovici appartiene a questa sorta di terza via: non mi
è stato chiesto il permesso di musicare testi determinati e nemmeno di scriverne
uno per l'occasione, ma piuttosto di collaborare ad un progetto. Io ho proposto vari
materiali preesistenti, altri sono stati cercati da Liberovici stesso fra i miei scritti, e
ci siamo accordati su una relativa libertà d'uso. Credo che questo modello
collaborativo possa essere interessante, poiché non si tratta più né di un'idea nata
su commissione, né dell'utilizzazione di un testo concepito al di fuori della musica,
ma del lavoro di un musicista su dei materiali poetici che gli vengono messi a
disposizione e che può riorganizzare secondo le proprie esigenze.
In realtà, la mia attenzione alle sperimentazioni che coinvolgono musica e
letteratura non è nuova. Ho incominciato a lavorare in collaborazione con
musicisti all'inizio degli anni Sessanta, segnatamente con Berio. Berio è forse il
musicista che meglio incarna la mia idea di collaborazione, che si è prolungata fino
ad oggi, con episodi qualche volta anche lontani nel tempo, ma senza che mai si
rompesse una linea di continuità, anche perché è accaduto che, pur modificandosi
le nostre poetiche e le forme del nostro linguaggio com'è naturale in una ricerca, ci
siamo mossi sempre con qualche simmetria: i problemi, sia di linguaggio poetico
sia di linguaggio musicale che si ponevano, presentavano spesso delle analogie,
pur nell'ovvia differenza di due modalità comunicative piuttosto eterogenee. Con
Berio e con altri musicisti, il lavoro era di volta in volta mutevole, ma aveva la
costante di appartenere sempre a quel genere di musica che consideriamo “grave”,
seria, legata al teatro, alla sala da concerto, o anche a soluzioni cameristiche, ma
lontana dalla cosiddetta pop music, vale a dire da una musica di più largo
consumo, che usa modalità di comunicazione popolare, nate o divenute tali.
Questo ambito mi ha sempre appassionato, dapprima attraverso le suggestioni del
jazz, poi con lo sviluppo del rock e di altre forme più recenti, dalla discomusic alle
posse. Oltre a questo interesse specifico, quando sottoposi a Liberovici alcuni dei
miei materiali, ero mosso dall'idea, che lui del resto condivideva, che il rap fosse
prima di tutto una tecnica evidentemente ritmica e musicale, ma anche una tecnica
del discorso verbale, un modo paradossale per “recitar cantando” , in cui
l'importanza del testo è molto forte e permette di utilizzare anche dei
componimenti che non abbiano una preordinata struttura ritmica, ma che si
costruiscono attraverso giochi verbali. Io ho fatto uso, almeno in molti dei miei
testi, dell'allitterazione, della rima ribattuta e questo si prestava bene ad essere
trasformato in rap, con poche modifiche di replica, di iterazione, di variazione.
Dopo aver accolto la proposta per un rap, suggerii a Liberovici di andare oltre, di
pensare ad uno spettacolo in cui il rap rimanesse la struttura essenziale, ma
accanto ad esso venissero usati testi musicali tradizionali - per violoncello, ad
esempio - poi registrati in modo da creare, sia da un punto di vista scenico e
gestuale, sia da un punto di vista verbale, una grande possibilità di movimenti
diversi nelle direzioni più varie. Essendo soddisfatto del risultato ottenuto, lo
stesso Liberovici pensa ora di curare e ampliare questa forma e creare uno
spettacolo ancora più ampio, innestando ulteriori elementi (come la canzone o
altre modalità) altrettanto eterogenei rispetto al materiale preordinato. Questo
lavoro ha quindi una sua struttura già organizzata, ma è anche un lavoro in
progress perché suscettibile, nelle intenzioni del musicista, di continui sviluppi.
Da un punto di vista tematico, Liberovici era poi partito da un soggetto su
cui potevo offrire molto materiale: il motivo del sogno; perciò l'ho lasciato libero di
montare i miei testi e di giocare - come io auspicavo che potesse avvenire - sulla
congiunzione di parti eterogenee tra loro, ma che in una logica onirica ritrovavano
un loro senso di montaggio. Del resto, molta della pop art, intesa non soltanto nel
senso pittorico, ma di arte pop, nell'accezione in cui si impiega questa parola
quando si parla oggi del folclore di massa, è degna di grande attenzione; e c'è uno
scambio continuo, qualche volta consapevole qualche volta inconsapevole, tra le
espressioni tradizionali d'arte e le espressioni di massa legate al consumo e alla
cultura dei giovani. In fondo, si ritrova in questo rapporto qualcosa che la
tradizione ha sempre conosciuto e che poi ha un po' perso: se si guarda al modo in
cui la musica del passato ha operato con ciaccone o gagliarde o minuetti o valzer, si
vede che tutta la musica più seria, qualche volta persino seriosa, ha utilizzato delle
forme di danza che erano consumate contemporaneamente dalla cultura
“popolare” del tempo. In seguito c'è stata una scissione o almeno una maggiore
difficoltà di relazione tra questi elementi, anche se l'influenza del jazz sulla musica
seria, ad esempio, ha toccato musicisti come Debussy e Stravinskij e credo che
questa forma di contaminazione non solo possa continuare, ma possa diventare
più esplicita e consapevole, e più programmatica di quanto sia accaduto nel
Novecento.
Anche la scrittura letteraria e il lavoro sulla parola potrebbero trovare in
questa sorta di ibridazione una spinta ulteriore per rompere con il “poetese” in
senso negativo, cioè il gergo lirico, la selezione verbale verso realtà superiori dotate
di aura, e stimolare maggiormente ad un impiego poetico del linguaggio
quotidiano, di tutto quello che è il mondo della prosa moderna, della tecnologia,
delle feconde mescolanze di lingue diverse. D'altra parte è importante ricordare
che in una certa letteratura americana all'epoca della cultura beat, ci sono stati
autori, come Kerouac e Ginsberg, che dichiaravano di essersi ispirati molto al
ritmo del jazz o alla pop music, proprio come ritmo di scrittura; ci sono esempi, in
poesia come in prosa, di una letteratura che ha subìto questo influsso della ritmica
musicale, sul terreno del romanzo e della narrativa, come su quello poetico e credo
che, in questa direzione, si possano ottenere degli sviluppi ancora più ricchi.
Nel valutare la situazione italiana, occorre però fare le dovute differenze. Gli
esperimenti degli anni Cinquanta e Sessanta per creare una canzone d'autore o lo
sviluppo dei cosiddetti cantautori hanno dato risultati assolutamente discutibili.
La tipicità della canzone italiana appare molto imprigionata entro limiti di
melodicità tradizionale, per cui diventa o tardo melodramma riciclato, nel migliore
dei casi, o tarda romanza da camera. Ciò non toglie che ci siano stati anche dei
risultati positivi fra gli autori (perché Paoli o Conte hanno forse aperto delle
strade) e degli interpreti piuttosto straordinari, anche dal punto di vista del
costume, come Mina o Patty Pravo. Tuttavia un limite è sempre stato la prevalenza
di melodicità e di poeticità; anche i tentativi di scrivere testi per canzoni fatti da
Pasolini, da Calvino, da Fortini, persino da Moravia e Soldati seppure molto
episodicamente, non hanno poi trovato conferma né continuità, perché in fondo la
vera musica popolare aveva altre direzioni. L'intervento del jazz e del rock è stato
invece veramente un fatto insopprimibile nello sviluppo del linguaggio musicale, il
solo che possa trovare equivalenti nella sperimentazione letteraria. Accanto al
“poetese” , c'è stato un “canzonettese” : l'Italia purtroppo è il paese di Sanremo,
per dire tutto in una formula, e questo ha rappresentato e rappresenta un limite
molto forte.
Anche dal punto di vista dei contenuti, delle idee, benché la canzone abbia
avuto un pubblico larghissimo, in sostanza è sempre rimasta prigioniera di
atteggiamenti, per così dire, piccolo-borghesi. Molta della protesta orientata in
quel senso è rimasta imparagonabile alla rottura espressiva proposta da tanta
musica anglosassone, dai Rolling Stones ai Sex Pistols, per esempio, in cui
radicalismo e anarchismo hanno raggiunto una violenza che da noi è rimasta
praticamente sconosciuta o veramente episodica ed eccezionale. Il limite della
canzone italiana è davvero anche un limite ideologico e di classe. Tentare
l'esperimento del rap significava per me uscire davvero da questi confini, passare
davvero ad altro: fare un lavoro, con un musicista, in una direzione che non
rimanesse poi nemmeno prigioniera della forma del rap, ma la utilizzasse come
una sorta di riferimento fondamentale, nell'organizzazione della struttura di
un'esperienza spettacolare, senza rinunciare a nessuno degli elementi che oggi, sia
la parola, sia il suono possono proporre.
Io tendo sempre più ad insistere sul momento anarchico come momento di
pulsione della grande arte critica del Novecento. Se questo momento ha trovato
incarnazione, non è stato tanto nella forma della canzone “all'italiana”, quanto
piuttosto nelle esperienze di certo rock violento e oggi, semmai, del rap e di altre
espressioni di questo genere.*
* Il testo di questo intervento è il risultato di una conversazione con Edoardo Sanguineti,
rielaborata insieme a lui, e pensata per il numero 4-5 di “Bollettino Novecento” (maggio
1996). L'occasione di parlare di un esperimento di rap poetico si è trasformata in un
discorso ampio ed organico sulle relazioni tra la letteratura e la musica, nella tradizione,
nel nostro secolo e nelle loro potenzialità future [Anna Frabetti]
Luciano Berio
da: A-Ronne
(1991)
La musica, per fortuna nostra, non coincide mai completamente con quello
che il suo autore si propone di comunicare - non solo come espressione di una
idea, di un concetto e di una visione poetica, ma anche come documento di (o
commento a) una realtà concreta. Un testo, poetico o no, è invece una realtà
concreta che coincide di solito con quello che il suo autore si propone di
comunicare. In altre parole (e semplificando), un poeta, mettendo in atto
meccanismi denotativi più o meno complessi, può non solo creare un labirinto di
associazioni significative ma può anche permettersi il lusso di mentire
consapevolmente e di manipolare la realtà e i referenti. Il musicista non può
mentire, non ne ha gli strumenti, è un puro (con tutto il male che ne deriva): lui :
quello che è e i meccanismi connotativi della sua musica sono quello che sono,
anche se assiduamente frequentati e condizionati dai fantasmi della storia, delle
tecniche, degli ascolti possibili e anche se il senso di quello che fa è sempre un po’
altrove e non coincide mai completamente, appunto, con quello che egli si propone
di comunicare.
Ma la creatività musicale ha sempre cercato di sviluppare diversi nodi di
complicità con la realtà concreta e con le idee che la abitalo: con la vita pubblica,
per esempio, con la vita privata, la scienza, i1 teatro, i dati naturali e le tecniche. E
ogni volta il musicista cerca di assimilare, sublimare e trasformare eroicamente
quella realtà concreta in un’altra cosa (magari solo in un titolo), anche senza apersi
porre il problema di definire che cosa veramente essa sia. Non c’è alcun dubbio che
si tratti di una definizione abbastanza difficile che richiede strumenti di natura
filosofica analoghi, mi sembra, a quelli che vengono usati quando si cerca una
definizione del tempo. Quando, da soli, pensiamo alla realtà concreta, sappiamo
sempre cos’è. Se però qualcuno ci chiede cosa essa sia, non sappiamo più cosa
rispondere e siamo assaliti dal dubbio che quello di realtà concreta (e di tempo)
non sia un concetto ma, piuttosto, un modo di dire assai poco concreto. Comunque
sia, nell’immenso repertorio di “realtà concrete” con le quali il musicista si è
sempre misurato, la realtà della lingua parlata e scritta, della poesia e della prosa,
occupa sicuramente un posto privilegiato. Quel osto che è responsabile del vasto
mare della musica vocale dove appunto la realtà della lingua parlata si associa alle
virtualità del linguaggio musicale.
In A-Ronne, per cinque attori, su una poesia di Edoardo Sanguineti
(realizzato nel maggio 197 per la Radio Olandese di Hilversum), si ritrova forse
poco di queste considerazioni: esse hanno però avuto una funzione catalizzatrice
nella concezione di questo lavoro che, tanto sul piano verbale che su quello
musicale, si pone il problema di combinare assieme e di elaborare, senza volerle
trascendere musicalmente, solo associazioni e riferimenti specifici, solo
denotazioni e, nei limiti del possibile, solo realtà concrete.
A-Ronne non è una composizione musicale in senso stretto. Avrei
certamente incontrato delle difficoltà se avessi voluto definirla con una delle
consuete indicazioni di genere che accompagnano le composizioni vocali (cantata,
madrigale, canzone, concerto ecc.). Ho optato invece per quella che mi è sembrata
la descrizione sintetica più appropriata: documentario. Di documentari se ne
fanno tanti e sugli argomenti più diversi (su dettagli della vita pubblica, della vita
privata, della scienza, del teatro ecc.): perché non su una poesia? In A-Ronne,
documentario per cinque attori su una poesia di Edoardo Sanguineti, c’è poca
musica ma, come vedremo dopo, i criteri che lo organizzano sono musicali: a volte
essi svolgono le funzioni di una macchina da presa che, invece di esplorare un
soggetto o una situazione da diversi angoli e con lenti diverse, esplora una poesia.
A-Ronne non appartiene dunque a un genere musicale noto. Concepito
originariamente come lavoro radiofonico, può forse suggerire qualche tenue
legame coi madrigali rappresentativi, cioè col teatro degli orecchi (della mente,
diremmo oggi), del tardo Cinquecento.
Avevo chiesto a Sanguineti una poesia piuttosto breve, condotta su un
discorso non lineare, facilmente segmentabile e costruita possibilmente su
immagini permutabili, come fossero parte di un congegno modulare. Cosi è,
infatti, il suo A-Ronne. Nella sua grande coerenza e intensità evocativa sembra
guardare continua-mente dentro se stesso e ai suoi stessi congegni, ai suoi
frammenti e alle sue rovine. Uno degli aspetti più singolari di questa poesia è
l’essere rigorosamente e ossessivamente costruita di citazioni che ruotano su loro
stesse e ritornano spesso tradotte in lingue diverse. Anche il titolo è una citazione.
A-Ronne: come dire A-Zeta, Alfa-Omega. Ronne è una delle tre abbreviature poste
un tempo alla fine della tavola dell’alfabeto, dopo la Zeta. Esse sono: Et, Con e Ron
(quest’ultime due sono una trasformazione di cum e della desinenza latina orum).
Le designazioni fiorentine, utilizzate da Sanguineti a conclusione della poesia,
erano Ette, Conne, Ronne. A-Ronne è diviso in tre brevi strofe: il tema della prima
strofa è l’Inizio, il tema della seconda è il Mezzo e quello della terza è la Fine.
I
a: ah: ha: hamm1: anfang2:
in principio: nel mio
principio:
am anfang: in my beginning3:
ach: in principio erat
das wort: en arché en:
verbum: am anfang war: in principio
erat: der sinn: caro4: nel mio principio: o lògos: è la mia
carne:
am anfang war: in principio: die kraft:
die tat:
nel mio principio:
1 Omaggio a Samuel Beckett (Hamm, personaggio di Fin de partie).
2 «Anfang» (principio): Sanguineti chiarisce che il Vangelo secondo Giovanni comincia con le
parole: en arché en o lògos, «in principio era il verbo», «in principio erat verbum». Nella
traduzione di Lutero: «Im Anfang war das Wort». Nella scena «Studierzimmer» del Faust (I)
di Goethe, Faust ne prova successivamente diverse traduzioni sostituendo «das Wort»
(verbum) con «der Sinn» (il pensiero), «die Kraft» (l’energia) e «die Tat» (l’azione).
3 Il secondo dei Four Quartets (intitolato «East Coker») di T. S. Eliot comincia con le parole
«In my beginning is my end» e finisce con le parole «In my end is my beginning».
4 Allusione a Giovanni: «et verbum caro factum est» (e il verbo si fece carne). Può essere
dunque il «caro» latino (carne) o il «caro» italiano (da cui: «è la mia carne»).
II
nel mezzo5: in medio:
nel mio mezzo: où commence? 6: nel mio corpo:
où commence le corps humain?
nel mezzo: nel mezzo del cammino: nel mezzo
della mia carne:
car la bouche est le commencement:
nel mio principio
è la mia bocca: parce qu’il y a opposition: paradigme:
la bouche:
l’anus:
in my beginning: aleph:7 is my end:
ein gespenst geht um: 8
III
l’uomo ha un centro: qui est le sexe:
en méso en: 9 le phallus:
nel mio centro è il mio corpo:
nel mio principio è la mia parola: nel mio
centro è la mia bocca: nella mia fine: am ende:
in my end: run:10 is my
beginning:
l’àme du mort sort par le pied:
par l’anus: nella mia fine
war das wort:
in my end is my music: 11
ette, conne, ronne:
Questo gioco di specchi, questa combinatoria di unità semantiche, quasi
frammenti culturali di un palazzo terremotato, sembra volerci ricordare un
assioma tanto vero quanto solenne: significato è relazione. Il percorso di relazioni
verbali tracciato da Sanguineti è complesso e intricato quanto l’accumulazione di
significati e di segnali che vengono marcati dal loro rapporto con lingue diverse.
Inoltre, ogni possibile relazione fra gli elementi diversi non è regolata
sintatticamente e resta quindi sostanzialmente aperta. La poesia di Sanguineti,
concettualmente “musicale” per conto suo, ci ricorda in maniera particolarmente
5 «Nel mezzo» (in medio), l’inizio della Commedia dantesca.
6 «Où commence...»: un passo di Georges Bataille (citato da R. Barthes) dove viene trattato un
tema antropologico, molto frequente fra i “primitivi”, dove sia il principio e dove sia la fine del
corpo (quindi, dove entri nel corpo, alla nascita, l’anima, e dove esca alla morte).
7 «Aleph» è la prima lettera dell’alfabeto ebraico.
8 “Ein gespenst geht um”: le prime parole del Manifesto di Marx ed Engels.
9 “En méso en” (in mezzo era): calco sul Vangelo secondo San Giovanni.
10 Omaggio a J. Joyce (run da riverrun di Finnegan’s Wake).
11 «Is my music»: omaggio a Luciano Berio (lettera privata).
vivida un altro solenne assioma che interessa da vicino l’esperienza della musica
vocale: il significato di una parola può esser sempre lo stesso (un tavolo è sempre
un tavolo) mentre il senso e le funzioni di una parola sono sempre mutevoli. Una
modificazione di contesto, di intonazione e di inflessione possono dare un senso e
un peso diverso allo stesso enunciato. Cioè, una modificazione sul piano
dell’espressione equivale a una modificazione sul piano del senso. Ed è proprio
questo il tema centrale del documentario A-Ronne, tema che non solo è già
implicito nella poesia di Sanguineti, ma che è evidentemente presente ogni volta
che si ha a che fare con l’incontro e la compenetrazione espressiva di una struttura
verbale e di una struttura musicale (o meta-musicale). Nel documentario A-Ronne
le modificazioni espressive (e di senso) vengono ossessivamente e arbitrariamente
imposte, sempre diverse, su un testo relativamente breve. Non solo. In A-Ronne
non c’è musica in senso proprio e quindi non c’è un vero incontro (o scontro) fra la
dimensione linguistica e quella musicale. Le situazioni musicali sono esempi di
comportamento vocale fra i tanti ed evocano banali maniere di canto. I cinque
attori leggono e rileggono il testo poetico originale illuminandolo, trasformandolo
e filtrandolo attraverso un vasto repertorio di gesti vocali specifici (dal richiamo
all’insulto, dal piangere al ridere, dall’eloquio volgare al sussurro erotico,
dall’afasia all’acrobazia articolatoria, dal rumore fisiologico al canto di chiesa, dal
confessionale alla piazza, alla caserma, alla lezione di canto ecc.). Si tratta in
sostanza di una ri-lettura continua delle citazioni di A-Ronne attraverso un ampio
repertorio di “citazioni” di gesti e di stereotipi vocali: una ri-lettura continua
condotta senza vere e proprie “interferenze” musicali, con gli strumenti del testo
stesso.
Un testo, quando è complesso, va comunque riletto e va esplorato da angoli
diversi. La grande polifonia vocale del passato, nel cui ambito si è sviluppato il
pensiero musicale europeo, “metteva in musica” soprattutto testi universalmente
noti. Per esempio il testo della Messa. Chi ascoltava sapeva cos’era un Kyrie o un
Gloria e, diversamente dall’autorità vaticana, non si sentiva minimamente
defraudato se ardite e complesse architetture contrappuntistiche gli impedivano
una percezione vocale, parola per parola, del testo. Anzi, è stata proprio questa
libertà “acustica” nei confronti del testo della Messa che ha permesso ai grandi
creatori di esplorare nuovi territori musicali di grande intensità e complessità
espressiva (Ockeghem, Palestrina, Bach e Beethoven). In epoche più vicine a noi,
invece, forme e maniere letterarie da una parte e forme e maniere musicali
dall’altra avevano un ampio campo di coincidenza metrica, prosodica, retorica e
formale: basti pensare a Mozart, alla grande stagione liederistica e a Debussy, dove
questo rapporto di contiguità fra testo poetico e musica promuove una interazione
illimitata di campi espressivi omogenei. Oggi ¡è frequente il caso di compositori
che “mettono in musica” testi letterari di grande complessità, di difficilissima
comprensione quando cantati e, anche, di ardua lettura. Il compositore dovrebbe
allora organizzare musicalmente diversi gradi di percepibilità, decidendo quali
parti del testo possano essere occultate, o quasi, dalla musica e quali invece
debbano esserne illuminate. C’è infine una tendenza che faccio mia e che, nella sua
globalità, non esclude necessariamente le altre. Penso alla possibilità di usare
criteri musicali per l’analisi e per la riscoperta espressiva di un testo, dando, a chi
ascolta, la possibilità di percorrere e ripercorrere coscientemente il meraviglioso
itinerario, sempre da riscoprire anche nell’esperienza musicale, fra suono e senso.
Nella musica vocale questo itinerario è meno “astratto” e più tangibile che nella
musica strumentale. E comunque profondamente emozionante che il pensiero
musicale ci permetta la conquista di un senso ulteriore, e di un altro e poi di un
altro ancora, senza mai perdere contatto con quello che “dice” la voce. Questa
tendenza alla globalità dell’espressione vocale implica innanzitutto il rifiuto di una
concezione dualistica e un po’ archeologica del linguaggio, che pone il suono da
una parte e il senso dall’altra, in una prospettiva che, adattata alla musica, può
condurre a una divisione moralistica fra suoni e rumori, fra vocali e consonanti e,
fatto qualche passo più in là, fra il bene e il male.
Tutti gli elementi del linguaggio possono concorrere all’espressione poetica
e al senso, cosi come ogni elemento vocale può essere convertito in musica. Roman
Jakobson, che ho avuto la fortuna di conoscere, amava raccontare un aneddoto. In
Africa c’era un missionario che si lamentava del fatto che gli indigeni fossero
sempre nudi. «Ma anche tu sei nudo» gli dissero un giorno gli indigeni indicando
la sua faccia. «Certo, ma è solo la faccia». «Ebbene - replicarono gli indigeni - per
noi la faccia è dappertutto». Lo stesso vale per la poesia, conclude Jakobson: la
faccia della poesia è dappertutto, ogni elemento linguistico può essere convertito in
figura poetica. […]
(in: A.Ziino (a c. di), Musica senza aggettivi. Studi per
Fedele d'Amico, Firenze, Olschki, 1991)
NANNI BALESTRINI
Edoardo Sanguineti
Come agisce Balestrini
(1963)
Il nome di Balestrini è oggi legato, con un certo sapore di scandalo,
soprattutto alle prime sperimentazioni di una poesia ex machina: e diciamo subito
che sarebbe assai ingiusto insistere sproporzionatamente sopra questo aspetto del
suo lavoro, e da questo voler dedurre la sua intiera immagine di scrittore, come
sarebbe ingiusto, per contro, mettere questa zona della sua attività, pudicamente e
prudentemente, tra buone parentesi. La verità è che la poesia elettronica è, di tutte
le sue ricerche, almeno in un senso ideale, ma certo anche secondo una tutta
empirica cronologia, il naturale esito estremo.
In effetti, Balestrini ha composto versi che tendevano al collage e, più oltre,
e più allusivamente, alla poesia ex machina, assai prima di impiegare direttamente
questi strumenti specifici: si è servito, a partire già dalle sue primissime prove, di
una condizione di discorso per cui la parola era, ad un tempo, sospesa dai normali
rapporti sintattici e trattata come elemento bruto, ostentatamente gravida, nei
continui effetti di parlato, del suo peso pratico, e proprio di pratica alienazione,
compromessa dal consumo immediato, e rimontabile, per ciò stesso, in un patetico
calcolo combinatorio. Chi guardi oggi all’intiero tracciato di Come si agisce, può
ristabilire, per quel tanto di fedeltà alle date che lo scrittore ha dimostrato, in
essenza, nell’atto di esporre il suo lavoro come un tutto coerentemente svolto, i
morbidi trapassi verificabili, di volta in volta, dall’una all’altra fase, in un continuo
processo di chiarimento, sino all’esplicita e clamorosa rivelazione contenuta nelle
pagine ultime. E si voglia qui anche indulgere per un attimo alla eventuale
diffidenza dell’ingenuo lettore, e interrompere l’esplorazione del libro alle soglie
delle prove concrete ed elettroniche, e, per estrema cautela, ancora al di qua di
quelle Tavole dei poemi che sono pure la chiave di volta della lettura, poiché
proiettano, sopra tutto lo scheletro del libro, la configurazione interna di ognuno
dei singoli testi. Si resti insomma, per ipotesi, alla sezione che ha per titolo Lo
sventramento della storia, e si tenti di degustarla secondo i modi più
pacificamente tradizionali: si sarà costretti a cercare un appoggio in quelle tante
dichiarazioni tutte scoperte ("giacché ogni struttura di valori oggi è una struttura
falsa è una struttura / falsificante”), che ci riportano, immancabilmente, dai
contenuti alle forme, dalla "struttura di valori” che il libro intende sottoporre a
giudizio (e a "sventramento”), alla struttura formale che regola l’esercizio di quel
medesimo “sventramento": alle strutture sventrate, appunto, proprie di Balestrini.
Inutile dire che nella medesima pagina potremo leggere di “un avvenimento
puramente linguistico". Se i campioni minimi che abbiamo scelto sono scelti bene,
dedurremo cosa facilmente verificabile per tutto il volume: il carattere
drammaticamente e ironicamente critico del testo.
Cerchiamo subito il significato ultimo del libro. Al limite, si può dire che
questo volume così concluso tende a presentarsi, intrinsecamente, come
estensibile all’infinito: è un’apparenza necessaria al sistema del testo. Si vorrà poi
anche dire che è, interiormente, nelle sue parti e frammenti, sostituibile e
modificabile: e in quest’apparenza è il suo significato. Perché appunto, a voler
scolasticamente risolvere Come si agisce in una serie di tesi (il che pare essere
proprio di ogni libro che ha davvero un significato), la prima rubrica potrebbe
consacrarsi alla capacità di significato espressivo indiscriminatamente conferibile,
per puro gesto, alla totalità del dicibile, una volta che intervenga uno straniamento
dal contesto pratico, perché il lacerto possa essere, come sopra si diceva, sospeso e
rimontato. Il fenomeno invera i vecchi propositi di poetica dell’autore, dal tempo
in cui apparve l’antologia dei Novissimi, allorché Balestrini scriveva: “Le strutture,
ancora barcollanti, prolificano imprevedibilmente in direzioni inaspettate, lontano
dall’impulso iniziale, in una autentica avventura. E da ultimo non saranno più il
pensiero e l’emozione, che sono stati il germe dell’operazione poetica, a venire
trasmessi per mezzo del linguaggio, ma sarà il linguaggio stesso a generare un
significato nuovo e irripetibile”. Si capisce come Giuliani evocasse allora, in
proposito, i collages di Schwitters. L’opera esprimerebbe così, in senso
diagnostico, quella totalità di suggestione, automatica e sradicata, che il fatto
verbale, oggi, storicamente possiede, denunziando intanto che la suggestione non
è raggiungibile se non per via di automazione e sradicamento. Si svela il carattere
di mistificazione magica di tutti i linguaggi presenti, attraverso la semplice
sospensione della loro praticità concreta, e in ferma conservazione della loro
praticità ideale, e cioè, , direttamente, dei valori semantici. Si opera così la
trasformazione magica, esattamente al modo in cui, per ottenere un sogno, è
sufficiente ed è necessario dilatare e comporre i residui diurni (che è poi, teste
Vico, il modo che la fantasia tiene nei confronti della memoria).
Di qui, come è ovvio, tutta l’ambivalenza dell’opera: essa dimostra, per un
verso, che tutto il dicibile è trasformabile in sogno (ossia in poesia), cui la ragione
assista, come è buona regola (anche con l’intervento di buone macchine razionali,
se occorre al caso); ma per altro verso essa toma a confidare, ancora una volta,
sopra la categoria romantica della dilatazione e della composizione, riprendendo il
mito al suo punto estremo, e precisa-mente al punto del suo sventramento. Da un
lato si dimostra così l'incapacità di resistenza di tutto ciò che, nella nostra mente, è
coscienza di realtà; dall’altro lato, su questa stessa incapacità di resistenza, si
instaura una speculazione estetica. Balestrini interrompe, come conviene, la
composizione del libro, al punto in cui il lettore, posto che abbia ripercorso
adeguatamente le fasi operative e appreso di conseguenza l’insegnamento che esse
comunicano, può continuare per proprio conto. E avrà imparato, appunto, “come
si agisce". Ma chi intanto discorre di opera aperta trova nuovo esempio, e, nel
profondo, nuova categoria: perché l’apertura è qui, non più l’accidente in sostanza,
e cioè un criterio formale e formativo, ma il contenuto stesso del libro, la sostanza
di tutti i suoi accidenti. E ciò comporta il superamento della categoria originaria,
nella misura in cui essa era costituita come relativa e compresente (idealmente e di
fatto) alle opere chiuse della tradizione: avventura contro ordine. Il libro di
Balestrini, più radicalmente ormai, e più semplicemente, ignora la possibilità
stessa della chiusura formale: è una calcolata combinazione che viene proposta,
esplicitamente, come scelta tra le infinite combinazioni possibili del materiale
linguistico, in un universo tutto formato di mere possibilità e combinazioni
linguistiche. La macchina, a questo punto, può certamente aiutare, ma non può,
altrettanto certamente, far meglio del poeta, in materia di arte combinatoria.
Abbiamo voluto precipitare le cose, sino a ricercare, prima di una vera descrizione,
un significato. Ora si può anche dire che il metodo seguito qui era assolutamente
indispensabile: l’opera di Balestrini tende infatti a consumarsi, per natura, nella
sua descrizione. Se Balestrini incontra, a un certo punto, una paralisi provvisoria
della facoltà poetica, siamo di fronte a un imbarazzo tutto interno, al solito, al
sistema. La descrizione dell’imbarazzo, si potrebbe persino suggerire, è la finalità
interna dell’opera, una teleologia che l’autore, per avventura, poteva anche
ignorare, nel momento in cui si poneva al lavoro, ma che l’opera, per sé medesima,
conosceva da sola, e prima del suo autore. Nell'ex machina in cui Balestrini va a
parare, chi non sentirà allora la vecchia presenza del deus? Il divino furore del
poeta, giusta i primitivi e sacri canoni tipologici, si converte nell'infinita possibilità
tecnica dello strumento elettronico, eletto a stimolo immaginativo e a esecutore
manuale, e esattamente in proporzione alla capacità del poeta di interiorizzare,
con il dio, la macchina che lo assiste e che sbriga il lavoro servile.
Ma occorre, di fronte al calcolo combinatorio del poeta, per buona
simmetria, combinare bene gli elementi della nostra diagnosi. Perché tutta
l’interpretazione di Balestrini è e sarà condizionata, non meno del significato che
potrà scaturire da due elementi di una sua combinazione, da un prima e da un
dopo. Si capisce infatti che se muovo a parte subjecti, e guardo a questa novissima
poetica del dilatare e del comporre, mi trovo un Balestrini che taglia i suoi fiori
asettici di radici quadrate, secondo un’immagine che è già classica, e posso evocare
tutti i mostri delle avanguardie novecentesche, e anzi, volendo, ripartire da Vico: e
riuscirò anche a non fargli toccare mai terra. Potrò stabilire che tutto questo che si
è detto si svolge in laboratorio, e potrò anche non avvedermi, con le migliori
intenzioni, del fatto che sono io che, in laboratorio, svolgo queste operazioni di
descrizione, interpretazione e giudizio che mi istituiscono e autorizzano, tutto
criticamente specializzato, a discorrere di “un avvenimento puramente
linguistico”. Eppure avrei il sacrosanto timore, in tale ipotesi, che il deus ex
machina di Balestrini prendesse della mia diagnosi allegra vendetta, dilatandomi e
combinandomi, dopo avermi fatto a brani. Così, per sfuggire allo strazio, e per
avvertire il mio errore combinatorio, sarà sufficiente che io mi provi a ripetere
l’operazione muovendo a parte objecti, e cioè muovendo da quella tale
disponibilità indifesa verso la magia del sogno che l’opera massicciamente e
minacciosamente testifica, non più per sé, ma per l’universo di linguaggio in cui
siamo chiamati ad agire. E qui è il sugo della faccenda: perché allo psicologo
domanderemo, volendo, e posto che egli sappia risponderci, le cause del nostro
molto sognare, ma è domanda assai più imbarazzante, e difficile a indirizzarsi,
quella che metta in questione il fenomeno per cui, piaccia o non piaccia,
l'esperienza del reale in cui siamo immersi, ivi compresa, per supremo sintomo, la
nostra capacità di pensiero, si rende passibile di fruizione soltanto se vissuta
autenticamente come residuo. Che io impieghi i residui nel sogno o le parole in
poema, è cosa che non modifica in ' nulla la qualità dell’esperienza: il fatto dice
qualcosa che non mette in causa né i sogni né i poemi, immediatamente, ma,
piuttosto, la realtà. Al più potremo dedurre che i fantasmi del sogno dicono
qualcosa di vero, nella misura in cui il libro è, come deve essere, allegoria del
mondo.
Non si dovrà con questo nascondere il fatto che il volume conserva tutto il
naturale segno del suo peccato di esistere, se entrambe le possibilità di
combinazione del giudizio possono rimanere logicamente in piedi: che è
l’ambiguità di cui sopra. E sarebbe molto se anche per questo fatto si potesse
ripetere: è interno al sistema. Ma qui, veramente, cessano le responsabilità di
Balestrini, il quale, almeno al riguardo, il sistema se lo è trovato tutto pronto, nelle
condizioni storiche. Chi voglia fare di lui una figura di quella che ormai si definisce
come la nuova avanguardia, ha buon giuoco: purché avverta la forza di simile
condizione storica, e tutto quel registro che essa implica e impone. Il limite storico
sarà poi, nel suo caso, che il processo romantico della fantasia rimane non
superato e non superabile, se non in quanto, precisamente, è superato ancora nella
forma della fantasia. E sia pure, come sappiamo, di una fantasia ex machina. Su
questo siamo in grado di precedere molte inevitabili recriminazioni, e fare di più:
dire come sopravviva, nello sventramento, tutta quella fiducia romantica nella
magia della parola straniata e sospesa, nella parola disinteressata, e cioè dilatata e
combinata. Ma si rovesci ancora: perché tutto sopravvive nell’informe di così
energico sventramento.
Ricordo le prime poesie di Balestrini, che lessi, nel 1957, sopra il “Verri”.
Oggi, a rileggerle in volume, si sente che vengono tanto prima del diluvio delle
prove ultime, e che quel diluvio invocano, proprio come complici della forma della
fantasia, come ancora remote, per insistere su questi termini, dall’informe dello
sventramento. Balestrini è giunto davvero in fondo, senza esitazioni, a quel vicolo
cieco che, fatalmente, lo attendeva. Ed è fortuna che del suo libro si possa dire,
comunque abbia a prolificare in qualità di duro esempio, che non apre nuove
strade: appunto per questo può riuscire, oggi, allegoria amaramente credibile del
nostro mondo.
(in: Ideologia e linguaggio, cit.)
N.B.
“Spezzando le frasi e anche le parole,
accostandole in modi apparentemente arbitrari,
voglio arrivare a far scaturire un significato più profondo, irrazionale,
che generi emozioni mentali, come fanno la musica e la pittura,
non ragionamenti”
Empty Cage *
1
ci sono tante e tante cose che possono andare insieme
senza sapere quale sarà il risultato
ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova
abitare il mondo intero non frammenti separati del mondo
ciascuno di noi è il centro del mondo senza essere un io
il mondo non è diventa si muove cambia
2
non ho nessuna idea di come tutto questo avviene
qualsiasi cosa causa ogni altra cosa
non crediamo nella natura umana
ci sono due modi di scendere dalla montagna
le circostanze determinano i nostri atti
l'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima
3
immaginiamo una strada con molta gente
un silenzio pieno di rumori
ciascuno di noi è il centro del mondo senza essere un io
ciò che conta è ciò che avviene
senza sapere quale sarà il risultato
è una maniera di aprirsi all'assenza di volontà
* Allusivamente organizzato in sestine (con preciso, benché “labile”, riferimento al metro
introdotto da Arnaut Daniel), questo testo, quasi un manifesto della poetica balestriniana,
riprende manipola sovrappone ricombina frammenti teorici di John Cage, per forza di un' “ars
combinatoria” puntata verso l' “indeterminato” e l'aperto. – Sul Balestrini “combinatorio”, v. “il
verri”, n.38, ottobre 2008, numero monografico Attività combinatorie – da partire dal “Tristano”
di Balestrini. Per quel che riguarda le collaborazioni con musicisti, da parte di Balestrini (a partire
da quella con Luigi Nono), v. Milleuna: parole per musica, prefazione di M.Gamba, Roma,
DeriveApprodi, 2007 (libro+cd).
4
non crediamo nella natura umana
il nulla è in tutte le cose quindi anche in me
ciò che conta è ciò che avviene
il mondo reale non è un oggetto è un processo
qualcosa che avviene qualcosa di inatteso di irrilevante
ci sono due modi di scendere dalla montagna
5
un modo è quello di cadere giù quando la state scalando
continuando a restare schiavi dell'azione e della logica
il significato è l'uso
il sentimento è in ciascuno di noi non nelle cause esterne
l'uso assicura il non ordine la libertà
la possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa
6
bisogna andarsene da qui
abitare il mondo intero non frammenti separati del mondo
il mondo reale non è un oggetto è un processo
qualsiasi cosa causa ogni altra cosa
le cose devono entrare in noi
l'istante è sempre una rinascita
7
le cose vanno e vengono
ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova
è soprattutto questione di cambiamento
l'indeterminazione è il salto nella non linearità e nell'abbondanza
ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente
poiché tutto già comunica perché voler comunicare
8
perché tutto possa accadere
mentre nella conversazione nulla si impone
non solo non lo voglio ma voglio distruggere il potere
princìpi e governi sono ciò che favorisce l'oblio
bisogna andarsene da qui
siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci
9
ci sono tante e tante cose che possono andare insieme
struttura e materiale possono essere legati oppure opporsi
quello che mi interessa non sono le regole ma il fatto che le regole cambino
il mondo non è diventa si muove cambia
le vecchie strutture del potere e del profitto stanno morendo
un modo è quello di cadere giù quando la state scalando
10
il nulla è in tutte le cose quindi anche in me
un silenzio pieno di rumori
qualcosa che avviene qualcosa di inatteso di irrilevante
incontri tra elementi eterogenei che possono restare senza alcun rapporto
ammucchiati tutti insieme e allo stesso tempo
un gioco senza scopo un'assenza di finalità
11
è l'uguaglianza del comportamento nei confronti di tutte le cose
costruire cioè riunire ciò che esiste allo stato disperso
immaginiamo una strada con molta gente
è un'opera su un'opera come tutte le mie opere indeterminate
io non ho niente da dire
comunicare è sempre imporre qualcosa
12
mentre nella conversazione nulla si impone
ciascuno è libero di provare le sue emozioni
l'uguaglianza dei sentimenti verso ogni cosa
lasciando alle cose la libertà di essere ciò che sono
le cose devono entrare in noi
l'istante è sempre una rinascita
13
struttura e materiale possono essere legati oppure opporsi
ammucchiati tutti insieme e allo stesso tempo
frantumare la loro linearità
perché tutto possa accadere
quello che mi interessa non sono le regole ma il fatto che le regole cambino
è soprattutto questione di cambiamento
14
costruire cioè riunire ciò che esiste allo stato disperso
senza sapere quale sarà il risultato
l'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima
un clima molto ricco di gioia e di smarrimento
le vecchie strutture del potere e del profitto stanno morendo
occorre liquidare il dogma produttivistico e del profitto
15
frantumare la loro linearità
lasciando alle cose la libertà di essere ciò che sono
la tirannia e la violenza sono dalla parte della linearità
comunicare è sempre imporre qualcosa
continuando a restare schiavi dell'azione e della logica
princìpi e governi sono ciò che favorisce l'oblio
16
non solo non lo voglio ma voglio distruggere il potere
occorre liquidare il dogma produttivistico e del profitto
respingere le esclusioni le alternative radicali tra opposti
sforzandosi di provocare un altissimo grado di disordine
un clima molto ricco di gioia e di smarrimento
siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci
17
la tirannia e la violenza sono dalla parte della linearità
l'indeterminazione è il salto nella non linearità e nell'abbondanza
non sopprimere le possibilità ma moltiplicarle
è una maniera di aprirsi all'assenza di volontà
le cose vanno e vengono
le circostanze determinano i nostri atti
18
cerco di non rifiutare mai nulla
ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente
sforzandosi di provocare un altissimo grado di disordine
l'uso assicura il non ordine la libertà
ciascuno è libero di provare le sue emozioni
il sentimento è in ciascuno di noi non nelle cause esterne
19
incontri tra elementi eterogenei che possono restare senza alcun rapporto
cerco di non rifiutare mai nulla
respingere le esclusioni le alternative radicali tra opposti
non sopprimere le possibilità ma moltiplicarle
la possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa
l'uguaglianza dei sentimenti verso ogni cosa
20
è un'opera su un'opera come tutte le mie opere indeterminate
un gioco senza scopo un'assenza di finalità
non ho nessuna idea di come tutto questo avviene
io non ho niente da dire
poiché tutto comunica già perché voler comunicare
il significato è l'uso
(in: Caosmogonia, Milano, Mondadori, 2010)
Le Milleuna
di Nanni Balestrini
Sai di
Salata
Saliva
Saltandola
Sangue dal
Sanguina
Saturata
Saziare
Scaldando le
Scambiandosi
Scende la
Schiuse le
Schiuma
Sciogliere
Scivola dentro
Scivola via
Scivolosa
Scoprire
Segnandola
Sei entrata
Sempre meno
Sempre più
Sensibile
Sentendo la
Sentendosi
Sente le
Senza forza
Senza le
Separandole
Se ti fa male
Se ti muove
Se respiri
Seta
Sete
Sfinendosi
Sfiorare
Sgusciando
Si appoggia sul
Si apre
Si arresta
Si chiude
Si contrae
Si curva
Si gira
Silenziose
Si riempie
Si schiude
Slacciata
Slargando
Smarrita
Smuove
Sobbalza
Soffice
Sognando
Soggiaci
Solletica
Sollevandola
Solo con
Solo nel
Soltanto
Sommersa
Sommessa
Sospesa al
Sospinta
Sospirando
Sospiri
Sottile
Sotto il peso
Sotto le mani
Sotto vibrando
Spaccata
Spalle in
Spasimare
Spingendo
Spinta verso
Sporgendola
Spossata
Spremendo
Staccatasi
Stanca
Standoci dentro
Stando ferma
Strappandola
Stremata
Stretta
Stringendo
Strisciare
Strizzando
Successiva
Succhiando
Sudate
Sugli occhi
Sulla pelle
Sul ventre
Supina
Svanire
Svegliandosi
Svelta nel
Svestita
Svuotata
[Pièce per danza di Valeria Magli, 1978, con musica/esecuzione di Demetrio Stratos]
Marzia D’Amico
«Valeria balla milleuna»
balestrini sciamano asemantico
per la trance vocale di Demetrio Stratos.1
Le cerimonie sciamaniche delle genti primitive, come testimoniato da diversi autorevoli studi di etnologia e antropologia poi ripresi da teorici della performance,2 erano al
contempo riti sociali ed eventi d’arte. Spesso banalizzati da
ambigue etichette magico-mistiche dovute ai rigidi parametri culturali occidentali, i riti cui è utile guardare oggi
per arrivare a una definizione puntuale dello spazio della
1
Questo lavoro consiste nella rielaborazione di un capitolo della mia tesi di Laurea Magistrale, discussa presso l’Università La Sapienza di Roma nel luglio del
2013. Ringrazio i miei relatori, Tommaso Pomilio e biancamaria Frabotta, per
la disponibilità con cui hanno guidato le mie ricerche. Per l’aiuto e la testimonianza che mi ha concesso intorno all’evento qui trattato ringrazio anche, di
cuore, nanni balestrini.
2
bisogna citare almeno il lavoro di Richard Schechner, tra i piú importanti teorici della performance contemporanei, e in particolare il suo studio actuals del
1970. nel saggio l’autore spiega alcuni fondamenti della teoria della performance attraverso l’analisi delle pratiche rituali della società nordaustraliana
Tiwi. il suo percorso teorico passa attraverso l’estetica di Platone e quella di
Aristotele. Cfr. R. Schechner, actuals: a look into performance eory, in A.
Cheuse – R. koffler (a cura di), e rare action: essays in Honour of Francis
Fergusson, Rutgers University Press, 1970, in particolare pp. 35-67 (trad. it. actuals: rituale primitivo e teorie della rappresentazione, in «La scrittura scenica»,
n. 7, a. 1973, pp. 32-68).
265
performance nel campo dell’estetica erano (e sono tuttora
presso alcune civiltà) composti dalla simultaneità di diverse
azioni poetiche che la figura centrale dell’avvenimento, lo
sciamano, doveva comporre con sapienza esatta3 o ripetere4
nel momento dell’esecuzione. La funzione di questa figura,
capace di raggiungere una sorta di ipotesto assoluto da cui
trarre i materiali da performare – il cosiddetto ‘tempo del
sogno’5 – come si raggiunge un luogo concreto, era quella
3
Pena il mancato riconoscimento del suo ruolo di guida spirituale e di voce poetica presso la comunità. in ogni caso, a riprova del carattere interattivo (e dunque autenticamente performativo) delle pratiche in questione, alcuni studi
dimostrano che il pubblico poteva intervenire per salvare il performer da una
perdita dei suoi doni dovuta a una cattiva esecuzione dei moduli colti nel dreamtime. A questo proposito vd. J. Rothenberg, technicians of the Sacred, Garden City, Doubleday, 1968, p. 385; e in particolare l’autorevole A. Lommel,
Shamanism: the Beginnings of art, new york, McGraw-Hill, 1967, p. 148. in
questo testo Lommel afferma che «the shaman’s social function consists above
all in bringing psychic calm and confidence to the tribal community by revitalizing
and intensifying its notions of the world» (p. 12), ma dal suo processo terapeutico scaturisce una creatività artistica i cui risultati sono effettivi prodotti artistici mai adeguatamente indagati dagli studi.
4
Giacché, come vedremo, le cerimonie erano costruite su una grammatica memorizzabile che prevedeva costitutivamente l’opportunità di riproporre i medesimi
‘testi’ con le uniche varianti dettate dalla natura stessa di ogni esecuzione performativa: reazioni, stato fisico dell’attuante, circostanze ambientali e simili.
5
il dreamtime è un concetto nato appunto negli studi etnoantropologici sulla
trance. Si fa largo uso del termine anche nei performance studies. Per un approfondimento vd. tra gli altri: F.A. Wolf, e dreaming universe: a mind-expanding journey into the realm where psyche and physics meet, new york, Simon &
Schuster, 1994; G. Gotti – D. Sandrini (a cura di), dreamtime: lo spirito dell’arte aborigena, Venezia, Marsilio, 2011. Curiosamente, il concetto potrebbe
risultare familiare a chi ne sente parlare per la prima volta in termini antropologici e nelle sue ripercussioni estetiche ricordando i vari e vivaci influssi che
ha avuto nella cultura popolare: da raffinati comics postmoderni e graphic novels
di Grant Morrison alla serie televisiva Star trek, in cui il mitico Capitano kirk
esce dalla nostra dimensione proprio per esplorare la realtà primordiale del dreamtime. La vicenda fantascientifica è testimoniata da una versione letteraria
della saga. M.W. bonanno, Star trek novel: Strangers om the Sky, Londra,
Titan books, 1987. Per Grant Morrison, il riferimento è alla serie di fumetti
degli anni novanta e invisibles. La fortuna pop del dreamtime è comunque
precedente: per esempio la band inglese e Cult, pubblicava già nel 1984 un
266
di apprendere canti e danze presso gli spiriti depositari della
memoria e di trasmetterne la conoscenza agli spettatori attraverso la ricomposizione di moduli voco-corporali. Tali
moduli corrispondono a quelle indicazioni fisse ma variamente declinabili che nelle arti agite si definiscono script6
(note di regia, nude descrizioni di azioni, prescrizioni su
tono, timbro, pronuncia di parole o suoni, etc.).
il ruolo dello sciamano dunque (e a specchio, in tutte le
sue successive forme autentiche, quello del performer) non
si limitava all’esecuzione di danze, canti, enunciati poetici
e azioni; comprendeva una fase creativa, una compositiva,
una puramente performativa e, non secondariamente, una
comunicativa a sua volta caratterizzata da alcuni elementi
fondamentali: interattività, trasmissione didattica, formulazione artistica ma universalmente comprensibile di contenuti ricevuti dal pubblico, conservazione della memoria
e accoglimento della responsabilità di fornire un modello
di contegno estetico-spirituale. Tale ruolo prevede dunque
una sorta di interessante deontologia, in parte sintetizzata
da un efficace passaggio schechneriano:
i viaggi dello sciamano non sono né fini a se stessi né
personali, dal momento che dovrà insegnare ad altri
tutto ciò che ha appreso. Svolge, insomma, una funzione
sociale. Lo sciamano è apprezzato dalla sua gente. È un
esempio e un modello per tutti quelli che vogliono acquistare potere. È l’uomo che sa e ricorda.7
album ispirato al misticismo aborigeno dal titolo, appunto, dreamtime. D’altro
canto è evidente come il ciclo di chtulu che ha reso celebre il romanziere H.P.
Lovecra e il suo terrificante personaggio sia basata su una simile mitologia.
6
«non li chiamo testi, che vuol dire documento scritto» dice il già citato Schechner a proposito di questi elementi minimi dell’arte performativa, «li chiamo
script che significa qualcosa che preesiste a qualunque esecuzione, che funziona
da traccia, che resta identica da un’esecuzione ad un’altra». R. Schechner,
dramma, script, teatro e performance [1973], in id., la teoria della performance,
a cura di V. Valentini, Roma, bulzoni, 1984, pp. 77-111: 79.
7
R. Schechner, actuals: uno sguardo alla teoria della performance [1970], in id.,
la teoria della performance, cit., pp. 39-76: 47.
267
Tutti gli studi che convergono sulle azioni considerabili
arte e sugli attuanti considerabili poeti analizzano dunque
gli elementi che, con le loro variazioni difficilmente prevedibili, possono in molti modi influenzare la resa del prodotto finale che considereremo senza specificazioni ulteriori
un testo. Tale testo è infatti il risultato, oltre che della composizione degli script attinti nel corso della fase creativa iniziale, della «interazione fra spazio, tempo, performer, azioni
e pubblico»8. È importante aggiungere a tali elementi un
pesante aspetto che li permea tutti, essendo costituito sia
da una componente materiale embodied sia dal suo statuto
di medium comunicativo: la voce. nonostante le distanze
geografiche e culturali di diverse tribú, gli script prettamente
vocali si manifestano sempre riconoscibili: assieme agli altri
compongono quei canovacci virtuali che, come abbiamo
visto, presiedono non solo alle singole performance ma anche
alle loro eventuali ripetizioni identiche o ristrutturate.
Sono dunque parte delle posture psicofisiche che portano
allo stato di trance, come il resto descritto negli studi sui
riti aborigeni e riscontrato in quelli teatrali e piú in generale
di performance theory – nei quali in sostanza coincide con
la fase creativa di secondo grado, che segue alla composizione iniziale piú sopra collegata al viaggio nel dreamtime
degli sciamani.9
Quanto fin qui rapidamente sintetizzato porta ad alcune
conclusioni provvisorie sulla performance in genere: si tratta
di una forma d’arte di matrice rituale in cui un ipotesto indicativo presiede all’esecuzione di molteplici testi autonomi,
tutti definitivi nel qui e ora esperito da chi li riceve (il pub8
R. Schechner, actuals: uno sguardo alla teoria della performance [1970], in id.,
la teoria della performance, cit., p. 72.
9
Particolarmente utili per intuire la fisionomia della trance sono gli studi condotti in bali da belo. Cfr. J. belo, trance in Bali, new york, Columbia University Press, 1960.
268
blico) ma al contempo passibili di modifiche anche sostanziali
in successive, altrettanto originali e autentiche ripetizioni
che ne condividono gli script ma non lo spazio e il tempo di
attuazione. Adagiando un simile punto di partenza analitico
come una coperta sull’inafferrabile statuto di quella che nel
secondo novecento è stata definita poesia performativa, possiamo cominciare a intravederne un profilo definito.
L’esecuzione (e non la semplice lettura) di un testo poetico infatti dà origine, secondo gli stessi principi, a una vera
e propria performance. Considerando il singolo momento
di ‘scrittura’ primigenio alla stregua della fase creativa del
dreamtime (dunque a una raccolta di indicazioni e non alla
nuda stesura del testo) e le successive attuazioni come eventi
in cui gli script prendono le loro molteplici e tutte definitive
forme (facendosi loro stesse testi), ci troviamo ad avere a
che fare con un genere letterario in cui ad ogni qui e ora
corrisponde una nuova poesia e in cui perciò l’analisi dei
singoli avvenimenti non può prescindere dalle variabili che
abbiamo già elencato (interazione, moduli virtuali a monte,
traiettorie della voce e cosí via).
il medium performativo in qualche modo supera l’esperienza classica della poesia come «testo da vedere»,10 rendendola non solo ovviamente multimediale (il corpo dell’attuante si vede, la sua voce si sente, nello spazio in cui
opera ci sono odori etc.) ma valicando anche altri limiti
imposti dalla codice gutenberghiano. il testo da vedere della
stampa tradizionale è stabile, immutabile e, rispetto alla
trasmissione orale, gode di un maggiore prestigio che mette
in cattiva luce gli stilemi dell’oralità, che assumono un’apparenza primitiva rispetto al progresso che ha portato alla
scrittura – quando sarebbero invece semplicemente il ri10
P. bootz, poetic machinations in new media poetry: poetic innovations and
new technologies, Visible language 30.2, Rhode island School of Design, Chicago, 1966, pp. 118-137.
269
sultato di una diversa linea evolutiva11. Rispetto all’immutabilità del testo stampato e della sua diffusione, il testo
della performance è sempre variabile: ogni volta si assiste a
una delle potenzialmente infinite espressioni possibili. Anche gli imprevisti, che in manoscritti ed edizioni costituiscono guasti ed errori, possono essere interpolati felicemente
al testo: il classico «‘buco di memoria’» ad esempio, «il
‘vuoto’, è nell’esecuzione non tanto un incidente quanto
un episodio creatore» come efficacemente spiega Paul
Zumthor12. Esiste dunque una differenza sostanziale tra
testi lineari semplicemente letti ad alta voce e testi performativi, che contengono già al loro interno la tensione all’esecuzione. A spiegarlo in maniera semplice ed elegante è
il filosofo Hans-Georg Gadamer, che ritiene «esserci una
certa differenza tra il fatto che un testo viene scritto per essere recitato, ed il fatto che un testo debba essere letto da
un foglio; tra il fatto che un testo debba essere recitato, e
sia stato scritto per questo, oppure che, come è diventato
sempre piú consueto nella nostra cultura, si calcoli di avere
a che fare solo con la lettura muta»13.
il caso che vorrei prendere qui in esame è abbastanza
particolare sia per i soggetti che lo costituiscono, sia per la
tecnica compositiva che presenta. La poesia, un lavoro di
nanni balestrini, viene infatti performata (e registrata per
uso successivo) da una voce ulteriore, quella di Demetrio
Stratos, che come vedremo si appropria del testo e ci offre
un esempio lampante di come l’esecuzione sia generatrice
efficace di un nuovo testo, anzi, dell’unico vero testo. in
sostanza tra gli aspetti piú interessanti del lavoro analizzato
11
Su questi argomenti restano fondamentali gli studi di Paul Zumthor e Walter
Ong. Cfr. almeno P. Zumthor, la presenza della voce, bologna, il Mulino,
1984; e W. Ong, oralità e Scrittura, bologna, il Mulino, 1986.
12
P. Zumthor, la presenza della voce, cit., p. 279.
13
H.G. Gadamer, persuasività della letteratura, Ancona, Transeuropa, 1988, p.
31.
270
in queste pagine c’è la netta distinguibilità delle diverse
fasi creative di cui abbiamo appena trattato: l’ipotesto di
script linguistici (anche se, come vedremo, peculiarmente
dissociati da ogni codice) è raccolto dal poeta, che affida
l’invenzione di quelli vocali e agiti a due diversi soggetti
che a loro volta li performano, separatamente. intervengono
per di piú due forme di dilazione dei qui e ora sovrapposti:
l’ipotesto è registrato su carta, l’esecuzione degli script
vocali è registrata su nastro e le azioni sono danzate dal
vivo nel corso di una riproduzione dei precedenti.
La scrittura asemantica di nanni balestrini prevede di
per sé una tensione musicale e sonora già avvertibile nel
corso di una lettura muta. Una simile predisposizione alle
«esperienze sonore, [a]i modi di organizzare i suoni, di inventare insiemi di suoni»14 non può che sposarsi con la ricerca vocorale di Demetrio Stratos, che come vedremo ha
lavorato a sua volta sull’espressività pregrammaticale raggiungibile dalle pure «foníe».
Quella di Demetrio Stratos è una vicenda davvero singolare e, nell’ambito dei percorsi della voce nell’arte performativa, addirittura unica. nato ad Alessandria d’Egitto come
Marinetti e Ungaretti, cresciuto ad Atene e lí formatosi come
musicista, si trasferí in italia nei primi anni Sessanta meno
che ventenne a seguito del colpo di stato di nasser. Divenne
famoso come cantante rock e beat, dapprima con “i Ribelli”
(particolarmente celebri il brano pugni chiusi del 1967 e la
cover di oh darling! dei beatles tradotta in italiano) e poi
con gli “Area”, un gruppo di virtuosi musicisti progressive e
fusion che destò l’attenzione non solo del pubblico ma anche
di raffinati musicologi. non a caso alle soglie degli anni Ottanta Stratos fu invitato da Jasper Jones a new york, dove
collaborò con John Cage e Andy Warhol alla performance
14
M. Gamba, Prefazione, in n. balestrini, milleuna parole per musica, Roma,
Deriveapprodi, 2007, p. 7.
271
musicale e coreutica event. Proprio a new york tuttavia,
ammalatosi gravissimamente forse a causa di una bizzarra
condotta farmacologica (per anni, su discutibile consiglio di
un medico, prese ininterrottamente un antibiotico al giorno),
morí a soli 37 anni nel 1979.15
negli ultimi anni della sua vita, l’artista condusse una
sorprendente ricerca sperimentale sulla propria voce, che
divenne capace di suoni quasi impossibili, addirittura studiati scientificamente da esperti di acustica come Franco
Ferrero, Lucio Croatto e Andrea Accardi. Gli studiosi
hanno concluso, descrivendo elettroacusticamente le emissioni di Stratos, che durante alcuni vocalizzi l’artista riusciva
ad emettere dei fischi distinti a diverse frequenze, tutte attestate oltre le capacità della vibrazione delle corde vocali.16
La ricerca di Stratos comunque non è riducibile alla dimensione piú “atleticamente” performativa: egli sfruttava
la sua sola voce per registrare vere e proprie musiche astratte
composte da suoni diversi ma eseguiti in contemporanea.
Lui stesso li chiamava “flautofonie”, “diplofonie” e “triplofonie”. Gli ultimi due termini costituiscono il titolo di un
suo celebre pezzo, in cui è sintetizzato gran parte del portato
dei suoi esperimenti. Oltre a poterla ascoltare nelle registrazioni Cramps,17 l’opera è stata anche scritta sulla pagina
dall’artista in diverse forme, una delle quali pubblicata postuma nel raro fascicolo d’arte codice Biancaneve interna15
Le informazioni bibliografiche qui sintetizzate sono desunte da J. Haouli, demetrio Stratos. alla ricerca della voce-musica, Milano, Cramps-Auditorium,
2009. La monografia – che contiene un utile compendio dei piú estremi esperimenti vocali di Stratos in CD – è anche stata utile per reperire i riferimenti
bibliografici per gli studi scientifici piú avanti menzionati e citati.
16
Cfr. E. Ferrero – L. Croatto – M. Accardi, descrizione elettroacustica di alcuni
tipi di vocalizzo di demetrio Stratos, in «Rivista italiana di Acustica», n. 4,
1980, pp. 229-258. L’articolo è corredato da grafici e schemi illustrativi.
17
Oltre che nel CD dell’etichetta Cramps inserito nella monografia poco sopra
citata, il pezzo è pubblicato – nella versione sottotitolata investigazioni – su
youtube <http://youtu.be/D9p7iMTzCf0>.
272
tional curato da Dario Villa e Franco beltrametti.18 in essa,
efficacemente sintetica del tipico lavoro à la Stratos, il cantante emette una lunga nota vibrata su cui, con ritmo variabile, esplodono dei brevi suoni simili a pizzicati o a note
di xilofono. La nota usata come basso continuo riparte ogni
volta che finisce il fiato e progressivamente sale, finché non
raggiunge un culmine in cui, inspiegabilmente, si sdoppia
in due note: una piena e una piú sottile, simile a una vibrazione acuta di cristallo o all’onda di uno strumento elettronico. Le note “schioccate” come di xilofono si diradano e
la voce, in chiusura, perde ogni connotato umano, diventando un ruggito simile a un’interferenza.
il percorso è ben rappresentato nella sinteticissima immagine su codice Biancaneve nella quale, su un breve pentagramma, è indicato un do semibreve definito «voce vettoriale» e seguito dai segni del vibrato che ascendono fino
a un si disegnato come una semibreve nera duplicata in un
re “fantasma”, segnato con un tratteggio (si tratta, credo,
della terza voce che interviene raggiunto il culmine ascensionale). Di lí la situazione si complica e l’autore segnala la
18
D. Stratos, diplofonie, triplofonie, in «Codice biancaneve international», n.
0, 1992, p. 32.
273
«rottura del percorso comunicativo», rappresentato da
una discesa delle linee del vibrato e da un gruppo di “semibrevi piene”: prima l’accordo sol diesis-do, poi un si bemolle,
poi un la, tutti legati a una pausa finale puntata e diramati
da un segno. nella «rottura» assistiamo a un passaggio
dalla voce ancora umana – per quanto ai limiti del possibile
– a una voce letteralmente sovrumana, e dunque a un eccezionale superamento del significante sul significato: non
solo l’opera parte già dall’assenza di codice linguistico, ma
arriva persino a superare con la voce il suono della voce
stessa, attestandosi a un livello di asemantico lirismo assoluto. non a caso la «triplofonia» somiglia alle trifonie
della musica tradizionale mongola, una tecnica che rende i
cantori capaci di emettere tre suoni armonici nel corso di
canti spirituali di trascendenza.
Per l’occasione d’incontro con lo sciamano balestrini,
avvenuta alla fine degli anni Settanta, questo attuante oltreumano permette al testo affidatogli dal poeta di concretizzare foneticamente le sue caratteristiche stilistiche. Voce
narrante di una vicenda scivolante in esse (cosí è costruito
milleuna, il componimento qui in esame) Stratos, forse
non a caso anche lui chiuso onomasticamente tra sibilanti,
raggira quasi con ironia la versificazione pensata dall’autore
e, con le corde vocali, dà forma – seppure immateriale – al
significante d’inchiostro sulle pagine, densificandone il significato con la dizione.
il bagaglio di multiforme esperienza di utilizzo della voce
come strumento a diversi livelli permette al performer di
vivificare la sonorità intrinseca di cui abbiamo parlato a
proposito della scrittura balestriniana attraverso esperimenti
di lettura inizialmente improvvisati e poi cristallizzati come
script. Secondo la testimonianza diretta dell’autore, con cui
ho avuto occasione di conversare in merito alla collaborazione con Stratos, nella performance finale il repertorio di
274
toni e timbri è stato gestito «come una tastiera»19. nello
studio di registrazione Stratos, a memoria di balestrini, ha
letto dieci volte l’ipotesto lineare tentando ogni volta diversi
possibili script vocali da applicarvi.
Come anticipato, la registrazione su nastro dei cento
ipo-versi per dieci volte consecutive – il titolo milleuna ne
consegue aritmeticamente – venne utilizzata da una ulteriore
performer, Valeria Magli, per una ulteriore improvvisazione,
questa volta però agita col corpo e messa in scena senza registrazioni al Teatro Out\Off di Milano nel 1978. Quell’una
che si aggiunge alle mille, per inciso, mi pare indicare proprio
la ‘milleunesima’ esecuzione dei versi, quella completa anche
di danza che in fondo – nella sua unica versione avvenuta
in un qui e ora ormai perduto – rappresenta il solo vero
testo in questione.
Su un palco che il poeta ricorda come «un ring di
box», mentre il nastro recitava di seguito le attuazioni
sonore del componimento, Magli eseguiva – con l’aiuto
di diversi oggetti, quali ad esempio «un ombrello, delle
ali, una bombetta» – i propri movimenti scenici appaiando agli script linguistici, a loro volta legati a script sonori,
una terza serie di script visivi. La fotografia scenifca si basava su un effetto di buio intermittente, costruito come
in una sala di discoteca, che offriva al pubblico – numeroso
– che prese parte all’evento una straniante percezione di
continue immagini fisse, proprio come avviene in ambienti
stroboscopici. Magli agiva liberamente e dinamicamente
sul palco, ma la luce le regalava una multiforme composta
immobilità, una serie di scatti continuamente interrotti
mentre la sonorità del testo procedeva senza alcuna interruzione nella scioltissima dizione di Stratos. L’impressione
19
Da qui in poi le citazioni tra virgolette caporali prive di diversi riferimenti
sono da considerarsi tratte dalla conversazione avuta con nanni balestrini da
chi scrive nell’agosto del 2013.
275
finale doveva essere quella di una sorta di galleria fotografica proiettata sul basso continuo delle parole asemantiche, rese significative dalla prosodia.
Possiamo in parte ricostruire l’«occasione» storica che
mise in moto tutto. Mino bertoldo, allora come oggi direttore del teatro, aveva progettato una serie di spettacoli e
performance a tema erotico e aveva invitato balestrini ad
aderire. balestrini scrisse allora milleuna già pensando a
Magli (il sottotitolo dell’ipotesto è d’altronde esplicitamente pièce per danza di Valeria magli), e pensò poi che
per fare agire i versi fosse necessario che le parole, tutte in
‘s’ e raccolte in fila come moduli svuotati del loro senso originario, venissero riempite (o meglio, colorate) con il senso
assoluto e primigenio, slegato dalla necessità di contesti logici, che solo una spiccata intelligenza vocale può dare attraverso la morfologia prosodica. Coinvolse dunque Stratos,
e l’intera operazione – oltre naturalmente a rappresentare
un singolare esempio di commistione tra poesia, performance
orale e performance coreutico-teatrale – ha finito per costituire l’unico indizio oggi rintracciabile del lavoro che il
poeta e il vocalista avrebbero voluto compiere ma che la
prematura morte di Stratos ha impedito. balestrini dichiara
ancora oggi infatti che avrebbe voluto collaborare di nuovo
e piú a lungo con il cantante sebbene, fuori da milleuna
(che d’altronde è solo uno dei numerosi duetti a cui il ‘novissimo’ ha partecipato con vocalisti e attori), non ci siano
altre tracce dell’intenso sodalizio artistico che i due intendevano intrecciare. Ma torniamo all’analisi.
Se diversi dei vocaboli in esse – forse proprio il ‘microincipit’ di ogni verso è l’insistito riferimento al sesso richiesto
dal tema del ciclo ideato da bertoldo – che si susseguono
sulla pagina mantengono un’oscillazione di significato, la
lettura offerta da Stratos prende una direzione e la fissa. il
testo, sulla pagina,20 è costituito da venticinque quartine di
276
versi brevissimi, tendenzialmente di una o due parole, ed è
quasi un tautogramma visto che ognuno dei cento versi comincia appunto – lo ripeto un’ultima volta – in ‘s’. Alla maniera di balestrini, il cui stile è caratterizzato dal collage di
brani di linguaggio estratti dalla realtà e giustapposti con
tagli e montaggi, formule comunissime vengono mutilate
(«sai di»; «sangue dal»; «sempre piú»; «spalle in»; «si
appoggia sul»; «svuota la»; etc.) e presentate come crudo
significante vicino a diversi aggettivi al femminile («soffice»;
«sommessa»; «stretta»; «supina»; «salata»; etc.), pochi
nomi («schiuma»; «seta») e verbi variamente coniugati
(«succhiando»; «svanire»; «saturata»; «sente»; «si
apre»; «sei entrata»; etc.). L’esecuzione di Stratos come
anticipato va in questo senso. Con la voce, il performer fa
davvero agire le parole, rappresentandole foneticamente: «saliva» ad esempio è pronunciato deglutendo, «saltandola»
con improvvisa allegria e insistendo sullo schiocco della dentale, la parola «schiuma» ribolle nella bocca e quando sono
emesse locuzioni come «se respiri» o «sei entrata» l’esecutore inspira l’aria creando un suono d’inghiottimento. Gli
script vocali sono anche molto articolati e allusivi: «sensibile»
è pronunciato con l’apparato fonatorio abbandonato, come
quando si tenta di parlare dopo aver subito un’anestesia dal
dentista, in riferimento alla perdita di sensibilità che si ha
quando si addormenta la bocca; le pronunce di «si curva»
e «si gira», invece, imitano l’“effetto doppler” che si perce20
Composto quasi certamente per l’occasione, è raccolto sotto il titolo ahimé
lontana la signorina richmond sogna Valeria che balla milleuna al XXV canto
del “Secondo Libro” (la signorina richmond se ne va) di le avventure complete
della signorina richmond. Questa versione è tuttavia graficamente rimodellata
per somigliare a una danza già sulla pagina: le parole sono smembrate e i moduli sono sistemati sulla linea del verso anche in disordine, con spesso in evidenza sulla coda (nella posizione in cui dovrebbe esserci il rimante) le ‘s’ ‘sch’
‘sc’ etc. che costituiscono la trama allitterante del testi. Cfr. n. balestrini, le
avventure complete della signorina richmond seguite dal pubblico del labirinto,
introduzione di O. Del buono, Torino, Testo&immagine, 1999, pp. 90-92.
277
pirebbe se chi emette la voce si muovesse rapidamente in
tondo attorno all’ascoltatore. Si creano, in linea con la suddivisione in quartine, dei gruppi strofici in cui i versi agiscono
in concerto: nel distico «sangue dal | sanguinosa» le tre ‘s’
sono pronunciate in modi diversi in una progressione dal sonoro al sordo; la sequenza «spasimare | spingendo | spinta
verso | sporgendola || spossata | spremendo | staccatasi |
stanca» viene pronunciata con sforzo e costrizione sempre
maggiori, acuendo il tono, finché l’ultimo verso non disinnesca improvvisamente la climax in un crollo vertiginoso, allentando di colpo la tensione in accordo col significato.
in maniera interessante Stratos non tenta mai di leggere
logicamente o di legare i versi in possibili strutture sensate:
quando ha a che fare con strutture mutile le interpreta indugiando, come se non gli venisse la parola mancante, anche
quando quella parola potrebbe essere il verso successivo.
Cosí i primi versi non diventano “sai di salata saliva”, ma si
attribuisce uno script diverso a ogni modulo: «sai di» pronunciato con indecisione e allungato in un mugolio pensieroso, «salata» pronunciato con le labbra allappate e
«saliva» – l’ho già detto – deglutendo.
in pratica, significativamente, Stratos riscrive foneticamente il testo di balestrini: non lo interpreta, non scorcia le
sue possibilità di lettura e non ci chiede di aderire alle proprie
conclusioni. La poesia è transcodificata e riofferta a chi
ascolta nello stesso grado di indeterminatezza e nudità semantica che aveva nella pagina. Ecco confermati i parallelismi
con gli elementi della performance tribale visti all’inizio.
Un altro dettaglio interessante è costituito dal fatto che,
nell’esecuzione registrata, il performer ripete piú volte l’intero poema. Ciò è significativo perché, pur non riuscendo
a eseguire una performance esattamente identica, Stratos
riusa pedissequamente la stessa sequenza di script. Le azioni
vocali (sostituzioni dell’espirazione con l’inspirazione, pro278
nuncia particolare delle ‘s’, cambi di tono, linee della prosodia, versi, vibrazioni allungate etc.) si ripetono nel medesimo
ordine associandosi alle medesime parole e chi ascolta può
facilmente accorgersene con la propria memoria uditiva.
Ecco dunque che all’ipotesto verbale si associa un ipotesto
prosodico e solo dall’esecuzione simultanea dei due si ottiene quella porzione di testo definitivo su cui, in ultimo, si
innesta l’ipotesto poi agito da Magli.
È interessante notare come la variante testuale proposta
da Stratos non venga accolta nella riscrittura del componimento che balestrini ha operato in occasione della pubblicazione de le avventure complete della signorina richmond,
raccolta che vede milleuna tornare muta sulla pagina con
un nostalgico titolo (ahimé lontana la signorina richmond
sogna Valeria che balla milleuna) secondo una nuova disposizione nel layout. Confrontando le due versioni salta subito
all’occhio come, pur secondo uno schema e un assetto scelti
di proprio pugno, la variazione offerta sulla pagina – posteriore alla versione performata da Stratos – acquisti una mobilità e una varietà di distribuzione dei caratteri che la trasforma radicalmente. il pubblico, questa volta composto da
lettori, si trova di nuovo, ma solo mentalmente, ad interagire
col testo. il titolo, in primo luogo, rimanda a un’esperienza
a cui si potrebbe aver preso parte o comunque offre gli elementi necessari per una ricerca (anche rapida e svogliata nel
web) che risolva l’enigma memoriale nascosto: l’avvenimento
performativo rammemorato dal riferimento alla danza di
Magli. in secondo luogo l’irregolarità dell’ordine dei vocaboli, distribuiti nello spazio bianco della carta, obbliga a
uno sforzo di attenzione e di ricomposizione attiva delle
possibili linearità presenti simultaneamente sulla pagina.
Una volta di piú si manifesta quella predisiposizione all’azione che rende certa poesia balestriniana – in questo
caso addirittura, nella raccolta finale, performata tipografi279
camente – costitutivamente diversa da quella muta, buona
al limite per letture ad alta voce.
Certamente piú vivace e coinvolgente visivamente, secondo questa nuova disposizione il componimento torna
dunque sulla pagina con nuovi connotati di performatività,
come testo nuovo e carico di aspettative nei confronti di
chi legge (a cui si richiede un impegno che l’arte di balestrini
ha sempre manifestato e preteso, sotto ogni punto di vista).
La poesia vocalizzata da Stratos e danzata da Magli sfida
ancora oggi, anni dopo la sua unica manifestazione come
testo completo, le possibilità combinatorie e interpretative
richiamando un pubblico solitamente silenzioso e passivo,
quello dei lettori, a un corpo a corpo ingaggiato al limite
della classificazione come semplice poesia. Quello che la
scrittura di balestrini, di per sé peculiare in questo senso,
eredita dall’esperienza subita al Teatro Out/Off è l’esasperazione della necessità della partecipazione degli altri a
quell’azione, altrimenti insopportabilmente solitaria, che
è la letteratura.
in "Smerilliana 16" (2014),
a c. di E. D'Angelo e T.Ottonieri
280
ALBERTO ARBASINO
Luca Scarlini
Lirica
Arbasino ha con il melodramma una dimestichezza che si radica nella sua
infanzia e che lo ha visto coinvolto a livelli diversi, ma sempre con grande capacità
di intervento, di volta in volta come narratore, critico, regista (in un unico caso: la
celeberrima, contestatissima Carmen strutturalista realizzata a Bologna nel 1967)
e anche come librettista sui generis. E come se il teatro in musica fosse stato lo
specchio di tutta la definizione del suo universo espressivo, instabile,
perennemente in bilico tra narrazione e riflessione saggistica, appassionato di
scatole cinesi e cortocircuiti arte-vita, che ha trovato in alcune occasioni proprio
nell’opera il proprio punto di riferimento centrale. Lo scrittore lombardo è quindi
in primis il diarista di una riscoperta che lui stesso ha paragonato per impatto a
quella dei primitivi per i Preraffaeliti: uno shock culturale profondo, che ha
cambiato il destino estetico di una generazione. Così infatti scriveva a margine di
una Sonnambula del Covent Garden: «la novità di questi anni è stata invece la
riscoperta del melodramma del primo Ottocento proprio sul piano del gusto,
preparata da Gui e Rossini a Glyndebourne ed esplosa con un trasporto pari alle
eiaculazioni di tre generazioni fa per la pittura antecedente a Raffaello» 1.
L’affermazione si riferiva alla situazione britannica, ma vale anche per l’analogo
fenomeno italiano di poco precedente, che lo scrittore ha precocemente
individuato e raccontato e di cui prima di lui era stato solitario profeta Bruno
Barilli, spesso citato nelle sue pagine, che esaltava controcorrente la «musica
vermiglia» del Trovatore2. In questo sono già esplicite le pagine dei racconti che
compongono l’opera prima Le piccole vacanze, in cui i protagonisti parlano del
Maggio Musicale Fiorentino e della Giuditta di Vivaldi 3, oppure di Gian Carlo
Menotti e Leonard Bernstein4 e quelle davvero magnifiche e degne di riesame, de
La narcisata, frenetica cavalcata fonetica nel jet-set romano e vera e propria
caccia al flatus vocis gergale come mezzo di rappresentazione del reale, in cui i vari
personaggi alludono freneticamente al melodramma come loro primo punto di
riferimento linguistico. Il lavoro (il cui titolo era stato suggerito da Pasolini)
prende un ironico andamento melodrammatico già dal sottotitolo: Una notte del
demi-monde e in seguito le citazioni davvero si sprecano. Si fa accenno a
immaginari bozzetti di Léger e Dubuffet rispettivamente per II Flauto magico e
Aida5, secondo il gusto inventato dal Maggio Musicale Fiorentino negli anni
Trenta e ancora in voga al tempo, di abbinamenti tra pittori di grido e titoli
classici, oppure, in seguito, la nobildonna Ferri Fazzi viene segnata da una
passione per i trittici (ne possiede uno di Simone Martini, ma anche non si separa
mai da una confezione dello stesso nome delle celebri calze Mille Aghi) e quindi
non può che tornare per assonanza ritmica e tematica, che da una
1 Alberto Arbasino, Grazie per le magnifiche rose, Feltrinelli, Milano 1965, p. 91.
2 Bruno Barilli, Il paese del melodramma, Adelphi, Milano 1999, p. 18; tra le numerose
citazioni da libri di Barilli reperibili nelle opere di Alberto Arbasino, si veda tra l’altro
Grazie per le magnifiche rose, cit., p. 398 e p. 468.
3 A.A., Luglio, Cannes, in Le piccole vacanze, Einaudi, Torino 19712, pp. 181-206.
4 A.A., Racconto di Capodanno, ivi, pp. 243-254: p. 253.
5 A.A., La narcisata, Einaudi, Torino 1973, p. 14.
rappresentazione all’Opera del Trittico pucciniano6. Ma il gioco delle tracce
moltiplica e divide; i riferimenti sono davvero troppi per tentare di categorizzarli e
vai meglio un percorso obliquo che il rischio di una catalogazione astratta.
Fatto fondamentale della sua opera è indubbiamente l’incontro con la
Callas, ascoltata precocemente in memorabili serate milanesi dei primi anni
Cinquanta e poi inseguita intorno al globo. Come ognun sa, la totalità delle
citazioni della cantante nelle opere di Arbasino (inclusi gli scritti di occasione e
d’elzeviro, spesso nostalgici e dolciastri, degli ultimi anni) andrebbe a costituire di
per sé un libro a parte, ma è soprattutto in un caso che il nesso diviene centrale.
L’Anonimo lombardo ha, nel riepilogo dei valori novecenteschi che stenta ancora a
decollare seriamente al di fuori delle consuete polemiche salottiere che il 2000 ha
innescato con precisione dinamitarda, il peso e la grazia a un tempo di un’opera
necessaria, in cui il meccanismo strettissimo di relazione tra il melodramma e la
trama fitta delle storie mixa magistralmente immagini e fantasmi ottonovecenteschi. Nel libro ci sono pagine categoriche nel descrivere una serie di
emozioni davvero soverchiami e che non possono che essere preliminari ai
turbamenti dell’eros. In tal senso è davvero memorabile il brano iniziale che narra
il sorgere di una attrazione sulle note della Medea di Cherubini da cui varrà la
pena di citare uno dei passi più riusciti e noti: «mi accorgevo appena che la Callas
ormai entrata spiegava il suo canto che non potevo cogliere se non nei soliti
termini di “arcano”, di “misterioso”, di “sortilegio” e minuti e minuti passavano
senza che i miei occhi riuscissero a lasciare i suoi al suono di una marcia
trionfante, non sapevo se esultare o tremare, sfilava l’esercito portatore del vello
d’oro e lui mi faceva cenno che non lo fissassi così ma le mani a un certo punto
cominciano a cercarsi, anche se uno non ha mai letto Pompes Funèbres che ha la
stessa trama della Norma»7. E poi in seguito ancora più categoricamente: «è per
merito di registi o scenografi già ammirati per lavori fatti al cinema o in prosa, o la
fama di qualche cantante celebre di cui si son sentiti ottimi dischi... ecco, ci si trova
attirati alla Scala, una sera tutt’altro che impegnativa perché ci si va con
l’intenzione di venire via appena ci si stufa. Ci sono rimasto e ci siamo tornati; ed è
tutta una generazione ventenne che ha preso questa strada ignota ai padri e agli
zii: i gruppi “avanzati” si lasciavano prendere dai melodrammi dati con gusto e con
spirito, e loro hanno aperto la via a quelli che andavano ancora alla rivista, e si
appassionavano alle figure delle “Divine” con un vero culto della personalità e in
questo senso la Callas è erede naturale della Osiris» 8. E in varie recensioni negli
anni seguenti: «delirante, sconvolgente, la figlia di Minosse arde di
espressionistiche violenze provando che la sua condizione naturale è il gruppo del
Laocoonte, dell’Eracle furente, è l’eccesso»9, oppure affermando con orgoglio i
congegni del suo gran meccanismo narrativo: «e una volta di più mi congratulo
per aver legato tanti anni fa coi nessi maniaci dell’Anonimo lombardo un congegno
di Romanzo sul Romanzo travestito da romance di Amore-che-non-osa-dire-ilproprio-nome all’intero viluppo melodramma-Medea-Callas, anche parecchi anni
prima delle srììanie operistiche della frangia scadente della nostra café society
letteraria»10. Ed è testimonianza diretta e di grande potenza di un continuo
movimento stilistico che nel palcoscenico melodrammatico trova il proprio
specchio più efficace.
Sulla stessa linea, ma con ancor maggiore forza, sta ovviamente Fratelli
6 Ivi, p. 61.
7 A.A., L’Anonimo lombardo, Feltrinelli, Milano 1959, pp. 20-21.
8 Ivi, pp. 109-110.
9 A.A., Grazie per le magnifiche rose, cit., p. 94.
10 Ivi, p. 196.
d’Italia, dove l’opera lirica è davvero onnicomprensiva e fagocita il libro in un
unico, continuo, rimando. La sgangherata gang itinerante di amici gay che
chiacchierano in continuazione e riducono la storia appunto a conversazione,
come in una squisita conversation piece debordata nell’assoluto, non fanno altro
che vedere opera, sentire opera, amare opera (e per sovrammercato percepire il
mondo sub specie operistica). Il melodramma è davvero quindi il termine di
paragone delle loro esistenze e non per caso il romanzo si apre di nuovo con la
Callas, che tutti insieme hanno deciso di andare a vedere in Grecia per cedere poi
rapidamente il posto alla Sutherland (che Arbasino definì altrove «la vittoriana» 11
evidenziandone efficacemente le peculiarità e le differenze rispetto al modello
callasiano) in scena a Napoli per una belliniana Beatrice di Tenda. Ma la musica è
davvero ovunque: «il grammofono va continuamente nella casa. Opere, quasi
sempre, le più romantiche di tutte, o musicals degli anni scorsi a Londra» 12 e in
seguito diventa così pervasiva da essere davvero il linguaggio più normale di
espressione e da offrire il destro a giochi, allusioni e addirittura quiz. «Mai sentire
un disco per più di mezzo minuto: a pochi centimetri per volta. Sempre lì con la
puntina sui solchi, avanti e indietro, come un aratro, per cascar giusto su una frase
o su un accordo: rovinandoli, si capisce» 13. E il repertorio si estende e diffonde
davvero a macchia d’olio, parlando di titoli nuovi (Klaus, il compositore tedesco
che parla del suo nuovo lavoro, rimanda in parte a Hans Werner Henze, che al
tempo in cui si ambienta la narrazione, era in scena a Spoleto con cospicuo
successo con il bel melodramma neoromantico Die Prinz von Homburg) e
vedendone di antiche e moderne in un continuo percorso on the road tra città e
amicizie. E ovvio che il gran romanzo, di cui recentemente Adelphi ha mandato in
libreria la versione definitiva (salvo ulteriori interventi), trovi un clamoroso
controcanto proprio nelle pagine di Grazie per le magnifiche rose, regesto sommo
degli scritti spettacolari edito nel 1965, da troppi anni assente dal mercato e di cui
è auspicabile una ristampa con cospicui apparati. Si tratta di uno specchio, doppio,
in cui le pagine vanno e vengono, acquisendo via via definizione saggistica o
narrativa, com’è evidente ad esempio per il capitolo Palais de danse con le
recensioni dedicate al Festival di Spoleto vicinissime a quelle consacrate al festival
nei Fratelli d’Italia14, ma soprattutto è evidente per quello che resta l’episodio più
strepitoso di osmosi tra le due opere, che dà occasione a un vero e proprio
manifesto estetico. L’argomento è un Trovatore estivo all’Opera di Roma (una
vera e propria spedizione punitiva), che offre il destro a una presa di posizione,
ribadita con lievi differenze nei due volumi. Scrive infatti Arbasino 15: «Perfino
all’Opera capitiamo, stranamente aperta, e fanno dei Puritani e dei Trovatori sotto
ogni immaginazione. Non manca niente: soprano grassa, tenore vecchio, baritono
senza voce, abbietta zingara vestita da Brighella. Si arriva lì magari di corsa con
l’intenzione di andar via subito per finir la serata alla Stazione, ma non si riesce
più a venir via. Così ha da essere l’opera: una corrida! Ruote di carro, fuochi di
carta rossa, pance sporgenti in fuori, elmi da pupi siciliani, penne di struzzo
altissime su tutte le teste, parrucche d’oro con l’orecchio sordo fuori dai boccoli
per sentire il suggeritore, protagonisti addormentati su pelli d’orso, scenografie
daMefistofele, comprimari che fanno la Manon e la Carmen, comparse che
11 Ivi, p. 94.
12 A.A., Fratelli d’Italia, Feltrinelli, Milano 1963, p. 65.
13 Ivi, pp.261-262.
14 A.A., Palais de danse, in Grazie per le magnifiche rose, cit., pp.168-194.
15 A.A., Fratelli d’Italia, cit., p. 351; con alcune lievi differenze la pagina è reperibile in Grazie
per le magnifiche rose, cit., pp.12-13.
arrivano dalla Turandot e daìYAida e nel pubblico falpalà e tacchi alti, belletti da
tabaccaio, parrucche da uomo e da donna, ordinarie in raso bisunto, che
espongono l’ascella col pelo, onorificenze da Principessa della Czarda. Che opera!
Che spettacolo! Che città!».
Le citazioni, d’altra parte, si moltiplicano nella sua produzione, in un gioco
continuo e soggetto a sempre nuove diramazioni, rigorosamente a tema o
clamorosamente fuori tema. Per cui, ad esempio e senza alcuna pretesa di
completezza, una poesia giovanile poi pubblicata ne «Il caffè» si intitola
ironicamente con un rimando alla Adriana Lecouvreur di Cilea Poveri fiorì 16, ne
La bella di Lodi il carcere in cui è rinchiuso lo sventurato Garbagnati Franco
«fuori, sembra il castello del Trovatore» 17, in Super-Eliogabalo i riferimenti sono
onnipresenti, nell principe costamele azioni del protagonista vengono paragonate
a quelle del Principe Igor18, nel superbo romanzo pop-decostruzionista Specchio
delle mie brame la conclusione è un controcanto dal Don Giovanni con il coro
delle nozze di Zerlina e Masetto a commentare con malizia quelle improbabili e
anglosiciliane tra Judy e Michele19 oppure, in quel radicale contro-ritratto degli
anni Settanta («un decennio poco amato»; così recitava il sottotitolo) che è Un
paese senza, l’invivibilità di Roma viene stigmatizzata con un passo del libretto di
Faustini per L'Ormindo di Cavalli, dove si afferma categoricamente: «Che città,
che città, / che costumi, che gente / sfacciata ed insolente!»20.
Quindi il melodramma è allo stesso tempo lessico comune e luogo della
dismisura, sentimentale ed espressiva. Sullo sfondo di questo proclama
articolatissimo e di grande lucidità, in cui la provocazione camp si unisce a una
precisa indicazione critica, sta in realtà un riferimento preciso: la svolta storicista
di Visconti, geniale recupero e reinvenzione di una tradizione nei suoi elementi
costitutivi e modello per un lunghissimo periodo (almeno un trentennio, ma gli
echi continuano a risuonare, anche se in genere ad opera di tristi epigoni) della
messinscena operistica euro-americana. Il regista è in un certo senso destinatario
occulto di molte riflessioni dello scrittore lombardo sull’opera e certamente ne è
stato per lungo tempo punto di riferimento per un discorso critico sul recupero
alla modernità delle convenzioni melodrammatiche. Arbasino recensore lo segue
da vicino: in un primo momento adotta totalmente la sua visione in occasione
della rivoluzione scaligera del triennio 1954-1957 di cui è evento centrale La
traviata, e poi ne parla diffusamente in occasione del Macbeth spoletino del 1958
in cui il grande costumista-scenografo Piero Tosi aveva preparato una «saga di fori
muscosi e atri cadenti» dipinti su tulle e ispirati al romanticismo storico più
flamboyante, su cui aleggiava il fantasma di Hayez (com’è noto consulente per
Verdi dei costumi della prima fiorentina dell’opera), indicando, con un’esattezza
condivisa in Italia all’epoca solo da Fedele D’Amico e pochi altri, gli elementi
costitutivi della rivoluzione-rivelazione viscontiana. In tal senso sono
fondamentali le pagine su un altro importante repêchage, Il duca d’Alba
donizettiano che nel 1959 fu in un certo senso il culmine del percorso storicistico,
con uno spettacolo che era basato sulla scelta filologica radicale di recuperare le
scene ottocentesche originali in un magazzino romano, lavorando assolutamente
«dall’interno» alla ricostruzione di un mondo espressivo a lungo travisato e
negletto. «Ripescate nei magazzini di Parravicini, le scene originali di Ferrario per
una rappresentazione dell’82 all’Apollo [di Roma,n.d.a\, sono un vero capolavoro
16 A.A., Poveri fior, in Matinée. Un concerto di poesia, Garzanti, Milano 1983, pp. 27-30.
17 A.A., La bella di Lodi, Einaudi, Torino 1972, p. 87.
18 A.A., Il principe costante, Einaudi, Torino, 1972, p.62.
19 A.Arbasino, Specchio delle mie brame, Einaudi, Torino 1974, pp. 132-133.
20 A.A., Un paese senza, Garzanti, Milano 1980, pp. 140-141.
di quella riproduzione pedante della realtà architettonica nel gusto
tardoottocentesco da “opera” che si può considerare, come la Galleria di Milano,
orrido o meraviglioso o tutt’e due insieme. [...] Affondando nelle più tarlate
peluches di Scribe e Delavigne, Visconti e Filippo Sanjust hanno disegnato un
monumentale sipario blu e oro, gonfio di frange e drappeggi e una serie di costumi
di colori bellissimi e sfacciati, carichi di squillanti pennacchi rosa-salmone o
giallo-limone o carnicino o verde tenero e poi adottato una illuminazione
perfettamente ottocentesca, ferma, con pochi riflettori, l’idea piuttosto delle
candele e del fumo, del gaz, infatti le fiammelle della ribalta proiettano una forte
luce giallognola sulle facce in primo piano, lasciando al buio quelle dietro: alla
Daumier»21 A questa dichiarazione ideologica, seguirà poi il distacco con una
recensione acida alle Nozze di Figaro romane trasferite in terra di Spagna, in
omaggio alla riscoperta filiazione con l’ambientazione originale del testo di
Beaumarchais22 e infine una vera e propria frattura con questa eredità culturale ne
La maleducazione teatrale, dove in preda a furori strutturalisti afferma: «la scuola
viscontea rappresenta piuttosto l’estetica Liberace in Italia: eseguire Liszt con un
frac d’oro su un pianoforte d’argento, interrompendosi di tanto in tanto con
commenti estemporanei rivolti al pubblico» 23, dichiarazione rafforzata poco dopo
da un velenoso inciso chiara-mente indirizzato alla scuola storicista, in Off Off,
dove nell’elenco finale delle nequizie della scena italiana postbellica deplora «il
melodramma come nei negozi di passamanerie» e le «squallide ricognizioni nel
bric-à-brac della Porta Portese del melodramma» 24. La presenza di Visconti è
comunque forte e di lui si parla tra ammirazione e sarcasmo, solo per restare alle
opere narrative, ne I blue jeans non si addicono al signor Prufrock 25, ne La
narcisata, nei Fratelli d’Italia e in Super-Eliogabalo, rispettivamente in un elenco
di mondanità romane: «fa venire Luchino, la Lilla e la Lola, scegliti un bel
Balenciaga nero da Alfredo mode...»26, sotto il camuffamento semi-trasparente di
Ottorino Ghislieri, «quarant’anni di carriera, e per il melodramma “habillé”
sempre il più bravo di tutti»27 e infine negli sterminati elenchi d’arredamento
dell’imperatore pop: «lì uno psicodramma hippy con regia di Visconti, scene e
costumi di Zeffirelli, musiche di Giordano e Cilea» 28. In un certo senso è proprio
lui insieme alla Callas il nume tutelare di questo intensissimo percorso
melodrammatico.
A questi primi due capitoli che vedono lo scrittore coinvolto come narratore
e saggista (anche se i confini, come si sa, sono labili e le pagine, come dimostrato,
sono inquiete e cercano sempre nuova collocazione), va segnalato quello più vicino
alla scena, che è il meno conosciuto e che ha visto Arbasino impegnato come
regista e «librettista» (le virgolette sono d’obbligo) estemporaneo. La carriera in
scena si limita per le messinscene d’opera (è da registrare in campo teatrale
sempre nello stesso anno un Prova inammissibile di John Osborne, protagonisti
Tino Carraro e Nora Ricci) alla celeberrima Carmen strutturalista (con doviziose
citazioni da Barthes) del 1967. Questa rappresentazione dava corpo alle sue Note
sulla Traviata, contenute ne La maleducazione teatrale edita l’anno precedente,
in cui lo scrittore affermava: «un’impostazione praticamente coerente, non
21 A.A., Grazie per le magnifiche rose, cit., pp. 170-171.
22 Ivi, pp. 384-387.
23 A.A., La maleducazione teatrale. Strutturalismo e drammaturgia, Feltrinelli, Milano,
1966, p. 23.
24 A.A., Off Off, Feltrinelli, Milano 1968, p. 281.
25 In Le piccole vacanze, cit., p.58
26 La narcisata, cit., p. 28.
27 Fratelli d’Italia, cit., p. 95
28 Super-Eliogabalo, Feltrinelli, Milano 1969, p. 119.
potrebbe essere che questa: scene semicircolari, o magari poligonali (evitando ogni
taglio obliquo o di sbieco). [...] Un oggetto grande e ingombrante dovrà
ingombrare - pesantemente semantico il centro della scena in ciascun atto
determinato tematicamente dall’atto stesso: tavola da pranzo nel primo; divano
rotondo con palma in mezzo nel secondo (padiglione o serra), scala tortile (ma non
sono tanto sicuro) nel terzo (dopotutto è un arnese molto secondo Impero); e il
letto naturalmente nel quarto»29. Il discorso critico indotto dalla messinscena era
quindi assolutamente antistoricistico e antiviscontiano: le scene di Gregotti e i
costumi di Giosetta Fioroni puntavano ad una rappresentazione d’attualità con
infiniti riferimenti al tempo presente (fece scandalo l’apparizione di Dancairo e
Remendado vestiti di tute argentate, con capelli alla Beatles e lo stesso accadde per
la presentazione del torero Escamillo in vesti di Superman). In piena diffusione del
modello viscontiano, che egli stesso aveva contribuito a storicizzare, l’autore
puntava su diversi parametri: «cercando di farne una rappresentazione stilizzata,
semantica, funzionale a tutti i livelli, un Barthes portato all’estremo, colori,
persone, gesti usati come puri segni: una realtà né veristica, né pacchianamente
cubistica o comunque astratta, ma diventata simbolo, emblema» 30.
Infine, ma è davvero solo una forzatura per comodità di trattazione, giacché
l’opera arbasiniana è unita e davvero tout se tient, la scrittura per musica. Va detto
innanzi tutto che la destinazione di queste pagine non è esplicitamente operistica,
segue invece le fortune e i fasti del cabaret romano di fine anni Cinquanta, creando
un modello di teatro musicale moderno, che ha le proprie radici nella librettistica
buffa del primo Ottocento, riscoperta e apprezzata come equivalente dei mirabili
giochi di parole di Lear o Carroll (e non a caso proprio lo strepitoso finale dell
turco in Italia chiude L’Anonimo lombardo). Destinatari di questi incantevoli
pezçi erano Laura Betti, per le due antologie Giro a vuoto e Potentissima signora
(tra le tante songs è impossibile non citare almeno Seguendo la flotta, che
indimenticabilmente inizia con «Ossigenarsi a Taranto / E stato il primo errore /
L’ho fatto per amore / di un incrociatore»... e via di seguito 31), per la musica di
Fiorenzo Carpi, Luciano Chailly, Gino Marinuzzi jr. e Mario Peragallo, e Giancarlo
Cobelli con degli incisi molto divertenti per La piccola vedette lombarda.
Altrettante testimonianze di una stagione altissima di intrattenimento letterario in
cui furono coinvolti Pasolini, Calvino, Moravia, Parise e chi ne ha più più ne metta
e che varrebbe decisamente la pena di recuperare e ristudiare complessivamente.
Infine, last but not least, è da citare l’unico esplicito progetto per un musical
«patriottico e antifascista» firmato insieme al regista Mario Missiroli: Amate
sponde!. Il testo, concepito come controcelebrazione del pomposissimo Centenario
dell’Unità Italiana nel 1961, era stato pensato per una compagnia destinata a non
realizzarsi (Asti, Betti, Cobelli) e venne pubblicato nel 1962 su «Paragone». In
questa sfrenata cavalcata nella storia del Belpaese un attonito trio familiare
(composto dalla Mimi, dall’Ida e dall’Eugenio) assiste nel proprio lindo salotto
borghese all’irrompere della storia (tutto succede sempre lì fino al delirio) e ne
segue gli esiti fino agli estremi limiti. L’Italietta viene passata a fil di spada da una
serie di malvagi couplets in cui davvero la rima diventa uno strumento di
ribellione politica, unendo in una sola dimensione cose apparentemente remote e
invece vicine, vicinissime, talvolta quasi identiche, fino a sovrapporsi o annullarsi.
Tra i tanti momenti riusciti di questo micidiale divertissement, o se si preferisce
operetta (ma nel senso lugubre che il termine acquisisce nel titolo della omonima
29 Esercitazioni. 1. Note sulla Traviata, in La maleducazione teatrale, cit., pp. 90-105.
30 Nello Ajello, Arbasino toreador, in «L’Espresso», 5 marzo 1967, pp. 14-15.
31 Ora in Matinée, cit., pp. 83-84.
pièce di Gombrowicz) vai la pena di citare almeno un passo del Cotillon
imperiale32.
«Indigene:
Badrone badrone
Sì belle e sì buone
Venute da terre
Civili e lontane
Invece di guerre
Vi offriamo banane
Vi offriamo perbacco
Colonia e tabacco
Tabacco di Harar
La Sfinge:
Tutto puoi colonizzar
Dai baobab alle zanzar!
Ida e Mimi: Wunderbar! Wunderbar!».
Una dimostrazione chiarissima, evidente, di un appuntamento mancato
dello scrittore lombardo come librettista con il melodramma contemporaneo, che
avrebbe dato frutti certamente di grande interesse, concludendo il ciclo che aveva
visto cospicue iniezioni di librettistica passare con grande autorevolezza in
funzione ironica o drammatica nelle pagine dei romanzi.
in “Riga” 18 (2001),
a c. di M.Belpoliti e E.Grazioli
32 A.A. e Mario Missiroli, Amate sponde!, Einaudi, Torino 1974, pp. 68-69.
A.A.
Addio alla Marescialla
L’IGNOTA:
Me ne torno a danzare a Berlino! a Berlino!
(Come tu mi vuoi)
Bombardata, distrutta, schiacciata sotto i piedi, impoverita e divisa, una
capitale fra le più grandi s’è vista strappar via duramente ogni prerogativa, una
dopo l’altra. Ma se il potere politico e il prestigio scientifico e il centro degli affari
sono trasferiti lontano, sembra che Berlino brilli anche più di prima come capitale
di straordinari spettacoli; e praticamente, in una zona franca dove ogni altra forma
di prova-di-forza politica o militare rimane sospesa fra i due blocchi, la
competizione propagandistica è soprattutto viva sul terreno dei colpi-di-mano
culturali, a partire da teatri e musei (oltre che, si capisce, su quello delle vetrine
piene: ma è anche naturale che qui il settore orientale, più Noi Vivi che non Dolce
Vita, lasci perdere gli elettrodomestici e le minestre in scatola, e punti
essenzialmente sulle meraviglie della Collezione di Pergamo e sulle Res Gestae
della Vedova Brecht).
Arrivando quindi per qualche giorno in questa Troia non da Troiane di
Euripide ma di Troilo e Cressida secondo John Erksine o Christopher Morley, e
guardando subito ai programmi dei teatri, si può anche perdere la testa di fronte
alla ricchezza delle offerte: mai meno di venti o venticinque spettacoli, tutti
insieme, tutti non male, e parecchi molto promettenti, sia nel campo greco, sia in
quello troiano. Soltanto l’ignoranza linguistica riesce a tener lontani dal Deutsches
Theater che fu di Max Reinhardt, dal-l’Hebbel e dallo Schiller, dal Komodie, dal
Tribüne, dal Gorki, dal Renaissance, dallo Schlosspark, dal Kurfürstendamm,
confinandoci con riluttanza alle sale d’opera. Non ci escluderà comunque dal
Berliner Ensemble: col pretesto che intanto un testo di Brecht lo si può conoscere,
bene o male, “anche troppo,” e comunque passa volentieri in secondo piano
davanti ai giochi di palcoscenico.
La competizione lirica pare poi sfrenata fra la Stàdtische Oper di Berlino
Ovest, che rinfresca pulitamente e con mano leggera i suoi classici, e la Komische
Oper di Berlino Est, dove trionfa invece il più selvaggio scatenamento
espressionistico. Sembra invece estranea ai ripensamenti estetici la grande Opera
di Stato di Berlino Est, e va avanti con le sue Aide e i suoi Franchi Cacciatori nella
polvere.
1. Leporello, un’altra cena
All’Opera Municipale, ancora nella sua sede provvisoria, un. exteatrone
d’operette d’anteguerra, avevo cominciato a vedere del Mozart limpido e vivo, in
edizioni 'ne varietur’ tipo Lezioni di Stile. Nessuno tende a strafare. Il canto e i
gesti incantevolmente composti in un giustissimo equilibrio, costante, fra le voci e
l’orchestra; la misura della grazia non eccede il necessario; e alla fine niente risulta
sacrificato, neanche i ‘pianissimo’ di Cherubini, che si sentono perfettamente.
Scene e costumi nello spirito di quel pacato barocco 'internazionale’ che diffondeva
nelle Corti periferiche, dalla Danimarca al Piemonte, l’Esprit de Versailles: ma
senza eccessi di grandiosità o sofisticazione. Nelle Nozze di Figaro, sale tenute su
una dimensione ragionevolmente umana, sale dove sembra possibile vivere. E nel
Cosi fan tutte, elementi mobili e 'trasparenti’ disposti dentro una cornice nera e
dorata che simula una scena dentro la scena: la mia Dorabella, la mia Fiordiligi,
Elisabeth Grümmer, Dietrich Fischer-Dieskau, Joseph Greindl, Ernst Haefliger,
Rita Streich...
Alla stessa Opera Municipale ho avvicinato per la prima volta due opere
indispensabili per intendere il punto di vista dei compositori nella grandiosa crisi
del Gusto cominciata agli inizi del secolo, quando l’arte europea si libera del
rutilante decorativismo ereditato dopo le bicchierate simbolistiche degli anni
Ottanta e Novanta, volta le spalle ai gioielli falsi di Moreau e di Wilde, ai ferri
battuti di D’Annunzio, al post-impressionismo dei nipotini piti fremebondi di
Wagner e Debussy, e sulle rovine del Liberty nascono insieme, serie e magre, la
pittura di Klee e di Mondrian, le sillabazioni di Valéry e di Gide, e l’architettura
moderna: nascondendo ormai il proprio decadentismo nell’intimità piti profonda,
come il Principe Ignoto della Turandot – “Ma il mio mistero è chiuso in me!” – o
come Lenin nel vagone piombato. Proust, ancora tutto dentro la Belle Époque,
spaventevolmente a bagno nel cromatismo dei Sinfonisti dell’Ultimo Giorno,
abituato ai programmi di Franck e Saint-Saëns e Reynaldo Hahn, si era subito
accorto di questo “giro di vite” estetico; e aveva già fatto fin troppo, da parte sua.
Sia pure con un accompagnamento di gentili dileggi: nella Recherche la
“efflorescence prodigieuse” dei Balletti Russi non rh vela soltanto il genio di
Stravinski e Nijinski e Bakst, ‘lancia’ anche definitivamente in società la
principessa Yourbeletieff con la sua immensa aigrette, e Mme Verdurin col suo
salotto, come se le due sublimi creature fossero state portate dai russi nei loro
bagagli; e il loro successo diventa sempre più rapido. Sorride la leggibilità,
allegoricamente volgare, del Genio Contenuto in una Fodera di Vizi: quando il vero
motivo immediato della presenza chez Mme Verdurin di un sottosegretario alle
Belle Arti, tre ambasciatori, e numerose duchesse, per una serata definita
'parisienne’ daì grosso pubblico e dai 'giornalisti filosofi,’ altro non è che la
relazione fra Charlus e Morel, e il vivo desiderio di Char-lus di dar la massima
risonanza possibile ai successi artistici di Morel, e di ottenergli la Legion d’Onore;
così come la relazione fra Mlle Vinteuil e una cert’altra signorina mettono in moto
una serie d’iniziative geniali che conducono alla rivelazione degli spartiti di
Vinteuil, a una sottoscrizione, all’erezione di un monumento sotto il patronato del
Ministero della Pubblica Istruzione: i rapporti personali colpevoli servono dunque
come scorciatoie grazie alle quali il mondo raggiunge talune opere senza i détours
dell’incomprensione e dell’ignoranza (che peccato che Proust non abbia potuto
descrivere l’Età della Callas e il Grande Ritorno delle Checche al melodramma
verdiano...). A Richard Strauss arriva, però: per osservare come tanta gente dotata
di un gusto istintivo e sicuro per la cattiva musica, arriva a mortificarselo, grazie
alla Cultura Sinfonica; ma appena Strauss sembra accogliere nel suo Éblouissant
Coloris Orchestrai dei motivi volgari, con un’indulgenza degna di Auber, tutti
immediatamente trovano nella sua autorità l’alibi per incantarsi sconciamente per
Salome, senza scrupoli e con una doppia gratitudine, trovandovi tutti i piaceri di
cui s’erano privati in Les Diamants de la Couronne. Non è neanche necessario
riprendere le sue osservazioni specifiche sui Balletti Russi per accorgersi che
Proust aveva già capito tutto: la prova migliore la dà proprio nella concezione
basica dell’intera Recherche, dove la tenerezza per la Paillette Riempitiva non
interferisce mai con la decisione strutturalistica di fare quel certo ‘buon uso’ del
Tempo.
Arrivando però al ‘test’ teatrale del Moses und Aron di Schönberg, ci si
rende conto che quel grande amore di Proust e nostro, Stravinski, potrebbe essere
stato un falso bersaglio. Dal Sacre che faceva delirare Oriane e Marcel, alle ‘novità
assolute’ che ci sconcertano ogni autunno a Venezia, tutti i capolavori della sua
straordinaria carriera di Trasformista, più che di Libertino, non sono poi tanti
meravigliosi punti d’arrivo, in fondo a tanti vicoli ciechi, al di là dei quali non si
potrebbe far altro che comporre dei nuovi piccoli Petrushka, piccoli Pulcinella,
piccoli Oedipus Rex, piccole sinfonie più o meno concertanti, e poi, battere il naso
contro il muro?
2. Mosè e Aronne
La musica ‘nuova’ di Arnold Schönberg, cosi diversa dalle sue prime cose
(quella Verklàrte Nacht che è ancora puro Vinteuil, quel Pierrot Lunaire che
doveva piacere a Puccini), e cosi difficile, severa, priva di buon gusto e densa
piuttosto di un delirante ascetismo, come un Bach rapinoso del nostro tempo,
come un nuovo Brahms di cui si possa dire che “come l’austera Cordelia,
nascondeva le sue emozioni più preziose piuttosto che esporle alla gente” o “come
Grillparzer, si sforzava per un Effetto, non sugli altri ma su se stesso,” apre a viva
forza una porta per cui potrà uscire e avviarsi al lavoro una quantità di compositori
successivi. E si capisce bene come mai Thomas Mann, che a differenza di Proust
conosceva di prima mano l’autore del Moses und Aron, abbia puntato tanto su
Schönberg nella composizione del Doktor Faustus; e per compiere un tour de
force fra i più incredibili – la descrizione di partiture musicali che non esistono! –
si sia fatto assistere da Adorno che non lo ammira poi molto, l’autore del Moses,
quantunque
riconosca
benevolmente
qualche
sintomo
d’involuzione
tradizionalistica nella “grandiosa ingenuità” della sua lotta contro le Ombre
Informi delle Forze che Distruggono l’Individualità. “Ho in mente qualche cosa
di religioso-satanico, di pio-demoniaco, di strettamente legato e delittuoso, che
schernisca talvolta l’arte e risalga all’elementarità primitiva... che rinunci alla
suddivisione delle battute e magari dell’ordine tonale (glissando di tube); inoltre,
qualche cosa di quasi ineseguibile praticamente: antiche tonalità ecclesiastiche,
cori a cappella, che debbono essere cantati in atmosfera non temperata, di modo
che sul pianoforte non se ne trovi né un suono né un intervallo...” (Romanzo di un
romanzo). Sembra che manchi molto poco a un ultimo passo: l’applicazione delle
impazienze di Eduard Hanslick contro Richard Strauss (e contro i “giovinastri
pittorici e poetici che si stanno moltiplicando,” discendenti di Berlioz, Liszt,
Wagner: “Il virtuosismo nell’orchestrazione è diventato un vampiro che insidia il
potere creativo dei compositori...” “Questa cosa ripugnante non è pittura tonale,
ma piuttosto un cumulo di sgorbi lucenti, un’orgia tonale franante, metà baccanale
e metà sabba di streghe...”) nientemeno che agli eredi diretti e legittimi del
sublime Requiem Tedesco.
La ‘success story’ dell’affascinante Moses und Aron è ormai notoria: e del
resto assai simile a quella di parecchi altri Trionfi Postumi del nostro tempo,
dall'Uomo senza qualità all’Angelo di Fuoco, al Gattopardo. Schönberg fra il ’28 e
il ’33 compone la musica dei primi due atti e completa il libretto, ispirato all’Esodo
e corredato d’inquietanti didascalie: “processioni di cammelli carichi, asini, cavalli,
con portatori e carri, entrano da ogni lato, portando offerte d’oro, grano, orci di
vino, otri d’olio, animali per il sacrificio... i macellai immolano le bestie, buttano
pezzi di carne alla folla: fra lotte e contese, gli astanti afferrano lacerti sanguinanti,
e li divorano crudi... i capi tribù ammazzano il giovane, montano a cavallo e
s’allontanano... scorre il vino da ogni parte... ubriachezza generale... le vergini folli
porgono i coltelli ai sacerdoti ebbri, e questi le afferrano per la gola, affondando i
coltelli nei loro cuori, le vergini raccolgono il sangue nei vasi, li porgono ai
sacerdoti, e questi lo versano sull’altare... nella folla, distruzioni e autoimmolazioni... carri distrutti, giare fracassate, tutto viene lanciato attorno: spade,
lance, scuri, vasi, arnesi... chi si trafigge con la spada, chi si butta nel fuoco, e poi
corre bruciando per la scena... un’Orgia di Eccesso Sessuale.” Nel ’33 Schönberg
fugge il nazismo, si riconverte alla religione ebraica, si rifugia in America, e non
tocca più la sua opera: forse bloccato alle soglie del duetto risolutivo come Puccini
allo ‘scioglimento’ della Turandot. Se ne occupa invece, e intensamente, Thomas
Mann: tanto da “scrivergli addosso” il suo capolavoro. Ma Schönberg non ne è
affatto contento. Muore nel ’51. E il Mosè comincia a farsi strada da solo. Né opera
né oratorio, incompleto e giudicato irrappresentabile, viene invece eseguito nei
teatri d’opera in approssimazioni sempre più soddisfacenti che durano le loro tre
ore e risultano passabilmente ‘compiute.’ Rivela anche una vitalità sconcertante.
Diventerà infine un bestseller: sale esaurite, e pubblico che zufola all’uscita vertici
di dodecafonia diventati paradossalmente orecchiabili.
Si capisce che le difficoltà d’esecuzione sono pazzesche: un monologo
tragico programmaticamente ostile ai Mass Media, due titanici protagonisti quasi
sempre in scena, pochi comprimari che non devono fare quasi niente, una
partitura impervia, numerosi cori continuamente impegnati, accavallandosi, versi
di profonda nobiltà, quelle didascalie dissennate... Lo stesso autore prevedeva che
si sarebbe forse riusciti a presentarla tutt’al più in forma di oratorio – se pure si
arrivasse a sopprimere tutti gli ostacoli di natura musicale.
Sopprimendo tutto il lato Theda Bara della situazione, e approfittando di un
generico astrattismo da Jeu de Cartes nel Gran Teatro Naturale d’Oklahoma (ma
che pretende di non rinunciare a un suo pittoresco), l’Opera berlinese ha
semplificato molti problemi di messa in scena. Nel primo quadro (roveto ardente),
per esempio, pendono dall’alto dei finti mobiles di Calder, fettine di lamiera
infilate negli spaghi, e ondeggiano lievemente in un lume fucsia-ciclamino. In
quanto ai cori, una metà abbondante è registrata su nastro, con la sua inevitabile
fastidiosità metallica, e un effetto da Stereorama: gli altoparlanti sono disposti nel
lucernario, dietro le barcacce, e in altri posti barocchi; vien quasi da rimpiangere le
fronde tropicali e gli incensi odorosi caldeggiati dall’autore.
La direzione di Scherchen è superba: non per nulla nel gran romanzo di
Mann ha più di un merito, insieme a Klemperer e a Bruno Walter, nel rivelare la
“musica del futuro” deH’immagina-rio Adriano Leverkühn. E attraverso questo
arrovellarsi tormentoso dell’orchestra e dei cori viene fuori efficacemente, se non
uri Apocalypsis cum figuris, l’ansia di esprimersi di Mosè, che non riesce a farsi
ascoltare dal suo popolo, l’incontro con Aronne che Dio gli manda con fini di
volgarizzazione e di editing, perché spieghi le sue idee in termini facili all’Uomo
della Strada, e la lunga controversia fra l’intransigenza dell’uno e il possibilismo
dell’altro. Ma la disputa in realtà più che religiosa è politica, più che politica
sembra retorica, e oltre che retorica diventa linguistica. Schematizza due posizioni
fin troppo note. Aronne è un simbolista, usa l’Immagine, abusa dell’Icona, ama
l’Allegoria, adora la Visione, predilige la Metafora. Parla di Vitello d’Oro cosi come
altri potrebbero dire Gita al Faro, Pelle di Zigrino, Balena Bianca, Folle de Chaillot.
Andrebbe quindi d’accordo con Sant’Agostino (”un segno è una cosa che, oltre la
specie ingenerata dal senso, richiama di per sé anche altra cosa”), nonché col
Petrarca, il Marino, il Montale. E infatti canta, con voce di tenore lirico: mentre al
suo antagonista il Canto è negato: come se il “mi manca la voce” su cui s’insiste nel
Mosè precedente di Rossini avesse funzionato da Tanto Tuonò Che Piovve nei
confronti di questo Mosè dodecafonico, basso-baritono incatenato alla Parola
Ritmica.
Questo Mosè è un wittgensteiniano addirittura truculento. Per lui, il
Simbolo è Degradazione: dalle Tavole della Legge alla Terra Promessa (per non
parlare dei Miracoli...) è ostilissimo addirittura al Segno. E non per nulla si
esprime come voce recitante: come Monsieur Jourdain, e come Moravia,
qualunque cosa dica, gli viene fuori in prosa. Barthes lo ridurrebbe a una catena di
sintagmi. Jakobson lo assegnerebbe alla categoria metonimica. Si trova cosi
d’accordo con Erodiade, in quell’altra disputa semiologica-biblica esemplarmente
sceneggiata da Oscar Wilde. Erode svapora nelle Associazioni Sostitutive (come i
romantici, i simbolisti, i lirici russi, i film di Bergman, i simboli onirici di Freud, la
critica tematica, il discorso aforistico). La sua Parola Parlante sbanda dal nesso
convenzionale al nesso esistenziale. Appena vede la luna: “Non ha uno strano
aspetto, la luna, stanotte? Sembra una donna pazza, una donna pazza in cerca
d’amanti dappertutto. È anche nuda. È tutta nuda. Le nuvole cercano di velare la
sua nudità, ma lei non consente. Vuole mostrarsi nuda nel cielo. Vacilla attraverso
le nubi come una donna ebbra... Sono sicuro che cerca degli amanti. Non vacilla
forse come una dorma ebbra? Sembra una donna pazza, no?” E invece Erodiade
(come gli epici eroici, i romanzieri realisti, i film di Griffith, gli epigrammi di
Marziale, e il ‘New York Times’): “No; la luna somiglia soltanto alla luna, tutto qui.
Andiamo dentro... Non hai niente da fare, qui fuori.” (Ma Mosè fa un passo più
avanti: il Linguaggio è veicolo d’impossibilità...)
Il Popolo d’Israele compare e agisce non più accomodato in un emiciclo
universitario come nell’orrido Roi David di Honegger alla Scala, ma stavolta issato
su un’impalcatura alla Léger e dedito alle più varie occupazioni su diversi livelli,
come nelle grandi composizioni fiamminghe che ritraggono le attività di villaggi
interi. Di là in alto si sviluppano i contrasti e le invettive a proposito del Dio
vecchio e di quello nuovo, visibile oppure invisibile, sull’andare o no nel deserto,
col rischio di non trovare abbastanza locuste da mangiare; e in sostanza si discute
a lungo se sia opportuno o no, in genere, lasciar perdere gli interessi mondani per
concentrarsi sul Sacro e sull’Essenziale. Ma com’è poi l’Essenziale? Quando Mosè
se lo sente spiegare nei termini di buon senso di Aronne, frana
nell'Incomunicabilità più sconfortata...
I costumi sono delle tuniche a righe e a triangoli, di diversi colori
contrastanti, qualche volta di tipo pinguino, altri tipo i marziani alla Fiera di
Milano. E i miracoli non sono mostrati; il pubblico vede solo un bastone, li per
terra, e poi un’olla; e gli deve bastare questa negazione del Vedete Per Credere.
Però le masse ebraiche si convincono, sotto lo sguardo seccato di Mosè, che viene
fuori, da una caverna quasi-platonica, non si rende conto che anche la Caverna è
ima metafora, ha visto il Sole in tutta la sua Gloria (altra metafora?), insomma ha
contemplato la divina purezza della verità metafisica, e quindi trova molto cheap
la propaganda religiosa a base d’immaginette (”o si crede, o non si crede! e meno
sciocchezze!” gli scappa detto quando non ne può più); e il primo atto termina con
una pittoresca marcia di guerra contro il Faraone, in forma di Doppio Canone, a
cui segue un Interludio di Smarrimento in forma di Doppia Fuga.
Il secondo atto è anche abbastanza infelice da guardare, perché gli sfondi
viola e zafferano sono proiettati con la lanterna delle diapositive pubblicitarie negli
intervalli al cinema, e si paventa quindi la lode al cognac o l’invito al gelato. Ma se
non si bada al vitello d’oro (che è poi un gattone a geroglifici), e si passa sopra
all’ebbrezza dei sacerdoti (un Palio di Siena fatto dagli allievi di Brera) e
all’esibizione delle odalische in calzabraga (puro Chelo Alonso), la grandiosa danza
pagana è un pezzo di Grand Opéra fra i più impressionanti; e continua a montare,
a montare, nel duetto dopo il ritorno di Mosè, di una monumentalità wagneriana,
di una ‘rifinitura’ bachiana, su cui s’inserisce non il Mar Rosso di Rossini ma il
Coro della Trasmigrazione (mentre sulla scena si frana nel film biblico povero).
L’ultimo atto, in cui Mosè dovrà trionfare rimproverando ad Aronne le sue
debolezze per il Significante rispetto al Significato, viene rappresentato, piuttosto
curiosamente, cosi: l’orchestra va via, la sua fossa rimane al buio, e mentre i nastri
magnetici srotolano come ‘background music’ la registrazione dei cori del primo
atto, Scherchen rimasto solo con la sua lampadina dirige il recitativo dei cantanti,
che declamano in proscenio la rimanenza non musicata del libretto. Ne viene fuori
il disperato rimpianto di Mosè per non essere un grande compositore
dell’Ottocento: se fosse Beethoven, sarebbe in grado di Comunicare la Verità molto
più direttamente che Henry B. Luce, molto più pulitamente di Aronne, con tutte le
sue parafrasi plastiche, le sue circonlocuzioni figurative,i suoi canoni
schönberghiani.
3. Casa Faninal
Anche Capriccio, altro affascinante figlio del Requiem Tedesco (nel quinto
movimento, “Ihr habt nun Traurigkeit,” si sentono già la Marescialla, la Contessa,
oltre che i Kiniertotenlieder e Das Lied voti der Erde figli della Rapsodia per
Contralto: come sembra ormai remota l’incompatibilità proclamata da Hanslick
tra le Father-Figures di Brahms e di Wagner...) è il testamento di un grande
musicista; ma qui, trattandosi di Richard Strauss, non è più il caso di parlare di un
coetaneo del Floreale, Strauss è il Floreale medesimo. E il suo Carteggio con
Hofmannsthal riesce almeno come le Memorie di Alma Mahler a definirlo come
gran personaggio: un Uomo Senza Principii musiliano e affarista, con
superficialità grossolane e doppi fondi inquietanti; e il suo attivismo fragoroso; e la
sua mancanza di problematiche addirittura macchiettistica; e la moglie Pauline
che gli spende tutti i soldi, dispettosamente, in parrucchieri e gioielli; e le
discussioni su Mommsen coi colleghi, a tavola; e l’incontro folgoratorio con la sua
Belle Dame Sans Merci, la resa di fronte alla Marescialla del Rosenkavalier,
quando Hofmannsthal gli presenta questa testa di Medusa infinitamente
seducente e ornata di tutte le grazie più irresistibili del Passato... e ‘congela’ un
musicista tutt’altro che ‘pietrificato’ (lo riconosce lo stesso Hanslick); anzi, dopo
tutto, le sue ‘rotture’ nel senso dell’avvenire le stava compiendo – con l’Orgia
Coloristica o il Vampirismo Orchestrale, o con la Sensualità Patologica Extramusicale – nei poemi sinfonici o ricorrendo magari paradossalmente alla solita
Salome di Wilde...
Strauss non sarà mai più lo stesso dopo l’incontro con quella figura rococo
che veramente – alibi affascinante e insidioso! – “riassume tutto un passato” o
“compendia e conclude un’intera epoca” (tanto per sputtanare i clichés della critica
di second’ordine). Abbagliato da tanto Settecento chic cade cioè pesante come il
suo Barone Ochs “che ogni mattina ha reso omaggio dietro un paravento al bagno
della Principessina Brioche” nella stessa trappola che una fata assai simile, Oriane
de Guermantes, spalancava davanti al Proust ‘antiquario’ di Pastiches et mélanges
e che il narratore della Recherche elude proprio salvandosi in un Tempo che non è
quello dei calendari o degli almanacchi, neanche quello degli storici o dei filosofi –
tanto meno quello dei Laudatores Temporis Acti: come il Balzac di M. de
Guermantes o la vetrata di Gilbert le Mauvais – ma piuttosto uno spazio
soggettivo dove la ‘durata’ è un’incognita, forse non esiste, comunque non è
chiaro: perché insomma non si è mai capito se l’Immobile è un’apparenza e il
Moto è la realtà, o non piuttosto (plotinianamente) viceversa...
Confondendo invece il fine dell’arte col riepilogo del passato, l’autore della
Donna senz’ombra sembra voltare le spalle al moto fluido e incessante della
Realtà. Nato dieci anni prima dello ‘stilita’ Schönberg, diciotto prima del
‘punteggiatore’ Stravinski, gioca svogliato (o entusiasta) sia con la Tradizione sia
con la Musica Nuova, troppo epicureo (o troppo debole) per abbracciare Luna, e
rinnegare l’altra, o comunque per riflettere sul proprio Dovere Artistico. Siede
appagato di fronte a quella mera apparenza che potrebbe essere l’Immobilità
secondo i nemici di Bergson: il Mistico e il Telespettatore, ugualmente convinti
che “in eo vivimus et movemur et sumus,” vuoi parlando di Dio, vuoi del Secondo
Canale.
Cosi raggiunge lo scopo di soddisfare industrialmente una smisurata
clientela middle-class e middle-brow, sia luterana sia cattolica, che domanda solo
d’essere confermata, vittorianamente, nelle più tranquillanti (e ‘medie’) certezze,
da lui raggiunte attraverso l’Eccesso Sistematico, poi proiettate all’indietro in uno
Status Quo Ne Varietur decorosamente agghindato. E naturalmente non
s’interrogherà mai, come Schönberg, su che tipo di musica sia giusto comporre,
ancora prima d’incominciare a comporla (tanto più, con l’intenzione d’imporre
Nuove Forme alla Musica Vecchia). Cioè, la questione morale travestita da
questione musicale. Né si chiederà mai, come Blanchot, perché mai uno scrive; se
quello che scrive vuol dire veramente qualche cosa. Se l’ufficio dell’opera sia di
“trasformazione e negazione’’ nel mondo in cui entra, tentando di riconoscere “il
paese dove quest’opera trascina autore e lettore...” Se cioè il compito dell’artista –
non aver nulla da dire, però esser tenuto a dirlo, volente o no – ha il senso
essenziale di ricondurlo al Silenzio Originario. Cioè, all’Apprentissage de la Mort.
Dove si ricongiungerebbe con Kafka e Beckett, Gadda e Céline e Borges, giunti alla
medesima conclusione per vie tutte diverse. E con Webern. E con l' 'accattone’
Stravinski, che ha avuto il coraggio di buttar via tutto, chiudersi le porte alle spalle,
e andar mendicando di casa in casa: cosi ha ricostruito la sua eredità; e questo gli
dà il diritto di dichiarare che la musica di Strauss lo soffoca, perché è una enorme
massa senza muscoli.
Ma il lato inquietante di Strauss coincide con la sua ambiguità: mentre
propone così sontuosamente le sue Profonde Sintesi fra il Comico e il Tragico,
nello Spirito del Diciottesimo Secolo, telescopando ogni greve ironia attraverso le
Opere nell’Opera, si rende mai conto – o no – di stare introducendo nella
Pomposità Absburgica più d’uno spiffero di Bittersweet alla Noel Coward?
Nel Carteggio, Hofmannsthal appare come il Prodotto Tipico di una Civiltà
al Tramonto, fin troppo squisita: timido, solitario, altero, nervoso, estetizzante,
carico di sensibilità a scapito della vitalità. Strauss: vigoroso, estroverso,
impulsivo, permaloso, scaltro, un po’ terra-terra culturalmente ma dotato di un
gran buon senso istintivo, capace di grandi entusiasmi, pieno di grande vitalità, e
non privo di un suo spirito sveglio, pronto a riconoscere la necessità di “scappar
via tutti subito dagli urli erotici di Wagner.”
Le continue influenze reciproche fra i due sono uno spettacolo singolarissimo.
Vivono lontani: Hofmannsthal difficilmente esce dalla sua Torre d’Avorio; Strauss
ha pianificato da bravo businessman la sua esistenza: per sei mesi all’anno
viaggiare come direttore d’orchestra guadagnando tanti soldi; per gli altri sei mesi,
d’estate, riposarsi a Garmisch vestito da campagna, e dedicarsi alla composizione.
Ognuno ha un’idea chiarissima dei pregi e dei limiti propri e deË’altro: non se ne
risparmiano le analisi e i rinfacci. Hofmannsthal, più giovane di parecchi anni, non
esita a trovar banale e volgare il gusto di Strauss, e a dirglielo; e Strauss se lo lascia
dire. Però sono d’accordo sul fatto che l’istinto drammatico più potente appartiene
al musicista; il poeta con le sue preziosità ha il fiato corto, non può farci niente.
Hofmannsthal arriva a riconoscere d’essere ignorantissimo in fatto di musica, non
fa che ripeterlo: però è sorprendentemente sua l’idea che sia necessario ricamare
un valzer via l’altro nella partitura del Rosenkavalier-, un’intuizione di genialità
incomparabile, anche se poteva sembrare bizzarro riempire di valzer e non di
minuetti un’opera che è il trionfo del Settecento. (Reciprocamente: i versi più felici
dei libretti obbediscono a misure metriche fissate dal musicista.)
È patetico vedere come tutte le volte che i due si accingono a una nuova
opera si propongano in buonissima fede di fare “almeno stavolta” un qualche cosa
d’allegro, di leggero, addirittura di operettistico. “Dopo tutto,” asserisce Strauss
nel 1916, “io sono l’unico compositore al mondo dotato di humour, di senso della
parodia, di voglia di divertirmi. Perciò mi sento destinato a diventare l’Offenbach
del ventesimo secolo, e voi dovrete essere il mio poeta.” Poi, si sa, il poeta non
resisteva all’amore per le strutture complicate e per i simbolismi fantasiosi; e il
musicista soffriva troppo ad arrestarsi nell’elaborazione dei temi. Nasceva invece
dell’operina un luna-park raffinatissimo nei particolari ma d’una macchinosità
mai vista. “Come al solito il sinfonista nel vostro cuore ha prevalso sul
drammaturgo!” rinfacciava Hofmannsthal, che da parte sua non aveva arretrato di
fronte a nessun doppiofondo pensabile, nella struttura del libretto:
“Contrappunto, sviluppi tematici, elaborazioni orchestrali, che sono la linfa vitale
nella sinfonia, diventano il veleno funesto dell’opera... il testo viene oscurato, i
cantanti devono sacrificar tutto al volume... e l’aria, che voi stesso definite 'l’anima
dell’opera,’ agonizza e soccombe...” E al tempo del Rosenkavalier (opera che
doveva durare “non più della metà dei Maestri Cantori’’), a proposito del coro dei
servi di Faninal, nel secondo atto: “Era scritto per squillare burlescamente, nel più
trasparente stile alla Offenbach; non avete fatto che opprimerlo con una musica
pesantissima, e cosi si distrugge completamente il senso delle parole.”
Nemici della semplicità, ostili alla concisione, avversari della naturalezza, i
due recitano sublimi scene del più toccante donchisciottismo ogni volta che si
pongono programmi di chiarezza e secchezza, sia musicale sia drammatica,
ripetendo con convinzione che ciascuno nella propria sfera sarà capacissimo di
ottenere tutto quello che vuole. Non di rado, in questi duetti, prendono il tono di
due personaggi della loro Ariadne auf Naxos: il poeta si comporta come la
sognatrice Arianna, sempre con gli occhi tesi verso lontani orizzonti, mentre il
musicista fa la parte della prosaica Zerbinetta, coi piedi ben puntati per terra:
sembra .difficile rovesciare più doppiamente il dilemma fra Aronne e Mosè...
Hofmannsthal sermoneggia. “In tutto quello che potremo fare insieme,” scrive nel
1912, “il criterio finale di giudizio può solo essere la sensibilità estetica, e se
permettete m’incarico d’ora in poi d’essere io solo il guardiano e tutore del lato
estetico a nome di tutt’e due.” “Ho paura del vostro opportunismo,” insiste,
qualche anno dopo, “perché il pericolo nel quale continuate a ricascare nonostante
ogni periodico tentativo di tirarvi su, è la totale indifferenza alle esigenze della vita
intellettuale.”
Strauss d’altra parte lasciava molto fare al poeta, si fidava molto del suo
fiuto straordinario per ogni atmosfera teatrale, della sua abilità nell’evocare con
precisione pungente il ‘colore’ di certi periodi, del suo genio nel mettere a posto
ogni particolare psicologico e drammatico in un’azione complessa perfettamente
unitaria (senza contare il leggendario gusto figurativo di Hofmannsthal, e la sua
bravura nel curare la parte visiva dello spettacolo, che a Strauss non importava
niente).
Così, preso per mano dal poeta innamorato dei momenti più decadenti e più
morbidi del passato, il musicista finiva per soccombere alle nostalgie rococo latenti
in fondo alla sua spettrale anima monacense, e lentamente voltava le spalle alla
strada faticosa della musica del futuro, per cui stavano avviandosi gli Schönberg e i
Webern ansiosi di “respirare l’aria di un nuovo pianeta...”
Le congratulazioni reciproche fra i due per la sapienza e l’intelligenza
dimostrate nella stesura del Rosenkavalier non cessano praticamente mai, nei
diciotto anni fra la composizione dell’opera e la morte di Hofmannsthal: è difficile
immaginare un contrasto più piccante coi malumori di Verdi, quando ripete a
chiunque d’essere “fra i maestri passati e presenti il meno erudito di tutti,” se si
vanno a ritrovare nei Copialettere le analoghe situazioni Verdi-Boito, prima di
tutte la quarantennale ricerca di un buon libretto per opera buffa. Boito che
razzola nel più vieto Du-gento alla caccia di grullerie da mettere in bocca a
Bardolfo e a Pistola, che ghiotto pendant per le preoccupazioni di Hofmannsthal
relative a cori di elfi buoni e di elfi malvagi, a certe conchiglie giganti che “devono
suonare esattamente come un telefono occupato” nella Maria Egiziaca.
Se poi si trova capriccioso il giudizio di Hofmannsthal per cui la differenza
tra Wagner e Puccini sarebbe che il primo compone tante opere ‘uniche’ mentre il
secondo ripete ogni volta la medesima opera, neanche Boito scherza quando
definisce la Wal-kyria come “un’azione insulsa che cammina più lentamente di un
treno omnibus, fermandosi ad ogni stazione.”
Però è difficile trovare nei rapporti fra Poeta e Musicista un esempio più
impressionante di musicista che non capisce niente di musica, e ha Insogno di uno
scrittore che gli spieghi assolutamente tutto, come nel caso Proust-Hahn.
A nessuno al mondo l’autore della Recherche ha voluto bene più che a
Reynaldo Hahn. Venezuelano, ricco, viziato, con una bella voce di tenore, molto
gattone di temperamento, Hahn aveva diciannove anni ed era un piccolo idolo di
molti salotti Verdurin quando incontrò Proust, di tre anni più vecchio. E basta
guardare le lettere che Proust gli ha indirizzato per ritrovare intatto, più intimo e
giovanile, il tono di Un amour de Swann. Si firma ogni volta con un nome diverso:
Poney, Hibuls, Binibuls, Buchnibuls; per divertire Reynaldo, fa di tutto: versi,
disegnini buffi, prese in giro di signore alla moda, commenti a versi di Mallarmé,
indiscrezioni sulle polemiche di Léon Daudet... Ma la parte più singolare del
carteggio riguarda proprio la musica: è singolare notare come qui lo scrittore
vedesse subito più chiaro e più lontano del musicista.
Veramente sembrano quasi incredibili gli sforzi di Proust per convincere il
suo amichetto che il Pelléas è un’opera importante, che Debussy e più tardi
Stravinski sono i veri musicisti dell’avvenire; mentre Hahn, senza mai capir
niente, gli ride in faccia, lo tratta da dilettante incompetente, e proclama la
grandezza di Gounod, di Massenet (e per bene che vada di Saint-Saëns).
Quando poi si tratta di scrivere a sua volta un’opera, e non più delle
romanze da salotto, Hahn finisce per produrre la celebre Ciboulette, rappresentata
nel ’23 e piuttosto divertente: però è un’operettaccia, da epigono pigro di
Offenbach, e con un odore di Belle Époque putrefatta che in nulla la distingue da
Véronique, Monsieur Beaucaire, Les mousquetaires au couvent, Coups de
roulis... Soltanto un’operettaccia.
Andando poi avanti a sentire il Rosenkavalier, ci si rende conto come non
sia affatto, o non sia soltanto, quella scaltra e felice combinazione consacrata dal
Luogo Comune Critico fra i talenti di un esteta decadentissimo rotto a tutti i froufrou del Gusto, e di un grosso borghese eupeptico e soddisfatto che beve tanta
birra e va in montagna in braghe di cuoio e fa a macchina tanta musica grossa e
opaca, come viene viene. Più si considera Strauss da vicino, più lo si considera
sconvolgente... Filisteo? Nasce a ridosso di Wagner, come Berg a ridosso di
Schönberg, e Ravel a ridosso di Debussy: come se le mutazioni della musica
moderna dovessero effettuarsi attraverso coppie imbarazzanti di 'gemelli...’ Parte
imbullonando i ponti monumentali di ghisa e i palazzi di giustizia guglielmini e le
cattedrali-stazioni dei grandi poemi sinfonici. Già oltre la soglia sonora che
immette nel cerchio diabolico esplode o putrefa il tristanismo ‘Liberty’ con un
tessuto di parole-e-musica grandioso come negli affreschi di Mahler e sottile come
nelle miniature di Debussy; e gli stupidi che si scandalizzavano per i Valzer nel
Settecento potrebbero forse domandarsi “ea Micene?” ogni volta che la sua Elektra
ne mette in moto uno col nominare Oreste (forse più Metonimia che non
Metafora...): mentre la sua Salome s’abbiglia degli equivalenti sonori non tanto di
Moreau ma dell’oro falso e dei gioielli pailletés come fiori di smalto in Der Kuss e
Die Jungfrau di Gustav Klimt... Sembra calarsi nel più galante rococo? Ma è la
stessa ‘Secession’ alto-borghese di Musil; e tra un pastiche e l’altro, daVdAriadne
al Capriccio, un po’ farà il Tiziano e un po’ il Tiepolo e il Guardi: comunque, il
pittore ‘coloristico’; finché dopo tanti godimenti del “suono per il suono” (che
mascherano forse alla superficie “artisticamente composta,” o pantagruelica alla
Makart, degli inquietanti crepacci psicanalitici) finisce ottantenne con un suo
Falstaff privato che non è affatto la ‘catastrofe’ riscontrata da Walter Benjamin
nelle Ultime Opere dei Grandi Maestri (“per cui le opere compiute pesano assai
meno di questi frammenti ai quali lavorano per tutta la vita: essi tracciano il loro
cerchio magico nell’opera frammentaria”), ma risulta una gran bella conclusione
per una Vita d’Artista: i grigi perlacei e i marroncini morandiani del Secondo
Concerto d’Oboe e delle Metamorfosi...
Alla luce poi di quello che si è venuto imparando negli anni recenti sulla
Vienna di Musil e Klimt e Freud e Mahler e Wittgenstein e Broch e Berg e
Schönberg e di alcune fondamentali Scuole Viennesi di filosofia, economia, diritto,
come diventa chiaro che il Rosenkavalier appartiene alla medesima civiltà
intellettuale – le lezioni d’astronomia di Alma Mahler... – con un’infinità di nessi
profondi, non soltanto esteriori, con l’Uomo senza qualità-, metamorfosi, in tutt’e
due, del Rococo in Secessione, e viceversa: nello spasimo più acuto dell’Art
Nouveau, i due austriaci stanno lavorando nello stesso senso di Beardsley e di
Gaudi, con gli stessi Tannhäuser e le stesse ringhiere; risentono sia del
pointillisme di Seurat sia delle sgargianti toilettes di Sargent; si protenderebbero
fino alle nostalgie senili di Matisse per i verdi ireos di ferro nelle stazioni del Métro
di Guimard...
“Che cosa strana è il Tempo – Lasciamo passare la vita, non è nulla – Poi, a
un tratto, non sentiamo che lui – Ci è attorno, è in noi!...” Questi versi della
Marescialla potrebbero spettare a Oriane de Guermantes, naturalmente, o
riguardare il Barone di Charlus: ma la Marescialla appartiene alla specie delle
Diotime e delle Bonadee, piuttosto (l’ambiente è lo stesso, la casa è identica, un
palazzo Leinsdorf); e gratta gratta il generale Stumm von Bordwehr e troverai il
barone Ochs von Lerchenau, gratta Tuzzi e verrà fuori un Faninal, mentre il
negretto, quello, è sempre lo stesso, per Musil e per Strauss-Hofmannsthal, con le
stesse funzioni di ‘chiudere’ una situazione piccante con uno sberleffo o un
ammicco. Ma in realtà la relazione fra il Rosenkavalier e l’Uomo senza qualità è la
stessa che meno oscuramente collega Madame Bovary al Bouvard et Pécuchet:
l’opera ‘chiusa,’ delle due, occulta trame profondamente affini a quelle che l’opera
'aperta’ ostentatamente propone nell’étalage delle sue Soluzioni di Continuità.
Nei primi anni dell’ultima guerra, arrivato a un’età gravissima, e chiuso in
uno chalet in montagna insieme a Clemens Krauss, lontano da un mondo
profondamente cambiato dai tempi quando le Salome scandalizzavano i borghesi
aggrappati all’Undecimo Co-mandamento Vittoriano, “Mai lasciarsi scoprire,” e il
Linguaggio Ornamentale che-non-ha-nulla-da-dire inaugurato da Dante Gabriele
Rossetti intorno al 1850 non era ancora franato nei “palmy days” dello Yachting
Style, e le estetiche musicali non si erano ancora impennate sulla manutenzione
della tonalità, Richard Strauss aveva avuto più di un lungo inverno per ripensare
alle fasi d’una carriera fra le più doviziose dell’intera storia della Musica. Davanti
alle cime alpine che gli avevano ‘ispirato’ tanti anni prima tante contemplazioni
pae-saggistico-romantiche, complete di campanacci di vacche, yodel di montanari
svizzeri, e tutto, cominciava forse a'rivolgersi, a settantotto anni, domande ben più
criticamente consapevoli, e definitive, sulla natura della Musica e della Poesia,
sulla essenza del Bello a teatro, come in un dialogo di Valéry. Cosi finalmente
giungeva ad affidare il senso delle sue meditazioni a un’operazione estetica simile
a quella tentata da Verdi col Falstaff, però più chic, anche se il titolo ricade
involontariamente sul Tutto nel Mondo è Burla: una “conversazione sulla musica”
in forma d’opera da camera in un atto (ma lunga due ore e un quarto). Questa è
appunto Capriccio.
Qui il favoloso vecchio già catalogato in tutte le enciclopedie per aver fatto
prorompere dall’interno l’orchestra romantica, gonfiandola artificialmente in gara
con Mahler e travolgendola nel parossismo della Danza dei Sette Veli e nelle
dissonanze dell’Elektra, lo strumentatore maniaco che nei poemi sinfonici della
maturità aggiungeva strumenti sopra strumenti, i più rari e inconsulti, come per
esplorare ogni possibilità dell’orecchio educato, si libera in pubblico d’ogni
ornamento che sappia anche lontanamente di princisbecco, proprio come quando
Salome butta in faccia a Erode uno dopo l’altro tutti i suoi veli e tutti i gioielli
‘fantasia’ comprati dal tabaccaio, e rimane con niente addosso; o anche come
quando la Marescialla capisce perfettamente a tempo il momento di tirarsi da
parte per lasciar fare l’amore ai più giovani, tra di loro. Cosi Strauss nelle opere
supreme riduce la sua orchestra a dimensioni più magre ancora di quelle prescritte
da molti colleghi ‘avanzati’; ma ha l’eleganza finale di farlo senza scendere
dall’Olimpo rococo e viennese che è soltanto suo. Quando s’apre il sipario siamo
sempre in una delle incantevoli familiari residenze ereditate dalle Nozze di Figaro,
tutte un finto-marmo; e nella Contessa che graziosamente siede al centro di un
gruppo di poltroncine bianche e dorate – puro Ritz – abbiamo il piacere di
riconoscere ancora una volta la Marescialla.
Subito il musicista Flamand e il poeta Ulivier s'avvicinano a corteggiarla:
uno sostiene che “prima la musica, dopo le parole”; l’altro, come l’abate Casti, che
“prima le parole, e poi la musica” – “Musik oder Dichtkunst?” – e intorno ai
simboli fin troppo trasparenti la disputa si svolge con squisita eleganza, su
citazioni di Gluck, Piccinni, Corneille, Goldoni, Couperin, Rameau, Me-tastasio,
accortamente infilati da Krauss nel suo libretto. Olivier recita un suo sonetto, e
Flamand fa eseguire un suo sestetto. Abbiamo una minuscola orchestra in scena,
come nel Don Giovanni, e l’espediente del teatro nel teatro, come nell 'Ariadne
auf Naxos. Accordi di clavicembalo, lezioni di canto come nel Barbiere di
Siviglia-, considerazioni sui Sentimenti, sul Cuore... Arriva il Direttore del Teatro,
“che rappresenta lo spirito pratico,” e discorre solo di quel che può piacere al
pubblico: trucchi, macchinismi, viscontismi, tempeste, apparecchi del tuono e
“musiche sull’acqua” (e va vicino a certe boutades del Teatro alla Moda, però
Strauss e Krauss non citano Benedetto Marcello...). Arrivano, portando argomenti,
il Regista e la Ballerina, la Grande Attrice, entusiasta, e il Conte, fratello della
Contessa, scettico e possibilista: e sono, intorno all’incomparabile Elisabeth
Griimmer, Haefli-ger e Brauer, la Wagner e la Otto, e Joseph Greindl che si è
appena tolto la barba del Mosè. Finalmente entrano due tipi di cantanti italiani
all’estero spassosamente sgangherati, con una certa malignità alla Téophile
Gautier.
Il loro duetto è uno dei parecchi 'numeri’ che interrompono il continuum
sonoro tessuto di citazioni melodrammatiche delle epoche più varie, come
sottofondo orchestrale alla conversazione pétillante e melodiosa. E l’esibizione
della soprano mediterranea gigiona e golosa, che emette torrenti di trilli fra un
tortino e l’altro divorati sotto gli occhi scandalizzati del maggiordomo (lei gli
sottrae rosoli e vinsanti per versarli in segreto al suo tenore) avvia al pezzo
mirabolante: un concertato clamorosissimo, travolgentissimo, con quattro gruppi
di cantanti in scena che agiscono in diversi punti, allegri o arrabbiati, o
indifferenti, mangiando e bevendo un’infinità di cose, come negli strepitosi finali
“a sette” del Re Teodoro di Paisiello, e con in più tutti gli ah ah del “che baccano”
nel Ballo in Maschera.
Il concertato termina tuttavia su una sentenza piuttosto dura, nei riguardi
dell’opera italiana. “Ci siamo divertiti abbastanza,” dicono, pressappoco, i padroni
di casa, “ma adesso basta, mandateli fuori” (e la povera gaglioffa viene trascinata
via in lacrime dai lacchè, con le sue finte cavatine di Donizetti e una seggiola
impigliata nello strascico). Poi, mentre tutti escono a cambiarsi per il pranzo, e la
conversazione è finita, senza conclusioni, un drappello dei soliti servi entra a
rimettere in ordine il salone, ballet-tisticamente, come in casa Faninal. Ma il
finale, quando la Contessa rientra in abito di gala, sorridente e splendida, indecisa
più di prima fra la Poesia e la Musica, ma felice d’essere corteggiata
da tutt’e due, e di sentirsi più primaverile della Marescialla, stra- ' namente
riconduce per sue certe fantomatiche vie all’ultima scena del T'ristano: solo,
naturalmente, gli strazi importanti di Wagner sono qui diluiti (“Liberty vo
cercando...”) in un’aura dolcemente, teneramente sentimentale...
4. Il caso Turandot
L’Opera Comica di Berlino Est volta invece le spalle alla compostezza
nell’allestimento, alla puntualità senza sbavature nella caratterizzazione dei
personaggi, alle lezioni di stile fatte con musicalità, omogeneità, leggerezza,
eleganza. Ha lasciato indietro i sicuri terreni della convenzione, e con la scuola di
Felsenstein si abbandona alle più stimolanti eccitazioni dell’esperimento: dalla
vagotonia del realismo agli espressionismi più simpaticotonici. Con un’inesausta
ricchezza d’invenzioni, Felsenstein riesce a ficcare ima quantità d’oggetti
incredibili nella sua interpretazione d’ogni opera; ma anche i suoi allievi non
arretrano di fronte all’Eccesso. Basta entrare nella hall del loro bel teatro rococo,
crema e oro, con tante divinità di stucco che pendono dal soffitto; salire le scale;
esaminare le diapositive a colori delle produzioni più cospicue, attaccate su tutte le
pareti disponibili. Tutto un decadentismo isterico, e tanta tanta roba in scena,
dappertutto: si vede meglio naturalmente nei Fra Diavoli e nei Racconti di
Hoffmann-, ma anche la loro Traviata dev’essere ghiotta: l’entrata dei toreri in
casa di Flora è puro Baden Baden, mentre il banchetto del primo atto è puro
Palazzo del Ghiaccio, coi suoi Pattinatori di Wald-teufel. L’Otello invece pare
semplicissimo, con poche scene essenziali e giapponesi.
La sala è larga, bassa, con un ampio ordine di palchi e una vasta galleria.
Una poltrona costa pochissimo, cinque o seicento lire, e gli spettatori sono quasi
tutti giovani, coi loro abiti blu e un gran traffico di pettinini. Anche una giacca da
smoking a fili d’oro, come i teddy-boys qualche anno fa. Gli spettacoli cominciano
verso le sette e mezza, e sono finiti per le dieci.
Sono capitato in una sera di Turandot, cosi l’apparato del palcoscenico era
tutto sul barbarico: grate ritorte, tipo Klee in ferro battuto, al posto del sipario;
quinte di finto marmo verde prolungate fino a coprire i palchi di proscenio; e un
grosso gong carico di emblemi appeso sopra l’orchestra, come se si fosse alla
Locanda della Settima Felicità nelle baracconate con Ingrid Bergman. Il cielo,
appena s’illumina perché comincia, è un cielo molto à la page: conosce Dubuffet. E
le masse rantolano come in ima Buona terra diretta da Brecht. Le guardie che le
tormentano arrivano invece dritte àsiiTAleksandr Nevskij, ancora con su le loro
armature da Ordine Teutonico, e tutte quelle medesime cose di cattiveria col
debole.
L’opera, si sa com’è. Pepa con le più sanguinose efferatezze (“Ha inizio – la
cerimonia! andiamo – a goderci l’ennesimo supplizio!” “Ma se la spogli nuda – è
carne! carne cruda!”) il banale aneddoto della Presentazione Mal Capita, su cui si
basavano innumerevoli jokes di commessi viaggiatori, nonché l’indimenticabile
trasmissione “Insomma, Lei chi è?” – gemma del-l’EIAR negli anni trenta. Però fra
un’eiaculazione e l’altra provocate dalle fantasie masturbatone di Octave
Mirabeau, nasconde il personaggio-chiave del ‘mito personale’ di Puccini: quel
Gran Cancelliere Ping che giustappone vis-à-vis Torre del Lago (”E potrei tornar
laggiù – presso il mio laghetto blu – tutto cinto di bambù”) alle Voci Interne che
gli sussurrano: “Ungi, arrota – che la lama – guizzi, sprizzi – fuoco e sangue.” Nel
libretto, Adami e Simoni cercano di trasferire con qualche moderato dileggio
(“Dormi!... Oblia!... Liù!... Poesia!...”) il Giardino dei Supplizi sul terreno del
‘Corriere dei Piccoli’: “O Divina! – Nella luce – Mattutina – Che dolcezza – Si
sprigiona – Dai giardini – della Cina!” E la musica di Puccini, spesso è orientale
come quei motivetti alla Shanghai Lil che fanno “tipitipitin, tipitìn, tipitipitòn,
tipitòn” tutte le volte che compare una governante cinese nei film di Lana Turner.
Però ha i suoi momenti affascinanti, e un bellissimo Inno alla Luna che potrebbe
andare come Inno Olimpico a Tokyo nel 1964 meglio ancora dell’Inno al Sole di
Mascagni alle Olimpiadi di Roma.
Mal suonata e mal cantata, la sua figura non la fa. Ma non è sul lato
musicale, evidentemente, che si concentrano le attenzioni in questo teatro. Con
tantissimi mezzi a disposizione, è chiaro che al regista Joachim Herz importava
piuttosto metter su uno spettacolone sgargiante che evidentemente è la
conseguenza d’una smodata infatuazione per il film I Vichinghi, però si vede
abbastanza volentieri, come un gagliardo banchetto con tante portate di tanti
colori, anche se il Principe Ignoto pare Achille Togliani abbigliato da Pasqualino
Maragià, e i tre Ping Pang e Pong, esageratamente truccati da clowns, fanno dei
lazzi da Toni e Giacomino. Finisce il primo atto, “quando rangola il gong la morte
gongola!” e su e giù per il foyer in una folla di mangiatori d’insalata di patate al
prezzemolo, di fette di pasticcio di carne, di bastoncini di marzapane ricoperti di
cioccolato; girano intorno al loro bell’albero di Natale; da bere, solo del vino
bianco e dell’orrendo caffè da stazione svizzera.
Il primo quadro del secondo atto è presentato come una satira gogoliana
della burocrazia, coi tre pagliacci in vesti d’Arlecchino che s’affannano tra scrittoi
altissimi in una stazione della Transiberiana addobbata con qualche pittura su
rotolo di seta. Come secondo quadro, esattamente l’interno di San Marco, con un
po’ di Budda al posto dell’iconostasi, e i sacerdoti dell’Aida che dànno un party per
il Grande Inquisitore del Don Carlos, presentandogli jongleurs kabuki e giochi di
foulards interessanti per quanto un po’ lunghi.
Si sa cosa succede a questo punto: una specie d’antico tote calcio cinese, con
la differenza che per vincere basta far tre, chi perde però finisce male, e il montepremi è indivisibile, trattandosi della figlia dell’Imperatore. La ricchezza
dell’apparato qui è inverosimile: colpi di xilofono, esercizi di acquasantiere, ed
enigmi in astucci da torrone. Ma le modalità del quiz sono le stesse di “Lascia o
raddoppia”: soltanto, al posto del notaio siedono i tre clowns, facendo delle
smorfiacce invereconde; e invece di urlare “la risposta è esatta!” si suona l’Inno
Olimpico tutte le volte.
Quando finalmente appare Turandot, si presenta ima cantante che non è né
magra né giovane, con tendenza per di più ad assumere toni furbetti da Lilia Silvi.
Subito si ha l’impressione che per l’esagerata difficoltà degli enigmi lei abbia
dovuto star lì ad aspettare moltissimi anni prima di trovare un pretendente
abbastanza fortunato, perdendo anche un po’ di voce, a furia di cantare da sola. Si
capisce perciò anche troppo lo smarrimento e la confusione del povero principe
Calaf, che dopo tutta la fatica e i rischi si trova davanti un’anziana signora che
potrebbe essere la sua mamma, appesantita da troppi castagnacci, e per un
“giuramento atroce” e un “fosco patto” si vede costretto all’Amore.
All’inizio del terzo atto, Andrea Chénier all’assedio di Poitiers. Quando
entra troppa gente, subito la Kovaticina. Lo spogliarello delle tentatrici, puro
Dodo d’Hambourg. Però il “Nessun dorma” è con estrema precisione uno di quegli
incubi politici moderni, quando per esempio Mao li tiene su tutti per tutta la notte
a dare la caccia alle zanzare o alle rondini. L’entrata di lei in portantina, invece, è
senza dubbio l’arrivo di Sofonisba da Massinissa, in Scipione l'Africano. E il finale
è la solita incoronazione del Boris. Ma anche in uno spettacolo così ambizioso, si
vede troppo da che parti vengono le luci: si può risalire quasi sempre addirittura al
singolo riflettore.
[inverno 1960-’61]
(da: Grazie per le magnifiche rose, Milano, Feltrinelli,
1965)
GIORGIO MANGANELLI
Due risvolti di copertina
Improvvisi per macchina da scrivere
(1989)
La macchina da scrivere nasce dai capricciosi amori di un cembalo estroso e di una
mite mitragliatrice giocattolo. I suoi connotati più suasivi sono la tastiera e il
macchinoso frastuono. Per codesto amore, il cembalo ha deposto le sue arie, e la
mitragliatrice i suoi infantili, innocui furori. Le lettere che leggete sui testi sono
quanto resta degli antichi melodrammi, delle favole pastorali in cui il cembalo,
complice consenziente, venne coinvolto. Fu un amabile dono di nozze.
Incidentalmente, per questo la macchina da scrivere racconta volentieri romanzi e
progetta epistolari.
Nell’anima del dattilografo — inteso nel senso più ampio — si nasconde un solista
dei tasti; è consanguineo del pianista, del clavicembalista, di tutti coloro che
vivono di e per una tastiera.
Sommamente invitante è la tastiera; davanti ai tasti neri, alle lettere bianche, le
dita si innervosiscono, come danzatori prima del ballo. Così accadeva quando il
cembalista sedeva, solo, davanti alla tastiera. Non cercava né pentagramma, né
metronomo; solo una tastiera voleva, e un pubblico silenzioso. Precipitosamente
esatte percorrevano le dita i tasti candidi e notturni: improvvisavano. Per
generazioni l’aria del mondo rabbrividì di delizia a quelle volatili improvvisazioni
che non ascolteremo mai. Se Mozart avesse potuto imprimere su di un mobile rullo
pentagrammato i capricci di una mano danzante!
Improvvisazione: la macchina da scrivere ha questo dono difficile: cattura
l’improvvisazione. Vi furono improvvisatori pianisti, violinisti, cantanti, anche
poeti: ne resta solo la stupita testimonianza di qualche spettatore. Altri improvvisò
discorsi: ne vennero catastrofi. Ma la minima, umile macchina da scrivere è oggi la
naturale tastiera dell’improvvisatore. Esigua, futile e svelta è l’improvvisazione: un
po’ furba un po’ sciocca, un gioco patetico, insulto soave, graziosa villania; infine,
istantaneo, già scomparso, è il rintocco di un riso già dimentico di ciò di cui si è
riso.
*
Rumori o voci
(1987)
Se avete una intima inclinazione per il baccano, il bordello, il fracasso, il frastuono,
la gazzarra e il putiferio, non dovete supporre di essere un pervertito auditivo; non
vi toccherà un inferno di silenzio, sussurri, fievoli fiati; ma piuttosto significherà
che ospitate una occulta e forse disattesa vocazione per le chiacchiere, i
pettegolezzi, il commerage del cosmo. Frastuonando cianciano gli asteroidi,
ammiccando bisbigliano i satelliti, brontolano le indaffarate meteore. Se un poco
di inclinazione ai valori perenni della civiltà sapiens indugerà in voi, certo sarete
degustatori del diavoleto, ovvero diavolio, o meglio pandemonio, ma anche il
semplice, nonnesco inferno è termine non inesatto per dir grandissima cagnara; e
appena si notino certe delicatezze come boato e rintocco, detonazione e sospiro,
conflagrazione e crepitio, chioccolio e bisbiglio, che tutt’insieme paiono alludere ad
una storia di bella ed intima drammaticità. E chi smusica, miei cari? Chi dal
tramenio trapassa all’uggiolio e al roucoulement? Chi, altrimenti, sarabanda e
tracotando in un rombazzo scroscia, fa trambusto e subbuglio e infine schianto?
Ma che è mai, che è mai codesto finimondo? Non sarà, per l’appunto, se stesso?
da: Rumori o voci
explicit
[…] Ma a te non sta di fronte una dialettica verbale, una eloquenza purchessia, ma
un agglomerato vocale che non conosce inizio o conclusione. E dunque ascolta
come la tua intenzione, pia e virtuosa, si trasformi in una impennata di voce, una
voce monotona, aspra, irta, iterativa, che via via verrà misurandosi con l’altra che
tu hai scelto, insensato senso. Non diresti che questa, che abbiamo detto altra
voce, eccepisce? Direi che non v’è dubbio. Articolando suoni infimi, echi e
rintocchi sordi, la voce resiste, con più furbizia che onestà, ma non credo che
l’inonestà sia estranea a questa invasione delle voci, e forse anzi tutte le voci sono
inoneste. Eccepisce con strenua, sorniona sordidezza, sordamente, sommessa;
querula e, lo osasse, litigiosa; certo blandamente, anche flebilmente accusatoria,
quasi gemendo come disattesa, disamata, disertata, derelitta; fingendo, se qui è
lecito distinguere finzione da recita, una sussurrata e corrucciata blandizie;
sperimentando elaborate cadenze, delicati capricci vocali. Cui tu farai diniego, o
solamente farai mostra di calcolata indifferenza. Ma ora odi una voce acre,
dispettosa, non ancora pronta alla furia, ma colma di ira, e insieme trattenuta da
una sorta di paura di te, o paura d’altro che la voce conosce, ma non tu, non io;
altro che sarà pur sempre in qualche modo voce. Ed ora ascolta: l’ira si impenna, il
furore vocale percorre istantanei cieli, dovunque si libra uno stormo di volatili
vocali. La voce, furibondo uccello, scende disegno di sillabe per l’aria, in forma di
becco infinito, assalta quella che ora è viltà vana, reticenza astuta, e ferisce a fondo
le viscere d’aria dell’ostinato diniego. Infine sperimenti di silenzio; il cielo è colmo
di suoni morti, piume sonore di volatili, uccisi rintocchi; si celebra la morte del
suono. La voce è spenta. Una goccia. Una porta. Un vento disperde una polvere di
rantoli e strida. Ascolta: può essere che la notte abbia una fine? Che tu venga
assolto da questo tuo acquattarti, esentato dal diniego, che la mappa delle voci
venga dichiarata illegale, e dolcemente, fermamente sottratta alla acuzie delle tue
mani? Può essere. Io dovrei parlarti, io nonvoce, della lacerazione della notte, e
della progettazione dell’alba, del barlume. Scinde il silenzio un grande, nobile
stridore. Questo ora vorresti sapere, vero? Che è mai questo frastuono? Questo
subito fragore, quale mai hai udito? Questo urlare della notte, scheggiata in una
moltitudine di notti, perle, gocce dì notte? Che è questo rombo, farnetico,
frastuono, quale rissa governa il mondo, dilata lo spazio? E che vuoi che sia questo
biscanto, questo bailamme, questo stridore e fracasso, questo sibilo dell’aria,
questo brivido sonoro? E che vuoi che sia, mio caro nottambulo, mio sedentario
delle tenebre, se non questo, questo appunto — la resurrezione dei morti?
Scaricare