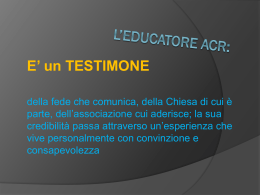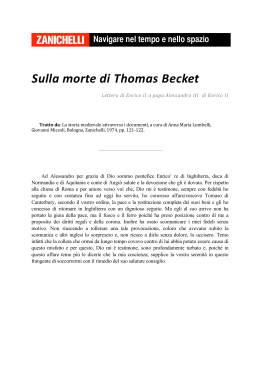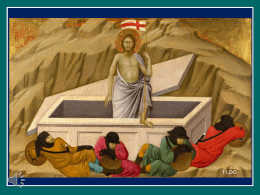LA COSTRUZIONE DELLA STORIA E LETTERATURA TESTIMONIANZA FRA Daniela Padoan «Una necessità forte come la gravità condanna l'uomo al male, gli vieta ogni bene se non strettamente limitato, difficilmente ottenuto, tutto intriso e imbrattato di male» scrive Simone Weil nel 1942; ed è la letteratura – quando non è finzione, ovvero quando non è immorale – a fargli provare «la gravità come la si prova guardando un precipizio, essendo al sicuro e non soggetti a vertigini»; permettendogli di distinguere «l'unità e la diversità delle sue forme in quell'architettura dell'abisso».1 Per Weil, solo il genio nella sua piena maturità può declinare morale e letteratura; tutto il resto è fittizio. Nella scrittura delle testimonianze, i testi che nel tempo sono divenuti classici non poggiano sul genio individuale ma sulla posizione abissale del narratore, capace di restituirci, proprio in quanto testimone, un racconto irripetibile di ciò che ha visto. Una posizione non sostituibile da altri, che nel farsi scrittura – dunque nel rendersi leggibile, comunicabile – ci conduce a sporgerci su ciò che per definizione possiamo chiamare architettura dell'abisso. «Non vorrei mai sentire qualcuno parlare del Lager senza esserci stato» dice Giuliana Tedeschi, «sarebbe un disastro. Ci vogliono gli scritti, le testimonianze di quelli che ci sono stati, di chi sa di che cosa parla, quando dice Auschwitz. Il Lager ha una sua parola inconfondibile […]. È impossibile trovare le parole, o anche i silenzi, che rispondano in modo perfetto a quella realtà, senza averla vissuta».2 Ma se la scrittura del Lager è scrittura morale (a differenza della narrativa sul Lager, che rischia sempre di oltrepassare il limite «oltre il quale l'esercizio di un'arte, qualunque essa sia, diventa un insulto o una disgrazia», come ha lapidariamente scritto Maurice Blanchot),3 perché questa scrittura si faccia esperienza e memoria collettiva, deve essere resa, secondo le regole che le sono proprie, da chi «sa di cosa parla quando dice Auschwitz». Tuttavia la maggior parte dei testimoni non ha scritto, pur avendone spesso un acuto desiderio; per mancanza di fiducia nelle proprie capacità, o per la sensazione che tutto fosse già stato detto da altri. «Ci ho pensato mille volte» ammette Liliana Segre, «ma il foglio bianco mi terrorizza. Qualche volta mi mandano le testimonianze sbobinate, ma la scrittura è un’altra cosa. Poi hanno scritto in tanti, e alcuni hanno scritto così bene che non potrei mai fare altrettanto».4 E così le esperienze che non si sono date nella forma della scrittura – spesso rese canone nella testimonianza orale e nelle registrazioni – sono patrimoni destinati a una permanenza circoscritta agli archivi, a meno che non si spezzi l'interdetto e che una seconda 1 Simone Weil, Morale e letteratura (in «Cahiers du Sud», n. 263, gennaio 1944, pp. 40-45, firmato Emile Novis), tr. it. di N. Maroger, ETS, Pisa 1990, pp. 23, 25. 2 Giuliana Tedeschi, in D. Padoan, Come una rana d'inverno, Bompiani, Milano 2004, p. 174. 3 Maurice Blanchot, La scrittura del disastro, tr. it. di F. Sossi, SE, Milano 1990, p. 49. 4 Liliana Segre, in D. Padoan, op. cit., p. 47. 1 persona intervenga a prestare al testimone il lavoro della scrittura; una scrittura fondata sull'ascolto, possibile solo attraverso l'articolarsi di una relazione basata su una reciproca autorizzazione, imprendibile nelle griglie di un “metodo”. Non si può testimoniare in astratto, sostiene Giuliana Tedeschi, «ma solo davanti a un interlocutore profondamente disposto all’ascolto».5 Si tratta di un discorso intimamente connesso all'argomento di questo convegno che, proponendosi una riflessione sul guadagno ottenuto dalla storiografia nell'allargare lo sguardo alla deportazione femminile, non può fare a meno di interrogarsi sulla richiesta di relazionalità espressa dalle testimoni. Certo, è molto diverso considerare il testimone come fonte o come protagonista di una narrazione: nel primo caso è l'oggetto sul quale lo storico lavora per la raccolta e la conservazione del reperto; nel secondo caso è il soggetto della propria storia e sta con essa in rapporto di autorialità, indipendentemente dal fatto che sia o meno egli stesso a scriverla. Dove il testimone è fonte, dove si fa riferimento a una trascrizione esatta del parlato, non si dà racconto, perché il racconto è costruzione e artificio; tuttavia capita che proprio quella costruzione e quell'artificio abbiano la prerogativa di giungere non solo a una dicibilità e a una trasmissibilità dell'esperienza, ma anche, paradossalmente, a una maggiore approssimazione alla verità dell'esperienza. Mi è stato chiesto più volte se le conversazioni che ho raccolto possano essere considerate fonti, o se il lavoro di manipolazione del testo le renda problematiche. Quale necessità è sottesa a questa domanda? a quale concetto di verità, di autenticità, fa riferimento? Quasi che l'imprendibilità dell'esperienza, e più in generale l'inafferrabilità delle esistenze umane, si potesse racchiudere nei perimetri di una disciplina o di un metodo, anziché tentare di giungere a un accostamento di frammenti che solo nella pluralità del loro disporsi formano un disegno, mai identico ma sempre in movimento. «La critica storica» dice Paul Veyne, «ha per unica funzione quella di rispondere al seguente quesito, postole dallo storico: io giudico che questo documento mi apprende la tale cosa; posso sotto questo riguardo dargli fiducia?»6 Fiducia rispetto al suo essere vero, perché, se la storia è aneddotica – dice ancora Veyne – e interessa raccontando, similmente al romanzo, essa è racconto di avvenimenti veri. Che la fiducia sulla verità della testimonianza possa darsi solo a condizione di poggiare sul lavoro della storiografia, capace di delimitare un territorio che non ci faccia precipitare nella menzogna o, peggio ancora, nella perdita del concetto che «questo è stato», è evidente; ma il lavoro della storiografia diviene a sua volta impensabile senza le testimonianze, ovvero senza l'offrirsi di un racconto che appare perlomeno impervio voler piegare a una misura di scientificità. Sono più affidabili – tenendoci dunque al concetto di fiducia – le pure sbobinature e trascrizioni di interviste? Sono convinta di no, perché per giungere alla scrittura di una testimonianza è essenziale l'instaurarsi di un patto di fiducia tra colui che narra e colui che 5 6 Giuliana Tedeschi, in D. Padoan, op. cit., p. 171. Paul Veyne, Come si scrive la storia, tr. it. di G. Ferrara, Laterza, Bari 1973, p. 24. 2 ascolta al fine di giungere assieme al lavoro della scrittura (e per scrittura intendo, in certo modo, anche la necessaria costruzione visiva di un documentario, fatto di testo e paratesto). È sufficiente che, nel caso di autori come Primo Levi, Jean Améry o Charlotte Delbo, per fare un esempio, le figure di testimone e scrittore coincidano, per considerare le loro opere attendibili dal punto di vista scientifico? Qualcuno avrebbe chiesto loro una rassicurazione sul proprio essere fonti? È proprio Levi a dire, a proposito dei Sommersi e i salvati: «questo stesso libro è intriso di memoria: per di più, di una memoria lontana. Attinge dunque a una fonte sospetta, e deve essere difeso contro se stesso».7 Un paradosso, o un'iperbole. Ma anche questa, come tutte le figure per eccesso, potrebbe rivelarsi utile a riflettere sul caso più spiccio, per quanto non privo di aspetti problematici, in cui una figura esterna si presti al lavoro della scrittura, pur lasciando l'autorialità al testimone, e con esso proceda a un affinamento e messa a punto di contenuto e di stile. Parlo di stile perché quella che possiamo chiamare un'accettabile approssimazione alla verità si dà anche tramite scelte estetiche (il che non vuol dire scegliere le parole più “belle”, ma scegliere le parole più somiglianti al loro pronunziatore) fino al momento in cui al testimone sia possibile dire: questo è il mio testo, questa è la mia esperienza, detta con queste parole e non con altre. Perché è proprio del lavoro della scrittura – benché possa essere riscritta mille volte – di farsi sedimento e traccia non cancellabile, sempre più ancorata a quelle specifiche parole man mano che si dà nello spazio pubblico della lettura. Se leggiamo le trascrizioni degli interrogatori in tribunale, così come le sbobinature delle interviste, vediamo che la lingua risulta viziata e innaturale, priva di una fluidità che la renda utilizzabile narrativamente fuori da un ambito di ricerca giudiziaria, sociologica, antropologica, storica o di qualsivoglia altro sapere, e questo anche nei casi di chi ha maggior capacità di eloquio, per il semplice motivo che il parlato ha bisogno di una traduzione per diventare scritto. Il passaggio perché ciò avvenga – perché, dunque, il testo si dia come leggibile – non sta solo nell'applicazione delle regole grammaticali e della sintassi, ma nell'interpretazione di un voler dire, lontanissimo dalle retoriche del “dar voce” in cui, anche con le migliori intenzioni, già nella formulazione è implicita una disparità. Una scrittura messa al servizio dell'altro, dove non sono i tuoi aggettivi, i tuoi concetti, a forzare il voler dire che ti è stato consegnato, ma dove il risultato sta nello sporgersi verso l'altro per giungere a una restituzione. Un atteggiamento in cui la persona che raccoglie la testimonianza mira a tenersi in disparte ma non ad annullarsi, consapevole di non poter ipostatizzare una neutralità per il fatto (quasi una tautologia) che gli scambi tra umani si danno nell'umanità, e che dunque la traccia o il sedimento della relazione non solo non contamina la purezza della fonte, ma la rende attingibile ad altri. Proprio perché il darsi della fonte allude a qualcosa di sorgivo, attinto per la prima volta (è la stessa struttura simbolica implicata nella scelta del termine a condurre a concetti che stanno nell'opposizione purezza/contaminazione, visto che neppure la 7 Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986, p. 23. 3 lingua è neutra) quando leggiamo sbobinature smozzicate, piene di ripetizioni, balbettii, esitazioni e inciampi ci ritroviamo in una postura di padronanza che origina dalla supremazia che lo scritto ha sull'orale, quando la prospettiva sia quella della lettura. Ben diverso sarebbe se la prospettiva fosse quella dell'ascolto, dove l'ordine del testo scritto suonerebbe ampolloso e innaturale (dunque falso), proprio perché «ciascun medium considera un valore ciò che l'altro considera una minaccia».8 Ogni discorso, registrato e sbobinato fedelmente (è interessante qui notare, a dispetto della comunanza etimologica, la profonda differenza che intercorre tra i concetti di fedeltà e fiducia) fa il medesimo effetto di assenza di filo logico, di smarrimento di subordinate, di incisi aperti e dimenticati, di sovrapposizioni e ripetizioni, perché lo scambio che si dà tra due persone segue delle regole sue proprie, diverse da quelle del discorso in pubblico e soprattutto da quelle del testo scritto: non può essere aurorale né sorgivo, deve attraversare il processo del “fatto ad arte” (da cui deriva il concetto di artificio) per suonare vero, e dunque per farsi veicolo del vero. La registrazione delle fonti orali è imprescindibile, e non solo perché ci mette in grado di ascoltare le precise parole dette da un particolare testimone, ma perché può farcene “fare conoscenza” grazie a un supporto su cui sono miracolosamente rimasti impigliati un tono di voce, un'esitazione o un'improvvisa alterazione; nel caso di una registrazione visiva, uno sguardo, un fugace sorriso. È il prodigio che si dà quando abbiamo l'occasione, per esempio, di trovarci “faccia a faccia” con Primo Levi, di percepirne la timidezza, il riserbo, l'implacabilità; di coglierne tutto ciò che non si dà nella scrittura, ma che con la scrittura sta in dialogo. Tuttavia, ciò che davvero resta, fuori dagli archivi accessibili agli specialisti, è ancora una volta il testo, e a quello facciamo riferimento quando parliamo di trasmissibilità della memoria. Un testo che non è trascrizione, ma letteratura. Le testimonianze di Elie Wiesel, Primo Levi, Jorge Semprun, Robert Antelme o Ruth Klüger permangono perché si sono date come letteratura: solo così hanno potuto parlare a tutti. E non perché per parlare a tutti occorra un linguaggio semplice, levigato, privo di asperità e inciampi, ma perché la scrittura ci chiama in causa, ci spinge all'identificazione, mentre la trascrizione, pur avendo una maggiore pretesa di verità, ci mette di fronte a un organismo immerso nella formalina, e lo sguardo che lo fissa è quello dell'entomologo; uno sguardo in cui alberga un collocarsi altrove, nella protezione di un sapere. La relazionalità della testimonianza trova espressione nella letteratura perché, non facendosi schermo di saperi, di metodi, di discipline, ed essendo perciò spiazzante, porta in sé la necessità primaria di immaginare, accogliendo ciò che è illuminato e ciò che non lo è come elementi egualmente costitutivi della narrazione, lasciando al lettore la cucitura tra luce e ombra. «Per ricordare, occorre immaginare» dice il filosofo e storico dell'arte Georges Didi-Huberman, che si è a lungo interrogato sullo statuto della fotografia nella memoria della Shoah, prendendo le mosse dallo scarso interesse mostrato dalla storiografia per le 8 Alessandro Portelli, Storie orali, Donzelli, Roma 2007, p. 104. 4 immagini (in particolare quelle scattate di nascosto dall'anonimo membro del Sonderkommando di Auschwitz nell'agosto 1944, raffiguranti la cremazione di corpi in fosse aperte e un gruppo di donne spinte verso la camera a gas del crematorio V), e il cui discorso può essere utilmente sovrapposto a quello sulla testimonianza. «Nelle foto il fumo nasconde la struttura delle fosse, il movimento del fotografo rende sfuocato e incomprensibile quanto avviene nel bosco di betulle. Ora, è proprio questo – questo doppio regime di ogni immagine – che disturba spesso lo storico e lo “distoglie” da un materiale simile».9 Un doppio regime tra verità e oscurità che, sostiene Didi-Huberman, ci porta a domandare troppo, o troppo poco, all'immagine. Se le domandiamo troppo, cioè «tutta la verità», saremo ben presto delusi: le immagini non sono che lembi strappati, pezzi di pellicola; sono inadeguate e addirittura, in qualche modo, inesatte. Se le domandiamo troppo poco, però, relegheremo l'immagine nella sfera del simulacro, estromettendola così dal campo storico, oppure la relegheremo nella sfera del documento, cancellandone la fenomenologia, la specificità, la sostanza.10 Parimenti, chiedere troppo poco alle testimonianze porta a considerarle simulacro; chiedere troppo porta a considerarle inadeguate, induce alla diffidenza suscitata negli storici dal loro essere per definizione soggettive e condannate all'inesattezza. Annette Wieviorka cita il caso di un ex deportato che, invitato a un convegno, si è indignato nel sentire alcuni storici parlare dei testimoni come di documenti viventi,11 per poi commentare che questa vicenda pone «il problema della tensione tra il testimone e lo storico; una tensione, o meglio, una rivalità, e perché no, una lotta per il potere, che sta al centro degli attuali dibattiti sulla storia del nostro tempo».12 Questa la posizione paradossale dei testimoni: documenti, o fonti, sui quali si procede a costruire un edificio a loro non più abitabile, dal quale però non possono uscire, pena l'accusa di tracimazione. Posto che di lotta per il potere si tratti, da parte dei testimoni, non può sfuggire la disparità tra i contendenti. «Non vedono l'ora che ci togliamo di mezzo» mi ha detto un giorno Goti Bauer, parlando dell'incomprensibile dissidio alimentato da alcuni storici nella necessità di definire in quale discorso, testimoniale o scientifico, collocare la viva presenza di chi, avendo vissuto e patito la Shoah, continua a portarne una narrazione. «Quando noi saremo morti – e non ci manca molto, perché siamo sempre meno, sempre più deboli – non dovranno più protestare perché lo spazio che ritengono spettare alla storiografia è invaso dai testimoni. Ma senza le nostre parole, senza il racconto di noi che abbiamo visto e che ne portiamo ancora i segni, non so davvero come faranno. Alle nostre parole dovranno sempre riferirsi, dare un significato». Le parole, i segni di cui i testimoni sono portatori, costituiscono il lascito che ci viene consegnato perché ci sia possibile continuare a sforzarci, attraverso l'immedesimazione e la germinazione di un ri-sentimento, di capire quello che sta a noi 9 Georges Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, tr. it. di D. Tarizzo, Raffaello Cortina, Milano 2005, p. 52. Cfr. Ivi, p. 53. 11 Cfr. Annette Wieviorka, L'era del testimone, tr. it. di F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 1999, p.140. 12 Ivi, p. 141. 10 5 capire, sapendo che, come dice Elie Wiesel, «voi che non eravate sotto il cielo di sangue, non saprete mai che cos’era. Anche se leggete tutte le opere, anche se ascoltate tutte le testimonianze, resterete dall’altra parte del muro».13 La letteratura è precisamente ciò che, per metafore e paragoni, ci conduce a guardare oltre quel muro che non possiamo in alcun modo oltrepassare. «La riflessione sulle condizioni umane è mai qualcosa di diverso dal risalire da ciò che si conosce a ciò che si può riconoscere come affine?» chiede Ruth Klüger. «Senza paragoni non si arriva da nessuna parte. Altrimenti non si può far altro che mettere la cosa agli atti, un trauma che si sottrae all’immedesimazione».14 Nel corso di un'intervista, ho citato a Ruth Klüger un passaggio dello scrittore israeliano Aaron Appelfeld, anch'egli sopravvissuto alla deportazione, secondo il quale la letteratura è la sola a dire al testimone: «guardiamo questa particolare persona. Diamole un nome, un luogo. Offriamole una tazza di caffè. […] La forza della letteratura risiede nella capacità di creare un'intimità. Quel genere di intimità che ci tocca personalmente».15 Intendevo, con questo, domandarle che cosa pensasse della contrapposizione che si è venuta a creare fra testimoni e storici. «Appelfeld ha ragione» ha risposto, «ma avrei qualcosa da aggiungere: la letteratura della Shoah è una letteratura di sopravvissuti, di scampati, e questo dà la confortevole sensazione che tutti ce l'abbiano fatta; tuttavia non dobbiamo dimenticare che la maggior parte delle persone sono morte nei campi. È solo questa evidenza a poter davvero parlare della morte, e non delle sofferenze che i pochi sopravvissuti hanno patito per pochi anni. Parliamo di circa sei milioni di persone che sono state uccise, e questo è ciò che viene raccontato dai sociologi e dagli storici, e non dalla letteratura. Così abbiamo bisogno di entrambe».16 Dando dunque per acquisito il rifiuto di ogni sterile contrapposizione tra storico e testimone (di cui peraltro non si trova traccia nei testi di grandi storici della Shoah, da Poliakov a Hilberg, da Browning a Bauer, da Mommsen a Friedländer) se vogliamo parlare della trasmissibilità della memoria e quindi del modo in cui le parole dei testimoni possano continuare, pur nel loro farsi storia, a essere vive e a parlare a un pubblico di lettori e non solo di specialisti, dobbiamo attardarci a ragionare su quel «caffè» scambiato tra lettore e testimone, e su quella «intimità che ci tocca personalmente», perché proprio lì sta la possibilità della permanenza, ovvero la possibilità che non si metta «la cosa agli atti». Eppure, prendendo le mosse dalle parole di Appelfeld, Annette Wieviorka – che di questa contrapposizione sembra essere divenuta un emblema, anche oltre le tesi sostenute nei suoi testi – si disfa a buon mercato dell'invito all'intimità della relazione testimoniale. «Tale concetto di intimità va ben al di là della semplice testimonianza della Shoah» scrive. «Sta al centro della nostra società e del funzionamento dei media […]. Nelle 13 Elie Wiesel, Parole di straniero, tr. it.di O. Miani, Spirali, Milano 1986, p. 11. Ruth Klüger, Vivere ancora, tr. it. di A. Lavagetto, Einaudi, Torino 1995, p. 106. 15 Aaron Appelfeld, cit. in Nathan Beyrak, To rescue the individual out of the mass number: intimacy as a central concept in oral history, in Ces visage qui nous parlent, a cura di M. Cling e Y. Thanassekos, Atti dell’incontro audiovisivo internazionale sulla testimonianza dei sopravvissuti dei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Fondation Auschwitz e Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Bruxelles-Paris 1995, p. 137. 16 Ruth Klüger, Senza un altrove, sospesi tra i vivi e i morti, intervista di D. Padoan, "Il Manifesto", 25 ottobre 2005. 14 6 trasmissioni dell'intimità, l'occhio della telecamera spia l'occhio del testimone».17 Con questo passaggio, Wiewiorka limita all'ambito della spettacolarizzazione un argomento – quello dell'intimità, appunto – che linguisti e filosofi annettono al farsi stesso dell'opera, nella relazione costitutiva tra autore e lettore; per poi ricavarne, a ben vedere con un salto logico, che «il testimone si rivolge al cuore, e non alla ragione. Suscita pietà, compassione, indignazione e talvolta persino un senso di rivolta. Il testimone stipula un “patto di compassione” con colui che lo ascolta».18 Così è divenuta purtroppo consueta, nei convegni dedicati alla testimonianza, la figura del relatore che, mentre svolge con professionalità il suo intervento, sfoglia una copia ormai consunta dell'Era del testimone, infiorettata di post-it colorati a segnare i consueti passaggi, punti non più eludibili di una liturgia sulla tracimazione dei testimoni e sul loro «aver occupato la scena»; luoghi resi comuni, concetti divenuti assiomatici. La comunità discorsiva, in un determinato tempo e luogo, sempre trasceglie, all'interno di un'opera, un filo di pensiero a scapito di un altro; e questo dice, più ancora che dell'opera, della koinè dei parlanti. Credo non faccia giustizia all'autrice – la cui brutale schiettezza nel porre la questione ha quanto meno il merito di averla resa palese – il disprezzo con cui, poggiando su questo libro, si continua da anni a parlare dell'attitudine dei testimoni a «rivolgersi al cuore e non alla ragione», per finire col salmodiare l'inevitabile domanda: «come costruire un discorso storico coerente se ad esso si contrappone costantemente un'altra verità, quella delle memorie individuali? Come fare appello alla riflessione, al pensiero, al rigore, quando i sentimenti e le emozioni invadono la scena pubblica?»19 Per uscire dal vicolo cieco della presunta inconciliabilità di emozione e pensiero, che proprio le testimonianze della Shoah, nel loro toccare l'estremo, ci indicano come inestricabili, è necessario uno sforzo che porti ad accogliere il concetto della differenza (e non solo quella di genere); una libertà che ci consenta di uscire dagli universali, dalle maiuscole, dalle declinazioni dell'Uno. Liliana Segre ricorda spesso le parole di un noto storico proferite nel corso di una celebrazione pubblica: «Devono parlare gli storici. I testimoni sono i patetici burattini della memoria». Parole su cui si è a lungo tormentata: «Ha detto proprio così, ho potuto risentirle perché avevo la cassetta registrata. Quella frase mi ha fatto molto pensare e devo dire che, sì, la testimonianza, al di là di un giudizio così duro, effettivamente si presta a una manipolazione. Quello di cui parlo è uno storico di gran valore, quindi di certo non vede il testimone come un intralcio, come qualcosa che sarebbe meglio non esistesse; ma questa è precisamente la posizione di revisionisti e negazionisti, per i quali attaccarsi alla seppur minima imprecisione, a un’imperfezione nel racconto, è una manna dal cielo. E io non vorrei fare nessun favore a revisionisti e negazionisti. Siccome gli anni che passano possono portare a una deformazione della realtà nel ricordo, noi testimoni dobbiamo essere molto severi 17 Annette Wiewiorka, op. cit., p. 152. Ivi, p. 153. 19 Ivi, p. 154. 18 7 con noi stessi, non dobbiamo indulgere mai a qualcosa che sia anche minimamente diverso dalla realtà. Per quello che mi riguarda, faccio sempre estrema attenzione a saltare un passaggio piuttosto che ad aggiungere anche una sola parola di cui non sono assolutamente certa. Mi dispiace molto se lo storico può aver ragione del testimone, perché il testimone è un uomo, o una donna, con pregi e difetti, e può cadere in una piccola contraddizione che però, nel caso della Shoah, diventa gravissima, mentre non è vista con altrettanta gravità in testimonianze di altro genere. Se, per esempio, uno è stato testimone di un incidente d’auto in cui ci sono stati dieci morti e ne ha visti nove, nessuno gli si scaglia addosso per questo; invece un testimone della Shoah, se appena appena dimentica un dettaglio o lo aggiunge, povero lui, si trova stuoli di storici a dire che la testimonianza è addirittura negativa».20 Nel suo continuo arrovellarsi sui dettagli, nella tensione a una puntigliosa quanto commovente precisione, Goti Bauer mi ha raccontato di aver letto, nella documentazione conservata al Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, la testimonianza di Frida Misul, sua compagna di prigionia nella baracca 27 di Birkenau. «Secondo lei, su quegli stracci che ci venivano dati al posto delle casacche all'esaurirsi dei rifornimenti dalla Germania, sarebbe stata dipinta una striscia rossa col sangue tolto a noi prigionieri. Ma non è vero! Era vernice, vernice rossa, per renderci riconoscibili e impedire ogni tentativo di evasione. Ma la cosa peggiore è che nella sua testimonianza sta scritto che le SS violentavano le ragazze davanti alle madri. Non è mai successo. A Birkenau non c'era questo tipo di violenza. Lì hanno fatto cose molto più spaventose; che bisogno c'è di inventare efferatezze? Come se non bastasse che hanno gasato e bruciato la gente, che hanno ucciso migliaia di bambini. Noi testimoni parliamo in tono minore, non vogliamo contendere la scena a nessuno: vogliamo soltanto essere creduti. Proprio per questo non possiamo consentire che invenzioni di questa portata – fatte senz'altro in buona fede, frutto di grande sofferenza – gettino discredito sulla nostra testimonianza, minandone la credibilità».21 Goti Bauer scrisse una lettera, firmata anche dall'amica ed ex compagna di Lager Hanna Kugler Weiss, in cui chiedeva che quella testimonianza non venisse più resa accessibile al pubblico. Le fu risposto che tutte le testimonianze, al pari della sua, hanno identico valore. Una risposta che, come ovvio, la ferì profondamente. Qualche tempo fa, ho fatto questo racconto a una studiosa della Shoah, riflettendo su come la posizione dei testimoni sia, in fondo, pienamente tragica. La sua risposta mi è rimasta impressa quasi parola per parola: «È così, il loro ricordo è quanto di meno credibile, eppure non possono accettare di non essere in grado di dire la verità su ciò che hanno vissuto È del tutto evidente che le due testimonianze si equivalgano. Nella Misul è interessante la creazione di un mondo fantastico: non avendo strumenti interpretativi, metaforizza nella fiaba, nel libretto d'opera. Ha avuto un'infanzia di grande povertà, il padre faceva il cantante d'opera, e il Lager si è trasformato nel 20 21 Liliana Segre, in D. Padoan, op. cit., pp. 49-50. Goti Bauer, Archivio D. Padoan 2007. 8 castello di Barbablù. L'invenzione, nel suo caso, diventa modalità comunicativa». Sono parole su cui si potrebbe discutere a lungo, ma per me stanno come una pietra miliare a segnare un crocevia, un passaggio pericoloso e infido. Per quanto necessaria, la tensione a catalogare le fonti secondo qualità e affidabilità, a verificare la credibilità e le incongruenze del racconto, a comprenderne e analizzarne le metaforizzazioni, non può liberarsi da un atteggiamento di condiscendenza verso il testimone: un atteggiamento che porta in sé il frutto avvelenato della perdita di rispetto. Corre, tra gli specialisti, un fastidio sulla ripetitività delle testimonianze, sulla loro costruzione retorica, su certi passaggi che si danno sempre molto simili nella scelta delle parole e nell'intonazione. Ma chi, quando ci presentiamo in pubblico, ha il diritto di chiederci l'autenticità della nudità? Al testimone invece si chiede di darsi nella nudità del trauma, quasi che la verità della sua esperienza potesse manifestarsi solo ora, solo qui, davanti a me che lo ascolto. È una domanda sulla cui impudicizia occorre riflettere. Cosa ci dice su di noi e sul concetto di verità, di autenticità cui, ancora una volta, continuiamo a fare riferimento? Solo se ci soffermiamo davvero a immaginare cosa debbano essere, nel corso di un'intera esistenza, gli assalti del ricordo e la necessità di tenerli a bada – per il proprio istinto di sopravvivenza psichica, per la salute dei propri figli e della propria ricostruita intimità familiare – e la decisione, o la necessità, di rendere testimonianza di qualcosa che continua a essere inaudito e inesplicabile, possiamo interrogarci sulla ripetitività della testimonianza senza dare giudizi in qualche modo osceni, accostandoci a quelle sedimentazioni per comprendere non solo l'ossificarsi del trauma ma per accogliere con rispetto la necessità di trovare uno schermo a difesa dal dolore del proprio ricordo. «Un giorno guardavo mia nuora con i suoi bambini» mi ha detto Ruth Klüger, «i miei amati e meravigliosi nipoti, e ho pensato: e se qualcuno venisse a prenderli, a strapparli da lei? E poi ho pensato, no, è una cosa che non le potrà mai accadere, questa donna californiana è qui al sicuro, non accadrà... E per me questo è un regalo. Non gliel'ho detto, perché immagino che mi avrebbero preso per pazza, ma in quel momento ero nel mio vecchio mondo, dove potevano venire uomini in uniforme e prendere i bambini. Questo non passa, questo è sempre qui. Possiamo perdere tutto. È un sentimento di fondo molto forte in me: essenzialmente niente mi appartiene, tutto mi può essere tolto, anche la vita dei miei più piccoli familiari».22 Il presente va nel passato e il passato va nel presente. Ciò che hanno vissuto sarà sistematizzato e seguirà, come sempre accade, il metabolismo del tempo, ma loro hanno convissuto più di sessant'anni con ciò che hanno patito e visto patire, e hanno continuato a interrogare quella storia attraverso le molte persone che si diventa con il trascorrere degli anni. «Ora che sono vecchia» mi ha detto ancora Liliana Segre, «penso in modo diverso ai miei nonni. Quando faccio fatica a salire su un treno, vedo i miei nonni spinti su 22 Ruth Klüger, intervista di D. Padoan, cit. 9 quel predellino, e soltanto ora capisco. Ora che sono come loro. Ora che mio padre ha l'età di mio figlio».23 I testimoni – martyr, secondo l'etimo greco di «colui che ha visto» – sanno qualcosa che noi non potremo mai sapere, su cui però vogliamo insegnargli qualcosa. Nel loro essersi massimamente avvicinati all'orrore, lasciati soli nel loro dire, costretti a temere che «lo storico possa aver ragione» su di loro, non possono che affidarsi all'ascolto empatico, cercando quelle che chiamano «candele della memoria», perché ad accogliere chi è uscito dagli inferi non c'è il mondo dell'antica Grecia, capace di assumere come valore fondativo l'ethos del racconto, ma il mondo della postmodernità, basato sugli specialismi. Quando, ormai quattordici anni fa, Lidia Beccaria Rolfi, nel primo convegno dedicato alla deportazione femminile, diceva: «Si sa, la storia vera la fanno gli uomini, è destinata agli uomini. Donne e bambini sono soltanto un incidente di percorso, non hanno volto e non hanno nomi, vanno bene solo a completare i quadri dell'orrore con le loro manine alzate, il numero sul braccio e gli occhi da animali feriti»,24 certo non vedeva la necessità di un allargamento di categorie, così da aggiungere le donne ai rom, ai sinti, agli omosessuali, ai testimoni di Geova; chiedeva piuttosto un allargamento di pensiero, di sguardo. Dire che «la storia vera la fanno gli uomini» non è privo di implicazioni: significa che la storiografia usa lenti forgiate da una cultura che porta i segni del mancato incontro con la differenza. Eppure oggi il discorso sulle donne deportate nei Lager sta prendendo la strada di un'ulteriore specializzazione, e storici, ma soprattutto storiche donne, lo articolano secondo rischiosi stereotipi – mestruazioni, ricette, solidarietà, veri o presunti abusi sessuali – mettendo in fila frammenti di diverse testimonianze, non più discorso complessivo ma dato quantitativo. Ma può il corpo non essere sessuato, può la lingua essere neutra, quando si parla della situazione specifica dell'essere donna nel Lager? Proprio perché l'ideologia che ha sostenuto l'organizzazione dello sterminio era permeata fino al parossismo dalle categorie e dalle catalogazioni, dovremmo sempre interrogarle per sapere fino a che punto ci sono utili, e trascenderle quando diventano gabbie che limitano l'umano. Il guadagno, l'apertura data dall'aver visto la necessità della differenza, dovrebbe stare nella possibilità di accettare davvero un dialogo, di articolare un ascolto in cui si è disposti a farsi spostare dall'altro, a farsene modificare, già nel linguaggio. Dovrebbe servire nel senso che Georges Bensoussan indica alla filosofia: accogliere l'umanità in ogni vittima dello sterminio.25 E anche ad accogliere la pluralità dei linguaggi nell'approccio alla testimonianza. Tra gli storici vi sono stati grandi scrittori – intellettuali che si muovevano tra letteratura e filosofia, nell'alveo di quella cultura umanistica non ancora ghermita dalle specializzazioni – capaci di creare opere che pur nel loro rigore scientifico si sono date nella forma della letteratura, rispettandone le leggi narrative. Tuttavia quello che viene chiamato il postmoderno oggi ghermisce anche la 23 Liliana Segre, Archivio D. Padoan 2007. Lidia Beccaria Rolfi, La deportazione femminile nei Lager nazisti. Convegno internazionale, Torino 20-21 ottobre 1994, Franco Angeli, Milano 1995. 25 Georges Bensoussan, L'eredità di Auschwitz, tr. it. di C. Testi, Einaudi, Torino 2002, p. 78. 24 10 letteratura, che troppo spesso, anziché dare dicibilità al dolore, scrive Claudio Magris, «agisce come un analgesico nei confronti della lacerazione della vita e della storia; elude il negativo, lo isola dietro un cordone sanitario o lo inserisce in un quadro generale che ne neutralizza l'assolutezza dirompente. È un po' come inserire l'irriducibile sofferenza di un individuo - o di molti - in una statistica, sempre meno inquietante di un grido e perciò sempre inadeguata rispetto a quel grido. È stata soprattutto la grande arte d'avanguardia novecentesca a esprimere quel grido, assumendo la sua dissonanza nelle sue stesse forme e facendo del negativo la sostanza della poesia. Oggi il cosiddetto postmoderno tende a relegare il Novecento, e specialmente la sua disperazione formale ed esistenziale, nel museo del passato».26 È in quella disperazione formale ed esistenziale che dovrebbe continuare a trovare posto il dolore, perché la memoria non divenga una messa agli atti. Resta un compito della scrittura, anche della scrittura degli storici, porsi il problema del negativo, e dell'adeguatezza a un grido che non può farsi statistica né specialismo. 26 Claudio Magris, La letteratura e il dolore indispensabile, "Corriere della Sera", 22 giugno 2008. 11
Scaricare