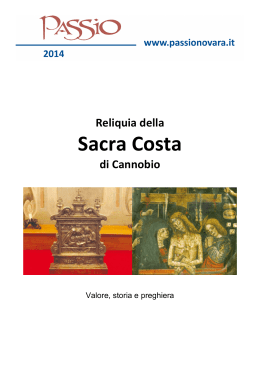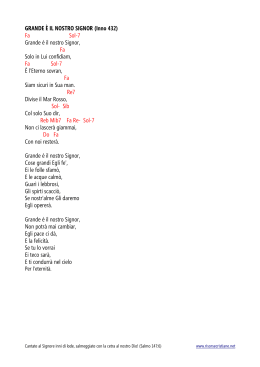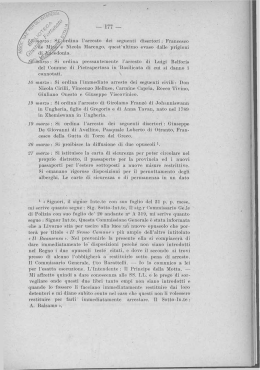Premessa del Rettore del Santuario della Ss. Pietà Nell’ottobre 1987, il Vicario Generale della Diocesi di Novara, il futuro vescovo di Casale Monferrato monsignor Germano Zaccheo, cannobiese “D.O.C.”, volendo rivitalizzare l’ammuffito ambiente cannobino di Santuario e “ospizio del pellegrino”, vi fa emigrare dal Sacro Monte di Varallo Sesia il rettore, l’Oblato padre Francesco Carnago, personalità eccezionale per le sue doti di intelligente organizzatore. E padre Francesco, lì giunto e scoperta l’esistenza di un voluminoso archivio, aggancia immediatamente il suo Professore degli ultimi anni di Seminario, don Mario Crenna, il quale, incuriosito dal quantitativo di carte antiche (dal 1522 in poi) presenti, si immerge in quella paziente e minuziosa ricerca grazie alla quale anni dopo pubblicherà la storia del santuario nel volumetto Il Miracolo di Cannobio (1977) e nell’articolo del Bollettino storico per la Provincia di Novara “Come e perché si è edificato un santuario. Dall’archivio della Ss.ma Pietà di Cannobio ” (2006). Ma padre Francesco – che veniva via via informato oralmente da don Mario Crenna delle importanti notizie ricavate da quell’archivio in cui pochi altri avevano già messo mano (con tanta buona volontà, ma competenza storica e paleografica molto scarsa) – fremeva dal desiderio di far sapere alla gente di Cannobio in itinere quanto stava venendo alla luce e così riuscì a convincere “il Don” a scrivere nel frattempo “qualcosa” anche per il Bollettino della Ss. Pietà. Ne è nata così una corrispondenza con cadenza pressoché mensile, in cui “il Don” con molta semplicità raccontava le sue “scoperte” con uno stile scorrevole e “leggero”, che non è certo quello classico che troviamo nei suoi altri studi e articoli da “Professore”, ma sempre con la stessa, solita, lucidità e la sua nota precisione. Ora, proprio per sottolineare l’opera benemerita di padre Francesco (perché in fin dei conti è a lui che si deve l’aver spinto don Mario Crenna in queste ricerche) si è pensato di pubblicare sul web anche queste note di storia del Santuario, così come all’epoca sono state fornite ai lettori del Bollettino per conservarne la freschezza e l’immediatezza. don Bruno Medina Nota redazionale Grazie a don Bruno Medina, che a sua volta è stato allievo di don Mario Crenna (come il sottoscritto, del resto), riporto gli articoli di don Mario Crenna pubblicati a puntate sulla rivista “La Ss. Pietà” del Santuario di Cannobio tra il 1992 e il 1996: la corposa serie “Per una storia del Santuario” (che continua con “Per chi vuol saperne di più…”), la serie “La più bella storia del borgo di Cannobio” in tre puntate e altri monotematici. Le foto riportate sono soltanto quelle che “il Don” aveva inviato a padre Francesco con la raccomandazione di pubblicarle. Per ciascuna puntata ho riportato la numerazione che a essi è stata assegnata nell’archivio di Don Mario Crenna insieme con numero e data di pubblicazione del relativo esemplare della rivista, per privilegiare la compattezza e la coerenza delle due serie di scritti a puntate rispetto alla cronologia con cui sono questi stati consegnati alla tipografia. Sono state tante le ricerche fatte da don Mario Crenna sul miracolo di Cannobio del gennaio 1522 e sulla costruzione del Santuario. Ha studiato e analizzato uno per uno i documenti e i libri contabili conservati in archivio, con una passione che cresceva sempre di più mano a mano che lui, piuttosto scettico sui miracoli medioevali, si accorgeva che qualcosa era successo davvero, per la dovizia dei particolari trovati in fonti diverse. Il lavoro era tanto appassionante che decise di pubblicare ciò che riteneva utile per i Cannobiesi in tempo reale, a puntate, sul bollettino del loro Santuario, per poi raccoglierle rielaborandone un estratto infine pubblicato sul Bollettino Storico per la Provincia di Novara di cui era Direttore Responsabile. 1 Padre Francesco Carnago era al corrente anche della gran mole di lavoro che don Mario Crenna già svolgeva in quel di Novara e ne apprezzava quest’ulteriore impegno che lo portava ad andare spesso a Cannobio percorrendo quell’unica strada di accesso che non è certo breve né facile, ma trovava questi scritti talmente stuzzicanti e appetitosi da volerli sempre, o quasi, introdurre con un suo “cappello”, che ho evidenziato in grassetto e altre foto per necessità didattiche e tipografiche. Nelle pagine che seguono tutto ciò è evidente. C’era un archivio presso il Santuario della Ss. Pietà in Cannobio e c’era e c’è anche l’archivio presso la Parrocchia di San Vittore in Cannobio. Ci sono anche altri “fondi archivistici” in varie sedi, perfino prestigiose e rispettabilissime, che si riferiscono a Cannobio. Qualcuno aveva già gettato qualche fuggevole occhiata qua e là in quella sterminata “miniera” di documenti che don Mario Crenna aveva accettato con vero entusiasmo di esaminare. Ci voleva però un ricercatore storico competente e appassionato come lui per scavare a fondo, interpretare, leggere e confrontare, insomma, studiare con acribia scientifica il materiale depositato nei secoli dentro uno di questi archivi, quello della Ss.ma Pietà di Cannobio, lasciando a padre Francesco tutto il tempo per occuparsi seriamente della ristrutturazione e della rinascita dell’ospizio del pellegrino. Un’opera lungimirante e benemerita che continuerà a svilupparsi con il successore don Bruno Medina, che ha generato il grazioso hotel a tre stelle “Il Portico” con l’omonimo ristorante, entrambi all’altezza del pubblico internazionale che nella bella cittadina del Lago Maggiore è sempre numeroso e trova un’accoglienza ad hoc. Ecco perché, come ha scritto monsignor Germano Zaccheo nella prefazione alla riedizione nel quaderno di studio “Santuario Ss. Pietà di Cannobio” fascicolo 7 – 2007, “al prof. Crenna va la riconoscenza di quanti, tra noi Cannobiesi, siamo orgogliosi eredi di questa storia”. Mario Crosta RACCOLTA DEGLI SCRITTI DI DON MARIO CRENNA in LA SS. PIETÀ Rivista associata all’Unione Redazionale Mariana Direttore Responsabile: † padre Francesco Carnago Con approvazione Ecclesiastica – Autorizzazione Tribunale Verbania n. 186 del 29-2-1988 2 Ricerche d’archivio Per una storia del Santuario 1 (fascicolo N. 2 – marzo 1992) «Non domandare un piacere a chi ha poco lavoro, non si scomoderà – chiedilo piuttosto a chi è oberato di lavoro, perché farà tutto il possibile per soddisfare la tua richiesta». Così sentenzia un proverbio. Seguendo questa antica sapienza – che condivido –, ho pregato il prof. don Mario Crenna di “entusiasmarsi” della Santa Pietà. Ed egli ha accettato volentieri di rovistare in archivi – compreso il nostro – per approfondire la conoscenza del Miracolo, con una rilettura delle testimonianze; evidenziare i momenti e gli interventi d’inizio nella costruzione del Santuario; per raccogliere e lumeggiare quanto di religiosità popolare è fiorito e maturato – canti, gesti, invocazioni, ex voto... – lungo i secoli. Ciò che ora viene pubblicato è un “modestissimo assaggio” per il quale – e, più ancora, per la disponibilità – vada un sentito ringraziamento al caro Professore. Sul foglio di guardia sta la dicitura Libro dell’anno 1575 sino al 1615. Si contiene la spesa e cavata fatte da Signori Priore e Tesorieri della Veneranda Scola di Santa Pietà, con il rendimento de loro conti, con diverse notationi di molte altre cose pertinenti alla Fabrica della Chiesa sudetta di Santa Pietà. Per 252 fogli in ottavo grande, raccolti in uno spesso volume rilegato in cuoio scuro pressato con eleganti disegni e bordure, i tesorieri Gio Battista Mazirone, Gio Antonio Ponzio, Bartolameo Reschigna, Bernardo Luato, Bartolameo Cironio, Gio Andrea Galarino, Giosef Reineri, Gio Battista Romerio, bei nomi cannobiesi, si sono succeduti nella buona e nella cattiva sorte di introiti e di spese, impegnando la personale dirittura morale e il buon nome del loro casato nella minuziosa registrazione di cassa. «Nel nome del Signor Idio, adì 15 magio 1575» inizia l’interminabile catena di “partita doppia” significata nelle obbliganti dizioni «Il Depositario de’ dare – De contra de’ havere». Il “dare” si materializza mese per mese, anno per anno, nelle registrazioni dei più disparati rivoli di danaro introitato, con annotazioni talmente meticolose da scoraggiare (diremmo noi oggi) qualsivoglia pignoleria fiscale. Trasparenze d’altri tempi. Trasparenza anche di acque, del lago e del Cannobino, non ancora ecologicamente discutibili: accanto al modesto introito dei «4 soldi di ova cinqui havuti in elemosina» – tanto simili all’evangelico obolo della vedova – figurano offerte di «trute, vaironi, anguille, arborelle fresche e seche, un luccio» e tutta la merceologia della valle con castagne, vino, rista, foglie secche per materassi; e poi bigiotteria, tante maniche mutando le quali era come essersi cambiati d’abito, gli accresciuti legati post-tridentini, i lasciti di madonna Maria Catelina Mentasca, moglie dell’altolocato Bernardino Luato, i “capitali censi” gemellati ai lasciti di Francesco Homarino, Agostino Carmine, Francesco Romerio e – botto finale – di Gio Pietro Tassano con case e terreni. Per quanto prolisso possa apparire, è questo un modestissimo assaggio, un “tuffar le mani” entro un costante e corale concorso popolare di sovvenzioni, perché proprio in quegli anni si stava ampliando l’oratorio, o «Santa Devozione», concesso inizialmente ai Cannobiesi nel 1526, con la monumentale ristrutturazione disegnata con limpide linee architettoniche dalla genialità del Tibaldi, come aveva voluto san Carlo Borromeo. Al «De’ dare» si contrappone il «De’ havere». Questa seconda partita si popola di maestri da muro, manovali, facchinaggio di donne, scalpellini, intagliatori, capomastri, carpentieri, trasportatori, fabbri: tutti nomi passati di memoria, anonimamente perduranti nell’opera che il loro mestiere ci ha lasciata dinnanzi, ma riscattati, o riscattabili, nella loro individualità di lavoratori a paga giornaliera, grazie alle scolorite registrazioni, per l’appunto, del «De’ havere». Semmai volesse un ipotetico revisore dei conti esaminare la contabilità di quegli anni, dal 1575 al 1615, troverebbe che per due innocui errori materiali di trascrizione esiste uno sbilancio tra le due partite di ben due soldi! 3 È auspicabile che in tal caso non faccia raffronti con la realtà di altri tempi: ne sarebbe sconfortato, soprattutto considerando che i bravi tesorieri in definitiva amministravano denaro pubblico. Piuttosto si diletti del colorito d’ambiente che le tante annotazioni, rivitalizzate, sanno restituirci. Valga un esempio acconcio per il tempo di Quaresima. Leggiamo nel nostro libro a foglio 21, in data «10 gienaro 1579»: «E più contati [spesi] a messer Desiderio per le rosete lire 4 imperiali». Istintiva ci sovviene un’immagine floreale, suggerita dalla mite riviera tra Cannero e Cannobio, ubertosa nei tempi andati per vigneti ed ulivi. Ma lascia perplessi quell’essere di gennaio, quando le ventilazioni del Ceneri e del Valmaggino prendono il lago d’infilata... Più in là, a foglio 28, sotto la data del 23 marzo 1581, cala il dubbio e cresce il sospetto, leggendo che lire 4 e soldi 10 sono date a messer Desiderio «per tante rosete de argento per le batiture». Con ostinata riluttanza mentale ci si appiglia all’immagine di borchiette argentee, anche se mal si comprende perché mai, allo stesso giorno, vengano pagate lire 1 e soldi 10 a messer Melchion Tirainanzi «per conzar le batiture». Quale aggiustatura è mai questa, se a foglio 81, nel gennaio del ‘90 si spendono lire 3 e soldi 3 «per oncie 1 e 3/4 di seda per comodar le batiture»? E quando finalmente, a foglio 85, il mese di marzo 1592 leggiamo di quella «1 lira, costo de once 6 polvera et quinternetto carta per il Giobia Santo», il dato appare con tutta chiarezza: con teatralità secentesca, cruda e devota, una teoria di flagellanti per le vie del Borgo ripropone l’arcaico gesto penitenziale, che, ispirato all’ascesi di san Carlo, attinge alla venerazione per l’Imago Christi del santuario che con passione di popolo si sta erigendo. Informazioni successive rifiniscono il dato acquisito con aggiunte raccapriccianti o commoventi nella loro semplicità: a foglio 174, l’8 marzo 1603, lire 4 e soldi 2 sono pagati «a domino Gio Luato speciaro per tanta polvere costretiva [cicatrizzante] et carta grossa [assorbente per le lacerazioni]»; a foglio 177, in data 2 novembre dello stesso anno, il tesoriere dichiara che «de’ haver lire 10, sono lamontar de stelete de argento n° 200 comprate per le batiture»; a foglio 180, l’11 aprile 1604, vengono pagate lire 5 e soldi 10 «per far ordenar 26 batiture», poi confezionate «dal Magoneto con cordelle, manighi et ciodi». Il giorno successivo, mentre la liturgia, spogliati gli altari, invita a sostare in adorazione di Cristo deposto nel sepolcro, il sagrestano Gio Pietro Marcion si sta guadagnando una lira e mezza «per haver lavato [dal sangue] le veste et batiture». 2 (fascicolo N. 3 – aprile 1992) «Le vie del Signore... infinite e i più modesti percorsi degli uomini» quando si incontrano – e in piena sintonia proseguono, – operano, realizzano cose meravigliose – che, purtroppo, rimangono sconosciute o quasi; bisogna scoprirle. Vale anche per il nostro Santuario, monumento nazionale! Don Crenna con notizie “stuzzicanti” ci introduce alla conoscenza di “segrete cose”. Ecco un brano oltremodo interessante. Che avrà un seguito. Per definizione, il “monumento” è quell’opera di scultura o di architettura posta in luogo pubblico in memoria di una persona o di un avvenimento. Così si può apprendere da ogni dizionario. Se poi vogliamo scomodare la filologia, questa ci avverte che il vocabolo è radicato nel latino monere, ricordare. Perciò, propriamente: la cosa che serve come ricordo, come memoria. E tale, con buona ragione, può essere il Santuario della Pietà: nel suo insieme è l’artistico reliquiario di un’Immagine miracolosa, ma ancor più, come monumento, costituisce la testimonianza di singolari vicende. Si era nel maggio del 1575. Con un piano previsionale assai più fiducioso nel buon Dio che non nelle disponibilità finanziarie, si diede inizio all’impresa. Lo scopo era di ampliare la Devozione, il modesto oratorio ricavato nelle due stanze superiori dell’ex osteria degli Zacchei: lo intendeva Carlo Borromeo, lo progettava il Tibaldi, vi consentivano i Delegati del Borgo. 4 Una robusta sostruzione sul davanti della Devozione ne avrebbe sorretto il prolungamento terrazzato verso il lago, senza per altro ostruire la strada costiera, da trasformare anzi in un andito porticato. A più riprese, con intervalli tecnici e con forzate pause di depressione finanziaria, si rizzarono muri irrobustiti da cantonali in pietra viva, si adornò l’interno con colonne di mischio d’Arzo e con marmi di Candoglia, si completarono le coperture in beole cannobine, si eressero tiburio e lanterna impreziositi da lastre di piombo, e nel 1614 il Santuario era praticamente ultimato. Quello stesso edificio che, prescindendo da qualche ritocco posteriore, ancor oggi ci sta staticamente dinnanzi: artisticamente pregevole, ma ancor più prova tangibile di una “ostinata” ed ammirevole devozione. Ce lo dimostrano le minuziose registrazioni di cassa redatte dai confratelli della Ss. Pietà per gli anni 1575-1614, gli anni di “fabbrica”. Ne traspare un giro panoramico da Sesto Calende ad Ascona, da Ponte Tresa a Falmenta, entro cui si mobilitano maestri da muro e da scalpello, cavatori e intagliatori di marmi, fornaciai e cementieri, barcaioli traghettatori di “medoni”, di calcina, di “prede” grezze e lavorate; ma ancor più, e certo non ultimi, i tanti oblatori di quell’insostituibile “collante” che, a ripetizione e per anni, consentì, legando pietra a pietra, di erigere il monumento testimone della loro generosità. Le vie del Signore possono permettersi d’essere infinite; ma anche i più modesti percorsi degli uomini sanno talora ottenere assai originali confluenze. Ne portiamo un esempio. La parola e il concetto stesso di elemosina non destano di per sé immagini di esaltante altruismo, bensì di marginali disponibilità nel campo del superfluo. Ma proviamoci a compilare le diverse voci che sono entrate nel computo delle offerte, o elemosine, per la “fabbrica” del Santuario. E scopriamo che per la costruzione dell’edificio fu impiegata, ovviamente con diverso trattamento, forse tant’acqua quanto vino: l’una per “bagnar la calcina”, e l’altro per sostenerne le spese. Ben 900 brente di vino furono offerte, raccolte con la “cerca” e messe all’incanto per il periodo suddetto dal 1575 al 1614. Con una continuità pressoché paragonabile agli adduttori del Verbano: il torrente Cannobino dell’omonima valle, il Margorabbia di Val Travaglia o il Giona di Val Veddasca. Un rivolo incessante di vini bianchi e rossi da Brissago, Pino, Cannero, Donego, Casino, Colmegna, Tronzano, Piazzo, Trarego, Cheggio, Viggiona, Carmine, Luino, Campagnano, Lignago e, beninteso, Cannobio: insospettabili aree vitivinicole d’altri tempi. Un defluire contrassegnato da autentiche “büzze” negli anni stagionalmente più fruttuosi, del 1575 con 73 brente poste all’incanto, dell’86 con 116 brente, del ’93 con 52 brente, del ’604 con 83 brente; in perfetto sincronismo col tenimento delle “caneve” dei particolari, nei mesi autunnali quando occorre stivare il prodotto di nuova vinificazione, e nei mesi primaverili quando, in prossimità della fioritura della vite, si muovono i depositi fecciosi ed i vini vanno trasmutati... Sono i bei periodi quando i vari Barletino, Rosso, Mainetto, Magoneto e Rizetto remigano con ben altro “spirito”, che non quando fanno rotta su Luino, Maccagno, Porto, per “caricar calcina e prede cotte” alle fornaci del Zapo o del Cesare Gallo. E potremmo continuare... 3 (fascicolo N. 4 – maggio 1992) Le scontate mie due righe d’inizio avrei voluto collocarle questa volta in chiusura, con un “grazie” e tre punti esclamativi, Non l’ho fatto. Vorrei che siano i lettori – appassionati – a porre qualche esclamativo dopo la lettura delle interessanti notizie che ci fornisce il prof. don Crenna. Il quale, avvezzo alla polvere degli archivi – ovviamente, polverosi – promette altre notizie... appetitose. Tutti uguali, questi ricercatori: noi, curiosi frettolosi; loro, incalliti speziali, ti centellinano dosando ben bene le notizie. Tutto sommato, è meglio così. Si rileggono con calma e si gustano meglio. 5 Il Bagatello, per chi non lo sapesse o non se ne ricordasse più, faceva l’oste a Cannobio nel 1595. E la sera del 2 luglio di quell’anno, nel suo locale servì una cena memorabile. Ne aveva fornito l’occasione un avvenimento che, nella migliore tradizione dei capomastri e dei muratori, ancor oggi si usa festeggiare: era stata finalmente completata la volta grande del santuario della Pietà, e l’edificio cominciava davvero a prendere forma. Mancava, è vero, il tiburio, però era ormai possibile, al chiuso e sufficientemente al coperto, fare con comodo le proprie devozioni. Onorava la mensa il fior fiore delle maestranze locali: il capomastro, o ingegnero, Pietro Bareta (o Beretta) di Brissago; i maestri di scalpello Stefano Bareta, Antonio Baretino e Ambrogio, tutti di Brissago; due altri scalpellini, Giovanni e Gottardo, di Lugano; i maestri da muro Angelo, e Battista del Ronco con Eusebio di Carmine; Domenico e Paolo di Cenzago, figli del maestro scultore Gio Angelo d’Arzo; e poi garzoni e manovali. In una parola, gli artefici che hanno fatto del santuario un mirabile compendio geologico tra mischio d’Arzo, marmo di Candoglia, granito del Montorfano e pietra porfirica di Brissago, il tutto da loro trasformato nel lustro insieme di colonne, capitelli, paraste, modanature: splendida decorazione policroma della Ss. Pietà. A forza di braccia e di elemosine si era dunque giunti al tetto, e all’interno della chiesa gli altari ormai funzionanti erano due: quello modestissimo della parete a Nord (come lo è tuttora) dedicato alla Madonna; una devozione questa, radicata tra la gente del Borgo, tant’è che già nel primo oratorio ricavato dalla stanza del Miracolo nel 1522 si volle ci fosse l’altarino della Vergine Assunta. E poi il cosiddetto altare maggiore, collocato dalla parte donde oggi si entra in chiesa, ma non ancora elegante e ricco quanto l’attuale, per la semplice ragione che il progetto del Tibaldi lo voleva trasferito sul lato opposto, come in effetti lo fu, con gran rispetto e silenzio, nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1602. L’altare della Madonna, come si è detto, era invece già definitivamente posizionato. E non appena l’impresa della riedificazione mobilitò un po’ tutti e il fervore edilizio toccò un suo massimo nel 1593, quasi ne fossero a loro volta stimolati, s’accesero ancor più anche i pii sentimenti legati a detto altare. E se, via lago, da Luino e da Sesto si traghettavano i barocchi «ogi di marmore negro» per le prese di luce laterali, pagati un occhio della testa allo scultore comasco Benedetto Erba, un bel giorno di settembre tra sbarchi di mattoni, sassi e calcina approdò a Cannobio un domenicano fatto venire apposta da Milano. Anche per lui non si badò alle spese: tanto si ritenne indispensabile che padre Daniele di Vigevano, col carisma della sua predicazione e con la competenza che gli era connaturata, organizzasse l’istituzione della Confraternita del Santissimo Rosario. Come mise piede in chiesa, il frate dovette convincersi, semmai ancora ne abbisognasse, che le intenzioni dei fedeli cannobiesi erano quanto mai serie: un gran baldacchino, messo insieme da Simonino Luato, foderato di «pomelada de oro e argento», custodiva la statua lignea della Madonna rivestita di «tocadoro ornato de oro e de argento», affiancata da due figure angeliche in legno scolpito, pregevole fattura di messer Santo nonché di elevatissimo costo (ben 162 lire); l’altare, recintato da «rastelli» e fornito di «tavolette» e di «preda secrata» proveniente da Carmine, nonché provvisto di cassetta di noce per le elemosine. Tanto per cominciare, erano state acquistate appositamente da messer Pietro Francesco Boviso, al santuario della Madonna del Monte, tre dozzine di rosari in ebano. Non bastavano, e ne furono aggiunte altre diciassette più andanti, ne seguirono altre sedici, e si concluse con ancora sette dozzine. Una dimostrazione palmare di quanto ampiamente la devota iniziativa fosse attecchita. Ne dovette certo lodare Iddio in cuor suo il buon padre domenicano, mentre ridiscendeva per lago verso Sesto Calende, gratificato com’era dal tanto entusiasmo riscosso e dalla regalìa di 48 lire e 8 soldi, ricevuti in offerta per il suo convento. Però occorreva ancora garantirsi, al cospetto degli uomini, che la fruizione di indulgenze e d’ogni altro beneficio spirituale fosse lecita perché legittima. E qui intervenne l’autorevolezza delle bolle di conferma: una prima fu “levata” per via del tutto informale e per poche lire nell’ottobre dello stesso 1593. 6 A questa seguirono per canali ufficiali, a ripetizione (non ne comprendiamo il motivo), le due del 30 maggio e del 21 luglio 1595. Costarono qualcosa di più, tre scudi ciascuna (18 lire e 4 soldi) oltre alle 6 lire e 6 soldi versati alla moglie di Domenico Ghislo che a Roma s’era recata a prelevarle al convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva. Però, in compenso, si presentano tutt’oggi assai eleganti nella grafia umanistica e nell’ornato multicolore, con tondi miniati pregevoli per disegno e rifinitura cromatica, anche se purtroppo gli ori si sono pressoché totalmente dileguati. Per il tempo successivo, la confraternita si mantenne sicuramente assai viva; e non torni qui sgradito se facciamo ricorso ad un caratteristico elemento che, senza ombra di dubbio, è in grado di darcene conferma. Se infatti scorriamo le superstiti registrazioni dei quattrini che si andavano recuperando dalle “bussole”, le quotazioni della cassetta per le elemosine posta all’altare della Madonna appaiono sostenute, con un rapporto costante di due a tre sul totale delle raccolte. E questo si può constatare fino all’anno 1598, quando con ogni probabilità fu necessario, da quell’anno, adottare una strategia finanziaria globale onde tener testa alle spese edilizie rese pesantemente gravose dalla costruzione della parte absidale del santuario, del suo tiburio, con annessa costosissima copertura in piombo. Qualora detto sistema d’accertamento sembrasse troppo prosaico, sempre al fine di illustrare la vitalità dei confratelli del Rosario, potremmo appigliarci al registro delle spese di culto che, in quanto tali, potranno apparire meno “interessate”. Scopriremmo allora che nel 1594 il priore Gio Battista Omacino dovette saldare il salato conto per la confezione del gonfalone della Madonna, più in là rifinito con sfrangiature d’argento. E perché facesse ancor più bell’effetto, si vestirono a nuovo con appropriati abiti di tela sangallo i due confratelli che avrebbero dovuto reggerlo processionalmente. Allora fu anche sostituita la mensa lignea dell’altare con una tavola in pietra lavorata dal mastro Francesco de Bassi di Falmenta. Non si trascuri che nel frattempo continuava l’operazione di acquisto rosari. Nel 1595 mutò d’abito anche il simulacro di Maria, che fu rivestito con «tocadoro e pizzetti», e a cui fu posta in capo una corona d’argento del valore di 34 lire... 4 (fascicolo N. 5 – giugno 1992) Un invito sincero, da amico. Chi ha gustato con interesse e con intelligenza le tre passate puntate non tralasci questa, che porta a conclusione la precedente – con preziose novità – e presenta la pergamena del 1595. Può sembrare scontata, ma non lo è; anzi l’attestazione è quanto mai appropriata: la pergamena si legge d’un fiato; grazie alla traduzione del prof. don Crenna e al contenuto, forse per la prima volta fatto conoscere nella sua interezza. Non anticipo nulla. Rinnovo l’invito. Concludiamo qui in bellezza segnalando un’ultima spesa, dato l’interesse che può suscitare nei cultori d’arte: nell’ottobre del 1603 Gio Batta Marco venne pagato per certi assi che furono mandati a Milano «per fabricar li Misteri del Rosario». Per 12 lire il maestro pittore Alfonso Tetono dipinse le tavole lignee che, con ogni probabilità, sono quelle stesse che ancor oggi incorniciano l’edicola della Madonna nell’omonima cappella. E questo fu fatto in ottemperanza a tassative prescrizioni, come è possibile constatare scorrendo il testo, qui sotto riportato in traduzione, identico nelle due bolle sopra citate. Entrambe recano la firma autografa del frate Ippolito Maria, datata al settimo anno del suo incarico generalizio. Risultano protocollate rispettivamente ai fogli 293 e 294 di un registro di cui non abbiamo memoria, e controfirmate da fr. Vincenzo da Gubbio predicatore e da fr. Paolo Castruccio Maestro provinciale e socius Terrae Sanctae. Vi sta anche dichiarato che scrittura e decorazioni sono opera di Giacomo Squillio da Firenze, cittadino romano, che, su mandato del Maestro generale, le confezionò in uno scrittorio affacciato sulla piccola corte dei Sabelli, alle spalle della chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Il costo era di soli tre scudi, mentre la spedizione era gratuita, «come tutti dovevano sapere, sempre e dovunque». 7 Nel nome della santissima e individua Trinità del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e a lode e gloria della beatissima e sempre Vergine Madre di Dio Maria nostra Signora ed alla devota venerazione del santo nostro padre Domenico autore e promotore del santo Rosario noi Ippolito Maria Beccaria di Monte Regale professore di sacra teologia umile maestro generale e servo di tutto l’ordine dei Predicatori a tutti i destinatari delle presenti lettere auguro eterna salvezza nel Signore. Così come crediamo che l’essenza della perfezione cristiana consiste nell’unione intima tra i Cristiani e con Cristo a guisa di membra unite al capo fonte d’ogni perfezione, altrettanto ci riteniamo edotti da ragione e da esperienza che il mezzo più valido per aspirare a tale perfezione sia la preghiera. Ora quel metodo per pregare Iddio secondo il quale viene venerata la Santissima Vergine Maria Madre di Dio con centocinquanta salutazioni angeliche e con quindici preghiere dominicali a guisa di salterio davidico, e che passa sotto il nome di Rosario, dapprima concepito dal nostro santo padre Domenico e poi ammesso dai Sommi Pontefici romani su rispettosa istanza dei padri del nostro Ordine, ed arricchito di grandissimi privilegi ed innumerevoli indulgenze e di altri favori apostolici, tale metodo, tra i molteplici ammessi dalla Chiesa al fine di raggiungere la perfezione, se non andiamo errati, risulta quanto mai salutare. Perché oltre al fatto che tanto ripetutamente viene invocata la Beatissima Madre di Dio, la cui intercessione può impetrarci detta perfezione, tale modo di pregare di per sé, se fatto rettamente, oltremodo facilmente e compendiosamente la consegue in quanto ci fa ripercorrere, meditando, tutta la vita del nostro Salvatore riassunta nei quindici Misteri. In devota considerazione di tutto ciò voi, amatissimi in Cristo e piissimi fedeli di Cristo del Borgo di Cannobio Diocesi di Milano, e al fine di ottenere, accrescere e mantenere codesto metodo di preghiera, avete eretto la Confraternita del Salterio, ovvero del rosario, sotto l’invocazione della Beata Vergine Maria nella chiesa di Santa Maria della Pietà di detto Borgo dall’anno 1593, coll’aiuto della predicazione del R. P. Frate Daniele di Vigevano predicatore dell’Ordine e avete istituito e ordinato il suo altare e avete fondato ed eretto la cappella; desiderando poi che tale erezione ordinamento e costituzione fossero da noi accettati approvati e confermati con nostre lettere patenti, con insistenza avete fatto domanda per l’interposta persona del signor Gerolamo Poli Zaccheo di detto Borgo affinché, accogliendo codesta vostra Confraternita, ci degnassimo di ammetterla approvarla e confermarla con adeguate grazie e favori. Pertanto sensibili ai vostri desideri e alle vostre devote richieste per autorità apostolica a noi concessa in codesta regione, a tenore delle presenti lettere accogliamo codesta Confraternita istituita così come è stato detto, la approviamo e confermiamo e le aggiungiamo il vigore di una perpetua durata, e qualora occorresse, nuovamente la erigiamo in forza delle presenti lettere, purché non sia stata eretta secondo le norme un’altra simile società in detto Borgo o nelle sue vicinanze entro un raggio di due miglia. Ed accettiamo ed ammettiamo a godere delle grazie, privilegi ed indulgenze delle quali godono le altre consimili confraternite erette nelle chiese del nostro Ordine sia in vita che in morte la vostra Confraternita e tutti i fedeli di entrambi i sessi ivi iscritti o da iscriversi, richiamandovi che la festa di detto Santissimo Rosario deve essere celebrata ogni anno alla prima domenica del mese d’ottobre nella medesima cappella secondo il decreto e l’istituzione di Papa Gregorio XIII di felice memoria in rendimento di grazie per la passata memorabile vittoria contro i Turchi impetrata ed ottenuta grazie alla preghiere effuse in quel giorno (come piamente si ritiene) dai confratelli della Società e impetrata e ottenuta con l’aiuto e l’intervento della Santissima Vergine Nostra Signora. Di codesta vostra Società e Cappella deputiamo per cappellano l’attuale rettore pro tempore della vostra chiesa, il quale voglia iscrivere accettare ed aggregare con nome e cognome tutti i fedeli che chiedono di essere accettati ed aggregati, in un apposito registro. Benedica i Salteri ossia le corone, commenti con rispetto e come si conviene i sacri Misteri del Rosario ed operi tutto ciò che i nostri fratelli a ciò designati nelle nostre chiese possono fare e in base alle norme furono sempre soliti fare. Imputiamo alla sua coscienza per il Giorno del Giudizio se per siffatta accettazione, aggregazione, scritto e benedizione esigerà qualcosa che in qualsivoglia modo sia di puro lucro temporale; ma piuttosto ogni sua prestazione sia gratuita come vogliono le prescrizioni e le sanzioni della pia Società, così come anche noi per il culto di Dio e per la gloria della Sua Santissima Madre Nostra Signora e per la salute e la crescita interiore dei fedeli gratuitamente prendiamo e gratuitamente offriamo e concediamo. 8 È nostra precisa volontà ed assoluto comando che sull’effigie sacra della Cappella vengano dipinti i quindici Sacri Misteri della nostra redenzione e che per adeguato riconoscimento della concessione fattavi sulla medesima icone compaia dipinta la venerabile immagine del nostro santo padre Domenico autore del Sacro Rosario, mentre inginocchiato riceve dalle mani della Vergine Madre di Dio le corone del Rosario. Qualora si operasse diversamente o si trascurasse di fare quanto indicato in queste nostre lettere, esse non potranno più essere utilizzate né da voi né da chi venga dopo di voi e non abbiano più alcun significato né valore. Infine abbiamo creduto bene e dichiariamo che qualora occorresse ai nostri fratelli l’assegnazione di una chiesa entro il Borgo o nel suo circondario per un raggio di due miglia, per ciò stesso immediatamente, e questo valga già da ora, senza ulteriori dichiarazioni ma solo in forza di queste lettere a detta cappella siano tolti la confraternita, le indulgenze e i privilegi a lei concessi e assolutamente e totalmente siano trasferiti a detta nostra chiesa con tutti i beni temporali acquisiti in qualsivoglia modo da detta Società e queste clausole siano tenuti ad accettare e sottoscrivere di propria mano i parroci e gli addetti sia alla citata chiesa sia alla confraternita. E tutto ciò deve essere rogato ed esplicato chiaramente per mano di un notaio con pubblico istrumento. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amen. A chiunque operi contrariamente, nonostante. E in fede di ciò con queste lettere patenti munite con sigillo del nostro ufficio abbiamo sottoscritto di nostro pugno gratuitamente ovunque e sempre. Date a Roma nel nostro convento di Santa Maria sopra Minerva il giorno 21 del mese di luglio nell’anno del Signore 1595. 5 (fascicolo N. 6 – luglio 1992) Non saprei dire quante, ma parecchie sono le volte che ho sentito affermare, anche senza punta di malizia: «Ha le lacrime in tasca». Come a dire: è una persona facile alla commozione. Comunque non mi risulta – anche ai giorni nostri – che «avere le lacrime in tasca» sia un difetto o una colpa da recriminare. Tuttavia, se vi dico che, giunto alle ultime righe di questa quinta puntata, ho provato nel profondo dell’anima una grande commozione, almeno per una volta, dovete astenervi dalla sbrigativa affermazione di sapore proverbiale. Leggo: «Mediante il lavoro di donne (50 giornate) a portar terra e sassi...» nella costruzione del santuario! Ancora: «Nel santuario si “materiava” il convincimento corale della sconvolgente autenticità di quei fatti – umanamente incomprensibili, eppure lì accaduti – dai quali aveva tratto origine la pietà popolare. Forse ancora oggi – da quanto è stato testimoniato – si potrebbe trarre giovamento per temperare in certa misura qualche nostra perplessità». Il garbo non fa difetto. E sono parole di uno storico, quale don Crenna. Vanno sottolineate col lapis rosso-blu. In origine per i Cannobiesi fu «la Santa Devozione»; poi venne detta «Santa Maria della Ss. Pietà»; è ancor oggi comune l’abbreviazione di «Ss. Pietà». Si potrebbe supporre che si tratti di una innocente sostituzione di vocaboli, ma una serie di dati pare suggerire altra spiegazione. In quei giorni del febbraio 1522 i fatti accaduti nella casa degli Zacchei a Cannobio, per la loro fattispecie, a dir poco, rasentarono l’assurdo. A prescindere dalle deposizioni testimoniali a noi pervenute, e non volendo apparire ingenui o semplicioni, ci dovremmo domandare perplessi se l’impatto emotivo causato dal “miracolo” non rientrasse tra le isterie collettive. Tanto più che della “brava gente” del Borgo e dei suoi “ottimati” d’allora poco si sa. Però ci è noto che, malauguratamente, le loro case stavano su un lembo di litorale lacustre divenuto, in quegli anni, una specie di corridoio naturale, percorso e ripercorso nei due sensi da soldataglie – mercenari cristiani o predoni – d’ogni estrazione, talora accomunate solo dalle pestilenze: tempi grami per tutti, tali da fiaccare anche la fiducia nella Provvidenza; tempi purtroppo adatti per gli isterismi di massa, euforici o depressivi, tanto rapidi nell’attecchire quanto nel dissolversi al primo sereno. 9 Ma come Dio volle, e si riprese fiato, anziché affievolito, l’attaccamento al quadruccio della Pietà si rivelò ben radicato e consistente, con un crescendo così curiosamente spontaneo, che l’oggetto venerato finì per identificarsi con lo stesso sentimento di venerazione, divenendone il simbolo: e per tutti, Cannobiesi e gente rivierasca del Lago Maggiore, il primitivo piccolo oratorio in cui esso era conservato divenne, per antonomasia, «la Santa Devozione». Semplicissimo tale vocabolo, ma certamente tipica la sua significazione, invalsa per anni fino a quando, raggranellando con ostinazione lira su lira, si diede forma alla successiva costruzione della «Santa Maria della Pietà». Avvezzi come siamo all’ingrediente della sponsorizzazione (dalla quale, provvidenzialmente, non va esente neppure il Colosseo), ci vien fatto di pensare all’intervento dei Borromei, per quell’epoca – passi la parola – veri boss del Lago Maggiore: è risaputo l’intenso fervore di san Carlo per la Pietà di Cannobio, né inferiore fu l’attenzione dimostrata dal cardinal Federico. L’apporto finanziario derivato dal sullodato casato sta registrato nei libri contabili della Confraternita della Ss. Pietà, che costituiscono la più dettagliata fonte documentaria d’ogni pur minimo contributo a pro dell’erigendo santuario, dall’inizio delle opere di fondazione nel 1575 fino alla copertura in piombo del tiburio, nel 1614. In data 10 agosto 1599, troviamo annotata un’entrata di «lire 34 e soldi 6 per tante ha pagato D. Gio Batta Galerino di ordine del Illustrissimo Signor Conte Renato Borromeo». E ancora costui, nel giugno del 1601, non più d’ogni modesto Cannobiese, dà l’elemosina di 2 lire – come era solito farsi – per il palio usato al funerale della contessa Margherita sua madre. A gennaio del 1602 leggiamo: «lire 32 e soldi 16 per tante ha date il Tesorere di Mons. Ill.mo Cardinale Federico Borromeo di suo ordine». Ne sappiamo il motivo: potendosi ormai, dato l’avanzamento dei lavori della chiesa, trasferire l’altar maggiore da un capo all’altro della navata per la sua definitiva collocazione nella parte absidale ad oriente, il cardinale fu dapprima raggiunto da una delegazione di Cannobiesi recatisi in barca ad Arona alla residenza dei Borromei sulla rocca. Successivamente, il barcaiolo Rizzetto, «con homeni otto» accompagnatori, andò a prelevare dal palazzo dell’Isola Bella il cardinale, perché di presenza verificasse le modalità del trasferimento. Fu l’oste, signor Giuseppe Mazirono ad allestire degnamente la mensa per il porporato; il che, tradotto in lire, significò una provvista di «salvatici, caponi et trute» da parte del suo congiunto Gio Batta e di Sebastiano Pianta per 44 lire di spesa, a cui s’aggiunsero altre 100 lire di servizio. Più che plausibile dunque, in percentuale, l’elemosina del cardinale. Null’altro pervenne ufficialmente da parte dei Borromei. Va però aggiunto che, per concessione di san Carlo, fu gratuito il materiale edile recuperato «dalle case derupate di Santo Laurenzio» mediante il lavoro (50 giornate) di donne, pagate dalla Confraternita 10 soldi al giorno «a portar terra et sassi». Fu perfino regolarmente liquidato il conto delle 8 lire richieste dal «signor Pelegrino (il Tibaldi) per li disegni de la fabrica de la Devocione quali sono presso Mons. Ill.mo», il vero committente. La vicenda del santuario è stata dunque scritta altrove, da coloro che non ebbero mai altisonanza di nomi o di gesta da consegnare alla storia. Dire quanti furono sarebbe come pretendere di numerare «le prede, i medoni, le piode ed i marmori», messi assieme grazie all’affluire delle più disparate loro elemosine. Di alcuni sarà possibile individuare l’identità; di tutti però già sappiamo che, praticamente soli con la propria industriosità e le proprie risorse, per quasi un secolo, segnato da crisi e da pestilenze, mai vollero rinunciare al massimo risultato che fosse loro consentito: il santuario lo sta a dimostrare in ogni sua struttura. Per tutti, esso fu «la Santa Devozione»: perché in esso si “materiava” il convincimento corale della sconvolgente autenticità di quei fatti – umanamente incomprensibili, eppure lì accaduti – dai quali aveva tratto origine la pietà popolare. Forse ancor oggi da questo dato testimoniale si potrebbe trarre giovamento per temperare in certa misura qualche nostra perplessità. 10 6 (fascicolo N. 7 – agosto-settembre 1992) Fuori, sulla piazzetta del santuario, in pieno sole paiono sbiancati i graniti della facciata. Dall’ingresso, quasi improvvisamente iscurita, ci si schiude dinnanzi la navata, ove il chiarore che piove smorzato dalle vetrate disegna appena la doratura degli stucchi. Ci pervade la penombra del luogo sacro che sa di misticismo e di orazione. Ma gli occhi scorrono perplessi dagli illeggibili teleri lungo le pareti alle spente policromie degli affreschi sulle volte, agli indecifrabili ornati di quel luogo d’arte. Vien fatto di pensare al fastidioso dilemma, alla lamentevole divaricazione tra il sentire devoto e l’assaporare estetico. È una diatriba che non intendiamo affatto qui affrontare, bensì possibilmente aggirare. E dunque ci domandiamo, affidandoci ai documenti, cosa mai si era prefissa di tramandarci la gente di Cannobio che volle, con tutta l’anima, codesto suo santuario, e che per un interminabile giro d’anni attinse caparbiamente alle proprie risorse in quel remoto angolo di lago. Per anni fu questo l’unico modo appagante con cui i Cannobiesi – quanti? – segnarono della loro presenza un’opera che poi i figli dei figli avrebbero condotto a compimento: purché si concretasse l’intento comune di erigere una monumentale – e perciò più umanamente convincente – attestazione che il loro Borgo era stato privilegiato da un evento straordinario. In ogni sua componente il santuario della Ss. Pietà è testimonianza di tali presenze: chi entra per pregarvi non può non sentirsene avvolto e confortato nella propria devozione. Lo stesso appesantimento decorativo operato sulla linearità architettonica pensata dal Tibaldi dà al cultore d’arte la misura cronologica della tenacia con cui, per generazioni, l’impresa fu perseguita. E lo fu nei modi più estemporanei, geniali, fragranti per generosità semplice e spontanea. Per quanto succintamente redatte dai tesorieri della Confraternita della Ss. Pietà, le motivazioni delle offerte, registrate nel loro libro mastro dal 1575 al 1615, compongono l’immagine di un borgo colto nella vivacità del suo vivere quotidiano. Protagonismo di giovani: con baldanza di età e goliardia di intento, mettono alle strette i «novàdeghi», perché, prossimi agli sponsali, è giusto che paghino lo scotto di un ideale pedaggio verso il nuovo corso coniugale. E il depositario Josef Reynieri annota le 115 lire e 2 soldi «havute dalli gioveni che hanno scosso per li novadeghi». Né si sottrae a così gioviale intraprendenza, per una certa assonanza concettuale, la categoria dei «vedovi remaridati», e fra mani del «signor Gio Andrea Gallarino et compagni» l’oblazione risulta corposa, con ben 144 lire. E chi lo penserebbe? dal versante opposto si muovono i vedovi che solidarizzano tra loro per una equivalenza di 325 lire! Ne è plausibile motivazione l’urgenza della costosissima copertura in piombo del tiburio. A conferma di quel mobilitarsi cordiale e strapaesano, il «signor Benedetto Herba», uomo di rango, si fa oblatore di 46 lire e 8 soldi, soddisfatto di aver accasato la figlia; e così si piazza come capofila dei tanti che, avendo preso moglie non proprio “dei paesi suoi”, a Bellinzona, ad Ascona, o anche a Intra, si sono cautelati con la protezione della Ss. Pietà. Quella stessa che, effigiata nel «palio nuovo» e nel «palio vecchio» (ove la differenza consiste solo nella pia offerta, da pochi soldi a tre lire) fa da mesto corredo funerario ad ogni Cannobiese nel suo ultimo tragitto terreno. Chi ha bastante età per rimembrare quel “date oro alla Patria” ricorderà certo quante fedi nuziali finirono nei crogiuoli di Stato. Fu certamente un sacrificio, tant’è che il regime d’allora pensò bene di reclamizzarlo regalando anelli sostitutivi d’acciaio. In tutt’altro contesto, ed è lecito supporre con spontaneità meno spuria, a siffatto sacrificio affettivo ricorsero in anteprima i Cannobiesi: stupisce infatti la frequenza con cui anelli d’oro e d’argento furono generosamente posti all’incanto al fine di realizzare tutto il.possibile denaro fresco di cui abbisognava la Fabbrica del santuario. 11 E quando i Gio Batta Mazirono, i Pietro Martire Omacino, i Gio Giacomo Poscolonna ed altri ancora, i meglio accreditati finanziariamente (e tra essi si inserì la signora «podestaressa», moglie di Ottavio Torto podestà del luogo, che nel febbraio 1613, come s’addiceva ad una first–lady, si aggiudicò «uno zoiello d’oro» per 14 lire e «66 perle picole» per altre 14 lire), quando – dicevamo – i notabili facoltosi danno segni di cedimento nell’onorare convenientemente le aste, senza perplessità alcuna ci si rivolge alla piazza di Milano, come dichiaratamente si rileva in data ottobre 1589: «Lire 71.11.6 receputi per certi dinari anelli et scufioti in filo d’oro venduti a Milano per più avantagio». A Milano i tesorieri della Confraternita si direbbe siano di casa, e precisamente quali frequentatori del “maestro della zecca”, o in alternativa del cambiavalori Teodoro del Bianco. Se oggi i corsi monetari si scoprono inquinati da soldi di malaffare, sporchi o riciclati che dir si voglia, a quei tempi, mutatis mutandis, circolavano con variopinta nomenclatura «danari calanti o bassi, monete balzane, quatrini forestieri e falsi». I governi normavano i corsi legali sulla volubilità delle loro emergenze politiche e per i contravventori riservavano il sequestro delle «crumene» e d’ogni altro tipo di bisaccia. Mandavano però esenti da tale provvidenza correzionale le bussole e le casse dei luoghi pii. Trionfava dunque la buona causa della Fabbrica, e al chiudersi dell’annuale esercizio finanziario e dell’anno liturgico gli scarti e i rottami di cera, unitamente ai «quatrini et monete false» rinvenuti nelle cassette, partivano da Cannobio per Milano: destinatario il signor Gio Batta Marco che, in due distinte partite, pagava ai Confratelli il corrispettivo per la cera ed una equivalenza in valuta legale da lui «barattata col maestro della cecha» per il restante collettame numismatico. Va notata codesta eterogeneità monetaria perché costituisce per noi una preziosa spia di come convergessero sulla Santa Devozione pellegrini provenienti anche da paesi esterni alle regioni rivierasche. Il Lago Maggiore, da tempi immemorabili, è stato una via d’acqua economicamente sfruttata in direzione delle regioni interne, assai più sistematicamente di quanto non lo fosse militarmente in direzione opposta. Come si provvide ad ostacolare eventuali affluenze ostili da nord riducendo al minimo le carreggiate, così ripetutamente si dovette depurare il transito di mercanti di mercerie, di vini e di derrate frumentarie dagli “sfrosatori”, con avvistamenti e sfuriate di remi. Per gli anni dei quali discorriamo la vigilanza era gestita dal “Capitano del Lago”. Ed è curioso come costui si sia ripetutamente mostrato benefattore della Fabbrica dirottando nelle casse della Confraternita le multe irrogate ai contrabbandieri, italiani o svizzeri che fossero. Ignoriamo come poi rimediasse la contabilità con la competente autorità superiore; desumiamo comunque che fosse individuo assai concreto e sbrigativo da una soluzione compromissoria da lui adottata: 12 messe in suffragio dell’anima della sua suocera in cambio di una veste di lei donata «per suplire al carico di lire 6» dovute al celebrante. D’altro canto già i Reggitori di Cannobio più volte avevano devoluto alla Fabbrica le somme percepite a seguito di sanzioni pecuniarie imposte dalla Magistratura: un modo autorevole e politicamente vistoso con cui si affiancavano all’impegno universalmente dimostrato dalla popolazione. O forse anche per una specie di simbolico risarcimento offerto alla Comunità, ritenuta ingiustamente lesa dal malaffare di qualche suo membro. Se così fosse ... gente, che tempi! 7 (fascicolo N. 8 – ottobre 1992) Oblatori o benignità sovrana? Don Crenna non risolve l’interrogativo. Certo alla serenissima Regina Margherita di Spagna non venne omaggiato il libretto del miracolo di Cannobio semplicemente per accondiscendere ad una curiosità regale. E, comunque, resta il fatto che l’ebbe! «Un’autentica chicca...». Ad ogni puntata sulle vicende del Santuario don Crenna offre una notizia impensata, interessante. A lettura avvenuta, con attesa e curiosità ci si domanda: quale sarà la prossima? 12 «Lire 8 e soldi 14 spesi in fare acomodare uno libreto del miracolo dela Santa Pietà, che fu donato alla serenissima Regina margarita nostra signora in Milano». Alla 147ª pagina del libro «ove si contiene la spesa fatta e la cavata de’ signori Priore e Tesoreri della venerabile schola di S. Pietà» per gli anni 1575–1615 si legge codesta annotazione, vergata dal «depositario» Bartolameo Cironio, in data 10 gennaio 1599. Mimetizzata fra la minuteria delle spese correnti, essa è un’autentica chicca per chi voglia documentarsi sulla convinta devozione di cui, in Cannobio, s’è materiato il santuario della Pietà. Poco importa sapere se in quella circostanza sia stato attivato in Milano Alessandro Pinotino, abituale procuratore presso l’autorità governativa ed arcivescovile, oppure si sia costituita una qualificata rappresentanza di Cannobiesi, o comunque di personalità auliche disposte ad assumersi tale incombenza. Un dato è inequivocabile: fu contattata la Corte di Spagna al suo più alto livello. Ed anche supponendo che il nostro immaginario disponga soltanto delle movie-fictions propinate di recente e rievocanti l’impatto tra Cristoforo Colombo (che pronosticava la via delle Indie) e i sovrani aragonesi, possiamo ben avvertire la stranezza dell’approccio, cent’anni dopo, tra un manipolo di sudditi – si badi – latori di un «libretto del miracolo» e la Signora di una Spagna ormai giunta all’apogeo di potenza europea. Si trattò di una inaudita supponenza di oblatori o di una inimmaginabile benignità sovrana? ma, in ogni caso, quali poterono esserne le motivazioni? Si tengano presenti le regole inflessibili escogitate a tutela della sacralità – inavvicinabile ai più – dei Reali: perfino la loro mensa era presidiata da assaggiatori e degu–statori, naturalmente dignitari di Corte. Si aggiunga che Margherita d’Habsburg, nata a Graz nel 1584 dall’arciduca di Stiria, Carinzia, Carniola ecc., Carlo, fratello di Massimiliano re di Boemia e di Ungheria e poi imperatore nel 1564-76, fu dal 1589, per imperativi dinastici, assegnata maritalmente a Filippo III degli Asburgo di Spagna, ed effettualmente confermata nell’altissimo rango a Valencia nel 1598, primo anno di regno del consorte. A codesta «Serenissima Regina» di Spagna, sorella di Ferdinando II, a sua volta re di Boemia e di Ungheria e successivamente imperatore nel 1619-37, viene omaggiato il «libretto del miracolo» di Cannobio! Le 8 lire spese per accomodarne la veste esteriore non ci ragguagliano granché sulla dignità di tale operazione. Ma un’indiscrezione sulla modestia della stesura, quale sortì dalla penna del suo autore, detto il Cigolino, ci viene fornita dal Sasso Carmine che ebbe fra mani e lesse il «libretto intorno ai Miracoli composto in forma men bella da un sacerdote appellato per nome Tomaso Pizzallo», alias il Cigolino. Costui con ogni probabilità poté attingere a testimoni diretti ancora superstiti ai suoi tempi. Di lui, canonico di S. Vittore, sappiamo che fu designato nel 1574 da Carlo Borromeo a coadiuvare il prevosto Ponzio; il Sasso Carmine ne elogia la «gran virtù e religiosa vita, molto amato e pregiato in Cannobio, il quale lasciò questa misera spoglia l’anno 1600 incirca». La sua operetta fu data alle stampe una prima volta nell’aprile del 1589, con una tiratura di 200 copie che costò 24 lire e 8 soldi, e poi ancora nel marzo del 1604 in una ristampa di 500 copie, per un costo complessivo di lire 33 e soldi 15 «comprese L. 8.15 per cusirle, a ragione de soldi 35 il cento». Alla Sovrana fu dunque offerto un esemplare edito dieci anni prima, di supponibile pochezza tipografica a cui si dovette porre rimedio, ma il cui prevalente valore contenutistico fugò negli offerenti ogni dubbio che non fosse dono degno della Regina di Spagna: affidata a quelle pagine stava infatti, a loro giudizio, la più schietta e conturbante attestazione di quello che occhi e menti di uomini avevano visto e saputo intendere ad iniziare «dall’ora prima di notte, nell’ottavo giorno del gennaio 1522». Un’osservazione curiosa e forse di poco conto: le due edizioni del «libretto del miracolo» coincisero con le fasi più roventi dei lavori di fabbrica e delle più sofferte congiunture finanziarie. Tale attività editoriale ci appare quasi un contrappunto che, in quanto tale, si richiama all’assunto principale e gli dà sostenutezza: «questo Santuario dovrà essere compiuto perché costituisca il contrassegno umano solenne e persuasivo che, proprio qui, nel nostro Borgo, si è manifestata la Pietà del Signore». 13 E richiamandoci a quanto fu rinvenuto, nell’ultima ricognizione, dentro la custodia lignea ove sta riposto il quadruccio della Pietà, ci domandiamo in quale misura il volumetto ivi conservato Relatione dei miracoli avvenuti nel borgo di Cannobio sopra il Lago Maggiore l’anno 1522, stampato a Milano dal Gariboldi nel 1655, si rifaccia al «libretto del miracolo» qui ricordato. Fa notare lo Zammaretti (Il miracolo di Cannobio e le sue reliquie, 1987, 2.a ediz.) che in una pagina di fondo sta la dicitura Jo. Franciscus Saxus Carmenus S.(?) U. D., ed ha pure riscontrato la sostanziale e formale conformità con la descrizione contenuta nella Informazione storica del Borgo di Cannobio, ove però – sempre secondo lo Zammaretti – al cap. XVII, dallo storico non sono stati ripresi stranamente alcuni rilevanti dettagli riportati invece dalla Relatione. Sarebbe quanto mai auspicabile che la buona sorte concedesse a qualche ricercatore di rinvenire, in un fondo dismesso d’archivio, l’aureo libretto menzionato, fortunatamente, dal Bartolameo Cironio. 8 (fascicolo N. 9 – novembre 1992) Chissà che qualche bravo organista, magari nella «giornata del Perdono», incuriosito, s’accosti al vecchio organo, con vecchie canne, con vecchi registri e ci faccia gustare dolci melodie. Si tenga certo l’appassionato maestro d’organo che, se fosse privo di «barca», una vettura potrà «condurlo e recondurlo» a casa di meriggio o di sera, dopo aver aspirato volute d’incenso e ammirato «candelette di cera rossa»... Proprio così. Credevo di sapere tanto e m’accorgo che ancor molto mi resta da conoscere – e forse non solo a me. Grazie dunque al prof. don Crenna per le notizie, in attesa di nuove... scoperte. L’attività del cantiere edile si protrasse dal 1575 fino al 1614. Però la originaria angusta Devozione di Cannobio poté dilatarsi fino a raggiungere la volumetria dell’attuale Santuario della Ss. Pietà. E ciò ad opera della genialità del Tibaldi, della devota tenacia dei Cannobiesi e di improvvisazioni finanziarie a non finire. Alla prova dei fatti, l’unica entrata veramente affidabile era costituita dalle offerte che si raccoglievano ogni anno il 9 di gennaio, «giornata del Perdono». In tale occasione, nel 1585 fu raggiunto il record di 645 lire e 16 soldi; nel 1598 si racimolarono soltanto 313 lire e 5 soldi, e si toccò il minimo di 165 lire e 10 soldi nell’anno 1610. Un introito cioè estremamente variabile; ma non per questo lo si può contestare senza offesa al pudore, essendo l’elemosina un provento sui generis sottratto ad ogni immaginabile contrattazione, semmai privatamente pattuito tra l’offerente e – se ci sta – il buon Dio. A scanso di idiote considerazioni preferiamo osservare come il diagramma della buona riuscita o della decrescenza delle bussole si è modellato sulle ricorrenti epidemie di peste di quei tempi. È scontato che la pestilenza abbia avuto le stesse percorrenze degli uomini; infatti a più riprese essa marchiò i transiti di Valmaggia e Leventina, Mesolcina e Centovalli, cioè quelle direttrici commerciali che si irradiavano dalla nostra area subalpina verso l’Oberland bernese e i paesi dei Grigioni. Per l’appunto, dall’inizio del 1596 e per un paio d’anni, la peste indugiò a Faido, Preonzo, Tavernelle, Torricella; e proprio allora al Santuario si registrò l’affievolimento delle offerte. Nel 1610 poi, come è noto, tornò ad imperversare nelle terre lombarde, e al Santuario si toccò il fondo. D’altronde, che fare? Ci si rintanava pressati dalle gride di sanità e dal pericolo del contagio e, ad ogni suo allentarsi, ci si affollava nei luoghi più acconci ove implorare da Dio con più forza una tregua misericordiosa. Così dovette accadere in quel 9 gennaio 1585, giorno del Perdono: dal forte introito di elemosine veniamo informati che dalle valli tutt’attorno a Cannobio, liberate dall’incubo della peste, tanta altra gente s’aggiunse ai residenti ed ai rivieraschi. Anche in tal modo il pio convincimento radicato tra i Cannobiesi trasse appropriata motivazione dagli eventi infausti di quel tempo per diffondersi devozionalmente su un più vasto circondario. 14 Ce lo fa arguire persino il rinnovarsi dei festosi inviti alla festa del Perdono: una ripetuta messinscena che di anno in anno cresceva in risonanza, forse enfatica ed effimera, ma certo attraente e suggestiva, all’insegna di pio entusiasmo e di propositi mai dismessi. Aumentarono gli onorari agli officianti; le umili guarniture di bosso sempreverde andarono arricchendosi di «palper tinto e orpel»; sempre più numerose le candelette di cera rossa per la luminaria, e non ultima folclorica aggiunta, «la polvera d’archabugio per onorarvi il Santo Perdono». Preci devote e querimonie penitenti trovavano un percorso, dalla terra al cielo, ingentilito da volute «d’incenso, garofalo, canella, storazo e belzovino calamita». Tanto ci voleva per conferire quel minimo di chiesastico ad un ambiente nominalmente sacro, ma tuttora grezzo e affatto spoglio d’ogni connotazione che lo facesse apparire tale; se fuori il lago s’increspava livido sotto «l’inverna», all’interno il rigore sembrava stemperarsi in quella mistica velatura di fumi odorosi. Non ci giureremmo che fosse intervenuto il locale «medico Gallo» a stabilire il dosaggio opportuno perché tale suffumigio riuscisse pure medicamentoso. Infatti, all’epoca, un ricettario di farmacopea suggeriva un pregevole miscuglio d’incenso (Solibanum electum), bacche di ginepro, belzoino, zucchero, fiore di lavanda, petali di rose odorifere e radice di cascarilla, da usarsi pro suffitu, cioè pro fumo per i casi di artrite, pur senza garantirne l’efficacia; era invece sicuramente valido quale correttivo dei cattivi odori! Nessun dubbio invece sulle virtù fluidificanti dello storace: una lacrimazione balsamica rossastra dall’incisione sullo Styrax officinale; le gocce resinose, rassodate e friabili, mescolate con segatura di legno, passavano sotto il nome di storace calamita, e, poste su un braciere, emanavano un soave profumo; si era cioè evitato di usare per la Devozione lo storace comune, una specie di segatura (utile per cataplasmi con farina di linosa), meno pregiata e assai meno odorosa. E che dire del belzoino, o Styrax benzoin? Codesta fragile resina proveniente dalle Indie orientali, di colore giallino, di odore balsamico e gradevole, era anche assai ricercata per la tintura alcolica che se ne estraeva per confezionare il detergente latte verginale. Una nuance complementare era data dall’effumazione di «cannella e garofoli», o forse meglio cannella garofolata, Myrthus caryophillata: pure questo un prodotto delle Indie Orientali dal delicatissimo profumo di garofani (e per nulla di cannella). Dunque un elaborato e costoso mélange di aromi, i cui apporti olfattivi e inalatori ben si integravano col sentore ieratico diffuso tutt’attorno dalle vocalità del ben temperato organo. La voce di questo strumento non venne mai meno nonostante fosse messo a rischio dai rifacimenti edilizi e dai conseguenti trasferimenti da un canto all’altro. Lo si accudì ripetutamente con «vachette e corami per li mantesi», con «sonza di porco e sego per ongerli, cera rossa per le canne», e soprattutto facendo intervenire l’organaro accordatore di Pallanza, ogni volta profumatamente pagato, oltre alla spesa della «barca a condurlo e recondurlo». Che l’organo sia stato tenuto costantemente in efficienza è provato dal regolare stipendio trimestrale di sei lire versato all’organista: dapprima lo stesso cappellano Cristoforo Porolo, dal 1587 con onorario triplicato il signor Desiderio Carmino. Ma al riguardo non si badava a spese, ancor meno nel giorno del Perdono: per l’occasione ci si assicurava della presenza di un maestro di cappella con relativi coristi, ingaggiati da Pallanza e, nel 1612, addirittura da Locarno. Così andarono le cose fino al 29 settembre 1609. In tale data leggiamo nel libro delle spese: «L. 178.5 sono pagate per el costo de uno Regale, comprato dal rev. Padre di santo Francesco con participazione de li reverendi signor prevosto Stefano Broco et Teologo di ciò esperti”. Perché non ci sfugga l’entità dell’operazione – a prescindere dal suo costo – basti ricordare che due anni innanzi il Monteverdi usava il regale per il suo Orfeo e che, ancora nel 1666 il Cesti lo impiegò nel suo Pomo d’oro. Codesto strumento, già noto nel XII secolo, era dotato di registri ad ancia, con l’aggiunta, nel XVI secolo, di registri labiali, e con una estensione sino a quattro ottave. Bastava, aggiunto al tastierista, una seconda persona che ne azionasse i mantici. Pregio non indifferente: lo strumento era trasportabile. Va da sé che il regale fosse visto dai confratelli della Devozione come investimento fruttifero. Da quell’anno infatti le chiese del circondario di Cannobio furono toccate dalla tournée di codesto regale. Passi il calembour: ne beneficiò la pietà dei fedeli, ma ancor più ne beneficiò la Ss. Pietà di Cannobio 15 Per una storia del Santuario Per chi vuol saperne di più… 9 (fascicolo N. 1 – gennaio 1993) Il professore don Mario Crenna, sabato 16 gennaio, nella sala Convegni de “Il Portico” ha tenuto una conferenza sul tema: “Storia del Santuario: architettura ed economia”. Al termine ho raccolto tra i numerosi intervenuti qualche impressione. «Sono di Cannobio, ma queste notizie mi sono assolutamente nuove» – «Sarei rimasto fino a sera ad ascoltarlo» – «Mi auguro che torni ancor: è stato molto interessante»... Bene, il fuoco è acceso... e divampi! Ma don Crenna è sempre presente, anche quando è assente. Sì, perché ogni mese sul Bollettino ci offre il frutto delle sue ricerche. Leggete questa “puntata n. 9” voi che eravate presenti – e, con un pizzico di rammarico, anche voi che eravate assenti –, rivivrete il clima dell’incontro. Professore, grazie e buon lavoro; a presto. Anche un’elica aiutava a spingerli: a bordo era forse questa l’unica innovazione moderna. La grande vela rettangolare, gonfia di “inverna” se si andava verso Brissago, e, tornando, resa panciuta dal Valmaggino o dalla Tramontana, i lunghi remi, la lunga barra del timone e il fasciame pesantemente calafatato dentro e fuori, per chi se li ricorda ancora, erano i contrassegni dei barconi del Lago Maggiore. Tozzi e senza pretese di rotta o di orari, affidabili – si diceva – ma sempre con la linea di galleggiamento messa in forse dal sovraccarico di sabbia, pietrisco e d’ogni altra cosa che risultasse troppo ingombrante per essere inoltrata lungo la strada litoranea dei tempi passati. Sono pressoché scomparsi perché decrepiti ed anacronistici. Eppure alla loro epoca migliore, stando ai documenti, essi erano “le navi”, governate da professionals, quali i cannobiesi Bernardo Barletino col socio Garlanda, Battista Rizetto e Laurenzio Bilino, con i rispettivi figli Defendente, Battista e Giovanni, naturali rincalzi per diritto di sangue marinaro. E dal 1575 fino al 1611 troviamo registrate nei libri contabili della confraternita della Ss. Pietà le rotte battute da codesti carrettoni d’acqua, a fondo piatto, che salpavano dal porto di Cannobio verso gli approdi di Sesto Calende, Arona, Meina, Pieggio, Intra, Luino, Germignaga, Porto Valtravaglia, Maccagno, Ascona, Ronco, Brissago, Ponte, Piaggio Valmara. Attingendo alla loro stiva, furono trasbordate alla fabbrica del Santuario tonnellate di materiale edile. Le puntuali registrazioni di bilancio, redatte dai tesorieri della confraternita, ci consentono di ricuperare visivamente quel gran movimento cantieristico: la provvista di calce viva presso le fornaci del Zapo, di Porto e di Maccagno, raggiunse i 25 quintali. Toccò poi alle donne di Cannobio, di volta in volta improvvisate portatrici d’acqua a otto soldi al giorno, “spegnere” codesta massa di calcare calcinato. Dai «pioderi» della Valmara, di Varenzago, di Cannero e di Cheggio, con un interminabile «spezzar sassi» si stivarono pietre fino a 246 «navate», con l’aggiunta di altre 23 di “scaioni” utilizzati per compattare le volte. Da Cerro, Luino, Besozzo e Porto furono traghettati complessivamente 38.100 mattoni o “prede cotte”. Oltre ai duemila coppi, occorsero 314 «barche» di piode, per lo più cavate a Brissago. Fu impresa di sua natura impegnativa e costosa la squadratura delle pietre angolari nelle cave di Ascona, Brissago, Fontanella e Oggebbio, ed il loro trasporto con traino di buoi sino agli approdi. Furono 94 le navate di materiale che, scaricato sulla riva antistante la fabbrica del Santuario, veniva poi rifinito dai maestri scalpellini di Brissago e di Ascona. Dapprima si provvide al traino in cantiere con la doppia pariglia di buoi di Defendente Reschigna. Un’operazione che in seguito, a conti fatti, risultò più economica procurandosi un proprio “sistema di locomozione”, come risulta in data 10 agosto 1586, con l’acquisto di due buoi pagati 96 lire. 16 Nei libri contabili non v’è però traccia successiva di un ricavo da rivendita dei due bovini: forse un capitale fruttifero estintosi per assimilazione? Imprecisato è il numero dei trasporti di materiale più a rischio: fusti di colonne e balaustre di mischio d’Arzo, abachi e basamenti di marmi di Candoglia, cornici e lesene di pietra d’Angera e di Valmara, occhi di marmo nero da Como, pezzi di marmo segati a Meina da Francesco Paranchino e tirati poi a lucido con piombo e pomice dagli esperti maestri marmorini di Ascona e di Brissago. Verrebbe spontaneo, con una punta di malizia, dubitare se mai i Cannobiesi abbiano avuto chiara previsione di ciò che stavano per accollarsi in quei momenti nient’affatto favorevoli, per vari versi, ad un’impresa del genere, a causa dei ricorrenti chiaroscuri politici e delle conseguenti emergenze economiche, oltre alle ben risapute tribolazioni sanitarie di quel secolo. E francamente stupisce quel loro accanimento nel portare innanzi, praticamente da soli, ottimati e popolani locali, un impegno tutt’altro che dappoco, tanto più quando sopraggiunse, voluto da san Carlo, il progetto di Pellegrino Pellegrini detto il Tibaldi. E va tenuto presente che a metterci mano fu un artigianato imprenditore di tutto rispetto: da Cristoforo Casanova di Brissago ai Beretta Pietro e Stefano, padre e figlio, da Francesco De Bassi di Gurro ai fratelli Andrea e Giacomo Piotti detti i Franchiti. Operò un complesso di 42 maestri da muro guidati, in successione, da quattro capomastri o “maestri ingegneri”: il sopracitato Casanova, Pietro Beretta coadiuvato e poi rimpiazzato dal figlio Stefano, Andrea Pozino e Giovanni Faiti; undici i maestri di scalpello ben individuati. Codesta maestranza proveniva da Brissago, Ascona, Lugano, Scaiano, Ronco, Giazzo, Novaso, Formine, Falmenta o Gurro, Oggebbio, Sant’Agata e Carmine. Lavorò in cantiere per un totale di 14.303 giornate, ivi comprese le 1.327 giornate di donne, 5.035 di manovali e 1.207 di garzoni. Un altro dato, di per sé sconfortante per la tenacia dei Cannobiesi, sarebbe dovuto essere anche il processo inflattivo in corso dalla metà del secolo, che fece lievitare il costo della vita quasi raddoppiandolo: inevitabile fu il riflesso nelle retribuzioni alla manodopera e nel costo dei materiali. Per il periodo preso in esame dal 1577 al 1611, il prezzo del mattone passò da 4 ad oltre 7 denari, la calce viva dai 15 soldi al «centenaro» (circa 76 kg) raggiunse alla fine del secolo i 25 soldi. Se passiamo alle retribuzioni giornaliere, troviamo che dai 32 soldi dati al primo direttore del cantiere, il maestro Cristoforo Casanova, progressivamente ci si portò a 40 soldi per il Beretta e a 35 per il figlio suo aiutante. I muratori che dapprima percepivano 26 soldi (24 se locali), ebbero un incremento di busta paga fino a 35 soldi (30 se locali). L’aumento raggiunse anche le retribuzioni per i manovali (dai 15-18 soldi ai 20-22) e per i garzoni (da 10 a 15 soldi). Persino le donne videro crescere il loro salario da 8 a 11-12 soldi. Non per questo ci fu un arresto nell’attività di fabbrica: dal massimo di 1.688 giornate lavorative del 1595 alle 1.133 del 1598, alle 948 del 1601, alle oltre seicento del 1607 e 1611. Si tenne testa all’aumento dei prezzi escogitando i più svariati modi onde usufruire d’ogni risorsa locale pur di sopperire alla spesa crescente: dal 1580 fino al chiudersi del secolo ogni resoconto finanziario di fine anno segnò un attivo, sia pure sovente ridotto a poche lire. Finché nel 1611 si ebbe il botto finale: terminata l’ultima parte muraria, cioè la sopraelevazione del tiburio, si volle provvedere alla sua copertura con lastre di piombo... 10 (fascicolo N. 2 – marzo 1993) S’è sfilacciata la corda della “seconda”, la campana dedicata a S. Lorenzo. Occorreva sostituirla. Staccai con riconoscenza la corda – vecchina; era l’ultima carezza. Anche lei aveva avuto le sue gioie: su e giù, su e giù nei giorni feriali; più a lungo nelle domeniche e nelle solennità. Stimolato dalla dovizia di informazioni segnalate da don Crenna in questo articolo, dalla torre campanaria ho voluto osservare il tiburio con le colonnine, gli archetti, le mensole... E chissà se prima di collocare la croce sul «balone de arame» per qualche tempo hanno fatto sventolare la bandiera? E che tipo di bandiera? Una cosa è certa: al di là del Miracolo, la costruzione del Santuario costituì un avvenimento singolare non solo sotto il profilo religioso ma anche civile. Grazie a don Crenna per queste e per le prossime notizie. 17 Ispirandoci all’operazione nazional-patriottica di “mani pulite”, ci siamo proposti di inquisire i confratelli della Ss. Pietà in rapporto al loro esercizio finanziario 1575–1615: sia pace alle loro anime, con l’acrimonioso sospetto che entro quel gran reticolo concorrenziale di fornaci, cave, commesse, aziende fornitrici, trasportatori, progettisti, maestranze e manovalanze, almeno per assonanza ai nostri tempi, anche allora gli intrallazzi ci siano stati. A dire il vero, l’inchiesta su codesta presunta Tangentopoli, targata secolo XVII, si è rivelata più noiosa che difficile: è bastato ricorrere alla sommatoria aritmetica degli addendi lungo le meticolose registrazioni in partita doppia portate innanzi dai confratelli ostinatamente per mesi ed anni, ed il risultato finale era lì, sotto gli occhi: disarmante in tutta quella sua innocente nudità di totale di spesa. Il santuario della Pietà, così come fu progettato dal Tibaldi, riattando ed amplificando il primitivo ambiente della cosiddetta «Devozione», venne a costare – chiavi in mano – non più di un miliardo e ottocentocinquanta milioni odierni. Questo dato vien fatto emergere, ora, per la prima volta: è sicuramente attendibile, perché corredato da documentazione storica. Eppure ha dell’inverosimile: basti riandare alle terrificanti lievitazioni in miliardi, connotazioni ormai consuete per le opere pubbliche dei nostri giorni. Ma ancor più sbalorditivo è quel contenimento di spesa, allora verificatosi a Cannobio, se consideriamo che, per ragioni di spazio, le strutture portanti del santuario, forzatamente, vennero piazzate pressoché nella battigia del lago; che l’attività nel cantiere subì rallentamenti e pause, perché talora si dovette trovare scampo alle esplosioni epidemiche di fine secolo, o ripetutamente rimediare a debilitazioni finanziarie. Ci è possibile stabilire – grosso modo – che ci furono tre fasi lavorative: e questo, grazie alle caratteristiche “onoranze”, tradizionali tra le maestranze edili. Sappiamo infatti che, nel giugno del 1595, all’osteria di Bartolomeo Bagatello, mastro Pietro Beretta, capo cantiere e direttore dei lavori, con i suoi muratori e manovali commemorò «la seratura della volta grande»: quella, cioè, sostitutiva delle quattro soffittature a vela, originarie della Devozione. La scena si ripeté – ma stando ai soldi spesi, non si andò al di là di qualche boccale – nel settembre del 1600: la volta ultimata era la copertura di quel prolungamento della Devozione, mediante il quale era stato raggiunto lo sviluppo perimetrale definitivo del santuario. Ora occorreva coprire l’area del presbiterio, innestando sull’apposita imposta poligonale la calotta del tiburio, con relativa torretta o lucerna. E qui non è chiaro in base a quali perplessità architettoniche, insorte a margine del progetto del Pellegrini, sia stata allora escogitata l’imbracatura del tamburo, con colonnine e archetti marmorei, a guisa di tribunetta circolare, leggiadra e poco tibaldesca. Esplorando tra le registrazioni di cassa per gli anni dal 1606 in poi, il bandolo della faccenda è forse da rinvenire in una serie di spese così descritte: – «24 ottobre 1606. Lire 36 sono pagate a domino (signore) Bernardo Paranchino per diverse fatiche, visite fatte et disegni intorno alla fabrica, a firmato di monsignor Mazenta». – «31 novembre 1606. Lire 1.15 spesi in mandare a tore il Parenchino per divisare il negotio del tiburio, et poi condurlo a Luino». – «15 gennaio 1607. Soldi 12 per diversi cartoni per fare desegni per la fabrica». Nel frattempo il Beretta si dava un gran da fare, quale mastro «ingeniere», sfidando i rigori invernali, per individuare i materiali più acconci; tant’è che in data 15 gennaio 1607 troviamo annotata la spesa di «lire 2 e soldi 15 pagate a Cosmo barcarolo per viaggi tre, fatti a condurre maestro Petro a servicio della fabrica». Dove? Leggiamo: «Lire 2, pagate (al suddetto) per sua faticha condota alle montagne a visitare pietre». Intervenne anche «il figliolo di mastro Francesco de Bassi (di Gurro), conduto a insegnare ove si trovavano molte prede nascoste, per la fabrica» tra le montagne del Vergante, «nella valle di Ogiabia e nel fiume di Cannero». Ma l’area più battuta fu quella a ridosso di Brissago, da dove, ancora nell’agosto del 1610 (quando ormai si lavorava alla lanterna) giunse l’informazione, così tradotta nel linguaggio di spesa: «Lire 16 sono pagate a mastro Jacomo Ciapino di Cadagno, jurisditione de Brissago, per pagamento di uno grande sasso di marmore cavato ne’ soi lochi di Cadagno, che ancora resta parte di cavare». 18 E da Brissago gli elementi architettonici provenivano già pronti per la posa in opera, perché rifiniti sul luogo dai maestri di scalpello Andrea e Giacomo Piotti: i fratelli Franchiti. Veniva, cioè, evitato di appesantire il costo dei lunghi tempi di lavorazione con le spese aggiuntive, sia di trasferta e d’alloggio in Cannobio per i maestri, sia anche per eccedenze di materiale grezzo o semilavorato inutilmente trasportato al cantiere. Infatti, al 6 maggio 1607, troviamo annotati i 15 soldi pagati «a un barcarolo che andò a Brissago a domandar li Franchiti»; e al 3 giugno successivo, che la pattuizione fosse avvenuta troviamo conferma nelle 196 lire pagate «a bono conto delle prede hanno essi di lavorare per il tiburio conforme l’accordo» (esclusa la posa in opera). Il compenso venne fissato in 400 scudi, al cambio di sei lire per scudo: quindi un totale di L. 2400 (= 84 milioni odierni) da versare in quattro rate semestrali ad iniziare dall’agosto dell’anno corrente. Impegno finanziario non eccessivo trattandosi di una componente architettonica vistosamente scenografica, quale poteva essere il tiburio. Comunque, fu un esborso di poco inferiore a quanto successivamente si spese al fine di tutelare la turrita prominenza ottagonale con una copertura di sicura tenuta alle raffiche ventose che calano dal Ceneri e ai rovesci di pioggia che dal budello della valle Cannobina si scaraventano giù verso il lago. Non v’era altra scelta, se non il ricorso al piombo: d’altronde era in gioco un ambizioso coronamento, un traguardo insperatamente raggiunto. E ci si buttò. Nell’aprile del 1611, mentre i due fratelli Piotti ( o Franchiti) verificavano le strutture murarie e ornamentali del tiburio, al suo fastigio venivano istallati i 22 grossi assi di larice del telaio che avrebbe dovuto supportare la copertura metallica. Nel frattempo a Milano Gio Francesco Mazirono contrattava con mastro Antonio Zavata, comasco, per il piombo, che alla «resiga del Barbé» venne poi approntato in lastra. Un primo carico di 16 lastre, che, pesate alla stadera di Milano, risultarono di 6557 libbre (poco meno di 50 quintali), per un costo di 1639 lire, venne trasferito da Porta Nuova a Porta Ticinese, e da qui per via d’acqua inoltrato a Cannobio: una condotta costata 24 lire (vale a dire 840.000 lire d’oggi). Seguì un secondo carico di 10 lastre, di 4526 libbre (pari a q.li 34,5), pure condotto per barca fino a Cannobio, per 700.000 lire nostre. La posa in opera fu effettuata da tre maestri specializzati, prelevati a Germignaga, dove erano giunti da Milano cavalcando. Lavorarono per quindici giorni effettivi, con una paga giornaliera di 4 lire ciascuno (L. 140.000 d’oggi). Naturalmente spesati di tutto. Fu prelevato ad Angera, il 25 agosto, un verificatore dei lavori ultimati, messer Josef «ditto de Varese»: un sopralluogo alla lanterna, il suo, costato 14 lire (L. 490.000 d’oggi). E sulla lanterna, svettante, era stata collocata la croce, e «un balone de arame posto al calce della croce, entrambi indorati» a Milano. Complessivamente, l’operazione della copertura in piombo raggiunse così le 3136 lire di spesa, equivalente cioè a quasi 110 milioni attuali. Ogni scorta finanziaria fu polverizzata. Ma fece il suo ingresso in campo la “graziosa” beneficenza di alcuni magnati locali: essa merita un capitolo a sé. 11 (fascicolo N. 3 – aprile 1993) Notizie che non finiscono di stupire. Sì, perché vien ricordato che anche i defunti... diedero una mano per finanziare la costruzione del Santuario! Anche allora le cifre color rubino non erano gradite, potevano riservare brutte sorprese; bisognava intervenire al più presto, perché tra creditori e conto in rosso – già a quei tempi –non correva buon sangue. Insomma, quando don Crenna raccoglierà e ordinerà i suoi appunti, ci offrirà la Storia del nostro Santuario interessante e attraente come un romanzo. E romanzo non è, ma storia vera. Professore, buon lavoro. A presto. Concedeteci la metafora: fu davvero una gran “tegola” la copertura in piombo del tiburio, nel 1611. 19 Già nel gennaio di quell’anno il depositario, o tesoriere della confraternita della Ss. Pietà, Gio Battista Romerio, aprendo la contabilità del libro mastro si era trovato “in rosso”: un passivo di cassa di 533 lire, che, momentaneamente ridottosi a 103 in coincidenza con la festa del Perdono, a settembre aveva celermente raggiunto e superato le 573 lire. Cioè, per meglio capirci, dagli attuali 3 milioni e mezzo, in meno di sette mesi, il deficit era volato oltre i 20 milioni. D’altronde che fare? I muratori impegnati alle strutture del tiburio e, più di loro, i maestri di scalpello andavano pagati: una retribuzione giornaliera, questa, oscillante tra le centomila giornaliere dell’«ingeniere» Giovanni Faiti, alle 70-80 mila degli altri, cioè di Andrea Pozino e Gottardo di Brissago, Francesco del Giazzo, Antonio Capeleto da Genzago, Giacomo e Andrea Piotti-Franchiti e Francesco Besa; costui mastro carpentiere. Senza tener conto dei quattro o cinque garzoni ausiliari. Non bastava più l’apporto finanziario di quei mesi, frutto di donativi, elemosine, legati, né il concorso popolare degli incanti, per quanto tuttora sostenuto nelle forme più disparate: «formagielle, ova, vino, castagne, polastri, varoni», persino un vitello ed un castrato; capi di vestiario, «dalle gorgiere ai giuponi, alle calze del fu signor Girolamo Mantello», vendute – sissignori – agli “Oh bei, oh bei” di Milano. Né mancarono i preziosi: «uno scufioto d’oro, il gioiello pagato da madonna Vittoria Carmena». Diedero una mano – si fa per dire – anche i defunti, grazie alle elemosine per il palio della Ss. Pietà che, da buoni Cannobiesi fino all’ultima ora, avevano voluto s’accompagnasse al proprio funerale. E quell’anno furono tanti: per due volte nella casa di Bernardino Zacagno, poi la figliola di Bartolomeo Mantello e la seconda moglie del signor Gerolamo Mantello, la Catelina Rasenata, la moglie di Gio Paolo Olginate, Rocco da Carmeno suocero di Gio Antonio Petrolino, la madre di Gio Batta Omacino, la povera Capona, il figlio di Gio Marcion... Ma è al foglio 230 del libro mastro che il tesoriere Romerio ci fa intendere – e lo mette graficamente in risalto – quanto scioccante, anche se previsto, sia stato per tutti i confratelli il «conto del piombo posto a coprire la volta del tiburio delle 8 parti le 7 che va in conto a mastro Antonio Zanata» (e non Zavata, come erroneamente è stato scritto). Il contraccolpo sta lì evidente a fondo pagina nella vertiginosa impennata del totale di spesa: lire 3737.10, vale a dire 130 milioni e 795 mila lire. Un foglio più in là, sotto l’intestazione «al nome di Dio a dì 31 gennaio 1612», il passivo ha già raggiunto lire 4185.16, cioè i 546 milioni e mezzo. Ancora nel nome di Dio, nell’agosto di quello stesso anno, il Romerio chiuse la sua personale partita «passando di questa a miglior vita». Non per ciò abbiamo motivo di supporre che si sia trattato di uno sconcertante e compassionevole decesso provocato da motivi traversi. Però al riguardo vale la pena di rifarci ad un episodio particolarmente illuminante circa i modi con i quali a quei tempi si concepiva la gestione del denaro altrui: nel nostro caso, il denaro della confraternita. Accadde proprio a Gio Battista Romerio, quando, qualche anno prima, il 16 ottobre 1605, quel grand’Uomo del cardinal Federico Borromeo andò in visita pastorale a Cannobio. Come di norma, fu revisionato anche il libro contabile della confraternita, girato dal suo ragioniere Gio Francesco Mazirono al convisitatore Cesare Pezzano, «canonico della insigne collegiata di S. Ambrogio Maggiore». A pag. 188 troviamo infatti una postilla autografa di detto canonico, ove si precisava che, alla data citata, il tesoriere Romerio aveva a disposizione 1064 lire, 1 soldo e 3 denari a pro della fabbrica del Santuario. Qualche tempo dopo, arrivò l’ordinanza del cardinal arcivescovo: il Romerio era perentoriamente invitato a depositare presso un nuovo tesoriere, entro un mese, la somma di denaro indicata dal canonico Pezzano, salvo errore di calcolo, e se non erano intervenuti defalchi per spese effettuate nel frattempo. Altrimenti si sarebbe proceduto contro di lui sequestrando tutto e comminando in aggiunta la scomunica... ad evitandam omnem fraudis suspicionem, cioè per quelle ragioni di trasparenza, che oggi ben conosciamo. Ma qui va aggiunto un dettaglio, o meglio, una variante: il Romerio subentrò a se stesso nell’incarico di tesoriere, e vi durò fino all’agosto 1612, quando per l’appunto cessò di vivere. La storia ci insegna dunque che agli avvisi di garanzia non è detto debba sempre seguire l’incriminazione di attività truffaldina. 20 Morto dunque il Romerio, si fece il consuntivo, «il restreto di quanto sta in debito la fabrica», e verso chi. Il creditore più ostico era il citato mastro Antonio Zanata, comasco trapiantato in parrocchia di S. Bartolomeo intus, a Milano. Il conto per la prima fornitura di lastre di piombo, di 6557 libbre, risultava già pagato dal signor Bartolomeo Pianta con lire 739, denaro di chiesa, e saldato con altre 900 lire prestate dal signor Sebastiano Pianta. Ancora scoperta era invece la seconda provvista di lastre, per libbre 4526 (essendo risultata insufficiente la prima fornitura): altre 1131 lire da pagare, oltre alle 56 per stagno, rame e pece. E per di più lo Zanata con pubblico strumento rogato dal notaio Gio Pietro Omacino il 14 ottobre 1611, controbattendo alla difficoltà di onorare il debito espressagli dal priore della confraternita Giuseppe Raynerio e dai sindaci Gio Francesco Mazirono, Gio Battista Romerio (al tempo ancora vivente), Gio Battista Zaccheo e Sebastiano Pianta, aveva chiaramente fatto intendere che non ammetteva dilazione alcuna, dovendo a sua volta liquidare il proprio fornitore. Aveva perciò fissato un termine di otto giorni a partire dal primo del mese, scaduto il quale, egli senz’altro indugio avrebbe prelevato la somma dovutagli ad cambia et recambia in civitate Mediolani a quibuscumque bancheriis et campsoribus, expensis et denariis dictae scholae seu dictae ecclesiae: avrebbe dunque acceso un prestito oneroso e rateato presso qualsivoglia finanziere milanese che si fosse dichiarato a ciò disponibile, mediante ipoteca sui beni della confraternita o della chiesa. Con un’unica deroga: consentiva di scalare di volta in volta quel denaro pronta–valuta, scuta certa, che gli venisse eventualmente sborsato dai confratelli. Ancora una volta intervenne Sebastiano Pianta, che, subentrando al creditore Zanata, chiuse la partita con detto comasco in due soluzioni di danaro: 550 lire il 26 marzo 1613 e 581 lire l’anno successivo. Da un altro versante giunse la benemerenza postuma del ex depositario Romerio, che chiuse ogni falla con un legato d’ultima volontà di 900 lire. Alla luce di quanto si è qui detto, si spiega perché mai il nuovo tesoriere Giosef Raynerio potesse riprendere, sempre «al nome di Dio a dì primo settembre 1612», la contabilità del “dare e avere”, con un azzeramento del deficit, anzi, con un attivo di cassa di ben 28 lire! Da quel momento il tiburio della Ss. Pietà, sotto un cielo rasserenato, sta ad insegnare a tutti quanto strane siano le vie del Signore e impensabili i rigiri degli uomini. 12 (fascicolo N. 4 – maggio 1993) Se don Crenna continua con questo ritmo a sfornare notizie, sarà opportuno pensare ad una pubblicazione che le raccolga. Risulterà certamente interessante – e non solo per gli iscritti alla Università della Terza Età. Però, caro Professore, i tre puntini in chiusura m’han fatto l’effetto di tre piccole lische in gola. Leggo: – La casa di messer Tomaso de Zachei fu comprata «per pretio de lire...». E quanto hanno sborsato? Alla prossima puntata, d’accordo. Resto in attesa. Grazie, comunque per tutto il resto. Si era nel 1611, quando l’aerea struttura del tiburio, quale estetica gemmazione, dava al santuario della Ss. Pietà il coronamento conclusivo. Un traguardo architettonico era finalmente raggiunto, e un voto – tacitamente pattuito per quasi cent’anni in seno alla comunità – trovava anch’esso compimento. Ci soffermiamo su quest’ultimo aspetto, a motivo della sua singolarità. Anno 1526: tempi durissimi a causa della nefasta accoppiata di guerra e pestilenza, propter bellorum et pestis impedimentum que totum fere ducale Dominium perturbarunt et presertim dictum Burgum Cannobij; un’esistenza quotidiana ridotta talmente allo stremo, entro un contesto di disordine e di soprusi, che i Cannobiesi stentavano a procacciarsi l’indispensabile per sopravvivere, durantibus semper bellorum perturbationibus et angarijs extremis, quibus tantum gravantur ipsi homines ut vix suppetant facultates ad vite necessaria. Sono le pesanti considerazioni con le quali s’apre il rogito che il notaio Bartolomeo Albertini sta vergando in San Vittore, il sabato 21 aprile di quell’anno. 21 Attorno a lui i roganti: i canonici del Capitolo, prete Bernardino de Carmeno preposito, prete Giovanni Antonio de Macironibus, prete Francesco Concini, prete Francesco de Mantellis, prete Francesco de Tremedio e prete Andrea de Formeno. E poi, ancora, il magnifico signor Pietro de Mantellis podestà e reggitore del Comune, il signor Bartolomeo de Mantellis, il signor Giacomo de Poscolonia, il signor Francesco Zanotelli a nome anche del signor Antonio Giorgio de Columnis, Bernardino figlio di Stefanino Cereti, Giuseppe de Zacheis e Giovanni de Mantellis quali deputati del Consiglio generale del Comune, oltre al maestro Pietro Zanlete procuratore generale della Comunità in qualità di suo rappresentante. Assistono alla stesura dell’atto il notaio Giovanni Francesco figlio del rogante e il protonotaio Giovanni Luigi figlio del citato magnifico signor Pietro de Mantellis. Quali testimoni: il signor prete Matteo de Poscolonia figlio del fu signor Damiano e preposito della chiesa di San Lorenzo in Cannobio; Domenico de Furno figlio del fu signor Nicola abitante alla porta orientale della parrocchia di San Pietro a Milano; Giacomo figlio del fu Francesco Todeschino e Giovanni figlio del fu Giacomo Todeschino abitanti a Crevoladossola; Matteo figlio del fu maestro Giovanni di Quarna e Giacomo figlio del fu Giulio Ulcelino di Vigezzo, entrambi abitanti di Cannobio. Tanta ufficialità trova spiegazione nella presenza di monsignor Francesco Ladino, vescovo titolare di Laodicea e suffraganeo dell’arcivescovo di Milano Ippolito d’Este, quale delegato dell’arcidiacono bobbiense Giovanni Maria Tonso, dottore in utroque iure e vicario generale della diocesi milanese. Si attende dal prelato una risposta alle ripetute istanze che la Comunità cannobiese ha mosso fin dall’anno in cui accaddero fatti straordinari nell’abitazione di Tommaso de Zachei: l’autorità ecclesiastica conceda facoltà di trasformare in “devozione” la stanza del miracolo, al piano superiore di detta casa, beninteso prescrivendo clausole e modi di esecuzione. Per brevità omettiamo di riferire le condizioni imposte dal vescovo Ladino, anche perché già compiutamente esposte dal compianto prof. Aquilino Zammaretti nel suo Il Miracolo di Cannobio e le sue reliquie, ristampa del 1987 a cura della Società storica novarese. Vorremmo piuttosto cogliere il significato più profondo di due passi contenuti nel rogito di quel 21 aprile. Vi si dice: «“Essendo piaciuto a Dio nell’anno 1522, all’8 di gennaio, svelare il suo potere miracoloso, che, sia pure sempre e ovunque palese, lo fu allora in particolar modo nel borgo di Cannobio. Cum de anno MDXXIJ et die octavo ianuarij ipsius anni placuerit Deo (sicut pie creditur) ostendere miracula sue potentie que semper et ubique resplendentis precipue tamen eo anno et die in burgo Canobij...» Pare si debba ravvisare in questo enunciato un’emozione assai più riflessa di quanto non sia la stupefazione esaltante – e alla lunga talora effimera – suscitata di norma dai fatti ritenuti straordinari. Qui è chiaro il convincimento di essere stati privilegiati: una formulazione, cioè, derivante soltanto da una pacata operazione mentale, che, come tale, al di là d’ogni stadio emozionale si radica su costatazioni dirette, positivamente accettabili e persuasive. Ben si comprende allora la determinazione che, ad ogni livello e subito, la comunità cannobiese dimostra con l’assumere e perseguire un progetto inteso come doverosa contropartita con Dio: quel “sacello” che – a somiglianza dell’evangelico granello di senape – si è poi visto crescere, ampliarsi e completarsi, come si è detto, nel 1611. E infatti ha il senso di una risposta data a Dio, squisitamente umana anche per l’impostazione totalizzante, ciò che segue più oltre nel rogito. «I tempi funesti hanno fin qui impedito di mandare ad esecuzione ciò che era in animo a tutti di fare; tuttora si vive fra estreme strettezze. Ciononostante, riteniamo sia per noi più urgente e giovevole rendere a Dio l’onore dovutogli, impegnandoci nella cura delle immagini a Lui sacre; e questo, sia per la salute delle nostre anime, sia per la provvida salvaguardia dei nostri averi e della nostra incolumità personale. Attendentes nichilominus quantum eis prodesse possit, non solum ad salutem animarum, sed etiam ad comodum et utilitatem bonorum, et tranquilitatem et securitatem personarum, si rebus divinis animum intenderint et divinum cultum augere curaverint, et sanctorum imaginibus, in quibus Deus honoratur, debitum honorem impenderint». 22 Se è vero il detto che “il tono fa la canzone”, ebbene qui non si avverte la consueta implorazione di favori divini, bensì la puntigliosa determinazione di onorare un certo debito di cui creditore è Dio stesso, per l’indubbia preferenza da Lui accordata alla gente del Borgo, avendola gratificata di tanto miracolo. E la comunità si organizza con fattivo unanimismo: non v’è traccia di isteria collettiva. Da parte sua, Dio può ben disporre di onnipotenza a Suo piacimento, anzi è l’Onnipotente; ma i borghigiani cannobiesi, pur defraudati da angustianti guerre e pestilenze, sanno fare quanto è in loro potere. Ed è commovente la dicitura apposta al loro primo libro-inventario datato (si noti) al 2 maggio 1526: «Jesus. A nome de Dio omnipotente Patre fiolo et spirito santo. Questo si è il libro nel quale partitamente se descriveno tuti li beni et denari, et tuto quello è offerto et donato, et che ne lo advenire se offerirà et donarà a la Devotione de la sanctissima Pietà al Imagine del redemtore nostro messer Jesu Cristo; et tuti li crediti, et quanto altro intrarà al beneficio et utile de la dicta Devotione; e più li dinari che a la giornata occorerano pertenere a la dicta Devotione cavati da tute le casse, zoè a la Devotione de la Pietà et in sancto Victore a la Costa. Et etiam tuto quello è speso et consumato et ne lo advenire se spenderà et consumarà al beneficio de la predetta Devotione». Segue la lunga serie degli oggetti inventariati, i più disparati, di uso comune o di pregio: essi costituiscono la documentazione più ravvicinata ai fatti straordinari e la prova più diretta della reazione popolare e dell’incredibile coinvolgimento generale che ne seguì in ordine alla realizzazione del primo embrionale oratorio devozionale. Varrebbe la pena di riportare il tutto per esteso, cioè con la dignità che ogni documento veramente storico si merita. Lo spazio non lo consente; potrebbe forse anche risultare una lettura affaticante. Tuttavia apriamo almeno uno spiraglio, e subito ci si imbatte in una prima sequenza di cose attinenti alla moda d’allora: le maniche. Paia di maniche strette o larghe, «de veluto verde, de brochado doro, de damascho cremexile, de drappo d’argento, de terzanello nigro». Seguono «scufiotti de tocha gialdo con li bindelli morelli, de veluto nigro et tila doro». Ci s’imbatte nei corsaletti: «corezino uno texuto doro con la fibia de mazaglie de argento indorato et spranghe (pendagli) undeci d’argento». Nutrito il reparto di bigiotteria e preziosi: «corona una de coralli con una croxeta d’argento et uno dinar dentro», una modesta «corona una picinina de coralli picinini... de coralli con le crosete d’argento, corona una longheta de coralli mezzana con botoni vintiduij picinini de argento, braceleto uno de coralli con botoni dui doro». Il reparto di teleria è fornitissimo di «sugacapi cinquantacinqui tra larghi e stretti sorenghino, tovalie vinti strette lavorate a negro, scossale uno de sorenghino, tovaioli tri (perché mai?) a la Palavicina». Dobbiamo chiudere. Ed ecco la cosa più importante, a fine elenco: «la caxa ne la quale occorseno li miraculi de ditta devotione et ne le quale se fabrica la giesa sua. La quale caxa era de messer Thomaso di Zachei et fu poij comprata per li agenti de ditta devotione et dal ditto messer Thomasio per pretio de lire...». 13 (fascicolo N. 5 – giugno 1993) Leggendo – e gustando – questa 13a puntata, don Crenna mi richiama lo scriba saggio, di cui parla il Vangelo, il quale dal suo “deposito” trae fuori cose vecchie sempre nuove. Questo è certo: i Cannobiesi escogitarono iniziativa su iniziativa per esaltare il Santo Miracolo e conservarne degnamente la memoria. E ben venga anche la benedizione implorata da mons. Ladino... e l’indulgenza di 40 giorni per ogni oblazione. Non è affatto una novità che per ogni iniziativa degna di rispetto le coordinate siano il patrocinio e la sponsorizzazione. Col primo ci si tutela da eventuali impiccioni, col secondo si ha modo di constatare che c’est l’argent qui fait la guerre. E quelli di Cannobio, intenzionati com’erano di farsi una loro particolare “Devozione”, dovettero ovviamente fare i conti con l’alto patrocinio di Ludovico Borromeo, uomo di rango e signore del Borgo. 23 Va subito ribadito che si tratta di due fattori ben distinti tra loro: un patrocinio mai si banalizza in una somministrazione di danaro; gli basta essere nobile e gratificante accondiscendenza. Al confronto, la sponsorizzazione risulta goffamente prosastica e pragmatica. Era dunque ovvio che monsignor Ladino, delegato dell’arcivescovo milanese Ippolito d’Este, tenesse grandi parlari col conte Borromeo sul da farsi a Cannobio, super huiusmodi negotio pluries sermonem habuit. E questo dovette bastare, non essendosi rinvenute impronte d’altro genere nei registri finanziari della confraternita della Ss. Pietà. Altrettanto serrato confronto di pareri ci fu sul fronte dei presumibili paganti, cioè cum agentibus pro Commune et hominibus dicti Burgi... et multa hinc inde fuerunt dicta et proposita. Ci si interpella stando coi piedi per terra: sul dove e sul come allestire quell’oratorio che tornasse gradito a Dio, alla B. V. e ai Santi, sperantes se facturos rem gratam Deo Beate Marie Virgini eius matri et sanctis suis; a quale “perito architetto” affidare la progettazione e l’esecuzione; occorrerà poi provvedere l’oratorio di suppellettili sacre, paramentis, calicibus, libris, luminariis ac aliis necessariis ad divinum cultum , perché vi si possano celebrare le officiature consuete; si dovrà designare un cappellano con congruo stipendio, un amministratore delle offerte che verranno date dai fedeli e che già sono state raccolte, oblationes et elemosinas ac obventiones que ibi fuerint et sint erogate et porrecte. Sarebbe intollerabile che la Devozione, una volta iniziata, restasse incompiuta, o anche soltanto disadorna e trascurata, inornata et destituta, a causa forse anche di inopportune divergenze che potrebbero sortire dalla conduzione dell’impresa. Una prospettazione questa, impietosa e debilitante, che andrebbe forse intesa come prova di risolutezza dei Cannobiesi nell’affrontare un rischio calcolato; o forse anche come perplessità ad oltranza dell’autorità ecclesiastica, impersonata da monsignor Ladino, nell’impegnare il proprio prestigio – si noti – a due passi dalla “eresia protestantica”, avallando un progetto che, in buona sostanza, è affidato ad una sponsorizzazione praticamente di solo lodevoli intenti. Non ci deve stupire se anche per gli uomini di Chiesa riesce ostico inglobare i parametri della Provvidenza negli algoritmi della contabilità... Mettendoci un pizzico di fantasia, ce lo possiamo immaginare il monsignore, che trae dal profondo un “Che Dio ve la mandi buona!”; anche se, più seriosamente, nel rogito di Bartolomeo Albertini leggiamo: Tandem omnibus diligenter intellectis et consideratis, attendens prefatus reverendus dominus episcopus et suffraganeus propensum et religiosum animum et accensum affectum dictorum hominum ad dictum sacellum erigendum in loco predicto in quo dicta miracula effluxerunt... Con traduzione disinvolta: “Impossibile schiodare i Cannobiesi da quel loro intestardirsi nel volere un oratorio là dove per loro il miracolo c’era stato, eccome!”. Era comunque indispensabile costituire un referente locale, che in certo senso salvasse ufficialmente la faccia a tutti, a cominciare dagli organici ecclesiastici milanesi, ove – come è noto – spesseggiavano uomini cresciuti nell’arte giuridica e nelle attitudini amministrative dei casati nobiliari. E fu così che, con universale consenso, fu eretta la schola laycorum utriusque sexus, ossia la confraternita della Ss. Pietà. Da questa, come anche dalla comunità, dovevano estrapolarsi sei personalità con prerogative di soprintendenza e di amministrazione, sex homines gubernatores et administratores probi et discreti qui sint prefecti et deputati ad constructionem et conservationem dicte ecclesie et sacelli et omnium reddituum... et ad omnes expensas faciendas. Ampi accenni sulle caratteristiche competenze di codesta confraternita aperta a uomini e donne, ricavati dal medesimo rogito dell’Albertini qui utilizzato, si leggono presso A. Zammaretti, Il miracolo di Cannobio e le sue reliquie. In luogo di inutili ripetizioni, valga un accostamento tra i sistemi oggi escogitati per far convergere l’attenzione e il soccorso dell’opinione pubblica verso zone attualmente doloranti e disastrate, e l’apparato suggestivo approntato consensualmente in quell’anno 1526. Indovinatissima, diremmo, quella cinquina di Pater e Ave imposta alla recitazione quotidiana dei confratelli, in onore delle cinque piaghe dalle quali scaturì il sangue di nostra redenzione (e con realistica presa diretta) que contemplantur ex inspectione dicte imaginis Pietatis. 24 Alla seconda domenica d’ogni mese il coinvolgimento comunitario: riaffermato processionalmente con croce, vessillo, canti, muovendo dalla parrocchiale di S. Vittore al luogo destinato per la fabbrica dell’oratorio. È questo il momento ufficiale della raccolta di fondi tra i confratelli, a seconda delle loro disponibilità; ma uguale per tutti è l’indulgenza di 40 giorni per ogni oblazione. Vien fatto di pensare alla querela luterana contro la seminagione di indulgenze tra gli oblatori della fabbrica di S. Pietro a Roma. Ma è pura assonanza: a Cannobio non si fa incetta né svendita di “perdonanze”; se date, sono gradite. Ciò che conta è serrare i ranghi: quasi un consorzio tra reggitori della comunità, prevosto e canonici, confratelli e capifamiglia (gli homines). Si vuole tener fede ad un impegno senza doversi mai smentire. Una nostra esagerata visione di cose? Valga questa particolarissima clausola conclusiva, contenuta nel citato rogito (e passata inosservata allo Zammaretti). Riassuntivamente: mons. Ladino, preso atto che nel Borgo redditi e proventi di vari oratori sono amministrati da privati cittadini, ottiene il consenso che da quel momento in poi ogni frutto, già percepito o futuro, passi direttamente sotto controllo e amministrazione dei sei delegati preposti alla fabbrica della Devozione. Viene suggellata ulteriormente l’intesa tra le componenti sociali del Borgo, dirimendo una annosa vertenza tra prevosto e canonici da una parte, e gli agenti del Comune dall’altra, in questi termini: la comunità a proprie spese provvederà al totale fabbisogno della sacrestia di S. Vittore e alle riparazioni e manutenzione della chiesa stessa. Si accollerà dunque, secondo consuetudine e giusta l’entità richiesta, la cura omnium paramentorum, ornamentorum, paliorum, librorum et aliorum necessariorum ad cultum. Sarà invece devoluto alla comunità (nel senso che transeat in dictam sacristiam seu laycos) tutto ciò che proviene ex sepolturis, paliis, crucibus, angelis, pianetis, tonesellis, campanis et aliis apparatibus eventualmente richiesti dai fedeli in particolari circostanze religiose. Vi saranno aggiunte le rendite primi anni canonicorum receptorum vel de novo recipiendorum , nonché le offerte que pro tempore fient in dicta ecclesia, ad eccezione di quelle che si raccoglieranno alla Messa solenne di Natale e di Pasqua. Una gran bonaccia: tant’è vero che prevosto e canonici si dichiarano pronti a non desistere a celebratione divinorum offitiorum et divino cultu iuxta eorum laudabilem consuetudinem. Che anzi, si impegneranno in melius procedere iuxta eorum devotionem et discretionem. 14 (fascicolo N. 6 – luglio 1993) Recita un proverbio: “Dove riposi bene la mente, ritorna di frequente”. Così ho fatto. Avendo incontrato don Crenna in cattedra, quand’ero io nel banco, son ritornato più volte – con soddisfazione, sempre! – ad attingere alle sue “conoscenze” e continuerò... Un auspicio: per avere – fra un anno o due... – il testo critico delle deposizioni del 1522, rogate dai notai, “con aderente traduzione italiana”. Professore, grazie in anticipo, a nome di tutti. Padre Francesco – bontà sua – ha voluto insignire questa rubrichetta mensile col titolo “Per una storia del Santuario”. Il che, a ben vedere, potrebbe essere inteso almeno in tre modi: o si vogliono trattare le “vicende architettoniche” dell’edificio sacro in quanto tale (peraltro già brevemente compendiate, nel 1982, dal compianto prof. A. Zammaretti); ovvero ci si propone di precisare con quale collocazione e “polarità” il santuario si sia piazzato entro i cicli devozionali; oppure si potrebbe tentare di riesumare quel substrato popolare e comunitario che, a Cannobio, diede storica fondatezza ad una serie di eventi umanamente assurdi, e corposità materiale alla Ss. Pietà, perché rimanesse una testimonianza monumentale di siffatte vicende “miracolose”. 25 A nostro giudizio questo terzo aspetto è il più consono al caso: perché non ci si ridurrebbe a mirabolanti e spesso sterili rimembranze, non si scade a raffazzonato ed effimero raccontino di circostanza, né si impalcano pirotecnie spiritualistiche o stilistiche. Pur ammettendo che anche la storia del santuario possa assumere sembianza di racconto (possibilmente gradevole al lettore), nel caso della Ss. Pietà e nella prospettiva detta, essa è in grado di proiettarci entro una concatenazione di situazioni e di comportamenti che oseremmo dire non solo inusitati, ma di valenza tale da provocare, più che appagante curiosità sui fatti di altri tempi, perplessità di giudizio sulla loro motivazione. Si tratterebbe di un esperimento di tracciato storico, fino ad oggi forse non ancora tentato. A nostro giudizio, esso è preferibile ad ogni apriorismo apologetico sulla Operatività Divina, nel senso che ci consente una realistica comparazione sull’utilizzo dei criteri discrezionali nostri e dei Cannobiesi del XVI secolo. Un assunto questo che ci ha indotti ad una prima constatazione de visu: all’epoca del “miracolo” operavano a Cannobio e nel suo plebanato, con tanto di matricola, i notai Bartolomeo Carmine, Bartolomeo Albertini, Giovanni Mantelli, Gio Francesco Mantelli, Defendente Mazironi, Gio Giacomo Besia, e Giacomo Poscolonna. Già dalla consistenza voluminosa dei loro minutari si arguisce da quale vivacità di vita fosse quotidianamente segnato il Borgo. Un semplice scandaglio entro così vasta documentazione ci consente di misurare la caratura di tale dinamismo: fittissimo intreccio di operazioni patrimoniali, costituzioni mercantilistiche di gruppi societari, consistenti lasciti testamentari, assetto urbanistico evidenziato dalle residenze dei Luati, Tassani, Mantelli, Omacini, Zacchei, la confetteria di via dell’Amore, immancabili querimonie beneficiali ad ogni vacanza capitolare... e poi le imperversanti forniture logistiche alle soldatesche transitanti, fossero queste di Francesco I o del De Leyva. Non vien fatto di pensare, scorrendo contratti matrimoniali, atti di emancipazione o di adozione, querele e compromessi e quietanze, ad una popolazione borghigiana culturalmente opaca, con tardanze credulone o impennate emotive. Tutto si è svolto con regolarità ai banchi notarili anche nei giorni “roventi” del gennaio e febbraio 1522. Le stesse dichiarazioni rilasciate a caldo dai testimoni oculari e rogate da Bartolomeo Albertini – e che andrebbero rilette con aderente traduzione italiana – sono segnate non da debordanti isterie, ma da ben comprensibile sbigottimento. La determinazione di intendere rebus divinis, di dare cioè una risposta adeguata a quanto fu ritenuto convintamente operato divino, poté concretarsi solo quattro anni dopo, nel 1526, nei termini concordati il 21 aprile alla presenza di monsignor Ladino (come già detto nella puntata precedente). Fu un inciampo provocato dalle folate di pestilenza e dalle scorribande dei convogli militari. Al delegato arcivescovile furono denunciate le “estreme angherie” di quegli anni, e ci è possibile valutarne la pesantezza solo citando quella consegna forzata di vettovaglie da parte della popolazione del Borgo ai soldati francesi nel 1524: centocinquanta vitelli, duecento tra capre e pecore, oltre a granaglie, vino e danaro. Non si trattò comunque di una tardanza, come lasciano intendere questa serie di date: all’incontro del 21 aprile con monsignor Ladino seguì, al 1° maggio, la convocazione del Consiglio generale del Comune, ove venne ratificato quanto era stato concordato tra le parti. Presiedeva il reggitore e podestà di Cannobio, il magnifico e generoso signor Pietro de Mantellis, presenti il procuratore della Comunità Pietro Zanlete e ventuno dei ventiquattro consiglieri che costituivano la Credenza. Seduta stante, ci si accordò sulla scelta di otto notabili deputati a mandare ad esecuzione quanto per lunghi anni si era escogitato di fare nella casa di Tommaso Zaccheo. Li coordinava lo stesso signor Pietro Mantelli, loro priore. E già il giorno successivo, 2 maggio, veniva redatto il primo registro confraternale, nel nome di Gesù. Varrà la pena di soffermarci su questo primo documento perché estremamente significativo per il modo in cui si presentano le sue prime pagine, autenticate dal notaio Bartolomeo de Albertinis. 26 15 (fascicolo N. 7 – agosto-settembre 1993) Verissima l’iniziale constatazione. Di fronte ad un “segno” così singolare come la Santa Pietà non ci si “inquieta” e riteniamo di “sdebitarci con un Pater, Ave ed una candela”. Ma aldilà del fatto religioso devozionale, pure importante, il discorso di don Crenna va oltre. Mi sembra che abbia intravisto l’evolversi della struttura del Santuario – peraltro ancor poco nota – e accostando vari frammenti (date, spese, parentele, lasciti rilevati dai rogiti notarili e dal registro della Confraternita) ne sta componendo con pazienza il grande disegno; dove, tra l’altro, risulta sommamente interessante il coinvolgimento dei responsabili religiosi con la comunità del Borgo, nient’affatto semplice spettatrice. Anzi! E voglio evidenziare l’interrogativo “mozzafiato” posto da don Crenna: la casa di Tommaso de’ Zachei era poi un’osteria? Un quesito: in definitiva, cosa sappiamo veramente sul “miracolo” della Pietà? Si noti che virgolettiamo il vocabolo sia perché – a rigore – non si tratta di oggetto di fede neppure per un credente; sia soprattutto perché la memoria dei fatti, col tempo, si è talmente rinsecchita che nel migliore dei casi si riduce ad uno stereotipo di racconto, più o meno toccante o convincente, per nulla inquietante. Lo ascoltiamo con dovuta compunzione per poi sdebitarci con un “Pater, Ave” ed una candela, come fossimo indifferentemente nella basilica del Santo di Padova o in san Vittore di Cannobio. Lontano anni luce da noi ed ovviamente irrepetibile è quel subitaneo sbigottimento dei primi testimoni diretti che, la sera del mercoledì 8 gennaio 1522, coeperunt cum planctu clamare “misericordia!”, perché dinnanzi ai loro occhi capitavano strani fatti, di significato oscuro ed ancor più conturbanti a quei loro giorni così saturi di cattiverie e di pestilenze. 27 Fermo restando che oggi riuscirebbe insoffribile per chiunque l’invito ad una surriscaldo affettivo, sia pure a titolo commemorativo, però un’indagine che, aderente ai documenti, ci sappia trasferire in medias res riuscirebbe più accettabile e forse più intellettivamente efficace. Se non altro, apparirebbe più legittimata anche una nostra ripulsa ad ammettere la veridicità di accadimenti tanto estranei alla comune esperienza; ci risparmieremmo comunque atteggiamenti interiori inconsistenti. Entrando nel merito: un dato è da anteporre, perché significativo benché sia stato lasciato finora in ombra. Lo ricaviamo dal primo libro mastro redatto dalla confraternita della Pietà a datare dal 2 maggio 1526. Ne abbiamo fatto cenno nella “puntata” di luglio. Vi sta scritto a chiare lettere che la gestione (per così dire) del miracolo con annessi e connessi fu marcatamente di matrice laica, cioè quella presunta operazione divina fu lasciata alla mercé della Comunità di Cannobio. Ora, non avendo motivo accreditato per figurarci un Borgo particolarmente “codino”, si dovrebbe escludere che esso non si sia lasciato indurre a sobbarcarsi ad una messinscena di quella fatta; come, per altro verso, viene ad essere notevolmente accantonato il sospetto di manipolazioni pseudo-clericali. È ben vero che dal 1422 i Cannobiesi si trovarono infeudati ai Borromei. Ma facciamo un po’ di luce: codesti finanzieri oriundi di Toscana, approdati alla Milano dei Visconti, dall’inizio furono sagaci manovrieri politici come poi ancora con gli Sforza; strateghi in accumulazioni patrimoniali in ogni campo – beneficiale compreso – seppero presentarsi sotto lusinghiera copertura di munificenza umanitaria, blasonata nel “simbolo parlante” dell’Humilitas coronata, a testimoniare nulla più che distribuzioni di pane e vino ai più meschini. Si dovrà però attendere l’epoca di san Carlo e del cardinal Federigo perché la cifra borromaica divenga simbolo promozionale di adeguamento religioso e di conformismo devozionale. Illuminanti sarebbero cognizioni meno generiche sulla conformazione e sui ritmi sociali della Comunità cannobiese: sappiamo della preminenza di una consistente categoria di ottimati, consapevole di sé e solidale anche a motivo degli allacciamenti parentali; parecchi i notabili possidenti o commercianti di pannilani e di pelletterie di produzione locale, benestanti esercenti in olio e vino. Gli amministratori locali appaiono tutt’altro che illetterati e bastantemente scafati – fossero essi dei Mantelli o dei Luvati – a fronte dei gabellieri camerali di Arona o degli agenti borromaici in occasione di quitanze per biade e sale elargite alla gente del Borgo. Dei tanti oscuri borghigiani o vicini, alcuni emergono dall’anonimato grazie alle loro volontà testamentarie che piamente aprono col tradizionale e ricorrente lascito di pochi soldi alla fabbrica dell’erigendo duomo di Milano, immancabilmente raddoppiato per il loro San Vittore; segue l’obolo all’ospedale di santa Giustina, alla chiesa di sant’Ambrogio, a quella di san Lorenzo degli Umiliati... E, iniziando già dal 1523, compaiono anche i primi lasciti domui Pietatis seu agentibus pro ea: di un Lorenzo figlio del fu Zanni Bertolatii, che vuole assegnati 10 soldi al Duomo ed altrettanti alla “casa della Pietà”; mentre invece un Antonio del fu Giovanni Reschigna raddoppia; un certo Bartolomeo, detto Bartola, lascia disposizione nel 1525 perché nel sacello della Pietà siano affrescati, dinnanzi a lui genuflesso, i santi Cosma e Damiano... Riportiamo questi pochi dati esemplificativi a riprova di come i fatti, che indussero gli astanti sbigottiti a gridare piangendo “misericordia!”, non lasciarono incertezza alcuna e stravolsero l’abitabilità della casa (e perché mai “osteria”?) del signor Tommaso de’ Zachei (non abbiamo ancora appurato a quale dei due rami egli appartenesse: se dei “Cerini” o dei “Peazi”). Costui dovette, o volle, ben presto sgomberare, di modo che il piano superiore della sua abitazione fosse trasformato in “casa della Pietà”. Le citazioni, qui sopra riportate, dei lasciti e degli “agenti per la Devozione” già operanti nel 1523 non lasciano dubbi in merito. Lo comprova peraltro una voce inclusa nell’inventario dell’«Avere», redatto il 2 maggio 1526 ed incluso nel primo libro confraternale, di cui si è detto sopra: «item la caxa ne la quale occorseno li miraculi de dicta devotione e ne la quale se fabrica la giesia sua. La qual caxa era de messer Thomaso de Zachei. Et fu poi comprata per li agenti de ditta devotione. Et de dinari de essa dal ditto messer Thomasio per pretio de lire ..... como ne appare instromento rogato per .....». 28 Questa annotazione va integrata con quanto si legge, alla stessa data del 2 maggio 1526, poco più oltre nella partita dei «Debitori»: « item se retrova Zoan Antonio fiolo del quondam messer Thomaxio Zaché debitor de la predetta devotione de lire ..... soldi ..... dinari ..... como ne appare instromento rogato per .....». Sembra dunque potersi intendere che il Tommaso, non solo abbia ceduto la propria abitazione perché vi si attrezzasse un primo ambiente devozionale, ma abbia pure elargito agli “agenti per la Devozione” anche la somma di denaro pattuita per la cessione dello stabile. I dati mancanti relativi alla somma e al notaio rogante indurrebbero a supporre che le due operazioni (l’atto formale di vendita e il trasferimento di denaro) non fossero ancora perfezionate al 2 maggio 1526 (quantunque già avviata a quella data «la fabrica della giesia») a motivo del sopravvenuto decesso del Tommaso; di lui si dice infatti nunc quondam: testé defunto. Questo particolare è sfuggito all’esimio prof. Aquilino Zammaretti, che va dunque riveduto a questo riguardo. Abbiamo però esaurito lo spazio disponibile: per l’assunto principale ci risentiremo prossimamente. 16 (fascicolo N. 8 – ottobre 1993) Seguendo in filigrana le annotazioni che don Crenna ci offre, pure io richiamo quanto egli stesso sottolinea; non a caso, ma con consapevole importanza. «Veramente spiacevole sarebbe se si dileguasse presso i Cannobiesi d’oggi la memoria di come i loro antenati vollero esprimere e tramandare una propria certezza attraverso il Santuario, e quanto fecero perché il loro disegno si realizzasse». E dunque, la ricerca è rendere vivo, attuale il “segno” – noi diciamo: il miracolo – per cui gli “antenati” tanto si adoperarono per la costruzione del Santuario. Grazie, e avanti... caro Professore!. Manca di parecchi fogli. Eppure è un buon documento il registro-contabile attivato dai confratelli della Pietà il giorno stesso in cui si costituirono tali, il 2 maggio 1526. A quella data – più che altro – fu data veste ufficiale ad un esercizio finanziario, che aveva preso avvio quattro anni innanzi sotto la pressione di una sequenza sconcertante di episodi, a dir poco, inverosimili, e che si sarebbe protratto, tra forzate interruzioni e caparbie riprese, fino al 1611, a fabbrica del Santuario ultimata. E che si fosse puramente trattato di formalizzare un allestimento contabile, sta esplicitamente enunciato alla prima pagina del registro (integralmente riprodotta nel numero di luglio del Bollettino). Vi si legge che verranno trascritti «partitamente»: a) «tuti li beni et denari et tuto quello è offerto et donato, et che ne lo advenire se offerirà et donarà; et tuti li crediti et quanto altro intrarà al beneficio et utile de la Devotione de la sanctissima Pietà» (la partita dell’«avere»); b) «tuto quello è speso et consumato, et ne lo advenire se spenderà et consumarà al beneficio de la predetta Devotione» (la partita del «dare»); c) così pure «se descriveranno li ordini et li cunti saldi de dicta Devotione et sua fabricatione; et como più amplamente in el presente libro se vederà». In effetti qualcosa almeno è rimasto delle enunciate registrazioni: a foglio 68 leggiamo l’«inventario de tuti li denari rittrovati a la Devotione dal dì soprascritto [2 maggio 1526] indretto». In detto giorno Pietro Mantello, magnifico priore neoeletto, i confratelli a ciò designati signori Bartolomeo Albertino, Giacomo Poscolognia, Francesco Zanotello e Bernardino Cerreto, assistente il prevosto di san Vittore e – si noti – «a la presentia de quelli hanno regulato la dicta Devotione dal dì soprascritto indreto», conteggiarono lire 455 e soldi 6 imperiali, «le quale sono cavate da tute le casse, zoè a la Devotione de la Pietà, et in sancto Vittore a la Costa», oltre a lire 90 e soldi 14 «cavati da un’altra parte». All’incirca un totale di 25-30 milioni d’oggi: una somma certamente non entusiasmante entro un contesto di normalità economica; ma è davvero sorprendente che tanto denaro sia potuto sgorgare da un assetto sociale – quale si ebbe tra il 1522 e il 1526 – disastrato da requisizioni belliche, con circuiti mercantili e finanziari messi a soqquadro, tra diffusa carestia e ricorrente pestilenza. 29 Non per nulla ci s’interroga quali ineludibili motivazioni possono aver spinto a tanta oblazione, su quale spessore di convinzioni si sia sorretta tanta persistenza; ovvero – con ottica inversa – la ragione di tutto fu un diffuso presagio di oscuri castighi incombenti? e perché mai? Interrogativi, questi, che – se ci raggiungono – perdono ogni sapore accademico, e ricusano risposte artefatte. Per un motivo essenziale: protagonista fu la “comunità” di Cannobio; non un gruppo di invasati o il fanatico di turno, ma tutto un insieme di gente, accomunata da un medesimo intento, partecipato ed esplicitato dai suoi reggitori – personaggi di rango – e materialmente definito da quelle quattro mura della “saletta” di casa Zacchei. “Toccata” dal terrificante passaggio di Dio, a Lui doveva d’ora in poi essere sacra, luogo sacrificale e d’impetrazione. Questi furono il motivo, la convinzione, il “timore di Dio” di tutti a Cannobio, a datare da quel mercoledì 8 gennaio 1522. Proviamoci infatti a penetrare il senso di quelle poche parole annotate a margine delle succitate 455 lire e 6 soldi: «le quale furono poi prestate alla Comunità di Cannobio, et da lei anco restituite». Perché non affidarle all’ufficialità ecclesiastica del prevosto e del Capitolo di san Vittore? Perché la Comunità, subentrando, supplisce anche gli “agenti” della Pietà, i più ovvii custodi delle offerte devote? Più oltre leggiamo: «a dì 26 de zugno [1526] cavato da la casseta de la Pietà» (nella ex casa degli Zacchei) 61 lire più gli spiccioli di 1 soldo e 3 denari; «a dì 21 luglio [successivo] tolto fora de la casseta [c.s.] lire 6 soldi 2 denari 9»; «e a dì 17 novembre 1526 tolti da la casseta in Sancto Vittore posta per la oblatione alla Costa de la Pietà lire 5 soldi 10, e a dì dicto tolte dalla casseta de la Pietà [nella ex casa degli Zacchei] lire 83 soldi 4». Un esplicito orientamento devozionale ed un inequivocabile pronunciamento che si ripete: «a dì 12 magio 1527 tolti fora da la cassa a la Pietà lire 55; e a dì detto tolti da la cassa in Sancto Vittore lire 10». Veramente spiacevole sarebbe se si dileguasse presso i Cannobiesi d’oggi la memoria di come i loro antenati vollero esprimere e tramandare una propria certezza attraverso il Santuario, e quanto fecero perché il loro disegno si realizzasse. Un’ulteriore prova che diremmo “visiva”, tant’è intrisa di colore d’epoca, ci viene fornita al foglio 60 del medesimo registro: «Inventario de tuti li beni mobili et immobili et crediti rittrovati a la Devotione predicta, dal dì soprascritto [2 maggio 1526] indretto». È quanto di meglio potessimo rinvenire onde capacitarci e documentarci su come fosse radicato ed esteso tra la gente del Borgo il fenomeno di quel loro singolarissimo unanimismo. «Rittrovate ne la cassa de dicta Devotione quale è missa a loco de l’altar», per una iniziativa evidentemente invalsa da tempo e da tutti condivisa, stanno elencate le cose donate in surrogazione delle offerte in denaro, rese allora problematiche anche dalla scarsità di moneta circolante. Poste all’incanto, esse avrebbero potuto comunque fruttare alla Devozione una loro equivalenza di liquido. Descritti nell’inventario sono i più disparati capi di vestiario: maniche (parti di abbigliamento allora intercambiabili) per abiti femminili e maschili, corsaletti, gorgiere, cuffie, copricapi, veli, ricami, passamanerie, pezze di tela, tovaglie e tovaglioli, fazzoletti (addirittura 487!), sottovesti. Il tutto in vario tessuto: velluto, zendado, damasco e broccato, drappo serico e tocca intessuta di filo d’oro e d’argento... fino alla più umile terzanella. E poi tanti oggetti d’oreficeria: anelli d’oro e d’argento con incastonatura d’ambra e di granati, collane di corallo, di perle e di perline legate in metallo prezioso, braccialetti, pendagli ed orecchini... Agnus Dei in argento. Un campionario di costume e di stili, dai «corenzini [corpetti] dui di seda del tempo vechio» ai «sugacapo tre a la Palavicina». Il tutto poi, per ogni garanzia, «reponuto nel cassono de le tre ciave», in attesa che fra’ Bartolomeo lo vendesse all’incanto. 30 Un piccolo esempio: «1527 a dì 12 de mazo [maggio]. Nota como de le robe soprascritte sono vendute le robe infrascritte, zoè sugacio 6, fodreta 1, tovaglie 4, paneti 11 et bareta 1 de homo. Tute vendute per pretio in tuta soma de lire 14 soldi 1». Il che significa oltre 500.000 delle nostre lire. Stupefacente! Meritano però ogni nostra attenzione i primi quattro fogli del registro, fittamente scritti e siglati col segno notarile di Bartolomeo Albertini. Leggendone il contenuto, ben si comprende quanto intenzionalmente siano stati lì collocati perché facessero da apertura alla vicenda della fabbrica della Pietà... 17 (fascicolo N. 9 – novembre-dicembre 1993) Don Crenna ha ripreso in mano la trivella e approfondisce la ricerca. Sì, perché il “Fatto” inizialmente produsse sconcerto, poi entusiasmo tale che non si sopì nel volger di poco tempo, anzi sorse tosto la preoccupazione su chi doveva provvedere alla “saletta del miracolo” per trasformarla in luogo di orazione: il Prevosto con il Capitolo o gli “Uomini” del Borgo? La Curia intervenne, inviando mons. Ladino. E là dove è avvenuto il miracolo, presso piazza Baciocchi, si stabilì che dovesse sorgere il Santuario, proprio dove stava la casa dei notabili Zacchei (notabili, altro che semplice locanda di un umile oste!). E la trivella con ritmo costante continua a penetrare. Poniamo che sia accaduto qualcosa di grosso: chi ha visto di persona sa tutto; ma i tanti altri, che non erano presenti, smaniano di sapere come è andata. Si ricorre dunque alla cronaca: più è dettagliata e circostanziata, meglio ci si persuade che il fatto riportato è veridico. Non molto dopo, la cosa finisce per essere risaputa e vien data per scontata: per ciò stesso circostanze e dettagli appaiono superflui; ciò che ormai conta è il nocciolo. E qui cominciano i guai, perché ci si ritrova a raccontare un fatto “storico”, di sua natura emotivamente svuotato, e quindi bisognoso di essere rivitalizzato con infiorescenze ed “invenzioni”. Nel senso cioè che crediamo doveroso ricorre a “trovate”, atte a ridestare almeno momentaneamente la curiosità. Concludendo: all’originaria smania di certezza è subentrata la fabulazione, che sicuramente è la più indicata per generici sentimentalismi... Come se quei Cannobiesi di cinquecent’anni fa si fossero prodigati per oltre un secolo a mettere su un santuario al solo scopo di favoleggiare con i loro pronipoti! Proprio per il dovuto rispetto alla loro memoria, riportiamoci agli inizi e studiamo con attenzione le loro mosse: possibilmente una cronaca documentata, non un pio racconto. Dicevamo, nell’ultima “puntata” di questa ministoria del Santuario apparsa nel bollettino dell’ottobre scorso, che il primo registro contabile (ufficialmente iniziato il 2 maggio 1526 dalla neo-confraternita della Ss. Pietà) si apre con due rogiti, muniti di autentica tabellionale del notaio Bartolomeo de Albertinis, datati rispettivamente al 21 aprile ed al 1° maggio di quell’anno. Tale inserimento documentario ci risulta tutt’altro che casuale: è una palese impostazione di princípi, che due parti contrapposte (prevosto con Capitolo di San Vittore e Deputati a rappresentare la Comunità) hanno concordato in due tempi distinti (un’assemblea in San Vittore e una convocazione del Consiglio Generale del Borgo nella casa della Comunità). E proprio i verbali di questi due incontri sono stati ritrascritti, integralmente ed autenticati, sulle prime pagine del registro contabile. Il compianto prof. Aquilino Zammaretti ne ha dato la traduzione in lingua italiana, non completa ma sufficiente, nel suo Il miracolo di Cannobio e le sue reliquie (1967), ristampato con aggiunte dell’A. a cura della Società storica novarese nel 1987. La divergenza tra dette parti era di per sé inevitabile, perché già contrapposte in terminis erano l’ottica clericale e quella del laicato cannobiese. Si ritenevano legittimati – prevosto e Capitolo – di monopolizzare da allora in poi, in ogni suo aspetto, una vicenda originata nientedimeno che da un miracolo del Signore; in ciò opponendosi i notabili di Cannobio, anche perché autorevolmente responsabili di un Borgo direttamente visitato dall’Onnipotente entro le mura di casa di uno di loro. 31 Volessimo inacidire un tantino la faccenda, dovremmo dire che su un versante stava la previsione di una non indifferente quanto inattesa integrazione beneficiale a base di lasciti, di elemosine a vario titolo, da non mollare; sia pure con tutto l’ossequio dovuto ai reconditi disegni della Provvidenza; dall’altro versante – noblesse oblige – vi replicava contro, con uno spunto di demagogica intraprendenza, il ceto locale più accreditato, messo in allarme e smanioso di aggiustare i conti col buon Dio dopo gli indecifrabili messaggi da Lui inviati dalla casa del signor Tommaso Zaccheo. Ma veniamo ai fatti, enunciandoli nella loro naturale sequenza. Dalla sera dell’8 gennaio 1522 presero inizio a Cannobio quelle strane cose ormai note a tutti per tradizione. A sbigottimento, commozione, curiosità, seguirono le prime risoluzioni: un comitato, una raccolta di fondi per trasformare la “saletta del miracolo” in un luogo di orazione. Lì era rimasto il quadruccio della Pietà. Tutto il resto stava altrove, depositato in San Vittore: una bilocazione estemporanea, però inopportuna e fastidiosa. Infatti nella Vicinía, in riva al lago, si stava formando un polo devozionale, decentrato e concorrente, inviso ai rappresentanti locali della Chiesa ufficiale, sebbene fosse sempre più gradito alla gente del Borgo; a tal punto che si andava progettando, non appena fossero cessate pestilenze guerre e carestia, la fabbricazione di un sacello a regola d’arte, ove ricollocare ciò che per emergenza era stato riposto in San Vittore. Ma a tale riguardo gli inghippi da frapporre stavano sottomano ed erano tutti legali: qualora si realizzasse il detto oratorio, chi provvederà alla decenza del luogo sacro? alle suppellettili indispensabili per i riti liturgici? alla retribuzione degli officianti? alla manutenzione delle cassette per le elemosine? alla registrazione dei lasciti? La casistica canonica poteva nel merito divenire, volendo, debitamente inesauribile. Innanzi che i cavilli ostruissero il passo – sta scritto nel primo dei due rogiti – una delegazione Communis et hominum dicti Burgi et plebis (dunque ufficialmente laica) raggiunse Milano, onde conferire col reverendo signor Ruffino de Belingerijs vicario generale di Ippolito d’Este arcivescovo di Milano (che, sia detto per inciso, eletto alla sede ambrosiana mai vi mise piede, dato che a quei tempi i grandi ecclesiastici usavano anche comportarsi così). Venne cioè contattata quella stessa personalità che aveva fatto rogare dal notaio Bartolomeo de Albertinis il 25 di gennaio e dal 3 al 5 di febbraio (all’indomani dei fatti miracolosi) le prime testimonianze oculari, e che aveva poi formalmente emesso un giudizio positivo sulla loro veridicità: dicta miracula et signa esse vera, e perciò meritevole di summa veneratione l’immagine della Pietà. Ma la lugubre insopportabile trilogia dell’epoca – guerre peste e carestia – s’interpose fiaccando progetti ed iniziative per alcuni anni, durante i quali ci si ritenne fortunati di sopravvivere, dato che vix suppetant facultates ad vitae necessaria. A tal punto che la Giustizia celeste apparve pesare assai, a giudizio di tutti: fu determinazione comune nel Borgo che quel progettato sacello in casa Zacchei andava fatto, onde riconciliare un Dio tanto corrucciato; e questo per il bene comune, e di anima e di corpo. Ovvero, detto in un latino facile facile: non solum ad salutem animarum, sed etiam ad commodum et utilitatem bonorum et tranquilitatem et securitatem personarum. Ma stavolta non si fece più anticamera nel vescovado di Milano: che invece fosse il nuovo vicario generale, il dottor d’entrambe leggi Giovanni Maria Tonso, ad intervenire di persona, perché con prevosto e Capitolo mettesse una buona volta in chiaro dove mai si volesse collocare quel sacello, da tutti gli altri voluto nel luogo del miracolo, e quant’altro annesso e connesso fosse da stabilirsi ancora: et etiam circa quaecumque alia dependentia, connexa et emergentia. E la Curia milanese si mosse. Non il vicario generale, pluribus impeditus negotiis, ma, da lui delegato il 2 marzo 1526 con poteri discrezionali, monsignor Francesco de Ladinis, vescovo titolare di Laodicea e “suffraganeo” della sede milanese. Costui, procedendo con piedi di piombo, s’abboccò un po’ con tutte le parti in causa: dal feudatario conte Ludovico Borromeo al prevosto coi suoi canonici, ai più in vista “uomini” del Borgo. Et multa hinc inde fuerunt dicta et proposita: il che significa che ci fu un gran parlare in cui tutti dissero la loro. 32 Ma, tirate le somme (e questo va tenuto ben presente al momento di trarre noi valutazioni conclusive) l’elemento – l’unico – che fece presa e indusse monsignor Ladino a sentenziare fu quel propensum et religiosum animum et accensum affectum dictorum hominum ad dictum sacellum erigendum in loco predicto in quo dicta miracula effluxerunt. Alla faccia di chicchessia! Licenza e facoltà ai rappresentanti della Comunità ed alla gente del Borgo, di farsi – che se lo meritano! – il Santuario, là sulla riva del lago, presso piazza Baciocchi, dove sta la casa dei notabili Zacchei, perché là è avvenuto il miracolo, ed è giusto che in tale luogo siano rese grazie a Dio ed alla Beata Vergine. (continua) 18 (fascicolo N. 1 – gennaio-febbraio 1994) Ho letto e riletto l’articolo provando in corpo una certa goduria mentre gli occhi strabuzzati erano fissi sulle pagine; ma, allora, tutto da rifare? Tutto proprio no. E subito mi sono aggrappato alla parola ultima: continua! Per sapere che altro ci riservano le vecchie scartoffie – si fa per dire – di don Crenna. Zaccheo oste suocero di messer Antonio Omacino? L’osteria sta diventando un salotto di persone aristocratiche, di quelle che contano! Coraggio, Professore; continui, continui... Remore ed obliquità furono messe fuori causa dalla risoluzione autorevole del delegato arcivescovile monsignor Francesco Ladino. Su di lui avevano fatto presa essenzialmente le ferme determinazioni degli uomini del Borgo, ai quali dunque in quel 26 aprile 1526 veniva ufficialmente consentito di trasformare la residenza degli Zacchei in sacello e chiesa, a tutti gli effetti purché in debita forma. Era quanto essi si attendevano da almeno tre anni. Lo attesta esplicitamente la dizione di domus Pietatis, “casa della Pietà” o “Devozione”, impiegata già dal 1523 nei rogiti notarili dei primissimi lasciti, per indicare la casa di Tommaso Zaccheo. Per lui infatti il “miracolo” equivalse praticamente ad un esproprio; né poteva essere altrimenti, conoscendo l’ubicazione della saletta degli eventi miracolosi. A questo locale, adiacente alla camera da letto dei padroni di casa, si poteva accedere mediante un “corridore”, entrando dall’attuale piazzetta del Santuario, cioè dal lato posteriore dell’edificio. Oppure, venendo dalla parte del lago, si entrava nella cucina del piano terra, e lì una scala interna, comunicante con i piani superiori, dava accesso direttamente alla saletta soprastante, per l’appunto supra caminatam. Caminata stava ad indicare il locale fornito di camino, detto anche “stanza da fuoco” o coquina. Lo Zammaretti, per l’assonanza con “camminare”, erroneamente tradusse con “corridoio”. Era praticamente impossibile – data la sua collocazione – isolare quella saletta dal contesto abitativo; e divenne insostenibile, già dal primo giorno del “miracolo”, un normale ménage famigliare, spiazzato com’era dal viavai di oranti, curiosi e pellegrini. I proprietari di casa dovettero risolversi ben presto a sgomberare; se vogliamo, era anche raccapricciante abitare là ove, sotto gli occhi di tutti, un riquadro di membrana animale, una pergamena dipinta con l’effigie di Cristo in Pietà tra la Madonna e S. Giovanni ripetutamente si era messa a grondare sangue ed acqua, e poi a buttar fuori nientedimeno che una costola in miniatura. Per buona sorte –si fa per dire – il gruppo famigliare degli Zacchei non finì sul lastrico, sfrattato dal Padreterno, né il capofamiglia si trovò equiparato ai cassintegrati a zero ore a causa della cessata attività di quell’osteria che una fasulla tradizione gli ha affibbiato. Da tre rappezzi imbastiti alla buona n’è sortita infatti questa arlecchinata: 1) mercoledì sera 8 gennaio Tommaso Zaccheo ha ospiti in casa; 2) il giorno successivo è mercato a Locarno; 3) uno degli ospiti testimonia d’essersi recato il giovedì 9 a detto mercato. Dunque: lo Zaccheo è un oste con tanto di osteria alloggio e stallazzo, comoda sosta per il pernottamento di chi il giorno dopo intenda recarsi al consueto mercato del giovedì a Locarno. 33 Così fu combinata un’autentica insolenza storica ai danni d’un casato di rango, dotato di larghe disponibilità, e di parentado e di sostanze, sicuramente schifiltoso come tutti gli altolocati del tempo, ma addirittura schifato alla sola supposizione degradante di rendere servigio ad avventori di bettola con annessi e connessi. Può darsi che, rovistando tra le carte dei notai cannobiesi, ci si imbatta, prima o poi, nel nome di Tommaso Zaccheo, onde appurare se costui sia stato un aristocratico bordato di redditi patrimoniali o piuttosto un facoltoso borghese affermato nel settore della mercatura o della finanza. Ma un dato è fin d’ora incontestabile: né lui, né la moglie – la domina signora Elisabetta – né la loro casa, ebbero mai a che vedere con osti ostesse e osterie. Per prima cosa, in aderenza con le deposizioni testimoniali d’allora, riportiamo alla loro precisa identità gli “ospiti” di quel mercoledì 8 gennaio 1522. Raccolto nel tepore della caminata di casa indugia il gruppo dei famigliari, sebbene il signor Tommaso (da qualche tempo ormai è suonata l’Avemaria) si sia già accomiatato ritirandosi in camera, al piano superiore: si trattengono invece la signora Elisabetta con le due figlie minori, la tredicenne Antognina e la piccola Bernardina; l’Antognina già nutrice delle bambine; il genero Gio Antonio de Carmeno figlio del dominus signor Pietro, con il cognato Stefano Ferrario figlio di Tommasino de Portu di Traffiume, suo sororio perché marito della sorella; un conoscente senza particolari qualifiche, certo Dumnino di Cavaglio, che non verrà poi neppure citato come testimone dall’inquirente arcivescovile. È evidente che costoro non hanno un ruolo di generici avventori. Poi d’un tratto le grida della figlia Antognina, lo scompiglio in casa e per tutta notte, col ripetersi dei fatti sconcertanti, il trambusto della gente che accorre dalle case vicine. Qui occorre mettere a fuoco il comportamento di due personaggi: il suocero e il genero. Il giovane Gio Antonio fa le ore piccole (fino “alla quinta ora di notte” ed oltre) nel verificare cum lampade accensa il rosseggiare di ferite stillanti umori sanguigni dal quadruccio della Pietà. Una nottataccia, anche per lui – a dir poco – stressante, trovandosi d’improvviso trasferito in una dimensione surreale, ove l’aggressione emotiva è pari allo sconcerto razionale. Però se ne distoglie, muovendosi di buon’ora per raggiungere il mercato di Locarno. E ciò sorprende, non tanto per il tragitto in barca (consentendolo gli sbuffi di Tramontana o le folate del Valmaggino) o sulla ghiacciata strada costiera: suppergiù sono 18 chilometri di percorso, sia remigando sia cavalcando, non piacevoli ai primi di gennaio. Ciò che veramente colpisce è l’incongruente suo trasferimento dal miracolo alle bancarelle. L’ibrido accostamento tra questi due ordini di cose tanto sproporzionate tra loro riesce plausibile soltanto ad una condizione: che fossero in gioco interessi consistenti ed indilazionabili. Trova allora spiegazione anche quel conciliabolo famigliare della sera innanzi, e così pure il comportamento del capofamiglia, che a tutta prima appare assai strano. È già coricato quando le invocazioni della figlia lo fanno trasalire; accorre nella saletta e constata trasecolando ciò che sta accadendo, per più di un’ora, noncurante di farsi trovare in camisia al sopraggiungere dei vicini di casa. Finché, rabbrividendo dalla testa ai piedi, si ributta sotto le coperte. Ma per poco tempo, aliquantulum: un grido «Videte la Vergine Maria che alza la mane, et santo Giovanne buta aqua dalli ogi» lo fa balzar fuori nuovamente. I presenti si accalcano sotto il quadretto miracoloso perché nessuno di loro vuol perdere di vista per un solo istante ciò che sta accadendo. E lui, il padrone di casa, è alle spalle di tutti, non può osservare come vorrebbe, et tunc reversus fuit in lectum. Proprio così: se ne torna a letto! È forse un comportamento strano? Lo si può escludere se si pensa che il signor Tommaso, oltre a sentirsi scosso e frastornato per ciò che capitava in casa sua, tentò, almeno prima che albeggiasse, di prendersi quel minimo di riposo indispensabile per poter sbrigare con sufficiente lucidità i suoi affari al mercato di Locarno. Surrexit in mane diei Jovis, si rimise in piedi al levar del sole per porsi in viaggio col genero... Non ce la fece? Fu sconsigliato dai famigliari perché non s’assentasse? proprio mentre entrava in casa anche la gente del Borgo, sia dalla via di Santa Giustina, sia dal lungolago. 34 A Locarno andò il genero; all’imbrunire era già di ritorno, proprio mentre altri “segni” ancor più impressionanti stavano per comparire. Chi era dunque Tommaso Zaccheo? Un signore in grado di assegnare all’ultima sua figlia Bernardina, sopra citata, una ragguardevole dote nuziale di 550 lire imperiali (arrotondando, 30 milioni attuali) che, stando ai parametri della legittima solita riservarsi alle ragazze nubili, era pari ad un ottavo o ad un sesto del reddito annuo del patrimonio di casa. La “nobile madonna Bernardina Zachea” andava sposa (correggiamo qui un errore del prof. Zammaretti) al “magnifico messer Antonio Omacino”, con cui generò il figlio Giacomo, poi “dottor di leggi e uno dei Regi Vicari Generali del Stato di Milano”. Non è la fiaba di Cenerentola: più prosaicamente, un dato storico in più per rimettere in auge il denigrato Tommaso Zaccheo & C. (continua con la puntata 23 nel fascicolo N.1 – gennaio-febbraio 1995) 23 (fascicolo N. 1 – gennaio-febbraio 1995) Per una storia del Santuario Per chi vuol saperne di più… Don Crenna non si rassegna. Avendo posto mano alla Storia del Santuario, con puntiglio lavora un po’ con la trivella e un po’ con lo scandaglio. Il lavoro è ancora lungo, a meno che gli arrida un colpo di fortuna. Per lui e per noi. Grazie; buon lavoro, Professore. Il 1922, anno centenario del Miracolo della Ss. Pietà, non è poi così confinato nel passato; d’altronde a Cannobio si respira aria buona, il che senza dubbio deve aver contribuito a far durare in vita chissà quanti di coloro che hanno memoria di come sia stata allora celebrata la ricorrenza dell’8 gennaio 1522. Il numero unico celebrativo del quarto centenario, allora stampato con l’approvazione dell’autorità ecclesiastica dalla tipografia Alganon di Arona, trasuda l’enfasi di un proclama: «Il Borgo di Cannobio riprende il suo ritmo di gloria... sulla scia luminosa delle orme degli avi... del suo sangue romano... della sapienza dei suoi statuti, del valore delle armi... È un’improvvisa aurora che tinge il suo cielo deserto, tra mille e mille voci che giungono da ogni lembo d’Italia. Che sono queste fiumane di popolo che dalle navi pavesate a festa sbarcano su questo lido? Uno solo è il grido, uno l’osanna e il fremito: al tempio, al tempio del Sangue di Cristo!». Con l’irruenza provocatoria di un’aperta sfida fa seguito un interrogativo: «Chi osa corrugar la superba fronte e atteggiar il viso ad un cenno di incredulità? Chi sperduto nei sofismi di una filosofia che pesca per lo ver e non ha l’arte potrebbe rinnegare l’opera di Dio?». Ma siccome esiste un proverbio che dice “scherza coi fanti e lascia stare i santi” riteniamo lecito, senza pervicacia alcuna, fare i guastafeste proprio al riguardo delle affermazioni pedestri (trattandosi di “fanti” ) di chi, scrivendo allora con eccesso di entusiasmo e di zelo, non ha “pescato per lo ver”, bensì ha fatto una gran confusione. È pure questo un modo, forse incolpevole ma certamente colposo, di “rinnegare l’opera di Dio”. Leggiamo infatti nel sopracitato foglio commemorativo: «O umile casetta di Tomaso de Zacchei, imporporata del sangue miracoloso di Gesù!... Nella casetta facevasi osteria, ed essa apparteneva a certo Tommaso, la cui famiglia era formata dalla moglie Elisabetta e da due figlie, di cui la maggiore, Bernardina, era sposata a Gio Antonio de Carmine, e la minore, per nome Antonietta, era ancora una fanciulla sui tredici anni». 35 E lì, quella sera dell’ 8 gennaio 1522, «stavano riscaldandosi al caminetto alcuni avventori e discorrevano [oibò! non riusciamo a ravvisarvi l’osteria, bensì un’agenzia ANSA] della miseria dei tempi, della pestilenza che s’annunciava in diverse parti d’Italia, della nomina del nuovo Papa Adriano VI, successo a Leone X, e della guerra che si svolgeva nel Milanese, ove stavano di fronte Lautrec capo delle truppe franco-svizzere e il Marchese di Pescara e Prospero Colonna, capi dell’esercito imperiale». L’audacia fantasiosa del cantastorie raggiunge addirittura livelli da capogiro poco più oltre, quasi non gli bastasse, per spiazzare la sana ragione, il racconto di ciò che sarebbe successo di lì a poco (imputabile, questo sì, al buon Dio!): eccoti infatti la «beata fanciulla Antonietta, che prima vedesti il grande prodigio e lo gridasti ai parenti», alle prese con acciarino, stoppino di candela e maligni spifferi, per tre volte (non due e non quattro!) affaccendata su e giù per le scale, dal piano terra alla saletta superiore, ogni volta col cero acceso che poi le si spegne, inspiegabilmente, dato che le finestre di casa sono tutte chiuse. Stenta a capire la poverina... perché ha soltanto tredici anni! Ma poiché deve forzatamente raccapezzarsi che sta per accadere il miracolo, una forza misteriosa taglia corto e «l’afferra per i capelli e la costringe a guardare alla parete di fronte, dove, in alto, sta appesa una tavoletta». E quella grida finalmente, non per i capelli strappati, come vorrebbe la logica, ma per ciò che vede, eccetera eccetera. Una barocca e ripugnante ingegnosità miracolistica non suffragata da alcuna autentica testimonianza d’epoca, che non regge l’animo di ricondurre al concetto di Dio. È piuttosto l’introversione di un devozionismo scaduto a populismo. Inoltre, occorre purtroppo mettere in chiaro anche gli svarioni causati da indubbia faciloneria nel leggere criticamente i documenti. Ne riportiamo qui alcuni contenuti nei brani riportati dal citato fascicolo celebrativo del 1922: – Tutt’altro furono sia la “povera casetta”, sia quel “certo Tommaso”, e tanto meno si trattò di osteria con dentro lui in qualità di bettoliere. – Il Gio Antonio da Carmine fu tutt’altro che un Pinco Pallino di quella terra, e tanto meno si coniugò a Bernardina Zacchea. – Gli avventori di quella sera non erano abituali briscolanti, sebbene siano stati fabulosamente accreditati di alati discorsi sul vivere del gran mondo. – La ressa di curiosi accorsi nella saletta di casa Zaccheo alla sera dell’8 gennaio e poi ancora nei giorni successivi non fu un indiscriminato andirivieni di gente. Quanto basta per concludere che le incrostazioni fabulatorie e le sedimentazioni sentimentali, quantunque siano di pronto effetto, vanno rimosse: sono fuori luogo, semplicemente perché prive di fondatezza storica. E per rispetto al buon Dio, o quantomeno alla nostra intelligenza, la veridicità va ricercata nei documenti, a cominciare da quella prima verbalizzazione ufficiale delle testimonianze rese il sabato 25, cioè ancor prima che finisse quel fatidico mese di gennaio, diremmo “a botta calda”. Prima pagina dell’Istrumento dei miracoli 25 Gennaio 1522 36 24 (fascicolo N. 3 – aprile 1995) Ha fatto bene don Crenna a riproporci la testimonianza di Tommaso de Zacheis (e mi pare che voglia continuare con altre). L’esposizione è fatta con semplicità, senza forzature e infingimenti. Leggiamola con attenzione, senza pregiudizi. Ci aiuterà a conoscere l’evento della Santa Pietà in modo più personale, più vero; e non per sentito dire. Rifacciamoci al recente caso della “Madonnina di Civitavecchia” lacrimante sangue. Alla pari di ogni fatto imprevisto, ci ha stupito; non rientrando esso nella norma, chi ha potuto è accorso sul luogo per meglio constatare, e – per la curiosità di tutti gli altri – si sono moltiplicati interviste, servizi fotografici, reportages giornalistici e informazioni televisive. Si è giunti pure alle inchieste da parte della magistratura e agli accertamenti sulla base di analisi del DNA. Il tutto tra immancabili riverberi di devozione, credulità, dubbio e scetticismo, a seconda delle qualifiche interiori di ciascuno. Proviamoci dunque a supporre come si vedrebbero i fatti “miracolosi” di Cannobio, se, anziché nel 1522, accadessero ai nostri giorni: intendiamo riferirci a quelle ripetute lacrimazioni, nonché alla fuoruscita di una costola miniaturizzata e sanguinolenta, dalla sottilissima pellicola di colore che servì a dipingere, su quel riquadro di pergamena, le figure di Cristo “in pietà”, della Vergine e di S. Giovanni. Roba da scoraggiare anche il più ostinato bigotto! Tranne che (cosa talmente assurda da risultare insostenibile per le nostre facoltà mentali) non ci riuscisse di equivocare su quanto avviene proprio sotto i nostri occhi... può anche darsi che ci rifiuteremmo di guardare in tale direzione. Dobbiamo ammettere che assai poco scomodante e praticamente innocuo è invece il “racconto” del miracolo della Pietà, distante com’è di secoli e imbastito con personaggi stinti su un fondale illanguidito. Si tratta comunque di uno svilimento inammissibile per la storia, che, come tale, rivendica quanto meno la veridica ricostruzione di ogni accadimento attraverso la validità delle testimonianze documentarie. La storia si avvale di un dato inoppugnabile: l’efficienza della mente umana si dimostra costante lungo tutti i tempi cosiddetti storici. In termini più coinvolgenti: i borghigiani di Cannobio nel ’500 non erano di certo o più ritardati o meno scaltriti di quanto non lo siano i cittadini d’oggi. Ultima pagina dell’Istrumento dei Miracoli Se ci provassimo dunque a riprendere in considerazione direttamente le dichiarazioni di quei trapassati testimoni, così come attualmente leggiamo le interviste di Civitavecchia e dintorni? Valutando cioè la presumibile veridicità di chi le rilascia e l’autorevolezza di chi le rileva. Ovviamente la precedenza va data a coloro che a Cannobio sono stati testimoni oculari, a cominciare dal padrone di casa, quel signor Tommaso de Zacheis, notabile facoltoso, coniugato con la signora Elisabetta del casato dei Luati, altrettanto notabili e danarosi imprenditori nel settore della lavorazione del cuoio (si tenga presente che ancora a quell’epoca si trattava di una materia prima, addirittura strategica in ambito militare). 37 Attenendoci strettamente all’originaria stesura latina, traduciamo qui in linguaggio a tutti intelligibile la deposizione del primo testimone, che fu convocato nel «giorno di sabato 25 del mese di gennaio 1522, in presenza del reverendo signor prete Gabriele de Tremedio prevosto della chiesa di S. Vittore di Cannobio, del magnifico dottore in leggi signor Simone Enrigheto podestà di detto borgo di Cannobio e Pieve, entrambi ivi deputati dal reverendo signor Rufino Bilingerio vicario della curia arcivescovile di Milano mediante lettere del corrente 15 gennaio nei termini ivi ampiamente descritti. Il signor Tommaso de Zacheis figlio del fu signor Filippo, abitante del borgo di Cannobio, presentatosi come testimone, invitato da detti signori deputati a rispondere in modo veritiero alle interrogazioni che gli saranno rivolte, ha giurato di farlo nelle mani di me notaio Giovanni Antonio de Albertinis. E in primo luogo richiesto di esporre con verità ciò che sa e ha visto circa i miracoli riscontrati ed accaduti nei giorni precedenti nella sua casa di abitazione, nella piccola tavola, su cui è dipinta l’immagine della B. V. Maria sulla destra, l’immagine di N. S. G. C. in pietà (nel mezzo dello stesso quadretto) e (sulla sinistra) l’immagine di S. Giovanni Evangelista, ha testificato sotto suo giuramento, ha risposto e detto che mercoledì 8 del corrente mese di gennaio, verso le ore venti (circa horam secundam noctis), mentre stava a letto nella stanza di detta sua casa di abitazione posta in riva al lago, di sua esclusiva proprietà, udì Antognina, figlia sua, di circa tredici anni, che chiamava la signora Elisabetta, sua madre e moglie del testimone, dicendo queste o simili parole “O Matre, corete che la nostra Donna et messer Jesu Cristo et sancto Joanne piangeno sangue”. Udito tale grido, il teste si alzò dal letto e venne nella saletta in cui stava detta figlia e detto quadretto. E similmente vi erano detta signora Elisabetta sua moglie, Giovanni Antonio de Carmeno suo genero, un tale detto “el feraro de Transflumine” (parente di Giovanni Antonio) ed un altro uomo, di Cavaglio, Pieve di Cannobio, ed anche Antognina, già nutrice dei figli del teste, tutte persone che in quel momento si trovavano nella sua casa. E immediatamente il teste vide che dette immagini stillavano sangue soprattutto dagli occhi. Volendo osservare meglio, montò sulla cassapanca che stava sotto il quadro, facendo luce con una candela accesa, e vide l’immagine della B. V. Maria che aveva l’occhio destro arrossato da sangue vivo; e anche dall’occhio sinistro stava per sgorgare una grossa goccia, pure di sangue vivo. Anche l’immagine di N. S. G. C. stava emettendo sangue vivo dagli occhi e dalle ferite del costato e delle mani. Ed anche l’immagine di S. Giovanni Evangelista aveva gli occhi pieni di sangue, non così rosso, ma apparentemente misto ad acqua. Osservando tutto ciò, gli astanti sopra citati, compreso il teste, si misero a gridare piangendo “Misericordia!”. Attratti dalle loro grida, accorsero parecchie altre persone del vicinato, tra le quali Cesare de Baciochis, Battista Perolini, Innocenzo Monaci e mastro Petrino de Tassanis, il reverendo signor Raffaele de Castiliono, un figlio del signor Minale de Tattis, il signor prete Giovanni Antonio de Mazironibus, il signor prete Matteo de Poscolonia, oltre a parecchi altri, dei quali il teste al presente non ricorda i nomi. E mentre stavano lì, per un’ora circa, egli vide che dall’occhio destro dell’immagine della B. V. una goccia di sangue era scesa lungo la guancia, come pure quella goccia di sangue, che egli aveva notato sporgere dall’occhio sinistro, era scesa giù lungo le guance. E parimenti vide l’immagine di Gesù Cristo di nuovo rosseggiare di sangue vivo dagli occhi e dalle ferite. Il teste, dopo aver osservato questi fatti, poiché indossava la sola camicia e sentiva freddo, ritornò a letto, ma dopo breve tempo udì quelli che si trovavano nella saletta gridare di nuovo “Misericordia!”, per cui si levò nuovamente, tornò di là e sentì dire dagli astanti e soprattutto da coloro che più erano prossimi al quadretto “Videte la Vergine Maria che alza la mane et santo Giovanne buta aqua dalli ogi”. Al che il teste cercò di avvicinarsi al quadretto per vedere anche lui, ma non vi riuscì a causa della ressa delle persone lì accorse. Allora tornò a letto e vi rimase fin verso l’aurora del giovedì. A quell’ora (tra le 5 e le 6) rientrato nella saletta, notò che quelle antiche figurazioni apparivano nitide come fossero appena ridipinte, mentre sua moglie e gli altri che erano rimasti lì tutta la notte gli dicevano che verso la mezzanotte (circa horam quintam vel sextam noctis) la figura di Gesù Cristo era apparsa in rilievo a guisa di corpo vivo, con occhi ferite e segni della flagellazione pieni di sangue vivo. 38 Questo è quanto lui sa dei fatti straordinari di quella prima notte. Parimenti il teste ha detto e attestato che in quello stesso giovedì, verso le sei di sera (circa horam primam noctis), mentre stava nella cucina (in caminata) della sua casa, posta al pianterreno sotto la saletta, udì gridare “Misericordia!” da coloro che là si trovavano. Egli corse sopra e vide la tovaglia, che stava stesa sulla cassapanca sotto al quadretto, macchiata da parecchie gocce di sangue, ed era macchiato anche un fazzoletto lì posto. Inoltre proprio sulla tovaglia vide una piccola costola sanguinante che gli parve trattenesse residui di carne viva e sanguinolenta. E notò sulle vesti di alcuni degli astanti parecchie gocce di sangue. Allora il teste mandò uno dei presenti a chiamare i signori preti del borgo. Vennero immediatamente il signor prete Bernardino de Carmeno e i sopracitati prete Matteo e prete Giovanni Antonio, i quali, appena giunti, si misero a pregare; dopo di che, prete Bernardino, tolta la piccola costola dalla tovaglia, la pose in un calice, asportando anche la tovaglia, il fazzoletto e quei panni di lana, lino o canapa segnati dalle gocce di sangue, e il tutto fu da loro processionalmente portato alla chiesa di S. Vittore del borgo. Inoltre il teste ha detto che nella stessa notte di giovedì vide per due volte, ad ore diverse, l’immagine di Cristo emettere ancora sangue vivo dagli occhi e dalla ferita della mano sinistra, e l’immagine della Madonna stillare sangue vivo dagli occhi. Inoltre il teste ha dichiarato che il venerdì successivo, verso la ventiquattresima ora, vide le immagini di Gesù Cristo e della B. V. di nuovo emettere sangue vivo dagli occhi, davanti ad un gran numero di persone, tra le quali vi erano Giovanni Antonio de Carmeno, prete Bernardino de Carmeno, il signor Francesco de Poscolonia, Matteo servitore del conte Lodovico Borromeo, e gli sembra che siano stati presenti al fatto anche l’illustre conte Federico Borromeo, ed anche i due fratelli Borromei, reverendo signor Carlo e magnifico signor Camillo, che in quei giorni si erano essi pure mossi. E questo è tutto ciò che il teste sa dire circa i fatti straordinari. Richiesto sul come sappia queste cose, il teste ha risposto che le sa perché fu presente, vide, ed apprese, così come ha deposto. Richiesto su chi fosse presente, in qual luogo e in qual tempo, il teste ha risposto che presenti furono lui stesso, i sopracitati e parecchi altri dei quali non ricorda i nomi, nel luogo e nel tempo sopracitati. Sulle richieste generali ha dato risposte esaurienti; la sua età è all’incirca di 55 anni». Nello stesso giorno viene chiamato a deporre Giovanni Antonio de Carmeno, figlio del signor Pietro abitante a Carmeno, Pieve di Cannobio. 25 (fascicolo N. 4 – maggio 1995) Lentamente, con somma attenzione leggo queste testimonianze che mi attraggono, mi appassionano, e trovo parole, incisi, sempre nuovi. Mi sembra di inoltrarmi per una tortuosa valle dove ogni curva ti rivela un paesaggio, una baita, una vetta innevata... che ti obbliga a sostare e a contemplare. Grazie, don Crenna. Attendo altro, e presto. Delle deposizioni rese a Cannobio il 25 gennaio 1522 e rogate dal notaio Bartolomeo de Albertinis esiste la trascrizione fatta dal figlio – anch’egli notaio – Giovanni Antonio, a ciò autorizzato l’anno 1550 «dai magnifici signori abati del venerabile collegio dei signori notai di Milano». Ad una prima testimonianza, rilasciata dal signor Tommaso Zaccheo circa i fatti accaduti proprio a casa sua (v. puntata precedente), fa seguito la deposizione del suo genero Giovanni Antonio de Carmeno. I de Saxo de Carmino, poi «cognominati solamente de Carmino, ovvero Carmini» (come riferisce l’Informazione istorica del Borgo di Cannobio di Gio Francesco del Sasso Carmino), erano un casato «assai ricco e possente in Cannobio e molto numeroso, sempre stato dato più alle armi che alle lettere, né vi ha in quel Borgo famiglia alcuna ch’abbia insino ad ora prodotto maggior numero di soldati e persone armigere di questa, sebbene non siano mancati uomini di valore anche nelle lettere ed altre virtù». 39 Insignito di cittadinanza milanese dai Visconti, tale casato «per arme usa la biscia de’ signori Visconti di Milano, senza però il fanciullo in bocca e senza la corona in testa, in mezzo a due gran sassi ovvero scogli, con l’acqua ossia lago sotto, in campo bianco». E, come è tradizione dei grandi casati, vi venivano tramandati i patronimici Pietro, Antonio, Francesco, Agostino, e l’esercizio della mercatura sulle rotte «di Piemonte, di Lione, di Vallese, ora in Alamagna ed ora a Vinetia e ad altre città e luoghi d’Italia». Non sappiamo per ora specificare quale fosse il genere di «mercanzia» gestita dalla famiglia, a meno che si voglia trarre indizio da quell’apparentarsi di inizio ’500 tra un Sasso Carmine e una nobile milanese, Caterina, figlia di Gio Antonio Biancardi «che fu il principale armarolo, non solo in Milano, ma anco della nostra Italia et fu inventore di molti belli secreti in quella professione». Il genero del signor Tommaso Zaccheo – si noti – risulta imparentato per parte di sorella con il ferraro di Traffiume, ed è pur egli un mercante con giro d’affari che non ammette deroghe, neppure in presenza di fatti mirabolanti, come si ricava dalla sua deposizione. «Sotto giuramento il teste risponde e dice che in verità il mercoledì, giorno 8 del corrente mese di gennaio, all’incirca verso le 9 di sera (circa horam tertiam noctis), mentre egli si trovava nel borgo di Cannobio, nella casa d’abitazione del suocero signor Tommaso de Zacheis situata presso la riva del lago, udì la figlia di detto Tommaso, Antognina, che da una saletta al primo piano di casa gridava “O Matre, corete che la nostra Donna e messer Jesu Cristo et santo Zovanne piangeno sangue”, o parole simili. Precipitosamente egli, Elisabetta moglie del signor Tommaso, il proprio parente per parte di sorella Stefano ferrario di Traffiume, Dumino di Cavaglio, e l’altra figlia del signor Tommaso, Bernardina, accorsero in detta saletta, lì subito raggiunti da detto signor Tommaso, che si era coricato nella contigua sua camera da letto. Non appena giunto sul luogo, il teste vide che l’immagine della B. V. Maria dipinta sulla tavoletta aveva gli occhi pieni di sangue vivo, e subito s’accorse che dall’occhio sinistro di detta immagine stava fuoruscendo una grossa lacrima di quel sangue. E vide che anche la figura “in pietà” del N. S. Gesù Cristo dipinta su detta tavoletta aveva gli occhi e le ferite del costato e delle mani pieni di sangue vivo, e parimenti vide che l’immagine di S. Giovanni Evangelista, dipinta sulla stessa tavoletta aveva gli occhi pieni di sangue chiaro e vivo. A tal vista il teste ed i sunnominati tutti si misero a gridare ad alta voce “Misericordia!”. Richiamati da tale clamore, presero ad accorrere alcuni vicini di casa, tra i quali egli ravvisò Francesco Cigolini di Cannobio e Orsina moglie di Bernardino Stefanini, pure di Cannobio, la quale disse al teste che doveva andare a prendere in casa di lei una certa lampada per accenderla davanti a dette immagini. Ed egli subito vi si recò e, tornato nella saletta con la lampada già accesa, la appese dinnanzi alla tavoletta montando sulla cassapanca collocata lì sotto; per meglio osservare il miracolo, preso in mano un cero acceso, si avvicinò ancor più alla tavoletta. Fu allora che vide come l’immagine della B. V. Maria avesse alquanto sollevato la mano destra e l’avesse avvicinata più di quanto non lo fosse prima al fianco o costato di N. S. Gesù Cristo, e vide pure che la figura dipinta della Pietà di N. S. G. C. prendeva rilievo come fosse di carne viva, con i segni dei flagelli rosseggianti di sangue vivo stillante da dette ferite. E questo accadde verso la mezzanotte (circa horam quintam ipsius noctis). E di lì a poco vide che l’immagine della B. V. emetteva detto sangue dagli occhi lungo le guance, come pure l’immagine di N. S. G. C. nuovamente stillava sangue vivo dagli occhi e dalle cicatrici. E vide allora che pure la figura di S. Giovanni Evangelista emetteva lacrime chiare dagli occhi, e in particolare osservò una grossa lacrima chiara che dall’occhio destro discendeva fin sulle mani di detta immagine di S. Giovanni. Questo è quanto egli è in grado di dire relativamente ai miracoli. Alla domanda se il teste poté osservare altri miracoli compiuti da dette immagini il giorno di giovedì ed alla sera del successivo venerdì, risponde che al giovedì non vide nulla, poiché si era recato al mercato di Locarno; ma al suo ritorno in quello stesso giorno verso la prima ora di notte (circa le sette pomeridiane), apprese che dall’immagine della Pietà erano fuoruscite una costola ed una notevole quantità di gocce di sangue che si erano sparse sulla tovaglia stesa sulla cassapanca e sugli astanti più vicini e sui loro capi di vestiario. 40 Ed egli stesso vide alcuni di tali panni e tale tovaglia con le macchie di sangue, ed anche detta costola sanguinolenta tra le mani dei signori preti della chiesa di S. Vittore di Cannobio, che avevano trasportato il tutto in S. Vittore in gran processione, a cui il teste partecipò, la sera stessa di giovedì. Rispondendo ad interrogazione, dice pure che il giorno di venerdì successivo, circa all’Ave Maria (ante primam horam noctis), vide ancora le immagini della B. V. e di N. S. G. C. lacrimare sangue vivo dagli occhi, e dall’occhio sinistro della B. V. scendere una goccia di sangue lungo le guance. E non vide altro. Interrogato quale sia la fondatezza di ciò che asserisce, quali siano altri testimoni oculari, quali le circostanze di tempo e di luogo, risponde che conosce tali fatti perché vi fu presente, vide e udì ciò che ha deposto. Presenti oltre a lui testimone i detti signor Tommaso de Zacheis, la signora Elisabetta sua moglie, Stefano ferario, Dumino di Cavaglio, e le dette figlie del signor Tommaso, Francesco Cigolini, Cesare de Bachiochis, Innocenzo Monaci, i signori preti Gio Antonio de Mazironibus e Matteo de Poscolonia, nonché parecchi altri, sia del borgo di Cannobio, sia di Castiglione e di Pallanza e de Serono, dei quali non ricorda i nomi; e ciò nel luogo e nei tempi suddetti. Dichiara di avere all’incirca 32 anni». 26 (fascicolo N. 5 – giugno 1995) Siamo alla 26a puntata. Don Crenna merita un encomio per la fedeltà, la disponibilità, la puntualità nel collaborare al Bollettino, soprattutto per la competenza. Agli abbonati – se ce ne fosse bisogno – rivolgo un caldo invito per una lettura attenta di queste puntate: sono le deposizioni sull’evento della Santa Pietà raccolte dalla viva voce dei testimoni. Credetemi! Le ho lette e rilette con interesse – e un pizzico di curiosità. Non sono rimasto deluso. Anzi. Quello stesso mercoledì 25 gennaio 1522 fu convocato il terzo testimone, Francesco figlio di Pietro Cigolini, abitante nel Borgo di Cannobio. Il prevosto di S. Vittore ed il podestà, in base alla delega avuta dal rev. Ruffino Bilingeri, vicario della Curia arcivescovile milanese, richiesero al teste di deporre sotto giuramento. «Alla domanda “che cosa egli sappia dire circa i miracoli avvenuti in casa del signor Tommaso de Zacheis sulla tavoletta che gli è stata specificata”, attesta e giura esser vero che il mercoledì 8 del corrente gennaio mentre, circa le ore 8 di sera (circa horam secundam noctis), si trovava in casa di Stefano Sebastiano de Mantellis – in prossimità della casa di detto signor Tommaso – in compagnia del pescatore Ambrogio da Pallanza, sentì dire da certe donne che nell’abitazione del signor Tommaso “vi era una tavoletta che faceva miracoli” E allora, subito, corse col detto suo compagno di Pallanza alla casa dello Zaccheo e, salite le scale ed entrato in una certa saletta situata al di sopra della cucina, vide – appesa ad una delle pareti – la tavoletta su cui stavano dipinte le figure della Beatissima Vergine Maria, del Signor Nostro Gesù Cristo in sembiante di Pietà, e di S. Giovanni Evangelista. Ed allora egli si avvicinò alla tavoletta e salì sulla cassapanca lì sotto collocata, tenendo un lume acceso in mano. E vide che l’immagine della B. V. stillava sangue vivo dagli occhi, e similmente l’immagine della Pietà dagli occhi e dalle cicatrici del costato e della mani. E vide anche che l’immagine di Giovanni aveva gli occhi pieni di sangue misto ad acqua. E quella stessa notte vide che la detta immagine della Pietà si era fatta come viva, con gli occhi e le ferite e le piaghe della flagellazione rosseggianti di sangue vivo. E non vide altro in quella notte, perché non rimase lì costantemente, ma a più riprese andò a chiamare altri suoi amici onde venissero a vedere siffatti miracoli. Interrogato se avesse assistito ad altri miracoli fatti da quelle immagini nei giorni successivi di giovedì e venerdì, risponde che, mentre egli si trovava in detta saletta nel giorno di giovedì, all’incirca al suono dell’Avemaria, aveva constatato che parecchie persone lì presenti si erano trovate cosparse di numerose gocce di sangue. Fu allora che egli si mosse da lì per andare a chiamare il signor prevosto della chiesa di S. Vittore di Cannobio ed il signor prete Gio Antonio de Mazironibus, canonico di detta chiesa. 41 E come ritornò nella saletta, sentì dire che dalla figura della Pietà una costola era caduta sulla tovaglia stesa sopra la cassapanca, e che anche la tovaglia era rimasta macchiata di quel sangue. Tuttavia egli non poté constatare tutto ciò direttamente, a causa della ressa di persone nel frattempo lì convenute. Però, dato che il tutto fu dai signori preti trasportato processionalmente la sera stessa nella chiesa di S. Vittore, egli poté là vedere la costola, e la tovaglia ed un fazzoletto e certi panni segnati dalle gocce di sangue. Ed altro non vide, benché sentì dire che, dopo, ancora due volte le dette immagini avevano fatto miracoli. Interrogato quali siano i motivi della sua consapevolezza chi altro fosse presente, e quali le circostanze di tempo e di luogo, risponde che è consapevole di ciò che ha deposto perché è stato testimone oculare ed ha raccolto testimonianze dirette nel luogo e nel tempo suddetti, presenti il signor Tommaso, la moglie di lui donna Elisabetta, le sue due figlie ed anche il genero Gio Antonio de Carmino, il ferraro di Traffiume, Dumino de Cavalio, Gio Antonio Homacini, Antonio de Gurono, Giacobino Ferratini, il signor prete Gio Antonio de Mazironibus, maestro Petrino de Tassanis, Cesare de Baciochis, Innocenzo Monaci, e parecchi altri dei quali al momento non ricorda i nomi. Dichiara di avere più di quarant’anni d’età». Dunque, una relazione di fatti, la sua, che non si discosta dalle deposizioni già rese dal padrone di casa, il signor Tommaso, e dal suo genero Gio Antonio de Carmino (v. nn. 24-25). Ne possiamo però ricavare alcuni elementi utilizzabili per impostare una specie di sopralluogo o di ricostruzione scenica. E questi sono: l’affidabile età del nostro personaggio; la sua presenza, quella sera, nella più che rispettabile casa Mantelli e la contiguità di questa con casa Zaccheo; quel suo affannarsi per far accorrere altri testimoni: ad vocandum de amicis suis ut irent ad videndum talia miracula. E ne cita alcuni: Omacino, Gurono, Ferratino, Tassano, Baciocco, Monaco. È una sequenza di nomi che ci riporta a «quelle case del Borgo inferiore che ora si vedono lungo la riva e fanno sì bella vista agli occhi dei riguardanti», come ebbe a scrivere nel ’600 il Sasso Carmino. Quelle case oggi hanno numero civico e designazione catastale, ma la loro individuazione – nei tempi andati – veniva stabilita mediante le “coerenze”, cioè in base a quello che stava a mane (est), a meridie (sud), a sero (ovest), a monte (nord) di ciascuna di esse. La combinazione di tali dati, ricavabili dai rogiti notarili di successioni, spartizioni, permute, vendite, acquisti e pignoramenti di stabili, rende possibile configurare – quasi in un abbozzo di mappa topografica – l’insediamento abitativo del Borgo inferiore, ricostruendo la concatenazione delle singole proprietà edili: dalle «confetture», o laboratori, di cuoi e di pellami dislocate lungo la via Castello, alle residenze allineate da piazza Baciocchi (oggi piazza Indipendenza) fino alla «plateola de la Motta» (all’attacco di via Marconi). Una ricostruzione che, peraltro, in certo modo è facilitata dal poter individuare quelle case con a mane ripa lacus (ad est la riva del lago) e coniugarne poi le rispettive altre coerenze fino ad ottenere la sequenza degli edifici affacciati sul lungolago. È l’itinerario lungo il quale l’affannato e trasecolato Francesco Cigolini, in quella notte dei miracoli, bussò alle porte di mercanti di lane e pelli, di banchieri, di notai, di uomini di lettere e d’affari, di borghigiani politicamente in quota: nell’ordine di casa lungo piazza Baciocchi, i Romerio, i Tassani, i Baciocchi, i Mantelli, i Gerroneti, i Gallarini, i Cigolini. Al di là dello «scurone» e della «contrada della Motta» fino a subtus lobiam dell’omonima piazzetta l’hospitium (l’Hotel Cannobio del tempo) gestito da «el padre da Torno» e il «canepale de ripa», l’osteria accanto alle case illorum Cerini de Zacheis (si noti: in tutt’altro sito e di tutt’altro casato che non quello del signor Tommaso), e poi ancora: i Luvati, i Sasso Carmino, gli Scarlioni, i Peazo-Zacchei. Codesti individui – gente ben ancorata al pragmatismo degli affari e al prestigio della propria nomea – vengono dunque allertati dal Cigolino, il quale dice loro... che in casa del signor Tommaso, una pergamena lacrima... trasuda sangue, eccetera eccetera. E quelli, incredibilmente, si smuovono e accorrono! Ma per vedere che cosa? Ce lo dicano! 42 27 (fascicolo N. 6 – luglio-agosto 1995) Non sa di offesa al buon Dio se i fatti relativi alla Pietà di Cannobio appaiono incredibili o addirittura assurdi, tanto esulano dall’ordine naturale delle cose e stanno in così netta contrapposizione ai parametri della sana ragione. Che fare dunque? Non dar loro peso, o cozzarvi contro, o metabolizzarli? In quest’ultimo caso basta raggirare la ripugnanza mentale barando col sentimentalismo di bassa lega o sconfinando nel magico, vale a dire immettendosi su traiettorie opposte ai percorsi dell’onesta fede. Nelle altre due suaccennate ipotesi può riuscire salutare la massima di quel sant’Uomo che fu Agostino d’Ippona: credo quia absurdum. Il che praticamente equivale al tentare di capacitarsi sull’entità di un fatto, di per sé abnorme, collegandosi per quanto possibile in presa diretta... e poi stare a vedere cosa succede dentro di noi. Tale procedimento dovrebbe risultare agevole in special modo ai Cannobiesi di oggi, che hanno a disposizione le testimonianze rese da alcuni loro antenati a botta calda, non più di venti giorni dopo i fatti successi in casa di Tommaso Zaccheo, ufficialmente rogate dal notaio Bartolomeo Albertini del loro Borgo. Per un minimo di attaccamento a costoro, scorrendone le deposizioni, dovrebbero quantomeno restare perplessi se considerarli o no pazzi integrali. Si tratta di un rogito: per sua natura deve prevalere su qualsiasi altra tardiva rielaborazione, più o meno fantasiosa, dettata da fuorvianti devozionismi. Non per nulla tale documento fece testo nel 1550, ripreso – su concessione del Collegio notarile milanese – da Giovanni Antonio Albertini, figlio del succitato Bartolomeo. E integralmente fu dato alle stampe dai Confratelli della Ss. Pietà nel 1586, mentre fervevano i lavori di costruzione dell’attuale santuario. Assai più tardi si cominciò a fantasticare! Non per nulla ve lo riproponiamo (a puntate) nella sua stesura integrale. Poi ognuno si farà la propria opinione. 1522, 3 febbraio, lunedì. – L’escussione dei testimoni oculari, sospesa per una settimana, riprende con la convocazione di Stefano figlio di Tommasino de Portu, abitante a Traffiume e lì esercitante l’arte del fabbro. Sotto il rituale vincolo del giuramento, interrogato egli depone: « che il mercoledì 8 dello scorso gennaio egli si trovava nella casa di abitazione del signor Tommaso de Zacheis, situata nel Borgo di Cannobio presso la riva del lago, circa la seconda ora di notte (circa le venti) in compagnia di Gio Antonio de Carmeno e di Dumino di Cavaglio,volendo essi recarsi al mercato di Locarno; quando udì Antognina, la figlia di detto signor Tommaso che si era portata al piano superiore della casa, gridare e dire queste o simili parole “O matre correte, che la Vergine Maria et messer Giesù Christo piangeno sangue”. Ciò udendo,egli insieme a donna Elisabetta, moglie del signor Tommaso, e con Gio Antonio de Carmeno, Dumino e Bernardina, figlia di detto signor Tommaso, accorsero nella saletta soprastante alla cucina della casa, salendo per le scale interne, e come raggiunse la saletta scorse una tavoletta su cui erano dipinte le immagini di N. S. Gesù Cristo in sembianza di Pietà e di S. Giovanni Evangelista e della Beatissima Vergine Maria, appesa ad una delle pareti di detta saletta. E fattosi più vicino a quella tavoletta,osservò che la detta immagine della Beatissima Vergine versava lacrime di sangue, e poco dopo le vide scorrere lungo le guance; vide che anche la detta immagine della Pietà emetteva e stillava sangue dagli occhi e dalle ferite del costato e delle mani; e osservò che anche la detta immagine di S. Giovanni Evangelista aveva gli occhi pieni di sangue ed acqua, e che poco dopo lacrimò acqua chiara dagli occhi, lacrime che discendevano giù per il volto. Ancora quella stessa notte, circa l’ora quinta (verso mezzanotte), vide tutto il corpo di detta Pietà in rilievo come fosse vivo, con gli occhi e le ferite e le striature dei flagelli su tutto il corpo pieni di sangue vivo. Questo è quanto egli sa dire al riguardo dei citati miracoli, poiché dopo egli si congedò; ma a lui sembra proprio che la detta immagine della B. V. Maria in quella notte abbia sollevato la mano destra avvicinandola al fianco dell’immagine della Pietà, quantunque egli non abbia colto il muoversi della mano. 43 Alla domanda «quale fondamento abbia ciò che dice di sapere, quali ne siano i testimoni e quali le circostanze di luogo», risponde che egli sa perché vide con i propri occhi i fatti esposti, ne fu presente con gli altri sopracitati nel tempo e nel luogo suddetto coerenziato da ogni lato dalla proprietà del signor Tommaso. Dichiara di avere all’incirca 45 anni». 4 febbraio, mercoledì. – Viene convocato Innocenzo del fu Stefano Monaci, pure lui abitante del Borgo. Premesse le formalità processuali, rilascia questa deposizione giurata: «risponde e dice di sapere circa i miracoli questi soli fatti, cioè esser vero che il mercoledì 8 dello scorso gennaio, alla sera di quello stesso giorno circa la seconda ora di notte (v. s.), mentre egli transitava per strada, all’altezza della casa d’abitazione del signor Tommaso de Zacheis, situata in detto Borgo di Cannobio presso la riva del lago, udì un gran clamore provenire da detta casa, e distinse una voce che diceva che la gloriosissima Vergine Maria e N. S. Gesù Cristo lì facevano miracoli. Udito ciò, subito egli entrò in detta casa, salì per scale interne raggiungendo una certa saletta ove s’imbatté in detto signor Tommaso de Zacheis, donna Elisa betta sua moglie, due figlie del signor Tommaso, e anche Gio Antonio de Carmeno genero dello stesso signor Tommaso, un tale noto come el ferraro di Traffiume, un altro di Cavaglio detto Dumino, Bernardo Stefanini di Cannobio, e certe altre donne. E vide quella tavoletta, piccola, sulla quale stanno dipinte le immagini della Beatissima Vergine Maria, di N. S. Gesù Cristo in sembiante di Pietà e di S. Giovanni Evangelista, appesa ad uno dei muri della saletta, abbastanza in alto dal pavimento. E nell’accostarsi alla stessa, vide dagli occhi della beatissima Vergine Maria uscire sangue vivo e scendere dagli occhi giù per le guance; vide anche dagli occhi di detta immagine di N. S. Gesù Cristo, dalle ferite delle mani e del costato uscire sangue vivo, e quel sangue che stillava dagli occhi e dalle ferite delle mani scendeva sia lungo le guance sia sopra le mani. E ancora vide che l’immagine di S. Giovanni Evangelista aveva gli occhi pieni di sangue e di acqua, e che in breve tempo lacrimò dall’occhio sinistro una goccia d’acqua grossa e chiara che scese giù fin sopra la mano della stessa immagine di S. Giovanni. Alla vista di ciò i presenti esclamavano ad alta voce “misericordia”. E verso l’ora quinta di notte (v. s.) osservò la detta immagine di N. S. Gesù Cristo così pronunciata da sembrare di carne viva, ed aveva gli occhi e le ferite e le lacerazioni dei flagelli pieni di sangue vivo. E dice di non aver visto altro in quella notte, dato che tornò alla propria casa per coricarsi; ma il giorno dopo, giovedì, di sera circa l’ora dell’Ave Maria, mentre egli stava in quella stessa saletta, sentì dire dalla signora Susanna, moglie del signor Vittore de Luvatis «portate qui uno lume, che me sento cascar aqua à dosso». E accostato questo lume, egli vide che la detta signora Susanna e molte altre donne presentavano numerose gocce di sangue vivo sugli abiti, ed alcune tra loro sulle mani, altre sul collo; e parimenti vide la tovaglia che stava stesa al di sotto di detta tavoletta cosparsa di parecchie gocce di sangue vivo, come pure un tovagliolo lì steso al di sopra di detta tovaglia. E fu allora che notò sopra la tovaglia costiolinam sanguinolentam, una costicina insanguinata di dimensione proporzionata alla detta Pietà; e osservò che il costato della stessa Pietà era tutt’attorno pieno di sangue vivo. A tale vista egli, che stava appresso alla succitata cassapanca e alla tavoletta, e i parecchi lì attorno si misero a gridare “misericordia”. E all’istante mandarono a chiamare i signori preti. E di lì a poco giunsero il signor prete Matteo de Poscolonia, il signor prete Bernardino de Carmeno, ed altri preti, che prelevarono la detta costola, la tovaglia, il tovagliolo, e i panni macchiati di detto sangue, e tutto trasportarono in gran processione, la sera stessa, alla chiesa di S. Vittore di Cannobio. Richiesto se egli vide l’immagine della B. V. alzare la mano destra e portarla al fianco di N. S. G. C. la notte prima del mercoledì, risponde che non vide, ma sentì ben dire allora da una certa donna «guardate che la Vergine Maria alza la mane». Interrogato se in seguito vide compiersi altri miracoli, risponde che il martedì precedente, 28 dello scorso gennaio, verso la prima ora di notte, mentre egli stava nella stessa saletta, osservò tutte tre le immagini cosparse di gocce d’acqua, e vide dalle mammelle di detta immagine della Pietà affiorare grosse gocce d’acqua viva che si asciugarono poi nello spazio di un quarto d’ora; eccettuata una grossa goccia che rimase al di sotto della gola dell’immagine della Vergine per un’ora circa. Altro non vide né sa. 44 Interpellato sulla fondatezza delle sue asserzioni, e chi potesse attestarne la veridicità, e dove e quando, risponde che egli conosce i fatti da lui attestati in quanto presente unitamente a parecchi altri, che all’istante non ricorda, nelle circostanze di tempo suddette e nel luogo sopra citato e da lui ben definito. Ha 32 anni circa». 28 (fascicolo N. 7 – settembre 1995) Dalle testimonianze fin qui pubblicate (nn. 25, 26, 27) sappiamo con precisione chi furono i primi ad accorrere, e in quale successione, alla casa del signor Zaccheo, circa dalle otto di sera in poi, quel mercoledì 8 gennaio 1522. I fatti là accaduti risultano talmente assurdi che si avverte la necessità - per nostra igiene mentale - di circoscriverli entro la rigorosa ricostruzione delle circostanze, senza indulgere ad inopportune facilonerie scenografiche, sia pure dettate da urgenze devozionistiche affatto inconcludenti. Il gruppo famigliare raccolto in casa, e precisamente nella caminata, o stanza da fuoco, o cucina che dir si voglia, è composto da: il signor Tommaso, la moglie donna Elisabetta, le due giovani figlie Antognina e Bernardina, il genero Giovanni Antonio de Carmeno, il ferraro di Traffiume suo parente, il conoscente Dumino di Cavaglio, e l’altra Antognina, l’ex nutrice di casa. In tutto otto persone. Dalla saletta superiore giunge lo strillo della figlia Antognina, sgomenta per ciò che sta vedendo. Tutti quelli di casa la raggiungono. Allarmata dal trambusto improvviso accorre anche una prima vicina di casa: Orsina moglie di Bernardino Stefanino (come si rileva dalla deposizione del genero del signor Zaccheo). Proprio allora, da piazza Baciocchi (oggi piazza Indipendenza), lungo la strada costiera, Innocenzo del fu Stefano Monaci sta per rientrare nella sua abitazione, appena al di là di casa Zaccheo; ma qui transitando, rimane sorpreso dalle voci concitate che ne provengono. Entra, sale le scale, e vede. Accorre allarmata anche la figlia dell’altro Monaci, Giovanni: vede e concitata corre subito dai Mantelli che hanno la casa coerente a quella degli Zacchei dal lato di piazza. Occasionalmente là presente, con il pescatore Ambrogio da Pallanza, è Francesco figlio di Pietro Cigolino, che senza frapporre indugio si porta sul luogo del miracolo, da dove a più riprese va a chiamare altri suoi amici. Nella saletta stanno raccolte ormai sicuramente almeno dieci persone quando vi salgono i due Tassani, il chirurgo Petrino figlio del signor Giovanni e Astolfo figlio del signor Vittore. Dall’entrata di casa che dà sulla via di S. Giustina sopravvengono il medico Aloisio Mantelli figlio del dottor Maffeo con due suoi ospiti, il rev. signor Raffaele de Castiliono e il signor Francesco de Tattis di Varese, e qualcun altro. La saletta contiene a stento tutti costoro: da qui l’impressione che Maffeo Mantelli ha di una gran ressa. Il tutto si svolge in meno di un’ora. E ognuno dei sopravvenuti ha potuto constatare direttamente ciò che sta accadendo, tra sorpresa e, ovviamente, sconcerto. Ora si noti che questi soli, qui sopra singolarmente ricordati (escluse le donne, come di regola), vengono richiesti di deporre pressoché immediatamente da parte del delegato arcivescovile, rogante il notaio Bartolomeo Albertini. Si tratta con evidenza di testimonianze selezionate, ognuna delle quali indubbiamente accreditata nell’estimazione pubblica, ma – ciò che più importa – nessuna può dirsi inficiata da possibili suggestioni o travisamenti da psicosi collettiva. Un modo di procedere obbligato se si vuole che una serie di accadimenti innaturali e conturbanti tale rimanga, evitando di renderla mirabolante e perciò ridicola. Nell’ordine risultano infatti essere stati convocati alla presenza dell’inquirente ecclesiastico e del podestà del Borgo, il 25 gennaio il signor Tommaso, il suo genero e Francesco Cigolino; il 3 febbraio Stefano il ferraio e Innocenzo Monaci; si prosegue col maestro chirurgo Petrino de Tassanis del fu signor Giovanni, abitante del Borgo di Cannobio. 45 Richiesto ed esaminato, costui rilascia questa deposizione giurata: «E’ verità che lo scorso mercoledì 8 gennaio verso la seconda ora di notte (circa le 8 di sera) mentre il testimone se ne stava nella propria casa situata nel Borgo di Cannobio, adiacente a quella del signor Tommaso de Zacheis, avendogli detto una certa ragazza figlia di Giovanni Monachi che nell’abitazione di detto signor Tommaso erano apparsi alcuni miracoli, subito di lì si mosse e andò a detta casa di detto signor Tommaso; e come raggiunse una saletta situata al di sopra della caminata di detta casa, vide lì raccolto un gran numero di persone che osservavano la tavoletta che stava lì appesa sul muro della stessa saletta, dipinta con le immagini della Beatissima Vergine Maria, del Signor Nostro Gesù Cristo in sembiante di Pietà, e di S. Giovanni Evangelista. Non appena si appressò a detta tavoletta, vide che l’immagine della gloriosa Vergine aveva gli occhi pieni di sangue vivo e che una goccia di sangue era fuoruscita dall’occhio sinistro; vide che anche dall’occhio destro della suddetta gloriosa Vergine usciva una goccia di sangue e scorreva alquanto lungo la sua faccia, come ancora adesso si può constatare. Vide anche gli occhi di detta Pietà e le impronte delle ferite del costato e delle mani piene di sangue vivo. E nel mentre lì si tratteneva alquanto, osservò che il detto costato della Pietà si era fatto tumido, pieno di sangue vivo, per poi tornare subito com’era, rimanendovi però il sangue vivo. Vide anche in quella stessa notte verso la quinta ora (circa le 11) che detta immagine della Pietà sembrava fosse viva, con gli occhi, le cicatrici e le impronte della flagellazione pieni di sangue vivo. Nel contempo vide anche che la detta immagine di S. Giovanni lacrimava acqua dagli occhi. Disse ancora il testimone che il giovedì seguente, verso la prima ora di notte (tra le 6 e 7 di sera), mentre si trovava in detta saletta dove sta la tavoletta, vide che parecchie donne avevano sui loro abiti, ed alcune sul collo ed altre sulle mani, numerose gocce di sangue vivo, come pure macchiata di sangue appariva la tovaglia, con sopra un fazzoletto, stesa sulla cassa posta al di sotto della tavoletta. E scorse sopra la stessa tovaglia, in corrispondenza della tavoletta, una piccola costa sanguinolenta, di proporzioni rispondenti a detta Pietà, fuoruscita, come crede, dal costato destro di detta Pietà; poiché così gli parve, e tuttora gli pare, ed è fermamente convinto, senza dubbio alcuno, che la cicatrice del costato in quell’ora si sia fatta più estesa di come adesso si vede, e più di quanto non lo fosse alla sera del mercoledì precedente. La costola con la detta tovaglia e fazzoletto e con i panni segnati di sangue, come si è detto, la sera stessa di giovedì, verso la seconda o terza ora di notte (tra le 7 e le 8) fu da lì rimossa e portata alla chiesa parrocchiale di S. Vittore in grande processione dai signori preti di Cannobio. Vide ancora, il venerdì successivo verso le ore ventiquattro, che dagli occhi della suddetta gloriosa Vergine e della Pietà sgorgava sangue vivo e scorreva lungo le guance. Così pure disse lo stesso testimone che il martedì 28 dello scorso gennaio, verso la seconda ora di notte, mentre egli stava in detta saletta, osservò che l’immagine della gloriosa Vergine presentava all’altezza della gola una grossa goccia d’acqua che si fermò lì alquanto e poi si asciugò. Dice pure il testimone che oggi, circa l’ora di pranzo, ha visto le suddette tre immagini e pressoché tutta la tavoletta cosparse di sudore acqueo e che ripetutamente sgorgavano gocce d’acqua da dette immagini, s’ingrossavano rimanendovi per la durata di un’ora o circa per poi asciugarsi da sole. Non sa altro. Richiesto che chiarisca da dove ricavi questa sua conoscenza da lui fatta, in presenza di chi, in qual luogo e tempo, risponde che la sua conoscenza è fondata essenzialmente sul fatto della sua presenza e della sua osservazione diretta, come ha deposto; inoltre alla presenza, per la prima notte, di Giovanni Antonio de Carmeno, di un tale chiamato il ferrario di Traffiume, di detto signor Tommaso con la sua moglie e le figlie e parecchie altre persone che ora non ricorda dettagliatamente; per la sera poi di giovedì, dice che ricorda che erano presenti il rev. don Raffaele de Castiliono, lo spettabile dottore in arti mediche il signor maestro Aloisio de Mantellis, il signor GioPietro de Zacheis, Astolfo de Tassanis, ed altri della casa di detto signor Tommaso, oltre ai parecchi dei quali non ricorda i nomi; per il suddetto giorno di venerdì ricorda di aver visto gli illustri signori conti Federico, Carlo e Camillo Borromei con parecchi loro domestici, ed inoltre il signor podestà del Borgo di Cannobio e molti altri. 46 Il martedì successivo, benché vi fosse una gran ressa di gente, dice di non ricordarsi se non dei famigliari di detto signor Tommaso e di Innocenzo Monaci. Tra coloro poi che oggi furono presenti per vedere i detti miracoli dice di aver scorto il signor Giofredo de Locarno, il signor Cristoforo de Rotiis de Ranzio, e certi altri forestieri di Castiglione e di Varese, il predetto signor maestro Aloisio, quasi tutti i signori preti di Cannobio e parecchi altri che sarebbe troppo lungo elencare. I tempi e il luogo sono quelli da lui sopra precisati. Dichiara di avere circa trent’anni di età». 29 (fascicolo N. 8 – ottobre 1995) I fatti accaduti a Cannobio in quei giorni di gennaio e febbraio 1522 apparivano talmente abnormi che il passo fu breve e si gridò al miracolo. Orripilante era poi quel trasudare sangue vivo e lacrime sanguigne dall’insignificante tavoletta appesa al muro. E si gridò “Misericordia!”. A noi che oggi, curiosi o devoti, scrutiamo quello stesso rettangolo di pergamena, “miracolosa” circa cinquecent’anni fa, le arcaiche figure lì dipinte appaiono del tutto statiche ed innocue; né forse conviene pretendere altrimenti. Comunque, potrebbe riuscire più appagante il nostro impatto con codesta “tavoletta” di casa Zaccheo se volessimo prestare la dovuta attenzione alle deposizioni giudizialmente rilasciate dai primi diretti testimoni, alcune delle quali addirittura in contemporanea con i surreali accadimenti di quei giorni. Ne riportiamo qui altre tre, con una annotazione a margine opportuna per suffragare, all’occorrenza, la competenza del secondo testimone. Infatti va tenuto presente che già dal secolo XIII arti e scienze mediche si erano evolute pragmaticamente nel campo dell’indagine e dell’identificazione dei processi biologici naturali La rielaborazione dei testi arabi e greci di anatomia, di medicina pratica e di veterinaria fu attiva e feconda a Bologna, ove la pratica della dissezione e lo studio sistematico dell’anatomia ebbero particolare rilevanza. I trattati specifici, che ne derivarono, contribuirono – nelle scuole di Montpellier, di Padova, di Torino – al notevole progresso dei metodi chirurgici più razionali La divulgazione di compendi o inventari nosologico-terapeutici nel Piemonte sabaudo e nello Stato di Milano attestano quanto, all’inizio del ‘500 (e quindi all’epoca dei fatti di Cannobio), arti e scienza medica avessero raggiunto affermazione e prestigio; dai quali non v’è motivo per esentare il magnifico artium et medicinae doctor dominus magister Aloisius de Mantellis. «4 febbraio – Astolfo de Tassanis, figlio del signor Vittore, abitante del detto Borgo di Cannobio, presentatosi e richiesto di deporre il vero sotto giuramento, risponde alle domande dell’inquirente attestando che realmente l’8 gennaio scorso, circa le 8 di sera, in una saletta situata al di sopra della caminata della casa d’abitazione del signor Tommaso nel Borgo di Cannobio presso la riva del lago, egli vide quella tavoletta affissa alla parete e su cui stanno dipinte le immagini della gloriosa Vergine Maria, della Pietà di Nostro Signor Gesù Cristo e di S. Giovanni Evangelista, e vide che dagli occhi di dette figure ed anche dalle cicatrici del costato e delle mani di detta Pietà usciva sangue vivo; però il sangue che usciva dagli occhi di S. Giovanni Evangelista sembrava mescolato ad acqua. Non vide altro in quella sera perché era febbricitante e lasciò la casa. Ma quando vi tornò il giovedì seguente verso le sette di sera, mentre ginocchioni stava sulla cassa collocata al di sotto della detta tavoletta, con in mano un cero acceso, gli sembrò di notare dei riflessi sulla parte destra del costato della Pietà e d’improvviso sentì che parecchie donne lì accosto dicevano “fateme un poco lume che me casca aqua adosso” o parole simili. Egli allora fece per scendere dalla cassa e in quel mentre s’accorse che la tovaglia e un fazzoletto posto lì sopra erano schizzati da parecchie gocce di sangue fresco, e che sulla tovaglia, in corrispondenza a detta tavoletta, stava una piccola costa sanguinolenta. Additò ciò che scorgeva ai presenti, che tutti a tale vista, e per di più constatando che parecchi tra loro erano spruzzati di sangue fresco, si misero a gridare “misericordia”. E all’istante mandarono a chiamare i signori preti che, come giunsero, asportarono tali cose processionalmente da lì alla chiesa parrocchiale di S. Vittore di Cannobio. 47 Parimenti il testimone dice che lo scorso martedì verso le sette di sera, e pure oggi verso l’ora di pranzo, ha visto che le dette figure dipinte su detta tavoletta stillavano numerose gocce d’acqua, restando così con tali gocce per alquanto tempo per poi asciugarsi da sole. E non sa altro. Richiesto di specificare quale sia la fondatezza di questa sua conoscenza, se fatta in presenza d’altri, in qual luogo e tempo, risponde che di presenza egli ha visto quanto ha deposto, unitamente a detto signor Tommaso e famiglia e a parecchi altri che sarebbe lungo enumerare, nei tempi e nel luogo precisati. Dice di avere circa diciannove anni di età». «Convocato, in quello stesso giorno si presenta il magnifico dottore in scienza medica signor maestro Luigi de Mantellis, del fu magnifico dottore in medicina signor maestro Maffeo. Attesta con giuramento che lo scorso mercoledì 8 gennaio verso le otto di sera mentre se ne stava nella propria casa di abitazione situata nel Borgo di Cannobio, fu chiamato perché andasse a vedere i miracoli che accadevano nella casa d’abitazione del signor Tommaso de Zacheis. Udito ciò, all’istante si mosse e, accompagnandosi al reverendo signor Raffaele de Castiliono, al signor Francesco de Tatis di Varese e a certi altri, andò alla casa d’abitazione del signor Tommaso posta in detto Borgo presso la riva del lago, entrando dalla porta posteriore di detta casa [da via S. Giustina]. Come si trovò nella saletta ubicata al di sopra della caminata di detta casa, vide lì raccolta tanta gente che osservava la tavoletta appesa alla parete di detta saletta e su cui stanno dipinte le immagini della gloriosa Vergine, della Pietà di Nostro Signor Gesù Cristo e di S. Giovanni Evangelista. E come egli, appressatosi a detta tavoletta, si mise ad osservarla con attenzione, vide gli occhi di dette figure pieni di sangue vivo, come pure le cicatrici delle mani di detta Pietà piene di sangue. Però il sangue presente negli occhi di S. Giovanni era chiaro ed appariva mescolato con acqua. E mentre lì si tratteneva per un certo tempo, vide dagli occhi della Beata Vergine e della Pietà fuoruscire gocce di sangue e scorrere lungo le guance delle due figure. Altro sangue vide uscire dalle ferite delle mani e scendere alquanto lungo le mani stesse. In quella sera non vide altro perché se ne venne via. Ma il giovedì seguente, verso le sette di sera, trovandosi nella medesima saletta, vide che parecchie donne inginocchiate dinnanzi alle dette immagini presentavano sui loro abiti, ed alcune sul collo ed altre sulle mani e in viso, parecchie gocce di sangue fresco; e pure la tovaglia che copriva la cassa collocata al di sotto della tavoletta, con quel fazzoletto che in quel momento le stava steso sopra, risultava schizzata di sangue fresco. E vide inoltre che su detta tovaglia, in corrispondenza alla soprastante tavoletta, ma leggermente spostata sulla parte destra della tavoletta, vi stava una piccola costa proporzionata alla figurazione di detta Pietà, sanguinolenta per sangue fresco e vivo. E detta costa egli ritiene senza alcun dubbio sia fuoruscita dal lato destro di detta Pietà. E nell’esaminarla accuratamente riscontrò che essa aderiva alla tovaglia e che aveva lasciato un’impronta curva di sangue sulla tovaglia, pari alla configurazione della costa. Alla vista di tali cose fu convenuto dagli astanti che era bene richiedere l’intervento dei preti di detta Terra di Cannobio. E così si fece. E di lì a poco giunsero detti signori preti che prelevarono la costola, la tovaglia e il fazzoletto e con grande processione trasferirono tutto alla chiesa di S. Vittore di Cannobio. Da quel momento non vide altro; tranne che oggi, verso l’ora di pranzo, avendo sentito che accadevano di nuovo fatti miracolosi in detta casa, subito vi si recò e vide le immagini e pressoché tutta la tavoletta stillare lacrime di acqua chiara, in due riprese: lacrime che vi rimanevano per la durata di un’ora circa e che poi vide asciugarsi da sole. Non sa altro, quantunque abbia sentito dire che le medesime immagini nel mese scorso hanno fatto altri miracoli, ai quali però egli non ha assistito. 48 Richiesto che chiarisca da dove ricavi questa sua conoscenza, se da lui fatta in presenza d’altri, in qual luogo poi, risponde che la sua conoscenza si basa sul fatto d’essere stato personalmente presente e di aver osservato direttamente ciò che ha deposto presenti pure le persone da lui citate e parecchi altri, soprattutto detto signor Tommaso e famiglia, nei tempi e nel luogo precisati. Ha trentatrè anni circa di età». «Lo stesso giorno si presenta il signor Cristoforo de Rotiis de Rantio, del fu signor Gio Alberto, abitante in detto luogo di Ranzo, pieve di Cuvio, ducato di Milano, al presente soggiornante nel Borgo di Cannobio. Richiesto di deporre sotto giuramento, risponde alle domande dell’inquirente attestando che al riguardo dei predetti miracoli sa soltanto dire questo, e cioè: proprio oggi, avendo sentito che fatti miracolosi si verificavano nella casa d’abitazione del signor Tommaso de Zacheis, essendosi recato precisamente in quella casa stessa, in una certa saletta situata sopra la caminata di quella casa, aveva visto le immagini della Beata Vergine Maria, della Pietà di Nostro Signor Gesù Cristo e di S. Giovanni Evangelista dipinte sopra una piccola tavoletta stillare lacrime di acqua viva, e poi rinnovarle; ed una lacrima più grande si era fermata sul petto di detta Pietà; stettero così per la durata circa di un’ora, e poi le vide asciugarsi da sole e non rimanerne più traccia. Non sa altro, sebbene abbia sentito dire che nei giorni scorsi quelle immagini fecero parecchi miracoli, soprattutto emettendo quel sangue che tuttora si può notare disseccato sia all’altezza degli occhi di dette immagini, sia accosto alle ferite della Pietà. Richiesto come può accreditare la conoscenza dei fatti da lui esposti, se altri siano stati presenti, in che luogo e in che tempo, risponde che egli è a conoscenza dei fatti perché vi fu presente, e gli furono riportati e li apprese nei termini suddetti; presenti con lui il signor maestro Luigi de Mantellis fisico, il signor Pietro de Zacheis, il signor Giovanni Antonio Homacini, molti altri di Castiglione [d’Olona] e di Varese, e moltissima gente locale che egli non conosce, nei tempi e nel luogo precisati. Ha trenta anni circa di età». 30 (fascicolo N. 2 – marzo 1996) È questa l’ultima tra le deposizioni raccolte a Cannobio dal Vicario della Curia arcivescovile Ruffino Bilingeri. È del mercoledì 5 febbraio 1522, e, come le precedenti, è rogata dal notaio cannobiese Bartolomeo de Albertinis. Il verbale delle sedute inquisitoriali, come già si è detto, ci è giunto in copia redatta dal figlio di Bartolomeo, Gio Antonio, egli pure notaio. La trascrizione dal latino notarile, già di per sé disadorno, è qui resa stilisticamente povera nel preciso intento di non discostarci dalla scarna relazione dei fatti, come fu rilasciata dal testimone. «Convocato si presenta il signor prete Battista de Buziis del fu signor Antonio, rettore della chiesa di S. Pancrazio di Vedano della pieve di Castelseprio ducato di Milano. Richiesto di deporre, egli giura ponendo le mani sul petto, come è norma per gli ecclesiastici. Ed attesta che in verità, mentre egli sostava sotto i portici di riva del Borgo di Cannobio, vedendo un gran numero di persone correre verso la casa d’abitazione del signor Tommaso de Zacheis ed avendo appreso che detta gente là correva per vedere fatti miracolosi che in quel momento vi accadevano, anch’egli subito si recò in quella stessa casa, e lì salite le scale ed entrato in una saletta, vi scorse appesa ad una delle pareti una tavoletta su cui stanno dipinte le immagini della Beata Vergine, della Pietà di Nostro Signor Gesù Cristo e di S. Giovanni Evangelista. Ed essendosi avvicinato alquanto a detta tavoletta, vide che non solo le figure ma anche la croce lì dipinta e pressoché tutta la tavoletta trasudavano grosse lacrime di acqua chiara che in parte scorrevano lungo la tavoletta ed anche più sotto, su una cassa di legno di sandalo. E quelle lacrime vide rifarsi due volte su detta tavoletta e restarvi per lo spazio di circa un’ora e poi asciugarsi da sole. Altro non vide né sa, all’infuori delle informazioni avute: che cioè le stesse immagini nei giorni scorsi fecero parecchi altri miracoli, soprattutto stillando sangue dagli occhi ed anche dalle cicatrici di detta Pietà, come ancora al presente tale sangue può essere osservato, e appunto lo si nota disseccato agli occhi e alle cicatrici. Altro non sa. 49 Richiesto che chiarisca da dove egli ricavi questa conoscenza da lui fatta, in presenza di chi, in qual luogo e tempo, risponde che conosce le cose da lui dette perché è stato presente, le ha viste, ne fu informato nei termini suddetti, presenti oltre a sé, il signor Giovanni Pietro de Buziis, suo fratello, lo spettabile signor maestro Luigi de Mantellis fisico, il signor Giovanni Antonio Homacini, il signor prete Giovanni Antonio de Macironibus, il reverendo signor Raffaele de Castiliono, il signor Francesco de Castiliono e parecchi altri, forestieri e abitanti di detto Borgo, quanti la saletta poteva contenerne, nei tempi detti e nel luogo precisato. Ha trent’anni circa». Sottoscritto con segno tabellionale: «Io, Giovanni Antonio de Albertinis del fu spettabile signor Bartolomeo, abitante nel Borgo di Cannobio diocesi di Milano, notaio pubblico milanese per imperiale autorizzazione ed avendo l’autorità di trascrivere strumenti e scritture rogate e redatte dallo stesso mio defunto genitore, già notaio pubblico milanese, e ciò in base all’autorizzazione concessami lo scorso anno 1550 dai magnifici signori, alla data, Abati del venerabile Collegio dei signori notai di Milano, ho fatto estrarre fedelmente dall’originale, esistente presso di me, parola per parola le soprascritte testimonianze giurate rilasciate dai suddetti testimoni interrogati dal mio signor genitore, e dopo aver confrontato questa copia con l’originale, mi sono qui sottoscritto apponendo la mia solita cifra, tralasciando tuttavia la deposizione del signor Gio Pietro de Buziis, undicesimo testimonio in quanto imperfetta». È datata al 27 febbraio di quello stesso anno 1522 una dichiarazione perentoria, rogata dall’altro notaio cannobiese Giacomo de Poscolonia a nome di un gruppo eccellente di visitatori. Sono costoro: frate Francesco de Ugenio dell’Ordine dei Frati Minori e guardiano del monastero di Santa Maria delle Grazie del borgo di Bellinzona, frate Benedetto de Leuco di Milano, entrambi in quei giorni “predicatori della parola di Dio” nel borgo di Cannobio; frate Benedetto de Padono e frate Agostino di Varese, pur essi di detto Ordine, al momento residenti a Cannobio; il signor prete Bernardino de Meno, arciprete della chiesa di San Vittore di Calcio, cappellano del conte Federico Borromeo; il signor Bonaventura de Ascona, milanese; gli aronesi signor Giacomo Cotta e Stefano Chirono; Ambrogio del fu Giovanni Arlino di Pallanza, Bernardino Abondis di Bellinzona, Tonino figlio di Protasio de Cannobio, abitante a Locarno; Bernardino di Crana di Vigezzo; Ludovico Suardo di Milano, Giovanni fu Bondelli di Stresa e Pagano fu Romanolo di Orgnana di Gambarogno, e parecchi altri, borghigiani e forestieri. Con molta enfasi (e siamo soltanto al 27 febbraio 1522), perché la verità sempre emerga e rifulga agli occhi di tutti, a vantaggio di coloro che avvertono quanto siano importanti le cose da loro dichiarate, unanimemente e singolarmente dichiarano recisamente quanto segue. Mentre nel borgo di Cannobio essi sostavano nella casa di Tommaso Zaccheo posta alla riva del lago, e precisamente in una certa camera o locale superiore alla caminata, ove sta appesa una tavoletta con dipinte le figure del sacro Corpo di Cristo in sembiante di Pietà eretto sul sepolcro, e di Sua madre la Vergine Maria, e del beato Giovanni Evangelista, con i contrassegni della Passione, in quel momento, a notte fonda, in detta camera fortemente illuminata cum maximo lumine, hanno osservato con piena evidenza expresse et manifeste su dette immagini la presenza di un certo liquido nonnullum liquorem quasi fosse sangue vivo in modum sanguinis viventis soprattutto sul corpo di Cristo, che sembrava fosse stato di recente flagellato. E questo durò e fu notato per quasi due ore Il documento risulta redatto nella camera stessa suindicata, alla presenza del dottore Luigi fu maestro Maffeo de Mantellis, del signor Luigi fu Donato de Zacheis, del signor Francesco fu Gabriele de Postcolonia e di Bernardino fu Stefano Monaco de Pizaliis. Nel 1696 viene edita a Milano la Relatione de’ miracoli avvenuti nel borgo di Canobio. Lì si giunge alla terza fase: se allo smarrimento tremebondo dei più immediati testimoni era subentrato il compiaciuto cristiano orgoglio di poter attestare le opere di Dio (vedi sopra), ora la parabola discendente devozionale si completa con un racconto propinato aggiungendovi il deleterio ingrediente del mirabolante. 50 Ed anche in seguito, chi più ne ebbe più ne mise. Ne diamo un assaggio, ricavandolo da quanto fu scritto in occasione del quarto centenario del Miracolo di Cannobio. «Nella casetta... facevasi osteria... La sera dell’8 gennaio 1522 stavano riscaldandosi al caminetto alcuni avventori che discorrevano (ohibò!) della miseria dei tempi... della nomina del papa Adriano VI... della guerra nel Milanese... del marchese di Pescara e di Prospero Colonna... Elisabetta ordina alla figlia Antonietta di andare al piano superiore... e questa obbediente accende un cero e ascende le scale; ma giunta alla porta della saletta, il lume arcanamente si spegne (e si spegnerà tre volte, ma quella, capite?, testardamente per tre volte lo riaccende! Entra nella saletta, e qui...) una forza misteriosa la afferra per i capelli e la costringe a guardare alla parete di fronte (dove stava appesa la tavoletta. E la bambina grida spaventata). Al rimbombo di cotal grido... accorrono i famigliari... e in un baleno la saletta è ripiena di gente accorsa a vedere l’annunciato prodigio... La luce era tenue e il raccoglimento dominava l’assemblea adoratrice. All’improvviso tutti gli astanti sentonsi bagnare di liquido umore il viso, il collo, le mani, le vesti, come se la pioggia stillasse dal cielo aperto!». Ma qui ci manca la forza d’animo per proseguire. 51 1 (fascicolo n. 6 – luglio-agosto 1996) La gente di Cannobio volle il suo Santuario, e nei più disparati modi, riassumibili in oblazioni di centinaia di migliaia di uova, di altrettante migliaia di anguille trote e cavedani... e poi... cosce di agnello, archibugi e spade... il tutto... per mesi ed anni, ininterrottamente per oltre due secoli. Praticamente i santuari si differenziano da ogni altro luogo di culto per il credito vero o presunto di cui godono: di funzionare come canali preferenziali per il sollecito disbrigo di pratiche personali con la Provvidenza. Come tali, ovviamente, stanno inseriti in una graduatoria di merito fissata in base alla loro maggiore o minore affidabilità, alla caratura più o meno gratificante del presunto intervento soprannaturale che ne ha segnato l’origine. È consuetudine che vi si acceda pellegrinando; è di prammatica che il ceto ecclesiastico vi svolga fruttuosa intraprendenza promozionale; che lì convergano le copiose elargizioni di personalità non immemori del proprio aldilà; non ci si stupisce se la decrescenza devozionale li sfoltisce qua e là, purché permangano a conforto delle nostre infermità quelli di Lourdes o di Compostella. È quanto genericamente si può dire dei santuari; ma spiacerebbe assai se i Cannobiesi, anche i più D.O.C., avessero perso memoria della tipicità del proprio santuario della Ss. Pietà. Al riguardo occorre fare tutt’altro discorso: si tratta infatti di una vicenda minuziosamente documentata, eppure ancora tutta da raccontare, perché la si è lasciata insabbiare, surclassare da certa artificiosa oratoria chiesastica venuta in voga tra Seicento e Settecento (e purtroppo importata anche a Cannobio), di pronto effetto e di cialtrona qualità. Le si può imputare di aver inquinato l’attendibilità delle scarne testimonianze dirette, di aver stravolto le ambientazioni e declassato i connotati dei protagonisti, e con barocche manipolazioni d’aver immiserito episodi di per sé altamente drammatici riducendoli a ballons d’essai. Schematicamente: la storia del santuario della Ss. Pietà presenta aspetti del tutto originali, non riscontrabili altrove, e talmente provati da rendere superfluo ogni velleitario sciovinismo. È arcinoto che il quadretto della Pietà trasudò acqua e sangue tra gennaio e febbraio del 1522, là ove poi fu eretto l’attuale santuario. Ma non si è posta attenzione alcuna alle dichiarazioni ufficialmente rese in quei giorni: che nel borgo, già atterrito dalle scorribande militari di quei tempi, ciò che stava accadendo sotto gli occhi di tutti, laggiù in riva al lago, in una delle case borghesi e precisamente nell’abitazione dei signori Zacchei, fu visto come ancor più oscuro e allarmante presagio di collera divina e di castighi incombenti. Non per nulla si gridò atterriti «Misericordia», e non esultanti «Al miracolo». Rimase nell’ombra il Capitolo di San Vittore, estraneo l’Arcivescovado milanese, marginale il Casato dei Borromei. La pronta mobilitazione fu dei Borghigiani, laicamente guidata dai loro Notabili. E con incessante quotidiana oblazione di denaro e di qualsiasi cosa avesse un pur minimo valore venale fu sovvenzionata la ristrutturazione delle stanze al primo piano della casa, ben presto ceduta alla comunità dal signor Tommaso per farne un luogo sacro. E questo fu chiamato non a caso “la Devozione”: infatti non intendevano i Cannobiesi saldare un debito di riconoscenza al buon Dio per il miracolo glorificante a loro elargito, bensì scongiurare ulteriori sventure riservandoGli a mò di caparra, quale omaggio ligio, ossia di devota fedeltà, per il momento un luogo a Lui consacrato, e ripromettendosi – non appena le avversità congiunturali lo avessero consentito – di dedicarGli un edificio il più possibile sontuoso e degno di Lui. Tutto questo ce lo hanno lasciato scritto a chiare lettere. 52 La Devozione veniva dunque a collocarsi al di fuori della tradizione dei santuari-dispensa di grazie personalizzate, come peraltro se ne ha conferma dall’assenza, a lungo protratta, di quegli abituali attestati o ex-voto che servono bellamente ad accreditare il prestigio di un santuario. A Cannobio il richiamo fu ben altro, ben più forte e diretto, e si mantenne immutato fino a che fu raggiunta la totale esecuzione di quanto era stato inizialmente progettato: un’operazione che si sviluppò lungo un arco di tempo di quasi tre secoli. Ed è possibile ricostruirla in ogni suo dettaglio perché registrata pressoché quotidianamente nelle pagine dei tre grossi volumi di contabilità di cassa dai tesorieri della Confraternita della Ss. Pietà. Un resoconto con migliaia di voci di entrata e di uscita – il dare e l’avere di quei tempi: vi si possono ricavare ambite informazioni sui tempi di lavorazione, sulla composizione delle maestranze, sull’apporto dato all’erigendo santuario da architetti, scultori, decoratori, pittori, orefici. Ma soprattutto vi sta evidenziato un dato che obbliga a riconsiderare con estrema attenzione ciò che accadde nella saletta di casa Zaccheo in quei primi giorni del 1522. Perché altrimenti rimane inspiegabile come la gente di Cannobio abbia potuto ostinatamente volere codesto suo santuario: essa sola (a prescindere dalle poche lire elargite in due soluzioni dal cardinale Federico e dal conte Giberto) e nei più disparati modi, riassumibili in oblazioni di centinaia di migliaia di uova, di altrettante migliaia di anguille trote e cavedani... e poi “gipponi”, anelli, cosce di agnello, archibugi e spade, pani di burro e scarpe dismesse o guardaroba dei propri defunti; il tutto messo all’incanto per coprire le spese della costruzione, per mesi ed anni, ininterrottamente per oltre due secoli. Queste cose i Cannobiesi d’oggi forse le ignorano, ma varrebbe la pena che ne recuperassero la memoria. È la più bella storia del loro Borgo. 2 (fascicolo n. 7 – settembre 1996) Trascriviamo qui dal foglio 137 del libro mastro della Schola o Confraternita della Ss. Pietà di Cannobio per gli anni 1615-1645 la registrazione fatta dal tesoriere Francesco Rossetti: Si sono cavatte lire 548 soldi 12 denari 6 d’elemosina à effetto per far comprare una lampeda dargento per la nostra cappella, li quali dinari si sono racolti per la cercha fatta per il nostro borgho sin adì 13 magio 1635, compresi ducati n° 12 havuti dal signor Gio Antonio Homacino per la fracia del signor Marcho Baddi suo gienere. Chiariamo subito che fracia era detto lo scotto in danaro estorto con gioviale e tradizionale ribalderia dei giovani borghigiani da chi passando a nozze “tradiva” il celibato o la vedovanza Al successivo foglio 141 lo stesso tesoriere annotava tra le spese: si è pagato lire 1501 soldi 12 al signor Gio Ambrogio Schagno horefice in Milano al segno del Melone per saldo de lire 2114 soldi 10, l’ammontare della lampeda dargento havuta dal suddetto sì come per sua lista e confesso (quietanza). Della lampada si è persa memoria e lugubremente ci chiediamo quale ne fosse il valore: artistico, monetario, testimoniale. Valore artistico: ebbene, si tenga presente che dello Scagno esiste una pregevole opera persino alla Certosa di Pavia. Valore monetario: potremmo tradurre il prezzo della lampada nella valuta d’oggi. Ma è più efficace commisurarlo sulla disponibilità finanziaria dei borghigiani, dato che essi, come risulta, furono i principali committenti. Allo scopo disponiamo di alcuni riferimenti approssimativi, sapendo che le retribuzioni giornaliere dei più comuni mestieri oscillavano dai 18 soldi per gli apprendisti ai 35 per l’operaio finito, ai 45 per il qualificato. Anche l’eterogenea serie delle cose che i Cannobiesi mettevano all’incanto – e che rappresentarono il più consistente cespite per finanziare la fabbrica del Santuario – ci consente un abbozzo di paniere casalingo: il costo di un uovo s’aggirava su un soldo; per una libbra di burro (8 etti circa) si pagavano 10 soldi, per un pane 6 soldi, per una libbra di pesce 18 soldi (11 gli agoni, 17 le anguille); una formaggella valeva all’incirca 20 soldi, un pollo dai 10 ai 15 soldi; per un boccale di vino (un litro circa) occorrevano tre soldi e mezzo. 53 Tenendo ora presente che 12 denari facevano un soldo, e 20 soldi facevano una lira, ne ricaviamo che le 2114 lire e 10 soldi della lampada d’argento significavano 2460 giornate lavorative di un garzone o 984 di un operaio qualificato; oppure equivalevano al costo di 3530 polli, di 3524 dozzine d’uova, di 12082 boccali di vino, eccetera eccetera. Messa in questi termini, veridici e solo apparentemente banali, la riaccensione emotiva per la lampada d’argento, che si verificò nel borgo in quel 1635 (si badi, a distanza di 113 anni dal fatidico 1522, l’anno del “miracolo”, o presunto tale per chi si reputa smaliziato), e che coinvolse una discendenza di Cannobiesi ormai giunti alla quarta o quinta generazione, mal si presta a configurarsi come un collettivo revival ante litteram, se non altro perché a differenza di quelli oggi in voga era finanziariamente autolesivo, e doveva risultare quanto mai indisponente per la comunità del borgo, e indecoroso per la Confraternita della Ss. Pietà. Basti ricordare che la gente del borgo si cimentava da oltre quarant’anni con la fabbrica del santuario: un’impresa tecnicamente impegnativa ed oltremodo costosa per la prossimità alla riva del lago. Per far fronte al disavanzo di cassa, si erano escogitati i più originali espedienti: oltre alla pressoché quotidiana somministrazione d’ogni cosa che messa all’incanto facesse denaro, erano state disseminate cassette d’elemosina dentro e fuori San Vittore, le si erano piazzate sulle barche dei traghettatori di mestiere, all’ingresso della guardina comunale, tra i banchi del mercato, all’esattoria, negli uffici del dazio e persino in quello dei giudici di pace. Si andavano racimolando i più disparati contributi: basti dire che i maestri di scuola avevano tramutato le sanzioni disciplinari in ammende pecuniarie, e la gioventù “brava” del borgo appostava ormai chiunque, indigeno o brinzaghese o asconese o intrese che fosse e capitasse a Cannobio per prendervi moglie, onde estorcere goliardicamente la “fracia” a pro della fabbrica della Pietà. E questa, finalmente, nel 1612 trovava compimento nella copertura del tiburio mediante lastre di piombo: 3029 lire di solo materiale e un pesante disavanzo di cassa, solo in parte rimediato grazie a prestiti, concessi a tasso zero dai borghigiani meglio attrezzati. Due anni dopo restavano ancora da pagare i barcaioli che avevano traghettato i quintali di piombo da Porta Ticinese lungo il Naviglio, e poi per lago sino a Cannobio. Ma già nel 1617 veniva stilato un nuovo contratto con lo stuccatore Taddeo Querini di Lugano perché decorasse con statue e fregi in rilievo il coro della Pietà: per la sua prestazione artistica fu concordato un compenso di 1200 lire, a cui si aggiunsero le spese per i materiali impiegati, “vergelle di ferro, marmore masnato, calce sabbia e quadrelli, pignatini e cadini di legno”, nonché 60 lire per i 280 boccali e 1/2 di vino a sostegno dell’estro degli stuccatori, oltre alle spese per il loro alloggio. Tre anni dopo, nel 1620, fu la volta dell’orefice milanese Defendente Besa, che su ordinazione confezionò la cassa d’argento in cui venne riposta la Sacra Costa. La fattura del reliquiario comportò un esborso di altre 462 lire. Seguì a ruota, nel 1621, il fonditore Luca Borella di Lugano, a cui venne commissionata una campana di oltre due quintali: occorsero 4 moggia di carbone e 435 lire di manodopera. È dell’ottobre 1628 il deposito di una caparra di 20 ducati, effettuato presso il fondegaro di Varese Gaspare Masnago, con cui si impegnavano i maestri scultori Ludovico e Nicola de’ Rossi di Arzo ad allestire la balaustrata in marmi dell’altare della Pietà. E questo sarà architettonicamente rinnovato a partire dal 1636 (quindi non appena acquistata la lampada d’argento di cui s’è detto) ad opera degli scultori Pietro Giacomo Verda e Francesco Rusca Castello, e con la supervisione degli ingegneri Crivelli, Maraviglia ed Herlichino. Di conseguenza vennero rifatte le decorazioni del coro dallo stuccatore Pisoni, mentre la ricollocazione dell’ancona gaudenziana abbisognò dell’intervento del pittore De Giorgi, che curò anche il restauro dei quadri laterali all’altare e degli affreschi della volta sovrastante e del cupolino. E lui ebbe pure la committenza dei quattro quadroni con le Storie del Miracolo, poi debitamente incorniciati dal maestro di legname Gian Angelo Bruni, con dorature di Giuseppe Antonio Rostino, entro i contorni marmorei eseguiti da Giovanni Pellegatta marmoraro di Viggiù. 54 Seguirono nel tempo l’allestimento della cappella di san Lorenzo e l’affrescatura della navata centrale ad opera di Cristoforo Giussani d’Angera, la fornitura di altre due campane, gli interventi di Bartolomeo Tiberino d’Arona per il “depositorio” in San Vittore, e nel Santuario per “l’antina” del quadretto della Pietà. Ci si chiedeva, in apertura, quale fosse il valore testimoniale di una lampada d’argento, comprata per 2114 lire e 10 soldi nel 1635: nulla più che una domanda artificiosa, come ben si arguisce dalla serie di segnalazioni qui a bella posta condensate, e che non mancheranno certo di mettere sul chi vive i cultori d’arte. Diciamo meglio, la questione va riproposta in questi disadorni ed inquietanti termini: «Ma chi e che cosa gliel’ha fatto fare ai Cannobiesi?». 3 (fascicolo n. 9 – novembre-dicembre 1996) Non mi ritengo un sognatore. Ma quando leggo ciò che don Crenna ci offre, sogno quel giorno... in cui si scoprirà il progetto del Santuario commissionato da S. Carlo all’architetto Pellegrino Tibaldi; in cui si troverà la spiegazione della nicchia all’interno del campanile; in cui sarà chiara la ragione per cui fin oltre la metà del ‘600 non ci sono ex voto... Intanto, mentre si lavora su “le sudate carte”, un sogno si sta realizzando, presto verrà dato alle stampe. A pag. 20 del volumetto di G. Zaccheo e C. Bernardi, I lüminéri, la festa della Pietà di Cannobio, leggiamo: «Sulle modificazioni e traversie della festa della Pietà nell’Ottocento non abbiamo ragguagli precisi e puntuali». Va detto che al riguardo disponiamo di notizie sicure, a cominciare dal 1575, da quando nella confraternita della Pietà prese inizio la registrazione bilanciata di entrate (il dare debitorio del tesoriere) e di uscite (l’avere creditizio dello stesso): erano in quell’anno iniziati i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’oratorio originario, la cosiddetta “Devozione”. Si tratta di una serie ininterrotta di dati che si estende fino al 1778, relativi dapprima ai soli «officij fatti alla Santa Giesa, il giorno della solennità di detta Devocione» l’8 gennaio e, ad iniziare sicuramente dal 1585, alla loro reiterazione voluta da san Carlo al lunedì di Pentecoste o seconda festa di Pentecoste: «come fu ordinato dalla Gloriosa Memoria di San Carlo» perché in periodo meno inclemente tanti altri potessero essere ammessi «al Sagro Baccio della Sagratissima Costa». Disponiamo dunque di un tracciato sui generis, eppure suggestivamente descrittivo della crescente intensità del pio richiamo esercitato dalle due ricorrenze, sostenuto dalle invenzioni di connotazioni esteriori atte a propagarne l’ascolto: dapprima una contenutissima spesa di addobbi con fronde di nasso comprate in val Cannobina entro coinvolgenti odori d’incenso e di storace, per poco più di 25 lire, tutto compreso, anche l’obolo per l’officiante; poi, con l’accrescersi delle strutture portanti e con la gettata della volta grande del nuovo santuario, al finanziamento ostinato dei soli borghigiani s’aggiunse il contributo esterno dei pellegrini, e l’apparato devozionale assunse toni fastosi. E comparvero i musici di Pallanza, poi il gruppo aronese di trombetti e timpani, poi i complessi musicanti ancor più forestieri corredati di regale, sino ai cantanti di grido provenienti da Milano. Alle fronde di nasso si aggiunsero le tappezzerie; alle voci melodiche gli scoppi dei mortaretti caricati con crusca e il crepitio degli archibugi, con sempre più abbondanti provvigioni e scorte di polvere nera comprata ad Ascona. E non mancarono i falò. Prese piede la tiratura dei libretti contenenti la “relatione del Miracolo”, con frequenti riedizioni, “aggiornate” con qualche fantasia di troppo; non si fecero mancare i due-tremila inviti annui distribuiti su larga scala. Lievitò anche la spesa che raggiunse le 200/400 lire al colpo; però nel contempo si riuscì a piazzare il tiburio con copertura in pesanti lastre di piombo, si completò la struttura della cappella grande, si passò alle decorazioni, ai marmi, agli stucchi, ai quadri. 55 Un impegno costante, una dedizione ammirevole compensata da successo, tant’è che nel 1726 maturò l’«Ordinazione dei Confratelli di far esponere ogni anno nel giorno 9 gennaio nella chiesa collegiata di S. Vittore la Sagra Costa ad un hora di notte in circa, con una previa processione di tutte le Scuole [confraternite], che s’incomincia nella chiesa di S.ta Pietà; e questo in memoria del giorno ed hora in cui è uscita miracolosamente dal sagro quadretto; et in questa occasione si fa un discorso nella suddetta chiesa di S.to Vittore, rammentativo del benefizio». In una successiva disposizione del 16 gennaio 1729 leggiamo: «Convocati e congregati li signori priore e deputati della veneranda Scola del Ss.mo Miracolo, abbiamo risolto di concludere, per maggiore gloria di Dio, di proseguire l’incominciata fonzione nella chiesa di S.ta Pietà, cioè il giorno 9 di gennajo, dopo l’antecedente festa in cui successe il grande miracolo, unite le Scole nella suddetta chiesa, coll’intervento del venerando Capitolo e reverendi Padri Capuccini; e portandosi dalla suddetta chiesa di S.ta Pietà alla Collegiata di S.to Vittore alle hore 23 circha per ivi colà adorare quel Sacro Pegno che Iddio ci ha donato per suo amore, dove si vede con grande concorso di tutto il popolo quello adorato, e con panagiricho di facondo horatore per maggiormente animare il popolo a sì santa divozione. Similmente si propone il proseguire anche la di già incominciata fonzione nelli anni scorsi, cioè nella terza festa di Pentecoste, e questo a fine di dare il comodo al popolo di Canobio per il bacio. Vedendosi che ogn’anno cresce sempre più il numero de’ Popoli forastieri, quali concorrono all’adorazione della Sacratissima Costa, et riflettendo anche non esser possibile nella seconda festa di Pentecoste, come fu ordinato dalla Gloriosa Memoria di San Carlo, admetter tutti i concorrenti al Sagro Baccio di quella, con quella riverenza et divozione che si richiede, congregati noi deputati et officiali della veneranda Scola di S.ta Pietà, a cui aspetta provedere a questa fontione sì santa, ordiniamo che si debba far cantar messa et vesperi solenni la terza festa di Pentecoste nella Collegiata di San Vittore, et che si esponga la detta Sagratissima Reliquia in quella giornata, a fine di poter ammetter al Sagro Baccio di quella il Popolo di Cannobio, che avrà datto luogo a’ forastieri il giorno antecedente; pur che sia concessa la facoltà dall’eminentissimo signor Cardinale Arcivescovo, dal quale si spera ogni grazia a favore e beneficio delle Anime nostre». Fu certamente un saggio smistamento onde evitare ressa ed incrementare il concorso dei pellegrini. Ma affinché tali accorgimenti non degenerassero in virtuosismo devozionale troppo finalizzato ad incrementare i proventi di bussola, il 20 agosto 1758 i confratelli della Pietà ridussero le disponibilità di spesa assegnate al priore «nella forma come siegue, cioè: che la Scuola suddetta non debba d’oggi in avanti passare a cadauno priore che sole lire 326, cioè lire 126 per la festa di genaro e lire 200 per la festa di Pentecoste, proibendo espressamente alli signori priori d’oggi in avanti il fare fonzioni di musica e sinfonia ed altre superflue spese come per lo passato, e ciò per anni sei a venire, incaricando però a detti priori il fare dette fonzioni con decente apparato e sbarro de mortaletti»; beninteso, purché anche in questo non si degenerasse, come si deduce dalla denuncia di una santabarbara collocata in modo alquanto improvvido: «1761, 21 maggio. Ordiniamo che nell’oratorio sotterraneo [del santuario] o in altro sito non si permetta mettervi polvere da schioppo od altro e, nel caso che vi si trovi indebitamente, si rimuova sotto pene a noi arbitrarie rispetto al sagrista che darà il ricovero. Carlo Cassirago, cancelliere della visita». Ma di certo qualche priore, forse anche per eccesso di zelo devozionale, dovette scalpitare contro codeste limitazioni finanziarie, tant’è che in data 8 agosto 1763 troviamo rinnovata per altri sei anni la suddetta ordinanza, «perché così si stima per il maggior vantaggio della chiesa, come anche per facilitare ad intervenire li soggetti ad accettare la carica di priore» Tale prescrizione doveva dunque, a giudizio della confraternita, durare fino all’agosto del 1770; ma il priore tesoriere signor Giovannino Zoppi la pensò decaduta allo scadere del sesto anno, cioè nell’agosto 1769. Perciò, nel giugno 1770, «per le feste di Pentecoste in occasione della fonzione, per intiero, con musica e sinfonia» si ritenne legittimato a spendere ben 279 lire e 15 soldi. Ne sorse questione. 56 Per troncarla «ed operare con prudenza fu conchiuso di portarsi ambe le parti dal signor dottor Muggietti, presentaneo giudice di Cannobio, e comunicargli le rispettive ragioni per stare a quanto si sarebbe da lui verbalmente deciso. Il giudice dichiarò che l’ordinazione del 1763 doveva intendersi terminata nel 1769, onde la congregazione fu necessitata accordare al detto signor priore quanto di elemosine si era da lui appropriato con notabile danno della chiesa, perché tale funzione fu fatta con musica e sinfonia come si praticava prima delle citate prammatiche [con spese che toccavano le 500 lire]. Donde nel bilancio dei conti fatti si era riconosciuto che la spesa aveva assorbito l’ordinario cavato, peraltro scarso a motivo del pochissimo raccolto. Di conseguenza l’8 settembre 1770 la congregazione ha determinato di dare le seguenti prammatiche provvidenze: 1°. Li priori che saranno pro tempore per la fonzione di genaro li sarà sovvenuto dalla chiesa, solamente e non altro, lire centoventinove, e per la fonzione di maggio cioè di Pentecoste lire duecento, raffermando quanto era stato ordinato nelle prammatiche 20 agosto 1758 e 8 agosto 1763, con che però li priori che succederanno debbano fare la fonzione decentemente con sbarro de mortaletti e qualche contorno di cendali [festoni] semplicemente al cornisone della chiesa ed alle fenestre della capella maggiore, secondo si è introdotto e praticato in questi ultimi anni dopo d’esser stata ristaurata delli stucchi e fregiata con li novi quattro quadroni; proibendo però ulteriore apparato ancorché li priori soddetti volessero spendere del proprio. Che se poi qualche priore volesse far dette fonzioni con musica e sinfonia, fochi arteficiati ed altra spesa, riservato quanto sopra, si dichiara che sarà detta ulteriore spesa di musica sinfonia e fochi a carico di quel priore e la chiesa non dovrà essere aggravata per niente di più a quanto sopra resta espresso, avertendo però che tutte le elemosine che si ricaveranno, sì in chiesa che fuori, dovranno sempre essere ad utilità e beneficio e di ragione della detta chiesa, come pure le lire dodeci che passa il Borgo per la terza festa di Pentecoste». Un richiamo qui non dovrebbe guastare: ripartiamo dal 1575. Allora, e negli anni successivi, l’8 gennaio e il lunedì di Pentecoste erano per i Cannobiesi «i Giorni del Perdono», perché tutti – e i giovani che avevano sentito raccontare, e i vecchi che avevano visto – provavano ancora un brivido se richiamavano alla mente ciò che era accaduto in casa Zaccheo tra le grida di “Misericordia!”. Poi, tra musiche, mortaretti e devozioni prevalse “la festa dei lüminéri”. Seguono gli articoli monotematici pubblicati sulla rivista 57 (dal fascicolo N. 2 – marzo 1994) Per una storia del Santuario 19 Per chi vuol saperne di più… Ho letto con attenzione questo brano di don Crenna a proposito delle “tre chiavi”. Quando il Signore decise di compiere il Miracolo a Cannobio non chiese parere a nessuno, ce l’ha regalato quale dono prezioso. Quando si è dovuto “gestirlo”: onorarlo, farlo conoscere... si son presi per i capelli. Don Crenna mi perdonerà questo richiamo biblico fuori luogo, ma non troppo. La storia si ripete. Gesù – narra il Vangelo – entrò in Gerico e l’attraversò, circondato da molta folla. Parlò, compì miracoli... poi – raccontavo ai ragazzi – si fece avanti il Sindaco, responsabile civile della città, e lo invitò a casa. Con inchini e gesti il Capo della Sinagoga, responsabile religioso della città, fece intendere di essere onorato di ospitarlo nella propria casa. Lui tirò diritto; giunto sotto l’albero dov’era salito Zaccheo, che voleva vedere Gesù ma era piccolo di statura, guardò all’insù e disse: «Scendi giù! Nella tua casa oggi voglio fermarmi». «Grazie», esclamò Zaccheo. «Signore, desidero destinare la metà dei miei beni per aiutare i poveri». Intanto il Sindaco e il Capo Sinagoga, per l’occasione perduta, discutevano sull’opportunità che Gesù avesse chiesto ospitalità in casa di un esattore di tasse considerato pubblico peccatore. La gente – i devoti pellegrini – continua a seguire Gesù con una chiave sola, quella che apre il cuore. Si tratta di un usciolo in noce scuro, ad una imposta, tutto scolpito con figure in gran rilievo. Sta in San Vittore, infisso sulla parete di sinistra, alquanto in alto, proprio a lato dell’altar maggiore dalla parte del Vangelo. Sul lato del battente due toppe stanno ad indicare una doppia possibilità di chiusura. E di una terza serratura è fornito un cancelletto di ferro retrostante, pur esso posto a custodia di un vano ricavato entro lo spessore del muro: oggi inutilizzato, ma in tempi meno recenti lì erano riposte le insigni reliquie della Ss. Pietà. Infatti, eccettuando il quadro del “miracolo”, sempre rimasto là dov’era, in casa Zaccheo, nella saletta subito trasformata in luogo di devozione, tutti gli altri oggetti “toccati” dal miracolo, ivi compreso il calice con la “sacra costa”, vennero raccolti e custoditi al gran completo in San Vittore. Fu una risoluzione estemporanea e d’emergenza, che diede avvio a situazioni tutt’altro che pacifiche; anzi, ben presto fu maretta tra le due componenti del Borgo, laica ed ecclesiastica, e si evitò che finisse in burrasca quando si pose di mezzo il vescovo ausiliare Francesco Ladino, appositamente a ciò delegato dal vicario generale della diocesi milanese Giovanni Maria Tonso. Insistenti erano state le richieste di un intervento dall’alto avanzate dagli ottimati del Borgo. Non ci risulta che si fossero altrettanto mossi il prevosto e i canonici: da parte loro nessuna sconfessione dei fatti accaduti, ma anche nessun compiacimento per quel “decentramento devozionale” che, a seguito del miracolo, andava prendendo piede, caldeggiato com’era dai notabili, e sempre più diffusamente dai borghigiani. Il clero locale non se la sentiva di attribuire interesse alcuno al progetto d’un sacello – e addirittura di una chiesa – se non fosse stato di sua esclusiva competenza; anzi, nutriva forti dubbi che mai tale progetto si sarebbe concretato in una futura rendita beneficiale di qualche consistenza. 58 Semmai, tirando le somme, una buona combinazione risultava essere l’acquisizione di tutti i “prodotti” tangibili del miracolo: veli e panni segnati di sangue e, beninteso, la Sacra Costa. Segni ostensibili, questi, devozionalmente conturbanti, e dunque da non mollare perché sarebbero serviti da richiamo per i cultori della nascente devozione alla Ss. Pietà, facendoli così dirottare a tutti gli effetti su San Vittore. La divergenza, nel giro di qualche anno, si era fatta assai complessa. Infatti: 1) la trasformazione della saletta del miracolo in oratorio è significativamente voluta dai notabili, ma non entusiasma, anzi riesce ostica al prevosto e ai canonici; 2) dovendo prendere una decisione, è giocoforza o appoggiare l’iniziativa della fabbrica, o accantonarla; in entrambi i casi una delle parti “perderebbe la faccia”; 3) la conseguenza più grave si avrebbe se perdente fosse la parte laica: per i riflessi negativi sulla già discussa consuetudine che «Comune e uomini» di Cannobio debbano provvedere ad ogni necessità di culto in San Vittore (onus providendi rebus necessariis sacrastiae ecclesiae sancti Victoris) e soprattutto farsi carico dell’ordinaria manutenzione ed ancor più delle riparazioni straordinarie alla chiesa stessa (sed etiam reparationi seu provisioni dictae ecclesiae). 4) La sdoppiata presenza di reliquie, in San Vittore e nella saletta-oratorio della ex-casa Zaccheo, comporta una duplicità di introiti di cassa; non potranno infatti mancare – sia qui che là – le oblazioni ed elemosine provocate dalla pia mozione degli affetti: denari, ovviamente, da destinare ad opere di religione. Ma qui sorge il dilemma, se affidare l’amministrazione dei proventi sacri ai maggiorenti laici che bramano la fabbrica d’una chiesa sul luogo del miracolo, ovvero agli ecclesiastici di San Vittore che sembrano marciare in tutt’altra direzione. In tal caso, però, occorre tener conto che per norma consuetudinaria sono di esclusiva spettanza del Comune e degli Uomini di Cannobio – perché possano far fronte alle necessità della loro chiesa – tutte le oblazioni solite darsi in occasione di funerali, d’impiego di stendardi, croci, paramenti sacri, immagini ed ornamenti, suono di campane ecc. (omnia emolumenta quae provenient ex sepulturis, paliis, crucibus, angelis, planetis, tonesellis, campanis et aliis apparatibus), incluse anche le rendite canonicali del primo anno di nomina. 5) Per ultimo: qualora si realizzasse la progettata nuova chiesa, chi ne dovrà garantire l’esercizio del culto in tutti i suoi aspetti, liturgici ed amministrativi? Se poi tale chiesa dovrà costituire il polo devozionale che testimoni il miracolo ad onore della Ss. Pietà, le reliquie depositate in San Vittore, con annesso gettito di elemosine, a chi spetteranno di diritto? Dunque un groviglio di istanze e di mugugni, di prerogative canoniche ecclesiastiche e di inveterate consuetudini comunitarie. Per buona sorte a dipanare la matassa bastò la qualificata destrezza giuridica di mons. Ladino, non per nulla Decretorum doctor. Con accorto dosaggio delle rivaleggianti supponenze, riuscì con autorevole mediazione a varare un concordato sottoscritto dalle parti – podestà e consiglieri, prevosto e canonici – convenuti alla sua presenza in San Vittore, il 21 aprile 1526. Restava stabilito che tornava a gloria di Dio e a lode della religiosità cannobiese la fabbrica di una chiesa, quale decoroso attestato sul luogo stesso del miracolo. Tutti i proventi, comunque e ovunque derivanti dall’immagine della Ss.Pietà e da ogni altra reliquia ad essa pertinente, erano da utilizzarsi esclusivamente per detta fabbrica. Erano competenti, in tutti i sensi, fino al compimento dell’opera e successivamente per la sua conservazione e funzionalità, unicamente ed esclusivamente sei laici designati dalla comunità in base alla loro rispettabilità, ed inquadrati ecclesiasticamente, perché assoldati nell’apposita confraternita della Ss. Pietà, tempestivamente eretta. A costoro era devoluta in toto l’amministrazione degli introiti di tutte le chiese del Borgo – ivi compreso San Vittore – escludendo da allora in poi ogni ingerenza del clero locale. A nome della comunità i sei delegati si assumevano però l’onere di provvedere a tutte le occorrenze del culto e di mantenere la consueta elargizione annua di 12 lire imperiali al prevosto e ai canonici, quale attestazione della loro preminenza ed onorabilità; agli stessi spettavano anche le elemosine ottenute dall’amministrazione sacramentale e le offerte raccolte alla Messa solenne di Natale e di Pasqua. 59 La trasparenza amministrativa veniva garantita da un inventario annuale di tutti i proventi e da una doppia registrazione contabile, tenuta dal tesoriere designato e vistata a tempi debiti dai sei delegati, con facoltà di verifica estesa al prevosto di San Vittore. Altrettanto controllate erano le due cassette, in San Vittore e alla Devozione, corredate entrambe da tre serrature, le cui chiavi erano affidate rispettivamente al podestà, al priore della confraternita, al prevosto o ai loro delegati. Per aprirle fu stabilito che fossero consenzienti almeno due dei tre depositari, nel qual caso quod tertius teneatur et ipse accedere cum sua clavi. Vale a dire: dinnanzi all’usciolo di noce scolpito, di cui si è detto all’inizio, sta il «magnifico, generoso ed onorando podestà e reggitore della comunità» il signor Pietro de Mantellis; a titolo personale, non tamen tamquam potestas sed tamquam persona dicti Burgi, è anche priore della neonata confraternita. È la prima chiave. Lì sta anche Francesco Zanotello tesoriere della confraternita, nonché consigliere comunale. È la seconda chiave. Da quanto si è detto sopra non vi è dubbio che i due si trovino consenzienti nell’accedere al vano delle reliquie: due toppe, due chiavi e il battente in noce viene schiuso. Rimane ancora serrato il cancelletto di ferro retrostante, la cui chiave – la terza – è tenuta dal prevosto Benardino de Carmeno, e questi è dissenziente. Ma con la clausola avallata da mons. Ladino ogni animosità viene troncata sul nascere, con buona pace di tutti, apparentemente senza vincitori e vinti: proprio quello che allora premeva di più, come ce lo spiegano tuttora le figurazioni scolpite a gran rilievo su quell’usciolo in San Vittore. (dal fascicolo N. 3 – aprile 1994) Per una storia del Santuario 20 Per chi vuol saperne di più… Le notizie che don Crenna di volta in volta fornisce sono sempre interessanti; queste – su piode, travi... –, giungono anche a proposito, quindi doppiamente interessanti. Ancora: grazie, a don Crenna. Occorre genialità perché una soffitta diventi mansarda. Se è lasciata allo stato grezzo, viene classificata “spazzacà’”, giusta la dialettale definizione di strampalato deposito dei nostalgici ricordi di famiglia. Così più o meno si presentò il sottotetto del Santuario della Ss. Pietà: messo all’aria – nel vero senso della parola – lo si è trovato ingombro di «someri e travi di lareso e di castagno», di «canteri e codighe di peccia», di «assi di pobbia». Tutto legname ossificato, dopo quattro secoli, dagli spifferi del Valmaggino filtrante tra le sconnessure delle beole, e reso sghembo dal gran carico di piode. Un materiale che andava rimpiazzato, ma ricordi che fatalmente scompaiono: quanto alle travi, sapranno gli antiquari come riciclarle; quanto ai ricordi, facciamone almeno un cenno. Tre le fasi di allestimento del tetto: tre tappe nella lunga storia della fabbrica del Santuario. La prima fu raggiunta nell’ottobre del 1575, quando, risistemate le quattro stanze della ex casa Zaccheo per ricavarne l’unico ambiente della Devozione, entrarono in scena il Cimero e il Rizzetto, che traghettarono da Maccagno tre grossi «someri» coll’aggiunta di assi di larice e di abete, e da Giazzo, forniti da GioAngelo, quattro barconi di piode. Il «resegatto» Gietto, dal canto suo, approntò 19 travi ed altre 9 furono comprate da Stefano Pizzalo. Alla fine di dicembre il Capitularo terminava la copertura: una spesa complessiva tra 25 e 30 milioni. Poi tutto fu rimesso in ballo per trasformare la modesta Devozione in elegante Santuario: lo volevano quelli del Borgo, lo volle l’arcivescovo Carlo Borromeo, lo progettò il Tibaldi, e lo consentirono le finanze. Per anni, dal 1577, ci fu un gran daffare con «prede, medoni e marmori». 60 E finalmente, nel giugno del 1595, all’osteria di Bartolomeo Bagatello in Cannobio, Pietro Beretta, capocantiere e direttore dei lavori, poteva commemorare – giusta l’onoranza tradizionale delle maestranze edili – con i suoi muratori e manovali, la «seratura della volta grande»: praticamente quella che dal muro attuale di facciata si spinge all’altezza del presbiterio. Ritornarono di scena le barche del Rizzetto e del Cimero per trasportare le 370 braccia di piode, comprate a Brissago da Giacomo del Matto, e da un certo Giovanni a Piodina: una superficie complessiva di 125 mq di beole. E si noti il particolare curioso: a L. 40.000 circa per beola, proprio quant’è l’offerta oggi richiesta dal buon padre Francesco. Da Maccagno e da Colmegna furono traghettate le «codeghe di pecia», da Cero 21 «canteri» di larice e 24 di castagno e da Brissago una trentina di altri legni. La “onoranza” per il lavoro compiuto si ripeté, in tono dimesso, nel settembre del 1600: si era infatti ultimata la copertura del breve prolungamento che completava lo sviluppo perimetrale del Santuario: molti i fondamenti nella ripa del lago, ma poco tetto. (dal fascicolo N. 6 – luglio-agosto Per una storia del Santuario 1994) 21 Per chi vuol saperne di più… C’è chi del Santuario “ostenta” di sapere tutto. Io mi apparto e volentieri, con somma soddisfazione, leggo ciò che il carnet di don Crenna mi offre. Sapevate che originariamente la calce per il Santuario fu presa a Maccagno e a Porto Valtravaglia e le sabbie dal Maggia e dal Cannobino? Eppure conoscete quasi a memoria il trattato di Marco Vitruvio Pollione! Leggete ciò che don Crenna scrive, per lo meno venite a sapere quanto oggi s’è fatto pe rendere “bello” il santuario. A qualcuno può venire... la nostalgia di vedere presto la ripresa dei lavori. Ho letto sul bollettino della Ss. Pietà del giugno scorso: «In una foto del 1932, sulla parete del santuario rivolta al lago si legge la scritta, in grande, “Santuario della Ss. Pietà – Monumento Nazionale”. Ora la scritta non c’è più. E se si rimettesse? Poi, col naso all’insù, con tanti altri, ho ammirato quel gran bell’effetto ambientale che fa la nuova copertura di beole grezze e la finitura “fratassata” in color bianco dorato che esalta ed accentua le dimensioni della fiancata destra del santuario. E all’ingresso con vero sollievo d’occhi, non ho più dovuto indovinare entro l’oscurità delle volte le modanature a stucchi, o congetturare quali mai fossero i soggetti pittorici degli indecifrabili teleri posti alle pareti: perché da insospettate e riapparse vetrate figurate a colori s’è messa a piover giù una luminosità morbidamente diffusa, che mette, sì, in risalto le inevitabili rughe e crepe dei quattrocent’anni mal calcolati, ma perlomeno evita al visitatore e al pellegrino il fastidioso sconcerto di un ingresso al santuario pari a un salto nel buio d’una catacomba. Indubbiamente c’è voluto più cuore a rimettere concretamente in sesto questo monumento dei Cannobiesi, anziché segnalarne la qualifica mediante dicitura didascalica, assai gratuita e di cattivo gusto: ma nel 1932 era purtroppo invalso l’uso di imbrattare le pareti esterne delle case degli italiani con scritte enfatiche e cubitali. Non è infrequente che il “far immagine” si risolva in una camuffatura suppletiva della sostanzialità, e che quest’ultima di norma sia avversa all’esibizionismo. Di ciò è prova la piccola epigrafe (cm 35x40) che ricorda Pietro Beretta, figlio di Giovanni, di Brissago, intagliatore di pietre (vulgo: scalpelllino) e riconosciuto capomastro edile, per anni direttore della fabbrica del santuario fin quasi alla sua completezza. La scritta latina lo ricorda infatti (sciogliendo le abbreviazioni paleografiche) Petrus Bereta Johannis filius Brissagensis scalpendi et aedificandi faber celebris hujusque templi architectus fecit – MDCI. 61 Ci auguriamo che l’epigrafe, rimossa durante i recenti lavori, venga ricollocata in situ, nel rispetto delle buone ragioni che la vollero collocata nel corpo della fabbrica, più impegnativo, del prolungamento absidale del santuario verso l’instabile ripa del lago. La data (1601) ricorda la conclusione della volta grande e delle strutture portanti per il tiburio, che il Beretta – prematuramente deceduto – non poté però vedere ultimato. I nominativi di tutti gli altri operatori, scalpellini, muratori e “piodari”, carpentieri, intonacatori, stuccatori e marmorini, generici manovali maschi e femmine, barcaioli e traghettatori, stanno riposti nei registri contabili della confraternita della Ss. Pietà: tutti assoldati da un’unica impresa, e questa fu il Borgo stesso di Cannobio. Oggi si sono mosse le Soprintendenze, e in certa misura il “Beretta” odierno può dirsi il geom. Fiorino De Sario, posto a dirigere una complessa operazione di rifacimenti conservativi, come si conviene ad un monumento che è anche “nazionale”. Limitandoci ai lavori di restauro della fiancata destra del santuario, sappiamo che si iniziò “svestendola” totalmente dalle sovrapposizioni degli intonaci, compreso quello originario fatto di calce presa a Maccagno e a Porto Valtravaglia e di sabbie del Maggia e del Cannobino. Sulla murata messa a nudo sono riapparsi i connotati della parete di mezzodì della casa degli Zacchei e quelli delle prosecuzioni murarie con le quali fu ampliata la capienza dell’originaria piccola Devozione ricavata nelle quattro stanze al primo piano di detta casa. Le aggiunte edilizie verso il lago si sono rivelate di «quella fattura antica definita incerta, che dai sassi posti gli uni sopra gli altri e legati alla rinfusa, è resa, se non bella, certo assai più soda della reticolata, perché il muro, infarcito di pietre piccolissime e saziato dall’abbondanza della calce, trova maggior umido, non dissecca presto e resta meglio congiunto». È questo un criterio, sicuramente arcinoto agli addetti ai lavori, che abbiamo voluto richiamare utilizzando un passo ricavato dal trattato De Architectura di Marco Vitruvio Pollione, omaggiato a Cesare Augusto nell’anno 27 a.C. Non deve apparire una stranezza questo collegarci ad un classico della scienza e dell’arte edilizia, la cui validità di ammaestramento a tutt’oggi sta concretamente dimostrata dalla solidità e dall’imponenza di tanti ruderi d’epoca. E a Cannobio si è voluto operare con altrettanta serietà, come possiamo dimostrare riascoltando gli insegnamenti di Vitruvio: «Nelle fabbriche di cementi convien pria di tutto aver cura di trovare l’arena; cioè, che ella sia buona per fare la calce e che non sia mescolata con terra. Le specie dell’arena fossile sono queste: la nera, la bianca, la rossa ed il carbuncolo. Di tutte queste la migliore sarà quella che strofinata fra le mani, scroscia, perché quella che contiene qualità terree non ha quest’asprezza... Quella poi di fiume, a cagione della sua magrezza, battuta a guisa di smalto coi mazzapicchi, rende durissimo l’intonaco... Déesi anco usar tutta la diligenza riguardo alla calcina, la quale dev’essere formata da pietra bianca, o selce, cotta... Spenta che sarà, si farà l’impasto della medesima coll’arena, se sarà di cava, ma con due parti se di fiume... essendo questa la giusta proporzione della mistura». Ascoltiamo ora il responsabile dei lavori, geom. De Sario: «Previo rattoppo di crepe con calce bianca e conci, si è operata una zoccolatura lungo tutta la fiancata del santuario, mediante zaffatura di un composto di calce anti-sale per ovviare alle acque di risalita: il tutto per un’altezza di due metri da terra. Si è fatta seguire una prima mano d’intonaco dello spessore di circa cm 1,5 in funzione del supporto. Una rete metallica zincata a maglia fine vi è stata sovrapposta nella parte di mezzo della fiancata, la più antica, corrispondente al muro originario della casa degli Zacchei. Per una seconda mano d’intonaco si è utilizzata malta di una speciale calce idraulica Laforge con sabbia del Toce. La rifinitura è stata condotta fratassando al color bianco dorato un selezionato composto Medolago di calce e sabbia quarzifera. Il tutto a garanzia di resistenza agli agenti esterni, e in modo da consentire la massima aderenza del rivestimento alla muratura sottostante». Un nostro suggerimento: non dimentichi il geom. De Sario di annotare, sia pure in forma minuscola, il proprio nome all’opera compiuta. 62 (dal fascicolo N. 7 – settembre 1994) Per una storia del Santuario 22 Per chi vuol saperne di più… A ferragosto si parla di esodo: tempo di svago, di riposo di curiosità, non certo di silenzio. Ebbene, a ferragosto alcune persone hanno “scoperto” il Santuario e anche il Bollettino. Strano. Forse neanche tanto. Una volta ancora – per rispondere alla richiesta – ricordo che l’Autore di questa rubrica è don Mario Crenna, direttore del Bollettino Storico per la Provincia di Novara – non aggiungo altro! A cui va la riconoscenza dei lettori per la ricerca storica sul Santo Miracolo e sul Santuario e – va pure detto! – per la fedeltà e la puntualità nell’inviarci i suoi scritti preziosi, sempre attesi. L’operazione “fabbrica della chiesa della Ss. Pietà” ebbe avallo ufficiale il 21 aprile 1526, a quattro anni dagli inspiegabili fatti accaduti in casa di messer Tommaso Zaccheo. Da quel gennaio 1922 lo sconcerto – diciamolo “timor di Dio” – anziché affievolirsi, alimentato com’era dalle afflizioni di peste ricorrente e dalle pressoché stagionali traversie belliche, aveva pervaso il «Comune et Homini» di Cannobio. Gli ottimati, i borghigiani ed i vicini persistevano nel voler la nuova chiesa, intendendo così cautelarsi – anima e corpo – a fronte di quell’enigmatico messaggio che, depositato dal buon Dio in casa Zaccheo, date le circostanze, non lasciava presagire niente di buono. Nicchiavano invece i canonici ed il prevosto della collegiata di San Vittore. Ovviamente: in buona sostanza, vedevano profilarsi un fastidioso contraltare devozionale, sia pure in nome della Ss. Pietà, con inevitabile dislocazione di introiti; il che sarebbe stato incomodante ancor più della bega provocata tempo addietro dall’erigendo oratorio di San Lorenzo: fu osteggiato dal Capitolo, ma voluto dagli influenti Cannobiesi, monaci e laici, «fratelli Umiliati della casa di santa Giustina», alla fine gratificati dall’arcivescovo Ottone Visconti. Le reiterate istanze della gente avevano dunque smosso la Curia metropolitana. Non l’arcivescovo Ippolito d’Este, pastoralmente in perenne latitanza, bensì i due ecclesiastici di rango: il vicario generale Giovanni Maria Tonso, dottore in diritto civile e canonico nonché consanguineo di quel Tonso Marco Antonio (niente di meno!) commissario generale per la «tassa dei cavalli», l’imposta base delle entrate ducali che servì poi per indicizzare ogni altra esazione fiscale nello stato di Milano. Non si mosse di persona, trattenuto da incombenze di ben altro livello. Inoltrò a Cannobio il suo ausiliare, mons. Francesco Ladino, dottore in decretali e vescovo di Laodicea in partibus infidelium, quale mediatore tra le parti e giudice inappellabile. Si provvide a contattare preventivamente anche il conte Ludovico, rappresentante di quel casato borromaico che, da quasi un secolo, manovrando a suon di ducati con i Visconti e poi con gli Sforza, si era ormai accaparrato quasi tutte le terre attorno al Lago Maggiore; il che consentiva di controllare la grande via d’acqua commerciale tra le regioni svizzere e, tramite Ticino e Naviglio Grande, la metropoli lombarda. Dai tempi di Vitaliano, dal 1442, Cannobio era passata in feudo ai Borromei, divenendo cioè una tra le tante voci del loro bilancio. Ma il vero inserimento nel giro d’affari dei Borromei si ebbe quando gli Umiliati di Cannobio affidarono loro i beni più vasti e pingui, quelli situati nella pieve d’Angera, con un contratto livellario a scadenza novennale costantemente rinnovato dal 1458 al 1551 dai prepositi della Casa di S. Lorenzo. Fu un vero cordone ombelicale tra il Borgo e il casato comitale, assai più vincolante di qualsivoglia aggregazione istituzionale. E va tenuto presente che quasi tutti i prepositi provenivano dalle famiglie cannobiesi più in vista e godevano localmente di ascendente finanziario e politico per il fatto stesso che, unitamente all’ufficialità del Comune, gestivano pro indiviso i due mulini “di Fondo” e “di Mezzo”: cioè, data l’epoca, la massima concentrazione industriale di apparati idraulici, mole e vagli per gli sfarinati, «reseghe» e «peste per la follatura de panno» e per confezionare il cuoio. 63 Ben si comprende perché mai su una delle pareti interne del collegio delle Orsoline, corrispondente al lato di ponente della ex casa degli Umiliati ed abitazione dei monaci, si sia rinvenuto fortunatamente, affrescato su un lacerto di intonaco originario a mo’ di decorazione, uno dei simboli araldici dei Borromei: il morso per cavalli (di grazia, non la graticola di S. Lorenzo!). Era inevitabile che il connubio tra finanza e politica inducesse ad estendere l’alto patrocinio dei conti sulla domus sancti Laurentii fratrum humiliatorum. Né sorprende che al ventinovenne cardinale Carlo Borromeo, protettore dell’ordine degli Umiliati, all’indomani del breve del 2 marzo 1517 con cui Paolo V li sopprimeva, venisse conferita dallo stesso pontefice piena discrezionalità circa i beni patrimoniali confiscati all’Ordine disciolto; e fu pacifico che il santo cardinale nel 1581 offrisse ai confratelli della Ss. Pietà il materiale edile ancora utilizzabile per la fabbrica del santuario, raccolto dalle «case dirute di S. Lorenzo», oltre alla campana, per la quale, quell’anno stesso fu eretto il primo campanile, al di sopra della volta grande del santuario appena terminata, dal lato di mezzodì. Era impensabile dunque che mons. Tonso, mons. Ladino e i rappresentanti della comunità, nonché prevosto e canonici di S. Vittore tenessero all’oscuro il conte Ludovico in vista dell’incontro, come s’è detto in apertura, tenuto in S. Vittore il 21 aprile 1526. Nel Bollettino del marzo scorso sta scritto quali risoluzioni furono prese relativamente all’erigenda chiesa della Ss. Pietà. Sinteticamente: ne fu stabilito il piano finanziario, fu affidata la piena competenza ai confratelli della Ss. Pietà, e soprattutto fu ordinato di trasferire ogni reliquia (eccetto il quadro miracoloso) in S. Vittore, entro un apposito vano ricavato sul lato del Vangelo presso l’altar maggiore. Il tutto (Sacra Costa compresa) sarebbe stato riportato nel nuovo santuario a discrezione dei confratelli. Detto “sacrario” era difeso da una porticina in legno di noce, con figure scolpite ad altorilievo e di ottima fattura: quella stessa tuttora visibile in S. Vittore al luogo indicato. Possiamo considerarla un piccolo monumento a ricordanza dell’accordo stipulato in quel 21 aprile, che varava ufficialmente il progetto di fabbrica della Ss. Pietà. Vale la pena di decifrarne le figurazioni, in particolar modo quelle araldiche onde evitare interpretazioni errate: come ogni altro linguaggio, anche quello araldico esige di essere inteso nel suo giusto senso. Il pannello è tripartito. Nella sua parte superiore stanno segnalate le personalità ecclesiastiche. Si notano infatti: la tiara pontificia sormontata dalla tipica corona simboleggiante le famiglie patrizie (papa Clemente VIII allora regnante era del casato fiorentino dei Medici); al di sotto – precedute dal lato sinistro da una croce semplice astile diocesana o vescovile, e a destra da una raggiera simbolo della fabbrica o del Capitolo della chiesa metropolitana milanese – stanno appaiate due mitre vescovili sormontate dai galeri prelatizi (cappelli tondi a larga tesa) con due ordini di fiocchetti pendenti (1+2+3=6). Dietro al galero di sinistra spunta il pomo della mazza prepositurale, o capitolare, e più in basso un bastone dottorale al di sotto del quale vi è un elmo grigliato, in posizione frontale e incoronato, simboleggiante il conseguimento di dottorato in giurisprudenza e l’appartenenza a famiglia titolata. Codesti simboli parlanti descrivono le qualifiche del vicario generale mons. Tonso. Dal lato opposto, scorrendo dall’alto in basso, dopo il pastorale, il galero e la mitra, si ripetono il bastone del dottorato e l’elmo grigliato, però coronato con serto d’alloro: i contrassegni araldici del vescovo Ladino, decretorum doctor. Detti simboli sono contenuti in un riquadro contornato sui due lati da una serie di dati (diremmo) cronologici, relativi alla Passione di Cristo: dal lavarsi le mani di Pilato alla colonna della flagellazione, al sudario della Veronica, all’insegna apposta alla croce; e poi ancora la tunica inconsutile, la deposizione dalla croce, il vaso dei balsami. Nella parte centrale del pannello campeggia la riproduzione del quadro miracoloso della Ss. Pietà. La parte inferiore è riservata al casato dei Borromei, la cui presenza a Cannobio, come si è detto, era evidenziata dal loro rapporto con la Casa di S. Lorenzo. Ciò spiega la raffigurazione del martirio di S. Lorenzo, compresa tra i due simboli parlanti del casato borromaico: in alto l’Humilitas coronata, in basso il freno, o morso da cavallo. 64 È complesso il significato di quest’ultima figura araldica; più chiaro è il riferimento dell’altra, che iniziò a decorare lo scudo dei Borromei dall’epoca di Vitaliano, il quale intese evidenziare strumentalmente il risvolto sociale delle proprie finanze sovvenzionando di pane e vino i più miserandi (gli umili) di Milano. Che poi questo simbolo araldico sembri essere stato un’esclusiva di san Carlo, visto l’impiego che ne fece e il ben diverso significato che gli attribuì, è tutt’altro discorso: non altera affatto la cronologia che va assegnata al pannello di S. Vittore, da ricondurre senza dubbio alcuno ai fatti sopra descritti. Sui due lati di quest’ultimo riquadro, in sequenza stanno i simboli che richiamano l’efferatezza e i generi di martirio inferti dal mondo romano (la corazza e l’elmo): carrucole, ruote dentate, spade, gogna, tenaglie. Un piccolo capolavoro di invenzione figurativa! (dal fascicolo N. 9 – novembre-dicembre 1994) Testamento del nobile cannobiese Giacomo Omacino 34 Non c‘era bisogno di parole che accompagnassero l’articolo giuntomi a mezzo fax. Era evidente la decisione di don Mario Crenna di pubblicare il testamento di Giacomo Omacino. Così mi fu confermato poi. Dunque questo non è che un “assaggio gustoso” di quanto verrà pubblicato prima sul Bollettino Storico per la Provincia di Novara poi sul Fascicolo n. 4 edito dal Santuario. Mi si consenta di richiamare l’attenzione su Bernardina Zaccheo; un inciso che non è di poco conto per la storia del Santuario. Altro non aggiungo, se non un grazie cordialissimo a don Crenna. Casa Omacini sta allineata tra altre case antiche sul lungolago di Cannobio: attualmente a tre piani, con quattro campate di portico in facciata, aperte su piazza Indipendenza. L'ingresso è contrassegnato dal numero civico 31; ma più significativa connotazione gli viene data dalla scritta apposta centralmente sul fronte del palazzo: «Giacomo Omacino giureconsulto uno dei magnifici vicari generali dello Stato di Milano. 1574». Indubbiamente un personaggio di spicco, che sappiamo coevo di Carlo Borromeo. È noto infatti che la sera del 30 ottobre 1584 egli ospitò il santo arcivescovo, che da Ascona rientrava a Cannobio prostrato da un reiterato accesso di febbre terzana e per di più stremato per il tragitto fatto in barca «con vento gagliardo e tempo travaglioso» (morirà a Milano il 3 novembre successivo). Lo avevano sbarcato poco discosto; gli restavano da superare i pochi metri di piazza Baciocchi per raggiungere la casa di fronte. E lì pernottò, accolto, per l'appunto, del magnifico signore Giacomo Omacino. Qualche essenziale ragguaglio su costui e sul suo casato ci viene fornito da Gio Francesco Del Sasso Carmino (Informazione istorica del borgo di Cannobio, 1633). Apprendiamo da lui che gli Omacini rientravano nel novero delle famiglie cosiddette «vicine» perché, sapendosi «originarie e naturali», si consociarono, costituendo in tal modo la prima struttura del borgo. Si avvalsero di questa elementare demarcazione al fine di meglio identificarsi culturalmente e nel contempo salvaguardare da elementi spuri la propria comunanza di orientamenti politici ed amministrativi. Ne derivò, come corollario, che esse detenessero «negli antichi tempi mero e misto imperio ed onnimoda giurisdizione, sì civile come criminale; ed erano padroni assoluti, o, come si dice, signori a bacchetta». Di categoria subalterna erano «i non vicini, ovvero adventizii, comunemente appellati Appoggiati», ai quali peraltro non era precluso un avanzamento di rango purché il loro inserimento si fosse dimostrato utile alla comunità, o risultasse accreditato da particolari loro prerogative: «per prescritta consuetudine o per privilegio». Comunque, per tale promozione sociale occorreva l’unanime consenso del Consiglio generale, risultante da scrutinio segreto. 65 Formalmente dunque un ordinamento interno ben sorretto da una forte motivazione di base, e all’apparenza di indubbia stabilità, come ne dà riscontro la citata Informazione: «Viveva questo borgo con la sua pieve in libertà e reggevasi e governavasi da sé stesso a guisa d’una piccola repubblica e non riconoscendo altro superiore nelle cose temporali che l’Imperadore, sotto cui eleggeva i suoi podestà e vicari ovver rettori, dando loro amplissima possanza ed autorità». Quantomeno tale tributo d’ossequio all’istituto imperiale veniva ostentato dai casati dei Vicini, che – quasi tutti – vollero apporre la simbolica aquila nera su campo giallo in capo alla propria arme. O forse, più banalmente, si trattò di un’aggiunta boriosa: infatti, leggendo sugli scudi patrizi le elaborate figure parlanti di torrioni, castelli, scalpitanti puledri, leoni rampanti, e tori e camosci, con tanto colore e rosso e bianco; osservando i portali e le strutture abitative, tenendo presente la dislocazione stessa delle residenze entro il circuito del borgo, si ha netta la percezione, per così dire stratigrafica, di una diffusa orgogliosa concorrenzialità nell’esibire possanza, ricchezza, autorevolezza. Le ostentazioni di forza erano fatalmente destinate a trascendere in manifestazioni di prepotenza: l’emulazione stessa nel proporsi come paladini del buon governo degenerò ripetutamente in avversione, rancore e violenza faziosa, sia dovendosi designare i membri del Consiglio generale, sia occorrendo eleggere in seno a detto Consiglio un nuovo podestà o un nuovo vicario. Fu dall’epoca della contesa tra Chiesa ed Impero che il borgo si trovò ammorbato dalla faziosità, divenuta poi una specie di afflizione endemica, come si desume dalle reiterate “paci” rogate dai notai cannobiesi. Le faziosità trovavano una loro descrizione topografica nella suddivisione stessa del borgo in Superiore ed Inferiore: il primo, dichiaratamente ghibellino, essendo il più popoloso fu il vincente, all’insegna del ramo d’alloro; il secondo, costituito da quelle case «che ora si vedono lungo la riva e hanno sì bella vista agli occhi dei riguardanti» – le case Omacini, Tassani, Zacchei, Cervetti ed altre – fu guelfo e soccombente, all’insegna del ramo d’olivo. Comunque dal novembre 1342 non fu più competenza del Consiglio generale l’elezione dei rettori o vicari e, nel febbraio 1441, Cannobio e pieve furono dal duca Filippo Maria Visconti dati in feudo a Vitaliano Borromeo «suo Cameriere, poi creato conte d’Arona, per sé, suoi figliuoli e discendenti maschi legittimi nati e che nasceranno di legittimo matrimonio e di linea mascolina in infinito». Col consolidarsi delle signorie viscontea e sforzesca si aprirono per gli ottimati cannobiesi le vie del nascente apparato burocratico milanese: tra costoro in prima linea gli Omacini Gio Antonio e Giacomo. Il dato storico più antico di cui ora disponiamo, risale ai due fratelli Omacini: il magnifico signor prete Gio Maria ed il magnifico signor Antonio. Costui prese in moglie la nobile madonna Bernardina Zaccheo, figlia di Tommaso (per la sbadata lettura dei documenti da parte di certuni che ne scrissero, questa nobildonna, oltre a trovarsi il padre declassato ad oste, fu bellamente assegnata in moglie ad un oscuro Gio Antonio da Carmine; superfluo deprecare il successivo passamano di codeste errate asserzioni). Da lei ebbe due figli, così ricordati dal Sasso Carmine: «Gio Antonio, dopo d’aver atteso lungo tempo all’arte del notaro in Milano ed essere stato cancelliere del senator Giulio Claro, poi reggente in Ispagna, tanto celebrato, fu poscia per opera d’esso Claro reggente sottosegretaro dell’eccellentissimo senato di Milano [...] abbandonò questa mortal vita l’anno 1583 e di sua età 53 avendo lasciato solamente due figliuoli, cioè un maschio ed una femina. Fu sepolto nel tempio vecchio di S. Celso in Milano». L’altro, Giacomo, «è stato giureconsulto e de’ Vicari generali dello stato di Milano, il quale passò a miglior vita gli anni passati [il Sasso Carmine scriveva nei primi decenni del 1600], avendo lasciato di sua moglie, gentildonna milanese, quattro figliuoli maschi con due femine ora maritate; e giace sepolto nella chiesa di Santa Giustina di Cannobio dove vivendo fece porre nel coro di essa chiesa a man destra un bello e sontuoso deposito di marmo». 66 Si è già detto in quale emergenza costui impensatamente si trovò ad ospitare il febbricitante cardinale Borromeo, rimanendo di certo esterrefatto quando il presule (come scrive il biografo Giussani) «essendo preparato un letto, lo fece levare collocandosi nel fervore del male sopra il pagliarizzo per mantenere l’uso della solita sua penitenza» e, lì steso, si mise a discorrere sulla vita e virtù di san Francesco con i padri Cappuccini del vicino convento di santa Maria Maddalena «trattenendoli in ragionamenti spirituali». Fosse casualità o conseguenza, pochi giorni dopo, il 17 novembre, il magnifico signor Giacomo Omacini depositava presso il notaio Gio Antonio Albertini il proprio testamento olografo sigillato in cera rossa. Un documento veramente illuminante e degno di considerazione 67
Scaricare