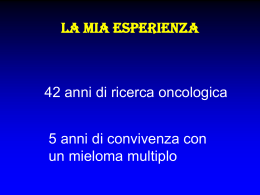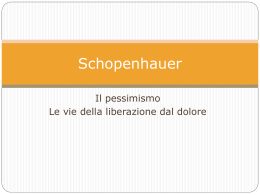I QUADERNI DELL’AIST Associazione Italiana per lo Studio del Dolore e dell’Ipnosi Clinica 1 2 Quaderno N° 2 DOLORE E SOFFERENZA NELLE VARIE COMUNITA’ UMANE 30 Marzo 2005 a cura di Prof. Angelico Brugnoli Medico Chirurgo Ipnoterapeuta Esperto in Stati di Coscienza Modificati Neurofisiologici. Esperto del Biometeolab Università di Milano Presidente AIST Associazione Italiana per lo Studio del Dolore e dell’Ipnosi Clinica e Dott. Maria Paola Brugnoli - Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione Perfezionamento in Agopuntura Direttore Scientifico AIST 3 Statua lignea policroma del XVI secolo raffigurante un "oppiato" «Il dolore è in effetti il processo di purificazione che solo permette, nella maggior parte dei casi, di santificare l'uomo, di distoglierlo cioè dalla volontà di vita. Perciò nei libri di edificazione cristiana viene così spesso nominata la virtù salvatrice della croce e del dolore, e molto propriamente la croce, strumento di sofferenza e non di azione, è il simbolo della religione cristiana.» Arthur Schopenhauer Il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è ancora dolore. Albert Einstein •È sincero il dolore di chi piange in segreto. Marziale 4 •I dolori leggeri concedono di parlare: i grandi dolori rendono muti. Seneca •Il dolore è ancor più dolore se tace. Giovanni Pascoli La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza. Albert Einstein Non aspettare il momento opportuno: crealo! George Bernard Shaw Il dolore è la sapienza del cuore, perché ti fa domandare a ogni istante. (Don Giussani - Tracce ott. 2007. p.17) PERCHE’ 5 LE RELIGIONI DI FRONTE AL DOLORE Il forte flusso migratorio registrato in Italia negli ultimi anni ha prodotti mutamenti profondi nella società. Non cambiano soltanto il volto delle persone, ma anche le sensibilità di fronte ai problemi. Cambia tutto anche per i medici, che devono tornare a confrontarsi con problematiche desuete, oltre che con i nodi della comunicazione e della comprensione. Di questo tema si è parlato a Milano in un recente congresso della Società Italiana di Cure Palliative: i rappresentanti delle religioni cattolica, ebraica, musulmana, protestante e buddista hanno presentato la loro visione etica della malattia e della morte, facendo quindi il punto sulle cure palliative, l’assistenza ai malati inguaribili, l’accanimento terapeutico e l’eutanasia, alla luce degli insegnamenti delle rispettive confessioni religiose. Cattolici A parere del teologo, il credente cattolico dovrebbe ricordare che la vita è un dono e che la morte si presenta contemporaneamente come un evento indisponibile (il morire non dipende dall’uomo) e insieme come decisione libera (dipende dall’uomo come morire). Accettare la caducità della condizione umana è la premessa per scegliere di “morire bene”. Per la religione cattolica è dunque questione etica decisiva elaborare le forme della “buona morte”, superando i concetti di eutanasia e di accanimento terapeutico, due atteggiamenti rifiutati dal magistero ecclesiatico, perché pretendono di dominare tecnicamente la morte. Ø LA MEDICINA PALLIATIVA È UNA RISPOSTA CONCRETA AI BISOGNI DEL MALATO INGUARIBILE E LO AIUTA A SUPERARE L’ALTERNATIVA TRA ACCANIMENTO TERAPEUTICO ED EUTANASIA; protegge il morente dal dolore; lo cura ma sa rinunciare a interventi sproporzionati ed eccessivi, riconoscendo l’ineluttabilità della morte; gli offre un accompagnamento e una prossimità che, nella prospettiva cristiana, testimoniano la speranza di un futuro oltre la morte. La religione cattolica consente di comunicare ai malati inguaribili la vera prognosi, anche se infausta. Ebrei I principi base dell’etica medica ebraica sono: l’obbligo religioso di proteggere la vita e la salute; la sacralità riconosciuta alla vita, dalla nascita alla morte; la fiducia nel medico competente; la dignità riconosciuta alla persona, sia in vita sia in morte; il concetto che la vita non appartiene completamente all’individuo. Il problema dell’eutanasia si pone quando la vita si presenta come invivibile. La risposta dell’ebraismo è che non è consentito indurre la morte in persone sofferenti. Vanno comunque distinte due forme di eutanasia. 6 NON È CONSENTITA L’EUTANASIA DIRETTA, che consiste nello staccare la spina o erogare del veleno. E’ CONSENTITA L’EUTANASIA INDIRETTA, che consiste nel non supportare il malato con apparecchiature. Ø IN OGNI CASO SOMMINISTRARE SEDATIVI O ANALGESICI AI MALATI INGUARIBILI, COME AVVIENE NELLA MEDICINA PALLIATIVA, NON È EUTANASIA (NEPPURE SE LA TERAPIA POTENZIALMENTE PUÒ ACCELERARE LA MORTE), A CONDIZIONE CHE MANCHI L’INTENZIONE DI DAR TERMINE ALLA VITA. L’ebraismo non ha invece regole univoche sul problema se rivelare (o meno) la vera prognosi all’inguaribile; certo è consentito mentire “per amore”, ma l’atteggiamento da tenere dipende dalla persona malata e dalla sua volontà e capacità di affrontare la verità, che vanno valutate dal medico. Musulmani L’atteggiamento musulmano verso la malattia e la medicina è attivo e positivo. La Sharia insegna come va trattato il corpo e comprende anche consigli per un’alimentazione corretta e per la prevenzione delle malattie. Ø GLI INSEGNAMENTI DEL PROFETA INVITANO A CERCARE E USARE LE CURE PER TUTTE LE MALATTIE E NELL’ISLAM LA NEGLIGENZA DI UN UOMO NEL CURARSI È CONSIDERATO UN GRAVE PECCATO VERSO DIO. Ø LA POSIZIONE DELL’ISLAM SULL’EUTANASIA È NETTA: È SEMPRE PROIBITA PERCHÉ NON È CONSENTITO MUTILARE O UCCIDERE IL PROPRIO CORPO, CHE NON APPARTIENE A NOI MA A DIO. Nella legge islamica l’eutanasia è considerata un omicidio. I musulmani sono preparati alla morte e l’Islam ritiene che al malato inguaribile vada detta la verità sul suo stato di salute, a meno che non sia in condizioni di spirito particolari. Ma una volta che il malato è informato, bisogna cambiare tono, introducendo nella conversazione messaggi di speranza e ricordando che Dio può guarire tutto. Valdesi Per i valdesi la malattia non va vista, come qualcosa che giunge dall’alto ma come il risultato di un degrado da ricondurre agli esseri umani e alla loro vita individuale e collettiva. La medicina, con il suo sviluppo scientifico, è un dono di Dio e risponde alla necessità di umanizzare la vita e la morte. Ø LE CURE PALLIATIVE SONO UNA RISORSA PER RENDERE DIGNITOSA LA VITA E IL MORIRE DI UN MALATO TERMINALE. I CRISTIANI EVANGELICI SONO FAVOREVOLI ALLE CURE PALLIATIVE E CONTRARI ALL’ACCANIMENTO TERAPEUTICO. 7 Ø PER I VALDESI IL TEMA DELL’EUTANASIA, ATTIVA E PASSIVA, È UN CAMPO APERTO: QUANDO LA MALATTIA INFLUISCE SULLA DIGNITÀ DELLA PERSONA, NON È ACCETTABILE CHE UNA LEGGE POSSA COSTRINGERE AD ALLUNGARE LA VITA. In questo campo si gioca il destino di laicità di uno stato: non c’è nessuna norma che possa andare bene per tutti. Lo stato laico, che non può essere il risultato di un’ideologia dominante, crea spazi di diritto condivisibili, garantisce la vita e il degno morire secondo la coscienza della persona. Bisognerebbe prevedere degli spazi per decisioni individuali. In merito alla diagnosi, generalmente il protestante preferisce sapere la verità, seppur con dolcezza. Buddisti Le preghiere e le pratiche devozionali tibetane liberano dal dolore psichico ma non dal dolore fisico. Per questo occorrono le cure mediche, che devono essere praticate in modo adeguato, anche il trapianto di organi. Non è ammesso invece l’accanimento terapeutico. I principali suggerimenti del buddismo ai sanitari che curano un malato terminale sono quelli di creare equilibrio e di rispettare le sue credenze, senza cercare di modificarle negli ultimi istanti della sua vita. Ø IL BUDDISMO È FAVOREVOLE ALLE CURE PALLIATIVE PER I MALATI INGUARIBILI, TUTTAVIA FA UNA ECCEZIONE: BISOGNEREBBE INTERROMPERE LA SOMMINISTRAZIONE DI SEDATIVI AL MORIBONDO NELL’IMMINENZA DEL TRAPASSO PERCHÉ QUESTI FARMACI POTREBBERO IMPEDIRGLI LA LUCIDITÀ NECESSARIA PER PRATICARE IL TRASFERIMENTO DI COSCIENZA. Sul tema della verità al malato inguaribile, il Buddismo considera giusto informare il morituro delle sue condizioni, perché così si può preparare alla morte. 8 BENTHAM Le quattro fonti del dolore e del piacere § 1. Si è mostrato che la felicità degli individui di cui una comunità è composta, vale a dire i loro piaceri e la loro sicurezza, è il fine, e l’unico fine, a cui il legislatore deve mirare, l’unico criterio in conformità al quale, per quello che dipende dal legislatore, si dovrebbe far sì che ogni individuo modelli il suo comportamento. Ma che sia questa o un’altra la cosa che va fatta, non c’è niente per mezzo del quale si possa in ultima analisi far sì che un uomo la faccia se non il dolore o il piacere. Avendo considerato in generale questi due grandi oggetti (cioè il piacere e quel che equivale alla stessa cosa, cioè l’immunità dal dolore) come cause finali, sarà necessario considerare il piacere e il dolore stessi come cause efficienti o mezzi. § 2. Si possono distinguere quattro fonti da cui il piacere e il dolore derivano: considerate separatamente, possono essere definite fisica, politica, morale e religiosa, e dal momento che i piaceri e i dolori propri di ciascuna di esse sono in grado di fornire una forza vincolante a qualsiasi legge o regola di condotta, possono tutte essere definite sanzioni. § 3. Se il piacere o il dolore ha luogo o viene atteso in questa vita, e dal normale corso della natura, non modificato di proposito dall’intervento della volontà di qualche essere umano o dall’intervento straordinario di qualche essere superiore invisibile, allora si può dire che quel piacere o quel dolore proviene dalla o appartiene alla sanzione fisica. § 4. Se è nelle mani di una particolare persona o gruppo di persone nella comunità, che, sotto nomi che corrispondono a quello di giudice, vengono scelti col particolare proposito di dispensarlo, secondo la volontà del sovrano o del supremo potere dominante dello stato, si può dire che esso proviene dalla sanzione politica. § 5. Se è nelle mani di persone a caso nella comunità, persone con cui può capitare che la parte in questione abbia a che fare nel corso della sua vita, secondo la disposizione spontanea di ciascun uomo, e non secondo qualche regola stabilita o convenuta, si può dire che proviene dalla sanzione morale o popolare. § 6. Se deriva direttamente dalle mani di un essere superiore invisibile, nella vita presente o in una vita futura, si può dire che proviene dalla sanzione religiosa. § 7. I piaceri o i dolori che possiamo aspettarci che provengano dalle sanzioni fisica, politica o morale ci si deve attendere di sperimentarli tutti, se mai, nella vita presente; quelli che possiamo aspettarci che provengano dalla sanzione religiosa ci si deve attendere di sperimentarli sia nella vita presente che, in una vita futura. § 8. I piaceri e i dolori di cui si può avere esperienza nella vita presente naturalmente non possono essere altro che quelli di cui è suscettibile la natura umana nel corso della vita presente; e tutti i piaceri o i dolori di cui la natura umana è suscettibile nel corso della vita presente possono derivare da ciascuna delle fonti suddette. 9 Riguardo a questi dolori o piaceri, quindi (gli unici di cui ci occupiamo in questo luogo), quelli propri di una qualunque delle quattro sanzioni in ultima analisi non si differenziano nel genere da quelli propri di una qualunque delle altre tre: l’unica loro differenza sta nelle circostanze che accompagnano la loro produzione. Ad esempio, una sofferenza che colpisce un uomo nel naturale e spontaneo corso delle cose sarà denominata calamità. In questo caso, se si suppone che questa sofferenza lo colpisca a causa di qualche imprudenza da parte sua, potrà essere denominata come punizione derivante dalla sanzione fisica. Ora, la medesima sofferenza, se inflitta dalla legge, sarà quella che viene comunemente chiamata pena. Se la sofferenza sorge dalla mancanza di amichevole assistenza, negata a causa della cattiva condotta, o supposta tale, della vittima, si dirà che è una pena derivante dalla sanzione morale. Se è inflitta dall’immediato intervento di una particolare provvidenza, una pena derivante dalla sanzione religiosa. § 9. Supponiamo che i beni di un uomo, o lui stesso, siano distrutti dal fuoco. Se questo succede per quello che viene detto un incidente, si tratta di una calamità. Se avviene a causa della sua stessa imprudenza (per esempio, perché ha dimenticato di spegnere il lume) si può descrivere come pena della sanzione fisica. Se avviene a causa della sentenza di un magistrato politico, pena della sanzione politica, cioè quella che si chiama comunemente pena. Se avviene per mancanza di aiuto da parte del suo prossimo, a cui non piace il suo carattere morale, pena della sanzione morale. Se avviene per un’immediata manifestazione del dispiacere di Dio, a causa di qualche peccato da lui compiuto, o perché la mente è sconvolta dal terrore di poter provocare tale dispiacere, pena della sanzione religiosa . § 10. Per quel che riguarda i piaceri e i dolori propri della sanzione religiosa, dal momento che riguardano una vita futura, non possiamo sapere di che genere siano. Sono fuori dalla portata della nostra osservazione. Nel corso della vita presente costituiscono solo materia d’aspettativa, e sia che questa attesa derivi da una religione naturale o rivelata, se il genere particolare di piacere o di dolore è diverso da tutti quelli che sono alla portata della nostra osservazione, è qualcosa di cui non possiamo avere un’idea. Le migliori idee che riusciamo ad ottenere di tali dolori e piaceri non sono affatto qualitativamente chiare. In un altro luogo considereremo sotto quali altri rispetti le idee che di essi abbiamo possono esser chiarificate. § 11. Di queste quattro sanzioni, possiamo osservare che quella fisica è sempre a fondamento di quella politica e di quella morale, e anche di quella religiosa, nei casi in cui quest’ultima riguarda la vita presente. La sanzione fisica è inclusa in ognuna delle altre tre. Essa (vale a dire ciascuno dei piaceri o lei dolori suoi propri) può operare in ogni caso indipendentemente dalle altre tre, ma le altre tre possono operare solo per mezzo suo. In una parola, i poteri della natura possono operare da soli, ma né il magistrato, né gli uomini in generale, possono operare, né si 10 suppone che nel caso in questione Dio lo possa, se non attraverso i poteri della natura. § 12. È sembrato utile trovare un nome comune per questi quattro oggetti che nella loro natura hanno così tanto in comune. È sembrato utile, in primo luogo, per la convenienza di dare un nome a certi piaceri e dolori per i quali altrimenti sarebbe stato difficile trovarne uno altrettanto caratterizzante. In secondo luogo, allo scopo di sostenere l’efficacia di certe forze morali, la cui influenza tende a non essere sufficientemente osservata. La sanzione politica esercita un’influenza sulla condotta degli uomini? Anche la sanzione morale e quella religiosa lo fanno. Ad ogni passo della sua carriera l’operato del magistrato politico è soggetto ad essere aiutato o impedito da questi due poteri estranei che, l’uno o l’altro o entrambi, sono sicuramente suoi rivali o suoi alleati. Gli capita di non calcolarli? Sicuramente si accorgerà di aver sbagliato risultato. Troveremo abbondanti prove di ciò nel seguito di questo lavoro. È doveroso per lui, quindi, tenerli continuamente davanti agli occhi, chiamandoli con un nome che mostri la relazione che essi hanno con i suoi propositi e progetti. (J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, cap.III) Jeremy Bentham Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Fu un politico radicale e un teorico influente nella filosofia del diritto angloamericana. È conosciuto come uno dei primi proponenti dell'utilitarismo e dei diritti degli animali che influenzò lo sviluppo del liberalismo. Bentham fu uno dei più importanti utilitaristi, in parte tramite le sue opere, ma in particolare tramite i suoi studenti sparsi per il mondo. Tra questi figurano il suo segretario e collaboratore James Mill e suo figlio John Stuart Mill, oltre a vari politici (e Robert Owen, che divenne poi uno dei fondatori del socialismo). Argomentò a favore della libertà personale ed economica, la separazione di stato e chiesa, la libertà di parola, parità di diritti per le donne, i diritti degli animali, la fine della schiavitù, l'abolizione di punizioni fisiche, il diritto al divorzio, il libero commercio, la difesa dall'usura, e la depenalizzazione della sodomia. Fu a favore delle tasse di successione, restrizioni sul monopolio, pensioni e assicurazioni sulla salute. Ideò e promosse un nuovo tipo di prigione, che Bentham chiamò Panopticon. Morendo nel 1832 non lasciò solo il retaggio della sua dottrina morale e politica, ma anche quello di un'istituzione nuova in Inghilterra, l'Università di 11 Londra, distinta dalle tradizionali università inglesi di Oxford e Cambridge per il suo carattere rigorosamente laico e subito tacciata dagli avversari come «l'Università senza Dio». Indice 1 Pensiero filosofico 2 Vita 3 Note 4 Altri progetti Pensiero filosofico La consapevolezza degli squilibri socio-economici, causati dallo sviluppo industriale dell'Inghilterra della seconda metà del settecento, trovò espressione in Bentham come in altri nella dottrina dell'utilitarismo. Bentham è considerato l'iniziatore di questa corrente di pensiero proprio per le sue riforme alla legislazione britannica. Nel 1789 pubblica la sua opera principale Introduzione ai princìpi della morale e della legislazione. Bentham riformula il principio della «massima felicità per il massimo numaero di persone» degli illuministi (Cesare Beccaria, Helveétius, Hutcheson). Se la morale vuole diventare una scienza deve basarsi sui fatti (come nel positivismo) e non su astratti valori, infatti la felicità, di cui sopra, non è altro che il piacere. Piacere e dolore sono fatti quantificabili così da poter essere assunti come criterio dell'agire. Bentham formula un'algebra morale cioè un calcolo quantitativo che ci permetta di conoscere le conseguenze dell'agire quantificando la felicità prodotta indirizzandoci verso azioni che massimizzino il piacere e minimizzino il dolore. Le buone azioni saranno quindi le azioni che promuovono la felicità non solo per il singolo ma anche per la collettività, viceversa le cattive azioni ostacolano la felicità. Se quindi la ricerca del piacere, del singolo, è ben indirizzata promuoverà la felicità di tutti, per cui egoismo e altruismo tendono a confondersi. Forte di questa teoria, Bentham, non ritiene valida l'ipotesi contrattualistica del giusnaturalismo, alla base dello Stato non vi è alcun contratto sociale ma una necessità utilitaria di promuovere collettivamente la felicità, il piacere di tutti. Le leggi avranno così il compito di incoraggiare le azioni buone (cioè che promuovono l'utile) e di impedire e sanzionare quelle che ostacolano il bene comune. Vita Bentham nacque a Spitalfields, Londra, in una ricca famiglia Tory. Era un bambino prodigio e, bambino, fu trovato seduto alla scrivania del padre, intento a leggere una storia dell'Inghilterra in più volumi. Cominciò lo studio del Latino a soli tre anni.[1] 12 Frequentò la Westminster School e nel 1760 fu mandato dal padre al Queen's College di Oxford, dove raggiunse il grado di Bachelor nel 1763 e di Master nel 1766. Ricevette una formazione da avvocato e (anche se non praticò mai) fu ammesso all'attività forense nel 1769. Rimase profondamente frustrato per la complessità del corpus giuridico inglese, che soprannominò "the Demon of Chicane". Tra le sue tante proposte per riforme legali e sociali: un progetto per la costruzione di una prigione, che egli chiamò Panopticon. Benché non abbia avuto realizzazione pratica, l'idea influenzò significativamente le successive generazioni di pensatori. Il filosofo francese del ventesimo secolo Michel Foucault attribuiva al Panopticon il ruolo di paradigma di riferimento per tutta una serie istituzioni penitenziarie del diciannovesimo secolo. Bentham intratteneva corrispondenze con molte persone influenti. Adam Smith, per esempio, fu contrario a porre un limite legale ai tassi di interesse, prima che le argomentazioni di Bentham lo convincessero del contrario. In seguito alla corrispondenza con Mirabeau e altri capi della Rivoluzione Francese, gli venne conferita la cittadinanza onoraria francese, benché Bentham sia stato un critico feroce del principio rivoluzionario dei diritti naturali e della violenza che dilagò dopo la presa del potere da parte dei Giacobini (1792). Nel 1823, insieme a John Stuart Mill, fondò la Westminster Review, il periodico del movimento "Radicale"; attraverso questa pubblicazione, insieme ad un gruppo di giovani discepoli, esercitò una notevole influenza nella vita pubblica inglese.[2]. Frequentemente, Bentham è associato alla fondazione dell'Università di Londra, specificatamente dell'UCL (University College London), malgrado avesse già 78 anni all'apertura dell'UCL, nel 1826, e lui non avesse partecipato attivamente alla sua costituzione. Comunque, è probabile che, senza la sua ispirazione, l'UCL non sarebbe stata fondata in quel periodo. Bentham credeva fortemente che l'educazione dovesse essere fruibile il più largamente possibile, e in particolare anche a chi non apparteneva alle classi sociali superiori o alla Chiesa, criteri che erano invece indispensabili per gli studenti di Oxford e Cambridge. Dal momento che l'UCL fu la prima Università inglese ad ammettere tutti, senza distinzione di razza e credo politico o religioso, essa fu decisamente coerente con la visione di Bentham, il quale inoltre patrocinò la nomina di uno 13 dei suoi allievi, John Austin, come primo Professore di Giurisprudenza nel 1829. Come richiesto nel suo testamento, il suo corpo fu preservato e conservato in una cassa di legno, chiamata la sua "Auto-Icona", all'University College London. L'Auto-Icona è conservata alla fine del chiostro sud della parte principale del College e può essere visitata. Ciò ha portato alla nota, ma falsa, storia secondo cui l'Auto-Icona verrebbe occasionalmente portata alle riunioni del College Council, in cui Bentham risulterebbe "presente ma non votante". L'Auto-Icona ha sempre avuto una testa di cera, dal momento che il capo di Bentham fu gravemente danneggiato nel processo di preservazione. Jeremy Bentham’s auto-icon sits at University College London. 14 Notizie in... Controluce Mensile di cultura e attualità dei Castelli Romani e dintorni Versione digitale del mensile dell'Associazione Photo Club Controluce in 12.000 copie cartacee gratuite DOLORE ED ETICA Remore, difficoltà e possibilità nel trattamento con oppiacei dei malati terminali. Il presente articolo si sviluppa in note successive che prenderanno in esame: 1) Alcune premesse al tema; 2) Pericoli reali e pericoli esagerati dell’uso medico degli analgesici oppiacei; 3) La situazione legale: il caso dell’Olanda; 4) La situazione legale: il caso degli USA; 5) La situazione legale in Italia; 6) Il problema religioso; 7) Conclusioni.. L’autore, Giovanni Ceccarelli, quasi settantenne, è medico pediatra specializzato in bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma. Per trent’anni si è occupato dello studio dei farmaci sia a livello dell’Università ha insegnato Farmacologia Clinica preso le Scuole di specializzazione in Farmacologia e Medicina Interna della Sapienza - sia nell’Industria - è stato direttore Medico per l’Italia di Pfizer e di società dl gruppo Schering. NOTA 6: I PROBLEMI DAL PUNTO DI VISTA RELIGIOSO. Resta un ultimo punto, ma non certo di minore importanza: le remore poste ad una adeguata terapia farmacologica del dolore grave nel malato terminale da concezioni e credi religiosi. Il tema non è facile - e lo affronto ancora una volta solo sulla base delle mie personali opinioni di credente che tiene conto dei pareri offerti alla meditazione delle coscienze da diversi magisteri. Come si esprime un autorevole anche se discusso teologo morale cattolico - Bernard Haring: “L’insegnamento del Magistero cattolico su argomenti concernenti la professione medica… richiede una cooperazione continua tra le autorità ecclesiastiche, la comunità dei teologi moralisti e degli studiosi di etica e gli appartenenti al mondo sanitario; non si tratta né deve trattarsi di una via a senso unico”. Questa posizione, tra l’altro, ha - a mio parere - il merito di evitare quella contrapposizione tra “sacralità della vita” e “dignità della vita” che troppo spesso tinge di mera ideologia un tema squisitamente umano come quello del morire. Non posso - non ne ho adeguata preparazione - e non voglio entrare nelle concezioni del dolore e della sofferenza umana che sono proprie di molte religioni, dall’ Ebraismo all’Islam al Buddismo all’Induismo alle credenze religiose dell’Africa e del Giappone: per una breve ma efficace rassegna di tali posizioni rimando al bel libretto di Flavia Caretta e Massimo Petrini pubblicato nel 1999 da Città Nuova. 15 Nella Bibbia Giobbe, di cui è nota e proverbiale la fede in Dio, invoca la morte: “Preferirei essere soffocato: la morte piuttosto che questi dolori!”. Il tema dell’eutanasia, se non altro, non nasce certo oggi. Ma il problema che qui vuole essere trattato ed è stato trattato, ormai dovrebbe essere chiaro, non è quello di indurre la morte o agevolarla (vale per noi sempre la frase di un bioetico del calibro di Edmund Pellegrino: “Intending the death of the patient would never be licit” che riecheggia la voce antica di Ippocrate), bensì quello di aiutare il sofferente, il malato con grave dolore in vicinanza della morte. A mio avviso, il punto di riferimento può meglio essere trovato nel vangelo di Matteo al versetto 34° del capitolo 27: Gesù è condotto al Golgota per essere crocifisso e, dice Matteo, “gli diedero da bere vino mescolato con fiele”. Si tratta (e poco importa che in altre versioni il “fiele” diventi “mirra” o il vino “aceto”) di una “bevanda inebriante che le donne giudee compassionevoli avevano la consuetudine di offrire ai condannati per attenuarne le sofferenze” (il commento, al contrario della sottolineatura, non è mio: è quello della Bibbia di Gerusalemme). Davanti al dolore del condannato, i compassionevoli astanti sentono il dovere, l’obbligo, di lenire le sue sofferenze: questo è il dovere, l’obbligo - a mio avviso - che il medico, come chi assiste compassionevole alle dilanianti sofferenze del malato, deve sentire. Poco importa da questo punto di vista, poi, che, sempre seguendo il racconto di Matteo, “Gesù, assaggiatolo, non ne volle bere” (Mt 27, 34b): la libertà del sofferente, la libertà del malato va sempre conservata e seguita oggi diremmo va seguito il suo diritto alla autodeterminazione, secondo il principio di autonomia, intesa come espressione di una libertà responsabile, consapevole e matura: e chi più responsabile consapevole e maturo del Cristo? - ma rimane il gesto della volontà di coloro che assistono al dolore di lenire le sofferenze. D’altra parte, il nostro specifico tema venne affrontato dal punto di vista cattolico - e a mio avviso risolto - con la famosa risposta data dal pontefice Pio XII al quesito posto nel 1957 dai partecipanti al IX Congresso della Società Italiana di Anestesiologia: “Voi ci domandate: la soppressione del dolore e della coscienza mediante narcotici, quando ciò è richiesto da una indicazione medica, è consentita dalla religione e dalla morale al medico e al paziente, anche quando si avvicina la morte e si prevede che l’uso dei narcotici accorcerà la vita? Bisognerà rispondere:” (è sempre il Papa che parla) “se non ci sono mezzi e se, nelle circostanze concrete, ciò non impedisce l’adempimento di altri doveri morali e religiosi, sì”; la risposta, molto chiara, a mio avviso, si completa e si precisa poco dopo quando si esige, ovviamente, per il comportamento su indicato che il malato dia o abbia dato il suo consenso. Gli interventi su questo tema dei pontefici successivi e delle Autorità ecclesiastiche non hanno modificato tale impostazione (Cito: “Spetta al medico essere sempre al servizio della vita ed assisterla fino alla fine, senza mai rinunciare a quel dovere squisitamente umano di aiutarla a compiere con dignità il suo percorso terrestre”; “Il dovere del medico consiste nell’ultima fase di una malattia incurabile nell’adoperarsi per calmare 16 la sofferenza”; “L’uso di analgesici per alleviare la sofferenza del moribondo anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni può essere moralmente conforme alla dignità umana se la morte non è voluta né come fine né come mezzo ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata e a questo titolo devono essere incoraggiate”; “Non sarebbe tuttavia prudente imporre come norma generale un comportamento eroico; al contrario, la prudenza umana e cristiana suggerisce per la maggior parte degli malati l’uso dei medicinali che siano atti a lenire o a sopprimere il dolore, anche se ne possono derivare come effetti secondari torpore o minore lucidità.”). La Sacra Congregazione arriva addirittura a esprimersi così: “Quanto a coloro che non sono in grado di esprimersi, si potrà ragionevolmente presumere che desiderino prendere tali calmanti e somministrarli loro secondo i consigli del medico” (si tratta qui, come si vede, di una posizione del tutto analoga a quella accettata e propugnata da bioetici “laici” come Jonas - che afferma: “Here the oath “not to harm” can come into conflict with the duty to relieve, when harmful doses became necessary to cope with the torture of intractable constant pain. Which duty should prevail ?” - e Engelhardt jr.). In seguito, richiamando la ricordata risposta di Pio XII, la Congregazione spiega che nel caso cui il Papa fa riferimento “la morte non è voluta né ricercata benché se ne corra il rischio per una ragionevole causa: lenire il dolore in maniera efficace, usando a questo scopo gli analgesici di cui la medicina dispone” (è singolare, a mio avviso, la posizione, che appare analoga a quella della recente sentenza della Suprema Corte degli USA, già ricordata in una mia nota precedente, ma in cui la Chiesa viene a vantare una priorità di venti e forse di quaranta anni rispetto alla pronuncia della Corte) anche se nel caso di analgesici che producano perdita di coscienza va sempre ricordato che “non è lecito privare il moribondo della coscienza di sé senza grave motivo” (la sottolineatura e il corsivo sono miei: ne consegue che con il “grave motivo” la cosa è lecita). La eventuale perdita di coscienza indotta viene tollerata (dal punto di vista etico) ma non intesa o voluta: diverso ovviamente sarebbe il caso “se con l’uso di dosi massicce di analgesici oppiacei si praticasse scientemente anche se in maniera occulta una eutanasia vera e propria” (la sottolineatura è mia). 17 L'Essenza della religione ed il suo scopo Voglio qui rispondere a tre domande: 1) Qual è l'essenza della religione? 2) Lo scopo della religione viene raggiunto in questo mondo o proprio al mondo a venire? 3) Lo scopo della religione è per il bene del Borè o per il bene degli esseri viventi? Ed a prima vista si sorprenderà chiunque prenda visione delle mie parole e non capirà le tre domande che mi sono posto come tema di questo articolo. Poiché tutti lo studiano già dall’infanzia, e chi non saprebbe cos’è una religione? E tanto più la ricompensa e la punizione riguardo ad essa, che è sperata e prevista soprattutto al mondo a venire. E senza parlare della terza domanda, poiché tutti sanno che essa avvantaggia gli esseri viventi per guidarli al benessere ed alla felicità. E che altro c'è d'aggiungere a questo? Ed in verità non ho da aggiungere niente, però dal fatto che tutti sanno queste tre conoscenze, ed è così abituale nelle loro bocche dalla loro infanzia alla perfezione, fino a che non hanno nessuna aggiunta e nessuna chiarificazione di cose per tutta la loro vita, ecco questo indica una mancanza di conoscenza in queste cose sublimi, essendo esse necessariamente tutti i fondamenti della base sulla quale si appoggia ed è costruito tutto il carico dell'edificio religioso. Ed allora ditemi, come può essere che un ragazzino di dodici o quattordici anni (ndr. Prima e dopo la cerimonia di Bar-Mitzvà, all’età di 13 anni), sia già pronto nel suo intelletto a comprendere in perfezione ed a capire queste tre conoscenze da indagare sottilmente? E tanto più in modo talmente sufficiente che lui non debba (da non dover) aggiungervi altra conoscenza ed intelletto in tutti i giorni della sua vita? In effetti qui è sepolta la cosa! Dato che questa supposizione frettolosa ha apportato a tutta la sventatezza ed alle conclusioni selvagge che hanno riempito l'aria del nostro mondo in questa generazione! E ci portò ad una situazione nella quale la seconda generazione si è quasi tutta persa dalle nostre mani. Il «Bene Assoluto» E per non affaticare chi studia con cose lunghe, mi sono appoggiato a tutto ciò che fu scritto e spiegato negli articoli precedenti e soprattutto su quello che è stato commentato nell'articolo «Il Dono della Toràh», i quali sono tutti come una prefazione al tema sublime che è davanti a noi. E qui parlerò concisamente e più semplicemente possibile, affinché sia comprensibile ad ogni Nefesh (ndr. Lett. Ad ognuno). 18 E per prima cosa bisogna comprendere il Boré, il quale è il «Bene Assoluto». Vale a dire che in nessun caso al mondo è possibile che Egli provochi del dolore a qualcuno, cosa che è da noi compresa come prima assioma. Poiché il buon senso ci fa vedere chiaramente che la base di tutti coloro che provocano del male è definita esclusivamente come "desiderio di ricevere". Questo vuol dire, che per il fatto di essere avido di ricevere dei benefici per completare se stesso, proprio per questo va a far del male al prossimo, per il "desiderio di ricevere" il proprio completamento. Così che se la creatura non avesse trovato nessuna soddisfazione per se stessa, non ci sarebbe stata nessuna creatura al mondo la quale faccia del male all'altra. E se ogni tanto noi troviamo qualche creatura la quale danneggia l'altra senza nessun desiderio di ricevere piacere per se stessa, essa non lo fa altro che per un'abitudine precedente che all'inizio le giunse dal desiderio di ricevere, quando l'abitudine la libera ora di qualunque causa nuova, come è risaputo. E dato che è da noi compreso che il Borè è Completo di per Sè, e non ha bisogno di qualcuno che Lo aiuti per il Suo completamento, essendo Lui stesso Precedente ad ogni cosa, quindi è chiaro che Lui non ha nessun “desiderio di ricevere”. E dato che non ha nessuna distinzione di desiderio di ricevere, comunque non ha nessuna base di far male a qualcuno, e questo è una semplicità assoluta. E non solo, ma è accettato ed è consono al nostro cuore con assoluta semplicità l'assioma che Lui ha desiderio di Dare in assoluto, bene al prossimo, vale a dire le Sue creature, cosa che ci viene dimostrata da tutta l'immensa Creazione che ha creato ed ha disposto davanti a noi. Perchè necessariamente ci sono qui in questo mondo creature che percepiscono o una sensazione buona o una cattiva sensazione. E, qualunque sia la sensazione che percepiscono, essa è necessariamente loro provocata dal Borè. E dato che si sa con assoluta certezza che non esiste nella legge del Borè il far del male, come è stato chiarificato, se è così che necessariamente tutte le creature ricevono da Lui solo benefici, ecco che creò le creature solamente per beneficiarle. Abbiamo appreso che Lui ha solamente desiderio di dare in assoluto solamente il Bene, ed in nessun modo non sarà tracciato nella Sua legge nemmeno un grammo di danno e di sofferenza che provenga da Lui. Quindi Lo abbiamo definito con il nome «Il Bene Assoluto». E, dopo aver saputo tutto questo, andiamo ad osservare come Lui Dà in assoluto solamente Bene a loro nella concreta realtà che viene diretta e governata da Lui. 19 «La Sua Provvidenza è diretta alla meta» È da noi compreso da di tutti i sistemi della natura che sono esposti ai nostri occhi, che in ogni singola creatura dei quattro tipi: Inanimato, Vegetale, Animale e Parlante, sia in genere che in particolare, noi troviamo in essi la provvidenza "mirata”, vale a dire uno sviluppo lento e graduale nel modo di sviluppo secondo "causa ed effetto”. Come il frutto sull'albero, il quale è supervisionato a buon fine, affinché alla sua fine sia un dolce e bel frutto. E vai e chiedi al botanico, quante situazioni passano su questo frutto dal momento che è visibile ai nostri occhi fino a quando giunge al suo scopo, il che è il termine della sua maturazione. Quanto a tutte le situazioni che precedono il suo termine, esse non soltanto non ci fanno vedere nessun esempio che sia in conformità al suo fine bello e dolce, ma in più, come per irritarci, ci fanno vedere l'opposto della forma finale. Vale a dire che quanto più il frutto è dolce al suo termine, è più amaro e più spregevole nelle precedenti situazioni nella sequenza del suo sviluppo. Ed è così per la specie animale e per quella "parlante", poiché l'animale il cui intelletto è scarso alla fine del suo sviluppo non è così deficiente durante il suo sviluppo. Al contrario dell'uomo, il cui intelletto è vasto al termine del suo sviluppo, è molto carente nella strada del suo sviluppo. Poiché «il vitello di un giorno viene considerato toro», vale a dire che ha la forza di stare in piedi sulle sue zampe e muoversi ed ha l'intendimento per riguardarsi da rischi che si trovano nella sua strada. Mentre invece il neonato di un giorno è disteso come se fosse privato dei sensi. E se ci raffigurassimo chi non è abituato alle esperienze di questo mondo, esso, osservando questi due nati, avrebbe certo detto per quanto riguarda il neonato dell'uomo, che esso anche alla fine (ndr. del suo sviluppo) non riuscirà in niente. E per quanto riguarda l'animale nato avrebbe detto che qui è nato un grande eroe. Vale a dire se avesse giudicato secondo la misura della saggezza del vitello in confronto al neonato umano stupido e privo di tutti i sensi. Ecco è evidente che la Divina Provvidenza sulla realtà che ha creato non è altro che una Provvidenza "diretta alla meta", senza prendere per niente in considerazione la sequenza delle fasi di sviluppo. Dato che all'incontrario la loro maniera è quella di ingannarci e di distoglierci dal comprendere il loro fine essendo sempre nella situazione opposta al termine della loro opera. E riguardo a cose così, noi diciamo «Non esiste un saggio come chi possiede esperienza», dato che solamente chi ha l'esperienza, avendo l'opportunità di vedere la creatura in tutte le situazioni del suo sviluppo fino al suo giungere alla sua completezza, può tranquillizzare tutto questo turbamento, affinché non si abbia per niente paura per tutte quelle immagini guaste, nelle quali la creatura si appiglia durante le fasi di sviluppo, avendo solamente fede nel termine della sua maturazione bella e limpida. 20 Ed ecco sono state chiarite in modo esauriente le vie della Sua Divina Provvidenza nel nostro mondo, la quale è solamente la distinzione di Provvidenza diretta verso la meta, nella quale la misura del bene non è per niente riconoscibile prima che la creatura giunga al suo punto terminale, al termine della sua forma e della sua maturazione. Ed all'incontrario, la sua via è quella di svilupparsi sempre in un involucro di guasti rispetto a chi osserva. Ecco è davanti ai tuoi occhi che il Creatore dà in assoluto alle Sue creature solamente Bene, ma che questo Bene viene da Esso provvisto per mezzo della Provvidenza diretta alla meta. Le due vie: la via della sofferenza e la via della Toràh Ci è stato dunque spiegato che il Creatore è il Bene Assoluto. Ed Esso ci provvede con completa Benevolenza senza nessun miscuglio di male. Indubbiamente nella distinzione di provvidenza diretta ad una meta. Il che vuol dire che la Sua Provvidenza ci obbliga a ricevere un ordine di situazioni diverse nel modo di causa ed effetto, vale a dire ciò che precede e che ne risulta, fino a che si diventa qualificati a ricevere il Bene anelato. Ed allora giungeremo al nostro fine, come il bel frutto alla fine della sua maturazione. E con questo è compreso che questo fine è di certo assicurato a noi tutti, perchè altrimenti tu apponi un difetto sulla Sua Provvidenza, dicendo che non sia sufficiente per la Sua meta. Ed è quello che dissero i nostri Saggi: «La Shkhinà negli inferiori è un bisogno supremo». Vale a dire che, dato che la Sua Provvidenza è diretta alla meta, la quale è portarci alla fine alla Sua adesione, affinché Essa risieda in noi, ecco che questo viene considerato come una necessità suprema. Vale a dire che se noi non arriveremo a questo troveremo imperfezione nella Sua Provvidenza. E la cosa assomiglia ad un grande re che, ormai vecchio, ebbe un figlio e gli volle molto bene. E quindi, dal momento nel quale lui nacque, pensò a benefici per lui, e fece la raccolta dei libri più preziosi, ed i dotti ed eccellenti dello Stato e preparò per lui una scuola di Saggezza ed andò a chiamare i più famosi costruttori e costruì per lui palazzi di delizia e riunì tutti i musicisti e cantori e gli preparò case di canto e chiamò i cuochi migliori che gli forniscano i cibi più prelibati del mondo. Ed il bimbo crebbe e diventò grande. E lui è ignorante e non ha interesse per gli studi, è cieco, non vede e non percepisce la bellezza dei palazzi, ed è sordo e non sente la voce dei cantori e degli strumenti musicali ed è malato e non gli è permesso mangiare altro che una fetta di pane grezzo, che sdegno e rabbia! Però un fatto simile può succedere ad un re in carne ed ossa, cosa che non è possibile dire nei confronti del Creatore, che sia benedetto, dato che non esiste in Esso alcun inganno. Di conseguenza ci ha preparato due vie di sviluppo: 21 L'una è la Via della Sofferenza, la quale è la sequenza di sviluppo inerente alla Creazione di per sè, la quale è obbligata per sua natura a continuare a ricevere, nella via di causa ed effetto, situazioni diverse una dopo l'altra, per mezzo delle quali noi ci sviluppiamo piano piano, fino a giungere alla consapevolezza di scegliere il bene e ripugnare il male, e giungere alla qualificazione che ha lo scopo da Lui desiderato. E questa via è in effetti assai lunga e colma di sofferenze e dolori. Quindi Egli ci ha preparato in confronto a questo una strada piacevole e benefica, la quale è la via della Toràh e dei precetti, la quale ci può rendere idonei alla nostra meta in breve tempo e senza sofferenze. Esce da tutto ciò che la nostra meta finale è la nostra qualificazione alla Sua adesione che sia benedetto, affinché Egli risieda in noi. E questa meta è una cosa sicura senza nessuna possibilità di deviare da essa. Dato che la Divina Provvidenza è imposta su di noi con i due modi della Sua Provvidenza, che sono la via delle sofferenze e la via della Toràh, come è stato spiegato. Però per quanto riguarda la realtà pratica, noi troviamo che la Sua Provvidenza giunge con le due vie assieme, ed esse vengono chiamate nei detti dei nostri saggi: «Derech Erez- Via della Terra» e «Via della Toràh». L'essenza della religione è sviluppare in noi stessi il senso della conoscenza del male E queste sono le parole dei nostri Saggi: «E perchè cosa importa al Creatore a chi macella (l'animale) al collo o alla nuca? Ecco che non furono dati i precetti se non per purificare con esse le creature». Ed il fatto di questa purificazione è stato chiarificato in modo esauriente nell'articolo «Il Dono della Toràh». Però qui chiarificherò cosa è l'essenza di questo sviluppo che è ottenuto per mezzo dell’occupazione della Toràh e dei precetti. E sappi che è il riconoscimento del male che è in noi stessi. Dato che l'occuparsi dei precetti è capace di purificare chi si occupa di essi con una purificazione graduale e lenta, quando il criterio dei gradi della purificazione è proporzionata alla misura della riconoscenza del male che è in noi. Poiché l'uomo è già pronto, per sua natura, a respingere ed estirpare ogni cosa maligna dal suo intimo. E questo è nella stessa misura in ogni singola creatura. Però tutta la differenza fra una creatura e l'altra consiste solamente nel riconoscimento del male, quando una creatura più sviluppata riconosce in se stessa una misura più grande di male ed in ogni caso discerne e respinge il male da se stessa in una misura più grande. E la creatura non sviluppata si trova a percepire in se stessa una piccola misura di male e quindi respingerà da se stessa solamente una piccola misura di male e di conseguenza rimane in essa tutta la lordura, dato che non la riconoscerà per niente come sporcizia. 22 E per non stancare chi studia, chiarificheremo il bene ed il male in generale, come è stato chiarito nell'articolo «Il Dono della Toràh», quando il male, in generale, non è altro che amore per se stessi, che viene chiamato «egoismo», essendo in opposizione di forma al Creatore, il Quale non ha per niente il desiderio di ricevere per Se Stesso, ma solamente quello di dare in assoluto. E come è stato chiarito nell'articolo «Il Dono della Toràh», il piacere e la delizia sono del tutto e per tutto nella misura dell'equivalenza di forma al suo Artefice. E perciò l'egoismo ci è disgustoso e ci apporta del tutto dolore, non essendo in equivalenza di forma con l'Artefice. Però questa repulsione non è uguale in ogni anima ma si divide fra di noi in misure diverse. Dato che l'uomo selvaggio che non è per niente sviluppato, non riconosce l'egoismo come una cattiva qualità. E quindi ne fa uso in modo esplicito senza vergogna e limiti, egli deruba e ammazza alla luce del giorno, per quanto gli sarà possibile. E chi è un po' sviluppato già percepirà una certa misura del suo egoismo nella distinzione di male (o come malefica) e per lo meno si vergogna di prenderne uso in pubblico, di derubare ed ammazzare le Nefashòt in un posto evidente ed in riserbo commette il suo crimine. E colui che è più sviluppato, si trova a percepire l'egoismo come una cosa del tutto disgustosa, fino a non poterlo sopportare in se stesso e lo respinge e lo espelle del tutto, secondo il valore della sua conoscenza di esso, fino a che non vuole e non può godere del lavoro altrui. Ed allora iniziano a risvegliarsi in se stesso scintille di amore per il prossimo, che viene chiamato «altruismo», il quale è l'attributo del Bene in generale. E anche ciò si accende in lui in una sequenza di sviluppo graduale. Vale a dire che all'inizio si sviluppa in lui il senso di amore e di Ashpaà nei confronti di coloro che gli sono vicini e della sua famiglia, secondo lo scritto «Ashpaà a tutti coloro che sono nel suo ambiente, che sono i cittadini della sua città o della sua nazione. E così continua fino a che si sviluppa in lui la distinzione dell'amore per il prossimo, per tutta l'intera l'umanità. Sviluppo consapevole e sviluppo inconsapevole E sappi che due forze sono a nostro servizio e ci spingono a salire ed a scalare i gradini della scala menzionata, fino a che giungeremo alla sua cima nel Cielo, la quale è il punto di meta dell’equivalenza di forma con l’Artefice, che sia benedetto. E la differenza fra quelle due forze è che l’una ci sprona dal di dietro. Ed è quella che abbiamo definito col nome «Via della Sofferenza» o «Via della Terra». E da essa ci è giunta la filosofia della morale, chiamata Etica, la quale è basata sulla conoscenza empirica, vale a dire dalla critica della intelligenza pratica, l’essenza della quale non è altro che il sommario dei danni nati davanti ai nostri occhi a mezzo dei semi dell’egoismo. 23 Ed ecco queste prove sono giunte a noi per caso, vale a dire inconsapevolmente e senza nostra scelta. Ciononostante esse apportano indubbiamente alla loro meta, dato che l’immagine del male continua a chiarirsi nei nostri sensi. E nella misura nella quale noi riconosciamo i suoi danni, nella stessa misura noi ci allontaniamo da esso. Ed allora noi giungiamo ad un gradino più elevato nella scala. E la seconda forza ci spinge "consapevolmente", vale a dire con la forza della nostra stessa scelta. E questa forza ci attira dal davanti. Ed è quella che abbiamo definito con il nome «La via della Toràh e dei precetti». Perchè dedicandoci alle Mizvot ed al Lavoro (Spirituale) per compiacere il nostro Artefice, si sviluppa in noi con eccezionale velocità il senso della conoscenza del male, come è stato spiegato nell'articolo «Il Dono della Toràh». E noi guadagniamo due volte: 1) per prima cosa per il fatto di non dovere aspettare le prove della vita affinché esse ci incalzino dal di dietro, quando l'intera misura della loro spinta che è in esse viene misurata solo secondo la misura dei dolori e della distruzione che vengono provocate dalla esistenza del male in noi stessi. Però nella via del Lavoro (Spirituale) per il Creatore, si sviluppa in noi la stessa consapevolezza senza l'anticipo delle sofferenze e della distruzione ed al contrario dalla sensazione di piacevolezza e del diletto che noi percepiamo nel puro servizio per il Creatore, per compiacerLo, si sviluppa in noi un atteggiamento relativo di consapevolezza della bassezza di quelle scintille di amore per noi stessi, dato che esse ci interferiscono nella nostra strada per ricevere questo squisito gusto di Ashpaà al Creatore. In tal modo il senso graduale della consapevolezza del male continua a svilupparsi in noi nei momenti di delizia e grande tranquillità, vale a dire ricevendo il Bene lavorando per il Creatore, dalla sensazione di soavità e diletto che giunge a noi allora per l'equivalenza di forma con il suo Artefice. 2) Risparmiamo tempo, dato che Lui opera "a nostra consapevolezza" ed è nelle nostre mani incrementare il nostro lavoro Spirituale ed affrettare i tempi secondo il nostro desiderio. La religione non è per beneficio delle creature ma del lavoratore. Molti sbagliano e comparano la nostra santa Toràh alla filosofia dell'Etica. Però questo giunse a loro perchè non hanno mai gustato il gusto della Religione ed io proclamo riguardo a loro lo scritto: «Gustate e vedete che il Creatore è buono». In effetti è vero che tutte e due, l'etica e la Religione, mirano ad un'unica cosa, la quale consiste nell'innalzare l'uomo dalla lordura del gretto amore per se stesso e portarlo all'apice della vetta dell'amore per il prossimo, ciononostante esse sono lontane l'una dall'altra come è lontano il Pensiero del Creatore dal pensiero delle creature. Poiché la Religione è protratta dai pensieri del Creatore e l'etica proviene da pensieri degli uomini e dalle loro esperienze di vita. 24 Di conseguenza è evidente e pronunciata la differenza fra esse sia in tutti i punti che sono nelle distinzioni pratiche, che nella meta finale. Dato che la conoscenza del male e del bene che si sviluppa in noi per mezzo dell'etica, accumulando esperienza, ha una connessione relativa al successo della società, come è ben saputo. Non è così riguardo la Religione, quando la conoscenza del bene e del male che si sviluppa in noi, praticandola, ha una connessione relativa solo all'Unico Creatore, vale a dire dall’opposizione di forma dall'Artefice, fino all'equivalenza di forma a Lui, che viene chiamata «Adesione», come ti è stato chiarito nell'articolo «Il Dono della Toràh». Ed esse sono del tutto lontane una dall'altra per quanto riguarda la meta. Dato che la meta dell'etica è il benessere della società secondo la critica dell'intelligenza pratica, che proviene dalle evenienze della vita, quando alla fin fine la meta non assicura a chi vi si occupa nessuna elevazione al di sopra dei confini della natura, e quindi questa meta non è ancora scaturita dalla critica dell'intelligenza pratica, come è risaputo, perchè chi potrà provare al singolo la misura del suo bene in modo così estremo che sarà obbligato a diminuire il proprio essere in qualche quantità, per la felicità della società. Mentre invece la Meta Religiosa assicura la felicità dell'uomo stesso che si occupa in essa. Perchè abbiamo già dimostrato che nell'apportare l'uomo all'amore per il prossimo, esso si trova direttamente nella distinzione di Adesione, la quale è l'equivalenza di forma col Suo Artefice, assieme alla quale l'uomo passa dal suo mondo ristretto colmo di dolori ed ostacoli ad un mondo eterno ampio di Ashpaà al Creatore ed Ashpaà alle creature. Troverai anche una significativa e pronunciata differenza per quanto riguarda il sostegno, perchè l'occupazione secondo l'etica viene sostenuta dalla base di piacere alle creature. E questa cosa è simile all'affitto che conviene alla fine dei conti, e quando la persona si abitua ad un lavoro simile, ecco che non potrà innalzarsi nemmeno nei gradini della morale, perchè è già abituato a questo lavoro che è retribuito molto bene da parte della società che lo paga per le sue buone azioni. Mentre invece nell'occuparsi della Toràh e dei precetti per provocare piacere al proprio Artefice senza ricevere premio, ecco che lui continua a scalare i livelli della morale proprio secondo la misura della attività, dato che non riceve nessun pagamento per la sua strada, e spicciolo dopo spicciolo, si riunisce in un grande conto, fino a che acquisisce una seconda natura la quale è Ashpaà al prossimo, senza nessun risveglio del ricevere per se stesso escluso solo il necessario per la sua esistenza. E si è trovato che veramente si è liberato da tutte le coercizioni della Creazione, perchè quando l'uomo abomina il ricevere per se stesso e la sua anima aborrisce le cose superflue di piccoli piaceri corporali ed onore e cosi via, si è trovato che lui passeggia libero nel mondo del Creatore, e gli è assicurato che qui non gli verrà apportato nessun danno e nessun incidente, dato che tutti 25 i danni sono percepiti e giungono all'uomo solo da parte del ricevere per se stesso che è impresso in lui. Ed ecco è stato chiarito in modo appropriato che la meta della Religione è solamente per l'individuo che opera in essa e vi si occupa, e non è per niente per l'uso ed il beneficio delle persone comuni, nonostante tutte le sue (dell'individuo) azioni sono imperniate al bene delle creature e sono misurate da atti tali. Ma questo non è altro che una distinzione di passaggio verso la meta sublime, la quale è l'equivalenza alla forma dell'Artefice e con questo viene anche compreso che la meta della Religione viene riscossa vivendo in questo mondo. 26 IL DOLORE NELLE TRE RELIGIONI MONOTEISTE L'approccio della fede cristiana, ebraica e muslmana nella testimonianza di un sacerdote cattolico, una diaconessa valdese, un rabbino e un esponente della comunità islamica Quando il dolore e la sofferenza fisica diventano esperienza di vita l’uomo si interroga, cerca spiegazioni, aiuto, risposte capaci di donargli serenità interiore e forza per affrontare la malattia. Alcuni riscoprono così la fede, o rafforzano il proprio rapporto con Dio; altri se ne allontanano o non riescono più a conciliare la propria concezione del divino con quanto devono affrontare e soffrono quindi anche nello spirito. Quali differenze e quali gli elementi comuni tra cristiani, ebrei, musulmani di fronte al dolore e alla morte? Quali risposte al problema della sofferenza dalle 3 grandi religioni monoteiste? Un confronto fra i diversi approcci (messo a fuoco dal Centro Peirone di Torino con un Convegno nel capoluogo piemontese, a fine 2002), permette di cogliere come, pur essendovi nelle diverse fedi differenti sensibilità e spiegazioni, vi sia comune necessità di rivolgersi a Dio per trovare un aiuto e si condivida l’impegno alla vicinanza e alla solidarietà nei confronti di chi è provato dal dolore. «Per comprendere il significato della sofferenza nella propria esistenza – spiega don Paolo Mirabella, docente di Morale alla Facoltà teologica di Torino – il cristiano deve liberarsi da 2 equivoci: che il dolore sia un valore in sé e che in quanto tale sia desiderabile e vada ricercato. Quanto al primo equivoco, esso si radica su un ambiguo presupposto, cioè che Dio voglia il dolore dell’uomo, anzi che sia lui stesso a procurarglielo al fine di castigarlo per la sua disobbedienza. La morte in croce di Gesù è invece contemporaneamente l’espressione massima della sua condivisione con noi: in questo modo il Crocifisso rivela da una parte l’amore misericordioso di Dio, che è all’origine della stessa iniziativa di salvezza che vuole l’uomo elevato alla vita divina, e dall’altra la giustizia di Dio che esalta l’uomo al punto da volerlo coinvolto e protagonista nell’attuazione della redenzione, per cui lo invita nella libertà alla collaborazione. Di qui una prima considerazione: il Dio di Gesù Cristo non è né invidioso né vendicativo, Egli vuole il vero bene dell’uomo». Se il dolore per il cristiano non è voluto da Dio, non è neanche da ricercare, quanto da affrontare e da accettare come parte dell’esistenza, nonostante la società attuale cerchi di negarlo. «Compito del nostro tempo rispetto al tema del dolore – prosegue Mirabella – sarà pertanto quello di ritrovare gli affetti e le parole per dire questa esperienza: solo a questa condizione sarà possibile affrontarla senza doverla forzatamente emarginare oltre i confini dell’umano. Oggi il dolore viene infatti trasformato e ridotto a tabù su cui si erge il divieto di parlarne, di sopportarlo, di avvicinarlo nelle persone che soffrono». Un tabù che non fa che aggravare la situazione di chi sta vivendo l’esperienza della malattia e quindi sta sperimentando il contrasto tra la dipendenza dagli 27 altri e la sensazione di estraneità nei confronti di chi è sano e sta provando il senso di abbandono dalla salute, dalla vita e dagli affetti. Nel dolore si tocca la radicalità del proprio limite, l’attaccamento alle uniche cose che possono restare come fondamentali «e che – conclude Mirabella – devono essere garantite, sia attraversol’attestazione che non tutto è perduto, sia con una presenza che non è saccente, che non giudica, non sottovaluta, non minimizza superficialmente». La presenza accanto al malato può anche aiutare spiritualmente il sofferente nel conciliare la sua situazione con la fede. «Al credente – spiega la diaconessa Gabriella Casanova della Chiesa evangelica valdese di Torino – è chiesto non di negare l’assurdo della sofferenza, né di proclamare chiaro ciò che è oscuro, ma di vivere anche l’assurdo al cospetto di Dio. Gesù ci testimonia che Dio è vicino anche quando la situazione si fa desolata, assurda, disperata. Vissuta nella fede, la sofferenza, da minaccia per la vita, può diventare occasione di crescita, di comprensione, di forza, di riflessione, di fiducia». Anche dai testi biblici emerge per il cristiano l’invito alla vicinanza al malato e alla preghiera. «Il testo della lettera di Giacomo – prosegue la diaconessa – mi ha particolarmente colpita perché affronta il problema della sofferenza fisica e psicologica non protestando, né interrogando, né cercando spiegazioni. Bensì pretendendone il superamento. La sofferenza psicologica e la gioia sono vissute in un rapporto diretto e personale con Dio, nei confronti della malattia fisica, invece, si è invitati a chiamare ‘gli anziani della chiesa’, e a pregare per il malato ‘ungendolo con olio nel nome del Signore’. Giacomo punta dunque all’empatia verso chi sta soffrendo, al tocco dell’amore (unzione con olio), alla preghiera. Oggi non esiste quasi più la pratica dell’unzione (ad eccezione dell’estrema unzione praticata dallaChiesa cattolica), ma il contatto fisico come tenere la mano, accarezzare la fronte, ravvivare i capelli, sono azioni fondamentali per trasmettere il calore della vita. Dio non si colloca come alternativa alla nostra sofferenza, ma all’interno di essa. La croce di Cristo, espressione della sofferenza umana, diventa anche sofferenza di Dio. La croce che egli porta è la nostra. Dio in Cristo non è estraneo al dolore e alla sofferenza, li assume per dare consolazione e sollievo. Spesso nelle nostre preghiere chiediamo a Dio di cambiare o modificare le situazioni che ci arrecano tormento sia fisico che morale, ma Dio vuole innanzitutto cambiare noi stessi. Il vero miracolo non è il cambiamento delle situazioni esterne, ma quello della nostra realtà interna che ci dà la capacità di vedere e riconsiderare in modo nuovo e diverso le condizioni in cui ci troviamo». La sofferenza si può dunque trasformare in un’ottica cristiana in occasione di crescita, di riflessione sulla vita. Nella concezione ebraica invece il dolore, pur essendo inteso come prova alla quale viene sottoposto il giusto, è considerato una minaccia non solo per la vita fisica, ma anche per quella spirituale e quindi deve essere il più possibile rifuggito e alleviato: la preghiera diventa fondamentalmente una richiesta a Dio di abbreviare le sofferenze. La solidarietà della comunità ebraica nei confronti del malato rappresenta comunque una priorità, da attuare con impegno e attenzione nei confronti delle 28 necessità materiali e spirituali della persona. «Un’assistenza – ha ricordato il rabbino Giuseppe Momigliano della comunità ebraica di Genova – che richiede la disponibilità a pregare, a cogliere il dolore, la sofferenza, la preoccupazione: gli stati d’animo espliciti e quelli a volte taciuti dal malato o dai suoi famigliari». Anche il musulmano trova nella comunità un sostegno prezioso nel momento della malattia, unincoraggiamento alla perseveranza, anche se spiega Hasan Amghar El-Boujarfaoui della comunità islamica di Grenoble : «i testi fondanti dell’Islam, il Corano et la Sunna utilizzano assai poco la parole ‘sofferenza’, il termine ‘dolore’ non esiste: si trovano soprattutto dei termini come ‘male’ o ‘prova’. Nel giardino Adamo et Eva, gli uomini, erano protetti dalle sofferenze di questo mondo. Quando si sono ritrovati sulla terra erano sottoposti alle leggi della natura senza protezione: è questo che il Corano chiama “prova”, ma non è una condanna. Dio chiama l’uomo ad assumersi le sue responsabilità, ma può intervenire in ogni momento per alleggerire la sua sofferenza ». Se la sofferenza rappresenta una prova, l’Islam rifiuta il «Mektoub», cioè la fatalità, mentre invoca un altro termine citato nel Corano: l’«As-sabr», che viene tradotto come «pazienza» o come «costanza ». La valorizzazione della pazienza e della costanza virtuosa, mostra come l’Islam esorti il musulmano a battersi per uscire dalla sofferenza, convinto che il domani sarà migliore. Anche l’Islam infine invita ad uno slancio di solidarietà verso coloro che soffrono, «un appello – conclude Hasan Amghar – rafforzato dal fatto che Dio nel giorno del giudizio verrà in aiuto a chiunque abbia aiutato un credente». Federica Bello 29 IL SENSO DEL DOLORE NELL'ISLAM Come si pone la cultura musulmana rispetto ai temi della sofferenza e della morte? Quale atteggiamento propone di fronte alla malattia? Quali regole fisse per la sepoltura dei defunti? Sono le questioni messe a fuoco nelle prossime pagine, con l’intervento di studiosi e testimoni L’atteggiamento dell’islam nei confronti del mistero della sofferenza è a tratti simile, a tratti differente rispetto alla rivelazione ebraico-cristiana. Il cristianesimo si fonda su un Dio crocifisso e risorto. La dimensione della croce è dunque costitutiva della fede cristiana, qualunque sia il modo concreto in cui venga intesa. L’islam nega la morte in croce di Gesù: benché sottomesso lui stesso alla prova, non è pensabile che un autentico profeta musulmano sia lasciato morire dal Dio che lo invia. Al contrario, l’obiettivo che informa la proposta musulmana è il successo, constatabile già sulla terra. La religione musulmana non conosce la dimensione della storia della salvezza e della redenzione. Conosce invece un Dio che crea, che mantiene in vita la creazione e che attende gli uomini per il giudizio finale. L’islam si caratterizza per l’assoluta sottomissione ad Allah e alla sua volontà, sempre disponibile e accessibile a ognuno che crede attraverso il duplice «segno» del Corano e delle vicende dell’esistenza. È Allah che domina e dirige il cammino, la vita e la morte dei suoi fedeli. Nulla sfugge al suo Decreto. L’atteggiamento fondamentale raccomandato ai musulmani, dunque, è quello della pazienza nelle avversità, nel dolore, nella malattia e nella morte. Così dice il Corano: “Il vostro Dio è un Dio unico, sottomettetevi dunque a lui! E tu dà buone notizie a quelli che si umiliano, a quelli che trepidano in cuor loro sentendo ricordare il nome di Dio, a quelli che pazientano nei mali che li affliggono, a quelli che sono fedeli alla preghiera ed elargiscono una parte dei beni che abbiamo loro accordato. (Cor 22,34-35). O voi che credete! Cercate aiuto nella pazienza e nella preghiera, perché Dio è con i pazienti (…) Vi metteremo alla prova con la paura e la fame, con la perdita dei beni, della vita e dei frutti della terra; tu però dà il lieto annuncio della felicità eterna ai pazienti i quali, quando sono colpiti da una sventura, dicono: «In verità, a Dio apparteniamo e a Dio ritorniamo». (Cor 2,153.155- 156)” 1. La sottomissione e la pazienza di cui parla il Corano non vanno intese come «fatalismo». L’islam non propone la sottomissione al fato impersonale e cieco ma alla volontà positiva di Allah, che non dimentica mai i suoi fedeli e si interessa del loro bene. Cercheremmo invano nel Corano e nella Sunna gli interrogativi e le proteste di Giobbe di fronte al male che domina il mondo, alla sofferenza innocente, alla morte prematura e «ingiusta». Vi sono invece molte espressioni che echeggiano l’atteggiamento di Giobbe nei primi due capitoli del libro omonimo, benché le premesse siano differenti. 30 Ciò che il Corano ripete in alcuni versetti è illustrato ampiamente, variato, amplificato e talora arricchito di sfumature diverse nella tradizione normativa o Sunna. Alcuni hadîth 2 illustrano la modalità di rapportarsi ad Allah nella disgrazia e nella malattia. Ne riportiamo in particolare due che riguardano la famiglia di Muhammad 3 e che pertanto diventano estremamente significativi e «didattici» per la comunità dei credenti musulmani: La figlia del Profeta gli mandò a dire: «Mio figlio è in punto di morte: vieni ad assisterci». Egli mandò il suo augurio di pace, e a dire: «Appartiene a Dio ciò che Egli prende, ed è Suo ciò che Egli dona: ogni cosa è annoverata presso di Lui secondo un termine fisso: sii paziente e rimettiti alla ricompensa di Dio». E lei mandò a scongiurarlo che si recasse da lei; egli si alzò per andare. (…) Il bambino fu sollevato fino all’Inviato di Dio, che se lo fece sedere in grembo; il suo animo trasalì, e gli si inumidirono gli occhi. Sa’d gli chiese: «Inviato di Dio, che cosa c’è?»; ed egli rispose: «Questa è compassione, che Iddio ha posto nel cuore dei suoi servi». (I, n. 29a, p. 20) L’Inviato di Dio entrò da suo figlio Ibrahim che già stava affrontando la morte; e gli occhi dell’inviato di Dio presero a versare lacrime; ‘Abd al-Rahman ben ‘Awf intervenne: «Anche tu, Inviato di Dio?!»; «Figlio di ‘Awf, questa è compassione». Riprese a piangere un’altra volta e disse: «L’occhio versa lacrime, e il cuore è afflitto, ma non diciamo che ciò che soddisfa il nostro Signore. E noi, Ibrahim, siamo afflitti per la tua separazione» (VII, n. 34, p. 279). Le due tradizioni, la prima delle quali echeggia quasi letteralmente la prima risposta di Giobbe nella sua disgrazia (cf Gb 1,20-22), operano una distinzione netta tra la compassione (rahma) di fronte alla sofferenza umana per la malattia mortale del nipote e del figlio del Profeta e la sottomissione piena alla volontà di Dio, unico Signore che dispone della vita e della morte. La sottomissione al volere di Dio non vanifica e non toglie valore alla compassione e al pianto, anche se li relativizza, come suggerisce un hadîth piuttosto duro: Il Profeta passò accanto a una donna che piangeva nei pressi di una tomba (secondo un’altra versione: piangeva su un suo bambino), e disse: «Temi Iddio e sii paziente». Lei replicò: «Vattene via da me; non sei stato colto tu dalla sventura che mi è capitata – e non la conosci!». Le dissero: «Quello è il Profeta!». Allora lei andò alla porta del Profeta, non vi trovò portieri, e disse: «Non ti avevo riconosciuto». Egli disse: «La pazienza si esercita al primo arrivare del colpo». (I, n. 31a, p. 22) Considerando la situazione dal punto di vista cristiano, non sfuggirà la grande differenza tra l’atteggiamento di Muhammad e l’atteggiamento di Gesù nei Vangeli: la compassione di quest’ultimo si traduce normalmente in un intervento di guarigione o addirittura di risurrezione; la compassione del primo si limita alla considerazione della volontà divina, che ha posto un termine fisso per la vita di ciascuno. Tale termine fisso è stabilito, secondo un altro hadîth, prima ancora della nascita di ogni persona: 31 L’Inviato di Dio, la cui sincerità è confermata, ci parlava così: «È sotto forma di una goccia di sperma che la creazione di ciascuno di voi è radunata nel ventre di sua madre per quaranta giorni. Poi sotto forma di aderenza per uno stesso periodo; poi sotto forma di una massa molle, ancora per il medesimo periodo di tempo. Poi gli è inviato l’angelo che viene a insufflargli lo spirito e riceve l’ordine di proferire quattro parole: quella che fissa ciò di cui sarà composta la sua sussistenza, il termine della sua vita e le opere che egli compirà, e infine quella che fissa se egli sarà felice o sfortunato». 4 La vita, la malattia, la disgrazia, la morte sono dunque inserite nel piano provvidenziale di Allah, che il credente è chiamato ad accettare integralmente, pur non comprendendone il perché. Il mistero dell’esistenza rimane oscuro, ma non è cieco. La vita è dono divino di cui ringraziare il Creatore nonostante le prove e le sofferenze: L’Inviato di Dio disse: «Nessuno di voi si auguri la morte a causa di un male che gli sia capitato; se non ne può fare a meno, dica: “Mio Dio, conservami in vita per quanto la vita sia la cosa migliore per me, e chiamami a Te qualora la morte sia la cosa migliore per me”». (I, n. 40, pp. 23-24) Non si tratta, ancora una volta, di rassegnazione nel senso passivo del termine, ma di accettazione attiva di tutto ciò che Allah ha progettato per il bene del suo fedele. Per inciso, questo hadîth mostra la proibizione del suicidio e dell’eutanasia. L’islam propone un’etica positiva della vita, che va accettata e valorizzata fino al suo limite naturale. L’accettazione attiva del decreto di Dio non impedisce di aver paura della morte. Alcune curiose tradizioni riferiscono che due grandi «profeti» dell’islam, Mosè e Abramo, non accolsero di buon grado il momento della separazione da questa vita: Abu Hurayra narrò: L’angelo della morte fu mandato da Mosè, il quale non gli aprì la porta. Tornò dal Signore e gli disse: «Mi hai mandato da un tuo servo che rifiuta la morte». Rispose il Signore: «Torna da lui e digli: “Metti una mano sulla schiena di un bue; otterrai un anno di vita per ogni pelo in cui hai affondato il dito”». «Signore, e poi?» domandò Mosè. «Poi morirai». Venuto il momento, Mosè chiese a Dio di essere avvicinato alla Terra Santa, alla distanza del tiro di un sasso 5. L’esempio di un grande «profeta» è assai significativo. La preghiera da una parte e la benevolenza divina dall’altra possono modificare il decreto segnato per ciascuno ancora prima della nascita. È una prova ulteriore che l’islam non crede in un destino cieco, ma nella libera volontà di Dio, che dispone a piacimento della vita e della morte dei suoi servi. Per quanto riguarda Abramo, «l’amico di Dio» per eccellenza, un altro stupendo hadîth afferma: 32 Abramo disse all’angelo della morte che era venuto per prendere il suo spirito: «Hai mai veduto un amico far morire il suo amico?» Allora Dio gli rivelò: «Hai mai veduto un amante rifiutare l’incontro con colui che ama?». Abramo allora rispose: «Angelo della morte, prendimi subito!» 6. Per coloro che nella vita presente sono stati fedeli la morte apre dunque la strada all’incontro eterno con Dio nella vita futura 7. La ferma fiducia nel governo divino della vita umana impregna profondamente anche oggi la vita dei pii musulmani. In molti si riscontra come sappiano accettare con costanza e serenità le prove dell’esistenza confidando fermamente in Dio. Ancora oggi il musulmano sincero non domanda conto a Dio di ciò che fa o di ciò che permette. Questo atteggiamento raggiunge tutta la sua profondità di fronte alla morte, sia per il moribondo che confessa Dio un’ultima volta sia per chi gli è vicino. L’esempio del Profeta diventa regola di vita per i credenti in Allah. Purificazione La sofferenza appare talora come provvidenziale, in quanto purifica dalle colpe in questa vita e prepara alla ricompensa nella vita futura. In questo senso vanno alcuni hadîth, che ancora riecheggiano affermazioni dell’Antico e del Nuovo Testamento: Dio purifica con la sofferenza coloro che egli più specialmente ama”. “Colui per il quale Iddio voglia un bene, sarà colpito a causa di esso. (I, n. 39, p. 23) Attraverso questi detti fa capolino anche nell’islam l’enigma della sofferenza innocente. E tuttavia non ne viene chiesto conto ad Allah. Piuttosto viene invertito il senso del dolore: non più come punizione, ma come segno di amore. Il credente è immediatamente spinto a porre la sua fiducia nel Dio provvidente, «misericordioso e compassionevole», di cui parla in continuazione il Corano. Il primo dei due hadîth richiama in particolare Ben Sira (cf Sir 2,1-7) e la lettera di Giacomo (cf Gc 1,2-4) 8, mentre il secondo introduce il concetto della sofferenza come «prezzo» da pagare in risposta ai doni divini, che in ogni caso hanno un valore immensamente superiore al loro «costo» in sofferenza. In questo contesto emerge anche il tema della sofferenza come «prova» della fedeltà, che qui indica la volontà di sottomettersi liberamente e totalmente, senza ribellarsi alla volontà divina: L’Inviato di Dio disse: «Il credente e la credente non cessano mai dall’essere messi alla prova, in se stessi, nei loro figli e nei loro beni, finché incontreranno Iddio Altissimo, non avendo un peccato a loro carico». (I, n. 49, p. 27) L’Inviato di Dio entrò da Umm as-Sa’ib e chiese: «Che cosa succede che rabbrividisci?»; rispose: «È la febbre, non la benedica Iddio!»; «Non inveire contro la febbre – avvertì – perché essa toglie i peccati dei figli di Adamo come il mantice toglie le scorie del ferro». (XVIII, n. 221, pp. 470-471) 33 Il dolore è dunque il segno umanamente sperimentabile della «pedagogia» purificatrice divina nei confronti dei suoi fedeli: non più oggetto di maledizione, ma di benedizione, motivo di ringraziamento. Il rovesciamento di senso della sofferenza riposa senza dubbio su motivazioni razionalizzanti di un mistero che rimane inaccessibile, ma si fonda anche e soprattutto sulla fiducia cieca in Allah, che non desidera il male degli uomini e che quando usa il bastone lo fa solo in vista di un bene maggiore. Il dolore assume allora funzione di espiazione già in questa vita dei peccati commessi: Dal Profeta, che disse: «Non coglierà il Musulmano sofferenza, o malattia, o afflizione, o dolore, o danno, o tristezza, o financo la puntura di una spina che abbia a subire, senza che per questo cancelli Iddio qualcuno dei suoi peccati». (I, n. 37, p.23) L’Inviato di Dio disse: «Quando Iddio vuole il bene del Suo servo, gli commina in anticipo la pena in questo mondo; e quando Iddio vuole il male del Suo servo, si astiene dal punirlo per il suo peccato, finché non arriva per lui il giorno della risurrezione». Il Profeta disse inoltre: «La ricompensa più elevata è proporzionata alla grandezza della prova; e certo, quando Iddio Altissimo ama un popolo, lo mette alla prova, e chi si accontenta, si spande su di lui il favore divino; e chi nutre risentimento, si spande su di lui lo sdegno divino». (I. n. 43, pp. 24-25) Si noti che nei due detti non viene considerato l’uomo in generale, ma direttamente il fedele, qualificato nel primo caso come «musulmano» (muslim) e nel secondo come «servo (adoratore)» (‘abd). Evidentemente si tratta di una «catechesi» interna, tesa a rispondere a quesiti posti dalla comunità dei pii. Non manca certo nell’islam il rapporto tra condotta e retribuzione. Ma nei due hadîth riportati questa relazione non è affatto evidente. Tutto dipende dalla volontà suprema dell’Uno, che sovranamente distribuisce gioie e dolori in vista di quanto ha decretato per i suoi servi. Vi emerge in primo piano la dottrina del «Decreto divino» (uno dei pilastri della fede) 9. Come abbiamo visto precedentemente, l’islam non è la religione del fato impersonale e cieco ma del Dio Uno e Unico. Il paradiso e l’inferno dopo la morte non sono frutto dei «meriti» umani ma della decisione divina, che spinge i fedeli e gli infedeli ad assumere atteggiamenti morali coerenti con quanto è stato decretato per la loro fine eterna. È dunque possibile che il male e il bene operati dall’uomo non abbiano conseguenze visibili in questa vita. Eliminando il rapporto tra condotta e retribuzione su questa terra viene lasciata aperta fino al momento del giudizio finale la soluzione degli enigmi della vita, gli stessi che tormentavano l’uomo biblico tanto da farlo dubitare della giustizia divina (cf Gr 12,1; Sal 73; Giobbe, Qohelet, ecc.). Solo in quel contesto infatti potrà apparire nel suo vero splendore il Decreto divino e si comprenderà l’apparente ingiustizia della prosperità dell’empio durante l’esistenza terrena e il senso delle sventure che accadono all’umanità: 34 ‘A’isha interrogò l’Inviato di Dio sulla pestilenza, ed egli la ragguagliò dicendo: «È un castigo che Iddio Altissimo manda a chi vuole, e allo stesso tempo Iddio Altissimo l’ha posta a misericordia per i credenti: non vi è servo che incappi nella pestilenza, e rimanga nel suo paese, pazientemente e mettendola nel conto del suo stato, sapendo che non gli capiterà altro che quello che Iddio gli ha ascritto, senza che per lui vi sia una ricompensa pari a quella del martire» (I, n. 33, p. 22) La sofferenza in quanto purificazione e prova della fedeltà, cioè della sottomissione di fede ad Allâh, ha segnato in maniera significativa la vita del Profeta dell’islam, decretandone però alla fine il successo davanti a Dio e agli uomini. Per questo egli viene presentato come il «bel modello» (Cor 33,21) per tutti coloro che hanno creduto al messaggio affidatogli dal Signore. I musulmani sono invitati ad avere fiducia nel loro Dio e a esercitare la pazienza attendendo la fine di tutte le cose. Un altro hadîth racconta: L’Inviato di Dio disse: «Quando muore il figlio di un servo, Iddio Altissimo dice ai suoi Angeli: “Avete ghermito il figlio del Mio servo?”; ed essi rispondono: “Sì”; “Avete ghermito il frutto delle sue viscere?”; “Sì”, rispondono; ed Egli chiede: “E che cosa ha detto il Mio servo?”; “Pronuncia le Tue lodi e la formula del ritorno a Te”, rispondono. E allora Iddio Altissimo dice: “Edificate al Mio servo una casa in Paradiso, e chiamatela ‘la Casa della Lode’”». (VII, n. 29, p. 278). Valentino Cottini Note 1 Le citazioni coraniche sono tratte da C. M. Guzzetti, Il Corano, LDC, Leumann (TO) 1993. 2 Letteralmente «hadîth» significa «detto». Il termine viene adoperato per qualificare detti e fatti del Profeta raccolti nella Sunna, la serie delle collezioni normative apparse nel secoli IX e X della nostra era. Seconda «fonte» dell’islam dopo il Corano, la Sunna è talora più importante del Libro sacro nella vita pratica, in quanto prende in considerazione le più diverse circostanze dell’esistenza normale, non trattate direttamente nel Corano. La Sunna in particolare ha dato un contributo decisivo alla formazione delle scuole giuridiche dell’islam e alla cultura religiosa popolare. I detti (o tradizioni) riportati in seguito solo con l’indicazione del libro, del numero e della pagina sono tratti da un’opera preziosa e molto diffusa tra i musulmani: Il Giardino dei Devoti di al-Nawawî (1233-1278) (trad. italiana a cura di A. Scarabel, Società Italiana Testi Islamici, Trieste 1990), la quale funziona come una specie di summa della vita musulmana ortodossa. 3 Tutti i figli maschi di Muhammad morirono in tenerissima età. 4 Questo hadîth assai importante si trova nelle raccolte «autentiche» di alBukhârî (bad’ al-khalq [inizio della creazione], 6) e di Muslim (qadr [destino], 1). 5 La tradizione interpretativa successiva amplierà il racconto: Mosè risponde a Dio che ha paura della morte e del suo amaro sapore; quando 35 arriva l’angelo della morte, rifiuta di lasciarsi «sfilare» l’anima dalle varie parti del corpo, in quanto sempre a servizio di Dio. Ma alla fine, piuttosto di dilazionare la morte, che in ogni caso sarebbe arrivata anche dopo la procrastinazione degli anni contati secondo i peli del bue, Mosè preferì morire subito, seguendo il decreto già stabilito da Dio (cf R. Tottoli, Viat di Mosè secondo le tradizioni islamiche, Palermo 1992, pp. 94-96). 6 Questo bellissimo hadîth non è riportato nelle raccolte classiche della Sunna ma nell’opera principale di al-Ghazâlî, la personalità più rappresentativa della tradizione musulmana (morto nel 1111) (cf Etudes Arabes. Dossier 90 [1996/1], P.I.S.A.I., Roma, p. 161). 7 Un altro hadîth racconta: «Dal profeta, che disse: “Colui che ama incontrare Dio, Dio amerà incontrarlo. Colui che detesta incontrare Dio, Dio detesterà incontrarlo”. ‘A’isha, o qualcun’altra delle sue mogli, esclamò: “Ma io ho paura della morte!”. Rispose: “Non si tratta di questo! Poiché, quando la morte si presenta al credente, gli vengono annunciati il beneplacito e la generosità di Dio e niente è più amabile per lui di quanto gli verrà posto innanzi. È per questo che egli ama incontrare Dio e che Dio ama incontrarlo. Quanto al pagano, venuto il momento, gli vengono annunciati il castigo e la punizione di Dio e niente è più odioso per lui di quanto gli verrà posto innanzi. È per questo che egli detesta incontrare Dio e Dio detesta incontrarlo”» (Da Bukhârî, riqâq, 9, cf Etudes Arabes. Dossier 90 [1996/1] 148). 8 Ricordiamo tuttavia che a identità o somiglianza di contenuto e di espressione non corrisponde un identico orizzonte ermeneutico. Spesso formulazioni simili hanno valore molto differente. 9 I pilastri della fede (arkân al-îmân) non vanno confusi con i più noti cinque pilastri dell’islam (arkân al-islâm). A livello coranico non esiste una classificazione completa dei primi. Il versetto che più vi si avvicina è 2,177: «La pietà non consiste nel volgere la faccia a oriente o ad occidente. È pio invece chi crede in Dio e nell’ultimo giorno, negli angeli, nel Libro e nei profeti e, per amor di Dio, dà una parte dei suoi beni ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti e ai mendicanti e per riscattare i prigionieri. È pio chi compie la preghiera e paga la decima, chi mantiene gli impegni presi, chi è paziente nella tribolazione, nell’avversità e nei giorni dell’angoscia. Questi sono i sinceri, i timorati di Dio». La formulazione completa si trova, con varianti, nella Sunna: «Il Messaggero di Dio disse: “La fede è che tu creda in Dio, nei Suoi angeli, nei Suoi libri, nei suoi Messaggeri e nell’Ultimo Giorno, e che tu creda nel Decreto divino, sia nel bene che nel male”» (cf P. Branca, Introduzione all’islam, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, 174). Il decreto divino corrisponde alla predestinazione. Il Corano si limita a ribadire il concetto che tutto dipende dal volere positivo di Allâh, mentre sottolinea, in altri luoghi, la responsabilità dell’uomo. L’argomento sarà dibattuto a lungo nel kalâm, cioè nella riflessione musulmana posteriore. 36 UN DOVERE: VISITARE CHI SOFFRE L’islam raccomanda di visitare i fratelli nella fede, specialmente se sono ammalati e si trovano nel bisogno. La visita è motivata da puro amore in Dio nei confronti del fratello Sul tema della visita ai sofferenti, alcuni hadîth suonano piuttosto familiari all’orecchio di un cristiano, tanto da poterne quasi scambiare la provenienza: Il Profeta raccontò: «Un uomo si recò a far visita ad un suo fratello che viveva in un altro villaggio, e Iddio Altissimo dispose un Angelo sul suo cammino; e quando gli fu di fronte, chiese: “Dove intendi andare?”; “Intendo andare da un mio fratello che vive in questo villaggio”, rispose; “Forse possiedi qualche bene di cui è incaricato, e intendi controllare l’amministrazione?”, chiese; “No, rispose, non vi è altra ragione che il mio affetto per lui in Dio Altissimo”. Disse: “Io sono l’inviato di Dio presso di te; Egli ti ama come tu l’hai amato in lui”». (I, n. 365, p. 129) L’Inviato di Dio disse: «Il giorno della risurrezione, Iddio Potente e Glorioso dirà: “Figlio di Adamo, ero ammalato e non sei venuto a trovarmi”; “Signore!, e come potrei venire a trovare Te, che sei il Signore dei mondi?!”: “Forse non sapevi che il Mio servo Tal dei Tali era ammalato, e non sei andato a trovarlo?! Non sapevi forse che andando a trovare lui avresti trovato Me con lui?! Figlio di Adamo, ti ho chiesto di darmi da mangiare, e non me ne hai dato!”; “Signore!, e come potrei dar da mangiare a Te, che sei il Signore dei mondi?i”; “Non sapevi forse che il Mio servo Tal dei Tali ti aveva chiesto da mangiare, e tu non gliene hai dato?! Non sapevi forse che se tu gli avessi dato da mangiare qualcosa, l’avresti ritrovato presso di Me?! Figlio di Adamo, ti ho chiesto di darmi da bere e non me ne hai dato!”; “Signore!, e come avrei potuto dar da bere a Te, che sei il Signore dei mondi?!”; “Ti ha chiesto da bere il Mio servo Tal dei Tali e tu non gliene hai dato; non sapevi forse che se tu gli avessi dato da bere qualcosa, l’avresti ritrovato presso di Me?!”». (VII, n. 3, p. 272) Questi due hadîth hanno come presupposto la vicinanza di Allah ai suoi fedeli e il suo amore per loro. Mostrano che l’islam non è una religione che non conosce l’amore di Dio per gli uomini, come si sente spesso affermare. L’islam sunnita ortodosso infatti nega che il tipo di amore che Dio ha per l’uomo sia uguale all’amore che un uomo ha per un altro uomo. Il musulmano crede fermamente che Allah è misericordioso e colmo di amore ma non si sbilancia ad affermarne la natura, timoroso com’è di deturpare in qualsiasi modo la trascendenza divina mediante il riferimento a ciò che è immanente e corporeo. Nella prima delle due tradizioni andrebbe interpretato dal punto di vista musulmano il come finale, che non è qualitativo ma quantitativo. Se mettiamo a confronto questo detto con quello del Vangelo di Luca a proposito della misericordia («Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro», Lc 6,36) abbiamo esattamente il contrario: qui infatti la comparazione è di ordine qualitativo, non quantitativo. Più chiara è la seconda tradizione, che ripete quasi alla lettera Mt 25 e che si interessa in particolare della vicinanza di Allah ai credenti che si trovano in necessità. Si noteranno le differenze più vistose: l’accentuazione dell’assoluta 37 autosufficienza di Allah e la vicinanza, non l’identificazione con la persona che si trova nel bisogno. L’autosufficienza divina dipende dalla concezione generale di Dio nell’islam, per il quale l’incarnazione è inconcepibile. Uno dei novantanove «bei nomi» (cioè attributi) di Dio è infatti al-ghanî, letteralmente «il ricco», nel senso dell’assoluta autosufficienza, incomparabile con la povertà umana. E questa concezione spiega anche perché Egli non possa identificarsi con un uomo, tanto meno con un uomo in difficoltà. Ma il suo amore e la sua misericordia sono «vicini» al povero e all’indigente per calcolare e testimoniare la preziosità dell’opera di colui che visita l’ammalato, come attesta un altro hadîth: L’Inviato di Dio disse: «A chi va a trovare un malato, o fa visita a un suo fratello in Dio, un annunciatore proclama: “Sei stato buono, ed è buono quello che è stato preparato per te, e verrai ad abitare una dimora nel Paradiso”». (I, n. 366, p. 129) La visita agli ammalati è talmente importante che diventa un vero e proprio ordine dato dal Profeta ai suoi seguaci: L’Inviato di Dio disse: «Andate a trovare l’ammalato, date da mangiare all’affamato, e rimettete in libertà il prigioniero». (VII, n. 4, p. 272) La cura del corpo è funzionale alla cura dello spirito, per cui la fede nel Dio dell’islam è preferibile alla guarigione fisica (per la sensibilità cristiana attuale questo hadîth risulterebbe piuttosto duro). Questo spiega la sollecitudine del Profeta di fronte a un ammalato non musulmano: Un ragazzo ebreo che era al servizio del Profeta s’ammalò, e il Profeta andò a trovarlo: sedette all’altezza del suo capo, e lo esortò: «Fatti musulmano»; il ragazzo guardò verso suo padre, che gli stava vicino; questi disse: «Obbedisci ad Abû l-Qâsim [cioè: a Muhammad]»; ed egli si fece musulmano. E il Profeta uscì dicendo: «Sia lode a Dio che lo ha strappato al Fuoco [cioè: all’inferno]». (VII, n. 7, p. 273) Per l’islam quindi la cura dell’ammalato è assai importante: assicura la ricompensa eterna quando è fatta con e per amore e conduce vicino ad Allah, il quale è particolarmente presente accanto alla persona che soffre ed è nel bisogno. Ma anche il modo in cui curare l’ammalato va considerato. Ad esempio, il pudore femminile, soprattutto nell’islam arabo, è assai rilevante. Da parte degli operatori sanitari sarà necessaria una particolare attenzione a questo dato culturale. Un hadîth racconta: Ibn ‘Abbâs chiese al Profeta: «Vuoi che ti faccia vedere una donna che fa parte della gente del Paradiso?»; «Certamente!», risposi; disse: «Questa donna negra si recò dal Profeta e disse: “Ho degli attacchi di epilessia, e poi mi ritrovo scoperta: prega Iddio Altissimo per me”. Egli disse: “Se vuoi, sii paziente, e per te ci sarà il Paradiso; oppure, se vuoi, pregherò Iddio Altissimo perché ti risani”. E lei decise: “Che io sia paziente”; poi aggiunse: “Io però mi ritrovo scoperta: prega Iddio che non mi ritrovi scoperta”. Ed egli pregò per lei». (I, n. 35, p.23) V.C. 38 «Caro Martini, solo Dio può darci la morte» di Andrea Tornielli [Da «il Giornale», 24 gennaio 2007] Parlare di eutanasia, del caso Welby e del dibattito suscitato dall’ultima uscita del cardinale Martini, con lui significa fare sul serio. Alessandro Maggiolini, 76 anni, vescovo uscente di Como - domenica prossima è previsto l’ingresso del suo successore, Diego Coletti - è una delle maggiori personalità dell’episcopato del nostro Paese, unico italiano nella commissione internazionale che ha redatto il nuovo Catechismo della Chiesa cattolica sotto la guida dell’allora cardinale Jospeh Ratzinger. Da qualche anno ormai, Maggiolini non è più soltanto il prelato «controcorrente», poco amante del felpato e autoreferenziale linguaggio «ecclesialese», il vescovo che con largo anticipo su tutti ha denunciato i rischi di un’immigrazione selvaggia, l’ecclesiastico schietto e mai banale che ha scritto un libro per annunciare la fine della cristianità così come l’abbiamo concepita e vissuta fino a oggi. Da qualche anno, a causa di un cancro al polmone e poi del morbo di Parkinson che l’ha praticamente immobilizzato in carrozzella, Maggiolini è un credente che fa quotidianamente i conti con la sofferenza. Un paziente di riguardo, che non nasconde la sua paura della morte e che trascorre ogni santo giorno quattro ore in confessionale, a incontrare i fedeli. «Tra persone che soffrono, basta un’occhiata per intendersi», sussurra con un filo di voce vescovo inchiodato alla carrozzina dallo stesso morbo che ha colpito Giovanni Paolo II e che affligge lo stesso cardinale Martini. Che cosa pensa dell’articolo del cardinale sul caso Welby? «Penso, in tutta sincerità, che un cardinale dovrebbe tacere oppure, se ha qualcosa da dire o da dissentire su certi argomenti, debba scrivere direttamente al Papa in modo riservato e personale, senza esporsi in una maniera pubblica. In fondo, il cardinalato non è un cavalierato, un titolo onorifico, ma il segno di una obbedienza particolarissima al Santo padre, fino al martirio. Ora, nessuno chiede di effondere il sangue, ma di tenerlo da conto sì». Che cosa obietta, nel merito, a Martini? «Premetto di aver detto, a suo tempo, che io i funerali religiosi a Welby li avrei celebrati. Ho letto sui giornali che quest’uomo, negli ultimi istanti di vita, ha pregato. Se ciò è avvenuto, se davvero alla fine si è affidato a Dio, bisogna tener conto del fatto che basta un sospiro di richiesta di misericordia per riscattare una vita intera. Il cardinale Martini, però, non tocca questo argomento, non parla di questa revisione morale della vita, ma entra nel merito della sospensione dei trattamenti che il malato non sopporta più o che provocano dolore... ». 39 Il dolore e il suo riverbero psicologico non sono elementi secondari. «Il problema del dolore, attualmente, nella quasi totalità dei casi, è risolto grazie all’uso di potenti analgesici e anestetici che lo eliminano pur provocando spesso la perdita della coscienza del malato. Il problema, semmai, è proprio quello della persistenza della coscienza. Tanto che la Chiesa consiglia il paziente che sta per essere sottoposto a queste cure palliative, di mettere a posto prima le ultime volontà». La sofferenza non più accettata non può essere un motivo per rifiutare le cure? «La sofferenza, quando c’è, non è un motivo per smettere le cure. Semmai è un motivo per spingere ad aumentare le cure per far soffrire il meno possibile. Non riesco a capire che cosa significhi sospendere le cure e così permettere che uno muoia». Martini ha parlato di eutanasia come di «un gesto che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte». E ha aperto alla sospensione delle cure, come prevede la legge francese. «La differenza tra eutanasia cosiddetta “attiva” e quella “passiva” esiste già da almeno ottant’anni, non è una notizia da prima pagina. Si è sempre detto che un conto è ammazzare e un conto e lasciare che uno muoia. Dunque non mi sembra poi una gran scoperta. Il problema è che su questi argomenti così delicati, che ci toccano così da vicino e così nell’intimo, non si può discutere sulla base di formule teologiche astratte ma è necessario un confronto tra il teologo moralista - non il biblista - e il medico, cioè colui che sa che cosa sta capitando davvero nell’organismo di una persona». Eppure la Chiesa, come dice no all’eutanasia, è altrettanto contraria all’accanimento terapeutico. Come lo definirebbe, lei, questo «accanimento»? «L’accanimento inizia quando cure straordinarie e sproporzionate non garantiscono più speranza di miglioramento e la morte è comunque sicura. Vorrei però aggiungere che una cosa è sospendere la somministrazione di medicinali atti a contrastare il male, un’altra togliere al paziente le risorse per vivere. Per esempio, essendo l’aria è necessaria per vivere, non credo sia lecito toglierla staccando il respiratore. Il cibo così come l’idratazione non possono essere considerate “cure”». Martini invoca un maggior coinvolgimento e un maggior protagonismo del malato. «Non ci si deve però dimenticare che il responsabile è il medico. Il malato non è l’ultima istanza, deve confrontarsi con il medico che lo cura, sennò rischia di scambiare una fitta passeggera con un tumore. Il medico, insomma, 40 non può essere deresponsabilizzato. Altrimenti si arriva a concedere il permesso di ammazzarsi nelle corsie degli ospedali». Posso chiederle come sta vivendo la sua malattia? «Sono lontanissimo dalle sviolinature circa l’importanza del dolore e della sofferenza. Conosco la teologia, ma devo dire che non credo necessario esaltare il soffrire. Secondo me il problema è di mantenersi nell’atteggiamento di dipendenza dal Signore. Se lui vuole che io abbia il Parkinson, è la sua volontà, anche se a me dà fastidio. Così non è stato piacevole il taglio di un lobo di un polmone, ma se serve a mantenermi ancora in vita, l’accetto! C’è un aspetto umano, cioè il riconoscersi limitati e dopo aver cercato di allontanare il più possibile gli elementi negativi, accettare la malattia che il destino ti assegna. Ma c’è anche la voce del soprannaturale che ti sussurra che quella è la volontà del Signore». Questo abbandono, questo atteggiamento di dipendenza, aiuta a vivere la sofferenza? «Il primo risultato pratico è che ti costringe a non fare il gradasso, e non sgomitare per esibirti. Ti costringe a essere malato, il che vuol dire accettare un certo nascondimento e la compassione degli altri, che non è mica sempre bella. Poi ti aiuta a capire la redenzione di Cristo, che ha scelto volontariamente di salire sulla croce. La malattia accettata senza entusiasmi artificiosi ma con la pacatezza di chi accoglie la volontà di Dio, rende più buoni e aiuta a capire la sofferenza degli altri. Da quando sono malato, in confessionale colgo una corrente di simpatia, perché tra persone che soffrono basta guardarsi negli occhi per capirsi». © il Giornale 41 La croce, il Parkinson e il giudizio dei medici di Vittorio Messori [Dal "Corriere della sera", 17 Maggio 2002] Sospira, un po’ imbarazzato, l’autorevole geriatra cui leggo i testi d’agenzia. Mi dice: «Sono cattolico ma anche medico. Sono uno specialista che ha a che fare ogni giorno con anziani affetti da morbo di Parkinson. E’ dunque con disagio che mi permetto di dire che sembra esserci qualche incongruenza nelle dichiarazioni di quei due cardinali». Come si sa, Oscar Rodriguez Maradiaga, salesiano honduregno e arcivescovo di Tegucigalpa, ha risposto così, ieri, alla domanda di un giornalista: «Se Giovanni Paolo II dovesse rendersi conto di non potere continuare a svolgere il suo ministero, avrebbe il coraggio di dimettersi». A richiesta di un altro cronista, il cardinal Joseph Ratzinger ha replicato: «Se il Papa vedrà che non ce la fa proprio, sicuramente rinuncerà». Commenta il mio interlocutore: «Spiace dirlo, ma i due porporati presuppongono che un malato di Parkinson, giunto a una fase avanzata, conservi intatte le facoltà di critica e di giudizio e, dunque, possa stabilire che è il momento del definitivo ritiro. Ma sono proprio quelle facoltà che, purtroppo, vengono tolte dal morbo. Le statistiche rilevano che il 65 per cento dei parkinsoniani che hanno superato gli ottant’anni presentano sintomi gravi di deficit cognitivo. Nelle fasi successive, si giunge molto spesso a una quasi totale insufficienza mentale che è indicata con il termine crudele, ma tecnico, di "demenza"». Prosegue lo specialista:«Certamente, i colleghi che hanno in cura il Papa gli somministrano un farmaco, la levodopa, che diminuisce la rigidità delle membra e aiuta a ritrovare una certa capacità di movimento. Ma questa sostanza ha effetti collaterali neurologici, portando talvolta ad allucinazioni. In ogni caso, rischia di aggravare il quadro psicologico, appannando ulteriormente la lucidità. Sul mero piano medico, dunque, sembra illogico attendere che sia il paziente a decidere sullo stato reale delle sue condizioni. Una simile decisione dovrà, semmai, essere delegata ai sanitari che seguono il decorso del male. A quei medici va la mia solidarietà: potrebbero essere chiamati a decidere quando sia giunto il momento davvero storico delle dimissioni di un Papa, per giunta straordinario come Giovanni Paolo II». Se questa è la voce della medicina, quella della cronaca sembra parlare un linguaggio diverso. Tutti hanno visto come, durante il suo ultimo viaggio, a Ischia, Karol Wojtyla non solo abbia fatto fronte all’impegno, ma si sia addirittura concesso qualche battuta. La sua agenda non ha subito amputazioni, come sempre è fitta di impegni faticosi. Chi gli è vicino assicura che anche il lavoro quotidiano di gestione della Chiesa non ha registrato rallentamenti. La sola differenza, rilevata da Ratzinger, è il rarefarsi della parola: sintomo tipico, secondo lo specialista, dell’avanzare del morbo che, alla fine, rinchiude il malato in un totale mutismo. Ma è lo stesso Prefetto della Fede che aggiunge che il Papa, pur parlando poco, ascolta con attenzione, rivolgendo poi brevi ma lucidissime domande che confermano come la sua percezione dei problemi sia intatta. Come intatta è la volontà di continuare a portare la sua croce. 42 Sempre Ratzinger ha detto: «Se si tratterà solo di soffrire, sopporterà, così come da sempre è abituato a fare». Ma di quale tipo sono le sue sofferenze ? Stando ai medici - e stando a chi gli è vicino - non sono di carattere fisico ma, soprattutto, psicologico. E’ il dolore, prima di ogni altro, della perdita dell’autosufficienza. «In un caso come il suo» dice il medico «già da tempo non avrei avuto alcuna esitazione ad autorizzare la concessione dell’assegno di accompagnamento: il contributo pubblico, cioè, per avere accanto di continuo qualcuno che assista nelle funzioni quotidiane - dal cibarsi al vestirsi - che non si è più in grado di svolgere da soli». Per l’atletico cinquantottenne divenuto, nel ’78, il primo Papa slavo della storia, questa perdita di autonomia personale è certamente una sofferenza crudele. Eppure, nella sua prospettiva di fede, deve sembrargli anche un misterioso privilegio, assimilandolo ancor più alla sorte di quel Pietro di cui è successore. Nell’ultimo capitolo dell’ultimo Vangelo, quello di Giovanni, Gesù predice a colui che dovrà pascere il gregge dei fedeli: «In verità, in verità ti dico : quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi». Drammatica - e insieme straordinaria - anticipazione di un calvario che sembra rinnovarsi, duemila anni dopo, nei palazzi fastosi sul colle Vaticano. Non occorre, comunque, essere profeti per prevedere che, un giorno, la Congregazione per le cause dei santi sarà chiamata a giudicare un dossier intestato come «Karol Wojtyla, Sommo Pontefice con il nome di Giovanni Paolo II». Ed è altrettanto facile prevedere che proprio gli anni del tramonto - quelli del «quando sarai vecchio, un altro ti cingerà la veste» - saranno valutati con emozione particolare da quei giudici severi che, proprio in questa sofferenza così accettata , avvertiranno un sentore inconfondibile di evangelo. © Corriere della sera 43 Il Grillo (4/2/1998) Salvatore Natoli Il senso del dolore Documenti correlati -------------------------------------------------------------------------------Natoli: Sono Salvatore Natoli. Insegno Filosofia all'Università di Bari. Mi sono interessato delle questioni teoriche della filosofia, dei rapporti tra ragione e passione, quindi anche di teoria degli affetti, e, in particolare, del dolore. Ho scritto un libro: L'esperienza del dolore, che è poi il tema di oggi. Quindi passiamo a vedere la scheda di presentazione dell'argomento. Il dolore, si dice, è universale. Ma è proprio vero che sia così? Nel dolore universale è di certo il danno - esempio: una malattia, un handicap -, non il modo in cui il danno è vissuto. Ma il danno, quand'anche è universale, è variamente interpretato. Un induista soffre in modo diverso da un cristiano, questi, diversamente, da chi non crede. Se così è, l'esperienza effettiva del soffrire è data dalla circolarità tra danno-senso, più esattamente dalla tensione tra il senso, a cui sempre e in ogni caso si appartiene, e il non senso che il dolore produce. Il dolore infatti lacera la ragione, costringe l'uomo a interrogarsi su di sé. Perché a me? Cosa ho fatto per meritare questo? Ma ancor più sul senso del mondo. Le cose si inabissano e l'enigma del male irrompe in tutta la sua atrocità. Eppure mai, come nella sofferenza, si cercano parole per dare senso all'insensato. E, bene o male, le si trova. Abbiamo preso a soffrire nel momento stesso in cui abbiamo cominciato a vivere. Gli uomini nascono in scenari di senso che li precedono e che danno loro il linguaggio e i termini per divenire interpreti, più o meno abili, del loro soffrire. Abili, e non da soli, gli uomini infatti riescono a condividere la comune sofferenza, a farsene reciprocamente carico. Ed è anche giusto dire che lo devono. Tuttavia nessuno è mai sostituibile nel suo dolore. Ognuno è chiamato a giocare la sua parte. Riuscire, nonostante il dolore, a portare a compimento una vita. Ma di questo poco si può dire. Infatti nulla più del dolore svela la fragilità dei singoli, la loro irrepetibile unicità. Manifesta insieme la comune esposizione all'imponderabile. STUDENTESSA: Buongiorno, professore. Come abbiamo visto nel filmato, nel passato si aveva una concezione diversa del dolore da quella odierna. Come può il tempo modificare questo? Natoli: Ecco, la sua domanda già ci porta nel cuore della esperienza del dolore. Lei introduce passato, introduce tempo. Ecco, l'esperienza del dolore, diciamo, ha due facce. C'è una parte oggettiva del dolore, che è il danno, che può essere rompersi un braccio, avere una grave malattia. E l'altro è il senso, cioè quale significato si attribuisce a questo atteggiamento. Allora, per capirci, brevemente, lei immagini un induista, immagini un cristiano, immagini un non 44 credente. La stessa sofferenza è diversamente interpretata. Ci sono delle culture in cui la sofferenza è interpretata come la dimensione dell'apparenza. Ci sono delle culture in cui la sofferenza è vissuta in modo profondo: il dolore vivo. Ci sono delle esperienze, per esempio quella cristiana, dove c'è il dolore vivo, ma è visto nella dimensione della redenzione. Ecco lo stesso danno è vissuto in diverso modo. L'esperienza del dolore sta nella circolarità tra danno e senso. Ecco perché, pur essendo universale, il dolore è diverso. STUDENTESSA: Professore, Le volevo chiedere: la tecnica moderna tende ad annullare il dolore in maniera diversa da come si faceva nel passato. Prima lo strumento fondamentale era l'uso della parola. Secondo Lei oggi è superato? E' superata la parola? Ecco, qui bisogna fare una considerazione preliminare. Non annullare, la tecnica cerca di fronteggiare - magari riuscisse ad annullare il dolore -, cerca di fronteggiare il dolore. E' chiaro che in epoche diverse, quando la tecnica non aveva ancora raggiunto il livello di qualità e di efficacia di oggi, c'erano altre modalità per affrontare il dolore, modalità, per molte volte, per molti casi, esse stesse tecniche. Cioè la tecnica è molto antica, non sofisticata come oggi. Ma già con Ippocrate in fondo il dolore cerca di essere dominato attraverso il gesto tecnico. C'è una bella formula di Ippocrate, in cui si dice: "Il medico e il malato devono, insieme, combattere contro la sofferenza". Ecco, allora bisogna distinguere nella sofferenza tra la parola "efficace" e la parola "non efficace". Qui c'è un punto importante da considerare: il dolore, come esperienza estrema, è sempre al di sotto e al di sopra della parola. E' al di sotto della parola perché sono poche le parole efficaci. Chi soffre cade nel mutismo. Non a caso si parla di pietrificazione. Il dolore pietrifica, che dire. Dall'altro lato il dolore è eccesso di parola, c'è la farneticazione. Nel dolore costantemente ci si domanda: "Perché io soffro, perché a me?". Ricorderete tutti in Manzoni di Tonio, scimunito dalla peste: "A chi la tocca, la tocca. A chi la tocca, la tocca", fino al grido, la parola inarticolata. Ecco quindi, in quanto lacera il dolore, eccede il linguaggio. Ed è' sempre di troppo e troppo poco. Allora si cerca la parola "efficace". Per esempio nella credenza religiosa la parola "efficace" era la preghiera, perché magari il dolore non cessava, ma c'era una speranza, un "tu", una confidenza, un'attesa del miracolo. Questo non cancellava, non cancellava il dolore, ma lo rendeva in un certo modo sostenibile, vivibile. E poi con la parola "efficace", che è quella della tecnica, oggi l'uomo, quando soffre, a chi si rivolge in primo luogo, a cosa pensa, dove trova la parola "efficace"? La trova nella tecnica. Ecco allora il passaggio di civiltà, i modi diversi in cui quella circolarità tra danno e senso di cui parliamo prima, di volta in volta si attiva. STUDENTESSA: Poiché attraverso la lacerazione dei sensi, l'animo di colui che soffre riesce a raggiungere dei livelli, potremmo dire di conoscenza superiore, è possibile quindi concludere che il dolore, che poi in realtà è sinonimo di male, in realtà è anche bene? Ecco, qui, già c'è una considerazione preliminare da fare: coscienza superiore. Che vuol dire? Ecco, il dolore abbrutisce, il dolore strazia, il dolore 45 indebolisce la mente, quindi non sempre nella condizione di dolore il soggetto accede a un punto di vista superiore. Nei dolori si sviene. Quindi non bisogna dimenticare la dimensione impoverente del dolore. Però c'è anche un'altra dimensione: il dolore non è sempre vivo. Anche nel sofferente ci sono momenti alterni. E che cosa produce il dolore? Il dolore produce una forte interrogazione su di sé. Che senso ha la vita, se io soffro? Se la vita è lo spazio in cui l'uomo deve realizzare le proprie possibilità, ecco, nel dolore che cosa si sperimenta? Si sperimenta non solo il dolore vivo, ma la interruzione delle proprie possibilità. E allora ci si interroga: perché, che senso ha vivere? Allora nel dolore l'uomo diventa una questione centrale. Il pensiero a sé diventa il pensiero di sé nel mondo e quindi il senso del mondo. Ecco perché, a partire dall'esperienza del dolore, l'uomo si interroga sul male e quindi sulla realtà, la verità dell'esistere. Da questo punto di vista il dolore pone una condizione di interrogazione e di domanda su di sé e quindi in un rapporto tra sé e il significato del mondo molto alto. Allora da questo punto di vista, per quanto abbrutisca, pone anche delle condizioni di interrogazioni radicali e profonde. Per cui, se il dolore non abbatte - e molte a volte abbatte e cancella - diventa una occasione per crescere. STUDENTESSA: E quindi, se non abbatte, contrariamente invece si può anche rafforzare? Può essere un modo attraverso cui l'uomo scopre risorse che altrimenti non avrebbe scoperte. E quindi può ricostruire una dimensione di sé, una immagine di sé altra, nuova, per molti versi, appunto, se non è sconfitto, vittoriosa. Quindi il dolore non è mai in assoluto un qualcosa di negativo. Può diventare un passaggio di crescita, senza dimenticare però che può essere anche una ragione profonda di sconfitta. STUDENTE: La scienza, la tecnica, la conoscenza possono alleviare il dolore dell'uomo col passare del tempo, come sembrerebbe da un'interpretazione del mito di Prometeo, oppure esso è parte integrante, essenziale, dell'esistenza umana? Ecco, che il dolore sia intimo alla vita, su questo, diciamo, che la storia del mondo ne è testimone. Anzi addirittura i Greci vedevano nel dolore l'altra faccia della felicità, cioè l'esistenza è insieme generativa e crudele. La stessa potenza che genera, la natura, distrugge. E quindi dolore e felicità stanno insieme. Ecco, ma non è di questo che voglio parlare, ma voglio venire alla sua domanda. La tecnica allevia il dolore. Beh, certo, direi che lo ha alleviato. Il dolore vivo è diminuito. Molte malattie sono gestibili, controllabili. Si può ottenere per venire alla guarigione. Quindi sarebbe chiudere gli occhi se non si ammettesse che la scienza ha ottimizzato la vita e quindi, nel contrasto col dolore, è stata appunto, come dicevo prima, parola potente. Però è chiaro che non lo ha sconfitto. Allora, a fronte di questa grande crescita e sviluppo della tecnica si sono create come sempre delle controfinalità. Per cui, se per un lato la tecnica ha riscattato un uomo da molti dolori, lo ha esposto a forme nuove di sofferenza. Per capirci, un esempio. C'è una bella formula di Epicuro, che dice: 46 "Se la malattia è grave, è breve. Se è lunga si può apprendere a convivere con essa". Oggi la tecnica ha creato un quadro nuovo di esperienza. Ci possono essere malattie gravi che possono diventare lunghe, cioè la tecnica può mettere l'uomo nelle condizioni di essere sotto una ipoteca di morte per lungo tempo. Che si fa in questo tempo? Ecco, allora, come la tecnica, pur avendo risolto tanto dolore, crea condizioni diverse di problematicità, perché un uomo, che non ha futuro, come riempie questo spazio di tempo? Può la tecnica risolvere questo? Non sempre. Per cui, grazie ai successi della tecnica, noi abbiamo ridotto il dolore vivo, ma la sofferenza si è riformulata secondo un'altra qualità. E allora, per affrontare questo, ci vuole un altro linguaggio, a cui la tecnica non è sufficiente. STUDENTESSA: Il dolore fisico ha anche un'attività pratica, in quanto serve ad allontanarci dal pericolo. Possiamo dire la stessa cosa del dolore morale? E se sì, in che senso? Dunque il dolore fisico lo si è detto sempre, è un segnale, uno stimolo che preserva, che allerta. Tant'è vero che nella medicina classica il dolore era considerato un sintomo della malattia. Non era esso malattia. Poc'anzi si parlava di tecnica. Oggi, con lo sviluppo della tecnica, noi siamo arrivati al punto che il dolore ha cessato di essere solo sintomo. E' diventato esso stesso malattia. Perché? Perché, mentre prima, bisognava curare la malattia per togliere il dolore, oggi con malattie, anche gravi e incurabili, si può controllare il dolore senza con ciò estinguere la malattia. Allora da questo punto di vista il dolore oggi non è più solo un sintomo, un allarme, ma esso stesso un male. E quindi si possono evitare morti atroci, nel momento in cui la tecnica può trattare quello che un tempo era un sintomo, come un male. Il dolore morale esigerebbe una riflessione per suo conto, ma per stare alla sua domanda voglio risponderle in modo molto breve. Non bisogna separare il dolore morale, io preferirei chiamarlo il dolore mentale, dal dolore fisico, perché ogni dolore fisico mette a disagio la mente. E quindi esiste una somato-psicosi, cioè il disagio del corpo mette in crisi la mente, allo stesso modo in cui il disagio della mente o di rappresentazione mette in crisi il corpo. Quindi si tratta di definire il grado di questa circolarità. Ma ogni dolore fisico è anche mentale, ogni dolore mentale è anche fisico. Non possiamo mai scindere nell'uomo la rappresentazione di sè dalla sua condizione effettiva, corporea. STUDENTE: Visto che si dice che il dolore affina le conoscenze, di conseguenza, secondo Lei, il piacere ottunde gli animi. Eppure Leopardi, affinato da una vita di dolore, desiderò con tutto se stesso il piacere! Ecco, ho già detto prima, che non sempre il dolore affina. Il dolore anche abbrutisce, riduce l'intelligenza. Pensate quando avete un dolore atroce, anche di quelli passeggeri, insomma. Ma, quando c'è un momento acuto di dolore, beh, tutto il corpo è tratto in questa esperienza, non pensa più che il dolore fa male. Quindi affina. Affina nel senso che poi, essendo in questa situazione, trovandosi in questa situazione, per un lungo periodo si alternano i momenti estremi con momenti di maggiore vivibilità. Talora la sofferenza entra 47 nell'intero della sofferenza, dell'esperienza, e allora, come dicevo prima, l'uomo scopre, latente, dimensioni di sé, modi di rapportarsi con gli altri, che gli permettono forme diverse di realizzazione. Questo è un tema che bisognerebbe trattare, nel senso che una delle caratteristiche del dolore è quella di produrre la separazione dagli altri. E allora come ci si incontra con gli altri? Ci si incontra in un altro modo. Anche qui si aprono dimensioni di pietà, di sensibilità diverse. Allora tutti questi sono modi in cui pur nella sofferenza si può crescere. Ora, detto questo, non si può sostenere che il piacere invece faccia male o ottunda. Ecco, una caratteristica del piacere è che, nel momento del piacere, non si pensa al dolore. Nel momento del piacere, la caratteristica del piacere è che il dolore viene messo tra parentesi, però il piacere esso stesso affina la sensibilità. Il piacere del suono affina la sensibilità. Si può sentire il canto delle cicale, il rombo, il rullare dei tamburi, il vento, la musica. Il senso stimolato dal piacere si specializza, si arricchisce. Quindi lo sviluppo della sensibilità o del piacere, di per sé, non è un elemento di riduzione d'intelligenza, ma di grande accrescimento dell'intelligenza. Certo che ci sono dei tipi di piacere, in cui l'elemento eccessivo, lungi dal perfezionare il senso, lo deturpa. Un suono troppo forte non perfeziona l'udito, lo fa perdere. In altre situazioni ho detto: "lasciamo stare la qualità estetica delle musiche da discoteca". Non voglio entrare nel merito estetico, ma se fanno perdere l'udito, se indeboliscono l'organo, sono negative. Allora ci possono essere delle dimensioni di piacere eccessivo ottundente, ci può essere un gioco variato del piacere, che invece è un accrescimento della sensibilità, il gusto del silenzio. Il silenzio è un qualcosa che si ascolta paradossalmente. Quindi, se nel dolore si può crescere, non per questo si deve dire che il piacere ottunde. Ottunde quando diventa monomaniaco, eccessivo, quando, anziché sviluppare la sensibilità, la fossilizza in un punto di eccessiva stimolazione. E l'eccessivo stimolo distrugge l'organo. STUDENTE: Scusi, professore, si potrebbe parlare di una gradualità del dolore? Certo, si può parlare di una gradualità del dolore in un senso elementare, nel senso che una piccola contusione non è un grande trauma. Un grande trauma non è una grave malattia. Ma allora qui ci sono due distinzioni da fare. Ci possono essere dimensioni di dolore vivo, molto forte, ma anche molto breve. Allora, quando si ha un dolore vivo molto forte, ma se ne conosce la natura, questo dolore viene meglio sopportato, di un dolore accennato, di cui non si conosce l'origine, perché quello può essere grave, perfino mortale. Allora cosa vuol dire grado del dolore? E' il dolore vivo oppure ciò che il dolore significa. Un dolore vivo, di cui si ha però la persuasione che svanirà, che è curabile, diventa meglio sopportabile, soprattutto con l'aiuto dei farmaci che oggi abbiamo a disposizione, di quanto non lo sia un dolore ambiguo. Quindi già si capisce bene come l'interpretazione del dolore definisca il grado del dolore o quello che comunemente si dice la "soglia" del dolore. Quindi la "soglia" non è mai oggettiva. Visto che abbiamo introdotto questo tema, allora torniamo di nuovo al discorso che si faceva all'inizio, la circolarità tra danno e senso. Anche questo gradua il dolore, perché è in una situazione in cui a un dolore anche grave si riesce ad attribuire un significato, questo dolore lo si 48 sente meno. Pensiamo, in una certa tradizione cristiana, il dolore offerto in espiazione, per esempio, offerto in espiazione del male, che intenzionalmente gli uomini fanno, allora questa dimensione dell'offerta non annullava il dolore, ma in un certo senso lo finalizzava e allora diventava più sostenibile. E allora il modo di interpretare il dolore, soggettivo, cioè per quanto riguarda l'individuo, e culturale, ne definisce il diverso grado. STUDENTESSA: L'esperienza del dolore può trasformare il rapporto con il proprio corpo? E l'immortalità dell'anima può derivare da questo? Ecco, certamente l'esperienza del dolore trasforma il rapporto col proprio corpo. Mi capita spesso di portare un esempio elementare. Lei immagini di fare una gita in montagna in una giornata d'estate. Allora ad un certo momento ha camminato, è sudata, trova una fonte, c'è questa acqua fresca, lei si bagna, la beve, l'arsura è placata, sente un grande ristoro. Che cosa sente? Sente la freschezza dell'acqua, sente l'acqua, sente il mondo, sente gli odori. Immagini di avere una lesione al labbro, quando lei accosta le labbra all'acqua, sente immediatamente il bruciore alla bocca. Non sente l'acqua, sente il corpo. Ecco allora che cosa cambia: nel dolore il corpo è vissuto come ostacolo nei confronti del mondo. Nella sanità il corpo è sentito come apertura verso il mondo. Il corpo sano sente il mondo, il corpo malato sente il corpo. E quindi il corpo diventa una barriera tra il proprio desiderio, l'universo delle possibilità, e la realizzabilità delle medesime possibilità. Cosa vuol dire "venire al mondo", la parola "venire al mondo"? Che il mondo è lo spazio delle nostre possibilità. Il bambino viene al mondo, comincia a camminare nel mondo, i primi passi, tocca, raggiunge le cose. Il corpo colpito ha dinanzi a sé un mondo irraggiungibile. Ecco allora perché si cambia la dimensione dell'esperienza del proprio corpo. Si cambia anche soprattutto la dimensione dell'esperienza di sé nei confronti degli altri. Ecco perché il dolore separa. Si dice: il dolore inchioda. E' inchiodato a quella sedia. Gli altri vanno per il mondo. Potranno avere compassione, pietà? Lasciamo stare gli atteggiamenti, ma intanto loro vanno, perché la vita li chiama. Hanno anche dei doveri, e intanto tu sei inchiodato lì. Ecco allora, la dimensione di immutato rapporto col proprio corpo significa anche il mutato rapporto con gli altri. L'esperienza del dolore è anche esperienza della separazione. Immortalità dell'anima. Forse una delle ragioni per cui gli uomini hanno pensato all'immortalità dell'anima è dovuta dal fatto, è dovuta al fatto che questo mondo della rappresentazione, che, pur nel dolore, sussiste, si è formulato come mondo separato. Quello che io penso non coincide con lo stato di cose che realizzo, però continuo a pensarlo. Forse c'è una dimensione di me, allora, che può trovare pienezza al di fuori dei limiti del corpo, visto che il corpo si presenta come limite. Questa è una credenza, è un modo per spiegare questo tipo di credenza. Non solo, ma storicamente è diventata, questa, una forma di consolazione, di compensazione. In una umanità che credeva l'immortalità dell'anima, era persuasa di questo, ecco pensava il mondo a venire come un bilanciamento del male di questo. E' chiaro che non tutto il Cristianesimo si risolve in questa credenza. Per molti versi il Cristianesimo è altra cosa. Ma certamente nei secoli cristiani gli uomini hanno pensato all'altro mondo come quel mondo in cui l'uomo sarebbe stato 49 riscattato dal dolore del presente. Questo era un modo attraverso cui la stessa sofferenza diventava assennata, pur nella lacerazione. L'immortalità era un modo per dare senso al dolore del mondo. Fine destino e Dio che consola, che protegge, che redime soprattutto. STUDENTESSA: Lei prima ha detto che il dolore mentale è una conseguenza del dolore fisico e viceversa. Ma in realtà si possono considerare come due forme differenti di dolore? Io più che usare la parola "conseguenza", che è troppo impegnativa, anche perché definire i nessi di causa ed effetto non è mai molto semplice, ho usato quella di "circolarità". Cioè un male fisico prende la mente e un male mentale prende il corpo. Ecco, certo l'origine non è coincidente. Ci possono essere delle forme di dolore, che prendono il corpo, che nascono dal disagio della mente. Allora, da questo punto di vista, noi ci rappresentiamo sempre in un mondo. L'uomo esiste in quanto è relazione. L'uomo non è una realtà atomica, non è una pietra. L'uomo è rappresentazione. Quindi, lo stesso nostro corpo è in uno spazio, e noi ci vediamo in uno spazio, in uno spazio fisico, la possibilità di raggiungere le cose, in una relazione con gli altri, con le altre persone, che interloquiscono, che ci corrispondono o ci rifiutano. Allora il modo di rappresentarsi il mondo ce lo porta vicino o lontano. Allora è chiaro che le forme di rappresentazione della realtà, il modo in cui noi viviamo le cose, il modo in cui stiamo nell'esistenza, può essere agiato o disagiato. Ed è chiaro che, se il nostro modo di rapportarci agli altri o al mondo-ambiente, è disagiato, bisogna andare a trovare le ragioni, questo immediatamente produce disagi del corpo. Però il disagio del corpo - una grande malattia che nessuno ha deciso e che ci prende - mette a disagio la mente. Allora lì bisogna ricostruire il contatto, ristabilire, se è possibile - non sempre è possibile - la relazione. Ecco, allora qui siamo dinanzi a una rete di nessi, molto complicata. Le voglio dire una sola cosa però, che, mentre nel disagio del corpo, fisico, per esempio una malattia, la mente è messa in questione, però l'uomo è, in certo senso, presente a se stesso, nel disagio della mente è la mente stessa che è portata fuori di sé e quindi è più difficile metterla in rapporto, di coerenza con se stessa. In questo senso il disagio mentale è enigmatico, meno chiaro del dolore del corpo. STUDENTESSA: Secondo Lei, uomini o donne hanno un modo diverso di porsi di fronte al dolore? E se ciò è vero dipende da un fattore fisico o culturale? Qui il problema più che riguardare il dolore riguarda alla cosiddetta "differenza". Certamente gli uomini e le donne sono diversi. Sono diversi dal punto di vista fisico, sono diversi dal punto di vista culturale. Quindi se è vero quello che io ho detto fino adesso, che c'è una circolarità tra danno e senso, probabilmente anche nell'esperienza della sofferenza l'elemento del sentirsi uomo e del sentirsi donna la caratterizza con delle variabili di diversità. Ecco allora è chiaro che poi bisognerebbe andare a vedere, entrando nei mondi storici, come le donne hanno sofferto differentemente dagli uomini. Credo che 50 questo è un lavoro che si potrebbe anche fare, cioè probabilmente delle condotte diverse ci sono state. STUDENTESSA: Ma è vero che comunque per la donna è più facile affrontare l'esperienza dolorosa che per un uomo? Io qui non vorrei essere arbitrario, perché bisognerebbe appunto vedere questi modi storici, queste abitudini culturali. Certamente, così, a prima vista, si può dire che la donna è stata maggiormente legata alla figura della pietà. La dimensione pietosa della donna come ausilio, come accoglimento, questa figura materna, in fondo quando si soffre si diventa sempre un po' bambini, si ricade in questa gracilità originaria. Allora questa figura pietosa, materna, è stata associata al femminile. Ma questo è un discorso abbastanza generale, direi generico, per affrontare queste differenze bisognerebbe fare un'analisi antropologica molto dettagliata e rigorosa, altrimenti si rischia di dire cose senza fondamento. STUDENTE: Professore, buongiorno. Vorrei sapere come Lei si pone di fronte al problema sull'eutanasia. Ecco, questo è un problema che meriterebbe una riflessione, preso da solo, per sé solo. Ecco il ragionamento che io faccio circa l'eutanasia è questo. Dinanzi a situazioni finali, in cui il dolore è forte e non c'è nessuna possibilità di risanamento, il dolore comincia a diventare inutile. E perché allora far sopportare agli uomini un dolore inutile, una inutile crudeltà? Allora lei sa bene che si parla di accanimento terapeutico. In alcuni casi, in certe malattie si continuano a produrre cure che non hanno nessun risultato, tengono in vita una entità - che non possiamo più neanche chiamare persona - solo per farla soffrire. In taluni casi addirittura non c'è più neanche la sofferenza, perché siamo a un livello di insensibilità, di assenza di coscienza, dove l'accanimento, non solo tiene in vita ciò che non vive, ma è anche uno spreco di risorse rispetto a persone, che invece potrebbero essere aiutate. Allora in questo quadro oggi sono tutti d'accordo, anche su posizioni diverse, che l'accanimento terapeutico bisogna evitarlo e quindi bisogna lasciar morire, che non è in senso proprio l'eutanasia, perché l'eutanasia suppone che un soggetto decida lui che non può vivere più e dove la questione non è soltanto non sopportare un dolore inutile, ma è anche mantenere la propria dignità, perché effettivamente il dolore mortifica anche; c'è un problema di rispetto di sé. Allora in questi casi l'uomo deve diventare titolare della sua fine. E qui la situazione è difficile. Anche se in astratto si può condividere l'idea che, quando non si può più vivere, anziché entrare in un tunnel oscuro, è più giusto andarsene, - che era il modo in cui gli antichi pensavano l'eutanasia, la grande uscita dalla vita. La pensavano. Poi anche nel mondo antico non è che l'eutanasia fosse così facilmente praticata -, ma se in linea di principio si può accettare questo, ci sono dei problemi di fatto. Chi decide, quando decide, come e perché? Basta avere a che fare con dei malati, che ci si accorge molto spesso che passano da fasi di depressione a fasi di euforia. Quando sono depressi vorrebbero morire, quando sono euforici vorrebbero vivere. E poi dipende anche dal tipo di 51 rapporto che c'è tra il sofferente e gli altri. Io ho visto dei sofferenti che sino alla fine della propria vita ritenevano di dovere portare a compimento un'azione. Si sentivano responsabili di un compito e quindi non volevano morire. Allora chi decide? Quando, come, perché? Può essere una decisione solo medica? Allora entriamo in delle situazioni di fatto, in cui, anche ammettendo, in linea di principio, la legittimità dell'eutanasia, è molto difficile trovare una oculata giustificazione per praticarla in certi contesti. Tant'è vero che il problema si formula sempre di più in termini di diritto. Come, quando, qual'è la legittimità? Ecco, questo è il tipo di problema. STUDENTE: Sì, però consideriamo il fatto che Dio ha creato la vita. Ha diritto un uomo di levare la vita ad un altro individuo? Dal punto di vista di chi è credente, è chiaro che la eutanasia è esclusa. E qui torniamo ancora di nuovo al problema che la sofferenza non è mai un dato puramente oggettivo. Intanto il credente stesso non entra in una logica di eutanasia, perché interpreta il suo dolore in modo diverso. E' vero che la sofferenza può far vacillare anche le fedi, però il credente non è in una logica di eutanasia. E il credente si rapporta anche con credenti. Quindi trova modi di conforto, modi di portare a termine la sua vita nell'ambito della credenza stessa. Diverso è il discorso per il non credente. Infatti, anche se si ammettesse giuridicamente l'eutanasia, non vuol dire per ciò stesso che tutti la praticano. Ci sarebbero delle persone che vivono il dolore in un modo diverso, correlato a un senso di riscatto, che non accederebbero all'eutanasia. Quindi anche qui il problema della decisione dipende dal modo in cui si vive il dolore, a secondo della interpretazione. Ecco perché direi che l'eutanasia è una questione più sulle condizioni di possibilità che sulla effettività. Quando si parla di eutanasia, si parla delle condizioni di possibilità perché questo atto divenga legittimo, ma la decisione dipende sempre dal soggetto e soprattutto dal modo in cui il soggetto si relaziona agli altri. Perché su questo è delicato. Cioè, è vero che c'è un dolore inutile, che è assurdo sopportare, ma molte volte, soprattutto nel nostro mondo, l'eutanasia è voluta, non tanto da chi soffre, ma da coloro che gli stanno attorno, che non sono loro capaci di pietà, che non sono loro capaci di farsi carico del dolore dell'altro. E allora dicono che il suo dolore è insopportabile perché non lo sopportano loro. E in una società spietata come la nostra un modo per liquidare il dolore lo sai qual è? Togliere di mezzo il sofferente. Se si toglie di mezzo il sofferente il dolore non c'è più. E siamo noi una società spietata. STUDENTESSA: Scusi, professore, volevo chiedere se la vita di un uomo non fosse intervallata da momenti di dolore, potrebbe allora esistere la felicità? Beh questo, questo tipo di ragionamento, diciamo che si discosta dall'esperienza che noi abbiamo della vita, perché la vita, come dicevo prima, come i Greci pensavano, è insieme crudeltà e felicità. Ci sono mondi, credenze, che accennano ad un mondo, in cui non ci sarà più il dolore e la morte. C'è un versetto di Isaia, che dice appunto che "ci sarà un giorno in cui Dio asciugherà le lacrime su ogni volto". Ma questo può essere solo creduto. Appartiene a 52 quelle dimensioni di senso attraverso cui il dolore è interpretato. Però l'esperienza della lacerazione, in cui anche le stesse credenze sono messe a rischio, è quotidiana. Ecco allora direi che il dolore fa parte della vita, però non la nega, non la estingue. Può essere vissuto. Nonostante tutto, la sofferenza è un momento della vita. C'è sofferenza fino a che c'è vita. Quando si perde la coscienza del soffrire non si soffre neanche più. E allora se c'è sofferenza perché c'è vita, al fondo di ogni sofferenza bisogna promuovere fino a che è possibile la vita. E questo è importante nella relazione con gli altri, con la persona che soffre. Quando noi ci rapportiamo alla persona che soffre, l'unico modo per potere dare un senso non è compatirla, ma liberare in lei la vita. Il modo profondo, vero di compatire, nel significato originario della parola, sunpatere, vivere con, qual è? Non è essere pietosi del soffrire dell'altro, ma nel soffrire dell'altro capire che l'altro è importante per noi. Se l'altro si sente importante per qualcuno, anche se soffre, ha motivi di vivere. Se non si sente importante per nessuno, può chiudere la sua partita. In questo senso, anche nel silenzio, noi possiamo aiutare a vivere l'altro, se l'altro percepisce in noi, che è importante per noi. E quindi deve vivere per gli altri. In questo senso la pietas grande alimenta la vita, anche nel più profondo della sofferenza. 53 Il dolore . : pagina iniziale . : antologia . : links . : filosofi . : riflessioni . : sentenze . : biblioteca Ogni dolore è facile a disprezzare; quello che comporta sofferenza intensa dura poco tempo, e quello che perdura molto tempo nella carne comporta sofferenza temperata. (Epicuro) A cura di Cristiano Turbil Il termine dolore (Pain), assume diversi significati, rispetto al sistema etico e al contesto storico-culturale in cui è inserito. In questo saggio breve, si ha l’intenzione di definire il dolore, all’interno di due sistemi etici che ne hanno una considerazione opposta. Il primo, quello cristiano cattolico, all’interno del quale il dolore viene considerato nella sua veste forse più positiva, assume non più il ruolo di ente negativo che affligge l’uomo ma diventa il mezzo usato dall’umanità per raggiungere e completare, all’interno del viaggio che è la vita, le sofferenze del Cristo, per riscattarsi dal mondo del peccato e raggiungere a pieno titolo la salvezza eterna . Nella seconda parte, invece, il dolore non viene più analizzato rispetto alla sua valenza negativa o positiva sull’uomo, ma viene studiato all’interno di un contesto logico atto a determinare la sua reale posizione in rapporto con il suo diretto corrispettivo opposto “ Piacere” (Pleasure), muovendo una critica logico-psicologica al valore e al ruolo che hanno questi due termini all’interno delle dottrine etiche di carattere Edonistico quantitativo (ovvero i sistemi etici in cui si agisce con il fine di massimizzare la quantità di piacere senza preoccuparsi della sua qualità) e utilitaristico. Il dolore nelle etica cristiana: §1 54 La tematica del dolore all’interno dell’uomo, nell’orizzonte etico cristiano, viene espresso esaurientemente all’interno della lettera enciclica Salvifici Doloris, qui il Pontefice cerca di spiegare come il dolore e la sofferenza siano inseriti necessariamente all’interno della vita dell’uomo. La lettera si apre con una frase di Paolo tratta dalla prima lettera ai Colossesi “Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo che è la chiesa”[1], questo piccolo estratto che sarà poi il filo conduttore di tutta la discussione, mette subito in rilievo come la sofferenza nell’uomo e per l’uomo, sia mezzo per raggiungere la salvezza divina. Va inoltre precisato che il tema della sofferenza, è profondamente inserito nell’anno liturgico della redenzione come giubileo straordinario (Anno 1984). Qui la sofferenza viene considerata come caratteristica propriamente umana, in quanto oltre a rappresentare il dolore fisico che l’uomo condivide con gli animali, assume un senso più alto, sembra infatti appartenere alla trascendenza dell’uomo e addirittura ad uno di quei punti a cui l’uomo è destinato. §2 La prima grande questione affrontata è la definizione dell’idea del dolore, e tutti i temi ad essa correlati, soprattutto il rapporto tra dolore Fisico e Morale. Il settore più conosciuto della sofferenza nella società moderna è quello medico che alla luce della scienza dà una più precisa ed esauriente descrizione del dolore e ne determina i diversi metodi del reagire (cioè della terapia). Tuttavia questo è solo un settore, il campo della sofferenza umana è molto più ampio. 55 Infatti l’uomo soffre in diversi modi, non sempre contemplati dalla medicina, neanche nelle più avanzate specializzazioni. Tutto ciò si può capire nella differenza che intercorre tra dolore fisico e morale: · corpo. · La sofferenza fisica si manifesta quando duole in qualsiasi modo il La sofferenza morale si ha quando duole l’anima. La vastità della sofferenza è quella che fornisce il superamento della medicina come conoscenza della terapia del dolore fisico. Il dolore fisico è solo la parte inferiore del concetto di sofferenza, la vera sofferenza è quella dell’anima. Infatti della sofferenza morale si trovano moltissimi esempi nelle scritture e in particolare all’interno dell’Antico Testamento, in cui troviamo molti esempi di situazioni che recano i segni della sofferenza: · Il pericolo di morte · La morte del figlio primogenito · La mancanza di prole · La nostalgia della patria Tutti questi esempi e molti altri portano a considerare l’uomo come un insieme psicofisico che fa un tutt’uno con la sofferenza, dove la sofferenza viene intesa nel significato più ampio di “esperienza del male”. Nell’ etica cristiana la nozione del male non esiste propriamente, in quanto tutto ciò che esiste è bene, perché proclama la somma e assoluta bontà del 56 Creatore per le sue creature. L’uomo quindi soffre a causa del male, che è una mancanza, una distorsione del Sommo Bene. La sofferenza umana costituisce quindi un mondo che esiste insieme all’uomo e possiede una valenza sia soggettiva che collettiva ed ha in sè una propria precisa compattezza. §3 Il dolore fisico è ampiamente diffuso nel mondo degli animali, però solamente l’uomo soffrendo sa di soffrire e se ne chiede il perché. Questa domanda l’uomo non la pone al mondo che sembra essere causa delle sue sofferenza, ma la pone invece a Dio. La risposta a questo interrogativo la si trova all’interno del libro di Giobbe, uno dei grandi libri dell’Antico Testamento, dove si narra la storia di Giobbe un uomo giusto che non conosce il peccato che viene colpito da innumerevoli disgrazie. Qui viene mostrato come il male non sia soltanto inteso come pena (espiazione di una colpa), ovvero data da Dio all’uomo nel momento del peccato e dell’errore, quindi intesa come mezzo redentivo per ristabilire la giustizia. Ma si evince anche, e soprattutto nel caso specifico di Giobbe, ovvero di un uomo senza alcun peccato e che quindi non merita alcun dolore, che la sofferenza data da Dio deve essere intesa come un mistero che l’uomo non è in grado di penetrare fino in fondo con la sua intelligenza. E’ vero quindi che la sofferenza sia legata alla colpa, ma non è altresì vero che essa sia legata unicamente alla colpa. E un importante prova di questo la troviamo appunto nel caso di Giobbe. Il libro di Giobbe, pone il perché della sofferenza ma non ne dà la risposta; fa solo capire che la sofferenza è l’utile per l’uomo, in quanto serve alla conversione, cioè alla ricostruzione del bene del soggetto che riconosce la misericordia divina nella penitenza. §4 La soluzione della sofferenza, la troviamo però nella figura di Cristo: “Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna”[2] 57 Questa frase che può essere considerata uno dei pilastri portanti del nuovo testamento mira ad esprimere la vittoria dell’amore sulla sofferenza; infatti Dio dà il suo unico figlio al mondo, per liberare l’uomo dal male, che porta in sè la definitiva e assoluta prospettiva della sofferenza. Qui si può facilmente notare come ci si è spostati dalla dimensione della sofferenza come giustizia o mistero (Libro di Giobbe), alla nuova dimensione della redenzione, in cui la sofferenza assume il suo ruolo definitivo, ovvero il mezzo per raggiungere la vita eterna. Il peccato diventa quindi il contrario della salvezza, la perdita della vita eterna; la vera missione del figlio di Dio assume il ruolo di vincere il peccato e la morte e con la resurrezione ottenere il perdono e la vita eterna. Grazie a questo, anche se la vittoria di Cristo non abolisce le sofferenze temporali della vita umana, né libera la totale dimensione dell’esistenza, tuttavia getta su ogni sofferenza una luce nuova, che è la luce della salvezza. Questa nuova verità, cambia l’intero quadro delle sofferenze umane nelle sue fondamenta, nonostante il fatto che il peccato originale si sia radicato come “Peccato del mondo” e come somma dei peccati personali. Dio ha mandato il Cristo, affinché tocchi le radici più profonde del male con la sua innocente sofferenza e salvi l’uomo con la sua morte e resurrezione. §5 Nel simbolo della croce di Cristo, non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta. Cristo si è addossato il male totale del peccato. L’esperienza di questo male su Cristo, diventa il prezzo della redenzione e cosi il mondo della sofferenza viene aperto agli uomini in un modo del tutto nuovo, che permette di considerare il dolore in una nuova prospettiva finalizzata alla salvezza La croce di Cristo diventa qui il simbolo di tutto ciò: essa getta in modo tanto penetrante la luce salvifica sulla vita dell’uomo perché mediante la fede lo raggiunga con la risurrezione. La sofferenza diventa quindi una prova per l’uomo, una prova dove tramite la sua debolezza manifesta la sua potenza, la sua grandezza morale la sua maturità spirituale. E in conclusione tutti coloro che partecipano della sofferenza di Cristo, comprendono il mistero della croce e della resurrezione, nel quale Cristo 58 scende nella debolezza e muore ma allo stesso tempo compie la sua elevazione. §6 Alla luce di tutto questo, il vangelo assume quindi il ruolo di vangelo della sofferenza, in cui Cristo è la chiave di volta di tutto il sistema, che vince la morte con la sofferenza e ottiene la salvezza con la resurrezione. La stessa cosa dovranno fare tutti gli uomini, come dice Paolo “Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in cristo Gesù saranno perseguitati[3]”. Questo è in conclusione il vero messaggio della sofferenza, che perde nell’etica cristiana quasi tutta la sua valenza negativa e assume un significato oltremodo positivo, diventando il mezzo anzi sarebbe meglio dire il percorso che permette all’uomo di raggiungere la promessa di vita eterna, completando nel suo corpo. tramite il dolore. i patimenti del Cristo che grazie alla sua morte ci ha salvati dal mondo del peccato. Il Dolore e il Piacere nell’analisi di Gilbert Ryle La tematica del Piacere e del Dolore viene analizzata all’ interno del saggio Dilemmas[4]. Nel capitolo quarto di questa piccola raccolta di dilemmi, Ryle analizza le nozioni di Dolore e Piacere rispetto ad una critica motivata del ruolo che assumono all’interno delle classiche dottrine etiche edonistico-psicologiche. §1 Nella prima parte della breve dissertazione, l’autore fornisce una veloce ma precisa analisi del ruolo del piacere e del suo corrispettivo all’interno dell’edonismo, descrivendo i vari assiomi che solitamente venivano attribuiti ai comportamenti umani, i quali assumevano proposizioni abbastanza plausibili ma talvolta e nella fattispecie non plausibili. 59 Si considerava infatti l’uomo come mosso e determinato nei suoi comportamenti rispetto ad alcuni desideri, che venivano considerati tutti come desideri del piacere: di conseguenza ogni azione intenzionale compiuta dall’uomo era motivata solo ed esclusivamente da un incremento quantitativo del piacere provato dall’individuo agente e da una netta diminuzione del dolore dello stesso. In un sistema cosi strutturato, i piaceri differivano tra di loro, solo ed esclusivamente, non su un rapporto di qualità ma semplicemente su un rapporto di quantità, ovvero un piacere ά era migliore di un altro piacere β solo se esso era rispettivamente più intenso o prolungato o tutte due le cose insieme rispetto all’altro. Perciò in base a questi assiomi sembrò logico considerare l’altruista come colui che incrementa il piacere altrui e l’egoista come colui che incrementa il proprio piacere. I termini piacere e dolore venivano quindi ad assumere il ruolo di effetti di atti, il cui movente degli atti stessi veniva ad essere il desiderio di quei piaceri. I piaceri venivano quindi ad essere considerati come delle sensazioni, prodotte da azioni o altri eventi, come ci dice Ryle “ il desiderio di provare queste sensazioni era interpretato come quel che ci spinge a compiere o a garantirci quelle cose che le producono”[5], di conseguenza si assumeva che il dolore stesse al piacere, come il dolce all’amaro, il buio alla luce, cioè essi venivano considerati come l’uno l’antitesi dell’altro o più facilmente come i due poli opposti di una stessa scala graduata, dove il calcolo e la misurazione del piacere doveva essere l’esatto opposto del calcolo della quantità di dolore, quindi dove aumentava uno, diminuiva l’altro. §2 Anche se queste teorie ci dicono che il concetto piacere è l’esatto opposto del concetto di dolore, in quanto ambedue sono sensazioni, tuttavia ci sono obiezioni invalicabili che non permettono di considerarli come opposti diretti. 60 Noi uomini siamo abituati a dire che alcune cose ci provocano piacere mentre altre dolore, però non abbiamo la capacità e la possibilità di determinare, ad esempio, il momento in cui abbiamo provato piacere e la sua durata precisa nel tempo. Noi, infatti, possiamo dire al medico dove e quando proviamo dolore ma non possiamo descrivere perché non ne saremmo mai capaci, dove e in che modo proviamo un piacere e come dice lo stesso Ryle “In una parola, il piacere non è affatto una sensazione, e tanto meno una sensazione sulla stessa scala con malesseri e dolori fisici”[6]. Infatti, come ci spiega poi in seguito l’autore, alcune sensazioni sono piacevoli, mentre altre sono spiacevoli, però le une possono cambiare e produrre risultati opposti se cambia il contesto in cui sono inserite, come ad esempio un calore può essere spiacevole, mentre se lo stesso calore prodotto da un the caldo può risultare piacevole. “Se fosse giusto classificare come sensazione il piacere, dovremmo aspettarci che fosse anche possibile descrivere quindi alcune di queste sensazioni come piacevoli, altre come neutre, ed altre come sgradevoli ma questo è impossibili”[7], ma tutto ciò come spiega Ryle è impossibile, perché se le sensazioni fossero neutre e spiacevoli ci troveremmo di fronte ad una contraddizione, mentre se esse fossero piacevoli risulterebbe una ridondanza. Anzi, noi abbiamo addirittura la possibilità di ignorare una sensazione, se siamo impegnati a fare altro, per esempio se proviamo male ad un dito ma siamo impegnati in un gioco che occupa tutta nostra attenzione, la sensazione di dolore non viene considerata. §3 Mentre, scrive Ryle, per quel che compete alle nozioni di Piacere e Disgusto, esse sono connesse alla consapevolezza in un modo del tutto differente dalle sensazioni. Infatti non è possibile né logicamente, né psicologicamente che una persona goda di una musica senza prestarne attenzione, vi è quindi una contraddizione di fondo nel descrivere qualcuno come mentalmente assente da qualcosa che sta gustando o detestando. Infatti “il piacere e il disgusto non richiedono diagnosi, mentre possono benissimo richiederne le sensazioni”[8]. Le sensazioni e i sentimenti hanno una precisa collocazione nel tempo, esse possono essere un antecedente, un concomitante oppure un susseguente di altri avvenimenti, mentre per il piacere questo non é possibile. 61 Noi possiamo benissimo determinare il momento esatto in cui proviamo un dolore ma non possiamo altresì cosi facilmente determinare l’esatto istante in cui proviamo piacere per aver visto un bel film, o per aver mangiato qualche cosa di gustoso, in quanto il piacere non essendo una sensazione, non ha una collocazione precisa nel tempo. §4 Per tornare al discorso iniziale, l’assimilazione del godimento e del disgusto all’ interno delle sensazioni, era solo una piccola parte del programma etico teso alla realizzazione della condotta umana. In questa teoria i desideri e i piaceri, dovevano essere i corrispettivi mentali della pressione, dell’urto e di tutte le cose proprie della teoria meccanica. Mentre i moti psichici sarebbero diventati calcolabili e misurabili quanto l’intensità dei piaceri e dei desideri. Un piacere sarebbe stato quindi determinato di una precisa grandezza, almeno per ciò che compete alla sua durata e intensità. Mentre, seguendo le obiezioni di Ryle sopra riportate, si nota precisamente che il piacere non essendo una sensazione, non può essere un processo. I processi, infatti, sono caratterizzati da una precisa durata, mentre l’uomo non può provare un piacere in modo veloce o lento. Quindi, il ruolo che le nozioni di piacere e disgusto assumono nella teoria etica dinamica non possono di certo avere la valenza di processo. I dolori, alla luce di quanto detto, vengono ad essere considerarti come “l’effetto di cose come la pressione di una scarpa su un dito del piede, e la causa di cose come gesti agitati di insofferenza”[9]. Dopo aver espresso tutto questo, l’autore muove un ultima critica alle teorie etiche edonistiche ed utilitaristiche; avendo dimostrato l’inefficacia di tutti i sistemi che considerano il piacere come un processo, fa notare come tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita i nostri momenti edonistici e utilitaristici e ne siamo rimasti insoddisfatti. In essi non abbiamo trovato, soprattutto nell’analisi profonda delle nozioni di disgusto e godimento,delle certezze le quali hanno subito delle sottili e sospette trasformazioni, allorché sono state presentate come le forze di base che determinano le nostre scelte ed intenzioni. §5 62 Nell’ultima parte della dissertazione, Ryle si impegna a definire il concetto di piacere nella descrizione della vita e della condotta umana, scusandosi però di trattarlo da un punto di vista che può ,per il lettore, suonare come arcano o prescientifico. L’autore definisce infatti come passioni tutti gli stati d’animo agenti sull’uomo potenzialmente sovversivi, come il terrore, la collera, l’allegria, l’odio ecc, e determina che godere o detestare un qualche cosa non vuol dire essere vittime di una passione. Infatti , se una persona è perfettamente padrona di sé nelle sue azioni, non può essere descritta come agitata, in collera o in preda al panico, nozioni tutte appartenenti in modo intrinseco alle passioni. Ma nessuna di queste connotazioni si addice al piacere, infatti come ci dice l’autore “se godere di qualcosa con una certa intensità equivalesse ad essere fuori di sé in pari misura, si dovrebbe essere dissennati per tutto il tempo dedicato alle proprie occupazioni preferite”[10]. Una persona in uno stato di perfetta calma può quindi provare anche un grande piacere, la nozione di godimento rifiuta perciò di passare attraverso lo stesso cerchio logico in cui passano le passioni. Il godimento non è qualcosa che noi proviamo a reprimere, che soffochiamo o non riusciamo a soffocare, è una nozione totalmente scollegata al dominio delle passioni. §6 In conclusione e per riprendere il filo del discorso precedente,Ryle fa notare che i concetti di godimento e disgusto sono stati erroneamente collocati come appartenenti alla categoria delle sensazioni e dolori fisici, alla categoria di accadimenti come causa di altri accadimenti e al dominio più generale delle passioni. Ma queste nozioni, come fa ben notare l’autore, opporranno sempre resistenza a ogni tentativo di avvicinarle ai concetti di queste altre famiglie. Per concludere come sostiene Ryle nelle ultime frasi di questo capitolo “I dilemmi derivano dall’attribuzione erronea di analogie di ragionamento”[11], ovvero come detto appena sopra ad ogni uso non proprio dei concetti di Piacere e Disgusto. 63 -------------------------------------------------------------------------------[1] Lettere ai Colossesi 1,24 [2] Vangelo di Giovanni 3,16 [3] Seconda lettera a Timoteo 3,12 [4] Gilbert Ryle, Dilemmas 1966 Cambidge University Press, London Utilizzata nella traduzione italiana a cura Enrico Mistretta 1968 Ubaldini Editore, s.r.l. Roma. [5] Dilemmas, p. 61 [6] Idem p. 62 [7] Idem p. 62 [8] Idem p. 63 [9] Idem p. 64 [10] Idem p. 69 [11] Idem p. 70 64 Il buddhismo è una religione? del venerabile Ajahn Sumedho © Ass. Santacittarama, 2008. Tutti i diritti sono riservati. SOLTANTO PER DISTRIBUZIONE GRATUITA. Dal libro "La mente e la via" Traduzione di Elizabetta Valdrè Estratto del libro "La mente e la via", su gentile concessione dell'Editore Ubaldini. Ci piace pensare che comprendiamo la religione perché è profondamente radicata nella nostra prospettiva culturale. Nondimeno, ci è utile contemplare e riflettere sui veri scopi, propositi o intenti della religione. A volte, le persone ritengono che religione significhi credere in un Dio o negli dèi, e la identificano con la posizione teistica di una particolare forma o convenzione religiosa. Spesso, le confessioni teistiche considerano il buddhismo una religione atea, oppure non lo ritengono affatto una religione. Lo considerano una filosofia o una psicologia, perchè il buddhismo non parte da una posizione teistica. Non trae le proprie radici da una posizione metafisica o dottrinale, ma dall'esperienza comune a tutta l'umanità: l'esperienza della sofferenza. Il buddhismo presuppone che riflettendo, contemplando e comprendendo quella comune esperienza umana, si possano trascendere tutte le illusioni mentali che la creano. Il termine "religione" deriva dalla parola latina religio, che significa legame. Si riferisce a un vincolo col divino che avvolge interamente l'essere. Religiosità vera significa legame col divino, o realtà suprema, e impegno di tutto il proprio essere in quel legame, fino al raggiungimento della realizzazione suprema. Tutte le religioni hanno parole come "liberazione" e "salvezza". Termini di tale natura comunicano libertà dall'illusione, libertà completa e assoluta, e comprensione totale della realtà suprema. Nel buddhismo, la chiamiamo illuminazione. 65 Comprendere la natura della sofferenza L'approccio buddhista consiste nel riflettere sull'esperienza della sofferenza, perché è ciò che tutti gli esseri umani condividono. Sofferenza non vuol dire necessariamente una grande tragedia o una terribile disgrazia. Allude semplicemente a quel genere di scontentezza, infelicità e delusione che tutti gli esseri umani provano in vari momenti della loro vita. La sofferenza è comune agli uomini e alle donne, ai ricchi e ai poveri. Qualunque sia la nostra razza o nazionalità, la sofferenza è il legame comune. Perciò, nel buddhismo, la sofferenza è considerata una nobile verità. Non è una verità suprema. Quando il Buddha insegnò che la sofferenza è una nobile verità, non era sua intenzione legarci alla sofferenza e farci credere ciecamente in essa come se fosse una verità suprema. Al contrario, ci insegnò a usare la sofferenza come nobile verità su cui riflettere. Contempliamo: che cos'è la sofferenza, qual è la sua natura, perché soffro, qual è l'oggetto della sofferenza? La comprensione della natura della sofferenza è un'intuizione importante. Ora, contemplatela nell'esperienza della vostra vita. Quanta parte dell'esistenza investite nel tentativo di evitare o di sfuggire quelle stesse situazioni spiacevoli o non volute? Possiamo avere la felicità immediata, l'assorbimento immediato, le realtà che chiamiamo non-sofferenza, quali l'eccitazione, una storia d'amore, l'avventura, i piaceri dei sensi, il buon cibo, l'ascolto della musica o qualunque altra cosa. Ma non sono altro che tentativi di sfuggire alle paure, alle insoddisfazioni, all'ansia e alla preoccupazione: stati mentali che tormentano la mente umana non illuminata. L'umanità sarà sempre tormentata e spaventata dalla vita fintanto che rimane ignorante e non coltiva lo sforzo di guardare e capire la natura della sofferenza. Capire la sofferenza significa accettarla e non semplicemente sbarazzarsene o negarla, o incolparne qualcun altro. Possiamo accorgerci che la sofferenza è provocata, che dipende da certe condizioni, le condizioni mentali che abbiamo creato, o che la cultura e la famiglia hanno instillato in noi. La nostra esperienza della vita e il processo di condizionamento iniziano il giorno in cui nasciamo. La famiglia, l'ambiente in cui viviamo, la scuola instillano nella nostra mente prevenzioni, opinioni, pregiudizi, alcuni buoni, alcuni no. Ora, se non facciamo veramente attenzione a queste condizioni mentali e non le esaminiamo per quello che sono effettivamente, esse ci faranno interpretare l'esperienza della vita secondo certi pregiudizi. Ma se scaviamo a fondo nella natura stessa della sofferenza, iniziamo a esaminare stati mentali quali la paura e il desiderio e scopriamo che la nostra vera natura non è il desiderio, non è la paura. La nostra vera natura non è condizionata da alcunché. 66 Il condizionamento, l'incondizionamento e la coscienza Le religioni mettono sempre in luce il rapporto del mortale, o del condizionato, coll'incondizionato. O meglio, se di ogni religione ne mettete a nudo l'essenza, scoprirete che tutto ruota intorno al punto in cui il mortale, ciò che è condizionato e legato al tempo, cessa. In quella cessazione sta la realizzazione e la comprensione dell'incondizionato. Nella terminologia buddhista si afferma che: "c'è l'incondizionato; se non ci fosse l'incondizionato, non potrebbe esserci il condizionato". Dunque, il condizionato sorge e svanisce nell'incondizionato; ciò che deve attirare la nostra attenzione è, quindi, il rapporto tra condizionato e incondizionato. Siccome siamo nati in un corpo umano, dobbiamo vivere un'intera vita con le limitazioni e le condizioni del mondo sensoriale. La nascita implica l'emergere dall'incondizionato e il manifestarsi in una forma separata, condizionata. Tale forma umana implica la coscienza. La coscienza definisce sempre un rapporto tra il soggetto e l'oggetto, e nel buddhismo la coscienza è considerata una funzione discriminatrice della mente. Contemplatela in questo stesso momento. Siete seduti e state prestando attenzione a ciò che dico. Questa è l'esperienza della coscienza. Sentite il calore della stanza, vedete l'ambiente che vi circonda, udite i suoni. Tutto ciò significa che siete nati in un corpo umano, e per tutto il resto della vita, finché il corpo vive, proverete sensazioni e si manifesterà la coscienza. La coscienza crea sempre l'impressione dell'esistenza di un soggetto e di un oggetto, perciò quando non investighiamo, quando non indaghiamo la vera natura delle cose, ci vincoliamo alla visione dualistica: "Io sono il mio corpo, io sono le mie sensazioni, io sono la mia coscienza". L'atteggiamento dualistico nasce dalla coscienza. Con la capacità di immaginare, ricordare e percepire con la mente, costruiamo una personalità. A volte ci piace, in altri momenti ci procura paure irrazionali, opinioni sbagliate, ansie. L'aspirazione della mente umana Attualmente, gran parte dell'angoscia e della disperazione presenti in qualsiasi società di questo mondo materialistico deriva dal fatta che, di solito, i nostri punti di riferimento non sono nulla di più elevato del pianeta in cui viviamo e del nostro corpo. L'aspirazione della mente umana alla realizzazione suprema, all'illuminazione, non è concretamente promossa né incoraggiata nella società moderna. Di fatto, sembra che spesso venga impedita. 67 Senza un rapporto con la verità suprema, la vita è priva di significato. Se non possiamo riferirci a nulla che trascenda le esperienze di un corpo umano su un pianeta che ruota in un universo misterioso, tutta la vita si riduce a occupare il tempo tra la nascita e la morte. Ma allora, che scopo ha, che cosa significa? Perché ce ne preoccupiamo? Che bisogno abbiamo di uno scopo? Perché mai la vita dovrebbe avere un significato? Perché vogliamo che significhi qualcosa? Perché abbiamo parole, concetti e religioni? Perché nella nostra mente c'è quel desiderio intenso, quell'aspirazione, se tutto ciò che c'è mai stato, o che può esserci, è l'esperienza che deriva dall'ideal del sé? È possibile che questo corpo umano, con i suoi processi condizionanti, ci capiti addosso accidentalmente, in un sistema universale che sfugge al nostro controllo? Viviamo in un universo che è incomprensibile. Possiamo solo fare congetture a riguardo. Possiamo intuire e scrutare l'universo, ma non incapsularlo. Non possiamo farlo diventare qualcosa nella nostra mente. Le tendenze materialistiche che coltiviamo nella mente ci spingono a non porci neppure domande simili. Al contrario, ci fanno interpretare le esperienze esistenziali con la logica e la razionalità, basandoci sui valori del materialismo e della scienza empirica. L'esperienza del risveglio Il buddhismo si rivolge a quell'esperienza universale, comune a tutti gli esseri senzienti che è la sofferenza. Propone anche come uscirne. La sofferenza è l'esperienza del risveglio. Quando soffriamo, cominciamo a porci domande. Tendiamo a guardare, investigare, fare congetture, cercare di scoprire. La storia del principe Siddharta (il nome del Buddha prima dell'illuminazione) ci racconta che egli visse in un ambiente colmo di piacere, bellezza, comodità, vantaggi sociali: tutto il meglio che la vita potesse offrire. Poi, racconta la leggenda, all'età di ventinove anni, Siddharta lasciò il palazzo per scoprire il mondo esterno, dove conobbe i messaggeri della vecchiaia, della malattia e della morte. Potremmo obiettare che all'età di ventinove anni avrebbe già dovuto conoscere la vecchiaia, la malattia e la morte. Nel nostro sistema di pensiero, ci è del tutto chiaro sin dalla primissima infanzia che tutti invecchiano, si ammalano e muoiono. Nonostante ciò, il principe fu tenuto al riparo da queste esperienze, e nella sua mente non si risvegliò alcuna coscienza della loro presenza finché non le sperimentò direttamente. Anche noi possiamo vivere un'intera vita nella convinzione che tutto vada per il meglio. Persino l'infelicità e le delusioni che fanno normalmente parte della nostra esperienza non sono necessariamente occasione di risveglio. Magari per un po’ ci poniamo qualche domanda a riguardo, ma ci sono tante 68 opportunità per non tenerne conto, per non accorgersene. È facile incolpare gli altri della nostra infelicità, non è così? Possiamo dare la colpa al governo, a nostra madre e a nostra padre, agli amici e ai nemici, alle forze esterne. La mente si risveglia alla vecchiaia, alla malattia e alla morte quando si rende conto che anche noi vivremo quelle esperienze. Cose del genere non si comprendono in astratto, ma con una sensazione che ci prende alle viscere, quando intuiamo che questa è la sorte di tutti gli esseri umani. Ciò che nasce, invecchia, degenera e muore. Il quarto messaggero che si presentò al Buddha era un samana. Un samana è un monaco, un cercatore spirituale, un uomo che si è dedicato unicamente alla ricerca della realtà suprema, la verità. Il samana, così come lo ritrae la leggenda, era un monaco dal capo rasato con indosso una tunica. Nel simbolismo buddhista i quattro messaggeri sono: la vecchiaia, la malattia, la morte e il samana. Significano il risveglio della mente umana a una meta religiosa, a quell'aspirazione del cuore umano alla comprensione della realtà suprema che è libertà da tutta l'illusione e la sofferenza. La pratica buddhista Oggi si tende di frequente a ritrarre la meditazione buddhista come un abbandono del mondo, come lo sviluppo di uno stato mentale di estrema concentrazione, che dipende da alcune condizioni attentamente controllate. Perciò, negli Stati Uniti e negli altri paesi in cui la meditazione buddhista sta diventando sempre più popolare, molti credono che sia uno stato mentale concentrato in cui la tecnica e il controllo sono molto importanti. Le tecniche di questo tipo vanno benissimo, ma anche se iniziate a sviluppare le capacità riflessive della mente, non è sempre necessario, e nemmeno opportuno, che passiate il tempo a cercare di perfezionare la mente e portarla al livello in cui tutto ciò che è grossolano e spiacevole viene annullato. È meglio aprire la mente alla pienezza delle sue potenzialità, a una sensibilità piena, per venire a conoscenza che le condizioni di cui siete consapevoli al momento, ciò che sentite, vedete, udite, fiutate, gustate, toccate, pensate, sono impermanenti. L'impermanenza è una caratteristica comune a tutti i fenomeni, che si tratti della fede in Dio o di un ricordo del passato; che sia un pensiero di rabbia o un pensiero d'amore; che sia qualcosa di alto, basso, grezzo, raffinato, buono, cattivo, piacevole o doloroso. Qualunque sia la sua qualità, osservatelo come oggetto. Tutto ciò che sorge, scompare. È impermanente. Ora, l'apertura della mente di cui parlavo, vi permette, come pratica e riflessione di vita, di avere una visione d'insieme delle emozioni e delle idee, della natura del vostro corpo e degli oggetti dei sensi. 69 Tornare alla coscienza in quanto tale: la scienza moderna, la scienza empirica, ritiene che il mondo della materia che vediamo, udiamo e sentiamo, sia il mondo reale, l'oggetto dei sensi. Il mondo oggettivo è chiamato realtà. Vediamo il mondo della materia, conveniamo sulla sua esistenza, lo udiamo, lo gustiamo, lo tocchiamo, o addirittura concordiamo su una percezione o sul nome da attribuirle. Ma anche quella percezione è un oggetto, non è così? Dato che la coscienza crea l'impressione che esistano un soggetto e un oggetto, crediamo di star osservando qualcosa che è separato da noi. Il Buddha, tramite i suoi insegnamenti, portò alle ultime conseguenze il rapporto soggetto-oggetto. Insegnò che tutte le percezioni, tutte le condizioni che ci attraversano la mente, tutte le emozioni, le sensazioni, gli oggetti del mondo materiale che vediamo e udiamo, sono impermanenti. Disse: "Ciò che sorge, svanisce". E questa, lo ripete in tutti i suoi insegnamenti, è la visione profonda che ci libera da ogni forma di illusione. Ciò che sorge, svanisce. Si può definire la coscienza anche come capacità di conoscere, esperienza del conoscere. Il soggetto che conosce l'oggetto. Quando guardiamo gli oggetti e gli diamo un nome, pensiamo di conoscerli. Pensiamo di conoscere questa o quella persona perché sappiamo il suo nome o ci ricordiamo di lei. Pensiamo di conoscere cose di tutti i tipi perché ce ne ricordiamo. La capacità di conoscere, a volte, è condizionata: sapere che, piuttosto che conoscere direttamente qualcosa. La pratica buddhista consiste nel rimanere in quella pura attenzione in cui si trova ciò che chiamiamo conoscenza intuitiva, o conoscenza diretta. È una conoscenza non fondata sulla percezione, su un'idea, su una posizione, o una dottrina, ed è possibile solo tramite l'attenzione. Ciò che intendiamo per attenzione è la capacità di non attaccarci ad alcun oggetto, che appartenga al regno materiale o al regno mentale. Quando non c'è l'attaccamento, la mente è in uno stato di pura consapevolezza, intelligenza e chiarezza. Questa è l'attenzione. La mente è pura e ricettiva, sensibile alle condizioni esistenti. Non è più una mente condizionata che si limita a reagire al piacere e al dolore, alla lode o al biasimo, alla felicità e alla sofferenza. Se adesso, per esempio, vi arrabbiate, potete seguire la rabbia. Potete crederle e continuare a riprodurre quell'emozione, oppure potete soffocare la rabbia e cercare di interromperla per paura o per avversione. Tuttavia, invece di comportarvi in uno dei due modi, potete pensare alla rabbia come a qualcosa che può essere osservato. Ora, se la rabbia fosse il nostro vero sé, non la potremmo osservare; ecco ciò che intendo per "riflessione". Che cos'è che può osservare e riflettere sulla sensazione della rabbia? Che cos'è che può esaminare e investigare la sensazione, il calore del corpo, o lo stato mentale? Quella che osserva e investiga, è ciò che chiamiamo mente riflessiva. La mente umana è una mente riflessiva. 70 La rivelazione della verità comune a tutte le religioni Possiamo porci domande quali: chi sono io? perché sono nato? che cos'è la vita? cosa succede quando muoio? la vita ha un significato o uno scopo? Poiché pensiamo che altri conoscano ciò che noi non conosciamo, gli chiediamo delle risposte, invece di aprire la mente e aspettare pazienti e vigili che sia la verità a rivelarsi. La rivelazione è possibile, tramite l'attenzione e la vera consapevolezza. La rivelazione della verità, o della realtà suprema, è l'essenza dell'esperienza religiosa. Quando ci leghiamo al divino, e in quel vincolo impegniamo la totalità del nostro essere, facciamo sì che la rivelazione della verità che chiamiamo visione profonda, una visione profonda che sia vera e intensa, penetri nella natura delle cose. Anche la rivelazione è ineffabile. Le parole non sono assolutamente in grado di esprimerla. Ecco perché le rivelazioni possono essere molto diverse. Il modo in cui vengono esposte o si concretano nelle parole può variare all'infinito. Perciò le rivelazioni di un buddhista hanno un'aria molto buddhista e le rivelazioni di un cristiano danno un'impressione molto cristiana, il che è abbastanza giusto. Non c'è niente di sbagliato in questo. È necessario però riconoscere i limiti della convenzione del linguaggio. Dobbiamo carpire che il linguaggio non è vero né reale in senso assoluto; è un tentativo di comunicare ad altri la realtà ineffabile. È interessante vedere quanta gente oggi cerchi una meta religiosa. Un paese come l'Inghilterra, prevalentemente cristiano, ha ora molte religioni. Ci sono tanti incontri interconfessionali e in questo paese si fanno molti tentativi per capire l'uno la religione dell'altro. Possiamo rimanere a un livello elementare e sapere semplicemente che i musulmani credono in Allah, che i cristiani credono in Cristo e i buddhisti in Buddha. Ma quello che mi interessa è andare al di là delle convenzioni e arrivare a una vera comprensione, alla comprensione profonda della verità. Questo è un modo di parlare buddhista. Oggi abbiamo l'opportunità di lavorare in direzione di una verità comune a tutte le religioni; possiamo iniziare ad aiutarci l'un l'altro. Di questi tempi, convertire la gente, o competere gli uni con gli altri, non sembra avere alcuna utilità o valore. Invece di cercare di convertire, la religione può farci risvegliare alla nostra vera natura, alla vera libertà, all'amore e alla compassione. È un modo di vivere in piena sensibilità, completamente ricettivi, così da godere del mistero e delle meraviglie dell'universo per il resto della vita, e aprirci ad esse. *** Domanda: Il buddhismo è una religione/filosofia che volge il suo sguardo prima di tutto all'interno? Risposta: È quello che sembra, inizialmente, perché nella meditazione buddhista ci si siede, si chiudono gli occhi e ci si volge all'interno. Ma in realtà, la meditazione fa comprendere la natura delle cose, la natura del tutto. 71 In quanto esseri umani, avete una forma assai sensibile. Il corpo è molto vulnerabile ed esiste in un sistema universale immenso e impossibile da capire. È facile lasciarsi intrappolare da una prospettiva in cui il mondo è un oggetto esterno. Secondo tale visione, che si esprime in termini di interno ed esterno, rivolgersi all'interiorità sembra meno importante. Ciò in cui state penetrando sembra poca cosa in confronto alla vastità del sistema universale esterno. Se però lasciate andare le percezioni, lo stato condizionato della mente, iniziate a percepire l'universo in un altro modo. Non si presenta più come una separazione tra soggetto e oggetto. non abbiamo le parole adatte a descrivere quella sensazione, possiamo solo dire che "la realizzate". L'analogia più calzante che mi viene in mente è con un apparecchio radio. Il nostro corpo è una forma sensibile, come la radio o la televisione. Le cose lo attraversano e tendono a manifestarsi a seconda degli atteggiamenti, delle paure e dei desideri. Quando liberiamo la mente dalle limitazioni degli stati condizionati, iniziamo a percepire che queste forme umane sono recettori di saggezza e compassione. D.: Allora in che cosa credono i buddhisti, ammesso che credano in qualcosa? R.: È una domanda comune a cui non è facile rispondere. Se dichiariamo di non avere alcun credo, la gente dice: "Allora non credete in nulla". Noi replichiamo: "No, non è così. Non crediamo neppure che non ci sia nulla". E ribattono: "Allora, credete che ci sia qualcosa; credete in Dio?". Rispondiamo che non riteniamo necessario credere in Dio. E loro: "Allora credete che non ci sia nessun Dio?". E possiamo continuare a girare intorno al problema in questa maniera, perché la gente pensa che religione equivalga a un credo specifico: credere in determinate dottrine e posizioni teistiche, oppure avere una posizione atea. Sono i due estremi della mente: credere nell'eterno e credere nell'estinzione o nell'annullamento. Ma quando parlate del buddhismo, non potete servirvi di tutte le idee che vi siete fatti sulle altre religioni, perché non vanno bene. L'approccio buddhista parte da un'angolazione diversa. Non siamo disposti a credere alle dottrine, agli insegnamenti, ad alcunché ci provenga dall'esterno. Vogliamo scoprire la verità per conto nostro. La verità insita nelle cose deve essere a nostra disposizione. Altrimenti, siamo solo essere impotenti, perduti in un universo misterioso, senza alcuna possibilità di capire cosa ci accade e perché le cose sono come sono. Siamo una sorta di incidente cosmico, o qualcosa di più? Gli esseri umani avvertono che c'è qualcosa al di là dell'apparenza del mondo sensoriale. Il sentimento religioso, la sensazione di star procedendo verso qualcosa, di innalzarsi verso qualcosa, lo troviamo sia nelle società primitive sia in quelle moderne. Siamo tutti coinvolti in un grandioso mistero, e vogliamo sapere come confrontarci con esso. 72 Cosa possiamo fare nello stato in cui ci troviamo, incarcerati come siamo in un corpo umano per sessanta, settanta, ottanta, novant'anni? Se c'è una verità, dobbiamo essere in grado di aprirci ad essa e conoscerla. Altrimenti saremo continuamente catturati dall'illusione, vivremo un'esistenza senza speranza né scopo. Senza la verità, la vita non significa nulla, e non importa quel che fate; la vita non ha valore di sorta. Ma anche se sceglieste di accettare la visione nichilista secondo cui la vita è priva di significato, non ne sareste comunque certi, non è così? Magari preferite credere che non ci sia alcun significato, piuttosto che credere che ci sia, ma ancora non lo sapete. Quello che sapete adesso è di non sapere, e le cose, per ora, stanno così. C'è l'atto del conoscere, non è vero? C'è l'intelligenza. C'è l'inclinazione al buono e al bello. C'è il desiderio di sfuggire al dolorose e al brutto. Gli esseri umani hanno sempre avuto aspirazioni. Ci odiamo quando viviamo una vita meschina, autoindulgente, brutta. Proviamo vergogna quando compiamo azioni malvage o grette: speriamo che nessuno ne venga a conoscenza. Se la vita fosse totalmente priva di significato, non ci sarebbe alcun bisogno di vergognarsi: potremmo fare le solite cose e non avrebbe alcuna importanza. Ma poiché abbiamo la sensazione che alcune delle nostre azioni non sono né meritevoli né sagge, aspiriamo a elevarci al di sopra degli istinti del corpo e della mente. Abbiamo l'intelligenza umana; formuliamo concetti elevati; concepiamo mentalmente le cose migliori. La democrazia, il socialismo, il comunismo derivano da pensieri di natura elevata in merito alla forma di governo più giusta e più equa. Ciò non significa che i nostri governi ottengano effettivamente gran che, ma ci provano. C'è il valore che attribuiamo a ciò che è esteticamente raffinato: la bellezza nella musica, nell'arte e nell'uso del linguaggio. Tutto ciò è indicativo dell'aspirazione umana verso il bello e il buono. Aspiriamo a una visione del mondo più ampia e universale: un solo pianeta, un unico sistema ecologico, una sola famiglia umana. Questo genere di percezione è sempre più diffuso. L'umanità è ora una famiglia globale, sotto molti aspetti: ciò che accade in Mongolia o in Argentina riguarda tutti. Possiamo espandere la capacità percettiva, spostarci dalla prospettiva individuale in cui ci occupiamo solo di noi stessi, a una prospettiva globale in cui della nostra famiglia fanno parte tutti gli esseri umani e non solo la famiglia attuale o quella nazionale. Quando espandiamo la coscienza, diamo vita a percezioni e concetti molto più amorevoli e compassionevoli, che vanno al di là del prenderci cura di noi stessi come individui. Si può andare ben oltre l'attenzione alla famiglia, al gruppo, alla classe e alla razza. Si può espandere la coscienza fino a comprendere tutti gli esseri umani, poi tutti gli esseri. La coscienza diventa universale. 73 Il dolore inutile di Franco Toscani. Ciò che noi definiamo “dolore” è il prodotto di un meccanismo evolutivo che permette, attraverso un sistema di premi/punizioni, il riconoscimento e la valutazione delle esperienze essenziali alla vita animale, e di adattare i comportamenti alle circostanze. È il dolore che ci avverte che stiamo facendo qualcosa di sbagliato come afferrare un oggetto rovente; che un certo movimento è oltre le nostre possibilità; che qualcosa di pericoloso sta avvenendo nel nostro corpo per cui è meglio digiunare che abbuffarsi. Quei rari sventurati che per motivi congeniti non percepiscono il dolore sono destinati a malattie, incidenti e morte precoce. Il dolore è anche uno degli elementi determinanti per fissare nella memoria le cose che non si devono scordare. Lo schiaffo del genitore fa sì che il bambino, anche dopo anni, ricordi la lezione. Il dolore era largamente usato nell’alto Medioevo e nelle consuetudini giuridiche germaniche per garantire che l’evento fosse ben saldo nella memoria degli interessati, ed era questa la funzione del ceffone (la paumée) che il cavaliere riceveva durante la sua investitura, perché non si scordasse il codice di comportamento del suo nuovo stato. È stata per secoli la frustata del maestro a inculcare nozioni, regole e valori al discepolo. Il significato del dolore, il suo “senso”, è stato per millenni solo di ordine metafisico, ed è solo da poco che i suoi meccanismi biologici sono stati cercati ed individuati. Alcmeone di Crotone (V secolo a.C.) fu il primo a formularne una teoria razionale, attribuendolo all’alterazione dell’isonomia, l’armonia tra gli organi. Erofilo e Erasistrato di Chio (III secolo a.C.) dimostrarono l’esistenza di nervi motori e sensoriali e il loro collegamento al cervello, permettendo a Galeno (II secolo d.C.), di postulare l’origine neurologica del dolore. Ma è Cartesio che, nonostante le sue fantasiose teorie anatomiche e ontologiche, lo interpretò come risposta condizionata, un riflesso “meccanico” fondamentale per la conservazione dell’integrità dell’organismo. In effetti, il dolore è ben più di un messaggio nervoso. Esso è il risultato di una complessa interazione tra percezione e psiche: cioè, una faccenda assolutamente soggettiva. L’influenza dell’esperienza, del carattere, dell’umore, delle emozioni, delle aspettative, del valore a esso attribuito, delle circostanze esterne e interne è sostanziale, e spiega come mai un identico stimolo possa produrre, in soggetti diversi, dolori di intensità diversissime. Oggi il concetto di “soglia del dolore” è uno dei fondamenti delle discipline che se ne occupano. Il dolore è elemento naturale e necessario. Tuttavia esistono situazioni dove esso non funziona come dovrebbe. In alcuni casi non ci avverte in tempo di malattie pericolose, né riesce a farci cambiare abitudini come avviene nel caso del diabete o dell’ipercolesterolemia; e talvolta è presente senza una causa, o permane a lungo anche quando ciò che l’ha causato si è definitivamente allontanato. La minaccia senza allarme, e l’allarme senza 74 minaccia. In questi casi, a cosa serve il dolore? E a cosa serve il dolore puramente o prevalentemente psichico, la “sofferenza”? In sostanza: qual è il senso, il significato del dolore? Su questi interrogativi si apre una infinita serie di porte metafisiche, antropologiche, epistemologiche. E teologiche. Il dolore è usato come metafora di tutto ciò che nel mondo è spiacevole, non solo fisicamente, ma anche moralmente. Il dolore rappresenta il male. Ma come dare una giustificazione convincente alla presenza del male nel mondo, soprattutto all’interno di una cultura pre-scientifica? È concepibile la coesistenza di Dio e quella del dolore? E se c’è Dio, perché c’è il dolore e il male? Si potrebbe affermare che l’esistenza stessa delle religioni è spiegabile col tentativo di dare risposta a queste domande. Ciò che è fondamentale per la comprensione dell’atteggiamento della medicina nei confronti del dolore è esaminare come le religioni giudaico-cristiane, sino a ieri la principale (o, forse, la sola) chiave interpretativa dell’universo nel mondo occidentale, lo hanno giustificato, dal momento che l’ethos religioso ha plasmato l’atteggiamento – e quindi le azioni, le “cure” – che la società e l’individuo hanno nei suoi confronti. Il dolore – afferma la Bibbia – è punizione divina per chi non rispetta la legge di Dio. Anche se oggi si tende a mitigarne il significato attribuendo questa posizione alla necessità politica di compattare il popolo di Abramo minacciato dall’impero babilonese, l’idea che il dolore provenga da Dio (e che chi soffre, in fondo, se lo meriti) ha permeato tutta la nostra cultura. È il peccato originario di Adamo ed Eva che ha causato dolore e morte, per loro e per tutti i loro discendenti. E la punizione è tanto terribile da colpire non solo i malvagî, ma anche coloro che ai comandamenti divini obbediscono: sul giusto per antonomasia, Giobbe, fuori da ogni apparente logica giuridica per una scommessa tra Dio e il Demonio. Colpisce anche gli innocenti, i neonati, che non sono ancora in grado di peccare. Perfino sul Dio-uomo Cristo, che certo non può essere in alcun modo considerato “peccatore”! E continuano a colpire l’umanità, nonostante il sacrificio di Cristo, che quel peccato originale l’avrebbe definitivamente mondato. La colpa è perdonata, ma la punizione resta. Se il dolore è giusta punizione, allora è anche mezzo di catarsi, e chi soffre deve gioirne perché attraverso la sofferenza sarà redento. Cosa sono poche ore d’agonia in confronto alla beatitudine eterna? Non solo: il dolore accomuna l’uomo a Dio, sperimentando le sofferenze di Cristo, e quindi, il sofferente, imago Christi, concorre anche alla redenzione altrui. Il dolore è segno della predilezione di Dio: e quindi lo si accetti, non lo si combatta. E se stenta a venire per conto suo, perché non dargli una mano con scapolari e cilicî? Il dolore è essenza dell’universo, è necessità fondante dell’esistenza umana? Ma allora, se persino Dio si sottrae alla implorazione di Sé stesso-suo figlio nell’orto dei Getzemani e tace; se persino Dio si manifesta sofferente come un qualsiasi peccatore, esigendo la nostra compassione in cambio della Sua, come possiamo, noi mortali, massa damnationis, rifiutarlo? E quale dovere o giustificazione avrebbero mai i medici per combatterlo? 75 Questa dottrina, conosciuta come “Dolorismo” ha permeato la cultura occidentale. Oggi è forse un po’ passata di moda e, almeno nella comunicazione di massa, di esortazioni al masochismo se ne fanno poche, probabilmente più per il cambiamento della mentalità della gente che per la timidissima revisione di Giovanni Paolo II. Ciononostante, venti secoli di dolorismo hanno lasciato traccia, e il tentativo di rendere accettabile al (buon) senso comune uno dei più complessi e insolubili rovelli teologici ha portato a una serie di posizioni altrettanto indimostrabili quanto bizzarre. Tra le più comuni sta la tesi che il dolore è necessario per comprendere la serietà della vita che attraverso l’esperienza del dolore diventa più attraente e interessante; e che il dolore è indispensabile per far sorgere una coscienza morale. Sebbene sia ovvio che lo star male renda ancor più apprezzabile lo star bene, si farebbe fatica a sostenere che per dar valore alla libertà si dovrebbe tutti sperimentare il carcere, o che per capire che non è giusto rubare sarebbe indispensabile essere stati derubati! La medicina non è stata immune da questo modo di pensare, che s’intravede da aforismi del tipo «Si deve soffrire se si vuole guarire», «Il medico pietoso fa la piaga purulenta», oppure «Di dolore non si muore, ma d’allegrezza sì». Sedare dolorem sarà anche stato sempre considerato opus divinum: tuttavia ben poco la medicina si è sforzata di provvedervi. A parziale sua discolpa sta il fatto che il dolore è un sintomo importante, uno degli elementi cruciali per individuare e monitorare una malattia, tanto più quando l’unico strumento diagnostico disponibile erano le mani e gli occhi del medico. Oggi però abbiamo a disposizione mezzi di indagine molto precisi, e il sintomo dolore è utile solo per un primo inquadramento diagnostico: ciononostante, l’abitudine a sottostimarlo e a curarlo poco e male è ancora la regola. Eppure è da molto tempo che si conoscono farmaci analgesici di grande efficacia. Il succo essiccato del Papaver somniferus, pianta originaria dell’Asia Minore, e chiamato “oppio” da Teofrasto, era conosciuto e usato dai Sumeri nel terzo millennio a.C. ed è nominato nel papiro egizio di Ebers, della metà del secondo millennio, e in alcune tavolette assire del VII secolo. Probabilmente era conosciuto anche da Omero, che cita un phàrmakon usato da Elena per lenire il dolore proprio e quello degli eroi che la circondavano. Ippocrate, Democrito, Galeno e Plinio ne parlano nei loro scritti, e Andreas, medico di Tolomeo Filopatore, lo prescriveva nella pratica oftalmica. Dioscoride, vissuto nel I secolo d.C., conosce l’uso dell’oppio, della cannabis, del solanum e del giusquiano, e ne fa uso per rendere il malato insensibile al dolore. L’hakim Albucasi ne descrive minuziosamente l’estrazione dalla capsula del papavero. Gli Arabi l’introdussero in tutta l’Asia e i crociati e i medici ebrei in Occidente, dove era caduto nell’oblio durante i secoli bui. Raimond de’ Viviers, medico di Clemente VII, ne consiglia l’uso regolare al pontefice. Nel ‘500, Paracelso, grande prescrittore e consumatore in proprio di oppio (che definiva “chiave dell’immortalità”) ne raccomandava l’uso per gli effetti sonniferi e analgesici. In pieno ‘600, l’inglese Thomas Willis dimostrò che esso agisce sul sistema 76 nervoso centrale, deprimendo le funzioni della corteccia. Sydenham, uno dei padri della medicina moderna, inventore e degustatore del laudano (una soluzione alcolica di oppio) scrisse nel 1680: «Tra i rimedi che la Misericordia Divina ha donato all’uomo per lenirne le sofferenze, nessuno è così universale ed efficace come l’oppio». Tra i suoi allievi, Dower, più noto come corsaro al servizio della corona d’Inghilterra, inventò la polvere di Dower, somministrata ai feriti della sua ciurma dopo la battaglia. “Spugne soporifere”, a base di oppio erano usate da alcuni chirurghi fino al Seicento. È noto che gli interventi chirurgici sono molto dolorosi: ciò malgrado, anche l’anestesia ha stentato a essere accettata. L’etere fu scoperto da Raimondo Lullo nel ‘200, ma non fu utilizzato fino al XIX secolo. Il Paré, uno dei più grandi chirurghi del passato, respinse ogni forma d’anestesia. Nel XVII secolo il barbiere-chirurgo Bailly de Troyes cercò di anestetizzare i suoi pazienti, ma le corporazioni mediche insorsero e lo fecero condannare da un tribunale. Nell’Ottocento viene scoperto e utilizzato il protossido d’azoto, l’etere e il cloroformio e, grazie a loro, l’anestesia permise lo sviluppo della chirurgia moderna, nonostante idroterapeuti, omeopati e suffragette vi si opponessero giudicandola come pratica innaturale. Anche la religione entrò nella polemica: quando nel 1847 James Young Simpson la introdusse nella pratica ostetrica, il clero calvinista scozzese considerò il parto indolore un insulto alla Bibbia. Young si difese sostenendo che persino il Padreterno addormentò Adamo quando gli tolse la famosa costola, ma ci volle la Regina Vittoria, aiutata dal cloroformio a partorire il suo ottavo figlio, a mettere a tacere la protesta. Tutto ciò è cosa del passato? Assolutamente no: oggi si conosce tutto sull’uso degli analgesici, sui loro meriti e sul modo di usarli. L’anestesia è un cardine della moderna medicina e altre discipline, come l’algologia e la medicina palliativa, hanno fornito conoscenza e regole per il controllo del nemico atavico. Eppure in molti Paesi, tra i quali l’Italia, il dolore è sottostimato, poco considerato e pochissimo curato, tanto che il Ministero della Salute ha intrapreso azioni concrete per convincere i medici a trattarlo. Medici cattivi? Crudeli? Ignoranti? Mala sanità? Assolutamente no: semplicemente figli inconsapevoli di un modo d’essere e di pensare vecchio di secoli. La causa di una tale chiusura è da ricercarsi nella tradizione medica che attribuiva un valore religioso all’opera del medico. Essa si fondava sul riconoscimento del carattere divino della physis, la natura universale, matrice d’ogni cosa. Tutto ciò che è parte della natura, le sue regole e leggi, erano ritenute intrinsecamente giuste e pertanto dotate di valenza etica. Il dolore è tanto più necessitas naturae quanto più anatomia e fisiologia ne dimostrano la “naturalezza”. Se è naturale, allora è anche buono. Questo atteggiamento non può che essere stato potenziato dalla tradizione cristiana e dalla sua visione salvifica del dolore. Inoltre non va dimenticato che l’etica medica riteneva più importante il dovere di guarire rispetto al dovere di sedare il dolore: infatti, la salute – il fine dell’Arte – era definita dal buon funzionamento del corpo (come previsto, 77 appunto, dalle leggi della natura), e solo in seconda battuta dal benessere (cioè dall’assenza di sofferenza). Questo era pertanto eventuale conseguenza della ritrovata salute, e non poteva essere perseguito indipendentemente, o magari al posto di essa. Oggi l’etica medica sta cambiando, ma il processo non si è ancora completato. È il singolo individuo che deve decidere, secondo le proprie convinzioni e le proprie antropologie, quanto dolore è disposto a sopportare, che sia o meno provvisto di senso trascendente. Il senso lo diamo noi alle cose del mondo, e questo può mutare da persona a persona e da epoca a epoca. Non ci sono ontologie. Se qualcuno “sceglie” di credere che ci siano, esse devono valere solo per lui. Edonismo? Forse, e perché no? Ciascuno decida per sé, ne sia responsabile e consapevole. E orgoglioso delle proprie scelte e della propria unicità. E forse il dolore cesserà di essere un tormentone fisico e metafisico. L’autore Franco Toscani, medico palliativista, Direttore scientifico della Fondazione “Lino Maestroni” (Istituto di ricerca in medicina palliativa); socio onorario di “Libera Uscita” (Associazione nazionale e apolitica per la legalizzazione del testamento biologico e la depenalizzazione dell’eutanasia). 78 Il trattamento del dolore Paola Sarno, N. 8/9 agosto/settembre 2004 A confrontarsi su questa tematica così delicata, ma tuttavia così importante sono stati chiamati esperti di centri oncologici di tutta Italia, da Salvatore Mercadante, direttore del Centro Oncologico “La Maddalena” di Palermo, a Andrea Messeri dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze a Franca Benini dell’Università di Padova, insieme, ovviamente, agli esperti del Policlinico Gemelli, Antonio Chiaretti, ricercatore presso la Clinica pediatrica dell’Università Cattolica di Roma e coordinatore del Workshop, “un corso destinato ad avere un valore educativo per medici, infermieri e familiari, un appuntamento che verrà riproposto annualmente per sensibilizzare e promuovere nei medici e negli infermieri di tutta Italia una cultura tesa sempre più a combattere la malattia “dolore” e la malattia “sofferenza” nell’adulto come nel bambino: un percorso già iniziato da tempo (con l’Ospedale senza Dolore del Prof. Veronesi) che però deve ancora fare molta strada per giungere a compimento”, l’oncologo Riccardo Riccardi e il neurochirurgo e direttore del Dipartimento di Scienze pediatriche Medico chirurgiche e Neuroscienze, Concezio Di Rocco. Il dolore nei bambini “Soprattutto nei bambini il dolore in generale, anche dopo un intervento chirurgico, viene particolarmente sottostimato”, esordisce il professor Riccardi. “Quindi non gli viene somministrata una terapia adeguata. Ciò avviene per diversi motivi. Intanto il bambino può lamentarsi, ma non come l’adulto che sa indicare con precisione l’esatta entità e la localizzazione del dolore. Esiste quindi innanzitutto un problema di misurazione. Infatti, anche se esistono delle scale è difficile applicarle all’universo infantile. Inoltre, in generale, nel nostro Paese non si è ancora diffusa la cultura che il dolore vada combattuto (e di fatto consumiamo un decimo della morfina che si consuma, in media, negli altri Paesi europei). Quindi se esiste un atteggiamento di sottostima nell’adulto, la sottostima aumenta ancora di più nell’età pediatrica, proprio per la difficoltà di darne una valutazione oggettiva”. Il dolore oncologico “Per quanto riguarda esclusivamente il dolore oncologico, poi”, spiega Riccardo Riccardi, “si possono identificare tre momenti in cui il dolore si fa sentire con particolare insistenza: dopo un intervento chirurgico – soprattutto quelli dell’area cerebrale o addominale - , durante l’ago aspirato del midollo che è una procedura tipica che si effettua nei bambini affetti da leucemia, e nelle punture lombari. Al Gemelli eseguiamo perciò queste procedure in anestesia generale (anche se la sedazione dura poco), perché al di là dell’animazione e dei clown il dolore oncologico è difficile da combattere con un protocollo esclusivamente psicologico. Se poi il dolore non dovesse più appartenere alla sfera della terapia, ma riguardare quella fase finale della vita che richiede per essere vissuta in maniera dignitosa e il più serena possibile, per il bambino e per i suoi genitori, il ricorso alle cure palliative”, continua il professor Riccardi, “non bisogna sottovalutare il ricorso alla morfina e ai suoi derivati sintetici, che hanno la stessa efficacia e minori effetti collaterali”. 79 La somministrazione della terapia analgesica Ma, in che modo è possibile somministrare questo tipo di analgesici ai piccoli pazienti oncologici? “In particolare quello che noi facciamo al Gemelli per i bambini e per gli adolescenti è la cosiddetta P.C.A., cioè la Personal Controlled Analgesya. Si tratta”, specifica l’oncologo, “di una siringa molto grande, un vero e proprio contenitore per il farmaco, che consente al ragazzo o addirittura al bambino (da 4 anni in su) la possibilità di scegliere il momento e la quantità di farmaco da dosare. Con questo sistema è stato dimostrato in tutto il mondo che la quantità di farmaco autosomministrato è inferiore a quella che impiegheremmo noi, medici o infermieri, mettendolo direttamente in flebo. Questo tipo di intervento “autogestito” ha, inoltre, un forte beneficio non solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico, perché diminuisce senz’altro anche l’ansia dell’accesso doloroso, proprio perché i soggetti sanno che è nelle loro mani la gestione dell’antidolorifico. Ma quando il bambino è piccolo, per non dire piccolissimo, a volte, purtroppo addirittura neonato, come si può intervenire? “Il dolore in questo caso si può avvertire solo osservandolo attentamente, perché questi bambini presentano deformazioni in viso… Si tratta di un dolore mai riconosciuto, ma sicuramente presente e disumano (e doverosamente evitabile, ndr)”. Oltretutto tenendo il dolore sotto controllo si ottiene anche un miglioramento dello stato di salute generale dell’organismo che migliora più rapidamente e quindi va a incidere positivamente sul decorso della malattia. Un’altra modalità di intervento, relativamente recente, è quindi, per esempio, la via transdermica, cioè il “cerotto”, che rilascia nel tempo (un periodo prolungato che raggiunge anche le 12 ore circa) la sostanza antidolorifica prescelta (essenzialmente morfina) per il protocollo di cura. “Tuttavia la cosa più importante è la terapia corretta del dolore”, precisa il professor Riccardi. “Non bisogna fare cioè come ancora, purtroppo, fanno tanti medici che somministrano l’antidolorifico solo in presenza della crisi di dolore, ma la terapia deve essere organizzata per quel tipo di dolore. Invece di aspettare che venga un “mal di testa”, insomma, bisogna prevenire con una somministrazione classica di antidolorifico ogni sei ore, in modo da garantire una copertura completa durante tutto l’arco della giornata”. Oltretutto la somministrazione della terapia antalgica viene eseguita, senza particolari problemi, anche dagli infermieri, essendo di semplicissima applicazione. Esistono, infatti specifiche linee guida al riguardo che non possono davvero mettere i difficoltà nessun camice bianco. Ciò che quindi ancora una volta lascia stupefatti e sconcertati è come mai tanta gente e – in questo caso – tanti bambini vengono lasciati morire senza quelle umane carezze che prendono il nome, ormai noto, di “cure palliative” e come mai queste non vengano correttamente applicate. Timori infondati “Ancora esistono resistenze e paure”, avverte Riccardo Riccardi, “che il bambino, per esempio, possa andare incontro magari a un arresto cardiocircolatorio. Non è vero. Se il protocollo antalgico è applicato correttamente, la sicurezza del risultato è totale e un certo tipo di timore e riluttanza nell’adesione alla terapia del dolore in età pediatrica non ha nessun 80 fondamento scientifico. Inoltre”, insiste il professor Riccardi, “non si può neanche parlare di sensibilità in questo senso, ma solo di capacità. Le cure palliative non sono un optional e non c’è davvero più nessuno che muoia per una terapia antidolorifica. È dunque importante che si crei una coscienza comune in questa direzione, anche nei genitori stessi, che sappiano che possono chiedere e che non si mettano in una posizione di vassallaggio mentale nei confronto di medici incapaci”. Il dolore deve essere evitato Ovviamente contrario a certe posizioni che non è più possibile giustificare, se non con l’ignoranza, è anche il principale promotore del Workshop del Gemelli, il professor Concezio di Rocco, anche lui convinto assertore della terapia del dolore in età pediatrica, quando questa è codificata e ben fatta. “Dobbiamo prendere l’abitudine a pensare che il dolore può essere evitato per tutti, anche per il bambino. L’Italia, purtroppo, ha una cultura che non aiuta in questo senso. Un altro degli pseudoproblemi che vengono addoti come scusa da chi non esegue protocolli antidolorifici è quello dei costi: i cateteri costano, gli apparecchi per la somministrazione degli analgesici costano e così via… Perciò gli ospedali tendono a non fornire queste attrezzature, senza rendersi conto che un bambino con dolore può avere una degenza più lunga di uno che non ne ha. Infatti un bimbo così sofferente da non muoversi è facile che sia soggetto al rischio di trombosi, o alle piaghe da decubito, mentre il bambino che non soffre si muove prima, e anticipando la guarigione fa sì che il discorso diventi conveniente per la struttura ospedaliera anche solo sotto il profilo strettamente economico”. Coinvolgimento dei familiari Concezio Di Rocco insiste molto anche sull’importanza del coinvolgimento dei familiari. “Bisogna far capire loro che i bambini non soffrono di meno solo perché non sono capaci di dirlo. I bambini sotto i due anni di età, per esempio, ancora non si esprimono verbalmente in modo comprensibile da tutti e, in questo caso, è importantissimo il coinvolgimento dei familiari. Ma già a 4 anni sono in grado di usare le scale. Certo ci sono dei casi di bambini con ritardo mentale, che non ricevono un trattamento antidolorifico solo perché non sono in grado di esprimere la loro sofferenza. E anche in questo caso esiste un imperativo etico ad intervenire e ad interpretare il disagio. Oltretutto la richiesta dei bambini è spesso inferiore a quella necessaria (v. box psiconcologia). Certo il dolore non scomparirà del tutto, ma se siamo in grado di spiegarlo al genitore in modo che possa a sua volta farlo capire al bambino, questo non sarà più spaventato da quel dolore, ma sa che si tratta di un dolore di guarigione, che può essere vissuto in maniera diversa rispetto a qualcosa di spiacevole che non si conosce”. “È dunque necessario affrontare il tema del dolore nei bambini in maniera efficace ed adeguata”, conclude Antonio Chiaretti, coordinatore della prima giornata di lavori al Gemelli. “È già da tempo che cerchiamo di cambiare il modo di pensare dei medici al riguardo, per rispondere alle indicazioni del Ministero della Salute e dell’Oms in merito a questa tematica che ha della terapia del dolore uno degli obiettivi principali in campo sanitario”. Gli aspetti relazionali del dolore 81 Infine, Patrizia Paglia ha voluto soffermarsi sugli aspetti relazionali del dolore: “A volte l’interpretazione del dolore è condizionata dai legami che si creano tra le varie persone. È cioè difficile stabilire quanto un bambino soffra realmente perché spesso questo non viene manifestato palesemente per senso di colpa nei confronti del genitore, per non ferirlo, per non procurargli un dispiacere. Un bimbo molto preoccupato perché vede la mamma che piange non dirà di avere un dolore per proteggere la madre oppure un ragazzo più grande può sminuire un dolore per non dare un dispiacere al suo medico: questa dinamica è stata ormai chiaramente verificata. Se, da una parte, i sintomi si possono esasperare moltissimo perché non si tollera di stare in ospedale, non si sopporta la gente che si ha intorno, portando una persona ad accusare molto di più il dolore, così avviene anche il contrario. Questo tipo di valutazione”, conclude Patrizia Paglia, “è quindi importantissimo perché ci aiuta a decifrare la vera entità del dolore e della sofferenza patita e può indirizzare meglio ogni tipo di strumento terapeutico”. Il tumore pediatrico I tumori sono un’evenienza rara, ma non troppo nell’età evolutiva. Costituiscono, infatti, la prima causa di morte dopo i traumatismi nei soggetti da 1 a 15 anni. Solo in Italia si contano 1.200 nuovi casi all’anno e costituiscono un motivo di grande preoccupazione, visto che le altre malattie infantili, sono state, più o meno, tutte debellate. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito all’aumento dei tumori cerebrali nei bambini, con 33 nuovi casi all’anno per milione di abitanti, pari all’1% circa. Si tratta di una crescita reale, non legata semplicemente a una migliorata capacità di diagnosi, e che si ritiene dovuta essenzialmente a fattori ambientali. Viene riscontrata infatti in tutti i Paesi occidentali. Il tumore cerebrale ha così superato la leucemia linfatica acuta, che comunque costituisce oltre la metà dei tumori infantili. Fortunatamente il 65% dei bambini guarisce, sempre che il tumore sia diagnosticato in fase iniziale. Purtroppo, infatti, - avvertono gli esperti – quando la neoplasia è già metastatica il tasso di guarigione si abbassa drasticamente. La giornata nazionale del sollievo La III Giornata nazionale del sollievo, per la promozione delle cure palliative e in particolare della terapia del dolore, in Italia è stata celebrata il 30 maggio scorso, sotto l’egida del Ministero della Salute, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti. La Giornata, come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, si svolge ogni anno l’ultima domenica di maggio e ha lo scopo di informare e sensibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini sull’importanza di promuovere la “cultura del sollievo” ed estendere la consapevolezza che il sollievo non è solo desiderabile ma anche possibile. 82 In questa giornata, infatti, si afferma la centralità della persona malata e l’affrancamento dal dolore inutile e viene evidenziata l’importanza che rivestono nell’alleviare la sofferenza non solo le terapie più avanzate ma anche il sostegno psicologico e la capacità di rapportarsi umanamente a chi soffre considerando il malato nella sua interezza e ponendo attenzione a tutti i suoi bisogni, psichici, fisici, sociali e spirituali, in modo da creare la migliore qualità di vita per il malato e per la sua famiglia. Il supporto psicologico al malato e alla sua famiglia All’interno del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma operano anche alcuni psicologi, fra i quali la dottoressa Patrizia Paglia, alla quale abbiamo chiesto di spiegarci qual è l’impostazione del lavoro condotto sui piccoli pazienti e sulle loro famiglie. “Ci rivolgiamo essenzialmente all’intero nucleo familiare, perché nel tempo abbiamo riscontrato come la malattia oncologica colpisca il bambino nella sua componente fisica, ma la sofferenza si estenda all’intera famiglia. Il nostro impegno di supporto psicologico va quindi sì al bambino e a genitore che lo assiste, ma vogliamo dare anche un'attenzione particolare agli altri componenti della famiglia, che fisicamente possono non essere presenti sempre, ma che lo sono in fasi alterne”. Infatti la malattia oncologica e la cura di un bambino affetto da tumore si protrae per un periodo di tempo molto lungo, a volte anche per anni. “Dobbiamo dunque tenere conto di un disagio che non è un disagio transitorio”, aggiunge la dottoressa Paglia, “ma uno stato di sofferenza che si proietta nel tempo e che implica spesso la separazione dei componenti di una stessa famiglia, magari di un altro fratello che vive uno stato di abbandono forzato”. L’importanza della normalità: la “scuola in ospedale” Ma quali modalità di intervento si usano nel campo della psico-oncologia pediatrica? “Di vario genere: soprattutto si cerca di mantenere un legame con la vita normale anche in una situazione che normale non è. Ciò significa per i più piccoli poter continuare a giocare e ad andare a scuola”, spiega Patrizia Paglia. “Per questo abbiamo pensato alla ‘scuola in ospedale’, dalla materna alle superiori. Il bambino/adolescente che è ricoverato può frequentare la scuola in ospedale e i risultati figurano nella sua scuola statale di appartenenza. In tal modo non perde l’anno scolastico, perché può essere scrutinato qui, fare gli esami qui. La ‘scuola dell’ospedale’ si mette in costante contatto con la sua scuola. E questo è solo uno degli strumenti che noi abbiamo a disposizione per garantire ai pazienti una continuità nella vita esterna. Poi, per i più piccoli si è pensato al gioco, sotto varie forme. Oltre alle due sale giochi predisposte nel reparto, ci sono degli animatori, ragazzi volontari, un gruppo strutturato e preparato con rigore e una ludoterapia di tipo più professionale, con operatori con competenza specifica. Ad ogni bambino, a seconda della sua età arrivano delle diverse proposte per far sì che possa essere mantenuta una dimensione di normalità anche attraverso il gioco. Per i ragazzi il discorso si fa più complicato, perché l’adolescente non vuole giocare, piuttosto vuole gli amici, vuole uscire, stare su un campo di pallone, ecc. 83 Allora ciò che abbiamo visto essere più funzionale allo scopo di mantenere attivo un livello di “normalità” è proprio il rapporto con i ragazzi volontari che si occupano dell’animazione, per lo più studenti universitari, che vengono vissuti come un gruppo di pari, come gli amici. Con loro si parla, si ascolta musica, si guarda lo sport, si vive, insomma una sostituzione rispetto al gruppo di amici che loro hanno perso”. E per i genitori? “L’intervento ha un carattere decisamente più psicologico”, spiega ancora la dottoressa Paglia, “con colloqui più o meno strutturati per raccogliere quelle che sono le angosce, le ansie e le preoccupazioni relative alla malattia, ma anche al resto della famiglia. Tutto ciò viene gestito non tanto in chiave patologica, ma semplicemente come un accompagnamento durante l’iter della malattia per i vari bisogni che si possono man mano presentare” Inoltre, uno strumento recentemente introdotto al Policlinico Gemelli, anche nella psiconcologia pediatrica, è quello della mediazione culturale. “Abbiamo infatti molti piccoli pazienti stranieri ed è necessaria la figura di un ‘interprete’, un ponte fra due mondi, per poter dare un supporto psicologico a una persona che non capisci”, afferma Patrizia Paglia. “La realtà del mediatore culturale, poi, ci ha permesso di entrare in contatto con culture diverse, con diverse modalità di affrontare anche il dolore e la sofferenza ed è stata sicuramente una fonte di arricchimento, perché il senso del dolore e della sofferenza in altri mondi e in altre religioni è molto diverso dal nostro e non possiamo quindi prescindere da questa valutazione se vogliamo dare un’assistenza che sia equilibrata”. 84 Riflessioni e pensieri Come il bambino vive la malattia: il caso clinico tra realtà aziendale e idea di cura Daniele l’ho visto nascere, anche sua sorella Serena, ero la pediatra in sala parto. Della loro mamma Susanna conosco la vita, le debolezze e la forza, i problemi gravi di dipendenza dall’alcool, che si è curata con successo. Me lo ricordo piccolo, caschetto di capelli biondi sugli occhi, correre nudo e scalzo nell’orto di casa sua, in campagna. Oggi è un adolescente lungo e secco con i pantaloni enormi, i capelli turchini, come quelli della fata, un orecchino e gli occhi furbi color nocciola. A gennaio di quest’anno, con un’atroce certezza e una irresponsabile speranza ho inviato il mio paziente Daniele da un collega di un’ ospedale famoso, per gli esami clinici, un’ecografia ed un Rx torace. Il sospetto è diventato certezza e in 24 ore Daniele è stato ricoverato per una biopsia ad un linfonodo sopracleare sn. Dopo la biopsia (si trattava di un linfoma di Hodgkin) il linfonodo è stato asportato e D. è tornato a casa. I punti li ho tolti poi io. Sono passati quattro giorni e già l’equipe della oncoematologia dell’Ospedale lo aspettava insieme alla famiglia per comunicare il referto e la diagnosi. Alla riunione ha partecipato tutta la famiglia e D. ha saputo con le dovute cautele, vista l’età, (ha compiuto 14 anni dopo la seconda seduta di chemioterapia) la diagnosi, l’iter terapeutico le controindicazioni, gli effetti collaterali e tutto quello che un ragazzino può voler sapere in queste circostanze. Ha anche chiesto se poteva morire se non accettava di curarsi e Susanna non ha mentito: Daniele ha accettato la cura. Dopo 5 chemioterapie la massa di linfonodi mediastinici si è molto ridotta e l’equipe è cautamente ottimista. Susanna, dopo un momento di stupore incredulo ha accettato la diagnosi, io non ci speravo, e si è dimostrata molto coraggiosa e responsabile. Ha convenuto con un misto di sorpresa e soddisfazione, che nel privato ciò che ha avuto gratuitamente dal SSN: accuratezza della diagnosi, velocità , partecipazione umana, competenza e professionalità, non solo le sarebbe costato migliaia di euro, che lei spesso non ha, perché il suo lavoro non le permette guadagni sicuri, ma non le avrebbe assicurato quell’iter terapeutico così ben organizzato e soprattutto così sistematizzato con protocolli completi che nulla lasciano al caso. Si è sentita protetta e rassicurata, è convinta che Daniele ce la farà. Questa storia è una fra tante, ma dimostra in modo inequivocabile che la Sanità Pubblica quando serve veramente, quando il bisogno di cura è serio e forte, quando la vita è in pericolo, funziona non sempre, ma spesso e soprattutto nei casi gravi! Il Welfare che si vuole smantellare e delegare ai 85 privati……, quella Sanità che dividerà i ricchi dai poveri, le Regioni del Nord produttivo da quelle del Sud, sempre a rimorchio……… La realtà Aziendale è oggi, anche se in modo incompleto ed imperfetto un dato oggettivo. Tra molte difficoltà di tipo concettuale (la professionalità sanitaria mal si sposa con concetti di empowerment, management ecc..) e gravissimi oneri economici, ogni USL si è trasformata in Azienda quasi in modo obbligato, non era possibile fare altrimenti, e anche chi per mentalità o formazione non voleva il cambiamento, si è dovuto adeguare. I risultati ci sono, anche se imperfetti e suscettibili di miglioramento. Il D.Lgs.502/92 e il 229/99 hanno trovato un substrato sempre meno impreparato e sempre più “rassegnato” alla politica sanitaria dell’Azienda. Tutto ciò ha permesso un notevole cambiamento anche dei “pazienti”, non più o almeno non sempre persone semplicemente preoccupate per la propria salute e ostaggio del scienza del medico o del professionista sanitario. Si è lentamente sviluppata una diversa mentalità: i pazienti sono soggetti di diritti, aiutati spesso in questo cambiamento dalla presenza sempre più attiva, ed informata delle associazioni per i diritti dei malati. L’ultima ricerca del Censis , che indagava sulla domanda di salute del cittadino, ha evidenziato che la coscienza dei propri diritti relativamente alla diagnosi, alla cura, al rispetto della propria dignità di uomo malato e della privacy, fanno ormai parte delle competenze che ogni cittadino ha. E l’Azienda che fa? La salute pubblica è migliorata? I cittadini stanno meglio? Difficile dirlo: è evidente che è cambiato lo scenario delle patologie, l’epidemiologia ha evidenziato lo spostarsi della cura dall’Ospedale al Territorio, la popolazione invecchia, la famiglia si evolve in un modello di tipo monoparentale che cambia il quadro l’assistenza domiciliare e dell’assistenza sociale, richiedendo un nuovo modello d’integrazione socio-sanitaria, le patologie degenerative croniche aumentano, rendendo sempre maggiore il divario tra coloro che “possono” e coloro che “chiedono”: l’Azienda ha invece logiche di mercato che devono tenere conto del contenimento dei costi a fronte di sempre più limitate risorse economiche. Un fatto è certo però: quando si è veramente malati, quando si vuole veramente guarire, soprattutto per alcune patologie che fanno riferimento a “trials clinici” internazionali, i pazienti ricorrono alle strutture pubbliche, dove sanno che possono trovare non solo le cure adeguate, anche se con molte difficoltà pratiche, ma la possibilità di un confronto e di un dialogo, che nella autoreferenzialità di una struttura privata, spesso manca. Se verrà smantellato questo sistema perfezionabile, non perfetto , i cittadini di serie B (prima o poi ci diventiamo tutti) saranno discriminati dalla vita e dal Welfare. Riflessioni sul vissuto del dolore fisico e psicologico 86 La gravidanza, una possibile realizzazione di rapporto tra un uomo e una donna e una speranza…… Nove mesi,……. ecografie e amniocentesi hanno reso la curiosità se sarà maschio o femmina un fatto già risolto da mesi. Poi nasce il bambino. SANO perché la condizione insita nella realtà dell’ essere umano è la sanità e la ricerca dello stare bene. La scienza medica è nata proprio per curare per la guarigione e il ripristino di una situazione naturale di sanità. Sanità, che ne sa un bambino della salute? Ne sa nella misura in cui dopo quel viaggio incredibile e fisicamente sconvolgente che porta il feto fuori dall’utero, subito dopo la nascita l’organismo biologico viene investito dalla luce, dal freddo, dai suoni, sensazioni e irrompono i bisogni, diventa essere umano. La vitalità di essere umano neonato lo fa sopravvivere, si forma quella prima immagine mentale che fonde la realtà mentale con la realtà biologica. Poi qualcuno lo copre, lo scalda, lo nutre, lo ama. Sta bene…… è sano, vivo e vitale si dice, ed ha tutte le potenzialità di rimanere tale, ma se questo non si realizza per cause intervenute durante la gravidanza o nel periodo della nascita o subito dopo, crescerà con la consapevolezza di essere malato e quanto la malattia potrà incidere sul suo sviluppo? E se invece si ammala quando è già più grande? La vitalità e l’identità del bambino si sviluppano attraverso la relazione primaria con la madre nel primo anno di vita, passano attraverso il rapporto inconscio con la madre, il neonato sente la voce, i gesti e la passione della madre e risponde attraverso i gorgheggi, i pianti, il movimento e le espressioni. Risposte, non solo, anche iniziative e richieste che fanno ricco il rapporto umano di questi primi mesi. E’ la dinamica trasformativa del rapporto interumano che permette di rendere superabili o insuperabili vicende di malattia che la vita ci presenta. La madre riconosce, se ne è capace, accetta con il suo modo di relazionarsi la nascita del figlio, la vitalità del bambino cresce, il bambino va… incontro a mondo nuovo tutto da scoprire. Può succedere che ci siano piccoli episodi di malattia e sospensione di quel benessere che ci fa sentire a nostro agio nella nostra pelle, ma tutto passa……. e se non passa? C’è da fare i conti con la malattia e con il dolore e mi sembra logico assimilarli, anzi sento che è così: non c’è malattia anche piccola senza dolore perché il binomio mi sembra inscindibile, c’è da fare i conti con la perdita della salute (momentanea?) e con una possibile diminuzione della vitalità. E c’è da fare i conti con il dolore che può essere quello brevissimo di una puntura e quello infinito, gravoso e pesante della malformazione o del difetto cromosomico o della malattia cronica. Volutamente non distinguo tra malattia cronica e malformazione, se entrambe si manifestano alla nascita perché da pediatri dobbiamo fare la diagnosi della malattia e curare, ma la cura deve sempre tenere conto del bambino e della sua identità. 87 L’OMS, istituito dall’Onu nel 1948, definisce la salute è uno ”stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. E’ un diritto di tutti gli esseri umani sancito dalla dichiarazione di Alma Ata del 1978 e dalla 1 Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute del 1986 a Ottawa . Il bambino nasce sano… e dovrebbe rimanere tale. Non sempre è così, non sempre è stato così, non è così dovunque. Per secoli i bambini non hanno avuto nessun tipo di diritto, soprattutto non si riconosceva al bambino, prima che acquisisse il linguaggio, nessuna capacità di pensiero e quindi nessuna identità. Tra gli antichi romani era il pater familias che decretava la possibilità di vivere di un neonato, se non lo riconosceva il bambino poteva essere abbandonato o venduto come schiavo. E’ solo nel ’700 che il Diritto Napoleonico introduce il concetto di docimasia che distingue tra il feto e il bambino nato e ne sottolinea l’identità giuridica. In molte culture il dolore e le sofferenze fisiche vengono considerate indispensabili esperienze che permettono il passaggio dall’età infantile a quella adulta: i riti d’iniziazione che contengono un cambiamento emotivo fondamentale che è quello della separazione dalla madre e dalla famiglia. In molte religioni il dolore e la sofferenza sono considerate strumenti per avvicinarsi a Dio (vedi l’uso del cilicio nel medioevo) e i riti di auto-flagellazione della Settimana Santa in molte regioni del Mediterraneo. In modo religioso per secoli il concetto di malattia è stato assimilato al concetto di male: vedi le grandi epidemie di peste inviate agli uomini per punirli, gli ammalati di epilessia che fino ai primi del ‘900 venivano considerati indemoniati da esorcizzare e l’herpes zoster che in tempi non remoti veniva chiamato “Fuoco di S. Antonio”. Si dice siamo nati per soffrire……. Nel XX secolo, solo da pochi anni, diciamo 30, si riconosce ai bambini e poi anche al neonato e al prematuro la sensibilità al dolore. Si riconosce finalmente che i bambini sono soggetti di diritto, soggetti con un’identità che va rispettata. Si crea la carta dei diritti dei bambini in ospedale…… si creano ospedali amici dei bambini ma ancora oggi il pronto soccorso e il 118 sono dedicati indistintamente ad adulti e bambini, solo nelle grandi città ci sono Ospedali Pediatrici. C’è ancora molta strada da fare e molto da studiare….. Intanto di recente si è scoperto che le vie nocicettive si formano a partire dalla 26a settimana di gravidanza, ma solo dopo la nascita si completa lo sviluppo delle vie sensitive, più tardi quello delle vie inibitorie e quindi i piccoli sono più sensibili al dolore. E se il tempo di conduzione è più lungo, per una certa immaturità delle vie sensitive, il percorso è sicuramente più breve. Qualcuno si è preso l’impegno di misurare quante sono le manovre dolorose in una terapia intensiva neonatale e con quale frequenza si ripetono, sono una 88 ogni 18 minuti! Quali ripercussioni avranno sul vissuto del neonato queste esperienze? Eppure negli anni ’50 si operano di adenoidi i bambini senza anestesia, io sono tra quelli, negli anni ’70 i cardiochirurghi considerano inutile l’anestesia per la legatura del dotto di Botallo, la circoncisione dei neonati nelle lussuose cliniche private romane si fa negli anni ‘80 senza l’anestesia locale, tanto dura poco; negli anni ‘90 la medicazione di gravi ustioni viene praticata senza anestesia. L’Italia è un paese strano, piena d’attenzioni per il feto, il grembo materno e senza rispetto per i nati…. come dice sulla Stampa di Torino il 6 dicembre Chiara Saraceni che in un articolo sull’aborto sottolinea quanto sia ipocrita il pensiero che predilige proteggere lo zigote per poi lasciare in povertà e analfabetismo migliaia di figli nati. Negli ospedali pediatrici italiani l’uso di terapie antidolorifiche è agli stati iniziali, c’è la paura del danno e della dipendenza mentre si somministrano farmaci altrettanto “pericolosi” con disinvoltura. Negli ultimi tempi però le cose stanno cambiando, ci sono stati moltissimi convegni sul dolore e si riesce a prescrivere in terapia la morfina (se serve) quasi con la stessa facilità con cui si somministrano gli antibiotici. Molti pregiudizi hanno impedito al nostro paese di sviluppare un cultura del rispetto del dolore, pregiudizi e violenza che hanno a che fare con le donne, i bambini e gli anziani, di coloro cioè che sono considerati i fragili della società. Perché ci si chiede…. Perchè raccontare la malattia e il suo dolore, verbalizzarlo, comunicarlo non è facile per un adulto, figurarsi per un bambino. E se non si è capaci di parlare, raccontare forse non si può neppure sentire, soffrire e soprattutto pensare…. Eppure: mi ricordo di Emanuele, morto in clinica pediatrica a 12 anni per leucemia: trovarono nell’armadietto il suo diario, lui trascriveva con diligenza quotidiana i risultati delle sue analisi. Sapeva o intuiva l’importanza di quei dati e nessuno se ne era accorto: che solitudine e che sofferenza vissuta nel silenzio dei medici e dei suoi familiari. E allora trovo molto interessante l’intuizione di un’infermiera americana che sostiene drammaticamente la necessità dell’analgesia in pediatria. Questa donna intuisce il nesso tra corpo e mente, che è stato ignorato per più di 2000 anni. Intuisce con una sensibilità naturale che tutti dovremmo avere, che il neonato pur senza parole pensa e ogni sofferenza fisica può essere insieme una sofferenza per la realtà mentale. Non ha le basi teoriche che spiegano come nel bambino l’immagine mentale che si forma con la nascita e precede il linguaggio verbale è una forma di pensiero, ma ci arriva lo stesso. Forse ha avuto semplicemente quella sensibilità indispensabile per occuparsi della malattia degli esseri umani. Dopo queste scoperte il rispetto per il dolore nella malattia diventa doveroso , pertanto si creano protocolli terapeutici e comportamentali per ovviare ai possibili danni prodotti da anni di indifferenza da parte del personale sanitario. 89 Il grosso problema è ora rendere oggettivabile e quindi comprensibile una sensazione unica e riferibile solo alla persona che soffre, e in caso di bambini molto piccoli impossibile da descrivere a parole. Ecco quindi le scale di misurazione del dolore. Ma il dolore ha un colore? Be’ il dolore ha il colore grigio dell’esclusione….. Gli altri quando tu stai male si muovono su uno sfondo lontano da te, magari luminoso e colorato e tu da solo in bianco e nero sei fuori , lontano dagli altri…. la paura non sempre c’è ma c’è inevitabilmente il sentirsi esclusi e incompresi, nessuno sa e capisce e anche questo è dolore. Un bambino che si ammala vive questo evento in un contesto relazionale che comprende i genitori e il nucleo familiare ma anche la realtà sociale che lo circonda: la scuola e lo sport con i coetanei e gli altri adulti. E’ nel contesto di queste relazioni che si sviluppa il modo di vivere la malattia e sopportarne le conseguenze. Se la vitalità e l’immagine interna del bambino sono integre, potrà elaborare la malattia e la sofferenza con relativa facilità. Ma se ha poca vitalità potrà vivere l’esperienza come lutto e perdita irreversibile . Ogni essere umano vive le proprie esperienze in modo completamente personale e soggettivo e le risorse di ciascun bambino attingono al mondo relazionale con i genitori in modo molto stretto . E’ importante che gli adulti vivano la malattia come un momento traumatico accidentale, togliendole quell’aura religioso-superstiziosa di sfortuna, sciagura e colpa che connotano spesso il vissuto di malattia degli adulti. C’è da dire poi che i bambini hanno un preciso senso di realtà ed esigono dagli adulti rispetto: Si deve rispondere con sincerità alle domande su ciò che sta per succedere, si deve permettere che il bambino manifesti la propria paura, con la sensazione precisa di essere preso in considerazione. Si deve e si può spiegare a parole semplici la patologia, il decorso, volta per volta e se possibile la durata; non bisogna mai mentire su manovre e terapie e se possibile evitare strazi inutili con un programma di analgesia che tenga conto anche della partecipazione del bambino, con il rispetto della sua intimità e della sua privacy. Il bambino che soffre ed è ammalato vive le sensazioni momento per momento , sono i genitori che progettano e fanno calcoli sul domani e possono sentirsi in qualche modo colpevoli : la patologia può essere vissuta come una punizione , e a volte questo pensiero violento può essere trasferito sul bambino che può pensare ”sono stato cattivo e vengo punito…..” Altro motivo di sofferenza e per il bambino vedere il dolore e la preoccupazione dei genitori, il suo stare male fa male alle persone che ama di più. Perciò i genitori devono essere così sani da resistere all’urto emotivo di una diagnosi in modo da sostenere il bambino, gli si può spiegare che i genitori sono adulti, pertanto capaci di accompagnarlo con serenità nel suo iter diagnostico e terapeutico, e l’operatore sanitario ha il compito di indirizzare i comportamenti degli adulti affinché il bambino abbia intorno a sé delle figure di sostegno e di aiuto. E se è vero che nella assoluta unicità di ciascuno di noi il dolore come tutte le esperienze emotive è squisitamente soggettivo, è vero che la sensazione 90 dolore ha dei riscontri oggettivi inequivocabili dei quali tenere conto per non sottovalutarli. E l’operatore sanitario deve conoscerli per usarli al meglio. Ecco quindi le scale di valutazione del dolore diversificate per età dai lattanti ai bambini più grandi. Queste scale riferite alla sensazione dolore sono importanti perché ci aiutano nella pratica quotidiana, ci permettono infatti di non annullare il dolore dei pazienti, ci impediscono di renderci indifferenti per difenderci dal dolore degli altri, ci obbligano a cercare la causa del dolore e della malattia per eliminarla, ricordandoci che il nostro compito è “primum non nocere”, poi diagnosticare, e curare per la guarigione. 91 IL SENSO DELLA SOFFERENZA Mondo greco e cristiano a confronto. L'uomo sperimenta quotidianamente una realtà segnata dal dolore, un dolore che rende precaria la sua esistenza e lo impegna nel continuo, quando mai inutile, tentativo di evitarlo. Per questa ragione, egli è stato spinto in ogni tempo ad interrogarsi su questa dimensione oscura della vita, ed ha elaborato uno spettro d'interpretazione della sofferenza tanto vasto da dimostrare come ogni tentativo di definirla sia da considerarsi parziale .</problema> <icristiani>Con l'avvento dell'era cristiana, la cultura occidentale ha trovato nell'interpretazione teologica e spirituale della passione e morte di Cristo una nuova originale lettura della condizione sofferente dell'uomo che, soprattutto per opera di Paolo di Tarso, entrò in rapporto con importanti acquisizioni del pensiero ellenistico, sviluppando quelle intuizioni filosofiche che sentiva più conformi al messaggio evangelico. Soprattutto gli Atti dei Martiri e le Passioni mostrano come l'agiografia cristiana abbia elaborato una serie di prototipi dell'uomo sofferente che non ignorano, pur trasformandoli nel loro significato, alcuni modelli tipici della cultura pagana(1) . Benché "sia rischioso voler rintracciare necessariamente precisi influssi ellenistici nella letteratura cristiana dei primi secoli, e nella stessa letteratura agiografica" (2), alcuni contatti con tipologie dell'aretologia pagana sono chiaramente riscontrabili a questo livello, sia implicitamente che esplicitamente . La fortezza di quei pagani che avevano sopportato enormi sofferenze, o sacrificato la propria vita per l'affermazione degli ideali in cui credevano, suscitò l'ammirazione di molti cristiani e costituì per loro un modello di comportamento degno di essere imitato, e un esempio a cui riferirsi. Gli stessi termini che gli agiografi usarono per definire le virtù dei martiri vennero ripresi dal patrimonio culturale del mondo pagano, e sebbene siano stati oggetto di modificazioni semantiche, il loro uso sta ad indicare come l'originalità del messaggio evangelico si sia sviluppata su un "humus" culturale preesistente. Clemente Alessandrino (+215) - per esempio - non esitò a paragonare la pazienza cristiana nel sopportare le sofferenze alla fortezza stoica dei famosi eroi del mondo antico (3), e lo stesso Tertulliano (+220), che certo non spicca per la sua simpatia verso il mondo pagano, cita lungamente modelli di virtù dei grandi del passato, evidenziando la contraddittorietà del comportamento di tutti coloro che erano disposti a tributare loro sommi onori, e non riconoscevano analogo valore all'atteggiamento dei martiri cristiani </icristiani> - <i-pagani> <la-filosofia>Tali pretese, originate da chiari intenti apologetici, non potevano, però, che risultare vane poichè, il Dio dei cristiani, così diverso da "l'idea assoluta" di Platone, dal "motore immobile" di Aristotele, dal "principio razionale" degli stoici, suscitava nei suoi fedeli comportamenti così originali che non potevano non determinare perplessità e dubbi nei filosofi pagani . Chi era abituato, infatti, alla ricerca e all'esercizio della "apatia" e considerava deleterie tutte le passioni dell'animo, non poteva stimare o condividere atteggiamenti come quelli dei martiri, che testimoniavano ardentemente la fede davanti ai loro giudici e desideravano i tormenti di cui erano minacciati . Sebbene si dimostrassero intrepidi nel sopportare il dolore erano agitati, infatti, da 92 sentimenti violenti, da speranze, da eccitazione per la gloria e il trionfo, che spingevano Plinio il Giovane (+136) a definirli: "Adepti di una superstizione sfrenata e pericolosa" (5), e suscitavano il biasimo di Marco Aurelio (+180), che non vide mai nel loro comportamento qualcosa che potesse esser degno di ammirazione . Anzi, l'imperatore, certo che il modo con cui i martiri affrontavano il dolore non solo non fosse degno di un filosofo, ma di dimostrasse addirittura riprovevole per ogni uomo che ricercasse la virtù, non trovò altro aggettivo per definirlo agli occhi dei suoi contemporanei, che quello di tragedia, riconoscendo così implicitamente uno stretto rapporto tra il modo cristiano d'intendere il patire e questa fondamentale esperienza del mondo classico: "Oh, qual è l'anima pronta se necessario, a sciogliersi subitamente dal corpo ossia ad estinguersi, o a dissolversi, o a sopravvivere! Ma quest'attitudine derivi dal tuo proprio giudizio, non sia l'effetto di una mera opposizione come quella dei cristiani; sia meditata e dignitosa e convincente per gli altri, non tragica"(6). </la-filosofia> <la-tragedia>Partendo da questa testimonianza aureliana, e poiché, risulta ormai essere un dato universalmente riconosciuto che la filosofia antica, più che interpretare la sofferenza, ha tentato di relegarla tra gli aspetti irrazionali dell'esistenza, sembra opportuno rilevare come i più alti traguardi nell'indagine di questa ineliminabile condizione della vita umana, siano stati raggiunti dall'elaborazione religiosa del mito e della tragedia . Quest'ultima, poi, per le caratteristiche che la determinano, rappresenta secondo Hans Urs Von Balthasar l'espressione del mondo classico che più si avvicina al cristianesimo: "la serietà assoluta della grande tragedia - scrive il teologo tedesco -si riversa e si risolve nel dramma di Cristo, e interamente al punto che, in epoca post-cristiana diventa irripetibile .La tragedia greca e non la filosofia greca, con la quale i cristiani hanno soprattutto dialogato, rappresenta la grande e valida cifra di Cristo evento dell'umanità in quanto assomma in sé, e supera tutte le cifre anteriori"(7) . In essa la grandezza dell'eroe si concretizza, come per Pindaro, nell'"agon" (8), nel combattimento tra la dolorosa determinazione della natura cui la condizione umana è legata, e il desiderio di vincerla, desiderio che non implica necessariamente l'eliminazione della sofferenza, ma solo l'affermazione di un libertà morale che non costringa a rinunciare ad una parte della propria esistenza solo perché, dolorosa . Così la tragedia celebra colui che, realizzandosi in questo combattimento, "ha imparato ad amare il crogiolo purificante del dolore"(9), dimostrando che questo, non solo non è accidentale ma costituisce un fattore imprescindibile per la comprensione della sua realtà, per cui è vero uomo solo colui che lotta, che lottando soffre, che soffrendo esiste . "Qui il dolore non è negato continua Von Balthasar dichiarato illusorio e reso filosoficamente trasparente, né, fuggito per amore di una inesistente "eudemonia", ma attraverso di esso si scava in direttissima una strada dell'uomo verso Dio e verso la rivelazione profonda dell'essere. Questo è il coraggio dell'inerme cuore umano che la filosofia non avrà e che sta immediato davanti a Cristo"(10) . Secondo la prospettiva tragica, dunque, la sofferenza è l'intima essenza e la caratteristica tipica di ogni realtà e costituisce lo strumento principe attraverso cui l'uomo matura, diviene adulto rappresentando la fonte e il culmine di tutta la "paideia" . Non c'è modo di definire l'individuo, nei rapporti con i suoi simili 93 e con la divinità, se non in quest'ottica, poiché, nel soffrire, da cui non esiste liberazione, sta la sua dignità, la sua dimensione esistenziale che "né gli dei, né gli animali possono sperimentare" (11) . La concezione del dolore e della morte che soggiace a questa grande esperienza del mondo classico e che riassume in s, un immenso patrimonio culturale, da Omero ad Esiodo, dal mito ai poeti lirici, rappresenta, dunque, la testimonianza più vera e meditata del modo con cui i greci interpretavano la loro condizione esistenziale, nonché, una chiara indicazione del concetto di virtù che stava alla base del loro agire .</latragedia> </i-pagani> <ipotesi>Dati questi presupposti, e volendo porsi domande sui rapporti tra mondo greco e cristiano sulla concezione del dolore e della virtù che origina dal modo di affrontarlo e sopportarlo, mi sembra imprescindibile confrontare le testimonianze cristiane con quelle emergenti dai testi tragici . Non si tratta, tramite la determinazione di parallelismi o l'individuazione di dipendenze, di riproporre l'annosa questione sull'ellenizzazione del cristianesimo o sulla cristianizzazione dell'ellenismo, anche perché, non è possibile rintracciare nella letteratura cristiana antica riferimenti diretti alla tragedia, un genere di spettacolo che, come i mimi e i giochi circensi veniva esplicitamente condannato dai Padri della Chiesa(12) . E' comunque innegabile, però, come abbiamo visto, che la profonda speculazione che il cristianesimo operò intorno alla presenza e al valore da attribuire alla sofferenza, a partire da quella redentrice sopportata da Cristo sulla croce, non ha avanti a s, antecedente più rilevante di quello rappresentato dalla tragedia classica . Per questa ragione non mi sembra fuor di luogo affermare che nell'attribuire un senso al patire umano, i cristiani non poterono non aver presente, valutandoli alla luce della rivelazione divina, tutta quella grande varietà di culti, di esperienze mistiche e religiose che giunsero loro attraverso la cultura greca e di cui la tragedia dà ampia testimonianza . In ambiente ellenistico, dunque, nell'incontro di diverse civiltà, furono poste le basi delle concezioni fondamentali, delle ideologie portanti e della storia del pensiero dell'occidente, una storia e un pensiero che - come fa notare Salvatore Natoli - "è stato capace sempre d'inconcepibili alchimie, di mescolanze a prima vista impossibili. Da tali mescolanze, per il dolore è nata una nuova scena"(13)</ipotesi> .</ipotesi> I . L'UOMO TRAGICO I .1.Eschilo: la virtù attraverso la sofferenza L'importanza che la tragedia classica ha attribuito alla sofferenza e all'opera di chi se ne fa carico a nome e a vantaggio di tutta la comunità, ha fatto sì che in ogni epoca le venisse universalmente riconosciuto quel valore che l'ha resa uno dei momenti più alti della civiltà occidentale . Tra i molti prototipi di umanità sofferente da essa elaborati quello di Prometeo è certamente uno dei più densi di significato poiché, tramite questo mito il mondo ellenico ha cercato di affrontare ed interpretare i fondamentali problemi dell'esistenza umana . La famosa vicenda del "Dio crocifisso", già trattata da Esiodo (14), fu riproposta da Eschilo in una trilogia di cui ci è rimasta una sola tragedia, per altro del tutto insufficiente per permetterci di dare un'esatta valutazione degli intenti dell'autore . Le varie ipotesi avanzate dagli studiosi sull'ordine con cui si sarebbero succeduti i tre drammi che costituiscono l'opera, lasciano adito a diverse interpretazioni ma, la di là di queste, è evidente che l'atto di carpire il 94 fuoco, così come ce lo mostra il Desmotenes, caratterizza la persona che lo compie come colui su cui grava una manchevolezza, e Prometeo con il suo furto, si rivela ""l'alter ego" dell'umanità, l'eterna immagine della sua forma d'esistenza fondamentalmente deficiente"(15). Per molti, la trilogia sarebbe incominciata con il Pyrforos, il portatore di fuoco, narrando l'evento del dono igneo fatto da Prometeo agli uomini, e ad essa sarebbero seguite il Desmotenes, e il Lysomenos, secondo uno schema caro all'autore per cui all'atto di "hybris" sarebbe seguita la dolorosa punizione che dopo aver dimostrato la superiorità di Zeus, avrebbe portato alla liberazione del reo punito (16) . L'insanabile conflitto tragico emerge così in tutta la sua evidenza . Senza il fuoco l'umanità sarebbe stata completamente distrutta e questo pericolo spinge il Titano, deciso ormai a condividerne pienamente il destino, a sovvenire alle necessità dei mortali tramite il dono del fuoco e di tutte quelle arti che reputava necessarie alla loro sopravvivenza . Il suo tentativo non riesce, però, a sanare la precarietà dell'esistenza umana e la violazione delle norme stabilite da Zeus in cui incorre con il suo furto, ha come unica conseguenza quella di renderlo compartecipe della sofferenza degli uomini . L'eccessivo amore verso questi, spinge dunque Prometeo a voler infrangere quell'ordine che racchiude in se stesso il motivo del loro soffrire e proprio da questa solidarietà originano i suoi patimenti . Sia lui che gli uomini nel cui interesse ordisce i suoi inganni, continuano, infatti, a rimanere esposti al totale arbitrio della divinità e le nuove cognizioni ed abilità tecniche che vengono acquisite, non mutano assolutamente quello stato di cui ora, anch'egli, condivide le caratteristiche . Per questo rivolgendosi a lui il coro può dirgli: "Benché, tu abbia dato agli uomini tante scoperte non sei capace di liberare te stesso da tali sciagure".(17) In questo senso Prometeo è proprio prototipo e rappresentante dell'umanità, e la possibilità di sottrarsi al dolore non diviene, anche per lui, che una lontana speranza . "O Prometeo, preoccupati più di te che dei mortali. Speriamo che un giorno tu liberato dalle catene abbia un potere simile a quello di Zeus".(18) Al suo dolore non c'è, dunque, alcun conforto se non nella speranza di un nuova concezione di giustizia di cui la sofferenza patita diviene quasi il momento iniziale di attuazione . Nella trilogia prometeica, infatti, la conciliazione tra l'eroe troppo favorevole agli umani e il duro ed inflessibile Zeus, passa attraverso l'eterno dolore di una divinità che non può morire, ma senza il sacrificio della quale non si sarebbe potuta svelare quella dimensione di provvidente e giusto reggitore del mondo che caratterizzava Zeus così come ce lo presenta Eschilo nella preghiera che Agamennone, ritornando vincitore da Troia alla casa degli Atridi gli rivolge, celebrandolo come padre degli uomini e degli dei (19). Così la somma divinità, dopo aver piegato con la sofferenza il Titano ribelle, diviene più favorevole agli uomini e concede loro spontaneamente quei doni che gli erano stati sottratti con l'inganno.(20) Questa conciliazione tra le due divinità, avviene, dunque, in seguito alla totale sottomissione di Prometeo che, attraverso la sofferenza assume una nuova visione del mondo, muta il suo atteggiamento, impara che il retto comportamento è quello di colui che avendo conosciuto quali siano i suoi limiti evita di oltrepassarli, astenendosi così da ogni atto di "hybris". . E' a questo livello che si pone, dunque, nella tragedia, il valore didattico-pedagogico del patire, e soltanto in questa prospettiva è 95 pienamente comprensibile il sacrificio di Prometeo . Accettando consapevolmente di andare incontro alla punizione e al dolore che deriva dalla sua ribellione all'inflessibile volere di Zeus, egli non solo impara che occorre rispettare l'ordine immutabile degli dei, ma diviene esempio per tutti gli uomini, affinché, anch'essi imparino ed acquisiscano tale profonda conoscenza della realtà senza incorrere nella sofferenza che da essa scaturisce: "Queste cose io imparai guardando le tue luttuose vicende o Prometeo" .(21) Questa idea secondo cui il dolore dell'esistenza umana si inscrive in un piano divino dalle caratteristiche provvidenziali in quanto chiarifica l'uomo nel suo agire e lo rende cosciente della sua essenza, è espressa esplicitamente da Eschilo nell'Agamennone: " E' Zeus che ha avviato gli uomini alla saggezza stabilendo come valida la legge: attraverso la sofferenza la saggezza . E invece del sonno stilla davanti al cuore la sofferenza fatta di doloro si ricordi, e anche a chi non vuole arriva la saggezza . C'è sicuramente una grazia da parte degli dei che usano violenza occupando il venerando seggio del timoniere."(22) Il grande tragico elabora, infatti, uno schema di connessioni secondo cui l'uomo, inorgoglito dall'eccessiva abbondanza, viene spinto ad avere un comportamento tracotante contrario alla norma, macchiandosi di una colpa che gli dei punivano con la sofferenza, affinché, egli imparasse come non fosse bene andare oltre il limite stabilito per lui dalla natura . Tale processo viene sintetizzato nel famoso apoftegma:"alla saggezza attraverso la sofferenza" (23), che appunto esprime la convinzione che il dolore costituisca uno strumento pedagogico di grande importanza educando l'uomo a non aspirare a cose che non siano in accordo con la sua condizione sociale o esistenziale . Letto in questa prospettiva il dolore prometeico non può non essere un chiaro segno di un sacrificio di se stessi che il Titano compie non tanto per procurare all'umanità determinate "tecnai" (24), quanto per stabilire un nuovo ordine razionale dell'universo in cui la divinità che lo regge o governa, sia più favorevole ai mortali . Questo valore espiatorio e conciliatorio del patire emerge chiaramente anche nelle Eumenidi, dove Oreste, scisso secondo l'antico mito, tra il dolore impostogli dagli dei di vendicare l'assassinio del padre con l'uccisione della madre e l'affetto filiera che glielo vietava, nello sconvolgimento della mente in cui cade dopo il matricidio, diviene con la sua sofferenza il fulcro dinamico di tutta l'azione drammatica . Dalla tragedia emerge chiaramente, infatti, la convinzione che una cerimonia esteriore, come il rito della lavanda con sangue animale a cui viene sottoposto da Apollo nel tentativo di espiare il suo delitto non potesse purificarlo dalla sua colpa né, tantomeno estinguere la maledizione che si estendeva sulla casa degli Atridi e secondo cui ogni omicidio ne implicava sempre un altro in una catena che sembrava non dovesse aver mai fine. Infatti, soltanto l'atroce tribolazione che lo investe quando viene assalito dalle Erinni, le oscure e terribili divinità preposte a vendicare i delitti di sangue perpetrati contro i parenti, costituisce l'elemento indispensabile attraverso cui queste incontenibili potenze dell'abisso ostili agli uomini, vengono trasformate in benevole protettrici della città . "L'ordine del mondo non è già dato fin dall'origine, né, raggiunto alla fine sistematicamente da sintesi filosofiche: tutto è centrato sulla gloria dell'evento divino, affidato alla divina rivelazione di cui non si possono anticipare i tempi e i modi"(25), ma senza il sacrificio di qualcuno che fosse disponibile a soffrire 96 per la stirpe, la città, il popolo, la divinità non avrebbe potuto conciliare a sé, il mondo e manifestare così la sua gloria . I .2 .Sofocle: il mistero del dolore La successiva indagine condotta da Sofocle sulle radici del dolore, pur non escludendo lo schema razionale colpa-punizione-sofferenza, elaborato da Eschilo, mostra di sentirlo estremamente riduttivo e preferisce trascurarlo nella convinzione che l'indagine di questa dimensione inquietante della realtà non possa concludersi in modo così semplice . Lo stesso agire della divinità viene deliberatamente privato di ogni valore didattico e la tragicità delle sue opere s'incentra tutta sulla sofferenza che l'esistenza umana implica necessariamente in ogni rapporto con gli altri . Il dolore dei personaggi sofoclei è una realtà inspiegabile, ma capace di rivelare, mettendo alla prova la virtù, la grandezza dell'uomo e di evidenziare la soggettività sofferente dell'individuo, nella convinzione che il patire sia un mistero troppo grande per essere racchiuso in un qualsiasi schema razionale . Paradigmatica diviene, in questa prospettiva, la figura di Antigone, che, per non violare le "leggi non scritte degli dei"(26), muore avendo disobbedito all'ordine di Creonte, re di Tebe, di non seppellire il cadavere del fratello Polinice, il traditore che aveva osato portare le armi contro la propria patria . L'eroina è pienamente consapevole dell'immenso dolore che dovrà sopportare per aver tributato onoranze funebri al corpo del caro congiunto, ma sa anche di non poter venir meno a quei doveri della pietà religiosa che le impongono di dar sepoltura ad un morto. Per questo davanti alla tracotanza del sovrano che la rimprovera e la minaccia, essa può affermare: "Affrontare questa fine è quindi per me un dolore da nulla; dolore avrei sofferto, invece, se avessi lasciato insepolto il corpo do un figlio di mia madre; ma di questa mia sorte dolore non ho".(27) Antigone concepisce dunque la sua vita come inevitabilmente segnata dalla sofferenza, ma riconosce anche nel sottomettersi ad essa liberamente, in obbedienza al volere degli dei, la possibilità di conseguire meriti eterni e di attuare quegli ideali del "kalòn" e del "klèos" proposti da tutto il pensiero greco come fine del comportamento morale e piena realizzazione dell'individuo: "E' bello per me morire in quest'impresa .Cara a lui che mi è caro giacerò, per un santo crimine: perché, ben più a lungo dovrò esser cara ai morti che ai vivi. Laggiù in fatti, riposerò per sempre; ma se credi, disonora ciò che tra gli dei ha onore". (28) Eppure questi valori che sembravano determinanti per la sua azione e che tanto la rendono simile alle grandi figure dei martiri cristiani, nell'istante supremo della prova, vengono a cadere e sono quasi rinnegati in uno struggente rimpianto per la vita che si abbandona: "Ho forse violato la giustizia divina? Ma perché, un'infelice come me dovrebbe rivolgersi ancora agli dei? E a chi do manderò aiuto, se per la mia pietà mi sono guadagnata il nome di empia? Ebbene, se così par giusto agli dei, dopo aver sofferto riconoscerò il mio errore; ma se i colpevoli sono loro, non abbiano a soffrire pene maggiori di quelle che ingiustamente mi affliggono".(29) Certamente Sofocle non intende, con queste parole pronunciate da Antigone nel momento più cupo del suo dramma, gettare un ombra sulla giustizia degli dei, ma soltanto negare ogni contatto tra questi e la protagonista, rigettando l'idea che questi possano attraverso il dolore stabilire un qualche contatto con l'uomo, poiché, la sofferenza che egli sperimenta non serve ad altro che a renderlo consapevole della propria tragica condizione esistenziale e ad isolarlo da ogni 97 altra realtà circostante (30) . L'affermazione con cui si chiudono le Trachinie, rappresenta un'altra chiara testimonianza di ciò . Illo davanti alle sciagure che anno colpito il padre Ercole, e alla sua imminente morte afferma l'assoluta estraneità della divinità ad ogni evento, soprattutto doloroso dell'esistenza umana, pur riconoscendo, in ultima analisi che tutto origina e discende da Zeus.(31) Recuperando antichi modelli omerici ed esiodei, l'unica conoscenza che Sofocle mostra possibile per l'uomo, è quella che sperimenta Creonte nel rendersi conto, dopo aver scoperto il suicidio del figlio e della moglie in seguito alla morte di Antigone, che "quando la disgrazia sia accaduta anche lo stolto capisce" (32) . La sofferenza chiarifica all'uomo il proprio destino, e si manifesta come aspetto fondamentale della sua ontologia, per cui ogni liberazione da essa diviene impossibile, e la virtù non si riduce ad altro che alla rassegnata accettazione di questa tragica realtà . Anche quando all'eroe schiacciato da un infinito dolore, come a Filottete nell'omonimo dramma, la tragedia pone accanto la divinità, questa non resta mai coinvolta nelle sue tristi vicende, e la sua epifania, sebbene testimoni che la gloria divina sta al vertice dell'esperienza del patire umano, non dimostra affatto che questa rappresenti una via di ascesa a Dio, poiché, gli dei, anche quando si compiacciono dell'amore di un mortale, non possono certo condividere i suoi travagli e, davanti a questa terribile esperienza, lo lasciano inesorabilmente solo . Così anche Euripide, presentandoci questa situazione nell'Ippolito, evidenzia chiaramente come l'eroe, giunto al termine della sua vita tra atroci tormenti, non possa che essere abbandonato anche da Artemide che pur tanto lo aveva amato: Ip. "A che son ridotto, vedi, Signora?" Ar."Vedo, ma versar pianto non m'è per messo." [ ...] "Addio! Perché, non mi è lecito vedere estinti, né, si conta mini il mio viso con l'alito dei moribondi".(33) E' chiaro, dunque, come il dramma classico non rappresenti il tentativo di una teodicea, n, quello di dare una spiegazione alla presenza del male nel mondo, quanto quello di determinare un quadro organico in cui poter collocare la realtà della sofferenza . "Di fronte all'evidenza del divenire e della crudeltà connessa con ogni nascita e morte o, in senso fisico, ad ogni generazione e corruzione" - scrive ancora Natoli - " il greco elabora la visione tragica del mondo. Il dolore non deve essere giustificato più di quanto non lo esiga, o lo debba essere l'esistenza. Ma l'esistenza è in primo luogo un fatto reale e non apparente".(34) Lo schema peccato-colpa-punizione elaborato da Eschilo, nel tentativo d'includere questa atroce esperienza della vita umana in una dimensione razionale, non riesce ad informare di sé, la cultura classica, e l'eroe greco è chiamato, dalla tragedia, soltanto a saper affrontare il suo destino di sofferenza e ad amarlo al di là di ogni spiegazione, nella coscienza che l'unica alternativa ad esso sia la morte. (35) L'uomo ha dunque davanti a sé, un'esperienza terrena bella e dolorosa, e non può in nessun modo eliminare tale contraddizione se non decidendo di amarla e di sceglierla come sua propria sorte . In questo modo il suo grido di dolore diviene la sua autocomunicazione, il suo modo di esprimersi, il modo per affermare la sua esistenza II.L'UOMO CRISTO II .1 .Il sacrificio di espiazione La grande novità del messaggio evangelico originava dalla fede nell'amore divino che, per salvare il mondo, aveva inviato tra gli uomini il Figlio, affinché, condivisa la loro condizione di miseria e sofferenza, potesse redimerla sottoponendosi ad essa fino alla morte . Come fa notare Simone 98 Weil, infatti, "Colui che ignora fino a che punto la volubile fortuna e la necessità tengano ogni anima alla propria merce, non può considerare come suoi simili n, amare come se stesso quelli che il caso ha separato da Lui con un abisso" (36) . Il problema del dolore umano, del suo senso e del significato da attribuire alla volontà di colui che decideva di sottomettervisi in vista di beni maggiori, costituì uno dei principali motivi che mosse la speculazione cristiana dei primi secoli e la spinse, nel tentativo d'interpretarlo alla luce dell'opera redentrice di Cristo , ad avvalersi di tutte quelle realtà culturali e filosofiche che sentiva a sé, vicine. In questa prospettiva, la condizione umana così come l'aveva descritta la tragedia classica nel suo essere sottoposta alla forza della necessità, nel suo saper resistere eroicamente ad essa in nome della virtù o dell'acquisizione di un vantaggio comune, rappresenta uno dei grandi contributi che la grecità ha fornito alla cultura occidentale e che, giunto alle soglie dell'era cristiana, avrebbe informato di s, il messaggio evangelico, facendone, addirittura, proprio per questo, - pensava Weil - l'estremo frutto della cultura classica (37) . Il cristianesimo, infatti, come la tragedia, vedeva nel peccato la causa del male e del patire umano (38), anche se non condivideva la convinzione che il dolore originasse dalla trasgressione, più o meno volontaria, di una qualche norma divina che si perdeva nel mito, ma lo attribuiva, invece, alla libera volontà umana di rifiutare la legge di Dio . Concordava, inoltre, con il mondo greco sull'idea che, data la condizione esistenziale dell'uomo, non fosse possibile, così come invece era convinzione della mentalità giudeofarisaica, anche per chi lo volesse, un perfetto rapporto con Dio nell'osservanza di ogni più piccola norma religiosa, e quindi concepiva l'esistenza umana come costantemente segnata dalla colpa(39) . Ciò che Eschilo esemplificò nella "maledizione della stirpe" (40), veniva indicato da Paolo di Tarso nella tensione al peccato che era comune a tutta la discendenza di Adamo e alle cui conseguenze nessuna poteva sottrarsi . La sofferenza che originava da questa situazione, non doveva, però, essere considerata ontologica, connessa, cioè, alla natura umana, ma accidentale, in quanto derivante dal peccato, ovvero dalla libera scelta dell'uomo di opporsi a Dio . Se, dunque, nell'antichità il dolore era considerato effetto di una trasgressione, l'opera redentrice di Cristo inaugura senza dubbio, con un radicale mutamento di prospettive, una nuova interpretazione della sofferenza, rifiutando non solo di considerarla castigo per una colpa, ma rendendolo addirittura "segno di grazia" . Cristo, infatti, decide di affrontare il peccato e subendolo soffre e muore; ma i patimenti e la morte che derivano da questa determinazione vengono superati definitivamente dalla resurrezione, segno della vittoria non tanto sul dolore, ma sul peccato che lo implicava (41) . Per questo la croce, simbolo primigenio della sofferenza che Cristo affronta, diviene per Paolo punto centrale della sua predicazione in quanto segno di salvezza e di grazia che sta ad indicare come tramite il dolore il peccato, con tutte le sue conseguenze, sia stato affrontato e sconfitto . La sua presenza diviene quindi, manifestazione visibile della azione operante di Dio che si muove per salvare il mondo . Ma per far questo, poiché, il peccato aveva potere sulla carne e sul sangue,, cioè, sulla totalità dell'esistenza umana, il Cristo doveva affrontarlo a questo livello, divenendo cioè, solidale con tutta l'umanità(42) La figura del "Servo sofferente di Jahwe"(43), elaborata dal profetismo ebraico, come colui i cui patimenti apportano salvezza 99 a tutto il popolo, viene riletta da Paolo in questa prospettiva . << La redenzione>> - scrive ai Romani - <<è stata stabilita da Dio in Gesù Cristo, quale propiziazione nel sangue di Lui>> (44) . "La parola che comunemente è tradotta con propiziazione," - fa notare Charles Harold Dodd -"non significa propiziazione; essa è più propriamente l'appagamento di una persona irritata [ ... ] ma, mentre l'uso pagano rende spesso Dio oggetto di quest'atto, quest'idea è suggerita solo tre volte nell'Antico Testamento, e mai nel Nuovo [ ...]. Nel nostro testo, di Dio si dice che: "ha stabilito un mezzo di espiazione", cioè un trattamento per il peccato. Questo mezzo è espresso nei termini del sacrificio dalla menzione del sangue [ ... ]. Il sacrificio di Cristo, non è concepito come un mezzo per placare la divinità irritata, ma come un atto di Dio stesso che affronta il peccato devastatore della vita umana"(45). Questo concetto, così ben evidenziato da Dodd, segna la linea di demarcazione tra il mondo cristiano e quello greco, e costituisce l'originale interpretazione che la nuova religione fornisce del modo con cui il pensiero ellenico aveva valutato il dolore dell'esistenza umana . La totale dedizione di Gesù di Nazareth, non si limita a sopportare la "necessità" a cui sono sottoposti i mortali, ma sceglie di condividere la sorte dei miseri, il patibolo degli schiavi, cose alle quali avrebbe potuto sottrarsi fino all'ultimo momento . Il dolore, dunque, nella prospettiva cristiana, non viene accettato perché, necessario, ma come necessaria conseguenza della condivisione del destino umano nella totale dedizione di sé. Per questo Paolo, nella Lettera ai Galati evidenziando come Cristo abbia voluto condividere con la natura dell'uomo anche gli effetti della sua colpa afferma: "Egli ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, divenendo lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: maledetto chi pende dal legno"(48) . II .2 .Il senso del dolore: mondo greco e cristiano a confronto La metafora della maledizione è, dunque, una realtà comune al pensiero antico che porta con s, profonde implicazioni . Maledetto era, secondo la tragedia, colui che trasgrediva la "norma" offendendo gli dei e andando, come abbiamo visto, contro l'ordine da loro stabilito; ma maledetto era anche l'eroe innocente che, per amore verso i suoi simili decideva, combattendo, di farsi carico di una situazione di sofferenza che gravava la famiglia, la stirpe o la città . E' facile notare come le analogie riscontrabili a questo livello in un paragone tra pensiero greco e cristiano non possano lasciarci indifferenti . Entrambi celebrano la generosità e le forza coraggiosa di chi volontariamente prende su di s, gli effetti di una maledizione che pesa sulla società umana e decide di subirne le conseguenze, così che possa considerarsi estinta(47) . Quest'interessante confronto nella delineazione della figura di una divinità decisa a sopportare per amore degli uomini, la sofferenza tipica della loro condizione, merita di essere approfondito, e se certo non possiamo giudicare l'opera prometeica alla luce del concetto di redenzione del cristianesimo,, né individuare influssi dell'antico mito nell'agire e nella figura di Cristo, è certamente degno di sottolineatura il fatto che - come afferma Charles Kerenyi (48) - Il titano rappresenta il "mitogema" dell'esistenza umana, e si avvicina molto, pur senza alcuna pretesa teologica, alla concezione paolina di Cristo "nuovo Adamo"(49), archetipo di una nuova umanità . Senza dubbio le ragioni per cui Prometeo e Cristo patiscono sono agli antipodi, in quanto il primo sconta un atto di disubbidienza a Zeus, mentre il secondo soffre per obbedire 100 alla volontà del Padre, ma il fatto che entrambi siano spinti dalla determinazione di far causa comune con l'umanità, facendo scaturire da questa situazione il paradosso della loro condizione, determina un'analogia che non può essere trascurata . Infatti, non si può certo negare che qui, come nelle Eumenidi o in Antigone, sia il generoso patire di un animo innocente a spezzare la catena dell'odio e del dolore e a rappacificare in sé, e tra loro, gli uomini e le divinità, le quali, perduto il loro aspetto ostile e terrificante, arrivano a costituirsi come benevole patrone dell'uomo e garanti del diritto e delle norme religiose . Ma la mentalità greca non poteva spingersi oltre nel delineare un tipo di rapporto umano con gli dei, e non si può certo attribuire ad essa tutto ciò che rappresenta il frutto più alto della speculazione ebraica prima, e cristiana poi . "Prometeo e l'ecce homo" - fa notare Josè Lasso De La Vega "sono simboli di un'umanità intesa in modo assai diverso e i dolori per i peccati del mondo sono in Gesù Cristo qualcosa di radicalmente diverso dalla sofferenza prometeica"(50), soprattutto perché, Cristo non è un ribelle che si oppone alla divinità, n, soffre vittima della sua ira vendicatrice . Il Crocifisso non minaccia come il Titano eschileo, ma dalla profondità del suo dolore si abbandona a Lui, e inaugura così un nuovo fecondo modo di viverlo . Non si tratta, dunque, d'interpretare la sua opera in funzione di una conciliazione all'interno dell'ambito divino, o tra questo e quello umano, ma di considerare come a causa della sofferenza di suo Figlio, Dio non sia più estraneo e minaccioso nei confronti dell'umanità, ma sperimenti la sua condizione, e quindi renda possibile un dialogo, invitando a fidarsi di chi si era sacrificato in suo favore fino alla morte . Poiché,, dunque, l'uomo non è più solo, e il mondo non è più separato da Dio, tutti quei princìpi etici che nascendo dall'eroismo dell'autarchia umana, erano alla base delle virtù del mondo antico, non possono trovar riscontro nell'ambito cristiano . Il valore redentore e conciliatorio della sofferenza accettata liberamente, rappresenta in Cristo l'azione di un uomo che viene a coincidere con quella di Dio, e l'ordine che così si delinea, non è quello di una nuova "polis", o di un nuovo Olimpo, ma quello di una nuova creazione . La sofferenza, il sacrificio personale di Gesù di Nazareth, hanno come conseguenza, infatti, la nascita e lo sviluppo di un atto sovrastorico non ancora concluso, e la sua morte non ha posto fine alla sua esistenza, ma nella sua resurrezione si è aperta ad una nuova indefinibile prospettiva che comprende ogni realtà esistente . Se il dolore di Oreste e di Antigone, il sacrificio di Prometeo, il sangue di Eteocle e Polinice, mischiato insieme per reciproca uccisione, avevano riportato le loro famiglie e le loro città allo stato di pacificazione anteriore alla colpa, il sangue e il dolore di Cristo aprono l'esistenza ad una nuova dimensione ontologica . In essa pur restando presente la sofferenza, si nutre la speranza nella certezza di una vita senza morte e senza dolore che attuandosi nell'aldilà, tende a relativizzare la condizione terrena . Il conflitto tragico del mondo greco non ha dunque più ragione di essere . " La liquidazione del tragico ha fondamentalmente messo fuori gioco la convinzione che la vita" -scrive ancora Natoli -" sia insieme crudeltà e bellezza, attività e conflitto. [ . . . ] La tradizione ebraico-cristiana ha enfatizzato la possibilità di una vita senza dolore, ha inoculato l'idea che il dolore potesse essere separato dalla vita"(51) . L'iniziale attingere al patrimonio culturale greco ha avuto, dunque, per il cristianesimo un esito 101 totalmente diverso . Non a caso il discorso che Paolo rivolge agli ateniesi sull'Areopago (52), se inizialmente era riuscito ad accattivarsi la simpatia degli ascoltatori, fallisce miseramente sul cardine della dottrina cristiana: la resurrezione . Per un greco, infatti, se la vita era necessariamente sofferenza, non aveva senso rinnovarla, mentre se avesse potuto esistere senza dolore, avrebbe perduto il suo spessore ontologico . CONCLUSIONE La civiltà greca non riuscì, dunque, a dare un'interpretazione univoca della sofferenza umana, e se con il progredire della speculazione filosofica seppe eliminare il problema relegandolo tra gli aspetti irrazionali dell'esistenza, dal punto di vista religioso questo restò drammaticamente irrisolto, lasciando all'uomo la grande domanda del suo significato particolarmente in rapporto alla divinità . Soprattutto Eschilo tra i tragici, incominciò a concepire la sofferenza come strettamente connessa al mondo degli dei, i quali a causa di una non ben determinata colpa, insegnavano all'uomo, con il dolore, a conseguire, come suprema virtù, la determinazione a non voler aspirare a cose che andassero al di la della propria condizione . Se però, come ha sottolineato Vincenzo Di Benedetto(53), la tragedia classica ha fallito in questo suo tentativo di fondare una teodicea che riuscisse a dare una spiegazione del patire umano, il concetto che gli dei educassero l'uomo attraverso la sofferenza non rimase senza sviluppo, ma fu recuperato dal cristianesimo . Questo, infatti, evidenziando l'esemplarità della sofferenza del Redentore, mostrò come la sua passione avesse insegnato a conseguire la virtù e le realtà eterne dell'esistenza, e quindi inserì il dolore in un quadro didattico che originava come per i greci dalla divinità, ma che, fatto questo originalissimo, coinvolgeva la divinità stessa . Cristo, uomo perfetto, riassume in sé e nel suo comportamento ogni ideale di virtù, e la determinazione ad essere uomo autentico, perseguita dalla grecità come grado supremo dell'"areté,", diviene per il cristiano l'invito ad assimilarsi a Dio . In questa prospettiva la tribolazione non ha più la funzione di condurre l'individuo a prender coscienza della caducità del proprio essere, ma di costituirlo capace di conoscere ed apprezzare i valori per cui soffre e attraverso i quali è chiamato a partecipare alla natura divina . </sofferenza> 102
Scaricare