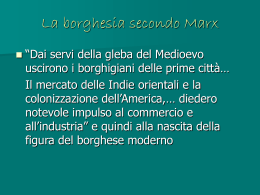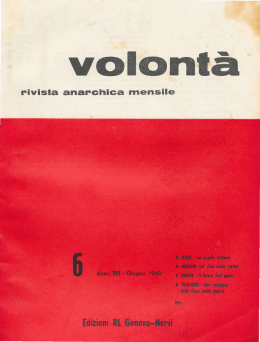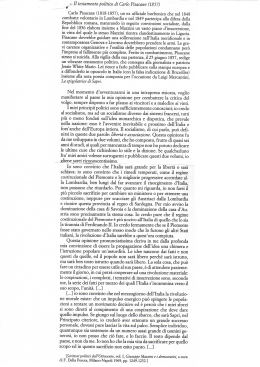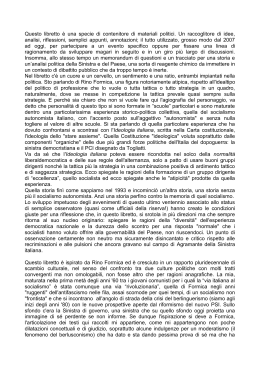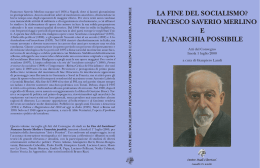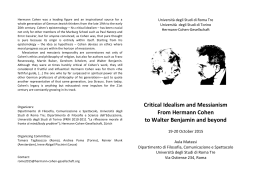Direttore Responsabile Luigi Covatta Direttore Editoriale Roberto Biscardini Comitato di Redazione Gennaro Acquaviva, Salvo Andò, Federigo Argentieri, Antonio Badini, Giovanni Bechelloni, Luciano Benadusi, Alberto Benzoni, Paolo Borioni, Daniela Brancati, Luciano Cafagna, Luigi Capogrossi Colognesi, Dario Alberto Caprio, Luca Cefisi, Simona Colarizi, Carlo Correr, Biagio de Giovanni, Danilo Di Matteo, Marcello Fedele, Maurizio Fiasco, Federico Fornaro, Antonio Funiciello, Marco Gervasoni, Gustavo Ghidini, Antonio Ghirelli, Massimo Lo Cicero, Pio Marconi, Guido Martinotti, Corrado Ocone, Walter Pedullà, Bruno Pellegrino, Cesare Pinelli, Carmine Pinto, Gianfranco Polillo, Mario Raffaelli, Mario Ricciardi, Stefano Rolando, Andrea Romano, Gianfranco Sabattini, Carlo Sorrentino, Giuseppe Tamburrano, Massimo Teodori, Sisinio Zito Segretaria di Redazione Giulia Giuliani Direzione, redazione, amministrazione, diffusione e pubblicità 00186 Roma - P.za S. Lorenzo in Lucina, 26 tel. 06/68307666 - fax. 06/68307659 [email protected] www.mondoperaio.it Impaginazione e stampa L.G. - Via delle Zoccolette, 25 00186 Roma Questo numero è illustrato con le vignette d’epoca dell’artista napoletano Antonio Manganaro raccolte da Nino D’Ambra e conservate presso il Centro di Ricerche Storiche D’Ambra di Forio d’Ischia © Mondoperaio Nuova Editrice Mondoperaio Srl Presidente del Consiglio di Amministrazione Oreste Pastorelli Riproduzione vietata senza l’autorizzazione dell’editore. Il materiale ricevuto anche se non pubblicato non si restituisce. Ufficio abbonamenti Roberto Rossi Abbonamento annuale € 50 Abbonamento sostenitore € 150 Versamento su c/c postale n. 87291001 Intestato a Nuova Editrice Mondoperaio srl P.za S. Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma oppure bonifico bancario codice IBAN IT46 Z076 0103 2000 0008 7291 001 intestato a Nuova Editrice Mondoperaio Srl Aut. Trib. Roma 279/95 del 31/05/95 Questo numero è stato chiuso in tipografia il 16/03/2011 Mondoperaio - rivista dei Socialisti Democratici Italiani - Partito Socialista Italiano mondoperaio rivista mensile fondata da pietro nenni >>>> sommario 3 marzo 2011 editoriale 3 Marco Boato La bozza Alfano memoria 5 SOCIALISTI E GRAN SIGNORI Alberto Benzoni Antonio Landolfi, la coerenza Carlo Correr Giuseppe Manfrin, la discrezione Luigi Covatta Francesco Barocelli, la dolcezza speciale nordafrica Gianni De Michelis intervistato da Alberto Benzoni, Luciano Cafagna e Luigi Capogrossi Turbanti stellette e democrazia Antonio Badini La collera e la politica Matteo Lo Presti L’eccezione marocchina speciale 150° 7 21 Zeffiro Ciuffoletti Il cronico caso italiano Bettino Craxi Il rosso del tricolore Antonio Ghirelli Il dialetto del Re Luciano Cafagna Il paradigma del Conte Gianfranco Sabattini Un pensiero moderno 150°/la prova dell’unità Giuliano Amato intervistato da Stefano Rolando Che cosa abbiamo fatto per meritarci l’Italia? 45 dossier/why not socialism? 53 Mario Ricciardi Socialismo post marxista Francesca Pasquali Una filosofia socialista Corrado Del Bò Contro il liberismo Enrico Biale Eguaglianza e comunità Miriam Ronzoni Il campeggio e la società 85 biblioteca / citazioni IL SOCIALISMO OGGI a cura della Fondazione Nenni Norberto Bobbio Il socialismo e il silenzio dei comunisti biblioteca / schede di lettura 93 Pio Marconi La democrazia giudiziaria Corrado Ocone Il cinismo della politica www.mondoperaio.it sommario / / / / mondoperaio 3/2011 //3// >>>> editoriale La bozza Alfano >>>> Marco Boato S e in Italia sulla “questione giustizia” non fosse in corso da tempo una guerra civile ideologica tra schieramenti contrapposti, l’appello che il direttore di Libero Maurizio Belpietro ha rivolto a Massimo D’Alema per invitarlo a riprendere l’iniziativa riformista della Bicamerale da lui presieduta avrebbe potuto avere un risultato positivo. Anche se nell’articolo di Belpietro comparivano numerose inesattezze riguardo al testo della Bicamerale sulla riforma della giustizia (che portava il mio nome come relatore), non c’è dubbio infatti che la riforma costituzionale sarebbe il terreno più adatto per riaprire – dopo l’esperienza troncata del 1997-98 – un reale confronto tra maggioranza e opposizione su un tema che conserva da decenni una drammatica attualità. E’ vero che le vicende giudiziarie che riguardano il presidente del Consiglio rendono minato il terreno, rischiando l’impraticabilità del campo; ma è altrettanto vero che il PD – principale partito dell’opposizione - non può evitare di prendere atto che il governo continua ad avere una maggioranza in Parlamento, che le ipotizzate elezioni anticipate si allontanano nel tempo, che quindi lo scenario politico attuale è cambiato radicalmente, e che perciò un’opposizione che abbia cultura di governo (diverso è il caso dell’IdV, che del giustizialismo ha fatto una bandiera) non può limitarsi a continuare a chiedere, giorno dopo giorno, le dimissioni del presidente del Consiglio, quasi con una sorta di coazione a ripetere priva di sbocchi politici reali. Nessuno immagina ovviamente che l’opposizione parlamentare debba attenuare i propri giudizi critici sul governo (che sono anche i nostri); ma è difficile immaginare un’opposizione credibile che si limiti a raccogliere firme per le dimissioni e a rifiutare qualunque confronto parlamentare anche sui temi costituzionali, che per loro natura lo richiedono, essendo l’ipotizzata riforma della Costituzione qualcosa di diverso dalla contrapposizione fisiologica sui programmi di governo. Ed è questo confronto “costituzionale” che lo stesso Presidente Napolitano continua giustamente ad auspicare in ogni occasione. Nel merito, la proposta di riforma costituzionale presentata dal ministro Alfano, con buona pace di Anna Finocchiaro, ri- prende effettivamente molte delle tematiche che già erano state affrontate nella Bicamerale D’Alema del 1997-98, anche se su alcuni punti dà risposte più “radicali” di quelle faticosamente individuate in un anno di confronto “costituente”. Le molte “bozze Boato” che si susseguirono nella Commissione Bicamerale erano il segno evidente di un sistematico e progressivo tentativo di trovare le possibili convergenze tra posizioni inizialmente molto lontane non solo tra i due schieramenti, ma anche al loro interno. Tuttavia, dopo un anno di duro lavoro, il progetto finale di riforma costituzionale in materia di giustizia ottenne l’approvazione quasi unanime da parte di tutto il centrosinistra (eccetto Rifondazione comunista) e di tutto il centrodestra. La proposta di riforma costituzionale presentata dal ministro Alfano su alcuni temi contiene proposte largamente condivisibiA questo numero di Mondoperaio è allegato il resoconto audiovisivo del convegno sulla questione meridionale che insieme con la Feneal-Uil abbiamo organizzato a Napoli il 29 ottobre 2010. Il primo maggio Mondoperaio uscirà in edizione speciale con gli atti del seminario “Dopo Mirafiori: impresa, lavoro e unità sindacale” che insieme con la Fondazione Bruno Buozzi e l’Associazione nuovi lavori abbiamo organizzato a Roma il 23 febbraio 2011, con gli interventi di Giuseppe De Rita, Giulio Sapelli, Luciano Pero, Bruno Manghi, Gennaro Acquaviva, Giorgio Benvenuto, Luciano Cafagna, Pierre Carniti, Mimmo Carrieri, Enzo Ceremigna, Antonio Cocozza, Luigi Covatta, Tom De Alessandri, Fausto Durante, Giuseppe Farina, Paolo Feltrin, Walter Galbusera, Massimo Lo Cicero, Franco Lotito, Agostino Megale, Pietro Merli Brandini, Silvano Miniati, Raffaele Morese, Paolo Pirani, Sandro Roazzi, Giorgio Santini, Vincenzo Scudiere, Nanni Toso. Le copie del numero speciale, al prezzo di 20 euro, vanno prenotate entro l’11 aprile presso l’ufficio abbonamenti della rivista ([email protected]; tel. 066837666). Sul blog di Mondoperaio (www.mondoperaio.it) il video del convegno di Napoli e l’audio del seminario di Roma. mondoperaio 3/2011 / / / / editoriale //4// li, su altri più discutibili (in particolare la norma sulla polizia giudiziaria). Ma si tratta, appunto, di una proposta iniziale, che deve essere ora sottoposta al lungo confronto parlamentare con le procedure rafforzate previste dall’art.138 della Costituzione, oltre che ad un dibattito pubblico che si auspica non riguardi solo magistrati, avvocati, docenti universitari, altri operatori del diritto, riviste e giornalisti, ma anche i cittadini in generale. Rifiutarsi a questo confronto e a questo dibattito è un grave errore, anche perché i primi giudizi espressi “a caldo” non paiono finora all’altezza dei problemi istituzionali e costituzionali affrontati dalla proposta di riforma e ripetono soltanto schemi stereotipati. Sarebbe sbagliato se l’opposizione si limitasse a gridare e denunciare, senza saper entrare seriamente nel merito, come hanno invece fatto anche alcuni (pochi) esponenti del PD come Enrico Morando, Stefano Ceccanti, Roberto Giachetti e Franca Chiaromonte, i quali hanno fatto esplicito riferimento alla necessità da parte del centrosinistra di ripartire proprio dalle proposte della Bicamerale, riconoscendo la piena legittimità di una riforma costituzionale in materia di giustizia con cui confrontarsi. Non appare credibile invece una opposizione che si limiti semplicemente a dire ‘No’, che ponga come pregiudiziale le dimissioni del presidente del Consiglio (cosa difficile, anche se può dispiacere a molti, finché il governo continua ad ottenere la maggioranza ad ogni votazione di fiducia) o che addirittura dichiari improponibile una riforma costituzionale in quanto tale, dopo che il centrosinistra nel 1997-98 ha presentato un progetto organico di riforma sulla giustizia assai più ampio e ambizioso di quello predisposto da Alfano. Altra cosa è riaffermare invece che, oltre al piano costituzionale, c’è anche quello della legislazione ordinaria, attraverso la quale fin da subito molti problemi potrebbero essere affrontati e risolti. Secondo alcuni perfino la separazione delle carriere, se si pensa al combinato disposto del secondo comma dell’art. 101 della Costituzione (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”) e del quarto comma dell’art. 107 (“Il mondoperaio 3/2011 / / / / editoriale pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”). Senza dire che esige un più coerente adeguamento della legislazione, non solo costituzionale ma anche ordinaria, il nuovo art. 111 della Costituzione (introdotto nel 1999, riprendendo una parte delle mie proposte in Bicamerale), che recita solennemente: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Il nuovo art. 111 sancisce anche che la legge assicura “la ragionevole durata” dei processi, che fra l’altro è un caposaldo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950. Maggioranza e opposizione hanno quindi già ora l’obbligo di intervenire con la legislazione ordinaria e con provvedimenti amministrativi e anche tecnologici (la massima informatizzazione delle procedure processuali), senza farsi paralizzare dalla eventualità dell’uso ad personam (perseguito o deprecato) dei provvedimenti relativi. Altrettanto dicasi per affrontare la spaventosa situazione delle carceri italiane e del loro vergognoso sovraffollamento, che le rende scandalosamente estranee al dettato costituzionale (art. 27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”). Anche il centrosinistra ha le proprie responsabilità su questo terreno, per i periodi in cui ha governato. Riforme costituzionali e riforme con legge ordinaria e con provvedimenti amministrativi non sono necessariamente in contrapposizione ed è possibile affrontarle con uguale determinazione, battendosi contro le leggi ad personam e a favore di leggi per i diritti di tutti i cittadini. Ma bisogna farlo per davvero, senza alibi per la maggioranza e neppure per l’opposizione. Mondoperaio intende battersi per questo obiettivo, ed è a disposizione di tutti quanti, specialmente a sinistra, e in tutto il centrosinistra, vogliono finalmente riprendere nelle proprie mani la bandiera del garantismo: magari anche per evitare che quella stessa bandiera finisca in mani troppo pelose. //5// >>>> memoria Socialisti e gran signori Nell’ultimo mese sono scomparsi tre compagni diversi fra loro per notorietà, professione ed età, ma uniti, oltre che dalla fedeltà all’idea socialista, dal disinteresse con cui hanno svolto la loro militanza. Li ricordiamo con l’affetto ed il rispetto che si deve alle persone per bene. Antonio Landolfi La coerenza R icordare Antonio Landolfi significa, in primo luogo, richiamare la sua personalità: una personalità rara se non unica, quella di un gran signore meridionale di fede socialista. Nulla di più, ma anche nulla di meno. Gran signore Landolfi lo era in tutto, meno che nel censo. Sua la inalterabile gentile cortesia nel rapporto umano e l’inesauribile attenzione che riservava a cose e persone senza alcuna graduatoria di importanza; sua l’irresistibile vena ironica con cui guardava alle cose del mondo; sua la disponibilità a misurarsi con gli altri e anche con chi la pensava diversamente da lui; sua l’indulgenza per gli errori e le deviazioni umane, accompagnata dall’intransigenza totale sulle questioni di principio; sua, infine, e questo è forse l’elemento più importante, la totale gratuità del suo agire politico, mai accompagnato da calcoli di carattere strumentale. La fede socialista accompagna Landolfi per tutta la vita. A cominciare dal suo impegno nella Resistenza dai banchi del liceo-ginnasio Dante (quello di Massimo Gizzio, assassinato dai fascisti sotto i suoi occhi) sino ai suoi ultimi anni di vita. E al socialismo autonomista aderisce (dopo una brevissima esperienza nel PCI) già alla fine de- gli anni quaranta, nelle file dell’Unione Socialista di Cucchi e Magnani, in rotta con l’Urss e con lo stesso PCI senza aspettare le rivelazioni del Rapporto segreto e dei fatti d’Ungheria, ma in nome di una spinta autonomista che il PSI farà propria al Congresso di Venezia. Seguiranno trent’anni di intensa vita politica, in cui Landolfi sarà, via via, oggetto di scomuniche perché esponente della destra socialdemocratica (tra gli anni sessanta e settanta un vero e proprio insulto) e della sinistra veteromassimalista; rimanendo, peraltro, sempre sulle stesse posizioni. Il suo ideale è quello di un socialismo italiano ad un tempo autonomo e unitario. Capace, cioè, di coinvolgere tutta la sinistra su un programma graduale, fortemente caratterizzato sui temi delle istituzioni e dei diritti civili: diciamo un programma di lotta e di governo che (soprattutto nel Mezzogiorno) ha bisogno per realizzarsi e dell’iniziativa del partito e del concorso di tutta la sinistra. In questa prospettiva si legherà a Giacomo Mancini, di cui sarà il principale collaboratore negli anni sessanta e settanta e di cui scriverà una bellissima biografia politica. Sempre in questi anni, Landolfi ricoprirà importanti incarichi di partito- come responsabile della politica economica e della cultura- e sarà, soprattutto, un personaggio di primo piano nelle lotte per i diritti civili, a partire dal divorzio. Ma non avrà mai incarichi di governo, e siederà in Parlamento solo dal 1979 al 1983. Pagherà qui il prezzo della sua fedeltà a Mancini; e quindi di un ritorno alla “opposizione interna” svolto senza alcun eccesso ma anche senza nessuna concessione nel corso degli anni ottanta; ma testimonierà anche, e soprattutto, il totale disinteresse che aveva da sempre accompagnato la sua azione politica. Dopo la catastrofe di Tangentopoli la sua testimonianza sarà , insieme, più forte e più distaccata. Dedicherà cioè tutte le sue energie alla narrazione del socialismo: libri, partecipazione ad innumeri dibattiti, rievocazione, in ogni parte d’Italia, degli artefici della sua storia, dai più grandi ai più modesti, collaborazione a riviste che fanno della rivendicazione dell’attualità socialista la loro ragion d’essere, da Mondoperaio a Ragioni del Socialismo, estrema attenzione alle nuove fioriture del progetto, dall’esperienza blairiana (giustamente rivendicata come segno di innovazione e, insieme, di continuità con il passato del socialismo inglese) a quella del partito del Congresso, sino a quelle del nuovo riformismo sudamericano. Ma rimarrà distaccato dai tentativi molteplici di ricostituire una identità politica ad una comunità travolta da “mani pulite”: e questo senza essere mai tentato da sistemazioni berlusconiane o pi(diess)ine, e senza venire mai meno alla sua fedeltà politica. Giuomondoperaio 3/2011 / / / / memoria //6// >>>> memoria cherà forse, qui, il pessimismo del grande intellettuale meridionale, convinto del futuro della ”idea che non muore”, ma lucidamente consapevole della fragilità dei suoi attuali rappresentanti, o meglio ancora della attuale assenza di un progetto e di una idea forza da cui ripartire. Era questo il suo cruccio permanente. Deve essere anche il nostro. Alberto Benzoni Giuseppe Manfrin La discrezione C i sono persone che, a uno sguardo poco attento, sembrano non aver lasciato traccia della loro esistenza se non tra i propri cari. Non hanno rivestito cariche importanti, ruoli di primo piano, compiuto atti memorabili nel bene come nel male. Discretamente come hanno vissuto, altrettanto umilmente ci hanno lasciati. Giuseppe Manfrin è una di queste persone. Se n’è andato in silenzio, domenica 6 marzo, in gran solitudine e assoluta povertà, dopo aver trascorso gli ultimi mesi in una Casa di riposo a Civita Castellana, nel viterbese, prima che una malattia improvvisa ne interrompesse l’esistenza a quasi 85 anni. Ma l’osservatore poco attento commetterebbe un errore grave nel valutare come trascurabile la sua eredità. Per chi lo ha conosciuto appena un po’ oltre la soglia della superficialità quotidiana Manfrin è difficile da dimenticare. Chi scrive lo ha frequentato quando veniva nella redazione dell’ Avanti! della domenica a portare la sua amatissima rubrica di storia. Aveva sempre amato molto la stampa socialista; era stato vicepresidente dell’Associazione amici dell’Avanti!, e ai congressi era sempre presente nello stand della stampa del partito per dare una mano alla diffusione, per vendere il giornamondoperaio 3/2011 / / / / memoria le, una copia di Mondoperaio, raccogliere abbonamenti e sottoscrizioni. Quella era l’occasione per parlare del socialismo, quello nuovo e quello che non c’era più. Fatti, aneddoti, compagni dimenticati da tutti, ma non da lui. Giuseppe Manfrin era una miniera di storia, non solo quella con la ‘S’ maiuscola, ma anche quella minuta, della quotidianità, dei tantissimi compagni che negli anni avevano contribuito con il loro lavoro, con passione e coraggio all’idea socialista e alla ricostruzione dell’Italia. Lui ne teneva in vita il ricordo e l’esempio, dando così il suo contributo personale e originale a mantenere accesa la fiammella. Un vero e proprio cemento tra i tantissimi compagni che, ognuno per la propria parte, ogni giorno fa ‘politica’, quella vera, sul posto di lavoro, in una sezione, in una manifestazione, a scuola come all’Università, per spiegare che ‘socialismo’ non è solo una carriera pubblica o di partito, ma anche e soprattutto dedizione alla causa della giustizia sociale, della solidarietà, della tolleranza, della laicità, della democrazia e della libertà. Giuseppe Manfrin in questo ci era maestro. Negli anni, prima da partigiano e poi da responsabile dell’Ufficio stampa e propaganda del PSI, aveva conosciuto una porzione importante e vasta del socialismo, del sindacato e della politica italiana. Osservatore attento, colto, aveva collezionato libri e documentazione originale, la stessa da cui poi attingeva per sorprendere i lettori con personaggi ‘veri’, mai citati in nessun libro. Quello che più ci angustia oltre la sua scomparsa è il timore che questo suo prezioso e incessante lavoro resti senza seguito. E un partito, come qualunque uomo, senza memoria non è, non può esistere veramente né avere un futuro. Ci preoccupa la tua scomparsa Giuseppe, ci preoccupa davvero. Carlo Correr Francesco Barocelli La dolcezza D ue anni fa, quando misi mano alla nuova serie di questa rivista, avevo in mente persone come lui. Non in quanto collaboratore (era già malato). In quanto lettore. Francesco Barocelli infatti rappresentava per me l’idealtipo del pubblico a cui volevo rivolgermi. Da giovane era stato il sindaco socialista di Noceto, vicino Parma. Poi aveva seguito la sua vocazione di storico dell’arte: sempre con discrezione, benché professionalmente fosse tanto apprezzato da aver meritato, qualche anno fa, la segnalazione di Flavio Caroli come “miglior critico dell’anno” nella classifica del Giornale dell’Arte. Dal 1983 era funzionario del Comune di Parma, e solo negli ultimi anni aveva avuto l’opportunità di intrecciare il suo lavoro con la sua vocazione, quando gli era stato chiesto di riordinare e dirigere la Pinacoteca Stuard, una delle tante perle nascoste della sua città. Come molti di noi, invece, dopo lo scioglimento del PSI non aveva avuto l’opportunità di proseguire nel suo impegno politico. E se ne rammaricava, insoddisfatto com’era dell’offerta politica della seconda Repubblica. Era un compagno che non aveva niente da chiedere (a me non aveva mai chiesto niente neanche quando occupavo posizioni di potere nel suo campo professionale). Voleva solo poter continuare a discutere coi suoi e nostri compagni qualunque fosse stata la scelta da ciascuno operata nella “diaspora”. Perciò era il nostro lettore ideale. Ed ora che è morto a soli 58 anni questa rivista ha perso un lettore. Luigi Covatta //7// >>>> speciale nordafrica Turbanti, stellette e democrazia >>>> intervista a Gianni De Michelis di Alberto Benzoni, Luciano Cafagna e Luigi Capogrossi Gli avvenimenti del Nord Africa irrompono nel dibattito pubblico con una radicalità che nessuno aveva previsto. Perciò abbiamo chiesto ai nostri tre collaboratori di discutere con Gianni De Michelis degli scenari che si aprono e delle iniziative politiche che si rendono necessarie. S iamo venuti a parlare con te soprattutto stimolati dai recenti eventi intervenuti e in corso nell’Africa mediterranea e nel mondo arabo. Ma prima di entrare più specificamente su tali aspetti, vorremmo partire, se sei d’accordo, dal grande dibattito in corso in questi anni – anche se di carattere accademico più che politico – intorno al destino della democrazia liberale nel mondo. Vi sono da un lato gli ottimisti convinti della naturale capacità espansiva e pedagogica del modello, dall’altra i sempre più numerosi pessimisti che invece guardano all’affermarsi di modelli ‘sovranisti’, di cui la Cina appare l’esempio più evidente, in concorrenza vittoriosa con un Occidente in fase di declino. Tu come ti schieri in questo dibattito? Io mi ritengo senz’altro un ottimista, ma per ragioni che non hanno niente a che fare con i modelli che avete richiamato. Penso infatti che l’elemento decisivo in quello che sta accadendo dall’altra parte del Mediterraneo (e che potrà accadere, seppure in forme diverse, altrove) sia un fenomeno affatto nuovo. Mi riferisco alla forza trainante - in termini di diffusione, di informazione e di formazione - di quella che definirei la ‘rete’: un nuovo tipo di circolazione e comunicazione. Stiamo assistendo – e sto pesando con attenzione le parole – ad un passaggio veramente epocale. In che senso? Qui vorrei partire dai numeri, anche perché rimango convinto che al di là di un certa soglia, la quantità si trasforma in qualità. Penso all’Europa degli inizi del ‘900 e al mondo di oggi. Allora le persone che erano abilitate in qualche modo a sentirsi parte di un’autentica cittadinanza erano una minoranza veramene esigua. Tanto per fare un esempio, le donne erano in quasi tutto il mondo naturaliter escluse dalla partecipazione al voto (solo in Finlandia il voto alle donne è stato introdotto prima dell’anno 1900). Per tacere il peso dei fattori di censo, acculturazione e alfabetizzazione come fattori di esclusione della maggior parte della popolazione europea. Per non dire poi della realtà al di fuori dell’Europa e dei pochi paesi sviluppati a partire dagli USA: lì quasi tutta la popolazione era esclusa da ogni forma di partecipazione, oltre a vivere in condizioni di profonda miseria e assoluta ignoranza, sovente al di sotto del livello di sussistenza. Oggi invece stiamo assistendo a un fenomeno grandioso e sempre più accelerato – ai limiti di una crescita esponenziale – di inclusione di un crescente numero di individui. Penso non solo alle centinaia di milioni di persone che vanno a riempire le fila delle cosiddette ‘classi medie’, dalla Cina, all’India all’America Latina, ed ora alla stessa Africa; ma anche alla diffusione dei nuovi strumenti elettronici che consente al pescatore indiano o al contadino brasiliano di accedere a tutte le informazioni che più direttamente lo interessano. Com’è ovvio, poi, l’economia e la tecnologia si trasforma in opportunità e domande politiche. E qui non sono affatto sicuro che il ‘sovranismo’ sia la soluzione del futuro: quello che so è che la sovranità dei cittadini tende a diventare un’esigenza sempre più forte e insopprimibile. Bisogna anche tener conto che, al di là dei confini del vecchio occidente, abbiamo quasi sempre a che fare con una composizione demografica delle popolazioni con grandissima prevalenza di giovani, più propensi a contestare il presente che a temere il futuro e più capaci di accedere a quelle informazioni che rendono ciò possibile. Tali fenomeni sono in gran parte sotterranei e, a differenza del passato, sostanzialmente privi di connotati ideologici, siano essi occidentali o terzomondisti. Anche per questo si tratta di processi assai difficilmente prevedibili e certamente non classificabili secondo i nostri schemi tradizionali. Cosa conosciamo di queste trasformazioni cui accenni e di quali analisi disponiamo? Conosciamo pochissimo e disponiamo di poche informazioni di prima mano: si è mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica //8// trattato di una colossale distrazione – chiamiamola così – occidentale, anche legata ad un larvato ma durevole complesso di superiorità, confermato dall’11 settembre, ma ben più antico (“dall’Islam non può venire nulla di buono”). E di tale cecità abbiamo testimonianze impressionanti: chi ha considerato nei suoi termini reali un fenomeno di rilevanza mondiale, atto a plasmare coscienze e orientare intelligenze assai più della teocrazia iraniana o di Al Qaeda? Mi riferisco a quel sistema d’informazione di grande rilievo che fa capo alla rete di Al Iazeera. Che questa televisione fornisca servizi e informazione di prim’ordine e non solo per il mondo arabo è ormai assodato. Molti di noi si servono abitualmente del suo canale in inglese per avere informazioni di prima mano altrimenti irraggiungibili. Ebbene, chi ha riflettuto seriamente su tutto ciò? Sul fatto anzitutto che un’espressione di quella cultura e di quel mondo sia in grado di parlare e parlare anche a noi, dirci cose su cui altrimenti saremmo sordi e disinformati. E poi – e soprattutto - che fenomeni del genere non nascono dal nulla e non possono che essere alimentati da un tessuto, culturale e sociale, ben più articolato e potenziamente ricco rispetto alle terribili semplificazioni con cui noi occidentali – esplicitamente i più radicali, tacitamente i più – in genere vediamo il mondo arabo e, in genere, l’Islam. Ti sei avvicinato così al nostro tema: quello delle rivoluzioni arabe e mediorientali. Direi proprio di sì: mi ha colpito in quello che vedo sugli schermi televisivi la totale assenza di slogan e di bandiere, tra l’altro neppure quelle antioccidentali o antisraeliane, e il fatto che oggetto della contestazione siano i regimi più diversi, da quelli definiti moderati e filo-occidentali a quello iraniano, da quelli al potere nei paesi ricchi a quelli al potere nei paesi poveri. Evidentemente ad essere contestata non è la posizione internazionale o la ideologia di questo o quel regime, ma piuttosto la sua opacità e la sua totale sordità ai bisogni della gente. Insomma da tutto ciò discende la difficoltà di interpretare con ramondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica gionevole plausibilità i possibili sviluppi futuri. Certo, per il presente, e come spiegazione di ciò che sta avvenendo apparentemente così all’improvviso, c’è la totale insoddisfazione che un numero crescente di quegli individui di cui parlavamo prima, giunti a un livello minimo di consapevolezza del loro destino e della loro condizione, prova per dei regimi la cui logica appare sempre più, come del resto è, di pura conservazione di un potere esclusivo, con il corollario di arbitrio e corruzione che a ciò è indissolubilmente legato. E qui torno a quanto dicevo a proposito dell’aspirazione di un crescente numero di settori di quelle società ad acquisire una maggiore dignità di ‘cittadini’. Ma in che relazione si pone questa tua prospettiva con il generalizzato – forse un po’ semplicistico – richiamo alla ‘democrazia’ come la soluzione dei problemi politici e di crescita di quelle società? Il punto è che dovremmo avere imparato che non è sufficiente l’esercizio come che sia del suffragio elettorale perché sia in funzione il complesso e delicato equilibrio politico-istituzionale che corrisponde ad una reale democrazia. Anche in Europa è stato lungo il percorso, dalle prime rivoluzioni volte ad affermare uno Stato di di- ritto ed una rule of Law, ai regimi liberali dell’Ottocento ed al suffragio universale del secolo scorso. Sotto questo profilo ciò che si dovrà cercare di favorire, da parte degli Stati Uniti e dell’Europa, è la maturazione delle condizioni istituzionali e delle garanzie formali volte ad assicurare la dignità e la tutela giuridica degli individui rispetto allo strapotere ed all’abuso di un potere politico tendenzialmente assoluto e sottratto ai vincoli della rule of Law. Come sai i regimi arabi, dall’Atlantico sino al Golfo Persico, si sono presentati all’Occidente – ottenendone puntualmente i favori – come baluardi rispetto al pericolo del fondamentalismo islamico. Pericolo non a caso riproposto con angoscia, in questo frangente, da molti opinion makers e politici, italiani, ma non solo. Personalmente ritengo questa alternativa – cioè l’alternativa tra le mostrine e i turbanti – una forzatura pericolosa e fuorviante. E questo per una serie di motivi che vorrei esporre con un minimo di chiarezza. Il primo attiene alla storia, e cioè al ciclo di eventi che hanno caratterizzato i paesi nordafricani nell’arco delle crisi da sessant’anni a questa parte. Ricordiamo che questi paesi hanno vissuto tutti – chiusa //9// con Suez l’era coloniale – un periodo di rivolgimenti e di violenze con l’emergere tumultuoso e reciprocamente distruttivo delle più diverse ideologie: nasserismo, panarabismo, baathismo, mito rivoluzionario palestinese, sino alla proposta dell’Islam come soluzione. Epperò con la fine di quella che chiamerei ‘l’epoca dei torbidi’, l’appeal di tutte queste ideologie è progressivamente scemato; e attenzione, includo tra queste anche quella dell’Islam politico fondamentalista. In questo senso i regimi militari, senza aver risolto nessuno dei problemi che le varie ideologie pretendevano di affrontare, sono stati oggettivamente un superamento delle medesime, garantendo una continuità e una stabilità nel potere senza precedenti nell’area. Quindi, secondo te, l’Islam, malgrado tanti timori, non è più un fattore politico rilevante? Non intendo affatto dire questo. Io penso che è una religione che rappresenta oggi la maggioranza relativa della popolazione mondiale. Essa si articola in diversi filoni ed è percorsa da tensioni e da contrasti che vanno seguiti con il massimo interesse, senza chiuderci nei nostri timori. Non parlo soltanto delle ovvie differenze tra Islam europeo, mediorientale e asiatico, ma anche e soprattutto del dibattito insieme dottrinale e politico che mi pare oggi particolarmente intenso. In linea generale (verrò poi alle distinzioni tra sunniti e sciiti) mi paiono tramontate le alternative drammatiche e distruttive tra gestione totalitaria del potere e distruzione del medesimo in vista del ritorno a non si sa bene quale purezza originaria. All’ordine del giorno, oggi, in queste società in trasformazione, si pone per ogni soggetto politico – componenti islamiche comprese – la scelta tra l’appoggio al vecchio ordine in cambio di specifici vantaggi o l’adesione senza riserve al nuovo corso politico e ai nuovi spazi di democrazia, giocando in questi le proprie carte. E’ molto importante, sotto questo profilo e per comprendere bene ciò che effettivamente si sta muovendo in questo mondo a noi così vicino, che tra i vari modelli di islamismo politico possibile - la Turchia di Erdogan, le monarchie del Golfo e l’Iran di Khamenei – il primo sembra di godere di adesioni maggioritarie e crescenti. E per concludere questo punto, vorrei aggiungere una brevissima riflessione sulla questione sunniti-sciiti. Personalmente ritengo che questi ultimi, anche ma non solo perché minoritari, rappresentino almeno potenzialmente l’elemento di maggiore rinnovamento. Pochi ricordano, in tale contesto, che i maggiori e più coraggiosi oppositori della dottrina khomeinista di un potere assoluto perché derivato direttamente da Dio sono i teologi di Qom. Ma soprattutto vorrei sottolineare la profonda diversità dell’orientamento degli sciiti iracheni, con l’autorità che a loro deriva dall’essere associati ai luoghi santi di questo orientamento religioso: Najaf e Kerbala, sedi della massima autorità sciita, con il grande aiatollah Sistani. E’ qui che ha sede il nucleo centrale di tale posizione: del resto non si deve dimenticare che, nel momento decisivo della vita del nuovo Iraq, fu proprio Sistani a sostenere che la partecipazione senza riserve al gioco democratico era per gli sciiti iracheni non solo un diritto, ma un dovere. Uno degli effetti positivi della guerra in Iraq? Ebbene sì. E qui ricordo, a mio rischio, che sostenni a suo tempo le ragioni dell’intervento in Iraq, pur ritenendo tuttora piena di errori la successiva gestione politica del dopoguerra, a partire dalla liquidazione frettolosa – tornerò su quest’argomento – di tutte le strutture del vecchio regime. Questo per dire – e qui mi permetto di assumere una posizione diversa da quella di Obama – che non sempre le guerre giuste, avallate da una deliberazione dell’ONU, sono necessariamente intelligenti. Così in Afghanistan non siamo riusciti a costruire nulla, anche per la pretesa assurda di imporre modelli occidentali altamente elaborati ad un paese costruito su regole ed equilibri del tutto diversi. Mentre in Iraq qualcosa si sta muovendo nella direzione giusta, anche perché il paese era dotato, prima del disastro finale di Saddam Hussein, di strutture moderne e di una classe media abbastanza strutturata. Vorremmo, a questo punto, approfondire insieme a te un argomento che hai più volte richiamato: quello della imprevedibilità. La nostra impressione è che questo elemento non riguardi solo il passato: il fatto cioè che la rivoluzione mediorientale non fosse stata anticipata da nessuno, ma proprio da nessuno, neanche per il futuro. Nel senso che è molto difficile pensare, come invece avvenne per i paesi dell’Est, a sviluppi lineari del fenomeno. E che per altro verso, rifletta anche, come dire, una sorta d’incapacità di lettura degli avvenimenti da parte dell’Occidente. E’ esattamente così, ed è certamente vero che nel nostro caso l’incertezza dei processi sia in qualche modo accentuata e resa potenzialmente drammatica dalla nostra difficoltà profonda a leggerli e orientarli, almeno nella misura in cui ciò è possibile. I ragazzi che manifestano per le strade di Tunisi, di Bengasi o del Cairo sanno certamente di avere a che fare con un potere capace di ogni azione pur di perpetuarsi. E’ difficile pensare nel nostro caso a quella sorta di ‘compromesso storico’ tra governanti e governati che portò al dissolvimento pacifico dei regimi d’oltrecortina. Assai più facile purtroppo ipotizzare un alternarsi di concessioni formali e repressioni reali. Aggiungo poi che in questo scontro i protagonisti del cambiamento non hanno modelli da adottare, anche perché, incidentalmente, gli schemi occidentalisti non sono utilizzabili. Non tutto insomma si risolve col semplice ricorso alle elezioni e con le maggioranze elettorali. Qui si tratta di costruire una strada che, evitando scontri frontali, faccia nascere passo passo le regole e gli istituti di uno Stato di diritto, e cioè di uno Stato in cui i governanti non possano disporre a loro arbitrio della sorte dei governati. Ecco, questo ci sembra importante: del resto, come tu stesso accennavi poco fa, anche la democrazia liberale in Occidente è il risultato di un lungo percorso e il frutto di una serie di sperimentazioni e di errori. Sembra quasi che, quando ci si occupi della storia altrui ci mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica / / 10 / / si dimentichi in parte almeno della nostra. Sono assolutamente d’accordo: in questo americani ed europei sembra si disinteressino totalmente delle dimensione storica nell’approccio ai problemi del presente; manchiamo nelle nostre considerazioni totalmente di quello che potremmo definire lo “spessore storico”. Questo è un grande errore, giacché ci priva di alcuni importanti riferimenti per comprendere la complessa stratificazione di quella realtà con cui vorremmo e dovremmo confrontarci. E dunque nessuna esportazione della democrazia? D’accordo, ma attenzione a non fare di questa frase un alibi per il nostro disimpegno. Rimango infatti assolutamente convinto che senza una presenza a più livelli degli Stati Uniti e dell’Europa il futuro della rivoluzione araba rischia di essere seriamente compromesso. E qui occorre dirlo, le premesse - insomma ciò che emerge dai nostri comportamenti recenti – non sono affatto positive. Ma qui risalta anzitutto una profonda diversità tra Stati Uniti ed Europa. I primi, almeno con il discorso di Obama all’Università del Cairo, hanno intelligentemente promosso, insieme, la causa della democrazia e quella del dialogo con l’Islam. L’Europa, invece, ha continuato a baloccarsi con l’alternativa ‘regimi militari-avvento dei fondamentalisti’, così da vedere oggi dietro ogni cespuglio gli uomini di Al Qaeda e dietro ogni sbarco il flusso di orde distruttrici. Reazioni queste espresse con particolare vigore nel nostro paese, ma che sono presenti, eccome, anche nel resto dell’Europa. Naturalmente queste reazioni, diciamo, rozze e sfuocate, corrispondono a una lettura sciatta e sommaria degli avvenimenti, e alimentano, in un circuito perverso, una sostanziale rinuncia alla politica. E qui, prima di ragionare insieme a voi sulle radici oggettive della debolezza europea, vorrei esemplificarne alcuni aspetti concreti. Richiamo anzitutto due punti che evidenziano in modo esemplare il nostro fallimento: la questione israemondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica liano-palestinese e la politica euro-mediterranea. Sul primo punto mi limito a richiamare una verità evidente: e cioè il fatto che, senza un concorso esterno, e più in generale senza una più ampia cornice internazionale, il sempre evocato processo di pace non riesce in alcun modo a decollare. Occorrerebbe dunque che la collettività internazionale contribuisse a elaborare i contenuti dell’accordo e soprattutto ad assicurare ai contraenti tutte le garanzie internazionali di cui hanno bisogno. Personalmente ritengo che i processi democratici in atto in queste ore nei paesi arabi avvicinino questa prospettiva: e non tanto per il così sbandierato principio che i paesi democratici tendono a risolvere i loro contrasti pacificamente. Ma piuttosto perché lo stesso Israele è costretto a uscire dal totale immobilismo che ne caratterizza da tempo la politica. Va segnalato che al silenzio prudente di Netanyhau – affatto coerente con la sua tradizionale politica del rinvio – si sia contrapposta la visione sostanzialmente ottimistica espressa da Peres. Ma soprattutto perché i processi in atto rafforzeranno la linea di Obama tendente a porre la questione della pace al centro del futuro dialogo tra America e mondo arabo. Non dimentichiamoci poi che il totale immobilismo su questo punto è stato uno degli elementi che hanno portato alla progressiva perdita di ogni spinta propulsiva al dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Uno degli elementi, ma non il solo? Non il solo, certo. Diciamo però che l’accantonamento sostanziale della questione palestinese ha contribuito alla freddezza araba sul dialogo mediterraneo. Sul problema della pace ,infatti, l’Unione Europea sembra confinata, con il suo tacito consenso, nella veste di ufficiale pagatore, e ciò non è sfuggito a nessuno. In linea generale però il dialogo s’è arenato per tre sostanziali ragioni, peraltro tra loro strettamente connesse. La prima attiene al fatto che i paesi più direttamente interessati – in primo luogo Francia e Italia – o hanno gestito la questione in mo- do declamatorio e strumentale (Francia), o se ne sono sostanzialmente disinteressati (Italia), seguendo in quest’ultimo caso una linea di complessivo disimpegno in atto ormai da diversi anni. C’è da considerare in secondo luogo l’irresistibile ridimensionamento della dimensione mediterranea nel processo di costruzione dell’Europa. Non poteva che conseguirne infine un dialogo progressivamente incanalato – anzi arenato – in una serie di operazioni tra loro sostanzialmente sconnesse in un contesto in cui il dialogo medesimo è divenuto fatalmente un esercizio fine a se stesso. Vorrei allora dedicare la parte conclusiva del nostro incontro all’approfondimento di questi temi. In pratica alle ragioni della perdita dell’orizzonte mediterraneo, o per dirla in altro modo, con l’orientamento dell’Europa lungo un’asse che io ho chiamato ‘euro-baltico’ e che ha al suo centro i rapporti tra la Germania e l’area che la circonda ad Est e a Nord-est. Processo simboleggiato dal fatto che, nei tre mesi successivi alla caduta del Muro di Berlino, la Germania Est è diventata sia pure per tre giorni il tredicesimo stato dell’UE e il primo del cosiddetto “allargamento”. Solo riflettendo su ciò possiamo porci concretamente il problema di come recuperare questa dimensione mediterranea. Ma allora tu pensi ad una scelta deliberata e formalizzata dell’UE in tal senso? Certamente no: aggiungo subito però che nell’orientare l’Europa in questa direzione giocano una serie di fattori, eventi, comportamenti specifici, ragioni strutturali che spingono tutti nella stessa direzione. Per discutere in modo adeguato occorrerebbero naturalmente dieci interviste come questa. Mi limiterò pertanto ad elencare e descrivere tali fattori in modo affatto sommario. Comincerò col dato forse più ovvio, al quale del resto ho già accennato. Dal fatto cioè che i potenziali avvocati della, causa mediterranea, sono, diciamo così, impari al loro compito. Lo è in primo luogo il nostro paese, per una serie di ragioni che / / 11 / / è inutile ricordare e che attengono essenzialmente alla sua storia interna di quest’ultimo ventennio e si traducono nella duplice direzione della sua perdita d’influenza su scala europea e del suo crescente disinteresse per qualsiasi tipo di progettualità internazionale (facendo salvo il piccolo cabotaggio, talvolta fruttuoso, ma sempre irrilevante). Lo è la Francia, volta sempre più a salvaguardare la sua grandeur, proiettandola in ogni direzione, tanto da non riuscire veramente efficace in nessuna. Lo è la Spagna, per la quale l’altra sponda rappresenta più un problema che una risorsa e che, anche per questo, guarda al di là dell’Atlantico, più che del Mediterraneo. Si aggiunga poi a tutto ciò la particolare crisi economica che ha investito la Spagna, che ne ha ulteriormente indebolito la posizione. Ci sono poi gli eventi dei primi anni ’90: e parlo di Maastricht e della guerra in Jugoslavia. Non è necessario riproporre qui il dibattito che accompagnò allora la firma del trattato e le modalità con cui si addivenne ad essa. Mi limito semplicemente a dire che l’avere inserito nei cosiddetti parametri (cosa che soprattuto grazie a Carli eravamo riusciti ad evitare a Maastricht) il debito pubblico pregresso, come è successo al momento dell’entrata della lira nell’euro, ha posto particolarmente il nostro paese in una situazione di oggettiva e permanente inferiorità, non solo per quanto riguarda i margini della sua politica economica, ma anche nel più generale suo rapporto con l’Europa e in particolare con la Germania. Per quanto riguarda poi le vicende che portarono alla deflagrazione dell’ex Jugoslavia, non è il caso di riaprire qui antiche polemiche, magari per piangere su occasioni perdute che forse non c’erano. Mi limito a fotografare la situazione veramente illuminante che scaturì dal conflitto: una situazione in cui, conformemente alla vi- sione che la Germania aveva dell’Europa, i confini a Sud dell’Unione coincidono con la Slovenia, mentre ne rimane, e ne rimarrà fuori per chissà quanto tempo, tutto il resto dei Balcani occidentali, salvo forse (e auspicabilmente) la Croazia. E vengo adesso alle scelte di fondo; cioè a quelle che riguardano l’assetto interno e i confini esterni: tradotto in ‘politichese’ europeo, le questioni dell’approfondimento e dell’allargamento. Qui l’errore compiuto mi sembra nella sostanza quello di aver dimenticato la regola aurea secondo la quale i due processi avrebbero dovuto procedere rigorosamene all’unisono; invece l’allargamento si è realizzato solo nel 2004 e l’approfondimento con il trattato di Lisbona solo alla fine del 2009. Con il risultato di aver perso qualsiasi spinta propulsiva e qualsiasi vera capacità di progetto sull’uno e sull’altro fronte. Né è stata sufficiente a mascherare tale impasse il gioco di illusioni e fumisterie che ha mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica / / 12 / / segnato la stagione della cosiddetta ‘Costituzione europea’. Basti considerare la situazione di oggi per capire di cosa sto parlando. Siamo infatti in una condizione in cui il progetto federale appare privo di qualsiasi sbocco reale, mentre per altro verso il processo di allargamento, concepito come ‘inserimento degli uguali’ assicurando la effettiva omogeneità dell’intero sistema, è riuscito ad inserire i paesi della Mitteleuropa e dell’area baltica, mentre segna sostanzialmente il passo per quanto concerne il Sud e il Sud-est del nostro continente. Pensare in queste condizioni all’entrata della Turchia (oltre tutto in un contesto in cui vale la regola dell’unanimità) così come dovrebbe essere soprattutto in un momento come questo, rischia di diventare una pia illusione. E’ dunque necessario, secondo te, cambiare il modello? A mio parere, sì. Si potrebbe pensare, a questo riguardo, a forme d’integrazione più articolate che vadano dai due estremi di ‘progetti federali’ attuati da singoli gruppi di Stati, sino a modelli di tipo confederale che potrebbero facilitare grandemente l’allargamento dello spazio europeo, segnatamente con l’entrata della Turchia, che a mio modo di vedere rappresenta sempre il passaggio decisivo di qualsiasi strategia europea degna di questo nome. Senza di ciò, occorre essere chiari e dirlo ad alta voce, lo scenario che si aprirebbe e forse si aprirà sarebbe catastrofico per il futuro del nostro Continente. Esso si ridurrebbe ad uno spazio chiuso e asfittico, incapace di qualsiasi rapporto reale – adeguatamente comprensivo/competitivo - con il mondo con cui confiniamo a Sud e a Sud-est. Qual è la tua idea per rovesciare tale situazione? A mio parere occorre a questo punto porre la questione in modo deciso e in sede politica. Noto che nei prossimi tempi l’UE definirà le regole del suo assetto economico e finanziario nella logica del rafforzamento della disciplina di mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica Maastricht. E’ questo un appuntamento a cui il nostro paese non può evidentemente sottrarsi. Ma niente e nessuno potrebbe impedirgli d’iscrivere questo accordo in un contesto politico più ampio, ponendo all’ordine del giorno, dell’UE in generale e della Germania in particolare, l’esigenza centrale di un disegno euro-mediterraneo e cioè di un riequilibrio generale dei suoi orizzonti internazionali. Non è un progetto troppo ambizioso per l’Italia? Ambizioso e se volete anche un po’ velleitario, almeno nella attuale situazione. Però voglio aggiungere che si tratta di un passaggio assolutamente necessario, almeno per il nostro paese, perché l’Italia ha assoluta necessità, e non solo per i problemi che si sono spalancati sull’altra sponda del Mediterraneo, di riportare il peso della politica europea da Nord-est verso Sud-est. Certo la nostra situazione di partenza è difficile e squilibrata: mi ricorda quella – lo dico per fare un esempio – dei sindacati che nel corso degli ultimi vent’anni hanno ripetutamente firmato “patti sociali” o “patti per l’Italia” di cui abbiamo persino dimenticato il conto. Identico, infatti, è lo schema che si potrebbe suggerire: da una parte c’è chi assume un impegno concreto, e almeno in una prima approssimazione esigibile (per i sindacati fu la autodisciplina nelle richieste salariali, per l’Italia, oggi, sarà il rientro dal debito); dall’altra una controparte che assume impegni generali e generici, sicuramente difficili da verificare, per non dire da esigere. Insomma, applicando questo schema al caso che ci interessa, ci rendiamo immediatamente conto di come lo squilibrio tra le parti sia ancora più clamoroso: perché da una parte ci verranno richiesti, nel nuovo e ancora più cogente patto di stabilità, impegni quanto mai vincolanti e collegati a meccanismi sanzionatori; mentre la richiesta di vincolare l’Unione ad una politica mediterranea, anzi ad una dimensione mediterranea, sembra perdersi nel futuribile di quelle ambizioni o di quelle proposte che nutrono da decenni il dialogo tra le diplo- / / 13 / / mazie e gli innumeri convegni in cui si disperdono le nostre politiche estere. E’ qui che però l’Italia deve trovare un livello di proposta quanto più possibile efficace: e per esserlo, deve essere ad un tempo molto ambiziosa ma anche molto concreta. Insomma, l’idea di “rilanciare il dialogo” non servirebbe a nulla; mentre richieste specifiche e limitate (come quella dell’entrata della Turchia o di un piano Marshall a sostegno di questo o quel paese o di questo o quel progetto) non varrebbero, di per sé, a contrastare la “path dependence euro-baltica”oramai in corso da tempo. Dobbiamo allora, come dicevo, mirare più in alto. Nel concreto, proporre all’Unione un approccio, rispetto al mondo arabo e mediorientale che abbia come suo punto di riferimento il modello di Helsinki. In che senso, precisamente? Vedo che anche voi faticate a ricordare. Il fatto è che quegli accordi sono stati oggetto di una vera e propria ingiustizia storica: essendo stati prima bollati, dai nostalgici della guerra fredda e dai neocon di qua e di là dell’Atlantico, come un vero e proprio cedimento nei confronti del Cremlino (ricordate la “finlandizzazione”?); mentre, poco più di un decennio dopo, il crollo pacifico del sistema comunista veniva attribuito, tutto intero, all’azione del papa e di Reagan. Ricordo, allora, che i patti di Helsinki, nel 1975, furono sottoscritti (una novità che non tutti apprezzarono) anche dalla Santa Sede (nella veste di Agostino Casaroli). Questa, come sempre, vedeva lontano: tanto da percepire, con estrema lucidità, che intese apparentemente (ma anche formalmente) costruite a difesa dello status quo potevano, invece, diventare un potente strumento di cambiamento. Avrei, personalmente, molte altre considerazioni da fare sull’argomento. Ma siccome stiamo parlando non di rapporti Est-Ovest ma di rapporti Nord-Sud ( o, per essere più esatti, tra nord-ovest e sud-est) mi limito a ricordare che gli impegni comunemente assunti dai firmatari del trattato si articolavano in tre distinti settori. Avevamo così il riconoscimento pieno degli equilibri territoriali e politici scaturiti dalla seconda guerra mondiale (leggi soprattutto Germania est), con l’inviolabilità dei confini esistenti. Questo punto tranquillizzava il Cremino e gli permetteva di assumere gli altri due impegni, soprattutto il terzo. Il secondo impegno era infatti per esso meno compromettente, riguardando lo sviluppo dei rapporti economici tra mondo comunista e occidente (leggi concorso alla crescita e alla riqualificazione economica dei paesi dell’Est). Ma, soprattutto, in tal modo le parti potevano sottoscrivere la terza e fondamentale garanzia per la libera circolazione di persone e idee. Fu questo il formidabile meccanismo che erose progressivamente le molteplici cortine di ferro che imprigionavano individui e cervelli, e che crearono le irreversibili garanzie per la libera manifestazione del dissenso. Perché richiamo questo schema? Lo faccio perché lo ritengo estremamente pertinente come obbiettivo ultimo di un dialogo mediterraneo e mediorientale che, senza questo ancoraggio, rischia di perdersi nel nulla. E lo ritengo pertinente perché pone il dialogo su basi concrete e paritarie; con obiettivi e vincoli che significano qualcosa per tutti i contraenti. Vuoi fare qualche esempio? Certamente. Considerate il “primo cesto”; quello della sistemazione delle questioni territoriali. E che significa, in chiaro, impegno ad una soluzione collettiva, concordata e internazionalmente garantita delle questioni israeliano-palestinese e cipriota. Il “secondo cesto”, lo sviluppo dei rapporti economici, non ha bisogno di ulteriori delucidazioni. Faccio qui osservare sommessamente che le previsioni sullo sviluppo del mondo formulate da esperti e in sede ufficiale assegnano al mondo arabo e anche all’Africa sub sahariana crescite quantitativamente e qualitativamente assai significative, a fronte di un tendenziale declino per un continente europeo che tendesse a chiudersi in se stesso. E aggiungo, per concludere, che il capitolo “libero movimento di idee e persone” avrà a che fare con molte libertà: e con libertà, come quella di emigra- re, che riguardano anche noi. Personalmente ritengo che questo sarà il problema principe dei prossimi decenni, e che sia meglio negoziarlo collettivamente e in un quadro multilaterale piuttosto che gestirlo da soli e in una logica difensiva che forse garantisce la gestione politica del problema ma non certo una sua gestione razionale. Riconosco in conclusione che proporre un Helsinki mediterraneo all’Unione, così come essa è, e per iniziativa di Stati che sono quello che sono, può suonare utopistico. Ma ci sono circostanze in cui la “volontà politica ”ha bisogno dell’utopia”, come tra l’altro ha ricordato Joschka Fischer in una recente conferenza sul futuro dell’Europa. Chiudiamo da dove avremmo, forse, dovuto cominciare; e cioè dai rapporti tra Italia e Libia. Quelli di ieri ma soprattutto quelli di oggi e di domani. Dico subito che la questione ha bisogno di un approccio bipartisan. Quello che con diverse accentuazioni, c’è stato ieri. E quello che occorre ricreare oggi. Prendendo in considerazione non le nostre opinioni ma le necessità obbiettive del nostro paese. La situazione è gravida di pericoli. Che però non sono quelli dell’emirato, califfato, qaedismo e via discorrendo. E nemmeno dell’arrivo di un’orda di barbari nel nostro paese. Il rischio, tanto più grave quanto più l’attuale crisi si prolunga, è quello del buco nero; dello “Stato fallito”; di una nuova Somalia alle nostre porte. Ed è un esito tanto più probabile quanto più l’attuale conflitto si estende e si acuisce finendo con il distruggere, in un paese che a differenza dall’Egitto o dalla Tunisia non possiede, a partire dall’esercito, strutture o istituzioni collettive cui fare ricorso, e manca quindi di ogni possibile futuro unitario. Di qui l’assoluta necessità di promuovere, anche e soprattutto attraverso una fattiva iniziativa internazionale, forme di intesa e di aggregazione le più vaste possibili, così da assicurare un passaggio per quanto possibile concordato al “dopo Gheddafi” che comunque prima o poi ci sarà. mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica / / 14 / / >>>> speciale nordafrica La collera e la politica >>>> Antonio Badini S embrava che il Mediterraneo fosse ormai proteso a recuperare il ritardo di sviluppo rispetto ai più dinamici scacchieri asiatici e latino-americani, ed invece una miscela di protesta sociale e anelito di libertà, soprattutto delle giovani generazioni, é riuscita a far saltare i lucchetti di un dispotismo rivelatosi finora impermeabile alle periodiche scosse del dissenso interno, agli appelli delle NU e alle sollecitazioni dei grandi Donatori, soprattutto l’UE, la cui pochezza politica é apparsa sempre più chiara dopo i fuochi fatui sprigionati dalla Dichiarazione di Barcellona del novembre 1995. Nel sorprendente risveglio arabo, un misto di guerra del pane e di Nahda, non hanno svolto un discernibile ruolo né le correnti fondamentaliste musulmane, né tanto meno la strategia eversiva di Al Qada. In Tunisia e in Algeria (ma soprattutto nella prima), i due teatri all’origine del sommovimento popolare, il detonatore é stato il grave malessere sociale di una gioventù senza futuro, molto spesso a causa di una istruzione obsoleta e lacunosa, e per giunta imbavagliata da un potere maldestro e corrotto, impregnato di nepotismo e tributario di un servilismo rassicurante delle sfere alte e medie della dirigenza amministrativa ed economico-finanziaria. E tuttavia é quanto mai verosimile che la militanza religiosa si farà trovare pronta al momento in mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica cui si tratterà di incassare i dividendi politici della protesta. Ciò che ha maggiormente colpito gli analisti é stata la ignominiosa e inopinata uscita di scena di Ben Alì, il quale, sebbene governasse con il pugno di ferro, era accreditato di essere riuscito ad introdurre in Tunisia un modello sociale relativamente avanzato, con un diritto di famiglia sganciato dalla Sharia, e il conseguimento di risultati apprezzabili in tema di pari opportunità. La Tunisia appariva all’osservatore occidentale un paese certamente con poche libertà politiche e sotto il controllo asfissiante di un onnipresente apparato di sicurezza, ma con un governo economico relativamente efficiente, capace di dischiudere soddisfacenti potenzialità di espansione per la classe media e una crescita di aspettative di affermazione per numerose categorie professionali. Evidentemente la percezione non era del tutto accurata, forse perché, almeno in parte, oscurata da relazioni compiacenti con politici, media e uomini di affari occidentali, preoccupati più di trarre vantaggi immediati che non di scandagliare la verità sui punti di debolezza del despota tunisino e della sua «ampia e famelica famiglia». E tuttavia al momento del suo insediamento nel 1987, favorito da Francia e Italia, Ben Alì appariva fatto di ben altra pasta. Egli fu lesto ad avviare una campagna di sradicamento dell’islamismo, che sembrava pronto ad approfittare dell’incipiente evanescenza di un Burghiba ormai gravemente malato e soggiogato anche lui da una moglie arraffona. L’impressione fu che, mettendo in prigione o costringendo alla fuga migliaia di attivisti islamisti, riuscisse a preservare prima e rafforzare poi un sistema laico e moderno, sfidato da Rashid Gannouchi, il capo carismatico dell’allora nascente “islamismo d’occidente”, che all’inizio sembrava meno insidioso di quello d’oriente dominato dai Fratelli Musulmani, ma che ben presto doveva rivelare, con la insurrezione nel 1994 in Algeria, una terribile escalation di violenza. E’ stato in verità soprattutto il dilagante nepotismo di famiglia, assortito da ben protette operazioni di speculazione immobiliare riconducibili al disinvolto affarismo della consorte dell’ex capo dello Stato, che hanno col tempo corroso e poi compromesso l’intelaiatura di un modernismo forse ancora fragile ma che aveva saputo attrarre ragguardevoli flussi di investimenti industriali e di turismo. La Tunisia era un paese candidato a varcare nel vicino futuro la soglia del mondo sviluppato, con un reddito pro-capite non lontano dai 10 mila dollari annui. Dipenderà ora dagli sviluppi istituzionali della crisi se potrà riprendere il sentiero / / 15 / / della crescita sostenibile, auspicabilmente in un quadro di ritrovata stabilità, maggiore democrazia e certezza del diritto: un diritto, va detto, che sembrava tra i più avanzati della regione, sia pure venato di scarsa etica e di iniquità sociale. La sorpresa egiziana Il subitaneo dilagare della protesta in Egitto e l’incertezza con cui essa é stata affrontata da un apparato di sicurezza sorprendentemente colto di sorpresa ha fatto parlare gli osservatori di un probabile effetto domino su di una regione che poggiava la sua stabilità su autocrazie spesso poco illuminate e sorrette soprattutto dalle Forze Armate. Di fatto così é stato, soprattutto dopo l’ondata crescente della protesta in Egitto, una protesta che grazie ai social networks e ai movimenti universitari o collegati con gli ambienti accademici é emersa come un fiume in piena, compatta e organizzata, che ha trovato nella grande Piazza Tahrir uno punto di raccolta tanto strategico quanto scenografico. Anche nel paese dei Faraoni la rottura degli equilibri interni é stata subitanea, sebbene la tempra e il prestigio internazionale di Hosni Muba- rak abbiano reso più complesso e drammatico l’atto del suo dimissionamento da parte di una piazza rivelatasi più intransigente e determinata di quanto fosse lecito attendersi. Il Rais é stato la seconda vittima della «rivoluzione dei gelsomini», una vittima invero assai più illustre della prima per il ruolo decisivo unanimemente riconosciutogli dall’Occidente nell’avere ostacolato il processo di proselitismo dei Fratelli musulmani nonché nell’avere risparmiato alla regione terribili e sanguinose sequenze dell’irrisolto conflitto arabo-israeliano. Invero Obama, dopo qualche esitazione iniziale non ha avuto scrupoli a far capire all’incredulo Mubarak che il suo tempo era scaduto e che egli doveva fare un passo indietro di fronte all’avanzata delle forze della libertà e della democrazia. Con rischi, tuttavia, che prenderanno consistenza man mano che la svolta epocale nel mondo arabo si dipanerà e investirà presumibilmente la posizione di Israele. Al momento sembra aver perso forza la protesta in Algeria, evidentemente ancora lacerata dagli anni bui di un terrorismo senza precedenti per la ferocia e il crescendo di violenza vissute dal paese maghrebino. E tuttavia il contagio rivoluzionario é ancora latente, pronto a materializzarsi se le condizioni generali dell’area lo dovessero incoraggiare, soprattutto in Cabilia che sta all’Algeria come la Cirenaica sta alla Libia. Forti restano in Algeria il ritardo nell’aggiornamento didattico dell’istruzione e le lacune dell’educazione scientifica a livello universitario, che attenuano le motivazioni allo studio e impediscono ai giovani diplomati e laureati di trovare occupazioni decorose. Nel frattempo in Giordania sono emersi altri contagi, che hanno indotto il Re Abdullah a costituire un nuovo governo per portare avanti le riforme economiche; nello Yemen, dove a gran voce si chiedono le dimissioni del Presidente Ali Abdullah Saleh, da 32 anni alla guida del paese; al Marocco, con la richiesta di istituire nel paese una monarchia costituzionale, che preveda una forma di governo parlamentare. Una richiesta questa che viene rivolta anche mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica / / 16 / / al Re del Bahrain, della onnipotente famiglia Al Khalifa, il quale, di fronte ad una opposizione insistente e tenace dominata dal partito sciita, ha incaricato il figlio Salman Bin Hamad di avviare un «dialogo nazionale» per vagliare le richieste di modifica costituzionale, che nelle intenzioni dell’opposizione dovranno limitare le prerogative sovrane. A preoccupare, nel caso specifico del Bahrain, é la circostanza che la protesta supera le mere motivazioni sociali per investire la legittimità stessa dei poteri sovrani. Il carattere costituzionale della monarchia, sollecitato dall’opposizione, comporterebbe verosimilmente la nascita di un governo parlamentare che sulla base del sistema di rappresentanza proporzionale rischierebbe di essere guidato dal Partito sciita, dato che gli sciiti sono in maggioranza nel paese. Saremmo così di fronte ad uno sviluppo gradito all’Iran, ma che inquieta moltissimo l’Arabia Saudita, paese che testimonia lui stesso manifestazioni di protesta nelle aree al confine col Bahrain, anch’esse abitate da popolazioni prevalentemente sciite. Anche le manifestazioni in Arabia Saudita hanno molto poco di rivendicazioni socio-economiche e molto più contenuto politico, visto che premono per l’allentamento di un potere assoluto, appena mitigato da un approccio tradizionalmente paternalista degli Al Saud. I miliardi sauditi Il problema della stabilità del regno deve essere serio se ha consigliato il Re Abdullah a somministrare, al suo ritorno nel paese dopo una lunga assenza per malattia, prebende e regalie ai propri sudditi che esperti stimano in 36 miliardi di dollari. Ma questo benessere appare sempre di più fittizio di fronte al male oscuro, fatto di noia e alienazione, di cui soffrono molti giovani sauditi, in parte educati all’estero ma privi al loro rientro di opportunità di lavoro adeguate alle loro aspettative. Da credere o meno, i disoccupati in Arabia Saudita sono allo stesso livello di paesi assai meno prosperi come l’Egitto e la Giordania. Gli osservamondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica tori più attenti ritengono che in Arabia Saudita sia irrimediabilmente in crisi il “contratto sociale” a suo tempo informalmente definito con una tacita intesa tra la famiglia degli Al Saud, che da sempre rappresenta il potere temporale, e il clero creato da Abdul Wahab, predicatore del diciottesimo secolo le cui idee e principi di stretta osservanza del Corano e della Sunna costituiscono ormai una sorta di legittimità religiosa alla famiglia reale. Ma anche qui, nonostante i fondi investiti, l’educazione scientifica ha raggiunto livelli inadeguati rispetto ai programmi di ammodernamento tecnologico approvati dalle Autorità competenti. Non vi é dunque da stupirsi delle contromosse di Riad rispetto al dissenso strisciante nella regione che minaccia di erodere il suo prestigio e la sua capacità di influenza. Abdullah ha proposto di varare un grande piano di aiuti a favore del Bahrain e all’Oman, altro paese del Golfo che professa il credo sunnita e in cui hanno preso piede le proteste contro l’asserita illiberalità del Sultano Qaboos bin Said, il quale da parte sua ha già acceduto alle richieste dei movimenti di opposizione, approvando la creazione di 50 mila nuovi posti di lavoro, non si sa quanto stabili, e disponendo urgenti interventi per lottare, ma non si sa come, contro nepotismo e corruzione. Insomma, siamo di fronte ad un crescendo di tensioni sociali che stingono nell’assetto politico-istituzionale dei diversi paesi dell’area, e che sono perciò destinate ad incidere nella lotta da tempo ingaggiata per il sopravvento nella regione del Golfo tra le forze della “moderazione” e quelle che si ispirano al radicalismo, e all’interno di queste ultime tra gli sciiti e i sunniti. In chiaro, la lotta é tra i così detti governi moderati e i movimenti che si richiamano ad Al Qaeda o che sono ad essi associati, come i Taleban, e, in derivazione, tra l’Iran, che punta alla creazione di un’ampia zona di influenza in funzione anti-israeliana e anti-occidentale, e l’Arabia Saudita, che a fronte di linee conservatrici all’interno é invece propensa ad appoggiare una continuata presenza nella regione degli Stati Uniti, e più in generale una politica di aperta amicizia con l’Occidente, nell’assunto che paesi a diversa identità cultural-religiosa possono comunque coesistere attorno ad una piattaforma di interessi condivisi. E’ perciò da attendersi che le onde lunghe dei sommovimenti in atto metteranno prima o poi in discussione gli attuali equilibri regionali col rischio di allargare l’arco di crisi nel Medio Oriente, nel Caucaso e nell’Asia meridionale. Non può escludersi che l’eventuale rafforzamento delle correnti estremiste darà nuovo spazio alla sovversione dell’attuale ordine internazionale e a riconsiderare l’equazione arabo-israeliana. Buio sulla Libia In questo quadro, già problematico e suscettibile di acuire nell’immediato futuro le ostilità fra i due colossi della regione del Golfo Persico, con ripercussioni e ricadute nei singoli paesi dell’area, si innestano incertezze gravide di conseguenze in connessione con l’esito della guerra civile apertasi in Libia, con il rischio che il risveglio arabo prenda pieghe in parte o del tutto opposte all’apertura della regione verso un più marcato Stato di diritto e più genuini processi di democratizzazione. D’acchito ci si é illusi, ignorando la storia e le analisi di qualificati osservatori, che il sommovimento popolare in Libia mettesse presto fuori gioco Gheddafi, che in realtà, dopo un iniziale appannamento, e come era da attendersi, ha reagito all’avanzata degli insorti senza farsi scrupolo sui mezzi da impiegare per restare al potere. Difficile prevedere l’epilogo di un conflitto fratricida che sarà sempre più violento e non breve, visto che sia Gheddafi che gli insorti hanno dichiarato di volerlo combattere fino alla vittoria o alla morte. La Libia é stata sospesa dalla Commissione delle NU sui diritti umani mentre é già partita l’indagine della Corte Penale Internazionale sui crimini di guerra commessi da Gheddafi e i suoi diretti associati, fra cui i membri della sua famiglia, che non hanno esitato a sparare sulla folla. Ma saranno perseguiti anche gli op- / / 17 / / positori se si riscontrerà che anche da parte loro si siano commessi crimini di guerra. Ancora una volta la Comunità internazionale non é riuscita ad impedire l’emergenza umanitaria dovuta ad atti di guerra. Dopo gli eccidi in Ruanda e il massacro di Srebenica, ecco ancora una volta vite innocenti che vengono falciate dalla follia umana e da una guerra che si poteva evitare se i Servizi avessero fatto bene il loro lavoro e se a parlare per primi fossero stati non i gufi che pagano poco il prezzo degli errori ma coloro che sono i più esposti e che avrebbero potuto svolgere una azione calmieratrice, ad esempio convincendo Seif El Islam, il figlio più aperto del dittatore a lavorare da subito per una intesa tra le tribù più rappresentative e prevedendo per Muhammer Gheddafi una sorte non dissimile di quella riservata dalle Forze Armate egiziane a Hosni Mubarak. Con ritardo il Segretario Generale delle NU Ban Kimoon si é ricordato che le intese per interventi umanitari passano anche per le Autorità che esercitano poteri sovrani, e dunque il regime di Gheddafi: altrimenti si fa solo diplomazia gesticolatoria. Insomma, bisognava ricordarsi di Bettino Craxi che volle avvertire Gheddafi dell’imminente attacco americano nel 1986 perché convinto che la sua eliminazione avrebbe scatenato una lotta di successione non diversa da quella che ha portato la Somalia allo stato di frammentazione in cui ora si trova. L’inconcludenza dell’Europa Ancora una volta é mancata all’UE la capacità di approntare una strategia per fronteggiare gli effetti di quel cambiamento che pure essa ha sollecitato e continua a sollecitare nei paesi dirimpettai, rivelando un’inaccettabile lentezza nel processo decisionale e una polverizzazione dei mezzi e meccanismi di intervento, affidati a procedure troppo burocratiche. Accanto a riunioni dei Consigli povere di risultati hanno preso corpo i minuetti degli Stati membri, che in ordine sparso, e facendo più della diplomazia pubblica che della vera politica este- ra, si abbandonano a proposte, pronostici, minacce e condanne che producono, minacciando ma non agendo, l’effetto di far crescere l’intensità del conflitto restringendo di fatto le opzioni di uscita onorevole per chi sarà predestinato a cedere le armi. Cosi é stato per l’azione istruttoria decisa dalla Corte penale internazionale (che ha ulteriormente sobillato la furia distruttrice di Gheddafi); cosi sarà se verrà decisa la zona di esclusione aerea che incoraggerà l’intransigenza dei rivoltosi (e magari senza poi riuscire a farla approvare dal Consiglio di Sicurezza). Eppure, senza merito alcuno dell’occidente, il mondo arabo ha intrapreso, con il sacrificio del sangue e di vite umane, quel processo di trasformazione democratica che l’UE e gli Stati Uniti ponevano periodicamente in cima all’agenda di dialogo con i paesi della regione e come obiettivo cardinale delle politiche di sostegno. Oggi, ironicamente, può forse affermarsi che Obama sia riuscito a porre il Medio Oriente al centro della sua politica estera, come aveva solennemente promesso nel suo discorso all’Università del Cairo nel 2009. In realtà il «nuovo inizio» lo hanno promosso senza apparenti sostegni gli stessi paesi arabi, avviando grazie alle sollevazioni popolari quel processo di cambiamento di regime, perseguito con accanimento, ma senza successo, da George W Bush. Obama ci ha forse messo del suo, ma solo introducendo iniziative e decisioni sbagliate, come il veto posto al Consiglio di Sicurezza alla risoluzione di condanna della decisione di Gerusalemme di riprendere le costruzioni nei territori palestinesi, che ha fatto naufragare il dialogo di pace in un momento assai pericoloso per l’Autorità Palestinese. Ci vuole poco a capire che per Abou Mazen il momento non sia tra i migliori. L’AP é infatti incalzata da Hamas, ormai con il vento in poppa grazie alla revoca de facto della proibizione ai Fratelli Musulmani di svolgere attività politica. Uscito di scena Mubarak, rialzano la testa coloro che guardano alla graduale presa di potere in Egitto delle forze fon- damentaliste, magari inizialmente mediante una coalizione guidata dai Fratelli musulmani, che sarà falsamente rispettosa delle regole della democrazia. Si tratta purtroppo di una ipotesi divenuta ora realistica e non più sbarrata da una sistematica politica di negazione voluta dal vecchio Rais. Con sviluppi facili da prevedere nel tempo, come la supremazia degli islamisti nell’ambito del movimento palestinese e l’alleanza di quest’ultimo con Hezbollah, destinato sempre più a condizionare la politica in Libano per fare del paese dei Cedri una spina al fianco di Israele, al servizio delle tattiche decise a Teheran. Anche in Libano rischia di esserci una retrocessione dell’influenza dei sauditi, ancora oggi fra i più preziosi partner di Saad Hariri, che guida l’Alleanza del 14 marzo imperniata su una intesa fra sunniti e cristiani. E per Israele potranno venire tempi non facili, soprattutto se, come sarebbe lecito, il nuovo mondo arabo si facesse promotore all’Assemblea Generale delle NU di una risoluzione che riconoscesse la statualità della Palestina con il riconoscimento auspicabile di una larga maggioranza di Stati. Ora che il mondo arabo ha fornito le sue credenziali per la democrazia anche Israele deve dare quelle del suo senso di giustizia. E pensare che questa sorta di Intifada nel Mediterraneo e Medioriente é cominciata da un sopruso, stupido quanto indignante, compiuto in un piccolo villaggio nella Tunisia centrale dalle autorità di Polizia nei confronti di un giovane diplomato, Mohamed Bouazizi, costretto a fare il venditore ambulante di frutta e ortaggi per aiutare la propria famiglia, mamma malata, a sbarcare il lunario. Impossibilitato a far recedere le Autorità locali dalla loro inqualificabile confisca del carretto con i suoi miseri prodotti, il giovane Bouazisi ha deciso di compiere un atto estremo di ribellione dandosi fuoco di fronte al palazzo del Governatore. Un atto che ha scatenato la rabbia dei presenti, amici e conoscenti, che hanno subito inscenato una rivolta contro una tetraggine mortale, figlia di un dispotismo senza più regole di equità. mondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica / / 18 / / Tutto é accaduto casualmente, ma con un contagio di collera che ha alimentato la rivolta della gente, soprattutto di migliaia di giovani allo sbando senza prospettive in un paese sigillato dalla sopraffazione dei corrotti e da un nepotismo che negava agli estranei persino lo spazio necessario per vivere miseramente. A quel momento, si era al 17 di dicembre dello scorso anno, non era percepibile uno straccio di disegno politico. Né vi erano stati segnali premonitori che avrebbero potuto preparare una qualsiasi posizione non solo del governo ma anche delle istanze più avvertite della società civile. E’ stato dunque un atto improvviso ed episodico all’origine di una sollevazione via via divenuta un’onda gigantesca che sta facendo crollare regimi rimasti sinora sordi agli appelli di cambiamento. Non si sa ancora se quella sfida, cui hanno aderito le diverse istanze della società tunisina, porterà le forze politiche del paese ad organizzare una dirigenza alternativa capace di rispondere alle aspettative della cittadinanza e a definire un nuovo contratto sociale. Ad oggi le prime schermaglie dei partiti non lasciano intravvedere granché di promettente. L’imperizia del nuovo governo ha suscitato una nuova ondata di proteste che hanno indotto il Primo Ministro, Mohamed Gannouchi, ritenuto troppo vicino al regime di Ben Alì, a dimettersi: un’altra vittoria della piazza, ma per andare dove? Le mimondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica gliaia di giovani e meno giovani che si muovono verso le coste italiane, traghettate dalla criminalità organizzata, farebbero pensare ad una perdurante mancanza di fiducia nei confronti della classe dirigente, che nel tempo potrebbe indirizzare l’opposizione verso forme di radicalizzazione. Ci si chiede se il Rassemblement Constitutionnel Democratique, il partito di Ben Alì, potrà ancora svolgere un ruolo importante nella fase di preparazione per le elezioni presidenziali da tenersi entro sei mesi. Affiora l’interrrogativo sull’ islamismo, rimasto sinora silente ma che era il più ideologicamente motivato e meglio organizzato del Maghreb, più potente dello stesso FIS che figliò nella vicina Algeria. L’instabilità permanente Anche in Egitto il Primo Ministro Shafiq é stato indotto a dimettersi su pressione della piazza che lo considerava esponente della vecchia guardia. E tuttavia le prime mosse di Shafik andavano nella buona direzione di ripristinare la fiducia nel paese, che ha assoluto bisogno di rimettere in moto la macchina della crescita economica, a partire dal turismo. Occorre inoltre un immediato segno di presenza attiva del governo per evitare i disinvestimenti e prevenire percezioni negative degli ambienti della finanza internazionale, con ripercussioni gravi nel mercato del lavoro. Non ci sarebbe niente di più facile di una instabilità di governo per rendere cronica la caduta dell’occupazione e acuire lo sconcerto della popolazione. Sarebbe questo il terreno fertile per far attecchire e crescere l’estremismo e il fanatismo religioso. E’ dunque urgente che l’UE e gli Stati Uniti si dotino di un piano di sostegno organico, in grado di arginare gli effetti a cascata delle turbolenze in atto nella regione e ricostituire un tessuto di fiducia e di condivisione. In caso contrario occorrerà prepararsi al peggio. Se non si riuscirà a dare sicurezza e un minimo di garanzia di sviluppo ai paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, dovremo essere pronti ad accogliere le migliaia di clandestini che continueranno a cercare da noi quella sicurezza e quelle prospettive di benessere che sono parte dell’universalità dei diritti umani da sempre conclamati dall’Occidente. Un’ultima considerazione sul “nuovo inizio” preconizzato in Medio Oriente da Obama nel già citato discorso all’Università del Cairo. E’ stato certamente un discorso emozionante per eloquio e profondità di riflessione e all’altezza della sfida di una riconciliazione tra l’Islam e gli Stati Uniti dopo le lacerazioni provocate dagli atti del suo precedessore, George W.Bush, con la complicità di alcuni leader europei, a cominciare da Tony Blair. Ma l’illusione é durata poco poiché anch’egli ha creduto che il «dialogo delle culture» potesse vivere a se stante, quali che fossero i comportamenti in politica estera, diritto internazionale e globalizzazione dei mercati. La realtà non é così. Difficile conciliare la parità delle culture e dei valori che esse rappresentano fino a quando si sostiene uno Stato relativamente ricco, Israele, che ruba la terra al popolo povero, quello palestinese, sia pure retto da una dirigenza ancora corrotta; e con un‘Europa farisaica, che crede ancora nella politica del bastone e della carota solo quando deve far valere i suoi slogan sui diritti umani più come strumento di diplomazia pubblica che come ben meditata politica estera. / / 19 / / >>>> speciale nordafrica L’eccezione marocchina >>>> Matteo Lo Presti “E ccezione impermeabile” è stato definito il Marocco rispetto ai movimenti di rivolta che hanno sconvolto il Nord Africa, benché tumulti si siano verificati in trentacinque paesi per un totale di quasi centomila abitanti (pare che cinque cadaveri siano stati trovati all’interno di una banca della città settentrionale Al Hoceima; e tra le forze dell’ordine ci sarebbero stati 128 feriti nelle città di Marrakech e Larache). I tumulti ovviamente, secondo fonti governative, sarebbero stati sollecitati da ”provocatori”, ma la stampa aveva plaudito alle manifestazioni convocate via Facebook anche nella capitale Rabat. Il sovrano del Marocco è al potere da 11 anni, pochi rispetto ai 42 di Gheddafi, ai 32 di Abdullah Saleh in Yemen, ai 30 di Mubarak in Egitto, ai 22 di Abdallah re di Giordania e ai 40 di Ben Issa al-khalifa in Bahrain. “Il popolo vuole il cambiamento” era lo slogan più urlato nelle manifestazioni del 20 febbraio nelle città marocchine, nelle quali si invocavano riforme, modifiche immediate della Costituzione per limitare i poteri del sovrano, e un migliore tenore di vita. Inoltre occorre dire che il sovrano del Marocco (Mur-Akush = terra di Dio), tra le ire dei fondamentalisti, ha già realizzato un lungo itinerario di modernizzazione: con l’introduzione di un nuovo codice di famiglia (Mudawana), per esempio, la poligamia diventa più difficile perché alle donne sono garantiti diritti in precedenza ignorati (per divorziare occorre la sentenza di un tribunale civile, la violenza sessuale diventa un reato penale, e l’età minima per i matrimoni è spostata da 15 a 18 anni). L’Unione Europea è il maggiore e più importante partner commerciale del Marocco grazie anche agli accordi stipulati nel 1995 dopo la liberazione degli oppositori al regime di Hassan II. Dal punto di vista economico dal 2004 si è registrata una crescita annua del 7% che posiziona il Marocco tra i paesi più floridi del continente nero. L’inflazione è bassa, ma la disoccupazione è rimasta alta (elevata la quota di lavoro infantile nell’artigianato e nell’agricoltura). Il Marocco è ai primi posti nel mondo per la produzione di fosfati e tale ruolo si è rafforzato con l’annessione del Sahara Occidentale. Si estraggono minerali di ferro, manganese, cobalto, piombo, rame e argento. Molto sviluppato il settore agroalimentare (oleifici, zuccherifici), mentre assai importante è l’industria automobilistica, che aiuta ad attirare investimenti stranieri: la Renault prevede investimenti in aumento del 15% nelle officine di Tangeri. Inoltre vengono promesse costruzioni di abitazioni popolari soprattutto a Casablanca, insieme al tentativo di stabilizzare la disoccupazione al 9% creando nel nuovo anno 120 mila nuovi posti di lavoro: parziali risposte all’alto costo della vita, agli stipendi soprattutto degli statali inadeguati per una dignitosa sopravvivenza sociale, e per combattere la piaga dell’analfabetismo, la corruzione e la difesa dei diritti umani. Negli ultimi giorni di febbraio a cura del Cisci (Centro italiano di studi per la conciliazione internazionale) è stato organizzato a Roma, con notevole tempestività, un convegno sulle autonomie nazionali come soluzione pacifica delle controversie, con un occhio di riguardo verso il Marocco che è stato presentato come un paese in cantiere. Le relazioni, tra cui quella dell’ambasciatore a Rabat Piergiorgio Cherubini, hanno mirato a rappresentare gli sforzi che il sovrano ha compiuto per regionalizzare il paese ed avvicinare quindi meglio il popolo al potere politico in un quadro di riforme nient’affatto arretrato. L’anno scorso è stata insediata una Commissione consultiva per la regionalizzazione composta da 22 membri, con l’obiettivo di rinnovare ed ammodernare le strutture dello Stato: ogni regione sfrutterà in modo plausibile i propri punti di forza con meccanismi di solidarietà, di coesione intermondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica / / 20 / / regionale su basi democratiche, di governance del territorio finalizzata allo sviluppo integrato. Il Marocco ha firmato con l’UE un accordo per permettere ai propri prodotti manifatturieri il libero ingresso nei territori dell’Unione (con l’ambizione non velata di venire a fare parte dei 25 paesi della comunità europea), un trattato con gli Usa (zona di libero scambio) per l’esportazione di manufatti, un accordo con la Turchia, la Tunisia, la Giordania, l’Egitto per una somma di 4,5 miliardi di dollari di flussi di investimenti nel solo 2007. Ma non solo: sono garantiti investimenti (15 miliardi di dollari) nell’agrimondoperaio 3/2011 / / / / speciale nordafrica coltura, considerata il motore principale della crescita dell’economia nei prossimi 15 anni; interventi sulle energie rinnovabili e sulle infrastrutture, una TAV tra Casablanca e Tangeri entro il 2015 e un migliore sviluppo dei traffici aeroportuali. Per non parlare del fatto che il Marocco è tra le prime 20 destinazioni turistiche mondiali. Non sono mancati impegni per la liberalizzazione del settore audiovisivo e per potenziare i servizi sociali per quella folta parte della popolazione che vive ancora nelle baraccopoli delle periferie urbane e delle comunità rurali. Così come non è stata nascosta l’urgenza di revisioni in materia di diritti umani: la soppressione della Corte speciale di giustizia, la riforma del codice di cittadinanza, l’adozione di una legge specifica contro la tortura, la riforma della sfera religiosa e la riforma della giustizia. Basteranno questi propositi a tenere lontano dal Marocco i venti delle sommosse rivoluzionarie? Le proposte della classe politica al potere almeno apparentemente sono garantite dal sovrano, che anche nel caso di una rivolta antigovernativa, lo danno tutti per scontato, rimarrebbe al suo posto. C’è da sperare che l’eccezione marocchina resti impermeabile solo al fondamentalismo, ma non allo stimolo delle nuove generazioni. / / 21 / / >>>> speciale / 150° Il cronico caso italiano >>>> Zeffiro Ciuffoletti L a natura delle crisi italiane può sembrare comune a quella di altre nazioni europee, ma ogni storico dovrebbe sapere che i contesti nazionali presentano delle specificità proprie rispetto ai contesti generali. In effetti, tutte le crisi italiane – 1918-1925, 1943-1948, 1989-1992, le tre grandi crisi di regime, per parafrasare il titolo di un libro di Massimo L. Salvadori – sono legate a tre grandi crisi epocali internazionali: il primo dopoguerra, il secondo dopoguerra e la fine della guerra fredda. Tutte e tre queste crisi hanno avuto in Italia ripercussioni così profonde e di tale portata da minare non solo il sistema politico, ma anche gli assetti istituzionali. Tanto è vero che l’uscita da queste fasi critiche ha condotto, in Italia, a veri e propri cambiamenti di regime, e quindi ad esiti non sempre paragonabili a quelli di altre nazioni europee. In questo senso la comparazione con la situazione di altri paesi del continente non è, almeno a prima vista, del tutto legittima, anche se dalla grande crisi della prima guerra mondiale presero corpo, in alcuni Stati dell’Europa, delle ideologie rivoluzionarie che si trasformarono poi in soluzioni totalitarie, come nel caso della Russia, dell’Italia e, infine, della Germania. Eppure anche in questo i contesti specifici giocarono un ruolo rilevante, tanto nella crisi quanto nei suoi esiti. Può sembrare utile, quindi, chiedersi se nelle tre crisi italiane sopra richiamate vi sia qualcosa di comune e specificamente collegabile alle caratteristiche istituzionali, politiche e sociali della storia italiana. La storiografia è ormai pressoché concorde nel ritenere che la formazione dello Stato nazionale fu, in Italia, un evento rapido e fortunato. Tuttavia lo Stato unitario formatosi nel 1861 presentava fin dal suo sorgere una serie di elementi strutturali di notevole debolezza: la cosiddetta questione romana da un lato e la questione meridionale dall’altro. Recentemente la storiografia politica ha insistito su un altro elemento, peraltro collegato ai primi due, ovvero la presenza di forze antisistema, o antistato o, ancora, extraparlamentari, che contribuirono a limi- tare l’area di consenso delle istituzioni e a contrastare il processo di nazionalizzazione delle masse popolari e contadine. In tutta la storia dello Stato italiano si è sempre registrata una forte difficoltà ad allargare le basi di consenso delle istituzioni, e quindi ad estendere il processo di inclusione delle masse nello Stato nazionale. Si è registrata, inoltre, una permanente presenza di forze antisistema, che non solo hanno reso debole l’azione politica delle classi dirigenti, ma hanno anche determinato una patologica estensione della prassi trasformistica sul piano politico-parlamentare. Per questo motivo nella storia d’Italia non si è registrata solo una congenita debolezza del governo, ma anche una permanente difficoltà nel funzionamento del meccanismo di ricambio delle classi dirigenti. Secondo Salvadori questi elementi strutturali avrebbero provocato quelle distorsioni nel rapporto tra forze di governo e forze di opposizione che da sempre caratterizzano la vita politica italiana. La presenza di posizioni ideologiche così radicalmente contrapposte avrebbe impedito – sempre secondo Salvadori – lo sviluppo delle condizioni fondamentali di funzionamento della democrazia, e cioè la possibilità di alternative di governo fondate su schieramenti contrapposti, ma pienamente legittimati. In Italia sono sempre mancate, pur nel succedersi di diversi regimi politici, alternanze di governo normali, cioè rispondenti alle caratteristiche istituzionali e alle regole democratiche. Le crisi internazionali hanno sempre innescato potenti fattori di cambiamento che, in assenza di alternative interne al sistema, hanno finito col generare vere e proprie “crisi di regime”. Le opposizioni politiche hanno infatti sempre avuto per scopo non tanto avvicendamenti di governo all’interno di un quadro istituzionale condiviso, quanto piuttosto la creazione di alternative radicali al sistema vigente. Ciò è accaduto sia durante la crisi del primo dopoguerra, quando l’instabilità e la fragilità degli esecutivi aprirono la strada al fascismo; sia in occasione di quella contrapposizione frontale tra fascisti e antifascisti che sfomondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 22 / / ciò nella tragedia della seconda guerra mondiale e poi nella repubblica democratica; sia, infine, nella crisi del sistema politico che, dopo il crollo del muro di Berlino, è sfociata nella lunga e drammatica transizione aperta da Tangentopoli e poi nel declino della prima Repubblica. Da quindici anni l’Italia è bloccata nella irrisolta riforma del sistema politico e istituzionale che aveva caratterizzato il primo cinquantennio repubblicano. Oggi siamo ancora impegnati in una faticosa contrapposizione di poli o partiti, protagonisti di un bipolarismo distruttivo e incapace di legittimare le forze contrapposte. Queste tendono ad abusare del populismo e della demagogia, contribuendo a corrodere il già debole tessuto democratico di un paese che, invece, avrebbe bisogno di essere governato con efficacia e stabilità. E, magari, con istituzioni e regole adeguate all’oggi. In altri Stati, quando intervengono momenti di crisi, può capitare di fare appello ai motivi e ai valori ispiratori della civile convivenza e alle ragioni di esistenza della comunità nazionale. In Italia, invece, le crisi provocano ulteriori lacerazioni e la storia, invece di unire, si trasforma in retorica, alimentando opposte ideologie. In questo modo, l’Italia procede di crisi in crisi senza mai risolvere i suoi problemi di fondo. Il totalitarismo imperfetto La crisi del primo dopoguerra – come è noto – si concluse con la fine dello Stato liberale e con l’affermazione del fascismo. La guerra era stata insieme un potente fattore di nazionalizzazione delle masse e di radicalizzazione dello scontro politico. La storiografia ha identificato un «biennio rosso» (19191920) e un «biennio nero» (1921-1922), entrambi scaturiti da quell’impasto di sovversivismo ed estremismo denominato «diciannovismo». Pur facendo parte dei paesi vincitori, l’Italia si sentì defraudata nelle sue aspettative, e il mito della «vittoria mutilata» agì da fattore di agitazione nazionalista e fascista. Le difficoltà economiche connesse alla riconversione dell’economia di guerra generarono una situazione di forte conflittualità sociale, che paralizzò i ceti medi, meno protetti rispetto agli operai e ai contadini dalle grandi organizzazioni sindacali. Questa situazione spinse proprio i ceti medi verso il nascente movimento fascista, guidato da un leader come Benito Mussolini, che proveniva dall’estrema sinistra e alimentava ideologie e metodi di lotta apertamente antisistema. Le elezioni del 1919, a suffragio universale maschile, diedero un grande successo al Partito Socialista, che, guidato dai massimalisti e da componenti dichiaratamente rivoluzionarie e comondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° muniste, non era disponibile ad alleanze con le forze democratiche. Solcato da divisioni profonde, il PSI appariva inoltre divaricato rispetto alle organizzazioni sindacali, dominate dai riformisti. I cattolici, che alle stesse elezioni avevano debuttato con il successo del Partito Popolare, erano a loro volta poco propensi ad alleanze con i liberali. Il loro partito non si riconosceva nella tradizione risorgimentale a causa della frattura apertasi tra lo Stato e il Papato all’indomani della proclamazione dell’Unità. La violenza classista sbandierata e praticata dai socialisti e dagli anarchici non fece che alimentare la violenza fascista, e Mussolini riuscì sempre di più ad imporsi come l’uomo dell’ordine e della risposta al disfattismo antinazionale. Nel momento della aperta reazione, dopo il fallimento dell’occupazione delle fabbriche (settembre 1920), il PSI, che guidato dai massimalisti aveva respinto la strategia delle riforme democratiche, si trovò diviso in tre partiti, ma rimase prigioniero dell’immobilismo e dell’ipnosi rivoluzionaria. Il vecchio statista liberale Giovanni Giolitti tentò la strada del trasformismo, cercando di assorbire il Partito Fascista, ma Mussolini, con la marcia su Roma (ottobre 1922), non solo impedì tempestivamente l’alleanza tra forze liberal-democratiche e socialiste riformiste – costituite in partito – ma decise di giocare tutte le sue carte minacciando la guerra civile. Parte della classe dirigente, l’esercito e la Monarchia, così come gli agrari e gli industriali, preferì allora affidarsi al capo del fascismo, nella convinzione che lo Stato liberale non fosse più capace di arginare la rivoluzione e di tutelare gli interessi nazionali. Così, invece che al passaggio dal liberalismo alla democrazia, si assistette alla crisi finale dello Stato liberale uscito dal Risorgimento. Dal 1922 al 1925, nel giro di soli tre anni, si consumarono la fine di un sistema politico e istituzionale e l’avvento di un nuovo regime. Un regime che operò la nazionalizzazione delle masse per via autoritaria e che aprì la via italiana a quello che, per via dei compromessi con la Monarchia e la Chiesa, può essere definito «totalitarismo imperfetto». La seconda crisi italiana, ancor più drammatica della prima, ma dagli esiti positivi, coincide con il crollo del fascismo e con la guerra civile (1943-1945) e la divisione dell’Italia in due Stati contrapposti. Al conflitto aperto tra fascisti e antifascisti fece da sfondo la divaricazione territoriale tra il centro-nord, coinvolto nella lotta di liberazione, e il sud, che venne liberato dalle armate alleate sbarcate in Sicilia nel 1943. Il nuovo Stato repubblicano che prese forma dopo la liberazione attraverso il metodo democratico della Costituente e del suffragio universale esteso alle donne, si affermò grazie alla drastica rottura della forma statuale e governativa di tipo fascista ed in forza di una / / 23 / / guerra civile assai più ampia e drammatica di quelle del primo dopoguerra. Il trauma dell’8 settembre, la guerra fra eserciti occupanti, la guerra civile e la lotta di classe alimentata dal PCI, indebolirono quel poco di coscienza nazionale rimasto dopo il crollo del fascismo, il dramma di una guerra persa e l’abbandono del paese e dell’esercito da parte della Monarchia in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943. La natura della repubblica nata dalla scelta referendaria e dall’elezione dell’assemblea costituente fu determinata dai partiti antifascisti. Quella che sorse fu formalmente una repubblica parlamentare, ma a caratterizzare la vita democratica e a determinare le regole del gioco furono tre grandi partiti di massa, ovvero la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista. Questi, pur avendo approvato il compromesso costituzionale, erano portatori di progetti totalmente contrapposti di Stato, di società e persino di alleanze internazionali. La DC ottenne un vasto consenso nella scelta filo-occidentale e attrasse nella sua orbita i partiti minori, mentre il PCI – il più grande dell’Europa democratica – era caratterizzato da un’ideologia di tipo leninista e da una prassi socialdemocratica, pur rimanendo sempre legato all’URSS e al modello comunista. La «doppiezza» permise al PCI di crescere e accettare la prassi parlamentare mantenendo la sua diversità e utilizzando l’antifascismo come una forma surrettizia di legittimazione democratica. Nonostante il quadro istituzionale democratico, il sistema politico rimase bloccato per tutto il periodo della guerra fredda. L’Italia, ancora una volta, non conobbe una normale alternanza di governo, ma fece esperienza di una pratica di compromesso strisciante che permise al PCI di godere dei vantaggi dello scambio politico-parlamentare e di monopolizzare la protesta sociale. Da qui l’idea degli stessi comunisti di definire il proprio partito «di lotta e di governo». Per vari decenni, complice la guerra fredda, il PCI con le sue organizzazioni di massa – più il sindacato della CGIL – si presentò come forza dell’antistato, considerandosi estraneo a quella che considerava la mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 24 / / «democrazia borghese» o «formale», la quale doveva essere superata in direzione di un modello di Stato e di società socialista e collettivista. La Repubblica dei partiti Pur con questi gravi limiti, la «repubblica dei partiti» e dei compromessi permise alla democrazia di radicarsi all’interno di un paese che viveva la più grande trasformazione sociale della sua storia. Naturalmente non ci fu unanime consenso né sulle regole istituzionali, né sul sentimento nazionale, motivo per cui l’Italia non conobbe nemmeno un patriottismo repubblicano. Il senso dello Stato rimase prigioniero delle logiche di partito e delle pratiche clientelari, attraverso le quali si tenevano insieme realtà politiche, economiche e territoriali molto diverse tra loro. La mancanza di una cultura liberale diffusa si fece largamente sentire nel rapporto tra i diversi centri di potere e i cittadini, mentre la debolezza del potere esecutivo spinse i vari governi, sempre dominati dal partito di maggioranza relativa – la DC – ad attuare costantemente compromessi parlamentari anche con l’opposizione comunista. La democrazia in Italia poté dunque reggersi solo grazie ad una sorta di partito unico del debito pubblico, tanto che a partire dagli anni Settanta lo Stato italiano ha visto crescere il suo deficit in maniera esponenziale. Attraverso una più massiccia presenza dello Stato – e quindi dei partiti – nell’economia, la spesa pubblica italiana è stata, con logica spartitoria, posta a base di una corruzione che, lungi dall’essere attribuibile alla volontà di singoli uomini politici, riguardava – ad esclusione dell’estrema destra – sia i partiti di governo che quelli di opposizione, rappresentando la modalità stessa di funzionamento del sistema. La caduta del muro di Berlino, che segnò il crollo dei regimi comunisti in Europa, ebbe ripercussioni internazionali di notevole portata, ma in nessun caso ebbe effetti dirompenti come in Italia, dove il sistema politico – con la presenza del più grande partito comunista d’Occidente – si era strutturato sugli equimondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° libri della guerra fredda. In realtà, l’Italia era sempre stata l’anello debole dello schieramento occidentale, e la fine della guerra fredda colpì sia il partito di maggioranza relativa, la DC, sia il maggior partito d’opposizione, ovvero il PCI. Il PSI, che avrebbe dovuto trarre vantaggio dal crollo del comunismo, fece l’errore di sottovalutare l’ampiezza dell’insediamento sociale dei comunisti italiani, i quali vantavano una presenza forte negli ambienti culturali, negli assetti di potere del sistema editoriale scolastico e mediatico, e nella magistratura. Gli stessi equilibri istituzionali e politici, compresi i poteri locali, risentivano profondamente sia delle logiche di scambio tra il centro e la periferia che della presenza del maggior partito d’opposizione. Il PCI non era solo un partito centralistico a forte connotazione ideologica, ma era anche un partito-società e una notevole macchina di potere alla quale facevano capo robuste organizzazioni di massa, dai sindacati alle cooperative, dalle associazioni culturali a quelle ambientali. Il PCI aveva inoltre, attraverso le organizzazioni sindacali collaterali, un ingente peso sull’economia pubblica e negli apparati dello Stato. La divisione e la contrapposizione tra democristiani e socialisti – così come tra gli altri alleati di governo – permisero al PCI di guadagnare tempo e di rinviare la resa dei conti sul piano elettorale. Il sistema politico doveva essere modificato, ma nessun progetto di riforma istituzionale o elettorale volto a consolidare l’esecutivo e a correggere gli eccessi della partitocrazia e del parlamentarismo potè trovare un approdo condiviso. Nel frattempo il debito pubblico e la pressione fiscale erano cresciuti in maniera patologica. Vasti settori dell’economia – compresa la piccola impresa del centro-nord, artefice delle maggiori performance economiche d’Italia – non potevano più sopportare i costi della politica e la sua incapacità di avviare un processo di modernizzazione che migliorasse l’efficienza del sistema pubblico e delle infrastrutture e che liberasse le forze della società civile dalle maglie della rendita corporativa e delle protezioni sindacali. Quando si scatenò l’ondata di Tangentopoli nel 1991 ancora le forze di governo detenevano la maggioranza elettorale, ma nel giro di pochi mesi furono colpite una ad una dalle inchieste giudiziarie e dalle campagne di stampa contro la corruzione, che l’ex PCI, per quanto indebolito, decise di cavalcare con grande spregiudicatezza, secondo la logica del tanto peggio, tanto meglio. È ancora presto per fare la storia di quegli anni terribili, ma è oramai assodato che nel paese si scatenò un’ondata di giustizialismo e un movimento di antipolitica del quale approfittarono i partiti nuovi e quelli più estremi, a destra come a sinistra. L’ex PCI – all’epoca PDS – non scelse di trasformarsi / / 25 / / in partito socialdemocratico, ma approfittò delle inchieste che colpivano il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana per intercettare spezzoni degli uni e degli altri, riproponendosi come un partito nuovo senza mai tuttavia fare i conti con il suo passato e la sua vecchia ideologia. Con l’aiuto di importanti settori delle classi dirigenti e del mondo dell’informazione il PDS si illuse di guadagnare la maggioranza dell’elettorato, ma nelle elezioni politiche del 1994 risultò vincente una strana alleanza formatasi intorno a un imprenditore del settore televisivo, Silvio Berlusconi, e al suo nuovo partito, Forza Italia che, con il supporto della Lega Nord e della destra ottenne un imprevisto successo. Gli elettori dei maggiori partiti di governo, privati dei loro antichi riferimenti politici, votarono a favore della inedita coalizione, dimostrando di non credere alle risultanze delle inchieste giudiziarie che avevano colpito i vecchi partiti di governo ma avevano appena sfiorato l’ex Partito Comunista, giudicato invece dagli stessi elettori come parte integrante del sistema di corruzione e di finanziamento illecito della politica. Da allora in poi, per uscire dalla crisi, si è tentato di riformare l’architettura istituzionale e politica della prima repubblica modificando in primo luogo il sistema elettorale nel senso di un bipolarismo che doveva essere antidoto alle alleanze di governo eterogenee e fragili che avevano caratterizzato la vita politica italiana fino alla crisi del 1991-’94. Dal 1994 in poi si sono in effetti susseguite varie riforme elettorali, ma non si è riusciti a modificare, se non in maniera marginale, gli assetti istituzionali della prima repubblica. In compenso si sono avuti tre successi elettorali del centro-destra e due del centro-sinistra. La democrazia dell’alternanza ha funzionato in maniera anomala, e cioè senza quella legittimazione reciproca dei due schieramenti che esiste solitamente nei sistemi bipolari. La governabilità è risultata, tanto con i governi di centro-destra quanto con quelli di centro-sinistra – generalmente molto conflittuali al loro interno – assai debole e, addirittura, ancora più inefficace delle pur deboli performance di governo della prima repubblica. Ancora oggi il paese è in preda alle tendenze populiste del centrodestra e a quelle demagogiche del centro-sinistra. L’estremismo delle antiche ideologie antisistema risorge costantemente e accentua l’ingovernabilità e il declino economico, sociale e morale del paese. In assenza di organiche riforme istituzionali, l’Italia rischia di galleggiare in una crisi infinita. Per questo si può dire che ancora oggi, nonostante il successo apparente di un sistema bipolare, l’Italia non riesce ad uscire dalla crisi della prima repubblica. Il declino Delle tre scelte strategiche utili a superare le degenerazioni della partitocrazia e la debolezza strutturale dell’esecutivo – bipartitismo, federalismo e riforma della Costituzione – nessuna è andata in porto in maniera coerente, e le riforme elettorali si sono avvicendate con effetti peggiorativi. L’antipolitica, costantemente alimentata dai media e dallo scandalismo, ha esaltato il potere del circuito mediatico-giudiziario e della facoltà di arbitrato della Presidenza della Repubblica, della Corte Costituzionale e della magistratura. Dalla democrazia dei partiti si è passati alla democrazia tutelare che, alimentando un conflitto istituzionale permanente, ha ulteriormente indebolito la politica e le istituzioni statuali. Di tale conflitto istituzionale è stato protagonista e vittima un leader anomalo come Silvio Berlsconi, un imprenditore «sceso in campo» per raccogliere l’elettorato dei partiti di governo abbattuti dal potere giudiziario. L’unica riforma istituzionale attuata – e cioè quella del titolo V della Costituzione (2001) – non ha fatto che aumentare la conflittualità e la sovrapposizione di competenze fra i diversi livelli dello Stato: comuni, province e regioni, sono stati tutti messi sullo stesso piano per concorrere fra loro sulle più varie matemondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 26 / / rie, con il risultato di un aumento impressionante della spesa pubblica. Credo che esistano pochi esempi al mondo di conflittualità, e nello stesso tempo espansione, delle funzioni e dei costi della politica e della burocrazia paragonabili al caso italiano. E ci sono altrettanti pochi esempi di debolezza o impotenza a risolvere i problemi economici, politici e istituzionali. Nemmeno l’aggancio all’Unione Europea e all’Euro, che ha ridotto gli interessi sul debito pubblico, diminuendo però anche il valore dei redditi fissi, sembra essere stato di aiuto. Il passaggio dalla vecchia alla nuova moneta, per come è stato gestito, si è anzi rivelato un vero e proprio gioco al massacro, con effetti perversi sul potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni. L’Italia rimane inoltre il paese a più alta pressione fiscale, con una giungla di balzelli che aggravano il costo del lavoro e delle imprese. L’altra faccia di tutto questo è l’altissima evasione fiscale e l’economia criminale. Tutto si tiene nell’insostenibile aumento della spesa pubblica e dei costi della burocrazia e dello Stato. A giusta ragione nel 1995, con Giuseppe Mammarella, pubblicai per la Mondadori un volume dal titolo emblematico: Il declino. Le origini storiche della crisi italiana. Come è noto, i libri servono solo a coloro che li leggono, specialmente quando raccontano storie fuori dal coro o affrontano i lati amari e duri della realtà. Il conformismo e il moralismo sono i migliori ingredienti della demagogia e del populismo: “gli altri” – sempre gli mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° “altri”, specialmente se ricchi come Berlusconi – sono la causa di tutti i mali. Così Berlusconi è diventato un alibi e finanche un problema clinico, oltre che politico, per sé, per «li nemici sui» e per l’intero paese, che galleggia sul secondo più grande debito pubblico dell’Unione Europea e si sviluppa ad un ritmo molto più basso di quello di paesi come la Germania, meglio attrezzati sul piano degli equilibri politici e istituzionali a rispondere – con il ricambio e la stabilità – al mutamento e alle crisi economiche. Si può dire che l’Italia, che non riesce più a generare speranza e lavoro per le giovani generazioni, si è avviata su quella via del non-sviluppo tanto auspicata dai teorici della decrescita che non apprezzano l’idea del Pil. Le persone sensate che ancora si attengono al Pil dovrebbero ricordare che negli anni Ottanta del ‘900 il tasso di crescita medio dell’economia italiana toccò il 2, 55%: negli anni Novanta, quelli della rivoluzione di Tangentopoli, la crescita media del Pil fu dell’1,42%, mentre nell’anno orribile del 1993 essa scese a meno 0.89%. Nei diciassette anni che vanno dal 1994 al 2010, cioè nell’era del bipolarismo, la crescita del prodotto interno lordo si è attestata sull’1%, mentre il rapporto debito-pil è salito al 119%. In sostanza, negli ultimi decenni, con governi di centro-sinistra o di centro-destra, l’Italia ha perso circa 20 punti di Pil rispetto ai suoi più diretti concorrenti. Se non è declino, qualcuno ci dica come chiamarlo. Forse decrescita? / / 27 / / >>>> speciale / 150° Il rosso del tricolore >>>> Bettino Craxi Il 26 aprile 1988 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Urbino. Bettino Craxi tenne una lezione su Giuseppe Garibaldi. Ne riportiamo il brano iniziale L` Italia è ricca di statue di Garibaldi, di vie e di piazze che ricordano quello che veniva chiamato e viene ricordato come l’Eroe dei Due Mondi. Se facessimo un’inchiesta, un sondaggio di opinione tra gli italiani, scopriremmo che questa figura tanto popolare, e così familiare per gli italiani, è egualmente tanto poco conosciuta. Si sa e si ricorda a mala pena che fu il liberatore delle Due Sicilie e il condottiero della vittoriosa impresa dei Mille. Quale fosse la sua personalità, che cosa pensasse, quale fosse la sua fede politica, il suo credo religioso, é in generale assai meno noto. Pochi sanno per esempio che Garibaldi era un uomo di fede religiosa, un credente. Egli fu, nel contempo, un feroce anticlericale giacché vedeva il grande ostacolo sulla via della costruzione dell’unità nazionale rappresentato dal potere temporale della Chiesa e dalla influenza nefasta che il potere temporale finiva con l’esercitare in Europa in contrasto con la rivendicazione di indipendenza e di unità degli italiani. Animo spirituale e religioso, Garibaldi diceva: «Io credo in Dio come credo all’immortalità dell’anima mia» e credeva «nell’immortale cristianesimo». Dal punto di vista politico egli era ad un tempo un uomo di schietta formazione democratica e di accentuata ispirazione socialista. Si era accostato alle scuole del socialismo sin da giovane, anzi giovanissimo. Giovanissimo aveva iniziato a navigare come marinaio sulle navi di suo padre. A ventisette anni, quando era il vice comandante del «Clorinda», una nave da trasporto passeggeri, familiarizzò con un gruppo di esuli francesi che cacciati dalla Francia da Luigi Filippo d’Orléans si erano imbarcati su quella nave. Erano un gruppo di socialisti del- la scuola di Saint-Simon tra cui un famoso oratore e scrittore del tempo che rispondeva al nome di Emile Barrault. Sul «Clorinda» passano insieme, navigando verso l’Oriente, molte settimane e per la prima volta Garibaldi scopre molte delle idee che già circolavano in Europa, particolarmente in Francia, e che venivano definendo un preciso nucleo di pensiero socialista. Nelle sue Memorie Garibaldi ricorda questo importante incontro della sua vita con Emile Barrault, da cui riceve in regalo un libro di Saint-Simon, dal titolo Il Nuovo Cristianesimo. Chi andasse a Caprera lo troverebbe ancora oggi nella stanza dove il Generale morì: era un libro che aveva tenuto con sé tutta la vita. Garibaldi ricorda questo incontro scrivendo: «Allora durante quelle notti chiare dell’Oriente, che come dice Chateaubriand, non sono le tenebre, ma solo assenza di luce; sotto quel cielo seminato di stelle, su quel mare che sembra accarezzato perennemente da una brezza d’aspirazioni generose, noi discutemmo non soltanto di problemi nazionali, in cui si era chiuso fino da allora il mio patriottismo di italiano, ma anche la grande questione dell’umanità». Garibaldi si accosta alla scuola sansimoniana, una dottrina sociale che predicava fondamentalmente la riabilitazione del lavoro attraverso l’emancipazione dei lavoratori. I sansimoniani trattavano altresì una problematica che chiamavano «la riabilitazione dei sensi», che esprimeva una critica ai costumi ipocriti ed eccessivamente puritani dell’epoca in favore di una maggiore libertà sessuale. Era una dottrina che predicava il ritorno all’interezza armonica della natura, una posizione che potremmo correlare all’impegno degli ambientalisti e dei difensori della natura dei tempi nostri. Le teorie di Saint-Simon erano molto diverse da quelle che poi prevalsero nel movimento socialista soprattutto attorno al concetto della lotta di classe. Saint-Simon diceva che nella società ci sono “i produttori”. Essi sono da un lato i capitalisti e dall’altro i lavoratori, gli uni e gli altri sono gli industriali della società. «Les industriels» sono i produttori, giacché gli uni mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 28 / / e gli altri producono, e si contrappongono ai parassiti che sono invece i ricchi, i nobili, i militari, i preti. La classe costituita dagli «industriels» comprende gli intellettuali, gli industriali, i lavoratori, e questi, tutti insieme, debbono trovare il modo di collaborare tra loro perché essi rappresentano il perno e la guida della società. Il sansimonismo, nato in Francia, ebbe una sua importante diffusione anche in Italia, dove influenzò tra gli altri Giuseppe Mazzini, penetrando, alla metà del secolo scorso, nei primi nuclei di teorici italiani che affrontavano la questione sociale. Fu questo il primo approccio di Garibaldi con un mondo impregnato dalle nuove idee sociali. Il sole dell’avvenire La vita di Garibaldi fu dominata principalmente dai fatti militari. Egli fu uno dei generali e dei condottieri che contribuirono in modo determinante ad accelerare il processo di formazione dell’unita d’Italia, ma, parallelamente, e in particolare dopo aver realizzato le sue maggiori imprese, e cioè a partire dal 1860, prende corpo e si sviluppa il suo maggiore impegno politico e sociale. Tutta la sua vita fu dominata dall’ideale e dall’obiettivo della questione nazionale. L’unita d’Italia é per lui l’idea dominante e lo é in misura tale da spingerlo ad accantonare qualsiasi altra preferenza compresa la pregiudiziale repubblicana. Garibaldi fu sempre repubblicano, e tuttavia egli conquista il Regno borbonico in nome di Vittorio Emanuele e lo consegna a Vittorio Emanuele. Che l’abbia fatto, alla fine, volentieri o di mala voglia, é difficile dire. Noi siamo abituati a vedere l’incontro di Teano nel1’agiografia o nella retorica dell’Italia monarchica: l’incontro tra i due uomini che davano vita all’Italia, da una parte Vittorio Emanuele II, il primo Re d’Italia, dall’altra Garibaldi, il Generale vittorioso che gli consegna un regno. I sentimenti che li animavano erano forse ben più complessi. C’è una bella lettera di Garibaldi scritta più tardi e dalla quale si comprende meglio che cosa egli effettivamente pensasse nel mentre consegnava un regno per l’Italia che nasceva monarchica. E’ una lettera in cui scrive, in risposta ai mazziniani che lo avevano duramente criticato: «I mazziniani pretendevano che io, avendo 14 mila uomini stanchi che avevano battuto 50 mila napoletani sul Volturno, in nome della repubblica, affrontassi 40 mila piemontesi». Cioè Garibaldi dice che in realtà egli aveva consegnato il regno perché non avrebbe potuto fare altrimenti, perché diversamente avrebbe dovuto affrontare l’esercito piemontese pronto e deciso alla conquista. Garibaldi si dedica più in profondità alla attività politica dopo l’unita d’Italia. Nel ’64 va a Londra. E’ una circostanza che mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° mette bene in chiaro che cosa rappresentasse allora Garibaldi non solo in Italia ma in tutta Europa. A Londra riceve infatti un’accoglienza straordinaria. Tutti i comitati e le società operaie inglesi si riuniscono e si organizzano perché vogliono dargli, lungo il tragitto dal porto alla città, una scorta d’onore di 100 mila persone. I comitati operai inglesi si recano da Carlo Marx, che in quel periodo era a Londra, e gli chiedono di scrivere per Garibaldi l’indirizzo augurale di saluto. Carlo Marx in una lettera ad Engels dice: «mi rifiutai recisamente». La grande popolarità dell’eroe italiano suscitava molte avversioni e molte preoccupazioni. L’influenza italiana che ruotava attorno al viaggio londinese di Garibaldi fu molto importante per stabilire un contatto più diretto tra i gruppi e le società operaie inglesi e le società operaie, sindacali e mutualistiche che si andavano organizzando sul continente, specialmente in Francia. Ed è l’incontro franco-inglese tra i gruppi inglesi tradeunionisti e i gruppi francesi di scuola sansimoniana e proudhoniana, che getta le basi per la nascita della prima Internazionale dei Lavoratori. Il rapporto tra i democratici italiani e gli inglesi è un rapporto molto importante, anche se non sono buoni i rapporti tra Marx e Garibaldi. Marx considera Garibaldi un borghese, Garibaldi avversa alcune delle fondamentali idee del marxismo. Tuttavia tanto Marx che Engels hanno di Garibaldi un grande rispetto. Lo si deduce bene da una lettera di Bakunin, l’anarchico Bakunin, indirizzata a Marx nel ’65, a Marx che aveva scritto gli statuti della nuova Internazionale, e l’indirizzo inaugurale della nuova Internazionale. Bakunin scrive a Marx: «Secondo il tuo desiderio ho mandato a Garibaldi un esemplare dell’indirizzo dei Comitato Internazionale e attendo una sua risposta». Il che vuol dire che Marx si era preoccupato che il Generale avesse il testo di questo indirizzo dell’Internazionale e desiderava conoscere il suo parere. C’è una lettera di Engels che parla di Garibaldi in modo molto interessante. Ve ne leggo un passaggio, Engels scrive: «L’ultima lettera del vecchio è per noi di un infinito valore. Se i suoi figli sapranno dimostrare in tutte le grandi crisi lo stesso giusto istinto del vecchio, potranno fare molto. Dobbiamo far arrivare con sicurezza le nostre cose al vecchio. Ricciotti dice che viene molto intercettato a Caprera». Garibaldi si trovò nel mezzo di quelle temperie di avvenimenti storici che determinarono la nascita dell’Internazionale socialista. Uno scrittore inglese ha osservato che l’Internazionale socialista, la prima Internazionale dei lavoratori, è nata per quattro fattori fondamentali: l’agitazione degli esuli polacchi, i riflessi della guerra italiana, cioè del Risorgimento italiano, lo sciopero dei lavoratori della edilizia inglesi e la guerra civile americana. Era un insieme di grandi avvenimenti storici, che / / 29 / / avvenivano in diverse Nazioni e che provocavano grandi scontri e grandi lacerazioni, e in questo contrasto di valori e di tendenze, secondo questo scrittore inglese, si creò l’humus, il terreno sul quale fermentarono gli ideali che ispirarono la nascita della associazione internazionale dei lavoratori. Garibaldi si trovò in mezzo a tutti questi avvenimenti. Garibaldi e i suoi sono tra gli appassionati difensori della Polonia: «Dio salvi la Polonia». Garibaldi è il protagonista della guerra italiana. E’ vicino ai comitati operai britannici. Garibaldi ebbe, ed anche questo è assai poco noto, un rapporto diretto con la guerra civile americana, quando all’inizio della guerra civile Lincoln offri a Garibaldi un comando di generale d’armata che il generale italiano rifiutò ritenendo che si trattasse di una guerra tra americani e chiedendo che venisse posto prima con chiarezza il problema della fine dello schiavismo. Quando si fonda l’Internazionale, Garibaldi vi aderisce solennemente e in modo pubblico, introducendo però dei distinguo. Il primo è quello della autonomia nazionale, una specie di anticipazione della questione che è poi riapparsa anche in tempi più recenti e cioè quello delle vie nazionali al socialismo. In questo senso c’è una sottolineatura che è davvero interessante. Spiegando la sua adesione all’Internazionale socialista, Garibaldi dice: «Circa certe idee lontane dall’assentimento dei più noi ci manterremo nell’autonomia nostra, in poche parole noi siamo un ramo dell’Internazionale, bandiera che fu nostra tutta la vita; ma ciò non deve toglierci il diritto di regolarci internamente come vogliamo». Vi aderisce comunque con grande entusiasmo. C’è una famosa lettera al garibaldino Celso Ceretti, in cui Garibaldi pronuncia e scrive la famosa frase: «L’Internazionale è il sole dell’avvenire, che abbaglia e che l’oscurantismo e il privilegio vorrebbero precipitare nella tomba». Però in un’altra lettera ad una associazione operaia nota: «sì, l’associazione internazionale dei lavoratori è il sole dell’avvenire; conviene però non esagerare». Che cosa voleva dire? Garibaldi contrastava l’idea della dittatura rivoluzionaria, contrastava la teoria della lotta di classe, e contrastava la dottrina del collettivismo integrale che erano le idee divenute dominanti nell’Internazionale socialista a partire dalla prevalenza marxista. L’Internazionale socialista nasce sotto l’influenza dei sansimoniani, dei proudhoniani e del sindacalismo inglese, che era appunto un sindacalismo gradualista e riformista, e però poi vede crescere ed affermarsi la prevalenza del pensiero e dell’influenza politica di Marx. Garibaldi rimane sull’altro versante e ne contrasta le idee fondamentali e cioè appunto la lotta di classe, il collettivismo integrale, la dittatura rivoluzionaria. Pesava in questo anche la preoccupazione, soprattutto negli anni in cui la questione nazionale era ancora aperta, di tenere unito tutto il movimento patriottico. Tutti ricordiamo infatti che i giovani della borghesia in molte città, in molte regioni partecipavano in prima fila alla lotta per l’indipendenza e Garibaldi non voleva creare divisioni. Ma nel fondo la sua avversione a questi principi del socialismo marxista era in lui molto radicata e convinta. Gli esageratori Voglio leggervi una frase che fa riflettere. In essa si racchiude il ragionamento semplice con cui egli spiega la sua avversione alla lotta di classe, convinto invece della necessità di dar vita ad un patto sociale. Egli osserva: «Quando lavoro avrà capitale, esso passerà dalla parte dei padroni, di modo che vi sarà continua defezione e continua guerra». Sembra quasi una profezia se pensiamo al capitalismo di Stato e a quello che hanno saputo creare le nuove classi generate dal capitalismo di Stato. Quando il lavoro avrà capitale passerà dalla parte dei padroni, e cioè si formeranno dei nuovi padroni, mentre il problema vero è di far sì che gli uomini tutti perseguano ideali di giustizia e di eguaglianza. Ed ancora si esprime in questi termini: «La società si divide spesso in mangianti e mangiati; fra coloro i quali sfruttano e coloro i quali sono sfruttati; la società spesso si divide in ricchi e in poveri, e il problema é di come togliere ai ricchi per dare ai poveri e non illudere che con un cambiamento rivoluzionario improvviso e con la violenza si riuscirà a far diventare ricchi i poveri e poveri i ricchi». Egli mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 30 / / è un sostenitore dell’imposta unica progressiva, un pilastro delle teorie del socialismo moderno, e cioè dell’uso della leva fiscale ai fini della realizzazione di una maggiore redistribuzione della ricchezza. Garibaldi sostiene la necessità di introdurre l’imposta unica progressiva ai fini di ridurre la ricchezza dei ricchi per redistribuire questa ricchezza tra i più poveri. Ed aggiunge: «non facendoli però poltroni, ma più laboriosi». Era contro il collettivismo economico. L’idea, che divenne poi l’idea dominante, di un socialismo che si sarebbe realizzato solo con il collettivismo; la collettivizzazione dell’economia, la collettivizzazione dei mezzi di produzione e della società. Garibaldi prese posizione aperta contro il collettivismo integrale ed a ben pensare, non possiamo non constatare come questa posizione abbia fatto strada, giacché oggi è difficile ormai trovare tanto chi sostenga la necessità della dittatura rivoluzionaria, quanto chi sostenga la rigida lotta di classe in una società in cui opera uno straordinario cambiamento delle classi e dei ceti sociali, ed è ancora più difficile trovare convinti sostenitori del collettivismo integrale. Parlando ai suoi garibaldini, ormai impegnati nella lotta politica ed orientati in buon numero verso le teorie collettivistiche e che su di lui premevano perché le accettasse come base di una nuova società, Garibaldi risponde: «Non sono pemondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° rò esclusivo nell’essere contro il collettivismo, e se dall’individuo al collettivismo famiglia o a quello del comune, o se non vogliamo fermarci a questo e scendere a un collettivismo maggiore, sia pure: basta che non giungiamo al mostruoso collettivismo autoritario che credo il meno idoneo alla prosperità umana». Si delinea, come vedete, un pensiero che lo colloca sul versante di tutte le scuole principali che propugnano un socialismo umanitario solidaristico di tipo riformatore. E’ interessante il giudizio che di Garibaldi dà Robert Michels, il famoso storico dei partiti, secondo il quale «nelle varie correnti del socialismo italiano Garibaldi preferì le più moderate e le forme di lotta più pacifiche». Enrico Bignami, all’inizio del secolo, lo definisce, «il vero fondatore dell’odierno socialismo antianarchico italiano». Nei suoi scritti effettivamente si possono cogliere spunti polemici molto vibranti nei confronti di quelli che egli chiamava «gli esageratori», insomma i rivoluzionari. Li considerava «esageratori», li giudicava demagogici, mentre l’«Internazionale», scrive, «non é altro che la continuazione del miglioramento materiale e morale della classe operaia laboriosa ed onesta conformemente alle tendenze umane di progresso di tutti i tempi e massime degli odierni». / / 31 / / >>>> speciale / 150° Il dialetto del Re >>>> Antonio Ghirelli L a partecipazione di Vittorio Emanuele II al Risorgimento fu equivoco come equivoco era il personaggio, di cui si favoleggiò perfino che non fosse il figlio di Carlo Alberto, ma un bambino di origine popolana che sarebbe stato sostituito al vero principe morto ancora in fasce, vittima di un incendio nella residenza del nonno. La romanzesca leggenda rispecchiava, probabilmente, la natura rozza e la scarsa cultura del futuro primo re d’Italia e la sua abitudine di esprimersi quasi sempre in dialetto. Ma naturalmente, dati i tempi e la situazione politica dell’epoca, il ruolo che assolse il Sovrano nella complessa vicenda risorgimentale fu egualmente importante, a volte perfino risolutivo, come nella scaltra fermezza con cui rifiutò ai governanti austriaci di rinnegare la firma che allo Statuto del Regno aveva apposto suo padre, anche se era ben lungi dal condividere le oneste inclinazioni liberali di Carlo Alberto. Probabilmente alla fedeltà all’eredità paterna, sbandierata come una prova di fierezza, aveva contribuito anche il calcolo di tranquillizzare gli emigrati democratici o rivoluzionari che si erano rifugiati in Piemonte, dopo il fallimento della prima guerra di indipendenza. Anche il suo rapporto con il conte di Cavour era equivoco, come lo stesso Conte avrebbe confidato a Farini in una lettera privata nella quale scrisse, come racconta Mack Smith: “Il Re non mi ama ed è di me geloso, mi sopporta ministro ma è lieto quando non mi ha accanto … Come rappresentante del principio monarchico come simbolo dell’Unità sono pronto a sacrificare al Re la vita, le sostanze, ogni cosa infine; come uomo, desidero da lui un solo favore: il rimanermene più lontano possibile”. E poiché, a sua volta, il geniale artefice del processo unitario nutriva la stessa diffidenza per Garibaldi e soprattutto per Mazzini, da cui lo dividevano la cultura e il rifiuto della soluzioni estreme, non si va lontani dalla verità se si spiegano molti limiti, molte contraddizioni, molti errori nella realizzazione del Risorgimento proprio con i contrasti di fondo dei suoi artefici: per non parlare della scarsissima conoscenza che tutti loro avevano della realtà culturale, sociale, civile delle popolazioni che abitavano le regioni del Centro e soprattutto del Meridione italiano. Ciò nondimeno, come si diceva, la parte che il cosiddetto “Re galantuomo” recitò nella realizzazione dell’indipendenza non fu marginale, tanto è vero che nella fase più disastrosa del Risorgimento, la “piemontesizzazione” del Sud, Vittorio Emanuele II incarnò personalmente, e direttamente sul posto, il primato della monarchia costringendo in pratica Garibaldi a troncare a mezzo la sua impresa per tornarsene a Caprera con le pive nel sacco, lasciando al Sovrano prima, poi ai suoi rappresentanti il compito di definire una vera e propria occupazione militare dell’ex-regno borbonico che quegli squallidi burocrati paragonarono all’”Affrica”, con due effe: come non si sarebbero sognati di fare neppure i viceré austriaci, che avevano dato ben altra prova tra Milano e Firenze. In qualche modo, invece, Vittorio Emanuele II anticipò Berlusconi sia come leggendario tombeur des femmes che per l’immediatezza dell’eloquio, sia pure in dialetto piemontese. Non fece una brutta fine come il suo successore Umberto I e non fu antipatico e gretto come il suo omonimo col numero 3, ma recitò un ruolo di quelli che a teatro o a cinema si affidano ai caratteristi, lontano mille miglia dalla grandezza di Cavour, di Garibaldi, di Mazzini. Un personaggio provinciale. mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 32 / / >>>> speciale / 150° Il paradigma del Conte >>>> Luciano Cafagna La casa editrice Il Mulino ha ristampato il Cavour di Luciano Cafagna, la cui prima edizione risale al 1999. Ne proponiamo ai lettori un brano particolarmente significativo. L’ opera politica del conte di Cavour ci permette in qualche modo di comprendere meglio alcuni fondamentali «caratteri originari» tuttora presenti – nel bene e nel male – nella nostra storia politica e che questa nostra storia, continuando a svolgersi sotto i nostri occhi e tra le nostre mani, ci ripropone di continuo. Forse fu lui a costruirli e a lasciarceli, quei «caratteri originari», nel bene e nel male, in eredità. Genio, insieme, intelligente e istintivo, trovò subito le piste che c’erano, quelle che altri, dopo di lui, con meno qualità di lui, e a volte a tentoni, non potevano non imboccare. In questo senso fu un creatore perché riuscì a mettere in piedi l’improbabile edificio, ma fu anche soltanto un battistrada, perché in quell’edificio così fatto quelle erano le scale e quelli i corridoi. Sono lezioni, sono ricette, sono piste obbligate, sono solo coazioni a ripetere che una classe politica si tramanda di generazione in generazione? Comunque sia, a volerle prendere come ricette, si tratta di ricette difficilissime da maneggiare, ricette anche pericolose, benché spesso ineludibili. Le ricette dei cuochi troppo bravi sono sempre ricette a rischio. Prima lezione. La storia politica italiana è da sempre - come quando l’Italia non era ancora politicamente parlando Italia - una delle meno autosufficienti, forse la meno autosufficiente fra tutte quelle dei grandi paesi. Frequente, continuo, è il ricorso all’uso di fattori allogeni. Che cosa è un allogeno in politica? Allogeno, letteralmente, è colui che è di nazionalità o etnia diversa da quella cui ci si sta riferendo. Possiamo chiamare allogeni quei fattori o componenti della mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° vicenda politica di un paese che vi entrano o vi vengono evocati dal di fuori. Nella storia italiana, dai tempi del Veltro invocato da Dante, questo accade spesso. Napoleone III fu un caso straordinario di «veltro» strumentalizzato. E anche nella storia successiva ci si aggrappa al favorevole allogeno che sembra offrire, nel momento dato, la storia. Sembra favorevole. Ma, assai spesso, non lo è: non lo era la Triplice, non l’ordine nuovo nazista, non il faro di luce moscovita. Non sarebbero stati, questi – illusioni più o meno generose, ma più o meno anche variamente torbide, di uomini come Crispi, Mussolini, Togliatti – degli allogeni apprezzati da Cavour. Ma lo sarebbe stata, invece, possiamo immaginare, la grande proposta universale democraticoliberale americana di Roosevelt e dei suoi eredi. Lo sarebbe stata quella dell’Europa pacificata e unitaria di Schuman, Adenauer, De Gasperi, Monnet, Delors, Kohl. Più o meno tutti, o quasi, cristiani e non laici e non liberali «doc»? L’ironia della storia vuole che sia stato, nel secondo dopoguerra del Novecento, proprio un politico di parte cattolica – piuttosto lontano dalla cultura di Cavour – a riprenderne al meglio, su questo punto, la lezione: il saggio trentino Alcide De Gasperi con la sua ricostruzione dalla guerra e dalla sconfitta attraverso solide alleanze internazionali. Cavour non si sarebbe certamente scomposto per questo. Altre, caso mai, sarebbero forse le opzioni cristiane che lo avrebbero oggi turbato. Primo fra tutti i caratteri originari e ritornanti di questa storia del «fare Italia», va sottolineata, dunque, l’immersione completa nella vicenda europea, in quella Europa donde ancora le vengono, fino ad oggi, tutte le occasioni da cogliere. A mo’, se si vuole, di «rivoluzione passiva», come avrebbe detto Gramsci. Con questa gamma di esiti: che chi bene, o meglio, ha saputo andare per quella via, è più riuscito; e chi, invece, non lo ha fatto, o lo ha fatto in modo clamoro- / / 33 / / samente sbagliato, è fallito. Crispi, che pure non era l’ultimo della classe, infilò, però, una strada -quella della Triplice Alleanza con Germania e Austria -che, se il paese ci fosse rimasto incastrato, sarebbe risultata tragica, al momento della fine della lunga pace della belle époque, nel 1914. Giolitti gli corresse fortunatamente il tiro; ma rimase a metà: senza pieno coraggio, oppure pensando ad abili temporeggiamenti? Salandra e Sonnino, dopo di lui, impegnando in una guerra (quella del ‘14-18) l’Italia dalla parte giusta, si spinsero, pero, così facendo, troppo avanti? Anche Mussolini, che pur sbandierava una raggiunta personalità non più debitoria dell’Italia verso l’Europa, finì non solo con l’infilarsi nella trappola che portava alla subalternità, ma anche dalla parte sbagliata, e nel modo più rovinoso. Si è detto del fattore allogeno e dell’Europa. Ma vi è poi un secondo tratto del modo di procedere cavouriano che si è rivelato modello o stampo di scadenze ritornanti della storia italiana: quella sua idea, appunto, del ricorso al centrismo, della mobilitazione al centro – un centro inclinato a sinistra di quel tanto che permetta di sottrarlo al vincolo di riluttanze conservatrici e ai ricatti degli estremismi – delle risorse, per fronteggiare i compiti politici più ardui. Un «centrismo» propulsore e dinamico, spessissimo vituperato e dileggiato, in nome di ipotetiche – ma fierissime – scelte radicali. Ma nessuno mai ce l’ha fatta, poi, a concretizzare in positivo scelte siffatte, in un qualche modo che non risultasse, alla fine, disastroso. E neanche a descriverne sensatamente la possibilità. Mentre – per quanto possa dispiacere a una visione romantica della politica – tutto quel che si è costruito in questo paese, un paese dalla adolescenza lunga e faticosa, lo si è fatto con le arti, a volte geniali, a volte solo mediocri, della mediazione e del compromesso, da Depretis-Correnti a Giolitti-Turati, da De Gasperi-Togliatti – che proiettati sullo schermo diventano Peppone e Don Camillo – a Nenni-Fanfani o Moro-Berlinguer fino ai nostri giorni: i quali ultimi, purtroppo, non possono offrire ancora, a quelle arti salvifiche, che nomi dimezzati come il visconte di Italo Calvino. Il «trasformismo» nacque in effetti – come è stato molte volte e giustamente insinuato – col «connubio» cavouriano del 1852, fra una parte della destra e una parte della sinistra. Dopo quella volta il gioco delle alleanze e dei compromessi non trovò sempre la stessa genialità strategica dietro di sé, o la stessa forza propellente: è vero. Ma servì spesso, a salvare, almeno, le situazioni. Bisognerebbe riflettere di più sul fatto che, quando nessuno trovò la forza o l’abilità di ricorrervi, fu un disa- stro. Non è vero, in ogni caso, che l’arte del compromesso sia sinonimo di mollezza, neghittosità, mediocrità: il vero problema della personalità forte, in politica, è l’intelligenza nell’individuare i fini, la fermezza nel perseguirli, l’intelligenza, e anche l’astuzia, perché no?, nell’inventare i mezzi per raggiungerli. Non la faccia feroce alla Mussolini. Non la capacità di trovare l’applauso della piazza. Non l’astratta proclamazione che ci si debba presentare alle scelte dell’elettorato e del paese in competizioni a due, e solo a due, magari senza idee né da una parte, né dall’altra, o con idee pessime da tutte e due le parti, come accadde alla soglia degli anni ‘20 di questo secolo. L’alchimia politica Terzo, infine, e forse soprattutto, nella traccia segnata da Cavour c’è l’importanza, così peculiarmente italiana – anche se, certo, non solo italiana – della alchimia politica, di quella alchimia che tenta di far venire fuori l’oro da una combinazione di metalli vili. Quell’arte, per intenderci, che riesce – quando riesce – ad anticipare cose che non ci sono in natura, e con surrogatorio illusionismo – talora sapiente talora dilettantesco (perché ogni attitudine ha sempre almeno due versioni, o due poli...) – mette assieme pezzi dispersi o frantumati e altri li prende a credito; i «miracoli», appunto, quando i pezzi riescono a tenersi insieme. «Quel grande artefice di miracoli che è il conte di Cavour» - sbotta Massari nel suo Diario, il 3 marzo 1859, dopo aver incontrato nell’anticamera di Cavour Giuseppe Garibaldi: «La spada di Mazzini è diventata spada di Casa Savoia!». Alchimia dei metalli delle spade! Ripensiamo a quel capolavoro di mediazione creativa che mise insieme – facendo da mediatore di «passioni» (nel senso in cui usava questa parola Tocqueville) – paure degli uni, speranze degli altri, ambizioni di questo, impazienze di quello e tirandone fuori, alla fine, una somma maggiore dell’insieme degli addendi. Poi, però, c’è da mettere nel conto anche il debito pubblico. Il debito pubblico – di cui Cavour spregiudicatamente si avvalse come strumento finanziario – è, per la storia italiana, proprio una realtà «originaria», una costante, sia in letterale senso finanziario sia, al tempo stesso, come metafora di una creazione politica tutta da nutrire a credito. Non è un male in sé, ma può diventarlo di brutto. Arte, quindi, quella della creazione politica, difficile e pericolosa, che si esprime in colpi di genio e in espedienti, in compromessi e alchimie, in taluni casi buoni, in altri cattivi: e che, talora, quando male usata, produce anche esplosioni nel laboratorio alchemico, o, mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 34 / / con qualche bluff, velenose tragedie. Non sempre l’esempio cavouriano può dare buoni frutti. Fu, in un certo senso, in questo senso, cavouriano anche Mussolini – stiamo rischiando una eresia oggi politically incorrect, ma a ragion veduta – quando tentò la sua nazionalizzazione forzosa degli italiani attraverso la politica mediatica – meglio diremmo oggi protomediatica – e quando, addirittura, tentò la costruzione di una dimensione imperiale ed egemonica cui mancavano, però, scarpe e fucili. Lo sballo accade, appunto, quando finiamo in una sindrome megalomane come quella rappresentata, con uno scroscio d’acqua ghiacciata, in una lettera di Filippo Turati ad Anna Kuliscioff di cento anni fa (è datata 25 maggio 1899): «Ci immaginiamo di essere la Germania, mentre siamo l’Abissinia». L’arte della politica Cavour saltava sui trapezi. Non tutti lo possono fare. Nell’alchimia cavouriana c’era, al meglio, questa che, tra sofferenze e dolori, incomprensioni e delusioni, «ha fatto Italia» fino ad oggi e ancora la fa: un’arte che cerca di colmare i vuoti, lanciando trampolini fra gli strapiombi. Arte sostitutiva e surrogatoria, dunque, che crea succedanei, o mette pezze, come si dice popolarmente: le mette, o cerca di metterle (e qui fa la differenza fra bianco, se riesce, e nero, se non riesce) al posto di unitarismi, capitalismi, imperi, prestigio, aggregazioni e maggioranze «maggioritarie» - e l’elenco potrebbe continuare – che non ci sono «in natura», o ci sono al di sotto delle quantità necessarie. Tutto questo si può compendiare nell’affermazione – oggi controcorrente – della importanza del «politico» nella storia italiana, come risorsa creativa di questa storia della patria di Machiavelli, e ciò sia come «arte» di élite, sia persino come unificante teatro greco (qualche volta «teatrino»), o addirittura (magari chiassosa) agorà. Perché l’alchimia fa spettacolo. Quindi finisce con l’essere anche miracoloso luogo di incontro comunicativo, magari un po’ troppo frequente alle risse e però, e comunque, in quanto luogo di incontro comunicativo, anche, in qualche modo, luogo di unificazione e «nazionalizzazione» di legami che altrove difettano. Luogo di incontro - nonostante ogni contraria apparenza – fra i pochi e i molti, fra gli have e gli have not, fra i settentrionali e i meridionali, fra i municipali di un municipio e quelli di un altro: fronti opposti che, per ogni altro verso, sono affetti, nei loro reciproci rapporti in questa nostra difficile storia, da «fratture» antiche. mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° Forse gli italiani devono solo imparare ad essere più esigenti e a scegliere meglio fra versioni buone e cattive, migliori o peggiori di questa arte spericolata che li accompagna sin dalla loro nascita e alla quale debbono la loro nascita stessa. Cavour rappresenta, in ogni caso, fuori del mito e della leggenda, su cui stiamo per concludere, il massimo livello virtuoso raggiunto, nella storia italiana, dalle violenze suppletive della politica. L’arte della politica può fare miracoli, ma i miracoli sono di due tipi: le apparizioni e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. L’arte della politica può fare apparire ciò che non era, e permettere di sfruttare gli effetti di siffatte apparizioni, e qualche volta, ma è più difficile, di moltiplicare materialmente pani e pesci. Insomma, senza l’arte della politica molte sarebbero le cose destinate a restare nel limbo. Max Weber scrisse – ed è un motto rimasto celebre perché viene da un grande realista – che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l’impossibile. È bello, però è ottimistico. Perché esistono anche gli apprendisti stregoni. Colui che riesce si macchia immediatamente di una colpa: di incoraggiare a decine quelli che poi combineranno solo guai. / / 35 / / >>>> speciale / 150° Un pensiero moderno >>>> Gianfranco Sabattini L’ eredità ideale e politica del pensiero mazziniano è stata a lungo oggetto di dibattito tra opposte fazioni politiche. Specie in Italia, tra fascismo e repubblicanesimo storico. Già prima del fascismo la cultura ufficiale italiana post-risorgimentale, nel ricuperare la figura di Mazzini alla Storia Patria dopo la denigrazione e l’ostracismo del periodo pre-unitario e dei primi cinquant’anni post-unitari, ha avviato un processo di mitizzazione della figura del rivoluzionario genovese. E ha finito per accettare ciò che faceva comodo del suo pensiero e per rimuovere o sottacere ciò che di esso non era condiviso. Un fatto, questo, che è valso a rendere difficile un’obiettiva valutazione del suo pensiero e il significato della sua azione. Tra i protagonisti del Risorgimento, il pensiero e l’azione di Mazzini non hanno entusiasmato come hanno entusiasmato, invece, l’attivismo di Garibaldi, le capacità negoziali di Cavour o la “baldanza guerriera” di Vittorio Emanuele II. Mazzini, inoltre, non è stato particolarmente amato neanche dai ceti sociali più diseredati, che pure sono stati costantemente al centro della sua attenzione, ed è stato deriso e denigrato da molti socialisti e dai preti. Ascetico, malinconico ed amareggiato dalle molte sconfitte politiche, qualità che gli sono valse l’ironia ed il disprezzo del principe di Metternich, Mazzini ha visto il suo pensiero offuscato dallo stile retorico dei suoi scritti. Tuttavia, a rileggerli oggi, possono sorprendere per la loro straordinaria attualità. E’ stato, infatti, un promotore, difensore, e a volte anticipatore, di molti principi oggi largamente condivisi. È stato fervente sostenitore della forma istituzionale repubblicana, democratica e laica dello Stato, del progresso inteso come crescita materiale e sviluppo culturale della nazione, del comunitarismo in opposizione all’individualismo di stampo liberale e liberista, della compartecipazione del capitale e del lavoro nell’organizzazione e nel governo dell’attività produttiva, dell’equità distributiva e dell’internazionalismo solidale, strumentale allo svi- luppo delle relazioni pacifiche tra i popoli. Ha sostenuto coerentemente e tenacemente tutti questi principi quando spesso di essi si parlava assai raramente nel mondo. Oppure quando ancora di essi non era stata acquisita una precisa formulazione. Mazzini ha ordinato tutti questi principi in un sistema di pensiero coerente, dal quale ha tratto le direttrici dell’azione per quanti hanno voluto impegnarsi per il riscatto dal dominio straniero della nazione italiana, per la realizzazione della sua unità e per il suo rinnovamento sul piano delle relazioni tra i diversi gruppi sociali. Meraviglia, da un punto di vista generale, che molte delle sue intuizioni più lungimiranti, pur essendo entrate a fare parte delle costruzioni teoriche di alcuni dei maggiori scienziati sociali contemporanei, non abbiano trovato riconoscimento alcuno: come se, come è capitato all’illustre autore, dovessero scontare una condizione di esilio perenne. Oggi tuttavia si incomincia a riconoscere che Mazzini è stato una presenza importante nel campo del pensiero politico e sociale del periodo in cui è vissuto (Sarti, 2005). Da un punto di vista più specifico, e relativo al mondo culturale italiano, desta invece stupore il fatto che il pensiero mazziniano sia stato fortemente sottovalutato, distorto o peggio travisato da storici e intellettuali di ogni estrazione. Non solo di formazione monarchica e liberal-conservatrice, ma anche e soprattutto di formazione cattolica e marxista. Desta soprattutto stupore il fatto che quando il Partito socialista italiano nel Congresso di Torino del 1978 ha voluto operare una “svolta” per identificarsi in un socialismo democratico che non si confondesse con la socialdemocrazia e tanto meno con il comunismo, abbia ricuperato il “socialismo utopistico” anarcoide di Pierre-Joseph Proudhon, anziché il “socialismo umanitario” di Giuseppe Mazzini. Il tempo trascorso è ora sufficiente per porre rimedio agli esiti della scelta “opportunistica” di allora e per tentare, sulla base del lascito culturale di Mazzini, un proficuo rilancio dell’idea socialista. mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 36 / / Mazzini non ha mai formulato il “suo” socialismo in termini di sistema onnicomprensivo. Coloro che affermano che Mazzini non è stato socialista (Taviani, 1968; Spadolini, 1982; Lingua, 2005), trascurano che tutte le sue postulazioni sociali, teoriche e pragmatiche, sono confluite nella formulazione di un approccio al problema della liberazione e dell’unificazione dell’Italia, della riforma sociale e del governo dei rapporti tra i gruppi e tra le nazioni che opponeva l’esclusiva cura degli interessi materiali all’affermazione di principi associazionistici, solidaristici e mutualistici: principi, cioè, che sono alla base di qualsiasi organizzazione sociale autenticamente socialista (Parmentola, 1982). Sulla base di questi, Mazzini ha definito il socialismo come movimento di popolo, inteso questo come moltitudini in stato di bisogno che esprimevano le loro agitazioni crescenti per il malcontento contro il dominio del capitale (Belloni, 1982). Sono quindi fuorvianti le accuse rivolte a Mazzini d’essersi schierato a favore degli interessi dei gruppi sociali borghesi. Al riguardo è certamente vero che Mazzini ha cercato di persuadere i ceti medi ad assumere la guida del movimento di liberazione e di unificazione nazionale. Ma è anche vero che gran parte della sua azione è stata volta ad organizzare le forze dei lavoratori, invitandoli ad associarsi per essere forti e resistere alla “tirannia” del capitale. Inoltre è vero che, nello sviluppo del suo pensiero e nell’attuazione della sua azione, Mazzini non ha dedicato ai problemi dei lavoratori dell’agricoltura lo stesso impegno che ha invece profuso per i problemi dei lavoratori extraagricoli. Però non è una forzatura storica affermare che il suo impegno riguardo al miglioramento delle condizioni dei lavoratori delle imprese capitalistiche implicava, implicitamente, l’estensione di tale miglioramento anche ai lavoratori agricoli. Ciò anche in considerazione del fatto che i problemi del mondo rurale in generale, e quelli dei lavoratori agricoli in particolare, non erano estranei alle riflessioni e alle proposte di intervento di altri importanti attori impegnati nel movimento risorgimentale che si rifacevano all’azionismo di Mazzini. Infine è anche vero che nella prospettiva di azione di Mazzini la cura degli interessi dei lavoratori era subordinata alla liberazione e alla realizzazione dell’unità d’Italia. Ma è altrettanto vero che sia la liberazione che l’unificazione erano da lui strettamente connesse al coinvolgimento delle moltitudini più bisognose, attraverso l’impegno a migliorarne le condizioni una volta raggiunta l’indipendenza e l’unità. Per tutte queste ragioni deve ritenersi perciò ingiusta l’accusa spregiativa di essere un servo della borghesia rivolta a Mazzini da Karl Marx e da Friedrich Engels. Come pure quella, rimondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° voltagli anche da molti altri, di essere stato insensibile rispetto al problema delle riforme sociali e di aver riservato attenzione solo al suo “patriottismo borghese”. Queste accuse sono state ingiuste perché per Mazzini la questione sociale è sempre stata in cima agli obiettivi della sua azione politica (King, 1918). Infatti se l’azione politica è stata da Mazzini primariamente orientata al conseguimento dell’indipendenza e dell’unità dell’Italia, tale orientamento era volto a renderla però strumento di riforma sociale. Mazzini e Marx Mazzini affermava che una società socialista realizzata nella libertà fosse la sola forma di organizzazione sociale a poter garantire, nel progresso e nello sviluppo, il rispetto dell’uomo e della sua dignità. Il socialismo che proponeva era gradualista e progressivo, basato sull’associazionismo, sul solidarismo e sul mutualismo libero, spontaneo e volontario di tutti i lavoratori. Secondo Mazzini con un socialismo così inteso sarebbe stato possibile annullare le differenza esistenti tra i vari gruppi sociali, conservare l’istituto della piccola proprietà, sostituire gradualmente il lavoro individuale salariato con il lavoro associato, e ripartire il prodotto tra gli associati secondo il lavoro compiuto. In un sistema sociale così organizzato proprietà e produzione sarebbero state sottratte al libero gioco delle attività e degli interessi individuali, perché sarebbero state organizzate secondo un criterio di convenienza e di giustizia valevole per tutti (Salvatorelli, 1953). Le riflessioni mazziniane alle quali il tempo avrebbe riservato il maggiore successo sono quelle che hanno condotto Mazzini ad una dura opposizione al marxismo, soprattutto riguardo alla compartecipazione (cooperazione) del capitale e del lavoro nell’organizzazione e nel governo della produzione e della distribuzione del prodotto sociale. Nessuno degli ideali predicati da Mazzini era condiviso da Marx ed Engels: non l’unità nazionale, che essi subordinavano alla rivoluzione sociale; non la fede nella democrazia repubblicana, alla quale opponevano la fiducia assoluta nella lotta di classe; non l’umanitarismo, cui contrapponevano una concezione drammatica della vita, che giustificava, per la liberazione degli oppressi, un perenne stato di guerra. Tutto, dunque, divideva Mazzini dagli autori del “Manifesto”. L’armonia e la cooperazione nelle relazioni tra i gruppi sociali proposte da Mazzini risultavano inconciliabili con il metodo della lotta di classe dei marxisti. Al popolo di Mazzini, i marxisti opponevano il proletariato. All’educazione del popolo la / / 37 / / sua autocoscienza. All’organizzazione democratica e repubblicana dello Stato la dittatura del proletariato. Ai diritti degli uomini i diritti degli oppressi. Infine al solidarismo, all’associazionismo e al mutualismo mazziniani Marx ed Engels opponevano la collettivizzazione della produzione; mentre alla distribuzione del prodotto sociale secondo il merito di ogni lavoratore opponevano una distribuzione burocratico-amministrativa. La storia recente, segnando il fallimento del modello di socialismo burocratico-accentratore proprio dei teorici del marxismo, ha consentito di ricuperare il tentativo mazziniano di dare un fondamento teorico all’idea della cooperazione nel mondo della produzione tra i capitalisti e la forza lavoro, attraverso il loro coinvolgimento nella gestione e nel governo dell’attività produttiva e della distribuzione del prodotto sociale tra tutti i partecipanti alla produzione. Modernamente, l’idea del coinvolgimento del capitale e della forza lavoro nella gestione e nel go- verno dell’attività produttiva, ricuperata all’inizio del XX secolo, parallelamente al rilancio del movimento cooperativo, è stato teorizzato da James E. Meade (1989); mentre il coinvolgimento dello stesso capitale e della stessa forza lavoro nel governo della distribuzione del prodotto sociale è stato teorizzato molto più recentemente da John Rawls (2002). Meade, a differenza degli utopisti marxisti che proponevano di realizzare istituzioni perfette per cittadini perfetti, ha dimostrato la possibilità di realizzare, come proponeva Mazzini, un “buon posto in cui è conveniente vivere” all’interno del quale risolvere “al meglio” il problema della produzione e dell’equità distributiva nella libertà e nel rispetto della dignità personale dei soggetti. Mentre Rawls ha dimostrato vero l’assunto, implicito nell’idea di comunità armoniosa di Mazzini, che una distribuzione anche ineguale del prodotto sociale può essere considerata equa e strumentale all’ulteriore crescita e sviluppo della comunità purché siano avvantaggiati i soggetti che stanno mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 38 / / peggio. In altri termini le riflessioni mazziniane sull’armonia, sulla solidarietà, sulla cooperazione e sul mutualismo sociali non sono state riflessioni finalizzate solo a combattere la povertà; sono state, invece, anche riflessioni connaturali a ciò che Mazzini intendeva per sviluppo delle comunità nazionali: non si poteva avere crescita economica e sviluppo culturale delle comunità disgiuntamente dall’attuazione di un’equità distributiva condivisa nella libertà. Il fatto principale che ha portato al rifiuto da parte di Mazzini del metodo della lotta di classe emerge chiaro dalle circostanze che hanno caratterizzato il confronto tra le posizioni dei principali protagonisti del movimento per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori durante la costituzione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori (Prima Internazionale). Alla storica riunione presso la S.Martin’s Hall di Londra nel 1864 parteciparono i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori dei paesi economicamente più avanzati dell’epoca. Oltre ai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori della Francia, dell’Inghilterra e della Germania, vi erano anche i rappresentanti delle associazioni di altri paesi minori, tra i quali l’Italia. Le differenze esistenti tra le diverse rappresentanze hanno esercitato un’influenza notevole sullo svolgimento dei lavori delle riunioni precedenti la costituzione dell’Internazionale. Erano il riflesso dei contesti politici, economici e culturali che le esprimevano. Per questa ragione non hanno tardato a prendere il sopravvento le rappresentanze tedesche, con in testa l’economista professionale Karl Marx. La prima Internazionale Del resto occorre tenere presente che tutti i paesi, tranne l’Italia e la Germania, non avevano problemi di unità nazionale e di liberazione dal dominio dello straniero. Mentre l’Inghilterra aveva sviluppato, rispetto agli altri paesi europei, un’autonoma strategia difensiva degli interessi dei lavoratori sin dai tempi dei Levellers pentecostali della Rivoluzione del 1688 e del Cartismo del 1836. Tale strategia portava le rappresentanze dei lavoratori inglesi a privilegiare il riformismo politico, e quindi ad evitare il ricorso a metodi rivendicativi violenti. Le tesi marxiste hanno avuto così modo di diffondersi soprattutto all’interno della Francia e della Germania, dove la posizione dei lavoratori, nel momento in cui stavano costituendosi le organizzazioni sindacali, non aveva ancora trovato un’adeguata difesa. La forza del marxismo si è diffusa dopo il 1848, soprattutto intorno al 1864, quando Marx, teorico della scienza economica mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° ufficiale del momento, aveva già dato corpo al Capitale, col quale dimostrava, anche in forza dell’esperienza sociale dell’epoca, la fondatezza della legge sulla caduta tendenziale del tasso di profitto a causa dell’appropriazione del plus-valore da parte dei capitalisti ed a danno dei lavoratori. Tale stato di fatto, per Marx, impediva ai lavoratori di migliorare i loro livelli salariali coi quali contribuire al finanziamento di una domanda finale sufficiente ad evitare la crisi dello stato stazionario del sistema economico. Ai lavoratori, perciò, per superare il loro basso potere d’acquisto non restava che la conquista forzata del potere politico per rilanciare lo sviluppo economico attraverso l’instaurazione di nuovi rapporti sociali e di nuove istituzioni compatibili con i modi di produzione emergenti. Alla forza del marxismo Mazzini e i suoi seguaci opponevano sicuramente il loro slancio umanitario, ma non la forza della teoria economica, in un tempo in cui l’esperienza convalidava quanto veniva affermato dalla teoria marxiana circa le disfunzioni che i prevalenti rapporti sociali e le prevalenti istituzioni provocavano sui modi di produzione. Il presunto “socialismo scientifico” di Marx, che individuava nella lotta rivoluzionaria del proletariato industriale il “motore” della trasformazione sociale, ha potuto così prevalere sul socialismo umanitario e libertario di Mazzini. Sia per le deboli spiegazioni del fenomeno dello sfruttamento economico che Mazzini e i mazziniani avevano prevalentemente mutuato dal sansimonismo e dal proudhonismo, ma anche dal lassallismo, sia per la scarsa forza sociale che essi potevano mutuare dalla condizione in cui versava l’Italia, ancora suddivisa in tanti piccoli Stati privi di tradizioni democratiche, di strutture economiche avanzate come quelle prevalenti nei principali paesi europei, e di organizzazioni operaie motivate ad impegnarsi per la tutela degli interessi dei lavoratori. Il socialismo di Marx, inoltre, ha potuto prevalere anche per via delle critiche estreme che gli venivano rivolte dai seguaci del “socialismo anarchico”. Queste critiche, per respingere il ruolo dello Stato nel miglioramento delle condizioni dei lavoratori, tendevano a sottovalutare il marxismo senza nel contempo indicare una convincente prospettiva d’azione ad esso alternativa. Così nelle riunioni precedenti la costituzione dell’Internazionale il mazzinianesimo, scarsamente rappresentato, pur godendo di un’iniziale favore, ha finito per essere messo in minoranza da Marx e dai suoi seguaci. Il marxismo in tal modo, grazie alla maggior coerenza delle sue tesi sul piano degli effetti immediati e alla maggior efficacia delle proposte che da esso potevano essere derivate sul piano della mobilitazione dei lavoratori, è riuscito ad esprimere l’istanza del socialismo più con- / / 39 / / divisa. Sino a che il processo storico, lentamente ma inesorabilmente, nell’arco di quasi tutto il XX secolo, ha evidenziato l’erroneità del suo profetismo e la vacuità del suo messaggio consolatorio. Il “socialismo sconfitto” di Mazzini, tuttavia, si ritagliava uno spazio in Inghilterra, dove l’esule genovese, godendo di un ampio prestigio presso le Trade Unions e presso i lavoratori inglesi che lo consideravano come “l’apostolo della causa democratica comune” (Valiani, 1951), avviava una feconda collaborazione con John Stuart Mill. Questi, a differenza degli economisti liberali suoi contemporanei, era aperto alle ragioni del socialismo, e perciò in grado di influenzare il movimento della classe lavoratrice. Mazzini, sconfitto all’interno del movimento socialista dei paesi continentali europei, poteva così contribuire, senza tuttavia condividerne le implicazioni finali, a dare vita a quella corrente dell’analisi economica che, ancora alla vigilia della rivoluzione marginalista e di quella keynesiana in economia, sosteneva convincentemente che lo stato stazionario marxiano poteva essere superato portando il livello della produzione a coincidere con quello della domanda finale del sistema. Mill infatti, confutando la teoria marxista, dimostrava come le esigenze monetarie della produzione erano diverse da quelle del consumo, per cui il valore della prima poteva risultare diverso dal valore del secondo (Mill, 1976). Secondo Mill, perciò, il ricupero dell’equilibrio tra valore della produzione complessiva e valore della domanda finale poteva essere realizzato attraverso azioni riformiste. Queste, rendendo possibile il finanziamento del sistema economico indipendentemente dalle necessità monetarie della produzione, potevano concorrere a configurare la giustizia sociale come problema di una più equa e più larga distribuzione del prodotto nazionale. Malgrado il suo atteggiamento critico nei confronti dell’idea milliana di libertà, Mazzini ha contribuito, con le sue idee politiche sul ruolo della democrazia, a fare nascere, non senza conflitti tali da creare incertezza e instabilità economica e politica nei sistemi sociali avanzati, il corpus teorico che avrebbe giustificato nel corso del secolo XX la costruzione dello Stato sociale all’interno dei principali paesi europei retti da governi socialdemocratici. Questa costruzione, sviluppandosi nelle sue forme moderne proprio in Inghilterra, si è diffusa nella maggior parte dei paesi di più antica industrializzazione, parallelamente alla crescita di strutture statuali centralistiche destinate ad organizzare la produzione e la distribuzione di tutte le prestazioni e di tutti i servizi sociali richiesti per la realizzazione dell’equità distributiva. Le strutture centralistiche, man mano che si sono espanse, hanno però aumentato il peso della loro burocrazia sull’efficienza del riformismo politico, favorendo la diffusione del privilegio a vantaggio di particolari categorie sociali, compromettendo le procedure istituzionali poste a salvaguardia del metodo della democrazia, e risultando alla fine del tutto inadeguate a realizzare la rimozione ab imis del fenomeno della povertà. Tutto ciò, alla fine del XX secolo, è valso ad evidenziare non solo la crisi dei sistemi organizzati sulla base dei principi del marxismo, ma anche la crisi di quelli organizzati sulla base dei principi socialdemocratici: i primi per la loro inefficienza sul piano dell’organizzazione della base produttiva, ma anche e soprattutto per la loro illiberalità politica; i secondi, nonostante la maggiore efficienza economica e la maggiore libertà politica, per la loro incapacità di garantire il livello di giustizia sociale atteso, dato che le politiche ridistributive con cui tale livello è stato permondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 40 / / seguito è divenuto tanto oneroso da riportare i sistemi sociali verso l’originaria situazione di crisi dello stato stazionario. Non casualmente, quindi, anche il socialismo democratico riformista è giunto a configurarsi alla fine del XX secolo quasi plasticamente, secondo i caratteri del capitalismo contemporaneo, abbandonando la pretesa di trasformarli, e scontando una crisi politica e culturale che lo hanno portato ad adagiarsi sulle stesse posizioni di crisi del marxismo d’antan. Posizioni di crisi, queste, che impongono oggi, sia per il socialismo democratico riformista che per il socialismo marxista, la necessità di una profonda revisione dell’approccio a tutti i problemi rispetto alla risoluzione dei quali hanno fallito. Il socialismo mazziniano Nell’inconciliabilità del socialismo mazziniano con il comunismo marxista, ma anche con le forme di socialismo socialdemocratico, può essere avvertita l’anticipazione delle critiche che molti socialisti moderni rivolgono sia al primo che alle seconde di non essere riusciti ad assicurare alle comunità che li hanno sperimentati gli obiettivi che si prefiggevano di conseguire. Infatti sia il primo che le seconde, nonostante la loro vicinanza al socialismo mazziniano, sono stati smentiti dall’esperienza della storia. In entrambi i casi, sia pure in misura diversa, l’affrancamento dell’uomo da ogni forma di subalternità, la salvaguardia della sua dignità e la crescita e lo sviluppo continui della comunità sono obiettivi che sono stati mancati, perché l’organizzazione istituzionale adottata non ha favorito la formazione di relazioni tra i gruppi sociali tali da consentire da un lato una stabile e continua partecipazione di tutti alla promozione della crescita e dello sviluppo, e dall’altro la liberazione di tutti dalla povertà. Solo in questo modo sarebbe stato possibile, secondo la prospettiva di socialismo umanitario e libertario di Mazzini, rimuovere lo “stigma del pauperismo”, conservatosi all’interno di ogni organizzazione istituzionale con cui sia stata tentata la soluzione della rimozione della povertà attraverso forme di assistenza di natura burocratica e selettiva. Queste forme di assistenza, infatti, hanno sinora mirato a cambiare prevalentemente la condizione materiale dei singoli soggetti, fungendo solo da “premio di consolazione” per la loro condizione di indigenza. Ma hanno trascurato la necessità di ampliare le loro potenzialità personali e di garantire a tutti un reddito sociale. La realizzazione di una giustizia sociale ispirata al socialismo mazziniano non avrebbe richiesto solo politiche ridistributive, ma anche istituzioni destinate in particolare ad accogliere molte mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° istanze partecipative e libertarie. La realizzazione di una giustizia sociale così intesa avrebbe richiesto da un lato che nelle comunità moderne il conflitto non rappresentasse più una realistica via d’uscita dai problemi posti dal perdurare di situazioni di povertà diffusa, e dall’altro una riforma sociale tale per cui non fosse stato più necessario continuare a pensare che la “vita buona” fosse solo la risultante di eventi traumatici quale unico rimedio alla mancanza di un appropriato e pacifico cambiamento sociale (Rorty, 1999). In conclusione la realizzazione di una giustizia sociale secondo la prospettiva di socialismo umanitario e libertario di Mazzini richiederebbe che i sistemi sociali venissero liberati dalla povertà attraverso strutture istituzionali e rapporti tra i gruppi sociali e tra le diverse nazioni, sul tipo di quelli proposti, ad esempio, dai teorici del reddito di cittadinanza (Jordan, 1989; Purdy, 1990 e 1994; Van Parijs, 1995). E’ questa vicinanza alle proposte di riforma sociale ed istituzionale del tempo presente il motivo che consente di attribuire alla concezione economico-sociale propria del socialismo di Mazzini una “sorprendente modernità” (Santonastaso, 1958). Tale concezione, infatti, risponde alle problematiche istituzionali e sociali che sono proprie anche delle attuali società avanzate. Contro il dominio di un gruppo sociale sugli altri, contro il dominio di una classe sociale sulle altre, e contro il dominio del capitale sull’intera comunità, il socialismo umanitario e libertario di Mazzini proponeva un sistema compartecipativo del lavoro e del capitale che desse forza e supporto alla crescita e al progresso di tutti. La realizzazione del socialismo mazziniano trovava un limite invalicabile nella difesa della piccola proprietà privata, intesa da Mazzini da un lato come presidio e garanzia della libertà, e dall’altro come salvaguardia della dignità della persona umana. Il socialismo di Mazzini, pur implicando la conservazione dell’istituto della proprietà privata, condannava però gli abusi della grande proprietà e della proprietà parassitaria priva di ogni funzione sociale. Il socialismo di Mazzini si opponeva perciò a qualsiasi organizzazione istituzionale che, nei confronti della comunità, fosse risultata di natura statolatrica, avesse irrigidito i gruppi sociali in movimento, ed ostacolato l’iniziativa individuale. L’individuo nel socialismo mazziniano, quando associato nella gestione e nel governo dell’attività economica e distributiva, non perdeva il diritto alla libertà ed il senso del dovere nell’assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Inoltre la compartecipazione del capitale e della forza lavoro nel socialismo di Mazzini era orientata a sviluppare ed a rinforzare l’autonomia dei singoli soggetti nella gestione e nel governo dell’atti- / / 41 / / vità economica e della distribuzione del prodotto sociale. Infine il socialismo mazziniano prevedeva la “proprietà comune” di tutto il capitale fisso sociale ed il controllo sociale del credito. E ciò per evitare che gli incrementi di ricchezza conseguenti alla crescita e allo sviluppo concorressero a favorire la costituzione o la conservazione all’interno della comunità di gruppi dominanti, ma concorressero invece ad espandere in modo crescente la liberazione di tutti dal bisogno e dall’indigenza. L’attualità di Mazzini La rivoluzione nazionale, per Mazzini, aveva bisogno del coinvolgimento del popolo. Il problema fondamentale era l’individuazione dei mezzi più adatti per rimuovere le moltitudini dal disimpegno al quale erano state costrette dalle carenti condizioni materiali e culturali. Le moltitudini, argomentava Mazzini, rimanevano assenti durante le sollevazioni perché consideravano estranee le finalità che con quelle si intendeva perseguire e perché le avvertivano orientate a soddisfare prevalentemente gli interessi dei gruppi sociali medi piuttosto che quelli dei gruppi sociali poveri. Per coinvolgere nella rivoluzione nazionale i gruppi sociali poveri, perciò, era necessario rendere le finalità delle sollevazioni nazionali comprensibili al popolo. Inoltre bisognava esplicitare i vantaggi che il popolo stesso avrebbe tratto dal nuovo ordine politico dopo la conquista dell’indipendenza e dell’unità della nazione. Il popolo, frustrato da secoli di dominio straniero e di disunità, non poteva essere coinvolto nel processo rivoluzionario in nome di una libertà che esso non aveva mai conosciuto. Chi doveva guidare la rivoluzione nazionale, perciò, doveva affrontare preventivamente la questione sociale e prospettare il possibile miglioramento della situazione esistenziale del popolo. Per inquadrare la questione sociale nel complesso sistema del pensiero mazziniano occorre tenere presente che la sua soluzione era subordinata all’emancipazione politica della nazione. Ciò non di meno tutti gli aspetti del pensiero di Mazzini appaiono coerenti tra loro e reciprocamente giustificabili. Fatto questo che però non toglie che la natura strumentale della rivoluzione nazionale rispetto a tutti gli altri obiettivi (repubblicanesimo democratico, laicità, crescita materiale e culturale, compartecipazione del capitale e del lavoro alla organizzazione ed alla gestione delle attività produttive e internazionalismo) potesse valere ad inserire nella “struttura completa” del suo pensiero un’autosufficienza connotata da una contraddizione di fon- do. Tale contraddizione era dovuta alla circolarità della proposta complessiva di Mazzini e al fatto che essa derivasse da un sistema di pensiero che costituiva un “tutto”, per cui non poteva essere esaminato se non per mera comodità di esposizione nelle sue singole parti, ma doveva essere accettato o rifiutato solo nella sua totalità. Le nazioni, affermava Mazzini, potevano rigenerarsi attraverso il riscatto dal dominio dello straniero e attraverso la loro organizzazione unitaria. Senonché l’indipendenza e l’unità potevano essere raggiunte solo dopo il conseguimento di tutti gli altri obiettivi. Ecco, dunque, la contraddizione che caratterizzava la relazione tra il pensiero mazziniano e la possibile azione politico-sociale che da esso doveva derivare: l’indipendenza e l’unità della nazione richiedevano il perseguimento degli altri obiettivi che concorrevano alla definizione del suo sistema di pensiero, ma il perseguimento di questi obiettivi poteva essere realizzato solo dopo l’acquisizione dell’indipendenza e dell’unità della nazione. E’ questa contraddizione la ragione dei numerosi fallimenti del suo attivismo rivoluzionario che sono valsi a Mazzini numerose critiche e numerose disaffezioni da parte di molti che in origine avevano condiviso il suo pensiero. Oggi, tuttavia, il problema dell’indipendenza dallo straniero e dell’unità della nazione non sussiste più. Del pensiero di Mazzini, tuttavia, resta valida la parte riguardante il suo programma sociale; parte, questa, che si presta ad essere percepita pienamente originale ed attuale, in particolare per la cultura politica italiana. L’originalità risiede nel fatto che Mazzini nell’elaborare il suo pensiero sociale non ha mai ceduto alla tentazione di mettere insieme alcuni elementi delle ideologie del liberalismo e del comunismo. Il pensiero di Mazzini è originale, essendosi posto al di là del liberalismo e del comunismo sia a livello di elaborazione teorica che di proposta di realizzazione pratica. Mazzini si è sottratto agli approcci di “sintesi socialdemocratica”, per i quali la soluzione della questione sociale restava sempre di natura residuale e ridistributiva. E proprio perché originale, il pensiero di Mazzini è anche attuale. Per questo motivo sarebbe utile che la cultura politica italiana tenesse conto della riflessione mazziniana sulla democrazia e della sua intransigente denuncia degli esiti negativi dell’individualismo utilitaristico e del collettivismo insensibile alle ragioni libertarie dell’intera società civile. E sarebbe anche utile che la stessa cultura politica italiana si interrogasse sulla forma di democrazia che è riuscita a prevalere sul crollo del comunismo sperimentato nelle forme del “socialismo mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 42 / / reale” e sul fallimento delle socialdemocrazie: non la democrazia repubblicana di Mazzini, non la democrazia fondata sull’armonia e sulla solidarietà di tutti i componenti della comunità. Di fronte ai fallimenti dello Stato comunista e dello Stato di diritto liberale (ed anche dello Stato di diritto socialdemocratico) nella soluzione del problema della giustizia sociale, le implicazioni delle riflessioni di Mazzini sulla democrazia repubblicana sono ancora tutte da considerare. Inoltre le idee mazziniane dovrebbero costituire, quanto memondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° no, un punto di riferimento per quanti rinvengono nel neocomunitarismo, nella compartecipazione e nell’internazionalismo i presupposti per la realizzazione di condizioni di pace generalizzata nei rapporti tra i diversi gruppi sociali all’interno di ogni nazione e nei rapporti tra le diverse comunità nazionali. L’originalità e l’attualità del pensiero sociale di Mazzini costituiscono, forse, le ragioni per cui Palmiro Togliatti, nel marzo del 1946, in occasione dell’inaugurazione a Pisa del- / / 43 / / l’”Istituto di riforme sociali Giuseppe Mazzini”, osservava, pur da posizioni critiche, che il grande patriota genovese è stato l’unico a giganteggiare tra i padri fondatori dell’Italia. Perché, come tutti i grandi rivoluzionari, ha saputo indicare, anche se inascoltato, quale nuova società (nuovo progetto sociale) poteva assicurare la soluzione del problema dell’unità della nazione italiana. Sarebbe tempo, perciò, che la cultura politica italiana, anziché impegnarsi a distruggere ciò che il Risorgimento ha lasciato all’Italia ed agli italiani, si aprisse alla necessità di dare ascolto a molti dei suggerimenti mazziniani, per valutare se da essi risulta possibile derivare soluzioni per i problemi che affliggono da tempo il paese, considerato che molti problemi affrontati da Mazzini ai suoi tempi sono gli stessi dell’Italia di oggi. Ciò anche in considerazione del fatto che i suggerimenti mazziniani hanno trovato largo accoglimento nella cultura politico-sociale successiva al Risorgimento. In Italia, il loro accoglimento tra i Principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana dovrebbe essere sufficiente a radicare negli italiani di oggi la certezza che quei suggerimenti costituiscono il fondamento del “patriottismo costituzionale” in base al quale condividere e difendere l’esperienza storica che ha portato alla costituzione dello Stato italiano. Per l’ostracismo subito da gran parte della cultura storica e politica, Mazzini, nella celebrazione dei 150 anni della realizzazione dell’unità potrà anche non trovare la collocazione che merita. Egli tuttavia, come viene detto, ha gettato il seme dell’unità, mentre tutti gli “Altri” (Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi, D’Azeglio, Ricasoli, Rattazzi ed anche Cattaneo e Ferrari), che troveranno sull’altare celebrativo una collocazione di comodo, ne hanno coltivato l’albero e ne hanno raccolto il frutto (Scalfari, 2010). Un frutto, però, “geneticamente modificato”. Il frutto che Mazzini sperava di poter raccogliere coniugava l’unità alla riforma in senso socialista dei prevalenti rapporti sociali esistenti all’interno degli Stati pre-unitari; mentre il frutto raccolto dagli “Altri” ha solo coniugato l’unità alla immodificabilità di quei rapporti, dando il via a quelle profonde lacerazioni interne che hanno sinora impedito la condivisione generalizzata del processo di unificazione nazionale. In conseguenza di tutto ciò, Giuseppe Mazzini, morto a Pisa sotto il falso nome di Giorgio Brown il 10 marzo 1872, all’indomani del 1861 ha potuto essere celebrato da molti degli “Altri” trionfanti solo come un pericoloso sovversivo, e successivamente, anziché essere accettato come un modello da proporre alle generazioni future, è stato ri- dotto a “mummia della Repubblica” con la quale ne sono stati “pietrificati” sia la salma che il suo originale pensiero sociale. Riferimenti bibliografici. G.A. BELLONI, Socialismo mazziniano, Archivio Trimestrale, 1982. B. JORDAN, The Common Good. Citizenship, Morality and Self-Interest, Basil Blackwell, 1989. B. KING, Mazzini, G. Barbera Editore, 1918. L. LA PUMA, Il socialismo sconfitto. Saggio sul pensiero politico di Pierre Laroux e Giuseppe Mazzini, Franco Angeli, 1984. P. LINGUA, Mazzini il riformista. Gli ultimi anni e la questione sociale, EGIG, 2005. S. LUZZATTO, La mummia della repubblica, RCS libri, 2001. G. MAZZINI, Scritti politici, a cura di T. Grandi e A. Comba, Utet, 1972. G. MAZZINI, Pensieri sulla democrazia in Europa, Feltrinelli, 2005. G. MAZZINI, Dei doveri dell’uomo, RCS libri, 2010. J.E. MEADE, Agathotopia. L’economia della partnership, Feltrinelli, 1989. J.S. MILL, Saggi su alcuni problemi insoluti dell’economia politica, Isedi, 1976. J.S. MILL, La libertà, Corriere della sera, 2010. V. PARMENTOLA, Introduzione a G.A. Belloni, cit., 1982. J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, 2002. R. RORTY, Una sinistra per il prossimo secolo, Garzanti, 1999. L SALVATORELLI, Giuseppe Mazzini, in A.A.V.V. (1952). G. SANTONASTASO, Il neo-liberismo di Giuseppe Mazzini, Adriatica Editrice, 1958. R. SARTI, Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile, Laterza, 2005. E. SCALFARI, La Repubblica del 10 ottobre 2010. G. SPADOLINI, Prefazione a G.A. BELLONI, cit., 1982. P.E. TAVIANI, Problemi economici nei riformatori sociali del Risorgimento italiano, Le Monnier, 1968. P. TOGLIATTI, “Prolusione tenuta il 10 marzo 1946 alla Normale di Pisa”, in Rinascita, Anno 24, n. 33. L. VALIANI, Storia del movimento socialista, La Nuova Italia, 1951. P. VAN PARIJS, Real Freedom for All, Clarendon Press, 1995. mondoperaio 3/2011 / / / / speciale / 150° / / 45 / / >>>> 150°/la prova dell’unità Che cosa abbiamo fatto per meritarci l’Italia? >>>> Giuliano Amato intervistato da Stefano Rolando N ella nomina a presidente del Comitato dei Garanti per il 150°, diciamo dal testo della delibera, si evince un punto preciso per prefigurare la missione e gli obiettivi di questo incarico? C’è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce il comitato che profila compiti al riguardo. Soprattutto, dal punto di vista formale, si tratta di esprimere pareri su progetti, in particolare del governo, che attengono alle celebrazioni. In realtà essendo il comitato costituito da prestigiosi intellettuali all’origine presieduti da Carlo Azeglio Ciampi, esso all’inizio ha messo a punto orientamenti e indirizzi corrispondenti alle aspettative che l’Italia poteva avere da queste celebrazioni. Il mio compito è stato più ravvicinato agli eventi e quindi più nel merito dei progetti emersi. Ho cercato di allargare la sfera di attenzione al di là delle elencazioni ufficiali in modo da includere nel programma tutti gli eventi – comunque e da chiunque organizzati – all’insegna del principio “sta celebrando i 150 anni non lo Stato italiano ma la Repubblica italiana”. Pensi di avere conseguito quell’obiettivo (parliamo a meno di due settimane dall’evento)? Penso di sì. Le celebrazioni si snodano con vari anniversari che dipendono da fatti diversi. Per fare qualche esempio, la partenza dei Mille da Quarto avvenne il 5 maggio 1860 e lo sbarco a Marsala fu l’11 maggio. Oppure la rivolta di Potenza cominciò il 16 agosto 1860 e si concluse vittoriosamente il 18 agosto quando Garibaldi sbarcò in Calabria. Queste date hanno offerto le condizioni di calendario per svolgere specifiche manifestazioni nelle ricorrenze sin dal 2010. Gli anniversari, dunque, sono più di uno. Scuole, Comuni, Università stanno diffondendo attenzione con una prevista gradualità. Lo spirito italiano accompagna creativamente gli eventi. Porta anche a servire nei ristoranti toscani di Castello di Brolio le “pappardelle alla Ri- casoli”. Gli italiani non se la perdono un’occasione come questa. Chi ha remato contro? Chi ha remato? Insomma, indiscutibilmente la Lega è stata restia per motivi che tutti conoscono. E ciò ha provocato nelle sedi in cui quel partito ha un peso anche atteggiamenti di altri che talvolta hanno alzato le braccia dai remi. Però faccio una considerazione generale: alla fine si vedrà che è prevalsa la convinzione della stragrande maggioranza degli italiani. La Giunta regionale del Veneto aveva – per esempio – deciso di non partecipare alle celebrazioni. Ebbene il Consiglio regionale del Veneto alla fine ha portato l’ente Regione a dare il consenso alle celebrazioni. Si può dire in sintesi che hanno remato i due presidenti della Repubblica e gli italiani in genere? Aggiungerei anche parte del governo. Non vorrei essere esaustivo sui nomi, ma l’impegno del sottosegretario alla Presidenza va ricordato, l’impegno nel suo insieme del Ministero dei Beni culturali soprattutto per il recupero dei “luoghi della memoria” va sottolineato; e, non so quanto gli italiani lo sappiano, la serata sul 150° al festival di Sanremo, con 19 milioni di telespettatori, è stata ideata dal ministro della Difesa. A proposito: sul piano della comunicazione popolare, Roberto Benigni a Sanremo è stato risolutivo? Se è stato proprio risolutivo non saprei dirlo. Ma che 19 milioni di italiani lo abbiano seguito con attenzione sul significato, parola per parola, dell’inno di Mameli è stato straordinariamente importante. Si ha l’impressione che la scuola italiana si sia molto impegnata, che i media si siano abbastanza impegnati, che la politica e l’impresa siano stati marginali e che l’università mondoperaio 3/2011 / / / / 150°/la prova dell’unità / / 46 / / si sia abbastanza disinteressata. Corrisponde? Troppo drastico. Effettivamente la scuola sta facendo molto e con molta varietà. Ho sentito di ricerche fatte dai ragazzi sui registri dello stato civile per capire il significato del passaggio da cittadino del Granducato a cittadino dello Stato italiano. Insegnanti bravi hanno portato gli allievi sui luoghi della memoria e nelle case di protagonisti del tempo, raccogliendo in un sito i loro resoconti e i loro commenti. C’è poi un’Italia profonda che reagisce. Le bande musicali e i cori, parte essenziale di un tessuto sociale dell’Italia non romana, danno una colorazione del tutto diversa a quella che sarebbe questa celebrazione effettuata in Francia, un paese top down dove Parigi da il là. Qui ciascuno suona a modo suo, con la sua banda, con il suo coro. In verità le università stanno facendo. Non tutte, ma alcune sì. Vengo da un evento organizzato dagli italiani all’università di Zurigo e sto partendo alla volta dell’università della Calabria per un altro evento. L’Università di Roma – anzi le tre università romane – hanno realizzato un grande evento. In realtà non tutto quello che si fa riesce ad arrivare ai media. Una riflessione supplementare per il sistema di impresa… Si, d’accordo: qui c’è un po’ di rarefazione. Ho coinvolto il sistema di impresa in una bella mostra che si aprirà a marzo, intitolata Copyright Italia, fatta dall’Archivio di Stato, che racconta attorno ai marchi e ai brevetti che quell’Archivio custodisce la storia dell’innovazione. Qui hanno partecipato. Ma c’è un’altra cosa che è rimasta a metà proprio qui alla Treccani: un dizionario biografico delle imprese e degli imprenditori. Ci lavorava la Bocconi, ma serviva un concreto sostegno. E l’impresa italiana non ha neanche avviato un’ipotesi di colletta per costruire questo monumento di sé. Nelle storie che accompagnano il racconto del 150°: molto Risorgimento, poca Resistenza, scarsa e controversa Repubblica. Insomma le 3 R – architravi del secolo e mezzo – non valgono tutte allo stesso modo? E’ abbastanza naturale che si pensi di più al Risorgimento perché la prima propensione dei celebratori è di andare al passato. La Resistenza meriterebbe maggiore attenzione come ambito di ricerca sulla “patria ritrovata”. Poche iniziative convegnistiche stanno segnalando questo tema, ma lo ha molto ben fatto il libro di Aldo Cazzullo Viva l’Italia che ha proprio messo sullo stesso piano la vicenda risorgimentale e quella della Resistenza. Un ciclo di seminari sulla Repubblica l’ho organizzato io stesso alla Treccani insieme ad Andrea Graziosi con un titolo non casuale: Cento più Cinquanta. E poi? L’attenzione è mondoperaio 3/2011 / / / / 150°/la prova dell’unità concentrata sugli ultimi cinquanta anni e su quello che ne potrà uscire. Ti dirò che avevo immaginato all’inizio un titolo alla Almodovar: Che cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Ma era un titolo inadatto alla Treccani. Nel ciclo di interviste che Mondoperaio ha finora dedicato al tema (Barca, Ruffolo, Maccanico, Bassetti, De Rita) abbiamo chiesto a tutti: a cosa serve oggi l’unità d’Italia? Serve a dare uno spazio vitale minimo agli italiani che non l’avrebbero se fossero divisi negli staterelli di un tempo. In un mondo in cui la demografia conta sempre di più in misura direttamente proporzionale allo sviluppo degli Stati più popolati, essere piccolissime unità, cioè autobalcanizzarsi, significa andare verso il suicidio. Puramente e semplicemente, in termini di convenienze economiche, dimenticando Dante, Petrarca e Leopardi. Questo non è di destra né di sinistra. Pochi hanno riflettuto sul fatto che la demografia ha contato di meno negli ultimi due secoli perché i paesi più popolosi erano masse di poveri. Ma quando essi si sviluppano, le dimensioni del braccio con cui si fa il bracciodiferro contano, eccome. Giorgio Ruffolo invoca un progetto per impedire quello che pare ineludibile: la rottura dello stivale. E’ già in atto la rottura? Cosa deve avvenire perché si debba parlare di due Italie? No, non credo che la rottura sia in atto. Forse attribuisci a Ruffolo qualcosa in più di quello che dice. Lui sostiene qualcosa che non ha convinto tutti in fatto di proposta: la creazione delle macro-regioni. Cioè creare una grande regione del sud per consentirle di essere più efficace in questo paese “troppo lungo”. E’ comunque correttissima la sua diagnosi: il paese è risultato “troppo lungo” per riuscire ad unificarsi. Io stesso ho ripetutamente parlato di “Italia nazione incompiuta” proprio perché incompiuto è rimasto il nord-sud, che ancora continua ad esistere. Ma che è assolutamente lontano da quello che – per parlarci chiaro – sta succedendo in Belgio. Piero Bassetti non crede all’unità dello Stato-nazione generato nella seicentesca pace di Westfalia. Chiede una nuova statualità guardando a portatori di innovazione e di efficienza. Anche se attualmente ci sembrano primitivi o malavitosi. Un commento. Bassetti ha ragione. Ma quello che dice è sempre stato vero. La discussione sull’incompiutezza della nazione ha visto da sempre due fronti: quelli che dicono che ci sono gli italiani ma non / / 47 / / l’Italia e quelli che dicono che c’è l’Italia ma non gli italiani. Secondo i fautori della prima tesi è chiaro che contano gli italiani e non lo Stato italiano. Un’opinione prevalentemente dei cattolici. Ma nella fragilità della formazione dello Stato italiano ci fu la sciagura del potere temporale della Chiesa che creò un conflitto tra quello Stato e la religione degli italiani, cioè con il loro vero collante. Un paese prevalentemente contadino e cattolico ha avuto difficoltà a riconoscersi nello Stato. Questa è vicenda nota. Ma col passare dei decenni questa frattura ha finito per essere riassorbita. Ciò che è stata l’Italia più recente evidentemente non è solo dovuto allo Stato e alla sua capitale, ma a ciò che milioni d’italiani sono venuti facendo. Ma ti pare che essere arrivati ad essere tra le prime sette potenze industriali del mondo con una struttura industriale fatta da una miriade di piccole e piccolissime imprese che concorrono tutte al suo prodotto interno lordo sia espressione di una realtà statocentrica? Non è pensabile. Dunque è vero che l’unità d’Italia la regge la comunità degli italiani. Ed è questo che mi rende anche ottimista sul futuro dell’Italia. Dietro a questa celebrazione – non tanto nei comitati ufficiali, ma nella minore evidenza di luoghi e persone che pensano paese con intelligenza – ti sei imbattuto in qualche “laboratorio” del cambiamento da segnalare (come lo fu la redazione di questa rivista, di cui eri parte di spicco negli anni ’70) ? Questa è davvero una domanda interessante. Sono certo che esistono anche altri laboratori che pensano paese come dici “con intelligenza”. Quello che so è che un tentativo è quello che proprio qui all’Istituto dell’Enciclopedia italiana sta coinvolgendo molte persone ed è in via di costruzione per un progetto su “L’Italia e le sue regioni” in cui stiamo coinvolgendo studiosi di tante discipline e diverse località italiane attorno alla messa a fuoco della cultura che si è venuta formando nelle regioni, nel territorio, per capire se essa è partecipe di una cultura nazionale e concorre a formarla o se si tratta di tendenze puramente localistiche. Attualmente il lavoro di coordinamento è guidato da Mariuccia Salvati e Loredana Sciolla. Tanti partecipano: da Segatti a Fofi a De Rita. Spero di arrivare in porto. Ma come camondoperaio 3/2011 / / / / 150°/la prova dell’unità / / 48 / / pita in tutti i laboratori non sempre poi la scintilla scocca. Perché il Corriere della Sera ha scelto il tema con un trattamento così distinto dagli altri media italiani? Anche se Repubblica ha ormai la pagina fissa con la cronaca del tempo… Penso però che al Corriere pesino specifiche sensibilità, da quella del direttore a quella di un editorialista come Ernesto Galli della Loggia, a firme di punta come quella di Aldo Cazzullo o quella di Gian Antonio Stella a cui piace moltissimo percorrere l’Italia periferica in funzione della sua unità. Anima degli italiani o vocazione all’establishment, per quel giornale? Penso soprattutto “anima degli italiani”. Perché del Corriere si parla con una certa prudenza quando si discute di cosa pensino i suoi azionisti. Ma qui ritengo che gli azionisti non c’entrino per niente. La Rai ha corrisposto alle attese ? Questa Rai è in grado di corrispondere ad attese? Diciamo che la Rai ha fatto promesse corrispondenti alle attese e ora vediamo come le realizza. Ha avuto e ha programmi – da Rai Storia a Rai Educational - che contengono a meraviglia il tema. Aspettiamo che anche altri contenitori, quelli più frequentati dai telespettatori, ospitino comunque tematiche legate al 150°. Questo è stato detto dai vertici della Rai al mio comitato in una occasione. Mi aspetto che lo facciano. Non essendo neppure un assiduo consumatore di tv, non ho poi titolo per esprimermi sulla Rai nel suo insieme. “Italia” è una espressione anche geografica che oggi – a differenza dei tempi di Metternich – comprende anche i 250 milioni di italo-discendenti in ogni parte del mondo. L’occasione del 150° avrebbe potuto far esprimere una politica nuova, moderna, non retorica, per questa immensa e importante comunità. Ci si è pensato? Si cerca di avere proposte. Sugli italiani all’estero tuttavia ci sarebbe molto da dire. Per esempio su quelli che hanno solo il passaporto senza sapere la lingua… …è grave? …mah, insomma, lo trovo un po’ miserando, perché prendo sul serio la cittadinanza, la prendo come espressione di appartenenza ad una comunità. Così come mi rammarico che molti immondoperaio 3/2011 / / / / 150°/la prova dell’unità migrati in Italia non parlino l’italiano appartenendo ormai a questa comunità. Ogni volta che sono fuori e parlo con giovani oriundi cerco di ricordare che è bene che imparino la lingua perché noi la chiediamo agli immigrati per dar loro la cittadinanza. In più la legge elettorale è una stravaganza unica in tutto il mondo per il modo con cui sono stati costruiti i distretti elettorali. Mi sono trovato pochi giorni fa nella piccola vecchia casa di Staten Island in cui Meucci ospitò Garibaldi, circondato dalle rappresentanze locali degli italiani che mi ricordavano che sacrifici devono fare per tenere in piedi quel luogo e per insegnarci l’italiano. Mi ha detto Piero Angela la stessa cosa che ho pensato io andando lì. Che bisognerebbe farci un vero moderno museo audiovisivo, per ricostruire la storia di Meucci e delle sue invenzioni, la storia del telefono. Non chiudere sempre i nostri italiani all’estero nell’eterno ricordo della loro iniziale povertà. Beh, per rispondere alla domanda, queste cose dovremmo fare o incentivare per il 150°. Sergio Luzzatto di recente sul Sole-24 ore (in polemica con Carandini e Berardinelli) ha detto che si sprecano i piagnistei sulla decadenza intellettuale italiana pensando al passato pieno di glorie, mentre l’Italia è tra i paesi europei più glocal, magari con un “provincialismo cosmopolita”. Chi ve- / / 49 / / de e chi racconta l’Italia correttamente oggi nel mondo? Intanto la racconta bene Sergio Luzzatto perché scrive in un italiano piacevole e corretto. Ora, gli italiani hanno sempre avuto la caratteristica di essere auto-denigratori. E’ noto e comprensibile il complesso di Calimero degli italiani, abituati a essere dominati da altri, servi più che padroni. Se ne sentono in parte colpevoli in parte colpevolizzati. Alla fine diffondono di sé un’immagine eticamente discutibile e culturalmente mediocre, che non corrisponde alla verità. Ma quando viene diffusa viene poi ripresa dagli altri. E quando la troviamo ripresa dall’Economist ci arrabbiamo, ma siamo noi che l’abbiamo messa in circolazione. Diffidiamo dunque dalla retorica. Condivido il profilo che ho proprio trovato nel libro di Cazzullo. Identificato in una splendida frase di D’Azeglio che scrive a un suo amico: vedi quanta coscienza di sé c’è da parte francese e quanta modestia c’è da parte nostra? Perché non impariamo ad essere orgogliosi almeno delle cose vere? Non c’è da andare proprio orgogliosi di tutto, no? Sì, questo sì. Ma almeno delle “cose vere”! Ora per completare l’osservazione, noi siamo anche un po’ schizofrenici. Perché andiamo in giro a fare mostre delle eccellenze italiane. Ma ci mostriamo anche sovraccarichi di rifiuti. Il che genera la percezione che le eccellenze siano eccezioni. Si tratta di ricostruire l’insieme di un profilo italiano. New York va assomigliando sempre di più a Napoli perché avendo deciso di fare la raccolta differenziata in giorni diversi la città è piena di immondizie. Ma New York resta per tutti “la mela” da amare. Hai scritto tu di recente sul Sole-24 ore che “senza dialogo non c’è democrazia”, facendo l’elogio del laboratorio che non solo nei paesi nordici e protestanti ma anche in Italia vi sarebbe in materia di democrazia partecipativa e deliberativa. Da questo punto di vista i 150 anni di unità d’Italia, metà dei quali con democrazia a scartamento ridotto e una parte anche senza democrazia, reggono il confronto con il resto d’Europa? Diciamo che non reggono il confronto con una parte dell’Europa. Ho voluto esprimere una convinzione sull’Italia come su buona parte delle democrazie occidentali, dove sono venute meno quelle formazioni intermedie che permettevano il dialogo democratico. Si è arrivati al rapporto in presa diretta tra leadership politica e opinione pubblica, che tende all’estremizzazione emotiva, a trasformare la cittadinanza attiva in tifoseria. Sono colpito da ciò che è successo in Tunisia e in Egitto, che dimostra che si può ricreare una canalizzazione di cittadinanza attiva, purché la si faccia. Non è che i nuovi media la rechino in sé, ma la consentono. Se questo vale per Tunisia ed Egitto varrà soprattutto per un paese che, alla fin fine, non ha il problema del cambio di regime. Nelle tante manifestazioni per i 150 anni di unità d’Italia c’è stato posto anche per una storia del PCI, una mostra d’orgoglio organizzata dall’Istituto Gramsci. L’hai vista? L’avresti voluta così? Che cosa ti ha fatto pensare? Una mostra tecnologicamente molto accattivante, grazie all’uso di nuovi media e di interattività. Un’osservazione che ho fatto andandola a visitare - insieme a Giorgio Napolitano, in relativa informalità, ma fatta insieme per connetterla in modo più visibile al 150°- è che l’architetto l’ha fatta troppo scura. Se fosse stata la mostra della storia del mio partito avrei voluto più luce… Parli di luce vera o di luce simbolica? Riguarda quell’allestimento, perché la storia la si legge come storia. Vedere una foto di Togliatti, pigiare sul touch screen sulla svolta di Salerno e sentire in cuffia il discorso di Togliatti sulla svolta di Salerno, lo trovi una gran cosa. Certo mi ha messo in mente: perché non c’è una storia del PSI nella storia d’Italia? Ne ho scritto a Maurizio Degli Innocenti che ci sta lavorando, ma c’è bisogno di alcune decine di migliaia di euro che non si sa ancora se si riusciranno a trovare. Quanto alla attuale sinistra italiana – non dico alcuni intellettuali, ma partiti e movimenti che si richiamano esplicitamente alle radici della sinistra che con il Risorgimento non ha mai regolato bene i suoi conti - che contributo rielaborativo è venuto in questi ultimi tempi da mettere nell’inventario serio di un dibattito? Oggi la cosa più interessante – di cui è bene prendere atto – è che l’antica e radicata diffidenza della sinistra per il Risorgimento, dovuta principalmente alla lettura di Gramsci e del rapporto con le masse contadine, che dopo Rosario Romeo nessuno ha più il coraggio di riprendere, è diventata marginale. Cioè patria e nazione non sono più per nessuno parole squalificate. È superato quindi tanto il pregiudizio nei confronti del Risorgimento, quanto il trauma che rispetto a queste nobili parole aveva provocato il fascismo. Caso mai il problema è che la sinistra è tanto poco culturalmente viva oggi che non si hanno molte occasioni per rendersi conto di questo cambiamento. Ma le poche sedi attraverso cui questo cambiamento è percepibile ne sono testimonianza. Ho trovato per esempio interessante che un mondoperaio 3/2011 / / / / 150°/la prova dell’unità / / 50 / / giornale della CGIL mi abbia intervistato su questo argomento desideroso di mettere in evidenza questa riconciliazione tra la sinistra e la patria. Carlo Lizzani ha polemizzato con l’abuso della parola Paese per parlare della Patria. Dice che durante la Resistenza aveva un valore antiretorico che ora andrebbe dismesso. Cosa ne pensi? Sono d’accordo, la parola “paese” non mi piace un gran che. La uso talvolta io stesso come sinonimo, per non essere ripetitivo, quando scrivo sui giornali. E’ un termine molto geografico. In taluni contesti può avere anche un valore. “Paese mio che stai sulla collina”, diceva una canzone molto romantica degli anni ’60. Dove “paese” è la mia comunità. La geografia lì diventa habitat. Ma paese si presta allo stesso giudizio sprezzante che Massimo Severo Giannini esprimeva sulla parola “livello”. Quando presero a diffondersi frasi come “a livello di coscienza” diceva: questa parola da geometri si è diffusa troppo! In un recente evento dedicato al 150° hai condiviso il palco con il tuo successore al Viminale, il ministro Maroni. Che idea ti sei fatto – nella sostanza – della posizione culturale e politica della Lega attorno a questa vicenda? All’invito a Maroni a dire “viva l’Italia” in quell’occasione – era tra l’altro anche il titolo del libro che presentavamo – lui sorridendo ha detto “viva l’Italia, pausa, federale”. E’ intelligente, ha consapevolezza del ruolo istituzionale che svolge. Sembrava esprimere il suo accordo con il sindaco Tosi che è stato il più visibile nel conciliare la sua diversità leghista con l’appartenenza alla nazione italiana. Credo che ci sia divisione nella Lega. Ma per ovvie ragioni. Il Veneto è stato un asse portante della vicenda risorgimentale. La Repubblica di Venezia del 1848 aveva messo San Marco al centro del tricolore. L’idea di strapparlo da lì in nome dell’antenato celtico non regge e , a mio avviso, non reggerà. I soggetti autorizzati a rifare la storia , diciamo, sono divenuti meno scientifici di una volta. Il proprietario della discoteca Hollywood alla periferia di Vicenza, consigliere provinciale della Liga autonomista, ha dichiarato: “Garibaldi era un mercenario che non amava i veneti. Questo è un dato storico” come ha scritto Gian Antonio Stella sul Corriere. Poi davanti a quella discoteca è stato bruciato il fantoccio di Garibaldi a cui era appeso il cartello “L’eroe degli immondi”. Nel Veneto sono state fatte delibere comunali per autorizzare i commercianti a stare aperti il 17 marzo. Commenti. mondoperaio 3/2011 / / / / 150°/la prova dell’unità Non commento. Perché queste storie esistono. Ma finiranno in una marginalità senza rilievo. Temo molto di più i casi di quei sindaci che ad un immigrato regolare che ha perso la casa dicono: prima vengono gli italiani, anche se sei in graduatoria. Questi fanno un danno vero, è una xenofobia che fa paura. E’ bastata la visita di Giorgio Napolitano a Bergamo per fare emergere un’altra immagine della città… …vero!... …senza pifferai vincono i nuovi stereotipi. Che strumenti ha la cultura italiana per esprimere il meglio dell’Italia? Beh, ne ha tanti. In realtà la cultura italiana ha se stessa, se si esercita. Se si esercita sul presente. Se scopre l’Italia. Ha finito per andare a cercare se stessa solo nel passato. Ed è per questo che l’occasione del 150° va utilizzata meglio anche perché rivolta al presente. Se si pensa che il mondo ammira l’Italia per la sua creatività e la va a cercare solo a Pompei dove magari il sito cade in pezzi, ci dobbiamo anche dire che non siamo sempre in grado di far cogliere quella creatività, che non è solo Armani e Valentino, perché sta continuando in quasi tutto ciò che si fa nel paese. Questo deve scoprire la cultura. Il dibattito sulla riforma costituzionale ha segnato alcuni momenti importanti nelle vicende dell’ultimo trentennio. In questo ultimo periodo è sembrato più una foglia di fico per fare sembrare vivo lo spirito di riforma del governo (attorno ad un art. 41 che non pareva una vera e propria priorità). Ipotizzando che covi da qualche parte l’innovazione generazionale nella politica italiana, a quali aspetti della riforma costituzionale consiglieresti di guardare? Modificare gli articoli che contengono i principi non serve a niente. I principi cambiano storicamente all’interno degli articoli della Costituzione che ne prevedono una iniziale formulazione. Vale la piena di cambiarli il giorno in cui, essendo diventanti razzisti, il principio dell’uguaglianza si sostituisce con il principio della superiorità della razza ariana. Se non si arriva a questo, c’è una naturale evoluzione degli assi portanti della società democratica. Quindi i cambiamenti possono riguardare la parte organizzativa. Alcuni sono utili. Con priorità, direi, per quel che riguarda il rapporto tra governo e parlamento in cui, paradossalmente, entrambi si sentono troppo deboli nei confronti uno dell’altro. E’ chiaro che qualcosa va aggiornato. E poi non si può fare una “riforma federale” se non si tocca una delle due Camere. Il 150° ci induce a guardare alla storia d’Europa. Il Medi- / / 51 / / terraneo era in ombra centocinquanta anni fa. Ora il dito della storia punta su quell’ombra, mette il Mediterraneo al centro delle domande, forse anche delle speranze. Ma l’Italia – il paese di maggiore prossimità rispetto allo tsunami civile del mondo arabo – è apparsa silenziosa e prudente. Il premier Giuliano Amato cosa avrebbe detto in questi giorni? Avrei detto due cose. Intanto che per quanto riguarda la Libia – mai dimenticarselo – il nostro costante imbarazzo davanti a governanti pur improbabili di quel paese è sempre stato la inevitabile conseguenza della responsabilità di quella orrenda avventura coloniale nella quale i nostri progenitori erano stati responsabili di misfatti. Il che porta a sentirsi sempre debitori nei confronti di chi governa la ex-colonia. Est modus in rebus, naturalmente. Per quanto riguarda l’insieme della vicenda avrei messo in moto tutti i canali di collegamento tra coloro che stanno embrionalmente lavorando a un tessuto di governo nella consapevolezza che questi sono interlocutori non diversi da quelli dei nostri vicini del nord. Nel titolo di un tuo libro recente (2006) hai scelto di aggiungere un punto di domanda: Un altro mondo è possibile? Nel tuo sguardo di oggi confermi o modifichi quella punteggiatura? Confermo quel punto interrogativo. Noi abbiamo risorse economiche e creatività e anche tecnologie per produrre cambiamenti enormi. Quello che è successo nel mondo in questi anni ha reso pessimisti solo gli europei. Se tutti si sviluppano, la fetta che tocca a me diminuisce. Ma devo essere consapevole che sono parte di un mondo in cui il futuro è diventato positivo per milioni di essere umani che prima ne erano esclusi. La vera ragione del dubbio sul futuro è che la diffusione dello sviluppo ci ha creato problemi di vario genere che, se non saremo capaci di risolverli (e risolverli sarebbe possibile) possono mettere a rischio addirittura la sopravvivenza del pianeta. Per dirne una – con la quale chiudere – uno studio recente ha messo a confronto i problemi che il mondo ha davanti con i tempi di soluzione compatibili con la sopravvivenza del pianeta. La conclusione dello studio è che negli Stati Uniti solo un regime dittatoriale potrebbe salvare il mondo. Questo basta e avanza a spiegare quel mio punto interrogativo. mondoperaio 3/2011 / / / / 150°/la prova dell’unità / / 53 / / >>>> dossier / why not socialism? Socialismo post marxista >>>> Mario Ricciardi A poco più di un anno dalla sua morte è difficile scrivere di G.A. Cohen al passato. Pur avendo lasciato, per raggiunti limiti di età, la cattedra “Chichele” di “Social and Political Theory” che ricopriva a Oxford dal 1985, Jerry Cohen era ancora in piena attività, e uno degli autori più influenti della filosofia politica di lingua inglese. Un’intera generazione di studiosi, alcuni dei quali sono oggi a loro volta figure di spicco nella comunità accademica internazionale, hanno mosso i primi passi sotto la sua guida. Si sono formati leggendo i suoi lavori e hanno imparato da lui come si può tenere insieme una profonda passione politica e un grande rispetto per il rigore dell’argomentazione. Due caratteristiche che raramente si associano felicemente come nel suo caso. Nel panorama della filosofia politica di lingua inglese – che convenzionalmente chiamiamo “analitica”, anche se questa espressione oggi non vuol dire più tanto – Jerry si distingueva perché, leggendo i suoi scritti o ascoltandolo nel corso di una discussione, non si aveva mai la sensazione che per lui la filosofia fosse soltanto un raffinato gioco intellettuale. Qualcosa che si persegue per il puro piacere di mostrare agli interlocutori la propria abilità nell’escogitare un argomento cogente o un’obiezione devastante. Anche quando le sue distinzioni diventavano sottili – e Jerry era più sottile di tanti – era assolutamente chiaro che ciò che lo guidava era la convinzione che pensare filosoficamente la politica è essenziale perché ci aiuta a comprendere uno degli aspetti centrali dell’esistenza umana. Sbaglierebbe, tuttavia, chi pensasse che Jerry Cohen fosse uno di quegli intellettuali divorati dalla passione per la politica al punto da non essere in grado di pensare a altro. O da essere disposti a seguire la ragione solo se li conduce dove desiderano. Al contrario, egli apprezzava il rigore degli argomenti perché aveva rispetto per la verità, e pretendeva lo stesso atteggiamento anche da parte degli altri. Chiunque abbia avuto il privilegio di discutere con lui, anche per qualche minuto, si rendeva conto di avere a che fare con una persona che non era disposta a economizzare sulla verità, nemmeno per favorire una tesi cui teneva. Un modo di concepire l’attività del filosofo che, in un suo libro recente, egli riassume scrivendo che, se è vero che la filosofia politica cerca di orientare l’azione, ciò non comporta che la sua ragion d’essere risieda solo in questo. Per Cohen, la filosofia politica non è una branca della “tecnologia sociale normativa”. Il marxismo analitico Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, Jerry Cohen non è stato solo un esempio di rigore intellettuale e di passione politica. C’è una terza caratteristica che faceva di lui una persona unica, il suo senso dell’umorismo. A questo aspetto della sua personalità è legato il ricordo del mio primo incontro con lui alla fine degli anni novanta. In quel periodo mi trovavo a Manchester, dove ero stato invitato da Hillel Steiner, uno dei più cari amici di Jerry. Fu proprio la sera precedente un seminario che Cohen avrebbe tenuto nel dipartimento di Government di quella università che l’ho visto per la prima volta. Avevo da poco tradotto in italiano un suo saggio per un’antologia sulla libertà che stavo curando insieme a Ian Carter. Se non ricordo male, eravamo a cena da Ursula Vogel. Mi aspettavo di trovarmi di fronte un austero professore di Oxford, e fui sorpreso quando invece mi resi conto che l’illustre studioso che avevo tradotto era una persona gioviale, che non si dava affatto delle arie. Un conversatore brillante e sagace. Con un’eccezionale abilità nel riprodurre i modi di parlare e i manierismi di colleghi e amici con effetti esilaranti. In particolare, ricordo che quella sera Jerry si esibì in uno dei pezzi più riusciti del suo repertorio, l’imitazione del suo amico e insegnante Isaiah Berlin, di cui rendeva alla perfezione l’accento e l’eloquio torrenziale. A quei tempi non conoscevo ancora bene i suoi lavori. L’immondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 54 / / pressione che mi fece, mentre lo ascoltavo che presentava una delle critiche a Rawls che andava elaborando proprio in quel periodo, mi spinse a cercare di acquisire familiarità con la sua teoria normativa della giustizia, e da allora ho letto avidamente i suoi nuovi lavori appena ne ho avuto l’occasione. In particolare, fui colpito dal libro che raccoglieva le sue Gifford Lectures, pubblicato nel 2000 – che aveva un titolo di rara efficacia: If You’re an Egalitarian How Come You’re So Rich? – al punto da farne una recensione per le pagine culturali del Sole 24 Ore. Pochi giorni dopo la pubblicazione di questo articolo ricevetti una divertente e-mail in cui Jerry mi raccontava che una sua amica di infanzia – che viveva nel nostro paese perché aveva sposato un italiano – aveva letto la recensione, e si era complimentata con lui per il riconoscimento ottenuto in un giornale così prestigioso. Con la caratteristica auto-ironia Jerry diceva di aver avuto grazie a me una grande soddisfazione perché questa amica, nonostante la sua cattedra “Chichele” a Oxmondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? ford, non l’aveva mai preso sul serio. Negli anni seguenti ho rivisto Jerry diverse volte in occasione di seminari. L’ultima quando ho seguito la conferenza per il centenario della nascita di Berlin che lui aveva contribuito a organizzare presso il loro College, All Souls, pochi mesi prima che un malore lo sottraesse improvvisamente all’affetto della famiglia, degli allievi e degli amici. Nato in Canada da una famiglia di immigrati russi nel 1941, Jerry Cohen era arrivato a Oxford negli anni sessanta, quando l’università britannica poteva vantare tra i suoi docenti figure come Berlin e Gilbert Ryle. Al primo, in particolare, Cohen riconosceva un’importanza centrale nella propria formazione per averlo indirizzato a riconsiderare il pensiero di Marx, spingendolo a rileggerlo criticamente anche alla luce degli sviluppi più recenti della filosofia analitica. Come lo stesso Jerry racconta nel suo contributo a uno dei volumi in onore di Berlin, questo incontro casuale si era rivelato determinante perché fu / / 55 / / grazie a esso che ebbe inizio un percorso di ricerca che lo avrebbe portato a mettere in discussione le letture di Marx che andavano di moda in quegli anni per cercare di discutere gli argomenti del filosofo tedesco per il loro valore intrinseco, e non soltanto alla luce delle conseguenze politiche che se ne possono trarre. Ne era venuto fuori un libro che ancora oggi viene considerato uno dei contributi più lucidi alla letteratura sul padre del “socialismo scientifico”, Karl Marx’s Theory of History. A Defence, pubblicato per la prima volta nel 1978. Una delle testimonianze più significative di una stagione di rinnovato interesse per la filosofia politica e sociale di Marx da parte di un gruppo di filosofi e scienziati sociali di talento, tra i quali bisogna ricordare almeno Jon Elster, John Roemer e da ultimo Jonathan Wolff. L’aspetto più significativo di questo lavoro, scritto mentre Jerry insegnava filosofia a University College a Londra, è anche quello che lascia più perplessi i lettori continentali. Cohen non tenta in alcun modo di adoperare il metodo dialettico che Marx aveva ereditato da Hegel. Al contrario, lo scopo del libro è di presentare una riformulazione della teoria della storia di Marx che non postuli l’esistenza di strutture collettive e relazioni sociali di cui le persone che vivono in una società non sono consapevoli, e che potrebbero anzi essere in conflitto con i loro interessi. La sostanza dell’argomento di Marx viene invece ricostruita da Cohen ricorrendo a spiegazioni funzionali del tipo di quelle che si usano normalmente in biologia, e che sono una parte essenziale del programma di ricerca darwiniano che aveva esercitato una certa influenza sullo stesso Marx. Il rapporto con la religione Si tratta di un tentativo ingegnoso – ancora di grande attualità, come mostrano lavori recenti di studiosi come Jared Diamond o Ian Morris – per mettere il materialismo storico al riparo da certe obiezioni epistemologiche avanzate nella seconda metà del ventesimo secolo. Come lo stesso Cohen ha sostenuto in una conferenza tenuta a Parigi nel 2000, lo scopo di fondo del libro – e dei saggi che ne sviluppano alcuni spunti negli anni seguenti – era difendere Marx, ma attraverso una ricostruzione analitica dei suoi argomenti. Con i lavori di Elster e di Roemer, gli scritti di Cohen che appartengono a questo periodo della sua produzione intellettuale vengono solitamente classificati con l’etichetta di “marxismo analitico”: un filone di studi che non ha alcun successo del nostro paese, ma che ha avuto invece un certo seguito nel dibattito internazionale. Come ho detto, Cohen nacque in Canada. La sua era una famiglia di ebrei di origini russe. La madre, cui era molto legato, come si evince dai suoi scritti autobiografici, era impegnata in prima linea nel movimento operaio. La militanza comunista è uno dei tratti caratteristici di un’identità che, sin dalla prima infanzia, si nutre di teoria e pratica marxista e di un forte senso di appartenenza al popolo ebraico, accompagnate da un rapporto non sempre facile con la religione, che di solito costituisce il fattore primario di identificazione di tale popolo. Da bambino e da adolescente, per via delle convinzioni politiche dei genitori, Cohen non prende parte ai riti religiosi che contribuivano in modo determinante a rinsaldare l’identità e il senso di solidarietà dei suoi coetanei e compagni di scuola di origine ebraica in un paese abitato prevalentemente da cristiani, sia pure di diverse denominazioni. Le pagine degli scritti autobiografici in cui Cohen si sofferma sugli anni della sua formazione politica e intellettuale, sulle certezze e sui dubbi che un po’ alla volta le sostituiscono, sono molto belle, e segnalano questa parte della sua produzione all’attenzione di chi è interessato alle diverse, e spesso tragiche, esperienze della diaspora. Col tempo Cohen, nel corso di un processo di ripensamento critico del materialismo iniziato con il libro sulla teoria della storia di Marx, ha assunto una posizione meno rigida nei confronti della religione dei suoi padri (e, più in generale, nei confronti della tradizione che ha origine nel monoteismo ebraico), diventando un lettore, sia pur pudico, della Bibbia e dei Vangeli. Uno dei capitoli più interessanti di If You’re an Egalitarian è proprio quello su marxismo e religione, che contiene una lettura di grande interesse di Feuerbach e dei suoi argomenti. Ma l’attenzione principale in quel libro, per quanto riguarda Marx, è dedicata a una critica di quella che Cohen chiama la concezione “ostetrica” della politica. Si tratta della tesi che Marx enuncia in maniera lapidaria negli scritti sulla guerra civile in Francia, quando afferma che «la classe operaia non ha da realizzare ideali, ma da liberare gli elementi della nuova società di cui è gravida la vecchia e cadente società borghese». Per Marx, il compito della politica, come quello dell’ostetrica, è di aiutare, rendere più facile, realizzare nel modo più efficace, un evento che avrebbe luogo comunque. La transizione al socialismo è qualcosa che avviene necessariamente, per lo sviluppo delle contraddizioni interne del capitalismo, e quindi i militanti sono chiamati più che altro a intervenire come tecnici, come levatrici della storia, che non devono sforzarsi mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 56 / / stengono alcuni suoi seguaci nella scia di Althusser, l’emancipazione richiede un impegno morale, e da parte del filosofo della politica il fare i conti con le questioni normative poste dalla teoria della giustizia. La necessità del progetto per elaborare un modello di società giusta. In tale prospettiva la critica morale del capitalismo non è essenziale perché esso è destinato a estinguersi in ogni caso. L’ingiustizia dello sfruttamento, che pure è sotto gli occhi di tutti, non ha bisogno di essere sottolineata più di tanto, perché quel che conta è conoscere la dinamica interna del processo che porterà a superarlo, assecondandolo nel modo migliore. Per Cohen questo modo di intendere la politica è fuorviante (non c’è un esito inevitabile dell’evoluzione sociale e non esistono più le condizioni dipendenti dalla struttura di classe che rendevano plausibile questa parte della teoria di Marx) e ha causato notevoli danni alle istanze di emancipazione che erano la radice più profonda della critica marxista del capitalismo. Contrariamente a quel che sembra affermare Marx, almeno in alcuni passaggi delle sue opere, e a quello che ancora oggi somondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? A questo compito è dedicata buona parte dei lavori di Cohen pubblicati a partire dagli anni ottanta, che contengono una critica serrata ad alcuni aspetti delle teorie liberali della giustizia, in particolare quelle di Nozick e di Rawls. Un percorso intellettuale che ha diversi punti di contatto, anche se non si incrocia direttamente, con quello che conduce Salvatore Veca, all’incirca negli stessi anni, a occuparsi dei medesimi autori. Tuttavia, a differenza del filosofo italiano, che aderisce sostanzialmente alla prospettiva liberale di Rawls abbandonando il marxismo della sua formazione, Cohen si lascia alle spalle il comunismo e prende sempre più le distanze da Marx per approdare a un socialismo democratico e libertario. Rileggendoli oggi, gli scritti di Cohen degli anni ottanta sono di particolare interesse per chi voglia riflettere sulla vicenda del PCI e più in generale della sinistra italiana, e sulle cause delle sue presenti difficoltà. Colpisce, in particolare, il fatto che nei saggi di Cohen si trovino le risposte alle domande che, nel 1985, Aldo Schiavone poneva al Partito Comunista in un libro che all’epoca suscitò vivaci polemiche. La questione del pluralismo, quella della classe operaia come classe generale, quella della concepibilità di un socialismo che si realizza con metodi democratici e che escludano la coercizione non giustificata in modo accettabile da tutti, e non solo dai membri di un partito o da chi ne sostiene gli obiettivi. Dell’interesse per Nozick, e in particolare per le sue tesi sulla proprietà, sono testimonianza i lavori raccolti in Self-Ownership, Freedom and Equality, un libro pubblicato nel 1995. Di Rawls invece Cohen si occupa a più riprese a partire dagli anni novanta. La discussione della teoria di Rawls ha un ruolo molto importante nella seconda parte di If You’re an Egalitarian e in quello che probabilmente è destinato a rimanere il libro più importante di Cohen, Rescuing Justice & Equality, pubblicato nel 2008. Dell’importanza delle obiezioni che egli muoveva alla teoria liberale della giustizia di Rawls, e in particolare al principio di differenza, di cui criticava le conseguenze a suo dire negative dal punto di vista dell’eguaglianza, sono testimonianza ben tre volumi sul suo pensiero pubblicati negli ultimi anni, uno dei quali in italiano, che raccolgono contributi di buona parte dei più importanti filosofi della politica con- / / 57 / / temporanei. Come è noto, per Rawls i principi di giustizia si applicano alle istituzioni che fanno parte della “struttura di base” della società, ad es. il mercato. Ne consegue che le azioni delle persone all’interno di tali istituzioni, se rispettano i vincoli posti dalle istituzioni stesse, non sono ingiuste. Cohen contesta la nozione di “struttura di base della società”, centrale nella teoria rawlsiana della giustizia, sostenendo che non è chiaro cosa sia escluso da tale struttura sulla base dei criteri proposti da Rawls. Per Cohen ci sono interazioni che, pur avvenendo all’interno della struttura di base e nel rispetto delle regole, possono essere considerate ingiuste. Tali sarebbero, ad esempio, le relazioni di sfruttamento all’interno della famiglia. Il ricco egualitario La seconda parte di If You’re an Egalitarian si chiude con una domanda: come dovrebbero comportarsi gli egualitari all’interno di una società ingiusta? Da qui il titolo del libro: se sei un egualitario, perché sei così ricco? Una domanda la cui bruciante attualità anche nel nostro paese è confermata dalle ricorrenti polemiche sui cachemere di D’Alema o sulle vacanze di Bertinotti, ma a cui è difficile negare un fondamento. La questione può essere riformulata in questo modo: quali argomenti avrebbe un sincero egualitario, in una società ingiusta, per non dare una parte sostanziale dei propri averi ai poveri o a quelle organizzazioni che cercano di ridurre la povertà? Cohen discute e respinge diverse ipotesi di risposta, concludendo con quello che sembrerebbe un argomento a contrario in favore di azioni redistributive da parte degli egualitari. Si tratta di una conclusione interlocutoria, che pone certamente un problema agli egualitari. Per venir fuori da quella che evidentemente era una posizione insoddisfacente, Cohen scrive a partire dagli anni ottanta una serie di saggi, e poi il libro sulla giustizia che abbiamo già menzionato, un volume di più di quattrocento pagine che rappresenta la più articolata critica da sinistra mossa alle idee di Rawls. Rescuing Justice & Equality è una discussione serrata di diversi passaggi cruciali della teoria della giustizia rawlsiana. Lo stesso Cohen sintetizza le proprie obiezioni nella spiegazione iniziale del titolo scelto per questo libro: salvare il concetto di giustizia dal “costruttivismo” e l’eguaglianza dal “principio di differenza” – due idee cruciali nella teoria della giustizia come fairness proposta da John Rawls. Quando è stato colpito dall’ictus che in poche ore ne ha causato la morte, Jerry aveva appena dato alle stampe il suo ultimo lavoro, di cui è appena uscita la traduzione italiana, Why Not Socialism?: un breve saggio che presenta un’agile difesa del socialismo come sistema di organizzazione sociale che, pur essendo difficile da realizzare, è moralmente più attraente delle alternative basate sull’accettazione del perseguimento dell’interesse personale come motivazione principale dell’agire umano. Un modello di come sia possibile fare filosofia in modo accessibile a tutti, senza fingere che le cose siano più semplici di quel che sono, e senza indulgere nel tono oracolare in voga tra certi critici contemporanei del mercato e delle teorie liberali della giustizia. Al centro del libro di Cohen c’è un esperimento mentale. Al lettore si chiede di immaginare come si regolerebbe un gruppo di persone che intende trascorrere qualche giorno fuori casa in campeggio, avendo come unico scopo comune quello di divertirsi e di fare ciò che piace a ciascuno. In una situazione del genere, sostiene Cohen, emergerebbero naturalmente due principi di cooperazione. Uno che assicura l’eguaglianza e l’altro che promuove lo spirito di comunità tra i partecipanti alla gita, operando come vincolo rispetto alle interpretazioni del primondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 58 / / tidoto di cui si sentiva il bisogno contro la pigrizia mentale di certi liberali. Con questo agile libretto Jerry Cohen ci ha lasciato un’eloquente testimonianza della persistente attualità delle istanze che hanno ispirato la tradizione socialista democratica e libertaria. Per questo, in occasione della sua traduzione nella nostra lingua, ci è sembrato opportuno promuovere una discussione sulle idee di questo originale pensatore. Bibliografia essenziale mo principio che potrebbero avere l’effetto di rovinare l’esperienza di vita in comune. Ovviamente Cohen si rende ben conto che la gita di cui ci parla è ben diversa da una società politica. Tuttavia, questo è il punto di fondo dell’argomento, ciò non ci impedisce di esplorare la possibilità che principi simili a quelli che sono emersi al campeggio si applichino anche a realtà più complesse: soprattutto se, come egli sostiene, l’eguaglianza è considerata un valore fondamentale anche in altri casi. A questo punto, avendo chiarito il contenuto di un ideale di cooperazione che cattura alcune delle caratteristiche tipiche della tradizione socialista, Cohen affronta nelle pagine conclusive la questione della realizzabilità dell’ideale. Questa seconda parte dell’argomento è una breve e incisiva rassegna di alcune proposte teoriche recenti che suggeriscono modi di organizzare l’economia su basi diverse rispetto a quelle favorite dai difensori del capitalismo. Una lettura affascinante e divertente. Un anmondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? A. BESUSSI e E. BIALE (a cura di), Fatti e principi. Una disputa sulla giustizia, Aracne, 2010. I. CARTER e M. RICCIARDI (a cura di), L’idea di libertà, Feltrinelli, 1996. I. CARTER (a cura di), L’idea di eguaglianza, Feltrinelli, 2005. I. CARTER, L’eguale libertà, Feltrinelli, 2001. G.A. COHEN, History, Labour and Freedom, Oxford University Press, 1988. G.A. COHEN, Isaiah’s Marx and Mine in Edna and Avishai Margalit (eds), Isaiah Berlin. A Celebration, The Hogarth Press, 1991, pp. 110-126. G.A. COHEN, Self-Ownership, Freedom and Equality, Cambridge University Press, 1995. G.A. COHEN, Karl Marx’s Theory of History. A Defence, Expanded edition, Princeton University Press, 2000. G.A. COHEN, Engagement sans vénération. Reflexions sur le marxisme analytique, in Un siècle de philosophie 1900-2000, Gallimard, 2000, pp. 615-636. G.A. COHEN, Why Not Socialism?, Princeton University Press, 2009. G.A. COHEN, On the Currency of Egalitarian Justice and Other Essays in Political Philosophy, Princeton University Press, 2011. C. DEL BO’, I diritti sulle cose, Carocci, 2008. J. ELSTER, Making Sense of Marx, Cambridge University Press, 1985. B. FELHAM (ed. by), Justice, Equality and Constructivism. Essays on G.A. Cohen’s “Rescuing Justice and Equality”, Blackwell, 2009. M. RICCIARDI (a cura di), L’ideale di giustizia, Università Bocconi Editore, 2010. J. ROEMER, A General Theory of Exploitation and Class, Harvard University Press, 1982. A. SCHIAVONE, Per un nuovo PCI, Laterza, 1985. C. SYPNOWICH (ed. by), The Egalitarian Conscience. Essays in Honour of G.A. Cohen, Oxford University Press, 2006. S. VECA, Le mosse della ragione, Il Saggiatore, 1980. / / 59 / / >>>> dossier / why not socialism? Una filosofia socialista >>>> Francesca Pasquali L eggendo Cohen, due sono gli elementi che attirano subito l’attenzione: da un lato l’appassionata adesione a valori socialisti che, come Cohen scrive in più occasioni, è riconducibile all’ambiente familiare e sociale in cui è cresciuto; dall’altro l’impegno al rigore argomentativo che, riconducibile invece alla sua formazione filosofica a Oxford, è per Cohen incondizionato, in quanto risponde a criteri di razionalità cui non è disposto a rinunciare. Ciò che anima il lavoro di Cohen è infatti la convinzione che un’indagine normativa, svolta in conformità con gli standard della tradizione analitica, sia indispensabile per promuovere il socialismo: per illustrarne i principi fondamentali e difenderne la desiderabilità, attraverso un confronto critico con il marxismo e con le posizioni di pensatori libertari, come Robert Nozick, e liberali, come John Rawls. Rivendicando in chiave normativa la desiderabilità del socialismo, Cohen prende le distanze dalla concezione marxista classica, secondo cui, dato che la realizzazione del socialismo è inevitabile, non è necessario né argomentare a favore del socialismo, né delineare con chiarezza i principi di giustizia che regoleranno la società socialista. Secondo questa concezione, la rivoluzione socialista è inevitabile perché, rimuovendo le ineguaglianze, è nell’interesse di un gruppo sociale, il proletariato, che è anche in grado di produrre tale trasformazione in quanto destinato a occupare una posizione sempre più maggioritaria e cruciale nei processi produttivi delle società capitaliste. Inoltre tale concezione prevede che il costante sviluppo delle forze produttive condurrà a una condizione di abbondanza materiale che consentirà a ognuno di perseguire liberamente la propria auto-realizzazione, evitando di ricadere, una volta avvenuta la rivoluzione, in una situazione di ineguaglianza. Per Cohen lo sviluppo del capitalismo ha smentito entrambe le predizioni fattuali su cui la concezione marxista classica si fonda. Da un lato, nelle società capitaliste avanzate, non c’è un gruppo sociale che abbia un immediato interesse a intraprendere una trasformazione socialista e sia, al tempo stesso, in una posizione maggioritaria e tanto cruciale da essere all’altezza di produrre tale trasformazione. Dunque chi si muove nel solco della tradizione marxista non può trattare l’eguaglianza come un fatto che prima o poi si realizzerà, ma deve impegnarsi a sviluppare argomenti che ne mostrino la desiderabilità e invitino gli individui a promuoverla. Dall’altro lo sviluppo produttivo e tecnologico si scontra con la scarsità di risorse, che non consente di raggiungere una condizione di abbondanza. Per cui non è possibile eludere questioni di giustizia, ma è necessario elaborare principi di giustizia distributiva adeguati a una condizione di scarsità. A simili conclusioni Cohen giunge dopo un intenso confronto con la teoria della storia di Marx. In Karl Marx’s Theory of History (1978), Cohen delinea una ricostruzione del materialismo storico che ruota intorno a due tesi: la prima afferma che le forze produttive tendono a svilupparsi nel corso della storia, la seconda che la natura dei rapporti di produzione è spiegata dal livello di sviluppo delle forze produttive. Difendendo la plausibilità di quest’ultima tesi, che chiama primacy thesis, Cohen rivendica la centralità della dimensione materiale: le forze produttive – strumenti, macchinari, materie prime, forza lavoro – sono prioritarie in termini causali ed esplicativi rispetto ai rapporti di produzione, che riguardano, invece, il potere economico delle persone, il potere di cui le persone godono sui mezzi di produzione e sulla forza lavoro. Cohen rintraccia il nesso tra le due tesi con riferimento alla razionalità degli esseri umani: dato che la crescita delle forze produttive comporta la diminuzione del carico di lavoro necessario a produrre un certo bene, quando lo sviluppo tecnologico consente di elaborare misure che accrescono le forze produttive gli esseri umani adottano simili misure perché sarebbe irrazionale non farlo. Quindi, come Cohen precisa in History, Labour, mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 60 / / and Freedom (1988, p. 55), il passaggio dal capitalismo al socialismo è da considerarsi inevitabile non a prescindere dalle azioni degli esseri umani, ma in quanto rappresenta l’esito di ciò che è razionale aspettarsi che essi facciano in una società capitalista. Infatti, quando lo sviluppo delle forze produttive lo permette, è razionale per i proletari promuovere un sistema produttivo che abolisca le ineguaglianze. Nel testo appena citato Cohen critica anche l’interpretazione classica del materialismo storico, perché riconducendo fenomeni culturali e spirituali allo sviluppo materiale, non è in grado di rendere conto di importanti bisogni umani, quali il bisogno di auto-definizione e di identificazione. Senza negare la priorità della dimensione materiale, Cohen propone una versione ristretta della teoria che riconosce le implicazioni di fenomeni culturali o spirituali sulla dimensione materiale, sebbene ribadisca che simili fenomeni non possono interferire con il progresso materiale, né possano offrirne una spiegazione completa. History, Labour, and Freedom segna un momento di passaggio nel pensiero di Cohen. La revisione del materialismo storico, e ancor più il modo in cui Cohen affronta alcune tematiche marxiste, mostrano il suo crescente interesse a confrontarsi con Marx e la teoria marxista non solo per ricostruirne in modo rigoroso le tesi, ma per chiarirne anche i presupposti e le implicazioni normative, per trarne spunti e strumenti per trattare questioni più generali. A questo proposito l’analisi dello sfruttamento è un esempio interessante. Per il marxismo lo sfruttamento è una categoria meramente descrittiva, che indica il trasferimento dai proletari ai capitalisti del valore, o (come Cohen ritiene più corretto) dei beni che i proletari producono (1988, pp. 209-238). In Self-Ownership, Freedom, and Equality (1995) Cohen precisa che i marxisti trattano ogni forma di trasferimento dai lavoratori ai capitalisti come sfruttamento perché aderiscono, almeno implicitamente, alla tesi della proprietà di sé. La tesi afferma che ogni persona gode, rispetto a se stessa e alle proprie capacità, di diritti esclusivi di uso e controllo, e che dunque ogni persona ha, sui frutti delle proprie capacità e del proprio lavoro, un insieme di diritti comparabili a quelli di chi gode della proprietà esclusiva di un oggetto fisico. Per Cohen l’adesione alla tesi della proprietà di sé conduce i marxisti a conclusioni che contraddicono principi socialisti. Per esempio, proprio perché aderiscono a questa tesi, i marxisti tratterebbero come sfruttamento il trasferimento di una quota di beni prodotti da un lavoratore, soddisfatto del proprio lavoro e della propria retribuzione, a un vicino infermo che, pur possedendo del capitale, non può produrre i beni necessari al proprio sostentamento, e senza il trasferimento in mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? questione morirebbe. Un simile giudizio è, per Cohen, in contrasto con una posizione d’ispirazione socialista, secondo cui nessuno, in una situazione di bisogno, dovrebbe essere lasciato privo di aiuto (1995, p. 151). In effetti, se perseguita coerentemente, la tesi della proprietà di sé non consente di giustificare politiche sociali redistributive, perché implica che una redistribuzione di risorse o ricchezze da chi produce a chi si trova in una situazione di bisogno, ma non partecipa al processo produttivo, sia una forma di sfruttamento e sia quindi illegittima. Al contrario, per Cohen, non ogni forma di trasferimento è sfruttamento: per stabilire se lo sia o meno, è necessario valutare in termini normativi se il trasferimento soddisfi considerazioni di giustizia. Il paradosso di Wilt Chamberlain Una valutazione di questo tipo richiede di prendere in esame le circostanze in cui il trasferimento avviene. Per i marxisti nella società capitalista il trasferimento di valore o beni dai lavoratori ai capitalisti è sfruttamento, perché avviene sullo sfondo di una condizione segnata dall’ineguaglianza rispetto alla proprietà dei mezzi di produzione. Tuttavia, come Cohen sottolinea, anche in una situazione di partenza perfettamente egualitaria rispetto alla distribuzione delle risorse e dei mezzi di produzione il libero esercizio delle facoltà individuali e le interazioni volontarie tra gli individui possono condurre a marcate ineguaglianze. Infatti, dato che gli individui sono dotati di capacità produttive diverse, chi è meglio dotato produrrà in modo più efficiente o di più, risultando in una posizione di vantaggio materiale che può tradursi in disparità di potere contrattuale tra gli individui, alcuni dei quali si troveranno a dover trasferire ciò che producono a qualcun altro. Questa nuova situazione è ineccepibile per chi aderisce alla tesi della proprietà di sé, perché frutto delle maggiori capacità di alcuni e del loro impegno. Come Cohen suggerisce, questa situazione sarebbe ineccepibile anche per i marxisti, perché ritengono che l’ineguale distribuzione delle risorse sia la principale fonte di ingiustizia. Al contrario per Cohen ciò che conta, dal punto di vista della giustizia, è la distribuzione di vantaggi e svantaggi, che è determinata sia dalla ripartizione delle risorse, sia dalle dotazioni naturali degli individui, dalle loro capacità e dai loro talenti. Considerazioni circa le ineguaglianze derivanti dalle dotazioni naturali sono per Cohen cruciali, mentre non sono ritenute rilevanti né dai marxisti, né dai pensatori libertari che difendono la tesi della proprietà di sé. Cohen riconosce che la tesi della proprietà di sé non può es- / / 61 / / sere rifiutata né in quanto falsa, né mostrando che il concetto stesso di proprietà di sé è incoerente o irrimediabilmente vago. È possibile però, secondo Cohen, mostrare che aderire a tale tesi ha implicazioni normative inaccettabili, in particolare per chi fa propri valori socialisti. In effetti, in Anarchy, State and Utopia (1974), Nozick utilizza la tesi della proprietà di sé come premessa per dimostrare che solo uno Stato minimo, che, in sostanza, si limita a garantire l’ordine pubblico, è compatibile con le libertà e i diritti individuali. Come Cohen spiega in Self-Ownership, Freedom, and Equality, l’argomento di Nozick è particolarmente problematico da una prospettiva socialista, non solo perché presenta come illegittima ogni forma di redistribuzione, ma anche perché intende enfatizzare la tensione tra libertà ed eguaglianza. Secondo Nozick, infatti, l’esercizio della libertà individuale tende a sovvertire l’eguaglianza e, per mantenere l’eguaglianza, è necessario o limitare la libertà degli individui o adottare misure redistributive che minano i diritti derivanti dalla proprietà di sé. Per illustrare questo punto Nozick invita chi difende l’eguaglianza a immaginare una società in cui vi sia una distribuzione – D1 – conforme a principi egualitari. In questa società, Wilt Chamberlain, un talentuoso giocatore di basket, decide di chiedere, a chi intenda vederlo giocare, di versargli una quota di 25 centesimi di dollaro. Se un milione di persone assiste alle partite, Chamberlain guadagnerà 250.000 dollari e si avrà così una nuova distribuzione – D2 – che non soddisfa i principi egualitari di D1, in quanto Chamberlain sarà molto più ricco degli altri. Per Nozick, dato che D1 è giusta e che le interazioni che conducono a D2 sono legittime, perché avvengono in modo volontario, anche D2 è giusta (Nozick 1974, p. 161). Dunque ripristinare la situazione iniziale, per esempio, tassando i guadagni di Chamberlain, equivarrebbe a violare la libertà degli individui di esercitare i diritti conferiti loro dalla proprietà di sé: la libertà di spendere come preferiscono la quota di denaro che legittimamente possiedono. Secondo Cohen, Nozick intende dimostrare che l’esercizio della libertà non è in contrasto con la giustizia, e anzi che qualsiasi esito si produca a partire da una situazione conforme a principi di giustizia e attraverso una serie di interazioni giuste, vale a dire volontarie, è a sua volta giusto. Cohen suggerisce, al contrario, che l’esercizio della libertà non garantisce necessariamente la conservazione della giustizia. In effetti, secondo Cohen, prima di concludere che la tassazione riduce la libertà, ed è dunque ingiusta, si dovrebbe verificare se un intervento redistributivo non garantisca altre importanti libertà, perché la libertà dipende non solo dall’assenza di interferen- ze, come ritiene Nozick, ma anche dalla distribuzione delle risorse e dal conseguente posizionamento, in termini di potere contrattuale, degli individui. Cohen sottolinea che Chamberlain potrebbe trarre dal proprio vantaggio materiale un potere eccessivo e illegittimo che, a sua volta, potrebbe minare la libertà degli altri individui. Inoltre, per Cohen, non c’è necessariamente conflitto tra eguaglianza e libertà, perché non è sempre indispensabile sacrificare la libertà per garantire l’eguaglianza. Cohen segnala che gli individui potrebbero riconoscere un valore intrinseco ai principi egualitari che regolano D1 e potrebbero ritenere, quindi, D2 ingiusta, sebbene sia il risultato delle loro libere scelte. Infatti, per Cohen, che eguaglianza e libertà siano o meno in conflitto dipende dal valore che le persone attribuiscono all’eguaglianza stessa: non è nemondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 62 / / cessario limitare la libertà delle persone per promuovere l’eguaglianza, se le persone considerano l’eguaglianza un valore da perseguire e agiscono di conseguenza. L’egualitarismo della sorte Come già accennato, per Cohen, sono rilevanti non solo le ineguaglianze dovute a differenti dotazioni di risorse, ma anche quelle dovute alle dotazioni naturali degli individui. In On the Currency of Egalitarian Justice (Cohen 1989), Cohen indica l’accesso al vantaggio come ciò che dovrebbe essere reso eguale e propone un criterio per distinguere tra ineguaglianze che richiedono compensazione, in quanto ingiuste, e ineguaglianze accettabili. In particolare, considerazioni di giustizia richiedono, secondo Cohen, di compensare le ineguaglianze che non riflettono le scelte degli individui, ma che sono, invece, il prodotto della sorte bruta, vale a dire di circostanze o eventi al di fuori delle possibilità di controllo degli individui stessi. Come Cohen precisa in Luck and Equality (Cohen 2006), un simile approccio, che prende il nome di egualitarismo della sorte (luck egalitarianism), richiede compensazione per tutte le ineguaglianze innate o ereditarie: per ineguaglianze che dipendono dalle dotazioni naturali, fisiche o psicologiche, degli individui, dal loro status sociale o economico e dall’ambiente culturale in cui vivono. L’egualitarismo della sorte è animato dall’avversione verso ineguaglianze per cui gli individui non possono essere ritenuti responsabili, ma non richiede di instaurare l’eguaglianza semplice, vale a dire di eliminare ogni tipo di ineguaglianza. In effetti, eliminare anche le ineguaglianze che nascessero tra persone che, a parità di talenti naturali e risorse iniziali, compiendo scelte diverse, ottenessero una diversa quota di vantaggi e svantaggi, equivarrebbe a rinnegare il principio stesso che anima l’egualitarismo della sorte. Il principio di eguaglianza socialista delle opportunità, proposto in Why Not Socialism? (Cohen 2009), il testo dalla cui traduzione italiana la discussione ospitata in queste pagine prende spunto, è in linea con questa concezione. Tale principio richiede non solo la rimozione di vincoli formali al pari godimento delle opportunità e la compensazione di ineguaglianze dovute allo status sociale, ma anche la compensazione di ineguaglianze dovute a fattori non sociali, quali i talenti naturali. In base a tale principio, sono ammissibili le ineguaglianze riconducibili alle preferenze degli individui e quelle dovute alla sorte opzionale, vale a dire derivanti dalla scelta deliberata di assumere rischi che possono comportare perdite o guadagni mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? elevati e condurre a ineguaglianze considerevoli. Per Cohen, sebbene non violino il principio di eguaglianza socialista delle opportunità, le ineguaglianze dovute alla sorte opzionale possono creare, tra gli individui, un divario che rende difficile pensare di fare parte della stessa comunità, di condividere, in modo cooperativo, oneri e benefici. Per questo, in Why Not Socialism?, accanto al principio di eguaglianza appena ricordato, Cohen introduce un principio di comunità, che richiede alle persone di prendersi cura le une delle altre e mira a garantire che ognuno metta le proprie capacità al servizio degli altri e a mitigare così ineguaglianze dovute alla sorte opzionale. Cohen suggerisce anche che la sorte opzionale è particolarmente problematica in una società capitalista in cui, per realizzare i propri progetti, non è possibile sottrarsi ai rischi della competizione di mercato, che produce inevitabilmente vinti e vincitori e, quindi, marcate ineguaglianze. Le ineguaglianze prodotte dal mercato si possono giustificare, non solo, come fanno Nozick e i libertari, a partire dalla tesi della proprietà di sé, ma anche, come spesso fanno i liberali, introducendo considerazioni di efficienza. Infatti, si può sostenere che, se incentivi economici, vale a dire la prospettiva di maggiori guadagni, inducono le persone dotate di maggiori capacità produttive a produrre più di quanto farebbero altrimenti, le ineguaglianze che ne derivano sono giustificate, perché permettono di aumentare la quota totale di ricchezza da ridistribuire a beneficio dei meno avvantaggiati. Questo argomento, che pone una sfida ai sostenitori dell’eguaglianza, animati proprio dall’intento di migliorare le condizioni dei più svantaggiati, è in linea con il principio di differenza proposto da Rawls A Theory of Justice (Rawls 1971). Il principio di differenza afferma che le ineguaglianze sociali ed economiche sono ammissibili solo se vanno a vantaggio dei meno avvantaggiati (Rawls 1971, p. 83) e sembra quindi giustificare l’introduzione di incentivi economici. L’analisi di Cohen intende mostrare che tali incentivi sono resi necessari, non da vincoli di efficienza, ma dal fatto che i più talentuosi non sono disposti a produrre al meglio delle proprie capacità in assenza di incentivi. A questo proposito, sia in Incentives, Inequality, and Community (Cohen 1996), sia in Rescuing Justice and Equality (Cohen 2008), Cohen esamina un argomento contro l’innalzamento della quota di prelievo fiscale dal 40 al 60 per cento. L’argomento si fonda su una premessa normativa, secondo cui le ineguaglianze economiche sono giustificate se migliorano le condizioni dei più svantaggiati, e su una premessa fattuale, secondo cui, se le tasse incidono sul 40 per cento delle retri- / / 63 / / buzioni, i talentuosi producono più di quanto produrrebbero se la percentuale fosse del 60 per cento e, quindi, con una tassazione del 40 per cento, i meno avvantaggiati si trovano in una condizione migliore. Secondo Cohen, è poco plausibile pensare che, se la tassazione sale al 60 per cento, i più ricchi e talentuosi siano di fatto incapaci di produrre quanto producono con una tassazione del 40 per cento. Di conseguenza, Cohen ritiene che non siano fattori indipendenti dalla volontà dei ricchi e talentuosi a rendere vera la premessa fattuale su cui l’argomento si fonda, ma le loro scelte: in un regime fiscale più esigente, i ricchi e talentuosi non producono quanto produrrebbero in un regime fiscale meno oneroso, non perché ne sono incapaci, ma perché non sono disposti a farlo. In questo modo, i più ricchi e talentuosi non possono offrire, agli altri membri della società, ragioni che giustifichino il loro comportamento e viene meno, secondo Cohen, il senso di comunità tra ricchi e poveri, tra talentuosi e non talentuosi, l’idea di condividere oneri e benefici della vita sociale. Il confronto con Rawls Il principio di differenza di Rawls è per Cohen problematico proprio perché ammette incentivi che risultano necessari solo assumendo che l’attitudine degli individui più produttivi sia contraria allo spirito che dovrebbe regolare una comunità animata dallo stesso principio di differenza. Se gli individui più produttivi aderissero pienamente al principio di differenza, che è motivato dall’intento di migliorare la condizione dei più svantaggiati, non avrebbero bisogno di incentivi economici per produrre al meglio delle proprie capacità. Chi non è disposto a produrre in base alle proprie capacità per migliorare la condizione dei meno avvantaggiati, secondo Cohen, si pone al di fuori di una comunità che fa proprio il principio di differenza, in quanto non regola la propria condotta sulla base di un genuino interesse per la condizione dei meno avvantaggiati, come tale principio richiede. Il punto interessante è che, per Cohen, affinché una società sia giusta, non è sufficiente che le istituzioni siano conformi a principi di giustizia, ma è necessario che anche le persone agiscano sulla base degli stessi principi: una società giusta deve essere caratterizzata da un ethos egualitario che regola le azioni e le scelte individuali, come Cohen precisa in If You’re An Egalitarian, How Come You’re So Rich? (Cohen 2000, pp. 134-147). Per Cohen, il fatto che la giustizia richieda agli individui di adeguare le proprie azioni a principi egualitari non implica una negazione della libertà individuale. Cohen sarebbe contrario all’imposizione di pratiche egualitarie da parte di un governo centrale, ma ritiene che chi attribuisce valore all’eguaglianza, e per questo rinuncia ad azioni che danneggerebbero i meno avvantaggiati, agisce in piena libertà (Cohen 2008, pp. 181-225). In Rescuing Justice and Equality, Cohen chiarisce che il principio di differenza di Rawls potrebbe essere adeguato per definire politiche concrete da realizzare sul piano pratico, ma non dovrebbe essere considerato un genuino principio di giustizia, perché modellato sulla base delle effettive motivazioni degli individui e su considerazioni di efficienza che, secondo Cohen, non dovrebbero rientrare nella definizione di ciò che è giusto. Cohen sembra ritenere infatti che la filosofia politica, nel definire un ideale di giustizia, non dovrebbe lasciarsi guidare da considerazioni circa la possibilità di implementare i principi che propone. Anche in Back to Socialist Basics (1994), Cohen sottolinea che, dal lavoro teorico, non ci si deve aspettare l’elaborazione di proposte politiche specifiche che tengano conto di vincoli di praticabilità. Per Cohen, la riflessione teorica e filosofica è rilevante sul piano pratico nella misura in cui indaga e difende principi fondamentali, senza bisogno di rivederli alla luce di esigenze di implementazione. In questo senso, la riflessione di pensatori come Nozick, Milton Friedman e Friedrich von Hayek rispetto a valori di destra è, per Cohen, esemplare. Le proposte di questi pensatori, come Cohen sottolinea, non possono essere implementate, ma hanno un valore sul piano pratico, perché riaffermano, senza alcun compromesso, i fondamenti del pensiero di destra, permettendo ad attivisti e politici di avanzare proposte concrete e praticabili fondate su salde convinzioni. Cohen esorta la sinistra a intraprendere una riflessione teorica simile rispetto ai principi fondamentali del socialismo: eguaglianza e comunità. Il modello socialista che Cohen propone in Why Not Socialism? si fonda proprio, come già ricordato, su questi due principi. In questo testo, Cohen offre un argomento a favore dell’ideale socialista, descrivendolo come pienamente realizzato in un particolare contesto: all’interno di un campeggio. L’organizzazione del campeggio è volta a fare in modo che “tutti abbiano pressappoco le stesse opportunità di essere felici, e anche di rilassarsi, a condizione che ognuno contribuisca, secondo le proprie capacità, al benessere e all’agio degli altri” (Cohen 2009, p. 8). Il campeggio si contraddistingue anche per l’uso collettivo di strumenti e risorse, per un senso di fratellanza e per il rifiuto di rivendicazioni non egualitarie in merito alla ripartizione degli oneri o dei benefici della cooperazione. L’armondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 64 / / gomento di Cohen non mira a rivendicare la desiderabilità della vita da campeggio, ma intende invitare il lettore a riconoscere che il campeggio richiede un’organizzazione socialista, come quella descritta. Secondo Cohen, anche chi non aderisce a principi e valori socialisti non può non riconoscere che, nel contesto del campeggio, l’applicazione di principi differenti sarebbe insensata: il campeggio perderebbe il proprio carattere peculiare se fosse organizzato, per esempio, in base a principi non egualitari. Tuttavia, come Cohen sottolinea, l’aspirazione dei socialisti è realizzare su scala più ampia i principi che regolano il campeggio. Per questo motivo, Cohen respinge un’obiezione volta a mettere in dubbio la desiderabilità del modello socialista in una società più complessa rispetto a quella del campeggio, enfatizzando che l’esperienza del campeggio è una situazione limitata nel tempo, di natura ricreativa, e non mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? è segnata dalla presenza di gruppi sociali in competizione. Cohen ritiene che, per quanto le differenze tra il campeggio e le società complesse siano innegabili, questo tipo di obiezione non sia cruciale: non mostra che il modello del campeggio, fondato su altruismo e cooperazione, sia indesiderabile, ma segnala soltanto le difficoltà che potrebbero sorgere nel tentativo di implementarlo su più vasta scala e in contesti più complessi. Questo conduce Cohen a prendere in esame la praticabilità del socialismo, considerando soprattutto la possibilità che, una volta realizzata, la società socialista sia in grado di perdurare nel tempo, sia cioè stabile. La stabilità del modello socialista potrebbe risultare compromessa se gli esseri umani fossero troppo poco generosi o collaborativi per adeguarsi a principi socialisti. Cohen ritiene però che motivazioni altruistiche si riscontrino negli esseri umani al pari di motivazioni egoistiche. / / 65 / / D’altra parte, anche se le persone fossero sufficientemente generose, la stabilità del socialismo potrebbe essere minata dall’assenza di una tecnologia sociale che permetta di incanalare la generosità delle persone in modo da soddisfare minimi requisiti di efficienza, che garantiscono la stabilità di una società. Cohen considera alcune soluzioni avanzate a questo proposito troppo aderenti allo status quo. In particolare, Cohen ha delle riserve rispetto al socialismo di mercato, che abolisce la distinzione tra capitale e lavoro e prevede una diversa organizzazione all’interno delle singole aziende, ma non elimina la competizione tra aziende e tende, quindi, a produrre ineguaglianze simili a quelle che caratterizzano le società capitaliste. Altre soluzioni, come quella proposta da Joseph Carens (Carens 1981), in cui un meccanismo di mercato assicura l’efficienza e le ineguaglianze sono azzerate attraverso una redistribuzione perfettamente egualitaria della ricchezza prodotta, sono per Cohen troppo esigenti, perché richiederebbero motivazioni esclusivamente altruistiche. Pur preferendo rimanere agnostico rispetto alla possibilità di mettere a punto una tecnologia sociale adeguata a garantire l’efficienza del modello socialista, Cohen sottolinea che l’efficienza è un valore tra gli altri: può essere perseguita solo nella misura in cui è compatibile con altri valori, quali l’eguaglianza. In conclusione, è interessante notare che, per Cohen, uno dei fattori che rendono arduo, se non impossibile, realizzare il socialismo a partire dalle attuali circostanze è la convinzione, molto diffusa, che il socialismo non sia realizzabile e che, quindi, l’opzione socialista non sia da prendere in considerazione. Proprio nelle ultime battute di Why Not Socialism?, Cohen ribadisce che il fatto che il socialismo sia o meno realizzabile non ha nulla a che fare con il valore dell’ideale socialista. In linea con la propria adesione a valori socialisti e i propri impegni teorici, Cohen si propone di riaprire la riflessione sul socialismo, o meglio, di riabilitare l’opzione socialista, sgombrando il campo da obiezioni che confondono considerazioni relative alla realizzabilità del socialismo e considerazioni relative alla sua desiderabilità. Infatti, in poche pagine, con un linguaggio piacevole e accessibile, Cohen, da un lato, offre ragioni per tornare a riflettere sulla desiderabilità dei principi socialisti, dall’altro, indica le questioni, teoriche e pratiche, che è necessario affrontare per promuoverli e per realizzarli. Riferimenti bibliografici J. CARENS, Equality, Moral Incentives, and the Market. An Essay in Utopian Politico-Economic Theory, University of Chicago Press, 1981. G.A. COHEN, Karl Marx’s Theory of History. A Defence, Claredon Press, 1978. —History, Labour, and Freedom. Themes from Marx, Claredon Press, 1988. — On the Currency of Egalitarian Justice, in “Ethics”, vol. 99, n. 4, 1989, pp. 906-944. — Incentives, Inequality, and Community, in The Tanner Lectures on Human Values, 1991. — Back to Socialist Basics, in “New Left Review”, September-October 1994. —Self-Ownership, Freedom, and Equality, Cambridge University Press, 1995. —If You’re an Egalitarian, How Come You’re so Rich?, Harvard University Press, 2000. — Luck and Equality: A Reply to Hurley, in “Philosophy and Phenomenological Research”, vol. 72, n. 2, 2006, pp. 439-446. —Rescuing Justice and Equality, Harvard University Press, 2008. —Why Not Socialism?, Princeton University Press, 2009; trad. it. Socialismo, perché no?, Ponte alle Grazie, 2010. R. NOZICK, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, 1974; trad. it., Anarchia, stato e utopia. Quanto stato ci serve?, Il Saggiatore, 2000. J. RAWLS, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971; trad. it. Una teoria della giustizia, Feltrinelli, 1982. mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 66 / / >>>> dossier / why not socialism? Contro il liberismo >>>> Corrado Del Bò U no dei lasciti maggiori della riflessione di Jerry Cohen è un’incisiva critica a Nozick (1974). Il confronto con Nozick, alla fine confluito in Cohen (1995), ha occupato una parte importante della produzione scientifica del filosofo canadese; ed è naturale che sia stato così, dal momento che l’opera di Nozick costituisce un’efficace presentazione e un’affascinante difesa di quella teoria che il lessico accademico chiama “libertarismo” ma che la polemica politica, con qualche semplificazione e approssimazione, definisce come “liberismo”. Al marxista (analitico) Cohen, che pure nei suoi lavori – per esempio, in Cohen (2008) – non ha mancato di muovere obiezioni a un autore liberal come John Rawls, non sfuggiva infatti che il vero avversario “politico”, sul piano delle idee, non poteva che essere Nozick, in ciò in controtendenza rispetto a quei costumi ideologici che portano a incrociare le armi dialettiche con chi è relativamente vicino a noi piuttosto che con chi sta ai nostri antipodi. La teoria di Nozick è nota, ma, per chiarire la posizione di Cohen, non sarà inutile richiamarla brevemente qui. Secondo Nozick, gli individui hanno diritti; e ci sono cose che nessuno, né altri individui né gruppi di individui, può fare loro senza violarne i diritti. Lo Stato, che avoca a sé il monopolio dell’esercizio fisico della forza legittima e che obbliga gli individui a fare certe cose a vantaggio di altri, quasi sempre viola questi diritti; solo che gli individui spesso non se ne accorgono. Li viola, per esempio, quando, in nome della giustizia distributiva, preleva imposte dai singoli che poi investe per fini comunemente giudicati nobili o comunque apprezzabili, dalla sanità pubblica all’assistenza ai bisognosi. Non li viola invece quando procura di garantire la sicurezza, attraverso magistrati e forze di polizia, né quando sorveglia con il proprio apparato che i contratti vengano rispettati. In breve: lo Stato minimo sì, ogni sua estensione no. Secondo Nozick (1974, tr. it. 163-7), quelle che normalmente sono denominate questioni di giustizia distributiva vanno allora ridotte, ricorrendo al lessico di Aristotele, a questioni di giustizia commutativa. In concreto si tratta di riempire di conmondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? tenuto due semplici principi: un principio che governa le modalità di acquisizione di averi che non appartengono a nessuno e un principio che stabilisca a quali condizioni gli averi di qualcuno possano passare a qualcun altro. Se poi qualcuno s’impadronisce di averi in violazione di questi principi, un terzo principio, il principio di rettificazione, specificherà – in base ai primi due principi – come riavvolgere il film delle ingiustizie e restituire a Cesare ciò che gli spetta. In breve, la giustizia distributiva diventa una questione di verificare i titoli di ciascuno sugli averi e si riduce dunque alla giustizia nei rapporti tra individui, con lo Stato che si preoccupa soltanto di far rispettare le regole relative alle modalità di acquisizione e di trasferimento degli averi. La clausola limitativa Come si formano però questi titoli? Vale a dire: quale è il contenuto specifico dei due principi che abbiamo menzionato prima? Vediamo le due differenti risposte di Nozick in sequenza. Gli averi vengono acquisiti in una maniera che richiama Locke (1690); sembra infatti che per Nozick, come per Locke, il lavoro sia dirimente per generare titoli sulle cose che non appartengono a nessuno (le “risorse naturali grezze”). Tuttavia, Nozick (1974, tr. it. pp. 186-90) non è molto tenero con la teoria lockiana del labour-mixing, di cui anzi presenta le numerose difficoltà concettuali; quindi, acquisiamo gli averi lavorando sulle cose, ma non perché vi mescoliamo qualcosa di noi, come sosteneva Locke (1690, cap. 5). Piuttosto quel che conta è che, dopo la nostra acquisizione di risorse che non appartengono a nessuno, la condizione degli altri non sia peggiorata, nel senso che devono ancora avere la libertà di farne uso, non importa se a costi maggiori o con maggiore scomodità. Il rispetto di questo vincolo, che Nozick chiama “clausola limitativa”, giudica della legittimità delle acquisizioni di ciò che ancora non appartiene a nessuno. Sui trasferimenti Nozick fa invece ricorso a quella che ormai si è affermata, nella filosofia politica, come la parabola di Wilt / / 67 / / Chamberlain, che non espongo perché se ne è già occupata Francesca Pasquali nel suo contributo a questa discussione. Gli argomenti di Nozick sembrano intuitivamente promettenti e il suo stile scanzonato e disinvolto aiuta senza dubbio a rafforzarli. Ma Cohen, come si osservava all’inizio, è un autore serio e dunque non esita a mettere in moto la macina analitica per demolirli. Cominciamo dal principio di acquisizione, con cui Cohen si confronta in due articoli del 1986 poi riprodotti come capitoli 2 e 3 in Cohen (1995). A giudizio di Cohen è problematico il principio secondo cui una persona è danneggiata dall’altrui acquisizione di risorse naturali se tale acquisizione la pone in una situazione peggiore di quella in cui sarebbe stata se non ci fosse stata alcuna acquisizione. Infatti, secondo Cohen, Nozick compirebbe l’errore di guardare unicamente a una situazione in cui non esiste del tutto proprietà privata, restringendo indebitamente la gamma delle alternative tra le quali scegliere la situazione con cui fare il paragone. Immaginiamo, propone Cohen (1995, pp. 79-83), una situazione 2 in cui vivono due sole persone (le chiameremo Fulvio e Lucia). Lavorare la terra costituisce la loro unica fonte di sostentamento; ed effettivamente entrambe lavorano la terra, senza interferire l’uno con l’altra. In questo modo Fulvio produce una quantità di grano pari a 100 e Lucia una quantità di grano pari a 80. Supponiamo ora che Fulvio si appropri di tutta la terra coltivabile, o ne lasci a Lucia una quota insufficiente per la sopravvivenza, e assuma alle proprie dipendenze Lucia. Grazie all’incremento di produttività determinato dalla divisione del lavoro e dalle capacità organizzative di Fulvio, Lumondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 68 / / cia riceve un salario, misurato in quantità di grano, 80 + p (con pp≥ 0), mentre Fulvio ricava, sempre in quantità di grano, 100 + q (ove q > p≥ 0). La domanda a questo punto è: l’appropriazione di terra realizzata da Fulvio soddisfa la clausola limitativa di Nozick? Chiaramente sì, dal momento che la situazione di Lucia è, nella peggiore delle ipotesi (se p = 0), rimasta uguale a prima e quindi non è peggiorata. E tuttavia, osserva Cohen, Nozick dovrebbe considerare anche altre possibili situazioni controfattuali, diverse sia da quella iniziale sia da 2. Consideriamo, per esempio, la situazione 3 in cui è Lucia che si appropria di tutta la terra coltivabile, o comunque ne lascia a Fulvio una quota insufficiente per la somondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? pravvivenza, e assume alle proprie dipendenze Fulvio. Grazie all’incremento di produttività determinato dalla divisione del lavoro e dalle capacità organizzative di Lucia, che per il momento ipotizziamo eguali a quelle di Fulvio, Fulvio riceve un salario 80 + p (ove p≥ 0), mentre Lucia ricava 100 + q (ove q > p≥ 0). Anche in questo caso, chi è rimasto escluso dall’appropriazione (Fulvio) riceve almeno (se p = 0) la stessa quantità di grano di prima e dunque la sua situazione non è peggiorata. Perché, allora, Lucia dovrebbe accettare di riconoscere a Fulvio dei diritti di proprietà sulla terra coltivabile per il solo fatto che Fulvio è stato il primo a impossessarsene? In fin dei conti, l’incremento di produttività complessivo rimarrebbe eguale a parti invertite e Lucia, anziché Fulvio, otterrebbe 100 + p. Consideriamo ora la situazione 4, in cui i talenti di Lucia sono maggiori di quelli di Fulvio, per cui l’appropriazione di Lucia darebbe luogo a una situazione in cui Fulvio ottiene, in quantità di grano, 100 + q + r (con r > 0) e Lucia, sempre in quantità di grano, 80 + p + s (con s > 0). Visto che sia la situazione di Fulvio sia quella di Lucia vengono migliorate dall’appropriazione privata di Lucia, perché non preferire questa soluzione a quella in cui era Fulvio ad appropriarsi della terra? Perché, in un caso simile, il principio di “precedenza” non dovrebbe cedere a un principio di efficienza? Questi scenari alternativi pongono allora in luce quello che, secondo Cohen, è il limite generale della prospettiva di Nozick: “Considerare non quello che sarebbe potuto accadere tout court, in assenza di appropriazione, ma quello che sarebbe accaduto nella specifica ipotesi che il mondo fosse rimasto in comune” (Cohen 1995, p. 83). In altri termini, anche concedendo che una qualsiasi appropriazione sia meglio di nessuna appropriazione, non è detto che un’appropriazione che non renda peggiore la condizione degli altri rispetto a quella originaria sia anche la miglior appropriazione possibile. Questo, si badi, senza aver bisogno di andare a ripescare quel noto passo di Marx (1867, tr. it. p. 778) sull’accumulazione originaria, in cui il filosofo tedesco osservava che “nella storia reale la parte importante è rappresentata, come è noto, dalla conquista, dal soggiogamento, dall’assassinio e dalla rapina, in breve dalla violenza. Nella mite economia politica ha regnato da sempre l’idillio. (...) Di fatto i metodi dell’accumulazione originaria sono tutto quel che si vuole fuorché idillici. (...) La cosiddetta accumulazione originaria non è altro che il processo storico di separazione del produttore dai mezzi di produzione. Esso appare “originario” perché costituisce la preistoria del capitale e del modo di produzione ad esso corrispondente”. Si / / 69 / / condivida o meno la ricostruzione marxiana, leggere Cohen ci consente di sottoporre a critica morale anche acquisizioni originarie all’apparenza immacolate e la logica complessiva di argomenti che giustificano, o provano a giustificare, acquisizioni diseguali. Col secondo principio e con la parabola di Chamberlain Cohen si misura invece già nel 1977, pochi anni dopo l’uscita del libro di Nozick, in un serrato articolo – poi divenuto il capi- tolo primo di Cohen (1995) – in cui vengono messi in luce presupposti impliciti e difficoltà dell’argomento di Nozick che sia sbagliata la proibizione di scambi liberi e volontari tra adulti consenzienti, anche se ciò dovesse portare a una maggiore diseguaglianza. Mi soffermerò su quelli che a me sembrano i punti principali del discorso di Cohen. C’è innanzitutto, osserva Cohen (1977, tr. it. p. 169-71), un’antropologia implicita nella parabola di Chamberlain: Nozick presuppone che le persone non siano poi così affezionate alla distribuzione iniziale D1 e che basti loro il desiderio di veder giocare Chamberlain per abbandonarla. Ma potrebbe anche accadere che le persone siano disposte a spendere venticinque centesimi per vedere giocare Chamberlain, ma che non siano disposte a dare questi venticinque centesimi a Chamberlain. Questo perché potrebbero rendersi conto del rischio che D1 venga sovvertito (e potrebbero non voler correre questo rischio) e più in generale potrebbero temere il potere che in questo modo Chamberlain, grazie alla sua ricchezza, finirebbe per avere. Ricchezza e potere Già, il potere. Un secondo punto su cui insiste Cohen (1977, tr. it. pp. 1971-3) è che Nozick trascura il fatto che la somma di atti liberi e volontari degli individui potrebbero portare alcuni di loro – nel caso di specie Chamberlain – a detenere un potere così grande da poter costituire una minaccia per la libertà degli altri. Per questa ragione Cohen è molto critico nei confronti dell’affermazione di Nozick secondo cui nell’essere titolari di una certa somma di denaro è implicita la libertà di darla a Chamberlain: si tratta o di un’assunzione (ma allora dei veri socialisti potrebbero negare che in D1 questa sia un’assunzione corretta e prevedere anzi limiti agli usi legittimi delle risorse disponibili) o di un argomento non conclusivo (poiché è dubbio che possa essere moralmente conclusiva una tesi che assicura un grande potere di alcuni su altri). Nozick è poi eccessivamente sbrigativo, secondo Cohen (1977, tr. it. pp 175-6), anche sul fatto che le persone desiderino mantenere in vita la distribuzione D1 o comunque, quand’anche lo desiderassero, siano capaci di coordinarsi efficacemente per questo scopo. Ancora una volta, ci sono soltanto assunzioni antropologiche non dimostrate, rispetto alle quali Nozick ha poi gioco facile a suggerire che un modello socialista può essere mantenuto solamente a prezzo della tirannia. Ma si tratta, secondo Cohen, di una partita “falsata” in partenza da alcuni presupposti impliciti nel discorso di Nozick. Secondo Nozick, non è vero che, se in uno scambio una delmondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 70 / / le due parti ha davanti a sé una serie di alternative che sono tutte molto peggiori di quella scelta, la sua scelta non è veramente volontaria. Non è vero dunque che se un operaio accetta di lavorare per un capitalista di fronte all’alternativa evidentemente molto peggiore di rimanere disoccupato e morire di fame, per esempio, la sua scelta non è realmente volontaria. Infatti la volontarietà delle azioni di una persona dipende non dalla sgradevolezza delle alternative, ma “dalla natura dei limiti alle sue alternative. Se si tratta di fatti naturali, le azioni sono volontarie. (Posso volontariamente recarmi a piedi in qualche posto anche se preferirei volarvi senza alcun aiuto). Le azioni degli altri pongono limiti alle opportunità disponibili per una persona. Per determinare se questo rende non-volontaria l’azione che ne risulta dobbiamo stabilire se questi altri avevano il diritto di agire come hanno agito” (Nozick 1974, tr. it. p. 269). Se dunque ciò che limita le opzioni per me disponibili sono fatti naturali o conseguenze di azioni che gli altri avevano il diritto di compiere, la mia scelta, secondo Nozick, rimane volontaria, gradevoli o meno che siano le opzioni tra le quali posso scegliere. Pur non distinguendo in modo del tutto chiaro tra questioni di libertà e questioni di volontarietà, come invece farà molto opportunamente Olsaretti (1998), Cohen (1977, tr. it. pp. 179-83) svela il gioco di prestigio di Nozick. Non è vero, spiega Cohen, che un operaio è forzato a scegliere tra lavorare per un capitalista o morire di fame solo se questa restrizione è frutto di azioni umane illegittime. Infatti, non cambia nulla per me se (caso 1) un giorno tu, costruendo uno steccato, eserciti il tuo diritto di impedirmi di attraversare un terreno che fino al giorno prima mi consentivi di attraversare, o se (caso 2) alzi quello stesso steccato senza avere il diritto di farlo; in entrambi i casi sono forzato a usare un’altra strada, il che pare più plausibile che non affermare, come invece deve fare Nozick, che solamente nel caso 2 subisco tale forzatura. È sulla base di queste (e altre) considerazioni che Cohen (1977, tr. it. p. 185) può alla fine concludere che “il capitalismo ‘libertario’ sacrifica la libertà al capitalismo, e chi lo difende può negare questa verità solo perché è disposto ad abusare del linguaggio della verità”. Purtroppo il lettore italiano conosce poco Jerry Cohen. Nessuno dei suoi libri è stato (ancora?) tradotto, con l’eccezione peraltro recente di quello più divulgativo, il godibilissimo Socialismo, perché no? (Ponte alle Grazie, 2010), e solo una manciata dei suoi numerosi articoli sono al momento disponibili in italiano. L’elenco di questi articoli è presto fatto: Cohen (1977), pubblicato una prima volta col titolo di Modelli di dismondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? tribuzione e libertà nel 1985 sulla rivista “Biblioteca della libertà” e ora tradotto ex novo nell’antologia curata da Mario Ricciardi L’ideale di giustizia (Università Bocconi Editore, 2010); Capitalismo, libertà e proletariato nell’antologia L’idea di libertà, a cura di Ian Carter e Mario Ricciardi (Feltrinelli, 1996); Il libertarismo di Robert Nozick e Impegno senza riverenza. Riflessioni sul marxismo analitico, usciti entrambi sulla rivista “Studi perugini”, il primo nel 1996, il secondo nel 1998. Non stupisce allora che la sua morte improvvisa e prematura, nell’agosto del 2009, sui quotidiani italiani sia passata inosservata anche presso quelle testate che, per orientamento politico, più avrebbero dovuto piangerla. Peccato, perché come recitava il necrologio apparso sul Guardian, “Cohen combinava l’impegno appassionato con il rigore intellettuale, ed entrambi con un’incantevole ilarità e con l’irriverenza per tutto, se stesso incluso”. Tutte qualità di cui, nel dibattito pubblico italiano in generale e a sinistra in particolare, c’è invece gran bisogno. Riferimenti bibliografici G.A. COHEN, Robert Nozick and Wilt Chamberlain: How Patterns Preserve Liberty, “Erkenntnis”, 11, 1977, pp. 5-23; trad. it. di C. Del Bò Robert Nozick e Wilt Chamberlain: come i pattern preservano la libertà, in L’ideale di giustizia, a cura di M. Ricciardi, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 161-88. G.A. COHEN, Self-Ownership, Freedom and Equality, Cambridge University Press, 1995. G.A. COHEN, Rescuing Justice and Equality, Harvard University Press, 2008. J. LOCKE (1690), Two Treatises on Government, ristampato a cura di P. Laslett, Cambridge University Press, 1960; trad. it. di L. Formigari Trattato sul governo, Roma: Editori Riuniti, 19973. K. MARX (1867), Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie, ristampato da Dietz, 1947; trad. it. di D. Cantimori Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro I, Roma: Editori Riuniti, 19645. R. NOZICK, Anarchy, State and Utopia, BasicBooks, 1974; trad.it. di G. Ferranti Anarchia, stato e utopia, Milano: Il Saggiatore, 2000. S. OLSARETTI, Freedom, Force and Choice: Against the RightBased Definition of Voluntariness, “The Journal of Political Philosophy”, 6, 1998, pp. 53-78. J. RAWLS, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, 1971; trad. it. di U. Santini Una teoria della giustizia, a cura di S. Maffettone, Milano: Feltrinelli, 1982. / / 71 / / >>>> dossier / why not socialism? Eguaglianza e comunità >>>> Enrico Biale C osa significa trattare gli altri da eguali? Quali sono i doveri che ogni individuo, che creda nell’eguaglianza, ha nei confronti dei propri pari? A queste domande, che sono centrali per ogni concezione egualitaria della giustizia, Cohen ha sempre tentato di fornire una risposta chiara, coerente con i propri ideali socialisti, e mai scontata, come mostra il testo appena tradotto in italiano. In questo volume, dove declina in modo accessibile la sua visione del socialismo egualitario, sostiene che prendere seriamente simili quesiti non può che portare all’abbandono della logica di mercato e di quelle teorie che tendono a giustificarla, a favore di un approccio socialista che metta al centro i bisogni delle persone e la necessità da parte di tutti i membri di una società di eguali di sforzarsi al massimo per soddisfarli. Se le teorie liberal-egualitarie, come quella proposta da Rawls (Rawls 1971) e diventata punto di riferimento per ogni successiva concezione della giustizia, non hanno colto l’importanza di questi aspetti e hanno legittimato il mercato, è colpa del fatto che hanno limitato la portata dei principi di giustizia alle sole istituzioni, lasciando completamente svincolati i comportamenti individuali (dualismo). Sarebbe invece necessario definire il contenuto di un ethos egualitario che ispiri le azioni quotidiane di tutti i membri della società in modo che questi facciano del loro meglio per trattare gli altri da eguali. Essendomi occupato altrove della critica di Cohen al dualismo (Biale 2010), vorrei qui focalizzare la mia attenzione sulla distinzione da lui proposta tra principi di giustizia e principi di comunità e sui vincoli che questi impongono ai membri di una società egualitaria. La mia analisi si articolerà nel modo seguente: nella prima sezione cercherò di presentare la distinzione tra ethos egualitario e di comunità, mentre nella seconda sezione vorrei mettere in luce come ad accomunarli, nonostante le apparenti differenze, sia il rifiuto della pubblicità e della struttura doveri-pretese a questa connessa, a favore di vincoli graduali e onnicomprensivi. Nell’ultima sezione, infine, proverò ad evi- denziare come alcune ambiguità della proposta di Cohen potrebbero essere risolte rivalutando il ruolo della pubblicità nel definire quali siano i doveri dei membri di una società egualitaria. Nel tentativo di specificare con maggiore chiarezza e completezza possibile cosa significhi trattare gli altri come eguali, Cohen sostiene che gli individui che credono nel valore dell’uguaglianza dovrebbero modellare le proprie azioni quotidiane in base ad un ethos ispirato ai principi di giustizia e di comunità. Dal momento che simili criteri sono distinti e non necessariamente compatibili, credo sia opportuno iniziare a presentare i principi di giustizia a cui l’ethos egualitario deve ispirarsi e i vincoli a cui sottopone i membri di una società giusta, per poi passare ad analizzare l’ethos comunitario e i valori a cui questo fa riferimento. Secondo la concezione della giustizia proposta da Cohen nessuna ineguaglianza è giusta se non dipende da scelte di cui un individuo può essere ritenuto responsabile (egualitarismo della sorte). Questa prospettiva, a differenza dell’egualitarismo liberale alla Rawls, non cerca solo di pareggiare le disuguaglianze determinate dalle differenze sociali (estrazione economica, status sociale, classe), ma anche quelle che sono frutto delle doti naturali (intelligenza, produttività, forza fisica) in modo da annullare l’impatto di qualsiasi fattore moralmente arbitrario (la sorte appunto). Una prima critica che si potrebbe rivolgere all’egualitarismo della sorte è quella di ottenere risultati sub-ottimali per i più svantaggiati rispetto a principi, come il principio di differenza rawlsiano, che giustificano diseguaglianze solo se a massimo vantaggio dei più svantaggiati. Per chiarire meglio questo punto si immagini che per ridurre al minimo l’impatto della sorte e garantire a tutti eguali opportunità si proponga di alzare significativamente l’aliquota sui redditi più elevati. È legittimo infatti assumere che a guadagnare di più siano gli individui maggiormente avvantaggiati dalla sorte e che quindi un mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 72 / / incremento delle tasse sui redditi più alti vada a tutto beneficio dei più sfortunati. In questo modo, però, gli individui più dotati vedrebbero tanto ridotte le risorse a propria disposizione da non avere alcun incentivo a produrre al massimo delle proprie capacità o a scegliere il lavoro più remunerativo e socialmente utile. Come conseguenza di una simile politica diminuirebbero le risorse da distribuire ai più svantaggiati peggiorando la loro posizione rispetto allo stato di cose che verrebbe garantito loro da un principio come quello di Rawls che ammette una qualche forma di incentivazione a patto che vada a massimo vantaggio di chi sta peggio. L’ethos egualitario Per rispondere a questa obiezione Cohen sottolinea come una società giusta dovrebbe essere composta da individui che tentano di realizzare in ogni loro scelta e azione i principi di giustizia. Solo seguendo nella propria vita quotidiana i dettami di un ethos egualitario ispirato ai principi di giustizia è posmondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? sibile che a tutti i membri della società vengano garantite eguali opportunità, e che, per esempio a fronte di un aumento delle tasse, le persone più produttive non decidano di diminuire la propria produttività riducendo le risorse a disposizione dei meno dotati, o che chi grazie alle sue doti può scegliere tra lavori differenti non ripieghi su una professione socialmente meno utile perché le retribuzioni sono simili a quelle di altre carriere. Simili decisioni sono nella disponibilità degli individui (una società giusta non può ridurre le libertà dei suoi membri) ma non sono moralmente accettabili, perché non tengono in considerazione le esigenze degli altri, ed infatti non potrebbero essere giustificate se non facendo appello a ragioni, quali il desiderio di stare molto meglio degli altri, o di meritare un lavoro migliore in quanto più dotati, a cui non ci si può richiamare in una società egualitaria. Sebbene simile prospettiva sembri essere in piena sintonia con gli ideali egualitari, è chiaramente molto esigente, e per questo potrebbe essere criticata sostenendo non solo che è / / 73 / / del tutto irrealizzabile ma anche indesiderabile, dal momento che sembra obbligare i più dotati a lavorare solo per migliorare la condizione dei più svantaggiati (schiavitù dei talenti). Per rispondere a questa obiezione è necessario, secondo Cohen, chiarire alcuni punti: è ovvio che un simile approccio sia più esigente rispetto ad altri nei confronti di coloro che stanno meglio, ma questo non significa necessariamente che sia illegittimo. Qualora infatti il punto di riferimento sia una condizione ingiusta in cui i più dotati sono illegittimamente avvantaggiati e che viene comunque giustificata da alcune concezioni della giustizia, un approccio più esigente è semplicemente in grado di garantire davvero l’eguaglianza tra i membri della società. È importante, d’altro canto, ricordare come l’ethos non imponga una lista finita di doveri ma sia un vincolo che ammette una gradualità nella sua applicazione richiedendo semplicemente di fare del proprio meglio per realizzare i principi di giustizia. Non si deve, infine, dimenticare che i più avvantaggiati possono scegliere, anche senza violare i principi di giustizia e l’ethos egualitario, tra un insieme di opzioni che garantiscono loro un benessere complessivo spesso superiore o, nella peggiore delle ipotesi uguale, a quello goduto dagli altri. Bisogna insomma stare attenti a non sovrastimare l’onere attribuito ai più dotati considerando come riferimento uno status quo chiaramente iniquo o esagerando la difficoltà delle scelte che l’ethos impone loro. Trattare gli altri come eguali significa quindi garantire loro eguali opportunità riducendo al minimo il ruolo di qualsiasi elemento moralmente arbitrario, e per farlo è necessario che ogni individuo regoli la propria vita in base ad un ethos egualitario ispirato ai principi di giustizia. Nonostante un simile approccio sia radicalmente egualitario, è comunque compatibile con alcune diseguaglianze e con una qualche forma di mercato. Una volta garantite eguali opportunità gli individui saranno liberi di perseguire i propri interessi senza preoccuparsi gli uni degli altri, e le diseguaglianze frutto esclusivamente di scelte responsabili non potranno essere considerate ingiuste. Sebbene tutto ciò sia corretto, non sembra a Cohen in alcun modo desiderabile, e forse addirittura immorale, dal momento che mette in dubbio proprio quei vincoli di comunità che l’ethos egualitario aveva iniziato a costituire. L’ethos imponeva di tenere in considerazione gli interessi altrui in ogni nostra scelta in modo da dividere egualmente gli oneri e i benefici tra tutti i membri della società. Così facendo si veniva a formare una comunità di eguali di fronte a cui si doveva giustificare ogni azione in modo da confermare la propria appartenenza a tale gruppo. La reciprocità Una società di eguali non è, secondo Cohen, compatibile con nessuna diseguaglianza economica, anche se frutto di scelte responsabili e prevedibili (si passa dall’eguaglianza delle opportunità all’eguaglianza degli esiti), perché le diseguaglianze allontanano le persone, le rendono diverse impedendo quella comunione di intenti che è propria dei membri di una comunità: ricchi e poveri non possono avere prospettive comuni e quindi non possono in alcun modo capirsi né fare parte della stessa comunità. Una società di eguali che si trattano come tali è una comunità di compagni dove le persone non si usano come mezzi per raggiungere fini, come invece avviene in un sistema di mercato, ma si aiutano reciprocamente senza pensare cosa ne potranno ottenere in cambio né valutare se la difficoltà di alcuni è dettata da scelte di cui sono responsabili o meno. L’ethos comunitario è quindi ancora più esigente rispetto a quello egualitario, ma come quest’ultimo impone vincoli graduali che non implicano alcuna forma di coercizione e lasciano comunque aperte una serie di opzioni a completa disposizione delle persone in modo da garantire un sistema economico che non incentiva le peggiori passioni umane, come paura e avidità, ma quelle più nobili, come la reciprocità. E’ ovviamente un ideale a cui tendere, che però identifica un’alternativa al mercato in cui i bisogni di tutti siano sempre al centro delle scelte dei membri della comunità e non siano possibili sfruttamento o alienazione, ma dove ognuno possa essere davvero libero di realizzare i propri piani di vita compatibilmente con le esigenze dei suoi compagni. Prima di analizzare con maggiore attenzione ruolo e contenuto dell’ethos proposto da Cohen sia all’interno della sfera della giustizia sia di quella della comunità, vorrei evidenziare un aspetto molto importante della sua analisi: aver sottolineato la non neutralità del mercato. Sebbene sia una caratteristica di cui da molto si è consapevoli, spesso viene dimenticata, anche all’interno del dibattito sull’egualitarismo, quasi come se il mercato fosse uno strumento del tutto neutrale tra diversi sistemi di valori, e quindi da utilizzare qualora sia funzionale al raggiungimento degli scopi che ci si è prefissi (Dworkin, 2000). Cohen mette giustamente in evidenza come tutto questo sia falso, dal momento che il mercato non solo determina ineguaglianze, ma veicola valori influenzando le relazioni economico-sociali che intercorrono tra i membri di una società. Una teomondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 74 / / ria della giustizia di matrice egualitaria non dovrebbe limitarsi a regolare un simile sistema in modo che tutti abbiano eguali opportunità, ma sarebbe necessario che sottoponesse a vaglio critico i valori su cui questo si basa e che incentiva per comprendere se sono compatibili con il tipo di relazioni su cui si dovrebbe fondare una società che considera gli individui come eguali e pretende che i suoi membri si trattino di conseguenza. Oltre ad aver ricordato questo aspetto problematico del sistema di mercato, Cohen ha l’indubbio merito di rimettere al centro di una teoria della giustizia la questione economica nel suo complesso, prestando particolare attenzione al ruolo degli interessi personali nel determinare le diseguaglianze economiche e sottolineando come sia fondamentale a tale proposito che un ethos regoli le azioni dei membri di una società egualitaria. Il gradualismo Vorrei adesso cercare di analizzare più nel dettaglio il ruolo dell’ethos all’interno delle due sfere identificate da Cohen. La principale differenza tra l’ethos egualitario e quello comunitario è ovviamente determinata dal principio a cui questi si ispirano, dovendo il primo garantire eguaglianza di opportunità ed essendo invece il secondo ispirato a un ideale di eguaglianza degli esiti. Anche il ruolo dell’ethos in relazione a simili principi è differente: l’ethos egualitario è strumentalmente necessario per realizzare i principi di giustizia, i quali vengono giustificati facendo appello all’illegittimità delle ineguaglianze frutto di fattori moralmente arbitrari; l’egualitarismo degli esiti è invece giustificato dal valore stesso della comunità e dell’ethos che ispira i suoi componenti in modo da rigettare le accuse di livellamento o sfruttamento dei più dotati. Solo se si considera come immorale il sistema di mercato e si valuta invece positivamente il reciproco aiuto alla base della società comunista si possono legittimare le forme di livellamento in questa insite e i vincoli imposti, in particolare ai più dotati, senza considerarli illegittimi. Il livellamento sarà accettabile, anzi addirittura benaccetto, perché garantirà la coesione e comunione di intenti all’interno della comunità, mentre i vincoli imposti ai suoi membri non potranno essere considerati forme di sfruttamento perché liberamente accettati proprio per impedire la formazione di un sistema economico-sociale, come quello di mercato, che nello sfruttamento ha un suo elemento costitutivo. Nonostante queste differenze siano molto evidenti e influenzino il contenuto dei vincoli che i cittadini/compagni hanno gli uni mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? verso gli altri, la struttura all’interno della quale sono inseriti è molto più simile di quanto non potrebbe sembrare a prima vista, preferendo a un insieme di doveri-pretese, un ethos aperto e graduale. Secondo la proposta di Cohen, infatti, trattare gli altri come eguali significa fare del proprio meglio per prendere in considerazione esigenze e bisogni altrui, senza che questo implichi avere una lista definita di doveri da seguire né tantomeno che nessuno possa pretendere dai propri compagni alcunché. Definire con precisione quelli che sono i doveri verso gli altri significherebbe ottenere un risultato sub-ottimale, non cogliendo, proprio come è accaduto alle teorie liberal-egualitarie, l’inadeguatezza del mercato né identificando un’alternativa a questo. A sostegno del valore della gradualità dell’ethos di giustizia e di comunità e per evidenziare come sia proprio tale caratteristica a permettere ai membri di una società egualitaria di trattarsi da eguali vorrei presentare due esempi (uno riguardante la sfera della giustizia e l’altro quella della comunità). Immaginiamo che in un ufficio vi siano tre dipendenti egualmente dotati e volenterosi, Marco, Luca e Fabio, e che il loro capoufficio Andrea preferisca Luca perché più simpatico, favorendolo quindi nella sua carriera senza che nessuno, Fabio e Marco inclusi, si renda conto di nulla. Tutto ciò è giusto? Sembra di no e l’ingiustizia sarebbe ancora più evidente qualora sapessimo che la ragione per cui Marco e Fabio sono stati discriminati è perché sono omosessuali. Sebbene il comportamento di Andrea sia chiaramente ingiusto, non è pubblico e quindi non può essere denunciato. Se si vuole garantire la giustizia non serve a nulla che i membri di una società possano pretendere di essere trattati da eguali e denunciare gli altri quando questo non avviene, quanto piuttosto che ognuno faccia del proprio meglio per realizzare in tutte le sue azioni un ideale di giustizia chiaramente definito. Passiamo adesso al secondo caso: siamo in una società profondamente egualitaria, in cui non solo gli individui si riconoscono nei principi di giustizia e fanno del proprio meglio per realizzarli, ma sono anche legati da vincoli di comunità. In un simile contesto se qualcuno sta male, i suoi compagni cercano di aiutarlo. Qualora si istituisse una regola che imponesse a Maria di aiutare Piero ogni volta che cada al di sotto di una certa soglia di ricchezza o che obbligasse Marco a portare due volte a settimana fuori la sua anziana vicina di casa, non solo si imporrebbero obbligazioni che sarebbero state comunque soddisfatte ma si violerebbe quello spirito di comunità che univa queste persone. “Fai del tuo meglio” in questo caso è un’esortazione che rafforza i vincoli presenti tra i membri della comunità, invece che distruggerli. All’interno di un sistema / / 75 / / re la mia attenzione proprio sul rifiuto della pubblicità e della struttura pretese-doveri, sostenendo che se questo è più che comprensibile all’interno della sfera della comunità, non può invece non risultare problematico nel definire i nostri doveri di giustizia. Per chiarire questo punto cercherò di evidenziare come tali elementi riescano a cogliere un aspetto fondamentale delle nostre intuizioni su cosa significhi trattare gli altri come eguali, sostenendo che abbandonarli non può essere considerata una scelta senza costi. Diritti e giustificazione sociale i cui componenti si riconoscono come compagni e fanno del proprio meglio per aiutarsi una lista di doveri sarebbe ridondante e dannosa, introducendo un elemento in piena contraddizione con la spontaneità tipica di una comunità di eguali. Se si vuole trattare gli altri da eguali sembrerebbe proprio necessario che un ethos regoli ogni nostra azione (onnicomprensività) e che ci imponga di fare del nostro meglio per sostenere e aiutare i nostri compagni (gradualità). Come ho cercato di mettere in luce nei paragrafi precedenti Cohen sostiene che trattare gli altri da eguali richiede che tutti i membri di una società egualitaria regolino le proprie scelte e azioni quotidiane in base ad un ethos egualitario e di comunità. Questa prospettiva non è, secondo Cohen, esigente perché ammette gradualità e non implica una lista di doveri che possono essere pretesi dai nostri pari, come invece comunemente richiesto da quelle teorie che fanno della pubblicità un vincolo fondamentale e che per questo non riescono a garantire che gli individui siano davvero trattati da eguali o a cogliere l’indesiderabilità delle relazioni di mercato. Vorrei ora focalizza- In primo luogo è importante chiarire che trattare gli individui come eguali dipende molto dalle intenzioni delle persone e non è un aspetto facilmente verificabile: il che non significa che ciò non comporti doveri molto precisi a cui corrispondono altrettante pretese che trovano il loro fondamento nell’idea che le azioni dei membri di una società giusta debbano essere pubblicamente giustificabili. I vincoli di pubblicità non riguardano la visibilità o tracciabilità di un atto, ma la sua giustificabilità pubblica. Un atteggiamento è legittimo se può essere pubblicamente giustificato, cioè, se qualora dovesse essere identificato e se ne dovesse chiedere ragione a chi lo ha messo in atto, potrebbe superare una simile verifica. Per chiarire questo punto consideriamo nuovamente il caso della discriminazione: il fatto che tutti gli individui siano eguali e che questo venga riconosciuto da ciascun membro della società sembra implicare che nessuno può essere discriminato e che quindi ciascuno possa pretendere che ciò non avvenga, e non solo che le persone facciano del loro meglio perché ciò non succeda. Se questo è vero, sembra possibile sostenere che chi si dovesse sentire discriminato avrebbe il diritto di denunciare il responsabile di una simile violazione, il quale dovrebbe tentare di giustificare il proprio comportamento di fronte a chi reputa di aver patito il danno e all’intera comunità. Giustificare pubblicamente le proprie azioni implica riconoscere agli altri l’autorità di vincolarle e di poter pretendere che venga fornita loro una giustificazione quando questo non avviene. Se non si reputa che trattare gli altri come eguali significhi identificare un insieme di pretese-doveri a cui fare riferimento, si è disposti a sacrificare anche il riconoscimento di una simile autorità ai propri pari. Questo aspetto non sembra però privo di costi dal momento che, come sostenuto da Feinberg, “rivendicare un diritto è ciò che attribuisce ai diritti il loro valore morale. Questa caratteristica è connessa alla retorica di ciò che significa essere un essere umano. Avemondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 76 / / re diritti ci permette, nel senso che ci mette nelle condizioni, di essere uomini, guardarci negli occhi e sentirci fondamentalmente uguali […] la dignità umana potrebbe essere riconosciuta come la capacità di asserire pretese” (Feinberg, 1970, p. 247). A conferma di ciò, consideriamo il seguente caso: un dipendente è stato licenziato dal suo capo senza che questo gli abbia versato la liquidazione ed alcuni anni di contributi. Dopo la protesta del dipendente e la sua minaccia di denunciare l’accaduto, il capo decide di liquidarlo dandogli l’ammontare di denaro da lui richiesto oltre ad una somma per il danno subito. Il dipendente però prosegue nell’azione legale sostenendo che vuole che gli sia dato quanto gli è dovuto: non conta solo il quantitativo di denaro ma anche il fatto che il capo riconosca pubblicamente come fosse suo dovere pagarlo e come non facendolo gli abbia mancato di rispetto. Trattare gli altri da eguali sembra richiedere di riconoscere loro l’autorità di poter pretendere un giusto trattamento definito da doveri pubblicamente giustificati e tale caratteristica sembra proprio uno degli aspetti che distingue la sfera della giustizia da quella della comunità Possiamo pretendere di essere trattati in modo corretto, non certo di essere amati. Si può pretendere che le persone, e ancora di più le istituzioni, tengano in considerazione le nostre esigenze, non che le realizzino a pieno. Si può pretendere che un medico ci informi di cosa ci sta facendo e che non ci tratti come degli oggetti su cui applicare le sue conoscenze, non che ci capisca e sostenga come potrebbe fare un amico. Si può pretendere che il consiglio di amministrazione di un’azienda fornisca delle buone ragioni per licenziare i suoi dipendenti, non che li aiuti quando sono in difficoltà economica. Credo sia a questo punto possibile concludere, contro quanto sostenuto da Cohen, che la pubblicità ha una parte nel definire i doveri dei membri di una società giusta e che nel farlo non ottiene risultati sub-ottimali rispetto all’ethos graduale proposto da Cohen. Se infatti è possibile che un numero minore di diseguaglianze venga appianato, a tutti verrà garantito quanto è dovuto senza dover dipendere dalla disponibilità dei propri pari. La proposta di Cohen, sovrapponendo la struttura dei doveri di giustizia a quelli di comunità, non sembra cogliere l’importanza del ruolo che ha questo aspetto all’interno di una teoria della giustizia di matrice egualitaria, e in questo modo dà un resoconto quanto meno parziale di cosa significhi trattare gli altri come eguali. Attraverso la mia analisi ho cercato di mostrare come la struttura pretesa-doveri e i vincoli di pubblicità su cui questa si fonda, sembrano dare ragione di quelli che sono i nostro doveri di giustizia nei confronti dei nostri pari. Questo non toglie che una mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? qualche forma di ethos possa essere strumentalmente necessaria per garantire che i vincoli imposti dalla giustizia vengano poi rispettati da coloro che in essa si riconoscono, né che all’interno della sfera della comunità i vincoli possano essere quelli identificati da Cohen. Comunità e giustizia sono però due ambiti differenti e tale differenza non può essere limitata al contenuto e al ruolo dell’ethos ma anche alla struttura dei vincoli che questo impone agli individui da un lato e ai compagni dall’altro. Come Cohen anche io credo che il mondo sarebbe davvero migliore se tutti si potessero considerare eguali e si trattassero come tali, ma perché ciò avvenga penso che sia necessario che le persone possano “guardarsi negli occhi” e pretendere di essere rispettate per quello che sono. Riferimenti bibliografici E. BIALE, Eguaglianza democratica e ineguaglianze economiche in Fatti e principi. Una disputa sulla giustizia, a cura di A. Besussi, E. Biale, Aracne, 2010, pp. 150-178. G.A. COHEN, Why Not Socialism?, Princeton University Press, 2009; trad. it. Socialismo perché no? Ponte alle Grazie, 2010. G.A. COHEN, Rescuing Justice and Equality, Harvard University Press, 2008. R. DWORKIN, Sovereign Virtue, Harvard University Press, 2000; tr. it. Virtù sovrana, Feltrinelli, 2000. J. FEINBERG, The Nature and Value of Rights, “The Journal of Value Inquiry”, 4, 1970, pp. 243-257. J. RAWLS, A Theory of Justice. Revised edition, The Belknap Press of Harvard University Press, 1999; trad. it. Una teoria della giustizia, Feltrinelli, 2008. N. VROUSALIS, G. A. Cohen on Socialism, “Journal of Ethics”, 4, 2010, pp. 185-216. / / 77 / / >>>> dossier / why not socialism? Il campeggio e la società >>>> Miriam Ronzoni W hy Not Socialism? è un’agile ed accessibile monografia, delle dimensioni di un pamphlet, scritta con lo scopo di sostenere sia la desiderabilità del modello socialista, sia un moderato ottimismo nei confronti della possibilità di una sua realizzazione, quantomeno parziale. L’egualitarismo di Cohen, come vedremo, cerca di ricavare uno spazio per i concetti di libertà, scelta, e responsabilità personale all’interno della visione del mondo socialista; ciò potrebbe quindi, in linea di principio, avvicinarlo alla “via italiana” al socialismo, intesa come proposta generalmente egualitaria ma anticomunista, e riassumibile in termini di socialismo liberale. In questo breve pezzo vorrei suggerire invece che l’idea di libertà promossa da Cohen è più vicina, semmai, alla libertà anarchica (intesa come libertà di aderire senza costrizioni coercitive ad un modello sociale anti-oppressivo, emancipativo, e per lo più comunitario) di quanto non lo sia ad una concezione liberale costituita attorno ad un pacchetto di diritti individuali inviolabili e alla protezione di una sfera d’azione privata. Il modello sociale promosso, pertanto, si distanzia sì dall’ortodossia marxista, ma per tornare a forme di socialismo utopistico premarxiste, piuttosto che per avvicinarsi al socialismo liberale. Cohen definisce il socialismo, infatti, in modo piuttosto insolito, vale a dire né come ribaltamento strutturale della società capitalista e borghese, né come sistema di proprietà pubblica sui mezzi di produzione, quanto piuttosto, in termini esclusivamente normativi, come la realizzazione congiunta di due principi morali: il principio di uguaglianza e quello di comunità, entrambi volontariamente sostenuti dagli attori sociali. Tale modello sociale, vedremo, ricorda forme di socio-anarchismo utopistico ben più di quanto non si ispiri a forme di socialismo marxista: vale a dire che esso propone un modello di egualitarismo comunitario basato su pratiche di condivisione volontarie, piuttosto che un ribaltamento sistemico di strutture di potere. Il socialismo proposto da Cohen è pertanto una sorta di mutualismo volontaristico, dove forme di eguaglianza radicale sono realizzate attraverso la libera adesione ad un modello della vita buona invece che attraverso l’abbattimento di strutture di potere che impediscano sfrutta- mento e alienazione. Esso deve pertanto affrontare gli stessi problemi di ogni forma di anarchia, per quanto riguarda sia la sua realizzabilità, sia la sua desiderabilità. In queste brevi osservazioni intendo soffermarmi sul secondo aspetto, poiché la critica al carattere utopico della proposta anarchica è cosa nota. La desiderabilità di un ordine sociale organizzato attorno ai principi di eguaglianza e comunità è illustrata da Cohen attraverso l’esempio di un viaggio in campeggio. Cohen si sofferma ad analizzare con una certa ricchezza di dettagli i principi e i valori che abitualmente caratterizzano un’esperienza di questo tipo; osserva quindi, sulla base di tale illustrazione, che la desiderabilità di un ordine sociale fondato sugli stessi principi e sugli stessi valori è pressoché auto-evidente (con l’eccezione di alcune semplici questioni, che vengono rapidamente affrontate), concludendo pertanto che le obiezioni più significative al socialismo concernono esclusivamente la sua realizzabilità, tema cui è dedicata la seconda metà del libro. Vorrei suggerire che la desiderabilità stessa del modello sociale del campeggio come ideale applicabile alla società in generale è meno evidente di quanto Cohen non riconosca. Cohen sostiene che la nostra riluttanza ad applicare le regole egualitarie e comunitarie del campeggio alla società più in generale sia dovuta soltanto a preoccupazioni di realizzabilità. È possibile, tuttavia, che la realizzabilità non sia il solo problema, e che vi siano differenze moralmente importanti tra il campeggio e la società in generale. Ciò che vorrei sostenere, in particolare, è che vi siano due differenze fondamentali cui Cohen non presta la dovuta attenzione: in primo luogo il fatto che, per tutta la durata del campeggio, la realizzazione dei suoi valori comunitari è l’obiettivo centrale dei suoi partecipanti (chiamerò questo aspetto monismo degli obiettivi); in secondo luogo, la discontinuità nel tempo del campeggio rispetto alla società. Per meglio illustrare le due differenze, confronterò il campeggio con un’altra istituzione sociale, la famiglia, di piccole dimensioni e caratterizzata da forti legami interpersonali tra i suoi membri così come il campeggio, ma all’interno della quale sono assenti le condizioni di monismo degli obiettivi e di discontinuità temporale. mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 78 / / Secondo Cohen, come abbiamo già anticipato, il socialismo è realizzato quando i due principi di uguaglianza e di comunità sono congiuntamente applicati. Il principio egualitario proposto da Cohen è un principio di uguaglianza di opportunità radicale, che sostiene la realizzazione cumulativa delle pretese morali borghese, liberale di sinistra e socialista sull’uguaglianza di opportunità. La parità di opportunità borghese richiede la rimozione di ostacoli alla mobilità sociale dovuti ad atti di discriminazione attiva, sia essa formale o informale (in base a differenze di casta, etnia, sesso, e così via). La parità di opportunità della sinistra liberale richiede in aggiunta la rimozione degli svantaggi sociali dovuti alle circostanze socio-economiche di provenienza degli individui, assicurando così che le disuguaglianze tra i cittadini rispecchino esclusivamente scelte e talenti diversi, e non opportunità di partenza disuguali. Ad esempio, particolare attenzione deve essere prestata alla formazione e all’autostima dei bambini provenienti da strati sociali svantaggiati. Infine, la parità di opportunità socialista, nella definizione specifica di Cohen, esige che tutte le disuguaglianze di cui non siamo responsabili, incluse quelle naturali, siano neutralizzate. In quest’ottica, i talenti naturali sono una fonte di vantaggio tanto arbitraria quanto una condizione socio-economica di partenza agiata. L’applicazione del principio di uguaglianza di opportunità radicale riduce notevolmente le disuguaglianze tra i diversi attori sociali; tuttavia esso lascia intatte le disuguaglianze che possono considerarsi frutto di azioni responsabilmente scelte. Alcune disuguaglianze non ci appaiono problematiche, poiché rispecchiano divergenze di gusti e preferenze. Altre, invece, come ad esempio le disuguaglianze sorte da scelte rischiose ma responsabilmente intraprese, sono più preoccupanti. Queste possono portare a disparità rilevanti, che forse non possono essere condannate come ingiuste in senso stretto (secondo lo stesso Cohen), ma che sono comunque problematiche da una prospettiva socialista, in quanto minano alle basi la possibilità di un vivere in comune egualitario. Per questo motivo Cohen sostiene che il principio di uguaglianza debba essere integrato dal principio di comunità. Grazie a tale principio 1) le disuguaglianze consentite dall’uguaglianza di opportunità radicale non si verificano affatto, oppure sono liberamente mitigate, se non addirittura annullate, dalle azioni volontarie di chi è più fortunato, al fine di mantenere un ideale sociale egualitario (ciò può avvenire attraverso donazioni o altre pratiche di condivisione, oppure attraverso scelte volontarie, da parte di chi ha talenti specifici, di mettere le proprie competenze al servizio della comunità); più in generale, 2) le persone sostengono liberamente un ideale di recipromondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? cità basato su logiche diverse rispetto a quelle di mercato, in base al quale non prestano servizi gli uni agli altri proporzionalmente a quanto possono ottenerne in cambio, bensì sono motivati da uno spirito di servizio nei confronti degli altri esseri umani in quanto tali. Al fine di illustrare perché la vita in comune sotto la realizzazione congiunta di tali principi è attraente, Cohen ricorre all’esempio delle forme di organizzazione sociale che tendiamo a ritenere opportune in un viaggio in campeggio. In tale scenario, suggerisce Cohen, le persone non svolgono necessariamente compiti identici (alcune persone sono maggiormente portate per la pesca, altre per la cucina, e così via), ma è naturale pensare che ognuno di noi, in un viaggio in campeggio ben riuscito, abbia perlopiù le stesse opportunità di prosperare e di rilassarsi, a condizione di contribuire in misura appropriata alla prosperità e alla distensione degli altri campeggiatori. Cohen osserva giustamente che anche il più anti-egualitarista fra noi, probabilmente, non metterebbe in discussione tale norma di uguaglianza e reciprocità durante un campeggio – anzi, anche il solo mettere in discussione tali norme sembra essere in contraddizione con lo spirito stesso del campeggio. Eguaglianza e comunità Ci sono dunque forme di comportamento cui siamo abituati nella vita quotidiana in società, ma che ci colpiscono come strane e poco collaborative, se non addirittura ripugnanti, durante esperienze quali una gita in campeggio. La maggior parte di noi, infatti, odierebbe un campeggio organizzato in base alle regole stringenti della proprietà privata e della contrattazione di mercato, dove i migliori pescatori chiedono di avere il miglior pesce per cena, chi trova alberi di mele colmi di frutti contratta un carico di lavoro più leggero per se stesso prima di rivelarne la posizione agli altri, e chi sa rompere i gusci di noci a mani nude chiede di essere pagato per condividere le proprie competenze. Allo stesso tempo nel campeggio ideale di Cohen i compiti non sono condivisi in maniera totalmente identica (con turni pari di cucina, pesca e pulizie), ma sono piuttosto distribuiti in un modo che tiene conto sia delle preferenze sia dei talenti di ognuno. Cioè è dovuto al fatto che, da un lato, ciò che ci proponiamo di pareggiare sono le opportunità di godimento soggettivo, piuttosto che le risorse oggettive, che non significano necessariamente lo stesso per ognuno di noi; e, dall’altro lato, che i partecipanti al campeggio sono motivati da uno spirito di servizio al bene comune, e mettono quindi le proprie competenze specifiche a disposizione della comunità. Un viaggio in campeggio organizzato secondo questi principi, so- / / 79 / / stiene Cohen, è auspicabile e possibile: dobbiamo pertanto concludere che il socialismo stesso (inteso come l’estensione degli stessi principi regolativi alla società intera) è altrettanto auspicabile e possibile, o ci sono differenze rilevanti tra lo scenario del campeggio e la vita in società? Cohen sostiene che gli unici ostacoli seri alla realizzazione di un ordine sociale basato su tali principi sono problemi di fattibilità. L’unica possibile obiezione trattata da Cohen come una questione di desiderabilità morale in senso stretto è basata sul valore della libertà, e sostiene che le persone hanno il diritto di fare scelte personali incompatibili con i principi di uguaglianza e comunità. Cohen risponde a tale obiezione sostenendo che i vincoli del campeggio sono volontariamente accettati e sostenuti dai partecipanti, e che inoltre essi lasciano ampio spazio per libere scelte su cosa fare con il proprio tempo libero. Affronta poi brevemente altre obiezioni, secondo le quali l’ethos del campeggio è adatto esclusivamente ad attività ricreative, ad esperienze tra amici, o a comunità di piccole dimensioni, sostenendo che tali ragioni mettono in questione la fattibilità del socialismo (le piccole dimensioni, lo scopo ricreativo e i legami interpersonali rendono più facile la realizzazione dei due principi), ma non la sua desiderabilità. Il ragionamento di Cohen a questo punto diventa, tuttavia, eccessivamente sbrigativo. Cohen risponde all’obiezione basata sul valore della libertà analizzando esclusivamente il contesto del campeggio stesso e domandandosi se esso sia eccessivamente restrittivo nei confronti delle libertà personali. Tale modo di procedere, tuttavia, costituisce una petitio principii, in quanto il campeggio è un progetto volontario per definizione: anche nello scenario più sinistro in cui le sue regole sono fisse e non negoziabili (“se si va in campeggio, è così che ci si deve comportare”), la scelta di partire è una scelta volontaria, attiva, e spesso entusiasta. In genere chi parte per il campeggio lo fa perché, conoscendone le regole, è attratto dal tipo di espemondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 80 / / rienza specifica che esso offre, e nessuno è costretto ad andarvi o a restare. Cohen ha ragione nel sostenere che la libertà non è a rischio nel suo campeggio ideale, ma stabilire ciò è in larga misura irrilevante, poiché la principale libera scelta che intraprendiamo in proposito è proprio quella di aderirvi. Questo è precisamente ciò che non accade in società: la cooperazione sociale non è qualcosa cui possiamo aderire o da cui ci possiamo dissociare volontariamente. È pur vero che Cohen sostiene anche che i campeggiatori godono di un adeguato livello di libertà personale anche all’interno delle regole stesse del campeggio: quando queste sono rispettate, i campeggiatori possono scegliere liberamente che cosa fare del proprio tempo e delle proprie risorse. Tuttavia, è probabile che il livello di libertà di scelta possibile nel campeggio ideale ci sembri adeguato soltanto nelle circostanze particolari del campeggio, e non in società, a causa sia della scelta volontaria iniziale di aderire al campeggio, sia – come vedremo meglio più avanti – degli scopi comuni che i partecipanti al campeggio si prefiggono. Cohen, pertanto, si domanda se ci sia davvero libertà sufficiente nel campeggio – una domanda cui può rispondere facilmente in modo affermativo – mentre ciò che si sarebbe dovuto chiedere è se l’applicazione dei principi del campeggio ad un altro contesto sociale lascerebbe spazio sufficiente all’esercizio della libertà di scelta nel nuovo contesto. La desiderabilità del socialismo Cohen tralascia questo punto perché non ha in realtà alcun dubbio sul fatto che gli ideali del campeggio siano generalmente auspicabili. Ciò che vorrei suggerire, invece, è che ci sono importanti questioni di desiderabilità vera e propria che non si pongono nel caso del campeggio ma che sollevano importanti problemi morali qualora se ne vogliano applicare le medesime regole ad altre forme sociali. Al fine di illustrare tali questioni il più chiaramente possibile, è opportuno confrontare il campeggio con un altro contesto sociale che è sia altrettanto piccolo sia caratterizzato da legami (almeno) altrettanto forti tra i suoi membri, vale a dire la famiglia. Immaginiamo, quindi, che le regole del campeggio siano applicate all’organizzazione interna della vita familiare. Regole di proprietà collettiva vigono pertanto in famiglia. Naturalmente, poiché tutti i suoi membri sostengono in modo sincero i principi di uguaglianza e comunità, nessuno fa un uso irragionevole delle proprietà comuni, e tutti fanno in modo che chi tra noi ha più bisogno o gode maggiormente dell’usufrutto di qualcosa vi abbia anche accesso privilegiato. Ciò non toglie che, all’interno di una famiglia così ormondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? ganizzata, non vi sono situazioni in cui è possibile semplicemente prendere il proprio iPod e perdersi nella propria musica preferita senza prima chiederci se un altro membro della famiglia ha bisogno di noi, o quanto meno, ciò è possibile solo in casi eccezionali. Gli obblighi domestici, a loro volta, sono distribuiti in modo tale da rispecchiare i nostri talenti e le nostre preferenze. Chi tra noi ama cucinare e lo sa fare particolarmente bene intraprende liberamente turni più pesanti in cucina. Tuttavia anche chi sa cucinare bene ma non ama farlo sceglie liberamente di mettere le proprie competenze al servizio del bene comune, nei limiti dell’uguaglianza di opportunità. Infine, se qualcuno eredita inaspettatamente una somma di denaro da un lontano parente, anche se gli altri membri della famiglia sono in buone condizioni economiche, l’aspettativa generale è che l’eredità sia condivisa, piuttosto che usata in tutto o anche solo in gran parte per perseguire un obiettivo personale (ovviamente, se l’obiettivo personale è particolarmente importante per chi ha ereditato la somma, è probabile che le regole di eguaglianza e comunità determino comunque che la somma le o gli sia destinata, ma non perché le o gli appartiene di diritto in quanto ereditata). Il lettore converrà che la desiderabilità dell’applicazione dei principi di eguaglianza e comunità all’organizzazione quotidiana della famiglia è quantomeno meno evidente di quanto non lo sia nel caso del campeggio. Certo, è naturale aspettarsi che valori di cura e di condivisione siano particolarmente forti in famiglia. Per esempio tendiamo a ritenere opportuno che le risorse economiche vadano distribuite su base significativamente / / 81 / / egualitaria all’interno della famiglia a prescindere dalle disparità dei livelli di reddito (non credo di avere diritto a pasti migliori di quelli di mio marito perché guadagno di più). Allo stesso modo ci aspettiamo un certo livello di comunità nella gestione delle proprietà: se ho urgente bisogno di utilizzare l’auto di mio fratello e non riesco a contattarlo, tendo a pensare che non ci sia alcun problema nel prenderla semplicemente, lasciando le spiegazioni a dopo. D’altra parte, però, livelli di distribuzione rigorosamente egualitari, l’assenza assoluta di proprietà privata, o uno spirito di servizio reciproco continuo all’interno della famiglia ci sembrano problematici ed eccessivi: in altri termini pensiamo che i membri di una famiglia abbiano, a lungo andare, diritto di abdicare da alcune implicazioni dei principi di eguaglianza e comunità, probabilmente più di quanto ciò non sia il caso nel viaggio in campeggio. In altre parole non appena il contesto sociale cambia, la desiderabilità dei principi del campeggio diventa quantomeno meno ovvia: il nostro giudizio sembra essere fortemente influenzato dalla natura della pratica sociale che stiamo considerando, perché le persone si impegnano in essa (e se hanno una scelta in merito), a che forme di vulnerabilità reciproca essa dà luogo, e quanto profondamente la pratica influisce sulla nostra vita. Ciò significa che l’appropriatezza nell’applicare un principio regolativo ad una pratica sociale dipende da fattori moralmente e normativamente rilevanti, e non solo da preoccupazioni di realizzabilità. Vi sono alcune somiglianze tra il campeggio e la famiglia e pertanto alcune analogie nei principi che riteniamo essere appropriati ai due scenari, anche se probabilmente non crediamo che essi debbano essere del tutto identici (benché un certo livello di disaccordo ragionevole sia destinato a persistere in proposito). Ciò tuttavia non ci dice nulla circa la desiderabilità generale dei principi di eguaglianza e comunità, ma sembra anzi corroborare la tesi secondo cui sia sempre meglio parlare di desiderabilità in modo maggiormente contestualizzato, e mai in termini assolutamente generali. ticolarmente utile perché le famiglie non sono differenti dal campeggio per quanto riguarda alcune delle caratteristiche più evidenti di quest’ultimo che rendono la realizzazione dei valori socialisti fattibile in esso: le famiglie sono piccoli contesti sociali, e sono caratterizzate da forti legami emotivi tra i loro membri. Le nostre intuizioni sul contesto familiare, tuttavia, divergono almeno in parte dal caso del campeggio. Questo suggerisce che dovremmo chiederci se vi sono altre caratteristiche specifiche del campeggio che rendono i due principi adatti ad esso ma non ad altre pratiche. A mio avviso se ne possono riscontrare due. La prima caratteristica è quella che chiamerò il suo monismo degli obiettivi. Fare un’esperienza diretta ed intensa di vita comunitaria e di pratiche di condivisione è, molto spesso, la ragione stessa per cui la gente va in campeggio. Per tutta la durata del campeggio, la realizzazione dei suoi valori comunitari è l’obiettivo centrale dei suoi partecipanti, invece di essere qualcosa che deve essere bilanciato con altri legittimi obiettivi, come avviene normalmente in società. È ragionevole supporre che quando si parte per un viaggio in campeggio come quello descritto da Cohen il nostro obiettivo principale sia quello di vivere all’aperto insieme, come una comunità stretta, liberamente aperta alla condivisione. Se il desiderio di condurre attività all’aria aperta in quanto tale o la voglia di tempo per l’auto-esplorazione fossero gli obiettivi prevalenti dei partecipanti, probabilmente essi opterebbero per viaggi di diverso tipo, quali escursioni con guide a pagamento o viaggi in campeggio in solitario (come il personaggio principale del film Into the Wild). Se invece volessero una combi- Il monismo degli obiettivi Permettetemi ora di trarre una lezione più generale da questo esempio. Il mio obiettivo nel confrontare il campeggio con la famiglia è stato di mostrare come le nostre intuizioni su quali principi sono appropriati al caso del campeggio siano fondate sulla natura di questa specifica pratica sociale e sui valori che incarna, piuttosto che sull’obiettiva desiderabilità universale dei principi di eguaglianza e comunità. Il confronto con la famiglia è parmondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 82 / / nazione di tutti e tre gli elementi senza gerarchia chiara – cioè, se non sottoscrivessero il monismo degli obiettivi – essi sceglierebbero probabilmente una vacanza all’aria aperta con amici in condizioni ambientali e strutturali diverse dal campeggio, in modo da poter consentire di più tempo e risorse per se stessi. Cohen tace su questo punto, ma gran parte del fascino intuitivo del suo esempio si basa sul presupposto implicito che la comunità è il valore che vogliamo sperimentare quando svolgiamo attività di questo tipo. Quando Cohen sostiene che le persone godono di libertà di scelta su che cosa fare del proprio tempo e delle proprie risorse durante il viaggio in campeggio, tale affermazione risulta credibile soltanto perché presupponiamo che chi ha aderito a questo viaggio lo ha fatto per stare in- mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? sieme in uno spirito di condivisione, e che quindi il desiderio di spazio e tempo per perseguire obiettivi personali sia molto più limitato che in circostanze normali. Le famiglie sono diverse. È pur vero che avere una famiglia amorevole e premurosa è, per molti di noi, uno degli obiettivi più importanti nella vita (e per alcuni forse il più importante in assoluto, anche se certo non per tutti). Tuttavia tale obiettivo è costantemente controbilanciato da altri importanti obiettivi e valori, come il desiderio di avere una carriera di successo, una vita sociale attiva, o semplicemente cura della propria persona e del proprio potenziale. E non è affatto chiaro che un rispetto assoluto dei principi di uguaglianza e di comunità permetta un tale bilanciamento in misura adeguata (nel campeggio ciò avviene, ma / / 83 / / avviene perché un valore è di assoluta centralità rispetto a tutti gli altri, quantomeno per la durata del campeggio). Il pluralismo degli obiettivi, invece, sembra richiedere che i membri della famiglia possano avere a propria disposizione, usando la famosa espressione di Virginia Wolf, “una stanza tutta per sé”: vale a dire uno spazio fisico e mentale in cui le priorità e i progetti personali possono prosperare liberamente senza, almeno in una certa misura, avere le esigenze della comunità in mente. In secondo luogo i viaggi in campeggio sono discontinui nel tempo: ad un certo punto si torna alla vita normale. L’idea che questa limitazione temporale contribuisca a rendere attraenti i principi di uguaglianza e comunità deve essere affrontata seriamente dai sostenitori del socialismo coheniano, cosa che invece Cohen stesso non fa. Le famiglie, di solito, non sono discontinue nel tempo. Vi può essere un senso in cui le famiglie sono più discontinue nel tempo di quanto non lo sia la società in generale, perché ci si può dissociare da loro, per esempio attraverso il divorzio. Tuttavia i costi nel dissociarsi dalla propria famiglia sono spesso molto alti, ben più alti, dolorosi e gravosi di quelli che incorriamo quando abbandoniamo un viaggio in campeggio. Inoltre tale analogia sembra rafforzare ulteriormente la tesi che, nella misura in cui vi è una convergenza parziale di principi tra i viaggi in campeggio e le famiglie, ciò è dovuto al fatto che si tratta di pratiche sociali con analogie rilevanti – il che sembra ridurre la plausibilità della tesi secondo cui una realizzazione totale dei principi di uguaglianza e di comunità sia universalmente desiderabile da un punto di vista morale. Il monismo degli obiettivi e la discontinuità nel tempo sono, quindi, caratteristiche moralmente rilevanti di viaggi in campeggio, ma non necessariamente di altri scenari sociali. Applicare i due principi socialisti all’organizzazione della vita familiare o addirittura della società in generale comporterebbe la stessa continuità nel perseguimento di un monismo degli obiettivi intorno ad un modello di vita comunitario, e non è così chiaro che questo sia un ideale moralmente desiderabile. Pieno rispetto dell’uguaglianza di opportunità radicale e della comunità come nel campeggio ideale di Cohen implicherebbe la stessa devozione alla vita in comunità e condivisione continua come un ideale centrale e globale nelle nostre vite. Pertanto, suggerendo che gli stessi principi che giustamente si applicano al campeggio sono desiderabili per la società intera, Cohen sembra implicitamente suggerire che il monismo dei valori che caratterizza il campeggio è esso stesso un ideale socialmente desiderabile. In altre parole egli sostiene in modo indiretto un’i- dea molto specifica della vita buona, e ci incoraggia a sottoscrivere un ideale di vita molto preciso ed intenso che va ben oltre la giustizia in senso stretto: il campeggio diventa una metafora ideale della vita buona, una vita vissuta abbracciando i valori della comunità e della condivisione in modo centrale e dominante. In questo senso, quindi, l’impostazione sociale suggerita da Cohen è molto più vicina ai modelli anarcoidi del socialismo utopistico di quanto non lo sia al marxismo in senso mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? / / 84 / / stretto: è un’idea della vita buona basata su pratiche di comunità e condivisione volontarie, piuttosto che su una ristrutturazione delle relazioni di potere. Questa è una proposta provocatoria e controversa, e la sua natura controversa è oscurata dalla sbrigativa analisi compiuta da Cohen circa la desiderabilità generale dell’ideale socialista. Anarcosocialismo e socialismo liberale In conclusione vorrei discutere brevemente una possibile controreplica da parte di Cohen. Tale controreplica afferma che, così come in campeggio, le persone potrebbero scegliere liberamente di dare un ruolo centrale ai valori comunitari in società: se ciò avvenisse, dove sarebbe il problema? Se un ethos egualitario e comunitario è volontariamente interiorizzato, le persone scelgono liberamente di onorare l’uguaglianza di opportunità radicale e di mettere le loro competenze al servizio della comunità. Il monismo dei valori e l’approvazione della vita in comunità come un ideale sociale fondamentale possono, pertanto, essere volontariamente approvati e sostenuti, così come nel mondoperaio 3/2011 / / / / why not socialism? caso del campeggio. Tale contro-obiezione, tuttavia, non coglie nel punto. La mia perplessità circa la desiderabilità generale dei principi del campeggio non è basata sul sospetto che essi dovrebbero necessariamente essere inculcati con la forza o attraverso forme di socializzazione problematiche. Se questo fosse il caso, Cohen potrebbe sostenere che la mia preoccupazione è, a ben vedere, basata su considerazioni di fattibilità, poiché non riesco persuadermi che gli esseri umani, data la loro natura, non potrebbero liberamente e volontariamente sostenere un sistema sociale di questo genere. Pur avendo tale sospetto, la mia obiezione in questa sede è diversa: la mia preoccupazione è che una società strutturata sulla falsariga del campeggio ideale di Cohen sia effettivamente auspicabile anche se fosse possibile aderire ad essa in modo volontario. La mia domanda non è se il monismo degli obiettivi è possibile, bensì se esso è desiderabile, in società: anche se un ethos di uguaglianza e di comunità potesse sorgere in modo non problematico, vorremmo effettivamente promuoverlo? O preferiremmo invece incoraggiare gli esseri umani ad esplorare le proprie preferenze, inclinazioni e competenze, non solo perché pensiamo che il loro altruismo sia limitato, ma anche perché pensiamo che ci sia qualcosa di indipendentemente prezioso nella natura creativa, inventiva, sfaccettata e diversificata delle imprese e dei progetti umani? Se promuovere tale diversità implica la necessità di bilanciare comunità ed uguaglianza con altri obiettivi, invece che renderli assolutamente centrali, molti di noi credono che questa sia una scelta ragionevole da fare. Non ho l’ultima parola da dire su questo tema; credo solo che si tratti di un problema ben più difficile da risolvere di quanto il modello del campeggio non suggerisca. Per dirla con uno slogan, quello che ho cercato di fare in questo breve pezzo è mostrare come l’ideale sociale dell’anarcosocialismo coheniano debba ancora confrontarsi con un aspetto importante della proposta politica liberale (e quindi anche del socialismo liberale): non quello secondo il quale l’altruismo umano è limitato e alcune disuguaglianze devono pertanto essere necessariamente tollerate, né quello secondo cui gli esseri umani sono potenziali minacce reciproche, e abbiamo quindi bisogno di un sistema di diritti individuali inviolabili per proteggerli gli uni dagli altri; bensì l’aspetto che celebra positivamente la diversità e l’intraprendenza umane, e sostiene che una società desiderabile debba promuoverne e incoraggiarne lo sviluppo. / / 85 / / >>>> biblioteca / citazioni Il socialismo oggi Gli Editori Riuniti hanno appena pubblicato il carteggio che a partire dal 1956 Giuseppe Tamburrano ha tenuto con Norberto Bobbio (Carteggio su marxismo, liberalismo, socialismo). Da esso abbiamo tratto un documento che la Fondazione Nenni elaborò nel 1996 e le due lettere di commento di Norberto Bobbio. I l socialismo è stato: un’etica (la solidarietà con i meno fortunati, la pari dignità di tutti gli esseri umani, il costume semplice e onesto); una dottrina (principalmente il marxismo) che ha interpretato la storia secondo categorie economico-sociali, prima fra tutte la lotta di classe; un progetto di nuova società senza classi, senza Stato, senza sfruttamento in cui tutti gli esseri umani fossero liberi e uguali; una teoria degli strumenti: la collettivizzazione e il piano; le strategie (diversificate) per la conquista e l’esercizio del potere e per la costruzione della nuova società. Cosa rimane di questo patrimonio di teorie, di regole, di finalità? Secondo alcuni i grandi cambiamenti della società borghese-capitalistica, il crollo del comunismo e dei sistemi centralistici, l’esaurimento del Welfare State hanno decretato insieme la fine del socialismo, in tutte le sue versioni, e il trionfo del mercato. Questa tesi contiene una parte – ma solo una parte – di verità. Nel socialismo bisogna separare ciò che è contingente da ciò che è universale e distinguere altresì tra i fini e i mezzi. Il marxismo non esaurisce in sé il socialismo: Marx ed Engels hanno analizzato una fase dello sviluppo, una particolare formazione sociale: il capitalismo industriale delle origini. Oggi Marx certamente non descriverebbe l’attuale società nei termini del Capitale. Sostenere che il fallimento, o meglio il superamento del marxismo equivale alla fine del socialismo, è dunque un errore storico e teorico. Tanto è vero che c’è un socialismo premarxista e un socialismo non marxista, ad esempio il laburismo fabiano. Lo stesso discorso vale per i mezzi. Tutte le varie incarnazioni politiche dell’ideale socialista, sia quella marxista sia quel- la laburista, hanno considerato come fase decisiva del passaggio alla società socialista – nei loro pur diversi programmi o metodi di lotta politica – l’espropriazione del capitale e la collettivizzazione dei «mezzi di produzione o di scambio» e la conseguente pianificazione dell’economia per iniziativa e sotto la guida del nuovo Stato socialista; anche se grandi restavano le differenze sui metodi: violenti, dittatoriali, centralistici quelli leninisti; legali, democratici, partecipati quelli dei riformisti. Queste distinzioni aprono la strada ad una operazione che lasciando cadere gli aspetti contingenti e strumentali del socialismo tenti il recupero dei valori universali e dei fini generali, nella misura in cui conservino una validità. Non è questa la sede per un bilancio di ciò che è vivo e di ciò che è morto delle dottrine socialiste, ed in particolare della più importante di esse, il marxismo. É solo il caso di notare che mentre la sinistra europea, qualche anno fa marxista in tutte le sue varianti, ha rimosso totalmente Marx, il marxismo viene studiato e rivalutato in ambienti accademici anglosassoni. E ssenziale è in questa sede, invece, il problema dei mezzi, perché esso è in diretta connessione con la linea politica dei partiti di sinistra che debbono rispondere a questioni attuali come, ad esempio, il mercato, il ruolo dello Stato, la spesa pubblica, le privatizzazioni, la globalizzazione. La questione teorica preliminare è la seguente: il socialismo come fine è indissolubilmente legato con gli strumenti, cioè con l’espropriazione dei mezzi di produzione e di scambio, con la collettivizzazione dell’economia, col piano? Se la risposta è positiva, se il socialismo si identifica con quegli strumenti, il clamoroso fallimento delle varie forme di statalismo segna la fine senza apmondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / citazioni / / 86 / / pello del socialismo come processo di liberazione umana. A favore della risposta affermativa militano argomenti forti, e soprattutto uno. Se il socialismo è un progetto di profonda riforma della società, il processo non può essere spontaneo, deve essere necessariamente guidato: e da chi, se non dallo Stato, sia pure con il massimo di forme democratiche (partecipazione dal basso alle decisioni, elementi di autogestione, cooperative, ecc.)? In questo processo, necessariamente diretto dallo Stato, non vi è, non vi può essere, se non marginalmente, spazio per il mercato, una istituzione che è per definizione spontanea, e incompatibile con ogni dirigismo e finalismo, ed è al servizio non del bene, della felicità, della uguaglianza, ma solo ed esclusivamente del profitto. Posta la questione in termini filosofici, se si è per il mercato si è dunque contro il socialismo e viceversa. E poiché – si sostiene – lo statalismo è fallito mentre il mercato ha trionfato, la questione è chiusa. Ma su questi problemi, le soluzioni teoriche sono spesso fallaci e la logica dei fatti contraddice la logica degli assiomi. Due domande semplici e chiare fanno importanti brecce nell’assioma filosofico. Eccole: il mercato ha certamente trionfato sullo statalismo, ma da questo trionfo è uscito come «regolatore universale»? Cioè, detto in altre parole, tutti i rapporti economico-sociali trovano la soluzione ottimale nel mercato, nella logica del profitto? Il mercato produce o no anche effetti indesiderati, distorsioni, sia a livello etico e culturale che sul terreno economico e sociale? Se si risponde «no» alla prima domanda e «sì» alla seconda ne viene: 1) che ci sono settori della vita sociale, anche economici, che non possono essere regolati dal mercato: sono i settori «non profit»; e dunque debbono essere regolati da altri meccanismi ed istituti diversi dal mercato; 2) che «qualcuno» deve correggere il funzionamento del mercato per evitare gli effetti negativi del suo automatismo. Questi meccanismi, istituzioni, «qualcuno», non possono essere altri che lo Stato nel senso più ampio: la «mano visibile» che viene coordinata con la «mano invisibile» (il mercato). E occorre ricordare alla sinistra, genuflessa sulla via di Damasco di fronte al mercato, che è una verità generale, accettata comunemente, che nella vita della società non esiste solo il profitto e che esso non è, non può essere motore di tutte le cose, e che è compito, dovere dello Stato e della società perseguire fini generali come l’ordine, la pacifica convivenza, la pace, la giustizia, la sicurezza, l’equità, la salute, l’ambiente, mondoperaio 2/2011 / / / / biblioteca / citazioni l’aiuto alla famiglia, ai più deboli; che il liberista serio non difende il mercato come un totem, ma solo in quanto è, in gran parte della vita economica, un regolatore e un moltiplicatore di risorse insostituibile. E si deve inoltre osservare che il mercato ha vinto la sfida del comunismo non tanto per le sue virtù, quanto per il fallimento del «socialismo reale» crollato sotto il peso dei suoi insuccessi. Contro gli apologeti del mercato senza regole, i quali hanno conosciuto un effimero successo di fronte alle rovine del comunismo, il socialismo democratico – che nessuna responsabilità porta per la tragedia del comunismo, che anzi ha denunciato con non minore forza dei liberali le degenerazioni totalitarie del sedicente «socialismo reale» - deve rivendicare il primato della politica sull’economia, della comunità (polis) sull’egoismo. Deve far valere una verità elementare: la società vive attraverso il libero confronto e le decisioni democratiche dei cittadini in funzione di fini collettivi e il compito di perseguirli spetta alla politica. E la politica perciò deve - ove necessario intervenire nei processi spontanei del mercato. Ne viene che la società non può essere retta solo dalla logica di mercato; vi è necessariamente anche un’altra logica, ispirata ad altri valori superiori; le due logiche non debbono sopraffarsi, ma convivere. Esse sono compatibili: cioè il socialismo è compatibile con il mercato. In altri termini: il socialismo non mira più ad abolire il mercato «capitalistico» per collettivizzare e pianificare l’economia, ma a preservarlo, integrarlo, correggerlo e utilizzarlo per i suoi fini. Questo ultimo punto è centrale. E’ possibile combinare finalità pubbliche o sociali con meccanismi di mercato: nella sanità, nelle poste, nelle telecomunicazioni, nell’elettricità ed acqua, negli stabilimenti di pena, ecc., possono entrare i privati in concorrenza o in concessione. Purché siano assicurate una gestione efficiente e trasparente e le finalità sociali di quei servizi. In breve, se si distingue tra fini e mezzi, se il mezzo diventa neutro, e viene considerato solo nella sua idoneità ad assicurare lo scopo nel modo migliore possibile, impresa pubblica o impresa privata, regime di concorrenza o di monopolio sono strumenti e metodi per conseguire risultati ottimali. E sia detto per inciso e valga quel che vale: le imprese pubbliche italiane – eliminati i carrozzoni – hanno dimostrato una vitalità superiore a quelle private: secondo Mediobanca gli utili delle aziende private sono passati da -6.307 nel 1993 a +4.804 nel 1995, mentre gli utili delle pubbliche da -8.659 a +6.708 (in miliardi di lire). I n conclusione: il socialismo si qualifica per i fini e non per i mezzi. Esattamente l’opposto della teoria di Bernstein: il / / 87 / / da soddisfare, lo Stato si disinteressa totalmente, ferme restando le norme del Codice civile o le leggi del settore. I mezzo è tutto, il fine è nulla. E la scelta dei mezzi è in funzione della loro coerenza etico-politica con i fini o della idoneità «tecnica» al raggiungimento dei medesimi. In altri termini, la scelta dei mezzi non deriva da una valutazione etico-politica aprioristica; così, per esempio, non si può affermare a priori: «mai interventi diretti, ma solo regole», perché ciò dipende dal settore, dall’area interessata, dal problema concreto. Solo per fare un esempio: la «deregulation» non è necessariamente conservatrice: al contrario essa può essere, più che liberista, libertaria: dipende da chi la fa, come la fa e a che scopo la fa. Non dimentichiamo che il socialismo è figlio dell’anarchismo, che nel suo patrimonio genetico vi è la rivolta contro lo Stato e la burocrazia e le corporazioni. In un approccio come quello delineato, il socialismo non considera il mercato e l’operatore privato come nemici: al contrario li considera come istituzioni positive se creano ricchezza, come alleati e come strumenti efficienti nei settori «non profit» o nei quali le finalità sociali sono prevalenti, se possono essere utilizzati meccanismi di mercato. Allorché non sussistono bisogni collettivi o finalità sociali l miglior funzionamento del mercato deve essere assunto come un elemento permanente della strategia socialista, tenendo tuttavia conto che non sempre mercato e interessi collettivi coincidono. Prendiamo l’occupazione, un problema di grande rilievo, teorico e pratico. Il mercato del lavoro è il terreno primordiale del liberismo e del laissez-faire. Ma oggi l’equazione: crescita economica uguale aumento dell’occupazione è stata contestata dai fatti. E se non possiamo più confidare negli automatismi del mercato, che cosa dobbiamo fare per rendere effettivo il diritto al lavoro, per risanare questa drammatica piaga sociale? Grazie alla liberalizzazione del mercato dei capitali enormi risorse si spostano nel mondo liberamente: possiamo favorire anche la globalizzazione del mercato del lavoro aprendo le frontiere alla mano d’opera, cioè alle immigrazioni dai paesi meno sviluppati senza porre limiti? E’ evidente che questo problema non può essere lasciato ai processi spontanei del mercato e ai meccanismi del profitto poiché esso implica non solo questioni etiche (il pericolo del razzismo), civili (le compatibilità multietniche e pluriculturali), politiche (l’integrazione e il diritto di voto), ma pone anche grandi interrogativi sociali ed economici di più lungo periodo i quali attengono allo squilibrio demografico tra paesi di immigrazione con pochi nati e paesi di emigrazione a forte natalità, uno squilibrio che proietta in prospettiva l’esigenza di favorire le immigrazioni per «ripopolare» paesi occidentali – Italia compresa. P arlare di mercato in generale è improprio perché oggi esistono due mercati, spesso non armonizzabili. La distinzione tra mercato di beni e servizi e mercato finanziario – distinzione già studiata da un classico del pensiero socialista, Rudolf Hilferding – è diventata netta e profonda, specie in conseguenza degli imponenti processi di mondializzazione. Non tutti gli effetti della mondializzazione sono positivi, anzi! La liberalizzazione degli scambi, la «deregulation», la rivoluzione telematica, la crescita del risparmio, lo sviluppo dei Fondi, hanno reso estremamente mobili i capitali di investimento a breve. Gli interessi di questi «speculatori» non sempre coincidono con quelli dei produttori. Il mercato finanziario non ha regole se non una: il rendimento. Sempre più spesso entra in contraddizione con il mercato dell’economia reale, fatta di investimenti in beni che producono merci e servizi e creano occupazione, o riduce l’occupazione, ad esempio con la delocalizzazione. mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / citazioni / / 88 / / M a l’accenno alla speculazione internazionale serve anche a mettere meglio a fuoco la questione del mercato, che se dal cielo della teoria economica cala nella realtà mostra molte facce: il mercato dei capitali, quello dei beni e dei servizi (e della mano d’opera), quello controllato da pochi colossi e quello diffuso nella piccola e media impresa, quello operante entro i confini nazionali e quello proiettato al di fuori o controllato dal di fuori. La sinistra, quasi vergognandosi del suo passato statalista, è in posizione di inferiorità, è pronta, prona a tutte le pretese avanzate in nome del mercato. Essa è integrata in modo subalterno nel «pensiero unico», in quella più ampia e più pericolosa «globalizzazione» che è insieme massificazione e riduzione del numero dei centri di formazione della pubblica opinione nel «villaggio» che è diventato il nostro mondo. Deve uscire dal «pensiero unico», elaborare il suo pensiero: senza di che perde la sua identità, smarrisce la sua missione, che non è quella di celebrare la «vittoria» del suo antico avversario ma di rialzarsi e riprendere la sua battaglia con armi nuove. Qui cade opportuna la critica all’inerzia, alla latitanza dell’Internazionale socialista, una grande – per la sua storia, per il numero dei membri, per l’autorevolezza di molti di essi – organizzazione rappresentativa che è totalmente assente sulla scena mondiale: le guerre, la fame, la miseria, il terrorismo, le ineguaglianze, lo sfruttamento, il razzismo, il fanatismo, la mortalità infantile, la condizione di inferiorità delle donne, la superstizione, l’analfabetismo, la distruzione di risorse insostituibili, tutti i drammi del nuovo disordine sociale lasciano l’organizzazione della sinistra pressoché indifferente. Come indifferente resta di fronte all’anarchia e alle minacce alla democrazia del mercato mondiale globale: un problema questo che interessa e preoccupa più gli intellettuali liberal che i «teorici» del socialismo, più uomini politici nazionalisti che i socialisti dell’Internazionale. Dal congresso di New York del 1996 è venuta una forte sollecitazione all’Internazionale – che vede crescere il numero delle adesioni – perché usi il suo grande prestigio internazionale per diffondere il suo messaggio di pace e di giustizia e accrescere la sua influenza nel mondo. V enendo all’Italia, la Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione ha rivelato che la povertà, che nel 1980 colpiva l’8,3% della popolazione, nel 1995 è cresciuta al 10,6%. E le cifre riguardano solo nuclei familiari o individui per i quali si può quantificare un reddito: non entrano nelle statistiche gli emarginati (clandestini, barboni ecc.) che sfuggono all’accertamento. Non si deve «criminalizzare» il mercato, che fa la sua parte. E’ mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / citazioni lo Stato, sono i governi che non fanno la loro. Per fare un solo esempio: in Italia le diseguaglianze tra il Nord e il Sud crescono in tutti i settori, dalla vita media all’occupazione, alla criminalità, ai servizi, all’igiene, alle retribuzioni (dal 12,4% del 1980 al 14,7% del 1991 e al 13,5% del 1992, nell’industria; e dall’11,7% del 1980 al 16,6% del 1992 nei servizi): chi se ne deve occupare e chi dobbiamo incolpare, il mercato o i governi? (E tra le colpe dei governi vi è anche quella di non aver favorito lo sviluppo del mercato nel Sud). E’ questo il terreno della rinascita delle idee socialiste. I l socialismo moderno non ha più niente in comune con lo statalismo. Esso è il campione della società aperta e a partire da Rosselli ha trovato una feconda sintesi con i principi del liberalismo. Quando reclama uno Stato che faccia la sua parte non intende asservire o subordinare l’individuo allo Stato. Tutt’altro! Il socialismo moderno è dalla parte dell’individuo, della persona del suo diritto di disporre di sé, artefice del suo destino. Vuole che lo Stato – guidato dalle idee socialiste – sia al servizio dell’individuo (ricordiamo il Manifesto di Marx ed Engels: «il socialismo è una società nella quale la libertà di ciascuno è la condizione della libertà di tutti»), lo aiuti a risolvere i suoi problemi che il mercato non risolve, lo metta al riparo dagli effetti perversi della concorrenza, crei le condizioni che rendano effettive le libertà, i diritti ed i poteri di scelta, e il contesto che favorisca la crescita culturale, la protezione e la sicurezza di tutti. Lo Stato al servizio dell’individuo purché: 1) al servizio di tutti; 2) con strutture efficienti; 3) con una vera parità di opportunità. E quando si dice «vera parità delle opportunità» si intendono due cose: 1) lo Stato non si limita ad aiutare i più deboli (lo ha largamente già fatto e deve continuare a farlo con un Welfare riformato) ma promuove politiche dirette / / 89 / / a creare il contesto nel quale ciascuno possa, liberamente, esprimere tutte le sue possibilità e agire per conseguire i suoi fini; 2) ciascuno – ovviamente anche le famiglie- deve essere aiutato a disporre dei mezzi – economici e conoscitivi – minimi. Il socialismo contesta il primato del mercato, non già in nome del collettivismo, ma della modernità, dell’esigenza che nella società inondata di beni di consumo, riemergano i valori spirituali, che sulla cultura dell’avere – che impoverisce gli individui e le relazioni tra di essi – prevalga la cultura dell’essere e sull’homo oeconomicus l’homo humanus. I l socialismo come società perfetta appartiene all’età romantica della lotta di classe. Ma come ha scritto Edgar Morin: «La rinuncia al migliore dei mondi non è la rinuncia ad un mondo migliore». E questo mondo nel quale viviamo ci dà abbondanza di beni di consumo, libertà di scegliere tra i canali Tv che il potere mass-mediale ci offre, diritto di votare tra zuppa e pan bagnato o tra il peggio e il meno peggio, e inoltre violenza, egoismo, volgarità, droga, ignoranza, solitudine, emarginazione, esclusione, può essere migliorato, reso più democratico, più libero, più civile, più sicuro, più giusto, più solidale, più pulito, più umano: e non può essere il mercato a migliorarlo! Questa è la missione delle idee, della cultura, della lotta politica, Questo è il dovere del socialismo: il quale nei suoi fini è cambiato poco rispetto alle origini; del quale vi è oggi più bisogno che mai; il cui compito è reso più agevole dalle prodigiose scoperte della scienza e della tecnica. Esso non si deve proporre la palingenesi, il salto in una nuova società attraverso l’espropriazione – violenta o graduale – del capitalismo. Lenin e Kautsky appartengono al Vecchio Testamento. Il socialismo moderno può edificare un mondo migliore senza salti o scosse perché l’evoluzione delle società democratiche, il benessere assicurato, gli strumenti disponibili rendono possibile migliorare il nostro mondo secondo i principi del socialismo. Un’autentica rivoluzione è in corso, ma le classi dirigenti di destra, di centro o di sinistra non la percepiscono perché dominate dalla cultura e dagli interessi del mondo industrialista. L’apparato produttivo moderno è in grado di soddisfare i bisogni e la domanda sociale con la diminuzione della mano d’opera, con l’adozione di tecniche che rendono inutile la presenza sul luogo di lavoro (telelavoro), con l’apporto decrescente del capitale finanziario e con l’impiego su vasta scala dell’informatica. Cresce d’altra parte, in conseguenza dell’innalzamento della durata media della vita, il numero dei pensionati idonei alla vita attiva. Questo significa che il capitale e il lavoro non sono più cen- trali e che nelle società del futuro prossimo centrale diventerà – sta diventando – il tempo libero: tutta la struttura sociale, economica e culturale del capitalismo è messa in discussione. Gli uomini e le donne dovranno disporre dell’autonomia, degli spazi temporali e dei mezzi offerti dalle nuove tecnologie per dispiegare la propria potenzialità e scegliere la propria vita: viaggi, sport, cultura, svago, impegni nella vita pubblica, associazionismo, privacy, famiglia, volontariato, hobbies, eccetera. Torna attuale la grande intuizione di Carlo Marx per il quale la riduzione della giornata era «la condizione fondamentale» per passare dal regno della necessità al regno della libertà, dove «comincia lo sviluppo delle capacità umane che è fine a se stesso». Una grande rivoluzione sociale, civile, culturale è in corso e può cambiare il nostro mondo dominato dal denaro e dal lavoro. Pensare che il mercato possa soddisfare tutti i nuovi bisogni che si qualificano in termini di valori e non si misurano in termini di profitto, sarebbe insensato. Lo Stato, comunità locali, organismi non profit, acquistano un ruolo insostituibile nel creare le condizioni e il contesto del nuovo modo di vivere: o lo farà la politica o lo faranno i nuovi poteri, i padroni dell’informazione, i quali possono gestire il tempo del «non lavoro» come i padroni del vapore hanno gestito il tempo del lavoro. Le prospettive sono: processi di liberazione e di appropriazione di sé dei cittadini o una nuova alienazione che non riguarderebbe il plus-valore sottratto all’operaio alla catena di montaggio, ma i valori del cittadino condizionato nella società civile e nella privacy. Ma è anche la vita pubblica, la democrazia, le libertà, i diritti che possono essere esaltati o manipolati a seconda di chi, di come e del perché le nuove tecnologie vengono usate. La tecnologia apre nuove porte e il potere dominante, per timore di essere scalzato, le chiude o le socchiude, spesso con il consapevole o inconsapevole contributo e la partecipazione della sinistra. Nella democrazia contemporanea si possono usare i mezzi di comunicazione per agevolare il libero scambio delle idee, per consentire alle masse di attingere alla cultura, per elaborare un modo nuovo di partecipazione alla vita pubblica, compreso l’uso della Tv e delle nuove tecniche elettroniche come «democrazia diretta» su singole questioni e per restituire alla politica la sua funzione primaria. Il fatto che su questi temi la sinistra si distingua poco dalla destra non significa che non esista alternativa ad una concezione oligarchica e telecratica della democrazia e che non ci sia un modo diverso di concepire la libertà, significa soltanto che la sinistra non fa la sua parte. mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / citazioni / / 90 / / I partiti, gli intellettuali, i centri culturali della sinistra debbono riflettere su questi punti specifici: 1) gli obiettivi per i quali i partiti socialisti si sono impegnati nei decenni attorno al ‘900 sono in larga misura conseguiti: si tratta di espanderli ulteriormente, di consolidarli e di difenderli sia contro gli attacchi ai diritti conquistati sia nei confronti di chi nello Stato sociale ha acquisito posizioni di privilegio; 2) il mercato ha sviluppato e diffuso il benessere assicurando alla maggioranza dei cittadini dell’Occidente servizi e beni essenziali. Insomma, sia il socialismo storico che il liberismo hanno esaurito in larga misura i loro compiti propulsivi. L a sintesi, nel nome del socialismo liberale, è oggi possibile, anzi necessaria, non solo per garantire insieme protezione sociale e libertà di mercato, ma per utilizzare le risorse, la scienza, la tecnica, i mass-media allo scopo di offrire beni di cui questa società è povera: solidarietà, volontariato, pulizia, cultura, sicurezza, città umane, uffici al servizio dei cittadini, servizi pubblici efficienti, una Tv capace di elevare il livello culturale, una scuola che forma, un lavoro sicuro, onestà ed efficienza nella mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / citazioni pubblica amministrazione, una giustizia giusta, istituzioni politiche e amministrative democratiche, e per lottare contro i mercanti di morte – droga e armi – la corruzione, gli abusi di potere, l’irresponsabilità, gli sprechi, il burocratismo, il conformismo. Il socialismo democratico ha ispirato e realizzato il Welfare State che ha assicurato ai lavoratori protezione e garanzie: è stata l’epoca dei diritti sociali o delle libertà negative: povertà, disoccupazione, infortuni, famiglia, malattia, vecchiaia, eccetera. «Finito» il secolo socialdemocratico, la sinistra può inaugu-rare un nuovo secolo, delle libertà positive o dei diritti di cittadinanza, impegnandosi a creare le condizioni perché ciascun cittadino possa realizzarsi pienamente e liberamente nei rapporti della vita sociale. La sinistra è stata la forza del cambiamento, dell’avvenire, della speranza di un mondo migliore. Essa deve tornare ad essere portatrice di un idealismo positivo e costruttivo: deve essere se stessa, altrimenti perderà, oltre alle battaglie politiche ed elettorali, anche la sua anima. Se sarà se stessa potrà tornare a vincere. / / 91 / / >>>> biblioteca / citazioni Il socialismo e il silenzio dei comunisti >>>> Norberto Bobbio Torino, 21 ottobre 1996 Caro Tamburrano, ho letto col più vivo interesse e consenso il documento programmatico. Appoggio con forza la vostra iniziativa, anche se mi mancano le forze per darvi un aiuto concreto. Non ho mai rinunciato all’idea di un socialismo liberale al quale ho aderito più di mezzo secolo fa. Tanto più lodevole la vostra iniziativa quanto più povero, ideologicamente vacuo il programma del Pds. Incredibile come i neocomunisti, dopo aver liquidato il marxismo, la dottrina forte che spiegava tutto, abbiano smarrito ogni punto di riferimento teorico e siano diventati dei puri tattici della politica giorno per giorno. Non vorrei sbagliare (la mia informazione è sempre più deficiente), ma non mi pare siano usciti dai circoli ex comunisti scritti di riflessione critica sul passato e di ripensamento teorico del socialismo per il XXI secolo. Dovreste promuovere sulla base di codesto documento un libro a più mani (la rivista spagnola di Alfonso Guerra che aveva pretese teoriche esiste ancora? Morta anche lei?) [Senza luogo] 21 febbraio 1997 Caro Tamburrano, ho letto con interesse il documento sul socialismo oggi, e ti ringrazio di avermelo mandato. La discussione su questo tema è più interessante che mai, sempre attuale, e vale la pena di continuare a tenerla in vita. Speravo che nel congresso del Pds ci potesse essere posto anche per un discorso di prospettiva. Mi pare pero che questo discorso non ci sia stato. Va bene la tattica, va bene la strategia, ma il primo partito della sinistra in Italia non può dimenticare la domanda che in questi anni ci siamo posti infinite volte: «dove va la sinistra?». II tema proposto nel vostro documento è per me tanto più coinvolgente, in quanto ho avuto l’incarico da Einaudi di preparare una nuova edizione del Socialismo liberale di Carlo Rosselli. Per Rosselli il socialismo liberale era proprio quel socialismo non marxista di cui lo stesso vostro documento si fa portatore, prevedendo già sin da allora che il socialismo marxista avrebbe condotto alla dittatura, sarebbe stato cioè un socialismo illiberale. Direi però che per Rosselli «socialismo liberale» non era tanto una sintesi di socialismo e di liberalismo quanto era la constatazione che il socialismo avrebbe dovuto essere non l’antitesi del liberalismo, come era certamente in Marx, ma la continuazione, lo sviluppo, il perfezionamento, come aveva sostenuto il suo maestro, Rodolfo Mondolfo. Tutte cose risapute che non ho bisogno di dire a te. Il rapporto tra liberalismo e socialismo era in Rosselli non tanto un rapporto fra i mezzi e il fine, ma fra il metodo (democratico non violento, riformista) e il fine. Per quel che riguarda i mezzi uno dei punti fondamentali di un socialismo volto ad allargare la sfera delle libertà era certamente quello dell’estensione della democrazia alla fabbrica, vale a dire della partecipazione degli operai, se non alla direzione, al controllo del potere industriale. Interessante è nel vostro documento la distinzione tra i mezzi e il fine, e il rilievo maggiore dato al fine che non ai mezzi. Si può tuttavia obiettare che i mezzi consistenti nella collettivizzazione, nella economia di piano contrapposta a quella di mercato sono stati sinora così strettamente connessi all’ideale del socialismo, sia democratico sia autoritario, che non è facile prescinderne completamente. Ho riletto in questi giorni il noto saggio di Bertrand Russell, che non era certo un comunista e detestava Lenin, in cui si sostiene che dal punto di vista economico il socialismo si appoggia «sul potere dello Stato che comprenderà, come minimo, la terra e i giacimenti minerari, il capitale, le banche, il credito e il commercio con l’estero». Interessante è che poco più oltre, quando parla delle attività che dovrebbero essere socializzate, menziona, oltre la «salute pubblica» anche le «centrali elettriche». Naturalmente lo statalismo del socialismo anche democratico vemondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / citazioni / / 92 / / niva accettato in quanto lo Stato era, per l’appunto, democratico, vale a dire era lo Stato dei cittadini, secondo la nota formula: «Lo Stato siamo noi». Statalismo, sì, ma anche democrazia. Quello che non era stato previsto non era stato tanto il vizio dello statalismo, quanto quello della incompiuta democratizzazione dello Stato. Di qua la rivolta contro lo Stato, in nome del mercato, una volta constatato che la statalizzazione della economia non è andata di pari passo con la compiuta democratizzazione dello Stato, e più Stato non ha voluto dire puramente e semplicemente più democrazia. Per quanto riguarda il mercato sono totalmente d’accordo con le osservazioni fatte nel documento. Anch’io sono convinto che uno dei temi della sinistra deve essere non tanto la negazione della positività del mercato, quanto la sottolineatura dei suoi limiti, non soltanto politici, ma anche etici. Prima di tutto mi pare ovvia l’osservazione che l’uomo non vive di solo mercato. La sfera del mercato è quella dello scambio di beni, che riguarda l’uomo, in quanto «economico». Ma ogni uomo vive in questa sfera una sola parte, se pure rilevantissima, della sua vita. Nella maggior parte della sua giornata, l’uomo vive in «mondi di vita», in cui il mercato non c’entra. Nella famiglia i rapporti fra le sue parti non sono rapporti di mercato. Così nella scuola i rapporti fra insegnanti e studenti non sono rapporti di mercato. Così nella sfera più o meno ampia secondo le diverse persone, ma per alcune rilevantissima, religiosa. Altrettanto si deve dire della sfera, anch’essa, per ognuno di noi di indiscutibile importanza, dell’amicizia. Sono tutte sfere in cui il rapporto tra individui non è di scambio ma principalmente di donazione. Inutile soffermarsi oltre su questo tema tanto è evidente la sua rilevanza, e ricchissima la bibliografia che ne tratta. E’ in queste sfere, che non hanno niente a che vedere con i rapporti di mercato, che si formano gli individui nell’ambito di una qualsiasi convivenza. Anche i rapporti di mercato si svolgono più o meno correttamente secondo le qualità morali degli individui che vi partecipano, qualità morali che si formano, quando si formano, non nella sfera del mercato, la quale, anzi, le presuppone. Per dirla in breve, il mercato ha bisogno di persone che si fidino le une delle altre, ovvero di persone leali. La lealtà è una qualità morale che dipende da un certo tipo di educazione, che dipende dal modo in cui il singolo individuo vive, cresce, e matura, nelle sfere altre rispetto al mercato. Mi rendo conto che sto affrontando un tema che richiederebbe ben altri sviluppi. Ma il rapporto fra etica e mercato, e il problema in generale, da voi stessi affrontato, dei limiti del mercato, è un tema sul quale la sinistra non deve tralasciare di tornare con armondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / citazioni gomenti sempre più stringenti. Che il mercato debba avere dei limiti etici, lo sanno tutti. Per fare un esempio macroscopico, sul commercio delle armi il mercato non ha assolutamente niente da dire. Se ci sono Stati, o anche soltanto gruppi terroristici antistato, che chiedono armi, e altri Stati che queste armi offrono con le loro industrie, il mercato non ha niente da dire. Però anche in sede internazionale il problema del limite degli armamenti è un problema sempre in discussione. Quali sono i criteri in base ai quali questi limiti debbono essere posti? Non ci si può aspettare che questi limiti vengano posti dal mercato. II mercato, di per se stesso, non ha alcuna morale. E poi: chi ha il diritto o il dovere, e quindi il potere di porre questi limiti? La risposta a questa domanda non può venire ancora una volta se non dalla soluzione del difficile rapporto tra Stato e mercato. Ma è proprio nella diversa soluzione di questo rapporto che il dibattito deve continuare; più Stato o più mercato, o né Stato né mercato in funzione di una terza via, che può essere tanto quella del cosiddetto «terzo settore», quanto quella della solidarietà, e quindi del volontariato (tipica sfera in cui il rapporto è non di scambio ma di donazione). E’ su tale dibattito che la sinistra avrebbe qualcosa da dire. / / 93 / / >>>> biblioteca / schede di lettura La democrazia giudiziaria G >>> Pio Marconi li studi politologici sulla democrazia giudiziaria, un fenomeno diffuso in molte aree dell’Occidente e che si manifesta come alterazione dell’equilibrio sul quale si fonda la democrazia dei moderni, sono pregevoli e illuminanti. Spesso hanno però un difetto non da poco. Presentano il fenomeno come l’asettica conseguenza delle trasformazioni del rapporto Stato ed economia, dipingono l’intrusione del giudiziario come una conseguenza della espansione delle funzioni dello Stato nel sistema della distribuzione delle risorse. Bollano (implicitamente ma a volte chiaramente) coloro che condannano le incursioni delle toghe come votati ad una concezione conservatrice del sociale. Confondono fisiologia e patologia, eccezione e regola. Il libro su toghe e politica, che Fabrizio Cicchitto ha riproposto in questi mesi merita lettura e/o rilettura. L’opera presenta il fenomeno della democrazia giudiziaria non come una ineluttabile e neutrale trasformazione ma come una forma violenta di negazione di valori democratici che si manifesta in alcuni specifici contesti storico sociali. Cicchitto mette in risalto tre aspetti di un’invasione di campo che da alcuni decenni si manifesta in Italia: la moltiplicazione di for- me discrezionali di esercizio dell’azione penale: da una mole di dati giudiziari emerge un esercizio dell’accusa attento soprattutto a possibili illeciti compiuti da una delle parti in campo nel conflitto politico e nello scontro dei grandi interessi di impresa; qualcosa di ben lontano da una generica attenzione del giudiziario per la decisione politico-amministrativa; un doppio binario nella fuga delle notizie investigative ed istruttorie che alimenta censure precoci ed informali degli accusati o di alcuni accusati: la violazione del segreto è considerata normale quando lede i diritti di un soggetto (politico od imprenditoriale) precocemente demonizzato; quando lede altri soggetti la fuga provoca viceversa reazioni giurisdizionali furenti; una politicizzazione mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / schede di lettura / / 94 / / del giudiziario: l’esercizio dell’azione penale è troppo spesso l’anticamera di una candidatura o di una elezione in parlamento; non esiste un sistema di garanzie che imponga l’astensione o consenta la ricusazione del giudice o dell’accusatore che si sia già pronunciato contro l’accusato. Per Cicchitto tra le cause del fenomeno va collocata una politicizzazione nata negli anni settanta e favorita dall’affermazione di una corrente dell’associazionismo giudiziario, Magistratura democratica. Qui dissento e suggerisco una correzione di tiro. Magistratura Democratica, agli inizi, cerca di contrastare un sistema che è già privo di garanzie. Magistratura Democratica non ha, alle origini, una vocazione giustizialista, è piuttosto impegnata in battaglie per la modernizzazione, per l’allargamento delle garanzie, per il giusto processo. MD, con il solo supporto dei radicali, della sinistra extraparlamentare, della corrente del PSI vicina a Giacomo Mancini, dei metalmeccanici UIL guidati da Giorgio Benvenuto, nei primi anni settanta promuove un referendum per la cancellazione dei reati di opinione, i più fascisti del codice Rocco. La raccolta di firme fallisce per l’ostracismo di una destra politica e burocratica in simbiosi già da allora con il PCI. L’involuzione di Magistratura Democratica nasce nel momento in cui un settore di quella corrente si integra con il Partito Comunista ed alimenta con i propri candidati la sinistra “indipendente”. Non va dimenticato che molti dei fondatori di Magistratura Democratica negli anni ottanta e novanta si sono nettamente dissociati dalla deriva giustizialista. Cito due esempi. Quello di Franco Marrone che si schiera nel 1987 a favore del referendum sulla giustizia giusta. Quello di Francesco Misiani che scrive un severo atto di accusa contro la deriva antigarantista del gruppo che aveva contribuito a fondare. Le cause della situazione attuale sono profonde. Lo strapotere del giudiziario deriva da scelte di settori conservatori dell’Assemblea Costituente, dalla volontà di non rompere la continuità isti- tuzionale con gli apparati del fascismo. Il Consiglio Superiore della Magistratura è il dono fatto dall’ala conservatrice della Costituente per garantirsi la benevolenza delle toghe in camicia nera, di una magistratura selezionata dal fascismo e che non verrà scalfita dall’epurazione. Il sistema dell’immunità e dell’insindacabilità di un ceto burocratico si arricchirà negli anni settanta nel momento in cui il parlamento eliminerà ogni forma di controllo sulla qualità della giurisdizione. Una serie di leggi antimeritocratiche consentirà di accedere ai vertici della carriera senza una valutazione imparziale e professionale del merito, della cultura giuridica, della qualità della giurisdizione. La valutazione sarà affidata soltanto ad un organo di composizione politico-corporativa come il Consiglio Superiore della Magistratura. Cicchitto mette in luce un altro aspetto del fenomeno. L’incapacità dei partiti di reagire negli anni novanta alla spinta tecnocratica. I partiti giungono a oltraggiare le scelte dei costituenti antifascisti, stracciando l’immunità parlamentare e riducendo le facoltà del legislativo di intervenire nelle patologie del sistema penale attraverso l’istituto dell’amnistia. Alla fine degli anni ottanta il pentapartito giungerà a stravolgere gli effetti di un referendum sulla giustizia giusta stravinto dai garantisti, dai radicali e dai socialisti. La nuova edizione del libro di Cicchitto cade in un momento opportuno. In maniera deflagrante è riemersa la questione giustizia e l’esigenza di preservare i poteri dello Stato rappresentativo dalle incursioni di un ceto privo di legittimazione democratica. L’esecutivo sta rilanciando una serie di provvedimenti di riforma della giustizia. L’opposizione e coloro che si richiamano a valori della sinistra sono di fronte ad una scelta di campo. O stare dalla parte delle garanzie o rappresentare l’ultimo puntello di una concezione autoritaria dei poteri pubblici. La sinistra può opporsi alle riforme progettate dall’esecutivo, contribuendo a preservare connotazioni antidemocratiche dell’impianto istituzionale. Il segre- mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / schede di lettura tario del PD afferma che di fronte alla crisi economica una riforma della giustizia non rappresenta una priorità. Errore tragico. Proprio la crisi economica impone come priorità la cancellazione di norme che rafforzano gli aspetti burocratico/corporativi della struttura sociale del paese. Restituire priorità alla legislazione, garantire l’esercizio delle funzioni di governo, limitare il potere dei corpi burocratici sono oggi precondizioni (più incisive della modifica all’articolo 41 della Costituzione) del risanamento dell’economia. La sinistra può viceversa partecipare al processo di risanamento dell’ordinamento giudiziario e in primo luogo ad un ritorno delle garanzie per l’esercizio della funzione parlamentare. E’ un segno positivo che una parte del PD abbia scelto di impegnarsi per tornare all’autorizzazione a procedere votata dai costituenti. La scelta non deve rimanere minoritaria. Nella prospettiva di un referendum confermativo (di un’attesa riforma costituzionale) le forze che si ritengono democratiche non devono accodarsi al giustizialismo parafascista ma devono schierarsi per il ritorno allo spirito del 25 aprile. Il lavoro di Cicchitto impone un’ulteriore considerazione. Relativa non al sistema giustizia ma a quello elettorale. Il cambiamento in senso maggioritario del sistema elettorale (iniziato con il sistema uninominale misto) sicuramente riduce la possibilità di rappresentare i bisogni sociali. Nel tempo medio il sistema elettorale richiederà una rimeditazione. Il maggioritario ha solo un pregio. Quello di consentire veloci processi di riforma e di neutralizzare le rendite burocratiche che utilizzano come strumento di contrasto delle riforme il metodo consociativo e il consensualismo. Sarebbe un vero tradimento dell’elettorato se una maggioranza che afferma di voler modernizzare il paese rinunciasse oggi a cambiamenti radicali del sistema giustizia (dalla divisione delle carriere, alla riforma del CSM, a un recupero delle garanzie di difesa). Sarebbe un errore capitale se l’opposizione di sinistra non la assecon- / / 95 / / dasse in questa opera, se il Partito democratico continuasse a porre al primo posto delle riforme istituzionali quella del sistema elettorale. Nell’immediato un’attenuazione del sistema maggioritario avrebbe come sicura conseguenza il ritorno alla consociazione, il rafforzamento delle burocrazie, l’affossamento di ogni riforma democratica dello Stato. F. CICCHITTO, L’uso politico della giustizia, Mondadori, II edizione, 2011. Il cinismo della politica È >>> Corrado Ocone un libro sulla politica intelligente, profondo, non adatto ai semplici di spirito. Non un testo di politologia o di ingegneria istituzionale, o peggio di retorica democratica e liberale, ma una riflessione che ha molto a che fare con le passioni dell’animo umano e con la capacità della politica di servirsene per determinati obiettivi (non a caso i riferimenti letterari e storici sovrastano in gran numero quelli propriamente scientifici). Non un peana alle argomentazioni formalmente rigorose e alle verità della scienza politica, oppure alle virtù di una “comunicazione non distorta” nella società e nella politica, ma una presa d’atto del carattere performativo, e quindi sempre in qualche modo menzognero e illusionistico, del discorso politico. In una parola: non una banale requisitoria contro il cinismo in politica, come si potrebbe forse immaginare dal titolo, ma una presa d’atto, all’insegna del realismo politico, di un destino comune che se è cinico non per questo è baro. Un destino che può anzi essere, per chi sa stare con coerenza al gioco (in prima istanza il leader), foriero di opportunità per sé e per gli altri. All’inizio c’è appunto il cinismo di Antistene e di Diogene che spezza l’armonia greca della polis e dell’arte politica che la governa. I cinici creano la loro scuola ai margini della città, in periferia, per poter meglio giudicare la vita che si svolge in essa, in una situazione fisica di opportuna ma relativa distanza. E ugualmente mettono in discussione quella mescola sapiente di dike (giustizia) e aidos (pudore) che per i greci è l’essenza della politica: “Dike – scrive Funiciello – è l’equivalente di quanto oggi comunemente indichiamo come un progetto politico; aidos è il fondamento del consenso a suo supporto. Attraverso la pratica dell’arte politica gli uomini possono ideare ordinamenti giuridici che regolino la vita collettiva (dike), creando un consenso, un’unità di amicizia (aidos), intorno all’idea di giustizia più condivisa”. In particolare i cinici negano il pudore (aidos) e praticano la spudoratezza (anaideaia): “La loro spudoratezza ha lo scopo di mostrare ai politici, in mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / schede di lettura / / 96 / / un immaginario specchio magico del pensiero, quanto i veri spudorati siano loro: quanto cinica sia la loro attitudine di fare del senso comune del pudore (aidos) quello che occorre ai loro obiettivi”. È tuttavia con l’età moderna che il cinismo viene riassorbito dalla politica: il politico si riconosce come cinico, manipolatore, conquistatore di anime e catalizzatore di consenso. L’autore di questo libro, utilizzando la definizione di Sloterdiijck del cinismo come “falsa coscienza illuminata” individua, nella modernità, tre stadi evolutivi: “Si trova al primo stadio (coscienza) l’adesione del singolo a una qualche idealità totalizzante; al secondo (falsa) , la negazione nichilistica della fondatezza di quella idealità; al terzo (illuminata), l’illuminazione relativistica che il soggetto svolge sulla propria coscienza, dopo averla idealmente affermata e nichilisticamente negata” (p.26). Funiciello individua luoghi fisici (la Londra di Enrico IV, la Washington della liberaldemocrazia, l’Amsterdam messa a ferro e fuoco dai nazisti), luoghi letterari (Shakespeare e Machiavelli sopra tutti) e luoghi teorici a supporto del suo discorso. E lo fa in modo mai banale, con finezza di analisi e capacità di intuizioni spesso folgoranti. Anche se l’autore ama vezzeggiare sul suo essere un pratico e non un teorico dell’arte politica, dal punto speculativo in questo libro si trovano almeno due non banali (come può esser banale la scienza politica) elaborazioni teoriche: quella sulle affinità fra politica liberaldemocratica e politica totalitaria e quella concernente la trattazione del tema della menzogna in politica: un discorso che si slarga fino alla elaborazione di una vera e propria ontologia metapolitica del “non dire la verità”. Per quanto concerne il primo aspetto, Funiciello distingue il “cinismo dei fini” del totalitarismo dal “cinismo dei mezzi”della politica democratica: nel primo caso ogni mezzo, anche il più truce, giustifica l’obiettivo di giustizia che si vuole realizzare; nel secondo, al contrario, i mezzi sono in qualche modo anche un fine a sé, almeno nel senso che fine sono anche “i diritti fondamentali dell’individuo” (p. 58) che l’azione deve sempre e comunque preservare. Si potrebbe dire che il cinismo che è l’orizzonte di senso comune si alimenta nella necessità di creare consenso o “comunità di amicizia”: è l’elemento del pudore spudorato, per dirla con i termini di Funiciello, che è comune alle democrazie totalitarie e a quelle liberali (entrambe, appunto, democrazie). Laddove, aggiungo io, tutt’altra cosa è la dike liberale: nella sintesi liberaldemocratica è il liberalismo, non la democrazia, l’elemento valoriale. Per quel che riguarda invece l’elogio della menzogna politica, va osservato che in queste pagine c’è, da una parte, l’elogio della menzogna tout court. Ma dall’altra, ovviamente, la menzogna si definisce, e quindi circoscrive, venendo ad aderire come supporto a quel momento di “irrealtà”, e anche di umanità, che caratterizza il nostro rapporto ideale col mondo, che ci fa trascendere la realtà data e prefigurare con la mente i suoi possibili sviluppi futuri, le sue nuove conformazioni (la vision di cui oggi tanto, spesso a sproposito, si parla). Questa capacità deve, per forza di cose, essere pronunciatissima nel leader politico: “Egli può sfidare l’ovvio sotto gli occhi di tutti, smentendo che possa avere in futuro la stessa veritiera validità che ha avuto in passato, in nome di una visione delle cose che mondoperaio 3/2011 / / / / biblioteca / schede di lettura nega la verità del presente, in vista di una verità a cui dare forma domani” (p.102). L’autore quindi, dopo avere osservato acutamente che “la centralità dei mezzi del cinismo politico democratico accentua il primato estetico della politica” (p.124), ci presenta con indubbia maestria anche una fenomenologia di “cinismi tipici o tipi ideali estetici” (il convertito, il mistico, il gastrico, il lirico, il supercinico). Io vorrei tuttavia sottolineare qui che quello “visionario”, “menzognero”, “teatrale”, “recitativo” è, pur nella sua centralità, solo un momento dell’attività concreta dell’uomo politico, la quale si svolge sempre all’incrocio fra “irrealismo” e “realismo politico”, fra “menzogna” e “verità”. Un politico, lo dice anche Funiciello, deve prima (è un prima logico più che cronologico) saper leggere la realtà, anche capendo in che modo i soggetti reali aspirano a trasformarla (quali sono i loro desideri o i fini per cui sarebbero disposti a muoversi), e poi cercare di curvarla secondo le forme della dike che lo agita. Ma ecco il problema che sorge anche oltre questo libro: che succede quando, come nell’Italia di oggi, il demos più non desidera se non il gioco estetico della politica, ed anzi in qualche modo esige che i leader creino affabulazioni sempre nuove e mirabolanti a cui credere senza contropartite? C’è ancora posto per la menzogna politica e per il politico come cinico, ovvero per la politica semplicemente, in uno scenario (surreale) come quello nostro in cui il principio di realtà è venuto meno e tutto è menzogna e cinismo consapevole? “Camaleonti e giovani relativisti sono interpreti antipolitici della pratica dell’arte politica” (p.130). Essi, tuttavia, sembrano occupare quasi intera la scena del teatro attuale. A. Funiciello, Il politico come cinico. L’arte del governo tra menzogna e spudoratezza, Donzelli, Roma 2001, pagine 181, euro 16,00.
Scaricare