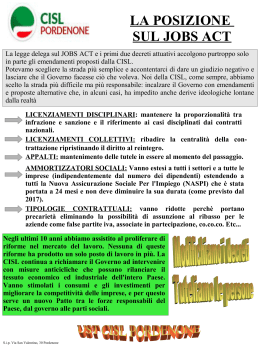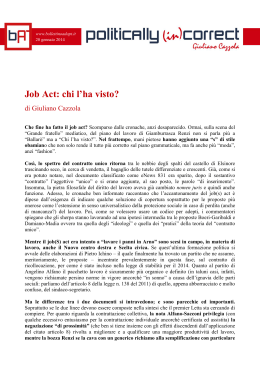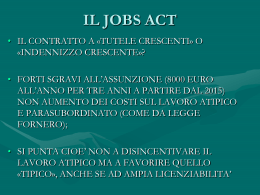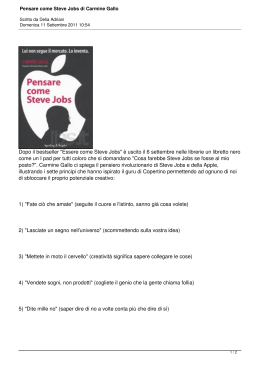Notiziario settimanale n. 546 del 07/08/2015 versione stampa Questa versione stampabile del notiziario settimanale contiene, in forma integrale, gli articoli più significativi pubblicati nella versione on-line, che è consultabile sul sito dell'Accademia Apuana della Pace 09/08/2015: Anniversario del lancio della bomba atomica su Nagasaki avvenuto il 9 agosto 1945. 12/08/2015: Per non dimenticare: 12 agosto 1944, la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema (LU) CHIAMATEMI STREGA Non importa chi sono. Non importa come mi chiamo. Potete chiamarmi Strega. Perché tanto la mia natura è quella. Da sempre, dal primo vagito, dal primo respiro di vita, dal primo calcio che ho tirato al mondo. Sono una di quelle donne che hanno il fuoco nell’anima, sono una di quelle donne che hanno la vista e l’udito di un gatto, sono una di quelle donne che parlano con gli alberi e le formiche, sono una di quelle donne che hanno il cervello di Ipazia, di Artemisia, di Madame Curie. E sono bella! Ho la bellezza della luce, ho la bellezza dell’armonia, ho la bellezza del mare in tempesta, ho la bellezza di una tigre, ho la bellezza dei girasoli, della lavanda e pure dell’erba gramigna! Per cui sono Strega. Sono Strega perché sono diversa, sono unica, sono un’altra, sono me stessa, sono fuori dalle righe, sono fuori dagli schemi, sono a-normale… sono io! Sono Strega perché sono fiera del mio essere animale-donna-zingaraartista e … folle ingegnere della mia vita. Sono Strega perché so usare la testa, perché dico sempre ciò che penso, perché non ho paura della parola pericolosa e pruriginosa, della parola potente e possente. Sono Strega perché spesso dò fastidio alle Sante Inquisizioni di questo strano millennio, di questo Medioevo di tribunali mediatici e apatici. Sono Strega perché i roghi esistono ancora e io – prima o poi – potrei finirci dentro. Monologo di Barbara Giorgi scritto per Franca Rame Segnalato da: Paolo Guidi Indice generale Evidenza...........................................................1 Parco di Castagnara: musica e sogni (di AAdP, Periferie al Centro) ...........1 TAV Torino-Lione, i conti non tornano (di Maurizio Bongioanni).............1 Approfondimenti.............................................3 Un miliardo l’anno: così accogliere i migranti fa girare l’economia italiana (di Redattore Sociale)................................................................................ 3 Come trasformare le migrazioni in una opportunità (di Luigi Manconi) ....4 Il Jobs Act tra confusione, propaganda e ideologia (di Enrico Pugliese) ...5 L’inganno del lavoro (di Francesco Gesualdi)............................................ 7 L’avanzata delle destre estreme e le responsabilità della sinistra liberale (di Matteo Volpe)............................................................................................ 8 La enciclica “Laudato sii” puntata e ristretta (di Antonino Drago) .............9 Il carrello della spesa? Riempiamolo di biodiversità! (di Slowfood.it) .....10 Evidenza Parco di Castagnara: musica e sogni (di AAdP, Periferie al Centro) Al parco di Castagnara, giovedì 30 luglio, una serata intensa: alle 19.00 il terzo incontro di progettazione partecipata, promosso dal Comune per coinvolgere cittadini e associazioni nella definizione di un progetto di investimento per il parco stesso; alle ore 20.00 una cena condivisa dove ognuno porta qualcosa e lo mette in comune; alle 21.30 festa con musica. Quando si levano le prime note di una canzone e parole ritmate corrono sullo schermo, subito le gambe si muovono al ballo e bravi cantanti improvvisati si esibiscono tra gli applausi di un piccolo pubblico: molte le famiglie con bambini e cani mansueti. Anche la luna piena sembra sorridere. E' successo di nuovo. L'Accademia Apuana della Pace e la rete di associazioni Periferie al Centro, assieme ai cittadini del quartiere, hanno portato anche quest'anno uno spettacolo di karaoke nel parco: e gli abitanti dei palazzi hanno risposto e sono scesi a fare festa. Per animare un parco od una piazza per una sera occorrono un budget di spesa modesto e pochi ingredienti: un passa-parola, un bravo professionista con la necessaria attrezzatura musicale e - nota dolente - la corrente elettrica, di cui questo parco è privo; per questa volta il Comune ha effettuato un allaccio provvisorio. Per le successive serate staremo a vedere. Sono in programma infatti una tombolata il 13 agosto e l'esibizione di un gruppo di samba il 27 agosto. Certo l'animazione di qualche serata non risolve i problemi di una periferia abbandonata. Serve però a richiamare l'attenzione. Serve a far sperimentare ai residenti che far delle cose insieme è possibile ed è bello. Serve a creare aggregazione. Serve infine a tener viva un'utopia a cui le associazioni organizzatrici credono profondamente: se gli abitanti si riappropriano del loro territorio, lo sottraggono alla piccola o grande delinquenza, alle vittime del disagio sociale e al degrado. Il problema è crederci: credere che è questa la forma più efficace di prevenzione, a Castagnara come in tutte le periferie. Ed in una cittadina piccola come la nostra, dove anche le criticità sono più contenute rispetto a quelle dei grossi centri urbani, una decisa volontà politica e pochi investimenti economici potrebbero risultare sufficienti … e vincenti. La scelta fatta quest'anno dall'Amministrazione comunale di inserire nel Bilancio partecipato 6 parchi pubblici di periferia accomunati da carenza di infrastrutture e incuria sembra indicare una prima inversione di tendenza e la scelta di restituire visibilità e centralità alle periferie. Vogliamo credere che sia così. E sperare che non sia il solito fuoco di paglia di una calda estate... Servizio fotografico dell'evento a cura di "Studio 8": http://www.aadp.it/index.php? option=com_phocagallery&view=category&id=62:periferie-al-centro2015&Itemid=118 Notizie dal mondo..........................................11 Sito Studio 8: http://studio-otto.com/ Patto militare Grecia-Israele (di Manlio Dinucci) ....................................11 Il conflitto tra la Turchia e i curdi (di Robert Fisk) ...................................11 Il sistema della giustizia militare israeliano – una catena di montaggio per la detenzione di massa (di Amira Hass).................................................... 12 Fuori dal coro: che montagna di ipocrisia... (di Campagna Ponti e non muri, Pellegrini di Giustizia 2015)........................................................... 13 TAV Torino-Lione, i conti non tornano (di Maurizio Bongioanni) 1 link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2319 Gli 813 milioni di euro di finanziamento europeo concesso a fine giugno non rappresentano che il 3 per cento dell'investimento necessario per la realizzazione dell'Alta velocità tra l'Italia e la Francia. Coprono -e in parte- solo quelli della tratta transfrontaliera del tracciato. In un documento di febbraio 2015, inoltre, un organo della presidenza del Consiglio dei ministri avvertiva che il costo complessivo dell'opera era ancora indeterminato A fine giugno la Commissione europea ha annunciato un finanziamento pari a 813 milioni di euro per la realizzazione della tratta Alta Velocità Torino-Lione. In molti hanno sottolineato come l'UE abbia così deciso di "finanziare" il 40 per cento dei lavori, rispettando le previsioni. Ma il costo stimato dei lavori per il Tav Italia-Francia è di circa 26 miliardi di euro, di cui 813 milioni rappresentano appena il 3%. ?Ciò significa, nuovamente, che c'è molta confusione intorno ai conti -che non tornanodella AV ferroviaria, e che la vicenda sia un pochino più complessa. Intanto è necessario dire che il cofinanziamento europeo riguarda solamente la tratta transfrontaliera, cioè la parte di tunnel a cavallo tra i due Stati. Il costo totale di tale galleria è di almeno 8,84 miliardi anche se, come abbiamo provato a spiegare sul numero di febbraio, sarebbe più corretto parlare di 11,97 miliardi. ? Per questa tratta trasnfrontaliera i proponenti assicuravano di poter contare su un contributo europeo del 40%, quindi all'Italia sarebbe restato da pagare poco più di 4 miliardi e alla Francia poco più di 3 (questo in virtù del fatto -è bene ricordarlo- che l'Italia copre il 58% dei costi di questa tratta, nonostante sia per il 78% in territorio francese). Ora, il 24 febbraio 2015, pochi giorni dopo la costituazione di TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) -il soggetto giuridico che gestisce il progetto TAV, dopo averlo ereditato da LTF- viene inviata una lettera di richiesta di cofinanziamento alla Commissione europea, firmata dai ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e francese, in cui si dichiara che per quanto riguarda il periodo 2014-2020 i due Stati avrebbero speso 3,06 miliardi di euro per costruire la prima parte della tratta transfrontaliera. ?Per questo motivo, la richiesta di cofinanziamento all'UE è di 1,28 miliardi (il 40% di 3,06 miliardi). Invece la Commissione, come si può leggere nella lista dei progetti cofinanziati in tutta Europa, "valuta" e considera ammissibile per quella prima tratta non una spesa di 3,06 miliardi ma "solo" 1,9. Ne consegue che il contributo scende a 813 milioni. Decisamente meno rispetto a quanto si aspettavano i proponenti: stiamo parlando infatti di 467 milioni di euro in meno rispetto alle previsioni: il contributo, cioè, è pari al 26,57% del costo "certificato" da TELT, e non al 40%. Continuiamo con i calcoli: se il 40% del contributo vale 813 milioni, ne consugue che l'opera totale dovrebbe costare -cioè aggiunte le risorse francesi e italiane- 2,03 miliardi al 2020 invece dei 3,06 dichiarati. Manca un miliardo, rispetto alle stime del proponente. Mario Virano, direttore generale di TELT dopo esser stato presidente dell'Osservatorio sulla Torino-Lione, in un comunicato stampa preferisce soffermarsi sull'ottenimento del finanziamento europeo invece di spiegare questa “mancanza”: "Stratta di un risultato straordinario che conferma l'importanza strategica della Lione-Torino per l'Europa. Ci impegneremo per iniziare i lavori principali entro il 2017". Nonostante l'ottimismo del Direttore rimane da spiegare perché l'Europa non abbia valutato il costo dell'opera da qui al 2020 in 3,06 miliardi. Secondo l’ufficio stampa della società italo-francese, interpellata da Altreconomia, in realtà, la “Commissione, dovendo gestire un numero elevatissimo di adesioni (681 richieste, nda) ha deciso di anticipare, per tutti i progetti, l’orizzonte di riferimento al 2019 anziché al 2020, prevedendo però, già nel 2018, il lancio di una nuova tornata di finanziamenti”. ?Perciò, secondo TELT, il resto della cifra verrà assicurata da nuove tranche che completerebbero la parte mancante della copertura finanziaria richiesta in origine, arrivando così a coprire i 3,06 miliardi domandati all'UE. Tali tranche aggiuntive tra il 2018 e il 2019 sarebbero “garantite dall’impegno politico-programmatico della UE per l’intera opera”. Di questo impegno però non c’è traccia. Nel documento “Proposal for the selection of projects” reso pubblico il 10 luglio e contenente le valutazioni dei progetti, non c’è alcun riferimento al fatto, come sostenuto da Virano, che i fondi sono da intendersi solo fino al 2019. Lì c’è scritto "end date December 2020". 2 Abbiamo chiesto direttamente alla Commissione europea, ma al momento della pubblicazione di questo articolo non ci è pervenuta alcuna risposta. E non è nemmeno stato possibile -come da noi richiesto- consultare il dossier della richiesta all'UE da parte della TELT. Tutto ciò che ci è dato sapere, come riporta nella sua risposta l’ufficio stampa, è che “ha risposto al bando europeo che chiedeva di evidenziare anno per anno le opere ed il conseguente fabbisogno finanziario per il periodo 2014/2020, ovvero il periodo di vita istituzionale dell’attuale Commissione Juncker” e di come la cifra richiesta (3,06 miliardi) sia stata certificata “a opera di un raggruppamento di engineering belghe scelte a valle di una procedura pubblica di selezione a livello europeo”. "Lo studio di 440 pagine sul Corridoio mediterraneo che la Commissione europea ha pubblicato a dicembre 2014 -spiega Luca Giunti, guardaparco e attivista NoTav- afferma che il percorso tra la Spagna e l’Ungheria presenta criticità diffuse che vanno dal diverso scartamento ai software di segnalazione, dai nodi urbani alle interconnessioni, dalle tratte mai progettate alle scelte divergenti che ogni Paese adotta". Insomma, il pezzettino tra Torino e Lione non sembra l’unico incerto, anzi. "Spulciando i dati raccolti, si apprende poi che tra Spagna e Italia le merci oggi viaggiano via mare per i 2/3, e quindi non è ragionevole spostarle sulla ferrovia. Oppure che tra Francia e Italia le merci percorrono per il 60% distanze minori di 200 chilometri, e quindi non è plausibile che in futuro sfruttino i treni". ?Intanto l’Europa riduce i fondi, come aveva già fatto nel 2013 per il cunicolo di Chiomonte e in Francia la Corte dei Conti prima e il Comitato di Mobilità poi hanno declassato la Torino-Lione a opera “non prioritaria”. Delle indeterminatezze italiane, invece, si parla poco. Alcune sono indicate all'interno degli Appunti che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha indirizzato al Governo il 19 febbraio 2015, nell'ambito dell'approvazione del Progetto definitivo del "Nuovo collegamento internazionale Torino Lione Parte comune italo-francese Sezione transfrontaliera Tratta in territorio italiano". ?"Le opere che compongono il progetto della tratta in territorio italiano non hanno, da sole, i requisiti di funzionalità -spiega il CIPE- posto che quest'ultima è assicurata dalla realizzazione della tratta in territorio francese della Sezione internazionale". L'del progetto, inoltre, "non consente comunque l’avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che resta subordinato all’approvazione di un protocollo addizionale "che dovrà tenere conto in particolare della partecipazione definitiva della UE al progetto". ?È piena di se, la strada dell'Alta velocità tra Torino e Lione. Sempre il DIPE, riporta poi in grassetto sul suo documento: “Rimane pertanto indeterminato l’importo a carico dell’Italia dell’intera Sezione transfrontaliera di cui il progetto costituisce uno stralcio non funzionale”. ??E dopo aver contestato l’utilità della stazione di Susa, finisce raccomandando, ancora in grassetto: “Occorre che siano indicati i costi, ancorché stimati, e la relativa fonte di provenienza, della Sezione internazionale e della Parte comune italo-francese”. ?Luca Giunti fa notare che pure il ministro Padoan è stato severo con l’opera: nell’Allegato infrastrutture al Documento di finanza 2015 il ministro afferma che l’opera non può essere finanziata dai privati, considerato il troppo basso tasso interno di rendimento per investitori di mercato ma che “occorrono contributi pubblici comunitari e nazionali a fondo perduto accompagnati da condizioni favorevoli di indebitamento”. Le voci critiche non si fermano qui. “La TELT dovrebbe impegnarsi a spendere 2 miliardi di euro (condizione per poter ottenere il cofinanziamento naturalmente, nda) in 2 anni e mezzo quando in precedenza LTF ha speso 700 milioni in 14 anni!”scrive il Movimento NoTav Presidio Europa. Mentre secondo il quotidiano economico francese Les Echos la decisione di ridurre il costo ammissibile dell'opera da qui al 2020 può essere spiegato in due modi: prima di tutto che Bruxelles avrebbe stabilito che francesi e italiani avevano una visione molto ottimistica dello stato di avanzamento dei lavori all’orizzonte 2020 e gli importi da sostenere entro quella data sarebbero stati più vicini ai 2 miliardi di euro, considerato che un certo numero di difficoltà giuridiche sono ancora da superare. Secondo l’autorevole giornale francese, però, questa prudenza di bilancio servirebbe anche per inviare un messaggio alla Francia: infatti, per poter beneficiare di sovvenzioni comunitarie, i governi devono specificare come intendono finanziare la propria quota. Così, se da una parte l'europarlamentare Karima Delli, membro dei Verdi, ha commentato la decisione europea dichiarando che “la somma di cofinanziamento annunciata sembra fuori luogo e non garantisce il progetto a meno di non mettere in pericolo le nostre finanze pubbliche per decenni”, dall’altra, come si può leggere nella domanda di finanziamento, l'Italia avrebbe già “archiviato” 2,5 miliardi: sono i fondi stanziati ogni anno da qui al 2027 così come previsto da una Legge finanziaria del Governo Monti. Intanto in Francia si pensa piuttosto di pagare il tunnel aumentando le tasse ai trasportatori su gomma (eurovignette) che già utilizzano i trafori di Ventimiglia, Frejus e Monte Bianco. C'è, infine, una ultima criticità, come spiega nuovamente il comitato NoTav Presidio Europa: se i due Stati iniziassero i lavori adesso potrebbero violare due articoli del Trattato di Roma da loro stessi sottoscritto il 30 gennaio 2012, quello che regola la realizzazione della tratta Torino-Lione: il primo sarebbe l'articolo 16, in quanto “i due Governi hanno deciso di iniziare i lavori senza disporre della totalità dei finanziamenti, quindi in assenza di costi vincolanti e di impegni di spesa certi, come lo esigerebbe “una gestione sana e attenta del denaro pubblico” (Articolo 126 del TFUE); l'articolo 18, invece, sarebbe stato disatteso affidando certificazione dei costi “a un subappaltatore invece che a un soggetto terzo indipendente: il subappaltatore in questione è la società GDF Suez Tractebel, che dichiara di aver lavorato per Lyon Turin Ferroviaire dal 2002 al 2006 e dal 2009 al 2013”. (fonte: Altreconomia - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis) link: http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=5235 Approfondimenti Immigrazione Un miliardo l’anno: così accogliere i migranti fa girare l’economia italiana (di Redattore Sociale) Ospitare nei centri chi arriva sulle nostre coste costa oggi fino 980 milioni, tutti spesi per lavoratori e commercianti italiani. Ma sono ancora tanti quelli che speculano sulla pelle dei profughi e per essi i controlli sono ancora scarsi. Parlano Di Capua (Sprar), Albanesi (Capodarco), Mossino (Piam) L’accoglienza dei migranti è un business. E non solo per coloro che sulla pelle dei profughi fanno affari illeciti. Assistere le persone che ogni giorno arrivano sulle nostre coste, ospitare nelle strutture i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, anche nel rispetto della legge e delle convenzioni stipulate con le prefetture, muove introiti che favoriscono innanzitutto gli enti territoriali e aumentano le entrate a livello locale. Profitti che in alcuni casi sono una vera e propria manna dal cielo, soprattutto per le zone in cui si soffre più la crisi. Parafrasando un vecchio spot del governo Berlusconi, insomma, l’accoglienza “fa girare l’economia”. 980 MILIONI L'ANNO Secondo gli ultimi dati forniti dal ministro dell’Interno Angelino Alfano, a giugno erano 78 mila i migranti ospitati nei centri italiani, tra strutture temporanee (48 mila), sistema di accoglienza per richiedenti asilo (20 mila) e centri governativi (10 mila). Per la loro assistenza lo Stato eroga ai centri convenzionati una somma media giornaliera di circa 35 euro al giorno a migrante (in cui rientrano anche i 2,50 euro al giorno del pocket money che spetta agli ospiti per le piccole spese giornaliere). “Quello dei 35 euro è costo calcolato mediamente per i progetti Sprar. Ma nel tempo si è attestato come costo medio anche per l’accoglienza straordinaria messa in pratica dalle prefetture – spiega Daniela Di Capua, direttore dello stesso servizio centrale Sprar (Sistema di protezione per rifugiati e richiedenti 3 asilo) – Tutte le convenzioni si sono quindi livellate su questo valore medio. Nel caso dello Sprar, in particolare, il costo viene calcolato in base al progetto che l’ente titolare presenta al momento in cui partecipa al bando. Nel presentare il budget ci si adegua anche al costo della vita locale, ci sono infatti territori in cui i servizi sono assenti e devono essere attivati, mentre in altri già esistono. Di tutto questo si tiene conto nel calcolare la spesa”. Stando alle cifre dichiarate dal ministero, dunque, la spesa massima quotidiana per l’accoglienza è di due milioni e 730mila euro, circa 82 milioni al mese, oltre 980 l’anno. I SOLDI NON VANNO AI MIGRANTI, RESTANO NEI COMUNI “Sono soldi che non vanno assolutamente in mano ai migranti – continua Di Capua – ma che rappresentano il costo del loro mantenimento. Se togliamo i due euro e cinquanta circa di pocket money, restano più 32 euro (il 92% del totale) a migrante che servono, prima di tutto, per coprire la spesa del personale: cioè per pagare gli stipendi, i contributi e i contratti degli operatori che lavorano nei centri, e che sono soprattutto giovani italiani. Una parte è spesa per l’alloggio e per il mantenimento delle strutture, che alcune volte sono di proprietà dei Comuni e vengono ristrutturate e altre volte sono prese in affitto da privati della zona. Infine, una parte serve a pagare i fornitori, da quelli di generi alimentari alle farmacie fino alle cartolerie”. Si tratta di una spesa che sostanzialmente rimane nei Comuni, spiega ancora la direttrice del servizio Sprar, non solo quelli vincitori dei bandi per l’accoglienza ma anche quelli limitrofi: “L’accoglienza è vantaggiosa da diversi punti di vista, quello culturale sicuramente, ma anche quello economico – dice Di Capua -. Nel caso dello Sprar sono 400 circa i comuni direttamente coinvolti nei progetti, ma secondo i nostri calcoli a beneficiarne sono almeno il triplo, cioè oltre mille. Questo perché spesso gli enti territoriali fanno accordi con comuni limitrofi per gestire meglio l’accoglienza. Stiamo portando avanti un monitoraggio proprio su questo e dai primi risultati emerge che il flusso finanziario ha un impatto positivo su un territorio ampio”. LA SPESA IN DETTAGLIO: DAL CIBO AI VESTITI Per la ripartizione dei fondi erogati per l’accoglienza, fa fede la convenzione che il gestore del centro stipula con la prefettura di riferimento: dentro quei 35 euro pro capite pro die ci devono rientrare l’acquisto e l’erogazione dei pasti, i servizi, il pocket money, la manutenzione delle strutture e in alcuni casi anche i progetti di integrazione. In una convenzione standard, per esempio, viene messo nero su bianco che i pasti al giorno devono essere tre, colazione, pranzo e cena, sette giorni alla settimana. Nella scelta delle pietanze (che devono essere genuini e di qualità) si chiede di prestare attenzione a cibi “non in contrasto con i principi e le abitudini dei richiedenti asilo”, in particolare rispettando i vincoli religiosi. Inoltra ai migranti va fornita una tessera ricaricabile da 15 euro, prodotti per l’igiene personale, vestiti, un posto letto adeguato, un servizio di lavanderia, assistenza nel caso di nuclei familiari con bambini. Infine bisogna rispettare gli ambienti devono essere puliti assicurando un “confort igienico e ambientale”. “Tolti i due euro e cinquanta di pocket money e il cibo che mangiano, ai migranti non va nient’altro – sottolinea don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco e della fondazione Caritas in Veritate, che a Fermo ospita 100 rifugiati in un progetto di prima accoglienza -. Il resto viene speso sul territorio. Bisogna assicurare personale adeguato: educatori, mediatori culturali, uno psicologo e una cuoca. E questi sono posti di lavoro. Il cibo poi viene comprato sempre in zona, così come le medicine e i vestiti". L'ACCOGLIENZA E' UN VANTAGGIO, MA NESSUNO LO DICE "L’accoglienza è chiaramente un vantaggio, questo nessuno lo dice – aggiunge Albanesi -. Al Sud in particolare è un modo anche per sistemare le persone, il caso più eclatante è il Cara di Mineo, dove il consorzio dei comuni, titolare del progetto, era interessato non tanto alla speculazione finanziaria quanto ai 500 posti di lavoro per le persone del luogo”. Ovviamente, spiega ancora Albanesi, sono in tanti quelli che continuano a lucrare sull’accoglienza, perché il ritorno economico è sostanzioso, soprattutto in un momento di crisi. “Per quanto riguarda lo Sprar il controllo c’è ed è costante, tutto deve essere tracciato e registrato – continua -. Ma i furfanti continuano ad esserci, e non è difficile truffare, soprattutto nei casi in cui si va in emergenza e si cercano posti senza preoccuparsi troppo di chi li gestisce. C’è molto margine d’azione, e non tutti sono interessati a fare un’opera adeguata, con onestà”. Il presidente della Comunità di Capodarco sottolinea infine il paradosso di chi continua a parlare di costi enormi per l’accoglienza: “quando c’è stato il terremoto a L’Aquila lo stato pagava per l’accoglienza ai terremotati 64 euro al giorno. Molti erano sistemati negli alberghi della costiera adriatica, ma nessuno ha protestato. Perché oggi 35 euro ci sembrano così tanti? Solo perché queste persone sono nere?”. MA PER CHI SPECULA, POCHI CONTROLLI Ad Asti, la onlus Piam, che da anni si occupa di tratta ma anche di accoglienza ai richiedenti asilo e rifugiati, ha lanciato addirittura una campagna mediatica dal titolo “L’accoglienza fa bene”. “Le Regioni guadagnano (l'Iva), l'Inps sta meglio (con i contributi versati ai lavoratori dell'accoglienza ), noi ne beneficiamo (una buona accoglienza è più salutare per tutti, le malattie si prevengono con un tetto, qualche pasto e una buona doccia)” si legge in uno dei suoi spot. “Gestiamo uno Sprar con 60 persone, ma nell’ultimo anno abbiamo ampliato il numero dell’accoglienza attraverso una convenzione con la prefettura, e in totale ospitiamo 140 migranti – spiega Alberto Mossino, presidente di Piam Una parte dei fondi Sprar sono destinati alla comunicazione, e normalmente le organizzazioni li spendono in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Noi abbiamo pensato di lanciare questa campagna per rispondere ai tanti pugni che ci arrivano da ogni parte, alle ruspe di Salvini, ai luoghi comuni che non possiamo più sentire – spiega -. Dopo l’inchiesta Mafia Capitale, su tutti coloro che lavorano nell’ambito dell’accoglienza si è abbattuta un’ondata di disprezzo. E perciò volevamo chiarire alcune cose: innanzitutto che l’accoglienza fa bene perché ne beneficia chi lavora nei luoghi dove essa viene messa in pratica. Un esempio? Questa mattina ho speso 500 euro in vestiti per i migranti che sono arrivati nel nostro centro, li ho comprati in un negozio qui vicino. Sempre qui compriamo gli alimenti, e quando abbiamo qualche lavoretto da fare ci rivolgiamo in zona. A Natale abbiamo speso quattromila euro per comprare delle biciclette ai migranti da un artigiano che lavora poco distante da noi. Questo va detto, bisogna chiarire che le ricadute ci sono”. Mossino invita però anche a fare i giusti distinguo: “c’è chi lavora bene e chi specula. Purtroppo i controlli, soprattutto nei casi dell’accoglienza straordinaria sono troppo pochi. Ci sono centri riempiti all’inverosimile, dove gli standard sono totalmente inadeguati ma nessuno se ne preoccupa. C’è chi si mette in questo giro solo per speculare, perché in questo momento è un guadagno che fa gola a tanti”. (ec) © Copyright Redattore Sociale link: http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/487585/Un-miliardo-l-annocosi-accogliere-i-migranti-fa-girare-l-economia-italiana Come trasformare le migrazioni in una opportunità (di Luigi Manconi) C’è un divario drammatico tra le esigenze e le aspettative originate dal fenomeno globale dei flussi migratori in atto e la realtà politica, dura e ruvida, in cui ci muoviamo. Nel Consiglio europeo del 25 e 26 giugno si era parlato di un possibile progetto di ricollocazione riguardante quarantamila richiedenti asilo già sbarcati sulle nostre coste: una cifra tragicamente esigua a fronte dei 626mila profughi che nel corso del 2014 hanno chiesto asilo nel complesso dei paesi europei. Oltre a questo si prevedeva un piano di reinsediamento che doveva riguardare circa ventimila richiedenti asilo provenienti dai campi profughi, in particolare da quelli del Libano e della Giordania, gestiti dall’Alto commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati. Alla lettera, una goccia nel mare. Certo, come ha detto lo stesso Matteo Renzi, se fino a ieri l’accoglienza a livello europeo riguardava zero richiedenti asilo, l’averne previsti quarantamila rappresenta una novità significativa, un piccolo passo avanti in termini di metodo e anche di sostanza. 4 Ma anche quell’esile “quarantamila” non ha avuto vita facile. Anzi. La riunione dei 28 ministri dell’interno dell’Unione europea, che si è tenuta il 20 luglio, ha dato un esito ancora più deludente: la riduzione fino a 32.256 del numero di quanti saranno ricollocati e l’aumento di 2.500 unità della cifra dei richiedenti asilo da reinsediare. L’Italia dovrebbe compiere la sua mossa del cavallo: uno scarto laterale, intelligente e audace Questa riformulazione dimostra come anche questo primo passo sarà assai breve, lento e non privo di ostacoli. Non solo. È l’ulteriore conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno, dell’urgenza di cambiare radicalmente politica. Se si avrà la determinazione per farlo, l’Italia avrà una grande occasione. Insomma, il nostro paese ha – meglio: potrebbe avere – l’opportunità di compiere la sua mossa del cavallo: uno scarto laterale, intelligente e audace allo stesso tempo, e soprattutto lungimirante, che possa consentirgli di svolgere un ruolo da protagonista. Dico uno scarto laterale perché è necessario, come prima condizione, sottrarsi al peso totalizzante e soffocante delle procedure finora adottate dalle istituzioni europee. Non si può fare a meno di esse, certo, ma si devono percorrere (anche) vie diverse e assumere (anche) strategie alternative. Per certi versi, possiamo dire che l’Italia è costretta a fare questa scelta: la collocazione geografica non offre alternative e ci obbliga a uno sforzo di innovazione e di fantasia, accettando i rischi che ciò comporta. Una camicia di forza Ecco due ipotesi. La prima: il nostro paese, proprio in virtù di quanto accaduto negli ultimi tempi e che prevedibilmente si riprodurrà nei prossimi mesi e anni, deve assumere con forza la decisione di dare voce e corpo a quel principio fondante dell’Unione europea che è la solidarietà tra gli stati membri, oggi palesemente calpestato. E dunque dovrebbe rivolgersi direttamente, attraverso una serie di accordi bilaterali, a quei paesi europei che già si sono mostrati disponibili a condividere e a gestire unitariamente il flusso di profughi verso il nostro continente. Il regolamento di Dublino grava come una cappa e come una camicia di forza che pretende di imprigionare i movimenti delle persone causando situazioni inestricabili, oltre che crudelmente dolorose. È proprio qui che serve un atto di coraggio e di indipendenza. Si può decidere di derogare a quel regolamento di Dublino attraverso un accordo tra l’Italia e quegli stati membri, pochi o molti che siano, già disponibili ad accettare le procedure di ricollocazione e di reinsediamento. Una deroga necessaria e assolutamente possibile, pur nell’attuale contesto dei trattati vigenti, dal momento che non danneggerebbe altri paesi. Si tratta evidentemente di assumere l’iniziativa e di cogliere aperture, spiragli, anche modeste opportunità, concentrando l’attenzione in un primo momento su quanto sin d’ora previsto. Attraverso, cioè, il più ampio utilizzo possibile del meccanismo dei ricongiungimenti familiari, che già Dublino III ha reso maggiormente flessibile. Autoriduzione di solidarietà C’è poi l’altra ipotesi, che va manovrata con prudenza e saggezza, ma che può rappresentare un autentico punto di svolta da cui far discendere un nuovo protagonismo politico dell’Italia. La premessa da cui partire è che il nostro paese è un contributore netto dell’Unione europea, il che significa, in parole povere, che l’Italia dà all’Ue più di quanto riceva in termini di risorse economiche, attraverso varie voci e differenti contribuzioni. Ebbene, di fronte alla evidente violazione di quel principio costitutivo della solidarietà tra gli stati, rappresentata dal rifiuto di una politica condivisa per l’immigrazione e l’asilo, viene meno inequivocabilmente ciò che per noi è la ragione prima, la base essenziale e il fondamento politico ed etico della stessa Unione europea. Alla luce di questa crisi della stessa idea costitutiva dell’Unione, l’Italia può assumere una decisione radicale e, al contempo, ragionevole. Scegliere, cioè, che quella quota eccedente il saldo zero tra ciò che si dà e ciò che si riceve nello scambio con l’Ue sia destinata alla creazione di un fondo speciale di solidarietà, da destinare a una politica comune per l’immigrazione e l’asilo. Ciò attraverso la cooperazione rafforzata con quei paesi – non importa quanti all’inizio – interessati all’elaborazione di una politica condivisa in materia. Detta grossolanamente, una sorta di “autoriduzione” finalizzata non a particolari interessi nazionali, bensì a una delle questioni cruciali per la definizione dell’identità dell’Europa e, molto concretamente, del suo programma politico e sociale. La proposta determinerà inevitabilmente una intensa conflittualità all’interno dell’Unione e va costruita con intelligenza e con tenacia. analisi alla confusione. Diversamente non si riesce a capire perché a una legge italiana venga dato il nome di un provvedimento americano che parla sostanzialmente d’altro e che non mostra neanche elementi comuni sul piano dell’orientamento in materia di politica economica. A scopo di chiarimento condurrò una breve analisi comparativa dei due provvedimenti - degli elementi comuni (pochi) e delle differenze (molte) allo scopo di introdurre il punto conclusivo dell’intervento: quello che riguarda i processi di produzione delle informazioni (e della disinformazione), le retoriche e lo stile comunicativo. Tutto ciò partendo dalla osservazione che il processo di produzione delle informazioni e le pratiche di convincimento e autoconvincimento non riguardino solo il capo del governo, o il suo staff in questo ambito, ma anche i mezzi di comunicazione di massa e i soggetti capaci di influenzare l’opinione pubblica. (fonte: Internazionale - segnalato da: Centro Studi Sereno Regis) link: http://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/07/22/migrantieuropa-flussi Cominciamo dal primo punto (il contesto). Il governo Renzi, segue il governo Letta che a sua volta seguiva il governo Monti. Non ci sono state grandi differenze nell’orientamento di politica economica e di politica del lavoro tra i tre governi. Si può dire che – come per altro su tutto il resto – il governo Letta sia stato meno aggressivo in questo ambito rispetto a quello precedente e a quello successivo. Ma la direzione è stata chiara e univoca. E se la stessa operazione del Jobs Act da un certo punto di vista rappresenta un balzo in avanti nell’attacco ai diritti e alle prerogative dei lavoratori, e in particolare della classe operaia, dall’altra rappresenta solo una iniziativa un po’ più drastica all’interno di una linea generale fissata dal governo Monti e non priva di qualche coerente antecedente. Si tratta di una linea chiara: essa non prevede alcuno spazio per politiche espansive, impone che la spesa pubblica vada contratta, esclude che il sindacato vada ascoltato e tanto meno preso in considerazione: si tratta di un elemento di disturbo e basta. Lavoro ed occupazione C’era una volta un Piano per il lavoro della Cgil Certo, è un progetto assai impegnativo, ma è la sola via affinché, per l’Italia e per il suo ruolo nel Mediterraneo in questo delicato momento storico, i movimenti di tanti esseri umani non rappresentino solo un problema lacerante, ma costituiscano anche una opportunità. Il Jobs Act tra confusione, propaganda e ideologia (di Enrico Pugliese) A differenza del Jobs Act di Obama, quello di Renzi rientra all’interno del sogno tradizionale per cui per aumentare l'occupazione vanno ridotte le protezioni dei lavoratori stabili e prolungata all’infinito la situazione di apprendisti e occupati non standard Ho trovato molto apprezzabile il contributo di Sbilanciamoci!, Workers Act, sia per la critica al cosiddetto Jobs Act del Governo Renzi (contenuto nella prima parte) sia per lo sforzo di produrre proposte per l’occupazione e per la difesa dei diritti dei lavoratori cui è dedicata la seconda parte. Pur ritenendo molto importante questo sforzo e che sia utile fornire commenti, critiche e integrazioni per questa seconda parte del lavoro di Sbilanciamoci!, il mio intervento si riferirà alla prima: alla critica del “Jobs act” di Renzi. Ciò non perché non sia d’accordo con l’analisi e le proposte. Anzi mi pare che la critica centri bene i principali punti della questione e trovo che sia ben argomentata. Intervengo perciò solo per sottolineare ulteriormente qualche punto e per commentare qualche aspetto che nel volumetto non è forse stato approfondito a sufficienza. Si tratta innanzitutto del contesto politico e sociale nel quale il Jobs Act - questa “Rivoluzione Copernicana” come l’ha definita il suo autore – è scaturito. Si tratta poi del perché questo piano di intervento nel mercato del lavoro sia stato chiamato dal suo proponente, prima ancora di renderne noti i contenuti, con il nome (in inglese) di una legge americana: il Jobs Act di Obama. Premetto che a mio avviso è non tanto – o comunque non solo – una questione di provincialismo, di mostrare che si sa parlare in ‘stranierese’. Probabilmente c’è anche questo ma non è l’aspetto principale. Anticipando il punto in questione si può ipotizzare che in questa scelta ci sia anche un tentativo di legittimazione: “anche noi sappiamo fare come si fa in America”. Ma vedremo che c’è ancora dell’altro, in particolare i vantaggi connessi alla mancanza di chiarezza, all’allusività, e in ultima 5 In un quadro di totale isolamento – con il Partito Democratico coinvolto direttamente o indirettamente nel governo di coalizione di Monti - la Cgil lancia qualche anno addietro il suo ambizioso ‘Piano per il lavoro‘. Si trattava di una proposta di interventi in materia di politica economica espansiva con indicazione di investimenti in diversi settori che avrebbe implicato un indirizzo della spesa e in generale della politica economica incompatibile con il governo del quale tuttavia il Pd, il partito più vicino alla (o meno lontano dalla) Cgil, era magna pars. Esso non voleva essere un semplice sforzo analitico a dimostrazione che esistono alternative possibili economicamente nell’indirizzo della spesa pubblica come il lavoro di Sbilanciamoci. Nel caso della Cgil, del più importante sindacato dei lavoratori, non si poteva trattare di una operazione del genere: doveva e voleva essere una proposta al governo, un progetto operativo per lo sviluppo economico e occupazionale quale contenuto di una strategia e di azioni rivendicative. Ma per far questo la Cgil, avrebbe dovuto attrezzarsi, decidere il tipo e i contenuti specifici delle rivendicazioni, valutare su quali gambe avrebbe dovuto marciare la proposta, quali mobilitazioni avrebbe dovuto mettere in campo, di che portata, di che natura e con chi. A queste cose invece – a me pare - non si pensò molto. Questa operazione mi sembra ora più una versione farsesca che una versione aggiornata della gloriosa esperienza storica del Piano del Lavoro della Cgil di Di Vittorio. Come si sa, la risposta (o la mancata risposta) del governo Monti sembrò riecheggiare quella parimenti arrogante data da De Gasperi una sessantina di anni prima alla Cgil di Di Vittorio “I piani non mancano, mancano i quattrini!”. In questo secondo caso comunque il ‘Piano’ fu semplicemente ignorato. Eppure, bene o male, delle proposte da prendere in considerazione erano presenti in questo progetto, dal nome inopportunamente pomposo, ormai dimenticato. A quattro anni di distanza dal suo lancio nessuno se ne ricorda più, a parte il cortese riferimento che ne fa il volume di Sbilanciamoci! I tempi dell’epoca neo-liberista sono velocissimi. Passata la serena stagione del governo Letta arriva il governo di Renzi e Alfano. Ed è proprio quest’ultimo ad anticipare a modo suo la linea del finto jobs act ponendo come punto caratterizzante del nuovo governo la soppressione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Ma Renzi fa di peggio: mentre ancora la Cgil - così come il Pd (o almeno la parte ancora di tenue origine social-comunista) – è lungi dall’archiviare il ‘piano del lavoro’, il segretario del partito e capo del governo lancia una alternativa radicale. Fa conoscere l’esistenza di una proposta di legge dal nome appunto di Jobs act che, detto in italiano significa legge sul (o per il ) lavoro – o, meglio, sui (o per i) lavori o, meglio ancora, sui (o per i) posti di lavoro. Ma dalle dichiarazioni che accompagnarono questa iniziativa di legge italiana (se riesco a tradurre bene la parola act) si capisce subito che vuole essere un nuovo piano per l’occupazione che però non ha niente a che vedere con quello della Cgil. Nei suoi discorsi Renzi promette grandi sviluppi dell’occupazione ma è subito chiaro che la sostanza del ‘piano’ consiste in un nuovo quadro delle relazioni sindacali. alle imprese italiane. Naturalmente la portata degli incentivi in America è più che proporzionale a quella italiana. Ma quello che conta è la spesa complessiva davvero enorme, oltre trecento miliardi di dollari. Ciò che impressiona – soprattutto osservando il coro di entusiasti suggeritori del Jobs act nostrano– è che per la sua natura esso esprime una netta svolta neo-liberista, un rovesciamento rispetto all’approccio del Piano della Cgil. L’obiettivo non è né solo l’articolo 18 né solo lo statuto dei lavoratori, ma l’intera tradizione del diritto del lavoro italiano a partire dalla seconda guerra mondiale. I contenuti del Jobs Act di Renzi sono ben illustrati nel libretto di Sbilanciamoci! e pertanto non è il caso di entrarci nel merito. Per entrare più in dettaglio delle differenze e a scopo di documentazione si può scaricare da internet un qualunque documento illustrativo prodotto dall’amministrazione o dal partito democratico per vedere di che si tratta. Le misure del jobs Act di Obama che riguardano la domanda sono comprese sotto il titolo generale di “far tornare sui posti di lavoro i lavoratori ricostruendo e modernizzando l’America”. Come esempio si può prendere la voce, lautamente finanziata, “Investimenti urgenti per strade, ferrovie e aeroporti” o quella relativa alla “Creazione di una banca nazionale per le infrastrutture” o quella avente l’obiettivo di “Evitare licenziamenti di insegnanti modernizzando oltre 35 mila scuole pubbliche”. Si noti il riferimento alle “scuole pubbliche” e non semplicemente alle scuole. Mantenendoci ancora nel tema del contesto è bene sottolineare la grave situazione del mercato del lavoro e dell’occupazione in Italia. Si tratta di problemi strutturali, problemi di povertà e crisi dell’apparato produttivo, problemi connessi al dualismo territoriale nel nostro paese: problemi dovuti alla carenza di investimenti pubblici e privati. Insomma problemi rispetto ai quali ulteriori iniezioni di flessibilità quali sono quelli proposti e magnificati da Renzi e dai suoi mentori possono fare ben poco. Con una disoccupazione vicina al 13%, con una disoccupazione meridionale superiore al 20%, con una disoccupazione giovanile meridionale (15-24 anni ) pari ai due terzi delle forze di lavoro nella stessa fascia di età, la proposta del piano di Renzi e i dei suoi, tutta basata sulla flessibilità, sembra venire da un altro mondo. E per quel che riguarda i contributi, lauti, alle imprese che assumeranno va ricordato che le imprese capaci di usufruirne stanno proprio nelle aree dove meno grave è la disoccupazione, cioè fuori dal Mezzogiorno. E’ vero che questo incentivo in linea teorica potrebbe anche produrre qualche occupato stabile in più nel breve periodo (magari non nel Mezzogiorno) nella fase iniziale. E ciò servirà sicuramente per l’opera di propaganda, che è già in corso. Poi l’effetto finirà in mancanza di altri stimoli. Obama non c’entra nulla Passiamo ora a un confronto tra il jobs act e il jobs act finto di Renzi. Una breve analisi comparativa dei due provvedimenti mostra differenze enormi. In sostanza trattano materie solo in parte analoghe e comunque con approcci differenti. La legge italiana ha come punto centrale tematiche di relazioni sindacali in particolare i criteri di riduzione delle misure di protezione all’impiego: tematiche che nel jobs act vero non sono proprio trattate. Al contrario - e questo è il punto principale – il jobs act vero si è basa anche su massicci investimenti pubblici che vanno dal finanziamento del sistema educativo a lavori pubblici: tematiche che sono assolutamente ignorate nella legge italiana che punta tutto sulla flessibilità sulla questione della ‘occupabilità’ nell’assunto di un basso capitale umano dei giovani disoccupati italiani, quelli che solitamente e malamente vengono definiti NEET. Insomma, al costo di ripeterci vale la pena sottolineare che, al contrario della linea di Renzi, il jobs act vero, quello americano, è basato su investimenti e quindi di un azione diretta sulla domanda di lavoro per far crescere così realisticamente l’occupazione al contrario di quello italiano. C’è da dire che in esso non mancano iniziative che possono farsi rientrare delle politiche attive del lavoro o anche delle politiche passive come interventi per i disoccupati di lungo periodo e gruppi disagiati. Ma la prima area di intervento è quella di maggior rilievo. Non mancano neppure sgravi fiscali per le imprese che assumono e questa può essere considerata una analogia con il bonus triennale dato 6 È ovvio che un intervento che riguarda anche l’offerta ma soprattutto la domanda come quello americano costa molto di più. E infatti il jobs act di Obama si basa su un elemento realistico e ovvio per cui per fare aumentare l’occupazione bisogna fare investimenti. Il finto jobs act di Renzi rientra invece all’interno del sogno tradizionale per cui riducendo le protezioni dei lavoratori occupati stabili e prolungando all’infinito la situazione di apprendisti e occupati non standard, l’occupazione aumenterà automaticamente. Per inciso vale la pena di ricordare che il decreto Poletti che prolunga all’infinito i nuovi contratti non standard è divenuto parte integrante del finto jobs act italiano. Al contrario nella mente dei creatori della ‘copia’ nazionale del jobs act non c’è alcuna intenzione di sprecare danaro in investimenti. Il disciplinamento dei lavoratori con le nuove forme di controllo e la riduzione della tutela fondamentale con l’eliminazione dell’articolo 18, dovrebbero rinnovare la fiducia degli imprenditori e stimolare così gli investimenti. Naturalmente non manca una dose di retorica neanche nel jobs act vero, quello di Obama. Così, in coerenza con l’ideologia dominante si sottolinea la riduzione del 50% delle tasse sul lavoro in base al principio di mettere più soldi nelle tasche di ogni lavoratore americano e di ogni famiglia. La retorica e la fraseologia su questo punto sono molto simili a quelle usate da Berlusconi e da Renzi: la retorica dei soldi in tasca ai cittadini, l’unico diritto che merita di essere rispettato. Infine mentre la retorica del conflitto intergenerazionale accompagna la presentazione del finto Jobs act italiano, c’è un'altra retorica che caratterizza il Jobs act americano che è la retorica patriottica espresso da misure a vantaggio dei reduci dal titolo “Returning heroes” . D’altronde man mano che in qualche modo i contenuti del Jobs act nostrano risultavano più chiari, il riferimento al Jobs act di Obama veniva dimenticato e rimaneva solo il nome. Le dichiarazioni ufficiali di Renzi e le azioni di propaganda hanno in genere obiettivi ed interlocutori diversi. Così a volte esse sembrano rivolte alla Confindustria e in generale ai datori di lavoro (sempre in maniera benevola) a volte esse sono rivolte al sindacato in maniera spesso insultante e con un intento evidente di delegittimazione. A volte infine Renzi parla alla sinistra spiegando cosa vuol dire ora essere di sinistra. Basta prendere una breve citazione: “Qual’è l’identità della sinistra in Italia?....essa consiste nel dare più diritti ai giovani, di dare possibilità ad una nuova generazione. Noi avevamo in Italia un apartheid del lavoro. Il Jobs act è la cosa più di sinistra che io abbia mai fatto”. Dove siano poi questi maggiori diritti ai giovani è difficile da immaginarlo. Eppure su questo si continua ad insistere. Ed è difficile dire se affermazioni di questo genere e l’intero quadro della propaganda di Renzi si basino sull’ideologia o su un conscio intento di disinformazione o se c’è qualcos’altro ancora. Probabilmente c’è un po’ di tutto. Confusione, propaganda e ideologia Passiamo con ciò all’ultimo punto, quello relativo all’ideologia e alla propaganda. La presentazione delle iniziative del governo Renzi è sempre accompagnata nei media da un grande battage pubblicitario che ne sottolinea la novità e al contempo la capacità di risolvere problemi strutturali dell’economia e della società italiana. Sempre nei discorsi c’è la promessa, anzi la garanzia, che i risultati dell’iniziativa saranno strepitosi, meravigliosi. Non si parla dei contenuti specifici delle misure ma degli effetti che esse avranno per la vita economica e sociale del paese. Allo scopo di rendere più confusa la situazione – o magari per semplice provincialismo – nel discorso ufficiale si abbonda di termini inglesi generalmente ricavati dal lessico americano, come abbiamo già notato in premessa. Non è una pratica originale questa dell’uso improprio di termini in inglese. Ormai siamo da tempo abituati e non a tutti viene il dubbio che ci sia il trucco: pensiamo al caso della cosiddetta ‘spending review’ e gli esempi potrebbero continuare all’infinito. Ma questo stile di comunicazione istituzionale nel caso del finto Jobs act raggiunge la sua massima espressione. Preparata da studiosi di fede governativa - ancor prima che fossero resi pubblici, e probabilmente prima ancora che fossero decisi, i contenuti specifici - questa legge (questo ‘act’ per dirla con loro) è stata pubblicizzata come la misura che avrebbe risolto in senso positivo il conflitto generazionale, avrebbe eliminato la contraddizione tra ‘insiders’ e ‘outsiders’ – una volta i primi si chiamavano ‘garantiti’ - avrebbe determinato un superamento della precarietà e una riduzione della disoccupazione giovanile soprattutto nel Mezzogiorno. Sul modo in cui si sarebbero raggiunti gli obiettivi si diceva ben poco. E soprattutto su quest’ultimo punto avevano ben poco da dire. Per tutta una fase si è discusso del provvedimento senza che ne esistesse una bozza ma c’era solo una vaga, per altro orale, indicazione degli obiettivi. Si discuteva senza un testo di riferimento. Anche coloro che criticavano il progetto dovevano basarsi anch’essi sul sentito dire, sulla tradizione orale. Di certo gli esperti sapevano che il cuore del provvedimento sarebbe consistito in misure riguardanti le relazioni industriali le quali avrebbero inciso sulla legislazione italiana riducendo il presunto eccesso di garanzia dei presunti ‘insiders’ (l’obiettivo era la classe operaia ‘centrale’, quella da anni sotto attacco). E autori di orientamento neo-liberista pubblicizzavano complesse soluzioni (solo in parte poi assorbite nella legge) che avrebbero garantito la quadratura del cerchio. Si trattava – come ben illustrato nel libro di Sbilanciamoci! - del famoso contratto a tutele crescenti. A questo poi si aggiungevano degli incentivi alle imprese per le nuove assunzioni consistenti in una vantaggiosa forma di contributo fiscale. A operazione compiuta, e mentre i decreti attuativi mostrano la ferocia dell’attacco ai diritti sanciti dallo statuto dei lavoratori (ultimamente sul piano della riservatezza personale), si può fare un brevissimo bilancio del rapporto tra proposte originarie – non le promesse che sono ben altro – e testo della legge. Dal contratto a tutele crescenti è ormai esclusa una larga fascia di quelli cui doveva essere destinato: i giovani da salvare dal precariato. E per quel che riguarda le tutele, se vogliamo considerare esagerata l’affermazione di Sbilanciamoci! secondo la quale esse sono ‘calanti’ anziché crescenti, non si può negare il carattere scandaloso delle norme definitive sui licenziamenti senza alcuna giusta causa con la libertà incondizionata di sbattere via il dipendente al costo di un piccolo indennizzo. Circa poi l’incentivo alle aziende, come accennato, esso è importante per la propaganda e per far vedere che l’occupazione aumenta grazie al Jobs act. Purtroppo questo effetto è destinato – come mostrano esperienze passate – a durare poco e vedremo che nel Mezzogiorno le cose, anche in caso di miglioramento della situazione congiunturale a livello nazionale, cambieranno di poco. I giovani, in particolare i neet del Mezzogiorno – dei quali tanto si parla allo scopo di aizzare il conflitto generazionale - non avranno alcun beneficio dalla riduzione dei diritti degli occupati stabili. E pochi ne avranno anche dai sussidi alle imprese. Ci vorrebbe ben altro. Tornando alla questione di prima sulla ideologia e sulle forme di comunicazione è evidente come le esternazioni di Renzi in materia si 7 basino su informazioni generalmente distorte. Con la sua usuale irruenza il Primo ministro e autore del finto Jobs act promette l’improbabile e l’impossibile senza mettere mai le carte in tavola. Non ci è dato di sapere quanto egli stesso creda alle sue mirabolanti promesse ma la scarsa attendibilità è chiara e abbiamo tentato di evidenziarlo. Nel complessivo processo comunicativo ci sono anche altri elementi, altri modelli di informazione ma anche altri convincimenti e visioni del mondo. Innanzitutto c’è una posizione assolutamente dominante, più sincera per così dire, che è dominata dall’ideologia. L’intero apparato neoliberista che è alla base dell’operazione del Jobs act nostrano – a parte qualche piccola evidente bugia detta “perché si deve anche campare” - è basato su presupposti ideologici che poi sono quelli dell’economia neoclassica tradizionale. Tra questi uno è rappresentato dal mito della flessibilità. Il volume di Sbilanciamoci! smonta in dettaglio con argomentazioni e documentazione empirica le tesi dei vantaggi della flessibilità (nelle sue varie dimensioni: salariale, numerica, etc). Eppure non ci si ferma neanche di fronte all’evidenza. E i mentori della politica renziana non sono affatto isolati in ciò. L’evidenza in materia di flessibilità e dei suoi fallimenti non frena neanche i responsabili delle organizzazioni internazionali. Renzi e associati sono in buona compagnia. C’è poi un’ulteriore forma di convincimento e autoconvincimento che riguarda probabilmente altri soggetti e non le teste d’uovo o i - riccamente stipendiati – consulenti del governo, insomma i produttori del finto Jobs act. Si tratta di una tendenza a vedere le cose come si desidera che esse siano: “il wishful thinking” come direbbero gli inglesi e gli economisti alla moda. Questo atteggiamento lo si registra tra i propugnatori del Jobs act per fede renziana o per odio nei confronti del sindacato. E lo si registra anche nella grande stampa. Esso infine riguarda anche qualche ministro distratto, come nel caso dei numeri sbagliati del ministro Poletti che, preso dall’entusiasmo, dimenticò l’esistenza della sommatoria e comunicò i grandiosi (inesistenti) risultati delle iniziative governative sul piano dell’occupazione. Per fortuna pare che a tutto ciò non credano invece una parte dei diretti interessati. Forse neanche le imprese che sanno che i problemi dello sviluppo e i rapporti con i lavoratori non si regolano a forza di cancellare i diritti sulla carta. Ma soprattutto non ci credono i giovani e i lavoratori. Renzi avrà ragione a dire che il Jobs act è la cosa più a sinistra che ha fatto (figuriamoci il resto). Ma la gente vuol vedere i risultati effettivi. Vuol vedere davvero lavoro e lavoro decente. E da questo punto di vista la prospettiva è nera. (fonte: Centro Studi Sereno Regis) link: http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Il-Jobs-Act-tra-confusionepropaganda-e-ideologia-30658 L’inganno del lavoro (di Francesco Gesualdi) Il Fondo Monetario Internazionale ha sentenziato che l’Italia avrà bisogno di 20 anni per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi. Ma ci sta prendendo in giro perché sa bene che di lavoro questo sistema non ne creerà più. Semplicemente perché non è il suo obiettivo, non è la sua missione come piace dire a chi vive l’economia come una religione. La missione di questo sistema è garantire profitto alle imprese e ai suoi azionisti. Quanto al lavoro è solo un costo da contenere e poco importa se dietro al così detto mercato del lavoro ci sono persone in carne e ossa, con una dignità, una vita, dei diritti da salvaguardare. Per il mondo degli affari il lavoro è solo una merce, è del tempo da comprare al prezzo più basso possibile. E poiché la legge di mercato sancisce che il prezzo scende quando c’è più offerta che domanda , per fare scendere il prezzo del lavoro bisogna creare più offerenti lavoro di quanto siano i posti disponibili. Il capitalismo può essere raccontato come la storia di un sistema che si è organizzato per creare disoccupazione e assicurarsi costantemente lavoro a buon mercato. Fra le strategie utilizzate, c’è prima stata l’estromissione dei contadini dalle terre comuni, poi la sostituzione degli umani con le macchine, infine la globalizzazione. Strategie in continuo cambiamento per ottenere un numero crescente di persone in sovrappiù che tengano basso il prezzo del lavoro. Un progetto definito da Papa Francesco come l“economia dello scarto”, e se fino a ieri gli scartati eravamo abituati a vederli nel Sud del mondo, oggi li troviamo sempre più nelle nostre case, a giudicare dalla crescita dei poveri e dei disoccupati. Fosse onesto, il sistema ci racconterebbe apertamente che l’esclusione fa parte della sua natura. Invece tenta di farci credere che lui, poverino, vorrebbe tanto dare un lavoro a tutti, ma per riuscirci ha bisogno di crescita, perché che volete, il lavoro lo creano le aziende e le aziende assumono solo se vendono di più. Peccato che ogni volta che si creano nuove opportunità di lavoro le aziende preferiscano le macchine alle persone e al tempo della globalizzazione, oltre ad assistere alla guerra fra lavoratori da un capo all’altro del pianeta, si assiste anche alla guerra dei robot contro gli umani. Lo stanno sperimentando anche cinesi da che hanno osato alzare la testa per chiedere migliori condizioni di lavoro. Ma la bugia più grave rispetto alla crescita è che ormai non è più compatibile con lo stato comatoso raggiunto dal pianeta. E mentre geologi, agronomi, climatologi ci informano che le risorse si stanno riducendo al lumicino e che i rifiuti ci stanno sommergendo facendo cambiare equilibri millenari come il clima, succede che industriali, politici, sindacalisti ed economisti, tutti insieme acclamino la crescita come l’unica via per tirarci fuori dai guai. E noi ci crediamo. Presi da quell’impellente bisogno di lavoro, anche noi corriamo dietro alla leggenda, finendo per sdoppiare la nostra personalità: pro sobrietà in nome dell’ambiente, pro crescita in nome del lavoro. Prima o poi scopriremo che la schizofrenia non ci porta lontano e che la sobrietà è l’unica strada per garantirci un futuro. Ma la buona notizia è che sobrietà non è sinonimo di vita di stenti né di disoccupazione dilagante. Al contrario è occasione di libertà, sovranità e inclusione. L’importante è convincerci che il lavoro è un falso problema. Nella storia dell’umanità, l’obiettivo non è mai stato il lavoro. L’obiettivo è stato vivere bene nel senso di avere di che mangiare, vestirsi, viaggiare, istruirsi, curarsi. Solo noi, figli del mercato, abbiamo trasformato il lavoro in idolo e non perché siamo impazziti, ma perché viviamo in un sistema che ci offre l’acquisto come unica via per soddisfare i nostri bisogni e ci offre il lavoro salariato come unica via per accedere al denaro utile agli acquisti. Per questo il lavoro è diventato una questione di vita o di morte e in suo nome siamo tutti diventati partigiani della crescita. L’unico modo per uscirne è smettere di concentrarci sul lavoro e concentrarci sulle sicurezze. La domanda giusta da porci non è come creare lavoro, ma come garantire a tutti la possibilità di vivere dignitosamente utilizzando meno risorse possibile, producendo meno rifiuti possibile e lavorando il meno possibile. La strada è ridurre la dipendenza dal lavoro salariato, in modo da interrompe la schiavitù dalla crescita delle vendite. In altre parole l’alternativa è l’autoproduzione in ambito individuale, per i piccoli bisogni personali e familiari, e in ambito collettivo per i beni e servizi fondamentali che richiedono strutture produttive organizzate. Quando ciò che ci serve lo potremo ottenere senza denaro grazie al lavoro non retribuito nostro e degli altri, in quel momento il lavoro smetterà di essere un costo e si trasformerà in ricchezza. In quel momento non ci sarà più interesse ad escludere, ma a ottenere la collaborazione di tutti. E se dovesse risultare che siamo troppi, potremo sempre dare una bella sforbiciata all’orario di lavoro con somma soddisfazione di tutti perché con meno lavoro potremo avere lo stesso livello di sicurezze. Capito che l’inclusione passa attraverso il ridimensionamento del mercato e il rafforzamento della solidarietà collettiva, la prima cosa da fare è arrestare la demolizione di ciò che ci è rimasto di pubblico. Basta con la politica delle privatizzazioni. Basta con il taglio alle spese sociali. Basta con una politica di bilancio che dà priorità al servizio del debito. Sì, invece, a una seria lotta all’evasione e ai paradisi fiscali. Sì a una tassazione progressiva dei redditi e in particolare delle rendite finanziarie. Sì a una ristrutturazione del debito. Sì a una sovranità monetaria al servizio dell’occupazione in ambito pubblico. C’è bisogno di politica nuova, ma potremo trovarla solo se saremo capaci di gettare il pensiero oltre il muro del sistema imperante. 8 (fonte: Mondo Solidale Massa Cooperativa Sociale) link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2321 Politica e democrazia L’avanzata delle destre estreme e le responsabilità della sinistra liberale (di Matteo Volpe) L’avanzata delle destre estreme si deve al fallimento storico (ennesimo) della sinistra liberale e degli intellettuali che ne hanno abbracciato i principi. Scoprire che l’idea, comunemente accettata negli ultimi trent’anni, secondo la quale sarebbe stato possibile garantire un livello accettabile di ricchezza a tutta la popolazione attraverso un’espansione del mercato, e quindi rimuovendo tutti gli ostacoli che ne impediscono tale espansione – ovvero l’intervento diretto dello Stato – scoprire all’improvviso che questa idea è sbagliata, ha generato dei mostri. La sconfitta individuale e generazionale del comunismo e del socialismo occidentali nel corso del Novecento (conclusosi tragicamente con il crollo di quello orientale e con la dissoluzione dell’URSS) è stata tramutata in una sconfitta antropologica e persino biologica. Incapaci di accettare il fallimento personale (che personale poi non è, perché dovuto a ragioni storiche) gli individui che ne hanno preso parte preferirono vedervi la realizzazione di una “legge di natura”, commettendo l’errore dei conservatori più accaniti, ovvero “naturalizzare” i fatti storici, e quindi in definitiva far scomparire la storia dall’orizzonte del pensiero, come era stato teorizzato da Francis Fukuyama. La sinistra ha così finito per arrendersi alla visione liberale, capitalista, mercatocentrica e globalista, poco prima che questa si schiantasse contro l’iceberg della storia. Ha riconosciuto anche questo secondo fallimento (più grande del primo, perché strutturale, non contingente) dichiarando nella semplicità più assoluta che il miglioramento delle condizioni delle masse è precluso, ed esso deve essere sacrificato sull’altare del dio Capitale, variamente coniugato (mercato, euro, “Europa”, globalizzazione, modernizzazione, ecc.). Perdendo il capitalismo qualsiasi fascino (come nelle illusioni dei rampanti scalatori sociali piccolo-borghesi degli anni ’80) e rivelando il suo volto peggiore, quello reale, fondato sullo sfruttamento di classe e sull’esproprio delle ricchezze delle classi inferiori a vantaggio del capitale finanziario, esso può esercitare il proprio dominio culturale in soli due modi: escludendo qualsiasi alternativa ad esso, descritta come utopistica o ignorata, censurata, derisa, banalizzata; descrivendo tutto ciò che si estenda oltre le colonne d’Ercole dei propri orizzonti come il baratro, il vuoto, la miseria totale, ovvero esercitando un vero e proprio terrorismo psicologico sulle masse. La sinistra, si diceva, ha riconosciuto questo fallimento, ma non fino al punto da ripudiare la propria conversione, non al punto da riconoscere lucidamente le cause di questo fallimento. Il capitalismo mieteva come sempre e con ancora più violenza che in passato le proprie vittime, ma permaneva il pregiudizio antimarxista che nella sinistra convertita risultava spesso ancor più feroce che nella destra da sempre ostinatamente liberale. Questa sinistra è stata l’alleato politico più prezioso del Capitale. Essa ha traghettato le masse politicizzate e sindacalizzate, ma disorientate dagli avvenimenti storici di fine secolo, entro il recinto liberale, provvedendo a tenervele rinchiuse. Mancando, però, la comprensione chiara delle cause, dei rapporti economici e una critica del capitalismo (sostituita dalla giustificazione, più o meno mascherata da critica, dello status quo economico) mancando un partito che organizzi un’opposizione teorica e pratica, la rabbia e la frustrazione degli strati sociali devastati dalla crisi rischia ora seriamente di emigrare verso altri lidi. La rabbia sociale repressa, non inquadrata politicamente e culturalmente sprovveduta, si trasforma in rabbia etnica. Non potendo lanciarsi verso l’alto, si sfoga verso il basso, verso i gruppi dei socialmente esclusi. Il principio etnico costituisce una chiave di semplificazione laddove viene a mancare il principio di classe. Le passioni sociali più violente possono trovare uno sfiatatoio: il conflitto di classe rimosso dalle coscienze si etnicizza, trova una discriminante geografica, da tutti facilmente riconoscibile e utilizzabile. di “è pazzia”. L’avanzata delle destre estreme e xenofobe, che si registra negli ultimi anni, si deve alla repressione culturale degli ideali socialisti e anticapitalisti scaturita dalla restaurazione neoliberista e dall’inasprirsi della guerra del capitale finanziario nei confronti di tutti gli altri settori sociali (eccezion fatta per il grande capitale industriale). La sinistra è stata non un oppositore ma un alleato in questa strategia, ha abbassato i ponti levatoi e spalancato le porte per far entrare le truppe nemiche, serbandogli tutti gli onori e difendendole contro i pochi resistenti che queste incontravano sul loro cammino. IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA 189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia…. Il salvataggio a ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. La crisi finanziaria del [in realtà, iniziata nel] 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione [politica] che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo… In definitiva, ciò che [oggi] non si affronta [più] con decisione è il problema dell’economia reale…. 190. In questo contesto bisogna sempre ricordare che «la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente».[134] Ancora una volta, conviene evitare una concezione magica del mercato, che tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli individui…. All’interno dello schema [attuale] della rendita non c’è posto per pensare ai ritmi della natura, ai suoi tempi di degradazione e di rigenerazione, e alla complessità degli ecosistemi che possono essere gravemente alterati dall’intervento umano. Inoltre, quando [oggi] si parla di biodiversità, al massimo la si pensa come una riserva di risorse economiche che potrebbe essere sfruttata, ma non si considerano seriamente il valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le culture, gli interessi e le necessità dei poveri. 191. Quando si pongono tali questioni, alcuni reagiscono accusando gli altri di pretendere di fermare irrazionalmente il progresso e lo sviluppo umano. Ma dobbiamo convincerci che rallentare un determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo a un’altra modalità di progresso e di sviluppo…. Si tratta di aprire la strada a opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo. 192. Per esempio, un percorso di sviluppo produttivo più creativo e meglio orientato potrebbe correggere la disparità tra l’eccessivo investimento tecnologico per il consumo e quello scarso per risolvere i problemi urgenti dell’umanità… La diversificazione produttiva offre larghissime possibilità all’intelligenza umana per creare e innovare, mentre protegge l’ambiente e crea più opportunità di lavoro. Questa sarebbe una creatività capace di far fiorire nuovamente la nobiltà dell’essere umano, perché è più dignitoso usare l’intelligenza, con audacia e responsabilità, per trovare forme di sviluppo sostenibile ed equo, nel quadro di una concezione più ampia della qualità della vita. Viceversa, è meno dignitoso e creativo e più superficiale insistere nel creare forme di saccheggio della natura solo per offrire nuove possibilità di consumo e di rendita immediata. 193. In ogni modo, se in alcuni casi lo sviluppo sostenibile comporterà nuove modalità per crescere, in altri casi, di fronte alla crescita avida e irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a rallentare un po’ il passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e anche a ritornare indietro prima che sia tardi. Sappiamo che è insostenibile il comportamento di coloro che consumano e distruggono sempre più, mentre altri ancora non riescono a vivere in conformità alla propria dignità umana. Per questo è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. Diceva Benedetto XVI che «è necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti caratterizzati dalla sobrietà, diminuendo il proprio consumo di energia e migliorando le condizioni del suo uso».[135] 194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di «cambiare il modello di sviluppo globale», [136]… Non basta [cercare di] conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita Questa sinistra dovrà rispondere davanti al tribunale della storia non soltanto per i massacri e i disastri sociali causati da un capitalismo dotato di “licenza di uccidere”, ma anche per le recrudescenze della frustrazione popolare, per l’enticizzazione del malcontento e per tutto ciò che ne deriva e ne deriverà. (fonte: Pressenza: international press agency) link: www.pressenza.com/it/2015/07/lavanzata-delle-destre-estreme-e-leresponsabilita-della-sinistra-liberale/ Religioni La enciclica “Laudato sii” puntata e ristretta (di Antonino Drago) L’ultima enciclica di Papa Francesco è certamente molto importante. Il primo motivo, secondo me, è l’aver acquisito alla dottrina sociale della Chiesa il tema dell’ecologia. Il secondo è di averlo fatto dirigendosi a tutti gli uomini, in un dialogo che si accorda con il pensiero ecologista e che implicitamente propone una nuova etica universale a cui tutti possono dare contributi. Questi fatti storici però vengono sminuiti dall’aver mantenuto il linguaggio tipico di quel tipo di magistero, in cui non risultano chiare le cause sociali, le responsabilità, i cambiamenti da compiere noi cattolici e più in generale, le prospettive storiche, il tutto in una concezione ben congegnata e senza sbaffi, riempitivi, diversivi, aggiunte consolatorie. Inoltre la lunghezza eccezionale della enciclica rischia di disorientare chi la voglia assumere come direzione di lavoro. Per rimediare a questi difetti si può fare una operazione: prendere la parte più saliente dell’enciclica e snellirla nel linguaggio, sì da renderla stringente. Ammetto che questa operazione è un po’ una forzatura; ma è anche una chiarificazione ideale; che se anche non rappresenta esattamente la mente di papa Francesco, però rende più chiara una delle direzioni di lavoro lì indicate. In questo senso, e con questa avvertenza, considero lecita e utile l’operazione del seguito. La parte più saliente di questa enciclica mi appare un brano che tratta non tanto i temi ecologici, quanto il quadro socio-economico in cui essa colloca il problema ecologico oggi, il Cap. V, IV. Questa parte descrive in maniera molto forte il problema della attuale economia mondiale, la quale è diventata una morsa oppressiva quasi insostenibile, senza che appaia una risposta politica adeguata. E’ di questa descrizione sistematica che oggi i cattolici e tutte le persone nel mondo hanno bisogno per orientare le loro vite a costruire assieme un mondo più giusto e più ecologico. Secondo me, se anche l’enciclica fosse ristretta a questo solo brano costituirebbe una novità radicale. Ma se queste 8 pagine restano immerse in un testo di 184 pagine, rischiano quanto meno di restare nell’ombra, o scomparire nel contesto di tanti problemi e di un frasario ridondante. Eccone una versione ottenuta semplicemente rinsecchendo quel brano alle parti più importanti e più forti. Nota. Mi sono permesso di modificare leggermente qualche punto dell’enciclica inserendo parole in parentesi quadre [], perché non sempre il testo ufficiale pubblicato sul sito “Vatican.va” è risultato fedele all’originale. Vedasi il famoso esempio della condanna della guerra nucleare al pt. 67 della Pacem in Terris: “alienum a ratione” che ancora oggi (vedi il sito) è tradotto con “riesce quasi impossibile pensare”, invece 9 finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso…. In questo quadro, il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe [i] valori del discorso ecologista all’interno della logica della finanza e della tecnocrazia, e [così] la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di marketing e di immagine. 195. Il principio della massimizzazione del profitto, che tende a isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia: se aumenta la produzione, interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell’ambiente; se il taglio di una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare l’inquinamento. Vale a dire che le imprese ottengono profitti calcolando e pagando una parte infima dei costi. Si potrebbe considerare etico solo un comportamento in cui «i costi economici e sociali derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future».[138]… 196. Qual è il posto della politica?… È vero che oggi alcuni settori economici esercitano più potere degli Stati stessi. Ma non si può giustificare un’economia senza politica [pubblica]… 197. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi…. Se la politica non è capace di rompere una logica perversa, e inoltre resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a non affrontare i grandi problemi dell’umanità…. [infatti] non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana dovrebbe essere capace di assumere questa sfida. 198. La politica e l’economia tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il degrado ambientale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri errori e trovino forme di interazione orientate al bene comune. Mentre gli uni si affannano solo per l’utile economico e gli altri sono ossessionati solo dal conservare o accrescere il potere, quello che ci resta sono guerre o accordi ambigui dove [= nei quali] ciò che meno interessa alle due parti è preservare l’ambiente e avere cura dei più deboli….” (fonte: Centro Studi Sereno Regis) link: http://serenoregis.org/2015/07/30/la-enciclica-laudato-sii-puntata-e-ristrettaantonino-drago/ Stili di vita Il carrello della spesa? Riempiamolo di biodiversità! (di Slowfood.it) Uno studio condotto nel 2011 da ricercatori dell’Università di Exeter ha previsto la scomparsa di una specie su 10 entro la fine del secolo: si è innescata quella che chiamano sesta estinzione di massa. Con la quinta – 65 milioni di anni fa – si erano estinti i dinosauri. Ma c’è una differenza sostanziale tra l’estinzione presente e quelle del passato. Il responsabile di questa crisi ecologica globale è l’uomo. In 70 anni abbiamo distrutto i tre quarti dell’agro-biodiversità che i contadini avevano selezionato nei 10.000 anni precedenti. Ed ecco alcuni esempi Api Nel 2007 le api mellifere – impollinatrici di gran parte dei vegetali che mangiamo – hanno cominciato a morire in massa. In Europa, le morie si sono attestate intorno al 20%, mentre negli Stati Uniti, nell’inverno del 2013/2014, hanno superato il 40%. Foreste 10 Ogni anno distruggiamo 10 milioni di ettari di foreste pluviali (nel Borneo, in Amazzonia, in Africa), per far posto a palme da olio e campi di soia. Mangrovie Le mangrovie e le barriere coralline, habitat di numerose specie e protezione fondamentale per i litorali, si sono già ridotte rispettivamente del 35% e del 20%. L’equilibrio si è rotto quando abbiamo iniziato a gestire le fattorie come industrie. L’industria non tollera i tempi della natura, non ha stagioni né pazienza. Deve produrre sempre, tanto, velocemente e nel modo più efficiente possibile. Deve produrre in serie. Prima di allora si arricchivano i terreni grazie alla rotazione con le leguminose (fagioli, fave, piselli) e al letame degli animali. Ma da quel momento, abbiamo iniziato a comprare fertilizzanti, pesticidi, diserbanti, carburanti per le macchine. Abbiamo iniziato a cibarci di petrolio. È un destino segnato? O possiamo favorire un cambio di direzione? Noi siamo convinti di sì! Possiamo, con le nostre scelte quotidiane, favorire altri comportamenti, altri tipi di agricoltura, di produzione alimentare. Iniziamo a scegliere il cibo con consapevolezza, partiamo dal nostro territorio, impariamo a conoscerlo: sarà ricco di ortaggi, frutta, razze locali, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali che sicuramente sapranno soddisfare anche i palati più esigenti. E quando facciamo la spesa teniamo presente alcuni piccoli accorgimenti. Ecco quali: Carne Continuare a mangiare carne con i livelli di consumo a cui si è abituato l’Occidente – e a cui si avvicinano anche i paesi emergenti – non è più possibile. I costi ambientali degli allevamenti intensivi sono enormi, per non parlare della sofferenza cui sono sottoposti gli animali allevati con questi metodi crudeli. Il nostro consiglio? Consumiamo meno carne, di migliore qualità, proveniente da allevamenti attenti al benessere animale e alla qualità dell’alimentazione del bestiame. Privilegiamo le razze locali e i tagli meno noti, così eviteremo che molta della carne vada sprecata. Gamberetti Vi siete mai chiesti da dove arrivano i gamberetti che porti in tavola? Perlopiù provengono da zone tropicali, dove sono oggetto di pesca intensiva. Il risultato? I loro stock sono vicini al massimo limite di sfruttamento e le tecniche utilizzate per pescarli sono devastanti per l’ambiente. Per non parlare delle condizioni inumane cui sono ridotti molti migranti costretti a lavorare sui pescherecci (ne abbiamo parlato qui) Meglio quelli di allevamento? No, perché, per allevarli, sono distrutte ogni anno ampie porzioni di foreste di mangrovia, con conseguenze gravissime per l’ambiente e per la sopravvivenza dei pescatori di piccola scala. Quali scegliere allora? Cerchiamo quelli che arrivano da mari vicini. Oppure proviamo alternative meno note ma molto buone, come gli scampi, le cicale di mare e tanti altri crostacei! Banane A livello mondiale, il commercio delle banane è in mano a cinque multinazionali che le coltivano su immensi latifondi, facendo uso di pesticidi, fertilizzanti chimici di sintesi e fungicidi, spesso sfruttando il lavoro degli agricoltori locali. La raccolta dei caschi di banane non è che l’inizio di un lungo viaggio – in nave, attraverso l’oceano – e poi su gomma – dai centri di stoccaggio, dove vengono fatte maturare, ai mercati. Il mercato è dominato da una sola varietà, la Cavendish, mentre moltissime altre sono perlopiù sconosciute. Quale scegliere? Proviamo quelle biologiche del commercio fairtrade, che offrono maggiori garanzie di sostenibilità ambientale e sociale! Una merendina e una bibita La maggior parte delle bibite disponibili sul mercato sono zuccherate con lo sciroppo di mais (Hfcs) e piene di additivi e coloranti. Ecco perché sono una delle principali cause dell’obesità. Per di più tantissime contengono l’olio di palma. E che problema c’è, vi chiederete voi: per fabbricarlo ogni anno, sono abbattute ampie superfici di foresta pluviale con conseguente devastazione di flora e fauna. Siete sicuri che valga la pena devastare il pianeta per uno snack? Aguzziamo l’ingegno, impieghiamo un po’ di tempo e scegliamo qualcosa di più buono e meno impattante per l’ambiente: una spremuta, un frullato fatti in casa, pane burro e marmellata. Una torta fatta in casa. Oppure cerchiamo di leggere bene gli ingredienti prima di effettuare l’acquisto! Spreco alimentare Dove finiscono le bottiglie di plastica, gli imballaggi delle merendine, il cibo che abbiamo comprato in eccesso o ancora quello che non abbiamo neanche potuto acquistare – la mela maculata, la carota storta – perché al supermercato non c’è mai arrivato? I numeri dello spreco mondiale sono impressionanti: in Nord America e in Europa ognuno di noi spreca circa 280-300 chili di cibo all’anno. E, nel resto del mondo, milioni di persone soffrono la fame. Facciamo più attenzione ai nostri acquisti! Compriamo prodotti di stagione, più vicino a noi quando possibile e tradizionmagari direttamente dal produttore. E impariamo dalla popolare: gli avanzi del giorno prima possono diventare vere leccornie. Da Slowfood.it (fonte: Unimondo newsletter) link: http://www.unimondo.org/Notizie/Il-carrello-della-spesa-Riempiamolo-dibiodiversita!-151795 Notizie dal mondo Il patto militare con Israele, stipulato a nome del governo Tsipras, non è solo un successo personale di Kammenos. Esso rientra nella strategia Usa/Nato che, nell’offensiva verso Est e verso Sud, mira a integrare sempre più strettamente la Grecia non solo nell’Alleanza ma nella più ampia coalizione comprendente paesi come Israele, Arabia Saudita, Ucraina e altri. Il segretario generale Stoltenberg ha dichiarato che il «pacchetto di salvataggio» Ue per la Grecia è «importante per l’intera Nato», essendo la Grecia un «solido alleato che spende oltre il 2% del pil per la difesa» (livello raggiunto in Europa solo da Gran Bretagna ed Estonia). Particolarmente importante per la Nato la base aeronavale della baia di Suda a Creta, usata permanentemente dagli Stati uniti e altri alleati, negli ultimi anni per la guerra contro la Libia e le operazioni militari in Siria. Utilizzabile ora, grazie al patto con la Grecia, anche da Israele soprattuto in funzione anti-Iran. In tale quadro strategico si ricompongono i contrasti d’interesse fra Grecia e Israele, da un lato, e Turchia dall’altro. La Turchia, dove la Nato ha oltre 20 basi e il Comando delle forze terrestri, in nome della «lotta all’Isis» bombarda i curdi del Pkk (veri combattenti anti-Isis) e, insieme agli Usa e ai «ribelli», si prepara a occupare la fascia settentrionale del territorio siriano. Appellandosi all’Art. 4 del Patto Atlantico, in quanto ritiene minacciate la propria sicurezza e integrità territoriale. L’arte della guerra, il manifesto, 28 luglio 2015 Grecia (fonte: Centro Studi Sereno Regis) link: http://serenoregis.org/2015/07/30/patto-militare-grecia-israele-manlio-dinucci/ Patto militare Grecia-Israele (di Manlio Dinucci) Kurdistan Quando in Grecia è andato al governo Tsipras, in Israele è suonato l’allarme: Syriza, sostenitrice della causa palestinese, chiedeva di porre fine alla cooperazione militare della Grecia con Israele. Di fronte alla brutale repressione israeliana contro i palestinesi, avvertiva Tsipras, «non possiamo rimanere passivi, poiché quanto accade oggi sull’altra sponda del Mediterraneo, può accadere sulla nostra sponda domani». Sette mesi dopo, cessato allarme: Panos Kammenos, ministro della difesa del governo Tsipras, è andato in visita ufficiale a Tel Aviv, dove il 19 luglio ha firmato col ministro israeliano della difesa, Moshe Ya’alon, un importante accordo militare. Per tale mossa, Kammenos, fondatore del nuovo partito di destra Anel, ha scelto il momento in cui la Grecia era attanagliata dalla questione del debito. L’«Accordo sullo status delle forze», comunica il Ministero greco della difesa, stabilisce il quadro giuridico che permette al «personale militare di ciascuno dei due paesi di recarsi e risiedere nell’altro per partecipare a esercitazioni e attività di cooperazione». Un accordo simile Israele lo ha firmato solo con gli Stati uniti. Nell’agenda dei colloqui anche la «cooperazione nel campo dell’industria militare» e la «sicurezza marittima», in particolare dei giacimenti offshore di gas che Israele, Grecia e Cipro considerano propria «zona economica esclusiva», respingendo le rivendicazioni della Turchia. Sul tavolo dell’incontro «le questioni della sicurezza in Medioriente e Nordafrica». Facendo eco a Ya’alon che ha denunciato l’Iran quale «generatore di terrorismo, la cui ambizione egemonica mina la stabilità di altri Stati», Kammenos ha dichiarato: «Anche la Grecia è nel raggio dei missili iraniani; se uno solo riesce a raggiungere il Mediterraneo, potrebbe essere la fine degli Stati di questa regione». Ha quindi incontrato i vertici delle forze armate israeliane per stabilire un più stretto coordinamento con quelle greche. Contemporaneamente il capo della marina militare ellenica, il viceammiraglio Evangelos Apostolakis, ha firmato con la controparte israeliana un accordo di cooperazione su non meglio precisati «servizi idrografici». 11 Il conflitto tra la Turchia e i curdi (di Robert Fisk) I curdi sono nati per essere traditi. A quasi ogni aspirante staterello in Medio Oriente era stata promessa la libertà dopo la Prima Guerra mondiale e i curdi inviarono perfino una delegazione a Versailles per chiedere una nazione e confini sicuri. Ma con il Trattato di Sèvres, nel 1920, hanno avuto una piccola nazione in quella che era stata la Turchia. Poi arrivò il nazionalista turco Mustafa Kemal Ataturk che riprese la terra che la nazione curda potrebbe aver guadagnato. E così i vincitori della Grande Guerra si sono incontrati a Losanna nel 1922-23 e hanno abbandonato i curdi (e anche gli armeni) che erano ora divisi tra il nuovo stato turco, la Siria francese e l’Iran e l’Iraq britannico. Quella è stata la loro tragedia da allora – e quasi ogni potenza regionale vi ha partecipato. I più brutali sono furono i turchi e gli arabi iracheni, i più cinici i britannici e gli americani. Non c’è da meravigliarsi se i turchi sono tornati a bombardare i curdi. Quando si sono ribellati contro Saddam Hussein in Iraq all’inizio degli anni ’70, gli americani li hanno appoggiati, insieme allo Scià dell’Iran. Poi il Segretario di stato americano Henry Kissinger, ha progettato un accordo tra Iran e Iraq: lo Scià avrebbe ricevuto un diritto territoriale, e, in cambio, avrebbe abbandonato i curdi. Gli Americani bloccarono le loro forniture di armi. Saddam ne uccise forse 182.000. “La politica estera”, osservò Mr Kissinger, “non dovrebbe essere confusa con un’opera missionaria.” Avreste pensato che i curdi forse potrebbero aver imparato la lezione, ma all’inizio della prima guerra del Golfo per liberare il Kuwait, sono stati spinti dagli americani – o piuttosto da una stazione radio segreta della CIA che operava dall’Arabia Saudita – a sollevarsi contro Saddam. E hanno obbedito. Gli americani li hanno lasciati morire a migliaia, di nuovo, soltanto costretti , settimane dopo, a creare una zona “sicura” nell’Iraq settentrionale dopo che decine di migliaia di civili curdi avevano fatto un viaggio a piedi sotto il fuoco in un esodo biblico verso la salvezza della Turchia. Alla fine la zona “sicura” dell’America si dimostrò illusoria. Anche quando gli Stati Uniti programmarono di invadere l’Iraq di Saddam attraverso il Kurdistan nel 2003, i curdi scoprirono che Turchi avevano intenzione di mandare 40.000 soldati con loro. I turchi volevano impedire che i curdi prendessero le città irachene di Mosul e Kirkuk; Ankara temeva che uno pseudo stato curdo con un governo proprio, si sarebbe insinuato in Turchia attraverso il confine. persona, è difficile immaginare una situazione in cui questa persona se ne stia in disparte e semplicemente esibisca cartelli contro la demolizione e che gli animi non si scaldino, soprattutto quando se ciò avviene di sorpresa,” ha scritto nella sentenza Keidar il 29 giugno. E quando i turchi iracheni combatterono l’ISIS l’anno scorso –mentre gli Americani decidevano di nuovo che i curdi in un certo senso erano utili – la Turchia osservava mentre il Kurdistan diventava l’avanguardia della battaglia dell’Occidente. Kobane era una mini Stalingrado e la sua difesa da parte dei di curdi di orientamento marxista ha reso l’umiliazione della Turchia più dolorosa. I combattenti del PKK (il Partito dei Lavoratori del Kurdistan) lungo la striscia settentrionale della Siria e dell’Iraq sono stati considerati degli eroi. “Non ci si può aspettare che una persona non resista alla distruzione della sua casa, così come ha fatto la gente di ogni settore del Paese, come ad Yamit, Gush Katif, Amona, Givat Amal [a Tel Aviv] ed altrove. In questi esempi ci sono stati (parecchi) proprietari di case che hanno preso iniziative violente e sono stati arrestati, ma non mi pare che siano stati trattenuti più di qualche giorno per essere interrogati e non fino al termine delle procedure legali nei loro confronti.” Questo non si poteva permettere. E così quando l’Isis attaccò i kurdi turchi che cercavano aiuto per la ricostruzione di Kobane, con un devastante bombardamento suicida a Suruc – seguito dal PKK che rivendicò la responsabilità dell’uccisione di due poliziotti turchi – la Turchia decise di attaccare il PKK sotto la copertura di un bombardamento contro l’Isis. Gli americani dovevano essere mantenuti contenti con la riapertura della base aerea di Incirlik – nel Kurdistan turco – e il mondo avrebbe dimenticato che i combattenti islamisti avevano ricevuto la libertà di attraversare il confine tra Turchia e Siria. Con la loro più recente campagna aerea, i turchi stanno seguendo la strada del Pakistan verso la corruzione totale, quando quel paese era diventato un canale per le armi e la guerriglia verso l’Afghanistan – con l’incoraggiamento degli americani – negli anni ’80. I pachistani hanno appoggiato in vari modi i mujahedin, i talebani e gli altri gruppi islamisti. L’accusa sostiene che Zagharna ha aggredito un poliziotto di frontiera con una pietra delle dimensioni di un pompelmo e che è ancora un pericolo pubblico. La difesa dice che è arrivato per difendere suo padre, che i poliziotti stavano picchiando. Qualunque festeggiamento nel caso di Keidar era prematuro; il normale sistema di giudizio è stato immediatamente rimesso a posto. Il pubblico ministero militare ha presentato appello contro la sua liberazione su cauzione e il vice presidente della Corte d’appello militare, il tenente colonnello Zvi Lekah, ha deciso che Zagharna, arrestato il 7 maggio, debba rimanere in carcere fino alla fine del procedimento legale. Questo è il modo in cui il sistema giudiziario militare obbliga i palestinesi al patteggiamento. L’imputato si dichiara colpevole perché se attende il processo in cui i testimoni sono interrogati in modo corretto, finisce per stare in prigione più a lungo di qualunque pena ricevesse in caso di condanna. In quanto ai curdi, si sono forse imbattuti per caso nelle parole di Arthur Harris, il capo dello squadrone della RAF che aveva contribuito a schiacciare l’insurrezione irachena del 1920? “Gli arabi e i curdi adesso sanno,” ha detto, “che cosa significano i veri bombardamenti in termini di vittime e danni. In 45 minuti un villaggio di grandi dimensioni può essere praticamente spazzato via e un terzo dei suoi abitanti può essere ucciso o ferito.” Chiaramente i turchi la pensano allo stesso modo. Un’eccezione come Keidar fa giurisprudenza e questa linea di condotta ci fa dimenticare che il sistema della giustizia militare è una catena di montaggio per la detenzione di massa, parte integrante dell’elaborato e sofisticato meccanismo di abusi per annullare i desideri di un popolo e la capacità di riprendersi la sua terra e la sua libertà. Da: Z Net – Lo spirito della resistenza è vivo www.znetitaly.org Fonte: https://zcomm.org/znetarticle/turkey-kurdish-conflict/ Originale : The Independent Traduzione di Maria Chiara Starace A differenza delle colonie di Amona e Gush Katif a Gaza, il quartiere di Sidri, dove vive Zagharna, non è stato costruito sulla terra rubata agli altri. La maggior parte delle sue case è stata costruita prima del 1967 o appena dopo. Israele non ha scuse per poterle demolire, ma può rendere piuttosto miserabile la vita dei residenti. 29 luglio 2015 http://znetitaly.altervista.org/art/18043 Palestina e Israele Tra queste, non includerli nel progetto complessivo del villaggio, impedendo loro di ampliare le loro case o costruirne di nuove e rifiutando di collegarli alla rete elettrica e idrica. Benché il villaggio di Ramadin sia stato inserito nell’area B, sotto il controllo civile palestinese, il quartiere di Sidri è inserito nell’Area C, sotto il totale controllo israeliano. Perché? Per prendersi più terra possibile da annettere a Israele. Il sistema della giustizia militare israeliano – una catena di montaggio per la detenzione di massa (di Amira Hass) A pochi chilometri dal rione di Sidri c’è Sansana, un avamposto non autorizzato e illegale costruito nel 2000, a cui il governo ha concesso il riconoscimento ufficiale nell’aprile 2012. Sansana, ora autorizzato ma illegale, avrà bisogno di spazio per ingrandirsi, e Sidri si trova sulla sua strada. (fonte: Centro Studi Sereno Regis) link: http://serenoregis.org/2015/07/30/il-conflitto-tra-la-turchia-e-i-curdi-robertfisk/ E’ anche parte integrante del meccanismo di annullamento dei desideri di un popolo e della capacità di prendersi la sua terra e la sua libertà Uomo morde cane – ecco perché il caso di Mohib Zagharna attira la nostra attenzione. C’è un giudice della corte militare di Ofer che considera l’uguaglianza un valore accettabile. Il tenente colonnello Shmuel Keidar aveva deciso che Zagharna avrebbe dovuto essere rilasciato su cauzione dopo che lui ed altri si sono azzuffati con le forze di polizia di frontiera e ispettori dell’Amministrazione civile che erano arrivati per smantellare la linea elettrica nel suo quartiere del villaggio di Ramadin, a sud della Cisgiordania. “Quando le forze di sicurezza arrivano per distruggere la casa di una 12 Nel 2008 la compagnia elettrica palestinese ha allacciato il rione al XX secolo, piazzando 40 pali e portato i fili della luce fino alle loro case. Anche questo è resistere all’occupazione. Ma nell’aprile 2012 l’Amministrazione civile [israeliana, in realtà militare, dei Territori occupati. N.d.tr.] ha emesso un ordine di demolizione dei pali elettrici. Sperando che il sistema israeliano dimostrasse un poco di correttezza, i residenti hanno iniziato una procedura amministrativa e legale per ottenere un permesso edilizio retroattivo per i pali. La demolizione ha avuto luogo nel bel mezzo di questa causa. Un arresto come quello di Zagharna ha l’obiettivo di far in modo che gli altri si sottomettano. I giudici militari devono essere semplici ingranaggi nelle ruote del grande bulldozer, ma sono ingranaggi con libertà di scelta. Un giorno si troveranno a dover difendere le loro decisioni in tribunale. Campagna Ponti e non muri Pellegrini di Giustizia 2015 per interviste e contatti con la stampa: 00972 543176361 15.07.15, Haaretz, (trad. di Amedeo Rossi) Fonte: Pax Christi Italia (fonte: Centro Studi Sereno Regis) link: http://serenoregis.org/2015/07/21/il-sistema-della-giustizia-militare-israelianouna-catena-di-montaggio-per-la-detenzione-di-massa-di-amira-hass/ (fonte: Pax Christi Italia) link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2320 Fuori dal coro: che montagna di ipocrisia... (di Campagna Ponti e non muri, Pellegrini di Giustizia 2015) Scusate, ma stando qui in Cisgiordania non si può non rimanere fuori da questo coro di commossa condanna e sgomento che tutti accomuna, nel nome del piccolo Ali, ucciso a Nablus. Anzi, se foste qui sareste nauseati dall'insistenza con cui i media italiani continuano a riproporre le immagini della casa di questo bambino data a fuoco dai coloni, semplicemente perchè dalla mattina alla sera vediamo centinaia di bambini come Ali minacciati dai soldati e aggrediti dai coloni. Ma essi non fanno notizia. E delle migliaia di Ali arrestati e detenuti non si deve parlare, come d'altra parte nessuno ha pubblicato anche solo una foto come quella di Ali per qualcuno deI quasi 500 (cinquecento) bambini massacrati esattamente un anno fa a Gaza. Nessun servizio di questi giorni ha accennato al primo anniversario del massacro di più di duemila palestinesi. Se foste qui non dareste certo credito alla “dura condanna” di Natanyahu verso questi “estremisti”, semplicemente perchè questi signori sono la maggioranza del suo governo ultranazionalista, con i leader più violenti dei coloni ad occupare le più alte cariche di governo. Se come noi aveste gli occhi pieni di queste “cittadine ebraiche” (così definiva gli insediamenti un giornale italiano) che crescono come funghi in territorio non “conteso” ma palestinese, non credereste certo alle dichiarazioni del ministro per la sicurezza, per cui “dovremo imparare la lezione”. Infatti il governo sta approvando anche in questi giorni nuovi piani di “sviluppo” con la costruzione di centinaia nuove case. Ma questo non scandalizza nessuno. Avremmo piuttosto voluto avere con noi anche un solo giornalista ieri a Bir Zeit, a pochi minuti dalla casa del giovanissimo Mohammed ucciso l'altro ieri dall'esercito, quando abuna Manuel, per tanti anni parroco di Gaza, ci ha chiesto di smuovere i nostri governi tiepidi ed incapaci di “dire la verità dei fatti che ha un nome: occupazione israeliana, così come hanno un nome le quattro colonne della pace: giustizia, verità, sviluppo e perdono. Tutte necessarie, certo, anche se per la Palestina e per la sua pace andrebbero puntellate soprattutto le colonne della giustizia e della verità!” E se dall'Italia la commozione dello Stato d'Israele vi è apparsa sincera nei confronti di un bimbo di 18 mesi bruciato vivo nella sua casa, abbiamo accolto con ben maggior credito le parole dell'amico israeliano Zvi Shuldiner, che ieri a Gerusalemme ci ha descritto come “un coro di ipocriti” queste condanne di suoi connazionali. “Tutti ripetono all'unisono: atto orribile e deprecabile! E così noi in Israele siamo soddisfatti, continuando indisturbati a tenere quattro milioni di palestinesi chiusi nell'enorme carcere gestito dall'”unica democrazia del medioriente”. E magari da voi in Italia tutti avranno pensato: guarda che grande prova di etica hanno dato i governanti israeliani!” Insomma, forse vi sembrerà strano che, vista da qui, non ci appare affatto positiva questa commozione generale per la terribile morte del piccolo Ali, perchè se il cittadino israeliano Shuldiner descrive i suoi governanti come “un coro di ipocriti”, a noi, cittadini italiani che in questi giorni ci ostiniamo a dar voce ai milioni di palestinesi schiacciati dall'occupazione e dalla colonizzazione, quella dei nostri media e dei nostri politici ci appare più che un coro: una montagna di ipocrisia. 13
Scaricare