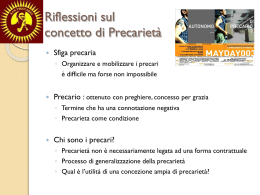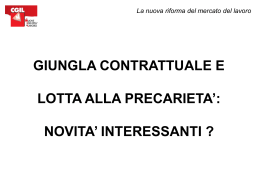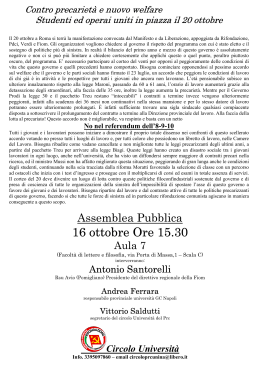Aris Accornero I precari non sono tanti, ma la precarietà sì: come mai? Ma davvero «siamo tutti precari>>?Quel che è certo è che condizioni dì lavoro precario e senso di precarietà del lavoro alimentano un malessere sociale che influenza i comportamenti, sia quelli individuali sia quelli collettivi. E che la precarietà, che spesso sisovrappone e si confonde con la flessibilità, è un carattere dominante della nostra società, da trattare con riguardo. L a precarietà del lavoro si è recentemente imposta all’attenzione come un tema cruciale, affrontato sia da documentari, film e siti web che raccontano storie di vita precarie, sia da ricerche e studi che hanno esplorato e analizzato il fenomeno’. Anche se la descrizione e la denuncia sono talvolta un po’ generiche, e se il termine stesso suona sfuggente e perfino ambiguo (il rotocalco del «Corriere della Sera» ha sparato l’immancabile titolone «Siamo tutti precari»), il fenomeno ha una sua pregnanza sociale, e un impatto non trascurabile sulla politica. Esso è stato riproposto dalla petizione di massa «Precariare stanca», lanciata da Stefano Rodotà in vista delle elezioni politiche2, mentre Fausto Bertinotti, neopresidente della Camera, ha affermato che la precarietà è «il male più terribile del nostro tempo». Del resto, dovrebbe pure insegnare qualcosa la rivolta dei giovani francesi, che hanno stoppato un contratto sul primo impiego assurdamente basato sulla libertà di licenziamento, cioè sulla precarietà dichiarata. Condizioni di lavoro precario e senso di precarietà del lavoro alimentano un malessere sociale che influenza i comportamenti, sia individuali sia collettivi. Non è necessario che il lavoro flessibile provochi mutazioni antropologiche (ieri Richard Sennett ipotizzava una «corrosione del carattered, e Luciano Gallino parla oggi di una «fragilizzazione» della personalità4):basta che nei giovani induca diffidenza verso l’ignoto e circospezione verso il futuro, frustrando gli stimoli a intraprendere, ad affermarsi, a creare. I1 modo in cui viene percepita e rappresentata la precarietà del lavoro influenza non soltanto i comportamenti dei singoli e delle famiglie ma anche quelli delle organizzazioni sindacali e delle forze politiche, le quali possono sbagliare sia quando vorrebbero evitare ai lavoratori le conseguenze delle novità, sia quando a forza di parlarne rischiano di creare una generazione di ansiosi. Affinché la precarietà non diventi una sindrome, bisogna affrontare il 483 tema con freddezza e serietà. I1 malessere che serpeggia non si può esorcizzare né sottovalutare: bisogna farci i conti. È qui che fanno difetto le recenti considerazioni di Pietro Ichino, troppo schiacciate sui dati statistici, da cui risulta che in Italia i lavoratori precari <<noncrescono>9.Effettivamente, nel 2005 la quota degli occupati temporanei è rimasta al 1 2 3 % (come nel 1999, nel 2002 e nel 20031, cioè a un livello inferiore alla media europea, che è stimata intorno al 13,7% e che viene superata da Francia e Germania. Le cifre non evidenziano dunque una precarietà diffusa, né ci piazzano fra i Paesi dove il lavoro flessibile ha colpito più duramente: l’Italia non è la Spagna. Però l’anno scorso il numero degli occupati temporanei ha superato i due milioni (2.027 mila) su un totale di 16 milioni e 534 mila occupati dipendenti. E anche se dal 1993 al 2005 il numero dei temporanei è cresciuto meno di quello dei permanenti (565 mila contro un milione e 773 mila), la dinamica dei primi ha nettamente superato quella dei secondi: 38,1% contro 13,3%. Così, secondo il sondaggio annuale svolto dalla Doxa-Gallup in 70 Paesi6, alla fine del 2005 appena 58 italiani su cento si sentivano sicuri del posto (contro i 69 dell’Europa occidentale), mentre ancora alla fine del 2001 erano 75 su cento; nel medesimo periodo erano saliti da 17 a 32 su cento gli italiani che temevano di perdere il lavoro. Analogo distacco aveva rilevato la Fondazione Europea di Dublino, che studia le condizioni di lavoro: il grado di soddisfazione del lavoro, misurato in termini di sicurezza del posto, vedeva l’Italia sotto la media europea7. Ecco dunque che il vero problema diventa questo: come mai da noi il senso di precarietà del lavoro è maggiore, benché la quota di precari sia minore? Di questo scostamento dovrebbero preoccuparsi anche gli esperti, e non soltanto i politici*. È altresì significativo che in Italia si preferisca parlare di precarietà anziché di insicurezza del posto, lajoob znsecuvzty cui è dedicata un’ampia letteratura sociologica e psicologica. Perché? Forse perché la dimensione temporale della precarietà non sembra poter durare indefinitamente, e deve quindi avere fine, mentre sembra impossibile conoscere il termine di scadenza dell’insicurezza, per cui non si può essere certi che finisca. Porre termine alla precarietà sembra dunque un obiettivo più credibile che porre termine all’insicurezza: alla prima non può che subentrare la stabilità, alla seconda soltanto la sicurezza, cioè qualcosa di un po’ meno «rassicurante». E poi la precarietà crea il tipo umano del lavoratore precario, mentre non si può dire che l’insicurezza crei il lavoratore insicuro.. . Un fenomeno non nuovo La precarietà, peraltro, non è un fenomeno nuovo. Chi ha una certa età ricorda i braccianti agricoli assunti a giornata, mentre i lavoratori delle costruzioni usufruiscono ancora oggi della Cassa edile, data la tipica instabilità del loro impiego. E questo vale anche per tutto il mondo dello spettacolo, tutelato dall’Enpals.Va ricordata altresì una categoria di precari universalmente riconosciuta, che opera proprio dove l’impiego è considerato più stabile e più sicuro, cioè nella pubblica istruzione. Chi non conosce qualche insegnante in attesa di supplenze che lo facciano entrare in ruolo dopo avere scalato le fatidiche graduatorie, periodicamente smaltite dal ministero con concorsi e sanatorie? Non solo. Lo Stato stesso, con il blocco numerico del turnover e con la fissazione dei tetti di spesa per i dipendenti, ha esteso l’area del precariato spingendo le amministrazioni locali e gli enti pubblici a utilizzare il contributo esterno di lavoratori temporanei, ma soprattutto di collaboratori coordinati e continuativi, che costano assai meno grazie allo sconto sui contributi previdenziali. È quindi per cattiva coscienza che la «riforma Biagi» ha esentato il pubblico impiego dalla novità del lavoro «a progetto», che avrebbe dovuto distinguere i veri para-subordinati dai dipendenti camuffati. È significativo che proprio questo tipo di rapporto, il più atipico in Europa, sia diventato l’emblema della precarietà. Qui da noi infatti è ritenuto precario non tanto chi lavora alle dipendenze con un contratto a termine, cioè il tipo di gran lunga più diffuso, e neppure il lavoratore interinale, il cui contratto è per definizione temporaneo, bensì il co.co.co., detto anche «autonomo di seconda generazione»Y.A costruire questa particolare immagine del lavoratore precario ha concorso innanzitutto l’uso disattento delle cifre. Basti dire che nel 2004 erano ismittiall’appositoFondo Inps ben 3 milioni e 373 mila co.co.co., di cui però meno di metà risultavano effettivamente attzui; fra questi, il gruppo più numeroso e l’unico omogeneo era costituito dagli amministratori di società, mentre i collaboratori «puri», privi cioè di tutele professionali e senza altri impieghi o proventi, erano circa 600 mila. A costruire l’idealtipo del precario ha inoltre concorso l’elevata visibilità dei collaboratori che operano presso giornali e riviste, radio e televisioni, case editrici e centri di ricerca, che offrono servizi qualificati alla persona o alle imprese, o che lavorano appunto per lo Stato, dai comuni alla sanità. Per inciso, la statistica non include nel lavoro temporaneo le prestazioni rese dagli autonomi, che come tali non sono né permanenti né temporanei. In Italia, questo è il caso delle «partite Iva» ma anche di quei para-subordinati meglio sarebbe chiamarli para-autonomi - che, non iscritti ad albi professionali, hanno rapporti con un solo committente, lavorano nella sua sede e con i suoi mezzi, dispongono di poca o nessuna discrezionalità, e spesso preferirebbero essere dipendenti veri anziché autonomi finti.,. Se li volessimo collocare fra i dipendenti e li aggiungessimo ai temporanei, l’area della precarietà si allargherebbe in Italia a 14 occupati ogni cento. L’area della precarietà Ciò che più espone il lavoro al rischio di precarietà è il carattere temporaneo di certe occupazioni. E infatti è questo il parametro che dà al fenomeno un fondamento empirico: in assenza di questa base, esso finisce nel vago come capita di sentire e di leggere con frequenza sconcertante. Naturalmente ci sono molte forme di precarietà. Ci si può sentire precari pur avendo un impiego permanente: basta che sia irregolare. Quanti sono i giovani, le donne e gli immigrati assunti sotto ricatto e costretti a lavorare «senza libretto», a spese delle assicurazioni, dei contributi, degli straordinari, della malattia o della «tredicesima», se non vogliono essere dasciati a casa»? Sono certo dei precari 485 ma non sono facili da contare, come i tanti dell’economia sommersa, che si stima siano un 10-15 per cento dei dipendenti. Beninteso, non tutti i rapporti temporanei sono anche insicuri, poiché una parte viene poi trasformata in impieghi permanenti; e non tutto il lavoro flessibile è anche temporaneo. Del resto, non più del 3 5 4 % delle imprese ricorre a contratti che «scadono». Vi sono inoltre dei rapporti temporanei in sé non precari, come quelli del lavoratore stagionale o del giovane apprendista. Per converso, non tutti i rapporti permanenti sono sicuri poiché possono sempre interrompersi in caso di crisi dell’azienda o di riduzione del personale: secondo I’Istat, il lavoratore permanente ha 4 probabilità su cento di perdere il lavoro nell’arco di un anno. Ma il lavoratore temporaneo ne ha 14. Ed è questa la vera novità: con il post-fordismo, il sistema delle imprese ha alterato le proporzioni fra gli impieghi permanenti e quelli temporanei. È un fenomeno ben databile’O. Fra i lavoratori nati nel 1950, ben 8 su 10 avevano sperimentato un impiego stabile, mentre fra quelli nati nel 1980 questa quota è scesa a 4 su 10: in sostanza, le probabilità dei 25enni di avere un impiego permanente sono oggi la metà di quelle che avevano avuto i 50enni. Che fra i lavoratori il senso di insicurezza e il rischio di precarietà crescano al diminuire dell’età - un fatto invero preoccupante - emerge puntualmente dalla ricerca sui cambiamenti del lavoro, recentemente presentata dai Democratici di sinistra”, che è la più vasta di questo genere (22.574 questionari, fra cartacei e online). Da una ricerca Isfol sulla qualità del lavoro svolta interpellando circa 2 mila lavoratori12,emerge altresì che le percezioni di precarietà del lavoro dipendono innanzi tutto dal rapporto di lavoro. Infatti, poco sicuri si sentono un po’ tutti gli occupati temporanei, a cominciare da chi lavora con un contratto a termine; meno sicuro è ritenuto il contratto interinale (o di «somministrazione temporanea»), benché un quinto-un quarto degli interessati abbia la probabilità di essere assunto; ancor meno sicuri sono ritenuti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di associazione in partecipazione e di socio in cooperativa: infatti più di metà degli interessati si sente a rischio. Al top della precarietà si colloca ovviamente la prestazione occasionale. Tre profili Come sono distribuiti i lavoratori che affrontano percorsi lavorativi resi discontinui da contratti che «scadono»? I dati più affidabili sono rilevati dall’unioncamere-Excelsior presso circa 100 mila imprese private. Escludendo il pubblico impiego, nel 2004 i temporanei erano così distribuiti: 626 mila con contratto a termine, 359 mila apprendisti, 332 mila co.co.co., 283 mila stagionali e 198 interinali. Totale: un milione e 798 mila, cioè meno dei due milioni e 27 mila stimati dall’Istat, che però tiene conto anche dell’impiego pubblico e che conta circa 400 mila co.co.co. Fra questi, i lavoratori meno a rischio sono innanzitutto quelli assunti con contratti «a causa mista», che dovrebbero addestrare e formare i giovani al lavoro in vista di impieghi permanenti; e poi quelli assunti con contratti «stagionali», che si attendono impieghi per periodi ben delimitati. Quelli più a rischio sono gli altri. In primo luogo gli assunti «a tempo determinato», che formano il gruppo più tradizionale e più folto; poi gli assunti con contratto di «somministrazione temporanea», cioè gli interinali, il gruppo più nuovo e più piccolo; e infine i prestatori d’opera con rapporto di collaborazione para-subordinato, il gruppo più eterogeneo e più atipico. Questi tre profili hanno vari tratti in comune, a cominciare dalla circostanza che in maggiore o minore misura sono tutti esposti a incertezze sulla durata del posto o dell’incarico, e poi alle conseguenti traversie dei percorsi lavorativi. Ansie, attese e vuoti accompagnano sovente le transizioni da un contratto a un altro, anche quando viene semplicemente reiterato. Perfino chi ha scelto i rischi di carriere frammentate può andare incontro a ristrettezze, angustie e smarrimenti. Ma i tre profili presentano anche vistose differenze. Gli assunti a termine hanno di fronte l’imprenditore tradizionale, il quale spende per loro leggermente meno rispetto ai dipendenti stabili. Gli interinali hanno a che fare con due soggetti: l’agenzia che li assume e l’imprenditore che li paga, il quale spende per loro più che per i dipendenti stabili perché deve pagare il costo dell’intermediazione. I collaboratori hanno di fronte un committente rispetto al quale dovrebbero essere autonomi nel condurre l’opera e nel contrattare la remunerazione, il cui costo contributivo è la metà di quello corrente. Differenze profonde vi sono poi nei livelli di protezione in caso di perdita del posto. Chi ha un contratto a termine può contare soltanto sull’indennità di disoccupazione «a requisiti ridotti»; chi ha un contratto interinale può chiedere l’indennità esclusivamente se è stato licenziato, il che non succede mai; e chi ha un rapporto di collaborazione non ha diritto a un bel niente poiché non è (considerato) un dipendente. La discontinuità dei tragitti Rispetto agli altri lavoratori, quelli temporanei sperimentano per definizione un maggior numero di lavori e di impieghi. Ce ne sono che cominciano male perché si intoppano presto in lavori di basso profilo e/o impieghi di breve durata, e altri che procedono a casaccio fra lavori ed impieghi sia buoni che cattivi senza approdare da qualche parte. Ci sono invece lavoratori che cominciano bene e non hanno grossi problemi perché poco dopo trovano una sistemazione accettabile, e altri che cercano di tracciare o di seguire dei sentieri più individualizzati fra lavori e impieghi. Soltanto i primi rischiano di precipitare o di rimanere nella precarietà, e non paiono in maggioranza: secondo Massimo Paci, «gli studi condotti fino ad oggi non permettono di attribuire sempre al lavoro flessibile e temporaneo la natura di una “condanna per la vita”»13. I tragitti dei lavoratori temporanei possono comunque essere considerati una «grande giostra»?14 In senso stretto la risposta è no, perché viene per molti il giorno in cui si stabilizzano con un rapporto permanente. Per molti, ma non per tutti: dipende. I più sfavoriti sono i giovani (più le femmine dei maschi), che stanno dando il maggior contributo alla flessibilità del lavoro e i cui tragitti lavorativi sono i più travagliati. Uno studio evidenzia che alla prima assunzione soltanto 3 su dieci hanno un contratto stabile; dopo tre anni 487 essi diventano 6 su dieci, e dopo sei anni arrivano a 8 su dieci. Le conclusioni sono che «il rischio di entrare nel circolo vizioso della precarizzazione non è elevatod5. Però in senso lato la risposta è sì, l’impressione è quella di una «grande giostra». Infatti con il post-fordismo i tragitti lavorativi tendono a diventare più discontinui, più compositi, talvolta più frammentati: anche il «posto fisso» è meno fisso di ieri. Da qui i rischi di precarietà che, pur non essendo dominanti o irrimediabili, non vanno sottovalutati in quanto generano allarme sociale. Orbene, è improbabile che i lavoratori temporanei aumentino indefinitamente, facendo via via crescere i soggetti precari; ed è altrettanto improbabile che un numero via via maggiore di lavoratori rimanga meno tempo nello stesso posto, facendo crescere indefinitamente il senso di precarietà. Ma gli itinerari lavorativi non dovrebbero penalizzare chi si rende più flessibile e dovrebbero consentire approdi più stabili: una mano d’opera che ruota perennemente non conviene neppure alle imprese16. Purtroppo, con la eriforma Biagi» le modalità d’impiego sono diventate dawero troppe (il centrodestra ha introdotto ben 11 rapporti temporanei), e questo complica e disarticola i tragitti in sequenze non facili da seguire e tanto meno da tutelare, sia per gli organizzatori sindacali che per gli ispettori del lavoro. L‘Istat ha contato 2 1modalità di rapporto atipiche, che salgono a 48 se si distingue fra quelle a tempo pieno e quelle a tempo parziale: 34 sono atipiche in senso stretto, come la collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro a chiamata (lob-on-calo,il lavoro condiviso (lob sharing),la «somministrazionea tempo indeterminato» (stafileaszng);14 sono parzialmente atipiche, come l’interinale o «somministrazione a tempo determinato», il lavoro stagionale e il telelavoro. Secondo la durata del rapporto, 12 modalità sono permanenti e 36 temporanee; secondo la natura del rapporto, 29 sono alle dipendenze e 9 autonome; secondo le garanzie previdenziali, 28 danno pieni diritti e 20 diritti ridotti. Infatti le tante novità intervenute - dalla normativa sui co.co.co. che risale al 1995 a quella sul lavoro accessorio (voucher)definita all’inizio del 2006 - hanno reso diseguali i regimi di protezione, e questo non può che alimentare il senso di precarietà. Sul quale influisce molto il fattore tempo. Psicologi e sociologi, studiando gli effetti della disoccupazione dopo la grande crisi del 1929, scoprirono che la mancanza di lavoro determina sul singolo effetti progressivi che dipendono essenzialmente dalla sua durata. Oggi, ciò vale anche per la precarietà del lavoro17. Impieghi disparati, occupazioni precarie, posti che vanno e vengono, periodi di prova interminabili, itinerari professionali incerti, vuoti di tutela, difficoltà a ottenere crediti: tutto questo influisce sui progetti personali e sui destini familiari, generando ansie e timori che demotivano e deprimono. Nei giovani, ciò ritarda l’emancipazione dalla famiglia d’origine e condiziona le scelte relative al matrimonio e all’avere figli. Ne deriva un senso di impotenza e di vulnerabilità che coinvolge anche i parenti. Cause dei senso di precarietà Secondo Emilio Reyneri, le statistiche sul mercato del lavoro italiano «non fanno pensare ad una precurizzuzzone destinata a crescere ininterrottamente>P. Dal canto suo, Luca Ricolfi, in base ai dati forniti dall’Istat, contesta l’ipotesi Ma il problema è proprio questo: perché gli italiastessa della precarizza~ione’~. ni si sentono via via meno sicuri del posto, e più timorosi di perderlo? Lo «sventagliamento» tipologico è una risposta. Molti italiani sono infatti convinti che il lavoro flessibile ha creato tanta precarietà perché il «pacchetto Treu» varato dal centrosinistra nel 1997, e soprattutto la «riforma Biagi» approvata nel 2003 dal centrodestra, hanno accresciuto le modalità d’impiego senza adeguare il sistema delle tutele. Il governo Berlusconi era addirittura convinto che con più modalità d’impiegoe più soggetti di intermediazione si sarebbero creati più posti: bastava che sul mercato ce ne fosse in quantità tale da soddisfare ogni necessità. Così ci troviamo con tanti, troppi tipi di contratto «alla carta», e troppe agenzie che dovrebbero far incontrare domanda e offerta: oltre a quelle private, infatti, sono stati abilitati anche enti locali, università, scuole, Camere di commercio, consulenti del lavoro: mancano soltanto le parrocchie.. . Ma i monitoraggi sui risultati della eriforma Biagi» dicono che tutta questa ridondanza non serve e non paga. Dopo avere interpellato un campione di 2.056 imprese con 560 mila dipendenti, la Confindustria riconosce che l’utilizzo dei nuovi tipi di contratto - stucchevolmente magnificati dal quotidiano confindustriale - è stato «sostanzialmentenullo, o marginale»; e 1’Unioncamere rileva che soltanto il 4 % delle imprese ha usato i nuovi soggetti d’intermediazione. Del resto, a cominciare dagli Stati Uniti, i Paesi industrializzati se la cavano con 5-6 tipi d’impiego e di agenzie. Non si può quindi dire che la «riforma Biagi» ha creato tanta precarietà, anche perché ha creato pochi posti. Però ha sicuramente alimentato la paura della precarietà: com’è possibile creare per legge il lavoro a chiamata (fallito anche alla Zanussi, dov’era stato sperimentato) senza considerare che, per sua natura, esso fa temere una nuova «ferita dell’esistenza,una fonte immeritata di ansia», come ha scritto Gallino? I1 punto è che nell’ultimo decennio il centrosinistra e il centrodestra hanno reso più flessibili le norme sul lavoro e sul mercato del lavoro, senza impostare un sistema di sicurezza sociale all’altezza dei cambiamenti introdotti. Ambedue le coalizioni si erano impegnate a farlo, ma non l’hanno fatto; neppure quella che per cinque anni ha goduto di una forte maggioranza. L‘una aveva parlato di una Carta dei lavoratori, l’altra di uno Statuto dei lavori, che però sono rimaste delle buone intenzioni. Un tale nulla di fatto spiega la sensazione diffusa che nella corsa alla flessibilità i perdenti abbiano superato i vincenti, e che la precarietà stia crescendo. Nella nuova regolazione del lavoro c’è in sostanza un grosso vuoto, e ciò non può che preoccupare. È qui che l’Italia fa difetto, rispetto a Paesi come l’Olanda e la Germania, che hanno cercato di adeguarsi al modello post-fordista. Da noi, invece, la spesa per i sussidi di disoccupazione e la percentuale di disoccupati indennizzati sono tuttora a livelli infimi, e per di più non sono previste forme di contrasto all’esclusione sociale (il centrodestra ha sospeso la sperimentazione sul reddito minimo di inserimento introdotta dal centrosinistra nel 1998e ha congelato la successiva legge n. 328 del 2000). I1 senso di precarietà ha dunque la sue buone ragioni. Perciò sbaglia chi se la prende con «la gente» perché soggiace alle impressioni. Infatti non è ammissibile che la regolazione del lavoro venga modificata e financo stravolta come nell’ultimo decennio, mentre le due coalizioni promettono, annunciano e poi rinviano la riforma degli «ammortizzatori sociali», un’espressione in sé già penosa e pelosa. Essa legittima infatti il sospetto di un ricorso a mezze misure, se non altro perché richiama un contesto storico-sociale in cui la famiglia tamponava le falle lasciate dalle politiche pubbliche facendo appunto da «ammortizzatore sociale». È un’espressione che dovrebbe essere ripudiata da chi ha capito la portata della trasformazione in atto nel lavoro. La trasformazione dei lavoro La trasformazione in atto è la terza, dopo la rivoluzione industriale avvenuta nel Regno Unito fra il Settecento e l’ottocento, che aveva creato il lavoro salariato; e dopo l’invenzione del taylor-fordismo negli Stati Uniti del primo Novecento, che aveva assicurato il predominio al lavoro industriale. I1 capitalismo delle prime manifatture aveva irreggimentato le masse operaie portate in fabbrica, mettendole a servire le macchine. Poi il capitalismo della produzione di massa ha standardizzato il lavoro, pre-determinandone i tempi con i sistemi di cottimo e i modi con la «catena di montaggio». Oggi il turbo-capitalismo post-fordista sta destrutturando e frastagliando l’impresa e il lavoro, mediante la produzione sneila e gli impieghi flessibili. Dalla fatica si è passati allo stress, dalla monotonia alla frenesia, dall’insensatezza al coinvolgimento, dai vincoli alle responsabilità, dalla rigidità alla flessibilità. Nell’Ottocento si temeva la frantumazione del lavoro e la degradazione dell’uomo; nel Novecento si temeva la dequalificazione del lavoro e l’alienazione dell’uomo; oggi si teme la precarizzazione del lavoro e la fragilizzazione dell’uomo. E stavolta le minacce non sembrano più provenire dalla tecnologia come nell’Ottocento, o dall’organizzazione come nel Novecento, bensì dal mercato2’. Secondo Ulrich Beck, Zygmunt Bauman e Robert Castel, ciò adombra una società «del rischio», o «dell’incertezza», o «dell’insicurezza». Può essere che il futuro non sia così fosco e che non si vada incontro ad una apocalisse del lavoro; ma le prospettive appaiono incerte. I1 fatto cruciale è che il post-fordismo sta rendendo flessibile il lavoro quasi quanto il fordismo lo aveva reso rigido. Nelle sue varie forme, la flessibilità influisce sul lavoro e sul lavoratore con effetti meno collettivi e più individualizzati di ieri, e fa sì che oggi il percorso conti a volte più del posto giacché le modalità d’impiego tendono a variare, la mobilità del lavoro a crescere e le anzianità aziendali ad accorciarsi. Non occorre evocare spettri o catastrofi: basta tenere presente che l’impresa nasce e muore, si fonde o si scinde, si integra o si smembra, piU in fretta e piU spesso di ieri. Tutto ciò comporta maggiori rischi, ma anche maggiori opportunità, sia negli itinerari professionali che nei percorsi di carriera e nella stessa mobilità sociale. L‘aspetto sistemico più rilevante è che le discontinuità possono rendere tortuosi e defatiganti i tragitti lavorativi. Quando poi si ripetono o si protraggono senza sbocchi stabili (quando ci si «insedia nella precarietb, dice 490 Castel*l),il lavoratore sente che il traguardo della buona occupazione si allontana e pensa che la formazione professionale non serva a niente. Così pure, la crescita della precarietà vanifica la crescita della qualità: cosa importa se oggi il lavoro sporca assai meno, comporta meno fatica, e soprattutto richiede più intelligenza? Antidoti aila precarietà dei Lavoro Che fare? Un rimedio sarebbe quello di ridurre le discontinuità, ma le possibilità di farlo sono limitate, né si potrebbe tornare al fordismo. Ha scritto Bruno Trentin: «Sono convinto che la flessibilità delle produzioni e dei servizi e la stessa flessibilità del lavoro - comunque si voglia chiamarla - sono un effetto oggettivo. Non penso che questa trasformazione strutturale del lavoro e della sua organizzazione possa essere esorcizzata con una normativa pubblica che ci riporti coattivamente ai contratti a tempo indeterminato»22.E Carlo Dell’Aringa: «I1lavoro a termine, quando diventa una trappola da cui è difficile uscire, diventa un problema sociale serio. I1 rimedio non è certo quello di abolire la flessibilità, che significherebbe ricacciare i lavoratori verso forme estreme di precarietà»23. La soluzione dunque non sta soltanto nel ridurre le discontinuità e nell’aumentare le coperture, ma proprio nel ridisegnare le tutele. Infatti la precarizzazione del lavoro non è affatto la conseguenza naturale del lavoro flessibile. È un rischio che subentra soltanto se il lavoro viene reso flessibile senza adeguati strumenti di tutela, senza un adeguato apparato di tutele. E questo succede quando imprese, Stato e società non si sono fatti carico deile conseguenze sociali ed umane della fle~sibilità~~. Chi passa da un impiego temporaneo a un altro non può ritrovarsi solo e sentirsi nessuno. Dovrebbe invece avere gli stessi identici diritti di chi passa da un impiego stabile a un altro: semmai merita qualcosa in più, non in meno. Coloro poi che nei propri tragitti incrociano modalità diverse di impiego temporaneo, magari intercalate da periodi di inattività o da lavori in nero, si sentono ancor più soli. Del resto, il lavoratore temporaneo che passa da un posto ail’altro, da un impiego all’altro, da un contratto d’altro, non cumula nessun beneficio, precedenza, anzianità, diritto, neppure se viene impiegato più volte dalla medesima impresa con un contratto a termine. (In questo caso - stabilisce la «riforma Biagi» - può essere preferito nelle assunzioni a tempo indeterminato, ma ci vuole l’intervento dei sindacati e comunque deve averne fatto domanda «a suo tempo»: quindi questa seniority non gli spetta di diritto.) Insomma, il lavoratore involontariamente temporaneo che transita da un lavoro all’altro resta in balia del mercato invece di essere aiutato a trovare un’occupazione a tempo indeterminato, se la vuole. Dal momento che il lavoro flessibile è necessario alla collettività, sarebbe più giusto che chi passa attraverso una pluralità di impieghi avesse almeno qualche vantaggio, e non dovesse soltanto accollarsi rischi, costi, e perfino penalità. A chi ha reiterato più impieghi temporanei nella medesima impresa si possono accordare contribuzioni «figurative» per la pensione e un diritto di seniority nelle assunzioni stabili. Ma si possono fare tante cose. Fissare dei 491 limiti alle reiterazioni del contratto, come ieri in Olanda e oggi in Spagna. Garantire una piena esigibilità delle anzianità lavorative e delle credenziali assicurative maturate, anche ai fini della «totalizzazione» dei contributi recentemente approvata. Prevedere un fondo per il mutuo casa a copertura delle garanzie bancarie, e dei contributi per l’affitto di un’abitazione. Uniformare le aliquote contributive per tutti i rapporti di lavoro, come base materiale di una eguaglianza delle opportunità previdenziali. Predisporre una copertura finanziaria obbligatoria (al di là della singola durata contrattuale), per attività formative che aiutino lo sviluppo professionale e il riconoscimento delle competenze. Sono idee già in circolazione. Quel che manca ancora, però, è l’enunciazione di un nuovo principioguida per la sicurezza sociale in epoca post-fordista, un principio che vada oltre la tradizionale difesa del posto e impronti un Welfare State universalistico all’altezza dei tempi. Lo Stato deve garantire una continuità di cittadinanza del lavoro nella discontinuità dei tragitti lavorativi. Questo principio deve tutelare ogni tipo di lavoro economicamente dipendente, sia temporaneo che permanente, sia a tempo parziale che a tempo pieno, mediante una rete di protezione leggera e uguale per tutti, che «tenga insieme» i tanti soggetti e percorsi del lavoro. È una necessità che oggi riconosce anche Sennett, nel suo ultimo lib1-0~~: infatti non basta deprecare i rischi cui va incontro l’uomoflessibile. D’altronde, chiediamoci perché non si sono awerate le fosche profezie del passato circa le conseguenze sociali e umane delle trasformazioni nel lavoro. Una spiegazione è che i grandi pensatori del passato consideravano fatali le tendenze in atto perché sottovalutavano gli effetti dell’iniziativa pubblica, dell’azione collettiva, del dialogo sociale. Sottovalutavano il socialismo scientifico, il comunismo utopista e il solidarismo cattolico; sottovalutavano gli Knights of Labor, le Trade Unions e le Chambres du Travail; sottovalutavano von Bismarck che combatteva la socialdemocrazia con le riforme, Samuel Gompers che lottava per la «coscienza del posto», e i coniugi Webb che predicavano la «democrazia industriale». Anche oggi, come nell’Ottocento e nel Novecento, gli esiti della grande trasformazione dipendono dal modo in cui, durante questo passaggio storico, il lavoro verrà difeso con i contratti, con le leggi, con gli accordi. Questa è la lezione del passato. Non basta appellarsi alla «responsabilità sociale dell’impresa». Nella Direttiva del 28 giugno 1999 l’Unione europea ha solennemente ribadito che il contratto a tempo indeterminato è «la forma comune» di rapporto di lavoro. L‘accordo fra le confederazioni europee dei lavoratori e degli imprenditori afferma a sua volta che l’impiego a tempo indeterminato è la <<formaordinaria di assunzione e di prestazione». Bene. Questo orizzonte va difeso e affermato. note ’ Vedi per tutti L. Gallino, Il costo umano della jlessibzlità, Roma - Bari, Laterza, 2001; G. Fullin, Vivere l‘instabilità del lavoro, Bologna, I1 Mulino, 2005. Commentando i risultati, l’amico Rodotà ha scritto su «la Reppbblica» del 24 aprile scorso che «il voto dei più giovani per l’Unione è anche il segno di una speranza». E molto probabile, ma l’esigua differenza registrata fra Camera e Senato rende arduo vederci anche lo scontento per l’impiego stabile che tarda. 492 R. Sennett, L'uomo flessibile (The corrosion ofcharacter), trad. it. Milano, Feltrinelli, 1999. L. Gallino, Se il futuro si tinge di nero, <<laRepubblica», 28.3.2006. 5 P. Ichino, Ma iprecari non crescono, «Corriere della Sera», 26.4.2006. Doxa-Gallup, Sondaggio difine anno sulle previsioni 2006 in Italia e all'estero, dicembre 2005. 7 European foundation for the improvement of life and working conditions, Third European survey on working conditions 2000, Dublin, 2001. * Mi permetto di rinviare al mio libro San Precario lavora per noi, di imminente pubblicazione per i tipi Rizzoli. 9 S. Bologna e A. Fumagalli (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia, Milano, Feltrinelli, 1997. lo Si veda l'indagine longitudinale su 4 mila famiglie e i 0 mila individui curata da A. Schizzerotto, Vite ineguali. Disuguaglianze e corsi di vita nell'italia contemporanea, Bologna, I1 Mulino, 2002. 'I M. Carrieri. C. Damiano e B. Uaolini (a cura di). Il lavoro che cambia. La r>iùvasta ricerca suilavoratori italiani, Roma, Ediesse, 2005. " 'I Isfol, La qualità del lavoro in Italia, a cura di M. Curtarelli, L. Incagli e C. Tagliariva, Roma, 2004. '3 M. Paci. Nuovi lavori. nuovo Welfare. Bologna. I1 Mulino. 2005. Agenzia' per l'Impiego del Veneio, Solo &a grande giostra? La dfiusione del lavoro a tempo determinato, a cura di A. Accornero, B. Anastasia, M. Gambuzza, E. Gualmini e M. Rasera, Milano, Angeli, 2000. '5 Vedi A. de Angelini, Mobilità e percorsi di ingresso nel lavoro dei giovani, nell'importante volume curato da B. Contini e U. Trivellato, Eppur si muove.. , Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano, Bologna, Il Mulino, 2006. l6 A. Accornero, G. Altieri e C. Oteri, Lavorojlessibile. Cosa pensano davvero imprenditori e manager, Roma, Ediesse, 2001. '7 B.J. Burcbell, The welfare costs ofjob insecurity: Psychological well-being and family lzfe, in Council of Europe, Reconciling labourjlexibility with social cohesion, Strasbourg, 2005. * E. Reyneri (a cura di), Il lavoro a progetto: uno studio interdisciplinare e comparato, Bologna, I1 Mulino, 2006. ' 9 L. Ricolfi, Tempo scaduto. I l «contratto con gliitaliani» alla prova deifatti, Bologna, I1 Mulino, 2006. lo Si veda A. Accornero, Epoche di storia e futuro del lavoro, in AA.VV., Enciclopedia Nova. Scenari del XXI secolo, Torino, Utet, 2005. " R. Castel, L'insicurezza sociale. Che cosa significa essere protetti, trad. it. Torino, Einaudi, 2004. 22 B. Trentin, Lavoro e libertà, in AA.VV., La «legge Biagis. Anatomia di una riforma, Roma, Editori Riuniti, 2006. '3 C. Dell'Aringa, Flessibilità sì, ma non eterna, «Il Sole-24 Ore», 13.1.2006. '4 A. Accornero, Different kinds of flexibility: Reconciling dzfferent interests, in Council of Europe, Reconciling labour flexibility with social cohesion, cit. ' 5 R. Sennett, La cultura del nuovo capitalismo, trad. it. Bologna, I1 Mulino, 2006. 3 4
Scaricare