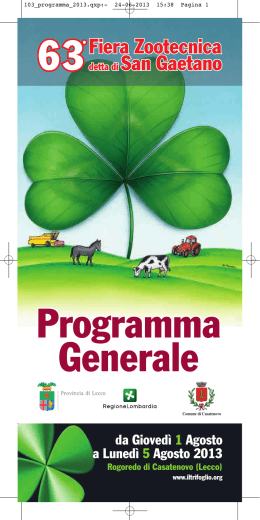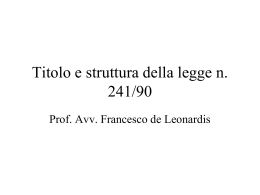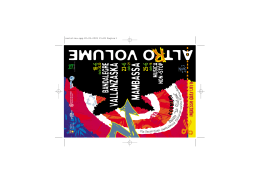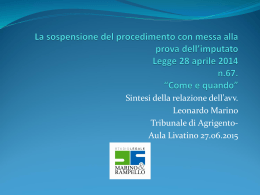rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 1 La rassegna stampa di Oblique «“Cosa vai a tirare fuori queste miserie? – dirà forse qualcuno. – Lasciale stare dove sono”. Ma allora come si fa a capire, non in linea generale, con discorsi astratti, come stanno davvero le cose, come funziona tutto quanto nel nostro paese, anche nel piccolo, misero Antonio Moresco mondo larvale in via di estinzione della cultura?». novembre 2008 – «Gian Burrasca come Marinetti, evviva i futuristi!» Mirella Serri, Tuttolibri della Stampa, primo novembre 3 – «Antonio Moresco, lettera ai conformisti dell’editoria italiana» Francesco Borgonovo, Libero, primo novembre 5 – «La sagra dell’editoria» Luigi Mascheroni, il Giornale, primo novembre 8 – «Così i libri diventano carta da macero» Paolo Bianchi, il Giornale, 2 novembre 10 – «La vita tumultuosa di Lee Miller, divina davanti e dietro l’obiettivo» Sandro Fusina, Il Foglio, 8 novembre 13 – «Il patriottismo insetticida di Marinetti» Antonio Carnevale, Panorama, 11 novembre 19 – «Il trionfo del Gattopardo», Gioacchino Lanza Tomasi, la Repubblica, 11 novembre 20 – «Franz Kafka e l’arte di disegnare gli incubi» Luigi Mascheroni, il Giornale, 14 novembre 23 – «Sono io il nuovo Bukowski» Alessandra Farkas, Corriere della Sera, 17 novembre 25 – «Gli scrittori italiani si occupano di realtà o di ideologia?» Mario Baudino, La Stampa, 19 novembre 27 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 2 – «Il gusto del fallimento» Francesco Borrelli, il manifesto, 22 novembre 29 – Se potessi vendere almeno 150mila copie» Mirella Appiotti, Tuttolibri della Stampa, 22 novembre 31 – «“Caro Hesse, come devo tradurre...”» Armando Torno, Corriere della Sera, 24 novembre 33 –«Vita ingrata del traduttore prigioniero di due lingue» Alessandra Iadicicco, il Giornale, 26 novembre 35 – «E l’italiano arrivò a quota 220mila» Roberto Beretta, Avvenire, 27 novembre 37 – «Crossover. Quando il best seller per ragazzi piace agli adulti. E quello per adulti piace ai ragazzi» Matteo Nucci, Il Venerdì della Repubblica, 28 novembre 39 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 3 «GIAN BURRASCA COME MARINETTI, EVVIVA I FUTURISTI!» Dalla copertina di «Porci con le ali» alla dissacrazione dei «Compagni», al giallo Mirella Serri, Tuttolibri della Stampa, primo novembre 2008 con Vanessa gay: una libido creativa Scrittore Italiano preferito? «Non ho dubbi, Antonio Pennacchi». Proprio lui? Proprio l’autore più rifiutato dello Stivale che ha ricevuto ben 55 no da 33 editori con il primo libro? «Poi, per mia fortuna, ce l’ha fatta, ha pubblicato parecchio. Viaggio per le città del duce (appena uscito da Laterza, n.dr.), ad esempio, è bellissimo. Ci sono narratori come Pennacchi o Cormac McCarthy che mi dispiace non facciano uscire un racconto tutti giorni. È in linea con i grandi paranoidi: Céline, Rousseau, Thomas Bernhard. Aggiungerei pure Dostojevskij, ma è troppo, non esageriamo». E l’autore del Fasciocomunista? Entusiasta per tanta considerazione? «Non proprio. È venuto a trovarmi a casa. Voleva litigare. Ha cominciato col dire che il futurismo faceva schifo». Per qualsiasi altro, un giudizio inoffensivo, ma una provocazione, uno schiaffo in faccia a Pablo Echaurren, artista polimorfo perverso quanto a libido creativa – pittore, fumettista, ceramista, romanziere, musicista – ma bibliofago (come si autodefinisce) e collezionista di tomi, con un’unica, immensa passione, Marinetti & C. Di miti ne coltiva tanti Echaurren, figlio d’arte del grande surrealista cileno Sebastian Matta. Il prolifico artista-betoniera (altra auto definizione), da quando aveva 17 anni macina quadri, giornali, libri, film, arazzi, copertine di libri che hanno spopolato, come Porci con le ali. Una sua mostra antologica si è tenuta al capitolino Chiostro del Bramante mentre le opere più recenti sono state proposte all’Auditorium di Roma. Adesso ha aggiunto un altro tassello alla sua personale mitologia, la parodia dei romanzi-noir destinati a diventare testi di riferimento nelle biblioteche dei giallisti: Le memorie di Vanessa (uscita da Fernandel editore) è un nuovo racconto della serie di Echaurren dedicata al commissario Vanessa Tullera («la mia poliziotta sta a Maigret come la mia casa editrice sta alla Adelphi», precisa), agente gay, forte e determinata in un giallo delirante, dove tra giochi di parole e ironie, si prende di petto lo splatter, l’anatomopatologia e il mondo dell’arte. A proposito di libri-culto, l’altarino di Echaurren vede in primo piano Porci con le ali, il racconto tutto sesso e politica scritto do Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera. Lei gli diede la definitiva consacrazione per il successo con la cover che mescola nudità varie e musi di maiali? «Quando dalla casa editrice Samonà e Savelli mi chiamarono per fare la copertina non chiesi di leggere il libro in procinto di essere stampato. Meglio non mettere limiti all’immaginazione, mi sono detto. Con il romanzo mi sono cimentato parecchio tempo dopo e per quella copertina non sono nemmeno stato pagato. Nel gruppo dei giornalisti di Lotta continua, di cui facevo parte, quel racconto però non era ben visto, era sinonimo di voyeurismo piccolo borghese con l’obiettivo di far quattrini. Io mi adattavo e se qualcuno mi chiedeva: “Sei tu quel Pablo della copertina?”. La risposta era:“Macché. È un altro”». I suoi autori di riferimento in campo artistico? «Erano sulle pareti di casa di mia madre. Tappezzata di Mirò, Calder, Max Ernst, Capogrossi – Forchettone. Mamma di quadri ne aveva parecchi, regalò alcuni Burri per cui ancora oggi mi mangio le mani. Mirò sì è sovrapposto a Topolino, con le due orecchione nero e la giacchetta gialla, e così, tra cartoon e passione per l’avanguardia,è nata la mia tecnica grafica». Libri letti da ragazzino? «Scritti di tassidermia, con le tecniche rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 per imbalsamare cadaveri e per impagliare gli animali. Gian Burrasca che oggi mi ricorda Marinetti. Il Signor Bonaventura con la caratteristica marsina, faccia ovale, il naso a virgola, prima squattrinato poi milionario. Al personaggio di Sergio Tofano mi accomunava la conquista dell’assegno da un milione. Ho 17 anni quando incontro il pittore Gianfranco Baruchello che mi presenta al critico e collezionista milanese Arturo Schwarz, cultore del dada surrealismo in Italia, che mi fa firmare un contratto di esclusiva. Compenso? Un milione». Letture scolastiche? «Frequentavo il severissimo liceo classico Giulio Cesare. Ero un allievo svogliato. Avevo i capelli lunghi, suonavo il basso ed ero un cubista,nel senso che ballavo sui cubi del Piper, marinavo la scuola un giorno sì e uno no. L’unica cosa che mi interessava erano i coleotteri.Informatissimo,aspettavo quella fatidica ora di scienze in cui la prof avrebbe affrontato quel capitolo. Avrei finalmente esibito tutto il mio sapere. Ma quel giorno ancora una volta saltò la scuola. Una fregatura. Mi innamoro di Italo Calvino, a cui poi manderò un mio disegno, e lo propongo come autore per la maturità. Ma il docente, avendolo scambiato per il riformatore di Ginevra, mi dice “lascia stare gli stranieri”. La musica era un’altra delle mie passioni: dai Beatles agli Animals ai Rolling Stones. Maledetti gli anni in cui diventa dominio dei cantautori: da Guccini a Dalla non li ho mai digeriti. Un giudizio sul quale, l’ho scoperto successivamente, non sono fortunatamente solo. Valerio Floravanti, il terroristsa nero con cui ho lavorato a quattro mani al film documentario Piccoli ergastoli e poi a Il ritorno di Silvio Pellico, Rebibbia rhapsody,tutti sul tema della condizione carceraria, condivide questa idiosincrasia. Per oblique studio Pagina 4 me, gli anni pre ’68 sono una stagione calda, di colori e di speranze e anche di musica propulsiva e vitale, poi con il ’68 tutto si trasforma e si incupisce in un plumbeo color verde militare». I sacri testi del movimento degli anni Settanta glieli fanno scoprire quegli intellettuali di sinistra a cui nel suo libro Compagni dedica sulfuree pagine? Bernardo Bertolucci, per esempio, descritto come un cineasta due pesi-due misure che, nei salotti borghesi, si scaglia contro lo sciopero dei lavoratori di Cinecittà «poiché dal momento che era lui a farli lavorare, scioperare era come boicottare sé stessi e i propri interessi»? Nanni Balestrini molto vanesio, «lo vedevi girare per mostre, librerie, manifestazioni con la testa sempre volta all’insù»: Paolo Flores d’Arcais: «Un tombeur de femmes implacabile… abitava a Monteverde e la sua era la casa più sporca e incasinata che avessi mai visto». «L’unico che si è un po’ arrabbiato per questi miei giudizi è il direttore di MicroMega. Ma non mi è chiaro il motivo. Tutte le abitazioni dei compagni “non brillavano”. Ho convissuto per qualche tempo con Paolo e altri amici. I vetri del suo bagno credevamo fossero smerigliati per quanto erano opachi. Collaboratore e poi redattore di Lotta continua non ero ben visto per il mio temperamento anarchico. Adriano Sofri mi consigliava di leggere le vita dei santi e Gad Lerner mi apprezzava. Ma tutto nasce con Massimiliano Fuksas. Dopo un’accanita discussione, punta il dito accusatore: “Non hai mai letto una riga di Marx ed Engels!”, sbraita. Era proprio vero. Da quel momento, addio agli amori precedenti». Dostoevskij e Céline, miei autori preferiti. Arriva il momento del Capitale». Lei ha disegnato anche le copertine dei libri di Walter Veltroni, come Il sogno degli anni ’60. Un decennio da non dimenticare: anche questo una sua piccolo Bibbia? «Veltroni è un collezionista come me delle figurine Panini. Dal punto di vista politico non mi considero schierato. Qui, sotto casa, a Roma sul Lungotevere, è apparsa su un muro la scritta “Echaurren artista di regime”. Qualcuno ha poi cancellato l’ultima parola. Ha fatto bene. Io ho fondato il “Partito del tubo” il cui slogan è “adotta un politico e convincilo a smettere”». Trent’anni di collezionismo insieme a sua moglie, la studiosa Claudia Solaris, hanno dato vita a una delle più grandi raccolte di reperti futuristi del mondo. Se li gode i libri che acquista? «È come chiedere a un collezionista di francobolli se affranca le sue lettere con il Gronchi rosa. Me ne guardo bene dal leggerli. I futuristi per lo più sono noiosissimi. Govoni e Palazzeschi mi sono sempre piaciuti. Ma a Marinetti antepongo però Carlo Emilio Gadda». Ovvero? «Campana, Gadda, i surrealisti, Pound, i dadaisti, Majakovskij, Salinger, e poi 4 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 5 Nel suo diario lo scrittore mantovano racconta il mondo della cultura. Unico modo per superare invidie e colpi bassi: adeguarsi al generale appiattimento Francesco Borgonovo, Libero, primo novembre 2008 lettera ai conformisti dell’editoria italiana antonio moresco La prima parte delle Lettere a nessuno di Antonio Moresco è uscita per Bollati Boninghieri nel 1997. Si trattava di un libro difficile da catalogare, una sorta di diario in cui lo scrittore di Mantova, autore di romanzi come Canti del caos (allora non erano ancora stati pubblicati, sarebbero usciti solo nel 2001 per Feltrinelli, che stampò anche Gli esordi nel 1998) raccontava la sua esperienza di autore inedito. Ora Einaudi manda in libreria una nuova versione delle Lettere (pp. 728, euro 22), corredata di una seconda parte in cui Moresco racconta (nella stessa forma diaristica) i suoi ultimi quindici anni. Trascorsi, questa volta, da scrittore «emerso», dopo che Giulio Bollati gli pubblicò, nel 1993, i racconti di Clandestinità. La prima parte era una sorta di memoriale dal sottosuolo, una collezione di avvenimenti e di pensieri annotati giorno per giorno nel corso di undici anni passati a 5 lavorare «sottoterra», a produrre romanzi e a proporli agli editori, costantemente rifiutato, talvolta neppure letto. Le piccole miserie dietro le quinte Se le lettere riportate nella prima parte e indirizzate a personalità molto note del panorama culturale italiano (Maria Corti, Claudio Magris, Giovanni Raboni e vari altri) non furono davvero spedite, a parte un paio, quelle della seconda sono state tutte inviate (tranne tre). La reazione immediata del lettore potrebbe essere: perché dovrebbero interessare a qualcuno le confessioni di uno scrittore i cui manoscritti vengono rimandati al mittente o a cui i grandi editori fanno tante promesse senza mantenerle? La risposta migliore la dà lo stesso Moresco, in un passaggio del libro: «“Cosa vai a tirare fuori queste miserie? – dirà forse qualcuno. – Lasciale stare dove sono”. Ma allora come si fa a capire, non in linea generale, con discorsi astratti, come stanno davvero le cose, come funziona tutto quanto nel nostro paese, anche nel piccolo, misero mondo larvale in via di estinzione della cultura?». Questo libro aiuta a capire come funziona la cultura italiana. Scrive ancora Moresco: «Se rinunciassi a parlare a viso aperto e mi autocensurassi non riuscirei a far vedere come stanno davvero le cose, mancherebbero le persone reali, i comportamenti, le dinamiche, gli esempi rivelatori di un clima generale e di un’epoca». Ovviamente, ci dobbiamo fidare di quanto racconta. Ma nessuno fra quelli che vengono citati nel testo, finora, lo ha smentito. Innanzitutto, da Lettere a nessuno emerge una tendenza dell’editoria italiana: quella ad uniformare il prodotto, a far uscire libri fatti con lo stampino. Nel libro seguiamo la vicenda del manoscritto de Gli esordi. Prima di trovare qualcuno che novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 6 lo stampi, viene rifiutato da molti. Il motivo? È troppo impegnativo, difficile, forse poco vendibile. Perlomeno diverso da quello che si manda abitualmente in libreria.Tutti coloro che lo leggevano riconoscevano: ci troviamo davanti a un grande autore; Moresco riporta una frase di Antonio Franchini, editor Mondadori: «Siamo coscienti di trovarci di fronte a uno scrittore vero, uno scrittore autentico». Ma il giudizio era la stesso: non possiamo pubblicarlo. È sempre Franchini, nel testo, a dire: «Ma come si fa a pubblicarlo? Bisognerebbe farne un caso letterario, come il libro della Morante… il prezzo di copertina…». col gruppo si chiude. Una parte di quel pamphlet viene riproposta da Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera qualche tempo dopo, in seguito all’uscita degli Esordi da Feltrinelli. Le reazioni delle terze pagine dei giornali sono pesanti. Dice Moresco: «Si sono scatenati tutti: “teppista, baldi giovinotti” (Raboni)… Baldo giovinotto a me, che avevo ormai passato la cinquantina! Gente che si stracciava le vesti, senza fare il minimo sforzo di capire l’urgenza delle cose che si cercavano di dire. L’icona letteraria dell’epoca era quella. Io ero un poco di buono». In realtà, quello che si vuole dagli scrittori sono sempre le stesse quattro cose, i medesimi argomenti triti. L’attualità, l’impegno politico. Muro impossibile da superare Franchini, almeno, si dà la pena di leggere il libro. Relazionarsi con altri, invece, è come trovarsi davanti a una barriera impossibile da superare se non entrando a far parte di una conventicola, un gruppo di potere, svilendo il proprio lavoro. Nella prima parte, Moresco racconta gli incontri con Goffredo Fofi avvenuti nell’arco di tre anni. Consegna il manoscritto di Clandestinità alla Feltrinelli. Fofi gli dice: «Telefonami tra un mese e ti darò senz’altro la risposta!». Scrive Moresco: «Il mese successivo, tra molte difficoltà, ho telefonato da un paesino del Gargano (…). Mi hanno risposto che eri in ferie. Bene. Ho richiamato il mese dopo. Non c’eri. Il mese dopo ancora. Non c’eri». Dopo mesi e mesi di telefonate mancate, i due si incontrano: Moresco vede Fofi con le stampelle, ha una gamba ingessata. Ha avuto un incidente e gli spiega: «Su di esso ha influito psicologicamente, lo confesso, anche la sua insistenza!». Il libro viene bocciato. Altro topos del mondo culturale italiano è l’icona intoccabile, la personalità di cui non si può parlar male. Singolare, a questo proposito, la vicenda che vede protagonista la redazione della rivista Riga di Marco Belpoliti. Lui e Moresco si conoscono, diventano amici, si frequentano. Antonio viene ammesso nel gruppo. A un certo momento, però, tutto s’incrina. Belpoliti chiede a Moresco un saggio su Calvino per la rivista. Lo scrittore mantovano, sulle prime, è titubante. Poi, dopo qualche insistenza di Belpoliti, accetta. Il pezzo, però, non piace. Moresco è troppo critico verso Calvino, l’articolo viene rifiutato e il rapporto di amicizia «Scrivi un romanzo sugli anni Settanta» Ecco un altro caso significativo raccontato in Lettere a nessuno. Moresco ha pubblicato da Rizzoli la seconda parte di Canti del caos, ma la sua editor, Benedetta Centovalli, viene sostituita da Stefano Magagnoli, fresco dal successo mondadoriano de Il Codice Da Vinci di Dan Brown. Magagnoli invita Moresco in pizzeria. «Mi dice che ha letto Lo Sbrego e Canti del caos e che ne è rimasto folgorato, che vuole battere un colpo, che vuole pubblicare i miei nuovi libri, mi offre di riproporre in economica i miei libri già pubblicati da altri editori, con calendario deciso da me, addirittura, pubblicità sui giornali del gruppo, articoli, foto, anticipi mai visti, perché “i soldi ci sono”, che mi vuole fare subito un grosso contratto ecc. ecc. E anche che ha preso Giuseppe Genna, che gli pubblicherà il prossimo libro, che Giuseppe gli farà anche da consulente, che lui è amico anche di Cordelli, che gli ripubblicherà il suo primo libro uscito tanti anni fa. Drizzo le orecchie… Le stesse cose le va a dire anche alla mia agente». Ma che tipo di romanzo si pretende da Moresco? «Alla fine del nostro primo incontro mi butta lì: «Perché non mi fai un romanzo sugli anni Settanta? Sono sicuro che ne verrebbe fuori una cosa fortissima». Eppure Moresco sarebbe capace di ben altro, potrebbe produrre qualcosa di più ambizioso,di più grande.Lettere a nessuno lo dimostra:non si limita alle piccole del mondo editoriale,non è soltanto un pamphlet di denuncia. In questo libro si ripercorre l’in- oblique studio 6 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 7 tera vita dell’autore e della generazione che l’ha accompagnato, ci sono pagine belle e potenti, si punta a vette che fanno sembrare ancora piccoli i ragionamenti sull’industria culturale. Ci sono passaggi di critica letteraria, incontri importanti (come quello con Ermanno Olmi che si innamora dei suoi libri),la storia terribile della piccola Antinisca, ragazzina che un mattino decide di impiccarsi a una trave davanti agli occhi del fratellino, i viaggi in Argentina dopo il crollo finanziario, escursioni nella Terra del Fuoco, riflessioni sulla scrittura. Ma tutta l’ambizione si cerca di smorzarla. «Criminalità organizzata» Per questi motivi Moresco ha scritto Lettere a nessuno. «Adesso sono uno scrittore emerso. Ho pubblicato diversi libri, alcuni scritti mentre ero sotto terra, altri dopo. (…) Ma sono successe anche cose che mi hanno fatto sperimentare ancora di più la terribile opacità e ostilità del mondo che gravita attorno alla parola scritta, non migliore di quello politico o addirittura della criminalità organizzata». In conclusione, Moresco dice di stare lavorando a un nuovo libro, che si intitolerà Le morti (mentre la nuova edizione di Canti del caos arriverà nel 2009). «Ho trovato un posticino segreto dove scomparire», scrive, «Di notte si vede il firmamento.(…) Scriverò lì quell’ultima cosa che ho in mente, se non crepo prima. Poi basta. Nonostante tutto, in questa disperazione e in questo orrore riesco ancora a incontrare di tanto in tanto dei piccoli momenti di gioia, che nessuno mi può rubare. Il mio ultimo sogno è che venga finalmente il giorno in cui mi dimenticherò persino di essere stato, un tempo, uno scrittore». “Cosa vai a tirare fuori queste miserie? – dirà forse qualcuno. – Lasciale stare dove sono” rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 8 La sagra dell’editoria Sempre più libri e festival (ma sempre meno lettori) Oltre 60mila titoli l’anno, premi, mostre e manifestazioni à gogo. Ma le vendite calano, le librerie chiudono e i volumi vanno al macero Luigi Mascheroni, il Giornale, primo novembre 2008 Benvenuti al luna park del sapere, avanti singnore&signori, si accomodino: la giostra gira e costa poco. Stacca anche tu un biglietto della lotteria Erudire et edocere, qualcosa vincerai. È la sagra della cultura: in principio furono i premi letterari, da ultimo i festival, senza dimenticare, in mezzo, il proliferare di centri universitari, nati elemosinando qualche corso per sedi distaccate e poi allargatisi a veri e propri atenei autonomi con moltiplicazione di corsi inutili e senza studenti. Un autentico «virus culturale» che ha colpito metropoli e cittadelle, paesini e villaggi, Pro Loco ed Enti Locali. «Ma resta il dubbio sull’effettivo valore culturale della maggior parte di queste manifestazioni», è il laconico commento di Ermanno Paccagnini, italianista dell’Università Cattolica, per anni critico letterario del Sole 24 Ore e oggi del Corriere della Sera, che sul numero della rivista Vita e pensiero in uscita l’8 novembre firma un impietoso saggio contro l’italico divertimentificio della cultura. Ossia contro i premi in crescita libera che hanno graoblique studio dualmente sostituito, senza peraltro elevare il livello medio culturale della popolazione in loco, «le vecchie e sacrosante sagre paesane della salsiccia, della toma o del vin santo»; i festival, «assaliti da vogliosi ascoltatori (con un certo tasso di guardonismo), libidinosi nel poter miracolisticamente toccare il proprio mito fissandoselo come reliquia nel telefonino, ma che per la verità raramente si trasformano in lettori»; e l’iper-offerta di mostre, congressi e convegni «col tempo divenuti sempre più pletorici, con poche vere novità e tanta carta inchiostrata da interventi utili solo a fare chili di pubblicazioni da presentare a concorsi e situazioni affini». Tutti parlano, nessuno ascolta. Tutti pubblicano e nessuno legge. Ancora più preoccupante la situazione editoriale. Gli ultimi dati ufficiali fanno rabbrividire: nel 2007 in Italia sono stati oltre 61mila i titoli librari prodotti – il 62% dei quali novità, il resto ristampe e riedizioni –, per un totale di 268 milioni di copie. Aveva ragione il mai abbastanza compianto Massimo Troisi in Le vie del Signore sono finite: «Io non leggo mai.Non leggo libri, cose… pecché… Che comincio a leggere mó che so’ grande, che i libri sono milioni e milioni? Non li raggiungo mai, hai capito? Pecché io sono uno a leggere, loro sono milioni a scrivere». Il «virus culturale» ha intaccato gli editori (che incredibilmente continuano a crescere: nel 2007 erano 2901), purtroppo però non i lettori. Sempre secondo i dati ufficiali più aggiornati, le persone alfabetizzate che nel 2007 hanno letto almeno un libro sono state meno di 24 milioni, cioè il 43% della popolazione, cioè parecchio meno della metà degli italiani. Cioè più della metà degli italiani alfabetizzati non legge neppure un libro in un anno. E quelli che leggono un libro al mese sono 3,2 milioni. Senza chiamare in causa i giovani: tra gli 11 e i 19 anni legge un libro all’anno il 53,8% dei ragazzi. In Francia il 66%, in Spagna il 72,3%. A confermare il disastro, i dati delle vendite di libri (preoccupanti) e lo stato di salute delle librerie (pessimo): mentre 8 03/12/2008 12.17 Pagina 9 9 fra agosto e settembre, il Giornale ha affrontato, in modo critico, la questione spinosa dei festival e dei premi letterari, si era già avanzato il pesante sospetto che né un Bancarella qualunque né un noir-infestival qualsiasi fanno vendere una copia (per dire) in più. Un intellettuale terzista, nel senso di super partes, come Ernesto Galli della Loggia, intervistato di recente dal Secolo d’Italia in uno speciale dal titolo «L’Italia dei festival: dove Marinetti e Gramsci si danno la mano», metteva in guardia dai facili entusiasmi: «Durante queste manifestazioni si possono avere delle buone suggestioni, si può restare affascinati da un pensiero, da un personaggio: ma imparare è un’altra cosa». E Mario Baudino, sulla Stampa, ha raccolto le critiche che da più parti si iniziano a sollevare sulle kermesse letterarie, denunciando come le stesse si sono trasformate, soprattutto per i giovani scrittori, in qualcosa a metà fra moda e mezzo di sostentamento. «Certo, è una settimana o una tre giorni da delirio e ubriacatura: ma – si chiede Paccagnini guardando anche il risvolto economico della faccenda – cosa resta poi nelle casse dei vari comuni da investire nella vera, necessaria e proficua operazione culturale, che significa lavorare con continuità in loco per avvicinare i propri cittadini alla lettura?». Risposta: poco, o nulla. È il destino di quest’epoca «spettacolare»: che confonde la nuova cultura di massa con la vecchia cultura popolare; che per richiamare pubblico (non lettori) è costretta a chiamare festival, cioè fiera o festa, una serie di incontri letterari; che sopravvive di bestseller; e che è costretta a mandare al macero tutti i libri di cui non si è parlato in tv la sera prima: quelli di Vespa, di Scalfari, di Camilleri. E per fortuna che c’è Saviano. ...loro sono miiloni a scrivere... crescono le vendite nei mega-store e nei supermercati, le librerie tradizionali sono in crisi. Entra poca gente e quella che entra capita che chieda – lo raccontava ieri un amico della storica libreria Croci di Varese – Il mercante in fiera di William Shakespeare, o Narciso e Bocca di rosa di Hermann Hesse, o Il giardino degli sfizi continui… non mi ricordo di chi… Sono quelli che leggono un libro all’anno. «Pecché io sono uno a leggere, loro sono milioni a scrivere…». Milioni a scrivere: in un Paese che brilla per scarsità di lettori tutti hanno un manoscritto nel cassetto. Ma il problema e che lo tirano pure fuori. Un esempio per tutti: la minimum fax di Marco Cassini, una delle case editrici più eleganti e sfiziose ma non certo la più grande sul mercato, ha confessato pubblicamente – si era tutti presenti la settimana scorsa a un premio letterario… – che riceve in media, solo di romanzi di esordienti, setto-otto plichi al giorno, e la sua casa editrice, nella collana di narrativa italiana, pubblica in media setteotto titoli all’anno. Uno su 365. In media. Tanto più che, come recita il sito internet, «le uscite italiane di minimum fax sono state già fissate fino alla fine del 2009. La quantità di materiale pervenuto è enorme e dobbiamo ancora valutare moltissimi dei manoscritti arrivati». Punto. A capo. Siamo da capo: tutti scrivono, tutti vogliono pubblicare, tutti indicono premi, tutti organizzano festival, tutti ci vanno («…quest’anno più dieci per cento, più dieci per cento!!!…»), nessuno legge. O per lo meno leggono sempre gli stessi (pochi). Scendere in piazza è facile, ma sedersi a leggere su una panchina è dura. «Del resto – constata amaramente Paccagnini – posto anche che le migliaia di assiepanti le piazze siano andati ad accogliere Dante più che ad ascoltare Benigni, quanti di costoro sono tornati al testo scritto?». E quando, ...pecché io sono uno a leggere... rs_novembre08_bis.qxp novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 10 COSÌ I LIBRI DIVENTANO CARTA DA MACERO Ecco come funziona in Italia il meccanismo dell’«eliminazione delle giacenze» del volumi invenduti. Alle case editrici (che non parlano) costa meno distruggere le copie avanzate che tenerle in magazzino Paolo Bianchi, il Giornale, 2 novembre 2008 Il destino dei giornali è di finire, nel migliore dei casi, nel cassonetto della raccolta differenziata. Un tempo, per rimettere a posto i giovani giornalisti vanitosi, i veterani ricordavano loro che quanto scrivevano sarebbe servito, l’indomani, per incartare il pesce. Sic transit gloria mundi. Ma per i libri no, per i libri è sempre stato diverso. Distruggere un libro è tabù. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una società dove le idee circolano liberamente e nessuno si sogna di distruggere un libro in pubblico, neanche il Mein Kampf o certe tirate antisemite di Céline, né il Libretto Rosso di Mao Tse Tung e nemmeno le farneticazioni di presunti comici semianalfabeti o di pseudogiallisti improvvisati. Però nel privato le cose stanno diversamente. Queste sono alcune frasi che un autore di romanzi (non possiamo farne il nome,ma come lui ce ne sono parecchi, quasi tutti) riceve in una lettera intestata della sua casa editrice: «Oggetto: macero parziale di n. 1.500 copie di (Titolo) (Autore). Nell’ambito della revisione periodica del nostro magazzino, abbiamo rilevato una giacenza eccessiva del titolo in oggetto. Vi informiamo pertanto della nostra decisio- ne di eliminare una parte della giacenza. Riteniamo che tale riduzione non comprometta la disponibilità commerciale e anzi ci consenta di eliminare le copie guastate dalla movimentazione… eccetera. Cordiali saluti». E tuttavia il provvedimento riguarda un autore il cui libro ha venduto bene, al punto che dalla stessa casa editrice gli sono stati proposti altri contratti con relativi anticipi. Le copie «guaste», nei contratti, sono in media calcolate intorno al tre per cento della tiratura complessiva,non di più. Il resto sono copie «avanzate»: gli ultimi Grisham che non sono andati benissimo; il secondo Faletti stampato in un numero di copie eccessive rispetto alle previsioni basate sul primo romanzo; molti semisconosciuti ma anche bestselleristi come Ammaniti; il grande giornalista di grido, che vende anche bene, ma che passato l’argomento del saggio, nessuno vuole più; i polpettoni americani rimasti sul gozzo dell’editore speranzoso di replicare in Italia il successo d’Oltreoceano… L’abitudine di «alleggerire i magazzini» – come dicono con un eufemismo gli addetti ai lavori – è ormai consolidata. Le cifre, anche andando per approssimazio- ne, sono ingenti. Secondo Gianni Peresson, responsabile dell’ufficio studi dell’Aie (Associazione Italiana Editori), «non esistono dati aggregati sul valore complessivo del macero». Dunque, si può andare solo per approssimazione. Esistono, invece, diversi studi sulle «rese», cioè sulle quantità di volumi stampati che ritornano all’editore come boomerang in tempi più o meno ristretti. «Il più recente di questi studi – spiega Peresson – sarà presentato alla Fiera della piccola editoria di Roma, il 5-8 dicembre prossimi». Ora, le rese sono un elemento fisiologico del sistema editoriale, che ormai ha caratteristiche molto simili a quelle di una filiera alimentare. E così, come la grande distribuzione degli ipermercati ci mette di fronte alla distruzione quotidiana di prodotti di breve scadenza (ortaggi, pesce) allo stesso modo le «eccedenze di magazzino» dell’editoria vengono distrutte in larga quantità. Siamo di fronte a un paradosso vero o solo apparente? È vero infatti che il Paese è povero di cultura, ma ci sono migliaia di biblioteche pubbliche, rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 11 periferiche e scolastiche, che non hanno soldi per acquistare libri. Nella scuola ci si lamenta genericamente del «caro libri», compresi quelli di lettura. Perché allora non innescare circoli virtuosi che permettano un riutilizzo intelligente di quanto viene distrutto? Le grosse case editrici nutrono molto ritegno ad affrontare l’argomento. Sempre pronte a far suonare le trombe per sottolineare il successo di un titolo o di autore, coprono con un velo di segretezza ogni informazione riguardante le rese e la distruzione delle copie invendute. In poche parole, il tabù è una realtà: la morte del libro. La sua reincarnazione è piuttosto una «reincartazione», perché ogni pensiero sparisce, triturato e sbiancato, per riprendere forma come supporto per altra scrittura stampata. Per usare ancora le parole di Peresson «è il meccanismo che l’editoria riserva ad alcune tipologie di libri che incidono sullo stato patrimoniale del bilancio». Sì, perché i costi di magazzino sono esosi. E poi ci sono sotto questioni fiscali e una legislazione specifica che fa sì che l’editore sia poco stimolato a regalare libri al pubblico. Questo, aggiunge Peresson, «avviene nel nostro Paese dove oltretutto le risorse per le biblioteche sono pari a un terzo o a un quarto rispetto ad altri Paesi sviluppati». In ogni modo, nello studio Aie di prossima pubblicazione, si considererà anche il fatto, non proprio edificante, che molti librai utilizzano il diritto di resa come strumento finanziario; ordinano i libri, li pagano, ma poco dopo li restituiscono e recuperano il denaro. E quei libri finiscono nel limbo dei magazzini, che più che un limbo è l’anticamera dell’inferno. Ma per fortuna l’alternativa non è secca: vendita immediata o riduzione in poltiglia. Ci sono delle vie di mezzo. C’è il cosiddetto «secondo mercato». In parole povere: il libro che conclude il suo ciclo primario può entrare, proprio come i film di seconda visione, in un circuito secondario, ma non meno efficiente del primo, come la catena di librerie «Il Libraccio», che vive sul recupero di volumi la cui prima vita raramente ormai supera i sei mesi. E gli stessi riciclatori non mandano tutto al macero, come ci conferma Daniele Cirucca della Euro Team di Solbiate Olona (Varese), che comprende un deposito di 12mila metri quadrati: «Ci sono libri più “classici” che durano almeno cinque anni e trovano un loro sbocco commerciale. In più, noi acquistiamo molti prodotti da edicola, libri compresi, che hanno una vita diversamente durevole: è chiaro che i film in dvd o i cd hanno più mercato dei libri». I libri sono un po’ la Cenerentola nell’affare del riciclaggio. Ma qualcuno, a modo suo, ci crede. L’amministratrice della casa editrice Studio Editoriale di Milano, Maria Antonietta Prina, ci racconta un episodio accadutole qualche anno fa: aveva portato al macero una piccola quantità di libri; per garantire che non fossero rimessi in commercio (cosa illecita) i margini erano stati macchiati di vernice. Alcuni mesi dopo, in una libreria del circuito Remainder’s, aveva trovato una certa quantità di quei libri tagliati di netto ai margini, in modo che non si vedessero le tracce di vernice. Avevano cambiato forma e proporzione, ma il contenuto era salvo. Naturalmente venivano rivenduti a un prezzo risibile. Un caso limite. Per evitare equivoci, gli editori oggi tendono a strappare le copertine dai volumi prima di consegnarli ai riciclatori. È un peccato che le case editrici siano reticenti sul tema. Fra tutte quelle che abbiamo consultato ha risposto solo la Mondadori spiegandoci attraverso una sua portavoce che «la politica aziendale non prevede la divulgazione di questi dati. Inoltre si tratta di una materia delicata dal punto di vista normativo e fiscale. Si potrebbero creare confusione». Da un bel volume di Oliviero Ponte di Pino, direttore editoriale Garzanti, dal titolo I mestieri del libro (Tea, 2008), che spiega con esemplare chiarezza il funzionamento della macchina editoriale, leggiamo: «Si possono trovare volumi a prezzi scontatissimi (per esempio nella catena dei Remainder’s): ma si tratta di rimanenze o rese di volumi che l’editore ha messo fuori catalogo, vendendo le giacenze a grossisti, creando un “secondo mercato” del libro (e salvando così quei volumi – spesso di grande qualità – dal macero)». E ancora: «Alla fine del ciclo di vita del libro nel “primo mercato”, la direzione commerciale può aiutare a valutare se i volumi pervenuti in resa hanno qualche possibilità nel secondo mercato, o se sono destinati al macero per alleggerire il magazzino». rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 12 «SIAMO OBBLIGATI: NON POSSIAMO REGALARLI» Il responsabile marketing di una importante casa editrice, sotto promessa di anonimato, spiega il meccanismo del macero dei libri: «Almeno una volta all’anno, dopo le vacanze estive, viene convocata una lunga riunione, che dura dal mattino alla sera, nella quale, titolo per titolo, vengono analizzate e calcolate tutte le eccedenze di magazzino». E questo lo fanno tutti gli editori? «Tutti, sì». Come si calcolano le eccedenze da «scremare»? «Ci sono formule complicatissime, delle specie di algoritmi. Una pretesa di scientificità che per mio conto è anche eccessiva. Però la gestione del magazzino è una faccenda seria. Riguarda le difficoltà nello stoccaggio, gli equilibri del bilancio, tiene conto di motivi fiscali…». Ma non sarebbe meglio regalarli, quei libri? «Non è consentito. Un conto è il buon senso, un conto sono le leggi e la pratica. Anche spedire i libri in omaggio ha un costo. E chi lo deve sostenere? Chi decide che cosa regalare a chi?». Gli autori vengono avvertiti? . «In genere sì. Nel caso di “macero parziale” il diritto d’autore rimane alla casa editrice. Quando viene proposto un macero totale i diritti tornano all’autore, che solo in que- sto caso può acquistare le copie invendute con uno sconto del novanta per cento…». Qual è la loro reazione? «Alcuni s’intristiscono, altri si angosciano. Quelli con un po’ d’esperienza non ci fanno caso. Sanno come funziona il sistema. Quello stesso libro, magari viene ristampato l’anno dopo». Le macerazioni risparmiano qualcuno? «È molto difficile calcolare in anticipo le vendite. A volte si ristampa con troppa fretta. E quindi può succedere che al macero vadano anche i bestseller, libri che sono stati a lungo in classifica. Sembra incredibile, lo so, ma è così». «ORMAI LO FANNO TUTTI, SONO DECINE DI TONNELLATE» «Abbiamo le carte in regola» è il motto del Gruppo Masotina Spa, impresa con sede a Corsico (Milano) tra le maggiori in Europa per la raccolta, selezione, trattamento e recupero della carta da macero. È gestita dai fratelli Masotina. Piergiorgio Corradi, funzionario Commerciale, soddisfa alcune nostre curiosità. «Le case editrici tentano la vendita dei loro prodotti a diversi livelli. Librerie tradizionali, mercati paralleli, grossisti, e così via. Il macero è l’ultima spiaggia. È un po’ una tristezza. Ci conforta però pensare che quanto viene rifiutato possa tornare a nuova vita senza danni per l’ambiente. Questo richiede un accurato lavoro di selezione del materiale». Abbiamo contato, solo in Lombardia, più di 13 aziende che si occupano di queste operazioni… «Sì, il mercato dei maceri è molto frazionato. In parte dipende dalla tipologia dei prodotti». Tutti i grandi editori effettuano macerazioni? «Per quanto ne sappia, sì. Anche quelli piccoli, in proporzione. Da noi arrivano in media 200 camion al giorno di materiali cartacei. Tra questi, ogni anno c’è qualche decina di tonnellate di libri». Per quanto riguarda i libri? Come vengono trattati di fatto? oblique studio «Vengono strappate le copertine, alla presenza di un rappresentante della casa editrice e di uno della Guardia di Finanza. Poi si procede alla triturazione». Non le sembra uno spreco e una specie di sacrilegio? «Credo di sì. Ma cosa vuole farci? Per le eccedenze alimentari ci sono già circuiti specifici, come il Banco Alimentare o la Caritas. Noi facciamo il nostro lavoro: recuperare il recuperabile. Tra l’altro, anche il valore della carta da macero è sceso, in periodo di crisi economica. E in Italia molte cartiere chiudono. E comunque, quello che noi riusciamo a recuperare serve anche per continuare a stampare i quotidiani». 12 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Pagina 13 La vita tumultuosa di Lee Miller, divina davanti e dietro l’obiettivo Sandro Fusina, Il Foglio, 8 novembre 2008 Anno domini 1954. Una fotografia ritrae il disegnatore Saul Steinberg in piedi, di profilo, con una matita in mano. Grazie al gioco dei piani sembra che Steinberg stia disegnando sulla collina dietro di lui il profilo di un uomo con le gambe e la braccia divaricate. Sembra che stia disegnando “L’uomo lungo di Wilmington”, la misteriosa opera tracciata chissà quando, chissà da chi nell’Inghilterra meridionale. L’autrice della fotografia è Lee Miller, la signora di Farley Farm. La fattoria Farley non ha solo il privilegio di guardare sull’“Uomo lungo”, ma ospita la più importante collezione privata di arte contemporanea d’Inghilterra. L’ha raccolta Roland Penrose, compagno in Francia, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, dei sogni e delle azioni dei surrealisti, fautore in Inghilterra dell’arte d’avanguardia. Penrose è un buon pittore, ma è anche un uomo ricco. Non cerca di vendere quadri, piuttosto ne acquista dagli amici artisti. Ha fondato e finanziato l’Ica, l’Istituto per l’arte contemporanea, in un paese come la Gran Bretagna che è rimasta a lungo ai margini della kermesse delle avanguardie, nella sua dimora ha raccolto una collezione di quadri straordinari. Sulle pareti di casa, tra maschere africane e oggetti di arte popola13 re, si possono vedere opere che diventeranno storiche, come l’elefante aspirapolvere, l’“Elefante Celebes”di Max Ernst,la“Donna con mandolino” del 1910 di Picasso, la “Foresta” del 1916 di Jean Arp, e decine di altre tele, di Giorgio De Chirico, di René Magritte, George Braque eccetera, ma anche l’umile serigrafia “Aidez l’Espagne” pubblicata nel 1937 da Joan Mirò e venduta a un franco per finanziare la repubblica spagnola, quando Picasso dipingeva “Guernica” e Penrose non si perdeva una sola delle manifestazioni organizzate dai suoi amici surrealisti. Farley Farm non ospita solo le opere degli artisti. Accoglie anche in carne e ossa gli artisti e gli intellettuali amici. I quali, per ricambiare devono prestarsi a svolgere i lavori quotidiani della fattoria. L’idea è stata di Lee Miller,moglie di Penrose,che li fotografa per un servizio su Vogue intitolato “Working Guest”, ospiti al lavoro. Così vediamo Alfred H. Barr, primo direttore del Moma, il Museo d’arte moderna di New York, che con un secchio dà da mangiare ai porci. Intanto Alfred Ayer, Freddie per gli amici, autore di un celebre libro di logica e professore di Filosofia a Oxford, regge una cesta di legna per il camino, mentre Sonia,la vedova di George Orwell, controlla malamente una grossa carriola sullo sfondo di una scultura di Henry Moore. Echaurren Matta, pittore surrealista della seconda ondata, rimira una scala a pioli che gli hanno messo in mano, perplesso come se non ne avesse mai vista una. Più a suo agio, il pittore Richard Hamilton lavora di forbice a una tenda a strisce. Si vede che sono tutti in posa. L’unica a lavorare davvero è Lee Miller,fotografa e padrona di casa.È fatta così. Ogni volta che deve realizzare un servizio si tormenta. Marcia a bottiglie di whisky e a pacchetti di sigarette, tot bicchierini e tot sigarette per ogni parola. Di lavorare non avrebbe bisogno, i coniugi Penrose sono straricchi. Roland ha ereditato una fortuna dal nonno materno, bella figura di banchiere quacchero. L’educazione familiare non conformista gli ha imposto la sobrietà elegante dello stile di vita, il denaro gli ha consentito di coltivare in libertà le propensioni personali.Giovanissimo ha frequentato il gruppo degli intellettuali di Bloomsbury che, intorno all’economista Keynes e alla scrittrice Virginia Woolf, coltivano in cerchio il gusto per l’intelligenza e la parola affilata e intrecciano rapporti affettivi non convenzionali in una Londra che non aveva ancora ben digerito lo scandalo di Oscar Wilde. A Parigi si è mischiato, con il distacco ironico che la sua educazione inglese gli permetteva, con la turbolenta setta dei surrealisti, senza partecipare al frenetico moto di aggregazione e disgregazione intorno all’assolutismo pontificale di André Breton. Quando Breton e Paul Eluard consumeranno un divorzio irrevocabile, Penrose riuscirà a restare in buoni rapporti con entrambi. Lee Miller, che mette in posa i suoi amici con attrezzi di stalla e d’orto, è la sua seconda moglie. Anche la prima moglie di Penrose, Valentine, lesbica militante e autrice di novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 una biografia di Erzsébt Bathory, la cinquecentesca balcanica contessa sanguinaria, vive per qualche tempo alla fattoria. I triangoli di ogni tipo, equilateri, isosceli, scaleni, sono una particolarità del posto. L’assegnazione agli ospiti delle stanze è solo indicativa. Può capitare che la signora Paul Eluard dorma nella stanza di Man Ray, mentre la signora Man Ray dorma nella stanza di Paul Eluard. Siamo artisti, aperti alle esperienze. Non ci stupiamo di nulla, neppure che una coppia arrivata insieme si ostini a dormire insieme. Dell’andazzo domestico non si stupisce neppure il piccolo Anthony,figlio naturale di Lee e figlio legale di Ronald. Non si stupisce, ma non è felice. La mamma non lo tratta bene, soprattutto quando ha bevuto un bicchiere di troppo, vale a dire oblique studio Pagina 14 ogni giorno della settimana, dalla mattina alla sera. E il papà non crede di dover derogare dal suo stile flemmatico per difenderlo.“Quando beveva, faceva paura. Non era mai violenta, ma con la parola poteva essere crudele (a furia di frequentare poeti si impara a maneggiare con efficacia le parole,ndr).Era pericolosa e imprevedibile,con cambi repentini di umore e di personalità. Dopo i dieci anni non riuscivo più a sopportare, facevo del mio meglio per comportarmi in modo orribile con lei”. Un grande inferno familiare, ambientato nella dolce campagna del Surrey, in una casa più che confortevole piena di capolavori e di persone interessanti, qualche volta affettuose con il bambino, come Man Ray.“Le nascondevo il whisky. Lei mi tormentava. Ero dislessico e pensava che fossi stupido. Sapeva essere crudele e Roland non mi difendeva”. Questi ricordi molto personali Anthony Penrose li ha condivisi con il pubblico in occasione della grande mostra che un’’istituzione compassata come il Victoria & Albert Museum di Londra dedicava nel 2004 all’opera fotografica di Lee Miller. Mezzo secolo era passato e il figlio si era pacificato con la madre ormai defunta, al punto di dedicarsi alla conservazione e alla valorizzazione della sua opera. A intaccare l’impalcatura di rancore che lo aveva amareggiato era stato un ritrovamento casuale. Sua moglie era salita a frugare nella soffitta di Farley Farm alla ricerca di fotografie di Anthony bambino.Era ridiscesa con un plico di fogli.Lee vi raccontava con parole toccanti l’assedio degli alleati a Saint-Malo, subito dopo lo 14 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 sbarco in Normandia.Anthony non sapeva neppure che la madre aveva partecipato come fotografa accreditata all’avanzata anglo-americana nell’Europa occupata dai tedeschi. Nel presente non c’erano abbastanza affetto, abbastanza confidenza, perché la madre condividesse con il figlio il passato. Quelle poche pagine bastarono a fare intravedere ad Anthony l’altra faccia della Luna: Lee non era solo un’ubriacona tabagista dal carattere in bilico tra indifferenza e crudeltà. Non era solo la donna disinvolta, capace di passare con indifferenza da un letto all’altro. Era una donna capace di vedere con chiarezza e sentire con intensità. Per la prima volta ad Anthony venne in mente di andare in America a cercare le tracce del male di vivere della madre. Nella cittadina di Poughkeepsie, sulle rive dell’Hudson, a una sessantina di chilometri di New York, dove Lee era nata e cresciuta, viveva ancora lo zio Eric. Poughkeepsie era la sede della Cia, intesa non come l’agenzia centrale di investigazioni, ma come il Culinary Institute of America, il più grande college di culinaria degli Stati Uniti. Anthony non poté fare a meno di ripensare al tratto più domestico di Lee che per la cucina, creativa secondo i modi dell’avanguardia, aveva una vera mania. A Farley Farm c’era una biblioteca di quattromila volumi sull’argomento e a tavola comparivano in continuazione i piatti stravaganti e molto elaborati che Lee preparava con le sue mani. Sulla sua infanzia a Poughkeepsie, Lee, che era vissuta poi nelle grandi città del mondo, a New York, a Parigi, a Londra, al Cairo, faceva dell’ironia. Quando a Roland fu concesso dalla giovane regina d’Inghilterra il titolo di commander dell’impero, Lee si fece stampare biglietti da visita intestati a Lady Roland Penrose di 15 Pagina 15 Poughkeepsie. In quella cittadina industriale sull’Hudson (a Poughkeepsie funziona fino alla Seconda guerra mondiale l’unico stabilimento della Fiat negli Stati Uniti), nella testa del fratello era conservata la chiave per leggere il mistero della sua imbarazzante psicologia. Una fotografia di Man Ray del 1931 mostra Lee in braccio al padre, con la testa appoggiata alla testa, con le braccia di lei intrecciate intorno al collo di lui, con le braccia di lui intrecciate attorno alla vita di lei. La giovane donna e il signore anziano si assomigliano molto. Hanno entrambi lo sguardo dritto in macchina, ma non guardano fuori di loro. Oppongono al mondo esterno la stessa espressione dura, lo stesso muro invalicabile. Più che l’intreccio dei corpi e quello sguardo condiviso che conferisce all’immagine un’aura di intimità imbarazzante. La fotografia sembra una versione moderna, disinvolta negli atteggiamenti, di “American Gothic”, il quadro di Grant Wood dipinto solo un anno prima. Le mani intrecciate fanno la funzione del forcone metaforico esibito dalla coppia rurale per scoraggiare ogni incursione dall’esterno. Il fratello di Lee racconta al figlio di Lee una storia che Lee non aveva mai raccontato a nessuno. A sette anni aveva subito un abuso sessuale di cui non si sarebbe sospettato, se i sintomi della gonorrea non fossero stati piuttosto insoliti in una bambina. Il responsabile, si disse, era un uomo maturo, molto per bene, molto vicino alla famiglia. Il fratello aveva poi cercato di dargli un volto tra gli amici che frequentavano la casa. Non vi era riuscito. Gli era venuto perfino il sospetto che fosse necessario cercare più vicino, dentro la casa. Il padre era un inventore, con la passione della fotografia. Il suo soggetto preferito era la figlia, il suo genere d’elezione era il nudo. Theodore Miller fotografava nuda la figlia, ancora quando Lee aveva vent’anni, quando già aveva frequentato la scuola d’arte a New York. Furono per Anthony confidenze preziose. Riconsiderò la storia di Lee, gli sembrò di avere trovato una chiave per ricomporre in un nuovo disegno i ricordi. I suoi comportamenti di madre incapace d’amore, di divinità indifferente, sperperatrice del corpo e avara dell’anima, forse non erano dovuti a una malattia del carattere, ma a un groviglio intimo, alle metastasi di un amore incistato, inconfessabile, indelebile nel ricordo. Alla riconciliazione postuma con il ricordo di una madre, alla nuova pietà filiale si deve se la storia della fotografia si è arricchita di un’opera importante. Fino a poco più di vent’anni fa Lee Miller compariva a stento nei repertori. Il suo patrimonio sterminato di negativi giaceva dimenticato nella vecchia casa. Per incontrare le sue opere bisognava sfogliare i vecchi numeri di Vogue pubblicati durante e subito dopo la guerra. Ma il rapporto di Lee con la fotografia era stato molto più duraturo e intenso del rapporto con qualsiasi essere animato che aveva attraversato la sua vita. Aveva cominciato come modella. Aveva già posato a lungo per il padre, quando in una strada di New York stava per essere investita da un auto. A scongiurare l’increscioso incidente fu Condé Nast, il fondatore dell’impero editoriale in persona, al quale non sfuggì che le caratteristiche fisiche della bella ragazza che aveva salvato corrispondevano perfettamente ai canoni promossi dai suoi giornali. Era la perfetta bellezza degli anni della grande depressione. Era snella, con piccoli seni “perfetti per riempire una coppa di champagne”. Aveva un profilo severo, un poco androgino. Le propose di lavorare per lui, la affidò ai più grandi fotografi del momento, da George Hoyningen-Huene a Arnold Genthe. novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.17 Ma fu Edward Steichen, già un monumento vivente della storia della fotografia, a renderla improvvisamente nota, illustrando con la sua figura intera, vestita con un elaborato abito alla moda, la prima pubblicità mai pubblicata su un giornale di un assorbente. Da tutti loro Lee imparò qualcosa. Quando arrivò finalmente a Parigi, in quegli anni meta obbligata dei giovani americani attratti dall’eccitazione intellettuale e dalla vita libera, aveva in testa di diventare fotografa, aveva in borsetta una lettera di presentazione di Steichen. Il più introdotto degli americani a Parigi, Man Ray, artista d’avanguardia e fotografo di moda, fu lieto di accoglierla come assistente. Fu, pare, un errore in camera oscura di Lee a suggerire a Man Ray la tecnica delle sue celebri “solarizzazioni”, fu il fascino e la disponibilità di Lee a dargli l’idea di farne la sua musa e la sua donna. Il grado di intensità della storia sentimentale tra l’artista affermato e la bella assistente suscita qualche perplessità. Quello per Lee, che più di tutto amava la sua libertà, fu davvero l’amore più importante di Man Ray? Però nella biografia dell’artista, pubblicata nel 1975, quando Man Ray e Lee Miller erano ancora vivi, Roland Penrose, che non pare soffrisse di gelosie, né attuali né retrospettive, cita solo tre volte Lee, e sempre come assistente o modella dell’amico. Comunque, a poco più di anno dal suo arrivo a Parigi, grazie agli insegnamenti e all’appoggio di Man Ray, Lee aveva già avviato un suo studio fotografico e lavorava già per la moda.Ancora un anno e rieccola a New York, ritrattista alla moda. Quando nel 1985 Anthony pubblicherà la biografia ufficiale della madre, la intitolerà “Le vite di Lee Miller”. Anche se fedele alla fotografia, Lee cambiava stile di vita e stili di lavoro con grande rapidità. Fu forse per questo che, in oblique studio Pagina 16 occasione della grande mostra antologica organizzata tra giugno e settembre di quest’anno a San Francisco, qualche critico, staccandosi dal coro degli ammiratori incondizionati, si è azzardato a sostenere che Lee Miller non era una grande artista, anche se poteva sembrarlo, perché in ogni nuova sua vita aveva saputo ricalcare con gusto lo stile e la visione del mentore del momento. Affermazioni di questo tenore suonarono come un’eresia. Ormai una fotografia della Miller in tiratura d’epoca (vintage, scrivono i cataloghi di vendita), riusciva a spuntare all’asta anche più di centomila dollari. La vita successiva si svolse in Egitto. La Miller non vi arriva con un viaggio organizzato dall’agenzia Cook. Preferisce sposare un industriale egiziano molto ricco e molto mondano e tollerante, Aziz Eloui Bey, il quale senza inibirle alcuna libertà, le consente un train-de-vie più che agiato tra il Cairo e Sankt Moritz. Dalle fotografie pubblicate non sembra che Lee si lasciasse prendere dall’esotismo islamico, negli anni Trenta ormai piuttosto consunto. Ai sukh arabi preferisce le luci e le forme del deserto, alle fotografia di figure tipiche preferisce i ritratti dei suoi amici e dei suoi compagni di escursioni, magari ripresi con gli sci ai piedi mentre si stanno per lanciare in uno slalom sulle dune. Aziz Bey le consente di fare lunghe escursioni fino a oasi lontane, fino sulle sponde del Mar Rosso, in coppia con amici. Sa che non si tratta di scampagnate innocenti, ma sa anche che Lee non è capace di rapporti profondi e duraturi. Per lei il sesso è solo un modo, forse piacevole, di stabilire rapporti sociali. Non passa molto tempo però prima che Lee senta il richiamo dell’Europa. Il marito, che era forse un po’ imbarazzato dalla vita libera che la moglie conduceva spensieratamente al Cairo, la lascia andare, senza neppu- re tagliarle l’appannaggio. Non divorzieranno che nel 1947, quando Lee conviveva già da anni con Penrose. Anche Penrose, si è visto, era molto ricco. Qualcuno si è chiesto se mai Lee si sia innamorata di un povero. È una domanda oziosa, giacché Lee in amore non faceva questione di censo, semplicemente non si innamorava. Con Penrose e Man Ray, che finalmente ha una nuova pupilla, frequenta gli artisti d’avanguardia tra Londra e Parigi, in quei mesi molto eccitati per la grave congiuntura internazionale. Lee, a parte un odio per i tedeschi, non sembra manifestare passioni politiche: fotografa tutti, molti se li porta a letto, da Pablo Picasso a Charlie Chaplin. Con Roland Penrose, che dai tempi di Bloomsbury non si è mai sognato di nascondere le propensioni omosessuali, instaura un vero menage, quasi un matrimonio. Ossequienti all’adagio per cui la vita matrimoniale è così pesante che per reggerla bisogna essere almeno in tre, la coppia coopta il fotografo americano David S. Scherman. Scherman, nato nel 1916,ha sette anni meno di Lee.Una volta tanto è giovane e non ricco. Comunque è abbastanza famoso. È il fotografo accreditato in Inghilterra da Life, la rivista che più punta sul giornalismo fotografico. Ha già nel carniere un risultato straordinario. Per caso si trovava su un piroscafo affondato da una nave fantasma tedesca. Naufrago, era riuscito a fotografare dall’acqua la nave camuffata. Preso a bordo dai tedeschi, era riuscito a nascondere il rullino in un tubetto di dentifricio. Le sue foto erano servite per identificare, rintracciare e eliminare l’Atlantis, la nave pirata che aveva già affondato più di venti navigli commerciali. A Londra, come la sua collega Miller documentava la vita quotidiana delle donne in tempo di guerra. Loro sono molte delle immagini che testimoniano la 16 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 capacità degli inglesi di occuparsi normalmente delle attività quotidiane in una città martellata dai bombardamenti tedeschi. Della Miller è la celebre immagine dell’amico scultore Henry Moore, ripreso mentre si ispira per una celebre serie di disegni in un sotterraneo della metropolitana di Londra trasformata in affollato rifugio contro i bombardamenti. Di Lee sarà l’idea di farsi accreditare da Vogue per accompagnare Scherman, accreditato da Life, nell’avanzata degli alleati attraverso la Francia e la Germania dopo lo sbarco in Normandia. Insieme arriveranno, primi fotografi, nel campo di Dachau, insieme saranno i primi a entrare nell’appartamento di Hitler a Monaco di Baviera. Sarà un’idea di Lee di spogliarsi dell’elmetto e della divisa militare per farsi fotografare nuda da Scherman nella vasca da bagno di Hitler. Fotografano insieme ma 17 Pagina 17 non hanno lo stesso stile. Sembra che la Miller non riesca a vedere le scene terribili della morte se non attraverso il filtro dell’arte. La guardia di Dachau che fluttua annegata nell’acqua ricorda l’Ofelia preraffaellita di John Everett Millais,la bella figlia del borgomastro ha assunto nel suicidio l’espressione estasiata della Santa Teresa del Bernini. Lee scrive anche i testi e le didascalie dei servizi,diffidando la redazione di Vogue di censurarli, di edulcorarli per il suo pubblico. Scrivere di quello che vede è doloroso, spossante, solo nell’alcol e nelle sigarette trova la forza. Fu l’istituzione di un archivio dei negativi, delle stampe e di qualche cimelio e la biografia scritta dal figlio a riportare in piena luce l’opera e la figura della Miller. Ha aperto la serie delle grandi mostre una antologica allestita nel 2001 da Richard Calvocoressi per la Scottish National Gallery of Modern Art, ripresa tre anni dopo dal Victoria & Albert Museum di Londra. Il 2008 è stato un anno denso. Dopo la mostra al Moma di San Francisco è stata inaugurata una grande retrospettiva che durerà fino al gennaio del 2009 al Jeu de Paume di Parigi.In Italia le avventure e le opere di Lee Miller hanno ispirato a Luca Romano un racconto costruito secondo i canoni classici del romanzo storico. Pubblicato da Fazi editore, si intitola “L’angelo egoista”.Tutti i fatti, i personaggi e i luoghi sono storici. Inventato, ma più che verosimile, è il narratore, un giovane artista inglese, evidentemente di buona famiglia e con buone relazioni sociali, irretito dal fascino e sconcertato dall’ineffabilità dell’angelo egoista. L’invenzione del giovanotto narratore ha più di un pregio, non ultimo quello di evitare di fare risalire la psicologia di un’artista gelosa della sua libertà a un trauma dell’infanzia, come invece fanno le biografie autorizzate della Miller. novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 18 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 19 Il patriottismo insetticida di Marinetti Antonio Carnevale, Panorama, 11 novembre 2008 “Noi canteremo le locomotive dall’ampio petto, il volo scivolante degli areoplani”. A rileggere oggi il manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti c’è da immaginare la faccia dei pendolari. Che a cento anni di distanza fanno il viaggio casa-ufficio su treni lenti e malandati in ogni regione d’Italia. Oppure il grugno imbufalito dei piloti di Alitalia, che di “scivolante” vedono soprattutto il posto di lavoro. Ma nel 1909 il futuro doveva ancora venire: il Novecento avrebbe portato innovazione in ogni casa, in ogni città. Iniziava il secolo della scienza, della tecnica, della velocità. “Noi siamo sul patrimonio estremo dei secoli! poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente”: un’ossessione, per Marinetti, la velocità. Tanto che la mise in pratica anche nell’arte, con una nuova letteratura che per correre più rapida voleva fare a meno della punteggiatura. Cominciò con la poesia, approdò al romanzo con Mafarka il Futurista (che gli valse un processo per oltraggio al pudore) e dopo qualche decina di altre opere tra versi, testi per il teatro e narrativa, finì con Patriottismo insetticida, uscito nel 1939 e poi mai ripubblicato. Ora quel romanzo “di avventure legislative” torna in libreria grazie ai tipi di Excelsior1881. Patriottismo insetticida narra le avventure di Paranza e Urò, due magistrati che passano i n esame una serie di imputati, tutti, infine, assolti dai loro improbabili reati. Qualche esempio? Assolto il signor Riccadonna perché ladro sì, “ma con degli ideali”. Assolto un tale che ha aiutato 206 suicidi a morire (d’indigestione): ha svolto “il compito umanissimo di semplificare e affrettare le agonie lente e dolorose”. Assolto il tale che si vanta “d’aver pestato un direttore di giornale che calunniava patrioti per aumentare pubblicità vendita e tiratura”. Negli ultimi capitoli il magistrato Paranza si concede anche un viaggio alle Isole Figi (inutile cercare il nesso col resto del romanzo: non c’è). E dovendo dare un giudizio morale su una comunità di cannibali assolve anche loro, perché “in certi casi” dice “l’antropofagia è difendibile”. Un Marinetti più anarchico che nazionalista, insomma. Che mentre celebra la patria e condanna l’esterofilia, scomoda anche temi come l’eutanasia, l’intolleranza, l’etica del commercio. Tutti argomenti che a distanza di un secolo, a differenza dei personaggi del romanzo, sono ancora sul banco degli imputati, in attesa di un giudizio. rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 20 Il trionfo del Gattopardo Gioacchino Lanza Tomasi, la Repubblica, 11 novembre 2008 Edoardo Sanguineti notò la tenuta sul mercato del titolo che si ristampa costantemente. Francesco Orlando ha elencato i cinque pregiudizi che offuscano la ricezione del libro Oggi ricorre il cinquantenario della pubblicazione del Gattopardo.Il libro ha fatto il suo corso e non ha rivali all’estero quale rappresentante della letteratura italiana del secondo Novecento. Per i non italiani, per i docenti di letterature comparate Il Gattopardo resta il titolo più rappresentativo della narrativa italiana del secondo dopoguerra. Le citazioni che potrei fare in proposito sono numerose, ma vorrei rammentare fra tutte un passo da Carta esferica di Arturo Pérez-Reverte, un narratore le cui ambizioni restano nell’ambito del successo popolare piuttosto che in quello del capolavoro. Lo scaffale di narrativa straniera in casa di Tànger Soto, funzionaria del museo navale, contiene un solo romanzo italiano: Il Gattopardo. La collezione di narrativa di Tànger è limitata. Ma vi sono anche Céline, Conrad, Joyce, Mann, Faulkner. Siamo al 2000, quarantadue anni dopo la pubblicazione del Gattopardo. oblique studio All’estero Il Gattopardo è un libro fondamentale perché è un libro per tutti. Ho citato Pérez-Reverte e non Edward Said, autore del più illuminante saggio sul romanzo e sulla personalità di Lampedusa, perché la citazione dello spagnolo dà per scontato che il libro è il solo romanzo italiano del Novecento ad avere un posto d’obbligo nella biblioteca di un lettore medio. E non soltanto. L’intervento di Olga Ragusa al Convegno su Tomasi di Lampedusa a New York (1993) evidenziava come Il Gattopardo avesse sollecitato una rivisitazione della teoria e tecnica del romanzo. Dilettante illuminato Lampedusa aveva offerto nel suo saggio su Stendhal un contributo alla narratologia che aveva stimolato una serie di confronti e risposte. E la Ragusa aveva allora previsto che il romanzo avrebbe prodotto qualche chiosa narrativa. Il che si è verificato con Auftrag in Tartu di Ulrich Knellwolf (1999) e Il ritorno a Stomersee (2002) di Boris Bianchieri. Un libro che genera libri. In Italia Il Gattopardo è certo presente. Ha una eccezionale tenuta sul mercato, quale romanzo italiano si ristampa costantemente dopo cinquant’anni? Ma al tempo stesso è un oggetto controverso. Edoardo Sanguineti al convegno di New York iniziava la sua relazione constatando che libro era ancora presente sul mercato italiano con 50mila copie annue di vendita e che il titolo si era infiltrato nella lingua corrente per descrivere un comportamento: «il gattopardismo», il cui senso oscilla fra il trasformismo ignobile e il trasformismo profetico. Ed a questo punto i letterati sperimentalisti erano stati costretti a prenderlo in considerazione. Fin dalla sua comparsa in libreria il romanzo ha destato rancori a volte anche violenti. Rammento ancora la filippica del filosofo Santino Caramella sulla sua immoralità, e la polemica iniziale della sinistra.Tanto sdegno segnava l’apparizione di un testo fra i più destabilizzanti per il costume nazionale. Questo vale tanto per il privato che per il pubblico. Siamo nell’inverno del 1959, e le deplorazioni di Caramella e di Leonardo Sciascia trovarono un riscontro diverso, più preciso nella motivazione, distante eppur affine nella sostanza, nel commento di mia zia, Lucia Lanza di Mazzarino. L’ispezione ecclesiastica a villa Lampedusa e la eliminazione delle reliquie false era ancora un vivido ricordo della sua adolescenza, e quando venne al giudizio disse soltanto: «Quei poveri morti! Ma non si poteva lasciarli in pace!». Dal privato al pubblico il passo è breve. Alcuni si sono risentiti per un testo che derideva le loro certezze. Sì, quelle certezze erano magari poco fondate, ma metterle in discussione equivaleva a complicarsi la vita. La storia d’Italia era quella che era ed i morti andavano lasciati in pace. rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 21 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Nel suo L’intimità e la storia. Lettura del Gattopardo, Francesco Orlando elenca nella premessa cinque pregiudizi che offuscano la ricezione del romanzo in Italia: 1) biografico, 2) immobilistico, e di qui il significato di gattopardismo e di gattopardesco, 3) ideologico, 4) sperimentalista, 5) regionalista. Ma salvo il quarto, lo sperimentalista, che è questione interna alla casta letteraria, gli altri quattro si formano all’interno di un contrasto fra l’ordine ufficiale delle cose e le spiacevolezze in cui si incorrerebbe se tale ordine fosse messo in discussione. Al centro di questo problema si staglia quello dell’Italia unita. È la situazione più conflittuale e pertanto rimossa della coscienza nazionale. E come non si ha reazione chimica senza calore non si ha rimozione senza pena e dolore. Tanto più che Il Gattopardo non è un romanzo filo borbonico o un romanzo immobilistico. Lampedusa fa votare il suo antenato a favore del plebiscito, ma al tempo stesso contempla che l’unità si è andata attuando in una camicia di forza, brogli elettorali, clientele, che ai gattopardi ed ai leoni sono subentrati le iene e gli sciacalli. Qualche giorno fa l’ineffabile Bruno Vespa ha dedicato una puntata di Porta a Porta al 4 novembre. Una deliziosa parlamentare del Pd battibeccava col patriottico La Russa. Si opponevano i caduti delle decimazioni di Cadorna agli eroi Baracca, Battisti, Rizzo, D’Annunzio, evocati in uno short caldeggiato dal ministero della difesa. Giulio Andreotti intervenne un attimo ricordando che fra tante battaglie sarebbe stato opportuno ricordare anche la battaglia del grano, ma non era clima di battute e nessuno ne colse la cattolica perfidia. Non tirava aria di sottigliezze ed in questo clima, che è poi il clima del momento, Il Gattopardo sarebbe stato l’intruso per eccellenza. Il paese è ancora alla oblique studio Pagina 22 ricerca di una identità e si pensa di poterla fornire facendo appello alla comunicazione di massa. Nella lontana Sicilia Raffaele Lombardo se l’è presa con un Lampedusa disfattista. La nazione siciliana da lui ipotizzata è anch’essa una formula a cui aderire pro bono pacis, non la Nazione, che ha eletto Barack Obama. E fra l’adesione e la partecipazione ce ne corre. Scorre poi ancora, sotterraneo e maggioritario, il largo fiume dei lettori del Gattopardo. Li ho visti nascere, crescere, resistere. Nell’inverno del 1958-59 si contavano a Palermo numerosi oppositori e scettici, con in prima fila i discendenti di Angelica. Perché in società tutto diventa personale e alcuni passi apparivano loro una postuma maldicenza. Ma non mancavano i critici anche fra gli intellettuali, colti di sorpresa da un evento inaspettato. Ed il prodigio che si andò sviluppando nel corso del 1959 e fino al Premio Strega fu di constatare come il lettore comune, il lettore allogeno non provasse risentimento alcuno, si riconoscesse anzi nella saggezza di Don Fabrizio.Anche i lettori che potevano esser ascritti alla categoria delle iene e degli sciacalli non furono sfiorati dal sospetto che questa collocazione li riguardasse. La sola possibile era l’identificazione con il Principe. La simpatia del personaggio aveva fatto loro cadere le scaglie dagli occhi e li aveva guidati verso occasioni, memorie di diletto da tempo cadute in oblio. Ricordo lettori per cui il libro rappresentò una sorta di epifania della memoria, memoria di passati piaceri. Una volta un tassista palermitano, che mi aveva riconosciuto, mi raccontò quale esperienza indimenticabile fosse per lui racchiusa nel commento al tratto con cui il senatore Tassoni si rivolge ad Angelica nel capitolo finale del romanzo: «Con lei aveva avuto una breve relazione galante trent’anni prima e conservava quella insostituibile intimità conferita da poche ore passate fra il medesimo paio di lenzuola». Ma il tassista non è un’eccezione. Vari lettori del Gattopardo parlano di questo o quel passo come di una scoperta a lungo attesa, tanto da potersi affermare che Lampedusa sia stato per loro un maestro di perenne diletto. La miscela salvifica, fatta di rivelazione e conciliazione, ha generalmente avuto la meglio sulle frequenti distinzioni di classe e di comportamento disperse nel flusso della narrazione. Il gruppo più motivato degli oppositori si colloca in Italia proprio nel mondo delle lettere militanti (quel che Orlando definisce il pregiudizio dello sperimentalismo). Per loro Il Gattopardo è, come ebbe a scrivere Contini, un grande testo di divulgazione letteraria. Anche in questo campo non mancano i pareri opposti. Ma lo zoccolo duro dei lettori italiani non riesce a sottrarsi all’identificazione col protagonista. Essi escono dalla lettura del romanzo come gli spettatori di una buona edizione del Rosenkavalier – fu con questa opera che il pregiudizio dello sperimentalismo separò definitivamente Adorno da Strauss –. Gli spettatori non sanno molto di Vienna e della finis Austriae, ma hanno ascoltato una favola d’incanti, ove si parla di un passato migliore, storicamente più sogno di desiderio che realtà. E si sono abbandonati alla favola. Ed essa ha parlato di un tempo e luogo in cui ciascuno ha potuto guardare in faccia le pene d’amore e l’angoscia della morte. E, per chi vorrà calarsi in questi testi, sotto la superficie si imbatterà in un reticolo fitto di esperienze storiche, psicologiche, narratologiche. Il Gattopardo potrà esser letteratura minore o maggiore, ma viene ritradotto e ristampato in trenta e più lingue. A cinquant’anni ha ancora la chiave della longevità. 22 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 23 Franz Kafka e l’arte di disegnare gli incubi Luigi Mascheroni, il Giornale, 14 novembre 2008 L’opera del grande scrittore praghese “riletta” attraverso la graphic novel. E il senso del capolavoro non cambia. Come è destino dei classici Esistono decine, centinaia di definizioni di “classico”. Da Thomas S. Eliot a Arnold Bennett si potrebbe tentare un’antologia d’autore su che cos’è un classico in letteratura. Riassumendo e semplificando, si potrebbe dire che un “classico” è quell’opera che resiste non solo al tempo ma alle “letture”, nel senso che continua a mantenere il proprio messaggio e il proprio valore anche quando viene re-interpretata in forme diverse, anche le più estreme: il caso del Giulietta e Romeo di Shakespeare in salsa tarantiniana nel famoso film “pop” di Baz Luhrmann del ’96 – dove il testo shakespeariano mantiene tutta la sua forza e la sua attualità anche in bocca ai peggiori ceffi di un gang metropolitana nella Californiana di oggi – è solo un esempio fra migliaia. “I classici sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale”, scriveva Italo Calvino. Ecco: inconscio collettivo.“Classico” è il testo il cui contenuto si deposita nell’inconscio umano, anche se – in tempi e luoghi differenti – mutano i “contorni”, le forme, i colori… In questo senso, un classico assoluto della modernità, forse il classico dei classici, è l’intera opera di Franz Kafka (1883-1924), lo scrittore ebreo praghese di lingua tedesca senza il quale il secolo scorso, e questo attuale, non sarebbero quello che sono. La 23 dimostrazione è l’infinità varietà di “letture” kafkiane che l’editoria, ma non solo, ci propone di continuo. Solo negli ultimissimi mesi non si contano le riedizioni dei suoi testi: nelle collane dei classici, appunto, in quelle per la scuola, nei tascabili, in versione audiolibro (La metamorfosi in versione audio, in due cd, per le edizioni Narratore Audiolibri)... E ora anche in versione graphic novel, ossia quel particolarissimo tipo di fumetto in cui le storie hanno la lunghezza del romanzo e si rivolgono a un pubblico adulto. Un genere letterario che sembra adattarsi perfettamente a Kafka e alla sue storie senza tempo. Due gli esempi più recenti. Da una parte, il capolavoro La metamorfosi (pubblicata da Guanda) nella versione dell’illustratore americano Peter Kuper (nato nel 1958 a Cleveland, nell’Ohio), fondatore della rivista politica a fumetti “World War 3” e disegnatore per grandi giornali come “The New Yorker”, “Time” e “The Washington Post”: qui la storia del commesso viaggiatore Gregor Samsa che si risveglia una mattina scoprendosi trasformato in un enorme scarafaggio ma continuando a pensare e ragionare come uomo, mantiene e anzi sembra arricchire l’impatto emotivo e la resa espressiva della scrittura kafkiana. Dall’altra parte, la biografia Kafka (appena uscita da noi per Bollati Boringhieri con un’introduzione di Goffredo Fofi) raccontata – anzi disegnata – da Robert Crumb, probabilmente il novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 più grande fumettista underground del mondo. Nato a Philadelphia nel 1943 e fin da giovanissimo vicino alla movimento creativo del comix underground e più in generale alla controcultura degli anni Sessanta-Settanta (acidi compresi), Crumb ha creato nella sua lunga e gloriosa carriera alcuni personaggi divenuti dei veri simboli come Fritz The Cat o Mr. Natural. Oggi il tratto underground Pagina 24 di questo maestro della matita dà corpo alla vita e alla fantasia onirica del grande praghese in una bellissima storia in forma di disegni e fumetti (con testi di David Zane Mairowitz) che porta il lettore sotto la bombetta del Signor K., fin dentro il cervello del grande scrittore-visionario che meglio di chiunque altro nel Novecento ha perlustrato gli anfratti della condizione umana. Dal tratto spigoloso, graffiato, duro di Kuper alle tavole “espressioniste” di Crumb, due modi “altri” di leggere l’opera di Kafka, ma identici nel trasmettere gli incubi – che poi non sono altro che le inevitabili declinazioni di quella strana regola che si chiama vita – terribili, claustrofobici, amari, sognati da un mite signore ignorato dalla sua epoca e che oggi è un Classico. rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 25 Sono io il nuovo Bukowski Alessandra Farkas, Corriere della Sera, 17 novembre 2008 Jonathan Ames: «Esorcizzare gli imbarazzi della cultura popolare americana» «Ieri sera ho mischiato assenzio e vodka. Non ho ancora messo il naso fuori perché stavo cercando di riprendermi».Sono le undici del mattino quando Jonathan Ames emerge arruffato e a piedi nudi sul portone del suo vecchio brownstone nel cuore di Boerum Hill, a cinque minuti dal ponte di Brooklyn, scusandosi per aver scordato l’appuntamento. 44enne autore di Sveglia, Sir! e Veloce come la notte ha tutti i motivi per celebrare. Il suo ultimo libro The Alcoholic ha appena ricevuto una lunga ed elogiante recensione sul New York Times; il suo corso in fiction alla New School è tutto esaurito e i produttori cinematografici di Hollywood vorrebbero fargli scrivere l’ennesima sceneggiatura tv. E se non bastasse in Italia – definita da Ames «il mio Paese preferito tra quel- li dove sono tradotto» – è da ultimo uscito Cosa (non) amare (Baldini Castoldi Dalai, traduzione di Francesco Casolo, pp. 346, € 16,50), come al solito ispirato alla sua vita. «Sono uno scrittore autobiografico», spiega ingurgitando un energy drink biologico, forse per superare la sbornia notturna. «Alla Jack Kerouac e Tom Wolfe, anche se non sono un fan di quest’ultimo. Il mio referente», precisa, «è piuttosto Charles Bukowski». Tutt’intorno, sui mobili, sulle poltrone e sul grande letto disfatto del bilocale sono ammonticchiate pile immense e traballanti di libri: una passione, spiega, istillatagli dalla madre insegnante quand’era bambino. «Ho appena ricevuto due romanzi di Moravia dal mio amico Jason Schwanman. Sono cresciuto leggendo Tolstoj, Baudelaire e Thomas Mann ma anche Italo Calvino e Primo Levi». In Cosa (non) amare, descritto dalla New York Times Book Review come «una gustosa e spumeggiante farsa di droghe, calvizie e complessi edipici», lo scrittore si abbandona a dettagliate descrizioni di funzioni corporee e bassissimi bisogni. «La cultura americana è molto puritana – teorizza – i miei lettori apprezzano che io abbia il coraggio di parlare di certe cose a voce alta: esorcizza il loro imbarazzo». Il protagonista è un uomo metropolitano, incerto nei rapporti con l’altro sesso, angosciato dal concerto d’identità e genere, perennemente insicuro dei propri attributi «Quella del fallo è un’ossessione tipica del maschio americano ebreo – ammette – Bret Easton Ellis scrisse addirittura un saggio sulla natura fallocentrica di quel libro, affermando che è il mio chiodo fisso». novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Dietro la nevrosi del protagonista («avevo un naso troppo grande e un pene troppo piccolo») si cela una metafora ben più profonda: l’ansia del sentirsi inadeguato. «L’ossessione fallica non è altro che il simbolo dell’Angst di cui parla Kierkegaard».A riscattarla è per fortuna l’autoironia, un espediente che lo ricollega idealmente alla grande tradizione ebraica a cavallo tra comicità e tragedia, da Mort Sahl a Lenny Bruce, da Woody Allen a John Stewart. «L’humour è la risposta migliore ai problemi della vita. Ridere è molto più catartico che prendere tutto sul serio. Comunque – precisa – io dirigo i miei strali comici sempre verso me stesso, mai all’esterno». Ames giura di «non scrivere mai sotto l’influenza delle droghe, perché non mi servono certo ad essere più creativo». Ma poi ammette che «ti danno spunti interessanti che non avresti da sobrio, specialmente la marijuana». Dopo l’uscita del suo primo libro, fu costretto ad andare coi genitori dallo strizzaceivelli – che continua a frequentare, ma telefonicamente – per spiegar loro che cosa nel testo fosse vero e cosa inventato. Perché preoccuparsi tanto? «Mamma e papà vivevano tranquilli nel sobborgo benpensante e conformista del New Jersey dove sono nato – replica – quando un bel giorno il loro unico figlio maschio pubblica un libro che parla di sesso selvaggio e stramberie varie, tra lo stupore-orrore dei vicini». Gli Ames si sono ripresi dallo shock, ma da allora hanno smesso di leggere i suoi libri. «Non mi dispiace se perfetti sconosciuti scoprono i miei segreti; è dei parenti che mi preoccupo. Soprattutto con l’uscita dei miei prossimi due libri: The Double Life is Twice as Good e If You Know Me Please Don’t Read This». «Una notte, quando mi sentivo particolarmenoblique studio Pagina 26 te in colpa per tutti i miei segreti, realizzai come per miracolo che vivere due vite opposte e parallele è un bene», rivela, «Così ho deciso di scrivere The Double Life is Twice as Good». Il suo modello è Klaus Kinski, musa di Werner Herzog,proprio in quanto uomo che «sapeva essere sempre sé stesso, senza vergogna. Quanto vorrei avere il suo fegato». E invece si deve accontentare di un impavido alter-ego: Patrick Bucklew, pittore e performance artist in odore di scandalo a causa della cosiddetta “mangina”. Una mega vagina in plastica di cui ha realizzato vari esemplari e che indossa ai party e durante le sue performance teatrali nei club più trasgressivi di downtown. «Patrick è completamente pazzo e sembra uscito dalla Berlino degli anni Trenta; io sono il suo biografo ufficiale». Il fascino per i transessuali è del resto uno dei leitmotiv delle sue opere. «Il transessuale è da sempre presente nella nostra cultura, dagli dèi hindu alle statue dei nativi americani. Come diceva Carl Jung, siamo tutti bisessuali». Grazie alla loro bellezza, secondo Ames, i trans permettono agli uomini di «esplorare la propria indole bisex senza vergogna». «Forse l’evoluzione della specie umana favorisce una convergenza dei generi: un’alternativa pacifista al macho aggressivo e guerrafondaio e alla femmina passiva e docile». In un angolo del disordinatissimo appartamento Ames riesuma uno dei quadri di Bucklew: il coloratissimo ritratto della cantante Fiona Apple. «È la mia girlfriend» spiega, «una donna estremamente sensibile e fragile, come tutti gli artisti». Ma il sogno di una famiglia tradizionale non è nelle carte: «Ho già un figlio di 22 anni che frequenta il college». Ames racconta, senza remora alcuna, che si è trattato di «un incidente». «Avevo 23 anni quando trascorsi una sola notte con sua madre, parecchio più vecchia di me. Due anni più tardi rice- vetti una lettera che m’informava di avere un figlio di 15 mesi». Rimpianti? «Nessuno. Credo di essere stato un buon padre single per mio figlio che oltre ad assomigliarmi come una goccia d’acqua porta il mio nome». A Brooklyn Ames è arrivato vent’anni fa, attratto dagli affitti economici che l’hanno trasformato nel quartiere degli artisti. Una comunità in realtà ben poco aggregata. «Non frequento gli altri scrittori della zona e soltanto alle feste mi capita d’incontrare gente come Jonathan Lethem e Paul Auster. Colson Whitehead, anche lui di Brooklyn, ha scritto un editoriale sul New York Times proprio per sfatare il mito della “comunità di scrittori”». Nel 1989, quando uscì Veloce come la notte, Ames fu paragonato a Bret Easton Ellis e Jay McInerney, due scrittori verso i quali, confessa, «allora provavo gelosia». Vent’anni più tardi, mentre Ellis e McInerney sono dati per «finiti» dai critici, Ames si è trasformato nel beniamino della critica. «Devo parecchio a Joyce Carol Oates, mia docente di scrittura a Princeton, la cui incredibile generosità è il più grande dono che un insegnante può fare a uno scrittore». Per lui si è scomodato perfino Philip Roth che nella prefazione di Veloce come la notte l’ha definito «un misto di Jean Genet e del Giovane Holden nell’età dell’Aids». Il sodalizio tra Ames e il leggendario autore di Pastorale americana è nato per caso. «Avevo dato una copia del libro a Joanna Clark, scrittrice polacca e amica mia di Princeton, che è anche amica di Roth.A mia insaputa lei gli spedì il manoscritto». Il resto è storia. «So solo – dice – che è la prima e ultima volta che Roth ha patrocinato uno scrittore sulla copertina di un libro». 26 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 27 Gli scrittori italiani si occupano di realtà o di ideologia? Il nuovo almanacco Guanda divide i critici Mario Baudino, La Stampa, 19 novembre 2008 I narratori sono tornati alla realtà. Dal «new epic» dei Wu Ming al «nuovo naturalismo» di Roberto Saviano, è l’ora dell’impegno. Questo annuncia l’Almanacco Guanda appena uscito a cura di Ranieri Polese col titolo Il romanzo della politica, la politica del romanzo, ma subito si scopre che l’affermazione non è così scontata. Polese sostiene che il cosiddetto «noir italiano» è stato il vero motore, negli ultimi 15 anni, di questo benedetto ritorno al reale, e apre un fronte polemico. Perché l’idea che il giallo sia il genere più vicino alla società in cui viviamo, spesso ripetuta orgogliosamente dai «giallisti» (nell’Almanacco, per esempio, lo fa Giancarlo De Cataldo),è stata spesso contrastato, e con forza. Filippo La Porta, per esempio, pubblicò due anni fa un memorabile saggio nel volume a più mani Sul banco dei cattivi (Donzelli) chiedendosi se non fosse proprio il giallo italiano il genere più congeniale a noi, cittadini di un Paese poco serio. 27 Fra i suoi tanti difetti – concludeva – il noir nostrano ha infatti quello di essere consolatorio, convinto com’è che «la verità più profonda sia nascosta in un mistero», ragion per cui «semplifica a oltranza la nostra vita interiore, la nostra psicologia e i nostri dilemmi morali». Detto in altre parole – molto «altre» – è un genere ideologico e complottista. Questo lo scrive Massimiliano Parente su Libero di sabato scorso, aggiungendo per buona misura che l’intento (dell’Almanacco Guanda) è «far passare ciò che un tempo era pacificamente “paraletteratura” come grande letteratura, spazzando via la letteratura che conta con la scusa piccina piccina del“reale”».È una truffa ideologica proclama il giovane scrittore. Luca Mastrantonio, dal Riformista, gli tira pacatamente le orecchie scherzando sul fatto che Parente mette mano alla pistola ogni volta che sente la parola realismo. Ma la domanda resta. Siamo di fronte a una generazione di scrittori finalmente tornati all’impegno, o a una finzione collettiva? Risponde Polese: «Più che di impegno parlerei di ritorno al reale. Nel giallo si parla di cose vere, per scriverlo bisogna avere almeno un’idea di come funziona l’Italia. Questo è un dato meramente tecnico. Ce n’è però uno di sostanza: l’attenzione vera ai contenuti e ai tipi del Paese in cui viviamo». Abbiamo lasciato alle spalle, continua, «quelli che Goffredo Fofi chiamava gli scrittori bonsai: storie private, personaggi privi di legami con una realtà specifica». Ora non è più così? «Direi di no. Basti pensare che su questa falsariga è venuto Gomorra, libro certo molto complesso; è pero anche il risultato di un’indagine». Saviano a parte, Filippo La Porta non ha cambiato posizione rispetto a due anni fa. «Il noir italiano ha deluso, tranne casi isolati. È un genere che mi pare “trapiantato”e non “reinventato”, come per esempio fece Sergio Leone con il western. Ha deluso quando ha creduto di essere il solo in grado di rappresentare la realtà. L’unico grande romanzo realista di quest’anno, invece, è per me Il contagio di Walter Siti. Realistico e visionario. Pasolini diceva del Belli che riesce a raccontare veramente il popolo perché è come se lo vedesse in sogno. Siti fa così». E gli altri, tutti bocciati? «C’è la cultura di intrattenimento e di massa, che soddisfa bisogni assolutamente legittimi. Detesto i libri che stanno in mezzo: romanzi che fanno finta di essere di genere, autori che si credono Proust. Siti novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 è uno scrittore impegnato perché l’unico impegno dello scrittore è quello conoscitivo». «L’unico impegno che ha lo scrittore è con la propria lingua», aggiunge Massimo Onofri, indaffaratissimo a organizzare il Tarquinia Cardarelli, un premio per la critica letteraria. E allora, Polese ha ragione o torto? «Polese ha ragione quando dice che la letteratura italiana insegue un feticcio di realtà. Ma questo di per sé non rende un libro più o meno interessante». Esempi? «Franco Cordelli e Siti sono scrittori della realtà, ma i loro grandi temi riguardano proprio l’irrealtà». Entrambi sono presenti sull’Almanacco. «Ed entrambi assumono un impegno col proprio linguaggio e con l’oggetto della rappresentazione. Mentre invece un autore molto lodato come Erri De Luca propone solo estetismo e megalomania dell’io. A me interessano quei romanzi oblique studio Pagina 28 che hanno a che fare con una verità profonda dell’autore». Forse il problema non è allora il giallo, inteso come genere il cui successo non sembra conoscere ostacoli, anche se pare arrivato al suo punto apicale. O forse sì. Se infatti ci rivolgiamo a chi legge per mestiere i manoscritti che in gran parte, come ovvio, non diventeranno libri stampati, troviamo indicazioni sconcertanti. «L’ottanta per cento dei testi che esamino per dare un parere all’autore sono ormai libri “gialli” a vario titolo», confessa Laura Lepri, ascoltatissima editor indipendente. Detto così, fa un po’ paura. «È vero però che grazie all’enorme successo del genere molti hanno imparato a lavorare sulle trame, il che in Italia non era così abituale». L’epidemia è alla fase acuta, ma finirà che dovremo accontentarci. Anche questa, in fondo, è scuola. 28 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 29 IL GUSTO DEL FALLIMENTO Tradotto «Easter Parade» del newyorkese Richard Yates (1926-1992) Francesco Borrelli, il manifesto, 22 novembre 2008 Una delle domande che vengono in mente girando l’ultima pagina del quarto romanzo di Richard Yates è come mai possa averlo interessato seguire tutta la parabola esistenziale di due sorelle senza particolare fascino, né vizi o doti esemplari, e per di più concentrarsi in parallelo su un terzo personaggio femminile, la loro madre, completando un quadro nel quale nessuna passione è sufficientemente evocata da far temere o incoraggiare una qualche identificazione. E una delle possibili risposte è che Yates intendeva – in Easter Parade (ora tradotto da Andreina Lombardi Bom per minimum fax «classics», pp. 283, € 11,50) – aprire un ventaglio di personaggi qualunque, che esaltassero la sua già dimostrata propensione a concentrarsi su esistenze fallimentari, aggiungendo altre vite malvissute al suo campionario della solitudine. In più, questo romanzo gli avrebbe consentito di esercitare la sua vena 29 narrativa in tre variazioni sulla figura della madre, una presenza che torna in tutta la sua opera. La madre di Yates si chiamava Ruth ed era una scultrice, ma i figli le preferivano il soprannome di Dookie: il richiamo a lei è in questo romanzo così esplicito che all’autore basta cambiare una lettera e chiamare Pookie il personaggio della madre, nonché affibbiarle una mania le cui conseguenze lui stesso aveva dovuto subire, ossia quella di sottoporre la famiglia a continui traslochi. Quando la trama prende avvio, il divorzio di Pookie dal marito, padre delle sue figlie ancora bambine, si è già consumato, e Yates annota, giocando sull’incipit di Anna Karenina, che né l’una né l’altra delle sorelle avrebbero avuto una vita felice e, a pensarci bene, tutto aveva avuto inizio con la separazione dei loro genitori. Il fatto è che tutti i matrimoni per Yates sono infelici allo stesso modo, litigiosi e destinati a approdare a una separazione, come esemplifica in maniera magistrale il suo primo e più grande romanzo, Revolutionary Road, che avrebbe condizionato tutta la sua narrativa posteriore, indicandogli un modello cui non fu più capace di corrispondere. Il meglio di sé Yates lo dà quando scende nel fondo dell’abbrutimento che lui stesso ha sperimentato, quando l’alcol ingerito dai suoi personaggi si converte nei fantasmi che lo hanno assillato, quando si rivede nei suoi personaggi, distaccato dalla sua volontà, promettere redenzioni che appaiono e svaniscono con la prontezza di un miraggio, e quando descrive i repentini sbalzi di umore che subisce una mente alterata: come quella di John Wilder, per esempio, l’uomo troppo basso per accettarsi fino in fondo e troppo lento nel leggere per venire a capo di qualsiasi libro, che beve smodatamente e insegue le ragazzine in Disturbo della quiete pubblica, un altro buon romanzo che Yates scrisse nel 1975 (minimum fax 2004). Le sinistre suggestioni di una famiglia avviata alla rovina, come quella dei Wheeler di Revolutionary Road – che abitano in una zona residenziale del Connecticut e incarnano buona parte dei cliché piccolo borghesi degli anni ’50 – qui tra le pagine di Easter Parade vengono a mancare, proprio perché la coppia si è già disfatta quando si apre la prima pagina. La figura dell’uomo è tutto sommato quella più equilibrata: gli è spettato il compito di subire le mattane novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 della moglie e ora lo attende il dovere di smontare delicatamente le idealizzazioni delle figlie. Siamo nel 1930, all’indomani della grande depressione,la madre di Sarah e di Emily è impiegata nel mercato immobiliare e cambia casa a seconda del suo estro e della sua fortuna, sempre mantenendo fede al principio di scegliere una dimora capace di catturare quella «finezza» che le sembra costituire il migliore ingrediente del successo sociale. Più modesto e più accorto, l’ex marito compare poco, ma quando c’è risulta amorevole e saggio nel disilludere le figlie circa le qualità che loro gli attribuiscono. Un giorno Walter Grimes le porta in visita al Sun, il giornale presso il quale le bambine credono che lui lavori a fare i titoli, mentre è un semplice correttore di bozze, e per di più non provvisto del talento che gli servirebbe per sbattere la porta di quel giornale reazionario e ultrarepubblicano e cercare un lavoro più affine alle sue simpatie politiche. Forse proprio perché lo fa comparire poco,Yates non si accanisce su di lui come su altri personaggi che ha votato alla disperazione, mentre mette a fuoco impietosamente tutte le miserie piccolo borghesi di cui Pookie è dotata, la sua abitudine a distorcere la realtà e a immaginare per le figlie e per sé stessa destini sociali che non si sono mai prefigurati, prima di abbandonarsi all’alcol e alla modesta depravazione che ne consegue. Così la si vedrà sempre più spesso imporre la sua verbosità agli altri e perdere il controllo sui suoi gesti,apparendo discinta e francamente inopportuna. L’unico dialogo con il marito è un fuori campo, che si svolge dietro la porta delle figlie restie a addormentarsi, con la piccola Emily che spera si stiano riannodando, in quella conversazione, fili invece rescissi per sempre. oblique studio Pagina 30 In quegli istanti che precedono il sonno si consumeranno le prime e ultime illusioni di Emily sul matrimonio, mentre la sorella Sarah ne coltiverà la sacralità, durante i lunghi anni della sua unione con un uomo che la picchia e, naturalmente, beve. La vita delle due sorelle procede parallela, prima a distanza ravvicinata, poi con una frequentazione sempre più rada: Sarah mette al mondo tre figli, abita in campagna nella casa dei suoceri e abbandona presto le sue velleità di scrittura. Il titolo del libro fa riferimento a un giorno della sua vita immortalato in una foto uscita sul supplemento domenicale del New York Times: era la Pasqua del 1941 quando elegantemente vestiti, lei e il suo futuro marito avevano sfilato in una macchina scoperta tra gli applausi degli astanti. La guerra incombente non li sfiora, né le figlie se ne preoccupano, né compare mai nei discorsi della madre,sempre occupata a raccontare ai conoscenti le meraviglie della tenuta nella quale Sarah si trasferirà dopo il matrimonio. Emily intanto vince una borsa di studio per il college, si confronta con la prospettiva di diventare «una intellettuale» e si interroga su ciò che questa parola vuole significare: una intellettuale può perdere la verginità durante l’incontro con un soldato, come a lei era capitato, ma quel che conta è «imparare a ricordarlo con un distacco ironico e divertito». Può permettersi di avere una madre che lascia vedere la sua biancheria intima quando si ubriaca, ma non può acconsentire a che la cosa le dia fastidio. Non deve parlare troppo né ammutolire alle feste, e deve imparare che, nel caso ci si sia resi ridicoli, non è elegante «rigirarsi nel letto, più tardi, in preda ai tormenti dello sconforto». Insomma, per essere una intellettuale bisogna dare a vedere che non si prende mai niente sul serio, e Emily ci prova. Poco o nulla filtra del suo dolore quando l’assistente di filosofia di cui si è innamorata si rivela impotente, né quando lui la lascia per dedicarsi all’analisi, né quando torna e la chiede in moglie. E tanto meno quando il loro matrimonio naufraga sulla impossibilità di consumare dei decenti rapporti sessuali: una delle tante prove di sfiducia che Yates esibisce nei confronti della psicoanalisi, da lui stesso sperimentata. E Emily non si scompone più di tanto nemmeno quando viene lasciata da un giovane marinaio mercantile che si rivela bisessuale e le preferisce un ragazzino suo amico. Né quando Jack Flanders, il caporedattore della rivista in cui lavora, reagisce alle sue frustrazioni di poeta mancato, rendendole la vita impossibile. Però alla fin fine anche lei cederà: dopo averle regalato una quantità di relazioni fallimentari, Yates sembra ribadire che nessun perdente può sperare in un riscatto: e così fa incontrare a Emily quello che sembrerebbe essere l’uomo della sua vita e poi fa sì che lui, ancora innamorato della prima moglie, la abbandoni per tornare dall’altra. Chi ha iscritta la sconfitta nel proprio destino – sembra dire quello che Esquire definì «uno dei grandi scrittori meno famosi d’America» – non ha scampo, e non gli restano, così Sara per Emily, altro che le seduzioni della solitudine: che chiama sé promettendo la sospensione del confronto con gli altri, la cessazione della fatica di scoprirsi inadeguati. Eppure, se fosse sopravvissuto alle complicazioni postoperatorie del piccolo intervento al quale si era sottoposto nel 1992, Richard Yates – che pure era stato abbastanza apprezzato da venire prescelto per scrivere i discorsi di Robert Kennedy quando era ministro della difesa – avrebbe visto il suo determinismo pessimista vacillare man mano che la sua fama cresceva e i suoi romanzi guadagnavano lo statuto di classici. 30 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 31 Se potessi vendere almeno 150mila copie Mirella Appiotti, Tuttolibri della Stampa, 22 novembre 2008 In tempi di crisi, facciamo i conti in tasca ai nostri scrittori: dai signori del bestseller come Camilleri al cabotaggio dei «precari» Per una volta indiscreti, invadenti, pettegoli: in questi tempi di crisi, facciamo un po’ di conti in tasca agli scrittori italiani. Dai grandi numeri (per il modesto mercato nazionale) dei nostri bestselleristi, più numerosi di quanto sembri a prima vista, ai piccoli o piccolissimi numeri dei «precari», termine che nell’hortus conclusus della creatività letteraria risulta, bisogna dirlo, molto meno angoscioso rispetto agli altri campi di lavoro. Insomma dai 15 milioni ineccepibili di copie di Camilleri, solo per quanto riguarda Sellerio e senza le sterminate traduzioni, alle 5-10mila in media di autori ormai di notevoli quanto non paragonabili prove come Tiziano Scarpa o Antonio Moresco del quale nel 2009 31 Mondadori pubblicherà la voluminosa trilogia dei Canti del caos, la terza parte inedita, con il corrispettivo pressoché umiliante di «6000 euro di anticipo, infatti io non camperei senza il lavoro di mia moglie». Tra questi due estremi, il percorso solido, con vendite robuste e piuttosto affollato, tra le 40 e le 50mila copie dei nomi che, alla fin fine, sostengono per larga parte la nostra editoria di narrativa grazie soprattutto al milione e mezzo dei cosiddetti lettori forti. Crisi mondiale a parte della quale non si conoscono per ora i possibili sviluppi anche nel mondo del libro (però, storicamente, «più le cose vanno male, più la gente legge» ricorda Sebastiano Vassalli), l’antico adagio Carmina non dant panem sembra dunque inapplicabile nel terzo millennio non solo all’universo dell’arte in generale, ma nella fattispecie alla letteratura. Benché, e il dato è abbastanza planetario, pressoché nessuno scrittore possa rinunciare all’«indotto», a quelle attività collaterali che, a seconda dei diversi livelli, rappresentano surplus di lusso o necessità di sopravvivenza. Da un calcolo approssimativo però vicino alla realtà, anche se ogni caso è sempre un unicum, l’autore che tagli il traguardo delle 150mila copie, raggiunte «di botto» o in un tempo più lungo, incasserà al netto circa 250mila euro. Partendo di qui sarà facile contare i proventi, da Mondadori, di un Saviano (1.700.000 di Gomorra) come di un novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Ammaniti (1.200.000 per Io non ho paura), o del fenomeno Giordano (1.000.000 con I numeri primi); di un Carofiglio (1.200.000 per i tre titoli da Sellerio con l’avvocato Guerrieri, 200mila da Rizzoli con Il passato è una terra straniera). Stellare e quasi incalcolabile l’universo Fallaci (vicine alle 600mila copie le Ciliege, uscite a luglio). E, sempre Rcs, per ogni titolo della Maraini in media 200mila, altrettanto la Aslan; 150mila la Mazzucco. Stabilmente in vetta, a milioni, Moccia, Littizzetto, Faletti. Un gradino più sotto ma pur sempre fuori classe: il De Cataldo di Romanzo criminale, 400mila copie; il Lucarelli del suo romanzo perfetto, Almost blue, 300mila circa, i Wu Ming di Q, 350mila, tutti einaudiani e si continuano a vendere. «I tempi sono molto cambiati, specie in quest’ultimo decennio – sottolineano abbastanza all’unisono agenti e editor indipendenti – ai grandi numeri arrivavano una volta quasi soltanto, fatti i dovuti distinguo, un Bevilacqua o un De Crescenzo e pochi altri. Poi venne la Tamaro, e poco dopo i cannibali… Gran svolta è stato il giallo italiano, tuttora il più richiesto all’estero: e a questa letteratura impropriamente di genere dovrebbero essere grati (effetto traino) anche i non giallisti». D’altronde fuori casa, la narrativa italiana, professionalmente forte, suscita sempre più interesse oblique studio Pagina 32 andando ad aumentare, sia pure moderatamente, gli introiti del 90% dei nostri autori. Se pur volando a quote alte, molti scrittori non abbandonano un vecchio o nuovo «lavoro» quotidiano (Carofiglio, prima magistrato, ora senatore; Buticchi scoperto da Spagnol e un super-Longanesi concessionario dell’unica spiaggia di Lerici dove sgobba d’estate, Mastrocola con oltre un milione di copie continua a insegnare) o sono catturati da cinema e televisione (non solo De Cataldo, ora su Sky, e «Montalbano» pigliatutto pure nella attuale nuova ondata, anche Veronesi e sino alla amatissima Oggero) da quota 150mila in giù l’indotto è una vera necessità. Tra i pochi che se ne defilano De Carlo cui la Bompiani ha dedicato una intera «linea»; Erri De Luca che con 100mila dice: «ho largamente di che campare»; altrettanto Corona tra i suoi boschi e in modo non molto diverso Vassalli: «Perché vivo in campagna, con modeste necessità» ma uno dei suoi hit, La chimera, ha avuto 23 ristampe con nove diversi editori oltre a Einaudi per un totale di 1.000.000 di copie. Nonostante le 150mila ad ogni uscita, Andrea Vitali continua a fare il medico e Piperno ha un’ampia pubblicistica, Scurati (50mila e più) una cattedra universitaria, Buttafuoco giornali e tv; né le 100mila dell’Elenco telefonico e neppure il passaggio da Sironi a Einaudi hanno allontanato Avoledo dalla banca, mentre il De Silva in gran crescita di Non avevo capito niente scri- ve per il cinema come da tempo anche Piccolo e la Ravera. Sotto la soglia delle 10mila copie si entra nel tunnel dei precari, non tutti vaganti nel variegato arcipelago dei piccoli editori, molti in scuderie importanti, giovani non ancora fortunati come Giordano ma anche nomi con splendido pedigree: esempio limite Marta Morazzoni, una delle nostre più interessanti scrittrici tra Longanesi e Guanda, insegnante a Gallarate, che racconta: «Vendo pochissimo, e quando mi capita come adesso che un giovane regista svedese voglia fare un film dal mio romanzo Casa materna, mi pare di non essere contenta ma piuttosto gelosa…». Ci starebbe invece Antonio Pennacchi, appena uscito da Laterza con Fascio e martello, dopo 4 romanzi e altrettanti saggi, scrittore di sinistra malamato dai suoi: «Paradossalmente mi fanno scrivere solo i giornali della destra, Fazio non mi inviterà mai, il mio indotto è l’ettaro di terra coltivato a kiwi…». Quanto ai rampanti da La Gioia a Raimo, lavorano nella factory di minimum fax, ma «capaci di rinunciare a qualche guadagno per dedicare tempo alla scrittura». Come ha fatto, ritirandosi per tre mesi in Scandinavia, Giorgio Vasta lodatissimo al suo debutto con Il tempo materiale. Essere precari può essere a volte non solo una scelta ma anche il passaporto per un bel conto in banca. rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 33 «Caro Hesse, come devo tradurre...» Il carteggio, raffinato e puntiglioso, tra Ervino Pocar e lo scrittore Armando Torno, Corriere della Sera, 24 novembre 2008 Ervino Pocar (1892-1981), il traduttore per eccellenza della letteratura tedesca in Italia, dopo avere studiato a Gorizia e a Vienna cominciò – correvano gli anni Venti – il suo lungo lavoro con la casa editrice Carabba di Lanciano. Nel ’34 diventava traduttore ufficiale dal tedesco e redattore capo del settore libri della Mondadori. Da Thomas Mann a Erich Maria Remarque, dal filosofo Ernst Cassirer a Franz Kafka, da Hermann Hesse a Novalis a Trakl, per limitarci ai più noti, il lavoro di Pocar permise a generazioni di italiani di accostarsi alla grande letteratura tedesca. Le traduzioni che lasciò in una sessantina d’anni di lavoro sono riproposte ancora oggi. Il suo archivio, conservato alla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori, consta di 346 fascicoli densi di preziose indicazioni che rivelano il volto di una civiltà della parola che stiamo dimenticando. 33 La lettera di Pocar e la risposta di Hesse che pubblichiamo in questa pagina risalgono al gennaio ’54. Sono l’ultima parte di uno scambio di impressioni e di richieste del traduttore, alle quali il tedesco (ormai svizzero a tutti gli effetti) replica con disponibilità e gentilezza. Sono il documento, dicevamo, di una civiltà scomparsa più che una serie di chiarimenti; riflettono un metodo di lavoro che a noi sembra eccezionale ma allora non lo era, tanto che si narra di un correttore di bozze della Mondadori mandato a Roma qualche anno prima per controllare edizioni rarissime di Bandello e stabilire una lezione definitiva per un passo delle opere che sarebbero uscite nei classici italiani diretti da Francesco Flora. Pocar, inoltre, in questa epistola offre un prezioso aiuto per comprendere la genesi del titolo italiano dell’opera più sofferta ed elaborata di Hesse e, di riflesso, anche la natura del singolare libro. La sua richiesta è formulata nella missiva del dicembre 1953. In essa, tra l’altro, leggiamo: «Lo scopo di questa mia lettera è duplice: primo, metterla al corrente e scusarmi per il ritardo del lavoro dovuto all’inconsueta difficoltà del testo; secondo, chiederle di aiutarmi nella giusta interpretazione di alcuni punti che non mi sono ben chiari, come ha fatto a suo tempo Thomas Mann». La professionalità non lasciava allora in un canto le buone maniere, quando si leggono le scuse di Pocar per la libertà che si è preso di «scriverle direttamente,rubandole del tempo». Parole che fanno una certa impressione, giacché l’illustre traduttore aveva già portato a termine quattro opere di Hesse: una per Mondadori, Il lupo della steppa, e tre per lo scomparso editore Martello. Soprattutto sono meravigliosamente inattuali le confidenze che invia allo scrittore: «Ora, Il gioco delle perle di vetro non è un libro facile, anche per i lettori tedeschi… spero di superare le difficoltà che il testo presenta. Ho solo bisogno di tempo. Ogni frase, anzi ogni parola del testo deve essere ponderata e fatta propria; ciò è assolutamente incompatibile con la fretta. L’editore però difficilmente si rende conto di ciò». novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 34 Lo studioso Sono preoccupato L’autore Un impegno scabroso Pregiatissimo Dr. Hesse, Innanzitutto la ringrazio di cuore per le righe gentili e le faccio i miei migliori auguri per la sua salute. Per quanto riguarda la mia traduzione, mi permetto di approfittare della sua disponibilità per sottoporle alcuni dubbi che mi preoccupano. Dapprima il titolo! Come si deve tradurre Glasperlenspiel? Nel contesto del libro la parola si presta a più di un significato, è cangiante e fluttuante, poiché il tedesco Spielen (come il francese jouer) ha un doppio significato. Purtroppo non esiste un equivalente in italiano. Nel testo si legge, per esempio, che Knecht porta a termine gli insegnamenti del Glasperlenspiel e progetta lui stesso Glasperlenspiele (plurale). E giusto parlare quindi di «Giuoco delle perle di vetro»? Ancora una domanda: l’opera è già stata tradotta in francese? In questo caso potrei verificare come se l’è cavata il francese. Inoltre, poiché in italiano non è possibile comporre le parole, un titolo come Il giuoco delle perle di vetro risulterebbe prolisso; io ometterei «di vetro» almeno nel titolo. Le chiedo inoltre cortesemente: chi è il Cigno di Boberfeld? Cosa sono Dormente risonanti? A pagina 301 la definizione gefordert («preteso») è corretta? Cito: «Le situazioni della storia universale, che un tempo avevano reso possibile e preteso la genesi dell’ordine» ecc… Oppure la parola doveva essere gefördert («promosso/incrementato»)? Ervino Pocar Stimatissimo Professore, grazie per la sua lettera. Cercherò di rispondere alle sue domande. L’edizione francese non è ancora stata pubblicata. È in preparazione presso la casa editrice Calmann-Levy di Parigi, rue Auber n. 6, alla quale in caso di bisogno può rivolgersi. Gli inglesi hanno risolto il problema del titolo chiamando il libro Magister Ludi. Pensavo alla possibilità di scegliere questo titolo anche per le lingue neolatine. Glasperlenspiel è da me inteso proprio nel senso di giuoco. Il fatto che la parola s’incontri anche al plurale, non è assolutamente una contraddizione. Esiste un giuoco degli scacchi e milioni di giuochi degli scacchi, cioè l’uno diverso dall’altro, anche se le partite sono tutte soggette alle stesse regole. «Schwan von Boberfeld» (Il cigno di Boberfeld) è il poeta barocco della Slesia Opitz. In molti conventi vengono chiamati Dormente sia i dormitori che i passaggi o corridoi tra i dormitori. Il risuonare (Holten) si riferisce all’acustica dei locali a volta. L’espressione «reso possibile e preteso» (ermöglicht and gefordert) a pagina 301 è da intendersi come «reso possibile, anzi preteso» (ermöglicht, ja sogar gefordert). Certo si tratta di un lavoro in parte scabroso. È costato anche a me a suo tempo parecchi anni. Saluti e auguri. Hermann Hesse oblique studio 34 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 35 Vita ingrata del traduttore prigioniero di due lingue Solitari, malinconici e pressati dal tempo: gli «interpreti» della scrittura altrui sono vittime di una missione impossibile Alessandra Iadicicco, il Giornale, 26 novembre 2008 Warum siehst du so traurig aus? «Ma perché hai un’aria tanto triste?», aveva chiesto il bel tipo col pointer alla ragazza che, il collo del dolcevita tirato su fino al naso, le maniche del maglione tirate giù sulle unghie, stava seduta in riva al lago con un libro in mano. Era ferragosto, a Costanza, Bodensee. Dopo tre giorni di clausura, di pioggia ininterrotta, si poteva mettere il naso fuori casa, purché infilato nella lana del golf. C’era freddo. Cigni arruffati. Il vento pettinava l’acqua contropelo. Il grigiore del lago saliva a cancellare la linea del cielo. L’insieme aveva una sua struggente bellezza. Perché tanta tristezza? Sarà per La malinconia del traduttore. Bel titolo. L’ha scelto Franco Nasi per i suoi racconti appena usciti da Medusa (pagg. 106, euro 11,50) e si vorrebbe rubarglielo. È un titolo bellissimo per un sentimento specialissimo. O è invece una malattia? Non è contagiosa. Neanche stagionale. Era certo che sarebbe esplosa quest’estate sul lago di Costanza, provocata più dall’incontro ravvicinato e prolungato con il carteggio tra Heidegger e Jaspers da riscrivere in italiano che non dai grigiori lacustri e dai rigori tedeschi. Sarebbe scoppiata anche ai tropici. Somiglia alla tristezza dei tropici, dell’antropologo che se ne va in un altro mondo per starne fuori, guardarlo di sbieco, vedere ciò che chi ci vive dentro non riuscirebbe mai a mettere a fuoco. Per il traduttore non è lo stesso. Si trasferisce sì in un altro clima, e ne subisce la 35 rigidità sulla pelle. Entra in un altro orizzonte di cultura e ci si nasconde dentro, facendone sparire l’estraneità. Si muove tra parole originali e deve prenderle per vere, rispettoso di un autorevole (autoriale) dettato. Non ha come l’etnologo il beneficio della distanza, il dovere di critica, il diritto di pronunciare il suo giudizio o di confessare la sua tristezza. La malinconia è il suo segreto. All’uomo a passeggio sul lago col cane non l’avrebbe mai detto. Che a quell’ora poteva essere al mare. Che se ne stava andando un’altra estate e non l’aveva neanche vista. Che di stagione in stagione, di traduzione in traduzione, presto sarebbe stata ora di dire «una volta ero una ragazza». «Sei singola, vero? Si vede», le aveva detto un’amica scrittrice. «Quand’è che ti togli di dosso quella faccia da studentessa?», le aveva detto un amico spietato. La solitudine del traduttore è la conditio sine qua non: la condizione dello studioso (o studente) mentre studia. Si lavora in silenzio.A casa.Da soli.In assoluta libertà – è questo il bello –, con la totale disponibilità di spazio e tempo. Non si risponde che al proprio senso del dovere – è questo il guaio –,a un’autoimposta disciplina.In mancanza di un orario o posto di lavoro ogni momento, ogni luogo, è buono per lavorare. Il mandato professionale si fa vocazione esistenziale, una missione. O è il contrario? Se ti hanno chiamata per commissionarti una traduzione è perché tu per prima hai detto sono qui. Quando? Molto presto. La giornata del traduttore comincia presto, prestissimo. Nell’ora in cui tacciono traffico e telefono. I vicini dormono. A chi non è abituato a esplorare quelle zone del giorno sembra indecente. C’è chi si spinge in là dentro le ore della notte. Ma un punto di equilibrio si trova. Come se alla tensione verso l’estrema concentrazione debba corrispondere una miracolosa distensione del tempo. La giornata si allunga perché tradurre è un lavoro lento. «Una lettura forzatamente rallentata del testo». La forza maggiore che ti frena è quella della scrittura. Potente più dell’urgenza della consegna, della scadenza del contratto, del numero di pagine «da fare» al dì che immancabilmente non si riesce a rispettare,ansia del traduttore... La sua palla al piede (o àncora di salvezza?) è la gravità della parola.Il peso della forma. La funzione poetica, o spessore scabroso del linguaggio su cui non può scivolare via come una comunicazione spedita vorrebbe. È un movimento innaturale. Una malattia, la malinconia della lingua. Che sia una patologia autoimmune protetta dall’epidemia della fretta? Comunque guarisce da sola. Con certi slanci di leggerezza in cui, spento il computer, chiusi i dizionari, si fanno cantare le frasi nella testa. Camminando, pedalando (anche nuotando). Si voltano da tutte le parti finché, quando meno te lo aspetti, trovi il giusto giro di parole. Dov’era? Sulla scrivania o in biblioteca. In città o sulla spiaggia delle vacanze (vacanze?). A Milano, Costanza, Tübingen, novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 36 Wilflingen, Silvaplana. Le mete non si scelgono a caso. Una volta là, non occorre accodarsi ai turisti per entrare nella torre della follia di Hölderlin o fotografare la piramide dell’eterno ritorno riprodotta su mille cartoline. Basta stare nei pressi, parlare la lingua, vedere i salici sul Neckar o le cime engadinesi dove Nietzsche concepì il pensiero più audace. A Wilflingen però l’avevano sorpresa. «Tesoro che c’è?», le aveva chiesto Liselotte, la vedova, quando, entrate assieme nella foresteria del castello, l’aveva sorpresa in lacrime. Era tutto come descritto nelle Cacce sottili. Il tiglio degli Stauffenberg davanti alla finestra. L’archeopterix, l’uccello fossile appeso nella cornice. I volumi di Hamann accanto al tavolo di lavoro. Le scatole entomologiche coi coleotteri spillati, gli orologi a polvere allineati sugli scaffali. Jünger aveva trascritto sulla pagina ciò che lei ne aveva tradotto e che ora ritrovava al proprio posto. Dov’è che il traduttore trova la parola giusta? L’educazione del traduttore. O iniziazione? Esercizio o ascesi? Metodo o regola? Ora et labora. Ma no. A volte la ricerca è caccia, collezionismo: di aggettivi, proverbi, etimi, sinonimi. E la contemplazione ha un che del voyeurismo. Spiando Celan che traduce Eluard, la Bachmann che traduce Ungaretti, Bertolucci Baudelaire, Celati Michaux, o i Salmi Ceronetti, si scoprono tesori proibiti. Gioie di un mestiere che non si fa col cilicio, non è macerazione. Né masturbazione mentale. Quando parla dell’entusiasmo, dell’«orgasmo del traduttore», Quirino Principe, maestro di traduzioni jüngeriane, nomina il migliore antidoto alla malinconia. La paura del traduttore.Viene tutta prima di cominciare. Non tanto per via della mole da affrontare. Cinquecentotrenta pagine dello Heidegger impossibile, incomprensibile, intraducibile le avevano detto quando aveva ventun anni. Non sapeva che ci avrebbe passato i successivi dieci anni. La paura viene prima di prendere la parola. Si deve indovinare l’intonazione, l’altezza della nota, il timbro, il registro. Chi sei tu per dar fiato alle corde? La tua voce non si dovrà sentire. Sarebbe come se il fotografo mettesse le dita sull’obiettivo o il doppiatore la faccia sul grande schermo. Il giornalista non fa mai notizia e inaudito resti il traduttore. E sai, caro lettore, stavolta traduttore è il giornalista. La giornalista,la traduttrice.Ero io quella.Volgi se vuoi,questo racconto al femminile, alla prima persona. Prendilo, se ti piace, per un piccolo esercizio di traduzione. Sinceramente tua. rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 37 E l’italiano arrivò a quota 220mila Tanti sono i vocaboli della nostra lingua secondo l’autorevole dizionario Battaglia. Del quale esce ora il Supplemento 2009 con 16mila novità Roberto Beretta, Avvenire, 27 novembre 2008 Errata corrige. Il «capitalista» non è nato, come finora si credeva, nel 1860, bensì mezzo secolo prima e lo tenne a battesimo Ugo Foscolo, esule in Inghilterra. Ma d’altra parte il «benestante» può far risalire le sue origini fino al Savonarola, il «multimilionario» appare sulla rivista Lacerba (1913), mentre per «cipputi» la data di nascita è assai più recente – il 1984 – e il padrino forse meno illustre: Giampaolo Pansa. Per tenere l’anagrafe delle parole ci vogliono curiosità, passione, ordine, pazienza e forse anche un pizzico di maniacale follia: non per niente Edoardo Sanguineti ama definirsi «lessicomane» e applica a sé stesso un verso in cui Giuseppe Baretti chiede licenza di andare «a fornicare un poco col mio dizionario prima che si faccia notte»… Come chiamereste, d’altronde, uno che coltivi per decenni il «vizio» di schedare i nuovi vocaboli non appena vedono la luce tipografica – in un saggio ultra- specialistico così come nei rotocalchi popolari –, prendendoli al volo col retino a maglie strette della filologia e compilandone tosto il certificato dattiloscritto: data, luogo, paternità? Settantamila schede per registrare ogni new entry in un dizionario di italiano. Anzi: «nel» dizionario, perché non diversamente tocca definire la ciclopica mole del «Battaglia» altrimenti detto Gdli (Grande Dizionario della Lingua Italiana), ventuno volumi la cui pubblicazione è iniziata ad opera appunto del linguista Salvatore Battaglia nel 1961 ed è stata portata a compimento da Giorgio Barberi Squarotti nel 2002. Proprio Sanguineti però ne aveva firmato già nel 2004 il primo Supplemento, con tutti i lemmi non repertoriati nei volumi precedenti, e adesso dirige anche il Supplemento 2009 – che la Utet ha appena affidato alle sue agenzie locali (vedi anche su www.utet.it). L’opera accoglie dunque 16mila voci «nuove», apparse magari durante l’uscita della monumentale raccolta e che vanno ad aggiungersi alle 183.594 (più 20mila circa nel precedente Supplemento) finora documentate in oltre 6000 autori: dal che si deduce che l’italiano sta dunque doppiando il capo del 220mila vocaboli; sono metà di quelli inglesi, ma pur sempre una cifra ragguardevole! Peccato che molti di essi, soprattutto i più recenti, siano in realtà dei «clandestini»… Come un doganiere scrupoloso, infatti, Sanguineti si pone ai confini della lingua e scheda chiunque voglia entrarvi: per una gran parte si tratta di stranieri puri, venuti al seguito delle nuove tecnologie o della finanza («net company», «new economy», «e-business», «call center», «compilation», «nomination»…) e in cerca di una cittadinanza non sempre gradita agli indigeni; poi ci sono i ricongiungimenti, ovvero il gran numero di parole che allegano il diritto di residenza al matrimonio con un suffisso – e qui davvero si sprecano gli anti- e i neo-, i poll- e i pluri-, i semi- e i meta- ma anche i mega- o i macro- (ma anche i micro- e i nano-), i super- ultra- multi- e ovviamente i video- e i tele-; ma più di tutto spopolano i bio-, gli eco- e soprattutto i post-: figurarsi che è registrato persino un «post-galantuomo» (Fruttero e Lucentini, 1983)! Certo, ci sono poi le novità assolute; in ordine di apparizione (e ciascun vocabolo davvero restituisce un’epoca): «can- rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 38 tautore» (1961), «bestiale» (1974), «camperista» (1983), «scafista» (1991), «prepagata» (1996), «spannometrico» (1998), «portale» (1999), «scaldasalviette» (2000), «tronista» (2004), «chiavetta» (2004), «tsunami» (2006)… Ma non solo; l’enciclopedico repertorio annovera infatti le «nuove accezioni» – ovvero i significati aggiunti di vocaboli già a suo tempo registrati –, le «nuove locuzioni» (i modi di dire) e circa 4500 «retrodatazioni»: ovvero la scoperta di prime citazioni più antiche di quelle finora note. E proprio qui – forse – si celano le scoperte più golose. Chi s’aspetterebbe difatti un «ottuagenario» Ippolito Nievo che parla di «fashion», neanche fosse un’adolescente moderna? Oppure una Matilde Serao discettare di «flirt»? Persino il modernissimo «programmare» risale al 1927. E se ammettiamo con una certa disinvoltura che il vate motoristico D’Annunzio immischi nel classicismo invenzioni rombanti quali «alettone» e «revisionato», chissà se qualcuno è disposto a credere che la prima uscita letteraria di «avana» – nel senso del sigaro – si deve nientemeno che al dolce Metastasio… Del resto, il cagionevole Guido Gozzano si rivela inatteso precursore della nomenclatura ciclistica, aggiudicandosi le prime menzioni italiche di «biciclettata», «cerchione» e «copertone»; ma quanto a «battistrada» non dello pneumatico si tratta, bensì del galoppino che un tempo precorreva le carrozze nobiliari. Sempre stando alla meccanica, si scopre una «chiave inglese» risalente al 1723 (citata da Lindoro Elateo, nome arcadico di Lorenzo Magalotti), mentre il primato di «superstrada» spetta inopinatamente a quell’introverso di Luigi Pirandello. Assai moderno pure Foscolo, che mostra di usare l’«affrancatura postale», mentre Leopardi preferiva l’«assicurata» e un’altra Leopardi – la sorella di Giacomo Paolina – addirittura aveva scoperto l’«intercettamento»: proprio nel senso della lettura di un messaggio altrui. oblique studio Nemmeno le parole sono nuove sotto il sole, si può ben dire scorrendo il Battaglia. «Devoluzione»? Lo disse addirittura Guicciardini all’alba del Cinquecento. «Federalistico»? Coniato da Antonio Labriola nel primo Novecento. «Municipalizzare»? Lo prescriveva già Eleonora Fonseca Pimentel nella Napoli settecentesca. «Revisionista»? Ne parlò Piero Gobetti quasi un secolo fa. E la «sprangata» non dovette aspettare il Sessantotto, visto che Scipio Slataper la citava oltre mezzo secolo prima. S’invertono poi i ruoli con Gramsci che fa il «menefreghista» mentre Mussolini sciorina un bel «classista». Curiose citazioni almeno quanto il «collezionismo» del serioso socialista Filippo Turati, il «confortevole» di Silvio Pellico (ex recluso allo Spielberg…), un «vandalismo» già recriminato ai tempi milanesi di Melchiorre Gioia e il «carrierismo» vituperato da Marinetti. Persino il gergo più giovanilistico rivela in realtà radici vetuste. «Balla» (nel senso di fandonia) sta già in Carlo Porta; «demenziale» è di fine Ottocento, nell’opera di Gian Pietro Lucini; «eclatante» fa data dal 1850, per mano di un tale Ferdinando Petruccelli della Gattina, «scazzottatura» è di Gaetano Salvemini, mentre «piizzonata» ha per antenato un purista come Emilio Cecchi (lo stesso che parlò per primo di «divismo»); e – per non essere da meno – il suo sodale Giovanni Papini ha coniato «mandrillesco». A questo punto è addirittura logico cercare in Emilio Salgari gli antenati italiani del «coyote», un po’ meno scoprire i «mustang» al galoppo in Francesco Domenico Guerrazzi, allorché per «salvare capra e cavoli» dobbiamo risalire addirittura a san Bernardino da Siena. Quanto alla definizione affibbiata alle donne che si dedicano alle faccende domestiche, la si deve a un noto Cesare, storico ottocentesco: macché Voghera, la prima «casalinga» fu quella di Cantù. 38 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.18 Pagina 39 CROSSOVER Quando il best seller per ragazzi piace agli adulti. E quello per adulti piace ai ragazzi Matteo Nucci, Il Venerdì della Repubblica, 28 novembre 2008 L’ultimo caso, in uscita, è «Il club dei padri estinti», che ha registrato un successo inaspettato tra i «teens». Un fenomeno su cui gli editori cominciano a interrogarsi. Ma che non è del tutto nuovo. Holden, per esempio… Holden Caulfield l’avrebbe bollata con una parola sola: phony. Una parola così significativa che in italiano si stenta a tradurla. Ma se gli avessero parlato del fenomeno crossover l’avrebbe usata di sicuro. Crossover? Adulti che leggono libri per ragazzi? Ragazzi che leggono libri per adulti? Volete farmi secco? Phony, solo phony. Roba fasulla, insomma. Roba insincera, inautentica, ipocrita e finta. Ma chi avrebbe potuto spiegargli, poi, che a stato lui è uno dei colpevoli? Uno dei capostipiti, dei padri, dei primi protagonisti paradigmatici della letteratura crossover? E come sarebbe stato possibile convincerlo che proprio quell’atteggiamento di disprezzo nei confronti del mondo adulto pieno di phonies, ipocrisie e falsità, l’aveva reso eroe dei ragazzi e non più degli adulti a cui era indirizzato il libro che lo rese immortale? Lui, il giovane Holden, il catcher in the rye, esemplare primo e perfetto di tutti gli adolescenti in crisi, in cerca della propria identità, in lotta contro il mondo degli adulti, pronti a far di tutto per non piegarsi alla miseria della sua inautenticità, phony appunto. Ma quanti anni avrebbe oggi Holden Caulfield? L’eroe creato da Salinger nel 1951 sarebbe ancora così veloce a disprezzare un fenomeno di cui parlano editori, 39 professori, esperti di letteratura, e che vede proprio in questi giorni in libreria una nuova uscita? Il club dei padri estinti (Einaudi Stile Libero, pp. 330, euro 17,50) di Matt Haig racconta la storia di Philip, undicenne che ha appena perso il padre e che ne vede il fantasma, un fantasma non proprio classico, tanto che via via che le pagine scorrono il lettore sarà portato inevitabilmente a chiedersi se non si tratti piuttosto di una visione, un ricordo, una speranza. Comunque sia, proprio come nell’Amleto, questo fantasma chiede a Philip di vendicarsi, perché suo fratello, lo zio di Philip, sembra pronto a rimpiazzarlo. «Ho raccontato un ragazzino che deve affrontare la morte del padre» spiega Matt Haig, inglese al suo secondo libro, «e che per la prima volta e costretto a capire da sé la verità. Le menzogne del mondo degli adulti, le cose più belle e quelle più brutte nella prospettiva di un undicenne. Forse è per questo che il libro, pubblicato per adulti, viene letto anche dagli adolescenti. In questo senso, sì, il pubblico e quello di un crossover». E dire che questo fenomeno cui gli editori stanno dedicando buona parte delle loro attenzioni è scoppiato nel senso esattamente inverso rispetto ai crossover di Salinger. «Il termine indica l’attraversare i confini delle fasce d’età e dei generi» spiega Elena Paruolo, ricercatrice all’Università di Salerno, esperta dell’argomento. «Ciò può accadere in due direzioni. Libri concepiti per un lettore adulto che poi diventano di culto fra gli adolescenti. E libri che invece nascono per gli adolescenti e rompono le barriere nel mondo adulto». E, come si diceva, il vero boom è partito da qui. «La ragione è semplice» osserva Rachel Falconer, docente di letteratura contemporanea all’Università di Sheffield, che ha appena pubblicato The Crossover Novel. Contemporary Children’s Fiction and Its Adult Readership, «e si chiama Harry Potter. Chi avrebbe mai immaginato che una saga potesse raggiungere così tanti lettori? Sapete cosa significa vendere 325 milioni di copie? Ma è, in generale, lo spostamento di lettori adulti su letteratura per ragazzi che è un evento mai esistito prima su questa scala. I nomi sono noti. Philip Pullman fra tutti. Ma pensate anche alla ripubblicazione delle Cronache di Narnia. Si può credere che sia un’operazione di marketing. A me pare che vengano prima i lettori. Il mercato segue gli interessi del pubblico. I libri vengono ripubblicati con diverse copertine, e, più tardi, dopo i libri trionfano i film crossover». novembre 2008 rs_novembre08_bis.qxp 03/12/2008 12.19 Pagina 40 In effetti da noi già è nelle sale la pellicola tratta dalla saga di Stephenie Meyer, Twilight, che sta consumando altri successi di un pubblico trasversale in libreria. Eppure i nostri editori non hanno ancora scelto la doppia copertina, come in molti Paesi anglosassoni, e si limitano a immagini neutre che vadano incontro sia ai gusti dei ragazzi che a quelli degli adulti. «Ma è proprio questa la vera novità» spiega Sandra L. Beckett, docente di Letteratura francese alla Brock University in Ontario, Canada, fresca autrice dell’altro must su questa letteratura: Crossover Fiction. Global and Historical Perspectives. «Perché il fenomeno è esistito da sempre. Non è né contemporaneo, né anglofono come si è portati a credere. E soprattutto non si limita a questo successo di libri per l’infanzia che passano in mano adulta, ma semmai, in passato, era piuttosto il contrario. In fondo, l’attuale Nobel per la letteratura Le Clezio ha sempre negato l’esistenza di una distinzione fra letteratura per ragazzi e letteratura per adulti. E quello è il punto. Voi, ad esempio, avete Ammaniti: narrativa realistica che può essere definita crossover, ma che non nasce come crossover, o sbaglio?». Non sbaglia affatto. Io non ho paura fu pubblicato per un pubblico di adulti e oggi le sue vendite s’impennano a inizio oblique studio giugno, con la chiusura delle scuole. Stesso discorso per Mark Haddon, autore di Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, uno straordinario successo fra i ragazzi, ma pubblicato originariamente nelle serissime edizioni dei Supercoralli. Entrambi, del resto, centrati su un adolescente che si trova davanti al terribile mondo degli adulti. Ma se questa è la caratteristica del crossover discendente, da adulti a ragazzi, dove potremmo trovare i caratteri di quello ascendente, da ragazzi ad adulti? «Hanno creato il termine kiddults per quel pubblico», spiega Rachel Falconer, facendo riferimento a un incrocio di kid e adult, ragazzo e adulto. Adulti che non vogliono crescere? «Forse. O forse adulti che vogliono risposte chiare. La letteratura contemporanea è segnata da storie complicate in cui spesso non si racconta che per allusioni. I libri per ragazzi invece affrontano i grandi temi come la guerre di religione o la relatività del bene e del male, e lo fanno in termini chiari, in prosa elegante e accessibile». «In fondo», riflette Matt Haig, «uno scrittore pensa sempre al suo pubblico, senza distinguere tra ragazzini e adulti. Io credo che i lettori siano in cerca di storie. Storie belle e raccontate bene. Nient’altro».
Scarica