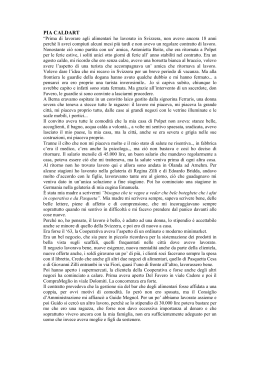DENARO, DONNE, DIO. Amo il denaro, strumento di libertà che sta in tasca. Amo le donne, emozioni viventi, sempre a un centimetro dal farsi capire. Amo Dio lassoluto: un apostrofo rosa tra le parole mi amo. Gianni Monduzzi è nato a Bologna il 21 luglio del '46, sotto il segno del Cancro. Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 71, specializzandosi poi in Psichiatria. È Presidente di una casa editrice da lui stesso fondata quand'era studente. Nell'81 ha pubblicato in proprio il suo primo libro Romanzo totale. Quattro anni dopo, con Mondadori, il Manuale della playgirl. Appena finito Il Morbo di Monduz, ha già in cantiere il suo prossimo libro: Il Vangelo secondo Monduz. Alla nascita, siamo tutti inesperti di seduzione. Siamo giusto in grado di sedurre la mamma: ma questo non conta. La seduzione, quella vera, prima o poi ci farà cadere in un trabocchetto. Quando arriva, sono dolori. Tutti ci abbiamo lasciato le penne, almeno una volta. Qualcuno ci si rassegna. Qualcun altro ci si fa frate. Qualcuno se la lega al dito. Studia, almanacca, si scombina. Tutto perché vuole «rifarsi». La reazione di un uomo può arrivare agli estremi: allestisce harem, serragli e pollai. Così nasce il famigerato «Morbo di Monduz». Chi osserva da fuori, nota soltanto gli aspetti esteriori del Morbo, ma non ne capisce l'essenza. Questo gran daffare per avere tante donne intorno, non è per spassarsela: è un tentativo di cura. Il paziente lotta costantemente contro una fissazione sempre in agguato: l'amore per una donna sola. Sarebbe la sua capitolazione, la caduta nel versante femminile del Morbo: il gioco di lei. Normalmente, una donna la si sbriga in qualche settimana. È un tempo ragionevole, per smantellare il suo castello di seduzione. Ma ci sono casi difficili, e il rapporto si allunga. Certi casi disperati, li si porta a casa, per sbrogliarli con calma. Con questa logica, si può arrivare al matrimonio. La seduzione è una nobile arte, simile al judo. Se vuoi arrivare alla cintura nera, devi fare esperienza. L'ultimo dan maschile è la costituzione di un harem. Ma non ci arriva quasi nessuno: c'è sempre una donna d'intralcio. Già, lei vuole battere proprio «quell'uomo»: in questo consiste l'ultimo dan femminile! Gianni Monduzzi Scarica gratuitamente il libro dal sito internet: www.giannimonduzzi.it. Biblioteca Umoristica Mondadori Dello stesso autore Nella collezione BUM Il manuale della playgirl ISBN 880430913-X © 1988 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano I edizione aprile 1988 Il Morbo di Monduz Giustificazione Un’autobiografia?! Nient’affatto! Questa, è una monografia di clinica medica. La trattazione comincia dall’infanzia per necessità dottrinale. Bisogna risalire alle origini familiari, per comprendere l’evoluzione del Morbo di Monduz. Questo morbo è già molto diffuso e c’è il rischio che invada l’umanità. Bisogna dunque valutare se prevenirlo o lasciare che si sviluppi liberamente. Quindi, documentiamoci e poi ciascuno decida per sé. Il quadro clinico Che cos’è il Morbo di Monduz? Fin dalla notte dei tempi il Morbo di Monduz ha disturbato imparzialmente i sonni di maschi e femmine di tutto il globo. Nella variante maschile, il suo quadro clinico presenta una strana, incontenibile ossessione: la smania di controllare il territorio per acchiappare quante più femmine possibile. Una specie di «delirio dell’harem». La patologia ha solide basi fisiologiche. Per istinto, ogni maschio tende a conservare la specie. E per «specie», beninteso, intende la sua personale. Il desiderio di accoppiarsi con quante più femmine possibili è, nell’uomo primitivo, un tentativo inconscio di far sopravvivere i suoi cromosomi. Nell’uomo «evoluto» (si fa per dire) l’ansia di prolificare è sparita, ma l’ossessione dell’harem è rimasta. Questo il quadro patologico: la ricerca ossessiva, in piccolo o in grande, di farsi un pollaio. Per ottenere il controllo sul territorio, certi maschi sono pronti a qualunque eccesso. Anche ad applicarsi ad attività inconsistenti, come il cinema, per avere leve di pressione sulle attricette. Fondano società d’affari smisurate per avere a disposizione uno stuolo di segretarie. Certi pazienti addirittura fanno della vita un sacerdozio: disc jockey, maestri di sci, istruttori di tennis, animatori di villaggi 8 Il Morbo di Monduz turistici. Tutti malati che hanno fatto sacrificio della vita, per assicurarsi un «territorio di caccia» ove giocare da padroni assoluti. I cantanti rock presentano i quadri clinici più gravi del Morbo di Monduz. Per avere tutte le donne ai loro piedi, fanno un patto col Diavolo! Le sterminate platee dei loro concerti, con tutte quelle ragazzine adoranti, sono il loro pollaio, harem giganteschi, per una sera. Moltissimi maschi sono affetti dal Morbo, anche se lo negano. Però prima o poi si tradiscono. Basta osservarli quando incontrano qualcuno con una donna fantastica. Bisogna guardare la faccia che fanno. Trasudano bile e invidia primordiale. Nulla è per loro più insopportabile di una bella donna al braccio di un altro. Io ne sono particolarmente disturbato. Molte notti non riesco a dormire, pensando che in quel preciso istante due miliardi di donne mi tradiscono con un altro uomo. Nelle donne il Morbo si presenta in forma diversa: l’ossessione di essere « l’unica donna del capo ». Il delirio si manifesta con studi maniacali d’estetica, ricerche applicate di psicologia maschile degne di un Nobel, equipaggiamenti paramilitari per la quotidiana guerra della seduzione. Nella santabarbara di ogni donna sono stipate armi micidiali, messe al bando dalla convenzione di Ginevra: gas nervini denominati «profumi», mimetismi sleali battezzati « make up », trabocchetti letali, come le famigerate calze a rete. Per non parlare delle tecniche di non farsi trovare al telefono e di mancare agli appuntamenti. La seduzione femminile è diventata un’attività bellica. Questo non può sfuggire a nessuno. Per convincersene, basta vederle in una palestra di body building: osservando i loro esercizi, viene il sospetto di essere in un reparto di marines. Il Morbo di Monduz 9 Anamnesi Gianni, perché Alla nascita, mi fu imposto il nome di Gianni. Sul nome, non ho mai avuto da ridire. Semmai sul cognome. Avrei preferito Agnelli. La scelta del nome comunque non fu casuale. Mossi da smania di emancipazione, i miei genitori speravano che da grande abbracciassi la professione di parrucchiere. Gianni era un nome adattissimo. Fin da quando ero piccolo, i miei lo sognavano scritto sopra un’insegna luminosa. Ho avuto in seguito tutto il tempo di pentirmi, per aver tradito le ambizioni paterne. Ho dedicato metà della vita a cercare ragazze e quattrini. Mio padre, che aveva predisposto tutto, mi aveva dato il nome giusto per ottenere le une e gli altri in abbondanza. Via Orfeo 23/2 Nacqui a Bologna, il 21 luglio del ’46, nella strada popolare di un quartiere elegante. Fu la prima delle mie contraddizioni. Via Orfeo è una piccola via, parallela e nascosta rispetto alla nobile via Santo Stefano. In via Santo Stefano ci sono i vecchi palazzi residenziali della nobiltà di Bologna. In via Orfeo ci stavano le maestranze e i plebei che vivevano di luce riflessa. Insomma, coloro 10 Il Morbo di Monduz che ai nobili davano forza, lustro, credibilità, e che, in pratica, ne giustificavano l’esistenza. Nel suo intimo, il popolo è l’unico a credere nella nobiltà, a mitizzarla. Io, da buon popolano, credevo che gli altri fossero più nobili e virtuosi di me. Ero consapevole dei miei limiti, non ancora di quelli degli altri. Pensate la delusione quando scoprii che il mio prossimo non era meglio di me. Non era questa la direzione, in cui speravo di riabilitarmi di fronte a me stesso. Intanto, più crescevo e più il resto del mondo diventava piccolo. Non è capitato anche a voi, tornando sui luoghi dell’infanzia, di trovare tutto rimpicciolito? La vastità dell’universo è un’opinione infantile. Però un bel privilegio, nascendo, l’ho avuto. Ero figlio unico, nato dopo dieci anni d’attesa dei miei, nipote unico di due nonni, una zia, due prozie, senza contare la bisnonna, che purtroppo morì quasi subito. Ero capitato, senza saperlo, al centro di un mondo affettivo di proporzioni galattiche. Tra le mie fortune, figurava una condizione residenziale davvero unica. Mia nonna viveva in una casa di proprietà delle Opere pie, a due passi dall’abitazione dei miei. Era la portineria di un convento andato distrutto secoli prima. La casa era piccola, ma aveva annessi un cortile e un orticello. Questo «orticello» era un ettaro di terreno! Dentro le mura di Bologna, in via Orfeo, un quartiere dove non c’era nemmeno una aiuola. A tre anni d’età ne divenni il custode esclusivo. Nessun maschietto entrò mai in quest’oasi di verde: solo le femmine avevano libero accesso. Ed era un bengodi, con un piccolo frutteto, l’orto, il pollaio e la conigliera. Un’Arca di Noè, con piccioni, galline, cani, gatti e conigli. Il cortile aveva un pesante portone impenetrabile dagli estranei. Quel diaframma rassicurante mi proteggeva dal resto del mondo. Anamnesi 11 Dentro al portone c’era un ampio porticato, con una scaletta che conduceva a un solaio pieno di cianfrusaglie. Mia nonna non buttava via nulla: era una tradizione di famiglia. Lì mi rifugiavo con le amichette nelle giornate di pioggia. Avevamo fondato un ospedale fantastico, dove ogni mattina, con l’aiuto delle mie assistenti, passavo in visita un’intera corsia di ammalati immaginari: la gatta Muccina, il rospo Gedeone e occasionali amichette di quartiere, richiamate dalla mia fama di taumaturgo e dalle torte della nonna. Andando oltre il porticato, c’era il cortile, lastricato di ciottoli, piuttosto duri per le mie ginocchia (ne porto ancora le cicatrici). Al centro, su un immenso albero, era stata montata un’altalena. Passando sotto un vecchio voltone, ultimo resto della cinta muraria dell’antico convento, si passava nell’orto e nel frutteto, che annoverava un giuggiolo e un rusticano, i cui frutti non giungevano mai a maturazione, perché ce li pappavamo ancora acerbi. Nel centro dell’orto, in un vecchio macero, mio nonno gettava le carpe che pescava, perché a nessuno in casa piaceva il pesce; così le carpe nello stagno crescevano a vista d’occhio, per la gioia della gatta, che incrociava lungo la riva. Rileggendo questa descrizione della mia oasi infantile, mi rendo conto che sembra fiabesca, eppure era esattamente così. Lì ho vissuto per sette anni, con mio padre, mia madre, la nonna e la zia. Aggiungendo le cinque-sei ragazzine che vi bazzicavano regolarmente, si può comprendere la beatitudine della mia infanzia. Se non facevo entrare i maschi non era per misantropia, ma per una considerazione pratica. Nel gioco del dottore, è fondamentale accordarsi sui ruoli: chi fa il dottore e chi l’ammalato. Con le ragazzine l’intesa era perfetta. I maschi avrebbero portato solo scompiglio. Non avrebbero accettato le ferree leggi della mia clinica. E furono radiati dall’Albo per sempre. 12 Il Morbo di Monduz Patologia familiare La nonna, che mi amava moltissimo, non voleva altri nipoti: nemmeno un briciolo di affetto doveva essermi sottratto. Per convincermi a fare pressioni psicologiche alla mamma, mi diceva: «Bada che se hai un fratellino, devi dividere tutto con lui!». «Anche le bambine del cortile?» ribattevo io preoccupato. «Anche quelle! » rispondeva la nonna. Quando la mamma mi chiedeva se avrei gradito un fratello, la mia risposta era un perentorio: «No, grazie!». La logica del cortile Da bambino «il tuo cortile» è il centro del mondo, con i tuoi cari, la nonna, le zie e le ragazzine dei giochi d’infanzia. Ti senti un sultano felice al centro del mondo, circondato dalle tue donne. II tuo cortile, posto entro l’antica cerchia muraria, è giusto nel cuore di Bologna, città che è il cuore d’Italia, come l’Italia è il cuore d’Europa, e l’Europa è il cuore dell’Universo. Poi, per uno strano movimento tellurico, il tuo mondo sposta il suo baricentro e le certezze si sfaldano. Scopri che Bologna è soltanto una piccola città. Altre sono le vere metropoli. L’Italia è solo una colonia del grande impero americano. Là valgono altri valori: il denaro, il potere, la forza. II tuo cortile resta la tua oasi sentimentale, ma le sorti del mondo non passano più di lì. II baricentro del mondo fisico non corrisponde al centro del tuo mondo affettivo. Scopri di parlare una lingua per pochi intimi, di praticare stili di vita sorpassati, che la capitale dell’impero si è spostata, che il tuo unico cortile sei tu. Ti rimbocchi le maniche e ricominci da zero. Sai di essere da sempre il centro del mondo; il duro ora sta nel convincerne gli altri. 13 Patologia familiare Il derby Di solito, un individuo decide di prolificare quando si è già fatta una bella esperienza, nella vita, in tema di fiaschi. A buon diritto, quindi, cerca in un figlio la buona occasione per riprovarci. Si mette al lavoro, con le migliori delle intenzioni. Vuole creare un prototipo così perfetto, che sia di modello per le generazioni future. Ma questi buoni propositi vanno incontro a una complicazione: un figlio lo si fa in due. E ciascuno dei contraenti ha, della perfezione, un concetto diverso. Naturale, ognuno proviene da culture familiari differenti. Con queste premesse, si scatena un gioco di squadra che vede contrapposti due stili di vita: la squadra di mamma contro quella di papà. Il pallone in campo sei tu. La squadra di mamma Il ramo del nonno materno, pur di nascita oscura, era in odore di aristocrazia: i Laffi forse erano discendenti apocrifi degli Ordelaffi. Ad ogni buon conto da alcune generazioni si erano dati alla caccia di ambizioni da soddisfare. Resisi conto che una generazione non bastava per ottenere successi apprezzabili, si tramandavano il mandato di padre in figlio. 14 Il Morbo di Monduz Il ramo della nonna era di diverso parere. La fede in Dio aveva dato alla famiglia una forte ossatura spirituale. Poco inclini per le attività secolari, avevano lasciato campo libero alle ambizioni dell’altro ramo, quello del nonno. La squadra di papà Il ramo della nonna è avvolto nel più fitto mistero. So soltanto che morì giovanissima, molto confortata dalla religione, dopo aver perfettamente previsto la data della sua morte. Papà me ne ha sempre parlato come di una pia donna, forse una santa. Il ramo del nonno, tutto di musicisti, coltivava forme diverse di devozione: le donne erano l’unica vera passione di famiglia, la musica solo un espediente per arrivare al loro sensibile cuore. Originari di Imola, si erano trasferiti in forze sulle montagne di Zocca. Sospetto che la trasferta sia stata consigliata da qualche marachella sessuale. Il pallone in campo Con due squadre familiari così eterogenee, naturale che nella vita abbia proceduto un pochino a zig-zag. In pratica per me è come avere due anime. Una logica, razionale e affaristica, che chiamo confidenzialmente «l’anima dell’OVVIO». L’altra, fantasiosa e strampalata, è «l’anima dell’ASSURDO». La storia della mia vita è un continuo altalenare tra queste due opposte tendenze. Sono curioso di vedere come andrà a finire, ma devo pazientare. So che seguirò il decorso fino alla fine, con immutato interesse. La prognosi del famigerato «Morbo di Monduz» non è mai sicura. Patologia familiare 15 Mia nonna Mentre le mamme sono l’ansia dell’umanità, le nonne ne sono il sollievo, perché le nonne sono le mamme pentite. In una piccola chiesa di campagna un giovanotto si avvicina a una ragazzina e le porge l’acqua benedetta. Un gesto antico. Per tutta la funzione le manda dei sorrisi. Lei è costretta ad abbassare gli occhi. Poi lui l’accompagna a casa e, nel salutarla, le stringe forte la mano. Era quasi un secolo fa. Così, senza tanti clamori, cominciai a nascere. Quella stretta di mano, tra mia nonna e mio nonno, fu uno dei tanti gesti d’amore disseminati lungo il percorso che determinò la mia esistenza. Lei era appena tornata dal Brasile, dov’era emigrata bambina, con la famiglia. Era stata via quasi dieci anni. Del Brasile aveva ancora negli occhi il solare ottimismo e quel rapporto affettuoso col mondo che non avrebbe mai perso per tutta la vita. Si sposarono presto e vennero a stare a Bologna, in via Orfeo al 15. Lui andò a lavorare al Pirotecnico, una fabbrica di materiale bellico sui viali di circonvallazione. Dal matrimonio nacquero due bambine: mia madre e l’amata zia Nella. Mia nonna sosteneva che quello era stato il più bel periodo della sua vita. Rassettava la casa, faceva la spesa e preparava il pranzo per la famiglia. Evidentemente l’amore rende meravigliose le occupazioni più semplici. Crescendo le figlie, aumentarono le spese, così la nonna decise di aprire una latteria, a pochi metri da casa. Gli affari andavano a gonfie vele, tanto che comprò un’altra latteria, nella quale mise a lavorare la sorella. Passavano gli anni. Nel frattempo la figlia maggiore si era spo- 16 Il Morbo di Monduz sata ed era andata a vivere con il marito, sempre in via Orfeo, al 23/2. Nel raggio di pochi metri era dislocato tutto l’universo della nonna: famiglia, figlia maritata e bottega. Quando nacqui, il Quartier Generale fu al completo. Tre anni dopo, la nonna rimase vedova. Ero il suo unico nipotino: mia zia non era ancora sposata e mia madre non aveva altri figli. La nonna non si dava pace per la perdita del marito, tanto che i miei decisero di andar a stare con lei e la zia, per tenerle un po’ su. L’operazione non era molto complessa, dal punto logistico, visto che stavamo due portoni più in là. Così i miei primi ricordi di vita cosciente sono legati alla casa della nonna. È stata lei la luce della mia esistenza. A lei debbo la struttura del mio pensiero, l’arte di ingegnarmi e quella di cucinare. Quando ebbi quattro anni, i miei tentarono di mandarmi all’asilo. Ma le suore, che io definivo «zitellacce cattive», non erano tagliate per me. Le bigotterie, i moralismi, la chiusura mentale di un mondo dove tutta la vita è una preparazione ossessiva alla morte, non facevano al caso mio. Un giorno, quelle befane mi punirono per un reato che non avevo commesso. Fu trovata una buccia di banana dentro la tazza del water. Un bambino, forse il vero colpevole, mi additò come responsabile. Io negavo, ma credettero a lui. Dovetti raccattare la buccia famigerata con le mani dentro il wc, al cospetto di tutta la classe. I bambini erano divertiti, anche le suore ci godevano. Nei loro occhi brillava una luce sinistra. Mi sentivo un cristiano dentro la fossa dei leoni. Mi chiusi in me e non parlai più con nessuno. Il mattino dopo, davanti all’entrata dell’asilo, avevo occhi così disperati, che mio padre mi riportò indietro. E quel giorno fu deciso che avrei passato le giornate con la nonna. Ogni mattina si ripeteva lo stesso gioco: fare le compere! La Patologia familiare 17 nonna scribacchiava la lista della spesa su un foglio di carta gialla mentre io già scalpitavo sul portone spalancato. Poi iniziava l’avventura più bella del mondo: un bambino impaziente che tiene la borsa e una nonna sorridente che con tre mandate di chiave richiude il pesante portone su via Orfeo. La prima tappa del nostro raid quotidiano era in Piazza Aldrovandi, al mercato delle verdure. All’andata, la nonna passava in rassegna tutte le bancarelle e memorizzava le variazioni di prezzo. Soltanto al ritorno faceva gli acquisti. Dopo Piazza Aldrovandi, ci trasferivamo al mercato del centro, in via Pescherie, dove avevano la mortadella migliore, le uova freschissime e il pollame ruspante. Ma per arrivare fin là c’era da superare una difficile prova quotidiana: la tentazione dell’imbonitore di turno, in piazza Minghetti. In questa piazza si appostavano venditori ambulanti che erano tutti mezzo imbroglioni. Ogni giorno veniva proposto qualche oggetto mirabolante e inutilizzabile che, nelle mani del ciarlatano, sembrava dotato di arcane virtù: affilacoltelli, affettatrici per trasformare legumi in dadini curiosi, tritatutto, strane macchinette per infilare il cotone nella cruna dell’ago. Questi imbonitori, per risvegliare la curiosità della gente, talvolta tiravano fuori serpenti addomesticati, con cui si esibivano in numeri di grand’effetto, avvolgendoseli attorno al collo o infilandoseli nei calzoni. «Sono tutti incantabisce!» sentenziava la nonna, alludendo alle loro esibizioni coi rettili. E mi strattonava via a fatica, perché gli imbonitori e i loro trucchi esercitavano su di me un fascino irresistibile. Qualche volta però anche lei ci cascava, intenerita dalle mie insistenze. A diverse riprese ci eravamo portati a casa arnesi deliranti per affettare le uova in dieci modi diversi, pelare patate senza sprecare la polpa, arrotare coltelli in due sole passate. Superata piazza Minghetti senza troppi danni, si arrivava al mer- 18 Il Morbo di Monduz cato di via Pescherie, il mio preferito. Da tutte le parti c’erano donne alle prese con negozianti ciarlieri che snocciolavano battute mordaci e intanto gli riempivano le sporte di alimentari. Questi bottegai erano in realtà dei veri showman, come non si vedono neanche alla TV. Il loro cabaret estemporaneo era irresistibile. Le donne preferivano un negoziante piuttosto che l’altro in base all’arguzia delle sue battute, alla simpatia del suo modo di fare. Spesso i prodotti erano gli stessi e anche i prezzi. Ciò che differenziava i banchetti erano i bottegai. La loro abilità eccezionale consisteva nel far sentire ogni donna la preferita, quella «servita» meglio di tutte le altre. Si stabiliva così un rapporto di fiducia basato su una presunzione di privilegio. Mia nonna si serviva dallo stesso salumiere e pollivendolo da più di vent’anni. Nessun’altra cliente era trattata meglio di lei, ne era convinta. Solo se avesse scoperto il «suo» bottegaio in flagrante «adulterio», ovvero a trattar meglio un’altra, si sarebbe decisa al divorzio. La sosta nel negozio del caffè di Filicori & Zecchini era un rito. Ho detto «negozio del caffè» per chiarire subito che Filicori & Zecchini non era un bar o una caffetteria. Era un monumento eretto al culto di bere il caffè, e mia nonna ne era una fedele proselita. Questo culto bolognese a quei tempi era distinto in due sette: i devoti di Segafredo e quelli di Filicori. Le due compagnie di torrefazione, entrambe con sede in via Orefici, l’una di fianco all’altra, avevano spaccato la città in due opposte scuole di pensiero, due versanti di gusto inconciliabili. Mia nonna era una sostenitrice sfegatata di Filicori e vi si recava in quotidiano pellegrinaggio. Mentre la nonna gustava il suo amato caffè, io aspettavo di bere la mia cioccolata, visto che la tazza era regolarmente arroventata. Affascinato, osservavo i chicchi che scorrevano lungo i silos traspa- Patologia familiare 19 renti, dov’erano contenuti: mi suggerivano un’idea di abbondanza, mi sembrava che non finissero mai. E facevo sogni bellissimi. Mia nonna, che era stata in Brasile, ogni tanto mi raccontava qualche aneddoto su quel lontano, felice paese: la raccolta del cacao, le piantagioni di ananas, l’estrazione dello zucchero dalla canna. Nel negozio di Filicori, l’arredamento stile coloniale, le immagini tropicali, gli affreschi che raffiguravano coloni sorridenti, tutto concorreva a creare la suggestione di un lontano mondo esotico. Mi lasciavo cullare dalla fantasia. Dal retrobottega provenivano inebrianti profumi di torrefazione. Io fantasticavo che vi si aprisse una porticina segreta, che mettesse in comunicazione il laboratorio con le piantagioni e i brasiliani sorridenti, tratti dai ricordi infantili di mia nonna. Nell’attraversare la strada, lei mi chiedeva di guidarla in mezzo al traffico. La cara nonna! Fingeva di aver paura a passare, per insegnarmi a non finire sotto a una macchina. Ultima tappa della nostra spedizione quotidiana era Ugo, il macellaio. Tappa minata di tentazioni: di fronte al macellaio c’erano Pino, il gelataio e Gitti, il droghiere dell’angolo, con le sue invitanti caramelle. «Nonnina, mi comperi una caramella?» Tutti i giorni era la solita manfrina. «Comprala tu, con i tuoi soldini!» replicava serafica la vecchietta. «Tutto sommato, non ne ho così tanta voglia» bofonchiavo io, perplesso. «Dopotutto le caramelle fan male ai denti! » Piuttosto di mettere mano al borsellino, rinunciavo perfino alle caramelle. I miei risparmi erano intoccabili. Ogni settimana, andavo alla Cassa di Risparmio a depositare i soldi accumulati con le «paghette» settimanali di mamma e papà, più quelli che la nonna e la zia mi passavano di nascosto. Ugo, il macellaio, era un amico di famiglia a cui la nonna aveva 20 Il Morbo di Monduz fatto favori in tempo di guerra. Assieme alle bistecche, tutti i giorni mia nonna riceveva da lui la «carne per il gatto». Quella carne era sempre stranamente magra e bella. Ma il povero gatto non se l’è mai ritrovata intatta nella sua ciotola. La parte magra della «carne del gatto» la usava la nonna per fare il ragù. Non mi pare di essere così vecchio da fantasticare sui bei tempi andati. Eppure ricordo che c’era nell’aria una strana allegria che ora è sparita. I garzoni sfrecciavano in bicicletta fischiettando le ultime canzoni del festival di San Remo, la gente si salutava per strada e ci si fermava volentieri a chiacchierare. Perdere tempo faceva parte dell’arte di vivere. Forse non c’era inquinamento. O sarà la deformazione della memoria? Che cominci a invecchiare anch’io? Tornavamo a casa per mano, sotto la tana rettilinea dei portici, come due ragazzini felici. Nei giorni di pioggia, per non bagnarci, prendevamo via Santo Stefano, evitando via Orfeo che è quasi tutta scoperta. Qualche volta si faceva un salto dalla Lisetta. Questa signora, appena più giovane di mia nonna, era una specie di fattucchiera buona che, con l’aiuto di alcune gocce d’olio versate in una scodella d’acqua, prevedeva il futuro e toglieva il malocchio. Dalla Lisetta c’erano sempre moltissime donne, in sala d’attesa. Solo donne. Mentre aspettavano, si raccontavano fatti inspiegabili: predizioni puntualmente avverate, strani intrighi di femmine maliarde e di uomini stregati contro il loro volere. Poiché ero l’unico bambino, c’era sempre un complimento per me, in quel salotto. Chi mi trovava bellissimo, chi di un’intelligenza impressionante. Mi stupiva che quelle persone, così benevole nei miei confronti, potessero costituire un problema per gli altri uomini. Io e le donne saremmo sempre stati alleati. Di fronte a quei complimenti, la nonna si schermiva, ma le Patologia familiare 21 faceva piacere: era orgogliosa del nipotino. Anche il nipotino lo era di lei. Quando veniva il nostro turno, io restavo in religioso silenzio, attaccato alla nonna. Ero un po’ impressionato di assistere a quei misteri. Guardavo con sacro rispetto le gocce d’olio che si dilatavano sul pelo dell’acqua, oscuri presagi di fortune e disgrazie. Se le gocce stavano strette e composte, era buon segno, ma se si dilatavano fino a scomparire nella scodella, erano guai. Ascoltavo le formule segrete che la Lisetta pronunciava in modo indecifrabile, facendo ampi segni di croce sulla scodella, con un crocifisso benedetto a Lourdes. Cercavo di capirne il significato. Annusavo il buon odore d’olio d’oliva. Mi domandavo se la Lisetta tutto quell’olio lo buttasse poi via o lo mettesse nell’insalata. Ogni giorno si arrivava a casa verso le undici e c’era il pranzo da preparare. Come dire che si cambiava gioco. Io salivo sopra un panchetto, per arrivare con le mani all’altezza del tavolo, mi mettevo davanti un tovagliolo come grembiule e mi dedicavo all’alta cucina. Con coltello e tagliere sfoggiavo la mia abilità nel mondare verdure, tagliuzzare erbette aromatiche, togliere ogni fibra di magro dalla «carne del gatto». Tutto fuorché stare ai fornelli: una volta mi ero scottato con un tegame, e da allora non avevo più buoni rapporti col fuoco. Ma la mia vera passione era fare la sfoglia. Qualche volta l’albume dell’uovo mi scappava per tutto il tagliere e non riuscivo ad arginarlo con la farina. Mi doveva venire in soccorso la nonna. Ma poi riprendevo in mano la situazione, tirando la sfoglia con la macchinetta e tagliando le tagliatelle senza una grinza. I tortellini erano più difficili. Riuscivo a chiuderli, ma mi venivano sempre con il cappello dritto all’insù. Lasagne e gnocchi, passatelli e ragù non avevano segreti per me. La nonna era una gran cuoca e io ero il suo degno cumin. Dopo il pranzo in famiglia, mia madre e mia zia andavano a 22 Il Morbo di Monduz coricarsi. Il babbo spesso era via, solo io e la nonna stavamo in cucina a rigovernare. Qualche pomeriggio ci dedicavamo a cucire in tandem con la Singer a pedale: lei teneva la stoffa sotto l’ago e io fornivo la forza motrice. Pedalavo come un forsennato costringendo la nonna a spericolate acrobazie. Nel tardo pomeriggio c’era sempre qualche faccenda da sbrigare nell’orto o nel pollaio. A levare le uova dal nido ci pensavo io: mi piaceva da matti, una specie di caccia al tesoro. Coi conigli la faccenda era diversa. Da quando un coniglio mi aveva morso, ci stavo più attento. La storia del coniglio morsicatore fu bella davvero. Mia madre, eterna apprensiva, temeva che l’animale avesse la rabbia. Si precipitò, con il figlio per mano e il coniglio in un cesto, al pronto soccorso della clinica veterinaria. Il medico di turno tenne in osservazione il coniglio colpevole. La settimana dopo la mamma tornò per il referto. Il coniglio non aveva la rabbia, ma non tornò più nella sua gabbia. II medico, imbarazzato, confessò di non poter restituire l’animale: era morto, inspiegabilmente, «di polmonite». Mia nonna sosteneva che era morto in padella. Non c’era mansione casalinga che la nonna non mi avesse insegnato. Io ero avido di imparare e lei trasferiva in me tutto quel che sapeva. Si mise a darmi lezioni di dialetto bolognese, a raccontarmi del Brasile per filo e per segno. Io imparavo all’istante e presto la nonna non seppe più cosa insegnarmi. Per fortuna cominciai ad andare a scuola. Così potemmo continuare il nostro gioco, invertendo i ruoli: cominciai ad insegnare io a lei, ed era un’ottima scolaretta. Mia nonna era incapace di un’azione cattiva; quelle buone, invece, le riuscivano benissimo. C’erano due signore molto povere che frequentavano regolarmente la nostra casa. Una era la Burzi, vecchia zitella di una nobile famiglia decaduta. Le mancava letteralmente Patologia familiare 23 di che mangiare. Quando se la vedeva brutta, ci veniva a trovare portando una bustina di origano: era un messaggio in codice tra lei e la nonna. La Burzi se ne andava ogni volta carica di provviste. Gliele aveva infilate la nonna, di nascosto, nella borsetta. L’altra vecchietta si chiamava Giannina ed era di origine veneta. Quasi ogni giorno portava mortadella e prosciutto a Muccina, la nostra gatta, che aveva adottato. Ogni volta che se ne andava, nel suo borsellino si erano materializzate alcune banconote, preziose per i due pasti del giorno dopo: il suo e quello della gatta. E negli occhi di mia nonna si accendeva una luce bellissima. La filosofia di mia nonna era semplice. Di ogni contrattempo, piccolo o grande, trovava sempre il lato positivo, l’insegnamento. Se si schiacciava un dito, se la prendeva con la sua mano: «Peggio per te, così stai più attenta la prossima volta!». Nei casi peggiori, mia nonna diceva che era «il destino»: una logica superiore alle nostre capacità di comprensione, ma comunque benefica. Insomma, per dirla con un eufemismo, mia nonna era ottimista. E non aveva torto. Chi è ottimista vive meglio, dispensa felicità a chi lo circonda e campa cent’anni. Mia nonna morì «prematuramente», a novantadue anni. La sua vita cosciente finì nell’ospedale di Brunico dov’era in villeggiatura. La colpa fu della temerarietà mia e di mia madre: non è saggio portare una arzilla vecchietta di quell’età a scarpinare per borghi medievali, a sperimentare ristoranti di nouvelle cuisine, a visitare musei d’arte contadina. Ma mia nonna sembrava immortale. Nel mio cuore, comunque, è ancor viva. Resterà sempre la mia compagna di viaggio, in questa strana avventura dell’esistenza. Fu lei a regalarmi la gioia di vivere. Mi fu sempre d’aiuto, anche nelle piccole cose. Schivai perfino il servizio militare, grazie a lei. Secondo la legge, era a mio carico, visto che non aveva figli maschi e io ero il suo unico nipotino. Attraverso di 24 Il Morbo di Monduz lei ho compreso a quali vertici di grandezza d’animo possono arrivare le donne. La nonna aveva lasciato detto alla zia di darmi, alla sua morte, la pendola che le aveva regalato il nonno quando si erano sposati. Ora la pendola è qui accanto a me. La carico ogni mattina e la spolvero con tenerezza. Il tic tac della pendola mi fa compagnia, come fosse il proseguimento del battito del suo cuore. Mio padre Mio padre era un musicista, ex sottufficiale di carriera, pensionatosi, per una strana legge post-bellica, a quarant’anni. Parlando di trascorsi militari, non si pensi che fosse un militarista. Non fu la bellicosità, ma la bolletta, che indirizzò mio padre alla vita militare. Infatti si era arruolato nella banda presidiaria, uno strano corpo dell’esercito, che aveva la funzione di tener alto il morale dei nostri soldati. Mio padre suonava il clarinetto in modo fantastico. Aveva frequentato il conservatorio e spaziava dalla musica classica al folk. Ma la sua specialità erano le tiritere cadenzate, caratteristiche delle montagne modenesi, dove era nato. In questo era ineguagliabile: era l’unico musicista di Zocca e dintorni ad avere frequentato il conservatorio. Lui stesso componeva nuove filastrocche in musica, come se non ce ne fossero già abbastanza. I suoi fans le giudicavano una più bella dell’altra. Per me erano tutte uguali. Si chiudeva nello stanzino e tattaracchiava per ore. Ogni tanto io entravo e lo spernacchiavo con un «Tattaratattaratà ». Lui si infuriava. Diceva che interferivo nel suo estro musicale. Ma poi veniva da me flautato perché gli trovassi un titolo alla nuova canzone. Modestamente, a mettere titoli alle canzoni tattaracchianti ero maestro. Patologia familiare 25 Mio padre aveva studiato il clarinetto durante un inverno. Si era buscato la polmonite. Quattro mesi era dovuto rimanere rinchiuso in un casolare sperduto tra la neve in montagna, lui solo, e quello strano tubo nero, unico possibile gioco. Mio nonno glielo aveva proibito e lo teneva nascosto gelosamente. Mio padre l’aveva scovato e non aveva saputo resistere. Si era messo a suonarlo di frodo. In un inverno aveva imparato a suonare il clarinetto meglio di altri che lo avevano studiato per anni. Mio nonno scoperse il grande talento di mio padre una sera, rientrando a casa anzitempo. Da lontano sentiva clarinettare e si domandava chi fosse: nessuno in paese suonava il clarinetto tranne suo padre, che però era morto da anni. Mio nonno temeva gli spiriti, e oltretutto faceva notte: si sentì gelare il sangue. Ma non c’era un fantasma, ad attenderlo in casa: era il figlio di sette anni, che aveva composto la sua prima canzone. Da quel giorno cominciò a insegnargli la musica. Era una tradizione di famiglia che andava avanti da generazioni, ma quel bambino era il più dotato di tutti. Cominciò per mio padre la carriera di bimbo prodigio: suonava nelle balere con l’orchestra del nonno. Qualche volta lo accompagnava il fratello Renzo, con la fisarmonica. Cominciarono così per lui le notti bianche, le feste mobili, gli applausi e i bagni di folla. Tutti gli pronosticavano un luminoso avvenire. A Zocca di Modena era nato un grande talento. Da mio padre capii che il genio, per farsi strada, non basta. Spesso, anzi, è di ostacolo. Il genio si innamora delle sue idee, è pronto a battersi in loro difesa. Invece, per avere successo, basta assecondare le idee che hanno già la vittoria in tasca, senza badare a chi appartengano. A mio padre del successo interessava poco. Gli bastava la calda stima degli altri, la felicità. L’intelligenza non è sprecata quando serve a divertirsi. Mio padre ha giocato fino a cinquant’anni. 26 Il Morbo di Monduz Erano memorabili le sue zingarate, in compagnia di Pepo e Carlino. Carlino suonava l’ocarina, un piccolo strano flauto di terracotta fatto a zampogna; Pepo cantava e strimpellava una buffa fisarmonica a organetto. Insieme, girovagavano per le campagne per tutta la notte. Dovunque andassero, erano accolti in trionfo. I contadini si alzavano nel cuor della notte: le donne si mettevano a cuocere piadine, gli uomini andavano in cantina a stappare bottiglie. Poi cominciava la baldoria. Nelle case d’intorno, con quel fracasso, si accendevano i lumi a petrolio: altri invitati si univano alla festa, portando salami, formaggi, bottiglie di vino. E tutti a ballare, a cantare fino alle luci dell’alba. Finita una festa, il trio dei musici cambiava località e passava a una nuova bisboccia. Finché, stremati di canti e d’allegria, si trascinavano nelle loro case, dove cadevano in un meritato letargo. Queste zingarate si ripetevano con una discreta periodicità, ed erano motivo di stizza per le rispettive mogli, tra le quali mia madre. Erano sposati tutti e tre, e la stessa battaglia si riproponeva in tre diverse famiglie. L’emergenza cominciava con una telefonata del babbo, che avvertiva di un certo ritardo... Era il segnale: il consorzio delle tre mogli faceva scattare il dispositivo. Si attaccavano alla cornetta per sfogarsi e almanaccare sofisticate vendette contro i mariti. A me scappava da ridere, ascoltando quelle lamentele. Trapelava una strana ammirazione delle tre mogli per i loro consorti. Questo confermava il mio sospetto di una naturale disposizione delle donne al martirio. Fin da piccolo, il babbo mi portava a caccia con lui. Era un’avventura che iniziava nel cuor della notte. Sveglia ad ore impossibili, nella casa addormentata. La stessa «attrezzatura» era per me di grande interesse: la civetta con gli occhioni stralunati dall’al- Patologia familiare 27 ba, che portavamo in una cestina, gli specchietti da richiamo che giravano con un congegno a molla, i fischietti e tutto il resto. Era una spedizione vera e propria: il nostro safari. Uscivamo nella notte, carichi di attrezzi rumorosi, attenti a non svegliare tutto il condominio. E poi via in macchina, intirizziti nell’umido freddo d’autunno. Chilometri felici, con l’auto che a poco a poco si riscaldava. Il sole nasceva all’orizzonte e ci illuminava di gioia. Ma era il segnale che ci dovevamo sbrigare: con l’alba, gli uccelli si levano in volo. Ci precipitavamo in mezzo ai campi, a fabbricare un capanno mimetico di sterpi e rami secchi, a montare i nostri marchingegni. Quando il sole era alto, mi rincantucciavo in un angolo, avvolto in una coperta e mi addormentavo sereno. Ci avrebbe pensato il babbo, armato fino ai denti, a difendermi dalle allodole. Prima degli esami, mio padre mi portava ogni mattina, presto, sui colli «perché mi ossigenassi il cervello». Questa abitudine era diventata una specie di rito, cominciato con gli esami di quinta elementare e finito con l’università. Ma era anche un pretesto per stare insieme, per sentirci uniti davanti al grandioso spettacolo di un nuovo giorno che nasce. Il sole che si spandeva sulla città ai nostri piedi, il cinguettio degli uccelli, il gioco di luci cristalline tra le foglie dissipavano la mia angustia. Cos’era, in fin dei conti un esame, di fronte all’immensità dell’universo? Dopo i cinquant’anni, mio padre si diede agli affari. La musica rendeva poco e farmi studiare costava parecchio. Eravamo in pieno sviluppo dell’edilizia: Bologna era una foresta di gru, un enorme cantiere. I costruttori guadagnavano milioni, ma non riuscivano a tenere il passo con le richieste: mancavano loro quattrini e maestranze. Gli appartamenti si vendevano ancor prima di iniziare gli scavi per le fondamenta. Quando i lavori erano conclusi, il loro valore era molto accresciuto. 28 Il Morbo di Monduz In quel periodo mio padre conobbe un cantante lirico che possedeva una piccola azienda di intermediazioni immobiliari. Cominciò a fraternizzare con lui parlando di musica, poi pensarono di mettersi insieme in affari. Nacque così l’Agenzia Casabella: due soci e un garzone, si fa per dire, visto che aveva sessant’anni suonati. Trattare con i clienti toccava a mio padre; quanto a simpatia, non lo batteva nessuno. Il socio di mio padre, l’ex cantante lirico, era piuttosto pantofolaio, così se ne stava in agenzia, a seguire le telefonate. «Curava il coordinamento», a suo dire, o forse « curava il sonnecchiamento», come diceva mia madre. Comunque fosse, gli affari andavano a gonfie vele. Nel giro di pochi anni mio padre ebbe i soldi per comprarsi il suo primo appartamento, e cominciò a commerciare in proprio, comprando e vendendo case con i suoi soldi. Sarebbe arricchito, se l’onorevole Moro, con una legge fatale, non avesse decretato il funerale di tutto questo bengodi. Con il blocco dei fitti prima, e l’equo canone poi, l’edilizia morì e fu sepolta. Mio padre fu sorpreso dalla legge proprio quando aveva tutti i suoi soldi, e i suoi debiti, investiti in una mezza dozzina di appartamenti. Se la vide brutta. Dovette svenderli a meno di quanto li avesse pagati. Gli restò soltanto la casa dove abitavamo, in via Buttieri, e un terreno, che aveva comperato con licenza di lottizzazione data per certa, ma poi revocata, per somma iattura. Mio padre non l’avrebbe rivenduto al prezzo di terreno agricolo, neppure sotto tortura. Quel terreno è situato a Pianoro, un paesino subito fuori Bologna. In attesa della lottizzazione, mio padre e mia madre ci passavano la villeggiatura d’estate, e io andavo a trovarli, al ritorno dal mare o dalla montagna. Ad ogni mio arrivo, c’era la stessa aria di festa di quand’ero venuto al mondo. C’erano conigli e galline, un orto curato dal babbo come un giardino, una coppia di pensionati che stavano nell’appartamento del piano terra e Patologia familiare 29 curavano il poderino. A volte c’era anche mia nonna, che passava lì qualche settimana. Quando arrivavo in auto, la scorgevo da lontano, che mi cercava all’orizzonte, dalla finestra del primo piano. A Pianoro, nel « terreno agricolo » più costoso del mondo, avrebbero dovuto godersi la pensione i miei vecchi. Pianoro invece fu il capolinea di mio padre. Lì suonò l’ultima nota del suo clarinetto: l’ultima espressione sonora della sua squillante genialità, forse sprecata, secondo il senso comune, forse realizzata, secondo la sua concezione di vita. A Pianoro mio padre morì per un’emorragia cerebrale, dieci anni fa, giusto l’anno prima che mia madre andasse in pensione. Il podere è ancora lì: una casetta abbandonata, col tetto pericolante. Un cespuglio di erbacce al posto dell’orto. Nella stia c’è ancora l’acre odore dei polli. Ma a Pianoro non ci posso andar più: ogni volta mi viene un tal groppo in gola, che mi si blocca il respiro. Spero davvero che venga lottizzato, questo terreno, e di farci un buon affare. L’ultimo buon affare di mio padre. Un uomo grande. Sensibile, geniale, sprecato, felice. Un padre difficile da dimenticare. Mia madre Per tutta la vita ha cercato di evitare il taxi. Forse anche da morta vorrà andare al cimitero a piedi. Da bambina, bastava lasciarla in un prato di fiori, e lei stava buona e tranquilla fino a sera, a raccoglierli: così raccontano. E alla sera, del prato di fiori non ci restava che l’erba: mia madre non brilla per il senso della misura. Il TUTTO per lei è una semplice piattaforma di partenza da cui rilanciare per ottenere DI PIÙ. 30 Il Morbo di Monduz L’esagerazione è il suo obiettivo minimo. Da piccola sognava di essere la figlia del re. Passava interi pomeriggi a corte con principi e duchi creati dalla sua fantasia. Chissà come si saranno sentiti i ragazzini del suo quartiere, che lei identificava come ciambellani, paggi e palafrenieri. Quanto al carattere, non c’era verso di tenerle testa. Maschi o femmine, non le mettevano soggezione. Al contrario della sorella, di indole remissiva, mia madre era una saltafossi con il temperamento di un colonnello. Qualunque pretesto era buono per prendere il ruolo di «protettrice dei deboli». A diciott’anni incontrò il principe azzurro, disceso col suo cavallo bianco (una moto Gilera) dal reame di Zocca (provincia di Modena). Dopo dieci anni di matrimonio, nacqui io, e qui comincia un capitolo a parte. Mia madre è sempre stata apprensiva nei miei confronti. Cosa comprensibile, se si considera che la maternità è stata la missione della sua vita. Affidare al mondo futuro i suoi cromosomi, opportunamente integrati con quelli dell’uomo da lei prescelto, ecco in sintesi il suo mandato. In questa ottica, mia madre può essere considerata un laboratorio vivente di ingegneria genetica. Nel suo progetto, io ero l’estensione di un gesto antico, ripetuto per secoli, che ha condotto all’evoluzione e al progresso: emanciparsi, per quanto possibile, e generare rampolli su cui scaricare le ambizioni residue. Quando andava in giro con il pancione, guardava dentro le carrozzine, per verificare gli esemplari della concorrenza. Una volta che passeggiava per i Giardini Margherita, allo scopo di ossigenare il nascituro, si chinò a osservare una carrozzina finemente agghindata di trine e merletti. La mamma era un’esperta: carrozzine di lusso solitamente contenevano marmocchi selezionati. Immaginate il suo orrore quando intravide tra le tendine un bambino con un idrocefalo enorme. Rimase sconvolta. Dopo Patologia familiare 31 una visita dal ginecologo per un consulto (e relativa canzonatura) si rivolse alla Lisetta, che aveva l’abitudine di prendere sul serio qualunque paturnia. La Lisetta le confermò la pericolosità di quella visione. Grazie a una combinazione ponderata di sortilegi, nacqui normale. Normale secondo il parere dei medici; mia madre, dal canto suo, non era affatto convinta. Giudicava i pediatri gente di parte, come i concessionari d’automobili, quando consegnano un nuovo veicolo. C’era da aspettarselo, che quelli cercassero di nasconderle eventuali mie imperfezioni, faceva parte del loro mestiere. Mia madre mi verificava con molto puntiglio, alla ricerca di qualche difetto di fabbricazione. Quando spalancai gli occhi incuriosito dal mondo lei si mise in sospetto. « Come mai quel bambino cerca tanto la luce? Vuoi vedere che è cieco? » Il dubbio fu superato con un breve consulto oculistico. In seguito fu assalita da un altro timore. Non le tornava il conto delle mie pieghe cutanee: nella gambina destra ce n’era una in meno. Mi sistemò un cuscino tra le cosce, per vedere se si riequilibravano. Incrociò per tutto il Rizzoli abbordando pediatri e radiologi, finché il grande Scaglietti in persona non la rimandò a casa con vivaci parole. La mia manutenzione era affidata solo a esperti: un’infermiera mi veniva a lavare tutti i giorni e le pappine erano calibrate col bilancino da una dietista. La mia pediatra era una vecchia zitella senza figli. Meglio per loro: li avrebbe uccisi sicuramente per eccesso di tecnologia. Fui perfezionato in vari modi. Il frenulo della lingua, troppo corto: pericolo di balbuzie, risolto col bisturi. Sospetto angioma sul petto: irradiato all’istante. Un apparecchio di ortodonzia impedì ai miei incisivi di deviare la loro condotta. A un esame accurato del cuore, venne fuori un 32 Il Morbo di Monduz soffio mitralico, molto sospetto. Su questa presunta cardiopatia c’erano due opposte scuole di pensiero: alcuni la sostenevano, altri dicevano che non era niente. A titolo prudenziale, venne preso per buono il parere dei primi. Mi si proibì ogni tipo di ginnastica. La cosa non mi disturbò più di tanto: mi rifeci benissimo con altre forme di passatempo, come si vedrà in seguito. Il piano educativo di mia madre era impostato nel concetto della «full immersion ». Mi faceva ascoltare mio padre mentre suonava il clarino, per educarmi la sensibilità musicale e la sera mi leggeva poesie per farmi addormentare. Così intendeva stimolare in me, a livello inconscio, la vena poetica. Insomma, ero il suo capolavoro: unico, inimitabile. Da piccolo, ero per lei la cosa più prossima alla perfezione. Poi, diventando grande, mi sono guastato sempre di più. La mia crescita è stata un costante, rovinoso peggioramento. «Gianni, come sei cambiato. Sei diventato cinico. E pensare che eri così carino da piccolo!». Questa frase l’ho udita da quando sono venuto al mondo. È il ritornello della mia vita. Mia madre era maestra d’asilo. Sposandosi, aveva interrotto il lavoro, ma quando io raggiunsi i tre anni d’età, lei riprese a insegnare, per contribuire al bilancio della famiglia. Come insegnante, a parer mio, era fin troppo brava: aveva un modo di fare con i suoi scolaretti che suscitava la mia gelosia. Quando, col babbo, la andavo a prendere da scuola in macchina, la trovavamo sempre in mezzo ai «suoi bambini» che pigolava come una chioccia con i pulcini. Mi ingelosivo e la chiamavo «matrigna». Al contrario di mia nonna, che aveva occhi solo per me, mia madre amava tutti i bambini indistintamente. Io purtroppo, nel frattempo, ero cresciuto; mi amava ancora, ma per lei «non ero più così carino come da piccolo»! Patologia familiare 33 A mia madre è sempre mancato il senso della misura. Anche ora, un invito per una breve scampagnata con lei può degenerare in un giro del mondo in 80 giorni. Ma la cosa più straordinaria, è che al ritorno so già che la lascerei afflitta sulla soglia di casa, con in bocca le parole fatidiche «Come, te ne vai via subito?». La sua salute è sempre stata grande argomento di conversazione. Ha avuto talmente tanti malanni che non riesco nemmeno a ricordarli. «Tutte malattie reali e documentate, mica ipocondria» afferma lei, con malcelato orgoglio. Spesso ha temuto di lasciarci la pelle. E ne va fiera, come un reduce da Caporetto. Mentre studiavo medicina, la consolavo dicendole che per lei non c’era pericolo: non aveva buscato ancora tutte le malattie dei trattati di patologia. Non poteva morire prima di aver esaurito l’indice analitico. Lo dicevo per scherzo, però a ben osservare, anche se piena d’acciacchi è ancora viva. È sopravvissuta a mio padre e a mia nonna, che sembravano invulnerabili. Forse lamentarsi di continuo per la cattiva salute le ha fatto bene. Che bene le voglio, povera mamma. Con tutte le sue malattie, è un laboratorio vivente di clinica medica. Per sua fortuna, almeno le è stato risparmiato il Morbo di Monduz! Patologia remota All’asilo Dopo la triste esperienza delle suore, i miei mi avevano tenuto a casa; mio padre però era preoccupato. Temeva che diventassi un ragazzo viziato, introverso. «La vita è una battaglia in campo aperto » sosteneva « non un cortile protetto tra le sottane.» Di fronte a simili argomentazioni, nemmeno mia nonna seppe più replicare. Prima o poi avrei dovuto affrontare il mondo esterno. Si decise che sarei andato all’asilo comunale, almeno per l’ultimo anno. Furono fatti gli investimenti adeguati per un’attrezzatura di prim’ordine. Grembiulino a quadretti, confezionato su misura dalla nonna, cestino di rafia, portatovagliolo d’argento con le iniziali, incise anche sul bicchiere di cristallo e ricamate sul tovagliolo. Le donne di casa provvidero al rito della mia vestizione, poi mi portarono davanti allo specchio. Sembravo la foto pubblicitaria di uno scolaro; loro, sullo sfondo, erano le dimesse ancelle di un capolavoro che incarnava tutti i loro sogni di emancipazione. Mi piaceva sentirmi il campione designato di una riscossa dinastica. Mi sarei impegnato a conquistare il mondo per loro. Osservavo le mie donne che mormoravano d’approvazione, identificandosi in me. Ricorderò sempre il primo giorno di scuola. Io e la nonna, 36 Il Morbo di Monduz eravamo usciti di casa in anticipo, per osservare l’entrata degli altri scolari. «Facciamo ancora un giretto, nonna?» supplicavo. E lei si lasciava trainare per un’altra breve divagazione. Eravamo già passati davanti a quell’edificio tre volte, ma non mi convincevo a entrare. Suonò la campanella. La nonna mi pilotò dentro come un automa. Mi consegnò alla maestra. Mi fece promettere che mi sarei comportato da uomo. Poi si voltò bruscamente per andarsene, ma si asciugava gli occhi. La vidi scendere, sola, le scale. Mi girai a cercarla dalle finestre dei corridoi. Lei si fermò sul marciapiedi davanti alla scuola, diritta con la sua borsa della spesa al braccio. Non accennava a muoversi. Nella sua mano non teneva più il nipotino, ma solo un fazzoletto. Sarebbe rimasta sola a fare la spesa. Anch’io piangevo. L’infanzia m’aveva sbattuto fuori, e mia nonna era rimasta chiusa all’interno. La maestra dell’asilo era dolcissima, sembrava una mamma premurosa. Aveva anche lei due bambini. E poi, per fortuna, ero capitato in una sezione mista. Il primo giorno, girando lo sguardo per la classe, vidi che c’erano parecchie bambine, non tutto dunque era perduto, delle mie vecchie abitudini. Poi lo sguardo mi si fermò su una stupenda ragazzina bionda. I suoi occhi azzurri avevano una dolcezza sconosciuta. Altro che le amichette del mio cortile: quella sì che era una donna! Cominciai a osservarla con attenzione. La maestra parlava, ma io non la stavo a sentire. Ero intento a studiare quella meraviglia biologica. Batteva gli occhi come una farfalla, si muoveva in un modo diverso: sprigionava una grazia naturale e indecifrabile. Ogni suo gesto era come rallentato. Che armonia! A ogni suo indugio, cresceva la mia passione per lei. Durante la pausa della merenda, pur di avvicinarla, le offrii perfino la mia ciambella. Le piacque moltissimo. Per forza, l’aveva fatta la nonna. Le chiesi il suo nome, dove abitava. Si chiamava Viviana, la Vivi, e stava in via Orfeo! Patologia remota 37 Perché non l’avevo incontrata prima? I suoi genitori la tenevano sempre in casa. Anch’io non uscivo mai dal mio cortile. Glielo descrissi e ne fu entusiasta. La invitai. Avrebbe chiesto ai suoi di lasciarla venire. Ero inebriato di felicità. Il mio giardino dell’Eden avrebbe avuto il suo fiore più bello. Nel pomeriggio, la maestra doveva fare l’assegnazione dei banchi, come di consueto all’inizio dell’anno. Le venne un’idea fantastica. Visto che maschi e femmine erano pari di numero, si poteva fare un bel gioco: ogni bambina avrebbe scelto il suo compagno. Ci fu molta suspense. Le ragazzine arrossivano e i maschietti nascondevano la testa sotto il banco. Quando toccò a lei, la Vivi non ebbe dubbi. Puntò dritto il suo dito verso di me. Il mio cuore fece un sussulto. Era la prima dichiarazione che ricevevo da una ragazza! Ripensandoci ora, forse era merito anche della ciambella. Comunque uscii dall’asilo, in cui ero entrato piangendo, con un’aria sicura e occhi allegri. Da quel giorno la Vivi si mise a frequentare il mio cortile con regolarità, anche se non fu facile per me farla accettare alle altre bambine, che ne erano gelosissime. Quell’anno, per carnevale, capitò un episodio che mi fece meditare. Eravamo andati tutti insieme ai Giardini Margherita a vedere la sfilata dei carri: io, la mamma, la zia e le mie quattro o cinque amichette del cortile. C’era anche la Vivi. La parata era verso la fine, quando dagli altoparlanti fu annunciato che c’era fra noi un ospite d’eccezione: Pablito Calvo in persona, il bambino attore protagonista di un film spagnolo di grande successo in quegli anni, Marcellino pane e vino. Quel film l’avevamo visto tutti almeno due volte. Ci fu un’ovazione nella folla, quando annunciarono che Pablito Calvo sarebbe passato su un’auto scoperta in coda al corteo. Le mie amichette parevano tarantolate. Mugolavano, si 38 Il Morbo di Monduz spintonavano, spingevano per trovarsi in prima fila al passaggio del divo bambino. Io schiumavo di rabbia. Mi voltai dall’altra parte chiedendo alla zia di avvertirmi quando quel macaco fosse passato, così mi sarei girato di nuovo. Ma non c’era bisogno che la zia mi avvertisse. La folla era in delirio, anche le mie amichette gridavano come invasate. Ero pazzo di gelosia. La Vivi giurava che Pablito aveva guardato verso di lei e le aveva fatto un sorriso. La Sandra era riuscita a raccattare una stella filante gettata da lui, e la stringeva al petto come una reliquia. Ero sconvolto. Quel tipo, che veniva da così lontano, con la sua sola presenza era riuscito a mettere scompiglio nel mio cortile. Tornai a casa preoccupato e meditabondo. Nessun cortile aveva mura abbastanza alte per mettermi al riparo dai guastafeste. Volente o nolente, sarei dovuto passare all’attacco. La mia vita sarebbe stata una battaglia. Sarei stato anch’io un grand’uomo e avrei avuto tutte le donne ai miei piedi. Sentii un brivido lungo la schiena. Il Morbo di Monduz aveva attecchito. Ormai il suo decorso era inarrestabile. I miei business Fin da piccolo ho avuto il bernoccolo degli affari. In casa, gestivo un servizio di riparazioni domestiche. Ero capace di aggiustare tutto: rubinetti che perdevano, lavandini intasati, prese di corrente, ferri da stiro. Mio nonno era un appassionato di bricolage e mi aveva lasciato in eredità la sua cassetta di attrezzi. Avevo imparato a usarli, un po’ da solo e un po’ con la consulenza del babbo. Idraulica, elettricità, falegnameria, erano il mio pane. E, soprattutto, gli impianti telefonici. I telefoni sono sempre stati la mia passione. Combinavo derivazioni «in parallelo» pazzesche, roba da denuncia, se fosse venuta un’ispezione. Mi ero fatto le ossa smontando ogni sorta di congegno per Patologia remota 39 vedere come funzionava: radio, orologi, macchina da cucire. Nel rimontarli a volte mi trovavo in difficoltà. Alla sveglia, ad esempio, non c’era stato verso di farle ingoiare nuovamente la molla. In cucina avevo appeso una tabella con i prezzi per ogni tipo di riparazione. Le mie tariffe erano imbattibili, ma pretendevo di essere pagato per ogni intervento. Gratis non avrei mosso un dito, era una questione di dignità professionale. Tutti i ricavi confluivano nel mio libretto di risparmio. Quello che mi rifiutavo di utilizzare per comperarmi le caramelle. Più tardi mi era nata la passione per l’erboristeria. In un manualetto della Hoepli avevo trovato le indicazioni per preparare decotti e tisane, contro ogni malattia. Una volta curai mio padre, che soffriva di artrite alle mani, con un impiastro d’aglio tritato. Quando lo sfasciai, era tutto coperto di vesciche e io dovetti rinunciare alla mia parcella. Di ogni festività avevo scovato il risvolto economico. Il primo dell’anno era oggetto di una strana superstizione, che tornava a mio vantaggio. Era convinzione diffusa che la prima persona incontrata quel giorno avrebbe influenzato l’andamento di tutto l’anno. Incontrare un uomo era di buon auspicio, una donna significava un anno di guai. Contava anche l’età: un bambino era il massimo della buonasorte. Io ero il più giovane di tutto il quartiere a fare gli auguri di professione, ed ero anche il più richiesto. Alcune signore aspettavano tappate in casa per tutta la mattinata il mio augurio liberatore. Poi finalmente potevano uscire e andare a messa, senza rischiare la malasorte di incontrare per prima una donna. Portavo sempre con me dei rametti di vischio, per rinforzare il buonaugurio, o meglio, per rinforzare la gratitudine delle mie «clienti». Così si ripeteva ogni volta il ritornello da me tanto gradito: 40 Il Morbo di Monduz «Ma perché ti sei disturbato, non dovevi! Aspetta che vado a prendere qualche soldino per le caramelle.» Era un business eccezionale: un rametto di vischio, costato poche lire all’ingrosso, presentato in quel modo, a domicilio, centuplicava il suo valore. Compleanni, onomastici e anniversari erano per me una cuccagna. Approfittavo di ogni occasione per fare regalini a tutta la famiglia. Il vero motivo di tanto altruismo era che ciascuno poi, di nascosto dagli altri, mi ricompensava in lirette sonanti. Per i miei compleanni, la faccenda era diversa: non volevo regali, ma solo denaro contante. Le elementari La scuola elementare fu un periodo funesto. Ero capitato in una sezione maschile e mi annoiavo. Studiavo il minimo indispensabile. Ai miei il maestro ripeteva il solito ritornello: « Potrebbe fare di più, ma non si applica! ». I maggiori problemi non venivano comunque dallo studio, ma dalla vita di relazione con i compagni. Non avevo nulla in comune con loro. Erano aggressivi e maneschi. All’uscita da scuola, si spintonavano come torelli. Ogni controversia tra loro finiva in una rissa. Quello dei maschi mi pareva un mondo primitivo, basato sui muscoli, più che sul cervello. Pensavo che i loro bicipiti sarebbero serviti a poco di fronte alla sottile scaltrezza femminile. Sprecavano i pomeriggi a correre dietro un pallone. Ma era una scusa per tirarsi calci agli stinchi. Anche il ping pong o il Patologia remota 41 calcetto erano solo pretesti per combattere, fronteggiarsi. Erano carichi di adrenalina! « Poveri cristi - mi dicevo - forse è meglio che si sfoghino così! » La mia riservatezza aveva dato nell’occhio. Non mi azzuffavo mai con nessuno. Non andavo a «giocare» con loro. Qualcuno cominciò a chiamarmi «femminuccia», a canzonarmi. Ma non raccoglievo le loro provocazioni. Me ne stavo felice e beato a «fare il dottore» con le mie amichette in cortile. A casa non studiavo neanche un po’. Per passare, mi bastava che ascoltassi quello che spiegava in classe il maestro. Per tutti e cinque gli anni delle elementari, sono stato il terzo della classe. Il terzo della classe La posizione di terzo mi accompagna fin da piccolo. A dir la verità, mi son convinto che essere terzi sia la scelta più saggia. A essere il «secondo della classe» ti viene il sospetto di gareggiare per il primo posto e di avere davanti qualcuno più bravo di te. Ma anche ad essere il primo, c’è il suo inconveniente: ti potrebbe venire il sospetto di essere finito nella classe sbagliata. Anche nel modo di ragionare ho sempre cercato una terza via. Ne è venuta fuori una strana modalità di pensiero obliquo, che mia madre definisce «pensare di traverso». Fra ubbidienza e trasgressione, ho scelto la simpatia, per fare a modo mio. La chiamo «rock ragionevole». Mia madre mi taccia di marpione. La mia teoria trova applicazione perfino nel modo di prendere le decisioni. In pratica, rifiuto il dilemma: chi è indeciso tra due soluzioni inconciliabili, manca di fantasia. La terza soluzione è quella giusta. Ma è soprattutto nella coppia, che la posizione del «terzo» è da preferirsi. Naturalmente, chi a scuola era il «terzo della classe» nella vita si troverà perfettamente a suo agio nei panni di «terzo della coppia». 42 Il Morbo di Monduz Le medie La maestra Facchini delle Medie amava il mio modo di scrivere. La lettura di un mio componimento per lei era uno spasso. Nei titoli dei temi in classe c’era sempre una provocazione per me. Li sceglieva appositamente, come seppi in seguito, per vedere che cosa avrei escogitato. La Facchini era una lettrice accanita, con la fortuna di avere a disposizione il suo autore preferito. Allora non lo sapevo, però con lei avvertivo un senso di sicurezza che mi rendeva disinvolto e spontaneo. Quando componevo un tema, ogni tanto alzavo gli occhi dal foglio e guardavo la Facchini, che mi sorrideva dalla cattedra. Immaginavo la faccia che avrebbe fatto nel leggere quel che stavo scrivendo, e mi scappava da ridere. Scrivere per le donne, lo trovavo bellissimo. Mi ricordo di un tema in cui descrivevo le mie vacanze in montagna, a Zocca, con i cugini. Raccontavo di aver costruito un carretto trainato da oche. Uno sport di nostra invenzione, tra il go-kart e la slitta coi cani. Il racconto, che iniziava con una minuziosa descrizione dell’infernale trabiccolo, si concludeva in una frana rovinosa di ragazzini e palmipedi. Il mio tema arrivò sul tavolo del preside, che aveva il pallino del «talent scout». Gli piacque talmente, che volle leggerlo all’altoparlante a tutta la scolaresca. Chi fosse passato quel giorno in via Garibaldi, avrebbe sentito tali risate da farsi una strana idea della nostra vita scolastica. Mi sentivo una celebrità. «Peccato che il San Domenico sia una scuola maschile» mi rammaricavo «che senso ha il successo, senza un pubblico di ammiratrici?» Il Morbo di Monduz dava già le sue prime zampate. Quando ci fu il concorso ministeriale per un componimento sullo «sbarco dei Mille», fu scelto il mio tema, in rappresentanza Patologia remota 43 della nostra scuola. Superò le eliminatorie cittadine e quelle regionali e arrivò fino a Roma, dove si impaludò senza che nessuno ne sapesse più nulla. Alla fine delle medie, la Facchini chiese a ciascuno di noi come avremmo proseguito gli studi. Saputo che sarei andato a ragioneria convocò i miei genitori dal preside. I miei erano preoccupati per quella chiamata. Mio padre mi sottopose a un terzo grado, sospettando che avessi combinato qualcosa di grave. Mia madre, dal canto suo, andò dal parrucchiere. Lo faceva solo nelle grandi occasioni. L’accoglienza del preside fu diversa da quella che temevano. «Di ragazzi come suo figlio, cari signori, ce ne sono pochi. Sarebbe un delitto escluderlo dall’università. Ha del talento letterario. La scuola giusta è senz’altro il liceo. Classico, naturalmente!» La Facchini, presente, annuiva con aria solenne. I miei tornarono a casa frastornati, commossi, felici. Di avere un figlio dotato ne erano convinti da un pezzo, ma non avevano osato farne parola. Ora, con una conferma così autorevole, potevano sfoggiare il loro orgoglio. Mia madre si pavoneggiava con le colleghe a scuola, mio padre con gli amici del bar. Naturalmente «riferivano» l’opinione del preside, senza dire che era anche la loro. Così nessuno poteva accusarli di vanità. Quel brav’uomo del preside, si preoccupò persino che finissi in una buona sezione e telefonò al collega del Liceo Galvani per raccomandarmi. Mi venne assegnata la sezione B, la migliore. Questo eccesso di zelo fu determinante per il mio avvenire. La sezione B era sì quella con i migliori insegnanti, ma era anche il covo dei più ricchi figli di papà. 44 Il Morbo di Monduz Patologia remota 45 Il clima del Liceo Galvani La Zòccoli Eravamo agli inizi degli anni Sessanta. In attesa della contestazione giovanile, tutto il vecchiume ideologico, bigotto e reazionario faceva bello sfoggio di sé. I preti erano una potenza. I loro dogmi imperavano, infiltrandosi in ogni comportamento civile. Si impicciavano dei fatti altrui penetrando in ogni più intima piega dell’esistenza, sotto le lenzuola, nei sogni. L’unica strategia possibile per spezzare quelle catene era l’aperta ribellione, che avrebbe richiesto, purtroppo, il supporto di una forte ideologia contraria. Il famoso Sessantotto non venne fuori per caso. Il classismo si insinuava ovunque. Figuriamoci tra i banchi del Galvani! Molti dei miei compagni non solo erano snob, ma avevano quell’aria di ostentata affabilità che ti chiude la bocca. Non si poteva nemmeno reagire rabbiosamente ai loro privilegi: erano così cortesi! In classe, trattavano me, e quelli come me, da terremotati bisognosi di solidarietà. Ma nella vita privata c’era un muro. A quell’età si bada molto alle apparenze. Quei privilegiati vestivano in modo diverso dagli altri; era soprattutto negli accessori firmati che si manifestava la loro superiorità. Gli occhiali, per esempio. Portavano i Polaroid. Già era difficile trovarli in negozio: il mio ottico non li aveva. Mi misi in cerca e li scoprii nella vetrina di un negozio del centro. Belli, luccicanti, tralucevano benessere da ogni lente. Entrai timido e presi atto, con amarezza, che costavano dieci volte quelli normali. La stessa cosa valeva per i pullover con rombi, di cachemire, e per le magliette con il coccodrillo. Capi di vestiario a prezzi inavvicinabili. Bastioni del privilegio contro gli assalti dei miseri imitatori. Quarant’anni ho vissuto e non ho mai odiato nessuno: di questo son fiero. Anche se non è vero del tutto: una persona che detesto c’è. La mia insegnante del Ginnasio. La ricordo come un ibrido tra la mantide religiosa, Torquemada e Rasputin. Se in mia nonna la femminilità ha toccato le sue vette più alte, nella Zòccoli, secondo me, ha conosciuto i più orridi precipizi. La Zòccoli, al mio primo tema, mi affibbiò un quattro. Da allora, il voto più alto nello scritto fu un cinque e mezzo. La mia fantasia non era regolamentare. Diceva che non conoscevo bene l’italiano. Forse perché non conoscevo il significato del termine «ipocrisia». Avevo le mie idee e scrivevo quel che pensavo. Lei non lo sopportava. Comunque, la Zòccoli aveva due scusanti, nel vessare un ragazzo: prima, che un ragazzo aveva tutta la vita davanti per rifarsi; seconda, che lei non era in grado di vessare nessun altro. Riuscì ad annichilire la mia sicurezza in italiano, a mandarmi a ottobre il primo anno in quasi tutte le sue materie. Mi presentò all’esame di quinta ginnasio con quattro in italiano. Niente di irreparabile, visto che mi ripresi subito e all’esame fui promosso con un bel sette in italiano. Poi al liceo tornai subito alla mia condizione di eterno «terzo della classe». Dopotutto, la miglior vendetta è il successo. L’archeologia Il preside del Galvani, un omino piccolo e autoritario, era stato soprannominato Angelino per via della bassa statura. Aveva una grande passione per l’archeologia. In istituto, aveva raccolto dei «reperti villanoviani»: a quanto sembrava, erano frammenti di 46 Il Morbo di Monduz anfore, ma si capiva a malapena, tanto erano sminuzzati. Purtroppo il Galvani non aveva i fondi per il restauro. Questo era il cruccio del preside. Quel lavoro doveva essere divertente, una specie di puzzle. Io e il mio amico Michele ci offrimmo di farlo gratis. Angelino non si fidava, ma era tentato. In assenza di alternative, ci mise alla prova. Ci procurammo colle e solventi. In pochi giorni, avevamo allestito un piccolo laboratorio di restauro, nell’aula di scienze. Ci vollero due settimane per montare la prima anfora. Nei ritagli di tempo, marinando qualche lezione di poco conto, senza dare nell’occhio. Era un’anfora molto bella. Angelino rimase stupito della nostra bravura e ci affidò l’incarico in forma definitiva. Soprattutto, ci rilasciò un permesso scritto per assentarci dalle lezioni in qualunque momento. Un vero e proprio salvacondotto contro le interrogazioni di greco! Il laboratorio di scienze era il «sancta sanctorum» dell’istituto. C’erano marchingegni scientifici vecchi di secoli, cimeli da Museo della scienza. Alambicchi, storte, ampolle con reagenti chimici, fossili, strani ordigni elettrici, che risalivano ai primordi delle ricerche sull’elettricità. Non mi sarei meravigliato di trovarci, imbalsamata, la rana del Galvani. Passavo intere mattinate a studiarli e restavo affascinato dalla fantasia e dall’umiltà degli inventori. La scienza. Ecco, finalmente, la mia religione. Mi sentivo in un tempio. Quelle reliquie, lasciate in eredità dai sacerdoti del progresso, mi raccontavano l’umile cammino dell’intelligenza, schiacciata fra l’oppio delle religioni e la frusta dei potenti. Il laboratorio di scienze era un piccolo tempio polveroso. Lì restavo in preghiera. Pregavo me stesso, la mia coscienza, di non perdersi né col Dio dei preti, né col Satana dei capi, ma di seguire la via della civiltà. Patologia remota 47 Il teatro del Galvani Sono sempre stato molto timido, forse anche per via della mia infanzia appartata. Me ne dispiaceva moltissimo. Ero convinto che un «vero uomo» non dovesse spaventarsi di fronte a nulla. Invece, di fobie ne avevo parecchie. Oltre alla timidezza, soffrivo di claustrofobia e di vertigini. Dovevo porci un rimedio. Me ne offrì l’occasione il mio amico Michele, che invece non aveva paura di nulla. Si era iscritto al Centro Alpino Italiano per fare alpinismo e speleologia ogni domenica. Quel che ci voleva per temprare il mio carattere. Mi unii al suo gruppo, con una fifa blu. La prima discesa in «corda doppia» da uno strapiombo di trecento metri, presso il Farneto, me la ricorderò finché campo. Per non parlare della prima escursione alle grotte della Spipola. Conoscevo già la paura. Finalmente capii cosa fosse il terrore. Però lo vinsi ed elaborai una mia teoria. La paura cieca è impulsiva, animalesca. Nasce dal non essere abituati a una certa esperienza. Questo è l’istinto. Ma l’uso della ragione serve appunto a digerire nuove situazioni. Con l’aiuto della ragione un precipizio diventa un semplice pezzo di universo, una sorta di cielo che la gravità ha attirato dalla parte contraria. Una grotta angusta non è altro che un involucro, né più né meno del nostro corpo. Un contenitore intorno a un altro contenitore, come una lattina di birra in una confezione famiglia. Più difficile fu vincere il panico di parlare in pubblico. Avevo la passione del cinema in 8 millimetri, e avevo realizzato un cortometraggio su Bologna così stravagante, che l’insegnante di italiano della F, incuriosito, volle vederlo. Dopo l’audizione, mi abbracciò dicendo: «Tu, Monduzzi, sei la persona che cerco!». Il professor Testa, appassionato di letteratura spagnola, aveva tradotto in italiano una commedia inedita di Cervantes, I Bagni di Algeri, e voleva allestirla nello storico 48 Il Morbo di Monduz teatrino del Galvani. Stava cercando uno studente a cui affidare la regia. Io non chiedevo di meglio. Con l’altoparlante, invitammo gli studenti del Galvani a presentarsi per un provino. Fu uno spasso. Quei guitti improvvisati possedevano un involontario talento nell’arte di parodiare un attore. C’era da tenersi la pancia dal ridere. Peccato dover allestire un dramma e non una farsa: con una simile compagnia di « attori drammatici » avremmo ottenuto un successo garantito. Mi ero riservato una particina piccola piccola, secondo il costume dei grandi registi. Era breve, ma non abbastanza da non farmi paura. Comunque avevo preso le mie precauzioni. Era possibile declamarla senza riprender fiato: avevo fatto le prove. Così non avrei rischiato, per la fifa, di rimanere in debito d’ossigeno. Non ricordo più la battuta, ma era qualcosa tipo: « Il pranzo è servito! ». Tre giorni prima del nostro debutto, capitò la catastrofe: il protagonista si ammalò. Aveva una febbrona da cavallo, non c’era speranza di poterlo recuperare. Eravamo nei guai. Oramai la data della nostra «prima» non poteva essere cambiata. Avevamo affisso le locandine in tutti i licei di Bologna, il teatrino del Galvani era stato lustrato e agghindato. Non potevamo più tirarci indietro: ne andava dell’onore di tutto l’istituto. Oltre all’attore infermo, l’unico a conoscere un po’ quella parte era il regista, cioè io. Ma l’idea di tenere banco per più di un’ora su quelle tavole mi faceva rizzare i capelli. Ed era proprio quello che mi chiedevano, con aria solenne, nell’austera sala delle riunioni, il professor Testa e il preside. Per farmi quella tremenda proposta, si era riunito il Consiglio d’Istituto al completo. C’era perfino il busto di Galvani, che mi squadrava minaccioso, dall’alto, come se volesse diffidarmi dal rifiutare. Già solo la presenza di quelle poche persone mi metteva una fifa mortale. Figurarsi l’idea di recitare di fronte a compagni, genitori e insegnanti! Patologia remota 49 Come se non bastasse, ci sarebbero stati anche gli allievi del liceo Minghetti. Non sarebbero certo stati bendisposti, data la ruggine che c’era da sempre, tra loro e noi galvanisti. Quell’idea mi fece trasalire. Non so cosa balbettai. Ricordo però che uscii dalla sala senza aver trovato il coraggio per dire di no. Ero sbigottito della mia stessa incoscienza. Persino gli angeli affrescati nei corridoi della presidenza mi osservavano preoccupati. Pensai alla recita e un brivido mi trapassò la schiena. Provai a studiare la parte, ma non riuscivo neanche a tenere in mano la sceneggiatura. Quella notte non chiusi occhio, nonostante le molte camomille che mi fece la mamma. La mattina dopo, alle sette, mio padre mi chiamò in salotto, luogo sacro dove ci riunivamo soltanto nelle occasioni solenni come Pasqua e Natale, e mi fece un discorso: «Questo tuo terrore all’idea di esibirti, mi fa ricordare la prima volta che suonai in pubblico, col clarinetto. Eravamo a Zocca e avevo otto anni. La notte prima non avevo dormito, come te. Al mattino, mio padre mi chiamò in cucina, mi mise la sua manona sulla spalla» e mio padre rifece quel gesto, anche la sua mano non era leggera « poi mi disse le cose che sto per dirti. Noi dello spettacolo questa paura del pubblico la chiamiamo Timor Panico. Ne siamo colpiti tutti, chi più, chi meno. Col tempo si affievolisce un po’, ma non scompare mai completamente. Fa parte della magia dello spettacolo. La tensione che avverti prima ti è indispensabile per caricare le batterie. È così che richiami in te tutte le tue forze. Ne avrai bisogno, su quella ribalta!» A sentir nominare il palcoscenico, un nuovo brivido mi corse lungo la schiena. «Quando sarai lassù, solo, sotto le luci, per un momento ti sentirai perduto. Ti sembrerà di non ricordare più nulla. E avrai una voglia matta di scappare dietro le quinte. A quel punto si compirà 50 Il Morbo di Monduz il miracolo. Fai due respiri profondi e attacca col tuo repertorio. È fondamentale che ricordi bene i primi passaggi. Dopo un minuto o due, sentirai nascere dentro di te una strana energia. Come se la forza emotiva del pubblico si trasferisse dentro di te. Una forza affascinante e terribile. Ti stupirai della tua stessa bravura e ti sentirai invulnerabile. Allora fai attenzione, non lasciare il tuo temperamento a briglia sciolta, potresti andare “sopra le righe”. E in questa fase di eccessiva sicurezza che nascono le stecche peggiori. Comunque, se sbagli, fai un cenno di scusa rivolto al pubblico. Stringiti nelle spalle. Prima o poi arriverà un applauso: la conferma che la platea fa il tifo per te. Non sarai più solo sul palco, ma un corpo unico con la folla. Vibrerai con lei. E non vorresti più smettere. Capirai cosa sia l’abbraccio del pubblico. Il “successo”!» Mio padre si era commosso. Quell’«abbraccio» non l’aveva mai cancellato dal cuore, ne conservava la nostalgia. «OK, babbo, ho capito. Due respiri, una strizza e via!» Venne il giorno del mio debutto. Mio padre e mia madre non c’erano, come avevo richiesto. Prima della rappresentazione, da dietro le quinte, osservavo la gente in sala. Erano tanti! Avrei voluto contarli per calcolare il mio svantaggio. Come avrei potuto fronteggiarli tutti? Avevo mani e piedi gelati e la lingua impastata. Un’interrogazione di greco era un’emozione da ridere, paragonata a quell’esperienza. Il pubblico si ingrossava. I posti a sedere erano già tutti occupati, molti erano rimasti in piedi. Spiavo la gente, attraverso il sipario che tenevo stretto tra le mani. Lo tenevo serrato, come se fosse la sottana della mamma: volevo impedirgli di aprirsi e di abbandonarmi, solo contro tutti, in balia dei riflettori. La platea rumoreggiava. Eravamo in ritardo. Si spensero le luci in sala. Un applauso! Ma era un applauso d’ufficio. Non era per me, anzi, era la testimonianza di un’aspettativa che non avrei dovuto deludere. Patologia remota 51 Si aprirono i lembi del sipario, con un cigolio di carrucole che mi parve sottolineare la modestia del nostro apparato. Il mio cuore era una bomba a orologeria, pronta a scoppiare sotto il travestimento da cavaliere spagnolo. Feci i due respiri regolamentari e mi tuffai diritto nella disperazione, arrancando con la mia spada di latta. Mi mancò subito il fiato. Feci una pausa per tirare il respiro. Mi si annebbiò la vista. Comunque, con quella luce negli occhi, non riuscivo a vedere altro che teste. File di teste senza volto. Improvvisamente ebbi una certezza: non ricordavo più nulla, della mia parte. Tutto scordato. A pensarci bene, non sapevo nemmeno perché fossi lì. La vertigine dello sgomento mi attirava nei suoi gorghi fatali. Mi guardai indietro, verificando con lo sguardo se fosse libera la via della fuga. II pubblico forse avvertì la mia situazione. Chissà che espressione disperata avrò avuto. Stavo andando incontro alla più riuscita delle catastrofi quando arrivò, inaspettato, un applauso scrosciante. Un fulmine a ciel sereno. Una flebo tonificante di sicurezza. Una droga potente e sconosciuta. Non ero più solo. Ogni testa ora aveva un volto sorridente, che mi incoraggiava. C’erano le mie compagne di classe coi pugni stretti che mi facevano forza, e il professor Testa e il preside in prima fila. Mi scappò da ridere. Rimasi sorpreso della mia lucidità. Non lo credevo possibile: ora tutta la parte era chiara, scritta in un libro spalancato davanti ai miei occhi. Era come se il tempo si fosse fermato soltanto per gli altri, e io vivessi una frazione di attimo dilatata. Il mondo era immobile e io mi ci muovevo veloce. Se una battuta non la ricordavo, la reinventavo all’istante. Ero in grado di comporre su due piedi un’altra commedia, se necessario. Il sangue cominciava a scorrere verso le estremità, come se una saracinesca si fosse spalancata. La voce mi si rinfrancò. Forse avrò recitato male, quel giorno, però mi sentii ugualmente un trionfatore. Non era nata una stella, ma avevo vinto per la prima volta la mia timidezza. 52 Il Morbo di Monduz Finito lo spettacolo, mi aspettava una nuova sorpresa. Che fantastica sensazione di rilassamento! Mi sdraiai per terra, sulle tavole in legno dietro il palco. Il cuore stava rallentando. Ascoltavo il mio corpo che faceva la pace con me. Era stupendo. Percepivo un senso di comunione con tutte le cose che mi circondavano. Ormai facevo parte di quel teatro e della sua storia. Mi sentivo inerte e felice, come una tavola appoggiata sopra alle altre. Un’anima in armonia con se stessa e col mondo. Le mie compagne vennero a congratularsi con me. Avevo decine di ragazze intorno. Quella era vita! Le gite scolastiche Parlando di liceo, si riaffaccia la nostalgia delle gite scolastiche, di cui, naturalmente, l’attività più appassionante era la caccia alle compagne. Queste stavano al gioco, anzi, lo teleguidavano con maestria. La bagarre cominciava alla partenza. I sedili sul pullman erano a gruppi di due, e l’accaparramento dei posti aveva un grande valore strategico. Il momento di salire era il più impegnativo. Era richiesta prontezza di riflessi e nervi d’acciaio. Bisognava avere in mente una graduatoria delle ragazzine, in ordine di preferenza, e poi giocare bene le proprie carte. Le tattiche a disposizione, in pratica, erano due. La prima, consigliava di salire subito e custodire il sedile al fianco per la compagna desiderata. Per tenere la postazione, a volte si rendeva necessario scalciare via qualche intruso, però il sistema era valido. La seconda tattica prevedeva di tallonare la propria «vittima» e di tuffarsi al suo fianco con aria di noncuranza. Era un sistema non esente da rischi: c’era il pericolo che la fanciulla si sedesse vicino a qualcun altro, che aveva usato la prima tattica. Patologia remota 53 Le ragazze lasciavano a noi maschi la convinzione di condurre la caccia, ma in realtà erano quasi sempre loro a «pescarci». Le nostre manovre di seduzione erano molto sofisticate. Data la timidezza e il timore di venire respinti, si procedeva con molta cautela: c’era in agguato il rischio di diventare lo zimbello di tutta la classe. Le ragazzine erano tremende, quando prendevano di mira qualcuno. Le sentivi spettegolare tra loro e ti venivano i brividi. Raccontavano goffi tentativi di corteggiatori maldestri e si facevano matte risate alle loro spalle. Le più maliziose, addirittura, si divertivano a illudere i maschi, per farsi belle con le compagne. Il gioco sull’autobus continuava anche dopo la partenza. A ogni tappa c’era il pericolo di perdersi la compagna a metà «lavorazione», ma c’era anche la speranza di stipulare qualche altro «combino». Eravamo talmente assorbiti dalle nostre manovre, che nessuno faceva caso ai musei o alle cattedrali, tranne il gruppo dei professori. Parlavano e blateravano, ma nessuno dava loro ascolto. Il momento culminante di ogni gita era il ritorno, col favore del buio. I professori, ormai stanchi, non facevano più caso a noi: si sedevano nei primi posti a lamentarsi dei loro stipendi. A volte si appisolavano nella penombra trapuntata di lucine accese sul corridoio del pullman. Per noi, quelle luci fioche erano maliarde come quelle di un night, un invito a farci più arditi. Ora o mai più! Anche i timidi tentavano il tutto per tutto. C’erano tafferugli, fughe dai posti, gridolini. Nell’aria volavano carezze e schiaffoni. Qualche volta scendevi dal pullman con una ragazza stretta per mano. Erano ore che la tenevi stretta, lungo la via del ritorno. Avevi le dita sudate, ma non avresti mollato la presa per tutto l’oro del mondo. Anche a me capitò qualche volta di scendere dal pullman con una conquista. Cercavo di darmi un’aria di indifferenza, ma dalla piega degli occhi si capiva benissimo che scoppiavo di felicità. Logica del liceo classico II liceo classico insegna a usare la logica. Così fornisce gli strumenti teorici per farti strada e al tempo stesso suggerisce il dubbio che ne valga la pena. Insomma, dà lezioni di attacco e di ritirata. Portandoti a dubitare di tutto, questa scuola offre la copertura ideologica a ogni tipo di fallimento: sarai sempre in grado di sostenere che gli obiettivi importanti erano altri. II classico insegna la filosofia antica e le «lingue morte». In realtà il loro studio non è così strampalato come può sembrare d’acchito. Una lingua «morta» è come un amore di cui ci si è liberati. Lascia il cuore libero per l’unico vero, saggio amore della tua vita: te stesso. II greco e il latino ti aiutano a sviluppare l’unica lingua che conta, quella che usi tu per pensare. Quanto alla filosofia, quell’accozzaglia di teorie bislacche e improponibili ti lascia libero di sviluppare una tua filosofia personale. Così esci da dogmi e ideologie, imparando a essere individualista. Di una cosa in particolare sono grato al Galvani: di non avermi insegnato tutto quello che poteva «insegnarmi », approfittando della mia tenera età. È soprattutto dalle sue lacune, che ho tratto beneficio. La scuola migliore è quella che sparisce senza lasciare traccia di sé. Riflettendoci, la maggiore utilità del liceo classico è di avermi aiutato a capire l’inutilità del liceo classico. Professione: playboy Ho amato una sola donna ma non ho mai capito quale. Da ragazzino, immaginavo il fare l’amore come qualcosa di meraviglioso e terribile. Un gesto antico e inquietante che mette alla prova le capacità di un uomo. Farsi cogliere senza esperienze mi pareva lesivo della dignità maschile, come dev’esserlo per una donna farsi sorprendere mentre si dà la ceretta. Provavo a ripassare con l’immaginazione tutte le fasi, per farmene almeno un’idea, per non essere troppo impreparato, la prima volta. Ma anche lavorare di fantasia mi angosciava. Non sarei mai riuscito a dissimulare la mia mala grazia di principiante. Mi pareva che un uomo la dovesse saltare, la sua prima volta. Bisognava che mi sbarazzassi di quel noviziato. Purtroppo ero in crisi persino all’idea di un bacio, che dopotutto era pur sempre un rapporto carnale. Anche la più sprovveduta avrebbe capito che ero un novellino. Marisa In prima liceo, mi capitò finalmente l’occasione che tanto avevo atteso e fuggito. Mi ero messo in testa di fare il regista cinematografico. Fin da piccolo ero appassionato di cinema. 56 Il Morbo di Monduz Ma i film, non mi piaceva starli a guardare. Mi piaceva vederli girare. A quei tempi, Bolognini era venuto a Bologna per filmare La Banda Casaroli. In via Santo Stefano c’erano fasci di luci artificiali, strani camion, grossi cavi dappertutto, ragazze stupende, tanti curiosi. Un giorno mi avvicinai. Era uno spettacolo fantastico. Semplici oggetti e persone banali come se ne incontrano tutti i giorni, nelle mani del regista, sotto le luci dei riflettori, sprigionavano una malìa insospettata. Del mio desiderio di fare il regista parlai così tanto in casa che alla fine mio padre mi comperò una cinepresa semi-professionale. Scrissi la prima sceneggiatura. Una storia surreale, ambientata a Bologna, un po’ in centro, un po’ in collina. Per il casting coinvolsi tutta la classe, ma mi mancava l’attrice protagonista. Roberto conosceva una ragazzina bellissima, che sognava di far carriera nel cinema. Gliene parlò. Marisa ne fu entusiasta: non vedeva l’ora di conoscermi. Lei stessa mi telefonò, per sollecitare un incontro. «Facciamo oggi pomeriggio?» proposi. Aveva già un appuntamento, ma l’avrebbe disdetto. Mai trovata una ragazza così disponibile! Cominciai a capire le molle che rendono attraente il mondo del cinema: permette di ribaltare le regole del gioco! Grazie al cinema, era lei, la più bella del quartiere, a telefonarmi. Non mi potevo presentare come un uomo qualunque, avrei rischiato una caduta d’immagine. Andai a prenderla in taxi, cosa molto chic a quei tempi, specialmente per un ragazzino di sedici anni. Marisa abitava in una villetta di via Siepelunga, in collina, ma non feci fatica a trovarla: mi attendeva già in strada, in un succinto abitino estivo, tirata al burro come una star. Era davvero stupenda! A me sembrava più bella di Brigitte Bardot. Me ne innamorai all’istante. Non so più quel che le dissi, ma ricordo Professione: playboy 57 che dovetti faticare per non perdere il vantaggio strategico della mia qualità di regista. Se mi fossi buttato ai suoi piedi l’avrei persa per sempre. Cercai di non tradirmi, di non consegnarmi vinto al potere della sua bellezza. Per darmi un tono, la osservavo da tutte le angolazioni, usando un linguaggio incomprensibile. Supponevo che un regista dovesse fare così. Tagliai corto quel primo incontro, per non svelare la mia eccitazione. Se fossi rimasto ancora si sarebbe accorta che il mio cuore galoppava come un cavallo. Mi sembrava che si dovesse vedere anche attraverso la maglietta. Guardai l’orologio e mi scusai, avevo un altro impegno, dovevo scappare. Mi sentivo un pugile alle corde, in attesa del suono della campana. Dovevo assorbire l’impatto di quegli occhi, di quelle gambe. Riarmare le mie batterie di difesa, travolte da una raffica di sguardi più micidiali di una salva di missili SAM 2. La salutai con aria professionale. Come primo approccio, poteva andar bene, le dissi, però ci voleva un provino, davanti alla cinepresa, per verificare la fotogenia. L’esito già lo sapevo: l’avrei scelta come protagonista di tutti i miei film. Nel frattempo diventò la protagonista di tutti i miei sogni. Il provino fu fissato, due giorni dopo, a casa di Roberto. Facemmo tutti i preparativi per imbastire un’ambientazione che fosse all’altezza. Disponemmo faretti abbaglianti ai quattro angoli della stanza, il registratore sopra un armadio, con il microfono appeso al lampadario. La macchina da presa la piazzammo al centro, sul cavalletto. Era minuscola, su quel treppiede in mezzo alla stanza. D’altronde era proporzionata al mio talento nella regia. Marisa arrivò in autobus. Quando entrò nella nostra sala di audizione fu colta dal panico. Perfetto: la messa in scena risultava efficace! Per farle coraggio, le presi affettuosamente una mano. 58 Il Morbo di Monduz Lei me la strinse con forza, rivolgendomi uno sguardo di adorazione. Nei suoi occhi c’era una luce fantastica, una sfida e un invito irresistibili. Sentivo nascere in me forze sconosciute. Mi sentivo pronto a osare qualunque cosa, per lei. Facemmo un provino - perlomeno supponevo che un provino si dovesse fare così. Parlandole della trama del film, le suggerivo gli stati d’animo che lei avrebbe dovuto interpretare. Marisa, dapprima imbarazzata, era sempre più sciolta e cominciò a seguire quel gioco, a divertirsi. Anche Roberto si era presa una bella scuffia, tanto che prendendomi da parte, mi propose uno strano baratto: se gli avessi lasciato libero il campo, mi avrebbe ceduto la sua Vespa a tempo illimitato. Sorrisi al candore della sua offerta. Guardai l’orologio. Ero in grave ritardo. Nell’andarmene chiesi a Roberto le chiavi della sua motoretta. Roberto interpretò quel gesto come un’implicita accettazione della sua proposta. Mi consegnò le chiavi all’istante, quasi temendo che cambiassi idea; per Marisa non avrei dovuto preoccuparmi, l’avrebbe accompagnata a casa lui. Ma io prevedevo che non sarebbe andata così, e infatti, appena misi in moto la Vespa, Marisa saltò con me sul sellino. Roberto restò a bocca aperta. Ci vide partire allibito, sotto i suoi occhi. Doveva imparare anche lui che in amore e in guerra i patti non si rispettano. Marisa mi stringeva più del necessario per tenersi in sella. Sentivo la rotondità del suo seno che mi premeva forte contro la schiena. Accentuavo la mia instabilità per offrirle il pretesto di stringermi ancora di più. Lei, come un brivido che mi scorresse lungo la schiena, mi premeva la faccia sulla nuca e si avvinghiava a me con tutte le forze. Scherzosamente l’avvisai che se faceva così, non avrei più risposto di me. Peggio che peggio. Si mise a darmi bacini, a mordicchiarmi le orecchie. Tanto fece che perdetti davvero l’equilibrio e uscimmo di strada. Professione: playboy 59 Finimmo su un prato, ribaltati l’uno sull’altra, ridendo a crepapelle. «E pensare che Roberto mi aveva offerto la Vespa se gli lasciavo libero il campo, con te!» «Ah sì? Sforzo inutile. Con lui non ci sarei mai stata! » « E con chi, allora? ». «Me lo chiedi?» E si avvicinò furbetta alla mia bocca, che la baciò senza nemmeno interpellarmi. «Il mio primo bacio!» gridavo in silenzio, dentro di me. E non era stato nemmeno difficile. Era una sensazione tutta particolare: avvertivo una strana complicità con quella ragazza e una certa vivacità dentro i calzoni. Si era creata tra noi un’intimità nuova. Prima, avvertivo un’ansia sottile, un’attrazione, che però ci teneva divisi. Ora tra noi era tutto diverso. Era come se quella donna mi avesse dato il semaforo verde per entrare nella sua vita. «Meglio riprovarci» mi dissi. Il secondo bacio mi riuscì meglio ancora del primo, senza un rumore, senza sbavature. Tecnicamente perfetto. «Un problema risolto» dicevo tra me. Sì, ma un nuovo problema era in agguato: quella ragazza non sarebbe stata per me soltanto la protagonista del mio primo film. Iniziammo a vederci regolarmente. Con Marisa avevo superato lo scoglio del primo bacio; e se avessi saltato il fosso del tutto, facendo l’amore con lei? Soltanto l’idea mi metteva la tremarella. Comuni amici assicuravano che Marisa non era una novellina, nonostante la giovane età. Ma io non avevo nemmeno il coraggio di tentare un’avance. Innanzitutto, temevo di offenderla. Mi sembrava una profanazione. E poi, soprattutto, temevo di fare con lei una gran brutta figura. E se lì, sul più bello, non mi funzionava? La terribile «prova della virilità» mi metteva una fifa blu. Così la nostra relazione andava avanti, tra baci e sospiri, ma niente di più. Certi pomeriggi Marisa spariva, nemmeno sua madre 60 Il Morbo di Monduz sapeva dove fosse finita. Il giorno seguente mi telefonava adducendo scuse poco plausibili. Cominciavo a nutrire sospetti. Un mio compagno che abitava a due passi da lei, in via Siepelunga, mi giurò di averla vista passare in motocicletta con un ragazzo. Teneva una coperta sotto il braccio e aveva tutta l’aria di una che stava per imboscarsi. La faccenda mi suonava storta. D’impulso le telefonai confessandole gli atroci sospetti. Lei precipitò dalle nuvole, anzi si arrabbiò, tanto che alla fine dovetti perfino chiederle scusa. Ma il giorno dopo il mio amico «spione» ricevette una strana telefonata. Uno sconosciuto gli aveva promesso una doppia razione di pugni sul muso, se non si faceva i cavoli suoi. Me lo riferì incazzatissimo. Il cerchio stava quadrando. Non avevo più dubbi. Quel pomeriggio mi incontrai con Marisa e vuotai il sacco. Non avevo più fiducia in lei. Non avrei più creduto a una sua parola. Ero disperatamente fuori di me. Speravo che trovasse una giustificazione plausibile, al limite che la inventasse, non avrei fatto il difficile. Avevo soltanto voglia di chiudere gli occhi e crederle ancora. Lei invece mi lasciò sfogare senza accampare la minima scusa, come se la cosa non la riguardasse. Non ero preparato a una reazione simile. Le dissi la prima cosa che mi passò per la mente, la più saggia, dopotutto: che la lasciavo. Vidi un attimo di stupore attraversarle gli occhi. Forse questo non se l’aspettava. Ormai ero prigioniero di quell’atmosfera melodrammatica, che io stesso avevo creato. Mi girai lentamente in modo plateale, e un passo dopo l’altro, cominciai ad allontanarmi da lei come in una scena al rallentatore. Forse speravo che mi corresse dietro a fermarmi, forse temevo di cambiare idea. Me ne andai così, a piedi, piano piano, senza voltarmi, lasciandola sulla soglia di casa. Sentivo il suo sguardo su di me, ma procedevo automaticamente, senza rallentare. Mi sentivo un soldatino di latta, con il Professione: playboy 61 cuore di piombo. Le orecchie tese, speravo di udire i suoi passi raggiungermi o il chiudersi della porta, che mettesse fine alla suspense di quell’addio. Niente di niente. Ripercorsi lentamente tutta via Siepelunga, ripassando la nostra breve storia d’amore. Quella strada mi aveva visto arrivare su un taxi, come un magnate di Hollywood. Ora mi vedeva appiedato, con il cuore in pezzi. Finì così, con Marisa. La mia prima storia d’amore, il primo bacio, la prima fregatura. Logiche di seduzione Problema: Mi piace una donna su dieci. Complicazione: Piaccio a una donna su cento. Mi sono spesso domandato come mai telefonavo alle ragazze quand’ero allegro e loro chiamavano me quand’erano tristi. È così che mi è venuto il sospetto di non essere un Alain Delon. Amare una sola donna è una forma di perversione, un disprezzo della femminilità. Forse chi ama una donna sola pensa: «tanto, son tutte uguali»? Ma chi ama veramente le donne parte dal concetto opposto: che sono tutte diverse! Eppoi, in amore è cosa saggia diversificare il rischio. Piuttosto che una donna bellissima ne ho sempre preferito due carine. Qualche volta mi sono spinto anche più in là, riducendomi con tre appena discrete. Però bisogna stare attenti a non farsi vedere con certi mostri per strada: ne va dell’immagine. Le donne, nel giudicarti, si basano sul parere delle colleghe: quando ti incontrano, salutano la donna che ti sta accanto. Se è uno scorfano orrendo, ti bocciano. La formula della seduzione ponderata si ottiene calcolando il numero di donne che sospirano per te, moltiplicato per il numero di uomini che sospiran per loro. 62 Il Morbo di Monduz Vendetta, tremenda vendetta L’episodio della Marisa mi bruciò nell’orgoglio come la peggiore delle disfatte. Quella ragazza l’avevo persa per ingenuità, per inadempienza virile, per inefficiente strumentazione. Nessuno me lo toglieva di testa. La sognavo la notte, nelle braccia di un altro, che rideva di me. Ero ancora un bambino da latte? Un perdente? Marisa era un pezzetto di mondo che mi aveva beffato. No, mi aveva dato soltanto una lezione. Il mondo non mi conosceva ancora bene. Gliela avrei fatta vedere io, chi era Monduz. La Nasa, dopo un lancio fallito, non riesamina forse le sue procedure? Io avrei messo sotto inchiesta tutto il mio strumentario di maschio. Mi chiusi in casa per una settimana, tra alti, e bassi d’umore. Nei momenti bassi, guardavo giù dalla finestra, valutando se dal quarto piano ci si sfracelli sul colpo. Nei momenti alti, per l’incazzatura, mi si drizzava il pelo sulla schiena. Nei momenti intermedi, ero lucido e levigato come una lama che si fa accarezzare dalla pietra, in attesa di materiali più soffici. Chiuso nella mia stanza come un frate trappista, feci un’analisi microscopica della mia esperienza. Volevo trarne il massimo insegnamento possibile. Smontai, pezzo per pezzo, ogni fase della vicenda. Le avevo battezzate «unità comportamentali». A ognuna di esse intestavo un foglio. Procedendo in questo modo, riempii pagine su pagine di schemi. Qualcosa di simile agli algoritmi che si usano nell’analisi per la programmazione di un computer. Quando il materiale era troppo cresciuto, procedevo a una sintesi, condensando più pagine in una sola. Poi continuavo. Mia madre era molto preoccupata. Ogni tanto faceva capolino alla porta della mia stanza, ma veniva scacciata con forza. Fuori dell’uscio avevo attaccato un cartello: « Divieto d’accesso, Professione: playboy 63 LIVORI IN CORSO». Uscivo solo a mangiare e a rifornirmi di un nuovo bottiglione di tè, quando l’avevo finito. Dopo alcuni giorni d’elucubrazioni, uscii dalla mia stanza con tre paginette di schemi chiarissimi. Il rapporto finale della mia inchiesta era articolato su tre punti: 1) situazione dei fatti, 2) tattica a breve, 3) strategia. 1) La situazione. Erano emerse carenze strutturali gravi, riassumibili nei punti seguenti. - Impreparazione psicologica. Insufficiente conoscenza dell’avversario. - Inesperienza operativa. Nessuna pratica nell’esercizio sessuale. - Inadeguatezza strutturale. Mancanza di un «trappolo»* e di un mezzo di trasporto. 2) Tattica a breve. Andavano intraprese le seguenti iniziative. - Dottrina. Ricerca testi di psicologia femminile e biografie di seduttori. - Praticantato. Collaudo ed esercitazioni con un’esperta. - Strumentazione. Acquisto di un ciclomotore usato e ricerca di un trappolo. 3) Strategia. Essere io, la prossima volta, quello che passava per via Siepelunga in moto, con una Marisa seduta dietro e un plaid sotto il braccio. Il 48 cc Comperare un motorino non era un problema economico, ma di politica familiare. Provai ad accennarne in casa, ma i miei era* Con questo termine, noi a Bologna indichiamo la garçonnière. Credo che tragga origine da «trappola». L’allusione è chiara: se una donna fa tanto di metterci piede, scatta un meccanismo automatico, per cui ci lascia le penne. 64 Il Morbo di Monduz no duri d’orecchio. Persino un piccolo 48 cc era considerato da loro un ordigno infernale, uno strumento di azzoppamenti, di mutilazioni e di morte. Iniziarono sfilze di raccontini apocalittici con giovani dilaniati dai camion, arrotati dalle automobili, travolti dal traffico. A sentire mio padre, pareva che dietro ogni curva si celasse una macchia d’olio su cui scivolare, a ogni incrocio un’auto pirata con istinti omicidi. Per di più le strade erano piene di alberi, bersaglio naturale di ogni motociclista. A nulla valsero rimostranze, accuse, rinfacciamenti: «Ma se la mamma mi ha detto che andavi a prenderla con la tua Gilera!». Mia madre si faceva piccola piccola. Aveva un po’ la mania di sbandierare la disinvoltura di mio padre alla guida. «Sì» rincaravo la dose «proprio tu, che viaggiavi come un forsennato, e nelle curve facevi le scintille sull’asfalto con i predellini! Nega, se puoi!» Mio padre, inviperito, guardava mia madre con aria di fuoco: «Sì, ma quelli erano altri tempi. Allora il traffico non esisteva. Da Zocca a Bologna, si incontrava un’auto sì e no. Adesso è tutto un caos. Lo vuoi capire che quando ti inzucchi con un’automobile (visto che prima o poi ci si inzucca per forza), sono le tue ossa che ti fanno da carrozzeria?! Quello dell’auto se ne va dal carrozziere, tu al traumatologico, se non all’obitorio!» Il suo discorso non faceva una grinza. Ma vallo a spiegare, a un ragazzo di diciassette anni, di andare a prendere una ragazza con l’autobus! Se fosse stato necessario avrei trasgredito. Non c’era altra via. L’avrei comperato di nascosto, il motorino. Mi parve che sarebbe stata una marachella minore, se lo avessi comprato usato, e poco costoso. Scelsi un Motom, un 48 cc a quattro tempi derivato dal motore di una motozappa. Macchina lentina, ma indistruttibile. Lo trovai subito, da un rivenditore. Era rosso, bellissimo. Gli cambiai il sellino, da uno a due posti. Professione: playboy 65 Ci feci mettere i predellini di dietro, per il passeggero, anzi, per la passeggera: erano chiare le mie intenzioni, in proposito. Lo andai a collaudare sui viali. Scoppiettava con la regolarità di un orologio, sembrava davvero una motozappa. Ogni tanto scappava fuori una marcia, e il motore andava in fuori giri, ma a me sembrava fantastico. Trovai il posto giusto per parcheggiarlo: l’androne di un vecchio palazzo, in via Santo Stefano, di fronte a via Buttieri. Abbastanza vicino a casa, ma non proprio sotto gli occhi dei miei. Il primo passo era fatto. Gli studi psicologici Iniziai a frequentare la biblioteca dell’Archiginnasio con regolarità. Condussi scrupolose ricerche negli schedari per argomenti, alle voci: «Seduzione», «Psicologia femminile», «Avventurieri». Realizzai un elenco di titoli lungo tre pagine, poi feci impazzire il bibliotecario a tirar fuori tutta quella scienza dai polverosi scaffali. La maggior parte dei testi si rivelò inutile. Psicologie femminili vecchie di duecent’anni erano poco affidabili: la seduzione veniva intesa come arte di praticare l’ipnosi. Quanto agli avventurieri, quelli operanti fuori dal campo sentimentale non erano pane per me. Comunque, alcuni libri preziosi rimasero nelle mie reti. Tra questi spiccavano Le deuxième sexe di Simone de Beauvoir, in due volumi e, soprattutto, una delle più grandi autobiografie di tutti i tempi, La storia della mia vita di Giacomo Casanova, edizione Il Corbaccio, 24 volumi. Ne venni a capo, senza lasciarmi intimidire dalla loro mole. Le deuxième sexe era ostico quanto prezioso: le più intime riflessioni sulle donne dovute a una di loro. La Storia della mia vita, invece, 66 Il Morbo di Monduz filava via come un sogno. Usavo l’astuzia di leggerne un pezzetto del primo, finché ero stufo, poi continuavo con il secondo, per rinfrancarmi, come fossero l’uno il pane e l’altro la cioccolata. Passavo quasi tutti i pomeriggi in biblioteca, poi quando mi fu concesso di portare i libri a casa, passai notti insonni sui testi. In poco più di sei mesi mi ero fatto una preparazione teorica sufficiente. Era venuto il momento di provvedere agli aspetti pratici. Quella tragica prima volta Bisognava farla finita, con quell’ignobile noviziato. Non volevo correre rischi: mi sarei rivolto a una professionista. Fu così che organizzai con gli amici una notte brava, all’insegna della trasgressione e del praticantato. Una romantica notte a puttane. La battuta fu preparata minuziosamente. In casa, dissi che andavo a studiare. Presi di nascosto l’auto del babbo. La sapevo guidare benissimo, anche se, a diciassette anni, la patente non ce l’avevo. A scanso di rischi inutili, ne avrei affidato la guida a Lucio, che era ripetente e patentato. Maestro di caccia sarebbe stato Fabio, esperto in quel tipo d’imprese. Aggregai alla battuta Michele, mio amico del cuore, perché mi confortasse. La squadra dunque era completa, ciascuno con la sua precisa funzione. Lucio alla guida, Fabio al coordinamento, Michele al sostegno psicologico e io alla motorizzazione, e alla fifa. Uscimmo alla chetichella, come una banda di cospiratori. Venni fuori dal parcheggio di casa con l’auto a fari spenti. Lucio mi aspettava all’angolo per darmi il cambio al volante. Michele e Fabio erano al bar sotto casa, che dissertavano di marche di profilattici. Ne avevano di tutti i tipi: stimolanti, ritardanti, anatomici e rostrati, chiamati da loro «tormientos». Una strumentazione di prim’ordine, nulla da eccepire. Professione: playboy 67 Ci avventurammo, con aria di bracconieri smaliziati, sui viali di circonvallazione, facendo la spola tra le postazioni più frequentate dalle belle di notte. Facemmo tre volte il giro di Bologna, soppesando il da farsi. Fabio si divertiva un mondo a intrattenere quelle signore. Molte lo riconoscevano e lui se ne compiaceva. Sembrava un habitué di un locale notturno che ci tiene all’inchino del direttore. Bisognava trovare una puttana che andasse bene a tutti, e invece c’era sempre qualcuno che poneva dei veti, battibeccando con i favorevoli. Io ero tra i giudici più severi. Da lontano sembravano tutte bellissime, ma guardandole da vicino erano orrende. Nelle loro parole sentivo l’eco di un’oscena violenza. Non mi pareva più un bell’inizio, il mio, con quegli articoli di macelleria. Cominciavo a dubitare della opportunità della mia iniziativa. O forse era soltanto una crisi di vigliaccheria? A furia di rimandare, arrivammo a un compromesso: la donna che posteggiava vicino alla fiera. Ci presentò il listino delle sue prestazioni, con la grazia che contraddistingue la categoria. Chiedemmo uno sconto per comitive, peccato che non valesse la tessera Enal. Ci accordammo e lei salì. Ero emozionatissimo: un conto era pensare di andare a battone, un altro averne sull’auto una vera. Siccome ero seduto davanti, per non voltarmi la sbirciavo clandestinamente dallo specchietto retrovisore. La voglia di scappare via c’era tutta. Ma con gli amici dietro, festanti, non potevo fuggire come un coniglio. E poi, c’era davanti ai miei occhi l’immagine di quella moto che risaliva via Siepelunga con Marisa sul sellino di dietro. Eh no, non mi sarei tirato indietro neanche di fronte all’Inferno. La bagascia ci guidò per un sentiero dietro ai cantieri della fiera in costruzione. Ci indicò un ponte, sotto cui ci fermammo. Nel silenzio, il mio cuore batteva più forte del Motom quando gli uscivan le marce. «Chi viene per primo?» chiese pragmaticamente la meretrice. 68 Il Morbo di Monduz «Gianni è il padrone dell’auto. Spetta a lui quest’onore!» sentenziò Fabio, ottenendo la generale approvazione. Scesero tutti, dileguandosi nel buio della notte. «Fai pure con calma!» mi sussurrò Michele. La puttana era di diverso parere: «Macché “fai con calma”! Fai alla svelta, invece, che la nottata è solo all’inizio!» Ecco l’incoraggiamento che mi ci voleva, per dare il meglio di me. La tizia, senza tanti preamboli, passò a vie di fatto, ma il mio corpo opponeva un netto rifiuto. Confessai che era la mia prima esperienza. La signora raddoppiò i suoi sforzi, rantolando come una baccante. Peggio che mai. Per sbloccare la situazione, le feci una proposta concreta. «Senta un po’, facciamo che abbiamo concluso. Così io salvo la faccia e lei la parcella! » Non era una cattiva idea. La battona mi fece una controproposta, deontologicamente ineccepibile: «Facciamo così: quando ho finito con tutti gli altri, ti richiamo dentro, diciamo che si è concordato di fare un bis! Così fai pure la figura del ganzo!» E negli occhi le brillava una luce diabolica. Dal suo punto di vista, quello doveva essere un grande favore, non mi sentivo di rifiutare. Aprii la portiera e mi sorpresi ad annusare il profumo della rugiada nei campi. Quanta nevrosi c’era in quell’auto, e quanta pace fuori! Feci un fischio e vidi materializzarsi dal buio Michele, che aveva vinto alla morra il privilegio di essere il secondo. «Tutto bene?» chiese. Mi parve un arcangelo materializzato dal nulla per tirarmi fuori da quell’imbarazzo. Uno alla volta, tutti gli amici fecero quanto dovuto. Poi, com’eravamo d’accordo, la signora mi richiamò, tra l’incredulità generale. Rientrai nell’auto con l’aria da gran viveur. Ma dentro quei vetri appannati, grondanti lussuria di terza classe, la situazione non Professione: playboy 69 era migliorata. La battona era sempre la stessa, con l’aggravante che era anche una battona più usata. Dichiarai immediatamente forfait. Tornammo a casa facendo baldoria. Mi toccò di sostenere la reputazione di mandrillo, due volte usurpata. Comunque l’esperienza non era stata del tutto inutile. Mi ero chiarite le idee. A puttane, nella vita, mai più. Se il sesso era quello, avrei preferito fare voto di castità. Il mio problemino restava. Dovevo ritentare in condizioni migliori. Innanzitutto, con una ragazza normale. E poi evitando automobili e amici. Ci voleva un trappolo, con tutti gli accorgimenti per farmi sentire a mio agio. Il primo trappolo Trovare un appartamentino in affitto, a diciassette anni e con pochi quattrini, era un’impresa. Avrei dovuto cercarmi un socio. Michele era il tipo giusto. Accettò subito la mia proposta, visto che aveva lo stesso problema. Michele abitava in una villetta fuori San Vitale, alla periferia di Bologna. Forse dalle sue parti era più facile scovare una sistemazione economica. Cominciammo a perlustrare le campagne di San Vitale in bicicletta, alla ricerca di una casa di contadini abbandonata. Battemmo in lungo e in largo tutta la zona. Alla fine trovammo quel che faceva per noi: una bellissima fattoria semidiroccata, in via Guelfa, poco distante dalla «montagna del rusco », il deposito comunale dei rifiuti. Dopo una prima ispezione, questa casa colonica risultò molto spartana. All’appello mancavano: bagno, riscaldamento, gas, acqua corrente ed elettricità. Però il tetto l’aveva. C’erano anche i muri e qualche finestra scardinata. A noi parve che potesse andar bene, con 70 Il Morbo di Monduz qualche modifica. Il problema più grosso era la totale assenza di servizi igienici. Una soluzione l’avremmo trovata. Non fu tanto facile convincere la proprietaria ad affittarcela. Era preoccupata delle possibili grane. Eravamo minorenni e poco affidabili. Sull’uso che intendevamo farne, non c’erano dubbi. Ma le facemmo una corte talmente serrata, che alla fine non poté dirci di no. Prima che cambiasse idea, tirai fuori carta e penna. Le feci notare che un accordo sulla parola non era elegante, per il nostro primo rapporto di locazione. Così stendemmo un «regolare contratto», su di un foglio a quadretti, che ancora conservo: «Noi sottoscritti Gianni Monduzzi e Michele C.. attestiamo di aver preso in affitto dalla signora Valeria B... un’abitazione in via Guelfa 43, ad uso di studio e ricreazione, a £ 10.000 mensili, con decorso dal 1° Novembre. Bologna, 21/10/63. In fede, Gianni Monduzzi, Michele C.., Valeria B... (firme autografe) In questo contratto c’era un 50% di verità e un 50% di bugie: non avevamo alcuna intenzione di applicarci allo studio, in quell’abitazione di via Guelfa. Quanto alla «ricreazione», invece, i nostri propositi erano limpidi: volevamo ricrearci con quante più ragazze possibile. Firmato il contratto, prendemmo possesso della nostra sede. A parte i soffitti mezzo sfondati, gli avvallamenti nel piancito, le porte scardinate e i vetri rotti, era fantastica: nessuna donna avrebbe più potuto resisterci. Al pensiero delle maratone erotiche che ci attendevano, non riuscivamo più a star nella pelle. Ogni minuto d’attesa era tempo perduto. Dovevamo sbrigarci a renderla operativa. Facemmo un piano di interventi. Avremmo provveduto insieme alle parti comuni e ai servizi. Bisognava inventare un bagno, Professione: playboy 71 qualche sistema di riscaldamento, portare la corrente, l’acqua e il gas, se possibile. Poi ognuno di noi avrebbe scelto la sua stanza e se la sarebbe arredata. La terza stanza restava libera. Magnifico! L’avremmo affittata a quel tincone di Momi, che dalla notte dei tempi cercava un trappolo senza trovarlo. Lo interpellammo. Era entusiasta. Ci accordammo per diecimila al mese: l’intero importo del nostro canone! Così avevamo risolto il problema dell’affitto. Restavano però i lavori da fare, e quelli erano a carico nostro. Con i nostri pochi quattrini era un problema. Dovevamo arrangiarci in economia. Ci improvvisammo muratori, idraulici, carpentieri ed elettricisti. Rabberciammo il tetto, puntellammo i pavimenti, inventammo un bagno un po’ da battaglia, con tubature in gomma e scarico che finiva dentro la porcilaia. Per arredare la mia stanza visitai tutti i rigattieri della città, in cerca di mobili più economici. Scelsi il meglio del peggio. Purtroppo i soldi finirono in fretta. Comunque, ormai il trappolo c’era. Ogni volta che uscivo, buttavo un’occhiata sul mio capolavoro d’arredamento, che migliorava a vista d’occhio. Era la più strampalata accozzaglia di stili che si fosse mai vista. Muri tappezzati di canne, sedie di vimini, un vecchio comodino trasformato in un mobile bar con gli specchi. Moquette di vero montone usato. Un registratore Geloso, nascosto in un cassetto dell’altro comodino che fungeva da impianto di Hi-Fi. Per regolare il volume, bastava aprire o socchiudere il cassetto. La fedeltà del suono non era proprio quella di un compact disc. Per risolvere il problema del riscaldamento e poter conferire all’insieme una nota romantica, avevo pensato che ci volesse un caminetto: l’avrei costruito io di sana pianta. Non l’avessi mai fatto! Costruire un camino è una bazzecola; è il tiraggio, il problema. Per quanto mi fossi scervellato a modificare la canna fumaria, ogni volta che lo accendevo uscivo dalla stanza affumicato come un wurstel. 72 Il Morbo di Monduz Dopo parecchi tentativi, mi ero arreso. Avevo lasciato il camino come motivo ornamentale, guardandomi bene dal metterlo in funzione. Per il riscaldamento avevo trovato una soluzione migliore: una vecchia stufetta a carbone, molto romantica, stile liberty. Ci avevo sistemato dentro un bruciatore a gas, collegato mediante un tubo d’ottone a una bombola, che stava nascosta dentro al comodino, giusto sotto il cassetto con il registratore. Era il comodino a più alto contenuto tecnologico che avessi mai visto. Tutto dunque era pronto, salvo qualche dettaglio. Mancavano solo la rete e il materasso. E, soprattutto, mancava la ragazza. Il Morbo di Monduz 73 Simona era al corrente dei miei problemi sessuali e voleva darmi una mano. Esaminò tutto il parco delle sue amiche, alla ricerca di quella più adatta. Giuliana! Ma certo. Si era appena lasciata con il suo ragazzo, aveva due anni più di me, una discreta esperienza. Era carina e maggiorenne. La tipa giusta per la mia prima volta. Anche l’età aveva il suo peso. In caso di un incidente, non c’erano rischi: dei due, ero io che avrei potuto incriminarla per corruzione di minorenne! Così mi diceva, ridacchiando, la mia amica Simona. La prima occasione Una donna per amico Pochi uomini conoscono il privilegio di una vera amicizia con una donna. Una donna per amico è come una spia tra le fila nemiche. Un fattore strategico di primaria importanza. Io ho avuto questa rara fortuna. Si chiamava Simona, ed era una ragazza bionda con gli occhi azzurri, stile «angelico», di quelle che ti fregano sempre. Ci amavamo come fratello e sorella. Eravamo una coppia di furboni matricolati. Lei aveva un anno più di me, ma non disdegnava di far strage di cuori fra i miei compagni di scuola. Io, dal mio canto, consideravo le sue amiche come il mio pollaio. Simona abitava vicino a casa mia. Ogni giorno, quando arrivava qualche nuova amica a studiare da lei, mi chiamava al telefono per avvisarmi. Io mi mettevo in vedetta alla finestra e poi, con una successiva telefonata, le dicevo le mie impressioni. E lei non si limitava a presentarmele. Parlava di me facendo tali panegirici che quando le conoscevo erano già cotte a puntino. Così mi risparmiava fatica inutile. Iniziare un flirt con Giuliana, sotto la regia della Simona, fu un gioco da ragazzi. Il problema era procedere oltre. Dovevo fare il gran balzo, ora o mai più. Feci un sopralluogo del trappolo e controllai che tutto fosse in ordine. Le luci basse facevano il loro dovere, creando un’atmosfera ovattata. Il registratore faceva capolino dal suo cassetto. Il nastro con la mia compilation era al suo posto. Erano tutte canzoni d’atmosfera: Sinatra, Leali, Tenco. La fedeltà del suono non era perfetta, ma a basso volume sarebbe andata benissimo. Controllai che il nastro fosse all’inizio per sfruttarne tutta l’autonomia. Detti un ultimo sguardo d’insieme. Tutto OK. Sarei tornato tra poco, per la grande avventura. Mi feci una doccia. Poi, tutto fresco e profumato saltai sul mio Motom 48. Giuliana si presentò in forma smagliante. Per consacrare il mio trappolo non avrei potuto chiedere di meglio. Ora però veniva il difficile. Ci spogliammo. Era emozionata anche lei. Quanto a me, facevo lo spavaldo, ma avevo i piedi che sembravano tolti dal frigo. Iniziò un corpo a corpo micidiale. Anche oggi preferisco sorvolare sui particolari. Diciamo che ero paralizzato, anestetizzato, 74 Il Morbo di Monduz morto e sepolto. Provai a bermi un cognac, a fumare una sigaretta, anche se non avevo il vizio del fumo. Niente da fare. Giuliana fu comprensiva, si sforzava di non mostrarsi delusa ma la sua indulgenza accresceva la mia angoscia. L’accompagnai a casa senza una parola. In motorino, sul sellino di dietro, sentivo ancora presente il suo corpo, ma la sua anima mi era sfuggita. La lasciai sotto casa sua, senza darle un bacio, che mi sarebbe parso ridicolo. Con grande sollievo la salutai e la vidi scomparire dentro il portone. Finalmente ero solo. Potevo suicidarmi con calma. La Simona voleva sapere com’era andata. « Un disastro! » le dissi. Mi restava un dubbio soltanto. Se suicidarmi subito, o aspettare domani. Aspettai. E l’indomani, mi rassegnai a sopravvivere. Il casto playboy Dopo quell’esperienza, rimandai sine die la prova fatale. Nel frattempo, essendo ormai un esperto di psicologia femminile, e avendo a disposizione un ciclomotore e un trappolo, era uno scherzo far strage di cuori. Non mi restava che recitare la parte del playboy. Cambiare spesso ragazza oltretutto mi tornava a fagiolo: potevo evitare di dar spiegazioni. Iniziai una collezione forsennata di donne. Una galleria di volti subito dimenticati e di nomi che annotavo con diligenza in un carnet segreto. A fare le spese di questa mania erano i miei amici. Nel corteggiare le donne erano goffi e maldestri. Quando me le presentavano, scoprivo in un attimo le loro lacune strategiche. Con due o tre mosse ben azzeccate, gliele soffiavo di sotto il naso. Una volta scoperta la tecnica era sempre più facile sedurre nuove ragazze. La fama di rubacuori, mi favoriva. Molte che Professione: playboy 75 uscivano con me per « vendicare » una loro amica, andavano ad allungare la mia lista di «vittime». Peccato che tanto ben di dio andasse sprecato. I pomeriggi che passavo con le mie prede, acquattato nel trappolo di via Guelfa, erano solo una copertura. Per inadempienze strutturali mi ero rassegnato a buttarla sul romantico. « Che sia nato così » mi chiedevo « il cosiddetto amore platonico? » Il mio amico Alfredo (Ah, come sono belle le donne degli altri!) Chi ci lasciava più spesso le penne, era il mio amico Alfredo. Questo ragazzo aveva attitudine alla santità, visto che sopportava uno come me. A ripensarci ora me ne vergogno. Alfredo è stato il mio primo vero, forse unico amico. Ci eravamo conosciuti alle elementari, era il mio vicino di banco. Facevamo un tale casino, da disturbare tutta la classe. Finivamo regolarmente sbattuti fuori dall’aula. Ma nemmeno fuori stavamo tranquilli: facevamo le corse con scivolata finale per i corridoi e mettevamo il naso dentro tutte le classi. Il maestro dovette cambiarci di banco, per evitare che passassimo tutte le elementari fuori dall’aula. Alfredo ed io ci frequentavamo solo a scuola. La mia vita privata era tabù: non avrei mai accettato di dividere il cortile di bimbe, in via Orfeo. Anche alle medie, ci ritrovammo nella stessa classe, così la nostra amicizia si cementò. Cominciammo a vederci fuori di scuola. Alfredo mi assecondava in tutte le mie passioni: modellismo, chimica, fotografia. Lui era molto più posato di me. Mia madre me lo additava come modello: «Gianni, sei troppo irrequieto, guarda Alfredo, com’è giudi- 76 Il Morbo di Monduz zioso! ». Una frase che mi ha rintronato per anni, dopo quella: « Com’eri carino da piccolo! ». Durante la mia carriera di scrittore prodigio, Alfredo era il più grande ammiratore dei miei temi in classe. Quando vinsi con un tema il concorso della Cassa di Risparmio, fu l’unico che mi accompagnò a ritirarlo. Quel ragazzo non era invidioso dei miei successi, anzi era fiero di essermi amico. Ma con le donne, purtroppo, Alfredo era una frana. Quando s’innamorava di una ragazza partiva in quarta all’attacco, con la delicatezza della corazzata Potëmkin. Cingeva di tali assedi la malcapitata, da metterne a repentaglio l’equilibrio mentale. La sua tecnica «a martello pneumatico» prevedeva telefonate tre volte al giorno, appostamenti fuori da scuola, attenzioni di ogni tipo: bigiotteria, fiori e «pensierini poetici». Toccava a me confezionargli quei componimenti allusivi. Cercavo di scantonare, ma Alfredo era un «martello pneumatico» anche con me. Quando mi presentava la vittima designata per estorcermi una consulenza strategica, non sapevo resistere alla tentazione di andare oltre i consigli. Gli fornivo anche l’esempio. In poche parole, gliela soffiavo. A lungo andare, non mi sopportò più: persi la sua amicizia. L’unico amico della mia vita l’ho perduto a causa del Morbo di Monduz. La prima sbornia La prima sbronza non me la posso scordare. Mi capitò una notte, a Pianoro, con Alfredo. Eravamo entrambi afflitti da problemi sentimentali e volevamo annegare i dispiaceri nell’alcool. Stappammo una bottiglia di quello buono del babbo. Spumava che era un piacere. Al terzo boccale, il pensiero dei nostri guai Professione: playboy 77 si era già affievolito parecchio. Pensammo che una seconda bottiglia l’avrebbe fatto scomparire del tutto. Ci era venuta un po’ di fame. In casa c’era solo pan secco. Però, nell’orto, a pensarci bene, c’erano i cipollotti del babbo. Uscimmo nella notte con una candela, alla loro ricerca. Ondeggiando nel buio per via del Lambrusco, e incespicando maldestri, procedemmo a un’ispezione approssimativa. Alle fine, eccoli, schierati come note su un pentagramma, i fantastici cipollotti paterni. Ne raccogliemmo una ventina: erano piuttosto smilzi e pizzicavano come dannati. Non ci lasciammo intimorire e li sbafammo tutti, gemendo, soffiando e lacrimando. Dopo cena, cercammo di smaltire i vigori dell’alcool e quello delle cipolle, sdraiati sull’erba, a vaneggiare di un mondo popolato di sole donne, oltre che da noi due, beninteso... Ma si capiva benissimo che per entrambi questo sogno era un compromesso dettato dalle circostanze. Ciascuno di noi aveva un’idea ben diversa: di un mondo di donne tout court senza neanche un amico tra i piedi con cui doverle spartire. Cullati da queste fate morgane, ci addormentammo come sassi e soltanto all’alba ci risvegliammo, tutti intirizziti. Però avevamo digerito benissimo. Fu il babbo a non digerire la nostra scorribanda nell’orto. Era infuriato contro «quei vandali che avevano sgraffignato due filari di agli, oltrettutto acerbi». Ecco spiegato perché quei «cipollotti» pizzicavano tanto. Professione: avventuriero Un grande maestro: Giacomo Casanova Parallelamente alla mia fittizia superattività sessuale, continuavo nelle letture con rinnovata passione. Lessi per la seconda volta la Storia della mia vita di Casanova. Trovavo quel libro sempre più bello. Non mi sembrava possibile che un uomo, in una sola vita, potesse aver fatto tante follie. Passavo interi pomeriggi assorto nella lettura. Riuscivo talmente a immedesimarmi, che dimenticavo di essere a casa mia, nel ventesimo secolo. Entravo in prima persona nelle vicende del protagonista e le vivevo con un’intensità sconosciuta. Casanova non sarà stato un Dostoevskij, ma la sua prosa aveva per me una misteriosa forza che trascinava. Il piacere di leggere un buon romanzo, a mio avviso, è limitato dalla consapevolezza che si tratta di una finzione, di un parto fantastico dello scrittore. Con Casanova era diverso. Ogni fatto era puntualmente accaduto: di qui nasceva il fascino delle sue Memorie. Quel libro era diventato per me una «macchina del tempo» che mi riportava indietro due secoli. Non avevo la sensazione di leggere una favola, ma di vivere un’altra vita. Nel cuore di ogni uomo, palpita un Casanova. È un sogno che ciascuno di noi ha coltivato, almeno una volta, in gioventù. Leggere le sue avventure mi rasserenava. Mi sentivo liberato da una grande responsabilità. Anche se non fossi diventato un gran se- 80 Il Morbo di Monduz duttore comunque un Casanova c’era stato, nella storia dell’umanità, a tenere alta la bandiera dell’incoscienza. Qualcuno aveva profuso tutto il suo coraggio, il genio e la fantasia al servizio delle donne e del piacere di vivere. Il morbo di Monduz aveva trovato un degno rappresentante. Un nuovo cortile: Cortina! Quell’estate non avevo voglia di restare a Zocca coi miei. Avevo superato l’esame di maturità, e il babbo, per premio, mi aveva regalato la 500 Fiat. Volevo orizzonti più vasti. Degli Appennini ero stanco: mi attiravano le Alpi. Anzi, le Dolomiti. San Martino di Castrozza era il paesello favorito di Lanfranco, mio sventurato compagno di banco al liceo. Quello a cui copiavo i compiti in classe di greco, per non far la fatica di consultare il vocabolario; poi correggevo gli errori e non gli passavo le correzioni, così lui prendeva quattro, io otto, e sua madre si inviperiva con me. Lanfranco era un altruista, adatto a introdurre un amico spaesato in un villaggio montano. Gli telefonai da Zocca, un pomeriggio, chiedendogli informazioni sul «clima» (leggi: ragazze) di San Martino. Lanfranco mi garantì che era buono. Mi fidai, e la mattina dopo partii, lasciando i miei genitori senza parole. Arrivato a San Martino, presi atto che i miei standard qualitativi e quelli di Lanfranco erano molto diversi: non c’era una ragazza decente. Solo crani orrendi. Razzolai in profondità le poche discoteche del posto, arrivai a intrupparmi in un villaggio turistico, tipo «polli in batteria», ma niente. Una sera mi ritrovai in una baita con un gruppo di ragazze che dicevano di fare le attrici. Avranno avuto senz’altro talento, brutte com’erano. Quella notte soffrii incubi orrendi. Sognavo che tutte le belle Professione: avventuriero 81 donne se n’erano andate in un altro pianeta, tipo Hollywood. La terra era invasa di scorfani. Mi svegliai terrorizzato. All’alba feci le valigie e schizzai fuori dall’albergo, sotto gli occhi addormentati del portiere di notte. Quando il bagaglio fu sistemato nell’auto mi sentivo già meglio. Consultai le mappe stradali. Non potevo tornare a Zocca con le pive nel sacco. C’era Cortina a soli due passi. E lì c’era Mario, rubacuori di tutto il liceo Galvani, amico mio ma fino a un certo punto, perché aveva troppo successo con le ragazze e mi rovinava la piazza. Eravamo in buoni rapporti, ma lo tenevo a una certa distanza di sicurezza. Ecco perché avevo scartato in un primo momento l’idea di raggiungerlo. Ormai però non avevo alternative, e puntai dritto su Cortina. Arrivai all’ora di colazione. Sbarcai alla Stella d’Oro, una locanda-osteria centralissima, che non c’è più. Mi fermai lì, perché c’erano parcheggiate davanti certe ragazzine in jeep, che mi fornivano una spiegazione dell’assenza di belle ragazze a San Martino: erano tutte finite su quella jeep. Tirai giù dal letto Mario con una telefonata. Mi disse di aspettarlo senza muovere un passo. Aveva importanti cose da dirmi. Ero davvero curioso. Arrivò come un fulmine, per confessarmi che la sua carriera di playboy era conclusa: si era innamorato di Susanna, anzi peggio. Susanna si era innamorata di lui. E Susanna non era il tipo da dividere un uomo con altre ragazze. Si trattava di una biondina con gli occhi taglienti, di quelle che gli ingenui definiscono romantiche. In realtà, nelle sue vene, scorreva il sangue di svariati generali prussiani. Era il tipino tedesco slavato capace di mettere in riga una guarnigione della Gestapo. E stava addestrando Mario a una disciplina marziale. Mario era sconvolto. Gli erano state confiscate le sue agendine piene di numeri telefonici selezionati. Aveva ancora una faccia di 82 Professione: avventuriero Il Morbo di Monduz bronzo, una Porsche nuova fiammante e simpatia da vendere, però tutto questo era inservibile, con quel cerbero alle costole. Il mio tenero cuore non poteva sopportare quello spreco. Gli proposi la mia complicità: una santa alleanza per non dilapidare i nostri vent’anni. Sarei stato il braccio operativo del sodalizio; gli sarei servito da paravento. A Mario brillavano gli occhi di una luce non ancora spenta, prese di tasca una rubrichetta segreta e andò al telefono senza perdere tempo. Portammo fuori due sventole mozzafiato, tipe che sembravano uscite dalla copertina di Vogue. A parte la loro bellezza, era il loro stile a togliermi il fiato. Anni-luce di cultura femminile dividevano quegli esemplari dalle donne che frequentavo di solito. Sentivo che la mia vita sociale stava per fare un balzo di qualità. A Cortina gli uomini avevano una strana sicurezza, uno sguardo deciso e risoluto. Vestivano con sobria eleganza, e una trasandatezza che non era mai veramente trasandata. Sembravano usciti tutti dalla sezione B del Galvani. Era l’aria di Cortina che conferiva alle donne quel fascino? O forse era questione di cromosomi? Fatto sta che appartenevano a un’altra razza. Avevano un modo di vestire colorato ma non vistoso, un sorriso affabile ma sicuro. Mani delicate, gambe dritte, idee chiare. Vestivano con meditata semplicità, evitando ogni ostentazione. Coltivavano la civetteria di infagottarsi per nascondere fattezze perfette. Normalmente, le donne nascondono i difetti, per mettere in mostra le parti migliori. Gonne lunghe e stivali occultano grossi polpacci, minigonne mettono in risalto gambe affusolate. Grossi maglioni fanno da alibi all’assenza di seno, camicette corazzate sostengono tettone pendenti. È cosa normale, che fa parte dell’istinto di conservazione. Quello che una donna copre si dà per scontato che è brutto. 83 A Cortina, invece, mi capitavano sotto gli occhi strani sperperi. Sottanoni da zingara che mantellavano gambe snelle e diritte, enormi maglioni mimetizzavano magnifici décolletés. «Che benessere, che opulenza di mezzi» ridacchiavo, folgorato da quelle rivelazioni. A Zocca le ragazze ostentavano le marche degli abiti, portando a spasso intere vetrine di griffes. A Cortina, invece, ci levavano l’etichetta. Come dire che erano loro il marchio di qualità. Era cominciato un nuovo capitolo della mia vita. Ogni giorno decidevo di prolungare quella vacanza, ogni mattina la mia 500 era ancora lì, parcheggiata davanti alla Stella d’Oro, come a un capolinea. Ogni sera andavo in giro con le valigie per trovare una nuova sistemazione precaria. Rimbalzai così per tutti gli alberghi. La vita me l’inventavo di giorno in giorno. Una libertà assoluta, come nei sogni. Come nei film. In questo modo, rimandai la partenza da metà luglio a metà settembre. Fino alle ultime luci d’estate. Finché fu in giro l’ultima ragazza carina. Avevo scoperto Cortina e Cortina aveva scoperto me. Eravamo fatti l’uno per l’altra. Quella gente, quel posto, li avevo sempre sognati. Erano lì, disponibili, grazie a dio. Non mi sarei più rassegnato a farne senza. Tornai a casa deciso a guadagnare quattrini per concedermelo regolarmente. I libri usati Mi ritrovai a Bologna, solo nella mia cameretta, a rimuginare sulla cronica assenza di soldi. Cercavo intorno a me qualcosa di vendibile. Perbacco, come mai non ci avevo pensato prima? C’erano i libri usati del liceo! Nel centro storico di Bologna, a ridosso del Pavaglione, esiste un ampio porticato detto «Il Portico della Morte», perché anti- 84 Professione: avventuriero Il Morbo di Monduz camente vi si affacciava un ospedale degli incurabili. In questo luogo, da chissà quanto tempo, gli studenti del liceo hanno preso l’abitudine di vendere i libri usati. Per tutto settembre e un po’ di ottobre si appostano agli angoli del portico, aspettando al varco i potenziali clienti. È tutto un brulichio di contrattazioni, una specie di Casbah. Chi vuol risparmiare, bazzica da quelle parti e viene regolarmente abbordato dai venditori. Anch’io mi appostai sotto il famoso portico, con la mia borsa dei libri. Li vendetti in poco tempo. Peccato, ci avevo preso gusto. Provai a telefonare ai miei ex compagni di scuola, per procurarmene altri. Erano tutti ben lieti di liberarsene. Il liceo è un capitolo che una persona assennata desidera chiudere in fretta. Vendere i libri era un gesto simbolico, per prendere le distanze da un passato che si vuole dimenticare. C’era chi mi chiedeva una bazzecola, chi me li regalava, addirittura. Gli affari prosperavano, compravo e vendevo in modo febbrile. Da solo non ce la facevo più. Avevo bisogno di un socio. Michele era il tipo adatto: accettò la mia proposta su due piedi. Mi ero procurato l’elenco dei diplomati, tramite il preside del Galvani e avevamo ingaggiato due nostre compagne per telefonare a tappeto, proponendo l’acquisto dei vecchi libri. A turno io e Michele andavamo in giro a raccoglierli con la nostra 500, e a turno si stava al banchetto al Portico della Morte. Un lattaio ci aveva affittato il suo retrobottega che ci serviva per immagazzinare quella marea di libri. Gli affari andavano a gonfie vele, grazie alla nostra memoria formidabile. Tenevamo a mente tutti i titoli in magazzino e le rispettive quantità. A ogni vendita e acquisto, aggiornavamo il nostro computer naturale, con pochissimi errori. Considerando che avevamo più di un migliaio di testi, stipati entro cassette da frutta, mi chiedo come facessimo. 85 Il lavoro era massacrante, ma non sentivo la fatica. Era tale l’entusiasmo per quell’impresa, che non avrei smesso nemmeno per andare a dormire. Spesso incontravo degli amici e scambiavo due chiacchiere. Ogni occasione era buona per abbordare qualche ragazza. Con la scusa dei libri mi facevo dare indirizzo e telefono, e li segnavo sulla mia agenda. Saltavo il pasto senza accorgermene e la mattina alle sette, dopo poche ore di sonno, ero già sveglio come un grillo. La droga fantastica che mi caricava di energie aveva un nome: SUCCESSO! Le ragazze mi guardavano in modo diverso, il loro sguardo si soffermava più del dovuto, nel mio. Mi sembrava che una donna diventasse fantastica, in quei momenti. Dilatava leggermente le palpebre e mi sorrideva con aria di complicità. Sotto quel portico, giocavo in casa, come un disc-jockey in discoteca, un maestro di sci sui campi di neve, un animatore nei villaggi turistici. Quando sei padrone del territorio, una donna lo sente e le piace. Ama il fluido che emana dai protagonisti. E tu, dal canto tuo avverti una sensazione stupenda di eccitante sicurezza... quella del mio cortile! Il Portico della Morte era una succursale del cortile della mia infanzia. Corsi e ricorsi del Morbo di Monduz! La scelta della facoltà Era arrivato il momento di iscrivermi all’Università ma non sapevo che facoltà prendere. Bella pretesa che un ragazzo diciannovenne sappia già cosa fare della sua vita! Io non ero uno di quelli che fin da piccoli vogliono fare il pompiere. Una cosa mi era chiara: volevo che la mia vita fosse un’avventura. Però una facoltà per avventurieri non esisteva. Mi rivolsi al centro per l’orientamento professionale, ove mi 86 Il Morbo di Monduz sottoposero a una sfilza di test. Passai tre giorni a compilare raffiche di questionari. Mi domandavo come potessero capire le mie attitudini in quel modo. E infatti non conclusero niente. Il responso fu ancor più generico delle mie domande. Secondo loro, ero portato per qualsiasi facoltà. Peccato che, tra le facoltà disponibili, non ce ne fosse una portata per me. Comunque, dovevo decidermi. Iscrivermi a due o tre facoltà contemporaneamente non era possibile, mi ero già informato. Avrei dovuto procedere per eliminazione. Scartai subito lettere, perché di greco e latino ne avevo abbastanza. Anche le altre discipline minori erano troppo tecniche, per le mie grandi ambizioni. Non mi restavano che tre soluzioni: Legge, Ingegneria e Medicina. Cominciai a frequentare le lezioni di Giurisprudenza, tanto per vedere che aria tirava e capitai a una noiosissima lezione di «Esegesi di Diritto Romano». No, tutti quei sofismi non avrebbero fatto per me. Tentai con Ingegneria. Mi intrufolai a una lezione di Analisi Matematica. Peggio che peggio: simboli, logaritmi, integrali. Formule, soltanto formule. In mezzo a tutti quei numeri, c’era il rischio di perdere il senno. Tentai a Medicina. Capitai a una lezione di Anatomia. Diapositive, disegni, budella e frattaglie. Be’, sempre meglio che formule o cavilli giuridici. Almeno qui si parlava di uomini. Forse Medicina era la meno inadatta per me. Corsi ad iscrivermi subito, prima di cambiare idea. L’internato di Anatomia Al primo anno di Università, notai tra gli studenti un ragazzo con la faccia sveglia e una giacca blu dai bottoni d’oro. II parti- Professione: avventuriero 87 colare che mi attirò fu lo stemma ricamato sul taschino della sua giacca: Cortina, la mia Mecca, il mio sogno proibito. Si chiamava Giancarlo, era figlio di un primario che si era visto soffiare via la cattedra di sotto il naso e ci aveva fatto una malattia. Così aveva riversato i suoi sogni di rivalsa sul figlio. La sua storia era dunque simile alla mia. Facemmo amicizia. I suoi genitori avevano innescato Giancarlo, in tenera età, come una spoletta a scoppio ritardato, facendogli credere che la professione del cattedratico fosse quanto di meglio esista. Ci eravamo conosciuti da poco, quando Giancarlo mi impartì una lezione preziosa. «All’Università, la cosa essenziale è partire bene: bisogna spianare la via con voti alti. In seguito, nessun professore se la sentirà di “rovinarti la media” con un voto scadente. Così vivi di rendita fino alla laurea! » Lo ascoltavo con molto interesse. Aggiunse: «Per ottenere voti alti nei primi esami, c’è un solo mezzo: essere allievo interno. E qui sorge il problema! I posti disponibili sono pochi, le domande numerosissime, così ci vuole la raccomandazione di qualcuno dell’ambiente universitario o di quello politico». Feci una rapida analisi delle mie relazioni familiari. No, non c’erano politici, né universitari. L’unica mia risorsa era Gino, bidello-portiere dell’istituto di Anatomia. Avevo solidarizzato con Gino fin dalle prime lezioni. Era un omone tarchiato, con un sorriso aperto tra i denti radi. Amava i gatti, come me. Una volta che passavo dal suo bugigattolo per accarezzare il micio, udii una musica familiare: una canzone folk-montanara, del tipo che mio padre suonava da anni imperterrito. Scoprii che Gino era nato nell’Appennino e ne serbava nostalgia. Gli regalai un disco del babbo, che gli piacque molto. 88 Il Morbo di Monduz Gino e io diventammo amici. Era la persona più simile a me, nella giungla universitaria. Un uomo semplice che viveva nella portineria dell’istituto con la famiglia: il figlio «che studiava» e la moglie grassona e simpatica, della quale non ho mai saputo il nome, la chiamavano tutti la «moglie di Gino». Mi sembrava di essere a casa mia. La nostra amicizia venne cementata da alcune gavette di salsicce che una volta avevo portato da Zocca e che arrostimmo insieme in un barbecue improvvisato nel giardino dell’istituto. In quell’occasione sviluppammo una curiosa teoria: dentro ogni palazzo importante c’è un padrone che ne dispone ufficialmente, ma è sempre, in giro, e c’è il portiere, che ci vive davvero e se lo gode. È lui il vero signore di ogni palazzo. Portieri a parte, il problema di essere accettato come allievo interno ad Anatomia si faceva pressante. Avevo fatto la mia brava domanda in foglio protocollo e l’avevo consegnata a Gino. Le domande erano già cinquecento, i posti, chissà? Il professore, si chiamava Borromeo, ed era appena arrivato per trasferimento da Cagliari. Si diceva fosse un tipo geniale e terribile, con occhi penetranti e pizzetto mefistofelico. Quanto ai suoi costumi in fatto di interni, nessuno ne aveva la più pallida idea. Bisognava aspettare e vedere. La sua decisione ufficiale tardava, ma Gino mi teneva informato sulla situazione ufficiosa. Alcuni rampolli di illustre schiatta avevano iniziato a frequentare l’istituto in modo informale: di fatto la «selezione» degli interni, dunque, era già cominciata. Ci voleva un’idea subito, o mai più. Da giorni stavo appostato nella portineria dell’istituto, in attesa dell’occasione propizia. Una mattina, finalmente, Gino mi avvisò che il Prof era solo in studio e di buon umore: quando sua moglie era salita a portargli il caffè, l’aveva trovato che fischiettava. Come un fulmine, salii le scale che portavano in direzione, Professione: avventuriero 89 mi sistemai la cravatta e, piuttosto tremante, bussai alla sua porta, con fare sicuro. Una voce secca, dall’interno, mi disse di entrare. «Buongiorno professore, sono Gianni Monduzzi! » feci io, senza aggiungere altro, come se avessi pronunciato una parola d’ordine e ne attendessi la reazione. « E allora?» rispose il Prof con aria interrogativa. «Ma... scusi... non le ha telefonato il professor Faccioli? » replicai interdetto, come se fossi imbarazzato (e un po’ lo ero davvero). «Il professor Faccioli? » Borromeo ci capiva sempre di meno. «Professore, mi scusi, forse sono stato intempestivo... il professor Faccioli mi aveva detto che le avrebbe telefonato ieri... mi scusi, ripasserò domani...» e feci per andarmene, ma frenando ogni passo: temevo che il Prof non mi fermasse. «No, aspetta. Raccontami un po’ come sta la faccenda! » « Vede, professore, desideravo fare l’interno di Anatomia; ne ho parlato con il professor Faccioli di Istologia, che mi aveva promesso una presentazione. Ma ora non so cosa pensare...» «Figuriamoci, con tutte le cose che ha per la testa, se ne sarà già scordato. La sua smemoratezza è proverbiale. Ma tu, dimmi, sei davvero interessato all’Anatomia?» «Davvero, professore. Si figuri che ho deciso di iscrivermi a Medicina dopo aver assistito a una lezione di Olivo, il suo predecessore.» «Bravo, come hai detto che ti chiami? » «Monduzzi.» «Bene Monduzzi, comprati un camice, guanti chirurgici e una serie di ferri anatomici. Domattina presentati alle nove!», e mi porse la mano con un sorriso di complicità. «Iuuhuu,» gridavo dentro di me « è fatta! » Correvo giù per le scale, e non riuscivo a contenere la gioia. Abbracciai Gino e la 90 Professione: avventuriero Il Morbo di Monduz moglie, che aspettavano sotto, curiosi di sapere com’era andata. Lo stratagemma aveva funzionato. Ecco cosa significa disporre di un servizio di intelligence! Gino me l’aveva riferito, che Borromeo era amico di Faccioli. Per il resto era tutta una balla. Faccioli l’avevo visto soltanto a lezione, non mi avrebbe raccomandato di sicuro. La mattina dopo, alle otto, ero già a gironzolare per l’istituto. I corridoi erano una lugubre sfilata di teschi, dentro polverose bacheche. Una collezione di qualche anatomico del tempo che fu. Ad ogni vetrina, mi fermavo e mi specchiavo sui vetri, per nulla disturbato dal macabro contenuto. Ammiravo l’aria di grande luminare che mi conferiva quel camice bianco immacolato. Nell’istituto ancora deserto c’erano lavori in corso un po’ dappertutto: il professore, che era appena arrivato da Cagliari, stava ammodernando la sede. Notai che non tutto era fatto a regola d’arte. Io me ne intendevo abbastanza: avevo passato nei cantieri intere giornate, assieme a mio padre, nel periodo in cui si era messo a fare il mediatore. Quei difetti, li feci notare al professore, appena arrivò. Ne fu molto colpito, lui che di edilizia non aveva alcuna esperienza. Il terzo giorno, mi affidò la sovrintendenza di tutti i lavori. L’Istituto di Anatomia, finalmente, era mio. Dopo un paio di settimane, il professore mi chiese di stilare, in via confidenziale, un elenco degli allievi interni. Aveva detto di sì a parecchia gente e non sapeva più quanti fossero. A un primo conteggio, gli interni mi risultavano undici. Ma dodici mi sembrava che suonasse meglio. Aggiunsi Michele all’elenco. Fu così che il mio amico, complice e socio, diventò il dodicesimo interno e la mia quinta colonna. 91 La festa delle matricole Per noi goliardi, c’era un periodo dell’anno, verso primavera, in cui bruciavamo nell’attesa della più pazza tra le feste: quella delle «matricole». Era una tradizione antichissima di molte università, tra le quali Bologna. Per due giornate, l’intera città rimaneva alla mercé degli studenti, che festeggiavano la chiusura della «caccia alle matricole». Le matricole erano gli allievi del primo anno, ancora sprovvisti del tesserino universitario, che veniva consegnato in primavera. In tutto il periodo da novembre a marzo, questi sventurati studenti-matricola, facilmente individuabili per la mancanza di tessera, erano braccati dagli anziani. Se venivano sorpresi senza la scorta di un accompagnatore tesserato erano guai. Dovevano sottostare a ogni sorta di soprusi, adattandosi alle fantasie dei loro aguzzini. L’offerta di un drink a tutta la compagnia rendeva le penitenze molto più miti: la matricola se la poteva cavare con una passeggiata in mutande o con la cravatta annodata in fronte. Non mancava un po’ di sadismo, in alcune varianti di questo gioco, come far spegnere le candele a chiappe nude, o il famigerato «carciofo»: costringere le ragazze a passeggiare con la gonna alzata e legata a sacco intorno al collo, come le foglie dell’omonimo ortaggio. Ma questi erano gli aspetti esteriori di una profonda filosofia. Gli anni dell’università erano un periodo di transizione tra la spensieratezza dell’adolescenza e l’impegno della maturità. Le follie di quel periodo erano un’occasione irripetibile per dare l’addio alla gioventù. Poi una coltre di «maturità», con mogli, famiglie e professioni, avrebbe cancellato quelle mattane. L’uso di terrorizzare le matricole sole era anche un espediente degli anziani per abbordare le studentesse novizie. Molte di loro venivano da fuori Bologna, e infliggere una penitenza poteva essere una maniera di fare amicizia. 92 Il Morbo di Monduz Con la feste delle matricole finiva la caccia all’uomo. In quei giorni, il Comune concedeva ai goliardi una semi-impunità. I vigili avevano istruzioni di lasciar correre, salvo casi gravissimi. Erano quarantott’ore di assoluta anarchia, specialmente nel traffico. Si procedeva puntigliosamente alle più svariate infrazioni del codice. Lanciavamo qualunque trabiccolo in grado di muoversi, nelle vie del centro e sotto i portici, a folle velocità. Ci si preparava per mesi, allestendo i veicoli più strampalati per scarrozzare in quei giorni. Per i finanziamenti c’era «la questua». Bastavano un cappello goliardico, un sorriso e faccia tosta. Io, come mia socia, avevo scelto Daniela, che era miliardaria fin sopra i capelli. Ci facevamo accompagnare sui colli dal suo autista in limousine. Cercavamo quartieri residenziali un po’ scomodi, nella speranza che non fossero già stati spremuti dalla concorrenza. Ci presentavamo nelle case più ricche della città come due poverelli. Raggranellavamo quattrini a palate. Chiedere l’elemosina con Mercedes e autista era uno sballo. A mezzanotte precisa di venerdì ci si ritrovava tutti in piazza Maggiore, aspettando i regolamentari dodici rintocchi dell’orologio. All’ultimo tocco esplodeva un boato. Da quel momento, per due giorni e tre notti non saremmo più andati a dormire. Canti e schiamazzi a ciclo continuo. Ogni tanto ci si appisolava appoggiati a un portone. Poi si riprendeva a cantare a squarciagola. Pochi riuscivano a conservare la voce fino al lunedì. C’erano continue sfilate di carri e teatrini improvvisati in piazza Re Enzo, dove si rappresentava la versione integrale della celeberrima Ifigonia in Culide, tragedia clitoridea in tre atti. Moltissimi erano travestiti in modo bizzarro e improvvisavano sceneggiate con i passanti. C’erano studenti di Medicina che proponevano interventi chirurgici sulla pubblica via, brandendo Professione: avventuriero 93 coltellacci arrugginiti a mo’ di bisturi e mazze da muratore come anestetico. Futuri dentisti che agitavano enormi tenaglie da fabbro e siringone spropositate. Chirurghi invasati che estraevano dalle viscere dei loro pazienti sfilze intere di salsicciotti. Il sesso e la religione erano i grandi tabù da mettere alla berlina. C’erano studenti vestiti da prete che dispensavano indulgenze plenarie. Uno s’era portato dietro addirittura un confessionale a rotelle da utilizzare come trappolo mobile. Abbordava ogni bella ragazza, garantendole un’assoluzione «in tempo reale» per tutti i peccati che avrebbero compiuto insieme. Si beveva vino in continuazione. A me la sbronza facilitava la vena poetica. Una notte, completamente brillo, inventai una sorta di processione dell’Ultima Cena. Cominciai in Piazza Maggiore, alla testa di cinque o sei amiconi più brilli di me. Avanzavo barcollante, con un turibolo colmo d’incenso e cercavo nuovi fedeli. Cantavo litanie improvvisate, senza sbagliare una rima. Le mie filastrocche erano messe in bocca a un cristo piuttosto incazzato, perché non disponeva dei dodici apostoli regolamentari. Continuavo a girare intorno alla piazza, tutto invasato, lamentando la crisi delle vocazioni. Quando mi voltai per controllare se avevo raggiunto il numero giusto di apostoli, mi accorsi di avere alle spalle due o trecento persone! Un brivido di soddisfazione mi percorse la schiena. Il primo anno Michele e io motorizzammo un portone monumentale, utilizzando parti meccaniche prese da un demolitore. Ci istallammo sopra un’intera stanza da bagno, completa di lavandino e WC. C’era anche una doccia azionata con una pompa a mano, che usavamo per annaffiare i passanti. A difesa dalle ombrellate, portavamo in testa un elmetto ricavato da un vaso da notte. L’anno seguente realizzammo una mostruosa auto da rally. Un modello avveniristico, a trazione integrale. C’erano due mo- 94 Professione: avventuriero Il Morbo di Monduz tori: uno sull’avantreno, l’altro sull’asse posteriore. Avevamo ottenuto questo prototipo unendo due parti anteriori di automobili in demolizione. L’originalità del veicolo nasceva dalla possibilità di sterzare su tutte e quattro le ruote. Naturalmente, era molto pratico per i parcheggi. C’erano due sterzi, così io e Michele potevamo guidare in due senza disputarci il volante. La direzione di questo infernale veicolo era un compromesso tra le intenzioni dei due piloti. Rischiammo più volte di sfracellarci contro una colonna, finché una manovra sbagliata divise il trabiccolo in due monconi a due ruote, molto più maneggevoli. Finito questo week-end di baldorie, il lunedì si andava tutti al cinema gratis. Bastava esibire il tesserino, in qualunque cinematografo, anche di prima visione. Ovviamente ne abusavamo. I più morigerati si vedevano quattro film, ma c’era chi se ne zuppava anche sette. A Bologna, lungo via Indipendenza, ci sono parecchie sale in poche centinaia di metri. Qualcuno approfittava di questo vantaggio logistico, per vedere contemporaneamente due film. Entrava e usciva da un cinema all’altro, come se girasse il telecomando. L’unico inconveniente dei cinema gratis era l’acustica. II casino era tale, che praticamente non era possibile capire una sola parola. C’erano goliardi travestiti da gangster che scaricavano salve di mitra contro lo schermo. I fischietti e i commenti erano a ciclo continuo. Una volta, stavamo vedendo un film di 007. Ogni volta che James Bond baciava una ragazza c’erano boati di incoraggiamento. Quando la protagonista venne freddata da una pallottola a tradimento, ci restammo tutti malissimo. Eravamo ammutoliti. Una donna talmente bella, ci sembrava uno spreco farla morire. Michele a quel punto si levò in piedi e gridò: « Almeno scopala, finché è calda! ». L’incitazione trovò tali consensi che a momenti venne giù il cinema. La gente partecipava con simpatia al nostro baillame. I vigili mostravano una pazienza incredibile. Si divertivano tutti, nono- 95 stante i lanci di borotalco, le bombette puzzolenti e gli approcci insolenti dei goliardi travestiti da donna. Quella festa portava una ventata di follia nella monotona routine bolognese. Feci appena in tempo a vivere le ultime edizioni delle Feste delle Matricole. Poi vennero gli anni della contestazione. Nel ’67 ci fu l’ultimo timido sforzo per tenerla in vita. Ricordo con tristezza un goliardo che non si era reso conto dei tempi mutati. Come ogni anno, s’era presentato in piazza della Mercanzia sul suo innocente trabiccolo. Portava la feluca ed era travestito da paggio. Venne accerchiato da un’orda inviperita di sessantottini. Gli strapparono il cappello e la gorgiera, e gli ribaltarono il carretto. La gloriosa festa delle matricole, sopravvissuta per secoli, non era riuscita a superare il sessantotto. Come superare gli esami (Senza studiare, è ovvio) Appena cominciarono le lezioni, anch’io, da brava matricola, presi a frequentarle con assiduità. Ma rimasi deluso. Mi accorgevo che i docenti la tiravano in lungo. Intorno a un concetto, ci costruivano una cattedrale. Con quel loro temperamento da primedonne, si facevano prendere dal fascino di avere dinanzi una folta platea. Trasformavano la lezione in uno show personale. Non v’era nulla da eccepire, sul piano artistico, ma ai fini dell’apprendimento era uno spreco di tempo. Ci doveva essere un metodo più veloce. Provai a studiare sui libri. Non l’avessi mai fatto! Questi, condensavano talmente i concetti da renderli incomprensibili. Il peggio era che esprimevano opinioni diverse da quelle esposte dal professore alle lezioni. Così non sapevi che pesci pigliare. 96 Professione: avventuriero Il Morbo di Monduz Ci voleva una verifica. Mi parve saggio assistere a qualche esame per vederne lo svolgimento. Feci una scoperta sensazionale: gli esami non avevano nulla in comune né con le lezioni, né con i libri di testo. I docenti, nauseati da quelle abbuffate di esami, finivano per condurli in modo automatico. Mi pareva che avessero imbastito mentalmente un questionario ridotto, per valutare i candidati con semplici oscillazioni del capo. Per scrupolo, compilai una statistica. Mi accorsi che ricorrevano sempre le stesse domande. Il bello era che gli studenti davano sempre le stesse risposte! Compresi l’antifona. Le loro risposte erano lo specchio fedele dei testi. Ma i professori avevano spesso parere diverso; lo si vedeva da come scalpitavano sotto la cattedra. Le loro sfuriate mi parvero molto istruttive, ne prendevo nota con diligenza. Che bello! Ascoltando parecchi esami avrei potuto conoscere, di ogni docente, i pallini, i tranelli e le più tenaci manie. Cominciai a frequentarli con metodo e a prendere appunti. Annotavo domande, risposte e interventi dell’esaminatore. Per eccesso di zelo, registravo anche la frequenza statistica di ogni quesito. Poi mi venne un’idea brillante. Si era mai visto un campione sportivo affrontare l’incontro senza aver studiato il carattere dell’avversario? Non potevo trascurare l’analisi psicologica del professore. Che ricerche scientifiche aveva fatto, in passato? In quali argomenti era più forte? Scoprii un metodo infallibile, per dare risposta a queste domande: il « Curriculum ». Ogni docente ne ha uno, è un fascicoletto che l’accompagna come un pedigree per tutta la carriera. Non era difficile scovarlo, nella biblioteca del suo istituto. Mentre i miei compagni andavano ogni mattina in gregge a lezione e poi sprecavano i pomeriggi a raccapezzarsi su astrusi 97 trattati, io mi intrufolavo nelle biblioteche a studiare i punti deboli degli avversari. Venne il giorno del grande collaudo: l’esame di Istologia. Fin dalla prima domanda misi il professore alle corde. Era stordito, di fronte a uno studente che rispondeva per filo e per segno come lui aveva sempre sognato. Lo misi KO citando una ricerca sull’embrione di pollo, da lui condotta dieci anni prima. Trenta e lode! Dunque, il metodo era efficace. Presi ad applicarlo su tutta la linea, passando di successo in successo. La cosa fu notata dai miei compagni di corso. Com’era possibile che prendessi la lode in ogni esame, disertando le lezioni e senza studiare? Cominciò a diffondersi la voce che fossi un raccomandato di ferro. Io non la smentivo. Non avrei mai svelato il mio sistema gratis. Ne avrei fatto un business, l’anno seguente. Nel frattempo, cercai di monetizzare i miei successi con il parentado. Compilai la seguente tabella, che esposi în cucina: TARIFFARIO ESAMI (ad uso di babbo, mamma, nonna e zia - Lire/Cadauno) trenta e lode: trentamila trenta: ventimila dal ventisette in su: diecimila Ma sotto il trenta scesi solo una volta, durante il mio primo esaurimento nervoso. Per il resto, il libretto era una sfilza ininterrotta di trenta e di lodi. Per la mia economia era una trasfusione di linfa vitale. Lucia Durante il primo anno di Medicina, nelle mie reti di bracconiere cadde un angelo di ragazza. Il suo nome, Lucia. Aveva tanta grazia, e un sorriso così dolce, da sciogliere anche un tipo coriaceo 98 Professione: avventuriero Il Morbo di Monduz come me. L’avevo conosciuta nel commercio dei libri usati. Mi ero offerto di portarglieli a casa, era solo un pretesto per sapere dove abitava. Le chiesi di rivederla, ma non raccolse l’invito. Tutte le mie astuzie, che con le altre funzionavano sempre, con lei non avevano la minima presa. Perbacco, era davvero una donna diversa. Iniziai a farle la corte con il metodo del «martello pneumatico», che tanto avevo criticato in Alfredo. Lucia frequentava l’ultimo anno del Galvani. L’andavo a prendere tutti i giorni a scuola. Ma lei cercava di evitarmi, non rispondeva che a monosillabi. Io duro, non mollavo la presa. Giorno dopo giorno, l’accompagnavo da scuola fin sotto casa. Lei non proferiva sillaba, e io stavo finendo il mio repertorio, ormai ridotto a snervanti monologhi. Ma ero deciso a resistere. Per scoraggiarmi, Lucia aggregò una sua amica al nostro convoglio. Non mi lasciai spiazzare, anzi, ne approfittai per conquistarmi la sua simpatia facendola ridere lungo tutto il percorso. Si divertiva come una matta e questo, mi parve, giocava a mio favore. Dopo un paio di giorni, l’amica sparì e Lucia si decise a parlare con me. Una volta arrivai in ritardo e la trovai che mi aspettava fuori da scuola. Era un segnale chiarissimo, ma volli fare una verifica. Per una volta non andai a prenderla. Il giorno dopo era tutta impermalita. Cominciammo a tenerci per mano, poi un giorno, quando mi dette un bacio, scappò in chiesa a confessarsi, neanche avesse passato in rassegna il Kamasutra. Era il suo primo bacio. Com’era onesta e sincera! Negli occhi si leggevano i pensieri che le passavano per la mente. Pensai a mio padre e a mia madre. Anche a loro doveva essere successo qualcosa di simile. No, non avrei voluto per Lucia e per me gli stessi mugugni, le stesse pene. Non avevo alcuna intenzione di farmi una famiglia. Ero consapevole di non essere il 99 tipo. Volevo vivere la mia vita come un’avventura. Non potevo coinvolgere quell’innocente ragazza. Dovevo cercare un sistema per uscire dalla sua vita senza far troppo rumore. Lo trovai accettando l’invito di Giancarlo ad andare in Inghilterra con lui. Vacanze a Londra Giancarlo andava in Inghilterra tutte le estati e me ne parlava con entusiasmo. Sarebbe piaciuto anche a me, figuriamoci! Lontano da casa e dai controlli paterni, in un paese leggendario, a quei tempi. Gli inglesi godevano fama di essere un popolo con il culto della libertà. E soprattutto le inglesi, godevano di un’ottima reputazione, ai fini nostri: circolava la voce che fossero di costumi più che disinvolti. Insomma un viaggio a Londra, a quei tempi, era il massimo dell’avventura, per un ragazzo. Le mode, le canzoni, le idee giovanili nascevano lì. Era la patria dei Beatles, di Carnaby Street, dei Rockers e dei Rolling Stones. Alcuni amici ci erano andati per una vacanza e non avrebbero più voluto tornare indietro. Finiti i soldi, si erano adattati a fare gli sguatteri, pur di rimanere in quel Bengodi. Era stato a Londra anche Alfredo, ed era tornato irriconoscibile. Capelli lunghi, mocassini Saxon, blue jeans. Ballava lo shake in modo strano e aveva un’aria tutta diversa. Si era disimbranato. Era perfino più furbo con le ragazze (fu un breve flash: in poco tempo tornò quello di prima). Se Londra era riuscita a smuovere Alfredo, figuriamoci me! Dovevo andarci assolutamente. Ma c’era il problema dei miei genitori. Non mi avrebbero mai lasciato partire, apprensivi com’erano. L’astuto Giancarlo era di parere diverso. «Naturalmente non ti daranno il permesso, se glielo proponi come una vacanza. Ma se invece accampi la scusa d’impa- 100 Professione: avventuriero Il Morbo di Monduz rare l’inglese, nessun genitore oserà negartelo!» Quel demonio di Giancarlo ne sapeva una più del diavolo. Non per niente era stato in collegio dai Gesuiti. Prevedevo tuttavia obiezioni anche di tipo economico da parte dei miei. Decisi di prevenirle, racimolando i quattrini in anticipo. Le interviste Leggendo un’inserzione sul «Resto del Carlino» avevo trovato un lavoretto. Si trattava di fare interviste per un’agenzia di marketing. Avevo girovagato per le case di Forlì, chiedendo alla gente che tipo di piastrelle avessero in bagno. I forlivesi si erano rivelati di un’ospitalità incredibile. Chi mi offriva il tè con i pasticcini, chi mi faceva assaggiare una torta. L’episodio più commovente mi capitò con una coppia di vecchietti che non volevano più lasciarmi andar via. Lui era sceso in cantina a stappare una bottiglia che custodiva da anni e lei mi aveva offerto una ciambella fatta con le sue mani. Quei cari nonnetti desideravano talmente un nipotino, che mi avevano adottato all’istante. Per questo lato umano, il lavoro delle interviste mi era molto piaciuto. Oltretutto me l’avevano pagato coi fiocchi. Così, quando me ne proposero altre, le accettai subito. Ero diventato un intervistatore di un attivismo incredibile, tanto che i capi dell’agenzia mi chiamarono a Milano per conoscermi in faccia. Dovetti far loro una buona impressione, perché me ne andai carico di questionari. Non chiedevo di meglio, quella per me era ormai diventata un’industria. All’insaputa dell’agenzia, infatti, avevo reclutato sette-otto excompagne di liceo che operavano sotto le mie direttive. Per non dare nell’occhio, con troppe interviste, avevo raccolto altro lavoro dalle agenzie concorrenti. Le avevo interpellate a Milano, 101 con un giro di visite a tappeto, pagine gialle alla mano. Sfornavo questionari a dozzine. Le mie collaboratrici facevano le interviste e compilavano i moduli. Io ne controllavo la correttezza, qualche volta mi inventavo una risposta mancante, poi spedivo via tutto. Quando arrivavano i soldi, tenevo una bella fetta per me. In un paio di mesi avevo racimolato abbastanza per il viaggio in Inghilterra. A quel punto passai all’attacco dei genitori. Inghilterra L’accerchiamento ideologico dei miei fu lungo e meticoloso. L’aiuto di Giancarlo si rivelò determinante. Fece telefonare a mio padre dal suo. Fornì referenze della vecchia signora che lo aveva ospitato negli anni passati. Stava a Bournemouth, purtroppo. Non era Londra, ma pur sempre Inghilterra. Giancarlo mostrò perfino le foto della casa e della nostra stanzetta. La vecchia era di costumi irreprensibili, Giancarlo ci andava da anni, ed era lì sano e salvo. Non drogato, non traviato, esente da malattie veneree. I miei tentarono la carta dei soldi, ma li avevo preceduti anche su questo terreno: tirai fuori il gruzzolo risparmiato con le interviste. Non avevano più argomenti da opporre. Cedettero. I preparativi del viaggio furono sproporzionati. Sembrava che dovessi partire per la terza guerra mondiale. Sterline di riserva nascoste nelle pantofole, vaccinazioni, maglie di lana, medicinali. Comperammo appositamente una valigia della misura più grande che c’era. Venne il giorno della partenza. I miei non la smettevano più con le raccomandazioni, scritte e verbali. Mio padre salì sul treno per abbracciarmi. In quell’abbraccio percepivo il suo grande affetto. Sulla pensilina, c’era mia madre con gli occhi lustri. Ero commosso. 102 Il Morbo di Monduz Professione: avventuriero 103 Non c’è nulla di più grande degli affetti, pensai. L’amore è l’unità di misura dell’uomo. Cavolo, che patrimonio stavo lasciando in quella dolce città. In nessun paese del mondo avrei potuto trovare qualcosa di paragonabile. Fui tentato di tirar giù la valigia e tornare a casa con loro. Il treno si mosse, spingendo via l’immagine dei miei con la mano protesa, soli sulla pensilina. Il braccio ondeggiante di mia madre tagliava l’aria come un bisturi mentre io sparivo dal loro orizzonte, in bilico fra nostalgia e desiderio di libertà. «le due uniche inglesi pudiche dovevano proprio toccare a me!» La mattina dopo, quando mi ripresentai nello scompartimento con le due tipe, nessuno pensò che i miei occhi cerchiati erano frutto d’insonnia per incazzatura. Anzi. I maschi mi bersagliavano di allusioni piccanti. Ancora una volta godevo di una fama usurpata! Ormai ci ero avvezzo. Mi trincerai in un «cavalleresco» no comment. Eppure, l’invidia dei maschi mi dava conforto. Un altro guizzo del Morbo di Monduz. Non mi ci volle molto per asciugarmi gli occhi. Il treno era colmo di studenti che, come me, andavano «a studiare» in Inghilterra. Chi s’era portato dietro la chitarra, chi il mangianastri. Eravamo tutti accomunati dal desiderio di evasione. Le ragazze erano numerosissime. Notai due inglesine che tornavano in patria, dopo una vacanza estiva a Riccione. Eravamo in una dozzina di maschi a coccolarle. Ero particolarmente svantaggiato, dato che parlavo pochissimo inglese, però strinsi un’alleanza col capotreno che si rivelò di grande valore strategico. A notte fonda, quando tutti si accovacciarono alla meglio nelle loro cuccette, proposi alle due figlie di Albione un pernottamento più confortevole, nello scompartimento del capotreno. Quelle non se lo fecero dire due volte. Così, senza dare nell’occhio, ero sparito con le due tipe, sognando notti di follie, in un vero letto, con vere lenzuola, come un pascià. Ma le cose dovevano andare in modo diverso. Insensibili ai maldestri arrembaggi miei e del capotreno, le due inglesine si trincerarono nei loro lettini, come due monache di clausura stretta. Non avevo mai visto tanta determinazione. Neanche avessero fatto un voto di castità. Ci dovemmo rassegnare a dormire. In quel letto con vere lenzuola fu un vero supplizio di Tantalo. «Maledizione» gridai, tanto quelle non capivano un’acca Londra! Appena sceso dal treno, nella Victoria Station, mi si parò davanti un mondo fantastico. Che rassegna di novità, peccato dover proseguire per Bournemouth. Mancavano un paio d’ore alla coincidenza del treno. C’era tempo per un giretto. Lasciai la pesante valigia al deposito. Mi sentivo le mani libere e il cuore leggero. Pronto all’appuntamento con la grande metropoli, che brulicava al di là delle vetrate della stazione. Comprai una cartina per orientarmi. Seguendo la mappa, come in una caccia al tesoro, puntai verso Piccadilly, a piedi, pensando di arrivarci in due minuti. Invece, dopo mezz’ora, mi ero spostato poco più di un centimetro. Che immensa città! Cento volte Bologna. Ero bombardato di novità, non riuscivo ad assorbirle tutte. Diversa moneta, guida a sinistra, taxi monumentali. Gente di tutte le razze, con i più strani costumi. Barboni, gentlemen in bombetta, hippies, tipi variopinti e altri tutti vestiti di nero. Si incrociavano per le strade, come in una grande parata. Mi sentivo in un immenso studio cinematografico, nell’ora di pausa. Quella gente, erano le comparse di film diversi, in attesa di andare sul set. Era meglio che al cinema. A Bologna, molto di meno sarebbe bastato a bloccare il traffico, mentre lì nessuno ci faceva caso: ero davvero capitato nel paese della libertà. 104 Il Morbo di Monduz Saltai su quel treno per Bournemouth appena in tempo, deciso a ritornare il più presto possibile in quella meravigliosa città. Alla stazione di Bournemouth c’era Giancarlo che mi aspettava con impazienza. Contava sulla mia collaborazione per dare l’assalto alle discoteche. Ne aveva già fatto l’inventario, così era tempo risparmiato. A casa c’era un’altra sorpresa: la nostra housekeeper, la terribile Mrs. Price. Una vecchietta dura e bitorzoluta come una radica. Arrotondava la pensione affittando tre stanze agli studenti. Conduceva quel piccolo pensionato con la disciplina di una caserma, era peggio di un colonnello. Orari ferrei per i pasti, pena il digiuno. Coprifuoco all’una di notte e sveglia alle sette. Avremmo dovuto adeguarci. La cucina era il supplizio peggiore. Come pranzo di benvenuto mi preparò un piatto di spaghetti in scatola, che servì spalmati sul pane. Dopo quel pasto nefando, Giancarlo e io uscimmo in missione nei locali notturni. Ma c’erano problemi di comunicazione. Io ero disinvolto con le ragazze, ma parlavo male l’inglese. Lui lo parlava benissimo, ma non aveva la mia faccia tosta. Eravamo costretti a procedere in tandem, come un’idra a due teste. Feci altre dolorose scoperte: Bournemouth era un paesino fuori dal mondo. Nulla a che vedere con Londra. Una piccola stazione marittima sulla Manica, frequentata da vecchietti in pensione. Ragazze ce n’erano poche, quasi tutte francesi. E quelle erano ossi duri, per noi. Oltretutto, la nostra fama di amanti italiani non funzionava. Un conto, abbordare una tedesca sull’Adriatico, un altro, una francese in riva alla Manica. Nelle discoteche c’era un fracasso da trauma acustico. Per non impazzire, mi tappavo le orecchie con tamponi di carta igienica inumiditi. Anche così, i toni alti rintronavano nella scatola cranica Professione: avventuriero 105 e i bassi rimbombavano nell’intestino. La conversazione ne risultava azzerata. Bisognava camminare a tentoni, perché non ci si vedeva a un palmo dal naso. Questo mi provocò un incidente spiacevole. Ero riuscito ad agganciare una biondina decente e ballavo guancia a guancia con lei, stringendola come un pitone, quando dai bordi della pista Giancarlo si mise a fare strani gesti. Pensavo volesse incoraggiarmi a concludere. Gli feci segno di portare pazienza: non era il caso di forzare i tempi; sapevo il fatto mio. Ma lui continuava a gesticolare. Che diavolo c’era? Voleva avvisarmi che la mia bella aveva una gamba di legno. Non me n’ero accorto, accidenti a quel buio. Insomma, i successi con le ragazze tardavano. Un vero peccato, visti i costumi liberali di quel paese. Una volta, passando nel parco, ci imbattemmo in una coppietta impegnata in effusioni da film a luci rosse. Intorno si era formato un capannello di curiosi, interessati agli sviluppi della vicenda. I due innamorati, per nulla turbati da quella platea, intensificavano il repertorio di arrapamenti. Si avvicinarono alla scena due bobbies, i severissimi vigili inglesi. «Adesso li arrestano», pensai. Per effusioni molto più caste, una volta, a Zocca, i carabinieri mi volevano portare in caserma. Quegli imperturbabili bobbies, invece, fecero cenno alla gente di circolare, senza disturbare gli svergognati. Ah, che civiltà! Studiando di giorno e annaspando di notte in discoteca, era già andata in fumo metà della vacanza. Che delusione! Bournemouth non era l’Inghilterra che avevo sognato. Giancarlo mi aveva turlupinato, rimorchiandomi in un ospizio per vecchiette inglesi. Ne avevo abbastanza. Mi sarei trasferito subito a Londra: lì c’erano Simona e una sua amica, sole solette. Mi avevano telefonato a Bournemouth un paio di volte, supplicandomi di andarle a trovare. 106 Il Morbo di Monduz Abitavano da una zitella inglese e si sentivano sperdute in quella grande città. Il mio tenero cuore non poteva resistere. Telefonai a mio padre. Gli spiegai la faccenda, da uomo a uomo. Quando la mettevo in certi termini, sapevo di trovare in lui un prezioso alleato. Lo convinsi a concedermi un salvacondotto per Londra. «Ma pochi giorni soltanto, mi raccomando! Guarda che non lo dico alla mamma, sennò quella non mi dà pace! » Avvisai la Simona che stavo per andare da loro. Dall’altro capo del filo mi giunse un boato di gioia. Piantai in asso Giancarlo, lasciandolo nella più cupa disperazione. Partii per Londra, deciso a riscattare la mia vacanza oltremanica. Arrivato a Londra ritrovai intatta l’atmosfera di follia che mi ero lasciato alle spalle, la prima volta. «Meno male, che è ancora tutto al suo posto» dicevo tra me, seduto sul taxi. «Londra aspettami, sto arrivando!» Londra, finalmente Sulla soglia di Mrs. Eaton, mi venne incontro una vecchia grinzosa, vestita come una gran dama. Aveva una faccia di gomma dura, stuccata col fondo tinta: più che una signora, sembrava un travestito avanti d’età. Mi venne incontro zuccherosa, salutandomi in italiano: «Buongiorno! Come va, vecchia faccia da culo?» Rimasi di sale. Mi aspettavo un benvenuto diverso da una irreprensibile lady inglese. Simona e l’amica, mezzo nascoste dietro la porta, mi facevano dei gesti convulsi. Ero interdetto. Poi mi fu svelato l’arcano: la vecchia desiderava imparare l’italiano, per andare in settembre a Riccione, e loro glielo stavano insegnando con qualche modifica. «Faccia da culo» era saltato fuori una volta, a tavola, casualmente. Era il vezzeggiativo che usavano tra loro per indicare la padro- Professione: avventuriero 107 na di casa. Lei, che aveva sentito, volle saperne il significato. Le avevano detto che era un complimento. Di lì si era sviluppata l’idea di continuare lo scherzo. Stavano insegnando a quella disgraziata aggettivi da casino e lei li ripeteva, convinta che fossero galanterie. A cena, ogni tanto «la vecchiaccia», questo era il suo nome in codice, faceva osservazioni degne di uno scaricatore di porto. E noi a tenerci la pancia dal ridere. « You don’t know my dear George... Oh pardon, tu non conosci quel rottinculo di George, vero? » C’era da farsi scoppiare il diaframma, nel tentativo di restar seri. Ma era impossibile, e allora, chi nascondeva la faccia nel tovagliolo, chi si mandava di traverso il mangiare. « Next year, prossimo anno, andare farmi fottere in Italia, a Riccione, chissà, grande amore... come dite?... Rompere me il culo! » E noi, tutti con la testa sotto la tavola: io fingevo di raccogliere il tovagliolo, Simona di avere un crampo alla caviglia. Giuliana era corsa a chiudersi in bagno per un bisogno impellente. Restava sola, la vecchia, a guardarsi in faccia con George. Sarebbe piaciuto anche a me essere a Riccione quando la vecchia avrebbe sfoggiato quel vocabolario! Giuliana, l’amica di Simona, aveva diciassette anni e un’aria da santerellina che non mi convinceva. Ragazze del genere hanno sempre solleticato la mia fantasia. Sono convinto che sotto ogni madonnina innocente c’è appisolato un vulcano. Quanto alla Simona, era per me una sorella, il che non escludeva qualche estemporanea effusione più che fraterna. La vecchiaccia era davvero una sagoma. Abitava da sola, ma ogni tanto riceveva le visite di George, strano amico, di vent’anni più giovane di lei. Uno squattrinato che vivacchiava come poteva. Tra l’altro, fabbricava vasi di terracotta col tornio. Mi mostrò alcune tazze da tè col manico, che non erano nemmeno brutte. 108 Il Morbo di Monduz Ne comperai tre, visto che costavano poco. Quel gesto toccò l’animo della vecchia. Quando seppe che non avevo dove dormire, mi invitò a passare la notte da loro. L’unica stanza disponibile era occupata da George. Fortunatamente, nella camera delle mie amiche c’era un divano-letto. Mi ci sarei adattato. Altro che! Passammo una notte di fuoco, in tre dentro quella stanza. Sembravamo tornati bambini. Ci tiravamo i cuscini, giocavamo ai fantasmi, ci scambiavamo le visite sotto le coperte. Che splendida, calda felicità! Mi sembrava di essere tornato alle gioie della mia infanzia. Senza averlo voluto, anche a Londra stavo per aprire la succursale del mio cortile di via Orfeo! Il Morbo di Monduz era sempre lì, che covava sotto la cenere. Dovevamo aver fatto un bel chiasso. Il mattino dopo la vecchia nel suo solito italiano forbito, mi pregò cortesemente di «andare affanculo». Scoppiavo ancora dal ridere, quando lasciai la mia valigia al solito deposito bagagli di Victoria Station. Mrs. Eaton abitava a pianterreno. La stanza delle mie amiche dava con le finestre sul cortile interno. Sarebbe bastato scavalcare il davanzale per entrare da loro. La sera stessa, dopo aver cenato da Mrs Eaton, salutai tutti con aria solenne. Si sprecarono i convenevoli e i «faccia da culo». Uscito dalla porta, rientrai subito dalla finestra, che la Simona mi aveva lasciato socchiusa. Il nostro terzetto si era ricostituito in barba a tutte le befane del mondo. Eravamo felici come discoli con il naso nel barattolo della marmellata. Dovevamo però evitare ogni rumore sospetto, e questo per me andava benissimo. Le ragazze non potevano reagire strillando. Questo alibi sarebbe stato sufficiente per la loro coscienza e io avevo spazio per allungare le mani. Professione: avventuriero 109 Andò avanti così per una settimana. Che vita da pascià. Non poter uscire allo scoperto mi procurava dei privilegi. Ogni mattina le uova al bacon mi venivano servite a letto e con un bacino. Andare in bagno era un’avventura: una distraeva la vecchia in cucina mentre l’altra mi accoglieva dentro la sua vestaglia, per coprirmi il passaggio lungo il corridoio. I miei soldi erano finiti da un pezzo. Ogni due giorni telefonavo a casa per avere una proroga e denaro fresco. Mio padre si era già spazientito. Credendo di costringermi a ritornare, si rifiutò di mandarmi altri quattrini. Ma io, pur di restare, vendetti il biglietto del treno. Così mi ero tagliato la via del rimpatrio. Non avevo altra scelta: nella vita, certe occasioni capitano una volta sola. Non volevo portare a casa rimpianti. Al futuro ci avrei pensato più avanti. Per quanto riguardava il presente, era una mattina di sole, e aspettavo le dieci per incontrare le mie compagne al solito posto, in Piazza del Parlamento. Stavo seduto sui gradini di Westminster Cathedral e sorridevo tra me e me, pregustando il piacere di vederle arrivare. Avremmo fatto la nostra consueta passeggiata in Hyde Park e lo shopping nei negozietti di Carnaby Street. Avrei allungato una carezza a una di loro, mentre l’altra si provava un vestito. Ci saremmo scambiati un bacio furtivo dentro il camerino o uno sguardo d’intesa davanti a un hamburger nei Whimpy Bar. Alzai lo sguardo e le vidi arrivare in lontananza lungo il Tamigi, in Abingdon Street. Mi alzai come un gatto sornione da una cesta di gomitoli e le presi tutte e due per mano. Chi c’era, al mondo, più felice di me? Il Big Ben me ne dette conferma, suonando dieci rintocchi. Strano, mi pareva che il tempo si fosse fermato. 110 Il Morbo di Monduz Parigi Le mie amiche restarono a Londra ancora una settimana, poi partirono per Parigi. Avrei tanto voluto andare con loro, ma avevo finito gli ultimi spiccioli. Non potevo dire a mio padre di aver venduto il biglietto per il ritorno, così cercai un lavoro. Lo trovai come imbonitore di un localetto di Soho. In pratica, stavo davanti all’entrata e distribuivo biglietti gratuiti alle ragazze. Prendevo una percentuale per ogni avventore maschio pagante. Poi trovai lavoro in un ristorante italiano. Cominciai una carriera di chef dalla gavetta, pelando patate. Venni promosso cuoco-aiutante quando il padrone scoprì la mia bravura a fare lasagne e tagliatelle. Modestamente, provenivo dalla scuola di mia nonna. Quel brav’uomo non voleva più che partissi, almeno finché non gli avessi svelato il segreto dei miei tortellini. Invece, appena racimolati i soldi per il viaggio, partii lasciandogli il dubbio se nel ripieno ci volesse o no la salsiccia. Raggiunsi le mie amiche a Parigi, quando ormai stavano per tornare in Italia. Con i miei genitori ero già ai ferri corti. Ogni giorno erano più spazientiti. «Torno domani! » era il solito ritornello. Comunque, una scusa per fermarmi a Parigi l’avevo. Qui c’era la sede della « Vandoren » la più grande fabbrica al mondo di ance da clarinetto. Mio padre non seppe resistere alla lusinga di una fornitura speciale di ance di prima scelta. Ne avrei comprato fino a esaurimento dei miei risparmi. Parigi mi piacque meno di Londra. Le mie amiche partirono quasi subito e mi lasciarono solo. Ogni sera vedevo passarmi davanti al naso, lungo gli Champs Elysées, stupende auto sportive cariche di parigini festanti e di donne da film. Entravano e uscivano da certi locali, in cui non mi era consentito di mettere il naso. Mi sentivo escluso. Era la stessa sensazione che avevo provato il primo giorno di scuola, al Galvani. Professione: avventuriero 111 Per vivere a Parigi alla grande, bisognava entrare nei giri esclusivi. Partecipare alla vita dei Vip. Purtroppo, io potevo soltanto fare il turista. Mi consolavo passando le giornate a visitare musei. Per me Parigi era come una festa a cui non ero stato invitato. Tornai sulla via di Bologna, con un pacchetto di ance, tre tazze col manico, qualche disco e mille lire in tasca. Non avevo altri souvenir, oltre quello di aver vissuto uno dei periodi più belli della mia vita. Donne e dolori Le festine di Michele Appena tornato dall’Inghilterra telefonai a Michele per proporgli di allestire nella sua cantina una discoteca privata. Le feste che venivano organizzate dalle ragazze mostravano gravi lacune, ai nostri fini: erano buone per conoscere donne, ma poco adatte a concludere. Bisognava allestirle noi, in un locale adeguato. Punti essenziali erano la buona scelta dei dischi e un impianto d’illuminazione giusto. Michele poteva fidarsi di me, in Inghilterra avevo fatto esperienza. Cominciammo subito a sfrattare dalla cantina di Michele le damigiane di vino del padre e a sistemare l’impianto di amplificazione. Sotto gli occhi sbigottiti dei suoi, trasformammo quello scantinato in un torbido locale notturno. La sua struttura era basata su pochi, chiari concetti. Impianto di illuminazione: assente. Il problema semmai era inverso: ottenere l’oscuramento. Le festine andavano fatte di pomeriggio, quando i genitori delle ragazze avevano la guardia abbassata. Quelli pensavano che, finché il sole era alto, certi peccaminosi pensieri sonnecchiassero. Invece avremmo ricreato le tenebre in pieno giorno, tappando ogni infiltrazione di luce. Con un nastro adesivo nero sui vetri ripassai ogni finestra, finché non restò la minima falla. 114 Il Morbo di Monduz La musica. Una compilation dei dischi più languidi sul mercato, integrati con le ultime novità inglesi, che mi ero portato da Londra. Per evitare il cambio del nastro, difficoltoso al buio, trovammo un registratore con un’autonomia sufficiente per tutta la festa. I clienti. Ingresso libero, per le ragazze. I maschi, invece, dovevano farsi accompagnare da due donne ciascuno. Erano previste deroghe per gli amici del cuore, come Mauro, Pitto e Marco, che se la potevano cavare procurando le bibite e i pasticcini. Vietato fumare. Non per motivi ecologici. Perché i fiammiferi facevano luce. Appena finito con gli arredamenti, passammo al collaudo. Andava tutto a puntino, tranne il registratore: con la spia luminosa, infrangeva di rosso le tenebre. Provvidi a oscurare anche quella con un pezzetto di scotch nerofumo. Ora sì, che era tutto perfetto. Chiamammo quell’ambiguo locale « Da Pluto », e lo inaugurammo in ottobre, con un grande veglione pomeridiano. Quella tana era il luogo più buio di tutta Bologna. Il trionfo delle tenebre sulla virtù femminile. Una perfetta palestra di seduzione. Assieme al trappolo di via Guelfa, costituì un sistema integrato per le nostre grandi manovre sessuali. Cosetta Durante il primo anno di Medicina una nuvola di capelli biondi occupava la prima fila alle lezioni di Istologia. Vicino c’era sempre lo stesso ragazzo, alto, magro, dall’aria truce. Lei era stupenda, la donna che avevo tante volte sognato. Modi eleganti, occhi azzurri e voce flautata. Si chiamava Cosetta e mi sembrava la ragazza più affascinante del corso. Malauguratamente, la facoltà di Medicina era frequentata da una maggioranza di uomini. Su Donne e dolori 115 cinquecento studenti, le femmine erano poche dozzine. Miriadi di sguardi maschili convergevano su Cosetta, quando entrava in aula col suo silenzioso accompagnatore. In situazioni del genere avevo la mia strategia: lasciar perdere. Non ero psicologicamente disposto a competere da posizioni sfavorevoli. Ma quando un mattino me la trovai, sola, nel laboratorio di Anatomia, il mio cuore cominciò a galoppare. Era un’allieva interna, come me! Questa provocazione del destino non potevo respingerla. Caddi nel blu dei suoi occhi, deciso a conquistarla. Ma era un osso duro. Il suo fascino si imponeva per semplice esposizione, il mio era tutto da dimostrare: si trattava di un’impari lotta. Non osavo chiederle come mai fosse tutta sola. Che quel tipo l’avesse mollata? Comunque non c’era da farsi illusioni, simili perle restano sfidanzate solo un paio di settimane, nella vita. Hanno pretendenti in lista d’attesa che sbucano da tutte le parti. Appena si sparge la voce che sono libere, il loro telefono è sempre occupato. Ogni mattina, ci si incontrava in laboratorio. Ero meravigliato di me stesso, della mia calma, quand’ero con lei. Riuscivo ad assumere l’aria un po’ tenera e un po’ disinvolta, di uno che scherza ma non si scompone. Era un gioco pericoloso, ma mi pareva l’unico gioco possibile. Ogni volta che uscivamo insieme mi trovavo alle corde. Però, a casa, ritrovavo le forze per il round successivo. Non potevo dichiararle il mio amore, dovevo dare modo anche a lei di cuocere un po’ nel mio stesso brodo. Alternavo i dispetti alle galanterie, cercavo di rivoltarle contro il suo stesso fascino. Se le avessi tolto il piacere della prima mossa temevo che l’avrei perduta per sempre. L’amore si nutre di dubbi. Dovevo resisterle e non farle capire cosa mi passava per il cervello. 116 Il Morbo di Monduz Andavo tutti i giorni a studiare da lei. Prendevamo il tè come vecchi amici, le raccontavo qualche storiella, ci facevamo quattro risate, poi me ne andavo con indifferenza. Appena fuori dalla porta di casa sua, mi cadeva il sorriso. Mi appoggiavo sul fondo dell’ascensore, a riprendere fiato. Passandomi la mano sulla fronte, emettevo un sospiro: ero salvo ancora una volta. Questo gioco di nervi andò avanti per settimane. Michele, da vero amico, tesseva le mie lodi e anche i tecnici di laboratorio facevano il tifo per me. Nell’Istituto di Anatomia giocavo in casa. A questo proposito, avevo la mia teoria: quando hai conquistato il suo territorio, una donna è già tua. Ma la pratica tardava a darmi ragione. Una sera, noi interni, uscimmo tutti insieme in discoteca. Si erano aggiunte anche altre ragazze, visto che in laboratorio eravamo dieci uomini e due donne soltanto. Io non mi perdevo un ballo, ogni volta con una dama diversa. Ma evitavo accuratamente di ballare con Cosetta, come se non ci fosse. Alla fine venne lei a invitarmi. Era tutta la sera che aspettavo quel gesto. Quando me la trovai tra le braccia, in un lento, ebbi la netta rivelazione che fosse la donna della mia vita. Non mi era mai capitato nulla di simile. Il suo corpo si accostò al mio, lieve, come un’impronta. La mia mano trovò subito la strada tra i suoi capelli e la sua guancia si annidò di misura sulla mia spalla. Quella ragazza era leggera come un’idea... la donna che avevo sempre sognato! Mi sembrò che tutto il mondo intorno a noi rallentasse. Che strana sensazione di leggerezza. Quando le strinsi la mano, lei si serrò a me. Che brivido! Dopo le danze, i più tornarono a casa, decimati dal sonno. Invitai i superstiti a finire la serata nel mio trappolo di via Guelfa. Donne e dolori 117 Eravamo in sei, accovacciati su quei cuscinoni, testimoni di tanti misfatti. Ci mettemmo a chiacchierare degli argomenti che ci stavano a cuore: l’amicizia, l’avventura, l’amore. Gli amici conversavano, io e Cosetta ci parlavamo con gli occhi. Nella penombra, la mia bocca si avvicinò alla sua. Incontrai il suo respiro. Tutto capitava da sé, senza forzature o premeditazioni. Quante stupidaggini avevo combinato, in amore! Mi sembrò di non aver mai baciato una donna, prima d’allora. Un bacio non è fatto di labbra che si incontrano, ma di anime che si sfiorano. Mai una donna mi aveva sfiorato così da vicino. Quando l’accompagnai a casa, volevo salutarla giù dal portone, ma non riuscivo a staccarmi da lei. Salimmo insieme in ascensore, fu un unico bacio dal pianterreno al quarto piano. Davanti alla porta del suo appartamento ci saremmo salutati una ventina di volte. Ogni volta era un bacio, l’ultimo, promettevamo. Ma ce n’era sempre un altro ancora. Guardammo l’orologio, erano le quattro del mattino! Da un’ora stavamo sulla soglia di casa, senza accorgerci del passare del tempo. Scappai via, senza darle un ultimo bacio, sennò non saremmo più andati a dormire. Allontanandomi, guardai verso le sue finestre, che si erano illuminate. Le prime luci dell’alba disegnavano lunghe pallide ombre sulle strade deserte. Era cominciato un nuovo giorno, il mio primo giorno d’amore. Un grande patrimonio di felicità era stato depositato sul mio conto e mi illudevo di avere tutta la vita davanti per spenderlo. Fu questo l’inizio della mia più bella storia d’amore. I suoi genitori osteggiavano i nostri incontri. Il padre si era accanito contro di me. Tanto che un giorno Cosetta mi arrivò sotto casa, con le valigie sulla sua 500. Voleva che scappassimo insieme. Sognava una chiesetta di campagna, un sì pronunciato in segreto. Una fuga d’amore in piena regola. 118 Il Morbo di Monduz Ma io non accolsi il suo sogno. Ero un uomo votato per l’avventura, pensai ciecamente; non avrei rinunciato a tutte le donne del mondo, per una soltanto. Questa follia, come una camicia di forza, mi impedì di cogliere quell’occasione. Un imperativo categorico, come un richiamo a una missione sconosciuta, mi proibiva di abbandonarmi alla felicità. Rifiutai quel dono di sé che Cosetta mi faceva, con gli occhi pieni di fiducia. La nostra favola era spezzata. Fu cancellata del tutto un mattino, ai Giardini Margherita, dopo una serie di liti e gelosie. Me ne andai senza voltarmi, come un vero duro. Quindici giorni senza telefonarle. Quindici giorni di speranza che mi chiamasse lei. Un orgoglio contro un altro orgoglio. Muro contro muro. Quando non ce la feci più, la chiamai. Venne all’apparecchio una donna diversa, che non conoscevo. Stava parlando a un estraneo. Parlava di me al passato remoto. Ormai per lei ero un ricordo. Diceva che non ero fatto per avere una donna. Ero nato per restare libero e solo. Ne era convinta. Io non ne ero tanto sicuro. Ero stato pazzo, a lasciarla. L’avrei voluta ancora, per tutta la vita. «Se mi avessi chiamato una settimana fa, avrei ceduto. E avrei fatto male, per tutti e due. Ora sono sicura che è meglio così. Tu sei un uomo libero, indipendente. L’ho fatto anche per te. Gianni, hai un grande valore. Forse nemmeno tu ne sei consapevole. Io l’ho capito. Ascolta il mio ultimo consiglio. Non buttarti via!» «Grande valore... non buttarti via... ma se tu sei la prima a buttarmi, allora, cosa dovrei fare di me?» Furono queste le ultime parole. Poi la porta della felicità mi si chiuse davanti e cominciarono i giorni bui. Non riuscivo più a mangiare: rimettevo tutto. E nemmeno dormivo. La notte era popolata di incubi, il giorno una specie di dormiveglia, di catalessi. Ero un uomo perduto. La donna più impor- Donne e dolori 119 tante della mia vita, me l’ero giocata. Quell’amore non l’avrei mai consumato. Altri avrebbero usurpato la mia felicità. Una parte della mia anima sarebbe finita nel letto d’un altro. Quella profanazione aveva i connotati di un rapporto contro natura. Attraverso Cosetta, la parte maschile del mondo mi violentava. In un mese avevo perso dieci chili. Mia madre era ricoverata al Rizzoli per un intervento all’ernia lombare. Quando l’andavo a trovare, era lei, ingessata fino al collo, immobilizzata su un letto, a consolare me. Sprofondavo in un gorgo di cui non vedevo la fine. Andai da uno psicologo. Mi prescrisse pillole di ogni tipo: la sera per dormire e il mattino per risvegliarmi. Ma non servivano a nulla. Ero sempre in una specie di catatonia mortale. Non mi fidavo più di guidare l’auto. Vendetti le mie moto da cross: non riuscivo a reggermi in sella. Trovavo un po’ di pace soltanto facendo lunghe passeggiate. Un giorno, durante una di queste, incontrai a Porta Castiglione un amico d’infanzia. Dapprima non mi riconobbe: avevo gli occhi cerchiati, ero pallido, con un’aria spettrale. Poi, osservandomi meglio, riuscì a identificarmi. «Gianni, sei proprio tu? Ma cos’hai!? Tu stai male!» «Sono nei guai. Non l’avrei mai creduto neanch’io. Una delusione d’amore, e poi... » «Tu hai un bell’esaurimento nervoso. Lo vedo bene: è capitato anche a me. Non dormi la notte? Hai l’ansia? Non riesci a mangiare?» Stava facendo un ritratto fedele della mia vita d’inferno. «Non disperarti» mi disse «vai dallo psichiatra che mi ha guarito, il professor Mari. Purtroppo è un po’ scomodo, abita a Modena. Ma è un medico eccezionale, molto sensibile. Sa come risolvere questi casi. Con me ha compiuto un miracolo. Guardami! Dormo, rido, sto bene, e mangio anche troppo. Vedi che ho messo su perfino la pancia! » Fece una piroetta e la sua pancetta annui sobbalzando. 120 Il Morbo di Monduz Mi scappò da ridere. Era la prima volta, dopo mesi, che sentivo il sapore dimenticato della speranza. Mi precipitai a casa per telefonare a questo dottore. Era molto impegnato, ma quando sentì come stavo, mi dette appuntamento per quel giorno stesso. Corsi alla stazione a prendere il primo treno per Modena. La mia speranza cresceva a ogni chilometro. Il professor Mari era davvero un medico straordinario. Infondeva una serenità senza pari. Spesso agli psichiatri manca qualche rotella. Questo era diverso. Mi ascoltò con molta attenzione, poi mi pregò di non preoccuparmi, di casi del genere ne aveva visti parecchi, anche più gravi. «E si guarisce?» chiesi trepidante. «Certo che si guarisce, eccome!» E scoppiò in una bella risata. Già il fatto di sentirmi in folta compagnia mi dava sollievo. Non ero più solo al mondo con la mia disperazione. Il caso era contemplato e c’era una via d’uscita. Mi dette dei tranquillanti, dei consigli e un appuntamento due giorni dopo. Feci la spola per tre settimane tra Bologna e Modena. Ogni volta mi sentivo un po’ meglio. Ero un tantino rimbambito, però riuscivo a dormire. Avevo perso pressoché totalmente la mia prodigiosa memoria, ma forse era un bene, in quella circostanza. Il cervello si era rallentato, mi sentivo un po’ ottuso, ma stavo meglio. «Non si sta poi tanto male, a essere rimbecilliti» pensai. « Ora mi accorgo come si deve sentire normalmente la maggior parte degli uomini! » Mi scappò da ridere. Era la mia prima cattiveria, dopo tanti mesi di autoflagellazione. Cominciavo a riconoscermi. Stavo davvero guarendo. In quei giorni mi giunse la notizia che Cosetta si era sposata con l’ultima persona al mondo che avrei sospettato: un signore rispettabile e anonimo, sponsorizzato dai genitori di lei. Donne e dolori 121 « Così, la fanciulla ha messo la testa a partito » mi dissi. « Ha messo la testa a partito e ha trovato un partito » aggiunsi, per esorcizzare l’ansia con un gioco di parole. Stranamente, quella notizia non mi colpì come avrei immaginato. Era come se Biancaneve avesse sposato uno dei sette nani. La cosa non mi toccava. Io ormai appartenevo a una fiaba diversa: quella del Bello Addormentato nel Bosco che un bel giorno si risveglia, nonostante il bacio mortale della Principessina Rosa. Chi ha molto sofferto prima o poi si riscatta. Mi ritrovai un mattino a dimenticare la pillola e avere dormito lo stesso. Mangiavo di buon appetito. Mi guardai allo specchio e vidi una ruga che prima non c’era. Nell’amarezza del mio volto era spuntato un nuovo sorriso. A prima vista mi sembrava una cicatrice, ma mi ci sarei abituato. Avevo ventidue anni, ero libero, avevo pagato i miei debiti alle illusioni. Forse ero felice, certo levigato e tagliente come una lama. Piano piano avrei recuperato gli amici, lo studio, la sicurezza, le donne. Una lucida spietata durezza stava prendendo il posto ai sospiri. «L’amore per una donna sola - mi dissi - è una forma di fissazione. Del resto si è visto dai risultati. Questo amore monogamo è roba da donne. Solo le femmine ci si trovano a loro agio. Ma se accetti queste condizioni, fai il loro gioco. Ogni sesso ha i suoi obiettivi. Loro vogliono essere uniche. Le uniche donne di un vero uomo! Ma un vero uomo non ci sta a queste regole. Un vero uomo deve averne tante, di donne. Deve averne un pollaio!» Il Morbo di Monduz si stava manifestando in tutta la sua gravità. 122 Il Morbo di Monduz Donne e dolori Logiche di follia Quando la tua personale follia non si integra bene con quella degli altri, vieni classificato per matto. E questa etichetta non giova alla tua guarigione. Se non hai provato la follia, non sai cosa sia l’inferno. Pochi riescono a fare il percorso a ritroso per venirlo a raccontare. Quando accade, lo chiamano con un eufemismo «esaurimento nervoso». Ma è semplicemente una follia con il biglietto di andata e ritorno. Vuoi sapere che capita? Semplice. Un’idea, piccola piccola, cresce gradatamente nel tuo cervello. Quando ti accorgi che l’idea ti sta spodestando dal governo della tua mente, è già troppo tardi. A quel punto lei guida il tuo pensiero e fa il bello e il cattivo tempo. Contrastarla dall’interno è sempre più difficile, perché l’idea succhia le tue forze. Tu sei spossato e in sua balìa. Così ti rivolgi agli esperti. Peccato che loro, spesso, siano ancora più gravi di te. Cercano di sostituire il tuo morbo col loro. Le medicine mal combinate completano il quadro. Ti istupidiscono fino a ridurti un vegetale. Ma è meglio che niente: gli ortaggi non soffrono. La memoria, te la puoi scordare. È tanto se ricordi il tuo nome. II male è dentro di te, è tutt’uno con te. Non puoi sfuggirgli: il male sei tu! Conti i minuti della tua sofferenza, in un incubo senza contorni dove sonno e veglia convivono confusamente. Ti lasci vivere senza illusioni. Sprofondi in un gorgo che non ha fine. Ormai sei rassegnato a staccare la spina, quando vedi confusamente, lontano, una luce. È una speranza in camice bianco. Ha il volto di un uomo, ma è un angelo che ti viene in soccorso. Ti prende per mano. Tu ti fidi di lui. E piano piano esci dal tunnel. Ritorna il sorriso. Gli inferi sono stati domati. Lucifero ha perso un cliente. Torni alla vita. Ora sì che l’apprezzi davvero. Solo chi è sfuggito all’Inferno, può apprezzare il Paradiso. 123 Via Zannoni Al tempo del mio esaurimento nervoso, avevo abbandonato il trappolo di via Guelfa. Una volta ristabilito, affittai una bella mansardina di via Zannoni, in società con Alfredo. Era il socio ideale per dividere un trappolo. In situazioni del genere, il rischio peggiore è l’affollamento. Con Alfredo il problema non c’era. Pochi amici offrivano così ampie garanzie di un uso morigerato. La mansarda era al quarto piano, senza ascensore. Ma i suoi sessantotto gradini non ci avrebbero dato fastidio, se gli inquilini dei piani di sotto non avessero avuto il vizio di curiosare quando salivamo le scale con una donna. Questi vicini erano di un moralismo asfissiante (o era invidia, la loro?). Comunque fosse, in principio qualcuno telefonò alla proprietaria per lamentarsi, sperando che ci avrebbe messo alla porta. Invece, quella simpaticona, che ci voleva un gran bene, li mandò a quel paese: «Ebbene? Vanno su con delle ragazze?! Fan bene! Se non si divertono adesso, che sono giovani!? Quando saranno arrivati alla mia età, vedrai che smetteranno di certo! » Così ci spronava a darci da fare, finché si era in tempo. Nel trappolino di via Zannoni c’era finalmente un vero riscaldamento con stufetta a gas di città, bagno con acqua corrente, telefono e filodiffusione: una sciccheria! Avevo provveduto personalmente al mobilio e agli accessori, con incredibile pignoleria. Inconsciamente, cercavo di compensare le mie manchevolezze amatorie sofisticando l’equipaggiamento del trappolo. Un giorno sarebbe stata quella la sede del miracolo tanto atteso. 124 Il Morbo di Monduz Donne e dolori La prima volta L’orgasmo - quest’incrocio tra uno starnuto e uno sbadiglio, con una marcia in più è l’istante che separa il desiderio di possederla dal pensiero di doverla riaccompagnare a casa. Era la sera di Santo Stefano. Sarei andato a Cortina il giorno dopo. Veramente avrei voluto esserci già, ma i miei non ci avevano sentito da quell’orecchio. Natale era Natale: dovevo passarlo in famiglia. Dopo due giorni di pranzi, satollo fino alle lacrime, telefonai ad Alfredo per andare al cinema insieme. Anche quella era una tradizione consolidata da anni. Finivamo per imbucarci regolarmente in una di quelle sale «a luci rosse» di allora, dove proiettavano film scollacciati che oggi passerebbero lisci nei cinema parrocchiali. Alfredo aveva un impegno. Doveva uscire con una ragazza. Perbacco, pensai, si sta dando una smossa anche lui! Non dovevo essere da meno. Passai in rassegna la mia rubrica, cercando una ragazza da portare fuori. Floriana era in casa, sconvolta dagli eccessi del suo pranzo natalizio. Boccheggiava tra vecchi parenti e prospettive infauste di una tombola in famiglia. Fu ben lieta di evadere. Scegliemmo un film di James Bond in seconda visione. C’era la riduzione Enal, in casi del genere. Ne approfittavo per avere lo sconto, anche se non mi ero mai sognato di fare la tessera. Di solito la maschera non ci badava. Quella volta, invece, in uno slancio di zelo, mi chiese di tirarla fuori. Inscenai una bella pantomima per salvare la faccia. Feci l’atto di cercarla in tutte le tasche, chiesi a Floriana se l’avesse lei; aggiunsi che, anche se me l’ero dimenticata, non era il caso di mettere in dubbio la mia buona fede. 125 Quel cocciuto non volle mollare: niente tessera, niente tariffa ridotta. Dovevo pagare la differenza. Non avrei accettato quell’umiliazione neanche morto. Visto che non si fidava, mi feci restituire i miei soldi, offesissimo. Uscimmo dunque dal cinema, io che mi tenevo la pancia dal ridere, Floriana che si vergognava come una ladra. Ormai di cinema c’era passata la voglia. Dove si poteva andare? Neanche a farlo apposta, eravamo a due passi da via Zannoni. Potevamo fare due chiacchiere e sentirci un po’ di musica. Ero tranquillo: non avevo alcuna intenzione di cimentarmi in tentativi infruttuosi. Ormai sulla questione della virilità ci avevo messo una pietra sopra. Ci stravaccammo sul mio lettone morbido e kitsch tutto foderato di pelliccia di agnello. Accesi la filodiffusione, poi, soprappensiero, le diedi un bacetto. Mi capitò un fatto insolito e miracoloso: un’energia sconosciuta mi scosse nelle più intime fibre. Tornai a darle un bacio. La misteriosa forza era ancora lì, all’altezza della cintura, più vitale di prima. Era un’idea precisa, un desiderio irrevocabile. Qualcosa in me che si affermava con forza, con rabbia, con rancore. Iniziai a svestire Floriana in modo automatico, senza cambiare posizione, temendo che un minimo gesto sbagliato potesse revocare il miracolo. Floriana opponeva soltanto una debole resistenza formale, forse era consapevole della magia del momento. Cominciai a spogliarmi anch’io, come un’automa. La situazione reggeva, incredibile! Il mio corpo era lì, vivo, pronto a seguire i miei desideri, a precederli. Mi accorsi che stavo facendo l’amore con lei. Era strepitoso, fantastico. Mi lasciai cullare dalla spontaneità dei miei gesti. Non volevo pensare più a nulla. Straordinario. Arrivai fino in fondo. Cavolo, ci ero riuscito! Mi alzai dal teatro di quel trionfo, grondante di gloria. Non sapevo contenere la felicità. Andai al frigorifero a prendere una 126 Il Morbo di Monduz bottiglia di spumante. Brindammo all’amore, riflettendo sul motto: «post coitum homo tristis est». Tutte balle: «post coitum Monduz felix erat»! Mi parve opportuno ribattere il ferro finché era caldo. La seconda volta andò ancora meglio. Era fatta! Ero un uomo. Avevo superato anche il terzo punto del mio riscatto sessuale: dal lato psicologico e tecnico ero già pronto da un pezzo, ora avevo anche passato il collaudo. La mia vita, finalmente, sarebbe stata perfetta. Adesso dovevo recuperare le occasioni perdute. La castità era una cosa bellissima: l’avrei tenuta da parte per la vecchiaia. Care Marise di tutto il mondo, ero pronto per voi. Il Morbo di Monduz aveva via libera. Alla ricerca del tempo perduto A Cortina quell’inverno non ebbi più limiti, tranne quelli di tempo. Imbastivo relazioni con tutte le donne che mi capitavano. Nell’arte della seduzione cercavo l’assoluto, la perfezione. Scrutavo l’animo di ogni ragazza, cercando la chiave d’accesso al suo mondo emotivo. Ogni donna ha nascosto nella sua fantasia un sogno inconfessato: il mio obiettivo era centrarlo all’istante come un maestro di scherma. Sono tuttora convinto che, nella seduzione, i più importanti sono i primi cinque minuti. Quando una donna comincia a rifletterci, diventa tutto più complicato. Alle feste, non toccavo cibo e non bevevo. «Un cane da caccia va tenuto digiuno» mi dicevo «così aguzza il suo fiuto.» Guatavo la popolazione femminile con occhi da segugio, alla ricerca dello sguardo più malizioso. Poi, passavo all’attacco, frastornando le mie prede con chiacchiere e provocazioni. Donne e dolori 127 Dopo mezz’ora erano sedute al mio fianco sulla 500, e se non accettavano di salir subito nella mia stanza, all’hotel Solimbergo, non mi vedevano più. Non avevo tempo da perdere, dovevo recuperare troppi arretrati. Le mie conquiste si accumulavano, giorno dopo giorno. Ero arrivato ai doppi e tripli turni. Vivere alla grande Il business delle dispense All’università, anche per Anatomia avevo seguito la mia regola d’oro: non mi era sfuggito nemmeno un esame, compresi quelli dei fuoricorso. Avevo collezionato un grosso malloppo di appunti. All’esame mi avevano fruttato un bel trenta. Sarebbe stato un peccato buttarli via. Decisi di farne delle dispense. Mi chiusi in casa a riordinare quel materiale. Tre mesi di duro, appassionato lavoro. Completavo gli appunti con le nozioni dei testi, cercando di evitare le contraddizioni dov’era possibile, e li arricchivo di disegni approssimativi. Uscivo dalla stanza solo per mangiare e per sostituire le bottiglie di tè vuote. Mia madre ormai non faceva più caso ai miei ritmi. Del resto io non sono capace di fare altrimenti: quand’ho un progetto, vivo di quello. Non mi do pace finché non l’ho portato a termine. Alla fine di quella maratona, raccolsi i manoscritti e li presentai a Padova ad un noto editore di libri scientifici. Ero convinto che me li avrebbe pubblicati con entusiasmo. In fondo portavo credenziali ineccepibili: la qualifica di allievo interno e un trenta all’esame! La reazione dell’editore fu molto diversa da quella che m’aspettavo. Mi canzonò. «Uno studente che pretende di scrivere un libro di testo? Ma che velleità!» Mi consigliò di ripassare dopo 130 Il Morbo di Monduz vent’anni, con la libera docenza di Anatomia in tasca. Tornai a Bologna con le pive nel sacco. Pensai che forse avevo mirato un po’ in alto. Ripiegai su una piccola casa editrice di Bologna, specializzata in testi scientifici. La loro reazione non fu molto diversa. Tentai con una minuscola libreria editrice. Stessa storia: non si fidavano di uno studente. Tornai a casa inferocito. L’editoria era in mano a una manica di imbecilli. Avrebbero presto sentito parlare di me! Il mattino dopo m’iscrissi alla Camera di Commercio, come editore. Avrei fatto tutto da solo. Con i risparmi comperai un’Olivetti usata e due risme di matrici da ciclostile. Nello scrivere a macchina però, ero lento come una lumaca. Per impratichirmi, m’iscrissi a un corso di dattilografia. Ero l’unico uomo, fra tante ragazze. Meglio che ai tempi del cortile in via Orfeo! Le insegnanti erano incuriosite dalla mia presenza. Quando ne seppero il motivo, furono entusiaste. Era la prima volta che un editore veniva di persona a frequentare i loro corsi. Una bella rivincita per la categoria! Una volta imparato a battere svelto, con le dieci dita, mi chiusi in casa per scrivere a macchina il mio capolavoro. Dieci ore al giorno, senza tregua. Bruciavo del sacro fuoco. Le pagine crescevano a vista d’occhio. Solo per il sistema nervoso e la topografia erano già duecento. Mi fermai. Inutile trattare tutta l’Anatomia senza la certezza di venderla. Era venuto il momento di passare al ciclostile. L’acquistai d’occasione. Era un vecchio modello, a manovella, ma costava poco. Comprai cinque macchinate di carta, mi sistemai in cantina e cominciai a manovellare. Dopo due giorni mi era venuto un braccio da tennista. Quando non ce la facevo più con la mano destra, mi alternavo con la sinistra, poi, esausto del tutto, cucivo i fascicoli con la puntatrice, per riposarmi. Andai avanti così per due settimane. Uscii da quella cantina, nero d’inchiostro e felice. Avevo realizzato 500 copie Vivere alla grande 131 delle dispense, in due volumetti. C’era dentro tutto quanto il distillato del mio sapere. Ora veniva il più difficile: provare a venderle. Un mattino, verso le 11, stipai la mia 500 con tutte le copie che ci stavano e mi recai all’Istituto d’Anatomia. Ero in combutta con Gino, il mio fidato amico portiere, perché le vendesse agli studenti, quando fossero usciti, a mezzogiorno. Come già dissi, Gino abitava con la famiglia dentro l’Istituto. Gli riempii l’ingresso di casa di libri. Agli studenti del secondo anno che entravano in aula, distribuii un volantino in cui annunciavo: « finalmente le dispense sono arrivate! ». Da un pezzo si sapeva in giro che le stavo scrivendo. Gino stesso aveva astutamente sparso la voce. Me ne andai con la macchina vuota e il cuore pieno di speranza. Lungo la strada cominciarono a venirmi i primi dubbi: e se non fossimo riusciti a venderle? Ci avevo investito tutti i miei risparmi: che pazzia! Mi venne un brivido. Mentre rimuginavo, continuavo a guidare in modo automatico, lungo i viali di circonvallazione. Mi accorsi che stavo circumnavigando Bologna per la terza volta. Rientrai a casa, in preda all’ansia. Qualcuno mi chiamava a gran voce dall’alto. Era mia madre, dalla terrazza. «Gianni, vieni subito su, c’è Gino al telefono. Ha già chiamato due volte. È molto agitato, dice che ha bisogno immediatamente di te!» «Alé, son fritto,» pensai «sarà scoppiata una grana. Vuoi vedere che il professore si è arrabbiato? O peggio, non ci saranno storie con la Tributaria, per via della licenza di vendita?» Qualunque congettura si affacciasse alla mente, era funesta. Arrivai al telefono trafelato, col cuore impazzito, non so se più per le scale o per la paura di guai. Gino era visibilmente agitato e si sentivano strani schiamazzi di sottofondo. «Monduzzi, torni subito qui con un’altra macchina di dispense, 132 Il Morbo di Monduz sennò questi scalmanati mi sfondano la vetrata. Le copie che mi ha portato si sono polverizzate. Quelli rimasti senza sono fuori che spingono, dicono che le vogliono subito: domani è sabato e loro tornano a casa. Ma quel che è peggio, tra mezz’ora escono quelli del secondo turno e c’è da aspettarsi il finimondo!» Mi scoppiò dentro una gioia improvvisa, incontenibile. Mio padre era nello stanzino a fare esercizio con il clarinetto. Stava suonando un suo valzer. In preda a un raptus, saltai al collo a mia madre e la costrinsi a ballare quel valzer con me, sottolineandone il ritmo a squarciagola. La mamma rideva e gridava temendo di rotolare per terra. Il babbo, sentendo quel trambusto, era uscito dallo stanzino senza smettere di suonare: nulla lo avrebbe convinto a interrompere il pezzo. Sembravamo tre matti. Tre matti felici. «Se ci vedessero i vicini!» esclamò la mamma, con aria di compiaciuta disapprovazione. Mio padre cercava di trattenersi dal ridere, ma non ci riuscì: gli venne fuori una stecca esemplare. Si dovette interrompere. «Ma siete impazziti? Che c’è?» chiese. «C’è che sono ricco!» gli risposi. Quel giorno, aiutato da mio padre, feci altri tre viaggi. Ogni volta tornavo a casa con tascate di soldi. Non ne avevo mai visti tanti, tutti insieme. In una settimana avevo esaurito le copie. Detti le matrici da ristampare a una copisteria. Non era il caso di rimettersi a girare la manovella. Ero milionario. Era venuto il momento di fare follie. Cosa poteva fare un tipo come me, a poco più di vent’anni, trovandosi dalla sera alla mattina pieno di soldi? Mi presentai all’Alfa Romeo e ne uscii con una Duetto spyder nuova fiammante, autoradio stereo megagalattico. Feci visita a Minarelli, camiciaio proibito, e gli ordinai mezza dozzina di camicie su misura. Poi fu la volta della Casa dello Sport, in cui avevo osato mettere piede solo una volta, per comperare una Vivere alla grande 133 maglietta vera Lacoste. Ricordavo ancora l’aria trepida di quando ero entrato a chiedere un preventivo. Stavolta entrai con la sicurezza dovuta. Mi ero guadagnato il mio posto nel mondo. Dopo essermi rifatto il guardaroba, comperai due casse di champagne Veuve Cliquot, da Scaramagli. Caricai tutto sull’auto e partii per Cortina, dove presi in affitto il primo piano di una villetta a Pezié, per tutto il periodo invernale. Al piano di sotto ci abitava una signora in pensione che si offri di sbrigarmi le pulizie. Depositai le mie masserizie e il mio impianto stereo. Sistemai sul letto la coperta di agnello, accessorio che aveva favorito i miei primi successi amorosi in via Zannoni (da allora mi seguiva ovunque, come la coperta di Linus). Mi istallai in modo permanente, deciso a strappare alla vita la stagione migliore. Cortina davvero! In tre mesi, dissipai tutto il mio patrimonio, senza rimpianti. Mi era scoppiata una gran voglia di vivere. Ero piombato su quel felice paese con l’entusiasmo di uno squilibrato tenuto per anni in camicia di forza. Mi sentivo padrone della mia vita. A differenza degli altri ragazzi in vacanza a Cortina, non avevo illustri natali. In compenso ero l’unico ventenne senza un ricco papà a cui rendere conto. Mio padre, facendomi nascere con pochi mezzi, mi aveva fatto il regalo di farmi nascere libero. Descrivere «quella» Cortina è quasi impossibile. Non era una stazione di villeggiatura, ma uno stile di vita; non una località, ma un sentimento. Noi pochi privilegiati, che ci stavamo i tre mesi invernali senza interruzione, avevamo una cosa in comune: zero pensieri per il domani. Ci bastava il presente e quei 1000 metri di altitudine, da cui sovrastare la vita degli altri rimasti in città a studiare o a lavorare. 134 Il Morbo di Monduz La vita quotidiana non aveva orari o luoghi fissi. Restavamo dove ci pareva, finché ci piaceva. Le compagnie cambiavano e sciamavano, ma un solo punto era di riferimento per tutti: la nostra sede sociale, l’«ufficio», come lo si chiamava, il «King’s». Come si fa a spiegare il King’s a uno che non c’è mai stato? Chiamarlo discoteca suonerebbe un insulto. Un ristorante? Un piano bar? Un salotto? Il King’s era tutto questo e altro ancora. Era un ecosistema, quel grande fienile ristrutturato. Entro le sue magiche pareti di legno secolare, sui puff di vero montone, sotto quelle luci oblique nascoste fra le travi, chiunque si trasfigurava, subiva una metamorfosi. L’atmosfera, quella percezione impalpabile che si cerca invano di ottenere nei locali notturni, lì era cucita addosso alle pareti. Il King’s era sempre affollato di belle donne. I loro sorrisi scoccavano quando passava Matteo, «tombeur de femmes» ufficiale; languidi sospiri volavano verso Gianni, poeta cantautore per poche intime. Billo era un’esplosione di simpatia, piccolo e rotondo come il soprannome. Sergio lavorava come disc-jockey, ma la sua era soltanto una copertura per conoscerle tutte. Assieme ad altri due o tre, avevano costituito una combriccola di professionisti della seduzione. Si erano consorziati tra loro, per avere il massimo risultato col minimo sforzo. Passavano la vita da un posto di villeggiatura all’altro. Vivevano con pochi spiccioli nelle località più esclusive. D’inverno a Cortina e d’estate in Sardegna. Abitavano insieme in un’enorme villona un po’ sbilenca, con molte stanze. Ospitavano sempre ragazze stupende e io ne ero sconvolto. Non mi era ancor chiaro, allora, il quadro patologico del Morbo di Monduz. Quelli erano ammorbati di prima categoria e avevano costituito una loro clinica specializzata, a Cortina. Le donne più stupende toccavano a loro. Non ne avevo mai viste tante, tutte insieme. Purtroppo erano fuori della mia porta- Vivere alla grande 135 ta. Restavo sbalordito dal loro successo. Li guardavo con invidia ammirata. Per quanto li studiassi, non riuscivo a impadronirmi del loro segreto. Non avevamo orari. Però ci alzavamo tardi, la mattina, salvo i casi in cui non si andava a letto del tutto. Vedevi certi sonnambuli sugli sci, che rotolavano giù per le piste: erano zombie che non volevano rinunciare allo sport, dopo notti bianche di bagordi. La prima colazione aveva luogo al Caminetto: un’unica tavolata, al sole, in mezzo alla neve. Ci conoscevamo tutti. Passavamo di tavolo in tavolo facendo assaggi nei piatti degli altri. Qualcuno si schifava un po’, vedendosi pescare dalla scodella, ma cercava di non darlo a vedere. Gli schizzinosi non erano graditi. Di pomeriggio, ognuno andava per conto suo. C’era chi faceva «visita» a qualche signora momentaneamente senza marito, e chi diceva di farla ma andava a dormire. Un caposaldo della vita mondana era l’appuntamento generale al Posta, ufficialmente per l’aperitivo, in realtà per mettere a punto i programmi notturni. Da un amico ne conoscevi un altro. Stando a Cortina per mesi, alla fine conoscevi tutti, con indubbio vantaggio strategico: ogni sera avevi decine di opportunità tra cui scegliere. Per la cena era facile trovare una compagnia femminile, ma c’era il pericolo di farsi scaricare, dopo mangiato. A volte la tua dama si dileguava nei meandri del King’s senza lasciare traccia di sé. Ogni bidone era ammesso. La regola era non aprire bocca, se venivi beffato. Protestare ti avrebbe reso ridicolo. Questo vezzo di scaricare con disinvoltura i cavalieri, a saperla sfruttare, presentava i suoi vantaggi. Mi era capitato di combinare anche con tre differenti ragazze, dalla cena all’alba. Purtroppo, un’ignota vicina di casa disapprovava questa mia pratica dei «tripli turni». Mi telefonava indignata ogni volta che arrivavo a 136 Il Morbo di Monduz casa con una nuova compagna. Lei minacciava di chiamare i carabinieri, e io la provocavo invitandola a unirsi al nostro festino. Dopo il terzo turno, con il sole che ormai saliva all’orizzonte, prima di andare a letto in modo definitivo, facevo ancora un giretto per le strade, come un segugio, sperando di agguantare qualche sconvolta che si fosse persa sulla strada di casa. Era un vizio più forte di me. Il Morbo di Monduz si era aggravato. La Société Internationale des Trapoles La nostra vita cortinese ebbe sviluppi piacevoli anche fuori dei suoi confini geografici. Sarebbe stato un peccato perdersi di vista, una volta finite le vacanze, quando ciascuno fosse tornato a casa sua. Avevamo dunque costituito un consorzio di amici di varie città. Requisito indispensabile: il possesso di una garçonnière. Max a Milano, Giovanni a Roma, Manuel a Venezia, Leo a Firenze, io a Bologna: ognuno aveva messo a disposizione il suo «trappolo». Tutti noi avevamo un portachiavi con la sigla «S.I. D.T.» che non aveva nulla a che fare con i Servizi Segreti. Stava per «Société Internationale des Trapoles»! I membri potevano peregrinare per mezza penisola e partecipare a feste e combriccole, disponendo di un pied-à-terre in loco. In questo modo, ci eravamo procurati una ragazza per ciascuno, in ogni città. A turno, andavamo a visitare le nostre «fidanzatine di zona». Barbara Barbara era una ragazza geniale, non solo carina, ma dotata di una simpatia che la trasfigurava. Una di quelle donne affascinan- Vivere alla grande 137 ti che vengono male in fotografia. Fissata in un fotogramma, era morta, come una farfalla in cornice. li movimento la rendeva bellissima. Era un tipo alla Liza Minnelli. Quando la conobbi, era appena uscita da una situazione sentimentale opprimente. Era stata con lo stesso ragazzo dai quattordici ai vent’anni. Costui l’aveva coltivata a scopo di matrimonio, come si alleva una gallina per il consommé di Natale. Lui se ne usciva con gli amici la sera e teneva lei da conto per metter su un giorno famiglia. Barbara non era tagliata per la professione di «onesta massaia». Quando lui aveva proposto il matrimonio, lei era fuggita a gambe levate. Le era scoppiata un’impressionante voglia di vivere, come rimbalzo degli anni di vita claustrale. La sua strada si incrociò con la mia quand’ero all’apice della mia esplosione di libertà. Io mi davo le arie di incallito playboy e lei si atteggiava a donna vissuta. Mise subito le cose in chiaro: «Non farti strani progetti, su di me. Sono una donna sentimentalmente appagata. Sto con un uomo sposato. Una condizione ideale, per godersi la vita. Ho molti amici. Se vuoi, c’è posto anche per te.» «OK, è quello che cerco» mi dissi. «Una donna, come amico, per fare follie.» Sperimentammo il nostro sodalizio una sera, andando a una festa di Carnevale da Mario. Sul travestimento non c’erano dubbi. Günther Sachs e Brigitte Bardot si erano appena sposati, dando molto daffare ai rotocalchi. Un playboy e una playgirl come noi non potevano che assumere le loro sembianze. Mi affidai a una truccatrice teatrale, che si sbizzarrì con basettoni posticci, fondotinta, lenti a contatto e ogni orpello utile a farmi sembrare un playboy modello anni Sessanta. Barbara non fu da meno: si presentò con una scollatura abissale e uno spacco alla gonna da perdere il fiato. Alla festa ci impegnammo a fondo nell’interpretazione dei nostri ruoli. Io ne ap- 138 Il Morbo di Monduz profittai per raccogliere una dozzina di indirizzi di donne, lei non so, però civettò per tutta la sera, come una forzata della seduzione. Ogni tanto veniva a darmi un puffetto, perché non mi dimenticassi che ero il «suo maritino». Per la premiazione della coppia migliore Mario aveva fatto le cose in grande: le coppie dovevano sfilare in passerella, sotto l’occhio di una cinepresa che avrebbe filmato la scena. Quando fu il nostro turno, mi parve che un bacio fosse il gesto più appropriato, per una coppia di seduttori. Fu il nostro primo bacio, un bacio vero, sotto gli occhi di tutti; rimase immortalato in una filmina. Poi, per tutta la sera, ci comportammo come se niente fosse accaduto. Al ritorno, sotto casa sua, eravamo sulle spine: né io né lei sapevamo che piega dare alla nostra vicenda. Davanti al portone, la salutai porgendole la mano. Stava già per salire, quando la richiamai indietro, per baciarla senza alibi cinematografici. Nel nostro strano rapporto, l’amicizia continuò comunque a prevalere. Ci divertivamo molto alle spalle degli altri. Andavamo insieme a tutte le feste, come amiconi disponibili alle avventure: ci presentavamo insieme, ma poi stavamo ciascuno per conto suo. Ogni tanto ci scambiavamo una strizzatina d’occhio, o ci rifugiavamo in toilette, per un rapido bacio. Era più divertente che rubare la marmellata. Lei trovava sempre qualcuno per civettare, ma poi le cose si arrestavano lì; io raccoglievo nominativi per la mia rubrica, e spesso le cose non si fermavano li. Barbara non se ne dava pensiero, la gelosia era bandita fra noi. In amore lei si dava arie di donna vissuta, però quando eravamo al dunque, nel mio trappolo di via Zannoni, cercava sempre di scantonare. Una sera, che la trascinai sotto le lenzuola, ebbi la sorpresa di scoprire che era la sua prima volta! A quei tempi era facile che una ragazza raccontasse bugie su quell’argomento, ma Vivere alla grande 139 di solito erano bugie opposte a quelle che aveva raccontato Barbara. Fu un regalo inaspettato. Le confessai che anch’io avevo bluffato. Dopotutto, lei era soltanto la seconda donna importante della mia vita! Facemmo l’alba a tirarci cuscini, accusandoci reciprocamente di falsità, correndo semivestiti per tutta la casa, provocando aspri risentimenti negli inquilini del piano di sotto, che picchiavano sul soffitto come dannati. Tutti i week-end li passavamo al mare insieme. Lei aveva solo vent’anni, ma era una donna molto evoluta, si manteneva da sola e faceva quel che voleva, cosa abbastanza rara per una ragazza, negli anni Sessanta. C’è un fotogramma del nostro rapporto che mi è rimasto impresso nella memoria. In un pomeriggio di sole andiamo insieme da Rimini a San Marino, sulla mia Duetto spyder nuova fiammante. L’impianto stereo è a tutto volume. Lei ha un foulard e io i capelli scompigliati dal vento. Andiamo forte, ubriachi di velocità. Due strambi sognatori felici: lei si sarà sentita Isadora Duncan, io mi sentivo James Dean. Per un attimo ebbi la sensazione di vivere un frammento d’eternità. Girai lo sguardo verso Barbara: «Si dice che quando uno è felice non se ne accorga. Non è vero. In questo momento io so con certezza di esserlo.» Lei mi si strinse contro, in uno slancio di gratitudine. Quella ragazza! Mi regalava la felicità e me ne era grata. Ogni volta che ho raggiunto la massima beatitudine, non l’ho saputa conservare. Forse non me la meritavo. O più semplicemente ho proseguito nell’escalation della felicità, per verificare il suo limite. Il Morbo di Monduz è anche l’eterna lotta del bene col meglio. Quando il sovraccarico di felicità supera il consentito, si spezza la fragile impalcatura che la sostiene e, purtroppo, si cade dal pero. 140 Il Morbo di Monduz Barbara faceva l’interprete. L’azienda in cui lavorava le offrì un trasferimento in Germania, nella filiale di Francoforte. Era molto tentata. L’unica cosa che la tratteneva era di doversi staccare da me. Me ne accennò, come di un progetto bizzarro. Voleva un mio parere, o meglio, voleva mettermi alla prova. Le donne hanno la brutta abitudine di tendere al loro uomo trabocchetti del genere. Chiedono pareri, ma si aspettano una determinata risposta. Se dai una risposta diversa, se la legano al dito. A me sembrava una bella idea che lei se ne stesse un po’ in Germania. Il nostro rapporto cominciava, per forza, a diventare una routine. La sua lontananza mi avrebbe restituito il piacere dell’avventura. La amavo, ma il mito della libertà era più forte, per me, dell’amore. Quando Barbara partì, la accompagnai alla stazione. Era tristissima. Cercavo di tenerle alto il morale facendo il buffone. Lei rideva piangendo. Certe situazioni ti spezzano il cuore. Ma il mio cuore si era già spezzato un anno prima e si era riaggiustato benissimo. Ormai mi ero accorto che, nella vita, il mio unico compagno fisso di viaggio ero io. La libertà! Bella parola. Però, arrivato alla stazione, la mia libertà non valeva tre soldi. Non l’avevo ancora lasciata e già mi mancava. Saltai sul treno con lei. Era un rapido e fermava solo a Milano. Per tutto il viaggio la coprii di baci. A Milano mi detti un contegno. Con un sorriso da duro e la morte nel cuore me ne andai alla Humphrey Bogart, senza voltarmi indietro. Il giorno dopo ero a tavola con i miei, quando suonò il telefono. Mia madre odiava le interferenze con le sue esibizioni di cuoca. Sbottò: «Sarà senz’altro per te! Fai presto, che si raffredda!» Era una telefonata da Francoforte. Barbara diceva che le mancavo. Si era sentita sola, nella sua mansardina in «Crucconia», come la chiamava lei, alla periferia di Francoforte. Vivere alla grande 141 Era un giovedì e l’indomani non lavorava. Aveva davanti tre giorni di libertà. Peccato che io non ci fossi... «Quando ci vediamo?» flautò. E io: «Va bene stasera?». «Dài, non prendermi in giro!» «Facciamo alle nove. Prenota un ristorante romantico e dammi l’indirizzo. Adagio, che non capisco un’acca di tedesco.» Dovevo trovare un alibi per i miei genitori. Il tragitto tra la mia stanza e la sala da pranzo fu sufficiente. «Era Lanfranco. C’è una festa galattica in campagna da sua cugina Elisabetta. Tre giorni d’amore e follia. Ho un lavoretto lasciato a metà con un paio di tipe che non vorrei proprio perdere. Uhm, buone le tagliatelle. Peccato che non ci sia tempo. Scusatemi, scappo subito, sennò perdo il tram! » Mia madre mi guardò allibita. A mio padre scappava da ridere. Le tagliatelle aspettavano fumanti nel piatto. I miei non si erano ancora ripresi che ero già in strada alla ricerca di un taxi. Le mie spoglie terrene erano ancora in via Buttieri, ma il mio spirito era a Frankfurt-am-Main. Durante il ritorno da Milano, il giorno prima, avevo studiato gli orari dei treni e dei voli e sapevo tutto sulle coincidenze. C’era un rapido, che partiva da Bologna giusto alle 13.30 o giù di lì, comunque in tempo utile per prendere il volo Milano-Francoforte delle 18. Dall’aeroporto di Francoforte in tre quarti d’ora di taxi sarei arrivato in città. Non avevo previsto che i posti fossero esauriti. A Linate, dovetti rassegnarmi alla lista d’attesa. L’assistente di volo mi avvisò che in seconda classe non avevo speranze: c’erano più di trenta persone prima di me. Trattenni il fiato e chiesi quanto costasse la prima. Mamma mia, che salasso! Arrivai a destinazione nel modo più costoso possibile, ma puntuale come un cronometro. Alle otto e mezzo suonavo alla porta. Un minuto dopo, Barbara, raggiante di felicità, era seduta 142 Il Morbo di Monduz davanti a me, in un ristorantino tipico di Sachsenhausen, con sottofondo di balalaike. Fu la prima delle mie numerose spedizioni a Francoforte, città che non sono mai riuscito a vedere. Dopo cena non avevamo voglia di ammirare il paesaggio. Stavamo tutto il tempo fra le lenzuola, salvo brevi pause per mangiare le sue terribili zuppe Campbell e quei filetti con champignon che sembravano di polistirolo. Un pomeriggio Barbara mi volle mostrare la Cattedrale sul Meno. Stavamo con la mano nella mano in mezzo alla piazza assolata. Avrei voluto che il sole si fermasse, per non interrompere la nostra felicità. E per un attimo mi parve che il sole si fosse fermato davvero. Non riuscivo ad acquietarmi. La curiosità, la ricerca di nuove esperienze mi portarono in rotta di collisione con Barbara. Pensavo che stare con una sola donna fosse una specie di tradimento verso tutte le altre: il Morbo di Monduz non mi dava tregua. Per Carnevale la feci grossa: partii per Cortina con due amiche, incaricando mia madre di cercare una scusa, se per caso avesse telefonato Barbara. Mia madre non era il tipo giusto per queste incombenze. Chissà cosa inventò! Fattostà che Barbara scoprì l’imbroglio. Al ritorno, nella posta, trovai due lettere dalla Germania. Nella prima c’erano appassionati messaggi d’amore, nell’altra un secco commiato. Le telefonai, ma Barbara non voleva parlarmi. Era tardi per l’ultimo aereo. Saltai sull’auto e partii. Mia madre, sulla soglia di casa, aveva i capelli dritti. Bologna-Francoforte senza scalo è un bel viaggetto: undici ore distribuite su mille chilometri. Arrivai che albeggiava. Nell’atto di suonare alla porta di Barbara pensai che poteva essere «in compagnia»: che thrilling! Invece, fortunatamente, era sola. Mi regalò gli ultimi due giorni d’amore. Ma poi fu inflessibile. Era finita. Vivere alla grande 143 Tornai a casa, felice e disperato. Le scrissi, le telefonai, ma lei mi impose il black-out. Barbara voleva essere la mia unica donna. Era la sua versione del Morbo. Due paranoie si erano confrontate. Se avesse vinto quella di lei si sarebbe formata una coppia. Ma il mio Morbo era troppo forte. Non avrei mai rinunciato, per una donna, a tutte le altre. «Ci risiamo» dissi a me stesso, e prima di attendere ulteriori sviluppi, presi un appuntamento col professor Mari. Il nuovo esaurimento nervoso fu una bazzecola, rispetto al primo. Ormai mi ero impratichito. Dopo l’episodio di Barbara, ero tornato alla vecchia determinazione di non cascarci mai più. Avevo compreso che, nei sentimenti, l’unico modo per non avere un padrone, era di averne molti. Dovevo diversificare il rischio affettivo, e quindi accaparrarmi quante più donne possibile. Con metodo e impegno, ripresi a collezionare ragazze. Custodivo la lista in un cassetto segreto. Avevo ancora affinato le mie armi, mettendo a punto diaboliche strategie. Truccacci ignobili per convincere le donne Scrivilo a matita il nome di ogni donna sulla tua rubrica. Così ti basta una sgommata, per cancellarla via dalla tua vita! Al telefono, con una che non senti da anni Pronto, sei tu..., stupenda donna dagli occhi tondi? Non hai gli occhi tondi? Forse allora è la mia memoria. Da mesi non faccio che pensarti... la tua immagine, a forza di girarmi nel cervello, dev’essersi arrotondata, come fanno i sassolini nell’alveo di un fiume, girati e rigirati dalla corrente. Biso- 144 Il Morbo di Monduz gna che ci vediamo al più presto, non vorrei ricordarti tutta rotonda come una palla! Cosa fai stasera? La casa da inaugurare (da ripetere all’infinito) Ciao, carissima! Lo sai che ho preso un nuovo trappolo? L’ho appena finito di arredare. È stupendo, almeno a me sembra. Adesso però bisogna collaudarlo. La cucina, ad esempio: ci sarà proprio tutto quello che serve per una cenetta? E, in bagno, non mancherà qualche accessorio? Vedi, io sono superstizioso. Sono convinto che la prima donna a entrare nel trappolo ne segnerà il corso storico. La prima è fondamentale: traccia la rotta, dà la sua impronta al futuro. Sarebbe di buon auspicio che fosse stupenda. Insomma, vorrei che fossi tu. Te lo chiedo in nome della nostra amicizia. Mi porterai fortuna, lo sento. Così il trappolo prende confidenza con la bellezza. E poi... se in futuro ci capitasse una bruttina, be’, mi consolerei pensando a te! La poesia riciclata Mia cara, dentro questa busta, troverai una busta più piccola: aprila adagio! C’è dentro una poesia, che ho scritto pensando a te. Leggila tutta di un fiato e bruciala subito, affinché questi versi, che mi hai ispirato, tornino per sempre al mittente senza lasciare traccia. Nessun’altra donna ha letto questa poesia, nessuna dovrà leggerla mai. Resterà un segreto fra me e te. La poesia si interrompe... non è finita... le ultime strofe possiamo solo scriverle insieme... (fotocopiata in numerosi esemplari, non numerati) Abbordaggi Scusi, signorina, potrebbe indicarmi la strada più breve per arrivare a conoscerla? Vivere alla grande 145 Il business cresce Esaurita la prima edizione delle dispense, avevo affidato le matrici a una copisteria e mi ero messo a vivere di rendita, con i profitti delle ristampe. Ma gli studenti si passavano i fascicoli usati, compromettendo il mio business. Dovevo pubblicare qualcosa di nuovo. Giancarlo era diventato un brillante interno di Otorinolaringoiatria. Lo incaricai di raccogliere appunti di quella materia. Io avrei cercato di piazzare le dispense di Anatomia in altre sedi universitarie. A Pavia ottenni i primi successi. Da una visita preliminare m’ero accorto che il mercato era promettente. Tornai sul posto con l’auto carica di libri e di dépliant pubblicitari. Avevo ideato una manovra «a tenaglia»: distribuivo i volantini agli studenti che entravano nell’aula di Anatomia, poi li aspettavo all’uscita con le dispense sopra un banchetto. Quei simpatici goliardi compravano a tutto spiano. Mi sentivo come una rock star assediata dai fans! I migliori risultati li ebbi in Sicilia e Sardegna. Trovai bidelli intraprendenti e professori di ampie vedute. Quelle stupende isole erano predisposte naturalmente alla mia penetrazione commerciale. Non mi fu difficile formare una rete di distribuzione alternativa, dentro istituti e cliniche. II sistema funzionava a puntino. Mia madre riceveva gli ordini per telefono e mio padre preparava le spedizioni in cantina. Un’impresina familiare in piena regola. Nel frattempo Giancarlo aveva raccolto gli appunti di otorino, che ebbero grande successo. Far scrivere gli altri era una gran bella trovata. Cominciavo ad apprezzare il mestiere dell’editore. Cercai studenti a cui affidare nuove materie e in un anno realizzai dieci nuove dispense. 146 Il Morbo di Monduz La distribuzione attraverso i bidelli mostrava dei limiti. Dovevo rivolgermi alle librerie. Cominciai a visitarle a tappeto, armato di piantine e pagine gialle di mezz’Italia. Dopo scarpinate solenni, la sera, in albergo, compilavo una scheda per ognuna di esse: posizione, vetrine, reputazione del titolare. In ogni città visitavo i docenti delle materie principali e raccoglievo ogni sorta di notizie e impressioni che schedavo accuratamente. Qualsiasi informazione poteva rivelarsi utile per i miei progetti editoriali. Era impossibile convincere i professori ad adottare le mie dispense. Erano bruttine e mal fatte, e poi non rispondevano alle esigenze didattiche. Perché non ne scrivevano loro, di nuove? Gliele avrei pubblicate senz’altro. Quell’idea li tentava, ma nutrivano dubbi sul credito della mia casa editrice. Non potevo confessare che l’editore ero io: avevo poco più di vent’anni! Per riuscire più persuasivo, fingevo di essere figlio dell’editore Monduzzi. Non bastava. Anche il mio catalogo, tirato col ciclostile, contribuiva ad accrescere la loro diffidenza. Per uscire da quell’impasse, stampai un bel catalogo in tipografia. Conteneva una dozzina di titoli in tutto, ma all’esterno sembrava quello di Zanichelli. Mancavano i titoli accademici degli autori. Poteva sembrare una forma di discrezione; in realtà erano tutti studenti. Nemmeno il catalogo elegante bastò. Quei malfidati dei professori volevano vedere qualche libro già pubblicato. Messo alle strette, cercai un espediente per uscire di stallo. Presi un volume di fisica di un grande editore. Era un libro poco diffuso, ma graficamente elegantissimo. Gli staccai il frontespizio e la copertina, che ristampai con qualche modifica: il nuovo editore ero io! Il mio legatore completò il lavoretto, confezionando un volume insospettabile. Quello stratagemma fu miracoloso. Ai professori dicevo di essere andato a visitarli su segnalazione dei consulenti di mio padre, Vivere alla grande 147 l’Editore. La loro reputazione era giunta fino a Bologna, la dotta! Mi chiedevano il catalogo, e tutto filava liscio. Quando poi tiravo fuori dalla valigetta il mio libro truccato di Fisica, «Uno qualunque del catalogo, nemmeno il più bello...», era fatta. Cominciarono a fioccare i contratti. Ero diventato un editore davvero! Non tutto il merito di quei successi spettava a me. L’origine emiliana favoriva le mie relazioni personali. A Bologna il mondo della produzione, che fa capo a Milano, s’incontra con quello della seduzione, che ha sede in Roma. Il Nord non ha stima del Sud e il Sud non ha simpatia per il Nord: Bologna sta in mezzo, e piace un po’ a tutti. Con i librai avevo elaborato una mia strategia. I loro negozi erano tutti nella zona universitaria, a pochi passi uno dall’altro. La concorrenza era spietata. Lo sconto era l’unico mezzo per attirare la clientela, e gli studenti se ne approfittavano. Giravano tutte le librerie, alla ricerca del prezzo migliore. Così, i guadagni dei librai si riducevano. Volli «moralizzare» il mercato a mio vantaggio. Unico, fra tutti gli editori, dimezzai le normali provvigioni ai librai. Non facevo altro che incamerare lo sconto che quelli praticavano agli studenti. Costretti a vendere a prezzo pieno, i librai non ci avrebbero rimesso una lira, ma erano infuriati ugualmente: lo ritenevano un affronto alla categoria. Però si dovevano rassegnare: i miei testi erano adottati dai professori. Li avevano scritti loro. Tutte le volte che incontravo un libraio era guerriglia. La malattia dello sconto è incurabile. Per evitare discussioni, avevo trovato un espediente. Mi presentavo come un semplice rappresentante della Monduzzi Editore. «Io mi limito a eseguire gli ordini.» Così loro potevano sfogarsi senza attaccar lite con me. Questo sotterfugio una volta però mi mise nei guai. Ero a Trieste e discutevo come al solito con un libraio. Quello si lamentava per gli sconti infami praticati da «quello strozzino» 148 Il Morbo di Monduz di Monduzzi. Io rincaravo la dose: Monduzzi era di un’avarizia sordida e nessuno poteva saperlo meglio di me, con lo stipendio di fame che mi ritrovavo. Questo stratagemma funzionava sempre. Il copione era collaudato: il libraio si commuoveva per il giovane rappresentante e accettava gli sconti bassi. Ma proprio in quel momento entrarono due ragazze in libreria. Erano due studentesse. Una l’avevo conosciuta a Cortina. Mi riconobbe e disse all’amica: «Ti presento una celebrità. Questo è quel Gianni Monduzzi di cui ti parlavo. Quello che ha cominciato scrivendo una dispensa di anatomia e ora sta diventando un grande editore! ». A sentire quelle parole, il libraio stralunò gli occhi e mi squadrò con aria feroce. «Ah, così! Il povero rappresentante! L’Editore avaro! Canaglia!» Pareva che volesse venire alle mani. Mi feci indietro e lo stoppai: «Mi meraviglio che un brigante par suo si scandalizzi. Se non fosse un pirata peggio di me, non avrebbe mai fatto strada nella giungla delle librerie universitarie. Io e lei siamo parenti! ». Il mio discorso lo paralizzò. Era incerto se tirarmi un cazzotto o darmi una pacca sulla spalla. Alla fine, decise di tendermi la mano: «Monduzzi, con quella faccia di bronzo, diventerà miliardario!» Era quello che avevo intenzione di fare. In quegli anni c’era stata la liberalizzazione dell’accesso agli atenei. Il mito della laurea era forte. Il figlio all’università era una specie di status symbol, come la seconda casa e la domestica. Medicina, che durava sei anni, era la più ricercata. Costituiva la fuoriserie delle facoltà, col suo motore a sei cilindri, contro i quattro regolamentari. A Bologna, in pochi anni, le matricole di medicina erano passate da seicento a duemilaottocento! La struttura universitaria non era preparata a quell’invasione. Per secoli aveva accolto un centinaio di allievi. Si arrivò ai tripli turni, le aule straripavano. I professori erano pochi e non potevano affrontare quella marea. L’Università già Vivere alla grande 149 scricchiolava quando venne il Sessantotto a completarne il ciclo evolutivo, trasformandola nel centro dell’ignoranza organizzata. Per quanto mi riguarda, mi aveva dato fastidio l’insolenza reazionaria degli anni precedenti e mi infastidì anche quel furore ideologico. Era un nuovo dogma che cercava di sostituirsi a quello passato. L’irrazionalità e il sopruso avevano cambiato bandiera. Quanto a me, in attesa che il mondo si emancipasse, mi ero fatto la mia rivoluzione personale. La Trisezione della Vita (denaro, cultura e gioventù) Il denaro è necessario. Esiste un circuito fatto di belle donne, fuoriserie, viaggi esotici e ottimi alberghi. Per convenzione, questo circuito ha adottato il denaro come mezzo di scambio. Se avessero adottato sorrisi e poesie sarebbe tutto meno prosaico. Ma prova a mangiare in un ristorante a tre stelle e pagare in versi. Dovevo quindi accumulare la maggior quantità possibile di denaro. Però, se da giovane mi fossi dedicato solo al profitto, mi sarei presentato alla maturità da discreto ignorante. L’ignoranza, ai miei occhi, era un malanno anche peggiore della miseria. Li vedevo, a Bologna, gli industriali in Maserati, pieni di soldi, analfabeti. Mi suonavano ancora nelle orecchie i loro discorsi, al Bar Zanarini, sotto il Pavaglione: «Guarda ben, che alla fine ci vuole la pilla, veh! Mica balle. Cosa vuoi che mi freghi di una laurea. Ne ho decine di laureati, nella mia fabbrica. E ce lo do io, lo stipendio. Se vogliono la paga, la devono venire a chiedere a me, che ho la licenza elementare. Ma cos’è ’sta cultura. Fesserie. Ci vogliono baiocchi, dico io. Ci voglion baiocchi!» Avranno avuto miliardi, fuoriserie e ragazzotte compiacenti, ma mi facevano orrore. La mancanza di cultura è più accettabile 150 Il Morbo di Monduz nella miseria. Almeno non dà nell’occhio. Ma un ricco ignorante è la caricatura dell’opulenza. Non potevo sprecare la gioventù per i quattrini, a scapito della cultura. Ma non dovevo neanche dedicare tutto il tempo allo studio, se non volevo diventare uno di quei laureati che ricevono lo stipendio da un analfabeta con la Maserati. Le cene domenicali in pizzeria e le vacanze «alternative» in collina non erano il genere adatto per me. Volevo assaporare il bello della gioventù, fare quattrini e anche studiare. Così decisi di procedere a una «Trisezione della Vita». Passavo tre-quattro mesi di lavoro febbrile, per la casa editrice, accumulando i soldi da spendere nei tre mesi successivi a Cortina; poi, finita la vacanza, mi chiudevo per tre mesi a studiare. Dopo gli esami, ancora due mesi in montagna, per le vacanze estive. In autunno di nuovo al lavoro, febbrile, maniacale. La nonna a Montecatini Da molti anni, ogni settembre mia nonna andava alle terme di Montecatini per passare le acque. La accompagnava la zia Cesira, che in realtà era sua cognata, e per simpatia e vitalità era la sola che riuscisse a tenerle testa. Quando a diciott’anni ebbi la patente, presi l’abitudine di accompagnarle a Montecatini io, con l’auto del babbo. Non vedevo l’ora che venisse settembre per fare quel viaggio con loro. Per tutto il tragitto, non facevano che ridere e scherzare. Erano un vero spasso. L’anno che mi presentai con la mia Porsche nuova erano eccitate come bambine. «Che bella macchina! Cos’è? Una Porce! E l’hai comperata con i tuoi guadagni? Che bravo! Che nipote che abbiamo, eh, Genoveffa!» Vivere alla grande 151 Mia nonna era al settimo cielo. «Peccato non avere più vent’anni.» «Eh, già! Pensa un po’ cosa dirà la gente vedendo due vecchiacce come noi su una Porce. Gianni, se qualcuno in autostrada ti fa dei gesti, so io cosa vuol dire. Che faresti meglio a depositarci nel primo ospizio e poi caricare delle belle ragazze.» «Forse penseranno che ci stai portando al ricovero! Lascia che pensino. Intanto noi ce ne andiamo a Montecatini!» In autostrada, il gioco proseguiva: «Ah, che bella macchina. È vero che va veloce? Vediamo un po’ quanto fa!» E io a pigiare sull’acceleratore: «Siamo ai duecento!». «I duecento! Ai nostri tempi, Cesira, si facevano i venti... ma che dico... i due all’ora, col somaro. Però com’è bello il progresso! Se va avanti così, andranno sulla Luna, su Marte, sul Sole!» «Sul sole farebbe un po’ caldo, nonna! Senti lo stereo, che musica! È un nastro che ho fatto io.» Così, sulla Firenze-Mare correvamo a duecento, con l’autoradio a tutto volume. Tre matti, accomunati dalla stessa allegria, senza età. Una volta ci volle accompagnare mia madre, per vedere anche lei Montecatini. Stava sul sedile davanti, per via del mal di schiena, e le due vecchiette, dietro, come scolarette un po’ discole, negli ultimi banchi. La mamma aveva una fifa blu. «Non correre, che ci ammazziamo.» «Ma lascialo andare, poverino, che sa guidare benissimo. Questa è una Porce, vèh. Mica una carriola» replicò Cesira. «Certe donnicciole andrebbero lasciate a casa! » sentenziò la nonna. «Siete due vecchie pazze. E pensare che gli anni li avreste, per avere un po’ di buonsenso! » sbottò mia madre, poi si chiuse in un mutismo ostinato per tutto il viaggio. Ne approfittai per viaggiare 152 Il Morbo di Monduz come un bolide, con la tacita approvazione delle due vegliarde. Ogni tanto mi facevano l’occhietto dallo specchio retrovisore, per dirmi di spingere. Eravamo oltre i duecento. A ogni sbandata la mamma sbiancava. Rischiammo un testa-coda. Mia madre sembrava paralizzata. Le due vecchiette fecero un gesto con le spalle, come per dire: «tanto, non si vive in eterno». Dopo quell’esperienza mia madre non chiese più di venire con noi. Per il pagamento delle spese di viaggio, erano liti ogni volta. Mi volevano pagare troppo e io non accettavo. Seguiva una febbrile contrattazione alla rovescia. Raggiungevamo un compromesso intorno a una cifra comunque esagerata. Con un autonoleggio avrebbero speso meno. Appena giunte a destinazione, tiravano fuori una busta con i soldi preparati durante il viaggio, e io controllavo che non ce ne fossero in più. Ma erano incorreggibili. La zia Cesira aspettava che la nonna di distraesse, per allungarmi altre diecimila di nascosto, facendomi gli occhi cattivi perché non fiatassi. Ero costretto ad accettarle per non mettere in piazza il suo gesto «sleale». Quando ormai le avevo salutate, la nonna tornava indietro, facendo finta di dovermi dire qualcosa. Era un pretesto per ficcarmi in tasca il suo diecimila di contrabbando. E non potevo rifiutare senza creare uno scandalo: a pochi passi c’era la zia, che osservava insospettita ogni gesto! Pranzi di Natale Ogni ricorrenza era buona per riunire «la famiglia» e ricostituire il nostro quintetto originale: nonna, babbo e mamma, zia e nipote. Mia zia, sposandosi, aveva aggregato lo zio, così eravamo diventati un sestetto. Il pranzo di Natale era un avvenimento solenne. La nonna e la Vivere alla grande 153 zia lavoravano per giorni alla preparazione di manicaretti prelibati. Passavamo ore a tavola. I miei parlavano, io trangugiavo. Riuscivo a stivare quantità pazzesche di cibo. Spolveravo tutto. Poi mentre i miei genitori giocavano a briscola con gli zii, stavo in cucina a chiacchierare con la nonna, come ai bei tempi. Verso le cinque telefonavo ad Alfredo, per concordare un cinema insieme. Prendevo la mia auto sportiva e uscivo dal vialetto sgassando. I miei zii stavano su una collinetta, costeggiata dalla via che scende verso la città. Ampio era il tratto di strada da cui si vedeva il loro terrazzo. Alzando gli occhi, scorgevo tre braccia che salutavano. Erano mamma, nonna e zia che, sfidando il freddo, erano uscite fuori per affidare a un ultimo gesto la loro testimonianza d’amore per me. Quei segni affettuosi, che mi accompagnavano lungo la strada, mi restavano stampati nel cuore. «Sono nato ben fortunato!» mi dicevo, con le lacrime agli occhi. E davo del gas al mio bolide. Avrei voluto conquistare il mondo per loro. Tre vite in una Nella mia Trisezione della Vita - studio, lavoro e divertimento le stagioni del divertimento figuravano due volte l’anno perché, a mio vedere, la gioventù è il bene più prezioso e irripetibile dell’esistenza. Quindi le dedicavo una buona metà del mio tempo, e il mio campo-base era sempre lo stesso: Cortina. Cortina esagerata A forza di ritornare e di starci per mesi, mi ero fatto una discreta entratura. Oltre ai quattro compagni della «Societé Internationale des Trapoles», avevo un amico bolognese con il 154 Il Morbo di Monduz quale dividevo la casa, e uno tedesco, ricchissimo, che mi portava a sciare in elicottero. Questo apparecchio era un meraviglioso strumento di libertà. Grazie a lui si andava con una certa sveltezza a prendere il caffè in Val Gardena o a fare uno spuntino in qualche malga sperduta tra i ghiacci. Queste escursioni mi affascinavano. Raggiungevamo baite impossibili, dove c’era gente che viveva isolata da mesi, in attesa del disgelo primaverile. Il nostro arrivo era per loro una festa. Era bello volare sulle montagne innevate, con i camosci che saltabeccavano sotto di noi, come delfini in un mare di bianco. Avevo cambiato casa. Da Pezié mi ero trasferito a Gilardon, in una villetta tranquilla con una veduta da infarto. Di notte, vista da lassù, Cortina era un presepe a grandezza naturale, illuminato da un anfiteatro di stelle. La padrona di casa si chiamava Lina, e per larghezza di vedute era una versione aggiornata della proprietaria di via Zannoni. Sopportava allegramente le mie manovre notturne, anzi ne andava fiera con i vicini di casa. Su quelle avventure non mi va di dilungarmi. Rischierei di travisare il senso della mia esperienza. Non sono mai stato un «playboy», anzi mi ritengo un «playmerlo». A me le donne piacciono perché non riesco a tenermele strette. Il nostro rapporto è all’insegna della precarietà: la mia ansia mi rende vulnerabile. Non sono mai riuscito a contrastare l’immenso potere che hanno su di me. Dopotutto, mi piace così. Comunque, almeno due storie le vorrei raccontare: quella della bella Rosin e dell’«onesta ragazzina padovana». La bella Rosin A quei tempi flirtavo con un’illustre damigella, che purtroppo aveva la pretesa di trattare gli uomini come lacchè, in virtù del Vivere alla grande 155 suo censo. Oltretutto era una spilorcia: toccava sempre a me di pagare i suoi conti! Sopportai per alcuni giorni le sue angherie, in attesa di trovare un modo elegante per darle il benservito. Mi capitò l’occasione giusta quando incontrai una bellissima camerierina all’hôtel Cristallo, dove ero andato a pranzare ospite di un amico. Si chiamava Rosin ed era di Mestre. A parte le manone rosse, che tradivano i molti piatti lavati, e la pronuncia veneta, sembrava una principessa, bionda, col nasino all’insù e l’incarnato regalmente pallido. La invitai fuori, ma feci una bella fatica per vincere la sua resistenza. Non si fidava di me. Era convinta che esistesse una linea di demarcazione invalicabile tra le cucine e la sala da pranzo: da un lato, il mondo dei domestici, dall’altro i «signori», eternamente in vacanza. Ci volle tutta la mia pazienza per farle capire che appartenevo a una terza categoria: quella dei domestici che hanno varcato la soglia. Il progetto che mi ero fissato con lei era molto ambizioso: una riedizione della favola di Cenerentola, con qualche aggiustamento in versione casanoviana. Volevo portare quella chicca di donna alla festa più importante della stagione, al posto della mia «fidanzatina» ufficiale, che volevo punire in modo clamoroso. Avrei dovuto dare qualche ritocco all’immagine della mia dama. I capelli, ad esempio, con quella trecciona raccolta sulla nuca non andavano bene. Ci avrebbe pensato Liborio, parrucchiere «in» di Cortina, a sistemarli. Per le mani non c’era nulla da fare, la rigovernatura di troppe stoviglie aveva lasciato una traccia indelebile. Ci vollero dei guantini di pizzo nero, a coprire la magagna. La Lida del King’s Shop mi prestò dei calzoni di velluto attillati e una camicia di seta da sera. L’effetto era straordinario sul piano visivo, ma c’era un problema fonetico. Se la fanciulla avesse aperto bocca, la sua pronuncia avrebbe dissolto ogni incantesimo. Non mi lasciai abbattere per così poco. 156 Il Morbo di Monduz La presentai come una principessa polacca, muta fin dalla nascita. Così si spiegava la sua aria stranita. Tutti capirono che era uno scherzo, ma nessuno osò smascherarci. Quella sera l’odiosa riccastra, abbandonata al suo destino, si presentò furibonda alla festa, per scoprire che l’avevo scaricata per una nobildonna polacca, nientemeno che la principessa Rosinsky di Mestrovic, alias Rosin di Mestre. Giustizia era fatta. Sicuramente Casanova mi avrebbe approvato. L’onesta ragazzina padovana Ho sempre avuto una vera passione per le ragazze oneste: più sono pure, più le ammiro e le rispetto. La più onesta di tutte, fu una ragazzina di Padova. Non ne ricordo il nome, ma non posso scordare la sua grande virtù. L’avevo conosciuta a Cortina. Era un tipo con gli occhialetti e i capelli castamente raccolti in una trecciona centrale che le dava un’aria da Madonna del Beato Angelico. Ne ero affascinato. Lanciava sguardi pudichi e arrossiva per un nonnulla. Quando si dice «una santa»! Sarà perché io fin d’allora cominciavo a subire il fascino delle cose sacre, sarà perché lei aveva il culetto alto, fattostà che mi ero invaghito di lei. Purtroppo c’era un inconveniente: la damigella era fidanzatissima con un tipo di una gelosia assurda, che sembrava quanto mai fuori posto, con un fiorellino di donna del genere. Mi divertivo a seminare zizzania tra loro: una coppietta così ben affiatata mi pareva un insulto per tutte le coppie tribolate del mondo. Ridimensionando la perfezione del loro idillio, avrei fatto opera di giustizia e combattuto per una maggiore eguaglianza sentimentale. Riuscii a carpire l’indirizzo padovano e il numero di telefono di quella santarellina. A Padova avevo una piccola base operativa in Vivere alla grande 157 società con un amico di Mestre. Da mesi non contribuivo all’affitto, ma conservavo la chiave e la utilizzavo di frodo. Padova era la mia seconda città. Per frequentare le padovane senza dare nell’occhio, fingevo di essere iscritto a quella Università. Bologna è una città di provincia, piuttosto pettegola: più di due o tre ragazze alla volta non si riescono ad amministrare. Così giocavo in trasferta, e con molta soddisfazione: le venete hanno una innata malizia, propiziata da secoli di cattolicesimo bigotto e asfissiante. Alle ragazze non pare vero di farla in barba a mamme e preti e trovano sempre qualche anima buona, come me, disposta ad aiutarle. Il sesso con un pizzico di peccato è una delizia. Di questo sono grato al cattolicesimo. La prima volta che capitai a Padova la invitai fuori, chiamandola direttamente dal bar sotto casa sua. È un mio vecchio trucco, che non lascia tempo alla «vittima» di organizzarsi. Se telefoni a una donna da sotto casa, stai pur certo che scenderà subito, senza tanti preamboli. Appena scese, chiarii che avrei voluto fare quattro chiacchiere da solo a sola. Sempre che lei si fosse fidata, o meglio, si sentisse sicura del fatto suo: «Non tutte le donne si potevano permettere di stare a tu per tu, con uno come me». Lei accettò la sfida e salì con me le scale della mia tana in via Cesare Battisti. Il primo passo era fatto. «Naturalmente non berrai un bicchiere di frizzantino, per non perdere il tuo fragile autocontrollo?!» insinuai. «Non sarà certo un bicchiere a farmi perdere la testa!» A casa c’era un caldo torrido: si era bloccato il termosifone al massimo. Non l’avevamo fatto aggiustare, perché ci andava bene così. Di solito, era un ottimo pretesto per cominciare a spogliarsi. Lei, invece, se ne stava trincerata nel suo cappottino. Doveva scoppiare di caldo. «Forse ti conviene tenerlo addosso, il cappotto, dopotutto è una difesa!» 158 Il Morbo di Monduz «Guarda Monduz, è meglio che ti togli definitivamente certe idee dalla testa: con me non attacca!» Si tolse il cappotto. «L’ho capito, che sei l’unica donna fedele del globo. Guarda che ti ammiro per questo, trovo un peccato soltanto di non essere io il destinatario di tanta virtù!» E intanto le riempivo distrattamente il bicchiere di bollicine ubriache. Si stava facendo sera. L’ultima fioca luce di un giorno di novembre filtrava tra le persiane socchiuse. L’atmosfera era intima. Lo stereo collaborava con una struggente canzone di Ella Fitzgerald. Le forze onnipotenti della seduzione si stavano tutte schierando al mio fianco. Tanto per accorciare le distanze, mi ero messo a giocherellare con un suo orecchino, senza un preciso obiettivo. Cercavo un’ispirazione. «A me una donna fedele non è mai capitata... Capitano sempre soltanto agli altri...» Mi accorsi di aver assunto istintivamente un’aria da pulcino bagnato. Ne approfittai per toglierle il ciondolo dall’orecchio. «A me sembra che essere fedeli sia la cosa più naturale del mondo. Come si può voler bene a qualcuno e stare con un’altra persona?» Colta dall’enfasi di quelle parole si tolse da sola anche l’altro orecchino. «Non so come si possa, io so che si fa. Comunque una donna fedele prima o poi dovrà pur capitare anche a me, no?» E le sfilai con indifferenza il bracciale, come se tale gesto potesse propiziarmi il futuro. «L’onestà: che parola consumata dall’ipocrisia! Quando parlo di onestà, tutti mi prendono per una marziana!» E si slacciò lentamente l’orologio, come per far cadere la frase fuori del tempo. «Il fatto è che non ho mai incontrato una ragazza virtuosa, Vivere alla grande 159 purtroppo» dissi in tono convinto, sfilandole uno stivaletto. «Comunque io sono convinta del fatto mio!» E si tolse l’altro con decisione, strizzandomi l’occhio. «Ebbene, viva la virtù!» replicai. Le levai con perizia la sottana, come la cosa più naturale, dopo una simile esclamazione. Pezzo per pezzo, tra i più ispirati aforismi e i migliori proponimenti, ci liberammo di ogni indumento. Celebrammo sotto le lenzuola il trionfo della virtù. Castìgammo i costumi con enfasi, fin nei dettagli. Le beghine dell’appartamento di fianco, che origliavano sempre alle pareti con un bicchiere, avranno avuto soddisfazione. Mentre ci rivestivamo, la vicenda toccò alte vette poetiche. La virtuosa fanciulla non demordeva: «Mah, continuo a non capire come si possa fare le corna al proprio ragazzo. Io non sarei mai capace di farlo!». E le scappava da ridere. «È proprio per questo che ti stimo.» Eravamo pronti a uscire. «Questa sì che è verecondia» dissi tra me. «Peccato che simili donne siano così rare.» Avevo il cuore gonfio di gioia: finalmente, anche a me era toccata una donna virtuosa. Achille e il Liceo Artistico Achille era più che un amico, era un prezioso collaboratore del mio tempo libero. In quel periodo lavoravo come un forsennato e non avrei mai trovato il tempo di organizzare le mie serate. Achille ci pensava per tutti e due. Ci eravamo divisi i compiti. Io finanziavo la struttura: case, motoscafo e automobile. Lui provvedeva al coordinamento logistico. 160 Il Morbo di Monduz Passando davanti al Liceo Artistico, Achille mi raccontò di avervi insegnato come supplente, per un paio d’anni. Con le allieve ne aveva combinate di cotte e di crude. La sua descrizione fu così entusiasmante da invogliare anche me. Secondo Achille la cosa era fattibile, visto che tra le materie del liceo figurava l’Anatomia Artistica. Entrai in Istituto e feci la mia domanda, per gioco. Dopo alcuni mesi, quando ormai mi ero dimenticato dell’episodio, arrivò l’investitura: ero stato nominato professore supplente! Mi avevano affidato tutte e quattro le sezioni femminili. Ancora una volta, il mio destino mi chiamava all’appello. I due anni in quella scuola di genialoidi strampalati furono uno spasso. Partecipare alle assemblee del Consiglio di Istituto era meglio che andare a teatro. Capitava di tutto. Il preside aveva baffetti alla D’Artagnan e si divertiva come un dannato quando gli insegnanti si accapigliavano. Come moderatore dell’assemblea, teneva a portata di mano un gong e lo suonava all’impazzata per ristabilire la disciplina. Quando non ci riusciva, faceva il gesto di scagliarlo, e c’erano filari di teste che si piegavano, per uscire dalla rotta di collisione. Ricordo con nostalgia le allieve di quegli anni. Quattro sezioni di sole ragazze, affidate alle mie cure, misero alla prova la mia deontologia professionale. Seppi trattenermi dal fare sciocchezze, ma organizzai due gite scolastiche memorabili, a Roma e a Parigi. Per tener tranquilli i genitori, mi ero procurato la necessaria copertura morale: coinvolgevo nelle mie malefatte l’innocente don Mario, insegnante di religione, che godeva fama di integrità. A Roma e a Parigi, con tutte le mie scolarette, mi sembrava di essere tornato ai tempi del cortile in via Orfeo. Stavolta giocavo al maestro, ma le emozioni erano le stesse: quelle predilette dal Morbo di Monduz. Vivere alla grande 161 La condotta a Molinella Avevo preso la laurea ed ero ancora impelagato nell’attività della casa editrice. Non sapevo che fare. Continuare a far l’editore o iniziare la professione? Da un lato vedevo quattrini, dall’altro una missione da svolgere. La mia solita indecisione! Forse era meglio procedere a una verifica pratica. Quando andai all’ordine dei medici per ritirare il tesserino (che emozione, ero finalmente collega di Freud e di Schweitzer!), mi informai se ci fossero occasioni per fare pratica. Mi indicarono un’intera bacheca di offerte. Mi attirò quella del medico condotto di Molinella, un paesino della Bassa, vicino al Po, che cercava un sostituto per andare in vacanza nel mese di agosto. Era un’occasione d’oro per fare esperienza. Lo chiamai e presi un appuntamento. Il boato della mia Porsche nuova fiammante risvegliava quelle valli assopite. Il medico condotto mi ricevette con affabilità nell’abitazione più kitsch che avessi mai vista. Faceva collezione di farfalle, di francobolli, di minerali ed era appassionato di modellismo navale. Aveva una casa piena di figli, rocce, galeoni, lepidotteri e soprammobili. Non c’era posto dove sedersi. Ci appartammo nel suo studio. Un ambulatorio sguarnito, con un lettino da mutua, un armadietto smilzo con una porta a vetri rotti rattoppati con cerotto adesivo. Nelle vetrine i medicinali erano ammassati senza una logica apparente. Si sedette a una scrivania rivestita di carta adesiva finto legno, mi fece accomodare su una sedia impagliata pericolante e mi raccontò la sua storia. «Pensi che vent’anni fa ero un giovane medico come lei, fresco di laurea. Cercavo una sostituzione per racimolare qualche quattrino. Venni qui in bicicletta, dopo aver letto un avviso esposto nella bacheca dell’Ordine, come ha fatto lei!» 162 Il Morbo di Monduz Effettivamente, fatta eccezione per il mezzo di locomozione, le situazioni coincidevano. Il medico continuò: «Presi il posto di quel medico condotto. Poveretti i miei primi pazienti. Mi capitò una donna che aveva da partorire. Era il mio primo parto, per fortuna la donna ne aveva già avuti altri sei. Finì che era lei a farmi coraggio, a momenti svenivo. Ma tutto andò bene, grazie a Dio! «Poi ci fu un bracciante che si era tagliato a una mano con una falce. Gli detti dei punti di sutura così per benino che sua moglie, che era una ricamatrice, mi fece i complimenti. «Così ho cominciato la professione. Quando il titolare della condotta ritornò dalle ferie, mi invitò a restare con lui. Il territorio era grande e c’era lavoro per tutti e due, tanto più che era già vecchio e faceva fatica, in casi d’urgenza. Ci dividemmo il lavoro: lui faceva l’ambulatorio e io le visite a domicilio. «Sua figlia era una gran bella ragazza e me ne innamorai... Laura! Vieni a salutare il giovane collega che è venuto da Bologna per sostituirmi! » gridò oltre la porta, poi riprese con voce più bassa: «Quella ragazza ora è mia moglie, mi ha dato sei figli!» La signora Laura entrò a darmi un saluto: era un po’ grassa, un po’ scarmigliata, con un’aria buona ma anche un tantino aristocratica, di signora moglie del medico. Mi fece un sorriso, poi dovette scappare, richiamata da un rumore inquietante: «Benedetti ragazzi! Cosa avranno rotto, stavolta? Come si fa ad avere una casa decente con dei monelli del genere?» E scomparve dietro la vetrata. Il medico continuò: «Il tempo è passato e non me ne sono neanche accorto. La gente mi vuole un gran bene. Per Natale mi regalano chi un cappone, chi un salame, chi addirittura un prosciutto. Tutti i giorni mi portano le uova fresche. La domenica vado a pesca, sa, ho preso un capanno sul Po. Nel tempo libero faccio le mie collezioni. Insomma, ho trovato la felicità. Vivere alla grande 163 Venni qui a Molinella convinto di starci un mese e, come vede, non sono più andato via! » A sentire il suo racconto mi si accapponava la pelle. Quella era proprio la felicità che temevo! Dissi che gli avrei dato una risposta al più presto e guadagnai la porta come un gatto arruffato. Lo lasciai sulla soglia di casa, con un bicchiere di vino in mano, sorridente. Non si sarà nemmeno domandato perché tanta fretta. Le persone felici non si fanno mai delle domande. La mia Porsche, ruggendo tra gli argini dei canali del Po, sembrava approvare la mia decisione. Anche a lei quelle stradine andavano strette. Per noi fuoriserie ci volevano orizzonti più vasti. Prima di ripiegare sulla felicità, volevo vedere se potevo aspirare a qualcosa di meglio. Ridimensionamenti Psichiatria Gli psichiatri sono le mannequin della fòllia: indossano con maggiore eleganza gli stessi abiti dei loro clienti. Dopo il secondo esaurimento nervoso, mi ero stufato di dipendere dagli psichiatri. Tutto sommato, mi conveniva «mettermi in proprio». Mi iscrissi dunque alla scuola di specializzazione in psichiatria, a Modena. La scelta era caduta su quella città perché il direttore si accontentava di una frequenza modesta. Questo requisito era per me indispensabile, con il ritmo di vita che avevo, tra le dispense e Cortina. Mi bastarono pochi giorni per capire che l’Istituto di Psichiatria non era di tutto riposo. C’era una logica progressiva nelle carriere. Gli allievi interni, spesso con barba e curiosi tic, sbacchettavano che era un piacere, ma eravamo soltanto al primo livello. Gli assistenti cominciavano a manifestare già turbe più complesse: si chiudevano di colpo in un ostinato mutismo, scappavano in bagno a risciacquarsi le mani, o telefonavano a casa per controllare se tutto era OK. Al direttore, naturalmente, spettava la palma della follia: trangugiava raffiche di pillole di non si sa cosa e saltellava sui talloni come un canguro. «Se questo è il curriculum» mi dicevo « forse è meglio fermarsi ai primi gradini!» Cominciavo a nutrire dei dubbi che fosse la carriera giusta per me. Decisi di cambiare Istituto. Cominciai così a frequentare la Clinica di Bologna, dove la follia era distribuita tra i medici in 166 Il Morbo di Monduz modo diverso: il direttore se ne faceva carico in toto, gli altri erano abbastanza normali. Familiarizzai con facilità. Era come una famiglia e non si stava malaccio. Tanto per cambiare, mi affidarono al reparto donne. Cominciai dalla gavetta: anamnesi e flebo. Mi trovai di fronte a casi pietosi, assurdi. Spesso non venivano ricoverati i matti, ma le vittime della follìa altrui. Figlie violentate dal padre, donne percosse da mariti violenti, ragazze maltrattate da matrigne crudeli. C’erano parecchi tentati suicidi, isteriche e malate immaginarie. E poi i casi più gravi, la vera follìa: schizofrenia, melanconia, paranoia. Io profondevo i miei sforzi per alleviare le pene delle «mie donne». Quelle ricoverate erano tutte di una bruttezza assoluta. Mi chiedevo talvolta se, in una donna, la bellezza costituisse un vaccino per mitigare la follia. Per mesi continuai a dimettere pazienti migliorate o guarite. Il merito non era mio, naturalmente. Ero solo un giovane apprendista e riferivo ogni cosa al caporeparto, un uomo alto, molto simpatico, che si chiamava Giuseppe. Quando mi trovavo in difficoltà, andavo da lui, con la certezza che avrebbe scovato la soluzione. Per la sua grande umanità mi ricordava il professor Mari di Modena. Alla fine di luglio me ne andai a Cortina, dopo aver dimesso le mie pazienti, tranne i casi più gravi. Ero soddisfatto di me e della mia professione. Tornando in clinica, dopo le vacanze, rimasi sorpreso nel vedere le stesse facce che avevo dimesso prima dell’estate. «Che fossero tornate per festeggiare la guarigione?» chiesi a Giuseppe. «Eh, no, purtroppo » mi rispose afflitto «non sono tornate per festeggiare, ma per ricominciare un ciclo di cure.» Tutti i miei sforzi erano stati vani. Scoprii che molte di loro tornavano puntualmente due volte l’anno, per tutta la vita, come se andassero Ridimensionamenti 167 «a fare il tagliando ». Mi prese lo sconforto e da allora continuai i miei studi, fino al diploma di specializzazione, frequentando la clinica il meno possibile. La psichiatria mi è stata di grande utilità: dopo il diploma, gli esaurimenti nervosi, li ho fatti venire anche agli altri. La consulenza della casa di cura Ancor prima che finissi la specializzazione, chiesero la mia collaborazione come psichiatra in una casa di cura privata. La clinica era sulla Riviera adriatica, avrei dovuto andarci una volta la settimana, per poche ore. Mi offrirono un compenso talmente elevato che non osai rifiutare. Poi ne compresi il motivo: quel lavoro era terribile. In quella clinica curavano, si fa per dire, poveri ragazzi handicappati. Era straziante osservare questi esseri, ridotti a vegetali, e soprattutto le loro famiglie. Genitori che non volevano accettare la realtà e si aggrappavano a speranze insensate. Una volta vennero da me i genitori di uno di questi infelici, chiedendomi di sottoporre il loro ragazzo a un test, per valutarne il quoziente mentale. Il poveretto aveva sedici anni e distingueva a fatica un cubo da una sfera. Mi chiesero un parere circa gli sviluppi possibili. Io non sapevo che dire. Erano due brave persone. Stavo per metterli di fronte all’amara realtà, quando il padre mi anticipò: «Intendiamoci bene, non siamo due illusi. Mica pensiamo che nostro figlio possa andare all’università. Saremmo contenti che prendesse un diploma!» E guardò la moglie che assentiva. Il loro delirio di speranza mi fece prendere una decisione. Quello non era un lavoro adatto per me. Detti subito le dimissioni. 168 Il Morbo di Monduz Ridimensionamenti Un tifone chiamato Laura Laura mi ha insegnato a non fare mai la guerra a qualcuno che si prefigga quell’unica guerra da combattere. Quell’inverno dovevo andare in Kenia con Alfredo, a Malindi, per le vacanze di Natale. Avevamo prenotato con una compagnia svizzera sconosciuta, dai prezzi preoccupantemente bassi. Mi chiesi se non si trattasse di un aereo a pedali. Comunque non vedevo l’ora di partire. Avevamo già versato la caparra, quando quello scalognato di Alfredo ricevette la «cartolina rosa» di chiamata alle armi. L’appello era per il giorno dopo l’Epifania. In teoria ce l’avremmo fatta a tornare in tempo, ma lui non si azzardava. Temeva qualche ritardo e si vedeva già ai ferri, a Gaeta, nel carcere militare. Se fossi andato in Kenia da solo l’infarto di mia madre era garantito. Rinunciai, ripiegando su Cortina. Questo contrattempo risultò fatale: su quelle nevi mi attendeva al varco il destino. Aveva diciott’anni, occhi verdi, e una gran voglia di combinare guai. Una ragazzina che era riuscita a strappare ai genitori il consenso per la sua prima vacanza in montagna, da sola, con un’amica. Incrociai il suo sguardo, entrando alla Stella d’Oro. Era seduta su una panca, tutta soletta, e si beveva il suo punch. Diavolo, che occhi! Mi guardava divertita con l’aria di sfottermi, come giocasse a chi avrebbe distolto per primo lo sguardo. «Questa ragazzina è in cerca di guai» dissi tra me «e può darsi che li abbia trovati!» Mi sedetti al suo fianco, come se ci fossimo conosciuti da sempre: «Hai sentito che freddo da lupi? Ho bisogno anch’io di qualcosa di caldo. Il tuo punch com’è? Al mandarino?» 169 «Non mi pare che noi due ci conosciamo!» «Non mi dire che sei il tipo da parlare con uno sconosciuto! Barman, un altro punch al mandarino... o due? Ne vuoi un altro anche tu... come hai detto che ti chiami?» Non l’aveva ancora detto. Ero in tempo a fuggire. Si chiamava Laura. Ci scolammo due punch a testa, poi affrontammo il gelo polare, tenendoci stretti per non cadere sul ghiaccio. Erano le cinque del pomeriggio, l’ora giusta per fare un salto all’Eggs Bar, di fronte al King’s, dove c’era il quartier generale della mia compagnia. La feci salire sulla mia decappottabile. La tenevo col tettuccio aperto anche d’inverno. Questo mi ha causato un’artrite cervicale, ma sul momento mi dava un’aria che faceva per me. In auto avevo uno stereo spaccacervello, che tenevo sempre ad alto volume. Mi facevo le compilation da solo, a modo mio. Se mi piaceva una canzone, la registravo tante volte di seguito, per tutta la lunghezza del nastro. Lo stereo aveva 1’autoreverse, così la musica girava a ciclo continuo. Quando ero arrivato mi portavo dietro il nastro e continuavo ad ascoltarlo nell’impianto di casa, giorno e notte. Una musica che mi piaceva era come una cotta: non vedevo l’ora di farmela passare. In quel periodo avevo preso di mira una canzone di Louis Armstrong, di grande atmosfera. Misi su il nastro e partii con All the Time a tutto volume. Avevo quattro ruote chiodate, il baule zavorrato con pezzi di ghisa prestati da Alfredo, e guidavo come un pilota di rally parzialmente ubriaco. Al secondo testa-coda, Laura era visibilmente inquieta, ma non voleva darlo a vedere. Faceva la spavalda, ma con gli occhi sbarrati. All’Eggs c’erano tutti gli amici, anche Gaia, la mia passione triestina. Gaia, vedendomi con una nuova ragazza, non seppe resistere: venne a farmi le fusa, per surclassare la rivale. La posta in palio ero io, naturalmente. Ma non ci cascavo più. Sapevo ormai come regolarmi 170 Il Morbo di Monduz di fronte al sano istinto di competizione femminile. Se avessi ceduto alle lusinghe, le avrei perse entrambe. Un uomo che si lascia sedurre con facilità non è una preda stimolante per una donna. Stetti a quel gioco, con molto fair play. Quella disputa mi divertiva, e portava acqua al mio mulino, visto che Laura aveva raccolto la sfida. Gaia era stupenda. Faceva la pubblicità di un famoso liquore. C’era stata una storia tra noi. Sarebbe più corretto dire che ero stato io, ad avere una storia con lei. Gaia era una seduttrice irresistibile e io non avevo saputo resisterle. Mi ero montato la testa, come a volte mi capita. In quei casi faccio pazzie che mi rendono simpatico, irritante o ridicolo, a seconda dei punti di vista. Più di una volta avevo fatto in auto il tratto Bologna-Trieste, solo per andare a prendere Gaia a scuola. Partivo da Bologna con la Duetto, mi facevo trecento chilometri, fino a Trieste, l’aspettavo all’uscita dal liceo e la riaccompagnavo a casa. Poi tornavo indietro. Tutto per un bacino sotto gli sguardi sgranati delle sue compagne. Mi ero fatto una strana reputazione. Uno che si sorbisce seicento chilometri d’auto, per accompagnare a casa da scuola la sua bella, non lasciava insensibile il temperamento romantico delle triestine. Di fronte a Gaia, Laura rivelava una padronanza inaspettata. Le teneva testa con grinta. Ogni tanto mi lanciava un’occhiata di verifica. Voleva scoprire per chi propendessi. Ma i miei occhi erano imperscrutabili. Per non tradirmi, mi rifiutavo di confessarlo perfino a me stesso. Conosco i miei limiti. So che, per le donne, gli uomini son libri aperti. Ma in un cervello maschile che non pensa, nemmeno una donna può leggerci dentro. Al termine di quel piacevole duello prendemmo appuntamen- Ridimensionamenti 171 to per cenare tutti insieme in una baita. Gaia non voleva lasciare la sfida a metà. Si annunciava una seratina frizzante. Una volta fuori, Laura si ricordò che aveva un impegno per cena, con un gruppo di amici e un giovane regista che aveva appena conosciuto. «Cambia film» le sussurrai alla Humphrey Bogart. «Se te n’eri scordata, non ne vale la pena!» Laura sostiene che in quell’occasione avevo un’irresistibile aria da satiro. Comunque annuì divertita: sarebbe venuta con noi. Al nostro programma avevano aderito altri. Partimmo tutti insieme, con grande trambusto. La colonna di macchine sembrava un commando che movesse all’assalto di polenta e capriolo. Mentre seguivo la carovana di amici, all’improvviso sterzai bruscamente in una via laterale, facendo a Laura una proposta che non si aspettava. «Che ne diresti di fare uno scherzo alla Gaia?! Andiamocene a cena per conto nostro. Basta che mi prometti di presentarle il tuo regista, come premio di consolazione!» La sua stretta di mano fu più eloquente di qualunque risposta. Cenammo insieme al «Caminetto» al lume di candela. Il proprietario mi trattò come un habitué di grande prestigio. Faceva parte del servizio. Quand’uno è in battuta con una ragazza, è importante che appaia padrone del territorio. Dopo cena, finimmo al King’s, dov’ero di casa. Passammo due ore a scherzare, a scambiarci battute. Io e Laura capivamo che quelli erano gli ultimi istanti vissuti da semplici amici. Centellinavamo il piacere di corteggiarci, di confrontare i nostri mondi ancora separati. Sentivamo di appartenerci. Ci era venuta una strana allegria, non saremmo più andati a dormire. Passammo in rassegna tutti i locali, fino a tardissimo. Festeggiammo l’alba a champagne, a casa mia, con una spaghettata alla Monduz. Sul tappo scrivemmo quella data memorabile: 6 gennaio 1972. Iniziò così una storia allegra e tribolata, tra due furbacchioni 172 Il Morbo di Monduz Ridimensionamenti 173 convinti di mettere l’altro nel sacco. Io però non avevo perso le mie abitudini. Rincorrere donne era per me una deformazione mentale. E non avevo nemmeno il pudore di nascondermi. Non riuscivo a vergognarmene! Visto che non provavo sensi di colpa, non facevo nulla di male, sostenevo io. Laura la pensava diversamente. Però non era gelosa come le altre. Questo la rendeva interessante ai miei occhi. Con una donna del genere avrei anche potuto resistere! Il suo unico timore era perdermi. Ma io la rassicuravo, a modo mio: «Perché dovrei mettermi con un’altra? Per cadere dalla padella nella brace! Tanto so già come andrebbe a finire: non starebbe tranquilla finché non mi avesse monopolizzato. Quindi mi tengo cara te, che mi lasci vivere, e rappresenti il male minore.» Nella loro follia i miei argomenti filavano. Laura scuoteva la testa, come un’infermiera con un malato difficile. di Laura, non fu difficile litigare. Così ci lasciammo. Seguirono alcuni giorni di sbandamento. «Oddìo, ci risiamo!» mi dissi «vuoi vedere che mi becco un esaurimento nervoso, come le altre volte?» Ma era soltanto un malessere passeggero. Mi ripresi benissimo. Iniziò così un intenso e felice periodo di scapolaggio. Cortina, Capri, Saint Tropez. Cambiavo località come un piccione viaggiatore. Appena iniziò il trimestre autunnale, mi misi al lavoro come un dannato. Non contento dell’attività di editore, cominciai a impartire lezioni di Anatomia agli studenti. Ero bravissimo, specialmente nel sistema nervoso. Riuscivo a seguire idealmente una fibra nervosa in qualunque parte del corpo, fin dentro al cervello. Conoscevo tutte le giunzioni, gli incroci, le vie. Il cervello era per me come un centralino. Ne ero appassionato come di tutto ciò che riguardava i telefoni. Quando lasciai lo scomodo trappolo di via Zannoni per trasferirmi in uno sotto le Due Torri, Laura mi aiutò ad arredarlo. Si divertiva a giocare alla moglie che mette su casa. Io avevo altri progetti per quel pied-à-terre. Il 23 ottobre (giorno propizio) mi ci trasferii in pianta stabile, rendendomi indipendente dai miei, fatta eccezione per il servizio di lavanderia. Fu un periodo di grande fortuna. La casa nuova, la laurea, gli affari che ingranavano, il sistema di «Trisezione della Vita» che funzionava a puntino. Mi sentivo forte e spavaldo. Era un momento magico, irripetibile. Ma c’era un impedimento alla mia smania di libertinaggio. Per quanto comprensiva e tollerante, Laura mi ostacolava. Bene o male, dovevo pur renderle conto. Mi sentivo intrappolato. «Ventott’anni capitano una volta sola» era il Morbo a parlare per me, «devi goderteli in libertà. » Con il carattere permaloso Il terzo esaurimento nervoso Davo lezione anche a cinque studenti per volta e guadagnavo cifre pazzesche, ma c’era da perdere il lume della ragione. Un giorno, mentre spiegavo la via olfattiva, fui colto da un blocco mentale. Non riuscivo più a pensare. Nulla. Black-out completo. Dovetti mandar via gli studenti e sdraiarmi sul letto. Il cervello si rifiutava di elaborare pensieri. Non mi era mai successo nulla di simile. Non riuscivo a dormire. Me la vedevo brutta. Almeno avessi avuto Laura, al mio fianco! Quando il suo nome attraversò il mio cervello decotto, mi prese un irrefrenabile desiderio di rivederla. «Ora sì che ci risiamo. Eccolo, finalmente, il terzo esaurimento nervoso. Il nuovo uragano!» Il tifone in effetti si era affacciato alle coste della mia mente. 174 Il Morbo di Monduz Volevo chiamare Laura, però temevo una brutta sorpresa. Erano passati tre mesi dal nostro litigio. Non avrei potuto biasimarla, se si fosse riorganizzata. Mi feci forza e telefonai. La trovai subito, inaspettatamente gentile. Le raccontai i guai che stavo attraversando. Mi aspettavo un atteggiamento come quello di Cosetta e Barbara. Invece Laura si mostrò preoccupata per la mia salute, e dopo dieci minuti era lì. «Lo sai che mi è venuto appetito?» le dissi, dopo i primi saluti. «È venuta fame anche a me!» Al ristorante, mangiammo di gusto. «L’amore, che attentato alla libertà! » sospirai. « Siamo in un mare di guai. Ti voglio bene, eppure non posso rinunciare all’idea di avere altre donne intorno. Tu, neanche a dirlo, vorresti essere l’unica. Come la mettiamo?» La mia dissertazione continuò fino al dessert. A Laura sembrava giusta la fedeltà? Anche a me, in teoria. Ma la pratica era un altro paio di maniche. Voleva vedermi ingrassare come un cappone? Fumare, bere, drogarmi, cacciare e andare a pesca munito di vermi schifosi? Voleva vedermi perduto nel gioco d’azzardo? Questo era il minimo che mi sarebbe capitato, per compensare la mancanza di donne. Non c’era altro rimedio che il sotterfugio, dichiarai. Avrei fatto le cose per bene, come ogni uomo, da sempre. Non avrebbe scoperto nulla: volendo, poteva anche illudersi che fossi cambiato. Ma mi sarebbe parso disonesto prometterle la fedeltà. Potevo ingannare così la donna-base della mia vita? Che diventassi monopolio di una sola donna, era da escludere. Avrei preferito la morte! Laura era divertita e pensosa. Mi sembrò colpita dalle mie parole. Ero un misto di sincerità e impudenza talmente fuori dai canoni, da lasciarla interdetta. Sorrise soltanto. Lo interpretai come un tacito segnale di assenso. Non so che cosa pensasse lei, ma mi lasciava dire, per il momento. Ridimensionamenti 175 Le fondamenta del nostro rapporto erano state gettate. Il gioco degli equivoci era già in atto. «Bene, considerami un malato. La mia malattia? Il Morbo di Monduz! Non credo si possa guarire. Dovrai farmi tu da infermiera. Comincia a frequentare un corso di nursing!» Bene o male, avevo superato il «Tifone Laura». Il mio terzo esaurimento nervoso si era risolto in modo diverso dagli altri due, con la collaborazione del tifone stesso. Il ritorno di Laura Al secondo round, tieni presente che il tuo avversario non è più quello di prima. In lui ora c’è anche qualcosa di te. Laura si mise a «curarmi». Per essere vicina al paziente, cominciò a dormire qualche volta da me. Poi iniziò a portarsi dietro il cambio di biancheria e la camicia da notte. Quindi si impadronì di un cassetto per metterci le sue cosucce. Seguendo un preciso piano di invasione, occupò nell’ordine: un’anta dell’armadio, un secondo cassetto e il vano dietro la specchiera del bagno. Era discreta, lo riconosco, ma chi mi toglie il sospetto che non fosse un’abile tattica per non scatenare la mia reazione? Senza che me ne accorgessi, aveva preso domicilio a casa mia, anche se in modo precario. Andava avanti e indietro con le borsine di plastica, come un’alluvionata. Andò avanti così per un paio d’anni. La vita a due sarà romantica, ma non è il massimo della praticità. Laura aveva l’abitudine di leggere a letto, prima di addormentarsi. lo invece, o mi addormento nei primi minuti, o faccio la notte in bianco. E poi c’era la scelta del canale TV. Mai una 176 Il Morbo di Monduz Ridimensionamenti volta che avessimo le stesse preferenze. Col telecomando, era una lotta all’ultimo sangue. Mi distraevo un attimo, e mi trovavo una telenovela. In bagno, al mattino, era peggio. Ci si avvicendava con un ritmo frenetico. Difficile sincronizzarsi. Sapere che c’era qualcuno in attesa dietro la porta non favoriva certe funzioni. Quando Laura mi comunicò che era meglio «regolarizzare» la nostra posizione, mi resi conto che vivevamo insieme già da due anni. Era stata così abile che non me n’ero accorto. Questa storia della «regolarizzazione» mi lasciò perplesso. Voleva forse che la adottassi? Be’, sì, avrei potuto sposare sua madre, cosa tecnicamente possibile, dato che era vedova. No, la sua idea era che ci sposassimo noi. Le giuste nozze E io che temevo nel matrimonio la fine della mia vita. Sciocchezze! La mia vita era già finita da un pezzo. La mia refrattarietà al matrimonio era proverbiale. Per evitarlo, mi ero cucito addosso una personalità che avrebbe dovuto scoraggiare qualunque donna, secondo me. Eppure, una disposta a sopportarmi l’avevo trovata! Mi chiedevo dove avessi sbagliato. Pochi anni prima, di fronte a una proposta di matrimonio, sarei fuggito a gambe levate. Questa volta la valutai. In fondo, anche Cristo era rimasto scapolo solo fino a trentatré anni; se ce l’avrebbe fatta a tener duro oltre, non si può dire, visto che proprio a quell’età gli era toccato un altro tipo di croce. Io, di anni 177 ne avevo già trentaquattro. Non sarebbe poi stata una resa disonorevole. L’occasione che mi si presentava era speciale: Laura forse era l’unica donna al mondo che avrei potuto sposare. Era meno gelosa di altre e mi lasciava lo spazio per respirare. Capitolai, a due condizioni: che ci saremmo sposati in municipio, con una cerimonia molto informale, e che ciascuno sarebbe tornato a vivere a casa sua, finché non si trovava una casa più grande. La cerimonia si svolse secondo le regole. Una mattina, alle 11, uscii dall’ufficio senza dare nell’occhio. In Comune raggiunsi Laura e i due testimoni: mia madre e la sua. Nessun altro. Le avevo riconosciuto la vittoria sul campo, ma avevo preteso l’onore delle armi. Il rito della capitolazione fu consumato alla presenza dei soli padrini. L’unico particolare offensivo, furono le felicitazioni delle sue amiche. Arrivavano telegrammi di congratulazioni da tutte le parti. Neanche fossi stato un cinghiale, da farci la foto col piede sul collo! Ma bisognava rassegnarsi: anche se siamo nei tempi moderni, quando una donna trova marito, tutte le donne fanno uno scatto di graduatoria in avanti. Nel cambio tra convivenza e matrimonio, entrambi ci guadagnammo. Le nozze sono un’istituzione flessibile. Si prestano a varie interpretazioni. Una dilettevole palestra fra equivoci e malintesi. Ma venne a galla un particolare che mi era sfuggito. Capii perché Laura aveva voluto sposarmi: non per mettere in pace la coscienza, o per placare sua madre, come diceva, ma per fare di me un fuorilegge sessuale! C’è un codice femminile, di cui non sospettavo l’esistenza: molte non escono con un uomo sposato, perché manca l’alibi di un possibile rapporto definitivo. Questo fu l’unico neo del mio gesto. Sposarmi, era stata una scorrettezza nei confronti di tutte le altre donne del mondo. Vita coniugale Confortati dal vincolo del matrimonio, ritornammo alla nostra bizzarra relazione e al pellegrinaggio delle «sportine». Tutto filava liscio, finché capitò un incidente. Un giorno lei, frugando in un cassetto, scoprì la mia agendina segreta! Quando arrivai a casa, mi recitò a memoria in ordine cronologico tutti i nomi delle mie conoscenti. Mi infuriai. Era un’operazione spionistica che interferiva indebitamente nei miei piccoli spazi. D’altronde, di che si meravigliava? Avevo mai detto di essere un ragazzo fedele? Il numero elevato delle mie amiche? Era una forma di precauzione. Quante più erano, minore il pericolo. Mi difendevo come potevo. Ogni uomo ha il suo hobby. Io non praticavo alcuno sport. Mi aveva mai visto tirare calci a un pallone? Non avevo nemmeno la passione del gioco. Lo sapevano tutti che me la cavavo male anche a briscola. Non amavo la caccia o la pesca. Non mi interessavo di bricolage. Non fumavo e non ero dedito all’alcool. Avevo un’unica grande passione, riconosciuta sana da tutti. Mi si poteva proibire anche quella? Le mie stringenti argomentazioni non la toccavano. Laura non stava a sentirmi. Si mise a braccarmi come un segugio. Voleva dimostrare che non le sarebbe sfuggito più nulla. Si era nuovamente installata nel mio appartamento, per tenermi sotto controllo. In casa era sempre baruffa. Ogni pretesto era buono per recriminare. L’avevo soprannominata «Lotta Continua», ma la situazione non era più sanabile con motti di spirito. Rasentammo il divorzio. Per fortuna, le cose a un certo punto si acquietarono. Ora, siamo giunti a una pace armata. Abitiamo nello stesso palazzo, però ciascuno in casa sua. Il mio appartamento-studio Logiche di matrimonio (degenerazione delle logiche di seduzione) II matrimonio nasce dal concetto del «compito a casa». Quando una cotta non riesci a smaltirla, te la trascini nel tempo. Non ti va di piantare il tuo partner prima di averlo debellato: sarebbe come lasciare un lavoro a metà. Per tenerlo sott’occhio, la convivenza è la condizione ideale. A volte il debellamento dura più del previsto e il matrimonio va avanti fino alla morte. Comunque prima o poi qualcuno ci lascia la pelle. L’inganno è un espediente per rendere felici due persone quando c’è spazio per una sola. Ci sono in ballo due sacrosanti principi da difendere: la fedeltà (dell’altro) e la libertà (propria). Ma la coppia è fatta di due persone, così i princìpi si incrociano e si accatastano. II matrimonio è una manifestazione agonistica. Il vestito da sposa è complicato e costoso, perché costruito con la logica dell’abito da corrida. Mancano solo le banderillas. Si è fatto tanto alla convenzione di Ginevra per regolamentare i diritti dei prigionieri, e nulla si è fatto per assicurare la dignità dello sposo, nelle feste nuziali. Tra vecchie zie esultanti e mamme che sollevano alla sposa il braccio guantato, in segno di vittoria, un uomo ci fa la figura del piffero . Sposandosi, un uomo deve sapere che la moglie finisce per adottarlo. Faccia quindi attenzione ai complessi edipici. Meglio non impelagarsi in lunghi amplessi. Protrarli nasconde un desiderio inconscio d’approvazione, del tipo: «Hai visto, mamma, come son bravo?». Per quanto si faccia, comunque, il coniuge diventa un consanguineo; alla lunga si configura un incesto. 180 Il Morbo di Monduz ha soffitti affrescati con nuvolette, poster, quadri, foto, libri e scartoffie dappertutto. La cucina è attrezzatissima e il frigo ben fornito. Sono autosufficiente, a eccezione del servizio di lavanderia. Ho messo nel bagno uno scrittoio, davanti al WC. Lo trovo indispensabile: è lì che vengono le migliori idee. Ho la mia libreria, il computer, lo stereo, le due linee telefoniche che mi seguono ovunque. Insomma, una casa da scapolo con tutti i crismi, per la mia personalità numero 1. Laura abita al piano di sotto. Divide un appartamento più grande con il nostro unico erede: il gatto Miago. C’è un grande terrazzo che dà sulle Due Torri. Nella buona stagione, ci coltivo la rucola e i pomodori. Fatta eccezione per l’orto, che è sotto la mia giurisdizione, questa casa se l’è organizzata a modo suo. È la mia casa da uomo sposato, per la mia personalità numero 2. Questa, dopotutto, è una soluzione accettabile. Il terrazzo non è grande come il cortile in via Orfeo, ma il concetto è lo stesso: un’oasi di quiete, un serraglio nel cuore della città. Un harem con una donna sola? No, questa è la mia casa di cura, per la convalescenza del Morbo di Monduz. I grandi viaggi Se sei scapolo, puoi anche tornare nello stesso posto ogni anno. Il paesaggio sarà sempre uguale, è la fauna che cambia. Se invece sei accoppiato, non potendo cambiare partner, il minimo che tu possa fare è cambiare paesaggio. E così ho fatto, visitando con cura e puntiglio i continenti, da Nairobi a Bangkok, da Los Angeles a Katmandu. Ridimensionamenti 181 Il Kenia Capitare in pieno inverno nell’Africa equatoriale era come aprire una magica porta tra i ghiacci e finire dentro l’estate. Non ero preparato per quel brusco trapasso. Siccome ho la pelle molto sensibile, mi ero comprato un caffettano di cotone che mi proteggesse dal sole e un cappellaccio di paglia che somigliava vagamente a un sombrero. Un’accozzaglia di stili da far ridere una vecchia americana in vacanza. Passeggiavo così intabarrato sul bagnasciuga, convinto di essere interamente protetto dai raggi del sole. Ma mi ero scordato un particolare: il dorso dei piedi! I raggi infocati individuarono subito il mio tallone d’Achille. Durante la notte mi si gonfiarono i piedi come focacce nel forno. Pernottai nella vasca da bagno con le estremità agonizzanti tra scaglie di ghiaccio che mi ero fatto portare dal cameriere. Sembravano triglie rossastre, sui banconi delle pescherie. Il giorno dopo non entravo nei sandali, dovetti fasciarmi con gli unguenti opportuni, infilarmi le calze e indossare un paio di pantofole adattate, con la tomaia scucita. Così visitai l’Africa tutta in pantofole. Non ero ancora guarito dalle ustioni, che ebbi un nuovo incidente. Io e Laura eravamo partiti per un safari fotografico, con un gruppo di turisti intruppati in un pulmino Volskwagen. Stavamo tappati dentro, secondo la logica del minimo rischio: portiere bloccate, finestrini sigillati e aria condizionata. La guida ci spiegava che era una zona molto pericolosa, infestata di fatali serpenti strozzaturisti. Tutti guardavano fuori dai vetri con aria trepidante, incerti tra il timore e la speranza di vederne qualcuno. Io invece ero assorto nei fatti miei, o più esattamente ascoltavo le budella che davano pericolosamente segno di sé. Erano tutto un groviglio di cattive intenzioni, un gorgoglìo, una sofferenza affatto particolare. Il mal di pancia, quando fa sul serio, è un tormento diverso da ogni altro dolore. Ti tocca alla radice dell’essere, ti fa 182 Il Morbo di Monduz comprendere la precaria condizione umana. Pensi all’inferno e capisci sin dove può spingersi l’ira divina. Una sorda vergogna ti nasce nel ventre, una sofferenza indecente si impossessa di te. Vorresti mettere decine di pesanti portoni tra il tuo dolore e il resto del mondo; cercare un angolo nascosto e massiccio, un angolo tra due spesse pareti blindate ai confini dell’universo, dove lo spazio finisce e non c’è niente di dietro. Questo era il mio stato d’animo, mentre mi trovavo stipato su quel pulmino in mezzo ai turisti festanti, sgomitanti e fotografanti. Le budella mi si attorcigliavano, sudavo freddo e mi trattenevo a grande fatica temendo che gli eventi mi prendessero - si fa per dire - la mano. Mi domandavo fino a che punto gli sfinteri potevano resistere a quella carica di peristalsi. Calcolando che avevo dieci secondi di autonomia, chiesi convulsamente alla guida di fermare un attimo, che avevo un bisogno. Il negretto mi guardò come lo steward di un volo transcontinentale guarderebbe un passeggero che chiedesse di scendere per comperare le sigarette. Mi spiegò cortesemente che ero matto da legare. E io a insistere: o mi faceva scendere con le buone, o saltavo fuori in corsa. Il negro si spaventò, intanto io mi aprivo un varco tra la gente e mi apprestavo a scendere. Lo sentii che mi gridava dietro qualcosa, in un misto concitato di inglese e swahili. Io ormai avevo guadagnato l’uscita e avanzavo a salti come un canguro tenendo in mano la cintura dei pantaloni e slacciandola mentre avanzavo, finché trovai una specie di buca cespugliosa che mi sembrò facesse al caso mio. Un tuono fecale rintronò nella foresta. Avvertii un rumore concitato, qualcosa che si muoveva, un animale senz’altro. «Alé, ci siamo,» mi dissi «ho beccato la tana di un serpente a sonagli e ci lascio le penne!» Mi aspettavo un morsicotto nel deretano, che avrebbe messo fine ai miei giorni. Almeno sarei morto con l’intestino sgravato! Ridimensionamenti 183 E invece si levò in volo un uccellaccio gigante, tutto incavolato e col becco visibilmente immondo per i rifiuti organici scaricati dentro il suo nido. Per tutto quel giorno fu un saliscendi dal pullman, tra la disperazione crescente della guida africana; alla fine arrivammo a un lodge, dove, guadagnato il bagno, mi ci rinchiusi definitivamente come un frate eremita. Gli USA L’anno dopo il Kenia andai negli Stati Uniti con l’amico Franco Mattioli. La prima tappa era New York, da lì avremmo organizzato il resto del viaggio. A me non piaceva arrivare in America senza una meta precisa, invece Franco mi ripeteva di non preoccuparmi, a New York conosceva un’agenzia con personale italiano che avrebbe organizzato i nostri spostamenti. Rimasi stupito dall’efficienza di quell’agenzia. Una signorina ci presentò una serie di depliant, consigliandoci le escursioni. Man mano che sceglievamo ne prendeva nota battendo sui tasti di un elaboratore. Quando finimmo il nostro viaggio con la fantasia, ci consegnò tutti i documenti già bell’e pronti: vaucher, biglietti di aereo, auto a noleggio, prenotazioni d’albergo con il numero di camera, perfino i biglietti per Disneyland. A me pareva incredibile. L’America era un paese meraviglioso! Ma era anche un paese dove i consumi avevano raggiunto il limite dell’aberrazione. Ecco cosa mi capitò a Disneyland. Arrivammo un mattino presto, da Los Angeles, con l’auto noleggiata, un macchinone azzurro di non so quale marca. Parcheggiammo in un immenso piazzale, seguendo le indicazioni dei posteggiatori, ed entrammo. Mi vennero incontro due ragazze vestite da Babbo Natale, offrendomi piccoli assaggi di pop corn. Erano 184 Il Morbo di Monduz gratis, e la cosa era sospetta: non mi pareva possibile che in America fosse sopravvissuto qualche filantropo. Compresi ben presto le motivazioni di quel gesto apparentemente generoso. I pop corn erano così salati da provocare una sete esplosiva. Cercai qualcosa da bere. Nessun problema: a dieci passi seguivano altre due Babbo Natale con un carretto di Coca Cola a prezzi da collezionista. Usciti da Disneyland ci trovammo in un bel guaio. Il piazzale si era riempito di auto e non riuscivamo più a trovare la nostra. Quel parcheggio era senza confini. Io e Franco provammo a procedere per un po’ a zig zag, ma dopo venti minuti ci rendemmo conto che ci avremmo messo tutta la notte. Eravamo ormai rassegnati ad aspettare che se ne fossero andati via tutti, quando incontrammo un inserviente sopra un trenino navetta. Gli spiegammo il nostro problema. Ci chiese a che ora fossimo arrivati, poi con un walkie talkie consultò la direzione e ci indicò il numero della sezione dov’era parcheggiata la nostra auto. Ancora una volta l’America mi aveva stupito. Mi piacque un po’ meno l’abitudine dei ristoranti di imporre l’aperitivo prima dell’assegnazione del tavolo. Questo rito costoso assumeva toni ridicoli. In un ristorante ci invitarono a prendere l’aperitivo in attesa che si liberasse un tavolo, quando si vedeva benissimo che non c’era un’anima. Nei bar, la logica del massimo profitto trovava la più esasperata conferma. Per non perdere tempo, quasi tutti i baristi dispongono di uno strano orpello multifunzione, una specie di serpentone di gomma che nasce dalle viscere del banco e termina in una testa di cobra con cinque o sei bottoni corrispondenti a una diversa bevanda: coca, selz, soda e chissà cosa. Per serviti una Coca, il barman dapprima stipa il bicchiere con Ridimensionamenti 185 cubetti di ghiaccio, poi, negli interstizi virtuali tra i cubetti, versa un’infinitesima parte di liquido marroncino. Ma non di Coca allo stato puro, bensì di una miscela di Coca con acqua, ottenuta tenendo premuto, in un punta-e-tacco fatto col pollice, il bottone del selz e della Coca insieme. Vedi i due rivoli di diverso colore che scendono nel tuo bicchiere, ma taci, rassegnato, considerando che forse è meglio così. Tanto la Coca, in fondo, è acqua sporca. A Las Vegas, scendemmo nell’albergo migliore, il Caesar Palace. L’entrata, di notte, tra file di sculture romane illuminate da batterie di lampade alogene, fu di grande effetto. Rimasi un po’ male scoprendo poi che le statue erano di polistirolo. La hall era una giungla di slot-machine. Difficile arrivare al banco delle accettazioni senza pagare il pedaggio. In compenso la camera era molto bella: divani in vinilpelle, tende di poliestere, tappeti di rayon e lampadari di poliuretano. Anche il bagno era stupendo, c’era persino il telefono dentro la doccia e di fianco al water. Il lavandino era immenso, tutto in onice. Mi meravigliai di quel lusso sfrenato. Ma quando mi cadde lo spazzolino dentro il lavello, fece uno strano rumore fesso. Perbacco, non era onice, era plexiglass! Mi venne il sospetto che anche le belle ragazze dall’aria equivoca, che girellavano per le sale da gioco, fossero bambole di polistirolo. L’Oriente Per riscattarmi da quel viaggio alla periferia del duemila, decisi di ripiegare sull’altro versante della civiltà. Partii, sempre con Franco, per un giro del Nepal e della Thailandia. 186 Il Morbo di Monduz La Thailandia era un enorme bordello. Evidentemente era passato da poco l’esercito americano. Offrivano donne e bambine a ogni angolo delle strade. Difficile sopravvivere a quell’assedio sessuale. Due uomini che vadano soli a Bangkok sono un’esca irresistibile per ogni tipo di ruffiani e battone. Appena giunti all’aeroporto, la guida ci propose una serata in famiglia: un’ammucchiata con la moglie, la figlia e la cognata, tanto per cominciare. Oppure una visita a un localino esclusivo e raffinato, dove una coppia di lesbiche si accoppiava con un somarello, sotto gli occhi benevoli di un transessuale superdotato che invitava il pubblico a usufruire delle sue prestazioni, pronto a fare le veci di uomo o di donna. Il taxista non voleva accompagnarci in albergo prima di averci fatto ammirare un bordello a ore, dove si potevano accatastare fino a venti ragazze in un unico amplesso. Resistemmo, scuotendo la testa, fino davanti al portiere, che ci propose una compagnia per la notte. C’era ampia scelta: una coppia di tredicenni smaliziate o un ragazzino bisex con la sorellina. Giunti in camera, squillò subito il telefono: era una ragazza illibata che ci prospettava un quarto d’ora di sesso sereno. Vivemmo così per cinque o sei giorni, tallonati da meretrici e lenoni, difendendo ostinatamente la nostra virtù. In altre condizioni, forse avremmo ceduto, ma in quel supermercato del sesso resistere era diventato un punto d’onore. Il Nepal fu un’esperienza speciale. Un angolo di medioevo sopravvissuto nei secoli ci apparve davanti come un miraggio, non appena scendemmo con l’aereo sull’altipiano di Katmandu. Lingue di sole giallo illuminavano la sera, a volo radente. Facce smunte ma serene riempivano i cortili e le stradine pavimentate di ciottoli. Noleggiammo un triciclo a pedali con conducente, una specie di taxi scoperto che aveva il vantaggio di non fare Ridimensionamenti 187 rumore, e girovagammo per il centro osservando con tenerezza scene del passato. C’era una strana grazia nei gesti della gente, che sembrava interpretassero un rito ben collaudato. Vecchi che giocavano con i bambini, animali che passeggiavano per le stradine, indisturbati. Un barbiere, approfittando delle ultime luci, tagliava i capelli a un ragazzo. Case e templi antichissimi si ammucchiavano gli uni sugli altri. Osservavo estasiato la liturgia di quei gesti, l’infinita struggente poesia di quello spaccato di vita. Una vecchietta venne alla finestra, a chiamare in casa un bambino che giocava giù nel cortile. Mi sembrò di vedere mia nonna, tanti anni prima, con me. Ecco, da dove veniva quel senso di pace, la serenità del vecchio cortile: via Orfeo! Sì, quella città con le sue suggestioni, il calore dei suoi sentimenti, era un immenso cortile, dove il tempo si era fermato. Patologia recente Nel mezzo del cammin... Avevo superato i trent’anni e, seguendo l’esempio di Dante Alighieri e di chissà quanti altri meno famosi, mi trovai a fare un consuntivo di metà periodo. Volevo esaminare l’evoluzione della mia vita per capirci qualcosa e cercavo un posto all’altezza del compito. Da anni non andavo più a Cortina. Era stata il teatro delle mie più belle avventure. Quell’agosto, tornai nella mia vecchia casa di Gilardon e mi sistemai in salotto, con il tavolo davanti alla finestra. Avevo una quantità di block notes, gomme, matite, pennarelli di tutti i colori. Iniziai i lavori in una mattinata di sole, con i vetri spalancati e l’arietta che entrava frizzante. Avevo davanti agli occhi il gruppo delle Dolomiti e, sotto, Cortina con le sue seduzioni infinite. Cominciai ad analizzare gli episodi principali della mia vita, cominciando dalle prime esperienze. Vidi scorrermi davanti agli occhi sfilze di fallimenti e successi. Perché tante inversioni di rotta? Avevo passato metà della vita a costruire prigioni e l’altra metà a studiare evasioni! Un bambino, quando rompe i giocattoli, non lo fa per vandalismo, come pensano i grandi. Lo fa per riacquistare la libertà di cambiare gioco. Io avevo spezzato carriere tranquille e sicuri successi per ritrovare la libertà di cominciare da capo. Una costante della mia vita era il business, ma solo per neces- 190 Il Morbo di Monduz sità. Non sentivo attrazione per l’attività di fare quattrini; potendo, avrei stampato direttamente le banconote. Fare l’editore, dopotutto, era un mestiere che ci somigliava. Non valeva la pena di spingersi troppo in là, con gli affari: perché gareggiare in un campo dove valeva il diritto di nascita? Lavorare una vita per essere pari a quelli che ricchi c’erano nati? Poi, c’era la passione per le donne: ecco la vera molla della mia esistenza. Questo era un fatto genetico. Quando una donna ti dice di sì, è la vita che ti offre il semaforo verde: dà l’omologazione ai tuoi cromosomi. Ti schiude il portone sul cortile dei posteri e inserisce il tuo nome nella lista dei partecipanti al sorteggio finale. Per superare il collaudo delle mie amate compagne, da ragazzino m’era bastata la simpatia. Da grande c’erano voluti anche un po’ di soldi, a conferma che in affari la simpatia dava i suoi frutti. «Accidenti» pensavo «appena ti metti comodo, cambi d’età, e sei costretto a organizzarti in un modo diverso! » Con gli anni, non sarebbe più bastato nemmeno il denaro, per vivere l’ultimo scampolo di seduzione. Ci sarebbe voluto un sospetto di genialità, un carisma che facesse perdonare i troppi anni vissuti. Un alibi chiamato «successo». Insomma, per continuare ad avere belle donne da vecchio, bisognava diventare un grand’uomo. Il «Romanzo totale» Da anni coltivavo il sogno di ritrovare la vena letteraria perduta al ginnasio, sotto le grinfie dell’atroce Zòccoli. Volevo scrivere un romanzo di almeno trecento pagine. Ci avevo provato un sacco di volte. Partivo di buzzo buono, con un titolo di grande respiro, scrivevo di getto le prime pagine e poi, regolarmente, alla seconda o Patologia recente 191 terza cartella esaurivo la vena. «Forse è il tema, che ho sbagliato!» pensavo, e mi veniva subito in mente un nuovo titolo formidabile. Così ripartivo in quarta, sotto la nuova bandiera, convinto che sarei riuscito a espugnare il numero di pagine regolamentari. Invece in tre o quattro paginette arrivavo alla fine. Ma come diavolo facevano i grandi romanzieri a tirarla in lungo per centinaia di pagine? Mai che avessero la tentazione di stringere. Da una divagazione passavano all’altra che era un piacere. Per descrivere la discesa dal letto, c’era chi impiegava due o tre miei romanzi completi. Ah, Proust, che splendida logorrea! Invece io, nello scrivere, soffrivo della stessa smania che avevo nel vivere. Poche chiacchiere e dritto al sodo. Non sarei mai riuscito a raggranellare un romanzuccio. Però con tutti quegli scampoli letterari, un bel po’ di materiale l’avevo. Mi venne un’idea. Avrei raccontato una storia che ben conoscevo: quella di un apprendista scrittore che tenta di scrivere un romanzo di trecento pagine senza mai arrivare a pagina due. Un giorno costui scopre di avere trecento romanzi di una pagina sola e decide di pubblicarli tutti e trecento, così come stanno. Provai ad assemblare le mie scartoffie. Ne usciva un libro talmente strampalato che, per la logica dell’assurdo, si sarebbe potuto anche vendere. Il titolo, come sempre, era la cosa più facile. Lo avrei chiamato Romanzo totale. Ora bastava trovare un editore e il gioco era fatto. Per primo interpellai Mondadori, naturalmente. Dopo alcuni contatti epistolari infruttuosi, ripiegai su arrembaggi telefonici, con risultati miserevoli. Esasperato, decisi di passare al corpo a corpo, presentandomi di persona a Segrate. Dopo aver driblato la palazzina della portineria, mi trovai dinanzi un parallelepipedo di vetro, appeso dall’alto, su immense campate di calcestruzzo. Il tutto circondato da prati e laghetti coi cigni. Un vero spettacolo. 192 Il Morbo di Monduz Mondadori e il Pentagono appartengono al club delle strutture meglio protette dalle infiltrazioni di postulanti e spioni. Quelle pareti di vetro si rivelarono muri di gomma. Non riuscivo a parlare con un editore incaricato. Non riuscivo neanche a sapere chi fosse. Dopo estenuanti passaggi fra corridoi labirintici, venni dirottato da nonsopiuchi alla vicesegreteria dell’Ufficio-Scoraggiamento-Presunti-Scrittori. Una segretaria ossuta, di sopra gli occhialetti a mezzaluna, di quelli con il cinghino per tenerli a tracolla, mi guardò con aria di commiserazione. I suoi occhi di madre erano un chiaro invito a cercarmi un’occupazione sicura e a lasciar perdere velleità fuori posto. Era proprio l’incarnazione dei timori inconfessati di uno scrittore alle prime armi. Il prototipo di un incubo letterario. Mi disse di lasciare il manoscritto, che lo avrebbe esaminato, ma mi sembrò che osservasse pericolosamente il cestino. Uscii adagio adagio, con l’orecchio teso a decifrare il rumore che fa una risma di carta buttata in canestro. Per qualche tempo, finché il manoscritto non mi fu reso, mi perseguitò tutte le notti un incubo piuttosto monotono: portavo il mio manoscritto all’Editore, e lo trovavo attorniato da centinaia di Presunti Scrittori laceri e macilenti, ciascuno con il suo manoscritto sotto il braccino rattrappito. L’editore aveva un ghigno sinistro e svariati cestini di carta zeppi di testi respinti. Per i manoscritti peggiori, aveva un cestino speciale, con la catenella per tirare l’acqua. Una specie di tazza del water modificata. Guardavo dentro il gorgo di quella tazza: c’erano decine di manoscritti che navigavano, e ognuno portava lo stesso titolo: Romanzo totale. Mi sentivo accapponare la pelle e mi dimenavo nel letto. Guardavo meglio sulla scrivania e vedevo centinaia di manoscritti che giacevano in ordine sparso, ciascuno con il suo bravo titolo, sempre lo stesso: Romanzo totale! L’Editore ghignava feroce e i giovani Scrittori Presunti gli facevano eco, mostrandomi il Patologia recente 193 titolo del loro pacco di scartoffie che, neanche a dirlo, era ancora lo stesso: Romanzo totale! Di incubo in incubo, passai in rassegna le principali case editrici, in ordine inverso al loro fatturato. Nessuna che fosse disposta a pubblicarmelo! Non era la prima volta che gli editori respingevano le mie proposte. Quindici anni prima, da un testo respinto era nata la Monduzzi Editore. «Ci risiamo, con questi editori» dicevo tra me «dovrò dar loro una seconda lezione. Ancora una volta, pubblicherò il libro per conto mio!» La casa editrice stavolta l’avevo, però non m’ero mai cimentato con un’opera di narrativa. Non avevo idea di quale palude fosse la distribuzione in duemila librerie. Pubblicarlo fu roba da ridere, distribuirlo fu il vero problema. Nessun distributore, consultato preventivamente, ne voleva sapere di quest’opera unica, di una casa editrice specializzata in tutt’altra materia. Comunque non mi sarei arreso per così poco. L’avrei distribuito io stesso, con l’aiuto di qualche rappresentante avventizio. Curai molto la veste grafica e l’impaginazione. Cosa non facile, visto che dentro quel libro c’era di tutto: racconti, aforismi, poesie, persino ricette di cucina e consigli per i naviganti appiedati. Mi pareva uno zibaldone originale. Di libri così non ne avevo mai visti. Lo diedi a stampare alla «Nuova Stampa di Mondadori » di Cles. Mi pareva di buon auspicio. Visto che non potevo essere pubblicato dal Grande Editore, almeno avrei usato la sua tipografia. Portai a Cles gli impianti in pellicola assieme a Benedetti, mio braccio destro. Cles è un centro stampa da fantascienza! Lavoravano a ritmi serrati, con le tecnologie più avanzate. Appena arrivai con le pellicole del mio libro, cominciarono a incidere le lastre, utilizzando un metodo a me sconosciuto. Tutto il testo veniva riprodotto in rilievo su un lungo nastro flessibile che, una volta montato sui rulli, sfrecciava a ritmi di formula uno. 194 Il Morbo di Monduz Patologia recente 195 Prima che me ne andassi, da quello strano ordigno cominciarono a uscire raffiche di Romanzi totali veloci come pallottole. Feci il conto che avrebbero completato la stampa ancor prima del nostro arrivo a Bologna. Poi il mio «nastro» sarebbe stato archiviato vicino a quelli dei grandi scrittori! Chissà che, frequentando compagnie aristocratiche, il mio romanzo non si impratichisse di letteratura. Appena arrivarono i bancali coi libri, iniziammo a distribuirli a Bologna. Mandai avanti Benedetti a fare le consegne nelle librerie del centro. Io lo seguivo di soppiatto, emozionato come un bambino. Osservavo le pile di Romanzo totale sugli scaffali, attraverso i vetri, perché mi vergognavo ad entrare. Alla libreria Rizzoli l’avevano esposto in vetrina! Ebbi un tuffo al cuore. Il mio antico sogno, eccolo là, che mi ammiccava dietro una bacheca, incarnato in un libro reale. Purtroppo ci furono ostacoli nella distribuzione. Molti librai non volevano prendere il libro nemmeno in deposito. Era una battaglia convincerli. Romanzo totale fu un «Fiasco totale». Nessun critico ne parlò, nemmeno per stroncarlo. Fu talmente un fiasco, che non se ne accorse nessuno. d’Anatomia. Volevo racimolare i soldi per andare a sciare e guarda che bel risultato: a Cortina non ci riesco più a mettere piede. Sono prigioniero dentro un ufficio. Questo non è un lavoro, è una condanna! » Nella casa editrice, ero sempre in prima linea. Ogni affare doveva passare per le mie mani. Questi metodi artigianali del «padrone che fa tutto lui» non erano tagliati per il mio carattere. Ci doveva pur essere un sistema di deleghe che lasciasse agli altri il diritto a sgobbare. Mi mancava una cultura imprenditoriale. Ecco il problema! Al liceo, avevo imparato Greco, Latino, Storia e Filosofia, lussi culturali che servivano poco, in un’azienda. All’università poi, con Medicina e Psichiatria, avevo completato il mio curriculum di studi su tutto quanto non mi sarebbe servito. Cercai una buona scuola di conduzione aziendale. Le migliori erano all’estero, naturalmente. Ma mi sembrava esagerato affrontare viaggi e lingue straniere. In fondo non avevo intenzione di fare concorrenza alla Gulf & Western: volevo organizzare un sistema di deleghe nella mia aziendina. Mi iscrissi all’Istud di Stresa: un piccolo staff di cervelli, aggiornati sulle strategie d’oltreoceano. Tenevano i corsi in un vecchio albergo sul lago Maggiore, privo di distrazioni, adatto alla concentrazione e al lavoro in piccoli gruppi. Gli studi aziendali Il primo giorno di scuola, entrando in classe ero un po’ intimorito dall’autorità dei compagni. A parte me, erano tutti dirigenti di grandi aziende, persone oltre i quarant’anni, con brillanti carriere alle spalle: Direttori Generali, Marketing e Commerciali. Io ero un caso atipico, l’unico giovane imprenditore, un self made man. Quando nelle esercitazioni facevo riferimento alla mia azienda, si mettevano tutti a ridere per il mio giro d’affari: erano abituati a trattare cifre con diversi zeri in più. Ma quando descrissi in aula i miei primi passi di imprenditore, ci fu un gran Dopo la batosta del Romanzo totale tornai prontamente nei ranghi. Ero rassegnato ad accantonare la « teoria del grand’uomo ». Avevo tentato la via del successo, e ci avevo rimesso tempo e quattrini. Era meglio che badassi alla mia casa editrice; dopotutto era stata l’unica a darmi soddisfazioni, anche se me ne lamentavo. «Accidenti a me» pensavo « e a quella malaugurata dispensa 196 Il Morbo di Monduz silenzio. La mia storia li appassionava. Avevano un misto di incredulità e ammirazione per la mia fantasia e capacità di sacrificio. Fatturati piccoli o no, dopotutto io non avevo padroni. Si divertivano con i miei continui riferimenti al mondo della seduzione. In affari avevo applicato gli stessi metodi che usavo per corteggiare le donne. Le tattiche del sex appeal e quelle del marketing, in fondo, si somigliano. Conquistare un mercato non è tanto diverso dal conquistare una bella ragazza. Ridevano come bambini, sotto le raffiche delle mie trovate. L’atmosfera solenne del corso cambiò. Qualcuno iniziò a raccontare le sue avventure amorose e, guarda caso, a trovarci un nesso con certe operazioni imprenditoriali. Cominciammo a mandare bigliettini galanti alle poche colleghe donne. Gli insegnanti facevano fatica a mantenere la disciplina: alcuni lanciavano palle di carta, altri sfilavano le sedie da sotto il sedere del vicino di banco. Sembravamo una scolaresca di ragazzini impazziti. Dopo le lezioni facevamo interminabili passeggiate lungo la riva del lago. In quelle serate di primavera ci sentivamo come collegiali nell’ora di uscita, quando tiravamo a calci i sassi nel lago. Trapelava in noi una tenerezza incancellata, la nostalgia dell’infanzia, come se fossimo tanti bambini cresciuti a nostra insaputa. Quando mi lasciai scappare di aver scritto il Romanzo totale ne vollero tutti una copia con dedica. Ne avevo sempre una scorta nel baule dell’auto. Fu quello il mio primo pubblico. A parte gli scherzi, studiavamo e imparavamo. Finalmente cominciavo a capire cos’era un bilancio, un organigramma, un cash flow. Quante utili conoscenze! Mi appassionai a tal punto che decisi di seguire un altro corso di Finanza e poi uno di Strategia. A quel corso, incontrai due dirigenti della Mondadori, la casa editrice presso cui avevo sognato di pubblicare il mio Romanzo totale. Uno di loro, Carlo Patologia recente 197 Binelli, rimase colpito dalla mia «opera prima» e mi dette un consiglio: «Paolo Caruso è il tipo giusto per te! Appena vieni a Milano te lo presento. È l’editore incaricato per la saggistica, quello che ha scoperto De Crescenzo. A proposito, conosco bene Luciano, è un tipo che ti somiglia. Sono certo che andreste d’accordo!» Binelli mi aveva dato un’indicazione preziosa, per il mio futuro di scrittore. Il vero business Una volta completati i corsi di Stresa, avevo messo in ordine i miei quaderni di appunti. Così, ogni sabato impartivo lezioni su tutto quel che avevo imparato ai miei principali collaboratori: Benedetti e Bettocchi. L’anno dopo sarebbero diventati i miei dirigenti. In un paio di mesi avevo finito il ciclo d’istruzione: oramai parlavamo la stessa lingua, come quelli del «Boston Consulting Group»! Cominciammo insieme ad applicare le nuove teorie alla pratica quotidiana. Mettemmo giù le premesse per fare della Monduzzi Editore una piccola industria moderna, gestita con il rigore e la logica della grande impresa. Sono rimasto in contatto con l’Istud. Gli sono riconoscente per il contributo dato allo sviluppo della mia azienda. La scuola ha pubblicato il mio caso aziendale, come esempio di strategia. Lo usarono all’esame di ammissione per un corso di Sviluppo delle abilità direttive. Logiche di denari Logiche politiche L’economia italiano non affonda grazie a quello che gli Italiani non pagano di tasse. Odio le zanzare perché mancano di stile nel succhiare il sangue. L’impresa aziendale è la migliore soluzione per arricchire. L’azienda è simile a un ospedale psichiatrico: vi si incontrano tante forme patologiche, suddivise in reparti omogenei: amministrazione, marketing, vendite... Qui però nessuno vuole curarsi, anzi desidera potenziare la sua personale follia, integrandola armoniosamente con quella degli altri malati. Lo scopo è nobilissimo: trasformare una corsia di pazzi in una corsia di milionari. Manager e imprenditori sono affetti dalla stessa malattia. C’è però una differenza tra loro: gli imprenditori sono casi più gravi. Per fare un parallelo corretto, potremmo dire che se tra i manager si trovano già delle belle nevrosi, solo tra gli imprenditori si riscontrano le psicosi da manuale. Questo merito è riconosciuto dal consorzio civile, e infatti guadagnano più di chiunque. Arricchire non è poi così difficile come può sembrare dall’esterno: basta continuare a guadagnare anche quando non se ne ha più bisogno. Il tuo prossimo farà il resto: appena capisce che di soldi ne hai già troppi, ti offrirà la sua collaborazione per guadagnarne ancora. Le banche faranno a gara per imprestarti quattrini. Chiunque ti proporrà lucrosi affari. Una volta raggiunto il benessere, la vera difficoltà è riuscire a evadere. Ecco la formula della ricchezza ponderata: si ottiene calcolando il numero delle persone che gravitano nel tuo sistema economico, moltiplicate per il loro giro d’affari. II giorno in cui ti avvicinerai alla politica, ti colpirà un senso di sollievo, scoprendo che tutte le ribalderie, che da anni progettavi di realizzare da solo, per ampliare i tuoi affari, sono già state inventate da tempo, e sono lì, pronte per l’uso, a tua disposizione. Scoprirai con stupore un’intelligente congrega, molto ben organizzata. Ognuno ha il suo compito: chi dà ordini, chi fa i controlli, chi punisce i contravventori, chi fa i bilanci e spartisce gli utili. C’è perfino un esercito a disposizione, per i casi più disperati. Qui potrai barattare denaro con favori, ricatti con interessenze, segreti con immunità, tangenti con evasioni fiscali. Se sei un brigante di razza, è inutile che perdi tempo con lupare e sequestri, tanto vale che parti subito con la politica di professione. C’è più soddisfazione a sgambettare lazzaroni nati, che a far inciampare le vecchiette per strada. Nessun senso di colpa potrà sorgere mai dall’aver truffato un truffatore. Qualunque bassa azione, scaricata su altri briganti, suonerà come una giusta punizione divina: tanto se la meritava! Ogni parlamento è un reparto chiuso, per i casi incurabili. Questi pazienti stan bene tra loro. La politica svolge così una funzione catartica, raggruppando nel Lazzaretto i migliori imbroglioni dell’umanità, nella speranza che si eliminino l’uno con l’altro. L’immunità parlamentare è un’istituzione giustissima: che senso avrebbe incriminare un politico? Nella sua funzione è già implicito tutto. La formula del potere politico comparato si ottiene calcolando il numero delle persone che tieni sotto ricatto, moltiplicato per quelli ricattati da loro. 200 Il Morbo di Monduz Vasco Rossi La casa editrice marciava come un orologio. I piani strategici erano formulati, bisognava svilupparli pazientemente. La mia presenza assidua in azienda comportava invece un tale sovraccarico di idee e innovazioni, da scatenare il panico tra i miei collaboratori. La Monduzzi Editore aveva bisogno di un periodo di tranquillità per consolidarsi. Insomma, era necessaria la mia assenza. Ne ero ben lieto. Cominciavo ad annoiarmi tra budget e piani di investimento. Volevo scrivere testi di canzoni, tanto per evadere un po’. «A proposito, che fine avrà fatto Vasco?» mi chiesi. Vasco era Vasco Rossi, che avevo conosciuto nel periodo in cui si occupava di una delle prime radio private: «Punto Radio» di Zocca. In quella gabbia di matti avevo perso un bel po’ di quattrini. Ora sapevo che si era messo in testa di fare il cantante. L’avevo sentito qualche volta per radio: la sua voce mi era parsa poco intonata, ma le ragazzine accorrevano ai suoi concerti. Ero curioso di saperne di più. A casa sua non c’era. Chiamai la madre, a Zocca, unico punto fermo della sua vita. Trovai la signora angustiata. Mi disse che Vasco era andato a vivere in un capannone industriale, a Casalecchio. Era preoccupata per la salute del figlio: si nutriva di pillole, latte e bustine dietetiche. Per una madre emiliana, la peggiore delle iatture è un figlio che rifiuti le tagliatelle. Vasco ed io, un poco ci somigliavamo: figli unici entrambi, coccolati dalla famiglia, avevamo il complesso di sentirci al centro del mondo. Eravamo colpiti tutti e due dal Morbo di Monduz, ma fra noi c’era una differenza: io mi arrabattavo per cercare una cura, lui invece ci si era piazzato fisso. Aveva costruito intorno al Morbo una muraglia ideologica e ne aveva fatto uno stile di vita. Patologia recente 201 Io, le donne, le coccolavo una per una, Vasco a plotoni. Ne aveva sempre una dozzina fisse, più qualche centinaio di casuali. Confesso che ero invidioso di tanta abbondanza. Non riuscivo a capire come facesse. Mi sentivo come un droghiere di fianco alla COOP. In quello squallido capannone, lo trovai più malridotto del solito. Stava su un letto immenso, sommerso di cianfrusaglie elettroniche. C’era un disordine da far paura. Vasco aveva l’aria macilenta e la barba lunga, ma in quello sfacelo di faccia, i suoi occhi azzurri, «chiari come l’acqua», brillavano d’intelligenza. Una mente geniale, al servizio dei vizi e della follia. Gli feci vedere le mie composizioni poetiche. Finse di leggerle, ma aveva in testa altri progetti per me: mi chiese di sostituire temporaneamente il suo manager. Dopotutto, volevo fare nuove esperienze e provare nuove emozioni. Accettai, senza averne chiaro il motivo. In realtà volevo studiare quel soggetto da trattato psichiatrico e comprendere, una volta per tutte, le sue diaboliche strategie con le donne. Per circa tre mesi cercai di pilotare quello sconvolto tra sale d’incisione, case discografiche e locali notturni. Cercai anche di convincerlo a ricoverarsi in una clinica svizzera per una cura del sonno. Ma non ci fu nulla da fare. Vasco era affezionato al suo Morbo. Si capiva che Rossi stava per decollare. Ogni giorno si facevano avanti nuovi impresari. Il telefono suonava in continuazione e le lettere di ammiratrici arrivavano a sacchi. Fare il suo manager era una vita d’inferno: tutte quelle ragazze impazzite per lui, che non mi degnavano mai di uno sguardo! Come si fa a vivere nel cortile di un altro? Quella, per me, era la morte civile. Passai la patata al suo vecchio impresario e tolsi il disturbo. 202 Il Morbo di Monduz L’esperienza con Vasco non era stata del tutto inutile. Con lui, avevo imparato ad apprezzare le discoteche... Elogio della discoteca Sarà una forma di masochismo, ma non so resistere, specialmente quando sono in vacanza: lo debbo fare. A volte ho tentato di andare a coricarmi senza, ma poi una forza superiore mi ha ordinato di rivestirmi, di parcheggiare l’auto in posizione assurda e, alla fine, di entrare. Sto parlando della discoteca più vicina, naturalmente: l’antro maliardo della frustrazione sessuale, il teatro stabile dello psicodramma collettivo sexy-analfabeta, il trionfo della lusinga afasica. Grazie ai suoi decibel da infarto acustico, qui finalmente il concetto di democrazia trova la sua massima applicazione: nella totale assenza di ogni forma di linguaggio evoluto, il tuo coefficiente mentale si livella armoniosamente attorno alla media di Canale 5. Dovendo star zitto, nessuno potrà schiacciare il suo prossimo con motti di spirito e argomentazioni complesse. L’aristocrazia del pensiero finalmente è neutralizzata. Qui tutta la tua scienza di animale pensante, le lauree, la tua biblioteca mentale crollano miseramente di fronte a due tettine che sobbalzano ritmiche, a un culetto che si dimena bene. Culetto e tettine cui manca soltanto il dono della parola, come a te, come a tutti, in quel frastuono. Che sottile rivincita! In questo antro felice, la fine intelligenza, questa antipatica pedante compagna di viaggio, soccombe di fronte alla potenza delle rotondità: l’acuto si inchina davanti al rotondo. Ogni volta che esco dai suoi megawatt, stravolto dalle acufeni, allucinato da visioni semi-mistiche di sobbalzanti divinità semisferiche, mi riprometto di non tornarci mai più. Ma poi ci rifinisco regolarmente. La discoteca è una droga. Patologia recente 203 I primi sintomi dell’assuefazione sono facilmente riconoscibili: tendenza a parlare per slogan, ammiccamenti recidivi, sorrisi tetanici, passaggi cadenzati dalla toilette a controllare lo stato del ciuffo. Il rituale è codificato: con la tua baldanza appesa a una sigaretta, sleghi una conversazione fatta di slogan a presa rapida. Devono essere brevissimi, prima che ti sfugga via la compagna, travolta dal fascino di qualcuno che tiene in mano il bicchiere con più sicurezza. La sensazione di rischio aleggia nell’aria: emuli di Humphrey Bogart si aggirano pericolosi nella penombra, con un sorriso studiato per ore allo specchio, osservando fatali orsacchiotte calzate con pesanti stivali di camoscio in piena estate, maestre di mimetismi degni di un commando di teste di cuoio. Tutti pronti a surclassarti. In discoteca, le tue credenziali le hai cucite in faccia: l’uso della convenzione verbale è interdetta, la tua parola è in ostaggio agli altoparlanti. Eppure ci vai e ci torni. Un’ansia ti chiama, una sirena che tormenterebbe i tuoi sonni con il sospetto della «grande occasione perduta». La visione inquietante è sempre la stessa: la donna (o l’uomo) dei sogni, la tua grande promessa, che vaga sconsolata alla tua ricerca per tutta la notte. Questa è la favola che ti perderesti, dormendo. Ma dentro ti attende un altro quadretto. In pista, sobbalzanti creature femminili, in preda a raptus di narcisismo, esibiscono il risultato dei loro studi davanti allo specchio. Miele irresistibile e tormento per le orde migratorie di occhi maschili attirati da tutto ciò che sobbalza, riluce, rigonfia. Nell’ombra confidenziale del bar staziona un bicchiere di whisky sospeso nel vuoto di una solitudine ironica e fiera. I tuoi occhi, che osservano divertiti quel carosello di uomini persi nel dolore/piacere di ritrovarsi tutti uguali, accomunati nella ricerca di essere tutti diversi. Stivalati, azzimati, finto-arruffati, bicchierati e sigarettati, tutti assorti nell’esibizione della propria esistenza: «Recito, ergo sum»! 204 Il Morbo di Monduz Il tuo petto, rigonfio per la durata di uno spot pubblicitario, il tuo sorriso di repertorio, si squaglieranno come neve al sole, davanti all’uscita, quando dovrai fare l’ennesimo consuntivo del tuo tempo perduto. Ma ora puoi tornare al tuo letto con la coscienza a posto: il tuo dovere l’hai fatto. Al quotidiano appuntamento con le illusioni, tu c’eri. Nel mondo dei sogni, la donna dei sogni non potrà rinfacciarti alcuna inadempienza. Operazione successo Tramite Binelli, avevo conosciuto Paolo Caruso, editore incaricato della Mondadori, l’uomo che mi era mancato, ai tempi del Romanzo totale. Paolo è un tipo geniale e scorbutico, adorabile e odioso a giorni alterni, preziosissimo sempre. Sa tutto dei meccanismi editoriali e qualche volta ne approfitta per angariare i miseri autori. Cominciammo a frequentarci sempre più spesso. Penso che lui fosse affascinato dalla mia rapida carriera di editore. Dal canto mio, ammiravo la sua padronanza di un ramo dell’editoria che non conoscevo: quella capace di smerciare libri sul tipo del Romanzo totale. Lo andai a trovare spesso a Segrate. Facevamo passeggiate nel pioppeto della Mondadori. Gli raccontavo la storia della mia vita e lui mi illustrava le vie per fare un bestseller. Era un mondo nuovo, per me. Scoprii che un libro, per essere pubblicato, doveva passare una sfilza di esami. Il primo filtro era il «lettore», un signore invisibile, che leggeva i manoscritti emettendo il suo verdetto inappellabile. Poi veniva il turno dell’editor, che dava il suo benestare. Infine c’era da superare l’approvazione del «comitato»: una specie di Santa Inquisizione, composta di vari direttori, che emettevano il verdetto finale. Me li immaginavo incappucciati di nero. Patologia recente 205 Gli ozii romani Caruso mi presentò Luciano De Crescenzo. Per me fu un incontro storico. In quell’ingegnere fuggito dall’Ibm riconobbi me stesso scappato dalla medicina. La prima volta che entrai in casa sua ero emozionatissimo. Mi pareva di entrare nel tempio della letteratura. Era il primo scrittore che conoscevo. E poi, un uomo che, prossimo ai sessant’anni, riceveva venti telefonate al giorno dalle donne più belle d’Italia, be’ era un caso degno di studio. A volte mi sostituivo alla sua segreteria telefonica. Fingevo di essere il messaggio registrato, e raccoglievo indirizzi preziosi. C’erano donne che entravano e uscivano a ogni istante. Mi ero messo a dirigere il traffico. Quella casa era un pollaio. Mi sembrava di essere da Vasco Rossi. Avevo fatto una scoperta importante: Luciano era malato del Morbo di Monduz, ed era ancora più grave di me. Da bravo ingegnere dell’Ibm, custodiva gelosamente le sue donne in un file del computer. Le aveva catalogate per età, bellezza, carattere, e altre caratteristiche che qui tralascio. Ce n’erano quasi duemila! Bastava premere un tasto, e venivano fuori come le volevi: per bellezza, per CAP, per età. Fantastico! Quando si dice: i miracoli del progresso. Altro che la mia modesta agendina! Ero affascinato da tanto ammorbamento. Luciano sarebbe diventato il mio maestro. Cominciai a frequentarlo assiduamente. Spesso andavo a Roma per passare una serata con lui. Luciano si metteva al computer, come un cuoco che consulti le sue ricette, e trovava i numeri telefonici di donne stupende. Una telefonata, e loro uscivano subito. Quell’uomo era un angelo! 206 Il Morbo di Monduz Dovunque andassimo, la gente lo riconosceva per strada. Ragazze che ci sorridevano, voltandosi verso di noi. Il suo successo era come un’aureola che straripava e si irradiava anche su di me. Gli stavo il più attaccato possibile per sentirne il benefico influsso. Vicino a lui mi sentivo spavaldo: io non ero famoso, ma il suo successo bastava per tutti e due. La notte, sdraiato sul divanoletto del suo studio, talvolta non riuscivo a dormire. Percepivo l’atmosfera creativa di quella stanza. Mi sembrava che la genialità di Luciano impregnasse le pareti e si diffondesse nella mia mente. Respiravo l’aria del suo successo e mi inebriavo. Tutto era magico. In un angolo, il suo computer mi pareva una moderna lampada di Aladino. Bastava strofinare i tasti fatati e si materializzavano le più belle donne dei sogni. Ci si vedeva sempre più spesso. Luciano mi aveva fatto conoscere i suoi amici romani: la famosa Banda Arbore. Erano un gruppo di matti molto affiatati. Attori, produttori e amici devoti tra cui, naturalmente, spiccava Renzo Arbore, genio assoluto. Anziché applicarsi alla scienza o agli affari, si era dedicato all’arte di gozzovigliare. Nessuno ci riusciva meglio di lui. Trovandosi con una mente come la sua, c’è chi dà la caccia al Nobel o tenta la scalata all’alta finanza. Arbore aveva il genio dell’imprenditore e dello scienziato, ma la sua azienda era il divertimento. La sua scienza: belle donne, successo, amici e vacanze. Il tutto perseguito in modo scientifico, a livelli d’industria. A Bologna ero abituato a sentirmi fra i più stravaganti della compagnia. In mezzo a quella combriccola sembravo un tipo normale. Erano tutti malati del Morbo di Monduz, molto più Patologia recente 207 gravi di me. Ne avevano fatto un sistema di vita. Il cinema, la letteratura, lo spettacolo, erano solo un pretesto per avvicinare più donne. Ero nel mio brodo. Mi accettarono subito tra loro come un nuovo malato che entrasse in reparto. 208 Il Morbo di Monduz Patologia recente Logiche geografiche Tra le nebbie di Bologna puoi trovare tagliatelle, tagliatelle e salsícce. Per cercare tutto il resto devi andartene da qui. La vita in provincia è un inferno. Oltretutto in provincia pullulano donne dal culo basso: quelle che ce l’hanno più alto di un tot emigrano volentieri a Roma o Milano. Quelle che ce l’hanno attaccato alle orecchie se ne vanno addirittura in America. Si fanno tante leggi contro la fuga di capitali all’estero e nessuna per la fuga delle belle donne. Si vede che siamo governati da una manica di ochemorte. Le ragazze carine, in provincia, stentano a prendersi «certe libertà», con la storia che debbono «farsi una famiglia». Se poi non volevano la famiglia, col cavolo che restavano in provincia. Sarebbero andate a Roma o Milano! Hanno cominciato con il latte scremato, ora scremano anche le donne. Si fanno tante leggi contro le frodi alimentari e nessuno per le frodi sessuali. E poi si meravigliano della fuga di «cervelli» dalla provincia! Sfido chiunque abbia cervello a rimanere in provincia. Di vere città in Italia ce ne sono due. Gli inglesi e i francesi non hanno problemi del genere: Londra e Parigi sono metropoli senza rivali. Ma l’Italia è bipolare: Roma e Milano. Roma è l’unica città mediorientale in cui si parli italiano. Ti accoglie festosa, ti coccola e ti seduce. Sulle prime ti fa sentire un grande conquistatore: si accontenta di poco, le basta che tu stia al gioco, sognando con lei. II rito è ormai codificato: uscire a pranzo per parlare di progetti che non si realizzeranno mai; andare a cena con ragazze dai costumi apparentemente facili, appese al tuo braccio fino al momento del conto, e poi scoprire un fidanzato uscito di galera giusto in tempo per attenderle sotto casa alle due di notte. Meravigliosa e affascinante città, troppo pericolosa per un provinciale incline a credere nelle favole, Roma tutto inghiotte e nulla restituisce. Osservando l’orario dei voli nazionali, ho notato che ogni giorno arrivano a Roma 24 voli da Milano, mentre da Roma ne tornano a Milano 21 soltanto. Sono convinto che questi tre aerei, Roma non li restituirà mai. Milano è l’unica città mitteleuropea in cui si parli italiano. Efficiente e freddina come una segretaria zitella, ma brava con la stenografia. Ti accoglie sospettosa, all’inizio. Ma è una forma di autodifesa. Sotto una scorza dura cela un animo generoso. Nel suo vasto grembo c’è posto per tutti, anche per te, se hai talento e voglia di fare. A Milano ci si conquista i galloni, a Roma ci si va per assaporare i trionfi. L’Italia è un armonioso organismo vivente, alla stregua di un corpo umano. Milano è il cervello, Bologna lo stomaco e Roma il sesso: Roma città della seduzione, Milano città della produzione, Bologna città della digestione. 209 Classificazione del Morbo Ormai si è capito: il Morbo di Monduz è il bisogno incurabile di avere intorno un pollaio di donne. Presenta tre livelli di gravità, l’ultimo dei quali irreversibile. 1) Piccolo Morbo. I malati di «Mania della Stia» si contentano di sfogare la loro ossessione su un piccolo territorio, solitamente un quartiere o una compagnia. Ostentano fuoriserie e simpatia. Nella seduzione, seguono un modello artigianale. Curano molto i dettagli: sono eleganti, hanno belle casette. Ogni donna è per loro un caso specifico. La corteggiano, le mandano fiori, insomma le fanno la corte. 2) Grande Morbo. I malati di «Delirio dell’Harem» fanno del Morbo un sistema di vita. Scelgono mestieri che offrano il controllo di un territorio popolato di donne. La loro esistenza è un sacerdozio per avere femmine intorno. Sono animatori di villaggi turistici, disc-jockey e maestri di sci. Con le donne, usano una strategia particolare: si mettono in posizione di forza, e le aspettano al varco. Amano vincere giocando sul numero. 3) Mega Morbo. Il quadro clinico è caratterizzato dal «Furore del Pollaio Universale». Si tratta di casi gravissimi, irreversibili. 212 Il Morbo di Monduz Non sopportano l’idea che possa loro sfuggire una sola donna. Hanno trasformato la seduzione in un’arte assoluta e ci vivono dentro a ciclo continuo. Non si contentano di palestre, villaggi turistici o discoteche. Il loro obiettivo è il mondo intero. Per raggiungerlo, si avventurano in mestieri stressanti: sono cantati rock, divi del cinema e della tv. Con la complicità dei mass-media, conquistano donne anche senza conoscerle. Il loro scopo è fare del mondo un immenso pollaio. Accesso acuto 213 Accesso acuto Il manuale della playgirl Un giorno rimuginavo sui possibili sviluppi del Morbo con Paolo Caruso e Luciano De Crescenzo. Loro sostenevano che ero un esperto di seduzione e che dovevo scrivere un libro: il Manuale del playboy. Io ero di avviso diverso. «Anche se qualcosina ho combinato, con le donne, è ben poca cosa, considerando gli sforzi che ho prodigato. Ho condotto una statistica, in proposito, e ho fatto una scoperta terribile: quando ho preso io l’iniziativa, spesso è andata buca. Con le donne, ho avuto successo soprattutto quando sono state loro a provarci con me. «Più che un playboy, potrei dunque definirmi un “playmerlo”. Ecco, forse un libro da scrivere ce l’avrei. Un manuale per insegnare alle donne come si fa ad abbindolare gli uomini. Qui sì che sono un esperto. Praticamente il libro è già fatto. L’hanno scritto le donne, sulla mia pelle. «Lo potremmo chiamare Il manuale della playgirl». Postulati ideologici della seduzione Sono quarant’anni che in Italia non si fanno guerre, nel modo convenzionale, tra uomini. Ma la bellicosità non è finita. Tra uomini e donne esiste una 214 Il Morbo di Monduz specie di «terza guerra mondiale» molto più sottile, ma non meno fatale, chiamata SEDUZIONE. E le nostre compagne ne sono maestre. La seduzione è un raffinato duello di psicologia applicata. Vinci se riesci a mettere in crisi l’avversario, facendolo cadere in una forma di sconfinata ammirazione per te, chiamata «amore». Un vero braccio di ferro emozionale. Amiamoci? No, armiamoci! Innamorarti, equivale a una disfatta sul campo. Significa che ti sei lasciato affascinare. Sei caduto nella sottile rete tesa dalla tua avversaria. Evidentemente non ti eri fortificato abbastanza. Mancavi di linee difensive e sei stramazzato, sospiroso, contro le prime batterie di sguardi-laser. Ti serva di lezione per la prossima schermaglia. Dovrai chiarirti le idee. La guerra oramai è stata dichiarata. Ti devi difendere. Provvedi subito ai dovuti stanziamenti. Il denaro è come l’acqua di Lourdes: sarà piena di microbi, ma pare davvero che faccia miracoli! Mica lo devi usare per comperare il nemico (questo è corruzione e meretricio): il denaro va usato per acquistare gli armamenti. Grazie ad esso, puoi sottoporti al fuoco incrociato di massaggiatori, estetisti, trapiantatori di bulbi piliferi, lampionai UVA. Finalmente scrittore Ma sì, era giusto che lo scrivessi, quel manuale. Le donne mi avevano spesso battuto e avevo imparato a portar loro rispetto. Quando un avversario è troppo forte, è più saggio farselo amico. Avrei preso le loro parti, insegnandogli a turlupinare i miei simili. In un paio di mesi scrissi il mio libro e lo portai a Segrate. Ero convinto che il comitato non l’avrebbe accettato. Caruso mi telefonò una mattina, con aria contrita. In tono da funerale, mi informò che il manoscritto era piaciuto. Lo avreb- Accesso acuto 215 bero pubblicato ai primi di giugno: «Probabilmente sarà la tua rovina. Condoglianze!». Ero rimasto senza parole: finalmente ero anch’io un vero scrittore. E non uno scrittore qualunque: ero un autore della Mondadori! Telefonai subito al mio illustre «collega» Luciano De Crescenzo. L’avventura letteraria era cominciata. Correggere le bozze di un’opera, studiarne la promozione, discutere la copertina, è la tappa più bella, lungo l’itinerario di un libro. Senti che la fatica è compiuta e ti attende il meritato trionfo. Ogni volta che prendi in mano le bozze, ti metti nei panni del potenziale lettore e rinnovi il piacere di rileggere, per la prima volta, il tuo «capolavoro». La notte scalci tra le lenzuola e non riesci a prendere sonno: ti immagini già la pubblicità sui giornali, le interviste, le recensioni... e poi, chissà! Perché porre limiti alla provvidenza? Potrebbe arrivare finalmente la Gloria... Successo, tremendo successo! Prima ancora di essere distribuito in libreria, questo Manuale della playgirl attirò la curiosità dei giornalisti. Perbacco! Un uomo che insegnava alle donne come si fa ad accalappiare gli uomini! Dovevo essere un tipo ben strampalato. I cronisti mi chiedevano interviste e io davo sfoggio del mio repertorio, per farli contenti. «Che cos’è questo Manuale della playgirl?» «Un manuale di guerriglia: leggendolo, ogni massaia può diventare una Mata Hari. E un libro didattico. Sono in contatto con il ministro della Pubblica Istruzione, forse lo adotteranno nelle scuole dell’obbligo al posto del libro Cuore, che ha già rotto le scatole a troppe generazioni!» 216 Il Morbo di Monduz «Come si trova lei, con le donne?» «Ho solo un problema: a me piace una donna su dieci. Purtroppo, a mia volta, piaccio a una su cento.» Il 12 giugno si era fatta una bella cerimonia di presentazione, a Milano. Il giorno dopo realizzai un servizio fotografico con due modelle, per un settimanale di attualità. Finite le foto, le ragazze mi avevano invitato a bere qualcosa da loro. Ma non ce la facevo a reggermi in piedi. Dopo tre giorni di interviste e fotografie, ero esausto. Andai a dormire distrutto. «Ecco a cosa porta il successo» mi dissi coricandomi solo soletto «ti offre le opportunità e ti leva le forze per metterle a frutto!» Cominciavo a nutrire i primi dubbi sull’opportunità di avere successo. Il Playgirl Club Le vendite del Manuale andavano bene. Eravamo alla terza ristampa in due mesi. La stampa e la TV continuavano a intervistarmi. Le lettrici mi scrivevano letterine affettuose. Non sapevo più da che parte girarmi. Oltretutto ora avevo un club di fans! In fondo al Manuale, una volta impaginato, rimanevano due pagine bianche. Avevo pensato di utilizzarle per lanciare una proposta alle lettrici. Perché non fondare un club, sulle basi ideologiche esposte nel testo? Doveva essere un club di sole donne, con un’unica eccezione: il sottoscritto. Mi pareva che una proposta simile nessuno l’avrebbe presa sul serio. Invece, quando il libro uscì in libreria, inaspettatamente, cominciarono ad arrivare decine di lettere. Erano ragazzine entusiaste del Manuale, che mi mandavano baci, indirizzi, fotografie, pensierini affettuosi. Accesso acuto 217 Cominciai col rispondere a ognuna, personalmente. Ma il postino continuava a inondarmi di lettere. Rimasi travolto. Non potevo rispondere a tante ragazze. Inviai una circolare, che confermava il folle progetto di costituire quel fantomatico circolo. Non l’avessi mai fatto. Le risposte si moltiplicarono. Più di mille erano ormai le socie di questo club che non esisteva. Non sapevo come uscirne. Oramai ero in ballo: dovevo proseguire in qualche modo l’operazione. Inviai a tutte le ragazze una tessera con lo stemma del coniglietto, ricavato dalla copertina del Manuale, carta da lettere, diplomi, distintivi e magliette. Quel gioco aveva un fascino misterioso: volevo vedere dove mi avrebbe portato. Cominciarono ad arrivare telefonate di «socie» che mi invitavano alle loro riunioni in varie città. Non ho mai saputo dire di no a una donna, figuriamoci a mille! Girai così mezza Italia, accolto da decine di ragazze festanti, con maglietta e distintivo del club. Le «sedi periferiche» erano diventate un centinaio, le socie duemila. In ogni città ero travolto dal loro entusiasmo. Un nuovo mondo affettivo ci univa. Un calore, una tenerezza che avevo già provato anni prima. Quel club era una nuova edizione del cortile della mia infanzia, in formato gigante! Monduz and the playgirls La circolare che inviavo alle socie cresceva ogni volta. Si era trasformata subdolamente in una rivista tipo «fanzine». Intanto le idee mi venivano fuori una dietro l’altra, come ciliegie. Avevo pensato di organizzare un concorso a premi su una nota rivista, un programma televisivo alla Rai, un trentatré giri e una «Fiera della Seduzione», che nella mia fantasia si dilatava ogni 218 Il Morbo di Monduz giorno di più. Ancora un po’ e avrebbe surclassato la Fiera di Milano. Qualunque proposta facessi, la gente mi stava a sentire e mi diceva di sì. Dipendeva dal mio entusiasmo, o dal profumo di successo che mi circondava come un’aureola? Mah! Comunque fosse, erano guai. Qualche volta speravo che la gente mi dicesse di no. Era come se improvvisamente tutte le donne del mondo ci stessero. Non ero attrezzato per una simile eventualità. Se non mi fermavano, ero perduto. Finiva che dovevo realizzare tutti quei progetti sul serio. Si fa presto ad avere un’idea, ma a metterle in pratica è tutta un’altra faccenda: le idee richiedono molta manutenzione. Purtroppo, quando sono di buonumore, do briglia sciolta alla fantasia e prendo un mare d’iniziative. Così m’ingolfo di impegni. Un quarto d’ora d’ottimismo può incasinarmi l’esistenza per mesi. Ogni volta che mi veniva un’ispirazione, era una nuova incombenza che si sommava. Sempre più bella, entusiasmante e irrealizzabile. Avevo un’azienda da condurre, un nuovo libro da scrivere e, nei ritagli di tempo, anche una vita da vivere. Già! Quante occasioni perdute, con tutte quelle ragazze che mi giravano intorno! Che fare? Buttarmi come un pesce, o continuare a collezionare successi? Qualunque cosa facessi, c’erano sempre i fantasmi delle altre a ricordarmi che le stavo trascurando. Il successo era una frenesia, un’angoscia, una droga che non sai quando finisca. La via del successo stava diventando la via dello stress! Accesso acuto 219 Un vicolo cieco chiamato Successo Il successo è agli antipodi della felicità. Il successo infatti è l’arte dell’aggiungere, mentre la felicità è l’arte del togliere. A Milano, talvolta incontravo il mio amico Franco Mattioli, che vi si era trasferito da anni, da quando era diventato un big della moda con la Ferré. Una sera che mi trovavo con lui, il discorso era caduto sul Morbo di Monduz. Tra noi malati, ci tenevamo aggiornati sul decorso reciproco della malattia. Nell’evoluzione del Morbo, ero arrivato a un vicolo cieco: il successo. «Pianta lì tutto, scappa finché sei in tempo» mi diceva Franco. «Nel successo, credi di trovare la felicità, e invece questa è nella direzione opposta. Guarda me: negozi, fabbriche, darei tutto per sentirmi contento.» «Me ne sono accorto anch’io» gli risposi «per avere successo, ci vuole una visione nitida della realtà. Devi fare l’anatomia delle situazioni vincenti. Che poi, sono sempre i sogni degli altri. Bisogna prevedere quale nuovo giocattolo sognerà domani il tuo prossimo e passare la notte a confezionarlo. Così domattina glielo potrai vendere. A forza di speculare sui sogni degli altri, non riesci più a sognare nulla di tuo, tranne il successo per il successo. Così esci dalla via che porta alla felicità. Perché la felicità è un’illusione tua, mentre il Successo è un’illusione degli altri. Credo che la felicità appartenga solo a quattro categorie: i semplici, i selvaggi, gli scemi del villaggio e gli asceti.» Franco era d’accordo. Quanto a me, escludendo le prime tre soluzioni, mi restava soltanto la carriera di asceta. 220 Il Morbo di Monduz I cinque inguaribili Ero preoccupato per il decorso del Morbo di Monduz. Io mi stavo inguaiando sempre di più, con le iniziative del Playgirl club, e anche i Grandi Ammorbati che conoscevo non se la passavano tanto bene. Franco si era dedicato alla moda, per vivere in mezzo alle indossatrici, poi si era lasciato prendere la mano dai soldi. Le sue fabbriche, le sfilate di moda, le fotomodelle non lo rendevano felice. Era sempre più angustiato dall’idea di sbagliare una mossa. Vasco, nel cercare di farsi il pollaio, si era lasciato prendere la mano dal successo. Era diventato una rock-star idolatrata dai giovani, ma la sua vita era dominata dall’ansia. Aveva paura di perdere la creatività, di essere scavalcato da altri cantanti. Sognava di conquistare più vaste platee. Per vincere lo stress, si era rifugiato nei paradisi artificiali. Avevo letto sui giornali che era stato sorpreso con la dispensa colma di spezie non omologate. Solo De Crescenzo, da grande filosofo, era rimasto fedele al vero obiettivo del Morbo: le donne. Continuava a stipare il suo computer di bellezze da infarto. Si era salvato tenendo il successo a bagnomaria, caldino quanto bastava per farne un uso saggio e niente di più. Dunque, lui solo aveva scoperto la via della salvezza? Andai a Roma per consultarmi. Lo trovai sull’orlo della follia elettronica, stravolto negli aggiornamenti del suo file di fanciulle. Aveva raddoppiato la memoria del computer. Gli brillava negli occhi una luce terribile, mentre mi mostrava i suoi giocattoli. Di sottecchi, scrutava l’effetto di quel ben di dio sulla mia anima di provinciale. Negli occhi aveva uno strano sorriso che non mi rassicurava. Era molto peggiorato anche lui. Cercai di Renzo Arbore, mio ultimo eroe. Non riuscii nem- Accesso acuto 221 meno a vederlo. Perfino Luciano era preoccupato per lui. Il Morbo lo aveva colpito in modo funesto. Ormai era un forzato del successo televisivo. Viveva braccato dai giornalisti. Non poteva più tornare a casa la sera, perché c’erano sotto i fotografi che lo aspettavano. Dormiva in albergo o a casa di amici, era ormai senza fissa dimora. Il telefono lo teneva staccato, perché suonava in continuazione. Appena inseriva la spina per chiamare un taxi, quello squillava. Che vita d’inferno! Intervento terapeutico Complicanze del Morbo di Monduz Ormai era chiaro. Nell’evoluzione del Morbo di Monduz, erano possibili due complicazioni: la Smania dei Soldi e il Delirio di Successo. In principio, denaro e successo erano solo strumenti per farsi un pollaio, poi, lungo il percorso, diventavano obiettivi finali. Si creava una fissazione nella fissazione. Una sera, Luciano mi aveva invitato alla prima cinematografica del suo ultimo film. Non avevo mai visto tante belle donne, tutte insieme. Ce n’era un cinema pieno. Uomini belli: nessuno! Perbacco, proprio il posto adatto per me, almanaccavo. E invece non c’era luogo meno proficuo. Tutte quelle bellezze erano refrattarie ai richiami del sesso, peggio che suore clarisse. Avevano fatto il voto di diventare famose col cinema. Dopo lo spettacolo, un ristretto gruppo di amici - quattro donne mozzafiato, Luciano, io e altri tre - ce ne andammo via con due auto. Luciano si prese le quattro stelline e lasciò noi tre uomini soli nell’altra macchina. Aveva un’aria da furbacchione. Sembravo io, quando da piccolo giocavo al dottore e lasciavo fuori dal portone gli altri bambini. Mi scappava da ridere. Stavolta ero capitato nel cortile di un altro! Riflettevo. Il successo porta a vivere di emozioni riflesse, attraverso l’invidia del prossimo. Quando il tuo sogno è spezzato, 224 Il Morbo di Monduz ti restano soltanto i sogni degli altri. Smarrito il cammino dell’Essere, ripieghi nell’Apparire. Molti anni prima, nelle mie meditazioni a Cortina, mi ero accorto che il denaro era il surrogato del successo. Ora mi stavo convincendo che anche il successo era il surrogato di qualcos’altro. C’era qualcosa che mi sfuggiva. Cos’era quell’ansia, che non si placava con il denaro né col successo e trovava soltanto un momento di tregua tra le braccia di una donna? Una ricerca di pace in se stessi, un desiderio di quiete assoluta. Qualcosa di trascendentale, di mistico. Vuoi vedere che cercavo davvero Dio? A Milano, con Franco, l’avevo detto per scherzo, ma forse, a modo mio, cercavo la via dell’ascetismo sul serio. Meditazioni a Montequestiolo Avevo acquistato una serie di libri sulle religioni e sul misticismo, sino a farmi una discreta biblioteca sul tema. Arrivò l’estate. Potevo interrompere il mio ciclo infernale di impegni. Avrei approfittato del mese d’agosto per leggere. Volevo verificare se le esperienze mistiche erano compatibili con le mie abitudini. Per un programma del genere, serviva un luogo esente da distrazioni mondane. Scelsi Montequestiolo, un cocuzzolo fuori dal mondo, nel comune di Zocca. Lì c’era ancora, vecchia di secoli, la casa dov’era nato mio padre. Questo cocuzzolo, che domina tutta la valle dintorno, è abitato da alcuni miei parenti che sono rimasti lassù a fare gli agricoltori: Antonio e Graziella, i loro figli e la famiglia dei cognati. Montequestiolo è un agglomerato di case tranquillo, dove gli unici rumori sono i muggiti dei manzi e il chiocciare delle galline nell’aia. Il Morbo di Monduz 225 Mi ero portato un’intera valigia di libri e una pericolosa cesta di lettere delle socie del Playgirl club a cui rispondere. Laura era venuta con me, con una provvista di libri gialli, parole crociate e scarpe da castagneto. Ci eravamo sistemati nell’antica casa colonica. I miei parenti non ci vivevano più da quando si erano trasferiti di fronte, in una villetta moderna. Iniziai la mia stagione di studi e meditazioni. Sveglia alle sei, qualche ora di lettura, passeggiate, meditazioni e ancora lettura. Per distrarmi, scendevo in cucina a chiacchierare con Laura e Graziella. Talvolta le trovavo intente a fare la sfoglia o a cucinare. In quei gesti naturali, affettuosi, traspariva una serenità antica. Perbacco, com’era semplice la felicità! Il profumo del pane nel forno, l’odore del rosmarino nella casseruola, erano carezze per il mio spirito. Mi veniva in mente quando stavo con la nonna in cucina, da bambino. In ogni donna che prepara il tuo pranzo, c’è un bellissimo gesto d’amore per te. La sera subito dopo cena mi sentivo scivolare nel sonno del giusto, e tuttavia continuavo a chiedermi: «Ma come si fa a distinguere il sonno del giusto da quello dell’imbecille?». Questo pensiero mi dava l’insonnia. Le mie letture proseguivano, ma incontravo alcuni problemi. Innanzitutto i libri sulle religioni si rivelarono noiosissimi. Mi domandavo come mai un Dio, nella sua perfezione, si circondasse di esegeti così poco dotati di spirito. L’altro problema era più serio. Tutte le religioni del mondo, fatte eccezioni rarissime, mettevano il sesso tra i più gravi peccati. Questo proprio non mi andava giù. Qualunque piacere era un peccato! E non c’era modo di aggirare l’ostacolo: in ogni libro sacro, il sesso era additato con una nota di biasimo. Unica ecce- 226 Il Morbo di Monduz zione, nel matrimonio. Evidentemente ai mistici non era sfuggito che, col matrimonio, il piacere si perde. Sesso contro religione: una bella battaglia! Una notte avevo fatto uno strano sogno. C’erano in campo due squadre di calcio: una di donne, l’altra di preti. Io ero l’arbitro. Le ragazze un po’ sculettavano e mi scappava qualche parzialità. I preti erano molto nervosi: non tiravano moccoli, ma quasi. Fecero un fallo di mano. Dare o no il rigore? Ero incerto: i preti mi prospettavano il paradiso se lasciavo correre. Le donne mi facevano l’occhietto. Non avevo dubbi: concessi il rigore e fu goal! Mi svegliai di soprassalto, scomunicato. Per colpa mia, il sesso aveva battuto la religione uno a zero! Bangkok e Hong Kong Amo viaggiare perché si fanno incontri con differenti culture; perché le abitudini, le tradizioni e le certezze consolidate, subiscono duri colpi. Si scopre che ogni paese ha convinzioni diverse. Nell’impatto con ogni nuova cultura, sorge un nuovo dubbio, si perde un’ulteriore certezza. Finché restano solo pochi valori indiscutibili: il sole, il cibo, l’amore, l’amicizia. Il 24 dicembre di quell’anno partii con Laura per Hong Kong e Bangkok. A Bangkok, anni prima, ero stato in un pianobar annesso a un albergo e ci avevo scoperto una perla d’oriente che serviva ai tavoli. Una dolcissima stupenda ragazzina dagli occhi a mandorla: Sorapin. Mi ero fatto dare il suo indirizzo, convinto, prima o poi, di tornarla a cercare. Mi aveva stregato con la sua millenaria dolcezza. Appena arrivato a Bangkok, tornai in quel locale. Nella sua quieta penombra, speziata di profumi orientali, il sorriso di Sorapin era ancora nell’aria. Ma Sorapin non c’era più. Intervento terapeutico 227 Una nuova faccia di ragazzina sorrideva, porgendo i liquori. Chiesi di lei. Nessuno se la ricordava. Qualcuno rise della mia nostalgia. Io insistevo, ricordando i suoi occhi innocenti, la sua gentilezza. «Di ragazze carine è pieno l’oriente» mi rimbeccò sogghignando il direttore. «Sorapin è un nome comune, a Bangkok, è il nome di un fiore.» Ebbi un senso di gelo. Chissà dov’era finita, quella ragazza dal nome di un fiore, in una città così spietata con i suoi fiori più delicati. Appena sceso a Hong Kong sentii nell’aria una strana atmosfera: il profumo della libertà. Mi pareva di essere senza radici, libero nel profondo dell’anima. Che bello! Un’emozione come quella che avevo provato a Londra, vent’anni prima. La sensazione di un’assoluta, vera, totale, indipendenza. Meravigliosa, forte, libera Hong Kong! I giorni fuggivano, su quell’incredibile isola incastonata nel cuore della Cina. Peccato non restare di più. Mi sentivo felice. Avrei voluto rimanere per sempre. Che contraddizione! Come si può restare legati a un paese che ti ha ispirato la libertà? Non era importante la città in sé, ma il suo spirito. Quello che aveva da dirmi, Hong Kong me l’aveva già detto, una notte, in un ristorante girevole che domina la città. Ero sospeso in un cielo trapunto di stelle. Avevo ai miei piedi la metropoli e le sue mille luci in movimento, il mare illuminato dai riflessi dei grattacieli, il brulichio della vita che traghettava tra una riva e l’altra del golfo. Mi sentivo mille metri sopra le cose del mondo, mille mesi distante dai miei affanni. Ora li avevo chiari davanti, messi a nudo dalle loro bugie. Ero vissuto per anni prigioniero delle mezze misure, a metà strada tra il coraggio di osare e il tepore rassicurante dei ricordi. Stavo lassù, in quello strano ristorante sospeso tra il cielo e la terra, e mi sentivo sospeso tra passato e futuro, parlavo tra 228 Il Morbo di Monduz me invasato e felice come un pazzo redento. «Cercare il successo per il successo: che stupidaggine! Piegare l’estro ai gusti degli altri, gusti presunti, oltretutto, che avvilimento! Io sono un poeta che ha le idee, ma cerca la rima. Ecco chi sono: uno che vuol mettere le sue fantasie in fila per due. Un idealista che non si concede un ideale. Che non lascia il geniaccio lavorare da sé. Uno che non si fida di se stesso. Un insicuro. Un pazzo dimezzato. «Sono stufo della mia mezza follia. Ne voglio una intera. Basta con questa mezza sofferenza, di queste arti a metà. Meglio fallimenti totali che realizzazioni parziali. Basta con le nostalgie, i confronti.» «Io non ho più ricordi. Non ho più parenti, radici, nonne e cortili da ricordare. Il mio passato sarà solo scuola per il futuro.» Era tempo che diventassi grande. Avrei fatto lo scrittore, da grande. Era scritto. L’avrei dovuto fare fin dall’inizio. Ma ero ancora in tempo per una redenzione totale. «Scriverò la storia della mia vita, o meglio, la storia della mia ossessione. Servirà ad archiviare questi benedetti ricordi, a chiarirmi le idee. La scriverò come viene, come mi sento, guardando dritto il lettore negli occhi. Un libro schietto, scarso di chiacchiere. Chissà, può anche darsi che qualcuno lo legga. Speriamo qualcuna!» Come sempre, il titolo del libro era per me la cosa più facile. L’avrei chiamato Il Morbo di Monduz. È deciso: scrittore! Avevo già quarant’anni suonati e non me n’ero nemmeno accorto! Perbacco, in tutto quel tempo avevo realizzato soltanto le prime tre o quattro idee della mia vita, la maggior parte erano ancora in lista d’attesa. Avevo notato che realizzare progetti porta via un sacco di tempo... rischiavo di trovarmi già vecchio Intervento terapeutico 229 ad aver scritto solo i primi capitoli della mia vita. Scrivere: forse era questa la soluzione. Quando si è afflitti da un’esuberanza di idee, bisogna rassegnarsi a metterle nero su bianco senza realizzarne nessuna. Ultimamente avevo commesso troppe sciocchezze. Era meglio davvero che mi mettessi a scrivere. La letteratura, in fondo, è un modo economico per tener occupata certa gente troppo ricca di idee, impedendole di fare danni peggiori. A scrivere c’è un grosso vantaggio: il foglio di carta oppone una resistenza modesta all’azione: ti guarda e annuisce. Ben diversa è la realtà. Lei ha sempre qualche obiezione, qualche imprevisto cavillo. Volendo affrontare la nuova professione, mi parve opportuno dare un’occhiata ai prodotti della concorrenza. Così mi rassegnai a leggere gli autori del momento e a rispolverare i classici. Li leggevo soprattutto la sera, prima di coricarmi. Certi libri importanti vanno presi come medicine. Mi reputo uomo d’idee, ma anche pragmatico. Ho amato più le azioni che le parole. Un uomo pratico, piuttosto che avere rapporti con pallidi fogli di carta, preferisce averne con ragazze abbronzate. Stavolta avevo una giustificazione per dedicarmi alla lettura: volevo imparare il mestiere. Purtroppo, più leggevo e più mi avvilivo. A ogni riga affiorava la follia dello scrittore. C’è chi scrive per convincersi di avere ragione. Chi ci scarica la depressione. Chi lo fa per darsi un tono da cinico. Chi per far sapere ai posteri quant’era bravo. Ma più di tutti mi infastidivano gli scrittori che si compiacciono della forma e quelli con la mania di scavare nelle emozioni, fino a sbudellarle. A forza di leggere, ero diventato uno specialista nel riconoscere la malattia mentale da cui ogni libro era nato. Ero diventato uno psichiatra di opere letterarie. 230 Il Morbo di Monduz Che gli autori fossero tutti bisognosi di cure, non v’era dubbio. Dalla salute non nascono libri: nascono belle giornate vissute. Avevo preso l’abitudine di portarmi dietro un taccuino per annotare le idee, visto che vengono quando vogliono e se non te le scrivi le perdi per sempre. Per non sprecarne nemmeno una, quando andavo a letto mettevo il notes sul comodino. Così ero pronto ad acchiapparle anche nel cuor della notte. La differenza tra uno scrittore e una persona normale penso sia proprio questa: se gli viene un’idea mentre è a letto nel dormiveglia, una persona normale si gira dall’altra parte; uno scrittore si alza e la scrive. Ponendomi l’obiettivo di fare un libro, naturalmente pensavo alle lettrici e al successo (cosa mai dovrebbe pensare, un uomo solo davanti a un computer?), ma dovevo far attenzione a sincronizzarmi coi tempi. Un po’ di lungimiranza è necessaria, però bisogna evitare le idee troppo in anticipo. Si può incappare in un successo postumo. La realtà odia i balzi verso il futuro. È come una bella ragazza: alla prima uscita non puoi anticipare le manovre previste per la terza serata. La perderesti per sempre. Sia le donne che il mondo apprezzano i visionari, ma li preferiscono di corto raggio. Professione: vivere La casa editrice continuava a marciare. Il mio problema più grosso era conciliare il lavoro di imprenditore con quello di scrittore part-time. Per scrivere è necessaria un’apertura mentale incompatibile con quella particolare grettezza richiesta a chi, istituzionalmente, deve occuparsi d’affari concreti. È il mio solito, eterno problema: correre dietro ai voli della Intervento terapeutico 231 Logiche creative Le tue idee non sono del tutto tue: appartengono alla «coscienza collettiva» del mondo in cui vivi. L’unico merito che ti sarà riconosciuto consiste nella tua capacità di pescare le idee dentro a questo «fondo comune ». Scrivere a volte è una vera battaglia, quando le idee non vogliono farsi acchiappare. In quei momenti, astieniti dalla TV, dalla musica, non leggere, non concederti distrazioni. Ti può accadere di passare interminabili ore senza che ti venga in mente nulla di buono. In questi casi, il massimo che ti è consentito è una passeggiata solitaria, a occhi bassi, intorno al divano. Tutto il cerimoniale ha uno scopo preciso: di far capire alle idee che sei determinato a snidarle. Se tieni duro, senza mollare, prima o poi la spunti: le vedrai venir fuori con le mani alzate. fantasia senza rinunciare al benessere. Non sono mai riuscito a conciliare emozioni e dobloni, così mi son rassegnato a vivere a rate. Il concetto della «Trisezione della Vita» tornava d’attualità. Negli ultimi tempi mi ero trovato alle prese con due opposte personalità: una creativa, con velleità di scrittore, e l’altra affaristica. Il mio cervello non era abbastanza capiente per ospitarle tutte e due, così mi trovavo nei guai. Rischiavo di scrivere racconti allegri come verbali di consigli d’amministrazione e di prendere decisioni manageriali troppo poetiche. Nei computer, quando la memoria non è sufficiente a tenere in linea due programmi complessi, si risolve il problema parcheggiandoli in un disco magnetico da cui ripescarli al bisogno. Anch’io fui costretto a trovare un parcheggio mentale per le due personalità e a focalizzarne una per volta. Il passaggio era laborioso: una conversione completa da Monduz 1 a Monduz 2 e ritorno richiedeva una settimana di viaggio mentale. Resistetti, arrabattandomi senza tregua tra le due anime, fino 232 Il Morbo di Monduz all’estate. Ai primi d’agosto mi ritirai a Montequestiolo per finire il libro in santa pace e meditare sul mio futuro. Montequestiolo bis Ero tornato a Montequestiolo equipaggiato alla grande. Mi ero portato dietro uno strano assortimento di suppellettili: il computer, la macchinetta automatica per fare il tè, una piccola scelta di libri sulle religioni (quelli che non parlavano troppo male del sesso) e tante lettere di socie del Playgirl club. Avevo allestito uno studiolo nella casa dov’era nato mio padre. Con Antonio, avevo trasformato una vecchia porta in un immenso piano d’appoggio, su cui stava disseminata la mia attrezzatura da scrittore: dizionari, libri, bloc-notes, matite, risme di carta, il tutto in un disordine ben organizzato. Avevo davanti a me una finestra che dominava la valle, i castagneti e la torre del Montecuccoli. Scenario perfetto per scrivere il Morbo di Monduz. Da quella finestra, chissà quante volte mio padre si era affacciato, bambino. Anche lui si sarà commosso, di fronte alla magnificenza di quella valle. Ah, la nostalgia, che brutto affare! Scrivere la storia della mia vita, forse mi avrebbe guarito dai ricordi. Chissà che, mettendo nero su bianco tutti i «cortili della mia infanzia», non riuscissi a staccarmene. Dovevo smetterla una buona volta. Mio padre era morto, e anche mia nonna. Io ero la loro speranza, il prolungamento del loro gesto di vivere. Ero mio padre e mia nonna e tutti coloro che mi avevano amato. La loro vita ora scorreva in me. Dovevo riprendermela con tutte le forze. Anno dopo anno continuavo a collezionare giocattoli per gingillarmi e rimandare la scelta. Trappoli, case, automobili, impianti stereo. Tutti questi balocchi rubavano tempo a tenerli in Intervento terapeutico 233 efficienza. Ormai distinguevo le giornate in cattive o buone, a seconda che fossero di più le cose che si rompevano o quelle che riuscivo ad aggiustare. Ora capivo perché San Francesco si era disfatto di tutti questi orpelli: per liberarsi dalla loro manutenzione! L’ultima fesseria era stata il Mercedes 500 SEC: trenta milioni in più per avere due sportelli in meno. Ma si può essere più deficienti? Non avevo abbastanza personalità da andare in giro con una piccola cilindrata? Quell’auto era la mia pelliccia, e io la sua puttana. In quei giorni, di pari passo con la stesura febbrile del Morbo di Monduz, mi chiarivo le idee sul futuro. Dovevo scegliere. Tagliare i rami secchi non basta. Bisogna tagliare i rami verdi, per dare all’albero la direzione voluta. Tornato a Bologna alla fine d’agosto avrei tagliato un verde ramo della casa editrice, cedendo la quota di minoranza ai miei due dirigenti; mi sarei messo a scrivere e a vivere a tempo pieno. Aggiornamento Il Morbo di Monduz ormai l’avevo finito. Avevo consegnato il manoscritto alla Mondadori, dicendo di sbrigarsi a pubblicarlo: la mia vita non stava mai ferma, e c’era il problema di mettersi in pari, con gli aggiornamenti. L’uscita del libro era prevista per la primavera. Avevo davanti a me un periodo di riposo. Dovevo organizzarmi per il prossimo libro. In futuro, volevo viaggiare sei mesi l’anno, con il mio nuovo computer portatile: tre chilogrammi, un gioiello della tecnologia. Scrivere era un’attività senza fissa dimora, proprio quel che ci voleva per me. Avrei scritto i miei libri nelle cornici naturali più belle, altro che aggrappato alla scrivania di casa mia! Nel frattempo, avevo continuato le intense letture di religione. Cominciavo a capire perché i mistici ce l’avessero tanto col sesso: non per i piaceri che il sesso procura, ma per i guai che combina. Naturale: perché loro con le donne non ci sapevano fare! Quelle letture erano molto fruttuose: cominciavo a intuire il concetto di Dio. Non era vero che Dio rappresentasse le forze del Bene. Queste forze sono rappresentate dai preti. Dio esprimeva le forze del Meglio! Quanto a me, tra il Dio dei preti e Satana, restavo neutrale: ero convinto che la salvezza dell’anima fosse nell’equilibrio fra le Grandi Potenze. 236 Il Morbo di Monduz Aggiornamento Gli appunti crescevano a vista d’occhio. Che strano libro sarebbe mai nato, stavolta? Eravamo prossimi al Natale. All’ultimo momento, organizzai un viaggio in Brasile con Laura. L’illuminazione Una bella donna è un pensiero di Dio riuscito bene. La mia passione per l’ascetismo cozzava contro l’altra passione: le donne. Dovevo rinunciare ai voti religiosi per un problema di incompatibilità tra le due vocazioni. Solo se mi avessero accettato in un convento di suore, avrei potuto dare alla mia vita un disegno unitario. Facevo il possibile per conciliare le mie due tendenze. Anche il viaggio in Brasile era un tentativo di sintesi: Rio de Janeiro potrebbe sembrare una strana località, come ritiro spirituale. In effetti, forse ero l’unico, su quell’aereo di italiani gaudenti, che si fosse portato in valigia una dozzina di libri di religione. A Rio, mi ero ben sistemato al Rio Palace. Passavo ogni mattino sul terrazzo dell’albergo, a leggere l’autobiografia di Santa Teresa de Avila, le Upanisad e un libretto sugli sciamani del centro Africa. Ogni tanto alzavo gli occhi, e protetto dai bicchieroni di drink tropicali, davo una sbirciatina salutare a quelle mulatte fantastiche. Un colpo alla materia e uno allo spirito: dopotutto mi sembrava un buon compromesso. Leggendo quei libri, mi sorprese un fatto curioso: ogni asceta aveva le visioni che più si aspettava! Santa Teresa de Avila finiva sempre alle prese col Demonio o la Madonna, Sant’Antonio col Bambin Gesù, Buddha vedeva il Nirvana, gli sciamani qualche divinità animale, con regolare equipaggiamento di zoccoli e corna. 237 Un giorno, ero talmente assorto in questi pensieri, che arrivarono le cinque del pomeriggio senza che me ne fossi accorto. Uscimmo a fare una passeggiata. Laura osservava il passeggio e io riflettevo su quel mistero delle visioni. Il sole stava per tramontare. C’era molta gente a quell’ora, ma non la vedevo neppure. Ero immerso nelle mie riflessioni. Percepivo nell’aria che stava per accadermi qualcosa di eccezionale. Ero teso e assorto. All’improvviso, finalmente, la folgorazione: nel cielo s’apri uno squarcio di luce, e indirizzò una scia sfolgorante sui grandi marciapiedi che dividono l’Avenida. Quel raggio miracoloso puntò diritto su una celestiale visione. Era un’entità aliena, rotondeggiante, e sobbalzava con ritmo, avvolta simbolicamente in uno strano sacrario. Mi pareva un didietro divino che guizzasse in un tanga. Era proprio un culetto brasiliano di quelli giusti, che traboccava senza ritegno! Risalii con lo sguardo lungo la schiena delle sublimi rotondità, e mi comparve anche il resto dell’apparizione. Era una mulatta di una bellezza trascendentale. Rimasi folgorato da quella visione. Sentivo uno strano groppo in gola, un urlo che non trovava l’uscita. Finalmente proruppe in un grido liberatorio: «Dio esiste!». Anche nel mio cuore di peccatore era esplosa la Fede. Eh, già! Ogni asceta ha le rivelazioni che più si merita! La mia missione Pensavo che le donne mi avrebbero allontanato dal terzo e ultimo gradino della mia evoluzione spirituale. Errore! Le donne erano state le mie alleate fin da piccolo. Chi mi avrebbe potuto aiutare a raggiungere Dio, più di loro, creature stupende, così 238 Il Morbo di Monduz vicine all’Assoluto? Ne dovevo tener conto, nel libro che andavo elaborando. Sarebbe stato un libro di religione molto diverso dal solito. Allegro, innanzitutto. I testi di religione sono spesso noiosi: così disamorano i fedeli. Non ho mai capito come Dio, perfetto com’è, possa mancare del senso dell’humour. Avrei colmato quella lacuna, scrivendo un libro di spirito sullo Spirito. Gli avrei dato un titolo non troppo ambizioso. Sì, l’avrei chiamato il Vangelo secondo Monduz. La cura miracolosa Ero appena tornato dal Brasile, quando mi telefonò Luciano De Crescenzo, tutto eccitato. Aveva trovato la cura del Morbo di Monduz! Renzo Arbore era guarito e anche lui stava facendo progressi. La cura era semplice, una specie di omeoterapia. Dovevo andare subito a Roma. La terapia funzionava secondo principi immunologici. Bastava somministrare al paziente l’agente patogeno attenuato, in dosi crescenti. Nel caso specifico del Morbo di Monduz, ci voleva una buona dose di donne attenuate, pardon, disponibili. Luciano l’aveva chiamata F. Immersion (full immersion?). Prima o poi saremmo guariti anche noi, come Arbore. La guarigione di Renzo era avvenuta per caso, conducendo «Indietro tutta». In quella trasmissione, stava in mezzo a un centinaio di ragazze, una più bella dell’altra. Cento donne, in un’unica somministrazione, si erano rivelate una dose terapeutica sufficiente anche per Arbore. Da allora era molto cambiato. Preferiva la compagnia degli amici. Prima di uscire, la sera si informava che non ci fossero donne. Non ne sopportava più nemmeno l’odore. Passando davanti a un negozio di biancheria femminile, si voltava dall’altra parte. Una risatina di donna, e gli venivano i brividi. Aggiornamento 239 Luciano era rimasto colpito da quella guarigione miracolosa e aveva voluto seguirne l’esempio. Perciò si era messo a frequentare con regolarità le vallette e le ragazze coccodè di «Indietro tutta». Non era ancora guarito, però anche lui si sentiva già meglio. Quella cura entusiasmava anche me. Mi offriva una nuova speranza. Nel mio intimo, l’avevo capito fin dall’inizio, che dal Morbo di Monduz si guariva così. Ma Laura mi aveva sempre osteggiato. Ora però, consapevole che si trattava di una medicina, avrebbe cambiato atteggiamento. Non poteva volermi così male da intralciare la mia guarigione. L’autorità di quella prescrizione mi dava conforto. Dovevo ricoverarmi. Che c’era di strano? Chi soffre di fegato va a Chianciano, chi è stitico va a Montecatini. Ognuno si cura nel posto adatto. Per il Morbo di Monduz, il centro terapeutico era il camerino delle «coccodè». Non avrei sopportato cavilli e ironie - non è bello far dello spirito su gente che soffre. Prima che la trasmissione finisse, mi precipitai a Roma, a curarmi. Non dico che sono guarito, ma vado benino. È solo questione di tempo: può darsi che ci vogliano anche vent’anni. Ma senz’altro, prima o poi guarirò. Commiato... I peggiori briganti sono attratti dalla politica, i più sconvolti sono portati per l’arte, i malati di mente passano il tempo a scrivere libri. che idea del mondo si può fare un ragazzo? Caro lettore, non so quale sia la grande passione della tua vita. Comunque, -ti invito a lottare per lei. Se non porta il reggicalze, pazienza! Quanto a me, la mia grande passione l’ho ritrovata. Era sempre stata al mio fianco, in attesa: è comunicare con gli altri (o 240 Indice le altre?). Gli anni che mi restano, voglio passarli a raccontare i miei sogni. Lasciamo perdere i gadget. Sono fesserie. L’importante è credere in quello che fai e amare il tuo prossimo, specialmente se indossa una sottana. Sentirti accettato dalle persone che ami; cominciando da te stesso, quando ti guardi allo specchio ogni mattina. Come vedi, sono cose semplici, a trovarle scritte, nero su bianco. Le follie sono più originali. Di questo vive la letteratura. Ma diverse sono le regole per la felicità e quelle per l’arte. E la tua vita val più di un romanzo. ... per le lettrici Ho scritto questo libro per raccontarti la mia storia, il mio viaggio perplesso nell’esistenza. Avrei preferito farlo a voce, guardandoti in faccia e ascoltando le tue obiezioni. Lo so, un libro è soltanto il surrogato di un rapporto umano. Chissà che, tra milioni di anni, in qualche forma di reincarnazione, non potremo raccontarci la nostra storia, guardandoci tutti insieme, uomini e donne, negli occhi... Che bello! Nel frattempo, spero di conoscerti personalmente. Adoro le lettrici, con quelle molecole allegre e quei loro sorrisi ospitali... Il mio numero è sull’elenco. Indice Indice 241 6 Giustificazione 7 IL QUADRO CLINICO Che cos’è il Morbo di Monduz? 9 9 ANAMNESI Gianni, perché Via Orfeo 23/2 12 La logica del cortile 13 13 14 14 15 24 29 PATOLOGIA FAMILIARE Il derby La squadra di mamma La squadra di papà Il pallone in campo Mia nonna Mio padre Mia madre 35 38 40 PATOLOGIA REMOTA All’asilo I miei business Le elementari 41 II terzo della classe 42 44 45 Le medie Il clima del Liceo Galvani La Zòccoli 244 Indice 45 47 52 L’archeologia Il teatro del Galvani Le gite scolastiche 54 Logica del liceo classico 55 PROFESSIONE: PLAYBOY Marisa 61 Logiche di seduzione 62 63 65 66 69 72 73 74 75 76 Vendetta, tremenda vendetta Il 48 cc Gli studi psicologici Quella tragica prima volta Il primo trappolo Una donna per amico La prima occasione Il casto playboy Il mio amico Alfredo La prima sbornia 79 80 83 85 86 91 95 97 99 100 101 106 110 PROFESSIONE: AVVENTURIERO Un grande maestro: Giacomo Casanova Un nuovo cortile: Cortina! I libri usati La scelta della facoltà L’internato di Anatomia La festa delle matricole Come superare gli esami Lucia Vacanze a Londra Le interviste Inghilterra Londra, finalmente Parigi DONNE E DOLORI 113 Le festine di Michele 114 Cosetta Indice 122 Logiche di follia 123 Via Zannoni 124 La prima volta 126 Alla ricerca del tempo perduto 129 133 136 136 VIVERE ALLA GRANDE Il business delle dispense Cortina davvero! La Société Internationale des Trapoles Barbara 143 Truccacci ignobili per convincere le donne 145 149 150 152 153 153 154 156 159 161 Il business cresce La Trisezione della Vita La nonna a Montecatini Pranzi di Natale Tre vite in una Cortina esagerata La bella Rosin L’onesta ragazzina padovana Achille e il Liceo Artistico La condotta a Molinella 165 167 168 173 175 176 178 RIDIMENSIONAMENTI Psichiatria La consulenza della casa di cura Un tifone chiamato Laura Il terzo esaurimento nervoso Il ritorno di Laura Le giuste nozze Vita coniugale 179 Logiche di matrimonio 180 181 183 185 I grandi viaggi Il Kenia Gli USA L’Oriente 245 246 189 190 194 197 Il Morbo di Monduz PATOLOGIA RECENTE Nel mezzo del cammin... Il «Romanzo totale» Gli studi aziendali Il vero business 198 Logiche di denari 199 Logiche politiche 200 Vasco Rossi 202 Elogio della discoteca 204 Operazione successo 205 Gli ozii romani 208 Logiche geografiche 211 CLASSIFICAZIONE DEL MORBO ACCESSO ACUTO 213 Il manuale della playgirl 213 Postulati ideologici della seduzione 214 215 216 217 219 220 Finalmente scrittore Successo, tremendo successo! Il Playgirl Club Monduz and the playgirls Un vicolo cieco chiamato Successo I cinque inguaribili 223 224 226 228 230 INTERVENTO TERAPEUTICO Complicanze del Morbo di Monduz Meditazioni a Montequestiolo Bangkok e Hong Kong È deciso: scrittore! Professione: vivere 231 Logiche creative 232 Montequestiolo bis Aggiornamento 235 236 237 238 239 240 AGGIORNAMENTO L’illuminazione La mia missione La cura miracolosa Commiato... ... per le lettrici 247
Scarica