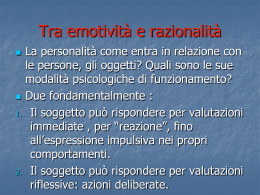Place Vendôme (17) ERRATA CORRIGE: I MIEI EROI PREFERITI SONO LEONCAVALLO E PIERINO Il mercuriale demiurgo di questa piazza ristabilisce la verità circa le sue personalissime gerarchie e predilezioni. Venendo da un’adolescenza dove ‘c’era il grigio stabile, inzuppato nel freddo, della scuola e c’era il nero, il buio paradisiaco del cinema’, non si perita oggi di affermare: ‘scusatemi, io sono di quelli che tra Fellini e un Matarazzo scelgono Matarazzo’. Così, come rammenta ai seguaci del sommo filologo Contini (privi, però, della sua sterminata cultura extra-filologica) che isolando ‘il momento della lettura tecnica’, si perdono altri assai necessari strumenti di ricezione del testo. E si smarrisce ‘il senso del rischio, il senso della mortalità che ci fa individui, il senso della avventura’. ________________________________________________________________________________ di Marzio Pieri o. Ma il tempo, ma il tempo. Ora chi glielo va a spiegare ai lettori di dèdalo che Garibaldi che Verdi non sono i miei eroi. Palladini mi hai messo nella rete, te tu l’hai sparata a titolo per chi facesse del leggere un’arte d’ironia. Una razza estinta, un villaggio sperduto di sopravvissuti, che parlano una lingua che niuno intende, dilà dal fiume Bravo, dilà dal deserto di Gila, dilà dalla Monument Valley, dilà dilà. Dev’essere stato in qualche film di Tarzan o di Winnetou (Karl May): la traversata rituale della cascata, il battesimo necessario a ritrovarsi dilà dalla muraglia di roccia, oltre il limite, dilà dallo specchio. Allora si lascia sbrigliar Fantasia. Dalla navicella di Noè si era staccata una fetta del ponte, un dado di legname che planò sulle acque e fu da tutti creduto perduto. Uomini, donne, qualche cucciolo d’uomo, il bue, l’asinello, la chioccia, due vaccherelle da latte, dei lupi per ballarci, sei chioccioline; e gatti, gatti. Scesero a ritrovare, in una valle aperta a cieli da non credersi, la felicità. Loro, del resto, credevano che fossero tutti gli altri ad essere morti. Ecco, per un millennio, per un altro millennio, per qualche secolo in più, la tribù favolosa di coloro che usavano della lingua come di un’algebra. Ogni parola reca il suo rovescio, più che Sintassi impera qui Polifonia. E ne scongaga i Fiaminghi. i. ii. Sul tetto delle case, delle chiese, non la croce cristiana né quella del sole assassino, svastica. Venerano una figura che ha molte punte terminali, avanti, e rappresenta un Delta. Ho nominato Winnetou. Non dire ultimo se non sei sicuro. Infatti Winnetou, eroe dei romanzi di Karl May (1842-1912), è una sorta di figlio o meglio nipote non carnale di Uncas, the last of Mohicans (1826). Le date parlano chiaro: in Italia solo un anno dopo sarebbero fioriti i Promessi sposi di quel tal Sandro, nella loro versione più ispirata, e il Pirata di Vincenzo Bellini, alla Scala, incarnazione dell’eroe maledetto e ‘romantico’. iii. iv. v. vi. Ma, con scorno dei nostri manuali ‘leghisti’ (l’Unità d’Italia, che non si fece in un giorno, mi ricorda più la nascita, dilagare di chiazze, della ‘lega’ attuale, solo che fu d’en haut e non, come oggi, d’en bas, in ogni caso vittime e portatori della sindrome cinese, quella che fu cinese perfino l’inventore del macinino da caffè), l’opera del Manzoni non fece nemmeno la sua rituale gita a Chiasso, a differenza dei libri di Fenimore Cooper (che, lo ripeto sempre, a Firenze ci venne e sai che impressione avrà fatto l’Arno a chi veniva dal Mississipi e il boschetto delle Cascine a chi aveva negli occhi i grandi boschi della regione dei laghi) e del (solo in Italia) deprezzato inventore del romanzo storico, lo scozzese Walter Scott, perlomeno tenuto stretto dagli operisti che ― distanti dai critici ― il loro pubblico lo conoscevano). E non fatemi dire di Victor Hugo. Ogni tanto si leggeva, per la penna di attenti musicografi: il Trovatore (variante: il Don Carlos) furono le Passioni (intendi quelle di JSBach) di Verdi. Coglievano, così dicendo, il momento rituale dell’ascolto. Ma noi, ai Miserabili, possiamo offrire in alternativa soltanto la Gioconda. L’opera di Ponchielli, su libretto di un Boito camuffatosi per anagramma, risaliva del resto a una cosa minore del teatro hugolista. La mente che non dorme mi dice che con Verdi non c’è partita, ma ci sono anche i piedi e se Milano o Roma fossero come Berlino, ci avessero tre o quattro teatri anche d’opera in funzione in contemporanea, e in uno d’essi dessero il Don Carlos, in un altro il Trovatore, e la Gioconda nel terzo, i piedi mi porterebbero a quest’ultimo teatro, fosse solo per nostalgìa (vidi la mia unica Gioconda a sedicianni e s’installò dolcemente nel mio immaginario d’adolescente un poco ritardato) e per rarità. A meno che nel Don Carlos non ci fossero, magicamente riuniti in questa vita, gli interpreti del mio primo Don Carlos teatrale (era passato un anno ma a quell’età vale un secolo) o a brandire la spada della ‘pira’ l’arcangelo Tamagno, l’espada Lauri Volpi. Umanamente ho la morte a schifo, ma vivo ormai con quasi tutti morti. Sarà solo perché avendo pagato il loro debito al corpo, che mi appaiono un’unica gloria? Debbo stare attento a non sbandare. La valle misteriosa degli uomini che dànno un riso ad ogni loro detto tende pericolosamente, in me, a identificarsi coi giardini beati. Al tempo! Al tempo! Ci sono dei misteri nei numeri, nelle date. Karl May morì tre giorni prima della nascita di mio padre. Winnetou fiorì l’anno dei Pagliacci. Se Palladini avesse titolato: “SON LEONCAVALLO E PIERINO I MIEI EROI PREFERITI” sarebbe andato più vicino al vero, ma il mio scritto non glie lo suggeriva. Depista depista, va a finir che ti prendono sul serio. Leoncavallo è il musicista napoletano che si rese immortale coi Pagliacci. Pierino è molto meglio che non ve lo spieghi. Tentiamo due parabole cinematografiche. Metto sùbito la, cronologicamente, seconda: si era al mare, io che odio l’acqua e la spiaggia non meno dei carnaî stavo chiuso in camera a scrivere deliziose stupidaggini che chiamavo lavoro; mio figlio, bambino, aveva strappato a mia moglie la promessa di accompagnarlo, la sera, al cine. Ma la prospettiva di vedersi un Pierino, nelle ore che lei, messi a letto da ultimo i pargoli, poteva dedicare al suo Gorgia, le aveva messo tale un malumore addosso, che decisi di ‘sacrificarmi’. Fu un sacrificio a rischio di morte, perché quando la maestrina dalle gambe storte su quei tacchi a vertigine scansa una buccia di banana (fatta cadere da Pierino, che la precede), ne scansa una seconda... una terza... la quarta... e quando finalmente il marciapiede termina e lei è salva: di botto la precipita in una buca di scavo. Risi, risi, risi da non sapermi più davvero fermare; e mi mancava il respiro. Morgante aiutami tu. Dire ch’ero sopravvissuto perfino alla Corazzata Potemkin. Seconda paravoletta, avevo dieci anni e c’era un cinema nella mia vita, a mezza strada fra la mia casa sull’Arno, a specchio delle prime Cascine (e a cinque minuti a piedi dal Comunale, il palazzo incantato e inaccessibile dell’Opera) e gli ultimi budelli che si aprono sulla piazza della Stazione. Si chiamava FULGOR e per lui vale quello che per Sàlgari: fulgór da fulgóre ma per tutti era fùlgor, come è impossibile credere che le tigri di Mompracem le abbia inventate un signor Salgàri. Sì all’anagrafe, ― ma che sa l’anagrafe? Il Fùlgor si divideva in platea e galleria e questo, mi direte, valeva per tutti i cinema o quasi (me ne ricordo uno ‘del prete’, che si chiamava Eden, e consisteva in un’unica saletta uguale per tutti, in nome non della democrazia, ma dell’esiguo spazio. Quando si diffuse il cinemascope, dovettero escogitare delle lenti che per stare sulla parete di proiezione disponibile, lunga quanto una cassa da morto, riducevano la schermata a francobollo e dovevi servirti di un binoccolo) ma, nel caso specifico, la selezione era, come dire, ‘di classe’: da basso i comuni spettatori, in galleria soldatini, servotte, garzoncelli, attempate signore con una piaga rosso fiammante al posto delle labbra, povere labbra consumate da quella che chiamavano, ipso facto, ‘la vita’. Al Fulgor vidi la Conquista del West (De Mille) senza riconoscervi (quello sì il mio eroe!) Buffalo Bill, affidato a un attore di terz’ordine; si arrivò in bicicletta, io sulla canna, con mio padre all’ultimo spettacolo pomeridiano e ricordo l’acquisto, su la via del ritorno, di una incartata succolenta di prosciutto cotto, odoroso e bianchissimo, il migliore ch’io abbia mai assaggiato. Vidi i Cavalieri del Texas (King Vidor) e si rivide due volte di séguito, perché una mia sorellina non intendeva sottrarsi alla visione degli indiani ‘in mutandine’. Gli ‘indiani’... quelli carichi in testa di cestoni di piume e di fronde come un Bacco dipinto (propriamente i o le pellirosse, come nel Buffalo Bill di Wellman), quelli dai crani rasati come teste di patata lessa, Uroni o Mohicani, come in Passaggio a Nord-Ovest, o nel Re dei pellirosse, questo una ennesima e non laida ritrascrizione del romanzo di Fenimore Cooper... Quelli vestiti da zingari del Massacro di Fort Apache... e quelli ‘in mutandine’, che rotolano massi giù da un costone sulla inane trincera dei rangers. Quando uno d’essi, un messicano, colpito dalla sfera di pietra, rotolava all’ingiù col sangue fuori dalla bocca e, in ultimo soffio: “adios”... mi pareva d’averla ricevuta io, portata io, nel petto, quella botta. Avevo dieci anni quando arrivati sulla porta del Fulgor (proustianamente sempre in compagnia di una nonna vecchia e non proustiana, amorevole e isterica), per il primo spettacolo pomeridiano (cioè alle due o alle due e mezzo della giornata), fu impossibile entrare. C’era la coda per tutto il marciapiede e davano Il grande Caruso. Non giurerei di non averci fatto anche una frignatina, la mia vita era semplice: c’era il grigio stabile, inzuppato nel freddo, della scuola e c’era il nero, il buio paradisiaco del cinema. Una droga per sopportare maestre, maestri, direttori didattici, bidelli (alle ‘medie’ cambiavano i nomi, non le funzioni inibitive e concentrazionarie). Tornammo il giorno dopo, con giusto anticipo sulla apertura, e fu lì che ascoltai, o forse riascoltai da qualcuna delle mie vite precedenti, “Ridi Pagliaccio”. Lo so, ci sono iniziazioni più superbe, più dichiarabili. Ma io sono di quelli che tra Fellini e un Matarazzo scelgono Matarazzo. Scusatemi, sto anchora inparando. Però badate: questo importa la scelta del ‘volgare’. Non dovette poi essere tanto diverso per Dante, per Boccaccio. Dante anche lo dichiara (sottochiave, ma non sfuggì all’Imbriani): ‘si va nel ciel per un pertugio tondo’. vii. viii. Sull’insegna: INMERDA MI LAUO. Se sia l’informazione merda o lavanda mi invita a meditarci l’amico Alvino, reduce da una salutare rispolveratura al groppone d’un tamburo principal della banda d’àffori. O Daffori, the DAFFOURI CIRCUS MAXIM BAND, una sorta di Mago Houdini o di Fontana delle Gazze Grauide. A me non sembra molto diverso dallo scriver di cinema del quondam Veltroni, Roma ha buoni salotti, qualche reduce centenario della Resistenza o degli anni di piombo, d’una parte o dell’altra. Che impiombatura, davvero. Il vero paternostro è il giornalista, credi davvero o Gualberto che metta conto occuparsene, farsene il sangue guasto? Il punto è sempre quello e il poco cammino mentale da me fatto partì con l’accorgermene quanto meno dal liceo: se Platone espone, teatralizza, contrappone i dilemmi che gli fermentano l’anima, e certo (visto che scrive, pressappocco inventa il Grande Stile di Prosa, diverso dalla visione verticale del poeta –qualcosa di simile a quando, a naso in sù e cor un mal di collo da chieder confessione, si cerca intravedere le figure in una cupola formicolante – e da quella cespugliosa dell’avvocato, cui si riferì per professione propria Cicerone) e certo, dico, nella presunzione di un pubblico, che legga, che ascolti, che cerchi di ritrovare il filo se s’interra, di tener stretto il gomitolo¸ se Platone lo fa in mille pagine, in centomila righe, in un milione di frasi, in una nebulosa di ansie esplorative e confutative, apologetiche o trucidaturchi, lacrimare di cose e di stelle: come possibile che la tiri tanto per le lunghe se un qualsiasi libero docente in vena di raccattar qualche quadrino risolve tutto il filosofo in qualche paragrafetto di manuale? Io, i manualisti, li fucilerei. I giornalisti te li lascio a te, O Gran Bastonatore d’Arfasatti. Un amico mettiamo di... di Lipadusa, o di Pantelleria, così confondo le acque e non si fanno pettegolezzi, siccome fa il didatta da una vita, difende appassionatamente il suo sobrio diletto di ‘insegnare a suonare’ ai pianisti in calzoni corti o coi primi baffetti da belloccio. Di-da-tta, non è una sequenza ulteriore di The Waste Land, significa insegnante di conservatorio, ed ha certo che fare col tambureggiare delle di-ta sui tasti neri e bianchi dello stromento. Erra chi aveva risolto: deriva da didaskein, greco ‘insegnare’. Lo stesso errore di quanti credevano che docente – indecente reductio ad unum d’ogni insegnare/ante universitario – avesse parentela con docere latino (pronuncia piana) e non con doccia o doccione ch’è la parte finale del tubo o canale di scarico esterno di una grondaia. Era spesso decorato con mostri o fantasime che scansassero dalla casa gli spiriti maligni e si chiamava anche gargolla o garguglia: ch’è puro Folengo o Rabelais. ix. L’amico mediterraneo ha i suoi principî, non credo abbia mai riflettuto che anche i principî della geometria, per tenerci al sodo, scontando come fanno dei postulati, si chiudono nella gabbia di una delle possibili geometrie. Così lui ha in gran dispitto le musiche estranee alla tradizione occidentale, si tiene al bastoncino dei convinti che extra ecclesiam – Bach Mozart Haydn Beethoven Mendelssohn, Ciaicovskij cum juicio, insomma ‘aimez-vous bramhs?’ – nulla salus. Regola numero Uno: non romper mai un giocattolo in mano di un bambino. (Sia chiaro: nella mia giovinezza era meglio tacere, con loro, di Schubert, informe, di Schumann, troppo rigido, e, da ultimo, squinternato, di Liszt puttaniere d’en haut, poi finto o credulo abate, di Wagner padre corrotto di corrotti fizi, di Bruckner e di Mahler, spropositati, del melodramma, partiam partiam!, di x. xi. xii. Busoni, solo pianista, compositore tutto ‘di testa’, di Strawinskij, dilettante di sensazioni facili, mondane, di Schoenberg, feccioso, e, diciamolo, ebreo, di Puccini, deamicisiano – Montale avrebbe poi scomodato Gozzano –, non parliamo del jazz, roba da negri!, e stando in casa nostra, ai nostri coccini, Mascagni era fascista, Pizzetti era fanatico, una noia!, Malipiero un fantoccio, jettatore per giunta, intanto crebbi e non avemmo le pustole di Darmstadt ma Renzo Rossellini, non favorimmo Nono ma Luciano Chailly, Berio un po’ meglio ma Rota vuoi mettere, Fellini mica ha cercato le musiche ‘così poco italiane’ di Berio, meglio Maderna, semmai, o Sciarrino ma il Sommo è il Tornatore, certo i più scaltri fecero centinaia di colonne da film e dieci od anche meno ne azzeccarono, ma con una innocenza culturale più tragica che disarmante e, semmai, col soccorso di eclettismi da lascia o raddoppia e scorciatoie da domenica del corriere ― fratelli ditaglia litaglia ormai è questa, un occhio nemmeno da pianger le resta, un poco di boria, se mancan le poma, nemmen la baldoria che fanno sul po). A rischio di Geenna, ho preso le distanze, che poi son le stesse che prendo dalla filologia testuale, tenendomi alle trappole e ai pericoli, e al fascino inguaribile, di una filologia ‘integrale’. Lo dico all’amico Gualvino, se ancora mi ascolta dalla sua torre lucente: ‘dimenticare Contini’, a un certo punto, si rese necessario. Il punto è che il sommo filologo aveva una cultura extra-filologica sterminata. Per questa non c’è metodo e non ci sono, parlando con rigore, discendenti. Il metodo si apprende, anzi ho sperimentato che i più bischeri fanno prima e meglio. Ma poi non si muovono di lì. Violetta canta, nel duetto del primo atto, con quell’Alfredo che le sembra un po’ più pulito degli altri e che a lei, generosa ma imprevidente, certo sprovvista di lettere se non le essenziali (‘informazione’), parrà un vero poeta d’anima, con tutti i luoghi comuni che viene spiattellandole sull’universo intiero e il misterioso, altèro, canta e ricanta Violetta: ‘dimenticare... di-men-ti-car...’ (ed è già innamorata, pronta a cedere). Non me ne voglia l’amico sicularabico se cito le Sue parole, perché le trovo perfette: Ho trascorso tutta la mia vita musicale nel tentar di venire a capo dei problematici rapporti tra partitura e interprete. E la moralità, la ‘responsabilità’ professionale dell’insegnante, che manda dotatissimi giovani pianisti a battersi nei concorsi d’esecuzione (i quali ormai sono l’unica loro strada per far carriera), ingigantisce ognora quei problemi. Comvengo con Lei, con me, che anche la più bella partitura possa essere un semplice accidente. Ma un accidente che, pur attraverso una notazione approssimativa, è e sarà fonte inesauribile di piacere musicale per l’interprete, fin dalla sua prima lettura. E l’interprete dovrà lealmente, rigorosamente, giudicare la qualità del sentimento di piacere che ne trarrà, depurandola, per così dire, da ogni lezio, e da ogni lectio!, da ogni enfasi e da ogni tentazione di falsificarlo... Dovrà poi onestamente, rigorosamente, giudicare la qualità del sentimento di piacere che egli sarà in grado di trarre dalla successiva realizzazione in suoni concreti di quella sua stessa rappresentazione ideale. E dovrè quindi puntigliosamente dedicare siffatto giudizio ad ogni suono (accidente)... Su un accidente del genere Alessandro Manzoni ci ripensò e smise di trascrivere. “eroica fatica”!, dall’originale la cronaca dell’Anonimo: “Imperciocchè, essendo cosa euidente, e da verun negata non essere i nomi se non puri purissimi accidenti...” Vero che l’autografo del buon secentista è tutto “dilavato e graffiato” mentre l’amico corrispondente fin dalle buste che compila si mostra pieno di grazia, chiarezza, facondia, xiii. ciceroniana ed attica ‘eleganza’. Ognuno vede quanto questi termini convengano a Beethoven a Ellington a Cage. ENTARTETE KUNST! Se fossi un eroe da melodramma, mi chiederei: “O Dio! come salvarlo?” Ho provato a rispondere: “La carriera... io mi son fermato alle soglie di quelle dei miei studenti. Non ho in mano né il tocco del destino né l’olio delle massonerie. Potevo solo trasmettere la mia esperienza: io ho sempre e solo letto per me. Se lo studente trovava in sé le ragioni di amarmi e di fidarsi, imparava guardandomi in quell’atto solitario. V’era anche del rigore, chi lo riconosceva mi amava; gli altri se ne andavano dai loro simili ed è una bella lezione di libertà. Il resto che venisse (o che mancasse) non mi ha mai riguardato. Paradossalmente ho anche appreso e applicato qualche rudimentale filologia, attinta a buone fonti. In questo resto crociano: è uno strumento, non un fine. E, laddove si esasperi isolandolo il momento della lettura tecnica, si perdono altre necessarissime strumentazioni. Il senso del rischio, il senso della mortalità che ci fa individui, il senso della avventura. A me pare paradossale che uno vada a scomodare l’arte per far di sé un impiegato scrupoloso. Questo non significa tradimento, slealtà, disonestà, ma una esposizione nuda, religiosa, totale, a fisica e metafisica di un testo. Sto rileggendo Giordano Bruno e lui insisteva: il piacere è il moto dallo stato della fame a quello della sazietà. è i l m o t o ; lo stesso centro, per un’anima barocca, non sta nell’equilibrio degli opposti ma nella scelta radicale, estremista, che di esso si fa. Ecco dunque gli Ariosto i Poussin gli Ingres i Foscolo. A mio giudizio Strawinskij è molto più estremo di Schoenberg, che pure fa normalmente del terrorismo ideologico. Mi dispiace che siamo su posizioni di dissenso irricomponibile; questo non detrae nulla ad amicizia, rispetto, stima personale. Ma, come i magi... ‘per diversa via’.”
Scaricare