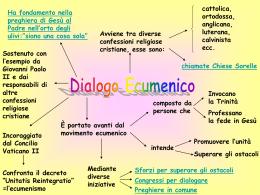Domenico Pezzini L'acqua e la rosa Traditio fidei come traditio amoris: trasmettere la fede è educare all'amore L'acqua e la rosa sono state all'inizio un quadretto del grande pittore spagnolo Francisco de Zurbaràn (1598-1664), che mi abbagliò come una rivelazione la prima volta che lo scoprii quasi per caso alla National Gallery di Londra. Di dimensioni modeste, tali che si rischia neanche di vederla, la piccola tela mostra, su un tavolo appena percettibile, una brocca in cui si intravede un filo d'acqua e una rosa recisa posate su un vassoio di peltro. Nient'altro. Il fondo nero mette ancora più in risalto queste due cose essenziali in cui non è difficile vedere una metafora di quanto costituisce la materia primaria del vivere: l'acqua, appunto, da cui la creazione è sorta e per la quale rimane nell'esistenza, e la bellezza, simboleggiata nel fiore che per antonomasia indica l'amore. Sono stato contento quando ho potuto realizzare il sogno di scegliere quell'immagine per la copertina e il titolo di un libretto nato un po' occasionalmente e dedicato a illustrare qualche regola elementare del vivere in relazione1. Sarà stato un caso, ma ho ritrovato acqua e rosa nei versi densi e a loro modo programmatici di una poetessa inglese che ha dedicato molto della sua riflessione al tema delle D. PEZZINI, L'acqua e la rosa. Piccola grammatica della vita di relazione, Centro Ambrosiano, Milano 2006. 1 relazioni interpersonali2. Elizabeth Jennings (1926-2001) riprende le due immagini in una poesia in qualche modo programmatica, Beyond Possession (Oltre il possesso), esattamente per dire che l'essenza più pura della relazione vissuta in libertà di cuore è la gratuità: non è necessario schiacciare i petali per avere il profumo della rosa, e non è possibile, anzi è decisamente stolto, pretendere di fissare i lineamenti, nostri o altri, su un'acqua che scorre. In parole povere: la relazione, ogni relazione, con gli oggetti come ancor più con le persone, muore nel momento in cui pensiamo di impadronirci dell'altro, di mettere le mani in modo rapace su ciò che sveglia il nostro desiderio. La Jennings ritorna spesso sulla metafora dell'acqua, in cui non è difficile vedere i vari aspetti della vita3. E simbolo della labilità e transitorietà delle cose, come si è appena visto, con la conseguenza che si è detto. Ma l'acqua di una fontana rimanda anche immagini di prodigalità, creatività, eleganza, e chi la osserva vi coglie «l'ammansire / il restar saldi nel fiorire di mille spruzzi / che costruisce questa energia», al punto da intuire «nella tensione un'immagine di calma sovrana, / una quiete» (Fontana). Quella calma che a volte è cullata dal gocciolio lento e regolare della pioggia, un po' come le note di una sonata per piano con cui Mozart «elabora il silenzio» (Mozart nel cuore della notte). E l'acqua, in una metafora riassuntiva, appare soprattutto emblema di docilità (Musica d'acqua): l'acqua si adatta, precipita dalle rocce «per giungere alla quiete molto più in basso», si distende in larghi estuari ove l'impeto della sorgente rallenta e si placa, sa adattarsi alle sinuosità delle rive, e se incontra un 2 E. JENNINGS, La danza nel cuore delle cose, a cura di D. Pezzini. Editrice Ancora, Milano 2007. 3 Ho esplorato brevemente il tema in "L'immaginario dell'acqua nei versi di Elizabeth Jennings", Il Piccolo, settembre/ottobre 2007, 22-23. I testi citati si trovano in questa antologia. ostacolo si trasforma in spruzzi festosi che fanno pensare ai riccioli di una testa solleticata dal vento. Ora, cosa ha a che fare tutto questo con il tema della relazione, e ancora più con la relazione in rapporto alla trasmissione della fede? Moltissimo, perché se è vero che «l'acqua è la vita, la rosa è la bellezza, e la relazione è la bellezza della vita», non si vede come da questo cerchio magico possa essere esclusa la fede, proprio per il rapporto intrinseco che essa ha sia con la vita che con la bellezza, e ancora più con la relazione interpersonale. In effetti, la risposta è già nella domanda, perché se traditio significa trasmettere, questa è un'operazione che non si dà se non all'interno di una relazione in cui uno passa qualcosa a qualcun altro, dove, ovviamente, i ruoli di chi dà e di chi riceve non sono né rigidi né immutabili. Anche in questo caso è l'immagine del cerchio quella che meglio aiuta a comprendere come funziona la trasmissione. Volendo riassumere il tutto in poche affermazioni, diciamo che la relazione è (1) il contesto in cui avviene la trasmissione, (2) il contenuto che è trasmesso, e (3) il frutto che germoglia in chi accoglie il messaggio. Quanto segue altro non è che uno sviluppo di queste tre affermazioni capitali. 1. La relazione è il contesto in cui avviene la trasmissione Cosa si intende quando si dice che la trasmissione della fede, che normalmente chiamiamo catechesi, avviene in un contesto di relazione? Certamente il fatto che c'è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta. La cosa, a ben vedere, accade anche quando si legge un libro in solitudine. Perché l'autore del libro è pur sempre una persona con la quale entro spiritualmente in contatto dal momento che mi metto in ascolto di quanto ha scritto. C'è, però, nella trasmissione della fede molto di più di un semplice contesto esterno che mette in rapporto due strumenti, un trasmettitore e un ricettore. Se la catechesi, qualunque forma assuma l'annuncio, avviene in un contesto relazionale povero o nullo il fallimento è garantito. Questo anche solo in ragione del messaggio, che ha a che fare con la vita nei suoi aspetti più fondamentali. Nel linguaggio cristiano la densità incredibile che deve possedere la trasmissione fino a far scattare una relazione tra chi parla e chi ascolta ha un nome ben noto: si chiama testimonianza. Il termine, con il suo ricchissimo retroterra biblico, dice molto, e ha fatto bene il Documento Base per il Rinnovamento della Catechesi (RC) a ricordare che «la predicazione non è semplice comunicazione di sapere, ma trasmissione di una parola che invita, interroga, provoca, consola, crea comunione e salva» (n. 35). Siccome il problema è trasmettere una «mentalità», e non delle semplici nozioni, si dice ancora che «la mentalità di fede è radicata nella persona... Con la grazia dello Spirito Santo, ciascuno sviluppa le sue facoltà di ammirazione, di intuizione, di contemplazione, di giudizio, di adorazione, fino a ratificare coscientemente la fede che ha avuto in dono» (n. 41). Ognuno vede come tale processo, in cui sono in gioco una mentalità da trasmettere e una persona che la trasmette ad altre persone, non possa avvenire se non in un contesto relazionale significativo, del tipo di quello che esiste, per intenderci, tra una mamma e il suo bambino, o di quello che Gesù ha illustrato nella celeberrima metafora del pastore in rapporto con le sue pecore. 2. La relazione è il contenuto che è trasmesso Quanto detto assume un valore ancora più grande se si pensa che al centro dell'annuncio cristiano sta un Diorelazione, un Dio-Trinità. Qui si rende necessario evitare ogni intellettualismo o l'istinto facile di confinare la fede nella Trinità in qualche ritualismo sterile, dal segno di croce tracciato come una formula magica alla percezione del sacramento come "cerimonia" tutta esterna o quasi. Il rischio c'è. Il cristiano, ci dice il Vangelo, è "ammaestrato" (vedi sopra), cioè educato a vivere la condizione del discepolo, e "battezzato" nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (cfr. Mt 28,19). Che significa? Basta forse un rito, per quanto elaborato e ricco di significati illustrati per bene, a far funzionare le cose? Basta un po' d'acqua per chiudere i conti con il "peccato originale" di cui laverebbe la "macchia" e fissare la persona in una condizione provvidenziale di anagrafe cristiana al riparo da sanzioni e castighi? Nessuno dovrebbe essere così ingenuo da poterlo anche solo pensare. I simboli, in effetti, funzionano quando il loro senso è colto, e quando la comprensione che ne deriva si materializza in azione. Le catechesi battesimali dei Padri sono a questo proposito una miniera di suggestioni, tanto più efficaci quanto più legate alla concretezza visiva ed emotiva di immagini e gesti. Ma basterebbe anche solo partire proprio dal senso etimologico del verbo "battezzare", che significa immergere completamente nell'acqua. L'acqua è simbolo archetipo di vita e di morte. Nell'acqua si nasce, nell'acqua si annega. Due sono, mi sembra, le applicazioni che la figura dell'acqua suggerisce. Penso anzitutto alla spugna, che immersa nell'acqua se ne imbeve e, spremuta, la restituisce. E se la spugna deve servire allo scopo va continuamente immersa, perché una spugna secca non serve a niente. Del resto, sarebbe bene ricordare che il segnarsi con l'acqua benedetta entrando in chiesa altro non è se non il gesto di chi vuole far rivivere le acque del suo battesimo nel momento in cui nell'azione liturgica torna a farsi "corpo" con quella comunità in cui il battesimo, appunto, l'ha innestato. Si pensi allora a cosa può voler dire essere battezzati nel nome della Trinità: significa essere, e rimanere, immersi nella logica relazionale di Dio, nientemeno. Come dire che il paradigma di riferimento per la vita del cristiano è il modo di rapportarsi delle tre persone, in cui la distinzione non genera conflitto od opposizione, ma fa sorgere la sinfonia della complementarità, in cui uno si definisce in rapporto all'altro. E un discorso che può parere astratto. In realtà noi non sappiamo niente di Dio. C'è, però, la via regale per entrare in questo mistero, ed è Gesù. Il Padre è il suo riferimento costante: con lui è "uno"; lo Spirito è il suo fiato che egli nella sua morte e risurrezione offre al mondo perché viva della sua vita. Gesù, l'uomo di Nazaret, è il crocevia che con la sua vita racconta la Trinità: una rete di relazioni in cui la regola è il dono, ricevuto dal Padre e donato nello Spirito. Come ben riassume il Documento Base: «Il sublime mistero della vita di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, deve essere proposto dalla catechesi nella maniera con cui è stato rivelato al mondo, e cioè, supremamente, attraverso la conoscenza e l'esperienza che ne ebbe Gesù e che Egli ha annunciato e offerto agli uomini» (RC n. 82). C'è però una seconda immagine legata all'acqua: la morte e la rinascita, quella così splendidamente illustrata dai verbi usati da Marco per Gesù, che «è battezzato», cioè immerso fino in fondo nell'acqua, da cui, però, «risale» (Mc 1,10). In una parola la kenosi e l'ascensione, l'abbassamento e la glorificazione (cfr. Fil 2,1-11). Il cristiano sa che tutta la sua vita è sotto il segno di questo morire per nascere, morire a un modo relazionale segnato dall'istinto di possesso per rinascere a un modo di essere marcato dalla logica del dono. Qui l'acqua diventa vita, perché vivere non è altro che rimanere immersi nella rete della relazione trinitaria. Come scrive brutalmente Giovanni: «Siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte» ( 1 Gv 3,14). Vorrei infine accennare a una terza immagine utilizzata dai Padri: il fonte battesimale come utero della Chiesa. Lì uno è concepito e covato fino al tempo stabilito, da lì, però, deve uscire se vuole vivere. E un tema su cui lascio a ciascuno di riflettere, perché è cruciale entrare in questa dialettica di dentro e fuori. La comunità di fede, a cominciare da quella microcomunità che è la famiglia, funziona da utero in quanto lì si impara a «formare la mentalità cristiana», che significa «nutrire il senso dell'appartenenza a Cristo e alla Chiesa» (RC n. 43). Più in dettaglio tale "«mentalità» è il frutto di un «educare i credenti all'adorazione, al rendimento di grazie, alla penitenza, al senso della comunità, alla familiarità con i segni che indicano la presenza di Dio e in vario modo la comunicano» (RC n. 44). Ma tutto questo non ha come traguardo la costruzione di un utero caldo in cui crogiolarsi e, alla fine, morire. Se la fede nella Trinità, così come ce l'ha rivelata Gesù, diventa una scuola di relazioni, è necessario che la lezione venga esportata. I luoghi dove il cristiano vive la sua fede, infatti, sono la mensa e la strada4, la comunità eucaristica e la comunità degli uomini. E scritto ancora nel Documento Base, citando il Concilio, che «la grazia del rinnovamento non può avere sviluppo alcuno nelle comunità, se ciascuna di esse non allarga la vasta trama della sua carità sino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per coloro che sono i suoi propri membri» ( A d Gentes 37, citato in RC n. 88). 4 Sulla rilevanza cruciale di queste due metafore e le loro ricche implicazioni mi permetto di rimandare a D. PEZZINI, ha strada e la mensa. Il discepolo nel vangelo di Luca. Edizioni Paoline, Milano 2005. 3. La relazione è il frutto che germoglia in chi accoglie il messaggio A questo punto del discorso, affermare che la relazione sia anche il frutto della traditio fidei è quasi pleonastico. E in realtà, la distinzione che si è qui operata è tutto tranne che una sequenza cronologica di momenti da vivere in successione. I tre aspetti della traditio, infatti, contesto, contenuto e frutto, stanno o cadono tutti insieme. Lo ricorda ancora il più volte citato documento sul rinnovamento della catechesi: «Il mistero cristiano è un mistero di "comunione". Nella catechesi non ci si deve mai stancare di presentare in questa luce ogni verità e ogni atto. Tutto il cristianesimo, nelle affermazioni della sua fede, nella sua costituzione vitale, nella liturgia, negli impegni che propone, nelle mete che annuncia, ha una struttura eminentemente comunitaria, che non può mai essere disconosciuta» (RC n. 78, sottolineatura mia). Non ho l'impressione che tale modo di pensare sia diffuso. Dovrebbe essere una seconda natura per il cristiano, la prima per importanza, ma basta vedere certe liturgie per avere la netta percezione che anche il culto, che più di ogni altra azione dovrebbe manifestare questo "mistero di comunione", è spesso inteso più come un self-service che non lascia traccia alcuna sul modo di vivere le relazioni tra le persone. Evidentemente si è persa qualche connessione. Perché, tanto per cominciare, bisognerebbe ricordare che Cristo è «il centro vivo della fede», e «cristiano è chi ha scelto Cristo e lo segue» (RC n. 57). Ne scende che Gesù è il nucleo centrale della traditio, e cosa ne consegue? Proprio perché questo non rimanga un concetto vuoto, si veda in che termini è descritta la "personalità di Gesù "che il discepolo deve assorbire. La catechesi, infatti, che scaturisce dal principio appena ricordato è chiamata a mettere in risalto «i lineamenti che meglio lo rivelano all'uomo del nostro tempo: la sua squisita attenzione alla sofferenza umana, la povertà della sua vita, il suo amore per i poveri, i malati, i peccatori, la sua capacità di scrutare i cuori, la sua lotta contro la doppiezza farisaica, il suo fascino di capo e di amico, la potenza capovolgitrice del suo messaggio, la sua professione di pace e di servizio, la sua obbedienza alla volontà del Padre, il carattere profondamente spirituale della sua religiosità» (RC n. 60). Un bel programma, davvero, e tutto segnato dagli aspetti più tipici della vita di relazione. Alla base della quale sta un concetto mai sufficientemente messo a fuoco, che la relazione cioè parte da una situazione di "indigenza", o di bisogno, in cui ciascuno viene a trovarsi dalla nascita, e alla quale ciascuno risponde creando, appunto, una rete di relazioni, che, se l'espressione non fosse abusata e fonte di equivoci, potremmo mettere sotto il segno del "mutuo soccorso". Del resto, i verbi che costituiscono la dinamica fondamentale della vita di relazione, e che ho derivato da Giuliana di Norwich, una mistica inglese del Trecento, sono tutti nel segno di una fragilità che ha bisogno di essere sostenuta e aiutata: custodire, sopportare/supportare, ravvivare e guarire. Queste azioni sono, al dire di Giuliana, «opera della misericordia» e «tenerezza dell'amore», quello di Dio naturalmente, ma anche il nostro (Rivelazioni, cap. 48). Tra i luoghi dove il cristiano viene educato alla relazione ci sono in primo luogo la famiglia e la parrocchia. Sulla prima non è il caso qui di spendere parole se non per ricordare che tutto quanto detto sopra dovrebbe trovare il terreno privilegiato di applicazione anzitutto nell'ambito familiare. Ma questo non basta, e accade anche che in certi casi non funzioni. L'ambito più largo, e comunque necessario, è la parrocchia, descritta idealmente dal Concilio come «luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le differenze umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della Chiesa» (Apostolicam Actuositatem n. 10). Ancora la duplice dimensione, dell'accoglienza e della missione. E «nella comunità parrocchiale, più che altrove, che la catechesi può divenire unitariamente insegnamento, educazione, esperienza di vita» (RC n. 149) proprio per la rete vasta e articolata di relazioni che in essa è dato di incontrare. Al di là di tutti i limiti e le difficoltà della parrocchia, «le sue aspirazioni e le sue possibilità restano pur sempre quelle di vivere e di annunciare in tutta pienezza il mistero cristiano, offrendo a ciascuno il dono di cui ha maggiore bisogno, con particolare sensibilità per coloro che sono soli, per i lontani, i bisognosi, i poveri d'ogni genere» (RC n. 149). 4. L'attenzione, il senso di gratuità, la bellezza Volendo concludere con qualche indicazione concreta circa l'opera di educazione alla relazione nel contesto della traditio fidei penso di dover tornare al punto da cui sono partito: l'arte e la poesia. Immagino che tale sentiero possa sembrare di primo acchito paradossale, utopistico, e alla fine persino futile. Con tutti i problemi che ci sono! Se però mi è concesso, vorrei sommessamente ricordare che - almeno questa è la mia esperienza - l'arte e la poesia, con la musica, contribuiscono in modo considerevole a educare tre aspetti senza i quali ogni raffinato ricettario psicologico per la vita di relazione rischia di rivelarsi, esso sì, futile e inefficace. Questi tre aspetti sono: l'attenzione, il senso di gratuità, e la bellezza. Chiunque rifletta scoprirà presto come la frequentazione della poesia, o della lettura in genere, contribuisca a rendere la mente attenta e attiva. Lo stesso effetto lo fa l'arte rispetto allo sguardo, e la musica rispetto all'udito. Nel bene e nel male, secondo che l'oggetto sia bello o brutto. Se si vuole uscire da un modo di relazione superficiale, bisogna avere il coraggio di dire che ci si deve educare all'attenzione, e questo passa dalla calma con cui si legge un testo, si guarda un quadro o si ascolta, nella pace, una musica pacificante. Non è con la velocità dei messaggini e con la loro lingua ridotta a mozziconi che si potrà costruire il linguaggio della relazione. Non è con la volgarità di un'arte ( ? ) che imbratta i muri che si impara a guardare con rispetto e pudore un volto. Non è con l'abitudine a una musica assordante che si può imparare a cogliere la delicatezza di sussurri e sospiri che chiedono la nostra attenzione. L'arte e la letteratura educano alla relazione perché sono esperienze di bellezza, e ancor più perché, come la bellezza, sono "gratuite". Dal punto di vista pratico niente sembra più inutile! E la nostra civiltà occidentale, purtroppo, sembra tutta centrata sull'utile, il profitto, il rendimento, in termini di soldi e di beni di consumo. Quanto una tale visione utilitaristica incida sul modo di vivere le relazioni è sotto gli occhi di tutti. Uno esiste solo se e finché "serve", poi lo si butta. Anche le relazioni interpersonali sono diventate - la denuncia è fatta spesso un bene di consumo! Ma quando è investita dalla ricchezza anche la bellezza, purtroppo, diventa volgare e merce di scambio. A tutti sarà capitato di incontrare, spero, persone economicamente povere e anche, come si dice, senza una grande cultura, che però hanno una sensibilità finissima, una saggezza da far invidia. Sono il segno che il cammino dell'attenzione, nutrito di bellezza vera e grembo fecondo della gratuità, è aperto a tutti, e non coincide con un particolare tipo di "ricchezza" materiale o intellettuale. Se di ricchezza s'ha da parlare, è di quella "spirituale" che qui si tratta. Vorrei terminare con un'esperienza recente. Mi trovavo in Belgio per delle conferenze a una comunità di trappisti sul tema del "riposo come categoria della vita spirituale". Ne ho approfittato per visitare la collegiata di Nivelles, una splendida costruzione romanica. Immerso in una luce cristallina, che esaltava le linee purissime della chiesa, e in un silenzio che era di per sé un'esperienza di contemplazione, ho vissuto un momento di profondissimo riposo interiore. C'era in corso un funerale. Il celebrante ha ricordato che la defunta era credente, anche se non praticante, ma ha rimarcato che amava i fiori, come si poteva vedere dalla sollecitudine amorosa con cui curava il suo piccolo giardino. E disse che chi ama i fiori non può non amare le persone. Ho pensato che chi è attento ai fiori è un cercatore di bellezza, ed è pronto a scoprirla dovunque, nei volti come nei cuori. Terminato il funerale sono salito all'altare dove un modello di nave, simbolo della Chiesa, portava sulle pareti della chiglia una serie di scudetti su cui gli adolescenti che avevano da poco fatto la professione di fede, avevano appuntato ciascuno una frase-programma. Una di queste diceva: «Amare ed essere amato: sono parole di Gesù che cercherò di seguire. Grégory». Le parole, in effetti, stanno all'inizio dello splendido dialogo sull'Amicizia spirituale di Aelredo di Rievaulx, un cistercense inglese del XII secolo, che le riprende da sant'Agostino5. Ma è ovvio che avrebbe potuto dirle benissimo anche Gesù, e devo dire che mi ha commosso ritrovare nello scritto di un adolescente dei nostri giorni il programma di un adolescente del medioevo. La Chiesa è una rete di relazioni che si estende non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Sarà bene tenerne conto, più di quanto non si faccia. 5 AELREDO DI RIEVAULX, L'amicizia spirituale, Prologo 1, ediz, a cura di D. Pezzini. Paoline, Milano 2004, p. 103. 5. L'intreccio di tre amori Termino citando una breve poesia che ho trovato in questi giorni leggendo un bel libro di Timothy Radcliffe, ex maestro generale dei domenicani. Sono versi scritti da un prigioniero di guerra in un campo di concentramento giapponese: Nessuno sapeva dirmi dove fosse la mia anima. Ho cercato Dio, ma Dio mi sfuggiva. Ho cercato il mio fratello, e ho trovato tutti e tre: la mia anima, il mio Dio e tutta l'umanità6. Il tema è noto, ma non è inutile rimetterlo al centro di una riflessione che si propone di illustrare come il trasmettere la fede significhi educare all'amore. E ancora una volta mi viene naturale ricorrere alla sapienza di Aelredo di Rievaulx, che nella sua opera più importante dedicata a esplorare la relazione in tutti i suoi aspetti ha scritto: Benché in questi tre amori, quello per sé, quello per gli altri e quello per Dio, sia evidente la differenza, essi sono però intrecciati in modo straordinario, così che ogni singolo tipo di amore si trova negli altri, e tutti gli altri in ciascuno: uno non c'è senza che ci siano gli altri, e quando uno vacilla, si perdono anche gli altri. Infatti, non ama se stesso chi non ama anche il prossimo e Dio; né ama il prossimo come se stesso chi non si ama. Inoltre è chiaro che non ama Dio chi non ama il suo prossimo: Chi infatti non ama il fratello che vede, come potrà amare Dio che non vede? (1 Gv 4,20)7. 6 T. RADCLIFFE, Il punto focale del cristianesimo, San Paolo, Milano 2008, p. 167. 7 AELREDO DI RIEVAULX, Specchio della carità 3 , 3 , ediz. a cura di D. Pezzini, Paoline, Milano 1999, p. 256. Ecco dunque la relazione come una rete che ha per autore e protagonista Dio stesso, e che si materializza nel-l'intrecciarsi di quei moti, che noi chiamiamo "amore", con cui, a partire da noi stessi, ci proiettiamo verso gli altri e verso Dio, l'Altro per antonomasia. Anche se, per esigenze di chiarezza, arriviamo a separare queste tre traiettorie, esse in effetti non fanno che intersecarsi, e in maniera tale che neppure più si riesce a distinguerle bene. Scrive ancora Aelredo: Questi tre amori vengono concepiti l'uno dall'altro, si nutrono l'un l'altro, si accendono l'un l'altro, e infine raggiungeranno insieme la perfezione. Ma avviene che, in un modo strano e ineffabile, quantunque questi tre amori siano in noi simultaneamente, e non può essere altrimenti, non sono però sempre percepiti in grado uguale, ma quel senso di quiete e di gioia è talvolta avvertito nella purezza della propria coscienza, talvolta viene mutuato dalla dolcezza dell'amore fraterno, altre volte lo si acquista in modo più pieno nella contemplazione di Dio8. Aelredo parla di "quiete e gioia" perché in questa sezione del suo trattato sta sviluppando il tema del "riposo" come vocazione e punto d'arrivo delle nostre esperienze di relazione. E chiaro, infatti, che se la relazione nasce da un bisogno che segna ogni creatura come non autosufficiente, la sua realizzazione è per ciò stesso appagante, qualcosa che ci completa, ed è proprio questo il senso del termine "quiete" che il nostro usa con frequenza impressionante. E un tema che non è il caso di sviluppare in questo contesto. Ma basta ricordare che il percorso prevede il raggiungere la pace con se stessi, con il prossimo, e con Dio. Nel primo caso il cuore è visto da 8 Specchio 3, 5, p. 257. Aelredo come una camera dove tutto è in ordine, nel secondo come una locanda che tutti accoglie e dove gli altri "passano" come ospiti che non possiamo e non dobbiamo "trattenere", nel terzo il cuore diventa santuario dove, rasentando l'esperienza mistica, si incontra il volto di Gesù in uno stato di grande dolcezza e serenità, un traguardo che è l'apoteosi della relazione, descritta come un «giubileo, nel quale l'uomo rientra in possesso dei suoi beni, ritorna cioè al suo creatore, per essere posseduto e possedere, essere conservato e conservare, essere trattenuto e trattenere»9. Gli orizzonti si dilatano, e una buona pedagogia prevede che il cuore venga educato alla grandezza dalla contemplazione insistente di paesaggi vasti in cui respirare oltre le angustie in cui a volte la stessa miseria dell'esperienza rischia di farci precipitare. Nella geografia dell'anima non c'è spazio più vasto di quello definito dal mondo delle relazioni. E questo il luogo dove dobbiamo costantemente imparare, e insegnare, ad abitare in modo corretto. Ne va del nostro "riposo". 9Specchio 3,15, p. 267
Scaricare