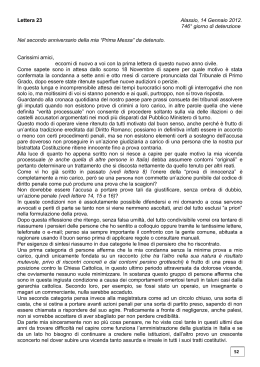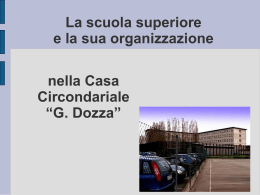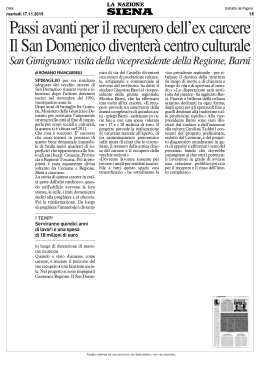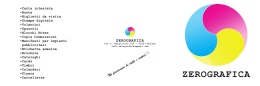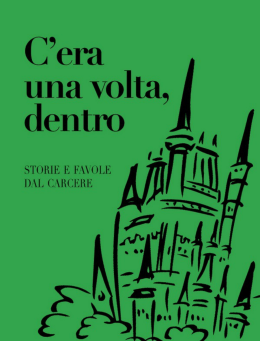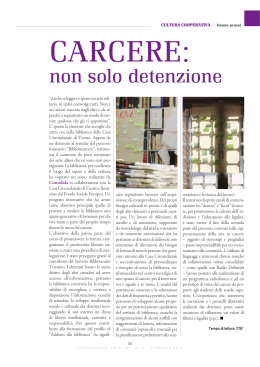Esercizi di volontà di Adriana Lorenzi Q uesto numero chiude un anno di attività della redazione di Alterego e inaugura quella successiva con il nuovo anno scolastico. Tanto è stato fatto, tante le attività che ormai ruotano attorno alla nostra redazione: le firme si fanno carico di commentare, rispondere agli eventi ai quali partecipano. Tanti sono i confini che siamo riusciti ad attraversare per mantenere il legame tra esterno e interno così indispensabile affinché la pena possa definirsi, per quanto e come possibile, rieducativa. Chi sta scontando la sua pena in regime alternativo continua a scrivere insieme a noi. Abbiamo invitato in carcere Paolo Berizzi, giornalista de La Repubblica e autore del libro La Bamba insieme al Poliziotto della Narcotici di Milano Angelo Langè. Quando io e Catia Ortolani abbiamo proposto in redazione la presenza del poliziotto, non ci aspettavamo la risposta unanime: “Perché no?”. Federico ha anche commentato che lo conosceva bene, poiché lo aveva arrestato la prima volta e se gli avesse dato retta allora, magari non ci sarebbe stata la seconda. Prezioso è stato soprattutto il dibattito tra Paolo Berizzi e i detenuti attenti a seguire il suo progetto TiraDritto. All’iniziativa ha chiesto di partecipare anche il Magistrato di Sorveglianza Zaniboni. Questi incontri ci confermano l’importanza di provare a osare per riuscire a dosare ingredienti come responsabilità e coraggio, partecipazione e narrazione di contro -storie per decostruire l’immagine scontata e prevedibile della popolazione carceraria. Paolo Berizzi ha poi commentato l’evento vissuto con uno scritto al quale i redattori hanno avuto voglia di rispondere. A teatro sono stati letti i brani che alcune donne avevano scritto per il convegno organizzato dall’Asl di Bergamo sul tema della violenza e la psicologa Chiaretta Aldeni ha parlato di come le donne vengano risucchiate nel circolo vizioso della violenza maschile. Sofia ha scritto alla psicologa, colpita dal suo discorso e dai progetti in atto a sostegno delle donnevittime e Chiaretta Aldeni le ha risposto con una lettera. L’Onorevole Laura Coccia in visita in carcere ha raccontato la sua storia di ragazzina disabile che non si è lasciata piegare dalle difficoltà, ma si è allenata per correre come i compagni di scuola, aprendo la strada alle gare di atletica per disabili. Ha offerto così una lezione di dignità e fiducia nelle proprie capacità e anche nei propri sogni che è stata accolta con commozio- ne dai detenuti che hanno provato a riflettere sul valore dello sport in carcere. Abbiamo proposto la visione del film Freedom Writers che racconta la storia di un’insegnante Erin Gruwell che riesce a interessare i suoi studenti alla lettura del Diario di Anna Frank e poi alla scrittura delle loro vite che si consumano nella rivalità di bande. A partire dal film, abbiamo scritto sul luogo che può diventare casa e sugli eroi che ispirano le azioni e sugli oggetti che diventano un talismano per non avere paura della paura, per non sentirsi soli, ma accompagnati perché, come ha scritto Federico, “quando si è il peggior nemico di se stessi, essere da soli non basta: serve piuttosto un’altra mano a fermare tutto”. E come ha sottolineato Santino: “La nostra scuola in carcere può fare molto perché l’atmosfera che si respira in aula non è la stessa che si respira nel cortile nell’ora d’aria, o in sezione o in cella. Il clima è diverso e anche noi finiamo per essere diversi”. Gli studenti del Liceo Classico di Piacenza si sono lasciati ispirare dalle nostre parole per scrivere le loro, sorprendendo anche la loro insegnante che si è accorta di non conoscerli affatto come ragazzi e ragazze alle prese con la loro adolescenza. Pagina 2 ALTEREGO Come sempre in estate Aldo Ghilardi ci ha regalato tre Letture sotto il berceau così come si svolgono al Circolino in Città Alta guidate dalla scrittrice Mimma Forlani. Da noi, in carcere, sono state ribattezzate Letture sotto il barbecue per via del caldo in un’area verde che non offre abbastanza riparo sotto gli ombrelloni, ma regala l’illusione benefica di essere all’aperto in compagnia di amici. Abbiamo interrogato gli autori: Pablo D’Ors sul significato della vocazione e del fare bene il proprio lavoro; Laura Bosio sull’infanzia quale età magica della scoperta; Sandro Bonvissuto sulla vita dopo la sua esperienza di detenzione. Le pagine di questo numero sono finestre sul presente e sul futuro di una società, quella carceraria, che non vuole fare finta di niente, ma cerca un antidoto al male che la abita, perché abita la società esterna. La galera, come scrive Bonvissuto “è un riassunto. In carcere è tutto vero; il carcere è l’ultima cosa vera che esista”. È vera anche l’attenzione che redattori e redattrici di Alterego mettono nel seguire progetti e nello scrivere articoli. Un’attenzione e un impegno che dall’interno possono essere esportate all’esterno. Esercizi del cuore e della volontà per imparare ad agire per il meglio senza aspettare che arrivi da altri. RESPONSABILE PROGETTO Mimma Pelleriti (Cisl Bergamo) DIRETTRICE EDITORIALE Adriana Lorenzi REDAZIONE Giovanni Bossi, Giuseppe Candido, Elina Carrara, Ermanno Ceccherini, Stefania Colombo, Angela Ghidotti, Ingrid, Federico Invernizzi, Lino Martemucci, Catia Ortolani, Laura P., Antonio Peluso, Vincenzo Santisi GRAFICA E IMPAGINAZIONE Bruno Silini (Ufficio Stampa Cisl Bg) I precedenti numeri di Alterego sono linkati e scaricabili in pdf sul sito internet della Cisl di Bergamo nella sezione “edicola” www.bergamo.cisl.it NUMERO 15 Pagina 3 SCAMBI EPISTOLARI PAOLO BERIZZI, giornalista e scrittore he bello quando i detenuti, anche quelli che sono dentro per droga, soprattutto loro, ti vengono incontro e ti stringono la mano e ti dicono grazie di essere venuto qui a parlarci di coca e di quanto fa schifo. Che bello quando ti dicono di tornare presto dopo che hanno rinunciato all’aria dell’ora d’aria per venire ad ascoltarti al chiuso di una sala convegni: loro seduti in platea, tu che gli dici che pippare coca non è da figo ma è da sfigato e che spacciarla è da verme, da vigliacco. E loro che annuiscono e adesso, faccia a faccia gli uni con gli altri, sono lì che sembrano guardarsi dentro e trovare la conferma che sì, pippare coca è da sfigati e spacciarla è da vigliacchi. Oggi, una settimana dopo l’invito a San Vittore, ho incontrato i detenuti del carcere del “Gleno” a Bergamo. Piacere doppio: incontrare chi vive chiuso dentro una cella scalda il cuore, ti fa sentire vivo, utile. E poi Bergamo, la mia città. C L’invito è arrivato da Adriana Lorenzi e Catia Ortolani: lavorano in carcere, seguono i detenuti e li rieducano attraverso la lettura, la cultura, l’informazione, l’amore per il sapere che è anche amore per la bellezza. Brave loro e bravi i detenuti di oggi. Una cinquantina. Molto preparati, molto curiosi, molto attenti. Mi hanno invitato al Gleno per parlare de “La Bamba” e di “Tiradritto- STOP cocaina”. Molti detenuti avevano letto il libro, e chi non lo ha letto mi ha promesso che lo avrebbe fatto presto. Fa piacere a ogni scrittore. È ancora più bello quando negli occhi delle persone scorgi la sincerità, il piacere generato dall’incontro, dallo scambio di conoscenza. E quella roba lì, non puoi spiegarla, devi viverla. Per me lo è stato. I detenuti del Gleno mi hanno stupito per passione, attenzione, curiosità: per la voglia di sentire i racconti e di raccontare. Ture, Ermanno che conoscevo e ci siamo abbracciati, Gigi che ha iniziato con le canne a 11 anni e con la coca si è spappolato il cervello, e poi quello che si chiama come un ex leader politico padano, e poi il giovane “peruviano” e poi tutti gli altri. Due ore filate via così e potevano essere anche il doppio e non ci saremmo stancati di ascoltarci. È così quando gli incontri hanno dentro un’alchimia speciale. La potenza della reciprocità. La magia dei diversi che si sovrappongono. Storie di coca e di gente che non ha tiratodritto. Storie italiane e storie sudamericane. Con me c’era Angelo Langè, poliziotto antidroga attore graffittaro e testimonial Tiradritto. C’erano i volontari, gli psico- logi, gli agenti di custodia, un magistrato di sorveglianza. C’era, soprattutto, tanta energia. Il desiderio dello scambio e della crescita. La forza indicibile e inenarrabile della seconda chance. Sbagli ma ti puoi rifare. La ripartenza, la rinascita passano anche attraverso il sapere, attraverso la conoscenza, la lettura, la scrittura (oh “peruviano”: aspetto di leggere le tue storie!). Che cos’è TiraDritto, mi chiedono? Occupiamo i fortini dello spaccio, andiamo sotto casa dei signori della droga e gliela facciamo sotto il naso: parliamo di coca dove la coca viene venduta. Per restituire quegli angoli di città alla legalità, alla gente per bene. Abbiamo la presunzione di fare da motore, vogliamo accendere la miccia di una rivoluzione culturale: tiratedritto!, la coca fa schifo, è una merda. Ti guardano stupiti, sembrano ammirati. Quegli sguardi sono magici, ti danno forza e coraggio a andare avanti più convinto di prima. Grazie. A presto. Promesso. ••• SHARK 4 giugno, giornata contro le droghe. Ho letto il tuo commento ed è sempre un piacere sapere che là fuori ci sono persone come te che combattono per dare un’altra possibilità. Io sono quel ragazzo che ti ha chiesto se il tuo libro non poteva essere una lama a doppio taglio: informare la gente, ma anche invogliare a entrare nel redditizio mercato della cocaina. Mi ero fatta questa domanda senza guardarti negli occhi e senza ascoltare. Bene, oggi penso che un libro debba essere letto con intelligenza e se passa il messaggio che 300 chili di cocaina arrivano dall'America a Corso Milano, ci sta perché è la realtà dei fatti. È giusto che esistano persone come te che danno queste informazioni e chissà che in futuro i controlli marini non diventino più efficaci per eliminare questa piaga sociale che fa più di 22 mila vittime l’anno. Sei un grande. Tra l’altro devo dirti che un giorno prima che tu arrivassi, gli agenti della polizia penitenziaria avevano trovato qui in carcere 50 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina, come riportato dall’Eco di Bergamo, quasi un segno della Divina Provvidenza, come dire: sta arrivando Paolo Berizzi, facciamo pulizia. Spero tu possa, oltre che nei fortini, portare il tuo messaggio nelle scuole, a quei giovani che cominciano tutto per gioco e finiscono per rovinarsi la vita. Nel mio passato ho iniziato come consumatore e piano piano è diventato un abuso continuo. Ho fatto nel mio passato qual- 2 Pagina 4 ALTEREGO cosa che pensavo fosse felicità, mentre oggi sono consapevole di aver solo distrutto. Oggi guardo avanti e Tiro dritto, non per riconquistare il mio passato, ma per ottenere il mio futuro e questo grazie anche a persone come te che oltrepassano queste mura per portarci messaggi importanti. Mi ha fatto molto piacere conoscerti e leggere il tuo libro. Sei in gamba. Questa mattina leggevo la fine di un libro che, grazie a Catia e ai suoi consigli non ho mollato e continuato a leggere con più interesse, e mi ha colpito una frase: «Oggi provo invidia per quel mendicante, tu puoi alimentarti ancora dell'elemosina di ieri, ma io non più della mia felicità di ieri». Spero di rivederti presto, perché le persone come te non possono che irrobustire il nostro carattere. dalla solitudine che il detenuto può trovare alla sua uscita dopo aver scontato la pena. Nel ringraziarti per l'attenzione che sono certo porrai ai nostri problemi, noi continueremo ad usare le occasioni che incontri con persone come te ci offrono per maturare il nostro cambiamento, con l’assunzione di responsabilità del nostro vissuto, dalla volontà di adesione a quel percorso di reinserimento che nell'accettazione delle regole ci porti a diventare soggetti attivi per la costruzione di un mondo migliore. Ancora grazie e spero di avere la possibilità di incontrarti di nuovo o leggerti in nuove pagine del tuo lavoro. TIRA DRITTO. ••• SOFIA ent.ma Dott.ssa Chiaretta Aldeni, sono l’autrice di uno dei brani che avete letto a teatro in carcere in occasione della riflessione: Violenza sulle donne. Ho ascoltato ogni parola del suo discorso e vi ho trovato tanta verità in tutto ciò che ha detto. Io non la conosco se non per averla vista e ascoltata a teatro e lei, ovviamente, non conosce me, ma mi è piaciuta perché ho capito che capisce e comprende a fondo il problema delle violenze sulle donne e i meccanismi che scattano nell’uomo che usa violenza. Sento la necessità di confidarmi con lei e spero che abbia voglia di spendere un po’ del suo tempo per leggere ciò che ho da dirle. Nel mio racconto sulla violenza subita, non sono scesa in particolari cruenti o dettagliati per scrivere ciò che ho subito, ma sono certa che lei conosce bene quali siano i veri e reali risvolti di certe situazioni. Durante il suo discorso ha fatto delle domande importanti, chiedendoci se sapevamo il motivo per cui una donna talvolta non va al Pronto Soccorso e il motivo per cui non se ne va da casa, lontana dal mostro con cui vive. G.B. L a lettura di queste tue riflessioni, oltre a gratificarci per il nostro impegno, ha confermato l'attenzione, non solo di maniera, che tu hai posto nei nostri confronti. Scusa se ti do del tu, io sono quello con il cognome dell’ex-leader padano, ma mi viene naturale, perché al di là della “purtroppo” maggior vita vissuta, mi sento in sintonia con le tue affermazioni e il tuo impegno. Io non ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti, ma ho sempre temuto per le mie figlie e “per fortuna”, ora che hanno ampiamente superato la maggiore età, penso di averla scampata. Perché dico “per fortuna”, perché sono convinto che anche se la famiglia è di fermi principi e segue i figli nel loro percorso educativo, molte sono le occasioni che possono intervenire e attrarre verso il proibito un adolescente, a volte anche solo per sentirsi parte di un gruppo e non lo sfigato di turno, senza rendersi conto che così è lui che diventa “conformista”. Non adeguarsi al comportamento “figo” ma avere il coraggio di avere idee e difenderle, sapendo che nulla ci viene dato gratis, ma la vita ci chiede sempre qualcosa di noi in cambio. Nel ringraziarti per quanto hai detto nell’incontro e hai espresso nella tua nota, ringrazio anche l’esuberante Angelo per la sua testimonianza. Non sono ringraziamenti formali, ma un vero grazie, perché persone come te e Angelo ci offrono occasioni per riflettere e aderire a percorsi di cambiamento tra le poche opportunità che il carcere offre alla rieducazione e al reinserimento. Purtroppo il carcere come rieducazione funziona a marcia bassissima, sia per la struttura, sia per una mentalità che spinge all’espiazione della pena (cosa giusta), ma fuori dal contesto sociale. Lo stesso carcere è costruito fuori dalla città, quasi che la gente non debba vedere e sapere. Invece è importante che del carcerato ci si occupi per non lasciarlo solo dopo che ha espiato la pena: perché se esce senza disponibilità economiche, senza riferimenti, senza lavoro, cosa potrà fare se non tornare a delinquere solo per sopravvivere? Ecco perché il lavoro dei volontari, l’attenzione che persone come te accendono nella società verso il problema del reinserimento, possono riuscire a innescare collaborazioni tra l’area educativa del carcere, le istituzioni, le associazioni di volontariato, perché si crei una rete protettiva dal rigetto, dal vuoto, ••• G Le risposte sono le più ovvie e le più semplici ma sono la pura verità. Io queste domande, anche se rivoltemi in tono d’accusa, le ho sentite durante le fasi del mio processo. Credevo di essere capita e compresa, perché sia il giudice delle indagini preliminari che quello che ha presieduto il processo vero e proprio, era donna. Invece come accade alla maggior parte delle donne che subiscono violenza non è stato così. Prima è stato convalidato il mio arresto e successivamente sono stata condannata a trent’anni di reclusione. Io so che il mio unico delitto davvero commesso è stato quello di affidarmi a delle persone alle quali avevo chiesto protezione che speravo potessero affrontare mio marito con pari virilità per far sì che smettesse di maltrattarmi e di fare del male a me e alla mia famiglia. Ma qualcosa è andato nel verso sbagliato e mio marito è morto. Per i giudici io risulto essere la mandante di questo omicidio non per fare cessare le violenze, ma per motivi economici, in realtà io non avevo alcun bisogno economico. Nella trascrizione delle motivazioni della mia condanna, un giudice donna ha sminuito gli atti di violenza di mio marito, facendoli apparire gesti di poco conto. Il ritratto finale di quell’uomo che ha causato il mio malessere fisico e psicologico per tanto NUMERO 15 tempo è quello di una brava persona che non ha fatto chissà che perché in realtà mi amava e questo lo hanno dedotto da una lettera ritrovata in un cassetto in cui lui mi chiedeva perdono per il male che mi aveva fatto e per le volte in cui non si era comportato bene. Ma il giudice ha finto di non leggere questa confessione. Ha tenuto in considerazione solo la parola “Ti amo” scritta in fondo alla lettera. Spesso sono andata dai Carabinieri e dopo parecchie loro insistenze l’ho denunciato. La sua domanda a teatro in carcere è stata “Perché le donne fanno fatica a denunciare?”. La risposta è: per paura, perché poi l’uomo in questione si comporterà ancora peggio. Io la denuncia l’ho fatta e il giudice ha trovato il modo di girarmi contro anche quest’azione, dicendomi che: se l’avevo denunciato senza timore, senza poi andarmene da casa, allora significava che lui non era poi così cattivo! Non le sto confidando queste cose pensando che lei possa cambiare la mia posizione giuridica, so che è impossibile, ma le sto scrivendo queste testimonianze perché voglio che si sappia quanto sia difficile per una donna reagire, trovare appoggi e sostegni. Sono davvero felice del progetto che state realizzando per le donne, di questa ‘rete’ che state creando per dare un aiuto concreto alle donne in difficoltà, per permettere loro di trovare appoggi su ogni fronte. La mia colpa è quella di non essere mai andata al Pronto Soccorso, perché avevo vergogna, perché non volevo che la gente sapesse e quindi il giudice ha affermato che io non avevo subito delle lesioni così gravi, senza soffermarsi a pensare che certe volte c’è molto altro oltre a delle lesioni fisiche. La mia colpa è stata quella di non essermene andata da casa perché non avrei saputo dove andare e non essermi tenuta un lavoro serio con cui mantenermi. Lui non voleva che io lavorassi in modo che dipendessi da lui. La mia colpa è stata quella di non essermi rivolta ad amici e parenti perché lui aveva fatto in modo che intorno a me ci fosse il deserto. La mia colpa è stata quella di averlo denunciato una sola volta perché speravo sempre che lui cambiasse e magari quella sarebbe stata l’ultima volta. La mia colpa è stata quella di aver sempre mostrato il mio vero carattere di fronte a chiunque passando in questo modo per la cattiva, mentre lui era quello buono perché non si rivelava mai di fronte a nessuno per mostrarsi per quello che era, ma si nascondeva dietro una facciata di comodo. Queste sono le mie vere colpe, quelle che sto pagando con una condanna a mio avviso sproporzionata. Forse avrei dovuto agire diversamente, avrei dovuto continuare a subire sino a quando sarebbe stato troppo tardi e non sarei stata qui e al mio posto ci sarebbe stato lui. Ma lui non avrebbe pagato delle colpe ingiuste, avrebbe pagato per tutto il male che mi aveva fatto. Sono molte le persone che come lei si battono e si dedicano al progetto di protezione delle donne maltrattate e io vi ammiro. Ma la mia esperienza mi ha portata a considerare che la solidarietà femminile non esiste quando l’obiettivo è fare carriera. Ma come può essere questo un buon esempio per tutte quelle donne che si trovano in certe condizioni? Quale messaggio trasmettono donne come il giudice che mi ha condannata? Non ho ricevuto un minimo di comprensione da Pagina 5 donne che dovrebbero tutelare il bene e condannare il male. Ora come ora ho solo la certezza che ci vorrebbero più persone come lei, con la sua apertura mentale, con la sua capacità di capire anche ciò che non viene detto, con dei messaggi positivi da trasmettere. Grazie per avermi ascoltata. ••• CHIARETTA ALDENI arissima Sofia, la tua lettera mi ha portato gioia e commozione insieme. Intanto grazie per avermi regalato un pezzetto della tua vita, è prezioso. Lo conserverò con la cura e l'attenzione che è giusto dare alle cose di valore. Quel giorno in teatro ti ho vista piangere, penso fossi tu, ma se anche così non fosse il pianto di quella donna smarrita poteva essere il tuo, il mio, di qualunque altra donna ferita nell’anima, prima ancora che nel corpo. E sono proprio queste ferite che non sono visibili allo sguardo, a volte distaccato o semplicemente distratto, o peggio ancora giudicante, della maggior parte delle persone. È molto facile, quasi istintivo, pensare e dire “ cosa aspetta quella donna ad andarsene?”. Ma un vecchio detto indiano recita: “prima di giudicare qualcuno cammina tre lune nei suoi mocassini". Ce ne dimentichiamo. Dobbiamo avere occhi diversi per vedere, sospendere il giudizio e aprire il cuore per comprendere. Ma ancora non basta. Bisogna impegnarsi a conoscere, coltivare il coraggio e tenere la speranza accesa. Forse tutto questo è davvero tanto, per la maggior parte delle persone troppo. E le persone fanno di lavoro il panettiere, la commessa, l'insegnante, l'operaio, il dirigente, il cassintegrato, la psicologa e anche il magistrato. E molto altro. Il sapere non sempre va di pari passo con il saper fare e ancora viene confuso con il saper essere. Nel nostro percorso di vita, affettivo o giudiziario che sia, incontriamo delle persone verso le quali nutriamo aspettative. A volte solo per la loro appartenenza a un genere. Ci aspettiamo protezione da un uomo, comprensione da una donna, tenerezza da una madre, sostegno e forza da un padre. C Ma sono “solo” persone, come te e come me, con tutto quello che questo comporta. Non sei sola. Anch’io, con le persone che incontro a volte fatico quando parlo di violenza di genere. Parlare di violenza in generale sembra più facile, ci trova tutti più d'accordo. Non è semplice nemmeno con le persone che mi vogliono bene e che vedono i miei sforzi e le mie fatiche nel tentativo di scalfire questa nostra cultura del potere e della prevaricazione. Perché di questo si tratta. Si tratta di rivendicare il diritto a essere meravigliosamente imperfetta e per questo amata. Di essere donna, semplicemente. Di essere libera di non nascondere sotto il burka l’oro della femminilità. Oggi mi sento molto onorata di essere stata scelta da te come destinataria del tuo raccontare. Voglio che tu sappia che è proprio nelle persone come te che io trovo la forza di continuare a fare il mio mestiere, è nei racconti delle vicissitudini dell’anima che scorgo il senso di ciò che ogni giorno scelgo di fare. Cara Sofia, ti auguro di avere la forza di continuare l'incredibile lavoro che stai facendo su di te e di trovare infine il modo per trasformare la tua ferita in un ricamo. Ti abbraccio forte. Pagina 6 ALTEREGO Scrittore finalista del Premio Bergamo 2013 In risposta alle pagine di Alterego n. 14 P reziosa Adriana – come non concordare con Giordano, liceale dallo sguardo limpido? – ringrazio tutti voi per questo numero di Alterego. Essendo umano, mi ha fatto piacere leggere quel che avete scritto di me, ma vi sono grato ancor di più e soprattutto per le belle e intense pagine sulle cicatrici. Le ho ammirate da scrittore, ma, ed è più importante, mi hanno molto colpito in quanto uomo. Maturare è un processo lento e laborioso, che non si dovrebbe interrompere mai: voi della redazione di Alterego, con l’aiuto di ottime maestre, state riuscendo a trasformare un luogo di pena in tutti i sensi - il carcere - nel “pezzetto di cielo” di un vostro possibile riscatto. Riscatto vostro, interiore, umano ancor prima che sociale. E questo è importante. Le parole, la capacità di organizzare le nostre emozioni in pensieri, e dare forma esatta ai pensieri nelle parole di un discorso: questo è il primo passo fondamentale e necessario al formarsi di una consapevole coscienza. Non è detto che sia un bene nel senso più superficiale del termine: spesso, una coscienza vigile ci fa soffrire di più, ci rivela più chiari le ingiustizie e i dolori del mondo. Ma, ciononostante, è un bene. Lo si capisce nel tempo, con gli anni: ci tempra dentro, ci dà la forza per saper giudicare noi stessi più severamente di come giudichiamo gli altri. Ci aiuta ad essere tolleranti quando occorre, e severi quando è necessario. Ci aiuta a non barare in quei momenti difficili in cui bisogna scegliere fra il giusto e il facile. In “Umiliati e offesi” Dostoevskij fa dire al cinico principe Valdoskij: “Se potesse accadere – ma la natura non lo permetterebbe mai – che ognuno di noi descrivesse tutto sé stesso, e lo facesse in modo tale, da esporre non solo quello che non osa dire ai migliori amici, ma anche quello che non osa, a volte, confessare a sé stesso, salirebbe dal mondo un fetore tale che soffocheremmo tutti”. Per questo, aggiunge, sono tanto buone le nostre convenzioni sociali, visto che “la moralità è stata inventata soltanto per comodità”. Per tutta la vita, di romanzo in romanzo, Dostoevskij ora diede ragione ora torto a questo suo personaggio, incerto sulla risposta all’eterna domanda: l’uomo è buono o cattivo? è angelo, per quanto caduto, o dèmone, seppur umiliato? Ma l’uomo è uomo. E non esistono assoluti di bene o male per questa folla concitata che sulla superficie della Terra si ama e si odia, si perde e si salva. Tuttavia lo scrittore Dostoevskij aiuta l’uomo Dostoevskij a maturare luminosamente. Nel suo prodigioso ultimo romanzo la domanda – immensa ingenua e senza risposta – è superata nei fatti. Nel funerale del bambino che chiude il libro, fra gli assurdi miseri e perciò tanto più veri rimproveri che si scambiano i genitori, Aliosca prende la parola, e si rivolge ai giovani compagni di scuola del piccolo morto: “Ricordate sempre quell’attimo quando piangeste. Questo vi resterà per tutta la vita. Forse non crederete neppure più, e il vostro cuore si sarà indurito, ma tuttavia ricorderete sempre quell’attimo di lacrime pure, di attimi simili non ce ne sono molti, ma ci salvano, ci salvano sempre. Anche se arriverete a ridere di tutto, di quelle non riderete mai. E se anche ne riderete, vi direte comunque dentro al cuore: no, ho fatto male a ridere, non si deve ridere di questo...” Dopo aver passato gran parte della vita a dar ragione al cinico Valdoskij, Dostoevskij gli diede scacco nell’ultimo e più bello dei suoi romanzi. Insomma, grazie davvero, e arrivederci a presto – sicuramente a settembre, ci conto! Un caro saluto a tutti voi. NUMERO 15 G.B. V enerdì 14 giugno si è chiuso ufficialmente l'anno scolastico della Casa Circondariale di Bergamo con uno spettacolo teatrale offerto dalla compagnia Brincadera intitolato “El viejo mundo”. Si è trattato di un teatro concerto di alta qualità sia rappresentativa che musicale a cui non tutta la platea era preparata. Lo spettacolo era una raccolta di testi, poesie, racconti, filastrocche di poeti e scrittori sudamericani e con una perla della nostra Alda Merini (L'anima innamorata) che si incastonavano tra loro in un rincorrersi di atmosfere sottolineate dalle musiche tipiche di quei paesi, come la bosa nova, la cumbia, il tango, la pancada. Tutte le parole, le note, i gesti, ogni elemento scenico ruotava attorno al rapporto con la morte, ora in modo divertito, ora in modo grottesco, ma sottolineando quell’ineludibile incontro che ci attende. Nell'incrocio delle storie un vecchio gioca con un bimbo a creare bolle di sapone e a sparare alla luna; un uomo gioca con il suo pupazzo, un ossuto, piccolo scheletro con cui vive momenti di gioia e dolore; una donna canta e legge creando personaggi cambiando trucco e abbigliamento e poi, sulla scena come narratori, rimangono i tre musicisti che rappresentano loro stessi nella diversità di emozioni create dalla musica: dalla malinconia alla gioia con la capacità di coinvolgere, riportando a momenti di nostalgia. Tutto lo spettacolo è un percorso sul filo dell'equilibrio della morte come spartiacque fra la nell'abisso e la danza con le gioie della vita vissuta o da vivere. Unico suggerimento: forse, la traduzione in italiano su un libretto dei testi recitati avrebbe favorito l'attenzione e la comprensione dello spettacolo. Pagina 7 SHARK l giorno 14 giugno si è svolto nella sala teatro dell'istituto la festa di fine anno scolastico e mi sono trovato a guardare uno spettacolo che divideva il mondo in due: i pirati dei caraibi da una parte e un gruppo hawaiano dall'altro. Hanno cantato e ci hanno divertito. All'entrata del teatro sono rimasto stranito nel vedere una donna così brava a rimanere immobile in posa che ci ho messo un po' prima di realizzare che fosse di carne e ossa. Il gruppo si chiama Brincadera che significa scherzo. Per noi nulla è stato uno scherzo, ma anzi un qualcosa organizzato per noi e fortemente condiviso dall'amministrazione penitenziaria. L'interesse elevato dei partecipanti ha permesso agli organizzatori e tecnici di affrontare lo spettacolo con entusiasmo e grande spirito teatrale e sottolineo anche un grande impegno da parte degli agenti di polizia. Infine la sorpresa è stata trovare come ospite l'onorevole Laura Coccia che ci ha comunicato di aver presentato un disegno di legge per lo sport all'interno degli istituti penitenziari. È un elemento trattamentale di grande interesse. Spesso nelle carceri lo sport si svolge in forma generalizzata come attività collettiva di sfogo al fine di creare un clima il più possibile tranquillo. Mi auguro con tutto il cuore che vengano organizzati e realizzati corsi di formazione sportiva, perché lo sport ci insegna a rispettare quelle regole che sono fondamentali nella relazione con lo staff carcerario, polizia penitenziaria, in particolare, ma anche tra i detenuti. Nell'educazione allo sport si ottiene anche l'educazione all'igiene personale e ambientale. Il detenuto deve ricordarsi di “vivere”, curando tutti giorni la propria immagine per sé e per gli altri, soprattutto nell'ora d'aria, a scuola, per chi ha I Pagina 8 scelto di prendere un diploma e ha avuto la fortuna di essere stato inserito nei corsi scolastici per la licenza elementare, media e superiore. Lo spazio più sottoposto alle regole comunitarie è quello previsto per l'ora d'aria, quindi anche durante le attività sportive. In questi luoghi ho potuto percepire negli anni un conformismo generale nei comportamenti, dove tutti fanno le stesse cose, come ad esempio il passeggio, tutti in un senso, vista la ristrettezza degli spazi. Alla base di questa uniformità di atteggiamenti stanno proprio le regole comunitarie diventate vere e proprie norme di rispetto. Ecco che lo sport organizzato che segue un programma semplice ma ben studiato, potrebbe essere un momento di comunità e, perché no?, di formazione e lavoro, perché dopo un’adeguata preparazione sportiva, anche gli stessi detenuti potrebbero diventare insegnanti. La formazione sportiva potrebbe rappresentare certamente un passo avanti di enorme emancipazione sociale, culturale e comunitaria: il nostro preparatore, dopo un vero e proprio studio e approfondimento (corsi formativi) con l'operatore sportivo specializzato, sarà in grado di stilare un programma generalizzato e periodico che con il tempo potrebbe diventare sempre più mirato e specifico. L'idea che il neo-preparatore possa trasferire la propria esperienza sportiva e professionalità, ai compagni d'area è certamente un importante segno di rieducazione, di generosità e di reinserimento sociale. Mi auguro con tutto il cuore che l’onorevole Coccia possa portare avanti questo disegno di legge, perché lo sport porta con sé luce e benessere. In un articolo precedente avevo scritto che non esiste Costituzione in alcun paese del mondo che non preveda che della libertà si possa essere privati: per ragioni serie previste dalla legge e con la garanzia che i propri diritti siano rispettati, la libertà può essere tolta. Ma nessun uomo per nessuna Costituzione in un qualsiasi paese può prevedere che una donna o un uomo possa essere privato della propria dignità e questo è il cuore della questione dei diritti umani da cui tutti i passi successivi dipendono: alzare una barriera a difesa della dignità della persona anche del peggiore assassino! E questo è il senso del Rapporto dei diritti umani nelle prigioni italiane ad opera della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Secondo gli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura che opera presso il Consiglio d'Europa dei diritti umani, ogni detenuto deve avere a disposizione quattro metri quadrati in una cella singola. Se ne ha a disposizione meno di tre metri quadrati, si è in presenza di tortura ed è per questo che un detenuto anziano o giovane e di qualsiasi razza, ha il diritto di muoversi oltre la cella. Il problema del sovraffollamento non è solo una questione di mancanza di spazio a disposizione del detenuto, ma è profondamente legato all'impossibilità di fare della carcerazione l'inizio del percorso di rieducazione e di riabilitazione sociale previsto dall'articolo 27 della Costituzione Italiana. Mi auguro arrivi questo mio messaggio a tutte quelle persone che credono che si possa cadere ma anche rialzarsi e affrontare la vita ponendosi degli obiettivi. A volte non riusciamo a portarli a termine, ma non importa, se abbiamo la forza di ricominciare e di credere in noi stessi, tutto cambia. Mollare è da tutti, ricominciare è per pochi ed è proprio mentre ci rial- ALTEREGO ziamo, che capiamo che siamo sempre più forti e stiamo iniziando qualcosa di nuovo, un viaggio verso un obiettivo migliore. Grazie ai brincaderas che ci hanno regalato una ventata di felicità. ••• ANTONIO PELUSO arissima Onorevole Coccia, Le scrivo dopo aver ascoltato il discorso che ci ha tenuto nel teatro della Casa Circondariale di Bergamo. Devo dire che ne ho sentite poche di parole così profonde e toccanti come quelle che Lei ci ha regalato venerdì scorso e mi sono entrate nel cuore senza che potessi farci nulla. Capisco quanto sia importante lo sport e la sua filosofia e proprio per questo ho deciso di scrivere un ringraziamento con la speranza che possa esserci una seconda volta per Lei qui da noi. Anche io ho avuto un professore di fisica stupendo, anzi a pensarci adesso mi pare che sia stato una sorta di ‘angelo’ per quanto era buono: usava il cuore. Prima di rovinarmi la vita e finire in galera, ho praticato tutti gli sport fino a livello agonistico per esempio con il Kung-Fu e proprio per via delle sue parole mi sono ricordato quanto contasse in quella disciplina il rispetto, la complicità, la sintonia con i compagni e il divertimento comune. Ho capito le sue parole perché questo è tutto quello che io stesso ho provato davvero. Ogni volta che sbagliavo, o cadevo come lei ha raccontato, anche io poi mi sentivo più forte ed è così che mi sono conquistato il soprannome di Tigre. Io voglio ringraziarla perché nei pochi minuti che ci ha parlato, mi ha dato forza e coraggio. Per fortuna che esistono persone come Lei che per prima cosa pensano a come aiutare gli altri. Vorrei dirle che le sue parole sono state ben spese, perché mi darò più forza per regalarla a chi ne ha bisogno. Le faccio i miei auguri per tutto il suo lavoro e non solo e Le mando i saluti più sentiti da uno sportivo come Lei. C ••• FEDERICO INVERNIZZI Mens sana in corpore sano Questo articolo è dedicato a tutte quelle persone che credono che nello sport si possa cambiare. Nella mia vita ho sempre amato lo sport e la gioventù mi ha portato tramite il campo Coni a conoscere varie discipline dalla pallacanestro alla pallavolo, al calcio. Poi strada facendo, grazie ad alcune amicizie mi sono iscritto all’età di 11 anni all’Harley Club Promolinea di Como dove ho giocato per un anno e poi per questioni economiche ho dovuto lasciare. Credo che, se a quell’epoca, i costi di quello sport fossero stati più accessibili, forse oggi non sarei qui in –carcere a scrivere questo articolo. Perché è lì, da quell’abbandono, che è cominciato il mio declino. Lo sport è qualcosa che hai dentro e ora che mi trovo in carcere ho avuto il tempo di conoscere una persona fantastica che mi ha buttato nella mischia. Il vero problema è trovare qualcuno che ci faccia riscoprire la passione per lo sport che è andata perduta. In questi ultimi anni nelle patrie galere, oltre a praticare lo sport ho studiato molto e in particolare quegli sport di NUMERO 15 gruppo che danno benessere grazie allo stare insieme, raggiungendo un forte equilibrio sia sul piano fisico che mentale. Ci sono sport che non necessitano di tante risorse economiche come il Sano Bas, un morbido cuscino che ben sigillato in un sacco diventa un incredibile attrezzo funzionale che coinvolge gruppi muscolari stabilizzatori su diversi piani di movimento. Il TRX, un attrezzo estremamente versatile adatto per l’allenamento e il recupero funzionale: è costruito con elastici a bande che, grazie ai principi della fisica, permette di eseguire diversi esercizi e di regolare l’intensità per adattare lo sforzo alle esigenze di ogni soggetto, quindi allenamento in sospensione. Il TAC FIT un insieme di 26 programmi dall’Alpha alla Zeta: ciascun programma di allenamento dura 20 minuti nei quali si riesce a bruciare grassi per l’equivalente di 4 ore di movimento. Ma ciò che più mi ha colpito è il mondo del CROSSFIT e mi ci sono buttato dentro sia in pratica che in studio. Il crossfit è un allenamento che sottolinea esercizi funzionali che non sono altro che tutti quei movimenti che usiamo durante il giorno, come per esempio raccogliere una mela, o portare un sacco della spesa. Questo programma fornisce una fitness che per sua progettazione è ampia, generale e include ogni possibile attività fisica. Il crossfit è progettato per essere modulato e adattato in modo da renderlo di perfetta applicazione per ogni individuo che voglia essere iniziato a questo sport a prescindere dalla sua esperienza. Il suo codice comprende tre elementi: movimento funzionale, intensità, variabilità. Questo codice fornisce una fitness sia per gli anziani che per gli atleti professionisti. L’unica differenza sta nell’uso dei carichi e nell’intensità che deve essere modulata e adattata al singolo individuo. In questi anni di carcere ho constatato che a molte persone piace fare sport di gruppo perché è proprio stando insieme che si ride, si scherza e si cancellano quei pensieri negativi suscitati da quattro mura. Avere una persona sportiva specializzata che insegna i movimenti corretti, che sprona ciascuno a fare attività fisica in un carcere è di estrema importanza. Spesso si notano persone con cifosi, lordosi o scoliosi che dipendono dalla sedentarietà. Possono anche scoppiare contrasti tra noi detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria con i quali siamo più in contatto rispetto ad altri operatori e il loro compito consiste nel far rispettare il regolamento penitenziario e prevenire l’insorgere dei conflitti tra noi detenuti. La possibilità di praticare attività sportive per esempio gruppi di crossfit, partite e tornei di calcetto, pallavolo maschile e femminile contro gli agenti di polizia penitenziaria permetterebbero certo di gestire meglio il rapporto conflittuale che si crea inevitabilmente tra le parti avverse. L’attività fisica è uno strumento per contenere, disciplinare l’aggressività. L’aggressività è un problema che appartiene a buona parte della popolazione detenuta. Uno sport organizzato elimina i pensieri delinquenziali, fornendo incentivi per un comportamento migliore. Molte volte lo sport viene praticato in carcere con esasperazione e così scatta la competizione che non crea benefici sul piano del comportamento umano. Pagina 9 Praticare uno sport in carcere ha una rilevanza sociale: potrebbe anche essere un modo per avviare una comunicazione tra mondo esterno e recluso, tra le persone che vivono aldilà del muro di cinta e quelle che fissano quel muro con la voglia di vivere oltre. Il sogno del recluso è proprio quello di uscire oltre il muro anche solo con il pensiero facendo una qualche attività sportiva: partite di campionato, i games come vengono chiamati nel crossfit, stage formativi brevi. Le parole di un amico sottolineano bene questa volontà: “Cerchiamo lo sport come cerchiamo l’aria”. Il diritto allo sport nelle carceri potrebbe tradursi in molteplici modalità: presenza di istruttori, partite amichevoli tra detenuti e squadre interne ed esterne con tornei, campionati all’interno del carcere. Certo mi rendo conto di come non sia sempre facile organizzare questi eventi. L’amministrazione penitenziaria prevede, infatti, delle situazioni di controllo che pongono grossi problemi di organizzazione allungando, ad esempio, i tempi per le verifiche delle incompatibilità tra le persone detenute – i cosiddetti divieti di incontro. Diventa difficile realizzare tornei tra detenuti che stanno in sezioni diverse o addirittura in istituti diversi. La situazione più complicata riguarda la ‘trasferta’, ossia la possibilità di ‘usare’ il detenuto per una partita oltre le mura. In linea di principio le amministrazioni sono favorevoli a promuovere queste attività, ma basta un agente non disponibile perché venga fatta saltare l’uscita. D’importanza cruciale diventa il Magistrato di sorveglianza che riceve dalla Direzione la lista dei detenuti che in termini di legge possono oltrepassare il muro. La presenza dell’istruttore di sport è utile ai detenuti non solo per far loro passare il tempo, ma per permettere loro di sfogarsi. Noi detenuti abbiamo bisogno di parlare con una persona che sta lì ad ascoltare i nostri guai. Mi auguro che questo scritto non diventi solo qualcosa da leggere, ma si faccia punto di partenza per quanti credono che si possa rendere il mondo migliore. Questi anni passati in carcere mi hanno insegnato molto, ma una cosa sopra tutte le altre: aiutare chi vive in situazioni difficili è l’unica via per diventare migliori. Una volta fuori da qui vorrei lavorare nel mondo sociale per mostrare come sia possibile ripensare agli sbagli compiuti, trasformare l’errore commesso in nuovo ripensamento e quindi possibilità. Vorrei farlo per chi, come me, ha sbagliato, ma può ricominciare a vivere la sua vita anche con poco. Perché la vita va vissuta fuori dal carcere. Pagina 10 ALTEREGO SHARK l 7 maggio abbiamo visto tutti un film Freedom Writers con un messaggio molto chiaro: la rieducazione. Una professoressa, Erin Gruwell, viene assegnata a un liceo di Long Beach, una zona di disagio dove le persone si uccidono perché appartengono a bande rivali. Lei con passione riesce, tramite la lettura del Diario di Anna Frank a far conoscere altre sofferenze. La lettura genera un forte cambiamento nei ragazzi. Mi ha colpito quando la professoressa che chiede ai suoi alunni di raccontare la loro vita attraverso un quaderno. È il primo episodio di comunicazione. La comunicazione non è da sottovalutare, soprattutto quando le persone vivono in condizioni di disagio. Parlo per esperienza personale. Stare in un carcere, come in un ghetto diventa solo una separazione, un isolamento. I luoghi difficili modificano con violenza le esperienze, le relazioni essenziali di ogni vita umana: la sessualità, la realtà familiare, il rapporto con l’ambiente naturale. Tutto questo costituisce la nostra esistenza. Ciascuno di noi è a partire da ciò che gli accade. Non possiamo nasconderci che i luoghi di disagio come un carcere o un ghetto curvano coattivamente e deformano la vita, la spezzano per tempi anche lunghi. Mi è rimasta impressa una frase che il padre dice alla figlia insegnante: “Ti è stato dato un dono che è un peso”. La scuola e lo studio sono molto importanti per chi, come noi, vive da recluso, ma anche per tutte le persone che vivono isolate. Per noi detenuti la figura di un professore o di un operatore creano un legame con l’esterno, coltivando in noi la speranza di ricostruire la nostra esistenza perché qualcuno fuori avrà magari meno paura ad accoglierci al termine della nostra pena. L’insegnante e l’operatore diventano una sorta di ‘luogo mentale’ dove è possibile ripensare alla propria vita in una prospettiva di responsabilità e autocritica. Mi viene in mente una bellissima canzone Uno su mille ce la fa di Gianni Morandi, perché per chi ce l’ha, il dono non è un peso ma una grande vittoria. I ••• G. B. l film propone alla nostra attenzione diversi temi, io prendo in considerazione l’insegnamento che si allaccia all’educazione. Varie insegnanti si preoccupano solo di insegnare le regole, la grammatica, quanto prevede il programma scolastico e valutano gli allievi, senza tenere conto di quanto vivono gli alunni fuori dalle mura scolastiche: le loro condizioni sociali, la loro vita quotidiana. L’insegnante è quell’impiegato che trasmette le nozioni imposte dal programma e che valuta il grado di apprendimento dell’allievo per selezionare i I ‘migliori’ che faranno strada nella società. Non conta se gli allievi partono da differenti blocchi di partenza, con doti e mezzi diversi, non forniti dalla natura ma dal contesto sociale nel quale crescono. L’insegnante protagonista supera il suo ruolo, assumendo quello dell’educatrice: si preoccupa delle condizioni di vita dei suoi allievi e si impone alla loro attenzione stimolando i loro interessi, facendo loro esprimere i loro vissuti, nominare le divisioni tra bande, proponendo dei modelli che in classe riportano quelle regole della civile convivenza che dovrebbero incontrare nella società nella quale vivono che, invece, è razzista e classista. Quale deve essere il ruolo dell’insegnante? O meglio quale ruolo deve avere la scuola: insegnare o educare? La formazione di un uomo si realizza con il concorso di diversi soggetti educativi che intervengono nella sua vita: la famiglia, il nucleo sociale in cui vive e la scuola dove passa buona parte del suo tempo e alla quale viene spesso delegato il processo di formazione del cittadino che si inserisce nei ruoli che la società gli riserva. Ma questi ruoli sono accessibili a tutti? Chi ha buone capacità ma proviene da contesti sociali degradati riesce ad accedere ai più alti ruoli o rimane discriminato? Una società giusta dovrebbe concedere a tutti pari opportunità e la scuola dovrebbe servire alla costruzione di questa società, superando i diversi livelli di discriminazione che sono dati dalle diverse appartenenze sociali: quella differenza che permette al figlio del medico di fare il medico e al figlio del disoccupato, forse di lavorare! Una scuola che educa deve far scoprire a tutti gli allievi il bello del conoscere, dell’approfondire, del capire e del vivere costruendo se stessi, sviluppando le proprie attitudini per costruire con gli altri una società giusta. In una scuola così, l’insegnante diventa un educatore. Nel film l’insegnante, Gruwell, che inizialmente cerca di trasmettere la sua materia, si scontra con il disinteresse della classe fatta dagli ‘ultimi’ che, oltre a essere discriminati nella società, lo sono anche nella scuola. L’insegnante non si adegua a questa consuetudine e s’interessa degli allievi, domanda loro da quale ambiente provengono, quali sono i contrasti che vivono perché di razza diversa. La diversità è appartenenza a un gruppo e difesa dei suoi componenti. Il primo problema che lei deve affrontare è la convivenza fra gli allievi e riesce a superare la prova facendo emergere come gli uomini, anche se diversi, vivono esperienze e dolori che li accomunano. Nel film la splendida scena nella quale ciascuno ricorda gli amici morti nella guerra fra gang nominandoli ad alta voce è il segno di questo cambiamento e la lettura di una pagina di diario da parte di uno studente che non ha mai avuto nome per nessuno così affermando la sua appartenenza alla classe scolastica ne è la certificazione. L’insegnante dà speranza, dimostrando che è possibile farcela non come nelle favole a lieto fine, ma grazie all’esempio che può essere toccato e testimoniato. Infine l’elemento che dà origine al titolo del film: la scrittura, i diari, la lettura di libri sono quegli strumenti che hanno acceso il cambiamento, l’interesse per il proprio riscatto. I diari di tutti diventano un libro che si fa memoria e testimonianza. È nei libri, negli scritti che gli uomini, tassello dopo tassello, depositano la loro storia e dalla conoscenza del passato costruiscono il futuro. NUMERO 15 Pagina 11 Mi sento a casa… G. B. N on è un luogo, non è un posto particolare dove trovo rifugio nei momenti di sconforto, di emergenza quando ho bisogno di ricaricarmi per affrontare il quotidiano. Nella mia mente trova spazio il rifugio, quel momento in cui, anche se in mezzo a una folla urlante, riesco a essere solo, non ascolto ciò che mi circonda, non vedo passare persone, cose, colori ma tutto è sfuocato, immerso in un bicchiere di acqua e anice che rende tutto come avvolto dalla nebbia che nasconde il mondo. In questo chiamarmi fuori dal reale dall’attimo di vita riesco a trovare me stesso e la carica per riaprire gli occhi sul mondo e dire: andiamo avanti. Il rifugio è uno stato mentale che vivo dissociandomi dal presente e che cerca nel cuore quelle risposte, quelle motivazioni necessarie per vincere le paure dalle quali ho cercato riparo. ••• ERMANNO CECCHERINI a quando ho sei anni sono seduto davanti a un pianoforte che mia madre aveva preso a noleggio perché un’insegnante venisse a casa mia a darmi lezioni. Capii subito che la musica sarebbe diventata la mia casa per tutta la vita e diventando più grande iniziai a cantare. A dieci anni stavo sul palco davanti al pubblico. E così per anni prima il pianoforte, poi il palcoscenico e il teatro hanno accompagnato e D segnato la mia vita. Oggi il carcere mi priva di tutto questo, ma molto presto spero di tornare a suonare, soprattutto per me. Questa è la mia prima casa: il pianoforte e la musica, attorniato da persone sintonizzate sulla mia stessa passione. ••• ANTONIO PELUSO difficile dire dove mi sento a casa, specie qua dentro, ma, a dire la verità anche fuori. Io non ho un posto dove mi sento a casa, o meglio mi sento estraneo un po’ da tutte le parti e, a pensarci bene, è triste non avere un ‘castello’ dove sentirsi al sicuro o ritirarsi quando niente va per il verso giusto. Allora ho inventato un posto tutto mio e questo posto non me lo possono togliere perché ovunque vada, qualunque cosa io faccia so che c’è il mio castello. È lì che mi aspetta e questo solo perché è dentro di me. Sì, io mi chiudo in me stesso e lì mi sento davvero a casa come non mi sono mai sentito in un nessun altro posto e ogni volta che ci vado mi sembra sempre più bello! È ••• SHARK Nella nostra vita ci sono dei posti che consideriamo rifugi. Il rifugio può essere quell’angolo della tua stanza, quello della panchina ai giardini, quel muretto sotto casa dove, quando ti ci trovi, dici “Quanto sto bene! Quanto sono a mio agio, quasi quasi mi sento a casa!”. È proprio lì che corri quando devi Pagina 12 ALTEREGO sfuggire dalla realtà che ti circonda, dal mondo del fast, da tutto ciò che ti stressa! Il mio rifugio è sempre stato un muretto sotto casa, quel muretto che ancora oggi se mi dovessi sedere, sentirei come una poltrona nella quale mi accomodo per far vagare i miei pensieri. Quel muretto è sempre stato per me un luogo di meditazione, un posto dove chiacchierare con gli amici. È il luogo dove fin dall’infanzia ci sono sempre stato bene e non mi ha mai dato delusioni. Lì sono sempre stato in pace con me stesso e quando si è in pace, il tempo prende significato. Quando invece si è infelici e a disagio si sente che il tempo dilaga ed è come se la giornata non dovesse mai finire. Quando trovi piacere in quello che fai e dove sei, il tempo passa molto in fretta e vorresti che proprio in quel rifugio la giornata avesse più ore. È importante imparare ad apprezzare tutto ciò si fa, assumere un atteggiamento giusto verso le situazioni. Si riuscirebbe a fare molte più cose e a farle con amore, come ad esempio vivere. Ciao muretto e a presto! ••• STEFANIA COLOMBO l luogo in cui mi sento a casa è quello dove mi sento bene, in pace con me stessa. Questo luogo è una spiaggia al mare, non è un luogo specifico ma si tratta di una qualsiasi spiaggia in un qualsiasi mare. L’unica condizione è che non ci sia nessuno o quasi attorno a me. Prediligo questo luogo fuori dal periodo estivo quando è troppo affollato di turisti oppure la sera quando le spiagge sono comunque deserte. Stare in riva al mare mi dà un senso di serenità, di libertà e di vero e reale contatto con me stessa. Non so nemmeno io definire esattamente a parole come mi sento. So solo che sto bene, sto bene con me stessa e soprattutto in quei luoghi riesco a capirmi e a riflettere su di me con serenità e lucidamente. Il mio desiderio è sempre stato quello di andare a vivere in una località di mare per potermi ritrovare a casa ogni volta che ne sento la necessità. I ••• LINO MARTEMUCCI to pedalando con la mia mountain bike per recarmi al lavoro. C’è un’aria frizzantina che mi colpisce il viso. Ascolto l’Ipod con le canzoni che non ascoltavo da tanto tempo. Mi accorgo che ho la pelle d’oca, forse dovuta a quest’aria frizzantina o all’emozione che provo dentro, sprigionata dalle tante aspettative. I desideri non invecchiano con il passare del tempo, soprattutto dopo quello speso male. In questo momento mi sento a casa pedalando sulla mia bici per le vie della città. S ••• LAURA P. i adatto a tutto perché sono io che faccio diventare casa il luogo nel quale mi trovo. Persino ora che sono in galera ho creato il mio mondo, la mia casa. Almeno finché mi troverò qui, cerco di costruire il mio spazio in modo che sia casa. La cella deve essere una stanza, un monolocale dove convivo con persone estranee che devo imparare a conoscere. M Cerco di vivere i diversi momenti come il pranzo e la cena come una famiglia, come sorelle che condividono la stessa camera da letto all’interno di una grande casa. Se devo pensare a un luogo nel quale sto bene, penso a una spiaggia, al mare. Mi trovo bene anche in campagna in mezzo agli animali, in particolare i cavalli. Non so bene in quale luogo mi sento a casa, perché, come ho detto, mi sento sempre a casa perché sono io che me la creo ovunque sono. ••• SANTINO NARDI o mi sento a casa in un libro che diventa quasi un nascondiglio per me. Il libro è molto democratico: puoi dirgli le parolacce e non ti risponde. Puoi piangergli addosso, puoi prenderlo a calci, picchiarlo pure e lui non reagisce. Puoi leggerlo, non leggerlo, saltare le righe, pure il capitolo e lui tace. Nei momenti di solitudine, o in quelli sentimentalmente negativi un buon libro ti prende per mano e ti porta via. Ti fa vivere un’avventura, non ti fa pensare ad altro che alla storia che racconta. Intanto il tempo passa e non vedi l’ora di sapere come va a finire la storia, o magari ti addormenti e finisci per sognare quello che stavi leggendo. Quando arrivi alla fine ci mediti su. Intanto ne cominci un altro e tutto ricomincia da capo e così il tempo passa. Per curare le ferite, non c’è niente di meglio che il tempo passi. Sì, il mio rifugio è dato dai libri degli altri. I ••• LUCA, studente del liceo M. Gioia di Piacenza a serie di stanze dove mangi, lavi i vestiti e dormi non è sempre il posto dove ti senti a casa, a volte è così, soprattutto da bambini, ma poi arriva un momento in cui capisci che quel luogo è in realtà la casa di qualcun altro e tu hai bisogno della tua. Ti senti a casa quando sei in quel posto che hai scelto tu e dove ci sono quelle persone e quegli oggetti e quei suoni e quegli odori che hai scelto tu, perché ti fanno sentire giusto così senza fingere, senza aggiungere né togliere nulla, casa è dove decidi di essere te stesso in ogni momento. L ••• FRANCESCA, studentessa del Liceo M. Gioia di Piacenza o trovo la mia casa in me stessa, nella mia creatività. Se mi sento a disagio o mi annoio o sono ispirata, in qualunque situazione mi piace riflettere, inventare storie o mille immagini. Mi piace dare loro vita, scrivendo e disegnando. Mi sembra di costruire una finestra nella mia casa per far circolare l’aria. Quella che entra non è buona come quella che è nella mia casa, ma porta novità, odori nuovi, nuove ispirazioni. Mi capita spesso di rifugiarmi nella mia casa, soprattutto quando sono da mio padre, dove dormo male e mi sveglio con il mal di pancia. Mi aiuta e mi protegge, esternando o comunque districando i miei disagi, facendo chiarezza sui miei sentimenti. I ••• NUMERO 15 Pagina 13 GIORGIA studentessa on so se non mi sento a casa da nessuna parte o in generale non voglio sentirmi a casa. Il senso è che io sono per il no casa. N ché il mio livello di consapevolezza era quello che era”. E grazie a te, mamma, guardo oltre e pensando a te mi fortifico… quando si è il peggior nemico di se stessi, essere da soli non basta, serve piuttosto un’altra mano a fermare tutto e questa mano per me sei tu, mamma. ••• ••• RICCARDO, studente Il mio rifugio sono i testi che scrivo, tutti diversi tra loro, alcune volte incompatibili poiché cambiano a seconda delle necessità. In essi descrivo un mondo diverso che in quel momento a me sembra migliore, con rigide regole che lo controllano, dove nulla è lasciato al caso, in cui conosco ogni anfratto che mi dia sicurezza. ••• ANDREA, studente L’unico momento in cui mi sento veramente a casa è quando dormo. Il sonno, secondo me, è la sola occasione che l’uomo ha per isolarsi da tutto, sia dalle persone e dai loro problemi sia da se stesso, da ciò che lo turba e dai suoi pensieri. Il mio eroe SHARK i sono dei momenti nella vita in cui ripensi all’infanzia, in cui pensi a come stavi bene quando non avevi pensieri e responsabilità. Ora quei momenti sono passati e se penso un po’ a tutta la mia vita, il mio vero e unico grande eroe è la mia mamma. Una donna che ha sempre lottato per l’amore verso i propri figli, sacrificandosi in tutto e per tutto. Ha lavorato tanto e nonostante tutto non ci ha mai fatto mancare nulla. Cara mamma, ci hai sempre donato il tuo cuore e le tue carezze. Sì, sei tu il mio eroe, quella persona che mi ha insegnato molto della vita, quella alla quale assomiglio in tutto e per tutto. Sei tu che, quando ripenso al passato, mi fai dire: Io ce la devo fare! Provo ancora dolore per avertene causato tanto, eppure oggi non è più accompagnato da sensi di colpa grazie a questo bagliore di consapevolezza “Ho fatto quello che ho fatto per- C G. B. in da quando ho cominciato a capire, ancora prima che imparassi a leggere e scrivere, mi veniva proposto un modello da seguire in famiglia, all’asilo e più tardi a scuola, all’oratorio, in chiesa. Questo modello era Cristo e io, come buona parte dei miei coetanei, vivevo la mia adesione a questo rito collettivo chiamato religione come qualcosa di ineludibile che era parte di una vita formale che trascinava nella routine quotidiana gesti e atteggiamenti che, ripetuti costantemente, diventavano un vuoto rito che si doveva celebrare per conformarsi al giudizio di chi divideva le persone fra buoni e cattivi cristiani. Le preghiere, il catechismo, la messa domenicale erano il metro di giudizio con il quale veniva misurato il mio grado di appartenenza all’una o all’altra categoria di cristiani, tra i 14 e i 16 anni la ribellione, l’uscita dalle regole, dal conformismo, la voglia di nuovo, di essere protagonista di scegliere il modo di vivere, la voglia di cambiare il mondo. Da qui anche il rifiuto di quella tradizione che per me era la religione, il cristianesimo nelle sue formule da recitare, nei suoi riti, nella sua struttura fatta di paludamenti e cerimonie commemorative dove si ripercorreva la vita di un uomo che serviva a dare un senso a questo chiamarsi cristiani. Di quel periodo erano però anche i dubbi, le domande irrisolte: perché l’uomo deve soffrire? Perché vivere nel dolore se ti aspetta solo la morte, in questa strana commistione di esaltazione e depressione? In certi momenti mi sentivo un leone e in altri meno di niente, mi sentivo impotente e in balia degli eventi e cercavo un’ancora che doveva darmi sicurezze e certezze. Proprio mentre ero in questa fase di ricerca, un amico mi ha fatto scoprire Cristo. Quello che per me era solo un simbolo, una favola o meglio un idolo a cui rivolgersi per ottenere grazie e consolarsi dei dolori che ti affliggevano, ora era un uomo vissuto in un periodo storico ben preciso di cui ci è stata data testimonianza. Molte le testimonianze che storicamente ne percorrono la vita e le gesta, le parole dette. Ecco che mi si presenta un uomo che fa e dice cose così strane per cui il mondo in cui vive lo emargina prima e poi lo toglie di mezzo: lo crocifigge. Ma se le cose che quest’uomo ha fatto e le cose che mi ha detto sono testimoniate allora – mi sono detto – mi trovo davanti a un grand’uomo a cui credere per tutto quello che ha detto, quindi anche che era figlio di Dio e che è risorto, oppure un illusionista che ha ammaliato le folle. Ecco il dubbio. Credere come molti hanno fatto fino a ripercorrere la sua strada e immolarsi per gli altri o rimanere indifferente al suo incontro, alla sua chiamata. La scelta, o meglio il dono di credere, mi ha fatto assumere quale eroe quell’uomo figlio di Dio che ha avuto la forza di caricare su di sé i peccati del mondo fino al più alto atto d’amore con quell’abbraccio della croce a tutti gli uomini. Un uomo, un Dio che non smette mai di perdonare. Nella mia pochezza di uomo fragile ed egoista so che troverò in lui rifugio come il figliol prodigo.STEFANIA COLOMBO F Pagina 14 ALTEREGO L a mia eroina è mia sorella e l’ho capito soprattutto da quando sono qua. Il fatto che io l’abbia capito in carcere dipende dal fatto che qui ho riflettuto parecchio sulla mia vita e sulla sua, mettendole a confronto e sui modi di reazione che abbiamo avuto di fronte a certi episodi della vita. Il risultato del mio pensiero è che avrei voluto che la mia vita fosse stata come la sua. E di sicuro ora non sarei qui. Lei ha sempre accettato tutto ciò che la vita le ha offerto sia il bello sia il brutto, gioendo per il bello e cercando di superare al meglio il brutto con una giusta dose di grinta e di calma. Nonostante sia stata sfortunata nei rapporti di cuore, è stata felice per tutta la durata del suo matrimonio, è diventata mamma di una bellissima figlia grazie alla quale è riuscita superare il divorzio dal marito. Poi ha affrontato un grave incidente senza mai perdersi d’animo nonostante le difficoltà e, allo stesso modo, con lo stesso coraggio ha affrontato la mia carcerazione e la mia condanna. Ha il potere di non arrabbiarsi e di accettare ciò che la vita le offre non con rassegnazione, ma con senso di responsabilità. Se fossi stata almeno in minima parte come lei e avessi condotto una vita come la sua ora sarei più serena e appagata di quanto io lo sia mai stata in passato e, soprattutto, non mi troverei in carcere. Spesso penso che, quando uscirò, dovrò ricostruire la mia vita e ho già il modello da imitare, quello della mia eroina per la vita. ••• LINO MARTEMUCCI utti da bambini abbiamo avuto degli eroi con i quali siamo cresciuti. I miei erano i personaggi dei cartoni animati, Mazinga Zeta, Rocky Jo, Scingo Tamai. Quest’ultimo più di tutti. Mi ricordo che dopo aver visto questo cartone animato, scendevo a giocare a pallone con i miei amici convinto di ripetere le stesse prodezze del mio eroe, galvanizzato più che mai dalle acrobazie di Scingo. Oggi non ho più degli eroi, forse potrebbero essere i miei genitori per avere affrontato tante difficoltà nell’arco della loro vita, anche un po’ per colpa mia. O forse potrebbe essere la Bibbia che ogni tanto apro, in quei momenti di annebbiamento. E per ultimo io potrei essere l’eroe di me stesso, per i grandi cambiamenti che ho fatto fino ad oggi. T ••• VINCENZO SANTISI miei eroi sono stati tanti, a cominciare dalla mamma e dal papà che non ci sono più. Quando ero piccolo, ero un ragazzo vivace e con mio cugino Mimmo combinavo delle marachelle. Una volta, avremo avuto sei o sette anni, abbiamo preso dalla cassa della mamma dei soldini, non ricordo neppure quanti fossero e ci siamo comprati un sacco di cioccolatini. Dopo, per la paura delle nostre mamme, ci siamo nascosti sulle piante di gelsomino. Ci cercavano tutti, ci urlavano di uscire fuori e che non ci avrebbero fatto niente. Io mi sono addormentato sull’albero, mentre mio cugino si è consegnato a sua madre. Mio padre strillava il mio nome e prometteva di non farmi niente perché mi voleva bene. Di colpo casco dall’albero proprio ai piedi di mio padre che mi ha abbraccia- I to e mi ha riportato a casa. Mia madre tra l’altro mi aveva dovuto lavare perché mangiando tanta cioccolata me l’ero anche fatta addosso. Ricordo anche che i miei avevano rimproverato il signore che ci aveva venduto tutta quella cioccolata. E io mi sono scusato con la mamma. Mio padre in quell’occasione mi ha dato tanta sicurezza e gioia nello stesso tempo e non ho avuto più paura dei castighi della mamma. Un’altra volta io e Mimmo siamo scappati dalla colonia dove ci avevano mandato e dove noi non volevamo stare perché preferivamo il nostro mare. Così passando da spiaggia a spiaggia siamo tornati fino al nostro paesello. Di notte ciascuno è tornato a casa e nel suo letto. Quando la mattina dopo la mamma mi ha scoperto, le ho detto che non potevo stare senza di lei e lei mi ha abbracciato e mi ha detto che se avessi fatto il bravo, non mi avrebbe mandato in colonia. E io e Mimmo siamo tornati ad andare al nostro mare, alle nostre spiagge con mio padre, le mie sorelle. Nella mia infanzia mio padre e mia madre sono stati i miei eroi. Poi sono arrivati mia moglie e mio figlio. Fin da quando è nato mio figlio, la vita mi ha sorriso. Lui e mia moglie erano le persone che sapevano darmi gioia e sicurezza insieme. Quando tornavo a casa la sera, al solo sentirlo chiamarmi “Papi, papi” mi passava la stanchezza e lo portavo a fare un giretto. Ogni cosa che facevo era per loro. Poi tutto è cambiato: io sono finito al fresco e i miei eroi mi hanno voltato le spalle. Non smetto però di sperare di incontrarli prima o poi, finché la vita continua. ••• CATIA ORTOLANI, insegnante miei eroi sono Giorgio Ambrosoli e Silvio Novembre. Ambrosoli venne chiamato a fare il liquidatore della Banca Privata del mafioso Sindona. Doveva individuare i responsabili del crack e farsi restituire i soldi. Un lavoro difficile. Al suo fianco Silvio Novembre della Guardia di Finanza. Me li immagino quei due, notte e giorno a lavorare, fumando una sigaretta dopo l'altra, mentre tutto il mondo gli remava contro. Ambrosoli cominciava a ricevere le prime minacce. La classe politica, ricattata da Sindona, faceva pressione sui due per trovare una risoluzione conciliante. La proposta venne da Andreotti: far pagare il buco ai cittadini, che tanto non si sarebbero accorti di nulla. Ma Ambrosoli e Novembre non volevano sentire ragioni. Erano stati chiamati per fare un lavoro ed erano decisi a portarlo a termine. Le attenzioni cominciarono allora a spostarsi su Novembre. Sua moglie è malata e in Italia non ci sono le cure adatte, ma in America... La cifra che viene messa sul tavolo di Novembre è di quelle che fanno vacillare. Novembre non porterà la moglie in America e Ambrosoli non farà pagare agli italiani il crack di Sindona. La moglie di Novembre morirà per la sua malattia che l'Italia non può curare. Ambrosoli morirà una sera d'estate, sotto casa sua, ucciso dal killer di Sindona e dalla politica che lo ha lasciato solo. Ambrosoli e Novembre sono i due minuscoli granellini che inceppano l'ingranaggio della corruzione. Ambrosoli era filomonarchico, io solo a sentir parlare dei Savoia mi viene l'orticaria. I NUMERO 15 Pagina 15 Ambrosoli mi ha insegnato che non importa quali siano le tue idee politiche, se sei onesto e capace, puoi fare del bene al tuo Paese. Silvio Novembre mi ha insegnato a non cedere alle tentazioni per quanto allettanti. Giorgio Ambrosoli e Silvio Novembre, i miei eroi, mi hanno insegnato il valore della dignità e dell’onestà. ••• PAOLA, studentessa del liceo M. Gioia di Piacenza enso che il mio eroe sia sempre stato lo stesso da quando ho memoria. Il mio migliore amico, Gabriele, ha subito la prima difficile operazione al cuore quando aveva sei mesi. Adesso ha 18 anni, di operazioni ne ha fatte tre, senza contare visite, cure, pastiglie da prendere e tutto quello che una malattia così comporta. Potrebbe avere a disposizione tutte le attenzioni, porsi al centro del mondo e ottenere tutto ciò che chiede solo alzando un dito, ma non lo fa. Si è sempre messo in gioco per gli altri, è il primo a sacrificare il suo tempo se qualcuno ha bisogno e ancora oggi io mi chiedo come faccia a sopportare una come me che a volte metto me stessa non prima di lui, ma prima di tutte le persone che conosco incurante dei loro problemi. Gabriele mi ha fatto capire che l’affetto, la cura e l’interesse per le altre persone – se è autentico – viene prima del tuo mal di gola, dei tuoi lamenti, di un voto basso e che, forse, ascoltando un po’ i problemi degli altri, superi anche i tuoi. A, studente hiunque può diventare un eroe. Eroi sono i genitori che ti crescono, che fanno di tutto ogni giorno per farti sentire meglio. Eroi sono i nonni che sono guida e che sono sempre presenti e ti danno consigli. Eroe è l’operaio che si ammazza di lavoro per i figli e la famiglia. Eroe è l’attaccante che fa goal al 90°. Eroe sono io. Eroi siamo noi. C P ••• RICCARDO, studente l mio eroe è Vincenzo M., professore di filosofia, perché secondo me è un grande uomo e insegnante. È capace di imparare dagli studenti e in modo creativo e passionale racconta le storie sul suo passato facendoci divertire. È un vero lavoratore, entusiasmante ed è molto simpatico. Inoltre sa giocare a calcio come pochi, è davvero un artista con la palla tra i piedi. Io e i miei compagni siamo molto affezionati a lui e lo stimiamo molto. È un peccato che il prossimo anno se ne vada in pensione. Siamo molto dispiaciuti. Il mio sogno è diventare come lui. I Un oggetto talismano SHARK ella mia vita se penso a degli oggetti che mi danno la forza di vivere, mi viene in mente un orsacchiotto il cui nome era Popo. Mi era stato regalato proprio per la paura che avevo del buio e mia madre, che le aveva provate tutte con lucine e campanelle, decise alla fine di farmi questo regalo. Lo tenevo con molta cura, addirittura da mia zia mi facevo fare dei maglioncini di lana perché dicevo che anche lui aveva freddo. Quell’orsacchiotto mi aiutava molto a sconfiggere quella paura che mi paralizzava. Con il passare degli anni non ho più avuto un qualche oggetto da conservare perché consideravo una sorta di fissazione quella di credere in un oggetto talismano. Oggi però, che mi trovo in una situazione difficile, mi accorgo di essermi affezionato al regalo di una persona per me speciale. Tempo fa mi ha regalato una stella, una di quelle che quando spegni la luce s’illumina. Ormai mi sta accompagnando da due anni e la guardo molte volte e, ammetto, quando mi sento un po’ giù, le parlo anche. Credetemi, vi sembrerò pazzo, ma per me quella stella è un punto di forza, un modo per andare avanti senza sentirmi solo. N ••• ALEXIA, studentessa no dei miei eroi è mio padre, il Boris. È venuto in Italia dall’ex-Jugoslavia quando aveva 18 anni per trovare lavoro e un futuro per sé e per la propria famiglia. Ha incominciato da zero con suo zio e ora ha una famiglia e un’attività che gestisce con fierezza. Di lui ammiro l’intraprendenza e il coraggio di avere incominciato da zero e di essere arrivato in alto. Dà sempre il meglio per la sua famiglia e non fa mai mancare niente a nessuno, lavora e si impegna per fare in modo che il futuro mio e delle mie sorelle sia rigoglioso: starà a noi continuare. Ha faticato molto per noi e lo ammiro tantissimo. Vorrei – e spero – di avere preso queste qualità da lui, essere come lui e renderlo felice. ••• U ••• STEFANIA COLOMBO ’è un oggetto che portavo sempre con me da quando mi è stato regalato. Si tratta di una cavigliera sottilissima in oro che non mi toglievo mai. Non era solo un ornamento, ma un portafortuna al quale ero molto legata affettivamente per via di chi me l’aveva regalata. Mi pareva che, indossandola, mi avrebbe sempre protetto, facendomi fare i passi giusti nel percorso della vita. Spesso controllavo che fosse sempre lì, al suo posto, allacciata alla mia caviglia destra e solo dopo averla sfiorata, mi passava l’agitazione che mi aveva assalito poco prima. Quando sono entrata in carcere, ho dovuto privarmi di quei gioielli che indossavo di solito e così ho dovuto lasciare la mia cavigliera. A distanza di due anni, ogni tanto mi sembra C Pagina 16 ALTEREGO di sentire ancora la sua presenza sulla pelle come un qualcosa di vivo e mi ritrovo ad allungare la mano per vedere se c’è. Ovviamente non c’è perché il mio portafortuna non è più con me. In quel caso però mi convinco che la sensazione di indossarla è il segno che la cavigliera sta agendo da portafortuna anche da lontano. Il mio portafortuna attuale è un ciondolo a forma di tartaruga che io indosso come orecchino. Tutte le mattine al mio risveglio lo indosso e lo porto sempre con me e credo in questo piccolo talismano sia perché la tartaruga è simbolo di fortuna, sia perché mi è stata regalata da una persona buona di cuore. ••• LAURA P. la musica che porto sempre con me. Lo so che non è un oggetto ma è il mio talismano. Da piccola i miei genitori mi avevano comprato una valigetta di Barbie con incorporato il walkman: non lo lasciavo mai. Nella mia camera di bambina avevo un giradischi con i dischi dei cartoni animati miei preferiti che già in quel periodo stavano un po’ scomparendo. Alle elementari la mamma mi comprò il mio primo walkman che mi appassionò a cantanti come Jovanotti, Raf, Baglioni, gli 883. Alle medie i miei mi comprarono lo zaino della Seven con incorporata una radio: ero al settimo cielo. Volentieri il mattino mi alzavo e con gli auricolari alle orecchie, in sella alla mia bicicletta andavo a scuola. Senza gli auricolari non potevo dormire la notte. Con la musica studiavo, facevo i compiti, aiutavo nelle faccende domestiche e portavo a spasso il cane. Dal walkman sono passata al cellulare, il motorino ha sostituito la bici, ma la musica non è mai scomparsa e ho seguito i vari cambiamenti della tecnologia: MP3, MP4, Ipod ecc… E la musica è sempre una buona amica che non m’abbandona, mi fa compagnia, mi isola, mi consola, mi fa pensare, innamorare. Mi fa ricordare il passato e a volte mi fa anche piangere. Ecco cosa mi sono sempre portata appresso la musica, vestita con abiti diversi ma sempre la stessa. Menomale che esiste. È ••• LINO MARTEMUCCI ono passati quattro anni e quattro mesi e dopo tutto questo tempo sono venuto in possesso dell’oggetto che mi ha sempre dato sicurezza: un bracciale. È un bracciale d’argento, piatto di un centimetro circa di larghezza con un’apposita chiusura dove si inserisce uno spillo, o meglio un ferretto. Porto questo bracciale da almeno quindici anni. Non passa - e non credo che passerà mai - di moda. Mi ricordo di aver girato non so quanti mercatini a Milano per riuscire a trovarlo. E adesso, finalmente dopo tanto tempo, è ritornato al mio polso e sono sicuro che nessuno potrà toccarmelo. Si è così tanto affezionato a me che mi ha seguito per tutte le carceri che ho girato, infilato nei sacchetti con gli effetti personali e senza che mai venisse smarrito. Questa è la mia perla, la mia perla d’argento. Mi dà la sicurezza che piano piano sto riacquistando con la mia libertà e insieme a lui, il mio bracciale. S ••• PAOLO CONSOLANDI, una voce dall’esterno volte usiamo vocaboli ai quali diamo un significato predefinito, senza conoscerne la vera etimologia; a me capita spesso. Oggi, prima di incominciare questo testo, pensando a cosa raccontare, mi sono accorto che non conoscevo il vero significato di talismano, avendolo sempre confinato a qualche contesto mistico-religioso. Ho scoperto che in effetti è nato in questo modo, ma non sapevo certamente che i greci con talismano intendessero “completo”, qualcosa cioè che in se racchiude ciò che ha un inizio e una fine. Appurato quest’aspetto, mi è balzato spontaneamente alla mente un oggetto cui sono affezionatissimo, un bracciale in cuoio regalatomi da un’anima a me vicina, che con quell’oggetto intendeva infondermi forza, amore, speranza. Era uno dei soliti colloqui che facevo il lunedì con mia sorella: l’ansia nella saletta d’accoglienza, aspettando che tutti i carcerati che avevano colloquio si riunissero, ognuno con qualcosa da bere o mangiare con chi veniva a far visita, non tanto perché si volesse mangiare o bere, quanto piuttosto per ricreare un clima familiare. Sembra una cosa puerile o troppo banale, e forse lo è, ma in galera ci si attacca a qualsiasi cosa pur di sentirsi ancora vivi, nonostante la struttura faccia di tutto per annientarti. A La camminata lungo il corridoio, la perquisizione e, finalmente, lo sguardo della persona che ti aspetta e quella luce di vita che con lei ti avvolge, ricordandoti che nulla è perduto, che sei vivo e che il tempo aggiusta… se vuoi. Mia sorella, un personaggio! Era diventata un’esperta dei colloqui: sapeva esattamente cosa poteva portare, come interagire con le guardie all’entrata e dava consigli a tutte le persone in visita che non sapevano bene come muoversi, in quel limbo abnorme. Un piccolo carcere per i parenti, in cui sottostare a rigide regole, accerchiati da guardie, porte blindate e telecamere Ad un certo punto, dopo un cenno di consenso della guardia, mi porge un braccialetto, con due iniziali ed io intuisco subito. Quel bracciale sembrava avesse una voce che mi diceva: “ti penso sempre, sono con te, non mollare e sii forte”. Sono passati più di due anni, ma lui è lì, al mio polso e mi parla sempre, come allora. Sono convinto che in ognuno di noi risieda un’energia a noi addirittura sconosciuta per quanto grande è; sta a noi prenderne coscienza e fare in modo di manifestarla ogni giorno, in ogni azione che compiamo e se ci ricorda che anche solo una volta ce l’abbiamo fatta, allora possiamo credere di potercela fare ancora. Nel mio caso questo bracciale racchiude la spinta che mi aiuta a essere migliore, più completo. Un bracciale, simbolo di vero amore. Amore che non chiede, amore che vuole il tuo bene a priori, amore che non ti lascia, nonostante quello che hai fatto, nonostante stereotipi sociali di presa di distanze. E da qui nasce una nuova responsabilità: essere maturo, consapevole, rigenerato e ritrovato, degno di portare il mio bracciale, che mi parla sempre. NUMERO 15 G. B. ’articolo 1 della Costituzione afferma che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e l’art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. È evidente che al lavoro si dà molta importanza sia in una dimensione sociale sia in un ambito personale. Per l’uomo il lavoro non è solo il mezzo per procurarsi il sostentamento ma è anche il modo per realizzarsi e sentirsi partecipe del processo di crescita sociale. Senza lavoro ti senti fuori e inutile, puoi deprimerti e se questa situazione perdura, puoi anche perdere la stima di te stesso. Ora, pensiamo a un uomo che ha pagato il suo debito con la società per gli errori commessi e che esce dal carcere senza risorse e senza riferimenti perché non ha una famiglia che lo aiuti, cosa può fare? Dove può andare? Certo, può rivolgersi a qualche mensa per i poveri, dormire in qualche dormitorio pubblico, bussare a qualche porta per cercare lavoro, ma è sempre accompagnato da quel marchio di ex-carcerato che si scontra con il pregiudizio che spesso alberga nelle menti delle persone. Ecco che il lavoro per un detenuto è un’ancora di salvezza che potrà aiutarlo a non riprendere quella strada che altrimenti con facilità si troverà a ripercorrere, tornando a delinquere. Un’importante iniziativa è stata attivata nel carcere di Bergamo per aiutare i detenuti ad affrontare il mondo del lavoro. Si tratta di una serie di incontri tenuti da un volontario, Massimo Vignati, che ha maturato importanti esperienze in ruoli decisionali in aziende a dimensione sia nazionale che internazionale in collaborazione con la Gi Group, azienda per il lavoro interinale L Pagina 17 e l’associazione degli Industriali di Bergamo. Si è così intrapreso un percorso per aiutare il detenuto a utilizzare l’esperienza del carcere come arma per affrontare il pregiudizio. Non si può nascondere il proprio vissuto, ma partendo dal riconoscimento dell’errore, dalla dimostrata volontà di cambiamento si può presentare l’esperienza maturata come un segno positivo che qualifichi le proprie attitudini sia umane sia professionali nella preparazione di un curriculum da proporre alle aziende. Durante gli incontri si è parlato di come affrontare la preparazione di un curriculum, le difficoltà presenti in un colloquio senza creare false aspettative o illusioni, ma i curricoli verranno proposti per eventuali inserimenti lavorativi. Questo è un primo passo che va nella giusta direzione: quella di creare una rete tra carcere, istituzioni pubbliche, comune, provincia, organizzazioni di categoria, volontariato che aiutino il reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale attraverso il lavoro. Il progetto – coordinato dall’area educativa del carcere – in vista del fine pena del detenuto deve orientare lo stesso con l’attivazione di borse lavoro, assunzioni in art. 21 dei detenuti oltre agli incentivi già previsti dalla legge Smuraglia. Un percorso in art. 21, prima come borsa lavoro, poi come assunzione a tempo determinato, può sicuramente dar modo a un detenuto di dimostrare il suo avvenuto cambiamento e magari offrirgli la possibilità che l’inserimento lavorativo si trasformi in lavoro stabile. È la creazione di una rete di collaborazioni fra i vari enti che coltiva il futuro e la speranza di noi detenuti. ••• Pagina 18 INGRID, una voce dall’esterno Più lavoro, più libertà C hi esce dopo anni senza un euro in tasca rischia di ricascare negli stessi errori, quelli che lo hanno portato in carcere! Per fare una famiglia e mettere al mondo dei figli, bisogni primari, naturali dell’esistenza umana, c’è bisogno di un lavoro che dia stabilità. Per chi esce dal carcere, non è certo facile trovare quel lavoro capace di garantire non certo il lusso, ma la sopravvivenza con un tetto sopra la testa e due pasti al giorno pur impegnandosi per tutto il resto a tirare la cinghia. Il lavoro è parte integrante del processo di riabilitazione cominciato in carcere e che deve continuare con la fine della detenzione. Credo di poter dire che la maggior parte della popolazione detenuta non naviga nell’oro e si è trovata a delinquere per necessità, per mancanza di altri mezzi di sostentamento e durante la carcerazione fatica ad acquistare in carcere i prodotti di primo genere per l’igiene e la pulizia personale e, una volta rimesso in libertà, finisce per buttare via quella stessa libertà trovandosi senza un alloggio, senza mezzi di sostentamento e senza un lavoro. Il lavoro in carcere è parte integrante del processo di riabilitazione del detenuto e penso che sia importante coinvolgere il più possibile le cooperative disposte ad assumere detenuti che beneficiano delle forme alternative alla detenzione. Grazie al lavoro svolto in carcere si comincia a credere nelle proprie capacità professionali. Così, almeno è successo a me che cerco di rifarmi una vita a partire dal lavoro che mi è stato offerto e che mi permette una certa autonomia e mi aiuta a confidare nella ripresa, quella che comincerà davvero quando al mio fianco ci sarà mia figlia. La crisalide d’argilla, Corso di ceramica M i iscrissi al corso di ceramica durante la mia prima carcerazione nel 2011 per poter apprendere una nuova arte secondo il famoso proverbio Impara l’arte e mettila da parte al quale fino ad allora non avevo mai creduto, forse perché non avevo mai capito appieno il suo significato. Notai subito la pazienza e la passione dell’insegnante Elena Gotti e delle ragazze che la stavano seguendo da tempo. Imparai i gesti: prendere l’argilla, maneggiarla, plasmarla senza fretta, ascoltare le istruzioni che mi venivano date, rispettare i tempi dell’asciugatura dell’argilla, preparare i colori, scegliere la tecnica giusta, mentre cercavo di mettere a punto il mio lavoro da realizzare. Facevo tutto e solo adesso penso che quegli insegnamenti valevano per l’argilla, ma anche per la vita. Gli stessi che, poi, ho riscoperto nel vangelo. In laboratorio per un paio d’ore scordavo di trovarmi in carcere e mi piaceva lavorare con le mie compagne, con l’insegnante e anche suor Simona che mi aiutavano ad avere pazienza, a perseverare senza cedere alla voglia che provavo, ogni tanto, di mollare tutto quando non mi pareva di avere ottenuto un certo risultato. Quando tornai in carcere nel 2012 per espiare la mia pena, vidi le splendide opere delle mie compagne e mi accorsi di quanto fosse evoluto questo corso con nuove tecniche e nuo- ALTEREGO ve produzioni artistiche e così mi iscrissi una seconda volta. Questa volta, ammetto, che ho compreso meglio i miei limiti: non sono affatto portata per i lavori manuali, ma ci riprovai con costanza e perseveranza perché ancora di più mi pareva di imparare non solo per la creazione d’argilla, ma per la mia vita. Dovevo imparare ad andare oltre, rispettando i miei limiti, ma cercando anche di plasmarli. Il laboratorio è stato anche l’occasione per conoscere un po’ meglio le mie compagne perché dopo aver lavorato con loro per due ore e torno in sezione, avverto di averle comprese un po’ di più. Dietro ogni qualsiasi creazione di ceramica ci sta una persona che l’ha lavorata: una persona con le sue fragilità, gli errori commessi che vuole però rivelare anche i suoi talenti. Ogni persona ha difetti, ma anche alcuni doni nascosti che i corsi come quello di ceramica possono scoprire. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Articolo 23), 1948 NUMERO 15 Pagina 19 LAURA BOSIO PABLO D’ORS Le notti sembravano di luna Avventure dello stampatore Zollinger Longanesi, 2012 Quodlibet, 2010 STEFANIA COLOMBO ercoledì 26 giugno abbiamo avuto un incontro con la scrittrice Laura Bosio per parlare del suo romanzo Le notti sembravano di luna che noi avevamo letto. Avevamo molte domande alle quali Laura Bosio ha risposto con molta semplicità e serenità. Il libro è in gran parte autobiografico così abbiamo conosciuto non solo la scrittrice ma anche la bambina Laura Bosio che aveva avuto la grande passione per la bicicletta. A me è piaciuta la scelta del punto di vista della bambina che ricordava senza troppi come e perché gli avvenimenti della sua vita. Ho apprezzato in modo particolare l’incontro con l’autrice che mi ha permesso di capire meglio la storia, i salti tra il passato e il presente della voce narrante. Non posso inoltre non ringraziarla perché con generosità ci ha raccontato tanti episodi della sua vita. G.B. M L ’incontro con l’autore delle Avventure dello stampatore Zollinger non si è limitato ai secchioni della redazione di Alterego che avevano letto il libro, ma a tutti gli studenti della Sezione Penale. La disponibilità dell’autore a confrontarsi con le nostre domande ci ha portato a discutere di ciò che lui ha messo al centro della sua narrazione: la vocazione e sul percorso da compiere per raggiungerla. Il suo libro si può inserire fra i racconti formativi: il protagonista con i tempi e i modi che il destino gli riserva, impara ad ascoltarsi, adattarsi, a fare al meglio ogni lavoro che gli si presenta fino a realizzare il suo sogno, la sua vocazione, quella di diventare stampatore. La capacità di imparare, di ascoltare, di accettare i tempi nel loro trascorrere, il fare bene ciò che sei chiamato a fare, il far memoria del vissuto, le buone relazioni sono gli elementi che permettono a Zollingher di raggiungere il suo obiettivo. Non si ribella a quello che la vita Pagina 20 ALTEREGO gli riserva, ma da uomo mite, così lo definisce Pablo D’Ors coglie le occasioni e con pazienza costruisce il proprio destino. Questa favola ben narrata, in modo pulito e scorrevole, è stata un’occasione di riflessione esattamente come il confronto con l’autore è certo stata un’opportunità per invitare alla lettura non solo come momento di evasione, ma anche di riflessione ed educazione. ••• Fare bene G.B. Nel leggere lo stampatore Zollinger è uscita la riflessione su come il protagonista cercasse di fare al meglio ogni lavoro che doveva affrontare e ci siamo quindi domandati cosa voglia dire “fare bene”. Io non ho mai avuto attitudini manuali e pratiche e quindi mi sono sempre trovato in difficoltà per ogni anche piccolo lavoro che dovevo affrontare e in particolare per quelle emergenze che spesso si presentano in casa: dalla corda della tapparella da cambiare, alla lampada da sistemare che diventano inevitabili occasioni di scontro con la moglie che si risolveva con la mia solita frase: “Ma perché ci sono gli artigiani se noi non li chiamiamo? Facciamo fare i lavori a chi li sa fare e sicuramente ci costerà meno!”. Quando, obtorto collo, sono costretto a fare qualcosa che non sta nelle mie corde, mi adopero per il meglio. Fare al meglio significa mettere nell’esecuzione tutto il mio impegno, la mia concentrazione e quell’abilità di cui sono capace che mi porta a capire il mio limite oltre il quale sarebbe presuntuoso inoltrarsi perché vorrebbe dire cadere in un sicuro fallimento. Questo limite da non superare deriva dalla mia passione per la montagna che ti insegna ad affrontare una via, un’ascensione in funzione delle tue forze, delle tue capacità e sa che se sbagli, metti in pericolo la tua vita e quella degli altri. Il riconoscimento dei propri limiti è la base del mio far bene. ••• SANDRO BONVISSUTO Dentro Einaudi, 2012 G.B. M ercoledì 3 luglio, ultimo incontro con un autore che per noi, questa volta, è particolare visto che il suo libro s’intitola Dentro e sembra quindi aver condiviso le nostre esperienze in carcere. Mi sono preparato con una serie di domande perché il libro mi era piaciuto per il modo di scrivere sintetico e capace di descrivere situazioni, ambienti, emozioni, sentimenti tanto da diventare quasi visibili nella mia immaginazione di lettore. In aggiunta all’esperienza carcerazione, due racconti restituivano altri due momenti di vita: il compagno di classe e l’insegnamento da parte del padre ad andare in bicicletta. Mi ha colpito l’attenzione dell’autore ai rapporti, alla costruzione delle relazioni, allo sviluppo dei sentimenti in un rincorrersi di attese, aspettative, miti, delusioni, sofferenze che la vita nel suo scorrere quotidiano riserva a ciascuno e le paure conseguenti. La capacità di vivere e superare la quotidianità cercando di costruire il futuro. Con le mie domande ero curioso di sapere dall’autore quanto la sua detenzione lo avesse aiutato a preparare il dopo carcere. Ma ecco che al momento dell’incontro, Sandro Bonvissuto mi spiazza, scegliendo di parlare del suo libro e del carcere da un punto di vista sociologico che mi era completamente sfuggito, ma che trovava piena conferma nella mia esperienza di detenuto. Lui sostiene che nelle società cosiddette ‘avanzate’ il carcere ha un numero di ‘utenti’ sempre maggiore ed è un ‘affare’. È anche una realtà che si vuole nascondere e a nessuno viene presentata come un’esperienza che, per diverse circostanze, potrebbe capitare. Il carcere è anche costruito ‘fuori’ dalla città: una presenza nascosta al quotidiano incedere della vita e dove si consumano le espiazioni dei reati, delle colpe di chi ha trasgredito la legge. Il detenuto per il sistema costituisce il reato che ha commesso, passa in secondo piano la sua dimensione di persona, e lo si riduce alla pena da scontare in un carcere dove tutto si basa su regolamenti, articoli del codice che definiscono quando potrà usufruire dei benefici se a un quarto, a metà, a due terzi della pena in funzione del reato. Il sistema sociale non tiene conto se durante il tempo della carcerazione le famiglie si sfasciano, il detenuto per la sua rieducazione fruisce di qualche ora annua di colloquio con gli educatori e ha a disposizione la buona volontà di chi si adopera con iniziative di volontariato utili a creare percorsi di riflessione e innalzamento personale. Alle istituzioni non interessa se il detenuto, una volta uscito dal carcere, non ha soldi, né una casa dove andare anche se lavoro e casa sono “elementi” indispensabili per ottenere dei benefici nello sconto della pena, eppure valgono soltanto per l’applicazione dei regolamenti e non in funzione della vita della persona. L’ordinamento, le regole superano la persona e la considerazione che si dovrebbe porre alla sua rieducazione e al suo reinserimento che sta alla base dell’espiazione della pena. La società vede il carcere come elemento per rafforzare la propria sicurezza e dimentica la grande umanità che si respira in carcere, che prende corpo e rende vivo il principio di rieducazione e reinserimento che sta alla base dell’esecuzione della pena. Un’umanità e un’attenzione che si respirano quando i detenuti condividono le difficoltà che vivono, cercano di venirsi incontro per alleviarle; un’umanità che s’incontra nella polizia penitenziaria attenta e rispettosa di ogni detenuto in quanto persona e nelle educatrici che, per quanto e come possibile, si attivano per cercare di costruire un “futuro” ai detenuti. Sì il carcere è pieno di umanità che nel libro di Sandro si legge anche nelle bugie o nelle cose non dette al compagno di cella ma è un’umanità soffocata nascosta da chi vuol stare al sicuro nella sua casa, nello studio, nella sua città senza sapere che un carcere diverso forse rende vera, concreta la sicurezza alla quale aspira perché chi ha sbagliato non tornerà più a sbagliare. NUMERO 15 Pagina 21 trice al piede sinistro. Le tante cicatrici attestano le mie diverse attività intraprese. A mia volta io ho fatto lo stesso con mio fratello sia per la bici sia per il nuoto. ••• ERMANNO CECCHERINI n carcere, durante il mio periodo di lavoro in cucina mi ritrovai una volta a portare i sacchi maleodoranti all’esterno nell’apposito cassettone - avevo il permesso ovviamente. Scorsi così appoggiata al muro una mountain-bike. Appoggiai i sacchi e feci un giro in bici intorno al Penale. Che bello! A 8 o 9 anni saltai la stagione della bici per il Ciao, quindi quello mi sembrava il mio primo giro in bici e mi trovai a pensare a quanto mi ero perso fino ad allora a non pedalare. Alla fine accostai la bici al muro e da allora non l’ho più vista. I La mia prima bicicletta SHARK uardavo sempre mio fratello e il suo amico Andrea scorrazzare con la bicicletta su e giù per la nostra via. Io ero piccolo e mi piaceva guardarli e dopo ripetute richieste un giro me lo facevano fare e così è nata la mia voglia tremenda di avere una bicicletta nuova e mia! Ed è passato un bel po’ di tempo prima di averla. E vi racconto come sono andate le cose. All’uscita da scuola io e mio fratello andavamo nel bar dove lavorava mia madre a mangiare e poi alle 14 prendevamo il pullman per rientrare a casa. Percorrevamo Piazza Duomo e poi Piazza del Popolo dove c’era la fermata del pullman. Un giorno eravamo seduti sulla panchina in attesa del pullman insieme a una signora che salì sul primo arrivato. Dopo qualche secondo io e mio fratello ci accorgemmo che al nostro fianco la signora aveva lasciato una borsa che noi, dopo esserci guardati, prendemmo prima di salire sul nostro pullman. Eravamo curiosi di sapere cosa potesse esserci dentro ed eravamo d’accordo di non raccontare a nessuno l’accaduto. Nella borsa, che avevamo aperto non appena entrati in casa, trovammo un sacco di soldi: 800.000 lire che noi certo non avevamo mai visto tutti insieme! La sera tornò mia madre e noi tenemmo la borsa nascosta, ma lei che aveva davvero un fiuto straordinario per riconoscere in noi qualcosa di strano, trovò la borsa proprio aprendo l’armadio. Non vi racconto la sua incazzatura. Tramite il documento presente nella borsa riuscì a risalire alla signora che arrivò elegante e a bordo di un’automobile di grossa cilindrata. Era così felice del gesto di mia madre nei suoi confronti che, appena saputo che la borsa in realtà l’avevamo trovata noi, ci chiese quello che desideravamo. Io, sfrontato, ho risposto: “Una Saltafoss”. Detto fatto. Lei è tornata con una Saltafoss color argento e blu metallizzato e io ero il bambino più felice del mondo. G ANTONIO PELUSO nestamente non mi ricordo molto di quello che è successo con la mia prima bicicletta. So però che era una Saltafoss. Ricordo anche che la presi subito perché così mi avevano detto senza spiegarmi come andarci. E così ho fatto, ma posso vedere ancora gli effetti di quel mio primo giro in bicicletta. Ho imparato da solo ma porto ancora la mia cica- O Il mio compagno di banco è oggi il mio compagno di cella. Abbiamo fatto amicizia e stipulato un’intesa per cercare di passare meglio possibile questa carcerazione. Lui è più fragile di me ma spesso ci sosteniamo e ci aiutiamo grazie a molte cose che abbiamo in comune quale per esempio l’arte di rendere meno acida la partita della vita. ••• MARIA VITTORIA, tirocinante universitaria stato mio fratello a insegnarmi ad andare in bicicletta, mi ricordo che siamo andati in giardino e lui, dopo averle tolto le rotelle mi ha fatto salire. Non ho molti ricordi di quel momento, è solo un flash: io che salgo sulla mia biciclettina bianca e Filippo che dandomi una forte spinta mi urla: "Adesso pedala!". C'era anche la mamma a guardarmi dalla finestra e sorrideva divertita. Il flash finisce qui: non ricordo se sono caduta o se ce l'ho fatta a stare in equilibrio, ma certamente ricordo l'emozione che ho provato in quell'istante. Mi sembrava un momento epico, qualcosa di molto importante che stavo facendo e soprattutto, porto nel cuore il bene di mio fratello, che qualche anno più tardi, mi avrebbe accompagnato durante la mia prima guida in macchina, sulla sua Ibiza nera! È ••• INGRID, una voce dall’esterno desso che rifletto, mi accorgo di quanti significati si nascondono dietro queste parole: la mia prima bicicletta. Bicicletta significa due cicli, due cerchi e in termini più simbolici cadute e risalite, l’andare oltre la paura della caduta. Anzi, più cadi, più ti rialzi e ti senti forte. La paura non ti deve bloccare, non ti deve far perdere la speranza come fa adesso mia figlia che non molla, non si arrende alla sua caduta dalla bicicletta ma torna a salirci sopra imparando a prendere qualche precauzione, a manovrare bene il manubrio senza il quale non si può condurre la bici e capisce l’importanza di avere due ruote per una maggiore stabilità. Da piccolina, mi avevano anche insegnato a prendermi cura della bici nel pulirla quando sporca, nel controllare la funzionalità dei freni. Mi accorgo che quei piccoli insegnamenti funzionano anche per la vita: non mollare nonostante la brutta caduta fatta che può essere considerata addirittura una prova; affidarsi a chi ha A Pagina 22 ALTEREGO maggiore esperienza e che può insegnare un modo migliore per vivere, pedalare, evitare pericoli inutili, stare attenta nelle discese apparentemente più emozionanti, ma infide delle salite che diventano ancora più faticose se ti sei sbucciata un ginocchio o magari te lo sei anche rotto. Da piccola pensavo solo a pedalare, ma ripensandoci ora colgo che quegli insegnamenti erano veri e propri pilastri della mia vita: cadere e rialzarsi, prendermi cura di me accettando l’aiuto di altri. I pezzi da soli non bastano, assemblati insieme possono formare un mezzo equilibrato di locomozione come una bicicletta. ••• G.B. P rimo giorno di scuola, sono stato assegnato alla 3° B dell'Istituto Magistrale Maffe Negro. Dovrò cimentarmi con il nuovo ambiente, io che arrivo dall'Itis. La prima grande differenza stava negli edifici: Itis moderno, costruito da poco, colorato e vivace come i suoi frequentatori; il Maffi Negro, grigio, severo con tutto il peso dell'Istituzione scolastica sulle sue spalle, ma anche sulle spalle degli insegnanti che, al di là di qualche incaricato, erano tutti incastonati nel grigio del luogo dove si potevano identificare, con gli stessi anni di vita dell'istituto, delle cariatidi in attesa della pensione, che ormai arrivavano alla terza generazione di studenti della stessa famiglia. Gli alunni, o per meglio dire, le alunne, perché di maschi, in tutto l'istituto, eravamo in nove su quattrocento, compite, formali, rispettose, inquadrate in attesa dell'appello per formarsi le classi. E così mi ritrovo solo con 27 compagne di classe. Tra loro un nome mi aveva colpito all'appello, Margherita. Alta come me, occhi verdi, bionda. La cerco. È una vicina di casa e, dopo averla trovata nella confusione, le propongo di stare in banco assieme e mi dice: però l'ultimo. In seguito ho capito che il tutto non era solo forma, ma anche in questa classe giaceva la brace. ••• CATIA ORTOLANI, insegnante ssendo io di sesso femminile, non ho avuto un compagno di banco, ma una compagna di banco. Si chiamava Menita, diminutivo o vezzeggiativo di Filomena. Arrivava da Potenza, una città che non avevo mai sentito nominare. Io e lei eravamo le più piccole della classe, anzi, della scuola, o forse di tutte le scuole del regno. Eravamo così piccole che nessuno pensava fossimo dell'età giusta per entrare in prima elementare. Ma si sbagliavano. Avevamo sei anni come tutti gli altri bambini. Di quel primo giorno di scuola ricordo solo lei, Menita. Sul suo minuto visino dominavano grandi occhiali che ingigantivano i suoi occhi. Gli occhiali, e di conseguenza gli occhi, erano più grandi di lei. Si avvicinò a me e mi chiese se volevo essere la sua compagna di banco. Io accettai, come se non potessi fare altrimenti, come se fossi destinata a lei. Scegliere la compagna di banco è come andare al canile per prendere un cane: non sei tu che scegli lui, ma è lui che sceglie te. Almeno per me è stato così. Siamo rimaste insieme per i cinque anni delle elementari e per i tre anni delle medie. Sempre compagne di banco e non ricordo di aver mai litigato con lei. Forse l'ho fatto, ma non lo ricordo, così come non ricordo come ho fatto a perderla di vista. È successo in modo naturale: come è stato naturale sceglierci, è stato naturale lasciarci. Ci siamo rincontrate due anni fa, dopo trent'anni e subito ci siamo riconosciute. Lei non porta più gli occhiali, ma i suoi occhi sono lo stesso grandi. Anche se ora ha 47 anni è la stessa ragazzina piccola col grembiule bianco e il grande fiocco blu. È sempre Menita, la mia compagna di banco. E Il mio compagno di banco FABIO l mio primo compagno di banco me lo ricordo benissimo perché eravamo diventati una cosa sola, Lello Parasporo. Era un bambinone, nel senso che era il gigante della classe ed era di una bontà infinita, nonostante la sua stazza, non avrebbe mai fatto male a una mosca. Siamo stati insieme per tutte le elementari, fino alla quinta quando dovevamo andare alle medie. Speravamo di essere insieme ma, purtroppo, non fu così. Le sezioni, all'epoca, erano divise per lingue, io avevo scelto l'inglese, perché tutti dicevano che era più facile, ma lui, sfortunatamente, venne messo nella sezione di francese e da allora un po' si divisero le nostre strade. Poi lui, in seconda, si trasferì con tutta la famiglia in un paese vicino e ne persi proprio le tracce. Quando dopo una quindicina d'anni lo rincontrai con la divisa da carabiniere, rimasi un po' stranito, perché io ero già stato in carcere. Non ebbi neanche il tempo di riprendermi dallo stupore che mi sono trovato abbracciato a questo omone, un carabiniere, il mio compagno di banco, il mio miglior amico delle elementari, Lello Parasporo. I NUMERO 15 Pagina 23 di ADRIANA LORENZI I mpossibile non aderire anche quest’anno al richiamo da sirena del convegno di Ristretti Orizzonti, perché questo è per me l’appuntamento annuale di maggio al Due Palazzi di Padova. La suggestione di quest’anno era ancora più forte a partire dal titolo del convegno Il male che si nasconde dentro di noi che mi ha evocato immediatamente una delle mie maestre, delle mie amiche di carta che mi accompagnano con i loro scritti. È Hannah Arendt che ha parlato del male e della sua banalità che si annidano nell’incapacità umana di vedere le cose dal punto di vista di un altro. Il male fiorisce come edera, quando ciascuno si trincera nel suo piccolo mondo e proietta sulla realtà il suo sguardo come luce di faro che tanto lascia nell’ombra e getta la sua rete di parole stereotipate che si lascia sfuggire molte verità. In Italia, come ha affermato Riccardo Iacona il giornalista del programma televisivo Presadiretta, “Sappiamo tutto e non facciamo niente”. Accade quando ci si sente schiacciati dai discorsi generali, respinti dal pessimismo dell’ideologia, ciechi e sordi agli echi delle contingenze perché, come ha detto il criminologo Alfredo Verde “il livello della riflessione scientifica molto spesso perde la freschezza del contatto con le emozioni”. Ogni relatore del convegno è invitato a usare una modalità narrativa e poco dottorale, a offrire la sua testimonianza di esperienza vissuta e ripensata per poter essere utile, efficace nel momento in cui passa dalla dimensione privata e personale a quella pubblica. Le relazioni più coinvolgenti sono state quelle che sono partite con tono emozionato e sommesso. Le voci più ascoltate in un silenzio rispettoso sono state quelle, all’inizio, più incerte, quelle che hanno ammesso di non sapere quale definizione dare al male, ma hanno continuato a cercare le parole per dirlo con pause e riprese, senza adottare specialismi e toni da comizio. Degli uni e degli altri sono ormai stanca, poiché ribadiscono quello che si dovrebbe fare, ma non si fa, l’ottimale che non concede alcuno spazio al possibile piuttosto allarga pozzanghere di impotenza di fronte alle quali ci si arrende o nelle quali si rischia di annegare. Ho ascoltato inve- ce con trepidazione quelle che potrei chiamare voci di controcanto che non hanno raccontato attraverso esempi dimostrativi, ma riflettenti che, direbbe la Arendt, indicano e non generalizzano. Sono state le voci dei redattori di Ristretti Orizzonti che aprendo la sezione dedicata di volta in volta a un tema specifico hanno offerto spesso dubbi più che certezze, hanno aperto domande senza chiudere con risposte. Penso a Dritan che ha parlato del tempo vissuto all’insegna di coraggio, onore e orgoglio, quelle parole che lo hanno portato ad aderire alle faide e quindi all’uccisione di un ragazzo prima di ricevere il perdono dal papà della sua vittima. È stato il perdono ad avviare il suo processo di ripensamento e cambiamento. Penso invece a Marina Valcarenghi che mi ha ipnotizzato con la sua testimonianza e anche con la sua postura. Gomiti appoggiati sul tavolo dei relatori, mani abbarbicate al microfono avvicinato alla bocca e occhi grandi puntati su di noi, il suo pubblico: tutta la sua postura significava che quello che aveva da dire era davvero cruciale. Una questione di vita e di morte e non c’è stato margine per la distrazione e il nostro ascolto si è fatto attento oltre che rispettoso. Si è chiesta subito cosa diavolo fosse il male. Il male è sfuggente, perché cambia forma nel tempo e anche nei diversi contesti. È però circoscrivibile a quei comportamenti considerati intollerabili dentro quel tempo e quel contesto. Il male è necessario perché c’è e ci dà la misura del bene. È nel carcere di Opera che Marina ha introdotto la psicoanalisi per le sezioni protette dove ci sono uomini che incarnano il male, qui ‘mostri’, così come vengono dipinti dalla peggiore informazione mediatica, che hanno agito la violenza sui corpi delle donne e dei minori. Lei ha lavorato con loro per aiutarli a liberarsi dei fantasmi che li abitano e accendono la miccia della violenza, della furia distruttiva che si abbatte sulle donne e altre persone che li circondano. Marina ha vissuto la sua esperienza in carcere come un appuntamento impossibile da rimandare per comprendere la sua vita oltre che quella degli altri. Pagina 24 Mi sono sentita molto in sintonia con Marina, attesa anch’io dal carcere perché la vita mi aveva già fatto incontrare il male e io avevo avuto paura dell’uomo che lo aveva causato. Ed è stato il carcere a insegnarmi a non avere paura del male che esiste e si rivela in quegli atti che un essere umano compie contro un suo simile, ma a vivergli accanto per riconoscere i suoi agguati. È al suo cospetto che si nutre la fiducia in quel margine di bene che ciascuno può sempre scegliere di far fiorire. Come afferma Hannah Arendt “il male non è mai radicale, ma soltanto estremo e non possiede né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero perché si espande sulla sua superficie come un fungo. Esso “sfida” il pensiero perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici e, nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua banalità. Solo il bene è profondo e può essere radicale”. Ho apprezzato Adolfo Ceretti che ha puntato sulle cesure da provocare dentro le narrazioni degli uomini violenti, dentro i loro pentimenti manipolatori. Come lui, anch’io, confido in percorsi possibili di rieducazione per spezzare la catena del male, agendo sulle biografie del carnefice e della vittima per variare, ancora una volta, il loro punto di vista. Non vedo altra via se non quella di portare l’uno a contemplare l’universo dell’altro. È sempre la Arendt a scrivere: “Condannare e perdonare sono in realtà due aspetti della stessa cosa che rappresentano, però, principi opposti. La maestà della legge esige che tutti siamo uguali dinanzi ad essa, quanto a dire che conta l’azione, e non la persona che l’ha commessa. L’atto di grazia, al contrario, valuta la persona: c’è condono per l’assassino o il rapinatore, ma non per l’assassinio o la rapina. Chi ha commesso il fatto, ma non il fatto in sé, può sperare nella grazia: per questo si pensa generalmente che solo l’amore abbia il potere di perdonare. Comunque sia, noi perdoniamo la persona, mentre la giustizia esige che tutti siamo uguali davanti alla legge, la grazia, invece, si basa sull’ineguaglianza degli uomini, e ciò fa sì che ogni uomo conti più delle sue azioni”. Il convegno di Ristretti Orizzonti mostra concretamente quanto contino più gli uomini delle loro azioni. Quest’anno avevo accanto a me un punto di vista completamente diverso, quello della figlia di Dritan ed è stato sicuramente un privilegio assistere al convegno accompagnata dal suo sguardo. Da anni conosco Dritan e sono stati i suoi scritti prodotti durante il mio laboratorio di scrittura a Padova che mi hanno permesso di conoscere la figlia della quale non ha mai smesso di raccontare. La ferita più dolente quella di non averla potuta crescere. L’orgoglio più grande quella di presentarmela in occasione del convegno. Stavo seduta nella mia solita sedia in prima fila per non perdere nulla dei diversi interventi e Dritan si è diretto verso di me e mi ha ‘ordinato’ – è il verbo più corretto per dire del suo tono – di tenere un posto per sua figlia che stava arrivando. Tenendole il braccio attorno alle spalle l’ha accompagnata da me per presentarmela e mostrarle il suo posto. Quello e non un altro, anche lei davanti a tutti gli altri perché sentisse bene, ALTEREGO perché sapesse del lavoro suo dentro la redazione di Ristretti. Forse perché fosse fiera di lui in quella situazione così diversa dal tempo e dallo spazio dei colloqui. Suela si è accomodata dopo avermi salutato con una stretta di mano timida e avermi allungato un cioccolatino. Mi ha intenerito il gesto, la sua giovinezza, il suo sorriso lieto e imbarazzato a un tempo. Non aveva un foglio e neppure una penna, così Dritan mi ha pregato di dargliene una, mentre lui recuperava il foglio. Era preoccupato che lei seguisse con attenzione e, come gli anni di redazione gli hanno insegnato, non si può stare attenti senza prendere appunti, senza trattenerle le parole sul foglio bianco affinché inneschino nuovi ragionamenti e altre suggestioni. A un certo punto si è accorto di quanto Suela patisse il freddo della palestra e così le ha fatto arrivare il suo giubbino da un compagno. Piccoli gesti di cura possibili anche in galera, nonostante la galera. Suela si è commossa quando il padre nel suo intervento l’ha citata e ha dichiarato la felicità di averla finalmente lì ad ascoltarlo parlare della sua esperienza e del suo cambiamento. Suela è arrossita quando lui ha comunicato a tutti di essere orgoglioso della sua bellezza e di quello che lei era diventata, crescendo nonostante la sua assenza. Sono i figli e le figlie come Suela che aspettano con speranza a diventare l’ancoraggio ai tanti ‘mai più’ pronunciati dai loro genitori in detenzione. Quando ci si sente aspettati da qualcuno, è più facile muoversi verso una vita altra rispetto a quella già vissuta. Infine è toccato a Suela parlare al pubblico di cosa ha significato nella sua vita avere un padre in carcere. Non parlava al pubblico ma a suo padre, a Ornella Favero, a Silvia Giralucci , alle persone al tavolo dei relatori che hanno lavorato negli anni per non farla sentire sola e diversa perché marchiata quale figlia di un omicida. Ha raccontato il bisogno di nascondere alle compagne di scuola, alla sua migliore amica la vergogna di avere un padre un galera con delle bugie... mio padre è via per lavoro… finché non è riuscita a confessare la verità al suo ragazzo e si è sentita meglio, più leggera. Si può avere paura di raccontare. Si può anche non avere alcuna forza di farlo. Eppure non smetto di credere che le parole – smozzicate, incerte, balbuzienti – siano il nostro antidoto alla vergogna, al rancore, al senso d’impotenza, all’ingiustizia avvertita nei confronti della vita, del destino che ci è toccato in sorte. Ogni volta che esco dal convegno di Ristretti Orizzonti mi accorgo che nella mia mente rimbalzano i tanti discorsi ascoltati e, mentre guido verso casa, penso a nuovi progetti, catalogo mentalmente i libri citati e che devo assolutamente leggere. In gioco non c’è solo l’informazione sulla galera, neppure soltanto i detenuti, ma la vita tutta che chiede di essere compresa, che implora di essere vissuta pensando e capendo. Non si può finire così come si è cominciato: inconsapevoli di sé e del mondo circostante. Questa volta, però, mi sono portata via anche il sorriso di Suela e quello di suo padre e l’immagine di lui che la tiene sulle ginocchia nonostante non sia più una bambina. Il carcere ferma sempre il tempo quando non arriva purtroppo a spezzarlo, eppure almeno in qualche caso le stagioni da vivere possono essere un po’ recuperate e rilanciate in nuove forme di relazione.
Scarica