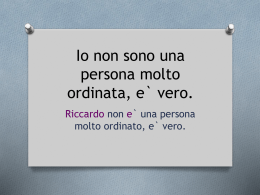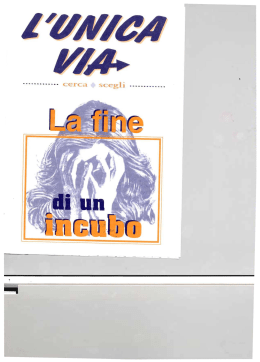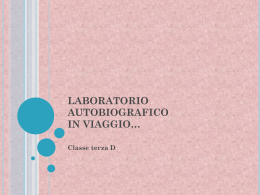CENTRO STUDI CSI VARESE 6a Edizione 2013 Perché no? PALESTRA DELL’ANIMA Se provi, la possibilità di realizzare qualcosa esiste. Se ti blocchi, non osi o hai paura sicuramente non realizzerai niente. ( Personaggi scelti e “Perché no?” commentati da Domenico Serino). 2 Premessa Il titolo al libretto del momento formativo per la sesta edizione della vacanza sportiva a Disentis ce lo ha suggerito un personaggio molto particolare che abbiamo conosciuto, ammirato ed amato la scorsa estate: Simona Atzori, la splendida ragazza pittrice, ballerina, scrittrice, nata senza braccia. Nel raccontarci il profondo rapporto che la legava a sua madre Simona aveva detto: “tra mia madre e me c’è sempre stata complicità e fiducia, non ci siamo posti limiti. Davanti ad ogni nuova esperienza continua a dirmi, come quando ero bambina, perché no? Se qualcuno mi dice che non posso fare qualcosa, penso a mia madre che mi ripete quel perché no? Che significa: PROVA!” Se hai un progetto, un desiderio, un sogno … PROVA! Non ti fermare, non ti arrendere prima di averci provato. In questi sette giorni: “PROVACI!” sarà la nostra parola d’ordine. Continueremo così le riflessioni ed i propositi che abbiamo fatto nel 2012 quando abbiamo conosciuto “i sogni” di Martin Luther King, del Mahatma Gandhi, di Albert Schweitzer, di Simona Atzori, di Alessandro Del Piero, dei fratelli Demetrio e Alessio Albertini, di Steve Jobs. La locomotiva che trascinerà i vagoni dei nostri buoni propositi di quest’anno deve correre su un sicuro binario. Una rotaia si chiama: “ho dei progetti per la mia vita”; l’altra: “devo avere la volontà di realizzarli”. E per realizzarli dobbiamo fare uscire la nostra locomotiva dalla stazione e lanciarla per monti, valli, colline, pianure, foreste ed anche deserti. Senza rimpianti e ripensamenti, con la certezza che riusciremo a vivere alla grande spinti dal nostro personalissimo: “ PERCHE’ NO”? Conosceremo ancora delle persone che, attraverso il racconto della loro vita, cercheranno di convincerci, come i personaggi dello scorso anno, che molto, se non tutto di quanto progettiamo, si può realizzare. Dipende da noi. Inizierà Roberto Baggio. Gli faranno compagnia: Nelson Mandela, Marcello Candia, Albert Einstein, Alex Zanardi e Javier Zanetti. 3 Primo giorno: ROBERTO BAGGIO. Benvenuti a Disentis, ragazzi, e grazie al vostro staff per avermi dato la responsabilità e l’onore di aprire il “momento formativo”. Voi avete la fortuna di essere guidati da uno staff composto da persone veramente eccezionali. Buoni atleti (alcuni lo sono ancora), grandi sportivi, appassionati educatori. Inizia per voi una settimana molto particolare che spero ricorderete per tutta la vita e racconterete un giorno ai vostri nipoti, iniziando più o meno così: “Allora sì che si facevano cose importanti … Eravamo in tanti … In un posto bellissimo … Si faceva tanto sport … Ma si meditava anche … Si progettava il nostro futuro-.. In questi giorni imparerete ad essere più autonomi, farete nuove amicizie, amerete di più la natura, praticherete tante discipline sportive e considererete lo sport come una grande occasione per crescere, maturare, dare valore alle cose che contano veramente nella vita. Così io ho considerato lo sport e per questo voglio essere ricordato, oltre naturalmente che per la mia bravura tecnica, dono di madre natura e frutto di tanti sacrifici. Mi sono dimesso dalla carica di presidente nazionale del settore tecnico giovanile perché vedevo i miei obiettivi, i miei programmi, il mio ideale sportivo mortificati dall’arrivismo, dal successo fine a se stesso, dal pericolo di illudere centinaia e centinaia di ragazzi col rischio di distruggerli come atleti e come uomini. Forse molti di voi mi hanno visto al festival di Sanremo; vi confesso che ho fatto fatica ad accettare l’invito di Fabio Fazio perché sono sostanzialmente molto timido e riservato. L’ho fatto pensando ai miei figli e a ragazzi come voi a cui volevo rivolgere dei consigli chiari, forti e soprattutto utili. Il vostro staff vi ha riproposto quel mio intervento. Credo molto in quello che ho letto e voglio trascrivere quelle poche parole su questo libretto perché possiate rileggerle quando i dubbi vi impediranno di affrontare il vostro “Perché no?”. Io sono diventato famoso giorno dopo giorno con grandi sacrifici. I sacrifici li4fanno tutte le persone che vogliono, onestamente e con le loro forze, diventare qualcuno, come li hanno fatti i miei amici calciatori Alessandro Del Piero e Demetrio Albertini che vi hanno raccontato la loro avventura sportiva ed umana lo scorso anno. Tra me e loro cambia la data ed il luogo di nascita. Cambiano le squadre in cui abbiamo militato. Con Albertini ci siamo incontrati nel Milan. Con Del Piero, l’erede naturale del mio numero 10, abbiamo in comune le origini venete e gli anni gloriosi passati nella Juventus. La Nazionale, a cui abbiamo dato molto e da cui abbiamo ricevuto moltissimo, è stata però la nostra vera squadra comune. La mia passione per il calcio mi ha fatto emigrare, a volte con fatica e sofferenza per l’attaccamento alla maglia ed ai tifosi, in diversi club, spesso in forte contrasto tra loro. Ve li ricordo tutti: Lanerossi Vicenza, Fiorentina (portata sempre nel cuore), Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia. E poi i miei tre mondiali: Italia 90, Stati Uniti 94 e Francia 98. Di tutta la mia lunga carriera vi voglio raccontare qualche episodio legato alla nazionale ed ai miei mondiali. Il primo a chiamarmi in nazionale è stato Azeglio Vicini. Ho esordito nella partita amichevole Italia-Olanda (1-0). Avevo 21 anni. Era il 16 novembre 1988. Il primo gol lo segnai su punizione all’Uruguay (1-1) il 22 aprile 1989, sempre in una partita amichevole. Il 20 settembre dello stesso anno segnai contro la Bulgaria una doppietta. Il primo dei miei due gol è passato alla storia perché era il 500° gol della nazionale italiana. Anche questa era una partita amichevole. Strano, vero? Ero destinato a giocare per “la pace”, per l’amicizia, per lo sport come incontro di popoli. Ma nei tre mondiali diedi il meglio di me stesso. Italia 90: allenatore Azeglio Vicini. Giocai col numero 15. La prima partita fu contro la Cecoslovacchia. Misi a segno un gol memorabile, considerato il più bello di quel mondiale e settimo nella speciale classifica FIFA della storia della Coppa del mondo. Partii da metà campo e dribblai mezza squadra avversaria. Mi ispirai al gol di Maradona, quello in cui si mangiò tutta la squadra inglese in quell’azione travolgente che ha fatto della sua rete il gol più bello della storia del calcio. Chissà … Forse tra di voi c’è chi riuscirà a fare meglio. A Italia 90 fummo sconfitti ai rigori in semifinale dall’Argentina. Arrivammo terzi vincendo contro l’Inghilterra per 2-1. Segnai un gol “furbissimo”. In pratica rubai il pallone al distrattissimo portiere inglese Shilton. Potevo segnare ancora su rigore, ma lasciai tirare Schillaci che con quel gol vinse la classifica di miglior realizzatore del mondiale con 6 reti. Stati Uniti 94: allenatore Arrigo Sacchi. Prima partita: Italia-Irlanda. Vinse l’Irlanda 1-0. Noi giocammo la peggiore partita del mondiale. Mi piovvero addosso critiche da tutte le parti … Ed erano meritate! Avevo una sola scusante: Sacchi ci fece giocare con lo schema 4–4–2 a cui non ero abituato e che non mi permetteva di spaziare per il campo a costruire gioco. Seconda partita: Italia-Norvegia. Dovevamo riscattarci nel gioco e soprattutto 5 il nostro vincere se non volevamo essere eliminati. Alla prima azione norvegese portiere Pagliuca venne espulso per aver toccato la palla con le mani fuori dall’area. Sacchi, per fare posto al nostro secondo portiere Marchegiani, fece uscire dal campo proprio me. L’avrei strozzato! Le televisioni di tutto il mondo immortalarono il mio labiale che diceva: “Ma questo è matto!” Se c’è un dio del pallone, quella volta ci aiutò. Vincemmo in dieci con un gol di testa di Dino Baggio. Terzo incontro: Italia-Messico. Pareggiammo 1-1. Giocai male. Ero deluso, demotivato, arrabbiato, offeso per le critiche di molti giornalisti. Ci qualificammo comunque agli ottavi, grazie al ripescaggio tra le migliori terze classificate nei gironi. Insomma: avevo giocato 3 partite orribili e l’Italia era già data per spacciata! Agli ottavi incontrammo la squadra rivelazione del torneo: la Nigeria che aveva eliminato la grande Argentina. Dovevamo riscattarci, lo giurai a me stesso. Ma al 26° minuto la Nigeria era già in vantaggio e noi per giunta eravamo rimasti ancora una volta in dieci per l’espulsione di Zola. Mancavano due minuti alla fine dell’incontro… Ricevetti non so come un pallone al limite dell’area… Lo accarezzai con gli occhi e poi lasciai partire un potentissimo rasoterra che, passando tra una selva di gambe nere e bianche, si infilò alla sinistra del portiere. Andammo ai supplementari. Ero concentratissimo. Servii un pallone d’oro a Benarrivo che fu falciato in area. Segnai il rigore spiazzando il portiere. Passammo così ai quarti. Incontrammo la Spagna. Eravamo rinfrancati, ci sentivamo forti. Vincemmo 2-1. Segnarono i due Baggio: Dino e Roberto. Chi non conosceva il calcio pensava che fossimo fratelli. Segnai un gol da posizione impossibile. Il portiere spagnolo, il grande Zubizarreta, non riusciva a capire da dove fosse passato quel missile. In semifinale incontrammo la Bulgaria del futuro pallone d’oro Stoichkov. Vincemmo ancora per 2-1. Questa volta tutte e due i gol furono miei. Finii la partita distrutto per il caldo e per la fatica. Ora sembrava una favola perfetta, ma ho dovuto imparare che spesso la vita ci riserva anche sorprese amare: tutti sanno come andò a finire la finale... Vinse il Brasile ai rigori per 3-2! Sbagliarono i rigori decisivi i due giocatori simbolo di quella nazionale: Franco Baresi… e Roberto Baggio. Quel tiro alto, altissimo sopra la traversa turba ancora i miei sogni. I rigori del resto li sbagliano soltanto quelli che hanno il coraggio di tirarli. Francia 98: allenatore Cesare Maldini. Quello francese fu il mondiale del dualismo Baggio-Del Piero. Prima partita: Italia-Cile. Finì 2-2. Segnò Vieri su mio assist ed io su rigore. La seconda partita la vincemmo 3-0 contro il Camerun. Presi un sacco di calci, tanto che Maldini fece entrare al mio posto Del Piero. Saltai la partita degli ottavi contro la Norvegia e rientrai ai quarti contro la Francia, padrona di casa. Entrai quasi allo scadere, sul pareggio, e per poco non segnai il gol della qualificazione. Invece andammo ai rigori e perdemmo. Io segnai il primo. Sbagliarono Albertini (come vi ha raccontato lui stesso lo scorso anno) e Di Biagio. Sono l’unico giocatore italiano ad aver segnato in tre mondiali. Per numero di 6 nei mondiali invece, ben 9, sono in compagnia di Vieri e Paolo Rosreti segnati si. L’ultima partita in nazionale l’ho giocata a Genova il 28 aprile 2004, a 37 anni. Mi volle Trapattoni in occasione di una partita amichevole contro la Spagna. Finì 1-1. Giocai alla mia maniera. Chiudevo, come avevo iniziato, con una partita amichevole, la mia carriera in nazionale. Ho avuto momenti esaltanti e lunghi periodi di sofferenza per i gravi infortuni che ho subito. Molti medici non hanno saputo spiegare come sia potuto ritornare sui campi di gioco. Io so che non è stato possibile con la mia sola forza di volontà … Ho avuto tantissimi riconoscimenti sportivi (il più importante il pallone d’oro del 1993) e ne vado orgoglioso; ma lo sono ancora di più per quelli sociali. Nel 2002 sono stato proclamato ambasciatore della FAO (il grande organismo dell’ONU che si occupa dei problemi derivanti dalla fame). Nel 2010 mi è stato assegnato il “Peace Summit Award” con questa motivazione: “per l’impegno forte e costante per la pace nel mondo e le relative attività internazionali”. Si tratta, ragazzi, di un riconoscimento assegnato ogni anno, da una commissione composta dai premi Nobel per la pace, a chi si è impegnato verso i più bisognosi. E’ il riconoscimento che amo di più, che sento più mio, perché l’ho ottenuto segnando con il cuore e non con i piedi. Vi lascio con le parole che ho letto a Sanremo. Prendetele come il consiglio di un amico che vi vuole bene, che vuole il vostro bene. “ A tutti i giovani e tra questi ci sono anche i miei tre figli. Per vent’anni ho fatto il calciatore. Questo certamente non mi rende un maestro di vita, ma ora mi piacerebbe occuparmi dei giovani, così preziosi e insostituibili. So che i giovani non amano i consigli, anch’io ero così. Io però, senza arroganza, stasera qualche consiglio lo vorrei dare. Vorrei invitare i giovani a riflettere su queste parole. La prima è passione. Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di voi. Non date retta a chi vi vuole influenzare. Guardatevi dentro e lì la troverete. La seconda è gioia. Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa. Ricor- 7 do la gioia nel volto stanco di mio padre e nel sorriso di mia madre nel metterci tutti e dieci, la sera, intorno ad una tavola apparecchiata. E’ proprio dalla gioia che nasce quella sensazione di completezza di chi sta vivendo pienamente la propria vita. La terza è coraggio. E’ fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere credendo in voi stessi. Avere problemi o sbagliare è semplicemente una cosa naturale, è necessario non farsi sconfiggere. La cosa più importante è sentirsi soddisfatti sapendo di aver dato tutto, di aver fatto del proprio meglio, a modo vostro e secondo le vostre capacità. Guardate al futuro e avanzate. La quarta è successo. Se seguite gioia e passione, allora si può parlare anche di successo, di questa parola che sembra essere rimasta l’unico valore nella nostra società. Ma cosa vuol dire avere successo? Per me vuol dire realizzare nella vita ciò che si è, nel modo migliore, e questo vale per il calciatore, il falegname, l’agricoltore o il fornaio... La quinta è sacrificio. Ho subito da giovane incidenti alle ginocchia che mi hanno creato problemi e dolori per tutta la carriera. Sono riuscito a convivere e convivo con quei dolori grazie al sacrificio che, vi assicuro, non è una brutta parola. Il sacrificio è l’essenza della vita, la porta per capirne il significato. La giovinezza è il tempo della costruzione, per questo dovete allenarvi bene adesso. Da ciò dipenderà il vostro futuro. Per questo gli anni che state vivendo sono così importanti. Non credete a ciò che arriva senza sacrificio. Non fidatevi, è un’illusione. Lo sforzo ed il duro lavoro costruiscono un ponte tra i sogni e la realtà. Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere il ragazzo che ero, che amava il calcio e andava a letto stringendo al petto un pallone. Oggi ho solo qualche capello bianco in più e tante vecchie cicatrici. Ma i miei sogni sono sempre gli stessi. Coloro che fanno sforzi continui sono sempre pieni di speranza. Abbracciate i vostri sogni e inseguiteli. Gli eroi quotidiani sono quelli che danno sempre il massimo nella vita. E’ questo che auguro a voi ed anche ai miei figli”. Guida alla riflessione. Ognuno, nei minuti di “deserto” può pensare e scrivere quello che il suo cuore gli ispira. Noi dello staff, per aiutarvi, vi suggeriamo di dare una vostra risposta a queste domande: 1) Cosa ti ha colpito di questo personaggio tanto da farlo diventare grande come atleta e come uomo? 1) Quale consiglio senti di poter far diventare tuo? 8 2) Sacrificio, fatica, impegno: li ritieni atteggiamenti utili per la tua vita? - Annota poi, giorno per giorno, i tuoi “Perché no?” che riesci a realizzare in questa settimana. Tipo: oggi sono riuscito a … Secondo giorno: NELSON MANDELA. Sono contentissimo, ragazzi, di essere tra voi. Consideratemi il nonno del vostro staff e il nonno bis o tris di tutti voi. Mi sono alzato prestissimo stamattina e mentre mi preparavo all’incontro con voi mi sono perso a guardare questo bellissimo panorama, questi prati, queste montagne, queste attrezzature sportive; ad ascoltare il vento, ad ammirare il volo delle rondini, a lasciarmi prendere dal suono delle campane dell’abbazia, da quello dei campanacci delle mucche al pascolo, dal fischio stridulo del trenino, dal rombo del torrente … Tutto così lontano e diverso dalla mia terra e dalla mia vita! Beati voi per l’esperienza che vi apprestate a vivere, beato tutto lo staff ad avere ragazzi così svegli e simpatici e beato anche me che ho l’onore di aiutarvi a riflettere su alcuni valori importanti per gli uomini di ogni tempo. Ho chiesto al vostro staff di poter guidare il momento formativo anche domani. Ho troppe cose da raccontarvi e non vorrei, per la fretta, trascurare proprio le più importanti. Sono stato accontentato. Oggi vi parlerò della mia giovinezza, della mia formazione, della situazione in cui il mio Paese si è venuto a trovare, dei miei progetti. Sono sicuro che, almeno di nome, mi conoscete tutti. Chi sa sintetizzare in una frase quello che ho fatto e per cui sono diventato famoso? … Prima di diventare “famoso” però ho dovuto subire e sopportare grandissime sofferenze e assurde umiliazioni … E non da solo purtroppo. Con me c’era un intero popolo di antica e nobile civiltà. Ma andiamo con ordine. Ho più di novant’anni, e ancora tanta voglia di fare e tanti progetti da realizzare, perché la mia battaglia per i diritti umani continua, deve continuare purtroppo anche oltre i confini della mia Patria. Sono nato il 18 luglio 1918 a Mvezo, un piccolo villaggio sulle rive del fiume Mbashe, in Sudafrica. Fui chiamato Rolihiahia, che nella mia lingua significa “che tira il ramo di un albero” cioè “attaccabrighe”. Un nome, un destino! Sono venuto al mondo proprio quando finiva la prima guerra mondiale e infuriava nel mondo una terribile epidemia influenzale, conosciuta in Europa come “la 9 spagnola”, che fece milioni e milioni di vittime. Alla pace di Versailles che doveva stabilire il nuovo assetto politico europeo e che tentò di mettere le basi per una pace duratura nel mondo, partecipò anche una delegazione dell’African National Congress (ANC) per denunciare le assurde ingiustizie che nella loro terra erano costretti a subire milioni di neri da parte di una minoranza razzista di bianchi. L’ANC era il partito a cui aderiva la maggioranza dei neri e una piccola schiera di bianchi illuminati e aperti ai problemi sociali. Di questo partito dovevo, dopo anni di lotta e sofferenze, divenire il leader indiscusso. Il Sudafrica è una splendida terra, dove il paesaggio è verde anche d’inverno. Mio padre era un capo villaggio, amato e rispettato, ma la sua autorità era condizionata dalla “fedeltà” al governo britannico a cui il Sudafrica apparteneva. Eravamo in pieno colonialismo. Molte nazioni europee si erano impadronite in pratica di tutto il continente africano, come se fosse terra di nessuno, con la scusa di “portare la civiltà a quelle disgraziate popolazioni primitive”. Mio padre era un uomo alto e di pelle scura, con un portamento solenne. Proprio sopra la fronte aveva un ciuffo di capelli bianchi. Ed io, da ragazzo, per essere come lui, prendevo della cenere e me la strofinavo tra i capelli. Ero ancora molto piccolo quando mio padre fu privato della sua autorità dal governatore inglese, perché, “camminava con la schiena diritta ed il capo eretto” davanti ai bianchi. La mia era una grande famiglia “allargata”. Nella cultura africana i figli delle proprie zie e dei propri zii sono considerati fratelli e sorelle, non cugini. Noi non pratichiamo le stesse distinzioni tra parenti in uso tra i bianchi. Non abbiamo fratellastri e sorellastre. La sorella di mia madre è mia madre; il figlio di mio zio è mio fratello; il figlio di mio fratello è mio figlio, o figlia. Tutto questo per dirvi che non sono mai stato e non mi sono mai sentito solo. In Africa la solitudine non esiste. Facevo il pastore: badavo alle pecore ed ai vitelli nei campi, amavo gli spazi aperti, gli animali, le piante, il respiro della natura. A cinque anni lavoravo come un grande, ma non mi pesava. La mia vita era sostenuta e modellata dalle nostre tradizioni, dalle nostre credenze, dai nostri rituali e dai nostri tabù. Di sicuro non ci sentivamo “primitivi” desiderosi e bisognosi di essere civilizzati. Al primo colonialismo dei bianchi boeri di origine olandese, si era sostituito in Sudafrica quello inglese, ma lo strapotere dei bianchi era rimasto assoluto. Possedevano tutte le ricchezze del Paese e pretendevano di essere padroni anche della nostra dignità. Eravamo schiavi nella nostra terra. Con le loro istituzioni i bianchi avevano portato nelle colonie anche la loro lingua e la loro religione, anzi le loro divisioni religiose. Molti si convertirono al cristianesimo. Alcuni perché convinti ed affascinati dal messaggio di amore di Cristo; altri perché si illudevano di migliorare le loro condizioni di vita o di essere più graditi ai bianchi. Mio padre rimase indifferente alla predicazione dei vari missio10 nari. Mia madre invece entrò a far parte della chiesa metodista e mi fece battezzare. Ero un bambino vivace ed intelligente e i missionari proposero ai miei genitori di farmi studiare. Mia madre era molto perplessa, nessuno era mai andato a scuola nella sua famiglia; mio padre invece accettò con entusiasmo, perché sapeva che solo con l’istruzione si possono conoscere e far valere i propri diritti. Avevo sette anni quando entrai in una scuola per la prima volta. Mio padre mi aveva adattato un suo vecchio paio di pantaloni per darmi un certo contegno ed una parvenza di eleganza. Mi andavano larghissimi, ma non ho mai portato nessun altro vestito con tanto orgoglio. La mia scuola era costituita da un un’unica stanza. La maestra, alla prima lezione, assegnò ad ogni alunno un nome in inglese. Il mio fu “Nelson”. Forse in onore dell’ammiraglio Nelson, il vincitore di Napoleone. Da allora e per tutti fui Nelson. L’istruzione che ricevetti era quella inglese. La cultura africana, per i colonialisti, non esisteva nemmeno. Avevo appena nove anni quando la mia vita cambiò radicalmente. Una grave malattia polmonare si portò via mio padre, il mio modello, la mia sicurezza. Mia madre decise di portarmi via dal villaggio in cui ero nato per accettare l’ospitalità e la protezione del capo Jongintaba, al quale mio padre prima di morire mi aveva affidato. Jongintaba era il sostituto del re e reggente del popolo Thembu. Lasciare il mio villaggio, i miei amici, i parenti, le mie abitudini, lo sentii come un’amputazione dell’anima. Per fortuna la mia vita migliorò in tutti i sensi. Il nuovo ambiente era molto accogliente e dignitoso. Jongintaba divenne il mio tutore, mi trattava come uno dei suoi figli e mi concesse i loro stessi privilegi. Mia madre, dopo alcuni giorni di permanenza nella grande casa del reggente, tornò nella sua capanna al villaggio. Non ci furono prediche, consigli, ammonimenti e nemmeno baci. Disse solo: “stai in gamba, figlio mio”. Non voleva che sentissi troppo pesante la sua mancanza. Prima di morire mio padre voleva per me un grande futuro. Sentiva che potevo trovarlo solo lontano dal mio villaggio. Ero solo un ragazzo, ma giurai a me stesso che non lo avrei deluso, che avrei sfruttato ogni opportunità, ogni occasione. Che in tutte le mie aspirazioni avrei gridato il mio “perché no?” I bambini si adattano in fretta, si dice, ai cambiamenti ed io mi lasciai conquistare da tutte le novità che ogni giorno mi cadevano ad11 dosso. Andavo a scuola volentieri e volentieri svolgevo i lavori che mi veni- vano affidati: aravo, guidavo il carro, facevo il pastore. Avevo il tempo però anche di giocare: cavalcavo, tiravo agli uccelli con la fionda, gareggiavo con gli altri bambini. A volte la notte danzavamo o ascoltavamo i racconti mitici del nostro popolo. La mia era una pluriclasse. Studiavo inglese, storia e geografia. Gli insegnanti mi presero a cuore e incoraggiavano la mia fame di sapere. Molto importante fu per me in quel periodo l’amicizia con i due figli del mio tutore: Justice e Nomafu. Justice era l’erede designato. Aveva 4 anni più di me ed eravamo diventati inseparabili. Era un ragazzo buono, generoso, sempre allegro. Bravissimo in tutti gli sport, specie nel rugby. Era amatissimo e le sue ammiratrici non si contavano. Con lui ho condiviso molti anni di studio, ho fatto le più svariate esperienze di vita e di lavoro fino a quando le nostre vite non si sono separate. Con il sostegno economico del mio tutore ho potuto frequentare le migliori scuole del Sudafrica, fino a laurearmi in legge. Un negro avvocato, non si era mai visto! Molte scuole erano state fondate ed erano rette con grande competenza dai missionari cristiani. Erano nettamente superiori a quelle statali e soprattutto non guardavano il colore della pelle dei loro alunni. Studiai con passione fino all’ultimo giorno di scuola. Se all’inizio lo facevo per mio padre, mia madre, il mio tutore e per migliorare il mio livello sociale, col tempo mi convinsi che dovevo farlo per il mio popolo: dovevo battermi per restituire giustizia, rispetto e dignità alla mia gente. Dopo la laurea entrai a far parte della direzione dell’African National Congress. Il mio impegno politico stava diventando la mia vita. Tutti voi, ragazzi, avrete sentito parlare di “apartheid”, i più grandi di voi sicuramente. Era un argomento trattato, dibattuto, discusso in tutte le scuole del mondo. Quel sistema era considerato la vergogna del mondo civile e doveva essere sradicato con ogni mezzo. L’Italia si dimostrò la nazione più sensibile e mi ha dato sempre un grandissimo sostegno morale. 12 La comunità internazionale aveva cercato in tutti i modi di costringe- re il governo razzista a cambiare rotta, ma senza risultati concreti. Furono imposti blocchi economici, furono interrotte relazioni diplomatiche, fu scatenata una fortissima campagna di stampa, fu impedita la partecipazione alle olimpiadi. Niente. Il governo razzista non cedette di un solo passo, forte delle immense ricchezze del territorio e della capillare organizzazione poliziesca. Apartheid significa separazione, ghettizzazione, proibizione assoluta per i neri di mescolarsi ai bianchi, di venire anche solo a contatto con i bianchi. Per non “sporcarli” con la loro inferiorità. Significa proibizione dei matrimoni misti, divieto di accesso ai quartieri abitati dai bianchi, separazione nei mezzi pubblici, nelle scuole, negli ospedali, nei locali pubblici, nei teatri, nei cinema. Significa proibizione di occupare cariche pubbliche, di esercitare alcuni mestieri e professioni. Apartheid significa razzismo, affermazione della superiorità della razza bianca, negazione dei diritti civili. Apartheid significa esistere per servire. I bianchi costituivano il 16% della popolazione totale del mio Paese e possedevano l’87% del territorio. Mi fermo qui. E’ troppo triste per me elencare le umiliazioni che eravamo costretti a subire nella nostra terra. Vedo, ragazzi, che anche voi, giustamente ne siete meravigliati e quasi increduli. A tanto arriva l’egoismo umano! Domani vi parlerò del mio impegno politico e di come sono diventato il primo presidente nero del Sudafrica. GUIDA ALLA RIFLESSIONE 1) Cosa intende dire Nelson quando afferma che: “in Africa la solitudine non esiste”? 2) Quale proposito di Nelson bambino pensi di poter fare tuo? 13 Terzo giorno: ancora NELSON MANDELA. Dove eravamo rimasti? Ah sì … Le ultime considerazioni riguardavano l’apartheid ed il razzismo. Ora vi racconterò di come sono riuscito a “liberare il mio Paese da questi due mostri”. L’African National Congress era costretto ad operare nella più assoluta clandestinità. I suoi capi erano considerati dei criminali e venivano, con le scuse più banali, condannati ad anni di carcere duro. Mia madre, i miei parenti, i miei amici, il mio tutore mi supplicavano di non lasciarmi travolgere dalla politica. Per loro troppo grande e troppo forte era il potere dei bianchi. Era impossibile abbatterlo. Non potevo ascoltarli, non volevo ascoltarli. Nella mia lotta e nel mio progetto politico io non volevo sostituire al potere dei bianchi quello dei neri. Volevo che nella mia terra tutti gli uomini, senza distinzione di razza e di religione vivessero in pace, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quel sogno, il mio sogno, doveva diventare realtà. Sapevo che negli Stati Uniti un pastore nero della Chiesa Battista stava lottando per i miei stessi ideali. Voi lo conoscete bene, vi ha raccontato la sua storia lo scorso anno e so che vi siete commossi per la sua morte. Luther King è stato mio sostegno morale e mio maestro. Mi ha onorato della sua amicizia e mi ha confortato nei momenti più difficili. Quando mi laureai in legge, come vi ho raccontato ieri, cominciai subito a difendere i neri in generale ed i membri dell’ANC in particolare, in tanti artificiosi processi inscenati con false accuse contro gli attivisti del nostro movimento. I bianchi prima cercarono di sottovalutarmi, di ridicolizzarmi, poi incominciarono a minacciarmi. Per fortuna mi imbattei nei tribunali in alcuni giudici che non avevano del tutto perso il rispetto di se stessi e della legge. Oltre l’attività di avvocato mi diedi anche ad organizzare pacifiche manifestazioni di protesta e a viaggiare in tutta l’Africa e in tutti gli Stati in cui potevo fare ascoltare il mio grido di dolore. Divenni mio malgrado famoso, ma la mia vita era costantemente in pericolo. Nei primi anni del mio attivismo politico avevo abbracciato il metodo della non 14Gandhi, ero convinto che il sistema di lotta del Mahatma fosse il più violenza di efficace. L’India, con la non violenza, era diventata una nazione indipendente e sovrana. Anche Luther King con la non violenza aveva ottenuto il riconoscimento dei diritti civili per i neri d’America. Anch’io volevo adottare lo stesso metodo di lotta. Ma di fronte ad una serie incredibile di sopraffazioni, di omicidi, di assurde violenze dei bianchi contro i neri inermi, dovetti però ricredermi. So di deludervi, ragazzi, ma in quella situazione era necessaria da parte di noi neri una prova di forza. I bianchi erano impazziti, la paura di perdere il loro potere li aveva portati a superare ogni limite di crudeltà. Gli arresti tra chi osava manifestare non si contavano più e la caccia ai membri dell’ANC divenne assoluta. Io non potevo fare eccezione. Mi ero salvato dalle carceri fino allora, ma avevo sulle spalle varie condanne di “messo al bando” che, limitavano la mia libertà di movimento e mi sottoponevano ad un costante controllo della polizia, anche se mi permettevano di stare in casa, con la mia famiglia. Il 25 e 26 giugno 1955 organizzammo, a poche miglia da Johannesburg, una grande manifestazione popolare che chiamammo “Il congresso del popolo”. Volevamo far conoscere al governo il nostro programma politico. Vi trascrivo alcuni passaggi che testimoniano la nostra buona fede ed il nostro desiderio di pace. “Noi, genti del Sudafrica, dichiariamo, perché il nostro Paese ed il mondo lo sappiano, che: • il Sudafrica appartiene a coloro che vi abitano, bianchi e neri, e che nessun governo può dichiararsi legittimo se non si fonda sulla volontà popolare; • il nostro popolo è stato derubato del diritto alla terra, alla pace, alla libertà da una forma di governo basata sull’ingiustizia e sull’ineguaglianza; • il nostro Paese non sarà libero di prosperare fino a che tutti i suoi cittadini non si considerino fratelli e non godano di uguali diritti e opportunità; • solo uno stato democratico fondato sulla volontà popolare può garantire a tutti il rispetto dei diritti fondamentali senza distinzione di colore, di razza, di sesso e di credo. • E quindi noi, popolo del Sudafrica, bianchi e neri insieme, come pari, compatrioti e fratelli, adottiamo questa carta della libertà. • Ci impegniamo inoltre a lottare congiuntamente, non risparmiando nulla del nostro coraggio e delle nostre forze, finché i cambiamenti democratici qui stabiliti non siano 15 stati conquistati.” Poi venivano elencati i vari diritti. • “Tutti gli uomini e le donne avranno il diritto di votare e di candidarsi per tutti gli ordini legislativi. • Tutto il popolo avrà il diritto di prendere parte all’amministrazione del Paese. • Tutti i gruppi nazionali e le razze saranno ammessi a pari condizioni negli organi dello stato, nei tribunali e nelle scuole. • L’apologia e la pratica del disprezzo e della discriminazione nazionale, razziale e di colore, saranno un crimine punito dalla legge. • Tutte le leggi e le pratiche dell’apartheid saranno abolite. • Le ricchezze nazionali del nostro Paese, patrimonio di tutti i sudafricani, saranno restituite al popolo. • Tutti i cittadini avranno diritto di commerciare e produrre dove vogliono, e di avere accesso a tutte le arti, i mestieri e le professioni. Eravamo orgogliosi di questa nostra carta della libertà. Nutrivamo grandi speranze di riappacificazione nazionale. E invece … La situazione si fece ancora più pesante. I massacri continuarono. La caccia agli attivisti dell’ANC si fece più serrata. Incominciai a temere rappresaglie anche verso la mia persona e la mia famiglia. La mattina del 5 dicembre 1956 fui arrestato con l’accusa di alto tradimento. Fui ospite di varie prigioni, prima di essere trasferito nella terribile prigione di Robben Island, in pieno oceano a sud di Città del Capo. Fu quello il mio mondo per circa 30 lunghissimi anni! Non ero solo. A soffrire con me c’erano decine di patrioti. Tutti assetati di giustizia, tutti decisi a resistere. Sulle mie spalle sentivo la responsabilità delle loro speranze e decisi di non deluderli. Poi, dopo tanti anni finalmente la situazione politica in Sudafrica cominciò a cambiare. La pressione diplomatica internazionale aveva costretto il governo a fare alcune concessioni. Tutti erano a conoscenza della mia ingiusta prigionia e il mio nome fu associato, come era avvenuto per Luther King, a tutte le lotte per i diritti civili. Nel 1979 mi fu assegnato in India il premio per i diritti umani “Jawaharlal Nehru”. Naturalmente non ebbi il permesso di partecipare alla cerimonia. Nel 1981 gli studenti dell’università di Londra mi candidarono, simbolicamente, alla carica onoraria di rettore. Tanti interventi e riconoscimenti spinsero il governo ad allentare le maglie del mio carcere duro. Così nel 1982 fui trasferito in un’altra prigione, a sudest di Città del Capo, con tre dei miei compagni di lotta. I locali erano ampi e dignitosi, avevamo persino dei veri servizi igienici. Nel 1984 fu conferito al vescovo anglicano Desmond Tutu, altro strenuo difensore dei diritti dei neri e mio carissimo amico, il premio Nobel per la pace. Questo riconoscimento indebolì ulteriormente il governo razzista. All’inizio del 1985, l’allora presidente, Botha dichiarò di essere disposto a libe16 rarmi se avessi abbandonato incondizionatamente la violenza come strumento di lotta politica. Questa offerta fu estesa a tutti i prigionieri politici. Io la respinsi, ma proposi di intraprendere insieme la strada dei negoziati e del dialogo. Il 10 febbraio 1985, era di domenica, mia figlia lesse, davanti ad un’immensa folla, la mia lettera di risposta al presidente Botha. Tra l’altro avevo scritto: “ Io non sono un violento. Soltanto nel momento in cui qualsiasi altra forma di resistenza ci era stata preclusa abbiamo preso la strada della lotta armata. (…) La mia libertà mi sta a cuore, ma mi sta a cuore molto di più la libertà del mio popolo (…) Quale libertà mi viene offerta se l’organizzazione del popolo riamane fuori legge? Quale libertà mi viene offerta se posso essere arrestato per la violazione di un permesso? Quale libertà mi viene offerta se non posso ricongiungermi alla mia famiglia? Quale libertà mi viene offerta se proprio i miei diritti di cittadino sudafricano non sono rispettati? (…) La mia libertà e quella del mio popolo non possono essere divise”. Iniziammo faticosamente i negoziati … Mi resi subito conto che i bianchi avevano paura che un cambio di governo o, per essere più chiari, un governo guidato dall’ANC, avrebbe scatenato una lunga catena di vendette. Risposi con quello che avevo scritto nella “Carta della libertà”: “Il Sudafrica appartiene a tutti coloro che lo abitano, bianchi e neri”. Ribadii che anche i bianchi erano africani come gli altri e che in un futuro governo la maggioranza avrebbe avuto bisogno della minoranza. Il 4 luglio 1989 il presidente Botha mi invitò ad un colloquio privato. Durante il colloquio fu cortese, amichevole, quasi ossequioso. Non arrivammo a risultati concreti, ma sentivo che non era più possibile tornare indietro. Un mese dopo Botha annunciò le sue dimissioni da presidente. Fu sostituito da De Klerk come presidente pro tempore. De Klerk era conosciuto come un normale funzionario di partito, poco incline alle riforme. Mi resi conto invece che non era un ideologo, ma un uomo pragmatico che considerava inevitabile un cambiamento radicale. Nel suo discorso di insediamento dichiarò che il suo governo voleva riportare la pace ed era disposto a trattare con chiunque fosse impegnato nella stessa direzione. 17 del Capo Capii che faceva sul serio quando fu organizzata una marcia a Città guidata dal vescovo Tutu. De Klerk autorizzò la marcia con la sola condizione che fosse pacifica. Decisi di incontrarlo quanto prima. Il 10 ottobre 1989 furono scarcerati i miei compagni di prigione e molti altri prigionieri politici. Sentivo vicina anche la mia liberazione. Poi il presidente De Klerk cominciò a smantellare molti capisaldi dell’apartheid. Aprì le spiagge sudafricane ai cittadini di tutte le razze, abolì la segregazione nei parchi, nei teatri, nei ristoranti, negli autobus, nelle biblioteche, nei gabinetti e in altri luoghi pubblici. Poi sciolse addirittura la polizia segreta istituita da Botha per combattere le forze antiapartheid. A partire dal 12 dicembre 1989 ebbi diversi incontri con lui. Fui chiaro ed irremovibile nelle mie richieste. Non volevo una finta democrazia, ma un’uguaglianza vera e totale tra tutti i cittadini. Solo su queste basi poteva nascere il nuovo Sudafrica. Il 2 febbraio 1990 De Klerk, di fronte al parlamento, pronunciò un discorso che gettò le basi di un cambiamento mai prima tentato da nessun capo sudafricano. Annunciava provvedimenti che eliminavano l’apartheid ed aprivano il paese alla democrazia. Tutti i partiti furono considerati legali e furono liberati tutti i prigionieri politici che non avevano commesso azioni violente. Per noi il mondo cambiava completamente dopo 40 anni di persecuzioni e divieti. La comunità internazionale applaudì l’azione coraggiosa del presidente. Il 9 febbraio ebbi con lui un altro incontro. Mi comunicò che il giorno seguente sarei stato scarcerato. Gli chiesi di rimandare di una settimana la mia liberazione per permettere alla mia famiglia ed al mio partito di prepararsi. Se fossi uscito di prigione il giorno dopo sarebbe stato il caos. De Klerk invece aveva organizzato alla grande la mia liberazione. Voleva che il mondo sapesse che il Sudafrica voltava definitivamente pagina. Un aereo mi avrebbe portato a Johannesburg; lì sarebbe iniziata la mia vita di uomo libero. Io invece volevo salutare i miei carcerieri e la popolazione di Città del Capo. Insomma “quando sarò libero – dissi – saprò io cosa è meglio per me”. Arrivammo ad un compromesso. Sarei stato scarcerato a Città del Capo, ma nella data da lui stabilita. Le televisioni e i giornalisti di tutto il mondo avrebbero 18dalla capitale la mia liberazione. annunciato Il presidente De Klerk versò due bicchieri di whisky per brindare. Alzai il bicchiere, ma feci solo finta di bere, perché il liquore era troppo forte per me. Uscii dal carcere la mattina dell’11 febbraio 1990. Era una limpida giornata di fine estate. Avevo settantun anni. Ero stato diecimila giorni in carcere. Dal balcone del municipio di Città del Capo pronunciai il mio primo discorso di uomo libero davanti ad un’immensa folla. “Amici, compagni, fratelli africani, vi saluto tutti in nome della pace, della democrazia e della libertà! Sono qui, davanti a voi non come profeta, ma come vostro umile servitore. E’ per i vostri instancabili, eroici sacrifici che oggi posso essere qui, e quindi pongo nelle vostre mani gli anni che mi restano da vivere”. Parlai dal profondo del cuore. Volli ringraziare tutti coloro che nel mondo avevano chiesto la mia liberazione, tutti i miei compagni di partito, i giovani a cui avevo dato e mi avevano restituito tanta speranza. Mi rivolsi alle donne africane che si riprendevano la loro dignità, a mia moglie e ai miei familiari che avevano sopportato sofferenze forse più grandi delle mie. Pronunciai un altro discorso al First National Bank Stadium di Soweto. Erano presenti 120.000 persone. Raccomandai alla mia gente di combattere ora ogni forma di degrado e di corruzione “perché la libertà senza civiltà, la libertà senza la possibilità di vivere in pace, non è vera libertà”. “Oggi ritornare a Soweto – dissi - mi riempie il cuore di gioia. Ma nello stesso tempo provo un profondo senso di tristezza nel vedere che qui la gente vive ancora in condizioni disumane. La carenza di case, la crisi del sistema educativo, la disoccupazione, la diffusione della criminalità sono problemi ancora presenti.” Ma le violenze continuarono. Nel marzo del 1990 la polizia aprì il fuoco, senza preavviso, su una folla di manifestanti. Ci furono 12 morti e centinaia di feriti. Ero molto amareggiato e minacciai il presidente De Klerk di interrompere i negoziati. Quel maledetto clima di violenza era favorito dalla polizia e dai servizi di sicurezza che non volevano accettare la fine del dominio dei bianchi. Nel novembre del 1992 il mio partito propose a De Klerk 19 un accordo di massima per un gover- no quinquennale di unità nazionale. Furono stabilite le elezioni per la fine del 1993. Le elezioni democratiche furono celebrate solo il 27 aprile 1994. Furono le prime elezioni non razziali a suffragio universale del Sudafrica. Per la prima volta la maggioranza nera si sarebbe recata alle urne per eleggere i suoi rappresentanti. Ne furono eletti 400 per comporre l’assemblea costituente con il compito di stilare la nuova costituzione. Nel 1994 mi fu assegnato, insieme a De Klerk, il premio Nobel per la pace. Ne fui profondamente commosso e orgoglioso. Alle elezioni del 27 aprile l’ANC ottenne il 62,6% dei voti. Ai festeggiamenti per la vittoria era presente Coretta Scott King, la vedova del grande Martin Luther King. Nel mio discorso volli rendere omaggio al martire per la libertà dei neri d’America. “Adesso possiamo gridare a gran voce la nostra gioia: siamo liberi, siamo liberi finalmente! Sono qui davanti a voi ammirato del vostro coraggio, con il cuore colmo d’amore per tutti voi. Considero un altissimo onore essere alla guida dell’ANC in questo momento della nostra storia. Sono il vostro servitore. Non sono gli individui che contano, ma la collettività. E’ il momento di guarire le antiche ferite e di costruire un nuovo Sudafrica”. Divenni così capo del primo governo democratico del Sudafrica. La mia missione fu quella di predicare la riconciliazione, di medicare le ferite del paese, di stimolare la fiducia e la confidenza reciproche. Non mi stancai di ricordare alla gente che la lotta di liberazione non era stata una battaglia contro un gruppo o una razza, ma contro un sistema di oppressione, e colsi ogni occasione per ripetere che ora i sudafricani dovevano prendersi per mano e dire tutti insieme: siamo un solo paese, una sola nazione, un solo popolo che marcia verso il futuro. Nominai due vicepresidenti: il mio compagno e grande patriota Thabo Mbeki e l’ultimo presidente bianco De Klerk. Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non tirarmi mai indietro. Ho fatto alcuni passi falsi lungo la mia via. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare. Adesso mi sono fermato un istante per riposare, per volgere lo sguardo sullo splendido panorama che mi circonda, per guardare la strada che ho percorso. Ma posso riposare solo qualche attimo perché, assieme alla libertà, vengono le responsabilità, ed io non oso trattenermi ancora. Ho tanto da fare … Guida alla riflessione 1) Cosa hai ammirato ed apprezzato di più di quello che ha fatto Nelson? 2) Prova anche a spiegare perché. 20 (Notizie e citazioni tratte da: “Lungo cammino verso la libertà” di Nelson Mandela) Quarto giorno: MARCELLO CANDIA. Sono contento quanto Nelson di essere qui con voi, ragazzi; ho conosciuto e condiviso il suo impegno civile; ho ammirato la sua costanza, il suo coraggio e la sua saggezza; ho esultato sinceramente per la sua vittoria. Forse pochi tra voi hanno sentito parlare di me. Non fa niente; anzi meglio così. Preferisco raccontarvi direttamente la mia storia; vedrete che gente più matta di me ce n’è e ce n’è stata veramente poca al mondo. Sono nato a Milano nel 1916, appena due anni prima di Nelson, ed ho avuto una vita apparentemente molto diversa dalla sua, perché in comune avevamo l’essenziale: un sincero amore per gli uomini. Prima della mia “grande decisione” ero un uomo ricco, rispettato, intraprendente, ammirato ed invidiato. Appartenevo ad una famiglia della Milano bene. Ho viaggiato molto, ho studiato con passione (ho preso 2 lauree con 110 e lode; una in chimica e l’altra in biologia), sono stato tenente di artiglieria durante la seconda guerra mondiale e, per venticinque anni ho diretto la fabbrica, ereditata da mio padre, che produceva anidride carbonica (quella per gasare le varie bevande che tanto piacciono a voi ragazzi) e la schiuma per gli estintori. L’avevo ingrandita e modernizzata; vi lavoravano 150 operai super specializzati. Vendevo in Italia e all’estero e gli affari andavano a gonfie vele. Mi consideravo un industriale moderno, aperto e sensibile ai problemi sociali. Con tutte le persone che lavoravano in fabbrica avevo creato un clima di fiducia e di rispetto reciproco. Ci sentivamo una grande famiglia e non c’era bisogno di scioperi e di proteste per attuare i famosi “diritti dei lavoratori”. Dicevo che ho viaggiato molto; preferivo i Paesi del cosiddetto terzo mondo. Avevo 21 anni quando mio padre mi regalò una crociera in Brasile. Viaggiai su un piroscafo famoso e lussuoso: l’Augustus”, ero vestito elegantemente, ci tenevo a sottolineare la mia appartenenza all’alta società. Per le serate mondane a bordo indossavo uno smoking bianco che era uno schianto. Ero ammirato e circondato dalle untuosità tipiche delle amicizie interessate. 21 A Rio de Janeiro presi alloggio nell’albergo più “in”; ma già il secondo giorno abbandonai i grattacieli e, ignorando tutte le raccomandazioni di prudenza, volli oltrepassare i confini della civiltà e mi avventurai nelle favelas. Ne avevo sentito parlare, ma altra cosa era immergersi direttamente in quel fango. Quelle donne, quegli uomini, quei bambini, quella vita, mi si stamparono nell’anima. Tutto il mio essere ne fu scombussolato. Non ero più io! Ero disorientato, stordito, incredulo … Eppure ero in qualche modo abituato ai poveri della mia Milano. Mia madre mi aveva coinvolto fin da bambino nei suoi giri di carità. Era una donna di grande fede e di grande sensibilità; instancabile nell’aiutare chi sapeva in difficoltà. Io la seguivo volentieri, non mi pesava lasciare i miei giochi, mi affascinava quella sua generosità, quel suo modo rispettoso e delicato di offrire aiuto. Il mio compito era quello di portare pacchi e pacchetti; lei portava il cuore. E ogni volta che tornavo nella mia bella casa sentivo uno strano senso di colpa o meglio, un bisogno indefinibile e confuso, data la mia giovane età, di fare di più. Con il passare degli anni, con la crescente esperienza che mi veniva dal lavoro, con la diretta conoscenza dei problemi attraverso gli studi ed i viaggi all’estero, quel disagio infantile diventò insopprimibile, fino ad esplodere. Ho visto le periferie del Cairo, di Dakar, di Smirne, di Bagdad, tutte uguali nella loro immensa miseria, tutte che gridavano al mio cuore “fai qualcosa! Non ti limitare alle solite considerazioni e a qualche lacrima di commiserazione”. Ma le favelas viste nel 1937 erano ancora peggio. Un uomo non può vivere così, mi diceva il cuore, la mente, la coscienza. Quando ne parlavo ai miei amici, ai miei parenti e anche ai miei operai, la risposta era sempre la stessa: “non puoi farci niente, non dipende da te, la colpa è dei politici, degli uomini di governo. A loro conviene mantenere nella povertà e nell’ignoranza il loro popolo”. Ma individuare i colpevoli non vuol dire risolvere i problemi. E poi è colpa di tutti 22 persone incapaci e disoneste. Se chi ci governa si comporta male se eleggiamo vuol dire che manca il necessario controllo, che i cittadini si disinteressano o peggio delegano troppo la gestione del bene comune. Ognuno di noi ha il dove- re di far sentire con forza critiche e proposte, di mandare a casa chi non è degno di rappresentarci perchè non ha un corretto comportamento morale, perhè non ha a cuore il bene comune, perchè pensa a procacciarsi privilegi ed onori che offendono la situazione dei cittadini comuni. Io ho ricevuto un’educazione cristiana essenziale, chiara e genuina. Ho imparato presto che il comandamento dell’amore verso Dio è vuoto se non sfocia nell’amore verso il prossimo. E quei milioni e milioni di diseredati erano il mio prossimo. Altro che non “puoi farci niente!” Dal Vangelo avevo imparato e mandato a memoria due brani in particolare: la parabola dei talenti e l’episodio del giovane ricco. Io di talenti ne avevo avuto almeno dieci: posizione sociale, studi, mezzi finanziari, esperienza, capacità organizzativa, amicizie importanti, sensibilità, una famiglia meravigliosa, il disagio interiore che mi spingeva a fare qualcosa di concreto, una fede genuina. Quindi ero obbligato come minimo a far raddoppiare i miei talenti; altrimenti, come dice in vangelo, il padrone, al suo ritorno, me li avrebbe tolti, li avrebbe dati ad altri e mi avrebbe considerato un servo incapace ed infedele. L’altro brano riguarda l’incontro di Gesù col giovane ricco. “Cosa devo fare per ottenere la vita eterna?” Aveva chiesto il giovane ricco a Gesù. Era sincero, nel suo desiderio di perfezione. Gesù gli disse semplicemente di osservare i comandamenti. Lui rispose che li osservava fin da bambino. Gesù, sottolinea il Vangelo, lo guardò con amore. “Se vuoi essere perfetto - gli disse allora - va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Poi vieni e seguimi”. Quel giovane non ebbe il coraggio di seguire il consiglio e l’invito di Gesù. Glielo impedirono le sue ricchezze o meglio l’incapacità di staccarsi da esse. Il Vangelo continua con le considerazioni di Gesù sulla salvezza dei ricchi. “ E’ più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli”. Che c’entro io col giovane ricco, già: che centravo! Io fin da giovane, con mia madre e sul suo esempio, avevo aiutato tanta gente. Non mi sentivo egoista. Eppure non mi bastava. Era diventato il mio pensiero dominante in tutte le pau23 ad ogni se e lontano dalle preoccupazioni del lavoro. Era il richiamo del cuore incontro con la povertà e la dignità dell’uomo offesa e calpestata. Facevo ad occhi aperti un sogno ricorrente bello ed allo stesso tempo angosciante: vedevo Gesù che mi sorrideva e mi tendeva la mano per invitarmi a seguirlo. Così un giorno afferrai quella mano e vendetti la mia fabbrica. Mi assicurai che i miei operai avrebbero conservato il lavoro, attraversai l’Atlantico e venni a costruire un ospedale a Macapà nella foresta amazzonica, col proposito di viverci e di morirci. Fu una storia di miliardi, il migliore dei miei investimenti. I primi a capirmi furono i miei operai e mi capirono così bene che da subito, e hanno sempre continuato a farlo, sono stati i più fedeli e generosi azionisti nella mia impresa di carità. Non avevo più una lira che fosse mia, ma non mi è mai mancato il denaro necessario per sostenere, in condizioni veramente difficili, il mio ospedale. C’erano 150 posti letto, sempre occupati come potete immaginare. Le visite ambulatoriali non si contavano e tutto era “miracolosamente” gratis. Io firmavo assegni per i fornitori, per i medici, per il personale infermieristico. A chi dubitava della copertura degli assegni, li rassicuravo con una frase che divenne storica: “non vi preoccupate, pago io”. Dove “io” stava per Provvidenza. E la Provvidenza aveva il volto, come dicevo, dei miei ex operai ed il cuore dei tanti milanesi e dei tantissimi amici che hanno poi conosciuto e condiviso la mia avventura. Mi davo da fare dalla mattina alla sera. Alla mia capacità organizzativa aggiungevo una buona dose di incoscienza, di finta sicurezza e anche un pizzico della classica spavalderia dell’industriale milanese. Mi credevano sulla parola e, quando non avevo contanti o assegni, mi facevano credito. Non mi bastava avere un ospedale dignitoso, capace di curare la popolazione di un territorio ben definito, volevo che fosse aperto alle necessità di quell’immenso territorio. Creai così una scuola per infermieri specializzati oltre che per il lavoro ospedaliero, anche nella medicina preventiva, nella cura della lebbra (allora ancora molto diffusa), nelle vaccinazioni, nelle visite a domicilio. Tutto questo significava spese a non finire. La soluzione era sempre la stessa, quella che ho detto prima. La mia “banca della Provvidenza” non conosceva la parola fallimento. Non ho avuto una mia famiglia, ma ho avuto più figli di quanti ne avrei potuto desiderare. Ragazze e ragazzi dal sorriso di sole, che ho amato e da cui sono stato amato con un legame più forte di ogni legame di sangue. Ho avuto veramente, in affetto e riconoscenza, il centuplo, come ha promesso Gesù ai suoi seguaci, su questa terra e la certezza che mi accoglierà nel suo paradiso, per completare la sua promessa. Ora mi conoscete almeno un po’, ragazzi. Avete capito che rientro a pieno titolo nel club dei cavalieri del “Perché no?” Non mi sono fermato davanti a nessuna difficoltà. Ho sempre osato, oltre ogni ostacolo. L’altro mio importantissimo “Perché no?” è stato Il lebbrosario di Maritu24 ba. 750 uomini, donne e anche bambini, accalcati in 60 costruzioni di un lazzaretto di stato. Baracche cadenti, marce, fatiscenti in una foresta di dolore in cui anche il canto degli uccelli rassomigliava ad un pianto struggente e disperato. Corpi in decomposizione, ma sospiri di anime degne d’amore. Arrivai a Marituba di notte. I guardiani dei cancelli spinati mi lasciarono passare. Loro che impedivano anche al vento di oltrepassare quel confine di morte. Marituba si trova a 25 chilometri dalla città di Belen, nello stato del Parà. A nordest dello sconfinato Brasile. Chi si ammala di lebbra deve scomparire dalla società civile, deve troncare ogni rapporto con gli altri uomini e rimanere solo, finchè dura il suo calvario. Lo stato, anziché curare i suoi figli, aveva inventato questo cimitero dei vivi. In quella notte senza stelle mi avvicinai ad ogni baracca, mi curvai ad ogni radice di albero che faceva da letto a monconi di carne. Non provavo alcun ribrezzo. Stringevo quel che rimaneva di una mano. Accarezzavo con gli occhi quei volti ridotti a solchi di lacrime, chiedendo a Gesù di ispirarmi una soluzione, di farmi capire come portare la sua presenza in quell’angolo di estremo dolore. Nel mondo ci sono cuori generosi più di quanto si immagina ed io ne trovai molti. Chiesi al governo di permettere ad un gruppo di suore di venire a vivere tra i lebbrosi. Non ricordo più le ore di umiliante anticamera che fui costretto a fare, ma alla fine la spuntai e vinsi quell’ignobile ipocrita burocrazia. Il mondo non doveva sapere che il grande Brasile, proiettato verso l’economia di mercato, nascondeva dei lebbrosi. Nel 1975 con i soldi della “Banca della Provvidenza” feci costruire “la casa di preghiera di nostra Signora della pace”. Vennero ad abitarla cinque suore, un vescovo, monsignor Aristide, più simile ad un contadino che ad un prelato di Santa Romana Chiesa e un allampanato cappellano, padre Valentino, reduce da una durissima missione in Birmania. Il cuore della casa era una piccola cappella, un generatore di “energia”, e sull’altare di radici contorte, una croce con un Cristo volutamente senza braccia e senza gambe. Come tanti di quei poveri infelici. Le suore erano giovanissime. Voglio farvele conoscere per affidarle alla vostra ammirazione. Si chiamavano: Eletta (35 anni di Bergamo), Celestina (58 anni di Cinisello Balsamo), Anna (31 anni di Amapà), Veronica (di 29 anni di Paranà), Stefania (di 48 anni di Angera). Si dedicavano alla cura dei corpi e delle anime. 25 Gesù era presente con le loro carezze, i loro sorrisi, le loro lacrime. Lo era soprattutto quando portavano l’eucaristia nelle capanne o cantavano i salmi sotto gli alberi al tramonto. Il lebbrosario era lontano 400 chilometri dall’ospedale di Macapà; era faticosissimo per me arrivarci, ma vi andavo a ricaricare le mie batterie di fede tutte le volte che potevo. Dopo quelle fatiche i miei amici medici di Milano e del Brasile mi obbligarono a ritirarmi a vita privata perché il mio cuore, dicevano loro, era troppo affaticato e poteva decidere di non battere più da un momento all’altro. Affidai così l’ospedale ai padri Camilliani e conservai per me una piccola stanza all’angolo nord dell’edificio. Mi restava però il privilegio di continuare a firmare assegni per non distogliere i buoni frati dal loro servizio ai malati. La mia stanza era vuota, ma nella mia scrivania avevo un cassetto speciale e segreto. Vi conservavo la “Cruzeiro do sul” la più alta onorificenza che il Brasile assegna ad uno straniero. Avevo accettato quell’onorificenza con orgoglio e come segno di legame assoluto con la meravigliosa terra brasiliana. Prima di lasciarvi, voglio raccontarvi un episodio che vi confermerà quanto ho cercato di trasmettervi sulla fiducia nella Provvidenza. Ero andato nel 1979 con due miei carissimi amici a San Paolo del Brasile. Una città fantastica, moderna, piena di grattacieli, grande 20 volte Milano. Pioveva. Avevo bisogno di un ombrello. Ero andato a comprarlo in un grande magazzino. Dovete sapere che quando mi spostavo dal mio ospedale portavo sempre con me una piccola borsa che in portoghese si chiama “pastina”. I miei amici e collaboratori la consideravano parte del mio abbigliamento, ma in realtà era la mia cassetta di sicurezza. Dentro avevo sempre una bella somma di denaro per pagare i vari creditori, dei documenti importanti che riguardavano le nostre attività e l’oggetto a me più caro: una corona del rosario che mi aveva donato Papa Wojtyla. Ero dunque entrato a comprarmi un ombrello, lo volevo semplice, ma robusto. Per provarlo avevo appoggiato la mia pastina su uno scaffale, un attimo, un solo attimo. Quando mi girai per riprenderla … volatilizzata! 26 subentrò la preoccupazione e poi il dispiacere. Per il soggiorno a Alla sorpresa San Paolo potevo contare sugli amici con cui avevo fatto il viaggio; il denaro lo avrei recuperato attraverso i tanti benefattori; i documenti li avrei rifatti. Ma per il rosario … Quello proprio era unico, era il mio legame fisico col grande Papa polacco, era la mia consolazione nei momenti difficili. Denunciai il furto senza alcuna speranza di ritrovare la mia pastina. Tornammo in albergo a tarda sera. I miei amici erano mortificati e tristi. Io pensavo alla mia corona del rosario. Prima di mettermi a letto, mi lamentai proprio di questo con Gesù. Poteva non ascoltarmi? La Provvidenza si materializzò nel suono stridulo del telefono. Era il direttore dell’albergo che mi passava la telefonata di una ragazza. Parlava in francese, una lingua che ben conoscevo, e mi diceva di aver trovato la mia pastina con dentro dei documenti, un rosario, ma senza un solo cruzeiro. Dai documenti aveva appreso il mio nome e per rintracciarmi aveva telefonato a molti alberghi, fatto annunci alle radio locali, interessato vari commissariati di polizia. Quella al mio albergo era proprio la sua ultima telefonata. Non riuscivo a parlare; Il solo “grazie” che pronunciai era rivolto più a Gesù che a lei. Mi raggiunse insieme al padre per consegnarmi personalmente la pastina. Erano due persone speciali. Quando li informai sulle mie attività e sul valore di quel rosario, scattò qualcosa che non so definire. Baciarono il rosario e poi la ragazza, una splendida ragazza, mi confidò che da tempo desiderava lavorare in un ospedale missionario. Ora è con me a Macapà. Il giorno dopo mi telefonò un ente assistenziale per dirmi che c’era stato un errore amministrativo nell’accordarmi una somma di denaro per i miei poveri. La somma era molto più alta di quella che in realtà avevo effettivamente ricevuto. Conclusione: un’anima bella si era aggiunta al mio ospedale; la somma che avevo nella pastina era più che raddoppiata; i documenti erano in perfetto stato; la corona del Papa era tornata a cantare le lodi di Maria, grano dopo grano, nelle mie mani. Si vede che il Signore aveva urgenza dei miei soldi in quel momento e si era servito. Il poveraccio che mi aveva derubato avrà potuto respirare per qualche giorno con la sua famiglia. La Provvidenza, come si sa, ha moltissimi clienti. PS. Marcello Candia è morto a Macapà nel 1983. Nel 1991 è stata avviata a Milano la causa per la beatificazione. Le sue opere continuano. Le fondazioni “Dott. Marcello Candia Onlus“ sono presenti in Italia e in molti Paesi del mondo. Guida alla riflessione. 1) Elenca, come ha fatto Marcello, i talenti che pensi di possedere e rifletti su come puoi farli fruttificare. 2) Cos’è per te la Procvvidenza. 3) A quale personaggio che conosci puoi paragonare Marcello Candia? 27 Torelli a (Notizie e citazioni tratte da: “ Da ricco che era”; intervista di Giorgio Marcello Candia) Quinto giorno: ALBERT EINSTEIN Tutti voi, cari ragazzi, avete visto la mia linguaccia (molto più lunga di quella di Del Piero esultante dopo i suoi gol) e la mia capigliature arruffata (molto più di quella di Angelo Branduardi che ci ha regalato l’inno Disentis 2013, imbiancata però e resa meno folta dall’età). Non mi dispiace quell’immagine, mi dicono che mi rende simpatico e dissacrante, come un discolaccio sempre in missione a compiere guai. Nella realtà sono ben diverso, anche se, devo riconoscerlo onestamente, mi è sempre piaciuto scandalizzare le persone “per bene”, a modo, “sedute”, rassegnate, sicure, che non cambiano mai idea, forti nelle loro personali verità. Nella mia esistenza ho fatto, come tutti, molti errori ed ho avuto molte contraddittorie opinioni sul mondo e sugli uomini. Gli errori ho cercato di correggerli; le opinioni le ho dovute cambiare costretto dalla storia, dalla realtà, e dall’ egoistico comportamento umano. Ho passato più giorni della mia vita a predicare la fratellanza e la pace che a portare avanti le mie intuizioni scientifiche. Mi piace riportare, prima di raccontarvi la mia vita, le cose belle che hanno scritto su di me, che condivido e in cui mi riconosco. • “fu uomo buono, affabile ed aperto”. • “Provò per gli uomini un profondo senso di solidarietà”. • “Odiava la guerra, gli istinti primitivi che la scatenano, la degradazione e la sofferenza che apporta”. • “Per un tragico destino, una sua idea aprì la strada alla più spaventosa arma di tutti i tempi: la bomba atomica”. • “Fu sprezzante dei dogmi e di ogni autorità precostituita”. • “Considerò la scienza come scoperta e liberazione”. • “Fu un coraggioso”. • “Apprezzò solo la verità”. • “Non esitò mai a parlare in difesa degli “eretici” e di tutti coloro che in questo nostro tempo disgraziato sono stati perseguitati per il loro spirito di indipendenza”. • “Gli furono ugualmente cari i valori della scienza e quelli etici”. • “Se i valori in cui ha creduto fossero meno calpestati, l’umanità potrebbe 28 verso un futuro più luminoso”. guardare Magari hanno esagerato, però veramente ho cercato di essere e di comportarmi così. Mancano i miei difetti … La lista sarebbe troppo lunga per trascriverli … E poi io desidero che seguiate i miei pregi, non le mie debolezze. Vi racconterò solo qualche episodio della mia vita perché mi preme di più farvi conoscere il mio pensiero. Sono nato a Hulm, in Germania nel 1879. I miei genitori erano di origine ebrea. Mio padre aveva una piccola azienda che produceva macchinari elettrici, ma gli affari non andavano troppo bene tanto che fummo costretti a trasferirci diverse volte alla ricerca di una situazione economica più stabile. E non è stato un male per me perché ho potuto vivere in varie città come: Monaco, Pavia, Berna, Milano e conoscere persone e culture che mi hanno arricchito. A 17 anni rinunciai alla cittadinanza tedesca per prendere quella svizzera. Mi trasferii a Zurigo dove terminai, senza eccellere, i miei studi. Colpa o merito di una dolcissima fanciulla serba, Mileva Maric, che incontrai in quell’università e che divenne mia moglie. La nostra unione fu allietata dalla nascita di 3 figli. Una bambina, Lieserl, che mori di scarlattina quando aveva appena un anno, e due maschi: Albert ed Eduard. Dopo la laurea trovai lavoro a Berna presso l’ufficio brevetti. Lì approfondii le mie intuizioni con studi, verifiche ed esperimenti. L’anno della svolta fu il 1905 quando le mie pubblicazioni scientifiche suscitarono l’interesse di molti studiosi. Quattro anni dopo ero professore all’università di Berna. Le mie scoperte fecero il giro del mondo e divenni molto famoso. Non è questo il luogo ed il momento per illustrarvi quello che la mia mente andava producendo. Vi trascrivo, semplificandoli, i nomi scientifici, sicuro che il vostro staff o i vostri genitori, quando tornate a casa, sapranno spiegarvi di che si tratta. “Quantificazione della luce”, “concetto di fotone”, dualismo “onda-particella nella meccanica quantistica”, ’”effetto fotoelettrico”, “teorie del campo unificante”, “meccanica statistica”, “teoria della radiazione”, “relatività della gravitazione o relatività generale”. Sono riuscito a meravigliarvi? Bene, è la mia specialità. Incominciarono ad arrivare inviti e incarichi da varie università; accettai le proposte di Praga, dove rimasi 3 anni, e soprattutto Berlino, dove insegnai per quasi 20 anni. Nel 1921 mi fu assegnato il premio Nobel per la fisica. Qualche anno dopo, nel 1927, sull’onda della mia notorietà, fui invitato dal go29celebrava verno italiano a partecipare al convegno internazionale dei fisici che a Como il centenario della morte di Alessandro Volta. Fui l’unico, tra i tanti scienziati, a rifiutare l’invito. Perchè? Rileggete la data … Il mio spirito libero non mi permetteva, con la mia presenza, di avvallare il regime dittatoriale fascista di Benito Mussolini. Quando Hitler, nel 1933 diede inizio alla più tragica dittatura della storia, mi trasferii negli Stati Uniti come “professore ospite” dell’università di Princeton. Hitler aveva subito indirizzato il suo odio contro gli ebrei. Tutti i professori universitari appartenenti alla mia “razza inferiore” furono licenziati. Gli scienziati tedeschi, che avevano osannato le mie scoperte ora le giudicavano frutto sviante della “fisica ebraica”, inferiore e falsa, in contrasto con la “ vera fisica ariana”. Nel 1940, distrutto moralmente dalle atrocità della guerra e di quanto stava avvenendo nella vecchia e, un tempo, civilissima Europa, accettai la cittadinanza americana e rimasi per sempre negli Stati Uniti. Nei campi di sterminio intanto si consumava la tragedia del mio popolo e di tanti altri poveri infelici, rastrellati nei territori occupati ed eliminati perché appartenenti ad una razza inferiore o semplicemente perché “diversi”. Tra quelle vittime ci furono anche alcuni miei parenti. L’Italia di Mussolini fu complice e collaboratrice di quel progetto infame. Mi fermo qui, ragazzi. Volevo farvi capire perché mi sentii moralmente costretto a consigliare il presidente degli Stati Uniti Roosevelt di affidare agli scienziati americani e ai molti scienziati europei, ebrei tedeschi ed italiani in particolare, che erano riusciti a fuggire da quell’inferno, la realizzazione della bomba atomica. Prima che arrivassero gli scienziati nazisti. Sì, i miei studi furono alla base della costruzione di quell’arma. Ma quando vidi i suoi effetti in Giappone e quando mi resi conto che la guerra non aveva insegnato niente ai nuovi governi, decisi di dedicare tutti i restanti anni della mia vita alla lotta per la riduzione e l’eliminazione delle armi nucleari. La mia vita terrena si è conclusa il 18 aprile 1955. Ho lasciato per testamento il mio corpo e in particolare il mio cervello alla scienza. Il mio corpo fu cremato, ma il mio cervello fu sezionato in 240 parti e consegnato ad altrettanti ricercatori. La parte più grande è ancora custodita nell’ospedale di Princeton. Macabro? No. Volevo permettere alla scienza di scoprire che cosa c’era di particolare nel mio cervello per giungere a quelle intuizioni e a quelle scoperte. Ora, che ho esaurito, spero, la vostra curiosità sulla mia vita, desidero chiarire meglio e condividere con voi il mio pensiero, senza pretendere di forzare la vostra volontà e di avere ragione su tutto quello che ho detto. Anzi mi piacerebbe essere contestato; forse il mio ed il vostro pensiero potrebbe essere complementare, utile a trovare qualche soluzione alle tante questioni che affliggono ancora l’umanità. Ecco cosa penso su alcuni temi che giudico importanti nella vita di un uomo. Non so se sono stato più scienziato che filosofo, più politico che filantropo, più uomo di cultura che costruttore di pace. 30 che più ho ammirato al primo posto in assoluto c’è Gandhi, l’apoTra le persone stolo della non violenza che voi avete conosciuto lo scorso anno. Sono convinto che le idee di Gandhi sulla libertà dei popoli si sono dimostrate le più illuminate e le più efficaci della storia. Noi dobbiamo rifiutare la violenza e lo scontro; dobbiamo convincerci che è sbagliato sostenere con la parola e l’azione tutto ciò che la nostra coscienza ritiene ingiusto. Dopo la II guerra mondiale ho sentito gravare sul cuore dell’uomo la minaccia di un nuovo e più distruttivo conflitto. Il mondo ancora spaccato tra due ideologie: capitalismo e comunismo. Qual è quella giusta? Io sono sempre stato favorevole ad un “socialismo democratico”. Ho sognato un’economia capace di rispettare i diritti umani, capace di trovare il giusto equilibrio tra il benessere del singolo individuo e quello della comunità intera. E poi le religioni! Invece di unire, elevare, purificare l’uomo, continuano a strumentalizzarlo, a imprigionarlo in mille forme di moralismo, ognuna con i suoi tradimenti alla parola che dicono aver ricevuto da Dio. Io sono molto restio a parlare della mia fede. Quando l’ho fatto era per reagire a quanti pretendevano di sapere meglio di me se credevo e in chi credevo. Molti mi hanno definito ateo. Niente di più falso. Mi sono allontanato, è vero, dalla concezione religiosa tradizionale ebraico-cristiana, ma credo in Dio. Credo in un Dio “oltre personale”, presente nella natura in modo misterioso. Ho sempre rispettato i valori contenuti in tutte le religioni, specie in quella ebraica e in quella cristiana. Ho ammirato moltissimo e sono stato fin da bambino affascinato da Gesù; da Gesù uomo della storia; da Gesù che appartiene a tutti gli uomini di tutti i tempi. Nessuno può leggere i vangeli senza rimanere coinvolto da quel messaggio di fratellanza, di giustizia e di pace. Non sono riuscito però a varcare i confini della ragione e credere nella sua divinità, nel suo essere figlio di Dio e Dio egli stesso. Non esiste alcuna contraddizione tra fede e scienza. La scienza senza religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca. In tutta la mia vita ho sentito il dovere di lottare per dare o restituire all’uomo la dignità calpestata, rapita o semplicemente ignorata. Tutta l’attività scientifica deve tendere a questo. Tutte le scoperte devono tendere a migliorare le condizioni di vita di tutti gli uomini, non di far star meglio e arricchire pochi privilegiati. Solo una vita vissuta per gli altri è una vita degna di essere vissuta. E siccome stiamo parlando di dignità, uguaglianza, di giustizia sociale, la prima istituzione destinata per sua natura a difendere la dignità umana è la scuola. La suola oltre ai contenuti specifici delle varie materie deve tramandare e far cono31 scere i valori che sono alla base della civiltà e far riflettere sulle sopraffazioni che un popolo ha subito o ha fatto subire. Deve trasmettere quella capacità critica che annienta il “subire” ed esalta il “collaborare”, cercando il bene comune. La scuola non deve produrre soggetti sottomessi, ma uomini liberi educati dall’amore e per l’amore. Perché non si riesce ad attuare una vera riforma educativa? Se la civilissima Europa ha prodotto in un breve periodo storico 4 terribili dittature (Stalin, Mussolini, Hitler, Franco) vuol dire che milioni di alunni non sono stati educati a ragionare con la propria testa, hanno lasciato che le forze del male si impossessassero della loro intelligenza e, come dicevamo, della loro capacità critica. Ogni dittatura vive sull’ignoranza. E’ sbagliato insegnare ai giovani che il successo è il supremo scopo della vita. E’ importante invece preparare i giovani alla vita in tutti i suoi aspetti e fare in modo che il lavoro diventi fonte di soddisfazione, di creatività e naturalmente di benessere personale e sociale. La scuola avrà adempiuto al suo compito solo quando ha formato individui con una personalità completa ed armoniosa, capaci di scegliere il loro futuro, di sviluppare i doni naturali che sono presenti in tutti, di operare in piena libertà, di non lasciarsi condizionare, di possedere e rimanere fedeli ai grandi valori della vita. Mi rendo conto, ragazzi, che sto esagerando. E’ facile dare consigli giusti agli altri, ma è difficile agire in modo giusto. E’ difficile, ma non impossibile. Bisogna osare … Tenere sempre presente il nostro personale “perché no?” Qualche pensiero sulla libertà. Ammettiamo che gli uomini svolgano il loro lavoro con la minore fatica possibile. Ammettiamo che con il lavoro producano il necessario per un’esistenza soddisfacente. Basta questo per essere felici? E allora da cosa dipende quell’indefinibile insoddisfazione che tanto spesso sentiamo in noi? Dipende dai limiti che ognuno di noi troppo spesso si pone o che gli altri ci impongono. Dipende dalla mancanza di libertà. Libertà significa poter esprimere le proprie opinioni, poter accedere a tutte le fonti di informazione per accrescere le proprie conoscenze, poter trasmettere i risultati dei nostri studi e delle nostre ricerche. Libertà significa non costringere l’uomo a vivere soltanto per il lavoro e privarlo di tempo e di energia per dedicarsi anche ad altri interessi ed attività personali. Libertà significa indipendenza di pensiero dalle limitazioni e dai pregiudizi. Libertà significa poter fare quanto è nei nostri mezzi e desideri senza arrecare danno a se stessi e agli altri. Ancora qualche parola sulla bomba atomica e sull’impegno degli scienziati. Con la scoperta di quest’arma micidiale le potenze occidentali misero fine ai progetti deliranti della Germania nazista, dell’Italia fascista e del Giappone impe32non raggiunsero la pace. rialista, ma Gli scienziati che hanno contribuito a creare l’arma più distruttiva di tutti i tempi furono tormentati da un senso di responsabilità e di colpa. Io più di tutti. Noi consegnammo quell’arma nelle mani degli americani e degli inglesi perché avevano combattuto contro dei mostri e promettevano al mondo finalmente la pace. Ma noi scienziati non vediamo garantita la pace. La guerra è stata vinta, ma non così la pace. Finita la guerra il mondo è sempre più diviso e la paura di una nuova e più terribile distruzione opprime le nostre coscienze. Il mondo doveva finalmente avviarsi alla liberazione del bisogno e invece la stragrande parte dell’umanità vive nella miseria mentre pochi privilegiati vivono nell’abbondanza. Le nazioni avevano ricevuto promesse di libertà e di giustizia, ma nuove gigantesche dittature si sono abbattute sull’umanità. Il blocco socialista ed il blocco capitalista si fronteggiano minacciosi e combattono un nuovo, ma non meno pericoloso, tipo di guerra: la guerra fredda. E con essa la corsa agli armamenti. Gli arsenali militari sono stati riempiti di migliaia e migliaia di ordigni nucleari che potrebbero distruggere mille volte l’intero nostro pianeta e che vengono prodotti con costi stratosferici, mentre milioni di persone continuano a morire di fame … Allora ho raccolto ed ho risposto all’invito di molti scienziati e uomini di buona volontà (come non ricordare il mio carissimo amico Albert Schweitzer che voi ben conoscete?) e ho girato il mondo per incontrare capi di stato, parlare nelle università, nei teatri e nelle piazze per dire: basta agli armamenti. Ho avuto la consolazione di aver fatto conoscere il problema e scosso l’opinione pubblica internazionale che ha costretto le varie potenze ad avviare i primi accordi per la riduzione e la messa a bando delle armi nucleari. Non basta. Vorrei che scomparissero dalla terra tutte le armi. “Più aratri e meno spade”. Per essere estremamente sintetico. Vorrei che tutte le ricerche e le scoperte scientifiche riguardassero il miglioramento della vita e l’elevazione morale dell’uomo, non la sua sopraffazione, la sua umiliazione, la sua morte. Grazie, ragazzi, per la vostra attenzione. Cercate, vi prego, di continuare nei modi e nella misura che potete i miei sogni, i miei “perché no?” Vi saluto con le parole che pronunciai quando ricevetti il premio Nobel. “Noi tutti che siamo impegnati per la pace e per il trionfo della ragione e della giustizia dobbiamo essere profondamente consapevoli di quanto poco la ragione e la buona volontà possono influenzare gli eventi politici. Ma comunque sia e qualunque sorte il destino ci riservi, possiamo essere sicuri che senza gli sforzi instancabili di coloro che si preoccupano del benessere dell’umanità nella sua totalità, la sorte del genere umano sarebbe ancora peggiore di quanto non sia ora”. Guida alla riflessione. 1) Cosa pensi della scienza e degli scienziati? 2) In quali settori gli scienziati dovrebbero concentrare maggiormente le loro ricerche 3) Quali pensieri di Einstein condividi di più? 33 (Notizie e citazioni tratte da “Pensieri degli anni difficili” di Albert Einstein) Sesto giorno: Alessandro Zanardi. Ciao, ragazzi, vi vedo in piena forma. Sta per finire questa vacanza e sono presenti in ciascuno di voi tutti i suoi effetti benefici, nel fisico e nell’umore. Così mi piacete e mi piacerete ancora di più quando vedrò realizzati tutti i propositi che avete fatto qui a Disentis sull’onda del “perché no?” Beh, se non proprio tutti, almeno qualcuno. Io, senza falsa modestia, posso definirmi il campione dei campioni del “perché no?” Lo capirete leggendo queste poche pagine. Mi presento intanto con qualche mia famosa battuta, tanto per darvi un’idea del mio carattere. • Io mi sento felice davanti ad un bicchiere vuoto, figuriamoci se lo trovo sul tavolo pieno a metà. • L’ottimismo esiste; la speranza non è solo un sentimento che affonda nel passato, ma si proietta prepotentemente nel futuro. • Se guardo il cielo e piove, le gocce di pioggia sono tinte di azzurro. • Io sono un ottimista. E’ una fortuna, non un merito. Questo mi permette di apprezzare le cose belle, desiderandole certo, ma senza dipendenza. • Io credo nella capacità dell’uomo di trovare sempre il modo di togliersi d’impaccio quando ha l’acqua alla gola. • Io ho avuto la fortuna di vivere una vita fantastica. E allora raccontiamola questa vita e cominciamo dalla fine … cioè dall’inizio … anzi da metà. Che confusione! Nella mia vita tutto coincide: fine ed inizio; metà 34 e fine; inizio e metà. Ho avuto almeno tre vite e non so quale sia quella giusta o meglio quella più bella e completa. Iniziare dalla fine significa dalla fine della mia vita di pilota “normale”, di pilota grandissimo in alcune specialità spettacolari, un po’ meno in formula uno; cominciare da quand’ero insomma molto conosciuto, apprezzato ed amato. Iniziare dall’inizio vuol dire dall’incidente, quando tutto faceva pensare che non esistevo più come pilota, come atleta, come uomo. Quando le mie gambe erano sparite, tritate, maciullate negli ingranaggi e nelle lamiere della mia monoposto. Iniziare da metà significa tutte e due le cose insieme, quando tutto sembrava finito, ma anche che tutto poteva, come è avvenuto,ricominciare. Ma incominciamo dalla mia esultanza ai giochi paralimpici di Londra 2012, quando con una sola mano tenevo altissima la mia handbike. Era il 5 settembre. Era la mia prima medaglia d’oro nella gara contro il tempo sul circuito di Brands Hatch. Due giorni dopo fui ancora medaglia d’oro nella prova su strada. L’8 arrivò la medaglia d’argento nella staffetta a squadre. Per tutti ero diventato un eroe, un simbolo, un esempio, ecc., ecc. Ma mi sentivo ed ero soltanto me stesso, quello che ero sempre stato: un uomo di sport, ma soprattutto un uomo che non si arrende mai, un uomo che fa di ogni avvenimento della vita un’occasione di crescita. Certo ero contento di quei risultati, ero orgoglioso di far sentire al mondo il nostro inno nazionale in un momento di crisi politica ed economica per l’Italia. Ero soprattutto felice del messaggio che davo, insieme a tutti gli atleti disabili, ai ragazzi di tutto il mondo. Con la forza di volontà, con la passione e con l’ottimismo si possono fare miracoli. La mia prima vita. Sono nato a Bologna il 23 ottobre 1966. Son cresciuto a pane e motori. Mio padre di mestiere era un idraulico, ma sapeva fare tutto, anche smontare e montare motori. Era un grande lavoratore. Non aveva orari. Si dava35 da fare per comprare la casa dei suoi sogni, che aveva adocchiato nel posto giusto del pa- ese, in cui voleva far crescere i suoi figli, una casetta di tre camere e un giardinetto. Mia mamma si occupava della famiglia e nel tempo rimanente, o meglio, rubando il tempo al sonno, faceva le camicie. Avevo una sorella, Cristina, di due anni più grande. Era uno strazio con la sua pignoleria, il suo ordine, la sua perfezione. Era, per giunta, anche bravissima a scuola, il punto di riferimento dei suoi compagni, la loro consigliera. Ero geloso di lei. La volevo tutta per me. Le volevo un bene dell’anima. Quanto l’ho rimpianta! Avevo 13 anni e lei 15 quando tornò in cielo per un maledetto incidente stradale. Fu un colpo durissimo per la mia famiglia. Ci stringemmo forte forte e reagimmo come sanno fare gli emiliani. La vita dà e toglie. Noi siamo abituati a guardare più spesso quello che dà. I miei primi giocattoli avevano tutti le ruote: dalle macchinine alle moto, dai camion ai trattori e perfino alle carrozzine. E fu proprio da una carrozzina per bambole di mia sorella che ricavai il mio primo go kart. Non c’erano nella zona strade in pendenza che non mi vedevano sfrecciare. A 14 anni disputai la mia prima gara con un vero go Kart costruito da mio padre. Negli anni ottenni risultati sempre più importanti fino a diventare campione italiano ed europeo. In quella specialità ho vissuto momenti esaltanti. Ricordo una gara in particolare; si disputava a Hong Kong. Mio padre, che mi seguiva ovunque, quella volta non poteva venire, ma il dio delle corse lo volle vicino a me. Ero il pilota ufficiale del team di go kart per il quale correvo. Davo per scontato che la mia vettura fosse perfetta. Io dovevo solo guidarla. E invece, poco prima della gara mi accorsi che il telaio era da buttar via. L’importatore locale l’aveva usato troppo, la scocca era piena di crepe, il sedile distrutto, l’asse storto. Mio padre si accorse della mia disperazione e in dialetto mi disse: ”Brisa preoccuperet, Sandren, Lo mettiamo a posto”. Con una corda e con un sasso costruì un filo a piombo, poi con l’assale di un vecchio go kart e alcune pietre raddrizzò il telaio. Trovò un trasformatore di corrente e lo fece funzionare come una saldatrice. Gli elettrodi li ricavò dal fil di ferro che rubò da una recinzione. Riuscì così ad eliminare tutte le crepe. Con quel telaio rabberciato vinsi la gara più impor36 tante dell’anno. Quell’intervento di “alta meccanica” da parte di mio padre mi insegnò a non arrendermi di fronte agli ostacoli, a ragionare sempre per cercare una soluzione. Di mio padre conservo un ricordo vivissimo, ma ho anche un grande rammarico. Se n’è andato troppo presto. Non ha avuto il tempo di condividere con me la gioia e l’orgoglio di tanti successi. Di vedermi reagire a tanti momenti difficili. Di rendersi conto di quanti insegnamenti preziosi mi aveva dato. Di vedermi contento della mia vita e sereno per la forza che mi trasmette mia moglie e l’entusiasmo contagioso che solo un figlio come il mio Niccolò può regalarmi. Dopo i go kart passai alla formula tre con una Dallara-Alfa Romeo, poi alla formula 3000 al volante di una Reynard fino ad approedare in formula uno nel 1991. I migliori risultati li ho ottenuti alla guida di una Lotus. Il mio primo grave incidente avvenne durante il gran premio del Belgio del 1993. Andai a sbattere a 250 chilometri all’ora contro le barriere che limitavano la pista. A causa della violenza dell’urto la mia schiena stava per disintegrarsi, invece resistette e mi ritrovai “cresciuto” di 3 centimetri. Ecco, ragazzi, un sistema per aumentare di statura in fretta, ma ve lo sconsiglio. Nel 1995 firmai un contratto che mi legava alle gare su pista molto diffuse e seguite negli Stati Uniti. Diventò la mia specialità. Conquistai due volte il titolo e divenni famosissimo per le mie vittorie spettacolari e per il mio carattere esuberante. Il 15 settembre del 2001 finì la mia prima vita ed iniziò la seconda. Si correva a Lausitzring in Germania sotto un autentico diluvio. Ero partito 22°. Riuscii a recuperare posizioni su posizioni fino a portarmi in testa. A 13 giri dalla fine, dopo aver compiuto la mia ultima sosta, uscendo dai box, persi improvvisamente il controllo della vettura, forse per la presenza di acqua e olio sulla traiettoria d’uscita. Feci un testa coda proprio al centro della pista mentre sopraggiungeva a oltre 300 chilometri orari la vettura di Alex Tagliani. L’impatto fu inevitabile e violentissimo. La mia macchina fu tranciata in due e con essa le mie gambe. Rischiai di morire dissanguato. Il mio cuore si fermò per ben sette volte. Ricevetti l’estrema unzione e fui trasportato in elicottero all’ospedale di Berlino più per scrupolo che con qualche speranza di salvarmi la vita. Quando giunsi in ospedale i miei parametri vitali si presentavano al di sotto di quelli stabiliti dalla NASA come limite minimo per la sopravvivenza. Per il manuale americano potevo solo morire, però dissi alla morte: “Morte, questa volta ho vinto io”. Il mio cuore riprese a battere perché dentro c’era una scintilla magica che lo rianimava. Mi tennero in coma farmacologico per tre giorni. In sei settimane subii una quindicina di operazioni, poi i medici mi rimandarono a casa per la riabilitazione. La riabilitazione e l’adattamento alle protesi fu un tormento. Ma quando al Motor Show di Bologna vollero premiarmi con un Casco d’Oro speciale e tutti si aspettavano di vedermi affranto su una sedia a rotelle, mi alzai in piedi ed iniziai il 37 mio discorso di ringraziamento così: “ragazzi, non fatemi questi scherzi. Per l’emozione mi tremano le gambe”. La gente piangeva, ma io sorridevo perché mi riprendevo la mia vita, perché l’incidente era un episodio che dovevo affrontare e risolvere. Ho messo la freccia e schiacciando sull’acceleratore ho sorpassato i miei guai. Ora sono nella mia terza vita. E sto facendo le cose che facevo nella prima e tante altre ancora. Ho ripreso a sciare, ad andare in barca, a fare pesca subacquea e … a correre nuovamente in macchina. Quando la gente mi domanda se non ho paura di affrontare simili rischi, rispondo che la vita è fatta di rischi e che, se vuoi vivere veramente, devi accettare che qualcosa possa accadere. Non sono un fatalista, tengo alla mia pelle, ma non voglio lasciarmi vivere. Io voglio vivere. E se dovessi rompermi una gamba, oggi mi basterebbe una chiave inglese da 4 millimetri e tornerei a posto in due minuti. La cosa più bella per me non è stato tornare a correre, ma comprarmi una moto a 4 ruote, andare a prendere mio figlio a scuola, vederlo crescere, fare la pizza con lui il sabato e tirarci addosso la farina con mia moglie che si arrabbia perché sporchiamo la cucina. Insegnargli a nuotare, leggergli una favola o guardare lo stesso cartone animato decine di volte, ridendo insieme per le stesse battute. “La mia vittoria più grande è stata pensare che, a dispetto di quel che è successo, per mio figlio sono ancora lo stesso papà di un tempo. Io per lui son sempre un cavaliere invincibile che lo ama e lo protegge”. Dopo la mia “guarigione” volli tornare a correre a Lausitzring per concludere la gara interrotta 18 mesi prima. Era una gara mondiale ed io ero stato chiamato per fare solo un’esibizione. Risultai il più veloce fra tutti i partecipanti. Fu la mia rivincita. Dopo la gara volli ringraziare gli organizzatori e la folla dei tifosi così: “Sono felice di aver corso in Germania oggi, perché anch’io ho il passaporto tedesco. All’ospedale di Berlino, dove sono stato ricoverato dopo il mio incidente, i dottori mi hanno trasfuso tanto, ma tanto sangue tedesco, per cui mi sento vostro consanguineo”. “Credo di aver percorso nella mia vita un cammino che mi ha dato saggezza, perlomeno più di quella che avevo. Ho capito che l’uomo si lascia tanto dominare dai cattivi pensieri quanto più ignora ciò che sta affrontando. Che se pone a se stesso un obiettivo impossibile continuerà a fare errori su errori, non sarà capace di dare il meglio di sé e di incontrare la felicità. E quando un uomo non è felice, difficilmente avrà qualcosa di buono da donare. Il sogno deve essere il motore che traina, la spinta che ti anima, ma dobbiamo sempre ragionare con la logica dell’obiettivo possibile, del traguardo che è alla tua portata”. Ecco, ragazzi, ho peccato ancora di presunzione, mi sono seduto in cattedra col microfonino attaccato alla camicia come faccio nelle mie trasmissioni televisive. Ma non lo faccio apposta, è il mio ottimismo che mi prende, è la forza della mia esperienza che mi spinge a dire: “osate, provate, tentate, ma senza pretendere da voi l’impossibile. 38 Nel mio programma “E se domani” sulla scienza e le nuove tecnologie non volevo trasmettere illusioni, ma fiducia e speranza. E in quello sulle “sfide” volevo fare conoscere e spiegare come hanno fatto tante “persone normali” a diventate “persone eccezionali”. Da voi questo voglio, questo spero e questo vi auguro. Guida alla riflessione 1) Ti sembra esagerato o fuori dalla realtà l’ottimismo e l’amore per la vita che Zanardi dimostra in ogni situazione? 2) Tu come ti comporti normalmente di fronte alle difficoltà? (Notizie e citazioni tratte da “Alex guarda il cielo” di Claudio Marcello Costa e Alessandro Zanardi). 39 Settimo giorno: JAVIER ZANETTI. Tutti i personaggi che mi hanno preceduto si sono dichiarati felicissimi di trovarsi tra voi, io lo sono più di loro perché siete ragazzi che amano lo sport ed io li conosco uno per uno questi tipi di ragazzi. So che tra di voi c’è qualcuno … 2 o tre… una diecina … una ventina … un centinaio … un miliardo di interisti e allora, così non ci pensiamo più, urliamo tutti insieme un bel “viva Inter!!!” Voglio ringraziare il vostro staff per avermi voluto tra i personaggi del momento formativo. Io non ho la pretesa di insegnarvi i grandi valori della vita. Voglio solo raccontarvi qualcosa della mia carriera e di quello che faccio oltre al calcio. Sarò contento se riuscirò a trasmettervi quel quid che vi faccia agire, tentare, provare ad emergere. Ricordatevi quel prezioso consiglio che Martin Luther King vi ha lasciato qualche anno fa: “Sii sempre il meglio di ciò che sei” con le tue forze, con i tuoi talenti, con le tue aspirazioni. Tutti sapete che le mie origini sono italiane, proprio come quelle del nuovo Papa Francesco che tra i tanti meriti e qualità ha anche quelli di amare il calcio. In Argentina gli “italiani” sono moltissimi, venuti da tutte le regioni d’Italia a cercare fortuna, ad iniziare una nuova vita lontano dalle brutture delle guerre e delle dittature che avevano distrutto l’Europa nel suo territorio, nei suoi abitanti, nella sua civiltà fin quasi alla metà del 1900. Alcuni sono poi rientrati personalmente in Italia, altri lo hanno fatto attraverso i loro discendenti. Io sono uno di questi, sono un emigrante di ritorno e in Italia ho trovato una seconda patria, un Paese che mi ha accolto quando ero uno sconosciuto, che mi ha dato tanto, che mi ha permesso di diventare un vero uomo di sport, di realizzare la mia storia d’amore con Paula, di veder nascere i miei figli. Vivo in uno dei posti più belli del mondo, sul lago di Como. Amo il cibo italiano, la musica italiana, l’arte, la letteratura, la storia, i tesori dell’archeologia grecoromana che questa nostra meravigliosa terra custodisce. Insomma non potrei vivere in un Paese migliore. Sto esagerando? Siete pronti ad elencarmi i tanti difetti degli italiani? Le tante situazioni che non vanno? Le degenerazioni della nostra classe politica? Ragazzi, tutte queste cose fanno parte della vita e quindi sono migliorabili, dipende dalla volontà di ognuno di noi, sì, in proporzione anche da voi, miei giovanissimi amici. Come? Facendo bene tutto quello che fate. Per tutti i motivi elencati, non ho alcuna intenzione di lasciare l’Italia e anche quando appenderò al fatidico chiodo le mie scarpette mi sentirò sempre la ban40 diera dell’Inter. Oggi sono pochi i giocatori che si affezionano ad una maglia, ma ci sono. Pensate a Maldini, Baresi, Albertini nel Milan; a Facchetti e Bergomi nell’Inter; a Scirea, Del Piero, Buffon nella Juve; a Totti e De Rossi nella Roma, a Di Natale nell’Udinese, ma ce ne sono tanti altri che ora non mi vengono in mente. Non è vero che noi calciatori siamo dei freddi mercenari che guardano solo ai soldi; forse è l’ambizione di giocare in squadre più prestigiose a spingerci a cambiare casacca. Noi ci affezioniamo ai compagni, all’allenatore, al Presidente e soprattutto ai tifosi. Per quanto riguarda la mia squadra io sono stato paragonato al grande Giacinto Facchetti … Non potevo pretendere di più. Fra pochi giorni e precisamente il 10 agosto compirò 40 anni … Molti mi chiedono il segreto della mia longevità calcistica. Non ho nessun segreto da nascondere, né nessuna pozione magica da consigliare. Devo ringraziare madre natura per avermi donato questo fisico e poi la mia serietà e costanza che mi hanno sempre spinto a fare una vita da atleta, sana, priva di eccessi. Non ho mai sgarrato, mi sono sempre allenato con la massima serietà e grande puntiglio (perfino la mattina del mio matrimonio) e, soprattutto, ho avuto la rara fortuna di non subire nessun infortunio grave. Almeno fino a domenica 28 aprile 2013 contro il Palermo. Eravamo sotto di un gol, non potevamo ancora perdere, non volevamo dare un’altra delusione ai nostri tifosi. Volai sulla fascia destra deciso a rimettere in piedi la partita; poi scartai all’improvviso verso il centro per evitare la marcatura di un avversario… Quel movimento troppo rapido mi ha spaccato il tendine d’achille costringendomi ad una lunga lontananza dai campi. Il dolore fisico non mi è pesato; il non giocare, il non poter dare una mano alla squadra, mi ha fatto invece stare veramente male. ma ho giurato che non mi fermerò a quarant’anni; il mio tendine ritornerà perfetto e mi vedrete ancora superare in velocità e potenza tanti calciatori ventenni. Vi dicevo all’inizio che non mi sento un maestro, uno di quei saggi che sanno dare le giuste direttive, ma ho l’ambizione di essere un esempio per i più giovani. Sono convinto che, con il solo talento, non si va da nessuna parte. Ci vuole spirito di sacrificio, costanza, applicazione, umiltà; saper stare in mezzo agli altri, sapersi confrontare, evitare ogni forma di invidia, accettare anche i propri limiti. Quando avevo la vostra età i miei eroi erano Kempes, Passarella, Bertoni, Tarantini, Ardiles. I vostri istruttori se li ricordano bene, alcuni hanno giocato anche in Italia. Sono gli eroi del mondiale 78. C’era 41 già Maradona, ma per quel mondiale fu considerato ancora acerbo dal commissario Luis Menotti. Si rifece, il grande Diego, nel mondiale del 1986. I festeggiamenti per la vittoria contro gli inglesi durarono intere settimane. Per noi era un riscatto generale, non una semplice vittoria di calcio. Poi venne il capolavoro della vittoria finale contro la Germania di un altro calciatore che ho ammirato moltissimo e che giocava, manco a dirlo, nell’Inter: Matthaus. Per strada ci salutavamo al grido: “Campeones!” “Ed io di notte sognavo. Sognavo di essere Diego, di dribblare tutta la difesa avversaria, di saltare il portiere e segnare, per poi lanciarmi in un’esultanza senza freni e raccogliere l’abbraccio e l’urlo della folla” La mia squadra del cuore era l’Indipendiente, quella dei “los diablos rojos”. Negli anni settanta l’Indipendiente vinse tutto quello che c’era da vincere: campionati, coppe Liberadores, coppe Intercontinentali. Aveva perso però, qualche anno prima (1964 e 1968), per due volte la coppa del mondo per club e sapete contro quale squadra? Tenetevi forte … Chi ha detto contro l’Inter? Sì bravo! Perse proprio contro la grande Inter di Herrera, di Facchetti, di Burgnic, di Corso, di Mazzola di … mi dispiace molto non ricordare tutta la formazione. Quell’Inter è paragonabile solo alla mia, quella di Mourinho, quella che “non ce n’era per nessuno”, quella di cui tutti voi ricordate la formazione al completo. L’Inter dunque vinse, per giunta allenata da un argentino giramondo, Helenio Herrera, contro la mia squadra. Il destino ha voluto che diventassi capitano dell’Inter, di quella squadra che, da bambino, consideravo nemica. Adesso l’Inter è casa mia! Ma per arrivarci ho percorso una strada lunga e faticosa. A soli 15 anni, quando ero riuscito ad entrare nelle giovanili dell’Indipendiente, mi ritrovai a spasso, scartato, tagliato fuori, eliminato. Motivo? Ero considerato troppo magro, troppo gracile, troppo basso. Restai fermo per un anno. Ero distrutto. Per la rabbia non volevo nemmeno vedere e toccare un pallone. Mi tirò fuori dal tunnel mio padre. Mi convinse a riprendere seriamente a studiare e a lavorare per aiutare il magro bilancio familiare. Feci il muratore, “il ragazzo del latte” e altri piccoli lavoretti. Il mio fisico si irrobustì e tutti quei sacrifici mi 42 fecero maturare. Ripresi gli allenamenti ed ebbi una nuova squadra: il Talleres, nella zona sud di Buenos Aires, poco distante dal quartiere dov’era cresciuto Maradona. Il Talleres era una società polisportiva con un’ottima squadra femminile di basket. La più brava era Paula. Ne fui folgorato. Ora è mia moglie e l’angelo di tutte le iniziative umanitarie di cui vado orgoglioso e che vi illustrerò più avanti. Il mio esordio tra i big dell’Argentina avvenne al Monumental, il mitico stadio del River Plate. Era il novembre del 1994, Daniel Passerella, il commissario della nazionale, inserì il mio nome nella rosa della seleccion. Incominciai ad essere famoso in patria. Per me questo era già come toccare il cielo con un dito, invece il bello doveva ancora arrivare, era solo iniziata la rincorsa sulla mia pista di decollo. Una sera, mentre ci trovavamo in tournée in Sudafrica con la nazionale argentina, Daniel Passarella venne a bussare alla mia camera per annunciarmi che voleva comprarmi l’Inter. Credevo si trattasse di uno scherzo, balbettai emozionato: “L’Inter? L’Inter di Milano? La squadra che sconfisse l’Indipendiente? La squadra dove hai giocato anche tu? La squadra dove ha giocato Matthaus?” Chi poteva aver fatto il mio nome ad uno dei club più famosi del mondo? Era stata una vecchia gloria argentina: Anton Valentin Angelillo, centravanti dell’Inter tra gli anni cinquanta e sessanta e che ancora detiene il record di reti segnate in un campionato italiano di serie A: 33. Cominciarono ad alternarsi nella mia testa dubbi, tristezza, timori e felicità. Avrei dovuto lasciare la mia patria, la mia famiglia, la mia Paula, i miei compagni di squadra. Felicità significava non lasciarmi sfuggire quell’occasione. Decisi di seguire quello che il destino mi offriva. Ho fatto, ora posso confermarlo, la scelta giusta. Fui presentato ufficialmente ai tifosi dell’Inter il 5 giugno 1995. Non so che impressione feci. Per quanto mi riguarda ero orgoglioso, emozionato, sicuro di essere arrivato a casa. Ma avevo bisogno di una guida … Mi venne incontro Giacinto Facchetti. Mi ha insegnato tutto. Mi ha fatto capire cosa significa indossare la maglia dell’Inter e che nel calcio contano i risultati, ma esistono valori molto più importanti: la lealtà, la correttezza, l’onestà, il rispetto degli avversari. A questi valori mi sono fin qui sempre attenuto. Chi mi conosce me ne può dare atto. Lo stesso comportamento raccomando a quelli che tra voi praticano una disciplina sportiva. Si gioca con qualcuno, non contro qualcuno. Si vince nel rispetto delle regole, non a qualunque costo. Si perde riconoscendo la superiorità dell’avversario, senza farne un dramma, anzi usando la sconfitta per crescere e migliorare nel carattere. Giacinto era un gigante buono, uno che incuteva rispetto, uno che non sprecava il 43 fiato in parole inutili, uno che non amava i ri- flettori e la notorietà. Uno che non ha mai abbassato la testa davanti ai potenti. Uno che aveva fatto proprio un celebre principio morale di Tolstoj: “ Più crederemo dipendere solo da noi l’esito delle nostre azioni, più questo sarà possibile”. Quando mi fu assegnata la fascia di capitano dell’Inter decisi di portarla con la stessa dignità ed onore di Giacinto Facchetti. Considero il più grande dei complimenti quello che mi definisce “il degno erede di Facchetti”. Sono convinto che un “capitano deve essere guida in campo e fuori. Nella mia carriera credo di non aver mai litigato con nessun avversario, né tantomeno insultato qualcuno. Non voglio passare per santo, ma sono così di carattere. Quando gioco do l’anima, ma non mi piace provocare, né ricorrere ad astuzie particolari. In tutta la mia vita ho subito una sola espulsione, per somma d’ammonizioni; peccato, avrei voluto concludere la mia carriera con la fedina calcistica immacolata. Pazienza. La mia correttezza in campo è stata riconosciuta e premiata in diverse occasioni. Nella mia bacheca spiccano 5 San Siro Gentleman, il riconoscimento assegnato al giocatore che mostra il maggior fair play in campo nelle partite disputate a Milano. Senza dimenticare altri premi, come “L’Altropallone” assegnato “a chi si batte per uno sport solidale”. Non mi sono mai piaciuti i capricci e le proteste in campo. E se qualche mio compagno si abbandona a scene isteriche sono il primo ad intervenire con lui con durezza ricordandogli che non gli è consentito offendere nessuno e tantomeno lo sport. Non voglio dilungarmi nel racconto dei miei lunghi anni nell’Inter. Con questo sono diciotto consecutivi. Mi ci vorrebbe un’enciclopedia. I successi sportivi li conoscete tutti. Vorrei invece parlarvi di alcune persone e di alcune esperienze che hanno dato sapore alla mia vita. Dopo Facchetti il primo giocatore e grande uomo da ricordare è “lo zio” Beppe Bergomi. Quel brav’uomo intuì il mio carattere generoso e mi incastrò subito in una delle tante sue iniziative umanitarie: i Bindun. Bindun è il nome di un’associazione che si batteva e si batte per regalare un sorriso a chi dalla vita ha avuto poche occasioni per sorridere. Si tratta in sostanza di racimolare soldi per avviare e sostenere case di accoglienza per ragazzi sfortunati o abbandonati a loro stessi. Non ci pensai un attimo ad entrare nel suo “club umanitario”. Da lì probabilmente è partita la scintilla per dare avvio, anni dopo, alla mia fondazione PUPI. La famiglia dell’Inter è impegnata in tante altre iniziative umanitarie e noi giocatori siamo fieri di appartenere ad una società che fuori dal campo è sempre in prima linea nella solidarietà. Una solidarietà mai sbandierata, ma concreta. Da anni, tanto per fare un esempio che riguarda da vicino il CSI, offriamo l’affiliazione e l’iscrizione ai campionati di calcio delle varie categorie agli oratori e a gruppi sportivi che non potrebbero sostenerne le spese. Lo stesso facciamo con i campus specifici che i nostri tecnici guidano in varie nazioni del terzo mondo. La più originale è quella legata alla causa zapatista e al subcomandante Mar44 raccolto fondi per costruire un acquedotto per il villaggio di Zinacos. Abbiamo cantan, spedire medicinali e acquistare un’ambulanza per le persone che vivono al confine tra Messico e Guatemala, le sfortunate popolazioni del Chiapas. Per sostenere questo progetto avevamo deciso di destinarvi tutti i soldi derivanti dalle multe prese da noi calciatori per i ritardi agli allenamenti o per le sanzioni disciplinari. Non posso dire che molti di noi facevano apposta ad arrivare in ritardo o a farsi dare il cartellino giallo nelle partite, ma sicuramente non ne eravamo troppo dispiaciuti. Nella nostra sede fa ancora bella mostra la lettera di ringraziamento che ci inviò il comandante Marcos e la foto in cui lui, con addosso il solito passamontagna, tiene in mano la mia maglia nerazzurra numero 4. La lettera tra l’altro diceva: “Fratelli nerazzurri vi invitiamo in questa terra per condividere idee ed esperienze”. Ci voleva persino ad un incontro amichevole con la nazionale “dell’esercito zapatista di liberazione nazionale.” Non siamo arrivati a tanto, ma lo spirito di condivisione era quello. Altro nostro vanto è aderire alle iniziative di Emergency di Gino Strada che cura tutte le vittime delle guerre. L’ultimo sostegno, in ordine di tempo, lo abbiamo dato alla lotta contro la mosca tse-tse che, in Africa e soprattutto in Congo, causa la terribile malattia del sonno. Pensate, ragazzi, che è stato scientificamente provato, proibito ridere, non sto scherzando, che i nostri colori ipnotizzano la mosca e le impediscono di pungere le sue vittime. Questo merito lo condividiamo con l’Atalanta che si fregia dei nostri stessi colori sociali. Non c’è cosa più bella che aiutare, a ogni latitudine, in ogni modo, con ogni mezzo. Ora voglio parlarvi della mia creatura: la fondazione PUPI. Tutto cominciò con la terribile crisi economica che colpì l’Argentina nel 2001. Paula ed io guardavamo angosciati le immagini di miseria e di disperazione che giungevano dal nostro Paese. Io mi vergognavo dei tanti pseudo problemi di cui 45 ero circondato. Ci rendevamo conto che a pagare le maggiori conseguenze nella nostra terra erano i bambini dei quartieri più poveri delle nostre metropoli. Mentre al tempo della dittatura dei colonnelli il popolo era stato privato della libertà, ora lo era anche del pane quotidiano. Provavamo un senso di rabbia perché l’Argentina è sempre stata uno dei maggiori esportatori di generi alimentari al mondo. Quella crisi stava sbriciolando ogni speranza. Mia moglie ed io allora decidemmo di fare qualcosa. L’esperienza con l’associazione di Beppe Bergomi ci spinse a non avere paura, a osare, a credere che molte persone generose, a cominciare dai miei compagni di squadra, ci avrebbero aiutato. Ero diventato un calciatore molto famoso anche fuori dall’Italia, decisi di sfruttare la mia notorietà. Non facemmo alcuna fatica a scegliere il nome della fondazione, la chiamammo PUPI. Pupi era il mio nomignolo calcistico, lo facemmo diventare l’acronimo di “Por un piberio integrado”, ossia “Per un’infanzia integrata”. Gli obiettivi della nostra fondazione erano molto chiari: garantire ai bambini alimentazione, educazione, igiene mantenendoli nel loro ambiente e quindi aiutando anche le loro famiglie. Nelle aree urbane dell’Argentina abitano più di due milioni e mezzo di bambini da zero a nove anni. La metà vive in estrema povertà. Nel distretto di Lanus si registra la situazione più disperata. Decidemmo di concentrare il nostro intervento in quel territorio. Poco distante da Lanus c’è Villa Fiorito, il quartiere dov’è nato Maradona. I bambini sono lasciati allo sbando, vivono di espedienti, spesso sono costretti da bande di criminali a vendere droga, a mendicare, a prostituirsi. Abbiamo iniziato con 23 bambini segnalatici dall’assistenza sociale. Oggi Paula ed io siamo genitori adottivi di 150 bambini e siamo sicuri che aumenteranno. Con l’aiuto di tanti amici siamo arrivati a dare speranza di un futuro ad oltre mille persone, calcolando anche i familiari dei bambini. I responsabili della fondazione PUPI sono persone che appartengono quasi tutte alla mia famiglia: mio suocero, ex professore d’università, è il presidente; mia suocera, che è una psicologa, si occupa dei problemi educativi; Paula ed io siamo i ministri dell’economia. La struttura logistica della fondazione è diventata punto di riferimento e vera casa per moltissimi bambini. All’inizio i nostri piccoli ospiti rimanevano nella casa dal lunedì al venerdì, poi tornavano nel loro misero quartiere per il sabato e 46 Non volevamo sradicarli. Ci accorgemmo però che questo sistema la domenica. non funzionava. In quei due giorni svanivano tutti i benefici e i frutti del nostro lavoro. Adottammo allora un programma integrale coinvolgendo i familiari. Lo facemmo preparare da un’equipe di esperti; ve lo riassumo così: al mattino ogni bambino viene prelevato dalla propria abitazione e portato in pullman all’asilo o a scuola. Al termine delle lezioni vengono accompagnati alla fondazione dove pranzano e quindi iniziano tutta una serie di attività a seconda dei loro bisogni e attitudini: musica, ginnastica, danza, disegno, teatro, nuoto, rugby e, ovviamente calcio. Qui entra in azione la mia Inter con i suoi istruttori che organizzano, in estate, un campus tutto speciale a cui partecipano anche i ragazzi della zona. Chi ha bisogno di attenzioni e cure particolari può contare sull’aiuto di uno psicoterapeuta. Attorno alla struttura principale stanno sorgendo ora altre case con attività dirette ai familiari. Le donne imparano a cucire; gli uomini a fare il falegname, il contadino, il muratore, ecc. Una piccola abitazione ospita le donne incinte e i neonati. Molti medici, infermieri ed ostetrici offrono gratuitamente, fuori dal loro orario di lavoro, la loro opera. I progressi che abbiamo visto in tanti bambini ci ripagano abbondantemente dei sacrifici che facciamo. Paula ed io torniamo in Argentina ogni volta che possiamo ed è superfluo dirvi che il tempo maggiore lo passiamo con “i nostri bambini”. L’accoglienza è sempre incredibilmente festosa; ci sommergono di abbracci, vogliono mostrarci i loro progressi, farci conoscere i nuovi arrivati. Alcune storie mi stanno particolarmente a cuore. Martin era un bambino dato per sordomuto. Le cure e l’affetto lo hanno guarito. Ogni volta che lo incontriamo, ci salta addosso gridando: “Javier!!!, Paula!!!” poi parla e parla come un fiume in piena. Gisela era venuta nella fondazione a 4 anni, segnalata con un grave ritardo mentale. In due anni le nostre pedagogiste hanno fatto miracoli. Ora frequenta regolarmente la scuola elementare ed il suo quoziente intellettivo è considerato nella norma. Nazarena era stata per anni vittima di un padre alcolizzato e violento. Aveva solo cinque anni quando è arrivata da noi. Aveva un bisogno vitale di affetto. Ora vive con la nonna. Ride, gioca, scherza come tutti i bambini. Infine c’è Denise. A 4 anni non riusciva a camminare a causa di una lieve malformazione fisica. Nessuno l’aveva aiutata, nessuno le era stato accanto, nessuno l’aveva incoraggiata. Un nostro fisioterapista l’ha seguita per 12 mesi. Ora cammina perfettamente. Non avrei potuto realizzare tutto quello che vi ho raccontato senza l’aiuto determinante dei miei compagni di squadra, di tanti tifosi e la determinazione di mia moglie Paula. Capite benissimo che una fondazione come la mia ha bisogno continuamente di molto denaro. Siamo riusciti per ora a contenere le spese entro i 300.000 euro l’anno. Paula è inesauribile, organizza eventi, aste di beneficenza (con i trofei sportivi che mi hanno regalato i giocatori delle squadre che ho incontrato in tutti questi anni), sfilate di moda, concorsi canori (vi partecipo anch’io e alcuni miei compa47 i persogni di squadra a cui piace cantare), calendari, ecc. Riesce a coinvolgere naggi più impensati (molti sono famosi e vogliono rimanere nell’anonimato). Non c’è nulla di più bello che essere di aiuto agli altri. Il 25 aprile 2013 ho avuto la fortuna di incontrare una persona veramente speciale: Papa Francesco. Ci tenevo moltissimo. Un Papa argentino come me. Di origini italiane come me. Appassionato di calcio quasi quanto me. Sensibile verso i bisognosi più di me. L’ho incontrato con mia moglie ed i miei bambini in visita privata. Eravamo emozionatissimi, ma lo abbiamo subito sentito amico. Gli abbiamo parlato della nostra fondazione “PUPI”, dei campus che l’Inter organizza e sostiene in molti Paesi Sudamericani, dei bambini che abbiamo adottato. Ha stretto a lungo le nostre mani nelle sue e, con la sua voce calma, quasi sussurrando ci ha detto: “Continuate così… Dio vi benedica”. Ora Vi lascio, ragazzi, facendovi le stesse raccomandazioni e auguri che rivolgo ai miei figli Sol e Ignacio. “L’affetto e l’amore non si misurano solo con i regali e le carezze; voglio che cresciate in un ambiente sano e che abbiate tutte le possibilità di scegliere, ma che capiate anche che nella vita bisogna sempre darsi da fare per raggiungere degli obiettivi”. Guida alla riflessione Ci sentiamo di dirti soltanto: “Bravo Javier! Ricevere e dare. Grazie della lezione. Nel nostro piccolo proveremo anche noi a comportarci così. (Notizie e citazioni tratte da “Javier Zanetti: Capitano e gentiluomo”). 48 Conclusione Potevamo scegliere molti altri personaggi per farci da guida in questa nostra settimana sportiva. Per fortuna non mancano gli esempi positivi. Di una in particolare avremmo voluto raccontarvi la storia: Rita Levi Montalcini. La nostra grandissima scienziata; l’unica donna italiana insignita del Nobel per la medicina, per i suoi studi sul cervello. Rita è morta il 30 dicembre del 2012 a 103 anni, sempre attiva, sempre incredibilmente impegnata in tutto, anche in politica da quando, per i suoi meriti, era stata nominata senatrice a vita. A conclusione del nostro libretto ci facciamo regalare da lei alcune perle della sua saggezza. Facciamone tesoro. • Credo che il mio cervello sostanzialmente sia lo stesso di quando ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni. E non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell’organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare. • Penso più adesso di quando avevo vent’anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente. • Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita. • Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. • Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto il bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. • Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi. • Il futuro del pianeta dipende dalla possibilità di dare a tutte le donne l’accesso all’istruzione ed alle leadership. E’ alle donne infatti che spetta il compito più arduo, ma più costruttivo, di inventare e gestire la pace. • Tutti dicono che il cervello è l’organo più complesso del corpo umano, da medico potrei anche acconsentire. Ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore. Ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c’è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni. • Quando muore il corpo sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. Il tuo staff 49 SI PUÒ FARE INNO DISENTIS 2013 50 Si può fare, si può fare si può prendere o lasciare si può fare, si può fare puoi correre e volare. Puoi cantare e puoi gridare puoi vendere e comprare puoi rubare e regalare puoi piangere e ballare. Si può fare, si può fare puoi prendere o lasciare puoi volere e puoi lottare fermarti e rinunciare. Si può fare, si può fare puoi prendere o lasciare si può crescere e cambiare continuare a navigare. Si può fare, si può fare si può prendere o lasciare si può fare, si può fare partire e ritornare. Puoi tradire e conquistare puoi dire e poi negare puoi giocare e lavorare odiare e poi amare. Si può fare, si può fare puoi prendere o lasciare puoi volere, puoi lottare fermarti e rinunciare. Si può fare, si può fare puoi prendere o lasciare si può crescere e cambiare continuare a navigare si può fare, si può fare si può prendere o lasciare si può fare, si può fare mangiare e digiunare. Puoi dormire e puoi soffrire puoi ridere e sognare puoi cadere e puoi sbagliare e poi ricominciare. Si può fare, si può fare puoi prendere o lasciare puoi volere, puoi lottare fermarti e rinunciare. Si può fare, si può fare puoi prendere o lasciare si può crescere e cambiare continuare a navigare si può fare si può fare puoi vendere e comprare puoi partire e ritornare E poi ricominciare. si può fare, si può fare puoi correre e volare. si può piangere e ballare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare si può prendere o lasciare si può fare, si può fare puoi chiedere e trovare. Insegnare e raccontare puoi fingere e mentire, poi distruggere e incendiare e ancora riprovare. si può fare, si può fare si può fare, si può fare si può fare, si può fare si può fare, si può fare si può fare, si può fare 51 52 Elaborazione grafica di Gelasio Paolo - CSI Varese
Scarica