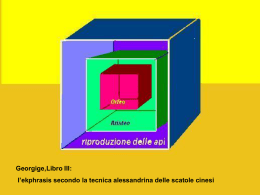LUCIA PERGREFFI “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” (Adone, V, 137) Lett(erat)ura di due Orfeo del Seicento 1. Aminta /Armida. I due libretti in questione sono quello parigino del 1647 del quasi dimenticato Buti e quello veneziano dell’Aureli (con un occhio al libretto monteverdiano di Striggio). E se non è quasi possibile una lettura di testi stesi per musica senza il canto, loro prezioso e vivificante supporto, qui ci si è provato, per indagare gli ascendenti letterari non meno degli altri aspetti più “di mestiere” che condizionavano il letterato per musica. Ché se il teatro in musica nacque dall’iniziativa filologico-poetica di chi aspirava ad una resurrezione della tragedia greca e della sua musicalità di verso, non meno fu debitore in questa ricercata armonia sonora, ai sapienti verseggiatori del Quattro e Cinquecento: il Poliziano volgare – traduttore in lingua e genere italico della vicenda di Orfeo– e soprattutto Tasso e Guarini, autori dei versi preferiti dai compositori contemporanei. Dapprincipio, infatti, i letterati e poeti che parteciparono al grande esperimento del dramma per musica, Rinuccini, Rospigliosi, Striggio, Chiabrera, lo fecero senza uscire dal solco della tradizione armonica e pastorale che pervadeva le loro accademie ed educava musicalmente il loro orecchio. Il grande successo della pastorale infatti, anche a prescindere dalla sua funzione di ponte verso il mondo dell’opera, era dovuto soprattutto a questa sua caratteristica di indugio quasi musicale sulla voce sola del personaggio parlante, oltre che all’opportunità di trasfigurare la realtà della corte spettatrice in un mondo boschereccio e favoloso. Come osserva il Pieri in relazione ai primi libretti, “L’Aminta”, così musicale da essere ancora oggi letto come un piccolo melodramma senza musica, “canta in essi un canto inesausto”1. Se, del resto, l’Aminta è il frutto maturo della sperimentazione poetica e musicale del Tasso dei madrigali, il suo stile non poteva che essere quello di un grande componimento musicale, che proprio dal melodico ritorno di suoni e parole, traesse la sua coerenza e la sua raffinatezza. Analogo discorso può valere per l’altra grande pastorale, sul finire del secolo dei poemi cavallereschi e del rinato teatro: Il pastor fido, forse meno melodico e più teatrale, così ricco d’intrecci, ma pur sempre costruito secondo lo stesso principio della ripetizione, come un madrigale a voce sola. Del resto, fu proprio il passaggio graduale, ma sempre – quantitativamente e geograficamente più risoluto dalle armonie contrappuntistiche al madrigale monodico, ad incidere in modo determinante non solo sulla 1 Cfr. Marzio PIERI, Introduzione a I libretti d’opera, scelta e introduzione di Marzio Pieri, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2001, p. XXXV. L. Pergreffi cosiddetta nascita dell’opera, ma anche e soprattutto sui moduli compositivi delle singole parti dei drammi per musica. Soprattutto in lamenti ed invocazioni amorose, come quelle che abbondano negli Orfei, è facile individuare la discendenza diretta dal madrigale monodico, in cui l’espressione dell’emotività del momento è l’elemento più intensamente sviluppato, tanto nel testo – in genere di tema amoroso (ed infelice) – quanto nell’andamento melodico. C’è, naturalmente, una relazione molto stretta tra questo tipo di testi ed il genere pastorale, dove i protagonisti sono i personaggi di un mondo idealizzato, convenzionalmente identificato con l’Arcadia, che cantano e si esprimono in maniera poeticamente armoniosa e fonicamente melodiosa. Come dire che non si possono separare le due cose: il passaggio alla monodia come attenzione alla parola drammatica (piuttosto che a quella descrittiva) e l’evoluzione dello stile pastorale, genere ibridato, contaminato da tragico, lirico, comico, bucolico vero e proprio, ma pur sempre il luogo per eccellenza dove il canto si sposa senz’alcuna aporia con la comunicazione verbale. Sempre il Guarini scrive, a proposito di questo, le famose parole che descrivono la sua opera, ‘quasi una fantasia’ dei generi teatrali esistenti e dei registri poetici più raffinati, dall’Ariosto degli episodi comici, al lirismo del Tasso pastorale, alla tragedia: la tragicommedia è una combinazione in cui tragici sono i personaggi, ma non l’azione giacché le passioni sono mosse, ma attutite, v’è piacere non tristezza, pericolo, ma non morte. Il lieto fine e l’ordine comico, ossia la disposizione dell’azione derivano dalla commedia e v’è un elemento di riso che si alterna a quello patetico2. E la versificazione dei libretti, specialmente nei passaggi più lirici, deve molto alla tecnica compositiva del Guarini. Numerosi stilemi guariniani e tasseschi, imitati quasi immediatamente dal Marino, situazioni, rime, immagini tratte dall’Anguillara si ripetono nei libretti dell’Euridice e degli Orfei. Uno di questi è la ripetizione cadenzata di un verso o due, che informa tanto la strofa poetica, quanto la composizione musicale, fornendole ritorni e possibili echi variati: Guarini ricorre a questa tecnica tanto nelle scene di monologo come di coro, ovvero nei momenti d’introspezione individuale o di riflessione collettiva. Nel Pastor Fido, quinto atto, scena terza – solo per fare un esempio – il coro dei pastori, alternandosi ai sacerdoti ed agli altri personaggi, invoca Diana, con una formula ripetuta: “O figlia del gran Giove…”, così come, nelle due scene finali, si rivolge al nume dell’unione matrimoniale con “Vieni, santo Imeneo…”. L’effetto è di una grande preghiera collettiva in forma responsoriale, con evidenti echi nel coro nel secondo atto di Striggio (“Ahi caso acerbo, ahi fato empio e crudele!”) ed in quello del secondo atto di Buti (“Ah, piangete! Ah, lacrimate!”). E ancora: i “ritorni” guariniani sono ancora più evidenti nei versi ripetuti dei lamenti butiani, nei discorsi per persuadere all’amore ed in alcuni temi topici della commedia, come quello dell’onestà3. 2 Cfr. Battista GUARINI, Compendio della poesia tragicomica, 1601. Cfr. B. GUARINI, Pastor fido, vv. 619-620, Corisca: “Ch’altro alfin l’onestate / non è che un’arte di parere onesta” comparato a Francesco BUTI, Orfeo, atto II, sc. 2, Vecchia: “…E che credete / Ch’altro sia questo onor ch’una garbata / delle donne invenzione / per indur l’huomo a supplicarle?”. 3 2 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” Un passo che, per il suo ripetersi d’autore in autore, è davvero esemplare è quello in cui Aminta, prima, e Mirtillo, poi, chiamano a testimonianza del loro amore le selve ed i sassi, che, a differenza della fanciulla amata, si sono inteneriti ai loro lamenti. In Aminta, vv. 338-345: “Ho visto al pianto mio risponder per pietate i sassi e l’onde, e sospirar le fronde ho visto al pianto mio; ma non ho visto mai, né spero di vedere, compassion ne la crudele e bella, che non so s’io mi chiami o donna o fera.” Nel Pastor fido, vv. 296-303: “Ch’i’ t’ami e t’ami più de la mia vita se tu nol sai, crudele, chiedilo a queste selve, che tel diran e tel diran con esse le fere loro e i duri sterpi e i sassi di questi alpestri monti ch’i’ ho sì spesse volte inteneriti al suon de’ miei lamenti.4” Il richiamo a questo topos è ben presente nel libretto di Striggio, ma con ben altro peso: Orfeo, infatti, muove letteralmente, gli animali e la natura minerale e vegetale con i suoi lamenti musicali, fino a giungere persino nell’aldilà!5 Il riferimento a questo passo, perciò è duplicato dal librettista: nel secondo atto, per ricordare i momenti dello struggimento amoroso, che ora culminano nella felicità, ai vv. 180-184: “Vi ricorda, o boschi ombrosi, de’ miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi a’ miei lamenti rispondean, fatti pietosi?” E nel lamento finale, dove ormai, soltanto monti e sassi potranno rispondere pietosamente al cantore, dopo la definitiva morte di Euridice, ai vv. 570-571 e 575-578: L’artificio di ripetere un verso, soprattutto in apertura e conclusione di un componimento, è anche di Catullo: si vedano i carmina XVI, XXXVI, LVII e soprattutto il carmen LII “Quid est, Catulle, quid moraris emori?”, che ritorna, per costruzione e per tematica tragica, nel lamento butiano di Aristeo (III, 3): “Uccidetemi, o pene!” e in quello d’Orfeo (III, 10): “Lasciate Averno, o pene, e me seguite” che si conclude proprio con le parole di Catullo, parafrasate in “Ma che tardo a morire? / […] / Orfeo, dunque, à morire!”. Cfr. anche il commento di Anna Maria Ferrero ai carmina catulliani citati, in CATULLO, Poesie, a cura di Luca Canali, Giunti, Firenze, 1997. 4 I corsivi sono miei, anche quelli dei passi seguenti citati. 5 Il tema topico è ben noto anche al Marino, che all’invocazione a sassi, selve alpestri e belve fa seguire il famoso catalogo degli alberi, pretesto per uno sfoggio di erudizione georgico – letteraria. Cfr. G. MARINO, Orfeo, vv. 678-689 e 714-888 seguiti dalla descrizione degli animali incantati ed attirati da Orfeo ai vv. 889-1057. 3 L. Pergreffi “…che poss’io più, se non volgermi a voi, selve soave?…[…] Voi vi doleste, o monti, e lacrimaste Voi, sassi, al dipartir del nostro sole ed io con voi lacrimerò mai sempre, e mai sempre dorrommi, ahi doglia, ahi pianto.” Ed è proprio questo eco dall’Orfeo mantovano che è ripreso da Buti, nel secondo lamento d’Orfeo, in III, 10, e persino da Aureli, nel primo lamento del cantore dopo la notizia della morte della moglie, in III, 3, qui in agili e scorrevoli ottonari, che manifestano tutt’altra intenzione di quella di scendere all’oltretomba! 2. Melodramma senza musica. Arcadia e Inferno, alternate e contrapposte, animarono le scene degli intermezzi fiorentini dell’ultimo scorcio del sec. XVI e poi, sul nascere di quello successivo, quelle della Mantova gonzaghesca e monteverdiana, non solo sul palcoscenico ma anche nella miscela poetica che gli umanisti dei testi per opera – non già librettisti, che questo fu un mestiere e quello un passatempo – rielaboravano e sintetizzavano nella rappresentazione del mito d’Orfeo, cantore e pastore, antico o novello pellegrino all’aldilà, mago e musico insieme. E se di pastori e di canto si nutriva l’avanguardia musicale del tempo, non si può sottovalutare l’apporto di chi rielaborava il genere dell’idillio teocriteo, il Marino, che vi insufflava nuova linfa tratta dalla contemporaneità. Nel 1620, a Parigi, usciva la Sampogna, la prima raccolta di componimenti esplicitamente denominati “idilli”, sul solco di una tradizione che il poeta napoletano si proponeva di rinnovare. La sampogna, ossia il flauto a sette canne di Pan, è raffigurata anche nella prospettica disposizione dei componimenti secondo il loro registro, tuttavia il titolo ha funzione poco più che di accorgimento drammaturgico a determinare il genere. Se infatti la contrapposizione fra lira apollinea e zampogna pastorale era l’ostinato de La Musica in cui Orfeo è l’autore del “Tu totum Caelum quasi canoram cytharam temperas”, il profeta dell’harmonia mundi6 e nuova figura Christi, di fatto la scelta stilistica dell’autore è, in via nuova ed eccezionale, per la contaminazione di registro pastorale sannazariano con quello lirico tragico di derivazione classica. Imbraccia la lira, il Marino, e vi esegue nuove variazioni sul tema mitologico, anzi un “contrappunto su canto fermo”, come egli stesso afferma nella prefazione alla Lira. Non un’innovazione assoluta la sua, della rielaborazione fiorita: già il Cinquecento aveva coronato di grande successo due traduzioni di Ovidio, quella del Dolce e soprattutto quella Dell’Anguillara, vera e propria “riduzione” alla contemporanea ottava ariostesca delle Metamorfosi, premiandone tanto le fioriture (che 6 Giovanbattista MARINO, La musica, in Dicerie Sacre e la strage degli innocenti, a cura di Giovanni Pozzi, Einaudi, Torino, 1960, p. 225. Che le Dicerie, in particolar modo la seconda, siano state palestra di scrittura, maturazione ed elaborazione di temi utilizzati successivamente, è tesi caldamente sostenuta anche dal Pozzi, nella Nota a La Musica, ibidem, p. 207. 4 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” fecero triplicare mediamente il numero dei versi originali) quanto la modernizzazione in direzione di una collana di appassionanti novelle metamorfico-boscherecce, di cavalleresca memoria. La com-posizione mariniana avviene, tanto nel poema, quanto negli idilli della Sampogna, per intarsi, per incisi, per aggiunte e volute, ricami e digressioni , soprattutto descrittive, ad alludere alle innumerevoli fonti. Sicché, dove in Ovidio si narrava un mito, con la già complessa costruzione dei racconti narrati dal protagonista Orfeo, dove in Poliziano l’azione era rappresentata visivamente e drammaticamente con l’apporto del Virgilio bucolico, nell’idillio d’esordio della raccolta, Marino narra la vicenda, “dipinge” le scenografie e “canta” la supplica del poeta tracio a Plutone, riproducendone la melodia in un caleidoscopio di dotte allusioni e di metri antichi e moderni, nel registro più alto. Ospite della corte mantovana e spettatore attento delle rappresentazioni del teatro in musica del 1608, Arianna e Il ballo delle ingrate, dei quali serberà un ricordo che lascia traccia esplicita nell’Adone7, il Marino si misura con il teatro in musica in un testo lirico: “battezza – scrive il Pieri8 – gli ondeggiamenti…sulla linea del melodramma. Un melodramma per la via degli occhi e senza musica.” E gli “ondeggiamenti” sono soprattutto quelli della lirica d’ascendenza cinquecentesca che tiene d’occhio la monodia del teatro musicale, quella costruzione del verso per i suoi valori fonici, la composizione “per echi” e ritorni sonori, a riprodurre una condizione intermedia del testo poetico tra canto ed eloquio prosastico, cosicché gli oltre mille versi non si articolano in strofe, se non in determinati passaggi, bensì in forme libere dove i punti di riferimento sono le tensioni narrative e le intensificazioni emotive. Rimandano invece esplicitamente alla favola in musica gli inserti descrittivi dell’Orfeo musico, che recita cantando (“non sommerge gli accenti, / non confonde le rime; / e le parole in guisa / spiega chiare e distinte / che l’aria a l’arte sua ragion non toglie, / né de’ versi, che forma, i sensi occupa”), in parte tratti dalle ottave dell’Anguillara, ma sviluppati poi, nella particolareggiata descrizione del canto stesso, con trilli, cadenze, emissioni di voce (vv. 205-272)9. La stessa preghiera di Orfeo a Plutone, in strofe saffiche, con l’eco dato dalla rima al mezzo del terzo verso, sembra una vera e propria indicazione musicale per un eventuale – ma non previsto – compositore: “O dell’abisso tenebroso e nero, monarca formidabile e severo, sotto il cui ‘mpero stansi ubbidienti furie e serpenti”10 7 Cfr. Canto VII, ott. 88. Cfr. Marzio PIERI, Giambattista Marino, in Il Barocco. Marino e la poesia del Seicento, scelta ed introduzione a cura di Marzio Pieri, Istituto poligrafico e zecca dello stato, Roma, 1995, p. 24. 9 Anche in questo caso l’illustre precedente era il Guarini con il suo famoso madrigale Mentre vaga angioletta, che descrive i gorgheggi di un cuore innamorato, sempre più assimilato ad un usignolo. Fu musicato anche da Monteverdi e contenuto ne L’ottavo libro de’ madrigali: madrigali guerrieri et amorosi, pubblicato nel 1638. 10 Cfr. Orfeo, vv. 276-279. I corsivi sono miei, a rilevare le rime, in particolare quella al mezzo. Si noti il particolare andamento prosodico della strofa saffica, che alterna misure binarie e ternarie (spondei o trochei, con dattili). La musicalità delle rime mariniane, dell’Adone questa volta, è apprezzata ed elogiata dal veneziano Busenello, in un’epistola al Marino: “Hanno le rime un’agilità che, recitate, non toccano la lingua; ascoltate, non istancano le orecchie; lette, innamorano gli occhi; cantate beatificano la musica: e l’anima vorrebbe esser tutta memoria per rubbarle alle carte.” In Il Barocco, op. cit. p. 774. Il corsivo è mio. 8 5 L. Pergreffi Si misurava con la poesia per musica, il Marino, ed infatti numerosi madrigali suoi divennero i testi di altrettanto numerose raccolte di compositori e fu musicato anche il lamento di Arianna, di rinucciana memoria, contenuto nell’omonimo idillio, sempre della Sampogna11. La scelta di un “danzante tono melodrammatico”12 si respira anche in quest’idillio – assai vicino ai nostri libretti – nell’alternarsi di endecasillabi e settenari in cui la rima informa la logica del ragionamento di Bacco suadente, nel ditirambo di matrice polizianesca e soprattutto nel registro del lamento, in settenario lirico, amplificato fino a diventare una collana di madrigali (vv. 512-603). Gli echi di questo tipo di poetica, con o senza Orfeo protagonista, non tardarono a farsi sentire nella librettistica, in particolare quella romana, tanto permeabile alla commistione dei generi e strettamente legata alla tradizione letteraria. È questo, infatti, il codice metrico e retorico del Buti e da questo nemmeno l’ironico Aureli potrà prescindere, se il rovesciamento e la negazione esistono solo a partire dalla convenzione. Le risonanze tra i testi, sono, in alcuni casi, puntuali: esemplare, in questo senso è la scena della morte di Euridice in cui la lingua operistica è un vero e proprio calco dal Marino: “Io moro, e di già queste / mie luci s’incominciano (ahi destino!) / a coprir di caligini funeste” canta l’eroina di Buti (atto II, scena 9), a fronte del mariniano “Repentina caligine i begli occhi / offusca e chiude” (Orfeo, vv. 108-109). Ma soprattutto è prodromo del teatro in musica da venirsi il lavoro del Marino per il suo articolarsi su tempi alternativamente veloci e lenti13, nel suo accostare ed innestare contemporaneamente le parti di un’azione drammatica, con le descrizioni e le digressioni circolari o centrifughe che costringono il lettore ad interrompere il flusso del suo pensiero per divagar(si) nello scialo del particolare sovrabbondante: nella sua pluralità è già Opera. Il poeta assorbe nell’Adone, più che altrove, da tutte le fonti precedenti, raccoglie a piene mani e con sagacia, scompone e ricompone la materia in modo tale da renderla nuova, esempio e fonte inesauribile di spunti per i librettisti, “elaboratori o meglio complicatori all’infinito”14 di schemi narratologici convenzionali. Di fatto, la nascita del poema da un nucleo di tre episodi è la crescita per interposizione di materiale narrativo e descrittivo, una tale dilatazione del tempo fra un episodio e l’altro che cessa persino di essere un “intermezzo” e diviene essa stessa linfa del poema, essa stessa divertimento e spettacolo. “La meraviglia –ahimé!– degl’intermedi!”15 11 Il passo fu musicato da Pietro Possenti e pubblicato nella raccolta Canora Sampogna nel 1623. Cfr. Vania DE MALDÉ, Introduzione ad Arianna, ne La Sampogna del MARINO a sua cura, Guanda, Parma, 1993. 13 La velocità variabile cui mi riferisco è tanto del livello microscopico – più immediato – della forma metrica, in cui si alternano versi di lunghezza e ritmo differenti, quanto quello macroscopico dell’organizzazione del materiale, nel continuo inserimento di episodi e descrizioni digressive che modificano il ritmo di “scorrimento” della trama. 14 Cfr. Marzio PIERI, Opera e letteratura in Storia dell’Opera Italiana a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, vol. 6: Teorie e tecniche, immagini e fantasmi, EDT/Musica, Torino, 1988, p. 269. Sullo scomporre il materiale per ricomporlo, scrive Asor Rosa, nell’introduzione ad un’antologia mariniana da lui curata per un’edizione Rizzoli del 1967, che l’Adone, non ha un passo, un frammento che non possa essere ricavato da una fonte precedente “…sì che ne risulta una singolare novità fatta tutta dall’accostamento di cose vecchie. […] Il suo risultato più rilevante…consistette nello spezzare definitivamente l’unità di quella tradizione, riducendola ad un cumulo di frammenti, ad un ammasso di materiali da repertorio.” (p. 76). Sono i materiali su cui si costruiva il melodramma, gli stracci colorati per i costumi. Del resto è proprio con un accostamento di cose vecchie, note e re-impastate che a Venezia si costruivano le convenzioni del genere “opera”. 12 6 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” Il poema fantastico, eroico, “divino perché parla di dei”16 è il vero doppio della tradizione precedente, non più cavalleresco, non solo mitico, non solo descrittivo, non solo amoroso, dilatato, diversivo, sovrabbondante di ottave di fioritura e racconti nel racconto. In molti casi è irriconoscibile, se non per qualche spia retorica in alcuni echi e strutture sintattiche, il suo prelievo dalle fonti, tanto da non poter più essere considerato arte allusiva, bensì una vera e propria “operazione trasformativa17 dei vecchi significati presenti nelle fonti”: la parola è ciò che è e ciò che era, “segno di segno”18 e porta ad un abisso. Il Marino, con il suo augurarsi di raggiungere le vette della poesia fantastica delle Metamorfosi (“E utinam le mie fossero tali…”19), apriva una nuova porta: novello Ovidio della letteratura contemporanea, avrebbe segnato il passo nella librettistica veneziana. 3. “Puoté la novità più che il tuo canto” L’Orfeo di Buti . Francesco Buti, giurista e letterato della corte Barberini, partecipa al complesso momento culturale – in cui la corte romana assimilava e reinterpretava le grandi novità del teatro fiorentino e quelle della tradizione spagnola – e politico della caduta in disgrazia della potente casata, protagonista poi dell’italianizzazione della corte francese del giovane re Sole. È opera sua la declinazione della cultura romano-barberiniana agli usi degli spettacoli regali francesi, nel testo dell’Orfeo parigino, allestito per il carnevale del 1647. Tragicommedia per musica, questo libretto suona sul frontespizio come una dichiarazione di poetica, come a dire che lo spettacolo era gradevolmente lieto, ma scritto con le più elevate intenzioni retoriche e stilistiche – nello stile tragico – per il più colto ed importante pubblico immaginabile. Di tragico non vi è molto in effetti, mentre, al contrario, dalla commedia provengono situazioni, locuzioni e personaggi topici. Lo stile comico, si noti, era estraneo alla tradizione pastoral-mitologica degli ambienti fiorentini e mantovani, mentre era stato introdotto più volte – e con successo – nelle sontuose scene romane, alla maniera spagnola. 15 Anton Francesco GRAZZINI detto IL LASCA, celeberrimo verso del madrigale burlesco La Commedia che si duol degli Intermezzi, citato in apertura del capitolo relativo alla musica degli intermezzi del XVI sec. di N. PIRROTTA, Li due Orfei, da Poliziano a Monteverdi, Torino, Einaudi, 19812 (prima edizione italiana Torino, ERI, 1969), p. 200. 16 Sono parole dello stesso Marino, in una lettera a Girolamo Preti, riportata in G. MARINO, Lettere, a cura di Marziano Guglielminetti, Einaudi, Torino, 1966, pp. 394-97. 17 Cfr. Giovanni POZZI, Guida alla lettura nel secondo volume dell’edizione dell’Adone a sua cura, Adelphi, Milano, 1988, pp. 88-90. Il corsivo è mio. In ambiente francese, dove Sampogna e Adone furono completati e pubblicati, la trasformazione, la metamorfosi ed il cambiamento erano il vero e proprio pedale ostinato degli spettacoli, specialmente quello del ballet de cour, in cui comparivano, come costanti, i maghi e le incantatrici, come Circe, che trasforma gli uomini in animali, e sottomette la natura e le sue forze al suo potere. Cfr. il saggio di Jean ROUSSET, La letteratura dell’età barocca in Francia. Circe e il pavone, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 21-46. 18 Cfr. Marzio PIERI, introduzione a Il Barocco, op. cit. p. XV. 19 G. MARINO, nella già citata Epistola al Preti, in Lettere, op. cit. 7 L. Pergreffi Non solo: apparteneva anche a molti passi del poema ariostesco, già fonte de Il palazzo incantato di Atlante, rappresentato a Roma con libretto di Rospigliosi e musica dell’illustre Rossi, collaboratore del Nostro nell’impresa francese. Dalla tradizione comica deriva esplicitamente la Nutrice scaltra e disincantata che raccoglie i più reconditi palpiti della figlioccia per curare poi le di lei relazioni amorose, in genere illegittime, con il protagonista. Anche in questo caso, pur mantenendosi nel ruolo di aiutante positiva, la balia, moderatrice di affanni ed emozioni troppo accese, abbandona il ruolo di tutrice morigerata e vigile quando concorderà perfettamente sul fatto che l’onore sia una pura convenienza sociale senz’alcuna funzione se non quella di indurre gli uomini al corteggiamento. Il Satiro, al contrario, originariamente personaggio della pastorale, privato delle pulsioni sessuali elementari, di cui è figura, rimanendo semplicemente una voce misogina all’interno della trama, finisce per diventare un personaggio comico. Infine il Buti introduce Momo, il cinico, il mordace commentatore delle sciagure presagite. Il sarcastico personaggio non ha altra identità che il suo registro, né altra funzione drammatica: è la divinità che rappresenta il biasimo, è il pedagogo ipercritico, l’Esculapio di Aureli. È però soprattutto uno dei protagonisti del VII canto dell’Adone, cui sono dedicate numerose ottave: il protetto di Mercurio (e questi è novellatore20) è introdotto, nel giardino dell’udito, al banchetto della dea dell’amore per allietare i convitati, ad inscenare insomma uno spettacolo come quelli che accompagnavano le cene delle corti rinascimentali e barocche. “Orribile e difforme”21, eppure “critico nume”22 di sottile ingegno, non è altro che “fiato ed inchiostro”23 (in fondo tutto e nulla), “Lecca talor piacevolmente e scherza / nondimeno sempre morde, e sempre sferza”24, narrerà a Venere (ed ai suoi convitati), per conquistarne le grazie di mecenate, proprio l’episodio della scoperta dei suoi amori adulteri con Marte e della vergogna pubblica cui fu esposta dal marito Efesto. Dopo la captatio benevolentiae dell’esordio, la sferzata25. Il Buti, dunque, in apertura della vicenda in musica introduce un’allusione trasparente al canto “del suono”26 del poema mariniano. 20 Adone, V, 98: “…il messaggier sagace / …né qui ponea / freno al garrir, novellator loquace.” Così si conclude l’ampia parentesi narrativa di Mercurio, per indurre Adone all’amore fedele e costante. 21 Adone, VII, ottava 168. 22 Ibidem, ottava 167. 23 Ibidem ottava 170. 24 Ibidem, ottava 181. 25 Momo è il figlio “informe”, (ottava 168, due versi sotto è “difforme”), indomito della Satira e di Mercurio, tagliente nella lingua e nella penna, il nemico della Fama e della corte, simile alla morte, nel prendere di mira tutti (ottava 174). La descrizione che segue attualizza a tal punto il personaggio, con un’allusione al poema dello Stigliani, il Mondo nuovo, nell’accenno a chi cantando Colombo finisce per riportare dalle Indie non oro, ma piombo (ott. 187), da far identificare Momo con il Marino stesso. Questa lingua arguta, forte del vero, che però chi ascolta non vuole sentirsi dire, persino “Il gran Monarca eterno [Giove o il Dio unico cristiano?] / nota, punta, ripicca e prende a scherno” (ott. 174). Un’allusione alle Dicerie Sacre, prosa omiletica–aretiniana e quindi “sacrilega”, o solo un’iperbole per la sua spregiudicatezza polemica? Cfr. anche M. PIERI, Giambattista Marino, in Il Barocco, op. cit. p. 22. 26 Nel percorso di Adone nel regno di Venere, il giovane è edotto nei piaceri dei cinque sensi in altrettanti luoghi preposti. Il canto VII è dedicato al giardino della musica. 8 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” Sono numerosi anche i topoi comici trasposti nello spettacolo per musica: gli scambi di persona ed i non sense, come la canzoncina intonata da Aristeo nella sua follia finale, la lite-baruffa fra le dee e il dissacrante ed aspro rimprovero di Plutone a Caronte, per la sua memoria corta (“E quante volte e quante / rimbambito che sei, t’ho già ridetto / […]”). L’opera, sontuoso svago, è costellata, inoltre, di ariosi momenti di comicità, come le affermazioni epigrammatiche del Satiro e di Momo, come la battuta di Cupido sulla sua non-responsabilità nella sofferenza d’amore (I, 4). Il testo però è intessuto anche di richiami alla letteratura non teatrale antica e moderna, come il presagio che apre la narrazione ovidiana del mito di Orfeo, negli altri libretti ignorato, duplicato qui in due scene con lessico, però, d’eco virgiliana. Ancora di stampo classico è il coro che conclude luttuosamente il secondo atto, “Ah piangete, ah lacrimate”, ignorato completamente in Ovidio27, ma ben presente nella narrazione agreste delle Georgiche28, nel terzo carmen di Catullo29 e, nella consuetudine della tragedia classica di concludere l’azione con un coro, come aveva fatto Striggio nel suo Orfeo. L’apparizione di Venere ad Aristeo, amante infelice, al contrario è di matrice boschereccia e, naturalmente, prezioso modello di contaminazione delle fonti e di stile dovette essere la Sampogna. E probabilmente l’idillio mariniano fu fonte non solo dal punto di vista strettamente letterario, ma anche per la produzione vera e propria, nell’ideazione delle scenografie e dei costumi. Il Marino, infatti delinea con pochi tratti efficaci il paesaggio infernale e la fisionomia di Plutone, mentre indugia con compiacimento sull’abbigliamento del cantore e sui suoi gesti di fronte all’auditorio oltremondano30. Buti inserisce altri garbati accenni alle grandi opere che lo precedevano, l’Aminta, per esempio, dove il verso conclusivo della supplica di Momo, Apollo e Giunone a Cupido –“Cangia, cangia maniere”– è una citazione dalla frase di Dafne, che inizia la riottosa Silvia all’amore per il pastore31. E ancora: in ossequio a Dante, e con l’occhio all’imprescindibile libretto accademico di Striggio, l’apparizione ad Aristeo dell’ombra di Euridice maledicente, in III, 3, è di tono e ritmo dantesco, “Onde tu sia con più dolente sorte / morte furia et inferno di te stesso, / rifiuto dell’Inferno e della morte”. È però soprattutto nello sviluppo scenico e nell’articolazione della vicenda, la chiave del libretto. L’azione è elaborata per moltiplicazione degli elementi significativi, fino a raggiungere tre trame parallele ed intrecciate. Come se, da una digressione esplicativa, si indulgesse nella narrazione di un nuovo racconto, così si moltiplicano i personaggi e, proporzionalmente, le scene. 27 Cfr. Ibidem, vv. 11-12 “Quam satis ad superas postquam Rhodopeius auras / deflevit vates…” Cfr. VIRGILIO, Georgiche, IV, 460 e sg. “At chorus aequalis Dryadum clamore supremo / implevit montis…” 29 Cfr. CATULLO, Carmina, III, 1 “Lugete, o Veneres Cupidinesque” 30 Per il paesaggio oltremondano cfr. G. MARINO, Orfeo, vv 167-178. Per Plutone i vv. 397-408. Si vedano invece i vv. 186-224 per l’abbigliamento ed i gesti d’Orfeo, questi ultimi a loro volta mutuati dalla versione delle Metamorfosi ovidiane, dell’ANGUILLARA, X, 4, 1-8, (già amplificazione di OVIDIO, Met. X, 15-16.) e X, 37, 1-4. La veste purpurea e dorata d’Orfeo, infine, al v. 666, si cambia in una “Spoglia negra e lugubre”. Un abbigliamento analogo indossa un musicista nella Musica, op. cit. p. 307. 31 Cfr. Torquato TASSO, Aminta, v. 129 e sgg. “Cangia, cangia consiglio…” 28 9 L. Pergreffi Oltre ai protagonisti, prendono parte attiva alla vicenda anche i personaggi comici e soprattutto gli dei, presenti in ogni ordine e grado: Venere e Amore, le Grazie, Giunone e Apollo, le personificazioni di Gelosia e Sospetto, Plutone, Caronte, Proserpina gelosa, Bacco ed infine Giove e Mercurio a riequilibrare, ex machina, la forza centrifuga di tanto narrare rappresentando. Ma soprattutto ha grande peso drammatico il pastore Aristeo, pretendente rifiutato e vero motore della vicenda, protagonista alla pari con il suo rivale Orfeo. A partire dall’amore non corrisposto dell’eroe bucolico, intervengono le divinità, schierandosi con l’uno o con l’altro pretendente, trasferendo in questo terzo intreccio le rivalità di sempre. Nella rappresentazione una trama si incunea e si alterna all’altra come in una spirale infinita, tanto che vi è una pari dignità di episodi “ortodossi” ed “eterodossi” del mito nell’innescare l’azione. A volte sono persino gli eventi di fioritura a generare o ri-generare l’azione principale della morte, risurrezione e di nuovo morte della ninfa amata da Orfeo. Ad aprire e a chiudere il testo, inducendo alla lettura allegorica, è la presenza delle divinità; sono dei che permeano il mondo del loro influsso, umani, ma lontano dall’umanità terrestre, forse, come i pastori di qualche decennio precedente, figure degli abitanti della “corte olimpica” parigina. In un gioco quasi infinito di specchi, l’opera rappresenta chi la guarda, finendo per identificarsi con il proprio auditorio, ed omaggia in prologo ed epilogo, la cattolicissima corte francese, quando la morte di Orfeo, si sublima nella sempiterna costellazione della Lira-Lilium di Francia32. Re Sole “ferma ne le bell’onde il guardo intento, / e la propria sembianza entro vi vede.”33 E lo spettacolo –costosissimo e finanziato con denaro statale – fu investito dalle polemiche34. Una rilettura per aumentazione delle fonti latine e del Poliziano è alla base del libretto di Buti e, d’altra parte, il rallentamento del ritmo narrativo e l’espansione del tempo rappresentato sono la grande risorsa del teatro musicale, grazie alla musica che può dilatare o contrarre la narrazione35. Del resto, da un lato, la moltiplicazione degli episodi e dei passaggi da uno all’altro deve molto alla tradizione epico-cavalleresca, dall’altro, è anche conseguenza di un teatro che aveva nella dimensione visiva, nella molteplicità dei cambi di scena, proprio uno dei suoi punti forti e il Buti doveva ben saperlo, collaborando con l’osannato scenografo Torelli. Se, dunque, nella sua articolazione della vicenda in numerosi e vari episodi, l’abate romano risponde alle esigenze scenografiche del nuovo genere teatrale, tuttavia non indulge sulla cantabilità e ripetitività mnemonica di metri e rime, imbocca piuttosto la strada della lira, palesandola soprattutto nei momenti di maggior pregnanza emotiva. 32 La Lira di Orfeo, per opera divina, sarà posta in cielo come costellazione, assimilandosi al Lilium, il Giglio di Francia, simbolo della casata reale. 33 Cfr. G. MARINO, Adone, V, 24, 1-2. Narciso al fonte. 34 Cfr. Robert M. ISHERWOOD, La musica al servizio del re, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 143 e sgg. 35 Cfr. Carl DALHAUS, Le strutture temporali nel teatro d’opera, in La drammaturgia musicale, a cura di Lorenzo Bianconi, Il Mulino, Bologna, pp. 183-4. 10 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” L’accurata scelta dei metri in base ai registri poetici che si susseguono di volta in volta nel testo è la spia di una scelta di poesia ancora “alta” e “letteraria”, non già e solo “per musica”, che ancora melodiosamente rivendica per sé un’autonomia musicale, di accento, di suono, di ritmo. I settenari e gli endecasillabi rimangono lo strumento dell’emotività sublime, degli affetti alti, degli accorgimenti linguistici più raffinati, mentre i metri binari sono il terreno del comico, del palpito, della danza e dell’irrazionale bacchico oppure onirico, nel caso di ottonari e senari. Non solo, proprio nella scelta di affidare alla polimetria l’espressione dei sentimenti complessi ed ondeggianti, alla ricerca di un ritmo duttile, proprio dell’eloquio “naturale”, il Buti rivela di attingere alla tradizione del recitar cantando e della lirica contemporanea. Basti osservare, un esempio fra tanti, le analogie tra la strofa con cui esordisce Aristeo (I, 3): “O tormento mortal, peggio di morte, Ch’io, tanto adorator, tanto infelice, Habbia a veder la mia bella Euridice Al mio rivale Orfeo fatta consorte ! O tormento mortal, peggio di morte ! E qual tormento avanza il mio tormento ?36” e un passo analogo dal lamento dell’Arianna mariniana (vv. 512-516 e 534-536): “Deh pria (prego) m’uccida Questo dolor mortale, mortale ed omicida; solo però ch’è tale, ch’uccidermi non vale. …Ma che? Mancherai forse a chi di morir brama altre guise di morte?” Ancora, ad alludere al triangolo delle fonti del mito orfico nel teatro – Poliziano, Ovidio/Anguillara, Marino – non ignaro del libretto teosofico dello Striggio, v’è la versificazione in ottonari del passo bacchico, tronco nel coro e sdrucciolo nel canto del dio, in analogia con la Fabula di Orfeo, (vv. 370 e sgg.), con i passi di Arianna (vv. 636-709) e Adone (VII, ott. 118-122 in endecasillabi sdruccioli) , e con il coro striggiano (V, vv. 617 e sgg.). Non è ancora presente la schizofrenica divisione del frammento in recitativo ed aria, anzi i due accorgimenti del teatro musicale sono perfettamente integrati per un avanzamento organico della trama; ce ne dà la misura l’amplissimo ricorso alle cosiddette arie in funzione realistica, ossia brani che risulterebbero cantati anche senza lo spettacolo in musica. Lo stratagemma, già presente nel teatro di prosa, era un’invenzione “musicale” soprattutto romana per legittimare l’inverosimile presenza in scena di cantanti trillanti e gorgheggianti, tuttavia era destinata a rimanere anche in seguito come convenzione del teatro d’opera, associata alle situazioni comiche, con forme poetiche e musicali semplici ed immediate. 36 I corsivi e le sottolineature sono miei. 11 L. Pergreffi Non così in Buti, che le privilegia per dare maggior risalto ai brani di canto espressivo, come le preghiere di Orfeo, in cui, giustificatamente, il tempo della rappresentazione si dilata. Sembra, da questo punto di vista, di essere di fronte ad un’edizione aggiornata dell’Euridice fiorentina, eppure siamo lontani, in quest’opera moltiplicata su se stessa, dal teatro musicale che si rifaceva alla prosa melodica dei greci: non vi sono antefatti, bensì soltanto un presente assoluto; né si sottintendono azioni in spazi nascosti alla platea e narrate poi da messaggeri, bensì tutto è visibile e ruota velocemente sotto gli occhi della corte francese, ivi compresi i balletti di tradizione locale. Siamo di fronte, insomma, ad una vera Opera, al primo Grand-Opéra barocco. Lo sa anche il Buti, che narra, per bocca di Caronte, l’ultimo fallimentare tentativo di Orfeo di ripetere la sua impresa canora agl’inferi (III, 9): […ciascuno gli chiuse] Le porte in faccia e gridò Radamanto: “Puotè la novità più che il tuo canto!” Scrive secondo la più illustre tradizione, il Nostro, però è ironicamente consapevole che il successo dell’allestimento non sarebbe dipeso dai suoi versi, del resto dimenticati nella penombra che circondava la fama di Rossi e Torelli, laddove si esportava la novità non di un genere poetico o musicale o architettonico, ingegneristico-scenografico o coreografico, bensì di una colossale impresa di sintesi cumulativa di tutto questo, la “multimedialità” del molto, l’Opera. 4. Dilettar gl’ascoltanti e gradire a chi spende. Ovvero la via metamorfica di Aureli. Disinnescata la grande fantasia ovidiana dei temi (quel molteplice fantastico del Marino epistolare37), i librettisti della laguna riattivavano però sulle loro trame convenzionali, una rielaborazione all’infinito: un infinito circolare che doveva ritornare, nuovo, ma ancora riconoscibile, su se stesso. Per la reiterazione sempre più straordinariamente spettacolare, sempre più comune – miracoloso ossimoro della laguna – dell’evento teatral-musicale era imprescindibile, infatti, un codice convenuto tra ideatori e spettatori che lo rendesse comprensibile per questi e riproducibile per quelli. Aurelio Aureli è un esperto di produzioni teatrali, sulla cresta dell’onda, con un libretto o più l’anno, per oltre cinquant’anni, si definiva, per l’appunto, “librettista”, a ribadire la dignità e l’identità di un genere che non era più un diletto di corte o d’accademia, bensì un’attività vera e propria. Il suo lavoro è nella piena maturità quando stende l’Orfeo per il carnevale del 1673, da rappresentarsi al teatro San Salvatore con la musica di Antonio Sartorio. E nelle mani dei due navigati capitani, il vascello ovidiano solca le acque non amichevoli dello svogliato pubblico veneziano, quasi irriconoscibile, mascherato fantasma di ciò che era stato in altre corti. 37 Cfr. G. MARINO, Epistola a Girolamo Preti, in Lettere, op. cit. pp. 394-97. 12 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” Il vistoso rimaneggiamento della vicenda è ampiamente spiegato, come si conveniva, nella prefazione al libretto, preceduto da un programmatico “si finge”. Aureli introduce, infatti, insieme con Aristeo, la sua amata e tradita Autonoe, a costituire la seconda coppia di amanti, tradizionale presenza dei libretti veneziani; trasporta dalla Tessaglia alla Tracia tutta la scuola del centauro Chirone e vi aggiunge, in “condonabile anacronismo”, Ercole. La declinazione di personaggi ed azioni al gusto lagunare è tanta e tale che l’opera cambiò titolo un paio di volte in seguito, in quelli che cinematograficamente chiameremmo remake: nel 1689 divenne Amor spesso inganna, con la musica del Sabadini, poi Orfeo a torto geloso, overo Amore spesso inganna, nel 1697. Del resto, elencati tutti i protagonisti e le comparse, con le loro caratteristiche stilizzate e apertamente importate dal teatro di prosa comica e dalle convenzioni dell’opera contemporanea, non serviva altro che muovere l’ingranaggio per garantirne il funzionamento, anche senz’alcun accenno al mito: se il protagonista non si chiamasse Orfeo, nulla cambierebbe nell’economia drammatica e se la sua amata non fosse Euridice, il testo risulterebbe ugualmente efficace. Eppure è proprio in questo che l’Orfeo veneziano costituisce un giro di boa nel mare magnum della tradizione musicale del mito. La vicenda è articolata in tre atti, con i medesimi accorgimenti già osservati in Buti: lo spostamento “nascosto”, ovvero lasciato immaginare allo spettatore, ed il lasciare una situazione per riproporla più in là, come in un montaggio alternato. Mentre, però all’interno della corte parigina, Orfeo ed i suoi conterranei cantavano e danzavano in ambientazione boschereccia, nel teatro di Venezia, al contrario, il cantore tracio è il princeps di una corte che vive tra un sontuoso palagio ed un giardino, elaborazione architettonica del locus amoenus. I nobili aureliani finiscono nei boschi, mentre i personaggi pastorali si ritrovano, spaesati, nelle stanze di palazzo e soltanto nell’ultima parte del testo la scenografia “ritorna alle origini”, con il ruscello e la quercia della poesia bucolica. Scompaiono i cori, sostituiti da finali d’atto vivaci ed affollati, come quello della danza di ninfe e pastori (nel giardino di corte!), al termine del primo atto, per festeggiare lo scampato pericolo di Aristeo, minacciato da Achille. Spassosa e vivace, la trama raccoglie tutti i personaggi ed i luoghi comini della tradizione, propone gli avvenimenti, numerosi e variegati, a ritmo sostenuto e costante, leggero, come di un unico ballo, dove quasi ogni scena è scandita da un’aria d’entrata ed i metri sono appositamente scelti per questo scopo musicale e teatrale. Anche in Aureli compare la nutrice, Erinda, ma non di Euridice, bensì di Aristeo, l’aiutante realista e cinica, discendente dei servi della commedia. Si innamorerà di un giovane, promettendogli lauta ricompensa per il suo interessamento, producendo un esilarante effetto, nel suo ruolo di tenore travestito. D’altra comicità sono investiti Ercole ed Achille, allontanati già dalla loro scena d’esordio, la caccia, dalla loro caratteristiche: incantati alla vista di Autonoe, perdono completamente il senno e la inseguono ovunque. 13 L. Pergreffi Sono stati trasformati nelle figure tradizionali dei generosi, forti e sempliciotti, dimentichi di tutto e tanto impulsivi che Achille proporrà ad ogni occasione di uccidere Aristeo per vendicare la sua amata. Tutt’altro che casti, leggiadri ed accorti, indisciplinati piuttosto, Aureli ne ha fatto le anti-ninfe. È il protagonista, però, a farci rendere conto delle numerose licenze poetiche, o piuttosto ironiche, che l’autore si è preso: è un Orfeo signore di palazzo, non pastore tracio, bensì sovrano, tormentato da una gelosia incontrollabile ed irrazionale, più che da questioni estetiche e musicali. Aristeo, pure presente ed importante nello sviluppo, è suo fratello, il fratello minore, tanto umorale e capriccioso quanto Esculapio, il maggiore, è saturnino. Soltanto nel secondo atto, un accenno ai suoi straordinari poteri – disprezzati, però, per non potergli alleviare il tormento della gelosia – fa riconoscere in lui il cantore mitico: “Oh Dio, col canto / Movo le piante e fermo il corso ai fiumi”, laddove, in I, 13, Aristeo dichiarava di appestare l’aria che respira: “Sono un mostro d’ardori / […] / E crederei / co’ fiati miei / […] / Infettar l’aure e avvelenare i sassi.” Proprio quando il pubblico coglie la vera identità del protagonista, inizia una fitta serie di allusivi, e paradossali contemporaneamente, richiami al mito. Mentre Orfeo ha appena assistito ad una conversazione che, erroneamente interpretata, suscita la sua terribile gelosia, è un inedito Achille ad esibire le proprie doti di cantore e poeta, nella sala da musica del padrone di casa e accompagnandosi con il suo arpicordio. È l’unica aria in funzione realistica nell’intero libretto ed a cantarla è un personaggio del tutto estraneo e alla corte e al mito orfico, proprio in un momento in cui Orfeo non ha ancora cantato in maniera significativa e il cui ruolo di protagonista non è ancora emerso. Anzi, il sovrano tracio irrompe in sala minacciando Euridice co’l ferro alla mano, bloccato solo dalla prontezza di Ercole e la sua collera aumenta: “Sin colà negli abissi / ti seguirò” grida alla moglie, in un buffo rovesciamento della mitica discesa agli inferi. Non basta: il Nostro ordina ad un servo incredulo di tendere un agguato alla fedifraga e di ucciderla. Anche Aristeo, nei paraggi, incontra Euridice e le si propone con insistenza: “Ti seguirò s’anco il mio piè dovesse / scender per te sulla Tartarea porta”. Alla poveretta, “moglie affettuosa, e fedele” fino al parossismo, non resta che spirare nella consueta maniera: morsa dal serpente, senza il conforto del pianto delle ninfe butiane e senza il minimo rallentamento nel ritmo narrativo, quasi che questo sia semplicemente un accidente necessario alla trama, ma di non troppa importanza. Dopo essere stata minacciata per ben due volte nel giro di poche ore, la morte per causa del veleno di un serpente assume la dimensione di un banale incidente, non certo di una fine fatale, alla quale si rivolge l’ironia del librettista. Tutta la sceneggiatura dell’episodio, infatti, è pensata in modo tale, per ciò che precede e segue, da svuotarlo completamente della sua funzione cardine di tutta la vicenda, come era stato in Rinuccini, Striggio e – anche se in misura minore – in Buti. 14 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” È cosa di poca importanza la scomparsa di questa donna: per il marito il dono del fato di una ritrovata libertà (Esculapio in III, 8: “Lacrimar perduta moglie, / folli sposi, è vanità”), per il pretendente Aristeo, un dolore passeggero da dimenticare con l’aiuto del vino. Bacco stesso, in trionfo con alcuni baccanti – con funzione coreografica qui ed assenti poi dal finale – provvede con il suo trionfo a distogliere il figlioccio dal pensiero dell’amata. Non v’è altra partecipazione che questa, ironico rovesciamento dei cori di disperazione che riecheggiavano negli allestimenti di Striggio-Monteverdi e di Buti-Rossi. E l’ultimo atto, ancora in un parallelismo con il libretto butiano tanto sorprendente da non poter essere casuale, si riapre su uno scenario bucolico38, ma con un Orfeo completamente cambiato. Il protagonista ha riacquistato la sua “identità letteraria”, “spogliato dell’abito reggio, con la Lira alla mano”, si ricongiunge anche con l’iconografia tradizionale. Si lamenta, con un’aria con da capo, in quinari “sospetti” per la situazione, della propria infelicità per il tradimento della moglie (!) Però, come in un sonetto spiritoso, fulmen in clausola, solo alla fine confessa quale sia l’oggetto del pianto: “Per l’infedele empia beltà”. Ancora ignaro della morte della moglie, all’arrivo di Orillo gli chiederà con ansia se abbia già compiuto la sua missione omicida, poi, nell’apprendere la notizia della morte di lei a causa del morso fatale, con totale incoerenza, maledice Aristeo, secondo lui causa dell’incidente, e si accinge al vero e proprio lamento. Non però una melodia sul tradizionale tetracordo discendente, bensì una più generica aria di dolore che finisce per lasciarlo estenuato e sopito in un sonno profondo. Su tetracordo sarà la paziente Euridice ad esortarlo a scendere agl’inferi, comparendogli insieme a due fantasmi, convenzione operistica ed ancora parallelismo con il libretto del Buti in cui la donna spettro, nel medesimo punto, appare ad Aristeo per maledirlo e provocandone la pazzia. Euridice, la paziente, premurosa nei confronti di un marito piuttosto pavido, per la verità, sembra la vera ed unica eroina del testo veneziano. A conferma di ciò, mentre il marito rinfrancato ha dato l’addio alle piante della superficie per scendere all’Ade per amore, nel mondo dei vivi gli altri personaggi continuano la loro vicenda vorticosamente rapida: Aristeo non accetta i consigli della nutrice di dimenticare la povera Euridice e ritornare tra le braccia dell’antica promessa; Autonoe minaccia vendetta con l’aiuto dei suoi “bravi”, Achille ed Ercole, di nuovo in fuga dalle lezioni del centauro; Esculapio espone al giocane Orillo la teoria dell’inutilità del piangere una moglie perduta. Quando finalmente si ritorna alla scena infernale, in III, 11, è beffardamente troppo tardi: Plutone sta già decretando la vittoria di Orfeo (“Orfeo, vincesti”) con un canto commovente, articolato, drammatico. La grande preghiera orfica, luogo della magia ficiniana in Striggio, dell’arte allusiva di Buti, è completamente 38 Mentre Buti modifica la scena all’interno dello stesso atto e sempre tra un atto e l’altro, Striggio, al contrario, più vicino al teatro accademico tradizionale, cambia la scena soltanto tra secondo e terzo atto e tra quarto e quinto. La scelta di Aureli sembra intermedia, in questo caso. 15 L. Pergreffi assente sulla ribalta lagunare del carnevale; al contrario, il ruolo del re degl’inferi e del cantore sono rovesciati a tal punto che questi non canta nemmeno. Infine, la scena della disperazione finale di Orfeo è il luogo in cui maggiormente l’esigenza di un ritmo narrativo regolare e vivace prevale sulle ragioni di espressività degli affetti. Dopo l’incipit nel tradizionale binomio endecasillabo-settenario, dopo un breve recitativo, il lamento vira su una struttura ritornellata con versi più brevi (tutti settenari piani e tronchi) e di argomento misogino, quasi una cabaletta, al termine della quale, senz’altro motivo, il poeta conclude la sua performance sulla scena. Lo spettacolo si conclude, sanato dal lieto fine della seconda coppia, Autonoe-Aristeo, finalmente riappacificati, e con l’intervento ex machina di Teti, non a coronare una possibile lettura allegorica della trama, bensì a calmare l’ira dell’irascibile figlio Achille, risentito per il rifiuto dell’amata. Quasi con funzione di marchio della Venezia ospitante, la ninfa del mare, co-protagonista della vicenda di Troia, era poi associata alla nascita di Roma, del cui impero la Serenissima si riteneva l’erede naturale. Nella gioia finale la tragedia Orfeo ed Euridice è completamente dimenticata e, d’altra parte, il pastore tracio ha perduto il suo ruolo di cantore, suddiviso da Aureli, tra Achille, Euridice e Plutone. Non solo poi il nostro protagonista non è più il musico-mago in grado di modificare la realtà con il suono, ormai anche il suo eroismo è scomparso, a favore di una nuova ri-narrazione dei fatti ironica, dissacrante, rovesciata. Eppure, sebbene sia chiaro che Aureli non aveva affatto bisogno di ricorrere ad una fonte letteraria per inventare un nuovo efficace libretto, una storia di gelosia ed intrigo con intarsi puramente comici qual è questa, tuttavia mostra di ricorrervi nelle allusioni e alla tradizione latina della storia e alle elaborazioni dei libretti precedenti. Il mito è viva sorgente sotto la superficie convenzionale dell’opera, e la alimenta con la sua presenza, come pure grazie a velati riferimenti, oppure brillando per la sua assenza ed il suo stravolgimento: genera – com’era sua funzione in questo tipo di teatro – un prodotto nuovo, ma non irriconoscibile, cioè un’opera convenzionale. “Aureli ha prodotto – osserva la Rosand – un dramma per musica convenzionale, nonostante il mito. Tuttavia è il mito, tanto con la sua assenza quanto con la sua presenza, il vero grande responsabile dell’acume del libretto”39. Il codice retorico del libretto d’Aureli, il suo modo di distribuire sillabe nei versi e i versi in arie e recitativi è la misura del punto di elaborazione della convenzione operistica, nel teatro impresariale veneziano. Le scene sono trattate quasi tutte in maniera uniforme, concluse (e spesso anche aperte) da un’aria, preferibilmente in versi binari oppure, comunque brevi, ariosi, scorrevoli e comprensibili. Gli ondeggiamenti dei versi più lirici – e più “recitabili” – sono quasi scomparsi, se non in alcuni pochissimi passaggi in cui assumono un peso assai più rilevante, quello della loro quasi-anomalia: il canto di Achille (non di Orfeo!), quello di Plutone, ed infine il lamento conclusivo di Orfeo; al loro posto sono preferiti versi 39 Cfr. E. ROSAND, L’Ovidio trasformato, in A. AURELI – A. SARTORIO, L’Orfeo, Ricordi, Milano, 1983, p. XXXI. La traduzione è mia. 16 “Pasce con gli occhi e per l’orecchie beve” di struttura meno complessa, ma con il vantaggio di non entrare in corto circuito con la musica alla quale erano destinati, ma, al contrario, di consegnarvisi in una lingua semplificata e scarna. La scelta dei metri nell’Aureli librettista non è ascrivibile soltanto alle semplici finalità musicali dei versi, anzi: spesso la metrica partecipa del gioco satirico della trama di cui costituisce il supporto. Laddove, ad esempio, il letterato accademico si aspetta l’endecasillabo, il librettista imprenditore fa trovare, tutt’al più, un settenario alternativamente piano e tronco (secondo lamento d’Orfeo) quando non un ancor più rapido senario (primo lamento, in III, 3). E se Buti aveva imboccato la via della Lira, quella di Aureli non è nemmeno più una Sampogna, casomai un sintetizzatore elettronico che rimandasse indietro riprodotti e distorti i codici letterari e metrici della tradizione, mantenendo però il tempo. (agogico, ma anche “la moda”.) Non più inverosimili, né narrative, semplicemente elementi del gioco teatrale, in Aureli più della metà delle arie sono o d’entrata o d’uscita40, elemento della drammaturgia musicale per scandire il tempo narrativo, riepilogare l’accaduto ed eventualmente sdrammatizzarlo. Con il moltiplicarsi del numero delle arie, infatti, queste avevano perso la loro funzione di introduzione al personaggio o alla nuova situazione, come nel primo teatro veneziano, ed erano diventate il luogo del rito convenuto fra musicisti, cantanti e pubblico: l’applauso scrosciante al termine dei virtuosismi, anche a costo d’interrompere il fluire dell’azione. Fu giocoforza, a questo punto, collocare questi pezzi di bravura al termine della sequenza narrativa e renderli, di conseguenza, punti cardine dell’articolazione delle scene, scheletro portante dei testi, oltre che esigenza imprescindibile della produzione di successo. La finezza dell’Aureli non sta tanto nel rovesciare la vicenda in altro-da-sé, bensì nell’affidare alle parole ed ai metri, nella loro metamorfosi o dislocazione improbabile che fa di esse “altro nell’altro”, le spie del riconoscimento dei personaggi noti, sotto le loro maschere veneziane. Ancora una volta siamo di fronte ad una via metamorfica, le lacrime di Mirra diventano la resina di un albero con il suo nome, e sotto la scorza del tronco dell’alloro si intravede ancora il profilo di Dafne. 40 Si chiamano Arie d’Entrata le arie cantate immediatamente prima dell’uscita di scena, cioè dell’entrata dietro le quinte, quelle che la E. ROSAND, Opera in Seventeenth-Century Venice.The creation of a genre, Berkley and Los Angeles, University of California Press, 1991, cap. 10, p. 291 e sgg. chiama “exit aria”; Arie d’Uscita, al contrario, sono le arie con le quali esordisce un cantante appena entrato in scena, ossia uscito dalle quinte. 17
Scaricare