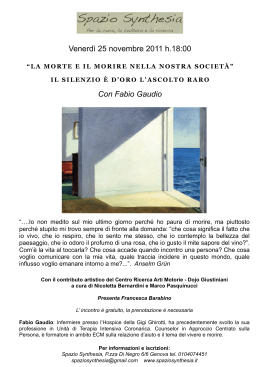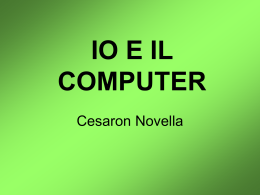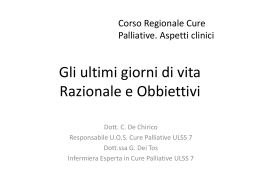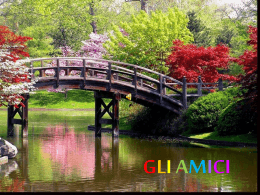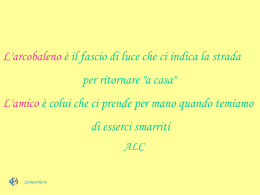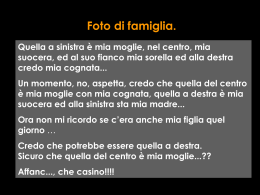IMPARARE A DIRSI ADDIO giornata di studio 21 maggio 2008 Bianco Speranza Assessore Politiche Sociali Provincia di Bergamo - - Benvenuti a tutti! Con l’incontro di oggi intendiamo proseguire l’esplorazione e l’approfondimento di temi importanti per la qualità del prendersi cura. Lo scorso novembre, nel corso della giornata di studio “Cure benevoli per sostenere l’anziano fragile”, il Prof. Guaita ha esplorato le potenzialità di un nuovo modello di assistenza, il Gentle Care, nel sostegno ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie. Oggi vogliamo riflettere intorno ai temi dell’assistenza al morente, del significato della sofferenza e dell’elaborazione della perdita. Accompagnare una persona che sta percorrendo l’ultimo tratto della sua vita terrena, sostenerla nella ricerca di un senso da dare all’esperienza che sta vivendo, aiutare i familiari che l’hanno amata ad affrontare il distacco, è probabilmente uno dei compiti più difficili che toccano agli operatori dell’area anziani e non solo. Affinché la relazione con il malato e con i familiari possa essere umanamente confortante è necessario che chi sta vicino al malato sappia confrontarsi liberamente con il mistero della morte e, insieme, con il senso profondo della vita. E’ proprio questa consapevolezza a riportare la pratica assistenziale al suo significato originale che è quello di offrire condivisione e contatto umano, prima ancora di atti medici. Prendersi cura delle sofferenze fisiche e psicologiche dell’altro fino alla fine della sua vita è sempre un’esperienza dura e difficile da vivere. Ogni operatore, ogni familiare che l’ha attraversata sa che può essere un’occasione di maturazione e di crescita se il dolore della perdita può essere condiviso, accettato e quindi contenuto e infine elaborato. Ci aiuteranno nella riflessione su questi temi relatori particolarmente qualificati, diversi per formazione e ruolo professionale: la dottoressa Eliana Adler Segre, psicologa e psicoterapeuta, con una lunga e solida esperienza professionale sia nella formazione e nel sostegno agli operatori, sia nella cura di malati terminali e di loro familiari. Nel suo intervento tratterà degli aspetti relazionali presenti nell’assistenza di un malato in fine vita, dei diversi linguaggi agiti da tutti gli attori in gioco, dei loro bisogni e di come sia possibile costruire un contesto di vita ricco di comprensione e di affetto; don Maurizio Chiodi è, tra l’altro, docente di Teologia Morale al Seminario di Bergamo, membro del Comitato Etico degli Ospedali Riuniti di Bergamo e dell’Istituto Medea della Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Si occupa da tempo delle implicazioni etiche della sofferenza e della terminalità. La prospettiva etica aiuta a leggere il passaggio tra la vita e la morte nella sua profondità umana e ad accogliere il bisogno fondamentale di ogni persona di non essere lasciata sola. La Provincia di Bergamo è vicina agli operatori che si devono confrontare molto spesso con questo e con altri difficili temi. Contiamo di programmare più volte all’anno giornate di studio come quella del 15 novembre scorso e come questa. Speriamo in questo modo di offrire a tutti gli operatori dell’area anziani una possibilità di aggiornarsi, di osservare sotto una nuova luce le difficoltà con essi incontrano quotidianamente e di amare sempre più il loro mestiere, così prezioso, delicato e utile per l’intera comunità. A tutti l’augurio di buon lavoro! Eliana Adler Segre Psicoterapeuta, autrice del libro “Imparare a dirsi addio”. Buongiorno a tutti, mi ha già presentata la dott.ssa Federica Mangione, sono Eliana Adler Segre quello che volevo dirvi è grazie di essere venuti e grazie, in primo luogo, all’ amministrazione provinciale di Bergamo che ha avuto il coraggio d’affrontare un tema come questo che, a mio avviso è di grande attualità, perché tutti quanti dobbiamo morire, perché la morte fa parte della vita, soltanto che questo è un tema tabù di cui non si riesce mai a parlare. Prima di cominciare, io ho chiesto alla dott.ssa Mangione chi sono i partecipanti perché ho visto ragazzine molte giovani e ho visto delle persone che invece paiano avere già delle esperienze più mature e quindi mi domandavo quale potrebbe essere l’argomento che è più indicato per voi. Dopo 35 anni di lavoro professionale preferisco parlare a braccio perché desidero stabilire con il mio auditorium un rapporto più diretto, più vero e più autentico e spero di riuscire a farlo anche con voi. Guardando in sala mi pare, come al solito, di vedere quasi tutte donne, come se l’accompagnamento alla fase terminale della vita sia dovuto esclusivamente alla donna. Credo che i familiari dell’anziano o di qualunque altra persona che sta morendo abbiano bisogno di avere intorno delle figure professionali diverse e gruppi di auto-aiuto. Ognuno di noi ha il suo modo di percepire le diverse situazioni di vita e può mettere in atto modi diversi di vicinanza rispetto alla morte. Sarebbe molto bello che più uomini partecipassero a questi percorsi, per offrire a chi sta morendo forme di comprensione diverse, muoiono uomini e muoiono donne. Ho pensato di parlare, come prima cosa, dell’accompagnamento che è un’operazione estremamente complessa e difficile; come secondo argomento, proprio perché vedo presente delle persone giovani che stanno preparandosi alla professione, mi sembrava fondamentale parlare di come accompagnare bene e che cosa vuol dire farlo con professionalità ed umanità. Per poter fare un buon accompagnamento è necessario conoscere i bisogni che hanno i malati, i bisogni degli anziani che seguite o le persone di cui vi occupate che con voi fanno un cammino, a volte difficile, verso la fine della vita. Voi siete, per loro, come dei compagni di viaggio e compagni di un percorso, il tempo del vostro lavoro, durante il quale ci si prende la mano per fare un tragitto. Questo è il vostro compito e allora questo tragitto che cosa mette in luce? Fa emergere dei bisogni sia della persona che viene assistita e sia della persona che assiste. Bisogni come li abbiamo tutti noi, da esseri viventi. Ricordiamoci che chi è morente è un essere vivente, chi è anziano è un essere vivente e, in quanto tale, ha dei bisogni che diventano specifici a seconda dell’età e della situazione. Parlerei quindi dei bisogni, parlerei delle difese che possono esserci sia da parte di chi ha una malattia grave, sia da parte di chi deve invecchiare e non ne ha affatto voglia. E poi ci sono i bisogni dei familiari che provano le stesse emozioni dei loro malati, che mettono in atto delle difese che vogliono avere per se dei momenti di comprensione, che trovano momenti d’intolleranza, di rabbia, di ribellione. Tutto un complesso molto intricato di sentimenti accompagnano il viaggio verso la morte. Li chiamiamo ”difese psicologiche”, sono umane, le abbiamo noi, nella nostra vita quotidiana con il nostro marito, compagno, figli, chiunque ci frequenta, vicino di casa piuttosto che persona che incontri mentre guidi la macchina. E’ necessario far attenzione: esistono i bisogni e le difese nei malati, nei loro familiari e negli operatori che accompagnano lungo questo percorso di vita. Durante il corso dell’accompagnamento tre grandi gruppi sociali si incontrano con la loro cultura, con la loro etnia, con le loro abitudini, con le loro diversità, con le loro diverse esperienze di vita. Sono i malati, gli operatori e i familiari. Pensate che in un momento così difficile come quello terminale della vita si mettono insieme delle persone che hanno idealità, valori, culture, modi di essere assolutamente diversi e che, per essere veramente di aiuto diventa necessario incontrarsi per trovare armonia e comprensione reciproca. Se non ci si viene incontro non si costruisce niente. Ogni operatore “sotto il camice è uomo”: questo è un aspetto che va sempre tenuto presente. Il camice, a volte, è come se coprisse assolutamente tutto, come se rendesse tutti uguali, tutti solo professionisti. Il camice mette in risalto la funzione. Il medico appare con il camice bianco e sembra che la funzione che gli viene richiesta sia solo quella di tipo 2 sanitario, mentre invece, a chi è malato, non basta una prestazione sanitaria perché ha un’anima, ha un cuore, una mente, uno spirito. L’essere umano è composto dall’insieme di più parti, non esiste una parte sola. Se c’è una parte che non funziona tutte le altre ne risentono quando si sta male. C’è un’attenzione emotiva a sentire che cosa ti dice il medico, che cosa trapela dal viso della persona che ti sta assistendo, dal suo modo di comportarsi, dal contatto fisico che ti offre c’è un linguaggio non verbale molto ricco e complesso che per voi deve avere un’estrema importanza. Il morente, molto spesso, ha bisogno di qualcosa che non è l’intervento clinico, che va incontro alla sua sofferenza psicologica, alle sue paure. Ha bisogno di vicinanza intelligente, di serenità. Ogni operatore deve sapere che la qualità del suo lavoro sta anche nella capacità di superare le proprie inquietudini. Da psicoterapeuta vi posso dire che, anche per me, è sempre difficile “staccare la spina” ; non è con un “click” che si allontana tutto ciò che si sta vivendo o che si è appena finito di vivere… Questo si chiama coinvolgimento. Una delle cose che vi sono richieste come operatori è anche la capacità di tenere una giusta distanza. A questo proposito mi viene sempre in mente un cartello presente sulle autostrade con scritto “mantenere la distanza di sicurezza” ed io che sono una persona non abilissima nella guida, mi chiedo sempre chissà di quanti metri è la distanza di sicurezza? La distanza di sicurezza, per noi che lavoriamo con persone così gravi, è una necessità e non dobbiamo vergognarci di questo, non sentirci degli egoisti perché distanza di sicurezza vuol comunque dire essere presenti, essere partecipi, vuol dire stare vicino agli altri, occuparsene, mettere il proprio cuore a disposizione tenere presente che lui sta morendo, che lui sta invecchiato, ma che io ho diritto alla mia vita e se la posso vivere bene posso aiutare, posso far bene il mio lavoro. Dobbiamo mantenere l’idea che comunque questa distanza è fatta per poterci incontrare, per poterci avvicinare all’altro e non per segnare una lontananza. Dobbiamo anche essere capaci di lavorare senza mettere la maschera della difesa perché non reggiamo il lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo mantenerci la garanzia di poter continuare il nostro lavoro e quindi di avere i nostri spazi, di avere il nostro tempo libero, la nostra vita fuori dal lavoro. Una delle gravi conseguenze del lavoro di cura il born-out. Sapete cos’è il born-out? E’ uno dei temi che credo che sia stato più trattato in psicologia negli ultimi tempi. Consiste in una caduta della propria capacità emozionale. E’ come uno stato d’apatia, di distacco dal lavoro, di disagio, di malessere. Il born-out è una condizione, uno stato d’animo che porta a lavorare male e a star male. Il born-out ha conseguenze sulla persona che si ritrova in questo stato di disagio emozionale ma anche sui compagni di lavoro, sulla sua famiglia e su tutte le persone che le stanno intorno. Per questo è molto importante che chi opera in questo nostro ambito, che è così difficile e così serio, abbia degli spazi personali per poter parlare del suo lavoro e dei sentimenti che prova, uno spazio per poter elaborare le proprie difficoltà, i propri disagi. Ciò è possibile se esiste fiducia e confidenza nell’equipe di lavoro. Mi rendo perfettamente conto perché ho lavorato tanto con gli operatori e so benissimo che non è facile il lavoro di assistenza, come dall’altra parte non è facile lavorare alla FIAT, come non è facile lavorare in un qualsiasi ambiente. Tutti troviamo dei disagi e delle difficoltà, c’è chi c’è simpatico e chi c’è antipatico, sicuramente nel nostro ambito lavorativo capitano, gli stessi pettegolezzi che capitano in tutti gli ambienti e questo rende difficile “starci dentro”. Rende difficile la vita tra le persone, rende scontrosi e invece bisognerebbe essere un po’ più capaci a aiutarci reciprocamente. Se esiste una buona relazione tra le persone che lavorano insieme, un’armonia all’interno di un equipe, le cose funzionano meglio, si sta meglio e si cura meglio la persona di cui ci si deve occupare. Abbiamo parlato dei bisogni dei malati terminali e degli operatori che se ne prendono cura. Ora vorrei parlare del luogo in cui si conclude il percorso di vita, dove una persona muore. Chi lavora in ospedale incontra tipi di malato che hanno che hanno bisogno di una relazione diversa, di accompagnamenti fatti in casa o in hospice. In un hospice, che è un servizio per la fase terminale della vita, i tempi di permanenza possono essere brevi, pochi giorni, qualche mese. E’ il momento delle cure palliative, quando serve alleviare il dolore, guardare soprattutto alla qualità degli ultimi tempi di vita. I primi hospice sono nati per i malati di AIDS, poi per quelli oncologici. Sono presenti a Brescia, a Milano ed anche a Bergamo. Il nostro Assessore, dottor. Bianco Speranza, parlava di quello di Palazzolo. Sicuramente gli operatori che lavorano nell’Hospice hanno dei bisogni diversi da quelli che lavorano con i malati anziani. Non è agevole lavorare con una persona che non ti capisce, a cui comunque si deve rispondere : il luogo in cui si assiste è determinante. Un conto è fare assistenza in una struttura, un altro è essere soli in una 3 casa. Ora vorrei parlare dei comportamenti delle persone gravi o dei morenti e di alcune difese che loro mettono in atto; del linguaggio che il morente utilizza e le possibili risposte che gli operatori possono dare. Mi sembra che questi argomenti vi possano interessare. Che cosa capita, alla persona morente, al malato terminale? Quando ci si ritrova a essere una persona che dal momento della diagnosi sa che morirà, si attraversano delle fasi emotive che si ripetono e si alternano. Noi abbiamo come compito quello d’occuparci dei morenti: il malato morente spesso manifesta, un’alternanza, una trasformazione continua del proprio stato psicologico che è segnato da tratti d’aggressività, di rivolta e di depressione misti anche a una nostalgia per il tempo passato, ad un senso di lutto dovuto ogni volta alla perdita di chi lascia. Una persona morente vive alternativamente dei sentimenti molto complessi, molto articolati, molto contraddittori man mano che progredisce la malattia e va sempre più verso la morte. Aumenta l’angoscia e questo è un sentimento che tutti proviamo perché tutti abbiamo paura della morte. Io credo che anche chi se ne occupa da tanti anni è del tutto guarito, perché la fine inevitabile della vita, fa sempre paura. Eppure la morte fa parte della vita, lo diciamo, lo sappiamo, ci crediamo, alcuni fortunati ci credono per fede, però abbiamo paura di quello che ti aspetta, l’angoscia del dolore che potremmo provare, la paura di quello che sarà dopo, di quello che ci aspetta dopo la morte. Non credo affatto che questo argomento sia un tabù, anzi credo che, considerandolo un tabù faccia sì che non se ne parli, anche se il timore della morte è umano: sfido chiunque di noi a non aver paura della morte e di quello che sarà dopo. Mi sono occupata, di morenti per tre anni; ho condotto un gruppo di malati terminali, ragazzi malati di AIDS che sapevano di dover morire. Ogni volta che moriva qualcuno io mi angosciavo: io ho retto tre anni. Avevo un gruppo di 5 persone più una che veniva saltuariamente al gruppo. Io, in tre anni, ho visto morire 20 persone. Dopodiché mi sono detta: “Il gruppo resta in piedi, io resto viva, ma io non posso reggere questo costante morire..” e quindi ho deciso che era meglio facessi della formazione, che ritrasmettessi quello che questi ragazzi mi avevano insegnato e chiesto di dire. Da questa esperienza è nato il mio primo libro che ho scritto con il Professor Zapparoli. Allora ero convinta d’aver imparato tutto, ora ho i miei dubbi, ho imparato quello che quei ragazzi, amorevolmente, mi hanno dato. La cosa che volevo trasmettervi e che ho imparato sul serio è che le persone che tu aiuti ti rispondono con gratitudine, gradiscono il tuo aiuto e te lo fanno capire, per cui l’aiuto diventa reciprocità e scambio. Quando si aiuta qualcuno si riceve gratitudine, si instaura uno scambio reciproco, come nell’amicizia è nell’amore e questo sentimento resta vivo fino alla fine. Credo che comunque non si possano aiutare tutte le persone nella stessa maniera, credo che si crei un’empatia particolare con alcune persone. Da alcuni pazienti puoi avere di più e da altri puoi avere di meno. Come succede anche agli insegnanti, si può avere più simpatia per degli allievi piuttosto che per altri, e ciò dipende anche dal carattere, dalle modalità di comportamento dell’altro. Una persona è più gradita, nasce un’empatia più intensa, un legame oggettivo che poi rimane dentro e che fa soffrire quando quella persona se ne va, muore. Elaborare il lutto della perdita di una persona è necessario per mantenere la capacità di continuare il lavoro di cura. Pensiamo alla solitudine delle badanti, chi elabora con loro quel lutto? Chi le aiuta in questo percorso? Ho una badante che è stata 15 anni con un’anziana, non fa altro che parlarmi della “sua signora”, perché quel legame per lei è stato fondamentale ed ora non c’è più perché è morta. Dopo la morte della signora i familiari le avevano offerto ospitalità ancora per tre mesi, ma lei, dopo una settimana ha voluto partire ed è tornata in Sri Lanka, il suo paese d’origine. Quello è stato il suo modo per scappare dal dolore, dal lutto. E’ questo che viene chiesto anche a noi, di essere chiari e onesti, puliti. Tu offri, se ti senti d’offrire, però quando offri “ci metti dentro del tuo”, sempre con quei confini di cui vi parlavo prima per preservarvi e poter continuare il lavoro che fate. Se non ci riuscite sappiate che non si può continuare per sempre a scappare senza elaborare, ci si ammala. Qualcosa dentro di noi resta, ci portiamo a casa un pezzo del nostro lavoro, abbiamo bisogno di imparare a prendere la giusta distanza che non è scappare via. Il morente, chi sa che deve andarsene, sa di avere molto poco tempo davanti, vive una progettualità limitata nel futuro e ha molta paura di perdere quelle che erano le sue prerogative, i suoi ruoli. Il contesto sociale nel quale viviamo privilegia solo l’essere attivi, capaci, “funzionare bene”, non chiedere aiuto a nessuno, non avere bisogno di niente. Questo è quello che sentiamo intorno a noi, ma quando si è fermi a letto, quando si continua a dimagrire, quando le risposte alle tue domande sono sempre meno ed hai sempre più bisogno di essere rassicurato, provi il terrore di essere abbandonato, di morire solo, di dare fastidio e di essere un peso per gli 4 altri. A volte sono davvero un peso, assistere questi malati è faticoso e, ogni tanto, noi no ne possiamo più. Vivono in una grande ansietà, hanno bisogno di rassicurazione costante che se non trovano li può portare a un certo momento a un ripiegamento su se stessi, a un isolamento emotivo, ad essere meno partecipi, talvolta anche aggressivi. A volte, soprattutto nella fase terminale della vita, possono vivere una forma di regressione, diventare più dipendenti, molto esigenti, molto attenti a quello che gli altri dicono a quello che gli altri fanno, a come si comportano.Talvolta i malati, negano completamente quello che hanno, fanno finta di non avere niente, altre volte cadono in uno stato depressivo di disperata impotenza. Tutto questo come lo esprimono? Molto spesso usano un linguaggio molto semplice, molto poco articolato, molto simbolico. A volte dicono semplicemente “so che si avvicina la mia ora”, molti di voi che lavorano con gli anziani sanno che questa è una delle frasi più comuni. Altre volte, per richiedere un po’ d’attenzione, mantengono il silenzio, come i bambini piccoli, non mangiano, fanno un po’ i capricci… E’ un modo anche quello per chiedere vicinanza, affetto, solo che molto spesso noi siamo irritabili, irritati e non abbiamo voglia o non sappiamo rispondere a questo linguaggio così simbolico e così semplice, infantile, come se avessimo a che fare con un bambino. Probabilmente questi stessi disagi li provano anche i familiari che si occupano di loro, perché non accettano che una persona che ha avuto un ruolo d’importanza sino a quel momento l’abbia perso completamente. Nella fase terminale, spesso i malati ricordano i bei tempi passati, vanno indietro con la memoria, questo negli anziani è molto tipico, ricordano dei periodi positivi e si immergono in quel periodo. A volte, in stadi molto avanzati della malattia, chiamano spesso la mamma come se fossero realmente piccoli, come se avessero realmente questo bisogno. Accompagnare un morente presenta delle difficoltà estreme e di questo dobbiamo tenere conto, esserne consapevoli. Sappiamo che i malati mettono in atto che delle difese anche molto particolari, ne parla in modo molto chiaro Elisabeth Kubler Ross nel suo libro, forse un po’ datato, “La morte e il morire”. Kubler Ross era una psichiatra americana che ha cominciato per prima ad occuparsi sistematicamente di malati terminali; credo che ne abbia visti più di 700 nel corso del suo lavoro. Attraverso lo studio dei casi di cui si è occupata ho potuto individuare una gamma di difese tipiche che comprendono prima di tutto la negazione. Sono soprattutto i malati terminali, i malati gravi, a difendersi dall’angoscia della morte imminente negando. Dalla diagnosi in poi dicono no, non è possibile, si sono sbagliati, non posso avere un tumore, non è vero. Questa sorta di rifiuto, è, in certi momenti, anche ribellione come dire: “Perché deve capitare a me, doveva capitare a qualcun altro”. Non c’è cattiveria verso gli altri, c’è soltanto la non accettazione che una cosa così grave sia capitata proprio a loro, quindi la negazione, la ribellione, e poi si passa ad una sorta di patteggiamento, come dire va bene, sono malato, speriamo comunque nelle cure, nel medico e forse anche nello “stregone”. C’è la chemioterapia, la radioterapia e tante altre possibilità. In altri momenti può comparire una forma di depressione, un desiderio d’isolamento e in altri ancora si può arrivare all’accettazione, ma forse più che accettare ci si rassegna, si arriva a patti perché si sa che quella è la realtà. Questi meccanismi di difesa non si presentano secondo una schema preciso, non sono tappe di un percorso che una volta superato non si presenterà più. Sono emozioni e come tali cambiano e si intrecciano a seconda dei momenti che si stanno vivendo. Noi siamo esseri estremamente complessi, molto articolati, sia nella salute che nella malattia, nell’amore, nei nostri rapporti affettivi, nei nostri rapporti umani. Chi sta per morire ci chiede di essere rassicurato, di non essere abbandonato, e soprattutto, di non morire da solo. Qualcuno ha detto tutti moriamo da soli è vero, ma l’accompagnamento prevede anche tutta la parte terminale della vita, quando la persona è ancora viva, ma quando non parla più e ti guarda, quando ti parla con gli occhi, e in qualche modo comunica, vuole un contatto. Ecco, io credo che gli anziani, i malati terminali, come in fondo tutti quanti noi, cerchino lo sguardo per capire se quello che viene loro detto corrisponde a verità. Ricordatevi che è un bellissimo lavoro il vostro, se fatto però nell’empatia, nel rapporto buono con i colleghi, io non sono per il buonismo acritico, sono per una relazione di scambio. Si tenga presente che deve esistere la relazione di scambio tra noi e il malato terminale ma anche tra noi e i nostri colleghi. Per esempio nel corso del mio lavoro di formazione ho trovato che hanno un grande beneficio gli operatori che riescono a ottenere dalle loro amministrazioni la possibilità di un momento d’incontro, un momento in cui possono parlare delle proprie difficoltà. Il nostro è un lavoro in cui le personali difficoltà di lavoro fanno parte del mestiere e devono essere elaborati insieme a chi lavora con noi. Pensate che in Francia quando c’è un lutto tutti quanti elaborano questo lutto. Muore un paziente in un Hospice e tutti gli operatori hanno un momento d’incontro in un luogo speciale che chiamano (liè de parole), 5 luogo della parola. Parole, in francese, vuol dire scambio, qualcosa di più complesso, più articolato del semplice parlarsi e questo è fondamentale. Ho voluto scrivere questo mio libro “Imparare a dirsi addio” per offrire un occasione di riflessione e di apprendimento. Serve anche leggere e studiare perché certe cose bisogna saperle, ma serve anche quello che voi potete dirvi tra di voi e potete dire con i vostri medici: inserite i medici nel vostro dialogo, nei vostri rapporti perché anche loro sono persone che possono darvi aiuto nel comprendere, sappiate chiedere della morte. Il tema è scottante, è un tema che non circola molto volentieri. Oggi interessano di più altri argomenti, ma noi siamo persone che si occupano di questi problemi e siamo tanti,ci siamo e vogliamo parlare della morte come un elemento vitale e che merita il nostro rispetto e il nostro interessamento. Ecco, io chiuderei qui e lascerei spazio per le domande che intenderete farmi, vi ringrazio. 6 Don Maurizio Chiodi Sacerdote, docente di teologia. Buongiorno a tutti voi, io credo che mi troverò abbastanza in sintonia con quanto già detto dalla dottoressa Eliana Segre. Il titolo che mi è stato assegnato è “Prendersi cura della persona in fine vita, aspetti etici”, mi domanderò soprattutto quali sono le questioni etiche che si pongono nel rapporto con un morente e dunque al centro di questa nostra riflessione c’è una relazione e questo è un aspetto importante da tenere presente, non ci sono delle persone isolate che si incontrano, ma ci sono dei soggetti che sono in relazione e sono modificati dalla relazione. Devo dire che qualche volta quando si tratta questo tema del prendersi cura della persona in fine vita, si rischia di scivolare facilmente nel porre il problema in termini puramente antagonisti, eutanasia sì, eutanasia no, o accanimento sì o accanimento no, anche se tutti dicono almeno a parole no all’accanimento terapeutico. Ecco, io credo che quest’impostazione del dibattito sia riduttiva, in realtà la domanda che noi ci poniamo va al di là degli slogan, è una domanda molto personale e anzi tutto riguarda coloro di cui noi ci prendiamo cura, cioè il paziente, il morente. Riguarda innanzitutto l’altro che muore, riguarda una domanda di vicinanza. Sicuramente si tratta di una questione molto personale che riguarda l’altro che si sta avvicinando alla morte e come intende vivere questo tempo d’avvicinamento alla morte, alla propria morte. Questa è la domanda che riguarda lui, c’è anche un’altra domanda che riguarda gli operatori, i familiari, gli amici e i parenti. Io sottolineerò alcuni aspetti di questa domanda, innanzitutto l’esperienza della morte è un’esperienza di sofferenza, il morente è una persona che soffre, è una persona che magari ha il corpo devastato dalla malattia, partendo da lunghi mesi di sofferenza, d’immobilità. Pensate che cosa vuol dire essere costretti a stare immobili per mesi, non potersi muovere e quindi è un’esperienza forte d’impotenza. La sofferenza è un’esperienza molto particolare della vita, è un tempo particolare, a me piace dire che la sofferenza è un tempo di prova, non perché ci sia qualcuno che ci mette alla prova ma è un’esperienza faticosa, particolarmente probante, è un’esperienza di lotta, di debolezza che mette certamente alla prova. Che cosa? Credo che la sofferenza che non piace a nessuno di noi, anche se nel passato devo dire che anche noi credenti, anche noi cattolici abbiamo forse eccessivamente sottolineato che l’esperienza della sofferenza va accolta, va quasi apprezzata. Un modo di pensare verso il quale io sono decisamente critico era il dolorismo, una sorta di compiacimento dell’esperienza della sofferenza. Mi sembra che oggi stiamo toccando l’estremo opposto, non voglio dire che la sofferenza sia una cosa buona, assolutamente, la sofferenza è un’esperienza dura, diciamo che mette alla prova la fiducia nella bellezza della vita. Tuttavia l’esperienza della sofferenza fa parte in modo costitutivo della nostra vita. Ma allora possiamo fuggire semplicemente dalla sofferenza? Dalla sofferenza portata dall’avvicinarsi della morte. Credo che la sofferenza non cercata, ma vissuta quando si presenta, possa essere vissuta anche con frutto. Mi riferisco ad un’espressione che usavano i tragici del mondo greco e che dicevano che la sofferenza, il patire, istruisce l’agire, istruisce il vivere. Conosco molte persone che sono state profondamente istruite dalla sofferenza che hanno vissuto. Conosco certo anche molte persone che si sono ribellate, che hanno espresso tutta la rabbia l’insofferenza verso il soffrire, ma anche delle persone che hanno saputo vivere con frutto il patire e in questo senso l’esperienza della morte che ti mette alla prova, può essere vissuta con frutto, come un’istruzione. Una seconda caratteristica è che l’esperienza della morte, l’esperienza del morente comporta una profonda dipendenza dagli altri. Il malato in genere, soprattutto il morente è uno che ha bisogno di tutto, perché è debole, deve essere accudito, deve essere lavato, deve essere nutrito come un bambino. In effetti, l’esperienza del morire si avvicina ad alcuni aspetti dell’esperienza dell’infante, del bambino che non sa parlare. Quest’ esperienza di dipendenza dagli altri rende molto forte il riemergere di alcuni bisogni fondamentali. Il morente è completamente dipendente dagli altri magari nella sua vita lavorativa è stato un dirigente, oppure un lavoratore estremamente impegnato, a un certo punto si ritrova lì debole, impotente, dipendente dagli altri. Anche per questa ragione il morente è tentato di “sfruttare” questa situazione, cioè è tentato di assumere degli atteggiamenti regressivi d’infantilismo, chiama in continuazione, vuole essere rassicurato, cerca la presenza di altri oppure si lamenta diventa noioso, pesante, difficile da sopportare. Oppure quest’esperienza d’impotenza reale che costringe continuamente a chiedere può far nascere nel morente un senso d’inutilità, un sentimento di colpa per essere causa di fatica per gli altri. C’è un terzo aspetto nell’esperienza di chi sta per morire ed è il senso di perdita e di distacco, il morente è un uomo che si avvicina alla fine della vita e che sente che la vita gli sta sfuggendo. Quando il respiro diventa affannoso la 7 vita diventa più difficile, più faticosa, si può anche attaccare il ventilatore artificiale ma non passa l’affanno di uno che sente che la vita lo sta lasciando, il respiro diventa debole, affannoso. Spesso è molto difficile parlare, invece che un lungo discorso, il morente è capace di dire poche parole e in quelle poche parole deve dire tutto. Ogni parola, quindi, diventa ancora più espressiva, densa di significati e chi mette in relazione con lui è necessario che abbia un’attenzione intensa al detto e al non detto. Quello che sfugge al morente non è soltanto la vita biologica, piano, piano sente che gli verranno a mancare le relazioni, gli affetti, questo mondo al quale tutti siamo profondamente attaccati, è necessario distaccarsi da tutto ciò, da tutto il mondo, da tutte le relazioni alle quali durante la vita ci siamo fortemente appassionati, per fortuna. Cambia quindi anche fortemente il rapporto con gli altri. Si modifica il rapporto con gli altri e cambia perché il morente è costretto a modificare e quindi a trovare delle nuove forme di relazione. La fatica sta proprio nell’essere costretto a trovare delle nuove forme di relazione con chi gli sta accanto. C’è un bellissimo piccolo libro che io mi non stanco mai di suggerire a chi lavora nel campo della cura del morente. E’ un piccolo romanzo di Tolstoj che si chiama “La morte di Ivan Illich”, un libretto dove l’autore descrive bene il mutamento vissuto dal protagonista nelle sue relazioni personali. E’ un libro molto bello perché aiuta a comprendere il percorso di trasformazione delle relazioni. La relazione con gli altri, a volte, cambia in bene cioè la consapevolezza dell’avvicinarsi della morte rende più profonda la relazione con chi ci sta accanto, è come se alcune cose secondarie o poco importanti della vita, al cospetto della morte, in qualche modo si dileguassero e allora si ritrova ciò che è fondamentale. A volte, quindi, la morte dell’altro, l’avvicinarsi dell’altro alla sua morte, porta ad un approfondimento della relazione, a volte in male e allora attorno al morente si sviluppa un clima di menzogna. Uso una parola forte, menzogna, potrei anche dire di commedia in cui non ci si mette in gioco, si recita e a volte anche il morente stesso partecipa attivamente a questa “teatrale” come avviene nel caso del protagonista Ivan Illich. Gli altri sanno che si sta avvicinando la morte ma non parlano, lui lo sa, non è stupido, sente che il corpo soffre, che si va disfacendo. Allora la medicina era meno potente, dunque i segni incisivi della malattia modificavano evidentemente il corpo e tuttavia tutti decidono di tacere, di non parlare. Nel caso di Ivan Illich nessuno, tranne un servo della campagna russa, dice la verità. Nessuno ha il coraggio d’instaurare con il morente un dialogo che lascia spazio all’ascolto dell’altro in questo momento così importante e decisivo della sua vita. Certo io sono convinto che davanti alla morte è bene avere un atteggiamento di pudore, dunque non un atteggiamento superficiale, intrusivo, banale. Un pudore da rispettare legato alla difficoltà di comprendere l’esperienza dell’altro. Questo pudore che è bene avere nei confronti dell’altro non è una buona ragione per fuggire dal dialogo con lui e questa è la grande questione del comunicare la verità al morente. Capisco che dire la verità sia una questione ampia, magari se qualcuno è interessato, la possiamo riprendere nel dibattito. Che cosa vuol dire, dire la verità al morente: naturalmente è una questione che vede implicati in modo differente i diversi operatori, l’accompagnatore spirituale, il cappellano, i parenti, gli amici, i volontari. Certo in modo è differente, ma resta una grande domanda. Che cosa vuol dire, dire la verità, io credo che si debba dire la verità, non è scritto soltanto nel codice deontologico, tuttavia non è così semplice saper dire la verità, perché per dire la verità occorre tenere conto di tre cose, c’è uno che parla, c’è uno che ascolta e c’è qualcosa a cui voglio comunicare. Capite che a volte, la soluzione alla grande domanda del dire la verità al morente, risulta in modo troppo semplicistico. Come faccio a dire la verità a uno che non conosco? E’ impossibile, dunque se io non ho tempo per fermarmi un momento, per capire chi ho di fronte, non saprò mai dire la verità, alla fine credo che dire la verità voglia dire fare la verità, essere veri, essere presenti, vuol dire all’altro io ci sono, puoi contare su di me. L’ultima questione: è evidente che il malato che si avvicina alla fine della vita è uno che aspetta di morire, quest’espressione mi incuriosisce sempre, cosa vuol dire aspettare di morire? Posso aspettare d’incontrare un amico, posso aspettare di rivedere un compagno, posso aspettare una cosa bella, posso aspettare un futuro roseo, non so… ci sono tante forme di speranza e d’attesa ma come una persona può aspettare di morire? Che cosa vuol dire aspettare di morire? Perché la morte è la fine del futuro, e in questo senso sembrerebbe la fine di ogni attesa. Ecco, che cosa vuol dire allora aspettare di morire? Qui si apre anche un’altro grande problema che è la difficoltà della nostra cultura a confrontarsi con l’esperienza della morte. Io credo veramente, che la morte sia un tabù. Ci sono grandi filosofi che hanno messo in rilievo come l’unica cosa certa della nostra vita è il morire. Tuttavia la morte è la cosa di cui noi non possiamo e non dobbiamo parlare, non è corretto parlarne, appare sempre fuori luogo. Epicuro diceva: “ La morte non è un problema che mi riguarda…” perché,…” in sintesi, “… quando ci sono io non c’è lei, quando c’è lei non ci sono io…” e tuttavia anche Epicureo, che negava che la morte fosse un problema che lo riguardasse, non ha potuto fare a 8 meno di parlare della morte. Non si vede mai la morte, si vede la morte dell’altro e vedendo la morte dell’altro vedi te stesso morire. Noi viviamo in una cultura che tende a rimuovere, nascondere, sfuggire alla morte e dunque il morente è uno che in particolare ci provoca, ci pone dei problemi, delle difficoltà, perché ci mette la morte davanti agli occhi, anche se non è la nostra ma è la sua, tuttavia so che io non sono diverso da lui. Il morente è uno che sta facendo i conti con una realtà di cui tutti abbiamo “giustamente paura”, abbiamo paura perché non sappiamo che cosa ci attende dopo. La morte pone inevitabilmente la domanda dell’aldilà, che cosa c’è al di là di questa soglia? Uno può dire non c’è nulla, un altro può dire c’è il compimento di ciò che io attendo, un altro può dire non lo so, non posso dire né una cosa né l’altra, si pone comunque e sempre questo il problema. Questa è una domanda che si fa anche il credente naturalmente, non è che per il fatto di essere credente significa che si è avuto qualche rivelazione particolare con la quale si è visto che cosa c’è dopo. Che cosa c’è al di là della soglia e dopo la morte è una domanda che riguarda tutti, è abbastanza interessante anche che Gesù abbia avuto paura di morire, ed è così diversa la morte di Gesù da quella di Socrate. Socrate che va incontro con grande serenità alla morte. Socrate è un po’ l’icona dell’uomo greco, almeno di un certo tipo dell’uomo greco, mentre invece Gesù, profondamente ebreo, ha paura di morire e vive anche la sua morte in croce come una situazione drammatica. Non c’è nessuna meraviglia se noi abbiamo paura di morire, tuttavia come diceva Schiller, un altro grande filosofo del novecento, “…La nostra cultura vive come una paura raddoppiata della morte, anche se poi bisogna dire che in altre culture la morte fa più parte della vita e in questo senso viene accettata. Che cos’è in fondo l’esperienza della morte? La morte noi la viviamo un po’ come un furto, morire è un po’ come subire un furto, sapere di dover morire è un po’ come sapere di dover subire un furto, in un certo senso un’ingiustizia. Mi rendo conto che mentre dico questo suggerisco in fondo questo pensiero: la morte non dipende da me e in questo senso è un furto, è come se qualcun altro mi privasse di me stesso, non so chi, non so come, tuttavia accade che io muoia. In questo senso io credo che la morte anticipata nel pensiero della mia morte è sempre un momento solenne. E’ questo il luogo, lo spazio della parola non del mondo, secondo la lingua francese la parola morte è scambio, è un dialogo. La parola si concretizza attraverso l’intrigo, la trama le relazioni. In questo senso è molto bella l’esperienza del luogo della parola, perché quando accade che un altro muoia, anche se lo conosci poco, l’hai conosciuto in quel tratto finale della sua vita è importante che ci si dica, che ci si comunichi quello che è accaduto e quello che ciascuno ha provato. Per sua natura l’esperienza della morte, il momento della morte è un momento religioso in cui ci pare di toccare la soglia del mistero, che cosa accade quando un uomo cessa di respirare? Adesso ci sono anche le strumentazioni molto tecniche per accertare la morte, ma nel 99 per cento dei casi è la cessazione del respiro il segnale che poi ti fa pensare che l’altro sia morto. La morte in questo senso è oscura, è un’esperienza della quale noi non siamo padroni. Come dire, la morte così come il nascere non è nelle nostre mani, non è in nostro potere. Non è un caso che i latini dicevano abbiano i verbi deponenti come nascondo e, muoio e patisco. Il verbo deponente è un verbo che ha forma passiva, ma significato attivo, è come dire che nel nascere, nel morire e nel patire sei tu che muori e, tuttavia, accade qualcosa che ti sorpassa. Per questo credo che in questo nostro tempo nasca la tentazione di voler accorciare il tempo della vita, di volere anticipare la morte, credo che questa, in sostanza, sia la tentazione dell’eutanasia, l’impossibile illusione di sentirsi padrone anche della morte. In realtà la morte è più forte di me, io non posso decidere se morire, posso decidere eventualmente quando morire, ma non se morire, in questo senso la morte mi mette sotto scacco e nasce anche la tentazione di voler posticipare la morte. L’accanimento terapeutico è la tentazione di voler procrastinare, allontanare la morte senza riconoscere la sua ineluttabilità e allora io ho cercato, di descrivere l’esperienza della morte, di comprendere l’esperienza della morte parlando dell’altro che muore, ma in realtà, più di una volta, mentre parlavo me ne sono accorto, mentre parlavo dell’altro sono stato costretto a parlare di me. Quando parlo dell’esperienza del morente non parlo solo dell’altro, parlo anche di me, perché noi sappiamo che il tempo del morire fa parte del tempo del vivere, è vero che non possiamo non morire e tuttavia ci sono modi così diversi per morire. Ho visto delle persone che sono morte in pace, delle espressioni del volto, oppure delle parole, le ultime parole o i gesti della mano che dicono la pacificazione della morte, anche nella scrittura si dice per esempio che ci sono i vecchi patriarchi muovono sazi di giorni. Il secondo passaggio che voglio sviluppare è il nostro compito accanto, meglio insieme con il morente ci si deve continuamente lasciare interrogare da ciò che egli vive, certo con la giusta distanza senza identificarci, mantenendo una distanza di sicurezza, per non morire con l’altro, ma facendoci prossimi, facendoci vicini, esprimendo sollecitudine, attenzione, ciascuno valorizzando anche la propria specifica competenza professionale. Senza nascondere 9 dietro il camice la nostra umanità. Anche la partecipazione affettuosa, l’accompagnamento fraterno sono parte della professionalità di questo compito di stare accanto al morente, vorrei sottolineare tre cose molto sinteticamente: la prima cosa è la presenza, il primo compito non è né ciò che devi dire, né ciò che devi non dire, ma è il fatto stesso di esserci. La presenza è quanto di meglio si può offrire a una persona che sta vivendo un momento di prova così forte come quello d’avvicinarsi alla morte. La semplice presenza di una persona sulla quale il morente può contare, la semplice presenza di una persona fidata può consentire di superare la difficoltà, la paura, l’ansia, l’insicurezza. E’ vero che si muore da soli, ma è anche vero che se muori con accanto a uno altro che dice: ci sono per quello che posso, cercherò di lenire il tuo dolore, ci sono, puoi contare su di me. Direi che l’essenziale è fare in modo che il morente comprenda che la nostra presenza, le nostre parole, il nostro agire è l’espressione di un patto, questo è importante. La presenza dice c’è un patto tra noi, dice c’è un’alleanza, in questo momento non ti abbandono, non mi sbarazzo di te, io sono con te, in questo momento in cui tu non puoi che essere solo. Tuttavia rimango qui accanto a te per donarti la possibilità di vivere bene anche il tempo della morte. Naturalmente questa presenza sollecita, attenta, sensibile si deve incarnare soprattutto in due cose, in due forme: innanzitutto i gesti, le opere della cura, i gesti della presenza della cura, la presenza e la cura, l’alleanza, la sollecitudine, la prossimità si dice innanzitutto con dei gesti concreti e umili. Sto pensando a quei gesti piccoli che sono i gesti delle cura, asciugare la fronte, bagnare le labbra, avere attenzione alla posizione nel letto, adesso abbiamo i letti tecnologici ma a cosa serve un letto supertecnologico se chi ti sta accanto non ha quest’attenzione? Anche l’attenzione con cui noi provvediamo alle necessità fisiologiche del morente, è cura come stretta di mano, il fargli sentire la presenza, oppure altre volte basta una presenza silenziosa, basta dedicare un minuto, e non è un tempo perso. Ecco, a proposito della questione dei gesti della cura, io credo che è in questo contesto che si possa comprendere il senso dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico. La grande questione dell’accanimento terapeutico e delle cure tecniche che siano realmente proporzionate al paziente, sono una questione seria della medicina di oggi. Quali sono le cure tecniche che sono realmente proporzionate, adatte all’altro che si sta ineluttabilmente avvicinando alla morte? Accanirsi terapeuticamente significa non riconoscere l’ineluttabilità della morte e questa è un’illusione molto forte, una tentazione molto forte. Non entro troppo in questa questione, eventualmente la possiamo riprendere nel dibattito, naturalmente riconoscere che le cure tecniche pure possibili, non sono più proporzionate è altra cosa dal decidere di praticare l’eutanasia. Un conto è sospendere le cure che tu ritieni sproporzionate, riconoscendo che questa decisione spetta in ultima istanza al paziente, e all’interno della relazione, con gli operatori sanitari in particolare con il medico. Ecco, riconoscere che l’accanimento terapeutico è una forma cattiva di prendersi cura dell’altro e quindi di riconoscere che c’è un momento in cui bisogna sospendere le terapie quando queste siano sproporzionate, io credo che sia un’altra cosa rispetto all’eutanasia. Al contrario, credo che l’eutanasia come l’accanimento terapeutico nasca dall’illusione di pensare, come dicevo prima, di padroneggiare la morte. In questo senso l’eutanasia mi sembra una falsa soluzione. La cura dell’altro richiede di riconoscere che l’altro è prezioso, unico, singolare e tuttavia mortale. Infine l’ultima cosa sono le parole della cura e dell’alleanza, in quella presenza, i gesti, le opere, le parole. E’ difficile trovare le parole giuste dinanzi a chi soffre e a chi si avvicina alla morte, è difficile, è molto più facile dire delle chiacchiere, dire delle banalità, magari evitare, fuggire dai problemi. Sicuramente non sono delle parole giuste. Le parole false e pietistiche “di consolazione” con le quali si dice “su non ti preoccupare, magari è una cosa che ti passerà..”, con la quale inganniamo non soltanto l’altro ma anche noi stessi perché nascondiamo a noi e al morente la fatica, il peso, la tragicità, la gravità, e anche direi la bellezza del momento della morte. Spesso, piuttosto che parole stolte è meglio tacere, quindi è meglio il silenzio, un silenzio fatto però d’ascolto, di presenza. In ogni caso il silenzio è l’occasione che tu per creare uno spazio perché l’altro possa dire qualcosa, una parola o possa fare un gesto. Tacere, fare silenzio significa dare all’altro la possibilità di parlare, e soprattutto, se dai all’altro la possibilità di parlare, sarà lui stesso che in un certo senso ti mette le parole sulla bocca, se tu ascolti l’altro in ciò che ha da dirti saprai anche che cosa dirgli. Federica Mangione Moderatrice Grazie Don Maurizio, sono state due relazioni molto intense che mi hanno profondamente commosso. Vorrei approfittare del tempo che ci resta per ridare la parola alla dottoressa Eliana Segre, per un suo commento. 10 Eliana Adler Segre L’ultima parte della relazione di Don Chiodi mi ha interessato molto, quando tratta dell’esperienza della morte. Mi è parso molto interessante avere trattato la morte come oggetto e noi come persone che rifiutando la morte vogliamo a tutti i costi ridefinirci come immortali e in grado di decidere che cosa sarà il proprio futuro. Si è portati a pensare di poter accorciare i tempi del morire, oppure procrastinarli perché non tolleriamo la nostra fine. A volte le cure sono inutili, e certi accanimenti sembrano il rifiuto della mortalità, l’affermazione di ieri, la conferma che la morte è un tabù. Mi sembra che il modo con cui Don Chiodi ha espresso questi concetti sia stato molto chiaro: il rifiuto della fine, il bisogno d’eternità e soprattutto questa supponenza umana di voler dominare tutto e quindi di dominare anche la morte. Non avevo mai letto in questi termini l’eutanasia. Vedevo soprattutto all’accanimento terapeutico, mi sembra ingiusto, che un uomo si permetta interventi inutili e dolorosi su un altro uomo che non può decidere. L’altra cosa che mi verrebbe da sottolineare è consigliare nuovamente la lettura del libro di Tolstoj perché è bellissimo, soprattutto nella parte in cui il malato chiede disperatamente di sapere se morirà o non morirà. La moglie nega, l’amico nega, tutti negano e lui rimane solo con questo pensiero e questa è una cosa tragedia che investe situazioni che noi vediamo nella realtà quotidiana quando la malattia viene negata nella sua gravità. Si illude il malato, in un certo senso lo si usa proprio per salvaguardare noi stessi. La sofferenza che aveva Ivan Illich, che era un Giudice, un personaggio a volte un po’ incolore e forse anche squallido nella sua vita, assume invece in questa sua sofferenza un valore, una grandiosità commuovente. Mi ricordo di aver letto questo libro in una sera perché è intenso, ti prende e ti dice tutto. Invece il mio libro è più un manuale per operatori, per persone che devono imparare delle cose e ha un altro scopo, è un libro clinico, è un libro che contiene altro. Non dimentichiamo che a volte ci sono dei film e dei libri che sono molto importanti che possono darci attraverso delle suggestioni diverse, una comprensione dei fenomeni della vita che poi non ci rimane come cognizione, come arricchimento. L’intervento di Don Chiodi ha permesso di aprire uno sguardo meno realistico e più d’arricchimento interno, altro non saprei dire. DIBATTITO Intervento Volevo fare una domanda alla dottoressa, si è parlato tanto di paura della morte, vorrei sapere cosa ne pensa del fatto che alcuni ospiti delle case di riposo invece invocano la morte, vogliono morire e spesso dicono “Ho tanta voglia di morire, speriamo che il signore mi tiri su…”. Dott.ssa Eliana Adler Segre Io credo che il desiderio di morire sia altrettanto vero, chi vive un tempo lungo di deterioramento e di sofferenza del proprio corpo è come se vivesse un lutto per la perdita di una parte di sé. Nel grande anziano credo veramente ci possa essere la richiesta che la vita finisca, questo credo che sia vero, mentre credo che sia meno vero per il malato, relativamente giovane. In questo caso io credo che ci sia sempre l’illusione che la nostra tecnologia e la scienza possano dare qualcosa di risolutivo. Credo che una donna di 50 viva la malattia terminale come un torto e desideri in tutti i modi sperare di guarire, di non morire, merita il nostro rispetto e anche la nostra attenzione. Voi che lavorate con gli anziani penso sentiate queste frasi anche di frequente e che nel momento in cui vengono dette meritino rispetto perchè sono vere. Penso sia vero che gli anziani desiderino morire perché per loro vivere in certe condizioni, diventa intollerabile. Dobbiamo forse interrogarci allora su come vengono assistiti, li vediamo a volte nelle case di riposo lasciati soli seduti su queste sedie magari con delle piaghe, magari con dei pruriti, magari con dei fastidi è triste, ci addolora. Lì in quel luogo, c’è una richiesta vera di confronto, di vicinanza più che di medicina. 11 Don Maurizio Chiodi Questa domanda sollecita anche la mia risposta: volevo aggiungere soltanto una parola, io credo che la domanda che noi ci dobbiamo fare quando l’altro, qualunque cosa dica, è che cosa nasconde e che cosa rivela la sua parola. A volte la parola dice il contrario, di quello che la persona realmente vuole. La parola diventa veramente come un velo che mentre vela svela, questo è importante da capire. Credo che chi assista debba affinare questa capacità d’interpretare il senso nascosto nella parola dell’altro. Dobbiamo fare lo psicanalista è ovvio, però l’attenzione alla parola dell’altro, non è solo degli psicoanalisti, dei filosofi, dei teologi ed anche di chi si prende cura. Dietro una parola che invoca la morte ci possono essere tantissime situazioni, esperienze differenti. Per esempio potrebbe essere una parola che dice sono stanco, oppure potrebbe dire il contrario, sono felice di quello che ho vissuto e mi basta, sono sazio di giorni. Oppure potrebbe essere una parola che invoca la morte per paura, ho paura di quello che mi aspetta e allora invoco la morte come una liberazione. Può essere anche un’invocare alla morte come amica. C’è qui un altro libro che forse varrebbe la pena suggerire, è un libro, credo di una psicologa, che ha lavorato per tanti anni in un Hospice parigino, Marie De Ennezel, “La morte amica”. Intervento Volevo fare una domanda a Don Chiodi, la nostra esperienza personale, religiosa quanto può incidere sulla vicinanza a questi anziani? Voglio dire, ci permettiamo magari di scherzare, sull’inferno, sul paradiso, chiedo se è giusto che noi, a livello personale poniamo questioni di questo tipo. Intervento Buona sera a tutti, ringrazio per stare qui. Volevo parlarvi di un’esperienza che ho vissuto come badante e ho avuto la fortuna di conoscere una persona importantissima, Monsignor Andrea Spada. Questa persona, ex direttore dell’Eco di Bergamo. Diceva sempre “i miei bagagli sono pronti per partire” era saggia questa persona. Un giorno, dopo che lui ha fatto la colazione l’ho lasciato così, gli ho detto: devo andare a fare la spesa. L’ho lasciato così, ho fatto le mie cose, sarà passata un’ora, sono andata a vedere cosa gli era successo verso le undici e invece era morto. Mi sono spaventata, ho urlato e non mi ricordavo il numero di telefono per chiamare le persone che dovevo chiamare. Come tutti quelli che faranno questo lavoro, io dico che la persona deve avere tanto amore per fare questo lavoro, deve avere tanto amore e volere tanto bene alle persone che sono ammalate. Don Andrea se né andato e fino adesso mi manca tanto perché mi parlava di tante belle cose e mi ha insegnato anche tante belle cose, dopo che la persona se ne va, anche se noi non siamo niente per quella persona, quella persona però ci manca tanto, le sue esperienze, le cose che ci hanno raccontato. Io potrei dire tante cose, voglio però solo dire quest’esperienza che quando uno se ne va è triste sapere che non c’è più che non può più dirti le cose, grazie. Intervento Volevo chiedere a Don Chiodi, lei è Sacerdote vero? Ci ha fatto capire di essere contrario all’accanimento terapeutico, comprensibile la visione della chiesa contro l’eutanasia, però la CEI si è anche dichiarata contro il testamento biologico, faccio un po’ fatica a capire se può spiegarci, mi chiedevo se lei fosse d’accordo con la CEI. 12 Don Maurizio Chiodi La sua domanda introduce il grande tema della speranza. Per voi che siete degli operatori che hanno a che fare, non in modo puramente tecnico, con l’altro che muore non potete sottrarvi al dialogo che affronta due questioni: la speranza dell’altro e la vostra speranza. Parlo così della fede religiosa, come una forma di speranza, non un’illusione ma una speranza e dunque direi che la speranza dell’altro debba essere ricevuta, accolta come una testimonianza, magari nella sua semplicità. Non sempre la semplicità è un difetto, è un difetto il semplicismo, non la semplicità. La semplicità ha un che di bello, di cristallino, di puro che va accolto, quando io pensavo a persone che ho visto morire bene mi riferivo a mio nonno che era una persona semplice, ma molto profonda, non aveva fatto le scuole alte, però era una persona che aveva una vita molto piena, era forte. A volte ci sono delle testimonianze di grande semplicità che voi potete riconoscere e accogliere. La speranza dell’altro va accolta, va raccolta come una testimonianza, come un dono. C’è la testimonianza dell’altro ma c’è anche la tua. La tua speranza, può darsi che tu l’abbia una speranza, e allora la testimoni ma con sobrietà, non esibendola e la testimonianza della tua speranza non sta tanto nei discorsi con i quali tu vorresti convincere l’altro nelle cose in cui tu credi, ma è la testimonianza di un dono, cioè io porto qui me stesso intero. La forma della speranza è la carità. La carità, l’amore, la sollecitudine, la prossimità. Se invece tu non hai questa speranza in ogni caso tu gli stai accanto con amore e anche questo, secondo me, è un modo per dare speranza. “Fare le valigie, la valigia è pronta”, espressioni bergamasche dei nostri vecchi. E’ una riflessione molto bella, che dice siamo pronti per un viaggio, siamo pronti per andare oltre, ciò ci ricorda questo senso dell’essere pellegrini. Poi a riguardo della domanda sul testamento biologico posso dire di essere favorevole al testamento biologico e l’ho anche scritto in diversi modi, in diversi articoli e libri. A volte però la semplificazione mediatica non giova alla comprensione delle questioni complesse come questa. Da quanto conosco non c’è nessuna presa di posizione della chiesa a livello magistrale contraria al testamento biologico, anzi io credo che il testamento biologico sia un modo ultimo per garantire. Il vero problema è che il testamento biologico sia una forma surrettizia per introdurre l’eutanasia, questa è una paura che, secondo me, non è fondata perché il testamento biologico non è una forma nascosta per assegnare al paziente l’autonomia assoluta e insindacabile sulla propria vita. Direi che forse, la questione sulla quale il mondo cattolico ha maggiori perplessità, è quella relativa all’alimentazione e all’idratazione artificiale. Per esempio la questione del testamento biologico, nel 2005 è stata discussa almeno due volte nel comitato nazionale di bioetica ed è stata votata all’unanimità da tutti i componenti anche d’area anche dell’area religiosa, cattolica. Le posizioni quindi sono più articolate e l’unico spunto sul quale alcuni dei cattolici si sono dichiarati contrari, è stata la questione dell’alimentazione e dell’idratazione. Direi che da questo punto di vista c’è una certa pluralità di posizioni possibili anche nella Chiesa. Il relatore di maggioranza che era il Senatore Ignazio Marino è un cattolico e io l’ho sentito diverse volte parlare su questa problematica. Ha sempre spinto su questa posizione di non voler creare delle contrapposizioni, delle fratture ma di voler trovare il maggiore consenso trasversale possibile. Sulla questione dell’alimentazione, dell’idratazione artificiale su questo argomento è vero, ci sono realmente delle posizioni contrastanti, ma, personalmente, sono possibilista però qui mi rendo conto che si aprirebbe un dibattito ulteriore. Una cosa interessante da considerare, potrebbe essere questa: molto spesso noi riduciamo la Chiesa, soltanto al magistero ecclesiastico, ma in realtà la Chiesa è ricca, la Chiesa è il popolo di Dio e ci sono anche i teologi. Il compito della teologia dovrebbe essere quella di pensare, quindi c’è un dibattito legittimo e anche una certa pluralità di opinioni in questo dibattito, ci possono essere dei teologici che sono contrari per delle loro ragioni, ci sono altri teologici che invece sono favorevoli. una E’ riduttivo ancora volta porre la questione come se ci fossero da una parte i cattolici e dall’altra parte i laici. Io credo che anche questa posizione che pure è trionfante in Italia, ed è la contrapposizione tra laici e cattolici non sia utile alla ricerca di una soluzione possibile, ma perché occorre opporsi a priori, vediamo qual è la tua posizione, quali sono le tue argomentazioni andando al di là anche di una rigida e semplicistica contrapposizione tra la ragione e la fede. In realtà, io che sono credente, cerco di pensare e il mio sforzo di pensare non rifiuta l’atto della fede, ma si pone al suo interno. 13 Intervento Buonasera dottoressa Segre. Lavoro in una casa di riposo per cui ho contatti diretti con i pazienti, gli ospiti anziani, molto anziani e non solo, anche con persone giovani con delle grosse difficoltà di sopravvivenza. La mia difficoltà è il confronto con le famiglie al momento dell’ultima ora di vita. E’ difficile affrontare i sentimenti dei parenti, aiutarli a superare quel momento, perché è molto difficile per noi accettare che la persona che stia morendo e lo è di più per le famiglie. Volevo sapere se c’è qualche modo per aiutarci? Eliana Adeler Segre Certamente nel grande gruppo umano che comprende l’accompagnamento, in questo percorso della fine della vita sono compresi i familiari che non sempre capiscono la fatica del lavoro degli operatori. Da quello che io ho sentito dalle varie operatrici, sembra che i familiari diventino particolarmente ostili se si sono occupati poco del malato nel percorso della sua fine vita. Quasi come se scaricassero i loro sensi di colpa sugli operatori. E’ attraverso le sensazioni del contatto epidermico, che è l’ultima cosa che l’uomo morente perde, che il morente chiede fino alla fine. Probabilmente questa domanda di non essere lasciati soli ha due vie di scambio di contatto, l’occhio e il tatto, I bisogni più primitivi non sono più mangiare, dormire, ma essere aiutato a respirare, a stare un po’ meglio. Allora diventa importante bagnare la bocca, aggiustare i cuscini, accarezzare. Credo che un accompagnamento di questo tipo sia è un accompagnamento affettivo, che consola e rassegna. E poi ogni persona che sta per morire sceglie, fra chi gli sta intorno, qualcuno a cui consegna il compito di accompagnarla e questo qualcuno non sempre è un familiare. A questo proposito mi viene in mente un’infermiera di un reparto di medicina dell’Ospedale San Carlo di Milano, che si è ritrovata durante la notte con una signora anziana che stava per morire. Ha capito che sarebbe durata poco, però aveva l’angoscia se chiamare immediatamente le figlie o non chiamarle, se disturbarle nelle cuore della notte o aspettare la mattina. Ad un certo punto la paziente le ha detto “mi dà un bacio” e lei, usando un’espressione che io ho citato nel mio libro perché è sua, ha detto “…E io sono stata una stupida e l’ho abbracciata”. L’infermiera ha fatto un atto che è stato un dono, questa donna anziana morente aveva bisogno di un gesto d’affetto, di un abbraccio e lo ha chiesto. Eppure questa infermiera dice che se ne è vergognata enormemente, che aveva paura di non essere stata professionale, perché era un’infermiera di un reparto di medicina e quindi non le sembrava che fosse un suo compito, fare con il cuore e non con il cervello. Anche le famiglie dei malati hanno bisogno di aiuto perché spesso sono lasciate sole e spesso di fronte alla gravità dei loro impegni sono spaventate, hanno paura, hanno bisogno di una mano, ma una mano vera che è una mano d’aiuto. Altrimenti, e non per cattiveria, rinunciamo a questa persona fino alla fine e la portiamo in Ospedale. Entrano in ospedale solo per morire, non si sa la loro storia, non sai se parlano o non parlano, i parenti non spiegano…. Poveretti, dopo ore ed ore d’attesa in Pronto Soccorso, non hanno più neanche la forza di ragionare eppure, in molti casi, hanno fatto l’assistenza correttamente, impegnandosi realmente. E’ chiaro che a un certo punto, come operatore, tu sei con un ignoto, uno sconosciuto che devi assistere. A Milano capitano tanti casi di malati oncologici portati in Ospedale a morire, dall’altra parte, nelle case di riposo, non c’è un’assistenza adeguata per la fase terminale e quando hanno paura che qualcuno soffochi o stia male, li ricoverano e questi vecchi soli, vanno a morire in Ospedale. Considerata la complessità nella quale si trovano i familiari, sarebbe troppo comodo squalificarli come persone che non capiscono, sono persone allo stremo delle forze, fanno quello che possono, fanno i turni, chiedono i permessi, non c’è più questa famiglia allargata, come diceva Don Chiodi, quando ricordava suo nonno che bene o male suppliva la mancanza di servizi attuali, anche i bambini partecipavano. Ora i bambini non devono vedere… Una delle domande che mi viene spesso fatta è cosa si dice ai bambini e se i bambini devono sapere o ignorare, è un problema molto complesso. I familiari sono in una situazione di grande fragilità. Allora abbiate comprensione perché non sono pronti, nessuno li ha preparati ed è difficile per voi capirli e soprattutto aiutarli, perché loro rifiutano il vostro aiuto. Il lutto è pesante per chiunque, probabilmente loro ve lo scaricano addosso per liberarsene, negando la vostra professionalità. A volte sono invece generosi e contenti dell’assistenza, vi gratificano. C’è molta varietà e 14 comunque importante che i familiari vadano tenuti in considerazione come persone, per quello che tentano di fare. Ricordiamoci che le situazioni sono sempre complesse e che i familiari fanno parte, anche loro, di un mondo che fa fatica a accettare la morte. Intervento Ho una domanda per la dottoressa Segre. Volevo esprimere un disagio che trovo io e quando vedo che gli anziani soffrono fisicamente, hanno dolori forti, mi fa soprattutto un po’ arrabbiare. Posso dire che la mentalità di certe persone porti a vedere nella sofferenza un’espiazione, un modo per diventare migliori. Io sono proprio a disagio per questo e sento che a volte anche i pazienti dicono. “… ma cosa ho fatto di male per soffrire così…” e io non so dire niente. So che il nostro corpo, purtroppo si ammala, non è un corpo perfetto, è bellissimo, ma a un certo punto, come diceva lei, la centralina non funziona più. Mi trovo a dover fare molta attenzione per non urtare la suscettibilità del paziente, della persona che ho di fronte, ma al tempo stesso sono molto arrabbiata per questa mentalità che tanti hanno. Per me la sofferenza non nobilita, per me la sofferenza è una cosa brutta, io sono una sostenitrice delle cure palliative. Vorrei sapere cosa ne pensa lei. Eliana Adeler Segre Io le dico cosa ne penso personalmente, guardi che io faccio più parte della generazione che è un po’ cresciuta in un contesto sociale in cui si pensa che “il sacrificio nobilita l’uomo”. Non dimentichiamo che quando è esplosa l’Aids, tanto per parlare di aspetti clinici, era considerata la peste del secolo ma era anche qualcosa che ti sei voluto. Ci sono stati familiari che hanno detto: “… te lo sei preso o perché ti sei fatto un buco,…” oppure “… sei un omosessuale e quindi…” e cose di questo genere. I malati poveretti rispondevano “…ma io non potevo sapere che lo scambio di siringhe portava all’Aids, al massimo pensavo a un’epatite virale, qualcosa di gravissimo ma non mortale”. Sono anche io contraria all’idea che il dolore nobiliti, negli Hospice si praticano le cure palliative e tutti somministrano farmaci che leniscono il dolore. Così i nostri malati terminali arrivano fino alla fine e riescono ad essere persone che possono fare ancora delle cose. Questa cultura del sacrifico e del dolore è superata, ormai e una cosa superata anche dalla chiesa cattolica. Io faccio un lavoro con i volontari della Clinica Columbus, che è l’Hospice dell’Ospedale Sacco di Milano. La clinica è gestita dalle suore di Santa Francesca Cabrini che sono per le cure palliative e la somministrazione di farmaci contro il dolore. Non c’è paziente che soffra per il dolore, anche se resta la sofferenza dello stare a letto, l’impossibilità ad alzarsi. Probabilmente anche i farmaci determinano una prestazione che aggrava il disagio ma si può affermare che questa cultura oggi è passata. Certo che un signore che ha 90 anni, che è cresciuto in quella cultura, non può che consolarsi pensando che la sofferenza che trova gli porterà un qualche beneficio spirituale. Sono d’accordo con lei sul fatto che noi abbiamo a che fare con una generazione che è cresciuta in una mentalità diversa. In ogni caso, prima di qualsiasi decisione, il malato deve essere informato e deve avere la possibilità di cambiare idea, anche se ha fatto il testamento, dico che in fondo è una rivalutazione dell’essere pensante, ossia dell’uomo come capace d’intendere e volere. Don Maurizio Chiodi Io sono sollecitato da questa domanda. Penso che sia una domanda giusta. Se noi avessimo la pazienza di scorrere la storia del pensiero filosofico ci accorgeremmo che ci sono state delle filosofie molto nobili che hanno stimato il dolore pur non essendo di aspirazione cristiana. Per esempio lo stoicismo, gli stoici pensavano che il dolore veramente rafforzasse l’uomo. Lo stoicismo è quella filosofia che si è diffusa nell’Impero Romano un secolo prima e due secoli dopo l’avvento del cristianesimo. Anche il buddismo affronta la questione della sofferenza in un modo non dolorista, però anche per il buddismo la questione del dolore è questione centrale. E’ vero che in alcune sue forme il cristianesimo sembrerebbe favorire un dolorismo, in realtà io credo che il dolorismo sia una caricatura del cristianesimo, la fede cristiana pone lo scandalo della 15 sofferenza e domanda: se Dio è buono, se Dio è onnipotente, se il male esistente, com’è possibile? La questione del dolore non è affrontata e risolta in modo banale nella fede cristiana. Se voi leggete il libro di Giobbe non potete rimanere che stupefatti che di fronte a quest’uomo che chiama Dio in causa e gli chiede perché. Probabilmente anche questa è una parola da interpretare che nasconde forse anche soltanto, una richiesta d’aiuto, aiutami a capire questa cosa perché adesso non mi torna, non mi quadra. Questo, tuttavia, secondo me, pone la grande domanda sul senso della sofferenza e una domanda che non si risolve semplicemente lenendo il dolore fisico perché c’è un dolore esistenziale complessivo che chiamiamo sofferenza, e che appartiene alla condizione dell’uomo. Da questo punto di vista ho dei dubbi che la risposta al dolorissimo consista in una cultura che insegue l’illusione del benessere a tutti i costi espungendo, cioè rimuovendo il dolore, il dolore è questione profondamente umana, non c’è nessuna religione, nessuna cultura che non si esima dall’affrontare la grande questione del dolore. Eliana Adeler Segre Mi viene in mente una risposta, piccola piccola, alla domanda che mi era stata fatta prima dalla persona che lavora con gli anziani e diceva: ” …quando chiedono di morire perché non ne possono più…”. Ecco io credo che contenga una cosa ulteriore, il dolore psichico, ossia una persona che si vede decadente, una persona che si vede con tutte le perdite possibili e immaginabili, che non ha progettualità, che non può avere un futuro, che il domani sarà peggio dell’oggi, il dolore psichico esiste, il dolore psichico c’è dal momento in cui c’è una diagnosi, c’è dal momento in cui noi abbiamo sentito le storie di oggi. Ecco, io credo che sia molto importante anche tenere in conto che noi non abbiamo solo il dolore fisico, quando si vive la chiusura di una storia, l’abbandono, una madre che ti lascia, una separazione, un lutto tutto ciò dà dolore psichico e non ci sono farmaci per poterlo guarire, per farlo passare ; credo poi che quando si uniscono dolore fisico e dolore psichico la vita diventa intollerabile, credo che sia questa condizione a farci paura e allora sì che la morte diventa come una liberazione perché ti toglie da quel patimento. E poi, quello che mi sembra fondamentale per chi lavora in una istituzione che si occupa di morenti, è di ragionare sulle proprie ideologie che non devono condizionare la vita degli altri. Si deve rispettare chi crede e chi non crede, chi ha una diversa religione, una cultura diversa. Ecco credo che questo sia doveroso, professionale addirittura, e sicuramente parte del comportamento etico che vuol dire fare il meglio per quella persona. Federica Mangione Grazie mille a entrambi i relatori e a tutti voi che siete rimasti fino al termine di questa giornata di studio, grazie. Credo che sia stata molto ricca e, come succede per le buone formazioni, ci portiamo a casa molte domande, molti spunti di riflessione, molte emozioni. Spero che ci sia, in futuro, l’occasione di tornare su questo tema e d’affrontare sotto questa formula anche altri argomenti d’interesse degli operatori dell’assistenza. 16
Scaricare