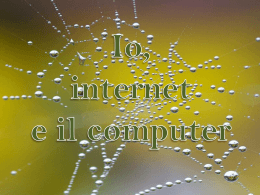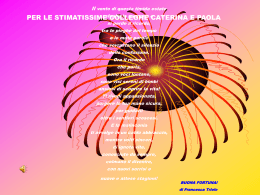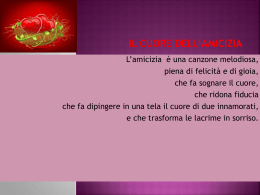TESTIMONIANZA «Io li ho conosciuti» di Silvano Boccardi Siamo rimasti in pochi ad avere vissuto la seconda guerra mondiale e gli anni tumultuosi che sono seguiti. Io sono uno di quelli. E ho voglia di ricordare alcune delle persone eccezionali che ho potuto conoscere in quegli anni. Giovane medico, mi sono laureato nel 1947, ho avuto la grande fortuna di essere indotto ad un mestiere allora ignoto in Italia: quello che solo molti anni dopo si sarebbe chiamato ‘fisiatria’. Mi sono così giovato del vantaggio di chi non ha concorrenti, o ne ha comunque pochi. Così, se una persona notevole aveva qualche problema motorio (si trattava per lo più delle conseguenze di un ictus) mi chiamavano a vederlo e a curarlo. Ho imparato solo dopo che in realtà non si trattava proprio di curarlo, secondo i dettami della scienza medica allora ancora piuttosto arretrata, ma di aiutarlo a cavarsela nella vita : adesso diciamo aiutarlo a riabilitarsi. Vorrei cominciare da quelli da cui ho imparato molto e forse tutto, e che hanno condizionato la mia visione della riabilitazione. Per prima, Adelaide Colli Grisoni, donna eccezionale, a cui dobbiamo la prima lucida esposizione dell’intervento riabilitativo nei bambini con paralisi cerebrale infantile, e in qualche modo l’affermazione di una neuropsichiatria infantile (mi sono a volte dovuto chiedere se infantile è la neuropsichiatria o il neuropsichiatra) libera dal giogo di un’eccessiva medicalizzazione. Ricordo due lapidarie affermazioni tratte dall’introduzione a “L’assistenza educativa al bambino con pci nella prima infanzia”, pubblicato da Cappelli nel 1968: «L’opera di recupero nei primi anni è diretta dal Medico e svolta dalla madre» e «niente ginnastica, niente metodo X, niente terapista a casa che fa la seduta». Interessante tra l’altro che la “m” di medico sia maiuscola e quella di madre minuscola: forse un tentativo di farsi perdonare da una categoria la cui egemonia, nel campo dell’assistenza al bambino con paralisi cerebrale, veniva così lucidamente messa in crisi. È stato un vero colpo di fulmine. In margine al primo congresso della Società Italiana di Ginnastica Medica, nel 1952, in una bella mattina di primavera in gondola, sulla laguna di Venezia, chiacchieravo con Adelaide Colli Grisoni, reduce da un viaggio di ricerca su quanto e come si faceva nei Paesi più evoluti in fatto di assistenza ai bambini con pci. In Italia, un paio di anni dopo doveva essere promulgata la prima legge sull’assistenza agli spastici (è brutto, ma allora erano chiamati così). E in Italia mancavano strutture e soprattutto medici e terapisti preparati. La Colli (come la chiamavamo) mi chiedeva di aiutarla a realizzare una scuola per terapisti. Mi sembrava un sogno, ma solo un anno dopo presso l’Ospedale Ca’ Granda di Milano partiva il primo corso ufficiale per fisioterapisti istituito dall’ACIS: non c’era un Ministero dalla Sanità. La ricordo alta, sottile, di una eleganza sobria, non amava indossare gioielli: ricordo le difficoltà incontrate quando abbiamo deciso di dimostrarle con un dono il nostro affetto. Era difficile resistere alla Colli, anche quando chiedeva energicamente alle mamme di occuparsi a tempo pieno ma “come una mamma” e non come una terapista del loro bambino spastico, e di non trascurare gli altri figli: e anzi le incitava ad avere un secondo bambino quando il primo era spastico. E Alfredo Grossoni: il miglior neurologo che abbia conosciuto. Non era specialista e tantomeno ‘’professore”. Ma aveva un impegno nell’approccio al paziente che ho riscontrato raramente: mi ha insegnato che una visita neurologica seria non può durare meno di un’ora. E un fiuto clinico incredibile: ho assistito alla discussione di un caso con un altro bravo neurologo del tempo, Alessi, su un caso interessante. Alessi gli richiamava la pag. 231 in alto a destra di un poco noto trattato tedesco, che conosceva a memoria e che suggeriva una diagnosi. E Alfredo gli ricordava a sua volta, grattandosi il naso affilato con una mossa che gli era abituale quando era perplesso, il caso di «quell’avvocato che abitava in via Carducci, che aveva una cravatta a pallini e una cameriera che preparava un ottimo caffè» per il quale avevano fatto insieme un’altra diagnosi che si era dimostrata giusta. E naturalmente aveva ragione lui. Aveva introdotto in Italia la pneumoencefalografia. Fasiani, il primo neurochirurgo italiano di fama, chiedeva a lui di segnare sulla cute del cranio del paziente il punto dove avrebbe dovuto aprire. Aveva fatto la resistenza. Comunista fino alla tragedia dell’Ungheria, quando ha avuto il coraggio di dichiarare in sezione il suo dissenso: allora ce ne voleva. Ma soprattutto gli volevamo bene per la sua disponibilità e generosità. Mi ha insegnato lui a non farmi pagare le visite. Magrissimo, mi ricordo un caldo giorno di estate, a mezzogiorno, seduti su una panca del grande atrio centrale della Ca’ Granda. Mi mostrava commosso il panino con prosciutto che gli era stato offerto dalla moglie di un paziente del contado, dicendogli: «Poverino, mangi, è così magro». Aveva una Citroën due cavalli, con una sedia al posto del sedile di guida, e si meravigliava che non avesse mai bisogno di rabbocchi di acqua e olio, ma neanche di rifornimenti di benzina. Gli amici facevano a turno per riempirgli di notte il serbatoio. Silvano Mastragostino, ortopedico rizzoliano di grande valore: per questo, e per il carattere schietto di romagnolo, non è mai salito in cattedra. Si chiamava Silvano, perchè era nato un anno dopo di me e le nostre mamme erano molto amiche. Era primario al Gaslini e si era fatto una grande esperienza di interventi in età evolutiva: allungamenti di arti, correzioni di scoliosi, trasposizioni tendinee. Era quindi destino che ci reincontrassimo. Silvano andava tutti gli anni in Kenya, al centro di riabilitazione di Ol’ Kalou, dove era atteso come un messia. Provvedeva a tutto lui: i viaggi dei suoi accompagnatori, suoi collaboratori ma anche altri specialisti, e tecnici ortopedici. Per tre anni (‘86-‘88) ha portato anche me. Ma anche materiale per gli interventi e le ingessature, farmaci. E soldi. Aveva impiantato a Ol’ Kalou, con l’aiuto di una ditta di Genova, una piccola officina ortopedica perfettamente funzionante: produceva ortesi, scarpe, corsetti, anche ottime protesi. Erano molto belle e produttive le sedute dell’intera équipe che decidevano gli interventi: più di un centinaio ogni anno. Le conclusioni erano all’insegna, a me graditissima, del togliere tutto quanto non fosse essenziale. L’esperienza africana aveva insegnato a Silvano, e poi a tutti noi, come obiettivo dell’intervento, chirurgico e riabilitativo, dovesse essere il recupero della funzione, anche se questo implicava la rinuncia alla soddisfazione dell’operatore per interventi complessi e difficili. Un’osteotomia sopracondiloidea (tra l’altro piuttosto semplice sulle ossa sottili del bambino poliomielitico: spesso bastava un’osteoclasia) era di gran lunga preferibile a un intervento di trasposizione del bicipite pro quadricipite, che dava problemi anche in fase di rieducazione e di solito era scarsamente efficace: tranne nel cammino, dove a volte il bicipite trasposto, stirato in fase di appoggio, si contrae in quanto flessore mentre agisce come estensore. La stessa regola valeva per le ortesi: a che pro dare al bambino delle scarpe ortopediche fabbricate con le correzioni perfette al momento, se poi doveva indossarle nella boscaglia o nella savana e non aveva possibilità di ripararle o di sostituirle per un anno? Lezione che ha influenzato il mio modo di pormi nell’attività quotidiana. È giusto sottoporre un emiplegico, che statisticamente può aspettarsi in media due anni di sopravvivenza, a lunghi fastidiosi periodi di rieducazione e addirittura a restare in letto fino a sei mesi, come preconizzato da varie parti, fino a che non abbia recuperato le sinergie corrette prive di sincinesie? E intanto ha dissipato un quarto della sua aspettativa di vita. Poi Silvano e i suoi collaboratori operavano. I risultati funzionali erano davvero spettacolari e le complicanze rarissime. In un anno, su 120 interventi, un solo caso di infezione nonostante le difficoltà ambientali: ho visto il famoso chirurgo lavarsi prima di un intervento le mani in un catino smaltato mentre la fanciulletta nera gli versava l’acqua da una brocca. Grande lezione di efficienza e anche di umiltà: quello che conta alla fine dei conti è se e di quanto abbiamo migliorato la vita e le “possibilità di partecipazione” del paziente Piergiorgio Mazzola, grande esperienza di informatica che lo ha aiutato nella sua preziosa opera di divulgazione a favore dei disabili. Tetraplegico C6-C7 per aver ruotato bruscamente il capo mentre era alla guida della sua auto, perché la figlioletta di pochi anni piangeva sul sedile posteriore: drammatica dimostrazione della persistenza dei riflessi tonici del collo in età adulta, in particolari condizioni. Appena in grado di muoversi su una carrozzina, dapprima manuale poi elettrica, ha messo la sua intelligenza e la sua disponibilità al servizio dei suoi compagni di sfortuna. Sono stato con lui fin dal principio: abbiamo condiviso per un certo tempo il mio tavolo di lavoro al centro pilota della Fondazione Don Gnocchi. Gli incontri con lui e i suoi amici e compagni erano molto fruttiferi. È nata in quel gruppo la sostituzione, anche nei documenti ufficiali della regione Lombardia, dei negativi termini in uso fino allora, anche a designare le associazioni: invalidi, incapaci, minorati. con il termine “disabili”. Tutto sommato molto meglio anche dei termini… pietosamente pietosi che usano adesso: anche Usain Bolt è “diversamente abile”. E poi, l’anziano fragile come una statuetta di Sèvres o di Meissen! Sono nati così, per merito di Piergiorgio, la pubblicazione “Informazione e Riabilitazione” e il Centro Studi e Consulenza Invalidi, al Centro pilota, per elargire informazioni e consigli preziosi a centinaia di disabili tutta Italia, che avrebbe visto il suo coronamento nell’istituzione da parte della Fondazione del SIVA (Servizio Informazione e Valutazione Ausili), che sotto la direzione di Renzo Andrich presto sarebbe diventato leader del settore, e non solo in Europa. E il DAT, l’odierna struttura del Centro di cui la Fondazione può andare orgogliosa, dove si può conoscere e toccare con mano quanto i progressi della tecnologia e l’esperienza dei disabili mettono a punto per migliorare la loro autonomia, non è che l’ingrandimento di quanto Piergiorgio , con l’aiuto prezioso della sua formidabile moglie, aveva raccolto nella sua casa milanese, mettendolo a disposizione di chi volesse conoscerlo e provarlo. Piergiorgio non si dava da fare solo per i singoli disabili. Suoi sono interventi a volte determinanti sulla agibilità delle strutture architettoniche. Ricordo, per avervi partecipato, la durissima lotta per ottenere la costruzione di rampe sui lati della scalinata del Duomo, dove non si poteva entrare in carrozzina. Impresa eroica, si trattava di mettere d’accordo la Fabbrica del Duomo, la Diocesi, il Comune e i suoi assessorati, la Sovrintendenza ai monumenti, la Vigilanza Urbana: adesso le rampe, anche se non molto comode, ci sono, ed è possibile andare dall’interno del Duomo a Piazza della Scala in carrozzina. Lì poi, con il traffico che c’è... Altre battaglie per la concessione dei permessi di guida ai disabili: Piergiorgio era fiero perché riusciva a ingannare i componenti le commissioni per la concessione delle patenti sul livello della sua lesione agitando le mani inguantate a riprova della loro efficienza: guidava benissimo la sua automobile modificata. E la sua partecipazione alla lotta condotta in Italia, con ottimi risultati, per la introduzione dei bambini disabili nella scuola normale. Aveva due splendide bambine, una è stata mia allieva. Anche Piergiorgio ci ha lasciato: che, come ci ha insegnato a dire Gianni Brera, la terra gli sia lieve. E naturalmente don Carlo Gnocchi. Ho potuto stare insieme a lui poche volte, nei primi anni 50, ma sono stato conquistato subito dal suo magnetismo. Mi ha chiarito molte delle idee incerte che coltivavo da qualche tempo, soprattutto che non fosse sufficiente dare ad un bambino poliomielitico la possibilità di camminare ancora, e neanche insegnargli un mestiere. Bisognava trovargli un lavoro, anche se questo lo allontanava per molti anni dalla sua famiglia. Oggi, se Dio vuole, da noi non è più necessario, ma ho ritrovato la stessa esigenza quando sono stato in Kenya. Mi ricordo un pomeriggio di autunno, a Roma in occasione di un congresso sulla poliomielite. Eravamo a palazzo Barberini, su un divano nero di pelle, e don Carlo mi spiegava come faceva a trovare aiuto economico dalle persone che potevano darglielo. E mi ha fatto vedere un libretto nero con l’elastico, dove annotava le speculazioni fatte in borsa dall’interlocutore, che alla sua vista tirava subito fuori il libretto degli assegni. È strano come si presentino i ricordi: quasi sessant’anni dopo, ho ancora vivi nella memoria la penombra della sala, il nero del divano, il nero della tonaca, il nero del libretto, l’azzurro degli occhi di don Carlo. Don Gnocchi era un grande santo lombardo. In questa rubrica, ho ricordato alcuni di quelli con i quali ho condiviso passioni e idee. Ma nei primi due decenni dopo la guerra, Milano era davvero ribollente di idee, iniziative e personaggi: era il tempo della ripresa - forse val la pena di ricordare che Milano era stata distrutta al 60°% dalle bombe alleate - e poi del boom economico. Emblematico il ritorno di Toscanini alla Scala. Ho avuto la fortuna di assistere ad una delle ultime prove, nascosto tra le poltrone della sala. Toscanini non ammetteva intrusi, e le sue reazioni erano molto vivaci. Tra gli altri ricordi cominciamo, noblesse oblige, con un presidente della Repubblica dei primi anni ‘60, Antonio Segni, che sono stato chiamato a visitare a Roma perchè era stato colpito da un ictus da trombosi cerebrale, con danni motori e gravi problemi di linguaggio. Peccato, perchè mi sarebbe piaciuto chiedergli qualcosa di mio zio, Fernando Tambroni ( chiamato in famiglia “il gerundio”), che era stato coinvolto sotto la sua presidenza in un brutto affare, il caso SOLO e la prima partecipazione della destra fascista al governo. È venuto a Milano, alla Casa di Cura Sanatrix, una piccola clinica di poche camere nata per la nostalgia per la riabilitazione di Felice Casari, che era stato il primo, amato primario dell’Istituto di Terapia Fisica di Niguarda dal ‘48 al ‘53, caratterizzata, oltre che da un’ottima attività riabilitativa, dalla ancor migliore cucina curata dalla moglie parmigiana del proprietario. Ricordo il presidente alto, sottile, con il soprabito blu e la bella sciarpa di seta bianca, che si armonizzava bene con i bei capelli argentei. Un gran signore. E una lunga sfilata di politici milanesi di tutte le sponde ben noti allora: Malvestiti, Masini, Marcora, Rivolta, Peruzzotti…la passione politica si scaricava per lo più sulla muscolatura della colonna. Mio è padre era pianista, e in quegli anni difficili si dava da fare per la rinascita di una vita musicale milanese, organizzando con la Camerata Musicale preziosi concerti: per cui molti miei ricordi sono legati al mondo della musica. Nell’immediato dopoguerra, la rivelazione del Nuovo Quartetto Italiano. Quattro giovani, Borciani, Pegreffi, Farulli e Rossi, che di lì a poco dovevano incantare il mondo. Quattro folletti, come li ha battezzati Giulio Confalonieri, principe dei critici musicali e grande giocatore di scopone scientifico al bar Giamaica, a Brera. Ricordo un’ affannata corsa in taxi per recuperare un archetto del violoncello a Rossi: il suo si era rotto al’ultimo minuto. E in serata un commovente quartetto di Debussy nell’ospitale ma gelida casa di Giulia Maria Crespi in via Borgonuovo. I termosifoni in quel primo dopoguerra non funzionavano: gli invitati erano pregati di portare un ciocco di legno per il camino. Poi, e prima di tutti, Maria Callas, la voce di soprano più emozionante di tutti i tempi al servizio di una musicalità ineguagliabile, in quei tempi regina del teatro alla Scala. Era alle prese con un peso corporeo che giudicava eccessivo e che avrebbe, come si sa, combattuto con successo senza perdere, come tutti temevamo, l’incanto della sua voce. Veniva all’Istituto con il suo cagnolino e ci intratteneva con tante e non sempre generose storie sul suo mondo, e soprattutto sui suoi colleghi. E in particolare su Renata Tebaldi, ottima soprano e sua principale rivale. Unito nel ricordo a Maria Callas, Leonard Bernstein che l’ha diretta in una trionfale Medea di Cherubini, la sua originalità interpretativa, la sua simpatia: una volta si è presentato a una prova scaligera vestito da gondoliere veneziano. Ricordo anche le sue bretelle color viola, che sfidavano il malocchio e naturalmente il suo mal di schiena. Il mio mestiere mi ha portato in casa Abbado, una casa dove si respirava musica. Sono stato accolto con grande signorilità da Michelangelo, ottimo violinista e padre di Marcello, poi direttore del Conservatorio di musica di Milano dove mio padre ha insegnato nel primo dopoguerra, e di Claudio, al quale debbo tanti indimenticabili momenti di grande musica e, recentemente, il sogno di vedere scambiata la sua giusta mercede con 95.000 alberi da piantare a Milano: davvero un sogno, temo, dati i tempi bui, ma non per questo meno affascinante. In quell’occasione mi ha fatto dono di una sua recente edizione della Cenerentola di Rossini. Nel campo dello spettacolo Milano era al centro della scena. Erano gli anni della rivelazione del piccolo Teatro, di Strehler e di Grassi, ma anche dei molti teatri che non ci sono più. Ricordo la prima di “Questi Fantasmi” di Eduardo al Mediolanum. Ero vicino di posto di un entusiasta Ruggero Ruggeri. E Anna Magnani, allora soubrette di Totò, con la quale ho attraversato, di notte, una piazza del Duomo deserta. Sono state clienti dell’Istituto di Terapia Fisica di Niguarda, per dei danni muscoloscheletrici, tre belle e brave attrici: Agostina Belli, Giulia Lazzarini, Lucilla Morlacchi. Era divertente ascoltare da loro i retroscena di un mondo che mi ha sempre incantato. E ho conosciuto professionalmente Paolo Stoppa, che si lamentava con la sua voce inconfondibile di un bruscolo nell’occhio. L’ho visto, in una bella vestaglia nella sua camera all’Hotel de Milan e, senza grande merito, guarito. E negli anni seguenti Marcello Moretti e poi Ferruccio Soleri, ineguagliabili ambasciatori di italianità nel mondo con il loro Arlecchino servitore di due padroni. Mi piacerebbe poter pensare di avere una piccola parte di merito nella prodigiosa giovinezza di Ferruccio, che continua a recitare splendidamente una parte fisicamente molto ardua, nonostante i dolori alla schiena di cui mi ero occupato anche io. Gli attori sono fragili, e io ero chiamato a confortarli. Dario Fo e Franca Rame li ricordo nella loro casa di piazzale Baracca, con i quadri di Dario alle pareti e i compagni più meno ammaccati di Soccorso Rosso su materassi stesi per terra: il Nobel era ancora lontano. E dopo, la vergognosa aggressione a Franca vissuta con grande forza e dignità, in un lungo faticoso recupero. In un campo molto diverso, non posso dimenticare Giulio Natta, premio Nobel per la chimica nel 1963 per i suoi studi sui polimeri. Era affetto da una forma grave di morbo di Parkinson a inizio omolaterale controllato abbastanza bene da in intervento stereotassico, in gran voga in quegli anni. Il danno si è esteso all’altro lato, e un nuovo intervento non solo non ha migliorato la situazione, ma ha determinato un crollo grave di tutte le facoltà cognitive. Succedeva, dopo interventi bilaterali. Era terribile vedere una delle migliori intelligenze della prima metà del ‘900 ridotto a non farsi capire neanche dalle persone a lui più vicine. Poi, i nomi della grande borghesia milanese, non facilmente distinguibile dalla aristocrazia: ne ricordo soprattutto le belle case e i bellissimi quadri. La duchessa Gallarati Scotti. La sua camera da letto nel mio ricordo è enorme, con un letto enorme, nel quale la minuta duchessa mi riceveva, parlando nella sua splendida lingua milanese. E aveva un fondo oro senese alle spalle. Casa Belgioioso: il principe mi intratteneva con il suo abito di campagna, naturalmente elegantissimo, sull’andamento dei raccolti di quell’anno. Grandi case e splendidi quadri: le scale di palazzo Bagatti Valsecchi impreziosite dai generali di Enrico Baj, che ammiravo mentre il padrone di casa mi parlava dei suoi dolori, tanto per cambiare alla schiena. I Galtrucco di via Annunziata: ero entrato a casa loro perché la deliziosa piccola Giovanna era stata colpita dalla polio. Ce la siamo cavata bene, e Giovanna è rimasta una delle mie migliori amiche. Approfittavo della intelligenza e della forza di carattere di mamma Galtrucco, per avere conoscenza diretta di tutte le proposte spesso strambe e ancor più spesso truffaldine che circolavano sul trattamento dei postumi di polio: mamma Galtrucco andava a verificare dal vivo e mi riferiva. E io avevo notizie dirette sull’inconsistenza della proposta, e potevo parlarne male e dissuadere con le prove i genitori degli altri piccoli sempre in attesa del miracolo. Mi ricordo quando ha portato Giovanna dal mago di Napoli, allora celeberrimo, portando con sé il lenzuolo pulito sul quale Giovanna doveva essere trattata… E giacchè siamo in via Annunziata, Alberto Pirelli, allora senza dubbio il più importante industriale di Milano. Della sua abitazione mi sono rimasti impressi il silenzio sepolcrale e i grandi vasi cinesi. Il clan dei Falck: ricordi belli, come la disponibilità di mamma Cecilia e le grazie di Orietta. Erano tempi strani: molte giovanette della Milano bene avevano una scoliosi. Altri buffi. Alla morte del capofamiglia, la famiglia aveva regalato al Centro pilota di don Gnocchi due splendide palestre. All’ingresso c’era una testa in bronzo del benefattore. Erano i tempi della contestazione: i giovani poliomielitici in carrozzina gareggiavano a chi faceva fare alla testa, che poggiava non fissata su un perno, il maggior numero di giri colpendo il naso con una pallina di carta. E dopo l’omelia di monsignor Pisoni, presidente della Fondazione, che aveva invitato a dimostrare gratitudine ai benefattori, nell’intervento con chitarra (allora era di moda) il più audace dei ragazzi usciva, a nome anche degli altri, in un: “Signore, tieni lontano da noi tutti i benefattori”. E non aveva torto: ribadiva che tutto quanto serviva per una vera riabilitazione era un diritto del giovane disabile e doveva essere a carico della comunità, e quindi dello Stato. Non ho mai assistito a un “Ite missa est” eseguito con maggiore celerità. Per restare nello stesso ambiente, ricordo una cena del Rotary a Monza, dove tra l’altro si era mangiato, come spesso accadeva, malissimo. Avevo dovuto chiedere, controvoglia, ai facoltosi convitati un contributo per i bambini distrofici muscolari. Si cominciava allora ad occuparsene: non godevano della legislazione favorevole che interessava poliomielitici e spastici. Un autorevole membro affermava la scarsa importanza sociale del problema, i distrofici non potevano essere più di qualche centinaio. Lasciava qualche migliaio di vecchie lire, e si avviava all’uscita: inciampava sulla soglia e si faceva male. È tornato indietro a versare un altro po’ di denaro. L’ho sempre ricordato come un segno dell’esistenza di una superiore giustizia. Era anche il tempo della guerra del Vietnam. “Terre des Hommes”, l’agenzia svizzera che si occupava dell’assistenza ai giovani vietnamiti del Sud travolti dall’ingiusta guerra, inviava al nostro Centro, scelto tra i Centri di tutto il mondo, i bambini affetti da lesioni motorie, in prevalenza poliomielitici. C’era qualche cerebropatico e un paio di malformati congeniti. È stata un’esperienza entusiasmante. Anche i bambini di due-tre anni avevano un comportamento di una serietà e di una educazione incredibili. Alla festa del Tet, quando l’ambasciatore di Saigon a Roma veniva a festeggiare l’inizio dell’anno con i bambini, un delizioso pranzo vietnamita (abbiamo saputo dopo, a Parigi, che la cucina vietnamita è una delle migliori al mondo) veniva consumato tutti insieme, in un’atmosfera quasi religiosa. E tutti i giornalini comunisti cinesi e nordvietnamiti che arrivavano con gli studenti universitari che accompagnavano i bambini sparivano misteriosamente dalle camerate: non ho mai saputo dove finissero. Ho capito invece perchè i nordamericani non l’avrebbero mai spuntata in Vietnam quando ho visto Van Guyen, un cosino di meno di dieci chili, nato prematuro e poi poliomielitico, non in grado di camminare, aspettare Joseph, un bambinone camerunense con spalle da campione dei mediomassimi che pesava quattro volte lui, sulla porta della camerata con un bicchiere pieno d’acqua in mano. Sapeva che Joseph indossava due tutori i cui montanti in ferro sporgevano dal tacco della scarpa consumato dall’uso intenso. Mi ha detto: «Sta a vedere, io butto l’acqua per terra, Joseph scivola e cade e io gli salto sopra». E così è stato. Ed erano anche gli anni della orrenda vicenda del Talidomide, il sedativo diffuso tra le donne in attesa di un figlio, che ha provocato un numero impressionante di malformazioni dei feti. Ne avevamo diversi al Don Gnocchi: un’altra lezione sulle capacità di difesa dell’uomo anche in situazioni disperate. Ricordo una bambina africana di uno o due anni: amelica bilaterale completa, mancava anche delle scapole, le sue piccole spalle rotonde ricoperte di seta nera. E Rosangela, una bambina deliziosa di nove anni. Anche lei era amelica bilaterale, mancava completamente dei due arti superiori, scapole comprese. Aveva imparato a fare tutto con le dita dei piedi, portava i cibi alla bocca, cuciva, scriveva. L’avevamo dotata di una protesi meccanica in uso negli anni del dopoguerra: la sistemazione di due “dita cinesi”, ditali di paglia intrecciata che si gonfiavano, e quindi si accorciavano, quando veniva introdotto un gas; erano inserite su dei tiranti che muovevano le dita meccaniche della protesi, ottenendone la flessione e quindi la presa. Rosangela ne otteneva il riempimento e lo svuotamento schiacciando una valvoletta che comandava con il mento. Una delle sensazioni più tristi della mia vita, che pure non mi ha certamente risparmiato sensazioni dolorose, la ho avvertita quando ho visto Rosangela in piedi davanti alla lavagna: stava scrivendo con un gesso quando l’anidride carbonica contenuta nella bomboletta si è esaurita. Le dita si sono di colpo aperte, il polso è ruotato in supinazione. La mano artificiale è sembrata una mano vera, morta. Rosangela è scoppiata a piangere. Mi rendo conto di non aver forse fatto una cosa corretta a inserire nei miei ricordi i nomi dei loro protagonisti, in tempi di ossessione per le intercettazioni telefoniche e di esasperazione della privacy. Ma avevo molta voglia di rispolverare i miei ricordi, oltre al fatto che delle persone nominate potevo solo parlare bene e che la maggior parte di loro non c’è più. E a me non rimane che attendere serenamente che il mio testis dexter diventi rigidus et convulsus, sintomo che nostro padre Ippocrate (Aforismi, 93) considerava letale.
Scarica