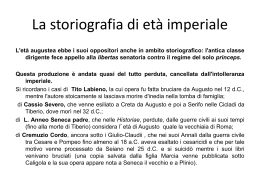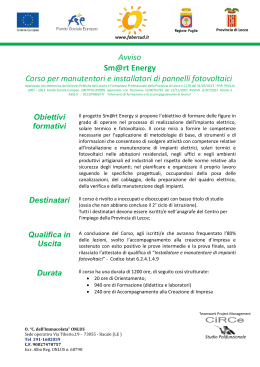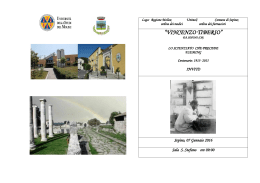Le Perle / Letteratura Collana di narrativa Francesco Bricolo Tutto bene, signora Titolo del libro: Tutto bene, signora Autore: Francesco Bricolo ISBN 9788897792376 Edizioni Pragmata www.edizionipragmata.it Facebook: Francesco Bricolo Official Siti web: www.francescobricolo.it - www.francescobricolo.com TUTTI I DIRITTI RISERVATI La riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, non è consentita senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Autore. © 2013, Francesco Bricolo http://www.francescobricolo.it [email protected] © 2013, Cervello Stavagantissimo http://www.cervellostravagantissimo.it [email protected] Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e avvenimenti sono frutto dell’immaginazione dell’autore o usati in chiave fittizia. Qualsiasi rassomiglianza con fatti e località reali o con persone realmente esistenti o esistite è puramente casuale. The gunfire around us makes it hard to hear. But the human voice is different from other sounds. It can be heard over noises that bury everything else. Even when it’s not shouting. Even when it’s just a whisper. Even the lowest whisper can be heard over armies... when it’s telling the truth . • Edmond Zuwanie - The Interpreter, 1998 Gli spari intorno a noi c’impediscono di udire ma la voce umana è diversa dagli altri suoni e può essere udita al di sopra dei rumori che la seppelliscono, persino quando non grida, persino se è solo un bisbiglio. Il più lieve bisbiglio può essere udito al di sopra degli eserciti quando dice la verità. • A Paola, Pietro e Lorenzo: per il tempo che papa passa a scrivere al computer invece che con voi. Tutto bene, signora Parte prima Milano 1 Corso Porta Nuova era un incubo per i parcheggi a quell’ora, Tiberio lo sapeva bene ma non era partito prima, tanto, era praticamente impossibile ad ogni ora parcheggiare e, infatti, ci volle più di qualche minuto per trovare un posto. Di per sé, da Cesano Boscone a Porta Nuova, non era un viaggio lungo, anche se molto dipendeva dal traffico che, comunque, in quel freddo mattino di Novembre, non era stato poi così terribile. Durante il viaggio, di nuovo, Sabrina aveva tentato di sganciare a suo marito Tiberio qualche informazione su questo esame, che il medico di base gli aveva prescritto, ma non aveva ottenuto nulla di più di quello che sapeva già. Per quanto fosse ben abituata ai silenzi di suo marito, faceva sempre molta fatica a sopportarli e, in questo caso, si doveva proprio imporre di tacere, altrimenti avrebbero fatto una delle loro inutili litigate. Si sentiva un po’ offesa, questo sì. Per quanto tutti le dicessero che era una sciocchezza e che di esami di questo genere se ne facevano a centinaia ogni giorno, dentro la testa di Sabrina s’era costruito un sillogismo: gastroscopia = tumore. Se n’era ben guardata dal dirlo a suo marito ma nella sua testa era un continuo martellamento, che teneva per sé. Erano sposati da più di vent’anni e i suoi occhi ancora luccicavano quando lo guardava. Il capello riccio era ancora moro, anche se con abbondanti inserimenti bianchi. Sarà stato il suo metro e ottanta, il capello, forse anche il lavoro, sta di fatto che Sabrina trovava in lui la sicurezza di cui aveva bisogno ed era innamorata, oggi come all’inizio. A furia di dai, lo aveva convinto ad andare almeno dal medico di base. Ultimamente aveva perso qualche chilo e mangiava poco. Tiberio andò dal medico e ne uscì con una ricetta rossa con scritto sopra “esofago gastroscopia”, aveva prenotato l’esame sempre senza dire nulla a Sabrina, che lo aveva scoperto per caso e quella volta s’era davvero infuriata. «Mi dici, per cortesia, che cosa ti ha detto il medico?» chiese di nuovo Sabrina seduta alla destra di Tiberio. Bardati di cappotti e sciarpe per difendersi da una mattinata gelida, erano arrivati perfettamente in tempo ed ora erano seduti nella seconda di tre file di sedie con le gambe coperte dalle loro varie palandrane. «Te l’ho già detto, devo fare questo esame» rispose ermetico. «Ma l’esame serve a cosa?» «Per vedere se c’è qualche problema.» «Appunto e che problema?» chiese, trattenendo la rabbia Sabrina. Tiberio tacque e lei si tenne la rabbia per sé. Avrebbe voluto dirgli che non lo sopportava quando faceva così e avrebbe anche aggiunto che, facendo così, le mancava di rispetto ma si morse la lingua. In fondo, era lui che da lì a qualche minuto sarebbe entrato in quell’ambulatorio e non era il caso di farlo agitare. Sperava di rientrare a scuola verso fine mattina, visto che l’esame era alle nove, ma si era tenuta prudente. La porta finalmente si aprì, comparve un infermiere vestito di bianco che fece uscire un signore anziano che se ne andò senza fermarsi. Tiberio lo scrutò alla ricerca di qualche segno di disagio, per vedere se l’intervento avesse lasciato qualche segno ma non trovò nulla di strano. Certo non era sorridente ma quello era ovvio. Nessuno gli aveva detto che l’endoscopia era una passeggiata, alla fine era un tubo che t’infilano in gola e, tanto contento non lo sei, quando te lo fanno. Qualcuno si fa prendere dal panico ma alla fine se ne fanno a decine ogni giorno e quello che succede è che quando uno si spaventa o si agita gli danno qualche goccia di Valium e tutto finisce lì. «Brambilla» disse l’infermiere, cercando con lo sguardo qualche segno. Tiberio si alzò con timidezza, una volta in piedi si girò alla sua sinistra verso sua moglie, come a darle il cappotto e la sciarpa ma stava solo tentando di prendere tempo, una buona e sana paura che Sabrina colse e di cui fu meravigliata. Certo non era abituata ad essere lei quella dei due che dava sicurezza all’altro ma svolse il suo ruolo, anche se tutto si limitò a pochi secondi e a uno sguardo in tutto. Lo seguì con gli occhi fino alla porta e poi rimase in piedi, sentendosi il cuore in gola e avendo cura di non farlo vedere. Si era organizzata con il suo immancabile Kindle e, sedutasi, lo tirò fuori e lo accese, immergendosi nella lettura. In quelle settimane stava leggendo uno dei suoi libri impossibili, Storia della filosofia indiana di un certo Giuseppe Tucci e, tolto con un tocco il segnalibro blu in alto a destra, ricominciò a leggere dalla pagina dove era arrivata l’ultima volta. I libri erano la sua base sicura ma in quel momento erano le fondamenta stesse a tremare e la sua solita sicurezza traballò. Si sforzò a leggere imponendosi di arrivare in fondo alla pagina ma si trovò a rimettere il segnalibro dove lo aveva appena tolto e, con non poca rabbia, decise di alzarsi. Era meglio muoversi, star lì ferma ad attendere davvero non ce la faceva e nei minuti successivi, vagò senza una meta precisa per il corridoio del Fatebenefratelli, tenendo sugli avambracci tutti e due i cappotti. Doveva solo far passare il tempo e avrebbe voluto farlo senza molto pensare a ciò che accadeva ma la sua mente sempre lì andava. Era come se la parola tumore fosse una pallina da ping pong che rimbalzava senza sosta dentro il suo cranio. Nel suo camminare in giro per l’ospedale, si trovò prima davanti al bar, dove non fu nemmeno tentata di entrare, mentre si fermò volentieri davanti all’edicola che, come spesso capita in quei luoghi, fa da piccola libreria. Appena vide dei libri ci si fiondò, era come tornare a casa, sapeva che lì sarebbe stata bene e, carica dei vari cappotti, si piazzò davanti ad un piccolo scaffale dove trovò un po’ di tutto. Considerando che era un ospedale, alcuni titoli gli sembrarono assurdi, come Io uccido di Giorgio Faletti, ma lei sapeva bene che al cuor e alla lettura non si comanda. Sorrise nel vedere l’eterna sezione Harmony, sempre piena di volumi che non erano solo i soliti volumetti, ce n’erano alcuni di grandi dimensioni. Ne prese in mano uno, quasi con la sensazione di sporcarsi le mani, tanto era convinta dentro di sé che quel tipo di editoria fosse il simbolo della superficialità e della banalità. Lo mise giù subito e passò lo sguardo ad altro. Era incuriosita da Lilli Gruber con il suo Eredità. Una storia della mia famiglia tra l’Impero e il fascismo, ma decise di dare prima uno sguardo generico, anche perché lei sui libri aveva una regola ferrea o meglio alcune regole ferree. Prima di tutto se ne legge uno alla volta, secondo se ne compra uno nuovo solo se lo si legge subito e, tra quelli che vedeva, non ce n’era uno che la conquistasse. Il cuore fece bum e una vampata rossa le prese il volto, quando vide un librone grosso, copertina bianca con al centro un piccolo granchio grigio visto da sopra, come autore un nome orientale impronunciabile e come titolo L’imperatore del male, che certo non lasciava pensare al sottotitolo Biografia del cancro, che le provocò una palpitazione. S’immerse subito nella lettura del retro e dell’interno, per scoprire che lo aveva scritto, non un giornalista ma un medico, dunque uno del mestiere e che aveva ottenuto per esso il Premio Pulitzer 2011 per la saggistica. In quel momento quelle settecento pagine furono le sue uniche amiche, in quella carta trovava esattamente le parole che voleva. Rimase in piedi qualche minuto lasciandosi andare a quel fiume di pensieri che le scorreva in testa, ma poi dovette cedere. I cappotti pesavano e stare in piedi a leggere un libro che non avrebbe comprato certo non era possibile. L’unica cosa da fare era tornare in sala d’attesa, l’ultima cosa che voleva era che Tiberio uscisse da quella porta e non la trovasse. 2 Nell’ambulatorio, intanto, le cose erano andate avanti. La dottoressa Barbara Chelli era arrivata con qualche minuto di ritardo e aveva trovato, come al solito il paziente già pronto, steso sul fianco sinistro con il camice azzurro addosso e pronto per procedere. Un rapido sguardo attorno per la sua checklist: paziente in posizione, l’endoscopio si doveva trovare sull’apposito piedistallo e, l’identità del paziente, doveva essere confermata dal paziente stesso, perché questo significava che si faceva la cosa giusta alla persona giusta. «Tiberio Brambilla?» chiese leggendo il nome dalla cartella. «Sì.» Tutto corrispondeva, ora toccava ai guanti. Ogni volta che faceva quel gesto, la Chelli riviveva il proprio dramma. Aveva iniziato come chirurga e si era subito conquistata una certa fama tra i colleghi per la sua manualità. Poi un incidente banale, un intervento leggero alle mani e il suo presente come chirurga si dissolse. Le mancava il teatro della sala operatoria, le mancava infilarsi il camice sterile, lavarsi le mani, chiudere il rubinetto con i gomiti, aprire la porta con una spallata nella classica entrata a saloon dei chirurghi e poi il momento topico dei guanti con l’infermiere che li prepara e il chirurgo che, con un solo movimento per mano, se li infila. Ogni volta che si infilava da sola i guanti di lattice non sterili da usare per l’endoscopio, la dottoressa si ricordava che non era più tra gli dèi, era fuori dall’olimpo. Anche se lei era comunque riuscita a farsi conoscere come endoscopista e ora era molto ricercata dai colleghi, la ferita non si sarebbe mai chiusa. Sarebbe vissuta tra i mortali per tutto il resto della vita. «Operativi?» chiese con la sua voce squillante, trasudando buon umore. Tutti la chiamavano Regina invece di Barbara, per la sua somiglianza con Regina Taylor, attrice di colore nota per il suo ruolo di protagonista della serie televisiva The Unit. Barbara Chelli era, in effetti, una Regina Taylor bianca, bassa di statura, obesa, con un seno gigantesco, le mani piccole grassocce e le dita tozze. Nel periodo in cui aveva frequentato l’olimpo ed era dèa tra gli dèi, si era divertita molto a “sembrare non adatta”. Quando diceva che era una chirurga, nessuno ci credeva mai, non tanto per il suo fisico, quanto per le sue mani e questa cosa la inorgogliva molto. Sembrare non adatta e, invece, dimostrare di essere non solo adatta ma anche brava la esaltava. «Operativi dottoressa!» disse l’infermiere che la assisteva. Barbara era nota per il suo eterno buon umore, un buon umore che a molti sembrava eccessivo e che la rendeva simpatica. «Vado allora» disse. «Ok doc» disse l’infermiere. Nessuno parlava mai all’inizio, perché era il momento più difficile. Doveva centrare con l’endoscopio prima la cavità orale, poi la faringe, poi la laringe e infine l’esofago. L’endoscopio è un tubo lungo, più stretto alla fine e più largo all’inizio e, nella parte prossimale, quella in mano al medico, ha un visore e una manopola che viene manovrata con la mano destra. La parte distale del tubo, quella opposta alle manopole, viene introdotta nella bocca del paziente usando la mano sinistra, mentre la mano destra tiene saldamente la parte prossimale del visore attraverso la manopola. Erano i quattro passi, gli inglesi li chiamavano 4S, acronimo di four steps, in sequenza cavità orale, laringe, faringe, esofago. Sembrava una sciocchezza ma non lo era e, infatti, nessuno fiatava durante i 4S. Nei primi secondi, lo sguardo della Chelli era rivolto alla bocca, ma appena la punta dell’endoscopio era entrata, passava subito al monitor alla sua destra, continuando a usare la sinistra per condurre il tubo e la destra per tenere in mano la manopola nella parte prossimale. I più imbranati tra gli endoscopisti, facevano danno addirittura in bocca, provocando lacerazioni e facendo saltare qualche dente, ma Barbara vantava lo zero assoluto, aveva sempre fatto i 4 steps senza sbagliare. Le gocce di sudore le si erano condensate sulla fronte; negli anni aveva imparato a respirare durante gli interventi, mentre all’inizio andava in apnea. Il coordinamento mano destra, mano sinistra e occhi era perfetto. La parte distale del tubo sembrava quasi un’anguilla nelle sue mani. Ormai aveva fatto i tre quarti del tragitto e si trovava davanti all’esofago. Quando aveva studiato sui libri la tecnica, si era persa tra le parole e aveva chiuso il libro seccata. Poi si era messa a fare le prove e, allora, la tecnica le era risultata chiara e l’aveva imparata velocemente. Quello che era scritto in tante parole sulla carta, adesso lei lo faceva in pochi secondi. Se le 4S erano il momento fondamentale, poi arrivava un secondo momento altrettanto importante. Centrare l’esofago per poi esplorarlo. Le reazioni dei pazienti erano le più diverse. Alcuni rimanevano immobili, altri si aggrappavano fisicamente al medico, in rari casi tentavano anche la fuga. Anche se non succedeva spesso, qualche volta i pazienti le si aggrappavano letteralmente addosso e lei doveva sempre essere pronta a reggere il loro peso senza interrompere l’intervento. «Siamo dentro» disse soddisfatta, rilassandosi e sorridendo. Essendo interventi fatti senza anestesia, quindi con il paziente sveglio o al massimo un po’ rintronato da qualche goccia di Valium, la regola d’oro era di verbalizzare. Ormai era diventata un’abitudine, dire a voce quello che stava facendo significava, di fatto, raccontare passo per passo ciò che accadeva. «Esofago libero nel primo tratto» disse scendendo e incontrando, verso metà, le prime formazioni villose, i diverticoli e qualche piccola varice. «Eccoci qui, diverticoli e piccole varici venose, facciamo prelievo.» Per fare il prelievo doveva infilare un filo di acciaio dentro uno dei canali dell’endoscopio, fino a quando non lo vedeva sbucare nel campo visivo della telecamera. La punta del filo era una pinza con la quale doveva strappare un pezzo di tessuto. Quando era alle prime armi, era qui che andava in apnea la seconda volta. La respirazione era fondamentale per il chirurgo. Il timore era che lo strappo del tessuto provocasse un’emorragia ma ciò non avveniva quasi mai. Le mani si muovevano sempre lentamente, movimenti sicuri e continui con una sicurezza che veniva da anni di esperienza. L’occhio era sempre alla ricerca di gesti sbagliati, di reazioni non previste ma tutto stava filando liscio, tanto che la Chelli sorridente sotto la maschera poté pronunciare la frase preferita. «È fatta ragazzi» disse, estraendo l’endoscopio e osservando che Tiberio si era subito mosso per mettersi a sedere. La dottoressa notò il movimento lesto di Tiberio e rimase ferma a osservarlo. «Non si alzi subito, stia seduto almeno un minuto…» Non aveva certo voglia di gestire un paziente svenuto in ambulatorio di primo mattino per uno sbalzo della pressione. Tiberio sorrise a capo chino e attese. La dottoressa sentiva urgente il bisogno di andare al gabinetto ma non si fidava di quel paziente, aveva deciso di tenerlo a vista. «C’è qualcuno che l’aspetta fuori?» «Si, mia moglie.» Tiberio ebbe la sensazione che il minuto non fosse trascorso, quando la dottoressa gli fece segno di alzarsi. «Tutto a posto?» chiese di nuovo, osservandolo con attenzione, quasi pronta a sorreggerlo. Tiberio fece cenno di sì, la seguì verso la porta. Sabrina aveva ripreso a leggere o almeno a far finta di leggere il suo libro sulla filosofia indiana e, tenendo il capo chino sul suo Kindle, non si accorse che Tiberio era uscito, se non quando se lo trovò di fronte. Barbara Chelli si era fermata in corridoio ad osservare il ricongiungimento tra Tiberio e sua moglie e ci fu uno scambio di sguardi tra i tre. Sabrina, che si era alzata repentinamente e in modo un po’ goffo nel vedere materializzarsi lì Tiberio improvvisamente, si mosse con decisione verso la dottoressa alla quale strinse la mano. «Ha eseguito lei l’intervento?» chiese sorridendo Sabrina dopo essersi presentata, certa che quelli erano i pochi secondi che le erano concessi per spremere tutte le informazioni possibili. La Chelli la guardava stralunata. Era una scena un po’ eccessiva per una endoscopia. «Non era un intervento…» specificò subito, come a dire che lei non tagliava. «Ma si l’ho eseguito io ed è andato tutto bene, signora» disse la Chelli vedendo lo stato d’animo alterato. «Grazie infinite, dottoressa, temevamo...» Era una situazione effettivamente strana. Sabrina e la dottoressa bianca e azzurra erano in piedi in corridoio, Tiberio era in piedi e si stava infilando il cappotto a pochi passi e, nella testa del medico, era chiaro che quella donna che non conosceva, stava facendo non poca confusione. Quel “temevamo” stava a dire che si aspettavano dall’endoscopia quello che l’endoscopia non poteva dire. Era sicura che il paziente aveva ascoltato le sue parole, quando aveva detto che in esofago c’era qualcosa e che aveva fatto il prelievo e contava che fosse lui a dirlo alla moglie. «Abbiamo trovato qualcosa ma bisogna fare l’istologico per sapere di cosa si tratti.» Sabrina sbiancò e il sospetto che nella testa di quella donna ci fosse molta confusione diventò una certezza. Servivano poche parole, descrittive ed era davvero da molto tempo che la Chelli non le pronunciava. «Posso solo dirvi che nel terzo inferiore, diciamo nella parte più vicina allo stomaco, c’è qualcosa che non dovrebbe esserci ma, prima di preoccuparci, attendiamo l’istologico, direi.» «Ma non doveva esserci?» disse Sabrina con tono serio, facendo capire alla dottoressa che non mollava il pezzo. Tornare a fare il medico gli piaceva, sentiva di nuovo il sangue scorrere dentro di lei, anche se, nello stesso momento, sapeva che quella situazione doveva essere chiusa subito. «Signora, l’esofago è fatto di una parete liscia e noi abbiamo trovato qualcosa che sporge. Tra una settimana arriverà la risposta» disse aggiungendo una mimica decisamente brusca. Moglie e marito tacquero e la dottoressa se ne andò a passo deciso, lasciandoli lì impalati. Erano andati là per sentirsi dire che non c’era nulla e ora sapevano che c’era qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Sabrina era atterrita dalla notizia e fiera di sé, perché sapeva che, se non fosse andata li, non lo avrebbe mai saputo da suo marito. Durante il viaggio di ritorno si lasciò andare ad un piccolo battibecco, infilzando Tiberio con qualche farse del tipo “hai visto che tu non volevi nemmeno andare dal medico”, per poi accorgersi che era meglio tacere, perché quel qualcosa poteva essere un tumore e non era davvero il caso di gioire. Nella settimana successiva nessuno dei due proferì parola sull’argomento. 3 Dani California, la prima traccia dell’album Stadium Arcadium 2006, un live dei Red Hot Chili Peppers, riempiva l’abitacolo della macchina con grande soddisfazione di Tiberio, che stava andando da un cliente e aveva appena smaltito alcune telefonate con la sua segretaria Gianna. Era uno dei suoi album preferiti, tanto che sapeva le tracce in sequenza a memoria: Dani California, Snow ((Hey Oh)), Charlie, Stadium Arcadium, Hump de Bump, She’s Only 18, Slow Cheetah, Torture Me, Strip My Mind, Especially In Michigan, Warlocks, C’mon Girl, Wet Sand, Hey Mars, Desecration Smile, Tell Me Baby, Hard To Concentrate, 21st Century, She Looks To Me, Readymade, If, Make You Feel Better, Animal Bar, So Much I, Storm In A Teacup, We Believe, Turn It Again, Death Of A Martian. Non avrebbe mai potuto ascoltarlo in presenza di Sabrina ma ora, da solo, poteva dare libero sfogo al suo piacere e, infatti, aveva anche messo il volume abbastanza alto. Il cliente era nella zona ovest di Milano e, per raggiungerlo, stava percorrendo Porta Genova nella parte sud della città, una sorta di raccordo anulare che racchiudeva Milano in un giro ideale di sette Porte. Il volume era così alto, che perse la prima telefonata. Aveva imparato che il numero del Fatebenefratelli cominciava con 0226 e che il resto delle cifre non si vedevano se erano loro a chiamare, perciò, quando a semaforo rosso vide una chiamata persa con quelle quattro cifre, scattò sull’attenti e chiamò subito, cercando ovviamente della dottoressa Chelli. Gli ci vollero cinque “per favore attenda”, ma alla fine la voce di Barbara Chelli uscì dal viva voce della macchina. I Red Hot Chili Peppers, per il momento, erano stati spenti. «Salve, dottoressa, ho visto una chiamata dall’ospedale e ho pensato fosse lei.» «Sì, l’ho chiamata prima.» «È arrivato l’istologico?» «Sì.» Quei pochi istanti in corridoio con Sabrina, tra le sedie della sala d’attesa e la porta dell’ambulatorio in mezzo alla gente che passava avevano fatto sentire di nuovo a Barbara Chelli l’odore del sangue, l’adrenalina che circolava nelle vene e il richiamo della foresta aveva avuto la meglio. La Regina Taylor bianca aveva chiamato il laboratorio e si era fatta anticipare l’esito, che era positivo e aveva chiamato subito Tiberio. «Ma non aveva detto una settimana almeno?» «Sono stupita anch’io, a dire la verità.» Il calcolo di Tiberio fu rapido. Se la notizia fosse stata buona, l’avrebbe già data o avrebbe comunque usato il solito tono d’umore. Invece, era diversa dal solito e, se uno più uno faceva due, allora le cose andavano male. «È andato male vero?» Avrebbe dovuto dirgli solo che doveva prendere appuntamento con un oncologo o, al limite, avrebbe potuto dirgli che faceva lei da tramite con l’oncologo ma l’onda era alta e lei non aveva intenzione di scendere. Si riprometteva di non fare più una cosa del genere ma, nello stesso tempo, non si tirava indietro. «Venga e ne parliamo, non posso dirglielo al telefono.» Ora aveva la certezza. “Porca puttana!” sbottò Tiberio in macchina mettendosi le mani nei capelli. «Quando posso venire dottoressa?» chiese sperando in un subito. Se gli avesse detto di aspettare qualche giorno sarebbe impazzito. «Senta, sono incasinata in questi giorni…» disse timidamente la Chelli. «Dottoressa, io vengo adesso, lei per cortesia trovi cinque minuti, cinque per me, la prego.» Barbara Chelli sentiva che Tiberio aveva mangiato la foglia, stupido non era. «Va bene, sono in endoscopia e potrebbe andare per le lunghe, venga, si armi di pazienza e chiami sua moglie.» Tiberio si morse la lingua in senso figurato. Non sopportava di aver intuito che era andata male in quella maniera e non ascoltò nemmeno l’invito a chiamare Sabrina. Fece tutto in automatico, guidò, parcheggiò e camminò fino agli ambulatori dell’endoscopia. Il corridoio era pieno di gente che andava e veniva e si sedette tranquillo sulla sedia davanti all’ambulatorio numero tre, dove aveva incontrato la Chelli. Mentre guardava passare lettighe e infermieri indaffarati, Tiberio pensava male. 4 Furono alcune ore di attesa che ottennero, per lo meno, l’effetto di calmare Tiberio. La Chelli era in endoscopia e non poteva certo uscire per lui, era già un miracolo se gliel’avevano passata al telefono. Quando alla fine, alle tre del pomeriggio, Barbara Chelli lo accolse, a stomaco vuoto, nel primo ambulatorio libero, Tiberio era provato dalla lunga attesa e tutti e due si sedettero carichi di stanchezza. «Non ho mangiato» buttò lì la Chelli. Il volto cupo e teso non prometteva bene. «Dottoressa, non so cosa dirle se non grazie per il tempo che mi dedica» disse Tiberio, rendendosi conto che effettivamente la dottoressa era lì con lui senza aver pranzato, seppure anche lui non avesse mangiato. La Chelli prese il telefono e chiese all’infermiere di portarle la cartella di Tiberio e dopo poco l’infermiere entrò e la consegnò alla dottoressa, che nel frattempo era stata ferma e zitta, sempre con il volto cupo. «È andata male?» La Chelli tacque e aprì la cartella, tirando fuori la lettera del laboratorio che lesse senza proferir parola, quasi avesse bisogno di un’estrema conferma. «Sì, Tiberio, è andata male, in effetti.» «È un tumore allora?» «Sì» rispose subito, mantenendo lo sguardo sul foglio ma senza leggerlo. «E dei peggiori, questo è il problema.» Tiberio restò basito. Anche se ciò che gli aveva detto era chiaro, c’era una parte di lui che non voleva ascoltare, non voleva accettare quella frase. «Ora le spiego, Tiberio, mi scusi ma sono davvero stanca, non ho mangiato e comunque di queste cose dovrà parlare con qualche oncologo.» «Se vuole andare a mangiare, l’aspetto» disse Tiberio. «No, no, facciamo ‘sta cosa, che così ce la togliamo» disse la dottoressa senza accorgersi che la frase aveva un doppio effetto e non aiutava molto Tiberio che, all’espressione “ce la togliamo”, aveva sentito come un taglio dentro lo stomaco. «È maligno?» La Chelli aveva davanti la lettera con i codici della malignità. Non era la lettera originale, sopra c’era scritto “copia”. Lo stadio I si ha quando il tumore si trova soltanto nella mucosa, lo stadio II quando rimane limitato negli strati della parete dell’esofago, lo stadio III quando invade altri tessuti e infine lo stadio IV, lo stadio più avanzato e finale, quando il tumore ha formato delle metastasi. Quindi gli mostrò il foglio con la tabella con tutti e tre gli stadi descritti e la segnalazione che lui aveva lo «Stadio III», con la relativa spiegazione «invade altri tessuti». La tabella era organizzata in cinque righe e tre colonne. La prima riga, letta da sinistra a destra, riportava rispettivamente Stadio, Descrizione e poi Presente/Assente, mentre le tre righe sotto la parola Stadio riportavano i numeri romani progressivi da uno a quattro. La riga del terzo stadio aveva una X nello spazio sotto la colonna “Presente/Assente”. «Ma, allora, non ho le metastasi» disse Tiberio, alzando lo sguardo speranzoso verso la Chelli. «Non lo sappiamo Tiberio, bisognerà fare una PET probabilmente…» e lasciò la frase sospesa. La dottoressa sapeva bene che, purtroppo, l’invasività di quel tumore era tale che le metastasi, se presenti, non facevano nemmeno in tempo a dire ba’, perché la massa, occupando lo spazio dell’esofago, impediva progressivamente alla persona di mangiare, provocando vomito e dimagrimento. Poi, quando raggiungeva determinate dimensioni, la massa premeva sugli organi circostanti producendo altri sintomi. Quello che la Chelli non aveva il coraggio di dire era che si moriva prima per l’occlusione dell’esofago che per le metastasi. Le chemioterapie servivano a poco, spesso non fermavano il tumore e debilitavano il paziente e lei era contro la chemio nel caso di Tiberio, ma stava sempre facendo un lavoro che non era il suo. Pisciava fuori dal vaso, come dicevano i colleghi tra di loro, quando uno non stava al proprio posto. Era la sua parte di chirurgo mancato, che la portava a fare queste cose. Le mancava molto il rapporto con il paziente, sedersi al tavolo e discutere la diagnosi e la terapia con lui, quando si trattava di una situazione estrema come quella di Tiberio. Essere lì con quel paziente a discutere della sua prognosi era un po’ come rimontare in sella e rivivere per un attimo da chirurga. Tiberio trasse un respiro profondo, piegando la testa e poi alzandola, per guardare la Chelli negli occhi. «Dottoressa, mi dice tutto per favore?» chiese con le parole e con lo sguardo. La Chelli guardò Tiberio negli occhi e capì che doveva vuotare il sacco. «Le prenoto una PET, che ci dirà delle metastasi, così poi lo sapremo con certezza ma alcune cose le sappiamo già, Tiberio» disse, puntando il gomito destro sul tavolo e portando la mano a coprire la bocca tenendo però lo sguardo basso. Silenzio. La testa della Chelli si alzò, lo sguardo non esitò a cercare quello di Tiberio che si rese conto che quello era il momento della verità senza indugi. «La massa arriverà presto a occupare l’esofago, lei se ne accorgerà perché riuscirà sempre di meno a mandare giù il cibo e vomiterà sempre di più e, allora, si farà il così detto intervento palliativo» disse d’un fiato la Chelli senza sottrarre lo sguardo e senza mollare con il tono e il volume della voce. Se fosse stata solo la prima parte del discorso, sarebbe stata leale con Tiberio ma si fermò lì. «Ma quando vomiterò la devo chiamare?» La dottoressa rimase in silenzio, guardandolo. «Sì, mi deve chiamare, non c’è dubbio» disse, facendo capire che c’era dell’altro. «Che c’è, dottoressa?» La Chelli trangugiò. Lui intuì, capì. «Quanto tempo ho?» Lei tacque. Tiberio sentì una fitta allo stomaco. «Poco, Tiberio, poco» disse la dottoressa Chelli. «Un anno…» «Un anno?» La Chelli crollò e sottrasse lo sguardo, abbassando il capo. «Un anno ad essere ottimisti» disse e poi sollevò lo sguardo. «Bisogna vedere come evolve ma potrebbero essere pochi mesi.» Tiberio esplose. Calde e salate lacrime scesero prima dagli angoli degli occhi, percorrendo i lati del volto, mentre con la mano sulla fronte, cercava di celarsi allo sguardo della dottoressa, piegando anche la testa verso il basso. In un primo momento il pianto fu silenzioso, quasi in apnea, ma subito dopo arrivarono i singhiozzi e, nel giro di pochi secondi, l’acme. Eros e thanatos erano lì assieme ma non per molto ancora. Barbara Chelli aveva la sua soddisfazione, si stava cinicamente nutrendo del dolore di quell’uomo, in un gioco perverso di specchi, nel quale lei risultava la dottoressa premurosa che accudiva il paziente mentre, in realtà, era guidata dalla nostalgia dell’olimpo, dal quale la sorte l’aveva fatta scendere. Non fece nulla, non disse nulla, osservò solamente la disperazione di Tiberio. Le parole, in quei momenti, non servono, mentre serve la distanza fisica. Tutti e due rimasero seduti al proprio posto. Tiberio si alzò per il tempo necessario a rinfrescarsi, per poi tornare al tavolo e sedersi di nuovo davanti alla dottoressa. «Senta, Tiberio, facciamo così, provo a dirle alcune cose concrete e a spiegarle i motivi.» L’uomo non aveva la forza di parlare e annuì, soffiandosi il naso per l’ennesima volta. «Noi consigliamo sempre due cose in questi casi.» Tiberio era incuriosito. «Mettere a posto le proprie cose e farsi aiutare.» Tiberio la guardò stralunato. Si aspettava parole come “chemioterapia” o “radioterapia” ma, quel “mettere a posto” e “farsi aiutare”, non riusciva a collocarli da alcuna parte. «Testamento e psicologa» disse la Chelli, che ora aveva appoggiato la schiena allo schienale della sedia, come a dire che tutto era più tranquillo. Tiberio sgranò gli occhi. Non ci credeva. «Scusi, e le terapie?» sbottò come arrabbiato. «Non le danno quello che lei vuole, Tiberio» disse sicura di sé, sempre con la schiena appoggiata, certa di essere nell’olimpo in quel momento. Mediatrice di Thanatos. «E che cosa voglio, scusi?» chiese, con tono provocatorio e irritato. «Tempo, Tiberio, lei vuole più tempo.» Sembrava quasi che la Chelli avesse preso a prestito da Blade Runner le parole dell’androide: “Voglio più vita, padre”. Era vero. Tiberio si sentì come tagliato in due, in una parola c’era tutto. Avrebbe voluto urlare e piangere ma non aveva più la forza e, debilitato, distrutto, si era come arreso. «Meglio che vada dottoressa, grazie per il tempo. Grazie davvero.» La Chelli lo guardò alzarsi e restò seduta. «Mi promette una cosa, Tiberio?» Mettendosi il giaccone nero egli annuì. «Quando inizierà il vomito, mi chiama?» Barbara Chelli sapeva che dal vomito in poi c’era poco da fare, tutti interventi sintomatici e palliativi, ma non aveva il coraggio di dirglielo. L’unico pensiero era di non lasciarlo solo in quel guado. Era la prima volta che si lasciava andare in quel modo, non le era mai capitato di pisciare fuori dal vaso da quando si era messa a fare endoscopie. Era sempre rimasta al suo posto e si chiedeva come mai questa volta avesse ceduto e avesse fatto una cosa del genere. Si ripromise di non farlo più, almeno non con altri pazienti e, chiudendo gli occhi per dei lunghi secondi mentre guardava Tiberio alzarsi, ricacciò nel profondo del suo animo quel pensiero che voleva prenderle la testa e ossessionarla. Aveva passeggiato qualche minuto con Thanatos, di nuovo, dopo molto tempo. Aveva sentito ancora una volta quell’adrenalina marcia che tanto le piaceva e sapeva bene che lo aveva fatto proprio per il bisogno di sentire di nuovo quel brivido e tornare per un attimo nell’olimpo. Ora però basta, avrebbe messo un tappo a quella falla. Quando riaprì gli occhi, vide che Tiberio era in piedi e si stava abbottonando il giaccone. «Io spero che lei mi chiami prima per la PET» disse, allungando la mano e facendo capire che a lui importava prima di tutto non avere le metastasi, nonostante la Chelli gli avesse detto che importava di più l’ostruzione dell’esofago. «Spero di chiamarla nei prossimi giorni.» La Chelli decise che per la giornata era anche troppo e, alzatasi, lo accompagnò alla porta e lo salutò dandogli la mano e Tiberio, in stato confusionale, percorse in automatico i corridoi dell’ospedale e poi di lì fino al parcheggio. 5 Era già la terza volta che la segretaria metteva dentro la testa e trovava Tiberio sempre al telefono. Negli anni si erano creati tra di loro dei gesti che funzionavano da codici per comunicare in maniera essenziale. Per esempio, se la telefonata era una seccatura, Tiberio faceva delle smorfie per far capire che era una cosa noiosa, della quale non vedeva l’ora di liberarsi. Altre volte, invece, quando si poteva, chiedeva a Gianna, la segretaria, di chiamarlo a voce alta, in modo che fosse chiaro che aveva un motivo per interrompere la comunicazione. Ora però Tiberio non diceva nulla, né a parole né con il volto, e Gianna sapeva che bisognava solo attendere che finisse, anche se andava avanti almeno da mezz’ora e diventava davvero ingombrante, perché le cose da fare non mancavano. Finita la telefonata, Tiberio restò fermo dondolandosi sulla sedia, un raggio di luce entrava dal velox illuminandolo. Dondolandosi sulla sedia, si prendeva un tempo di decompressione dalla telefonata e si guardava bene dal chiamare Gianna. La stanza del suo studio era tutta strana, lui ne andava orgoglioso e alcuni suoi amici anni prima erano andati a fotografarla. La porta dalla quale si accedeva era l’unica via per entrare e uscire e si apriva dall’esterno all’interno verso destra. Non potevano farla aprire verso sinistra, perché c’era subito il muro e avrebbe sbattuto continuamente. Tutte e quattro le pareti erano coperte da librerie grezze, scaffali di acciaio, stracolmi di libri che venivano spolverati solo ogni tanto. Entrando dalla porta, le due pareti laterali erano oblique, iniziavano larghe e finivano più strette e la cosa era visibile. Le fonti di luce erano due. Il velox, esattamente sopra la testa di Tiberio, e una piccola e striminzita finestrella, quasi a livello del pavimento della parete a destra della stanza entrando dalla porta. Tiberio aveva lasciato una parte dello scaffale libera per poter arrivare ad aprire e chiudere il vetro, mentre gli scuri restavano sempre aperti. Si riconoscevano le stagioni dell’anno dalla luce che entrava dal velox. Ma la vera originalità della stanza era il gradino. La scrivania di Tiberio si trovava dalla parte opposta della porta d’ingresso e non aveva cassetti. Un’enorme asse di legno scuro, spessa circa venti centimetri. Il legno era vecchio e segnato dagli anni di uso e non era neanche piallato bene. La superficie era irregolare, anche grazie alla presenza di diversi nodi che creavano piccoli avvallamenti e sporgenze. Era sostenuta da due gambe fatte a candelabro e unite da un tronco orizzontale. Sul tavolo, il caos. Fogli di carta, un computer portatile piccolo e una lampada di quelle che sembravano venire da chissà quale ripostiglio. Scheletro in ottone giallo, un grande coperchio verde fatto a vaschetta voltata verso il basso con dentro una lampadina. Tre borse di pelle erano sempre presenti appoggiate alla gamba destra del tavolo verso la porta. La prima era giallo chiaro, con la maniglia logorata dal tempo, e conteneva dentro le carte del giorno. Gianna, la sua segretaria storica, sempre in dolcevita chiara e con il capello grigio tenuto corto alla maschietto nonostante i suoi sessanta anni passati, aveva il diritto di accedervi per metterci le carte della giornata. In gergo Tiberio e Gianna la chiamavano “la gialla”. Le altre due borse avevano funzioni diverse. Una, marrone scuro, più grande, era sempre pronta con un cambio e Tiberio la usava per i viaggi di una giornata o due. La portava a casa solo perché, rientrando dal viaggio, la svuotava e la riempiva. Se Gianna una mattina arrivava a lavorare e non la vedeva, voleva dire che era partito all’improvviso e che sarebbe tornato entro un paio di giorni. La terza era sempre in pelle come le altre due, di un cuoio chiaro ma non gialla come la prima e Tiberio la usava per andare da clienti per i quali doveva portare via parecchie carte. Gianna poteva usare anche quella per riempirgliela. La domanda che tutti gli facevano sempre, quando vedevano per la prima volta lo studio, era come mai lo tenesse vuoto. La stanza, infatti, era tagliata in due da uno scalino, che partiva da una parete e arrivava all’altra. Entrando dalla porta lo si vedeva correre per terra, da sinistra a destra. Tra la parete della porta e lo scalino c’era almeno un paio di metri e ci sarebbe stato spazio per un bel tavolo operativo o magari un piccolo salotto di due poltrone per accogliere gli ospiti. Niente da fare. Tiberio lo aveva sempre lasciato libero, riempiendolo solo dei suoi sguardi durante le telefonate. Il tavolo dei progetti era in una stanza apposita, dove aveva il suo ufficio operativo il geometra. 6 Quando Gianna entrò quel mattino e trovò finalmente Tiberio senza telefono all’orecchio, si avvicinò lesta ma silenziosa con il suo blocco note e la penna in mano. Occhiali da presbite con catenina rossa, volto ovale, sorriso accennato e pantaloni di lana. «Hanno chiamato di nuovo.» «Chi?» chiese Tiberio, che non era ancora completamente presente. «I tedeschi.» Quando era arrivato al lavoro quel mattino, egli aveva saputo da Gianna, che aveva chiamato una ditta da Berlino. Gianna aveva sentito la voce di un uomo apparentemente adulto che, in un italiano con pronuncia tedesca, cercava l’ingegner Brambilla. «Abbiamo un numero?» «Sì.» «Chiamali e passameli.» Il telefono squillò sul tavolo, mentre Tiberio si era alzato e si stava sgranchendo le gambe. «Ingegner Brambilla?» L’accento sembrava quasi quello di Sturmtruppen, tanto era marcato. «Sì, con chi parlo?» chiese Tiberio, guardando comparire la foto di Sabrina sullo schermo del proprio telefono. Con il polpastrello dell’indice pigiò il pulsate rosso. Era un accordo che durava da anni e funzionava bene tra lui e sua moglie. Se interrompeva la chiamata, era perché in quel momento non poteva rispondere. Sabrina spesso lo chiamava nei momenti liberi che aveva, il che voleva dire tra una lezione e l’altra, in genere tra i cinquanta e i sessanta minuti dell’ora o a ricreazione e, cioè, tra le 11.40 e le 12.00. In alternativa nelle ore di buco. «Sono Hans Schäfer, direttore della Zementbau, una ditta di costruzioni di Berlino.» «In cosa posso esserle utile?» chiese Tiberio, mentre sul portatile digitò il termine “Zementbau”, e il traduttore di Google restituì “calcestruzzo”. La cosa lo rasserenava, erano anche loro del mestiere probabilmente. In quel momento il telefono vibrò e comparve ancora la foto di Sabrina ma come messaggio. Decise di aprilo e leggerlo. «Noi vorremmo venire a Milano per presentarle un progetto, è possibile stabilire una data?» chiese Hans Schäfer. Tiberio rimase stupito. Non si aspettava una richiesta così chiara. «Certo, si può fare, adesso non ho con me l’agenda, ma poi si mette d’accordo con la mia segretaria.» «Va bene, allora ci vediamo da lei, spero presto.» Tiberio rimase come disarmato da questo Hans Schäfer. Era svelto e conciso e, preso come in contropiede, cercò di recuperare lucidità in pochi istanti per fare una domanda. Il messaggio di Sabrina diceva «Hai notizie dell’istologico?» Tiberio pensò, che era davvero incredibile quella cosa. Da quel giorno non ne avevano più parlato e, improvvisamente, ora una telefonata e un messaggio. «Sì, tutto bene» scrisse, inviando immediatamente il messaggio, per tornare subito al signor Schäfer che aspettava la sua domanda. «Scusi, signor Schäfer» disse, sperando di avvicinarsi il più possibile alla pronuncia esatta del cognome. «Mi dica, ingegnere.» Il telefono vibrò di nuovo, un nuovo messaggio di Sabrina che Tiberio aprì mentre ascoltava le parole del tedesco al telefono. Il messaggio conteneva solo un’emoticon, una faccina gialla sorridente. La cosa era del tutto inusuale per Sabrina, che aveva sempre molto criticato quel modo di comunicare. «Posso chiederle come mai avete chiamato me?» «Ingegnere, abbiamo visto sul vostro sito i suoi lavori e siamo rimasti impressionati» disse d’un fiato. «Grazie.» «Arrivederci.» Gianna entrò nello studio, quando sentì che era finita la telefonata. Tiberio amava lavorare all’estero ma non gli capitava così spesso. Era stupito e contento. «Sentili e stabilisci un appuntamento.» «Va bene» disse Gianna sempre perfetta in piedi nella parte inferiore dello studio. «Si ricorda, vero, che ha un appuntamento adesso?» «Con chi?» Gianna fece una smorfia di disapprovazione. Il problema non era con chi ma dove. Era dall’altra parte della città. «Via Vivaio» disse la segretaria, sapendo che così Tiberio fotografava bene la cosa. Era la sede della Provincia e doveva andare a presentare un progetto cui teneva molto. Tiberio, in effetti, si illuminò. «Le carte?» Gianna le aveva in mano e le mostrò. Tiberio si chinò alla sua destra, prese la gialla e la mise sul tavolo, ma era piena. Mentre Gianna raggiungeva la postazione, Tiberio estrasse in un blocco le carte che si sparsero sul tavolo facendola rabbrividire ma non intervenne. «Tanto è tutta roba da buttare via» disse Tiberio che, tuttavia, temeva che non fosse così. Mentre infilava le carte del progetto per via Vivaio nella gialla, vide che per terra, a destra, c’era un foglio e, chinatasi, lo raccolse per darlo a Tiberio, occupato nel frattempo a setacciare il mucchio per vedere se ci fosse qualcosa d’importante. Gianna gli passò un depliant a tre pieghe. Egli vi buttò l’occhio e vide i loghi della Regione Lombardia e del Comune, più alcune onlus. Era di colore grigio ed era intitolato “Psiconcologia: tra limiti e speranze”. Chissà se Gianna lo aveva letto. Tiberio si costrinse al silenzio ma il cuore gli era andato in gola. Era un depliant che gli aveva dato la Chelli, il giorno in cui gli aveva comunicato l’esito dell’istologico. Era un convegno che si sarebbe svolto a Palazzo Marino. Per leggerlo Tiberio si era leggermente girato dando le spalle a Gianna, che stava sistemando le carte nella borsa. Mentre la controllava con la coda dell’occhio, il suo sguardo passava velocemente sull’interno del depliant che aveva aperto. «Che giorno è oggi, Gianna?» chiese. «Venticinque.» Tiberio si morse il labbro inferiore nel vedere che la data del convegno era proprio quella. «Che ore sono?» «10.30.» «A che ora devo essere in via Vivaio?» «Tra mezz’ora.» Il convegno era il pomeriggio, quindi ce l’avrebbe fatta. Gianna chiuse la borsa. «Penso che ci vedremo lunedì, oggi pomeriggio ho da fare.» «Va bene, ingegnere» disse Gianna. Lui dava del tu a Gianna e Gianna dava del lei a lui e andavano avanti da anni così. 7 Tiberio fece in tempo ad andare a presentare il progetto in Provincia, mangiare un boccone e poi andare a Palazzo Marino. Le due sedi non erano lontane. Via Vivaio si raggiungeva comodamente prendendo via Francesco Sforza da Porta Romana, mentre per Palazzo Marino doveva per forza entrare in centro. Mangiò un piatto freddo con calma in un bar vicino a Palazzo Marino e fece una telefonata a Sabrina per non destare sospetti. Da quando la Chelli gli aveva detto del vomito, mangiava sempre pieno di paranoie, masticando a lungo e cercando di bere molti liquidi. Gli aveva detto che, ovviamente, i liquidi passavano più facilmente dei solidi e così Tiberio sperava di rimandare il primo conato di vomito, che attendeva come un segnale divino dell’inizio della fine. I cartelli dell’evento erano visibili già all’entrata e questo fece piacere a Tiberio che, terrorizzato dal ritardo, arrivò in anticipo. La sala non era molto capiente e, maliziosamente, egli sorrise. Non era capiente proprio perché l’argomento era impossibile, pensava entrando e perlustrando con lo sguardo lo spazio. Due gruppi di sedie, separate da una corsia in mezzo, un tavolo lungo e stretto sopra una pedana di almeno mezzo metro, un paio di microfoni. Tutto, pavimento, pareti e soffitto di pietra grigia. Le sedie erano terribilmente scomode. Scheletro di tubi di acciaio cromato del diametro di un paio di centimetri, con due pezzi di finta pelle nera che fungevano da seduta e da schienale. Tiberio rimase solo per alcuni minuti, dopo di che arrivò un po’ di gente alla spicciolata. Cenni di sorrisi imbarazzati per essere lì in quattro gatti e poi, da parte sua, la ricerca di volti che sapessero di pazienti come lui. Non aveva la minima idea di come fosse possibile riconoscerli, non sapeva che segni distintivi cercare, anche se l’idea che si era fatto era che ci fossero solo psicologhe. Il tavolo del relatore però era ancora vuoto e la prima donna che vi si avvicinò era una di quelle sessantenni tutte tirate e plasticate che lo facevano inorridire. Capello ancora caldo di phon, un trucco pesantissimo, collane e braccialetti esagerati, un completo di giacca e gonna con calze scure e un paio di scarpe chiuse con il tacco alto. La Chelli questa volta aveva preso un granchio, pensò tra sé e sé Tiberio. Mai e poi mai Tiberio si sarebbe affidato a un’allampanata del genere. Caricato di cattiveria e di cinismo, la scrutò trovandole tutti i difetti possibili e ripromettendosi di svignarsela al più presto. Gli sembrava impossibile che una come la Chelli gli potesse aver dato una dritta del genere, anche se, a pensarci bene, ripercorrendo con la memoria i fatti, gli pareva di ricordare che la dottoressa gli avesse solo dato il depliant senza far commenti. Quindi non sapeva se quello era un consiglio o solo uno spunto. Proprio mentre ripercorreva con la memoria la storia di quel pieghevole, notò che sulla pedana era arrivata una suora e la sessantenne allampanata le era andata incontro abbracciandola. La cosa diventava quasi ridicola. Sulla stessa pedana una suora, per altro di quelle di madre Teresa di Calcutta, con la classica veste bianca dai bordi azzurri, e una sessantenne mille miglia lontana dalla spiritualità e dall’umiltà di quella suora. Ora bisognava solo capire chi delle due fosse la relatrice, visto che erano le uniche due al tavolo. Pensò che la donna allampanata dovesse essere un pezzo grosso che finanziava con progetti le opere di carità delle suore di madre Teresa. Indeciso se rimanere o andare via, rimase, solo perché voleva verificare chi delle due fosse la relatrice, anche se gli pareva ovvio. La curiosità veniva anche dal fatto che quel depliant glielo aveva dato la Chelli ma ciò che veramente lo intrigava era la possibilità che quella donna ingioiellata fosse la psicologa, nel qual caso davvero se ne sarebbe andato schifato. Le due confabularono un po’ tra sorrisi tiepidi della suora e ampi della sessantenne e poi fu tutto chiaro. La suora tirò fuori dei fogli e li mise sul tavolo, il che voleva dire che li avrebbe letti, quindi era la relatrice. L’allampanata si avvicinò al microfono. L’introduzione fu lunga e noiosa. Dalla Presidenza della Regione all’ultimo assessore del comune la donna nominò tutti i fanti e i santi e già quello era abbastanza per darsela a gambe levate ma il peggio doveva ancora venire. La suora venne presentata come Claudia Pacor, laureata in psicologia con lunga esperienza di psicoterapista e attuale responsabile provinciale delle suore di madre Teresa di Calcutta o, più precisamente, Missionarie della Carità. Al sentirsi chiamare con il nome da ragazza, la suora di madre Teresa reagì con rossore e imbarazzo e la presentatrice dovette scusarsi per l’errore. Nell’immenso banale che la donna trasmetteva mentre parlava, Tiberio rimase colpito da un dettaglio. Forse per rimediare all’errore che aveva fatto, osando chiamare con il nome da laica la suora, nome per altro scritto sul depliant, la presentatrice si lasciò andare ad una lunga descrizione delle Missionarie della Carità come una congregazione femminile che racchiudeva in sé lo scrigno segreto della spiritualità, con un’attività caritatevole quasi esagerata. Da quello che si capiva, di per sé era impossibile che una missionaria della carità potesse esercitare una professione da laica, tanto rigide erano le norme che regolamentavano la loro congregazione. Doveva essere una donna straordinaria, pensò Tiberio, se le sue superiori si fidavano a farle continuare la professione di psicologa. “Va bene!” esclamò Tiberio dentro di sé. Aveva deciso di rimanere, se non altro per sentire quello che questa super suora aveva da dire. Non era in grado di dire se la suora sapesse ciò che diceva, se il contenuto scientifico c’era, ma come ascoltatore, in un gioco di parole perverso e cinico, visto il tema della conferenza, poteva dire che era una noia mortale. Forse era anche brava come psicoterapeuta ma, nel parlare, aveva una flemma glaciale, capacità di comunicazione sotto i tacchi delle scarpe e, oltre tutto, leggeva rendendo ancora più tragico e inconsolabile il quadro. Ora, però, almeno sapeva come si chiamava questa dottoressa Pacor, che da suora aveva preso il nome di Maria, o sister Maria, dato che loro parlavano solo inglese. La noia fece il suo effetto dopo pochi minuti, quando l’emorragia di spettatori iniziò. Qualcuno avrebbe dovuto fermare quello scempio ma poteva farlo solo la sessantenne allampanata che, invece, esibiva impettita tutto l’interesse possibile per la relatrice, alternando diverse posizioni nell’ascolto. Prima era ferma sulla sedia poi, siccome la suora psicologa era alla sua destra, si mise seduta girata verso di lei. Le mosse ulteriori consistevano in leggeri movimenti della sedia e il tutto diventava goffo e insensato. Restando fino alla fine, Tiberio avrebbe ridotto l’imbarazzo degli altri e così rimase. Non seguiva molto la relazione, non ci provava nemmeno e lo scempio si consumò fino alla fine. Quello che rendeva davvero insopportabile il tutto, era la mancanza di contatto visivo. Sister Maria non sollevava mai lo sguardo dai fogli, vai tu a capire se per un ordine superiore di esibizione di un’umiltà, che non ci stava davvero, o se per uno stile autentico, che però era comunque fuori luogo. La sessantenne allampanata fece il suo applauso accompagnato da quello di Tiberio e di altre due persone, gli unici rimasti. Non ci furono domande e la presentatrice mostrò, questa volta sì, il suo imbarazzo, dichiarando improvvisamente chiusa la conferenza e asserendo che la sala serviva entro pochi minuti ad altro convegno di cui non c’era alcun cartellone e, dopo aver molto ringraziato la suora psicologa, disse che doveva lei stessa andarsene subito per impegni dell’associazione che rappresentava. Non sapeva nemmeno lui come mai fosse rimasto, anche se, in fondo, la doppia identità della psicologa suora l’aveva in qualche modo affascinato. Ci vedeva dentro qualcosa di ideale. Tiberio si trovò facilitato nell’avvicinare la suora che, a testa bassa riuniva le sue carte, mettendole in uno zainetto marrone, che poi si caricò sulla spalla destra, mentre si incamminava mestamente verso l’uscita, in una imbarazzata e triste solitudine. Tiberio con una piccola corsetta raggiunse goffamente la suora buttando lì un «Complimenti». «Grazie» disse la suora psicologa, concedendo a Tiberio, che era alla sua destra, più una lieve sbirciatina che uno sguardo. In un mesto silenzio, con ancora però un lampo di vita sulle gote, quasi davvero credesse alla sincerità di Tiberio, la suora psicologa continuò a camminare e, uscita dalla stanza, puntò in fondo al corridoio e alle scale. Tiberio guardò avanti, se non avesse parlato ora, sarebbe stato tutto più difficile. Il problema era che non sapeva nemmeno lui perché lo facesse. La doppia identità della donna lo affascinava, questo sì, ma certo la conferenza era stata un disastro. Poi c’era anche il fatto che lui faceva fatica a fidarsi e gli sarebbe stato utile sapere se la Chelli conoscesse questa sister Maria, “dottoressa Claudia Pacor”. In fondo, se la Chelli la stimava, forse per la proprietà transitiva anche lui l’avrebbe stimata o magari le avrebbe dato credito. «Lei ha uno studio, può dare appuntamenti?» chiese Tiberio mentre camminava mezzo passo indietro rispetto alla suora, senza essere nemmeno sicuro che l’avesse sentito. La suora psicologa dalla faccia tonda sorrise di nuovo e annuì e, per farsi vedere da Tiberio, si voltò leggermente a destra. Tiberio si chiese come mai non avesse risposto con un semplice sì, quel movimento della testa in fondo gli sarebbe potuto sfuggire mentre camminavano. Si accorse di essere angosciato, come timoroso di perdere quella possibilità, quasi non ce ne fossero altre. Che fosse o non fosse un sì, decise di procedere. «Come posso contattarla per prendere un appuntamento?» chiese, vedendo avvicinarsi pericolosamente le scale e temendo che là non avrebbe ottenuto più nulla. Tutti e due sorridevano mentre, in maniera del tutto raffazzonata, Tiberio scriveva sul depliant, che ormai era tutto spiegazzato, un numero di telefono. «Grazie» disse Tiberio, guardando la suora psicologa allontanarsi, quasi avesse fretta di andarsene. 8 Via Forze Armate non era lontana da casa, bastava prendere la Bisceglie. L’emozione era tanta, non sapeva nemmeno lui perché o forse, a pensarci bene, lo sapeva. Per la prima volta in vita sua andava da una psicologa e questa psicologa era una suora. Seduto in macchina Tiberio guardava la strada verso di lui vergognandosi dei propri pensieri maliziosi. Quelle suore di madre Teresa lo affascinavano ma aveva come la sensazione che fossero scarse nell’igiene personale. Stando vicino a sister Maria, aveva sentito quell’odore che si sente un po’ come retrogusto, un filo di fondo che aveva tutta l’aria di essere un olezzo e che veniva da respingere, come se il solo sentirlo fosse in qualche maniera un’offesa. Se lo avesse sentito di nuovo cosa avrebbe fatto? Glielo avrebbe detto? Non aveva il coraggio e si sentiva una merda per il solo fatto di averlo pensato. Sta di fatto che da un quarto d’ora buona, al culmine dell’imbarazzo, era seduto nella sua macchina parcheggiata e non aveva il coraggio di muoversi. La telefonata era stata breve e dolorosa. Sister Maria gli aveva dato un appuntamento alle calende greche e Tiberio l’aveva presa sul personale. “Non lo capisci che se ti cerco è perché ho un tumore”, aveva urlato dentro di sé, mentre con la voce pacata faceva notare che aveva bisogno prima. L’aver dovuto insistere per incontrarla prima era stato un ulteriore motivo di rabbia e di disagio, che rafforzava un sentimento che ormai albergava stabilmente in lui. Siccome stava morendo, aveva dei diritti, che gli altri non avevano e voleva che questi diritti gli venissero riconosciuti, anche se non diceva della sua malattia. Se questo poteva valere per sister Maria, che in qualche maniera sapeva che lui qualche problema oncologico l’aveva, Tiberio mostrava queste pretese anche verso Sabrina, che invece non sapeva nulla. Quando la porta si aprì, sister Maria era lì sorridente, pronta ad accogliere Tiberio immerso in un profondo imbarazzo. Appena vide la suora, il suo naso percepì subito l’olezzo e, forse, fu proprio quello a scatenargli una serie di pensieri. Pensieri che si ripetevano e che avevano il compito di allontanare l’imbarazzo che aveva provato nel risentire quell’odore, che viveva come una mancanza di rispetto per la suora. Così, per distrarsi, iniziò a dirsi che aveva sbagliato ad andare e che stava togliendo tempo prezioso ad una donna che aveva da fare cose ben più importanti che stare dietro a lui. Il percorso fu breve, sister Maria arrivò subito alla stanza che le faceva da ufficio e da studio. Si accedeva attraverso una porta di legno con la parte superiore di vetro e, nemmeno a dirlo, la stanza era spoglia come del resto lo sono sempre quelle delle Missionarie della carità. La forma della stanza era rettangolare e di fronte alla porta d’ingresso c’era un tavolo con una sedia. Anche il tavolo era spoglio. Un computer portatile spento e chiuso, una lampada da tavolo che non aveva nemmeno il filo elettrico, qualche foglio e un cellulare che fece comparire il sorriso sul volto di Tiberio. Era meno a disagio nel constatare che anche loro, nonostante tutto, avevano il telefonino. Quello che metteva in difficoltà Tiberio era la mancanza di libri, una psicologa senza libri gli sembrava strana. Non fece però in tempo a pensarci molto, perché sister Maria lo fece accomodare su una poltrona che veniva dall’eredità di chissà quale vecchietta ed era appoggiata al muro davanti alla porta. Il bordo della poltrona di pelle aveva preso il colore del muro, grattandolo e scolorendolo. «Mi ricordi il tuo nome...» disse sempre china su se stessa sister Maria, dando del tu a Tiberio che invece le dava del lei. Con una buona dose di malizia, Tiberio stava perlustrando con lo sguardo l’ambiente e la stessa sister Maria. Cercava un segno che gli potesse confermare che l’olezzo non era un’invenzione. Il collo non era visibile, il velo lo copriva completamente e, già questo, faceva pensare male Tiberio. L’occhio indiscreto e cattivo, andò in cerca delle parti del corpo esposte: volto, mani, piedi, il collo solo davanti. Le mani erano ben visibili, certo non aveva le unghie dipinte, come non aveva il trucco sul viso ma non vedeva quelle classiche righe o strisce grigie, magari sfumate, che si creano per sfregamento sui piedi, sulle mani ma anche sul collo. D’estate quando fa caldo e si suda tanto, spesso, a fine giornata, un po’ tutti hanno addosso queste piccole corone di rivoli vari che vanno dal grigio al marrone. «Tiberio, Tiberio Brambilla, sono un ingegnere, lavoro qui a Milano» disse, interrompendo la ricerca morbosa che aveva fatto con gli occhi sul corpo della suora e rispondendo alla domanda che aveva lasciato sospesa. «È un piacere conoscerti, Tiberio Brambilla» disse sorridente e ricurva suor Maria. Chissà se si era accorta del suo sguardo malizioso? Tiberio sorrise infastidito dalla luce che proveniva dalla finestra proprio davanti a lui. Quando sister Maria lo aveva fatto sedere lì, egli si era irritato dentro di sé, perché la luce che veniva dalla finestra era accecante e lui non era un missionario della carità che sopportava tutto. «In cosa posso esserle utile, Tiberio?» «Sorella, non so nemmeno da dove iniziare e mi vergogno un po’ di essere venuto da lei, che avrà certo di meglio da fare con persone più bisognose di me» sbottò Tiberio. Sister Maria tacque senza sottrarre lo sguardo e senza spegnere il sorriso. «Mi hanno diagnosticato un brutto male, sorella» disse, trattandola come un’analfabeta e dimenticando che era una psicologa, con la quale almeno la parola “tumore” si poteva usare. Era come un riflesso condizionato. Vedendola così dimessa, gli veniva da trattare quella donna come se avesse la quinta elementare. «La dottoressa mi ha consigliato di farmi aiutare dal punto di vista psicologico.» «Le ha dato un buon consiglio quella dottoressa, deve essere brava» rispose sempre con lo stesso tono di voce. Chissà come era da laica quella donna, si chiese Tiberio, formulando di fatto il primo pensiero non malizioso su sister Maria e ricordando la faccenda della “suora” e della “sister”. «Una chirurga che consiglia una psicologa ad uno che deve morire suona strano» buttò lì cinicamente Tiberio dando già la misura della sua rabbia. «Tutti dobbiamo morire, Tiberio.» «Io tra meno di un anno, sorella» puntualizzò lui, come se sister Maria gli avesse dato una sberla e lui dovesse restituirla subito. Come inizio era decisamente aggressivo e Tiberio ci rimase male. Si aspettava che una sister dovesse, se non consolarlo, certamente non dirgli una frase del genere e si chiese di nuovo se avesse fatto bene ad andare là. «Pregherò per te, Tiberio.» «Grazie sorella.» Tiberio si rendeva conto che stava come sputando addosso alla sister, le buttava addosso la sua rabbia e la sua cattiveria e non si tratteneva. Quelle parole non gli erano piaciute, non si era sentito accolto e sentiva quasi il bisogno di andare via. «Ne hai parlato a casa?» Tiberio sorrise, sentendosi colto sul fatto. «Non ho detto nulla, nemmeno a mia moglie, non so nemmeno io perché o, forse, lo so» disse, sollevando lo sguardo a sinistra sul muro scalcinato della parete tra le due finestre, per trovare riposo dalla luce della finestra che lo accecava. Gli sembrava davvero che tutto lì dentro fosse un’esibizione di povertà. “Ha il computer e il telefono, ma l’ambiente deve essere degradato” sentenziò tacitamente. «Hai paura di qualcosa forse?» chiese sister Maria. «In effetti sì, temo di diventare un caso pietoso e, soprattutto, temo che questa cosa cambi la mia vita e io non voglio, vorrei vivere normalmente questi giorni che mi rimangono.» «È questa la tua paura allora, che il tuo male ti cambi la vita?» «Non il mio male ma la notizia del mio male in famiglia» specificò Tiberio aggiungendo subito «E, comunque, mi scopro incazzato, molto incazzato.» «Penso che sia normale essere arrabbiato, Tiberio, con una diagnosi di questo genere.» «Anche con Dio è normale essere arrabbiati?» disse beffardo Tiberio, con la mano appoggiata sul volto e il gomito appoggiato sul bracciolo della poltrona, palesando una calma assoluta. «Soprattutto con Dio, Tiberio, e non credere che lui non apprezzi queste rabbie» disse sister Maria sorridente e ricurva. «A dire il vero, sister, sapere che è normale essere incazzati o che Dio interpreta come preghiera questa mia condizione, non mi aiuta per nulla» disse Tiberio pacatamente ma con dentro il fuoco. «Ma tu cosa vuoi risolvere, fammi capire?» La domanda era chiara ma Tiberio la percepì come insidiosa. Che domanda era?! Che senso aveva chiedergli cosa volesse?! Uno che sta morendo, che altro può volere se non vivere? Nella testa di Tiberio rimbombavano le parole di Barbara Chelli, quel terribile “non le dà quello che lei vuole” e, di nuovo, Tiberio era Roy Batty, l’androide di Blade Runner che voleva più vita. In quel momento si vedeva proprio su quella terrazza, all’acqua e al buio a combattere, anzi a salvare Rick Deckard, il poliziotto interpretato da Harrison Ford. Certo, Tiberio non poteva cogliere quel particolare, quel dettaglio. Lui aveva solo in mente la scena del film, non il sottile gioco psicologico che Roy Batty e Rick Deckard mettevano in scena secondo un copione disegnato a tavolino, per andare dritto negli abissi dell’anima. Rick Deckard era lì per togliere il tempo a Roy Batty, perché era intollerabile che un androide, una macchina, volesse più vita e, dunque, andava abbattuto, andava eliminato, andava messo a tacere, prima che potesse generare altri Roy Batty, altri androidi che chiedevano più vita. Certo, alla fine Rick Deckard vince e Roy Batty perde, alla fine l’uomo controlla il computer ma non come eroe, quanto come antieroe. Nel combattimento che si svolge sulla terrazza, infatti, è Roy Batty a vincere e Rick Deckard si trova salvato da Roy Batty, che lo tiene sospeso nel vuoto con la forza di una sola mano. Il cattivo salva il buono, la vita artificiale che si sta spegnendo salva la vita umana che continua e, poi, la vita artificiale si spegne da sola. L’eroe vince per le sue forze, l’antieroe vince per la debolezza del cattivo e in Blade Runner l’eroe è un antieroe. In quei pochi minuti di film Ridley Scott aveva messo in scena un complesso gioco psicologico, che sapeva perforare tutto e conficcarsi dentro l’anima, e Tiberio in una frazione di secondo si era inconsapevolmente immerso in quel pozzo, divorato dalla sua voglia di vita. Certo, Tiberio non era mai stato un uomo perspicace nella psicologia, lui costruiva ponti, lui si metteva al tavolo, matita e carta, e faceva nascere dei numeri e quei numeri in mano ad un geometra facevano stare in piedi i ponti. Eppure, in quei pochi secondi la sua mente lo aveva trasportato su quella terrazza, dove la sua anima si era frammentata spargendosi sul terreno catramato, bagnato. Non poteva essere Roy Batty, perché Roy Batty era un androide, ma nello stesso tempo era Roy Batty, perché portava in sé lo stesso urlo, voglio più vita. Non poteva essere Rick Deckard, perché Rick Deckard aveva la missione di spegnere quel voglio più vita, ma nello stesso tempo aveva bisogno di essere Rick Deckard, perché aveva un estremo bisogno di essere salvato e, come Rick Deckard, gli sembrava di essere salvato dall’abisso. Non era né Roy Batty né Rick Deckard e nello stesso tempo era un pezzo di tutti e due ed era proprio questo essere spezzato, frammentato, mischiato, che lo faceva urlare dal dolore. «Sister, voglio più vita, più tempo, non sono preparato a dire addio così presto.» «Ti aiuterò a prepararti allora, Tiberio» disse sorridente suor Maria. Lui fece una smorfia, come incredulo. Per un lungo istante odiò quelle parole e odiò quella suora. Voleva dirle: “Come mi aiuterà a prepararmi?! Le ho appena detto che voglio più vita, non che voglio prepararmi a dire addio!” Era ancora su quella terrazza e la sua anima sanguinante e frammentata, voleva esplodere. Tiberio chiuse gli occhi, abbassò il volto e prese un respiro. Il luogo della sua anima in cui sapeva che la suora aveva ragione era inaccessibile e dovette violentarsi per arrivarci. «Tu preghi, Tiberio? Ricevi l’eucarestia?» Tiberio si professava credente non praticante ma, in quel momento, aveva ben presente che una posizione del genere, sarebbe stata poco sostenibile davanti a Lui. «No, sister, non faccio nulla di queste cose, anche se a modo mio credo.» «Beh, intanto partiamo da una buona base, se credi, Tiberio.» Un’altra smorfia comparve sul volto di Tiberio, che sentiva tiepida la conversazione. «Forse, sister, c’è una cosa che in fondo mi angoscia, anche se, ad oggi non ne ho mai parlato nemmeno con me stesso.» Sister Maria restò in silenzio e Tiberio iniziò a capire che quei silenzi erano parole. Avvolta nel suo manto bianco con bordi azzurri, parlava con il corpo. «Come si fa, come è possibile dire addio alle persone a cui si vuole bene? Io non ce la faccio» disse Tiberio, guardando in alto a destra e cercando inutilmente di evitare lo specchio della finestra. «Tiberio, tu dovresti convincerti a parlare con tua moglie, almeno.» «Se lo faccio, sono finito, la conosco bene, poi si dedicherebbe completamente a me e io non lo sopporterei, mi sentirei marcato troppo stretto.» «Non sarei così sicura della reazione di una persona davanti a notizie così drammatiche.» «Lei dice che magari la mia previsione non è poi così certa?» La sister tacque e sorrise. «Dimmi, Tiberio» disse dopo poco «a tua moglie cosa piace?» Tiberio ascoltò quella domanda e si sentì scoppiare. L’ultima volta aveva pianto con la Chelli, poi qualche lacrima nascosta tra bagno e camera da letto di casa. Quando sentì arrivare la lacrima, alzò la testa quasi a pregare di non piangere ma scoppiò a valanga subito con singhiozzi, quasi quella povertà esibita e quell’olezzo potessero essere, in fondo, il luogo della sua consolazione. Da quella povertà sgusciarono improvvisamente fuori dei fazzoletti di carta, che subito Tiberio riempì con le lacrime e con le soffiate del naso. Il pianto era talmente dirotto e i singhiozzi così profondi, che Tiberio non provò nemmeno a opporsi, trattenere quella furia era inutile e a stupirsi ci avrebbe pensato dopo: ora bisognava solo lasciar uscire quel fiume di detriti che aveva dentro di sé. Prima chinato in avanti, quasi a celare il proprio viso, poi di lato e, infine, chissà se volendolo o solo per disperazione, non esitò a mostrarsi disperato agli occhi di quella missionaria della Carità, che con una domanda lo aveva sgonfiato. «Vuoi sciacquarti, Tiberio?» Tiberio annuì per scoprire che la sua mente maliziosa non era per nulla intimidita da quel pianto dirotto. Appena sister Maria gli aveva posto quella domanda, lui aveva subito pensato che, andando davanti ad un rubinetto, avrebbe potuto verificare le condizioni igieniche del posto e questo pensiero lo lasciò sconcertato. Si domandava come mai fosse così incattivito verso quelle povere donne e si ripeteva che, anche se fosse stato vero che non erano pulite, lui non aveva il diritto di trattarle così. Uscito dalla stanza seguendo sister Maria, Tiberio si trovò dentro una toilette con water e lavandino, molto spartana e senza nessun olezzo. Chinatosi sul lavandino striminzito, non prima di aver perlustrato il piccolo bagno con brevi sguardi nei vari angoli in cerca di sporco, si spruzzò acqua fresca sul volto, per pulirsi poi con una salvietta che gli venne offerta da sister Maria. «Qual era la domanda?» chiese, ridendo di se stesso. «Cosa piace a tua moglie?» Tiberio sorrise come a dire che non sarebbe crollato. «Voglio un gran bene a quella donna, sa, sister Maria?» «Credo» rispose lei con il solito sorriso. «È una donna che ha gusti ben definiti ma che cosa voleva sapere in particolare?» «Te lo chiedevo, perché certe volte, quando non si riesce a perdonarsi, si cerca di perdonarsi, facendosi perdonare dagli altri.» Tiberio non capiva. Lui sapeva costruire ponti, disegnava linee e scriveva numeri sulla carta: li passava a un geometra e il ponte veniva fuori. Lui imbrigliava la natura e il risultato era che la gente poteva guidare la sua macchina a qualche centinaio di metri da terra, senza preoccupazione e tutto grazie ai suoi calcoli. «Perdonarmi?» «Tutti dobbiamo perdonarci, Tiberio.» «E di cosa, scusi?» «Tu non senti il bisogno di perdonarti?» «Sister, io non ho ammazzato nessuno, per che cosa posso rimproverarmi?» Sister Maria tacque e non sottrasse lo sguardo. Era la sua grande forza. «Mi stai dicendo che tu non riesci a dire addio alla tua famiglia: che cosa te lo impedisce?» Tiberio si sentì offeso. “Cosa cavolo vuol dire con quella domanda?” pensò irritato dentro di sé. «Beh, sorella, vorrei vedere lei se dovesse lasciare i suoi cari.» Era una vera e propria aggressione e, del resto, lui si sentiva aggredito. «Tiberio, io sono in pace con me stessa, Dio può prendermi quando vuole, sono pronta.» Tiberio non provò ammirazione per quella frase ma odio. Se lei era pronta, lo era perché era una suora ma lui aveva figli e moglie. «Sister, senta, a me sembra la cosa più ovvia del mondo il fatto che io come padre e come marito faccia fatica a lasciare i miei cari. Che senso ha la sua domanda?» «Certo, Tiberio, è ovvio, non c’è dubbio, sono legami forti e lasciarli costa, ma non c’è dubbio anche su un’altra cosa» disse, lasciando la frase sospesa e leggendo negli occhi di Tiberio la richiesta di una risposta. «Proviamo a ragionarci, dato che la tua domanda è chiara: che cosa ti impedisce di lasciare i tuoi cari?» Tiberio scrutò il volto di sister Maria: gli pareva sincera. «Tiberio?» chiese sister Maria, quasi a scuoterlo. «Mi dica.» «Hai sentito la domanda?» In quel momento Tiberio non era nemmeno più sulla terrazza con Roy Batty e Rick Deckard. Non sapeva nemmeno lui dove fosse, l’unica cosa che sentiva era un’enorme spossatezza e il vuoto. In fondo, quella era l’unica cosa da fare. Se non voleva più soffrire, doveva separarsi da quel dolore e, per farlo, doveva tagliare il cordone ombelicale con la sua anima spaccata. Come se fosse davvero possibile farlo, egli lanciò lontano da sé il proprio cuore, sperando in quella maniera di trovare pace. «No, scusi, me la ripete?» «Che cosa t’impedisce di congedarti dai tuoi cari?» «Penso che sia la paura che ho, di sapere che non mi avranno più» disse demolito nelle proprie difese. «Questa volta, Tiberio, hai parlato con il cuore» disse con sorriso e posizione immutati. «Non so quanto possa essere utile ma è difficile per me pensare che Chiara, che ha diciassette anni, dovrà crescere senza suo padre.» «Senza suo padre in terra. Non potrà baciarlo, non potrà abbracciarlo, non potrà andarci in vacanza ma suo padre sarà il suo angelo custode sempre con lei.» Tiberio si commosse ma obbligò le lacrime a non scendere e buttò lì un’altra frase dura e aggressiva: «Romantico, molto romantico, sister, ma non mi aiuta, davvero non mi aiuta.» «E che cosa potrebbe aiutarti, Tiberio?» «Non lo so, in certi momenti penso che nulla può aiutarmi a dire addio a mia moglie e ai miei figli.» «Sì, sento che in te c’è una grande difficoltà ma, se posso, Tiberio, vorrei farti notare una cosa.» Tiberio fece un cenno di assenso. «Tu ora sei qui e sei qui per cercare di congedarti dai tuoi, ci stai provando e ti sei affidato a questa sister qui. Magari nemmeno tu credevi di fare una cosa così nella tua vita.» «In effetti...» disse ironicamente Tiberio. «Allora senti, Tiberio, se vuoi ci vediamo ancora, dimmi tu.» «Certo che ci vediamo ancora» sbottò Tiberio, che aveva avvertito in quelle parole la possibilità che quello fosse il primo e l’ultimo incontro. Aveva fatto così tanta fatica ad andarci che il solo pensiero di ricominciare lo faceva rabbrividire. «Va bene allora possiamo darci appuntamento per la settimana prossima, se vuoi.» «Un’altra volta in questa settimana non può, sorella?» Dentro Tiberio c’era una sorta di combattimento tra le due parole “sister” e “suora”. Si era imposto di chiamarla sister e di pensarla sister per una forma di rispetto dopo quella valanga di pensieri maliziosi. Alla fine però aveva sbottato con quel “sorella” che voleva dire con chiarezza che aveva abbassato le proprie difese. Sister Maria sorrise. «Certo, posso.» «E per il denaro?» chiese forzandosi un po’. «Io non lo chiedo mai ma puoi fare tutte le offerte che vuoi» disse sister Maria e i due si salutarono. 9 Treviso La mattina era fredda, l’umidità si era fatta vedere, ghiacciando un po’ tutto, e Tiberio con le sue pedule, pantaloni di velluto, maglione, giacca pesante, sciarpa e berretto era in piedi fuori dall’albergo in attesa del pulmino con il quale il geometra sarebbe passato a prenderlo. Era abituato a quelle levatacce, anche se era un po’ stufo di farle e continuava a pensare che ormai avesse anche l’età per delegarle ma non si era mai deciso a prendere un collega che le potesse fare per lui. Un ingegnere che lavorasse per un ingegnere gli suonava strano. Sotto i pantaloni aveva messo anche una calza a maglia, sapeva che non conveniva fare troppo i furbi in quelle occasioni e che la lana a contatto con la pelle l’avrebbe protetto. Il Ducato arrivò puntuale, nessuno parlava mai molto a quell’ora, anche i saluti erano ridotti a cenni. Il trio ora era definitivo: ingegnere, geometra e capo degli operai. Il pulmino ci mise una mezz’ora ad arrivare al baracchino del cantiere che faceva da base e, quando arrivarono, per aprire la serratura, dovettero usare dell’alcol per sciogliere il ghiaccio. Con una stufa elettrica, provarono a riscaldare l’interno della baracca e Flavio, il capocantiere, non esitò ad usare subito il termos del caffè mentre Tiberio e Camillo Formenti, il geometra, ripassavano i fogli del progetto. Tra un sorso di caffè e uno sguardo alle mappe passò un’altra mezz’ora, ora il sole era sorto e potevano iniziare il giro. La stufetta non aveva nemmeno iniziato a scaldare, il fiato faceva ancora la nuvola bianca ma era il loro lavoro e nessuno si lamentava. Lo schema era fisso. Il geometra elencava a Tiberio gli hotspot del cantiere, spiegando di ognuno la posizione e il tipo di problema. Nella maggior parte dei casi, gli operai da una parte e il geometra dall’altra, esponevano il problema e proponevano anche le soluzioni. Si poteva trattare di problemi di tipo strettamente tecnico, come alcune misure da prendere in determinati punti o, invece, anche di problemi legati alla sicurezza, come la necessità di costruire bene gli accessi e le uscite e di utilizzare le corde e i caschi. Camillo sembrava un boscaiolo americano con la sua barba incolta, la classica camicia rossa a quadratoni e il giubbotto imbottito a mezze maniche. Era la prima volta che lavorava con lui e si era trovato bene fino a quel momento. Una volta identificate tutte le criticità sulla mappa e discussi i vari tipi di problemi, si iniziava il primo giro via radio. Flavio aveva già avuto la lista punti caldi dal geometra la sera prima e aveva predisposto due uomini muniti di radio per ognuno dei luoghi. Uno ad uno Camillo li chiamava, chiedeva una descrizione del problema e poi trasmetteva le indicazioni che riceveva dall’ingegnere che asua volta ascoltava la viva voce di Camillo e la voce dell’operaio sul posto dalla radio. Se durante il giro con la radio non si riusciva a risolvere il problema, allora Tiberio e Camillo si munivano di pazienza e salivano sul pulmino per andare nel luogo specifico a vedere direttamente il problema e decidere come risolverlo. Quel mattino c’erano in particolare due problemi che, dopo il primo giro via radio, non erano stati risolti. Uno riguardava la sicurezza. Il geometra aveva lasciato in sospeso il problema solo perché sapeva che, se poi l’ingegnere fosse stato in disaccordo, se la sarebbe presa con lui e ancora non conosceva abbastanza bene Tiberio per sapere come regolarsi. Quando arrivarono sul posto e Tiberio vide la situazione, non esitò a dare il nulla osta. Bisognava costruire una balaustra che mettesse in sicurezza un tratto sul quale gli operai erano molto esposti alle cadute e la balaustra costava tempo e denaro. Era il solito problema trito e ritrito, motivo principale del conflitto tra l’ingegnere capo e la ditta che eseguiva i lavori. La sicurezza costava e la ditta tendeva sempre a allentare di un po’ la sicurezza per risparmiare, però, se poi succedeva qualcosa, ci andava di mezzo chi aveva responsabilità e, cioè, l’ingegnere. Tiberio negli anni aveva imparato a chiarire tutto prima di firmare il contratto. Chiarire tutto, significava dire alla ditta che lui avrebbe rispettato in pieno le regole della sicurezza e questo significava spese. Dato il nulla osta alla costruzione della balaustra per proteggere gli operai, Tiberio, sempre avvolto nel suo piumino da cantiere (così lo chiamava lui perché lo usava sempre nei cantieri ed era sempre impolverato), rimontò sul pulmino per andare al secondo posto da visitare, dove c’era un problema di misure e lì perse qualche ora tra litigate e frenate. A Tiberio non piaceva litigare con gli operai, sapeva che facevano un lavoro difficile e, purtroppo, anche nei suoi cantieri, qualche morto ci scappava ancora. Su alcune cose però Tiberio aveva imparato che non doveva mollare, perché sapeva che poi, se le cose venivano fatte diversamente da come voleva lui, il lavoro riusciva male, mentre lui si era costruito la fama di uno efficiente e affidabile sul lavoro. Nell’edilizia non c’erano solo le ditte che volevano risparmiare sui costi della sicurezza, c’erano anche gli operai che non volevano fare alcuni lavori e che creavano problemi. L’ingegnere di primo pelo poteva anche commuoversi e dare ragione agli operai ma di certo non quelli navigati come Tiberio che, infatti, prese una posizione ferma e risoluta, ovviamente facendosi odiare dagli operai. Certo chiedeva di fare un lavoraccio, si trattava di fare un lunghissimo muro di cemento armato che secondo gli operai non serviva a nulla. Tiberio provò in un primo momento a dare le sue spiegazioni ma, quando vide che l’opposizione era testarda, allora si impose. Ci furono alcuni momenti di tensione nei quali Tiberio tacque per confermare, tuttavia, che il lavoro si dovesse fare assolutamente e in tempi stretti. Quando Tiberio tornò sul pulmino verso le tre del pomeriggio, senza aver pranzato e avendo passato le ultime due ore a litigare con gli operai, si portò dietro l’incazzatura e non scambiò una parola nemmeno con Camillo Formenti. I due che se la sarebbero dovuta vedere con gli operai, alla fine erano il geometra e il capo cantiere. L’unico aiuto che Tiberio poteva dare, oltre ad aver incontrato faccia a faccia gli operai, era quello di mettere per iscritto il suo ordine con le specifiche e, in effetti, quando arrivò al baracchino si mise a scrivere. Mentre Tiberio scriveva sul libro mastro della sua visita, Camillo Formenti, con il quale non parlava da una mezz’ora, gli si presentò con un sacchetto, nel quale aveva un paio di panini con il salame e una birra. «Grazie» disse Tiberio sorridendo e aprendo il sacchetto per guardare dentro. Camillo non aveva più addosso il giubbotto e stava lì in piedi con quella camicia da boscaiolo e quel pelo scuro e irsuto sul volto, sul quale pareva comparire una smorfia di sorriso. Sempre senza pronunciare parole, il geometra gli offrì anche un giornale, come a dire che poteva mettersi lì tranquillo a mangiare e a leggere, se avesse voluto, e che poi lo avrebbe accompagnato di nuovo in albergo. 10 Tiberio aveva prenotato solo per una notte, quindi all’arrivo in albergo sarebbe sceso dal pulmino e salito direttamente in macchina per prendere la strada di casa. Panini, birra e giornale dopo quella giornata erano decisamente un pensiero gentile, non li aveva chiesti e nemmeno pagati. Chiuso il libro mastro, Tiberio liberò un pezzo di tavolo dalle carte dei progetti e, capovolta la sedia, si sedette appoggiando il torace allo schienale e mettendosi a cavalcioni. Aperto il sacchetto, posò la lattina di Budweiser sul tavolo e tirò fuori il primo panino, avendo cura poi di aprire bene il giornale per leggerselo con calma, mentre si gustava il primo boccone di pane e salame. Non trattenne una risata, quando si accorse che il giornale era del giorno prima, ma pensò che poco importava e se lo lesse ugualmente. Ad un certo punto egli si immerse nella lettura di un pezzo di Gian Antonio Stella che, come al solito, sviscerava i privilegi e le nefandezze dei politici e restò a leggerlo anche dopo che erano finiti panini e vino. Stella raccontava di stipendi che si cumulavano tra i diversi incarichi e faceva esempi così agghiaccianti da sembrare artificiosi. Tra le pagine poi notò un pezzo in cui si parlava della morte di Lucio Giannini, un giornalista che lui non conosceva. Non era un trafiletto ma un piccolo articolo che rivelava come anche questo giornalista di sinistra fosse stato vittima di un tumore maligno e avesse scelto di andare a morire in Svizzera, dove la morte dolce, per addormentamento, è legale. Tiberio aveva sentito parlare di questa possibilità in Svizzera e sapeva che c’era una sorta di migrazione degli italiani da quelle parti. Nell’articolo si citava anche la onlus che aiutava in Italia chi avesse voluto contattare una delle cliniche svizzere specializzate nel dare la morte dolce. Tiberio diede una rapida occhiata al geometra per vedere se lo stesse guardando e, dato che era ancora impegnato con gli operai alla radio, si propose di leggere di nuovo l’articolo. Non aveva ancora deciso cosa pensare di quella notizia letta e la rilettura aveva ottenuto come unico effetto, quello di aumentare la sua curiosità, e nel frattempo si alzò, vestì e poi mosse verso il geometra con il qualche riprese a parlare. Seduto davanti sul pulmino, Tiberio provò a collegarsi con il suo Blackberry, per vedere di trovare qualcosa in rete ma il traballare del pulmino per quelle strade bianche e le curve poi sulle strade asfaltate lo convinsero che conveniva aspettare. Arrivato all’albergo e salutato il geometra, questa volta con una stretta di mano e qualche parola di ringraziamento, Tiberio si sedette in macchina e di nuovo provò a cercare con il telefono ma si fermò subito. Ci avrebbe messo almeno tre ore a rientrare a Milano e non era il caso di attendere molto, visto che erano le sei del pomeriggio. Il viaggio si presentò subito abbastanza teso. Tentò di distrarsi con la musica, la sua fedele compagna di vita, ma nemmeno i Red Hot Chili Peppers lo aiutarono molto, anche se, una traccia dopo l’altra, tutte le canzoni dell’album si fecero sentire. 11 Milano Casa Brambilla era un appartamento al numero 13 di via Isonzo a Cesano Boscone. Un piccolo condominio ben tenuto con parcheggio sotterraneo e ascensore che permetteva di salire direttamente agli appartamenti. La porta di accesso all’appartamento era esattamente davanti all’ascensore ed era blindata. La si apriva con una di quelle chiavi lunghe con le ali di farfalla alla fine. Di solito Tiberio, dopo aver fatto scroccare la serratura e aver abbassato la maniglia, la spingeva con la spalla. Una volta entrati ci si trovava in un piccolo atrio, ricavato tirando su una piccola parete che impediva di vedere subito la sala e nascondeva un attaccapanni, un portaombrelli e un portachiavi attaccato al muro. Le finestre sulla parete di destra della sala erano ampie e garantivano una buona illuminazione durante il giorno. Sulla parete di sinistra c’era una porta che conduceva alla cucina, mentre la parete opposta alla porta d’ingresso consentiva l’accesso al corridoio che portava alle camere e al gabinetto. In mezzo alla sala un divano a quattro posti con davanti un tavolo di cristallo e ai fianchi due poltrone, tutte bianche. Un enorme televisore a schermo piatto era appeso alla parete. Quando Tiberio entrò trovò la TV accesa, qualcuno la guardava, erano Sabrina e Chiara appollaiate sul divano. La regola che aveva imparato a spese proprie, era che, se la TV era accesa, era meglio tacere e lasciare agli altri la decisione se salutare o no e così fece. Sabrina e Chiara nel vederlo tacquero e solo quando lui si avvicinò al divano Sabrina si voltò verso di lui e lo salutò con un sorriso e un gesto della mano. Tiberio era entrato in casa bruciato dal fuoco sacro di Internet, aveva un bisogno urgente di mettersi seduto comodo con il suo tablet e sviscerare la questione della Svizzera che non gli aveva dato pace durante le ore del viaggio in macchina. Il problema era che ora però c’erano altri riti da consumare e per vari motivi era meglio non cambiarli. Doveva lavarsi e mangiare e gli sarebbe servita almeno mezz’ora o quarantacinque minuti. Sapeva che Sabrina si sarebbe offerta di scaldargli la cena e fargli compagnia e la cosa, tra l’altro, andava bene secondo le regole che gli aveva dato la Chelli, cercare di mangiare e dormire regolarmente. Questo significava, ovviamente, resistere al bisogno urgente che aveva di usare il tablet. Decisione presa. Avrebbe rispettato i riti. Tanto valeva darsi da fare subito. Così, mentre Sabrina gli scaldava la cena, lui fece una doccia poi, indossata una tuta, si precipitò in cucina dove raccontò a spizzichi e bocconi della visita al cantiere e mangiò o, meglio, trangugiò quello che Sabrina gli aveva preparato: un piatto di penne con del pomodoro e una bistecca di manzo con zucchine trifolate. Ora che tutto si era compiuto, si infilò a letto con il tablet. In un primo momento la ricerca non diede gli esiti sperati, perché usava parole come “Svizzera” e “clinica”. Irritato per la difficoltà che incontrava e per gli sbadigli che aumentavano di frequenza e intensità, finalmente trovò il nome giusto, “Humanitas”, ma invece di utilizzarlo come stringa di ricerca in Google, decise che poteva digitarlo nella barra degli indirizzi internet. Trovò così, finalmente, il sito Humanitas.ch, dove c’era davvero tutto, foto, documenti, indicazioni stradali, però era troppo stanco e decise di dormire per dedicarsi alla cosa l’indomani dall’ufficio. Con le lacrime agli occhi lesse però un pezzo specifico. Sul sito c’era scritto: A nome di tutte le persone che oggi e in futuro hanno bisogno di aiuto, l’associazione “Humanitas vivere degnamente morire degnamente” ringrazia la popolazione zurighese per la sua posizione inequivocabile e liberale nei confronti del suicidio assistito, sottolineata dal risultato della duplice votazione del 15 maggio 2011. Al contempo, Humanitas esorta le autorità federali e cantonali a prestare una volta per tutte attenzione alla tutela della vita umana dove più è necessario. Rimase impressionato dalla data. Una notizia così sensazionale, lui non l’aveva mai letta in Italia. 12 Era il 7 dicembre, la pagina web di Humanitas presentava in alto a sinistra il logo e poi una foto delle montagne svizzere e le bandierine corrispondenti alle lingue tedesca, francese, italiana e inglese. Tiberio scelse subito la lingua italiana e lesse così la traduzione dello slogan “Vivere degnamente, morire degnamente”. Due colonne verdi, una a destra e una a sinistra, definivano i margini della pagina e in mezzo una foto in dissolvenza mostrava con tutta probabilità l’équipe degli operatori. Le foto erano state scattate all’interno di un giardino: prima con gli alberi sullo sfondo e poi con una parete a vetrata che già piaceva a Tiberio. Nella colonna verde di destra c’erano i riferimenti per i contatti, in mezzo la frase che aveva letto la sera prima e a sinistra un menù che permetteva di accedere ai contenuti: chi siamo, servizi e attività, documenti, dicono di noi, da sapere. Tiberio si gettò a capofitto nella lettura del “da sapere”, mosso dal bisogno di conoscere quella cosa, che all’inizio aveva etichettato come una clinica svizzera per signori e che, invece, pian piano prendeva un aspetto diverso. Il fondatore di quella realtà aveva passato i suoi bei problemi per portarla avanti, confrontandosi anche con la volontà popolare. Cliccando sui paesi che prevedono l’accompagnamento alla morte, compariva una mappa in cui, oltre alla Svizzera, si vedevano indicati Belgio e Lussemburgo ma anche Oregon, Washington e Montana negli Stati Uniti. Alcune voci aprivano pagine vuote e la cosa lo irritò, pensò che forse sotto ci fosse un gioco sporco anche se, alla fine, le notizie che voleva le aveva trovate. Il depliant per esempio era completo, perciò scaricò e stampò il pdf. Quando Gianna arrivò in ufficio, egli era nel suo studio, immerso nella lettura del depliant di Humanitas, dal quale stava avidamente acquisendo i dettagli, ormai convinto che quella cosa facesse per lui. Aveva una gran bella impressione di tutto quello che stava capendo, gli sembravano persone serie e, soprattutto, gli offrivano vicino a casa esattamente ciò che lui voleva, la possibilità di andarsene tranquillo, senza patimenti. Anche se in quel momento non ce l’aveva presente, Tiberio il giorno stesso sarebbe dovuto andare da sister Maria e la faccenda l’avrebbe tirata fuori certamente. La sua attenzione si concentrò sulle procedure. Avrebbe dovuto farsi dare dalla Chelli la documentazione della sua malattia. Ma, a pensarci bene, ce l’aveva già. Aveva la lettera di dimissione e i CD delle diagnostiche che aveva fatto. Avrebbe dovuto poi iscriversi a Humanitas e fare delle visite mediche, ma gli sembrava che tutto fosse in qualche maniera logico e conseguente e nemmeno troppo complicato. Un giretto là avrebbe dovuto farlo ma anche quello non era difficile da organizzare. Avrebbe preso il Cisalpino a Milano Centrale, avrebbe detto a tutti che aveva un cantiere da visitare e nessuno avrebbe sospettato nulla. Se prima della lettura delle informazioni era incuriosito, ora invece era convinto, quella cosa faceva al caso suo, non c’era dubbio. L’uomo delle linee e dei numeri, che piega le forze della natura con una matita e un foglio, che valuta sempre razionalmente tutte le cose, bilanciando vantaggi e svantaggi, aveva preso una decisione in cuor suo, una decisione sull’onda dell’emozione, fiducioso nella prospettiva di potersi addormentare serenamente, senza sputare sangue e senza farsi ammazzare dai farmaci. Con il sorriso sulle labbra e l’eccitazione nelle vene Tiberio, clic dopo clic, perlustrò la rete in cerca di notizie usando i vari termini: “eutanasia”, “suicidio assistito”, “morte dolce”, “accompagnamento alla morte” e progressivamente si trovò a leggere la posizione dei due grandi schieramenti, quello pro e quello contro. Che la Chiesa cattolica fosse contro, lo sapeva e la cosa non solo non lo aiutava ma gli creava un serio problema. Non andava in chiesa la domenica e non si confessava da un po’, da molto a dire il vero non pregava, insomma non era certo un praticante. Ma di lì a dire che riuscisse a fregarsene del niet cattolico sul suicidio assistito ne passava. C’era da perdersi fra le mille pagine che stava aprendo sull’argomento e, secondo lui, era tutto un delirio. Tutto gli sembrava urlato e quasi pugnalato, come se si trattasse di una vera e propria guerra fra schieramenti opposti. Capiva razionalmente la posizione del Vaticano e della Chiesa e la condivideva anche. L’uomo non è padrone della propria vita, non può decidere quando nascere e nemmeno quando morire, questo era il succo e non aveva nulla da obiettare. Razionale, logico, ben piantato. La stessa razionalità, però, la si poteva usare per dei distinguo e uno dei distinguo poteva riguardare proprio il suo caso, un tumore maligno con una prognosi infausta a breve scadenza. Qui però il muro era levato, il dialogo nullo. La Chiesa non si smuoveva, bastava solo leggere gli accenni che si trovavano e tutto era chiaro. Digitando su Google il binomio “Chiesa cattolica” e “suicidio assistito”, era risultata una pagina di Wikipedia in cui si citava letteralmente il Catechismo della Chiesa Cattolica, Parte III, Sezione II, Capitolo II, Articolo V. Tiberio lo stampò per leggerlo con calma ed ebbe subito la misura del problema. L’eutanasia 2276 Coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un’esistenza per quanto possibile normale. 2277 Qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l’eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile. Così un’azione oppure un’omissione che, da sé o intenzionalmente, provoca la morte allo scopo di porre fine al dolore, costituisce un’uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo Creatore. L’errore di giudizio, nel quale si può essere incorsi in buona fede, non muta la natura di quest’atto omicida, sempre da condannare e da escludere. 2278 L’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’ “accanimento terapeutico”. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. 2279 Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d’ordinario sono dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte. L’uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate. Sempre sulla pagina di Wikipedia si leggevano altre citazioni come quelle dall’enciclica Evangelium Vitae, confermo che l’eutanasia è una grave violazione della Legge di Dio, in quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una persona umana e altre che portavano tutte alla stessa conclusione. Non c’era molto da stare allegri, pensò tra sé Tiberio che, più leggeva quei documenti che emergevano dai suoi clic, più sentiva dentro di sé montare la rabbia. In un primo momento aveva provato a fare una ricerca specifica, perché aveva notato che Humanitas aveva tre punti saldi nel suo protocollo. Il primo punto saldo riguardava la malattia, che doveva avere alcune caratteristiche. Il secondo punto era che colui che chiedeva il suicidio assistito dovesse farlo nella piena padronanza di sé e in maniera del tutto esplicita. Il terzo punto era forse il più importante, un dettaglio spaventoso e terribile. Nel momento clou, quando cioè la persona doveva assumere il farmaco che si prendeva per bocca, il medico lo preparava sciogliendo la polvere nell’acqua, ma era la persona che lo assumeva. Non era il medico a dare la morte, era la persona stessa a farlo. Il dettaglio aveva il suo bel peso perché, nel caso la persona non fosse in grado di assumere da sola il farmaco, non si poteva procedere, nemmeno un parente poteva farlo, altrimenti non si sarebbe trattato di suicidio. I brividi correvano gli correvano lungo la pelle della schiena e degli avambracci; certo non leggeva quelle cose per interesse culturale o ideologico. Alla conclusione della lettura, Tiberio si ritrovò decisamente furibondo. Anche se capiva il razionale di partenza, gli sembrava impossibile che non fosse possibile distinguere tra persone condannate ad una morte tragica e persone che stavano bene. La mattinata di Tiberio fu pessima. L’entusiasmo e l’eccitazione che aveva provato leggendo il depliant con tutte le informazioni, si erano trasformati in rabbia e rancore che non riusciva a trattenere e di cui la sua segretaria si accorse subito. 13 Sister Maria gli aprì con il suo solito sorriso e con la veloce lentezza che le conferivano quei passi strisciati ed esageratamente umili. Seguendo miss umiltà, Tiberio entrò nella stanza già carico di tutte le sue “difese”, come le avrebbero chiamate gli psicologi. La sua principale difesa era l’insulto e così pensò che forse fosse da lì che avrebbe dovuto iniziare. «Ho una novità» sbottò, cercando di mostrare una calma che non aveva. «Sentiamo» disse sister Maria. «Sa che in Svizzera c’è il suicidio assistito?» chiese Tiberio con un tono moderato, che poco si conciliava con il suo stato d’animo burrascoso e insolente. «Sì, ne ho sentito parlare, dicono che ci vanno in molti.» «Ho deciso di andarci anch’io» disse Tiberio, mettendosi subito a scrutare millimetro per millimetro il volto della sister, alla ricerca di qualche indizio. Non sapeva nemmeno lui cosa attendersi, se silenzio o parole, se un sorriso o il fiato sospeso. «È una decisione definitiva?» Tiberio fece una smorfia di disapprovazione. Non si aspettava quella domanda, la sentiva quasi impertinente. Che senso aveva sapere se era o meno definitiva questa scelta per un uomo che aveva i giorni contati? Sister Maria colse il disappunto. «Decisione presa al volo, senza pensarci, totalmente emotiva» disse sorridendo, sapendo di non poter essere sconfitto in quello, perché sincero. «Ma vorresti pensarci un attimo, parlarne?» «Penso che mi farebbe solo bene in effetti» disse ancora sorridendo. «Ho sentito un tremendo bisogno di venire qui a parlarne anche se so che lei cercherà di impedirmelo.» «Impedirtelo?» chiese sister Maria sorpresa. «Beh, la “sua” Chiesa mi manda dritto all’Inferno se vado a morire là» disse beffardo e attaccabrighe. «La mia Chiesa…» ripeté la sister Maria, selezionando quelle parole dalla frase di Tiberio ma con tono pacato. «Sono incazzatissimo con la sua Chiesa, non mi esprimo perché non voglio essere scortese con lei.» «Incazzatissimo?» «Beh, scusi provi a pensarci. Un povero cristo ha i giorni contati e potrebbe finirli in pace, invece, quattro preti so tutto io, gli dicono che se lo fa va dritto all’Inferno. Non ho il diritto di essere incazzato?» Sister Maria non fece una piega. «Dunque, il punto, è che va all’Inferno se va a morire in Svizzera?» «Il punto, cara la mia suora psicologa, è quella frase maledetta che Cristo ha detto…» disse Tiberio tenendo sospesa la frase. Siccome non gli veniva in mente e la sister non gliela suggeriva, provò a vedere se cadeva in una lusinga. «Lei la saprà meglio di me, credo che sia più o meno “quel che legherete sulla terra resterà legato nei cieli…”» «Matteo 18,15-35 “Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in Cielo, ciò che slegherete sulla terra sarà slegato anche in Cielo”» disse senza esitare sister Maria, che aveva mantenuto il suo aplomb anche davanti alle espressioni dure che Tiberio aveva usato. La lusinga aveva funzionato e Tiberio era soddisfatto. La sister poi tanto umile non doveva essere, se cadeva in quei tranelli. «Ecco, appunto, lei lo sa sicuramente meglio di me e, comunque, scusi per la bestemmia, è che Matteo 18 è come una prigione per me, mi impedisce di andare via.» «Apprezzo le scuse e certo se tu non bestemmiassi sarebbe davvero bello, ti sarei molto grata» disse, aggiungendo subito «senti, Tiberio, dimmi una cosa, perché la voglio capire bene. Dici di essere arrabbiato con Matteo 18, dico bene?» «Sì, non sapevo che fosse Matteo 18, mi fido di lei, non conosco le Scritture.» «Nemmeno io le conosco e, comunque, penso che ci sia più di un brano nello stesso Matteo che dice la stessa cosa e poi ce ne saranno anche altri. Ma non credo comunque che tu sia qui per collezionare citazioni evangeliche.» «Sister Maria, io voglio solo andarmene in pace, perché non posso farlo con la benedizione della Chiesa?» chiese serio Tiberio. Sister Maria sentì il pianto degli angeli in cielo quando ascoltò quelle parole di Tiberio. Erano almeno una ventina di anni che bazzicava tra anime disperate e solitarie, tra diagnosi di tumore e addii, tra sguardi vuoti e urli alti ma mai aveva trovato una persona che le ponesse la questione come gliela poneva Tiberio. Da una parte sembrava una speculazione teologica, una di quelle faccende da sesso degli angeli su cui discuti per millenni senza decidere ma dall’altra ci vedeva un’anima davvero in pena, alla quale tra l’altro non sapeva rispondere. Madre Teresa però le aveva dato la luce e sister Maria, che l’aveva conosciuta direttamente, sapeva cosa fare. Madre Teresa le aveva insegnato l’accoglienza, l’accoglienza sopra di tutto, sopra il dissidio, sopra i disaccordi. Sister Maria avrebbe accolto Tiberio con le sue incazzature, con le sue rabbie, con le sue bestemmie, l’avrebbe accolto nel suo ribellarsi e nel suo cercare una pace che sembrava irraggiungibile. «Ne hai parlato a casa?» «No.» «Forse, se lo fai, riesci a trovare la pace che cerchi.» «La mia pace arriverà quando la Chiesa non mi maledirà per quello che faccio, sorella» disse incazzato Tiberio. «Ma perché non lo dici a tua moglie?» «Gliel’ho già detto, sister» disse Tiberio irritato «poi mi fa diventare un caso speciale e io non voglio.» «Caso speciale?» «Li avrei tutti addosso e non li reggerei, ho già le mie di paturnie.» Tiberio era davvero imbufalito. Possibile che sister Maria perdesse ancora tempo su queste cose? Ne avevano già parlato e non voleva sprecare il tempo del colloquio parlando di quello. Non si accorgeva però di quello che gli stava accadendo, non si accorgeva che quei momenti con sister Maria erano già diventati così importanti da non volerli sprecare. Quella donna lo aveva sedotto e lui si era lasciato prendere da quel suo modo di fare sottomesso fino al fastidio, eppure accogliente. Più odiava quel viso che non esprimeva emozioni, più ne aveva bisogno. «Ma sei davvero così sicuro di questo? Io non lo sarei. Mettili alla prova, Tiberio. Dì loro la verità, parla a cuore aperto e così troverai la forza di riconciliarti con loro e di congedarti.» «Riconciliarmi, sorella? Congedarmi?» disse con acredine. “Che stronzi che sono questi psicologi! Ma si sentono quando parlano?!” pensò Tiberio, ancora una volta chiamandola sorella. Era come se quelle due parole, sister e sorella, rappresentassero due stati d’animo, due livelli. Se la chiamava sister, era razionale e rispettoso; mentre quando sbottava, la chiamava sorella. «Ognuno di noi ha bisogno di perdonarsi, Tiberio.» “Ora basta!” urlò dentro di sé Tiberio. Avevano parlato di quelle cose la volta precedente e davvero non voleva tornarci su ancora. «Senta, sister Maria, andiamo avanti però, perché davvero ne abbiamo già discusso l’altra volta» disse Tiberio buttando fuori l’arrabbiatura. «Le ho già detto che non sento il bisogno di perdonarmi perché non ho ammazzato nessuno, non capisco ‘sta cosa del perdono.» Sister Maria non conosceva il costruttore di ponti, l’uomo che con numeri e linee faceva star in piedi una strada in grado di resistere ai mezzi di passaggio e alle intemperie. Ora però per la prima volta, forse, si trovava davanti proprio a quelle linee e quei numeri e si rendeva conto che con Tiberio forse bisognava solo seguire l’insegnamento di madre Teresa e accoglierlo. «Senti, Tiberio, io credo che ti farebbe bene parlarne con i tuoi, in ogni modo vorrei farti una proposta.» Tiberio sgranò gli occhi terrorizzato. Non si vedeva a pulire merda e piedi puzzolenti e si irrigidì al solo pensiero che sister Maria gli proponesse di farlo, magari come gesto di carità che poteva aprirgli gli occhi. La sola idea di fare il volontario gli faceva schifo. «Lei accetterebbe di parlare con un prete per confessarsi?» Non erano piedi puzzolenti né latrine putride. Tiberio tirò il fiato. «Confessarmi?» chiese stupito Tiberio. «Ma intende per la bestemmia?» La suora psicologa questa volta si lasciò andare ad un più ampio sorriso e la cosa divertì Tiberio, sempre alla ricerca di imperfezioni umane nel volto di sister Maria. Le prime serigrafie di Andy Warhol risalivano agli anni ‘60. Il mondo si trovò davanti all’assurdo riprodurre i volti di personaggi noti da Marilyn a Mao Tse-Tung: quest’ultima era andata all’asta su base 30.000 dollari ed era stata venduta per più di 300.000. Chissà cosa volesse dire prendere i volti di personaggi famosi e riprodurli ingigantiti sempre uguali a se stessi e sempre diversi. Certo era una provocazione ed in fondo era proprio quello che Tiberio sentiva, quando sister Maria lo guardava impassibile proprio come se fosse una serigrafia di Andy Warhol. Vederla così immutabile, impassibile, quasi incapace di esprimere emozioni anche quando lui le buttava addosso quelle cose terribili, era per Tiberio quasi un incitamento, era come se quel volto immobile con quel cenno di sorriso gli dicesse “buttami addosso quello che vuoi, non mi fai male”. Ora però gli aveva proposto di confessarsi e doveva risponderle. «Certo, anche per quella, ma direi che più che altro dovresti confessarti perché così chiuderesti il cerchio.» La smorfia interrogativa di Tiberio sul volto era sufficiente. «Prova a seguire il mio ragionamento e vediamo se riesco a spiegarti bene.» Tiberio diede una sorta di via e sister Maria iniziò. «Ci tieni alla morte dolce?» «Sì.» «Da uno a dieci quanto è importante?» «10.» «Ma c’è Matteo 18 che te lo impedisce giusto?» «Diciamo che è Matteo 18 applicato al divieto di morte assistita o eutanasia che dir si voglia.» «Certo, se la Chiesa approvasse il suicidio assistito, non saresti così furioso, non c’è dubbio, e magari loderesti Dio invece di bestemmiarlo» disse sorridendo. «Esatto, “that’s correct”, come dicono gli inglesi.» «Ma tu ci vai in Svizzera in queste condizioni?» «Così incazzato intende?» «Sì, così incazzato.» «In effetti me la devo far passare, se voglio andarci.» «Vedi, Tiberio, allora è tutto chiaro; devi fare pace con la Chiesa, se vuoi andarci davvero.» Tiberio sorrise e pensò che fosse davvero assurdo. Non era mica lui che doveva fare pace con la Chiesa, era la Chiesa che doveva rendersi conto che tradiva se stessa ma questo lo tenne per sé. «Ma scusi, io credevo che voi strizzacervelli andaste a cercare sfighe nell’infanzia o cose del genere, invece lei mi manda nella bocca del lupo.» «Bocca del lupo?» chiese la sister Maria non cogliendo la battuta. «Sono incazzato con i preti e i vescovi, sono qui che li maledico e li bestemmio e lei mi manda da loro?» disse Tiberio quasi divertito. «Vedi alternative?» Tiberio era disorientato davanti alla proposta peraltro appena ribadita. «Ma mi faccia capire una cosa, io mi confesso e puff tutto si risolve? Facciamo pace?» disse tra il serio e il faceto. «Tiberio, ti dico solo che il punto mi pare ben centrato, se vuoi andare in Svizzera e a impedirtelo è Matteo 18 applicato al divieto di andarci, tu stesso ammetti che così incazzato non riesci a fare questa scelta e che hai bisogno di serenità.» Non c’era dubbio, il ragionamento non faceva una grinza, almeno secondo la logica di sister Maria. 14 Tiberio non voleva darle soddisfazione anche se il ragionamento non faceva una grinza e così tirò fuori il cavallo di battaglia. «Sa una cosa?» «Cosa?» «Ma perché i preti e i vescovi accettano queste ipocrisie?» «Quali ipocrisie?» «Beh, per esempio, se io non vado in Svizzera a morire, non è per fede, non è per coerenza con i principi della Chiesa ma è per il terrore di finire all’Inferno: è solo per il senso di colpa che me lo impedisce.» «Vuoi dire che se uno è spinto dal senso di colpa e dalla paura a fare le cose che la Chiesa dice di fare, allora non vale?» chiese sister Maria, sempre più sorpresa dalla terribile lucidità emotiva e intellettuale di Tiberio. «Beh, scusi, io costruisco ponti e non ci capisco nulla ma mi sembra molto ipocrita come metodo. Io mi sto muovendo solo perché sono terrorizzato dall’Inferno, diciamo che aderisco ai dettami della Chiesa solo per paura.» Sister Maria tacque un attimo. «Ma a ben guardare però le cose non stanno esattamente così» disse sister Maria con un volto stuzzicante che diede grande soddisfazione a Tiberio che aveva colto la nuova smorfia. «E come stanno?» chiese Tiberio incuriosito. «Scusa, tu sei qui con me che cerchi di arrivare ad una scelta in maniera autentica: forse parti dalla paura, spinto dal terrore, tutto vero ma, insomma, prima mi hai detto che non volevi nemmeno entrare e adesso abbiamo già finito il nostro tempo e te ne dispiaci. A me sembra che tu ci stai mettendo del tuo e che la paura dell’Inferno ci sia ma sia una parte.» Tiberio rise con una mano sul volto. Era la prima volta che veniva esplicitato il fatto che quel tempo con sister Maria era prezioso e Tiberio iniziava a rendersene conto. «Lei la sa girare bene la frittata, suora, del resto è il suo lavoro, io costruisco ponti.» «Allora fai anche questo di ponte, fallo tra te e la Chiesa» disse sorridendo sister Maria. Tiberio rise di nuovo e questa volta senza la mano sul volto. «Mi dia il nome, perché a questo punto, se non altro per curiosità, voglio andarci da questo prete.» Quella che doveva essere una psicoterapia improntata al supporto all’angoscia di morte, stava diventando un complesso e perverso gioco di ritratti, una schermaglia tra due amanti della vita che erano predisposti a non incontrarsi mai, avendo fatto scelte diverse, ma che poi la vita aveva fatto incontrare e forse anche amare. Nel suo pettegolezzo infinito attorno a quella povertà esibita, a quella immobilità del corpo, a quell’olezzo che le narici di Tiberio sentivano sempre quando entrava nel tugurio, in quella infinita schermaglia in cui le frasi del fiato e del corpo si intrecciavano scintillando, Tiberio stava trovando la strada per fare i conti con l’Eterno, con quel Dio verso il quale si scagliava trascinato da un odio impazzito e violento. Matteo 18 aveva bussato alla sua porta, chiamandolo a rapporto prima del tempo, lui si ribellava e scalciava, tentando di gettarlo lontano e sister Maria, che gli era sembrata come una tela di Andy Warhol, incapace di modificarsi qualsiasi cosa succedesse, quel giorno aveva mollato gli ormeggi e gli aveva concesso una smorfia, anzi due, e per Tiberio quello era un vero e proprio successo. Sister Maria usava la tecnica che la sua madre spirituale le aveva donato e che lei aveva fatto propria. Accogliere, accogliere tutto e in ogni condizione, accogliere e amare tutto. Anche se poteva sembrare un accostamento azzardato, sister Maria aveva sempre associato madre Teresa al test di Rorschach, quelle macchie d’inchiostro che erano solo macchie e dentro le quali ognuno metteva quello che voleva. Con Tiberio stava funzionando, non solo lo aveva agganciato ma il loro stare assieme in quella stanza, in quelle ore, era diventato importante per Tiberio e anche se il suo abito le imponeva di non affezionarsi, anche sister Maria era legata a quell’uomo che sentiva così vicino. 15 La strada era quasi vuota quando Tiberio uscì dal portone delle Missionarie della carità e rimase fermo sul marciapiede a guardarsi attorno, aggiustandosi la sciarpa e i guanti. Non che ne avesse davvero bisogno, non c’era un freddo pungente ma la discussione con la suora psicologa lo aveva segnato. Si aspettava una levata di scudi, una difesa d’ufficio delle ragioni della Chiesa ma non era stato così e questo lo faceva pensare. Erano trascorsi pochi minuti da quando era stato seduto sulla poltrona nello studio di sister Maria ed egli sentiva il bisogno urgente di fare mente locale. Aveva anche bestemmiato, si era pentito e vergognato e si ripeteva che sarebbe andato a confessarsi dal prete che gli aveva consigliato la suora ma non era quello il punto. Il punto era che se lui avesse voluto davvero andare in Svizzera, avrebbe dovuto fare pace. Andò indietro con la mente, mentre calpestava il marciapiede di pietra fino al luogo dove la macchina era parcheggiata. Mani in tasca, sguardo basso, per brevi istanti andava anche a occhi chiusi, quasi il buio potesse riportarlo al primo istante. Certo il primo istante. Tutto era nato là, in quell’ambulatorio dove la Chelli gli aveva fatto vedere la tabella con i quattro stadi di malignità del tumore. Il sorriso comparve sul volto di Tiberio che aveva ormai raggiunto la sua macchina, aveva estratto le chiavi dalla tasca del cappotto e aveva pigiato con il pollice destro sul telecomando allungando la mano verso la macchina e controllando che scattassero le quattro frecce e si aprissero le porte. L’aveva comprata nera metallizzata, gli piaceva così, anche se era poco funzionale per i suoi viaggi nei cantieri. Alla fine si riempiva sempre di polvere che, sul nero, sembrava quasi brillare. L’aveva comunque scelta così perché aveva fatto un calcolo. Negli ultimi anni le abitudini erano cambiate. I suoi viaggi ai cantieri non erano più come prima, quando faceva tutto da solo. Ora aveva un ruolo diverso e, quando andava ai cantieri, c’era una sorta di comitato di accoglienza. Teneva la macchina all’albergo dove venivano a prenderlo e lo riportavano e questo gli permetteva di tenere la macchina lontana dalla polvere. Erano le cinque del pomeriggio, doveva andare in ufficio a sbrigare alcune faccende. Guidava in automatico sempre con il pensiero a quanto era accaduto in quella stanza con la sister. Era meravigliato nel vedere come quella donna reggesse la situazione, era meravigliato dell’aplomb con cui aveva reagito alla sua bestemmia, era meravigliato del punto che aveva colto e di come lo aveva colto. Gli aveva fatto una domanda precisa, gli aveva chiesto se lo volesse davvero e Tiberio aveva scoperto che non lo sapeva. Fermo al semaforo, mano destra con guanto di pelle nera sul volante, guardava davanti a sé l’incrocio e attendeva il verde. La macchine passavano davanti a lui da destra a sinistra e da sinistra a destra. Lo sguardo era fisso, guardava ma non vedeva, guardava fuori ma si guardava dentro. Il punto era davvero quello che la sister aveva colto, se lui lo volesse davvero, e tutto l’entusiasmo che aveva avuto prima, ora non lo ritrovava. Nemmeno lui sapeva più se lo volesse, anche se, a pensarci bene, forse poteva capire cosa avesse voluto solo se avesse fatto pace. Già, fare pace. Come fosse stato facile. La macchina sembrava andare da sola, la guida era assolutamente automatica, chissà dove stava andando. Lo avrebbe scoperto più tardi, ora la sua testa era totalmente concentrata sulla pace, perché, in effetti, una cosa stava diventando chiara dentro lui. Certo la morte dolce era meglio di quella in agonia. Ma c’era troppa rabbia dentro di lui, troppa voglia di vendetta, troppo odio verso tutto e tutti. Mentre la macchina si muoveva lungo la strada, sorpassando, frenando, accelerando, la testa di Tiberio trovò un lido dove riposare. La sua memoria gli riportò alla mente una frazione di secondo della conferenza. Era un vero e proprio fotogramma, sister Maria aveva la testa piegata sui suoi fogli che però non erano appoggiati sul tavolo, le due mani li reggevano. Tiberio si ricordò che ad un certo punto aveva alzato la testa e i loro sguardi si erano incrociati. Proprio in quell’istante stava parlando di “congedo”, ora lo ricordava bene. In fondo, morire significa congedarsi, lasciare tutto, lavoro, famiglia. Tiberio continuava a sorridere e a scuotere la testa, perché quella suora, tutta tonda e così inadatta a parlare in pubblico, lo aveva condotto al punto focale. Il punto non era Svizzera o non Svizzera, il punto era che, qualsiasi modo avesse scelto per andarsene, sarebbe dovuto arrivare là senza quella rabbia, quell’odio, quel rancore che si portava dentro. Una serie di immagini confuse ballarono dentro la sua testa mentre gli occhi, le mani e i piedi si coordinavano in completa autonomia, portando la macchina in giro per le strade di Milano, come alla deriva. Non aveva la più pallida idea di dove si trovasse e dalla sua memoria emergevano immagini statiche, videoclip di piccoli gesti, odori, parole pronunciate. Erano i volti di sister Maria, di Barbara Chelli, di Sabrina che danzavano dentro di lui, lasciandolo senza potere di controllo, mentre di nuovo le lacrime, lacrime silenziose, lacrime lunghe, lacrime salate, lacrime disperate scendevano. La sciarpa, i guanti, il cappello finirono sul sedile del passeggero alla sua destra, il dorso della mano destra diventò il primo asciugamano ma non durò molto. Le strade di Milano sembravano fatte apposta per perdersi nel pianto: era tutta gente che non si guardava, che non si parlava, immense e lunghe solitudini che volevano muoversi tutte assieme alle cinque del pomeriggio e lui faceva parte di quel momento. Ma chi guardava chi? Era lui che guardava Milano o era Milano che guardava lui? Era confuso e disorientato, non sapeva nemmeno dove fosse e aveva assolutamente bisogno di non saperlo. Era lì ma non era lì e quel sogno doveva durare, non doveva infrangersi, non doveva spegnarsi, lui non poteva svegliarsi. Solo così sarebbe riuscito a tenere a bada per qualche minuto il dolore del morso di thanatos che l’aveva afferrato e gli faceva vedere ciò che non voleva e non poteva vedere senza impazzire. I suoi occhi non vedevano più Milano, il suo cuore non batteva più, il suo respiro non diventava più vapore, quando usciva dalla sua bocca, e i suoi passi si movevano su quel marciapiede in mezzo a quelle persone, senza che lui fosse lì davvero. Quello che i suoi occhi vedevano in quel momento era solo la terra che si allontanava mentre lui precipitava in un abisso. C’era un posto auto libero, lo prese al volo. Non poteva tornare a casa in quelle condizioni, aveva bisogno di un bar dove poter usare il gabinetto e bere un bicchiere d’acqua. Ne trovò uno con gente fuori che beveva, persone vestite bene, calici di vino e di Campari, una vetrata che permetteva di vedere dentro. Tiberio entrò, sorridendo in maniera imbarazzata alle persone che incontrava: ragazzi e ragazze che sembravano stampati, tutti uguali, avvolti in abiti tutti uguali, con pettinature tutte uguali, sorridevano tutti in maniera uguale. Cappotto appeso all’attaccapanni, sciarpa, guanti lasciati in macchina, il miscelatore sull’acqua tiepida, mani insaponate e finalmente l’acqua e il sapone sul viso. Quella donna verso la quale provava sentimenti da montagne russe, lo aveva portato al centro del mirino, facendogli fotografare la pace come obiettivo da raggiungere in tempo di guerra. In poco meno di un’ora aveva odiato e amato la stessa persona e ora guardava il suo sfogo di prima con il sorriso ritrovato. Le montagne russe stavano finendo e la tranquillità stava arrivando anche se a passi molto brevi e soprattutto guardinga. Tiberio rimase a guardarsi il volto allo specchio, alternando diverse smorfie per vedere se fosse stato capace di farle, una prova generale di ritrovato funzionamento. Adesso doveva tornare a casa e doveva essere sicuro di reggere l’urto. Sorriso, dolore, indifferenza, Tiberio faceva le prove e, una volta convinto, si trovò sul bancone di legno a prendere una birra e gustarsi le ragazze che lo circondavano. Era un piacere per gli occhi guardarsi attorno. Quasi tutte in pantalone con scarpe chiuse e tacchi alti. Età media sui trent’anni, a volte coppie di ragazze, a volte coppie miste, a volte piccoli gruppi misti, tutti sorridenti, tutti tranquilli, tutti che stavano bene. Il capello corto biondo, il rosso lungo, il castano alla maschietto e il nero ricciolo. Tiberio era sicuro che tutti lavorassero, nessuno di loro avesse figli, marito o moglie che li attendevano a casa e tutti vivevano in quel magnifico limbo che è l’età giovane del lavoro, avvocati, commercialisti, ingegneri, veterinari, insegnanti, medici. Era come galleggiare e farsi coccolare dolcemente dalle curve di quelle ragazze, dai loro sorrisi, dai loro sorsi sui calici dal gambo alto con le tracce di rossetto sul bordo dell’ampolla, dai loro portacenere pieni, dai loro seni, dalle loro dita dalle unghie lunghe e colorate. Tiberio si lasciò sedurre da quel luogo meraviglioso che lo stava tranquillizzando, anche se sapeva che avrebbe dovuto riprendere il contatto con il proprio mondo. Doveva fare i conti con le chiamate perse che aveva visto sul suo Blackberry. 16 Il lettino con le gambe di acciaio cromato e il materassino di gomma coperto da una plastica blu era alla sinistra della scrivania, quasi attaccato ad una libreria che non aveva certo l’aria di essere stata comprata all’Ikea. Del resto era lo studio di un primario del Fatebenefratelli, non di un ospedaletto di provincia,. Tiberio seduto a petto nudo sul lato del lettino che dava verso la libreria si stava facendo visitare da Roberto Mingardi, il primario, che lo aveva ricevuto subito, grazie all’interessamento della Chelli. Tiberio era andato là armato di cartelle e di cd e la visita stava andando avanti da almeno mezz’ora. Quando finalmente Mingardi si sedette e Tiberio dopo essersi rivestito fece la stessa cosa, ci fu un silenzio interrotto da qualche telefonata che però Mingardi rimandò con dei brevi: «Tra un quarto d’ora». «Allora, Tiberio, riassumiamo.» Silenzio e timore. «Lei faceva fatica a deglutire, giusto?» Tiberio annuì. «Disfagia, sintomo classico. Le hanno prescritto una serie di esami: endoscopia e istologico, li ha fatti e sappiamo che c’è un adenocarcinoma al terzo stadio.» Sentire la parola adenocarcinoma lo aveva fatto rabbrividire. «Poi le hanno prescritto le indagini radiologiche per le metastasi e le ha fatte. Le hanno già detto il risultato?» Pelato, magro ed elegante, Mingardi non aveva osato buttarla lì senza capire prima se Tiberio sapesse. «Ne ho parlato con la Chelli.» «L’endoscopista?» Tiberio si stupì di quella parola. Non riusciva a collocare la Chelli in un recinto così stretto, lui l’adorava per come era stato trattato da lei e per lui era un medico con le palle. «Allora adesso che l’ho visitata posso dire che tutto combacia. Quello che si vede con le diagnostiche si sente con le mani, i linfonodi sono interessati e quindi penso dovrà prendere delle decisioni sulla terapia.» «Le chemio?» Tiberio aveva chiara una cosa nella sua testa. Era meglio far finta di accettare il trattamento e poi non farlo che mettersi a discutere la cosa. Loro, i medici, avevano bisogno di tutelarsi e se gli dicevi “mi mo ma” loro erano tenuti a recitare il loro copione pietoso. «Sì, la chemio è prevista in questi casi.» «Professore, posso farle delle domande sulla malattia?» «Certo.» «Ma allora le metastasi ci sono?» «Linfonodi del collo sì, ma anche in altre zone.» Le solite non risposte. Tiberio decise, in cuor suo, che non gliel’avrebbe data vinta. Voleva a tutti costi che glielo dicesse in faccia, pensava di averne il diritto e ormai li conosceva abbastanza per portarli dove volesse lui. Bisognava fargli domande precise. «I linfonodi sono ingranditi per le metastasi?» «Sì.» Uno a zero. «Quanto tempo mi rimane?» Mingardi tacque e sottrasse lo sguardo mettendo una mano sulla bocca e guardando il tavolo. Tiberio lo perdonò, aveva capito che servono le palle per dire certe cose e anche la sua adorata Regina Taylor aveva sottratto lo sguardo nei loro incontri hot. Bisognava colpire con il ferro caldo. «Però, professore, non mi dica che è difficile dirlo, io mi devo organizzare, sono già in terapia da una psicologa e mi trovo molto bene.» Per un costruttore di ponti, che non capisce nulla di psicologia, il gioco che stava facendo non era niente male. Gli aveva detto quelle cose, per farsi dire la spudorata verità. Ora che sapeva che era “protetto” dalla psicologa, probabilmente avrebbe mollato un po’ le redini. «Quanto le hanno detto?» “Bastardo”, pensò Tiberio. “Cosa te ne frega di quello che mi hanno detto, dimmi la tua no!?” «Prima della notizia delle metastasi intende?» Il professore annuì. «Un anno ad essere ottimisti» disse soddisfatto, per dare l’impressione ancora una volta di reggere l’urto. «Sei mesi ad essere ottimisti, ma non tanto per le metastasi, quanto per l’occlusione.» Il colpo era arrivato dritto al cuore. Tiberio si impose di non traballare ma non riusciva a comprendere appieno il termine “occlusione” per quanto chiaro. Nella sua testa il problema erano le metastasi ma ora gli dicevano che il problema era l’occlusione. Con la mano nascosta sotto il tavolo, sicuro che non l’avrebbe visto, Tiberio fece il dito medio con la mano destra. “Se mi manca così poco non voglio certo passare il tempo in mezzo ad aghi e letti di ospedale.” Doveva comunque riconoscergli che gliel’aveva detta dritta, in effetti, e faceva un gran male. «Scusi, dottor Mingardi, me lo rispiega?» Mingardi tenne il volto basso, la mano sul mento e disegnò due linee parallele sul foglio. «Questo è l’esofago.» Tiberio annuì. «La massa tumorale lo occuperà prima che le metastasi le possano dare fastidio» disse Mingardi riempiendo di nero lo spazio tra le due righe. Quello che la Chelli non aveva avuto il coraggio di dirgli, ora glielo spiegava Mingardi con un disegno che non lasciava spazio a dubbi. «Il vomito, giusto?» «Sì, la difficoltà a deglutire prima e poi il vomito.» «I primi sintomi quando me li devo attendere?» «Riesce a mangiare?» «Sì.» «Potrebbero essere settimane o mesi, Tiberio.» «Potrei stare bene qualche mese?» «Difficile con un profilo così.» “Vecchio bastardo ti ho incastrato” pensò Tiberio nel sentirgli dire quella frase. Prima erano mesi e adesso settimane. «Perché la chemio e non l’intervento chirurgico?» «Dai dati che leggo, la chirurgia non va bene nel suo caso, per problemi vascolari.» «Quindi chemio e poi?» «Interventi palliativi.» «Cioè?» «Quando la massa occupa tutto lo spazio del tubo esofageo, si prova ad infilare dentro un tubo che dovrebbe impedire meccanicamente alla massa di occludere lo spazio e dovrebbe far passare il cibo.» Tiberio ascoltava impaurito e incattivito. «Sa una cosa, professore?» «Mi dica.» «Non so nulla di questo mostro che ho dentro, non me ne hanno parlato mai con calma.» Le lacrime trovarono come varco gli angoli laterali e scesero lambendo le basette e gocciolando dall’angolo della mandibola. La penna del dottor Mingardi non si muoveva più sul foglio A4 sul quale c’era l’esofago con il tumore dentro. Ma riprese. Mingardi si rese conto che Tiberio aveva bisogno di sentirsi dire qualcosa del tumore e non si tirò indietro. «Sono circa venticinque, trenta centimetri in tutto» disse scrivendo quei numeri di fianco. «Le pareti sono foderate di muscoli e noi, per deglutire, usiamo proprio quel muscoli. All’interno c’è una mucosa ricca di ghiandole che producono muco, che serve per lubrificare e far passare il cibo.» Il dottor Mingardi parlava e disegnava. Aveva messo attorno alle linee che delimitavano il tubo i muscoli e all’interno la mucosa e poi aveva disegnato una sezione frontale del tubo, per far meglio capire. Era un cerchio abbastanza ampio. «Ecco vede, signor Brambilla, il tumore dell’esofago è dovuto alla crescita incontrollata delle cellule, possono essere le cellule del rivestimento interno o anche quelle che producono muco.» Tiberio osservava stupito. Un medico che gli dedicava così tanto tempo, sembrava strano e ne voleva approfittare, lasciandosi andare anche a domande che per lui erano una curiosità. «Ma è frequente?» «È il sesto tumore più comune nei paesi non industrializzati, il diciottesimo nei paesi industrializzati, sono più colpiti i maschi e si presenta di solito nei sessantenni.» Tiberio fece una smorfia e disse «Allora sono stato sfigato». «Quattro casi su centomila ogni anno in Italia ma il vero problema è che è aggressivo» disse Mingardi, tralasciando la seconda frase sulla mortalità elevata. «Ma ho sbagliato qualcosa, dottore?» chiese Tiberio, cercando di capire se la cosa poteva essere legata al proprio stile di vita. «Fuma? Beve?» Tiberio scosse la testa. «Pensi che le persone che fumano e bevono insieme, hanno un rischio di ammalarsi di cancro esofageo 100 volte superiore a quelli che non fumano e non bevono.» «Allora sono proprio sfigato, non ho nulla delle cose che sono considerate a rischio» sbottò Tiberio, passandosi le mani nei capelli. «In effetti è così, Tiberio. Pensi che è un tumore considerato circoscritto al Nord Italia, arco alpino e lo si ritiene associato all’uso di alcolici artigianali, tipo la grappa fatta in casa. Se lei non beve alcolici, è stato davvero sfortunato ma è stato anche in gamba a decidere di farsi aiutare, Tiberio. In pochi riescono a farlo, le fa molto onore.» Una valanga di pensieri cinici e rabbiosi travolse la testa di Tiberio. “Bella razza anche i medici. Stanno lì a sputar sentenze e intanto i poveri cani entrano nello schiacciasassi delle loro terapie, manco morto mi faccio fare la chemio.” «Bisognerebbe fare di più per la lotta al tumore, dottore, io non ne sapevo nulla…» «Pensi, Tiberio, che in Italia al Sud c’è il 50% di tumori in meno che al Nord.» Tiberio sgranò gli occhi. «Intendo dire tumori in generale, non il suo…» disse Mingardi, intuendo il fraintendimento. «Mi faccia capire, dottore, la gente del Sud ha metà tumori rispetto al Nord?» «Esatto.» «Come mai?» chiese Tiberio folgorato da questo dato. «Noi siamo quello che mangiamo, Tiberio, al Sud si mangia meglio, meno carne, più legumi, più pesce, olio di oliva invece che burro...» «No, no, dottore questa me la deve spiegare bene» disse Tiberio incredulo. «Vuole dire che basterebbe mangiare meglio e ci sarebbero metà dei tumori?» «I dati dicono questo, Tiberio.» «Beh, ma, scusi, se il dato è così chiaro, come mai non ci sono campagne informative? Bisognerebbe educarci a mangiare meglio!» disse Tiberio scandalizzato. «Tiberio, io faccio il clinico, bisognerebbe domandare a chi ha responsabilità per la prevenzione.» «Guardi, sarà che sono toccato nel vivo, dottor Mingadi, ma mi sembra davvero da delinquenti non fare nulla, se la soluzione è così semplice» disse Tiberio, tentando di contenersi. «Forse cambiare modo di mangiare non è poi così facile» disse il dottor Mingardi, pensando che non era il caso di aggiungere altro, Tiberio era troppo carico. 17 Il freddo era pungente quel mattino e, anche se aveva indossato i guanti, le mani erano congelate. Seduto al posto che aveva prenotato, Tiberio aveva messo sul tavolino il portatile Sony Vaio di cui andava orgoglioso e il Blackberry. Cappotto, berretto, guanti, sciarpa e la borsa One Day erano sopra, disposti in modo che non occupassero troppo spazio. Il Cisalpino di martedì 13 dicembre partiva dal binario 3 alle 10.28. Il posto di Tiberio era verso il corridoio, quasi sicuramente si sarebbe dovuto alzare per far passare il passeggero che aveva prenotato il posto al finestrino alla sua destra e durante l’attesa non voleva collegare il filo elettrico del portatile. Aveva ancora freddo e poi i fili potevano intralciare, così decise di godersi il filmino delle entrate, la visuale era ottima, era uno dei primi posti dalla porta d’ingresso e dava verso la porta. Erano tutti professionisti, tutti vestiti di scuro, che fossero pelati, con i capelli, giovani o adulti erano quasi tutti white collar, nessuna famiglia e poche cose interessanti. Sembravano fatti tutti con gli stampini, tutti facevano la stessa cosa, si accomodavano, mettevano in ordine le loro cose e poi computer portatile e telefono. Mentre tutto scorreva come previsto e la carrozza si riempiva, l’occhio di Tiberio cadde su una donna che, appena entrata, sembrò illuminare lo scompartimento. Un completo giacca pantalone gessato si riconosceva sotto un cappotto blu corto con una cintura di pelle che inizialmente le stingeva in vita ma che si stava già slacciando. La camicia bianca con il bavero lungo e con due soli bottoni sbottonati, castigava un seno fatto per essere visto. Un cappello di lana con una piccola visiera faceva intravvedere i capelli rossi sia sulla fronte che dietro l’orecchio. Il trucco valorizzava gli occhi verdi ed era a dire poco perfetto. Il bordo del pantalone lasciava intravvedere solo la punta della scarpa nera e la punta di un tacco che aveva tutta l’aria di essere un chiodo, tanto che era sottile e appuntito. Sembrava altissima. Tiberio rimase ipnotizzato. Furono pochi lunghi secondi in cui Tiberio ebbe il privilegio di rimanere da solo con quella donna che, fatto un passo in avanti tenendo nella destra il biglietto e nella sinistra il trolley, controllava i numeri appesi per identificare il proprio. Quel Dio che Tiberio aveva lungamente bestemmiato nei giorni precedenti diventò subito oggetto di preghiera e Tiberio lo pregò di farla sedere davanti a lui. Uno sguardo a sinistra, uno a destra, un passo avanti poi altri sguardi e finalmente la donna dai capelli rossi si fermò e concesse a Tiberio quello che sarebbe stato l’unico sguardo e un cenno di sorriso. Non ci furono parole, solo gesti. La donna dai capelli rossi si era fermata per sedersi lì. Con gesti veloci e sicuri liberò la cintura dopo aver sfilato i guanti dalle mani e averli infilati nel berretto. Tutto si svolse in un battibaleno, riempì il portabagagli con cappotto, berretto, guanti, sciarpa e trolley. L’occhio malizioso di Tiberio aveva approfittato di quei gesti per cogliere il seno della donna che prometteva bene, ma concedeva zero. Sembrava sodo e tondo, una misura certamente superiore alla seconda e privo di interventi umani. La camicia di seta e il reggiseno non permettevano di vedere se il capezzolo desse segni di vita. Aveva avuto il privilegio di assistere a quella elegante danza senza avere competitori, se l’era gustata da solo e il suo inguine dava segnali di soddisfazione, anche se ora che la donna si stava sedendo proprio davanti a lui, come aveva pregato che fosse, non poteva più lasciarsi andare a sguardi espliciti. Voleva e doveva sembrare indipendente dalla sua bellezza. Non potendola seguire nella metà superiore senza tradirsi, Tiberio approfittò dei pochi secondi di permanenza in piedi in corridoio dopo il deposito bagagli e puntò lo sguardo in basso. Il piede coperto dalla calza nera scompariva nella scarpa, il tacco era un’arma contundente, mentre il pantalone blu gessato cadeva sul dorso del piede senza nasconderlo del tutto e saliva fino alla vita per celarsi sotto i lembi della giacca che era chiusa. La camicia bianca era scientemente abbottonata, impedendo ogni scorcio sul decolleté, deludendo e rendendo inutili i tentativi del testosterone di condurre gli occhi maschili alla ricerca del loro diritto al piacere. Una collana di perle cadeva aggrappata ad un collo lungo e stretto che finalmente diceva qualcosa della pelle, una pelle di un colore bruno, figlio di ore di lampade e di creme. Era un dipinto, un quadro, una composizione che rasentava la perfezione. I dettagli dicevano di anni di esperienza nel dosare colore, tempo, materiali e il collo raccontava di un pittore che aveva sapientemente scelto la dose di bianco da mettere sul bruno di quella pelle, facendo lambire a quei ciottoli bianchi la fossetta che indicava la fine dello sterno e l’inizio della trachea. Mentre lo sguardo di Tiberio procedeva sfacciato nella perlustrazione di quel corpo femminile, fregandosene di tutto e di tutti, le dita della donna erano entrate nei capelli che erano stati troppo a lungo schiacciati dal cappello di lana. Erano capelli rossi, corti, la riga era a destra, la frangia cadeva leggera sulla fronte, lasciando intuire che anche quella distanza era frutto di uno studio accurato. Il rosso pareva originale e introduceva l’ambizioso contrasto degli occhi. Dal centro all’esterno si leggeva nero, verde, nero, bianco, nero, bruno, rosso. Il verde dell’iride era incastonato come un diamante all’interno di un cerchio nero sottile che lo separava nettamente dal bianco del resto dell’occhio e questo nero, verde, nero, bianco a sua volta era dentro un nero, bruno, rosso. Come fosse un pozzo senza fine, Tiberio si era perso dentro quel mare di piacere. Una potente erezione lo accompagnò per lunghi minuti, il respiro si era fatto fitto, il battito del cuore era accelerato e Tiberio aveva finalmente lasciato gli ormeggi, abbandonato le sue ossessioni, i suoi odi, i suoi amori per una piacevole deriva che durò fino a quando il controllore non lo svegliò per vidimare il biglietto. Il treno aveva superato la barriera di Como e di Chiasso, si stava dirigendo a Bellinzona e, in tutto quell’andare, Tiberio aveva masturbato il suo sguardo addosso a quella donna che lo aveva come travolto senza dire una parola. Come una vera e propria macchina da guerra, con la sicurezza di un generale veterano di lunghe battaglie, la donna dai capelli rossi era perfetta regista di quello che le accadeva attorno e, da stratega perspicace e consapevole, sapeva che poteva condurre la sua giornata solo se il suo sguardo non avesse incrociato quello dei maschi adoranti che le facevano sentire l’odore della caccia. In nessun momento la donna dai capelli rossi perse il controllo della situazione, non ebbe alcuna sbavatura, il suo occhio ammirato e bramato si posava solo in tre posti, sul finestrino per distrarsi, sullo schermo del Laptop della mela mangiata che aveva sempre aperto e sullo schermo dell’iPhone. Al telefono parlava inglese con una pronuncia assolutamente corretta, impeccabile che sapeva molto di anni passati oltremanica e questo aumentava il fascino di quella donna alfa, che sapeva scatenare i ferormoni attorno a sé, semplicemente stando ferma e non concedendo sguardi a nessuno degli spettatori. Quello che Tiberio ossessivamente notava era un dettaglio. Il capello era corto, cortissimo, alla maschietto e aveva tutta l’aria di essere del colore originale. La riga a destra permetteva di verificare sbavature, scoloritura della radice che però non c’erano nonostante il meticoloso e scrupoloso controllo che Tiberio aveva compiuto, mentre il Cisalpino abbandonava la valle e raggiungeva e superava i primi colli per immergersi nelle valli alpine. La donna dal capello rosso non mostrava alcun disagio nell’essere perlustrata, nel sentirsi addosso gli sguardi che si infilavano maliziosamente in ogni microscopico pertugio che concedeva, perdendocisi incapaci di uscire dalla ricerca ossessiva di un pezzo di carne da mangiare, di un respiro di vita con cui nutrire la passione carnale che animava gli inguini di tutti i lupi circostanti. Tiberio non aveva mai tradito Sabrina, né da fidanzati né da sposati. Stavano bene assieme e anche la loro vita intima era regolarmente nutrita da momenti che strappavano alle giornate tutte uguali che si ripetevano quasi sterili. Quella donna però lo stava rapendo, gli stava facendo vivere una vita che non conosceva, una vita nella quale avrebbe voluto perdersi volentieri, avvolto in bianche lenzuola e appoggiando il capo su morbidi cuscini. Il capo invece si appoggiò al sedile, Morfeo si portò via la coscienza di Tiberio, il respiro diventò profondo e solo uno scossone del suo compagno di viaggio lo destò da un sonno pesante che lo aveva preso a Vaduz e se l’era portato fino a Zurigo. Imbarazzato e imbranato, con la bava che gli era colata dal margine destro della bocca fino a gocciolare sulla giacca, Tiberio si alzò per far passare l’altro passeggero e ne approfittò per riassestarsi, sperando che la sua dèa non lo avesse visto ridotto così. La sua dèa però non era più al suo posto e Tiberio, confusamente, la cercò con lo sguardo mentre, sbagliando tutti i gesti e mettendo in difficoltà anche gli altri passeggeri, cercava di infilarsi il cappotto e di mettere in borsa gli strumenti tecnologici che alla fine non aveva nemmeno acceso. Gli occhi di Tiberio riposarono solo sul cappello di lana della donna, che era in piedi, vestita, pronta per uscire e gli dava le spalle. Non l’avrebbe più vista, se non si fosse affrettato, e così, tra una piccola spinta e un passo allungato, Tiberio la raggiunse e percorse al suo fianco il tratto tra la carrozza e la strada, dove la vide prendere un taxi e scappare verso quella vita che a Tiberio invece stava fuggendo. Fermo, in piedi, con il fiato che si colorava di bianco quando usciva dalla sua bocca, ricordandogli il freddo pungente che c’era anche se il sole di Zurigo scaldava, Tiberio stava male. Quasi provasse una astinenza da quella bellezza, quasi non gli fosse possibile lasciare quell’eccitazione che la donna gli aveva fatto provare, Tiberio non voleva che quel taxi la strappasse dal suo fianco. Anche se aveva programmato di fermarsi ad ammirare la bellezza di quella stazione ferroviaria, che in mezzo alle Alpi era stata costruita sull’acqua, in quel momento poco gli importava di ammirare quella che gli esperti consideravano un’opera architettonica da apprezzare. Un fiume si biforcava subito sopra la stazione, un ramo passava sotto i binari mentre l’altro lo si poteva vedere subito dopo la Bahnhofplaz, con il risultato che la stazione si trovava praticamente su un’isola. Le strade attorno alla stazione avevano i nomi classici. A destra della stazione c’era un enorme edificio che ospitava un museo che dava il nome alla strada, Museumstrasse. La Bahnhofstrasse e la Bahnhofquai erano invece proprio davanti alla stazione. Tiberio s’incamminò timidamente a testa bassa verso il lato sinistro della stazione, percorse la Bahnhofstrasse fino a prendere la Lowenstrasse. Prima di partire aveva lungamente guardato Google Maps e aveva visto che girando a sinistra sulla Schützengasse, gli sarebbe poi bastato girare a destra sulla Lowenstrasse per arrivare al St. Gottard, l’albergo che aveva prenotato. Aveva pensato lungamente se andare in macchina o in treno e poi affittare una macchina. Aveva scelto il treno per vari motivi. Il Cisalpino gli piaceva molto, la stazione era un’opera d’arte che avrebbe rivisto volentieri e l’albergo era raggiungibile a piedi. Tutto vero anche se il vero motivo per cui era andato in treno era il terrore del viaggio in macchina e di trovarsi a vomitare sangue da solo ai centotrenta all’ora. La Chelli gli aveva spiegato che il tumore sarebbe cresciuto occupando lo spazio del tubo esofageo, impedendo al cibo di scendere. Quindi sarebbe arrivato prima un po’ di reflusso gastroesofageo e poi il vomito. Tiberio bighellonò confuso e depresso per diversi minuti, ancora stordito da quella vita pulsante e meravigliosa che quella donna gli aveva regalato, chissà se con innocenza o impudenza. Era lì per organizzare la sua morte ed era stato travolto dalla bellezza di una donna. La sua vita nelle ultime settimane era stata tutta una montagna russa, un salire le vette e un discendere nella tormenta. Le lacrime lo facevano bagnare, gli stappavano brandelli di anima e poi all’improvviso apparivano dei chiarori come se la vita non volesse andarsene. Le lacrime arrivarono di nuovo, questa volta però Tiberio aveva l’asciugamano, aveva il cuscino pulito, aveva il bagno. Steso sul letto, si era levato le scarpe, aveva acceso la TV, ancora una volta alla ricerca di un segno di compagnia e di vita e poi si era lasciato andare al pianto, provando per la prima volta una profonda rabbia verso quell’altalena, verso quella scala, verso quel turbinio di stati d’animo che lo facevano salire e scendere e che lui non voleva più provare. Era venuto lì, sarebbe andato a visitare la clinica di Humanitas; questo si era proposto prima di prendere una decisione, quasi fosse possibile decidere dove e come morire solo dopo aver visto il posto. 18 Zurigo Per colazione non aveva preso quasi nulla, aveva lo stomaco chiuso e la cosa ovviamente lo preoccupava ma non lo sorprendeva. Vai tu a distinguere se era la tensione o il tumore. Non poteva chiamare il taxi troppo presto e non voleva tornare in camera, aveva fatto la borsa e aveva liberato la camera. L’appuntamento era verso le dieci del mattino e gli conveniva stare lì ad attendere, anche se non sapeva come far passare il tempo. Certo, se almeno i giornali fossero stati in inglese, avrebbe potuto leggerli così pensò di usare il tablet per farsi una scorpacciata di Italia. Uno alla volta passò i siti: Repubblica nella versione classica web proponeva qualcosa di leggibile, mentre il Corriere on-line gratis non proponeva nulla di minimamente piacevole e la versione classica non era free. Verso le dieci si alzò e andò al front office per chiedere il taxi e finalmente partì. Non era in veste professionale. Aveva un paio di pantaloni di fustagno, un maglione di lana e una sciarpa che avrebbe messo sopra il giaccone. Chiese al taxista di andare ad un paesino appena fuori Zurigo, in direzione sud est, ed egli vi si diresse senza alcun commento. Tiberio si era fatto l’idea che tutti lo sapessero e lo accettassero. Si ricordava di quel brano sulla pagina web di Humanitas in cui lo staff ringraziava la popolazione per aver votato a favore del loro progetto. La cosa lo rassicurava. Dopo una decina di minuti di viaggio, il taxi sbucò nella campagna attraverso scorci che rapirono lo sguardo di Tiberio, che si trovò fermo davanti alla sede di Humanitas quasi all’improvviso, tanto si era piacevolmente lasciato andare ad ammirare la Svizzera con le sue case tipiche e le sue vette. Pagato il taxi e prese le sue due borse, la solita gialla e la One Day, Tiberio percorse il vialetto che dalla strada portava all’ingresso. Nel procedere a piedi, perlustrava il sentiero, ben tenuto, pulito e senza rami che sporgessero eccessivamente all’interno. All’ingresso, dopo la porta a vetri, si trovavano un bancone apparentemente senza nessuno e a sinistra un piccolo salottino di comode poltrone attaccate alla parete a vetri. Una ragazza con un paio di piercing alle labbra e al naso era seduta e stava parlando al telefono. Non era visibile dalla porta perché il bancone era più alto. Tiberio posò le due borse a terra, si appoggiò al bancone e attese la fine della chiamata alternando lo sguardo alla ragazza e alla perlustrazione dell’ambiente. Quando la ragazza riagganciò il cordless, si rivolse subito a lui con il volto sorridente. Non sapeva che lingua parlare e provò con la propria. «Salve sono Tiberio Brambilla, ho un appuntamento.» «Benvenuto, signor Brambilla» rispose con un accento tedesco marcato. Poi con lo sguardo andò al videoterminale e con la mano sinistra al mouse, doveva essere mancina. «Brambilla?» chiese la ragazza che sulla targhetta portava scritto “Margit”. Tiberio capì e, senza dire nulla, tirò fuori dal portafoglio la carta d’identità e la mostrò, in modo che potesse digitare le lettere esatte. «Si accomodi pure, tra poco la chiameranno.» Appese il giaccone e si trasferì sulla poltrona con le due borse. Il tavolino davanti alla poltrona era pieno di depliant e si immerse nella lettura. Un libretto ben fatto raccontava le avventure che Humanitas aveva passato e, tra date e nomi di vie a lui sconosciute, Tiberio entrava dentro una storia che iniziava ad appartenergli sempre di più. Di una cosa era stupito. La Svizzera aveva legiferato al riguardo del suicidio assistito non con una norma decisa in parlamento ma con un referendum e questo lo rattristava molto, perché pensava che una referendum del genere in Italia non si sarebbe mai potuto fare e sempre a causa della presenza della Chiesa cattolica. Il libretto presentava anche la parte economica con le varie voci di spesa e si parlava di quattromila euro per gli aspetti medici e di duemilacinquecento per quelli amministrativi. I secondi, forse, erano più importanti dei primi, perché comprendevano il testamento biologico, la cremazione e tutte le pratiche burocratiche necessarie al trasferimento delle ceneri. L’attenzione di Tiberio si concentrò però su un dettaglio, la questione delle due stanze. Si trattava di una strategia studiata a tavolino e ben organizzata, che metteva assieme un po’ tutte le esigenze. Il medico doveva avere i suoi spazi e i suoi tempi secondo uno schema preciso, mentre il paziente doveva poter salutare i propri cari. Così la prima stanza era chiamata la stanza del congedo, perché lì si fermavano i parenti o, comunque, coloro che avevano accompagnato il paziente. Tiberio pensò che potesse essere chiamata stanza delle lacrime. Lì per esempio il medico parlava con il paziente nell’ultimo tentativo di dissuasione e, secondo i dati dell’associazione, il 40% dei soggetti ci ripensava e rinunciava. La cosa veniva presentata come positiva e questo l’ingegnere faticava a capirlo. Abituato a lavorare per obiettivi e per risorse impiegate per perseguire gli obiettivi, pensare che fosse considerato un successo la rinuncia all’obiettivo nella sua mente suonava stonato. La seconda stanza era quella dell’assunzione del farmaco, Pentobarbital-natrium da prendere per bocca previamente sciolto nell’acqua. Il gesto senza il quale Humanitas non sarebbe esistita. Tutto era fondato sul fatto che la persona si potesse dare la morte da sola e se questo non fosse stato possibile non si combinava nulla. «Brambilla?» Tiberio si alzò, scosso nel sentire il proprio nome. Egli seguì l’uomo che non si era presentato e si trovò seduto in un ufficio davanti ad una scrivania. Gli era sembrato molto brusco nel modo di fare e già la cosa partiva male. Era un ufficio anonimo, di quelli arredati badando alle spese, poteva essere un qualsiasi ufficio amministrativo. «Aveva chiesto una visita della struttura, giusto?» chiese l’uomo che non si era ancora presentato e guardava una cartella. Tiberio si seccò di nuovo. Aveva solo un appuntamento e già avevano una cartella a suo nome e lui non aveva firmato nulla sulla privacy. «Sì.» «La visita che scopo ha?» chiese l’uomo. Tiberio rimase in silenzio, irritato e mal disposto. Pensava che fosse una sciocchezza quella domanda. Uno veniva lì per cosa? “Testa di cazzo!” pensò tra sé. “Uno viene qui con l’angoscia fino al collo e voi gli domandate che viene qui a fare?” «Glielo chiedo, signor Brambilla, perché ci sono molti giornalisti che vogliono visionare la struttura e in alcuni casi si fingono pazienti. Noi dobbiamo impedirlo e facciamo firmare una dichiarazione se uno vuole visitare la struttura. Se lei è un paziente che vuole fare riferimento al nostro progetto, siamo lieti, ma se ha altri scopi, la pregherei di dirlo subito e ci salutiamo civilmente o prendiamo appuntamento per una intervista.» Tiberio si sentì uno scemo. Era scattato subito, risentito e cattivo, e ora, davanti alla spiegazione, gli sembrava tutto chiaro e accettabile. Prima della malattia non era così, non si irritava così facilmente, non provava sempre questa altalena di sentimenti. Questa cosa stava diventando difficile da gestire. «Mi hanno diagnosticato un tumore all’esofago e la PET ha rilevato già delle metastasi polmonari, mi hanno dato meno di un anno di vita.» Max Petterson, così si chiamava l’uomo pelato, fece un lungo silenzio. «Lei vorrebbe usufruire dei nostri servizi?» Tiberio notò che la parola delle parole, morte, non veniva pronunciata. Probabilmente era anche una scelta precisa e, in fondo, lo stesso Tiberio ammetteva che fosse meglio così. Il solo sentirla pronunciare, portava un grande dolore anche se ormai era trascorso più di un mese da quando la Chelli gli aveva fatto il prelievo e aveva saputo dell’istologico. 19 Mentre il taxi lo riportava a Zurigo, dove calcolava di prendere il treno per il ritorno a Milano, Tiberio pensava di non aver inteso nulla di ciò che aveva sentito dire dal suo cicerone. Aveva percorso gli spazi della struttura in uno stato confusionale totale e ora sentiva una grande delusione, anche se qualcosa era rimasto fissato nella sua memoria. Ora sapeva molte cose. Sapeva l’esatto indirizzo, come arrivare, sapeva tutto ciò che dovesse fare e quando lo dovesse fare. Aveva visto la prima stanza, aveva visto la seconda stanza, gli avevano spiegato bene la faccenda dei farmaci antiemetici che vanno assunti una mezz’ora prima del veleno per impedire eventuali accessi di vomito che vanificherebbero l’assunzione di veleno. Anche se la spiegazione che gli avevano dato era assolutamente chiara e ragionevole, gli seccava la faccenda dell’accompagnamento, perché temeva che compromettesse tutto. Nessuno poteva fare un passo del genere da solo, tutti venivano accompagnati da qualcuno e lui poteva farsi accompagnare solamente da Sabrina ma non lo voleva assolutamente fare. Quando Max Petterson gli aveva chiesto chi l’avrebbe accompagnato, Tiberio era stato evasivo e ora si stava facendo un bel po’ di paranoie su questo. L’idea che si era fatto era che loro lo chiedessero per la questione del pagamento successivo, per essere sicuri che qualcuno ci fosse sia per sbrigare le pratiche che per pagare. Mentre percorrevano gli spazi interni, l’uomo aveva notato il suo sguardo perso e gli aveva detto che la cosa succedeva regolarmente a chi visitava la struttura per la prima volta. «Vede, signor Brambilla, quando una persona visita la nostra struttura per poi venire a ricoverarsi, spesso si trova a provare grandi emozioni che lo confondono e privano della lucidità ed è per questo che è importante che la visita venga fatta dalla persona interessata al ricovero, ma anche da un parente o un amico importante, colui che poi lo accompagnerà nella prima stanza.» Tiberio ricordava perfettamente quella frase che lo aveva spaventato. «Ma è obbligatorio farsi accompagnare?» «È fortemente consigliato e se la persona rifiuta, allora si può provvedere da parte nostra a fornire comunque un accompagnatore.» «A pagamento immagino?» «Sì, certo.» L’aveva scampata per un pelo, aveva temuto che gli dicessero che doveva per forza farsi accompagnare ma quell’accompagnamento lo aveva salvato alla fine. Era seccato che il suo stato confusionale fosse stato così evidente. 20 Mancavano pochi giorni a Natale, Milano era addobbata per le feste. Mentre camminava lungo via Felice Bellotti e controllava i numeri civici alla ricerca del 10, Tiberio pensava a come potesse essere questo padre Ernesto. Certo, sister Maria non poteva davvero conoscere e tantomeno mandarlo da uno di quei pretini tutti perpetue e brodini caldi. Quella donna era diventata davvero importante per lui, forse anche più che importante. La sua forza era un punto fermo della vita di Tiberio in quel momento e Tiberio non solo si fidava di lei ma sentiva che aveva un gran bisogno di averla al proprio fianco. Era come se in quel momento fosse lei a tenerlo in piedi. Lui aveva un grande bisogno di buttarle addosso tutta la sua tragedia e di sapere che non le avrebbe fatto del male, sapere che lei lo avrebbe retto, sapere che pur aggredendola, pur bestemmiando, pur odiando non l’avrebbe scalfita e lei gli avrebbe fatto quel sorriso imperturbabile che tanto odiava. Non sapeva molto di sister Maria ma quel suo passare con la massima tranquillità da un lavoro all’altro era davvero straordinario. Quella donna poteva pulire piedi puzzolenti e culi sporchi e poi lavarsi le mani per chiudersi con lui in quella stanza disadorna, spoglia, disagevole e tragica e trovare Dio in una cacatina di mosca o in una sua bestemmia. Una donna così, che prete poteva presentargli? Tiberio si aspettava un bel monaco tutto d’un pezzo, con due spalle da taglialegna, che mangiava tuoni e cacava fulmini, che sistemava i miscredenti con quattro sganassoni e che affrontava a petto nudo quelle quattro checche che osavano mettere in dubbio l’esistenza di Dio, solo perché potevano stare tutto il giorno a pontificare su Facebook pagando due euro alla settimana di Mobile Internet. Forse era stata la PET a caricarlo, forse erano state le due stanze di Humanitas, forse era quell’immagine, quel bicchiere con l’acqua avvelenata che avrebbe dovuto bere da solo, forse era stato quell’essere smascherato nel suo stato confusionale, forse era la sua vita che ruggiva dentro e che non voleva spegnersi, sta di fatto che ora nella montagna russa era bello alto e doveva solo sperare che padre Ernesto lo reggesse anche così carburato. La suora che aprì il portone del convento dei benedettini era piccola come sister Maria e, trascinandosi come sister Maria, lo portò attraverso corridoi puliti e nuovi alla stanza di padre Ernesto. Tiberio si era dato una spiegazione dell’esistenza di sister Maria. Il Padre Eterno le aveva volute per prendere a schiaffoni i “so tutto io” della nostra epoca e la grandezza di quelle donne stava proprio nel loro nascondimento, nel loro essere invisibili e fragili. Faceva più fatica a spiegarsi l’esistenza delle benedettine. Sarà stata anche una grande cosa la preghiera ma lui non ci vedeva la provocazione come in quella carità puzzolente ed esibita che andava dritta al cuore. Mentre la suorina benedettina gli sembrava inutile, le Missionarie della carità con la loro sfacciata umiltà andavano dritte al punto e lui, in fondo, era orgoglioso di quella poltrona lontana e nascosta che gli permetteva di sputare veleno e di non essere cacciato. Certo, erano pensieri maliziosi e cattivi e con questi pensieri Tiberio arrivò davanti ad una porta in un corridoio grande e luminoso. La porta era mezza in legno e mezza in vetro opaco, la maniglia era piatta, più larga verso l’interno e più piccola verso l’esterno. La suora bussò ma entrò senza attendere, anzi mise dentro la testa e quando la tirò fuori fece cenno a Tiberio di accomodarsi. La stanza era rettangolare e, come quella di sister Maria, aveva due finestre sul lato opposto a quello della porta. Erano ampie e davano molta luce senza procurare fastidio come quelle di sister Maria e Tiberio si sentì rasserenato dalla cosa. Padre Ernesto era seduto dietro una scrivania di legno intarsiato, chiusa davanti e sopra la quale c’erano fogli, lampada e computer acceso. Aveva i capelli a ciuffo spettinato alle tempie, certo nessuna donna si prendeva cura di lui, almeno non dei capelli. Sulla settantina, se ne aveva di meno li portava male, dentiera non proprio ben messa, ma almeno ce l’aveva, naso un po’ ricurvo e barba rasata, occhi incavati. Tiberio ebbe un momento di timore quando, avvicinatosi, temette che si potesse trattare di uno di quelli dall’alito tremendo e, teso come una corda di violino, affrontò la stretta di mano aspettandosi un fiato morto in volto, che però non arrivò. Le mani erano grandi e forti, la stretta possente e la veste era di quella lana bianca pezzo unico dalla testa ai piedi con una cintura a cordone. Non vedeva le scarpe ma sperava per lui che le avesse. «Salve, sono padre Ernesto.» «Ah sì, scusi, Tiberio Brambilla, mi manda sister Maria» disse, come beccato in contropiede, mentre ancora il suo sguardo stava spettegolando sul corpo del prete. «Ah sì, ricordo…» disse padre Ernesto e poi aggiunse «Ci siamo sentiti al telefono, vero?» Tiberio aveva sperato che quel, “ci siamo sentiti”, volesse dire che sister Maria aveva già raccontato a padre Ernesto la sua storia e questo gli avrebbe risparmiato di tirar fuori di nuovo tutte quelle parole che gli bruciavano dentro. Quello che Tiberio amava di sister Maria era la sua forza, la sua resistenza. Le poteva buttare addosso le peggio cose, dicendo spropositi verso gli uomini e verso Dio e lei se li prendeva tutti senza nemmeno fiatare e questo lo sollevava molto. Non ce la faceva a tenersi dentro il fetore della morte e ora che aveva davanti quel prete sperava proprio che anche lui potesse fargli da secchio e prendersi tutti gl’improperi che già sentiva ribollire dentro. La stanza era grande e luminosa, un tappeto persiano rossiccio copriva parte di un pavimento a mattonelle grandi, apparentemente composte da pezzi di altre mattonelle. La sedia del prete era intarsiata come il tavolo. Lo schienale scomodo solo a vedersi era costituito praticamente da una lastra di legno nero incastrata tra due bastoni quadrati che salivano alti almeno una spanna sopra lo schienale. Due braccioli sempre neri e quadrati davano l’impressione di essere così sottili, di non più di cinque centimetri di lato, da non permettere nemmeno l’appoggio dell’avambraccio. Tiberio si sforzò di non spettegolare più con lo sguardo e portò la testa verso il prete. «Grazie, padre Ernesto, grazie per avermi accolto così in celermente.» «Questa volta era possibile, altre volte non lo è» disse sorridendo padre Ernesto. «Sister Maria mi ha consigliato di venire da lei…» disse Tiberio, tenendo la frase sospesa. «Fa un grande lavoro quella donna, la ammiro molto» disse padre Ernesto con una smorfia di approvazione. «Sì, ho avuto modo di apprezzarla in effetti» disse Tiberio anche se l’aveva vista all’opera solo su se stesso in quella stanza. «Ma in cosa posso aiutarti? Ti do del tu…» Era la stessa frase che gli aveva rivolto sister Maria e rispose nella stessa maniera con la quale aveva risposto alla suora. Gli disse che non sapeva nemmeno lui perché fosse li e che in fondo un po’ si vergognava ad essere lì, sapendo che, come prete, certo aveva persone a cui stare vicino che stavano peggio di lui. Non gli disse che aveva una gran voglia di vomitargli addosso quella rabbia che lo attanagliava dentro e gli toglieva il fiato. «Sì, mi dia del tu, perdoni se non faccio altrettanto. Forse, padre Ernesto, il punto è proprio quello.» Tiberio aveva nella sua testa quella parole, “aiutarti”, che gli rimbalzava dentro come una pallina da ping pong impazzita e rimase come paralizzato. Padre Ernesto fece una smorfia interrogativa. «Matteo 18» disse in modo secco e provocatorio Tiberio associando un piccolo sorriso. «Bel capitolo quello» disse sorridendo soddisfatto padre Ernesto. Tiberio sorrise. Per lui non era una questione di speculazione teologica, ma padre Ernesto non lo sapeva ancora e forse era il caso di dirglielo. «Diciamo che sono incazzato con Matteo 18» disse sorridente Tiberio, ottenendo una seconda smorfia interrogativa da padre Ernesto. «Ma forse è il caso che glielo spieghi bene, vero?» «Meglio, sì.» «Mi hanno diagnosticato un tumore maligno e mi hanno dato meno di un anno di vita. Non l’ho detto a nessuno della famiglia e ho deciso di andare in Svizzera da Humanitas» buttò fuori d’un colpo Tiberio. «Ho deciso, ma c’è quel maledetto Matteo 18 che me lo impedisce o, almeno, così la vedo io.» «Matteo 18 glielo impedisce?» chiese padre Ernesto. «Se non ci fosse Matteo 18, la Chiesa potrebbe dire quello che vuole che nessuno le baderebbe. Matteo 18 però c’è e così o si obbedisce alla Chiesa o si va all’Inferno.» Padre Ernesto era basito. La logica di Tiberio era stringente, inattaccabile, quasi formidabile, non faceva una piega e padre egli capiva bene che non doveva rispondere citando Matteo 16 o altri pezzi del Vangelo; se lo avesse fatto si sarebbe impantanato e lo era già abbastanza. Fu Tiberio stesso a salvarlo. «Posso continuare, padre? Tanto vedo che lei mi regge» disse Tiberio con volto serio. Padre Ernesto pensò a quelle due parole “mi regge” e ci vide dentro tutto. «Immagino che lei non sia d’accordo ma provi a vederla dal mio punto di vista. Io chiedo solo di crepare in pace, senza penare, senza rovinare la vita ad altri e, invece, mi viene detto che devo morire in un letto d’ospedale, magari pieno di farmaci inutili. Ma dico, siamo pazzi? Come si fa a non permettere ad un cristiano di morire in pace, se si può?» «Le hanno detto che morirà soffrendo?» chiese padre Ernesto. «La massa ostruirà l’esofago, il cibo non passerà più, ho già le metastasi, sono qui che aspetto le prime vomitate che vogliono dire che l’esofago si è già chiuso.» Padre Ernesto tacque, non sapeva che dire e soprattutto era smarrito davanti alla logica stringente di Tiberio e non sapeva a che livello rispondere. Gli venivano da citare altre Scritture ma continuava ad avere la sensazione che avrebbe inasprito la situazione. Il vantaggio che padre Ernesto percepiva era che Tiberio era un fiume in piena, lui gli aveva dato solo il via e non si fermava e, anche se era aggressivo e cinico, buttando fuori tutto mostrava di fidarsi e magari si sarebbe rilassato un po’. «Io so solo che vi odio, odio i preti, odio i vescovi, odio tutte queste persone che decidono delle cose e poi ci mettono sopra Matteo 18 e bum, rovinano la vita alle persone. Sono incazzato poi anche con Dio, che l’ha fatta davvero grossa a mettere in mano a quattro mentecatti rincoglioniti una bomba del genere. Davvero, dove aveva la testa Dio quando gli è venuto in mente di dire quelle parole?! Non lo sapeva che poi ne avrebbero fatto un uso sconsiderato?» Ci fu una pausa. Padre Ernesto non conosceva Tiberio ma tendeva a pensare che, se glielo aveva mandato sister Maria, poteva fidarsi, non era pericoloso e, in fondo, spesso can che abbaia non morde. «Lo so, padre, ho bestemmiato, ma purtroppo questa cosa mi scatena davvero un odio senza fine e, se mi permette, ho da dirle anche un’altra cosa.» Padre Ernesto non aveva in mente la strategia dell’accoglienza di madre Teresa di Calcutta ma taceva lo stesso e ascoltava. «Mi perdoni, mi perdoni se parlo così, padre, ma davvero ho dentro la morte e vorrei misericordia e non condanne all’Inferno. In ogni modo la rabbia viene da questo, provo a spiegarglielo, Padre. Vede, io sono qui davanti a lei e gliele dico in faccia le cose, ma voi preti no, voi non verificate, a voi importa solo della formalità. Se io, per esempio, adesso recito la parte del pentito, lei mi dà l’assoluzione e io sono a posto perché c’è Matteo 18 che sistema tutto. Se invece le dico che io non sono pentito, lei non mi dà l’assoluzione e allora Matteo 18 mi manda all’Inferno. Se io faccio il cagnolino obbediente, non vado a Humanitas e muoio in un letto d’ospedale magari in mezzo ai dolori, voi siete tutti contenti e mi mandate in Paradiso. Se io invece vado a Humanitas a morire con calma, in pace e senza dolori voi mi mandate all’Inferno. Ma le pare una cosa dignitosa? Ma non vi rendete conto che quei cagnolini obbedienti che voi addestrate, obbediscono solo per paura e che non c’è adesione sincera? Non c’è nulla da fare, a voi Matteo 18 ve lo fa diventare duro, vero?» Tanti anni di pastorale, di assistenza spirituale ai malati tumorali ma non gli era mai capitata una cosa del genere. Nella testa di padre Ernesto vagava una pallottola. Si chiedeva se questa volta sister Maria non avesse preso un granchio. Di solito non gli mandava gli sciroccati e padre Ernesto ormai sapeva che quando qualcuno arriva da sister Maria erano esclusi disturbi psichiatrici, almeno quelli più gravi. In questo caso però, covava il sospetto che Tiberio potesse essere un paziente psichiatrico. Quello di Matteo 18 poteva essere sì un dramma spirituale ma anche una paranoia e poi non aveva mai sentito che uno se la prendesse così tanto per un brano evangelico. 21 Padre Ernesto era provato, Tiberio lo aveva sconvolto, sia per quello che aveva detto che per come lo aveva detto. Se non glielo avesse mandato sister Maria, avrebbe avuto bisogno di mettere in dubbio, di verificare ma, visto che veniva da sister Maria, padre Ernesto dava credito alla persona e al suo travaglio. «Senti, Tiberio, ci diamo del tu, è meglio, e vorrei provare a dirti una cosa breve, una cosa formale e vera, un dettaglio che non credo ti aiuterà ma che è la pura verità e io in primo luogo devo dirti la verità.» Ecco la differenza tra padre Ernesto e sister Maria. Padre Ernesto era addestrato a difendere i principi prima di tutto, sister Maria invece metteva al primo posto l’accoglienza e assieme formavano una squadra perfetta. Sister Maria glielo aveva mandato, sapendo che avrebbe provato a chiarire la faccenda dal punto di vista teologico, anche se era perfettamente inutile. Tiberio ascoltò il religioso sia con le orecchie che con gli occhi e lo seguì mentre, alzatosi, andò a prendere un libro e lo sfogliò. «Salmo 14 1. Lo stolto pensa: “Non c’è Dio”. Sono corrotti, fanno cose abominevoli: nessuno più agisce bene. 2. Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio: se c’è uno che cerchi Dio. 3. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; più nessuno fa il bene, neppure uno. 4. Non comprendono nulla tutti i malvagi, che divorano il mio popolo come il pane? 5. Non invocano Dio: tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. 6. Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio. 7. Venga da Sion la salvezza di Israele! Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele.» «Vedi, Tiberio, se tu vuoi trovare nella Bibbia la frase “Dio non esiste”, la trovi, c’è scritto così nel primo versetto del Salmo 14, ma se leggi tutto c’è scritto “…Dio non esiste”, solo che la frase intera è “Lo stolto dice Dio non esiste”.» Tiberio aveva la Bibbia in mano e leggeva il primo versetto. Era molto chiaro quello che voleva dire padre Ernesto. «Vedi, Tiberio, tu hai scelto il capitolo 18 di Matteo, ma c’è anche il capitolo 16 sempre di Matteo e ci sono poi altri brani delle Scritture. Insomma la Chiesa non è Matteo 18.» Tiberio ascoltava e capiva ma contestò subito. «Voi non avreste il potere che avete, se non ci fosse Matteo 18 o 16 che dir si voglia» disse Tiberio. «Tiberio, senti, il tuo è un dramma umano; credo che a te freghi davvero poco di un dibattito teologico su Matteo 18, ma volevo dirti questa cosa del Salmo 14.» «Suor Maria dice che non riesco a perdonarmi e che è per quello che non trovo la pace, dice anche che troverò la forza di andare in Svizzera solo quando mi perdonerò e io non capisco padre Ernesto, che cosa devo perdonarmi, mi aiuti a capire. Che colpe ho?» «Non so che colpe abbia, ma ti puoi confessare per le colpe che hai, credo che sister Maria si riferisca al fatto che ognuno di noi trova la sua serenità quando si perdona, questo è vero per tutti.» «Ma per cosa padre Ernesto? Per aver messo le mani nella marmellata?» Padre Ernesto iniziava a conoscere il costruttore di ponti e la cosa in qualche maniera lo rasserenava. Per lo meno così sapeva cosa pensare. Padre Ernesto sembrava seguire al millimetro il copione che sister Maria aveva disegnato e decise di passare dal Salmo 14 a Galati 5. Era del tutto asimmetrico rispetto a quello che Tiberio gli stava dicendo. Tiberio era lì con il cuore in mano alla ricerca del significato della parola perdono, un significato che gli sfuggiva e che da buon costruttore di ponti non capiva. Padre Ernesto fece la cosa che sapeva fare, provò a dare un po’ di luce con la Parola, lui che se ne nutriva giorno per giorno. «Allora, Tiberio, visto che dobbiamo affrontare queste faccende teologiche, credo che tu almeno debba conoscere alcune cose delle Scritture e la maniera migliore, adesso che conosci Matteo 18 e il Salmo 14, è affrontare la lettera di Paolo ai Galati al capitolo 5.» «Sentiamo Galati 5, allora» disse Tiberio incuriosito. C’era qualcosa di interessante, di affascinante, in quei nomi, Matteo 18, Galati 5 e Tiberio voleva entrarci. Forse, almeno così, avrebbe allontanato per qualche istante i suoi fantasmi. «Qual è il dono più grande che Dio ha fatto all’uomo?» chiese padre Ernesto, come se lo chiedesse ad uno scolaretto. «La vita» disse Tiberio, anche se detto da lui era paradossale. «Esatto, la vita, questo, almeno si dice, ci hanno insegnato che il bene supremo è la vita e molte persone danno questa risposta..» «Invece…» disse Tiberio quasi anticipando l’avversativa che era nell’aria. «La libertà, Tiberio, la libertà di usare la nostra vita come vogliamo.» «Ma la frase di Paolo qual è?» Padre Ernesto allungò la mano, Tiberio gli passò la Bibbia e, sfogliatala, gliela restituì aperta al capitolo 5 della lettera di Paolo ai Galati. “1. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 2. Ecco, io Paolo vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. 3. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. 4. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella legge; siete decaduti dalla grazia. 5. Noi infatti per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo. 6. Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. 7. Correvate così bene; chi vi ha tagliato la strada che non obbedite più alla verità? 8. Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama! 9. Un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta. 10. Io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente; ma chi vi turba, subirà la sua condanna, chiunque egli sia. 11. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? È dunque annullato lo scandalo della croce? 12. Dovrebbero farsi mutilare coloro che vi turbano. 13. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. 14. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. 15. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 16. Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne; 17. la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 18. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. 19. Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, 20. idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21. invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23. contro queste cose non c’è legge. 24. Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. 25. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 26. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.” Tiberio vista la lunghezza sgranò gli occhi spaventato e padre Ernesto sorrise. «Versetto 13.» “13. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà.” Tiberio non cercava una lucidità teologica ma padre Ernesto gliel’aveva data lo stesso e lui era rimasto colpito. Padre Ernesto si accorse che Tiberio aveva calato le difese. Il suo silenzio era indicazione di un effetto di Galati su Matteo e questo era quello che voleva, poi che durasse la frazione di un secondo non importava. «Sa cosa penso, padre Ernesto?» chiese Tiberio sereno, facendo sperare l’interlocutore in una tregua. Un cenno di padre Ernesto e Tiberio continuò dicendo le stesse cattiverie sui preti che aveva detto a sister Maria. «Penso che, se preti e vescovi fossero un po’ più umili e rispettosi, sarebbe meglio.» La frase non era tenera ma nemmeno terribile come quelle di prima. «Voi sapete che qualsiasi cosa dite c’è Matteo 18 che la scolpisce indelebile, eppure non avete l’umiltà di lasciare davvero che noi usiamo la nostra libertà. Io chiedo solo di morire tranquillo e riconciliato con Dio, morire senza soffrire, morire avendo mia moglie e i miei figli vicini e un prete che mi confessa.» Padre Ernesto sapeva perfettamente quale fosse il principio teologico secondo il quale la Chiesa condanna ogni forma di eutanasia: era il principio per il quale l’uomo non è padrone della vita e non può decidere se iniziarla e tanto meno se finirla. 22 Ora però, che aveva davanti Tiberio con la sua tremenda franchezza e la sua drammatica realtà, si chiedeva davvero che senso avesse condannare l’eutanasia senza se e senza ma e si rendeva conto che la Chiesa nel suo essere Madre e Padre avrebbe fatto meglio ad accogliere questa richiesta da uno dei suoi figli. «Tiberio, ti ho parlato del Salmo 14 e di Galati 5 solo perché credo che tu debba conoscerli, possono aiutarti nel tuo travaglio. Credo, però, che dovresti davvero seguire i consigli di sister Maria e cercare di perdonarti.» Tiberio fece una smorfia con la quale ripeté tutto quello che aveva detto prima in proposito. «Vuoi confessarti, Tiberio? «Confessarmi?» «Prova.» «Cosa devo fare?» «Devi chiedere di confessarti, devi volerlo tu prima di tutto, Tiberio.» Tiberio sollevò lo sguardo per cercare la luce dentro. «Non ho rubato e non ho tradito, non vado a messa e non mi confesso, da quando mi hanno fatto quella diagnosi bestemmio e offendo la Chiesa, preti e vescovi, sono nervoso, cattivo, pettegolo, acido, distruttivo e non mi riconosco più» disse d’un fiato, lasciando scendere lacrime asciutte dagli angoli degli occhi. Padre Ernesto sorrise dentro di sé. Quello che aveva davanti era un uomo meraviglioso, se ne stava innamorando. Quelle parole buttate fuori con il cuore e senza freni erano la preghiera più bella che Tiberio potesse fare e padre Ernesto lo assolse. Capo chinato, frasi sommesse, padre Ernesto alzò la testa senza aprire gli occhi, tracciando un ampio segno della croce nell’aria mentre diceva «Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.» Tiberio trangugiò, non se l’aspettava. Credeva che ci fosse tutta una serie di riti da rispettare e, soprattutto, credeva che padre Ernesto lo avrebbe dovuto aiutare a distinguere le sciocchezze che aveva detto dalle cose serie. «Sono pulito adesso?» chiese Tiberio sentendosi un bambino. «Se davvero Matteo 18 funziona, allora tu hai appena ricevuto la grazia del perdono, Tiberio» disse serio padre Ernesto. Ci fu un lungo silenzio. «Posso rubarle ancora del tempo, padre?» «Certo.» «Senta, io prima non le ho dato soddisfazione ma la faccenda di Galati 5 mi ha colpito.» Padre Ernesto sorrise. Doveva ringraziare sister Maria per avergli mandato quel figlio di Dio così disperato e terribile ma anche così profondamente umano e dolce. «Mi dice qualcosa dei Galati?» chiese Tiberio, mostrandosi colpito dalla faccenda della libertà. «Geograficamente la zona dove abitavano i Galati era la Galazia in Asia minore, Licaonia, Iconio, Listra, Antiochia di Pisidia. Paolo aveva predicato là, dicendo che bisogna credere in Gesù, mentre dopo di lui andarono a dire che invece quello che valeva era solo la legge di Mosè. Paolo scrive che Mosè va rispettato ma bisogna anche avere fede e seguire gli insegnamenti di Gesù.» Tiberio ascoltò senza molto entusiasmo. Non era quello che voleva sentirsi dire, non gli fregava molto di quei cenni storici ma era ancora tramortito dalla confessione e non si oppose. «Il cristiano è giustificato dalla fede o dalle sue opere?» chiese a bruciapelo padre Ernesto, sapendo di fare centro. Tiberio si illuminò. La domanda gli interessava molto e padre Ernesto colse la scintilla negli occhi di Tiberio. «Paolo che diceva?» chiese Tiberio che forse se la sarebbe cavata nel dire che cosa sono le opere, ma che sulla fede non avrebbe saputo dir nulla. «La fede, il cristiano è giustificato dalla fede.» Tiberio sorrise. «Simpatico Paolo» disse ironicamente. «Ma allora, padre, io posso fare quello che voglio purché abbia fede?» «Ovviamente no, Tiberio» disse padre Ernesto. «Paolo si riferiva alla circoncisione, però il tema di fondo è proprio quello della fede.» Il volto di Tiberio si fece serio. «Comunque rispetto al tuo dramma personale, Tiberio, possiamo ben dire qualcosa.» «Cosa?» «È vero che la Chiesa condanna l’eutanasia, non c’è dubbio» disse padre Ernesto. Tiberio rimase deluso, era come se il teologo volesse difendersi con quella parole. «Però?» «Però tu devi fare la tua scelta e metterci dentro tutto l’amore possibile e, secondo me, lo stai già facendo, altrimenti non andresti da sister Maria e non saresti venuto qui.» Tiberio rise. «Siete straordinari» disse Tiberio scuotendo la testa. Padre Ernesto percepì lo stesso cinismo di prima. «Vai pure, Tiberio, vai, mettici tanto amore dentro e vedrai che poi Dio ti perdona. La Chiesa ti condanna, Matteo 18 ti manda all’Inferno, ma tu non fare caso a questi piccoli dettagli, vedrai che, se ci metti amore, Dio ti perdona» disse sprezzante Tiberio, ferendo padre Ernesto che non si aspettava un rigurgito di rabbia a quel punto. Padre Ernesto era confuso e disorientato. Gli pareva di aver fatto dei passi avanti in quell’ora. Prima quel silenzio di Galati 5 aveva segnato un punto, Tiberio era interessato, chiedeva, si era confessato, lui gli aveva dato l’assoluzione. Non ci stava quella cattiveria di nuovo. Padre Ernesto guardò Tiberio dal profondo dei suoi occhi incavati e si rese conto di una cosa. I suoi calcoli su quell’uomo erano sbagliati. C’era qualcosa di immensamente più tragico del previsto e non se la sarebbe cavata con quattro citazioni evangeliche. Ma dentro l’anima di padre Ernesto si era affacciato un altro pensiero e quello sì che era un problema. Padre Ernesto aveva fiducia in quella pazza di Dio che era sister Maria, era certo che quell’uomo non fosse uno squilibrato pericoloso, altrimenti sister Maria glielo avrebbe detto. Per quanto lui dentro avesse una fiducia sconfinata nell’anima folle di quella donna in abiti bianchi e azzurri, padre Ernesto scopriva per la prima volta di avere paura. Lui che si nutriva ogni giorno della Parola, lui che conosceva la Parola perché la mangiava, la beveva, la portava con sé ovunque e la donava a tutti quelli che gliela chiedevano, lui che era stimato e ricercato per la sua capacità di sciogliere i nodi spinosi della Parola, rendendola appetibile a tutti, ora si trovava tramortito e confuso davanti alle parole di quell’uomo che lo impauriva. «Sa cosa mi viene in mente sentendole dire queste cose, padre Ernesto?» Padre Ernesto scosse la testa temendo un’altra bordata. «Lei non ha l’età per aver visto Happy Days e non sa chi era Fonzie» chiese Tiberio con un cenno di sorriso. Padre Ernesto annuì come a dire che era vero. «Be’, Fonzie aveva una caratteristica fondamentale e sa qual era?» «Mi dica.» «Non sapeva chiedere scusa e, quando doveva farlo, per forza non riusciva nemmeno a pronunciare la parola, gli si ingolfava in gola, era come se dovesse vomitare» disse ridendo al colmo del suo cinismo. Ci fu silenzio. «La Chiesa è proprio come Fonzie, non avete il coraggio di dire abbiamo sbagliato, no, voi, dritti per la vostra strada, ve ne fregate dei poveri cristi. Nessuno di voi mi convincerà mai che ha senso ricattare un uomo con l’arma della pena assoluta, delle fiamme eterne, solo perché con un tumore in corpo che lo divora vuole crepare senza penare e con attorno i propri cari. Siete dei vigliacchi, dei bastardi, dei figli di puttana e io vi odio.» 23 Certo, stava morendo. Certo, aveva una diagnosi terribile e una prospettiva di vita infame. Certo, era lì che contava i giorni senza vomito perché, quando fosse arrivato il vomito, non ci sarebbe più stato nulla da fare. Certo, era un figlio di Dio da aiutare. Certo, andava aiutato. Certo, era venuto lì, aveva fatto la fatica di guardare in faccia il suo nemico del momento e chiedergli anche aiuto. Certo, aveva ammesso lui stesso, scusandosi che la malattia l’avesse trasformato, incattivito, che la rabbia lo divorasse e che le bestemmie gli salissero da dentro come il vomito dell’anima disperata. Tutto vero. Quelle parole taglienti, spudorate, piene di sangue e di cattiveria, dette in faccia, padre Ernesto non le aveva mai sentite. E sì che non era un novellino appena uscito dal Seminario, ne aveva visti di malati terminali, eppure non gli era mai capitata una cosa così. Aveva guardato in faccia Tiberio mentre pronunciava quelle parole offensive e terribili e si era sentito ferito nel profondo. Forse però non erano nemmeno le parole a ferirlo, forse quello che tagliava in due l’anima di padre Ernesto in quel momento, facendola sanguinare, era il fatto che quell’uomo fosse lì seduto davanti a lui, era stato Tiberio a cercarlo, era stato Tiberio a chiedergli aiuto e a farlo commuovere dicendogli, prima dell’assoluzione, come la malattia lo avesse cambiato. Ora non ci riusciva, ora padre Ernesto era tramortito dall’offesa, dallo schiaffo a viso aperto che Tiberio gli aveva dato ma nel suo profondo padre Ernesto sentiva che quell’uomo sfidava la Chiesa e che la Chiesa avrebbe dovuto avere lo stesso coraggio e guardare quell’uomo negli occhi e dirgli che aveva ragione e che nella sua condizione aveva il diritto di morire in pace. Era come se tutto quello che aveva fatto in più di quarant’anni di pastorale s’infrangesse dissolvendosi e padre Ernesto vedeva chiaramente la ragione di Tiberio e il torto della Chiesa. Ma la Chiesa in quel momento erano loro due, erano sister Maria e padre Ernesto, ed erano loro due che dovevano essere Dio per quel figlio di Dio. «Che ne dici, Tiberio, se ci rivediamo?» Tiberio non rispose con un sorriso. Quando buttava fuori calibri da novanta e li sentiva deflagrare poi aveva bisogno di tempo per riprendersi. Padre Ernesto rimase in attesa della risposta di Tiberio ma era contento ora. Non avrebbe dormito quella notte se dalla propria bocca non fosse uscita quella frase, quella domanda. Era il minimo che poteva fare per essere in pace con se stesso. Non poteva lasciare andare quell’uomo come se la sua fosse una consulenza specialistica, tipo fuori uno, dentro l’altro. Accompagnare quell’uomo in quel momento della sua vita era il suo compito e, se avesse anche solo provato a sgattaiolare via con una scusa qualsiasi, allora davvero la sua coscienza di prete e di uomo avrebbe pianto. Era riuscito a fare quella domanda con la voce intera senza rotture, senza inclinazioni, aveva padroneggiato i muscoli della laringe anche se dentro di sé stava traballando, sconvolto come era da quella paura che aveva provato prima e che non era un timore per la propria incolumità, era qualcosa di profondo e terribile che non aveva mai provato e che solo la tragicità di quell’uomo gli aveva mosso dentro.
Scaricare