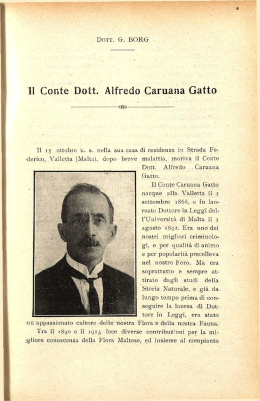godot 44 IL CONTE LIBERTINO RENZO PARIS © 2013 Gaffi editore in Roma www.gaffi.it design: IFIX «Sa di Romanzo» Roger de Bussy-Rabutin «Il pensiero dominante è la giovane principiante» Mozart Mattino Didlòn, didlòn. L’intercity proveniente da Vienna e in proseguimento per Palermo, atteso alle ore sette e trenta, arriverà e partirà dal binario undici, anziché dieci. Effettua la prima fermata a Napoli centrale. Didlòn, didlòn, attention please… Seduto su una panchina della stazione Termini, il prof Ruggero Rubanti attendeva assonnato il treno. Indossava un impermeabile chiaro sopra un paio di jeans, un maglione blu e una giacca dello stesso colore. Reggeva una ventiquattrore sulle ginocchia. Poggiava sopra la liscia similpelle entrambe le palme delle mani, godendone l’effetto sotto i polpastrelli. Tra i folti capelli neri, si muovevano, irrequieti, occhi d’anice. Meditava, in maniera discontinua, sul fatto che i prof, di qualsiasi ordine e grado, pendolari di concetto, erano scaduti a soggetti di cronaca nera. Su un cadenzato di quella linea, era stato ritrovato, nemmeno una settimana prima, il corpo sfigurato di un insegnante di liceo. A quando quello di un suo collega o, perché no, il suo? Già vedeva i titoli: “Assistente di Storia moderna dell’Università di S., barbaramente accoltellato nella toilette di un intercity Roma-Palermo”. “È giallo!” avrebbero gridato gli speaker dei telegiornali all’unisono, aggiungendo che le indagini si diramavano a tutto campo, compresi gli ambienti della camorra. I talk show, con la loro nota arroganza, si sarebbero sbizzarriti sul movente misterioso. Per l’occasione i media avrebbero rispolverato le foto di quando era bambino, quelle di sua madre, quelle delle sue donne, compresa Chantal, la sua grande amica. 8 RENZO PARIS E avrebbero interrogato i suoi colleghi che lo avrebbero dipinto come un lavativo. Non aveva nemici il prof, non aveva mai fatto male a una mosca, era rimasto single, non era gay e allora, chi l’aveva ucciso? Immaginava un lunghissimo processo mediatico sul nulla che ogni volta si mordeva la coda, infangando il suo nome per decenni, come del resto accadeva a chiunque fosse finito in quei tritacarne. L’annuncio lo obbligò a spostarsi al binario accanto. Quando tornò a sedersi, riprendendo la stessa postura, gli parve di essere stato inseguito da uno sferragliare, un cozzare di spade e di elmi, come se si trattasse di un cavaliere della tavola rotonda che, armato di tutto punto, raggiungesse anch’egli il nuovo binario. Si stropicciò gli occhi e sudando freddo ascoltò una voce simile a quella del padre di Amleto quando gli era apparso, per la prima volta, in guisa di fantasma, sulla torre antica; solo che questa aveva venature sarcastiche, che lo spaventarono ancor di più. «Ti proibisco di parlare di me!» gli aveva gridato con voce cavernosa, puntandogli l’indice contro, Roger de Rabutin, proprio lui, il conte di Bussy, protagonista assoluto del suo seminario, materializzatosi in un luogo poco consono al suo alto lignaggio. Era, neanche a dirlo, alto, statuario, vestito da soldato, come in un noto ritratto: gli occhi grandi e vivaci, i baffi molto sottili e un viso lungo e pronunciato. Gli si era parato davanti, quasi a schiacciarlo contro la colonna che perimetrava la panchina. Una massa di riccioloni biondo-ruggine gli copriva la fronte e scendeva a cascata sulle spalle, sul giustacuore foderato di rosso e ricamato d’oro e d’argento, sul mantellone blu notte, che nascondeva la spada, il vistoso reggi-palle e gli stivali alti fin sopra il ginocchio. Nei ritratti giovanili il IL CONTE LIBERTINO 9 conte aveva occhi grandi e dolci, la bocca ben fatta, il naso aquilino, la fronte prominente, il viso aperto, il corpo anguilla, i capelli biondi, delicati e chiari. Ma quella mattina aveva il viso sbattuto di un qualsivoglia pendolare di concetto, in attesa del treno. «Se non la smetti, professore, mi vendicherò. Se non bruci immediatamente quel saggio su di me, non muoverò un dito per evitarti le cose molto sgradevoli che riguardano il tuo immediato futuro. Hai le ore contate, professore!». Un venticello improvviso gli fece oscillare i boccoli d’oro, coprendogli parte del volto. «Ma quale saggio?» rispose frastornato Rubanti, scattato sull’attenti, asciugandosi il sudore della fronte e guardandosi attorno, preoccupato che qualcuno potesse ascoltarlo mentre parlava da solo. Non che non ce ne fossero di quelli che amavano il soliloquio, nelle stazioni e altrove, anzi da qualche tempo in qua erano aumentati, o almeno così gli sembrava, ma essere colto in flagrante delirio proprio non lo sopportava. «Mi riferisco ai plichi che nascondi nella tua borsa!». «Non sono prolifico io come i miei colleghi, si tratta di poche, striminzite paginette. E poi di quale futuro parli?» chiese, nascondendo la ventiquattrore dietro la schiena, per il timore che il conte l’aprisse e si mettesse a leggere ad alta voce dai suoi quaderni riempiti con una scrittura fitta, in attesa di volgere il tutto nella sua Olivetti lettera 32. «Mi sono già sbarazzato di una decina di studiosi come te che volevano fare carriera sulle mie disgrazie. L’ultimo si chiamava Joubert, che tu nemmeno hai mai sentito nominare. Anch’egli conservava in una cassa di manoscritti con parecchie pagine su di me. Sainte-Beuve, sì, il grande critico, autore di 10 RENZO PARIS Port-Royal, più di duemila e cinquecento pagine, ha dovuto cancellare il mio nome e cognome tutte le volte che compariva, proprio tutte. Poi uno stuolo di universitari come te, che hanno fatto una fine non proprio bella, cominciando da quell’Orieux che credeva di lodarmi mentre mi imbrodava». Il professore, che era superstizioso, non poté fare a meno di toccarsi con una mano la patta dei pantaloni, mentre con l’altra faceva oscillare la ventiquattrore come volesse lanciarla in aria. Ma adesso quell’illustre leggeva anche nel suo pensiero? Guardò meglio il conte. Gli parve vecchio, vicino a quel colpo apoplettico che gli tolse la vita nel 1693, a settantacinque anni. Era tornato deluso nel suo castello quando Luigi XIV, finito l’esilio, non gli aveva rivolto più la parola. «Lasciami in pace, Rabutin. Ma non vedi come sono ridotto? E ho già quarant’anni, pronto ai primi infarti, il corpo che comincia a ingessarsi. Non avrò eredi io. Di quel saggio spurio, misto a episodi della tua vita, ancorché pubblico, ti assicuro che non si accorgerà nessuno!». I rari utenti di quel treno rimasero lontani da quella strana conversazione, concentrati nel loro fumare intenso, prima di salire su una carrozza che glielo vietava. Rubanti sconsolato tornò a sedersi mentre il conte, di tanto in tanto, si voltava verso il grande corridoio, come se dovesse sorvegliare qualcosa. «Ho letto quello che ho potuto trovare sul tuo conto» diceva come a se stesso, abbassando la voce al punto che nemmeno lui la poteva sentire, come in una nenia piagnucolosa: «Mi sono sciroppato la tua Storia amorosa delle Gallie, le tue Lettere, le tue Memorie, le Massime d’amore, persino la genealogia della tua famiglia, i consigli che davi ai tuoi figli per farli crescere colti e forti, La carta della Braquerie e Le considerazioni IL CONTE LIBERTINO 11 sulla guerra, i libri apocrifi come La Francia Galante. Ho speso un patrimonio per avere le edizioni originali, le prime edizioni dei tuoi libri in pelle, che figurano come un trofeo nella mia biblioteca. Conto di diventare associato con un libro su di te che, ripeto, leggerà soltanto una innocua, sparuta, distratta, commissione di storici. Sono vivo io, nonostante il crollo di tutti i miei ideali giovanili. E adesso tu, di primo mattino, vieni a predire la mia morte. Ma oh!». Il conte, offeso da quel modo di comunicare, ma con l’aria di chi aveva già espresso il suo avvertimento mafioso, si girò di scatto e allontanò quel rappresentante del secolo delle masse senza qualità battendo i tacchi: colossale, rinserrato nel suo mantello, alla ricerca del suo irrequieto cavallo, che aveva legato al box ancora inattivo delle informazioni. Era un cavallo alto, bianco, con una criniera scura che cadeva, quando abbassava la testa per specchiarsi nel lucido pavimento della stazione, a onda sulle zampe anteriori. Il rumore cadenzato degli zoccoli sul pavimento somigliava al crepitio di una mitragliatrice. Appena lo vide la bestia iniziò a rinculare, alzandosi con le zampe anteriori, in una specie di saluto, poggiando la coda nello sportello vuoto del box delle informazioni che, in precedenza, aveva riempito di pallette di sterco. Era come se lo invitasse a saltargli sulla sella bardata di filamenti dorati, cosa che il conte fece con una certa agilità, infilando gli stivali nelle staffe, spingendolo al trotto lungo il corridoio, bene arcionato, tra l’indifferenza cieca dei viaggiatori. Guardava avanti, verso il bar Trombetta, altero, come se tutti, proprio tutti i viaggiatori e gli avventori, dovessero inginocchiarsi al suo passaggio. Quando virò a destra, tra gli eroinomani di via Marsala, Rubanti si stropicciò gli occhi e tornò al suo binario. Aveva sempre soffer- 12 RENZO PARIS to di allucinazioni. I personaggi dei libri che più lo colpivano, prima o poi si materializzavano, li vedeva. Mai che gli regalassero un sorriso, sempre accigliati se non imbufaliti. Dapprima da ragazzo erano i personaggi dei romanzi che leggeva di notte, costretto dalla madre che di giorno voleva che leggesse solo i libri di scuola, poi furono i libri di storia a ossessionarlo e prima ancora o, mescolati ad essi, quelli dei miti greci. Gli si paravano davanti, neanche fossero vivi e vegeti, come folletti, ognuno con la sua brava richiesta, come nell’inferno di Dante. Solo che il prof Rubanti non aveva il suo Virgilio a fargli da guida e certo, psicanalisti e sciamani, non erano bastevoli per un compito così difficile. Dietro una colonna comparve finalmente il treno, che, nel suo consueto ritardo, si avvicinò lento al respingente. Rubanti salì perplesso. Si sistemò in una carrozza semivuota, sbirciando dal finestrino, con il timore di rivedere quel fantasma, venuto a turbare il suo nuovo mattino. «Ma che bel cavallo!» esclamò, ricordando alcuni dei tanti cavalli nella storia dell’arte e specialmente quello del conte dipinto in un quadro appeso nel suo castello avito, che sembrava anticipare quelli dei manieristi. «Sto esagerando» si disse, «non sarò mica finito in un racconto di Italo Calvino o in un quadro di De Chirico?». Niente di tutto questo, era incappato in una nuova ossessione, come quella volta che era entrato nel salotto di uno sciamano di città per liberarsi del fantasma di Ercole, sì, proprio Lui, il dio dei palestrati, promotore, da quando non era più venerato, di ogni terremoto. Era estremo nell’amore quel semidio che si narrava violasse più di sette vergini a notte, senza tener conto della fatica dovuta al malcelato dolore di un’operazione del genere; ma di più nell’odio. Com’era stato IL CONTE LIBERTINO 13 possibile che per secoli non c’era borgo nel mondo che non sacrificasse vitelli in suo onore e all’improvviso era stato archiviato come oggetto di studio? Anche l’ultimo terremoto, quello dell’Irpinia, era stato provocato dalla forza della sua rabbia. Quante volte gli era apparso il testone di Eracle alla finestra del suo salotto, tappandola tutta, vietandogli la bella veduta del viale sottostante che finiva sulle mura aureliane. A volte non era la testa ma l’enorme piede a coprire la vista. Quando poi entrava nel salotto e si sedeva nella “poltrobabbo” che gli aveva lasciato suo padre prima che morisse, gli sembrava un sacrilegio. Era così grosso che la poltrona scompariva e la testa toccava l’alto soffitto di quella stanza e i piedi si allungavano fin nel corridoio, costringendolo a rinchiudersi nel piccolo vano del cesso, cercando di avvertire il portiere di un tale mostro che si era piazzato a casa sua. Il portiere, un giovanotto con un lungo codone che gli giungeva fin sulle natiche, rubizzo, scanzonato, lo guardava sornione e fingendo di credergli procurava tuttavia a salire in ascensore e a bussare alla porta del professore per verificare. Solo che al suono del campanello il semidio si dileguava, non tanto per paura del giovane corpacciuto e forte anch’egli, quanto per una questione di lignaggio. E chi era il portiere per poter essere graziato di una vista simile? La conclusione era la risata in sordina del guardiano, che riprendeva l’ascensore in discesa, sempre più convinto che tra i suoi casigliani ce n’erano sì di strani ma questo professore era uno dei più sconvolti. Aprì la ventiquattrore, sfilò il giornale che aveva acquistato nel chiosco della stazione, cercando di distrarsi da tutto il resto. Apparteneva alla categoria dei soprannumerari, parcheggiato nelle aule di diverse università del sud, dapprima come borsi- 14 RENZO PARIS sta e poi, con decreto sindacale, assistente e ora, se non vinceva l’ultimo concorso di associato, ramo secco a vita. Contava fino a quel momento di stupire il suo capo, il prof Drago, specialista di Richelieu, e il ristretto mondo degli storici senza più Storia, con quel volume sul conte gentiluomo. Era anche andato a visitare il bel castello avito nelle sue terre della Borgogna, ne aveva ammirato le guglie azzurro cupo, il giardino verdeggiante, le grandi stanze zeppe di ritratti dei suoi avi, lo studio dove aveva vergato gran parte delle sue opere. Escluso dai lauti stipendi degli ordinari, i baroni, proprio quelli che avevano ossessionato la sua ribelle gioventù, Rubanti cercava di recuperare il sonno perso, arrossando una guancia sulla ruvida tela, chiudendo gli occhi per non vedere la teppa internazionale che avanzava, senza che i faretti dei media ancora se ne accorgessero, fin nella prima classe di quel cadenzato pubblicizzato come un intercity. Che mattino scombussolato! Scosso all’alba dal reiterato bip della sua sveglia, il professor Rubanti aveva subito poggiato i piedi nudi sul pavimento. Si era difeso da un raggio di luce che aveva colpito il suo occhio sinistro, quello dove ci vedeva di meno. Sbandando paurosamente nel corridoio che divideva la sua camera da letto dal bagno, aveva urinato a fatica. Era rimasto inebetito a guardare la tazza, attendendo la comparsa di quei leggendari topi nuotatori che, a detta di molti, soprattutto nei primi piani dei palazzi antichi, di tanto in tanto affioravano, castigando i gioielli di chi spremeva il ventre per augurarsi una felice, sgombra, giornata. «Noo!» si disse, vedendone uno affiorare «non sei vero!». Sgrullò il pisello e andò a lavarsi la faccia, a sbarbarsi, stando attento a ripetere quei gesti abitudinari almeno nove volte, IL CONTE LIBERTINO 15 partendo dal tre, che era il suo numero preferito. L’antico tatuaggio sul collo, una decina di righe nere che terminavano con la sua data di nascita, stava stingendo. Gliel’aveva tatuato una ragazzina indiana in un suo viaggio a Delhi, una specie di codice a barre, come fosse il retro di un libro. I suoi colleghi l’avevano preso in giro per qualche tempo, finché non si stancarono di sottolineare le bizzarrie di quel professore, che non aveva fatto carriera secondo loro, perché aveva creduto nella Storia e in specie a quella Moderna, legata a filo doppio con la Rivoluzione. In realtà il nostro voleva ricordare a se stesso più semplicemente di essere una merce umana, degradata, scaduta. No, non si piaceva proprio davanti allo specchio. Faceva boccacce per sembrare un mostro. Per rianimarsi di solito entrava in cucina e si preparava un caffè. Sedeva davanti alla finestra che dava sul giardino, pensando di ascoltare gli uccelli che salutavano il sole, lieti di esserci, invece le cornacchie avevano azzittito gli usignoli e anche i gabbiani si erano dovuti allontanare, se non volevano fare la fine dei piccioni. Quei feroci gabbiani, che da qualche anno erano triplicati in un cielo che solo negli anni Settanta non ne aveva visto nessuno, gli ricordavano che Roma era vicina al mare. Dopo il caffè si era rollato uno spino. E così, alleggerito dei pesanti sogni notturni, aveva infilato una cassetta porno nel suo videoregistratore. Voleva rivedere il fiore aperto di quelle ragazze dell’est, un fiore straziato da sessi nerboruti e per nulla eleganti, che il conte di Bussy avrebbe classificato come asinini. Ma non era tanto il mercato dei genitali a solleticare il nostro quanto le voci che, a volte, non gli sembravano finte, dico le voci femminili che simulavano l’orgasmo. Il set della cassetta di quella mattina era un orto con una capanna. All’interno della capan- 16 RENZO PARIS na una ragazza bionda fornicava con un ragazzo che era entrato all’improvviso mentre lei si ficcava la mano nella vagina, tra la paglia odorosa. Naturalmente la telecamera ora riprendeva, e l’audio trasmetteva dei sospiri che sembravano reali. Dopo quel su e giù entrò un uomo anziano, un contadino, che si sbottonò i pantaloni e cacciando il ragazzo in malo modo, poggiò il glande sulle labbra della ragazza. Quella, ingorda, cominciò a succhiarglielo. La gara era aperta. Chi la faceva godere di più? Ma l’anziano, a stare alle grida scomposte della pollastra ammaestrata! Attraverso la paglia adesso filtrava il letame e il corpo di lei mentre godeva, sembrava si rotolasse dentro un truogolo di maiali. L’Italia era stata invasa dalla pornografia negli anni Settanta, ma era soltanto alla fine di quel decennio che era entrata in massa nelle famiglie italiane, che la usavano per rinverdire gli amori finiti. Ce n’erano di costosissimi, dove si poteva assistere a sedicenti squartamenti in diretta di ragazzini e ragazzine, a cani che montavano furiosi le loro padroncine, a cavalli che penetravano sessi slargati di donne assatanate, a teen di dodici tredici anni che allargavano il loro sesso fino a farci entrare mezzo braccio, a vagine di neonate a gambe larghe sul seggiolino e poi il corteo delle lesbiche e dei gay, ma le cassette più deliziose, secondo Rubanti, erano quelle dei cartoni animati giapponesi, dove l’audio era perfetto e la fica, chissà perché, sempre misteriosamente oscurata insieme ai sessi maschili. Oh le ragazzine giapponesi che si truccavano, posando da neonate, con quelle vocine da sturbo! Quelle ambientate in Thailandia, in Cambogia, nel turismo sessuale dell’Oriente, presentavano ragazze magre come alici. Lasciavano ai loro montatori i sospiri del godimento, mentre, soltanto alla fine, emettevano soffi anoressici, appena percettibili. Se IL CONTE LIBERTINO 17 qualcuno gli avesse detto che, trascorsi pochi anni, anch’egli avrebbe avuto un computer dove collegarsi in internet nei siti pornografici di tutto il mondo, Ruggero non ci avrebbe creduto. Tutti incollati, fin dal mattino, su sessi di ogni dimensione, a masturbarsi davanti all’inorganico. “Non sono dio, nemmeno un semidio e allora perché per tanto tempo ho pensato che la morte non mi riguardasse? È possibile che la stupidità umana sia vicina al periodo della vita migliore, la giovinezza?”. Aveva chiuso il videoregistratore ed era tornato alle sue ubbie. Già, perché Ruggero Rubanti da quando aveva cominciato a criticare, nei momenti di acidità mescolata all’invidia, una giovinezza che non possedeva più, non faceva che pensare alla morte. Ad esempio, non gli piacevano più i romanzi di formazione dell’Ottocento, che lo avevano deliziato verso i trent’anni, pieni di giovanotti pronti a sperimentare qualsiasi cosa pur di uscire dal tunnel giovanile. Gli unici romanzi di formazione che sopportava, l’avrete capito, erano i dvd, dove c’era un vecchio che insegnava alla fanciulla il modo migliore per godere. Il sesso pedagogico, ecco dove si era rifugiato il romanzo di formazione. Quello che Rubanti non aveva previsto era la fortuna dei gialli, che allora erano considerati spazzatura di cui vergognarsi, da lasciare sui sedili degli scompartimenti dei treni e che presto, invece, rinnovellati con la parola noir, sarebbero entrati nelle sfacciate classifiche dei libri più venduti. Vispo e speranzoso, nonostante tutto, del nuovo giorno, Ruggero si era infilato i jeans, il maglioncino blu e la giacca dello stesso colore, l’impermeabile ed era uscito di casa, in leggero anticipo, pur sapendo che il treno avrebbe avuto una mezzoretta di ritardo. Per strada sentiva dentro di sé una voce che sem- 18 RENZO PARIS brava provenire da una caverna. Non era la prima volta che la ascoltava. Era come un rumore di tuono lontano. Attorno a lui tutto sembrava reale ma dentro di lui c’era un’altra dimensione che, con il passare degli anni, si era ingigantita, divorando la realtà quotidiana, quella più rassicurante. Mentre metteva i piedi uno dietro l’altro, sembrava che l’asfalto si aprisse e scoprisse una vera selva di ossa. Quella voce adesso gli indicava il suo scheletro fresco, ancora inzuppato nel sangue e nella carne. All’imbocco di via Marsala, un barbone lo aveva salutato con una strizzatina d’occhio. Ruggero gli aveva sorriso. Ecco una persona reale, fiera del suo spago che aveva attorcigliato prima sui suoi pantaloni e poi attorno al palo della luce, in modo tale da rimanere imprigionato. Era quello uno dei primi barboni che avevano scelto come residenza estiva e invernale i portici matematici della stazione. Quel suo impiegare tutto il tempo nell’avvoltolare uno spago bianco attorno ai pantaloni, come volesse sembrare un antico pastore errante nell’Asia, quel guardare il professore come per chiedere un parere, ne faceva un eccentrico come il barbuto, che dormì nella sua Renault rossa un paio di notti e quando il prof lo redarguì, costringendolo a uscire, quello rispose: «E io dove vado a dormire adesso?». Ce n’era un altro, davanti al bar Trombetta, tutto ripiegato in due, sempre con lo stesso impermeabile grigio sporco, che parlava da solo già a quell’ora del mattino. Che meraviglia chiedere un cappuccino con un cornetto e berselo con calma, avvertendo, mentre scendeva nello stomaco, il riavviarsi del sangue nelle vene. Era lì insieme a un trans altissimo e due turisti inglesi. La voce, nel frattempo, era scomparsa. Sotto i portici dormivano eroinomani che, una volta svegli, restavano pencolanti tutto il dì finché non stramazzavano al IL CONTE LIBERTINO 19 suolo. Declinata l’offerta di una vecchia zingara slava per un bocchino veloce nel sottopasso con la figlia tredicenne, che l’attendeva già con la bocca aperta; scansate le zingarelle, che già dalle sei del mattino attendevano l’obolo degli assonnati viaggiatori, aveva guadagnato finalmente il suo binario. Nel dormiveglia, sbirciando dal finestrino, gli era sembrato di aver visto una gonna frusciare sopra due gambe snelle e scattanti, nel marciapiede ormai affollato. L’aveva subito riconosciuta. Quella gonna apparteneva a Chantal, docente di filosofia antica della sua stessa università. E andava fluttuando nella direzione opposta di chi prende il treno. In uno scatto improvviso, che gli aveva fatto cadere il giornale e la ventiquattrore sul pavimento, Rubanti aveva gridato il nome di Chantal, aveva gesticolato ma era ricaduto sul sedile con la voce di quella cocciuta single nelle orecchie. Quel modo di camminare a grandi falcate, quel modo di spostare la massa dei capelli come se dovesse prendere il volo, quell’occhio vigile, estintore di qualsiasi ombra, rivelatore di ogni più nascosto desiderio maschile, lo impietrivano. Scendevano da quei treni alla sera stremati, si davano appuntamenti che spesso, all’ultimo momento marinavano, come se la comunicazione fosse legata soltanto alla velocità delle rotaie, che spingeva Chantal a superare con la voce quel clangore. Spesso tra loro avvenivano dei veri e propri corti circuiti ed era come se, in quelle occasioni, lo pregasse di attendere ancora un poco. Era quella l’amicizia amorosa, cantata dai poeti? Un possibile bivio per l’amore tout court? L’amicizia e l’amore, un tema seicentesco quanti altri mai, che compariva in tutti gli epistolari più famosi dell’epoca, compreso quello tra il conte di Bussy e sua cugina Madame de Sévi- 20 RENZO PARIS gné. Che meraviglia quelle conversazioni scritte, dove giocavano abilmente il ruolo dell’Honnête homme e della Honnête femme contro le dame prudes e coquettes, senza per questo diventare conversazioni devote! Rubanti aveva smesso del tutto di considerare Chantal come una donna sensata, di quelle sedute nella carrozza ristorante a sorseggiare bevande calde con gli amici e gli occhi sbarrati sul vetro appannato. Chantal correva dietro a chi sa quale nuova avventura; magari era appena scesa da un treno del nord. Dopo aver sistemato nel bagagliaio la ventiquattrore riaprì il giornale. Il treno si stava finalmente muovendo, riempito di extracomunitari. Erano rifugiati politici, ma anche tra i primissimi in cerca di lavoro da noi, iniziando l’ondata che a metà degli anni Ottanta diventerà inarrestabile. I giornali parlavano del Veneto arricchito, dei giovani che preferivano lavorare in fabbrica invece di andare a scuola e non ancora dell’immigrazione che era già cominciata, silente, nei primi anni Settanta, con la crisi del petrolio. Di quei fogli preferiva quelli culturali, dove c’erano le recensioni a libri considerati importanti. Tuttavia le firme più note della terza pagina di quel giornale le conosceva anche di persona oltre che nei loro gusti. Non c’era più insomma la novità e la lettura procedeva svelta e senza sugo. Quanto lontani i tempi di quando comperava i giornali stranieri francesi, inglesi e americani e tutto sembrava una novità. Le Grandi Narrazioni erano scomparse non soltanto nella mente degli storici più importanti ma anche nei narratori che puntavano al Nobel. Si era all’improvviso ridotto il paesaggio, particolarizzato. Tutto era diventato minimo e il mondo sembrava finalmente a una sola dimensione, quella americana. Questo gridavano quei giornali, senza il minimo IL CONTE LIBERTINO 21 sospetto della grande Globalizzazione che di lì a poco avrebbe riacceso guerre e narrazioni. Verso la stazione di Fondi lo svegliò l’Uééé lungo e roco del collega Filippo Disastro; così soprannominato per un saggio su Sartre, che, pubblicato con i soldi dell’università, aveva poi inflitto a tutti i colleghi, compresi i bidelli. Filippo Disastro vestiva rigorosamente di nero, ma non come un punk, bensì come un uomo provato da continui lutti famigliari, mentre avrebbe voluto sembrare un esistenzialista fuori tempo massimo, sbirciato con curiosità dalle dark di Sessa Aurunca, che andavano a Napoli a studiare. Filippo gli si sedette di fronte con la bocca aperta, come se ci tenesse a un suo commento, finché non gli rubò il giornale, per leggere, diceva, le colonnine dei messaggi delle puttane. «Ma stamattina non mi chiedi niente?» gli disse all’improvviso. «Che stupido!» esclamò Rubanti, «il solito». Filippo, guardandosi attorno, tirò fuori da una tasca interna della giacca una bustina di erba e gliela allungò. Rubanti la nascose nella tasca dei pantaloni e pagò le trenta dovute. «Questa è buona eh», disse Disastro, che vendeva l’erba ai prof della sua università, arrotondando il magro stipendio. «Dove la prendi? Sempre dallo stesso gruppo? Ho letto che si stanno ammazzando tra di loro, che è ricominciata la guerra della camorra». Disastro rispose che quella guerra non era mai finita, che lui l’erba la prendeva da un suo parente che lo teneva aggiornato, un giovanotto che non aveva voluto continuare gli studi e che già al liceo si era accantonato un bel gruzzolo. «Certo è rischioso fare il pusher serio, mi ha detto, ma ne vale la pena, è il mestiere del futuro!». Disastro si permise anche un consiglio. «Quel mio parente mi ha detto che se vuoi puoi fare il corriere da Roma a S. e ritorno. 22 RENZO PARIS Uno alla stazione ti dà le bustine, ma questa volta sono di polvere bianca e a S. un altro te le prende. Ci fai bei dobloni, pensaci. Mostro sacro!». Per la verità Rubanti aveva pensato da subito di mettere a frutto tutte quelle ore di viaggio, ma non per fare il corriere della droga, altrimenti con un volo a Medellín avrebbe guadagnato molto di più. Aveva pensato a trasportare merce di lusso, oro, gioielli. Ma rispose a Disastro di tenerlo in caldo quel giovanotto, ci avrebbe pensato su, soprattutto ai rischi che correva. «Siamo incensurati, i prof universitari! Chi ci pensa a noi!» aveva risposto Disastro, riprendendo a leggere il giornale. Rubanti si intristì, pensando a come era caduto in basso il suo mestiere, a come non era più distinguibile nemmeno dagli abiti. Una volta i prof universitari indossavano i pantaloni a coste, le giacche inglesi, avevano un loro fascino. Da più di un decennio invece vestivano casual, all’americana, e mai nessuno, vedendoli, avrebbe potuto intuire alcunché. Dopo il francesista dovette sopportare la presenza dell’ispanista Gullitor, brizzolata figura della sua università. Anzianamente signorile, Miguel, lo spettro di tutti loro, abbonato a vita alle Ferrovie dello Stato per un pugno di stupidotte, come chiamava le sue studentesse che inciampavano sull’italiano figurarsi sullo spagnolo, ritto sulla porta e attorniato da assonnati maghrebini che sognavano l’ombra dell’albero dove avevano stazionato fino al giorno prima, pareva un notturno vascello, appena rivelato dalla luce del mattino. Si lasciò cadere nel posto vuoto, esibendo un eterno sorriso. Si appisolò subito dopo, suscitando lo stupore di Filippo che si aspettava le feste dell’ispanista, lasciando sulle ginocchia una plaquette, sempre la stessa, su un petrarchista, che gli specialisti consideravano IL CONTE LIBERTINO 23 una finzione e che Gullitor invece, dopo anni di ricerche, aveva scoperto corrispondere a un corpulento portoghese del Seicento, autore di sonetti sfacciatamente italianeggianti, in onore di dame napoletane simili a trumò. «Questo beve solo vino, è la sua droga!» disse Disastro, aggiungendo: «Ancora il terremoto!», leggendo ad alta voce un articolo sul terremoto dell’Irpinia, di cui anche la loro università aveva subito da poco le scosse. Erano infatti quelli i primi mesi di ripresa dopo il terribile sommovimento tellurico che aveva distrutto ben 66 paesi della provincia di S. I professori che avevano trascorso le feste di Natale e Capodanno nelle loro città d’origine, per lo più del nord, ripresero in quel funesto fine gennaio 1981 le lezioni, ma sempre con il piedino, per così dire, fuori dell’aula, per scattare verso la stazione, verso le rotaie della libertà. Rubanti ricordava bene che il terremoto aveva sorpreso quelle teste d’uovo nei ristorantini del golfo, dinanzi a un piatto di gamberoni e una bottiglia di Gragnano. Era il ventitré novembre 1980, ore diciannove e trentaquattro. Le scosse furono due, di novanta secondi l’una, di magnitudo sette per alcuni e dieci per altri, a seconda della scala, Richter o Mercalli. Scosse che fecero duemila morti per alcuni e duemila e novecento per altri. In Italia, si sa, il mistero si infittisce su tutto, anche su chi ha aperto il gas prima che la casa esplodesse. Trecentomila senza tetto e centomila feriti. Settantasettemila case distrutte. I paesi di Lioni, Baronissi, Conzo, Sant’Angelo dei Lombardi, Pescopagano, comparvero nel telegiornale la mattina dopo il disastro. La televisione, che era a colori già dal 1977, era lenta e i soccorsi poi ancora più lenti. I nomi di quei paesi a Rubanti ricordavano la provenienza di molte delle sue studentesse, che prendevano 24 RENZO PARIS autobus all’alba per raggiungere dapprima il villino dell’università, sito sotto il grande ponte dell’autostrada e poi il palazzo di sei piani accanto al fiume psichedelico, con le aule ricavate dalle stanze da letto e le camere da pranzo di quel casamento. L’università che si doveva costruire a Fisciano, in provincia di S., era ancora di là da venire. Il presidente Pertini contro il parere del presidente del consiglio, che allora era Forlani, si avventurò in quei paesi per portare conforto, con la sua pipa eternamente accesa. La sera del terremoto Rubanti aveva disertato i ristorantini del golfo zeppi di colleghi che proprio non sopportava e si era seduto nella cucina popolare di un oste di Baronissi, che parlava molto, fino a farsi fiorire la bava alla bocca e in dialetto stretto, ma sapeva fare una pasta al pomodoro davvero speciale. Tutto tremò e ballò in quel cucinino, dopo un rombo mostruoso. Ruggero Rubanti fece appena in tempo a uscire che fu travolto dalla folla che, urlando «a mare! a mare!» si precipitava verso il porto. All’improvviso quella folla, un momento prima così certa della bontà del mare, della sua protezione, tornò a correre in salita verso l’autostrada, temendo un maremoto, che li avrebbe risucchiati come nel ventre di una balena. A quel punto Rubanti si fermò, si sedette su una panchina e finse che non fosse successo nulla, attendendo con calma la sua fine. Si era arreso, come Gesù. Ricordò il terremoto del Belice nel gennaio 1968, le immagini in bianco e nero del disastro. Poi però lo assalì un vero e proprio terrore. Si alzò di scatto e si precipitò alla stazione dove prese il primo treno per Roma. Rinchiuso nella toilette, vomitò anche l’anima. Fu allora che gli comparve nello specchietto il faccione di Ercole, che gli diceva che voleva essere adorato ancora, che era IL CONTE LIBERTINO 25 il dio dei “tremoti”, che ogni tanto per l’ira dell’abbandono e della dimenticanza, si girava e rigirava sotto terra, provocando boati e distruzione. Cadde in ginocchio. Gli promise che sarebbe andato in pellegrinaggio nei paesini dell’ex lago del Fucino, dove si narrava fosse andato a morire, lontano da Deianira, che avrebbe convinto la gente di Trasacco, di Venere ad innalzare un altare, a sacrificare un vitello, ad arrostirlo, per fargli respirare quel devoto fumo. Conosceva bene quei luoghi dove i suoi genitori avevano trascorso infanzia e adolescenza. Era stata sua madre a raccontargli che quando ballò la terra nella Marsica, agli inizi del Novecento, la gente pensò subito a Ercole, che era morto proprio dove si era aperta la faglia disastrosa. Lei, da piccola, schizzava fuori di casa ogni anno e a notte alta, così come era vestita, appena quel dio si rigirava. Oh il corpo palestrato di Ercole che fin da piccolo aveva dimostrato la sua forza contro i serpenti, che avrebbero voluto soffocarlo nella culla. In Campania, in Abruzzo, come nel Lazio e in tutte le regioni italiane c’erano tracce del suo passaggio, resti di templi e di statue. Rubanti era rimasto affascinato dagli ultimi anni di quel grande, rifugiato nei monti brulli di Trasacco, da dove ammirava la vitrea acqua del lago di Fucino, cantato da Virgilio, che per primo notò la sua vitrea unda. Visse con la sua giovane amante, mentre sua moglie piangeva e lo malediceva, spedendo il figlio a ricercarlo. Per ben difenderlo dai rigori dell’inverno, gli fece pervenire il manto di chi prima di morire gli aveva promesso vendetta, del bilioso Centauro di nome Nesso che aveva osato, trasportando sua moglie nelle acque del fiume, desiderarla. Ma quel manto gli scorticò la pelle e Ercole tanto ne soffrì che fece innalzare una pira, si sdraiò su quella legna e pregò la sua amante di accenderla. Questa volta non si 26 RENZO PARIS trattava di un vitello, ma il suo stesso corpo era carne da sacrificio. Felice Roto, lo sciamano di città, a cui lo aveva indirizzato Disastro, sudò le proverbiali sette camicie prima di liberarlo da quella grande ossessione. Era posseduto da un dio potentissimo, che, per fortuna, non lo volle più come devoto. Già, perché Rubanti apparteneva alla genia dei laici devoti che alla fine del Novecento erano diventati una vera fiumana, annidati dovunque, tra sottane e cattedre. Era la paura dell’ignoto che li spingeva per l’intanto a farsi il segno della croce, pur non ricevendo alcun accenno dall’altro mondo. Felice Roto era stato in Nepal dove aveva conosciuto il suo spirito guida. Tornato in Italia riceveva in casa e nei casi eccezionali si spingeva anche negli appartamenti dei pazienti per cacciar via la folla degli spiriti cattivi. Era uno sciamano di città, come ce n’erano a New York. Si servì anche di un saggio di Rubanti sugli ultimi giorni di Ercole dove in maniera a volte molto sboccata citava i suoi amori con la giovane amante. Ercole, il dio dei palestrati, era capace di far godere la sua fresca amante anche settanta volte di seguito, superando il numero di Messalina che si fermava a venticinque, nonché quello dell’Indiano citato da Rabelais e riferito a Teofrasto che era rimasto bloccato a settanta. Rubanti conosceva Il supermaschio di Alfred Jarry ma le imprese erotiche di André Mercueil gli erano sembrate mentali, dettate da uno spirito avanguardistico, legato più alle macchine che ai corpi. Ercole non si sarebbe spaventato della macchina dell’amore e dei suoi riscaldamenti, l’avrebbe fusa con la sua grande energia umana. Mentre Gullitor sonnecchiava, Filippo Disastro non la smetteva di commentare ad alta voce l’articolo sui soccorsi: «Ma se sono arrivati cinque giorni dopo l’evento, quando la maggior IL CONTE LIBERTINO 27 parte degli anziani e dei bambini era spirata sotto le macerie! E nessun accenno alla camorra che si è accaparrato tutto il bottino degli aiuti statali e no. E mai che dicessero che ci vogliono le case antisismiche, che siamo messi come il Giappone e quelli hanno provveduto da tempo!». Annoiato dai discorsi inutili, visto che non era accaduto nulla sul piano della ricostruzione, Rubanti notò un muso di cavallo che compariva e scompariva fuori dal finestrino, come se quest’ultimo fosse il riquadro di un televisore. Si precipitò a guardare meglio. E vide il suo conte che gareggiava in velocità con le macchine in un tratto della statale Roma-Napoli, ben assiso sul suo cavallo bianco. Quell’animale correva tra le vetture, come un ghepardo a caccia di gazzelle. Tra le zampe anteriori e quelle posteriori, nel salto lungo, superava due bolidi alla volta. La fluente capigliatura che copriva parte del mantello del cavaliere, gareggiava con quella scarmigliata del conte. Erano talmente confusi che sembravano appartenere al corpo di un centauro redivivo. Quel tratto di strada scomparve quando il treno si infilò in un tunnel e con esso il cavallo e il cavaliere. «Pazzo!» disse Rubanti, al cavaliere ma anche un poco a se stesso, ché quella mattina delirava più del solito, e si rimise a sedere. «Ma come può un cavallo gareggiare con un treno?». Nella stazione di Priverno, cavallo e cavaliere ricomparvero accanto al capostazione, il quale aprì la porta del suo scompartimento con l’aria di omaggiare un simile illustre signore, capitato per caso nella sua stazioncina di provincia. A ben vedere però non era il conte che omaggiava ma una avvenente signora che procedeva al suo fianco. Il conte tirò sul treno anche il cavallo e si sistemò accanto al finestrino insieme a un giovane africano. Ruggero tremò: «Ancora lui! E il cavallo?» sospirò. 28 RENZO PARIS Sentì un nitrito che proveniva nella direzione del bagno. Quel povero animale, con le froge fumanti, piegato ad angolo retto, aveva il petto e il muso nel corridoio e il di dietro dalla parte della porta del cesso. Ora si trattava di sapere come facevano gli avventori di quel treno a passare nel corridoio del suo scompartimento per raggiungere il ristorante bar. «Pazienza, è pur sempre un fantasma», si disse Rubanti, ridacchiando sulla sua follia visionaria. Non aveva scritto un rigo sull’Africa il conte di Bussy. Le uniche persone di pelle scura che aveva fatto in tempo a vedere, erano disegnate negli schizzi mostruosi delle rare gazzette che parlavano del Nuovo Mondo, popolato di gente dalla pelle scurissima. Che effetto doveva fare a un superbo esemplare della corte di Luigi XIV quel ragazzo africano! Eccolo infatti che lo allontanava con robusti spintoni, chiamandolo «scimmia». «È finito il transfert, caro conte… non riesco più a identificarmi con te. Troppo tardi! Non sei più il mio ideale. Cadute le ideologie della fame, sono una persona sola, come tutti, in una comunità impossibile, attorniato dalle ombre di sempre. E poi cosa c’è di così tanto sgradevole nel mio futuro prossimo?». «Ma che stai dicendo?» gli chiese Filippo Disastro «cazzo, con chi parli?». «Niente, niente, sta tranquillo. Ripassavo la lezione del mio seminario ad alta voce. Nulla di cui preoccuparsi, non sono ancora del tutto scimunito come…» e accennò con il volto a Gullitor, indicando i pantaloni con la zip aperta e la mutanda ombrata bene in vista di quell’emerito spagnolista, che un giorno avrebbe varcato la soglia del Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica, in devoto ascolto dei suoi consigli politici. Disastro rise. Intanto il conte ammirava il IL CONTE LIBERTINO 29 fondo schiena dell’avvenente signora omaggiata dal capostazione. Sembrava volesse avvertirla della presenza del suo cavallo, che non andava disturbato, essendo molto sensibile a ogni strofinamento, per di più femminile. Rubanti si sentì a un tratto appesantito. Si toccò la fronte e la trovò, guardando nello specchio, piena di capelli non suoi. Si avvicinò al finestrino. Mise una mano sulla sua spalla, ancora boccoli d’oro. «È troppo, questa me la paghi», disse rivolto verso la toilette, dove pensava si fosse rifugiato per sorvegliare il suo cavallo. Invece il conte, vestito del suo impermeabile bianco, con le mani appoggiate al finestrino aperto, si prendeva il vento in faccia come un anonimo passeggero del Novecento. Guardava con compassione quelli che non avevano ancora trovato il posto giusto e uscivano dalla pancia del suo cavallo come fosse quello di Troia. Una cosa gli era rimasta del suo secolo, il reggipalle, davvero spropositato. Rubanti tornò a sedersi. Ora Disastro si lagnava della situazione politica, dell’ascesa dei socialisti, che neanche quelli gli piacevano, nonostante fossero stati loro ad aprire le università con il primo centrosinistra degli anni Sessanta ai non figli di papà. Per calmarlo Ruggero commentò: «Non c’è via di uscita… il popolo ha i governanti che si merita, sono l’uno lo specchio dell’altro», ma il tono della sua voce era così sfalsato che anche Disastro lo notò e scoppiò a ridere dicendo: «Senza passato e senza futuro, eh, obbligati a guardare fisso il presente. Ma che schifo!». Rubanti si guardò le scarpe e non le riconobbe. Ma dov’erano finite le sue clark azzurrine? Calzava invece un paio di stivali che sembravano fuori moda, ma tanto fuori che non ci volle molto perché capisse che erano gli stivalacci del conte. E poi non erano 30 RENZO PARIS della sua misura! Il suo piedino non aveva nulla a che vedere con quello erculeo del libertino. Il conte dunque si prendeva gioco del suo specialista e per fortuna che rimaneva privato, senza che né Disastro né Gullitor potessero appurarne nulla. C’era però l’africano che si era messo a guardarlo con curiosità, dopo aver risposto a male parole al conte che lo linciava con gli occhi. Rubanti si guardò le mani e scoprì che le aveva piene di anellacci d’oro, con accecanti rubini. Quando voltò la testa nel corridoio, l’africano bofonchiava qualcosa con un signore vestito proprio con i suoi abiti. Rubanti, infastidito, si alzò e entrò nel corridoio per farlo smettere. «A me i travestimenti non sono mai piaciuti, caro conte, perciò ridammi i miei abiti e continua pure la tua cavalcata da Grand Tour altrove. Questo è un treno di pendolari, di gente che va a lavorare di mattina presto. Quello che ti è accanto è un povero cristo venuto qui per chiedere l’elemosina a gente ferocissima, lui sa di magia, ti ha visto per quello che sei; lui sì che s’intende di magia, di vudu… e speriamo che non lo faccia, altrimenti, caro conte, muori per la seconda volta». L’africano scoppiò a ridere e li lasciò, procedendo verso la toilette. «Per favore, a Napoli scendi con il tuo cavallo e sparisci, capito?». Il treno si era avvicinato alla stazione partenopea. Dal finestrino si vedevano le bufale dei camorristi che pascolavano in una specie di palude nera, poi grandi filari di viti alte quanto gli alberi che le sostenevano. Il cavallo adesso era scomparso. Gli era sembrato di vederlo abbeverarsi nella fontana delle bufale, sporcarsi il bel manto bianco. Del resto, come poteva resistere quel povero animale sia pure immateriale, incastrato tra il bagno e il primo finestrino? «A quale casato appartengono queste terre?» chiese Rabutin. Rubanti non fece più caso al cavallo, visto che quella mat- IL CONTE LIBERTINO 31 tina il virtuale superava di molto la rugosa realtà. Decise di stare al gioco. «Caro conte, mi corre l’obbligo di aggiornarti. Il re di Francia, durante la rivoluzione, iniziata nel 1789, fu ghigliottinato. E il nostro re fu esiliato, alla fine della Seconda guerra mondiale, quando il popolo scelse la Repubblica. Perciò, fattene una ragione, voi nobili siete finiti da un bel pezzo» rispose con calma. «Che vuol dire ghigliottinato?». «Che gli hanno mozzato la testa in un sol colpo, zac!». «Immagino che sia stato un Bassompièrre». «No, niente crapuloni, sono stati i rivoluzionari, gente che non esisteva nella tua epoca». «Frondeurs dunque. Non c’è più la monarchia assoluta?». «È scomparsa, mio caro, datti pace, e dove c’è ancora, come in Inghilterra, è solo un cimelio». «Tutti malnati, senza merito, borghesucci, gentucola! Dove sono finite le parole come: nobiltà, esprit, bellezza, coraggio? Che cosa credete di aver fatto inventando questi aggeggi infernali chiamati treni. Avete perso il punto di vista di chi cavalca e poi in velocità il mio cavallo dà i punti al vostro treno. Ma come fate a ubbidire a uno che non ha il sangue blu? Dove la prendono l’autorità i vostri padroni e i vostri giudici? Da quella scatola dove si vedono immagini? E non vi siete ancora ribellati? E che idea di giustizia avete? Immagino che la Chiesa abbia vinto su tutto». «Né Monarchia né Chiesa, anche se il papa è l’ultimo imperatore». Rubanti non se la sentì di vantare la superiorità di quel treno, che al massimo toccava i novanta chilometri all’ora. Ma volle 32 RENZO PARIS precisare: «Si chiama massa, Rabutin, la massa colorata che vedi deambulare qui e che vedrai anche a S. quando scendiamo. Molto schematicamente: prima c’era la Monarchia, poi la Borghesia, stufa di finanziarvi le guerre, vi ha ghigliottinati e se l’è dovuta vedere con il proletariato, quelli che non hanno niente se non la prole. La guerra tra borghesi e proletari è tutt’ora in corso, ma è ridiventata la vecchia guerra tra ricchi e poveri. I nobili, quelli rimasti, quando hanno avuto qualcosa da vendersi, hanno fatto gli stilisti o hanno affittato i loro castelli ai grandi attori americani». «Ma chi dà il beneplacito per stampare lettere e memorie, se non c’è più il Re?». «Bella domanda. È l’editore che decide se stampare o no e lo fa solo se guadagna». «Dunque anche l’arte è diventata merce, vile denaro». «Proprio così. È la democrazia magica, Rabutin!». «La ruota girerà di nuovo a nostro favore, una volta toccato il fondo dei malnati». Adesso però era il professor Rubanti a fare le domande. Come non approfittare di un testimone del Re Sole e della grande arte del Seicento? Guardò nello scompartimento e si accorse che anche Disastro sonnecchiava, anzi russava, con la bocca aperta e rumorosamente. Si vedevano i molari guasti e i denti d’un color grigio topo. Non avrebbe mai immaginato allora che un giorno, l’ambasciatore francese a Roma lo invitasse a tenere compagnia agli scrittori di successo durante fastosi pranzi con vista sui giardini pensili. E nemmeno di conversare con loro, di dare consigli all’ambasciatore sugli artisti italiani da invitare. Dopo aver chiesto dei grandi tragediografi, da Corneille a Racine, IL CONTE LIBERTINO 33 Ruggero volle sapere da quel pazzo scatenato se aveva mai conosciuto Madame de Lafayette, autrice del romanzo che all’unanimità viene situato all’origine della letteratura moderna: La principessa di Clèves. «L’ho incontrata qualche volta, ma non l’ho frequentata. Certo, ho letto quel suo romanzetto. Fecero un gran rumore lei e La Rouchefoucauld, anche se non lo stampò con il suo cognome. Si vergognò di firmare un libro considerato di intrattenimento. A un certo punto sembrava che non l’avesse scritto nemmeno lei ma il suo amico amoroso!». «Romanzetto!» esclamò Rubanti. «Perché, lo leggete ancora?». «Ha vinto lei, caro Rabutin. La tua Histoire amoureuse des Gaules non interessa più nessuno, lo vuoi capire? Non l’avresti mai immaginato eh! Hanno vinto le devote, le femministe del tuo tempo!». Il conte lo guardò con odio. Restò muto per un po’ e poi sbottò: «Ma allora non hai letto la lettera in proposito indirizzata a mia cugina Madame de Sévigné? Si trova nelle Memorie insieme a tutto il nostro apprezzato epistolario, dove figurano molte lettere scritte di pugno dal mio Re. Te la riassumo. Le dico di averlo letto con spirito di equità, senza farmi influenzare dallo scatenato dibattito delle gazzette. Ho trovato la prima parte ammirevole, meno la seconda. Nella prima, se si eccettuano parole ripetute che infastidiscono lo stile, ma non sono in gran numero, tutto è naturale. Nella seconda parte la confessione della principessa a suo marito mi è parsa stravagante. Si può fare, certamente, ma in una storia vera. Non si può dare a una eroina da romanzo un sentimento così straordinario, non trovi? Non ha seguito il buon senso, ha cercato lo scanda- 34 RENZO PARIS lo, il suo non doveva rassomigliare a nessun romanzo. Raramente una donna confessa a suo marito di qualcuno che è innamorata di lei, ma mai rivela nella realtà di essere innamorata in prima persona di un altro che non sia il marito, e poi, comunque, non buttandosi ai suoi piedi, oltraggiandolo. D’altronde non è verosimile che una passione d’amore possa coniugarsi con la virtù. Insomma passione e virtù cozzano tra di loro. E nemmeno può darsi che l’amante resti nascosto ad ascoltare; sa di Romanzo, anche se le parole sono ben scelte». Rubanti si scusò di aver dimenticato quella preziosa lettera, tra le tante del loro epistolario, ma appena si era messo a parlare gli era tornata in mente. «Ma che vuol dire per voi: sa di Romanzo?». «Dio onnipotente, ma non ricordi nemmeno il dibattito sulla verosimiglianza che si scatenò sulle gazzette? Lo so, tanta acqua è passata sotto i ponti, ma se un romanzo debba essere vero o verosimile credo se ne discuta ancora oggi, no? Nel romanzo, dicevano i critici, i gesti e le azioni devono essere non vere ma verosimili. E io con la verosimiglianza ho sempre avuto qualcosa da ridire. Mi hanno accusato di non essere stato un vero storico, di non tenere al vero nemmeno nelle Memorie. Ma lasciamo stare queste ubbie. Voglio sapere se Petronio Arbitro è ancora letto». «L’autore del Satyricon è ancora molto apprezzato». «Questo mi rallegra. E gli Accademici di Francia, di cui io stesso facevo parte, tutti caduti nell’oblio?». «La Bruyère? Un classico». «Questo mi consola, anche se era un vero misogino». «Ma dimmi, perché eri così prevenuto nei confronti dei devoti e dei solitari di Port-Royal?». IL CONTE LIBERTINO 35 «Ho sempre seguito il mio Re, il quale non sopportava i giansenisti. Avrei dovuto seguire le dame della devozione, ma erano tutto il contrario di ciò che volevano apparire. Di gran lunga migliori le Preziose delle Devote. Come sai il mio mondo, sia quello del soldato che quello dell’amante, si basava sui classici latini e quelli ignoravano che cos’era il mondo interiore. La Chiesa ha sempre cercato di tagliare le gambe alla Bellezza, mettendo avanti la Grazia, certo, ma apprezzandola solo come viatico per il Padre Eterno. Oh il mio re aveva capito tutto, anche se, per motivi politici, perseguiva l’armonia». «Già, ma fu lui che fece distruggere il convento di PortRoyal, non sopportava i giansenisti. Sainte-Beuve ha seguito nei dettagli la fortuna del convento dei Solitari, soffermandosi sulle grandi personalità letterarie che lo frequentarono, da Racine a Corneille, soprattutto Pascal. Port-Royal è un libro davvero esaustivo su quella che chiama una setta religiosa, che all’inizio voleva tornare alla santità della chiesa e che divenne invece pura ortodossia cattolica, pura teologia e in ciò poco condivisibile ai suoi occhi». Rabutin si innervosì. «Ma lo vuoi capire che il mio era un libertinaggio neo-antico, da gentiluomo del re e che le sette religiose erano l’ultima cosa che potevano attrarmi? È vero, per un attimo fui affascinato dalla Fronda, ma durò lo spazio di un mattino. Lo so, i libertini che vennero dopo di me ce l’avevano con il Re, ma io no, l’ho sempre servito con devozione e sono stato ricambiato con il carcere prima e l’esilio poi. Voi chiamate ancora romanzo un libretto spaccato in due, con una prima parte noiosissima e una seconda delirante. Siete buffi, ma che romanzi si scrivono oggi?». Era tornato bruscamente sul suo punto dolente, 36 RENZO PARIS la fortuna della Principessa nell’Otto-Novecento e l’inabissamento della sua Storia. «Sono gli americani che detengono il primato in questo campo, gente che nel vostro secolo era considerata meno che selvaggia». «Gli americani? E i francesi? E voi italiani, che eravate considerati il massimo in tutte le arti? Io avevo un amico che attaccò oltre ai giansenisti, gli italiani e il loro gusto barocco che aveva, secondo lui, guastato la naturalezza dello stile francese. In un suo libro inserì come esempio dello stile naturale da contrapporre a quello artificioso italiano, alcune mie lettere presenti nelle Memorie. Anch’egli tra gli Antichi e i Moderni scelse questi ultimi». «Gli italiani vivono una loro lunghissima discesa, iniziata proprio nel Seicento, il secolo della decadenza dell’Europa». «Il mio nome non deve più circolare in un’epoca di massa… Fu affossato dalla corte del Re Sole e tanto mi basta. In quanto alla televisione, avete distrutto dunque il teatro… del resto nei cessi dove abitate come inserire il teatro, che cretini!». «Ah se avessi avuto anche tu una vita interiore invece di copiare i classici latini più licenziosi, chi sa che agli occhi del tuo re non…». «Ma allora non capisci. La vita interiore? E perché? Quella l’ho lasciata volentieri ai borghesi piagnoni. Su quella vita hanno basato, su quelle lacrime, tutte le loro fortune. E dapprima con l’amore gentile del tuo Dante e poi con la religione trasformata in un enorme piagnisteo divino. Mi taccio. Fu la schizofrenia del re che… Non conosci l’argomento, bon, bref, passons!». Un vento più forte scompigliò i boccoli del conte, che nel frattempo aveva ripreso i suoi abiti. Il treno penetrava, rallentando, IL CONTE LIBERTINO 37 nella periferia napoletana. Rubanti rientrò per evitare qualche sasso vagante, lanciato da scugnizzi inferociti. Non si augurò che venisse colpito il conte, ma non se ne sarebbe dispiaciuto se fosse avvenuto, visto che si trattava pur sempre di un fantasma. Filippo Disastro e Gullitor non poterono continuare a godersi il loro sonno innocente. Salirono e scesero una torma di scugnizzi e di padri di famiglia che chiedevano l’elemosina o volevano vendere panini, stoffe, orologi rubati, radio, perfino un televisore. Poi finalmente il treno riprese la corsa e quando tagliò i vicoli della camorra, qualcuno chiuse il finestrino. Il tratto Napoli-S. fu allietato da una comitiva di giapponesi che scesero a Pompei, fotografando tutto quello che non videro. «Bombei» gridava uno sciancato, scuotendo il carrello delle bibite, che si misero a tintinnare come in un concerto dadaista. All’improvviso entrò l’africano che aveva questionato con il conte, si sedette accanto a Rubanti, tirandosi su la sua lunga zimarra. Disse di provenire dal Senegal, di essere un rifugiato politico, di aver visto quel signore vestito con abiti del passato. «Stai attento» lo avvertì «quello è un mago pericoloso: Io l’ho potuto vedere perché conosco la magia. Scompare solo se non lo pensi. Appena lo pensi compare, è cattivo, feroce, è stato un pluriassassino nella sua epoca…». Poi l’africano si alzò e scomparve, un momento prima che il treno uscisse dal tunnel e si fermasse alla stazione di S. «Che mattinata movimentata» si disse Rubanti, svegliando i due colleghi e afferrando la ventiquattrore.
Scaricare