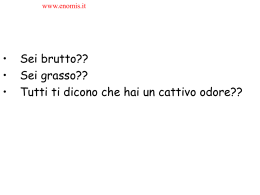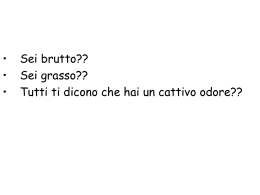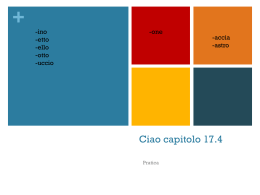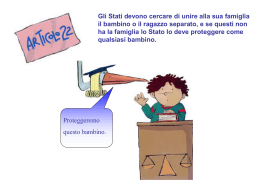Umberto Lollio A GRANDE RICHIESTA TUTTI I MIEI MIGLIORI RACCONTI FORZA ROMA EDITORE 2 A GRANDE RICHIESTA Tutti i miei racconti migliori «Misericordia! cos’ha, signor padrone?» «Niente, niente,» rispose don Abbondio, lasciandosi andar tutto ansante sul suo seggiolone I Promessi Sposi - Alessandro Manzoni 3 INDICE MIO FIGLIO ERA FIGLIO... 7 UNA SITUAZIONE 21 L’ADOLESCENTE 30 RAPPORTO SUL PIANETA ACQUA 35 L’OMICIDIO NON È UN GIOCO 42 X-n-WY 55 IL BARLUME, OVVERO STORIA DI UN’AMICIZIA INCREDIBILE 63 IL MIO ANNO PREFERITO 93 OTTOBRE ’72 105 MIO FIGLIO ERA FIGLIO... 8 I Mio figlio era figlio del suo tempo. E la nostra era la migliore epoca che l’umanità avesse mai avuto. Avevamo raggiunto un tale livello di evoluzione fisico-intellettuale e avevamo organizzato una società così perfetta che anche un’eventuale divinità avrebbe provato invidia. Tutto era iniziato con l’unificazione delle razze e dei popoli in un’unica, grande “Organizzazione” su scala mondiale, migliaia di anni prima. Ciò era stato possibile grazie allo sviluppo scientifico raggiunto, che permise di accelerare l’evoluzione della nostra specie favorendo la comparsa nel nostro genoma di geni favorevoli ogni nuova generazione e non nell’arco di decine di migliaia di anni come era stato fino ad allora. Come si intuisce, ciò non significava “scegliere” chi far nascere secondo un mero e comunque soggettivo criterio morale, estetico o fisico, ma isolare e favorire mutazioni che sarebbero comunque avvenute durante la nostra naturale evoluzione, sebbene in un lasso di tempo così lungo che forse non avrebbero fatto in tempo a manifestarsi. In pochi secoli, insomma, sapemmo quale era il fine naturale dell'evoluzione: noi stessi. In verità fisicamente non eravamo cambiati molto: dal momento in cui la nostra specie aveva cominciato ad evolversi rapidamente il nostro fisico si era indebolito, eravamo più alti in media di circa dieci centimetri, praticamente senza più nessuna differenza razziale di colore o struttura fisica, con unghie molli ed altre piccole e non importanti differenze strutturali. Ma un grosso, importante e decisivo cambiamento si era verificato nella struttura del nostro cervello: l’Uomo aveva raggiunto la maturità. La nostra era una società ricca ma senza le beghe delle leggi economiche, nella quale ognuno si dedicava alle più svariate 9 attività creative o scientifiche, mentre dei robot svolgevano i lavori più umili e soddisfacevano i nostri fabbisogni e piaceri. Questo cambiamento, questa trasformazione, era stata possibile grazie alla comparsa nel nostro sistema nervoso di una nuova funzione che i fisiologi avevano denominato “Istinto Ontogenetico del Sapere”, per la quale, proprio come per istinto, l’essere umano fin dal primo vagito ripercorreva “ontogeneticamente” le tappe del Sapere, assimilando indelebilmente tutta la scala “filogenetica” della cultura e della scienza che la nostra specie aveva creato e scoperto nella sua storia vecchia di quasi un milione di anni. Questo significava che, senza nessun maestro, un bambino sapeva parlare e leggere alla perfezione la nostra attuale lingua a circa sette mesi di età e cominciava a scrivere e a comporre testi prima di saper camminare, a condizione che gli si facesse trovare un ambiente culturale adatto, quale quello esistente presso qualunque nucleo familiare. Verso i cinque anni, poi, il bimbo aveva acquisito conoscenze storico-archeologiche e un grado di curiosità tali che il suo passatempo preferito era lanciarsi in pseudo-viaggi tramite la TV a 3D; all’età di sei anni ormai conosceva alla perfezione tutte le lingue morte anche senza averle mai sentite e ciò gli consentiva di consultare tutto il nostro scibile in lingua originale. A sette anni leggeva e componeva musica per ogni strumento od orchestra: in questo periodo le personalità cominciavano ad essere ben distinte e i bambini già offrivano alla società le loro performances. Quasi tutta la musica che ascoltavamo era stata composta da bambini di quell’età. Tra i sei e i sette anni inoltre il bambino completava la sua conoscenza botanica e zoologica e scopriva il principio biochimico della vita. Molti si appassionavano alla geologia e alla paleontologia, altri invece si dedicavano all'astronomia. Ma l’età più bella di questo fantastico cammino si aveva verso gli otto anni, tanto che l’ottavo compleanno era celebrato nelle famiglie in modo speciale: al festeggiato veniva regala10 to un piccolo ma completo laboratorio con il quale egli poteva cominciare il cammino nella conoscenza della Chimica e della Fisica pura, ed evolvere e completare la preparazione matematica. Intanto anche gli altri campi dello scibile venivano seguiti dal bambino fin verso i dieci anni, come le arti grafiche, l’architettura, la letteratura, la medicina o l’ingegneristica, ma dopo quell’età i ragazzi, pur continuando nel loro eclettismo, cominciavano a seguire un qualche ramo particolare della Conoscenza, umanistico o scientifico: io, tanto per fare un esempio, mi ero dedicato all’Ingegneria aerospaziale e, solo da qualche anno, mi stavo occupando del software di una particolare funzione di bordo delle astronavi che riguardava l’Idrogeno. Mia moglie aveva scelto il teatro con discreto successo, sia come attrice che come regista. Ma torniamo alla mia storia, cioè a mio figlio: dicevo che era figlio del suo tempo e quindi all’ottavo compleanno gli allestii il laboratorio fisico-chimico che già era stato mio. Pochi giorni dopo quella data, egli entrò nel mio studio trafelato, annunciandomi: «Papà! E=mc2!!» Mi ricordo che avevo il viso imperlato di sudore, perché stavo lavorando con il microscopio elettronico manipolatore a non so quale microcircuito. Comunque gli sorrisi bonariamente, meravigliandomi ed inorgogliendomi un poco per come presto aveva raggiunto quella antica ma basilare tappa della Fisica. Non ricordo se risposi, ma ricordo perfettamente ciò che lui disse dopo: «Ti rendi conto delle enormi possibilità di cui si potrebbe disporre a poter usare tutta l'energia contenuta anche in un solo sassolino? Ma che dico! In una singola molecola?». Questa sua riflessione mi lasciò perplesso: mai mi era venuta in mente una cosa simile, perché avevo sempre pensato a quella formula collegandola alle relative implicazioni sull’utilizzazione dell’energia nucleare, di fissione e di fusione, peraltro 11 ormai da tempo abbandonata. Anche adesso non comprendo come si possa solo supporre una simile teoria. Ma mio figlio non solo era figlio del suo tempo, era anche qualcosa di più: me ne accorsi perché, nonostante l'età, abbandonò ogni altra branca del Sapere, pur cercando di dissimularlo e si gettò anima e corpo nello studio della chimica e soprattutto della fisica. Io ero un po' preoccupato da questa sua anomalia, ma non mi sarei mai aspettato quello che successe due anni dopo. II «Papà, vuoi venire un momento nel mio laboratorio? Ho da mostrarti una cosa» Lo seguii. «Ecco» continuò una volta entrati «vedi quel liquido?». C'era uno strano contenitore trasparente, con le pareti molto spesse, largo un metro ed alto non più di venti centimetri, posto sopra una specie di macchinario cubico di cui faceva parte. Dentro, in una cavità sferica di dieci centimetri di diametro, era contenuto ciò che lui aveva chiamato liquido, completamente trasparente, nel quale si muoveva casualmente e lentamente un piccolo ovoide luminosissimo. «Quel liquido» continuò mio figlio «in verità è materia allo zero assoluto, e ciò non è certo una novità per la nostra tecnologia1. Questa materia è il substrato che mi è servito per poter trasformare ogni corpo che voglio nel suo contenuto di energia, per di più in maniera biologicamente assimilabile» Nota di precisazione del ragazzo al padre: «Ora tu sai che per la teoria della relatività in pratica, massa ed energia sono una in funzione dell'altra, anzi sono effettivamente un’identità ed una grandezza che non sono statiche come nella fisica primordiale, in cui m=f/a, ma variano in funzione della velocità e quindi più questa si avvicina a c (=velocità della luce) più la massa aumenta e con essa il contenuto di E (=energia). Ma in fin dei conti, a livello molecolare, cos’è la velocità? Non è altro che energia cinetica, che si misura in T (=temperatura). La T aumenta all'aumentare della velocità delle molecole. E questo vale per tutti gli stati fisici: anzi, lo stato fisico (solido, liquido e gassoso), è tale solo perché le molecole sono più o meno veloci: nell’acqua le molecole si muovono più che nel ghiaccio e meno che nel vapore» 1 12 Rimasi attonito, cercando di intuire i concetti che aveva espresso, poi ribattei allarmato: «Ma... quell’ovoide luminoso allora... è energia... A cosa apparteneva? A quanto ammonta?» In maniera distaccata mi informò: «Era, anzi è, un cubo di ferro di un grammo di massa inerziale». Poi continuò: «Ti starai chiedendo che effetto ha sugli organismi se somministrata... Ecco» e mi mostrò una gabbietta di vetro «qui dentro c'è un’Effimera: ieri le ho somministrato una frazione infinitesima di quel cubo di ferro ed è ancora viva. Pensavo poi che sarebbe diventata grandissima, oppure fortissima. Invece ha accelerato i suoi processi biologici e riparativi ad una velocità impressionante: per questo è ancora viva. In pratica quindi, usa questo enorme surplus di energia per restare nelle sue attuali condizioni il più a lungo possibile. D’altronde ciò, se ci si riflette, rientra nella logica della biologia degli esseri viventi» Detto questo catturò l’Effimera con delle pinzette e le strappò un’ala: almeno sembrò avesse fatto questo, solo che l’ala rimase al suo posto e tra le sue dita era apparsa un’altra ala. Ovviamente era successo il contrario, ma ad una velocità tale da confondere le idee. Poi schiacciò tra le dita il povero animaletto, e lo tenne così per qualche minuto: come fosse di gomma, l’Effimera si materializzò nuovamente appena allentata la presa. La ripose nella gabbietta. «Ma come è potuto succedere...» mormorai stupefatto. E lui, pedantemente, mi spiegò: «Si crea una particolare miscela gassosa contenente tutti gli elementi della tavola periodica; si cerca di mantenerla per un millesimo di secondo (quindi un tempuscolo piuttosto lungo) a dieci milioni di gradi centigradi. Capito dove era finito quel tuo contenitore magnetico per UHT (ultra-high-temperature) che avevi perso? Ora cerca di seguirmi: prendi il millesimo di secondo e dividilo in milionesimi. È ovvio che un milionesimo di millesimo di secondo è un tempuscolo così piccolo da 13 avvicinarsi molto al teorico tempuscolo infinitesimo ɛ (épsilon). Questo è quanto sono riuscito a realizzare con l’aiuto del mio fedele Tommy...» (Tommy era il suo PC: considerate che fino ad allora la scienza ufficiale, disponendo di tutt’altro che di Tommy, non era mai riuscita a raggiungere tali frazioni temporali in una reazione chimica. E in questo, se ci fosse stato bisogno di ulteriori prove, si poteva intuire che razza di genio fosse mio figlio: forse era l'effetto di una nuova mutazione, dopo che per secoli non ne erano più avvenute di favorevoli? Ma sentiamolo concludere). «Quindi io e Tommy prendiamo questa miscela gassosa, la portiamo a dieci milioni di gradi centigradi per un millesimo di secondo e proprio nell’ultimo milionesimo di millesimo di secondo avviciniamo un qualunque oggetto solido, dal quale si voglia ricavare energia. Se lo avvicinassimo al milionesimo di millesimo precedente, si dissolverebbe insieme alla miscela, divenendone parte indistinguibile. Altra condizione necessaria è raffreddare il tutto allo zero assoluto al milionesimo di millesimo di secondo successivo al contatto: la miscela, che sta iniziando un processo di fusione nucleare e quindi è diventata materia elementare, si blocca per assenza di energia cinetica: l’oggetto che ne è venuto a contatto non ce la fa a trasformarsi in materia elementare, ma sparisce come massa e rimane come energia pura, quasi “materializzata”: se noi comunque potessimo analizzare quella luce, scopriremmo che non sono né protoni, né elettroni, né fotoni. Forse sono quanti, ma non sarebbe certo rilevabile1. Comunque, non essendoci materia, in quell’energia non c’è energia cinetica e ciò la rende assimilabile senza “fonderci” con essa. La stessa temperatura di “zero assoluto” in cui è confinata impedisce che si possa ritrasformare. Non sono però ancora riuscito a capire 1 In verità, è impossibile che esista energia senza massa. Ma altrimenti, che racconto fantastico sarebbe? (n.d.a.) 14 come questi processi avvengano: è solo un caso che le cose stiano così. Inoltre, come noterai, l’Ovoide Energetico un po’ si muove e questo dimostra l’instabilità della reazione, come il fatto che probabilmente lo “zero assoluto” non è stato ancora raggiunto, al contrario di quel che ha dimostrato la nostra scienza» Guardai affascinato quel ragazzino di dieci anni: altro che figlio del suo tempo! Altro che genio! Non avrebbe sfigurato neppure come dio. Allora gli chiesi incantato: «E come fai a far assimilare quelle “pillole” energetiche ad un essere vivente...» oltre che incantato ero anche curioso e forse un po’ presuntuoso, dato che pensavo di conoscere la risposta: difatti, dentro il recipiente, appeso tra il coperchio e la superficie della miscela, c’era un aggeggio tipo contagocce manovrabile dall’esterno. Così, mentre finivo di formulare la domanda: «...con questo “contagocce”?» provai anche ad usarlo, spingendolo verso l’Ovoide luminoso, per “aspirarne” qualche “goccia”. Nell’attimo in cui lo toccai, avvertii una fortissima scossa, rimanendo intontito per qualche secondo. III - CONCLUSIONE «PAZZO! Incredibile pazzo ciaccione!! Troglodita!!!» Furono le prime parole che sentii dopo l’accaduto, e che stridevano proferite da una voce infantile «Non è così che si usa!» Guardai con apprensione al contenitore e con sollievo notai che l’Ovoide c’era ancora... ma subito notai anche che mancava il “contagocce”... «Cos’è successo?» gli chiesi allarmato. Ironicamente e con perfidia, mi spiegò: «È successo che hai assimilato TUTTO il cubetto di ferro!» «E l’Ovoide che si vede...» balbettai io. «È il “contagocce”» aggiunse cinico lui «che poi non era un contagocce ma un “Trasportatore Temporale di Energia” che 15 attirava quantità infinitesime di energia pura dall’Ovoide e le trasportava nell’Iperspazio fino all’essere vivente che si voleva infondere, Trasportatore che ho ideato io stesso con mezzi rudimentali1 » e così dicendo mi fece notare un altro apparecchietto-contagocce simile a quello scomparso, posto sulla gabbietta dove era rinchiusa l’Effimera. «Ora» continuò «tu l'hai distrutto, mettendolo in contatto con l’Ovoide e contemporaneamente ne hai assimilato tutta l’energia, una quantità tale che per scriverla in forma numerica non basterebbe un elenco telefonico. Potevi diventare anche tu “Energia pura” e in verità, oltre al contagocce, è disciolto anche il tuo braccio, che il tuo organismo energizzato ha già ricostruito...» mi guardai subito il braccio e notai che infatti era nudo e privo della mia vecchia cicatrice al gomito «...e sarebbe stato meglio come ipotesi...» aggiunse amaramente «...penso infatti che tu sia diventato irrimediabilmente immortale. Cioè, forse continuerai ad invecchiare, magari un giorno ogni centomila anni, ma ciò ti sarà di magra consolazione. E non c’è modo di neutralizzare l’effetto, proprio per definizione: tu hai in ognuna delle tue cellule un po’ di quell’energia disciolta e, anche immergendoti nell’Ovoide, non faresti che peggiorare la situazione, perché le tue cellule “berrebbero” avidamente ulteriore energia pura» «Ma tu riuscirai certamente a trovare l’antidoto! Tu sei un genio» gli dissi, cercando più di rassicurare me stesso che una conferma. Mio figlio mi guardò con aria scettica, poi aggiunse voltando le spalle e accingendosi ad uscire dalla stanza: «Essere un genio non significa poter eseguire magie o miracoli, tant’è che queste non esistono, e solo loro potrebbero l’impossibile» 1 Non male, eh? (n.d.a.) 16 Tralascio ulteriori particolari di quel lontanissimo giorno, che capitava pochi mesi prima del mio trentatreesimo compleanno. In seguito mio figlio divenne mio fratello, poi mio padre, infine mio nonno. Lo stesso ciclo seguirono i miei nipoti e pronipoti. Dopo circa duecento anni persi il conto dei figli e delle famiglie che ebbi, non riuscendo neanche più a rintracciare la mia famiglia originaria. Mi specializzai in tutte le scienze e le arti che potevo scoprire. Dopo centomila anni non ero minimamente invecchiato, ma la mia specie cominciò a regredire. Fui Presidente, Imperatore, Re, Capotribù. L’ultima moglie che ebbi era così diversa da me, così regredita e brutta che non riuscii neppure a farla procreare. Mi ritrovai alfine solo, su di un mondo deserto e ostile e col sole che minacciava di esplodere in nova da un millennio all’altro. Non mangiavo e non bevevo da migliaia di anni, anche perché non c’era più cibo né acqua: ma non ne risentivo, come non m’importava del gelo che stava attanagliando quel mondo morente. Decisi di costruirmi un’astronave e di andarmene, altrimenti avrei rischiato di passare il resto dei miei milioni di anni nel vuoto, dopo che il sole si fosse trasformato in nova. Per l’energia che serviva a muovere l’astronave, non c’era problema: ne disponevo comunque in quantità illimitata, poiché avevo conservato il recipiente con l’Ovoide al quale avevo nel frattempo riposizionato un nuovo Trasportatore d’energia, perfezionato anche per usi non biologici. Cominciai a peregrinare per lo Spazio alla velocità della luce. È passato, da quel giorno fatidico, più di un milione di anni. Nel frattempo ho visitato decine di mondi nei quali si erano sviluppate forme di vita: in alcuni (pochi, per la verità), queste avevano prodotto delle specie intelligenti, ma con civiltà decisamente primitive. In uno degli ultimi, mi successe un fatto curioso: fui scambiato per un predicatore locale, certo Salvatore, forse per la mia altezza o per la mia carnagione 17 chiara e i lunghi capelli biondi che mi distinguevano e mi facevano risaltare rispetto a quel popolo umanoide becero e primitivo. Comunque fui anche “giustiziato” in sua vece in modo davvero originale e crudele: mi crocifissero. Feci finta di morire e me la svignai tre giorni dopo dal sepolcro, quando si erano calmate le acque, togliendo così quel poveraccio da una brutta situazione. Adesso sono proprio solo. Infatti, lo scorso millennio, è morta anche l’Effimera, unico altro essere energizzato oltre me, con la quale avevo imparato a comunicare, anche se in modo molto elementare. Dovrei avere (ho in effetti perso il conto del tempo) ad occhio e croce raggiunto il trentaquattresimo anno di età reale, anche se fisicamente sono immutato. Sto tentando alcuni esperimenti: assimilo tutte le sostanze più carcinogene che conosco. Chissà se, riuscendo a sviluppare un tumore maligno questo, fornitagli la dovuta energia, non riesca a sopraffarmi... prima della fine dell’Universo. FINE (?) 18 Questo racconto è il mio preferito, perché da subito è piaciuto a tutti e continua a riscuotere un discreto successo (è pubblicato su Wattpad in rete). L’ho scritto ai tempi dei primi anni universitari, un periodo fecondo anche se purtroppo la maggior parte dei racconti che scrissi sono andati persi. È un racconto di fantascienza per cui non cercate il pelo nell’uovo, sarà pieno di inesattezze scientifiche! Però l’idea è divertente e il finale originale. 19 UNA SITUAZIONE «Cristo! Non mi diverto affatto! Proprio per niente! Che cavolo ci sto a fare io qui. Sono quelle situazioni che ti fanno incazzare a bestia! Ecco cosa ci si guadagna ad accompagnare i vecchi: loro ti rifilano a qualche stupido figlio dei loro amici, che è terribilmente diverso da te, e questo ti trascina in qualche stupida festa e ti abbandona! Che cazzo gli frega a lui che cazzo faccio io! Lui va con la sua stupida amica puttana e ti pianta a fare la statua in mezzo al casino e alle luci psichedeliche! M’avesse presentato un cane, quel lurido bastardo! Dev’essere anche un po’ fascio. E chissà per quanto ne ho ancora...» Finì d’un sorso la coca e si mise a guardare gli altri che si dimenavano. C’erano ragazze e ragazzi sicuramente in pari numero e tutti si dimenavano e si divertivano. Certamente erano tutti accoppiati, figurarsi. Doveva essere uno di quei ritrovi del sabato pomeriggio, dove tutti quelli di un giro si davano appuntamento in casa di uno. Che cazzo ci faceva un estraneo. Niente: e questi poi lo ignoravano tranquillamente. «Ah, i miei amici! Quelli sì!» pensava mentre si scolava un’altra coca: «Però hanno un bello stereo! Cazzo! I soldi questi ce li hanno! Marantz... due piatti... il mixer...deve valere un fottio...» Stava ammirando ora l’apparato delle luci quando una voce femminile gli chiese: «Ti stai annoiando eh?» «Beh... sì, un po’» “E questa chi è” pensò “che sia una come me?” Era un po’ sorpreso, soprattutto per non averla notata prima. Lui notava tutte le ragazze, era un suo vizio. Qualche volta guardava anche i maschi, soprattutto se erano in coppia con una ragazza, per vedere se stavano bene, se si miglioravano o meno l’uno con l’altra. Ma le ragazze le notava tutte, belle o meno: parti- va dalle gambe e le squadrava fino ai capelli, non si capiva se per sfacciataggine o ingenuità. «Sai» continuò lei «anch’io non conosco nessuno. Come te. Perché tu non conosci nessuno, è un po’ che ti guardo. Ti guardavo e pensavo: questo o ha litigato con la bimba o è stato trascinato qui come me. Ma poi ho pensato che non avevi la faccia triste ma scocciata e allora ho capito che non era perché avevi litigato con la tua ragazza ed eccomi qui» Le rispose con un “mh” e poi pensò tra sé un po’ colpito: “Ma sentila, ha pensato che ero scocciato... e se a me non andava di vedere nessuno? Bella faccia! Però... ha delle belle caviglie. Sì, proprio niente male: anche con i calzini le si indovinano bene...”. Poi tornò a guardare gli altri. Gli scocciava che lei fosse stata così invadente. Sentiva quasi un complesso d’inferiorità: pensò che se lui fosse stato al posto suo, sì insomma, se fosse stato lui a notare lei, forse non avrebbe avuto il coraggio di avvicinarsi. E questo lo faceva sentire quasi umiliato. Ma non era proprio scocciato... anzi, chissà se quella giornata balorda prendeva una svolta diversa... Lei pure comunque non lo guardò e non parlò più. Si limitò a stargli seduto vicino, con le gambe di sghembo, come stanno le ragazze, ed il mento sui pugni chiusi, e guardava gli altri. In verità non guardava: pensava a quello strano ragazzo e pensava che non si era comportato mica bene. Le aveva a malapena rivolto la parola. Che si fosse sbagliata? Sembrava così spaurito e timido, con quegli occhiali, vestito diverso e non all’ultima moda, ma con i soliti jeans e maglione, un po’ come lei. Le aveva fatto un misto di tenerezza e curiosità. E poi era carino. Comunque stettero ancora una decina di minuti senza parlare, sorseggiando le rispettive coche. Si vedeva però che stavano soltanto cercando un pretesto per ricominciare a parlare. Lui faceva finta di ascoltare la musica, ma in verità il suo cervello stava turbinosamente cercando un qualche argomento di conversazione. Intanto, furtivamente, la guardava: era decisamente carina: le gambe finivano dove 22 dovevano finire, anche se al buio si vedeva poco: il seno era piacevolissimo e le si indovinavano i piccoli capezzoli, mentre il viso era semplicemente angelico, contornato da una cascata di capelli di cui non si capiva il colore. Gli sembrava anche di aver intravisto delle lentiggini. Certo che doveva essere giovane... quattordici, quindici... non di più. Che cosa ci faceva una cosina così giovane lì. Ma lui aveva un debole per le giovani (oddio, non che fosse vecchio! ma a diciotto anni ci si sente adulti), e lo attirava specialmente il particolare dei capezzoli che tiravano la lana... e così, come suo solito e senza accorgersene, cominciò a fissarla. Lei pure, comunque, non è che l’avesse dimenticato. Si era un po’ rintanata sulle sue per il suo comportamento e ora, semplicemente, gli lasciava l’iniziativa. Se lui l’avesse ancora ignorata, non avrebbe fatto che togliere le chiappe di lì e andare in veranda al fresco; anzi, questa era quasi quasi una buona idea: gli avrebbe detto “beh, ciao!” e sarebbe andata a godersi il fresco e ad aspettare che quella stronza di sua cugina la riportasse a casa invece di continuare a puttaneggiare. E che lui si tenesse il suo broncio, i suoi occhiali, i blu jeans e tutte le coche che voleva. Se gli piaceva annoiarsi, che cavolo ci poteva fare lei. Si girò per salutarlo... e lo vide che la fissava: aveva anche la bocca mezza aperta. Gli mancava solo la bava e poi era veramente a posto. Lì per lì rimase quasi sconcertata, poi qualcosa le disse di buttarla sul ridere e lo apostrofò: «Beh? che c'è? che per caso ho le scarpe slacciate?» Lui diventò rosso come un peperone rosso, ma le luci psichedeliche lo salvarono. Si riprese maledicendosi in silenzio e schiarendosi la voce, un po’ impacciato, disse: «No... cioè non lo so... ecco... io veramente stavo pensando solo ai fatti miei. Mi sto veramente scocciando, e...» «Beh, scusami!» questa volta era proprio incavolata per il suo modo di fare «tanto ora me ne devo andare» 23 «No! Aspetta!» questo lui lo urlò quasi e qualcuno si voltò nonostante il casino. Lei ora era in piedi e lui per un attimo notò che aveva anche le gambe fatte bene, ma che ora delle gambe e del resto gli importava di meno: era stata solo la sua abitudine. In effetti quella ragazza era un appiglio e lui lo stava perdendo «Aspetta! Non hai capito! Non è che ti volessi mandar via... è che... che cosa possiamo fare?» «Vieni fuori un momento dal casino. Vieni a prendere una boccata d’aria in veranda. Qui si soffoca» Gli dette la mano per alzarsi: sentì che lui gliela stringeva e si tirava su in piedi. Sentì anche che aveva una mano da ragazzo e vide anche che aveva il corpo da ragazzo e che era poco più alto di lei. Inoltre sembrava non avesse ancora barba. Chissà quanti anni aveva, si sorprese a pensare. Lui le mormorò un grazie, poi fece per seguirla in mezzo ai forsennati. In piedi la musica era più assordante e lui cercava di non perderla seguendole la nuca. Non sapeva un accidente di come era fatta quella casa e non sapeva dove era la veranda. Inciampò in un corpo, che come un automa continuò a dimenarsi, cambiando colore a tempo di musica. Poi raggiunse la veranda. Lo sorprese il fatto che era già buio. Guardò l'orologio e vide che erano le otto e capì che ormai era vicino il momento di andarsene: non si sentì per niente contento. La veranda era in mattoni rossi di cotto, poco illuminata, e dava su un pratino all’inglese. C’erano delle poltrone di vimini, un tavolino e nel punto più in ombra si intravedevano delle sedie a sdraio. Si guardò intorno per capire dove diavolo si fosse cacciata, ma non la vedeva. Poi riconobbe un “ehi!” e la individuò dove erano le sdraio. Vi andò e la trovò distesa su una sdraio con i piedi sul muretto, che guardava il prato. Era bello essere fuori dal fumo e dal casino: si cominciava addirittura a percepire il rumore dei grilli. La luce della luna (o di un lampione, ma lui preferì pensare che fosse della luna) la colpiva e le faceva risaltare, come fossero fosforescenti, solo il maglione e i calzettoni tra gli scarponcini e l’orlo dei 24 pantaloni, perché erano bianchi. Lui fu colpito da quella posizione e gli piacque. Gli piaceva la naturalezza della situazione e sentiva una specie di calore nella pancia, a vampe. Sentiva anche il sesso che si ingrossava, ma decise di ignorarlo. Sentiva come un impulso di prenderle le caviglie, alzargli le gambe e mettersele in grembo sedendosi sul muretto di fronte a lei, per parlarle piano accarezzandola fino alle ginocchia, poi dolcemente scivolarle tra le gambe fino ad abbracciarla in ginocchio e ad appoggiare la testa sul suo seno accoccolandosi su quel maglione bianco per sentire il battito del cuore. Sentiva precisamente questo impulso e si spaventò un poco perché lui era già innamorato di una ragazza e le altre le guardava e basta, mai sentiva questi impulsi. Ma lo sentiva, e questo era tutto. Comunque si sedette impacciato su una sedia a sdraio vicina cercando di non guardarla «Bella serata» lei constatò, riflettendo tra sé che era proprio una bella conversazione, sì, proprio bella. E d’altra parte che cosa pretendeva, che in un’ora si raccontassero tutta la propria vita? Ogni volta, ogni giorno, qualcosa le cadeva dentro. C’era stato un tempo che lei riteneva che tutti i ragazzi e le ragazze si potessero capire con pochi gesti e che bastava guardarsi in faccia per intuire le varie personalità o scoprire i problemi che uno aveva. E forse era così, o forse era così perché c’erano meno esigenze. Ora non avrebbe saputo cosa dare per scoprire che stava pensando quello, che problemi aveva, se era felice o no, se e cosa studiava... Dio quante cose c’erano da chiedergli! Ad un certo punto pensò che se si fosse alzata e gli avesse dato un bacio subito si sarebbero sciolti. Ma poi pensò che nel migliore dei casi tutto sarebbe rimasto uguale ed, anzi, ci sarebbe stato ancor più imbarazzo. E poi che cavolo di pensieri le venivano in mente! Un bacio non si dà mica al primo venuto. Per quel che ne sapeva, lui poteva anche essere uno stronzo, e datogli un dito si sarebbe preso il braccio... e tutto il resto. Oppure era un frocio... Accennò un sorriso a questo pensiero e cercò di immaginarsi come com25 portarsi ad una simile eventualità. Le sarebbe davvero dispiaciuto che lui fosse omosessuale e... ancora si sorprese: “Anna” si disse tra sé, “ma che cavolo di pensieri ti vengono in mente! Stasera hai l'immaginazione un po’ stravolta! Non avranno mica messo aspirina nella coca!” Lui pensava che gli sarebbe piaciuto sapere come si chiamava. Non sapeva perché, ma credeva che si chiamasse Laura, o Elena. Stava per chiederglielo, quando si disse che poi ci mancava solo che le chiedesse anche quanti anni aveva, che scuola faceva, dove abitava, insomma tutta la solita sfilza di domande banali che venivano fatte in questi casi. D’altronde non poteva mica esordire con “Cosa ne pensi della disputa ideologica tra Craxi e Berlinguer?”. Stava sorridendo all'idea, quando sentì una voce: «Anna! Dove sei!» «Sono qui!» rispose lei «Vestiti!» continuò la voce «che è tardi! Si va via!» «Beh,» disse lei a lui «devo andare. Divertiti. Ciao» Lui la guardò alzarsi con un senso di impotenza e mormorò: «Cristo, come siamo scemi. Ma perché!». Lui l’aveva mormorato, ma lei sentì; si voltò, lo guardò a sua volta e gli rispose: «Non lo so. Ma forse è meglio così. Io con te ho immaginato tante cose piacevoli, e anche se sembra stupido, sono stata bene e in fondo mi sembra di averti conosciuto e che mi piaci: ma è solo una mia illusione, e ora è bene che scappi cosicché questa illusione rimanga ancora per qualche ora». E se ne andò. Lui rimase a bocca aperta e voleva urlarle di rimanere, voleva urlarle che l’amava, ma poi capì che aveva ragione lei, che era tutta immaginazione, sì insomma, che era un’illusione. Sorrise, guardò la luna (o il lampione...), chiuse gli occhi e si abbandonò felice a quell’illusione, poggiando i piedi sul muretto ed immaginandosi ancora il maglione e i calzettoni bianchi illuminati. ESTATE 1979. 26 Questo raccontino l’ho scritto in un momento di romanticismo e di nostalgia per l’adolescenza perduta da poco. In quel periodo stavo leggendo tutto Hemingway, e forse lo stile lo ricorda un po’. 27 L’ADOLESCENTE 30 Oramai il momento era giunto. Lo sentiva dentro il proprio corpo, sentiva di non essere più un bambino: fra poco sarebbe diventato un Adulto, avrebbe conosciuto altri Adulti, avrebbe fatto quello che facevano Loro, sarebbe entrato nel Loro mondo. Fin da piccolissimo, fin da quando aveva preso coscienza di sé, non aveva fatto altro che sentir parlare di questo favoloso momento: fra poco avrebbe lasciato quel mondo popolato solo di bambini e bambine, lo avrebbe lasciato definitivamente. Non capiva che cos’era che gli dava questa illusione: aveva solo visto quello che accadeva ai ragazzi più grandi ed era certo che ciò stava accadendo anche a lui; qualche tempo prima, si ricordò, un ragazzo più grande gli aveva confidato di aver provato delle strane sensazioni verso le ragazze, quasi voglia di assalirle e gli aveva detto che per questo pensava che tra non molto gli Adulti lo avrebbero chiamato. Difatti, di lì a poco, si era aperta la Porta messa in fondo al loro mondo, e una moltitudine di ragazzi grandi, compreso il ragazzo con cui aveva parlato, vi si era precipitata tra l’indifferenza degli altri bambini. Quella volta si era chiesto come mai gli altri bambini non fossero così curiosi come lui e non avessero tentato di seguire quella moltitudine come invece aveva tentato di fare lui. Purtroppo allora, giunto vicino alla Porta aperta, aveva provato una paura indicibile ed era corso indietro. Non era trascorso molto tempo da quell'episodio, la Porta si era riaperta solo qualche altra volta, ma sentiva che la prossima lui sarebbe stato chiamato ed aspettava impaziente: già due ragazze si erano difese dai suoi assalti (effettivamente la seconda l’aveva importunata più per provare agli Adulti di essere cresciuto che per desiderio). Si guardò intorno, in cerca di qualcuno dei suoi amici che probabilmente sarebbe partito con lui: ne riconobbe uno e lo raggiunse per confidarsi. Questi stava mangiando e quando lo vide lo salutò calorosamente. Anch’egli era dell'avviso che la prossima volta gli sa31 rebbe stato concesso di vedere gli Adulti. Si ammirarono entrambi e lodarono vicendevolmente i rispettivi fisici, come per rassicurarsi tra loro che l’infanzia fosse trascorsa del tutto: i muscoli delle cosce fremevano per la voglia di correre e il cuore batteva forte nel petto di toraci che ormai avevano la possanza di quelli adulti. Mentre erano lì a discutere la Porta si aprì. Non capì come se ne accorse, sentì solo un desiderio fantastico di correre verso quella Porta e, mentre correva, percepì visioni di amplessi, di corse, di lotte, di quel mondo che lui aveva sempre solo immaginato e che finalmente stava per incontrare. Il cuore gli batteva all’impazzata. Si voltò a guardare per l'ultima volta e con un pizzico di rimpianto la moltitudine di bambini che rimanevano e che si erano fermati per guardarli andar via, con occhi pieni di invidia. Solo i piccolissimi continuavano a giocare. Poi si trovò al buio. Chiamò il suo amico e capì che era davanti a lui. Si ritrovarono in una specie di corridoio, spinti dalla moltitudine degli altri. Il corridoio era stretto e basso, poco illuminato. Procedevano a fatica, e cominciava a mancare l'aria, quando il corridoio curvò e... Quello che vide fu allucinante: gli Adulti erano lì, immensi, molto più di quello che non aveva mai pensato. Si vedeva di Loro solamente delle enormi gambe: davanti a sé e agli altri un percorso obbligato; procedette come un automa, poi si sentì prendere alle caviglie e si ritrovò a testa all'ingiù, ormai quasi impazzito dal terrore. Anche gli altri ebbero lo stesso trattamento e tutti insieme furono trascinati in avanti. L’ultima cosa che gli sembrò di percepire fu un gigantesco strano volto schiacciato, con gli occhi frontali, senza penne (forse il viso di un Adulto?), poi il collo gli si infilò tra due sbarre, avvertì un dolore acutissimo e infine più nulla: la cresta gli divenne paonazza, le ali gli ciondolarono inerti e un rivolo di sangue gli uscì dal becco semiaperto; entrò in uno strano 32 macchinario assieme a centinaia di altri galletti appesi e ne uscì spennato e incellofanato. Nel capannone di allevamento dei pulcini, la “Ferormon Automatic Door” si richiuse con uno scatto1. FINE Grant Wood - Adolescence - 1940 I ferormoni sono sostanze simili agli ormoni, però volatili, di cui fanno grande uso gli invertebrati come gli insetti o i primi vertebrati come i pesci, ma sembra anche gli esseri più in alto nella scala evoluzionistica, come gli uccelli, i mammiferi e gli stessi primati. Tra le molteplici funzioni attribuite a queste sostanze, vi è quella di influenzare la vita sessuale. 1 33 Un giorno assistetti ad un documentario televisivo, forse era la serie “A come Agricoltura”, nel quale veniva descritto un moderno allevamento di pollame. Si parla di una trentina d’anni fa. Probabilmente mi stavo preparando un frugale pranzo e distrattamente guardavo la TV. Il documentario mi colpì perché chi lo commentava ne parlava in modo positivo mentre a me pareva la descrizione di un lager. Poco dopo, mentre leggevo una copia di una rivista, probabilmente “L’Espresso”, vidi la foto del quadro di Wood “Adolescence”. Fu come se si fosse accesa una lampadina: ritagliai la foto, scrissi di getto il racconto e... il risultato lo avete appena letto. Ritengo il quadro parte integrante del racconto, come fosse parte dello scritto. Quando lo scrivevo, stava nascendo, o era al mondo da poco, lo scrittore Foer Jonathan S., autore di “Ogni cosa illuminata” e “Molto forte, incredibilmente vicino”. Tra le sue cose, ha scritto un saggio che si intitola “Se niente importa” che vi invito a leggere e che parla, in modo molto più serio, del problema degli allevamenti intensivi. 34 RAPPORTO SUL PIANETA ACQUA Al Magnifico Ecc.mo Sovrano e Imperatore dell’Intero Universo SEQUOIUS II IV Pianeta del Sistema Siriano IMPERO VERDE OGGETTO: Rapporto sull’esplorazione del III Pianeta del Sistema Solare Mi inchino ai Suoi Millenari Rami. Come Ella stabilì, due secoli siriani or sono, nel II millennio del Suo Impero, partì un drappello di piante per esplorare il III pianeta della Stella “SOLE”. Questo drappello si componeva del Capitano Algus Carnosus e del Tenente Rododendrus Arboreus, del Sergente magg. Pinus Maritimus, dei militi Cardus Rasposus e Abetis Major, nonché del sottoscritto Colonnello Comandante Platanus Secolaris. Ci accompagnavano in qualità di esperti la biologa Rosa Purpurea, il geologo Lichenis Abbarbicatus e gli Ingegneri Reali Ananas Succulentus e Palma Altissima. Mio compito è ora riferirLe i risultati della missione. Come i Nostri Scienziati avevano scoperto pochi millenni fa (ricordo che ero cadetto in Accademia), il III Pianeta di Sole presenta condizioni ideali per lo sviluppo di forme di vita simili alla nostra, poiché è ricoperto dalle acque per 3/4 della sua superficie. Inoltre, anche le terre emerse sono ricche di corsi d’acqua e di laghi, e solo poche zone si possono considerare completamente aride: e difatti abbiamo chiamato questo pianeta “Acqua”. Infine, Atmosfera, Temperatura media, Gravità, cicli stagionali e Humus sono forse più favorevoli che su Sirius IV: nessuna meraviglia quindi abbiamo mostrato constatando l’abbondanza di vita ivi presente, sia di tipo acquatico che terrestre. Del poco che abbiamo sperimentato (siamo rimasti su Acqua solo 152 anni siriani), le specie incontrate sono molto simili a quelle presenti sul Nostro Pianeta, sia macroscopicamente che strutturalmente. Persino i processi biochimici sono praticamente gli stessi, a parte qualche enzima di secondaria importanza, e la clorofilla abbonda in tutte le specie. Sembra poi che anche la filogenesi abbia seguito un corso simile a quello avvenuto sul Nostro Pianeta: abbiamo scoperto esseri primitivi unicellulari come batteri e alghe azzurre, altri esseri poco evoluti come le felciacee e esseri altamente specializzati ed evoluti, che hanno preso il sopravvento e rappresentano la maggioranza delle specie che hanno colonizzato il pianeta, quali ogni tipo di alberi, erbe, cespugli, arbusti e piante acquatiche. C’è una caratteristica di questi esseri però che lascia a dir poco perplessi: nonostante il loro alto grado di evoluzione, non sembra che abbiano sviluppato un sistema nervoso, neanche rudimentale, e quindi appaiono assolutamente immobili e insensibili. Ma se questo può già destare profonda meraviglia, un altro mistero sconcerta profondamente: nonostante la sicura e provata condizione puramente esistenziale e priva del pur minimo barlume di intelligenza di questi abitanti, il pianeta brulica di strani macchinari complicatissimi, in parte frutto di elevata tecnologia, soprattutto bioingegneristica, da far apparire i nostri prodotti più sofisticati ridicoli e antiquati. Questi macchinari sono in grado di fornire cibo e anidride carbonica in quantità pressoché illimitata: non solo! per fabbricare queste sostanze, essi utilizzano elementi di scarto come cadaveri di piante o parte di eccesso delle piante (chiome arboree troppo folte, erbe, etc.), ma anche loro stessi, una volta guastati. Da prime impressioni sembra ci siano al36 cune di queste incredibili macchine deputate a “distruggere” quelle in sovrappiù. Questo fatto ci ha lasciato perplessi, perché non è stato individuato dove questi macchinari vengano prodotti. Probabilmente c’è un sistema industriale automatizzato che produce un numero programmato di macchine, anche perché il notevole grado di sofisticazione raggiunto presenta come rovescio della medaglia un facile deterioramento, per cui la durata media di queste macchine è di pochi anni. A parte ciò, questi aggeggi incredibili devono essere stati concepiti da menti geniali: già ho riferito come essi producano molto cibo e anidride carbonica; la cosa straordinaria è che essi non utilizzano per funzionare combustibili, fossili o non, né energia elettrica, ma (udite!) Ossigeno! Lei è sicuramente conscio dell’angoscioso problema dell’eliminazione dell’Ossigeno dai nostri pianeti e soprattutto da Sirio IV a causa del vertiginoso aumento della popolazione negli ultimi millenni. La maggior parte delle nostre risorse tecnologiche sono state investite ultimamente in questa questione, e i migliori scienziati hanno fallito o hanno proposto soluzioni insoddisfacenti. Spinti quindi dalla possibilità di dare un grande contributo alla soluzione di questa situazione drammatica, abbiamo esaminato e smontato una di queste macchine meravigliose. Dopo un’attenta cernita, abbiamo deciso di esaminarne una abbastanza rappresentativa come numero e sufficientemente longeva da permettere un qualche esperimento. La macchina prescelta dura circa 70 anni, ancora poco per capirne sufficientemente il funzionamento, anche perché se si cerca di smontarle, queste spariscono nel giro di pochi giorni, come liquefacendosi. È comunque la durata di questi esemplari prescelti tra le più alte; alcune difatti non siamo neppure sicuri che esistano, poiché sono apparse e scomparse in poche frazioni di anno. La macchina prescelta, è fornita da quattro appendici, due prensili e due deambulatorie, che ne denota la sua funzione multiuso. La meccanica è banale nella sua sem37 plicità, ma non per questo meno geniale: sotto certi punti di vista assomiglia alle nostre: vi si trova ad un’estremità una fessura, difficilissima da vedere per i rapidissimi movimenti che effettua, dove sembra si introducano gli scarti: un po’ come la “bocchetta” del serbatoio del metano che si trova sulle nostre. Da questa fessura, parte un tubo flessibile che trasforma gli scarti stessi in cibo, per tutti i gusti. Il meccanismo di trasformazione è solo un’intuizione della nostra biologa Dr. Purpurea, anche se gli ingegneri Palma e Ananas non sono del tutto d’accordo. Comunque, secondo la Dr. Purpurea, questo meccanismo non consiste nella mera “aggiunta” di materie prime al metano, come avviene nelle nostre, perché gli stessi scarti introdotti li contengono in “nuce”, ma dovrebbe esserci una trasformazione dei prodotti (enzimatica?) all’interno del tubo, che li depura, e una produzione di metano da parte probabilmente di batteri metaniferi. La Dr. Purpurea suggerisce tra l’altro che questa soluzione era stata prospettata agli Ingegneri Reali dal suo Maestro, Prof. Roseto, alcuni secoli or sono, e che essi scartarono, sicuramente allora per validi motivi, ma che portarono al suicidio il valente scienziato. Allora fu scelta invece la soluzione prospettata dal Prof. Ing. Bao Bab Gigans, suo Illustrissimo cognato, che comunque sembra abbia risolto solo minimamente i problemi di eccesso d’Ossigeno e scarsità di Metano che ci affliggono. Difatti, altra intuizione geniale che hanno avuto gli ignoti progettisti di queste macchine Solari, è stato l’inserimento di un sistema a mantice semplicissimo, per cui viene aspirato ossigeno, utilizzato come carburante per la trasformazione degli scarti in cibo, producendo ed espellendo anidride carbonica, al contrario delle nostre macchine, che utilizzano il metano stesso per la fabbricazione del cibo, non producono anidride carbonica e la quantità di ossigeno bruciata, che doveva essere la soluzione dei nostri problemi, si è rilevata largamente insufficiente. Ma a parte tutto ciò, anche se concettualmente tutto quello che c’era di rivoluzionario è stato det38 to, la cosa che più a stupito noi profani di queste macchine è la varietà infinita di cibo prodotto, già caldo e con aromi e spezie che fanno impallidire le nostre cucine più elaborate. Ve ne è per tutti i gusti, a seconda di quale macchina si scelga: alcune lo producono da cereali, con odorini leggeri e delicati, altre da sostanze altamente proteiche, dai sapori forti e profumi intensi, altre ancora sono in grado di variare i loro prodotti a secondo del tipo di materiale che viene introdotto. Che scorpacciate! Anche nelle acque, a detta dell’Ufficiale Algus Carnosus che si è occupato di quel settore, esistono macchinari in grado di produrre cibo senza mai uscire sulla terra, forse utilizzando l’ossigeno sciolto nell’acqua. Rimane un quesito: chi le ha progettate e prodotte? Come si possono essere conservate fino ad ora ho già formulato quale possa essere l’ipotesi. Riguardo all’ultima domanda non è facile fornire un’ipotesi convincente: forse un’unica razza, intelligente ma timida, che al nostro arrivo si è tenuta nascosta o è fuggita in qualche pianeta vicino (Acqua ha tra l’altro un enorme satellite, quasi un pianeta gemello); oppure sono frutto di un’antica Civiltà, estinta per cause sconosciute, forse per una guerra fratricida; o ancora gli attuali abitanti non sono altro che dei vuoti simulacri di una popolazione trasformata da qualche malattia che ne ha distrutto le facoltà intellettive. Possiamo solo dire che abbiamo trovato enormi giacimenti di carbon fossile e petrolio che fanno pensare ad un’estinzione di massa. È certo che per capire il mistero di Acqua vi sarà bisogno di una lunga serie di viaggi e missioni. Prostrandomi alle Sue Radici Comandante Platanus Secolaris 39 Questo “divertissment”, che fa morire di risate i bambini quando glielo leggo, soprattutto quando descrive i sapori e i profumi delle “fatte”, l’ho impostato proprio durante una seduta, sull’unico supporto là disponibile, un rotolo di carta igienica. Come mai avessi avuto anche una penna con me, resterà un mistero. 40 L’OMICIDIO NON È UN GIOCO 42 1. Un uomo banale Si può definire la mediocrità? La banalità può essere un concetto che prescinde da epoche e civiltà? Un nome, infine, può condizionare una vita? Alle cinque e un minuto il signor Rossi si alzò dalla scrivania e, indossato il soprabito, s’incamminò verso l’uscita. Timbrò il cartellino e si diresse verso la sua vecchia utilitaria parcheggiata nel cortile della banca. Per coprire i cinque chilometri dalla banca a casa ci metteva dai 10 ai 13 minuti. Incontrava cinque semafori: il secondo e il terzo erano collegati in modo che se il secondo era verde necessariamente il terzo sarebbe stato rosso. Solo una volta, un giovedì che per lui era restato storico, un giovedì estivo di tre anni prima, c’era stata quella rara coincidenza per cui aveva attraversato il secondo semaforo nell’attimo in cui era scattato il verde e, senza rallentare, era arrivato in velocità al terzo che aveva ancora acceso il giallo. A questa rara evenienza, si era aggiunta la fortuna di trovare gli altri tre semafori tutti verdi. Quello storico giovedì aveva impiegato nove minuti netti. Cercò di ripararsi con la vecchia cartella perché si era messo a piovere intensamente: era la fine dell’inverno ma ancora non c’erano segni di primavera. Appena entrato, i vetri della piccola auto si appannarono all’istante. Mise in moto e accese il riscaldamento, avviandosi verso casa. Giunto al cancello del cortile, trovò il passo carrabile occupato da un’altra auto che nel tentativo di uscire dal cortile a marcia indietro si era incastrata nel paletto del cancello. Il guidatore stava provando maldestramente a disincagliarsi, peggiorando la situazione e distruggendo la fiancata. Dopo qualche secondo, il signor Rossi scese sotto la pioggia battente e, impaziente, bussò al finestrino dell’altra auto. Il guidatore, anzi, la guidatrice abbassò il vetro: lui riconobbe una segretaria del 43 piano superiore, gli sembrava si chiamasse Elena o Eleonora, con un cognome che finiva in etti, tipo Capetti o Losetti. Era una donna non più giovane, schiva, ma con due grandi occhi chiari imploranti e, in quel momento, disperati. S’impietosì e le chiese se avesse potuto risolverle lui la situazione. Annuendo grata, la donna scivolò sul sedile del passeggero e poi uscì dall’auto, aprendo un ombrello. Lui si mise al volante e in pochi secondi liberò l’auto: quando però cercò di uscire, si accorse che la portiera si era incastrata e non si apriva più. Uscì anche lui dalla parte del passeggero, pensando che la moglie sarebbe già stata impaziente. Una volta che ritardò di pochi minuti, la trovò sbraitante, ché doveva uscire e blà blà blà. Ma mentre stava risalendo sulla sua utilitaria, la donna gli si avvicinò e gli sussurrò: «Mi potrebbe accompagnare lei a casa?». Rimase sorpreso, cercò di inventarsi una scusa ma poi i suoi occhi lo bloccarono: «Non me la sento di guidare ed abito qui vicino, in via...». Calcolò che in effetti era una piccola deviazione e poteva farlo. parcheggiò l’auto di lei e la invitò a salire sulla sua. Lei si sedette rigida, senza guardarlo. Partirono e lui si immerse nella guida. I tergicristalli faticavano a tenere pulito il parabrezza: all’interno lo stesso era così appannato che colavano gocce. Alzò il riscaldamento al massimo ma con scarso risultato. Prese un panno dal ripiano mezzo sfondato sotto il cruscotto e asciugò il vetro. Trovò il primo semaforo verde. Quando giunse al secondo semaforo, si accorse che stava per verificarsi la rara congiunzione col terzo: l’AVANTI! pedonale lampeggiava e lui passò senza rallentare nel momento in cui scattava il verde. Sorrise soddisfatto guardando la donna, che era rimasta impassibile, poi realizzò che non poteva sfruttare quell’occasione. Difatti, cento metri prima del terzo semaforo avrebbe dovuto girare a destra per accompagnarla. Rallentò bruscamente e scalò in seconda grattando, svoltando quasi con rabbia. 44 «Ha una guida molto... sicura» commentò lei. Questa osservazione lo rabbonì. Dopo poco si fermò davanti ad un anonimo palazzo che lei gli aveva indicato. «Grazie. È stato molto gentile». Poi, senza preavviso, quasi d’istinto, lo baciò in bocca, fugacemente. Arrossì immediatamente e scese correndo sotto la pioggia, dimenticandosi persino di aprire l’ombrello. Lui rimase per qualche istante sorpreso. Poi, perplesso, tirò la levetta d’accensione e ripartì verso casa. Aprì il portone di casa con quasi quindici minuti di ritardo. Come aveva previsto, la moglie, in ciabatte e scarmigliata, lo investì di lagnanze. Il figlio maggiore, un bambino grassottello e indolente, senza aspettare che la madre finisse le sue invettive cominciò ad accusare la sorella di non si sa quale angheria nei suoi confronti. Forse per la prima volta nella sua vita, li considerò tutti sotto un’altra luce. Li odiò. Tutti. Anche la figlia, apparsa nel frattempo, che era identica al fratello e dal quale si distingueva soltanto per una lunga treccia nera. Fu quasi sorpreso dell’intensità di quello che provava. Si sentiva come uscito da una trance, come se qualcuno con un forte schiocco lo avesse risvegliato da un’ipnosi. Fino ad allora c’era stata indifferenza, forse anche rassegnazione. L’ineluttabilità della sua vita lo aveva sopraffatto. Aveva poco più di quarant’anni ma si sentiva vecchio. Non riusciva a distinguere i giorni l’uno dall’altro. L’unica parentesi da qualche anno l’aveva avuta d’estate, quando il resto della famiglia passava una settimana al mare da un’amica della moglie e lui restava solo, godendo essenzialmente della sorpresa che la solitudine gli procurava. Ma anche quell’occasione probabilmente si era persa: difatti aveva saputo per caso, e non dalla moglie, che c’era stato un tremendo litigio tra le due amiche. 45 Qualcosa delle sue sensazioni dovette essere percepito anche dalla moglie e dai figli, perché quasi subito le lamentele cessarono. Lui si tolse il soprabito, posò la borsa e andò nel suo studiolo, come faceva di solito. Si sedette e l’intensità di ciò che aveva provato non accennava a diminuire. Ad ondate lo assaliva, togliendogli quasi il respiro. Chi era quella gente che aveva invaso la sua casa, la casa dove era nato e che era stata dei suoi genitori. Come aveva fatto quella donna ad entrare nella sua vita. Ma si maledisse: era stata colpa sua. Ricordò come quindici anni prima l’aveva vista uscire dalla casa dei suoi sogni, quella villetta viareggina che lo assillava ogni volta che ci passava vicino. Già allora era una donna sgraziata e quasi asessuata, ma sua coetanea. Seppe che, orfana, viveva con la zia, sorella del padre, proprietaria della villetta. Il corteggiamento durò pochissimo e nel giro di sei mesi si sposarono. Fu tutto inutile. Alla morte della zia, dovettero rinunciare all’eredità per il rischio di perdere anche la sua di casa. Riuscirono a salvare solo alcuni mobili, di nascosto, non ancora inventariati. A questi ricordi una rabbia omicida lo riprese: se avesse potuto li avrebbe uccisi, tutti e tre, e ne avrebbe goduto. Forse l’episodio accaduto all’uscita dal lavoro, rompendo per la prima volta un ritmo uguale da anni, aveva compiuto il miracolo di farlo tornare in sé. E non stava certo fantasticando sulla scialba segretaria, di cui nemmeno ricordava bene il volto, ma solo gli occhi. D’altronde non era certo un fanatico del sesso né pensava di essere stato mai innamorato in vita sua. Eppure quel sentimento d’odio così violento gli dava uno strano piacere, così che indugiava, ci si crogiolava, cercava di non perderlo. Sentì persino un’iniziale eccitazione che involontariamente lo sorprese a toccarsi. Sorrise, quindi aprì la cartella e tirò fuori “La Settimana Enigmistica”, insieme ad un lapis 2B ben temperato ed ad una gomma per cancellare. Dispose tutto in ordine sulla scrivania e aprì la rivista sugli “Incroci Obbligati”. Risolse il cruciverba in poco più di un quarto d’ora senza nemmeno aver avuto bi46 sogno di usare la gomma. Una volta finito, quasi soprappensiero, lesse il corsivo sotto il cruciverba, anche se sapeva perfettamente cosa c’era scritto: “Destinato ai solutori più che abili”. Era vero, lui era un solutore più che abile. Risolveva senza difficoltà tutto ciò che era pubblicato sulla rivista, rebus, crittogrammi, cruciverba, indovinelli, sciarade... Era giunto il momento di risolvere qualcosa di più complesso e che gli potesse dare qualche reale vantaggio. 2. La Premeditazione e il Movente Un delitto. Cos’è un delitto? Per la nostra civiltà il crimine è qualcosa di ben catalogato, misurato, fin dai tempi dell’antica Roma. Ogni tipo di reato ha una sua punizione, graduata secondo criteri etici ed obiettivi. Le pene sono enormemente variabili e ogni caso giudiziario è a sé stante. La Legge sa bene che tipo di pena somministrare. E il Re dei reati è sicuramente l’omicidio premeditato. Più è elaborato, più ha la possibilità di sfuggire alla Giustizia e più la Giustizia s’incazza e non perdona. Ecco il motivo per cui l’omicidio premeditato, anche se non danneggia nessuno al di fuori della vittima, ottiene sempre il massimo della pena. In Italia l’ergastolo ma in altre nazioni addirittura la pena capitale. Certo, anche la rapina a mano armata con morti, oppure le stragi volontarie possono ottenere la stessa sentenza: eppure in quei casi è più facile trovare circostanze attenuanti, nonostante per la Società quei delinquenti siano decisamente più pericolosi. In effetti, chi elabora un piano per uccidere una persona precisa e solo quella, e ci riesce, ha ottenuto il suo scopo e probabilmente non lo farà più. Sicuramente al vicino di casa, che venga arrestato o meno il colpevole, non viene compromessa la sua sicurezza. Ma queste riflessioni non facevano che eccitare il Signor Rossi, il Signor Nessuno come si sentiva considerato, a sfidare la sorte. C’era il vantaggio appunto che gli altri lo consideravano un mediocre, mentre 47 invece era un fallito (e questa è una condizione decisamente più pericolosa); inoltre agli occhi degli investigatori praticamente non avrebbe avuto movente: per quale motivo avrebbe dovuto premeditatamente far fuori tutta la famiglia? Che vantaggi economici o altro ne avrebbe conseguito? Questi delitti si compiono d’istinto, sotto un raptus, non dedicandoci mesi e mesi di preparazione. Inoltre, quasi sempre si concludono con il suicidio dell’autore. Lui, invece, era pronto a dedicare tutto il tempo che ci voleva per portare a termine il suo piano. Anche anni. L’odio che provava, quello sì forse irrazionale, invece di portarlo al raptus lo portava freddamente a giocare, a considerare la premeditazione come un quiz di una rivista di enigmistica: “Come uccidere moglie e figli e uscirne libero e felice godendosi il resto della vita”. E non era certo un enigma facile. Già è complesso premeditare un “delitto perfetto”, figuriamoci tre, possibilmente in contemporanea. Quello sì che si meritava la dizione “destinato ai solutori più che abili”. Infine, ma non certo meno importante, che aveva da perdere? In Italia non è prevista la pena di morte. Anche se fosse stato scoperto, non avrebbe fatto altro che cambiare tipo di galera. La moglie aprì la porta dello studiolo senza alcun preavviso e con tono impersonale lo informò che era pronta la cena. Questo diritto arbitrario che i suoi familiari avevano di impedirgli una qualsiasi intimità lo irritò ancor di più. Guardò la sveglia sulla scrivania: in effetti erano già le otto e mezza. Era stato più di un’ora a rimuginare. Si alzò svogliatamente e li raggiunse a tavola. I due bambini avevano ricominciato a litigare ma lui non se ne accorse neppure. Mangiò in silenzio, non fece alcun tentativo di conversazione su alcune considerazioni fatte dalla moglie. Poi, si alzò prima del caffè e, con una banale scusa di lavoro, si chiuse nuovamente nello studiolo. 48 3. Elisa Scarlatti Elisa Scarlatti, così si chiamava la donna soccorsa il giorno prima, aveva lasciato sulla sua scrivania un biglietto. Con una certa curiosità lo lesse: “Caro Mario - posso chiamarti così, vero? - la tua disponibilità è stata per me come se il sole fosse apparso tra quei grossi nuvoloni grigi che ieri rattristavano la giornata. Per la prima volta nella mia vita ho conosciuto un uomo gentile, disinteressato, che mi ha fatto sentire importante. Non sai quanto bene mi hai fatto! Mi piacerebbe conoscerti meglio, sapere qualcosa di più su di te, sulla tua famiglia. Ti prego, dammi la possibilità di diventare tua amica, non te ne pentirai. Tua Elisa” La sua prima reazione fu di fastidio. Il biglietto era patetico, ridicolo. Anche se l’ultima frase conteneva una certa ambiguità... Comunque prese un foglio bianco e cominciò a risponderle: “Gentile Signorina Elisa, Il Suo biglietto mi ha fatto molto piacere. Purtroppo come Lei sa bene, sono felicemente sposato e ho due meravigliosi bambini...” A questo punto però si interruppe di colpo, come folgorato. Accartocciò la lettera e distrattamente la gettò nel cestino. Aveva passato parecchie ore la sera prima nel suo studio a cercare di abbozzare una linea di condotta, un qualche piano che prevedesse un alibi plausibile. Era giunto ad una conclusione sulla quale si era arenato: in ogni caso non ci sarebbero stati altri indiziati che lui, unico sopravvissuto. Non era cre49 dibile infatti inscenare una rapina nella quale miracolosamente sopravviveva solo lui, oppure riuscire ad ucciderli e poi far credere di essere da un’altra parte. Invece se fosse esistita almeno un’altra persona che potesse avere un movente valido da giustificare una tale strage. Ma dove trovarla? Loro non avevano parenti né amici o creditori o debitori. La loro vita sociale rispecchiava la sua vita lavorativa. Ma un’eventuale amante disillusa... Doveva sapere di più su questa Elisa. Andò a trovare il suo capufficio, che aveva fama di “tombeur de femmes” e si narrava che in banca non se ne fosse fatta scappare una che non fosse men che accettabile. Prese con sé il biglietto di Elisa e bussò al suo ufficio: «Giuseppe, ti posso disturbare un secondo?» «Vieni, vieni avanti!» Gli raccontò la vicenda del giorno precedente e gli fece vedere il biglietto. «Bene, bene! Sembra che l’uccellino si sia finalmente svegliato!» commentò sarcasticamente Giuseppe «Io, fossi in te, Elisa non me la farei scappare. È un po’ lunatica, ma anche una gran scopatrice. E poi fa certi lavoretti...» «La conosci bene?» Giuseppe lo guardò con un sorriso da marpione, che da solo valeva più di una risposta. «È» riprese il signor Rossi perplesso «che ho paura d’impegnarmi... sai, la moglie, i figli. Una scopatina me la farei ma possibilmente senza rischi». Il capufficio si fece serio, poi disse: «Senti, Elisa è una ragazza molto calda. Se si appassiona ti fa perdere il capo. Qui se la sono fatta oltre a me almeno altri due, e non ci sono stati particolari problemi. Stava al gioco. Tutti e tre siamo sposati e anche lei aveva un convivente da molti anni. Però devo dire con tutta sincerità che la situazione è cambiata. Il suo uomo l’ha piantata alcuni mesi fa e lei non l’ha presa bene. Io farei così: invitala senza impegno qualche sera, guarda che aria tira e poi agisci. Se hai bisogno di qualche consiglio fammelo sapere. Comunque starei in campana: un biglietto così a me non l’aveva mai scritto». Il signor Ros50 si ringraziò il suo capufficio per i consigli e tornò alla sua scrivania. Se qualcuno si fosse preso la briga di scrutargli il volto l’avrebbe trovato raggiante. Prese carta e penna e rispose a Elisa: “Mia dolce Elisa, mai avrei sperato che tu mi notassi, l’insignificante Signor Rossi, figuriamoci che tu addirittura volessi conoscermi. Da quando mi hai baciato...” Le scrisse una lettera così appassionata e intrisa di luoghi comuni che mentre la scriveva ci rideva sopra. Ma tutto filò come aveva previsto. 4. Sei mesi dopo... Le urla, i pianti che si sentivano dentro la toilette del personale della banca, avevano attirato molti impiegati. Soprattutto si sentiva la voce di Elisa Scarlatti, mentre tra una sua frase urlata e l’altra, il signor Rossi rispondeva quasi sussurrando. Lei urlava frasi tipo “Non puoi farmi questo! Non dopo tutto quello che c’è stato!” oppure: “Non è vero! Non ti credo! Non puoi lasciarmi! Non è giusto!” e infine, chiaramente: “Quella stronza! Se potessi l’ammazzerei come una cagna!”. A quel punto si udì anche il signor Rossi: “Calmati, tesoro, non è ancora tutto perduto. Vedrai, oggi ne riparleremo e cercherò di convincerla”. Uscirono dai bagni mentre il resto dell’uditorio si dileguava facendo finta di niente. Da alcune settimane erano diventati lo zimbello della banca tra litigi e riappacificazioni. Persino il Direttore ne era infastidito e temeva per il prestigio della filiale. Ma per il signor Rossi tutto stava andando esattamente come era nei suoi piani. Erano passati solo sei mesi. Sei mesi nei quali tutto si era svolto secondo le sue previsioni. Era incredibile come qualunque cosa avesse previsto si era puntualmente verificata. La facilità con la quale era riuscito a farla innamorare. Il divertimento a mentirle, a tenerla sulla corda. Finalmente il frutto era maturo. Contrariamente a quanto 51 pensavano di sapere i colleghi e la sua amante, la moglie e i figli erano all’oscuro completamente della sua relazione adultera. E ovviamente non era vero per niente che la moglie lo avesse minacciato di impedirgli di rivedere i figli se lui avesse continuato a frequentare “quella donna”. Le aveva promesso che avrebbe lasciato la moglie per andare a vivere con lei, le aveva fatto credere che la moglie avrebbe capito, che era una donna intelligente, civile. Ma anche le aveva detto chiaramente che non sapeva immaginare la sua vita lontano dagli adorati figli. Aveva quindi inventato il ricatto della moglie, ogni giorno aggiungendo particolari, dando false speranze per poi toglierle il giorno dopo. Giurandole eterno amore per poi ritrattare piangendo, pregandola di capire che lui doveva rinunciare al loro amore perché senza i suoi figli si sarebbe ucciso. La stava esasperando e attirarla nelle toilette per rendere pubblica l’ultima scenata era stato il suo “tocco finale”. Tutti l’avevano sentita urlare che avrebbe desiderato uccidere sua moglie. La creazione di un altro indiziato più credibile di lui stesso era compiuta. Soprattutto se questo fosse a sua volta morto e non fosse stato in grado di difendersi. Non restava che terminare il gioco. Aveva definito anche gli ultimi particolari: il giorno precedente le aveva sottratto di nascosto la piccola calibro 7,65 che le aveva regalato qualche mese prima, con la scusa che, vivendo sola, potesse esserle utile. Il mattino successivo lei sarebbe stata libera, perché aveva un appuntamento con il ginecologo, mentre dopo l’una, come al solito, tutta la sua famiglia era a casa. Non doveva far altro che chiamarla e dirle che l’avrebbe aspettata il giorno dopo con la moglie a casa sua durante la pausa pranzo. Lui sarebbe stato in strada e insieme sarebbero saliti al suo appartamento. Una volta entrati l’avrebbe uccisa usando la sua pistola, con un colpo a bruciapelo alla tempia e poi, all’apparizione della moglie e dei figli avrebbe sparato anche a loro. Subito dopo avrebbe inscenato un omicidio-suicidio e sarebbe tornato in banca. Ai colleghi, prima della pausa pran52 zo, avrebbe detto che sarebbe andato a mangiarsi un panino nel parco di fronte. Arrivò il giorno fatidico. Elisa accettò senza sospetti tutto quello che lui le disse. La illuse nuovamente dicendole che la moglie aveva finalmente capito e non l’avrebbe ricattato con la storia dei figli. La poveretta al telefono era raggiante. Quella mattina, come ulteriore precauzione, aveva lasciato l’auto dal meccanico per un tagliando e si era fatto prestare un veicolo sostitutivo, tra l’altro una piccola utilitaria identica alla sua ma di colore diverso. Riteneva giustamente che così nessuno avrebbe potuto notare la sua auto nei pressi di casa all’ora del delitto. Uscì gongolando e eccitato dalla banca all’una esatta. Passò il primo semaforo con il verde. Arrivato al secondo semaforo, notò con soddisfazione che anche la sorte gli era favorevole. L’AVANTI! stava lampeggiando e lui accelerò sorridendo passando nell’attimo in cui scattava il verde e già adocchiando il prossimo semaforo ancora verde. Contemporaneamente, però, il conducente di un grosso furgone proveniente da sinistra, vedendo scattare il giallo accelerò a sua volta passando il semaforo nell’attimo in cui si accendeva il rosso. L’urto fu violentissimo, essendo tutti e due i mezzi in accelerazione. La piccola utilitaria fu scaraventata contro il palo di un lampione, il motore schizzò fuori dal cofano posteriore e s’infilò dentro l’abitacolo di una grossa berlina parcheggiata venti metri prima dell’incrocio. Dopo pochi attimi, la piccola auto prese fuoco. Anche il conducente del furgone fu scaraventato fuori attraverso il parabrezza e si schiantò contro un’auto che si era appena fermata di fronte, entrando nell’abitacolo attraverso il parabrezza. Solo a tarda sera riuscirono a capire chi era quel cadavere carbonizzato. Nessuno, invece, si accorse della piccola pistola quasi fusa sul pavimento accartocciato dell’utilitaria. FINE 53 Ecco un gialletto. Non è un genere nel quale riesca molto e in fin dei conti il racconto di giallo ha poco. Quello che però secondo me rende il racconto interessante è il tratto psicologico del protagonista, la sua rabbia verso il fallimento della sua vita. Si sente defraudato, superiore intellettualmente all’umanità che lo circonda, ingiustamente relegato ad un ruolo comprimario dalla vita. La vicenda è senza tempo, anche se vagamente si potrebbe collocare negli anni settanta. 54 X-n-WY Il DIP (Dispositivo Integrato Personalizzato) l’avvertì: «È presente ad una distanza max. di 20 metri un X-300-WY. Vuoi contattarlo?». Un brivido le percorse la schiena. Un X300... Ne aveva sentito parlare dalle amiche, aveva visto tutti gli spot che lo riguardavano. Sì, doveva contattarlo. Doveva assolutamente vederlo dal vivo. Si morse le labbra e si guardò intorno. Riguardò il messaggio sul display del suo vecchio X200-WY. Il proprietario dell’altro X era lì intorno e anche lui aveva sicuramente ricevuto un messaggio analogo. Tutti gli apparecchi della serie X si riconoscevano. Aspettò, fremendo. Era uso dare comunque un segnale di ricevuto, magari anonimamente. La sicurezza che ciò avvenisse però non ce l’aveva e se il proprietario si allontanava senza rispondere avrebbe perso questa occasione unica. Decise quindi di prendere l’iniziativa. Riguardò il piccolo schermo per accertarsi che il messaggio ci fosse ancora e poi dettò al suo DIP: «Ciao. Mi piacerebbe vedere il tuo nuovo X-300. Se sei d’accordo, manda il segnale di riconoscimento. Alla fine del messaggio partirà il mio». Guardò il messaggio dettato, poi si fece coraggio e ordinò: «Invia!». Dopo pochi secondi l’apparecchio cominciò ad emettere il classico bip-bip che aumentava d’intensità man mano che si avvicinava all’altro DIP. Scoprì subito il proprietario, un ragazzo della sua età magro, con la faccia simpatica e gli occhi sinceri, sorridente. Il Centro Incontri quel sabato pomeriggio brulicava di persone, famigliole, coppie di anziani. I pannelli pubblicitari insistevano con l’immagine del modello X-300-WY, ma lei sapeva che ben pochi avevano già potuto permetterselo. Lei era l’unica del suo gruppo ad essere riuscita ad acquistare un DIP della serie X, già tre mesi prima. Le sue amiche avevano tutti vecchi modelli di sei, otto mesi fa e non riusciva a capire come potessero continuare il loro tran-tran senza cambiare i loro apparecchi. Finché non aveva acquistato il suo, lei non riusciva a dormire, aveva paura di perdere occasioni importanti, di rimanere emarginata. Aveva già vent’anni e ancora non 56 era riuscita ad uscire dalla sua Unità Territoriale. Ed era fortunata perché, lavorando nella Ditta che produceva i DIP della serie X, poteva avere delle piccole facilitazioni al loro acquisto. Era convinta che solo il possesso di quegli apparecchi dava la possibilità di uscire dall’Unità Territoriale d’appartenenza, grazie ad eventuali contatti fortunati. Quel pomeriggio però rimase delusa: conosceva quel ragazzo, anche se solo di vista, e sapeva che anche lui abitava nella stessa Unità. Lui, d’altronde, non si aspettava certo un incontro importante, sapendo quale modello lo aveva contattato. Fece un sorriso di circostanza e la salutò. «Posso vederlo?» gli domandò. «Eccolo» e le mostrò il suo nuovissimo X-300. A prima vista sembrava uguale al suo ma il ragazzo la prevenne: «Pesa 1 grammo meno del tuo ed è ben 5 micron più sottile. Inoltre mi hanno assicurato che la batteria dura almeno 30 secondi di più...». 30 secondi! Incredibile. Lei cominciò ad invidiarlo e guardava l’X-300 con avidità. «Sai che non posso fartelo toccare perché riconosce solo le mie impronte» «Ti è costato molto?» «Puoi immaginarlo...» «Beh, grazie» «Ciao» «Ciao». Il ragazzo scomparve tra la folla e con lui scomparve anche l’avviso sul display. Da quel momento i suoi pensieri non furono altro che per l’X-300-WY. Doveva averlo. A tutti i costi. Sentiva una specie d’angoscia allo stomaco che le diceva che se entro poco non fosse riuscita a comprarlo, sarebbe crollata la sua vita, le sue speranze. Però costava, lo sapeva, costava troppo. E doveva ancora finire di pagare quel maledetto X-200! Guardò l’ora nei numerosi schermi del Centro e capì che per quel giorno non poteva fare più nulla. E il giorno dopo era domenica. L’angoscia l’attanagliò. 57 Come passò il giorno festivo lo ricordò appena. Non finiva mai. Spilluzzicò qualcosa a pranzo e a cena. Nessuno venne a trovarla e l’apparecchio rimase silenzioso. Lei lo guardò con odio. Era sicura che se avesse avuto un X-300-WY la domenica sarebbe stata certamente diversa. Il suo micromonolocale doppio spazio con servizi a scomparsa le sembrava addirittura troppo grande. Pensò a quanto avrebbe risparmiato se l’avesse cambiato con uno a spazio singolo. Fece e rifece conti su conti per vedere se poteva permettersi il nuovo X300-WY, poi sconsolata si sdraiò ed entrò in sonni agitati. Il lunedì arrivò al lavoro stanchissima. Interrogò il Computer Capo per chiedere un’ora di permesso, che le fu accordata al prezzo di 10 centesimi di titolo. Erano tanti, poiché aveva richiesto negli ultimi due anni già tre permessi, e ogni permesso in più ne aumentava la trattenuta di un centesimo l’ora. Inoltre aveva anche avuto ben due giorni di malattia e altri due di riposo obbligatorio e il prossimo stipendio sarebbe stato di quasi un titolo in meno. Pazienza. Le fu accordato un permesso di un’ora a partire dalle 11:00. Appena apparve il segnale delle 11:00, schizzò al quinto piano dove si trovava il Computer Economo. Si sedette e lo interrogò: la situazione non era affatto rosea. Quel mese avrebbe avuto uno stipendio di 14,27 titoli. Di questi le sarebbero rimasti solo 5 titoli, il minimo ritenuto necessario per la sopravvivenza. Il resto andava per l’affitto e soprattutto per le rate dell’X-200-WY: ben 7 titoli, 42 centesimi e 7 millesimi. E questo per altri 10 anni. E fortuna che lavorava per la loro Ditta, così che gli interessi applicati alle rate invece che del 42% erano solo del 41,54%. Chiese al Computer se poteva permettersi l’acquisto di un X300-WY. il Computer elaborò i dati per alcuni secondi, poi apparve una striscia rossa intermittente con scritto in nero: ‘IMPOSSIBILE’. Sapeva che il Computer era programmato prevedendo per lei un tempo massimo di impiego di 10 anni, per cui aveva previsto la risposta. Infatti, la maggior parte 58 degli impiegati della Ditta, tra cui lei, venivano assunti all’età di 15 anni e si prevedeva che lavorassero al massimo per 15 anni. Poi di regola ricevevano offerte di impieghi più pesanti ma più redditizi e si licenziavano. Solo pochi continuavano per quello stipendio e chiedevano la conferma. Lei ipotizzò altri dieci anni di impiego e riformulò la domanda, questa volta speranzosa, ma di nuovo comparve la scritta ‘IMPOSSIBILE’. Chiese quanto tempo doveva rimanere impiegata per poter avere il prestito. Il Computer dopo pochi secondi indicò: «50 anni, 3 mesi, 14 giorni, 7 ore, 32 minuti, 15 secondi. Vuole confermare?». Guardò l’orologio. Erano le 11:24. Chiese: «Se dovessi licenziarmi prima di quella scadenza, quanto mi costerebbe?». Il Computer rispose: «L’intero prezzo del modello X-300-WY più gli stipendi corrisposti fino ad allora maggiorati del 50%. Vuole confermare?». Le 11:31. Che doveva fare? Sapeva di avere un apparecchio che non le serviva più a nulla ed inoltre lo stava pagando una fortuna. Le condizioni erano onerose, però forse con l’apparecchio nuovo la Grande Occasione sarebbe finalmente arrivata. Sempre tramite il Computer Economo cambiò il suo micromonolocale con un altro a servizio singolo: risparmiò quasi un anno di ferma. E di nuovo: «Vuole confermare?». L’orologio pulsava le 11:45. Tutto le girava intorno, poi come un automa sussurrò: «Sì». Sullo schermo del Computer apparve: «Parola non conosciuta. Prego rispondere con voce chiara Sì o No. Vuole confermare?». Le 11:53. Drizzò la testa, si schiarì la voce e pronunciò chiaramente: «Sì!». Lo schermo si riempi di numeri per qualche secondo poi apparve il messaggio: «Ritirare il buono necessario all’acquisto del modello X-300WY dall’apposita fessura». Lei guardò in basso, dove tre mesi prima aveva ritirato il buono per l’X-200-WY ed eccolo. 59 Ce l’aveva fatta! E anche in tempo. Infatti erano le 11:56. Tornò di corsa al suo piano, si sedette al suo posto ed attivò la presenza alle 11:59:32. Le avrebbero ritirato solo 10 centesimi. Mezz’ora dopo la fine del turno era al piano terra, allo spaccio per i dipendenti. Arrivò trionfante al banco e mostrò il buono: solo allora si avvide che il commesso era lo stesso ragazzo proprietario dell’X-300-WY incontrato il sabato pomeriggio al Centro del Territorio. «Vedo che non hai saputo resistere...» «Eh, già. Che dici, ho fatto male?» «Stai scherzando. Vedrai. Ti cambierà la vita. Lo sai che i messaggi ora sono personalizzati?» «Fantastico!» «Mi raccomando, tienilo sotto carica la prima volta almeno per due giorni. Poi accendilo e toccalo. Da quel momento sarà solo tuo» «Lo so, come feci per l’X-200-WY» «A proposito: dammelo, tanto ora non ti servirà più, e riconoscendo solo le tue impronte, una volta attivato l’altro ti diventa inutile: infatti sai che è proibito possederne due» «Eccolo. Te lo do volentieri». Il commesso lo prese e lo tagliò in due, come una carta di credito, gettandolo nella spazzatura. Poi, in modo cerimonioso, le consegnò la confezione dove campeggiava la scritta ‘X-300-WY’ e le disse: «Benvenuta nell’esclusivo club dei possessori dell’X-300!». Lei uscì dallo spaccio aziendale raggiante. Aveva dimenticato tutte le angosce, i sacrifici, gli infiniti anni che avrebbe passato alla Ditta. Dopo due giorni lo attivò e aspettò impaziente il sabato pomeriggio. Infine il grande momento arrivò. Alle 15:00 in punto, appena aprì il Centro Incontri del suo Territorio, lei fu tra le prime ad entrare. Girava tenendo d’occhio solo il display e... finalmente apparve il messaggio di avviso, davvero personalizzato: 60 «Ciao! sai che qui vicino, massimo a 20 metri, c’è un X-400WY? Vuoi contattarlo?» FINE 61 Quanti di voi stanno aspettando l’iPhone 5? Meditate, gente, meditate 62 IL BARLUME, OVVERO STORIA DI UN’AMICIZIA INCREDIBILE Sabato 26 febbraio 1966 - Martedì 2 agosto 1966 Il Barlume (Nino) «C’è qualcosa che non torna» si disse «Io mi chiamo Nino, ho undici anni, dodici fra cinque mesi, a luglio. Non supero i quaranta chili e il metro e mezzo, eppure mi sento come un vecchio quarantenne calvo e grasso. È vero che ho la mente confusa, quasi solo un barlume di coscienza e non ricordo bene come mai. L’ultima cosa che ricordo è l’allenamento che ho fatto con la squadra e che domani pomeriggio andrò all’Olimpico con papà a vedere il derby. Per l’occasione lui mi ha regalato il completo della Roma con il numero sette sulla maglia, lo stesso che ho io in squadra. Insieme a queste poche cose però ho anche vivida una visione da incubo: mi stavo portando in braccio morto. So che è impossibile: ma la sensazione era proprio questa. Nell’incubo io stesso portavo il mio corpo esanime in braccio per seppellirlo sotto un grosso pino...» «Sono nel buio più totale, ma insieme a me avverto la presenza di un altro. Una presenza immanente e molto più forte di me, che ha la completa padronanza del mio corpo. Questa presenza non mi permette alcuna volontà. Non posso vedere, percepire o muovermi. È come se stessi in un nulla e sono terrorizzato. Se provo a ricordare qualcosa di più mi accorgo di invadere parte di quest’altra presenza e la cosa mi spaventa e mi ritraggo. A volte l’altra presenza mi lascia inaspettatamente un po’ di spazio e avverto alcune sensazioni. Come quella di avere un vecchio corpo imbolsito. Oppure riesco a percepire qualche cosa dall’altra presenza. Desideri, pensieri, ricordi assolutamente estranei. Adesso l’altra presenza si sta ritraendo: provo a riprendere il controllo. Ecco: riesco ad aprire un occhio. Sono in una stanza 64 sconosciuta, dentro ad un letto matrimoniale e vicino a me dorme una donna che russa. La stanza è praticamente al buio... L’altro si sta riprendendo velocemente ed io mi ritraggo nuovamente e abbandono il controllo. Sono confuso e spaventato. Non so cosa fare. È come essere contornati da una nebbia fittissima, non solo esteriore ma anche interiore. Non posso chiedere aiuto. Non posso neppure sfogare la mia disperazione. L’unica certezza che ancora mi dà un minimo di forza per non soccombere completamente è quella della mia identità. Ma la coscienza dell’altro è fortissima e agisce ignorandomi completamente. Inoltre ho la sensazione che non sarebbe una buona cosa che l’altro mi “sentisse”. Devo approfittare dei momenti in cui per stanchezza lascia un po’ di campo libero per capirci qualcosa...» «È passato del tempo. Non so quanto, ma direi abbastanza. Le cose che sto scoprendo via via sono sconvolgenti. Ho capito che il mio corpo è cambiato. O forse non esiste più. Ora sono davvero vecchio ma è come se non fossi io. Non mi riconosco in nulla. Inoltre ho capito che siamo veramente durante il mio dodicesimo anno. Cioè, non sono passati trenta e più anni. Il poco di realtà che l’altro mi concede di percepire è lo stesso di quel poco che riesco a ricordare. Qualche momento fa, l’altro si è ritirato per un po’, come succede quando si addormenta. Ho aperto gli occhi (ogni volta che lui si ritira è l’unica cosa che riesco a fare) e ho visto che ero seduto al volante di un’auto in sosta, una Giulia, e che eravamo sicuramente a Roma anche se in un quartiere che non conosco. Le auto che passavano erano le stesse che vedo tutti i giorni. Davanti c’era un cartellone pubblicitario comunissimo, quello della benzina Supercortemaggiore, con il cane a sei zampe. Poi ho sentito una donna che chiamava -Mario!-. L’altro s’è svegliato (ormai posso dire che è così) e io sono tornato nel mio rifugio dove non percepisco più nulla, e che ho chiamato Limbo. Però ho im65 parato a non essere completamente all’oscuro. Riesco a sfiorare le sensazioni che prova l’altro per cercare di capire. Quando si lascia andare, oppure quando è molto impegnato a fare qualcosa, riesco anch’io a partecipare senza che se ne accorga. Ma se provo a forzare, a farmi sentire, l’altro mi invade fino quasi ad annientarmi. Anche se la sua è una reazione inconscia. L’altro non sa che ci sono. Oppure semplicemente non fa caso a me...» «Comincio a rendermi conto di tante cose. Devono essere passati alcuni mesi. Infatti fa caldo. Probabilmente siamo in piena estate. Ormai dovrei aver compiuto dodici anni. Il mio ospite si chiama effettivamente Mario e sono sicuro che il corpo che, ora lo posso dire, coabitiamo, è il suo. Io sono un intruso. Come ci sono arrivato, non lo so. Come non so se sono esistito o se esisto ancora da qualche altra parte, o in qualche altra dimensione. Certamente non conosco quest’uomo né le persone che lui frequenta. Non conosco questa parte di città e non ho più visto il mio quartiere. In tutto questo tempo, infatti, non siamo mai capitati dalle mie parti, al quartiere Nomentano. Ho conquistato una zona della sua mente che lui non sfrutta mai, così sono riuscito a ricostruire parte dei miei ricordi. Ho scoperto infatti che andando verso zone del cervello che lui non usa o usa pochissimo (e ne ha tante), riesco ad impadronirmene e a sfruttarle per ricostruirmi. Adesso ricordo distintamente i miei genitori, la mia sorellina Anna, la mia bella casa, la mia classe, il mio amico del cuore, i miei giocattoli... Insomma, tutto quello che fa (o faceva?) parte del mio mondo. Chissà se esiste ancora, se io esisto ancora, o addirittura se è mai esistito quel mondo. Se non sono che un desiderio inconscio di quest’individuo. Ho tanta tristezza e melanconia. Ma devo stare attento: quando sono molto giù e la disperazione che sento è fortissima, lui percepisce qualcosa. Fortunatamente però crede sia un suo stato d’animo. A volte, in questi casi, si 66 ubriaca. In quei momenti io divento padrone assoluto della sua mente, anche se purtroppo non riesco a comandarne il corpo. Così sono riuscito anche a conoscere di più la sua vita. E non mi piace per nulla. Quest’uomo mi fa paura. È cattivo con la moglie, che picchia spesso. Litiga con tutti. Una volta ha preso a pugni un altro e mentre lo faceva un’onda di piacere proveniente da lui mi ha sfiorato. È una specie di mostro. Non ha un lavoro fisso: vive di furti che compie con dei suoi pari. Ma ho capito anche che ha dei soldi nascosti, avuti in modo certamente poco lecito, con cui ha comprato l’auto, di cui va molto fiero e che guida in modo a dir poco spericolato...» Martedì 2 agosto 1966 - mercoledì 3 agosto 1966 Roberto I quattro ragazzini uscirono dal cinema che era quasi ora di cena. Erano eccitati e divertiti. «Hai visto che fico quel “Biondo”?» «E com’è zozzone “il Brutto”! È fortissimo!» «Anche Lee Van Cleef, però, è forte! È cattivissimo!» «A Robbè, te nun dichi gnente?» «Sì, sono d’accordo ragazzi. Però ora devo andare a casa. È tardi, fra meno di un quarto d’ora torna mio padre e andiamo a cena» «Anvedi che palle che sei!» «Lascialo stà, ha raggione. Anch’io devo annà a casa. Senti, Robbè, ci vediamo domani? Forse annamo a Ostia coi miei» «No, Maurizio, da domani mio padre è in ferie e partiamo per la Val d’Aosta per due settimane. Prima però ci fermiamo a Torino dai nonni. Torniamo dopo ferragosto» «Ah, ggià che te sei torinese e juventino! Ecco perché sei così fregnone!» 67 «La volete smette de rompergli le palle? A Robbè dijelo te che nun è vero che sei fregnone!» «Lascia stare, Maurizio, lo sai che mi sento romano. Non ho mai vissuto a Torino. E del calcio non è che mi interessi più di tanto. È più una tradizione familiare che tifo vero. Comunque ragazzi, davvero, mi piacerebbe restare ancora un po’ con voi, ma proprio non posso. Ci rivediamo dopo ferragosto! Ciao, eh?» «Ciao Robbè. Divertiti. Portece quarche stella alpina!» Roberto inforcò la sua Atala rossa n. 24 tre marce con il manubrio stretto sportivo, a cui aveva applicato ogni sorta di accessorio: le frecce a pila, il tachimetro, gli specchietti, le strisce di plastica colorate che ciondolavano alle estremità del manubrio, così che gli sembrava di cavalcare Napoleone, il cavallo di Capitan Miki, invece di una bicicletta, e mentre il tramonto si era già trasformato in crepuscolo, attaccò la dinamo e partì verso casa. Abitava a pochi isolati dal cinema, meno di due chilometri. Il fruscio della dinamo gli teneva compagnia e in quel momento si sentiva bene, eccitato dalla vacanza che lo aspettava, divertito dal film appena visto a cui ripensava, soprattutto dalla scena del “triello”. Quando la Giulia lo bloccò contro il marciapiede la prima reazione fu di sorpresa e quasi si indignò per la maleducazione del guidatore. Poi tutto avvenne velocemente, come in un sogno. Un uomo trasandato, che sembrava vecchio, calvo e in canottiera scese dal lato di guida, gli si gettò addosso e, sollevandolo letteralmente dalla bici, aprì lo sportello posteriore destro e lo scaraventò dentro l’auto, entrando a sua volta. Gli premette sul viso con una mano un fazzoletto che aveva un’odore molto forte e tutto svanì. I ricordi da quel momento si fecero confusi e disordinati. In seguito l’unica cosa vivida nella sua mente fu quella di essersi trovato nudo, bocconi, su un materasso sporco e maleodorante, immobilizzato da un peso sopra la schiena. Quan68 do provò a divincolarsi, qualcosa gli strinse la gola soffocandolo e di nuovo tutto si fece buio. Il Barlume (Nino) «Lo sta facendo di nuovo. Sta facendo ad un altro quello che ha fatto a me. Tutto mi è chiaro ora: mi ha ucciso, ad un certo punto mi ha ucciso. Ha aspettato che fosse pagata una parte del riscatto e poi mi ha ammazzato. Mi ha ucciso e mi ha sotterrato sotto il grosso pino dell’aia di questo podere. Non era un incubo. E tutto si sta svolgendo esattamente come era successo a me. Anch’io stavo tornando a casa in bicicletta, dopo aver fatto l’allenamento. Anche il mio rapimento si è svolto come questo. Solo l’auto era diversa, una vecchia millecento. Ora ha una Giulia comprata con quei soldi maledetti. Anch’io sono stato gettato nel sedile posteriore e drogato: ho provato di nuovo lo stesso terrore insieme alla sensazione di onnipotenza e di eccitazione che lui mi ha trasmesso quando ha fatto le stesse cose a questo povero ragazzo. E ora lo sevizierà e poi lo ucciderà, come ha fatto con me. E lui vivrà questi ultimi momenti in uno stato di semi-incoscienza indotto dal terrore, dal dolore e dalla droga. L’unica cosa che ancora non capisco è come e quando sono finito nella sua coscienza, anzi, nella sua mente. Mi sembra di ricordare come un vortice nero nel quale mi sono tuffato. Un vortice come... Come questo che si sta formando sotto di me!» «Adesso ho cambiato, di nuovo. Sono insieme alla coscienza di questo ragazzo. La vedo, anzi. È ripiegata su se stessa, assolutamente immobile. Provo a sfiorarla, ad invaderla, a trasmetterle degli impulsi. Ma è come se fosse annientata. E anch’io mi sento soffocare. Ho bisogno di ossigeno. Sta morendo! Devo riuscire a farlo respirare. Mi concentro e finalmente il senso di soffocamento se ne va. Sto respirando 69 di nuovo. Sì, adesso è meglio. Anche il cuore mi sembra abbia ricominciato a battere più regolarmente. Ora che la situazione è tranquilla, esploro questo cervello: provo a salire in superficie, ad aprire gli occhi. Sono sul materasso. È incredibile come tutto sia rimasto uguale a quando questo è successo a me. Lo stesso odore nauseante. Lo stesso materasso lurido. Solo la temperatura è diversa: quando è successo a me c’era un freddo tremendo che mi aveva quasi anestetizzato. Ora invece fa un caldo afoso. Per questo ragazzo deve essere davvero un’esperienza terrificante. Mario al momento non c’è. Mentre mi trasferivo deve essere uscito dalla stanza. Cerco di riordinare i ricordi di quando ero io al posto suo. Ogni volta che ero più cosciente, prima mi spaventava con minacce terribili se i miei non avessero pagato, poi mi iniettava un po’ di droga e usciva dalla stanza, chiudendo la porta a chiave. Io non ho mai provato ad uscire o a scappare. Non ne ero in grado. Rimanevo sdraiato in stato d’incoscienza in attesa della visita successiva. Fino a quando, ormai ridotto ad una bambola senza alcuna reazione, lui mi strangolò. Fu il senso di soffocamento che paradossalmente mi riportò in vita, anche se solo per un attimo. E in quell’attimo si aprì il vortice sotto di me ed io semplicemente non mi opposi a quel fenomeno» «Provo a fare quello che non mi è mai riuscito mentre ero ospitato nel cervello di Mario: provo a prendere possesso di questo corpo. È facile. La coscienza di questo ragazzo è completamente paralizzata. È come se fosse morto. La droga non sembra faccia alcun effetto sulla mia volontà. Forse lo stato di catalessi era dovuto solo al dolore e al terrore, e Mario poco fa non gli ha iniettato nulla. Anzi, prima di trasferirmi ho percepito un impeto di rabbia da parte di Mario: sono certo che pensa di averlo già ucciso» 70 «Rapidamente riacquisto tutta la corporeità perduta. Muovo le braccia, le gambe. Apro e chiudo gli occhi. Mi rigiro supino e mi metto a sedere. Provo di nuovo a stimolare l’altra coscienza, senza risultato. La stanza è come me la ricordo. C’è una finestra, chiusa con un foglio di cellofan. È notte fonda e si sente il frinire di migliaia di grilli. Ci deve essere luna piena perché nella stanza c’è abbastanza luce. Sono completamente nudo e ho le cosce bagnate di urina. Ho escoriazioni alle braccia e alle gambe, ma niente di rotto. Cerco qualche straccio da mettermi addosso, ma non c’è traccia dei vestiti di questo ragazzo. Mi avvicino alla finestra e strappo una parte del cellofan per guardare fuori. In effetti la luna è quasi piena e illumina l’aia con il grosso pino e la sua auto parcheggiata. Il podere è completamente isolato. Non c’è una luce visibile da nessuna parte. La finestra è però troppo alta per poter scappare. Era prevedibile perché anche nella stanza è il tetto della casa che fa da soffitto. Provo con la porta, sperando che Mario l’abbia lasciata aperta ritenendo questo ragazzo ormai morto. Invece è chiusa a chiave. Mi accorgo però che il pavimento è pieno di detriti e che le assi di legno del tetto sono nuove. Non erano così quando successe a me. Anzi, non c’era neppure il cellofan alla finestra, che era semplicemente priva di infissi. Capisco che stanno ristrutturando. Strappo del tutto il cellofan e guardo in alto. Il bordo del tetto, con la gronda di rame nuova nuova è lì, a poche decine di centimetri dalla parte superiore della finestra. Mi accovaccio per riflettere. L’avere un corpo così simile al mio mi sta esaltando. Sento che posso fargli fare le stesse cose che facevo io. Mi guardo le mani e le braccia, le gambe... Sì, ce la posso fare. Mi dimentico completamente della presenza della coscienza proprietaria di questo corpo. Sono di nuovo io, Nino Proietti di anni undici e mezzo (anzi, ormai dodici). E sono anche un ragazzino spericolato. Me lo dicono sempre i miei. Mi arrampico su tutti gli alberi, so fare la ruota e la verticale 71 camminando sulle mani a testa in giù. Ho fatto salti da quasi tre metri d’altezza. Inoltre sono un atleta, un’ala destra imprendibile, come Angelillo. O come Sivori, anche se purtroppo non gioca con la Roma. È vero, mi sono anche rotto un braccio quando avevo otto anni, cercando di saltare un ostacolo con i pattini. Che sarà mai perciò arrampicarsi su questo tetto. Pulisco bene il davanzale dai detriti e mi ci siedo, con la schiena rivolta all’esterno. Facendo scorrere le mani lungo il bordo della finestra cerco di aggrapparmi alla grondaia, ma è troppo in alto. Capisco che debbo salire in piedi sul davanzale. Lo faccio, prima mettendomi in ginocchio, poi centimetro dopo centimetro tirandomi su. Ora sono in piedi sempre con la schiena rivolta fuori e la testa a pochi centimetri dal bordo del tetto. Sono eccitato e spaventato. Ho il cuore che mi batte a mille ma queste sensazioni perdute sono bellissime. Sono aggrappato ai bordi della finestra e comincio a far scorrere la mano destra fino ad alzarla e ad afferrare la grondaia. Poi allento le ginocchia e provo a saggiare la resistenza della grondaia: non ha difficoltà a reggere il mio peso. Così allungo anche l’altra mano e mi aggrappo alla grondaia con tutte e due. Provo a penzolare: non succede nulla. La gronda regge perfettamente. Rimetto i piedi sul davanzale e finalmente sporgo la testa sopra il tetto. Poi mi do una spinta sia con le gambe che con le braccia e mi trovo con il petto appoggiato alla gronda. Riesco a tirare su la gamba destra ed ad appoggiare il piede sulla gronda e... è fatta! Sono sul tetto. Sono euforico! Salgo fino in cima al tetto, facendo attenzione a non far rumore con le tegole. Mi guardo di nuovo intorno. La luna sta tramontando e fra poco sarà più buio. Dall’altro lato della casa c’è un terrazzo collegato a terra con una scala. Probabilmente l’entrata principale. Mi avvicino e mi metto sdraiato sul bordo per capire che altezza c’è: dal bordo del tetto saranno meno di tre metri. Decido di provare a saltare. Sempre sdraiato a pancia sotto, sporgo prima le gambe e poi mi 72 lascio scivolare lentamente oltre il bordo fino ad aggrapparmi alla gronda e penzolare nel vuoto. Guardo sotto: il terrazzo è veramente vicino. Mi lascio andare e atterro non troppo bruscamente ammortizzando con le ginocchia. Un dolore acuto al calcagno destro però mi strappa un lamento. Rimango immobile per qualche secondo sperando che Mario non si sia accorto di nulla. Poi mi siedo e mi guardo la pianta del piede ferito. Sono atterrato su una scheggia di mattone che mi si è conficcata nel calcagno. La estraggo e una piccola bolla di sangue ne esce fuori. La tampono e provo ad appoggiare il piede: non mi fa poi così male. Posso camminarci. I muscoli dell’avambraccio, invece, dopo questi sforzi, mi fanno male. Questo ragazzino non mi sembra molto allenato. Non deve avere un gran voto in Educazione Fisica! Chissà che aspetto ha il suo viso. Se è biondo o moro. Mi accarezzo la testa: è strano non sentire sotto le dita i miei riccioli. Infatti questo ragazzo ha i capelli lisci, con la divisa a sinistra, almeno mi sembra, perché in verità sono arruffati e appiccicosi. La luna sta tramontando velocemente. Scendo le scale e arrivo sull’aia. Mi fermo accanto alla Giulia e mi viene un’idea. Mi guardo intorno e trovo quel che mi serve, un chiodo. Svito i tappi delle ruote e aiutandomi con il chiodo sgonfio tutti e quattro i pneumatici. Poi, sempre più euforico, comincio a correre attraverso l’aia verso la strada... In quel momento mi accorgo che i muscoli stanno contrastando la mia volontà. Capisco che la coscienza di questo ragazzo si sta svegliando. Mi fermo, proprio sotto al grande pino e mi sdraio sull’erba umida, forse proprio sopra di me...» Roberto Roberto aprì gli occhi e vide sopra di sé un cielo con milioni di stelle, in parte coperto dalle fronde di un grosso pino. Cercò di ricordare cos’era successo. Sentì l’umidità dell’er73 ba sulla schiena e sulle gambe nude, poi si appoggiò sui gomiti e guardò avanti. Vide il podere avvolto nell’oscurità e la Giulia ferma davanti. Di colpo il terrore che aveva provato lo invase di nuovo e cominciò a tremare. Gli tornò in mente tutto, lucidamente e vividamente, come uno schiaffo di violenza inaudita. L’unica cosa che non capiva era come fosse finito lì, sul prato. Si alzò in piedi e un dolore acuto al calcagno destro gli strappò un piccolo urlo. Si ributtò in terra e si massaggiò il piede alleviando il dolore. Poi si alzò di nuovo, appoggiando solo la punta del piede destro e si avviò zoppicando lungo il bordo erboso della stradina, allontanandosi dal podere Il Barlume (Nino) «Come con Mario, non riesco a mettermi in contatto con la coscienza di questo ragazzo. Però, quando si è ripresa, io non mi sono ritirato subito ma l’ho aspettata e per uno strano fenomeno e solo per un attimo sono stato lui. Si chiama Roberto, ha qualche mese meno di me, infatti ha finito la quinta elementare mentre io sono, cioè ero, già in prima media. Ha un carattere completamente diverso dal mio ma è un ragazzo sincero e buono. Forse un po’ troppo timido. Il problema però è che sta facendo delle cose idiote e così rischia di farsi riprendere. Sta già albeggiando e lui cammina zoppicando a due all’ora! Gli sto urlando di correre, di lasciare questa stradina e di buttarsi giù, verso la macchia. Di nascondersi! Mario può uscire da un momento all’altro e sono sicuro che anche con le ruote sgonfie ci inseguirà. Ma non riesco a comunicargli nulla. Nulla! Mi guardo indietro per vedere... Ehi! Sono riuscito a girare il collo. E lui me l’ha lasciato fare. Forse ha pensato ad un gesto automatico...» Roberto 74 Roberto si volse automaticamente, e vide che stava sorgendo il sole. Si bloccò impaurito e di colpo capì che doveva nascondersi, togliersi da lì dove poteva essere ripreso. Ormai aveva intuito di essere scappato. Senza sapere come, forse in “trance”, ma era scappato e non si sarebbe fatto riprendere. Cercò di appoggiare il calcagno del piede ferito. In fondo non faceva così male. Guardò a sinistra, dove alla fine di un campo incolto in pendenza cominciava una macchia. Ecco dove si sarebbe nascosto. Cominciò a correre giù per la sterpaglia. Sentiva bucare le piante dei piedi da sterpi e sassi ma la frenesia cominciò a prenderlo e non si fermò se non quando si trovò ben dentro il bosco. Si mise a sedere su un tronco caduto, ansimando per la corsa e per la paura, e si massaggiò i piedi doloranti e feriti. Le mani gli si macchiarono di sangue. Cominciò a singhiozzare a grosse lacrime. Dopo poco smise e una grande stanchezza lo invase. Scivolò dal tronco e perse di nuovo conoscenza. Il Barlume (Nino) «È svenuto! Però è probabile che anch’io avrei avuto le sue reazioni. Ora non sono reale, sono solo un ricordo lontano di quel che mi è successo. D’altronde quando mi è successo non sono stato in grado di fare nulla e sono stato ammazzato. Comunque forse è meglio sia svenuto. Ecco... la sua coscienza è di nuovo ripiegata su sé stessa. Ritorno alla corporeità e metto in allerta tutti i sensi. Sento il motore della Giulia e il rumore dei pneumatici sgonfi. Appena in tempo. La stradina sterrata è a circa cento metri da qui ma siamo ben nascosti. L’auto sparisce dalla visuale e il rumore si allontana. Decido di prendere in mano la situazione. Mi alzo e comincio a camminare parallelo alla strada. Non c’è segno di altre costruzioni ma di fronte, a meno di un chilometro, c’è un’altura ricoperta dalla vegetazione, attraversata dalla 75 strada che porta al podere. Difatti dopo poco vedo la polvere sollevata dalla Giulia. Calcolo la direzione e mi inoltro nella macchia. Fortunatamente non è molto fitta. Il problema sono i piedi nudi. Capisco che così vado avanti troppo lentamente. Mi guardo intorno: ci sono delle felci. Ne strappo un po’ e mi avvolgo i piedi con quelle foglie larghe e abbastanza resistenti, fissandole con dell’edera che funge da cordicella. Funziona. Posso camminare più spedito senza provare dolore. Certo, dopo poco il bendaggio artigianale si disfa, ma è solo questione di perfezionarlo. Roberto è ancora in catalessi e mi auguro che ci rimanga. Ripeto l’operazione ai piedi e ricomincio a camminare. Dopo un’oretta arrivo ad un torrente, quasi un fiume. Nonostante l’estate avanzata l’acqua è abbastanza impetuosa. Impossibile provare ad attraversarlo. Sulla destra, ad un centinaio di metri, c’è il ponte della strada che porta al podere. Ma appare irraggiungibile perché l’argine è impraticabile. Mentre sto pensando a come fare sento che Roberto sta tornando in sé...» Roberto Roberto si appoggiò al tronco di un albero e si guardò intorno. Di nuovo quella sensazione di assoluta confusione. Davanti a sé un torrente impetuoso, dietro il bosco e, in parte nascosto dalle fronde degli alberi, il podere. Non ricordò come ci era arrivato. Poi di colpo la realtà gli ripiombò addosso. Stava scappando da un mostro. Misto al fragore del torrente, sentì il rumore di un’auto. Si sporse e vide poco lontano un ponte, sulla destra, in direzione della corrente. Subito sul ponte apparve la Giulia che si fermò proprio nel mezzo. Ne scese il mostro e Roberto si ritrasse immediatamente tra i cespugli. Si inginocchiò e attraverso le foglie spiò quello che succedeva. Aveva un po’ paura, ma non tanta come prima. Si rendeva conto di essere ben nascosto. Il fatto poi di essere 76 stato capace di scappare e di essere ancora libero gli dava un senso di fiducia. L’uomo si sporse da una parte e dall’altra del parapetto e scrutò le acque tumultuose. Neanche per un momento volse lo sguardo in direzione del nascondiglio di Roberto. Poi risalì in auto e ripartì verso il podere. Roberto si sentì decisamente più tranquillo. Notò di avere i piedi fasciati da foglie di felce: anche questo non ricordava di averlo fatto, ma si congratulò con sé stesso. In effetti camminare era molto meno doloroso. Si sedette e cominciò a ragionare. Il sole era già alto, ma non ancora a picco. Qualcosa gli suggerì che doveva trovare il modo di attraversare il torrente: se la strada lo attraversava e poi finiva al podere, voleva dire che per uscire bisognava andare dalla parte opposta. Calcolò velocemente se conveniva provare a raggiungere il ponte, ma scartò subito l’idea. Un po’ per la paura di incontrare il suo aguzzino, e poi anche perché da dove si trovava sarebbe stato impossibile a patto di tornare sulla strada. Anche cercare di guadare il torrente sarebbe stata un impresa. Il letto nel punto dove si trovava era larghissimo, venti o forse addirittura trenta metri. La sponda era alta almeno tre metri, ed era a picco. La corrente poi era davvero molto forte. Inoltre, l’acqua sembrava profonda ed era molto torbida, con pezzi di legno e detriti portati dalla corrente. Probabilmente più a monte doveva esserci stato un temporale. Il torrente infine in quel punto faceva una larga curva e la sponda dove si trovava il ragazzo era quella esterna, dove la corrente era più impetuosa. In montagna suo padre gli aveva sempre detto che più si risalgono e più i torrenti diventano stretti. Decise di seguire questo consiglio. Prima però strappò un paio di enormi foglie che aveva notato sulla sponda e, utilizzando dei rampicanti a mo’ di cintura, si preparò una specie di gonnellino con cui finalmente si coprì. Sembra niente, ma quando si è vestiti in qualche modo ci si sente meno vulnerabili. Così conciato, come un piccolo elfo, cominciò a camminare dentro il bosco per non farsi vedere, cercando di dirigersi contro corrente, guidato dal rumore del77 l’acqua, e allontanandosi dal ponte. Dopo quasi due ore la macchia si aprì in una piccola radura e ritrovò nuovamente di fronte la sponda: il torrente lì compiva una curva brusca, quasi ad angolo retto. Inoltre scorreva dentro una specie di gola, profonda una ventina di metri e larga una decina. Sotto l’acqua ruggiva in modo assordante. Però era anche il punto dove il torrente era più stretto. Si sporse con cautela (soffriva terribilmente di vertigini) e osservò affascinato la rapida: incredibilmente non provò alcuna paura del vuoto. Come se non avesse mai sofferto di vertigini. Si alzò e si guardò intorno. Nella radura c’era un grosso leccio e all’altezza del primo ramo partivano due corde tese sopra la gola che erano legate ad un albero analogo sull’altra sponda. Erano messe una sopra l’altra a distanza di un metro circa. Aveva già visto un passaggio analogo durante le sue escursioni in montagna, utilizzato da persone esperte con cime di sicurezza. Sapeva come andava usato: ci si metteva in piedi di traverso sulla corda inferiore aggrappandosi a quella superiore e piano piano, passo dopo passo, mantenendo sempre tre punti di appoggio, si giungeva dall’altra parte. Sul tronco del leccio, chi aveva costruito quel rudimentale ponte aveva anche inchiodato delle assi di legno, a formare un abbozzo di scaletta per arrivare al ramo dove erano fissate le corde, ramo che si trovava almeno a tre metri da terra. Si sedette appoggiandosi al tronco, chiudendo gli occhi. Facendo dei gran respiri, per calmarsi e riflettere, cercò di trovare il coraggio e la concentrazione per provare quel passaggio. Si sentiva ancora condizionato dal timore che, una volta lassù, si sarebbe paralizzato per le vertigini. Poi di scatto si alzò, si strappò via le foglie di felce dai piedi e cominciò a scalare il tronco. In breve si trovò sul ramo. Subito si accorse di un altro imprevisto: le due corde erano ad una distanza comoda per un adulto, non certo per un bambino. Si mise in piedi sul ramo e si allungò il più possibile per cercare di afferrare la corda più alta, ma non ci riuscì, per pochissimo. Più avanti, lungo il ramo, le due corde sem78 bravano avvicinarsi. Strappò un rametto a forma di uncino e facendo una cosa che mai avrebbe pensato di essere in grado di fare, cominciò a camminare lungo il ramo, come un equilibrista: dopo soli tre passi allungò il rametto e agganciò la corda tesa sopra la sua testa, tirandola in basso. Con l’altra mano e allungandosi riuscì finalmente ad afferrarla, ma proprio in quell’istante il piede di appoggio scivolò e si trovò a penzolare nel vuoto aggrappato con una sola mano. Lasciò il rametto e si aggrappò alla corda anche con l’altra mano, poi facendosi dondolare riuscì a ritrovare sotto i piedi la sicurezza del ramo. Dopo essersi ripreso dallo spavento, cominciò la traversata. Arrivato dove il ramo diventava troppo sottile, passò sulla corda inferiore: la traversata si compì senza altre brutte sorprese e in pochissimo si trovò sull’altra sponda, scese dall’albero gemello usando una scaletta analoga e lanciò un urlo liberatorio di sfogo e di esultanza... Il Barlume (Nino) «È stato in gamba Roberto! Io non sarei riuscito a fare di meglio. Giuro che non l’ho aiutato! Ha fatto tutto di testa sua. Cioè, forse con la faccenda delle vertigini... che poi è solo paura del vuoto... Quando si è sporto, ho visto chiaramente che la sua mente stava creando una visione terrorizzante del suo corpo che precipitava nella gola. Non ho fatto altro che buttarmici sopra a pesce (alla visione) e lui ha percepito solo quello che vedevano i suoi occhi, senza immaginarsi niente di catastrofico. Ci credereste? Quando si è trovato sul leccio, il fenomeno non si è più presentato. Penso di averlo guarito! Comunque devo ricredermi: il ragazzo ha stoffa e coraggio e quel pizzico di prudenza che io non avrei. Inoltre conosce delle cose straordinarie. Io avrei cercato sicuramente di usare quelle corde, ma chissà in quale modo suicida. Mi sono proprio divertito. E che emozione quando è scivolato! Sono orgoglioso di lui, è un degno rappresentante di noi undicenni!» 79 Roberto È incredibile come il dover agire prima e il successo dopo ti galvanizzino, ti diano sicurezza. Roberto, un bambino di undici anni, un “soldo di cacio” come dicevano sempre i suoi genitori, che poche ore prima giaceva inerte come un bambolotto, ora si sentiva invincibile. Aveva fame e soprattutto sete, ma questi problemi non facevano altro che stimolarlo, che farlo sentire vivo. Si guardò intorno: questo lato del torrente sembrava decisamente meno selvaggio. Un sentiero simile a quelli che percorreva con i genitori nelle passeggiate in montagna, partiva dalla radura e rapidamente scendeva verso la sponda del torrente, fino ad arrivare al livello dell’acqua. L’acqua stessa formava dietro alcuni grossi massi delle morte dove era placida e limpida. Si diresse subito verso quel posto invitante. Si sfilò il vestito improvvisato e entrò nella più grande di queste pozze. L’acqua era fredda, alta non più di mezzo metro e calma e lui, arso dalla sete, bevve ad ampie sorsate. Poi si immerse e godette della frescura e della sensazione di pulizia. Dopo il bagno, si rimise il gonnellino silvestre ed esplorò i dintorni della sponda trovando un roveto da cui colse alcune manciate di more dolcissime, placando anche la fame. Infine, stanco ma felice, si sdraiò sul prato vicino alla sponda, sotto l’ombra di un alberello e si appisolò. Roberto e Nino Roberto si svegliò con la sensazione che qualcuno stesse giocando a pallone. Sentiva infatti dei tonfi ritmici come quando si prende ripetutamente a calci un pallone. Aprì gli occhi e si sedette. Davanti a lui, nel prato, c’era un bambino biondo e riccio, suppergiù della sua età, che indossava un completo della Roma con il numero sette sulla schiena e che stava pal80 leggiando da dio, colpendo la palla con tutti e due i piedi e anche con le ginocchia e contando i palleggi ad alta voce: «Settantotto, settantanove...» Roberto lo osservò ammirato: lui a calcio era sempre stato una frana, anzi una “pippa” come dicevano i suoi compagni, che le rare volte che lo facevano giocare lo mettevano sempre in porta. Arrivato a novantanove, il ragazzino calciò la palla più in alto e poi, concludendo con un: «...e cento!», prima che ricadesse a terra si girò e la colpì in sforbiciata al volo di destro, con un gesto simile a quello che c’era sull’album delle figurine Panini. Il pallone arrivò addosso a Roberto, che d’istinto lo parò respingendolo. «E bravo Roberto! Bella parata!» esclamò il ragazzino avvicinandosi e sedendosi a gambe incrociate davanti a lui. «Tu mi conosci?» domandò Roberto perplesso. «Certo, ma anche tu mi conosci» Roberto lo guardò curiosamente. In effetti quel bambino gli era familiare. Era sicuro di non averlo mai incontrato, ma era come se lo conoscesse da sempre. Soprattutto non era sorpreso di vederselo davanti. «Tu sei Nino!» affermò d’improvviso, come se si fosse ricordato di una cosa ovvia «Nino Proietti!». Poi aggiunse confuso: «Ma sei vero o ti sto sognando?» «L’uno e l’altro» rispose Nino «Se in questo momento arrivasse qualcuno vedrebbe solo un ragazzino con un buffo gonnellino di foglie addormentato sotto un albero. Quasi una scena da Peter Pan, lasciatelo dire! Però io sono anche reale. Diciamo che comunque lo sono stato» Allungò le braccia verso di lui e aggiunse: «Dammi le mani...». Roberto obbedì e afferrò le mani di Nino. Subito seppe ogni cosa, sul mostro e su quello che era successo cinque mesi prima, un sabato di fine febbraio. E poi per un momento infinito diventò lui stesso Nino, così che il suo mondo, i suoi ricordi e i suoi sogni si mischiarono ai propri. Si rese conto che loro due erano diversi ma anche simili. Che parole come 81 “amicizia” o “lealtà” avevano lo stesso significato per tutti e due. Quando si lasciarono le mani, Roberto aveva gli occhi umidi di pianto, ma Nino sorrideva. «Ora sono contento» disse «so che la mia breve vita è custodita per sempre da un grande amico» ...in seguito Quella giornata finì velocemente. Roberto, seguendo il sentiero, uscì dalla macchia e trovò, ai margini di un campo di stoppie, un contadino che vicino ad una baracca stava zappando l’orto ascoltando un transistor. Passata la sorpresa di trovarsi davanti quel bambino seminudo, lo portò con il proprio Apino alla stazione dei Carabinieri del paese vicino. Lì fu riconosciuto subito dal Maresciallo come il bambino di cui era stata segnalata la scomparsa, Roberto Ferlinghetti, e da quel momento gli eventi portarono velocemente ad una giusta e logica conclusione. Roberto, oltre a far arrestare immediatamente il rapitore pedofilo e il suo complice, il proprietario del podere, indicò il posto dove era stato sepolto Nino raccontando che era stato lo stesso rapitore a mostrarglielo, con la minaccia di fargli fare la stessa fine se avesse tentato di ribellarsi. Da allora Roberto ebbe una vita serena e piena di soddisfazioni. Diventò una discreta ala destra, procurandosi l’ammirazione dei compagni, specialmente quando palleggiava, anche se non praticò il calcio che per diletto. Inoltre da giovane si appassionò alle scalate in parete e al volo a vela, di tutti i tipi, dal deltaplano al parapendio e anche al paracadutismo. Tutte le volte che vola (perché ancora vola) o scala una parete difficile, ripensa a Nino. Diventato medico, cercò anche una spiegazione logica al fenomeno che aveva vissuto. Poteva essere successo che nel momento estremo, un barlume della coscienza di Nino, desiderando di sopravvivere, avesse trova82 to rifugio nella mente del bruto suo malgrado, durante quell’incontro fisicamente e psichicamente coinvolgente anche se terribile e terrorizzante. Per cinque lunghi mesi questo barlume si era alimentato con le energie di quel cervello, sostenuto solo dalla volontà di sopravvivere come identità. Quando la stessa cosa era toccata a lui, quella coscienza ritornata ad essere Nino riuscì a passare nella sua mente, questa volta scientemente, sfruttando i momenti drammatici ma così simili che aveva già sperimentato. Nel breve ma intenso e unico loro incontro, Nino gli comunicò quello che aveva sentito nel momento del trasferimento: «Mario ti stava uccidendo perché ti eri ribellato. Probabilmente non ti aveva drogato abbastanza e quando ha iniziato a... farti del male, tu ti sei ribellato, ti divincolavi e l’hai morso. Per reazione ti stava strozzando e in verità la tua coscienza si è spenta quasi subito e non respiravi più. Io ero disperato perché non sapevo come impedire questo nuovo delitto, però mi ero accorto che il terrore che avevo “sentito” veniva da te. Mi sono guardato intorno e ho notato nuovamente quella specie di vortice che mi aveva consentito di far passare l’ultimo barlume della mia coscienza nella mente di Mario e l’ho utilizzato. Come sono “entrato” nella tua mente, mi sono accorto che la tua coscienza era priva di qualunque volontà. Anche il cervello non reagiva quasi più e c’è voluto da parte mia uno sforzo enorme per farti riprendere a respirare. Sono convinto che quel mostro pensava di averti già ucciso» Più passava il tempo e più Roberto era sicuro che Nino avesse ragione e che la sua esistenza la doveva interamente a quel bambino. Da quel giorno “il barlume di Nino”, come lui stesso si era autodefinito in quell’incontro, non si era più manifestato. Ma non credeva che fosse sparito: semplicemente non c’era più bisogno che si nascondesse e quella parte di Nino che era sopravvissuta si era fusa con lui stesso. Ora lui era Roberto, certamente, e l’infanzia che ricordava era la sua. Ma 83 distinta e non per questo meno reale, trovava posto anche la breve esistenza di Nino. Mercoledì, 27 maggio 2009 Roberto «Eccole la ricetta, signora» «Dottor Ferlinghetti, c’è il Dottor Costa al telefono per lei» disse entrando nell’ambulatorio l’infermiera. «Me lo passi» rispose Roberto. «Roberto, hai finito? Sono quasi le sei!» «(coprendo un attimo la cornetta) Mi scusi signora, un collega... Ho l’ultima visita, se me la fai finire» «Ma ti rendi conto che fra poco più di due ore comincia la finale? Guarda che io massimo alle sette e mezza voglio stare all’Olimpico» «Non ti preoccupare che la partita non ce la perdiamo. Ti aspetto sotto casa alle sette. Andiamo con il tuo scooter, vero?» concluse Roberto. «Che va a vede la finale, Dottò?» s’intromise la paziente «Ce vanno puro mi marito co mi fijo e i nipoti. Tutti a gridà Forza Roma! Io nun posso pecché so vecchia. La guarderò su Scai» «Sì signora,» le rispose Roberto «vado alla partita con degli amici. Però io tifo per la Juve. Sono torinese, sa» «Vabbè, nessuno è perfetto. Comunque nun è grave, nun se preoccupi. Vedrà che stasera guarirà» Roberto non era mai entrato in uno stadio in vita sua. Il calcio professionistico era sempre stato un mondo marginale dei suoi interessi. Quel giorno, però, non poté fare a meno di rimanere colpito dai colori e dalla coreografia che il pubblico aveva preparato per quell’avvenimento eccezionale, soprattutto nel settore della curva sud. Una volta che si sedette in 84 tribuna, con un gruppetto di amici tutti juventini, il dottor Costa tirò fuori da un sacchetto due magliette bianconere, una di Del Piero e una di Trezeguet, e dette quella del francese a Roberto «No,» si schernì lui «Ma dài che stasera gliene facciamo quattro» «Meno male che sei ottimista» «Non è ottimismo: è realismo. Abbiamo vinto lo scudetto e in campionato loro sono arrivati quinti. Li abbiamo stracciati sia a Roma che a Torino» «Mah, sarà» replicò Roberto «Io ti dico che non sarà una passeggiata. La Roma gioca bene, è una partita secca, sono nel loro stadio» «Perché non sei un vero tifoso» replicò con stizza il dottor Costa «E meno male» gli rispose Roberto «almeno vedo le cose con più distacco e obiettività» La partita iniziò e Roberto si dimostrò certamente più realista. Alla fine del primo tempo le squadre erano ancora sullo zero a zero ma la Roma aveva obiettivamente giocato meglio. «Che ti dicevo, Marco?» «Ma che tanto tanto vòi portà jella? Li abbiamo fatti stancare. Ora entra Alessandro e vedrai...» Ma anche nel secondo tempo il gioco lo condussero i giallorossi e all’ottantesimo accadde l’inevitabile. Da un anticipo di Juan, il pallone passò a De Rossi che di prima imbeccò Tonetto. Rapido scambio con Vucinic, poi cross teso a mezza altezza e dal limite dell’area bianconera il Capitano colpì in sforbiciata al volo di destro, “come il giocatore sulla copertina dell’album delle figurine Panini”, pensò Roberto, “anzi, come avrebbe fatto Nino” e il pallone s’insaccò nel set, imparabile anche per Buffon. L’urlo gli uscì liberatorio e cominciò a saltare, unico con la maglia bianconera, ebbro di gioia, gridando a ripetizione 85 GOOOL! e FORZA ROMA! Gli altri lo guardavano stupefatti. Il dottor Costa disse malignamente: «È questo il tuo distacco?». Roberto lo guardò raggiante, poi si tolse la maglietta e gliela gettò addosso: «Questa non credo che mi serva, tu che dici? Te saluto, Marco! Godite la sconfitta!» Proprio sotto di loro, ad una decina di metri, una famigliola stava festeggiando rumorosamente. Roberto fu colpito dal bambino, un ragazzino di dieci, undici anni, con i riccioli biondi, che indossava un completo della Roma decisamente retrò, con la maglietta di lana leggera di un rosso d’altri tempi e il colletto a polo giallo, non ocra, i pantaloncini bianchi di cotone e i calzettoni di lana rossi con la risvolta gialla. Sulla schiena un bel sette bianco. Roberto non ebbe alcuna esitazione. «Bel completo che hai» disse al ragazzino. Lui si voltò e continuando a saltare di gioia gli rispose: «Era di mio zio!» «Lo so. Di tuo zio Nino» «Anch’io mi chiamo Nino!» «Non avevo dubbi» «Scusi, ma lei conosceva mio fratello?» li interruppe la madre. «Praticamente eravamo la stessa persona» le rispose Roberto. «Il suo nome, se non sono indiscreta?» lo interrogò con sospetto. «Sono Roberto Ferlinghetti, signora Anna». La madre del piccolo Nino mormorò tra sé rivolta al marito: «Il bambino che fece arrestare l’assassino di mio fratello...» poi rivolgendosi di nuovo a Roberto, «Ma lei non può averlo conosciuto. Nino era già morto da più di cinque mesi» «Oh, si sbaglia signora. Sa, quando si è bambini la nozione del tempo è molto soggettiva. Lo conoscevo, suo fratello. Lo 86 conoscevo molto bene». Parlando poi al piccolo Nino continuò: «Sai, l’ultima volta che ho visto tuo zio, era vestito proprio con il completo che ti ha lasciato e mi ha fatto un tiro identico a quello di Totti di stasera. Solo che io l’ho parato. Anche se ripensandoci forse voleva che lo parassi...» «Senta» sbuffò la madre «questo è impossibile! Mio fratello non ha mai indossato questo completo, glielo posso assicurare!» «Se lo dice lei, deve essere vero...» confermò Roberto strizzando l’occhio al piccolo Nino. Poi, di nuovo al bambino: «Hai una sciarpa anche per me?» «Tieni!» fece Nino, passandogli la sua. «Posso sedermi vicino a te per assistere alla premiazione?» «Certo, zio, vieni qui che a ‘sti juventini jamo fatto li bozzi!» FINE 87 Quanti di voi hanno già letto “Diario minimo...” troveranno molti punti in comune con questo racconto, scritto nel 2008, a cominciare dal nome di uno dei due protagonisti e dall’epoca, anche se la storia è completamente diversa. Inoltre, il fantasma di Nino è il personaggio più commovente che ho mai ideato. In letteratura c’è una cosa simile, un romanzo di una scrittrice sudamericana, Gioconda Belli, intitolato “La donna abitata”, che però ho scoperto dopo aver scritto questo racconto. Infine voglio dare questa precisazione: il racconto è stato scritto l’anno che la Roma sfiorò lo scudetto con Spalletti e immagina che la finale dell’edizione di Champions League dell’anno successivo, che si sarebbe svolta a Roma, avesse come protagoniste la Roma e la Juve. E forse in un mondo parallelo è andata proprio così. Di seguito ho allegato anche un po’ d’iconografia. 88 ICONOGRAFIA Mi sono divertito a ritrovare le foto degli oggetti e dei personaggi nominati nel racconto. Così ho allegato le immagini di Angelillo, Sivori e della copertina dell’album della Panini del 1966 (ho ancora gli album dei Calciatori dal 1963 al 1966, quelli che ho riempito da bambino), della Alfa Romeo Giulia e della Fiat 1100, della pubblicità d’epoca della Supercortemaggiore, il manifesto de “Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo” e infine alcune strisce di Capitan Miki dove l’eroe si rivolge al proprio cavallo. 89 90 91 IL MIO ANNO PREFERITO PREFAZIONE Nick Hornby ha pubblicato una divertente raccolta di racconti scritti da personaggi più o meno famosi in Inghilterra e Irlanda che hanno come tema il tifo per la propria squadra di calcio. In particolare ognuno doveva descrivere l’anno calcisticamente più importante o particolare. La raccolta si intitola “il Mio Anno Preferito - Racconti di Calcio” e in Italia è pubblicato da Guanda. Le storielle sono simpatiche ma hanno il limite per noi italiani che riguardano solo squadre inglesi o irlandesi, a volte di serie infime (third o fourth Division) e di un ambiente che non conosciamo. Se da una parte ti rivela un mondo del calcio decisamente più sano e radicato rispetto al nostro (quando mai in Italia ci sono 30.000 persone a vedere partite di C2?), d’altro canto la maggior parte di allusioni o di ricordi riguarda eventi a noi sconosciuti. Così ho provato a prendere spunto dal libro come fosse un invito e ho scritto anch’io un resoconto di quello che per me fino ad oggi considero l’anno più incredibile che ho passato da tifoso. Dalle Stelle... alle Stalle Roma 1985/86 I tifosi hanno sempre degli stati d’animo estremi. O sono in un momento di eccezionale felicità o di tremenda disperazione. E questo a prescindere di come si comporti la squadra del cuore. Anche il campionato più anonimo porta sempre delle aspettative: quella data partita, quel turno di coppa. Il sabato si è in trepida attesa e la domenica o si è al settimo cielo o alla disperazione. Chi è un vero tifoso lo sa: non esistono le mezze misure. Diffidate di chi si definisce tifoso e poi rimane tiepido di fronte ai risultati della domenica. Ci sono però dei periodi eccezionali dove questa alternanza non c’è e, o la squadra cade in un vortice irrefrenabile di sconfitte che porta inevitabilmente alla retrocessione (e in tal caso alla disperazione subentra una sorta di rassegnazione), oppure al contrario i propri beniamini diventano pressoché invincibili e ti fanno vivere in una specie di trance che hai paura possa finire da un momento all’altro. Situazione decisamente più rischiosa per la propria stabilità psichica. Anche se quello che affermerò ora sarà contestato dai tifosi dell’Inter, sono però arciconvinto che la mia squadra. per chi non lo sapesse ancora l’AS Roma, abbia una caratteristica che le altre presentano molto più raramente. Quella di illuderti, di farti sognare e poi di gettarti nello sconforto non in un fine settimana, dopo una partita, ma per un intero campionato o torneo internazionale. Non ricordo più quante partite già vinte sulla carta, incontri della svolta o delle conferme sono invece finiti con la sconfitta. È come se qualcosa si rompesse quando ormai il più è fatto. La Roma è riuscita a perdere campionati dominati, l’unica finale di Coppa dei Campioni disputata e per giunta nel proprio stadio, finali di coppa UEFA o semifinali di Coppa delle Coppe, finali di Coppa Italia. Se avesse vinto tutte le volte che è arrivata lì per lì adesso avrebbe una bacheca paragonabile a quella degli squadroni del nord. Ma il Campionato 1985/86 è rimasto e rimarrà inarrivabile. Forse si è avvicinato a quell’evento incredibile solo il Campionato scorso (2005/06), caratterizzato da un’entusiasmante rincorsa alla Fiorentina per il 4° posto (valevole per l’ingresso ai preliminari di Champions League) partendo da -12, 94 conclusasi con il sorpasso a metà circa del girone di ritorno grazie allo straordinario record di 11 vittorie consecutive, ma risoltasi a favore dei viola nell’ultima parte del campionato dopo un’alternanza di sorpassi e controsorpassi. Ma in questo caso la conclusione, seppur accompagnata da una delusione cocente, specialmente per me che vivo a Firenze, è stata abbastanza prevedibile (era già un paio di turni che si era capito che la Roma non aveva più birra). E poi lo scandalo di calciopoli ha reso vano tutto quanto. Nel 1985/86 la Roma veniva da un campionato precedente scialbo, finito con un settimo posto, il primo della coppia Clagluna - Eriksson in panchina dopo la partenza del “Barone” Liedholm, del “bimbo” Ancelotti e di Capitan Di Bartolomei (tutti e tre approdati al Milan). Di quell’anno si ricorda solo il coro “che sarà, sarà” cantato dall’intero stadio dopo l’eliminazione in coppa UEFA da parte del Bayern e che affascinò gli stessi giocatori e tifosi tedeschi. La breve ma intensa stagione di grandeur iniziata con il Campionato 1980/81 (quello del gol di Turone annullato e che regalò lo scudetto alla Juventus), culminata nel 2° scudetto (1982/83) e nella finale romana di Coppa Campioni persa ai rigori contro il Liverpool (30/5/1984), sembrava definitivamente finita. Il “Barone” aveva portato con la sua Roma il gioco a zona in Italia e quella squadra aveva fatto innamorare molti bambini di allora. Oserei dire che ancora oggi gli unici tifosi giallorossi non romani che ho trovato sono trentenni che all’epoca di Liedholm, Conti e Falcao avevano 10 anni e che ammettono candidamente di essere diventati tifosi della “Maggica” in quel periodo e per quegli atleti. Quel periodo è stato possibile grazie ad un grande Presidente, Dino Viola. Costui è stato senza dubbio il più grande Presidente che la Roma abbia avuto. Suppliva con la fantasia, la competenza dei suoi tecnici e l’audacia al gap economico con le tre grandi squadre del nord. Prima aveva scommesso e vinto con la zona e Li95 edholm, lanciando un giocatore semisconosciuto come Falcao. Poi, finito il ciclo, si ricordò di un altro allenatore svedese, che qualche anno prima aveva umiliato la grande Roma all’Olimpico con il suo Benfica in Coppa UEFA, e che predicava una zona molto più spregiudicata e aggressiva: Sven Goran Eriksson. Allora in Italia vigeva una regola che impediva di impiegare allenatori stranieri. Viola mise al posto di Liedholm un allenatore ombra, Clagluna, e ingaggiò come vero tecnico lo svedese più giovane, sfidando le ire del palazzo. Dopo il primo anno di quella strana coppia, Viola cercò di accontentare lo svedese e rinforzò la rosa. Arrivarono un buon terzino di fascia, Gerolin, un centrocampista di sostanza come Desideri e soprattutto il bello di notte, lo juventino Zibì Boniek. Boniek, uno dei migliori giocatori mai arrivati a Roma, giocò con la maglia giallorossa praticamente solo quel campionato, ma si innamorò completamente e incondizionatamente di quella squadra e del suo pubblico (e come non avrebbe potuto?) così che ancora oggi è uno dei primi tifosi giallorossi. Il campionato cominciò con fortune alterne. Dopo le prime due partite, vinte entrambe, la Roma cominciò una serie di vittorie casalinghe e sconfitte esterne che ad un tifoso superficiale fecero pensare nella migliore delle ipotesi ad un campionato di transizione (così i tifosi chiamano i campionati deludenti) di metà classifica, magari con qualche soddisfazione in coppa Italia. Ma io non ero un tifoso disattento e le poche volte che riuscivo a seguire la squadra mi accorgevo che il gioco espresso era semplicemente esaltante. La Juventus intanto volava, avendo vinto le prime otto partite e accumulato già un pesante vantaggio su quelle che si pensava potessero essere le concorrenti: le solite Inter e Milan, il Napoli di Maradona, il Verona campione in carica, il Torino e la Fiorentina. Eppure la Roma non era una squadra mediocre. Le sconfitte fuoricasa erano bugiarde. La Roma creava molte palle 96 gol che poi non sfruttava e in difesa ancora i nuovi meccanismi del fuorigioco non funzionavano a dovere. Ma la squadra divertiva e se la giocava. Io quell’anno vivevo a Pisa. Avevo cominciato a lavorare come medico delle Carceri e intanto mi stavo specializzando in Chirurgia. Quando non ero di turno al carcere, continuavo a fare il volontario nella Chirurgia ospedaliera dove ero arrivato ormai da quattro anni. Il Pisa quell’anno era in serie A, ma il reparto brulicava di juventini e interisti. In particolare il caposala della Sala Operatoria era uno juventino piuttosto acceso, che mi prendeva per scemo primo perché venivo a lavorare gratis, anche la notte, e poi perché ero romanista. Poco prima di Natale, domenica 15 dicembre 1985, ci fu la svolta. La Roma vinse la sua seconda partita fuoricasa, contro il Lecce, con un rotondo 3-0. Vedo già i sorrisini furbi di chi non ci può soffrire. Di chi sa come andò a finire. Eppure sì, come in un copione banale, tutto cominciò a Lecce. Nessuno ci fece caso se non pochi tifosi attenti come me. Il Lecce era ultimo e le prendeva da tutti, indifferentemente in casa e fuoricasa. Non era certo stata un’impresa storica. Però la Juve quella domenica pareggiò e i punti di distacco da 9 passarono ad 8. Si, eravamo esimi, tra noi e loro c’erano almeno altre cinque squadre. Ma quella domenica le occasioni furono sfruttate, i fuorigioco funzionarono a meraviglia. La squadra, insomma, dette spettacolo. E da allora continuò a darlo per tutta Italia. 4 -0 a Bergamo, 2-0 a Udine, 5 -1 a Avellino, 1 - 0 a Milano rossonera e a Torino granata. E poi vinceva in casa, ovviamente: splendido il 3 - 1 all’Inter con Cerezo che sbaglia 2 rigori e la Sud a urlare “Cerezo! Cerezo!”. E i punti dalla Juve diminuivano, uno alla volta, domenica dopo domenica. I versi del nostro inno (“Dimmi cos’è che ti fa sentire Re quando senti le campane la domenica mattina?”) avevano finalmente un significato reale. E ogni lunedì entravo in Sala Operatoria come un Re, guardavo l’odiato caposala e gli fa97 cevo: “Meno 7!” “Meno 6”... E lui a prendermi per il culo. Anche se ogni volta con meno convinzione. Intanto i ragazzi guardavano sempre più in alto. Superarono il Milan, l’Inter, la Fiorentina, il Torino, il Napoli. Ma non gli bastava? Ma che volevano? A cavallo tra febbraio e marzo ebbi l’occasione di passare tre settimane alle Maldive come medico di un villaggio turistico. Partii con entusiasmo, e quelle tre settimane sono state un sogno che ancora adesso riempie i miei ricordi. Ma la Roma era sempre lì, inguattata. Mi aspettò. La lasciai a 4 punti dalla Juve, ritornai che i punti erano diventati 5. Aveva perso nei minuti di recupero una partita incredibile a Verona per 3 - 2 dopo averla dominata e, dicevano, con un arbitraggio quantomeno strano. Ma non era vero: mi stava aspettando. Tornai giusto in tempo per godermi il più bello spettacolo di sempre. Domenica 16 marzo alle 14,30, sotto un cielo primaverile di un azzurro intenso, l’Olimpico si esibì anch’esso in uno spettacolo incredibile. L’anello era completamente diviso da innumerevoli spicchi alternati di giallo e rosso. Non c’era niente che assomigliasse vagamente a una bandiera bianconera. Sì, arrivò la Juventus. Arrivò l’apoteosi. E la Roma quella domenica imitò il suo pubblico. Fece sembrare la Signora una squadretta di periferia, non le concesse neanche l’ombra di una speranza che potesse finire diversamente da come finì. Quando Boniek siglò il 3 - 0 il destino sembrava ineluttabile: una sola squadra meritava di vincere quel campionato, e non erano certo gli sparring-partner in bianconero visti quella domenica all’Olimpico. E l’aggancio arrivò, naturalmente, ovviamente, puntualmente e senza discussioni alla terzultima giornata. La Roma vinse a Pisa 4 a 2 e la Juve pareggiò con la Sampdoria. Alla penultima giornata di campionato, un’altra splendida domenica primaverile, il 20 aprile, il giorno prima del Natale di Roma, la classifica recitava: Roma e Juventus 41, Napoli 35. La Roma 98 giocava contro il Lecce in casa, la Juve contro il Milan, sempre in casa. Qui faccio una pausa di riflessione. Vi invito, o voi che avete avuto la pazienza di seguire questa straordinaria e incredibile avventura a provare, anche se di fede avversa, a mettervi nei panni di un tifoso romanista quella domenica. A rivivere quelle splendide vittorie del girone di ritorno ridicolizzando squadroni ben più attrezzati, l’Inter, la Fiorentina, il Napoli di Maradona, il Toro e soprattutto la Juve. Il sogno si era già avverato. Poteva forse una squadra già condannata da mesi, che aveva vinto solo 4 partite e nessuna fuoricasa, una squadra già ampiamente battuta all’andata, anzi la squadra che aveva dato il là a quel sogno, poteva dicevo questa umile squadretta giallorossa (perché sono giallorossi pure loro...) di provincia rovinare la festa? Poteva distruggere il sogno di centomila persone? È vero che si gioca 11 contro 11, ma andiamo... C’è già stato il giro d’onore, Viola è già stato sotto la Curva Sud. Già si pensa a chi verrà per la nuova avventura in Coppa Campioni. E io in Tribuna Monte Mario a godermi quella festa annunciata, col “Messaggero” che in prima pagina presentava il disegno di un lupo famelico e sotto il titolo, kitch ma efficace: “S.P.Q.R. Sorpasso Per Questa Roma”. Poteva finire tutto in modo così incompiuto? Poteva, poteva... La partita cominciò e dopo solo 8 minuti la Roma era già in vantaggio. Alla seconda o terza occasione, Graziani di testa ci porta in vantaggio sotto la curva Nord. Siamo primi. Soli. La Roma continuò ancora per inerzia a macinare calcio, fino al 15’ circa quando Pruzzo raddoppiò in contropiede. Ma l’urlo si strozzò in gola, il guardalinee era fermo con la bandierina alzata. Fa niente. 99 Fa niente un cavolo. La Roma si spense, dopo quel gol. Come se uno girasse l’interruttore. Come se si fosse voltata indietro e avesse visto tutte quelle squadre sotto, la Juventus, poi il Napoli, poi il Toro, La Fiorentina, L’Inter, il Milan... Tutte dietro. E le vennero le vertigini. Il Lecce era una squadretta ma aveva giocato pur sempre in serie A. Poi quello stadio tutto giallorosso... E se fosse stato per loro? Che si prova? Che fate, campioni, ci fate provare che vuol dire? Solo un pochetto, poi vi facciamo vincere. tanto a noi che ce frega, come dite qua. Siamo già in B. Così Di Chiara si esalta sentendo il suo vecchio pubblico festeggiare, i tifosi che non l’avevano capito, la squadra che lo aveva snobbato. 1 - 1. Poi Barbas capisce i sentimenti del compagno: sono io l’attaccante del Lecce, ti aiuto io. Slalom, entra in area... Aoh, ma ‘ndo vai? Fermatelo! E lo fermarono. Rigore: 1 - 2. Fine primo tempo. E la Juve? Come. Quando mai chiedevamo che faceva la Juve? Beh, per una volta... Comunque, sempre 0 - 0. E centomila cuori cominciarono a chiedere il miracolo a chi la Roma l’aveva amata. A Capitan Di Bartolomei. Al Barone... Comincia il secondo tempo e la Roma pare ritornata se stessa. Azioni su azioni. Palo esterno! Parata! Ehi, ma non è Barbas quello? 1 - 3. E sul tabellone, freddo, implacabile: Juventus 1 Milan 0. A tre minuti dal termine Kawasaki segnò il 2 - 3, ma sott’acqua si vede male. Io non me lo ricordo. L’ultima cosa che mi ricordo di quella giornata strana, uscendo mestamente da un sogno e tornando alla realtà, fu una scena emblematica. Seduto sulla spalletta del ponte, mentre un fiume di persone silenziose gli sciamavano vicino come fantasmi, un omone grande e grosso, sicuramente sopra il quintale, con una barba di tre giorni sale e pepe e in dosso una ridicola perché troppo piccola maglietta della Roma con davanti lo scudetto e la scritta Barilla e dietro il 5 di Falcao, piangeva senza ritegno, come un bambino a cui hanno tolto il 100 giocattolo, e ogni tanto alzava lo sguardo al cielo e chiedeva: “Perché, perché proprio a me? Che ho fatto di male?” I tifosi della Roma non sono né meglio né peggio dei tifosi di tutto il mondo. Mi dà fastidio sentir dire da altri tifosi che una data squadra è antipatica perché i suoi tifosi sono teppisti che distruggono le vetrine quando vengono a giocare da loro. Da che esiste il tifo, e non solo nel calcio, ci sono purtroppo atti di teppismo. E sono questi che vanno demonizzati, non i tifosi. E’ ovvio che i tifosi del Treviso in trasferta a Roma, in un numero che non arriva a cento persone, sono più tranquil- li dei tremila romanisti che invadono la ridente cittadina veneta. Ma come i tifosi delle altre squadre di grandi o medie città che normalmente militano nella massima serie hanno i loro alti e bassi, così quelli della Roma possono essere più o meno violenti. Di solito sono bravi quando la squadra va bene, sono cattivi quando va male. I tifosi della Roma dopo quella partita diventarono forse un po’ più cattivi, almeno per qualche tempo. Bisogna capirli. In loro difesa, se in fatto di comportamento sono simili agli altri, devo dire che i tifosi della Roma sono forse unici in quanto ad inventiva e calore verso la squadra. Anche quando palesemente è una squadra di brocchi. Solo la Sud ha impedito che fatalmente in molte annate la Roma scivolasse in serie B. Molti dei cori che si sentono in giro in Italia per i campi di calcio sono nati all’Olimpico. Molte delle più belle coreografie le ha mostrate la Sud. A volte ripenso a quello strano anno e ancora non mi capacito di come possa essere successo. A distanza di vent’anni, mi dico che è stato solo un incubo. La Roma in vero vinse quello scudetto, sono io che sono scivolato in un mondo parallelo e crudele. Non ci sono altre spiegazioni razionali. Poi però rivivo quella rincorsa, le sensazioni di quell’anno. Sì, sarebbe stato tutto fantastico se avessimo anche vinto lo scudetto, ma comunque quello che c’è stato prima di quella partita è stato 101 vero e la dimostrazione sta nel fatto che per me il periodo più esaltante da romanista non sono stati gli ultimi due scudetti, ma quello straordinario, unico anno. Vincere forse sarebbe stato troppo... FINE 102 Allegati 1. Tabella dei distacchi tra Roma e Juventus del Campionato 1985/86: Giornata Data Distacco 1 8/9 - 2 15/9 - 3 22/9 -2 4 29/9 -3 5 6/10 -3 6 13/10 -5 7 20/10 -5 8 27/10 -7 9 3/11 -5 10 10/11 -7 11 24/11 -6 12 1/12 -8 13 8/12 -9 14 15/12 -8 15 22/12 -8 16 5/1 -7 17 12/1 -6 18 19/1 -5 19 26/1 -5 20 9/2 -4 103 21 16/2 -3 22 23/2 -4 23 2/3 -4 24 9/3 -5 25 16/3 -3 26 23/3 -3 27 6/4 -1 28 13/4 - 29 20/4 -2 30 27/4 -4 2. Classifica finale Serie A anno 1985/86 Squadra Gio Pti Vit Par Sco Gol Gol DR F S 1 JUVENTUS 30 45 18 9 3 43 17 26 2 Roma 30 41 19 3 8 51 27 24 3 Napoli 30 39 14 11 5 35 21 14 4 Torino 30 33 11 11 8 31 26 5 5 Fiorentina 30 33 10 13 7 29 23 6 6 Inter 30 32 12 8 10 36 33 3 7 Milan 30 31 10 11 9 26 24 2 8 Atalanta 30 29 7 15 8 27 26 1 9 Como 30 29 7 15 8 32 32 0 10 Verona 30 28 9 10 11 31 40 -9 11 Avellino 30 27 9 9 12 28 38 -10 12 Sampdoria 30 27 8 11 11 27 25 2 13 Udinese 30 25 6 13 11 31 37 -6 104 14 Pisa 30 23 5 13 12 27 40 -13 15 Bari 30 22 5 12 13 18 31 -13 16 Lecce 30 16 5 6 19 23 55 -32 In maiuscolo/grassetto la squadra Campione d'Italia, in rosso/grassetto le squadre retrocesse 3. Formazione della AS Roma campionato 1985/86 Tancredi, Gerolin, Oddi, Boniek, Nela, Righetti, Conti, Cerezo, Pruzzo, Ancelotti, Tovalieri, Gregori, Lucci, Graziani, Desideri, Impallomeni, Di Carlo, Bonetti, Baroni; Allenatore Sven Goran Eriksson 105 OTTOBRE ’72 Il ragazzo cominciò a fare l’autostop poco dopo le undici. I libri di scuola sottobraccio, legati con una cinghia elastica gialla tutta scarabocchiata, si era avviato lungo la statale, sul marciapiede, fin quasi al termine del paese, fermandosi dopo l’ultimo incrocio. Era una bella giornata, quasi estiva. Appena deciso dove appostarsi, mostrò il pollice col braccio teso alla prima auto in transito, una 125 color crema, che lo ignorò. Trascorsero così una ventina di minuti, senza che nessuna delle auto che transitavano, per la verità poche a causa dello scarso traffico, dessero speranza di un passaggio. Dopo aver inutilmente segnalato ad una Opel Kadett verde metallizzata, subito dietro sopraggiunse una Fulvia bianca, targata Spezia, che rallentò abbastanza bruscamente e si fermò accostando al marciapiede una ventina di metri più avanti, di fronte ad un tabaccaio. Il ragazzo si voltò a guardare l’auto speranzoso: non aveva capito se si era fermata per lui o per altro motivo. Dall’auto scese un uomo calvo, sui quarantacinque anni, senza giacca e con la cravatta allentata. Si stirò, ignorando il ragazzo, e si avviò verso il tabaccaio. Il ragazzo, deluso, tornò a scrutare la strada in attesa di altre auto e tese di nuovo il braccio con il pollice alzato ad una 128 giallo senape. Una volta dentro il negozio, l’uomo comprò una stecca di Marlboro morbide, pagando con una banconota da cinquemila lire e ricevendone di resto una da cinquecento. Uscendo dal Tabacchi, si fermò sul marciapiede, prese un pacchetto dalla stecca che poi, aperto lo sportello posteriore della Fulvia, gettò sul sedile. Aprì il pacchetto di sigarette e se ne accese una con un accendino Remington. Finalmente si guardò intorno, aspirando voluttuosamente la prima boccata, e notò il ragazzo che stava invano chiedendo un passaggio, di cui non si era accorto prima di fermarsi, perché intento ad individuare l’in- segna di un tabaccaio. L’uomo si era alzato presto quella mattina, per fare un giro di clienti che lo avrebbe portato la sera a Roma, dove la mattina dopo avrebbe avuto l’ultimo e più importante appuntamento. Se per molti il suo mestiere di rappresentanza era di scarso interesse, lui invece con quel lavoro aveva trovato un equilibrio perfetto e per nulla al mondo l’avrebbe cambiato. Sposato da oltre vent’anni e con un figlio ormai all’Università, nel poco tempo che passava in famiglia era un marito premuroso e un padre prima affettuoso e ora generoso. Durante i frequenti viaggi che duravano invariabilmente due-tre giorni, invece, da molti anni aveva potuto manifestare apertamente la sua omosessualità. Aveva potuto fare questa doppia vita proprio grazie al suo lavoro. La moglie non aveva mai sospettato della sua passione nascosta, così come i suoi conoscenti e parenti. Solo un paio di amici fidati conoscevano la sua seconda vita segreta. Tempo addietro aveva preso una sbandata importante per un avvocato, un uomo molto dolce e colto, con dei riccioli neri che ancora lo facevano sospirare di nostalgia. Una sbandata che aveva messo in sospetto la moglie. Grazie alla complicità dei suoi amici l’aveva scampata. Poi scoprì che l’uomo aveva almeno un altro amante e dopo una furiosa litigata si erano lasciati. Da allora aveva evitato accuratamente di avere storie con uomini del posto e s’incontrava solo con amanti trovati durante i suoi viaggi. Da alcune settimane aveva conosciuto un ragazzo romano di trent’anni, per caso e inaspettatamente. Era un autista di autobus a cui aveva chiesto le indicazioni per arrivare in un certo posto nel quartiere salario. Il giovane l’aveva convinto a terminare con lui la corsa perché stava a fine turno e, abitando vicino al posto dove doveva andare, l’avrebbe accompagnato volentieri. Parlarono per ore, cenarono insieme e si trovarono l’uno nelle braccia dell’altro senza quasi accorgersene. Non vedeva l’ora di arrivare quella sera a Roma. Con questi pensieri, finì la sigaretta e spense la cicca pestandola con la suola. Guardò di nuovo il ragazzo che, senza suc108 cesso, continuava a chiedere un passaggio alle auto in transito. Tipico adolescente, capelli lunghi chiari tenuti fermi da una fascetta di spugna da tennista sulla fronte, magro e non molto alto, le spalle larghe e il bacino stretto, fasciato dai jeans, dimostrava diciassette o diciott’anni. Indossava oltre ai jeans, una polo a maniche corte celeste, ai piedi i classici desert boot di camoscio chiaro che tanto andavano di moda. Bel ragazzo, anche se ancora molto giovane. Il ragazzo si voltò per un attimo per seguire con lo sguardo una 124 Special grigia che aveva rallentato, ma che stava rapidamente accelerando, cosicché poté vedergli il volto, un viso ancora acerbo, imberbe. Forse aveva anche meno, quindici o sedici anni. Non aveva mai avuto storie con ragazzini, né ci aveva mai pensato. Gli adolescenti lo intimorivano, non li capiva. Quel ragazzo però gli suscitava qualcosa di strano. Fisicamente era molto bello, già adulto. Gli tornarono in mente i suoi diciassette anni, durante la guerra, quando s’innamorò per la prima volta, un tenente dell’aviazione inglese che aveva trovato rifugio per qualche settimana nel casolare dove erano sfollati. Era l’estate del ’44. Il tenente lo capì quasi subito e lo sedusse dopo pochi giorni, iniziandolo alle gioie del sesso. Cullò per qualche istante questi ricordi, poi decise di concedere il passaggio al ragazzo. Era là da tempo e gli faceva tenerezza. Un po’ di compagnia durante il viaggio avrebbe spezzato la monotonia. Non era avvezzo a tirar su gli autostoppisti, era un tipo riservato che amava viaggiare da solo con i suoi pensieri, o ascoltando l’autoradio. Inoltre spesso trasportava oggetti di valore e poteva diventare pericoloso. Quel ragazzo però non era il classico autostoppista. Probabilmente era uno studente che, uscito anzitempo da scuola, stava cercando di tornare a casa prima. Senza contare che era veramente bello (almeno per i suoi canoni) e la curiosità di poterlo ammirare più da vicino vinse le sue ultime reticenze. Così richiamò la sua attenzione e gli fece cenno di avvicinarsi. Il ragazzo, dopo aver avuto conferma a gesti che l’uomo si rivolgeva pro109 prio a lui, si avviò di corsa verso l’auto bianca, soddisfatto di aver finalmente trovato un passaggio. Mentre si avvicinava, l’uomo l’osservò più attentamente. Correva con naturalezza, senza sforzo. Non riuscì a dargli un’età precisa, poteva avere dai sedici ai vent’anni. Arrivatogli vicino, gli chiese dove era diretto. Il ragazzo gli nominò un paese che lui non conosceva. «È sulla statale verso Roma?» gli chiese. «Sì» gli confermò «a meno di quaranta chilometri da qui» «Va bene, sali» Entrarono in auto. Appena seduto, il ragazzo si girò indietro per posare i libri sul sedile posteriore. L’uomo notò tra i libri una grammatica di greco antico. Partirono e per alcuni chilometri non parlarono. Il ragazzo all’inizio studiò incuriosito l’interno dell’auto, sfiorando con le dita il cruscotto e l’autoradio. L’uomo lo lasciò fare, mentre continuava a studiarlo, guardandogli le mani che erano delicate, le dita lunghe e i polsi sottili; gli avambracci e le braccia invece robusti, ricoperti solo da una leggerissima peluria trasparente che risaltava sulla pelle ancora abbronzata. Poi tornò a fare attenzione alla guida, mentre il ragazzo si voltò verso destra a guardare distrattamente il paesaggio che scorreva. L’uomo allora accese l’autoradio e la sintonizzò su Radio Montecarlo, tenendone il volume basso. Stavano trasmettendo l’ultimo singolo di Lucio Battisti. Guidava senza fretta, attraverso la campagna autunnale. In quel tratto la statale era molto tortuosa, piena di curve, cunette e dossi. Subito dietro una curva, si presentò davanti a loro una coda di una ventina di auto che procedevano lentamente. In testa alla coda si intravedeva una macchina agricola, un trattore con rimorchio. La Fulvia si accodò e l’uomo abbassò completamente il finestrino. Il ragazzo lo imitò. Una folata d’aria fresca e gradevole entrò nell’abitacolo. L’uomo approfittò e si accese una sigaretta, offrendone una anche al ragazzo, che accettò volentieri. Il gesto dette il via ad uno straccio di conversazione. «Fai il Classico?» 110 «Eh?» «Ho intravisto che tra i libri hai una grammatica greca, così ho pensato che fai il Liceo Classico. Che classe fai, la prima o la seconda?» «Sono al quarto anno» «Quindi fai la seconda». Il ragazzo non rispose, tirò una boccata e scosse la cenere nel piccolo posacenere sul cruscotto. L’uomo riprese a parlare: «Il Liceo Classico è difficile. Alla tua età... Diciassette, vero?» il ragazzo annuì. «Alla tua età ero sfollato, c’era la guerra. 1944. Però sono riuscito a diplomarmi lo stesso, nel ’47. In Ragioneria. Avevo un’amica che faceva il Classico. Quando scoppiò la guerra era in quinta ginnasiale, ma nel ’45 dette la maturità da privatista e la passò. Ora è avvocato. Io invece non sono andato all’Università. Te la cavi, con lo studio?» Il ragazzo tirò un’altra boccata, poi rispose: «Abbastanza» «Bravo. Sai già cosa vorrai fare dopo?» «No». L’uomo spense il mozzicone nel posacenere, imitato dal ragazzo. La coda si stava esaurendo e ora davanti a loro c’era solo una 500L blu e il trattore, che rallentò ulteriormente e imboccò una stradina sterrata sulla destra. L’uomo ingranò la seconda e, approfittando di un breve rettilineo sgombro, mise la freccia a sinistra superando in scioltezza la 500. Avevano percorso già una ventina di chilometri. L’uomo richiuse parzialmente il finestrino, il ragazzo invece tese il braccio destro fuori dal finestrino e si divertì a contrastare il vento. Poi, poiché l’auto aveva ripreso una discreta velocità, anche lui ritirò il braccio e chiuse il finestrino. Alla radio stavano discutendo di qualcosa, ma il volume molto basso impediva di capire cosa. Il ragazzo tirò su la gamba destra e l’appoggiò sul ginocchio sinistro, tenendosela con le mani e rilassandosi. L’uomo ebbe l’impulso di posare una mano sulla sua caviglia, ma si controllò. «Fai dello sport?» 111 «Al momento no. Da ragazzino ho fatto per un paio d’anni Judo e giocavo in una squadretta locale di calcio, ma ora non m’interessa più» «Hai un fisico da nuotatore. Avrei giurato che facessi qualche sport. Le spalle larghe, magro ma robusto. Hai davvero un bel fisico, complimenti» «Grazie». Il ragazzo si tolse la fascia di spugna dalla fronte e si ravviò i capelli. Una frangia gli calò sugli occhi e lui la rimise all’indietro con un gesto vagamente femminile. Poi si rimise la fascetta. «Certo, voi giovani avete certi capelli lunghi...» osservò l’uomo. Il ragazzo non replicò. Così l’uomo continuò: «Non sarebbe più comodo portarli corti? E più maschio? Magari molte ragazze invece li portano corti» «È vero» «Il mondo va proprio alla rovescia. Perché lo fate, per protesta o per cosa?» «Semplicemente perché mi piace averli lunghi» «I tuoi non dicono niente?» «Sono solo con mio padre. Mia madre è morta quando ero piccolo» «Mi dispiace...» «Fa niente. Tanto nemmeno la ricordo» «E ora tuo padre è solo?». Il ragazzo lo guardò con aria interlocutoria. L’uomo si affrettò allora a riportare la conversazione su argomenti più impersonali: «Scusa. Chiedevo così per chiacchierare. In effetti non mi dovrebbe importare. Ti occupi di qualcosa, oltre allo studio?». Il ragazzo sospirò, poi come se dovesse compiere un dovere, rispose. Nel farlo riportò giù la gamba destra. L’uomo fu distratto dal gesto e della risposta sentì solo la parola “assemblea studentesca”. «Ti occupi di politica, allora» «Non proprio. Più di rappresentanza di classe. Sono orientato a sinistra, ma non riesco ad identificarmi con gruppi o partiti. Frequento i CPS...». L’uomo stentava a trovare un argomento 112 che potesse ravvivare la conversazione, anche perché era distratto dalla vicinanza del ragazzo. Mentre cercava di dialogare, la sua mente vagava in fantasie sempre più spinte. Se lo immaginava nudo, cercava di indovinare se fosse ancora del tutto glabro o no. Sentiva un groppo alla gola e allo stomaco e aveva una semierezione che stentava a controllare. Il ragazzo, dalla sua, non dava segni di essere interessato ad una qualsivoglia conversazione con lui e rispondeva solo per cortesia. Si vedeva che non vedeva l’ora di arrivare. La cosa irritava l’uomo, che voleva invece cercare di far colpo, voleva cercare di entrare più in intimità, piccato di non suscitare nel ragazzo alcun interesse. Dopo poco, l’uomo riprovò a ricomporre una conversazione: «Tuo padre che lavoro fa?». Il ragazzo si voltò, infastidito dall’insistenza dell’uomo. Lui ne rimase quasi intimorito. Ma poi il ragazzo gli rispose, questa volta finalmente con qualche parola in più rispetto ai monosillabi pronunciati fino a allora. Forse aveva considerato che un po’ di relazione, se non altro per cortesia, era giusto elargirla. «Mio padre è medico condotto. Sono nato a... e abitiamo lì da sempre. Mio nonno era medico del paese e mio padre ne ha preso il posto. Abitiamo appena fuori, in una bella villetta. Tutti i giorni vado e torno da scuola con il treno. Ancora non abbiamo l’orario completo, così oggi siamo usciti alle 11 e ho fatto l’autostop per non aspettare il treno dell’una». Quindi lo guardò con un sorriso, convinto con questo di aver esaurito la conversazione. Ma l’uomo non desistette. «Vai d’accordo con tuo padre?» «Per il poco che ci vediamo...» «Ti somiglia?» La domanda gli venne spontanea, anche se si rese conto subito che era una domanda strana. Cercò subito di rimediare, giustificandola: «Anch’io ho un figlio. Siamo completamente diversi! Lui ha preso da mia moglie. Ora fa l’Università, Ingegneria. Ha qualche anno più di te. In effetti 113 anche noi non ci vediamo spesso: lui ha la sua vita, la sua ragazza... Tu ce l’hai la ragazza?» «Naturale». L’uomo non replicò. Finalmente era riuscito a finire su un argomento che poteva portare a discutere di cose più intime. Fingendo una complicità maschile, forse poteva addirittura azzardarsi a parlare esplicitamente di sesso. Magari spacciandosi per eterosessuale. Avrebbe cercato di eccitarlo evocandogli visioni femminili o inventandosi esperienze di amanti e di amplessi. Per qualche minuto si concentrò per superare un vecchio autotreno ansimante, che ad ogni accelerata li inondava di fumo nero. Una volta superato l’autotreno, riattaccò: «State insieme da molto?» «Quasi un anno» «È più giovane o più grande di te?» «Frequentiamo la stessa classe» «Perché non sei rimasto con lei, stamani?» «Perché doveva andare con i suoi» «Com’è, carina?» gli chiese con aria complice. Il ragazzo non si scompose: «Per me sì». Anche questa conversazione non stava portando a niente. L’uomo capì che se avesse provato a chiedere più esplicitamente qualcosa di più intimo, avrebbe trovato resistenza. Intanto non riusciva ad impedirsi di guardarlo, anche se di nascosto. Il ragazzo mostrava un’espressione annoiata, da bambino viziato. Era affascinato dal suo viso, perché glabro ma già spigoloso, virile. Un misto ancora tra fanciullezza e maturità. Completamente privo di basette, i lobi parzialmente coperti dai capelli lunghi, un ombra di peluria sul labbro superiore e radi peli matti sul mento. Il naso grosso, la fronte spaziosa, gli occhi azzurri, ravvicinati, con le sopracciglia chiare e le ciglia lunghe, delicate. Le labbra fini attraverso le quali s’intravedevano i grossi incisivi superiori. Con una fitta allo stomaco immaginò di baciarlo. Si era completamente dimenticato dell’amante romano. La tensione erotica che la 114 vicinanza di quel corpo giovane gli trasmetteva, il vago odore di sudore, lo stavano letteralmente soggiogando. Si accorse che lo stava desiderando come non aveva mai desiderato nessun altro uomo. Fantasticò su come iniziarlo, su come sedurlo. Ripensò a se stesso e al tenente inglese. Sentiva che era arrivato ad un punto di non ritorno. La stessa indifferenza nei suoi confronti che dimostrava l’atteggiamento del ragazzo, lo spingeva a fare qualcosa di più concreto per uscire dall’impasse. Allora, senza preavviso, con un gesto che cercò di far sembrare naturale, gli mise una mano sul ginocchio sinistro. Il ragazzo s’irrigidì, sorpreso. «È come con la tua ragazza, sai» gli sussurrò lascivamente. Il ragazzo non rispose. Però neppure si sottrasse a quel contatto. Rimase rigido, fissando la strada. L’uomo, come incoraggiato, continuò: «Sei bellissimo. Anche la tua ragazza è così bella? Dovete essere una coppia stupenda». Tolse la mano dal ginocchio e gli carezzò con il dorso delle dita la guancia e il mento: «questi peletti... Te la sei mai fatta la barba?». Il ragazzo a quel punto reagì: «La prego, smetta». L’uomo riportò la mano sullo sterzo. Poi però insistette: «È presto. Non è ancora mezzogiorno. Non vorresti fare un bel regalo alla tua ragazza? Sono sicuro che non hai problemi di soldi. Ma io ti darei abbastanza per farle un regalo bellissimo. E t’assicuro che per pranzo saresti a casa». Il ragazzo non disse nulla. «Quanto manca al tuo paese?» «Siamo quasi arrivati,» rispose il ragazzo sollevato «fra due chilometri c’è un sottopassaggio e dopo si entra in paese. Mi può lasciare alla stazione. Ho la moto là». L’uomo rallentò. Decise che a quel punto tanto valeva essere diretti. Non voleva perdere quell’occasione senza provarci esplicitamente. Se ne sarebbe pentito per sempre: «Diecimila lire» disse. Non avendo risposta, continuò: «Non devi fare nulla. Chiudi gli occhi e ti faccio tutto io. Prima del115 l’una sarai a casa». Una DS li superò rabbiosamente, suonando il clacson. Il ragazzo si girò verso di lui. Aveva gli occhi spalancati, leggermente umidi. Lo guardò con un’aria implorante. Sembrava un cucciolo intrappolato. L’uomo ne ebbe compassione e a malincuore decise di finirla là. «Va bene, caro. Non voglio insistere. Ti porto a casa». «Diecimila lire?» mormorò inaspettatamente il ragazzo, con un filo di voce. L’uomo accostò bruscamente sul ciglio della strada e fermò l’auto. Si voltò e prese tra le sue una mano del ragazzo. «Diecimila lire» confermò. «E io non devo fare nulla, vero? Non devo toccarti né altro. Fai solo tu» «Te lo giuro» «E poi mi riporti immediatamente a casa» «Contaci» Il ragazzo ritirò la mano dalle sue. Si girò verso il finestrino e senza guardarlo disse: «Va bene. Prendi quella stradina poco più avanti, sulla sinistra. porta ad un casolare abbandonato. Ci vado sempre con la mia ragazza». L’uomo, ancora incredulo per quello che stava succedendo, si guardò intorno e vide subito la stradina indicata dal ragazzo. Mise in moto e la raggiunse, imboccandola. Dopo poche centinaia di metri arrivarono all’aia del podere abbandonato, un rudere invisibile dalla statale. Una volta spento il motore, si voltò e cercò di riprendere la mano al ragazzo. Lui però si scansò e in modo molto pragmatico chiese prima i soldi. L’uomo sorrise. Gli venne in mente, chissà per quale strana associazione, il finale del secondo atto della Tosca. Scarpia che finalmente sta per agguantare la sua preda, ma quella chiede prima il salvacondotto. Si girò e prese la giacca dal sedile posteriore. Dalla tasca interna tirò fuori il portafoglio, ne estrasse un foglio da diecimila lire e lo consegnò al ragazzo. Lui lo fece sparire nella tasca anteriore dei jeans. Poi disse: 116 «Facciamo presto» e si abbandonò sullo schienale. «Eh no, ragazzino,» puntualizzò l’uomo «sono io che ho pagato e sono io che decido come fare» «Avevi detto che non dovevo fare nulla!» ribadì preoccupato il ragazzo. «Infatti. Lo confermo. Ma non lo voglio fare in macchina. Ora scendiamo e ti sdrai su un plaid che ho nel bagagliaio. Poi ci penso io». «E se non ci sto?» «Non c’è problema. Ce ne torniamo via. Mi ridai le diecimila lire e ce ne andiamo» bluffò l’uomo. Il ragazzo non rispose. L’uomo scese dall’auto e aprì il bagagliaio, tirandone fuori un grande plaid a scacchi e stendendolo accanto all’auto, su un piccolo fazzoletto di prato. Poi si alzò e aspettò. Il ragazzo, riluttante, scese dall’auto e rimase in piedi davanti a quel talamo improvvisato. Le braccia dietro la schiena, la testa reclinata in segno di sottomissione. L’uomo gli andò incontro eccitato: «Finalmente! Vedrai che ti piacerà» e fece per abbracciarlo. Quando già lo aveva praticamente tra le braccia, sentì una fitta dolorosissima al petto, così forte da lasciarlo senza respiro. Ebbe pochissimi attimi ancora di coscienza, che non gli bastarono per capire cosa stava succedendo. Forse non si rese neppure conto che stava morendo. Il suo corpo cadde fulminato all’indietro, gli occhi sbarrati con le pupille che lentamente si dilatavano, i calzoni che si bagnavano d’urina, qualche piccolo spasimo ancora delle mani, poi l’immobilità più assoluta. Il ragazzo rimase a guardarlo senza alcuna espressione sul volto per qualche secondo, poi lentamente si voltò e tornò all’auto. Prese la giacca dell’uomo e ne estrasse il portafoglio. Conteneva novantamila lire in pezzi da dieci e 15.500 lire in un altro scomparto. C’era anche un libretto d’assegni, che estrasse dubbioso se prendere o meno, ma lasciandolo poi sul sedile insieme al portafoglio svuotato. Indossò la giacca: gli stava a pennello. Era anche in tinta con i 117 jeans. Ripose i soldi nella tasca interna e girò dietro l’auto fino al bagagliaio. Lì trovò la ventiquattrore dell’uomo. L’aprì, forzandone le serrature con un cacciavite che prese dagli attrezzi della Fulvia. Dentro vi trovò alcuni gioielli e una mazzetta di fogli da cinquantamila lire. Li contò: erano un milione e mezzo di lire. Sorrise soddisfatto. Lasciò i gioielli e prese i contanti, riponendoli insieme agli altri soldi. Poi tornò all’abitacolo. Vide la stecca di Marlboro sul sedile posteriore e ne prese un pacchetto. L’aprì e si accese una sigaretta, fumandola con calma, seduto di traverso sul sedile dell’auto, con lo sportello aperto, guardando il cadavere dell’uomo. Finita la sigaretta, la spense accuratamente, strappò un pezzo di un giornale che stava nell’auto e ce la mise dentro, insieme alle altre cicche che c’erano nel posacenere, mettendosi tutto in tasca. Poi si alzò e s’avvicinò al morto. Gli guardò con interesse l’orologio, ma decise che non ne valeva la pena. Quindi s’inginocchiò alla destra dell’uomo, appoggiò la mano sinistra sul torace esanime e con la destra impugnò il manico d’avorio del coltello a serramanico che gli spuntava da sotto lo xifoide, estraendolo con un gesto secco, esperto. Solo una piccola bolla di sangue uscì dalla ferita. Quindi si pulì sommariamente sull’erba e nettò il coltello con il giornale che aveva trovato nell’auto. Lo ripiegò e lo ripose nella tasca posteriore dei jeans, dove stava di solito. Ritornò un’ultima volta all’auto, che aveva tre sportelli e il bagagliaio spalancati, guardando all’interno per vedere se aveva dimenticato qualcosa o se c’era qualcos’altro di utile. Sorrise vedendo i libri che poco prima aveva sottratto di nascosto ad una ragazza nel parco mentre stava pomiciando con un coetaneo. Li lasciò nell’auto. Prima di allontanarsi, dette un’ultima occhiata al casolare e si disse che quel giorno era stato davvero fortunato. Posto ideale. Quindi s’avviò fischiettando verso la statale. La imboccò in direzione opposta a quella dalla quale era venuto. Percorsi un centinaio di metri, sentì il rumore di un’auto che si avvicinava: si voltò, era una Giulia GT 1300 118 Junior rossa, forse una Quadrifoglio Verde. Continuando a camminare all’indietro, alzò il pollice. L’auto lo superò e poi si fermò poco più avanti. Dal finestrino aperto si sporse il volto di un uomo sulla cinquantina, capelli brizzolati, baffetti alla Clark Gable e fazzoletto al collo. Sorridendo, gli fece segno di avvicinarsi. Il ragazzo gli andò incontro di corsa, sorridendo a sua volta e toccandosi istintivamente la tasca posteriore dei jeans. FINE 119 E così siamo giunti all’ultimo racconto, anche in ordine cronologico. L’ho elaborato durante le ultime vacanze e l’ho scritto di getto al ritorno. Mi rendo conto rileggendolo che può apparire come un racconto omofobo: se così sembra anche al lettore, mi dispiace, non era nelle mie intenzioni. Ho cercato di presentare la vicenda in modo che il finale fosse completamente inatteso (la presunta vittima che invece è uno spietato carnefice). Soprattutto però la storia trae spunto da un episodio che mi è realmente accaduto all’inizio di ottobre del 1972, facendo l’autostop mentre tornavo da scuola. Fu imbarazzantissimo perché l’uomo che mi dette il passaggio poteva avere l’età di mio padre, ma fortunatamente si risolse in un niente di fatto e l’uomo mi accompagnò alla stazione senza insistere più di tanto né tantomeno chiedendomi qualcosa di esplicito, e salutandomi con un “Ciao, caro”. Però fu un’esperienza scioccante. Aveva una Fulvia bianca targata Spezia e stava andando a Roma. L’ultima parte del viaggio la ricordo con terrore, l’uomo che mi sfiorava il mento e mi palpava il ginocchio commentando la mia “bellezza”, assicurandomi che “è come con la tua ragazza”, ed io paralizzato, fino a quando l’ho pregato di smettere. Fu la prima e l’unica volta in vita mia che un uomo tentò di abbordarmi. Abbozzò, probabilmente resosi conto che la cosa poteva farsi pericolosa (ero minorenne e per niente consenziente. Inoltre già pensavo di segnalare la cosa ai carabinieri). Quindi anche questo racconto è stato una scusa catartica per mettere nero su bianco quella lontana vicenda autobiografica. Anche l’eventuale parallelo con la vicenda di Pasolini, di qualche anno più tardi, è assolutamente arbitrario, essendo i due contesti completamente diversi. Un caloroso saluto dall’Autore 120
Scarica