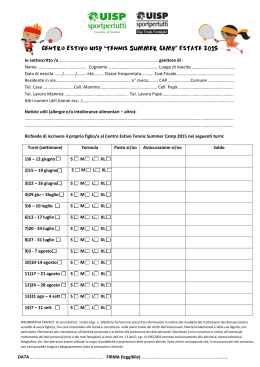Michele Vargiu PrecariEtà Quattro stagioni di vita precaria Anna. Racconto d’autunno. Tutte le mattine io metto giù i miei piedi dal letto, e so già che si poggeranno su un filo. Non è facile, camminare sul filo; i movimenti devono essere lenti, meditati e mai precipitosi; tutto deve avvenire con la massima leggerezza ed economia di movimento, altrimenti il filo si eclisserà rapido da sotto i miei piedi, l’equilibrio mi abbandonerà e io farò la conoscenza del vuoto; e non ci sarà nulla, a riportarmi lassù, con i piedi sul filo. Io cammino sul filo ogni giorno. Cammino sul filo quando sono per strada, quando giro per casa, quando mangio, quando studio, quando lavoro. Perfino quando faccio l’amore, io cammino sul filo. In questo momento ad esempio io sto camminando sul filo per andare dalla mia camera da letto fino alla cucina; è quasi ora di colazione, se non mi sbrigo rischierò di arrivare tardi. Neanche faccio in tempo a muovere i primi passi che subito il mio frigorifero mi si para davanti, mi guarda e mi parla. Pochi possono vantare di avere un frigo che parla; figuriamoci un frigo che ti parla quando sei in equilibrio su un filo. Il mio frigorifero mi parla mostrandomi la sua facciata ricoperta di post-it a loro volta ricoperti di appunti, orari, scadenze, liste della spesa; sbattendomi in faccia la sua fauna di coccinelle, elefantini, farfalle e altri animali magnetici che reggono bollette, avvisi, preventivi di spesa, lettere dell’amministratore di condominio. Il condominio dei funamboli, dove per i suoi corridoi, sulle scale, nei suoi cortili e nell’ascensore, si cammina tutti sul filo. Quando l’orologio segna le otto io sono già pronta; scendo per le scale e prendo la bici per andare in facoltà, come tutte le mattine; l’autunno ha il cielo grigio e l’aria umida e fredda, gli alberi scheletrici e le strade ricoperte di foglie, messe diligentemente a coprire l’asfalto di un unico colore; giallo, giallo, giallo, giallo, giallo. La strada la so a memoria; la faccio tutte le mattine da anni; corro veloce nonostante il freddo che mi graffia il viso, nonostante i semafori ancora lampeggianti e le macchine che se ne fottono dei ciclisti. Arrivo in facoltà e percorro gli stessi corridoi, le stesse scale, attraverso gli stessi androni. Arrivo dai miei colleghi e lui è già li. Ed è bellissimo. Nicola è sempre bellissimo. Oggi ha messo la camicia rossa. Quella che gli cade larga sui fianchi e lo ingrassa. Ma non importa. Nicola è bellissimo. Nicola è sempre bellissimo. Nicola studia da anni le proprietà delle cellule staminali. Lo fa in un laboratorio non a norma di legge, utilizzando un computer dai riflessi arrugginiti e dal cervello elettronico malato. Si porta il camice, i guanti e la mascherina da casa. Accanto a lui invece c’è Silvia, che fa le stesse cose che facciamo Nicola ed io. E poi ci sono io. Io mi chiamo Anna. E sono una ricercatrice precaria. Sono una di quei tanti cervelli che hanno rinunciato alla fuga. Una degli oltre duecentomila ricercatori precari di questo Paese che lavorano senza mezzi, senza sicurezza, senza un soldo; sono una di quelle che il cervello non potrebbero mandarlo in fuga nemmeno nascondendolo dentro un treno merci clandestino, nemmeno su uno di quei barconi della speranza che attraversano il mediterraneo. Io resto qui, insieme a tanti altri, a raggranellare i cocci della ricerca, a lottare con i computer senza memoria, ad attraversare i laboratori in punta di piedi nella speranza di non farmi male, muovendomi piano. Come se camminassi sul filo. Noi stiamo qui. I nostri cervelli non fuggono. I nostri corpi restano in bilico, come foglie ingiallite attaccate al loro ramo. In equilibrio precario, con la sensazione di crollare senza avere mai la certezza del quando. Poi una mattina d’autunno mi svegliai come al solito, e come al solito poggiai i miei piedi sul filo; come al solito il mio frigorifero aveva qualcosa da dirmi, come al solito le strade erano dipinte di giallo, come al solito la mia facoltà non si era mossa da li. Solo che in quella mattina d’autunno dal tetto dell’edificio spuntava un grande striscione: “università occupata, contro I tagli alla ricerca”. Percorro i corridoi, bianchi come il cielo che sta fuori; era autunno ma a me pareva di sentire caldo; e nonostante, come già sapete, io cammini sul filo, andavo cosi’ veloce da rischiare di perdere l’equilibrio; I laboratori erano vuoti, cosi’ come tutto il resto delle aule; percorrevo le scale senza nemmeno vederle, fino ad arrivare sul tetto, l’unico posto della mia università in cui non ero mai stata. Nicola era li. E insieme a lui Silvia. E Antonio, Andrea, Marta, e tutto il gruppo di ricercatori che lavorano con me. Avevano attrezzato il tetto come fosse un piccolo campo base, formato da tende da campeggio portate da casa, sacchi a pelo, piccole stufette a gas, un fornellino per il caffè. C’erano stati gli ennesimi tagli del ministero dell’istruzione alla scuola e alla ricerca; una mossa come un’ altra per giustificare la situazione di crisi economica di un paese che pretende di andare avanti distruggendo la ricerca, tenendo i suoi cervelli alla fame e spronandoli a fare sempre di più con mezzi assenti. Col tempo avevamo imparato a conoscerli tutti, i signori del Governo; li avevamo etichettati come i personaggi di una favola oscura: la ministra dell’ignoranza Maria Strega, il Ministro della Pubblica Amministrazione ReNano Brunetta, fino ad arrivare a sua bassezza, il premier del paese dell’intelligenza stuprata e dei cervelli in fuga . Per la prima volta, su quel tetto, ci sentivamo tutti parte di una famiglia unita dalla disgrazia dell’instabilità; precari, insicuri, senza futuro. Come morti che camminano. Come piccole foglie ingiallite attaccate ad un ramo per un tempo limitato ma che nessuno conosce. Ci sentivamo deboli ma forti, intelligenti, meritevoli, compatti. La nostra permanenza sul tetto andò avanti per giorni; dopo qualche tempo vennero a trovarci anche gli eroi della favola oscura; politici dell’opposizione, uomini di cultura, altri precari come noi, studenti, tecnici, docenti. Qualcuno invece si ostinava a dire che fossimo la parte peggiore del paese, di quel paese che sa solo lamentarsi senza rimboccarsi le maniche. Noi da lassù li vedevamo tutti, i nostri oppositori; e ci sembravano piccoli, insignificanti come formiche che si muovono mosse dalla legge del caos. Sapevamo di essere i custodi del progresso del paese. Sapevamo benissimo che senza ricerca, conoscenza, cultura, un paese non risparmia, ma diventa spaventosamente più povero. Sapevamo di avere ragione. Lo sappiamo ancora. Le nostre idee non sono morte. I nostri cervelli non fuggono. Restano qui, ad aspettare il freddo dell’inverno, i primi profumi della primavera, I venti secchi dell’estate. Restiamo qui senza muoverci, come foglie ingiallite che prima di staccarsi dal proprio ramo vorrebbero vedere nascere nuovi germogli. Io mi guardo intorno, e vedo tutti I colori del mondo su di un tetto in catrame, sbattere sul bianco lattiginoso del cielo. Vedo Nicola che è sempre bellissimo. E sogno un giorno di potergli dare la mano. Sogno un giorno che ci si possa togliere il filo da sotto i piedi senza cadere. E che si possa andare. Non importa dove, ma andare. Insieme. E senza muoverci da qui. Salvatore. Racconto d’inverno. Mi chiamo Salvatore. Da bambino mi dicevano sempre che vengo dal paese dei Santi, dei Poeti e dei Navigatori. Anche se in realtà i santi mi stanno bene solo inchiodati al muro, ognuno corrispondente ad un diverso giorno dell’anno, ognuno osservatore silenzioso del tempo che passa, dell’alternarsi delle fasi lunari, dei cambi di stagione. Le poesie mi annoiano. Pure alle elementari ti insegnano che una frase, per essere corretta, deve avere un soggetto, un verbo e un complemento. Altrimenti te la segnano in blu, e come minimo è un punto in meno sul voto finale. Navigare non mi è mai venuto facile. Credo che la colpa sia da attribuire al fatto che il mare l’ho sempre visto in cartolina e mai da troppo vicino. In compenso da qualche tempo navigo sulla rete, specialmente di notte. Vado a navigare sui siti zozzi. Quelli pieni di donne che fanno acrobazie zozze con uomini, altre donne, animali, piante e organismi geneticamente modificati, è cosi’ che li chiamano. Quelli pieni di finestrelle che si aprono, e dentro ogni finestrella c’è una donna seminuda che ammicca, ti guarda intensamente negli occhi e ti fa cenno di raggiungerla. Ti dice anche frasi provocanti in una lingua che non capisci, ma che interpreti come le frasi più zozze e bollenti che una donna ti abbia mai rivolto. Nei siti zozzi vedo un sacco di cose che nemmeno in sogno mi sarei potuto immaginare; cose degne della fantasia del primo Spielberg, ingarbugliamenti e incastonamenti umani inimmaginabili che formano un immenso patchwork fatto di carne; spuntano convulsamente braccia, gambe, labbra, clitoridi e prepuzi di varie forme, etnie e religioni. Un po’ mi vergogno a guardare tutto questo, a violare la privacy di quelle persone appiccicate tra di loro che un privato, da qualche parte, dovranno pur avercelo; ma per me è come vedere un documentario. Mi sento come uno di quegli studiosi rinchiusi nei laboratori di ricerca, che per anni spiano degli animali ignari da dietro un vetro. Mi sento come se partecipassi ad una lunga conferenza, dove i relatori sono nudi e disinvoltamente appiccicati fra di loro, e tengono i loro discorsi dimenandosi e gemendo. Questo almeno è quello che mi viene in mente di notte. Durante il giorno mi piace andare nei posti affollati; nei centri commerciali, nei supermercati, nei grandi outlet dell’abbigliamento o nei capannoni dei cinesi in fondo alla periferia, pieni di persone entusiaste che comprano il nulla a prezzi imbattibili. Ma la cosa che mi piace fare più di tutte è stare davanti alle casse del supermercato, a guardare la merce degli altri scorrere sul tapis-roulant per poi essere scansionata, imbustata, scontrinata. -Ha la tessera? Vuole un sacchetto? Non si scordi i bollini. Si capiscono tante cose, guardando i prodotti che compra la gente. Ad esempio il signore che ho di fronte in questo momento ha comprato un’insalata già lavata, tagliata ed imbustata, delle fette di prosciutto sottovuoto, del pane già affettato e della pasta surgelata, quella che con cinque minuti di padella diventa buona come la pasta surgelata del ristorante. Io capisco subito che dev’essere un uomo solo, che non ha una famiglia, una moglie a casa che l’aspetta; è uno di quegli uomini che mangiano l’insalata in busta senza nemmeno condirla, direttamente dal sacchetto come se si trattasse di un pacchetto di patatine, magari davanti alla televisione che trasmette qualche amichevole di calcio. La signora dietro di lui invece ha un carrello pieno di cibo, e cassette incellophanate d’acqua in bottiglia, assorbenti interni ed esterni, lattine di birra, shampoo e bagnoschiuma in dosi da caserma, sughi pronti, frutta, verdura e olio biologico in taniche di latta. Capisco subito che è una madre di famiglia, una che quando tornerà a casa avrà ad aspettarla un marito e dei figli stronzi che nemmeno le daranno una mano a scaricare la spesa. Come cambiano, le persone. Come sono diverse fra loro. Pure quando sono al supermercato, mi sento un po’ come quando sto dietro al monitor che trasmette i film zozzi. Mi sento un osservatore della natura, del comportamento umano. La mia vita però a pensarci bene non è stata un solo osservare. Ho lavorato per tanti anni io, ma ora, non lavoro più. Lavoravo in una azienda che produceva motori elettrici. Stavo alla catena di montaggio; ero l’operaio più veloce, quello più abile con le mani; “la mano del chirurgo”, mi chiamavano, perché non sbagliavo mai ad assemblare un pezzo, nemmeno quando il caporeparto aumentava il ritmo di produzione, facendoci scorrere i pezzi sotto gli occhi a velocità sempre maggiore. All’interno della fabbrica mi ero circondato di amici ma anche di invidie, malelingue, frasi dette sottovoce, quando magari sei girato di spalle, ma in fondo che me ne importava. Io il mio lavoro lo facevo bene. Per trent’anni, l’ho fatto bene. Poi è successa la disgrazia. E quando in fabbrica ti capita una disgrazia, quando cioè la macchina, la pressa, il rullo, la sega circolare decidono di farti un dispetto, il tuo cammino all’interno della fabbrica si arresta di colpo. Diventi all’improvviso come uno zoppo in mezzo ad un branco di centometristi. Non riesci più a stare al passo. E la fabbrica, da brava mamma selettiva coi suoi cuccioli, ti butta via. Lascia sopravvivere gli altri. La mia disgrazia è stata quella di farmi schiacciare quattro dita della mano destra, la mia “mano da chirurgo”, sotto il peso di una pressa. Forse è stato per il sonno, forse per la distrazione. Quattro dita adesso non le ho più, e non avevo nessuna assicurazione che pagasse i danni. Perché io, nella fabbrica, avevo sempre lavorato in nero. Per trent’anni. E quando c’è stato da chiedere i danni, quando sarebbe dovuto arrivare il momento di sollevare un polverone, io non ho fatto niente. Che il dottor Angelucci, il padrone della fabbrica, è un sant’uomo. E’ uno che pur di farmi lavorare ha rischiato di perdere la faccia ,per trent’anni. Che battaglie avrei potuto fare, arrivato a cinquant’anni; per me questo è l’inverno. Se non è la fine, poco ci manca. La cosa brutta del ritrovarsi a cinquant’anni con il peso della disgrazia sulle spalle e quattro dita in meno di una mano che fino al giorno prima funzionava bene, è la consapevolezza di non servire più. Di non poter più sentirsi utili. Della mia “mano da chirurgo” era rimasto solo un pollice. Bello, il pollice. Il dito più forte. Quello piu’ tozzo e più resistente. Il dottor Angelucci, una volta che mi allontano’ dalla fabbrica, mi diede una piccola liquidazione, un malloppetto stropicciato di soldi estratti direttamente dalla tasca sua. E quando quei soldi finirono cominciai a cercare un nuovo lavoro, un’occupazione anche piccola che potesse fare a meno della mia mano disgraziata. Un posto da operaio potevo scordarmelo; tutti i lavori che trovavo erano posti da venditore telefonico, con un contratto che nemmeno capivo; era una specie di lavoro a cottimo, dove piu’ telefoni e piu’ centesimi guadagni, e vai avanti cosi’, per otto, anche dodici ore al giorno, di centesimo in centesimo, davanti a uno schermo senza piu’ film zozzi, ma pieno di numeri dei “gentili clienti”, suddivisi in caste in base a quanti soldi l’azienda prevedeva di potergli spillare dal portafogli. Avro’ fatto trenta colloqui. E in tutti la risposta era la stessa: troppo vecchio, anche solo per parlare al telefono. Ci vogliono voci giovani, brillanti, che invoglino la gente a fidarsi. “Mi dispiace signore, ma è la politica dell’azienda”. Largo ai giovani. Largo ai giovani precari, magari laureati, confinati nello spazio fra uno schermo e un auricolare. Largo ai giovani. E per coloro che non sono più giovani restino solo briciole, guai e merda, un’intera vita di merda aspettando che arrivi l’inverno, quello definitivo. Ogni tanto faccio qualche piccolo lavoretto. Piccole riparazioni per le signore del mio palazzo, fatte con la mano sinistra e quel che resta di quella destra. A volte ci guadagno un buon pranzo, di quelli fatti ancora come Cristo comanda, senza pasta surgelata e insalata in sacchetto. Altre volte qualcuna mi paga con soldi veri. Io saluto, vado verso la porta, e prima di richiudere ringrazio e saluto ancora. E vado verso il supermercato. -Ha la tessera? Vuole un sacchetto? Non si scordi i bollini. Fuori comincia a nevicare. E’ finalmente arrivato l’inverno. Io passo i miei prodotti sul nastro scorrevole della cassa. C’è un signore di fronte a me che guarda la mia spesa, conta con gli occhi le cose che ho comprato e sta in silenzio. Chissà che idea si sarà fatto di me. Per un attimo ho la sensazione di sentirmi meno solo. Metto la mia spesa dentro il sacchetto ed esco dal supermercato, sotto questa prima neve d’inverno. Lancio al signore un’ultima occhiata che però cade nel vuoto; i suoi occhi stanno già studiando la spesa del signore che era dietro di me. “E’ giusto cosi’”, penso. E torno verso casa incrociando uomini, donne, e ragazzi di belle speranze. Tutti che si muovono in fila ed in silenzio. Ognuno con gli occhi bassi. Ognuno custode della propria disgrazia. Marco. Racconto di primavera. Ci sono due mosche che ronzano davanti al monitor del computer. Io le guardo rincorrersi, avvicinarsi e allontanarsi di colpo; e fra me e me penso che se solo per un istante si potesse evidenziare la loro traiettoria nell’aria con un qualsivoglia colore, sarebbero uno spettacolo piu’ divertente delle frecce tricolori. Volano in cerchio, poi in ordine sparso, poi si fermano nuovamente sulla superficie dello schermo, una di fronte all’altra, esattamente come due pugili che si studiano durante un incontro. Certo che se potessi essere io una mosca, se potessi avere il dono di poter volare via quando mi pare e piace, mi cercherei un posto migliore dove stare. Ma d’altronde, penso, in fondo le mosche sono mosche. E chi le ha mai capite, le mosche. In un certo senso, a quelle due mosche sventurate sono riconoscente; con tutti i monitor che ci sono qui dentro, hanno scelto proprio il mio per esibirsi nelle loro acrobazie; e mi ritrovo li a guardarle, e nel mentre che le guardo non penso a nient’altro che a loro; cerco di farmi piccolo piccolo per poterle capire meglio, per sentirmi anch’io un pochino più mosca, per capire quanta fatica si faccia nel volare cosi’ in fretta, e quanta determinazione ci voglia, per faticare cosi’ tanto e potersi rifocillare solo mangiando cadaveri e merda. Ma proprio nel mentre che sono completamente calato nel ruolo della mosca, il monitor cambia improvvisamente colore; io perdo le mie ali immaginarie da mosca, cado sbattendo il culo per terra, e torno al mio lavoro. “Servizio clienti, sono Marco, mi dica”. Questo è il mio lavoro. Che poi io non mi chiamo neanche Marco. Ma dopo un po’ ho capito che il nome Marco ai clienti piace, dà sicurezza e tutti se lo ricordano in fretta; se per esempio durante una telefonata cade la linea, il cliente può sempre richiamare e chiedere di Marco. Tutti i miei colleghi sanno che io qui dentro sono Marco. Mentre il vero Marco, che lavora a pochi metri da me, si fa chiamare Antonio. Abbiamo il nome d’arte. E tutti conosciamo il nome d’arte di tutti. Io con i clienti sono gentile. Mi piace parlare con la gente. “Pronto, servizio clienti, sono Marco, mi dica”. E tu, cliente, puoi dirmi tutto. Tant’è che la gente mi chiama per dirmi proprio di tutto. Mi chiamano gli studenti che fanno sega a scuola, le casalinghe frustrate, i mariti insoddisfatti in cerca di consigli. A volte gli amanti delle donne bollenti che pero’ le donne bollenti, nella vita reale, non se le possono permettere. Ogni tanto chiamano anche i clienti che hanno dei problemi tecnici. Non che io li sappia risolvere, i problemi tecnici. Io di telefonia non ci capisco niente. Ma d’altronde, non si può pretendere che una telefonata ti salvi la vita. Per ogni cliente che chiama il mio guadagno si aggira fra i 20 e i 50 centesimi, con punte massime di 80 centesimi, se la chiamata supera i 2 minuti. Ma se la chiamata dovesse durare, ad esempio, dieci, venti, trenta, cento minuti, il mio guadagno sarebbe sempre di 80 centesimi. Lordi. I nostri clienti sono tutti schedati e catalogati. Quando un cliente mi chiama, sul monitor del computer io vedo già se è un tipo “gold”, “silver” o “copper”. Un cliente “gold” è un cliente d’oro, che fa guadagnare soldi all’azienda, da trattare in guanti bianchi; un cliente silver è un cliente d’argento; un po’ meno nobile del precedente, ma ugualmente degno di rispetto. Mentre il “copper” è un cliente di rame. Il peggior cliente che si possa trovare; è il cliente micragnoso, che non spende mai una lira e che chiama per ogni fesseria. Per ogni tipologia di cliente c’è un trattamento diverso; guai a chi concede troppo tempo ai clienti copper, o a chi cazzeggia troppo sulla postazione; ci pensano gli AST a ristabilire l’ordine. Gli AST sono gli Assistenti di Sala. Gente che sta un gradino sopra noi altri. Generalmente si tratta di ex telefonisti come me, che leccando i culi giusti sono riusciti a guadagnarsi una posizione che gli consente di girare in abito, scarpe lucide e cravatta ogni giorno di un colore diverso. Gli AST fanno unicamente gli interessi dell’azienda, spronando il personale a lavorare di più in ogni situazione. Io, quando passano gli AST, faccio sempre di si con la testa, mentre mentalmente li mando affanculo. Dopo otto ore stacco il turno e torno a casa dai miei. A tren’anni vorrei potermene andare a stare per conto mio, magari con Irma, la mia fidanzata. Ma come si fa a farsi una vita con quattrocentocinquanta euro al mese, quando una casa in affitto non ne costa meno di seicento. Ogni volta che apro la porta di casa e mio padre incappa nei miei occhi spenti mi guarda e cerca di farmi coraggio, ripetendomi sempre la stessa frase. Dice che io sono uno fortunato; fortunato ad avere i miei cinquecento euro al mese, che lui quando era giovane era talmente povero da non avere nemmeno gli occhi per piangere. Io gli occhi per piangere li avrei. Ma a me, da piangere, non viene mai. Dopo otto o dodici ore di “pronto sono Marco mi dica” e di luce del monitor sugli occhi, non ho più voglia di fare niente. A casa evito persino di rispondere al telefono. Anche perché risponderei dicendo “servizio clienti, sono Marco, mi dica”. Ormai il corpo va in automatico. Mangio qualcosa davanti al telegiornale. Mio padre commenta ogni notizia ad alta voce, si gira verso di me in attesa di un segnale, di un gesto, un rantolo di approvazione o disaccordo. Ma io non dico mai niente. Sto con gli occhi bassi e do per l’ennesima volta a mio padre l’opportunità di formulare le sue teorie sui suoi tempi, sulla mia fortuna, e sui miei occhi per piangere. Vado nella mia stanza e mi sdraio sul letto. Guardo la mia laurea in lettere, incorniciata e appesa sul muro di fronte, complemento d’arredo utile come i souvenir dei viaggi, le foto di famiglia, le chincaglierie dei cinesi in plastica che sembra ceramica. Tutti oggetti che occupano uno spazio, che arredano, e dei quali non ci accorgiamo più. Mi addormento. In questi giorni faccio spesso sogni ribelli, incazzati e strani. Sarà colpa della primavera in arrivo, penso. In questi sogni mi capita di sognare il mio call center in cui gli AST girano per chiederti come stai, offrirti un caffè, una sigaretta, o invitarti a una partita di calcetto; altre volte sogno il direttore in persona che mi porge un contratto a tempo indeterminato, che mi stacca quell’auricolare dalle orecchie e comincia a farmi esprimere liberamente, senza dovermi presentare dicendo “sono Marco, mi dica”. Altre volte invece sogno delle rivolte sindacali, in cui con tutti i miei colleghi ci alziamo e smettiamo di lavorare, usciamo nel cortile dell’azienda, strozziamo gli AST con le loro cravatte e urliamo “Vaffanculo” al direttore, prendiamo possesso dell’edificio e rileviamo l’azienda con un golpe autorganizzato. E poi sogno un lavoro giusto per tutti noi che ammuffiamo li dentro come topi da laboratorio, sogno di potermi presentare a casa di Irma con il mazzo di rose più grande che lei abbia mai pensato di ricevere, sogno di baciarla sulla porta di casa e di urlare a tutti che voglio passare la mia vita con lei; sogno di potermi dimenticare gli occhi per piangere e di avere solo occhi per ridere. Sogno un futuro migliore. E so, una volta sveglio, che dovrò lottare per averlo. Nel frattempo, contate pure su di me. In fin dei conti, noi ci conosciamo già. Sono Marco. Servizio clienti. Pronto. Mi dica. Carla. Racconto d’estate. La telecamera inquadra il volto teso della concorrente; i suoi occhi lucidi, le mani sudate che non riescono a stare ferme, la bocca che non riesce a chiudersi. Il conduttore suda vistosamente, tiene gli occhi sgranati e le mani giunte; cerca di rassicurare la concorrente parlandole della vita, del prezzo delle scelte, del coraggio delle responsabilità. Le parla come un amico, mentre un grande orologio alle sue spalle segna gli ultimi istanti di una agonia che sembrava potesse non finire mai. La concorrente decide. Il tempo scade. Ha scelto di cambiare il pacco. Vittoria. La concorrente piange. Abbraccia il conduttore, che piange pure lui. Tutti applaudono, e se potessero tutti abbraccerebbero tutti. Fine. Pubblicità. “Anche questa sera hanno guardato il solito programma scemo”, penso io. Anche questa sera l’hanno commentato ad alta voce, anche questa sera si sono fatti travolgere dall’entusiasmo e anche questa sera pure loro avrebbero abbracciato la concorrente, augurandole ogni bene per la sua partenza verso il nuovo, luccicante mondo dei ricchi, proprio come si faceva tempo fa per chi invece partiva povero verso il Nuovo Mondo dei poveri. Credo che i miei genitori, anche se tanto giovani, si annoino; e d’altronde non è facile riempire il tempo, quando intorno a te non accade mai niente. Non che qui da me le cose cambino molto; però, ogni tanto, io mi concedo il gusto della novità; oggi ad esempio ho scoperto di avere delle mani, e di poterle muovere come voglio. Credo che questa sia una scoperta degna di nota, no? Voglio dire, credo che con le mani si possano fare un sacco di cose; talmente tante che per riassumerle non basterebbe nemmeno un enorme libretto di istruzioni! Avrei voluto rendere partecipi tutti di questa scoperta sensazionale; ma qui non c’è mai anima viva. - C’è nessuno? – Mi chiedo ogni tanto. Ma ogni volta, mai nessuna riposta; qui è tutto liquido, tiepido e ovattato. Qui ci sono sempre e solo io. E insieme a me c’è mia sorella. Ma mia sorella dorme sempre. Non fa testo. Secondo il dottore che fruga dentro la mamma, io e mia sorella dovremmo nascere il ventisette di agosto. Ma in realtà io e mia sorella sappiamo benissimo che nasceremo il quattro settembre. Il quattro settembre del duemilaundici. Io poi so anche che mi chiamerò Carla. E mia sorella sa benissimo che si chiamerà Barbara. Io e mia sorella siamo già entrate nell’ordine di idee che non appena verremo alla luce ci saranno un sacco di persone intorno a noi che non vedranno l’ora di prenderci in braccio, farci delle facce spaventose e cantarci una sfilza raccapricciante di filastrocche e canzoncine sceme. Fa tutto parte di un rischio calcolato; d’altronde, siamo noi che abbiamo scelto di nascere; sapevamo a cosa saremmo andate incontro. Una anticipazione spesso ce la da nostro padre, quando alla sera, al termine del programma scemo, si inginocchia davanti al pancione della mamma, lo accarezza, gli parla e e lo sfiora con l’orecchio, come se volesse origliare. Noi ce lo siamo già immaginato, il nostro grande papà. Con un po’ di pancetta, la camicia azzurra e una cravatta buffa, diversa ogni settimana; i capelli in ordine, un po’ di barba, e mani grandi e forti. La mamma invece ce la immaginiamo bellissima, con lunghi capelli, la pelle candida e lineamenti dolci come dune di sabbia. La nostra mamma lavorava in una ditta privata di spedizioni fin dai tempi in cui noi eravamo grandi quanto una ciliegia. Poi io e Barbara abbiamo incominciato a crescere, e con noi pure la pancia della mamma cresceva. E più questa cresceva, più il lavoro della mamma diminuiva. Fino a quando la mamma al lavoro non ci andò più. Restò a casa in maternità, ma con un diritto di maternità che non andava al di là della rotondità morbida della sua pancia; semplicemente la mandarono a casa, senza motivazioni, senza garanzie, senza niente. Da allora la nostra mamma lavora al suo romanzo: una sorta di storia complicata dove c’entrano gli antichi romani e tutti gli imperi che hanno conquistato negli anni. La mamma è sempre stata forte in storia. Non ha studiato che questo per tutta la vita. Papà invece è un insegnante; ma non un insegnante qualsiasi. Il nostro papà è un insegnante speciale. Il nostro papà aiuta a studiare tutti quei bambini che per loro sfortuna hanno un cervello che cammina fra le nuvole, più lento e distratto degli altri. Guai a chiamare “diversi” quei bambini di fronte a papà. Una volta, a pranzo, la nonna li chiamò in quel modo e lui si arrabbiò moltissimo. La puni’ offrendole doppia razione del suo budino al cioccolato. “Suo” in quanto comprato da lui nel discount sotto casa, aperto e servito come fosse una sua, geniale, creazione. Mamma e papà ogni tanto discutono, e parlano dell’affitto, delle bollette da pagare, delle spese che dovranno affrontare quando noi verremo al mondo; quando ci sono queste discussioni pure Barbara, che dorme in continuazione, si sveglia. Gira la testa lentamente, mi guarda, e con gli occhi mi sussurra : “Che c’è?” La mia sorellina ha due occhi grandi e bellissimi. E mi sento orgogliosa di poter essere ancora la sola a poterli vedere. Io la guardo e le sorrido, come per volerle dire di non preoccuparsi, che non c’è niente di cui aver paura. Lei sorride a sua volta, si raggomitola su se stessa, e torna a dormire. Mamma e papà invece continuano; continuano a parlare, a discutere, a preoccuparsi. Papà allenta il nodo della sua cravatta buffa. La mamma lo ascolta cercando di pensare ad altro: agli abitini del nostro corredo, ai commenti delle sue amiche, ai sistemi per riacquistare la linea dopo il parto, alle espressioni del conduttore del programma scemo; papà le dice che stanno eliminando tutti gli eroi dei bambini coi cervelli fra le nuvole, tutti gli insegnanti di sostegno come lui; dice che vogliono radunarli in una specie di ghetto per tenerli lontani dalla vita dei bambini normali. Dice anche che rischierà di perdere il lavoro. Anche lui, proprio come la mamma. Dice anche che la situazione non è buona. Poi, smette improvvisamente di parlare. La mamma lo guarda. Lui guarda la mamma. E nel silenzio si prendono per mano, si baciano e si stringono cosi forte da stringere anche noi. Sussurrano insieme. “Ce la faremo”, dice la mamma. “Ce la faremo”, risponde papà. E si baciano ancora. Io rimango ad ascoltarli e sorrido perché so che nascerò fra due persone che si amano, nonostante le ingiustizie, le difficoltà, nonostante l’imbecillità, nonostante tutto. Guardo mia sorella dormire felice e mi chiedo a quanti minuti di distanza nasceremo l’una dall’altra; mi chiedo chi sarà la prima, mi chiedo quanta strada potremmo fare insieme, mi chiedo se davvero valga la pena venire al mondo. E continuo a rispondermi comunque di si, nonostante tutto. Poi penso che ogni cosa sia destinata a cambiare, a muoversi, ad animarsi di vita nuova, proprio come la mia mano che mi è apparsa solo questa mattina; e penso anche che con il tempo il mondo diventerà anche nostro, e più il tempo continuerà a passare e più potremo continuare ad appropriarcene. Penso ad un futuro che appartenga a noi e non alle regole che vorrete imporci. Penso che rispetto a tutto ciò che di marcio ci lascerete, noi saremo sempre infinitamente più libere e veloci. Talmente veloci, da non permettervi di prenderci mai. ©Michele Vargiu 2011 – www.michelevargiu.com
Scarica