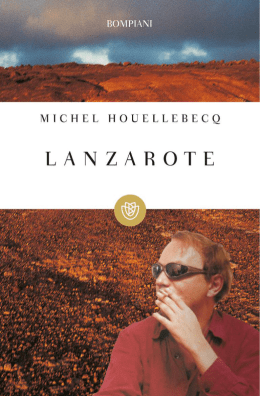Edizioni dell’Assemblea 92 A.N.P.I. - Sezione “Martiri di Berceto”, Rufina Comune di Rufina Lazzaro Vangelisti Una vita trascorsa sotto tre regimi Firenze, marzo 2014 Una vita trascorsa sotto tre regimi / Lazzaro Vangelisti. – Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2014 ((In testa al front.: A.N.P.I. Sezione “Martiri di Berceto”, Rufina, Comune di Rufina. 1. Vangelisti, Lazzaro 2. ANPI. Sezione Martiri di Berceto, Rufina 3. Rufina 945.5015 945.5016 Storia contemporanea – Toscana – Sec. 20 Strage di Berceto, Rufina – 1944 CIP (Catalogazione nella pubblicazione) a cura della Biblioteca del Consiglio regionale Questo volume è una riedizione a cura della sezione A.N.P.I. "Martiri di Berceto", Rufina Consiglio regionale della Toscana Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell’immagine Progetto grafico e impaginazione: Patrizio Suppa Pubblicazione realizzata dalla tipografia del Consiglio regionale, ai sensi della l.r. 4/2009 Volume pubblicato nell’ambito delle iniziative della Festa della Toscana 2013 Marzo 2014 ISBN 978-88-89365-37-3 Sommario Presentazione - Daniela Lastri 7 Prefazione - Mauro Pinzani 9 Introduzione - Morena Viciani 11 Una vita trascorsa sotto tre regimi Prologo 15 Monarchia 17 Fascismo 65 La Democrazia Cristiana 79 La strage di Berceto 137 Documenti 155 Intervista Vera Vangelisti a Berceto Interventi di Barbara Vangelisti in occasione delle commemorazioni annuali dell’Eccidio di Berceto Una lettera di Pratolini Altri documenti 157 161 177 179 Immagini 191 Immagini presenti nella precedente edizione 205 Presentazione E’ trascorso poco meno di un anno dal conferimento della medaglia di bronzo al merito civile al Comune di Rufina, per non dimenticare l’orribile eccidio di Berceto e l’opposizione del paese al regime fascista. Questo il motivo del conferimento voluto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: Nel corso del secondo conflitto mondiale la popolazione della cittadina toscana animata da fiera ostilità nei confronti del regime fascista, per aver favorito la lotta partigiana venne fatta oggetto di una feroce rappresaglia. La frazione di Berceto fu teatro di un’atroce strage, nella quale furono uccisi 11 civili fra cui donne, bambini ed anziani. Nobile esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio. Tra quelle donne e bambini c’erano anche la moglie e le figlie di Lazzaro Vangelisti: Anna Maria di tre anni, Iole di nove anni, Angelina e Bruna di ventidue e ventitre anni, la moglie Giulia di quarantasei anni. Lazzaro Vangelisti ha pagato un tributo alla causa antifascista che è impossibile riuscire a comprendere, come lui stesso ammette, sino in fondo. Solo le parole di Lazzaro possono avvicinarci allo stato d’animo che da quel momento segna tutta la sua vita futura. Rileggiamole queste parole e incidiamole nelle nostre menti e nei nostri cuori. Rileggiamole e, soprattutto, insegnamole ai giovani. Eccole: Io credo che non ci siano persone più barbare dei fascisti. Chissà chi può capire il mio stato d’animo in quei momenti. Non so chi mi diede la costanza di resistere al dolore, in quella stanza, trovandomi di fronte alle mie figlie e a mia moglie nell’immobilità della morte, distese sul pavimento, i corpi senza vita… Ad ogni modo la mia famiglia non si meritava di essere trucidata così, solo per aver dato da mangiare ai partigiani. E poi che colpa avevano le bambine. Una delle mie figlie uccise aveva tre anni. In quella strage perirono undici persone, fra cui mia moglie e quattro mie figlie. Mia moglie mi amava fin da quando era una bambina. Era sempre amorosa verso di me e degna di essere amata. Io l’amavo come me stesso. Da allora il mondo per me è diventato una tetra prigione. 7 Il mondo di Lazzaro Vangelisti è diventato un cupo carcere dove, però, ha trovato la forza di raccontare la sua vita, come dice lui, sotto tre regimi. E’ una storia che mette i brividi, che commuove, che fa riflettere sull’importanza cruciale di non abbassare mai la guardia contro ogni forma di fascismo, di intolleranza, di dittatura. Una storia che merita di essere raccontata, tramandata e per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di pubblicarla. E’ significativo che la pubblicazione avvenga dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge per le celebrazioni per il 70° anniversario della Liberazione che percorrerà il biennio 2014-15. Con questa iniziativa, ci uniamo ai meritori sforzi del Comune di Rufina, dell’A.N.P.I. Sezione Martiri di Berceto di Rufina e della famiglia Vangelisti, a cui va il nostro ringraziamento e la nostra più grande ammirazione. Daniela Lastri Consigliera Regionale, Ufficio di Presidenza 8 Prefazione Nel leggere questa nuova edizione della pubblicazione di Lazzaro Vangelisti “Una vita trascorsa sotto tre regimi” il lettore attento ha la possibilità di continuare nell’opera di memoria e ricordo della strage di Berceto e contribuisce così alla trasmissione e alla conoscenza di un episodio tragico della nostra guerra di liberazione. Nel libro si trova anche la possibilità di una lettura critica della nostra storia recente tra reticenze giudiziarie e operazioni politico-culturali di rimozione di fatti ed episodi che nel dopo guerra creavano imbarazzo e problematiche di rapporti internazionali e nazionali. Un caso emblematico delle tante vicende che non hanno avuto esito positivo del punto di vista giuridico con la scoperta e la punizione dei colpevoli di fatti orribili e crudeli, una vicenda esemplare sull’eroismo delle nostre popolazioni rurali durante il secondo conflitto mondiale, una testimonianza viva di sofferenza per i parenti delle vittime, ma anche un atto di testimonianza civile e politica nel senso alto del termine, nella tenace e costante ricerca dei colpevoli che non può non suscitare un moto di ammirazione per la figura di Lazzaro Vangelisti che si erge, giganteggiando, sulle tristezza e sulla miseria di una crudeltà senza limiti. Proprio la testimonianza è alla fine il compito che rimane dopo la lettura, testimoniare diventa un obbligo morale. Testimoniare diventa anche un impegno verso le vittime, in conto e per conto di ogni vittima di sopruso e violenza. Prolungare le loro urla in un tempo che da fisico diventa etico, farsi interpreti della loro disperazione come solidarietà viva verso ogni forma di negazione di libertà civile e politica, incanalare l’energia di una tragedia e trasformarla in una nuova fonte di speranza per le sorti di una umanità sempre in bilico nel tempo tra essere e rimanere umana, sono aspetti di questo impegno. Le Istituzioni devono assolvere nel rispetto delle proprie competenze al doveroso compito di celebrazione nelle ricorrenze cronologi9 che delle stragi nazifasciste, tutte devono compiutamente adoperarsi nella costruzione di una coscienza critica nelle popolazioni su questi temi, ognuno nel suo ruolo deve dedicarsi al rispetto dei luoghi teatri di tali avvenimenti, muti testimoni anch’essi della tragedia. Desidero ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che hanno permesso la presente edizione del libro di Lazzaro Vangelisti, il Consiglio Regionale della Toscana, l’A.N.P.I. Sezione Martiri di Berceto di Rufina, la Famiglia Vangelisti. Ognuno ha assolto il suo doveroso impegno e contribuito a “fare” giustizia. Mauro Pinzani Sindaco del Comune di Rufina 10 Introduzione Sono passati settanta anni ma non abbiamo dimenticato… non vogliamo dimenticare che il 17 Aprile 1944 a Berceto, sopra Pomino nel comune di Rufina, furono trucidate undici persone: nove civili e due partigiani. Il padre di una delle famiglie che ebbero vittime nell’eccido, Lazzaro Vangelisti, a cui furono trucidate la moglie e quattro figlie, ha scritto questo bellissimo libro, che racconta bene i fatti accaduti ed il contesto in cui si sono verificati. Noi vorremmo condividere e far conoscere questi fatti ai giovani, agli studenti delle scuole del territorio, ai quali dedichiamo questa seconda edizione, ma anche a tutti coloro che hanno a cuore la memoria e s’impegnano per combattere ogni forma di neofascismo e neonazismo. La sezione ANPI di Rufina è dedicata e porta il nome dei “Martiri di Berceto” perché la strage ha segnato profondamente il nostro territorio e ancora oggi sono aperte delle ferite nella popolazione locale. Il valore del libro è testimoniato anche da Vasco Pratolini con una sua lettera, ma ha un pregio ancora maggiore perché scritto da un uomo con il cuore straziato dal dolore che cerca giustizia; rende molto bene l’idea della vita contadina tra le due grandi guerre e del dopoguerra fino agli anni 70. Si tratta di un testo che molto meglio di un libro di storia fa capire come si viveva, si amava, si lavorava, come giovani come lui soffrivano e subivano le guerre, con gli occhi e la semplicità di chi l’ha vissuta in prima persona. Pur non essendo un romanzo, il racconto di Lazzaro rende benissimo l’idea di quanto il protagonista amasse intensamente sua moglie e i suoi figli e come la ferocia nazista gli abbia strappato questi amori, provocando sicuramente l’avvenimento più terribile e straziante capitato nella sua vita, dopo il quale la sua esistenza ha un solo ed unico scopo: affermare la verità, consegnare i responsabili alla giustizia. Non l’ha avuta giustizia Lazzaro, finché è stato in vita, solo recentemente è stato riconosciuto il merito al valor civile al Comune di Rufina per l’Eccidio, ciò ha reso giustizia alle famiglie delle vittime, alle istituzioni e 11 all’ANPI che insieme si sono attivate per ottenere il riconoscimento, coinvolgendo con la raccolta di firme la popolazione del territorio, che non ha mai dimenticato che anche quella strage come tante altre in quel periodo, era destinata a colpire la solidarietà presente nel luogo. Infatti il luogo dell’Eccidio per l’ANPI di Rufina dovrebbe diventare un Centro di documentazione della Resistenza dove, attraverso progetti sulla memoria con le scuole, si potrebbe approfondire la storia locale e dare strumenti ai giovani perché possano compiere scelte responsabili per il proprio futuro. Purtroppo invece, la casa sta crollando; per questo rinnoviamo l’appello alla proprietà perché non permetta che un luogo così ricco di memoria si trasformi in un cumulo di macerie e alle Istituzioni di sostenerci in questo percorso. Questa seconda edizione pubblicata per il 70° anniversario dell’Eccidio, per la realizzazione della quale ringraziamo il Consiglio Regionale e tutti coloro che hanno contribuito, è arricchita da foto, interviste e documenti che rendono al lettore un’idea ancora più completa del valore del nostro passato e di fatti che non devono accadere mai più! Morena Viciani Presidente ANPI Sezione “Martiri di Berceto” di Rufina 12 Lazzaro Vangelisti Una vita trascorsa sotto tre regimi Prologo Io ho ottantacinque anni, sono nato nel 1891. In tutto questo tempo credo di aver fatto il mio dovere, come cittadino. Ho fatto la guerra del 15-18, quatto anni di fronte, e ho dovuto fare tanti sacrifici: ho patito il sonno, la fame, il freddo; ho visto più volte in faccia la morte mentre si dava l’assalto alle trincee nemiche, quando ero di vedetta, quando ero di pattuglia. La ricompensa per questi sacrifici è stata quella che descriverò. Ho avuto a che fare con persone potenti, nel cercare di far valere i miei diritti, ma non ho ottenuto che umiliazioni. I fascisti, durante la seconda guerra mondiale, hanno ucciso mia moglie e quattro mie figlie. Di nuovo ho avuto a che fare con questi grandi personaggi, perché fosse fatta giustizia, ma non ho ottenuto che altre ingiustizie. Ho vissuto sotto tre regimi: monarchia, fascismo e democrazia cristiana. Posso affermare che è cambiato il nome dei governanti ma uguale è rimasta la sostanza. I miglioramenti che ci sono stati, sono stati strappati col sangue e il sudore dai proletari nelle lotte politiche, ma non è cambiato molto. Il fascismo sarà ora senza stivali, ma ogni tanto fa capolino e vorrebbe rimettersi i galloni. Quando ero ragazzo io la miseria regnava in molte famiglie. Tanti pativano la fame. Di scuole ce n’era una per comune. Quelli che abitavano lontano dalla scuola dovevano fare dei grossi sacrifici per poterci andare. Per molti era quasi impossibile andare a scuola. Io ero fra quelli e non potei fare neppure la prima elementare, per cui oggi so appena leggere e scrivere. Anche per questo oggi mi trovo così mortificato, perché vorrei raccontare cosa è stata la mia vita sotto questi tre regimi. In questo tempo non c’è mai stata pace. Ci sono state cinque o sei guerre, di cui due mondiali. Il peso è sempre stato sopportato dalla gente povera, dai lavoratori, come me. Ecco le ragioni per cui ho deciso di raccontare la mia vita. Per farlo userò le parole che so. 15 Monarchia Io nacqui nel mese di novembre del 1891. Avevo un fratello, che era del 1888. Mio padre era del 1847 e mia madre del 1857. Eravamo in un piccolo podere a mezzadria. Comincio da qui a scrivere qualcosa sull’operato della monarchia. Io avevo circa sei anni e veniva spesso un mio cugino a trovare i miei genitori. Era stato alla guerra d’Africa e raccontava le battaglie che aveva fatto. Una volta rimase ferito. Ci spiegava come era andata la guerra, cose che oggi si leggono nella storia, da Adua alla Mosa. I vari generali avevano a loro disposizione, fra tutti, circa 14000 uomini. Furono fatte terribili e disastrose battaglie. Non sto a dire tutto quello che raccontava mio cugino, ci vorrebbe troppo tempo. Dico solo che 14000 combattenti dovettero cedere di fronte a un nemico cinque volte più numeroso. Così la guerra fu persa e la colpa fu data ai generali, dicendo: qui sono andati troppo veloci, là troppo lenti. Finì che ci rimisero la vita due generali, 165 ufficiali e quasi 5000 soldati. Per quel che ne so io la colpa dovrebbe essere attribuita al governo che si era esposto in una guerra contro un nemico più forte. E poi sappiamo che le guerre portano spargimento di sangue, perdite di vite umane, distruzioni di ogni genere, e portano miseria a tutta la nazione. Io ne ho avuto l’esempio. Noi eravamo quattro persone e si lavorava quel poderino. Avevamo un raccolto di circa venti quintali di grano e venticinque di quintali di vino. Quando andava bene, a forza di tanto lavoro e facendo economia nel vestire e nel mangiare, si faceva pari. Si usava molta polenta di granoturco e castagne. Si diceva fortunato colui che poteva averne abbastanza per poter mangiare due volte al giorno. La situazione a quei tempi era molto critica. Si vedeva passare spesso delle donne con dei bambini per mano a chiedere l’elemosina. Si accontentavano anche di un pezzo di polenta fredda o di un pezzo di pane. Molti erano scalzi perché non avevano i soldi per comprare le scarpe e si accontentavano anche di un paio di ciabatte. C’era chi 17 pativa la fame. Anche questi fatti ce li conferma la storia. Eravamo in brutte acque. Nel 1898 si ebbero gravi tumulti in Sicilia, in Calabria e nelle Puglie. L’agitazione dilagò verso il nord, dando luogo a una feroce repressione. Milano rimase in stato d’assedio dal sei al nove maggio. A Firenze e a Napoli furono imprigionati centinaia di accusati politici. Furono soppressi i giornali e si ebbero severe condanne. Poi, il 29 gennaio 1900, fu ucciso il re Umbero I dalla rivoltellata di un anarchico. L’undici agosto fu data la missione al re Vittorio Emanuele III e nel 1901, nel mese di novembre, fu eletto Zanardelli presidente del consiglio, con Giolitti ministro dell’interno. Pareva che avessimo una migliore politica. Per me fu un triste anno il 1901, che mi lasciò un brutto ricordo. Non avevo ancora compiuto dieci anni. Mio padre mi portava spesso con sé nel campo a fare piccoli lavori, come raccattare i sassi dal campo. La mattina del sei luglio mio padre e io eravamo nel campo. Era quasi mezzogiorno. Mio padre mi comandò di andare a prendere la merenda, eravamo distanti da casa più di un chilometro. Il tempo si faceva brutto. Io partii. Quando giunsi a casa, mia madre aveva già preparato il necessario, ma il tempo si faceva sempre più brutto. Mia madre mi diede l’ombrello perché il cielo si era fatto scuro. Avevo fatto circa duecento metri di strada quando cominciarono a cascare dei goccioloni d’acqua e continuamente tuonava. Io aprii l’ombrello per non bagnarmi. I tuoni divennero sempre più frequenti. Poi venne un tono assordante, che annunciava l’avvicinarsi della tempesta. Il cielo divenne all’improvviso di un nero spaventoso. Cominciò a cascare la grandine, il vento mi portava via l’ombrello, e fui costretto a chiuderlo. La grandine cascava che parevan sassate. Tenevo l’ombrello chiuso sopra al capo perché la grandine non mi rompesse la testa. La strada era diventata un fosso. Durai fatica a raggiungere mio padre. Lui era andato in un piccolo rifugio coperto da lastre, ma era bagnato anche lui. Quando mi vide percosso nelle mani e nella fronte e tutto bagnato mi disse che se sapeva così sarebbe venuto a casa anche lui. Poi mi voltò le spalle. Prese il fazzoletto e cominciò ad asciugarsi le lacrime. Non voleva che io lo vedessi piangere. Nel vederlo tanto disperato venne da piangere anche a me. 18 Monarchia Non sapevo trovare una parola di conforto per mio padre. Mi disse “Ti dolgono codesti lividi?”. “Un po’, ma non da piangere. Voi piangete per questo?”. Lui rispose “anche per questo” ma poi aggiunse, “vedi, mio caro, quest’anno siamo alla fame” e fece un grosso sospiro, senza dire altro. La grandine batteva su quel tetticciolo che pareva dovesse spezzare le lastre. Eravamo tutti e due bagnati e si stava lì, zitti. Io vedevo che era una brutta tempesta e consideravo il dispiacere che aveva mio padre, non solo per me, ma per tutto il raccolto che sarebbe andato perso. Le sue parole si trasformarono in un lamento. “Tutte le mie fatiche, il lavoro di un anno, tutte le nostre sostanze sono distrutte. Che speranze posso avere ora?”. Appena passata quella terribile burrasca uscimmo fuori dal rifugio e vedemmo quel disastro. Il grano era tutto tritato sotto la grandine, non si vedeva più un filo ritto le viti non avevano più una foglia. Si perse il raccolto del vino anche l’anno dopo perché le viti ci rimisero le guaine, i tralci erano teneri e quando venne il gelo li seccò tutti. Fu veramente una tremenda burrasca. Aveva ragione mio padre a disperarsi. Eravamo così sconvolti e bagnati quando partimmo dal campo per tornare a casa, anche per cambiarci, e poi non avevamo neppure mangiato. Appena giunti a casa vedemmo anche gli altri contadini che come mio padre si davano alla disperazione. Chi bestemmiava, chi si raccomandava a Dio. Tutti si vedevano in brutte condizioni a causa di quella tempesta. Anche mia madre piangeva dicendo “come faremo quest’anno senza grano e senza granoturco e anche senza denari”. Per alcuni giorni mio padre non tornò neanche nel campo. Aveva perso ogni speranza. Erano passati circa dieci giorni. A me dispiaceva vedere i miei così avviliti. Dopo qualche giorno venne da noi un mendicante che spesso veniva a chiedere l’elemosina. Tante volte mio padre gli aveva dato alloggio. Passava quattro o cinque volte all’anno e sempre gli davamo qualcosa. Questa volta disse “sono venuto ma non per chiedere, mi vergognerei sapendo che avete perso tutte le vostre sostanze”. Si mise a parlare con mio padre e gli disse che non si era mai avuto un disastro così. Poi aggiunse “io sono venuto da voi perché mi hanno inca19 ricato di trovare un ragazzetto di 12 o 13 anni per parare una ventina di pecore. Ho pensato al vostro figliolo più grande. È un ragazzo in cui ho molta fiducia”. Mio padre rispose “non posso perché è lui che mi dà una mano. Da solo non potrei farcela”. Poi aggiunse “ci sono quei tre fratellini che passano spesso di qua a chiedere un tocco di pane. Quello più grande credo abbia 13 anni. Lui potrebbe andare bene”. Quest’uomo disse “quelli lì vanno più volentieri a chiedere l’elemosina che a guadagnarsi il pane con il lavoro”. Io ascoltavo. Mi feci coraggio e dissi “ci vado io”. Quest’uomo disse “tu sei troppo giovane, non puoi. La bandita è piccola, ci vuole uno più grande”. Io dissi “non è mica una fatica parare le pecore”. Lui rispose “fatica no, ma ci vuole molta attenzione”. Io replicai “son capace, sì, ci vado io, vado volentieri”. Il mendicante mi vide così risoluto che disse “se proprio ti senti sicuro io questa sera vado da quella famiglia e glielo dico. Verranno a vederti. Se ti prendono vai sicuro, perché sono brava gente. Vedrai che ti troverai bene”. Io dissi “sì, sì, ci vado”. Così, convinto delle mie promesse, il mendicante partì e andò da quella famiglia. Io, momento per momento, aspettavo di vedere arrivare quello a cui abbisognava un garzone. Mi sentivo contento di poter essere utile ai miei genitori. Li vedevo così tristi e disperati. Volevo dar loro un po’ di conforto, anche se mi costava sacrificio. A quei tempi non c’erano assicurazioni. Il comune e il governo non ci aiutarono. Nessuno ci aiutò. Bisognava arrangiarsi da soli. I miei genitori non erano tanto contenti, ma vedendomi così deciso non mi dissero di no. Ecco il giorno che arrivò l’uomo a cui serviva un garzone, come avevamo fissato con il mendicante. Appena mi vide anche lui sembrava poco contento. Mi disse “sei troppo piccolo, la bandita è piccola, si parano male una ventina di pecore”. Mi pareva che mi offendesse. Gli dissi “io le prometto di essere capace”. Lui disse “se vuoi, puoi provare. Tu vieni, se poi non sei capace ti riporto qua io dai tuoi genitori”. Io, sempre deciso, dissi “sì, sì, vengo”. Così fu stabilita la mia partenza. Mentre mia madre preparava la valigetta con il mio cambio si mise a piangere. Le cascavano lacrime fitte fitte. Non era contenta che io andassi via. Anche mio padre e mio fratello erano scontenti. Mia madre non si dava pace. Se non era per le 20 Monarchia tante promesse che avevo fatto avrei rinunciato alla partenza. Poi era venuto quell’uomo da tanto lontano, sulle mie promesse, e volevo essere d’aiuto in qualche modo ai miei genitori. Mi feci coraggio li baciai e partii per la prova. Quando fui fuori di casa mia madre mi abbracciò dicendomi “Dio ti aiuti”. Io le risposi “non vado mica in prigione. Se non ci sto volentieri torno a casa”. Anche quell’uomo ci faceva coraggio. Così lasciai i miei e andai con quest’uomo mai visto e mai conosciuto. Il distacco dai miei fu molto acuto. Avevo un cuore da bambino: perché dovevo allontanarmi per forza di miei cari e sacrificare la mia vita in così tenera età in tante sofferenze? Strada facendo, quest’uomo, era molto gentile, mi faceva coraggio. Mi disse che aveva due figli anche lui. Uno era quasi grande come me, aveva 8 anni. L’avrebbe mandato insieme a me quando non sarebbe dovuto andare con i maiali. Poi mi disse che se fossi stato capace di parare le pecore mi avrebbe dato la mancia tutte le domeniche. Disse “vedrai che con noi starai bene, ti troverai contento”. Dopo quelle parole mi sentii tornare il cuore in seno. Quando arrivammo vicino a casa sua ci videro i suoi figli e ci vennero incontro, contenti che il loro padre avesse trovato un garzone. Invece a me batteva il cuore dalla tristezza, ma loro mi fecero tanti complimenti. Entrammo tutti in casa e mi fecero festa. La tavola era già apparecchiata. Mi misero a sedere vicino al ragazzo più grande che voleva stare accanto a me. Mi pregavano di mangiare e mi dimostrarono subito di essere gente per bene, come aveva detto il mendicante. Cominciai a sentirmi più contento. Dopo mangiato mi portarono nella stalla. C’erano vacche, buoi, e vitelli. Il capofamiglia mi chiese se sapevo governare i buoi. Io gli risposi “se sono agevoli li governo volentieri”. Poi si andò ad aprire le pecore. Venne con me anche il capofamiglia per insegnarmi i confini della bandita. Mentre si andava su con quelle pecore non ci si faceva a tenerle nella strada. Le pecore andavano di qua, di là, tutti i buchi li trovavano, e io corri di qua e di là per rimetterle insieme. Ci feci una sudata. Dicevo fra me “incomincia male. Quell’uomo dirà che non sono capace”. Ma io non potevo fare di meglio. Forse le pecore erano affamate, io non ero pratico. Si durò fatica a condurle nel bosco. Ma quell’uomo pareva contento. Mi indicò i confini e 21 se ne andò. Io rimasi solo. “In quel bosco non ci saranno le vipere” pensai. Non ero punto soddisfatto. Le pecore fecero un monte di danni. Quello che più mi stava a cuore era che mi sentivo così lontano dai miei. Mi venivano mille pensieri. Mi trovavo pentito di aver fatto tante belle promesse. Poi, la sera, venne una sposa a prendermi perché da solo non ce l’avrei fatta a riportare a casa quei diavoli di pecore. Così in due, lei davanti e io dietro, non si fecero uscire di strada, forse perché non avevano più fame. Quando giungemmo a casa quella sposa mi fece un monte di elogi. Disse che ero stato attento. Tutti mi facevano dei complimenti, forse perché mi vedevano così scontento. Io cercavo di farmi vedere il più contento possibile, mi sforzavo, perché loro erano così cari con me. Mi fecero vedere la camera dove dovevo dormire. C’erano due lettini. In uno ci dormiva il ragazzino più grande. Dopo aver cenato si andò a letto. Io non potevo dormire. Fu un dormiveglia per tutta la notte, con quella tristezza. “Cosa diranno a quelli della mia famiglia” pensavo. Poi venne giorno. Ci si alzò. Mandarono me e il ragazzo più grande a prendere l’acqua poi si fece colazione. C’era un grosso cane. Mi dissero che mordeva e che non dovevo dargli noia. Io avevo paura quando mi veniva vicino e andavo sempre con i padroni di casa perché mi guardava poco bene, soprattutto i primi giorni, e mi dava sospetto. Venne l’ora di aprire l’ovile e condurre le pecore in bandita. Anche quella mattina venne il ragazzino con sua madre ad aiutarmi. Si mandarono bene, senza far danni. Poi loro tornarono a casa e io rimasi solo. Diedi sfogo alle lacrime trovandomi così lontano da casa mia, in quel bosco sconosciuto. Mi pareva di essere tanto sfortunato. Ma ormai avevo fatto tante promesse e non volevo fare brutta figura con quella famiglia dove erano tutti così gentili con me. E poi sapevo che i miei a casa si trovavano in brutte condizioni. Li avevo visti tanto disperati. A poco a poco mi adattai a quella vita, senza guardare al sacrificio. La domenica dopo vennero i miei genitori a trovarmi. Io dissi loro che in quel posto ci stavo bene e volentieri perché quanti erano in casa mi volevano bene. Ai miei genitori dissero che erano contenti di me e che non avrebbero creduto che io mi disimpegnassi così bene 22 Monarchia in quello che avevo da fare. Dissero a mio padre che mi avrebbero dato tre lire al mese e in più mi avrebbero fatto un vestito. Io mi sentivo contento perché potevo dare il mio piccolo contributo ai miei genitori. Loro rimasero contenti nel vedere che io stavo volentieri in quella famiglia dove tutti mi volevano bene. Così i miei genitori ci salutarono e ripartirono. Io rimasi alle dipendenze di quella famiglia per più di un anno. Quando venne mio fratello a prendermi per riportarmi a casa mi dispiacque lasciarli. Mi vennero le lacrime dal dispiacere, come a loro. Soprattutto a quel ragazzino più grande, che eravamo come fratelli. Salutai tutti e partii con mio fratello per casa mia. Io mi sentivo soddisfatto per aver fatto il mio dovere. Strada facendo mio fratello mi disse che era stato in pensiero, soprattutto quando c’erano quelle stagionacce e io dovevo andar fuori con le pecore. Mi pareva fossero passati mille anni da quando avevo visto per l’ultima volta i miei genitori. Li trovai più contenti di quando ero partito. Mia madre mi abbracciò stretto a lei. Erano tutti contenti del mio ritorno. Però avevano fatto un monte di debiti: con il padrone, con il mugnaio, con il calzolaio. Quella tempesta aveva sacrificato tutto. Si dovette comprare tutti i semi. Però la situazione migliorò in breve tempo. Si fece presto a far pari con tutti. Qualcosa avevo guadagnato anch’io, quasi 50 lire, e in più il vestito e le scarpe. Mi pareva di essere un eroe. Mio fratello andò a lavorare a Genova. C’erano tanti lavori. Quando ebbi compiuto 15 anni andai anch’io a Genova a lavorare. La situazione migliorò subito. A quei tempi non c’era bisogno del libretto di lavoro o di aver frequentato la scuola, bastava rendere l’utile al padrone e tutto andava bene. Mio fratello guadagnava tre lire al giorno, io due lire e cinquanta centesimi. Si faceva anche gli straordinari. Si mandava ai nostri genitori circa cinquanta lire al mese. Così mio padre si tolse tanti pensieri. Prese in affitto un po’ di terra con la casa. Lui e mia madre lavoravano lì e noi figli si lavorava fuori. A Genova c’erano le scuole serali. Noi dopo cenato si andava alla scuola, che però durò solo tre mesi. Mio fratello andò a fare il militare e io andai in Francia a lavorare, perché si guadagnava molto 23 di più. La prima lettera la scrissi che avevo 18 anni. Mi ero esercitato un po’ leggendo dei libri. La prima volta scrissi a mio fratello, che era nei cavalleggeri, a Saluzzo. Mio fratello rispose, ma fu la prima e l’ultima volta che ci scrivemmo. Appena mio fratello rispose alla mia lettera io gli mandai cinque lire, ma non ricevetti nessuna risposta. Quando il vaglia arrivò a Saluzzo mio fratello era già ammalato gravemente, se non era già morto, perché pochi giorni dopo ricevetti una lettera dai miei genitori in cui mi dicevano che avevano saputo della malattia e della morte in una sola volta. Mio fratello aveva avuto una terribile malattia che lo aveva portato alla tomba nel giro di due giorni. Quando ricevetti quella triste notizia mio fratello era già sepolto. Non lo rividi più, né vivo né morto, e mi dispiacque molto. Era stato lui che mi aveva instradato, era stato la mia guida. Mi aveva insegnato anche a leggere e ora, sapendolo sepolto, mi sentivo particolarmente solo. Non mi davo pace pensando che lui non c’era più e per non averlo potuto rivedere quand’era morto. Pensavo “perché non ci avranno avvertito in tempo? Forse perché era figlio di contadini? Perché era un operaio?”. Se fosse stato figlio di un generale o di un marchese forse avrebbero avuto più premura. Invece per mio fratello fu come se non avesse avuto nessuno, eppure era un figlio di mamma anche lui. La morte di mio fratello, sconvolse tutta la mia situazione perché anche i miei genitori non si davano pace ed erano sempre a scrivermi di tornare a casa. Non volevano che io rimanessi in Francia, perché ero troppo lontano. Mi scrivevano “abbiamo te solo, torna a casa. La tua lontananza ci fa soffrire, la morte di tuo fratello ci ha lasciato un triste ricordo”. Io ormai lavoravo e guadagnavo benino. Mi dispiaceva tornare. Ma tanto mia madre che mio padre erano così dispiaciuti della mia lontananza che a furia di scrivermi mi convinsero a tornare a casa. Mi dissero che avevano offerto loro un poderino a mezzadria e se io tornavo si poteva lavorarlo insieme. Si sarebbe stati più contenti, insieme. Io gli risposi di fissare il podere e quando sarebbe stato libero sarei tornato a casa per sempre. Così feci, infatti, il mese di ottobre dell’anno 1911. Lasciai la Francia col proposito di rimanere per sempre insieme ai miei genitori, così li avrei fatti contenti. Si andò in quel poderino, con la speranza di 24 Monarchia non lasciarci più. Eravamo tre soli, si andava avanti benino, anche finanziariamente, con il nostro lavoro. Qualcosa poi l’avevo portato io dalla Francia. Mio padre un giorno mi fece capire che avrebbe avuto piacere se io mi fossi sposato. Aveva paura che io ripartissi. Per gli operai, infatti, la situazione era migliorata, per i contadini invece era cambiato poco. Se uno si ammalava doveva pagarsi il dottore e le medicine. Se a uno di noi coloni succedeva un incidente non davano nulla mentre agli operai pagavano mezza giornata di lavoro più il dottore e le medicine. A me non mi andava bene di restare ma per accontentare i miei genitori continuai a fare il contadino. Avevo una certa passione per la caccia. La domenica prendevo il fucile e andavo a caccia con i miei amici. Una domenica passai davanti a una casa abitata da gente che conoscevo anche prima di partire per la Francia. Andai a salutare quella famiglia. Appena mi videro mi fecero un monte di complimenti e mi invitarono in casa. C’erano sei sorelle, la più grande aveva vent’anni. Ci si mise a parlare dei tempi passati. C’era una bambinetta, aveva dodici anni e sembrava una ragazzina, che era sempre allegra e sorridente. Io conversavo con quelle più grandi e con i loro genitori. Quasi tutte le domeniche passavo di lì, con l’intenzione di chiedere amore alla figliola più grande, ma più le parlavo e meno ne avevo voglia. Invece quella bambina più la vedevo e più mi garbava; quella di dodici o tredici anni, che si chiamava Giulia. A me pareva che avesse tutte le virtù, solo che era troppo giovane. Io volevo sposarmi presto e non era il caso di perdere tempo con quella famiglia. Andavo da altre parti. Passarono un paio d’anni, ma non trovai una che mi andasse bene. Avevo sempre in mente quella bambina. I suoi modi di fare mi avevano incantato, sentivo il bisogno di tornare da lei. Infatti un giorno mi decisi e l’andai a trovare. Lei stava facendo le faccende insieme a una sorella più piccola. Ebbi tempo di parlarle a lungo. Aveva già compiuto quattordici anni, era una ragazza sempre più bella, carina, con quei suoi modi di fare così eleganti. Vedevo che per me c’era solo lei ma era ancora troppo giovane per prendere marito. Non 25 volevo che la gente pensasse che mi stavo approfittando della sua innocenza. Poi avevo un certo riguardo per le sue sorelle maggiori ma ancor più per i suoi genitori. Però non potevo più aspettare. Vedevo che anche lei contraccambiava i miei sentimenti e le chiesi amore. Immaginavo la sua risposta ancor prima che parlasse. Mi disse “sono ancora troppo giovane, i miei genitori non sarebbero contenti, non ti posso promettere nulla”. Io le dissi “se sei contenta tu, ai tuoi ci penso io”. Lei disse “io ne sono più che contenta ma vedrai che mio padre non lo permetterà”. Prima di parlarne ai suoi volli aspettare un po’. Si andò avanti così, senza dir niente a nessuno, per cinque o sei mesi. Lei ora aveva circa quindici anni, mi era molto affezionata e io sentivo sempre più il bisogno di legarmi a lei, anche a costo di dover aspettare qualche anno. Un giorno mi consigliai con lei. Le chiesi se era d’accordo che io la chiedessi a suo padre. Lei disse “speriamo che non ti dica di no”. Così andai da suo padre e gli chiesi se era contento se io mi fidanzavo con sua figlia Giulia. A questa domanda non rimase sorpreso, forse aveva già intuito i nostri sentimenti. Mi disse “io non dovrei darvi questo permesso, Giulia è ancora troppo giovane, ma non voglio essere io a negare i vostri desideri, se veramente vi volete bene. Mi devi promettere di portarle rispetto. Tu vuoi sposarti presto, ma lei non è ancora da marito. Devi darmi la tua parola d’onore di aspettare che sia una ragazza da marito. Io le voglio molto bene e non vorrei che un giorno si trovasse pentita perché tu hai approfittato della sua innocenza. Hai la ragione adulta e conosci il bene e il male. Se mi prometti quello che ti ho chiesto per me va bene e son contento”. Io gli giurai di seguire i suoi consigli, di portare rispetto a Giulia perché le volevo tanto bene e non avrei osato farle alcun torto. Era l’unica speranza della mia vita. Anche i miei genitori erano contenti, vedendo che mi ero rassegnato a restare con loro. Aspettavo con ansia che Giulia avesse l’età per prendere marito, come se lei avesse portato la felicità nella nostra famiglia. Eravamo giunti ai primi giorni di gennaio del 1915. Giulia aveva compiuto diciassette anni. Io feci in modo di persuadere suo padre e sua madre a darci il consenso per sposarci. Era tanto che aspettavo. Si decise di sposarci in giugno. C’erano cinque mesi, poco più. 26 Monarchia Eravamo contenti e ansiosi, preparandoci per il nostro matrimonio. I giorni sembravano anni, non passavano mai. Negli ultimi giorni di marzo si sentì dire che la Germania aveva deciso di fare guerra alla Francia, in aprile c’era in giro la voce che anche l’Italia poteva entrare in guerra. Ma io ero l’unico figlio maschio e pensavo che non mi avrebbero chiamato come avevano fatto nella guerra di Libia, che ormai era finita, dove i figli unici non erano stati chiamati. Si stava aspettando solo il mese di giugno, pareva per noi la primavera della nostra vita. Finanziariamente si andava bene, avevamo solo il pensiero del nostro matrimonio. Erano i primi giorni di maggio, si contavano i giorni. Era tanto tempo che io aspettavo. Proprio in quei giorni mi arrivò la cartolina dell’esercito. Dovevo presentarmi al distretto di Arezzo. Restarono sospesi tutti i nostri sogni felici. Proprio in quei giorni pensavamo di unirci per tutta la vita, di celebrare il nostro matrimonio. Ma le cose cambiarono. Dovevamo già pensare a separarci, senza sapere per quanto tempo, chissà fra quanto tempo ci si sarebbe potuti rivedere. Forse mai più sapendo dove io dovevo andare: le truppe italiane erano già alla frontiera. La nostra primavera del mese di giugno, che ci doveva portare tante gioie e piaceri, si tramutò in una bufera di tristezze e dolori senza precedenti. Si doveva andare contro un abisso senza fondo. Io restai sorpreso da quella cartolina perché non pensavo di dover partire. Ma la mia fidanzata rimase più colpita di me per il fatto che dovevo partire per la guerra. Dal giorno che ricevetti la chiamata dall’esercito Giulia non ebbe più pace. Cominciò a perdere l’appetito; ebbe dolori di stomaco e stava peggio ogni giorno. Lei si vergognava a dire che era ammalata ma si vedeva benissimo che non era la solita Giulia. Se avesse manifestato subito il suo male forse si poteva rimediare in tempo e lei sarebbe tornata in salute. Invece in quei tempi si vergognava a chiamare il dottore per paura di essere considerata sciocca. Non lo chiamò finché non ne fu costretta. Io cercavo di farle coraggio dicendole che ero figlio unico e non mi avrebbero mandato al fronte. E se poi mi ci avessero mandato non ci sarebbe stato nulla di strano: migliaia di persone dovevano andare al fronte per difendere la patria. Lei era poco convinta. Mi diceva “io 27 penso invece che ti mandino di fronte al nemico armato di cannoni e di fucili e che cercheranno di ucciderti”. Non riusciva a farsene una ragione. Ero io che partivo e dovevo consolare quelli che restavano. Venne il triste giorno della mia partenza. Con il cuore impietrito dal dolore salutai i miei genitori, facendo loro coraggio. Nutrivano tante speranze in me. Pensai che poteva essere l’ultimo addio. Il 28 maggio partii per la vita militare. Mi presentai al distretto di Arezzo. C’era tanta gente e grande confusione. Erano state richiamate quattro classi, tutte lo stesso giorno. Fui destinato all’undicesimo reggimento fanteria di Forlì, per fare tre mesi di istruzione. Ci facevano fare tutto in furia perché al fronte avevano bisogno di rinforzi. Ci facevano fare lunghe marce, istruzioni interne e tattiche di guerra. Finite le istruzioni si stava in attesa della partenza per il fronte. In quei giorni mi giunse una lettera dalla mia fidanzata, dove diceva che stava sempre peggio. Il dottore le aveva ordinato di fare delle cure ma lei non vi trovava alcun giovamento. Le aveva consigliato di farsi i raggi. Era andata a Firenze con suo padre e aveva fatto tutto quello che le avevano detto di fare. Ma non le avevano trovato nulla. Allora era andata da un professore che l’aveva visitata e le aveva detto che aveva un grosso esaurimento nervoso, causato da un forte dispiacere. Come cura le aveva detto di stare il più allegra possibile. Inoltre le aveva ordinato una cura ricostituente, raccomandandole di riguardarsi. Le aveva detto che dopo un mese sarebbe stata meglio. Le sperava che questo professore avesse saputo individuare la vera natura del male. Da parte sua lei avrebbe fatto del suo meglio per guarire. Questa lettera mi raddoppiò il dolore perché sapevo che Giulia stava male a causa mia. Dopo pochi giorni mi scrisse mio padre. Mia madre era caduta dalle scale ed era gravemente ammalata. Avevano chiamato il dottore che le aveva fatto un certificato di malattia. Il certificato lo aveva spedito nella solita lettera raccomandata, credendo che io potessi avere un permesso per andare a fare loro una visita. Portai questo certificato medico al capitano che comandava il deposito per chiedergli il permesso di andare a casa qualche giorno. Lui mi disse “se tua madre fosse in fin di vita potrei darti il permesso, ma per una cosa simile non posso”. Non ci fu modo di averlo. 28 Monarchia Io sentivo una gran pena e non sapevo cosa fare. Leggendo quelle due lettere mi venivano mille pensieri. Mi sentivo scoppiare il cuore. Insieme a me c’era un mio cugino. Lui aveva la moglie incinta che doveva sgravare in quei giorni. Visto che i permessi non li davano si pensò di scappare a casa. Ma Forlì era zona di guerra e se ci trovavano fuori zona ci mandavano sotto processo. Così si decise di rinunciare a scappare. Io scrissi a casa che il permesso non lo davano e non potevo tornare. Il giorno dopo un tenente chiese sei uomini per ritirare quaranta bestie a San Piero in Bagno. Io mi feci mettere fra quei sei, con l’intenzione di andare a casa mia per rivedere i miei cari appena mi si fosse presentata l’occasione. Così il giorno dopo si partì per S. Piero in Bagno. Le bestie erano già arrivate. Si pesarono. Ce n’erano di quelle selvatiche che ci fecero fare una bella sudata, non si potevano maneggiare. Si finì che era quasi sera, le cinque del pomeriggio. Si prese in consegna le bestie. Ci fecero mangiare in fretta e furia e si partì per Bibbiena, dove c’era la stazione e il treno su cui dovevano salire le bestie. Per arrivare alla stazione c’erano trentacinque chilometri. Io, che avevo quell’ansia di rivedere i miei, chiedevo quanto era distante Pratovecchio. Mi dissero che c’era tanto, quanto per arrivare a Bibbiena. Ero sempre più persuaso di poter soddisfare i miei desideri, ero disposto a fare qualunque sacrificio. Si partì con le bestie e si andava molto piano. Si era legato le bestie a due a due perché non scappassero. Percorsi circa otto chilometri, le bestie stavano bene. Andai dal sergente e gli mostrai la lettera e il certificato del dottore e gli chiesi se mi faceva la gentilezza di lasciarmi andare a casa per rivedere i miei. Gli promisi che sarei tornato in tempo per caricare le bestie. Lui mi disse “se fosse per me ti manderei, ma c’è il tenente. Senti lui”. Io andai dal tenente e gli spiegai la mia situazione ma quello disse che non era possibile lasciarmi andare a casa perché eravamo in servizio e in pochi. Io gli dissi che abitavo vicino e che sarei tornato in tempo per caricare le bestie, ma non ci fu modo di avere questo permesso. Mi sentivo disposto anche ad andare in carcere pur di rivedere i miei. Verso le ventidue cominciai a pensare a come potevo fare per scappare. C’era una bella luna. Tornai dal sergente e gli dissi “se i miei sanno che sono passato di qui e non sono 29 andato a trovarli ci restano molto male. Mi faccia questo favore”. Lui mi disse “se proprio vuoi andare vai, basta che torni in tempo per caricare le bestie. Il permesso non te lo posso dare, però durante il viaggio non ti dò mancante. Ma devi essere al treno domani alle sedici”. Io gli promisi di stare alle sue raccomandazioni e lo ringraziai. Partii, con quell’ansia di rivedere i miei. Non sentivo neppure la stanchezza, benché fossero sedici ore che eravamo in piedi. Presi una strada campestre sulla destra, come mi avevano indicato. Camminai per circa mezz’ora. Trovai una casa solitaria. Era quasi mezzanotte. Mi dispiaceva chiamare e disturbare, ma non sapevo più dov’ero. Mi feci coraggio e chiamai diverse volte, finché non mi risposero. Chiesi se sapevano indicarmi la strada per Pratovecchio. Quello che si affacciò mi disse che lui non c’era mai stato ma sapeva da che parte si trovava e mi indicò la direzione che avrei dovuto prendere. Mi rimisi in marcia. Dopo mezz’ora di cammino trovai un gruppo di case e la strada prendeva tre direzioni. Non sapevo quale era quella che avrei dovuto prendere io, così chiamai di nuovo. Anche lì erano tutti a letto. Si affacciò un uomo alla finestra e fu molto gentile. Mi disse “Pratovecchio è molto lontano. Se vuole rimanere qui a dormire e ripartire quando è giorno”. Lo ringraziai ma a me bastava che mi indicasse la strada da prendere. Mi indicò una strada e disse “prenda quella. Attraversi un grande bosco, poi c’è un ponte. Dopo il ponte ci sono due strade. Prenda quella a destra. Dopo un po’ troverà una casa, lì sapranno dirle di preciso come proseguire”. Lo ringraziai e ripartii. Mi sentivo stanco. Erano quasi venti ore che camminavo e mi strapazzavo. Quasi mi pentivo di aver preso quella decisione ma quando ripensavo a quelle due lettere che avevo in tasca non sentivo più la fatica. Trovai subito la casa. Quando fui a cinquanta metri da essa mi vidi venire incontro un cane invelenito. Stava per avventarmisi contro. Io avevo solo il tascapane per difendermi. Strillai. Il cane si fermò in mezzo alla strada ma non mi lasciava passare. Chiamai i padroni del cane perché avevo paura e per sapere dov’era la strada che doveva prendere. Si affacciò un uomo, chiamò il cane e io lo ringraziai e gli chiesi quale era la strada che portava a Pratovecchio. La sua risposta mi ridiede coraggio. Mi disse che doveva proseguire 30 Monarchia ancora per mezz’ora sulla strada che stavo percorrendo e dopo aver oltrepassato la collina avrei trovato la strada per Pratovecchio. Lo ringraziai di nuovo e ripresi il cammino. Quando fui in cima alla collina si stava facendo giorno. Trovai subito la strada che cercavo e in distanza vedevo i monti che conoscevo. Mi si rinfrancò lo spirito. Ormai sapevo che ce l’avrei fatta. Arrivai a casa alle cinque. Mia madre era ancora a letto, con la gamba fasciata. Mi fece una triste impressione, però mi disse che stava meglio. Appena mi vide mi abbracciò stretto. Per lei era una grande sorpresa vedermi a casa. Anche per mio padre fu una sorpresa. Era andato a custodire le bestie e quando mi vide entrare nella stalla rimase senza parole. Mi abbracciò poi mi disse “perché ci avevi scritto che non saresti tornato?”. “Per fare una improvvisata” dissi io. Poi dissi “andiamo dalla mamma, che vi spiego tutto”. Quando rientrammo in casa mia madre si era alzata e cominciava a fare le prime faccende. Io mi misi a sedere, ero sfinito. Raccontai quello che avevo fatto quella notte, in cammino per strade sconosciute, in posti deserti. Alcuni momenti credevo di essermi smarrito. Però ero contento per essere riuscito a raggiungere il mio scopo. Anche loro erano contenti di rivedermi. Però mio padre, quando vide che non avevo il permesso, si turbò. Mi disse “hai disertato, se ti trovi qui senza permesso”. Non era persuaso di quello che avevo detto. Il giorno prima avevano ricevuto la mia lettera dove dicevo che permessi non ne davano. Però si persuasero quando dissi che dovevo prendere il treno alle 15 a Bibbiena e che dovevo arrivare in tempo per caricare le bestie, come mi aveva raccomandato il sergente. Li tranquillizzai e dissi loro che avrei fatto sempre il mio dovere. Poi dissi che volevo andare a trovare Giulia. Mia madre aveva preparato del caffellatte. Mentre si faceva colazione mio padre disse che aveva già preparato una domanda per il mio esonero. Appena fatto quello spuntino mi sentii subito meglio. Dissi ai miei genitori che io andavo a trovare Giulia, e a mezzogiorno sarei tornato a pranzo. Partii per la seconda visita che con tanta ansia desideravo fare. Non sentivo più la stanchezza. Per non farle un’improvvisata passai prima da casa di mia zia, così qualcuno sarebbe andato ad avvisare 31 Giulia del mio ritorno. Salutai la famiglia di mio cugino, stavano tutti bene. Poi mi misi in cammino verso la casa di Giulia. Quando fui vicino a casa sua la vidi venirmi incontro con due delle sue sorelle. Ci abbracciammo con tanto affetto. Trovai Giulia molto giù, sia fisicamente che moralmente. Aveva perso ogni speranza di guarire, non si faceva coraggio. Mi abbracciò e si mise a piangere, dicendo “non tornerò più in salute come prima”. Era così disperata che non sapevo come fare per consolarla. Cercavo di farle coraggio ma lei diceva “io morirò presto perché sono più di tre mesi che faccio questa cura e sto sempre peggio”. Queste parole mi toccavano il cuore, mi impedivano di rispondere, perché sapevo che si vergognava a dire che era ammalata, invece in quella circostanza diceva che per lei non ci sarebbe stato rimedio. Si sentiva infelice. Anche i suoi genitori li trovai addolorati. Mi dissero che la cura del professore non dava alcun risultato e che Giulia piangeva spesso, non sorrideva più e non aveva più il carattere di prima. Erano preoccupati anche loro per Giulia. Io stavo male sapendo che non avrei potuto farci nulla. Le dicevo che ero sicuro di tornare presto perché ero figlio unico, che mio padre aveva già spedito i fogli per farmi avere l’esonero e che presto sarei stato congedato definitivamente. Le dicevo queste cose per farle coraggio, anche perché vedevo che tutta la famiglia era in pensiero per me. Ma vedevo davanti a me un avvenire di bufere: la guerra, la fidanzata, la mamma, io che dovevo partire senza sapere se avrei rivisto Giulia. Mi dicevo “chissà se tornerò. Chissà se rivedrò Giulia. Come la ritroverò?”. Di fronte a loro mi facevo coraggio, cercavo di non far capire quello che mi passava dentro, mi sforzavo per convincerli che ero sicuro di quello che volevo dargli ad intendere. Ma lei non si persuadeva, anche perché proprio in quei giorni era giunta la notizia che erano morti due fratelli, ragazzi del nostro paese, che conoscevamo e di cui eravamo amici. Questo non lo potevo negare e Giulia era sempre più convinta che io andassi incontro alla morte. Non avrei voluto lasciarla ma dovevo prendere il treno alle quindici. Purtroppo quelle ore passarono in un lampo. Benché avessimo tanti pensieri venne il momento in cui dovetti partire. Le dissi di farsi coraggio e di seguire le istruzioni datele dal professore. 32 Monarchia Le dissi “la nostra felicità dipende dalla tua salute. Io sto bene e non devi stare in pensiero per me”. Con il cuore pieno di dolore salutai Giulia e la sua famiglia e partii per casa. Era già tardi, camminavo in fretta. Quando arrivai a casa era già pronto il desinare. I miei mi aspettavano ed erano in pensiero perché non mi vedevano tornare. Andammo a tavola. Mentre si mangiava si parlò della caduta di mia madre ed eravamo tutti contenti perché si credeva che il male fosse molto più grave, mentre lei stava migliorando. Sapevano anche loro che Giulia stava male ma io cercavo di nascondere il dispiacere che provavo per lasciarli più contenti. Mia madre aveva preparato un pollo arrosto per il sergente che mi aveva lasciato andare a casa. Avevo fatto tardi per il treno delle quindici. Partii con quello che doveva caricare le bestie. Lasciai i miei genitori in fretta e furia augurando loro buona fortuna. Misi il pollo nel tascapane e mio padre mi diede dieci lire. Partii di volata per non far tardi al secondo treno. Strada facendo non mi sentivo soddisfatto. Mi sentivo una pena, una tristezza, non sapevo cosa avevo addosso. Pensavo fra me “ho avuto quello che desideravo: vedere i miei cari. Dovrei essere contento. Sarà la stanchezza”. Erano circa trenta ore che camminavo, sempre a passo forzato, ma il pensiero mi andava sempre alla malattia di Giulia. Era quello che mi tormentava: averla trovata in quelle condizioni. Restai nel dubbio che forse le sarebbe venuta una grave malattia. Quando giunsi alla stazione il treno era già pronto. Partii per Bibbiena, dove c’era il sergente che mi aspettava e quando mi vide si mise a ridere. Scesi dal treno, salutai il sergente e corsi nel bar a comprare due fiaschi di vino e una bottiglia di cognac. Mentre il treno faceva manovre per agganciare i vagoni dove c’erano le bestie io ritornai dal sergente. C’erano anche i miei compagni, si salì sul treno. Il sergente mi disse “mi avevi fatto dubitare il peggio”. Io mi scusai e gli dissi che non avevo potuto fare più in fretta. Non volli dire davanti ai miei compagni che era stato lui a darmi il consenso. Levai dal tascapane il pollo e una forma di cacio pecorino che mi aveva dato il babbo della mia fidanzata. Si mangiò tutto e si bevve tutto. Mi passò un po’ di malinconia. Mi addormentai e mi svegliarono i miei compagni, a Lucca, per scaricare le bestie. Appena 33 si furono consegnate si fece ritorno a Forlì. Quando mio cugino mi vide mi chiese subito se mi avevano dato il permesso. Gli raccontai tutta la vicenda, quanto avevo giostrato, i posti deserti che avevo dovuto attraversare con la paura di essermi smarrito. Gli feci presente la situazione di tutti: i suoi stavano bene, sua moglie non aveva ancora partorito. Gli diedi il denaro che i suoi mi avevano dato per lui e gli dissi che si erano raccomandati di scrivere più spesso. Lui mi ringraziò per l’ambasciata e mi disse “devi aver patito tanto durante il viaggio, pare un sogno a sentirlo raccontare”. Dopo pochi giorni ci mandarono al fronte. Eravamo poco più di cento soldati che avevano fatto le istruzioni per la salmeria e i carreggi. Così cominciò il nostro destino al fronte. Ci portarono vicino a Colmus. Si sentivano gli spari dei fucili della prima linea. Ci fecero piantare le tende lungo un fiume perché c’erano alberi di alto fusto che ci nascondevano, soprattutto dagli aeroplani. La notte si vedevano i razzi luminosi e si stava sempre in allarme. Una notte venne un gran temporale. Quelli che avevano piantato la tenda vicino all’acqua non fecero in tempo a levarla. I soldati si salvarono a fatica e si rifugiarono nelle altre tende che erano fuori pericolo. Quando cessò la burrasca ci fecero togliere le tende rimaste e ci fecero accampare in un campo coltivato a viti e gelsi. Erano piante piccole e si piazzò una tenda per gelso, perché spesso sopra di noi passavano aeroplani nemici. Un giorno volò sopra di noi un aereo austriaco. Le nostre artiglierie non lo colpivano mai. Dopo poco arrivò un nostro aereo e ingaggiarono fra di loro una lotta accanita. A un tratto si vide il nostro aereo fare il cosiddetto giro-della-morte, pareva cascasse al suolo. Ma poi riprese quota e si diresse verso l’aereo nemico. Noi avevamo paura. Poi si vide l’aereo nemico che cominciava a bruciare lasciando una scia di fumo mentre cadeva. Cadde vicino a Colmus. Noi quando si sentivano arrivare gli aeroplani ci si nascondeva sotto i gelsi. Si rimaneva in quel posto in attesa dei muli con le salmerie. Arrivarono solo settanta muli e noi eravamo cento. Trenta di noi rimasero senza mulo e ci destinarono di rinforzo al nostro reggimento, in prima linea. Questo il dieci ottobre. Tutto ci faceva paura, in special modo quando eravamo di vedetta vicino al nemico, soli, nei 34 Monarchia posti avanzati. Anche il rumore di un topo ci faceva sobbalzare. Poi, il 18 ottobre, arrivò l’ordine del generale Cadorna di fare una grande offensiva, chiamata la III battaglia dell’Isonzo. I combattimenti durarono fino al 3 novembre. Si andava all’assalto delle linee nemiche, si conquistavano, poi cominciava il nemico a sparare con le sue artiglierie. Si dovette retrocedere. Non si poteva resistere, le perdite erano immense, fra morti e feriti, da ambo le parti. Anche loro avevano parecchi morti: lo si vide quando conquistavamo le loro trincee. Si rimase fermi quasi una settimana. La battaglia riprese il 9 sul monte Podgora; con tutte le nostre forze e le nostre energie. I combattimenti durarono due giorni interi. Conquistammo le linee nemiche con tanto sacrificio e gran perdita di uomini. Ma si vinse. I nostri superiori, contenti del nostro impegno, ci dicevano che si combatteva per un avvenire migliore. Noi si combatteva convinti che i nostri superiori non ci tradissero. Non si faceva caso ai grossi sacrifici che dovevamo sopportare; eravamo pieni di pidocchi, di fango e di freddo. Si dormiva bagnati, con una coperta inzuppata di fango. Si stava in quelle nicchie, nelle trincee sotto terra, come animali, per ubbidire ai nostri superiori. Si cercava di fare il nostro dovere con la speranza di vincere la guerra e tornare alle nostre case. Non si vedeva l’ora che finisse quella guerra così disastrosa, dove la morte ci stava sempre a fianco, di giorno e di notte. Passò un po’ di tempo senza grosse battaglie. Dal 15 al 24 maggio gli austriaci attaccarono le nostre linee e occuparono Asiago. Si scatenarono diverse battaglie ma senza risultati. Dal 6 al 9 agosto ci fu la presa di Gorizia. Verso le quattro del mattino le nostre artiglierie, di tutti i calibri, dal 75 al 420, cominciarono un vasto bombardamento e bombardavano anche noi che eravamo in prima linea. Quando scoppiavano le bombe e le granate tremava anche il terreno. Era tutto un tuono, non avevo mai visto un bombardamento così micidiale. Appena cessato quel fuoco si partì noi del reggimento. C’erano vari corpi: fanteria, bersaglieri, alpini, tutti quelli che erano sul Carso. Noi che eravamo sul monte Podgora, quasi al centro della battaglia, si dette l’assalto al nemico. Erano pochi a fare resistenza, soprattutto in prima linea: chi si dava prigioniero, chi scappava. E poi si videro delle cose che se non 35 si vedono non ci si crede: trincee piene di morti che in certi punti, per non pestarli, si doveva uscire dalla trincea. Benché fossero nostri nemici mi facevano compassione, non avrei voluto vederli così. Noi avanzavamo cercando di non farci colpire dal nemico. Un po’ a destra e un po’ a sinistra, secondo la nostra posizione. Cercavamo di avanzare velocemente per impedire loro di prendere posizione. Eravamo tutti mischiati: bersaglieri, fanteria, alpini. Si arrivò in fondo al monte che era quasi buio. Agli incroci dei sentieri avevano messo delle frecce con l’indicazione per ogni raggruppamento. Io appartenevo alla prima compagnia, mio cugino alla quarta. Vedevo dei suoi amici e chiedevo di lui ma nessuno l’aveva visto. Il giorno dopo ognuno aveva raggiunto il comando del proprio reggimento. Fecero l’appello. Ne mancavano diversi. Anche mio cugino mancava. Io stavo in pensiero perché il giorno prima, mentre si avanzava, si vedevano morti e feriti dappertutto e avevo paura che anche io cugino fosse fra questi. Dopo 4 o 5 giorni ricevetti da lui una lettera in cui mi diceva che era all’ospedale perché era stato ferito. Fecero fare armi e bagagli a tutti i presenti e ci dissero di tenerci pronti per la presa di Gorizia. La notte prima il genio aveva preparato tutte le passerelle. Si partì. La metà dei nostri avevano già passato le passerelle e molti soldati erano ancora sopra di esse quando si udì alle nostre spalle il crepitio di due mitragliatrici nemiche che sparavano con fuoco accelerato. Sparavano addosso ai nostri soldati, quelli che erano sulle passerelle e quelli che le avevano già attraversate. Fecero una strage. Il nostro comandante di reggimento diede l’ordine di ritirarci sotto il monte e noi che ancora non avevamo attraversato le passerelle le eseguimmo subito perché sotto il monte eravamo al riparo. Poi il comandante diede l’ordine a due caporali e a dodici soldati di formare due squadre per scovare le mitragliatrici nemiche. Io fui comandato fra questi dodici. Si tornò indietro. Eravamo quasi a metà del monte ma le mitragliatrici non le avevamo ancora trovate. Poi si vide un monticello di terra davanti al quale era cresciuta un po’ d’erba. In silenzio si circondò quel monticello e si avanzò stringendo il cerchio. Le mitragliatrici erano lì. Puntammo i fucili contro i quattro austriaci che stavano nella buca e questi alzarono le mani e si 36 Monarchia arresero. Gli si fece smontare le armi e li portammo al comando del reggimento. Il colonnello appena ci vide ci venne incontro e andò a stringere la mano ai quattro austriaci come se fossero stati degli amici. Poi si rivolse a noi e disse “questi sono guerrieri. Così si deve fare al fronte”. Disse ai due caporali di consegnare al comando di divisione i quattro prigionieri e noi ripartimmo con due ore di ritardo rispetto agli altri. Questo per noi fu un danno perché il generale ci vide arrivare in ritardo e cominciò ad averci in antipatia. Ma di questo parlerò dopo. Sulla strada per Gorizia si trovarono delle famiglie che avevano dei secchi di vino. Mentre passavamo ci riempivano la tazzina del caffè con gentilezza dimostrando di accettarci volentieri. Noi eravamo soddisfatti. Non solo per il vino ma per essere considerati amici. Dopo aver lasciato l’Isonzo il nemico non si sentiva più, solo alcune mitragliatrici in lontananza. In poco tempo si arrivò a Gorizia. Ci diedero mezz’ora di tempo per mangiare. Mentre si mangiava ispezionammo un po’ le contrade vicine. Si videro dei magazzini aperti, dove la roba era sottosopra, il padrone non c’era. La città era deserta e le case erano vuote. Si trovarono delle tavole ancora apparecchiate, era stato abbandonato tutto. Pensai a quelli che ci avevano dato il vino e mi dispiacque per loro. Era veramente un brutto spettacolo. I nostri soldati prendevano biancheria e roba da mangiare. A me e a tanti altri questo ci parve uno spreco, perché si faticava già a portare la roba militare. E poi, momento per momento, eravamo in faccia alla morte. Venne il momento dell’adunata e la situazione mutò. Mandarono in avanguardia l’undicesimo e il dodicesimo fanteria. Il plotone dove ero io aveva l’incarico di esplorare la strada principale. Si camminò per tre o quattro chilometri, attraversando un paesino, credo si chiami San Pietro, e arrivammo a una grande curva oltre la quale c’era un grande palazzo. Il comandante del plotone, un sottotenente, mandò due soldati a vedere se nel palazzo c’era qualcuno. Mentre quei due si avvicinavano al palazzo si sentì una fucilata, a sinistra, quasi alle nostre spalle. Noi di scatto ci si buttò nella fossetta della strada. Appena in tempo perché un istante dopo arrivò una scarica 37 di fucili e mitragliatrici. Pareva che cascasse la grandine: i proiettili alzavano la polvere dalla strada. Noi stavamo distesi in quella fossetta, dove non ci potevano colpire. Il loro fuoco ininterrotto durò per un quarto d’ora. Poi diminuì e si fece molto rado, finché cessò. Visto che nel palazzo non c’era nessuno si scappò da quella parte, di corsa, due per volta. Qui il comandante del plotone guardò la cartina. A circa duecento metri da noi c’era un fosso. Fra noi e questo fosso c’era un campo coltivato a viti, pianeggiante. Il sottotenente disse “avanti non si può andare, indietro non si può tornare perché ci sono ancora quelli austriaci e qui non possiamo restare in eterno. Perciò bisogna raggiungere quel fossato che ci riparerebbe per tornare a San Pietro”. Fino a quel momento non c’erano stati né morti né feriti per cui ci si fece coraggio. Si decise di partire a tutta velocità. C’era la paura di essere fatti prigionieri. Si partì di corsa per attraversare quel tratto pianeggiante. Gli austriaci ripresero a sparare con un fuoco serrato. Nell’attraversare quei filari molti inciampavano nei fili di ferro e cadevano. Anche io caddi due o tre volte e quelli seguitavano a sparare. Molti vennero colpiti e morirono, molti furono feriti. Cadevano a terra e noi non ce ne accorgevamo, ognuno pensava a correre. Si arrivò al fossato e si risalì l’argine. Un soldato che era davanti a me cadde all’indietro. Era stato colpito a una gamba. Lo portai oltre l’argine e gli legai la gamba con la cintura dei pantaloni per evitare che perdesse troppo sangue. Mentre aiutavo questo ferito dalla parte delle viti arrivavano i lamenti dei feriti. Alcuni soldati avevano un ferito addosso che cercavano di portare oltre l’argine. Ci si salvò in pochi. Ognuno aveva con sé un ferito. Arrivammo a quel paesino, dove c’era un posto di medicazione. Fu un terribile spettacolo. C’erano due stanze piene di feriti. Alcuni erano in fin di vita. I medici curavano quelli che potevano salvarsi, i casi più gravi li tralasciavano. Quelli feriti leggermente li mandavano a farsi curare nelle autoambulanze, perché non ce la facevano a curare tutti. I portaferiti erano continuamente occupati, le autoambulanze partivano sempre piene di morti o di feriti. Del mio plotone su sessantadue soldati ne rimasero ventisei. Molti erano rimasti in quel campo di viti. Rimasi tanto impressionato da quello strazio che non lo potrò più dimen38 Monarchia ticare. Pensavo a mio cugino. Non l’avevo più visto e pensavo che fosse morto sul monte Podgora. Ancora non avevo ricevuto la sua lettera dall’ospedale. Mi sentivo avvilito. Era l’unica persona cara che avevo vicino e ora mi sentivo ancora più solo e privo di speranze. Tutto il reggimento aveva avuto grosse perdite. Appena consegnati i feriti ci fecero raggiungere il nostro reggimento. Ci fecero avanzare dalla parte ove eravamo andati in perlustrazione. Gli austriaci erano in una pineta e dietro quei pini non si riusciva a vederli. Ci furono molte perdite anche per conquistare quella posizione. Dopo aver conquistato quella posizione si rimase sul posto per tutta la notte. Appena si fece giorno mandarono un caporale e sei soldati a far rifornimento di viveri perché avevamo finito quasi tutto il cibo. Fra quei soldati c’ero anch’io. I viveri erano in quel paesino dove avevamo portato i feriti. Mentre si scendeva incontrammo dei soldati con le borracce piene di vino. Alcuni avevano del vino anche dentro a delle bottiglie rotte. Noi si chiese “chi vi ha dato tutto questo vino?”. Ci risposero tutti la stessa cosa. C’era in paese una cantina abbandonata dove c’erano più di mille quintali di vino. Appena arrivati in paese si prelevarono i viveri, c’era solo pane, poi andammo a vedere questa cantina. Era piena di soldati: artiglieri, fanti, alpini, bersaglieri. Tutti avevano la borraccia piena e c’era chi riempiva anche altri recipienti. Era più il vino che andava per terra che quello preso per bere. Fuori c’erano parecchi soldati ubriachi: chi cantava, chi litigava per un recipiente. Anche noi si riempirono le nostre borracce e si tornò fuori. Aspettavano due nostri compagni che mancavano. Il caporale era disperato perché non riusciva a trovarli. Poi si videro: erano così ubriachi che non stavano in piedi. Il caporale si disperava perché non sapeva come tornare senza due soldati. I due scherzavano e ridevano. Poi uno rigettò. Si partì e quei due rimasero lì. Avevamo tre sacchi di pane e con questi in spalla ci si avviò verso la prima linea, lasciando quella cantina nelle mani di tutti quegli ubriachi. Era un peccato vedere sciupare tanta roba preziosa, mi pareva una cosa indecente. Tutto a causa della guerra. Un mio compagno disse che la strage vista il giorno prima era molto peggio della strage del vino e che i soldati non ne avevano colpa, era la guerra a portare la gente così in basso. 39 Si camminava costeggiando la ferrovia. A un certo punto si dovette attraversare una chiavica alta poco più di un metro. Con i sacchi in spalla non si poteva passare. Si presero quei sacchi uno per un pinzo e l’altro per la legatura e attraversammo la chiavica in fila indiana. Quando uscimmo dalla chiavica si cominciò a correre perché si sapeva che eravamo in vista del nemico. Ma due soldati rimasero feriti. Uno fu ferito a un braccio da una pallottola esplosiva. Mollò tutto, anche la borraccia piena di vino, e tornò indietro. L’altro soldato rimase ferito a un fianco, sempre da una pallottola esplosiva. Era molto grave. Il caporale andò a chiamare i portaferiti. Uno di loro tagliò i pantaloni al soldato ferito e sopra alla ferita ci mise del cotone e una benda. Poi lo caricarono su una barella e lo portarono al posto di medicazione. Si rimase in tre. Prendemmo i sacchi del pane e le borracce di vino, anche quelle dei due feriti, si tornò in prima linea. Ma qui erano pochi quelli che avevano voglia di mangiare. Erano tre notti che non si dormiva e poi quelle terribili tragedie che avevamo vissuto ci avevano avviliti. Il disagio maggiore era il pensiero dei nostri compagni morti o feriti. Così quelle cinque borracce di vino ci parvero una medicina. Se ne bevve un sorso ognuno, ma bastò solo per una trentina. Tanti rimasero senza. Il giorno 10 ci diedero il cambio. Era l’alba e mentre si lasciava la prima linea gli austriaci lanciarono un razzo luminoso, e spararono una raffica di fucilate. Due soldati morirono e quattro rimasero feriti. Mentre si andava c’era chi diceva che dovevano darci almeno venti giorni di riposo. Eravamo pieni di fango e di pidocchi. Quelli che avevano trasportato dei feriti erano anche imbrattati di sangue. Ci portarono vicino a Colmus e ci fecero montare le tende. Il giorno dopo c’era la voce che ci avrebbero rimandato in prima linea. I soldati dei due reggimenti, l’undicesimo e il dodicesimo, cominciarono a gridare. Questa cosa ci pareva ingiusta, specie per quelli che erano al fronte dal maggio del 1915, più di un anno in trincea. Il riposo ci spettava di diritto. La notte si cominciò tutti a gridare: “vogliamo il riposo, vogliamo toglierci i pidocchi, è più di un anno che ci dissanguano”. Qualcuno sparò anche qualche fucilata in aria. Il generale comandante del corpo d’armata era a Colmus. Prese con 40 Monarchia sé sei carabinieri e venne al nostro accampamento. Era passata la mezzanotte. Fece arrestare tutti i soldati che trovò fuori dalla tenda. Ne arrestarono più di settanta. Tutti noi restanti fummo rimandati in prima linea, nella peggior posizione che potesse esserci. Il nemico era a duecento metri, trincerato su una collina. Noi eravamo in piano, sotto di loro, e se si metteva una mano fuori dal nostro riparo ce la bucavano subito. Appena preso posizione ci ordinarono di dare l’assalto alla collina, senza prima aver bombardato le loro linee con l’artiglieria. Era come se ci volessero tutti morti. Il comandante del mio plotone salì due gradini della scaletta che serviva per uscire fuori. Quelli che ci avevano provato erano stati ammazzati o feriti. Così nessuno si muoveva più. Allora venne l’ordine di restare in trincea, nei posti avanzati rimasero solo le vedette. Appena messo la roba nelle nicchie cominciò la nostra artiglieria a bombardare la nostra linea. I comandanti telefonavano al comando d’armata perché allungassero il tiro. Ma la nostra artiglieria continuava a bombardarci e noi ci trovavamo fra due fuochi, il nostro e quello nemico. Ci rifugiammo nei posti avanzati per circa mezz’ora. I nostri comandanti di linea, visto che al telefono non erano ascoltati, mandarono un portaordini al comando della nostra armata. Intanto il tempo passava e noi eravamo sempre sotto il fuoco dei nostri cannoni e di quelli del nemico. In quelle trincee fonde un paio di metri era difficile essere colpiti ma a forza di bombardare più in qua e più in là molti di noi furono colpiti e morirono o rimasero feriti. Quando il portaordini arrivò al comando il tiro delle nostre artiglierie, invece di essere allungato, fu fatto cessare completamente. Questo misterioso bombardamento rimase impresso nella mente dei presenti per molto tempo. Tutti si chiedevano il motivo e la ragione dell’accaduto. Ma per il soldato non c’è mai ragione. Io pensavo “ci avranno bombardato per punirci, ma non è nostra la colpa di quello che è successo. Forse non ci considerano perché siamo tutti operai e contadini e siamo trattati come schiavi, specialmente i contadini”. Se uno voleva far valere la propria ragione dicevano “vai via, tu sei un contadino”. Come se un contadino fosse un delinquente o uno sfruttatore. A parer mio sarebbe più giusto dire “vai via, sei un mar41 chese”. La gente che viveva alle spalle degli operai e dei contadini non si vergognava neppure a sacrificare in quel modo coloro che permettevano di fare la bella vita. Se quella gente fosse stata emarginata si sarebbero evitati tanti guai, perché erano loro che volevano la guerra e che ne avevano un tornaconto. In quella trincea c’erano dei posti dove correva l’acqua. Il rancio l’andavamo sempre a prendere noi, a mezzanotte, dove lo lasciavano i conducenti dei camion che lo portavano, a un paio di chilometri di distanza dalla trincea. Si mangiava sempre all’una. C’era sempre molto freddo. Quando si andava e si ritornava bisognava attraversare dei punti dove l’acqua arrivava alle ginocchia e si doveva stare bagnati tutti la notte. Non c’era via di scampo. Per quaranta giorni si dovette fare quella vita. C’era solo la speranza di vincere la guerra e di essere ricompensati per i sacrifici fatti, come promettevano i nostri superiori. Dopo pochi giorni molti si ammalarono. Ma tutti quelli che marcavano visita venivano rinviati in servizio. Se qualcuno insisteva veniva punito. Cose che non sembrano vere. Vorrei che questo mio diario lo leggessero anche quelli che erano con me in quella trincea, così potrebbero confermare le mie parole. Passarono molti giorni e alcuni si ammalarono gravemente. Per non farli morire in trincea li portarono all’ospedale. Questi ammalati furono interrogati dai medici degli ospedali che li curavano. Poi un giorno venne in trincea un tenente medico con un infermiere. Presero le feci di diversi soldati per analizzarle. Dopo pochi giorni tutti quelli che marcavano visita venivano mandati all’ospedale. Si rimase in pochi e furono costretti a darci il cambio. Ci mandarono in riposo. Ma ormai eravamo quasi tutti ammalati. Non poteva essere diversamente dopo quaranta giorni di quella vita. Dormivamo sotto terra, nel fango, bagnati, al freddo, pieni di pidocchi. Questa era la vita di trincea. Se avessero veramente ricompensato i nostri sacrifici fatti al fronte avremmo potuto passare una vecchiaia tranquilla. Ma erano solo promesse. Dopo che ci ebbero mandati in riposo io feci domanda perché mi mandassero in salmeria. La domanda mi fu accettata e mi mandarono al fronte di Santa Lucia. C’erano delle grandi montagne. Si camminava quasi un’ora per portare il rancio ai soldati in 42 Monarchia prima linea. Anche lì si camminava sempre di notte, per non farci vedere dal nemico. Comunque io ci stavo meglio che all’undicesimo fanteria. Mi trovavo contento perché si era in pericolo solo un’ora al giorno, poi si stava più tranquilli. Ma il destino non mi voleva vedere contento, perché dopo pochi giorni mi venne una gran febbre. Ma io, per paura di perdere quel posto, continuai per tre notti a fare servizio. La terza notte feci molta fatica a tornare alla baracca. Feci scaricare il mulo da un mio compagno perché io non ce la facevo più. Mi stesi sulla branda ma non riuscii a dormire neppure un minuto. Passai una nottata che credevo di morire. La mattina dopo fui costretto a marcare visita. Eravamo in sei ammalati. C’era un tenente medico molto severo. Se il soldato che visitava non era molto ammalato lo faceva mettere al servizio interno. Quando mi ebbe visitato mi guardò in faccia poi disse “questo è molto ammalato, deve andare all’ospedale. Dovete portarcelo in barella perché le scosse gli sarebbero dannose”. Per riportarmi alla baracca diede ordine al caporale di chiamare due soldati che mi portassero di peso. Io pensavo a quelle tre notti che avevo fatto esercizio con la febbre. Appena giunti alla baracca il caporale chiamò il tenente di servizio e gli riferì quello che aveva detto il dottore. Lui si preoccupò perché per andare all’ospedale da campo ci volevano più di due ore e non c’erano strade, c’erano solo quei piccoli sentieri dove ci si poteva passare solamente con il mulo. Il tenente mi disse “te la senti di andare a cavallo di un mulo?”. Io avevo capito che sarebbe stato un grosso sacrificio per quei soldati che avrebbero dovuto accompagnarmi con la barella e decisi di andare col mulo. Così accontentai il tenente e i miei compagni. Quando fui nell’ospedaletto da campo l’infermiere mi misurò la febbre. Quando guardò il termometro mi disse “tu credi di farmi fesso”. Io non sapevo cosa voleva dire. Gli dissi “io non voglio far fesso nessuno”. Lui mi rimise il termometro e non mi lasciò un attimo. Poi lo guardò di nuovo e disse “avevi ragione. Però non dimostri di avere questa febbre”. Ma non mi disse quanta ne avevo. Chiamò subito il dottore, che mi visitò. Mi fecero subito una puntura e appena arrivò l’ambulanza mi portarono a Treviso. All’ospedale di Treviso c’era un medico veramente bravo, molto gen43 tile. Mi fece una visita completa poi si mise a sedere accanto a me, parlando come se io fossi stato un suo famigliare. Mi chiese dei miei parenti, se al fronte ero mai stato malato, dove ero stato e come mi avevano trattato. Io gli dissi come avevo passato la vita al fronte con l’XI reggimento fanteria. Lui allora disse “ne ho curati tanti di questo reggimento. Mi hanno raccontato delle cose strane. Tu devi dirmi la verità, come vi trattavano”. Io gli spiegai tutto con calma, cercando di essere il più preciso possibile. Alla fine del mio racconto il dottore disse “ai primi non ci credevo, mi pareva impossibile, ma ora sono convinto che quello che mi hai raccontato è vero, perché quasi tutti avete detto le stesse cose”. Poi mi chiese se in trincea avevo sentito dei dolori nei punti che mi indicava. Io gli dissi di sì ma che non avevo mai marcato visita perché vedevo che c’era gente che stava peggio di me e veniva lasciata in trincea. Si alzò in piedi e disse “sappiamo bene che la guerra porta tanti sacrifici, ma sacrificare così inutilmente la gente vuol dire non avere né coscienza né amor di patria”. Questo dottore mi curava con molta premura. Mi tenne lì venti giorni. Quando fui in grado di viaggiare mi fece portare a Mondovì, in Piemonte. Mi disse “quando ti sarà passata la febbre ti manderanno a casa in convalescenza per tre mesi”. Io scrissi ai miei che stavo bene e che presto mi avrebbero mandato a casa per tre mesi ma che per il momento mi trasferivano in Piemonte. La mia fidanzata mi scrisse che stava un po’ meglio. Dopo pochi giorni che ero a Mondovì mi venne la pleurite anche dalla parte sinistra. Mi sentii venire dei dolori sempre più forti, non riuscivo a respirare, non potevo chiamare. Un malato che era vicino a me se ne accorse e chiamò l’infermiere. L’infermiere chiamò subito il medico che venne a visitarmi. Poi chiamarono il maggiore medico, comandante dell’ospedale. Mi visitò anche lui e disse “forse hai preso qualcosa”. Io sapevo di non aver preso niente e gli risposi di no. Prepararono un altro letto vicino al mio e mi ci misero sopra. Quello in cui dormivo lo buttarono all’aria, credendo che io avessi nascosto qualcosa per farmi venire la febbre, ma non trovarono nulla. Poi mi rivisitò il maggiore medico. Scrollò il capo e si avvicinò al tenente medico. “Questo fa come quello lì” disse, e accennò col capo al letto 44 Monarchia dove il giorno prima era morto uno. Io mi mossi per ascoltare meglio. Il maggiore si accorse che cercavo di ascoltare. Tornò al mio capezzale e cominciò a farmi dei complimenti, dicendomi “cerca di stare coperto bene, vedrai che con la cura che ti faremo presto guarirai. Ti daremo una lunga convalescenza, presto sarai in grado di tornare a casa tua, fatti coraggio”. Mentre parlava mi dava dei buffetti sul viso, amichevolmente. Io veramente mi facevo coraggio, pensavo che si fossero sbagliati, di non essere malato come pensavano loro. Infatti otto giorni dopo il medico disse che avevo superato la fase più critica e che se non sorgevano complicazioni sarei stato fuori pericolo. Però facevo fatica a muovermi, un piccolo respiro pareva dovesse staccarmi i polmoni. Erano dieci giorni che non scrivevo a casa. Mi giunse una lettera dal padre della mia fidanzata, nella quale mi rimproverava perché io scrivevo troppo di rado a Giulia. Diceva “se non lo fai per amore di Giulia fallo per me perché sono molto in pensiero. Appena Giulia ha un piccolo dispiacere subito peggiora”. Io ancora non potevo scrivere e non volevo far scrivere ad altri, perché a casa se ne sarebbero accorti e avrebbero pensato il peggio. Non sapevo come fare e mi sentivo mortificato, avevo bisogno di conforto e dovevo confortare. Appena fui in grado di scrivere scrissi un paio di righe, perché di più non ce la facevo. Mi dava noia respirare e fare qualunque movimento. Scrissi un paio di bugie. Dissi che avevo scritto ma che forse le lettere erano andate perse. Sulla lettera misi la data del giorno in cui avevo ricevuto la lettera del padre di Giulia. Scrissi anche che mandavo solo poche righe perché c’era il postino che aspettava e che avrei scritto più a lungo nella prossima lettera. Dissi che io stavo bene e che non pensassero male di me. Ormai ero abituato a tutti i sacrifici. Il medico mi curava con tutto il suo impegno e mi promise che mi avrebbe fatto i fogli perché fossi riformato. Erano passati due mesi e miglioravo continuamente. Ero in attesa del modello 41 per essere riformato. Ma non ebbi quella soddisfazione. Questo dottore fu trasferito e ne venne uno nuovo. Mi visitò e poi mi disse che mi avrebbe mandato in convalescenza. Io gli dissi “mi viene sempre la febbre e poi il dottore che mi ha curato mi ha garantito che sarei stato riformato”. Lui disse “macché riforma, al 45 fronte c’è gente che sta peggio di te”. Io gli dissi “signor dottore lo vede anche lei che la febbre non mi lascia mai. Sono ammalato e non posso tornare a casa in queste condizioni”. Lui mi disse che se non volevo andare a casa mi avrebbe mandato al convalescenziario di Torino. Disse “sta a te scegliere: o a Torino o a casa tua”. Io scelsi casa mia perché se mi fosse tornata la febbre potevo andare all’ospedale di Arezzo e sarei stato più vicino ai miei. Decisi di andare a casa mia però non ce l’avrei fatta neppure a salire e scendere dal treno. Per questo mandarono con me un infermiere che mi accompagnò fino a casa. Mi diedero tre mesi di convalescenza. Quando mia madre mi vide mi abbracciò e vedendomi così malmesso si mise a piangere dicendo “il mio figliolo me l’hanno rovinato, non tornerà più come prima”. Anche a mio padre venivano le lacrime agli occhi e io non sapevo come consolarli. Insistevo che era stato il viaggio così lungo e scomodo e lo strapazzo per fare la strada a piedi dalla stazione a casa. Dicevo “vedrete che quando mi sarò riposato vi farò un altro effetto”. Ma loro non se ne facevano una ragione e dicevano “la guerra ci ha rovinati, non abbiamo più speranze. E poi tu ci scrivevi che stavi bene e invece sei diminuito della metà”. Io dicevo che era la stanchezza che mi aveva trasformato e l’infermiere mi dava ragione. Diceva che era sicuro che entro tre mesi la guerra sarebbe finita e cercava di incoraggiarli. Si cominciò a parlare del fronte e della mia malattia. Loro mi dissero come avevano mandato avanti l’azienda. Quando li vidi un po’ più tranquilli gli chiesi come stava Giulia. Mi dissero che da qualche giorno l’avevano portata in una casa di cura. Io non volli farmi vedere avvilito, cercai di continuare la conversazione, anche per riguardo all’infermiere, ma dentro di me era piombato un grande dolore. Mio padre se ne accorse. Cercò di alleggerire la gravità della cosa per non avvilirmi, ma io ormai sapevo. Era passato un anno e mezzo da quando l’avevo vista per l’ultima volta, stava sempre peggio, e poi suo padre mi aveva scritto che era molto preoccupato per lei, per cui non poteva pensare che stesse bene. In ogni modo mi feci coraggio. Si parlò di altre cose. Mia madre preparò la cena anche per l’infermiere che sarebbe ripartito il giorno dopo 46 Monarchia alle sei, col primo treno. Dopo cena si andò a letto, ma io pensavo continuamente a Giulia. Sarei partito anche a mezzanotte per andarla a trovare. Non potevo dormire tanto ero stanco. Il mattino dopo mia madre si alzò molto presto perché l’uomo che mi aveva accompagnato doveva partire. Appena fu pronto ci salutò e partì per il suo destino. Io pensavo a come fare per poter andare a trovare Giulia. Allora non c’erano automobili comode, come ci sono oggi, e dovevo andare a piedi. Le gambe le avevo fiacche. Mi alzai dal letto. Sentivo quella smania di rivedere Giulia. Ma le gambe non mi reggevano. Fui costretto a tornare a letto. Erano quasi le undici. La febbre era scemata, l’avevo a 37 e 6. Mi feci coraggio e mi rivestii. Ero ansioso di andare a trovare quella persona a me tanto cara. Avvertii i miei genitori. Ma non erano contenti. Dissi che stavo bene e che avevo poca febbre. Rimasero persuasi per accontentarmi. Mi dissero “vai, però, non fare buio”. Io promisi loro che sarei tornato presto. Mi sarebbe bastato vedere in che stato era Giulia. Dopo aver mangiato partii. Dovevo fare circa quattro chilometri. Mi misi in cammino. Volevo tornare prima che facesse buio, come avevo stabilito coi miei genitori, ma per fare tre chilometri ci misi più di un’ora. Arrivai alla casa di cura. Trovai Giulia seduta su una sedia. Appena mi vide fece un gran sospiro, come se le avessero tolto un peso di dosso. Senza far parola mi abbracciò baciandomi. Poi disse “sei stato un bugiardo, perché dicevi sempre di stare bene invece stai peggio di me. Ma mi dici cosa ti è accaduto per ridurti in questo stato?”. Io le dissi “ho fatto come hai fatto tu. Ti sei ammalata dal dispiacere quando io sono dovuto partire per il fronte perché mi volevi tanto bene e a me è successa la stessa cosa. È stato il dispiacere per la tua lontananza che mi ha ridotto così. Se io sto peggio di te vuol dire che io ti voglio più bene di quello che ne vuoi tu a me”. Lei disse “tu hai voglia di scherzare, ma mi pare che non ti dispiaccia tanto vedermi in questo stato. È passato un anno e mezzo da quando ho questo male e vedo sempre peggiorando. Io non so più cosa fare. Non mi giova nessuna cura. Anche qui non ci sto volentieri, sto meglio a casa mia”. Io non sapevo cosa rispondere. Quelle parole mi ferivano il cuore. Mi feci coraggio. Sempre scherzando le dissi “a me basta che tu guarisca quando 47 guarisco io e quando finirà la guerra tornerò a casa sicuro che un altro giovanotto non l’avrai trovato”. Lei si asciugava continuamente le lacrime. Disse “vuol dire che tu desideri che io rimanga ammalata”. Le risposi che io scherzavo, come aveva detto lei prima. “Vorrei vederti come due anni fa. Se ti sei ammalata a causa di un dispiacere devi farti coraggio, essere forte e tenerti il più contenta possibile, come ha detto quel professore. Devi sforzarti a mangiare, cercare di svagarti, di non pensare a tanti guai. Tu invece fai tutto il contrario. Io non voglio più vederti con le lacrime agli occhi quando vengo a trovarti, perché fai soffrire anche me. Vedi che anch’io ho bisogno di stare contento, quindi dobbiamo aiutarci uno con l’altro. Non dobbiamo perdere la speranza, vedrai che le cose cambieranno. La guerra finirà e supereremo queste avversità, realizzeremo i nostri desideri e saremo felici. Se ti curi e ti vedo migliorare sono felice anch’io”. Così tralasciammo questi guai e ci si mise a parlare dei tempi passati insieme, prima che io partissi per il fronte, di quelle belle giornate di gioia e allegria, con la speranza di trovare un po’ della felicità di quei giorni. Le raccontai poi come passavo le giornate al fronte con i miei compagni, ma le cose più tristi non gliele dissi. Le ore passarono velocemente e io dovevo tornare a casa prima che si facesse buio. Avevo poco tempo ma non avrei voluto partire da quel posto. Il tempo volava. Fui costretto a salutarla. Io non volevo farle sapere quanto ero ammalato e le dissi che il giorno dopo non sarei andato a trovarla perché dovevo fare delle visite ai miei parenti. La verità è che non riuscivo a stare in piedi. Ero preoccupato pensando a come avrei fatto a tornare a casa. La salutai affettuosamente e partii per casa mia. Ma le gambe le avevo fiacche e in alcuni tratti la strada era in salita. Camminavo piano e di tanto in tanto dovevo riposarmi. Feci tardi. Mi ero sforzato per essere puntuale ma non ce l’avevo fatta. Mi misi a sedere. Ero a circa un chilometro da casa. Era già buio ma non avevo la forza per alzarmi. In quel mentre udii dei passi: era mia madre che mi veniva a cercare. Mi diede la mano per mettermi in piedi e piano piano si tornò a casa. Mia madre raccontò a mio padre come mi aveva trovato, senza la forza di alzarmi in piedi. Era inutile che facessi finta di non essere ammalato, ormai avevano 48 Monarchia visto in che condizioni ero. Mi sentivo stanco, sfinito. Sarei andato a letto anche senza cenare. Ma vedevo i miei che stavano volentieri insieme a me a parlare dei tempi passati. Io gli raccontavo della vita al fronte e loro non sarebbero mai andati a dormire. Ma vedendomi così stanco mi dissero “parleremo domani più a lungo, ora andiamo a riposare”. Io accettai perché non ne potevo più. Ma non riuscii a dormire. Non ne potevo più di tanti dispiaceri. Mi misurai la febbre: era a 39 e 8. Pensai che la causa di questo male erano i guai che avevo avuto. Pensavo: “se avrò la febbre così anche domani mi faccio portare all’ospedale di Arezzo”. Invece al mattino la febbre era diminuita, l’avevo a 37 e 8. Tutti i giorni la febbre diminuiva. Dopo diciotto giorni non avevo più febbre. I miei genitori erano contenti vedendo che miglioravo. Mia madre era sempre premurosa. Tutte le mattine, alle sette, mi portava il caffellatte in camera. Dopo due ore mi faceva bere un uovo, come mi aveva ordinato il dottore. Mangiavo quasi sempre carne e bevevo vino vecchio. Dopo un mese ero tornato in forze. Andavo a trovare parenti e amici e non c’era bisogno che venisse mia madre a prendermi per la strada. Però fu merito suo se mi tornò la salute. Non mi faceva mancare niente di quello che mi serviva, non badava a nessun sacrificio. Qualche volta mi strapazzavo un po’ e mi veniva la febbre. Lei subito si turbava, le leggevo in faccia il dispiacere. Quando poi mi vedeva un po’abbattuto subito veniva a domandarmi, addolorata, come mi sentivo. Pensavo “come avrà sofferto quando mi ha visto partire per la guerra”. Come tutti i genitori, che chissà come soffrono nel vedersi prendere i figli per essere mandati di fronte alla morte. Anche le bestie feroci, se gli andate a prendere un figlio, soffrono e lo difendono anche a costo di rimetterci la vita. Ormai ero giunto agli ultimi giorni di convalescenza e stavo pensando alla mia seconda partenza. Mi sentivo in pensiero per i miei genitori e per Giulia che era stata ammalata due anni a causa della mia partenza. Vedendo che lei soffriva per me capivo che era sincera e mi voleva veramente bene e mi sentivo ancora più affezionato a lei. Soffrivo per tutti loro ma anche per me che dovevo tornare alla guerra e sapevo bene cos’era la vita al fronte. Ma non c’era niente da fare, 49 c’era la madrepatria che aveva bisogno, dovevamo servirla e difenderla. Con la speranza che un giorno la madrepatria si fosse ricordata dei suoi figli che l’avevano servita e difesa e li ricompensasse. Queste cose le dicevo ai miei genitori il giorno della partenza. Dicevo loro che era nostro dovere ubbidire ai superiori con la speranza di tornare sani e salvi. Dicevo tutte queste cose per farli contenti ma dentro di me sentivo una tristezza. Ero privo di ogni speranza, sapendo dove andavo. Cercavo di farmi vedere tranquillo e sicuro. Mi feci coraggio, salutai tutti affettuosamente e partii per la sede del mio reggimento. Arrivai a Forlì con il cuore infranto dal dolore pensando a quello che avevo passato e che avrei dovuto rivivere. Appena arrivai a Forlì il dottore mi visitò e mi diede tre mesi di riposo. Avrei dovuto essere contento. Pensavo che in quei tre mesi avrebbe potuto finire la guerra, e lo scrissi ai miei. Ma la contentezza durò poco. Proprio in quei mesi ci fu la grande ritirata di Caporetto e tutti noi che eravamo al deposito in riposo ci mandarono al fronte. Ci facevano fare decine e decine di chilometri a piedi, con lo zaino in spalla, e io, dopo la malattia che avevo avuto, non ce la facevo. Ero costretto a fermarmi spesso dal male, non potevo resistere. C’era un tenente che mi apostrofava con tutti i titoli, come se fossi stato un delinquente. Io, fra il male che sentivo e quelle offese così ingiuste, mi sarei tirato una fucilata da solo. Veniva l’ambulanza e portava all’ospedale quelli che marcavano visita. Chi non aveva la febbre veniva rimandato al battaglione di marcia. Era così tutti i giorni. Fra il male e le preoccupazioni e lo strapazzo, non ce la facevo più. Marcai visita perché avevo un po’ di febbre, e mi mandarono all’ospedale. Il giorno dopo non avevo più febbre e mi riportarono al battaglione. Io mi sforzavo a fare il mio dovere perché soffrivo e mi dispiaceva essere trattato così. Avrei preso più volentieri uno schiaffo che essere offeso in quel modo. Non ero solo, ma ognuno sente le sue. Però il male si faceva sempre più forte. Rimarcai visita ma dissero che non avevo nulla e mi rinchiusero in una tenda a pane e acqua. Quando c’erano da fare le istruzioni le dovevo fare anch’io. Quella fu la cura per la mia malattia. Dopo alcuni giorni venne un capitano a prendere ottanta soldati per formare i reparti d’assalto, chiamati gli ‘arditi’. 50 Monarchia In questi ottanta fui destinato anch’io. Mi rincresceva far parte di un reparto d’assalto, anche per doverlo scrivere a casa, ma questo era il mio destino. Ci portarono in provincia di Brescia, in un paesino di cui non ricordo il nome. C’erano delle montagne adatte per le nostre istruzioni. In tre mesi di esercizi si doveva imparare a conoscere diversi tipi di bombe e saperle usare. In più dovevamo abituarci a stare sotto il tiro dei nostri cannoni a pochissima distanza. Su una montagna avevano fatto due trincee, rappresentanti la prima e la seconda linea nemica. Mentre le artiglierie bombardavano la prima linea noi arditi ci portavamo il più vicino possibile alla trincea, circa ottanta metri. Quando le batterie allungavano il tiro per bombardare la seconda linea noi arditi si dava l’assalto alla prima con le bombe a mano. Poi l’artiglieria allungava ancora il tiro e noi si dava l’assalto alla seconda linea. Per tre mesi, tutti i giorni, si facevano queste manovre. Nei primi tempi ci furono parecchi morti e feriti perché non eravamo pratici delle bombe a mano. C’era sempre qualcuno che aveva paura quando la bomba era pronta per essere lanciata e per buttarla via al più presto la tiravano troppo vicino. Le schegge delle granate a volte si spandevano intorno per un vasto arco, soprattutto quando la bomba cadeva sulla roccia, e combinavano dei grossi guai. A volte, siccome la montagna era molto ripida, venivamo investiti dalla terra e dai sassi che ruzzolavano giù. Comunque, nonostante ci fosse più pericolo stavo più volentieri in quel posto che al battaglione di marcia perché in quel posto lo zaino non lo facevano portare ed era proprio quello che mi faceva male alle spalle a causa della mia malattia. Poi ci trattavano meglio, si mangiava di più e c’era una certa libertà. Finite le istruzioni ci mandarono al fronte. La prima battaglia che si fece con il nemico fu sul Montello. Fu molto dura e sanguinosa. Conquistammo le postazioni nemiche ma ci furono molte perdite anche fra i nostri. Vidi con i miei occhi una granata nemica uccidere un caporale, ferire diversi soldati e rompere una gamba a un tenente. Poi ci mandarono indietro per pochi giorni, quindi ci furono altre battaglie, in marzo e in aprile, nel basso Piave, tutte vittoriose ma 51 con molte perdite da parte nostra. Sul Grappa e su altri monti dove c’erano da conquistare posizioni importanti mandarono noi arditi a conquistare le prime linee, perché ci avevano addestrati a farlo e quello era il nostro dovere di reparti d’assalto. Poi ci mandarono in riposo in un paesino di cui non ricordo il nome. Si restò lì per diversi giorni. C’era solo un tabacchino, che vendeva anche vino, liquori e cartoline. La tabaccheria fungeva anche da trattoria e rivendita di generi alimentari. Era l’unica bottega del paese ed era chiusa. Venne il maggiore, comandante del gruppo, e bussò più volte. Poi si affacciò un omino che non voleva aprire. Il maggiore gli disse “se non apre le faccio togliere la licenza”. L’omino scese e venne ad aprire. Era tutto impressionato. Aprì la porta del negozio e prima che fosse dietro il banco il negozio era già pieno di soldati. Non riusciva a servire tutti così io e un mio amico ci si mise a girare per la campagna. Si cercava una famiglia dove avremmo potuto farci dare qualche uovo. Si vide una casa a molta distanza e si andò da quella parte. C’era una donna nell’aia e andammo verso di lei. Questa appena ci vide corse in casa e chiuse la porta. Noi non si sapeva cosa fare. C’erano tante galline e polli e si pensò che ci sarebbero state anche le uova. Ci si guardò intorno. Altre case non ce n’erano, nei paraggi. Si bussò alla porta ma non rispose nessuno. Si stava per perdere la speranza quando si vide un uomo nel campo. Ci si avvicinò e ci si mise a parlare, poi gli si chiese se era possibile avere due coppie di uova, meglio se sode e meglio ancora se affrittellate. Gli si sarebbero pagate e ci avrebbe fatto un grande favore perché non si trovavano botteghe. Quest’uomo rifletté un momento poi disse “venite con me, vediamo se ci sono”. Ci portò in casa. C’erano due ragazze sui vent’anni. Ci affrittellarono quattro uova e le misero in un piattino che deposero sopra alla tavola. Di pane non ne avevamo bisogno, avevamo il nostro. Quell’uomo ci portò anche un fiasco di vino. Io e il mio amico si rimase meravigliati. Prima non volevano farsi vedere e ora erano così gentili, anche quelle due ragazze. Dopo mangiato si parò del fronte, delle battaglie, delle trincee e dei sacrifici che bisognava fare, di tutto quello che ci aveva portato la guerra. Le due ragazze avevano i fidanzati al fronte e anche due fratelli. Si fece un po’ di conversa52 Monarchia zione e ci dissero che prima di noi, in paese, c’era un reggimento di artiglieria, nel medesimo quartiere dove eravamo noi arditi. Questi artiglieri avevano preso dei polli senza pagare e al tabacchino gli avevano portato via diversi fiaschi di vino, bottiglie di liquore e delle cartoline illustrate. Poi avevano detto che noi arditi eravamo peggio di loro, che quando si andava a mangiare in un ristorante si pagava con le bombe a mano, che si dava noia alle donne e cose del genere. Così in quel posto avevano tutti paura di noi. Ecco perché il tabacchino non voleva aprire e quelle ragazze non volevano farsi vedere, perché avevamo la nomea di avanzi di galera. A noi dispiaceva che non avessero fiducia. Gli si disse che in tutti i reggimenti c’erano i buoni e i cattivi. A me e al mio amico ci piaceva portare rispetto a tutti, ovunque si andava. Prima di partire si chiese quanto si doveva pagare, ma loro non si arrischiavano a chiedere. Dissero che non volevano niente. Noi gli si mise sulla tavola il valore di quello che avevamo consumato. Loro volevano renderci la metà del denaro ma noi non lo riprendemmo e si ringraziarono perché ci avevano fatto un grande favore. Dissero che se si voleva tornare si sarebbe stati ben accettati. Noi si ringraziarono di nuovo e si andò via. Il giorno dopo andammo da un’altra parte. Ma in questo posto erano tutti seri e non volevano conversare, ci guardavano come se fossimo stati dei delinquenti. Io e il mio amico si andava sempre insieme, eravamo come fratelli. Si chiamava Oreste Boldri ed era di Ferrara. Dopo due giorni si tornò dalla solita famiglia. Quando le due figliole ci videro chiamarono subito il padre. Forse non erano ancora persuase di quello che avevamo detto loro. Si fecero due chiacchiere insieme poi gli si chiese le solite due uova. Ci invitarono a casa e si mangiò come la prima volta. Mentre si mangiava dissi che mi dispiaceva di tutte le calunnie dette sul nostro conto e di come ci guardava male la gente. Avrei voluto avere il decoro che meritavo. Rivolgendomi al padre gli dissi “noi siamo come i vostri figli, non vogliamo sacrificare nessuno”. Lui rispose “quando uno paga non sacrifica nessuno. Se siete contenti di venire qui, quando volete venite pure”. Dopo mangiato si fece come la prima volta. Loro non volevano niente ma noi si lasciò sul tavolo lo stesso compenso. 53 In quei giorni c’era una festa in paese. Quell’uomo ci pregò di andare a pranzo da loro per quel giorno. Ci disse “mi sembrerà che ci siano i miei figli, venite, ci farebbe molto piacere”. Gli si promise che si sarebbe tornati il giorno di questa festa. E il giorno di questa grande festa si andò. Il padre della ragazza, quando arrivammo vicino alla casa, ci vide e ci venne incontro. Ci strinse la mano con affetto e ci portò in casa. Avevano preparato un pranzo di lusso. Noi avevamo portato due bottiglie di liquore. Si mangiò tutti insieme e quell’uomo disse “farò conto che ci siano i miei due figli. Sono due anni che non abbiamo fatto questa festa insieme a loro. Sarei contento se in questo momento i miei figli si trovassero come vi trovate voi ora”. Noi si cercava di fargli coraggio, ma anche lui era come tutti i genitori: aveva spesso le lacrime agli occhi. Poi in un giorno di festa trovarsi privi della compagnia dei propri figli e doversi accontentare di avere accanto due sconosciuti per dimenticare i pensieri tristi deve essere molto penoso. Erano circa quindici giorni che eravamo in quella frazione e c’eravamo già affezionati a quella famiglia. Si passò felicemente quella festa. Dopo pranzo si decise di partire e quell’uomo ci pregò di aspettarli, perché anche loro sarebbero andati alla cerimonia, in chiesa. Così partimmo insieme a loro. Quando si giunse vicino alla chiesa si vide una gran folla. C’era anche gente di altre parrocchie e c’era molta allegria. Borghesi e militari cantavano insieme. Ci si avvicinò anche noi. Al centro di questa folla c’era una botte di vino e due militari che lo distribuivano a chiunque ne volesse. E tutti ne prendevano: borghesi, soldati, donne, bambini, vecchi e giovani. Tutti venivano serviti con gentilezza, non bisognava pagare nulla. I borghesi gridavano “viva gli arditi”. Eravamo contenti nel vederci rispettati, trattati come fratelli. Fu veramente una giornata di gioia, di allegria e di soddisfazione per tutti. Il maggiore comandante, che aveva offerto la botte di vino, ci fece un discorso poi fece un elogio alla popolazione. Due giorni dopo questa festa, il 15 giugno, verso le 14, sentì suonare tutte le cornette dei nostri reparti. Suonavano l’adunanza con insistenza. Noi che eravamo sparsi per la campagna si dovette correre. 54 Monarchia Fecero l’appello. Eravamo tutti presenti. Quindi arrivò una colonna di camion. Ci fecero caricare le casse di munizioni, le mitragliatrici e ci fecero montare sui camion. Si seppe che il nemico aveva sferrato una grande offensiva, invadendo le nostre posizioni di Asiago, alla foce del Piave e avanzava a grande velocità. A un certo punto incontrammo le nostre truppe che si ritiravano. C’erano molti feriti, gli artiglieri avevano abbandonate le loro batterie. C’erano alcuni che avevano anche due feriti su un mulo solo. Tutti ci dicevano “ma dove andate, ci sono gli austriaci, vi faranno prigionieri”. Avanzammo per un chilometro circa. La colonna si fermò e si scaricarono le armi e le munizioni. Ognuno prese l’occorrente poi venne dato l’ordine di avanzare sparsi quando due granate nemiche caddero vicino a noi: una a una trentina e una a una quarantina di metri. Per fortuna quella che cadde più vicino a noi non esplose. Quella che esplose fece una gran buca nel terreno ma non colpì nessuno. Così si cominciò il contrattacco. Si avanzava allineati e compatti. Gli austriaci erano sparsi e stanchi. Ci opposero poca resistenza. Alcuni ripiegarono, altri si diedero prigionieri. La sera, quando fu buio, avevamo riconquistato tutte le nostre posizioni. Al mattino la battaglia riprese e si conquistò la loro prima linea. C’erano da scavalcare dei reticolati alti un metro. Non era facile oltrepassarli. Si trovavano dei fori fatti dalla nostra artiglieria che aveva bombardato il giorno prima la loro linea. Si passava uno alla volta, a stento. Stare ammassati sarebbe stato pericoloso. Io mi allontanai. C’era un’altra compagnia poco distante da noi. Erano già passati tutti. Passai da dover erano passati loro, per far prima. Credevo che fossero italiani. Un paio di loro mi fecero cenno di raggiungerli. Erano cecoslovacchi che combattevano al nostro fianco. Ce n’era qualcuno che parlava italiano. Mi parlarono della loro nazione e di come avevano fatto a raggiungere l’Italia. Mentre si avanzava, io, curioso di sapere cose nuove, facevo loro delle domande. Avanzavo con questi stranieri. Dopo un po’ cominciò un po’ di padule. C’erano delle piante che facevano siepe e io persi di vista i miei compagni. Io credevo che la mia squadra fosse a due passi e avrei voluto raggiungere i miei compagni. Ma questo padule non finiva mai. A un certo punto si vide una casa colonica in 55 mezzo ai campi. C’erano gli Austriaci. Quando ci videro si diedero alla fuga e noi dietro di corsa, sparando. Io non volevo farmi vedere vile e correvo insieme ai cecoslovacchi. Però non mi sentivo sicuro volevo tornare dai miei compagni. Ma quel padule era sempre più difficile attraversarlo. Tornare indietro? C’era più di un chilometro, proseguire con questi stranieri non me la sentivo. Mi feci coraggio. Entrai in questo padule. L’acqua mi arrivava al ginocchio. Passai dalla parte dei miei compagni, credendo che fossero avanzati con noi, invece non li vidi, né indietro né avanti. Da tutte le parti si sentivano sparare fucili e mitragliatrici. Le pallottole mi fischiavano intorno. Mi distesi dentro a un solco, aspettando di veder sopraggiungere i miei compagni. Ma non sentivo che colpi di arma da fuoco. Rimasi lì circa mezz’ora, fra due fuochi. Il cuore mi batteva come una mitragliatrice. Non sapevo cosa fare. A un certo punto sentii gridare, circa un chilometro dietro di me. Era la voce dei soldati italiani che urlavano ‘savoia’. Sentii anche gridare gli Austriaci. Aspettavo che arrivassero i miei compagni invece vidi venire verso di me una pattuglia di Austriaci. Venivano proprio verso il solco dove ero nascosto io per ripararsi dalle fucilate. Io sapevo che gli arditi non li facevano prigionieri. Se prendevano uno di noi lo fucilavano subito. Morto per morto sparai tutto il caricatore del moschetto contro i soldati di quella pattuglia. Loro si buttarono a terra. Ma io non stetti a pensare a loro. Ce n’erano altri poco più distante, e molto numerosi, che venivano anch’essi verso di me. Mi tolsi le giberne e il tascapane per scivolare meglio e rientrai nel padule per nascondermi. Vidi che nella casa dalla quale erano scappati gli Austriaci c’erano dei soldati ma non sapevo se si trattava di amici o di nemici. Camminai per questo padule. Ormai non ce la facevo più. Uscii dal padule e mi diressi verso la casa, con la speranza che dentro ci fossero degli amici. Infatti c’erano degli Italiani. Mi dissero che vedendomi disarmato avevano pensato che fossi un austriaco che si arrendeva. Se avessi avuto il moschetto mi avrebbero sparato. Mi dissero che credevano di essere il reparto più avanzato e mi chiesero come mai mi trovassi così avanti. Dissi loro dei Cecoslovacchi che ora erano ancora più avanti, e che non rividi più. Dopo pochi minuti venne l’ordine di 56 Monarchia ritirarci. Io tornai indietro con loro. Era una sezione di mitraglieri. Li fecero tornare alla linea di resistenza, e lì trovai i miei compagni. Mi dissero che loro non avevano potuto avanzare perché oltre il reticolato avevano trovato una resistenza accanita. C’erano stati molti morti e feriti, ne mancavano diversi. Dalla parte dei Cecoslovacchi invece gli Austriaci non avevano opposto resistenza. Questa battaglia durò diversi giorni. Subimmo molte perdite ma anche il nemico ne subì. Quando si avanzava si trovava sul terreno una gran quantità di morti che non avevano fatto in tempo a portare via. Dopo questa lunga battaglia noi arditi fummo riportati nelle retrovie, dove fecero l’appello. Ne mancava circa il 20%. Si sentì dire che nel Monbello erano rimasti prigionieri migliaia di nostri soldati fra artiglieri, fanti, alpini, bersaglieri, ma che il nemico si stava ritirando e aveva lasciato più morti e prigionieri di noi. Nel mese di agosto e in settembre si fecero alcune battaglie, tutte vittoriose e con poche perdite. Il 24 ottobre venne l’ordine di battaglia. Dovevamo attaccare, sarebbe stata una grande offensiva. Cominciarono i nostri cannoni di tutti i calibri. Bombardavano le trincee del nemico. E noi arditi avanzavamo e conquistavamo le loro posizioni dopo che i nostri cannoni avevano allungato il tiro. Era un tuono continuo fra i nostri cannoni e le granate nemiche. Pareva la fine del mondo. La stagione era brutta, quasi tutti i giorni pioveva, avanzavamo a stento. La sera del 26 si fece centinaia di prigionieri, ma si trovò anche molta resistenza. Nei primi giorni si prendeva le loro posizioni ma poi si doveva retrocedere perché le loro artiglierie ci bombardavano e non si poteva resistere. Fino al 28 ottobre ci furono lotte accanite. Subimmo molte perdite anche noi. Si combatteva fra due fuochi e subivamo dei contrattacchi micidiali. Avevano delle fortezze dove era quasi impossibile entrare. Ma si avanzava ugualmente. Si incontrarono delle famiglie che ci fecero compassione. Gli Austriaci gli avevano portato via tutto, anche i materassi del letto. Ci dissero che gli Austriaci andavano a dormire nelle loro case, buttando fuori gli uomini, e facevano da padroni. Le donne le tenevano in casa. Ai proprietari era proibito perfino andare nel campo a raccogliere una zucca. In casa non avevano più niente. Gli avevano portato via tutte le bestie. Era la stessa cosa per tutte le 57 famiglie della zona. Tutti ci raccontavano le stesse cose. Una famiglia ci raccontò che avevano appena ammazzato un maiale e avevano nascosto la carne e altra roba che gli avrebbe fatto comodo: vino, coperte, cibo. Portarono via tutto, anche il capofamiglia. Non rividero più nulla, neppure il capofamiglia. Quando si sentiva di queste storie l’odio per il nemico aumentava, si combatteva con più rancore. Dovunque si arrivava, avanzando, si sentivano raccontare le stesse cose. Nella mia squadra c’era uno di Belluno, con cui ero molto amico. Si stava avanzando proprio nelle vicinanze di casa sua. A un tratto la si vedeva bene, era a meno di due chilometri da noi. Chiese il permesso di andare a visitare la sua famiglia e gli fu concesso. La sera tornò piangendo. Ci raccontò quello che era successo. Aveva trovato la famiglia in un mare di lacrime. Gli Austriaci gli avevano ammazzato un fratello di sedici anni e avevano portato via tutto, come erano soliti fare. Due Austriaci avevano preso sua sorella e l’avevano portata di peso al piano superiore. Questa strillava e chiedeva aiuto. Il fratello era corso per prestare aiuto alla ragazza e i due Austriaci l’avevano ucciso. Quando raccontava queste cose piangeva da far pietà. A tutti noi che ascoltavamo mise ancora più odio e rancore contro il nemico. Si combatteva con rancore. Era diventata una guerra di vendetta più che di conquista. Così penso sia stato per tutto il fronte. Si combatteva senza badare ai sacrifici. Si mise gli Austriaci in fuga senza dar loro il tempo e la possibilità di appostarsi. Si combatteva sotto la pioggia e le artiglierie nemiche. Eravamo sempre bagnati in quei sei giorni che impiegammo per arrivare a delle montagne di cui non ricordo il nome. Venne l’ordine di star fermi, eravamo sfiniti. C’era una casa mezza diroccata dalle cannonate. Si entrò dentro. Ognuno diceva il proprio parere sul motivo di quella sosta. C’era chi diceva che ci avevano fatto fermare perché eravamo troppo avanti, altri dicevano che non ne potevano più e che la sosta serviva per darci un po’ di riposo. Poi, alla sera, si sentì dire che gli Austriaci si erano arresi, non combattevano più. Ma nessuno ci credeva. Il mattino dopo si sentì in distanza suonare la fanfara. Suonava la marcia reale. Pareva un sogno. Non ci si credeva tanta era la gioia. Ancora non si riusciva a rendercene conto, come non ci si rendeva più conto della differenza fra la morte 58 Monarchia e la vita. Si sentiva gridare dappertutto. Si sentiva gridare “è finita la guerra, abbiamo vinto”. Si era suggestionati, dopo tanti sacrifici e travagli di ogni genere, dagli stenti alla paura. Nel sentire quelle notizie ci venivano brividi di gioia, sembrava che non fosse vero. Noi dei reparti d’assalto il giorno dopo ci fecero tornare indietro. Ci portarono a Belluno, dove si restò per pochi giorni, quindi ci portarono a Treviso. Si vedeva la gente contenta per la fine della guerra, ma molti avevano le lacrime agli occhi. C’era chi aveva perso il figlio, chi il marito, chi il padre, chi il fratello. Erano pochi quelli che non avevano perso nessuno. Si vedevano tante donne vestite di nero. Mi tornavano in mente tutti quelli che avevo visto morire, quando si facevano quelle terribili battaglie, anche dei miei compagni. Quando si era al fronte sentivamo meno pena per i morti perché eravamo sempre sottoposti a duri sacrifici e la morte era sempre al nostro fianco. Ora che stavamo per tornare tutti alle nostre case, insieme ai nostri cari, ci sarebbe piaciuto essere stati tutti contenti. Purtroppo si sentiva dire che era morta troppa gente. Anche sul fronte francese erano morti tanti soldati italiani. Lo dice anche la storia. Nella battaglia sulla Marna, dal 15 al 24 luglio, della nostra armata composta da 24.000 uomini rimasero 14.000 soldati. Per forza di cose e per inettitudine dei nostri ministri non si poté fare a meno di tanto lutto nel nostro paese. L’uomo, in special modo il proletario, era considerato oggetto da guerra. Non bastava il nostro fronte, mandavano soldati anche all’estero. Treviso era stata circa un anno sotto il dominio degli stranieri. La gente ne aveva passate di tutti i colori. Il reparto dove ero io rimase un mese a Treviso. Poi ci diedero una licenza di dieci giorni più il viaggio. Appena fui a casa mia mi pareva di non essere più il solito, di essere in un altro mondo. Mi venivano brividi di gioia riabbracciando i miei genitori. Avevo passato più di diciassette mesi fra la vita e la morte, senza mai rivedere i miei cari. Li trovai molto invecchiati. Si vedeva che erano stati sacrificati anche loro, benché non fossero stati al fronte. Ma la guerra porta sacrifici a tutti. Quei dieci giorni passavano come un sogno tanta era la mia gioia. Andavo a trovare la mia fidanzata. Le dicevo “vedi che avevo ragione quando ti dicevo che dovevi guarire e che al resto si sarebbe rime59 diato”. Lei era guarita perfettamente. Prima che scadesse la licenza andai ad Arezzo per ritirare i documenti mandati a Firenze, all’ufficio regionale. Andai a Firenze a questo ufficio. I documenti erano pronti e l’esonero mi era stato concesso. Appena li ebbi nelle mani mi parve un altro sogno. Presi questi fogli e tornai al treno, che mi pareva andasse pianissimo data l’ansia che avevo di arrivare per dare la buona notizia ai miei genitori. Quando i miei videro che avevo ottenuto l’esonero furono molto contenti. Si riprese il nostro lavoro. Mi pareva un miracolo trovarmi libero cittadino, senza più il rombo dei cannoni nelle orecchie, senza avere paura di un nemico. Mio padre era rimasto un po’ indietro con il lavoro. Da solo non ce la poteva fare. Ma con un po’ di buona volontà si fece presto a rimettere in sesto la nostra azienda. Spesso si parlava con i miei di tutti i sacrifici e dei dispiaceri avuti, specialmente io al fronte. Mi faceva impressione rievocare tutte quelle terribili battaglie, le sofferenze della trincea, fra tante cannonate e fucilate che mi passavano vicino, e la mia lunga malattia. Ormai, visto che avevamo superato quelle difficoltà, ci pareva di essere contenti. Io dissi a mio padre che mi sarei sposato il più presto possibile. Lui e mia madre ne furono contenti, era quello che desideravano. Ne parlai con la mia fidanzata. Anche lei ne era contenta. Parlai con suo padre, ma lui disse che prima avrei dovuto aspettare che si sposassero le due sorelle maggiori, che si sposavano quell’anno. Io avrei dovuto aspettare l’anno successivo. Disse che non ce l’avrebbe fatta con le spese. A me e a Giulia questo non andava bene. Erano otto anni che si aspettava: prima perché lei era troppo giovane, poi la guerra. Ora c’erano le sorelle. Ci pareva troppo lunga l’attesa di un altro anno. Si stabilì di sposarci di giugno. Ormai gli ostacoli che impedivano il nostro matrimonio erano stati superati. Era il gennaio del 1919. Si aspettava con ansia il giorno del nostro matrimonio. Il 6 giugno fu il giorno più bello della nostra vita. Erano passati quattro anni precisi dal giugno in cui ci si doveva sposare. Tante volte durante quel tempo si era persa la speranza di poter realizzare i nostri desideri e di superare le avversità che ci avevano colpito. Il 6 giugno 1919 si andò all’altare e si giurò di esserci fedeli per 60 Monarchia tutta la vita. Io e la mia amata Giulia si rispettò la promessa. Non si badava a nessun sacrificio. Abbiamo avuto dieci figli, e uno che morì. Non ci siamo mai mortificati per le nostre disavventure. Ci fu anche il terremoto, a disturbare la nostra quiete, dopo pochi giorni dal matrimonio. Vennero diverse scosse, che fecero crollare alcune case. Si fu costretti a dormire all’aperto per quindici giorni, perché spesso venivano delle forti scosse che mettevano in pericolo la stabilità delle case. Non era bastata la guerra a metterci in subbuglio. Molti, tornando a casa, avevano trovato la campagna trascurata. Le officine erano state attrezzate per la produzione bellica e ora dovevano modificare gli impianti per una produzione diversa. Molte famiglie erano in miseria, molte nel dolore per la perdita dei cari, alcuni dei quali rappresentavano l’unico sostegno per la famiglia. Poi c’erano gli invalidi e i feriti di guerra, illusi come i disoccupati, ai quali i nostri ministri avevano promesso assistenza e occupazione. Ma finita la guerra si dimenticarono presto delle loro promesse. Il governo invece favoriva i grandi profittatori della guerra, la grossa borghesia dell’industria e del commercio, i grandi proprietari terrieri. Pensavano a come fare per pagare le spese di guerra. L’operaio e il contadino stavano con la speranza di essere ricompensati. Ma successe come dice il proverbio: ‘chi di speranza vive, disperato muore’. Vinta la guerra i nostri ministri non si ricordarono più delle loro promesse. Ma dopo le elezioni del 1919 vennero istituite le camere del lavoro, la previdenza sociale, e altre cose a favore degli operai e dei contadini. Non si chiedeva il podere per noi, come ci avevano promesso i superiori al fronte, ci bastava che fossero riconosciuti i nostri diritti. Prima c’erano determinati obblighi verso il padrone. Si doveva dargli una quantità di uova, costruire muri e strade, eravamo obbligati a fare tutto quello che voleva il padrone. Dopo l’istituzione della camera del lavoro questi lavori il padrone doveva pagarli. Inoltre il padrone aveva l’obbligo di fare tutti i lavori necessari al podere senza farli pagare al contadino, perché in genere erano opere che rimanevano al padrone anche quando il contadino lasciava il podere. Queste cose ai grandi agrari non andavano bene. Essi erano abituati a tenere i contadini come schiavi. Li tenevano 61 sotto il giogo come bestie. Con la formazione della Federterra le cose cambiarono un po’, e ci furono delle lotte, alcune anche sanguinose, che costrinsero i proprietari terrieri a cedere, a dare lavoro e a pagarlo meglio. Nel 1920 ci fu un rincaro fra i generi di ogni specie. I metallurgici avevano occupato le fabbriche e chiedevano quattro lire al giorno di aumento e tre giorni in più di ferie. Il padronato non voleva accettare, così vi furono altre cruente lotte. A questo punto non si chiedevano più solamente determinati miglioramenti di vita ma un cambio radicale nel governo del paese, visto che i ministri attuali non erano capaci di mantenere le promesse fatte, soprattutto ai combattenti. Il governo reggeva la parte dei padroni, i padroni e i fascisti difendevano i loro interessi, i proletari e i socialisti difendevano i loro. In questa situazione sorse in seno al partito socialista, guidato da alcuni intellettuali, un gruppo chiamato ‘Ordine Nuovo’, facente capo ad Antonio Gramsci. Questo movimento si sparse in tutta la nazione, e gli operai, organizzati, e i contadini della Federterra imponevano le leggi al padronato, che non poteva più fare come voleva. Gli operai avevano organizzato dei consigli di fabbrica e mandavano avanti l’azienda da soli e meglio di prima. Avevano fatto delle mense interne e distribuivano il mangiare anche alle famiglie povere. In più avevano formato delle squadre armate, chiamate ‘guardie rosse’, in difesa delle fabbriche, spesso attaccate dai fascisti che i padroni mandavano per non lasciare lavorare gli operai. Ci fu un fatto eccezionale. Una sera, dopo le nove, un gruppo di queste guardie rosse videro gironzolare intorno a una fabbrica tre uomini. Le guardie rosse chiesero a questi tre uomini cosa volevano. Loro dissero “niente, si guardava solo come si lavora in questa fabbrica”. Le guardie rosse gli dissero “se venite dentro vedrete meglio”. Questi tre individui sospetti non volevano entrare ma le guardie rosse li costrinsero a entrare. Quando furono dentro alla fabbrica li perquisirono. Avevano tre rivoltelle e tre cartoncini del fascio di combattimento. Le guardie rosse presero tre tute e le fecero indossare ai fascisti. Poi li portarono a dare il cambio a tre operai che erano ai forni. Gli dissero “ora vi renderete conto di come si lavora nelle fabbriche”. Quei tre fascisti, dopo pochi mi62 Monarchia nuti di lavoro, cominciarono a dire “ma qui si brucia”. Gli operai dicevano “voi siete fortunati che ci lavorate solo ora. Noi dobbiamo lavorare qui tutta la vita, e poi ci venite a disturbare”. I grandi industriali chiesero al governo di scatenare la forza pubblica contro gli operai che avevano occupato le fabbriche. Giolitti si oppose, perché c’erano state molte lotte che avevano cagionato 145 morti fra la guardia regia. Le forze dell’ordine poi si rifiutarono di obbedire ai loro superiori perché sapevano che gli operai erano armati, pronti a difendere la fabbrica e il loro lavoro. Così facevano i combattenti, gli invalidi, i mutilati e i feriti di guerra. Queste grandi masse chiedevano i loro diritti, e il governo era costretto a mantenere le promesse fatte. I feriti e gli invalidi di guerra superavano il milione e mezzo. Questa era la gente che gli dava più filo da torcere. Di fronte a tanta ragione il governo era costretto a cedere. Secondo me la situazione era questa: i grandi industriali e il governo si misero d’accordo per far sorgere il fascismo visto che gli operai e i contadini si erano organizzati. Con questo sistema pagarono tutti: liquidarono mutilati, invalidi, e tutti i combattenti che dovevano riscuotere l’indennizzo di mille lire per essere stati al fronte. Questa gente, permettete che lo dica, secondo me è senza scrupoli, non ha coscienza, non ha amore, non si vergogna di nulla, ha solo l’egoismo. Questa gente vive di inganni e di prepotenze, e non gliene importa nulla se vedono il popolo soffrire e fare una vita indegna. Non pensano a tutte le promesse che ci avevano fatto al fronte, a tutti i sacrifici che ci hanno fatto fare, in battaglia, nelle trincee, di vedetta. Abbiamo sofferto di tutti gli stenti, il freddo, la fame. Tanti erano rimasti congelati paralizzati agli arti dal freddo. Questi ministri senza cuore mandavano la gente a soffrire nelle trincee, pieni di pidocchi, coperti di fango e poi, giorno dopo giorno, di fronte alla morte. Infatti tanti ci hanno rimesso la vita. A chi è rimasto la ricompensa è stata quella che ora vi descriverò. 63 Fascismo Nel 1920 e 1921 fecero sorgere il fascismo. Si trattava di squadre di criminali. A capo di questa delinquenza misero Mussolini. Queste squadracce le armarono e misero a loro disposizione dei camion per combattere meglio i socialisti. Poi successero tanti fatti incredibili. Mi limito a descriverne alcuni. Il primo fatto successe nel comune di S. Nicolò, in provincia di Arezzo, alla famiglia Puri. Questo Puri era iscritto al partito socialista. Il giorno di Pasqua del 1922 passò da casa sua un camion di fascisti. Scesero e non badarono al fatto che si trattava di una festa solenne e di pace. Si avventarono sul Ferdinando Puri e lo colpirono con dei bastoni. Lo gettarono a terra di fronte alla moglie e ai figli. I parenti presenti non poterono far niente per difenderlo da quella gente armata e inferocita che mise la paura addosso a tutti. La moglie del Puri era incinta e vedendo ammazzare suo marito in quel modo senza potergli prestare il minimo aiuto, svenne. La portarono all’ospedale e il giorno dopo abortì, mentre suo marito, nello stesso ospedale, lo stesso giorno, moriva. Questi assassini furono portati in prigione ma non per essere puniti. Si voleva salvarli dalla vendetta della famiglia Puri e dei loro amici, perché il Puri, all’infuori dei fascisti, era amato e stimato. Dopo pochi giorni questi fascisti furono accompagnati alla stazione di Arezzo, al treno che li avrebbe riportati al loro comune: Pratovecchio e Stia. Il sindaco di Pratovecchio e la giunta comunale gli andarono incontro con la fanfara, come se questi assassini avessero compiuto un’azione eroica. Erano invece andati in una trentina, armati di tutto punto e a tradimento ad assassinare il Puri come un delinquente. Mentre il povero Puri era stato un difensore della patria, gli avevano fatto fare due guerre, ambedue vittoriose, l’avevano mandato a combattere in Abissinia perché i nostri ministri pensavano di portare laggiù un po’ di civiltà, invece loro la civiltà non sapevano neppure cos’era. Così fu liquidato il Puri. 65 Un fatto analogo successe in un paesino vicino a dove stavo io, chiamato Avena, alla famiglia Moneti. Una sera, dopo le dieci, quattro fascisti andarono dal Moneti e bussarono alla porta di casa. Il Moneti, che dormiva tranquillamente, sentì chiamare e si alzò, domandando chi era. Gli fu risposto “polizia. Vogliamo delle informazioni, faccia il piacere di venire un po’ giù”. Il Moneti senza perdere tempo e in buona fede aprì la porta premurosamente. Questi lo afferrarono, lo tirarono fuori e cominciarono a picchiarlo senza pietà. Il Moneti gridava “cos’ho fatto, sono innocente”. Ma questi non lo ascoltavano e seguitarono a picchiarlo senza pietà, fino a quando lo sentirono vivo. La moglie del Moneti, sentendo le grida del marito, corse fuori. Era buio. Chiamò più volte “Settimio, Settimio”. Ma Settimio non rispondeva. La moglie, col cuore trepidante, lo trovò poco dopo trucidato dalle bastonate. Morì il giorno dopo, vittima del fascismo. Poi si seppe che quello che dovevano bastonare era un altro, si erano sbagliati. Ma le autorità non difesero quell’innocente, quella era la giustizia applicata dopo la nostra vittoria. Non c’era nessuno che facesse giustizia. La ragione era sempre dei fascisti. Intanto aumentavano le adunate fasciste, le spedizioni punitive, la distruzione di cooperative di sinistra. La marcia su Roma fu fatta a spese del proletariato, anche in senso economico: furono aumentate le tasse, fu messa una tassa sul vino di venti lire al quintale e lo si vendeva a 65-70 lire. Un terzo del raccolto lo prendeva il governo, e guai a chi non rispettava queste leggi. Quando era l’ora della vendemmia bisognava avvertire il comune per avere il permesso. In comune davano un blocchetto con fogli a madre-figlia. Ogni volta che si trasportava l’uva a casa o alla fattoria bisognava annotare il carico su questo blocchetto. Se la finanza trovava qualcuno che non era in regola faceva la contravvenzione. Terminata la vendemmia bisognava dichiarare il totale del raccolto, poi passava la finanza a fare il controllo. Se la quantità prodotta risultava maggiore o inferiore alla denuncia fatta veniva fatta la contravvenzione. Ci fu il contadino a cui gli si rovesciò il tino. Questo contadino non avvisò il comune della perdita del vino. Quando passarono i finanzieri per il controllo gli trovarono quattro quintali in meno di 66 Fascismo vino che avrebbe dovuto produrre stando alla sua dichiarazione sul peso dell’uva raccolta. Ho parlato di questo fatto perché è accaduto a gente che conoscevo, ma so che casi del genere ce ne sono stati diversi. Queste erano le ricompense delle promesse fatteci al fronte per i nostri sacrifici. “Se vinceremo sarete ricompensati” dicevano i nostri superiori. Si vinse ma non ho avuto nessuna ricompensa. Non ho conosciuto né libertà, né giustizia, né pace. Ho visto invece purgare con l’olio di ricino, ho visto bastonare, ho visto ammazzare. Ma nessuno ha preso le difese di queste vittime del fascismo. Ho visto solo sacrificare i poveri. Ricordo un fatto successo ad un mio amico, un certo Rossi Niccodemo, nel comune di Pratovecchio, in provincia di Arezzo. Eravamo in un negozio di sale e tabacchi. Era di giugno, ma non faceva che piovere, era una stagione che rovinava il raccolto. Il Rossi disse “anche la stagione è d’accordo con quel testone di Mussolini per sacrificare i poveri”. Era presente anche un fascista del posto, che gli disse “cosa ti ha fatto Mussolini che lo tratti da testone”. Il Rossi disse “se non ha fatto niente a me ha fatto comunque del male a tanti”. Questo fascista disse “ti faccio arrestare, hai offeso il duce in luogo pubblico”. E così fece. Chiamò i carabinieri. Il Rossi fu portato in carcere. Passarono mesi e lui era sempre in attesa di processo. Siccome il Rossi era una degna persona tutti gli volevano bene, a parte i fascisti. Così la gente del paese, per aiutarlo, si rivolse al senatore Sanarelli. Questi fece fare un elenco di firme alla gente del paese. L’elenco di firme fu poi portato al senatore. Dopo un po’ di tempo finalmente il Rossi uscì di prigione. Nel comune di Pratovecchio successe un altro fatto, proprio al senatore Sanarelli. Questo senatore aveva un fattore che abitava in una casa vicino al fiume. Un giorno ci fu una festa fascista. Il fattore non espose la bandiera. I fascisti locali allora penetrarono in casa sua per bastonarlo ma il fattore scappò da una finestra che dava sui tetti di una casa vicina riuscendo a sfuggire ai fascisti. Questi allora andarono alla casa del senatore. La villa però era protetta tutt’intorno da una rete e per entrare bisognava sorpassare un grosso cancello di ferro. Mentre i fascisti perdevano tempo per entrare, il senatore tele67 fonò ai carabinieri. I fascisti dovettero andarsene e la villa fu piantonata per quindici giorni. Però a quei fascisti non gli fu fatto niente. Le cose peggiorarono decisamente dopo l’inizio della seconda guerra mondiale. Nel 1942, come sappiamo, ci voleva la tessera per tutto: vestiario biancheria, generi alimentari, olio, pasta. Di pane ne spettavano 250 grammi a testa. Però chi pativa la fame era il povero. Questi doveva fare i lavori più faticosi, specialmente i contadini, che dovevano lavorare quasi sedici ore al giorno. Non tutti avevano il lavoro vicino a casa. C’era gente che doveva alzarsi alle sei per essere sul posto di lavoro alle otto. 250 grammi di pane bastavano solo per la colazione e se uno faceva economia ce n’era anche a mezzogiorno, ma alla sera c’era solo poca minestra. Questa era la vita per il povero che non aveva soldi per comprarsi la roba a mercato nero. Invece i ricchi si alzavano a un’ora comoda, avevano roba e soldi, compravano e vendevano a mercato nero e nessuno diceva niente. Conoscevo un contadino che lavorava un podere con la propria famiglia. Dopo la battitura questo contadino si azzardò a non denunciare sei quintali di grano per venderli a mercato nero. Dopo aver caricato questo grano sul camion fu scoperto dai carabinieri che gli sequestrarono il grano e lo misero in galera. Al processo fu condannato a due anni di carcere e al pagamento delle spese del processo. Un altro caso successe a un mio amico che lavorava la terra di un marchese che possedeva diverse fattorie. Questo mio amico lavorava un podere molto vasto e raccoglieva circa duecento quintali di grano all’anno. Aveva una famiglia numerosa. Dopo la battitura il fattore gli lasciava un sacco di grano per sé e uno per ogni membro della famiglia, come faceva con tutti i contadini. Un giorno i carabinieri andarono a perquisire la casa di questo mio amico e gli trovarono alcuni quintali di grano in più di quelli a cui aveva diritto secondo la tessera. I carabinieri accusarono quest’uomo di aver rubato grano al padrone e lo misero in prigione. Senonché il contadino disse che il grano che aveva in più glielo aveva regalato il fattore. In attesa del processo fu arrestato anche il fattore. Dopo alcuni mesi il fattore disse che aveva avuto l’ordine dal marchese di regalare un sacco di grano ad ogni contadino e un sacco di grano per ogni membro della 68 Fascismo famiglia di ogni contadino. Appena queste cose furono appurate il fattore e il contadino furono rimessi in libertà. Di quella storia non se ne parlò più, venne tutto archiviato, perché il responsabile era un marchese. Questi faceva interessi colossali e di fronte al contadino appariva come un uomo generoso. In effetti il marchese regalava questo grano ai contadini perché questi denunciassero il raccolto che portavano alla fattoria secondo la quantità che stabiliva il padrone. Questo marchese possedeva 360 poderi. Facendo una media, per ogni podere lavorava una famiglia di dieci persone. I contadini che lavoravano per questo marchese erano infatti quasi 3600. Questo significa che il marchese regalava circa sei quintali di grano per podere. Ma su circa 2000 quintali di grano che regalava ne teneva altri 2000 per sé da rivendere a mercato nero. Il calmiere aveva stabilito il prezzo del grano a 100 lire il quintale circa, invece a mercato nero il grano veniva venduto anche a più di 3000 lire il quintale. Naturalmente faceva affari d’oro. I poveri comunque non potevano comprare a certi prezzi, così dovevano far la fame e star zitti. Se qualcuno si lamentava c’erano le squadracce con il manganello che lo zittivano subito. I fascisti approfittavano del fatto che il popolo era disorientato (molti erano alla fame) per organizzare delle bande composte da 5060 disperati. Li armavano e li pagavano per fare dei rastrellamenti, comandati da superiori fascisti. Fu così che si ebbero terribili tragedie. Nei mesi di febbraio e marzo del 1944 alcuni fedeli fascisti furono fatti entrare nelle compagnie dei ribelli partigiani per fare la spia. Potrei parlare di molti fatti di cui sono stato testimone, ma mi limito a narrarne alcuni. La prima tragedia di cui fui testimone successe nella parrocchia dove stavo io, detta Madonna dei Fossi, nel comune di Rufina, in provincia di Firenze. Ci fu uno scontro fra fascisti e partigiani. I partigiani erano nascosti nel bosco. Quando videro venire verso di loro dei fascisti spararono una raffica di mitra. Ci fu una sparatoria in cui morì un russo che combatteva insieme ai partigiani. Nelle file dei fascisti ci furono quattro morti e alcuni feriti. 69 Il secondo fatto successe nel comune di Stia, nel Casentino, in provincia di Arezzo. 17 partigiani si erano rifugiati in un bosco. Fra di loro c’era un fascista che si spacciava per partigiano. Un giorno questo fascista andò ad avvertire i suoi compagni della presenza di questi partigiani. I fascisti capitarono sul posto e colsero di sorpresa i partigiani. Li fecero tutti prigionieri e li condussero nel cimitero di Stia, dove li fucilarono tutti. Il terzo fatto successe sempre nel Casentino, alla famiglia Spighi. I fascisti diedero fuoco alla casa della famiglia Spighi. Poi presero il capofamiglia e due suoi figli e li portarono via. Li ammazzarono e li gettarono dentro a un fosso. I famigliari non riuscivano a trovarli. Tutti i vicini erano in cerca di questi tre sfortunati e li trovarono dopo due giorni di ricerche. Il quarto fatto successe a Vallucciole, sempre nel comune di Stia. Furono uccise 133 persone, fra le quali c’erano donne e bambini. Furono uccisi anche bambini che avevano pochi mesi. Dopo aver ucciso le persone che avevano trovato, i fascisti diedero fuoco alle case. Bruciarono tutto, ma dopo aver saccheggiato le case, come erano soliti fare. Avevano carta bianca, potevano fare quello che volevano, nessuno gli faceva nulla. Di questi fatti ne successero a centinaia. Ora parlerò del quinto fatto, accaduto a me e ad altre due famiglie vicine. Era il 17 aprile 1944. Quel giorno ci fu troncata definitivamente la felicità che ci restava. Al mattino verso le sei vennero a casa mia sette partigiani. Mi chiesero alloggio per poche ore, dicendo che erano stanchi perché avevano camminato tutta la notte e non ce la facevano più ad andare avanti. Nel sentire che avevano tanto bisogno mi fecero compassione. Li avvertii che il posto non era il più indicato perché c’era la monta taurina, c’erano i verri, e veniva gente anche da fuori, che nessuno conosceva, e che poteva fare del male sia a me che a loro. Per il loro bene gli consigliai di andare in un posto dove capitava meno gente sconosciuta. Mi dissero che ormai erano arrivati lì e ora avevano paura di essere visti dai fascisti e che avrebbe fatto loro piacere un po’ di riposo. Mentre si parlava 70 Fascismo giunse un mio vicino di casa. Disse ai partigiani di andare a casa sua, che sarebbero stati più sicuri. Ma loro non vollero andare. Visto che erano decisi a rimanere da me il mio vicino andò a prendere vino, pane e formaggio. Io misi a disposizione le stesse cose, sperando che dopo aver mangiato ed essersi riposati se ne andassero come avevano promesso. Invece uno di questi partigiani, dopo aver mangiato, si tolse il giubbotto e si mise a lavarlo nella vasca. Io mi avvicinai e gli dissi che non era così che si era combinato. Gli ripetei che era rischioso per lui farsi vedere. Lui disse “anche se mi vedono, non hanno mica il telefono in tasca”. Io insistevo che non era prudente restare. Gli dissi che o se ne andavano nella capanna o andavano via. Questo partigiano disse “vado a farmi attaccare un bottone poi andiamo via”. Mentre questi era dalla sartina si udirono in lontananza degli spari di fucile. Andai da quelli che erano nella capanna. Alcuni si erano tolte le scarpe. Dissi “avevate promesso che dopo aver mangiato sareste ripartiti. Ora si sentono degli spari e non state neppure all’erta”. Continuai a pregarli di andare via. Due di loro avevano le scarpe ai piedi e mi davano ragione, ma gli altri no. Io andai da quello che era dalla sartina. Pareva che fosse lui il capo di quella squadra. Mentre camminavo udii altri spari. Quello era sempre dalla sartina e quando lo vidi mi parve che fosse tranquillo, non aveva nessuna paura. Io gli dissi “quando siete arrivati avevate tanta paura di essere visti. Ora sentite degli spari e non avete paura”. Quello disse “sono i nostri compagni che sparano”. Io, che mi sentivo nei guai, gli dissi bruscamente “voi siete falsi. Quando siete arrivati avevate tanta paura di essere visti e avevate promesso che dopo esservi riposati sareste ripartiti subito. Vi abbiamo anche dato da mangiare e ora volete rovinarci. Se sono i vostri compagni che sparano, non c’era motivo di avere paura neppure quando siete arrivati”. Avevo i nervi a fior di pelle. Questo mi vide così irato che sfilò la rivoltella e me la spianò contro. Disse “se venite con le cattive io vi sparo”. Poi aggiunse “qui siamo al sicuro e di qui non ripartiamo”. Anche la sartina e sua madre pregavano questo partigiano di andarsene. Ma lui era risoluto a restare e non ci fu modo di convincerlo. Mentre si discuteva vidi un operaio della fattoria che abitava vicino a me. Per sentito dire era un 71 poco di buono. Io avvertii di questo fatto il partigiano. Lui disse “a noi non ci fa paura nessuno”, e gli andò incontro. L’operaio entrò in casa sua e questo partigiano lo seguì. Io seguii loro, tenendomi a una quarantina di metri di distanza. Mi avvicinai pian piano alla casa di questo operaio. Nei dintorni c’erano altri operai che erano venuti via dal bosco perché avevano sentito sparare. A uno di questi operai un mese prima gli fu ammazzato il fratello dai tedeschi mentre fuggiva nel bosco. Mentre parlavo con loro uscirono dalla casa il partigiano e l’operaio. Gli domandai se conosceva quel partigiano. Lui mi rispose che una volta gli aveva portato una lettera, in un posto chiamato Graina. Io pregai questo operaio di non dire nulla al fattore di quei partigiani, perché sapevo che il fattore era un fascista. L’operaio mi promise che avrebbe mantenuto il segreto. Poi aggiunse “devo andare perché il fattore mi aspetta”. Nel frattempo le fucilate erano cessate e gli operai tornarono al lavoro. Il partigiano tornò dalla sartina. Io tornai alla capanna per vedere se riuscivo a convincere gli altri ad andarsene. Ma erano solo in due a darmi retta, quelli che avevano le scarpe ai piedi, che dissero “se voi non venite ce ne andiamo noi due soli”, e si accinsero a partire. Nello stesso momento arrivò quello che era dalla sartina. Aveva la rivoltella in mano. Tutto invelenito disse, ai due che volevano andarsene “qui si sta alla sorte, di qui non parte nessuno”. Quelli che volevano andar via rimasero zitti e non reagirono. Poi cominciarono a spingermi fuori dicendomi che se non smettevo di molestarli mi avrebbero sistemato loro stessi. Io non sapevo più cosa fare. Pensai di darmi alla macchia. Tornai a casa per consigliarmi con mia moglie e i miei figli più grandi. Due partigiani mi seguirono, dicendo che andavano a prendere le sigarette. Entrai in casa. Anche mia moglie e le mie figlie non sapevano cosa consigliarmi. Andare nel bosco era troppo rischioso. Proprio un mese prima era stato fatto un rastrellamento dai Tedeschi e tutti quelli che furon trovati fuori casa vennero presi: anche un pastore che pascolava le pecore, un operaio che accomodava una strada, altri che lavoravano nei campi; quelli che erano in casa venivano lasciati in pace. Quelli che erano fuori casa li presero tutti. Se qualcuno tentava di scappare gli sparavano. Questa sorte toccò anche a un certo Cecconi Virgilio. 72 Fascismo Questi era in casa sua ma scappò dicendo che fuori sarebbe stato più sicuro. Invece quando i Tedeschi lo videro scappare gli spararono e lo uccisero. Quelli che venivano presi li portavano ad Arezzo, che era distante circa sessanta chilometri. Ad Arezzo li facevano scendere dai camion e li davano in consegna ai fascisti. Questi operai, contadini, pastori, venivano bastonati dai fascisti di Arezzo. Molti, a causa delle percosse, dovettero poi essere ricoverati nell’ospedale della città. Noi, pensando a queste cose, si decise di rimanere in casa sapendo di non aver fatto male a nessuno. Anche i boscaioli erano venuti via dal bosco, pensando che sarebbero stati più sicuri in casa loro. Poi noi eravamo dodici persone e non era facile nascondersi. C’erano anche dei bambini piccoli. Si decise di nascondere il ragazzo della classe 1925, perché questa classe era già stata richiamata e se lo avessero trovato in casa l’avrebbero fucilato o deportato, e un suo fratello. Uscii di casa per nascondere questi due figli. Vidi allora un gruppo di soldati tedeschi avvicinarsi alla capanna. Passai dietro la casa per nascondere i miei figli. Mentre si stava scegliendo il nascondiglio udimmo dei colpi di fucile provenire dalla casa. Ormai quei due miei figli erano al sicuro e io volevo tornare a casa. Mentre camminavo udii altri spari. Ero giunto a duecento metri da casa quando vidi venire verso di me due mie figlie, correndo. Una teneva due bambini per mano. Mentre correva verso di me si udirono ripetuti colpi di arma da fuoco. Sparavano contro di noi. Vidi la ragazza che teneva i bambini per mano cadere in terra. Credevo fosse stata colpita. Mi vennero i brividi. Mi pareva di essere al fronte, nella guerra del 1518. Mi alzai per prestare loro soccorso ma mia figlia disse che non erano stati colpiti. Le dissi di non alzarsi e di far mettere a terra anche i fratellini e di raggiungermi a carponi, per non fare da bersaglio. Quelli seguitavano a sparare. Si sentivano fischiare le pallottole sopra la testa. Eravamo costretti a rimanere lì per non essere colpiti. Mia figlia disse che avevano ammazzato due dei partigiani che erano nella capanna. Poi i fascisti avevano dato fuoco alla capanna. Quando lei vide queste cose tornò in casa per prendere il denaro che aveva lasciato. Mia moglie stava aspettando che tornasse Bruna, un’altra figlia. 73 Così scapparono Elina e Vera con i due fratellini. Questo fu il racconto della mia figliola. Mentre si aspettava con l’animo sospeso di veder arrivare gli altri della famiglia si udirono altri spari. Poi udii un urlo, era una delle mie figlie che non era con noi. Persi la speranza di veder arrivare quelli che aspettavo. Io mi sarei precipitato per andare da loro. Avrei rischiato la vita per dar loro anche il minimo aiuto, sentivo che erano in una tremenda situazione, ma avevo con me altri quattro figli che volevano seguirmi fino a casa e io non volevo che ci fossero altre vittime. Ero così addolorato per quella tremenda situazione che svenni. Non posso dire quanto tempo rimasi senza conoscenza. Quando ripresi i sensi mi pareva di aver dormito a lungo e di aver fatto un brutto sogno. Ma purtroppo non si trattava di un sogno. Appena riaprii gli occhi vidi davanti a me i miei quattro figli, spaventati. Le fucilate non si sentivano più. Mi alzai in piedi e vidi la mia casa e quelle dei miei vicini bruciare. Non vedevo nessuno dei miei cari rimasti a casa. Per ascoltare non respiravo neppure. Col cuore impietrito dalla paura mi precipitai verso casa. Ma non vidi nessuno. Vidi solo il fumo uscire dalle finestre e dalla porta di casa. Più mi avvicinavo e più perdevo la speranza di rivedere gli altri miei cari. Per entrare in casa dovevo passare davanti alla stalla. Vidi che avevano slegato tutte le bestie, che erano andate nel campo. Era rimasto solo il toro, perché non erano riusciti a slegarlo. Il toro era morto, asfissiato dal fumo. Io pensai “se hanno avuto pietà delle bestie avranno avuto rispetto dei cristiani”. Pensai che forse i miei cari li avevano portati via. Mi avvicinai alla porta di casa. Sentii correre per le scale di casa e rimasi sorpreso. Pensai si trattasse dei fascisti, perché i passi erano quelli di uomini adulti. Uscirono dalla casa due contadini che abitavano vicino a me. Erano molto turbati e impressionati. Mi dissero “fatevi coraggio, noi torniamo subito”. Io capii che in casa c’era stata una tragedia. Ma non avrei mai pensato di trovarmi di fronte a quello che vidi. Mia moglie e le mie figlie erano state barbaramente assassinate. Per prima vidi la figlia maggiore. Era distesa sul pavimento, morta, in una pozza di sangue. Era stata colpita al cuore, non ci sarebbe stata nessuna speranza di salvarla. Cercai le altre. Erano in 74 Fascismo un’altra stanza, in un lago di sangue, tutte morte. Sia le mie figlie che mia moglie erano irriconoscibili. Erano state trucidate in un modo indescrivibile. Non so parlare dell’impressione che mi fece quella scena, non ci riuscirei. Avevano tutte il cranio spezzato. Mia moglie aveva ancora la piccola Anna fra le braccia, contro il seno, e la teneva come un pegno adorato, morta, con la fronte e il cranio spezzati. C’erano pezzi di cervello attaccati alle pareti e sui vetri della finestra. Un’altra bambina di nove anni dava segni di vita. La presi in braccio, sperando di poterla salvare, e la portai fuori perché in casa non si poteva respirare, c’era un fumo molto denso e un gran calore. Appena fui fuori la bambini mi diede un ultimo sguardo e mi spirò fra le braccia. Anche lei aveva il cranio spezzato e si vedeva il cervello appiccicato ai capelli. Io credo che non ci siano persone più barbare dei fascisti. Chissà chi può capire il mio stato d’animo in quei momenti. Non so chi mi diede la costanza da resistere al dolore, in quella stanza, trovandomi di fronte alle mie figlie e a mia moglie nell’immobilità della morte, distese sul pavimento, i corpi senza vita. Pensai alla loro agonia nel vedersi intorno solo quei carnefici che picchiavano senza pietà. Immaginai la loro angoscia nel trovarsi senza una via di scampo. Non mi restava che piangere e baciarle sulla fronte ormai gelida e chiedere loro perdono perché non avevo saputo proteggerle. Questo fatto mi causò una ferita nel cuore che sanguinerà finché avrò vita. Veder trattare così la gente è la peggior cosa che possa capitare a un uomo. Donne e bambini assassinati in quel modo, innocenti, senza nessuna colpa, cose che non sembrano vere. Le uccisero perché avevamo fatto un’opera di carità, perché avevamo dato un pezzo di pane a chi aveva fame. Forse è stato per questo che hanno trucidato tante persone. Perché i fascisti non volevano che si aiutasse i partigiani. Però erano venuti anche dei fascisti a chiedere qualcosa da mangiare e noi, vedendoli affamati, gli avevamo dato da mangiare. Ad ogni modo la mia famiglia non si meritava di essere trucidata 75 così, solo per aver dato da mangiare ai partigiani. E poi che colpa avevano le bambine. Una delle mie figlie uccise aveva tre anni. In quella strage perirono undici persone, fra cui mia moglie e quattro mie figlie. Mia moglie mi amava fin da quando era una bambina. Era sempre amorosa verso di me e degna di essere amata. Io l’amavo come me stesso. Da allora il mondo per me è diventato una tetra prigione. A causa di quella gente. Gente che andava per le case a uccidere, a rubare e incendiare. Illusi: credevano di trovare la felicità nella vendetta e nel potere. Avevano fiducia in Mussolini. Per loro Mussolini era un dio in terra, andavano dicendo che Mussolini non sbagliava mai. Si è visto poi come è finita. Si assistette a tante tragedie. C’era chi ne approfittava per violentare le donne. Nella popolazione aumentava sempre più l’odio contro i Tedeschi e i fascisti. I Tedeschi portavano via tutto quello che gli faceva comodo, anche i materassi dai letti. Portavano via grano, vino, bestiame, uomini giovani e abili per il lavoro. Io avevo due figli, uno del ventotto e l’altro del venticinque. Furono costretti a nascondersi in una buca sotto terra, per più di un mese perché in casa c’erano i Tedeschi. Spesso le case venivano ispezionate dai Tedeschi, che portavano via tutti gli uomini che trovavano. Il mio figlio più giovane non resistette sotto terra e una notte tornò a casa. Il giorno dopo fu preso dai Tedeschi e portato via insieme ad altri. Appena fu di nuovo buio lui e altri due compagni riuscirono a scappare attraverso i campi. Lui dovette tornare nella buca, per uscirne solo quando i Tedeschi se ne andarono. Non si può descrivere le paure e le angherie che bisognava subire. Un giorno c’erano dei Tedeschi in casa mia. Arrivano degli Inglesi e si accorgono che in casa ci sono i Tedeschi. Cominciano a sparare cannonate contro la casa. Si fece appena in tempo a entrare nel rifugio che la casa fu traforata dalle cannonate. Un mio cognato fu colpito da una scheggia e rimase ferito leggermente. Nella stalla rimase ferita gravemente una mucca. Due camere andarono distrutte insieme al mobilio. Io ho fatto quasi quattro anni di guerra ma non ebbi mai paura come quella volta. 76 Fascismo Un giorno vennero quattro Tedeschi a prendere delle bestie, con un camion, come facevano dappertutto. Io mandai ad avvertire il fattore. Nel frattempo i Tedeschi caricarono sul camion un maiale che era mio, due manze e un vitello. In tutto saranno stati dodici quintali di carne. Mentre stavano per finire di caricare giunsero il fattore e due ufficiali tedeschi. Fecero una lunga discussione fra di loro ma le bestie le portarono via ugualmente. Io avevo mandato a chiamare il fattore perché non pensasse che io avevo fatto un interesse personale. Pensavo continuamente alla mia famiglia, barbaramente distrutta dai fascisti. Avevo perso anche la fiducia in Dio. Avevo perso il controllo della mia vita in quella terribile burrasca. Passarono mesi e anni ma non trovai più pace. Anche di notte stavo ore e ore sveglio, pensando a come potevo trovare i responsabili. Volevo vendicare quelle vittime innocenti. Avevo perso la fiducia in tutto. Pensavo che se davvero c’era un dio non doveva permettere certe cose. Mi pareva di avere gli spiriti addosso. Nessuno prendeva le mie difese. Mi sarei tolto la vita da me per levarmi da una vita così infelice. Cominciavo a odiare tutti. Il mio dolore aumentava sempre più vedendo quel vuoto nella mia famiglia. Col cuore infranto dal dolore pensavo “cosa conta vivere in queste tenebre?”. Erano state trucidate le persone che amavo di più, ma avevo altri figli che mi stavano altrettanto a cuore e se mi fossi ammazzato avrebbero sofferto ancora di più. Decisi così di restare nel dolore ma insieme ai miei figli. Pensai poi che nella vendetta non avrei trovato la pace che cercavo. Mi rimisi alla volontà di Dio. Lessi e riflettei parecchie volte sul discorso della montagna, nel Vangelo, e questo mi diede un po’ di sollievo. Però mi restò la pena che provavo nel vedere il Vaticano andare contro il Vangelo. Troppa differenza passa fra quello che diceva di fare Gesù Cristo e quello che si vede fare dal Vaticano. Sono i farisei di oggi. Gesù Cristo diceva ‘ama il prossimo tuo come te stesso’ invece il Papa benedice le armi dei criminali che servono per ammazzare il prossimo. Anche la mia famiglia era stata distrutta con le armi benedette dal Papa. Questo mi rattrista perché io sono credente. 77 La Democrazia Cristiana Amavo mia moglie come me stesso. Era l’unica speranza della mia vita. Cercherò di farle giustizia scoprendo i suoi carnefici, a costo di qualsiasi sacrificio. Voglio portare alla luce tutto quello che posso. Non lo faccio solo per rendere giustizia alle vittime innocenti ma anche per aprire gli occhi a coloro che sono all’oscuro di tante cose. Ai miei tempi questi erano tanti, perché il popolo era tenuto come schiavo, e anche al giorno d’oggi tante cose è bene dirle perché si sappiano. La gente dei miei posti era intimorita dal padrone e dal fattore. Se qualcuno sapeva qualcosa non parlava, per non mettersi contro gente troppo potente. Anch’io sapevo che era un rischio parlare e che la ragione era sempre dei fascisti e dei padroni ma ero spinto da tanta passione che non potevo stare zitto, era così evidente la mia ragione che non potevo non reagire. Mi sentivo deciso, anche per la fame di giustizia che avevo. Appena finita la guerra cominciai a indagare, giorno e notte, con quell’ansia di scoprire i colpevoli di quella strage. Quello di cui sospettavo maggiormente era il fattore, perché era un accanito fascista e capo settore della zona. Pochi giorni prima della strage questo fattore aveva detto: “Questo posto va bruciato perché i partigiani portano via tutto”. Si riferiva alla mia casa, che infatti poi fu bruciata. Un giorno venne da me. Aveva un foglio su cui c’era scritto tutto quello che avevano preso i partigiani nella fattoria. Questa nota la fece vedere anche a mia moglie. C’erano segnate anche le scarpe che poi furono trovate ai piedi dei partigiani ammazzati la mattina della strage. Quando ci presentò questa lista mancavano otto giorni alla strage. Il fattore si era lamentato spesso con noi dei partigiani. Io, che vagliavo questi fatti, pensavo che il fattore fosse uno dei responsabili dell’eccidio. Anche perché il fattore aveva ammazzato un inglese in fattoria. Questo inglese era stato fatto prigioniero dell’esercito fascista. Fu lasciato libero quando si sciolse l’esercito italiano. Questo inglese un giorno andò alla fattoria. Il fattore non c’era. La madre e la moglie del fattore lo fecero 79 sedere a tavola e gli diedero da mangiare. Quando arrivò il fattore l’inglese gli chiese duemila lire. Il fattore fece una brontolata e andò allo scrittoio. Mentre il fattore era nello scrittoio l’inglese preparò una ricevuta, credendo che il fattore gli portasse il denaro. Invece il fattore tornò e gli sparò. La ricevuta rimase sopra la tavola. L’inglese fu portato nello scrittoio. Chiamarono il dottore, a cui dissero che l’inglese era armato e aveva puntato la rivoltella contro il figlio del fattore chiedendo dei soldi. Il fattore avrebbe sparato per difendere il figlio. Ma il dottore non rimase convinto perché trovò l’inglese che aveva ancora il boccone in bocca. In più il fattore gli fece leggere quel foglio scritto in inglese che lui non capiva. Il dottore lesse ad alta voce quello che c’era scritto su quel foglio, in presenza di tutti coloro che lavoravano in fattoria. Oltre ai familiari del dottore erano presenti due sotto-fattori, il cuoco e un cantiniere. Il dottore tradusse in italiano quello che c’era scritto sulla ricevuta. C’era scritto: “Iddio salvi l’Italia e l’Inghilterra. La ringrazio del denaro ricevuto. Quando arriveranno gli alleati sarà ricompensato”. Sotto c’era la firma. Il dottore si accorse subito che il fattore mentiva. Fece un verbale preciso sul come aveva trovato la situazione. Però la ricevuta dell’inglese non fu più ritrovata, e il dottore morì poco tempo dopo in un incidente stradale. Il fattore, al processo, venne assolto per agito per legittima difesa. Io, che avevo quella bramosia di giustizia, prendevo nota di queste cose, dopo aver indagato. Venni poi a sapere un’altra cosa molto importante, un anno dopo la strage di Berceto, durante un colloquio col marchese, che mi lasciò un’impressione strana. Un giorno il marchese, proprietario della fattoria, venne a trovarmi. Si cominciò a parlare della strage fatta a casa mia. Io gli dissi: “Credo che senza il suo permesso non avrebbero osato venire a casa mia a fare quella strage”. Lui rimase impressionato, poi mi rispose: “Io glielo dissi, non fate come a Vallucciole”. Domandai: “A chi lo ha detto non fate come a Vallucciole?”, mi rispose: “Erano tedeschi, e io non li conoscevo”. Non mi volle dire altro, però ebbi l’impressione che lui sapesse qualcosa della strage di casa mia. A questo colloquio era presente anche un fattore, un certo Perpoli. 80 La Democrazia Cristiana Il giorno dopo andai da questo fattore per sentire cosa ne pensava del colloquio del giorno prima. Anche lui pensava che il marchese sapesse qualcosa stando a quello che aveva udito. In me aumentava la bramosia di saper la verità. Ma nessuno voleva aiutarmi, neanche i miei vicini. Se anche sapevano qualcosa cercavano di schivarmi perché sapevano che io volevo scoprire la verità e smascherare i criminali. Erano pochi coloro che avevano il coraggio di mettersi contro il padrone e il fattore. Io, invece, avevo sempre più sete di giustizia e cresceva il mio tormento nel vedere che tanti si rifiutavano di parlare di questi criminali. Tacevano anche coloro ai quali erano stati uccisi dei familiari, avevano tutti paura di parlare, come un giorno potei constatare. Il fattore mandò a chiamare tutti i capofamiglia a cui erano stati uccisi dei familiari. Il Soldeti Gino, Guido Ebicci e me. Appena si giunse alla fattoria questo fattore, coi suoi modi fascisti, tutto arrabbiato, si scagliò contro di noi dicendo: “Se continuate a fare indagini su di me vi denuncio, vi faccio arrestare, perché io sono innocente. Non voglio più sentir dire che io sono implicato in questi fatti. So che voi avete detto che sono responsabile della morte dei vostri cari. Se lo ripeterete avrete altri dispiaceri”. Mentre parlava saltava e batteva le mani sul tavolo, inviperito. Un operaio rimase zitto e l’altro gli chiese scusa, dicendo che non avrebbe più coinvolto il fattore nelle sue faccende. Eravamo in tre e io mi sentii abbandonato anche da coloro a cui avevano ammazzato i cari: a uno il padre e la moglie, all’altro il padre e una figlia. Come potevo sperare che qualcuno mi aiutasse? Io dissi: “Senta fattore, lei dice di essere innocente, allora perché si arrabbia tanto se noi cerchiamo i responsabili. Non dovrebbe aver paura se veramente è innocente. Il suo modo di fare mi fa dubitare di lei perché se veramente si sentisse innocente ci aiuterebbe a trovare quei criminali, anche perché la fattoria stessa ha subito dei danni. E poi siamo suoi operai, lei dovrebbe stare dalla nostra parte. E non creda che io le porti rispetto perché lei è il fattore o perché si fa vedere così offeso. Non rispetterei nemmeno mio fratello se lo sapessi responsabile di un così tremendo crimine”. Il fattore si calmò e poi disse che se avessi saputo qualcosa ci avrebbe informati. Così si andò via. Nel tornare a casa si parlava di questo 81 incontro con il fattore. Io dissi che sarebbe stato bene querelarlo. Uno dei due si rifiutò, perché aveva paura. Io, che continuavo sempre a indagare per scoprire qualcosa di nuovo, venni a sapere che questo fattore aveva mandato tre lettere ad un partigiano che in effetti era una spia dei fascisti. Una di queste l’aveva mandata a Berceto la mattina della strage. Io ero sempre più convinto che il fattore fosse uno dei responsabili della mia tragedia. Appena fui sicuro del fatto mio tornai dal fattore. Era in casa e mi portò allo scrittoio. Io gli chiesi se aveva saputo qualcosa, come eravamo rimasti d’accordo. Lui disse, un po’ annoiato: “Chi volete che mi abbia detto qualcosa, non ho saputo nulla da nessuno”. Io, che ero sicuro che lui sapesse la verità, dissi: “se lei vuole non ha bisogno di farsi dare informazioni da nessuno. Mi dica chi è colui al quale mandava le lettere. Ne ha mandata una anche la mattina della strage”. Lui si turbò e disse che non aveva mandato nessuna lettera. Io avevo tre testimoni che asserivano il contrario. Anche un mio figlio aveva visto il Fossati, uomo del fattore, consegnare una lettera a quella spia. Glielo dissi, ma il fattore negò. Io insistetti e quando vide che ero sicuro del fatto mio disse: “Se volete venticinque o trenta io posso darvele”. Io dissi: “Cosa significa questa cifra?”. Lui, credendo di avermi offerto una cifra troppo bassa, disse: “Anche sessanta o settanta”. Io mi persuasi che il fattore era veramente uno dei responsabili. Mi sentii offeso nel vedermi offrire del denaro. Gli dissi: “Non sono venuto qui per vendicarmi, non voglio denaro. Voglio che mi dica chi era colui al quale mandava le lettere”. Il fattore disse: “Ne ho mandata una sola al capo formazione di un gruppo di partigiani, Ferrero Ferrieri, a Bucigna. Non ne ho mandate altre”. Io ero sicuro che invece ne aveva mandate tre, compresa quella che il Fossati consegnò la mattina stessa della strage. Non resistevo più, avevo i nervi a fior di pelle. Mi rivoltai e dissi: “Non sono un delinquente come pensa lei e non mi vendo per denaro. Lei è uno dei responsabili della strage. Lei sapeva che quello a cui mandava le lettere era una spia dei fascisti, perché fu lui che ammazzò i due veri partigiani del gruppo, quelli che le avevano preso due paia di scarpe. Fu quello a cui lei mandava le lettere che mi spinse fuori malamente dalla capanna, che puntò la rivoltella contro 82 La Democrazia Cristiana di me e i due partigiani che volevano andarsene, dicendo che dovevano stare tutti alla sorte. Lo sapeva lui a chi sarebbe toccata la sorte. Lei teneva informata questa spia. Lei sa tutto e nega perché è uno dei responsabili della strage. Lei è un vigliacco perché ha ammazzato quell’inglese mentre era seduto a tavola a mangiare. Lei ha detto che quell’inglese voleva rubare nello scrittoio tenendo la rivoltella puntata contro suo figlio. Lei lo ha ammazzato e calunniato”. Gli dissi parole grosse. Lui chiamò sua madre perché non sapeva più come difendersi. L’avevo preso con le buone e con le cattive ma lui non volle dir niente. Quando arrivò sua madre io me ne andai, senza salutare. Dopo vari mesi dalla fine della guerra ero venuto a conoscenza di parecchie cose, a furia di domandare e indagare. La mia intenzione era quella di smascherare i colpevoli e i responsabili della strage. La spia che riceveva le lettere dal fattore la scoprii un anno dopo, per mezzo di una fotografia di quei due partigiani che furono ammazzati la mattina della strage. Questa fotografia mi capitò fra le mani per caso. Dietro c’era scritto il nome e l’indirizzo di uno dei due partigiani, che era Chiti Mauro. Pochi giorni dopo seppi da un certo Ponticelli Torello, che abitava in una piccola frazione detta “Il Guardo”, in provincia di Arezzo, dove i fascisti avevano lasciato il camion la mattina della strage, il 17 aprile del 1944, come si svolsero i fatti. Alcuni fascisti erano rimasti di guardia al camion. Quando tornarono quelli che avevano fatto il rastrellamento quelli che erano rimasti di guardia gli chiesero come erano andate le cose. Uno di loro, vestito da partigiano, disse: “Oggi è andata davvero bene. Abbiamo ucciso undici ribelli, fra i quali c’erano due del comando di liberazione nazionale. Eravamo dentro a una capanna di un contadino che voleva mandarci via. Quando si udirono i primi spari quei due partigiani vollero andarsene. Ma io gli ho puntato contro la rivoltella e li ho fatti restare. Poi abbiamo buttato fuori a spinte il contadino. Quando sono arrivati i nostri amici abbiamo ucciso i due partigiani e sterminato le famiglie che stavano nei paraggi”. Questo Ponticelli Torello era dietro la siepe del suo orto, accucciato e zitto, e ascoltò tutte queste cose che dicevano i fascisti. Si diede il caso che io venni a sapere questo fatto e andai a trovare il Ponticelli. Gli chie83 si se era vero che aveva assistito a un colloquio del genere. Lo trovai veramente coraggioso. Mi ripeté tutto quello che aveva udito. Gli chiesi se sarebbe stato disposto a testimoniare in un processo, a dire la verità. Lui rispose di sì. Lo ringraziai e tornai a casa molto soddisfatto. Poi misi in chiaro un’altra cosa. Il fattore Franciolini diceva di aver mandato quella famosa lettera a Ferrero Ferrieri per parlargli di una faccenda di grano che riguardava un certo Onofelli Placido. Qui è necessario far presente il valore di questa lettera. Le cose si svolsero così: Onofelli Placido era andato al mulino di Bucigna, disperato, perché non aveva da fare il pane per la sua famiglia. Aveva sei figli, il più grande dei quali aveva solo diciassette anni. Si era lamentato perché non aveva pane a sufficienza per sfamare i suoi figli. In questa occasione incontrò un capo partigiano chiamato Ferrero Ferrieri, che gli scrisse un biglietto il fattore Franciolini, dove gli ordinava di dare il grano all’Onofelli. In caso contrario sarebbe intervenuto lui stesso. Placido, che era operaio del fattore, portò lui stesso il biglietto alla fattoria. Quando il fattore lo lesse disse che lui il grano non l’aveva e non poteva darglielo. Poi disse: “Ora scrivo una lettera a questo Ferrero Ferrieri per sentire cosa vuol fare se viene di persona”. Così scrisse questa lettera, dicendo che era per il capo partigiano. Poi chiamò un certo Fossati Edoardo e gli diede la lettera, mandando ambedue gli operai a consegnarla. Ma il Fossati era d’accordo con il fattore di consegnare la lettera a una spia, certo Toci del Medico Osvaldo. Quando lo incontrarono il Toci disse loro: “Dove andate?”. I due operai dissero: “Andiamo a consegnare questa lettera a un capo partigiano, Ferrero Ferrieri, ci manda il Fattore di Pomino”. Il Tosi disse: “Là non ci potete andare, datela a me, gliela farò avere io”. Il Fossati disse: “Il fattore aspetta una risposta”, e gli consegnò la lettera. Il Toci prese la lettera e la portò a un certo Onitulli Rolando, anche lui falso partigiano, spia dei fascisti. Il Toci tornò poi dai due operai, dicendo che Ferrieri stava rispondendo al fattore. Invece Ferrieri non sapeva niente. Al fattore rispose questo Onitulli Rolando. Tutte queste cose le seppi in seguito; io non mi stancavo di cercare, avevo dentro una smania di fare giustizia. Non avrei avuto pace fino a quando non avessi scoperto i responsabili della strage. Il Franciolini 84 La Democrazia Cristiana Giuliano, dopo essere stato assolto dall’accusa di aver ucciso l’inglese, riprese servizio in fattoria. Capii che dovevo combattere anche contro la gente molto potente. Vedevo infatti certa gente protetta anche dalle autorità e questo mi faceva aumentare il dolore e l’odio contro il loro. Un giorno, non riuscivo più a resistere, denunciai il fattore Franciolini e il marchese Frescobaldi, che sospettavo responsabili della strage fatta a Berceto. Passarono due anni e non si sentì niente. Avevo messo al corrente della denuncia i carabinieri e il tribunale ma nessuno si mosse. Io presi i documenti che avevo e andai a Roma dai miei cinque nipoti. Eravamo nei primi mesi del 1947, uno dei miei nipoti aveva stretto amicizia col ministro di grazia e giustizia. Questo mio nipote mi accompagnò lui stesso dal ministro. Appena si videro mio nipote e questo funzionario si salutarono cordialmente. Poi fui presentato. Quindi mi misi a parlare della strage di Berceto e gli dissi tutto quello che era riuscito a scoprire. Questi mi chiese se avevo sporto denuncia. Io gli mostrai tutti i documenti che avevo e gli dissi che avevo già messo le autorità al corrente di tutto, ma erano passati due anni e nessuno aveva fatto niente. Gli dissi che ero andato a Roma perché non sapevo più cosa fare. Lui disse: “Bastano questi dati per far condannare la gente che ha denunciato”. Poi quest’uomo, molto gentile, dimostrò di prendere a cuore la mia situazione e disse: “Proverò a scrivere una lettera io al procuratore generale di Firenze”. Mi chiese se io avevo l’opportunità di andare a Firenze. Gli risposi di sì e lui disse che la lettera l’avrebbe data a me da recapitare. Scrisse subito la lettera e la mise in una busta, applicandovi il timbro del suo ufficio, e me la consegnò. Mi pareva un sogno essere stato a contatto con quella grande personalità che aveva preso le mie difese. Non sapevo come ringraziarlo per il suo interessamento. Nel sentir dire che sarebbero bastati quei dati per far condannare i responsabili della strage mi ero sentito pieno di gioia e di speranza. Presi la lettera e lo ringraziai di nuovo per il grande favore che mi faceva. Questo alto funzionario mi diede la mano e mi disse: “Stia tranquillo. Se avrà ancora bisogno di me venga pure, quello che potrò fare lo farò volentieri”. Mi augurò buona fortuna e mi batté una mano sulla spalla. Poi disse: “Io e suo nipote ci aiutia85 mo a vicenda”. Così ci salutammo. Io partii, con quell’ansia di consegnare quella lettera al procuratore generale di Firenze. Andai alla Corte d’Assise, all’ufficio del procuratore generale, che però non c’era. C’era il suo segretario, a cui dissi che dovevo consegnare una lettera al procuratore generale. Il segretario disse: “Il procuratore generale è ammalato, la dia a me che ci penso io”. Io gli dissi che dovevo consegnarla di persona. Questo segretario mi guardò e disse: “Allora torni quando il procuratore sarà guarito. Non vorrà andare a casa sua”. Gli mostrai la lettera e gli dissi che si trattava una cosa urgente. Quando vide la busta con il timbro del Ministero di Grazia e Giustizia si alzò di scatto e cambiò subito tono. Diventò gentile e disse: “Provo a telefonargli a casa e guardo se la può ricevere subito”. Telefonò. Poi mi diede l’indirizzo del procuratore generale e mi disse che potevo andare a casa sua. Il procuratore era veramente infermo: aveva una gamba ingessata ed era disteso sopra una poltrona. Lo salutai chiedendogli scusa per il disturbo e gli consegnai la lettera. Lui mi chiese come facevo ad essere in contatto con un funzionario così importante. Gli risposi che era amico con un mio nipote. Lui lesse la lettera e disse: “Ho capito. Faremo tutto il possibile, può andare tranquillo”. Io lo ringraziai e me ne andai, tutto soddisfatto. Tornai a casa e raccontai ai miei figli e ai miei vicini quello che avevo fatto e ottenuto. Dopo pochi giorni arrivò l’avviso del tribunale di Pontassieve a tutti quelli che avevo citato come testimoni e a quelli che avevo denunciato, oltre a me e alle famiglie colpite come la mia, cioè la famiglia Soldeti e la famiglia Ebicci. Si fu tutti invitati all’ufficio del pretore di Pontassieve per essere interrogati sul fatto successo a Berceto il 17 aprile 1944. Io ero felice che il mio viaggio a Roma non fosse stato inutile, mi sembrava di aver imbroccato la strada buona. Anche il fattore Franciolini dovette andare a fare la sua deposizione. Il pretore, con il cancelliere, ci mise tre giorni ad interrogare tutti quelli che aveva convocato. Finito questo interrogatorio io rimasi in attesa del processo, con la speranza che i colpevoli venissero condannati. Passarono giorni e mesi e non si sentì più nulla. Io tornai allora dal procuratore generale di Firenze. Mi dissero che era stato trasferito a Milano e che al suo posto c’era un altro procuratore. 86 La Democrazia Cristiana Il nuovo procuratore non mi volle dare udienza. Allora andai dal mio avvocato. Questo mi disse: “Sono cose che vanno per le lunghe. Io me ne interesso tutti i giorni e spero di chiarire le cose al più presto. Però sarebbe stato meglio se ci fosse stato l’altro procuratore. Comunque ci penso io, anche se questo procuratore non si interessa molto al tuo caso. Tu stai tranquillo, ti avverto io quando devi tornare a Firenze”. Passarono più di due mesi ma non ebbi nessuna notizia. Tornai a Roma da mio nipote insieme si tornò dal suo amico al ministero di grazie e giustizia. Ma le cose erano un po’ cambiate. Questo funzionario disse che non poteva fare altro, era a Firenze che dovevano fare giustizia. Mi consigliò di trovarmi un buon avvocato. Io gli feci presente che il procuratore generale di Firenze a cui avevo consegnato la sua lettera era stato trasferito. Lui disse: “È proprio per questo che non posso fare più niente”. Gli chiesi scusa per averlo disturbato una seconda volta e lo ringraziai per quello che aveva fatto per me. Con il suo interessamento aveva fatto muovere tutta la magistratura di Firenze ma ora eravamo al punto di partenza. Quando glielo dissi lui mi ripeté di trovarmi un buon avvocato. Lo salutai, ringraziandolo per il suo consiglio, e me ne andai, insieme a mio nipote. Mentre si tornava verso casa sua si vide in una via di Roma un gran portone con un cartello dove c’era scritto “Associazione delle famiglie dei martiri trucidati dai nazifascismi”. Si entrò e si chiese di poter parlare con il presidente di quell’associazione. Si presentò a noi un tale con il pizzetto. Credendo che il presidente fosse lui gli raccontai la mia storia, poi gli dissi che mi sarei iscritto anche io a quell’associazione. Dopo una lunga conversazione gli chiesi se loro avevano dei buoni avvocati per mandare in fondo questo processo. Il mio avvocato era spesso ammalato, non sempre era disponibile e lui stesso mi diceva che ci sarebbe voluto un altro avvocato che lo aiutasse perché da solo non ce la faceva. Questo, che si era spacciato come presidente disse che c’era un bravo avvocato, socio dell’associazione, a Firenze. Non avrei neppure dovuto pagarlo perché questo avvocato era pagato dall’associazione. Disse che gli avrebbe scritto perché prendesse a cuore il mio caso. Disse: “Vedrà che lo metto in buone mani. Ora si fa una succursale di questa associazione anche 87 a Firenze e non dovrete più venire a Roma”. Lo ringraziai e si uscì dalla sede di questa associazione. Io speravo ora in questo buon avvocato. Sia io che mio nipote eravamo convinti di essere stati consigliati bene. Salutai mio nipote e tornai a casa. Dopo pochi giorni mi arrivò una lettera nella quale si diceva che ero invitato a Firenze nella sede della succursale di quell’associazione. Andai all’indirizzo indicato, dove trovai una segretaria. Mi disse che io ero il primo socio di cui avessi sentito una storia così pietosa. Lei aveva fiducia in questo avvocato che mi avrebbe assegnato perché aveva fama di essere molto bravo. Mi disse che questo avvocato sarebbe venuto a trovarmi per fare un sopralluogo e sentire come si erano svolti i fatti. Mi sentii soddisfatto. Salutai la segretaria e andai a trovare il mio primo avvocato. Gli raccontai che il mio secondo viaggio a Roma e dell’associazione di Firenze che mi aveva messo a disposizione l’avvocato Zavataro Renato. Il mio avvocato storse la bocca e disse: “È un bravo avvocato, Zavataro, ma…” Io rimasi sorpreso, perché tutti lo lodavano. Chiesi cosa voleva dire quel: “ma”. L’avvocato disse: “È un pesce cane anche lui”. Allora gli chiesi se mi consigliava di prenderlo come avvocato oppure no. Lui rispose che era difficile dare giudizi sulla coscienza degli altri e consigliò di sentire se il Soldeti era d’accordo, perché anche lui avrebbe beneficiato dell’assistenza di Zavataro. Questo avvocato mi mise dei dubbi su Zavataro. Andai dal Soldeti e gli spiegai tutto. Il Soldeti mi disse che si era informato e tutti gli avevano detto che Zavataro era un buon avvocato, di gran fama. Disse che era disposto a tenere il nostro avvocato e in più anche Zavataro. Dopo pochi giorni venne a Berceto l’avvocato Zavataro per fare un sopralluogo sul posto dove era stata fatta la strage. Rimase a desinare con noi e pareva che si prendesse cura del fatto. Si interessava, domandava per chiarirsi le idee e io gli diedi tutte le informazioni che voleva e i dati e gli appunti che avevo preso. Lui prese questi ultimi dicendo: “Questi sono necessari”. Poi lui se ne andò e io rimasi con la speranza di vedere presto la macchina della giustizia rimettersi in moto. Pensavo a quello che mi aveva detto l’alto funzionario del ministero di grazia e giustizia, cioè che stava tutto nell’aver un buon avvocato. Ma passa88 La Democrazia Cristiana rono dei mesi e non seppi nulla. Erano passati tre anni dalla strage e ancora non ero riuscito a mettere davanti alla giustizia coloro che ritenevo responsabili della strage di Berceto. Si arrivò ai primi di novembre del 1947. Il giorno dei morti, in Pomino, c’è l’usanza di andare tutti in processione con il prete al cimitero per visitare i morti. Io non andai perché sapevo che non avrei retto al dolore trovandomi di fronte ai miei morti. Rimasi a casa per non disturbare coloro che partecipavano alla cerimonia. Fu veramente una fortuna che io restassi a casa, saranno state le anime sante a consigliarmi, perché non so cosa sarebbe successo se fossi stato presente. Alla cerimonia c’era anche il fattore con la sua famiglia. Ognuno si recò alla tomba dei propri cari defunti. Mia figlia scoppiò a piangere perché non poté resistere di fronte alle fotografie delle sue sorelle e della sua mamma. Si sfogò piangendo poi si rivolse al fattore dicendo: “Eccolo là quel canocchione. Anche per causa sua sono qua mia madre e le mie sorelle. Non sono morte di malattia, sono state trucidate dai suoi amici”. A queste parole il fattore disse: “Stai zitta bambina perché una l’ho fatta e un’altra sono pronto a farla”. A queste parole del fattore Franciolini si ribellarono tutti i parenti delle persone trucidate dai fascisti, dicendo: “Allora è stato lui davvero a cagionare quella strage. Cosa vuol fare ora, ne vuol fare un’altra?”. La gente si sfogò con il Franciolini e nel cimitero nacque una bufera. Anche quelli che erano stati in qualunque modo perseguitati durante il fascismo si ribellarono dicendo: “È ora di finirla, il fascismo è finito, ne hai già fatte troppe, hai ucciso l’inglese perché era un nostro alleato, per questo i partigiani ti molestavano. Cosa farai ora? Non ne hai già fatte abbastanza?”. Il Soldeti gli si gettò contro dicendo: “Ti scanno!”. Il cimitero era pieno di persone. C’era chi si dava da fare perché non succedesse qualcosa di grave. Il Franciolini scappò di corsa ed entrò in chiesa. Gli altri lo inseguirono ma nessuno entrò in chiesa. La gente gridava: “Buttatelo fuori, è un prepotente, in chiesa non ci sta bene”. A questo punto uscì il piovano che gli disse: “Andate via, è una vergogna, è ora di finirla, credo che basti”. La gente disse: “Il Franciolini ha detto che è pronto a fare un’altra strage, è sempre stato un prepotente”. “Ai prepotenti ci penso io” disse il piovano: 89 “Voi andatevene”. La gente non si oppose alla richiesta del piovano e ognuno tornò a casa. Il Franciolini rimase libero, nessuno lo aveva toccato. Appena se ne furono andati tutti fece una lista coi nomi di quelli che erano presenti e il giorno dopo gli mandò tutti a chiamare. Chi non andava a chiedergli scusa, sarebbe stato querelato. Molti, per paura di questo ricatto, andarono a scusarsi e per loro tutto finì li. Ma i miei tre figli, il Soldeti e suo figlio non andarono a chiedere scusa al fattore perché sapevano che le accuse che gli avevano fatto non erano calunnie ma verità. Da circa dieci mesi sapevo che il piovano era al corrente di come si erano svolti i fatti che portarono alla strage. Aveva informato anche la madre superiora delle suore canossiane di Firenze, che avevano il convento in via della Scala, al numero 33. Questa madre superiora era venuta da noi a farci una visita per dirci parole di conforto. Aveva saputo ciò che ci era successo e sapendo di fatti così pietosi era venuta a farci una visita per consolarci. Si diede il caso che poco tempo dopo mia figlia maggiore fu portata all’ospedale di Firenze per essere operata di appendicite. Questa madre superiora l’andava spesso a trovare, come se fosse stata una sorella. Dopo otto giorni dall’operazione mia figlia doveva lasciare l’ospedale. Era febbraio e la stagione era brutta. Questa superiora mi pregò di lasciare mia figlia con lei nel convento fino ha quando il viaggio per tornare casa non fosse stato così rischioso. Poi con loro mia figlia si sarebbe forse rimessa prima. Io accettai la proposta. Così mia figlia entrò nel convento delle suore canossiane. Spesso la madre superiore parlava con mia figlia del fatto atroce che ci era capitato e avrebbe voluto esserle di conforto. Un giorno la madre superiora, parlando con mia figlia, le disse: “Credi, mi dispiace vedere tuo padre così agitato, si vede che non sta bene. Porta rancore a Franciolini, pensa sia lui la cagione della vostra tragedia. Ma ti assicuro che il Franciolini è dispiaciuto per la vostra disgrazia. Lui fece fare il rastrellamento per togliere i partigiani da quella zona perché lo molestavano, non gli davano pace. Però non voleva che fossero molestate le famiglie. Io so da fonte sicura che il Franciolini vi voleva molto bene. Furono i partigiani che lo costrinsero a far venire quelle squadracce. Per le famiglie non le avrebbe chiamate”. Io un giorno andai a trovare mia 90 La Democrazia Cristiana figlia, che mi raccontò queste cose. Allora chiesi poi alla madre superiora di ripetermi quel discorso. La madre superiora mi disse le stesse cose che aveva detto a mia figlia. Io le dissi: “Mi potrebbe dire per favore chi è questa persona che l’ha informata? Perché non c’è da fidarsi di tutti”. La madre superiora disse: “Stia tranquillo, quello che le ho detto è verità. Queste cose me le ha dette il piovano di Pomino. Lui sa tutto di preciso”. Io credetti alle sue parole perché anche il marchese una volta aveva detto le stesse cose. Il marchese le aveva dette di fronte a me, ai miei familiari e al fattore Perpoli, ed aveva detto che avevano ordinato di non fare come a Valluccioli, dove erano morte più di cento persone. Erano circa dieci mesi che sapevo queste cose dettemi dalla madre superiora ma non avevo mai detto niente di questo colloquio a nessuno perché mi sembrava inutile. Avevo tante testimonianze che però non venivano mai ascoltate. Un giorno giunse un avviso dalla pretura di Pontassieve ai miei tre figli, al Soldeti e a suo figlio. Dovevano presentarsi di fronte al pretore per rispondere di frasi ingiuriose contro il Franciolini Giuliano. Io andai subito dal piovano di Pomino. Lo trovai vicino alla chiesa. Lo salutai. Credevo di avere un testimone in più, con lui, stando a quello che mi aveva detto la madre superiora. Gli dissi: “Signor piovano, mi trovo in un mare di guai, lei potrebbe darmi una mano. Io so che lei è al corrente di quanto è successo. Mi farebbe un favore se potesse venire a testimoniare e dire come si sono svolti i fatti, sia quelli inerenti alla strage che quelli successi al cimitero. Lei è al corrente di tutto. Deve sapere che ora il Franciolini ha querelato i miei figli e i Soldeti per calunnie. Comunque lei sa chi è stato a ordinare il rastrellamento”. Il piovano disse: “Io non so niente. Anzi le dico che mi ha citato Franciolini come testimone a suo favore. È ora che la smettiate di molestarlo. Dovete lasciarlo in pace”. Io, a questa risposta del piovano, rimasi come paralizzato. Non so come ho fatto a non fare una pazzia. Mi vedevo tradito anche da un sacerdote, che era d’accordo con i tiranni, non aveva cura dei nostri martiri innocenti. Forse perché eravamo poveri e le nostre ragioni valevano poco. Gli dissi: “Mia figlia è accusata di aver detto al Franciolini che è il responsabile della strage. Lo ha saputo dalla madre superiora delle 91 suore canossiane di Firenze che a sua volta lo ha saputo da lei stesso. Il Franciolini fece fare quel rastrellamento per liberarsi dei partigiani che operavano in quella zona. Il Franciolini mandò quelle squadracce per i partigiani, invece sono stati ammazzati anche dei nostri familiari. Non è forse responsabile anche il Franciolini?”. Il piovano disse: “Io non ne so niente e non ho detto niente a nessuno”. Negò tutto. Io mi sentivo bollire il sangue nelle vene. Credevo che il piovano fosse dalla mia parte invece me lo trovavo contro. Gli dissi: “Lei piovano fa come Don Abbondio, che negò i diritti a due anime giuste. Lei nega la verità ai vivi e ai morti perché ha paura dei potenti. Non pensa che la sua testimonianza oltre a far assolvere i colpevoli fa condannare gli innocenti?”. Gli dissi queste cose credendo di convincerlo, poi gli dissi: “Lei ha detto alla madre superiora che è stato il Franciolini a ordinare quel rastrellamento, e questo non lo può negare”. Il piovano ripeté che lui non aveva detto niente e che avrebbe testimoniato a favore del Franciolini. Con il cuore colmo di odio e di dolore lasciai il piovano. Mi vedevo abbandonato da tutti, anche dai ministri della Chiesa, in cui avevo un po’ di fiducia. Mentre tornavo a caso mi vennero i brividi pensando alle mie sventure. Mi pareva di essere l’uomo più sfortunato del mondo. Appena tornato a casa misi al corrente i miei figli del colloquio col pievano. Ma erano tutti molto giovani e nessuno di loro avrebbe potuto darmi qualche consiglio. Pensai alla madre superiora delle canossiane. Ebbi paura che non confermasse quello che aveva detto. La corriera per Firenze partiva alle sette e c’era solo quella corsa. Tornava alle diciassette. Io stetti in ansia tutta la notte, che mi pareva lunghissima. Mi alzai al mattino verso le cinque. Dovevo camminare circa un’ora per giungere alla corriera. Appena giunsi al convento fui accolto con molta gentilezza. Parlai con la madre superiora. Si cominciò, come al solito, a parlare delle mie sventure. Poi le raccontai del fatto successo al cimitero e le chiesi se si ricordava ancora quello che le aveva detto il piovano in merito al fattore. Le dissi anche che il piovano negava di averle dette quelle cose. La madre superiora disse: “Lui non se lo ricorderà ma mi disse testualmente che il fattore Franciolini aveva fatto fare il rastrellamento per liberarsi dei partigiani che operavano in 92 La Democrazia Cristiana quella zona e lo molestavano ma non voleva che molestassero le famiglie”. Io le chiesi se poteva farmi la gentilezza di ripetere quelle cose in tribunale. Lei disse: “Non mi faccia venire in tribunale. Posso confermare quello che ho detto davanti ai carabinieri o in presenza del suo avvocato, ma le sarei grata se non mi facesse venire in tribunale”. La ringraziai infinitamente e andai dall’avvocato. Questi mi disse che era una cosa seria perché il processo si sarebbe svolto in tribunale e non in pretura e la madre superiora avrebbe dovuto venire a deporre davanti al presidente del tribunale. Arrivò il giorno del processo, che si tenne a Firenze. Io avevo otto testimoni a mio favore, senza contare la madre superiora. Fecero l’appello degli imputati e dei testimoni. Dopo aver ascoltato tutti, i giudici si ritirarono in camera di consiglio. Dopo pochi minuti i giudici tornarono nell’aula e il presidente disse che non era competenza di quel tribunale giudicare se gli imputati erano innocenti o colpevoli. Così il processo fu mandato alla Corte d’Assise di Firenze. Fu fatta un’altra istruttoria, dove chiamarono anche me. Dovevo fare un confronto con il Franciolini il quale diceva che io lo avevo offeso quando eravamo nel suo scrittoio il giorno in cui gli chiesi chi era colui al quale mandò quelle famose lettere, quello che faceva la spia fra i partigiani. Il fattore sosteneva che io lo avevo offeso. Per primo fu interrogato il Franciolini. Il giudice gli chiese quali erano state le offese fattegli dal Vangelisti, cioè da me. Il Franciolini disse: “Mi ha detto che sono un delinquente e un assassino”. Il giudice istruttore mi chiese perché avevo offeso il fattore. Io dissi: “Non è vero che l’abbia offeso. Gli ho detto solo che aveva ammazzato l’inglese”. Il giudice disse, rivolto a me: “Il Franciolini chiamò sua madre per farle sentire che voi lo stavate offendendo”. Io dissi: “Chiamò sua madre per farle dire che lui aveva ucciso quell’inglese per legittima difesa. Comunque debbo aggiungere che Franciolini mi offrì delle somme di denaro. Prima 25 o 30 poi 60 o 70”. Il giudice chiese al Franciolini se era vero che mi aveva esibito queste cifre. Il Franciolini disse: “Io gli dissi 25 o 30 ma non dissi cosa avrei dato”. Così finì quel confronto. A me mi fecero uscire e il Franciolini rimase col giudice e il procuratore. Nell’uscire mi dimenticai di chiudere la 93 porta e udii quello che dicevano. Il Franciolini voleva che fosse messa a verbale la data di una lettera dell’Onofelli, di cui ho già parlato. Il giudice istruttore disse: “È meglio di no, non metta a verbale questa lettera perché oltre a questa ce n’è un’altra e risulterebbe che lei aveva un rapporto abituale con falsi partigiani. Inoltre lei stesso ha già dichiarato che di lettere ce n’era una sola, quella datata 17 aprile”. Poi il giudice istruttore disse ancora: “Il confronto di questa mattina è tutto a carico suo, caro Franciolini, ma questo non verrà messo a verbale, come la lettera”. Io udii chiaramente queste parole e mi vennero mille pensieri nel sentire che certe cose che erano a carico degli imputati non venivano messe a verbale. Poi udii un’altra frase del giudice istruttore, che disse: “Anche questo no, lei si dà la zappa sui piedi”. Io sarei entrato dentro l’ufficio, per farli scomparire tutti, per fargli sapere che avevo udito tutto. Ma non avevo testimoni. Erano tutti contro di me, non sapevo come comportarmi. Pensai: “Se entro e faccio valere le mie ragioni mi fanno passare per pazzo o da calunniatore. Mi potrebbero anche mettere in prigione per aver calunniato un magistrato”. Sapevo di avere la ragione, ma sapevo anche che avevo tanti testimoni che non erano neppure ascoltati. Volevano assolvere gli imputati, questo ormai mi era chiaro. Pensai che, un giorno, avrei detto quello che avevo udito quel mattino con le mie orecchie dicendo che ero stato informato da una persona competente e di cui ci si poteva fidare. Questo mio segreto non lo svelai neppure ai miei avvocati. Vedevo che erano in molti a tendere il laccio per prendermi a tradimento, perché stavo scoprendo i responsabili della strage di Berceto, che poi erano gli stessi responsabili della strage del Casentino. Per questo ero preso di mira. In seguito tutte le volte che mi interrogavano volevano sapere chi era il mio informatore. Così passarono più di quattro mesi e il processo non si fece ancora. Eravamo anche in attesa del processo contro i miei figli e i Soldeti, accusati di calunnia. Durante quel tempo riuscii a rintracciare la spia che riceveva le lettere dal Franciolini, e i suoi camerati che lo aiutavano a tradire i partigiani. Io, come ho già detto, riuscii a trovare la famiglia di uno dei due partigiani morti a Berceto per mezzo di una fotografia, sul cui retro c’era l’indirizzo di uno di 94 La Democrazia Cristiana questi due partigiani, che erano nella fotografia. I familiari di uno di questi due partigiani stavano a Carmignano. Quando chiesi loro: “Siete voi i Chiti?” questi risposero: “Sfortunatamente si!” Dissi che mi dispiaceva rinnovare il loro dolore per il figlio morto ma che fra sfortunati ci si poteva dare la mano. Gli feci vedere uno dei miei ricordini dove c’erano cinque fotografie e la scritta “trucidate dai nazisti”. Dopo aver guardato quel ricordino si guardarono in viso e mi dissero: “Anche lei l’ha avuta grossa. Ecco cosa ci ha portato il fascismo. Noi avevamo due figli. Uno è morto al fronte e uno è morto nei partigiani. Non sappiamo né come né dove sono morti. Sono morti nel fiore dell’età, lontani da noi. Non sappiamo in quali mani abbiano finito la loro agonia. Non ci può essere dolore più acuto di quello di un genitore che perde i figli così. Resta un dolore e una ferita nel cuore che non guarisce mai”. Io gli mostrai la foto del loro figlio morto a Berceto. La moglie del Chiti la prese e se la strinse al seno. Poi, mentre la baciava, disse: “Questo è mio figlio Mauro”. Si passavano fra loro la fotografia e la guardavano con espressione dolente. Poi mi chiesero dove l’avevo presa e il perché di quella visita. Risposi che avevo un processo in corso e che volevo scoprire gli assassini che avevano ucciso i miei cari, gli stessi che avevano ucciso il loro figlio. Dissi: “Sono venuto per sapere se voi conoscete dei partigiani che erano insieme a vostro figlio. Potrebbero essere utili per scoprire i colpevoli di quella strage. Io so che tre dei partigiani che erano con vostro figlio sono ancora vivi”. Il Chiti disse: “Uno sta proprio qui, a una ventina di metri da noi”. Chiesi quale versione aveva dato costui sulla morte del loro figlio Mauro. Dissero che questo partigiano gli aveva raccontato che Mauro era morto in un combattimento contro i tedeschi, nei pressi della Consuma, e non avevano potuto riprenderlo perché erano inseguiti dai tedeschi e dovettero scappare tutti altrimenti sarebbero stati presi anche loro. A queste parole capii che si trattava di un falso partigiano. Chiesi al Chiti se era possibile far venire a casa sua quel partigiano. Il Chiti, premuroso, mandò sua moglie a chiamarlo. Poco dopo arrivò. Appena mi vide cambiò di colore. Io feci finta di non sapere nulla e gli tesi la mano. Lui abbassò gli occhi e contraccambiò il saluto. Cambiava 95 colore momento per momento. Io gli chiesi cosa poteva dire in merito alla strage fatta a Pomino il 17 aprile del 1944, dove fu ucciso anche il Chiti Mauro. Mi rispose che quando arrivarono i tedeschi lui non c’era, era andato a comprare le sigarette. Io gli chiesi: “Perché quando il Chiti e l’altro se ne volevano andare gli impediste di uscire dalla capanna?”. Il partigiano rispose: “Non si credeva che sarebbero arrivati i tedeschi”. Io dissi: “Non erano tedeschi. E poi, perché sparaste due colpi di pistola?”. Rispose che lui non aveva sparato. Allora gli chiesi se sapeva dirmi dove abitavano i superstiti di quel gruppetto. Rispose che non sapeva dove stavano. Quindi dovette poi ammettere che Chiti Mauro era morto a Berceto e non in una battaglia con i tedeschi alla Consuma, come aveva detto ai genitori di Mauro. Io non potevo trattenermi perché il taxista che mi aveva accompagnato aveva fretta. Il partigiano se ne andò e rimasi con i Chiti. Chiesi loro se erano convinti, ora, che quel partigiano fosse un traditore. Il Chiti disse: “Non c’è dubbio, ha dimostrato che era un traditore”. Il taxista mi faceva fretta, dicendo che aveva degli appuntamenti. Salutai i Chiti e dissi loro che sarei tornato per chiarire questa faccenda. Li pregai di prendere informazioni su questo partigiano, che si dichiarava Bocci Lindo. Al mio ritorno si sarebbe parlato più a lungo. Partii. Speravo di aver trovato il bandolo della matassa. Tornai dai Chiti due giorni dopo. Arrivai alla sera alle diciotto e restai fino alla mattina. Per tutta la notte si parlò di queste cose. Mi dissero che Bocci Lindo si era iscritto nei fascisti della repubblica di Salò ed era stato a Empoli. Gli avevano dato 250 lire. Appena tornato da Empoli trovò Chiti Mauro e lo consigliò a iscriversi anche lui con quelli della repubblica di Salò. Avrebbero dato anche a lui 250 lire. Gli aveva detto: “Si va insieme a fare i rastrellamenti, non si patisce più la fame, si mangia quanto ci pare”. Ma Mauro non voleva fare parte dei repubblichini. Gli aveva risposto: “Ci penserò. Per il momento non posso prometterti niente”. Si lasciarono e il Bocci era un po’ indignato, come del resto Mauro. Il Chiti Mauro, tornò a casa e raccontò queste cose ai propri genitori. Il giorno dopo Bocci Lindo tornò da Mauro e gli chiese se aveva deciso. Mauro disse: “Io non ci sto, anche perché la guerra è ormai persa”. Il Bocci disse: “Ma 96 La Democrazia Cristiana prima che sia finita dobbiamo patire ancora tanta fame. Io mi sono iscritto coi repubblichini e non vorrei trovarmi male a causa tua. Se ora non ti iscrivi anche tu coi repubblichini io ti denuncio e ti faccio prendere dai tedeschi”. Dopo una lunga discussione Mauro disse: “Ti darò una risposta decisiva un’altra volta, ora non mi so decidere”. Il Bocci si impermalosì e gli disse: “Ti avverto, pensaci bene. Se ti decidi a venire si va insieme. Si va per le campagne, si può entrare nelle case, nessuno ci può far niente. Se invece tu vuoi affrontare i rischi che ti ho detto che corri non venendo con me allora sono affari tuoi”. Di nuovo si lasciarono un po’ male. Mauro era preoccupato e si consigliò con i propri genitori. Ma i genitori gli dissero che erano brutti momenti e che era difficile dare consigli. Durante questo colloquio era presente una zia di Mauro. Questa gli propose di andare da lei. Gli disse: “Io sto fuori paese, puoi venire a casa mia. L’importante è che non ti veda nessuno”. Così Mauro si nascose dalla zia. Dopo pochi giorni ecco il Bocci Lindo, in cerca di Mauro. Domandava ai vicini se l’avevano visto ma nessuno sapeva dov’era. Questo Bocci allora andò dai genitori di Mauro in veste d’agnello. Disse loro che si era pentito e che non voleva più stare coi fascisti. Voleva andare con i partigiani. Però da solo non andava volentieri, sarebbe andato solo insieme a Mauro. Così gli chiese se gli facevano il favore di dirgli dov’era. I genitori di Mauro gli dissero che erano in pensiero perché erano diversi giorni che non lo vedevano e non sapevano dove era andato. Gli dissero anche che la colpa era sua perché aveva detto che l’avrebbe denunciato ai tedeschi. Bocci Lindo disse: “È vero, però ora mi sono pentito. Ho capito che ho fatto uno sbaglio. Per ora non posso più stare qui altrimenti mi prendono i fascisti. Bisogna che vada con i partigiani altrimenti i tedeschi mi prendono e mi portano in Germania. Fatemi il piacere di dirmi dov’è Mauro. Staremo insieme. Insieme staremo meglio, ci conosciamo bene”. Fu così che i genitori di Mauro consegnarono il figlio nelle mani di Bocci Lindo. Gli dissero dov’era. Mauro e il Bocci partirono insieme l’11 marzo del 1944 per andare coi partigiani. Io mi feci dare dal Chiti una dichiarazione scritta di suo pugno di quanto aveva detto, poi dissi loro di continuare ad informarsi e cercare testimo97 ni, per cercare di scoprire gli assassini del suo figlio e dei miei cari. I Chiti mi promisero che si sarebbero interessati alla cosa. Io dissi che sarei tornato al più presto. Presi con me il foglio scritto e firmato dal Chiti e me ne andai. Erano le sei del mattino. Andai a casa del Bocci, che abitava vicino, per vedere se riuscivo a sapere altre cose. Ma non ci fu modo di sapere nulla. Mi fece i soliti discorsi. Disse che lui non sapeva nulla e non conosceva nessuno. Ma ormai si sapeva che era un traditore. A Firenze mi dissero che in città c’era un ufficio per il riconoscimento dei partigiani. Andai a questo ufficio, dove c’era un certo Corsinovi Pietrino. Il Corsinovi era proprio il capo formazione a cui apparteneva anche quella squadra di partigiani che vennero a Berceto il 17 aprile del 1944. Questo Corsinovi mi portò nel suo ufficio. Io gli mostrai la fotografia di Chiti Mauro e gli chiesi se lo conosceva. Mi rispose che lo conosceva bene perché faceva parte della sua formazione quando era partigiano. Poi mi chiese se io ero suo padre. Mostrai a Corsinovi uno dei miei ricordini dove c’era la fotografia dei miei familiari trucidati dai fascisti. Gli dissi: “Io sono il padre di queste quattro bambine e questa era mia moglie. Furono ammazzate la mattina del 17 aprile 1944 a Pomino, nel comune di Rufina”. Lui disse che era il capo formazione a cui apparteneva quel gruppo di partigiani che vennero a casa mia la mattina della strage. Mi chiese scusa mille volte, dicendo che lui però non ne aveva colpa, anche se fu lui a ordinare a quella pattuglia di sette partigiani di fare da retroguardia. Mi spiegò il suo piano per quel giorno. Dovevano fare degli appostamenti per occupare determinate posizioni e lui comandò a questi sette partigiani di fare da retroguardia. Ad un certo punto la formazione dovette cambiare strada. Il Corsinovi lasciò un partigiano all’incrocio, per restare in collegamento con la retroguardia. Lui e la sua formazione fecero circa quattrocento metri fuori strada. Il Corsinovi aspettò poi tutta la notte la pattuglia di retroguardia. Ma non arrivò nessuno. Allora il Corsinovi ordinò ad altri due partigiani di rintracciare quei sette che si erano sperduti. Aspettò poi fino a mezzogiorno ma non tornarono né i sette della retroguardia né i due che erano andati a cercarli. Così, mi disse il Corsinovi, quel mattino aveva perso nove partigiani. Io ascoltavo attentamente 98 La Democrazia Cristiana e cercavo di capire se il Corsinovi era sincero oppure era d’accordo con i traditori. Ma, per quel che mi risultava, aveva detto la verità. Il Corsinovi continuò il racconto dicendo che i due partigiani che erano andati alla ricerca della pattuglia che era di retroguardia arrivarono vicino alla capanna quando c’erano già i fascisti che le avevano appiccato il fuoco. Allora quei due tornarono indietro per rientrare nella loro formazione ma sulla strada del ritorno incontrarono i fascisti. Uno fu ammazzato e l’altro fu fatto prigioniero. Corsinovi disse che poi vide molto fumo quando bruciò Berceto e udì degli spari. Allora tutta la formazione rimase ferma, perché non fossero visti, ma pronti a sparare se fossero stati attaccati. Io, visto che aveva detto la verità, mi confidai con lui poi gli chiesi se conosceva quei sette partigiani che aveva messo di retroguardia. Lui disse: “So dove stanno di casa e come si chiamano. Se vuole andarci”. Io dissi: “Questi sette sono coloro che la mattina della strage erano a Berceto. Fra di loro c’è una spia, se non sono di più, le spie”. Lui ci rimase male, non ci credeva. Disse: “Se ciò fosse vero dobbiamo metterlo in chiaro. Come ha saputo che c’erano delle spie?”. Io gli chiesi se mi poteva far parlare con questi tre partigiani che conosceva lui e che stavano nei paraggi poi gli mostrai la dichiarazione scritta dal Chiti. Dopo averla letta il Corsinovi disse: “Questa è una cosa importante, dobbiamo andarci infondo”. Ci si dette appuntamento per il sabato successivo alle quattro del pomeriggio per parlare e fare un confronto con questi tre partigiani. Io partii, convinto che le cose stavano mettendosi bene. A casa i miei mi aspettavano con ansia. Erano due giorni che mancavo da casa. Feci loro presente ciò che avevo saputo di nuovo. Rimasero contenti anche loro dei risultati che avevo ottenuto. Ci pareva di aver trovato la strada per mettere in chiaro le cose. Poi ci si consigliò con le famiglie colpite come noi, e solo il Soldeti decise di venire con me all’appuntamento. Per essere più sicuro portai con me anche l’ex fidanzato della mia figlia maggiore Bruna, morta nella strage. Questi, terribilmente colpito dalla morte di Bruna, diceva: “Quando avrete bisogno di me venite pure, quello che posso fare lo farò volentieri”. Così, alla mia proposta, disse: “Allora ha trovato le spie. Spero che si riesca a scoprire anche gli as99 sassini. Verrò anch’io”. Il sabato successivo si andò all’appuntamento. Si arrivò all’ufficio partigiani, dove c’era già il Corsinovi, che ci aspettava. Dopo poco arrivarono anche i partigiani, che il Corsinovi aveva invitati dicendo a ognuno che doveva parlargli di cose che lo riguardavano. Era stato invitato anche il Bocci Lindo gli altri tre erano Toci Del Medico Osvaldo, Ottunni Carlo e Bolognesi Dino. Appena mi videro lì, con il Soldeti, rimasero tutti molto sorpresi, non mi aspettavano. Nel parlare facevano molta confusione, non si poteva capire. C’era chi diceva una cosa e chi un’altra, facevano di tutto perché nessun discorso venisse approfondito o portato a termine. Io chiesi al Corsinovi se si poteva parlare con questi partigiani uno alla volta. Il Corsinovi disse: “Quest’uomo ha ragione. Dovete sapere che, anche per causa nostra, a questi due è stata trucidata mezza famiglia dai fascisti. Ora dobbiamo aiutarli ad ogni modo”. Condusse i quattro partigiani in un’altra stanza poi mi chiese chi volevo chiamare per primo. Io gli dissi di chiamare Bocci Lindo, perché non avesse il tempo di informare gli altri della mia visita a Carmignano. Il Bocci venne subito. Sapevo già cosa avrebbe detto perché gli avevo già parlato, ma per convincere il Corsinovi chiesi di nuovo al Bocci cosa ne sapeva della strage. Lui disse: “Io non c’ero più quando arrivarono i tedeschi alla capanna. Io e un altro eravamo andati a prendere le sigarette”. Io gli chiesi: “Perché non andaste via quando gli altri due se ne volevano andare perché si sentivano degli spari?”. Il Bocci rispose: “Non si pensava che arrivassero i tedeschi”. Io chiesi ancora: “Perché quando andaste a prendere le sigarette sparaste due colpi di pistola?”. Il Bocci negò di essere stato lui a sparare ma non poté negare che i colpi furono sparati. Alla fine gli chiesi di firmare ciò che aveva dichiarato. Disse che non sapeva scrivere e fece una croce sul foglio. Per lui firmarono il Corsinovi e l’ex fidanzato di Bruna, Innocenti Dino. Il secondo che si chiamò fu Toci Del Medico Osvaldo. Io gli dissi: “Perché quando quei due volevano andarsene gli puntaste la rivoltella contro e gli impediste di andar via?”. Il Toci rispose: “Non si pensava che arrivassero i tedeschi e non volevo che ci si dividesse”. Io dissi: “Perché vi siete tolte le scarpe? Eravate tutti scalzi quando arrivarono i fascisti. Perché vi siete lasciati prendere 100 La Democrazia Cristiana così come fessi, e proprio lei, che diceva di non aver paura di nessuno e faceva tanto il prepotente?”. Il Toci disse: “Da fessi no. Si sparò finché non si rimase senza munizioni, poi si dovette arrenderci per forza”. Io dissi: “Ma a chi sparavate? Se fra i fascisti non ci furono né morti né feriti? “. Poi gli chiesi dove li avevano portati. Il Toci disse: “Ci presero a calci, poi ci fecero portare le loro munizioni fino a dove avevano i camion”. Io avrei avuto ancora tante domande da fargli ma per non perdere tempo chiamai Bolognesi Dino. Toci firmò la sua deposizione e venne Bolognesi Dino, al quale feci le stesse domande. Gli chiesi: “Perché quando quei due se ne volevano andare glielo avete impedito?”. Il Bolognesi rispose: “Per non dividerci. E poi non si credeva che sarebbero arrivati i tedeschi”. Io gli chiesi perché erano senza scarpe quando arrivarono i fascisti. Lui rispose che i fascisti erano arrivati di sorpresa e non avevano fatto in tempo a rimettersele. Io dissi: “Mentre sparavate facevate in tempo a rimettervele”. Lui disse: “Non si fece in tempo né a sparare né a rivestirci. Ci imposero di alzare le mani. Non si poté agire. Ci fecero uscire dalla capanna con le mani alzate”. Io gli chiesi: “Dopo che vi presero cosa vi fecero i fascisti?”. Il Bolognesi rispose: “Ci portarono su una strada dove avevano i camion, con i quali ci hanno portato a Firenze, in prigione”. Anche a lui si fece firmare le sue dichiarazioni e si chiamò Ottunni Carlo. Anche a lui chiesi perché non se ne andarono quando si udirono le fucilate mentre quei due se ne volevano andare. Rispose che non pensavano che sarebbero arrivati i tedeschi. Io dissi: “Voi dite tutti così, però quei due che volevano andarsene pensavano che i tedeschi sarebbero arrivati e voi gli impediste di uscire dalla capanna. E, fatalità, sono morti solo loro due, mentre voi, che eravate tutti così sicuri, ve la siete cavata tutti. Questo mi fa pensare che eravate davvero sicuri di non rischiare nulla”. Poi gli chiesi: “Dopo che vi hanno preso cosa vi hanno fatto?”. Ottunni Carlo rispose: “Ci portarono in un bosco. Si camminò più di un’ora per arrivare dove avevano i camion”. Anche lui firmò la sua deposizione. Si capiva che mentivano. Anche il Corsinovi lo pensò perché disse: “Avete ragione. Non avrei mai creduto di aver certa gente nella mia formazione”. Io, con queste deposizioni, andai dall’avvocato Zavataro, che mi consi101 gliò di portarle al procuratore generale. Così feci. Quando il procuratore mi vide mi accolse gentilmente. Poi disse: “Ma chi è che la consiglia a fare tutto questo?”. Io dissi: “Perché, non va bene?”. Il procuratore disse: “Se va bene o no lo vedremo in seguito. Ma chi la consiglia me lo può dire subito”. Allora io dissi: “Che importa chi mi consiglia, le deposizioni sono quelle”. Il procuratore insistette: “Quella persona potrebbe far comodo anche a me, si farebbe prima a mettere le cose in chiaro”. Io gli dissi: “Ho promesso di non dirlo a nessuno”. Il procuratore cominciò ad alzare la voce: “A me deve dire tutto. Lei non vuole scoprire la verità perché le cose più importanti le tiene nascoste. Mi deve dire tutto. Sarebbe lei da mettere in prigione”. Batteva le mani sopra al tavolo e voleva sapere a tutti i costi chi era quella inesistente persona che non volevo nominare. Io dissi, sempre calmo: “Signor procuratore non si arrabbi. Lei non ha bisogno di sapere chi è questa persona. Faccia arrestare quelle quattro spie e le faccia parlare. Loro sono al corrente di tutto. Faccia il suo dovere”. Il procuratore disse: “Cosa vorrebbe insinuare, io il mio dovere l’ho sempre fatto”. Io dissi: “Quello che ho fatto io l’avrebbe dovuto fare lei”. Il procuratore disse: “Io li faccio arrestare, se poi sono innocenti va in prigione lei”. Io dissi: “Saranno le loro deposizioni e le testimonianze a determinare la loro sorte”. Dopo pochi giorni vennero arrestati Toci del Medico, Bocci Lindo, Bolognesi Dino e Ottunni Carlo. Mentre questi erano in prigione le autorità fecero altre indagini, per dimostrare che si interessavano alla faccenda, ma erano già al corrente di tutto. Se volevano far giustizia avrebbero potuto farla. Poi pensavano che ci fosse qualcuno a spingermi a fare quello che stavo facendo e volevano a tutti i costi sapere chi era. Siccome avevo avuto contatti col ministero di grazia e giustizia, dove mi diedero quella lettera che portai al procuratore generale di Firenze, forse pensarono che era lì che c’era questa persona. Pensavano che fossi consigliato da qualcuno più grande di loro. Per questo fecero qualche passo avanti. Ma gli imputati non volevano condannarli. Eravamo nell’estate del 1948 e l’istruttoria continuava. Io avevo raccolto altre prove molto importanti. Loro traccheggiavano, per sentire tutte le campane e accordare il suono. Io purtroppo non avevo 102 La Democrazia Cristiana nessuno che mi proteggeva, non sapevo più a chi rivolgermi. Sapevo che il giudice istruttore e il procuratore volevano salvare gli imputati. Erano quasi quattro anni che lottavo con i tribunali per fare giustizia e non avevo ottenuto nulla, solo sacrifici e dispiaceri. Pensavo: “Eppure siamo in democrazia, ci sarà pure qualcuno di coscienza che riconosca le vittime del fascismo, i martiri della libertà”. Mentre quei quattro falsi partigiani erano in prigione il Chiti mi scrisse una lettera da Carmignano. Diceva che aveva fatto altre indagini sul Bocci Lindo e che aveva scoperto altre cose, molto più importanti di quelle che aveva scritto sul foglio che mi aveva dato la volta precedente. Mi diceva di andare ad aspettarlo alla stazione della Sita perché voleva consegnarmi una lettera su cui aveva scritto queste nuove prove della colpevolezza del Bocci, e che dovevo andare personalmente a ritirare questa lettera perché non la poteva mandare in quanto si parlava di cose molto importanti e delicate. Voleva incontrarsi con me ed essere sicuro che ricevessi quella lettera. Nello stesso periodo furono rimessi in libertà i quattro falsi partigiani arrestati. Io andai all’appuntamento col Chiti, ma questi non venne. Seppi poi che non era venuto perché aveva paura del Bocci, il quale, dopo essere tornato dal carcere, disse che lui era innocente, che quello che si diceva io e il Chiti erano calunnie e che nessuno parlasse più male di lui altrimenti gli avrebbe sistemati. Poi aveva fatto delle minacce, io, che ormai sapevo come erano andate le cose, non potevo rassegnarmi. Si diceva che eravamo in democrazia ma comandavano sempre i fascisti. Dopo l’istruttoria le quattro spie erano state rimesse in libertà, assolte in istruttoria per non aver commesso il fatto. Questa notizia l’ebbi dal giornale. Appena la lessi andai dall’avvocato Zavataro. Gli feci presente la cosa e lui disse: “Non c’è niente da fare”. Io gli chiesi se poteva venire con noi dal giudice istruttore per sentire cosa si poteva fare, visto che le quattro spie erano state ingiustamente assolte e scarcerate. Lui disse che sarebbe stato inutile fare altri passi perché se quei quattro erano stati scarcerati significava che non c’erano prove sufficienti per condannarli e tenerli in prigione. Insomma non volle venire. Io lo lasciai un po’ stizzito. Poi andai col Soldeti dall’avvocato Belli per vedere se veniva lui dal giudice istruttore. Infatti venne. Si 103 trovò il giudice istruttore mentre usciva dalla porta del palazzo dove aveva sede la Corte d’Assise di Firenze. Si salutò e lui rispose al saluto ma non si fermò. Io dissi all’avvocato: “Perché non gli ha detto niente?”. Lui rispose: “Non si può fermare un giudice per strada e fargli domande d’ufficio. Se fosse stato nel suo ufficio sarebbe stato diverso, ma per strada non è ammesso fare determinate discussioni”. Io, senza perder tempo, raggiunsi il giudice istruttore. Lo salutai di nuovo e gli chiesi, per favore, se permetteva una parola. Mi rispose di si. Gli chiesi perché aveva assolto in istruttoria le quattro spie. Rispose che lui non ne sapeva nulla. Io dissi: “Come non ne sa nulla. C’è scritto anche sul giornale che sono assolti per non aver commesso il fatto. A me non mi va bene”. Il giudice si fermò e disse bruscamente: “Lei vuole che io faccia a modo suo, tenta di corrompermi. Ma io la faccio arrestare questa mattina stessa se insiste. Quando sarà il momento saprò fare il mio dovere”. Si rimise in cammino. Io lo seguii, con il cuore colmo di passione. Gli dissi: “Farà molto bene a fare il suo dovere. Non faccia come la mattina che si fece il confronto io e il Franciolini, che le cose più importanti non furon messe a verbale”. A queste parole si fermò di nuovo e disse: “Cos’è che non è stato messo a verbale?”. Io dissi: “La lettera che il Franciolini voleva mettere a verbale, ma che lei e il procuratore gli consigliaste di non fare”. Il giudice non negò. Disse: “Forse perché si trattava di una cosa senza importanza”. Allora io dissi: “Lei consigliò al Franciolini di non mettere quella lettera a verbale dicendo che facendo così si sarebbe dato la zappa sui piedi. Significa che questo particolare aveva valore. Poi altre cose, di cui riparleremo quando avremo più tempo”. Il giudice si calmò e disse: “Chi è che l’ha informata di tutto questo?”. Io risposi: “Una persona seria e fidata. E lei sa bene che quei quattro sono colpevoli della strage di Berceto”. Il giudice, sempre più calmo, disse: “Vedremo in camera di consiglio quello che si deve fare”. Io gli dissi: “Cerchi di far il suo dovere come giudice istruttore perché poi ci sarà qualcuno che giudicherà lei”. Lo lasciai che era pensieroso. Tornai alla Corte d’Assise, dove c’erano il Soldeti e l’avvocato che mi aspettavano. Raccontai loro la discussione avuta col giudice. L’avvocato ascoltava attentamente. Poi disse: “Ha fatto bene, 104 La Democrazia Cristiana per lei è anche ammesso fermare un giudice per strada, ma io non potevo mettermi a discutere in piazza. Se fosse stato nel suo ufficio gli avrei parlato anch’io. Ora vedremo come ha preso le sue parole. Domattina vado a trovarlo. L’istruttoria non può durare in eterno. Prima o poi devono prendere una decisione. Ma si tratta di un processo molto frenato, ci sono molti nodi da sciogliere”. Io gli dissi: “Ora sta a voi avvocati fare qualcosa perché abbiamo in mano altre prove molto importanti”. Salutammo l’avvocato e si tornò a casa. Durante il viaggio si parlò dei nostri avvocati. Io volevo convincere il Soldeti a lasciar perdere Zavataro, che quella mattina non era voluto venire dal giudice. Il Soldeti però voleva tenere anche quell’avvocato, perché era un avvocato con un certa fama e poi ci era stato assegnato da una associazione che ci permetteva di non spendere una lira per pagarlo. Io avevo per conto mio anche l’avvocato Belli Pietro, che non era tanto famoso però mi sembrava più sincero di Zavataro. Appena tornai a casa mi consigliai con i miei familiari. Eravamo tutti in attesa della famosa decisione che dovevano prendere i giudici in camera di consiglio. Passarono una quindicina di giorni e io, che ero ansioso di sapere cosa decidevano i giudici, stavo sulle spine, perché mi sembrava che tutti volessero assolvere il marchese e il fattore. Così tornai a Firenze, dall’avvocato Belli. Questi mi disse che in effetti le cose erano un po’ cambiate. Mi disse che il giudice istruttore non aveva firmato l’istruttoria, che venne sospesa. A questo punto il marchese e il fattore non erano né assolti né condannati e le cose rimasero così per altri sei mesi. Il Franciolini non poteva agire perché si sentiva controllato, ma neppure io potevo agire perché mi pareva che mi fossero tutti contro: il Franciolini, il marchese, il piovano, il procuratore, il giudice istruttore. Mi venivano i brividi nel veder tradire così tanti innocenti. Ma poi ebbi la forza di resistere a questa idea e la costanza per resistere alle mie avversità. Dopo circa sei mesi al giudice istruttore Saladini venne una paralisi celebrale e nel giro di due ore cessò di vivere. Al suo posto fu eletto un altro giudice istruttore che firmò subito l’istruttoria, così gli altri due imputati furono dichiarati innocenti e assolti per non aver commesso il fatto. Mi riferisco al marchese e al fattore. Ecco allora il Franciolini 105 che riapre il processo per i fatti accaduti al cimitero. Cercò di dimostrare che la vittima era lui, perché lo avevano offeso e calunniato. Fece chiamare dal tribunale i miei figli e i Soldeti, denunciati da lui per offese e calunnie. A me aumentava la passione e l’odio, giorno per giorno. Prima dovevo lottare per far giustizia ai morti, ora dovevo lottare per i morti e i vivi. Era un doppio dolore e doppia era la mia ragione. Il Franciolini non pensava a quello che avevamo subito e a quello che avevamo passato nel vederci trucidare le persone più care, tutte innocenti, straziate dai fascisti. Che poi ci avevano rubato tutto quello che gli faceva comodo: prosciutti, salami, salsicce, fegatelli, che andarono a mangiare in un bosco a due chilometri da Pomino. Erano allegri e soddisfatti come se fossero stati ad una festa. Furono visti da vicino da persone del luogo, che dissero che i fascisti erano una sessantina. Questi fascisti ci avevano anche bruciato la casa. Ancora vige il codice fascista, che conta più della costituzione. Il Franciolini si servì di questo codice e vedendo che le autorità lo proteggevano ne approfittò per far apparire che lui aveva ragione. Io e l’avvocato Belli andammo alla redazione del giornale “La Nazione” per far scrivere alcuni articoli a quel giornale sul nostro caso. Si voleva che l’opinione pubblica si rendesse conto della nostra situazione e di chi era la colpa di tanto male fatto nella nostra zona. Quando il redattore ci vide si mise le mani nei capelli. Ci salutò e gli si chiese di fare un articolo sul giornale riguardante i fatti di Pomino. Il redattore disse: “Me lo immaginavo che mi avreste chiesto questo, appena vi ho visti. Ma non posso farlo assolutamente, mi spiace. Dopo che feci quell’articolo riguardante la strage di Pomino venne qui il prefetto in persona e proibì di fare qualsiasi pubblicità riguardo a questo fatto finché non fosse finito il processo”. L’avvocato disse: “Tu fallo ugualmente. Se ci saranno delle contestazioni ne risponderemo noi”. Il redattore disse: “Avete ragione, ma proprio per questo il prefetto non vuole che l’opinione pubblica si renda conto della causa di molti mali. Se io facessi un altro articolo come dite voi verrei subito licenziato. Vado contro la mia volontà ma dovete sapere che ho una famiglia da mantenere. Dove lo trovo un altro lavoro?”. Una volta ci avevo parlato anch’io con il prefetto e mi era sembrato che fosse 106 La Democrazia Cristiana d’accordo con i fascisti. Cosa potevo sperare? Eravamo come ai tempi di Mussolini, regnava il codice fascista anziché la costituzione. Successe come quando uccisero Matteotti, nel 1924. Luigi Alberti, direttore del “Corriere della Sera” di Milano, per aver fatto pubblicità al caso Matteotti scrivendo la verità sull’accaduto fu costretto da Mussolini a lasciare il giornale e a ritirarsi a vita privata. La stessa cosa sarebbe successo al redattore de “La Nazione” se avesse fatto il suo dovere. Ecco a che punto siamo, anche oggi. Io non sapevo più a chi rivolgermi. Vedevo che erano tutti contro di noi che eravamo i più sacrificati. Per me non è cambiato nulla, la ragione è sempre ai fascisti. Cosa conta cambiare il nome? Si sente ugualmente dire: “Noi abbiamo tanti quattrini e non ci fa paura nessuno. Ha voglia il Vangelisti a trovare testimoni, a noi non ci può far niente”. Io dovevo sentire queste parole e constatare che era proprio così. La situazione era talmente ingiusta che tornai a Roma. Andai alla redazione del giornale “L’Unità”, per vedere se avessero potuto fare col loro giornale quella pubblicità ai fatti di Berceto che il redattore de “La Nazione” non aveva voluto fare. Si dava il caso che un certo Mordenti Renato abitasse in casa di un mio nipote. Questo Mordenti era impiegato in un ufficio de “L’Unità”. Spiegai al Mordenti tutta la vicenda, poi gli chiesi se poteva fare qualche articolo su questi fatti sul giornale sul giornale in cui lavorava. A portarmi da lui fu sua madre stessa, che trovai in casa di mio nipote. Il Mordenti disse che l’avrebbe fatto volentieri, però prima dovevo andare alla sezione comunista del mio comune e far fare da loro gli accertamenti del caso e una dichiarazione. Poi lui, appena avesse ricevuto le notizie, le avrebbe fatte pubblicare. Dopo una lunga conversazione salutai il Mordenti e tornai a casa, sperando che alla sezione comunista mi facessero questa dichiarazione. Appena giunsi alla sezione chiesi ciò che mi serviva e mi dissero che avrebbero convocato il consiglio degli iscritti e avrebbero fatto quello che chiedevo. Ma probabilmente c’era qualcuno che mi spiava perché mentre la sezione comunista preparava questi documenti “L’Unità” pubblicò un articolo contro di me. In questo articolo si diceva che io ero campagnolo, un contadino, che non conoscevo la guerra e non potevo essere competente in fatti che riguardavano 107 la magistratura, come se fossi stato un cervellotico. Nessuno può immaginare come mi si rimescolò il sangue nel vedere che anche il giornale in cui avevo un po’ di fiducia mi si metteva contro in quel modo. Io andai alla sezione del partito comunista per vedere come si mettevano le cose. Mi dissero: “Se il giornale ha pubblicato questo articolo è inutile mandare alla redazione le nostre informazioni. Vuol dire che si sono già informati anche loro. E poi sarebbe uno scandalo, per il giornale, dare più versioni di uno stesso fatto”. Non vollero più prendere in considerazione il mio caso. Mi pareva di avere una spina nel cuore. Tutte le volte che trovavo una strada buona vedevo questa strada, dopo un po’, tramutarsi in un torrente che era impossibile percorrere. Non avevo altre speranze. Tornai a casa, con questo dolore. Anche i miei figli, soprattutto quelli più grandi, soffrivano per queste cose. Il giorno dopo vennero a casa mia tre uomini, fra i quali c’era un redattore de “L’Unità” di Firenze. Mi chiesero delle informazioni sul Franciolini. Io mostrai loro l’articolo scritto contro di me. Poi dissi: “Avete questa fiducia in me e ora mi venite a chiedere informazioni di questo genere. Dovreste vergognarvi. Dovrei bastonarvi, ma non voglio sporcarmi le mani”. Il redattore disse: “Io ho fiducia in lei, non l’ho scritto io questo articolo”. Allora dissi: “se ha tanta fiducia in me, faccia un altro articolo e ridatemi la fiducia che mi avete tolto”. Il redattore disse: “Io sono sottoposto, non posso fare quello che voglio, il direttore non me lo permetterebbe”. Io dissi: “Perché siete dei vili senza reputazione. Se mi promettete di dire la verità sui fatti successi qui, vi do tutte le informazioni che volete, altrimenti potete andarvene”. Questi se ne andarono, vergognosi e insoddisfatti. Io pensai che la causa di tutto quel putiferio fosse il direttore de “L’Unità” di Roma. La mattina dopo, sempre con la solita passione, tornai a Roma. Trovai Mordenti Renato nel suo ufficio. Gli mostrai l’articolo. Lui mi guardò come se la prima volta che ero stato da lui non gli avessi detto la verità. Io gli chiesi se poteva farmi parlare con il direttore. Il Mordenti disse: “Volentieri, fra pochi minuti dovrebbe arrivare”. Mentre aspettavo gli raccontai tutta la commedia che avevano fatto in quei giorni i suoi colleghi. Ma non lo vedevo molto persuaso. Arrivò il direttore. Lo salutai e gli 108 La Democrazia Cristiana mostrai l’articolo su di me, che avevo sottolineato. Lui lo lesse poi disse: “Tu chi sei”. Io dissi: “Sono quel contadino di cui lei parla in questo articolo. Dice che sono un campagnolo, che non conosco la guerra e che non posso essere competente per indicare i responsabili di tutto quello che è successo. Mi fa la gentilezza di dirmi chi l’ ha informato e perché, secondo lei, sarei un cervellotico?”. Il direttore disse: “Sono stato messo di mezzo anch’io. Forse hai ragione, ma non è colpa mia. Tutti dicevano che il Franciolini era la cagione di tutto, che era un criminale, che aveva ammazzato un inglese, che era stato un repubblichino. Tutti parlavano male di questo Franciolini. Io feci un articolo sul mio giornale di quello che si diceva, dell’inglese che era stato caposettore. Il Franciolini mi querelò. Io venni a Firenze a parlare con i partigiani che erano a Pomino. Chiesi loro se qualcuno poteva testimoniare che il Franciolini fosse responsabile delle colpe attribuitegli. Dissero tutti che queste cose le avevano sentite dire ma nessun aveva una prova sicura. Io ho avuto ottantaquattro querele. Quella è stata l’unica in cui ho dovuto prendere il torto. Fui costretto a fare un accomodamento con il Franciolini. Il Franciolini mi chiese di fare questo articolo e io l’ho dovuto scrivere per liberarmi della querela. Poi due persone mi dissero che un certo Vangelisti, di Pomino, era al corrente dei fatti. Io mandai tre uomini credendo che tu gli dessi informazioni precise invece mancò poco che tu li picchiassi”. Io dissi: “Se lei scrive un altro articolo per ridarmi la fiducia che mi ha tolto con questo, io le faccio avere le testimonianze sicure per fare condannare il Franciolini”. Il direttore disse: “Io non posso fare berlicche e berlocche. Ho già fatto due articoli, uno contro l’altro. Un altro articolo ora non lo faccio davvero”. Io gli dissi: “Mi pare che lei, direttore, abbia sbagliato in pieno. Lei ha detto che io non conosco la guerra. Invece mi pare di conoscerla meglio di lei. Deve sapere che io ho fatto quattro anni al fronte, ho saputo fare la vedetta, sono stato di pattuglia, ho fatto tanti assalti alle trincee nemiche e ho saputo riportare a casa la pelle. Significa che non è come dice lei. Poi lei dice che io sono un contadino e un campagnolo. Questo è vero, e non mi offende. Però mi sento offeso perché lei mi fa passare da cervellotico. Mi risponda a questa doman109 da: a cosa serviva la mia testimonianza se lei era già d’accordo con il Franciolini?”. Il direttore disse: “Quando io venni a Firenze ancora non mi ero accordato col Franciolini. Fui costretto a farlo in seguito perché non trovai testimonianze”. Io dissi: “Io non so quando fu che lei venne a Firenze. Io so che quando lei mandò quei tre uomini da me a chiedere informazioni sul Franciolini l’articolo contro di me era già stato scritto. Altrimenti per quale motivo avrei voluto picchiare il redattore di Firenze”. Gi mostrai l’articolo e la data della pubblicazione. Poi dissi ancora: “Lei si crede troppo furbo. Io, come contadino e campagnolo, le insegno a fare il direttore di giornale. Prima di offendere una persona ci pensi bene. Se fa così invece di ottantaquattro querele in breve ne subirà più di cento.” Il direttore disse: “Lo hai detto anche tu che il Franciolini ha ucciso un’inglese ed è un criminale. Se io avessi trovato subito i testimoni non avrei fatto questo articolo contro di te”. Io dissi: “Venni qui diversi giorni prima che lei avesse scritto questo articolo e il Mordenti, qui presente, lo può dire. Gli chiesi se poteva scrivere alcuni articoli sulla vicenda che riguardava me e il Franciolini. Se ci fossero state delle querele ne avrei risposto io. Ma il Mordenti mi rispose che non era possibile se prima non mi facevo fare una dichiarazione dalla sezione comunista del mio paese, per essere sicuro di quello che dicevo. Avrebbe dovuto fare così anche lei, signor direttore, per non trovarsi nei pasticci. Non creda di farla franca, io la farò scomparire”. Il direttore disse: “Se è vero che hai tante testimonianze contro il Franciolini perché non lo fai condannare?”. Queste parole furono per me come una coltellata al cuore. Gli dissi: “Non è ancora stato condannato perché i giudici sono come lei: gli piace mangiar bene e parecchio”. Il direttore disse: “Allora non sono il solo a darti torto” e andò via. Mentre si discuteva questo direttore cambiava spesso colore di faccia e c’erano dei momenti in cui non sapeva rispondere. Il Mordenti, presente alla discussione, vedeva che il direttore aveva torto ma non poteva dir nulla perché era sottoposto. Io pensai di parlare con l’onorevole Togliatti. Lasciai il Mordenti e tornai da mio nipote, che aveva una mescita di vini. In quel posto capitava gente di tutte le idee. Veniva spesso uno che faceva propaganda per il partito comunista. 110 La Democrazia Cristiana Io una sera mi misi al suo tavolo. Gli offrii una sigaretta. Questi l’accettò e ci si mise a parlare. Gli dissi che ero lo zio del gestore dello spaccio. Dopo una lunga conversazione, lo vedevo molto gentile, gli confidai la mia situazione e gli dissi che desideravo parlare con l’onorevole Togliatti. Questo, che era una degna persona, mi chiese se avevo la tessera del partito comunista. Gli dissi che non l’avevo e gli spiegai il motivo per cui non mi ero iscritto al partito. Gli spiegai anche il motivo per cui volevo parlare con l’onorevole Togliatti. Allora lui mi disse: “Se mi dà i documenti che ha con sé ci penso io a farla parlare con Togliatti”. Gli diedi quei pochi documenti che avevo. Lui mi disse: “Questa sera scriverò una lettera che domattina lei dovrà consegnare al segretario generale, perché credo che Togliatti non ci sia”. Mi salutò gentilmente e disse: “A domani”. Quella notte pensavo: “Chissà in che mani ho messo i miei documenti; uno mai visto e mai conosciuto”. Mi sembrava che quella notte durasse mille anni. Non vedevo l’ora che si facesse giorno. Mi pareva un sogno che fosse tutto vero. La mattina dopo, verso le dieci, mi incontrai con il gentiluomo. Mi accompagnò lui stesso dal portiere della sede del partito di Togliatti. Parlarono un po’ fra loro, in disparte, poi il portiere mi chiamò e mi accompagnò in un ufficio dove c’era il signorino. Quest’ultimo guardò tutti i miei documenti poi mi accompagnò in un altro ufficio dove c’era un impiegato. Questi mi chiese i miei documenti e andò nell’altro ufficio. Poi tornò e mi accompagnò all’ufficio del segretario generale Caparra, col quale ebbi un lungo colloquio. Prima cosa gli parlai della strage compiuta a Berceto dai fascisti il 17 aprile 1944, dove morirono undici persone, fra le quali cinque dei miei familiari innocenti. Poi gli diedi i documenti del processo che si doveva fare, parlandogli anche della denuncia contro i miei figli e i Soldeti fatta dal Franciolini. Il segretario generale osservò a lungo quei documenti poi disse: “Questi sono i frutti del fascismo. C’è ancora tanta oscurità, non sei il solo a soffrire. Cosa avresti intenzione di fare mediante la nostra amministrazione?”. Io dissi che volevo mettere alla luce queste barbare tragedie in modo che l’opinione pubblica potesse sapere come si erano svolti i fatti e chi era la cagione di tante rovine e tante ingiustizie. Siccome avevo 111 ancora fiducia nel suo giornale, “L’Unità”, gli raccontai anche la discussione avuta con il direttore del giornale e gli mostrai l’articolo scritto contro di me. Il segretario generale disse: “Questo è un fatto che riguarda proprio me”. Rimase mortificato. Poi disse: “Mi puoi lasciare questo articolo? Vedrò cosa si può fare in merito. Questo fatto è proprio di mia competenza. Ma riguardo al processo non posso fare nulla. Non è stata fatta l’epurazione che avremmo voluto fare e al potere c’è sempre la solita gente. Si sono visti tanti processi di questo genere ma le cose in chiaro non si sono mai viste”. Io dissi: “Purtroppo queste cose le so anch’io. Ero venuto per questo, non sapevo più a chi rivolgermi”. Gli consegnai l’articolo del giornale e la lettera datami quel mattino da quel signore. Poi lo salutai e gli chiesi scusa per il disturbo. Lui mi ringraziò per averlo messo al corrente, soprattutto per la faccenda dell’articolo e mi promise che se ne sarebbe interessato. Infatti lo fece. Dopo diciotto giorni dalla mia visita al segretario di Togliatti il direttore de “L’Unità” fu licenziato. Si vede che il segretario e Togliatti trovarono giuste le mie osservazioni. Sono stati gli unici che mi hanno dato una piccola soddisfazione. Fu da quella volta che cominciai ad avere fiducia in Togliatti e nel suo segretario. Se fossero stati tutti come loro sarebbero stati smascherati i responsabili della rovina della nostra società. Sarebbero stati chiariti i fatti come il mio ed altri più gravi ancora. Era per questo che la maggioranza di quelli che erano al governo erano contro Togliatti. Perché erano stati loro la causa di tante rovine e di tanto sangue innocente sparso. E non volevano essere scoperti, per cui tenevano la gente onesta e povera ai margini, perché non ci fosse giustizia. Soltanto i grandi capitalisti, che possiedono molti soldi, hanno sempre ragione. Rendiamoci conto di questo. Tengono il popolo schiavo, oppresso e lo perseguitano. Io ero nelle file delle vittime. Da Roma andai a Firenze. Si avvicinava il giorno del processo e non ero riuscito ad ottenere niente. Avevo un po’ di relazione con Mariotti, che ora è al Senato e ministro della sanità. Allora era assessore al comune di Firenze. Andai a parlare con lui. Vidi che mi prese in considerazione. Mi fece parlare con un deputato socialista, credendo che prendesse le mie difese essendo un avvocato. Parlai a lun112 La Democrazia Cristiana go con questo deputato, che però si rifiutò di prendere la mia difesa dicendo che era inutile, e mi spiegò i motivi, che erano quelli di cui mi aveva detto Caparra. Anche lui disse che c’erano sempre i fascisti al potere ed era inutile tentare di far valere le proprie ragioni in questi processi. Disse: “Ne ho visti tanti, ma nemmeno uno è andato in fondo. Purtroppo, capisco che ha ragione ma non si illuda, non riuscirà ad avere soddisfazione”. Tutti quelli con cui parlavo dicevano le stesse cose. Da un lato mi facevano rabbia ma dall’altro capivo che avevano ragione. Avevo constatato personalmente che tutti coloro che erano al potere volevano vedere assolti i criminali, come se fossero stati d’accordo con loro. Io, che volevo smascherare i responsabili, fui perseguitato. Questo non lo potevo sopportare. Era troppo il dolore causatomi la mattina del 17 aprile 1944 e nessuno sarebbe riuscito a impedirmi di cercare i colpevoli. Questi cercavano in tutti i modi di avvilirmi. Anche per altre cose fui perseguitato. Il maresciallo dei carabinieri di Rufina tentò di mettermi in un pasticcio, per aggravare la mia situazione. Fra i miei figli c’erano due maschi che ancora dovevano fare il servizio militare. Uno era del 1925 ed era stato rivedibile. Quando richiamarono la classe del ventisei a noi non giunse nessun avviso. Mussolini era andato giù, c’era una confusione indescrivibile. Molti di quelli che erano sotto le armi tornarono a casa e nessuno disse loro niente. Mio figlio non aveva ricevuto nessun avviso e non si presentò. Anzi, aveva fatto domanda per il porto d’armi ed era stato dal maresciallo dei carabinieri, che non gli aveva detto nulla in merito al servizio militare. Nel 1948 arrivò l’avviso dell’altro mio figlio, che era del ventotto, di andare a fare la visita militare. Fu dichiarato abile. Quando partì per fare il servizio militare arrivò l’avviso anche a quello del venticinque. Dovevano partire ambedue, insieme. Siccome c’era il decreto legge in cui si diceva che le famiglie in cui era morto un figlio per cause di guerra erano esentate dal mandare il figlio maggiore a fare il militare, io andai dal maresciallo dei carabinieri del mio comune per chiarire questa cosa. Io di figli morti per causa di guerra ne avevo avuti quattro e credevo di avere diritto di tenere a casa il primo. Invece questo maresciallo l’aveva messo come renitente e io sarei stato responsabile 113 quanto lui perché dovevo farlo presentare. Ci aveva denunciati tutti e due. Io gli spiegai le mie ragioni e lui disse che era stato il maresciallo dei carabinieri di Castel San Nicolò, dove il mio figlio maggiore aveva fatto la visita, a fare questa denuncia. Io andai da questo maresciallo di Castel San Nicolò che fu ancora più severo. Mi disse: “Lei andrà in carcere con suo figlio”. Ma io non mi sottomisi e non mi persuasi. Gli dissi: “ C’è questa disposizione del ministero in cui si dice che il figlio maggiore delle famiglie che hanno avuto un figlio morto per cause di guerra è esentato dal servizio militare”. Il maresciallo disse: “Io non ne so niente. È stato il distretto di Arezzo che ha mandato l’avviso. Il foglio dell’avviso di chiamata alle armi per quelli della classe 1925 era stato affisso e suo figlio doveva presentarsi. Ora vedetevela voi”. Io andai ad Arezzo, al distretto militare. Mi dissero che gli avvisi di chiamata alle armi per le classi 1925 e 1926 erano stati affissi e se a mio figlio non gli era arrivata la cartolina di chiamata la cosa riguardava i carabinieri del mio comune. Io tornai dal maresciallo dei carabinieri di Rufina e gli dissi quello che mi avevano detto ad Arezzo. Questo maresciallo disse: “Non crederanno di mettermi nel pantano per voi. Quando suo figlio si presenterà si vedrà cosa c’è da fare”. Io andai a Firenze. Avevo una certa relazione col professor Vannetti, ex console di Panama ed ex ufficiale dell’esercito. Lo misi al corrente di questo fatto. Questo Vannetti, molto gentile, telefonò alla legione dei carabinieri di Firenze. Prese appuntamento per me con il colonnello di questi carabinieri. Andai da questo colonnello e gli spiegai la situazione. Mi disse se mio figlio era andato via da casa e io gli risposi che era sempre rimasto in famiglia. Poi mi chiese se il maresciallo dei carabinieri di Rufina aveva mai fatto chiamare mio figlio. Io dissi di no e aggiunsi che mio figlio era andato da questo maresciallo per avere il porto d’armi. Il colonnello mi chiese se aveva già parlato con questo maresciallo prima di ricevere questo avviso. Io dissi: “Sì, abbiamo parlato tante volte, a causa di quella strage che è stata fatta a casa mia”. Disse: “Va bene, va bene, ho capito”. Chiamò il maresciallo e gli dettò una lettera, che fu battuta in doppia copia. Un foglio avrei dovuto consegnarlo ai carabinieri di Rufina e l’altro avrei dovuto tenerlo io. Mise i due fogli 114 La Democrazia Cristiana in due buste diverse, che mi consegnò. Salutai il colonnello e me ne andai. Però non sapevo cosa c’era scritto in quella lettera, se si trattava di cose buone o cattive. Mi incamminai per tornare dal professor Vannetti, ma per strada guardai cosa c’era scritto sul foglio. C’era scritto che mio figlio veniva esentato, permanentemente, dal servizio militare e poi c’era un’osservazione al maresciallo dei carabinieri di Rufina perché sarebbe stato suo dovere avvertirci e darci schiarimenti. Andai a ringraziare il professor Vannetti e tornai a casa. Portai quella lettera al maresciallo dei carabinieri di Rufina. Questi, dopo averla letta, cambiò subito tono. Disse: “Allora vediamo di esentare il suo figliolo dal servizio militare”. Io dissi: “Poteva farlo anche prima, senza farmi girare e patire tanto”. Lui disse: “Quando va bene al colonnello a me va sempre bene, ma non potevo agire di mia iniziativa”. Io gli dissi: “Ma il decreto legge era uguale per lei come per il colonnello”. Lo salutai e tornai a casa. Per quello che riguardava il servizio militare di questo mio figlio mi sentivo soddisfatto. Ma riguardo al processo contro i miei figli più passava il tempo e più perdevo la speranza che fosse fatta giustizia, perché il fascismo riprendeva vigore. Comandavano sempre i soliti. Se qualcuno prendeva le mie difese veniva subito trasferito. Come successe al procuratore generale di Firenze a cui avevo consegnato la lettera del Ministero di Grazia e Giustizia. Ero tornato a Roma, dal solito funzionario, ma anche lui mi aveva detto che non poteva fare più nulla. Le cose avrebbero potuto essere chiarite solo a Firenze, dove si erano svolti i fatti. Solo a Firenze la giustizia avrebbe potuto fare qualcosa. Quelle parole per me erano state un duro colpo perché sapevo che a Firenze erano tutti contro di me: prefetto, giudice istruttore, procuratore generale, marchese, avvocati, piovano. Nessuno di questi grandi personaggi ebbe la coscienza di riflettere su quello che avevo dovuto subire e quello che avevo provato nel ritrovarmi in un mare di sangue, dolore e di sofferenze. Loro non consideravano gli errori fatti dal fascismo. Eppure, tutti i partiti avevano lottato per sconfiggere il fascismo. Era stata fatta la costituzione. Il fascismo non avrebbe più dovuto esistere. Doveva essere stata fatta una epurazione dei fascisti. Invece li vedevi protetti dall’autorità. E quelli che furono colpiti dal 115 fascismo, che lottarono per sconfiggerlo, sono ancora perseguitati. Eppure siamo nel 1949, in democrazia cristiana. Io penso che avremo ancora dei guai e che i fascisti faranno altre vittime. Ma io non tacerò comunque la verità, per rispetto alle vittime innocenti. Venne firmata l’istruttoria che rinviava a giudizio i miei figli e i Soldeti. Ci arrivò l’avviso di presentarci in tribunale. Io andai dai miei avvocati. Durante questi mesi io avevo trovato testimoni importanti, che avrebbero potuto costringere il tribunale a fare giustizia. Quando l’avvocato Zavataro ebbe parlato con quei testimoni disse che sarebbe stato meglio rinviare il processo a un’altra data. Io non ero d’accordo. L’avvocato disse: “Bisogna che io studi sulle dichiarazioni di questi testimoni. Non possiamo andare in aula senza aver preso coscienza dei verbali”. Io dissi: “Ci sono ancora quattro giorni al processo. Se vuole faccio venire da lei questi testimoni, così li può interrogare a fondo e preparare i suoi verbali”. Lui disse: Se vuole che difenda i suoi figli si deve far rinviare il processo. Se invece vuol fare a modo suo si cerchi un altro avvocato”. Io non sapevo più cosa fare. C’erano solo quattro giorni al processo e un altro avvocato, che era all’oscuro di tutto, non avrebbe fatto in tempo a presentarsi. Andai dall’avvocato Belli, per sentire cosa mi consigliava di fare. Il Belli era del mio parere. Venne con me dall’avvocato Zavataro per discutere la cosa. Il Belli disse a Zavataro: “io credo che non sia possibile far rinviare il processo perché il tribunale ha già mandato gli avvisi. E poi, al punto in cui siamo, a cosa servirebbe un rinvio”. Zavataro disse: “Ci penserò io. Se volete che il processo sia rinviato faccio fare da un medico un certificato di malattia a una delle imputate e i processo non possono farlo”. L’avvocato Belli disse: “io credo che possano farlo ugualmente, perché sono tutti imputati per lo stesso motivo e se qualcuno non è presente può venir condannato per contumacia”. Zavataro disse: “Quando io dico una cosa sono sicuro di quello che dico. Se volete che io difenda gli imputati si deve fare rinviare il processo. Se poi volete fare come volete voi fatelo pure, io lascio tutto, non voglio responsabilità”. L’avvocato Belli, che si sentiva inferiore a Zavataro, finì per dargli ragione. Io non ero soddisfatto ma ero nelle loro mani e dovetti stare a quello che avevano deciso gli 116 La Democrazia Cristiana avvocati. E poi il dottore che doveva fare il certificato di malattia a una delle mie figlie era nipote del professor Vannetti, che mi aveva aiutato, e pensai che non sarei stato tradito. Zavataro disse che avrebbe pensato lui al certificato medico, a far rinviare il processo e ad avvertire gli imputati e i testimoni. Io tornai a casa, ma non ero tranquillo. Mi consigliai con i miei figli e i Soldeti. Loro dissero: “Se gli avvocati hanno consigliato di fare in questo modo probabilmente hanno ragione, non possiamo passare avanti a loro”. Avevano ragione, ma io quella notte non riuscii a dormire. La mia mente navigava sempre nella tragica sorte che mi era toccata e in quella a cui andavo incontro. Non avevo pace. Il giorno dopo tornai a Firenze per cerare di convincere Zavataro a non farmi rinviare il processo. Appena mi vide disse: “Ho già sistemato tutto. Ieri ho lavorato tutto il giorno per lei, vedrà che non si troverà pentito”. Dopo quelle parole non ebbi il coraggio di dirgli niente. Gli diedi l’indirizzo dei nove testimoni che avrebbero dovuto venire a deporre. Lo salutai e andai dall’avvocato Belli. Questi mi disse: “Se ha detto così, speriamo sia vero. Sarebbe un’offesa per Zavataro se il processo non venisse rinviato. Però io la consiglio di venire ugualmente in tribunale, così sentiremo a quando rinvieranno il processo”. Io gli promisi che mi sarei presentato. Lo salutai e lui di nuovo disse: “Guardi di non mancare, penso che la sua presenza sarà importante”. Io presi in considerazione il consiglio dell’avvocato Belli, perché l’avevo sempre visto sincero. Il giorno del nostro processo andai a Firenze. Cercai l’avvocato Zavataro, ma non c’era. Mi dissero che era andato a Brescia. Allora andai dall’avvocato Belli, col quale mi recai in tribunale. Lì ci dissero che il processo si sarebbe svolto quella mattina stessa, l’aveva deciso il tribunale, e che entro un’ora avrebbero fatto l’appello dei testimoni e degli imputati. L’avvocato Belli disse: “Ma Zavataro ha portato qui un certificato medico dove si dichiara che l’imputata Vangelisti Lina è ammalata e non può presentarsi”. Il giudice disse: “Se c’è un motivo giustificato non verrà giudicata ma il processo si fa ugualmente”. Questa fu per me una tremenda notizia. Mi vergognavo, di fronte a tanta gente. Il corridoio era pieno di curiosi che volevano assistere a questo processo, chiamato il processone. Era più di 117 un anno che questo processo era in corso. Quando fecero l’appello degli imputati e dei testimoni avrei voluto scomparire per non provare quella passione: dei miei non c’erano né imputati né testimoni. Pensai che Zavataro mi avesse tradito e che fosse d’accordo con i miei nemici. Il pubblico non conosceva ragioni. Probabilmente la gente pensava che i miei figli e i Soldeti fossero colpevoli perché di loro non c’era nessuno mentre quelli della parte del Franciolini c’erano tutti. Appena iniziò il processo il pubblico ministero chiese che gli imputati venissero giudicati in contumacia. L’avvocato Belli disse: “Non è colpa né degli imputati né dei testimoni se non sono presenti, ma dell’avvocato Zavataro, che ha detto loro di non presentarsi perché il processo sarebbe stato rinviato. Come vedete non c’è neppure Zavataro, che è il loro difensore”. I giudici si ritirarono in camera di consiglio. Dopo circa venti minuti tornarono in aula. Il giudice chiese all’avvocato Belli se in aula c’era qualcuno della parte interessata. L’avvocato disse: “c’è il padre dei Vangelisti”. Il giudice disse: “Lo faccia venire da me”. Io mi presentai davanti al giudice, che mi chiese se ero disposto a rispondere sui fatti della strage e su quelli avvenuti al cimitero. Io risposi di sì. Il giudice mi fece prestare giuramento e poi mi chiese perché i miei figli non si erano presentati. Io risposi: “Perché Zavataro, quale nostro difensore, ci disse che il processo era stato rinviato e che aveva fissato questo con voi giudici. Per me è stata una sorpresa. Non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione come questa dopo aver assistito al massacro di quattro miei figli e di mia moglie, che come lei saprà sono stati uccisi il 17 aprile del 1944. Quelli che sono scampati a quella strage oggi li vedo qui in veste di imputati, ma sono innocenti”. Il giudice chiamò il Franciolini e ci fece fare il confronto, in presenza di quella folla che non finiva più. Il giudice mi chiese se io avevo avuto con il Franciolini altre questioni. Io risposi di no. Il giudice disse: “Perché allora avrebbe fatto sterminare la sua famiglia?”. Io risposi: “Indirettamente. Stando a quello che dicono i testimoni e a quello che ho appurato io fu il Franciolini a ordinare il rastrellamento, in quanto voleva togliere i partigiani da quella zona perché lo molestavano continuamente”. Il giudice chiese al Franciolini: “È vero che lei 118 La Democrazia Cristiana veniva molestato dai partigiani?”. Il Franciolini rispose: “Non è vero io ho sempre aiutato i partigiani, ho sempre dato loro tanta roba, tutto quello di cui avevano bisogno”. Il giudice si rivolse a me dicendo: “Perché i partigiani lo molestavano se ha sempre dato loro tutto ciò di cui avevano bisogno?”. Io dissi: “Quello che dice il Franciolini non è vero. Ci sono testimoni che dicono che circa dieci giorni prima della strage il Franciolini disse che quel posto, quello dove successe la strage, andava bruciato perché i partigiani si rifornivano sempre di roba. Poi il Franciolini si arrabbiò con il contadino che abitava vicino a me perché aveva promesso degli agnelli alla fattoria e invece questi agnelli furono presi dai partigiani. In quell’occasione il Franciolini disse: “Sembra che qui siano padroni i partigiani. Vedete come va a finire”. Poi il Franciolini venne da me. Io ero nel campo insieme a mia moglie. Ci fece leggere un foglio in cui aveva elencato tutta la roba che gli avevano preso i partigiani. C’erano segnate anche le due paia di scarpe che poi furono trovate ai piedi dei due partigiani morti in quella strage. Il Franciolini si lamentò proprio di fronte a noi dei partigiani. Non è vero che dava loro la roba spontaneamente, gliela dava per forza, come disse a noi”. Il giudice chiese al Franciolini: “È vero che lei disse: “Questo posto va bruciato” al contadino che abita vicino al Vangelisti?”. Il Fattore rispose: “Si, ma lo dissi perché sapevo che i fascisti facevano così nei posti dove c’erano i partigiani, non perché io volessi che quel posto fosse bruciato e fossero uccise delle persone”. Il giudice gli chiese ancora: “È vero che lei fece leggere quella lista ai coniugi Vangelisti?”. Il Franciolini disse: “Si, ma quella roba l’avevo data io di mia spontanea volontà”. Il giudice mi chiese: “Se il Franciolini dava quella roba ai partigiani di sua spontanea volontà che motivo avevano questi di molestarlo?”. Io risposi: “Perché il Franciolini aveva ucciso un inglese, nostro alleato e nemico dei fascisti. Fu lì che nacque tutta la questione”. Il giudice chiese al Franciolini se era vero che aveva ucciso un inglese. A questo punto intervenne il difensore del Franciolini, che dissi: “In quella causa fui io a difendere il fattore Franciolini. Quell’inglese era entrato nella fattoria per aggredire il fattore e al processo il Franciolini fu assolto per aver agito per legittima difesa”. Il giudice si rivolse a me 119 e disse: Per legittima difesa è anche ammesso uccidere”. Io dissi: “Non è vero che l’inglese l’avesse aggredito, perché lasciò una ricevuta del denaro che aveva chiesto”. Il giudice chiese al Franciolini: “È vero che l’inglese lasciò una ricevuta?”. Il Franciolini rispose: “Si, lasciò un foglietto in cui non si capiva cosa c’era scritto. E poi non si sa di che nazionalità era. Forse era cecoslovacco, ma le scarpe erano di marca tedesca”. Il giudice chiese come sapevo che si trattava di un inglese. Io dissi: “Perché nella ricevuta c’era scritto: “Dio salvi l’Italia e l’Inghilterra. La ringrazio del denaro ricevuto. Quando arriveranno gli alleati sarà ricompensato” e sotto c’era la firma. Questo biglietto lo lesse il medico condotto in presenza del Franciolini e del personale della fattoria. Questo il Franciolini non lo può negare”. Il giudice mi disse se avevo altro da dire. Io dissi: “Si, il Franciolini mandava delle lettere a delle spie che erano fra i partigiani. Una la mandò la mattina stessa della strage. La ricevette quello che puntò la rivoltella contro di me e contro i due partigiani che volevano andarsene. Infatti poi quei due furono uccisi. Ma quello che ricevette la lettera e tutti gli altri che vollero rimanere non furono uccisi. Io penso che fossero d’accordo col Franciolini, mi pare chiaro”. Il giudice chiese al Franciolini: “È vero che lei spediva delle lettere a delle spie che erano fra i partigiani?”. Il Franciolini disse: “Ne ho mandata una sola al capo formazione Ferrero Ferreri, che non era una spia”. Questa lettera riguardava un fatto di grano di un certo Onofelli. Infatti era presente anche l’Onofelli quando un certo Fossati consegnò questa lettera al Ferreri”. Il giudice mi chiese come mai sapevo che colui che riceveva le lettere dal fattore era una spia. Io dissi: “Perché il Franciolini ne ha mandate tre, a quanto mi risulta, mentre lui lo nega. Una l’ha mandata in un posto chiamato Graina, una la mattina della strage e un’altra ancora è quella di cui parlava il Franciolini. Quest’ultima non fu mandata al capo formazione Ferrero Ferreri. La lettera la ricevette il solito Toci Del Medico Osvaldo. Il capo formazione non c’entra per niente perché so anche che la risposta a quella lettera non la scrisse lui. Qui si vede bene che quello che dice il Franciolini è tutto falso”. I giudici e i giurati si ritirarono in camera di consiglio. Erano circa le ventuno ed era dalle nove che eravamo lì, 120 La Democrazia Cristiana salvo un paio d’ore per il pranzo. Poco dopo i giudici tornarono in aula. Avevano stabilito di aggiornare il processo all’undici marzo. Io ero poco soddisfatto, la giornata si era presentata male. Comunque ora Zavataro poteva interrogare anche i nuovi testimoni. Poi vennero più persone a consigliarmi di trovare un accordo con il marchese Frescobaldi e il fattore Franciolini, che avrebbero anche ritirato la querela contro di noi. Ma io non volli fare accomodamenti con nessuno. Volevo solo che fosse fatta giustizia. Zavataro aveva detto che se il processo fosse stato rinviato avrebbe messo a posto le cose a mio favore. Quando arrivò l’avviso di ripresentarmi al processo non persi tempo. Andai a vedere se tutti i miei testimoni avevano ricevuto l’avviso. La madre superiora non era stata chiamata. Io le chiesi se poteva presentarsi, mi avrebbe fatto un grande favore. Lei mi disse che se la sua testimonianza fosse stata indispensabile sarebbe venuta. La ringraziai e andai a trovare il Ponticelli Torello. Anche lui non era stato avvisato. Gli chiesi se l’undici marzo avrebbe potuto venire al processo. Il Ponticelli disse che gli dispiaceva ma non poteva venire perché aveva un appuntamento con l’ingegnere del marchese Frescobaldi. Disse: “Sono rimasto d’accordo con il marchese che l’undici marzo si sarebbe fatta una permuta. È tanto tempo che sto dietro al marchese Frescobaldi per fare questa permuta e non posso perdere questa occasione”. Io pensai che era strano che il Ponticelli, dopo tanto tempo che voleva fare questa permuta, fosse riuscito a fissare un appuntamento proprio l’undici marzo. Gli chiesi se mi faceva la cortesia di scrivermi una dichiarazione indicando il motivo per cui non poteva presentarsi al processo, oltre al fatto che non era neppure stato avvisato. Lui scrisse su un foglio i motivi della sua assenza e lo firmò. Io lo ringraziai e tornai a casa. Ma non ero molto soddisfatto. Il Ponticelli era un testimone molto importante. Il giorno del processo tutti gli imputati e i testimoni erano presenti. Consegnai all’avvocato Belli il biglietto del Ponticelli. Dopo che fu fatto l’appello il Belli consegnò al presidente il foglio del Ponticelli. Il giudice osservò, a voce alta: “Proprio oggi il marchese Frescobaldi e l’ingegnere dovevano fissare con il Ponticelli. Proprio oggi”. Chiese al mio avvocato se voleva mettere la cosa a verbale. L’avvocato disse: 121 “Faccia come crede”. Il giudice disse: “Bisogna andarlo a prendere. Abita molto lontano?”. Il Franciolini disse: “Poco più di trentacinque chilometri. Se vuole andiamo noi a prenderlo. Abbiamo la macchina e facciamo presto”. Il giudice disse: “Lei non si preoccupi, ci penso io”. Poi chiese se c’era qualcuno che conosceva la strada per andare da lui. Rispose di sì un fattore del marchese Frescobaldi, il Perpoli. Sembrava che il giudice volesse veramente fare giustizia: mandò due carabinieri insieme al Perpoli a prelevare questo testimone. Mentre questi andarono e tornarono il giudice interrogò gli imputati e qualche testimone. Poi, prima l’avvocato del Franciolini e in seguito anche il giudice, chiesero se eravamo disposti a ritirare le denunce: il Franciolini avrebbe fatto altrettanto. Il Soldeti e suo figlio accettarono la proposta e si ritirarono. Ma io e i miei figli rispondemmo: “Noi vogliamo che sia fatta giustizia. Saremo nelle file delle vittime ma non in quelle dei vili”. La mia figlia maggiore disse: “Non posso permettere che sia negata la verità alla mia mamma e alle mie sorelle, innocenti, assassinate barbaramente. Mi sentirei macchiata d’infamia se non facessi il possibile perché i responsabili subiscano le conseguenze del loro gesto. Ora sta alle vostre coscienze decidere”. Il giudice disse: “Non c’è niente da fare, bisogna fare il processo”. Nel frattempo erano tornati i carabinieri col Ponticelli. Il giudice lo chiamò e gli fece prestare giuramento. Poi gli chiese cosa poteva dire riguardo ai fatti successi a Berceto la mattina del 17 aprile 1944. Il Ponticelli disse: “Riguardo a quel fatto posso dire ciò che ho udito da quei falsi partigiani che commentavano la faccenda. Li udii con molta chiarezza”. Il giudice gli chiese: “Come poteva sapere che si trattava di falsi partigiani? Li conosceva”. Il Ponticelli disse: “No, ma lo hanno detto loro mentre parlavano con quelli che erano rimasti di guardia al camion, che gli chiesero com’era andata. Uno di quelli vestito da partigiano disse: “Oggi è andata bene. Abbiamo ucciso undici ribelli, fra i quali c’erano due elementi del comando di liberazione nazionale. Abbiamo ucciso anche loro. Eravamo in una capanna. Quando si sentirono le prime fucilate il contadino voleva mandarci via. Anche i due partigiani volevano andarsene ma io gli ho puntato contro la pistola e li ho fatti restare, mentre il contadino l’abbiamo buttato 122 La Democrazia Cristiana fuori della capanna a spinte. Poco dopo è arrivata una nostra pattuglia. Abbiamo ammazzato i due partigiani e sterminato le famiglie vicine che aiutavano i partigiani, poi abbiamo bruciato le case””. Il giudice disse: “Come poté ascoltare questa lunga conversazione senza essere visto?”. Il Ponticelli rispose: “Ero nel mio orto. Stavo accucciato dietro una siepe molto fitta. Non mi mossi fino a quando non andarono via. Quando partirono, quelli che avevano un fazzoletto rosso al collo per sembrare partigiani, lo buttarono via e si misero a scherzare con gli altri”. Il giudice chiese: “Lei è parente del Vangelisti”. L’interrogato rispose: “No, lo conosco da poco tempo”. Il giudice allora chiese al Ponticelli: “Come ha fatto a mettere al corrente il Vangelisti di questo fatto?”. Il Ponticelli rispose: “un giorno venne da me il Vangelisti a comprare le sigarette e mi chiese se era vero che io avevo assistito ad una discussione di questo genere. Disse che lo aveva saputo da alcuni a cui avevo raccontato questo episodio. Io gli dissi di sì e lui mi chiese se ero disposto a testimoniarlo. Io gli promisi che lo avrei fatto perché sapevo di dire la verità”. Il giudice fece uscire il Ponticelli e chiamò il partigiano che riceveva le lettere dal Franciolini, lo steso che aveva impedito ai due veri partigiani di uscire dalla capanna. Il giudice chiese al partigiano, il Toci,: “Lei era a Berceto, in Pomino, il 17 aprile 1944, quando furono uccise tutte quelle persone?”. Il Toci rispose “Si, c’ero anch’io” il giudice disse: “Perché quando quei due partigiani se ne vollero andare non li lasciò uscire dalla capanna?”. Il Toci rispose: “Non pensavo che sarebbero arrivati i tedeschi, e non volevo che ci si dividesse”. Il giudice gli chiese se aveva ricevuto la lettera del Franciolini. Lui rispose di si. Allora gli chiese cosa c’era scritto in quella lettera. Il Toci disse: “C’era scritto che io…” A questo punto rimase zitto poi disse: “Non ricordo. Si trattava di grano, di olio, una cosa del genere”. Il giudice disse: “Riconoscerebbe quello che le ha consegnato la lettera?”. Il Toci disse: “Sì. Era un omino” il giudice fece venire il Fossati, che sarebbe stato l’omino. Il giudice chiese al Toci se era quello l’uomo che gli consegnò la lettera. Il Toci rispose: “Sì, è lui. Gli diedi anche la risposta per il Franciolini”. Il Fossati disse: “Io non portai né lettere né risposte”. Il giudice non fece loro altre domande, per evitare lo scan123 dalo. Si erano contraddetti e condannati da sé. Fu poi chiamato il piovano, Don Amato Fanetti, l’unico testimone a favore del Franciolini. Il piovano disse: “Io posso solo dire che il Franciolini è una degna persona e non si merita di essere accusato di aver causato la strage di Berceto”. Il giudice fece uscire il piovano dall’aula e chiamò a deporre la madre superiora delle suore canossiane di Firenze. Le fece prestare giuramento poi le chiese se aveva parlato col piovano di Pomino dei fatti successi a Berceto il 17 aprile 1944. La madre generale rispose: “Si, ne abbiamo parlato”. Il giudice le chiese cosa aveva detto il piovano a questo riguardo. La madre superiora disse: “Il piovano mi disse che erano state uccise 9 persone a causa dei partigiani. I partigiani molestavano il Franciolini, non gli davano pace, gli portavano via la roba e lo minacciavano continuamente e il Franciolini fece fare un rastrellamento per levare i partigiani da quella zona, perché portavano via la roba anche ai contadini. Fu costretto a chiamare i fascisti ma non voleva che fossero uccisi i civili”. Il giudice fece chiamare il piovano per fargli fare il confronto con la madre superiora. Ma il piovano non si fece più vedere. Fu chiamato più volte anche per i corridoi ma non c’era più. Era scappato appena aveva visto la madre superiora, per non fare il confronto. Si era presentato perché non pensava che la madre superiora sarebbe stata presente al processo. Infatti la madre superiora non era stata chiamata dal tribunale ma l’avevo mandata a chiamare io mentre il processo era in corso. Se il piovano fosse stato sicuro di aver detto la verità non se ne sarebbe andato in quel modo. Era l’unico testimone a favore del Franciolini e aveva agito in quel modo. A questo punto i giudici si ritirarono in camera di consiglio. Io pensai a come avrebbe potuto finire quel processo. Misi insieme tutti i motivi che potevano aver causato quella strage. Misi quella strage. Misi insieme quello che avevo visto e quello che avevo udito, quello che avevano detto gli imputati e i testimoni. Poi feci mentalmente un riassunto della situazione. Il risultato era che l’origine di quel disastro andava ricercata nell’uccisione dell’inglese che il fattore ammazzò nella fattoria. Questo inglese era stato fatto prigioniero dall’esercito fascista per cui per il Franciolini era un nemico. Quando Mussolini andò giù il go124 La Democrazia Cristiana verno cambiò colore e si fece alleanza con gli inglesi. Di conseguenza l’inglese diventò alleato dei partigiani. Questi erano contro il Franciolini, lo minacciavano continuamente, non gli davano pace. Quando usciva dalla fattoria aveva bisogno di una scorta perché aveva paura dei partigiani. Ecco il motivo per cui il Franciolini fece il rastrellamento. Con me e con il contadino che abitava vicino a me si era lamentato perché i partigiani gli avevano impedito di vendere gli agnelli. Aveva detto: “Sono padroni loro” riferendosi ai partigiani, poi aveva aggiunto: “Questo posto va bruciato”, come infatti fu bruciato. Poi venne da me mentre ero nel campo con mia moglie. Arrivò tutto agitato e si lamentò perché i partigiani gli avevano portato via la roba, di cui aveva fatto una lista che ci mostrò. Nella lista c’era anche una macchina fotografica e le scarpe che poi furono trovate ai piedi dei due partigiani uccisi a Berceto il giorno della strage. Erano due di quelli che lo molestavano e che lui voleva togliere dalla zona, come infatti fu fatto. I falsi partigiani dimostrarono di essere d’accordo con il fattore Franciolini. Questo era molto chiaro perché proprio quello che riceveva le lettere dal fattore mi puntò contro la pistola e in seguito non permise che due veri partigiani se ne andassero. Disse ai due partigiani: “Qui si sta tutti alla sorte”. Ma lui sapeva benissimo a chi sarebbe toccata la sorte. Infatti furono uccisi solo i due che se ne volevano andare, quelli che calzavano le scarpe del fattore. Quei partigiani quando arrivarono, quel mattino, non vollero rifugiarsi dal contadino vicino dicendo che avevano paura di essere visti durante il percorso. Ma quando si udirono i primi spari i falsi partigiani si tolsero le scarpe. Significa che non avevano più paura. Eppure erano momenti terribili per i partigiani. Questo dimostra che erano d’accordo con quelli che stavano facendo il rastrellamento. Io sapevo che il falso partigiano Toci Del Medico aveva ricevuto tre lettere dal fattore Franciolini, mentre il Franciolini negava di avergliene fatte avere. Questo significa che il fattore non voleva far sapere che c’erano dei fascisti fra i partigiani. Poi c’era quello che il Ponticelli Torello aveva udito chiaramente: tutta la conversazione fra quei falsi partigiani e i loro colleghi fascisti che erano rimasti di guardia al camion. Il fattore Franciolini era capo settore, in quella zona. 125 Tutto il popolo di Pomino sa che il Franciolini rappresentava quella zona ed era il responsabile di tutto quello che vi succedeva. Quando Mussolini ordinò di portare all’ammasso tutto il rame che ognuno possedeva e di consegnare l’oro, perfino l’anello matrimoniale, noi di quella zona si dovette consegnare tutto al fattore Franciolini. Era lui l’incaricato di raccogliere questa roba e noi si portò tutto alla sua fattoria. Una povera sposa non poté consegnare l’anello matrimoniale perché l’aveva perso. Il Franciolini la offese con i titoli peggiori, dicendole fra l’altro che era una traditrice della patria, come se senza quell’anello non si potesse vincere la guerra. Comunque lui era un capo fascista della zona e certamente era al corrente di quello che sarebbe successo a Berceto, la mattina della strage. Poi ci sarebbero tanti altri particolari, che tralascio, altrimenti ci vorrebbe troppo tempo. Ero in ansia, aspettavo che i giudici tornassero in aula per sentire cosa avevano deciso in camera di consiglio. Rientrarono in aula dopo circa mezz’ora. Il presidente lesse il verdetto: “Sono condannati Vangelisti Lina, Vangelisti Vera, Vangelisti Valerio, Soldeti Gino e Soldeti Silvano per le accuse a loro carico”. Per me fu un’altra coltellata al cuore vedere i miei figli condannati anche se ebbero la condizionale. Non rimasi soddisfatto della sentenza e ricorsi in appello. Lasciai l’avvocato Zavataro e presi l’avvocato Roncaglia. Questi andò a controllare i verbali poi mi disse che non era riuscito a trovare i motivi per cui il fattore e il marchese fossero responsabili di quella strage. Io mi ero immaginato che avessero cambiato le carte in tavola, ma non pensavo fino a quel punto. Raccontai al nuovo avvocato di quando udii il giudice istruttore suggerire al Franciolini come doveva deporre. Questi mi disse che ci volevano dei testimoni. Poi disse: “È difficile sciogliere una matassa così intricata. Se verrà fatta questa riforma potremo mettere in chiaro le cose, altrimenti l’unica cosa da fare è cercare di fare assolvere i suoi figli, senza andare oltre”. Prima lottavo per scoprire i criminali e fare giustizia, ora dovevo lottare per far capire che i miei figli erano innocenti e che avevano detto la verità, non avevano calunniato. Ma successe che quelli che avevano detto la verità furono condannati mentre i responsabili del massacro furono assolti per non aver commesso il fatto. Ora si tiene 126 La Democrazia Cristiana il crocefisso nei tribunali per far credere che siamo cristiani però, invece di seguire il Vangelo, la dottrina di Cristo, si segue il codice fascista, le leggi di Mussolini. Oggi si vede fare monumenti ai caduti, ai martiri del fascismo, e si vede rimettere sul trono i fascisti. Cosa possiamo sperare? Non ricordiamo più il passato? Forse solo quelli che hanno subìto una sorte come la mia si ricordano di cosa ha fatto il fascismo. Il fattore Franciolini si sentiva un superuomo. Amministrava 40 poderi, dove c’era olio, vino, grano, frutta, migliaia di capi di bestiame, migliaia di ettari di boschi, selve e abetine. La sua fattoria era corredata di tutto. C’era un falegname, un fabbro, vari muratori, due sottofattori, un cantiniere e anche il cuoco. Erano tutti a disposizione del fattore. Era servito e riverito. Pareva che non gli mancasse niente. Aveva sempre fatto il superuomo, aveva formato il suo spirito con il fascismo, come diceva lui. Se c’era qualche contadino che voleva far valere le proprie ragioni lo mandava via dal podere. Quelli che erano alle sue dipendenze dovevano ubbidirgli. Quello che faceva lui era sempre ben fatto. Voleva essere apprezzato e riverito. Io, che a causa del fascismo avevo perso moglie e quattro figlie, non mi sentivo di riverirlo e quando dovevo fargli delle osservazioni gliele facevo. Molte volte mi accorsi che quando andavo alla fattoria lui si nascondeva perché aveva paura. Da molti anni non veniva più nel podere di Berceto. Secondo me, perché si sentiva colpevole. Però mi perseguitava, voleva che io lasciassi il podere. Ma io non me la sentivo di lasciare quella casa, dove avevo visto spargere il sangue innocente dei miei cari. Così ci odiava sempre di più. Mi impediva di vendere e di comprare. Una volta vendetti del bestiame e andai dal fattore per sentire se era contento. Mi rispose di no, che non dovevo venderlo. Allora portai quel bestiame alla fattoria e lo consegnai al fattore per il prezzo a cui l’avevo venduto. Questo fattore si arrabbiava spesso con me perché era abituato ad essere riverito dagli altri contadini e pensava che quello che diceva lui fosse sempre ben detto, mentre io invece mi ribellavo. Gli aumentò il rancore contro di me. Un giorno pensò di compromettermi e mandò da me un sottofattore. La mattina del 12 giugno del 1954 mi trovavo nel campo con i miei due figli. C’era anche un certo Marpaganti Carlo, 127 che era venuto ad aiutarci a segare l’erba. Erano circa le nove. Arrivò questo sottofattore e cominciò a fare delle osservazioni ingiuste, forse voleva che mi compromettessi. Mi disse: “Perché non ha vangato i filari delle viti?”. I filari erano stati vangati. Gli dissi: “Sarà meglio che torni a studiare un altro po’ perché è molto indietro se non sa riconoscere il vangato dal non vangato. Cosa viene qua a fare osservazioni”. Questo prese la giannetta con le due mani, come se volesse picchiarmi. Io avevo il bastone che serviva a spingere l’erba sotto alla falciatrice. Lo alzai perché non si accostasse. Quell’uomo che ci aiutava mi prese il bastone. Il sottofattore si fece avanti per picchiare ma i miei figli lo trattennero. Così non successe niente. Si allontanarono tutti di una trentina di metri da me e si misero a parlare amichevolmente. C’era anche questo Marpaganti, che mi aveva tolto il bastone dalle mani. Gli fecero capire le mie ragioni. Questo sottofattore chiese scusa, salutò e andò a fare il giro negli altri campi. Tornò alla fattoria all’ora di pranzo, ma il fattore non c’era. Dopo pranzo il sottofattore riprese il lavoro. Verso le quattro del pomeriggio tornò il fattore. Il sottofattore gli riferì del giro fatto in mattinata e gli parlò della lite fra me e lui. Era quello che cercava il Franciolini. Consigliò al ragazzo di dire che era stato picchiato e di mettersi a letto. Poi chiamarono il padre e la madre di questo ragazzo, anche loro fascisti, e fra tutti obbligarono il sottofattore a dire che si sentiva male perché lo avevano picchiato e che gli doleva tutto il corpo dalle percosse. Pensavano che il dottore credesse a quello che gli avrebbero detto. Mandarono a chiamare il dottore che visitò il sottofattore e non gli trovò niente. Questo sottofattore diceva: “Mi fa male qui, mi fa male là” ma il dottore non trovò nulla. Il fattore Franciolini e il padre del ragazzo mostrarono al medico una piccola lesione che il sottofattore aveva sotto la gola e lo pregarono di fare un certificato per dire che il ragazzo sarebbe stato guaribile entro quindici giorni. Il dottore disse: “L’ho vista bene questa lesione, ma non giustifica un certificato come quello che mi chiedete voi”. Ma questi insistevano, volevano un certificato in cui si dichiarasse che il sottofattore doveva stare a riposo per quindici giorni. Questo dottore era a Pomino da soli due giorni e non poteva sapere chi era colui col quale aveva a che fare. Il fattore 128 La Democrazia Cristiana insisteva, dicendo: “Bisogna dare una lezione a quei contadini, sono dei delinquenti”. Il dottore disse: “Gli darò sette giorni di riposo, ma il male non c’è”. Questi ci rimasero male, soprattutto il Franciolini, perché prima che arrivasse il medico avevano avvisato i carabinieri perché venissero a Berceto ad arrestarmi insieme ai miei figli. Pensavano che il dottore dichiarasse ciò che volevano loro. Ma furono traditi dal loro stesso spirito vendicativo. Da Firenze partirono due camion di carabinieri e andarono alla caserma dei carabinieri di Rufina. Arrivarono verso le 23,30. Nel paese c’erano alcune persone ancora alzate. Videro questi due camion di carabinieri a un’ora così tarda e si incuriosirono. Poco dopo uscì dalla caserma un lavandaio e questi curiosi gli chiesero cosa ci facevano tutti quei carabinieri a Rufina. Questi disse: “Vanno ad arrestare i Vangelisti, perché oggi hanno picchiato il sottofattore che è a letto e non si può muovere”. Tutti sapevano che i miei familiari erano stati ammazzati dai fascisti e la gente diceva: “Hanno avuto poche disgrazie, ora li mettono anche in prigione?”. Qualcuno diceva: “Il fattore non va più a Berceto perché ha paura. Ma sarà vero?”. Decisero di guardare dove andavano quei due camion di carabinieri e videro che andavano in Pomino. Era circa mezzanotte. Ma il verbale che aveva fatto il dottore non permetteva l’arresto, così i carabinieri invece di venire a casa mia andarono alla fattoria. Io ancora non sapevo niente di tutto ciò. Queste cose le seppi in seguito da coloro che erano presenti nelle varie occasioni. La mattina del 13 giugno il fattore mandò a chiamare il dottore perché prorogasse di tre o quattro giorni il riposo del sottofattore. Gli promise di vendergli i locali dell’ambulatorio, che si trovavano in un palazzo appartenente alla fattoria. Ma il dottore non accettò. Allora il fattore e il padre di questo ragazzo gli chiesero di venire da me per convincermi ad andare alla fattoria per accomodarci e vedere se potevamo ritirare la denuncia. Il dottore venne da me alle sei. Io non lo conoscevo. Mi disse che era il medico di condotta, che era stato chiamato alla fattoria per visitare il sottofattore che io avevo percosso la mattina precedente. Poi disse: “Sono venuto per vedere se è disposto a fare accomodamento. L’hanno querelata e se non trova un accordo per lei può mettersi male”. Io dissi: “Non mi 129 meraviglio che ci abbiano querelati, perché so bene chi sono. C’è anche un testimone”. Il dottore disse: “Gli ho trovato una lesione sotto la gola. Dice che gliela avete procurata voi quando lo avete aggredito”. Io dissi: “Gliela avrà fatta il fattore la lesione. Lei non lo conosce, è capace di fare questo e altro”. Poi gli raccontai tutto quello che era successo e che c’era stato fra me e il fattore. Il dottore si mise le mani nei capelli e disse: “Ora capisco perché volevano che io gli dessi quindici giorni di riposo. Mi pento di avergliene dati anche sette. Se io avessi accettato lei e i suoi figli sareste stati portati in prigione. Sono stato messo di mezzo anch’io. Però le conviene venire alla fattoria e cercare un accomodamento. Un po’ di colluttazione c’è stata e ora lei si trova messo un po’ male”. Io dissi: “Sono sicuro di non averlo toccato, non posso aver torto. Alla fattoria non ci vengo. La ringrazio per avermi informato. Dica loro che se hanno bisogno di me possono venire qui. Io sono sicuro di quello che dico, ho anche un testimone”. Il dottore disse: “Vedrà che se non viene lei verranno qui i carabinieri”. Io dissi: “Può venire chi vuole”. Ci salutò e lui se ne andò. Dopo circa venti minuti arrivò il maresciallo dei carabinieri con un appuntato. Mi fecero la stessa proposta fattami dal dottore cioè mi consigliarono di andare alla fattoria. Io dissi: “Ma cosa devo accomodarmi col fattore se non ho fatto niente”. Il maresciallo volle che lo conducessi sul luogo dove c’era stato il battibecco con il sottofattore. Quando si fu sul posto disse: “Lei prese il bastone per picchiare il sottofattore”. Io dissi: “il bastone l’avevo per dare l’erba alla falciatrice. Senza bastone non si può falciare. Io alzai il bastone per difendermi perché il sottofattore aveva afferrato la giannetta con due mani per picchiare me”. Il maresciallo prese il bastone, lo guardò, poi disse: “Come nacque la questione?”. Io gli dissi la verità. Dissi: “Questo sottofattore venne qui a fare un monte di osservazioni ingiuste. Disse, fra l’altro, che quelle file di viti non erano vangate. Lo vede anche lei se sono vangate o no. Allora io gli ho detto che era meglio se tornava a studiare ancora un po’ e di tornare quando era in grado di fare osservazioni perché se non sapeva riconoscere il vangato significava che era ancora molto indietro. Lui si è sentito offeso. Ha preso la giannetta con due mani per picchiare e io 130 La Democrazia Cristiana ho alzato il bastone per difendermi. Il Malpagati Carlo mi ha preso il bastone e i miei figli hanno tenuto fermo il sottofattore. Non è successo niente di male”. Il maresciallo fece chiamare il Malpagati per sentire se avevo detto la verità. Arrivò il Malpagati e diede la stessa versione dei fatti che avevo dato io. Però la querela era già stata fatta e io non volevo accomodamenti così il maresciallo ci fece andare a Rufina per fare il verbale. Si andò, i miei figli, il Malpagati e io, a Rufina a fare le nostre deposizioni. In paese incontrai molti dei miei amici. Appena mi videro mi salutarono e mi diedero la mano, erano contenti di vedermi. Poi mi dissero: “Si credeva che tu fossi in prigione”. Io credevo che scherzassero. Raccontai quello che era successo e dissi che il maresciallo ci aveva invitati a Rufina per fare le nostre deposizioni. Loro dissero: “Questa notte sono arrivati due camion di carabinieri per arrestare te e i tuoi figli”. Io non ci credevo così loro mi raccontarono quello che avevano saputo e mi assicurarono che era vero. Li salutai e andai dal maresciallo, dove si fece tutti le nostre deposizioni. Quando il maresciallo ebbe finito di fare i verbali gli dissi: “Credevo che i carabinieri fossero più coraggiosi”. E lui: “Perché, non lo siamo?”. “Non mi pare – dissi – perché per arrestare uno come me sono venuti due camion di carabinieri da Firenze”. Il maresciallo mi chiese chi mi aveva detto quelle cose. Dissi: “Sono stati visti venire qui e poi dirigersi a Pomino”. Lui si mise a ridere e rispose: “È un caso, stavano facendo delle manovre notturne”. “Se date retta al Franciolini – dissi – quello vuota la testa anche a tutti voi”. E il maresciallo: “Le persone si conoscono frequentandole. Io l’ho visto un paio di volte e di lui non posso dire niente”. “Speriamo che lo conosca presto – risposi – a me ha fatto imbiancare i capelli”. Salutai il maresciallo e andai a prendere il giornale. C’era un articolo in cui si diceva che io e i miei figli avevamo picchiato il sottofattore che ora era a letto a causa delle percosse ricevute. Avrei voluto querelare il giornale ma c’era il certificato medico che parlava di sette giorni di riposo e poi avevo un solo testimone. Ora, comunque, dovevo aspettare un altro processo contro di noi. Ma ormai avevo fatto conoscere il Franciolini all’opinione pubblica e tutti sapevano cosa aveva fatto contro di me. Ormai il fattore aveva 131 perso la fiducia anche degli altri. Solo i fascisti lo difendevano. Io ero convinto che in tribunale sarebbe successo come nel precedente processo, dove si fu condannati, ma si sapeva di avere la coscienza a posto e di aver fatto il nostro dovere. Così ero deciso a fare anche questo processo. Anche se fossi stato condannato non importava, non volevo essere vile. Non avevo molti soldi, sapevo di essere perseguitato, ma in compenso sapevo di aver ragione. Dopo un po’ di tempo mi mandarono a chiamare per vedere se era possibile ritirare la querela. Io dissi che ormai l’avevano fatta e si sarebbe visto in tribunale chi aveva ragione. Poi andai dal dottore per vedere se in tribunale avrebbe confermato quello che mi aveva detto, cioè che il fattore aveva promesso di vendergli i locali dell’ambulatorio, che si trovavano in un palazzo di proprietà della fattoria, se lui avesse dato quindici giorni di riposo al sottofattore. Lui disse: “È meglio che troviate un accomodamento altrimenti finisco male anch’io”. Io gli dissi: “È gente di cui non ci si può fidare. Possono farmi fare questo accomodamento per farmi passare dalla parte del torto e mettermi in condizione di dover subire delle conseguenze peggiori”. Il dottore disse: “Lei faccia questo accomodamento. Se poi loro ne approfittassero per farle del male allora direi tutto. Ma non credo che possono farlo. Dia retta a me, altrimenti non posso prometterle di confermare quello che avevo detto”. Capii che anche lui era stato messo in mezzo. Seguii i suoi consigli. E poi la querela era stata fatta dal sottofattore e il Franciolini e il marchese non avrebbero potuto essere coinvolti nella faccenda e essere riconosciuti colpevoli, secondo la giustizia. Ma io lo sapevo che erano colpevoli, come lo sapeva il dottore. Prima di firmare feci molti sforzi per farlo. Dicevo: “Quello che avete fatto ai miei familiari, sia a quelli morti che a quelli vivi, ora lo state facendo a me”. Loro si sarebbero trovati in tribunale per la terza volta, sempre con il torto, sempre a causa loro, ma loro avevano i quattrini e io no; avevo solo la ragione, con la quale, però, gli davo molto filo da torcere. Probabilmente l’avrebbero spuntata anche questa volta. Con i loro quattrini avevano già vinto tutti i processi. Ma questa volta si umiliarono. Mi fecero un sacco di promesse: se io mi accomodavo con loro mi avrebbero venduto circa trenta ettari di 132 La Democrazia Cristiana terreno e tre case situate nel podere al prezzo di sette milioni. Io, visto che la causa riguardava solo il sottofattore, accettai. Mi diedero una pianta dove erano segnati i confini. Poi mi chiamarono per firmare il contratto. Prima però mi portarono da un avvocato per risolvere il fatto della querela. L’avvocato scrisse su un foglio che io non dovevo più tornare sui fatti passati, nemmeno sulla strage del ’44, e che non avrei più avuto niente a che fare con il marchese Frescobaldi e il fattore Franciolini e niente da dire per nessun motivo. Mi diedero questo foglio, io lo lessi e trovai subito alcune cose che non mi tornavano. Mi pareva di aver gli spiriti addosso tenendo quel foglio in mano. Lo buttai sulla scrivania e non volli saperne più niente. Mi fecero pensare che erano veramente responsabili, come già pensavo, di quello che era successo alla mia famiglia. Io avevo portato anche una mia figlia, con me. Anche lei era d’accordo. Firmai il foglio riguardante il fatto successo il 12 giugno del 1954 per fare questo accomodamento, ma non quello riguardante i fatti del ’44. Mi sento più ricco e felice avendo la coscienza tranquilla che avere un patrimonio e la coscienza sporca. Dopo aver firmato quel foglio mi accorsi che il Franciolini aveva sempre più paura di me. Quando andavo alla fattoria lui si nascondeva. Io ci andavo quando avevo degli interessi da fare, dimostrandogli che avevo la coscienza pulita più della sua e non avevo paura di nessuno, benché fossi solo un contadino. Invece lui, di cui tutti avevano soggezione, aveva paura. Dopo la querela del sottofattore non gli diedi respiro, visto che lui perseguitava me. Da molti anni io non andavo più alla messa in Pomino, da quando il piovano giurò davanti ai giudici che il fattore era una degna persona, mentre sapeva benissimo che aveva ucciso quell’inglese, nostro alleato. In più sapeva anche che era stato il Franciolini a ordinare quel rastrellamento dove furono uccise tredici persone: due a Cigliano e undici a Berceto. Il piovano sembrava non desse importanza a questa strage dove furono uccisi bambini, vecchi e donne. Se non avessero rubato tredici galline a lui chissà come avrebbe strillato; certamente avrebbe fatto mettere in prigione i ladri. Noi operai e contadini per il piovano si era gente senza importanza. Eppure, come quasi tutti i preti di campagna, anche questo piovano campava sul 133 lavoro dei contadini. Erano quelli trattati peggio quelli che lavoravano per un prete. Non a caso, infatti, c’è il proverbio che dice: “Eccomi come mi vedete: scalzo, ignudo e contadin di un prete”. Questo piovano era come Don Abbondio, che stava dalla parte dei potenti. Dopo la questione della querela fattami dal sottofattore ci fu festa del Corpus Domini. Il fattore ebbe il privilegio dal piovano di portare l’ombrellino durante la processione, per coprire il santissimo. Il fattore aveva accettato l’incarico, credendo che io andassi alla funzione. Alla processione c’era il baldacchino davanti e subito dietro il fattore con l’ombrellino. Quel giorno mi venne l’ispirazione di partecipare alla funzione, come facevano tutti, per onorare il Santissimo. Durante la processione mi avvicinai al baldacchino, e mi misi proprio dietro al fattore, accanto al quale c’era suo figlio maggiore. Questi mi vide e avvisò il padre. Il fattore si voltò e vedendomi gli venne la faccia bianca come la cappa che indossava. Stava sotto al baldacchino per stare lontano da me. Dimostrava di avere paura e di essere in colpa, benché la legge l’avesse assolto. Non si sentiva sicuro nonostante fosse vicino al Santissimo e ci fossero i carabinieri vicino al baldacchino. Si entrò in chiesa. Ci fu la funzione poi la gente uscì dalla chiesa e ognuno se ne andò per i fatti propri. Anche i carabinieri se ne andarono. Ma il fattore non lo vidi uscire. Io, visto che non usciva, mi misi a girellare nel piazzale, solo. Restai lì circa mezz’ora, ma il fattore non uscì. Chissà cosa pensava. Visto che non usciva lasciai il piazzale e andai sul marciapiede di fronte, dove c’era la casa del popolo. Per tornare alla fattoria il Franciolini doveva passare proprio di lì. Dopo pochi minuti vidi il fattore passare, scortato da due sottofattori, dal figlio e dal suo casiere. Lo avevano messo fra loro e camminavano raggruppati per tenerlo al sicuro. Io li seguii per un tratto di strada. Loro ogni tanto si voltavano. Era quasi buio. Andai da un contadino che abitava vicino alla fattoria. Rimasi lì fino a mezzanotte. Il Franciolini credeva che il lo volessi aggredire. Il giorno dopo chiese di lasciare la fattoria. Visto che io non accettavo né soldi né capitali forse pensò che volessi veramente vendicarmi. Ma io non mi sarei mai macchiato di sangue. Sapevo benissimo che la vendetta porta vendetta, lascia solo odio e rancore. Così il Franciolini 134 La Democrazia Cristiana Giuliano si decise a lasciare quella fattoria, dove era nato e aveva vissuto per cinquantadue anni. Erano trent’anni che amministrava quella grande azienda. Tutti temevano questo fattore, che però fu costretto ad abbandonare tutti i suoi sogni di potere sul popolo di Pomino. Aveva una cappella nel cimitero dove aveva sepolto i suoi genitori e sua moglie. Quando andò via portò con se anche le ossa dei suoi familiari, che mise nel cimitero di Firenze. A Firenze comprò una casa lussuosa. Poi si trasferì a Roma e aprì un grande negozio di pelletterie. Dopo due anni fallì e gli sequestrarono tutto, anche la casa di Firenze. Andò a lavorare in una cooperativa, in piazza San Firenze. Lo vidi io stesso caricare fiaschi di vino su un furgoncino per consegna a domicilio. Era diventato un poveraccio. Mi fece compassione. Io passavo spesso di lì, avevo comprato un appartamento da quelle parti. Quando vedevo quella scalinata del tribunale mi venivano i brividi, perché mi tornavano in mente tante tristi giornate. Allora mi voltavo dalla parte opposta, dove c’era il Franciolini al lavoro. Pensavo si sentisse umiliato, a causa mia. Ma sentivo di avere la coscienza pulita anche per questo. Dopo un po’ di tempo, passando da piazza S. Firenze, non vidi più il Franciolini. Chiesi dov’era e mi dissero che era andato via. Non chiesi dove, non mi interessava. Dopo molto tempo seppi che era morto. Gli auguro con tutto il cuore che sia stato perdonato e che possa godere la felicità nell’altra vita. Io credevo che il popolo di Pomino fosse contro di me, invece dopo che il Franciolini se ne fu andato ci furono elezioni per rinnovare l’amministrazione comunale e io fui eletto consigliere comunale nelle liste del Partito Comunista; settanta percento dei voti. Non me lo sarei mai aspettato, la cosa mi fece molto piacere. Non per avere una carica ma perché il popolo di Pomino aveva dimostrato di essermi amico e di stare dalla mia parte. Questa è la mia storia. Spero che serva a far pensare coloro che la leggeranno. Io ormai sono alla fine della mia vita e credo di aver capito come funziona la società. Noi operai e contadini siamo considerati come bovi o cavalli. Quando il cavallo fa il suo dovere gli si da una manciata di zucchero perché si affezioni al padrone ma se si impenna e non vuole tirare il barroccio dove vuole il padrone le cose cambiano. Non più zucchero 135 ma frustate, finché il cavallo non cede. Se poi insiste lo si manda al macello e se ne trova un altro che tiri il barroccio docilmente. La stessa cosa succede a noi proletari. Io ho avuto sei decorazioni di onorificenza, tra medaglie di bronzo, una medaglia d’oro, una croce al merito di guerra e una croce da Cavaliere di Vittorio Veneto. Queste erano le manciate di zucchero perché il cavallo continuasse a tirare il barroccio dove voleva il padrone. Quando eravamo al fronte nei momenti difficili, venivano i nostri padroni e ci dicevano, molto gentilmente: “Siamo tutti figli della madre patria, dobbiamo lottare per difenderla”. In quattro anni di guerra quante promesse fecero? E quanti cavalli morirono per difendere la madre patria? Dopo aver vinto la guerra il popolo tornò alle proprie case e ricordandosi delle promesse fatte sperava di essere ricompensato dei sacrifici. Essendo fratello degli altri italiani, in quanto figlio della stessa patria, ogni combattente chiese che venissero riconosciuti i propri diritti. Ecco dove il cavallo si impennò. Ai padroni non andava bene che il cavallo diventasse fratello del padrone, non ricordavano più quello che avevano promesso, non avevano nessun interesse a farlo. Sapevano solo che il cavallo doveva tirare il barroccio, o per amore o per forza. Noi sappiamo bene come fu trattato il popolo, ossia i poveri, coloro che avevano dato il sangue e sudore per la patria, dopo la guerra del 15-18. quelli che chiedevano il riconoscimento dei loro diritti venivano bastonati, esiliati e anche uccisi. La stessa cosa successe dopo la seconda guerra mondiale. Coloro che versarono sangue e sudore per liberarsi del fascismo e formare la repubblica chiesero, come cittadini italiani, giustizia. Così fecero pure i miei figli. Invece furono condannati loro. E furono fatti condannare proprio da coloro che mi diedero la croce di Cavaliere di Vittorio Veneto. A cosa sono servite queste onorificenze? Sono manciate di zucchero date al cavallo perché tiri il barroccio e stia zitto. Ma il popolo ed io compreso non potremo mai stare zitti, perché troppe sono le sofferenze e le ingiustizie che i padroni ci hanno fatto subire e troppa è la sete di giustizia che abbiamo. 136 La strage di Berceto Musa superna porgimi un aiuto: possa descriver questo fatto strano di quello che a Berceto fu accaduto, quel barbaro flagello disumano! I fascisti italiani hanno voluto fare la strage con sua propria mano, questa barbara gente così vile si crede poi così di essere civile. Il diciassette del mese di Aprile del millenovecentoquarantaquattro, sette persone armate di fucile avevan camminato un lungo tratto. Con parola pietosa e assai gentile, come diceva l’un diceva l’altro, nella notte non avevan riposato io di fargli alloggio fui pregato. Uno di questi sette c’era stato un’altra volta nei giorni passati, e come partigian si era presentato. Mi disse: – Questi sei oggi ho portati – e gentilmente si è raccomandato che tutti e sette li avessi alloggiati, dicendo: – Per noialtri partigiani sapete ben, sono momenti strani. – 137 Risposi: – Giovanotti siate umani, non lo posso far, abbiate pazienza, di qui è meglio voi stare lontani che in questo posto, lo so per esperienza, vengono tanti dei nostri italiani; non sappiamo se tutti avran coscienza, che tanto male a noi potrebber fare e queste cose possiamo evitare. Uno di questi rispose: – Vi pare, siamo stanchi, non si sta più in piede, in quella capanna lì fateci andare, si sta rinchiusi e nessun ci vede. Io non sapevo più quello che fare, che siano partigiani noi si crede; poi promisero a noi di non sortire fino a quell’ora che dovean partire. Dopo mezz’ora due vennero a dire che avevano bisogno di mangiare. Un uomo disse: – Vi prego di venire, più sicuri con me potete stare. – Gli fu risposto: – Stateci a sentire venendo ci potrebbero adocchiare, portateci voi qui mangiare e bere, state sicuri, non ci si fa vedere. – Il capo squadra, dovete sapere, uscì fuori dopo aver mangiato. Io dissi a questo: - Non fai il tuo dovere, 138 La strage di Berceto non è così che si era combinato. – Lui mi rispose: – Non dovete temere, sappiate bene, anch’io sono informato. – Mentre stavo con questo a contrastare un certo Fossati io vedo arrivare. Questo partigiano volli avvisare che l’operaio della fattoria, (“si nascondesse” lo stavo a pregare) aveo sentito dir ch’era una spia. Il partigiano lo va a salutare e ci conversa come niente sia; insieme all’operaio in casa è entrato e l’operaio una lettera gli ha dato. Anch’io da questi mi sono avvicinato, con l’operaio avevo confidenza. Di questo partigiano ho domandato se lui ci aveva molta conoscenza. – Sì, mi rispose, un giorno sono andato a portargli una lettera d’urgenza. Ora dal fattore io devo tornare, devo far presto, non pole aspettare. – E dopo poco si sente sparare, c’era dei boscaioli in quel momento. Io questo partigian volli avvisare, lui mi rispose tranquillo e contento, mi disse: – Non dovete dubitare, qui, vi assicuro, non c’è tradimento; 139 dovete aver fiducia al mio decoro, siamo informati cosa fanno loro. – Sempre di più insisto e non mi accoro: – E’ meglio che di qui voi ve ne andiate – gli operai che lasciato hanno il lavoro dicevan a questi: – Voi ci rovinate, andatevi a nascondere in un foro, sentite i colpi delle fucilate! – – Questi colpi, rispose quel malanno, sono i nostri compagni che li fanno. – Così noi tutti si pensò all’inganno io a faccia tosta gli volli parlare. Mi si rivolta male quel tiranno e la rivoltella mi viene a puntare. Parto, vado da quelli nel capanno a convincerli che devono andare. Pareva io gli dicessi un’eresia tronca rimase ogni speranza mia. Soltanto due volevano andar via s’eran convinti ch’io dicessi bene, e che meglio di lì ovunque sia e che partir di lì a lor conviene. Ma quello della lettera venia con sangue avvelenato nelle vene, la pistola puntò alle due persone: – Qui voi restate senza discussione! – Non volle più da me sentir ragione, 140 La strage di Berceto rimasero lì con faccia tranquilla. Io mi sentivo morir dalla passione, non sapevo cosa far con la famiglia, se dovesse venire una quistione partigiani e fascisti far guerriglia. Dopo pochi minuti si son visti alla capanna venire anche i fascisti. Con quelli di capanna si son misti, fanno i due partigiani allontanare mentre il moschetto puntano a quei tristi, invece quei due volevano scappare; gli altri cinque erano teppisti quei due per forza vollero ammazzare senza pensar neanche ai genitori; perdere i figli così son gran dolori. Essere ammazzati come traditori da un suo proprio vicino paesano e poi trattati di tutti i colori, dicendogli: – Da noi state lontano, voialtri non vi meritate onori, lasciarvi vivi qui sarebbe invano. – Solo quei due vennero ammazzati e dopo morti li han rifucilati. Il fattor che quei due avea imputati di aver preso la roba in fattoria avea detto: – Di mezzo van levati perché tutta la roba portan via. – 141 Invece gli altri furon rispettati, erano quelli che facean la spia: con il fattore avean collegamento scrivendosi per darsi appuntamento. Visto di questi tutto l’andamento, due mie figlie insieme a due bambini di uscir di casa han fatto appena a tempo e non li videro i barbari assassini. Ma un’altra squadra di rastrellamento che eran lì da noi molto vicini, vide i miei figli stavano a scappare e si di essi si misero a sparare. Una di queste la vidi cascare, credevo che l’avessero colpita. Il cuore in seno mi sentii gelare ma per fortuna la rimase in vita; venne da me e si mise a raccontare: senza le altre da casa era partita. In quel mentre a casa si è sentito i miei cari urlar: restai avvilito. Da questo estremo grido fui colpito perché da loro non potevo andare. Caddi a terra svenuto ed avvilito e non so quanto stiedi a ripigliare, senza più sensi, come aver dormito e come fosse stato un mio sognare. Dei miei non vedo e sento più segnali, 142 La strage di Berceto vedo le case in fiamme, tutte uguali. E quelle dei vicini tali e quali. Ma quella della spia han rispettato che portava le lettere a quei tali. Una la mattina stessa avea portato, come si trova scritto nei verbali, che dal fattore era comandato; invece noi che s’era lì vicino non si poteva aver peggio destino. Dei fucilati vi dico un pochino: Ebicci Torello e anche sua nora, nella famiglia del Soldeti Gino ucciso il padre e la sua figlia ancora. Poi altri cinque tutti in quel mattino. Di mia famiglia ve ne parlo ora se avrò costanza che mi regga il cuore di rinnovare l’immenso dolore. Io entro in casa tra fumo e calore, non so chi mi donò tanta costanza, la vidi morta mia figlia maggiore, colpita al cuore e non c’era speranza; in quell’abisso e tragico dolore le altre quattro trovai nell’altra stanza trucidate così barbaramente spezzato il capo avean completamente. In fin di vita trovai una solamente segni di vita lei poteva dare. 143 La presi in braccio ma inutilmente, lei mi guardava e non poteva parlare, avrà voluto dir di quella gente. Ma neanche quella potiedi salvare; ricoperta di sangue in quel macello credere non si può senza vederlo. Io fori la portai da quel flagello perché il fumo faceva soffocare. Rotto il cranio, fori avea il cervello, nelle mie mani la vidi spirare. Sopra a questa giurai: – se trovo quello, tutto farò per farlo condannare. – Subito dopo il fronte ho incominciato a interessarmi a chi può esser stato. Per primo fu il fattore interrogato, che denunziato aveva i partigiani, a capo settore era incaricato. E questa zona è nelle sue mani, avea detto: – quel posto va bruciato! – Poi difendeva i suoi repubblicani, dicendo questo lui sembrava digiuno: – repubblichini non c’è più nessuno. – Però aspettava il momento opportuno le spie tra i partigiani d’informare; gli mandava le lettere per uno che oggi questo vorrebbe negare perché si son da sé scoperti ognuno. 144 La strage di Berceto Con più testimoni un si può sbagliare: sono di questa strage la cagione è così chiaro per qual sia ragione. Oggi dicon così queste persone: – abbiam tanto denaro sufficiente e la legge ci dà sempre ragione a noi nessuno ci potrà far niente – io mi sento morir dalla passione dovendo contrastar con questa gente. Giuro sopra ai miei cari: son sincero, quello ch’io scrivo qui è tutto vero. Era il fattore con quel fez nero della strage di Berceto la cagione, da lui andò un alleato ex prigioniero. Ma neanche di questo ebbe compassione, era alleato l’esercito intero. L’inglese sperava buona l’occasione: avea la ricevuta preparato, a chieder due mila lire si è azzardato. In quella ricevuta avea spiegato: – Dio salvi l’Italia e l’Inghilterra – con tante grazie e si è sotto firmato come facevan i prigionier di guerra. Però questo fattore gli ha sparato così il povero inglese cade a terra; in fattoria morì tra pene e doglie, lasciò nel pianto la figlia e la moglie. 145 Però questo fattore un si distoglie, e dopo un anno viene al camposanto là sulle tombe che chiudon le spoglie dei nostri cari che si amava tanto; anche delle mie figlie e di mia moglie e quella dell’inglese lì accanto. Questo fattore venne lì presente come se di tutto lui fosse innocente. Per Ognissanti c’è tanta gente, ché non si può nasconder cosa è vero, e al fattor fu detto: – Delinquente! – Rispose: – Una l’ho fatta e un’altra spero. – Di far querela a questi, lui si sente, che l’hanno offeso lì nel cimitero; poi furon condannati in istruttoria, è cosa degna di metter alla storia. Che eterna sia per sempre la memoria, il terribile agir di questa gente, che poi l’autorità li tiene in gloria più di quello che vive onestamente. Gli par di avere avuto una vittoria a aver mandato assolto un delinquente, aver tradito patria e anche fratelli di carne umana aver fatto macelli. Oggi questi si deve vederli, ognuno al suo posto è ritornato. Io credevo di condannar quelli, 146 La strage di Berceto invece noialtri hanno condannato! La legge li protegge quei ribelli che tanti innocenti hanno ammazzato; perché i veri assassini sono stati sempre d’accordo con i magistrati. In tribunale si fu interrogati e al chiaro fu messa la ragione; sentiti di noi tutti i risultati, ai fascisti toccava la prigione ché da se stessi si sono condannati, quando hanno fatto la sua deposizione. Ma il tribunal non era autorizzato e alla corte di Assise ha rimandato. Io vidi nel giornale pubblicato: – La corte il processo non vuol fare, perché la procura ha già fissato gli imputati assolti di mandare. – Tradito fui anche dal mio avvocato, tutte le strade mi vedo serrare. Son sempre quelli da tanti milioni e così questi han sempre le ragioni. Si credon della legge esser padroni per voler pubblicar queste parole, quelli alla legge sono i lor garzoni e devon far cosa il padrone vuole. Così si avveran questi paragoni, – perché il processo suo far non si pole? – 147 Per noi poveri han fatto differente, uno lo han fatto e un altro l’è presente. Così è trattata la povera gente, per gli operai non c’è compassione, sacrificati noi barbaramente, peggio che fu ai tempi di Nerone. Pei nostri cari un affetto si sente forse più di un marchese o di un barone. Se questi non verranno giustiziati vuol dir che schiavi siamo ritornati. Sapendo tutto i nostri magistrati sapevan bene che noi si avea ragione, sapendo a cosa noi ci siam trovati e chi di questo stato è la cagione. Pure innocenti li hanno condannati, che coscienza può aver queste persone? che tanta autorità data gli sia, oggi l’è questa la democrazia. Il Procuratore general Fumia col giudice istruttore Saladini non crede ai testimoni né alla spia, ascoltan solo quelli dei quattrini, per loro noi si dice la bugia. Ma noi che al fatto eravam vicini abbiam veduto, udito e constatato, cosa si dice noi non è apprezzato. Dal giudice istruttore sono andato 148 La strage di Berceto su di questo si prese discussione. Gli dissi: – Cosa fate? – al magistrato – se non apprezza la deposizione. – A queste parole rimase umiliato, non mi diede né torto né ragione; rispose: – Questo per me niente vale, riguarda la Procura generale. – Io gli risposi: – Lei ha fatto uguale, li avete messi assolti tante volte, ne hanno fatte più loro di Marziale, sarebbero degni di pena di morte. Le deposizioni fanno il bene e il male poi i verbali restano alla corte; per giudicare chi ha depositato il più che preme non è registrato. – Mi rispose: – Voi chi vi ha informato che tutti i fatti non son registrati? – Risposi: – Io son sicur, non ho sbagliato e lo sapevan tutti i magistrati – gli dissi – nei verbali ch’io vi ho dato dei falsi partigiani già arrestati si eran condannati da se stessi e per questo in prigion furono messi. – Rispose: – Quelli erano dei fessi ma io credo di fare il mio dovere, non aveo bisogno che me lo dicessi ora al consiglio si potrà vedere. 149 Torto o ragione chi di voi avessi queste son cose ancora da sapere; per me questo non fa differenza, credo di far le cose con coscienza. Disse queste parole in mia presenza, ci lasciammo così un po’ adirati credevo presto veder la sentenza, invece i verbali vennero archiviati, qui successe una grave inconvenienza: circa sei mesi erano passati e al giudice istruttore sfortunato una morte misteriosa gli è toccato. Il giudice a lor piacere fu trovato e l’istruttoria firmò senza coscienza. I criminali assolti hanno mandato e si risulta noi la delinquenza; certo che d’assassinio si è trattato e ammazzata fu tanta innocenza, e questa verità noi approviamo così per questo condannati siamo. Condannati innocenti noi restiamo lo sa chi ha letto la deposizione, quella fatta dal falso partigiano e dalla spia che portava informazione. La Madre generale ed il Piovano in tribunale han fatto confusione: questa diceva differente a quello, 150 La strage di Berceto feci ricorso alla Corte d’appello. Io volevo al chiaro metter quello ma tutte le ragioni erano invano. Per salvare chi fece quel flagello ha giurato il falso anche il Piovano. Però il Marchese, dovete saperlo, l’ordine lui l’aveva dato umano; aveva detto a quella gente: – Andate, però come a Vallucciole non fate. – E così queste bande bene armate a Vallucciole misero terrore, centotrenta persone fucilate in quelle famiglie resta il crepacuore. A Berceto nove ne han trucidate, di una fui sposo, di quattro genitore, fin da certa distanza si sentia la lor pietosa e tragica agonia. Circa tre anni avea una figlia mia anch’essa fracassata avea la testa, il cervello gli han fatto schizzar via era nelle pareti e alla finestra. Non sarà stata partigiana o spia, le altre credo innocenti come questa. E poi questi assassini han dichiarato che undici ribelli hanno ammazzato. In questo atroce dolore son restato, lacrime agli occhi con pianto alla gola; 151 allora innocenti uccisi or condannato credo vi basti questa di parola. Il lettore non vorrei farlo annoiato, termino qui questa parola sola: chiedo perdono, scusatemi tanto se vi ho annoiato al doloroso canto. Dopo questo terribile flagello, eravamo tutti in un profondo dolore. Ma invece di darci conforto ci perseguitarono ancora di più. Fecero venire i Tedeschi nelle nostre case: erano una compagnia di telefonisti, vennero anche a casa mia per fare la sentinella al camion dove c’era il telefono e occuparono le stanze che gli facevan comodo. Io avevo due figli in casa, se li avessero visti li avrebbero presi, dovevan quindi dormire fuori. Il più giovane era della classe del ’28, credendo che non lo prendessero azzardò, ma i Tedeschi lo presero insieme a un’altra ventina; fortuna che la notte stessa mio figlio e altri due riuscirono a scappare, ma in casa non poteva venire, doveva stare alla macchia come altri partigiani. Anche il mio figlio maggiore, che era del 1925, era alla macchia con loro. Erano momenti terribili: avere i Tedeschi in casa a mangiare, bere e dormire e sapere che i nostri cari pativano fame e freddo. Un giorno i Tedeschi videro delle donne che portavano roba da mangiare nel bosco. Le artiglierie tedesche incominciarono a sparare granate incendiarie e fu bruciato circa 12 ettari di bosco. Noi si sapeva che là c’erano i nostri familiari e vedendo quel terribile spettacolo ci venivano i brividi nel sangue; fortuna che bruciò solo il bosco e le persone si salvarono tutte! Poi si sentiva dire: – Se non c’erano i partigiani non lo avrebbero bruciato tutto quel bosco! – Come se la colpa fosse dei partigiani! Per me queste parole erano coltellate. Era colpa dei partigiani se i Tedeschi erano venuti in casa? Se portavano via uomini e roba? A me portarono via più di 10 quintali di carne e più di 8 quintali di vino e se non fosse scappato mi avrebbero preso anche un figlio. Era 152 La strage di Berceto colpa dei partigiani? La colpa è sempre stata dei criminali fascisti che hanno rovinato l’Italia. Fossero stati tutti partigiani come Pertini o come quelli che lottarono contro i fascisti dal 1921 al 1925, quando ammazzarono centinaia di persone! Nella nostra zona fu ammazzato il Puri Federico, il giorno di Pasqua del 1922: era stato un combattente per sette anni in due guerre e tutte e due vittoriose. Vederlo ammazzare come traditore della patria e vedere gli assassini trattati come fossero eroi! Che poi andarono al governo. E uomini come Matteotti, Togliatti, Pertini, i fratelli Rosselli uccisi o messi in carcere! Questi erano uomini da mettere al governo, si sarebbe evitato anche la II guerra mondiale che per la nostra Italia è stata la rovina: 9 mila furono fucilati nell’isola di Cefalonia, 335 fucilati alle Fosse Ardeatine, 350 fucilati a Marzabotto, 133 fucilati a Valluccioli, la strage di Berceto; e quanti saranno stati in tutta Italia e in tutta Europa? E i milioni di morti nei campi di sterminio? Questo è il frutto della delinquenza e di quelli che li misero al governo nel 1925. E così successe nel 1948. Il governo della Democrazia Cristiana, pur avendo visto e toccato con mano queste sanguinose tragedie, pur sapendo chi ne era stata la cagione, non rispettò la Costituzione e non fece l’epurazione dei criminali fascisti. Ma non solo non fu rispettata la Costituzione, ma gli antifascisti furono tenuti ai margini della società, perseguitati e minacciati. A Togliatti, nel 1948, spararono quattro colpi di pistola. Antonio Pallante, l’aggressore andò, o fu mandato, proprio per uccidere Togliatti perché l’ultimo colpo lo sparò mentre era già caduto a terra. Il Pallante fu condannato a 5 anni di prigione, il minimo che gli potevan dare. Uscito di prigione fu messo nelle guardie forestali e, come fosse stato un eroe, gli fu dato fucile e porto d’arme. A mio figlio, condannato perché scopriva i criminali fascisti, gli fu subito ritirato il porto d’arme. Ma chi è più pericoloso, chi scopre un criminale fascista o chi attenta alla vita di un dirigente comunista? Così i fascisti rimasero tutti al loro posto e invece di condannare i criminali fascisti si condannava chi scopriva e denunciava i crimi- 153 nali. Io non saprei dire chi è più barbaro, quelli che fecero la strage o chi fece quei processi scandalosi? Oggi queste brigate si sono tinte di rosso per insudiciare il proletariato. Quando queste brigate erano nere nessuno le vedeva: ammazzavano famiglie intere, bruciavano case in pieno giorno e la legge non scopriva mai nulla. Oggi non si scopre nulla lo stesso. Il 16 marzo 1978, in via Fani furono ammazzati 5 carabinieri, l’On. Moro fu rapito e tenuto 54 giorni prigioniero. Per tutto questo tempo le forze dell’ordine rastrellarono l’Italia da cima a fondo e non trovaron nulla. Moro fu riportato morto nel centro di Roma e nessuno vide nulla: come all’epoca del fascismo. Abbiamo cominciato a veder più chiaro da quando c’è Sandro Pertini a capo dello Stato, solo da allora abbiamo cominciato a conoscere i nomi dei grandi personaggi coinvolti negli scandali. 154 Documenti 155 Intervista Vera Vangelisti a Berceto Vera Vangelisti è nata a Pratovecchio l’8 agosto 1930. Sopravvissuta all’eccidio, come sua sorella e 4 fratelli, si è trasferita con la sua famiglia a Berceto, nel 1940, nel podere del Frescobaldi, erano 10 figli ed i genitori Lazzaro e Giulia avevano bisogno di un podere più grande per sfamare tutti e si trasferirono a Berceto contenti e carichi di aspettative… Vera, ma questo libro com’è nato? Voi sapevate che Lazzaro stava scrivendo questo libro? Il libro nasce dall’insoddisfazione del babbo di non avere avuto la giustizia che si aspettava, mentre noi figli cercavamo di dimenticare, lui faceva di tutto che non si dimenticasse… Il babbo abitava con me in via de’ Pilastri, per anni vedevo il babbo che scriveva a mano poi spesso la notte non poteva dormire si alzava e si metteva a scrivere, aveva imparato da solo a scrivere a macchina e la notte ci svegliava con il rumore della macchina, qualcuno dei miei fratelli ce l’ha ancora mentre il manoscritto è andato perduto. Lazzaro per gli studi che ha fatto avrà avuto bisogno di aiuto per correggere le bozze chi l’ha aiutato? E’ stato aiutato tanto da Don Masi… attuale parroco nella chiesina di Baroncelli a Bagno a Ripoli. Lo conosceva bene perché era in seminario insieme a mio fratello Luigi, il quale se non fosse andato in seminario non avrebbe potuto permettersi di studiare, decise però di non fare il prete ma aveva legato una bella amicizia con Don Masi che per anni ha fatto il prete operaio al Vingone. Tutte le domeniche Lazzaro prendeva il tram e andava a fargli vedere quello che aveva scritto, correggevano insieme quello che c’era da correggere Appena finito lo fece vedere a Vasco Pratolini, come dimostra la lettera pubblicata. 157 Chi ha sostenuto le spese della pubblicazione? Qualcuno lo ha aiutato? La pubblicazione di 1.000 copie è stata tutta a suo carico, poi sono stati ripubblicati da noi familiari sempre a nostro carico. I libri Lazzaro ne ha regalati molti agli studenti quando li incontrava in Piazza D’Azeglio alle panchine e quando andava a parlare nelle scuole, dopo morto il babbo andava lo zio Enzo a parlare della guerra e dell’eccidio di Berceto nelle scuole. Ma ha scritto l’eccidio anche in ottava rima ? Certo prima di scrivere il libro aveva raccontato l’eccidio in ottava rima perché aveva la vena artistica e per lui era facile, andava spesso a stornellare anche in Casentino, lo conoscono ancora in molti. C’è qualcosa che oggi, se fosse possibile, consiglieresti di non fare a tuo padre? che ricordo ti ha lasciato? Quello che ha fatto merita solo rispetto, ha combattuto per avere giustizia e non l’ha avuta, ha raccontato e scritto perché non voleva che si dimenticasse, ovunque è ricordato come persona onesta e combattiva, sono orgogliosa di lui, sono contenta di avere avuto un padre come lui, esattamente com’è stato. Ovunque vado, incontro manifestazioni di stima nei suoi confronti da parte di chi l’ha conosciuto. Il riconoscimento con la medaglia di bronzo, che il Presidente della Repubblica ha concesso quest’anno al comune di Rufina come lo vedi? Mi ha fatto tanto piacere e ringrazio tanto tutti coloro che si sono adoperati per ottenere questo riconoscimento, hanno tutta la mia stima e dei miei familiari, è arrivata tardi avrei voluto che arrivasse quando mio padre era ancora in vita, ma lo sappiamo ci vuole sempre più tempo del necessario per riconoscere i meriti. Adesso se questo libro, come sta cercando di proporre l’ANPI di Rufina, venisse davvero pubblicato dalle Istituzioni pubbliche, sarebbe la soddisfazione più grande che potrei avere prima di morire, sarei grata davvero per questo gesto perché la memoria deve continuare a vivere e i libri servono per diffonderla, ciò che è successo a noi e a tante altre famiglie non dovrà succedere mai più a nessuno. 158 Siamo qui davanti alla casa dei tuoi ricordi se potessi esprimere un desiderio cosa chiederesti? Questo luogo mi emoziona ancora tanto. Qui ho passato anni felici con i miei genitori, li vedevo sempre d’amore e d’accordo, eravamo una famiglia allegra, ammazzando mia mamma e le mie sorelle ci hanno rubato gli anni più belli e le sofferenze degli anni successivi potrebbero essere perlomeno riconosciute non facendo cascare a pezzi questa casa. Avete visto in che condizioni è? Noi continuiamo a pagare l’affitto al Frescobaldi ma non la possiamo abitare, abbiamo sperato che così facendo prima o poi venisse rifatto perlomeno il tetto, abbiamo scritto al Frescobaldi per chiedere il rifacimento del tetto ma niente! Il mio sogno è che questa casa venga riparata e resa agibile e, come richiede anche l’ANPI di Rufina, diventi un centro di documentazione della Resistenza, avete visto quante cose ci sono ancora su in casa! La mia famiglia ed io saremmo felicissimi di poterlo affidare a qualcuno che come voi lo custodisce e lo valorizza per sempre. La realizzazione di questo progetto renderebbe davvero un po’ giustizia che non abbiamo mai avuta. Intervista video di F.Marranci e M.Viciani del 20/06/2013 Archivio Culture Orali “La Leggera” e archivio sezione ANPI “Martiri di Berceto” Rufina 159 Interventi di Barbara Vangelisti in occasione delle commemorazioni annuali dell’Eccidio di Berceto Pomino - 15 aprile 2007 15 aprile 2007 – ancora una volta un “grazie” per non dimenticare… Non sempre nella vita tutto va come vorremmo che andasse e ciò che è successo alla nostra famiglia ne è la prova lampante: a causa della furia e della cattiveria di uomini che, a parer mio non possono neanche essere paragonati a delle bestie per la loro crudeltà, io non ho potuto conoscere le mie bis-nonne e tutte le mie bis-zie anche se qualcuno lassù, ha fatto sì che potessi conoscere il mio angelo che mi ha resa partecipe del suo dolore e mi ha fatto capire che nella vita, probabilmente, non possiamo fidarci neanche di noi stessi. Ci sono momenti nei quali bisognerebbe stare in silenzio e riuscire a guardare con gli “occhi del cuore” piuttosto che con uno dei sensi dei quali siamo dotati e, in momenti come questo, l’unica cosa che dovremmo sentire è il desiderio di riunirci per ricordare un unico – grande dolore… Solo un giorno all’anno per ricordare un attimo in cui sono state spezzate decine di vite e spesso mi domando: “è giusto tutto questo?”; “è corretto, magari per 364 giorni su 365, vivere freneticamente pensando quasi sempre a ciò che dobbiamo fare nel presente e che dovremmo fare nel futuro, quasi dimenticandoci che siamo parte integrante l’uno dell’altro e che alcuni legami (come l’essere fratelli), “calpestati” da invidia o voglia di lucro, in realtà dovrebbero essere motivo di sostegno reciproco e di comprensione?”… Ci sono state due persone che prima di andarsene hanno cercato di insegnarmi certi valori morali piuttosto che materiali anche se, evidentemente, 161 non sono state ascoltate da tutti ma soltanto da chi (come loro) non ha vissuto solo di materialità ma anche e soprattutto di umanità e rispetto. Dicono tutti che la storia è un modo che insegna o che almeno dovrebbe insegnare a non ripetere più gli stessi errori del passato e che, proprio per questo, dovrebbe essere un aiuto per migliorare la realtà nella quale viviamo… bene, tutto quello che ho imparato a vedere (almeno fino a questo momento) è che, in realtà, suddetta disciplina insegnata anche a scuola è solo un mezzo per non dimenticare; sta solo a noi scegliere se è uno dei mezzi più giusti con i quali poter agire e tramandare esperienza anche se a volte, proprio quest’ultima, è la causa di dolori molto grandi. Grazie all’aiuto di persone come il Sig. Mauro Pinzani e di strutture come il Comune della Rufina che ogni anno si adoperano per organizzare al meglio questo momento di raccoglimento in un piccolo angolo di paradiso, è possibile ancora oggi riconoscersi nell’appellativo di “uomini” perché solo chi ha la forza e la voglia di ricordare, allora, è in grado di vivere per se stesso e per gli altri. Ciò che mi preme ricordare alla fine di un discorso che voleva comprendere una parte di presente legata al passato, è una persona che da poco più di un anno e mezzo non è più (almeno fisicamente) accanto a noi ma che nell’arco della sua lunga e meritata vita, ha permesso a molti di essere come sono e di possedere i valori che hanno ed è stata per questo, la nonna e l’esempio di tanti: la Sig.ra Lina (proprio come è sempre stata conosciuta)… Oggi “ancora un – grazie – per non dimenticare” al Sig. Pinzani, al Comune della Rufina e a tutti i partecipanti che quest’anno, come ogni anno, hanno reso possibile tutto questo a nome di tutta la famiglia Vangelisti e delle sorelle Vera ed Elina; a nome mio e a nome di tutte le famiglie che, come la nostra, hanno il coraggio di andare avanti e di parlare ancora oggi senza paura ma soltanto con coraggio. 162 Pomino - 25 aprile 2009 25 aprile 2009 – ancora una volta un “grazie” per non dimenticare… Un altro anno è passato e con lui, sono passati anche giorni di gioia e di dolore, momenti di rabbia e di euforia, istanti di felicità e di resa e sono trascorse anche giornate come quella di oggi, che vedono portare “dentro di loro” un pensiero ed un fardello comuni a tutti coloro che hanno sofferto senza mai trovare pace per una delle tante stragi che hanno spezzato la vita di troppe famiglie. Pensiamo di essere cresciuti, di aver cambiato il mondo e di averlo reso così perfetto da non poter neanche lontanamente immaginare lo spettro di un nuovo nazi-fascismo ma non è così: l’odio, la violenza, la follia e la voglia di potere assoluto e incondizionato non sono sepolti come le vite innocenti che sono state spezzate in questo luogo poco più di 65 anni fa, ma continuano ad esistere e a co-esistere con noi – talvolta – nei nostri modi di fare, di agire, di pensare e, nella maggior parte dei casi, ci portano a non capire quanto può essere sottile il filo invisibile che separa la vita dalla morte e il bene dal male e, quanto grande può essere il dolore che possiamo ancora causare anche solo al ricordo delle vittime che ci sono state. Tenere viva la fiammella della speranza verso un domani migliore; continuare – giorno dopo giorno – a stringere la mano (anche solo con il pensiero) a coloro che ce l’hanno fatta; dedicare poche ore di una giornata al ricordo di “ciò che è stato” per ricordare sempre “da dove siamo venuti” oppure, alimentare ricorrenze come questa – resa possibile ogni anno dal Sig. Pinzani, dal Comune della Rufina e da tutte le strutture che si adoperano insieme – è un modo per essere partecipi della nostra storia e del nostro passato affinché questi non arrivino a ripetersi nella stessa maniera in cui vengono riportati alla mente. Alla fine di questo discorso, tutto quello che posso ancora dire – ancora una volta – come parente delle vittime della strage di Berceto, è un “grazie” a persone come mia nonna Lina, mia zia Vera 163 e tutti i loro fratelli – i miei zii – perché è a loro che devo la consapevolezza del “vivere senza mai dimenticare”, e a persone come coloro che “oggi” come “ieri” hanno saputo come far rivivere chi non c’è più attraverso una preghiera, una canzone, un minuto di silenzio. Oggi “ancora un – grazie – per non dimenticare” al Sig. Pinzani, al Comune della Rufina e a tutti i partecipanti che quest’anno, come ogni anno, hanno reso possibile tutto questo a nome di tutta la famiglia Vangelisti e delle sorelle Vera ed Elina; a nome mio e a nome di tutte le famiglie che, come la nostra, hanno il coraggio di andare avanti e di parlare ancora oggi senza paura ma soltanto con coraggio. 164 Pomino - 18 aprile 2010 Ancora oggi “un grazie per non dimenticare” Ero in presenza della morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo terribile. Dal momento che arrivo ad essere un uomo che fa la guerra, non è l’idea di uccidere o di essere ucciso che mi tormenta: ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l’assoluto, l’assoluto che era rappresentato dalla morte. In tutta la sua crudele verità, questo è uno dei tanti discorsi che Giuseppe Ungaretti, volontario nel 19° reggimento di fanteria durante la 1^ guerra mondiale prima che poeta, scrive come introduzione a quelle poesie che sono da sempre considerate “il culmine dell’esperienza atroce del male e della morte all’interno del conflitto bellico” e oggi, proprio con questo discorso e con una poesia bene precisa, vorrei cominciare il ringraziamento verso coloro che, come tutti gli anni, sono presenti in questo luogo per ricordare ciò che non può e non deve essere dimenticato: il male dell’uomo accecato dall’odio… Sono una creatura Come questa pietra Del S. Michele Così fredda Così dura Così prosciugata Così refrattaria Così totalmente Disanimata Come questa pietra È il mio pianto Che non si vede La morte Si sconta Vivendo. 165 I versi appena letti, rappresentano «la forza interiore e la calda umanità di un essere umano (che dinnanzi alle brutture della guerra non ha mai smesso di amare e di vivere in sé il dolore altrui) e rappresentano anche la storia di un uomo che ha assimilato sul corpo e sullo spirito le forme del paesaggio straziato dalle armi, un paesaggio arido, brullo, arso, impermeabile e disumanizzante che gli è rimasto scolpito nel cuore e gli ha prosciugato anche le lacrime per piangere». Tante persone hanno sofferto e, altrettante, hanno perso la vita ingiustamente per i capricci e le manie di persecuzione di individui che hanno vissuto con l’unico scopo di arrecare dolore al prossimo; tanti bambini e tanti genitori si sono visti strappare dalle mani le loro ragioni di vita perdendo, con loro, anche le lacrime per piangere e la rabbia per reagire (proprio come afferma Ungaretti); tante famiglie come la mia e come quelle che ricordiamo in questo luogo ancora oggi, hanno sacrificato loro stesse ed i loro ideali per combattere il grande “mostro” che era il nazi-fascismo, che ad oggi cerca di ritrovare spazio nei pensieri di individui che, forse, non sanno cosa significhi la parola “sofferenza”… Potrebbero essere citati tanti casi e tante poesie, tanti orrori e tanti eccidi ma niente riuscirebbe a ripagare le migliaia di vite spezzate e le migliaia di lacrime mai uscite per parenti o amici mai conosciuti i visti morire senza una ragione, senza un perché… Il ricordo; l’amore verso coloro che, anche inconsapevolmente, hanno dato la loro esistenza per aprire le porte ad un futuro diverso; la voglia di scrivere e dedicare una parte di noi a coloro che almeno provano a cambiare il mondo reclamando la pace e la tolleranza; il tentativo di presentare posti e luoghi cardine dell’enorme fardello che è stata e che, ancora oggi, è la guerra… sono tutti elementi necessari e fondamentali per combattere ciò che è stato e che non dovrà più ripetersi. Siamo esseri umani e, per natura, siamo portati a sbagliare ma, come dice un detto, “sbagliando si impara” e allora dobbiamo guardarci negli occhi e chiederci se veramente vale la pena di concludere 166 i nostri giorni senza avere nel cuore la consapevolezza di aver almeno provato a cambiare la storia presente. Paul Tillich un giorno ha scritto: «la vita non si potrebbe continuare se non si gettasse il passato nel passato, liberando il presente dal suo peso». A nome mio, della mia famiglia e di mia nonna – che molto probabilmente ci osserva scrupolosamente dall’unico posto in cui il male dell’uomo non potrà mai arrivare – ancora oggi “un grazie per non dimenticare” al sindaco Mauro Pinzani, al comune della Rufina e a tutte quelle strutture che si impegnano a far rivivere coloro che non ci sono più nella maniera più umana e più giusta possibile. 167 Pomino - 17 aprile 2011 Dentro ad un libro un passato di memorie… …Ho avuto a che fare con persone potenti, nel cercare di far valere i miei diritti, ma non ho ottenuto che umiliazioni. I fascisti, durante la seconda guerra mondiale, hanno ucciso mia moglie e quattro mie figlie. Di nuovo ho avuto a che fare con questi grandi personaggi, perché fosse fatta giustizia, ma non ho ottenuto che altre ingiustizie. Ho vissuto sotto tre regimi: monarchia, fascismo e democrazia cristiana. Posso affermare che è cambiato il nome dei governanti ma uguale è rimasta la sostanza. I miglioramenti che ci sono stati, sono stati strappati col sangue e il sudore dei proletari nelle lotte politiche, ma non è cambiato molto. Il fascismo è ora senza stivali, ma ogni tanto fa capolino e vorrebbe rimettersi i galloni… È con queste parole che Lazzero Vangelisti comincia il prologo di quella che, più che un’autobiografia, è una vera e propria parentesi di storia, fatta di martiri ed ideali, di innocenti e persecutori, di lealtà e possessione, di libertà e prigione: il dolore per la perdita di sua moglie e delle sue figlie; la frustrazione nei confronti di un’esistenza che ha subito un brusco cambio di rotta durante la sua corsa verso il traguardo; la delusione verso quell’ “essere-fratello” che, in realtà, si è rivelato nella sua natura di “bestia” ed assassino e la consapevolezza che, nonostante esista un Dio, c’è qualcuno che dà la benedizione di uccidere nel suo nome, sono la realtà di un passato che non si identifica solo nel 17 aprile 1944 ma anche nel nostro attuale presente. Proclamiamo la libertà ma siamo i primi a trasformarci in oppressori se ci sentiamo minacciati da un qualcuno che, magari, non parla la nostra lingua o non pratica la nostra religione; cerchiamo di seguire l’insegnamento di colui che un giorno ha detto “porgi l’altra guancia”, senza renderci conto che – talvolta – l’unica e sola soluzione che conosciamo è la vendetta; affermiamo di essere umili, di accontentarci di essere in salute e di amare le persone per quello che 169 sono e non per come appaiono esteriormente ma – spesso – siamo in prima fila a condividere il pensiero di Oscar Wilde, che ha sempre affermato di avere dei gusti semplicissimi, poiché si accontentava sempre del meglio… Purtroppo, come ha affermato il mio bisnonno, viviamo sì in un mondo di bellezze e di ideali, ma anche di apparenze e di pericoli che – volenti o nolenti – «il fascismo senza stivali, che vuole rimettersi i galloni», sta cercando di far risorgere dalla fossa in tutta la loro violenza. Sono passati circa 35 anni dalla scrittura di queste parole: «…Col cuore infranto dal dolore pensavo “cosa conta vivere in queste tenebre?”. Erano state trucidate le persone che amavo di più, ma avevo altri figli che mi stavano altrettanto a cuore e se mi fossi ammazzato avrebbero sofferto ancora di più. Decisi così di restare nel dolore insieme ai miei figli. Pensai poi che nella vendetta non avrei trovato la pace che cercavo…» ma, oggi – ancora una volta davanti a questa lapide – è come se il tempo si fosse fermato a 67 anni fa, un tempo in cui l’amore contrastava l’odio e l’ideale ed il sangue di persone come i nostri partigiani continuava l’opera di coloro che 150 anni fa hanno reso possibile l’unità delle nostre terre. Oggi, nel giorno della “nostra” memoria, vorrei dedicare un “grazie” particolare a coloro che non ce l’hanno fatta; a tutte le persone che non hanno mai smesso di lottare per far valere i propri diritti; ad ogni singola persona che ha dato la sua vita per la nostra ed anche a tutti coloro che oggi vivono e ci insegnano a vivere senza mai dimenticare, tra i quali ci sono: mia nonna Elina – che molto probabilmente ci osserva scrupolosamente dall’unico posto in cui il male dell’uomo non potrà mai arrivare – mia zia Vera ed i miei zii Valerio, Luigi e Morando. Alla fine di tutto, anche quest’anno, un “grazie per non dimenticare” al comune della Rufina ed a tutte quelle strutture che si impegnano a far rivivere coloro che non ci sono più nella maniera più umana e più onesta possibile. 170 Pomino - 15 Aprile 2012 17 aprile 1944 Eravamo in dodici, ma una pallottola ci ha divise… vi ho viste morire e solo Dio sa quanto ho sofferto. Ho corso con i miei fratelli giù per i campi, senza sapere se ci sarebbe mai stato un giorno seguente per me e il mio futuro… Ho corso, Ho pianto, Ho urlato, Ho implorato che quello che avevo vissuto potesse essere stato solo un brutto sogno, ma poi ho capito che niente e nessuno poteva ridarmi voi che amavo più della mia stessa vita. Tu mamma, Tu Bruna, Tu Angiolina, Tu piccola Iole E tu Anna, fiore appena sbocciato e subito reciso… La mia anima piano piano si colmava di dolore, di pianto infinito, di infiniti sogni infranti, e quello che fino ad allora sembrava un cielo sereno si è chiuso, plumbeo, su di me… …e oggi, a distanza di cinquantasette anni, non riesco ancora a dimenticare l’immane tragedia che mi ha travolta come un fiume in piena, 171 ed i ricordi mi si fanno amari più delle mie stesse lacrime… La vita da e toglie. Ma quello che mi ha preso il 17 aprile 1944 è una parte di me che non tornerà mai… Quando mi guardo indietro vedo esattamente questo: paura, sofferenza, rabbia, vuoto incolmabile… Chi ha detto che il tempo allevia o cancella tutte le ferite? Chi, come la mia famiglia, ha vissuto la guerra e l’odio e la pazzia nazi-fascista non può e non potrà mai cancellare dalla mente quella parte della sua esistenza, perché – annebbiata o no che possa essere – è sempre lì, pronta a fare capolino la sera quando le luci si spengono o il giorno, tra le righe di un libro o le parole di una poesia… Molti di noi pensano che la vita sia un gioco e, molti altri – invece – sostengono che sia una sfida continua, che mette alla prova soprattutto il più debole; tante persone dichiarano di non aver mai sofferto per una perdita o per amore e, molte altre – al contrario – hanno passato la loro esistenza a dar voce al loro dolore o facendo parlare chi non ha avuto l’opportunità di farlo; tanti, tantissimi individui – specialmente i giovani di oggi – invocano un “mostro” chiamato “fascismo” in nome di una “capo” chiamato “Duce” perché sono inconsapevoli della loro e della nostra storia, mentre altri combattono da sempre in nome di “quel qualcosa” che a persone come ai nostri partigiani è costato la vita: la libertà… Oggi come ieri, siamo qui insieme a ricordare coloro grazie ai quali esiste la “nostra storia” e, allo stesso tempo, l’orrore che ci ha tanto uniti e che ha reso possibile la costruzione di una memoria collettiva che – ogni anno – è sempre più forte, talmente forte da essere in grado di richiedere un riconoscimento illustre come la medaglia al valore e non solo… In tutto questo, so che tante persone che oggi non ci sono più – in questo momento – vorrebbero essere qui accanto a noi, prima fra tutte mia nonna Elina, che tanto si è battuta per la causa del mio bisnonno e per la casa che è stata il paradiso e – allo stesso tempo – l’inferno della nostra famiglia. 172 A distanza di un anno, ancora una volta, vorrei ribadire che un semplice “grazie” non può bastare, anche se è l’unica cosa che posso dire per tutto quell’affetto incondizionato che, da qualche tempo a questa parte, ha dato un minimo di giustizia a quel buio ed a quella barbarie in cui ci siamo trovati a vivere io ed i miei cari per anni (insieme alle altre famiglie colpite dalla strage). Per quanto ho appena detto, “grazie” all’ex sindaco della Rufina Stefano Gamberi, alla sua giunta comunale ed anche a persone come l’attuale sindaco Mauro Pinzani, alla sua giunta comunale ed a tutte le autorità, le rappresentanze di tutte le associazioni ed ancora un “grazie” alla popolazione ed a tutti coloro che – fin da quando era ancora viva mia nonna – si sono dedicati alla “costruzione” del ricordo di uno degli eccidi che ha rischiato a lungo di non trovare spazio le pagine della nostra storia: l’eccidio di Berceto. Vorrei concludere dicendo che, nonostante sia vero il fatto che «i ricordi più belli sono quelli che facciamo vivere dentro di noi per sempre», sono convinta che quella che io amo chiamare “la casa della memoria” (la casa di Berceto) non dovrebbe continuare ad esistere (con ogni suo singolo mattone) solo nel mio cuore ma anche nel cuore e nella realtà di chi “vive per ricordare”. 173 Pomino - 21 Aprile 2013 Una memoria di 69 anni… Un altro anno è passato e – ancora una volta – siamo tutti qui, insieme, a ricordare un pezzo di storia che sarà sempre “presente”, come una ferita che non riesce e che non può rimarginarsi: 69 anni fa, in uno dei modi più atroci che si possano immaginare (e che possano esistere), sono stati barbaramente uccisi non solo i membri della mia famiglia, ma anche dei partigiani ed i membri di altre famiglie come i Soldeti e gli Ebicci, che avevano come unica colpa quella di avere fiducia nel prossimo e nelle sue azioni. Comunque la si metta o si ricordi, la verità è che degli innocenti sono morti per credere nel bene e che coloro che sono rimasti non sono più stati gli stessi, tanto sono stati l’orrore ed il male che si sono trovati davanti al momento della strage; lo stesso Lazzaro Vangelisti, ad un certo punto del suo libro, scrive: «[…] Uscirono dalla casa due contadini che abitavano vicino a me. Erano molto turbati ed impressionati. Mi dissero “fatevi coraggio, noi torniamo subito”. Io capì che in casa c’era stata una tragedia. Ma non avrei mai pensato di trovarmi di fronte a quello che vidi. Mia moglie e le mie figlie erano state barbaramente assassinate […]. Amavo mia moglie come me stesso. Era l’unica speranza della mia vita. cercherò di farle giustizia scoprendo i suoi carnefici, a costo di qualsiasi sacrificio. Voglio portare alla luce tutto quello che posso. Non lo faccio solo per rendere giustizia solo alle vittime innocenti ma anche per aprire gli occhi a coloro che sono all’oscuro di tante cose […]». Il mio bis-nonno, esattamente come me ed il resto della mia famiglia, era un uomo che credeva nella verità e nella giustizia, una giustizia che – con il passare del tempo – ha dovuto trovare da solo, con la sua perseveranza ed il suo bisogno costante di dar voce a coloro che – per mano di una bestia chiamata fascismo – non potevano più scrivere il loro futuro. Grazie a lui ed anche a persone come i miei nonni (Enzo ed Elina) ed i miei zii (Vera, Luigi, Morando e Valerio), sono cresciuta 175 con la consapevolezza che “non esiste una separazione definitiva fino a quando c’è il ricordo” e che vivere vuol dire anche e soprattutto avere il coraggio di combattere per ciò in cui si crede. A distanza di un anno, ancora una volta, vorrei ribadire che un semplice “grazie” non può bastare, anche se è l’unica cosa che posso dire per tutto quell’affetto incondizionato che, da qualche tempo a questa parte, ha dato un minimo di giustizia a quel buio ed a quella barbarie in cui ci siamo trovati a vivere per anni. Per quanto ho appena detto, “grazie” all’ex sindaco della Rufina Stefano Gamberi, alla sua giunta comunale ed anche a persone come l’attuale sindaco Mauro Pinzani, alla sua giunta comunale ed a tutte le autorità, le rappresentanze di tutte le associazioni ed ancora un “grazie” alla popolazione ed a tutti coloro che – fin da quando era ancora viva mia nonna – si sono dedicati alla “costruzione” del ricordo di uno degli eccidi che ha rischiato a lungo di non trovare spazio le pagine della nostra storia: l’eccidio di Berceto. 176 Una lettera di Pratolini Roma, 30 dic. 1978 Egregio Don Masi come Le avevo promesso, in questi giorni di fine d’anno ho letto l’inedito ‘Una vita trascorsa sotto tre regimi’ di Lazzero Vangelisti, che Lei mi sottopose durante il nostro rapido incontro del 23 nov. a San Giusto. La prima impressione conferma quanto Lei mi accennò: una biografia tracciata a grandi linee, raccolta dalla viva voce del protagonista. E qua e là, credo di poter aggiungere, sostanziata da riferimenti storici e da dati inquadrano la vicenda, già nel prologo e a pag. 1: ‘Da Adua alla Mosa…’, ecc. L’interesse del lettore scatta comunque là dove Vangelisti racconta per conoscenza ed esperienza dirette; ed i fatti, come sempre, sono molto più eloquenti d’ogni commento, d’ogni sentenziosità, e d’ogni pur giusta considerazione sulle condizioni e il ruolo delle classi lavoratrici nel corso del nostro secolo. Ora, nella parte iniziale (‘Monarchia’) fanno spicco gli episodi dell’infanzia e dell’adolescenza, ‘le opere e i giorni’ del bambino pastore e della famiglia contadina. Ad apertura, per es. padre e figlio sotto quel temporale, sono narrativamente stupendi, proprio in virtù dell’immediatezza con cui ci si rivelano. Così il periodo della giovinezza e le sue tribolazioni, l’amore dapprima contrastato, il richiamo della terra, del paese. Ci si aspetta magari, e sarebbe a questo punto cosa totalmente nuova, una testimonianza sulla sorte degli emigranti italiani in Francia a cavallo degli Anni Dieci. Quanto al successivo periodo della guerra ’15-’18, disadorna che ne sia la rievocazione, carica dei forti umori che la connotano, è come se, a momenti, parlasse, non più per bocca e dal punto di vista dell’ufficiale-scrittore Jahier o Puccini, ma in prima persona, un soldato Somacal o un soldato Cola. E sorprendendoci il soldato 177 Vangelisti per certo tono picaresco di segno tutto positivo, poi temperato dall’afflizione del reduce. Diverse e conseguenti le altre due parti (‘Fascismo’ e ‘Democrazia cristiana’). Dopo il ventennio fascista rappresentato come d’infilata, soprattutto nei primi anni, attraverso le persecuzioni e i lutti subiti, tra il Casentino e la Rufina, dai Puri, i Moneti, i Rossi, la narrazione si fa specificamente personale e documentaria. Vi campeggia, terribile, l’immagine della moglie e delle quattro figlie trucidate dai repubblichini. Qui il documento assume l’aspetto di vero e proprio memoriale. Davanti al quale il lettore – che come nel mio caso, apprende per la prima volta della strage di Berceto e della lunga,incessante, inappagata ricerca della verità – è costretto una volta ancora a meditare, col pensiero rivolto alle vittime, sui disastri della guerra e le amare, spesso oscure, conseguenze pubbliche e private di cui siamo eredi. Mi creda, coi migliori saluti Vasco Pratolini 178 179 180 181 182 Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione “Martiri di Berceto” di RUFINA Sede Presso Circolo ARCI P.zza 1°Maggio n.6 – 50068 Rufina (FI) Tel. 348/4732154 – 328/4262400 www.anpirufina.webnode.it – [email protected] Alla Senatrice Vittoria Franco Alla Deputata Rosa Priori Al Presidente della Provincia Fi All’Ass.Cultura Regione Toscana Al Prefetto di Firenze Al Sindaco del Comune di Rufina Oggetto:Eccidio di Berceto:documento del Congresso della sezione ANPI “Martiri di Berceto” di Rufina Il Congresso della Sezione ANPI “Martiri di Berceto” di Rufina svolto il 5-6/11/2010, si è interrogato sulle varie morfologie del neofascismo che è tutt'altro rispetto al fascismo che è stato vissuto durante il ventennio mussoliniano, ma non per questo meno pericoloso per la nostra comunità, in quanto si insinua nella nostra cultura attraverso mezzi subdoli che fanno perno sull'odio razziale, sulla xenofobia e su di uno spudorato revisionismo storico. Quindi cosa significa essere “Antifascista Oggi”? Significa combattere tutto questo per difendere la libertà che i nostri partigiani hanno duramente conquistato. Per tutto questo non possiamo tacere difronte al rifiuto della Commissione al Valore e Merito Civile presso il Ministero degli Interni riguardo l'istanza, presentata dall'amministrazione comunale di Rufina in data 28 Aprile 2008, per il riconoscimento alla memoria della ricompensa al merito civile (legge n. 658/1956) per l'eccidio di Berceto del 17 Aprile 1944, dove furono trucidate undici persone, di cui nove civili e due partigiani. Tra le motivazioni della commissione rilevate possiamo leggere che la Commissione ha ritenuto non dimostrato il coinvolgimento dell'intera collettività locale, in quanto l'eccidio ha riguardato prevalentemente una famiglia. 183 Noi pensiamo che questa risposta sia profondamente inesatta, oltre che offensiva e ne contestiamo la motivazione. Questa mancato riconoscimento significa molto per la nostra comunità, non perché una medaglia possa ripagare le vite di quei nostri poveri concittadini, bensì perché al pari di tanti altri episodi accaduti sul nostro territorio in quel periodo (eccidio della Pievecchia e l'eccidio di Legacciolo e Podernovo), rappresentano valida testimonianza del livello di barbarie a cui può giungere l'uomo quando smarrisce il rispetto dei diritti umani, per le generazioni presenti e per quelle future. Il congresso ringrazia l’Amministrazione Comunale di Rufina per l’impegno dimostrato nel valorizzare tematiche come la Resistenza, e chiede che la casa di Berceto, oggi di proprietà privata, possa essere ristrutturata e data in comodato d’uso all’Amministrazione Comunale e destinata a “Centro di documentazione della Resistenza” o Museo della Resistenza territoriale. Per dare ancora più valore a questi nuovi progetti, il congresso dell’ANPI, chiede al Comune di ripresentare nuova richiesta per il riconoscimento alla memoria della ricompensa al merito civile per l’eccidio di Berceto e alle personalità in indirizzo di sostenere questo riconoscimento. Approvato all’unanimità dal Congresso Rufina 6/11/2010 184 Sezione A.N.P.I.”Martiri di Berceto” Rufina (Fi) 185 186 187 188 189 Immagini (Archivio A.N.P.I. Rufina) 191 Vera Vangelisti a Berceto davanti alla casa dell’eccidio prima dell’intervista, aprile 2013 Vera Vangelisti a Berceto durante l’intervista di lato alla casa dell’eccidio, aprile 2013 193 La casa dove viveva la famiglia Vangelisti sta crollando Vera Vangelisti ritrova una vecchia foto di Lazzaro Vangelisti 194 La foto di Lazzaro Vangelisti ritrovata da Vera (dono della famiglia Vangelisti) 195 Resti della capanna, dove vennero trucidati i due veri partigiani: Mauro Chiti e Guglielmo Tesi Commemorazione del 17 aprile 2012 organizzata come ogni anno dal Comune e ANPI a Berceto 196 Berceto sta nel sentiero della Memoria 197 Targa del Comune di Rufina per il 60° anniversario dell’Eccidio di Berceto 198 Ciclisti di Rufina arrivano a Berceto durante la Pedalata per la memoria, settembre 2012 Un garofano rosso dei ciclisti per i Martiri di Berceto 199 Il fazzoletto dei partigiani della sezione intestata ai Martiri di Berceto L’ANPI di Rufina in visita a Marzabotto, maggio 2012 200 Vera Vangelisti riceve la tessera ad honorem, durante la festa della Liberazione di Rufina, settembre 2010 La famiglia Vangelisti alla festa della Liberazione di Rufina 201 Rosetta Masini testimone-bambina dell’Eccidio di Berceto e la sua testimonianza durante la festa della Liberazione di Rufina, settembre 2010 Medaglia di bronzo sul Gonfalone del Comune di Rufina per il riconoscimento al valore civile per L’Eccidio di Berceto ricevuto ad aprile 2013 202 Lazzaro Vangelisti 203 Immagini presenti nella precedente edizione 205 Foto della famiglia Vangelisti scattata nell’estate 1941. Dall’alto a destra: Valerio, Bruna, Angiolina, Iole, Elina, Morando; poi sotto Babbo Lazzaro con Luigi, Vera, Mamma Giulia con in braccio il piccolo Giuseppe ed in grembo Anna, che nascerà pochi giorni dopo 207 Le vittime della famiglia Vangelisti 208 Le vittime Isola Geri negli Ebicci, anni 49, e Alessandro Ebicci, anni 78 Le vittime Iolanda Soldeti, anni 19, e Fabio Soldeti, anni 81 209 Guglielmo Tesi, detto Teotiste. Partigiano ucciso Mauro Chiti, di Carmignano. Partigiano ucciso 210 Cerimonia di consegna Medaglia ANFIM 29 aprile 1962 211 La copertina originale del libro 212 Una selezione dei volumi della collana delle Edizioni dell'Assemblea è scaricabile dal sito www.consiglio.regione.toscana.it/edizioni Ultimi volumi pubblicati: Gabriella Nocentini (a cura di) Con l'aiuto della Signorina maestra. Elena Salvestrini e la scuola di Ponte Sestaione, Cutigliano (1926-1930) Giuseppe Panella La polifonia assoluta. Poesia, romanzo, letteratura di viaggio nell’opera di Vittorio Vettori Pamela Giorgi, Fabiana Spinelli, Serena Masolini (a cura di) Caterina Bueno. Inventario del fondo documentale Linda Luzzi (a cura di) Corso di aggiornamento e perfezionamento Addetti alle segreterie dei Collegi sindacali. Atti del Convegno Angela Maria Fruzzetti (a cura di) I giovani raccontano. Premio Maresciallo Ciro Siciliano Forno, 13 giugno 1944 - Pace, giustizia, libertà, democrazia Gabriella Nocentini Perché il silenzio non sia più silenzio. Dino Francini, deportato a Mauthausen, nel ricordo della figlia
Scarica