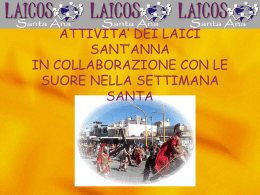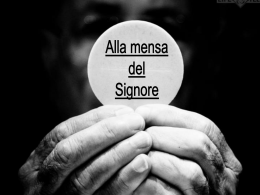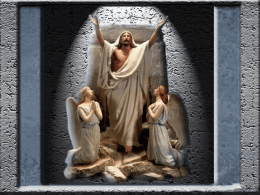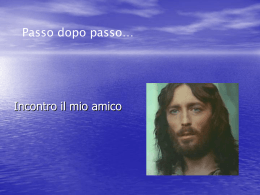Comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele Milano NEL CUORE DELL’APOSTOLO Una comunità: problemi e risorse Itinerario spirituale di Quaresima 1 Ogni anno sentiamo l’esigenza di proporre un percorso spirituale che ci aiuti a gustare la fede, ad approfondire la Parola di Dio e a crescere come comunità cristiana. Ci lasciamo guidare dall’apostolo Paolo: secondo la tradizione ricorre il bimillenario della sua nascita e la Chiesa si mette alla scuola della sua vita e dei suoi scritti. «Paolo vuole parlare con noi – oggi. Per questo ho voluto indire questo speciale “Anno Paolino”: per ascoltarlo e per apprendere ora da lui, quale nostro maestro, “la fede e la verità”, in cui sono radicate le ragioni dell’unità tra i discepoli di Cristo» (Benedetto XVI, 28 giugno 2008). La sfida della fede nella vita quotidiana Accompagnando il cammino di tante comunità, Paolo si è scontrato con i problemi e le sfide che nascono dalla vita quotidiana. Con lui il Vangelo si è tradotto nella cultura, nella storia dei popoli che ha incontrato. Anche per questo è chiamato “apostolo delle genti”. Anche noi vorremmo rileggere la vita quotidiana, i problemi che incontriamo nella storia e nella cultura del nostro tempo per ritrovare la forza trasfigurante del Vangelo di Gesù. Dopo aver iniziato il cammino su San Paolo negli esercizi spirituali di inizio anno a settembre e nel cammino di Avvento, continuiamo con la terza tappa nel corso dei venerdì di Quaresima in ascolto della prima lettera ai Corinti. 2 PRIMO INCONTRO - VENERDÌ 6 MARZO L a c e n a e l ’ a s s e m b le a Ca n to di in iz io Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. Mistero della Croce è il Sangue di Gesù. E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. Mistero della pace è il Sangue di Gesù. Il pane che mangiamo fratelli ci farà. Intorno a questo altare l’amore crescerà. S a lu to I n t r o d u z i o ne Quando ci raduniamo per ricevere l’eucaristia lo facciamo consapevoli della nostra indegnità e della nostra distanza. La sua misericordia ci raduna, la sua parola ci salva. Come alla mensa del pane, anche alla mensa della Parola ci avviciniamo con timore e tremore. Come il sacerdote bacia il libro del Vangelo, così anche noi con devozione e affetto ci avviciniamo a baciare la Parola che ci salva: “Signore, io non sono degno, ma di soltanto una parola e sarò salvato”. Tutti si avvicinano all’altare per baciare il libro dei Vangeli. P e r la pre gh ie ra Salmo 34 (33) 1 coro Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. 3 2 coro Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. 1 coro Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. 2 coro L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia. 1 coro Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 2 coro Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore. C’è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? 1 coro Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca la pace e perseguila. 2 coro Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. 1 coro Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 4 egli salva gli spiriti affranti. 2 coro Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. 1 coro La malizia uccide l’empio e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato. As c o lto de lla P a ro la (1Cor 11,17-34) E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio. Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l’altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo! Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e 5 un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non esser condannati insieme con questo mondo. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. Rif le s s io n e T e s to d i me d i ta z i o n e Per poter essere vera alleanza, la nuova alleanza fondata nell’eucaristia deve avere due dimensioni: la dimensione verticale di relazione con Dio e la dimensione orizzontale di fratellanza. Nell’ultima cena, la dimensione più evidente è quella orizzontale, di dono ai fratelli: il contesto è quello di un pasto preso in comune, contesto di fratellanza. Ogni comunione di mensa ha il significato di comunicazione fra le persone, di accoglienza reciproca, di relazioni amichevoli e fraterne. In questo contesto Gesù offre ai discepoli il proprio sangue, il proprio corpo: «Prendete e mangiate», «Prendete e bevete». Gesù dona, fa ai discepoli il dono completo di sé. Si tratta di una dimensione di comunione fraterna, espressa nel modo più intimo che si possa immaginare. Nel discorso del pane di vita, Gesù dice: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (Gv 6,56). Non si tratta quindi semplicemente di un’alleanza che mette le persone l’una accanto all’altra; si tratta di una interiorità reciproca, cosa inimmaginabile prima di questa attuazione straordinaria. Questo aspetto di comunione fraterna non si ritroverà sul Calvario. È un aspetto che è attuato da Gesù nell’ultima cena, ma che sul Calvario scompare. Gesù sulla croce muore per la moltitudine, ma muore solo, respinto dalla moltitudine. Invece, nell’ultima cena, Gesù sta con i suoi discepoli e dona se stesso a essi. La dimensione orizzontale dell’eucaristia non si restringe a una relazione reciproca tra Gesù e ciascuno dei discepoli singolarmente, ma comprende anche necessariamente l’unione fraterna fra tutti i discepoli. Lo dice chiaramente san Paolo: «Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti, infatti, partecipiamo dell’unico 6 pane» (1Cor 10,17). Ai corinzi l’Apostolo ricorda che l’eucaristia è completamente incompatibile con l’individualismo e l’egoismo. Scrive loro: « Quando vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore, perché ciascuno, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così l’uno ha fame, l’altro è ubriaco» (1Cor 11,20-21). L’egoismo e l’eucaristia non possono affatto andare insieme. Le divisioni e i contrasti sono direttamente contrari alla comunione, perché la comunione eucaristica è simultaneamente comunione al corpo di Cristo e comunione con le membra del corpo di Cristo, che siamo tutti noi. Così va capita la dimensione orizzontale dell’eucaristia. La dimensione verticale è meno evidente, eppure è essenziale, condiziona quella orizzontale. Non c’è vera comunione fraterna, se non c’è unione con il Padre celeste. Dove si manifesta la dimensione verticale dell’eucaristia nel racconto dell’ultima cena? Forse sareste nell’imbarazzo, se doveste rispondere a questa domanda. La dimensione verticale si manifesta prima dell’altra, si manifesta nella preghiera di Gesù che consiste in un rendimento di grazie. Gesù «prese il pane e avendo reso grazie lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo che è per voi”» (1Cor 11,23-24). È una sola parola in greco: eucharistesas. La Chiesa ha capito la sua importanza, perché ha scelto proprio questa parola per designare il sacramento: «eucaristia» in greco vuol dire «rendimento di grazie». Durante la sua vita, Gesù assumeva spontaneamente l’atteggiamento filiale di amore riconoscente, un atteggiamento che corrisponde alla sua situazione di Figlio: il Figlio riceve tutto dal Padre e lo riconosce con gioia e gratitudine. I vangeli ci riferiscono diversi casi in cui Gesù ha reso grazie in pubblico; si tratta regolarmente di situazioni nelle quali noi non avremmo pensato di ringraziare Dio, perché erano situazioni di mancanza, di sconfitta o di lutto. Una situazione di mancanza, di carestia, è quella che precede la moltiplicazione dei pani: ci sono cinquemila persone da sfamare e cinque pani a disposizione, che sono in realtà piccole focacce piuttosto che pani. Non sembrerebbe proprio il caso di rendere grazie, ma in questa situazione di carestia, Gesù comincia col ringraziare e poi distribuisce: inaspettatamente i pochi pani bastano per saziare tutti, anzi c’è sovrabbondanza. In un’altra occasione, Gesù era stato criticato; la sua predicazione non era stata accolta dalla gente perbene, dai sapienti, dagli intelligenti: Gesù rende grazie al Padre, perché è piaciuto al Padre fare la rivelazione ai piccoli. Un’ultima 7 volta - è la più impressionante -, davanti alla tomba del suo amico Lazzaro, Gesù fa aprire il sepolcro e prega dicendo: «Padre, ti rendo grazie, perché mi hai ascoltato» (Gv 11,41). Una preghiera completamente inaspettata in un momento in cui l’esaudimento non si è ancora manifestato e sembra impossibile. Gesù rende grazie anche durante l’ultima cena: c’è un rapporto con la moltiplicazione dei pani, perché all’inizio di un pasto conviene rendere grazie a Dio per il cibo che mette a disposizione. Gesù lo faceva, come tutti i buoni giudei. Quindi, quando hanno sentito che Gesù rendeva grazie, i discepoli l’hanno trovato un fatto molto naturale, tanto più che questa volta il cibo bastava, non era come nel deserto, c’erano pochi commensali. Sentendo la preghiera di Gesù, i discepoli hanno capito il primo significato di questo rendimento di grazie. Gesù prende il pane e dice: «Padre, ti benedico per questo pane che mi dai, tu che sei creatore di ogni cosa, la sorgente di ogni vita, tu che nutri generosamente tutte le tue creature; ti rendo grazie per questo vino, simbolo del tuo amore, con il quale rallegri il cuore degli uomini; ti rendo grazie perché posso continuare il movimento della tua generosità, distribuendo ai miei fratelli questo pane e questo vino». Questo potevano subito capire i discepoli. Gesù stesso, però, sapeva benissimo ciò che stava per dire e per fare nel momento immediatamente successivo: sapeva che il pane non sarebbe restato un pane ordinario, un cibo materiale, che il vino sarebbe stato trasformato in sangue d’alleanza. Quindi, Gesù vede che il Padre gli dà la possibilità di un dono incomparabilmente più grande, più sostanzioso, più generoso: il dono del pane celeste per comunicare la vita divina e quello del vino dell’alleanza per stabilire la comunione. Gesù aveva annunziato questo dono del Padre nel discorso sul pane della vita dicendo: « Non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero» (Gv 6,32). Per Gesù, il primo aspetto dell’eucaristia non è quello di essere un dono suo ai discepoli, bensì un dono del Padre celeste: «Il Padre mio vi dà il pane dal cielo». Gesù ne è consapevole, non pretende di avere lui l’iniziativa di questo dono meraviglioso, ma rende grazie: «Ti rendo grazie, Padre, perché per mezzo di questo pane, che ho nelle mie mani, io stesso diventerò pane per la vita del mondo. Ti rendo grazie di avermi dato un corpo che posso trasformare in cibo spirituale, di avermi dato il mio sangue che posso trasformare in bevanda spirituale, di avermi dato un cuore pieno d’amore, che desidera 8 ardentemente fare questo dono completo di me stesso per stabilire la nuova alleanza». Questo è il senso del ringraziamento di Gesù. (Albert Vanhoye, Pietro e Paolo, pg. 189-193) P re gh ie ra in sie m e (Didier Rimaud) E venne il giorno di aprire le braccia, di incatenare la morte alla croce: durante una cena, il Figlio dell’Uomo ai peccatori consegna se stesso. “Ecco il mio corpo, prendete e mangiate, ecco il mio sangue, prendete e bevete. Perché la mia morte vi sia ricordata farete questo finché io ritorni”. Ormai non temiamo la sete o la fame: si fa nostra carne il corpo di Cristo, e quando portiamo la coppa alle labbra sentiamo il gusto d’un mondo che è nuovo. Banchetto pasquale, dove il cibo è Dio, segno d’amore, fermento d’unione: tutti gli uomini, nati dall’alto, trovano i beni del regno futuro. Per Cristo Gesù, sacerdote perfetto, e nello Spirito, nostro conforto, per ogni dono, per ogni tua grazia, a te sia gloria, o Padre del cielo. P a dre No stro An tif o n a Ma ria n a 9 SECONDO INCONTRO - VENERDÌ 13 MARZO D o n i p e r l ’u t i l i t à c o mu n e Ca n to di in iz io Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta lode a te, Gesù, gloria al nostro Dio, gloria a Cristo re. Venga il tuo Regno, Regno di giustizia, Regno della pace, Regno di bontà. Torna, o Signore, non tardare più. Compi la promessa: vieni, o Gesù S a lu to I n t r o d u z i o ne Le nostre comunità rivelano spesso risorse inaspettate. Il Signore ha concesso a ciascuno di noi molti doni. Non devono diventare motivo di vanto o strumenti per cercare di prevalere sull’altro. Ciò che ci è stato regalato va condiviso e messo a servizio di un bene più grande che è un bene comune. Attraverso l’immagine del corpo e delle membra Paolo ci invita a contemplare un disegno dove l’unità non è uniformità e la differenza diviene ricchezza. Donaci Signore la meraviglia di scoprirci parte di un unico corpo, la pazienza di sentire come nostre le debolezze dell’altro, la gioia di condividerne i successi e la grazia di percepire sempre vivo e operante lo Spirito che ci mantiene uniti. P e r la pre gh ie ra Salmo 133 (132) Sac.: Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme! 1 coro: È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba, 10 sulla barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste. 2 coro: È come rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion. Tutti: Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. As c o lto de lla P a ro la (1Cor 12,1-27) Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell’ignoranza. Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l’impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire «Gesù è anàtema», così nessuno può dire «Gesù è Signore» se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al 11 corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto udito, dove l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie; e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Rif le s s io n e T e s to d i me d i ta z i o n e Sappiamo, da 1Corinzi, che l’abbondanza dei carismi provocava molte difficoltà nella comunità di Corinto. Paolo ne parla per tre capitoli. L’avidità dei corinzi per i carismi metteva la confusione nella comunità cristiana, sicché Paolo sentì la necessità d’imporre regole molto rigide. Però, diede prima lunghe spiegazioni. In particolare, Paolo prese il paragone del corpo, prima per dire che è necessario che ci sia una diversità di doni. San Pietro dice similmente che la grazia di Dio è multiforme. L’ideale cristiano non è l’uniformità. Potrebbe sembrare logico, al fine di conservare la carità, imporre a tutti un modo uniforme di pregare e di comportarsi, cioè regole molto strette perché sia conservata l’uniformità, e così preservata la carità. San Paolo dice che è un’illusione, perché il corpo deve avere membra diverse. Se c’è soltanto un’unica specie di membra, non c’è un corpo. San Paolo dice: «Il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra». E dice: «Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto udito, dove sarebbe l’odorato? Invece Dio ha disposto le membra in modo 12 distinto nel corpo come egli ha voluto», quindi la diversità è necessaria; è un bene che ci siano doni diversi, carismi diversi (1Cor 12,17-20). D’altra parte, san Paolo si preoccupò di preservare l’unità nella diversità. L’unità era in pericolo a Corinto, a causa della troppa importanza attribuita ad alcuni carismi, quelli più vistosi. Per aiutare quelli che avevano un complesso d’inferiorità, perché non erano dotati di grandi carismi, Paolo così si esprime: «Se il piede dicesse: “Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo»; il piede rappresenta il cristiano capace soltanto di camminare, cioè di comportarsi da cristiano. Non ha l’abilità della mano, che può fare tante cose, prendere tante iniziative, realizzando opere splendide. Ma Paolo dice: il piede, il cristiano semplice, fa parte del corpo. Similmente dice: «Se l’orecchio dicesse: “Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo”». Di nuovo, il complesso d’inferiorità: l’orecchio, capace soltanto di udire, rappresenta il cristiano capace di ascoltare la parola di Dio, ma non dotato del carisma profetico che percepisce visioni sublimi. A Corinto, molti avevano visioni e le riferivano nell’assemblea. Chi poteva soltanto ascoltare, si scoraggiava e diceva: non sono un vero cristiano, non ho visioni. Paolo nega tutto ciò e dice: «Non per questo non farebbe più parte del corpo» (12,16). E poi si rivolge agli altri, ai grandi carismatici, e dice: «Non può l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”». L’occhio, cioè il cristiano profeta, quello che ha le visioni, non può dire al cristiano attivo, che non ha le visioni: «“Non ho bisogno di te”. Né la testa può dire ai piedi: “Non ho bisogno di voi”». Il cristiano in grado di organizzare, di dirigere, di prendere iniziative non ha il diritto di escludere cristiani semplici, che svolgono attività più modeste. Paolo poi fa notare che quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie, e aggiunge: «Quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno». Paolo fa cenno al vestito: non vestiamo le nostre mani, né la nostra faccia; invece, le parti meno decenti, noi le copriamo con dei vestiti, che si cerca sempre di dotare di una certa bellezza; il vestito non è meramente utilitario, è anche estetico. Con questa osservazione, san Paolo suggerisce l’atteggiamento evangelico di attenzione speciale ai bisognosi, agli umili: invece di disprezzarli, far loro onore, dare loro la precedenza in certe circostanze, mostrare che sono il Signore per noi. «Ciò che avrete fatto 13 al più piccolo dei miei fratelli, l’avrete fatto a me». L’atteggiamento cristiano è questo. Non è l’atteggiamento del mondo: nel mondo, chi ha le doti, chi ha il potere, chi ha la ricchezza, viene onorato, mentre gli emarginati non ricevono onore. San Paolo invece invita, non soltanto alla solidarietà, ma alla delicatezza dei rapporti con le membra di Cristo che sono più deboli, meno dotate, e dice infine: « Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui». La vita nel corpo di Cristo è una vita di solidarietà affettuosa, non soltanto di solidarietà pratica ma di delicatezza, di partecipazione cordiale. In un’altra lettera, san Paolo dice che dobbiamo godere con chi gode, piangere con chi piange (Rm 12,15): questo è l’ideale cristiano, l’unione dei sentimenti, nella pena come nella gioia. (Albert Vanhoye, Pietro e Paolo, pg. 275-277) P re gh ie ra in sie m e (Didier Rimaud) Salvati dalle stesse acque, marchiati dallo stesso sangue, noi siamo il tuo popolo; uniti dallo stesso amore, segnati dallo stesso nome noi siamo il tuo popolo: a te rendiamo grazie per il Figlio, Gesù. Colmati dello stesso Spirito, portiamo uno stesso Fuoco e siamo il tuo popolo, piantati sullo stesso tronco seguiamo uno stesso Capo e siamo il tuo popolo: a te rendiamo grazie per il Figlio, Gesù. 14 Per essere uno stesso Corpo che vive la stessa vita noi siamo il tuo popolo; per prendere uno stesso pane e bere uno stesso vino, noi siamo il tuo popolo: a te rendiamo grazie per il Figlio, Gesù. Me m o ria de lla Co nf e rm az io ne Ciascuno si avvicina al sacerdote e riceve un segno con l’olio del crisma. Sac.: …, il Signore rinnovi in te i doni dello Spirito. P a dre No stro An tif o n a Ma ria n a 15 TERZO INCONTRO - VENERDÌ 20 MARZO l l d o n o p i ù gr a n de Ca n to di in iz io Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore! Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: via le lotte maligne via le liti! e regni in mezzo a noi Cristo Dio. S a lu to I n t r o d u z i o ne Quando sentiamo dire che bisogna “fare la carità” istintivamente mettiamo mano al portafoglio, o per fare un’elemosina che ci metta a posto la coscienza, o peggio per dimostrare agli altri la nostra generosità. La Carità, ci insegna Paolo, non è una questione di cose da fare, e soprattutto non è un vanto, un’opera che nasce da noi, dal nostro buon cuore e dalla nostra buona volontà. La Carità è Dio stesso, il suo stile, il suo modo di fare e di agire. E lo stile di Dio come ci mostra la vita di Gesù predilige l’umiltà del nascondimento, la povertà delle piccole cose, la totalità del dono, la pazienza dell’attesa, e la benevolenza nel guardare la vita dell’altro. Donaci Signore un cuore puro e uno spirito semplice. Insegnaci un amore docile, che sappia scorgere i segni a volte nascosti della tua opera nel mondo e sperimenti la gioia di accoglierli e di renderne grazie. 16 P e r la pre gh ie ra Salmo 37(36) Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fa' il bene; abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera; farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Sta' in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare, cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti. Ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco 17 per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi; perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati, tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito, per questo la sua stirpe è benedetta. Sta' lontano dal male e fa' il bene, e avrai sempre una casa. 18 Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia; la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia condannare. Spera nel Signore e segui la sua via: ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai lo sterminio degli empi. Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso; sono passato e più non c'era, l'ho cercato e più non si è trovato. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto, l'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i peccatori saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro difesa; il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e dà loro salvezza, perché in lui si sono rifugiati. 19 As c o lto de lla P a ro la (1Cor 12,31 - 13,13) Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità! Rif le s s io n e T e s to d i me d i ta z i o n e Talvolta si dice che il più grande carisma è la carità; dire questo è un errore, anche se capita che alcuni vescovi lo dicano. Infatti, che cos’è un «carisma», teologicamente? E un dono certamente prezioso, un dono di Dio, quindi va rispettato - e Paolo esprime rispetto per il carisma -, ma si tratta di un dono particolare, dato a certi cristiani e non ad altri, un dono utile alla persona, utile alla comunità (Paolo ritiene che parlare in 20 lingue non sia utile alla comunità, ma che sia utile soltanto alla persona stessa, perché è un modo di pregare dato da Dio per il bene spirituale della persona stessa); altri carismi sono utili alla comunità: la profezia, dice Paolo, è molto utile alla comunità, all’assemblea, e naturalmente carismi come il dono di fare guarigioni sono molto utili ad altre persone, e così via. Ma sono doni particolari, non indispensabili a ciascuno. Questo è il concetto di carisma in teologia. A questo proposito, san Tommaso parla di “gratia gratis data”, cioè di una grazia speciale gratuita. Il carattere specifico del carisma è che esso non è necessario a ciascuno. Invece, la carità, l’amore è indispensabile alla vita spirituale di ogni cristiano. San Paolo dice, infatti, che un cristiano può avere tutti i carismi che vuole, ma che se non ha la carità non è cristiano. Quindi dire che la carità è il carisma più grande, non è corretto. La carità è il dono più grande, questo è vero, ma non è un carisma. Talvolta, alcune parole diventano di moda e allora si vuole dare questa qualifica a beni e realtà che si vogliono mettere in rilievo: «carisma», ad esempio, è una di quelle parole che vengono adoperate in maniera incoerente. In 1Cor 13, 9.13 san Paolo dice che l’amore, a differenza dei carismi, è una cosa permanente, che dura, che rimane, una cosa necessaria a tutti, che è il dono più bello e più grande («Tre cose rimangono: la fede, la speranza e la carità»). Non si tratta di dire che rimangono nella vita eterna, perché la fede non rimane nella vita eterna: quando siamo nella visione di Dio, non abbiamo più la fede, abbiamo la visione. La speranza scompare quando abbiamo tutti i doni sperati, quindi non abbiamo più niente da sperare perché siamo colmati. Il senso della frase è che queste tre virtù rimangono come fondamento necessario e continuo della vita cristiana, la quale consiste nell’unione con Dio, per mezzo di Cristo, nella fede, nella speranza, nella carità. In ogni momento della vita cristiana dobbiamo vivere nella fede, nella speranza e nella carità; non possiamo mai rinunziare a una di queste virtù teologali che proprio costituiscono il nostro legame con Dio. Ma, conclude Paolo, «la più grande è la carità», l’amore generoso. Quest’ultima affermazione di Paolo è fondamentale nella vita cristiana: il valore più grande è l’amore generoso che ci è comunicato da Dio e che noi dobbiamo ricevere con immensa gratitudine, perché è la cosa di più grande valore. Il pensatore francese Pascal distingueva molto bene l’ordine della materia, l’ordine della conoscenza - che è già straordinariamente più alto - e l’ordine 21 dell’amore, che è completamente diverso, non senza legame con la conoscenza ma di una qualità molto diversa, una qualità suprema. Molto convinto dell’importanza dell’amore generoso, Paolo lo preferiva a qualsiasi altro dono di Dio. Ad esempio, nella Lettera ai Galati egli conduce una lotta a favore della libertà cristiana. Il tema principale della Lettera ai Galati è infatti la difesa della libertà cristiana. Paolo parla di ciò sin dall’inizio della lettera e ne fa una dimostrazione contro la legge di Mosè che opprime, e a favore della libertà. Ma quando giunge al tema dell’amore, Paolo sembra contraddirsi (Gal 5,13): «Voi, fratelli, siete chiamati a libertà - lo ha dimostrato per quattro capitoli -, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne; ma, mediante l’amore, fatevi schiavi gli uni degli altri». Dunque, la libertà è una cosa secondaria, nei confronti dell’amore. In realtà, nell’amore si trova la vera libertà. L’espressione di Paolo, che sembra contenere una contraddizione, manifesta proprio questa importanza suprema dell’amore generoso: «Mediante l’amore generoso, fatevi schiavi gli uni degli altri». Egli stesso, in 1Corinzi, dice: «Io essendo libero da tutti, mi sono fatto schiavo di tutti» (9,19). L’amore lo ha portato a questo. Questa specie molto particolare di schiavitù in realtà è allo stesso tempo il supremo grado di libertà: uno che vive soltanto per amore, che per amore si mette al servizio delle altre persone, si sente unito a Dio e nella libertà spirituale più completa. Ecco, quindi, l’orientamento della vita cristiana, in unione con il cuore di Gesù. È chiaro che non possiamo progredire nell’amore, abbondare nell’amore, se non riceviamo l’amore generoso dalla sua sorgente, cioè il cuore trafitto di Cristo. La nuova alleanza consiste proprio nell’unione al cuore di Gesù, per vivere sempre più nell’amore generoso; con tanta gratitudine, perché l’amore generoso lo riconosciamo come un dono di Dio, il dono più alto, più bello, il dono che ci mette nella dignità più alta perché veramente ci unisce a Dio stesso: «Dio è amore», ha detto san Giovanni, «e chi vive nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1Gv 4,16). (Albert Vanhoye, Pietro e Paolo, pg. 110-113) 22 Ado raz io ne de lla Cro c e Tutti si mettono in ginocchio davanti al crocifisso. Inizia la preghiera, intervallata dal canto: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. La carità è paziente, è benigna la carità. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. La carità non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. La carità non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. La carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. La carità non avrà mai fine. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. P re gh ie ra (Margherita Guidacci) Hai perduto la fede e la speranza, proprio ora, nel tratto più difficile e minaccioso, quando tutte le vie s’aggomitolano in labirinti e sempre più imperfetta è la conoscenza, sempre più lacunosa la profezia, sempre più nera la nube dell’enigma, proprio ora hai perduto quelle fide compagne! Ma la terza sorella, la più grande, non t’abbandona, anzi ti stringe a sé più fortemente. Arde di carità il tuo cuore e nel vincolo di fuoco adombrando la rosa, trasfigura in giardini tutta la tua intricata solitudine. 23 Quasi tu avessi già passato il varco oltre il quale, comunque, non possono seguirci fede e speranza, non più necessarie, la carità soltanto ti possiede per te da sola accende la visione. P a dre No stro An tif o n a Ma ria n a 24 QUARTO INCONTRO - VENERDÌ 27 MARZO C r e d er e ne l C r i s to r i so r to Ca n to di in iz io Credo in Te, Signore, nato da Maria: Figlio eterno e santo, uomo come noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi. Fino a quando - io lo so - Tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Padre della vita, noi crediamo in Te. Figlio Salvatore, noi speriamo in Te. Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità. E per mille strade, poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. S a lu to I n t r o d u z i o ne Proprio il centro della nostra fede, la risurrezione di Cristo dai morti, spesso è un mistero che resta ai margini della vita dei credenti. Tutto quello che rimane è una vaga idea del cielo, del paradiso, di una vita futura di cui non si sa nulla e comunque troppo distante per essere presa in considerazione e per incidere sulla vita presente; l’orizzonte in cui ci muoviamo e che detta le nostre scelte rimane racchiuso nei confini angusti di “questo mondo”. Al contrario per Paolo la risurrezione rimane la questione centrale; tolta questa certezza la fede e la vita cristiana non significano più nulla. Ricollocata al centro della nostra fede, la risurrezione diviene mistero che interpella e riordina la nostra vita, guida le nostre scelte e i nostri criteri, orienta le nostre decisioni. Donaci Signore di vivere nella speranza, di non temere la morte e di attendere con fiducia la nostra risurrezione. 25 P e r la pre gh ie ra Salmo 136(135) Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Lodate il Signore perché è buono: perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio degli dèi: perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Signore dei signori: perché eterna è la sua misericordia. Egli solo ha compiuto meraviglie: perché eterna è la sua misericordia. Ha creato i cieli con sapienza: perché eterna è la sua misericordia. Ha stabilito la terra sulle acque: perché eterna è la sua misericordia. Ha fatto i grandi luminari: perché eterna è la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno: perché eterna è la sua misericordia. la luna e le stelle per regolare la notte: perché eterna è la sua misericordia. Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti: perché eterna è la sua misericordia. Da loro liberò Israele: perché eterna è la sua misericordia. con mano potente e braccio teso: perché eterna è la sua misericordia. Divise il mar Rosso in due parti: perché eterna è la sua misericordia. In mezzo fece passare Israele: perché eterna è la sua misericordia. Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso: perché eterna è la sua misericordia. Guidò il suo popolo nel deserto: perché eterna è la sua misericordia. Percosse grandi sovrani perché eterna è la sua misericordia. uccise re potenti: perché eterna è la sua misericordia. 26 Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Let.: Tutti: Seon, re degli Amorrei: perché eterna è la sua misericordia. Og, re di Basan: perché eterna è la sua misericordia. Diede in eredità il loro paese; perché eterna è la sua misericordia. in eredità a Israele suo servo: perché eterna è la sua misericordia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: perché eterna è la sua misericordia. ci ha liberati dai nostri nemici: perché eterna è la sua misericordia. Egli dà il cibo ad ogni vivente: perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio del cielo: perché eterna è la sua misericordia. As c o lto de lla P a ro la (1Cor 15,1-34) Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l’ho annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano! Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è 27 risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato Cristo, mentre non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, che cosa farebbero quelli che vengono battezzati per i morti? Se davvero i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per loro? E perché noi ci esponiamo al pericolo continuamente? Ogni giorno io affronto la morte, come è vero che voi siete il mio vanto, fratelli, in Cristo Gesù nostro Signore! Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Efeso contro le belve, a che mi gioverebbe? Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi». Ritornate in voi, come conviene, e non peccate! Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio; ve lo dico a vostra vergogna. Rif le s s io n e 28 T e s to d i me d i ta z i o n e Non c'è nulla più consolante del sapere che il nostro corpo risorgerà, che la morte e la conseguente separazione dalle persone care non è la parola ultima. L'uomo è humus, viene dalla terra e ad essa ritorna. È mortale e cosciente di esserlo: questo lo rende umano. Tuttavia torna alla terra come un seme caduto dalla pianta, va là donde era venuto come promessa di vita. La risurrezione non è semplice rianimazione di un cadavere che riprende a vivere, mortale come prima. È invece quella pienezza di felicità e di vita - non c'è felicità senza vita - a cui da sempre aspiriamo. È il compimento del nostro desiderio originale: diventare come Dio (cf Gn 3,5). Un desiderio purificato, ordinato e realizzato da Dio stesso in Cristo. La risurrezione, centro della fede cristiana, riguarda proprio il corpo e si fonda sull'esperienza di Gesù risorto. La sua e la nostra risurrezione sono così intimamente connesse che non è vera l'una senza l'altra. La risurrezione di Gesù, infatti, è per noi; è l'inizio della risurrezione universale dei morti. L'intera storia è vista come un travaglio che genera la creatura nuova. E la stessa creazione attende con impazienza, «geme e soffre nelle doglie del parto», aspettando di venire alla luce della gloria dei figli di Dio, alla redenzione del corpo (cf Rom 8,19-24). Nulla a che fare con la teoria della reincarnazione che nega la risurrezione del corpo in quanto lo considera un peso da cui liberarsi. La risurrezione è la bellezza di Dio partecipata all'uomo e, in lui, a tutta la creazione: sono i cieli nuovi e la terra nuova contemplati da Isaia (65,17), dove tutto ha lo stupore di un perenne mattino che non conosce tramonto, di una gioia sorgiva e perenne. Finalmente l'uomo inquieto, che non trova «niente di nuovo sotto il sole», come dice Qoèlet (1,9), scopre quella novità inaudita che da tempo va cercando. L'eternità, la vita nuova e definitiva è già entrata, con la morte e risurrezione di Gesù, nella mia esperienza. È da me vissuta, qui e adesso, nell'indistruttibilità dei gesti che compio: di amore, di fedeltà, di perdono, di amicizia, di onestà, di libertà responsabile. Gesti nei quali supero misteriosamente il tempo raggiungendo l'eternità nella misura in cui mi affido alla vita e all'eternità del crocifisso Risorto che ha vinto la morte. 29 È bello pensare che posso riscattare l'angoscia del tempo, la storia del mio corpo, con atti di dedizione che hanno un valore definitivo, depositato nella pienezza del corpo risorto di Cristo! È bello pensare che ogni parola che dico nella preghiera è un mattone lanciato nell'eternità per costruire la dimora che non ha fine. Non siamo certamente in grado di raffigurarci la risurrezione del nostro corpo, come non siamo capaci di rappresentarci la luce e la vita, l'intelligenza e l'amore. Sappiamo però che da qui viene non solo ogni nostra raffigurazione, ma anche ogni realtà raffigurata. Per questo ne parliamo, come di ciò che dà senso al nostro essere uomini e donne. È la Parola che ci comunica il mistero. L'amore è il codice di vita di Dio, che comanda e informa. Se ascolto la sua Parola, vengo a poco a poco trasformato e trasfigurato in lui e, con la risurrezione del corpo, parteciperò della sua vita. Il mio corpo non è dunque semplicemente uno strumento per ascoltare e dire la Parola: questa gli dà la sua stessa vita. E proprio il mio corpo terreno che riceverà quale principio vitale lo spirito di Dio, che sarà completamente compenetrato dallo Spirito santo. Dal momento che Cristo, la Parola eterna del Padre, si è fatto carne, la mia carne verrà divinizzata. L'evento dell'Incarnazione del Figlio di Dio annuncia già che i nostri corpi mortali sono destinati a risorgere. «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno» (Gv 11, 25-26). A proposito dell'Eucaristia Gesù aveva affermato: «Chi mangia la mia carne... io lo risusciterò» (Gv 6,54). Per comprendere meglio il destino del nostro corpo vorrei anzitutto ricorrere al racconto della trasfigurazione di Gesù. L'evangelista Luca, non sapendo in quale modo indicare la gloria del corpo di Gesù, dice che le sue vesti divennero luminose come la folgore e che la figura del suo volto si "alterò"!, divenne altro (Lc 9,29). Risplendette cioè di una bellezza che è "altro" rispetto a quanto noi conosciamo: era la bellezza di Dio, del Santo. È importante sottolineare che nel mezzo della sua vita sulla terra, il corpo di Gesù rivelò la sua gloria nascosta, riverbero anticipato di quella finale che si manifesterà nella risurrezione. La luce divina si comunica al corpo non solo al termine del cammino; tutta la vita è un lento cammino di illuminazione progressiva, che pervade ogni giorno sempre più la nostra esistenza quotidiana. È una voce celeste che ci offre il principio di questa illuminazione: «Ascoltate lui» (Lc 9,35). Ascoltando lui, Parola fatta carne, che ha vissuto in pienezza il comando dell'amore, ogni carne partecipa della sua gloria. 30 Il volto del Padre, che tutti cerchiamo come luce del nostro volto e che nessuno può vedere, è quello del Figlio e di chiunque, ascoltandolo, si fa suo fratello. «È giunto il momento - scrive l'evangelista Giovanni - in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno ascoltata, vivranno» (Gv 5,24). E ancora: «Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,4). La vita eterna, che nel futuro germoglierà in pienezza, ci è già data: è la qualità di vita propria di chi ascolta la parola del Figlio e vive da fratello. È l'esperienza vissuta anche da san Paolo, che gli fa dire: noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la bellezza di Dio, veniamo trasformati a sua immagine, di gloria in gloria (cf 2Cor 3,18). Se quando nasco ho un certo volto che ho ricevuto come in eredità, quando sono cresciuto mi ritrovo il volto che ho cercato di costruirmi. Perché il volto è la sedimentazione delle mie esperienze dolorose e gioiose, di schiavitù e di libertà, di egoismo e di amore: manifesta il buio o la luce delle parole seminate e coltivate nel mio cuore. È un grande conforto capire che la nostra esistenza è un processo di trasfigurazione per diventare sempre più conformi all'immagine del Figlio di Dio. Attraverso la responsabilità di uomini e donne che vivono da figli e da fratelli si realizza l'ineffabile sogno di Dio che si è dato a noi, in Gesù, prima di ogni attesa e speranza umana, che ci ama e ci perdona gratuitamente. È il sogno che tutto ritorni alla Trinità da cui tutto viene e a cui tutto si dirige. È il sogno iscritto nella creazione: che nulla di ciò che è buono, bello e desiderabile vada perduto. E se ci fossero situazioni di ostinato rifiuto nei riguardi di Dio Amore - ma può rifiutare uno che ha conosciuto l'amore? -, il Risorto ci lascia comunque sperare, contro ogni speranza, che la misericordia del Padre saprà vincere ogni resistenza. Come il Verbo, che in principio era presso il Padre, ha voluto prendere il nostro corpo e di nuovo è presso Dio, così osiamo sperare che tutti un giorno saremo col nostro corpo presso Dio, nella sua luce e nella sua vita. Ma tutto ciò passerà per il dono d'amore del nostro corpo, dono serio e totale, senza riduzioni o rimpianti. (Carlo Maria Martini, Sul corpo, pg. 111-127) 31 P r o f e s s i o ne d i F e d e La professione di fede è recitata insieme e intervallata dal ritornello cantato Credo Signore, accresci la mia fede Io Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, Credo Signore, accresci la mia fede e in Gesù Cristo, Suo Figlio unigenito, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque dalla Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo; siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi ed i morti. Credo Signore, accresci la mia fede Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. la vita eterna. Amen. Credo Signore, accresci la mia fede P re gh ie ra (Didier Rimaud) Brillate oramai, luci di Pasqua, splendete per il giorno che è vicino, annunciate che lo sposo ritorna e ogni cosa rinasce al suo passaggio. La notte non potrà più trattenere quel corpo in cui cresce il desiderio di dare inizio a una diversa età. 32 Cede la terra dov’egli si rialza, come quel giorno in cui Dio gli diede lo Spirito, il suo soffio ed una voce nel giardino del primo paradiso. La carne prende nome dalla sua: la ferita che si porta nel fianco s’apre, perché un popolo nasca. Ed ecco il tempo in cui Dio si affretta: con la sua mano ricopre le acque, ne fa sorgere un mondo tutto nuovo e la vita dovunque riaffiora. La tomba di Dio? chi l’ha veduta? La morte ora è morta sotto gli occhi di chiunque crederà nella sua grazia. P a dre No stro An tif o n a Ma ria n a 33 QUINTO INCONTRO - VENERDÌ 3 APRILE S e g n i c o n c r et i d i b e ne Ca n to di in iz io Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a lui, che tanto gli uomini amò da dare l'unico Figlio. Lodate Dio, uno e trino Signore. Lodate Dio, meta e premio dei buoni. Cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, per tutti i secoli. Amen. S a lu to I n t r o d u z i o ne Le lettere di Paolo non sono solo ricche di contenuti teologici o di indicazioni morali, sono anche il racconto di vite concrete, fatte di segni di bene, popolate di memorie, ricordi, relazioni, affetti e amicizie. Il vangelo trova spazio e mette radici nelle case degli uomini, nei loro rapporti quotidiani, nell’esercizio concreto della solidarietà e della carità reciproca. Perfino i semplici saluti della vita quotidiana diventano annunci di Vangelo, benedizione e grazia per chi li offre e chi li riceve. Questa comunione di spirito permette di scoprire prossimo anche chi è lontano, ci tiene uniti, annulla e compone ogni distanza, fa crescere il corpo della chiesa. Donaci Signore un forte senso di fraternità, vinci ogni istinto individualista e apri i cuori alla comunione e alla condivisione dei beni. 34 P e r la pre gh ie ra Salmo150 1 Coro: Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza. Lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. 2 Coro: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra; lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Tutti: Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti; ogni vivente dia lode al Signore. As c o lto de lla P a ro la (1Cor 16, 1-24) Quanto poi alla colletta in favore dei fratelli, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, perché non si facciano le collette proprio quando verrò io. Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch’io, essi partiranno con me. Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, poiché la Macedonia intendo solo attraversarla; ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l’inverno, perché siate voi a predisporre il necessario per dove andrò. Non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po’ di tempo con voi, se il Signore lo permetterà. Mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande e propizia, anche se gli avversari sono molti. Quando verrà Timòteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi, giacché anche lui lavora come me per l’opera del Signore. Nessuno dunque gli manchi di riguardo; al contrario, accomiatatelo in pace, perché ritorni presso di me: io lo aspetto con i fratelli. Quanto poi al fratello Apollo, l’ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora; verrà tuttavia quando gli si presenterà l’occasione. 35 Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti. Tutto si faccia tra voi nella carità. Una raccomandazione ancora, o fratelli: conoscete la famiglia di Stefana, che è primizia dell’Acaia; hanno dedicato se stessi a servizio dei fedeli; siate anche voi deferenti verso di loro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro. Io mi rallegro della visita di Stefana, di Fortunato e di Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza; essi hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Sappiate apprezzare siffatte persone. Le comunità dell’Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa. Vi salutano i fratelli tutti. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore sia anàtema. Marana tha: vieni, o Signore! La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù! Rif le s s io n e T e s to d i me d i ta z i o n e «Non è bene che l’uomo sia solo», si legge in Genesi 2,18. È, questa, un’affermazione di grande importanza antropologica, che nel discorso dell’intera Bibbia troverà un grande sviluppo. L’essere umano è strutturalmente comunitario e dialogico. E stato pensato a «immagine di Dio», e Dio - come verrà poi rivelato da Gesù - è in se stesso una realtà dialogica: tre Persone divine che si amano e reciprocamente si donano. Si capisce perché la persona umana non è chiamata a vivere da sola, ma sempre in una comunità. L’essere comunità è dunque realtà creazionale. La comunità cristiana (di qualsiasi genere, dalla Chiesa nel suo complesso a ogni altra forma di comunità) è chiamata a sviluppare questa dimensione umana, a diventarne la trasparenza più trasparente. Mancasse questa dimensione comunitaria cadrebbe tutto, o quasi. Proprio perché realtà dialogica, la persona umana è al tempo stesso ricca e povera: ha bisogno di dare e di ricevere. Questo, ovviamente, anche in ogni comunità cristiana, se questa vuole davvero essere trasparenza di umanità: non solo dare, ma dare e ricevere. Il saper ricevere è importante come il saper dare. 36 La comunità cristiana è chiamata a vivere, in particolare, quella profonda relazione umana che si chiama «fraternità». È diversa da un gruppo di amici. Gli amici si scelgono, i fratelli e le sorelle li trovi. I fratelli li riconosci perché figli dello stesso padre. L’origine della fraternità è verticale. La relazione fraterna di una comunità cristiana (se è tale) è una testimonianza visibile del primato di Dio. L’essere figli di Dio è più importante di ogni altra parentela, più importante di ogni altra amicizia. E dalla fraternità che discende da Dio non può essere escluso nessun uomo, comunque esso sia. È dunque, per natura, universale. La comunità cristiana ha come origine e modello Gesù Cristo. Può perciò diventare un laboratorio dove si sperimenta che il suo amore è capace di costruire fraternità. È un di più di umanità, non un di meno: la struttura creazionale dell’uomo - appunto quella di essere «immagine di Dio» viene approfondita e dilatata. Naturalmente deve trattarsi di una comunità che si modella sull’amore di Cristo con molta serietà: dunque un amore reciproco ma al tempo stesso gratuito, particolare e al tempo stesso universale. Si legga Giovanni 13,34-35, dove appare il rapporto profondo tra gratuità e reciprocità dell’amore. La reciprocità ha la sua salda radice nella gratuità. Questo rapporto ha il tratto più significativo, che ogni comunità è chiamata a vivere e a mostrare, se vuole veramente essere un segno visibile a tutti. L’amore gratuito e reciproco è nuovo perché è il segno, il frutto e insieme la causa del mondo nuovo che la venuta del Cristo ha inaugurato. L’amore reciproco è la novità della vita di Dio che irrompe nel nostro vecchio mondo, rigenerandolo, ed è l’anticipo della vita futura a cui aspiriamo. La reciprocità dell’amore cristiano trova in Gesù il modello e la fonte: «Come io ho amato voi». Logicamente ci aspetteremmo: come io ho amato, così voi amate me. E invece no: «Amatevi gli uni gli altri». C’è dunque nell’amore di Gesù, cioè nell’amore che discende da Dio su di noi, una nota di gratuità e di universalità. L’amore di Dio non accaparra l’uomo: al contrario, è un dinamismo che lo spinge verso gli altri uomini. È amando i fratelli che si ricambia l’amore del Padre. Come in ogni vera famiglia. «Da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli»: quest’affermazione di Gesù taglia corto su ogni eventuale tentazione della comunità di chiudersi in se stessa. L’amore cristiano - proprio nella sua nota di reciprocità - non cessa di essere aperto, missionario: come l’amore del Padre che ha 37 donato il Figlio al mondo (3,16), come l’amore di Gesù che ha dato la vita per il mondo (6,51). Animata e caratterizzata dall’amore fraterno, la comunità deve stare ben visibile (è questa la vera visibilità del vangelo, non altra!) di fronte al mondo, a tutto il mondo, come l’alternativa della fraternità all’egoismo, della vita alla morte, della libertà alla schiavitù. (Bruno Maggioni, Come la pioggia e la neve, pg. 87-89) P re gh ie ra in sie m e (John Henry Newman) Conducimi, dolce luce, tra il buio che mi circonda, sii tu a condurmi! La notte è oscura e sono lontano da casa, sii tu a condurmi! Custodisci i miei passi, non ti chiedo di vedere la scena lontana: un solo passo per volta mi è più che sufficiente. Non sono stato sempre così, e non ho pregato sempre perché fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e vedere il cammino; ma ora sii tu a condurmi. Amavo il giorno luminoso e, nonostante le paure, l’orgoglio reggeva la mia volontà: non ricordare gli anni passati! Così a lungo la tua potenza mi ha benedetto, e sicuramente mi condurrà ancora. Oltre la landa e la palude, oltre il dirupo e l’impeto dei torrenti, fino a che notte non dilegui; e col mattino volti d’angelo, ecco, sorridano, quelli che da tanto ho amato, e perduto ho solo per poco. 38 P a dre No stro B e n e d i z i o n e c o nc l u s i v a Ciascuno si avvicina al sacerdote che, imponendo le mani sul capo, dice: Sac.: La grazia del Signore Gesù sia con te. An tif o n a Ma ria n a 39 Comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele - Milano U n a c o m un i t à : p r o b l em i e ri so r se venerdì 6 marzo La cena e l’assemblea (1Cor 11, 17-34) venerdì 13 marzo Doni per l’utilità comune (1Cor 12, 1-27) venerdì 20 marzo Il dono più grande (1Cor 12, 31 - 13,13) venerdì 27 marzo Credere nel Cristo risorto (1Cor 15, 1-34) venerdì 3 aprile Segni concreti di bene (1Cor 16, 1-24) 40
Scarica