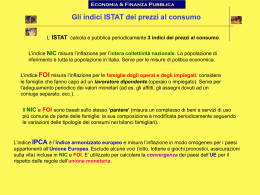DRY 3 © Alan Poloni 2014 © Neo Edizioni s.n.c. 2014 Neo Edizioni Via Volturno, 2 67031 – Castel di Sangro (AQ) info@neoedizioni. www.neoedizioni.it I edizione: febbraio 2014 ISBN: 978-88-96176-22-1 Dio se la caverà Alan Poloni A Lorenzo e Riccardo. Parte Prima db Un aguzzino? qp Un nazista? db pq Un sadico? db pq db E ancora pq db pq db e poi ancora pq db pq db pq all’infinito db pq db pq db pq db pq db pq db pq db pq db pq 9 db pq db pq db pq db pq db pq db pq db pq db pq Chi li aveva inventati, ’sti cosi? Chi era quell’aguzzino che aveva forgiato ’sti cosi e, non contento, li aveva messi assieme in un alfabeto? Chi era quel nazista che aveva espulso dall’intestino queste cacatine di mosca, queste cacatine che differivano l’una dall’altra solo per una piccola minuscola impercettibile e micragnosa gambetta? Perché questo sadico coniatore di cacatine di mosca non aveva coniato delle cacatine marcatamente differenti l’una dall’altra? td Perfino i suoni pb erano fv pressoché td pb fv identici. Si pronunciavano emettendo lo stesso refolo di fiato, usando gli stessi organi della bocca, componendo le stesse assurde acrobazie palatali. Era proprio necessario che per comunicare tra lo10 ro gli esseri umani dovessero arrotolare la lingua e posizionarla nell’incavo degli incisivi? Era necessario? Le rane facevano così? Le talpe facevano così? E le iene? Eppure comunicavano, si capivano, si dicevano cose, trasmettevano messaggi con grande dignità, senza ridursi a far vibrare la lingua tra le pareti del palato e i denti. a d n h iv C i n a Doveva andare in Cina. Gli avevano detto che la dislessia era diversa di paese in paese. A seconda della lingua, cambiava le sue caratteristiche e la sua incidenza. La logopedista gli aveva spiegato che il problema della dislessia era un problema di deficit nella componente fonologica del linguaggio. Deficit. Che brutta parola. Componente fonologica del linguaggio. Che brutte parole. Cioè che il dislessico non riusciva a stabilire una relazione tra un grafema e un fonema, tra un segno e un suono. Cioè: se gli occhi leggevano il grafema P, il cervello non lo traduceva nel fonema P, ma in un altro suono. Nic doveva ritenersi fortunato rispetto a un inglese, perché in Inghilterra il rapporto tra grafemi e fonemi era di 40 a 1220, mentre in Italia il rapporto era di 25 a 33, nel senso che c’erano 25 simboli per 33 suoni e non 40 per 1220. Solidarietà per i dislessici inglesi! Un giorno, sfogliando una rivista scientifica, Nic aveva scoperto che il cinese associava un significato a ogni simbolo. Per ogni simbolo, non uno o più suoni – come in italiano o in inglese – ma un unico e incontrovertibile significato. In cinese 11 quel deficit non trovava humus perché non era una lingua costruita sul rapporto tra segni e suoni: il cinese aveva una scrittura ideogrammatica, dove un segno non rimandava a un suono, ma direttamente a un significato più complesso. In cinese le parole non erano veicolate dalla decodifica sonora dei segni, ma dall’attivazione mnemonica di modelli visivi. E infatti degli studiosi avevano dimostrato che a restare inattiva nel dislessico inglese e nel dislessico cinese non era la stessa area del cervello: per i cinesi era quella della memoria, per gli inglesi quella della decodifica dei suoni. Nic aveva letto di un ragazzo inglese cresciuto in Cina, quindi bi-madrelingua, che si era rivelato fortemente dislessico quando leggeva in inglese ma che era tra i migliori della classe quando si trattava di leggere in cinese. Il suo cervello era svelto per uno dei due linguaggi, lento per l’altro. Era arrivato il momento di emigrare in Cina. Era vero, avrebbe dovuto imparare alcune migliaia di simboli ma, come dicevano tutti, lui aveva un’ottima memoria. L’importante era mettere una distanza tra sé e quellinsieme di aste e asticelle pendenti, di piccole insenature, di suoni imbizzarriti che gli si accavallavano nella mente… insomma, l’importante era non avere più nulla a che fare con le minuscole cacatine di mosca che in Italia gli avevano complicato la vita. Se lo sentiva: ancora qualche anno e la Cina sarebbe diventata la Terra Promessa dei dislessici di tutto il mondo, ancora qualche anno e da tutto il mondo sarebbero partite frotte di emigranti dislessici dirette verso quel Paese in cui il linguaggio non doveva passare attraverso un fottutissimo alfabeto fonosimbolico! Tra l’altro, la Cina era in pieno sviluppo economico e aveva tutte le carte in regola per diventare la nuova America. La nuova America avrebbe consentito ai dislessici di tutto 12 il mondo di non soffrire le pene dell’inferno per capire se una cacatina di mosca era una d oppure una b. Per uno come Nic, l’inferno era la scuola. I libri erano quartieri infernali in cui entrava con terrore perché sapeva che tra quelle pagine si celavano, negli angoli bui delle frasi e nei vicoli ciechi delle parole, le risate ironiche dei compagni, i rimproveri della maestra, lo sguardo atterrito della madre. Vicoli ciechi dove rimbombava un silenzio agitato, piazze deserte invase da stormi di lettere impazzite. E la scuola era una città il cui centro era questo quartiere oscuro e pauroso, un quartiere che agli altri svelava bellezza e conoscenza, ma per lui – solo per lui – nei brevi attimi in cui l’insegnante diceva “Aprite il libro a pagina 40”, si trasformava in un deserto, una landa infestata da bande di predoni che galoppavano impugnando scimitarre grondanti sangue. Che se il cuore della città non fosse stato quel quartiere… se solo quel quartiere si fosse limitato a essere una parte della città… un luogo da cui passare di tanto in tanto, pochi minuti al giorno… allora tutto sarebbe stato diverso. Le scorribande dei predoni non avrebbero fatto tanta paura e le scimitarre non avrebbero lasciato i quaderni sporchi di rosso. Naturalmente, durante il suo inferno, Nic se ne stava rintanato dietro un compagno, cercando di ridurre il più possibile la percezione della sua presenza, ripetendo dentro di sé che non si trovava lì, che era altrove, era al fiume o in camera o al funerale dello zio Alberto che lo prendeva sempre per il culo. “Io non sono qui. Io non sono qui. Io non sono qui”. Era convinto che fosse un buon talismano, questo, ma non funzionava sempre e, di tanto in tanto, gli toccava leggere. Quando poteva, si preparava all’inferno passando ore intere sul brano assegnato e il giorno dopo leggere ad alta voce si trasforma13 va in un esercizio di memoria in cui tutto filava liscio e nessuno sospettava quale fatica ci fosse dietro quell’esatto fluire di parole. Per studiare, c’era la mamma. Una signora dolce e paziente che gli leggeva decine di volte lo stesso paragrafo. Quegli strani difetti di Nic le erano sembrati sospetti fin dalla seconda elementare, ma l’Istituto di Istruzione Primaria Leonardo Da Vinci aveva sempre rispedito al mittente le sue preoccupazioni. Agli inizi della quinta, la madre si era fatta coraggio e aveva affrontato la cosa da sola. Era un pomeriggio di ottobre pieno di sole e freschi ricordi estivi, quando la specialista le aveva comunicato l’esito degli esami. «Nicola manca di automatizzazione nella conversione dei segni in suoni e viceversa». Alle pareti c’erano delle riproduzioni di quadri astratti. I colori erano puri e privi di sfumature, stesi sul quadro solo per riempire degli spazi, come negli album dei bambini. Dentro sfondi blu e rossi s’intravedevano lune e gatti, ma non ne era sicura. «In una parola, Nicola è dislessico». Come si leggeva un quadro astratto? Come andava interpretato? Le forme erano indefinite, non rimandavano a nessuna figura precisa, e in quell’ambiguità ognuno poteva vedere quello che voleva: un pezzo di formaggio, un lampione, una sedia. «Capisce signora? Ogni volta che Nicola legge è come se i segni grafici gli apparissero per la prima volta. Ogni volta». Eppure quello era un gatto. Ne era certa. «Signora?» La logopedista – una ragazza con occhiali e labbra sottilissime, i capelli ricci come esplosi in testa, i modi gentili – le parlava mostrando una tabella da cui emergevano otto devianze, un numero altissimo che delineava una situazione grave, quasi drammatica. 14 Per Nic, la scuola era un immenso quadro astratto che si estendeva a macchia d’olio su ogni centimetro della sua sfera vitale. «Si può… si può fare qualcosa?» La logopedista aveva consigliato di trasmettere quanto prima la certificazione alla scuola per evitare, finché si era in tempo, le tipiche degenerazioni che il disturbo recava con sé. La madre di Nic chiese di quali degenerazioni parlasse. «Un prolungato insuccesso scolastico può generare problemi di autostima. Dalla scarsa autostima deriva un disagio psicologico che, nel tempo, può strutturarsi e dare origine a un’elevata demotivazione all’apprendimento, a manifestazioni emotive particolari quali la forte inibizione, l’aggressività... In alcuni casi, poi, la depressione…» «Depressione?» «Sì, signora, la depressione». «Non… non pensavo… cosa devo fare?» «Parli con gli insegnanti, e poi si scelga una scuola media ben attrezzata». Nic, in cui prevalse la vergogna, finì le elementari passando dall’inferno al limbo. La maestra assecondò le sue paure, non svelò alla classe che era dislessico e fece di tutto per proteggerlo dalle situazioni più imbarazzanti, ma in questo modo non lo aiutò ad affrontare il suo problema. Quel tacito accordo tra lui e la maestra finì solo per rimandare le sue pene. L’anno trascorse placidamente, e quando venne il momento del salto alle medie, la madre insisté perché Nic affrontasse il problema diversamente. «Non ce la farai mai solo con le tue forze». «Sì che ce la farò. Ce la sto facendo anche adesso». 15 «Non è la stessa cosa. Alle medie non troverai la tua maestra. Le medie sono difficili». «Allora andrò in Cina». Una mattina a scuola, verso la fine della quinta, nell’ora di storia avevano parlato di Champollion, l’archeologo napoleonico che aveva svelato il mistero della Stele di Rosetta. Al termine della lezione, Nic aveva pensato che se c’era qualcuno che poteva capirlo questi era proprio Champollion: con pazienza, sagacia e un po’ di maniacalità, questo signore aveva decrittografato un testo inesplicabile. C’erano voluti anni per leggere la Stele di Rosetta; ci volevano anni per leggere un fottuto racconto di Robert Louis Stevenson, per quanto bello, piacevole, incisivo e narratologicamente perfetto. Certo, Champollion non aveva mai avuto a che fare con i programmi di traduzione vocalica. Una voce robotica, senza cadenze, senza umanità, che leggeva le pagine dei libri al posto di Nic. Una voce guida, come il cane dei ciechi. Nic apriva il libro, si metteva le cuffie, schiacciava play e tentava di star dietro al cane. Per un po’ ci riusciva, col dito. Gli stava dietro, ma poi, a un certo punto, si perdeva: uno strattone e il guinzaglio gli sfuggiva, il cane, attratto da una cagna o da un pezzo di carne, era scattato via. A quel punto, le pagine erano come scosse da un elettroshock e le lettere cominciavano a vorticare dentro i fogli, vorticavano come un mucchio di cartacce sollevate dal vento in una giornata d’estate troppo afosa, e a quel punto avevi voglia a rimetterle assieme, lassù, nel cielo, mentre volavano, avevi voglia a ricomporle, a ordinarle, a dare un ordine alle frasi: il dito si era perso, la voce robotica andava avanti e Nic restava indietro, si smarriva, si infilava negli spazi tra le parole, saltava da una riga all’altra, scendeva, risaliva, andava a zig-zag, salterellava, svolazzava, ma non riusciva in nessun modo a ritrovare 16 la strada. E allora guardava in alto, verso il soffitto bianco, il lampadario, e intanto ascoltava, sentiva di questo Dr. Jekyll, della sua incredibile metamorfosi, guardava il lampadario e assisteva alle scene criminose, al sangue sulle mani, guardava il lampadario e vedeva persone sgozzate, la polizia a cavallo, le provette del laboratorio, guardava il lampadario e vedeva il lampione di Londra, la paura del buio, un portone che si apriva e un uomo dall’andatura scimmiesca che ne usciva. Perfino uno Champollion, coi programmi di traduzione vocalica, sarebbe salito in cima alla piramide di Cheope e si sarebbe gettato nel vuoto. Poi venne il momento di passare alle medie. Sua madre incontrò il preside e gli parlò della dislessia. Lui la tranquillizzò e le disse che i suoi insegnanti avrebbero fatto il possibile per aiutare il ragazzo, ma quando mise al corrente il consiglio di classe, gli insegnanti lo ascoltarono come se stesse parlando delle previsioni del tempo in Tagikistan. Gli unici a prendere in considerazione la certificazione furono la professoressa di italiano, Giulietta Ametrano, e quello di motoria, Amilcare Licata. Purtroppo. La Ametrano, abbastanza vecchia per non fidarsi di una logopedista, si fissò – era sufficiente guardarlo negli occhi per capirlo! – che quella di Nicola era una normalissima forma di disturbo dell’apprendimento a sfondo motivazionale, un disturbo che nella sua lunga carriera aveva incontrato e risolto decine volte, disturbo provocato dall’esasperato cerebralismo dell’alunno e dalla pessima impostazione dei moderni testi scolastici. Condizioni che privavano Nicola di tutte le emozioni necessarie alla decodifica di un testo. Senza dare ascolto alla madre che aveva insistito sulla certificazione, per un anno intero la professoressa si accanì sul ragazzino con quella che lei aveva ribattezzato TPI, Terapia Poetica Intensi17 va, e cioè sottoponendolo a interminabili sedute di “grande poesia sentimentale” atta a scongelare il ghiaccio del suo disinteresse. Foscolo, Dante, Carducci, decine di ore trascorse a leggere i loro capolavori, ad attendere che quelle immarcescibili sequenze di sintagmi sentimentali compissero l’incantesimo. Ma Nic leggeva sempre allo stesso modo, zoppicando, confondendo lettere e invertendo sillabe. Lui avrebbe voluto spiegarle, avrebbe tanto voluto farle capire che messo davanti all’emozionantissimo e terapeutico incipit dei Promessi Sposi, lui vedeva nient’altro che questo: Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto, tra un promontorio a destra e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda ricomincia per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni... Il TPI era come un’aspirina per il colera, ma il fatto che la parola dislessia non venisse nemmeno presa in considerazione dalla professoressa (e quindi mai svelata ai compagni) a Nic faceva comodo. In fondo, era un po’ come se la maestra fosse invecchiata all’improvviso, si fosse semplicemente rincoglionita un po’, ma fosse ancora lì, alle medie, a proteggerlo. Fosse stato per lei, il limbo sarebbe proseguito ad oltranza. Ci pensò l’insegnante di educazione motoria a cambiare le cose. Il professor Licata, un Platone in adidas con pochissimi ma vaporosi capelli bianchi e trippa d’ordinanza, uomo di voraci lettu18 re e frequentazioni alternative, invasato dalle teorie di strane sette esoteriche e, allo stesso tempo, frustrato da decenni di scarsa considerazione da parte del mondo scolastico, si convinse che la dislessia fosse il primo grande segno di una nuova era, la nuova era dell’uomo nuovo, “la retta via evolutiva”, come la chiamava lui. Finalmente, dopo cinquemila anni di pseudo evoluzione sotto l’effetto lisergico del linguaggio, l’essere umano aveva modo di rimediare all’atavica deviazione riprendendo la retta via evolutiva: sì, perché l’avvento del Dislessico veniva finalmente a illuminare i nefasti limiti della Logica e della Grammatica, le dispotiche guardiane alla struttura del linguaggio, le guardiane della tirannia del logocentrismo. Per millenni il linguaggio era stato l’autocratica interfaccia del pensiero umano. Incapsulato dentro le categorie della consequenzialità, della contrapposizione soggetto-oggetto e dello spazio-tempo, il pensiero umano aveva finito per perdere libertà ed espressività e si era profondamente involuto. Per Licata, il pensiero era molto più dei banali segni che il linguaggio permetteva di esprimere: la mente dell’uomo aveva potenzialità inimmaginabili e il Dislessico – colui che se ne fotteva del linguaggio – veniva a portare la luce, era rivelatore di una nuova era. Così, ai suoi occhi, Nic divenne un totem, un piccolo Buddha, un predestinato. Divenne il prototipo dell’uomo nuovo, l’uomo libero dalle gabbie del linguaggio, il modello cui tutta l’umanità doveva tendere. «Correte come lui! Saltate come lui! Respirate come lui!» urlava alla classe che faticava a imitare i movimenti rigidi di Nic. «Idioti! Il Dislessico è lui! Dovete fare come fa lui!» I compagni erano perplessi. Si chiedevano il perché di quella pantomima. «Seguite il Dislessico!» sbraitava, accodandosi al gruppo e incitandoli. 19 Tutto questo metteva Nic in imbarazzo. Si voltava in continuazione e gli sembrava che tutti lo stessero scimmiottando. Per questo, di tanto in tanto, trovava il modo per non fare motoria e se ne stava seduto sui gradini della palestra con un finto dolore al ginocchio e la giustifica in mano. Licata l’aveva messo alle strette: era la prima volta che la parola dislessico riecheggiava a scuola, e succedeva in modo così eclatante. «Vedi Nic» gli diceva il professore, «vedi come sono poco evoluti i tuoi compagni? Sono talmente poco evoluti che non riescono a modificare il proprio modo di correre! Guarda come si muove Craveri! Sembra un totano! Il logocentrismo s’è impadronito della loro testa. Ma io non mollo, sai? La luce che tu porti è unica, non va sprecata: ci vorranno mesi, ma vedrai che riusciremo a illuminare i loro corpi e le loro menti!» Nic capiva poco di quei discorsi. Gli sembrava assurdo che Pietro e Giacomo, campioncini in erba di atletica leggera, fossero costretti a correre come lui. Anche i colleghi di Licata, nelle frequenti occasioni in cui esponeva le proprie teorie, capivano poco. Lo prendevano per pazzo o non lo ascoltavano nemmeno. Quando il consiglio di classe arrivava ad analizzare la situazione di Nic, Licata prendeva la parola ed esordiva dicendo: «Ho steso una relazione». A quel punto, un paio di colleghi andavano a farsi un caffè, altri estraevano il cellulare dalla borsa, altri ancora iniziavano a chiacchierare tra loro... Solo la vecchia professoressa di italiano prendeva sul serio il collega e lo ascoltava con grande attenzione, terrorizzata all’idea di andare in pensione lasciando mano libera a quel folle che voleva trasformare tutti in dislessici. Un giorno, gli si avvicinò dicendo: «Licata, ti rendi conto di quello che dici? Senza linguaggio dove finirà l’uomo?» «Senza Logica e Grammatica il pensiero evolverà». 20 «Ma il pensiero è il linguaggio!» «Ametrano, questa è una grossa cazzata. Tu perseveri nell’errore!» «Modera il linguaggio, Licata. Sei oltraggioso e senza un briciolo di sentimento». «Moderarlo? Lo distruggo io il linguaggio!» «Sei un barbaro». «Viva i barbari, allora! Attila correva come un Dio». «Che ne sai di come correva Attila?» «Si può immaginare». «Il linguaggio è il pensiero». «Hai solo invertito i termini: è così che speri di dimostrarmi il tuo teorema?» «Non è un teorema». «Te lo do io il teorema, ed è sotto gli occhi di tutti. Hai mai visto Nic correre? Dovresti vederlo. Il suo corpo e la sua mente sono liberi. Non ha filtri, non ha gabbie, non ha sbarre. Lui non ha il linguaggio e il suo pensiero è libero. Li-be-ro! Capisci? È l’uomo libero che l’umanità attende da millenni!» I due finirono per litigare e non parlarsi più. Nic, divenuto il feticcio attorno a cui si accapigliavano, salutò tristemente il limbo e, giorno dopo giorno, fu di nuovo risucchiato dall’inferno. La sua mente tornò a vacillare. Alla fine del primo anno di medie, la professoressa, per difendere il linguaggio dalle invasioni barbariche, bollò Nic col giudizio che da secoli accompagna i dislessici: scarso impegno e scarsa motivazione. Licata, dal canto suo, fece apparire, per la prima volta su una pagella scolastica, il sostantivo profeta. 21 Da alcuni giorni, non pensava che ai fenotipi e, mentre osservava la fotografia di Ron Howard nell’inserto del Corriere della Sera, Dave notò la somiglianza col calciatore del poster che il padre teneva appeso in camera: dalle sopracciglia alla bocca erano identici. Lo disse alla madre. «Chi, Franco Baresi?» «Il poster in camera». «Sembra Ron Howard? Fammi vedere… sì, è vero». Sul tavolo della cucina, s’intravedeva a malapena, sepolto da fette di zucchine e cetrioli, il titolo di una rivista che diceva Come crescere un figlio geniale senza fargli troppo male. Gli disse che quell’attore era nel cast di Happy days, uno dei telefilm con cui la sua generazione era cresciuta, uno di quegli appuntamenti quotidiani che nella società di massa hanno sostituito i riti religiosi e che, per questo, vengono definiti “di culto”. Erano passati molti anni da quella serie televisiva e adesso Howard faceva il regista. Il settimanale ne parlava perché aveva da poco girato uno spot elettorale a favore del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Gli disse inoltre che, ai suoi tempi, Ron Howard aveva i capelli. «Tra l’altro, anche Baresi li ha persi tutti» concluse. «Vuol dire che chi appartiene a quel fenotipo è destinato alla calvizie?» «Non c’è nessun fondamento scientifico. Due indizi non fanno un principio. Inoltre anche l’uso che fai del termine “fenoti22 po” è piuttosto azzardato: non bastano delle fotografie per stabilire un fenotipo». «E quanti indizi servono?» «Non ne ho la più pallida idea». «E io a quale fenotipo appartengo?» «Non so… ci vuole una certa competenza. Credo però che, in quanto caucasico-italiano, tu sia una miscela di fenotipi». Il discorso tornò sulla calvizie. La madre, però, restò vaga ed evitò di entrare in ragionamenti che implicassero la sfera ormonale. Abbassò gli occhi e riprese a tagliare le zucchine. Gli chiese se aveva finito di studiare. «Perché papà tiene i poster come un adolescente? Papà ha quarantadue anni». «Hai studiato scienze? Vuoi che ripetiamo insieme? Lo sai che dobbiamo perfezionare l’esposizione orale? Ricordi che la professoressa ti ha espressamente chiesto di migliorare questo aspetto dello studio?» «Perché in garage tiene i poster delle signorine nude?» «Ho capito: preferisci ripetere davanti allo specchio o vuoi che ti registri con la videocamera?» Talvolta lo registrava. Di notte, poi, vedeva il filmato, prendeva appunti e la mattina dopo, mentre facevano colazione, gli elencava errori e punti deboli della sua oratoria. Di errori, a dire il vero, ne faceva pochi; i punti deboli erano sintetizzabili in un’eccessiva velocità di pronuncia – che spesso lo portava a mangiarsi le parole – e nell’uso di una sintassi leggermente involuta nei ragionamenti più complessi. «No. Ripeto allo specchio». Si alzò trascinando la sedia sul pavimento. Lo stridio fu accompagnato dalla madre con una leggera inspirazione, cosa che faceva quando iniziava a innervosirsi. 23 Lui andò in bagno e si piazzò davanti allo specchio. Dopo aver studiato l’angolatura da cui il viso era più valorizzato, iniziò a ripetere la lezione sui fenotipi, ma quasi subito le parole smisero di fluirgli dalle labbra. Dave si era sentito irretito dal proprio volto e si era perso nei suoi occhi. A quale fenotipo apparteneva? A quello caucasico o a quello ispanico? La madre aveva ragione a definirlo una miscela? Come ci si sentiva ad essere una miscela? Imperfetti? Incerti? In via di evoluzione? Essere una miscela voleva dire, più o meno, essere “bastardo”? Nessun libro di scienze avrebbe potuto aiutarlo; nessuna insegnante avrebbe potuto dissipare quei dubbi. Osservò in particolare il taglio degli occhi (carattere decisivo nel definire l’appartenenza a un fenotipo) ma gli sembrò difficile ricondurlo a uno di quelli che il libro di scienze portava come modelli. Poi notò che le orecchie stavano diventando rosse: era l’allarme, la spia luminosa che entro pochi secondi doveva sedersi sulla tazza e scaricarsi. Si precipitò verso il water, calandosi i pantaloni durante la corsa. Si sedette. Proprio mentre iniziava ad evacuare, la madre bussò alla porta. Lui, che odiava essere interrotto mentre evacuava, disse che avrebbe ripreso a studiare nel giro di pochi minuti. Poi guardò in direzione dello specchio e si chiese perché proprio il volto, e non la mano o l’addome, racchiudesse gli elementi caratterizzanti di un fenotipo. «Lo sai che non devi chiuderti in bagno!» «Scusa mamma…» Sentì i passi di lei allontanarsi dalla porta, si accarezzò l’orecchio sinistro e riprese a ragionare sul volto della specie umana. Quando ebbe finito, il bagno era una piccola camera a gas. Uscì e tornò in cucina dove la madre stava ancora affettando una grossa zucchina. Si avvicinò al tavolo su cui c’erano altre verdure, inspirò voluttuosamente e si riempì i polmoni di cipolla. 24 «Posso ripetere davanti allo specchio di camera tua?» «Perché non usi quello del bagno?» «Inagibile per via della salubrità dell’aria». «Va bene, ma non sdraiarti sul letto. Rimani in piedi e inclina lo specchio in modo da vederti dal busto in su. Osservarti è fondamentale. Per fare in modo che l’osservazione sia funzionale, devi cercare di rendere il tuo sguardo oggettivo, di pensare che non stai guardando te stesso ma un altro, anzi, che tu sei un altro…» «Va bene, mamma. Io sono un altro». «Oppure che tu sei tu, ma a guardarti è un altro, magari la tua professoressa di scienze». Attraversò il corridoio socchiudendo gli occhi – come faceva di solito – per evitare di guardare uno strano quadro appeso alla parete, un quadro che fin dall’infanzia lo inquietava e che ancora adesso gli faceva paura. Entrò in camera. Passò davanti all’armadio e si fermò a osservare il poster di Franco Baresi: la fotografia lo ritraeva senza palla, in un momento di massima tensione fisica e mentale, probabilmente nell’atto di impedire a un avversario di sopravanzarlo e di lanciarsi a rete. Dave si mise in quella posizione, le gambe leggermente divaricate, la schiena di poco piegata in avanti, le braccia aperte a dare equilibrio: una belva pronta a scattare sulla preda. «Io non voglio essere la professoressa di scienze» ringhiò, «io voglio essere Franco Baresi». Restò lì, immaginando di essere a mezzo metro da un avversario, pronto a soffiargli il pallone. Chiuse gli occhi. L’avversario teneva il pallone sotto il piede destro. Sentì il sangue confluirgli alle tempie, segno che lo sforzo stava producendo una concentrazione felina. Passò un tempo incalcolabile, poi l’avversario si mosse, fece una finta a destra e scattò a sinistra. Lui restò lì, vacillante, e subito dopo cadde all’indietro con un gran tonfo. Una manciata di secondi dopo, l’avversario esultava. 25 «Tu non sei normale…» La madre era sulla porta con dei panni stirati poggiati sul braccio. «Stavo cercando di approfondire la percezione del fenotipo caucasico, quello rappresentato dal suddetto Franco Baresi…» Non si poteva stare tranquilli. Per come si esprimeva, per le cose che diceva, per i suoi atteggiamenti, per i tic, per la rotondità del suo corpo e il suo buffo modo di camminare, a scuola tutti lo prendevano in giro. Succedeva dalla prima elementare e probabilmente sarebbe andata avanti così per sempre. Inevitabilmente, a un certo punto dell’anno scolastico, che di solito coincideva con l’inizio della primavera, la madre si trovava a valutare l’opportunità di trasferire Dave in un’altra scuola, ma ogni anno, dopo lunghe e maceranti riflessioni, si convinceva che ovunque l’avesse iscritto, Dave avrebbe incontrato gli stessi problemi. Il problema era lui. Del resto, per chi si trovava in classe con lui non era facile resistere alla tentazione di deriderlo. Non era il fato, ma Dave stesso a scatenare intorno a sé le risate più crudeli, come quando, durante una conversazione sui sogni nel cassetto, aveva confessato che il suo era quello di avere una vita intestinale più regolare. O quando si era spacciato per un campione di nuoto e il giorno della gara provinciale aveva rischiato di annegare dopo un ridicolo tuffo a bomba. Era diverso dai suoi coetanei, e in questo la mamma aveva grandi responsabilità. L’aveva cresciuto asociale, senza contatti esterni, sotto una campana in cui lei filtrava esigue quantità di affetto materno, e aveva 26 preteso da lui un’evoluzione intellettuale precocissima. Ad esempio, si era fissata che dovesse capire Wittgenstein, e così, accanto alla raccolta di Geronimo Stilton, sulla mensola della sua cameretta aveva impilato l’intera bibliografia del filosofo austriaco. Quella della madre per Wittgenstein era una fissazione con radici autobiografiche. La storia era molto semplice: dopo il liceo scientifico, la madre di Dave si era iscritta alla facoltà di Filosofia e aveva dato gli esami del primo anno con discreti risultati; poi, all’inizio del secondo anno, si era arenata su Filosofia Contemporanea. Corso monografico: Wittgenstein. Aveva tentato più volte l’esame, ma sempre con esito negativo. L’epilogo si era sempre consumato sulla stessa inesorabile domanda: Mi enunci e spieghi la proposizione 3221. Tremiladuecentoventuno. Ogni volta. E ogni volta silenzio, vuoto mentale e mani fredde. Gli oggetti io li posso solo… sussurrava il professore, girando tra le mani la preziosa stilografica con cui vergava i libretti d’esami. Silenzio. …nominare… aggiungeva, cercando di aiutarla. Che vuol dire il filosofo con questa proposizione? Silenzio. Non si è preparata signorina? Certo che si era preparata, ma… silenzio, un silenzio sempre più grande, ingombrante, fastidioso. I segni ne sono rappresentanti. Forza signorina, non possiamo superare l’esame di Filosofia Contemporanea se non sappiamo spiegare la proposizione 3221 di Ludwig Wittgenstein. Silenzio. Sarebbe inconcepibile, signorina, che io la promuovessi, anche col minimo dei voti, senza averla sentita dire almeno una cosa sulla 3221. Inconcepibile. 27 Silenzio. Io posso solo dirne, non dirli. Gli oggetti. Capisce? Signorina… ha studiato? Comprende l’enorme differenza implicata dall’uso di un pronome piuttosto che un altro? Comprende? È grammatica, signorina. Qui si tratta semplicemente di comprendere il significato di una proposizione. Una proposizione può dire solo come una cosa è, non che cosa essa è. Una proposizione su una proposizione, tra l’altro. Eh eh… È straordinario notare come stiamo parlando di una cosa che descrive la cosa stessa di cui stiamo parlando… Capisce? Questo è Wittgenstein… eh eh eh… Silenzio. I mesi passavano e lei ripeteva quell’esame, sempre con quella sequenza di parole, sempre arenandosi sulla proposizione tremiladuecentoventuno. Più di una volta l’esame era iniziato bene, aveva saputo rispondere alle domande iniziali, il suo pensiero aveva preso quota lentamente, ragionamento dopo ragionamento, quesito dopo quesito, ma a un certo punto il professore finiva col chiederle la proposizione 3221 e lei si bloccava. Io posso solo dirne, non dirli. Gli oggetti. Capisce? Ogni volta, mentre si sedeva e porgeva il libretto al professore, mentre lui lo sfogliava e la guardava sottecchi attraverso gli occhiali d’argento come se la vedesse per la prima volta, si chiedeva se lui si ricordasse di lei oppure no. Si domandava se dietro quell’atteggiamento si celasse uno smemorato ai limiti della demenza o un sadico della peggior specie. A casa, nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi all’esame, così come in quelli che lo precedevano, passava le ore a ricostruire ossessivamente la scena, a riviverla, ad analizzarla fotogramma dopo fotogramma, quella scena che si era ripetuta più volte e sempre allo stesso modo, con le stesse frasi, le stesse reazioni, le stesse sensazioni. Una persona razionale, o meglio, una per28 sona capace di usare la ragione, avrebbe saputo rielaborare e analizzare la situazione in modo pragmatico, sarebbe stata in grado, comprendendo le dinamiche, studiando i dialoghi, prevedendo le emozioni, di evitarne il ripetersi (preparare a memoria la proposizione 3221, escogitare un percorso dialettico di un certo tipo, indirizzare la chimica delle reazioni), ma lei, che pure si considerava razionale, non ci riusciva. Non riusciva ad opporsi al ripetersi di quella scena. Tutto finiva sempre lì, davanti a quel vecchio, raggrinzito e bastardo figlio di puttana che le diceva: Prenda pure il suo libretto e non si disperi perché può sempre riprovarci. Che poi, ad anni di distanza, aveva capito. Aveva capito quelle parole limpide ed elementari di Wittgenstein. Era stato sufficiente cambiare il soggetto alla frase, togliere di mezzo proposizione. Una donna può solo nominare gli oggetti. Cioè, quando parla, una donna rappresenta degli oggetti. Con quella manciata di suoni, di segni, che gli uomini hanno selezionato per esprimersi, una donna può solo dire come una cosa è, non che cosa essa sia. Facile. Una cosa facilissima, come schioccare la lingua o fischiettare. Facile. Lasciata l’università, trovato lavoro da impiegata in un’azienda sanitaria, la madre di Dave aveva dimenticato la filosofia. Rimossa. L’unico legame che aveva mantenuto con quel mondo era il Tractatus, un volume dell’edizione Einaudi, quello utilizzato per preparare l’esame, che portava sempre con sé, ovunque andasse, nella sala d’attesa di un ambulatorio o in treno diretta al mare. Ci teneva a farlo vedere a tutti, sottolineato e masticato, un simbolo, 29 un modo per essere ancora una studentessa di filosofia, un virgulto di metafisica ancora non del tutto sbocciato. Poi si era sposata con un piastrellista. Un tipo verso cui non nutriva amore ma stima. Un tipo con delle enormi difficoltà relazionali che le rivolgeva parola solo se, rincasando, la trovava con una gonna sopra il ginocchio. Aveva avuto un figlio. Aveva imparato a leggere solo libri di cucina. Aveva fatto un corso di acquagym, un corso di bonsai, un corso di informatica, un corso di inglese, un corso di spagnolo. Una vita come tante altre, ma con un sortilegio da spezzare. E doveva pensarci Dave. Dave doveva diventare il più grande esperto di Wittgenstein al mondo, e per riuscirci doveva cominciare presto, prestissimo. Il difficile della filosofia era che talvolta si comincia troppo tardi, quando ormai il lessico si è fossilizzato, la sintassi instradata, il pensiero imbrigliato. Bisognava partire presto, come si fa con uno strumento musicale. Non si poteva iniziare a tredici anni. E infatti aveva cominciato a leggergli Wittgenstein quando Dave aveva otto anni. Era passata, da una sera all’altra, da Rino il Rinoceronte, al Tractatus. L’avevano letto, riletto e masticato insieme. Dalla prima proposizione in avanti. Con splendidi risultati, secondo lei. A undici anni erano giunti alla 5153, a metà circa della quinta proposizione. Erano a buon punto. Dave non sapeva chi era Bart Simpson ma sapeva perfettamente che un evento avviene, o non avviene; una via di mezzo non v’è. Dave capiva Wittgenstein ma faticava ad avere un amico. Dave era destinato a diventare il più grande esperto di Wittgenstein ma non sapeva cos’era una festa di compleanno. Dave non riusciva a instaurare rapporti coi compagni. Non sapeva parlare con loro. 30 Non sapeva di cosa parlare. Le uniche persone con cui parlava a scuola erano gli insegnanti. Alcuni erano delle vere ancore di salvezza. Letteralmente si incollò alla professoressa di scienze. Ogni mattina, appena lei varcava la soglia d’ingresso, se lo trovava di fronte col suo squillante “Buongiorno!” e la richiesta di portarle la borsa. La accompagnava per tutto il corridoio fino alla sala professori e durante il breve tragitto le raccontava, in breve, il sogno che aveva fatto la notte. Un incubo ricorrente era quello di trovarsi da solo in un bosco, tetro e misterioso, di incappare fortunosamente in un sentiero, di percorrerlo di gran lena fino a una radura, erba alta e umida, attraversarla tutta per trovarvi, al termine, una bara. Lui si avvicinava, ansimante di corsa e paura, si portava a pochi centimetri dal feretro, ne sollevava il coperchio, sbirciava dentro e vi trovava una vecchietta rinsecchita con una rosa in bocca. La professoressa di scienze, che lui aveva scelto per la dolcezza e la competenza scientifica, lo ascoltava sempre con grande curiosità e attenzione. Dopo qualche settimana si era perfino assuefatta ai particolari più macabri di cui erano farciti i racconti e lo ascoltava a passi lenti e col sapore del caffè in bocca. L’unica cosa che faceva al termine del racconto, era una risatina, lieve e cristallina, senza un grammo di isteria o preoccupazione. Era proprio il suo modo di reagire che lo faceva sentire tranquillo, anche se qualche volta appariva più turbata del solito. «Dave…» gli fece una mattina, con strana gravità. «Cosa c’è professoressa?» «Stai… stai bene?» «Abbastanza, prof». «Sembra… la trama di un film…» «È un modo per dirmi che mi sto inventando tutto?» 31 «Che sia un sogno o il frutto della tua fantasia, non c’è differenza. Tutto bene a casa?» «Mi scusi… lei mi trova strano, vero?» «Tutte le mattine mi aspetti fuori dalla sala professori per raccontarmi un incubo. Vedi per caso la fila? È chiaro che ti trovo strano…» «Quindi…» «Quindi niente. Forse vedi troppa televisione». «Non ne vedo affatto, prof». «Ah». «Sta per suonare la campanella. La saluto. E le chiedo scusa». «Non devi chiedere scusa. Aspetta un attimo. C’è una cosa che volevo chiederti… ma… tuo padre…» «Sì?» «Nei tuoi sogni… non c’è mai». «È vero». «E nella tua vita?» «Nemmeno». 32 Era un pomeriggio soleggiato di fine inverno, uno dei primi leggermente tiepidi, di quelli che lasciano presagire l’arrivo di giornate senza palandrane, di quelli che si fanno assaporare dalla pelle. Nic si trovava a pochi metri dalle acque del fiume, armato di canna da pesca e pazienza, gli occhi fissi sul galleggiante. Quando un pesce abboccava, sentiva un piccolo rigonfiamento al cuore, come se un palloncino fosse collegato alla valvola aortica. Ma non era per questo che gli piaceva pescare. Non era per l’attimo in cui la lenza tirava che andava al fiume. Ci andava perché amava ogni piccolo gesto del rituale, amava l’incanto dei mulinelli, amava l’attesa e le sue sfumature, amava lo scorrere del tempo scandito dal lento incedere dell’acqua, amava la sfida alla noia che in nessun’altra occasione sentiva alla sua portata. Andava al fiume quasi tutti i pomeriggi e ci restava per delle ore, anche quando la pioggia penetrava il k-way, anche quando nuvolette di vapore gli uscivano dalla bocca raggrinzita dal gelo, anche quando i litigi dei suoi lo facevano star male. Tra le poche distrazioni, nei suoi prussiani pomeriggi al fiume, c’era la merenda – di solito una mela – che consumava intorno alle quattro. Gli piaceva, dopo aver rosicchiato buccia e polpa fino ai semi, gettare il torsolo in acqua, gettarlo il più vicino al filo, incurante che il movimento prodotto allontanasse eventuali prede. Per lui era una specie di rito propiziatorio. Erano anche altre le cose che gli piacevano. Gli piaceva vedere chi vinceva tra la statale, sospesa a qualche decina di metri da lui, e il fiume, quale dei due rumori fosse più 33 forte dell’altro. Nic tifava per il fiume, che però vinceva raramente, di solito dopo una grande pioggia. Era da brivido, in autunno, la sfida del venerdì pomeriggio, quando la statale esplodeva di traffico e il fiume rimbombava del fragore pluviale. Poi gli piaceva leggere le scritte sui piloni del ponte. Succedeva qualcosa di strano. Mentre leggeva, aveva l’impressione che la dislessia sparisse, perché quelle parole dipinte sul cemento gli entravano nella testa subito, senza fatica, lisce e scorrevoli come il fiume che passava lì sotto. Era un sollievo. Si metteva lì, seduto o in piedi, la canna obliqua verso il cielo, il filo che spariva nell’acqua, i mulinelli a scavare buchi nel fiume, e posava lo sguardo sul cemento del ponte: niente gorghi di lettere. Leggeva e capiva tutto. Leggeva Fascio boia Comunisti merde Viva Lega Nord Forza Magica Dea Jenny ti amo Aprite le celle: Pino e Lollo liberi! Sbirri merda Samantha come sei tanta Vota No Euro La vita è altrove Il telegiornale ammazza la realtà Molly ci sei Droga libera Io per sempre. Leggeva benissimo, come se quelle scritte fossero in braille per dislessici, come se quelle parole, la loro vernice, la grafia, la posizione, violassero la regola degli stormi impazziti. Nic conosceva a memoria quelle scritte e appena posava gli occhi sul ponte, vedeva subito se c’erano cambiamenti, risposte, aggiunte. Si appassionava a quei piccoli dialoghi lunghi settimane e li seguiva come un telefilm. Prima puntata: Jenny ti amo. Seconda puntata (evidentemente ironica, da parte di estranei): Ma tu sei brutto come la fame… con i puntini di sospensione che diventavano lacrime. Terza puntata: una mano di bianco a cancellare tutto e su di essa Jenny ti amo sempre. 34 Quarta puntata: Ma se tu sei brutto, tanto brutto. Buttati da qui, con una freccia che dalla parola qui saliva fino al parapetto del ponte. La quinta puntata non c’era stata. La fiction si era fermata. Stavolta l’innamorato non era intervenuto. Aveva lasciato quell’imperativo tremendo, e forse l’aveva pure eseguito. Nic pensava che Jenny doveva abitare da quelle parti, o passava di lì tutti i giorni, se l’innamorato aveva deciso di scriverle da quel ponte. E Nic si chiedeva cosa pensava Jenny di quei messaggi, se le davano fastidio (magari adesso stava con un altro, oppure le piaceva essere libera), se la facevano pensare a lui, se quando passava di lì girava gli occhi da un’altra parte. Magari non era mai passata da quella strada. Magari Jenny abitava lontano e lui aveva solo voluto urlare il suo dolore al fiume. Ma un giorno era apparsa una scritta, vicino alla parola sempre che ormai cominciava a invecchiare e a scolorirsi. Era piccola, sottile e rossa, ma si stagliava bene. Diceva: lo so. Quindi Jenny c’era. Leggeva le scritte. Sapeva. I giorni successivi, prima ancora di iniziare a pescare, Nic gettava uno sguardo trepidante al ponte, ma non ci furono mai risposte. Poi erano venuti quelli del Comune. Avevano resettato tutto con il loro grigio topo mortifero e di Jenny e l’innamorato era stata cancellata ogni traccia. Il ponte era tornato a essere un ponte, e Nic era tornato dislessico. Gli era sembrato perfino di andare a pescare meno volentieri. Per fortuna, alcuni giorni dopo, erano riapparse le prime scritte. Fascio boia Comunisti merde Viva Lega Nord Forza Magica Dea, e il suo umore e la sua voglia di andare a pesca, erano tornati quelli di prima. Quel pomeriggio soleggiato di fine inverno i pesci stavano alla larga dall’amo come se qualcuno li avesse avvertiti. Neppure il 35 torsolo di mela, gettato vicinissimo al galleggiante, aveva propiziato abboccamenti. Poco importava. Nic guardava il fiume scorrere lento e ben pasciuto dalle piogge invernali. Il tepore del corpo si tratteneva nel suo giubbotto nero. Fissò la canna al terreno, si alzò in piedi e fece qualche passo per sgranchirsi le gambe. A pochi metri da lui un ragazzino si avvicinava sul sentiero. Era la prima volta che Nic lo vedeva. Era grassottello e camminava lentamente, portando una gamba avanti all’altra con una certa fatica, addirittura vacillando quando il sentiero si stringeva; teneva in testa uno strano cappello, di quelli che portano gli anziani coi baffoni, tipo birra Moretti, troppo largo per la sua testa e calato quasi fino alle sopracciglia; di tanto in tanto toglieva gli occhi dal terreno e volgeva lo sguardo al fiume, uno sguardo indagatore, vigile, come se stesse aspettando che qualcosa affiorasse dall’acqua. Gli ciondolava al collo una grossa macchina fotografica. Seguiva il sentiero e, a un certo punto, si trovò proprio alle spalle di Nic che intanto era tornato alla canna, gli occhi sul fiume. «Ciao» fece il ragazzino da dietro. «Fai piano» gli rispose Nic, senza voltarsi e portando l’indice alla bocca. «Perché hai gettato la mela? Così fai scappare i pesci». «È tanto che mi guardi?» «Un po’. Non scappano i pesci se getti la mela vicino all’amo?» «No». «Come no? Tutti sanno che i pesci scappano al minimo movimento dell’acqua…» «Tutti chi?» «Tutti». «È una cretinata. I pesci amano le mele. Le mele attirano i pesci». 36 «Va bene. Ciao». Il ragazzino riprese a trotterellare verso nord, in direzione del ponte, ma a un certo punto si fermò, restò un attimo perfettamente immobile, quindi ruotò su se stesso e tornò indietro. Nic lo vedeva con la coda dell’occhio. «Io mi chiamo Dave» disse quando gli fu di nuovo vicino. «Io Nic». «Vieni qui spesso, Nic?» «Tutti i giorni» sussurrò seccamente per ribadire che doveva parlare a bassa voce. «Ci sono molti pesci?» «Pochi. Le fabbriche scaricano troppa roba chimica. Certi giorni galleggiano morti in mezzo a grandi chiazze gialle». «Gialle?» «Sì, gialle». «Che schifo. E tu li mangi, questi pesci chimici?» «Non lo sono più di quelli che compri surgelati, sai?» «Sì… ma tra i surgelati ci sono spigole, totani, branzini, spada… insomma… specie che al palato danno certe soddisfazioni… diciamo che si può anche rischiare… cosa si pesca qui?» «Trote». «E basta?» «Alborelle». «E basta?» «Qualche persico». «E basta?» «Basta». Ci fu un attimo di silenzio durante il quale il galleggiante parve vibrare. In quel momento, un autotreno con rimorchio passò sul ponte e fece tremare tutta la terra circostante, forse anche la superficie dell’acqua. Nic si voltò e fece una brutta smor37 fia, come a dire che il pesce se l’era squagliata. Poi chiese a Dave cosa ci facesse lì da solo, ma Dave non rispose. Forse Dave si aspettava che Nic insistesse un po’, ma Nic non era il tipo da insistere troppo: una cosa avveniva naturalmente o non doveva avvenire. «Aspetto la balena» disse Dave un minuto dopo, quando ormai Nic non s’aspettava più la risposta. Entrambi masticarono quelle parole per alcuni istanti. Entrambi aspettandosi qualcosa dall’altro. «Hai capito?» ripeté Dave, sollevandosi il cappello dagli occhi «Aspetto la balena». «E aspettala». Era la prima volta che qualcuno non rideva di fronte a quelle parole. La prima volta che qualcuno non gli rispondeva che i cetacei vivevano nel mare, per la precisione negli oceani, e non nelle acque dolci. «Le balene» attaccò Dave con tono professorale «risalgono i fiumi, come è accaduto nel 2006 quando una balenottera ha risalito il corso del Tamigi ed è sbucata a Londra...» «Sì, mi ricordo». «… o come nel 1997, quando una balena ha risalito il Rodano ed è sbucata ad Avignone». «Questo non me lo ricordo». «Per forza: eravamo appena nati. Però sta scritto sulle cronache dei giornali. Ho un archivio molto ricco sull’argomento. Penso si tratti di uno degli archivi sulle incursioni di cetacei in acqua dolce tra i più ricchi d’Europa». «Sarà l’unico». «Sai, io ormai mi sono convinto di una cosa: la balena, in fondo, è un animale d’acqua dolce. A volte immagino una balena in uno dei nostri laghi alpini… Ma te la immagini una balena, non 38 so, nel lago Maggiore? O nel lago di Garda? Te la immagini una balena di fronte alla grotta di Catullo? Eh? Ma ci pensi come sarebbe felice?» «Non ci ho mai pensato...» fece Nic che non sapeva chi fosse Catullo. «Io sono praticamente sicuro che tutto quel sale dà maledettamente fastidio alle balene. Sono convinto che il lago sia la terra promessa delle balene». «Capisco...» Per tutto il tempo, Nic non si era mai girato e aveva continuato a fissare la canna da pesca. A un certo punto, Dave gli si era avvicinato per accertarsi che non stesse ridendo alle sue spalle, si era avvicinato con passi malcerti e gli si era seduto accanto. Per qualche minuto erano rimasti uno di fianco all’altro, in assoluto silenzio a contemplare l’acqua che passava; poi Dave aveva chiesto: «Perché non hai riso della mia storia?» «Eh?» «Non è strana?» «Per niente: a volte le balene risalgono i fiumi». «Sì, ma c’è un problema». «Quale?» «Che a differenza del Rodano o del Tamigi, il nostro fiume non sfocia direttamente nel mare…» «E allora? Sfocerà in un fiume che sfocerà nel mare». «Bravo! La balena è intelligente e può imboccare tutte le strade che vuole. Può fare tutte le deviazioni che vuole! Bene. Molto piacere di averti conosciuto. Adesso vado a casa perché devo fare i compiti. Tu stai qui ancora a lungo?» Nei mesi successivi si videro spesso, sempre nel punto del fiume in cui Nic gettava l’amo. 39 Come la prima volta, Nic era di poche parole: era sempre Dave a iniziare e finire un discorso. All’inizio Nic era infastidito dalla presenza di Dave, ma a partire dalla terza volta capì che il suo nuovo amico valeva, di tanto in tanto, l’interruzione del rituale silenzio. Un giorno Dave gli confessò che la ricerca della balena doveva restare un loro segreto, perché in casa avrebbero preso quella cosa come l’ennesima sua stranezza e gli sarebbe costata cara… magari una visita dalla strizzacervelli. Nic, sorridendo, gli giurò che non ne avrebbe parlato con nessuno. «Grazie. Prima o poi dalla strizzacervelli ci finirò, temo… Sai, ho tante di quelle allucinazioni... In casa vedo topi e serpenti, per strada armadilli e bisce. Tutti i santi giorni, sai? E non una volta che, invece, mi capiti di vedere una balena! Sarà tremenda la vita, eh?» Qualcosa si mosse nell’acqua emettendo un gorgoglio che attrasse la loro attenzione. Dave fissò il fiume. «È proprio importante per te fotografare ’sta balena, vero?» domandò Nic. «Voglio che il mondo intero sappia che una balena è stata qui» rispose Dave enfaticamente. «Voglio dimostrare che le balene tendono all’acqua dolce dei laghi». «E che il lago è la loro terra promessa…» «Proprio così» esclamò Dave perdendo enfasi, trasognato, «le balene hanno solo bisogno del loro Mosè!» 40 Aveva gli anni di suo padre. Un pensiero che, quando gli veniva, lo faceva sempre ridere. Ovunque fosse, con chiunque si trovasse, qualunque cosa stesse facendo. Gli era venuto alla visita per il rinnovo della patente, mentre rivedeva Shining, firmando un finanziamento di ottantamila euro, ascoltando l’inizio di Stairway to heaven, a cena con una ragazza molto carina, in tribunale prima di una causa importante, perfino davanti al corpo senza vita della madre (non appena morta, ma durante la veglia funebre), e aveva sempre finito per ridere. Aveva gli anni di suo padre. La sola idea che in quel momento della vita aveva gli stessi anni che suo padre aveva quando aveva iniziato a depositare su un conto separato i risparmi di una vita per consentire ai figli di studiare, lo faceva ridere. La sola idea che in quel momento aveva l’età in cui suo padre si era deciso a prendere (dopo vent’anni di libera partecipazione) la tessera del PCI, lo faceva ridere. L’idea che in quel momento aveva l’età in cui suo padre, impegnando tutti i sabati e le domeniche per quattro anni consecutivi, aveva tirato su una magnifica casa di tre piani, lo faceva ridere. Ecco: questo semplice pensiero lo faceva ridere, ovunque fosse, con chiunque si trovasse, qualunque cosa stesse facendo. Perché all’età in cui suo padre era entrato nella cinquina dell’academy per la migliore interpretazione di “uomo”, lui chiamava ancora le linee erotiche che gli solleticavano le zone erogene sussurrando... massaggio genitale al telefono: sensazione realistica 41 E di quelle Marike, Paolette, Stefanie che gli facevano pussypussy al telefono, lo Zio si innamorava. Viveva per loro, per vederle e sentirle almeno una volta al giorno, magari in privato, dove poteva chiedergli di girarsi sul divano e di mostrare meglio i glutei lucenti. Poi, un giorno, capì che quella risata era sarcastica e che normalmente il sarcasmo si rivolge agli altri e mai a se stessi. Allora arrivò alla conclusione che qualcosa in lui non andava. Era arrivato il momento di cambiare. Lo Zio decise che sarebbe diventato un uomo e giurò a se stesso che da quel momento si sarebbe impegnato al massimo nello scopo di diventare degno di suo padre. La prima cosa da fare era smettere col sesso telefonico e cominciare a darci dentro sul serio. Salutò con un’ultima partecipata telefonata le amichette in perizoma e inaugurò una nuova epoca. Purtroppo in quel momento della sua vita non aveva a disposizione materiale umano per darci dentro sul serio e così, per far fede al giuramento, ripose le proprie speranze nel sesso a pagamento. Le speranze furono esaudite ampiamente e, in breve, divenne un puttaniere di prima categoria, di quelli che nemmeno controllano se in giro c’è un lampeggiante della stradale, di quelli che non si fanno scrupoli davanti a niente, né un sorriso troppo giovane né un volto pieno di lividi. La prima volta, a dire il vero, non era andata granché bene. Essendo, lui, una persona molto riservata, aveva ritenuto buona cosa aiutarsi immettendo nel proprio organismo un discreto quantitativo di Nero d’Avola. L’effetto era stato quello sperato: bicchiere dopo bicchiere aveva osservato le proprie inibizioni sloggiare mestamente dalla corteccia cerebrale e, mentre imboccava una certa strada della bassa pianura, si era finalmente sentito capace di tut42 to. Ma il Nero d’Avola non si era limitato a rendere meno vigile il controllo del super-Ego e durante la consumazione si era ritrovato nell’imbarazzante situazione di non riuscire a dare libero sfogo al proprio piacere. Nel cercare di assolvere al servizio per il quale poco prima aveva vinto il bando di concorso, la signorina dell’est aveva dato prova di grande tenacia (benché accompagnata da scarso talento), ma né con l’ausilio della cavità orale, né con quello dell’arto superiore destro, era riuscita ad accontentare il cliente. A quel punto, gli aveva chiesto se avesse sniffato coca, e lo Zio le aveva risposto di no con un certo risentimento. Allora lei, provata e rassegnata, aveva esclamato: «Cocco, non riesco a farti venire…» e lui, con un sorriso un po’ ebete sulla bocca, si era chinato verso di lei per accarezzarle il viso ma lei si era ritratta disgustata, dicendogli che non poteva toccarle il viso e che il tempo era scaduto. Così l’aveva pagata e riportata nel punto in cui l’aveva raccolta. Mentre tornava a casa, nonostante come prima volta non fosse stata granché, si era sentito fiero per aver trovato la strada giusta per diventare uomo. Le volte successive, dosando meglio il Nero d’Avola, le cose erano andate meglio e così le sue escursioni notturne nella bassa erano diventate sempre più frequenti, anche se limitate dal misero stipendio di tirocinante. In seguito, quando ebbe aperto uno studio legale in società con un collega, poté intensificare la frequenza, arrivando anche a quattro o cinque sortite settimanali. I rondò, le strade, i parcheggi, ogni angolo di quel lembo di pianura entrarono nella sua mente a comporre un sordido planisfero del piacere: dove finiva l’Ucraina iniziava la Romania, dove finiva la Romania iniziava la Nigeria, dove finiva la Nigeria iniziava il Brasile. Non gli sfuggiva niente, né un nuovo arrivo né un’improvvisa partenza, una specializzazione da quattro stelle o una candida ine43 sperienza, e aggiornava il suo database mentale con grande meticolosità come si trattasse di lavoro. Teneva i bocconcini più succulenti per le serate in cui sentiva il palato più raffinato, le serate in cui si gustava i particolari di un corpo, le sottigliezze di un viso, i dettagli di un vestito; di contro, lasciava i pezzi più grossolani, quelli appena passabili, alle serate più pulsanti, quelle in cui si sentiva cieco e completamente servo dei sensi, un pistone progettato per sprigionare energia cinetica. Questa vita durò oltre un anno (durante il quale dimenticò il motivo per cui aveva iniziato il suo cammino d’elevazione…). Dopo, iniziò a scoprire il mondo dei locali notturni. Ve lo indussero certi colleghi giurisperiti, gente dal cognome illustre che alle sciatte frequentazioni stradali preferiva mixare coca e privè. Il merito fu soprattutto del suo socio in affari, un grande conoscitore di bordelli che possedeva una mappatura professionale di tutto il nord Italia più trasgressivo. Si chiamava Aldobrandi, aveva il corpo esile di un bambino e la testa grossa a forma di pera. Era un destrorso convinto (roba da “non si deve sparare ai gommoni ma ai negri” o “la donna è solo un imbuto”) perfino nell’impomatatura dei capelli, sempre umidi, luccicanti e scolpiti da etti di gel. A memoria d’uomo, non lo si era mai visto senza camicia scura e collanina con teschietto della decima. Frequentava i locali più cool e probabilmente anche ciò che accadeva nel privè avrebbe potuto ascriversi a comportamenti testosteronici tipici dell’Italia imperiale. Lo Zio e Aldobrandi si erano conosciuti ai tempi dell’università, più precisamente in treno, nella lunga e malservita tratta che separava Milano dalla loro provincia, e tra aule e caffè (soprattutto questi ultimi) si erano frequentati piuttosto intensamente. Persisi di vista più o meno a metà percorso universitario, si erano 44 rincontrati in tribunale nell’anno di praticantato. Aldobrandi gli aveva proposto di aprire uno studio. Lo Zio non ci aveva pensato troppo (Aldobrandi veniva da una famiglia di notai e portava con sé un corredo sostanzioso) e una settimana dopo stavano già sbrigando le pratiche in Camera di commercio. Se suo padre avesse saputo che si metteva in società con un fascio, si sarebbe rigirato nella tomba, ma il punto era che suo padre si era rigirato nella tomba tante di quelle volte che, il giorno in cui avessero aperto la bara, avrebbero trovato un mucchietto d’ossa aggrovigliate. Lo studio andava bene, e i due soci, che avevano specializzazioni differenti, si dividevano i clienti in base alla tipologia del caso. Fatturavano più di altri colleghi che all’epoca dell’università avevano dato la paga a tutti in quanto a voti. Lo Zio e Aldobrandi avevano il mix ideale per emergere in quel lavoro: un dosaggio equilibrato di tecnica e bastardaggine. Se l’intesa lavorativa rasentava la perfezione, non si poteva dire altrettanto di quella amicale; la cosa emerse quando cominciarono a frequentarsi nottetempo. Lo zio non sopportava di essere il discepolo, di fare sempre la parte del fesso, in particolare di essere trattato come un pivello di fronte a tutti, puttane comprese. «Hey Zio, mi ha detto la Jenny che non sai come si fa lo smorzacandela! Ma ti devo insegnare tutto io?» E giù risate. Così, dopo alcuni mesi di umiliazioni, una sera, l’orgoglio dello Zio proruppe incontrollato. Mentre Aldobrandi andava verso il privè con una tipa sotto braccio, lo Zio gli sentì usare un vezzeggiativo poco rispettoso nei confronti di quello che da sempre, nell’intimità, amava definire “l’ultimo dei Titani”. Un istante dopo gli stringeva il collo e gli sbatteva la nuca contro il muro. 45 Il mattino dopo sciolsero la società. Una settimana più tardi, investendo tutti i suoi averi e accedendo miracolosamente a un finanziamento bancario, lo Zio si metteva in proprio aprendo uno studio nuovo di zecca nella speranza che le proiezioni sui fallimenti matrimoniali del prossimo decennio, lette su una rivista specializzata, non fossero sbagliate. Erano esatte, e lo studio partì bene. Lavorava e portava a casa la pagnotta. Si prese pure la segretaria. La sera, proprio come i mariti annoiati che di giorno separava, si infilava nei night. Preferiva quelli più squallidi, perché in quegli ambienti c’era qualcosa di sordido che gli ricordava la strada, e perché era certo che in quei posti Aldobrandi non avrebbe mai messo piede. Gli piaceva, nelle scorribande notturne, portarsi dietro amici o conoscenti profani e sfoggiare la sicumera del depravato di successo. Le serate seguivano un canovaccio consolidato fatto di situazioni obbligatorie. La recita iniziava verso le otto nella piazza del paese, dove gruppetti di giovani e meno giovani si ritrovavano a fumare e bere un aperitivo. Lo Zio arrivava, preceduto dalle note di You shook me all night long sparate a tutto volume, gli occhiali da sole calati sugli occhi e una lattina di birra in mano. Scendeva, apriva il baule e invitava chi voleva a bersene una (sia d’inverno che d’estate teneva in auto una confezione da cinquanta lattine) mentre il basso ruggito dell’auto faceva tremare l’aria. A suon di divorzi si era preso un BMW Serie M, anche se, lo rimarcava sempre, si trattava di un’auto di seconda mano. Ostentava profondo disprezzo per quell’oggetto che guidava come si trattasse della sua vecchia 46 Fiat Punto (che a sua volta aveva sempre guidato come fosse un trattore Same); si rifiutava categoricamente di lavare la carrozzeria (tanto pioveva) e ripulirne l’interno da funghi e mucillagini; si disinteressava di sfregi e cicatrici, già numerosi su entrambe le portiere, e aveva sostituito gli specchietti frantumati con specchi adesivi da dieci euro. Distribuita la birra, caricate quattro o cinque matricole (ragazzetti senza patente assetati di nuove esperienze) lo spettacolo proseguiva in macchina, nel tragitto che portava al locale notturno. I primi minuti erano riempiti dalla musica ad altissimo volume, una sorta di iniziazione al metal cui sottoponeva gli invitati. Poi il BMW prendeva a divorare asfalto aggredendo le auto con sorpassi che, per come guidava lui, sembravano raptus dell’auto stessa. Di tanto in tanto, l’auto rallentava e accostava ai bordi della strada dove lo Zio salutava una Paula o una Stefania che gli restituivano il saluto chiamandolo per nome. Lui rispondeva che più tardi sarebbe passato a trovarle, poi sgasava e riprendeva la carreggiata, mentre i ragazzi in auto ridevano ammirati e si sentivano fieri di stare con lui. Arrivati al Piccolo taglio, o al Rum a gogò, o al Villa Grazioli, parcheggiava lontano dall’ingresso e invitava tutti quanti a svuotare la vescica contro un albero, poi dava una controllata al portafoglio, s’infilava una cicca in bocca, si sistemava per bene la camicia e si metteva alla guida del drappello come in un film di Scorsese. Entrava nel postribolo spalancando platealmente la porta (di solito i piccoli night che frequentava avevano l’aspetto di una casa qualunque e gli ingressi erano normalissimi portoncini da villetta trasfigurati da neon bluastri), cercava di sbriciolare la timidezza dei compagni con qualche battuta, quindi attraversava sprezzantemente il locale con i piedi a spazzaneve, le mani in tasca e 47 la schiena leggermente inclinata indietro. Arrivato nei pressi del bancone, schiudeva la bocca in un sorrisetto un po’ folle e ordinava una vodka secca per ciascuno dei suoi amici che puntualmente erano rimasti all’ingresso bloccati dal disagio cosmico. La ragazza del bar, che in questi locali era spesso la tenutaria, lo serviva cercando di iniziare la contrattazione, ma lui, gomiti sul bancone e gambe incrociate, le voltava le spalle e perlustrava la merce nella pista da ballo e sui divanetti. Un paio di minuti più tardi, lo Zio torceva il busto verso la tenutaria e le chiedeva, con tono un po’ deluso, quando sarebbero arrivate le ragazze nuove. A quel punto, di solito, la tenutaria gli rispondeva che erano arrivate da pochi giorni e chiedeva cosa c’era che non andava in quelle. Lui rispondeva che le voleva dell’est, e che l’unica donna di un certo interesse lì dentro era lei. Lei gli domandava se voleva un’altra vodka e lui rispondeva di sì. Qualche minuto dopo, tirato il collo ad un terzo bicchierino, cominciava ad aggirarsi tra i divanetti chiedendo alle ragazze se lì si combinava qualcosa. Le ragazze rispondevano sempre con dei sorrisi. Gli accompagnatori dello Zio dopo un po’ si erano sciolti e lo seguivano nel suo spettacolo fatto di brevi passi di danza, grevi battute sulla tenutaria o, rare volte, sussurri a una ragazza che lo aveva colpito e che magari sarebbe passato a prendere più tardi. Provava ribrezzo, infatti, all’idea di salire al piano di sopra e coricarsi in un letto dove altri uomini avevano fatto sesso. Preferiva l’auto, i suoi sedili, le fidate luci del cruscotto che gettavano flebili luminescenze sulla pelle della donna, i rumori di una statale in sottofondo. Al postribolo si rimaneva un paio d’ore, quasi sempre trascorse a ballare tra mulatte sovrappeso e a svuotare bicchieri sempre più piccoli. Poi, lo Zio riportava tutti in piazza. 48 I compagni d’armi, dopo essere scesi a fatica dall’abitacolo, barcollando sul pavé umido, lo salutavano con grande stima e un po’ di invidia per quello che si apprestava a godere. Lui, appena era rimasto solo, dirigendo il bolide verso il piacere prenotato, ascoltando un senso di sordido salirgli dall’esofago, non poteva fare a meno di domandarsi che senso avesse quello che stava facendo. Sapeva che tutto era squallido e degradante. Sapeva di non aver intrapreso alcun percorso di elevazione. Sapeva che il padre era irraggiungibile e che lui non sarebbe mai diventato un uomo. Tirarsi dietro quei ragazzini era forse la cosa peggiore. Era come mettere un velo di ipocrisia tra sé e la realtà. L’unica volta che era andato in un locale notturno con dei coetanei, tutto gli era apparso sotto una luce abietta. All’inizio della serata aveva riempito l’aria con le solite mosse copiate dai film di Scorsese, le solite battute, le sceneggiate, aveva interpretato la parte dell’uomo navigato, ma mentre le faceva, a differenza del solito rimando adolescenziale positivo, aveva letto sui volti delle persone che erano con lui molto, ma davvero molto, imbarazzo. A questo punto, perseverando nella propria interpretazione, si era mosso alla conquista degli spazi facendo la solita spola tra bancone e pista da ballo, ma tra una battuta laida e un apprezzamento volgare, tutto era risuonato, anche nella sua testa, penoso e insensato. A serata inoltrata, aveva cercato con lo sguardo le persone che erano con lui. Se ne stavano appartate in un angolino a bere e ridere come fossero in una birreria qualunque, incuranti della sua recita. Qualche minuto dopo, tornando con lo sguardo verso di loro, gli era sembrato addirittura che ridessero di lui. Aveva provato una rabbia violenta e si era maledetto per averli portati con sé. Poco dopo, uno di loro l’aveva raggiunto al bancone. 49 «Zio, noi andiamo…» «Va bene» aveva detto lui fingendo disinteresse e trangugiando un cocktail che non ricordava d’aver ordinato. Era rimasto lì in piedi per più di un’ora, a fissarsi nello specchio di una colonna, e per oltre un’ora aveva avuto davanti a sé un fantoccio ubriaco. Aveva gli anni di suo padre e non c’era un cazzo da ridere. 50 Contains sulphites - enthalt sulfite - obsahuje siricitany - sisaldab sulfitid - tartalmaz szulfitok - satur solfiti - sudètyje yra sulfitai - vsebuje sulfit - bevat sulfieten innehaller sulfiter - sisaltaa sulfitteja - zawiera siarczyny - periecei Jeivdh Il resto dell’etichetta, sobria e ben curata (si trattava di un Prunotto d’Asti del 2005), era occupata dai tipici imbellettamenti retorici, riferimenti storici e consigli enogastronomici atti a distrarre l’occhio da futili informazioni riguardanti l’aggiunta di additivi chimici. L’altra funzione di questa parte dell’etichetta – Augusto lo sapeva bene – era quella di estetizzare il prodotto indirizzandone il giudizio. Il consumatore medio, leggendo che il tale vino era l’ideale accompagnamento per esaltare la cacciagione selvatica, che si gustava preferibilmente a diciotto gradi, che proveniva dalle terre argillose delle nomatissime colline astigiane, che il suo era un sapore corposo arricchito da profumazioni fruttate, era come indotto a percepire, fin dalla prima sorsata, tutte le note di quell’eccessiva aggettivazione. Con quale forza l’acquirente poteva ammettere la deficienza sensoriale del proprio palato? Impossibile non provare le sensazioni indicate sul retro dell’etichetta, impossibile non sentirsi una spanna al di sopra del consumatore medio. Impossibile per tutti, ma non per Augusto. Augusto sapeva perfettamente che da una parte c’era chi vendeva un prodotto, dall’altra chi, attraverso quel prodotto, voleva elevarsi. Era solo un’illusione. Come gran parte del mercato, del resto. 51 Forse solo il suo Franti non si fondava su un’illusione. Il Franti prometteva risultati e li manteneva. Con le palpebre pesanti e la bocca impastata, Augusto si alzò dalla sedia e impugnò la bottiglia come se dovesse strozzarla, andò al lavabo, tolse il tappo, la capovolse e la fece gorgogliare fino all’ultima goccia. Spruzzi di rosso macchiarono le pareti inox mentre una linea irregolare di Prunotto s’infilava nelle fessure dello scarico. Glu glu glu. Non era stato facile; prima di capovolgere la bottiglia aveva avvicinato l’imboccatura alle narici e aveva dato un’ultima annusata. Per qualche istante era rimasto inebetito da quel profumo, come se una parte di sé stesse pensando “sono sicuro di quello che faccio?”, ma un attimo dopo l’altra parte aveva sentenziato che i responsabili di quell’inganno sensoriale erano i solfiti, che proprio la chimica, unitamente alla retorica, era la nemica infida da combattere. Glu glu glu. Adesso era fiero di quello che aveva fatto. Aprì il rubinetto e lasciò che l’acqua accompagnasse il vino verso l’imbocco delle tubature. Pensò che ogni giorno avrebbe celebrato un rito del genere. Uscì dalla cucina e andò nello studio. Dalla libreria prese un libro di Voltaire e cercò una frase. La trovò e la rilesse più volte, mandando a memoria le ultime parole. Non era un alcolista, o forse sì. Di certo, sapeva bene come fossero diverse le serate in cui rientrava in casa e c’era una bottiglia ad attenderlo. Non era un alcolista, o forse sì, ma quelle sere percorreva i vialetti del giardino con passo leggero, saliva i tre gradini dell’ingresso volando, metteva la chiave nella serratura come fosse un forziere e richiudeva il portone con un altro spirito, uno spirito capace di cancellare qualunque stress accumulato in giornata. Che poi gli bastavano un paio di bicchieri. Un leggero intorpidimento, un debole tremolio nelle sue percezioni. Solo un paio 52 di bicchieri, e quel paio di bicchieri lo portava decisamente dalla parte dei buoni, dei non alcolisti; un paio di bicchieri erano, in fondo, solo il doppio di una prescrizione medica. Ma, in realtà, la parte dei buoni non era così sicura... Augusto sapeva che quella soglia era dettata da un senso di responsabilità istituzionale, non da una vera capacità di autocontrollo: il vero artefice di quella limitazione era il suo lavoro, la sua figura, il suo ruolo. Ciò era dimostrato dal fatto che non appena il Franti si svuotava, lui non riusciva a fermarsi al secondo bicchiere. Non era un alcolista ma riconosceva che qualche crepa c’era. Se ne accorgeva soprattutto in un momento della giornata: quando, intorno alle diciannove e venti, cominciava a essere assillato dal pensiero che il supermercato stava chiudendo e che gli restavano solo pochi minuti per salire in macchina, fare mezzo chilometro, parcheggiare, varcare la porta automatica e dirigersi verso il reparto vini. Ecco: in quel momento, alle diciannove e venti, mentre iniziava a farsi rodere dal dubbio “vado o non vado” e qualunque impegno si assottigliava fino a sparire del tutto dalla sua agenda, riconosceva che qualche crepa nella sua mente doveva pur esserci. Nella sua mente, sottolineava. Non era tipo da dire nella mia vita. Non usava mai quelle parole. Circoscriveva il problema alla psiche, alla sfera dei bisogni, a un angolo della vita, uno dei tanti angoli della vita in cui si accumulano le bollette delle dipendenze. Sorrise al ricordo di quando, qualche anno prima, aveva pensato di andare dagli alcolisti anonimi. Che idea curiosa. Per due bicchieri a pasto. Un momento di smarrimento. Tornò in sala e pensò che non era il caso di accendere lo stereo. Gironzolò per qualche minuto gettando occhiate distratte ai libri, ai mobili, ai quadri, poi andò verso la scrivania, si sedette ed estrasse da una borsa un plico di documenti. Si accorse della pe53 nombra in cui era scivolato, allora accese la lampada e si mise a leggere con la massima concentrazione. Erano due domande di ammissione. Il Consiglio si era già espresso con parere positivo e mancava solo il suo placet. Scorse rapidamente le informazioni tecniche limitandosi a sottolineare alcuni dati relativi al percorso scolastico. Poi si fermò sulle schede specialistiche e le lesse con cura, tornando più volte su alcuni passi che la sintassi asfittica dei medici rendeva di difficile interpretazione. Era una serata tranquilla, come tutte le sere al Franti, anche se lui percepiva sempre una sottile tensione, un ronzio interiore come quello di elettrodomestici spenti che continuano a sfrigolare sommessamente. Stette una decina di minuti sulle diagnosi, alzando lo sguardo una volta sola per guardare la bottiglia vuota, poi aprì il terzo cassetto della scrivania ed estrasse un’agenda di pelle nera. La aprì solennemente liberandola da una cinghia con placche d’argento. L’argento ormai era opaco, ma a lui piaceva quel particolare. Non aveva mai dato la stessa importanza alle penne, che considerava infedeli per natura; l’agenda invece no. L’agenda era sua personale e l’usura sulla copertina stava a significare ferrea abnegazione al compito, devozione sincera, un affetto inossidabile. Alle undici, una delle due ammissioni era stata accettata, l’altra sospesa in attesa di incontrare i genitori. Augusto si alzò, andò alla finestra della sala e guardò fuori: una sottile nebbiolina vagava a mezz’aria appannando la percezione già sfumata della notte. Gli venne un pensiero intriso di paura ma rassicurante: cosa sarebbe successo se tutto quello non fosse esistito? Se tutto ciò che aveva creato fosse stato inghiottito dal nulla? Tutto ciò che aveva creato… era rincuorante ruminare quelle parole… 54 Alcuni anni prima, il Gruppo aveva chiesto a tutti i consulenti un’idea innovativa per un investimento di grande importanza. Augusto aveva speso molte energie nella ricerca di qualcosa di buono, ma senza cavarne granché. Poi, un giorno, mentre osservava nauseato dei giovani spiattellati sulle poltroncine di un treno, gli era venuta l’ispirazione. Aveva pensato all’imbarbarimento della civiltà occidentale, e in particolare a quale fosse – in questa discesa nel baratro – la responsabilità delle varie istituzioni educative. Gli era venuta una considerazione: perché un’epoca tanto incline alla decadenza morale, un’epoca così protesa al degrado, aveva smantellato, pezzo dopo pezzo, quell’efficacissima istituzione educativa e correttiva chiamata un tempo “collegio”? Perché la civiltà occidentale si era liberata di quegli avamposti della pedagogia, di quelle torri di guardia erette nelle zone più difficili e disperate dell’educazione, proprio negli anni delle nuove invasioni barbariche? Perché non ci si era accorti in tempo dell’utilità di questa istituzione che per secoli, tra mura odoranti sapone di Marsiglia e riecheggianti fustigate di nerbo, si era occupata di raddrizzare e correggere migliaia di esistenze deviate? Quanto bene aveva fatto alla società occidentale quella miriade di istituti, sparsa per il vecchio e il nuovo continente, in epoche più o meno lontane nelle quali miseria, ignoranza e violenza erano state dieci, cento, forse mille volte più diffuse di oggi? Quanto bene aveva fatto a un mondo di guerre mondiali, discriminazioni razziali, depredazioni classiste, repressioni sessuali, arretratezza morale? Tutte domande che trovavano risposta semplicemente focalizzando le persone (dirigenti affermati, imprenditori, politici locali e nazionali) incontrate nella sua vita che gli avevano confessato di essere state in collegio. Quel giorno aveva pensato che l’illusione del benessere aveva prodotto un indebolimento della morale che, a sua volta, era sfo55 ciato in un rammollimento educativo: padri terrorizzati all’idea di vedere le proprie gracili creature inghiottite dalle architetture severe di silenziosi edifici ottocenteschi più simili a prigioni che a luoghi di crescita e sviluppo. La paura di una sana scudisciata aveva decretato l’estinzione dei collegi. E, a quel punto, la domanda era affiorata automatica: quanto era disposta a pagare una società ormai invasa da orde di barbari, gang di assassini metropolitani e automi narcotizzati, quanto era disposta a pagare una società sull’orlo del baratro per ritornare all’ordine? Qualunque cifra, si era risposto. Nei giorni successivi si era messo a lavoro e aveva elaborato un progetto dettagliato e convincente, corroborato da documenti, grafici e statistiche induttive. Una di queste, in particolare, presa da una ricerca universitaria piuttosto recente, dimostrava l’inversa proporzionalità tra chiusura dei collegi e diffusione del disagio giovanile. Ora aveva il suo grimaldello. Al sicuro da ogni smentita, poteva dimostrare che l’estinzione degli istituti correttivi aveva acuito il malessere generale. Alcuni giorni dopo, davanti a una commissione del Consiglio Direttivo, Augusto presentò il suo progetto. Lo fece così bene che il Gruppo glielo approvò seduta stante assegnandogli la supervisione. Altri sette mesi e il Franti – primo collegio del Gruppo – apriva i battenti sotto la direzione di Augusto Loglio. I risultati furono subito positivi e nel giro di poco affermò e consolidò il proprio prestigio: il primo anno le iscrizioni furono 300, il secondo 370 e il terzo 400, così che il Gruppo dovette procedere, in breve, a un ampliamento della struttura e a un potenziamento dell’organizzazione. 56 Il “modello Franti” venne proposto in altre città del nord e, in pochi anni, il Gruppo diffuse i suoi istituti con la rapidità con cui i cluniacensi avevano propagato i loro monasteri nel medioevo. Un Gruppo bancario che entrava nel mondo dell’educazione, una piccola rivoluzione per i pedagogisti che imparavano a fare i conti con gente che faceva i conti da una vita. Con la loro impronta laica, con il loro pragmatismo, con la loro pedagogia nera (coercitiva quando non repressiva), i collegi del Gruppo divennero la soluzione alla disperazione dei genitori e la panacea contro il male di vivere giovanile, quel cancro della società d’inizio millennio che, se preso in tempo, come recitava il dépliant pubblicitario, poteva essere asportato. Per una casa più serena, per una società più ordinata I dépliant riportavano anche i dati strepitosi sulla percentuale di successo di ogni periodo correttivo. I rari casi di insuccesso andavano addebitati a cause genetiche: “Quando i cromosomi son più duri del bastone”, diceva un’altra frase. Naturalmente il dépliant ometteva di dire che per chi decideva un periodo di inserimento (che poteva variare da uno a cinque anni, anche se l’istituto sconsigliava interventi troppo brevi) il prezzo da pagare era – in termini affettivi e non solo – molto elevato: la durezza del modello educativo garantiva risultati quasi certi, ma non senza lasciare cicatrici sul carattere dell’utente. Del resto, ai genitori veniva consigliato, come rimedio ai sensi di colpa, di fare esercizio costante nell’immaginare i propri figli a diciotto o vent’anni persi tra i fumi dell’alcol, della droga, in preda a dissolutezze inenarrabili e con un futuro incerto davanti. 57 Nella costruzione della rigida ossatura ideologica dei collegi (dagli slogan commerciali al regolamento d’istituto) la mano di Augusto era stata fondamentale. Di fatto, nessuno poteva sospettare che dietro a quell’idea di ordine come rimedio sociale, dietro a quella cieca fede nell’autoritarismo, ci fosse una dura lotta interiore combattuta nell’arco di una vita. Nessuno sospettava a quali sottili fili del destino lui fosse stato appeso, per quali bivi fosse passata la strada che l’aveva condotto lì. Altro dogma seguito da Augusto nella fase costitutiva era l’intento di applicare il rigore scientifico alla pedagogia. Fedele alla sua formazione illuminista, aveva fatto in modo che nei collegi del Gruppo, tutto, dal quoziente intellettivo al grado di maturazione, fosse distinto, quantificabile, numerabile. Il test del QI era la prima cosa a cui gli utenti venivano sottoposti appena mettevano piede nella struttura. La gamma dei collegiali era ampia e variava da ragazzi socialmente pericolosi ad altri con semplici problemi d’apprendimento. Il loro percorso rieducativo era valutato su una scala che li collocava da un minimo di menocento, per indicare l’abisso da cui li si doveva elevare, ad un massimo di menodieci, la soglia più vicina allo zero, alla normalità, alla riammissione al mondo esterno. La valutazione veniva aggiornata ogni mese ed esposta sulla bacheca nell’atrio d’ingresso. Era un momento atteso dai ragazzi che si avvicinavano all’elenco con ansia e apprensione: scivolare sotto menosettanta significava un periodo duro, sotto il controllo continuo dei superiori; salire sopra menoventi equivaleva a un trattamento più umano. La nebbia cominciava a diradarsi e le vecchie mura del Franti – una vecchia caserma acquistata a prezzo stracciato grazie a certi favori politici – affioravano lentamente in tutta la loro aria mili58 taresca: difficile uscirne, impossibile entrarci, un gigantesco quadrilatero di enormi e inespugnabili muraglioni. Cosa sarebbe successo se tutto quello che era lì fuori, improvvisamente fosse sparito? Se tutto ciò che aveva creato fosse stato inghiottito dal nulla? Augusto ripensò ad alcuni momenti della sua vita in cui aveva rischiato di perdere contatto col mondo. Erano stati anni bui, di appannamento, di nevrosi. Se li era lasciati alle spalle faticosamente col lavoro di tutti i giorni, con la speranza che si poteva riemergere da qualsiasi passato. Ora la nebbia era sparita quasi del tutto e gli austeri bastioni del collegio tornavano a stagliarsi davanti ai suoi occhi. Di fronte a quella rassicurante epifania, il Direttore decise che era tempo di andare a dormire. 59 Eccolo lì, incastonato tra Sebastiano Timpanaro, il grande filologo leopardiano, e Ting Ling, una sconosciuta scrittrice cinese morta a Pechino nel 1986. Il suo nome, tra un filologo e un cinese. Non ricordava dove fossero gli occhiali, e allora avvicinò gli occhi alla Garzantina fino a vedere distintamente le lettere. Sentì un odore acre, come se tra le sue pagine fosse passata la morte di una cimice. Annusò con cura e l’impressione fu confermata. Non ricordava d’aver utilizzato la Garzantina per sterminare insetti, ma non escludeva la possibilità. Sono gesti che sfuggono alla rete della memoria, come quando si alza il finestrino dell’auto o ci si soffia il naso. Impugnò la copertina cartonata e sbatacchiò il volume con dei secchi colpi di polso: una piccola capsula marrone scivolò dal libro e cadde sul pavimento senza far rumore. Osservò la cimice morta per alcuni secondi, poi riaprì la Garzantina e appiccicò gli occhi alla voce dedicata a se stesso: Timpano Antonio (Milano 1953 – ) Scrittore italiano. È autore di romanzi in cui, con beffarda ironia, demistifica miti e convenzioni piccolo-borghesi (Quella nausea a Portofino, 1974; Come si fa a far senza?, 1977; Resurrezione e ascensione di una puttana, 1979; Memorie della pappagorgia, 1983; Ma il Paradiso è in Svizzera, 1986; Il bijou di famiglia, 1988) e di poesie di vena surreale (Oltretomba di famiglia, 1980; Incanti postcoitali, 1982). 60 Cinque righe. Cinque righe, in gran parte occupate dai titoli. Una manciata di aggettivi, qualche sostantivo, qualche verbo. Ecco com’erano ridotti trent’anni di lavoro. Ecco a cosa si riducevano trent’anni passati dietro la macchina da scrivere (prima) e al computer (poi). Ecco in cosa erano stati convertiti trent’anni a cesellare storie, limare frasi, lucidare sintagmi. Cinque righe. Rimise la Garzantina al suo posto, fece qualche passo e si lasciò cadere sul divano. Sentiva lo sconforto gravargli in testa come una cappa di piombo. Gli occhi si stavano inumidendo. Cercò di non pensare a niente concentrandosi sul soffitto. Si massaggiò un po’ le tempie. Si tirò su e guardò verso la tv spenta cercando il proprio riflesso. Vide un uomo con tante domande nel caricatore e premé il grilletto. Quale malsano sogno di grandezza l’aveva indotto a diventare scrittore? Quale sentiero biforcuto l’aveva condotto a quella vita di frustrazioni e avvilimenti? Perché non aveva previsto, mentre imboccava quel sentiero, la tragedia della rendicontazione? Perché non aveva previsto che quando uno scrittore deve tirare le somme si sente, oltre all’odore di cimice morta, quello di sapone sul nodo scorsoio? Un operaio, quando tira le somme, si gode la semifinale di champions sul suo schermo ultrapiatto. Un imprenditore, quando tira le somme, lo fa ai bordi della sua piscina. Un medico, quando tira le somme, ricorda le persone a cui ha fatto del bene. Ma uno scrittore… uno scrittore che – è bene sottolinearlo – non 61 è Tolstoj e neanche Maupassant, quando deve tirare le somme, uno scrittore non ha scampo. Ho raccontato storie bellissime! (ci sono portieri d’albergo che ne raccontano di più belle) Ho fatto emozionare migliaia di persone! (ne emoziona più Pieraccioni regista o le montagne russe) Ho smascherato vizi e dissolutezze dell’uomo moderno! (non esageriamo, eh…) Il conto corrente languiva. La piscina costava otto euro all’ora. Non c’era ombra di persone salvate. E la Garzantina gli dedicava cinque righe merdose. Si alzò dal divano e andò verso la libreria fermandosi di fronte allo scaffale su cui giacevano decine di copie dei suoi libri. Diede un calcetto alla cimice e la spedì verso il corridoio. Perché aveva scritto quei libri? Perché aveva insistito per pubblicare quella roba? Perché aveva permesso che venisse tradotta e giungesse fino in Francia e Argentina? Quei miseri ammassi di carta spediti con trepidazione all’editore… quelle escrescenze di ego patologico… quelle improbabili realtà finzionali divoratrici di mattine in riva al mare, di serate sulle terrazze a bere vino bianco, erano state l’investimento di una persona sana di mente? Quella cosa. Forse era giunto il momento di fare quella cosa. Ripensò alla sua carriera, dall’esordio su una rivista milanese alla vittoria del Campiello, passando per le partecipazioni ai talkshow televisivi e le telefonate dalle redazioni che gli chiedevano un’opinione sulla depilazione maschile. 62 Ripensò alla fase ascendente, piena di soddisfazioni e incontri. Poi a quella discendente, piena di sofferenza e solitudine. Il declino era iniziato parecchi anni prima. Ricordava perfettamente la chiamata del Direttore editoriale che gli parlava di vendite in ribasso. Poi la scomparsa dalle vetrine. Poi il declassamento a una collana minore. Poi la deportazione a una casa editrice locale. La stipsi della scrittura, la fatica a spegnere la televisione, la spossatezza dopo una singola frase. Il presente era di un’amarezza incommensurabile: poche centinaia di copie vendute, poche recensioni, poco affetto. C’era stato un tempo in cui i lettori gli scrivevano per sapere quanto mancava al suo prossimo libro, ora i pochi che lo facevano gli mandavano lettere minatorie. Mille volte si era interrogato sulle imperscrutabili rotte che avevano portato la sua vita a lidi tanto amari, ma solo in quel momento, con quelle cinque righe odoranti di cimice, gli pareva d’aver compreso il peccato originale. Aveva iniziato a scrivere in un’epoca in cui quel demistificare miti e convenzioni piccolo-borghesi aveva un senso, un’epoca in cui parlare di classi sociali suscitava ancora profondo interesse nei lettori, un’epoca ormai lontana e superata; argomenti anacronistici di cui lui continuava a scrivere come se il tempo si fosse fermato. Era giunto il momento di farlo. Del resto, era da un po’ che ci pensava. La prima volta – lo ricordava bene – era stato a Carpi, durante un piccolo festival di letteratura. Un festival della microeditoria, gli sembrava. Rallentamenti, che poco prima l’aveva raccolto dalla strada (molto, all’epoca, era stato scritto su come Einaudi l’aveva scaricato), aveva puntato su di lui e Timpano aveva accettato. 63 L’avevano mandato al festival come fiore all’occhiello del proprio esiguo catalogo e lui era partito per Carpi con orgoglio ritrovato, lieto di incontrare i suoi lettori. Da quando era approdato a Rallentamenti gli era venuto spesso da pensare a un personaggio di Bernard Malamud, un acciaccato e declinante campione di baseball che scende in una categoria inferiore e si mette in gioco per riprendere a brillare. A Carpi si era portato il libro di Malamud e l’aveva riletto con emozione. Non si era mai identificato così tanto in un personaggio letterario come con quel giocatore di baseball. Ma il giorno del suo intervento al teatro Villa le cose non erano andate come per il personaggio di quel romanzo. Quel giorno avrebbe dovuto discutere di “Scrittura e Modernità” insieme a Maurizio Maggiani. Diluviava e, all’orario previsto, nel teatro erano presenti ventisei spettatori. Questi ventisei, quando seppero del forfait di Maggiani, dovuto a cause di forza maggiore, si ridussero a quattro. Nei lunghi minuti di attesa che l’organizzazione aveva lasciato trascorrere nella speranza che qualche ritardatario rimpinguasse la platea, Timpano era riuscito a respingere imbarazzo e delusione e si era fermato a scrutare quei quattro: meritavano attenzione perché erano il capitale della sua rinascita. La sua riscossa sarebbe partita da loro e non voleva perdersi un solo sguardo, un solo cenno d’approvazione, un solo moto d’animo dipinto sul viso. Il dibattito, a quel punto divenuto intervista, durò un’ora precisa di orologio e Timpano, che ringraziò a più riprese Rallentamenti e parlò a lungo del suo ultimo libro, nel ridare la parola al moderatore approfittava per godersi quei quattro spettatori: due signore attempate e impellicciate fino al naso, un ragazzo stem64 piato con un quaderno tra le mani e un signore annoiato che non sembrava avere antidoto agli sbadigli. Al termine dell’incontro, Timpano si alzò e fece un inchino al pubblico che gli riservò un tiepido applauso. Mentre stringeva la mano al moderatore, vide le signore impellicciate che lo aspettavano sotto il palco per farsi autografare dei libri. Una sensazione di gioia perduta si espanse in lui e con un sorriso estinto da anni s’avvicinò a loro. Quando le signore gli allungarono timidamente due copie dell’ultimo libro di Maggiani, Timpano si sentì mancare. Se n’era tornato in albergo inzuppato di pioggia e, chiusosi in cripta, aveva inutilmente tentato di piangere. Poi si era fatto una doccia, aveva inghiottito una Roipnol e si era sdraiato sul letto, il televisore acceso su un programma di imitazioni. Maggiani e Maggiani, si era firmato. La seconda volta che ci aveva pensato era stato un anno più tardi quando era uscito il suo Tra le mura domestiche, un dramma familiare ispirato a un sanguinoso fatto di cronaca nella provincia pavese. Il libro era passato quasi inosservato. Solo una recensione sul “Tirreno” (la Rallentamenti era di Ancona) e una citazione nelle strenne natalizie di “Tuttolibri”. Per il resto, un silenzio assordante. Poi, all’improvviso, il silenzio era stato interrotto da una deflagrazione. Una mattina l’aveva chiamato una vecchia amica: «Corriere. Citati» si era limitata a dire al telefono, interrompendo subito la comunicazione. Citati! 65 Era corso in edicola, il fiatone più per l’emozione che lo sforzo. Aveva seviziato il giornale in cerca della cultura. Poi ecco: due pagine intere, un disegno di Pericoli in mezzo. Il cuore scoppiava. Lesse in piedi, fuori dall’edicola, saltando le frasi e mangiando le righe. Una deflagrazione. Una gragnola di chiodi e bulloni che gli crivellavano la faccia. C’era scritto che da anni Citati non si piegava dalle risate a quella maniera. C’era scritto che non poteva essere Timpano l’autore di quelle insulsissime pagine e che se l’autore aveva un merito era quello d’aver insegnato a scrivere al chihuahua di famiglia. C’era scritto che forse era il caso di rispolverare la vecchia teoria della morte dell’autore, in particolare quella di Timpano. Quella volta ci aveva pensato sul serio e aveva iniziato a programmare tutto. Non ne aveva parlato con nessuno, nemmeno con Gianni, uno dei pochi amici nel mondo della letteratura. Forse nel mondo in generale. Gianni, che era più vecchio di lui, ce l’aveva fatta, aveva scollinato, aveva affrontato la nuova epoca con lo spirito giusto, con la voglia di rinnovarsi e provare nuove strade. Pubblicava ancora con Mondadori. Si era spianato le rughe. Abitava a Roma. Andava in tv. Si era tecnologizzato, informatizzato, modernizzato. Non scriveva più di famiglie lacerate dall’incontrollabilità dei sentimenti, ma della fine dei sentimenti. 66 Non scriveva più di giovanotti e siringhe, ma di pasticche rosa e pasticche blu. Pasticche – romanzo carolliano ambientato in un mondo fantastico abitato da pastiglie in guerra tra loro per accaparrarsi i favori della gioventù – aveva venduto qualcosa come trecentomila copie prima di diventare una graphic-novel e poi un film d’animazione. Un giorno, discutendo con Gianni, Timpano aveva colto appieno l’entità della propria inadeguatezza. L’amico voleva mostrargli una cosa al computer. «Non funziona» gli aveva risposto Timpano. «Che cos’ha?» «Non so. È più di un anno che è così…» «Eh? E com’è che fai a scrivere?» «Sono tornato alla macchina da scrivere. Mi trovo meglio». «Cosa? E per navigare? Come fai a navigare?» «Non navigo». «Ma sei impazzito?» «Perché?» «Sei senza speranze! Aspetta qui, vado in macchina e prendo il portatile». Gianni si muoveva rapido tra finestre e link. In un attimo era arrivato in una pagina incorniciata da piccoli dipinti di Malevič. «Questo è il mio sito». «Il tuo sito?» «Ci ho lavorato sopra due mesi. Ho fatto tutto io. Guarda che roba…» Una finestrella apriva le immagini di un filmato e si vedeva Gianni intervistato in un talk-show. Un’altra finestrella mostrava tutte le copertine dei suoi libri, e ogni copertina svelava un’impressionante serie di informazioni. Molte informazioni aprivano ad altre informazioni. 67 Un’altra finestrella mostrava il blog di Gianni, con decine e decine di interventi di lettori e appassionati che si firmavano con nomi strani. «Yogy78 è la mia preferita. È una ragazza di Verona. Ha fatto una tesi su di me. Mi scrive post bellissimi quasi ogni giorno…» «Ma… come hai fatto?» aveva chiesto Timpano. «Ho imparato. Sono cose che s’imparano alla svelta, te l’assicuro. È un linguaggio semplice, chiaro, rassicurante. È una tecnologia pensata per la società di massa, non per una limitata schiera di eletti. A navigare, bloggare, taggare, spammare deve essere l’idraulico, non Torquato Tasso. Mica devi imparare a comporre sonetti in endecasillabi…» «Capisco». «Tutto ormai passa da qui. Come fai ad essere scrittore, oggi, senza saper gestire questa tecnologia?» «Non lo so. Finora ero convinto che se ne potesse fare a meno…» «Come no… i tuoi vecchi lettori muoiono, e quelli nuovi non sanno nemmeno che esisti. I nuovi lettori non sanno che farsene dei tuoi geroglifici!» Timpano non aveva risposto. Quelle parole erano le sue campane a morte. Gianni era andato avanti. «Scommetto che non usi nemmeno il termometro di Google». «No…» «Mai fatto?» «No». «Scrivi il nome di uno scrittore, qua dentro». «Vivente?» «Come vuoi. Anche un classico». 68 Timpano digitò Flaubert Gustave. «Ecco qua: lo vedi questo numerino?» «Lo vedo». «Un milione e cinquecentomila risultati». «Che sarebbero…» «Le pagine web in cui si parla di lui. Questo conteggio riguarda il nome Flaubert Gustave. Se ci accontentiamo di Flaubert saliamo a… aspetta… vedi? Due milioni e ottocentosettantamila. Prova con un altro dai». Scrisse Melville. 2.770.000 risultati. «Dai, scrivi il tuo adesso». Timpano scrisse Timpano. 2.300 risultati. A Timpano parve un numero incredibile. «Non illuderti. La maggior parte sono siti di vendita on-line; il resto non è altro che il trasferimento di articoli di stampa o di recensioni riportate identiche in diversi blog. Prova con un contemporaneo...» Scrisse Baricco. 947.000 risultati. «Tu quanti risultati hai?» «Non mi ricordo… fammi vedere…» Gianni aveva digitato il proprio nome. 876.800. A Timpano si era fermato il cuore. «Google è solo un termometro. Ti dice semplicemente quanto sei vivo. Ma a me non interessa solo questo. A me non basta esser vivo. Io inseguo l’immortalità e l’immortalità ha un tempio, il tempio del sapere contemporaneo, lo spazio culturale e mediatico che a tutti gli effetti sancisce la grandezza letteraria...» 69 «Di che parli?» «Wikipedia». «E ci sei dentro?» «Da oltre un anno». Quel pomeriggio era andato al centro commerciale e aveva acquistato un nuovo computer. Tornato, si era incollato allo schermo e c’era rimasto per tutta la sera, immergendosi e rovistando tra i duemila e trecento siti che citavano il suo nome. Era stato un viaggio interessante, a tratti della memoria, a tratti della scoperta. Aveva rinvenuto una vecchia recensione di Moravia che tanto l’aveva emozionato alla fine degli anni settanta; aveva trovato un’intervista sulla guerra del Libano che aveva molto fatto parlare di lui; c’era un elzeviro scritto per la morte di Caproni di cui aveva dimenticato l’esistenza. Poi si era cercato su Wikipedia. Non c’era. Aveva provato con altri nomi. C’erano quasi tutti gli scrittori della sua generazione, di quella successiva e di quella successiva ancora, ma di lui non c’era traccia. Evidentemente non era così importante da entrare nel tempio del sapere contemporaneo. Era andato a letto senza sonno, con gli occhi sbarrati, con un misto di eccitazione e angoscia che l’aveva tenuto sveglio per tutta la notte. Nei giorni seguenti gli prese una nuova mania: rimanere al computer giorno e notte a monitorare i risultati di google, attaccato al mouse come fosse in rianimazione, fremendo in attesa di una ripresa del battito cardiaco o di una reazione neurologica. Allo stesso modo, teneva d’occhio Wikipedia, sperando che la mo70 dernità enciclopedica lo risollevasse dalla sostanza melmosa in cui vegetava da anni. Poi, una settimana più tardi, appurato che nessun miracolo l’avrebbe estratto vivo dalle macerie della sua carriera, aveva spento il computer, si era avvicinato alla libreria e aveva estratto la Garzantina. Cinque righe. Adesso o mai più. Ci aveva pensato a lungo, e adesso era giunto il momento di farlo. Prese un foglio, una penna e si mise alla scrivania. A volte, quando si sente… Le parole non fluivano. Le frasi s’interrompevano. Il pensiero era spento. Provò orrore. Non era un disperato lampo di lucidità né un estremo ripensamento: l’orrore era per l’incubo che tornava, per la pochezza delle parole che gli venivano in mente, per la miseria di uno scrittore finito. Forse, si confessò, quelle cinque righe sulla Garzantina erano fin troppe per uno che non riusciva a mettere assieme nemmeno un biglietto di commiato alla vita. Si alzò e andò in camera. Dal cassetto del comodino prese la scatola di Roipnol. Sapeva benissimo che il suo declino era iniziato proprio con quelle pastiglie, ma cosa poteva importare a Citati e ai lettori? Per loro era solo uno scrittore finito. Pensò che forse il computer l’avrebbe aiutato, lo accese e aprì un nuovo documento word. 71 Provò e riprovò a scrivere. Non è, come diranno in molti, per potermi sciacquare la vita con “fatal gesto”, aulico e letterario, che mi accingo a togliere per sempre il disturbo. Diranno infatti che ho voluto imitare i grandi almeno nell’ultimo atto, visto che in tutti gli altri ambiti, la scrittura in primis, non ne s Dove eravate mentre la mia penna stilografica, la stessa con cui mi ero ritagliato un angolo di firmamento letterario in anni in cui erano più gli autori dei lettori, in anni in cui erano più belle le parole in quarta di copertina che dentro i libri, dove eravate mentre la mia penna stilografica componeva l’ultimo deg Era finito. Rileggeva e provava nausea. Era tutto freddo. Senza stile. Se ne accorgeva da come batteva le dita sulla tastiera, da come le lettere apparivano sullo schermo lente, quasi strascicate, da come il cursore vagava senza logica tra le righe, da come gli occhi andavano e venivano dal monitor a correggere e rammendare frasi incapaci di essere immortali. Non sentiva più la minima emozione. Si alzò e andò alla finestra. Mentre fissava un lampione sfocato pensò a quale sentimento dovesse tirare fuori ma si sentì uno stupido: non doveva sforzarsi affatto, se dentro non aveva più niente. 72 All’inizio, l’idea del buon Klaus di riaprire un vecchio cinema porno gli era sembrata folle. Non che avesse remore morali. Il fatto era che non vedeva in quell’impresa alcuna possibilità di guadagno. Che riscontro poteva avere una sala a luci rosse nell’epoca di internet? Inoltre la parola investimento era proibita dato il suo conto corrente: da che la gente aveva smesso di sposarsi (e quindi di separarsi), lo studio navigava in acque meno tranquille e la sua vita notturna continuava ad essere piuttosto esosa. Lo disse subito, a Klaus, che non gli sembrava un’idea geniale. «Un cinema a luci rosse… nel 2010…» «E allora?» «Escono fiche aperte e culi per aria anche da un computer spento...» Klaus girò intorno alla scrivania su cui lo Zio, in disordine meticoloso, teneva pratiche, documenti e faldoni. Si fermò alla destra della poltroncina in pelle su cui era seduto l’amico, si chinò sulla cassettiera e posò la mano sul pomello del cassetto più grande. Tirò e fece apparire una raccolta di riviste, stipate in verticale e compattate come fossero un corpo unico. Sorrise e infilò le dita tra i fascicoli. Poi ne estrasse qualcuno. Le copertine lasciavano poco all’immaginazione. Sorrise di nuovo e gettò le riviste sulla scrivania. «L’umanità ha un bisogno religioso di erotismo. Re-li-gio-so». Fece scorrere la mano su una copertina ad accarezzare i seni della fanciulla ritratta. Il suo volto era bloccato in una paresi estatica. 73 «L’umanità non so. Tu di sicuro» commentò lo Zio. «Re-li-gio-so». Klaus inspirò a fondo, trattenne il fiato per qualche secondo e poi lo emise in un sospiro esagerato. «Ci vuole la mia voce per tessere il panegirico di quest’editoria drammaticamente lontana e irrecuperabile?» Lo Zio incrociò le braccia e lo guardò perplesso. «Guarda qui: Le Ore, Playmate, Nuda e cruda, il Piacere… veri e propri gioielli editoriali. Qualità della carne e della stampa, passione per l’eros, cura dei particolari... Ci vuole la mia voce per decantare questo mondo pregno di sapiente affabulazione erotica? Ci vuole la mia retorica per comparare la bellezza di quest’iconografia alla spregevolezza delle immagini che girano in rete?» «A parte che la maggior parte erano giornalacci… fammi capire, vuoi combattere il web con una sala a luci rosse? Ma sei scemo?» fece lo Zio, lasciandosi andare a un sorriso di compatimento. Klaus sorrise e scosse la testa dicendo: «Una sola domanda, Zio. Quando vuoi vedere delle donne nude, quando hai voglia di vedere dei bei corpi di femmina, vai su internet o apri il cassetto della scrivania?» «Che c’entro io adesso?» «Internet o cassetto?» «Ma chissenefrega di cosa faccio io!» «Apri il cassetto». «Non è detto». «Ti sei mai chiesto il perché?» «Perché cosa?» «Perché apri il cassetto?» «Ma che ne so! Perché faccio prima?» «Non essere banale». «Dimmelo tu, allora». 74 «Semplice: perché trovi delle cose migliori». «Ah, ecco». «Non capisci? Cerchi la qualità estetica e, ti dico io, la qualità etica. Ti rendi conto di come la rappresentazione della sessualità sia cambiata, di come sia rovinosamente sprofondata in un budello dantesco?» «Budello che…?» «Dantesco. Non ti rendi conto di come sia cambiata la visione dell’amore? La visione e quindi la pratica, ovviamente?» Lo Zio pensò per qualche istante alla pratica dell’amore che aveva praticato la sera prima, e non ci vide nulla di dantesco. Aveva trascorso un magnifico quarto d’ora con Karima e gli bastava chiudere gli occhi per rivedere i bagliori della sua pelle brillare nella notte, sotto la luce del cruscotto acceso. Klaus aveva preso una delle riviste sul tavolo, era tornato dall’altra parte della scrivania e si era messo a sfogliarla di fronte allo Zio. «Guarda Patti Villani... Guarda che donna! Che femminilità, integra e decorosa! Lo sguardo trasmette lussuria, ma allo stesso tempo è pieno di dignità!» Lo zio si tirò su e buttò un occhio alla rivista, poi si risedette dicendo: «Klaus, lo sta semplicemente prendendo nel culo». «Non importa! Negli anni settanta la donna era ancora una manifestazione erotica. Non un buco da riempire. Negli anni settanta il porno era un prodotto cinematografico a tutti gli effetti, un progetto artistico con una sceneggiatura decente, una recitazione professionale, una calda rappresentazione della realtà!» «Dai Klaus, non metterti a celebrare i tempi che furono… se vuoi possiamo rimpiangere i cartoni animati di quando eravamo piccoli, ma l’operazione nostalgia sul porno mi suona un po’ stonata…» 75 «Cos’è successo da un punto di vista storico-antropologico? Negli anni ottanta tutti hanno comprato un videoregistratore ed è esplosa la mania delle VHS. Le sale a luci rosse, un po’ alla volta, hanno chiuso i battenti e ceduto il passo a una triste forma di onanismo domestico. È stato l’onanismo domestico, così vile e solitario, a spazzare via quel mondo fantastico fatto di aspettative e poesia? È così? È così, vero?» Lo Zio aveva abbassato lo schienale fino a poter stendere le gambe. Si era messo le mani dietro la nuca e guardava il soffitto. Di tanto in tanto, socchiudeva gli occhi e rivedeva Karima sollevarsi la gonna. Klaus intanto si era alzato, gesticolava animosamente brandendo un Le Ore. «Guarda la meraviglia di queste immagini! Queste pagine e quel cinema costruivano una società sanamente immorale, un’immoralità che, combattendo la moralità, in qualche modo la legittimava e allo stesso tempo trovava la propria legittimazione! “Amore” era ancora una parola usata da entrambi i sessi! L’amoralità contemporanea distrugge la moralità e non si legittima. L’immoralità contemporanea abolisce l’amore!» «Non ti seguo più, amico». «Siamo andati troppo in là. Ci siamo spinti oltre, Zio!» «Eh?» «Andare troppo in là è il concetto su cui dobbiamo riflettere». «Come?» «Perché ti piacciono gli AC/DC e non i Megadeth?» «Cristo, hai fatto uno studio di mercato su di me, per aprire un cinema porno?» «Ti piacciono gli AC/DC ma non i Megadeth perché i primi sono rock, rock spinto magari, ma non troppo in là. I secondi invece sono eccesso di rock, rock troppo in là». «Higway to hell, tum tum, Higway to…» canticchiò lo Zio. 76 «La pornografia degli anni settanta era amore spinto, ma non all’eccesso, alla trasmutazione. Il porno odierno non contiene più una goccia d’amore». «Higway to hell, tum tum… gran pezzo, eh? 1979!» «Cos’è l’erotismo? È ammettere che, nonostante il lavaggio del cervello fatto da sacramenti e super-Ego, io possiedo anche questo muscolo qua, e che tu, sorella, possiedi anche quella guaina lì. Loro ti dicono: non è roba tua! Io ti dico di sì, che queste parti appartengono al nostro corpo, al mio e al tuo, sorella, e che, sfregandole insieme, producono scintille. Il fuoco che si sprigiona è l’erotismo, ed è un fuoco che forgia l’umanità, le relazioni, la società. Capisci? Se noi togliamo il fuoco e lo sostituiamo con del brodo tiepido, la forgiatura non avviene, capisci?» «A me sembra che anche la pornografia di oggi sprigioni scintille…» «Onanismo, non scintille». «Klaus, le pippe se le facevano anche negli anni settanta…» «Non era carne infilzata, Zio». Suonò il telefono. Era la segretaria che annunciava un cliente. Lo Zio le disse di farlo aspettare. «Può darsi che ci sia del giusto in quello che dici» fece lo Zio «ma la visione d’insieme, quel dualismo amoralità-immoralità, mi sembra… forzato, artefatto, troppo filosofico…» «Quell’erotismo» insisté Klaus «non era semplice carne allo spiedo, Zio. Noi questo riusciamo ancora a percepirlo, perché noi veniamo da quel mondo là, ma un ragazzino che oggi ha quindici anni non può saperlo: per lui la sessualità è entrare in rosticceria e comprare carne infilzata, puro consumo. Quel prodotto invece era intriso di amore: le attrici conservavano il loro candore, le in77 quadrature indugiavano sulle giarrettiere e sulle curve dolcemente, gli intrecci sottostavano a procedure umane della seduzione, la finalità dell’atto sessuale non era l’umiliazione della donna ma la sua completa esaltazione…» Lo Zio era sempre ammirato dalla facilità con cui Klaus costruiva metafore, cosa che a lui non riusciva affatto: «Era carne affumicata e non allo spiedo…» sentenziò, poco soddisfatto della propria retorica. «E fino alla fine degli anni settanta è andata così. Fino ad allora abbiamo goduto di spettacoli in cui l’incontro tra uomo e donna era ancora una cosa armoniosa. C’era amore nel linguaggio del sesso. Dopo è stato un continuo rilancio, una corsa folle fino alla violenza gratuita. Hai presente la violenza del sesso sul web?» «Vagamente». «Ti rendi conto che esiste una categoria in cui la violenza sull’attrice è vera, reale? Cioè: ammazzano davvero le attrici!» «Vabbé… ora, però, devo lavorare. Sei un grande oratore, ma ammiro più il tuo fiuto per gli affari: fammi capire, in concreto, cosa vuoi fare». Allora Klaus gli spiegò che aveva in mente di riaprire il Prisma, una vecchia sala a luci rosse che aveva furoreggiato in città per tutta la seconda metà degli anni settanta. Nel 1984 aveva chiuso i battenti ed era stato, nei cinque anni successivi, riconvertito a normale sala cinematografica; poi aveva tentato di riciclarsi come sala conferenze; infine era stato sigillato da lucchetti e ragnatele e nessuno aveva più scommesso su un suo possibile riutilizzo. Nessuno più fino a Klaus, chiaramente, che c’era entrato per caso, qualche settimana prima, ed era rimasto folgorato dal perfetto stato di conservazione della sala. Le poltroncine in legno massello, le piccole insegne luminose, l’eleganza del botteghino, le fiammate di archeologia anni settanta, l’austerità frammista a leggerezza dell’insieme 78 architettonico avevano dato a Klaus un’emozione di tipo ascetico. Servivano poche migliaia di euro per rimetterlo in funzione. A quel punto, lo Zio domandò se quel piano perfetto avesse tenuto conto di due piccoli particolari: prima cosa, se a qualcuno potessero ancora interessare film porno desueti contaminati di pelurie eccedenti e gonne marroni al ginocchio; secondo, se i pochi interessati – un manipolo di vecchi pervertiti – fossero disposti ad abbandonare le foppe del proprio divano per andare a mostrare la propria faccia pervertita ad altri vecchi pervertiti e quindi, tutti insieme, questi allegri vecchi pervertiti con tanta voglia di socializzare, fossero in grado di sostenere il mercato di una sala cinematografica. «Zio… non devi mica pensare a tuo nonno. Oggi i vecchi ci danno dentro! Non sono più i vecchi solo Unicum & Nazionali di una volta. Il loro immaginario non è più di sola memoria. I vecchi di oggi hanno brama di presente: oggi la vecchiaia è rivolta unicamente al proprio corpo, forse in modo più ansioso e patologico dell’adolescenza! Pensa al Viagra che prolunga fino alla decomposizione la possibilità di erotizzare il proprio corpo…» «Mmm…» «E poi… il target è molto più ampio! Ho i dati di un’analisi di mercato relativa ai cataloghi anni settanta in vendita on-line: anche i giovani comprano quella roba». «Se vende di suo, che bisogno c’è di riaprire un cinema?» «Dobbiamo combattere l’onanismo. L’onanismo uccide l’amore». «Perché non lasci che i maschi di questo paese si facciano beatamente tutte le seghe che vogliono?» Risero entrambi. Lo Zio era dubbioso ma rispettava le intuizioni di Klaus: il suo fiuto per gli affari era indiscutibile, affari che erigeva su basi mal79 ferme – cercando di abbattere ogni convenzione del mercato – e che, poi, immancabilmente fiorivano fino a sembrare non aver limiti di crescita. Klaus era così. Non si sarebbe mai accontentato di aprire un banale pub o un’agenzia immobiliare. Subito dopo il diploma, aveva fatto bei soldi con una birreria ispirata alle saghe nordiche: serate a tema, letture teatrali, mostre artistiche, giochi di ruolo… un paio d’anni in continuo aumento di fatturato, poi un giorno s’era stancato e aveva ceduto la licenza per acquistare un negozio di modellismo ispirato alla prima guerra mondiale. Un buco di nemmeno sessanta metri quadri. Arrivavano da mezza Europa per comprare i suoi piccoli cannoni. Più recentemente, aveva rilevato una para-farmacia e aveva fatto soldi a palate vendendo esclusivamente prodotti realizzati da un ex-frate sospettato di alchimia. Klaus, madre italiana e padre tedesco, apparteneva a una ricca stirpe di imprenditori tessili. Aveva fatto studi classici (liceo classico, appunto, e poi lettere classiche, facoltà che aveva frequentato senza dare un solo esame per un triennio) ma, nonostante la formazione umanistica, non gli era mai mancato lo spirito imprenditoriale. Slanciato e ben tornito – un viso d’angelo e uno sguardo penetrante – aveva nel portamento qualcosa del dandy ottocentesco; vestiva sempre in modo sobrio ma non privo di qualche ricercatezza (di solito giacche in tweed, guanti in pelle e basco), ripassava le unghie tutti i giorni, limitava i propri pasti alla cena e tutte le mattine, appena sveglio, deglutiva un paio di moment che diceva preventivi. L’emicrania, che per lui era un tormento quotidiano, era anche fonte di meditazione sul senso del dolore, riflessione che l’aveva portato a definirlo utile, se non necessario. 80 Aveva una passione inguaribile per i biscotti caramellati della Lotus (aveva perfino visitato la fabbrica in Belgio) che consumava nelle notti di insonnia trascorse a leggere letteratura francese o saggi di antropologia; altrettanto intenso era l’amore per il punch all’arancia, la sua solita ordinazione quando si sedeva al tavolino di un bar. Aveva avuto ai piedi un numero imprecisato di donne che l’avrebbero sposato immediatamente, ma lui dichiarava d’aver fatto voto di poligamia. La sua relazione più lunga era durata tre settimane. A chi conosceva entrambi, l’amicizia tra Klaus e lo Zio sembrava improbabile, una sorta di scherzo delle relazioni umane. Uno viveva di crisi matrimoniali, collezionava riviste porno, ascoltava heavy metal e andava a puttane; l’altro trasformava in oro tutto ciò che toccava, acquistava una decina di libri la settimana, ascoltava Vivaldi ed era solito inaugurare una relazione sentimentale regalando i Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. Con le ragazze Klaus era impeccabile e brillante: abituato ad averne a iosa fin dalla prima adolescenza, sapeva perfettamente che la cosa dipendeva in gran parte dalla Bentley con cui attraversava la città, e tale consapevolezza gli aveva permesso di tenere a bada il tipico narcisismo casanovesco. Lo Zio, invece, con le ragazze non ci sapeva fare: pur non avendo un aspetto sgraziato, era sempre stato impacciatissimo, assolutamente incapace di comunicare con loro e di rendere qualunque storia abbastanza duratura. Le poche relazioni che aveva avuto erano state con delle crocerossine bravissime a prendersi cura delle sue paranoie ma inadatte a soddisfare le sue elevate esigenze sessuali. «Klaus» disse lo Zio, sfogliando un numero de Il piacere tutto dedicato alla lingerie 1988, «mi sembra un progetto strampalato, 81 soprattutto per l’ideologia che c’è alla base… il tuo programma di rieducazione sociale mi sembra un’immane stronzata…» «Dobbiamo tornare ad usare la parola “amore”, Zio». «Chi?» chiese lo Zio sentendosi tirato in ballo. «Noi maschi». «Non ce la fai proprio a fare soldi senza inventarti qualcosa di strano?» «Non credo. Comunque, come sai, il guadagno non è mai mancato nelle mie imprese...» «Lo so. Sei riuscito a vendere le pozioni di Fra Galdino…» «Facciamolo allora!» «Ci penso qualche giorno». Un paio di giorni dopo, lo Zio accettò. In poche settimane i lavori vennero ultimati e il Prisma riaprì i battenti. Manco a dirlo, andò subito bene e diventò, in poco, il locale più in della città. A contribuire al successo fu un’ottima promozione su tv e radio locali (lo spot diceva testualmente: “Non puoi non venire come si faceva una volta!”), qualche articolo sui quotidiani nazionali (in particolare l’inserto milanese del Corriere, che dedicò all’inaugurazione una pagina intera intitolata “Riapre il cinema degli amatori solitari”) e, naturalmente, la sagace scelta dei film, tutti capaci di narrare l’erotismo in una maniera stuzzicante e ormai dimenticata. Klaus rilasciò diverse interviste in cui dichiarava guerra all’infima pornografia dei siti web: l’intento del Prisma era quello di recuperare un certo erotismo riproponendo, soprattutto al pubblico maschile, una visione dell’amore più valoriale. 82 La prima settimana fu proiettato Gola profonda e la sala si riempì ogni sera. C’era di tutto: anziani in cappotto nostalgici di Janet, comitive di ragazzi incuriositi dalla fama del film, coppie di innamorati in cerca di trasgressione. La trama era deliziosa, tutta costruita sulla sessualità deviata di una ragazza che non raggiungeva l’orgasmo perché una malformazione le aveva posto il clitoride in gola. La platea gradì vistosamente. La sera dell’inaugurazione l’ingresso era gratuito, allietato da un ricco vernissage e impreziosito dalla presenza di due vecchie (ma non appassite) glorie del cinema erotico italiano. Gola profonda venne lasciato in visione per due settimane portando nelle casse del Prisma il primo cospicuo bottino. La terza settimana fu la volta di The Devil in Miss Jones, dello stesso regista di Gola profonda, la storia di una vergine che finisce all’inferno: dapprima le viene concesso di conoscere i piaceri della carne, ma poi le viene negato l’orgasmo ed è condannata a masturbarsi inutilmente per l’eternità. La quarta settimana, Klaus passò Le tenere notti di Amburgo, film tedesco del ’75 che racconta delle straordinarie imprese sessuali di una nazionale di calcio (verosimilmente l’Olanda di Cruyff e Neeskens) nel corso dei mondiali di calcio di Germania ’74: l’unica notte in cui i giocatori vanno a dormire senza aver dato sfogo ai propri istinti sessuali è quella che precede la loro unica sconfitta, quella della finale. Il secondo mese di proiezioni venne inaugurato con un film italiano, Fra Tazio da Velletri. Non un film particolarmente spinto bensì una commedia erotica cui Klaus era particolarmente legato. La proiezione aprì al genere boccaccesco e riscosse enorme successo. Dopo un paio di mesi si poteva già dire che l’apertura del Prisma era stata un affare. Lo Zio non aveva mai visto tanti soldi in vita sua. 83 Certo, per valutare gli intenti palingenetici del progetto bisognava aspettare del tempo, ma qualcosa già s’intravedeva. Una sera Klaus assisté a una scena che lo riempì di gioia: un vecchietto e un ragazzino gli si avvicinarono e si presentarono. Il vecchietto si complimentò con lui per avergli dato l’opportunità di mostrare al nipote dei film su cui formarsi eroticamente. Un’altra sera, si presentò al Prisma una scolaresca accompagnata dall’insegnante di lettere. Ogni volta che assisteva a scene del genere, Klaus sentiva che l’umanità era in procinto di rinsavire. Grazie a lui, sarebbe tornata ad usare la parola “amore”. Qualche giorno dopo, però, Monsignor Razzolato, il vescovo della diocesi, si scagliò contro il Prisma dalle pagine del quotidiano della curia locale. Disse che la riapertura della sala rappresentava un grande pericolo per l’integrità morale della comunità cristiana. Klaus e lo Zio ci risero sopra per un paio d’ore: c’erano i sexyshop a pochi metri dagli oratori e quei pretacci se la prendevano con il loro piccolo cinema d’essai! Una settimana più tardi, Klaus ricevette una telefonata da parte di un alto prelato della curia che, dopo un lungo giro di parole, gli chiese di prendere seriamente in considerazione l’idea di chiudere la sala. «Mi scusi, non ho capito bene» disse Klaus passando a due ragazzi i biglietti per il film che stava per iniziare. «Chiudere il Prisma». «Eh?» Nell’atrio c’era brusio e Klaus, incredulo per le parole intuite, dovette chiudersi nel suo ufficio. «Potrebbe ripetere, per cortesia?» «Chiudere la sala cinematografica» ribadì la voce al telefono. «Temo ci sia un equivoco: guardi che non sta chiamando l’oratorio di San Carlino» ridacchiò Klaus. 84 «Lei non si rende conto del male che fa ai cristiani. La sua sala cinematografica è un pericolo per l’integrità morale delle persone!» «Può scordarselo». «Come?» «Se io le chiedessi di chiudere le sue chiese perché mettono in pericolo l’integrità morale delle persone, lei cosa direbbe?» «Le chiese non mettono in pericolo l’integrità morale delle persone!» esclamò stentorea la voce del prelato. «Questo lo dice lei. Potremmo discutere a lungo della questione. Potrei dirle che noi diffondiamo l’amore, voi lo mistificate, che Sant’Agostino sta dalla nostra parte, non dalla vostra o che il medioevo è finito da un pezzo e che voi non ve ne siete accorti. Ma non glielo dirò, perché sono certo che lei non capirebbe. Sono molto rammaricato». «Mi sta dicendo che…» «Il Prisma non chiude». «Lei sta… lei sta spingendo la gente di B. all’Inferno!» «L’Inferno è un luogo metafisico. L’ha detto il suo Papa, quindi io, al massimo, sto spingendo la gente di B. verso un luogo metafisico. Il che non mi risulta essere una grave colpa». «Lei non… io non… mi preme ricordarle che, dall’alto del suo magistero episcopale, Monsignor Razzolato dice che…» «Mi perdoni, padre, ma devo lasciarla: sta iniziando la proiezione di Fino in fondo, stallone! Venga a trovarci quando vuole: biglietto omaggio per lei e le sorelle con cui vorrà accompagnarsi». 85 Un morbo insanabile, una sensazione di infermità, una vertiginosa parete liscia da scalare. Non so come descrivere la paralisi, l’impossibilità di scalfire, anche solo con una lettera, il bianco della pagina. Il foglio morto davanti agli occhi e tutto diventava bianco: la mia mano, la scrivania, quella mosca sullo stipite della porta, il mondo fuori dalla finestra. Avevo iniziato a vedere il Dottor Cacace esclusivamente per questo bianco. In fin dei conti, l’esaurimento della mia vena creativa era il mio unico vero esaurimento, la depressione delle mie doti narrative era l’unica vera depressione. Era per la letteratura che spendevo quattro ore settimanali a farmi notomizzare il cervello. Dopo averle provate tutte – compresa la religione – avevo sperato che la scienza psichiatrica mi venisse in aiuto, avevo sperato che in qualche pillola ci fosse il rimedio al mio malessere o almeno una musa della conoscenza che mi ispirasse. Non era andata così. Dicono che bisogna crederci in un percorso terapeutico, altrimenti è tutto inutile. Io all’inizio ci credevo, ci credevo come il peccatore che in punto di morte prende la comunione: avevo un disperato bisogno di scrivere, bussavo alla scienza dei cervelli malati e chiedevo l’assoluzione. All’inizio. Dopo qualche seduta guardavo il Dottor Cacace con disprezzo. 86 Lo trattavo come un inferiore, un sottoposto. Mi diceva cose che avrei trovato in edicola. Cose già vecchie negli anni trenta. Mi cadevano le braccia. Conoscevo abbastanza della materia per capire che Cacace mi propinava delle analisi da rotocalco: ovviamente era colpa della morte, ovviamente era colpa di mia madre o colpa dell’eros e della fase anale. Invece, durante una delle ultime sedute, il Dottore disse una frase che mi colpì. Dalla sua bocca, appena velata da timidi baffi rossicci, uscirono queste precise parole: «Lei ha bisogno di emozioni forti. Lei ha urgente bisogno di provare qualcosa di potente, qualcosa che gli sconquassi l’anima». In un primo momento quelle parole furono una stura per il mio sperticato narcisismo: iniziai a sciorinare, con una certa volontà di umiliarlo, tutte le emozioni forti che avevo provato sulla mia pelle: droga, sesso, violenze e ancora: occultismo, new age, cinismo, fama, ricchezza... Fu un elenco lungo che durò parecchi minuti e che lasciò il Dottore piuttosto spiazzato. In un secondo momento, però – e qua la memoria non mi sostiene perché non ricordo se ciò scaturì da una sua affermazione o semplicemente da un suo sguardo – compresi chiaramente che le sue parole si riferivano alla sola emozione forte che ancora mi restava da vivere. Si trattava della morte. Della mia morte, ovviamente. Sarei definitivamente guarito solo con quella. 87 Nei momenti di tensione, lo Zio caricava nello stereo Overkill e la sparava in aria ben oltre i decibel ammessi dalle regole della convivenza civile. Caricare e sparare. Bang. Il ritmo forsennato del doppio rullante, il basso veloce e rutilante, le chitarre infiammate e la voce cartavetrata di Lemmy gli si conficcavano nel cranio come un proiettile e gli facevano sparire dalla vista qualunque cosa. Overkill! Overkill! Cosa dicesse quella canzone non lo sapeva. Non era per i testi che ascoltava heavy metal. Per lui la voce del cantante era solo uno strumento a corde: ascoltava heavy metal perché era una terapia contro le rotture di coglioni, una pistola che si puntava alla tempia dall’età di dodici anni. Una cassetta nello stereo, un riff di chitarra e bang: il mondo spariva. Quel giorno la catarsi di Overkill era stata evocata da un pacco arrivato nella cassetta dello studio legale. Lo Zio l’aveva scartato sovrappensiero, poi, pian piano, mentre prendeva coscienza dell’oggetto, aveva sgranato gli occhi e la sua faccia aveva assunto un’espressione frammista tra terrore e sbalordimento. L’intera mattinata era trascorsa senza riuscire a mettere assieme due minuti di lavoro. Sulla scrivania, intonsa, campeggiava il cartone plastificato di una confezione farmaceutica. Un cartone bianco attraversato in 88 orizzontale da una striscia verde. In alto a sinistra, appena sopra la striscia verde, si leggeva in corsivo nero: Tubo da 30 g Sotto la striscia verde, a sinistra e in stampatello, risaltava in fucsia: USO INTERNO/ESTERNO Fra le scritte, al centro della striscia verde, in stampatello bianco e ben visibile, campeggiava: VASELINA BIANCA F.U. Dalle nove e per tutta la mattina, lo Zio non aveva fatto altro che pensare a quella scatola. Perfino quando era sceso al bar e si era trovato a pochi decimetri dai significativi seni di Caterina, non era riuscito a pensare ad altro. Mentre aspettava un panino allo speck aveva mandato un sms a Klaus. Tornato in ufficio, per niente alleviato dal tirolese trangugiato in un paio di minuti, la vista del tubetto l’aveva spinto a introdurre Overkill nel lettore. Nel primo pomeriggio aveva ricevuto un cliente piuttosto querulo. Aveva scribacchiato tutto il tempo credendo di prendere appunti, ma quando il tipo aveva sloggiato, lo Zio s’era accorto che sulle pagine della sua agenda c’erano solo parole senza senso. Alle quindici e trenta il citofono aveva suonato. Poco dopo, impegnatissimo sulla tastiera del cellulare, Klaus aveva fatto il suo ingresso in ufficio. Aveva visto la faccia dello Zio e aveva avuto un sussulto. 89 «Ancora ‘sta musica?» aveva detto, sbracandosi sulla poltroncina dei clienti «Perché non ascolti il cd che t’ho regalato?» «Mi fa venire sonno…» «Ma questa è musica da carpentieri, tu sei un avvocato!» ironizzò Klaus, tornando ai suoi sms «Tu devi ascoltare qualcosa che ti elevi, tipo Gaber, Battiato… Lo sai che il mio T9 dà probabbilmente?!» «Non rompermi i coglioni e guarda cosa ho trovato nella cassetta della posta». Lo Zio gettò la scatoletta sulla scrivania. «È per questa che mi hai chiamato?» «A-ah». Klaus diede un’occhiata distratta, poi chiese: «Dov’è il problema?» «Come dov’è il problema?» «L’hai provata e non funziona?» «M’è arrivata per posta e non l’ho ordinata io». «Non l’hai ordinata?» «Non l’ho ordinata». «Quindi si tratta di un… come possiamo definirlo… un omaggio?» «Aggiungi indesiderato». «Sei uno all’antica? Preferisci il burro?» «Smettila, cazzo». «Mmmhh… fammi capire… proviamo a metterci nei panni di chi te l’ha mandato». «No, mettiti pure nei panni di chi l’ha ricevuto…» «Dunque. Regalare vaselina. Perché? Anzitutto tenderei a escludere l’ipotesi che essa possa esserti stata regalata per fini diversi dal suo uso basilare, vale a dire lubrificare perni. Non si regala vaselina per ingrassare serrature o per oliare catene. Si regala vaselina per 90 lubrificare perni. E qui siamo di fronte al primo bivio speculativo: la vaselina è da intendersi per il tuo perno o per quello di terzi?» «Klaus, cazzooo…» si spazientì lo Zio. «Scusa, ma devo ragionare, Zio. Non capita tutte le mattine di ricevere cose del genere in regalo!» «Appunto. Porca troia!» «Prima possibilità, quella secondo cui chi ti ha spedito il tubetto pensasse al tuo perno: una delle tue donne ha sentito l’esigenza di farti capire che il sesso che praticate ha un che di… stantio, ripetitivo, monotematico? Oppure: una delle tue donne si è sentita in dovere di comunicarti che il sesso che praticate necessita di qualche piccolo accorgimento onde evitare spiacevoli sensazioni postume?» «Non ho donne, Klaus, lo sai». «Immaginavo… Altra ipotesi: ti risulta esista una persona di sesso imprecisato che, pur non avendo con te una relazione fissa, potrebbe essere interessata al tuo perno e quindi a percepirlo col minor attrito possibile?» «Ho pensato subito a te» fece lo Zio lasciando scappare un sorriso. «Ok. Abbiamo appurato che non è il tuo perno. A questo punto, però, devo comunicarti che rimane aperta una sola porta, o un solo orifizio, se preferisci…» Lo Zio accese una sigaretta, si alzò e aprì la finestra. Klaus, invece, era andato verso la libreria in cui campeggiava un vecchio Zingarelli. Quando lo Zio si voltò verso di lui, lo trovò avvolto in un sorriso pieno di soddisfazione. «È incredibile…» «Cosa?» chiese lo Zio, soffiando una boccata di fumo. «Come il linguaggio umano sia predisposto alla metafora… senti la definizione di “perno”. In meccanica: organo d’accoppia91 mento che permette a una parte di macchina di ruotare rispetto all’altra…» «Klaus, mi stai leggermente rompendo le palle. Qualcuno mi sta dicendo egregio avvocato del mio cazzo, preparati a qualcosa che riguarderà da vicino il tuo deretano implume… e tu, tu vieni qui a leggermi un dizionario?!» «Dai, abbiamo capito entrambi di cosa si tratta». «È un avvertimento, e ti ho chiesto di venire perché ho la sensazione che tutta ‘sta manfrina riguardi anche te». «Un tubetto per due? Basterà?» Il rumore del traffico saliva dalla strada ovattato dalle doppie finestre dello studio. Una cavalletta enorme e alcuni maggiolini si scaldavano sul vetro. In lontananza s’intravedeva il profilo delle Alpi stagliarsi nell’azzurro del cielo: dopo diversi giorni di pioggia il cielo era tornato limpido e il sole, stranamente caldo, evaporava l’umidità dell’aria. «Sai che raramente mi è capitato di seguire casi pericolosi: la maggior parte dei processi, in questo periodo, si concludono con un patteggiamento, un accordo tra le parti. Alla fine sono tutti contenti. Il mio lavoro non c’entra. Fidati: qui c’è di mezzo il Prisma». «Addirittura?» «Addirittura». «Sua santità il Vescovo che manda vaselina a due imprenditori locali: che storia! Dobbiamo avvisare quelli di Confindustria». «Dici che c’entrano i preti?» «Con la SIAE siamo a posto, no?» «Ti risulta che la SIAE vada in giro ad applicare sanzioni anali?» «Sai com’è… sono gli ultimi sussulti del diritto d’autore…» «Non so chi l’ha mandato, ma di certo è colpa del Prisma». 92 Lo Zio tirò l’ultima boccata di sigaretta, chiuse la finestra e tornò alla poltroncina. Si sedette, incrociò le braccia e sbuffò platealmente manifestando tutto il suo nervosismo. «Facciamo così» disse Klaus, «andiamo a farci un punch e rilassiamoci un po’. Poi facciamo l’unica cosa da fare in questi casi». «Cioè?» «Aspettiamo». «Mmh…”» «È l’unica cosa che possiamo fare, Zio. Il mittente si farà vivo, magari con qualcosa di meno ambiguo che ci permetterà di chiarire la situazione. Nel frattempo, sempre che il Prisma c’entri qualcosa, stiamo in guardia e teniamo d’occhio chi lo frequenta…» Ci fu un attimo di silenzio interrotto da un nuovo sbuffo dello Zio. «Klaus, pensi veramente che il tizio venga al Prisma a farsi sgamare come un coglione?» «In effetti, la mia vera soluzione al problema era andare a farci un punch». Come previsto, al Prisma non accadde niente di particolare. In quei giorni, quando lo Zio e Klaus si sentivano al telefono, era tutto un elencare ipotesi e cancellarle, costruire nemici e scagionarli. Klaus rimaneva perplesso rispetto all’ipotesi che il Prisma c’entrasse qualcosa; lo Zio, invece, ne era sempre più convinto. Aveva chiesto alla segretaria di preparargli una lista delle cause più delicate affrontate da quando aveva aperto lo studio e, una volta analizzata, era giunto alla conclusione che il suo lavoro non c’entrava nulla. Era dal Prisma che veniva la vaselina, e infatti, qualche sera più tardi, accadde una cosa rilevante. 93 Al termine della proiezione di Il mio regno per un cavallo, un uomo dall’aspetto elegante si avvicinò a Klaus e si presentò. Era curato, media statura, brizzolato, con il viso olivastro e finissimi baffi neri, coperto da un pesante cappotto marrone e con una valigia di pelle nella mano sinistra. «Permette? Aldo Ruopolo». «Piacere…» rispose Klaus distrattamente. Restarono in piedi qualche istante a guardare le persone che sfilavano dalla sala. Una ragazza, passando, salutò Klaus e lui la ricambiò con un gesto d’intesa. «A cosa devo?» chiese Klaus un attimo dopo. Guardando la valigia e valutando lo stile dell’uomo, Klaus pensò fosse della SIAE. «Fratellanza ideologica». «Le è piaciuto il film?» «A dire il vero non è il mio genere, ma condivido appieno ciò che gli sta dietro». «Il cavallo, intende?» sorrise Klaus. «Eh eh… no, mi riferivo ad altro… Diciamo che abbiamo gli stessi nemici». «?» «Noi siamo contro la chiesa. Più in generale contro tutte le rivelazioni». «Noi chi?» «Glielo dirò dopo. Lei crede in Dio, signor Jäger?» «Le piacciono le domande a bruciapelo?» «Eh eh…» Passarono di lì due ragazzi. Si avvicinarono a Klaus e gli chiesero se il Prisma assumesse, magari proiezionisti o cassieri. Klaus si scusò con Ruopolo e s’intrattenne con loro per un tempo opportuno. «Dunque» riprese poco dopo, «mi chiedeva se credo in Dio… Le posso dire che una volta, da ragazzino, ci ho creduto». 94 «Una volta sola? E poi, più nulla?» «Diciamo che non s’è più fatto vivo nessuno. Ci sarà da preoccuparsi?» «Suppongo di sì…» «Sa, a quell’età si percepiscono le cose in maniera diversa, intuitiva, alogica… Uno sente che una cosa è così, e si fida di quel sentire, nel senso che quel sentire vale mille dimostrazioni scientifiche. Purtroppo è un modo di affrontare le cose piuttosto infantile…» «Sono nato razionalista, quindi non posso capirla». «A volte mi capita ancora, mentre sto per dormire, di percepire l’eco di quel potentissimo intuito cognitivo… Lo sento come un fuoco che mi scalda, mi dà certezze. So perfettamente che si tratta solo di una sensazione indotta dal dormiveglia, un po’ come quando ti strafai di erba e senti la mente spiccare il volo…» «Anche questa è una sensazione che non conosco». «Una volta, da ragazzino, mentre giocavo in un campo di granturco, mi capitò – grazie a un mix irripetibile e inspiegabile di elucubrazioni e sensazioni – di arrivare con assoluta certezza alla dimostrazione dell’esistenza di Dio». «Interessante…» «Le giuro che in quel momento percepii senza alcun dubbio la sua esistenza». Il vociare degli spettatori scemava man mano che il Prisma si svuotava. Dalla porta, il vento entrava e andava a pungere la pelle di Klaus. Insieme all’aria entrava qualcos’altro della notte, qualcosa di ambiguo, come una sensazione di sospensione temporale. Una locandina si stava staccando e s’agitava sinuosamente sul vetro d’ingresso. «Cosa le hanno fatto gli indegni discendenti del Nazareno?» chiese Klaus. 95 L’atrio ora era vuoto. Un gruppetto di spettatori si era fermato fuori dal cinema. Fumavano chiacchierando rumorosamente. Uno di loro rideva come un demonio e l’eco dei suoi urletti rimbalzava sulle pareti dei palazzi. Dal cielo scendeva una pioggia sottilissima e silenziosa che il vento spostava a ondate improvvise. «Molto semplice: non ci piacciono i depositari di una rivelazione. Non ci piace che solo loro possano esprimersi su Dio. In fondo, su cosa poggia la loro rivelazione? Ci pensi un attimo… cos’è la Bibbia, se non un libro di narrativa?» «Non le piace il fantasy? Se la Bibbia fosse un testo di semiologia sarebbe diverso?» «Eh eh… lei mi piace, signor Jäger. Ha un’indole filosofica, non c’è dubbio. Il punto è che loro non possono continuare ad avere l’esclusiva su Dio, il monopolio sulla fede. Anche noi crediamo in un Dio, anche noi abbiamo lo stesso diritto che hanno loro». «Capisco. Posso sapere chi si cela dietro questo noi?» «Nessuna setta, signor Jäger: noi siamo il Circolo Spinoziano». «Spinoziano?» «Un circolo filosofico. Da oltre sei anni pubblichiamo il Foglio Spinoziano nel tentativo di divulgare il nostro pensiero, che poi è quello, come avrà intuito, di Baruch Spinoza». «Spinoza… ho dei vaghi ricordi liceali… Vi serve uno spazio promozionale? O avete un film sulle frenetiche attività sessuali del giovane Baruch Spinoza?» «Eh eh… no, nessuno spazio promozionale… le sto facendo questo discorso perché questo discorso la riguarda in prima persona. Riguarda lei e il Prisma». Ruopolo aprì la borsa ed estrasse un raccoglitore di plastica sulla cui copertina era scritto a pennarello Prisma. Dentro c’erano delle fotocopie. Ruopolo le prese e le passò a Klaus: erano stralci 96 delle interviste rilasciate nei giorni che avevano preceduto l’inaugurazione, brani in cui erano evidenziate, a penna rossa, le idee programmatiche del progetto Prisma. «Perché ha raccolto questo materiale?» chiese Klaus. «Fratellanza ideologica». Klaus si guardò intorno, poi andò verso la porta d’ingresso e la chiuse a chiave. Per qualche istante restò a fissare i lampioni che spandevano sul viale la loro triste luce biancastra. Cominciava a sentirsi irrequieto. «Che ne dice se andiamo nel mio ufficio?» «Volentieri». L’ufficio era un bugigattolo con una sola finestra alle spalle della grande scrivania su cui Klaus teneva un computer, una portapenne e un calendario. Il resto della stanza era a fatica riempito da una libreria striminzita e da un vecchio divanetto alla destra della porta d’ingresso. Dalle pareti, immortalate su coloratissime locandine, prorompevano le esplosive anatomie di alcune tra le più celebri dive del cinema erotico. Klaus aveva versato due bicchieri di cognac e ne aveva posato uno davanti a Ruopolo. «Quella è la locandina di Vixen…» «Le piace Russ Meyer?» «Conosco i primi film… Quando lo proiettate?» «Ci stiamo pensando. L’idea è di tenercelo buono per quando avremo la prima flessione al botteghino. Per ora le cose vanno bene, ma non sarà sempre così. Mi diceva che non siete una setta ma un circolo culturale…» «Filosofico». «Un circolo filosofico che si occupa delle vite altrui… una cosa alla Tom Ponzi?» «Eh eh… Non delle vite, ma delle idee. Tom Ponzi non c’entra niente. Il nostro faro è Spinoza». 97 «Mi piacciono molto i ritratti dei filosofi di quel periodo… Cosa vi lega a lui? È riuscito a dimostrare l’esistenza di Dio?» «Il sostantivo esistenza ha ingannato molti, non Spinoza». «Cosa c’è che non va nel sostantivo esistenza?» «Noi spinoziani diciamo Dio è, non Dio esiste. Questo è l’assunto da cui partiamo. Il nostro Dio non è quello della Bibbia, o quello di altri, eh eh… romanzi…» «Un dio che è invece di esistere? Questa è la chiave?» «Esatto. Dicendo esiste pensiamo al personaggio di un racconto. La povertà delle rivelazioni è disarmante, appartiene ad un’era antropologicamente primitiva, la stessa degli idoli pagani, per intenderci… quella delle narrazioni… eh eh… Ma Dio non è quello antropomorfico che l’uomo si è inventato! Quest’immagine ha portato fuori strada l’umanità, eh eh…» «Ride sempre così?» «Eh eh… cosa dovrei fare? C’è un signore vestito di bianco che ogni domenica, da una finestra, sostiene di essere il ponte tra Dio e gli uomini… come si fa a non ridere?» «E quelle scarpe o il copricapo? Almeno opinabili, non crede?» Ruopolo si era alzato, si era tolto il cappotto ed era rimasto in un completo verde sotto cui risaltava una camicia bianca a quadretti blu. Aveva una voce rauca e un po’ asmatica che, quando rideva, si faceva vibrante, come se le corde vocali fossero asfaltate sotto strati di catarro. Klaus lo osservava interessato e da qualche minuto si chiedeva se quell’uomo fosse implicato nella storia del tubetto di vaselina. L’istinto gli diceva di no, ma l’atmosfera che sentiva quella sera era molto strana. Non credeva fosse il caso di rilassarsi. «Noi spinoziani ci domandiamo: perché quando pensiamo a Dio dobbiamo per forza ricorrere alla rappresentazione? Dio non potrebbe essere spiegato solo in termini ontologico-metafisici?» 98 «Senza rappresentarlo». «Eh eh…» «Hanno ragione gli islamici allora…» «Adesso le svelo una cosa: Dio non produce nulla al di fuori di sé. Dio è il tutto e non ha bisogno di creare niente come un ingegnere qualunque. Dio è l’intera sostanza, come i filosofi del Seicento chiamavano la realtà. Mi segue?» «Abbastanza» rispose Klaus. «E come sarebbe questo Dio secondo la dottrina spinoziana?» «Ascolti… la sostanza divina è composta da due attributi, da non intendersi come “qualità” o “parti” perché non stiamo parlando di una creatura con un corpo, ma di attributi che ne esprimono l’essenza infinita ed eterna; essi sono gli unici che l’uomo è in grado di cogliere: il pensiero e l’estensione. Secondo Spinoza quando noi pensiamo e vediamo, noi pensiamo e vediamo Dio, anzi, noi siamo Dio». «Quindi noi siamo la prova dell’esistenza di Dio?» «Lasciamo perdere l’esistenza di Dio. È roba da situazioni subcoscienti, come diceva lei prima. Niente narrazioni. Se lei impara ad usare il verbo essere anziché il verbo esistere, tutto si fa più facile. A Spinoza premeva di dimostrare che la rivelazione non è stata quella di chissà quale profeta, ma quella che ogni giorno si manifesta davanti ai nostri occhi: la sostanza divina si rivela a noi da un lato sotto forma dei fenomeni materiali, dall’altro sotto forma dei fenomeni mentali». No. Non c’entrava con la vaselina. Aveva lo sguardo deciso ma buono. Niente a che vedere con la velata minaccia di penetrazione anale. «È molto interessante» disse Klaus. «S’intravede il tentativo di ridare dignità all’uomo, cosa che negli ultimi cento anni in pochi hanno osato. Però mi permetta di interrompere il suo ragionamen99 to con un paio di interrogativi: il primo è come spiegherebbe Spinoza il pensiero di una mente malata, di un pazzo, per intenderci; la seconda è: cosa c’entra Spinoza con Il mio regno per un cavallo?» «Alla prima rispondo che Dio è tutto: bene e male, sano e malato, dritto e storto, puro e immondo. Se abbandoniamo l’idea del Dio demiurgico infallibile, tutto è più semplice e possibile, anche un Dio che è follia». «E lo Spinoza erotico?» «Si è mai chiesto perché le persone frequentano la sua sala?» «Beh, per svagarsi un po’… provare sensazioni dimenticate. Abbiamo cercato di proporre un intrattenimento particolare». «Conviene con me che si tratta di un intrattenimento legato al desiderio?» «Certo che sì». «Ecco: Spinoza insegna cose straordinarie sul desiderio. Spinoza direbbe: Il mio regno per un cavallo non è né una cosa buona né una cosa cattiva. Il desiderio viene prima della cosa desiderata stessa: noi non tendiamo a una cosa, non vogliamo, non appetiamo, non desideriamo una cosa per il fatto che la riteniamo buona; al contrario, noi giudichiamo che una cosa sia buona proprio perché tendiamo ad essa, perché la vogliamo, perché la appetiamo, perché la desideriamo». «Mi sento già spinoziano. A proposito di cose buone: assaggi il cognac». Ruopolo prese il bicchierino e se lo portò alla bocca. Socchiuse gli occhi e bevve. Dopo aver deglutito, riprese il discorso. «La chiesa ha edificato una morale valutativa e prescrittiva. Questa cosa è buona, questa cosa è cattiva. La morale spinoziana, che noi abbracciamo e tentiamo di divulgare nel mondo, non è niente del genere. Spinoza ha delineato i diritti dell’individuo e la libertà di pensiero…» 100 L’uomo riaprì la cartelletta e prese delle altre fotocopie: riguardavano gli strali polemici che il vescovo aveva lanciato in seguito all’apertura della sala. «Che bell’anatema, eh?» disse lo spinoziano. «Difendono il loro territorio». «Non minimizzi… eh eh… come si fa a minimizzare di fronte alle intimidazioni che avete subito recentemente?» «A quale intimidazione si riferisce?» «Al farmaco lubrificante». «Come…?» «Sappiamo chi potrebbe essere il responsabile, meglio i responsabili, di tale avvertimento minatorio». «Ma come fate a sapere?» «In città esiste un altro circolo filosofico che, diciamo, si colloca in posizione antitetica rispetto al nostro. Si chiama il Virtuoso Giardino del Confessore e i suoi adepti sono gli agguerriti seguaci di Massimo Confessore, filosofo e stanatore di eretici del VI secolo dopo Cristo. Tra noi e loro è guerra aperta». «Sono un po’ confuso…» «È tutto sul sito del Giardino, signor Jäger ». «Tutto cosa?» «Invettive, condanne e calunnie verso il Prisma, nonché minacce di violenza nei confronti dei suoi proprietari». Ruopolo insisté perché Klaus verificasse coi suoi occhi. Accesero il portatile e attesero qualche istante che la rete fosse disponibile. La pioggia scendeva in controluce davanti ai lampioni. Il vento era calato e le gocce, enormi, picchiettavano l’asfalto. Il marciapiede davanti al cinema era vuoto e nessuna voce risuonava più in strada. Klaus versò dell’altro cognac e per qualche istante ebbe la sensazione di essere finito in un libro di Dan Brown. 101 «Stia tranquillo, signor Jäger, il Circolo Spinoziano è con lei. Siamo agguerriti e non la lasceremo da solo». «Quando racconterò tutto al mio socio, gli verrà un colpo». Lo spinoziano gli spiegò bene la storia delle due associazioni culturali. Massimo il Confessore era stato – oltre che filosofo – padre della chiesa. E infatti, il Virtuoso Giardino era nato su spinta della diocesi locale, una tra le più ricche del Paese e una delle più attive contro la diffusione del relativismo etico e del materialismo. Il Virtuoso Giardino del Confessore era sorto alcuni mesi dopo la fondazione del Circolo Spinoziano, probabilmente proprio per contrastarlo. Il Giardino stampava una rivista, Mistagogia, in cui denunciava il decadimento morale della città, stigmatizzava i comportamenti dei cittadini e contrastava i valori che alimentavano quei comportamenti. Gli articolisti si firmavano come Alberto Apocalisse o Claudio Memento Mori, e parlavano tranquillamente di fiamme dell’inferno e punizioni medievali. Oltre all’apparato intellettuale, il Giardino disponeva di un vero e proprio braccio armato, la Milizia di San Michele Arcangelo, che si occupava del lavoro sporco come azioni dimostrative o spedizioni punitive. In un primo momento, la presenza delle due associazioni filosofiche era passata inosservata, ma dopo qualche mese di attività, in particolare alcune iniziative di un certo richiamo (il Virtuoso Giardino aveva organizzato un ciclo di incontri sulla figura di Bonifacio VIII a cui avevano partecipato nomi di rilievo della politica e della cultura; il Circolo Spinoziano aveva avviato un cineforum sulla vita di filosofi e pensatori, dal Giordano Bruno di Montaldo al Galileo di Brecht), in città s’era cominciato a parlare del fenomeno come di un’insperata rinascita intellettuale. 102 Sul quotidiano locale erano apparsi articoli e reportage che raccontavano, con tono entusiastico, l’attività dei due circoli. Una volta c’era stato perfino un editoriale (“Platone pedemontano”), firmato dal Direttore, che aveva esaltato il fenomeno definendolo “un fermento culturale che dovrebbe esser preso ad esempio dall’intera nazione.” In questa atmosfera neoumanistica, le due associazioni avevano vissuto sparuti mesi di pacifica convivenza all’insegna del confronto aperto. A volte anche duro, ma sempre circoscritto alla dialettica intellettuale. Fino a quando, la sera dell’inaugurazione della nuova Biblioteca Civica – evento che cadeva a ridosso delle elezioni amministrative – tra il Circolo e il Giardino era scoppiata la guerra. L’inaugurazione si era svolta alla presenza di autorità locali, agenzie del territorio e associazioni culturali. Il Virtuoso Giardino e il Circolo Spinoziano avevano aderito in massa e ai presidenti delle due associazioni era stato chiesto di intervenire con un breve discorso. La serata trascorreva tranquillamente finché era salito sul palco Vittorio Cencini, presidente del Circolo Spinoziano. Già dalle prime parole, Cencini si era dimostrato pericolosamente caustico. Nel momento in cui aveva pronunciato la frase “senza lasciarsi inquinare l’intelletto da nebbie di irrazionalismo”, alcuni fischi si erano alzati dalla platea. Cencini non si era scomposto e aveva proseguito il discorso tornando su toni meno mordaci. Aveva elogiato apertamente l’amministrazione per la realizzazione del nuovo polo culturale e si era detto fiducioso che la nuova struttura sarebbe stata utile al risveglio delle coscienze dei cittadini. A un certo punto, però, non aveva saputo glissare sull’intitolazione della Biblioteca a Sant’Agostino. Gli pareva “una scelta inopportuna” poiché appariva come “l’ennesima in103 tromissione della religione nella società civile”. Mentre finiva la frase, una bordata di fischi – conditi di epiteti assai triviali – s’era levata dal fondo della sala. Cencini aveva atteso che la platea si ricomponesse e poi aveva esclamato che i crocefissi nelle scuole erano più che sufficienti e che era arrivato il momento di dare un taglio alle continue ingerenze del clero nella vita dello Stato italiano. Neanche a dirlo, era stato di nuovo coperto di insulti. Allora, con un sorriso tirato, il presidente era sceso dal palco e si era rifiutato di proseguire il discorso. Il giorno dopo, tra spinoziani e giardinieri, era scontro aperto. Il Foglio Spinoziano e Mistagogia avevano iniziato a scambiarsi articoli al vetriolo. Da una parte titoli come “Del perché Massimo il Confessore non amava l’essere umano”, dall’altra “Spinoza e il problema dell’omosessualità”. Lo scambio di opinioni si era fatto, numero dopo numero, sempre più feroce. Il foglio spinoziano – un sito che fino a quel momento si era distinto per studi filosofici di livello accademico, breviari di citazioni spinoziane per ogni evenienza e discussioni appassionate su ogni dogma di stampo spinoziano – da un giorno all’altro aveva visto il proprio forum passare dalla purissima dialettica… Dio è causa prima. Non esiste nulla che sia esterno a Dio e che possa essere causa delle cose. Quindi Dio è causa immanente e non transeunte. Ciò rimanda al fatto che la realtà è perfezione. … un forum in cui perfino gli auguri di Natale brillavano di razionalità… Un grande abbraccio di Buon Natale a tutti gli studiosi del pensiero del profondo e geniale Baruch Spinoza sen- 104 za la cui Opera tutte le nostre vite sarebbero prive di vera conoscenza. Tanti auguri a voi tutti sub specie aeternitatis. … a vere e proprie dichiarazioni di guerra… Spinoziani di tutto il mondo: uniamoci nella lotta al nemico cristiano. … e addirittura… Facciamogli il culo! Una volta che i confini della dialettica intellettuale erano stati varcati sulla carta, lo stesso era avvenuto anche nella vita reale: dapprima semplici scritte sui muri delle sedi (“Spinoza al rogo” – “Virtuosi, sì, ma del cazzo”), quindi lancio di pietre contro le finestre, infine tentativi di aggressione ai membri, quest’ultime solo da parte dei giardinieri. «È un racconto inquietante» disse Klaus, scuro in volto, «c’è da temere sul serio?» «Sinceramente sì. Sono fanatici. Credono di avere la verità in pugno, e questo li rende pericolosi, perché vedono il male ovunque non ci sia cristianesimo…» «Cosa mi consiglia di fare?» «Stare tranquillo e avere fede in Spinoza. Tenga, le lascio il Foglio Spinoziano». «Grazie, signor Ruopolo» concluse Klaus prima che l’altro si congedasse con troppe riverenze. 105 Ieri, per tutto il giorno, ero in preda a una strana eccitazione, una febbre elettrica che mi faceva vibrare il corpo come una corda. All’inizio ho pensato fosse per via delle vibrazioni del carrello che spingevo sull’asfalto, poi, quando sono salito in macchina, ho visto che le scosse continuavano e ho capito che la cosa veniva dal mio corpo. Ho sempre pagato in contanti (una piccola cifra estratta a dosi insospettabili dal bancomat nell’arco di due mesi). Ho inanellato, in poche ore, qualcosa come dieci spese mensili (questo è il tempo che mi sono dato). Una volta a casa, ho incastrato (non è stato facile) le decine di scatole, confezioni, barattoli, pacchetti, nell’ampio baule e sui sedili, compreso quello anteriore. Nel cuore della notte sono salito a Ridello. Non c’era nessuno e ho scaricato i viveri in tutta tranquillità, poi sono tornato a casa e ho dormito profondamente. Oggi mi sono svegliato alle nove e ho fatto le cose che faccio ogni mattina: ho bevuto una tazza di latte, mi sono fatto la barba ascoltando il giornale radio, mi sono seduto sul water e infine mi sono fatto la doccia. Nel pomeriggio, ho ripensato al Dottor Cacace. Chissà cosa penserà. Verso sera, ho schiacciato un pisolino. Ora sono le ventuno. Cerco di controllare il respiro, anche se non è facile. Sulla scrivania c’è il biglietto. Tra poco muoio. 106 Lo Zio sfogliava Il Foglio Spinoziano come fosse il dépliant pubblicitario di un supermercato. «Il prossimo numero parlerà del Prisma». «Wow». «Racconterà della minaccia alla libertà e offrirà ai lettori una visione oggettiva della situazione». Klaus sorseggiò il punch in attesa della reazione dello Zio. Erano al bar di sotto e, come al solito, Caterina ronzava attorno a Klaus arieggiandogli davanti i suoi boccoli profumati. Klaus la guardò: aveva occhi di un verde chiarissimo e le labbra polpose; gli zigomi erano alti e gli incisivi spessi e levigati. «Non mi piace per niente» esclamò lo Zio, lasciando cadere sul tavolo la rivista filosofica. «Cosa?» chiese Klaus. «Tutto». «Tutto cosa?» «’Sta rivista, i lillipuziani…» «Spinoziani. A me, invece, l’iniziativa del Foglio piace. Ci aiuteranno. Risponderanno colpo su colpo. Il Foglio e il Prisma alleati per la libertà». «Che stronzate, Klaus…» «Perché?» «Non possono farsi i cazzi loro?» Si erano sentiti nel pomeriggio e Klaus gli aveva raccontato dell’incontro con Ruopolo la sera precedente. Lo Zio, che dal giorno del pacco regalo non si scrollava di dosso una certa ap107 prensione, s’era limitato a ridacchiare nervosamente. Poi aveva acceso il computer e aveva constatato che in città c’erano davvero delle associazioni così fuori di testa. Quanto erano lontani i tempi della sua infanzia, quando le persone si sprangavano per futili motivi calcistici o, al limite, per sterili questioni politiche? Cos’era successo alla sua città, alla sua terra, se oggi le persone si spaccavano la testa in nome di Platone o Aristotele? Per primo, era entrato nel sito del Giardino Virtuoso. Aveva profuso una discreta manciata di bestemmie nel leggere gli articoli che minacciavano il Prisma e i suoi proprietari. La segretaria era entrata nello studio chiedendo se andasse tutto bene e lo Zio le aveva risposto di sì continuando ugualmente a bestemmiare, ma con più contegno. Poi aveva dato un’occhiata al sito degli spinoziani e aveva provato un accesso di ira nei confronti di Klaus. Invece di chiamare la Polizia, quel coglione si era rivolto a un’allegra torma di sfibrati filosofi. Era senza speranza. «Tu sei matto. Non hai visto i siti? Non so se hai capito che questi sono invasati, gente che va in giro con la mazza nel baule» disse lo Zio guardando l’amico negli occhi. «E io non so se hai capito che dietro al Prisma e al suo fatturato c’è molto di più». Erano soli nel bar e le loro voci sovrastavano il volume della radio. «L’erotismo, l’amore, meno seghe per tutti… lo so, lo so che c’è qualcosa di più…» «Il Foglio e il Prisma difendono la libertà, capisci?» «Libertà è solo una parola, Klaus». «Sì, una parola da difendere. Dovresti provare a leggerlo Spinoza…» «Bisogna difendere le persone, non le parole». 108 Caterina, mentre sfogliava una rivista di moda dietro il bancone, alzò la testa e fece una smorfia di compassione. «Il Virtuoso Giardino del Confessore… ma Klaus… ti rendi conto?» «È la libertà, fratello». «La esalti tanto, ’sta libertà, e poi non lasci che le persone si facciano le pippe come vogliono». «Prima elevare, poi rendere liberi». «Prima rendere liberi, poi spaccare il culo. Ti ricordo la vaselina». «Sei catastrofista». «Sono invasati, Klaus. Vanno in giro…» «… con la mazza nel baule. Ho capito». «Cazzo, a che serve discutere? Ognuno si tenga le sue posizioni e morta lì». «Hai paura» riprese Klaus. «Sì, ho paura». «Dietro il Prisma c’è un’idea per l’umanità: ci tengo troppo». «Tu tieni a un’idea, io al mio culo». Caterina gli mise davanti un po’ di salatini e una focaccia tagliata a pezzi. Ci teneva a farsi notare da Klaus. «Perché frequenti quest’uomo?» disse rivolgendosi a Klaus. «È un buon avvocato. E ha lo studio sopra il tuo bar». Lei sorrise e poi disse allo Zio: «Ecco, vedi perché mi piace tanto il tuo amico?» «Paraculi si nasce» commentò lo Zio. «Per favore» incalzò lei, «spiegagli cosa vuol dire seduzione». «Non può capire…» rispose Klaus. «Dev’essere un mio limite strutturale» precisò lo Zio. «Il tuo limite è il posizionamento del cervello» disse Caterina allontanandosi a piccoli salti e canticchiando una canzone che impazzava da un mesetto in tv. 109 Klaus la guardò e sorrise mentre lo Zio si attorcigliava ai propri pensieri: sul sito del Giardino aveva visto una cosa che l’aveva colpito. Un approfondimento sul rock satanico. Un prete scriveva d’aver incontrato numerosi giovani che, a furia di ascoltare un certo tipo di musica, erano diventati degli squilibrati. A furia era scritto ha furia, ma al di là di questo, che comunque era indice di qualcosa, ciò che più l’aveva impressionato era la spiacevole sensazione di déjà vu: da quant’era che non sentiva qualcuno tirare fuori la storia dei Led Zeppelin satanici? La storia, abusata, che sul terzo album, vicino all’etichetta del disco, Jimmy Page aveva fatto incidere l’esiziale motto di Aleister Crowley? La storia, trita e ritrita, che ascoltando al contrario Stairway to heaven si poteva sentire una voce cavernosa invocare Satana? «Devo farti vedere una cosa» proruppe all’improvviso. Salutarono Caterina e salirono in ufficio. Il computer era ancora sul sito del Giardino Virtuoso. Il giovane, in un primo tempo, acquista i suoi compact disc e si appassiona alla sua musica. Ma poi sente il bisogno di saperne di più. Il secondo passo è la conoscenza dei testi delle canzoni e il conseguente approccio con una filosofia di vita trasgressiva. Il terzo stadio è l’acquisto, da parte del giovane, di riviste musicali che parlano del suo cantante preferito. A volte vengono persino segnalati indirizzi di sette sataniche o siti Internet di cantanti legati al mondo dell’occultismo. Così, entra nel quarto stadio: la ricerca in rete. Partendo dalla semplice curiosità per i siti Internet di cantanti di rock satanico si rischia, poi, di passare ad un interesse per le pagine di vere e proprie sette, oppure per i newsgroup (gruppi di discussione) frequentati da satanismi ed esoteristi. A questo punto, il gioco è fatto. Il quinto ed 110 ultimo stadio è il contatto diretto del giovane, attraverso l’email, con una setta o con qualche cultore di magia nera. Molti ragazzi praticano il satanismo come forma di trasgressione, che si può riassumere nel motto dei satanismi: Fai ciò che vuoi. Ovvero: l’uomo che si mette al posto di Dio e sceglie di soddisfare soltanto il proprio egoismo. In questa ricerca di una vita spericolata e senza regole si può individuare il grande fascino esercitato da certe dottrine su alcuni giovani, che spesso attraversano un momento di solitudine e di crisi personale. «Che ti dicevo?» disse Klaus «Lo vedi che dobbiamo lottare? Dobbiamo resistere! Vogliono rispedirci nel Medioevo». «Sono una manica di invasati, Klaus». «Quelli del Giardino sì, ma noi stiamo dalla parte del Bene!» «E girano con la mazza nel…» «La ragione è dalla nostra parte!» «Ma loro hanno la mazza nel…» I timori dello Zio non erano infondati. Nelle settimane successive, il Prisma fu colpito da una serie di incidenti che ne segnarono l’immagine e compromisero gli incassi. Le locandine dei film in programmazione venivano sistematicamente imbrattate da scritte offensive e minacce ai gestori e ai frequentatori del cinema. Anche le pareti dell’edificio venivano coperte di scritte come “questa è la casa del diavolo” o insudiciate da disegni osceni. Un martedì sera, a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Una lussuria tutt’altro che passeggera, un ragazzo si alzò dalla poltroncina, avanzò fino allo schermo, si denudò davanti a tutti e, pronunciando frasi blasfeme, cercò di accoppiarsi con un vec111 chietto in prima fila. Pochi istanti dopo, due Carabinieri facevano irruzione nella sala e lo trascinavano via. Il mattino seguente tutti i quotidiani locali davano risalto all’avvenimento e alle parole del vescovo che tuonava contro quel luogo di perdizione. “Ecco la fine che faranno i nostri ragazzi!” vaticinavano gli occhielli. Il clima cominciò a cambiare e, man mano che i giorni passavano, il Prisma perdeva spettatori. Klaus si giocò la carta Russ Meyer, ma le cose non andarono come sperato. Arrivò anche un inaspettato controllo dell’ASL che rilevò una serie di piccole violazioni delle norme igienico-sanitarie obbligando il Prisma a chiudere i battenti per una settimana. Intanto, dalle colonne di Mistagogia piovevano scritti apocalittici che attribuivano al Prisma il decadimento morale della città. Gli articoli più feroci erano corredati di statistiche che mostravano il vertiginoso aumento degli stupri in città da quando il Prisma era stato riaperto. Il sito riportava un’intervista anonima a un uomo che si dichiarava assiduo frequentatore della sala e, guarda caso, agguerrito maniaco sessuale. La curia organizzò un corso, tenuto da un frate esorcista, per guarire dalla dipendenza sessuale. Un noto intellettuale conservatore parlò del Prisma in un importante talk-show nazionale dichiarando che la riapertura di un cinema a luci rosse avrebbe presto riportato l’Italia ai terribili anni settanta: le Brigate Rosse, il DDT e le P38 erano dietro l’angolo. L’apice della contestazione venne toccata nel corso della manifestazione che gli attivisti del Giardino Virtuoso organizzarono davanti all’ingresso del cinema. Una trentina di persone che, con fischietti, cori e cartelli, infastidivano i pochi spettatori rimasti invocando la moralizzazione, la responsabilità, la salvazione. Porta112 vano una maschera anti-gas e urlavano slogan tipo “Ripuliamo la città dagli zozzoni”. Quella sera, lo Zio aprì la portiera e se li trovò praticamente dentro la macchina. «CASTRAZIONE CHIMICA! CASTRAZIONE CHIMICA!» gli urlava uno nelle orecchie. La reazione dello Zio fu istintiva: una testata sul naso e lo sbatté a terra. «Vuoi provare quella manuale?» gli urlò strizzandogli la patta dei jeans. E proprio mentre stava per sferrargli un pugno in faccia, una mano lo trattenne. «Non commetta spropositi». «Chi cazzo sei?» «Sono Ruopolo. Il signor Jäger dovrebbe avergli parlato di me». Si allontanarono di corsa. Un attimo dopo, erano nascosti dietro un portone. L’uomo continuava a stringergli la mano con forza insospettabile. «È avvocato. Dovrebbe conoscere i rischi che corre aggredendo un uomo…» gli disse, col fiato rotto dalla corsa. Lo Zio detestava quella frase. Era ancora carico di adrenalina e fu sul punto di mollarlo a lui il pugno che gli avanzava. «D’accordo. Mi lasci la mano, adesso…» «Non deve reagire alle loro provocazioni. È esattamente quello che vogliono». «Ha ragione. Adesso, però, mi lasci la mano». «Mi ascolti bene: ero venuto al Prisma per una cosa molto importante, ma a questo punto è meglio rimandare, è meglio non tornare là». Gli lasciò la mano. Lo zio si sistemò il colletto della giacca e sputò per terra. 113 «La aspetto più tardi col signor Jäger al Circolo Spinoziano. Ho delle rivelazioni da farvi. Ora vada. Ma non torni al Prisma o qualcuno la concerà per le feste». “Testa di cazzo” pensò lo Zio massaggiandosi la mano. “Lei è un avvocato… dovrebbe sapere… ma vaffanculo!” Si lasciò inghiottire dal buio di una viuzza che scendeva verso il centro. Nell’aria c’era puzza di cipolla e dalle case usciva il bagliore delle televisioni. Si accese una sigaretta, masticò qualche bestemmia e una cinquantina di metri più avanti sbucò in una via piena di locali. Rallentò il passo e cercò di allontanare la rabbia concentrandosi su quello che vedeva. Un paio di ragazze, intabarrate da capo a piedi, chiacchieravano fumando. Un motorino gli sfilò accanto lentamente saturando l’aria di miscela. I pensieri gli entravano e uscivano dalla testa come api da un alveare. Erano pensieri rapidi, procedevano per associazioni e faticava a stargli dietro. Non era una persona che viveva per difendere le parole, tanto meno parole come libertà o moralità. Al massimo, poteva difendere parole come heavy metal o Jack Daniels, ma anche su questo nutriva qualche dubbio. Klaus e i suoi amici filosofi sapevano difenderle, le parole, con raziocinio ed eleganza, con argomentazioni e intelletto. Lui no. Lui finiva che la risolveva a pugni. Lui, il raziocinio ce lo metteva tutto in tribunale, poi non voleva più saperne. Non poteva credere negli ideali. Non poteva credere nelle parole. 114 Su parole date e non mantenute, lui ci campava. Era una persona che, all’età in cui suo padre era entrato nella cinquina per la miglior interpretazione di “uomo”, non aveva ancora letto il copione. Suo padre tirava su la casa, metteva al mondo dei figli, li amava, li cresceva, li proteggeva. Lui viveva in affitto, non aveva neanche un gatto da amare e spendeva metà del fatturato andando a puttane. Entrò in un bar e ordinò una birra. Tutti guardavano una partita. C’era un clima allegro e leggero. Lo Zio invidiò quegli uomini. Vivevano la propria storia senza caricarla di significati estremi, senza gravarla di ossessioni. Né le ossessioni di Klaus, l’uomo che sussurrava ai filosofi, né le sue ossessioni, l’uomo che doveva ancora diventare un uomo. Vivevano nella periferia, lontani dal grande centro delle ideologie, dei significati, delle battaglie culturali, ed erano liberi. Era il mondo in cui si riconosceva, anche se non aveva mai avuto la forza di farne parte. Portò il boccale alla bocca e sentì la tensione allentare la morsa. Gli arrivò un sms. Era suo fratello che chiedeva notizie. Non rispose. Sapeva che rispondergli significava prestare il fianco a una richiesta d’aiuto. Spesso si trattava di fare da baby-sitter al nipote. Suo fratello lo stava trattando come una merda, il figlio. Si era separato, aveva voluto tenerlo, e adesso lo trattava come una merda. La barista gli chiese se la birra andava bene, e lui rispose di sì. Aveva un bel sorriso, ma non rimase a guardarlo per più di dieci minuti. Un paio d’ore dopo, Klaus e lo Zio entravano nella sede del Circolo, un vecchio capannone in zona industriale donato all’as115 sociazione da un filantropo spinoziano. Ruopolo li accolse con un’espressione in viso che palesava tutto il suo orgoglio di riceverli. L’edificio era austero solo all’esterno. Entrando, si andava verso un ambiente caldo e accogliente che, nonostante uno stile estremamente minimale, creava un’atmosfera piacevole: colori alle pareti, scelta delle luci e numerose installazioni artistiche… una via di mezzo tra un centro sociale romano e un lounge bar di Milano Marittima. Nell’ingresso svettava una statua bronzea di Baruch Spinoza nell’atto di forgiare delle lenti. Nei corridoi, scaffali pieni di libri. Ruopolo spiegò che l’idea degli spinoziani era quella di accogliere i visitatori con la luce della ragione. Il soffitto della sala d’ingresso era impreziosito da un affresco neoclassicheggiante, un affresco simbolico che rappresentava il percorso del sole trainato dal carro di Apollo. Proprio nella sfera del sole, più o meno al centro dell’affresco, spiccava uno schema: Sforzo di autoconservazione (appetito, cupidità) Letizia------------------------------------------------Tristezza Bene Male Tutti gli altri affetti In fondo all’atrio – nell’unico spazio della stanza privo di libri – partiva una scala che portava al secondo piano, un lungo, largo e luminoso corridoio alle cui pareti erano appese decine di ri116 produzioni del filosofo, alcune in versione Wharol, altre Schifano. A destra e a sinistra del corridoio, s’aprivano numerose stanze. «È una sera particolare: stiamo festeggiando l’anniversario dell’Ethica ordine geometrico demonstrata e abbiamo diverse iniziative in corso» disse Ruopolo raggiante. In effetti, si sentivano voci e i rumori di un ambiente vivo e partecipato. «Cerchiamo di sviluppare percorsi conoscitivi che rispettino il cammino spinoziano: la conoscenza – dapprima confusa – inizia come immaginazione, prosegue come conoscenza razionale e diventa infine scienza intuitiva, ovvero conoscenza adeguata degli attributi e dei modi divini. Su questa scala imbastiamo la nostra proposta culturale». «Interessante» fece Klaus, «e questa conoscenza “confusa”, legata all’immaginazione, non potrebbe sfruttare il cinema?» «È una prospettiva estremamente allettante!» rispose Ruopolo. Lo Zio li guardava inorridito. Ruopolo li guidò lungo il corridoio del secondo piano parlando della libertà spinoziana e del suo significato. In particolare, esaltava gli spinoziani perché lontanissimi dal praticare la libertà in senso libertino. «Difendiamo una cosa preziosa ma poi non ne abusiamo, perché altrimenti perderebbe di valore». Lo Zio avrebbe voluto dire che difendere una cosa preziosa per poi non abusarne fino alla nausea gli sembrava una cosa stupida, ma si trattenne. Klaus, invece, era completamente rapito: il suo sguardo curiosava tra le stanze del Circolo come quello di un bambino in una scatola di mattoncini Lego. «Chi sono i frequentatori del Circolo?» chiese a Ruopolo. 117 «C’è di tutto: dallo studente di filosofia all’impiegato delle poste. La nostra forza sono i contenuti spinoziani e la loro trasversalità». Nell’Aula della Res Cogitans, il dottor Spaziani e alcuni soci discutevano sull’assenza della libertà nel campo della ricerca genetica. «Siamo una civiltà medievale. Abbiamo, per gli esperimenti scientifici, la stessa paura di un uomo del Pliocene!» «E pensare che il mondo intero non fa altro che allontanare lo spettro della morte, prolungare la durata della vita… non so… tutte quelle cazzate sul confronto età reale/età biologia, e poi non c’è libertà di sperimentare!» Nell’Aula della Res Extensa era in corso una lezione sul rapporto tra neuroscienze e filosofia. Il relatore, uno spinoziano che insegnava scienza della filosofia all’università di Zurigo, parlava dell’impossibilità di ricondurre tutto a livello neuronale trattando di coscienza. Una ventina di persone, la maggior parte giovani, l’ascoltava con grande interesse. «Spero comprendiate che affidare tutto all’interpretazione neuronale sarebbe come tentare di descrivere la complessa organizzazione di un formicaio soltanto nei termini dell’anatomia delle singole formiche…» Attraversarono l’Aula Deus sive natura, una sorta di ristorante autogestito dove, tra un piatto e l’altro, i commensali conversavano serenamente. C’era odore di bollito e il clima era un po’ formale. Salutarono Ruopolo e gli indicarono una caffettiera. In un angolo della stanza era appeso un televisore. Era spento e allo Zio, per antitesi, tornò in mente il clima del bar. Arrivarono in una saletta dove, attorno a un tavolo rotondo, c’era una mezza dozzina di persone immerse in un silenzio assorto. La sala era spoglia e anonima come una sala di un vecchio ora118 torio, completamente avulsa dal resto della struttura. Klaus e lo Zio vennero presentati a quelli che dovevano essere i membri più eminenti del Circolo e presero posto mentre Ruopolo chiedeva se gradivano un caffè. «E così avete fatto la conoscenza del Giardino» disse uno degli spinoziani, un ragazzo di vent’anni con basette lunghissime e occhiali spessi un dito. «Il grande filosofo verrà in vostro aiuto, vedrete». «Avete della grappa?» chiese lo Zio, mescolando lo zucchero nel caffè. «Eh eh…» fece Ruopolo «ricordate, signor Jäger, cosa vi dicevo? Ricordate i miei avvertimenti? Adesso avrete capito con chi avete a che fare… quella è gente capace di tutto… eh eh…» «Il signor Ruopolo ride sempre» sorrise Klaus, guardando in un punto imprecisato della sala. «… gente capace di tutto…» ripeté Ruopolo a denti stretti. «La sottile violenza con cui vi hanno prima intimidito e poi minacciato» esclamò il ragazzo con gli occhiali «esprime appieno la loro mentalità illiberale. Sono contro la libertà! Sono figli dell’Idolatria!» Alle parole “sottile violenza” lo Zio era trasalito e aveva mugugnato parole incomprensibili, probabilmente una bestemmia piuttosto articolata. «Tutto il casino che hanno fatto ci ha dimezzato il fatturato…» disse Klaus. «Stasera erano proprio in tanti…» affermò Ruopolo, ancora in piedi. «C’è della grappa?» chiese di nuovo lo Zio. Una donna – l’unica presente – si alzò e sgusciò fuori dalla stanza. «Oltre a essere illiberali, sono dei superficiali pazzeschi. Hanno preso il peggio di quel personaggio storico» sentenziò Ruopo119 lo che, nel frattempo, aveva preso il posto della donna. «Di Massimo Confessore hanno colto solo gli aspetti inquisitori, tralasciando completamente tutte le sfumature del suo pensiero. Si sono tenuti solo la violenza! Quella gente non l’ha nemmeno letto, Massimo Confessore…» «Non hanno mai aperto un libro, quei pezzenti!» esclamò con enfasi il ragazzo dai fondi di bottiglia. «Tu ne hai letti troppi…» sussurrò lo Zio. «Come?» chiese il ragazzo. Lo Zio gli mimò le lenti degli occhiali. «Quella gente mina la libertà degli individui e s’affaccia con violenza sulla realtà sociale» riprese Ruopolo. Ogni volta che diceva “quella gente”, la sua voce assumeva un che di sprezzante. Faceva una piccola pausa per cercare l’assenso delle persone intorno. Era il leader e gli spinoziani avevano grande rispetto di lui. Due di loro, in particolare un paio di signori sulla cinquantina con l’aria da funzionari delle poste, annuivano e mugolavano d’approvazione a ogni sua frase. «Ci stanno andando giù pesante…» commentò Klaus che ormai si esprimeva a frasi fatte. Contrariamente alle sue aspettative, si sentiva sempre più a disagio. Cercava lo sguardo dello Zio senza trovarlo. Non capiva esattamente cosa ma c’era qualcosa che non andava. Forse era colpa dei presenti che non gli ispiravano la stessa fiducia che gli ispirava Ruopolo. In quel momento, la donna che prima era uscita rientrò con una bottiglietta di grappa in mano. S’avvicinò allo Zio e l’appoggiò sul tavolo a pochi centimetri dalla sua tazzina. «Ma ci vogliamo rendere conto» disse «che il Giardino Virtuoso, esattamente un anno fa, si è macchiato di un gesto… terribile?!» «Sì, racconta, Clara» fece Ruopolo, «racconta». 120 «Ma ci rendiamo conto?» «Raccontagli Clara!» «E racconta!» fece lo Zio. «Hanno malmenato dei ragazzi che erano usciti dal nostro circolo!» «Buona…» fece lo Zio assaporando la grappa. «Picchiano!» proseguì la donna «Capite? Picchiano le persone!» «Una volta ho difeso un tizio che picchiava i propri alunni» sorrise lo Zio. I due funzionari delle poste emisero un gemito di disapprovazione e iniziarono a parlare tra loro. Ruopolo li apostrofò riportando immediatamente il silenzio in sala. «Che ne pensa, Jäger, avevo ragione?» «Beh… certamente…» «Si esprima, Jäger …» insisté Ruopolo. «Esprimiti Jäger!» fece eco lo Zio. «Beh… la cosa che mi lascia incredulo» disse Klaus guardando nel vuoto «è la disparità di trattamento che riservano a casi praticamente uguali: da un lato l’accanimento nei nostri confronti, un piccolo cinema che propone intrattenimento di qualità…» «Ha ragione!» esclamò la donna guardandosi attorno e visibilmente eccitata «In tv c’è di peggio! È una vergogna!» «… dall’altro» continuò Klaus, «il silenzio nei confronti di un sexy-shop che sorge a pochi passi da una scuola elementare. Ci fosse un solo articolo di Mistagogia su quel sexy-shop!» «È vero! A pochi passi!» commentò la donna con la voce invasa dal pianto «Ma sa che io, quando vado a prendere i miei figli, non so proprio come fare? È che mi tocca! Posso solo passare di lì! È una vergogna!» «Signorina, mi scusi, da dove arriva la grappa?» 121 «Una vergogna!» «Non deve stupirsi» intervenne Ruopolo puntando il dito verso Klaus, «non c’è assolutamente nulla di che stupirsi. Eh eh… lo sa chi è il proprietario del sexy-shop?» «No». «Lo sa chi è?» «Le ho detto di no». «Si chiama Tommaso Tommasi». «Non mi dice nulla…» «Da dove arriva la grappa, signorina?» «Per forza non le dice nulla: apparentemente è un nome come un altro… eh eh…» «Apparentemente!» proruppe la donna con lo sguardo spiritato. «Abbiamo fatto delle ricerche…» Ci fu un attimo di silenzio, prolungato ad arte da Ruopolo. Sul volto dei due impiegati postali era apparso un sorrisetto perfido. «Stia a sentire cosa abbiamo scoperto. Questo Tommaso Tommasi è a capo di una società per azioni, la Crucifige 2000 s.p.a. che, attraverso un intrico di compartecipazioni e pacchetti azionari, è riconducibile nientemeno che alla curia vescovile, in particolare a una certa corrente della medesima…» «Non ci credo» disse Klaus. «… Comunione e Transazione, signor Jäger ». «Siete nella loro morsa!» saltò in piedi il ragazzo dai fondi di bottiglia. Ruopolo trattenne un attacco di rabbia e lo pregò di sedersi. Poi disse: «Eh eh… non finisce qui». «Non finisce qui» gli fece eco la donna mentre i funzionari postali annuivano. «Ricordate il ragazzo che si è denudato nel vostro cinema?» 122 «Eccome, ci hanno rotto le palle per una settimana» intervenne lo Zio. «Mi dite, per favore, di chi è la grappa? Ve lo sto chiedendo per favore». «La fa mio nonno» rispose la donna degnandolo per la prima volta di uno sguardo. «Avete approfondito la cosa?» chiese Ruopolo. «In che senso?» chiese Klaus. «Avete indagato?» «No. Su cosa avremmo dovuto indagare?» «L’abbiamo fatto noi» esclamò con tono severo Ruopolo. «E cosa avete scoperto?» chiese Klaus. «Il ragazzo è un attivista del Giardino. Non è stato nemmeno denunciato. La Polizia era d’accordo. È stata tutta una messa in scena per far clamore attorno al vostro esercizio…» «Mooolto clamore: i giornali ci hanno rotto i coglioni per una settimana…» intervenne di nuovo lo Zio che intanto era arrivato al terzo bicchiere. «Dobbiamo smascherarli!» strepitò sempre più eccitato Ruopolo. «A morte quei maledetti ignoranti!» urlò il ragazzo con gli occhiali spessi. «Devono chiudere quel sexy-shop!» sbraitò la donna con le lacrime agli occhi. «Mmmmmhh…» bofonchiarono i funzionari postali. «Prosit!» fece lo Zio ingollando un quarto bicchiere di grappa. Poi uscì dalla stanza. Un’ora più tardi, Klaus lo raggiungeva all’ingresso del Circolo. «Ce ne hai messo di tempo… avete steso un piano di battaglia?» fece lo Zio avviandosi verso l’auto. L’amico era sovrappensiero. 123 «Non mi avrete preso la Kamchatka, spero!» ironizzò lo Zio. «Sono affranto» disse Klaus. «Ah, cominci a pensarla come me rispetto agli spinoziani?» «Sono deluso, Zio…» «Dai troppa importanza a tutta ’sta storia: l’amore, l’erotismo, i filosofi… ma che ti frega?» «Forse, una volta tanto, hai ragione» sussurrò Klaus. «Allora approfitto per dirti cosa penso fino in fondo: Spinoziani e Giardinieri sono della stessa specie. Gente che si sciacqua la bocca coi loro bei filosofi, e Spinoza di qui e Cicciabomba di là, ma sotto sotto sono peggio degli ultrà. Ma l’hai visto quel tipo, là dentro, il “ragazzo”, e i due becchini?» «Sì… sono rimasto turbato». «Tutto qua? Sei rimasto turbato?» «Ne riparliamo Zio, adesso vado…» Lo zio lo guardò allontanarsi mestamente. Scosse la testa e sputò per terra. Poi salì in macchina, mise un cd dei Motley Crüe e andò dritto a puttane. Il mattino dopo, la targa della sua automobile – evidenziata dentro un cerchietto rosso – risaltava sull’homepage del Giardino Virtuoso. Tra un vaffanculo e l’altro, mentre aspettava una visita della Polizia locale, chiamò Klaus. Gli disse che usciva dalla società. Dal canto suo, Klaus gli comunicò che aveva appena venduto il Prisma. Un certo Tommaso Tommasi gli aveva fatto un’offerta e lui non aveva saputo rifiutare. 124 Parte Seconda Il dado è tratto. Ettolitri di adrenalina evaporati in pochi minuti. Al suo posto ha fatto capolino il reflusso gastroesofageo. La mia coscienza è spenta. Non sento niente. Né bene né male. Se mi concentro, avverto qualcosa di pungente che spinge per uscire, come un urlo. Un urlo di sangue, forse di enzimi. Devo calmarmi. In fondo non ho ucciso nessuno, anche se la sensazione è esattamente quella. Quassù non si sta male. Fuori fa freddo e io ho quel che serve. Ho controllato che tutto sia a posto: che la casa sia chiusa ermeticamente, che le provviste siano sufficienti, che internet sia operativa, che la caldaia funzioni. Ho ripensato passo passo alla notte, al buio, la litoranea, il risucchio dell’enorme mulinello, la moto, la salita per le montagne… Nessuno mi ha visto, notato, riconosciuto. Mentre infilavo il casco, mi sono sentito protetto più che da un eventuale incidente. Mi sono allontanato dal luogo del delitto col cuore in gola. Ho guidato evitando le strade battute, per quanto a quell’ora non ci fosse nessuno. Ho ripassato mentalmente le risposte da dare in caso m’avessero fermato; ho aggredito la montagna pieno di energia; l’ho ri127 salita tornante dopo tornante; una volta arrivato al borgo ho capito che ce l’avevo fatta; furtivamente sono entrato nella viuzza che s’inerpica su per il monte e poi mi sono infilato, a motore spento, per il viale della villetta. 128 Le ore passano lente. Mi ci dovrò abituare. È questa la lentezza con cui dovrò convivere per non so quanto tempo. Oggi ho acceso la radio, poi il computer e mi sono connesso. Solo per distrarmi un po’, non m’aspettavo che qualcosa già si muovesse. Ci vorranno almeno un paio di giorni. Ho riletto un centinaio di siti col mio nome. Visitato altrettanti in cui non ero mai entrato. Sono sempre 2.300, come la prima volta. 129 Oggi è il terzo giorno. Mi sembra di star meglio. La paura di dover vivere in un ambiente chiuso sta lasciando il posto all’abitudine. L’attesa cresce e non penso ad altro. In mattinata ho rivisto un film di John Ford. Ho pranzato leggero, per evitare che mi venisse sonno. Non voglio cominciare a dormire il pomeriggio. Anche il vino lo bevo solo di sera. Devo darmi delle regole monastiche, altrimenti non resisterò a lungo. Fuori c’è un silenzio magnifico. Le poche abitazioni nei paraggi distano almeno un centinaio di metri. Contadini con qualche animale e operai che scendono ogni giorno a valle. Gente tranquilla, che non ficca il naso. In tutto il giorno avrò sentito passare sì e no una decina di auto. Di tanto in tanto, un cane abbaia e ho un sobbalzo – più di notte che di giorno – ma è normale che i cani abbaino. Nel pomeriggio ho letto qualche pagina di un vecchio saggio su Milton, ma avevo gli occhi pesanti e mi sono stancato presto. Sono entrato in rete (ogni volta che lo faccio sento l’elettricità nelle mani) e stavolta ho provato un po’ di delusione vedendo che non c’era niente di nuovo. Ho di nuovo trascorso un paio d’ore tra le mie 2.300 citazioni. 130 Ho ascoltato Fahrenheit. Niente. Tutto tace. Sicuramente i primi saranno loro. Chi inviteranno? Come imposteranno la trasmissione? Cosa diranno? Hanno parlato di Risorgimento. Hanno riesumato un vecchio libro di Carlo Levi. C’era Stefano Benni con la sua ultima… fatica… 131 Stanotte il cane ha latrato ininterrottamente fino all’alba. È normale che i cani abbaino tutta la notte? Ho due occhiaie spaventose. Mi sono alzato alle sette e mezza e ho sorseggiato un caffelatte. Non ho mangiato niente. Ho ascoltato il radiogiornale, ma senza troppa speranza, perché non è di primo mattino che arriverà la notizia. Ho gettato uno sguardo attraverso le imposte e ho intuito una giornata dai colori magnifici: per un attimo m’è venuta voglia di fare due passi, calpestare l’erba fresca, sedermi sotto un castagno, riempire i polmoni d’aria di montagna. Ho resistito. Ho acceso il computer e ho aperto l’home page dei principali quotidiani. Non c’era niente: solite scaramucce politiche e l’editoriale di un vecchio diplomatico convinto che i sistemi di Roosveelt possano tirarci fuori dalla crisi. Ho sfogliato il Faust. Ho trascorso il resto della mattina cercando di rilassarmi, prima guardando Ombre rosse, poi ascoltando musica classica allo stereo. Nel primo pomeriggio, ho lavato (a mano) gli indumenti intimi usati in questi giorni: far tornare il bianco è un’occupazione che continua a darmi equilibrio. Poi, saranno state le quattro di pomeriggio, è passata la cometa: passando davanti al computer in stand-by, è bastato sfiorare il mouse per vedere lo schermo riattivarsi. L’home-page era la stessa del mattino, ma nella colonna del sommario c’era qualcosa… 132 Ho sentito il cuore rallentare (era da settimane che mi chiedevo se questo momento avrebbe accelerato o rallentato le mie pulsazioni). Morto suicida lo scrittore Antonio Timpano. Ho letto e riletto. Morto suicida lo scrittore Antonio Timpano. Sì. Era vero. Ero morto. Ho scorso il sito in cerca dell’articolo, ma non sono stato capace di trovarlo. Mi sono alzato e ho acceso la radio. A Fahrenheit parlavano di urbanistica. Ho cercato su altre stazioni, ma c’era solo musica. Sono tornato al computer e di nuovo non mi è riuscito di andare oltre i sommari ed entrare nell’articolo vero e proprio. Ho riletto decine di volte Morto suicida lo scrittore Antonio Timpano. Ho provato a cambiare home-page. Ho aperto diversi quotidiani on-line, ma la notizia non c’era ancora. Ho chiuso tutto e sono ripartito da Google. Avevo memorizzato alcuni siti locali, in particolare quelli di cronaca locale, e li ho aperti. Ho aperto e chiuso decine di pagine. Quella mattina, intorno alle nove, un’auto in sosta vietata aveva insospettito due agenti della Polizia locale; questi avevano rimosso la vettura e avevano fatto scattare un’indagine; erano risaliti a me; avevano contattato la mia ex-moglie; in casa avevano trovato la mia lettera e tutto era sembrato chiaro. Ho atteso il giornale radio. Quello di Radio1 non mi ha nemmeno nominato; Radio2 ha dato la notizia senza commenti; Radio3 ha integrato la notizia con una 133 breve intervista a Piero Colaprico. Ha pronunciato due o tre banalità sul mio conto che, onestamente, mi aspettavo. Mi sono pentito di non avere in casa il televisore e sono tornato al computer. Poi hanno cominciato a spuntare notizie e commenti. Per cercare di dare un ordine logico ho deciso di seguire la gerarchia di Google, ma prima ho buttato giù un boccone perché non mi sentivo in forze. Sono tornato al monitor ancora col pane tra i denti. Ho aperto Google. Ho digitato il mio nome e ho premuto invio. Il miracolo si è materializzato in un attimo. Il primo miracolo della mia morte, ho pensato: in poche ore le pagine relative al sottoscritto erano diventate quasi 11.000. Undicimila! Senza leggere, solo passandole in rassegna, ho trascorso il resto della giornata. Ero eccitatissimo, ma lentamente, link dopo link, l’eccitazione ha lasciato il posto allo sconforto: ho realizzato che quell’ammasso di nuove pagine non erano altro che l’estenuante ripetizione della stessa notizia. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Undicimila volte. Quarantotto pagine per dire che Antonio Timpano era morto, suicida tra i flutti del lago di Lecco. Per il momento nessuno che lo piange, nessuno che lo rimpiange. Quarantotto pagine per dire la stessa cosa. 134 Col gelo addosso, mi sono detto che era meglio andare a letto, riposare, alzarmi presto l’indomani e attendere la vera reazione alla mia morte. Va bene la frustrazione iniziale, ma è indubbio che il piano stia riuscendo alla perfezione. 135 Oggi, invece, mi sono svegliato di pessimo umore. Ho cominciato a pensare che qualcosa non stia andando come dovrebbe. Comincia a sfuggirmi il senso di tutto questo, ma è una sensazione che ho allontanato mentre riaccendevo il computer. Ho digitato il mio nome su Google. Ho premuto invio. Dodicimila. Ho messo in ordine cronologico e ho aperto i venti link più recenti. Ripetevano solo la notizia della morte. Va bene. Sono morto. Grazie dell’informazione. Adesso che sono morto, mi mettete su Wikipedia? Sono entrato in Wikipedia. Non c’ero. Mi è passata la voglia di leggere. Ho spento il computer e sono tornato a letto. Mi sono alzato poco fa. Ora sono le diciotto. Dovrei scrivere qualcosa, registrare le mie sensazioni, ma non mi viene nulla. 136 Stamattina, mentre fuori pioveva, ho fatto il conto dei giorni da cui sono qui: trenta. Sono morto da un mese e non c’è traccia della mia resurrezione. Le acque di Google ristagnano morte e io sono fermo a 12.000 da settimane. Antonio Timpano è morto suicida tra le acque del lago di Lecco. Ho provato anche con altri motori di ricerca, ma i numeri sono ancora più bassi. Wikipedia si disinteressa di me. Ho due pensieri che non mi lasciano in pace. Il primo è che ho fallito: la mia morte non ha riattivato nessuna attenzione nei miei riguardi. Il secondo è che dalla mia morte non nascerà nessun capolavoro della letteratura italiana: il diario che sto tenendo è una fogna. Forse il limite massimo di una clausura non vocazionale è proprio questo: un mese. I segni del mio rigetto claustrale sono evidenti: conto le piastrelle mentre cammino, classifico le sfumature di bianco delle pareti, smeriglio l’acciaio della cucina fino a consumarlo. La mancata reazione del mondo alla mia morte è un duro colpo. Se commenti, interventi e quant’altro si fossero moltiplicati sul web, io – ne sono certo – sarei rinato, mi sarei lasciato travolgere dall’attenzione che il mondo manifestava nei miei confronti. 137 Le mie emozioni sarebbero state trascinanti. Avrei riempito pagine e pagine di scrittura grandiosa, eterna. Invece… tutto si è spento. Nel giro di due giorni tutto si è fermato, la rete ha smesso di battere il mio nome. 138 Oggi ho pensato di entrare nel sito di Gianni per vedere cos’ha scritto della mia morte. C’era un ricordo del sottoscritto accorato e toccante. Uomo discreto e al contempo arrembante, mi definiva. Sulle prime mi è sembrata un’ottima cosa, poi, riflettendoci, ho scovato l’inghippo: si riferiva al Timpano uomo. Non c’era traccia dello scrittore, nelle sue parole. Poi mi sono perso nella contemplazione del suo sito. Ha tolto Malevič e messo immagini che non ho saputo identificare. Ci sono decine di post che gli arrivano da lettori di tutta Italia e di tutte le generazioni. Ha appena pubblicato un romanzo. Pare sia un successo colossale. Parla di uno psicopatico che si sente la reincarnazione di Chinaski (l’alter-ego di Bukowski) e ne prosegue la vita. Quando scopre che in rete ci sono decine di falsi Chinaski, persone che usano quel nome d’arte nei social network, esce di senno. Li contatta e li rapisce uno ad uno. Poi li tortura costringendoli a diventare dei veri Chinaski (litri di alcol fatti ingollare con l’imbuto) fino ad ucciderli. 139 Stanotte non ho resistito e sono uscito. È stato bellissimo. Mi sono intabarrato da capo a piedi, ho verificato che la luna non ci fosse, ho atteso che fossero le tre, mi sono affacciato alla porta, ho teso bene le orecchie e sono uscito. Il buio della notte mi è parso il più bel regalo che mi si potesse fare: l’ho attraversato a lunghi passi, prima in un prato, poi sulla carreggiata della stradina che scende al paese. Ho ringraziato la notte e ho parlato a lungo con lei e, quando lei mi ha chiesto il nome, le ho risposto Novalis. All’inizio credevo mi sarei diretto verso il bosco, invece, non so perché, l’asfalto mi ha attratto di più. Sono sceso per una buona mezz’ora, ovviamente senza incontrare anima viva, poi, quasi senza fermarmi, invaso per un istante da un incontrollabile stato d’ansia, ho girato i tacchi e sono risalito di corsa, sempre riparato dalle ombre profonde della notte. Quando sono rientrato in casa, pur spossato e in un bagno di sudore, mi sono sentito bene: la fioca luce della cucina che negli ultimi giorni stava emanando esalazioni funebri, mi è parsa una stella luminosa. I polmoni come rigenerati. Ho aperto il frigo e mi sono messo a sgranocchiare pane e formaggio. La mente, libera come non era da giorni, ha prodotto pensieri positivi: devo resistere. Sono qui per scrivere un libro, un libro che parla della mia morte e della mia resurrezione. Poi, mi sono fatto una doccia e ho perfino canticchiato un po’. Per celebrare quel bellissimo momento ho aperto un libro, non un libro a caso, ma un mio libro, il mio primo libro. 140 Ne ho lette quaranta pagine trattenendo a fatica le lacrime. Che grande scrittore che sono! 141 Dopo tre anni di PROGETTO, Ostilio era ancora un menonovanta. Certo non un buon segno per quello che, sulla carta, doveva essere il suo avvenire. Il Rettore, quando parlava di lui coi colleghi, non esitava a definirlo “uno per cui è inutile sprecare energie”. Col padre, ovviamente, era meno categorico e nei lunghi monologhi che teneva dalla sua scrivania lasciava intuire qualche remota possibilità di redenzione: in fondo, Ostilio aveva solo sedici anni, era dotato di discreta intelligenza e di una buona competenza relazionale; insomma, ci si poteva lavorare… In realtà, Augusto sapeva che Ostilio non era uno facile da piegare, anzi, in alcuni momenti, sembrava proprio che il Franti sortisse su di lui l’effetto opposto, che l’Istituto stesse contribuendo a forgiare un futuro criminale. Il Rettore s’interrogava spesso sul fallimento di alcuni percorsi rieducativi, e solo attingendo all’ipocrisia riusciva a ridimensionare la frustrazione. Bestie come Ostilio, Augusto le teneva volentieri: la loro presenza spingeva la massa collegiale a credere nell’istituzione e nella pervicacia delle sue regole. Inoltre, la possibilità di comminare punizioni esemplari era un monito per tutti. Mediamente Ostilio visitava le lerce mura della guardina (una vera e propria cella di isolamento) dalle due alle quattro volte al mese. Ne usciva sempre più cattivo, più abietto, sempre più convinto della propria predestinazione. L’aveva anche scritto in un compito di storia sul calvinismo: “Santodio: questo scienziato sviz142 zero aveva proprio ragione: Dio decide prima ancora che noi nasciamo. Decide come saremo, dove andremo, cosa faremo. Se io, ad esempio, santodio, sono un infame di merda, è perché io sono stato predestinato a esserlo e non potrò mai cambiare questo mio destino. È già tutto scritto, anche una piccola cosa, anche che ieri ho rotto il naso a Piersanti o che domani manderò affanculo Prepuzio Solitario. Un mio amico diceva che il destino è una discesa. A me sembra poco: il destino è un salto dall’aereo senza paracadute, santodio. Cioè, all’inizio, i primi anni santodio, pensi di avercelo, sto cazzo di paracadute, perché tutti ti dicono puoi cambiare puoi migliorare puoi crescere insomma, poi col passare del tempo capisci che sulle spalle non ci hai un cazzo di paracadute, nemmeno un cazzo di ombrellino, e allora non puoi far altro che precipitare giù, fino in fondo. E atterri come atterri, santodio”. Quando rientrava in camerata, dopo una gita in guardina, ad accoglierlo c’era sempre un boato che i guardiani faticavano a sopire. I primi passi erano accompagnati da una canzoncina, intonata dai fedelissimi, che inneggiava alle sue imprese più celebri, poi, man mano che Ostilio procedeva fra i letti, i ragazzi s’avvicinavano ad occhi sgranati, lo abbracciavano, si complimentavano in un crescendo d’approvazione divinizzante. «Quanto sono stato dentro?» domandava sprezzante. «Dieci ore, Ostilio». «Sono volate». Ogni vacanza in guardina provocava eventi che seguivano uno schema fisso: prima le voci relative alla causa della punizione (raramente Ostilio era protagonista di cose eclatanti, si trattava in genere di traffici loschi all’esterno del collegio), poi i commenti 143 sulla sua reazione (talvolta si lasciava prendere dall’ira e minacciava il Rettore), quindi i pronostici sulla durata della punizione. Infine il rientro, vittorioso, tra due ali di folla festante. Greco e Paco, i fedeli scudieri, riuscivano sempre a raccogliere notizie veritiere e ingigantivano le sue imprese con epos degni della miglior tradizione ellenica. “Ha detto lei è una merda d’uomo in faccia al Rettore!” oppure: “L’ha fatta troppo grossa. Stavolta lo tengono dentro una settimana!” Di solito, dopo aver attraversato il dormitorio tra la folla in tripudio, Ostilio non si fermava al suo letto e tirava dritto fino ai gabinetti, apriva l’armadietto, si spalmava di schiuma da barba e si radeva. Quello gli restituiva il senso della vita reale e permetteva di prolungare il piacere dell’acclamazione. Poi tornava indietro camminando fra le mani protese dei suoi adepti che gli porgevano un pacchetto di sigarette o una manciata di biscotti. Sul letto, Paco e Greco gli avevano preparato sempre una bottiglietta di liquore (andava matto per il Bourbon) o qualcosa di serio da fumare. Era un ragazzotto alto e ben piantato, muscoli definiti, i capelli irsuti e fulvi tagliati a spazzola, la mascella volitiva, una lunga cicatrice intagliata sul collo. I tratti del viso erano irregolari e aveva uno sguardo impassibile che metteva a disagio chiunque; rideva poco e le rare espressioni del viso passavano attraverso gli occhi mentre la bocca era una fessura solo per cibo, aria e bestemmie. Sull’avambraccio sinistro aveva tatuato un magnifico cavaliere medievale nell’atto di decapitare un drago. Sulla spada del cavaliere erano incise le lettere del suo nome. Di tanto in tanto (anche d’inverno, perché Ostilio viveva a mezze maniche) capitava che qualche matricola s’avvicinasse a osservare il tatuaggio e manifestasse stupore per la bellezza del drago. 144 «Non vedi che sto per mozzargli la testa, al tuo drago del cazzo?» precisava Ostilio. I suoi parenti, contadini della bassa pianura, si materializzavano un paio di volte l’anno. Quando il clan (zii zie cugini cugine nipoti pronipoti) veniva a trovarlo, nel collegio era festa grande per via degli approvvigionamenti che portavano in dono. La madre non c’era più. Alcuni dicevano fosse morta; altri pazza e segregata in manicomio. Il padre era un uomo minuscolo, segaligno e taciturno, forse uno degli ultimi contadini italiani con le mani usurate dagli attrezzi (e la puzza di sterco attaccata addosso). Aveva mandato il figlio in collegio su consiglio dei Carabinieri: a tredici anni il piccolo (che già aveva la forza di un toro) rubava motorini, trangugiava alcol, cavalcava prostitute che neanche pagava. Un giorno sì e uno no, un appuntato dell’Arma glielo riportava a casa pregandolo di starci più attento. «Se non è in grado di occuparsene, trovi qualcuno che lo sia» gli ripetevano. Allora il padre, racimolati i risparmi di una vita, l’aveva abbracciato e l’aveva spedito lì. Come Ostilio, anche Dave era finito al Franti per decisione paterna. Una sera, dopo una sconfitta nel derby, il signor Patusso s’era alzato dal divano, aveva spento la tv, era entrato in cucina e, dopo dodici anni di completo disinteresse, aveva fatto irruzione nell’educazione del figlio. «Dave va in collegio» erano state le sue parole. Era stanco di dar retta alla moglie, di lasciare che la sua improduttiva dolcezza rovinasse il figlio. Dave non aveva bisogno di essere ascoltato, non aveva bisogno d’amore, non aveva bisogno di 145 contratti formativi. Dave aveva bisogno di disciplina, di scudisciate che sanzionassero ogni suo sbaglio. La moglie l’aveva guardato senza fiatare, abbassando lo sguardo ogni volta che la voce del marito si alzava. Aspettava quel momento da anni, dalle prime volte che s’era interrogata sul futuro di quello strano bambino che usava i Lego per spiegare la globalizzazione del mondo o vedeva serpenti strisciare per casa, quel bambino che non aveva amici, che aspettava le balene lungo il fiume, che prima di entrare in chiesa domandava se tra Gesù e Buddha ci fosse almeno stima reciproca, quel bambino che non piangeva, non rideva, non s’innamorava, che non giocava a pallone, che non navigava in internet, che non reggeva la vista degli spaghetti, che soffriva d’insonnia, che beveva solo chinotto, che cantava le canzoni di Tenco e si faceva tagliare i capelli da un ottuagenario mezzo cieco in una casa di riposo. Quel momento era arrivato, ed era arrivato – lei lo sapeva – più per espellere l’anomalia di casa che per un serio interesse. Più per nausea o vergogna che per amore. «Va bene» aveva detto lei, «ma te ne occupi tu». E il signor Patusso se n’era occupato. Aveva preso contatto, inviato i documenti, fissato un appuntamento e pochi giorni più tardi era andato all’incontro d’inserimento. Augusto gli aveva chiesto perché voleva che suo figlio entrasse al Franti. «Io faccio il piastrellista» aveva risposto lui, continuando ad asciugarsi compulsivamente il sudore delle mani sui pantaloni. «Io amo le piastrelle. Sono perfette. S’incastrano benissimo l’una con l’altra. Mio figlio dev’essere così». «Ah» aveva commentato Augusto e, non senza imbarazzo, aveva attaccato la nenia delle finalità e dei metodi del collegio. Al termine del colloquio, il signor Patusso aveva chiesto di vedere la cel146 la di punizione. Augusto aveva acconsentito a patto di sapere se la madre del bambino fosse o meno d’accordo sull’inserimento di Dave nell’Istituto. «Mia moglie ha deciso per dodici anni e non ha cavato un cazzo di ragno dal buco» aveva risposto Patusso. «Ora, se permette, decido io». Alcuni minuti dopo, Augusto aveva deciso di prendere il ragazzino. Nessun proponimento salvifico albergava nel suo animo. L’aveva preso semplicemente perché l’uomo – quel troglodita – estasiato di fronte alla guardina, aveva esclamato: «Lei è un genio!» e Augusto, quanto a complimenti, era insaziabile e fatalmente cedevole. Infine, mentre l’accompagnava all’uscita lungo un corridoio scandito dai busti di celebri illuministi, Patusso l’aveva fermato e gli aveva raccomandato di essere “il più possibile di destra”, perché di destra aveva bisogno quella gioventù degenere e di destra aveva bisogno questa umanità senza controllo. Augusto, cercando di non fissargli gli occhi bovini, aveva risposto che la sana educazione non era né di destra né di sinistra. «Ma questi personaggi sono di destra, vero?» «Mmmhh…» aveva tentennato Augusto «diciamo che appartengono a un’epoca precedente le nostre categorie di classificazione politica». «Cosa dice?» l’aveva incalzato Patusso «Se è possibile stabilire perfino se Giulio Cesare era di destra o di sinistra! Mi vuole far credere che non si può dirlo di questa gente del… cos’è… Milleotto?”» «Millesette». «Appunto! È tutta gente di destra, questa, vero?» «Sono illuministi, signor Patusso. Illuministi». 147 Mentre tornava dentro, Augusto si era sentito osservato dalle effigi di quei grandi pensatori: Diderot, Montesquieu, D’Alembert, perfino Helvétius e D’Holbach, tutti lo fissavano con uno sguardo altero. Rousseau, più di tutti, lo guardava torvo, con una severità che – lo capiva benissimo – stava a significare qualcosa tipo “Dove cazzo sei finito, Augusto? Torna in te e scappa via da questo cesso”. A quel punto, aveva cercato di affrettare il passo e aveva percorso gli ultimi metri del corridoio quasi di corsa. 148 La sera in cui Nic e Dave s’incrociarono in refettorio era un tiepido inizio di settembre. Era la terza sera che passavano al Franti, ma fino a quel momento non si erano incrociati o riconosciuti. Gli ultimi bagliori del giorno si spegnevano sulle Prealpi, le voci dei ragazzi schizzavano acute e fuori controllo per l’eccitazione, il fumo della pasta al pomodoro saliva dall’enorme pentolone ammaccato spargendo per il refettorio un odore acido. «Ma tu non sei… quello delle balene?» «Nic!» «Cosa ci fai qua?» «Boh. E tu?» «Dislessia». «Cioè?» Si sedettero e si raccontarono di come erano finiti lì. Poi rievocarono il fiume. Per Nic il ricordo era vivo e ancora doloroso, perché pescare era stata per anni la sua passione, mentre per Dave sembrava tutto sbiadito e lontano, come se l’attesa della balena fosse ormai il sogno di una stagione finita. Quando si furono raccontati tutto, ascoltarono i discorsi degli altri, perlopiù impressioni sui guardiani o sulla geografia del Franti. «Come ti trovi?» chiese Nic, versandosi un bicchiere d’acqua. «Una prigione fatta e finita, nelle fattezze e nelle frequentazioni». «Cioè?» 149 «Hai visto che gentaglia qui dentro?» Nic alzò la testa e si guardò in giro. «C’è anche qualcuno simpatico». «Bisogna intendersi su cosa vuol dire “simpatico”. Hai visto quel tipo con l’orecchino sulla lingua?» «Il piercing». «Lo conosci?» «Chi?» «´Sto Piercing». «Non è il nome…» «Ah… beh, sarà un menonovanta… come minimo… guarda che faccia! Tu che Indice hai?» «Menodieci». «Come me. Dici che ce n’è ancora di pasta?» Al termine della cena andarono insieme in Aula Magna, dove il Rettore avrebbe tenuto la Prolusione di Inizio Anno. Era un momento ufficiale a cui il Rettore teneva particolarmente. Lo faceva sentire il reggente di un’istituzione estremamente seria. Appena la sua pelata fece capolino in mezzo ai guardiani, l’Aula Magna piombò in un silenzio tombale. Il Rettore salutò i collegiali augurando un buon inizio anno, scolastico e lavorativo. «Soprattutto lavorativo» precisò. «Il lavoro nobilita l’uomo» aggiunse, poi, guardando fisso davanti a sé, come guidato da una forza superiore, «soprattutto l’uomo che non ha voglia di studiare». Spesso si chiedeva a quale dei grandi illuministi somigliasse di più. Era solito confrontare la propria biografia con le loro, e gli bastava scoprire d’aver un particolare in comune – il mese di nascita o cose del genere – per credere di poter emulare uno dei suoi idoli. 150 Era nato nel mese di Rousseau. Era alto come Kant. Aveva lo sguardo di D’Holbach. Quei momenti di autoillusione erano bilanciati da momenti di lucidità durante i quali si sollevavano irrisolvibili contraddizioni, come quella (illuminista della domenica) di essere a capo di un istituto che faceva uso di strumenti di tortura, o quella (illuminista un paio di palle) che la sua esaltazione del lavoro scaturiva essenzialmente da un profondo disprezzo per il volgo. La scuola del Franti aveva due indirizzi, uno tecnico e uno professionale. Per volere di Augusto, i corsi erano molto selettivi: gli insegnanti dovevano scremare il più possibile e indurre al lavoro manuale chi non era portato all’apprendimento. Veder scivolare un alunno dall’indirizzo tecnico a quello professionale era una delle massime gioie del Rettore. Le squadre di studio-lavoro erano l’ossatura della vita quotidiana del Franti. Erano formate da una decina di collegiali e alla guida di ciascuna c’era un educatore chiamato guardiano che si occupava dell’assolvimento dei doveri, del mantenimento dell’ordine e del rispetto delle regole. Le squadre si componevano ogni pomeriggio dopo il pranzo che seguiva la mattinata scolastica: intorno alle 14 tutti i collegiali si radunavano nel cortile esterno e si raccoglievano in piccoli gruppi davanti al proprio guardiano. Sotto la sua guida, si dirigevano verso il luogo di lavoro – un’aula studio o un laboratorio – e si metteva all’opera. La tipologia e la durata delle occupazioni si basava sull’Indice, la valutazione globale che veniva aggiornata mensilmente: per i menodieci la parte intellettuale arrivava ad occupare fino a tre quarti della giornata, per i menonovanta il rapporto era l’inver151 so. Chiaramente, la maggior parte dei collegiali era al di sopra del menosettanta e trascorreva gran parte del proprio tempo nell’officina meccanica, in falegnameria e in cementificio. «Il lavoro manuale è la maggiore opportunità che la società mette a vostra disposizione» proclamò Augusto, soddisfatto del silenzio sceso in sala. Nic e Dave lo ascoltavano irretiti, con la sensazione di essere parte di un grande animale che obbedisce al padrone. «Il lavoro manuale deve tornare al centro dell’Occidente, della sua cultura e della sua società. La civiltà occidentale s’è inebriata di terziario, s’è illusa di poter diventare, tutta quanta, un immenso Lussemburgo in cui tutti i cittadini si occupano di banche o intrattenimento! Un’illusione che ha disorientato l’Occidente e che sta mandando tutto in malora! Bisogna ricominciare a sporcarsi le mani di grasso, far scintillare i metalli, produrre quintali di segatura per asciugare tutta la merda del mondo! Bisogna ricominciare a mescolare cemento, a martellare chiodi, ad avvitare bulloni!» Il grande animale non respirava. Ascoltava immobile, nella semioscurità, il carisma del Rettore che si sbracciava in fondo alla sala, in mezzo al cordone dei guardiani. Nic si distrasse un attimo e guardò fuori. Di fronte a lui si ergeva l’imponente struttura del dormitorio, un’enorme colata di cemento appena scalfita da qualche terrazzo e sparute finestre. Da una di queste, in alto, più o meno al terzo piano, gli parve di vedere una luce. Nella camerata c’era qualcuno. «Vuoi i miei appunti?» «Su cos’è la verifica?» chiese Ostilio. «Tutta la rivoluzione francese». «Porc… ***». «Li ho presi bene». «Vaffanculo. Una verifica dopo tre giorni di scuola, cazzo». 152 La luce della lampada tagliava a metà il letto lasciandone una parte in penombra, s’infilava nel piccolo spogliatoio e illuminava le pareti su cui erano appesi dei poster. Le facce dei cantanti erano scure e cattive, i loro tatuaggi sembravano macchie di catrame mescolate dalle ali di un corvo. Intorno ai poster, sul tramezzo di legno laccato, si intravedevano disegni osceni scalpellati in profondità. «Sono quaranta pagine di manuale. Ti porto i miei appunti, dai». «Portami una Rothmans e lascia perdere i tuoi cazzo di appunti». Ostilio era sdraiato sul letto col libro di storia aperto sulla pancia. Lo vedeva salire e scendere insieme al suo respiro. Non c’era modo di prendere un voto più alto del tre, lo sapeva bene. Se avesse studiato tutta la notte, avrebbe preso un tre e mezzo, forse quattro, ma era fuori da ogni logica mettersi a studiare dopo tre giorni di scuola. Tutti li invocavano, gli appunti di Floriano, tranne lui. Floriano li vendeva a peso d’oro, mentre a lui li avrebbe regalati. Ostilio stava ripetendo il terzo anno di Istituto Tecnico. Quella mattina era stato interrogato in scienze e aveva racimolato un misero cinque e mezzo. Prima di trascrivere il voto sul libretto, il professore l’aveva guardato in faccia e gli aveva chiesto se aveva intenzione di farsi bocciare di nuovo. Ostilio aveva risposto che non avrebbe aperto libro per tutto l’anno e che i voti che avrebbe preso sarebbero stati frutto delle cose imparate l’anno precedente. Non era questo quella cazzo di cultura di cui i professori blateravano per ore? La cultura non era ciò che rimaneva quando si era dimenticato tutto? E allora? Valeva di più un suo cinque e mezzo senza aver aperto il libro o il nove preso da un cazzone che aveva studiato per una settimana intera? Se il mattino dopo la civiltà 153 fosse ricominciata da capo, mettiamo dopo una guerra nucleare, quale sapere sarebbe venuto più utile all’umanità? Il suo o quello del fottuto cazzone? «Tieni la Rothmans». «Bravo Flo… Quanti miliardi di ore hai studiato oggi?» «No…. poco… Sono stato attento in classe e adesso mi basta una rilettura degli appunti…» «Sono stato attento in classe» lo canzonò Ostilio, «è da quando sono nato che sento ipocrite teste di cazzo come te pronunciare questa frase… Sei una merda di ragazzo. Di questo passo diventerai una merda d’uomo. Lo sai?» «Sì». «Meno male». I due fumarono in silenzio, anche se Floriano avrebbe voluto parlare di mille cose, ad esempio di cosa sarebbe successo se li avessero beccati in quel momento. Trovarsi in classe Ostilio era stata una rivoluzione per la sua inquadratissima mente. Per dirne una: due giorni di Ostilio e aveva cominciato a fumare. Per dirne un’altra: stava fumando in dormitorio mentre tutti erano riuniti in Aula Magna ad ascoltare il discorso d’inaugurazione del Rettore. Verso la fine della sigaretta Floriano glielo chiese: «Ostilio… cosa ci fanno se ci beccano?» «Boh». «Ci mandano in cella?» «Può darsi». «…» «Al signorino l’idea non piaciue?» «Non ci sono mai stato…» «Puoi chiedere di portarciui il libro di storia». «Davvero?» 154 Ostilio non rispose. Per un attimo ebbe la tentazione di alzarsi, andare alla finestra, aprirla e mettersi a urlare, poi girarsi e guardare il terrore sulla faccia di Floriano. Sorrise. «Cosa c’è?» chiese l’altro. «Niente. Dimmi un po’, mister sonostatoattentoinclasse: come si chiama il tipo molto importante che trovano morto nella vasca da bagno?» «A Parigi, dici?» «Sì». «Marat». «Jim Morrison, scemo». “Vieni pure, guerra nucleare” pensò Ostilio. 155 Il Franti sorgeva ai margini della città, ai piedi del grasso colle su cui, tra ville del settecento e dimore liberty, era cosparsa la crema della borghesia cittadina. Medici specialisti, notai e piccoli imprenditori che, con sangue e sudore, avevano risalito la china e ora dominavano la città dall’alto. Tra le cose che la crema della borghesia poteva contemplare, un po’ più in là delle piscine e dei bersò, c’era il Franti. La prima impressione che se ne aveva era anche la seconda, la terza e la quarta: un incrocio tra casa circondariale e fortezza, una cittadella dall’aria ottocentesca e austera, mura alte sovrastate da reti metalliche, colori sbiaditi e tetri. Si fosse trovato su un isolotto roccioso, avrebbe sicuramente avuto bruma e gabbiani a completarne il profilo. Insomma: una prigione effettiva. In realtà, si trattava di una vecchia caserma che il Gruppo aveva rilevato a un prezzo fuori mercato grazie ad appoggi politici. Augusto, che per rimettere in sesto l’edificio aveva ricevuto un’inezia di stanziamento, aveva potuto fare ben poco per rimodernarlo. Vista dall’alto, l’immensa colata di cemento del Franti ricordava una esse squadrata che metteva in comunicazione i piedi della collina e la periferia della città. Era composto da tre grandi blocchi cubiformi messi in comunicazione da lunghi porticati: il blocco dei dormitori e del refettorio, il blocco scolastico e delle aule studio, e il blocco dei laboratori. Le poche classi che erano passate per i suoi ambienti avevano già ribattezzato le parti attingendo un po’ alla geografia, un po’ al156 la mitologia, come a voler dire che si trattava di un luogo reale e allo stesso tempo immaginario. I dormitori, divisi su tre piani nel blocco centrale – il cuore del collegio – erano chiamati Campi Elisi, perché ogni notte il Lungo Sonno prendeva per mano i collegiali e li conduceva lontano dalle vicissitudini diurne immergendoli nei paradisi artificiali dell’altra vita, quella onirica; i bagni, una decina per ogni dormitorio, irrorati di cloro al punto di impregnarne polmoni e vestiti in pochi attimi, erano le Isole Figi, per l’assonanza con la cosa più meditata al loro interno. Sopra i tre dormitori, al quarto piano del blocco, si estendeva il Limbo, le piccole stanze individuali per gli studenti di quinta che avessero un indice migliore di menotrenta (era quasi impossibile arrivare in quinta con un giudizio migliore di menotrenta), stanze anguste come cabine di una nave ma sconfinate per il senso di libertà dopo anni passati a dormire in mezzo a centinaia di persone. A completare il primo blocco c’era, al piano terra, il refettorio, il Gulag, perché si pativano fame e freddo contemporaneamente, un freddo così acuto che parzialmente allontanava il pensiero di ciò che si stava masticando; dietro il refettorio c’era il Canile, vale a dire le cucine, mefitico laboratorio di vivisezione in cui si tritavano carni di origine misteriosa per polpette e ragù. Pochi dubbi lasciavano invece i vermi nell’insalata o le unghie nel riso. I campi esterni, adiacenti al blocco dei dormitori, erano detti Machu Picchu (quello in alto, posto in cima ad un’erta collinetta) e Marassi (quello in basso, di fronte all’appartamento del Rettore), mentre il vasto cortile che separava il Marassi dal cancello d’ingresso – cortile utilizzato per le grandi adunate – non aveva nome ed era semplicemente “il cortile”. Il secondo blocco racchiudeva l’edificio scolastico e le aule studio. L’ala scolastica, al secondo piano, aveva aule chiamate Panno157 lineide (la classe dei primini), Paesibassi (la seconda, sprofondata in uno scantinato), Merdaio (la terza, vicina a tubature fognarie poco permeate), Laquarta (la quarta) e Osteoporosi (l’umidissima quinta, praticamente senza riscaldamento); l’aula di informatica era chiamata Commodor 64 (i computer erano piuttosto superati); l’ala delle classi di studio, al terzo piano, aveva un unico misterioso nome: Controgalapagos. Al piano inferiore del secondo blocco si trovava la palestra, ribattezzata Latrina per via della gomma del pavimento marcia e pestifera. L’ultimo blocco, quello dei laboratori di lavoro, annoverava nomi come Birkenau, Ruhr e Manciuria. Nel terzo blocco si trovavano anche l’Aula Magna, una sordida sala giochi e la cella di isolamento. Anche tra i collegiali circolavano soprannomi e nomignoli, talvolta chiari ed eloquenti, come Paolo Svuotapalle, Tiziano Puzzadicammello, Jimmi Cazzofossile, Alberto Castorama… in altri casi più ermetici, come Pier Ragù (un ragazzo la cui sudorazione ascellare non ricordava per nulla l’acqua di colonia), Giorgio Ladàvia (la madre non si occupava di merchandising per una grande azienda) o Mario Skrotone (era di origine calabrese e aveva due palle enormi). Le giornate erano dense di impegni, scanditi dal suono inflessibile delle campanelle. Non erano ammessi sgarri e arrivare in ritardo significava essere puniti. L’unico svago ammesso era lo sport, il calcio in particolare, che si praticava nei due campetti durante l’intervallo pomeridiano, e solo nel Marassi, perché il Machu Picchu era privo di illuminazione, dopo cena. Il calcio era, per passione o semplice sfogo, una delle attività più amate dai collegiali. Nei lunghi mesi invernali i campetti erano monopolizzati da un ristretto gruppo di ragazzi, mentre in au158 tunno e primavera erano accessibili a tutti. Venivano organizzati piccoli tornei a squadre. Le squadre erano formate sulla base della posizione disciplinare (c’era la squadra dei menodieci, quella dei menoventi, quella dei menotrenta e così via). Affrontare i menonovanta era una delle esperienze più pericolose dell’intero curriculum collegiale. Il team, composto dagli elementi più violenti del Franti, si caratterizzava per un’infima base tecnica (i giocatori faticavano a mettere assieme due passaggi consecutivi) e una notevole componente agonistica. Per chi affrontava i menonovanta era difficile, se non impossibile, uscire dal campetto con una vittoria e, in ogni caso, con le proprie gambe. Le partite più cruente erano quelle tra menonovanta e menodieci. Quando il sorteggio li metteva di fronte, intorno al Marassi si assiepavano centinaia di collegiali assetati di sangue. Dave sperimentò quasi subito la violenza dei menonovanta. Un pomeriggio di fine settembre, con due settimane di scuola alle spalle e le prime ansie da verifica all’orizzonte, l’ultima cosa di cui s’era preoccupato era la partita in programma quella sera. Mentre si trovava in aula studio a ripassare per una verifica di storia dell’arte, un paio di ragazzi, nettamente più grandi di lui, entrarono e s’avvicinarono al suo banco. Non avevano la faccia allegra. «Ciao bella, che fai stasera?» chiese uno con la barba. «Dite a me, ragazzi?» «Dove hai imparato a rispondere a una domanda con un’altra domanda?» ribatté quello con tono minaccioso. «Ti ha chiesto bella, che fai stasera?» aggiunse l’altro. «Scusate la mia… maleducazione… sapete com’è… sono nuovo e non conosco le usanze del collegio… Stasera… stasera ripasserò storia dell’arte… domani ho una verifica… Spero d’aver risposto in modo esauriente alla vostra domanda…» «Stasera tra le otto e le nove, stronzo». 159 «Ah!» fece Dave sorridendo stentatamente «Vi riferite al match calcistico!» I due ragazzi, conosciuti come Anulare e Nocca, due fidi scudieri di Ostilio (che, va detto, non s’interessava minimamente di calcio, un gioco che riteneva inutile e poco violento), gli si misero a fianco. «Sì, stronzo di merda, ci riferiamo proprio alla partita» disse Nocca, che era quello barbuto, schiacciandogli il piede col tacco. «Perché vi rivolgete a me con quell’appellativo?» chiese Dave sforzandosi di essere empatico. «Appella che?» fece Nocca. «Aggettivo, epiteto…» «Quale aggettivo, coglione?» chiese Anulare. «Sapete che nel regolamento dell’Istituto si invita i collegiali al reciproco rispetto e…» «Quale regolamento, stronzo?» chiese Nocca aumentando la pressione sul piede. «Ahhh…» guaì Dave «il regolamento che ci è stato consegn…» «Non so di cosa parli, stronzo di merda. Tu, Anu, hai mai sentito parlare di questo regolamento?» «No, ma la sai una cosa? Mi piacerebbe leggerlo, questo regolamento, per capire se mi sto comportando bene o male». «Ce l’hai qui, per caso, stronzo di merda?» «Dovrebbe essere… sì, eccolo qua». «Dunque… vediamo un po’… mmmh… mi pare non ci sia scritto da nessuna parte proibito chiamare stronzo di merda uno stronzo di merda… Ma forse ho dato uno sguardo troppo veloce… Vuoi dare un’occhiata anche tu, Anu?» Anche il compare finse di dare una letta, poi rispose di no, che nel regolamento non c’era scritto niente del genere. 160 «Ma allora Anu, perché il nostro amico stronzo di merda ci ha detto quelle parole… quelle strane parole… mmmh… com’erano, Anu?» «Reciproco… mi sembra… qualcosa tipo… stronzo reciproco, o qualcosa del genere…» «Rispetto reciproco! Bravo Anu! Hai una memoria eccezionale». Dave li guardava duettare impietrito, il cuore che batteva sempre più forte, la fronte gelata, gli occhi che di tanto in tanto scattavano verso la porta. «Però, sai che ti dico, Anu? Forse il nostro amico ha ragione e da qualche parte del regolamento si parla veramente di questa legge che vieta di chiamare qualcuno stronzo di merda…» «Ti conviene dargli un’occhiata più attenta, al regolamento, Nocca». Nocca ridacchiò e, col regolamento tra le dita, si allontanò a piccoli passi fino a uscire dall’aula studio. Anu, invece, rimase con Dave. Gli parlò dell’importanza che la partita aveva per la sua squadra. Del fatto che alla sua squadra non piacesse subire reti. Della statistica che riferiva gravi traumi agli arti inferiori tra i componenti delle squadre che avevano segnato più di una rete ai menonovanta. Poi Nocca rientrò e disse: «Avevi ragione. Sul regolamento c’è proprio un paragrafo dedicato allo stronzo di merda. Te l’ho evidenziato». Lasciò cadere il regolamento sul banco. Era imbrattato di qualcosa che ricordava gli escrementi umani. «Ci vediamo stasera». Poco dopo suonò la fine dell’intervallo e la squadra-studio rientrò in aula insieme al guardiano. Ripresosi dallo shock, Dave, che viveva in uno strano mondo fiducioso delle regole, fece l’unica cosa che non avrebbe dovuto 161 fare: si alzò, andò dal guardiano e chiese se poteva avere una nuova copia del regolamento perché, testualmente, un ragazzo più grande di lui l’aveva utilizzata per detergersi l’ano. Il guardiano lo ascoltò distrattamente e commentò l’accaduto dicendo che gliene avrebbe procurata un’altra. Per il resto del pomeriggio, Dave aspettò con fiducia che il guardiano si recasse dal Rettore a riferirgli dell’accaduto. Ma il guardiano non si mosse da lì, impegnato a studiare approfonditamente la Gazzetta dello Sport. Le ore di quel pomeriggio si fecero interminabili. Verso le sei, la voce era girata e Dave notò diversi compagni della squadra-studio parlottare guardando nella sua direzione. Alcuni s’avvicinarono a lui e si espressero con pietà e sgomento. «Te sei fuori». «Completamente». «Perché hai detto tutto al guardiano?» «Non… non dovevo?» «Te stasera ti spaccano la testa». «Te stasera ti spezzano le gambe». «Te stasera ti sfondano il naso». «Mi… mi sfondano cosa?» «È meglio che ti rinchiudi da qualche parte». «Fatti venire la febbre». «Ti spiego io come fare». «E infilati nel letto». «Nel letto?» «Forse…» «… però…» «… se ti trovano…» «… nel letto…» «… è peggio…» 162 «… perché…» «… se ti trovano nel letto…» «… ti sfondano il culo!» Dave li allontanò stizzito e cominciò a sudare freddo. Si alzò, camminò verso la scrivania del guardiano e chiese il permesso di andare in bagno. Uscì, guardingo, dall’aula e procedette tenendosi vicino al muro. Varcò la porta, entrò in un gabinetto e si chiuse dentro con un sospiro. Mentre liberava gli intestini, non pensò ad altro che agli intestini che si liberavano e passò qualche minuto di vero benessere. Pensò che avrebbe potuto stare lì dentro per il resto della giornata, della nottata, della settimana, della vita. Sì, era l’unica soluzione per sopravvivere. Starsene lì ad aspettare che la giustizia facesse il suo corso. Invece bussarono alla porta. Due colpi, prima. Tre colpi, dopo. Restò immobile, senza fiatare. «Dave!» chiamarono da fuori «Dave, sei lì dentro? Sono io». Io? Io chi? Quanti io c’erano sulla faccia della terra? «Sono io, Nic». Dave tirò lo sciacquone in segno di giubilo e uscì dal gabinetto. «Cos’hai combinato?» chiese Nic. «Niente. Ho solo chiesto al guardiano di fare da garante…» «Non devi chiedere aiuto, Dave! Mai! Devi arrangiarti da solo». «Ma… e il regolamento?» «Vieni, dai». «Ho paura…» «Vieni». «Ma come faccio con la partita? Mi spezzeranno le gambe». 163 «Non preoccuparti. Ci penso io». Quella sera i menonovanta vinsero dodici a zero. Dave non subì un graffio. Al suo posto giocò Nic che uscì dal campo a pochi minuti dalla fine con la caviglia grossa come un melone e un taglio sul labbro inferiore. 164 Gentile signorina Ardizzone, resto letteralmente basita apprendendo del suo interessamento per il personaggio in questione. Come diceva quella poesia? Attonita al nunzio sto. Priva di tono, credo significhi. Mi perdoni, ma non riesco proprio a capacitarmi del fatto che un essere umano possa essere attratto da qualcosa (in questo caso la sua cosiddetta “opera letteraria”) riguardante mio padre, non riesco a capacitarmi del fatto che un essere umano possa essere attratto dai suoi libri, dalla sua “letteratura”, come la chiama lei. Mio padre è stato una grandissima testa di cazzo, ecco che cosa mi sento di dirle, e ci tengo a precisare che tale affermazione prescinde dal fatto che mio padre abbia stupidissimamente deciso di abbandonare anzitempo la valle di lacrime a causa di stupidissime e improrogabili questioni letterarie. Mio padre è stato una grandissima testa di cazzo a prescindere, capisce? Signorina, parliamoci chiaro: credo che in Italia ci siano altri autori su cui valga la pena spendere dei mesi per una tesi di laurea. Ci sono autori che hanno lasciato un solco ben più importante, autori che hanno impresso alla nostra nazione un segno, non certo mio padre, che per decenni ha semplicemente rotto il cazzo agli altri uomini senza lasciare solchi o imprimere segni. Se le mie parole non fossero abbastanza persuasive e lei decidesse di proseguire nel suo stravagante progetto, la invito a rivolgersi a mia sorella che probabilmente sarà meglio disposta nei confronti della sua iniziativa. Saluti. 165 Gentile Laura A., mi scuso per il ritardo con cui rispondo alla sua e-mail. Non sono una grande habitué del computer e a volte rimango intere settimane senza utilizzarlo ed aprire la posta elettronica. Naturalmente, come è ovvio che sia, apprendere che qualcuno è interessato a mio padre e alla sua opera mi riempie il cuore di gioia! Mio padre, come lei scrive, è stato un grande scrittore che critici e editori hanno dimenticato troppo presto; ecco perché in questo momento una tesi di laurea su di lui potrebbe valere tantissimo, potrebbe essere il piccolo segno di un rinnovato interesse nei suoi confronti. Debbo però aggiungere, con tutta la sincerità di cui sono capace, che l’evento luttuoso che ha interessato la mia famiglia è ancora troppo recente per permettere al mio spirito di affrontare le sue richieste con la dovuta serenità. Per motivi attinenti la mia sfera privata, in questo momento mi sento equidistante sia dall’idea di rimuovere completamente la sua figura dalla mia vita, sia da quella di fare di tutto per mantenerla viva per sempre. Sappia comunque, e per il momento è tutto ciò che mi sento di dirle, che il suo lavoro mi giunge estremamente gradito e che, in futuro, non escludo l’ipotesi di poter collaborare con lei. Cordialmente. 166 L’amicizia tra Dave e Nic diventava ogni giorno più solida. Insieme imparavano a conoscere il mondo del Franti che, poco alla volta, svelava i propri segreti. Avevano imparato quali cibi evitare in mensa, in quali posti non farsi trovare soli, in quali modi sottrarsi ai lavori extra. Avevano imparato a convivere coi guardiani e soprattutto col Direttore che mensilmente li chiamava a raccolta per un colloquio temutissimo da tutti i collegiali. Avevano imparato che da menonovanta a menosessanta la forbice aveva le lame affilate. Avevano imparato che il letto (tra sogni e polluzioni) era un bel momento. Avevano imparato che la doccia non era un bel momento. Avevano imparato che il peggio che poteva capitarti era quando compariva un menonovanta mentre eri sotto la doccia. Avevano imparato che a bilanciare il terrore di certi momenti ce n’erano altri, come le lezioni di Italiano del professor Edoardo Yale, un quarantenne di origine inglese che sembrava l’incrocio (riuscito) tra un francescano e il bassista dei Sex Pistols. Nel Franti, dove il corpo docente considerava gli studenti tutt’al più delle piante da raddrizzare, i modi di Yale, che invece vedeva in loro rampicanti cui offrire muri o pali su cui avvolgersi, risaltavano come un lago al chiaro di luna. Ciò che faceva di lui un docente diverso in quel sistema educativo, era qualcosa localizzato a metà strada tra la metodologia didattica e la sua persona: a differenza degli altri insegnanti, Yale aveva il potere di rendere 167 viva la propria materia. “Non si chiama materia per caso” era solito ripetere, e infatti tra le sue mani la letteratura diventava qualcosa di vivo, qualcosa che pulsava e ti avvolgeva. I libri che portava in classe e su cui faceva lezione erano libri che maneggiava, assaggiava, sorseggiava, accarezzava, sbaciucchiava, leggeva. Erano libri che appartenevano a lui e non sembravano usciti dagli scaffali imbolsiti di una libreria domestica ma da qualche angolo recondito della sua vita. Tra le sue mani quei libri non partorivano teorie astratte o categorie filosofiche, periodizzazioni storiche o suddivisioni artistiche, ma idee concrete da applicare quotidianamente alla vita come garze sterilizzate su ferite aperte. Nel giro di qualche lezione, Dave si rese conto che quel professore, con le sue storie e le sue facce, con le citazioni e i suoi rimandi, apriva dei mondi: ogni volta che finiva una lezione in cui Yale aveva citato Goethe o Céline, Gadda o Cortázar, Dave si trovava a maledire la madre per averlo costretto a perder tempo dietro al suo cripto-filosofo. Pure Nic era attratto da quelle lezioni, anche se in maniera diversa. Tra lui e la letteratura c’erano sempre di mezzo degli strani oggetti chiamati libri, oggetti pieni di cacatine chiamate lettere, ma ciò non gli impediva di apprezzare Yale e il suo metodo: gli piacevano i salti che faceva, soprattutto i collegamenti tra cultura alta e popolare, tra poesia e musica, tra parole e vita. Durante le lezioni aveva ricevuto il permesso di limitarsi ad ascoltare, disinteressandosi completamente delle parole scritte; quando invece si trattava di scrivere, come nei temi, poteva dettare direttamente a Yale. Il martedì e il giovedì Yale faceva normaletteratura, letteratura italiana dalle origini al novecento, anche se di “normale” c’era ben poco dato che le lezioni erano concepite in maniera del tutto eccezionale. In classe era proibito il manuale (che veniva seque168 strato, non stracciato perché il gesto era, ai suoi occhi, oltreché citazionistico, oltremodo blasfemo) e gli studenti dovevano affrontare autori, movimenti e tematiche esclusivamente con le proprie forze, senza alcun ausilio interpretativo. I testi nudi e crudi erano l’unico strumento a loro disposizione. Gli studenti, guidati da Yale, scrivevano pagine e pagine di commenti, valutazioni, sensazioni, e in questo modo costruivano la loro storia della letteratura. Di tanto in tanto, poi, Yale riconsegnava i manuali di letteratura e si godeva l’avidità degli studenti che si districavano assetati tra paragrafi e capitoli. Le lezioni del sabato mattina, invece, erano dette Pindaro in my veins. Arrivava in classe con una valigia e, un pezzo alla volta, la svuotava sulla cattedra: fumetti, film, musica, libri di poesia, filosofia e teatro, riviste, magliette, giornali, sigari, riproduzioni di quadri e disegni, fotografie di attori e ritratti a pastelli, poster e stilografiche, mappe geografiche e dischi in vinile, decine di oggetti che, animati dalle parole eccitate di Yale, facevano da scenografia alla lezione. Era la mattina preferita dai ragazzi, anche perché negli ultimi minuti della lezione Yale indossava i panni di Amleto e declamava alcuni passi della tragedia. I ragazzi avvertivano che in quegli attimi lui diventava davvero il Principe di Danimarca e, per loro, quello era un momento incredibile, un po’ seduta spiritica, un po’ commedia della follia umana. Yale, che riusciva ad essere al contempo spiritato e parodico, recitava lunghi brani, inframmezzati (loro nemmeno se n’accorgevano) da frasi sue, frasi che più direttamente parlavano di loro, parlavano a loro. Al termine dell’interpretazione potevano fargli delle domande. Gli chiedevano se credeva in qualcosa tipo Dio, e Yale rispondeva: «È vent’anni che Dio e il Diavolo si giocano la mia anima. Si metteranno d’accordo, prima o poi, no?» 169 Gli chiedevano perché si doveva morire, e lui rispondeva: «Per far posto agli altri». Gli chiedevano chi era il più grande scrittore di tutti i tempi, e lui rispondeva: «Elvis Presley, indubbiamente». Il suo linguaggio era illuminante, colpiva la fantasia degli studenti. Diceva cose tipo “un uomo che non riesce a dar forma al proprio destino, in realtà è un cinghiale” o “hai la corona di spine nella sintassi” o “imparate ad ascoltare il punto di vista delle api”, e anche se non sempre tutti capivano, le sue parole avevano un’aura iridescente. Nel contesto carcerario del Franti le sue parole erano perle splendenti. Yale raccomandava, una volta diventati grandi, di non sprecare tempo a cercare la sintesi (“quel fottuto ciarlatano di Hegel…”), la sintesi fra tè alla pesca e rum, fra musica classica e rock, tra inferno e paradiso… Nessuna sintesi, nessuna mediazione tra posizioni estreme. Bisognava essere pendolo, tic e tac, di qua e di là. Del resto, Yale era maestro del motherfucker sintesi: un giorno era più volgare di una baldracca, un altro prodigava poesia anche dall’orifizio anale; un giorno ti guardava con gli occhi di un orso polare, l’altro con quelli del gatto con gli stivali. Quando i suoi studenti si chiedevano cosa ci facesse un personaggio così al Franti, l’unica ipotesi che gli veniva in mente era che gli avevano fatto firmare un contratto a tempo indeterminato per sbaglio e adesso non riuscivano più a levarselo di torno. Non c’era nessuno sbaglio invece, e sarebbe bastato chiederlo al Rettore, perché era solo Augusto Loglio a sapere com’erano andate le cose. Yale era un suo vecchio compagno di liceo che, da giovane, gli aveva salvato la pelle e il giorno in cui Loglio aveva avuto la possibilità di sdebitarsi, l’aveva fatto. Era accaduto un anno dopo l’apertura del Franti. Si erano incontrati per una rimpatriata tra 170 amici e Augusto aveva scoperto che Yale viveva di precariato scolastico, consumava troppi psicofarmaci e non aveva i soldi per pagare l’affitto. Augusto gli propose di insegnare al Franti – vitto e alloggio inclusi – e Yale accettò. Un attimo prima di firmare il contratto, però, Yale aveva alzato lo sguardo e gli aveva chiesto se era sicuro di quello che stava facendo: la sua impostazione pedagogica e quella del Franti non avevano un solo punto di contatto e gli sembrava azzardato assumerlo per affidargli una disciplina così importante. Secondo Augusto, invece, i punti di contatto erano diversi. Era convinto che le sue lezioni sarebbero state importantissime per gli studenti. Gli avrebbe fatto assaggiare un po’ di libertà e, allo stesso tempo, il peso che questa comportava. Naturalmente bisognava dosare gli ingredienti a dovere, non esagerare troppo da una parte o dall’altra, controbilanciare una cosa con l’altra e, in quello, Yale – il pendolo Yale – era praticamente un maestro. Un nebbioso sabato mattina di novembre, Yale entrò in classe per Pindaro salutando la classe alla sua solita maniera. «Buongiorno ragazzi. Vi tocca. Niente ictus nemmeno oggi…» Poi tirò fuori dalla borsa alcuni cd. Tra questi, Nic riconobbe una copertina che aveva visto a casa dello zio. Poco dopo stavano ascoltando Sympathy for the devil. Piacque parecchio, e il professore tradusse il testo. Poi la fece sentire una seconda volta, pregando i ragazzi di alzarsi e lasciarsi portare dal ritmo. Chi disinvolto, chi meno, tutti si fecero guidare dalle percussioni, dai graffi di chitarra e dalle curve dell’inciso. «Anni fa c’erano dei criminali in libera uscita» esordì Yale, mentre i ragazzi si rimettevano a sedere. «Questi criminali dicevano che questa musica era demoniaca. Pensate un po’: dei crimi171 nali che avevano sostenuto l’Olocausto, una ventina d’anni dopo non sopportavano il movimento pelvico di alcuni adolescenti! Musica del demonio la chiamavano…» Parlava spiritato e i ragazzi l’ascoltavano senza perdere una parola o un gesto. «Vedendo come vi muovete, forse dovrei spiegarvelo, il movimento pelvico…» Cercò le parole, ma non le trovò. Allora si piazzò in mezzo a loro, fece schioccare le dita quattro volte e si mise a muovere quella zona del corpo umano che il re del rock and roll aveva battezzato qualche decennio addietro. Poi si fermò e spiegò a tutti che quel ragazzo con la pinna in testa andava paragonato a Cristoforo Colombo, e il giorno in cui aveva mostrato al mondo il movimento pelvico equivaleva a quello in cui Colombo aveva baciato la sabbia di San Salvador. «Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi…» citò, con grande trasporto, dopo esser tornato alla cattedra. Rifece il movimento pelvico, poi aggiunse: «Un millennio a scrivere di lombi, a spiegare a parole come innescare la miccia, e la gente che non capisce cosa fare… Poi arriva lui, Elvis, e li muove i lombi, e tutti capiscono…» La discussione terminò. Yale fece portare in classe il videoproiettore e tirò le tende. Pochi istanti dopo, sullo schermo appariva la scritta I quattrocento colpi. Per tutta la durata del film sentì aleggiare una fortissima emozione. Gli piaceva insegnare a quei diseredati. «Ve l’hanno detto perché siete qui, vero?» disse a proiezione finita. La voce gli tremava ma non fece niente per nascondere la commozione. 172 «Paolo, ve l’hanno detto perché siete qui?» «Non mi sembra prof…» rispose un tipo esile dopo un lungo attimo d’esitazione. «Dave, tu lo sai?» «Per crescere prof!» esclamò Dave con sicurezza. «Per crescere? Mah… mi sembra un po’ poco…» Riusciva a scorgere distintamente i loro volti. Gli occhi rilucevano. Nella penombra lo sentivano camminare avanti e indietro. «Siete qui perché a casa non sapevano cosa farne di voi. Siete qui perché là fuori eravate pronti a sparire nei gorghi dell’Occidente mefitico». Lo guardavano. Un po’ capivano, un po’ no, ma sentivano tutto. «Nutritevi, ragazzi, nutritevi di bellezza». Poi mise in forno un cd e gli fece sentire Can’t help falling in love. 173 La loro reazione alla mia morte non mi stupisce: sono sempre state diverse nei miei confronti… Non mi stupisce ma mi ha fatto provare una strana sensazione, forse una delle prime interessanti da quando sono morto, una delle prime sensazioni davvero interessanti per un libro. È la prima volta che l’idea della mia morte – un’idea che finora ho sentito unicamente come costruita, un puro artificio letterario, nulla più che la morte di un personaggio – è una sensazione concreta. Se penso a un’immagine per questa sensazione, per quanto mi sforzi a tradurla in linguaggio, tutto ciò che mi viene in mente sono parole vacuamente letterarie come “stomaco fagocitato da una pianta carnivora”. Eppure la sensazione è così netta… com’è possibile che una sensazione così netta non possa tradursi in sintassi? Perché non riesco a rinchiuderla in una frase che non sia stomaco fagocitato da una pianta carnivora? Quando le parole non vengono, ho l’abitudine di guardarmi il corpo sperando di farle affiorare. Finisce che mi soffermo sul corpo sgraziato; i piedi troppo grandi per le ciabatte, la schiena incurvata dagli anni alla macchina da scrivere, la barba spinosa di un paio di giorni… Stare troppo sullo scrivere mi ha tolto il respiro. Devo cercare di concentrarmi sulla situazione. Sulla gabbia. 174 È la gabbia che devo indorare. Questa bestia deve crescere in gabbia. È morto un pessimo scrittore, è vero, ma quel pessimo scrittore ha tra le mani un’idea che gli permette di comunicare dall’aldilà. Genio. Posta elettronica. Falso nome. Dibattito intorno a me. Ha funzionato con Giulia e Clara, posso spingermi ancora più in là, mettermi in contatto con altre persone, tentare altre scorribande nel mondo esterno sotto mentite spoglie, registrarne le conseguenze. E scriverne. Mentite spoglie… È un buon titolo… Un libro realistico, duro, viscerale. Li stendo tutti. È incredibile come l’entusiasmo inneschi la creatività. Mattinata splendida, sotto mentite spoglie. La gabbia s’indora. Ho scritto incessantemente, martellando la tastiera del computer con una fluidità che mi ha sorpreso. In poco meno di un’ora ho scritto tante mail, a ogni parola che appariva sullo schermo ero sempre più vivo. La prima lettera l’ho spedita al Direttore del giornale della mia città. Ero un lettore di vecchia data e lamentavo, con toni apocalittici, la totale assenza sulle pagine del suo giornale di scritti riguardanti “un autore che aveva dato grande lustro alla cultura cittadina”. Ho pregato il Direttore di rispondermi via mail perché, per protesta, non avrei più acquistato il giornale. La seconda l’ho mandata a un conoscente, un vecchio critico letterario. Anche qui ero un lettore di Timpano schifato del silenzio disumano con cui aveva lasciato passare la morte dello scrittore. 175 La terza mail è stata per Einaudi. La quarta per Rallentamenti. La quinta per Fahrenheit. La sesta per Citati. Mentite spoglie é il titolo giusto. Indora, indora la gabbia, vecchio Timpano. Non c’è niente di più silenzioso di un tramonto in montagna. Oggi pomeriggio ho riletto il diario che ho scritto in questi mesi. Sta meglio anche lui, nella gabbia. Ho trascorso il resto della giornata con una certa allegria d’animo; pregustavo già la consueta uscita notturna. Ho visitato Google senza notare cambiamenti. Sono entrato in Wikipedia, ma il mio nome non c’era. Da qualche tempo, il silenzio di Wikipedia mi fa male: com’è possibile che nemmeno la morte abbia spinto qualcuno a inserirmi? Ci sono cani e porci lì sopra! Mentite spoglie mi riporterà in classifica. Einaudi mi supplicherà di tornare. Mangio qualcosa. È successa una cosa. Un fatto inaspettato che mi ha gettato nel panico. Verso le diciannove, mentre sul gas bolliva un brodo di verdure e io ascoltavo il radiogiornale, all’improvviso è suonato il citofono. Il cuore era praticamente fermo. È stato fermo per un tempo infinito. Poi sono riuscito a fare alcuni passi. Ho raggiunto il piano superiore cercando di non far rumore. Mi sono trascinato come un marine fino alla parete che dà sull’esterno, e ho sbirciato attraverso le imposte. Al cancello c’era un uomo in impermeabile grigio. 176 È rimasto lì cinque minuti buoni, suonando un paio di volte e saltellando per combattere il freddo. Poi se n’è andato con un’auto che ho solo sentito. Sono rimasto alla finestra per tre quarti d’ora, stordito e completamente svuotato. Poi ho sentito puzza di bruciato. Mi sono precipitato di sotto. La cucina era invasa da un fumo nero e denso. Il brodo era evaporato e il pentolino stava bruciando. 177 Per Augusto Loglio, il martedì non era un giorno come gli altri. Per Augusto Loglio, il martedì era un altro giorno. Cominciava a pensarci, a sentirlo, a pregustarlo fin dalla domenica sera. Mentre il resto dell’umanità si sentiva invadere dalla tristezza infinita del lunedì, lui cominciava a star bene perché il martedì era ormai alle porte. Il lunedì se ne andava via come un soffio. Il martedì mattina si svegliava come in un’altra vita, ed era così felice che a volte evitava di parlare con chiunque per non sembrare troppo buono. Era il giorno in cui si spogliava degli abiti stretti, il giorno in cui si liberava di una parte di sé diventata ingombrante, il giorno in cui un angolino della propria mente – un piccolo scoglio – prendeva possesso di un intero continente. Li vedeva quasi, questi quattro soldati, sbarcare sulla terraferma e andare a conquistare tutta quanta la sua mente e conficcargli una bella bandierina in mezzo al cervello. Il martedì pomeriggio, subito dopo pranzo, l’intera comunità collegiale sciamava dal Franti concedendo al Rettore alcune ore di perfetta solitudine. Lasciate alle spalle le massicce mura del collegio, la massa dei reclusi si riversava nelle strade della città e si dirigeva verso gli impianti sportivi di vari quartieri per l’attività sportiva settimanale. Per un po’ Augusto restava solo tra le mura della sua creatura, solo con una ciurma di fantasmi che da tempo aveva smesso 178 di frequentare ma da cui non riusciva a separarsi del tutto. Allora si avvicinava allo stereo, inseriva nel lettore un vecchio cd, e mentre la fiacca mano di Eric Clapton riempiva l’appartamento, Augusto andava in camera, si spogliava e si metteva in abiti comodi. Poi passava in cucina e accendeva il forno. Subito dopo faceva una sosta in bagno dove orinava e si lavava le mani, quindi tornava in cucina e stendeva la tovaglia sul tavolo, ci poggiava piatto, bicchiere e posate, toglieva le lasagne dal forno, stappava una bottiglia di vino (un bianco fermo del Friuli o del Trentino), apriva un quotidiano alla pagina della politica, si sedeva e cominciava a leggere. Ogni volta così. Sempre uguale. Con gesti meccanici. Era l’unico momento della settimana in cui beveva, leggeva e mangiava. A dire il vero mangiava tutti i giorni, ma la sbobba del refettorio non si poteva paragonare alle lasagne della Gastronomia F.lli Peruzzi. Mentre le papille assaporavano il bolo delizioso, la mente trangugiava commenti politici e il suo cuore assorbiva Pinot Grigio. Il martedì pomeriggio era il momento della rigenerazione attraverso libertà e piacere, due fantasmi che teneva il più lontano possibile dalla sua vita. Il fantasma della libertà gli distendeva i muscoli facciali. Poche ore erano più che sufficienti per mollare gli ormeggi di quella maschera, poche ore libero da interventi educativi, provvedimenti disciplinari, stesura progetti, eccetera, poche ore di tempo per affondare nei dubbi dell’esistenza e per sprofondare nei fumi dell’alcol. Il fantasma del piacere arrivava poco dopo. Aveva il sapore del vino, e svaniva dopo un paio di bicchieri lasciando il posto a quello della compulsione, che appena apparso rimestava le acque del pomeriggio e creava gorghi a cui era impossibile sfuggire. 179 A questo punto, il tempo che rimaneva era quello per colare a picco, dormire sui fondali della propria coscienza, riprendere contatto con la realtà, imporsi una doccia fredda, riemergere lentamente e, infine, tornare al proprio ruolo di Direttore. Nel dormiveglia, la coscienza e le percezioni allentavano la morsa permettendo alla tara del suo passato di venire a galla come un rigurgito. Contraddizioni e contrasti galleggiavano nella sua mente come relitti di un aereo schiantatosi in mare: un uomo che aveva sempre sognato l’anarchia dirigeva un collegio, uno che aveva sempre incensato la libertà assoluta dettava regole a quattrocentoventi persone, un uomo che aveva sempre bramato il piacere distribuiva bromuro. Veniva a galla tutto. E non era un bel vedere. Tutte quelle casse e quei corpi e i seggiolini che galleggiavano in mezzo ai pescecani: cosa c’entrava lui, un egocentrico col culto di De Sade, un materialista relativista nichilista corretto a forza di bastonate dall’illuminismo gesuita, un cane sciolto cultore dell’istintività, cosa c’entrava con i tassativi articoli di un regolamento, con il rigore di una cella di isolamento, con l’esaltazione della coercizione? Cosa c’entrava con le regole, la legge, la giustizia, l’amor proprio, il rispetto per gli altri, il senso della famiglia, la ricerca dell’identità, l’evoluzione della civiltà, l’idea di progresso comunitario? Cosa cazzo c’entrava un exalcolista e cocainomane con tutto questo? Cosa c’entrava un uomo becero, uno squallido arrampicatore sociale con un’istituzione a cui disperati padri di famiglia affidavano, speranzosi, le proprie creature? Galleggiavano, i relitti, tra i flutti schiumosi dell’oceano e il volo furioso dei gabbiani, avvoltoi del mare, mentre un silenzio irreale, come in un sogno a volume azzerato, regnava dopo l’addio dei soccorritori. 180 Poi, dopo questa catena di domande (sempre le stesse e senza risposte), sentiva finalmente le membra lasciarsi andare. Sentiva il sole tiepido appoggiato ai vetri della finestra e scivolava in un sonno ristoratore. Al risveglio era tutto svanito: il sole tramontato dietro i tetti, il sapore dei rigurgiti evaporato dalla bocca. Augusto si alzava dal divano, si passava le mani tra i capelli e si metteva in piedi valutando il proprio equilibrio. Sotto la doccia, sentiva che la parte dominante della sua anima – il continente – si riappropriava del suo spazio. Determinato, rivestiva i panni di Rettore e si scherniva per la debolezza mostrata poco prima. Adesso era un cocainomane dell’autostima. Ne aveva sniffata tanta. Ed era arrivato in alto. Aveva faticato molto ad arrivare dov’era. E lassù stava bene. Da lassù si vedeva tutto da un altro punto di vista. Si vedeva il continente. Non avrebbe permesso a nessuno di buttarlo giù. Così, alle 18:30, Augusto Loglio usciva dalla doccia, reale e materico, si asciugava il corpo, si piazzava di fronte allo specchio e, all’affiorare della testa glabra e rossa, si lasciava sfuggire un sorriso al pensiero di come, un tempo, lo chiamava Yale: ruber custos. Quant’era che il rosso custode degli orti non assaporava il grembo di una donna? Quanto che non rimestava la terra di un giardino privato a favore di fioritura? Alle 18:40, il Rettore indossava un completo blu che incorniciava il suo golf preferito – un vecchio golf amaranto che gli conferiva una severa aria da college – beveva un bicchiere d’acqua, 181 usciva dal proprio appartamento e si dirigeva verso il blocco centrale. Lì cominciava a passeggiare per i corridoi con lo sguardo assorto di chi sta pensando al bene dell’umanità e allo stesso tempo, per lo stesso bene, a sguainare la frusta. 182 Egregio Signore, rispondo alla sua e-mail per pura educazione, ma le confesso che il tono e il linguaggio della sua non meriterebbero alcuna replica da parte mia. Il silenzio a cui lei allude ha una motivazione ben precisa, ma non intendo certo precisarla a uno sconosciuto. Se la sua capacità intellettiva le permette di accettare la mia riservatezza, ne sono ben lieto, in caso contrario mi vedo irrimediabilmente costretto a mandarla affanculo. Cordiali saluti. 183 Gentile lettore, la nostra redazione sente l’urgenza di doverla ragguagliare in merito ad alcune affermazioni contenute nella e-mail da lei inviataci due giorni fa. Innanzitutto ci siamo chiesti in base a quali prove lei possa affermare che il nostro giornale si sarebbe disinteressato della scomparsa del compianto Timpano: nei giorni che hanno seguito la morte dello scrittore, sulle nostre pagine sono apparsi ben tre articoli, uno in cronaca e due in cultura. La stessa incoerenza rintracciamo nel suo colpevole acriticismo nel riferire che il compianto Timpano “abbia dato grande lustro alla cultura cittadina”: ci piace infatti sottolineare (e nei citati articoli lo abbiamo fatto) che la figura di Timpano è stata molto più controversa di quanto lei sostenga, e che il suo rapporto con la nostra città fu soprattutto conflittuale, in particolar modo a partire dalla pubblicazione di Mia tenera bambina di burro, testo nel quale l’autore stigmatizzava alcuni isolati fatti di cronaca locale, arbitrariamente ascritti ad una totale degenerazione morale dell’intera cittadina. Restiamo comunque aperti ad ogni forma di dialogo, purché sia improntata alla correttezza e all’onestà intellettuale. La invitiamo, quindi, a non smettere di leggerci e a scriverci, anche perché nei prossimi giorni pubblicheremo una notevole inchiesta che un nostro giornalista ha condotto nelle ultime settimane per cercare di far luce su alcuni aspetti poco chiari del suicidio dello scrittore. Cordialmente. 184 Caro lettore, Rallentamenti ha dedicato ad Antonio Timpano un commosso ricordo che può trovare sul nostro sito. In merito alla ripubblicazione delle sue opere, è ovviamente nei nostri progetti; ci piacerebbe molto riunire le opere, magari per decadi o tematiche, e riproporre Timpano con prefazioni ad hoc. Per il momento non ci è possibile dire di più. La invitiamo ad iscriversi alla nostra newsletter che le permetterà di venire aggiornato tempestivamente in merito al nostro lavoro. Cordialmente. 185 Nel Franti l’unità di misura della vita sessuale era la stessa che si usa per misurare i liquidi. Un collegio di adolescenti maschi ne produce ogni settimana ettolitri. Tutto questo, come in una condizione misterica e pre-scientifica, generava mostri: non pochi reclusi del Franti provavano turbamento nel vedere il proprio seme scomparire in fondo ai sanitari, e non di rado, quando s’interrogavano sul destino della propria progenie, qualcuno di loro finiva inevitabilmente per fare strani incubi. «Pierre, devo chiederti una cosa». «Eh». «Hai presente la storia del minotauro…» «Eh». «La lezione di Yale qualche settimana fa… quella della donna ingravidata dal toro…» «Eh». «Mi chiedevo… visto che si parla di un animale che ingravida una di un’altra specie… mi chiedevo…» «Eh». «Sai, tutte le seghe che ci facciamo…» «Eh». «Se dopo che finisce nella tazza del cesso, il mio sperma dovesse, per caso, finire nell’ovaia di… che ne so… un topo… cioè… una topa?» Invece di soccorrere quelle piccole menti malate, l’istituzione affrontava la tematica sessuale con un’unica parola: repressione. 186 Radicale, piena e assoluta, la repressione sessuale del Franti si traduceva nel dispiegamento di un’ampia gamma di interventi che andavano dalla somministrazione di bromuro (sciolto nelle minestre infrasettimanali) alla ronda negli spogliatoi delle camerate, dalle prediche sull’importanza del controllo delle pulsioni, alle intimazioni ariane sulla necessità di tenere l’organismo efficiente per il lavoro; dal controllo assoluto della programmazione televisiva, all’embargo totale di connessioni internet nelle camerate. Da un lato la profilassi dell’immaginario, dall’altra la brutale coercizione. Ma la repressione di un istinto naturale finisce sempre per scatenare reazioni opposte, e così i ragazzi del Franti s’ingegnavano in tutti i modi (con modalità forse antiquate rispetto all’epoca digitale) ed escogitavano sistemi innovativi per alimentare il proprio immaginario erotico. Miccia era specializzato nella “veduta panoramica con cannocchiale”, un posizionamento strategico che gli consentiva di guardare a distanza siderale le ragazze che passeggiavano per le vie del centro. Col cannocchiale professionale che aveva rubato al padre poteva contare persino i quadretti delle calze a rete. Rob “Manara” disegnava fumetti erotici che poi leggeva di notte nello spogliatoio. Clemente sapeva immaginare una donna nuda in atti osceni in qualunque momento della giornata. Se la rappresentava così bene che alcuni avrebbero pagato oro per un trapianto di cervello. I reclusi, veri e propri partigiani dell’antiprofilassi, aggiravano i periodici controlli in camere e camerate sfruttando l’unico spazio ritenuto sicuro: lo spogliatoio della palestra. Lì, tutti gli armadietti erano rivestiti di poster e paginoni da cui traboccavano tette, culi, reggicalze e perizomi. Abitavano in quegli armadietti corpi femminili che le menti turbate dei collegiali sentivano come propri, corpi privati, perso187 nali, corpi ammirati nella sudata intimità del dopo palestra, corpi custoditi gelosamente come l’ostia nel tabernacolo. Le rare volte in cui qualcuno mostrava agli altri il corpo della propria donna, lo faceva con la fierezza di chi diceva “Hai visto la mia?” e allo stesso tempo la vigilanza di chi intima “Giù le mani, stronzo!” Ovviamente i menonovanta erano quelli che si spingevano oltre arrivando ad appendere scene di sesso che nemmeno nella Sodoma biblica. Ogni volta che Anu o Greco si avvicinavano per aprire l’armadietto, tutti gli occhi dello spogliatoio viravano in quella direzione accesi di una morbosità primordiale. In quelle immagini, il corpo maschile era espunto, ritagliato o cancellato, come a voler preservare la moralità di chi le guardava. Accadeva che, nel corso di un litigio o di una rissa, venissero coinvolte le donnine dei poster e l’effetto era piuttosto comico vista l’assoluta ambiguità della faccenda. Non prendeva parte a questa gara il solo Ostilio che, inspiegabilmente, (nessuno aveva mai avuto il coraggio di chiedergliene conto) aveva appesa sull’anta dell’armadietto il corpo vintage e pudicamente vestito di Maria Giovanna Elmi. Luogo di insospettabile ispirazione erotica era invece la biblioteca. In quella notevole collezione di libri gestita con amore dalla signorina Ludmilla, annidate tra enormi scaffali, c’erano piste segrete che conducevano a libri scabrosi. Rinchiusi in un’enclave ferma nel tempo, privati delle sofisticate epifanie tecnologiche, i ragazzi del Franti si rivolgevano alla più antica delle sollecitazioni dell’immaginario, la parola scritta, e davano vita a vere e proprie cacce al libro, cacce a coiti descritti con tutti i tecnicismi del caso in romanzi di genere, cacce a pagine di grandi romanzieri che si erano addentrati con sapienza nelle pieghe dell’erotismo. 188 I collegiali s’incontravano su queste piste segrete e si passavano titoli di libri che avevano letto come fosse merce rubata. «C’è una scena pazzesca!» «Sì? Fanno anche…?» «Sì, sì! Lo fanno, lo fanno! Prendilo!» Qualcuno, isolato cercatore di pepite d’oro, si staccava dai percorsi battuti e si cimentava in ricerche personali partendo da un titolo o dalla fama dell’autore, imparando sulla propria pelle che il Richiamo della foresta non aveva alcun significato nascosto o che Gabriele D’Annunzio aveva scritto anche romanzi casti oltreché noiosissimi. Quando aveva saputo di questa attività, Yale ne aveva intuito la potenzialità e l’aveva subito incentivata. Un giorno, durante una lezione, aveva sorpreso un menotrenta che leggeva Lo squalo, orrenda paraletteratura da cui avevano tratto un celebre film. I ragazzi avevano confessato che si trattava di un libro “di quelli che si leggono con una mano sola”; lui si era messo a ridere e poi, scorrendo rapidamente le pagine incriminate, aveva storto il naso. Immediatamente aveva dettato al ragazzo una breve lista di testi di letteratura erotica con la “E” maiuscola. Quello stesso pomeriggio, una decina di ragazzi, divisi in piccoli gruppi, si addentrarono in biblioteca alla ricerca delle Dodici giornate di Sodoma, le Undicimila verghe e Petrolio. La signorina Ludmilla rimase sorpresa da quel via vai ma si sentì dire che stavano partecipando a una caccia al tesoro organizzata dal professor Yale. Al vedere i titoli che prendevano, Ludmilla capì al volo che era una delle tipiche stranezze del professore; notò anche che Yale si era divertito a disseminare tra quei titoli anche testi di grande purezza (libri come Zarathustra o Le città invisibili) che i ragazzi leggevano comunque fino in fondo per paura di perdersi qualcosa nelle ultime pagine. 189 La signorina Ludmilla, trentenne dalle forme generose, si occupava della biblioteca tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18. Si presentava sempre vestita di maglioni spessi, gonne larghe, lunghe e scure, collant coprenti e ballerine ai piedi. Si limitava a un timido rossetto e a una leggerissima passata di rimmel. Teneva i capelli biondi raccolti in una coda di cavallo, camminava a piccoli passi cercando il più possibile di evitare, quando doveva piegarsi in avanti, di sottoporre gli abiti ad ogni tipo di attillatura. Nonostante le precauzioni adottate, la visione della signorina Ludmilla, per ogni giovane uomo costretto al Franti, era l’equivalente di una pornostar al supermercato. In particolare per un adolescente come Dave. Dave era stato il primo, un pomeriggio di fine maggio, ad accorgersi del fascino nascosto della bibliotecaria. Nel giro di pochi minuti, la biblioteca si era trasformata in una serra e Dave aveva avuto il privilegio di ammirare l’inatteso sbocciare di un fiore: la bibliotecaria si era sfilata il maglione di lana che ancora a maggio si ostinava a portare; sotto aveva una camicia di lino, bianca e immacolata, risalente di certo a qualche anno addietro, a quando le forme della ragazza non erano ancora così pronunciate, una di quelle camicie che ci si mette solo nella certezza di non doverle mostrare. Dave, che intanto stava sbavando su certi sonetti erotici di Paul Verlaine, restò senza fiato alla vista di quella stoffa imbottita di carne. Poggiò il libro sullo scaffale, fece qualche passo sul ballatoio su cui era intrespolato e scese la scala a chiocciola per andare a veder da vicino cosa trattenessero a stento i bottoncini di quella camicetta. Era completamente in trance. Appena Ludmilla se ne accorse, si sedette al riparo del muro d’accettazione e si mise a riordinare nervosamente un raccoglitore di schede. Quando Dave le fu a un metro, lo fulminò con lo sguardo. Lui restò imbambo190 lato, poi cercò goffamente di protendersi oltre il muretto divisorio, sbattendo la fronte sul vetro. «Hai bisogno di qualcosa, Dave?» gli chiese con voce decisa. Dave sentì una forza incredibile spingere dalla trachea. Una grande energia calda che gli sussurrava “dille di sì, dille che hai bisogno di qualcosa, qualcosa che solo lei può darti…” «Hai bisogno di qualcosa, Dave?» ripeté Ludmilla ancor più severa. “… dille che hai bisogno di vederla spogliata, perlomeno della camicia…” «Dave… hai bisogno di qualcosa?» “… dille che non occorre si denudi tutta, anzi, nemmeno parzialmente… è più che sufficiente che si levi la camicia e rimanga in reggiseno… sì… è una richiesta più che ragionevole…” «Dave…» Dalle labbra di Dave uscirono le parole: «… più che ragionevole…» «Cosa più che ragionevole?» «… mi sembra una richiesta più che ragionevole…» «Dave?» «…nemmeno parzialmente…» «Dave… non vuoi farmi preoccupare, vero? Vuoi che chiami il Direttore?» Appena mosse la testa verso il telefono, Dave ebbe un sussulto. «Non alzi la cornetta! Sto benissimo!» Poi si ricompose, prima di scappare dalla biblioteca. Il mattino seguente, Dave crollava dal sonno e non smetteva di pensare a Ludmilla. Nell’ora di matematica fu interrogato sui trinomi. Fece scena muta e si beccò un tre. In quella di inglese ascoltò, con le lacrime agli occhi, un dialogo in lingua tra 191 due innamorati che si dicevano addio. Nell’ora di italiano, dopo una lezione sul simbolismo francese, Yale gli chiese se avesse letto le poesie di Verlaine. Dave rispose che le aveva lette tutte. Yale domandò come le aveva trovate. Dave rispose: «Eccessivamente volgari». «Ma come» proruppe il professore, «mi rompete tanto i coglioni perché vi consiglio autori troppo morigerati, e poi avete il coraggio di trovare “troppo volgari” le poesie di Verlaine? Ma allora siete proprio dei cazzoncelli!» Dave restò impassibile. Non lo stava nemmeno ascoltando. Quel pomeriggio, Dave entrò in biblioteca, salutò Ludmilla con un sorriso innaturale e si sedette al primo banco, a pochi metri da lei. Se ne restò lì tutto il tempo senza mai alzarsi, un paio di enciclopedie, che distrattamente sfogliava, e un quaderno aperto davanti. Guardava l’accettazione con la coda degli occhi, sobbalzando ogni volta che Ludmilla si alzava per andare verso uno scaffale o scomparire dentro un corridoio. Era molto coperta, con dei pantaloni blu, un maglione in cotone largo che le arrivava fino ai fianchi, le ballerine grigie. Non dava alcuna concessione, insomma. Per lui fu comunque una giornata meravigliosa. Ne seguirono altre simili. Poi un giorno, a rompere l’incanto di quell’idillio, fece la sua apparizione il Rettore. Da quel momento in poi, tutti i giorni – prima fugacemente poi immancabilmente – Augusto cominciò a passare in biblioteca per lisciarsi la bibliotecaria. Come un felino pronto all’attacco, Dave li scrutava inquieto. Cercava di carpire ogni messaggio nascosto nella loro comunicazione. 192 Il Direttore arrivava sempre verso le quattro e chiedeva consigli su determinati libri. Ludmilla rispondeva con gentilezza e grandi sorrisi. Lui le lanciava una battuta, dopo di che faceva una passeggiata tra i banchi. Passava le dita sul legno per misurare la polvere, quindi si fermava di fronte a Dave. Certi giorni lo salutava con un cenno del capo (“Sei qui anche oggi?” sembrava voler dire); altri gli rivolgeva parola chiedendo cosa stesse studiando. Dave mugugnava qualcosa tipo “Stendhal…” oppure “Congresso di Vienna…”, reprimendo a stento l’istinto di azzannargli il collo. Iniziò a trascorrere in biblioteca il maggior tempo possibile, soprattutto dopo le quattro, per impedire ai due adulteri di consumare la loro passione. Il martedì, in particolare, diventava paranoico fin dalla mattina al pensiero di cosa avrebbero fatto quei due durante la sua assenza. Il Rettore, allora, cominciò a passare più tardi, pochi minuti prima delle 18, in modo che – a Dave fu subito chiaro – la chiusura della biblioteca lo costringesse a lasciarli soli. Un pomeriggio Dave, approfittando che Ludmilla era in bagno, raccolse i suoi fogli e si inerpicò su un ballatoio vicino all’accettazione. Ludmilla tornò e si guardò intorno per sincerarsi che lui se ne fosse andato. Era bellissima. Aveva sciolto i capelli e si era passata un rossetto lucido sulle labbra. Dopo un quarto d’ora sentì i passi del Rettore, i soliti saluti formali, alcune battute ad alta voce e poi… come dei bisbigli, parole pronunciate a fior di labbra… quindi… il silenzio. Dovette imporsi di stare calmo. Se si sporgeva poteva vedere le loro ombre sul pavimento. Sembravano molto vicine. Sentì il sangue salirgli alla testa e pensò di lanciarsi nel vuoto. Esitò un attimo prima di sentire la voce del Rettore, leggermente incrinata d’emozione, pronunciare parole 193 chiare e distinte. Il Rettore proponeva a Ludmilla di condividere una piccola passione intellettuale! Aveva sentito bene? Le stava proponendo di portare avanti, insieme, un progetto culturale. Ci stava provando. Non aveva più dubbi. Quel fottuto fascista del cazzo, approfittando della sua posizione sociale, ci stava provando col suo unico amore. Probabilmente l’aveva minacciata di licenziamento, l’aveva ricattata, l’aveva costretta a cedere con l’inganno. «Mi piacerebbe che lavorassimo insieme ad alcune voci di Wikipedia». Wikipedia? Cos’era, un linguaggio cifrato? «Io ho poco tempo a disposizione e ho bisogno di una mano. È il progetto più incredibile che l’umanità abbia partorito dai tempi di Diderot e D’Alembert. È l’enciclopedia a contenuto aperto! La conosci?» «Certo Direttore. È uno strumento indispensabile, anche se per certe cose… preferisco i cari vecchi libri… Sa com’è…» Li sentì ridacchiare. «Però, Direttore, non so se sarò all’altezza…» «Cosa la spaventa, signorina?» «La mia cultura… temo sia inadeguata…» «Per scrivere su Wikipedia non è necessario conoscere: basta la semplice attitudine al conoscere! Guardi, le faccio vedere una cosa. Ecco qua. Le pagine sono parecchie. Si concentri solo sulle linee guida…» «Queste?» «Sì. Sono essenziali e… bellissime! Legga qua: Evita i pregiudizi… Rispetta il copyright… Rispetta gli altri contributori… Che ne dice?» «Sono bellissime… Direttore…» 194 «Cioè… io credo che questa sia veramente una grande opportunità che l’umanità si è data per risollevarsi dalle brutture di quest’epoca barbarica…» «…» «Un nuovo straordinario progetto enciclopedico!» «…» «Legga qua, Ludmilla!» Tu sei un redattore di Wikipedia. Wikipedia è priva di un capo-redattore o di un meccanismo centrale, dall’alto in basso, che controlla ed approva il progresso giornaliero dell’enciclopedia. «Capisce che cosa entusiasmante? Lei deve solo accedere a questa pagina, scaldare le dita sulla tastiera e dare vita a un Nuovo Illuminismo. È una vita che aspetto questo momento!» «…» «Modifica questa pagina! La cosa incredibile è che l’invito di Wikipedia arriva a sei miliardi di persone! Chiunque può dare il proprio contributo a quest’opera di capitale importanza!» «Però se non c’è gerarchia, non c’è ordine…» «Come?» «Ai tempi degli illuministi, l’enciclopedia raccoglieva il sapere umano con un ordine, un’impostazione, un punto di vista tutt’altro che irrilevante…» «Appunto: non era libera! Vi era un ordine precostituito che imponeva un punto di vista! Wikipedia va oltre. Wikipedia è la vera rivoluzione democratica nel campo del sapere!» «Io penso che fra la troppa democrazia e l’anarchia il passo sia breve…» 195 Augusto rimase stordito dalle parole di Ludmilla ma subito si riprese. «Il rischio che lei paventa è un rischio che si deve correre. La posta in palio è troppo grande per rinunciare in partenza!» Augusto sentì le proprie parole riecheggiare nella sala della biblioteca e poi nella sua mente. Erano parole grandiose, degne di un nuovo spirito illuminista, ma erano anche parole insopportabilmente stridenti con ciò che lui incarnava, col luogo in cui si trovava, con la propria parte destrorsa. Dopo un istante, la voce di Ludmilla spazzò via ogni tentennamento. «Ha ragione Direttore». Quella era sera di cineforum. Accadeva una volta al mese ed era Augusto a occuparsi della scelta del film, della presentazione e del dibattito a fine proiezione. La rassegna, di norma, ruotava attorno a tematiche impegnative come la pedagogia, il diritto, l’etica. Quella sera, invece, il film proiettato era Pretty Woman. Dave capì che il Direttore era bello che andato e decise che doveva fare qualcosa per fermare l’evolvere di quegli eventi funesti. Il giorno dopo, trovò Ludmilla al computer. Allungò gli occhi sullo schermo e vide che stava appuntando su un quaderno le Linee Guida di Wikipedia. «Scusi, signorina Ludmilla…» «Dimmi, Dave». «Mi servirebbe un libro che non riesco a trovare…» «Vengo a darti una mano». La scena si ripeté un paio di volte nel giro di un’ora, dopo di che, alla terza richiesta di aiuto, Ludmilla lo guardò e gli fece capire che non era il caso di insistere oltre. 196 Del resto, Dave non poteva pensare di tenerla lontana da Wikipedia per tutta la vita con quegli stupidi stratagemmi. Per fermare l’evolvere degli eventi funesti ci voleva ben altro. Quella sera Dave andò in Aula Informatica e, sotto la sorveglianza del guardiano, entrò in Wikipedia cercando di capire come funzionava. Lo colpì particolarmente una sezione dedicata al vandalismo wikipediano intitolata Politiche di messa al bando degli utenti. Una messa al bando di Wikipedia è una revoca formale della possibilità di modificare pagine di Wikipedia. Tale messa al bando può essere temporanea e di durata prestabilita, o indefinita e potenzialmente permanente. Qualche sera dopo, Dave cercò Marino, un menoventi finito in collegio per una dipendenza cronica dall’informatica. Tra loro correvano ottimi rapporti. I primi giorni al Franti si erano raccontati le loro storie e avevano sentito di appartenere alla stessa razza. «Niente di che. Entri. Prendi un account. E scrivi». «Si può entrare con una password che non è tua?» «Sì, ma la prima volta devi accedere al sito dal computer di un wikipediano». «Vuoi dire che non si può con un altro computer?» «Impossibile». «E quanto occorre?» «Un minuto. Mi spieghi cosa devi fare?» Dave rispose senza troppi particolari e omettendo i perché. Marino non fece domande e gli chiese se gli serviva altro. «Lo faresti tu? Io sono più lento…» «Dave, non sono mai stato in guardina…» 197 «È una cosa importante». «Capisco, ma è troppo pericoloso…» «Ti do la mia razione di prosciutto cotto per tutto il mese». «Tre mesi». «Affare fatto». Il pomeriggio dopo, Dave era puntuale in biblioteca. Salutò Ludmilla che rispose con il solito: «Buongiorno, Dave». Lui si sedette e finse di lavorare per alcuni minuti. Poi si alzò e cominciò a muoversi nervosamente tra gli scaffali e lo schedario. Dopo un po’, arrivò Marino. Prese da uno scaffale un grosso libro sulla seconda guerra mondiale e si sedette vicino all’accettazione. Per un quarto d’ora, Dave le passò davanti finché Ludmilla lo chiamò e gli chiese se aveva bisogno di aiuto. Lui annuì e disse che non voleva disturbarla. Lei insisté e allora lui andò da lei e le sparò un paio di titoli che sapeva disseminati nei luoghi più remoti della biblioteca. Lei si alzò e gli disse di seguirlo. Un attimo dopo erano spariti nei meandri della biblioteca. Marino entrò nell’accettazione e artigliò il computer. Quella sera Marino mangiò doppia razione di prosciutto e poi accompagnò Dave in Aula Informatica. Il guardiano, dati i suoi precedenti, sapeva che Marino poteva accedere all’Aula solo con un permesso scritto, ma appena lo vide entrare gli s’illuminarono gli occhi. «Marino!» esclamò «Che tu sia benedetto!» Gli si era appena impallato il computer nel mezzo di una finale a Fifa 2009. Risolto il problema in meno di un secondo, Dave e Marino si sedettero a una postazione e accesero il computer. Marino aiutò Dave a entrare nelle pagine di Wikipedia e digitò la password di Ludmilla. 198 «Adesso è tutto tuo» disse, poi si alzò e andò a navigare da un’altra parte, mentre il guardiano vinceva 2 a 1 contro la Germania. Dave restò lì, immobile e intontito. L’idea di essere penetrato nell’intimità di Ludmilla lo turbava molto. Le stava rubando qualcosa e si sentiva sporco e scorretto ma questa nuova consapevolezza non gli impedì di andare avanti. C’erano una ventina di righe sulla vita e una decina sulle opere più importanti di questo Márquez. Lesse più volte e poi manomise la sua data di nascita e quella di pubblicazione del libro più famoso. Quindi restò lì, a tamburellare le dita sul tavolo, indeciso se aggiungere altro o ritenersi soddisfatto. Il giorno dopo, il Direttore arrivò in grande anticipo, alle 16:50. In quel momento, Ludmilla era tra gli scaffali. Dave era seduto al solito posto con le orecchie in ascolto. Il Direttore era raggiante, camminava con passo allegro, le mani dietro la schiena, uno strano sorriso sulle labbra. Dave non capiva da dove venisse quell’allegria. Non aveva notato quale capra stava corteggiando? Márquez non era nato nel 1860 e Cent’anni di solitudine non era stato pubblicato nel 1881! Quando la bibliotecaria tornò all’accettazione fu sorpresa di vedere il Rettore così presto e la prima cosa che fece fu ravviarsi i capelli. Subito dopo, Dave capì perché il Direttore era così raggiante: non vedeva l’ora di sgridare Ludmilla. Era eccitato del fatto di poter rimarcare la propria superiorità intellettuale. «Mi spiace Direttore, ho inserito quei dati con poca attenzione… sono molto dispiaciuta…» «Ma no, Ludmilla, non è grave… Una distrazione capita a tutti! Le raccomando, in futuro, una maggiore attenzione perché un buon lavoro di ricerca può essere vanificato da ogni piccola disat199 tenzione. Comunque, ieri sera ho dato un’occhiata al suo lavoro e, visto che abbiamo la stessa password, l’ho subito corretto. Errare è umano. L’essenziale di Wikipedia è non lasciare i propri errori per troppo tempo!» «Sì, Direttore…» «Sa, forse per farle percepire il senso profondo di questa iniziativa dovrei spiegarle meglio alcuni concetti. Lei lavora in un luogo che ormai rappresenta solo il passato del sapere. Il primo mezzo di ricerca, oggi, è la rete, e qualunque ricerca lei faccia in rete, la prima risposta che le viene indicata è proprio quella di Wikipedia». «Lo so, Direttore…» «E sa chi sono gli Eccellentissimi Wikipediani?» «No, Direttore». «Sono i compilatori più prolifici di Wikipedia. C’è un magnifico premio a fine anno per questi meritori estensori». «Non lo sapevo, Direttore…» «Cosa c’è signorina? Perché si è rabbuiata?» «Direttore… lei insegue un obiettivo importante e io… non mi sento all’altezza. La mia preparazione non è all’altezza di un tale compito». «Non dica stupidaggini! Ricorda? Tu sei un redattore di Wikipedia. Tu! Chiunque può diventarlo! Ne è all’altezza, signorina, ne sono certo!» «Grazie, Direttore». «Voglio che insieme entriamo tra gli Eccellentissimi!» «Va bene, Direttore». «Non vuole sapere qual è il premio, Ludmilla?» Ci fu un attimo di silenzio. Dave vide che Ludmilla abbassava gli occhi. «Il premio, Ludmilla, è un viaggio per due persone a Praga». 200 Ci fu di nuovo silenzio. Poi lei disse, con un po’ di imbarazzo: «È una città molto bella, Direttore…» «Sì, è molto bella». Per un istante il Rettore si voltò verso Dave, corrugando la fronte. Dave gli rispose con una specie di ringhio. «Sotto col lavoro, allora!» «Va bene Direttore». «Ascolti: qualche tempo fa ho notato che la voce di Wikipedia riguardante Borges era incredibilmente povera, così ho iniziato un approfondimento che però non ho potuto completare. Le dia un’occhiata e veda se c’è qualcosa che si può integrare». Quella sera, intorno alle 21:36, passando attraverso le tastiere della piccola sala informatica del Franti, il grande scrittore Jorge Luis Borges divenne: Il più importante castratore di cani della storia argentina, famoso per l’abitudine di eseguire l’operazione utilizzando solo mani e unghie. Visse a lungo in patria, castrando all’incirca 20.000 cani nel corso di una gloriosa carriera, poi si trasferì in Spagna, a Valencia, dove aprì una piccola trattoria in cui si poteva gustare una deliziosa paella arricchita da prelibati testicoli canini. Il giorno dopo era martedì e l’obbligo di andare in città negò a Dave il piacere di assistere all’incontro tra Ludmilla e il Direttore. Mentre se ne stava in un angolo dell’autobus, immaginava Loglio sbattere i pugni sul tavolo dell’accettazione, urlare a Ludmilla dove cazzo avesse trovato quelle scempiaggini su Borges, e trattenere a stento gli insulti verso colei che gli aveva compromesso 201 la possibilità di entrare nella ristretta schiera degli Eccellentissimi Wikipediani. Invece quel pomeriggio, tra le 14:00 e le 15:45, i due fedifraghi s’erano intrattenuti sul fresco pavimento della biblioteca, poggiandoci, a turno, la schiena sudata. 202 Ho passato giorni tremendi. Ho avuto le palpitazioni e forse un po’ di tachicardia. Ho maledetto il momento in cui ho deciso di rinchiudermi in questo angolo di mondo senza portare le precauzioni a un’eventuale crisi ansiogena. Chi era quell’uomo? Cosa voleva? Chi lo mandava? Ho smesso di scrivere sei giorni fa. Ho anche smesso di uscire. Sono rimasto a letto per ventidue ore al giorno, alzandomi solo per andare in bagno. Ho mangiato sottilette e pancarré. Per calmarmi ho bevuto metà del vino che avevo da parte. Faticosamente sono riuscito a ritrovare un po’ di equilibrio e ieri ho ripreso a vivere. Mi sono lavato e vestito decentemente. Ho camminato per la casa. Ho pulito il pavimento. Ho mangiato. Ho acceso il computer. Ho riletto la mail del Tirreno. Ho riaperto la homepage del quotidiano, ho controllato gli articoli degli ultimi giorni, ma non c’è traccia dell’inchiesta. È probabile che nella versione on-line vengano inseriti solo alcuni articoli del formato cartaceo. Quale elemento può aver dato adito a un’inchiesta sulla mia morte? Il lago restituisce i cadaveri ad anni di distanza, quando li restituisce. A suonare il campanello potrebbe essere stato un agente immobiliare, o un messo comunale, o un uomo in cerca di informazioni. Se anche qualcuno avesse sospetti sul mio finto suicidio, non potrebbe mai arrivare fin qua. Sono a centinaia di chilometri da casa in un’abitazione che una vecchia zia mi lasciò in eredità ormai quin203 dici anni or sono e dove sono venuto di tanto in tanto da solo a scrivere, senza mai incontrare nessuno, senza mai conoscere o farmi conoscere. Nemmeno alle mie figlie l’ho detto. Nessuno mi ha seguito. Nessuno mi ha visto. Non ho schede telefoniche, bancomat o altro, e la wireless del computer è stata acquistata in contanti e lasciata anonima. Poi mi è venuta un’idea: spedire una nuova lettera al Direttore del Tirreno, ringraziarlo per i chiarimenti e domandargli in quale data verrà pubblicata l’inchiesta. Ma ho desistito immediatamente: se qualcuno sta veramente sospettando qualcosa, se qualcuno ha davvero fiutato qualcosa, una mia nuova mail potrebbe accrescere i dubbi e addirittura dettare una pista. Il sangue mi si è gelato: che la mia prima mail abbia già scatenato qualcuno sulle mie tracce? Forse comincio a esagerare. Sentirmi braccato in questa maniera… come se fossi un omicida… Devo riprendere a uscire, a prendere aria, a muovermi al di fuori di queste mura. Stanotte lo farò. 204 Nick, Dave e Marino erano affacciati alla finestra. Erano tristi e pensavano tutti alla stessa cosa. «Ho voglia di andare a casa» disse, a un certo punto, Marino. «Anch’io» fece eco Dave. «Ho voglia di andare a casa» incalzò Marino «e chiudermi in camera mia. Starci un mese di fila senza metter fuori nemmeno le antenne. Io e il computer, il computer e io. Come in luna di miele». «Anzi» fece Dave, «io non voglio andare a casa perché so già che lì mi aspetta il maledetto Wittgenstein». «Nessuno ti obbliga ad andare a casa» disse Nic. «Quando finisce la scuola, scappa via, prendi uno zaino e fai l’autostop…» «Vieni anche tu?» «Dove?» «In autostop». «Macché, io ho da fare a casa». «Tipo?» «Pescare. Voglio pescare giorno e notte». All’ultimo piano, i ragazzi di quinta preparavano gli esami di maturità nelle piccole stanze impregnate di fumo, chi ripassando astrusi teoremi, chi ingollando anfetamine come mentine per la raucedine al cervello, chi russando beatamente come se con la commissione ci fosse solo da scattare una foto ricordo. Peppe apparve alla portafinestra di Raul. Raul studiava a torso nudo e con un paio di bermuda beige, i lunghi capelli biondo cene205 re, un libro di storia spalancato davanti agli occhi su cui erano calati due vecchissimi Ray-Ban. Peppe salutò e Raul gli chiese se andava tutto bene. «Ho lo scroto che non sfigurerebbe a un concerto di bonghi». «Di svuotarlo non se ne parla?» Raul uscì sul terrazzo e si accese una sigaretta. Insieme fecero qualche passo di lato e sbirciarono tra le persiane della stanza da cui si sentiva russare. «Che idiota…» «Lo canneranno?» «È talmente inculato che sicuramente gli andrà bene…» «Per me lo cannano». Raul picchiò sul vetro e stette ad ascoltare: russava ancora. Batté più forte, un colpo secco. Non russava più. «Tognazzi!» Si sentì il cigolio metallico del letto, una mezza bestemmia e la persiana si aprì. Apparve un toro con la maglietta madida di sudore e le mutande uno straccio lercio. «Chi cazzo è che rompe il cazzo?» «Tognazzi, ce l’hai una birretta?» chiese Raul. «Uh» farfugliò il toro ritraendosi. Un’oscura marca slovena o croata, già stappata. Tognazzi ne comprava all’Iper un paio di cassette ogni martedì, dopo le partite di calcio, le portava in collegio di nascosto e le rivendeva al doppio del prezzo. Doveva aver messo assieme un discreto gruzzolo. Raul gli diede una monetina. «Studiato per domani?» Tognazzi lo guardò: il sopracciglio alzato tirava su mezza faccia. «Studiato cosa?» chiese. «Domani» s’inserì Peppe. «Domani cosa?» insisté Tognazzi. 206 «L’esame». «L’esame cosa?» «Fanculo». «Fanculo cosa?» «Domani c’è l’ultimo tema prima della maturità…» Tognazzi scrollò le spalle e rientrò in stanza, chiuse le imposte e tornò a letto. Raul tenne il tempo con le dita e prima di arrivare a dieci si sentì di nuovo russare. La birra durò pochi secondi, il tempo di affacciarsi una stanza più in là. Dentro, chino sulla scrivania invasa di libri, perso tra i capelli lunghi e corvini e assorto in una nenia schizoide, un mormorio che scandiva chissà quale lettura o ripasso, c’era Germano. Nei giorni precedenti Germano aveva elaborato un misterioso calcolo statistico. Aveva raccolto tutti i dati relativi alla prova di italiano da quando esisteva l’esame di maturità, aveva smadonnato sui dati per tre giorni e tre notti, li aveva scandagliati, stuprati, eviscerati, li aveva incrociati con decine di variabili e ne aveva tratto, infine, una rivelazione sconvolgente: all’esame sarebbe uscito Bacchelli, più specificatamente Il mulino del Po. Chiaramente, conoscendo le sue mattane, nessuno l’aveva preso sul serio. Raul batté il becco della bottiglia sulla finestra e lo salutò facendo un sorso alla sua salute. Germano alzò la testa e abbozzò un sorriso tirato. Poi sollevò la copertina del libro che stava leggendo. Il mulino del Po. Raul fece di no con la testa. «Ne sono sicuro!» urlò Germano. «No, no…» ribatté Raul scuotendo la testa. «SÌÌÌ INVECEEEEEE!!!» 207 Gli schiamazzi dei ragazzi arrivavano attutiti nello studio del Direttore. C’era caldo afoso. Yale curiosava tra gli scaffali della libreria e sfogliava un vecchio saggio sull’estetica romantica. «A volte mi sembra che tutto questo non abbia senso…» disse Augusto. «A volte?» sorrise Yale. «Non so. Mi sento come se una parte di me non c’entrasse nulla con quello che faccio… e quella parte si stia ribellando… è una sensazione strana…» «Stai scopando ancora con la bibliotecaria?» «Perché?» «Mah…» «Cosa vuoi dirmi, Edo?» «Niente. Mi hai preso per uno psicologo?» «Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a trovare un po’ di equilibrio interiore…» «Ricorda: chiunque ti dica come regolarti, ha l’alito che puzza di whisky». «Eh?» «Niente. Diciamo che stai per sbroccare». «Sto per… sbroccare?» «Yeah. Per carità, è un discorso che riguarda il novanta per cento degli occidentali. Oggi non c’è niente di più normale del non starci dentro. È più normale di qualsiasi altra cosa. Certo, tu te la sei cercata. Mi ricordo ancora quando sei entrato nel Gruppo… eheheh… ti ricordi quando sei entrato nel Gruppo?» «Certo che mi ricordo». «Che ridere mi facevi. Mi facevi morire…» Per un attimo il discorso rimase sospeso, come se tra loro stesse montando una strana distanza, poi entrambi proruppero in una risata liberatrice. Augusto un po’ isterica, Yale proprio di gusto. Il 208 Rettore andò in cucina e tornò con due bicchieri di rum e qualche cubetto di ghiaccio. Brindarono mentre rievocavano alcuni episodi di quel periodo. «Il giorno prima coltivavamo erba e sparavamo merda sulla borghesia; il giorno dopo ti ritrovo alle riunioni di un merdosissimo gruppo bancario…» Ridevano forte, e adesso la risata di Augusto aveva perso ogni sfumatura isterica. Il ventilatore sbuffava come in un vecchio commissariato da film poliziesco. «E quando ci vedevamo la sera e pomposamente mi nominavi il Gruppo, io dentro di me pensavo ma gli è scoppiata la merda nel cervello? Dovevi sentire come dicevi Gruppo. Dicevi GRRU-PPO, no anzi… G-RRUPP-PPO… con un tono che sembrava stessi parlando dell’accademia di Svezia… G-RRUPPPPO…» «Cosa potevo fare? Volevo un po’ di soldi. Volevo sistemare le cose, inseguire i miei sogni». «Come tutti, Augusto. Ma tu non avevi solo quei sogni». «Lo so… siamo tutti pieni di contraddizioni». «Lo vieni a dire a me?» sorrise Yale. «Tu sai tenerle a bada». «Io reggo i miei sdoppiamenti senza tante lagne. È come convivere con qualcuno, solo che non si tratta di altri esseri umani. Sai cosa mi viene in mente, certe volte, quando ti guardo?» «Cosa?» «Hai presente lo squartamento? Quando nel sedicesimo secolo ti legavano gambe e braccia ai cavalli e poi davano di frustino alle bestie?» «Ho presente». «Ecco, tu sei quel poveraccio smembrato. Dimmi un po’, ci scopi ancora con la bibliotecaria?» 209 «Sì, perché?» «I ragazzi lo sanno». Da qualche tempo, Nic e Dave si frequentavano meno. Dave passava i pomeriggi in biblioteca e le sere in Aula Informatica. Era sempre più torvo e lunatico, incapsulato in un mondo tutto suo fatto di rabbia e mistificazione della realtà. Era scollegato e Nic non stava più volentieri con lui. Nic invece aveva cominciato ad andare male a scuola e, un quattro dopo l’altro, stava colando a picco. Era chiaro che nel Franti non c’era traccia di una programmazione differenziata che tenesse conto della sua dislessia. A parte Yale, gli insegnanti lo trattavano come un lavativo o, peggio, un buono a nulla. E, come accade in ogni adolescenza difficile, il problema non era solo la scuola. Il problema era tutto. Tutto ciò che s’agitava dentro di lui. Tutto ciò che lo circondava. Tutto. Amava sempre più il buio e il silenzio. Così, inconsciamente, per far esplodere o implodere questo malessere cominciò a frequentare il gruppo di Ostilio. Una sera che uscì a fare due passi sul terrazzo del dormitorio, si sentì chiamare da una voce nell’ombra. Era Anu, accucciato contro la ringhiera, che lo esortava ad avvicinarsi. «Vuoi fumare?» «Sì» rispose Nic, stupito di sé. «Non è una sigaretta» precisò Anu. «L’ho capito». Si sedette e diede due tiri. Era tutto immobile e privo di sensazioni. Dopo un po’, si sentì la porta della camerata e i passi di qualcuno. Nic si ritrasse nell’ombra ma Anu lo tranquillizzò: era Ostilio con altri due. Quando arrivò, sputò nel vuoto e salutò Anu. 210 «Cazzo sei tu?» chiese, avvicinandosi al volto di Nic. Aveva l’alito che sapeva di cipolla. Nic non rispose. Sorrise timidamente nel buio. «È un menodieci. Sta fumando con me» disse Anu. «Un menodieci che fuma!» esclamò Ostilio sedendosi a terra. «Menoventi» puntualizzò Nic. «Ah, stai risalendo la china? Bravo figliolo… la mamma sarà contenta, vero ragazzi?» Risero tutti, alzando troppo la voce. Ripresi da Ostilio, finirono di fumare accoccolati nel silenzio tiepido della notte. «Adesso andiamo a fare quella cosa» fece Ostilio. «Posso venire con voi?» chiese Nic appena confuso dal fumo. «Non sai nemmeno dove stiamo andando» disse Anu. «Non importa. Fatemi venire lo stesso». «E se andassimo a tagliare la gola al Rettore?» «Verrei di corsa». Ostilio e gli altri si guardarono in faccia. Nic li vide sorridere e lo prese come buon segno. «Andiamo allora» esclamò Ostilio, «è arrivato il momento d’intaccare le grasse finanze di Prepuzio Solitario!» Nic si alzò e s’accodò agli altri. Rientrarono in dormitorio e attraversarono furtivamente le camerate e i corridoi. Scesero un numero imprecisato di scalini immersi nella penombra, perfettamente in fila, attenti a non far rumore, anche se, di tanto in tanto, uno sghignazzo sfuggiva al controllo. «Quanti anni avrà Prepuzio Solitario?» «Boh. So solo che se li porta male». «Cosa ti ha detto ieri, Ostilio?» «Dopo la guardina, dici?» «Eh». 211 «Le solite cose: se vai avanti così farai una brutta fine… stai facendo del male a te stesso… sempre le stesse stronzate». «E tu?» «Secondo te?» Nic era l’ultimo della fila. Si sentiva bene, per niente intimorito da quello che stavano facendo. Il fatto di non sapere dove stessero andando non gli creava nessuna ansia. Sapeva solo che stavano attraversando mezzo collegio e camminando in corridoi mai visti prima. Durante il percorso non gli dissero niente. Solo una volta Ostilio gli rivolse parola dicendo che in quel momento era arrivato a menotrenta. Ancora dopo, arrivarono ai sotterranei del collegio e percorsero quegli antri umidi illuminati da una torcia elettrica che Ostilio aveva preso dalla giacca. Sopra di loro correvano tubature arrugginite che sgocciolavano in testa. L’umidità era altissima e Nic si sentiva, ad ogni passo, sempre più sudato. A un certo punto, si trovarono davanti un portone di ferro. Anu s’avvicinò alla serratura e armeggiò per qualche secondo con un grimaldello mentre Ostilio gli faceva luce con la torcia. Dopo un attimo, la porta si aprì e diede adito a un immenso scantinato. Entrati, si chiusero dentro e trovarono gli interruttori. Le luci erano poche e fioche e l’ambiente era tutto impregnato di muffa. «Comincia la festa!» disse Ostilio, e ognuno di loro si diresse in una direzione diversa. Nic restò spaesato. Dopo pochi istanti Ostilio e gli altri riemersero con le mani piene di vivande di ogni genere e le gettarono sul tavolo. Anu porse a Nic un salame, ma Ostilio lo fermò. «Lascia che s’arrangi, il signorino. Finora si è limitato a camminare dietro di noi e, in pratica, gli abbiamo regalato un menotrenta. Se vuole arrivare a menoquaranta in una notte, deve sporcarsi le mani». 212 Nic, allora, iniziò a darsi da fare. Dopo aver addentato un panino stantio, andò a pescare un bottiglione da cinque litri di vino e lo portò al tavolo. «E bravo il nostro menoquaranta!» esclamò Ostilio agguantando il bottiglione. «È bravo, eh?» fece Anu. «Ma se non ha fatto ancora niente!» esclamò Nocca addentando una mela. «Vedremo nei prossimi giorni» sentenziò Ostilio. Bevvero insieme. Il vino era freddo e acido, ma lo tracannarono in pochissimo tempo. Con loro, Nic si sentì vivo come mai negli ultimi tempi. «Questa la dedico a mio nonno che è morto la settimana scorsa: salute nonno, e scusa se qualche pezzo di merda non mi ha lasciato uscire di qui nemmeno per il tuo funerale!» «Salute a tuo nonno, Pierre» fecero gli altri sollevando a turno il bottiglione. «Beh, salute non è proprio l’augurio giusto…» disse Nic. Risero prima di accendersi le sigarette e iniziare a tirare come forsennati. La prima volta che Nic finì in guardina fu per una canna. Gliela trovò un guardiano che si aggirava sul terrazzo delle camerate. Nic non fece nulla per nasconderla, continuò a fumarsela con una certa strafottenza. La mattina dopo, durante la lezione di matematica, il Direttore entrò in classe senza bussare e chiamò il cognome di Nic. Rimase in cella fino alle 23:00 di quella sera. Il Direttore, prima di chiudere il portone di ferro alle sue spalle, aveva detto: «Mi auguro che sia la prima e ultima volta». 213 Passò la sua prima giornata in isolamento seduto su una panca di legno, immerso nella cecità di quel buio che, stranamente, lo faceva star bene. Lasciò il passo ai ricordi felici. Rivide la madre che lo portava a lezione di batteria. Rivide la logopedista che gli faceva una carezza e gli asciugava una lacrima. Rivide un carnevale da bambino in cui s’era vestito da pellerossa. Rivide il professore di motoria litigare con quella di italiano. Rivide se stesso che voleva andare in Cina. Rivide il ponte al fiume con le scritte che leggeva senza difficoltà. Rivide lo zio che gli regalava un cd con una copertina strepitosa. Il buio non gli faceva paura. Vide un torrente fragoroso in cui guizzavano trote mastodontiche. Vide una ragazza che lo salutava dal finestrino di un treno e poi scendeva di corsa ad abbracciarlo. Vide un nastro trasportatore su cui sfilavano gelati alla crema. Vide suo padre chiedere di lui con vero interesse ai colloqui coi professori. Vide un cane leccargli le mani e scodinzolare come fosse felice. Vide un libro in cui le lettere non si muovevano come predoni del deserto. Stavano immobili e si lasciavano leggere come agnelli sacrificali. Da fuori, non veniva alcun rumore. Si ricordò cosa gli aveva detto Ostilio, e cioè che lo scopo della reclusione era di costringerti a pensare a una sola cosa per tutto il tempo: “Io non voglio più tornare qui”, e invece, diceva Ostilio, tu devi pensare esattamente al contrario: “Io voglio tornare qui”, perché vorrà dire che hai fatto qualcosa di buono, perché significherà che per molte ore nessuno ti romperà i coglioni, significherà che avrai davanti agli occhi tutto il peggio che ti può capitare al Franti. E tutto il peggio che ti può capitare al Franti non è in grado di scalfirti. Il buio era morbido, gentile. Era fraterno e gli faceva pensare le cose giuste. Pensò alla sua famiglia, allo zio, che tra tutti quelli che lo venivano a trovare era l’unico che vedeva volentieri, pensò alla sua camera, alla bicicletta e, ancora, alle scritte sui piloni del ponte. 214 Pensò a Dave, che non lo cercava più, e che forse non era un vero amico perché non aveva avuto bisogno di lui nel momento del bisogno. Pensò a Ostilio, il migliore di tutti, e ad Anu, uno che, se gli andavi a genio, avrebbe dato la vita per te. Alle 23:00 sentì aprire la porta. Il guardiano fece un mezzo sorriso e disse: «Hai finito», ma Nic non rispose. Rimase serio, indifferente. Arrivò in dormitorio che tutti dormivano. Si sentì più solo lì che per tutta la giornata in guardina. Si sedette sul letto, appoggiò i gomiti sulle ginocchia e mise la testa tra le mani. Rimase lì per qualche minuto, poi, quando si alzò per spogliarsi, sentì qualcuno bisbigliare il suo nome. «È una cazzata, vero?» chiese il Greco. «Sì» rispose lui, «è proprio una cazzata». «Non pensavamo ti tenessero dentro tutto il giorno». «È andata bene». «Un giorno intero per una canna… Prepuzio Solitario è davvero un bastardo…» «È andata bene così». «Andiamo a fumare, dai». Erano tutti fuori ad attenderlo e a Nic scappò un sorriso infantile. Gli offrirono subito da fumare. Ostilio, che stava ridendo di qualche oscenità detta da Nocca, gli fece posto vicino a sé e poi lo salutò con un coppino sulla nuca. «Battezzato?» gli chiese. «Battezzato». Non chiesero nulla della punizione. Questo riempì Nic d’orgoglio. Lo fece sentire uno di loro. A dire il vero, non parlarono di niente. Stavano in silenzio, ognuno assorto nei propri pensieri. 215 Nic fumava più degli altri. Quando gli arrivava la canna la teneva a lungo. Guardava gli altri e sorrideva. Si limitava a percepire le proprie sensazioni e gli sembrava di sentirle ampliate come da un riverbero. In particolare, si sentiva addosso una sensazione di leggerezza che non aveva mai avvertito prima. Era come se il passato non gli gravasse più sulle spalle, come se tutte le cose che gli erano capitate fino ad allora fossero svanite, come se tutte quelle che gli sarebbero capitate non esistessero ancora. Forse era quella la felicità. Poi, Ostilio disse: «Ragazzi, mi sembrate un po’ tristi…» «Cosa proponi?» fece Nocca. Ostilio si alzò in piedi e si girò verso la città brulicante di luci. Contemplò quella visione come un mistico in attesa della rivelazione. Gli altri aspettavano che parlasse, guardandolo come fosse il messia. «Andiamo al Pussy!» disse e tutti guardarono a valle. 216 Sono qui da cinque mesi. Google è fermo. Wikipedia se ne frega. Non scrivo più. Fallimento è l’unica parola che mi viene in mente. Qualche giorno fa ho preso a calci il computer. Glieli ho dati da acceso, così che sentisse meglio le botte, così che lo sentissi gemere e rantolare. PUM! PUM! PUM! Ha emesso gli ultimi rantoli e poi si è spento. Per un po’ non ha dato segni di vita. Poi, non so come, è ripartito. È uscito dal coma e si è riacceso. Ho sentito la mia coscienza risollevarsi. Era un segno del destino. Mi ha preso la solita eccitazione di contarmi su Google. La connessione alla rete non funzionava. Ci ho smanettato sopra mezza mattina, ma non c’è stato niente da fare. Stavo per riprenderlo a calci ma qualcosa mi ha trattenuto. Sono uno scrittore, mi sono detto, deve bastarmi la possibilità di scrivere, no? Allora ho aperto un documento word e ho scritto circa tredicimila volte “Antonio Timpano è morto, suicida tra i flutti del lago di Lecco”. Non col copia e incolla. Proprio lettera dopo lettera, parola dopo parola. 217 Sto riguardando Bergman. Vorrei essere Bergman. Avrei voluto essere Bergman. Ho visto otto volte consecutive il Volto. Tre volte Il Settimo Sigillo. Nove volte Il posto delle fragole. Vorrei scrivere un romanzo che il lettore ricomincia ogni volta. 218 Ho cucinato un risotto allo zola buonissimo. Ho finito il vino. Vorrei scendere al primo paese e farmi vedere da tutti e sentire tutti che dicono Quello lì è il grande scrittore Antonio Timpano ma allora è vivo porca puttana allora è proprio vivo il grande scrittore Antonio Timpano. Vorrei scendere entrare in un centro commerciale mangiare un trancio di pizza poi entrare in un negozio di elettrodomestici comprare un piccolo televisore poi caricarlo sulla moto risalire piano piano le curve poi entrare in casa, magari prima salutando i vicini, poi entrare in casa accendere tutte le luci spalancare tutte le finestre distendermi sul divano accendere la televisione e guardare per cinque mesi di fila la televisione dalle otto del mattino alle due di notte e guardare tutto quello che c’è e assorbirlo e rinascere e tornare ad essere una creatura pulsante vita. 219 Contrariamente a quanto era sempre accaduto, stavolta, quando si sedette alla scrivania del Rettore per il colloquio di verifica mensile, Nic non sentì alcuna emozione. Sapeva perfettamente cosa l’aspettava e questo lo rendeva estremamente tranquillo. I quadri alle pareti erano orrendi e c’era un odore di ammoniaca insopportabile. «Allora, Nicola, cosa stiamo combinando?» chiese Augusto «Addirittura la cella di isolamento, adesso?» Nic non rispose. Il Direttore attese alcuni istanti, poi inspirò violentemente e incalzò: «Ti ho fatto una domanda». Nic non batté ciglio. Dentro di sé lo stava mandando serenamente affanculo. Lo guardava di sbieco e gli sembrava che il suo viso avesse qualcosa di astuto e stupido allo stesso tempo. «Non ti va di parlare?» disse il Rettore «E va bene, parlo io». Augusto aprì una cartelletta, ne estrasse un foglio e glielo mise davanti. Poi fece alcuni passi in direzione della finestra e guardò fuori. Nic gettò una rapida un’occhiata al foglio e poi tornò a guardare davanti. «È il diagramma della tua carriera al Franti» sospirò il Rettore. «Nicola, tu lo sai che i nostri indicatori sono rigorosi e scientifici. Il numero che viene associato al tuo nome è frutto di dati incrociati elaborati al computer. Sei entrato qua dentro che eri un ragazzo a posto, un menodieci come tanti altri, un preadolescente promettente, un preadolescente ben avviato sulla strada della maturazione. Ricordi? Non davi nessuna preoccupazione perché la 220 causa dei tuoi problemi era chiara: un semplice e rimediabile disturbo aspecifico dell’apprendimento». Nic ebbe un sussulto. Era da quando era al Franti che nessuno faceva riferimento esplicito alla sua dislessia. «Guarda il foglio: da menodieci a menosettanta in un paio di mesi!» Nic continuava a fissare il vuoto. «È un record, lo sai? Da quando il Franti esiste, credo d’aver assistito solo un paio di volte a delle involuzioni così rapide e inaspettate…» Augusto si fece pensieroso e tornò a guardare fuori dalla finestra. Nic si sentiva invincibile. Poi il Rettore si voltò di scatto e gli lanciò un’occhiata al vetriolo: «Non sto a dirti la fine che hanno fatto i due in questione…» Poi tornò alla scrivania e si sedette sulla poltrona. Teneva il corpo proteso in avanti, i gomiti sul tavolo e le mani intrecciate. Cercava un segno di cedimento in Nic, un movimento accennato degli occhi o della bocca, ma il suo volto continuava a essere piatto come uno specchio d’acqua. «So che amavi andare a pesca…» Il Direttore sorrise pensando d’averlo toccato sul vivo. Aspettò un attimo e poi riprese: «Ti piacerebbe andarci domani?» Anche stavolta la domanda cadde nel vuoto. «Domani, capito? Come se non fosse mai successo niente… Come se tu fossi ancora un menodieci…» Stavolta alcuni muscoli della faccia si mossero, e il volto di Nic sembrò svegliarsi. Un attimo dopo, guardava il Rettore come fosse il più grande ipocrita al mondo. «Allora Nicola, ti piacerebbe andare a pesca domani?» «No» esclamò Nic, fermamente incazzato. 221 In quel momento, suonarono alla porta. Il Direttore si alzò dalla poltrona come ci fosse da sbrigare una delle tante formalità quotidiane. Quando aprì e vide Ludmilla stagliata sulla soglia, represse a stento la sorpresa. «Buongiorno… signorina…» fece con un tono di voce stridulo. «Ciao… Augusto…» rispose lei titubante. Aveva gli occhi arrossati e si stringeva nelle spalle. «C’è qualcosa che non va in biblioteca?» chiese lui calcando sul finale di frase. «No… tutto bene… in… in biblioteca… Ti posso parlare?» «È urgente?» chiese lui, mentre Nic si era voltato a seguire la scena con discreto interesse. «Sì». Augusto si morse le labbra e annuì, poi fece entrare Ludmilla e la fece accomodare in cucina, lontano dallo sguardo di Nic. Le versò un bicchiere d’acqua e le sussurrò che in pochi minuti sarebbe stato da lei. «Ho poco tempo a disposizione per la tua recita da duro…» «Posso andarmene quando vuole» fece Nic senza tradire emozione. «Smettila!» urlò Augusto scattando in piedi «Stai esagerando! Mi pare che tu abbia fatto fin troppe stupidaggini!» «Sarebbe a dire?» «Ripensa alle cose per cui sei finito in guardina. Ecco, quelle sono cose che non devi fare!» «Perché?» «Come perché?» «Come faccio a saperlo prima di averle fatte? Magari sono errori da compiere, magari bisogna commettere un certo numero di errori per capire cosa non bisogna fare…» 222 «Che diavolo dici?» «Lei non ha mai fatto delle stupidaggini?» Il Direttore si lasciò sprofondare nella poltrona. Non sapeva se valutare la domanda di Nic coraggiosa oppure oltraggiosa. Gettò un’occhiata verso la porta della cucina, poi fissò Nic dritto negli occhi e vide che continuava a tenergli lo sguardo. Era pronto per il menoventi. «Senti, Nicola, la prossima settimana io e te dobbiamo fare una bella chiacchierata. Sai quelle chiacchierate che risolvono tutto?» «Non sempre le parole risolvono tutto». «Sì invece. Una bella chiacchierata risolverà tutto, vedrai. Anche perché non saremo soli a farci questa chiacchierata…» «No?» «No. Ci saranno anche tuo padre e tua madre». «Bene. È un po’ che non li vedo». In quel momento, la porta della cucina si aprì e Ludmilla fece capolino. Aveva il volto pieno di lacrime. «Guarda da un’altra parte tu!» urlò Augusto a Nic trattenendo a stento un ceffone. Pochi secondi dopo, il Direttore era in cucina. «Che ti salta in mente?» «Non… non tornavi più…» «Sto lavorando, non vedi?» «Ti devo parlare». «Questo l’ho capito!» «È importante…» Augusto andò avanti e indietro un paio di volte, poi si fermò e le chiese a bruciapelo: «Sei incinta?» «Ma Augusto… cosa dici…» «No?» 223 «No. È questo che ti spaventa?» «Cos’è che mi devi dire allora?» Lei indietreggiò e andò a sedersi al tavolo. Si mise la testa tra le mani e fissò il pavimento. «Ludmilla…» «Non posso continuare così» disse, «non ce la faccio ad essere la vittima predestinata di un amore clandestino…» «Ludmilla…» Lei scoppiò a piangere. Pianse a lungo, sommessamente. «È tutto così… sporco. Non riesco a viverla serenamente questa storia. Augusto…» «Cosa?» «Tu ti accorgi che tenerlo nascosto rovina il nostro amore?» Lui annuì e le fece una carezza sul viso. Poi le diede un bicchiere d’acqua e le disse che sarebbe tornato immediatamente. C’era qualcosa che non tornava. La clandestinità del loro amore non era mai stato un problema, anzi, probabilmente era stata la miccia. Fu assalito dai dubbi. Anche il lavoro su Wikipedia aveva qualcosa di strano. Era impossibile che lei, una bibliotecaria colta ed esperta, commettesse errori del genere. L’ultimo orrore era stato quello su Voltaire, un pilota di Formula Uno che aveva vinto tre volte il titolo di campione del mondo. Non voleva andare a Praga con lui? Pensò che con Wikipedia aveva sbagliato qualcosa. Forse non l’aveva mai assecondata. Pensò che le avrebbe chiesto di scegliere lei un autore da inserire. Se non ricordava male, c’era un contemporaneo che a lei piaceva tantissimo. Sì, le avrebbe proposto di lavorare su di lui. Le avrebbe fatto compilare la voce su Wikipedia del suo scrittore italiano preferito. Perso in questi pensieri, si era dimenticato di Nic. Quando rialzò lo sguardo, il ghigno era ancora lì. Altro che menoventi. 224 «Cos’è quel sorriso?» «Quale sorriso?» «Il tuo». «Niente di che». «Nicola, alzati da quella sedia e tornatene in aula studio!» Quando Nic prese il largo, lo studio piombò in un silenzio irreale. Augusto rimase a guardare nel vuoto. Poi emise un lungo sospiro e andò in cucina. Ludmilla non c’era più. 225 Stamattina ho preso un po’ di sole. Era caldo e amorevole come se fosse intervenuto Hermann Hesse in persona. È passato un vicino e l’ho salutato. Mi sono presentato come il noto scrittore Antonio Timpano. Gli ho chiesto se voleva un mio libro autografato. Lui ha guardato la sua mucca ed è ripartito come se fosse in processione. 226 È stata una giornata magnifica. L’ho passata nei campi con Tìa, il pastore che mi tiene compagnia. Tìa è mio amico. Tìa è il mio migliore amico. Non gliene frega niente dei miei libri. Dice che tiene in casa solo un libro, la Bibbia, la sacra dorata immensa sconfinata Bibbia, ma non la legge. Non la legge perché è scritta troppo in piccolo. Tìa è mio amico. Tìa è il mio migliore amico. Non gliene frega niente dei miei libri. Né di quelli belli, né di quelli brutti, che io scriva o non scriva, che io sia pazzo o sano. Tìa ha tante mucche. Le mucche di Tìa sono bellissime. Le sue mucche sono animali meravigliosi. È bellissimo stare con loro! Con Tìa e le mucche! Devo ringraziare di nuovo Hermann Hesse per aver buttato uno sguardo quaggiù. 227 Mi è ripartito internet. All’inizio ho resistito, poi sono ricaduto nei gorghi dell’egotismo. Ho rimesso la chiavetta dopo non so quanto tempo. Connetti connetti connetti connetti… È ripartita. C’era ancora credito. Ho compiuto gesti automatici. Google. Antonio Timpano. Invio. È uscito un numero identico a quello dell’ultima volta. Poi sono andato su Wikipedia. Ho scritto Antonio Timpano. C’ero. 228 Parte Terza Rapire un ragazzino di quattordici anni non è esattamente una buona azione. E se sei un avvocato, e il ragazzino è tuo nipote, diciamo pure che hai non poche aggravanti. Ma se quel ragazzino è rinchiuso in un riformatorio ed è solo un piccolo uomo che i genitori hanno voluto estirpare dalla propria esistenza, essere suo zio ed essere avvocato diventano aggravanti se non lo rapisci. Vedere Nic con quattro ceffi più grandi dall’aria fumata, svaccato sulle gradinate del PussyPussy, con una mignotta ucraina che gli lambiva il jeans, l’aveva pietrificato. Da quando era stato affidato al padre, la vita del ragazzo era diventata quella di un orfano. Doveva portarlo via da quella prigione e, ovviamente, doveva farlo da solo. L’occasione si presentò a fagiolo solo qualche giorno dopo. Suo fratello l’aveva chiamato pregandolo di fare le sue veci a un colloquio col Direttore del collegio. Nic andava male, Nic stava prendendo una brutta piega, Nic era diventando una specie di teppista: cose così… Il problema era che suo fratello in quei giorni aveva degli impegni improrogabili. “Improrogabili un cazzo” aveva pensato lo Zio. “Sarebbe più onesto che tu stilassi un comunicato-stampa per abdicare da padre”. Uscì dall’autosrada e imboccò la stradina che portava al Franti. Parcheggiò nel cortile e vide che era in anticipo di un quarto d’o231 ra. Fece un giro. Arrivò a una terrazza che dominava il collegio. Si vedevano i campetti da gioco, le mura invalicabili, i lampioni d’inizio ottocento, le colonne di marmo finto, i pavimenti lastricati, le pareti scrostate. Nel campetto sotto di lui c’erano decine di ragazzi che correvano dietro a un pallone. Molti altri erano seduti su una gradinata a guardare. Sembrava l’ora d’aria di una prigione in un film gangsta. S’accese una sigaretta e gli venne da cantare I’m a problem child. Poi andò verso il portone e suonò il campanello. Disse che era lo zio di Nicola Pesenti. Fece l’ultimo tiro e varcò la soglia. Il Rettore si disse dispiaciuto per l’assenza dei genitori ma aggiunse che gli impegni di lavoro erano cosa sacra. Poi disse che, contrariamente a quanto preventivato, Nicola non avrebbe partecipato al colloquio perché in punizione. Lo Zio non chiese spiegazioni, si calò gli occhiali da sole sugli occhi e si preparò al monologo del Direttore. Nicola andava maluccio nelle materie tecniche, male nelle lingue, malissimo in quelle scientifiche. La dislessia non venne mai menzionata. Nicola era semplicemente un ragazzino svogliato, un “lavativo per scelta” che nessuno avrebbero mai potuto redimere. La bocciatura, insomma, era nell’aria. «A me risulta che il ragazzo sia molto intelligente» obiettò lo Zio, interrompendo l’omelia del Rettore «e che la scuola dovrebbe farlo sbocciare. La scuola dovrebbe sforzarsi di far emergere i talenti degli studenti, non crede?» «Gli insegnanti sostengono che suo nipote sia privo di talenti» rispose Augusto, scartabellando pagelle e registri. «Nessuno è privo di talenti» commentò laconico lo Zio. «Nicola non ne ha» sbottò il Rettore. 232 «Questo è altamente opinabile, Direttore» concluse lo Zio in tono assertivo e poi s’accese una sigaretta. Il Rettore parve stizzito. Gli allungò un posacenere e poi gli sventolò davanti una risma di fogli. «Guardi i nostri dati, guardi i nostri diagrammi! Li guardi!» «Mio nipote non è un’azienda. Piuttosto, mi sembra di avvertire un certo astio nei suoi confronti… umanamente, intendo». «Assolutamente». «Le ha fatto qualcosa di male? Le ha mancato di rispetto o ha messo in discussione la sua autorità?» «Nella maniera più assoluta». «Nella maniera più assoluta sì o nella maniera più assoluta no?» «No, ovviamente. Atteniamoci ai dati, alle rilevazioni…» La fase delle schermaglie era finita: era già duello, uno scontro tra l’ideatore di un istituto correttivo e un uomo che ne metteva in dubbio la validità. «E che mi dice della dislessia?» «Ah, già, la dislessia…» «Come sarebbe ah, già, la dislessia…?» sorrise lo Zio. «Dunque, il discorso sulla dislessia è… come dire… molto complesso». «Io ho tutto il giorno». «Le posso dire che il nostro psicologo, il dottor Prosperi, ha somministrato un test di controllo a Nicola. Sa, la dislessia va… come dire… misurata, periodicamente». «Ebbene?» «Il risultato dice che Nicola non rientra più nei parametri della dislessia». «Mi sta dicendo che Nic è guarito? Di cosa si occupa generalmente il vostro psicologo, di giardinaggio?» «Non dica…» «Mi perdoni… carpenteria edile?» 233 Il Direttore non rispose alla provocazione ma sentenziò che, stando ai nuovi test, tutta la storia scolastica di Nicola appariva sotto una nuova luce: Nicola aveva sempre finto. Era presumibile che in Nicola ci fosse un fondo di dislessia, ma il ragazzo ci aveva sempre ricamato sopra, ne aveva sempre approfittato… e, come se non bastasse, da qualche mese Nicola era irriconoscibile. Era diventato uno dei più disturbati dell’intero Istituto. Si era invischiato in losche vicende e più di una volta si erano rese necessarie delle misure punitive. «Insomma» incalzò il Direttore «Nicola è passato da… lei conosce il nostro metodo di valutazione comportamentale?» «Mi ragguagli, er Director». «I ragazzi sono classificati su una scala di valutazione che misura il percorso educativo. La scala va da meno dieci a meno novanta. Più si sale verso lo zero, più si torna alla normalità, si torna a galla insomma. Più si scende, più si sprofonda e ci si avvicina alla rovina». «Madonna santa… tornare a galla… sprofondare nella rovina… cos’è, la Bibbia? Ma che razza di Istituto avete messo in piedi? Per voi, questi ragazzi devono raggiungere lo zero? Per loro, la normalità è lo zero? Le devo confessare una cosa, caro il mio Direttore» aggiunse lo Zio, «poco fa mi chiedevo se da un punto di vista giuridico l’impiego di una cella di isolamento all’interno di un Istituto educativo sia legale, ma le confesso che adesso, dopo aver valutato l’Istituto nella sua globalità, posso dire che i miei dubbi sulla guardina erano quisquilie …» «Mi fa piacere che lei stia ridimensionando…» «Non sto ridimensionando un cazzo di niente». «Ah…» «Non è questione della cella di isolamento… il punto vero è che qui… tutta la merda che lei dirige… questa merda è un penitenziario!» 234 «Non c’è altro modo di correggere la crescita di…» «Non c’è altro modo nella sua inutile testa di cazzo!» Sul Direttore si dipinse una smorfia e un tremito nervoso gli attraversò il corpo, dalle caviglie alla base del collo. Lo Zio si alzò e in un attimo fu via dallo studio. Alle sue spalle il Rettore guaiva latrati infuocati. Grazie alla guida di un ragazzino, lo Zio trovò subito la classe di Nic. «Hey nipotino!» disse. «Zio!» «Vieni» gli fece mentre l’abbracciava, «andiamo via». Gli fece prendere solo il giubbetto di jeans e l’ipod. Del resto avrebbe fatto a meno. «Se ci fermano, stiamo andando a una visita medica, chiaro?» Nic non fece domande e lo seguì. Era felice di rivederlo. Incrociarono Anu. «Uè Nic, dove vai?» «Dottore». «Che culo!» Arrivarono al parcheggio e, dopo pochi secondi, l’automobile si lasciava alle spalle l’austera sagoma del Franti. «Non andiamo da nessun dottore, vero?» «Direi proprio di no». La casa dello Zio era un casermone del dopoguerra, un edificio alto e slanciato che si sviluppava su tre piani, più il solaio. Le finestre erano sigillate da inferriate e i balconi erano pieni di vasi vuoti. La parete dell’ingresso era interamente ricoperta di edera. Era arredata esattamente come l’avevano lasciata i genitori dello Zio, spoglia e austera. 235 Lo Zio accompagnò Nic al secondo piano. «Bene» disse spalancandogli uno studiolo, «da stasera tu dormi qua». «Non mi porti a casa?» «Qual è casa tua, scusa? Adesso fatti una doccia che poi usciamo a mangiare una pizza. Io faccio un salto in ufficio». Quando tornò, lo Zio trovò Nic sdraiato sul divano a guardare la tv. Nic disse che al Franti la potevano vedere una sera alla settimana, più i telegiornali. Poi uscirono. In auto, lo Zio mise su un cd. Alzò il volume fino a far tremare gli altoparlanti. Due giri di basso, poi un riff veloce e una sgroppata di accordi tesi e graffianti. La voce del cantante era un po’ stridula e nasale. Nell’inciso diceva i’m going off the rails on a crazy train. «Lo senti questo che canta?» «Sì, zio». «È un dislessico, come te!» Nic non commentò e si limitò ad ascoltare la canzone. La voce era a tratti ferina, a tratti drammatica. Verso la fine del pezzo, lo Zio abbassò il volume. «Nic, ce l’hai ancora il cd che ti ho dato l’estate scorsa?» «Certo». «L’hai ascoltato?» «Poco, però mi piaceva. Ultimamente ascoltavo altro». «Tipo?» «Un po’ di tutto… afro… noise… pop…» «Bravo! Non diventare come me, che ascolto la stessa musica da venticinque anni!» «Ascolti sempre la stessa musica?» «Sempre». 236 «Perché?» «Non so… fa parte della mia vita». «E papà, che musica ascoltava?» «Rock, anche lui. Magari più leggero del mio… ma sempre grande rock. Prima della morte della sua giovinezza, ovviamente». Adesso, nello stereo, c’era un pianoforte ipnotico che accompagnava le luci della strada e i cartelloni pubblicitari pieni di inviti alla gioia. «A te ti è morta?» chiese Nic. «Cosa?» «La giovinezza». «No» rise lo Zio, «io l’ho ibernata». 237 Un rapimento. Un rapimento a tutti gli effetti. Il padre non rispondeva. Della madre non aveva il numero. Doveva chiamare i Carabinieri? No. Il Gruppo non avrebbe apprezzato. E nemmeno lui. Il Franti non aveva bisogno di pubblicità. Il Franti era un luogo da cui non si scappava. Dal Franti si usciva. Rinnovati. Pronti per il mondo. Quel grandissimo pezzo di merda. L’avrebbe ucciso con le sue mani! Camminava avanti e indietro per lo studio. Si sentiva sempre più furioso. Andò in cucina e si versò l’ultimo goccio di vino. Lo trangugiò e tornò nello studio. «Ma come cazzo avete fatto a non accorgervi di nulla?» I guardiani stavano zitti. «Come è stato possibile, eh? COME CAZZO SI FA, ME LO DITE COME CAZZO SI FA?» «Direttore…» fece uno dei guardiani «noi… noi non c’entriamo nul…» «ZITTO! O vuoi che ti cacci fuori a pedate, eh? ZITTI! Dovete stare tutti ZITTI!» Uscì all’aria per un attimo. Davanti a sé c’era la sua creatura sprofondata in uno strano silenzio. Provò a respirare. 238 Era gente senza preparazione, gente che fino a ieri si occupava di caldaie e calcestruzzo. Era gente che non poteva occuparsi di cose tanto delicate. Era gente che non sapeva occuparsi di esseri umani. Del resto, lo sapeva. Aveva sempre dubitato della selezione del personale ma aveva erroneamente sottovalutato la cosa. Quindi, finché era in tempo, doveva mettere le mani nel motore e sostituire i pezzi. Il giorno dopo avrebbe convocato il responsabile delle assunzioni e avrebbe chiarito le cose. Si stava calmando. Trovare dei responsabili lo stava calmando. Rientrò e andò in cucina per vedere se c’era qualcos’altro da bere. Trovò solo croste di formaggio e verdura andata a male. Imprecò silenziosamente e guardò l’orologio. Erano quasi le sei. Tornò nello studio e disse ai guardiani che potevano andarsene, che li avrebbe chiamati più tardi per aggiornarli sulla situazione. Quasi le sei. Si sciacquò la faccia, si lavò i denti e si spruzzò un po’ di profumo. Poi corse fuori, verso la biblioteca. Fece i gradini tre alla volta. Quando fu sull’uscio rallentò di colpo, cercò di ricomporsi e varcò silenziosamente la porta. Ludmilla era in mezzo alla sala consultazioni e stava spegnendo le luci dei tavoli da lavoro. Era bella, seria e impettita, come sempre. Mentre ansimava, piegato sulle ginocchia, Augusto stette a guardarla. Poi lei lo vide. «Augusto, cos’è successo?» Lui non rispose. Sembrava un bambino disperato. 239 «Augusto, mi vuoi dire che cosa è successo?» «Un ragazzo è scappato» disse e continuò a fissare il vuoto davanti a sé. «Un ragazzo è scappato?» «Sì». «Augusto… Ma ti sei visto? Lo ritroveranno, vedrai. Non è così grave…» «È grave». Lui si alzò e si portò a pochi centimetri da lei. Appoggiò quasi la fronte alla sua. «Non capisci che per me questo posto è tutto? Non capisci che se questo posto va male, la mia vita è finita? Se i ragazzi fuggono, io sono rovinato!» «Ma…» indietreggiò Ludmilla «è solo scappato un ragazzo. Lo riprenderete, vedrai… anzi, tornerà lui! Oppure… pazienza… non sarà certo la fine del Franti». «Perché ti ritrai?» «Augusto… hai bevuto…» «Perché ti allontani da me? Lo stai facendo anche adesso…» «Hai bevuto, Augusto, lo sai che…» Lui fece per cingerla, ma lei si divincolò e sgusciò via lasciandolo senza equilibrio. Nello slancio, Augusto si trovò a reggersi sul tavolo. «Non stai bene. Chiamo qualcuno» fece lei irritata. «No, aspetta… mi dispiace per l’altro giorno» disse Augusto. «Anche a me». «Sono stato un idiota». «Mi hai trattata male. Non mi hai creduto. Ti ho giurato più volte che non avevo scritto io quelle cose». «Io cerco di crederti, ma faccio davvero fatica». 240 «Mi hai dato dell’ignorante davanti a tutte quelle persone». «Mi spiace… mi spiace veramente tanto… il fatto è che mi hanno cacciato, capisci? Mi hanno bandito! Non in quarantena, no! Sono bandito da Wikipedia!» Lei non disse nulla. «Ludmilla… ci tenevo tantissimo, lo sai». «E allora? Ti ho già detto che non sono stata io». «Mi hanno cacciato…» Lei sbuffò e incrociò le braccia al petto. Augusto non l’aveva mai vista così. L’insicurezza che, di solito, traspariva in ogni suo gesto era completamente sparita. «Ancora non capisci, Augusto? Perché avrei dovuto farlo?» «Per vendicarti». «Per vendicarmi? E di cosa?» «Per la fine della nostra storia…» «Sono io che ti ho lasciato, Augusto!» Le parole rimbombarono per tutta la biblioteca e Augusto si sentì frastornato. Si alzò e camminò verso la finestra. Quando fu lì, si mise una mano tra i capelli. Lei lo chiamò e lui si voltò, ma i suoi occhi caddero sul punto del pavimento in cui avevano fatto l’amore la prima volta. «Baciami, ti prego…» «Smettila». «Vieni qui…» insisté lui. Lei andò verso la ricezione e s’accovacciò per prendere la borsa. Quando si rimise in piedi, Augusto le era di fronte e aveva uno sguardo indemoniato. In un attimo le fu addosso e caddero a terra. Lui era a cavalcioni sul bacino di lei e le teneva ferme le braccia con le mani. Stringeva forte e cercava di far aderire il proprio petto al suo. 241 Ludmilla si dimenava. Quando lei, per un attimo, parve meno combattiva, lui le scivolò tra le gambe e le premette il pube addosso. Lei irrigidì le gambe come fossero di pietra. Lui le mollò un braccio e riuscì a strapparle la camicia. Alcuni bottoni volarono a terra. Poi gli riuscì di bloccarle le braccia con una sola mano. Infilò quella libera sotto il reggiseno e strinse la carne. Per un attimo, perso nel contatto della sua abbondanza, Augusto allentò la presa. Ludmilla, con un colpo di reni, riuscì a mettersi su un fianco e ad allontanarsi da lui, scivolando come una foca. Lui le tornò sopra e la bloccò di nuovo. I gemiti di lei si fecero più forti e lui, improvvisamente, li avvertì. Improvvisamente sentì i lamenti di una persona che stava subendo violenza. Era come se fino ad allora non fosse stato lì. Frastornato, allentò la presa. Lei sgusciò via e si rimise in piedi. Si sistemò i vestiti. Aveva gli occhi inondati di pianto. «Perché non… urlavi?» le chiese, in ginocchio davanti a lei. Lei si strinse nelle spalle. «Perché non urlavi? Perché non hai urlato, eh? Non hai visto cosa ti stavo facendo?» Adesso cercava i bottoncini della camicia sul pavimento. Ne trovò solo uno e se lo mise in tasca. Poi si rialzò, si sistemò meglio la gonna, indossò la giacca e riprese la borsa. Gli passò davanti e uscì velocemente. Lui la lasciò andare senza interferire. Era rimasto solo. Si alzò, spense tutte le luci e si sedette alla scrivania della ricezione. 242 Non aveva urlato. Voleva proteggerlo. Lo amava ancora. 243 Il mattino dopo, lo Zio si era svegliato presto e con un’idea in testa. La notte aveva chiamato il fratello per chiedergli com’era andato il colloquio. Il fratello aveva detto d’aver trovato delle chiamate dal Franti. Parlava col tono scocciato di chi ha cose più importanti da fare. All’una di notte. Allora lo Zio gli aveva ringhiato che Nic era con lui e che ci sarebbe rimasto un bel po’, e che se il Direttore del collegio o qualche altra testa di cazzo avesse chiamato a casa, lui avrebbe dovuto dire che Nic era con la sua famiglia perché la sua famiglia aveva deciso di portarlo via da quel merdaio. Poi aveva messo giù il telefono. Il fratello non aveva richiamato. Probabilmente qualcuno si sarebbe fatto vivo di lì a un mese, probabilmente sarebbe stata sua madre. Suo fratello. Il padre di Nic. Non era un uomo. Adesso ascoltava musica da discoteca. Gliel’aveva fatta sentire l’ultima volta che era stato con lui in macchina mentre andavano a un funerale. Un pagliaccio che urlava “senti che RROBBBA!!!” A ripensarci, ebbe un travaso di bile. Verso le otto e mezza era andato in bagno, si era lavato e vestito. Poi aveva preparato la colazione. Era andato da Nic e l’aveva chiamato. L’aveva osservato divertito, prima mugugnare qualcosa e poi sparire sotto il lenzuolo. A quel punto, aveva finto di essere 244 un guardiano del collegio e, scuotendolo vigorosamente, gli aveva intimato di alzarsi se non voleva passare una settimana nella nuova guardina extralusso. Aveva sentito Nic ridere sotto le coperte. Poco dopo, si erano trovati in cucina. «Cosa ti va di fare oggi?» «È uguale, zio». «Ti va se scongeliamo la mia giovinezza?» Dopo colazione, salirono all’ultimo piano, sollevarono una vecchia scala di ferro e l’appoggiarono alla parete vicino al solaio. Lo Zio s’inerpicò lungo quei quindici pioli e scomparve attraverso il pertugio. Una volta dentro, si spinse fino in fondo al solaio dove, tra tegole di ricambio, ragnatele e merda di pipistrello, l’attendevano una decina di scatoloni rigonfi. Stette lì a guardarli per qualche istante, col fiatone e una strana eccitazione. Poi li spinse, uno alla volta, fino alla finestrella dove spuntavano le aste della scala. C’era un vecchio paiolo legato a una fune. Saggiò la resistenza del nodo. Poi guardò di sotto titubante. «Nic, mentre calo il paiolo, togliti da sotto». Quando il primo cartone toccò terra, Nic emise un grido di gioia. «Adesso togli lo scatolone, ma non aprirlo però, va bene?» Mezz’ora più tardi, tutti gli scatoloni erano al terzo piano. Adesso restava solo di portarli al pianterreno e fu quello che fecero dopo il tempo di una sigaretta. Alla fine grondavano sudore e si abbandonarono sul divano. «Mi hai portato via da Prepuzio Solitario per trasformarmi in uno schiavo?» «Prepuzio chi?» 245 «Prepuzio Solitario, il Direttore». Lo Zio esplose in una risata fragorosa. «Sa che lo chiamate così?» «Non credo». Risero di nuovo. Lo zio aprì il primo cartone e immerse le mani. Lì dentro c’era il suo passato, un passato mille volte più intenso di quello nascosto nelle pagine di un qualunque diario. Sfogliò le prime riviste. Sentiva un’emozione profonda salirgli alla gola: migliaia di ricordi riaffioravano alla memoria e i suoi occhi non smettevano di luccicare. HM, Nuovo Metal Hammer, Metal Shock, Riff Raff… Chiome gialle e cotonate, chitarre bicorni, pantaloni in pelle, borchie, medaglioni, tatuaggi, maggiorate, palazzetti gremiti, striscioni, cover colorate, boccali di birra, corvette insaponate da ragazze in bikini… decine di immagini rivedevano la luce e andavano ad accendere le sue pupille. Estraeva la rivista, la guardava per un attimo, si perdeva da qualche parte che Nic non poteva immaginare, e poi la posava con cura sul tavolo. Continuò ad aprire cartoni, immergere le mani, estrarre riviste e affastellarle sul tavolo a decine e decine. Adesso Nic lo aiutava e, di tanto in tanto, si fermava a osservare un’immagine che l’aveva colpito. Alla fine, sul tavolo c’era una città scintillante di hard rock. Restarono lì a guardare quelle costruzioni: lo Zio padre maestro guru pronto a trasmettere la propria giovinezza al nipote adepto bisognoso d’attenzione. «Ecco Nic: qui dentro c’è la mia giovinezza». Nic annuì sorridendo. «Da dove cominciamo, ragazzo?» 246 HM. Una saetta tra le due lettere. Aprile 1993, quindicinale, il primo nell’heavy metal. In copertina il bassista dei Mister Big, alle sue spalle i nomi richiamo dei L.A. Guns e dei Black Sabbath, sotto la scritta POSTER SLAYER. Nelle prime pagine si parlava di Bruce Dickinson che stava costruendo il nuovo gruppo, dei Soundgarden che stavano registrando il nuovo disco, idem per i Pearl Jam, mentre dei Nirvana si diceva: Dopo alcuni ritardi dovuti a pazzie varie, casini mentali da successo e all’impegno di Kurt Cobain nella produzione del LP dei Melvins, i Nirvana alla fine sono entrati in una sala di Seattle per iniziare a registrare il nuovo album. «La scena di Seattle stava nascendo, ragazzino. Ciò che oggi per voi è storia, all’epoca era ancora da venire. Il Grunge… che fatica ascoltarlo… l’ho rivalutato dopo…» Lo Zio era un fiume in piena, commentava ogni fotografia. Era un’enciclopedia vivente che sputava nomi di gruppi, date, città, bassisti, batteristi, produttori, groupie, prezzi, sale d’incisione, litigi, assoli, record di vendite, cambiamenti nelle formazioni, e aggettivi, tanti aggettivi, di solito superlativi. Di tanto in tanto, si zittiva e s’immergeva nella lettura silenziosa di un trafiletto, poi scuoteva la testa e sorrideva. 247 Nic pendeva dalle sue labbra. Lo Zio si riconosceva in quel ragazzo dagli occhi incerti. Gli avrebbe evitato un sacco di menate. Il metal l’avrebbe salvato. Seguivano pagine con sfondo viola dedicate a gruppi sconosciuti e pagine su sfondo rosso dedicate ai Mr. Big, il cui bassista, Billy Sheehan, diceva che MTV e la moda avevano sconvolto il mondo del Metal. I bassisti non dovevano essere modelli di Armani! «Che capelli!» rise Nic. «Eh eh… dovevi sentirlo suonare! Faceva assoli col basso come se impugnasse una Stratocaster…» A un certo punto, lo Zio emise un fischio di stupore. Si fece serio e cominciò a leggere a voce alta. Era la storia di due gruppi che si erano fusi nella Birmingham di fine anni Sessanta, città in cui imperversano il blues bianco e la psichedelia. Dall’unione di queste due formazioni era nato un gruppo in cui si mischiavano lo spirito anarcoide del cantante e l’ossianesimo ottocentesco del chitarrista. Lo zio cercò di spiegare cosa significasse ossianesimo, ma non ci riuscì. Primi dischi venduti, discreto successo in Germania, tante speranze. Un giorno, il chitarrista ossianico – il genio creatore del gruppo – che di professione faceva il riparatore di macchine da scrivere, mentre stava lavorando in officina ebbe un incidente: il saldatore gli scivolò di mano e gli tranciò la metà superiore del medio e dell’anulare della mano destra, mano con cui impugnava la tastiera della chitarra. Per mesi tentarono di riattaccargli le parti amputate, ma non ci fu niente da fare, finché cominciò a credere che avrebbe potuto riprendere a suonare. 248 «Alla fine divenne un grande chitarrista». «E come ha fatto?» chiese Nic. «Due piccole protesi, un’accordatura più morbida e soprattutto una grande voglia di lottare contro il proprio destino». Lo Zio riprese a leggere. Il loro primo disco, intitolato Black Sabbath, uscì nel febbraio del 1970. Era un venerdì 13. Si alzò e accese il computer. Cercò un video d’annata, un live a Parigi. La macchina da presa indugiava a lungo sulle protesi. Il chitarrista era uno spilungone con dei ricci neri e dei baffi affilatissimi, più italiano che inglese. Un crocefisso gli luccicava fra peli del petto e camicia. Suonava la sua diavoletto rossa, leggermente scordata, con una corda non tagliata che si agitava tra le chiavi come uno spiritello impazzito. Il cantante, una smorfia perenne sulla faccia, aveva i capelli incollati alle tempie. Si attaccava al microfono come fosse la leva di una botola per l’inferno. Restarono per qualche istante di fronte alle immagini, poi lo Zio chiese a Nic: «Ti piace?» «Un po’…» «Solo un po’? È troppo lenta?» «Forse…» Allora lo Zio si rimise al computer e cercò un altro pezzo. Quando lo trovò, indugiò un attimo, poi mollò il mouse, si alzò, disse «Fanculo youtube!» e andò allo stereo. Inserì un cd e fece partire a palla la traccia numero 4. L’aria della stanza vibrò di hard rock. Durante l’ascolto guardò una sola volta Nic e gli sembrò di vedere lo sguardo più vivo che gli avesse mai visto in volto. Il brano squarciò il tempo e quando l’ultima nota fu sopita era come se la stanza fosse bruciata. «Ti è piaciuta?» 249 «È stupenda. Rimettila subito!» «A suonare è il tipo senza dita. A cantare è il dislessico che abbiamo sentito ieri in macchina». Riascoltarono il brano. Verso la fine della canzone Nic si era alzato dal divano e si era messo al tavolo sfogliando le riviste di un altro palazzo. «Perché queste hanno le pagine tagliuzzate?» «Perché usavo le fotografie per le copertine delle cassette». «C’erano ancora le cassette?» «C’erano solo le cassette!» Si rimisero a leggere. Scorrendo le pagine apparivano nomi sconosciuti e dimenticati, come gli svizzeri Messiah, i polacchi Vader, i The Power of Scotland, i Deicide… «Chissà che fine avrà fatto tutta questa gente…» si chiese lo Zio. Poi capitarono sulle pagine dei messaggi dell’epoca. Lo Zio ne lesse alcuni. Morboso gruppo già avviato di creature infernali cerca con urgenza un qualsiasi essere vivente che picchi su una qualche batteria! Cercasi disperatamente gente “seria”! Ma dove cavolo è finita tutta quella gente che il 16/11/92 affollava il Palaghiaccio con i Metallica?! Sono un metallaro, anche carino che vorrebbe corrispondere o conoscere ragazze metallare sotto i 15 anni di Roma. Stop! Ami l’heavy metal? Adori I fumetti? Sei una ragazza? Non hai problemi per spedirmi una tua “foto-sexy” di presentazione? (va bene anche un bikini marino). Allora 250 scrivi: ho 23 anni e un sacco di voglia di conoscerti (diavoletto). Cerco disperatamente l’indirizzo di Tony, metal kid di Salerno, conosciuto il 21/4 al Jefferson Club di Montecatini. Quella sera indossava il chiodo e la felpa dei Megadeth. Chi lo conosce gli dica di scrivermi a questo indirizzo… Hello mi chiamo Max, sono un metal boy di 17 anni e sono solo. Vorrei fare amicizia con tanti metal boy e girls della mia zona e anche per fare una band. Gli strumenti li ho io telefonatemi in ore serali. Hi guys! Avete 17-21 anni e volete vivere l’esperienza più sconvolgente della vostra vita? allora siete pronti per conoscere la persona più psico-dinamica che si sia mai messa sulla vostra strada. Gradita la foto. «Leggevi ’sta roba, zio?» «Certo» rispose lui sorridendo. «Non riesco a immaginarmelo…» Ne lessero un’altra. L’heavy metal è stata la mia salvezza; già lo ascoltavo da più di due anni eppure non avevo mai saputo cogliere quell’energia così tanto come qualche mese fa, quando volevo uccidermi a causa d’una delusione da un tipo (anche lui metallaro!). E ora direste “che stupida” eppure l’avrei fatto se non ci fosse stato Ricky che in una lettera mi scrisse: “… così faresti vedere a tutti che sei una perdente, e i metallari non sono perdenti: mai!!!” 251 «Scrivevi anche tu alle riviste?» «No, troppo timido e insicuro, io non ero normale. Tu sei dislessico; io non riuscivo a stare in mezzo agli altri. Mi facevano paura, mi sentivo a disagio. Con l’heavy metal tutto spariva. Capisci?» «Zio… mi stai facendo un predicozzo?» «Boh… perché?» «Mi fai ascoltare un dislessico, mi parli dei tuoi problemi… vuoi farmi capire delle cose, vero?» «Forse sì… ma forse no, forse stiamo solo sfogliano riviste metal… forse stiamo solo scongelando la mia giovinezza…» Andarono avanti per tutta la mattina. Di tanto in tanto, trovavano qualcosa che faceva scattare in piedi lo Zio. A Nic piaceva il suo entusiasmo, come se vedere un adulto che s’emoziona fosse una cosa strana. «Guarda qua… il batterista dei Kiss annuncia NON SONO MORTO… ERIC HA DECISO DI USCIRE ALLO SCOPERTO PER SMENTIRE QUESTI STUPIDI PETTEGOLEZZI… Nuovo Metal Hammer… luglio 1991…» Le voci sulla mia presunta dipartita da questo mondo sono state gonfiate moltissimo. Il cuore sta in una sacca, e normalmente tra la sacca e il cuore non c’è nulla. Ma quando arriva un’irritazione, si forma un fluido, il che è esattamente quello che è successo. Può essere pericoloso, se trascurato, ma ho preso delle medicine e mi sono subito sentito meglio. Poi mi hanno operato. Ero in piedi tre giorni dopo l’operazione. Nel pomeriggio mi hanno tirato fuori dalla terapia intensiva e dopo due giorni gironzolavo per l’ospedale. Insomma, mi hanno operato martedì e venerdì ero già pronto per andare a casa. In 252 realtà, non fosse per una piccola cicatrice sul petto, non saprei neanche di aver subito un’operazione! «Poveraccio…» commentò lo Zio. «Che fine ha fatto?» «È morto quattro mesi dopo». Lessero ancora. «Dimmi se questo non è incredibile! Gli Iron Maiden… 28 aprile ’93, gli Iron Maiden, no dico, gli Iron Maiden, guarda un po’ dove suonavano… Majano, campo sportivo!» «Dov’è?» «Boh! È questo il bello, no? E il resto della tournée? Domenica 2 maggio: Reggio Calabria! E i Ramones? Dove ti suonavano i Ramones in quella primavera del ’93? No, dico, i Ramones! A… Gaio di Spilimbergo! Hai la minima idea di dove si trovi Gaio di Spilimbergo?» Quando ebbero finito, spinsero i cartoni in un angolo della sala e lo Zio disse a Nic che da quel momento le riviste erano sue. «Ma zio… è una parte della tua vita». «La parte migliore della mia vita». «Appunto: non puoi privartene». «Sono più utili a te, adesso. Voglio che tu ti faccia una cultura. Voglio che ti appassioni al metallo. Voglio che questa musica ti aiuti». «Ma… se non riesco nemmeno a leggere…» «Ci sono tante foto. Leggerai quel poco che serve». «Zio…» «E non è tutto». «Cos’altro c’è?» Lo Zio gli porse due cartoncini rettangolari. 253 «Stasera andiamo a un concerto». «Zio!» «Il cantante dislessico non è in tournée, purtroppo, ma il chitarrista menomato l’ho trovato!» Mentre correvano sull’autostrada, lo Zio enumerò tutti i concerti a cui aveva assistito, dal primo degli Whitesnake quando aveva quindici anni all’ultimo dei Pearl Jam, un paio d’anni prima. Di tanto in tanto, interrompeva i racconti e riprendeva l’adagio che era diventato il must della giornata: il metal gli aveva salvato la vita. «Ti porterò al Gods, che è il massimo!» Si fermarono all’autogrill per bere qualcosa e fare benzina. Lo Zio notò che gli occhi del nipote si perdevano lontano. «Tutto bene?» «Sì, zio». «A cosa pensavi?» «Ai miei amici… a cosa staranno facendo in questo momento…» Ripresero il viaggio e lo Zio sentì che l’eccitazione saliva. Tra di loro c’era una piacevole armonia e passarono tutto il resto del viaggio sghignazzando e fumando insieme qualche sigaretta. Arrivarono verso le 19:00. Parcheggiarono senza fatica a poca distanza dallo stadio. Lo Zio era perplesso. Non si spiegava perché non avessero trovato centinaia di auto parcheggiate. Quando arrivarono ai tornelli, videro radi gruppi di ragazzi che bivaccavano sull’asfalto. Le transenne per la fila erano deserte, alcune persone stavano smontando dei tabelloni luminosi e gli ambulanti ammainavano le magliette. «Oh-oh…» fece lo Zio, rallentando il passo. 254 Prepararono i biglietti, s’avvicinarono a un tornello ma furono fermati da un ragazzo della sicurezza. «Come annullato?» chiese lo Zio. «Un malore improvviso». «Di chi?» «Il cantante, mi sembra. Per il rimborso del biglietto deve…» Lo Zio non ascoltò nemmeno il resto della frase. Si voltò verso Nic e gli lanciò uno sguardo disperato. Nic gli rispose con un cenno delle spalle, come a voler dire che non importava. Poi si diressero verso un gruppo di ragazzi che bevevano birra seduti su un marciapiede. Lo Zio gli chiese se sapevano qualcosa e loro risposero che Ronnie James Dio aveva un tumore. Il gruppo aveva interrotto la tournée. La notizia era apparsa sul sito degli Heaven and Hell diversi giorni prima ma l’annullamento del concerto era stato comunicato ufficialmente solo la sera precedente. Lo Zio, dopo aver masticato una bestemmia, chiese cosa ci facevano lì se sapevano già tutto. «Abbiamo pensato che… magari… suonavano lo stesso. Abbiamo sperato fino all’ultimo». «Però quelli che organizzano sono dei bastardi». «Vabbé ragazzi…» fece lo Zio «… l’avviso sul sito c’era… sarà per la prossima…» «Speriamo… non è mica messo tanto bene…» «Lo rivedremo presto. Vedrete, Dio se la caverà». Nic e lo Zio salutarono e si allontanarono mestamente. Uno dei ragazzi li chiamò e alzando una birra al cielo urlò: «Long life to rock and roll!» Lo Zio fece le corna con la mano destra. Vagarono per qualche minuto senza meta, poi si sedettero su una panchina e rimasero sconsolati a guardare il retro delle gradinate dello stadio. 255 «Zio, guarda che non fa niente… davvero». «Ok, Nic. Andiamo a mangiare un panino?» «Sì». «Sai dove andiamo dopo?» «Dove?» «Al mare». «Al mare?» «Andiamo a trovare un amico. Ci saremmo andati domani, ma a questo punto possiamo andare stasera! È un tipo in gamba, e voglio che tu lo conosca». La faccia di Nic fece un’espressione vagamente triste. «Non ti va?» «Mmh… zio, ascolta… non offenderti per quello che sto per dirti». «Non mi offendo». «Tutto quello che stai facendo è molto bello, anzi bellissimo. Mi hai portato via dal Franti, mi vuoi regalare la tua collezione di riviste, mi hai portato a un concerto…» «Concerto che è stato annullato». «Vabbè, non è colpa tua, no?» «Bastava guardare sul sito, cazzo…» «Chissenefrega! Mi hai fatto un bellissimo regalo. Sono stati due giorni magnifici». «Però, c’è un però, vero?» «Sì…» Nic guardò per terra. Per la prima volta tra loro si stava creando una distanza. Capendo che il discepolo si stava allontanando, il padre maestro guru si sentì indifeso. «Cosa c’è, Nic?» «Niente…» Lo Zio si sentì ferito nell’orgoglio, ma poi allontanò il dolore, guardò il ragazzo e capì. Lo Zio doveva smettere i panni di guru 256 padre maestro e accontentarsi di fare l’adulto. Sollevò il mento di Nic e gli grattò la testa. «Ho capito dai… non fa niente. Ci andremo un’altra volta». «Sì?» «Sì». «Mi spiace, zio…» «Non importa. È giusto che facciamo come vuoi tu». «Grazie, zio…» «Ti manca tanto quella cazzo di cella di isolamento, eh?» Risero e s’incamminarono verso l’auto. 257 Dave trovò la porta aperta ed entrò senza bussare. L’ondata di luce del tramonto attraversava radente la stanza costringendolo a chiudere gli occhi quasi del tutto. Quando riuscì a focalizzare, vide davanti a sé un lungo tavolo su cui erano sparsi riviste e quotidiani. Attorno al tavolo, erano tutti assorti a leggere. Verificò che non ci fosse il Rettore. Non sapeva perché era salito fino alla Sala Lettura dei professori. Sapeva solo che non poteva farlo. Sempre lottando contro il sole, individuò Yale, seduto all’estremità opposta del tavolo. «Professore…» sussurrò quando fu alle sue spalle. «Eh?» fece Yale «Ah, sei tu Dave. Che ci fai qua?» «Disturbo?» «No, no… stavo leggendo un articolo. Non leggo quasi mai la cronaca nera, ma in questo caso… vabbé, niente di importante… dimmi pure». «Ha saputo?» Yale lo guardò con sguardo interrogativo, poi ebbe un sussulto e capì. «Di Nic, dici? Sì, il Direttore mi ha riferito…» Ci fu un attimo di silenzio. Un paio di persone avevano sollevato lo sguardo mostrando di non gradire il brusio. «Sarai dispiaciuto…» «Moltissimo… non ci siamo nemmeno salutati». «Ti piacerebbe essere al posto suo?» «Magari… a quest’ora sarei già in un altro continente». 258 «Addirittura! A fare che?» «Non so…» Yale non era amato dai colleghi e gli sguardi di disapprovazione stavano aumentando. «Questo è un posto sacro» bisbigliò alzandosi dalla sedia, «è un sacrilegio interrompere la lettura dei quotidiani. Andiamo a berci un caffè». Mentre seguiva il professore, Dave si sentì invaso da un profondo scoramento. In quel momento, capì perché era salito fin lassù. Era una speranza assurda, immotivata, illogica, e non si spiegava perché gli fosse venuta. Era salito fin lì perché sperava che Yale lo facesse scappare o che, semplicemente, lo invitasse alla fuga. Era venuto fin lì perché sperava che Yale fosse il suo salvatore. Ognuno di loro aveva diritto a una speranza, no? Invece, Yale gli aveva detto poche parole, tre delle quali erano state: «Fa’ come Elvis». Quel pomeriggio Dave si sedette al banco e aprì svogliatamente il libro di storia. Già a metà del primo paragrafo, iniziò a fantasticare. La sua mente sollevò ampie volute attorno al verbo fuggire. Lo osservò da diverse angolazioni. Prima quella squadrata e astratta dell’infinito (fuggire, appunto); poi quella sferica e ipotetica del congiuntivo (fuggissi); poi quella spiraliforme e speranzosa del gerundio (fuggendo); infine quella piana e saporosa dell’indicativo. Gli piacque così tanto la concretezza dell’indicativo che coniugò il verbo in tutte i suoi tempi e assaporò immagini e sensazioni che da ogni tempo verbale scaturivano. Io adesso fuggo da qui. Esattamente una settimana fa, io fuggivo. 259 Io sono fuggito di prigione. Figli miei, quell’anno io fuggii… Con un ruggito io ero fuggito. Nipoti cari, il giorno in cui io fui fuggito… Maledetti voi tutti, io fuggirò! Non appena io sarò fuggito, l’uomo che è in me finalmente potrà sbocciare. Rispetto a quella di Nic, la sua fuga sarebbe stata diversa. Lui sarebbe fuggito da solo e fuggire da solo significava bucare da solo il bozzolo. La fuga di Nic, a dirla tutta, era stata facile. Era stato un parto indotto, un cesareo, una cosa aiutata dal forcipe. E poi non era stata una fuga verso la libertà. Nic era passato da una custodia all’altra. Era fuori dal Franti ma doveva comunque rendere conto a suo zio. Dave, invece, voleva scappare da solo e liberarsi di ogni legaccio. Voleva essere libero e lontano da tutti, in luna di miele col suo libero arbitrio. Non sarebbe stato facile vivere da solo ma ce l’avrebbe fatta. Sarebbe andato a Parigi, o Berlino, oppure a Londra (meglio Londra: l’inglese, per lui, era più che una seconda lingua). Era un ragazzino, ma era certo che se la sarebbe cavata. A Londra avrebbe trovato lavoro come sguattero in qualche ristorante italiano (ma anche non italiano) e una stanza dove dormire. Ce l’avrebbe fatta, se lo sentiva. Era un ragazzino, era vero, ma si sarebbe arrangiato. Portò le dita al viso e si accarezzò le guance: da qualche settimana sentiva qualcosa di ispido spingere da sotto la pelle. Con la barba sarebbe sembrato più grande. Con la barba, degli stivaletti e un giubbotto di pelle avrebbe dimostrato anche diciassette anni. Guardò i suoi compagni e sogghignò. Ancora poco, e non avrebbe più visto le loro facce rozze e stupide, non avrebbe più sentito i loro inutili discorsi. Pochi giorni e non avrebbe più avu260 to a che fare con quella giungla maledetta dove violenza e ignoranza imperavano incontrastate. Il ghigno si trasformò in una risata incontrollata e Giacomo, di un posto davanti a lui, si girò a guardarlo. Dave rispose con una smorfia e abbassò la testa sul libro, fingendo di rimettersi a studiare. La grande fuga. Fuga per la vittoria. Fuga da New York. Sì, sarebbe andato a Londra per essere libero. Libero di essere libero, in barba al Rettore e alla bibliotecaria, in barba a Nic e a Ostilio, in barba a sua madre e a suo padre. In barba grazie alla barba. Doveva passare a salutare Yale? No, neanche lui aveva colto il suo dramma interiore. Se ne sarebbe andato, anche in barba a Yale. In preda all’eccitazione, passò l’intera giornata trascurando gli impegni scolastici. Quella sera, infilatosi a letto col proposito di escogitare un piano di fuga, venne disturbato dalle voci provenienti dalla camerata di fianco. 261 Nic varcò il cancello con passo sicuro. Poi si voltò e vide che lo Zio era ancora là, col motore acceso e lo sguardo fisso su di lui. Gli aveva ripetuto più volte che sarebbe rientrato da solo, che avrebbe parlato da solo al Direttore, che avrebbe sistemato tutto da sé. Lo Zio aveva insistito per accompagnarlo, ma lui era stato categorico. Vide che gli faceva gli abbaglianti e che finalmente l’auto si muoveva. Gli restituì il saluto sbracciandosi vistosamente. Riprese a camminare e, dopo aver gettato un mezzo saluto al portinaio (che poco prima, preso dalla tv, gli aveva aperto il cancello senza reazioni particolari al suo cognome), si diresse verso l’appartamento del Direttore. Stava bene, immerso nella tiepida notte di maggio: i cortili erano tetri e silenziosi ma il profumo dei mandorli lo rassicurava. Salì a balzi i gradini che portavano al porticato e quando fu di fronte alla porta del Direttore suonò senza indugio. Il trillo rimbombò nella notte e Nic si guardò intorno per vedere se qualcosa reagiva allo stimolo. Aspettò qualche istante e risuonò. Nessuna risposta e nessun movimento all’interno. Allora, voltò le spalle alla porta e si appoggiò alla balaustra per sbirciare attraverso la finestra. Dentro era tutto fermo. Decise di andare a dormire. Era quasi mezzanotte. Si chiese che faccia avrebbero fatto gli altri, vedendolo. Gli avrebbero chiesto perché era tornato. Sicuramente Anu l’avrebbe preso in giro. Il Greco pure. Ostilio, invece, avrebbe capito. 262 Affrettò il passo. Salì le scale cercando di fare poco rumore. Quando aprì la porta del dormitorio, sentì una strana sensazione, una specie di rimorso che gli si diffondeva nel corpo come un liquido. Passò per il dormitorio di Ostilio e gettò un’occhiata verso il suo letto vuoto. In quel momento, un’ombra si sollevò da un letto a destra. A occhio, doveva essere quello di Marco, il menonovanta più intelligente del Franti. «Chi sei?» si sentì chiedere. Nic si avvicinò e si fece riconoscere. «Nooo! Che ci fai qui?» esclamò Marco balzando in piedi. «Non c’è Ostilio?» chiese Nic. «È successo un casino…» «Quando?» «Ieri, dopo che te ne sei andato». «Che casino?» «Il Direttore era incazzato… dopo cena ci ha convocato tutti in Aula Magna e ci ha fatto una predica delle sue, una tirata interminabile, di quasi mezz’ora. Sbraitava come un pazzo. Io e Ostilio, da dietro, ce la ridevamo di gusto. Aveva la pelata bordeuax! Pestava i piedi a terra. Ha mollato una sberla a un tipo in prima fila. Uno spettacolo!» «Ah… e cosa ha detto?» «Il Direttore? Ne aveva per tutti! I suoi sermoni apocalittici. Ma te, tranquillo, non ti ha nemmeno nominato! Poi…» Marco s’interruppe cercando di soffocare le risate. «Poi?» «Poi, a un certo punto, Ostilio si è alzato in piedi e… non ci crederai mai Nic… immagina la scena: il Direttore sta parlando, con la pelata rossa, tutta la sua prosopopea, sai come fa lui, no? 263 Ci sta tirando tante di quelle storie che non immagini: e voi non vi rendete conto di quanto la vita sarà amara con voi… e le vostre famiglie proveranno vergogna per voi… e le vostre madri malediranno il giorno in cui vi hanno messo al mondo… eccetera, tutto il suo frasario da Savonarola, presente? Ecco… allora, a un certo punto, Ostilio si mette in piedi e apparecchia uno dei suoi ghigni terribili, sai quelli che tutti pensano ‘Adesso ne spara una grossa’ o che significano ‘Mi passi direttamente le chiavi della guardina’, quei ghigni lì, hai presente? E appena il Direttore lo vede, ammutolisce. Allora Ostilio alza un braccio… e non ci crederai mai! Sta’ a sentire cosa gli ha detto…» «Cosa?» «Gli ha detto: “Ma Direttore, cos’è che la rende più nervoso, oggi? La scomparsa di Nic o quella della bibliotecaria?”» Marco pronunciò a stento le ultime parole. Stava facendo tanto rumore che un paio di ragazzi s’erano svegliati. Riprese a raccontare com’erano andate le cose e quando finì chiese a Nic se aveva voglia di fumare. Nic rispose che era stanco, che preferiva andare a letto. «Nemmeno un tiro?» «No Marco, grazie, davvero…» Salutò e s’incamminò verso la sua camerata. Lì dormivano tutti e c’era più buio che negli altri stanzoni. Brancolò fino a trovare il suo posto. Aprì la porticina ed entrò nel piccolo spogliatoio. Si chiuse dentro e accese la luce per cambiarsi. Alla vista di quel piccolo mondo, sentì di nuovo quell’amarezza liquida diffondersi nel corpo. La sentiva espandersi dal torace fino alle braccia e alle gambe. Un minuto dopo, era nel letto con le coperte fino agli occhi. Ascoltò il respiro dei compagni, i loro piccoli gemiti, gli impercettibili lamenti. Ripensò a quello che suo zio gli aveva detto del padre. Cercò di immaginarselo da gio264 vane, ma non riuscì ad andare oltre le poche foto di cui serbava il ricordo. Riusciva invece a immaginare il volto di tutti i suoi amici del Franti. Per un po’ cercò di prender sonno ma senza successo. Allora uscì dalle coperte e si mise a sedere sul letto; cercò le ciabatte e se le infilò. Camminò silenziosamente attraverso un paio di camerate e subito trovò il letto che cercava. S’avvicinò, sbirciando nel buio. «Dave… sei sveglio?» bisbigliò. «Chi sei?» si sentì chiedere da una voce mezza addormentata. «Nic». Dave restò immobile, come se si fosse appena materializzato un fantasma. «Sono Nic!» «Quale Nic?» «Nic». «Nic Nic?» «Nic». Dave si tirò su lentamente. Aveva la bocca impastata e le parole gli uscivano a fatica. «Sei venuto a prendere le tue cose?» «No». «Ti ha beccato la Polizia?» «Ma che dici…» «Senti Nic, devo dirti una cosa importante…» «Ti ascolto». «Anch’io voglio scappare. Me ne voglio andare da qui!» «Bene» rispose Nic, sorridendo nel buio. «Voglio andarmene in luna di miele col mio libero arbitrio». «Andartene dove?» «A Londra». «A Londra» ripeté Nic. «E quando?» 265 «Appena mi cresce la barba». «Eh?» «A Londra diventerò me stesso: la barba bucherà il bozzolo e uscirà un Dave con le ali». «Che cazzo dici, Dave?» «Niente. Ma tu che ci fai qui? Perché sei tornato?» Fece un passo verso la finestra e guardò fuori, verso l’abitazione del Rettore. Poi guardò in cielo e per qualche istante si perse nel pallido alone della luna. Tornò verso Dave che era sempre lì ad aspettarlo. «Nic! Hey Nic!» «Cosa c’è?» «Ti va di scappare con me?» «Eh eh eh… dai Dave…» «Il tuo piano era sbagliato! La tua fuga era cesarea. Devi ascoltare il mio piano di fuga». «E quando vorresti scappare?» «Come quando? Adesso ovviamente!» Nic scosse la testa e sorrise. «Va bene. A una condizione, però». «Quale?» «Niente Londra». «E dove si va allora?» «Dove ci sono le balene». Più tardi, sotto le coperte, pensò che era giusto così. Avrebbe sempre fatto in tempo a uscire di prigione. Un anno di buona condotta e via. Il Franti non era che una parentesi. Un problema di fondo irrilevante se paragonato a ciò che aveva trovato lì dentro. Gli amici erano preziosi. Era giusto viverseli ancora un po’. 266 Arrivò sulla costa adriatica verso le undici. Era una bella giornata e il mare luccicava come carta stagnola. Poco prima, Klaus al telefono gli aveva spiegato dove lasciare la macchina. Lo Zio scese, si stiracchiò, calò gli occhiali da sole sugli occhi e s’incamminò. Gli venne da pensare a Nic. In quel momento, probabilmente, era sotto le grinfie del Rettore, anzi sicuramente era già in guardina. Stizzito, tirò un calcio a un sasso e proseguì per la sua strada. Pochi minuti e arrivò al mercato. La maggior parte delle bancarelle vendeva abbigliamento; poche frutta e verdura; uno era un chiosco di fritti; un paio vendevano giocattoli molto datati. In coda a tutti, lo Zio riconobbe Klaus, anche lui dietro un bancone. Si abbracciarono. «Come ti va?» chiese lo Zio. «Non male». Non si vedevano da mesi, dalla vendita del Prisma. In tutto quel periodo, si erano scambiati solo qualche sms ma non si erano sentiti. L’amico raccontò che in poco tempo la faida dialettica tra gli spinoziani e i giardinieri s’era trasformata in una guerriglia urbana. Niente di catastrofico, a dire il vero: dopo un paio di attacchi all’arma bianca in pieno centro cittadino, i Carabinieri avevano arrestato i più facinorosi e fatto chiudere i battenti a entrambi i circoli culturali. Girava voce che gli scontri continuassero, però, in un sottopasso dell’autostrada, al riparo da occhi indiscreti. Klaus stesso aveva visto Ruopolo segnato in faccia e claudicante alla gamba destra. Si diceva che, con un morso, avesse stac267 cato una falangina al Direttore editoriale di Mistagogia, prima di essere pestato a sangue dal campione messo in gioco dalla squadra del Giardino Virtuoso. Klaus si era defilato dalle rappresaglie ideologiche e si era cacciato in una nuova avventura imprenditoriale. Sulla bancarella aveva centinaia di libri suddivisi per editore. Alle spalle del banco, c’era un furgoncino rosso tutto sgarrupato da cui partiva una piccola tenda per riparare la merce da sole e intemperie. Aveva una sedia in vimini e un tavolino di plastica su cui erano appoggiati alcuni giornali e un piatto vuoto. «Che idea t’è venuta, stavolta?» «Niente di speciale». «Una cosa normale non sarebbe da te. Ti va una birretta?» chiese lo Zio. «Magari… però non posso muovermi da qui». Due minuti più tardi, Klaus chiacchierava con una signora. La tipa aveva chiesto qualcosa di Camilleri e Klaus le aveva proposto un paio di titoli. Restarono a parlare per un po’, entrambi infervorati dalla discussione. Poi la signora pagò e se ne andò. «Allora, che storia hai messo in piedi?» chiese lo Zio. «Una specie di lotta per la sopravvivenza». «Spiega». «Ho preso tutti i miei libri, li ho caricati sul furgone e sono partito». «Per?» «Vedere quanto sopravvivo». «Eh?» «Dormo sul furgoncino. Mangio e bevo solo coi libri che vendo». «Una specie di sfida?» 268 «Più o meno». «Perché?» «Mi sono sempre chiesto a cosa servono i libri, anzi, mi sono sempre chiesto se servono veramente a qualcosa». «E come va?» «Certi giorni un panino e un’acqua minerale; altri un piatto di spaghetti e una birra». «E i tuoi biscottini Lotus?» «Merce rara». Lo Zio gli diede la birra e brindarono. Poi prese ad aggirarsi intorno alla bancarella in cerca di qualcosa. Un motorino passò davanti a loro infettando l’aria di miscela. «Sai una cosa?» «Cosa?» «Proprio ieri pensavo al mio soprannome». «Eh». «Lo sai come mi chiamo, vero?» «Certo». «Intendo, il mio vero nome». «Certo, Zio». «Sentiamo, come mi chiamo?» «Beppe». «Temevo non lo ricordassi». Finirono le bottiglie e lo Zio chiese a Klaus se ne voleva un’altra. «Però stavolta offro io». «Cos’hai venduto oggi?» «Un Camilleri e un Timpano». «E basta?» «Basta». 269 «Allora offro io». Lo Zio si stiracchiò, si calò gli occhiali da sole e andò verso il bar. Percorrendo la strada affollata del mercato vide la spiaggia, rallentò e si appoggiò al parapetto. Gli ombrelloni erano scossi dal vento e i bambini correvano a perdifiato sollevando nuvole di sabbia. In riva, alcuni ragazzi giocavano a pallone, uno di quegli orribili Super Santos che volano bizzosi e incuranti di ogni gesto tecnico. Il fragore del mare copriva i rumori ed era curioso essere vicino alle persone senza sentirne la voce. Si percepiva, tuttavia, la felicità. Nei loro corpi, nei visi, nei gesti delle mani. Lo Zio accese una sigaretta e pensò che sarebbe stato bello essere lì con Nic. Per un attimo, gli parve perfino di vederlo sorridere sul bagnasciuga. 270 Il cadavere dello scrittore Antonio Timpano, da mesi scomparso e dato per suicida, è stato rinvenuto ieri mattina dai Carabinieri di A. all’interno di un’abitazione sita nel comune di R. I Carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un abitante del luogo, M. L., un pastore residente a R. che da qualche tempo era entrato in confidenza con lo scrittore. I Carabinieri, dopo aver forzato la serratura dell’ingresso principale, hanno rinvenuto il corpo di Timpano impiccato ad una corda appesa a una trave del soffitto. Non si conoscono i motivi del gesto, né dell’ancor più misterioso suicidio inscenato precedentemente dal Timpano sulle rive del Lago di Lecco. Al momento, l’unica certezza è che lo scrittore deve aver trascorso gli ultimi mesi nella stessa abitazione in cui è stato ritrovato, un rifugio solitario con pochi collegamenti col mondo esterno: una radio e un computer. Proprio l’analisi del computer, già sotto l’esame degli inquirenti, potrebbe rivelare impor- 271 tanti retroscena sugli ultimi mesi di vita di Timpano. Al momento dell’ingresso dei Carabinieri, il computer era fermo sulla pagina di Wikipedia dedicata allo scrittore stesso. Una pagina piena di inesattezze circa la vita e le opere di Timpano che viene definito “il peggior scrittore che l’Italia abbia mai avuto” e che in alcuni passaggi viene paragonato ad un “verme incapace di intendere e volere, finito a scrivere libri di dubbia esattezza sintattica e scarso valore semantico”. Le figlie e la moglie dello scrittore, per ora, non hanno rilasciato dichiarazioni. 272 Ronnie James Dio (pseudonimo di Ronald James Padavona) è morto a Houston il 16 maggio 2010 al termine di una lunga malattia. Indice Parte Prima p. 7 Parte Seconda p. 125 Parte Terza p. 229 Collana Dry 1. Gobbi come i Pirenei, Otello Marcacci (II ed.) 2. Quattro soli a motore, Nicola Pezzoli 3. Dio se la caverà, Alan Poloni Collana Iena 1. E morirono tutti felici e contenti, AA.VV. – a cura di Massimo Avenali (II ed.) 2. Tre Io, Mario Rossi 3. I cani là fuori, Gianni Tetti 4. Antropometria, Paolo Zardi 5. Trema la terra, AA.VV. – a cura di Isabella Tramontano 6. Le 13 cose, Alessandro Turati 7. Il giorno che diventammo umani, Paolo Zardi (II ed.) Collana Potlach 1. Palace of the end, Judith Thompson 2. L’uomo che viaggiava con la peste, Vincent Devannes 3. Il sale, Jean-Baptiste Del Amo (II ed.) Collana Intimate 1. La mia Waterloo ventricolare, Roberto Di Egidio 2. Poesie antirughe, Alessandra Racca (III ed.) 3. Testamento di un poeta cimiteriale, Mauro Petrarca 4. L’amore non si cura con la citrosodina, Alessandra Racca Collana i Nei 1. Coi binari fra le nuvole (cronache dalla Transiberiana d’Italia), Riccardo Finelli (II ed.) 2. Circo Itaglia, Pep Marchegiani 3. Guida alla vita laica, Roberto Anzellotti Finito di stampare nel mese di febbraio 2014 presso Geca Industrie Grafiche – San Giuliano Milanese (MI) per conto di Neo Edizioni Printed in Italy Impaginazione e prestampa: Lucio E. Berardinelli Ristampa 3 2 1 0 2014 2015 Anno 2016 2017
Scaricare